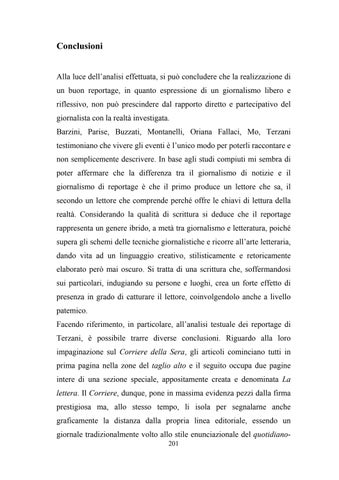Conclusioni
Alla luce dell’analisi effettuata, si può concludere che la realizzazione di un buon reportage, in quanto espressione di un giornalismo libero e riflessivo, non può prescindere dal rapporto diretto e partecipativo del giornalista con la realtà investigata. Barzini, Parise, Buzzati, Montanelli, Oriana Fallaci, Mo, Terzani testimoniano che vivere gli eventi è l’unico modo per poterli raccontare e non semplicemente descrivere. In base agli studi compiuti mi sembra di poter affermare che la differenza tra il giornalismo di notizie e il giornalismo di reportage è che il primo produce un lettore che sa, il secondo un lettore che comprende perché offre le chiavi di lettura della realtà. Considerando la qualità di scrittura si deduce che il reportage rappresenta un genere ibrido, a metà tra giornalismo e letteratura, poiché supera gli schemi delle tecniche giornalistiche e ricorre all’arte letteraria, dando vita ad un linguaggio creativo, stilisticamente e retoricamente elaborato però mai oscuro. Si tratta di una scrittura che, soffermandosi sui particolari, indugiando su persone e luoghi, crea un forte effetto di presenza in grado di catturare il lettore, coinvolgendolo anche a livello patemico. Facendo riferimento, in particolare, all’analisi testuale dei reportage di Terzani, è possibile trarre diverse conclusioni. Riguardo alla loro impaginazione sul Corriere della Sera, gli articoli cominciano tutti in prima pagina nella zone del taglio alto e il seguito occupa due pagine intere di una sezione speciale, appositamente creata e denominata La lettera. Il Corriere, dunque, pone in massima evidenza pezzi dalla firma prestigiosa ma, allo stesso tempo, li isola per segnalarne anche graficamente la distanza dalla propria linea editoriale, essendo un giornale tradizionalmente volto allo stile enunciazionale del quotidiano201