

UFFICIO S T ORICO



UFFICIO S T ORICO
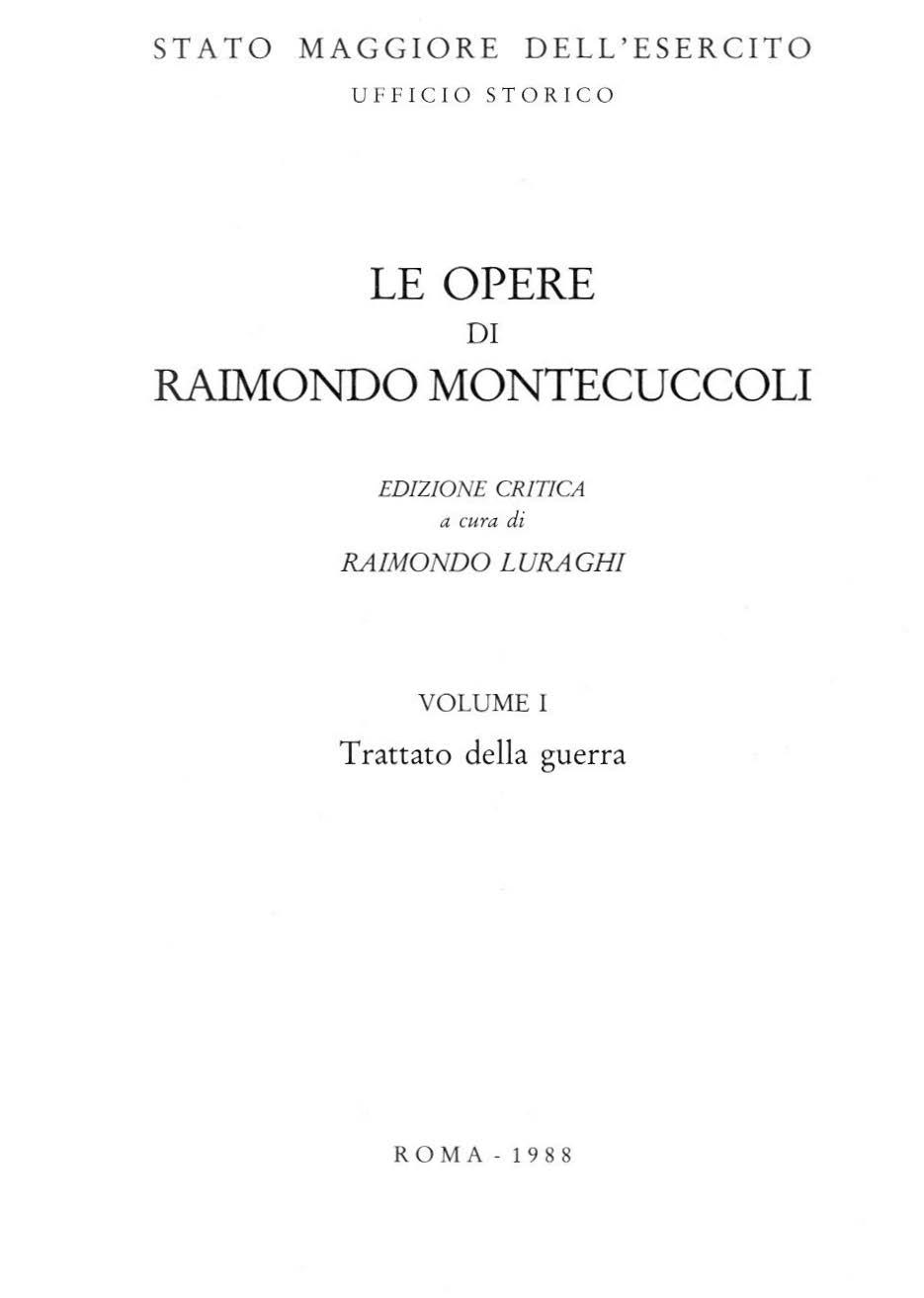
EDIZIONE CR !T!CA a cura di
RAIMONDO LURAGHI
VOLU ME I
Trattato della g uerra
ROMA - 1988
Stabilimento d'arti grafiche Gius. Laterza & Figli , Bari 1988
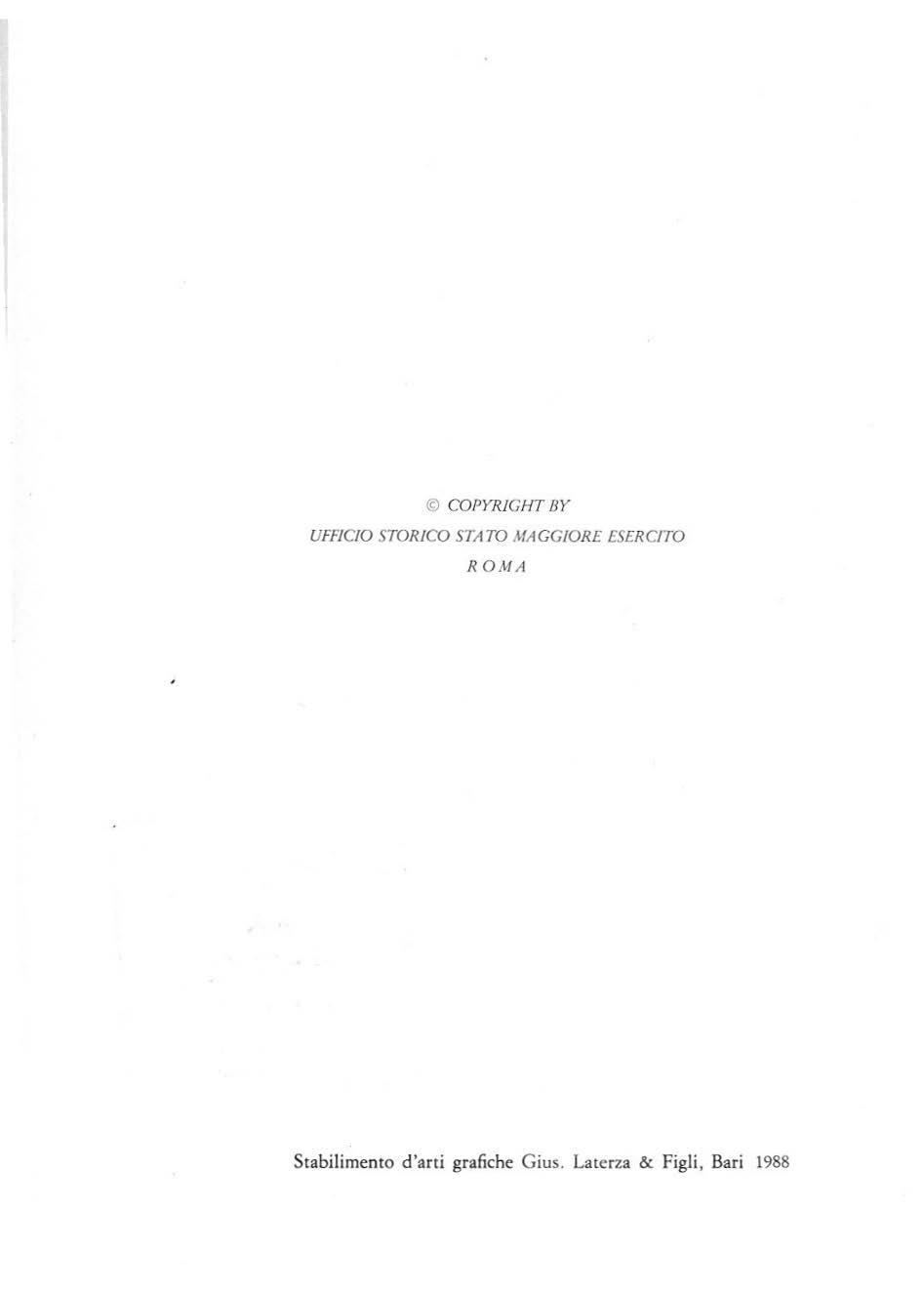 © COPYRIGHT BY UFFICIO STORICO STATO MAGGIORE ESER CITO ROM A
© COPYRIGHT BY UFFICIO STORICO STATO MAGGIORE ESER CITO ROM A
L'esigenza di procedere alfine ad una edizione critica integrale delle Opere di Raimondo Montecuccoli era sentita da anni da tutti gli studiosi. Per primo Piero Pieri, Maestro degli Storici militari italiani, aveva auspicato una tale intrapresa, sottolineando come fosse una vera e propria macchia che L'Italia non avesse mai provveduto - così come aveva fatto invece per gli scritti del principe Eugenio di Savoia - a pubblicare sistematicamentè le Opere di colui che era stato non solo il suo più grande teorico militare, ma uno dei maggiori pensatori in tal campo di tutti i tempi e di tutt i i Paesi . Sino ad ora infatti non si poteva disporre che di pubblicazioni parziali, mutile, incomplete, e nelle quali, inoltre, il pensiero del Montecuccoli appariva gravemente alterato e deformato: la stessa benemerita edi- ' zione curata dal capitano austriaco Veltzé appariva non priva di gravi pecche: a prescindere dal fatto che il pensiero del nostro non vi era riprodotto nel testo originale italiano, ma tradotto (e talvolta mal tradotto1 in lingua tedesca .
L'Ufficio Storico, iniziando tale impresa, è perfettamente conscio delle enormi difficoltà che gli si parano sul cammino: essa ha richiesto e richiede spirito di iniziativa, serietà scientifica ed anche, diciamolo, una buona dose di coraggio . Infine, ecco i due primi volumi, magistralmente curati dal professor Raimondo Luragh i, che includono - per la prima volta nei testi autentici stabiliti criticamente sui manoscritti originali di Montecuccoli - le maggiori opere teoriche militari del Grande. Il fine della presente edizione è stato di porre a disposizione degli studiosi il profondo e articolato pensiero militare del Montecuccoli: ques t o, non lo si dimentichi, è il suo vero e grande lascito. Perché egli fu, soprattutto e al di sopra di ogni cosa, pensatore militare, teorico e filosofo della guerra e condottiero . Malgrado le
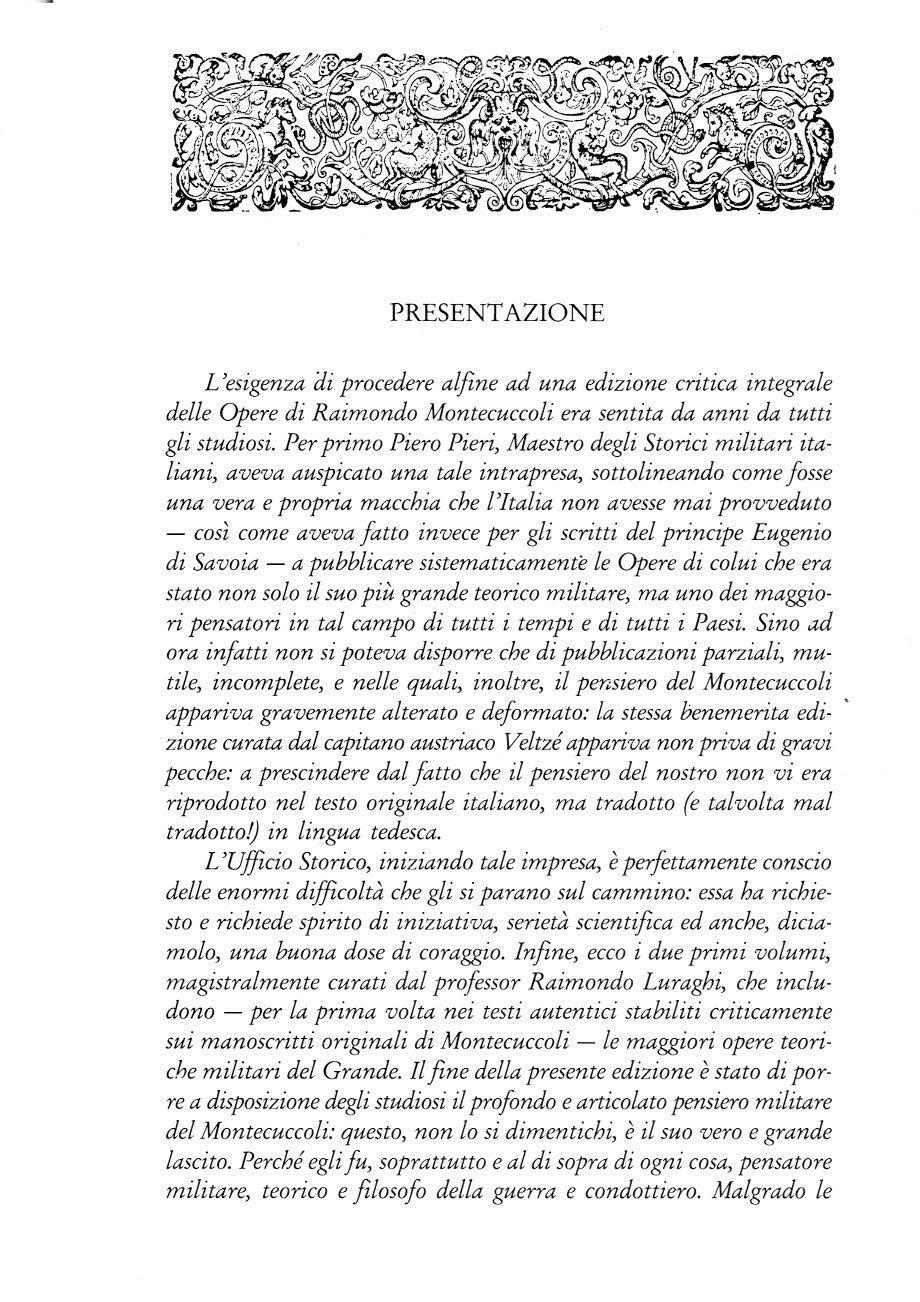
molteplici attività e gli straordinari meriti di quell'uomo inimitabile, giova ricordare che il suo pensiero militare è e rimane il suo più grande apporto: volerlo ignorare o sminuire significherebbe deformarne la figura e il valore storico.
Si auspica che altri volumi seguano, sino a completare questa che aspira ad essere la prima edizione integrale delle Opere di Montecuccoli: tuttavia l'aver dato alle stampe il complesso degli scritti teoricomilitari maggiori di quel Grande è già di per sé una realizzazione di cui tutti gli studiosi italiani e stranieri possono e potranno giovarsi.

Il compito di curare La prima edizione italiana, fondata sui manos critti originali, delle opere di R aimondo Montecuccoli si è rivelato assai più difficile, lento e complesso di quanto inizialmente previsto: ma~ però, un compito ingrato. Il vivere per diversi anni in compagn ia ed in so litario collo quio con un uomo di raro ingegno, di cultura enciclopedica e di profonda umanità è stato infatti un premio così grande in se stesso da illuminare e rendere liete le lunghe giornate, le settimane, i mesi, gli anni di questo lavoro .
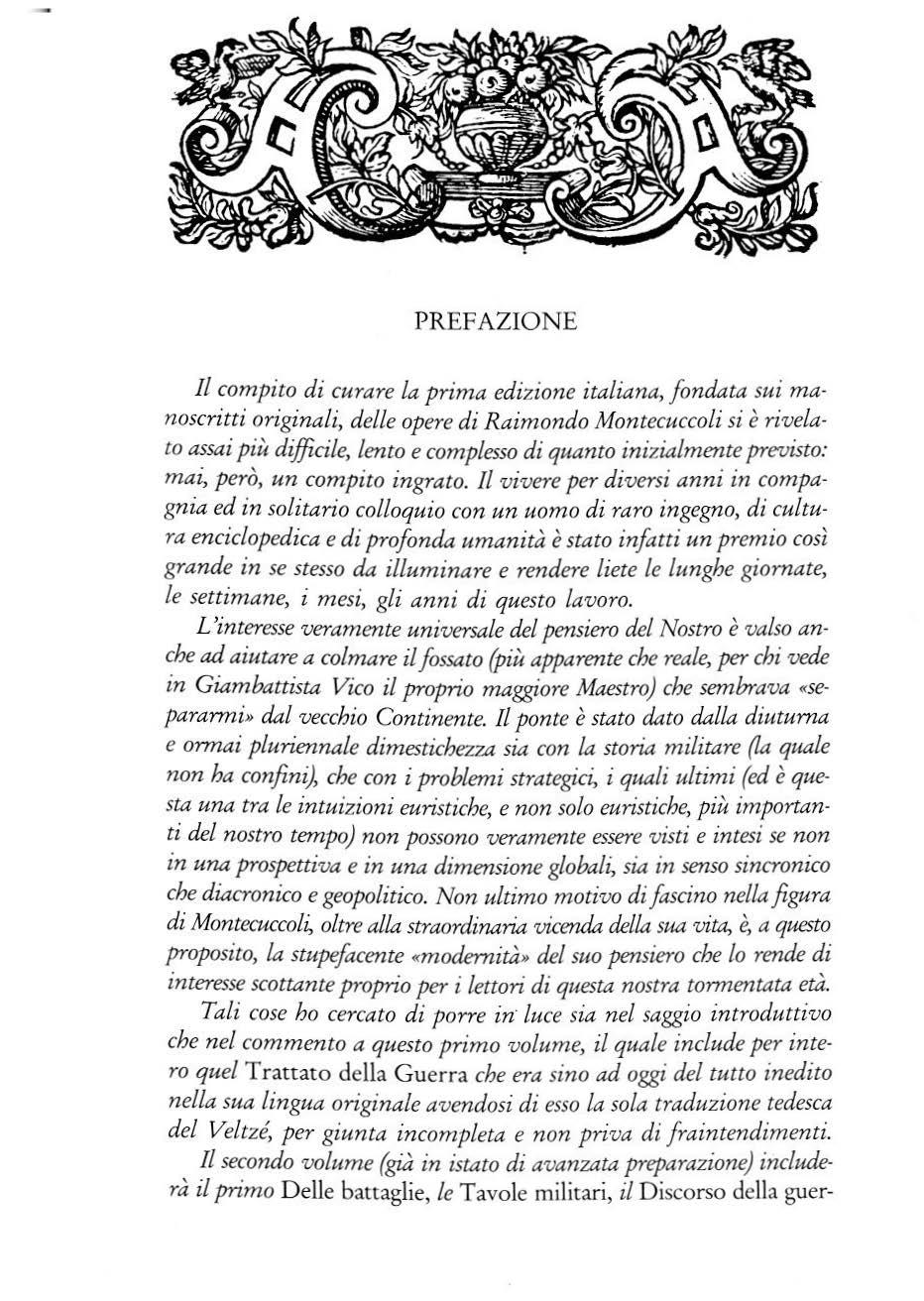
L'interesse veramente universale del pensiero del Nostro è valso anche ad aiutare a colmare il fossa.to (più apparente che reale, per chi vede in Giambattista Vico il proprio maggiore Maestro) che sembrava «sepa rarm i» dal vecchio Continente. Il ponte è stato dato dalla diuturna e ormai pluriennale dimestichezza sia con la storia militare (!,a quale non ha confini), che con i problemi strateg~ i quali ultimi (ed è questa una tra le intuizioni euristiche, e non solo euristiche, più importanti del nostro tempo) non possono veramente essere visti e intesi se non in una prospettiva e in una dimensione global~ sia in senso sincronico che diacronico e geopolitico . Non ultimo motivo di fascino nella figura di Montecuccol~ oltre alla straordinaria vicenda della sua vita, è, a questo proposito, la stupefacente «modernità» del suo pensiero che lo rende di interesse scottante proprio per i lettori di questa nostra tormentata età.
Tali cose ho cercato d i porre in· luce sia n el saggio introduttivo che nel commento a questo primo volume, il quale include per intero quel Trattato della G uerra che era sino ad oggi del tutto inedito nella sua lingua originale avendosi di esso la sola traduzione tedesca del Veltzé, per giunta incompleta e non priva di fraintendimenti .
Il secondo volume {già in istato di avanzata preparazione) includerà il primo De lle battaglie, le Tavole militari, il Disco rso della guer-
ra contro al Turco (del tutto inedito, e sfuggùo anche all'attento Veltze), i così detti ''Aforismi': il Dell'Arte Militare e infine il secondo Delle battaglie, testamento spirituale di uno tra i maggiori pensatori militari, ormai al tramonto di una Jant,astica carriera e deUa sua stessa vita.
Con tale secondo tomo (che mi propongo di dare alle stampe immediatamente dopo il primo) le maggiori opere teoriche militari del Nostro saranno state integralmente pubblicate, formando così , nell'ambito dei primi due volumi, un lavoro compiuto in sé.
Non so se la sorte mi donerà il tempo per continuare. In tal caso a questi due dovrebbero seguire altri volumi: le opere militari minori; i brevi scritti a carattere strategico e politico; le opere così dette storiche e diaristiche; quelle dedicate a problemi filosofici e scientifu:i; il legato letterario e poetico e infine l'immenso epistolario: ma quest'ultimo, sparso oggi in tre paes~ sovente redatto con una grafia tormentata e quasi indecifrabile, richiederebbe veramente un impegno diuturno la cui estensione nel tempo è ben difficile da prevedere. Mi auguro che altri, se io non lo potess~ conduca a termine questa intrapresa, la quale verrà a ridare definitivamente alla storia d'Europa uno tra i suoi maggiori protagonist~ ben degno di occupare un posto superiore a quelli stessi di Wallenstein o di Turenne e per lo meno eguale a quello di Gustavo Adolfo o di Mazzarino; alla storia delle idee un pensiero non solo strettamente militare, ma politico e strategico di primissimo ordine: ed insomma a recuperare una pagina di valore universale nella vicenda umana.
Evidentemente questo mio lavoro non sarebbe stato possibile se non avessi ricevuto aiuti cordiali e molteplici. Come ricordare tutti senza rischiare dolorose dimenticanze? Mi limiterò quindi a citarne alcuni, coloro che più di ogni altro meritano la mia gratitudine.
Vorrei anzitutto rivolgere il mio reverente pensiero a Chi non è più : parlo di Piero Pieri, a cui va la gloria di avere, nei nostri tempi, "riscoperto,, Montecuccoli e di avere, su quel Grande, richiamata molti anni or sono la mia attenzione (oltre ad aver contribuito a mostrarmi la via per apprendere i fondamenti della storia militare}.

Egli fu, indirettamente, L'ispiratore di questo mio lavoro, ed è per ciò che alla sua Memoria idealmente lo dedico.
Tra le persone e le istituzioni invece che hanno attivamente collaborato (ed ancora collaborano} alla realizzazione di questa intrapresa,
viene in primo piano l'Ufficio Storico dello Stato Maggi.ore Esercito, che ha assunto su di sé un compito editoriale tanto complesso e difficile, e per esso il suo Capo, generale Pierluigi Bertinaria e i di lui predecessori, generale Oreste Bovio (il quale oggi, come- Capo del V Reparto dello Stato Maggi.ore stesso, ha continuato a sostenere e ad incoraggiare il lavoro con tutta l'autorevolezza che gli viene dall'alta sua posizione) e generale (r) Rinaldo Cruccu; quindi i dirigenti tutti ed il personale del Kriegsarchiv di Vienna, (in particolare il Dr. Peter Broucek e il Dr. Kurt Peball, essi stessi illustri cultori di Montecuccoli e del suo lascito documentale), i quali tutti non solo hanno posto con la massima liberalità a disposizione senza alcun limite il materiale e i dati: ma si sono altresì prodigati in molti modi con la squisita cortesia e ospitalità viennesi ed hanno lungamente discusso con me i problemi storici e critici del Nostro e dell'età sua; nonché altri studiosi: austriaci come il Dr~ Siegfried Richter, con cui passai indimenticabili ore a Hohenegg, l'avita dimora nella quale Montecuccoli scrisse tanta parte delle sue opere e di cui, per impulso del Dr. Richter stesso, la locale comunità di Hafnerbach sta curando con amore il recupero; ungheresi, come il Dr. Géza Perjés e americani, come il Prof Thomas Barker, che posero generosamente a disposizione i loro studi e le loro inestimabili conoscenze storiche; i dirigenti e il personale della Nationalbibliothek di Vienna e della Biblioteca Estense di Modena, i quali pure hanno offerto la più vasta, cordiale e disponibile collaborazione; infine Alberto Rosselli, mio giovane allievo genovese, appassionato cultore di cartografia militare, cui sono dovute le riproduzioni degli schizzi fuori testo inseriti dal Montecuccoli nel T rateato della Guerra. Nessuno di loro, ad ogni modo, porta la responsabilità di qualsiasi errore che si potesse riscontrare nell'opera, la quale è assunta unicamente da me.

Ad essi tutti va il mio commosso ringraziamento: così come a mia moglie Germana, che in questi anni mi è stata non solo di aiuto, ma di sprone e di stimolo nei momenti di dubbio, che sono in agguato per qualunque studioso .
Torino e la Salle, 20 gennaio 1986
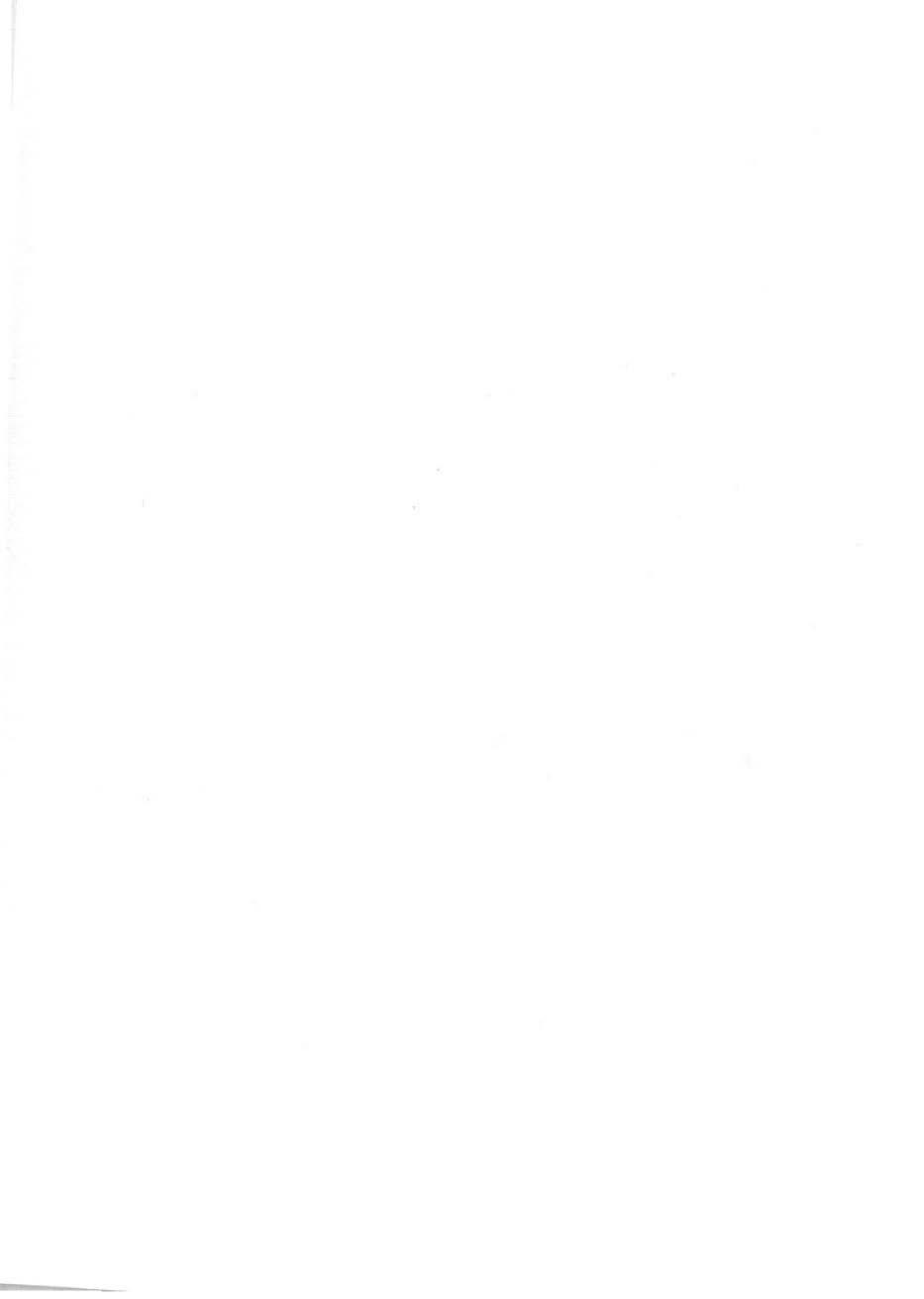
RAIMONDO MONT ECUCCO LI , L'AZIONE E IL PENS IERO
Premessa. i. La Guerra dei Trent'anni II. La Polonia e San Gottardo. !Il. Al vertice dell'Impero. IV L'insegnamento di Gustavo Adolfo e Wallen stein. V L'eredità militare dell'Italia del Rinascimento. VI. Le basi filosofiche. VII. Le opere teoriche militari e gli altri scritti. VIII. Ti generale e il teorico: la tattica IX. L 'organica e La logistica. X. La dottrina operativa e strategica. Xl. La strategia globale; considerazioni finali.
« R aimondo Principe di Montecuccoli, Conte dell'Impero, Luogotenente generale e Feldmaresciallo; Signore di H ohenegg, Osterburg, Gleiss e Haindorf; Pre side nte dell' I mperia! Consig lio Aulico Militare; Gran Maestro dell'Artiglieria e Fortificazioni; Governatore della Raab e Colonnello-proprieta rio di un R eggime nto di Cavalleria; R eale Cons igliere Segreto; Camerl e ngo e Cavaliere dell'Ordine del Toson d'Oro: tale suona la designazione ufficiale del co ndottiero, e l'esp e rto si rende conto che eg li concentrava in se stesso le più alte cariche militari, quelle che l'Imperatore romano-germanico pot eva conferire so lo ai più abili tra i suoi generali)}. Così Kurt Peb all , eminente studioso austriaco, introduce il personaggio dando immediatamente il se nso dell'enorme rilie -
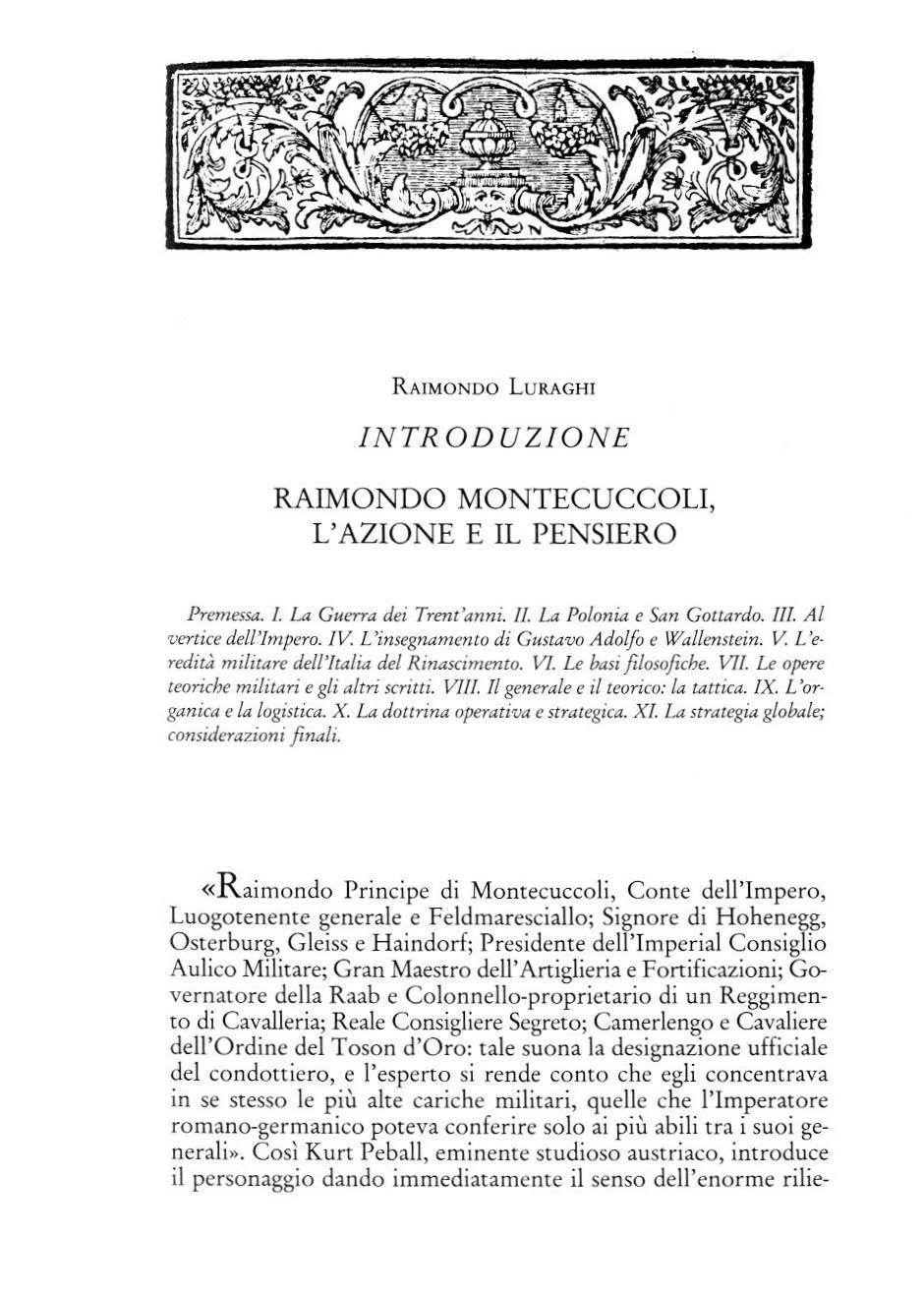
vo della sua figura, seconda, nell'Impero Absburgico, solo a quella del Sovrano 1 • E un altro storico, Harms Kaufmann, fa notare come Montecuccoli fosse pervenuto, dopo un'ascesa che non è esagerato definire meteorica, a concentrare nelle proprie mani tutti i più alti poteri militari dello Stato 2 •
Piero Pi eri, uno tra i maggiori studiosi ita liani di Montecuccoli, affe rma che il nome di questi, insieme a quello di Turenne, sintetizza l'arte militare della seconda metà del XVII secolo 3 ; e Thomas Barker porta su Montecuccoli le alte testimonianze di Federico il Grande, Scharnhorst, Napoleone, Folard, Guibert e del Maresciallo di Sassonia4 •
Non basta: Kurt Peball fa ancora notare come nessun generale austriaco avesse come Montecuccoli sperimentato di persona tutte le specialità del servizio; quanto elevate fossero le sue capacità sia di soldato che di diplomatico; quanto profonda la s ua religiosità5.
Infine il suo pensiero. D al Pieri, che pone in rilievo il peso decisivo dell'esperienza diretta nella formulazione della dottrina di Montecuccoli nonché la struttura dialettica del pensiero di lui 6 ; al Croce, che gli dedicò alcune acute osservazioni 7 ; al Gimorri, che vide in lui il tardo epigono dei grandi umanisti 8; al Bancalari, distinto ufficiale e studioso, che definì intramontabile la parte astratta degli scritti teorici di Montecuccoli e li giudicò più eminenti di quelli di Clausewi tz9 ; al Ki szling che mise in risalto la sua freddezza ed esattezza di giudizio sul nemico 10; infine ancora al Pe-
1 KuRT PEOALL, R aimund Furst Montecuccoli 1609-1680. Gedanken zum leben und Werk eines grossen osterreichischen Feldherm , in: Osterreichische Militarische Zeitschrifi , S, 1964, pagg . 301 sgg.
2 HARMS MUFMANN , Raimondo Graf Mont ecuccoli 1609-1680, Kaiserlicher Feldmarschall, Militartheoretiker und Staatsmann, Wien, 1974, pag. 1.
3 PIERO P tERt, il secolo XV!! - Raimondo Montecuccoli, in : Guerra e Politica negli scritt ori italiani, Napoli, 19S5, pa g 72 sgg.
4 THOMAS M. BARK ER , 7he Military lntellectual and baule · Raimondo Montecuccoli and the 7hirty Years War, Alba n y, NY, 197S, pag. 215, n. 14 e 1S.
5 K. PEBALL, op cit., pag 302-304.
6 P . P rERI, op. cit., pag . 9S sgg.
7 BENEDETTO CROCE, Storia dell'Età Barocca in Italia · Pensiero · Poesia e letteratura
· Vita Morale, Bari , 19S7, p ag 1S7
8 ADRIANO G1MORR1, Raimondo Montecuccoli, i viaggi, Modena, 1924, pag. lxxxiii.
9 GuSTAV BANCAl.A.R.l, Raimondo Montecuccol~ in Organ der Muitarwissenschafilicht>n Vereine, 22, 1881, pag. 148 sgg. Il Bancalari era maggiore del Corpo di Stato Maggiore austriaco.
10 R uooLF KiszuNG , Feldmarschall Raimund Furst Montecuccoli, 1609-1680, in: Wehrwissenschafiliche R undschau, 9, 1959, pag. 7 19 sgg.

ball che lo considera il fondatore della scie nza militare moderna 1 1 , tutti unanimemente pongono in rilievo l'importanza trascendentale dell'opera dottrinale di Montecuccoli, facendone uno tra i maggiori t eo rici militari che l'umanità abbia mai conosciuto.
Chi era dunque quest'uomo , generale, condottiero, diplomatico , pensatore, organizzatore, asceso alle più alte cariche del Sacro Romano Imp ero germa ni co sino a divenire usbergo e guida della monarchia absburgica? A diffe r enza di Bonapart e, egli si arrestò dinanzi ai gradini del trono; ma la sua non fu, come quella del primo Napoleone, un'età di rivoluzioni: sibbene del più stretto e rigido legalismo; tuttavia, anche senza il formidabile propellente di una rivoluzione , egli sall in alto quasi quanto il Bonapart e: e non partÌ, come questi, da un grado di ufficiale, ma dalla gavetta di semplice soldato. Se Montecuccol i non avesse mai impugnato la penna, sarebbero bastate le vicende della sua vita a dargli un posto più che cosp icuo nella storia; se non avesse mai comandato ese r citi, mai combattuto alcuna battaglia, le sue opere teoriche, per conve rso, gli avrebbero da esse so le garantito una dignità per lo meno uguale a quella di Clausewitz. Ma egli fu altro ancora. Politico, organizzatore, incaricato di delicate missioni diplomatiche che lo posero a contatto con Cristina di Svezia e Cromwell, uomo di cultura, fondatore e protettore di attività accademiche, scrittore di versi lodati da Fulvio Testi, dotto in filosofia e scienze naturali, Montecuccoli fu anche una tra le personalità più polie drich e di ogni tempo .

E pure oggi in Italia egli è pressoché dimenticato. Se anche si possa sos t enere che il nostro paese non brillò mai eccessivamente per riconoscenza verso i Grandi che lo hanno reso illustre, il caso di Montecuccoli appare addirittura sbalorditivo, apparentemente inespl icabile . Solo la piccola Austria oggi lo ricorda, e nemmeno tan to; quanto ag li altri paesi del defunto Impero absburgico, la Boemia, che pure dette i natali alla sua sposa, lo ha del tutto obliato: e l'Ungheria sino a ieri irrideva a lui e lo disprezzava cont r apponendogli il suo Zrfnyi (sebbene sia oggi merito di un grande studioso ungherese, il Perjés, di aver infine liquidato questa leggenda, co me più oltre si dirà). Anche la Germania, che pretende di avere con l'Austria comunità di lingua e, in parte, di cultura, non ne ha conservato il ricordo, inspiegabilmente (o così sembra) .
Ma una spiegazione, anzi, più spiegazioni (o, meglio, un complesso di spiegazioni) es iste: e sarà analizzando più da vicino la vita,
l'opera e il pensiero di Montecuccoli che s i potrà pervenire a comprendere l e ragioni di un sì immeritato oblio: e, insieme, a capire ed a valutare appieno un'attività ed una dottrina che sono più vive che mai e meritano di essere riesaminate a fondo, in quanto costituiscono un momento di importanza suprema nella storia del1' arte e della scienza militare. ·
N on è qui il luogo (e, p e r altro, farebbe difetto lo spazio) di intrattenersi troppo a lungo sulla v ita di Raimondo Montecuccoli: per essa si può ancora fare riferimento alle vecchie ma sempre valide opere del Campori e del Sandonnini, per lo meno fino a quando non venga scritta ex novo una biografia del Nostro veramente completa, moderna e soddisfacente 12 . Ci si limiterà quindi ad alcuni cenni: insistendo però su quelle esperienze della sua vita che furono essenziali p er la formazione del suo pensiero, il qual e , sia qui ben sottolineato, trovò l e proprie radici e le proprie fonti in un quadruplice ordine di elementi: l'e sperienza di soldato; la scuola dei grandi capitani; la tradi zi on e militare italiana; infine la profonda c u ltura scientifica e filosofica, di diretta disce n denza rinascimentale.
Raimondo Mont ec uccoli nacque il 21 febbraio 1609 nel castello avito di Mont ecuccolo nel Frignano situato entro i confini del Ducato di Modena, ter z o degli undici figli del cont e Galeotto, un piccolo nobile dell'Appennino 13
Nel 1619 il padre morì: e la famiglia, già di modesti mezzi, si trovò se non proprio alle soglie dell'indigenza, certo assai a disagio. Intervenne fortunatament e la benevolenza degli Estensi: per cui la madre , Anna Bigi , trovò collocazione come Dama di com-

12 CESARE CAMPORI, Raimondo Montecuccoli, la sua famiglia e i suoi tempi, F irenze, 1876; TOMMASO SANDONNINI , Il Generale Raimondo Montecuccoli e la sua famiglia, Mode na, 19 14, 2 vo i. Naturalmente occorre ve d ere le ope r e biograf iche più amich e, e pr ima di tutte qu ella del G u aldo Priorato, citata più oltre.
13 Il nome di Monrecu cco li è variamente interpr etato come monte del c uc u lo o (rifacendosi ad un a espressione dialettale modenese) monte delle ghi ande (o delle gh ianda ie) Sebbene ci si sia accanit i a trovare un'orig ine germanica alla famig lia , null a di ciò fu provato e l 'i ta lian ità dei Monrecucco li è cosa inco ntrovertibi le
pagnia presso la figlia del Duca, mentre il piccolo Raimondo, preso a ben volere dal Cardinale Alfonso d'Este fratello del Duca e Vescovo di Reggio, fu dapprima educato a cura di questi, indi da lui condotto a Roma come paggio. Nel 1624 Alfonso morì, lasciandogli una pensione annua di 90 scudi modenesi a condizione ch e Raimondo divenisse prete.
Il ragazzo aveva già cominciato a mostrare alcune delle doti che lo avrebbero reso eminen te nella v ita: di intelligenza pronta e vivace, maturo, studiosissimo , era anzitutto avido di sapere; e, nello stesso tempo, amante degli esercizi marziali e dell'equitazione, in cui eccelleva . Il tutto sembrava suggerire una pausa di ripen samento circa la decisione di avviarlo alla carriera ecclesiastica, per cui il Duca Cesare cominciò intanto a concede rgli due anni di proroga ; poscia cercò di farlo ammettere dal Cardinale P eretti nel Colleg io di Bologna, dicendolo « particolarmente inclinato alle Lettere>) 14; ma non essendovi posto, Raimondo continuò gli studi in Modena. Il suo carattere era ormai ben definito. Galeazz o Gualdo Priorat o, il primo dei suoi maggiori biografi, scrive di lui: « ... con tanta applicazione fece risp lend er e la vivezza del suo ingegno, che i di lui precettori ammirati del suo grande spirito conobbero, e pubblicamente predissero ch'egli dov ev a riuscire uno dei più grandi huomini d'Europa ... Oltre lo studio delle scienze più stimate, s'impegnò negli esercizi cavallereschi dell'armeggiar e, cavalcare ... nel che si rese così capace che non cede a qual che sia più habil e professore» 1 5.
La cultura ch e il giovane tanto avidame nte andava assorbendo era quella prestigiosa d~l Rinascimento e attraverso essa quella del1' Antichità classica, cosi co m e l'aveva trasmessa l' U manesimo; ancora viveva Tommaso Campanella (sarebbe morto di lì a poco, nel 1639), il cui pensiero av rebbe tanto profondam ent e influenzato Montecuccoli, talché ad esso avrebbe ancorato i pilastri del proprio; ed ancora viveva il Galilei . A costoro, più che ad altri, se si eccettua il Machiavelli, Raimondo sarebbe andato debitore dei fond am enti filosofici sopra i quali avreb b e costruito l'edificio della propria dottrina.
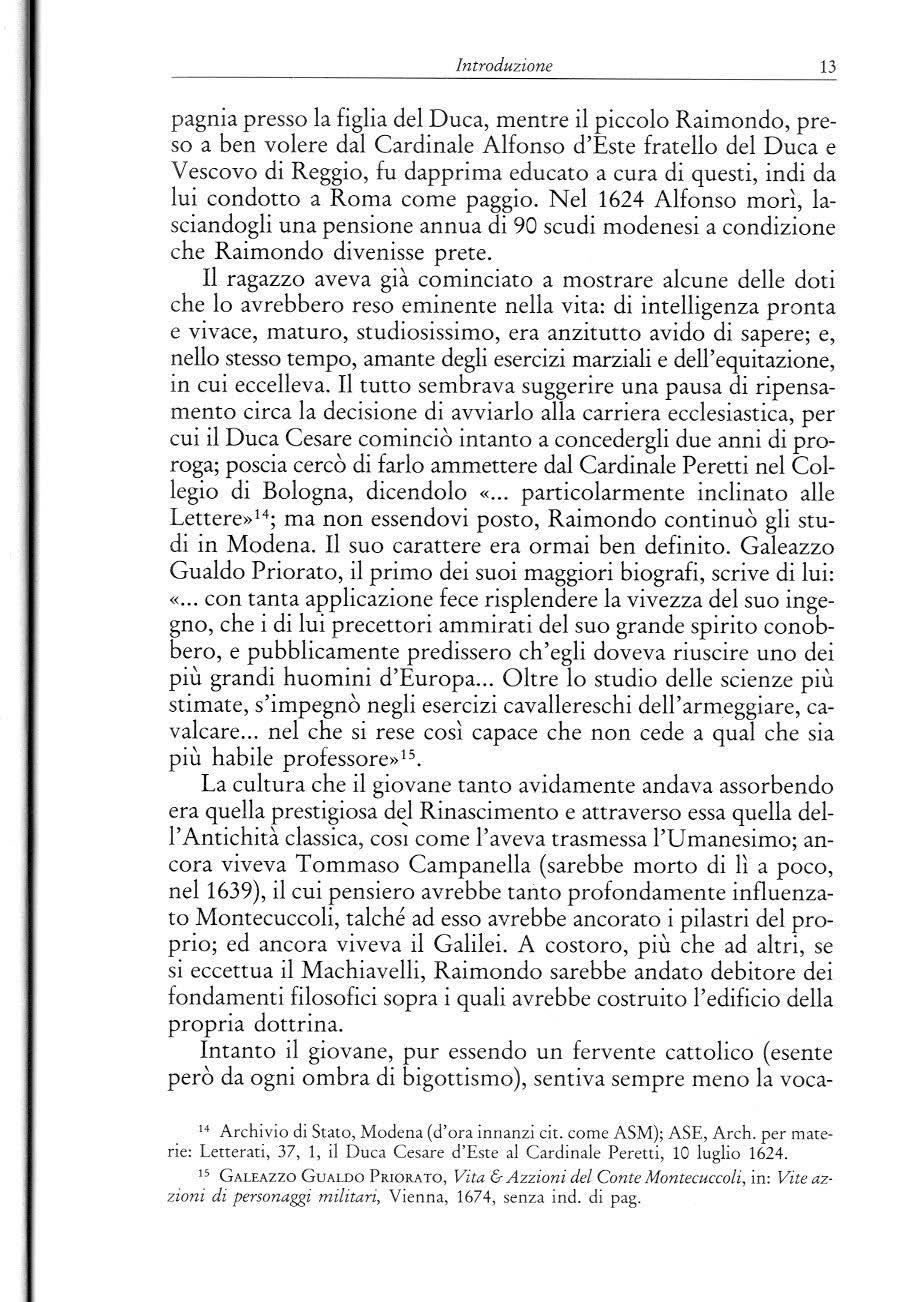
Intanto il giovane, pur essendo un fervente cattolico (esent e però da ogni ombra di bigottismo), sentiva sempre meno la voca-
14 Archivio di Stato, Mode na (d ' ora i nnanz i cit. come ASM) ; ASE, Arch. per materie : Letterati, 37, 1, il D uca Cesare d'Este al Cardi nale Peretti, 10 lu glio 162 4.
15 GALEAZZO GuALDO PRIORATO, Vita & Azzioni del Conte Montecuccoli, in : Vite azzioni di personaggi militari, V ienna, 1674, senza in d. di pag.
zione all'abito talare. La famiglia, grazie all'attività della madre, proba, economa, ottima amministratrice, si era ormai posta sulla linea di un modesto decoro: ed egli poteva cominciare a volgere il pensiero verso altre aspirazioni, altri lidi. Da tempo ormai un suo lontano cugino, Ernesto Montecuccoli (che Raimondo chiamerà "zio", forse per deferenza in quanto più anziano di lui di venticinque anni) era in servizio nelle forze armate degli Absbu rgo ove era stato in giovane età compagno d'armi di Wallenstein. Entrambi vi avevano avuto per maestro Giorgio Basta, probabilmente da Casale Monferrato, uomo che più tardi avrebbe riscosso la v iva ammirazione di Raimondo poiché (osservazione sign ificativa!) era uno dei pochi generali che avevano la pratica congiunta alla speculativa 16 •
Nell'Esercito imperiale Ernesto aveva fatto carriera, salendo fino al rango di generale dopo essersi battuto in Ungheria ed alla Montagna Bianca. Naturale che il giovane Raimondo sperasse in lui per poter adire a quel mestiere delle armi che egli sempre più sentiva come la sua vera vocazione. Fatto sta che nel 1625, allorché capitò a Modena il conte Rambaldo di Collalto, generale dell'Impero, Montecuccoli gli chiese di arruolarsi come semplice soldato e di seguirlo. Il Collalto (stimolato forse da Ernesto, o forse da un altro secondo cugino, Girolamo Montecuccoli, anch'egli alto ufficiale absburgico) accettò benignamente la richiesta di Raimondo che così, a sedici anni, partì dall'Italia per la grande avventura della sua vita.

Può parere strano che il Nostro, con le sue eminenti aderenze negli alti ranghi dell'Impero, dovesse sollecitare un sì umile posto nelle forze armate: ma il mestiere delle armi era severo, la Guerra dei Trent'anni infuriava e non c'era spazio nei ranghi per chi non si fosse dimostrato capace di conquistarsi i galloni sul campo. Raimondo voleva servire? Bene, cominciasse dal reggere la picca, cioè dalla gavetta. Poi, si sare bb e visto di che materia era fatto.
E ben tosto lo si vide . Presto avvezzo alla dura disciplina, salito dopo i primi combattimenti al rango di alfiere, fu nel 1629 chiamato da Ernesto a far parte del corpo di 17.000 uomini inviato dall'Imperatore nei Paesi Bassi a rinforzo del grande condo ttiero genovese Ambrogio Spinola. Eccolo dunque alla pr esa di Amersfoort ove egli, con lo stendardo imperiale, entrò per primo attra-
v erso la breccia e poscia nella città mentre ancora il nemico opponeva resistenza; già ferito in combattimento, nel 163 1 si trovò, da tenente, al comando di una compagnia di fanti (sarà promosso capitano l'an no successivo) e come tale partecipò alla presa di Neuhandenburg, ove gli toccò l'altissimo onore di consegnare le chiavi della città a Tilly che ebbe per lui parole di lode. Lo stesso anno combatté all'assedio di Magdeburgo; indi alla pres a di due fortezze : e di quella di Kollbus presentò a Tilly le bandiere che egli stesso aveva catturato.
Così Montecuccoli aveva modo di servire sotto il primo dei grandi condottieri che egli avrebbe incontrato. Rigido, spartano, seve ro con se stesso e con gli altri, il monacale ed austero Tilly gli dette senza dubbio un esempio di semplicità, di frugalità, di disciplina. Anche altre cose, purtroppo, il Nostro dovette apprendere: i paurosi saccheggi (quello di Magdeburgo conservò un triste primato) che lo inorridirono e lo spinsero, più tardi, a sostenere con energia l'esigenza di usare più umanità verso i civil i. Non solo si ribellava in lui la generosità del suo animo; ma la sua lucida ragione gli mostrava l'inutilità e il danno di un simile comportamento. A Tilly chiaramente sfuggiva un lato essenziale della guerra: la logistica. Era molto difficile che turbe fameliche, male o irregolarmente nutrite, si astenessero dal saccheggio, ma Montecuccoli, che vedeva lontano, avrebbe studiato a fondo il problema dei rapporti con i civili e lo avrebbe affrontato in maniera esauriente nel Trattato della Guerra , nel primo Delle battaglie ed in tutte le altre ope re sue.
Nel frattempo aveva lasciato la fanteria (ov e aveva compiuto profonde esperienze) per assumere il comando di uno Squadrone di corazzieri. Già in Olanda egli si era incontrato con uno dei grandi condottieri nemici: Federico Enrico. Ora si appressava l'ora dello scontro con Gustavo Adolfo di Svezia. E dell'incontro con Wallenstein.
Ciò che sgomberò i campi d'Europa per la lotta de i due giganti fu la catastrofica disfatta inflitta dal re di Svezia al T illy presso Breitenfeld, il 7 settembre 1631. Raimondo Montecuccol i, alla testa dei suoi corazzieri, si batté con il solito indomito coraggio finché, rimasto pressoché solo, gravemente ferito, cadde in mano al nemico. Prigioniero a Halle, ebbe sei mesi di tempo per ristabilirsi e meditare sulla battaglia: poscia fu liberato grazie al pagamento di un riscatto di mille talleri. Il Campori sostiene che la somma fu pr estata dal Duca di Modena, che sempre lo apprezzava e nu-

triva per lui un affetto paterno : certo a Modena egli era stimato. Vi si era recato più volte e vi aveva contratto un'amicizia - che sarebbe rimasta nel tempo - con il poeta Fulvio Testi .
Riassunse tosto il servizio, ché la guerra infuriava : dapprima con il grado di maggiore nel Reggimento di fanteria di suo cug ino Ernesto con cui combatté sul Reno e in Baviera (ed ebbe anche l'esperienza, amara ma preziosa, della r i ti r ata); poscia, divenuto Tenente colonnello, in un Reggimento di cavalleria. Da quando egli era rientrato dalla prigionia, Wallenstein comandava le ar mate imperiali : era così cominciato il suo tirocinio sotto il condottiero che l'avrebbe probabi l mente influenzato più di qualsiasi altro .
16 novembre 1632 : Gustavo Adolfo e Wallenstein si affrontano sul campo di Lutzen . Malgrado l'autorevolezza di Thomas Barker, sono perso n almente incline a ritenere, sulla fede del Bolognesi, che Montecucco l i abbia preso parte alla grande battaglia rimanendovi anche leggermente fe ri to 17 : ma ciò che lo impressionò più profondamente fu la morte di re Gustavo Adolfo, cu i egli dedicò un p r egevole sonetto indirizzato all'amico Fulvio Testi .
Ma n el 1633 un grave lutto colpì la famig lia: ferito in combattimento e preso prigioniero, Ernesto morì a E n sisheim . Raimondo pianse amaramente la perdita di quegli che era stato il suo mentore e q u asi padre adottivo : egli era adesso solo, ma o r mai er a stabilito solidamente nella stima di superiori e inferiori. F u a q uesto punto (il 25 febbraio 1634) che si verificò il tragico ed oscuro episodio dell'assassinio di Wallenstein. Sebbene gli italiani (a cominciare da Ottavio P iccolomini) vi fossero gravemente implicati , pare assodato che Montecuccoli sia ri m asto del tutto estraneo alla congiura 18 Certo, egli era un soldato total mente fedele all' I mperatore, e tale rimase per l'intera vita : sembra quindi corretto ritenere che le mene di Wallenstein non trovassero approvazione presso di lui, e che egli in sostanza ritenesse che al Duca di Friedland fosse toccato il destino dei ribelli, o per lo meno deg li uomini di dubbia fedeltà; rimane però il fatto che in tutti i suoi scritti futuri Montecuccoli non tacq u e mai la sua ammirazione per Wallenstein come condottiero, né mai si espresse a proposito di lui in modo meno che giusto.
17 T. BAR KER , op. cit, pag . 17 sgg.; la l ette ra di Otta vio Bolognesi, Ambasciat0re modenese in Vienna, è cit. da C. CAMPORI, o p. cit. pag 72 sgg.
18 Su Octavio Piccol omini, cfr.: THOMA S M . BARKER, GeneralLeutnant Ottavio Furst Piccolomini i n: Osterreichische Osthefie, Wi en , 1980, pag 322 sgg.; nonché quanto detto da: GOL o MANN, Wallenstein, Frankfurt am Main, 1971, tra d. it. : Firenze, 198 1.

Gli insegnamenti di Wallenstein erano certamente andati radicandosi in lui: e solo pochi mesi dopo, il 6-7 settembre 1634, Montecuccoli ebbe l'opportunità di farne mostra a Nordlingen, in occasione della grande vittoria imperiale sugli svedesi, ove egli comandò, nell'assenza del colonnello, il proprio Reggimento ed ebbe occasione (sintomo grande!) di elaborare una disposizione delle truppe in battaglia diversa da quella seguita allora dagli svedesi, che molti si sforzavano pedissequamente di imitare 19. Già prima, il 17 luglio, si era distinto all'assedio di Ratisbona e nel 1635 si coperse di gloria alla presa di Kaiserlautern ove una volta di più, quasi fosse stato ancora un semplice alfiere, entrò per primo dalla brecc ia alla testa dei propri uomini meritandosi le lodi di un altro illustre generale italiano: Matteo Galasso, principale artefice della vitt oria di Nordlingen. Seguì la nomina a colonnello e il comando di un Reggim ento di corazzieri.
Ma la fortuna degli Absburgo volgeva, in quella guerra, al tramonto: e cominciava ad imporsi una strategia temporeggiatrice, capace di salvare l'Impero e di pilotarne la navigazione attraverso acque tempestose in modo da conseguire il maggior risultato possibile. Lo aveva inteso Montecuccoli? Se teniamo presenti le straordinarie qualità di introspezione della sua mente speculativa e lungimirante si sarebbe tentati di dare una risposta affermati v a. 24 settembre 1636, Wittstock. Gli svedesi di Banér schiacciano gli imperiali di Melchiorre von Hatzfeld e i sassoni dell'Elettore Giovann i Giorgio. Nel grave momento della disfatta, fu Montecuccoli che còperse da maestro la ritirata alla testa di quattro Reggimenti di cavalleria, salvando l'Esercito imperiale dalla definitiva catastrofe. E pure egli aveva saputo vedere gli errori dei comandanti, specialmente l'uso sbagliato dell'artiglieria!
L'ora era tragica. Sebbene Montecuccoli trovasse sollievo al proprio s_pirito intrattenendo una intensa corrispondenza con Fulvio Testi (che gli inviò un suo volume di poesie) i tempi sembravano volgere contro di lui. Fatto dapprima oggetto di calunnie da parte di invidiosi, riuscì a smentirle. Mentre ancora era alle prese con tali problemi, dovette precipitarsi a Modena: era morta la sua adorata madre ed egli giunse appena in tempo per vederla seppellire n ella locale chiesa di S. Pietro, accanto alla tomba paterna. Tornato al fronte, nel maggio del 1639 fu catturato in combattimento dagli svedesi. La prigionia durò tre anni, un'eternità. Montecuccoli però ebbe la ventura di venir rinchiuso (da un nemico che

ormai lo conosceva e lo stimava) ent r o il palazzo dei Du c hi di Pomerania, a Stettino, ove gli riuscì di spezzar la noia della prigionia in una biblioteca tra le più ricche. Costretto all'inazione forzata, egli poté tornare in compenso ai suoi amati studi. Sappiamo che si dedicò alla scienza della pol itica, alla geometria, all'architettura, unendovi studi di diritto, medicina, filosofia, chi mica e botanica, affin andosi inoltre nel met odo speri mentale che aveva appreso dai suoi Maestri ideali, Campanella e Galil ei.
Ma sopra ogni alt ra cosa egli si dedicò a scrivere. P oesie, certo: ma sp ecialmente trattati. Non è questo il luogo per approfondire l'argomento: se ne parlerà oltre, quando verranno esaminate più da vicin o le opere di Montecuccoli. Basti dire che apparv e qui, per la prima volta, il tentativo grandioso di fornire alla dottrina militare una base scie ntifi co-matematica e che qui, probabilmente, fu terminato il suo primo trattato Della guerra, nonché il Delle battaglie ed altri ancora.
Liberato nel giugno 1642, tornato a Corte, vi fu accolto co n grande effusione dail' Arciduca Leopoldo Guglielmo che non solo gli fece dono di una gratificazione di 3000 fiorini: ma gli annunciò la promozione a generale insieme con i sensi della stima p erso nal e dell'Imperatore. E fu im mediatam ente inviato in battaglia, il che mostra quanto ora la Casa d'Austria si aspettasse da lui. La situaz ion e era grave : gli svedesi di Torstensson erano in Sles ia; da Ovest minacciavano i francesi co n qu el movimento co nverge nte che alla fine li avreb b e condotti alla vitt ori a. Montecuccoli mosse co ntro gli svedesi, li batté a Troppau. Di nuov o un intervallo moden ese . In Italia era scoppiata la così detta "guerra di Castro", intesa ad arginare le pretese espansionistiche di P apa Urbano VIII Barberini. A chi meg lio che al suo ormai illustre genera le poteva far appello il Du ca di Modena? Con l'autorizzazione dell'Imperatore, Montecuccoli partì per l' I talia, ove gli fu conferito il grado di Feldmaresciallo nella coalizione antipapale che egli guidò alla vittoria il 21 luglio 1643 nella piccola ma sanguinosa battaglia di Nonantola. P oi di nuovo in Austria, al cape zzale della vedova del cugino Girolamo, che morendo gli legò la proprietà di H ohenegg. Questo severo castello, in un luo go ancor oggi tranquillo e ameno della Bassa Austria, a poche decine di chilometri da Vienna, sarebbe diventato il suo soggiorno favorito, ove, nella pace agreste, avrebbe cercato ristoro dalle fatiche e dalle preoccupazioni della guerra e della politica, dedicando lunghe ore ai su oi amati studi ed alla stesura delle su e opere.
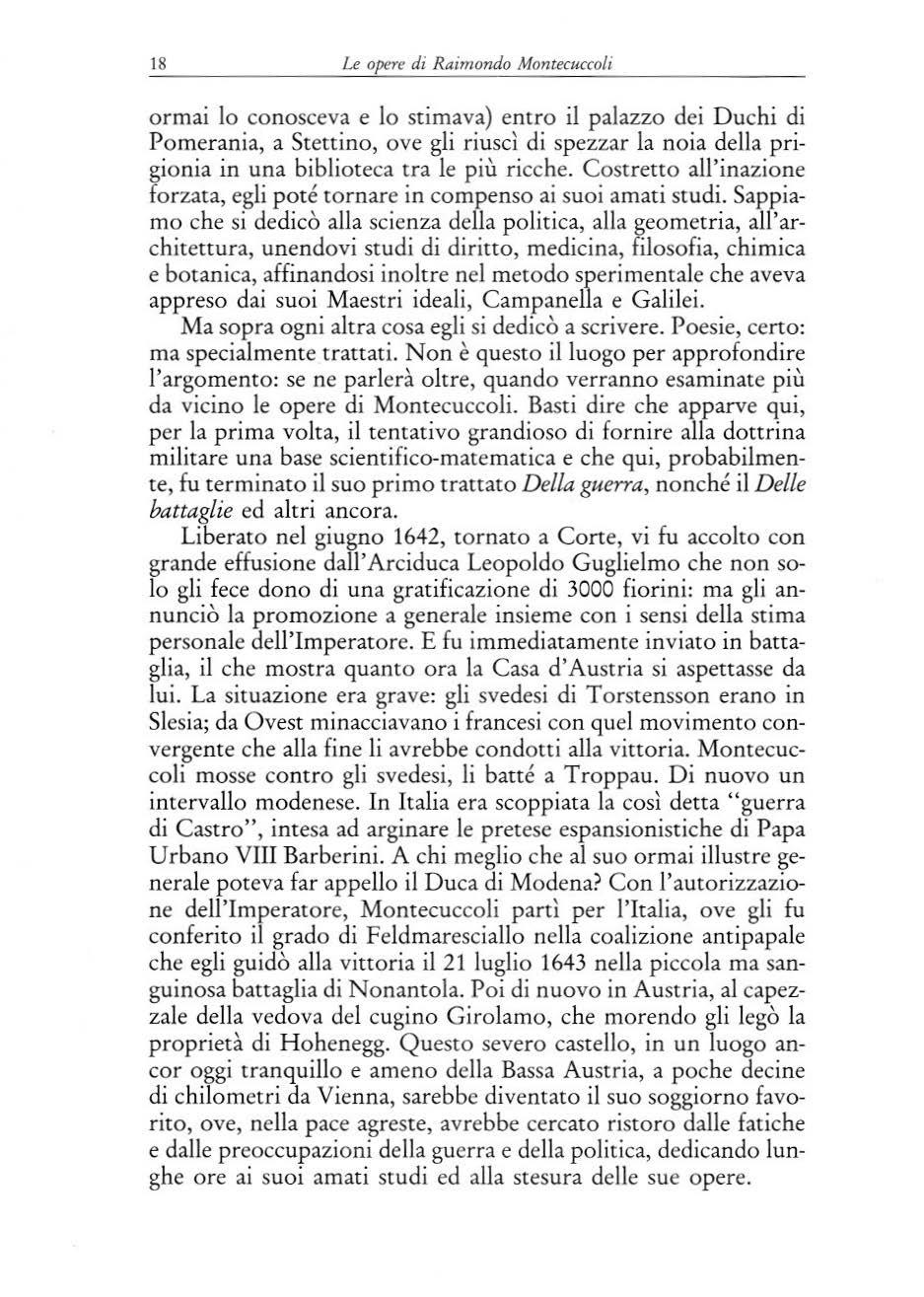
L'eredità di Hoh enegg gli giunse nel 1644: nello stesso anno ricevette la promozione a T enente-Maresciallo 20 proprio mentre il suo futuro, grande rivale Turenne veniva nominato Maresciallo di Francia 21
Ne lla sua nuova veste egli fu presente, si può dire, dovunque un imminente pericolo si profilasse per l'Impero. Dapprima in Sassonia, ove sventò l'avanz ata degli svedesi di Konigsmark; poscia a coprir e l'Ungheria, minacciata da un nuovo nemico, Giorgio Rak6czy, Prin cipe di Transilvania; infine al comando di tutte le forze imperiali in Franco nia. L'I mpero, stretto ormai da vicino dagli svedesi e dai francesi, stava incamminandosi verso la sconfitta: ma Montecuccoli era al culmine della sua gloria. Galasso, fino alla sua morte nel 1647, lo usò ormai come proprio braccio destro; attaccato da forze superiori, Montecuccoli riuscì a Magdeburgo a spezzare il cerchio uscendone con i reparti intatti.
Nuovamente ferito nel 1645, egli fu ora nominato membro dello H ofkriegs rat, ossia del Consiglio Aulico Imperiale di Guerra , l'organo supremo militare dell'Impe ro, nonché Gentiluomo di Camera dell'Imperatore 22
20 Nell'Esercito Absburgico i gradi degl i ufficiali generali avevano la seguent e scala, dal minore al più alto:
Generalmajor ........................................ ......
Feldmarschall-Leutnant ...............................
Generai der Kavallerie .......... .... ...... ...... ... ..
Feldzeugmeister .......................... .... .. ....... .....
Feldmarschall
Generale di Bri gata
Tenente-Maresciallo (Ten. Generale)
Comandante la Cav aller ia
Comandante l'Art igl ier ia
Fe ldm aresc iallo
Successivamente, al tempo de ll a Duplice Monarchia austro-u ngarica, tra il gr ado di Tenente-Maresc iallo e quello di Fe ldmaresciallo ne vennero introd otti altri due, vale a dire:
Generai der In/anterie Generale di C.d' A.
Generaloberst ...................... ................ .. ... G enerale d' Armata.
Ai tempi di Montecuccoli e fino alla Rivoluzion e Francese, la maggiore unità era la Brigata; più Brigate formavano un 'Armata. Pertanto, al di sopra del Generalmajor vi era subi to il Feldmarschall, con il suo vice, il Tenente-Maresciallo . In alcuni, pochissimi casi veniva conferito il titolo di Luogotenente Generale , il quale non era propriamente un grado, ma attribu iva, nel campo militare, un' autorità suprema, seconda solo a quella dell'eve ntuale Generalissim o, il quale ultim o, pure , rappresentava più una funzione che un grado: meglio potremmo dire, per entrambe queste caric he, un rango. Per il Montecuccoli, poi , venne coniaro l'altissimo grado di Feldmaresciallo Generale, portato da lui solo e che lo poneva al di sopra di qualsiasi altro eccetto l'Imperatore: infine, egli fu nominato Luogotenente Generale dell'Impero, con che il Sovrano gli delegava pane della sua autorità stessa (e non solo in materia militare) e che lo rendeva secondo al solo Imperatore.
21 G. BANCALARI, op, cit., pag. 151.
22 ASM, Carteggio di Osservat ori ed Agenti Estensi presso Corti, sottos. Cerma· nia, fase. 96, Ottavio Bolognesi al D. di Modena, 25 febbraio 1645. F u durante qu esta forzata pausa che eg li scrisse - veros i mi l mente a Hohenegg, divenuto suo appe na l'anno pri ma - lo Urschrift delle Tavole militari.

Ma Montecuccoli era già al fronte. La situazione per le armate imperia li andava peggiorando. Occorreva condurre una strategia temporeggiatrice che rallentasse il nemico, coprisse tutto quant o era possibile e non rinunziasse alla stoccate offensive ogni qual volta se ne fosse presentata l'occasione. Montecuccoli era dovunque: dapprima sul fronte della Boemia ove riuscì a soccorrere Brno, assediata da Torstensson che dovette ritirarsi; poscia in Baviera, ove gli riuscì di sventare e mandare a monte i piani offensivi del nemico, guadagnandosi l'ammirazione degli stessi svedesi; infine nel 1646-47 di nuovo in Boemia, ove con forze inferiori pervenne a bloccare l'avanzata dell'abile generale svedese Wittenberg, infliggendogli non poche stoccate: campagna, dice giustamente il Campori, mirabile e poco studiata 23 •
Nel 1647, riunitesi tutte le forze imperiali sotto il comando, invero mediocre, di Peter H olzapfel, riuscì l oro di infliggere presso Triebl una disfatta ag li svedesi di Wrangel: fu Mont ecuccoli, al comando dell'ala sinistra della cavalleria, che decise praticamente della giornata, distinguendosi anche per valore personale. Ciò gli fruttò la promozion e a Generai der Kavallerie.
Ma il nemico non dava re spiro; ed ora Turenne e W range! andavano convergendo co n chiaramente un obiettivo: Vienna. Il 17 maggio 1648 Holzapfel affrontò presso Zusmarshausen in disp erata battaglia svedesi e francesi uniti ed in numero superiore. La lotta fu accanita e feroce, finché il comandante imperiale cadde s ul campo . Già la vittoria totale sembrava a portata dei due capi alleati: ma Montecuccoli pervenne a coprire la ritirata con tale consumata abilità che l'e se r c ito fu salvo e Turenn e (che espresse parole di alta lode per il condottiero nemico) si vide privato dei frutti della vittoria. Ora fu praticame nte Montecuccoli cui spettò il compito di salvar e quanto era poss ibile d e ll'Impero, sinché le trattative condotte dai diplomatici in Westfalia ponessero fine alla guerra. Fu una campagna tra le più straordin arie della storia. Mantenendo le proprie forze intatt e , Mont ecuccoli riuscì a ritardare talment e il nemico che l'annun c io della pace ormai stipulata bloccò costui ancora lontano dall'obi ettivo di Vienna. Wrangel gettò a terra con rabbia il cappello alla notizia de l Trattato di W estfalia: non poteva m e glio riconoscersi battuto dal suo srande avversario che aveva saputo sfruttare il ristretto s pazio d1 possibilità ancora aperto per lui nel più egregio dei m o di. A Montecuccoli era dovuto se

l'Impero aveva potuto sopravvivere: nell'ultima fase della Guerra dei Trent'Anni era stato lui l'anima della resistenza 24 •
M algrado il Trattato di Westfalia avesse fatto definiti vamente tramontare il piano (se mai era veramente esistito in maniera concreta) di un predominio absburgico sulla G ermania aprendo la strada agli ambiziosi progetti egemonici di Mazzarino, esso aveva però salvato e, in un certo senso, omogeneizzato i domini di Casa d'Austria. Senza la strategia temporeggiatrice dei condottieri imperiali (e in primo luogo di Montecuccoli), ciò non sarebbe assolutamente stato possibile: Wrangel e Turenne a Vienna avrebbero significato la disgregazione dei domini absburgici con duecentosettant' anni di anticipo .
L' I mperatore Ferdinando III si rendeva ben conto di ciò: e la prova ne fu che a Montecuccoli egli affidò ora il delicato e difficile compito di ristabilire il credito dell'Impero presso una serie di stati-chiave d 'Europa. Occorre va anzitutto visitare quelle Corti che, pur essendo alleate d ella Francia, non intendevano esser vassa lle: e la prima tappa del Nostro fu dunqu e Stoccolma, presso Cristina di Svezia. Colà egli pervenne a stabilire, con quella strana, contorta, eccentrica personalità un ottimo rapporto di stima ed amicizia, talché più tardi fu Montecuccoli l'artefice principale della conversione della Regina di Svezia al cattolicesimo 25 • Successivamente fu a Londra, ove venne ricevuto da Sir Oliver C romwe ll ; nelle Fiandre, presso la Dieta Imperiale ed in una serie di Principati t edeschi.

Questa sua paziente opera di ricostruzione del tessuto diplomatico absburgico, che la guerra aveva lacerato, lo portò presso la Santa Sede, ove fu ricevuto dal P apa, indi nuovamente a Vienna.
In mezzo a tale periodo di continui viaggi e di pesantissime responsabilità, il Nostro era però anche riuscito a godere di un
24 F. STOLLER, Feldmarschall Raimund Gra[Mon tecu.ccoli 1609-1680, in: Gestalter der Geschichte osurreù:hs; Studien der Wiener Katholischen Akademie, vo i. Il, lnnsbruck-WienMiinchen, 1962, pag. 171 sgg.
2 s Cfr. i relati vi doc. in: Au sg,'Walhte Schriften des Raimund Fursten Montecuccoli, General-leutnant und Feldmarschall, a cura d i Alois Ve lt zé , 4 voi., Vienna e Lips ia, 1899 sgg .; vo l. 3 p ag, 235 sgg.
triennio di tranquillità relativa, tra il 1650 e il '53, che egli aveva trascorso in gran parte nella pace di Hoh enegg, il cas tell o che dalle basse colline boscose domina la ridente e verde piana della Bassa Au st ria. Colà aveva p o tuto immergersi nei suoi dil etti studi, e scrivere. Probabilmente a questo periodo apparti ene, tra gli altri, il manoscritto da lui intitolato Zibaldone, ove sono rintracciabili i fondamenti filosofici e scientifici del suo pensiero, e mediante il quale è poss ibil e misurare la sua imm ensa cultura.
Montecuccoli si er a semp r e distinto d ai suoi coetanei comp agni d'arme per un co nt egno estremame n te corretto nei confro nt i del sesso fe mminil e; durant e la lunga pri gioni a a $tettino s i era oss ervato quanto egli si distinguesse dagli altri, che "am mazzavano" il tempo giocando, ubrianc an dosi e frequentando prostitute. Ciò sebbene egli fosse assai apprezzato dalle donne e contraccambiasse tali senti menti, ma sem p re con la riservatezza e la signorilità di comportamento che era n o inn ate in lui 26 • Non aveva però ancora posto mente ad accasarsi: ma ciò avve nne nel 1657 allorché egli co ntr asse matrimonio con Margar eth e von Dietrichstein, proveniente da una t r a le più influ enti famiglie della Corte, di nobiltà boema. Mont ecu cco li avev a allora 48 anni e la sposa era di trenta più giovane di lui; ma il legam e tra i du e fu intens o e profondo e durò per la vita. Nello stesso anno Montecuccoli fu chiamato dall'Arciduca Leopoldo Guglielmo, insi gne umanista , a far parte dell'Accademia ita lia na dei Novelli, o "dei Crescenti", fondata l'anno prima ed a cui appart enev ano lo st ess o Imp eratore F erd in ando III , l'Imperatrice Maria ed un r istrettissimo gruppo di dodici alti nobili 27 • Ma ben altro lo attendeva , in qu el 1657 così importa nt e n ella sua vita. La guerra bussava nuovamente all e p orte dell'Impero. D opo l'abdi caz ione di Cristina, il nuovo re di Svez ia, C arl o X, aveva volto l'animo ad una politica di espansione e di conquista. Sperava egli in tal modo di porre da un lat o le difficoltà in cui si dibatteva il r eg no nordico m ediante una cate na di ulteriori conqu iste ne l Baltico ch e ne av rebbero anche co nsac rat o l' ege monia. Il pr etesto per l'attacco co ntro la Polonia nel 1655 fu t rova to nella p ersis t ente ostili tà che il ramo pol acco e cattolico d ei Vasa nutriva
26 La storia di un suo infelice amore è conten uta ne ll a novella autobiografica lsto· ria miserabile, ma vera, degli amori di Mq,rindo [X?! Arianna, il cui manoscritto (includente anc h e due sonetti) trovasi a Vienna, Oster r e1chisches Nationalbibliothek. La novella fu pubblicata nel 1923 sulla Strenna Frignanese , di P avullo, / nostri Monti, a.I (cfr. A
G IMORRI, op. cit., pag. l xrv).
27 H. KAuFMANN, op. cit. , pag. 21.

contro quello svedese luterano: e la guerra cominciò. La Polonia non tardò a trovarsi a mal partito e la Danimarca, alleata dei polacchi, addirittura sull'orlo della catastrofe. Fu a questo punto che gli Absburgo e le potenze marittime, Inghilterra e Olanda, si decisero a intervenire. La stessa Francia di Mazzarino guardava con preoccupazione al rinnovato attivismo svedese 28 • Per motivi più che altro politici il comando della spedizione austriaca fu affidato a M elch ior r e von H atzfe ld: ma quando anche il Voivoda di Trans il vania , Giorgio Rak6czy, si mosse ed attaccò a sua volta la Polonia, l' I mperatore ricors e a Montecuccoli.
Il condottiero partÌ nell'avanzato 1657, recando con sé al campo la giovane moglie, che gli era assai teneramente legata. I risultati della di lui presenza non tardarono a farsi sentire: il principe ungherese fu battuto e respinto, e Poznan e Cracovia riprese. L'anno successivo Hatzfeld morì e M ontecucco li , cui fu conferito il grado di Feldmaresciallo, fu nominato comandante supremo delle operazioni in Polonia e nel Baltico. Insieme ai Brandenburghesi egli batté gli svedesi ripetutamente, cacciandoli dal Meclemburgo, dallo Holstein e dallo Jutland, conquistando le isole di Als e Fyn e, infine, la stessa Pomerania e liberando la Danimarca . La Pace di Oliva (3 maggio 1660) coronò questa splendida campagna, sebbene l'azione diplomatica della Francia impedisse all'Imperatore di coglierne per inter o i frutti.

Ma Montecuccoli era già l ontano . Una nuova e più grave minaccia si andava addensando ai confini dell'Impero: i turchi, che Montecuc coli aveva sempre considerato, insieme alla Francia, il nemico capitale degli Absburgo 29 Una sola striscia di terra ungherese era rimasta alla Casa d'Austria: e d in essa, sul fiume Raab, chiudendo la strada per Vienna, era la piazzaforte di Gyor. Colà si diresse il Feldmaresciallo, cui era stato conferito il titolo di "Colonnello (ossia Governatore militare) di Gyor". Appoggiandosi a questa piazza ed alle altre fortezze, manovrando con le forze - certo non a bbondanti - che gli erano state date, doveva Montecuccoli bloccare l'avanzata dei tu r ch i, molto superiori di numero.
La crisi era cominciata proprio per l'intervento di Giorgio Rak6czy in Polonia. Agli Ottomani non era piaciuta la sua iniziativa, presa senza consultarli; il diverbio aveva suggerito alla Porta di inviare un esercito per rimettere Rak6czy alla briglia. Ne era seguito un urto armato, e il principe era morto in seguito alle ferite
28 j TLL L tsK, Th e strugr,le f or the Supremacy in the Ba/t ic: 1600-1725, Lond o n, 1967, pag. 97 e sgg.
29 H. KA UFMANN, op. c it ., pag. n.
riportate. Gli Absburgo si erano fatti avanti, proponendo un loro candidato alla successione, ma l'iniziativa era fallita ed ora il giovane e dinamico Gran Visir Ahmed Koprulu aveva spinto la Porta a dichiarar guerra all'Imperatore 30 Se Montecuccoli avesse soltanto dovuto affrontare simili difficoltà, ne avrebbe già avuto a josa: ma ad esse si aggiungevano i continui diverbi con il Bano di Croazia (ed eroe nazionale ungherese) Mikl6s Zdnyi, anch'egli un distinto scrittore e teorico militare, cui Casa d'Austria concedeva più iniziativa del necessario, allo scopo di non alienarsi del tutto gli ungheresi. Zrfoyi a sua volta, indifferente (quando non ostile) alla causa imperiale, voleva combattere la "propria" guerra, e si mostrava insofferente dell'autorità di Montecuccoli, che egli accusava di temporeggiamenti eccessivi (lo soprannominò magnus cunctator). La verità era che Montecuccoli applicava una strategia consona alle esigenze absburgic h e (cedere magari spazio per guadagnare tempo, in attesa che la coalizione antiturca che stava formandosi gli inviasse truppe a sufficienza per dar battaglia); mentre Zrfnyi voleva anzitutto contendere al nemico il suolo ungherese, poco importandogli se l'Imperatore ne traeva danno 31 • Sul tron o sedeva dal 1658 Leopoldo I , il terzo sovrano sotto cui ebbe a servire Montecuccoli. Anche Leopoldo av eva nel Nostro la più grande fiducia e lo confermò conferendogli nel 1661 il grado di Feldmaresciallo generale, che lo poneva al sommo della gerarchia militare absburgica, al di sopra di ogni altro 32 • Ma ora Montecuccoli doveva prepararsi a fronteggiare il terribile assalto di Ahmed Koprulu . Costui era forte di quasi 100.000 uomini, mentre il Feldmaresciallo generale poteva disporre di non più che 12 .000 regolari. Altri 28.000 (truppe di guarnigione) erano a presidio de ll e fortezze, mentre sui 15 000 di Zrfnyi si pote va fare ben poco conto 33 . Sottraendo le forze che Kopriilu era a sua vo lta
30 Su tutta questa parte, si veda : PETER SuGAR, Southeastern Europe under Ouoman rule, 13 54- 1804, Seatt!e (Wash ) and London, 1974; che però, pur essendo ottimo nel complesso, dimostra un a ben scarsa comprensione de lla strategia militare di Montecuccoli Sulle forze armate dell'Impero Ottomano , cfr.: RoBERT MANTRAN, L 'évolution de l'Armée Ottomane aux XVI et XVII siècles, rei. inedita presentata alla sedicesima settimana di studio dell'Ist. lncernaz. d i Storia Economica «Francesco Datini», Prato, maggio 1984.
3 ' Si paderà più oltre dell'aspetto ideologico della controversia t ra Zrfnyi e Monrecucco li: su d i essa si vedano gli ,studi fondamentali di GÉZA PERJÉS, Kinek volt igaza?
A Zr{nyi-Montecuccoli vita, in : Elet és Tudomany, 26/11 e 3/12 1961, pag. 1507 sgg. e 1539 sgg. ; nonché: A Metodizmus és a Zrinyi-Montecuccoli vita, i n: «Szazadok», 1961, n . 4-5, pag. 507 sgg.; e 1962, n. 1-2, pag. 25 sgg.

32 C. CAMPORI, op. cit., pag. 362.
33 KuRT P EBALL, Die Schlacht bei St. Gotthard-Mogersdorf 1664, in: Milàarhistorische Schriftenreihe, Heft 1, Vienna, s.d., pag. 5.
cos tretto a lasciar a guardia delle fortificazioni e d e ll e r etro vi e, si può calcolare che il Gran Visir potesse disporre di 60.000 effettivi : sempre una superio rià schiacciante su Montecuccoli. Ma il condottiero sapeva che tutta l'Europa stava ora destandosi alla minaccia turca. La Germania tremava: la Dieta dell'Impero (e Montecuccoli si era personalmente recat o a Ratisbona per questo fine) aveva deciso di entrar nel conflitto, per cui i Principi tedeschi avrebbero in v iato rinforzi; il Papa e gli Stati italiani stavano pure muo ve ndosi; soprattutto, incre dibil e a dirsi, il re di Francia Luigi XN stava per scendere in campo assieme ai non amati Absburgo contro i quasi-alleati Ottomani 34 Venezia impegnava fortem ent e i turchi a Candia.
Il problema quindi per Montecuccoli era ancora una vo lta di guadagnare tempo conservando le proprie forze intatte in attesa che l'arri vo degli alleati gli consentisse di assestare ai turchi un colpo demolitore che risolvesse una volta per tutte la g uerra. Contro di lui il Gran Visir aveva il vantaggio delle lin ee interne. Tra il 14 maggio e l'inizio del giugno 1664 egli si era audacemente spostato da Ess eg, alla confluenza tra il Da nubio e la Drava, ri salendo quest'ultimo fiume fino a Nagy Kanizsa, e schierandosi lungo la Mur, affluente di sinistra della Drava. Da là, egli poteva o traversare la Mur per tagliare a Montecuccoli i rifornimenti che discendevano lungo tale fiume da Graz, o portarsi rapidamente verso Nord-O vest, sulla Raab, sia per forzarla come aveva fatto Solimano II nel 1529, sia per tagliare da quella parte a Montecuccoli i ri fornimenti della linea Vienna-Oldenburg-Giins-St. Gotthard e poscia estendersi fino a Ostrande des W echsels per marciare su Vienna dal passo di Wiener-Neustadt e assediare la capitale, che allora era assai meno fortificata di quanto non lo sare bbe stata poi, nel 1683 35 •
Ma Montecuccoli aveva già spinto avanti tra la Mur e la Raab i suoi esploratori, e seguiva attentamente le mosse del n emic o. Egli non aveva ancora rice v ut o i rinforzi che gli erano indispensabili:
34 Sui rapporti fr anco-ottomani , cfr. la relazione inedita, presentata da Jean Berenge r al Congreso In te rnaz io na le di Storia militare tenutosi a Vienna ne l g iu g no del 1983: Les vicissitudes de l'alliance milùaire franco-turque, 1520-1800.
35 G EORG WAGNER, Die Schlacht van St Gotthard-Mogersdorf und das Oberkomman· do Raimund Montecuccolis · Mit Berucksichtigung der Manovrierkunst Raimund Monte· cuccolis vor der Schlacht und der Bedeutung seine A bwehrsieges an der Raab in: Accademia Nazio nal e d i Scienze, Lettere ed Art i - Modena, Atti del Convegno di Studi su Raimon· do Montecuccoli nel terzo centenario della battaglia sulla Raab, in Pavullo nel Frignano e in Modena, settembre 1964, M odena, 1964, pag. 155 sgg.; pag . 160. Il Wagner e il P eball, art. cit., n. 32, so no le gu id e più aggiornate e preziose per il quadro genera le della campagna di San Gott ard o

S : fortezze cristiane
't : fo r tezze t urchiz
c:::::::C> , k'iirru1ii 1GG4
_. : Montecuccoli 1664
llacx{> : Alì Pascià 1664
, de Souches 1664


Scagliane l og isti c a Scagl ione Logist;co Sc.aQhone l aQistica
1. Ago.rio i 661, Ore 13
Riserva: 7 B as (llo9er.sdorl)
e sebbene, quando li avesse avuti, non avrebbe potuto di sporre di più c h e 26 .000 uomini di prima linea contro circa 50.000 turchi, aveva de cis o di dar battaglia. Solo, avre bbe att e so che i turchi attaccassero: difensiva tattica, offe n s iv a op e rativa e strategica36 • Montecuccoli aveva preso posizion e di front e al Gran Visir sulla riva opposta della Mur: situaz ione fortissima che n ello st esso temp o gli consentiva di sorvegliare le mos se d e i turchi ed att e nde r e in relativa sicurezza i rinfor z i; ciò sebbene egli esprimesse preoccupazion e circa qualche pressione della Corte o del Consiglio Aulic o che lo costringessero a dar battaglia prima del tempo 37• Il fiume largo e profondo lo prote ggeva da ogni attacco n emico e nello stesso t e mpo g l i conse ntiva di so rv e gliare l e mosse dei turchi e controman ovrare rapidam e nt e , mentre l e s ue spalle e rano coperte dalla Drava. Kopriilii osservò per quasi un mese la posizion e : non c ' era verso di stanare Montecuccoli. La Mur era un ri spettabile fiume e cercar di passarla di fronte al nemico sarebbe stato un disastro, anch e se a quella data il grande capitano era ancora in attesa che i francesi e l'artigli e ria, che erano in arrivo, lo raggiungessero. Il 12 lugl io il Gran Visir si riso lse. Levò il campo e si pose ri solutam e nte in marcia verso Nord, in direzione della Raab. Sperava evidenteme nt e ch e o Montecuccoli gli sarebbe venuto dietro (ed in tal caso al turco sarebbe stato facil e attaccarlo in rasa campagna e schiacc i arlo sotto il peso della sua superi o rità numerica) o a lui sarebbe riuscito di passare la R aab e s cendere su Vi e nna. Il 26 luglio il turco raggiungeva la Raab davanti a Kormend: ma s ull'altra riva vi era già Montecuccoli schierato ad i nterdirgli il passaggio. Il grande capitano, che nel frattempo av e va ric ev uto i sospirati rinfor z i, av ev a divinato i propositi d e l n e mic o e non av e va fatto ne ss una dell e mosse ch e qu e sti sp erav a. In ve ce s i era posto r apidamente in mar c ia se mpr e ten e nd os i coperto dietro il corso d e lla Mur e posc i a d e lla L e ndv a; aveva p ass ato la Raab a San Gottardo,
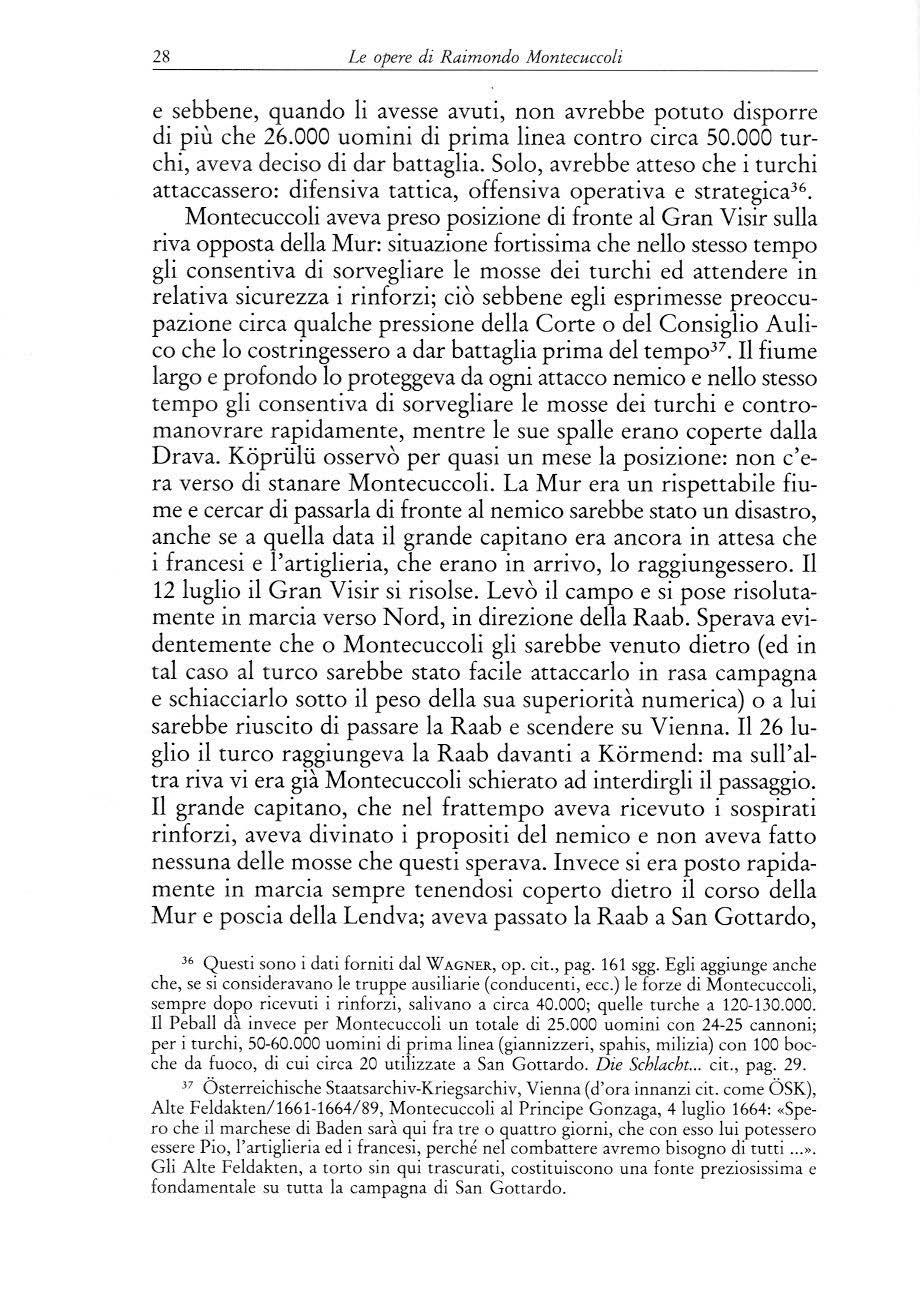
36 Q u esti so no i dati fornit i dal WA GNE R, o p. ci t., p ag 161 sgg Egli aggiunge anche ch e , se si cons ide r ava n o l e truppe a usiliar ie {cond uce nt i, ecc.) le forze di Montecuccoli , se mpre d opo r icevut i i rinfo r z i, sal iva no a circa 40 000; q u e ll e tu rche a 120-130.000 Il Pe ball dà in vece per Montecucco li un t ot ale di 25. 000 uom ini con 24-25 can noni; p er i tu rc hi , 50-60.000 u om i ni d i pr ima li n ea {gian nizze r i, spa hi s, m iliz ia) con 100 bocch e da fuoco , d i cui circa 20 u ti li zzate a San Got tard o Die Schlacht c it., pag 29 37 Osterr eichi sc h e Staat sarc hi v-Kr iegsarchiv, Vienna (d'o ra in nanzi cit. come 6SK), Alte Fel dakte n / 1661- 1664/89, Mo m ecucco li al Pr incipe Go n zaga, 4 lugl io 1664: «S p ero che il m arch ese d i Bade n sar à q ui fra t re o q uattro gi orni , che co n esso lui p otessero esse r e Pi o, l'art igl ier ia ed i francesi , p erché nel com b attere avre mo b isog no di t u t t i "·
G li Alt e Fe ldakten , a t0rt o s in q ui trascurati, cost ituiscon o una fo nte prezi os iss im a e fondamentale su tutta la campag na di San Gottardo.
30 chilometri a monte di Kormend, quindi aveva disceso il fiume bloccando il passo al turco, le cui mosse egli aveva seguito ora per ora mediante la sua cavalleria e i suoi esploratori 38 •
Ora Koprulii prese la decisione estrema: passare la Raab, dare battaglia, aprirsi la via con la forza. Ma non a Kormend, dove il fiume era troppo largo e profondo: a San Gottardo, ove era passato Montecuccoli. Il 30 luglio si pose in marcia, risalendo il corso del fiume. Montecuccoli era già in movimento ed aveva già scritto le 4irettive tattiche per l'.immi~ente gran~e _battaglia.: picchieri su 3 nghe, e appresso due nghe d1 moschetuen; ad ogni Squadrone di cavalleria 1 plotone di 24 moschettieri; fuoco di fila (o di riga): una spara, l'altra carica, mai tutte insieme; mai separarsi tra fanteria e cavalleria; nelle brecce nemiche doveva entrare la cavalleria leggera. Marcia in ordine di battaglia39 • Le forze a sua disposizione erano, a dir poco, composite. Le truppe regolari imperiali, tutte di prima qualità, consistevano in 5000 fanti e 5900 cavalieri; quelle dei Principi e degli alleati tedeschi, in 6800 fanti e 1500 cavalieri, di qualità assai disuguale e per lo più mediocre; i francesi disponevano di 3500 fanti (tra cui il Reggimento di Carignano, unità di élite, destinata poi a conquistare il Canada per il re di Francia) 40 e di circa 1900 cavalieri, che annoveravano il fiore della nobiltà francese: tutte truppe di primissimo ordine, al comando del Tenente-generale Jean de Coligny-Saligny e del suo pari grado (ma sottoposto) La Feuillade alla testa della fanteria (la cavalleria era al comando del generale de Gassion). I tre eserciti erano stati messi assieme all'ultimo momento; non c'era stato tempo per omog e-
38 OSK , Al te Feldak ce n/ 1661-1664/ 89, D iar io d i Mo nt ecuc co li, 27 lugli o 1664.
39 0 SK, A lte Feldakte n 166 1-1664 /8 9, o rdin e di b attaglia
• 0 I doc u me nti s ulle origi ni e la ge n esi del R egg im e nt o d i C ar igna no, uno tra i più i llu st ri e prestig ios i ne lla st oria m ilitar e pie m onte se e posci a francese , fondat o in Pi em o nte dal Pr in cip e Tom maso e r i m asto a r ecl utam e n to local e in grande maggiora nza an ch e d opo passat o a l servizio de lla F r ancia, sono in: Arch ivio di Stat o, T or in o (d 'o r a inn a n zi cit. co me AST ), Sez. I, Corte, R eal C asa, Lette re Prin ci pi d i versi, Savo iaC arignan o, mazzo 57, Letter e vari e di E manuele Fili berto Amed eo di Savoia. I docum. , ind ividu ati dappr im a grazie all a so ler z ia d el co m pi ant o Arc h iv ista d r. C aviglia, so n o d el nuovo proprietario d el R eggim ento, il P rincipe Emanuele F iliberto A mede o , fi glio di Tomm aso , e si esten d o n o d al 1657 fi n o al 1662 , q uas i alla vig ilia di S. G o t t ar d o . Per il peri o d o succ ess ivo, in cui i l R eggimento si cop er se di gl oria in Canad a dando un c ontri b ut o d ecisivo alla con q uist a di t ale paes e (e dove i su o i co m ponent i fond arono p iù d i u na illu st r e fam ig lia can adese), ved ansi : F .X. G ARNEAU, Histoi re du Canada depu is sa découver te jusqu 'à nos jours, II éd itio n... , t o m e I, Q u ébec , l 852, ove vi sono dat i co nsistenti su lle v ice n de am eri ca ne de l R eggimento (devo t ale segn alazion e alla cort es ia de lla co mpi anta amica L aura Co lon netti); non ché: W illi a m J. Eccl es , Canada unckr Lo uis XIV, 1663-1701, Toro nto, 196 4. I d ocum re lat iv i al periodo ca nad ese sono p er lo p iti in: Ar ch ives Nationales, P ar is (d ' or a in n an z i ind. co me ANP) , fondo Cll . (Cfr .: Les A rchives Nationales · état général de s fonds, tome lii: Ma rine et Outre -mer, Par is, 1980)

1. "Prima della battaglia, . .

a. Turchi o. fìran V,J;.ir c.lmper1Jlt
d,e. 7è.de.1c/J/ f. Trances/ g. Jrt,s,f.e
2.Durante la ba1tagl,a.:
h. ba/terie turche .I. Fràncesi
/{.Cavalier/a turca ala sn. l. Id.ala dr. rn. Id. al centro n.!d.riserva
neizzarli e le rivalità sotterranee erano forti. Da parte sua Ahmed Kopriilii si teneva certo della vittoria; già aveva fatto fondere a Belgrado 12 enormi cannoni per bombardare Vienna 41 •
Il 31 luglio i due eserciti si fronteggiavano attraverso la R aab, qui di dimensioni modeste, all'altezza di San Gottardo. Montecuccoli aveva schierato sulle ali le truppe più solide: gli absburgici a destra, i francesi a sinistra. Al centro (il posto più sicuro di tutti) gli alleati germanici42 •
Durante l'intera notte sul 1° agosto 1664 l'artiglieria turca batté le posizioni imperiali: il Gran Visir voleva creare uno stato di inquietudine e di tensione ed anche preparare l'attacco. Verso le 4 antimeridiane del 1°, i turchi scagliarono circa un migliaio di cavalieri contro l'ala destra di Montecuccoli nel chiaro tentativo di respingerla ed avvilupparla. Montecuccoli reagì inviando sul posto 1000 tra dragoni, croati e cavalieri tedeschi, tutte truppe scelte, al comando del generale von Sporck. Il nemico non insistette e, dopo un vivace combattimento, ripassò la Raab . Non era quello l'attacco principale 43 •
Il colpo di maglio arrivò alle 9 del mattino, quando Ahmed Kopriilii poteva pensare di aver ormai distratto l'attenzione del nemico verso l'ala: e fu diretto al centro. Il turco, scagliando qui la massa delle sue truppe migliori, giannizzeri e spahis, tentava di tagliare in due tronconi l'esercito nemico ed annientarlo. I turchi non ebbero problemi a varcare la Raab, larga colà non più di dieci passi, e con un'ansa nella loro direzione, sì che essi, stabilita la testa di ponte, si trovarono protetti sui fianchi dal corso d'acqua e non ebbero alcuna difficoltà a sbucar fuori all'attacco 44 •
Tosto essi arrivarono addosso alle truppe degli alleati tedeschi, le meno solide, che non tardarono a trovarsi a mal partito poiché, dopo aver respinto il primo assalto, contravvennero ai precisi ordini di Montecuccoli e si gettarono in disordine dietro il nemico. I giannizzeri poterono facilmente fermarli, ricacciarli e ribaltare la situazione contro forze ormai irrimediabilmente mescolate e confuse45 •
41 G. WAGNER, op. cit., pag. 162.
42 ÒSK, Alte Feldakten/1661-1664/89, Montecuccoli all'Imperatore, 8 agosto 1664.
43 ÒSK, Raimondo Montecuccoli, Relazione della Campagna dell'Annata capitale nell'anno MDCLXIV, 1 agosto 1664; ibid., seconda relazione, 2 agosto 1664, più note del 15 dicembre st. anno.
44 ÒSK, Raimondo Montecuccoli, Relazione , cit.
45 G. WAGNER, op. cit., pag. 192.

Nel m omento terribile Montecuccoli ordinò che ogni reparto mantenesse le propri e posizioni: &11ai se l'intera armata fosse accorsa al centro! Per parte sua invio in rinforzo un gruppo di elementi scelti: due Reggimenti di fanteria e uno di corazzieri, al comando di uno tra i suoi più valenti collaboratori, il march ese Erberto Pio di Savoia. Era la sola cosa che poteva farsi: Mont ecuccoli non dimenticava mai , neppure per un istante, di dover tenere un vastissimo fronte cont ro un nemico più che doppio di numero.

Ma intanto i giannizzeri premevano furiosamente al centro: due su tre dei Reggimenti inviati di rinforzo ebbero i colonnelli uccisi alla loro testa; le truppe degli stat i tedeschi, già malferme, cominciarono a rompere e furono cacciate dal vi llaggi o di Mo gersdorf che cadde in mano al nemico il quale ora riuscì a perforare il loro centro. Temp estivam ente Montecuccoli, avendo osservato che gli stessi ranghi turchi si erano alquanto sconnessi nell'immenso sforzo, gettò loro sui fianchi i Reggimenti germa ni ci freschi nonché tre R eggimenti austriaci scelt i. Ora i turchi ripiegarono entro la loro testa di ponte e il condottiero abs burgico pot é ricomporre i ranghi delle truppe attaccate 46 • Era mezzogiorno . I turchi rimanevano att estat i sulle posizioni e stavano comi nciando a scavarvi trincee : occorreva una rapida decisione s ul da farsi . Montecuccoli convocò una riunione dei suo i comandanti in sottordine, e pose loro dinanzi in chiari termini la situazione: o rimanere sulla difensiva, lasciando l'iniziativa al nemico, o contrattaccare immediatamente e coglie r e l'occasione di assestare ai turchi un co l po mortal e. Ma p e r far ciò occorreva impegnare a fondo il contingente francese : e qui si manifestarono le esitaz ioni di Coligny il quale obiettò c h e il suo re gli aveva affidato il fior fiore delle proprie truppe e c he egli non poteva rischiarne la distruzione. Andavano così emergendo tutte le debol ezze di una coalizione su cui non era stata data a Montecuccoli quell'au torità totale che gli sarebbe stata indispensabile. Fortunatamente Hohenlohe (comandante di quelle truppe tedesche alleate che non dip e ndevano dalla Dieta), e i francesi La Feuillade e Beau vez é sostennero Montecuccoli; fu infine raggiunta la decisione di attaccare il nemico da ogni lato e con tutte le forze 47 •
• 6 K. PEllALL , Die Schlacht..., cit., pag. 16 sgg.
47 Molte falsi t à e calunnie furono diffuse dopo la banaglia perché, come è noto, la vittoria ha molti padri, mentre la sconfitta è orfana. Tutti cioè si attribuirono il merito delJ'attacco finale, e prima di ogni altro proprio i francesi, da cui erano venute le

Immediatamente, non appena strappato il consenso di tutti i capi d ella coalizione, Mont ec uccoli si pos e ad elaborare il piano di attacco, impartÌ le disposizioni, diramò l 'o rdine di esecuzione. Ma intanto il Gran Visir, visto il successo del mattino, stava spingendo tutte le sue truppe oltre il fiume. Egli cadeva così nell a trappola che Montecuccoli aveva apprestato per lui, poiché qu esti - come Annibale a Canne - stava preparandosi ad attanagliare sulle ali il nemico che formava un grosso sali ente al centro : per il momento però occorreva che il centro di Montecuccoli regge sse ancora per un poco. I turchi premevano con una colonna d'assalto di 4000 spa hi s freschi, e dietro ne avevano già in iscaglione altri 10.000 da buttar nella breccia. Montecuccoli indirizzò colà il fidato von Sporck con un gruppo di trupp e scelte: il R eggim ento Montecuccoli insieme ad altri tre riuscì ad arginare e respingere l 'assalto. Erano le 13: ora il dispositivo d'attacco del condottiero italiano era pronto a scattare . Montecuccoli aveva schierato Battaglioni di fanteria e Squadroni di cavalleria alternati. Di colpo la morsa si strinse attorno all e forze ottomane; premendo avanti vigorosamente, le colonne dei collegati rag giu nsero in alcuni punti la riva del fium e alle spalle della t es ta di ponte turca. Tra le fil e nemiche cominciò il panico; numerosi, travolti nella rotta, perirono annegati nelle acque del fiume. Kopri.ili.i cercò di ripre1.dere il controllo delle sue truppe, uccise di sua mano otto sottufficiali che si eran o fatti pr endere dal panico, pervenne in qualche modo a riorganizzar e le sue forze e si pose tosto in ritirata. Ben tre Pascià erano caduti sul campo 48 •
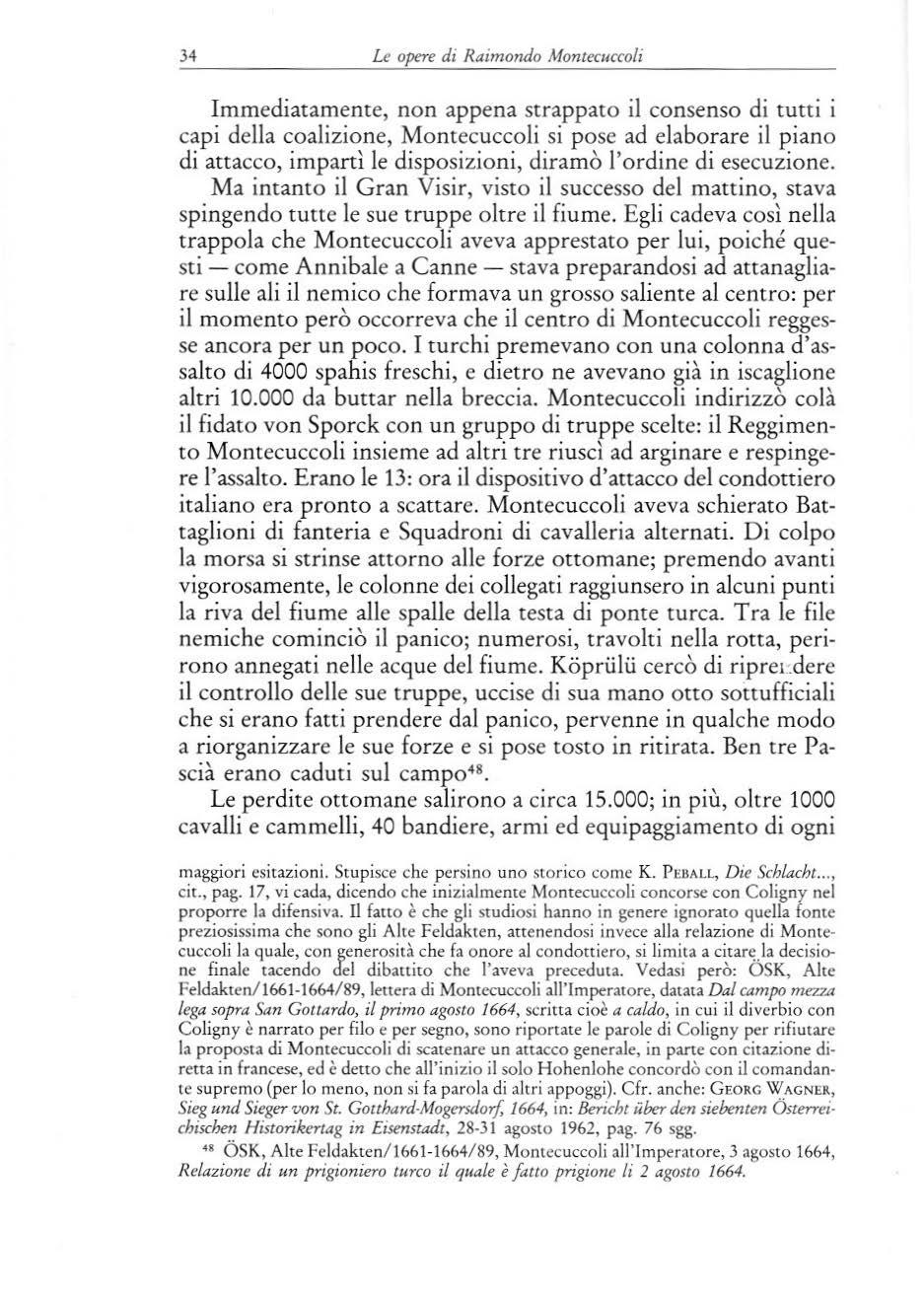
L e perdite ottomane sa lirono a circa 15 .000; in più, oltre 1000 ca valli e cammelli, 40 bandiere, armi ed equipaggiamento di ogni maggiori esitazioni. Stupisce che persin o un o stor ico come K. P EBALL, Die Schlacht , cit., pag. 17, vi cada, dicendo che inizialmente Momecuccoli concorse con Coligny nel proporre la difensiva. Il fatto è che gli studiosi hanno in genere ignorato quella fonte preziosissima che sono gli Alte Feldakten, attenendosi invece alla relazione di Monte· cucco li la qual e, con generosità che fa o nore al con dotti ero, si limi ta a citarE,,la decisione finale tace ndo del dibattito che l'aveva preceduta. Vedasi però: OSK, Alte Feldakten/ 1661-1664/89, lettera di Momccuccoli all'Imperatore, datata Dal campo me= lega sopra San Gottardo, il primo agost o 1664, scritta cioè a caldo, in cui il diverbio con Co li gny è narrato per filo e per segno, sono riportate le parole di Co ligny per rifiutare la proposta di Montecuccoli di scatenare un attacco generale, io pane con citazione diretta in francese, ed è detto che all'inizio il solo Hohenlohe concordò con il comandante supremo (per lo meno, non s i fa p aro la di altri appoggi). Cfr anche: GEORG W,AGNJ,R, Sieg und Sieger von St. Gouhard-Mogersdorf, 1664, in : Bericht M,er den siebenten Osterrei· chischen Historikertag in Eisenstadt, 28-31 agosto 1962, pag. 76 sgg.
48 OSK, Alte Fe ldaktcn /1661 - 1664/89, Montecuccoli all'Imperatore , 3 agosto 1664, Relazione di un prigioniero turco il quale è fatto prigione li 2 agosto 1664.
tipo caddero in mano ai vincitori che per parte loro avevano perso circa 2000 uomini tra morti e feriti 4 9 • La vittoria era decisiva e totale; la Porta si affrettò a chiedere di trattare, e solo le nubi che l'Imperatore vedeva addensarsi in Europa occidentale fecero sì ch e , inv e ce di continuare la guerra fino alla disfatta dei turchi , l'Impero accettasse di concludere con loro la tregua di Vasvar (1664). Forse, malgrado tutto, si sarebbero potute imporre ai turchi condizioni ancor più dure se Montecuccoli a vesse avuto a disposizione un esercito omogeneo, e non una coalizione composita che ora, vinta la battaglia, stava dissolvendosi perché gli alleati si affrettavano a tornarsene a casa propria lasciandolo con le sole truppe absburgiche, del tutto insufficienti a condurre una campagna di inseguimento contro un ne mico v into, sì, ma tanto più numeroso di loro. Montecuccoli non dimenticò questo: invero, tutti i seguenti anni della sua vita, pur in mezzo ad infiniti compiti, sarebbero stati dedicati a costruire quell'esercito imperiale absburgico che avrebbe consentito all' I mpe ratore di non dipendere più dai capricci di altri. Le proporzioni comunque della vittoria erano difficili da soprav valutar e ; essa av eva sbloccato Vienna, ove si erano ammassati 70.000 profughi; av eva allontanato la minaccia dall'int e ra Mitteleuropa ed aveva per il momento deci so il destino del continente. Per i turchi Montec uccoli di ve nne un demonio: mai più, fin quando egli visse, osaron o essi rinnovare l'attacco contro il cuore dell'Impero 50 •
I nsieme all'ammirazione dell'Europa, la riconoscenza dell'Imperatore non mancò al capitano vittorioso. Egli fu ora nominato
Luogotenente G e nerale de ll'Impero, carica che lo poneva al sommo d ella gerarchia militare , quasi al livello stesso del Sovrano5 1 ; se guirono le nomine a Presidente dell'Imperia! Consiglio Aulico Militare (equivalente alla carica odierna di Ministro della Difesa),
• 9
K. P EBALL , Die Schlacht ... , cit. , pag . 20 .
50 C. CAMPO RI , op cit , pag. 413.
s, L 'Im pe r a t ore st esso vo lle d argl iene not iz ia m ediant e d ue lette r e per so n a li, scr itte pe r defe r e nza in Italiano (vedile in: G. G ualdo Priorato, op. cit. , appendic e)

a Gran Maestro d ell'Artiglieria e Fortificazioni, a Cavaliere del Toson d'Oro. Nessuno mai, dai tempi di Wallenstein, aveva accumulato un tal potere n elle proprie mani; ma a differenza del Duca di Friedland egli era totalmente fedele all'Imperatore e ne godeva la personale, profonda amicizia. Di più in più egli era, di fatto, l'Impero: ora altre delicate missioni diplomati c he gli vennero affidate perché nessuno meglio di lui poteva e sapev a rappresentare il governo a bsbur gico di fronte agli stranieri .
F urono anche anni con momenti di relativa tranquillit à, in cui Montecuccoli poté dedicarsi, rella pace di Hohen egg, allo studio e alla stesura d elle s ue o pere. E di questi tempi il su o capolavoro, Sulla guerra col Turco in Ungheria, la cu i prima parte è me gli o nota con il titolo di Aforismi e di cui si dirà più oltre.

Aveva 63 anni quando il Sovrano gli affid ò ancora una volta il comando dei suoi eserciti in campo. Era una stran a situazione: Luigi XIV aveva attaccato l'Oland a; Austria e Spagna si preparavano a scen dere in guerra per blo ccare l' espansionismo del re di Francia. Montecuccoli che da tempo seg uiva la si tuazione aveva indicato chiaramente il da farsi: alleanza con il Brandenburgo; pass ag gio rapido del R eno e unione tra le forze absburgiche e quelle ispano-olandesi nei Paes i Bassi . N o n ci fu nulla d a fare. A Vienna il francofilo Cancelliere Lobkovic raccomandava che non si attaccasse se non provocati, per c ui Turenn e poté passare il R eno presso Colonia e invadere la Germania. Ora si com in ciò a capire che Montecuccoli aveva ragione; l'Imperatore gli fece dare illimitata autorità di condurre la ca mpagn a secondo i suoi criteri.
Dopo quasi venticinque anni eg li si trovava di nuov o dav a nti il suo antico avversario, il Maresciallo Ture nne . Era il 1673, i francesi, dopo aver costretto alla pace separata l'Elettore di Brandenburgo (come Momecuccoli aveva previsto) muovevano ora dalla Bassa Rena nia in direzione Sud, verso il Meno. Raggiunto tale fiume, Turenne intendeva risalirlo e muovere risolutamente incontro alle forze imperiali che, egli sap eva, stavan o concentrandosi in Boemia52 • Tutta via il condottiero francese faceva n otare a Louvois che, così operando, egli si sarebbe di necessità lasciato un vuoto alle spalle, sul basso R eno 5 3 Era il Tallone d'Achille dei francesi: e Montecu ccoli si apprestava a colpirlo .
Turenne per parte sua stava chiedendo rinfor zi a Louvois: gli sarebbero bastati 1000 fanti e quattro o ci nqu e Squadroni di ca-
si Arc hive s de la Gu e rre, Paris (d ' ora inn a nzi indicato come AGP) , Al 154, Turenne a Louvois , 12 lu gl io 1673.
H AGP , Al 347, 224 , Turenn e a L o uvoi s, 5 ag osto 1673
v all eria da inviarsi a presidiare almeno una delle fortezze ad E. del Reno ed a N. del Meno 54 • Non fu possibile: e Turenne che si e ra avanzato fino a W etzlar sulla Lahn (circa 60 km ad E. del Reno) mosse risolutamente in agosto verso il Meno, lo passò e penetrò in Franconia. Aveva udito che Montecuccoli era al comando degli imperiali e intendeva affrontarlo. Ai primi di settembre il Maresciallo generale 55 di Francia era davanti a Wiirzburg e di fronte a Montecuccoli. P er giorni i due avversari si studiarono : Montecuccoli sapeva benissimo che il francese intende v a dar b attaglia il più presto possibile, ed era ben deciso a non fare quanto l'avversario voleva. In effetti il grande italiano stava preparandosi a ben altro: a strappare l'iniziativa dalle mani del nemico e ad imporgl i la propr ia vo l ontà strategica . Montecuccoli non era solo un generale, ma anche un diplomatico di prim'ordine e ment re teneva a bada Turenne presentandogl i continuame nt e la punt a della propria spada, stav a trattando con il neutrale Vescovo di Wiirzburg per ottenerne il controllo dei ponti sul Meno. Il 17 sett e mbre scoperse repentinamente le proprie batterie: padrone dei p onti a Wiirzburg ed a Kitzingen, egli apparve alle spalle di Turenne che dovette adesso abbandonare il fiume e ripiegare verso O., in direzione di Eberstadt 56 • Ma Montecuccoli non intendeva seguirlo. Ripassato rapidament e il Meno, egli stava ora marciando su Francoforte e Magonza, che cadde nelle sue mani alla metà di ottobr e. Ad esso tra i francesi l 'a ll arme fu gen erale: Montecuccoli stava accennando a lanciare un ponte di barche per minacciare la stessa Francia! Di fronte al tremendo pericolo , Turenne dovette muo vere a marce forzate verso S. per varcare il Reno a Philippsbourg, ove c'era l'unico passaggio disponibile: ma Montecuccoli l o aveva ancora giocato. Ritirato velocem ent e il ponte mezzo finito, scese lungo il corso del fiume avendo imbarcato la gran parte delle sue forze (e il più d ell'artigli eria) sugli stessi barconi da pontieri; si ricongiunse a Coblenza con l'alleato Principe di Orange e investÌ Bonn , capitale dell'Elett ore Arci v esco v o di Colonia, alleato dei francesi: il 12 novembre 1673 la grande fortezza cadeva nelle sue mani. Scrive l'Ekberg:
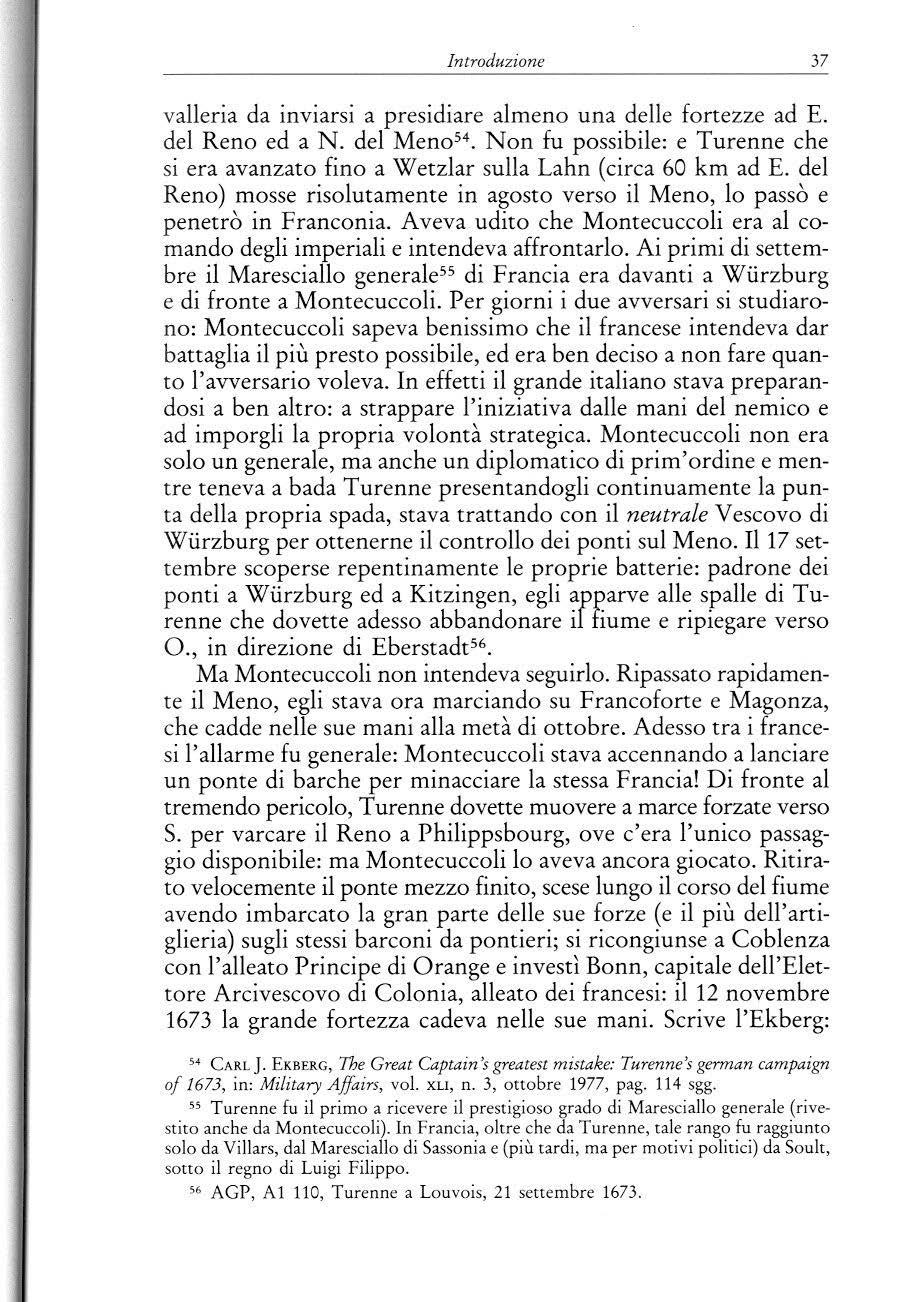
5 4 CARLj. E KBERG, Jhe Great Captain's greatest mistake: Tu renne's germ an campaign of 1673, in: Mi litary Affairs , vo i. XLI , n. 3, otto bre 1977, pag 114 sgg
55 Ture nn e fu il p ri mo a r ic e vere il prest igioso g rad o di Maresci a ll o ge ne rale (ri vest it o a n che d a Montec uccoli). In F r ancia, oltre che d a T ure nn e, ca le ra ngo fu raggiu nto solo da Vi llars , dal M are sci all o di Sasso nia e (pi ù tardi , m a p er mo t iv i p o lit ici) da So ult, sott o il r egno d i Lu igi Fi lipp o .
56 A GP, A l 110 , Ture nn e a Lo u vois, 2 1 sette mbr e 1673
«Fu una grande vittoria strategica e psicologica per i nemici di Luigi XIV. Essa fece svani re il mito dell'invincibilità fran cese; frantumò il dominio della Francia sul co rso del R e no; e fu un fattore decisivo nel convincere la Dieta dell' I mpero a dichiarare guerra alla Francia nel maggio seguente. Più di trent'anni sarebbero passati prima che un ese rcito francese osasse nuovamente penetrare in profondità in Germania. Sebbene M o nt ecuccoli sia più celeb rato per l a sua v ittoria contro i turchi a San Gottardo nel 1664, la campagna del 1673 fu a ragione chiamata il suo capo · lavoro)) 57 •
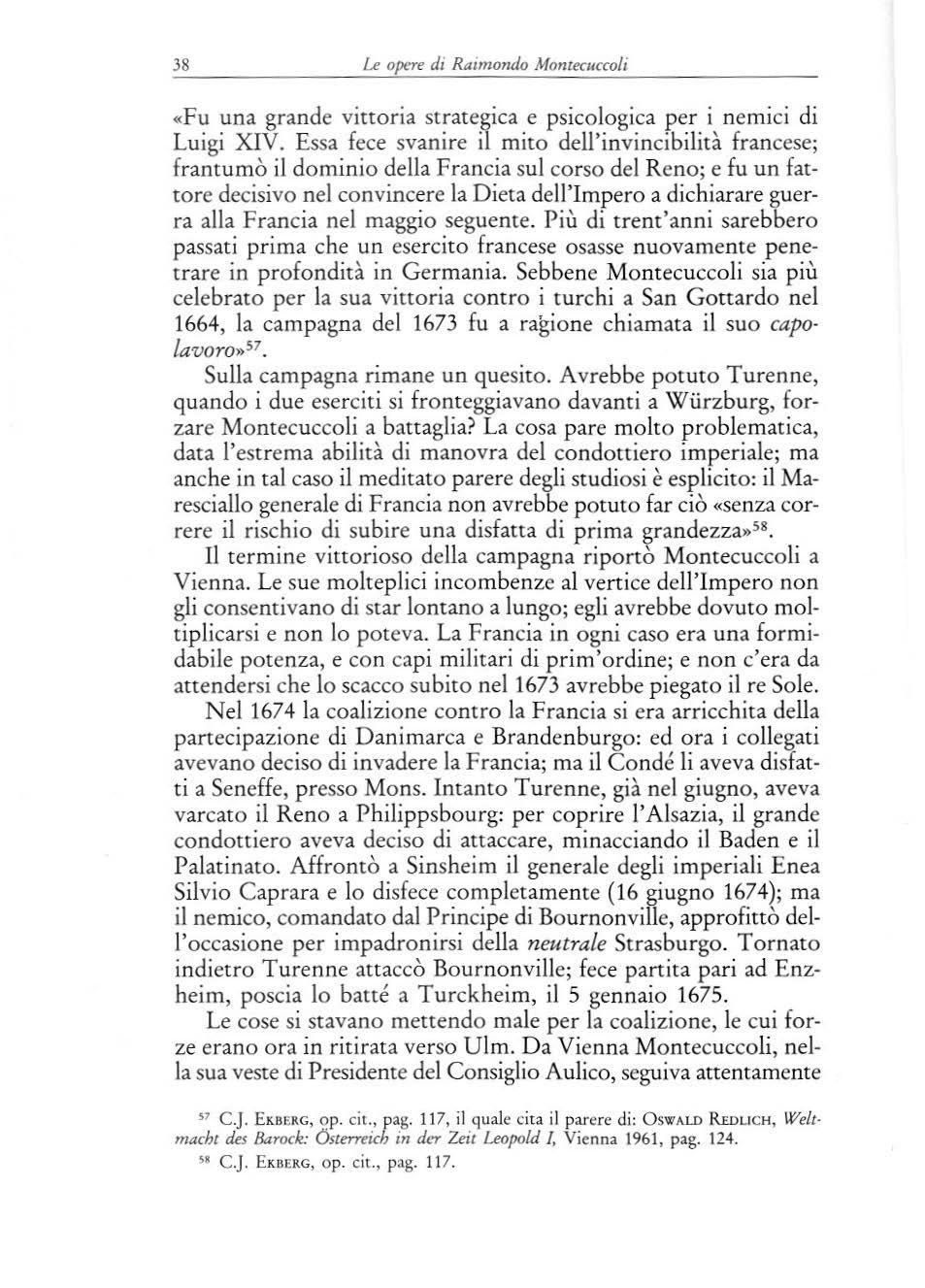
Sulla campagna rimane un quesito. Avrebbe potuto Turenne, quando i due eserciti si fronteggiavano davanti a Wilrzburg, forzare Montecuccoli a battaglia? La cosa pare molto problematica, data l'estrema abilità di manovra del condottiero imperiale; ma an che in tal caso il meditato parere degli studiosi è esplicito: il Maresciallo generale di Francia non avrebbe potuto far ciò «senza correre il rischio di subire una disfatta di prima grandezza» 58 •
Il termine vittorioso d e lla ca mpagna riportò Montecuccoli a Vienna. Le sue molteplici incombenze al vertice dell'Impero non gli consentiva n o di star lontano a lungo; egli avrebbe dovuto moltiplicarsi e non lo poteva. La Fran c ia in ogni caso era una formidabile potenza, e con capi militari di prim'ordine; e non c'era da attendersi che lo sc acco su bito nel 1673 avrebbe piegato il re Sole .
Nel 1674 la coalizione co ntro la Francia si era arricchita della partecipazione di Danimarca e Brandenburgo: ed ora i co ll egati avevano de c iso di invadere la Fran cia; ma il Condé li aveva disfatti a Sene ffe , press o Mons. Intanto Tur e nne, già nel giugn o, aveva varcato il Reno a Philippsbourg: per copri r e l'Alsazia, il grande condottiero aveva deciso di attaccare, minacciando il Baden e il Palatinato. Affrontò a Sinsheim il generale degli i m periali Enea Silvio Caprara e lo disfece completamente (16 giugno 1674); ma il nemico, co m an dato dal Prin ci pe di Bournonville , approfittò del1' o ccasio ne per impadronirsi della neutrale Strasburgo . Tornato indietro Turenne attaccò Bournonville; fece partita pari ad Enzheim, poscia lo batté a Turckheim, il 5 gennaio 1675 .
Le cose si stavano mettendo male per la coalizione, le cui forze erano ora in ritirata verso Ulm. Da Vienna Montecuccoli, nella sua veste di Presidente del Consiglio Aulico, seguiva attentamente
57 C.J. EKBERG, C! P· cit., p ag. 117, il quale ci ta il parere di: OswALD RwL1CH, Welt· macht des Barock: 6sterreich in der Zeit Leopold I, Vienna 1961, pag. 124.
~8 C.J. EK!l ERG, o p. c it., p ag . 11 7.
la situazione, ma si andava persuadendo che un suo intervento persona le era nuovamente necessario. Per il momento cominciò ad agire energicamente per rimettere in piedi l'esercito: cavalli furono acquistati in Argovia, Tirolo e Salisburghese; s i procedette a recl utare su vasta sèal a nuovi soldati in Germania e nelle terre di Casa d'Austria; si impiantarono imprese per ampi magazzini a Magonza, Francoforte, Mannheim ove furono fatte affluire vettovaglie dalla Franconia, dal Wiirttemberg, dalla Svevia; si cominciarono a fortificare numerose piazze nel Breisgau; i lavori difensivi della Chiusa di Bregenz furono migliorati e tutti i passi ve rso la Svizzera trincerati; Hohenems fu scelta come piazza d'armi fortificata. In altre parole, si procedette contemporaneamente sia a rendere formidabi le la difesa che a preparare una vigorosa cont roffensiva 59 • Appariva chiaro che Montecuccoli doveva, malgrado l'età e la salute malferma, assumere il comando in persona: solo lui e nessun altro avrebbe potuto opporsi a condottieri quali Turenne e Condé. Il 18 marzo 1675 l'Imperatore, che aveva in lui una fiduc ia totale, lo nominò ancora una volta Generalissimo 60 Così il destino rimetteva di fronte, già sul declinar della vita, i due maggiori condottieri del loro tempo. Mont~cuccoli, per assumere il comando, aveva posto condizioni che la Corte aveva accettato senza alcuna obiezione: autorità assoluta e piena indipendenza da Vienna .

Il suo problema era adesso di manovrare in maniera ta le da portare il suo grande nemico a battaglia nelle condizioni più favorevoli. P oiché Turenne aveva lo stesso obiettivo e stava in guardia, c'era da attendersi una partita a scacchi quanto mai complessa . Dapprima Montecuccoli tentò di persuadere la città neutrale di Strasb urgo a concedergli il passaggio sul Reno; non l'ottenne, ed allora si spostò rapidamente a Philippsbourg, gettò un ponte, minacciò la Lorena e l'Alsazia. Turenne, ammaestrato dalla precedente esperienza, non cadde nella provocazione e passò a sua volta il grande fiume esponendosi pericolosamente. Montecuccoli reagì tosto spostandosi su Offenburg e minacciando le comunicazioni del francese che dovette adesso ritirarsi precipitosamente. La notte sul 24 luglio Montecuccoli att accò, ma le esitazioni di Carlo di Lorena (che comandava le forze mobili) fecero svanire la prevista vitto-
59 ANTON MARx, Der Feldzug 1675 in Deutschland, in: Osterreichische Militarische Zeitschrift, 1839, vo l. I, pag. 136 sgg.; 290 sgg.; vo l. Il , pag. 267 sgg.; 1841, voi. II, pag. 28 sgg. 60 A. MARX, op. cit., I pag. 147.
ria. Fu ora la volta di Montecuc coli a doversi ritirare , schierandos i in fort e p osizione dietro il fiume Sassbach .
Chiaramente Turenne si stava domandando che cosa gli avrebbe preparato il suo grande avversario; e nel pomeriggio del 27 luglio si spinse personalmente fino alle prime lin ee per osservare lo schieramento imperiale. Qui, alle 16 , un proiettile di artiglieria leggera lo colpì a morte. Montecuccoli ricordò con parole di profonda stima il grande avversario caduto; ma non era, il suo, un di st rarsi dall'obiettiv o principale. Tosto fu addosso al nemico che, scosso dalla terribile p e rdita, era in piena ritirata e lo attaccò ad Alt e nheim. I francesi sapevano ancora difendersi, anche se non osavano più attaccare, e riuscirono a sfuggire alla morsa, ritirandosi oltre il Reno: ma la battaglia per essi fu perduta.
Ora da Pari gi si inviò il miglior co ndottiero ancora vivente , il Condé, a cercar di tagliare la strada a Montecuccoli che aveva già pr eso H agenau. Monte cuccoli moss e contro Condé, lo pose in iscacco, lo costrinse alla ritirata 61 •
Conclusa la ca mpagna invernale, il co ndottiero, v itt orioso, lasciò il comando a Carlo di Lorena e rientrò a Vi enn a. La sua sa lu te st ava andando di male in peggio, e già gli aveva creato gravi in co nvenienti durante la campagna. Nel 1668 aveva avuto ciò c he ci venne tramandato come un colpo apoplettico 62 o più probabilmente un attacco cardiaco ed ora comi nciava a soffrire di altri disturbi .
Ad aumentare la crisi venne la morte repentina, nel 1676, della sua ado r ata moglie . Fu un co lpo t e rribil e, dal quale il Nostro non si riebbe mai veramente. A lei dedicò un sonetto pieno di composto dolore: nessuno avrebbe potuto prevedere che la consorte da lui tanto amata, di trent'anni più giovane, lo avrebbe prece duto nella tomba.
Ciò nonostante Montecuccoli non abbandonò il suo p osto di lavoro. Svolse nuovi, profondi studi nel campo dell'artiglieria e delle fortificazio n i; ma soprattutto cont inuò la battaglia per la creazione di un esercito regolare absburgico, fondato su una miliz ia naz ionale (LandwehrJ 3 • C i volle tenacia, n o n c hé il supe ramento di mille difficoltà ed una lotta implacabile contro avversari pi e ni di livore, calunniatori ed anch e mentitori, con alla testa il to sc a-
61 ANTON MARX, Der Herbstfeldzug Mont ecuccolis segen Condé 1675 am Rheine und an der Mo sel, i n: Osterreichische Militari sche Zeitschrijt, 1842, II , 5, pag. 119 sgg .; i d 6, pag. 265 sgg.
62 C. CAMPORI, o p. c it., pag. 432.
6 l A. G1MORRJ , op . cit., pag. un.
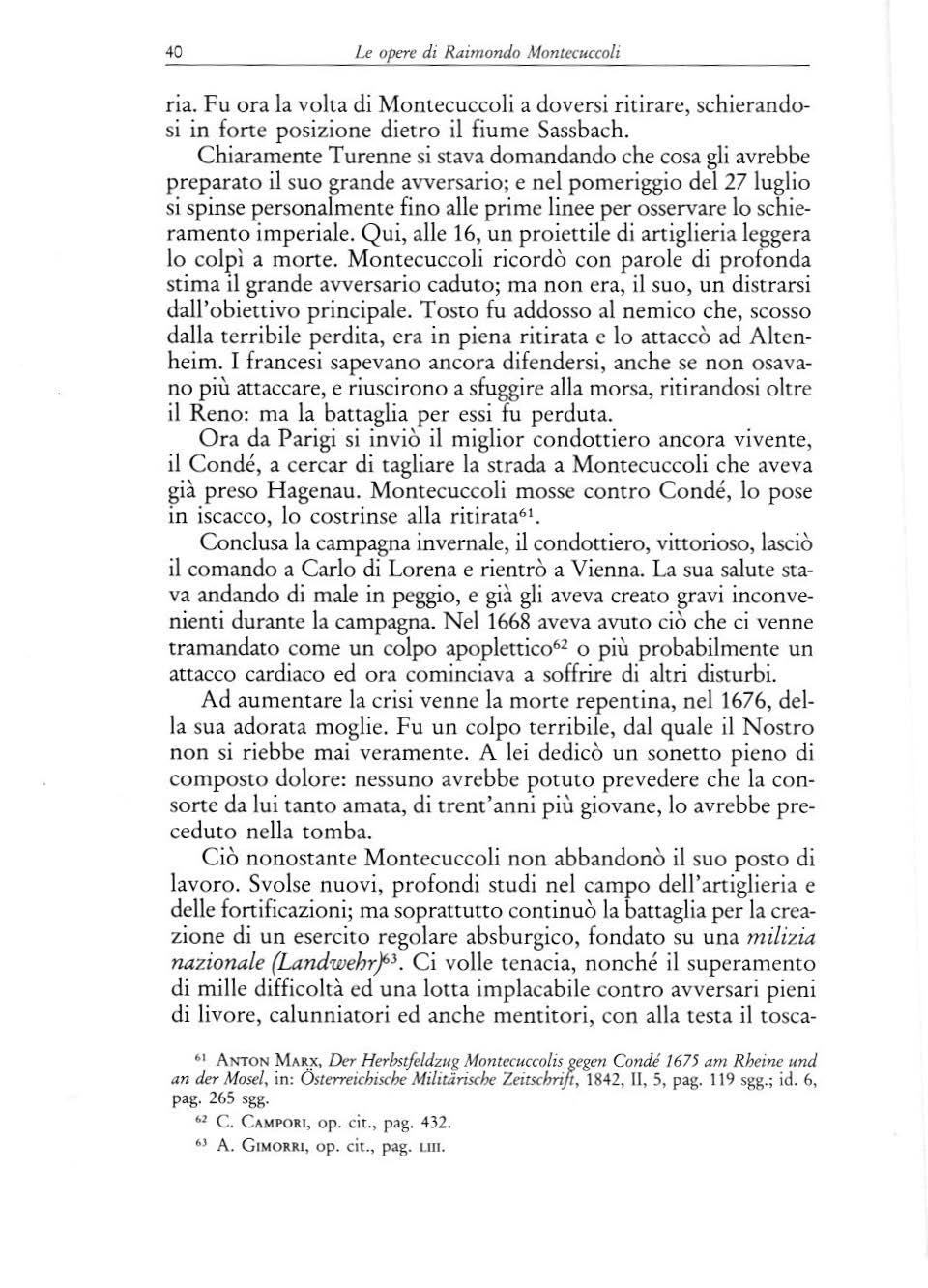
no L ore nzo Magalotti, diffamatore professionale, nonché il francofi lo principe di Sch warz enberg. Esasperato , Montecuccoli arrivò a presentare le dimissioni da Presid ent e del Supremo Consiglio Aulico , che furono naturalmente respinte 64 . Fu grazie ai suoi sforzi se sul finire del secolo l'Impero Absburgico avre bbe infine possed uto un vero esercito permanente di circa 100 .000 uomini: grandio so progresso a petto dei 25.000, di v isi in 9 Reggimenti di Fante~ia, 10 di Cavalleria ed un piccolo corpo di artiglieri che Ferdin ando III aveva mant e nuto in servizio permanente al termine de lla Guerra dei Trent'anni 65 .
Era non solo un ampliamento che faceva dell'Esercito re golare absburgico uno tra i più forti d'Europa: era anche il passaggio da misure che, in fondo, rimanevano provvisori e , ad una istituzione militare definitiva. Come ben sottolinea il Kaufmann, l'idea di Montecuccoli di un esercito permanente fu il nocciolo d ello stato militar e abs burgico 66 . Ma Montecuccoli dov eva sostenere altre battaglie. Non sopita era la sua polemica con gli ungheresi, cui dedicò un caustico scrit to , L 'Ungheria nell'anno 167767 e dei quali predisse (e non del tutto a torto) c he sa rebbero stati l a rovina dell'Impero68. Né trascurava le attività d ella cultura. Divenne Protetto r e dell'Accademia Leopoldina a Halle-an-de r-Saal e ; nel 1678 fu nom in ato anche Pr otettore Perpetuo d ell'Ac cademia dei Curiosi della N atura, ed all 'altissima distinzione rispose con un disco rso in latino 6 9 • Spe rim entator e infanticabile, pensava da tempo ad una carabina a 30-40 co lpi (già possedeva una pistola a tre colpi)70; ma le sue più importanti innovazioni furono nella struttura de lle forze armate. Qu esta parte dell'attività di Raim ondo Montecuccol i ancora attende , come tant e altre, il s uo st udioso. T utt o q uanto s i può dir e è ch e egli stabilì i Granatieri come corpo separato; ridusse il numero delle picche in rapporto ai mosch etti; in-
M THOMAS M . BARKER, D oppeladler und Halbmond, Graz, W ien u nd Kéiln, 1982, pag. 12 1 sgg. Il memoriale indir izzato all'Imperatore trovas i in: Ausgl!'".vahlte Schriften des Raimund Fursten Montecuccoli, hgb von Aloi s Ve ltzé, cit., voi. IV, pag. 352 sgg
6S ALPHONS VON WREDE, Geschichte der K.u.K. Wehrmacht, Vie nna , 1893 sgg., 5 volu mi; vo i. I, pag 13 sgg Anc h e: T.M. BARKER, The Military lntellectual , cit. , pa g 225, n 11 9
66 H. KAUFMANN, op. c it., pag. 18.
67 Ve d ilo i n: A. VELTZÉ, op cit., vo i. IV, pag. 42 1 sgg
68 Circa la polemi ca era Moncecuccoli e g li ungh eresi, cfr .: T HOMAS M. BARKER, Montecuccoli as an opponent of the Hungarians, in : Armi Antiche, 1972, pag. 205 sgg.
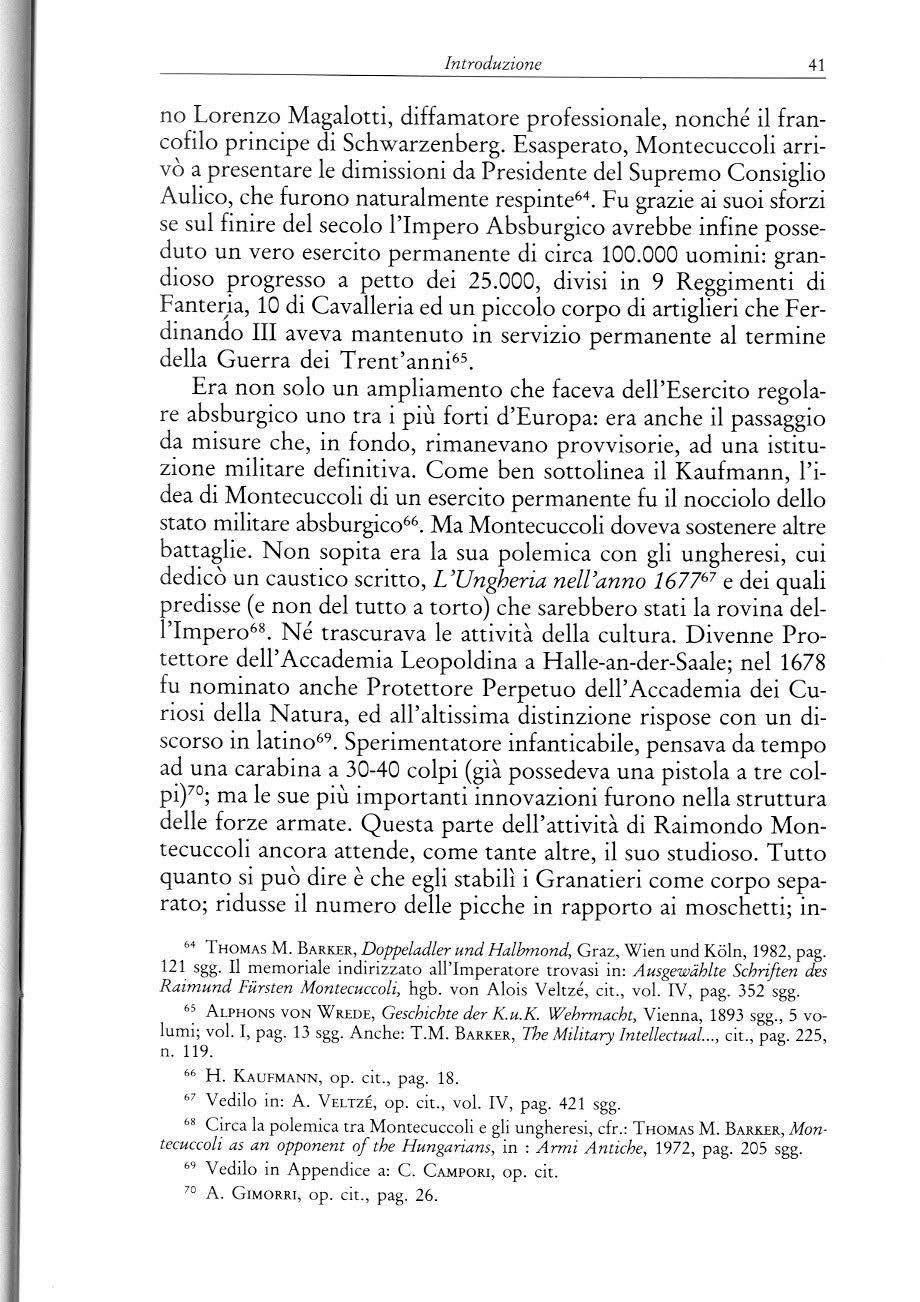
69 Ve di lo in Appendice a: C. C\MPORI, op cic.
70 A. GTMORRT , op . cic., pag. 26.
trodusse l'artiglieria leggera reggimentale; perfezionò il fucile (sistema Montecuccoli) e riformò completamente l'addestramento tattico 71 •
Ma la sua salute andava declinando ora con rapidità. Il 1° ottobr e 1680 in una lettera ad un confessore, padre Emerico, lo pregò di offrire nuovamente all'Imperatore le sue dimissioni da Presidente del Consiglio Aulico. In tale lettera appare ormai una se rena accettazione della morte e la consapevolezza di aver speso bene la propria vita 72 Pochi giorni ancora: e il 16 ottobre 1680 Raimondo Montecuccoli si spense a Linz, ove la Corte si era trasferita per sfuggire ad un'epidemia 73 •
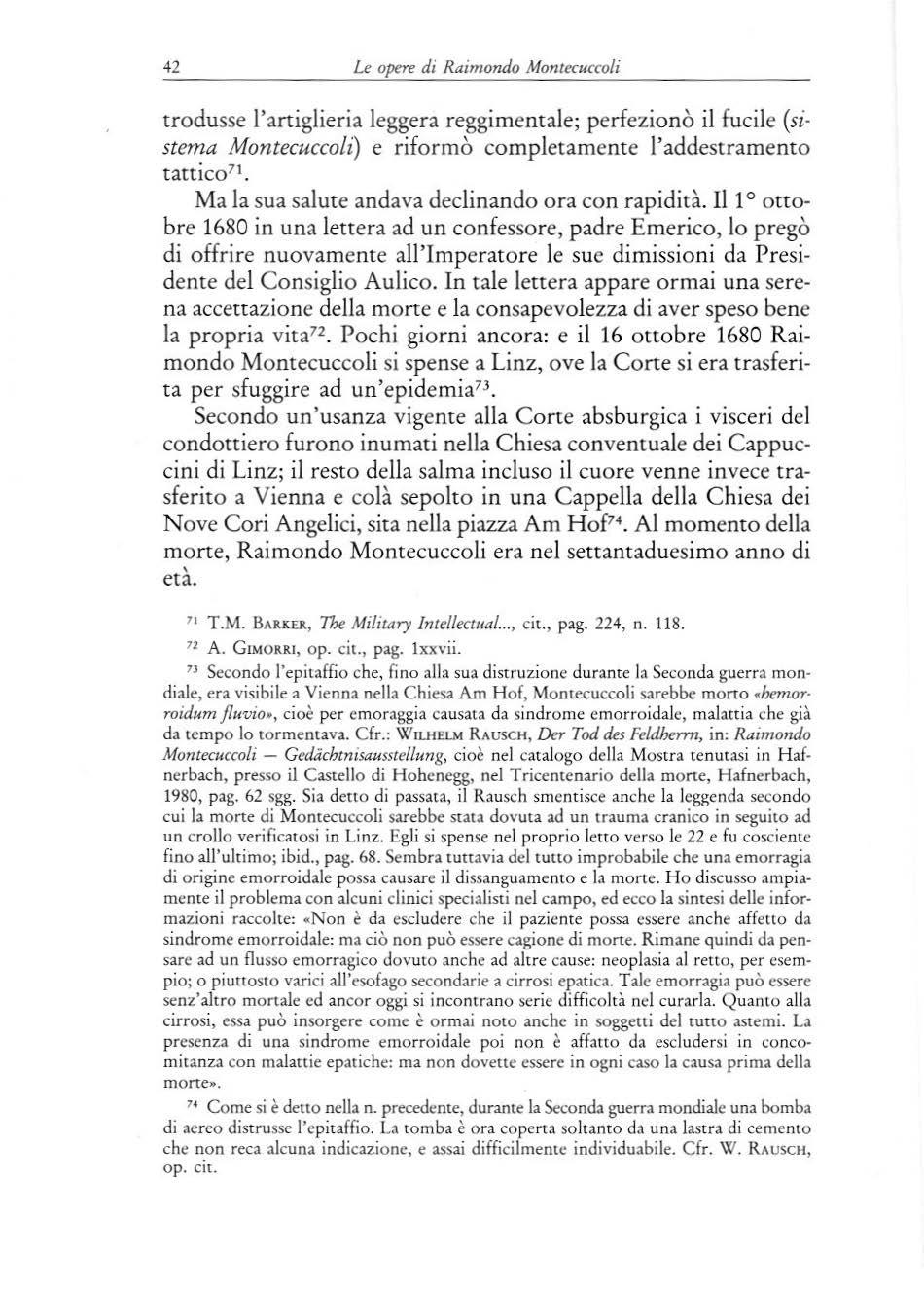
Secondo un'usanza vigente alla Corte absburgica i visceri del condottiero furono inumati nella Chiesa conventuale dei Cappuccini di Lin z; il resto della salma incluso il cuore venne in vece trasferito a Vienna e colà sepolto in una Cappella della Chiesa dei Nove Cori Angelici, sita nella piazza Am Hof74 • Al momento della morte, Raimondo Montecuccoli era nel settantaduesimo anno di età.
7 1 T.M. BARKER, 1he Military Intellectttal..., cit., pag. 22 4, n. 118.
72 A. GIM ORRJ, op. ciL., pag. lxxvii.
7' Secondo l'epitaffio che, fino alla sua distruzione d u rante la Seconda guerra mondiale, era visibile a Vienna nella Chiesa Am H of, Momecuccoli sarebbe morto «hemor· roidum jluvio», cioè per emoraggia causata da s indrome emorro idale, malatt ia c he già da tempo lo tormentava. Cfr .: W1LHELM RAUSCH, Der Tod des Feldherm, in: Raimondo Montecuccoli - Gediichtnisau sstellung, cioè nel ca talogo della Mostra tenutasi in Hafnerbach, presso il Castello di Hoh enegg, nel Tricemenario della m orce, Hafnerbach, 1980, pag. 62 sgg. Sia detto di passata, il Rausch smentisc e anche la leggenda seco nd o cui la morte di Montecu ccoli sarebbe stata dovuta ad un trauma cranico in seguit0 ad un crollo verificatosi in Linz. Eg li si spense nel proprio letto verso le 22 e fu cosciente fino all'ultim o; ibid. , pag. 68. Sembra tuttavia del tutto improbabile che una emorragia di or igine emorroidale possa caus are il di ssa nguamento e la morte. H o discusso am pi amente il problema con alcuni clinici speci alisti nel campo, ed ecco la sintesi delle informazioni raccolte: «No n è da escludere che il paziente possa essere anche affeuo da sindrome emorroidale: ma ciò non può essere cagione di morte. Rimane quindi da pensare ad un flusso emorragico d ovu to anche ad altre cause: neoplasia al rett o, per esempio; o piuttosto varici all'esofago secondarie a cirrosi epatica. Tal e emorragia può essere senz'altro mortale ed an co r oggi si incontrano se ri e diffic o ltà nel curarla. Qu ant o alla cirros i, ess a può insorgere come è or mai noto anche in soggetti del tutto astemi. La prese nza di una sindrome emo rroida]e poi non è affatto da esclude rs i in concomitanza co n malattie epatiche: ma non dovette essere in ogni caso la causa prima della morte,..
74 Come si è detto nell a n. precedente, durante la Seconda guerra mondiale una bomba di ae reo distrusse l'epi t affio La tomba è o ra coperta so lt anto da una lastra di cement o che n_on reca alcuna indicazione, e assai difficilmente individuabile. Cfr. W. RAuscH, op. Clt.
Ci siamo intrattenuti in misura relativamente ampia sulla vita di Montecuccoli non so lo per ciò che di straordinario e di eccezionale essa presenta: ma specialmente perché la sua esperienza militare costituì per lui una tra le fondamentali radici, tra le fonti basilari del suo pensiero. Da semplice soldato a Luogotenente Generale dell'Impero, egli passò attraverso tutti i gradi e tutte le special ità. Fanteria, cavalleria, artiglieria, ingegneria militare non ebbero segreti per lui, lungo una carriera di quasi mezzo secolo. Ma, come altrove già accennato, possiamo individuare altre tre radici, che insieme alla prima formarono la base quadruplice del pensiero militare di Raimond o Montecuccoli; ed esse furono: l 'esperienza diretta e l'analisi dell'arte militare dei grandi condottieri dell'epoca; la tradizione (tanto misconosciuta ) della grande arte e della scienza militare italiane dal Quattrocento al Seicento; infine l'eredità culturale del Rinasc im ento (e in ispecial modo del tardo Rinascimento) assorbita ed assimilata da lui attraverso profondi stud i durati decenni. Vediamole in sintesi .
Parlando dei grandi condottieri del Diciassettesimo secolo, una figura sembra tosto stagliarsi gigantesca e dominare sopra ogni altra : Gu stavo Adolfo 75 •
È con lo svedese che bisogna quindi inizialmente fare i conti, poiché, specialmente a causa dell a tradizione romantica postclausewitziana con il suo culto degli eroi, per anni Gustavo Adolfo fu considerato non solo un condottie r o geniale, un formidabile innovatore ed un uomo coraggioso al punto della temerità (il che è tutto vero); ma anche il genio militare dominante della sua epoca (il che invece esatto non è: per lo meno non nelle proporzioni comunemente ritenute).
La sto riografia contemporanea ha completamente abbandonato le teorie eroiche: e pur dando la giusta, importantissima parte alla funzione della personalità nella storia (che certo materialismo di bassa lega invano vorrebbe ignorare o sminuire), tiene in considerazione altri fattori i quali ci aiutano, situando le grandi e meno grandi personalità nel proprio contesto ossia nell'ambiente
75 Si vo ll e q ui ndi sostenere ch e Gustavo Adolfo sarebbe stato il maestro d i Monte· cuccoli, il quale alt ro n o n avr e bbe fatto che teor izzarne l'arte militare. Di cale parere fu inizi alme nte il Pi er i (Cfr .: Guerra e Politica negli scrittori italiani, cit. , pag. 132 s~g_., m a anch e alcrove) ; giudizio poi saggia me nte da lui atten uaro negli scr itt i successivi.
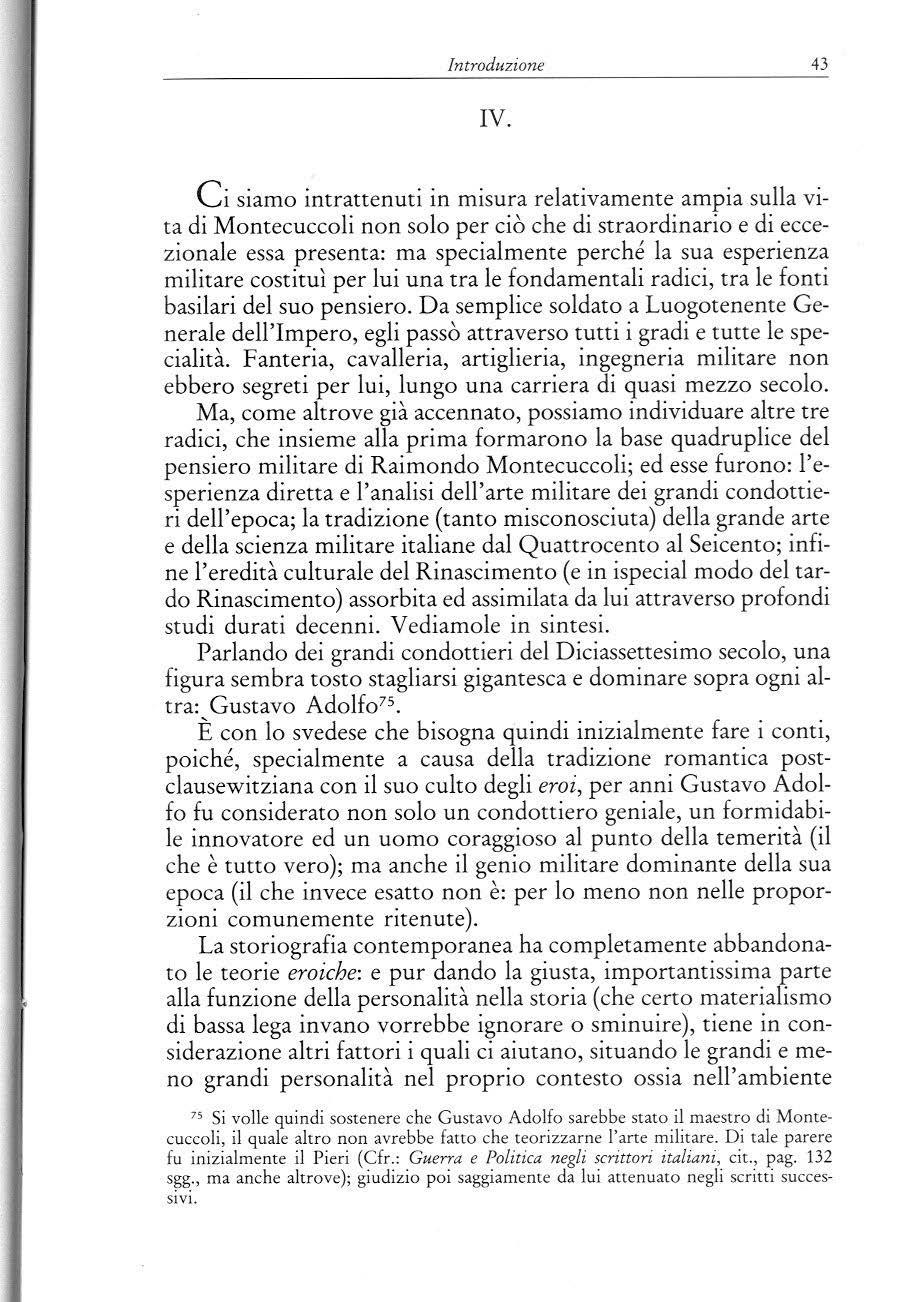
sociale, cultural e, economico in cui s i trovarono a operar e, a compre nderle meglio e, in definitiva, a giudicarle non fuori dal tempo, in una specie di illusor io pantheon dei grandi, ma completamente imm e rs e n ell'et à c he fu loro ed alle prese con i problemi concreti e specifici di tal e er a.
Il maggiore bio grafo di Gustavo Adolfo , Michael R o b ert s , nel secondo volume d ell a monumentale su a opera76 , fa giustamente osservare la s ituazion e peculiare della Svezia e l'importanza delle sue ricchezze min e rarie, sostenendo che le vittorie svedes i sa rebb e ro state impo ssi bili senza le miniere di rame . Fu facendo leva sull'ottimo metallo del pa ese che re Gustavo Vasa importò una élite di maestri fonditori dalla Germania creando una p r ima fond e ri a di cannoni a Stoccolma, ci oè gettando le bas i dell ' artiglieria svedese 77 .

Lo stesso può dirsi p er la di spo nibilità di mate riale umano: paese prevalente m e nt e di pi cco li contadini liberi (a ciò aveva as sai contribuito la rivoluzion e lut e rana) la Svezia pot eva fornire ottime (anche se non abbondanti) leve: lo capì ancora Gu stavo Vasa che n el 1544 aveva cominciato a formar l'esercito su base volontaria. Il non suffici ente afflusso consigliò p o i il ri corso alla coscr izione. La cavalleria non e ra num e rosa , ma fu pagata così bene c he i volontari accorsero, consentendo di scegliere i migli o ri. I finni ci specialmente offersero una cavalleria legge ra di prim'ordine. Il grand e fondatore d ell a monarchia sve dese aveva così ge ttato le basi p er le tre sp ec ialit à del futuro esercito: fanteria, cavalleria e artiglieria78 .
Ma l'uomo di genio c h e, trent'anni prima di Maurizio di Nassau, oscuro e ignoto ai co nte mp o ran e i, introdusse un nuovo ordinam e nto tattico, fu r e Enrico XIV. Colto, studio so sia dei romani (Vegezio, C es ar e) c h e di Mac hi ave lli aveva appreso dall' esp e ri e n-
76 M1CHAEL RosERTS, Gustavus Adolphus. A History o[Sweden, 16 11 -1632, London, New York and Toronto, 1958 sgg.; voi. 11, 1626-1632. È questa ormai l'opera fondamentale s ul g rande re svedese: per l'analisi esaustiva dell'intera bibliografia, per la lunga, minuziosa ri cerca di t utte le fonti ed ite e in edi t e che occu pò anni e che portò l'illusue Autore a scoprire nuovi documenti, possiamo be n co nsiderare definitivo il libro del Roberts, nella mi sur a e con i limiti con i quali questo concetto può essere usato nell e scienze storic he.
• 77 M. RoBERTS, op cit , pag 33; ibid. , pag. 192. Oltre all' opera fondamentale del Roberu, si è qui fatto uso di: H. DELBRUCK, Geschichte der Kriegskunst in R ahmen der politi· schen Geschichte, Berlino, 1920 sgg., voi. IV , p. 199 sgg.; J .F.C. FuLLER, 7he decisive baules of the Western World and their infltJence upon Hist ory, Lon don, 1965, vo i. II; infine della monumentale pubblicazi o ne dello Stato Maggiore svedese su lle campagne di Gustavo Adolfo: Svenska Generalstabcn, Stoccolm~ 1935 sgg , volumi IV-Vl
78 M. R OBERTS, o p. c it. , pag. 213.
za d el proprio paese l'importanza del fuoco; dagli svizzeri, quella della picca. Aveva così individuato il binomio che avrebbe dominato i campi di battaglia79 •
Nel pensiero tattico di Enrico XIV vi era una gemma, che avrebbe formato la base delle idee di Gustavo Adolfo anche se molti studiosi della sua opera non seppero comprenderlo: che cioè la picca, se bene usata e ben so~tenuta dal fuoco, non era già un'arma difen s iva, ma offensiva. (E ben vero però che il grande re svedese vi arrivò per derivazione dalle idee del suo illustre predecessore ma solo grazie all'esperienza, ché ini zial mente nel suo Battaglione la funzione d elle picche e del fuoco che le appoggiava erano state pensate come squisitamente difensi ve).
Poi erano seguiti anni di abbandono e di decadenza: l'esercito svedese, trascurato, veniva facilmente battuto dall'ottima cavalleria polacca.
Fu a questo punto che Gustavo Adolfo riprese l'op era di Enrico XIV. Già da qualche tempo in Olanda Maurizio di Nassau aveva cominciato a studiare ed a sperimentare nuove forme organiche e tattiche, dando attuazione pratica, sul campo di battaglia, ad idee assai simili a quelle di Enrico XIV di Svezia, che Maurizio, per altro, non aveva probabilmente mai conosciuto80. Ammiratore di Maurizio di Nassau, profondo studioso degli autori che erano stati alla base del pensiero di questi (Livio, Eliano, Frontino, Vegezio, Polibio, ed anche Machiavelli e Lipsio), ostile al -praticismo grossolano, Gustavo Adolfo fece però una pre z iosissima esperienza nelle guerre locali, p er cui al momento dello sbarco in Germania aveva acquisito una completa padronanza di ogni aspetto tecnico dell'arte militare 81 •
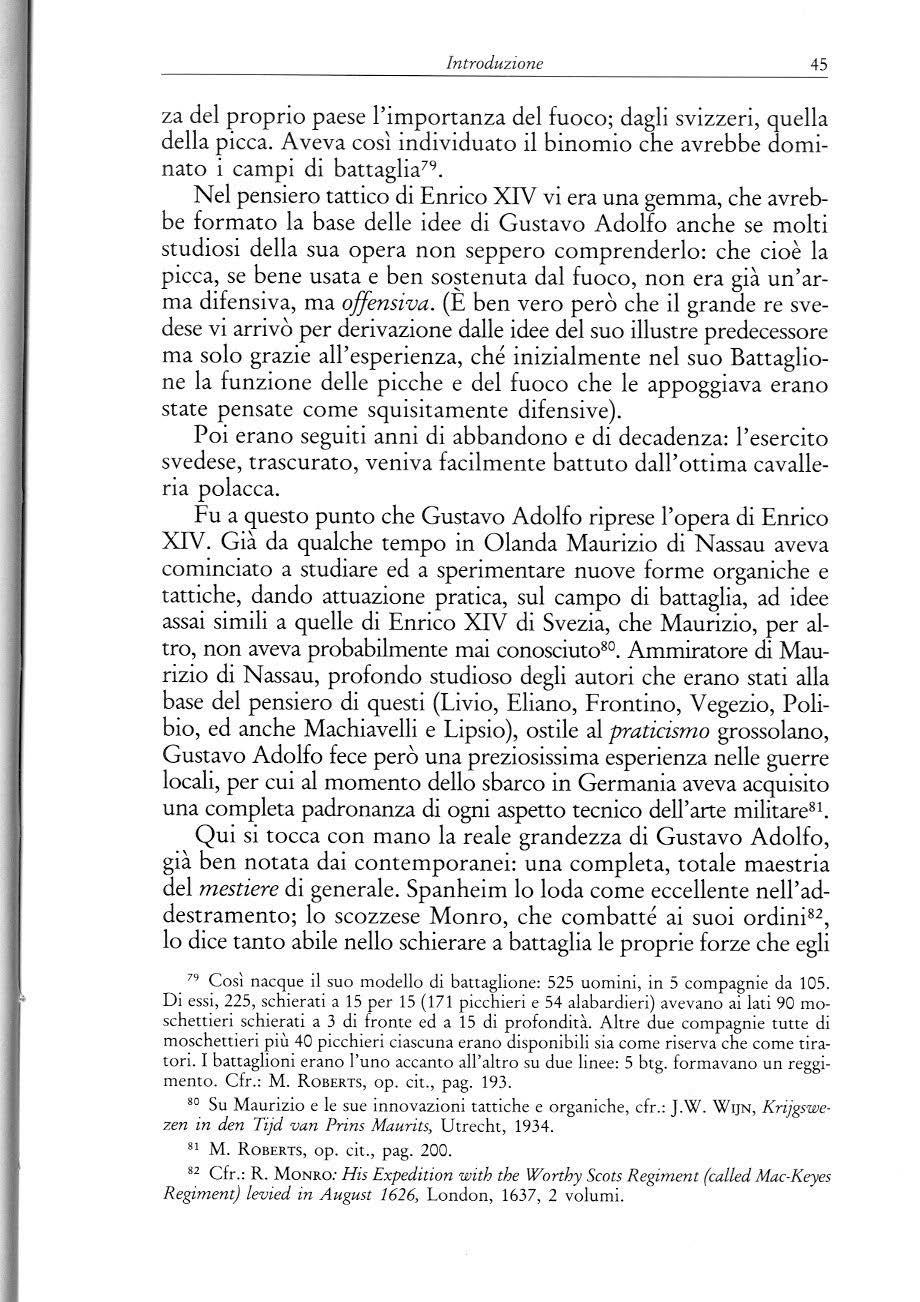
Qui si tocca con mano la reale grandezza di Gustavo Adolfo, già ben notata dai contemporanei: una completa, totale maestria del mestiere di generale. Spanheim lo loda come ecce llente nell'addestramento; lo scozzese Monro, che combatté ai suoi ordini 82 , lo dice tanto abile nello schierare a battaglia le proprie forze che egli
79 Così nacq ue il suo modello d i battaglione: 525 uomini, in 5 compagnie da 105. Di ess i, 225, sc hiera t i a 15 per 15 (171 picchier i e 54 alabardieri) avevano ai lati 90 moschettieri schiera t i a 3 di fronte ed a 15 di profond it à. Altre due com pagnie t utte di moschettieri p iù 40 picchieri ciasc una e ran o disponib ili sia come r ise r va che come tiratori . I battaglioni erano l'u no accanto all'altro s u due li nee : 5 btg. fo r mavano un r eggimento. Cfr.: M. R osERTS, op. cit., pag. 193.
80 Su Maurizio e le s ue innovazioni tattiche e organiche, cfr.: J.W. WIJN, Krijgswezen in den Tijd 'Van Prins Maurits, Utrecht, 19 3 4.
81 M. RoBERTS, op. cit., pag. 200.
8 2 Cfr.: R. MoNRO: His Expedition with the Worthy Scots R egiment (called Mac -Ke-yes Regimem) levied in August 1626, London , 1637, 2 vo lu mi .
avrebbe potuto essere il suo pr o pri o maggior generale, ossia capo di stato maggiore; esperto in artigli e ria, era un maestro nell'arte dell a fortifica zi on e campale che sove nte fu la sua vera forza; il suo occhio per il terreno e ra senza uguali. La sua e cc e llenza in qu est i camp i, se mpr e secondo M o nr o, lo portava ad un ec cessi v o accentram e nto: e qui stava, c ome più oltre si dirà , uno dei suoi più gravi lati deboli 83
Il genio militare de l re di Svezia si esprimeva e d eccelleva in t re campi: l'organica (sebbene qui molto egli dovesse al suo grande Cancelliere Oxenst ierna); la tecnica degli armamenti e infine la tattica.
Nel ca mp o organico il s uo maggiore contributo fu di co nsolidare qu e ll'equilibrio tra picch e e moschetti c he già Enrico XIV e M auri z io di N assa u avevano proposto e di alleggerire n ot evolmente il Battaglione di fanteria (che egli de nominò Squadrone) p o rtandolo a 564 tra ufficiali, sottufficiali e truppa. Va però osservato c he la leggenda secondo cu i Gu stavo Adolfo avrebbe a umentato il fuoco a detrimento delle picche (e che viene addotta per provare le sue tend e n ze innova t rici ) è del tutto priva di fondamento: in r ealtà nel Battaglione svedese la proporzione di pi cc h e e ra più alta c h e in quello di Maurizio di Nassau: 216 pi cc he contro 192 mo sc het t i, laddo ve l' o land es e ne sc hier av a 250 co ntr o 240 84 • Se si v uol quindi considerare conservatore (e n o n è vero) colui c he mant e n eva in lin ea un relativam e nte alto numero di picche, il r e di Svezia dovrebb e figurare , appunto, tra i conservatori: sarà inv ero p ro prio M o nte c ucco li a diminuire la proporzione delle picche in favore dei mo sc hetti, come più oltre si dirà.
Il Battaglione sve d es e fu comunque un'unità ammirevole p e r omogen e ità, armonia e fle ss ibilità; nato per una tattica di fe nsi va, si mostr e rà ottimo p er l'attacco, attraverso la cooperazione con l'artigli e ria e la cavalle ria e il sosteg no reciproc o di moschetti e p i cche.
SJ M. R O BERTS, op. c it., pag 200 sgg.
84 L'abbaglio, in cui caddero studiosi anche illustri (dr .: P. P 1ER1, G11erra e Politi· ca ... , cit. , pag . 78 e sgg.; HANS DELOROCK, o p. cit. pagg. 199 e sgg.; J.W WIJN, The armed forces and the conduct o/ war, 1610.1648, in: 1be New Cambridge Modem History, Cambridge (GB), 1964 sgg., 12 volu m i; voi. IV, Th e decline o/ Spain and the Thirty Years War, 1609- 1648/59, pag. 2 48 (trad. it. : Storia del Mondo Moderno, voi. IV , Milano, 1971) ecc., derivò dal fatto che nel Battag li one sve dese figuravano in più 96 moschett ieri aggiunt i o comandati, i quali però ven ivano usati agli avamposti, in esp lorazione o in collaborazione con la cavalleria, e solo raramente ap p arivano (per lo pi ù so lo in parte) nel Battaglio ne schierato in co mbatti mento. Cfr. a questo pro p osito il concl u sivo studio di M. R OBERTS, op. cit., pag 219 sgg.

La cavalleria, tutta organizzata in Reggimenti (eccetto i finni), aveva non solo le pistole, come quella imperiale: ma la sciabola. Era corazzata più leggerment e, causa la minor taglia dei cavalli sve desi. Ma la radicale innovazione in questo ca mpo fu dovuta, più che all'organica, all'uso tattico che il r e di Svezia ne fece. La rigidissima disciplina, il lungo, costante addestramento fecero il resto : ma va detto che alcune delle più rimarchevoli innovazioni organiche, come la divisione della Svezia in zone di reclutamento, ognuna delle quali doveva dare un reggimento; la distinzione tra il reggimento al deposito (amministrativo) che non si muo v eva mai dalla sua sede e quello da campo che effettivamente partiva p er il fronte 85 ; la creazione di specifiche zone di reclutam ento per la cavalleria non coincidenti con quelle della fanteria; tutto ciò fu dovuto al genio amministrativo del Cancelliere Axel Ox enst ierna 86 .
M erito del Sovrano fu in ve ce la fec onda introd uzione di una nuova unità organica: la Brigata, destinata ad operare nel campo ta ttico e composta di tre-quattro Battaglioni (il Reggimento rimaneva quindi essenzialmente un'unità amministrativa, anche nella sua edizione da campo); e così pure il tentativo di passar e dalla divisa (che variava sovente da compagnia a compagnia e da campagna a campagna, secondo gli umori del capitano ed anche la disponi bilità di stoffa) all'uniforme, prescritta da un regolamento e uguale per tutte le truppe nazi onali 87 Tal e tentativo ri uscì a metà, per le gravi deficienze logistiche; inoltre le uniformi svedesi furono sempre più diluite dalla introduzione in massa di mercenari, dapprima scozzesi e inglesi , poscia tedeschi 88 Sul secondo ramo dell'organica , e cioè il materiale (i l primo esse ndo dedicato al personale), nonché sulla tecnica degli armam~nti, Gustav o Adolfo lasciò impressa in maniera duratura la propria orma.
85 Distinz ione successivamente introdotta in tutt i gli eserciti del mondo, fino alla ma la ugurata est in z ione del sistem a reggimentale in gr an pane di ess i.
86 M RoBERTS, op. cit., pag 223.
87 Lo sforzo fu grande: il pr imo rego lamento fu de l 1622. Poscia nel 1626 e 27 si varò un pi ano per un depos it o centrale dell e unifor mi , co n un vasto gruppo di sa rti.
Cfr : M. Ro.B ERTS, op. cir. , pag. 237. Cfr. anche : H DELBROCK, o p cit., voi. fV, pag 139
88 Il che, sia detto di passata, fa gi ustizia della leggenda secondo c ui qu ello svedese sarebbe stat o il primo esercito nazional.e. Il re senza du bb io lo desi de rò (in un a lettera a Maurizio di Orange, del 1622, si spinse sino ad elencare le virtù delle milizi e nazionali a paragone dei mercenari); fece anche una deliberata politica di economia delle truppe svedes i; malgrado ciò il nume ro degli svedesi nelle sue file dec linò, passando dalla metà ne l 1629 a un decimo nel 1632, cioè in soli tre anni. Cfr. M. Ro.BERTS, op. cit., pag. 205, n. 4 e n. 7: 206; 207.

Si è già detto del t entativo di introdur r e l'uniform e. L 'artiglieria, da lui me ssa alle dipendenze di un Maestro Generale (dal quale a sua volta dipendeva un Comandante dell'artiglie ria in campo), fu orga niz z ata in Compagnie e Re ggimenti e posta al comando di L e nnart T orst e nss o n , ben pr es to apparso c ome il più grand e artig li ere della sua generazione. Non esagera il R o berts dicendo che l'artiglieria di Gustavo Adolfo (l'arma ch e conte neva l a più alta proporzione di sve desi) si ev olvette su lla base di una sperimentazion e costante: il che c onduss e, in c onclusione, alla «produzione di nu ove armi della maggi o re importanza, n o n so lo p er la Svezia, ma per l'int e ra storia militare dell'Europa occidentale»89 • Il r e comin c iò riclassificando tutti i pezzi in base al peso del proietto: entro il 1630 li avev a ridotti a tre tipi: 24, 12 e 3 libbre. I cannoni già in dotazion e furono nuovamente alesati per uniformarne i calibri; l e canne vennero accorciate per ridurne il peso, il che fu anche re so poss ibile dall'ottimo metallo sve dese. Di tutti, il più interessant e fu il cannone reggimentale da 3 lb. Tutto di metallo90 , pesava tuttavia po c h issimo; l'affusto era mode rn o, e il pezzo poteva venir trainato da un solo c avallo e, all'occorrenza, manovrato a man o d a du e-tre u omi ni. Per esso fu introdotto il cartoccio , u s ualmente a mitra gli a. Il tiro utile e ra di circa 300 metri 91 Il re se n e portò 80 in Germania e m o lti altr i li seguirono: essi rivolu zi onarono la funzione dell'artiglieria n ella battaglia.
Di più, cos tituirono per la prima vo lta un a autentica arma di a ccompagnamento, poi c hé in ogni Battag lione di fant e ria un plotone e bb e un p ezzo di tal e tipo 92 •
Il 24 libbre di Gustavo Adolfo fu talmente a lleggerito da poter venire facilmente trainat o, anziché usare la via d'acqua, com 'era consuetudine per i pezzi p es anti di allora.
In co nclusione, il cospicuo aumento di pot e nza di fuoco operato dal r e di Svezia ris iedette n eli'a rti glieria e non, come si è vo -
89 M. RoB ERTS , o p. ci t., pag. 231.
90 D a notare che i l famoso cannone di cuoio, progettato da Melkior Wurmhandt (tu · bo sott ilissim o di bro n zo, fasciato d i cuo io) , non durò in servizio più di du e anni ( 1627-29). Secondo alcuni au t0ri surriscaldava, secondo altri era fragile: cariche r idotte, scarsa veloc it à in izia le, scarsa gittata. Cfr.: M. Ros ERTS , op. c it. , pag. 232 sgg e, ivi , n 1. Esso fu presto sostit uit o dal cannone reggimentale da 3 libbre

9 1 M. R osERTS, op. ci t. , pag. 233 e n. 2 ivi.
92 Wallens tei n ne co mprese a ppie n o l' i mportanza, e durante i l suo secon do periodo di comando creò dal nulla un nuovo parco di artiglieria (era, come si vedrà più oltre, un fo rmi dabil e organizzator e e amm in ist raLO r c) con larga proporzione di pezzi leggeri per la fanceria. Aumentò però il calibro a 6 libbre, il che rese n ecessari q u attro cava lli per il trai no . C fr .: M. Roa 1:.RTS, op . cit ., !oc . cit.
luto sostene re, nei moschetti. L'enorme pot enziale svedese nel campo minerario e metallurgic o consentì una produzi one ecce lle nte e ampia di artiglierie (se ne esportavano addirittura!) e permise al re di iniziare la campagna tedesca con un rapporto di 9,4 bocch e da fuoco per 1000 uomini: un livello da Prima e Sec on da guerra mondiale 93 !
Il re organizzò anche la produzione di bocche da fuoco nella parte da lui occupata della Germania: ma non perve nne mai a produrre tutta la pol ve r e e gli artifizi n ecessari 94
Gustavo Adolfo dedicò altresì la massima cu r a alle armi individuali e mostrò pure in q u esto campo la più alta competenza . Contrariamente a quanto si crede, egl i comprese le enormi possibilità insite n ella picca e cercò di svilupparne l'uso aumentando il numero dei picchieri in rapporto ai moschettieri, piuttosto che di minuendolo. I suoi picchieri portavano elmo, corazza e bracciali; gli ufficiali avevano la partigiana. L a sua picca fu un po' più corta dell'usual e (ma non la mezza picca, detta dagli inglesi swine feather, che fu invece abolita nel 1628); essa era rivestita di ferro così da non poter ven ire troncata: ed era appuntita nel calcio per poter essere piant ata nel terreno 95 • Il re alleggerì sensibilmente il moschetto ma , contrariamente a quanto detto anche da contempora nei come Gualdo Priorato, non abolì il forcone, che rimase in uso nell'Esercito svedese fino ai tempi d i re Carlo Gustav o 96 • Non è sicuro che Gustavo Adolfo abbia effe ttiv am e nt e introdotto l'uso della cartuccia, ma fece qualcosa per standardizzare la carica di pol ve r e e garantÌ una uniformità dei calibri maggiore che presso gli olandesi e g li imperiali. «Nell'insieme», scrive ancora
93 Na poleone cons id erava come un buon rap porto que ll o di 4 bocche da fuoco per 1000 uo m in i: cf r. M . ROBER TS, op. cit., pag. 234 e n. 2 ivi; ne ll a Guerra Civ il e amer icana, all'inizio della campagna del 1864, il rapp orto medio sull ' in sieme de i fro nti era: Unione: 2,37 /1000, Confederazione: 2,50/ 1000, cfr. RAIMONDO LuRAGH I, Storia della Guerra Civile Americana, V ed., Milano 1985, pag. 984 sgg. e 1086 sgg .; nella Prima Guerra mo ndial e, alla deci ma battaglia de ll 'Isonzo, il rapp orto er a: Italiani: 9 ,52 /1000 (escluse le m it r agliatr ici, m a incluse le bombarde), Austro-ungarici: 8,9 3/1000, cfr.: Ministero dell a Guerra - Comando del Corpo di Stato Maggiore - UFFIC IO STORICO, L'Esercito Italiano nella Grande Guerra, 1915 -1918, Roma, 1927 sgg., 7 vo lu mi in 37 t o mi (31 pubblic ati a t utt' ogg i), vo i. IV, Le operazioni del 1917, tomo I, pag. 192 sgg.; id., tomo II , pag. 24 sgg .; nell a Seco nda Guerra mondia le, all a battag li a delle Ardenne, si ebbe : American i: 9,85/1000 (escluse le mitragliatrici ma inclu si i pezzi dei carri armati); cfr. : 0FFI· CE o ,, THÈ CttIEF o r, MILITARY H 1STO RY , U S ARMY , The United States Army in World War li, Was hi ngt o n, DC, 1947 sgg., 79 volumi (73 pubblicati a t utt'ogg i), H.M CotE, The A rdennes: Baule of the Bulge, pag. 665 sgg.

9
• M. RoB ERTS, op . ci t ., pag. 236.
9 s M. R OBf.RTS, o p. c it. , pag. 226.
96 J. ALM, Blanka vapen och skyddsvapen, St occo lma, 1932 , pag. 142.
il Rob erts, «le sue innovazioni nel mosc hetto furono meno radicali di quanto si volle immaginare; esse furono però del tutto sufficienti per giocare un importante ruolo n ella superiorità di fuoco che divenne così chiara a Breite n feld» 97 • La disciplina era, come si è osservato, rigidissima; l'addestramento era contin uo ed accurato (lo s i proseguiva anche durante la gu erra, nelle pause), per cui le truppe di re Gustavo Adolfo davano prova di quell'automatismo quasi perfetto, di quella capacità di iniziati v a e di quella elasticità che, insieme, costituiscono la base per ogni successo nel campo tattico. Fu qui che il r e di Svezia emerse sopra quasi ogni altro suo co nt emporan eo: eg li seppe cioè combinare in propor zione pressoché ottimale potenza d'urto, mobilità e capacità difensiva98 • P er anni aveva egli elaborato le sue esperienze: dai cavalieri polacchi aveva imparato l'uso della sciabola e della lancia, anziché della pistola , nonché la carica al galoppo; ed anche che la fanteria doveva esser capace, pu r se privata della propria cavalleria, di difendersi con successo mediante un'organica cooperazione di picche e mosc hetti. Tutto ciò lo condusse a risolvere tali problemi seguendo tre linee: l'intensificazione della potenza di fuoco, la cooperazione interarma e il miglioramento della cavalleria99 • Ma il passo decisivo, la chiave genialmente trovata ai problemi tattici fu la creazione d ella Brigata. Gustavo Adolfo era convinto ch e il Battaglione sve d ese non poteva tener testa al Tercio. Ma la Brigata, con 3-4 Battaglioni e circa 2000 uomini lo poteva, nello stesso te mpo superand o il Tercio in potenza d'urto e in forza difensiva ed eguagliando il Gruppo di battaglioni olandese in flessibilità e mobilità, ma battendoli di gran lunga entrambi in potenza di fuoco, poiché non solo i s uoi uomini eran o meglio addestrati al tiro, ma disponevano anche di 9-12 cannoni r eg gimentali. Se ora si tiene presente che nella Brigata svedese c'erano più picche che nelle formazioni sia imperiali che ola ndesi, poiché il re int endeva ridare va lore offensivo alla pi cca, s i comprende quanto sia stata e rrata e sviante la tesi di coloro che vollero v edere il segreto della ec cellenza tattica di Gustavo Adolfo in un presunto abbandon o
97 M. R OBERTS, o p. cit., p ag. 227. I s uoi m osc hetti e ri n o n avevano corazza.
98 «E ntro i lim iti imposti dalle circost anze del l'e poca, egli pervenne a sv ilu ppare un a ta tti ca ro busta in difesa ed incis iva nell'attacco e capace di una mobilità c he sbalordì i suoi avversar i» . M. R OBERTS, o p. ci t., p ag. 24 6.
99 M. RooERTS. o p. c it ., pag. 247. U re sv iluppò an c he l'u so dei dragoni, vera e propria fanteria montata, capace di spostarsi celer m ente a cavall o e combattere a pi edi Cfr.
H. D1ri.BR OC K, op. ci t., pag. 151. IL FuLL ER sosti e ne addirittura ch e fu Gustavo Adol fo a introdurne l'uso Q.F. C. F uLLER, o p. cit., voi. II, pag S4}.
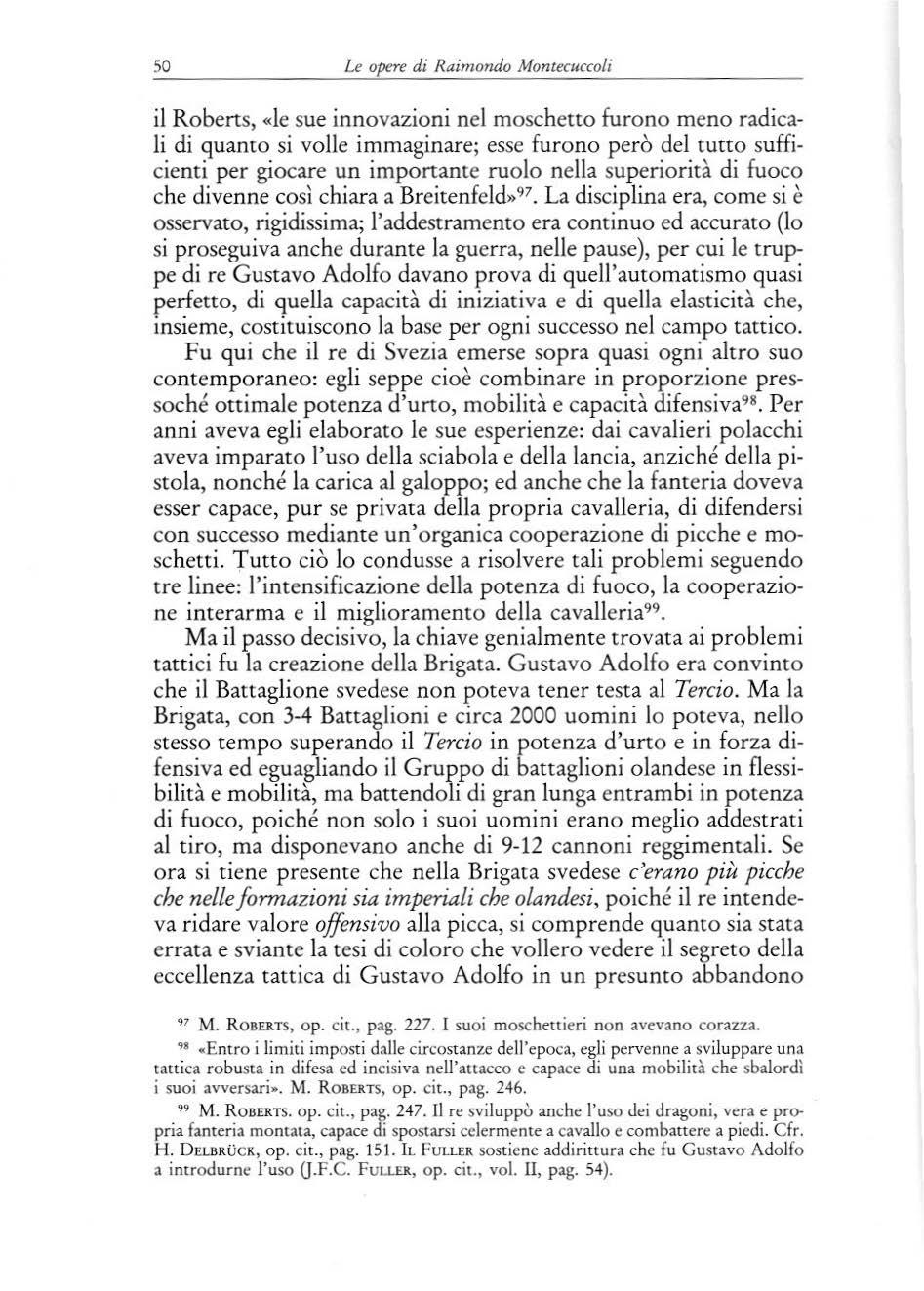
(o diminuzione) delle picche rispetto ai moschetti. Si può ben dire che costoro, inseguendo un fantasma, hanno perduto di vista il nocciolo autentico della grandezza del condottiero: cioè che per lui la questione picca-moschetto era del tutto secondaria o, meglio, non si poneva in realtà neppure poiché il vero problema che egli intendeva risolvere era quello di trovare un perfetto equilibrio fra tutti gli element i, ed insieme una così armonica cooperazione tra di essi da poter conseguire (e vi riuscì, con la Brigata) tutta la formidabile potenza d'urto e di difesa dei Tercios spagnuoli e imperiali, e insieme tutta la estrema flessibilità dei Gruppi di battaglioni olandesi. Ovviamente altri ingredienti entravano nella combinazione: il perfetto addestramento al combattimento, alla marcia e al tiro; la ferrea disciplina: ma di tutto ciò si è parlato. Ma il tutto doveva poi combinarsi in qualcosa che ripetesse la forza, l'armonia e la flessibilità della Brigata su scala generale: le Brigate erano quindi intervallate per consentire il passaggio alla cavalleria; se questa stava sui lati, gli intervalli erano coperti dalla Brigata della seconda linea.
Gustavo Adolfo aveva perfettamente compreso che il fuoco era di per sé incapace di procurare la vittor ia: occorrevano gli altri due elementi, movimento e urto; e che questo doveva vemre preminentemente dalla cavalleria100 • La cavalleria svedese perciò fu addestrata a caricare alla sciabola e veniva quindi schierata su tre righe; soltanto la prima scaricava una sola pistola, ma a bruciapelo. La caracolla nemica (carica al trotto, alla pistola) doveva essere ricevuta da una salva di moschetti: poscia la cavalleria svedese caricava al galoppo, a sciabola sguainata. Al rientro dei propri cavalieri, i moschettieri svedesi bloccavano con una seconda salva le eventuali velleità di inseguimento 101 •
Sebbene il sostegno di fuoco alla cavalleria fosse formidabile, specie quando vi erano anc h e i cannoni reggimentali, Gustavo Adolfo non tardò ad accorgersi che la cavalleria non poteva in realtà caricare che per gli ultimi 50 metri che la seraravano dal nemico: era un compromesso tra fuoco e urto 102 • I re di Svezia
100 Re Gustavo Adolfo a Oxenstie rna , 18 marzo 1630; M. ROBERTS, op. cit., pag. 255, n. I. Sulle innovazioni di re Gustavo Adolfo nel campo della cavalleria, cfr. anche: GEOR· GE T. DENISON, A History of Cavalry from the earliest times, London , 1913, pag. 210 sgg.
10 1 R. MONRO, op cit., voi. II, pag. 65.
102 Esso si rivelò t utta v ia efficacissimo tanto che i l nemico se ne appropriò (come ne lla fo rmida bi le car ic a d i Pappenheim a Liitzen). Da notare che anche qui Gustavo Adolfo si schierò piuttosto con i soste nitori dell'uso della lanc ia c he n on con i suoi avversari. Cfr. la lu nga d isc ussione su l p ensiero dell 'epoca circa l'u so della lanc ia o della pistola in: H. DELBRUCK, op. cit., voi. IV , pag. 154 sgg.
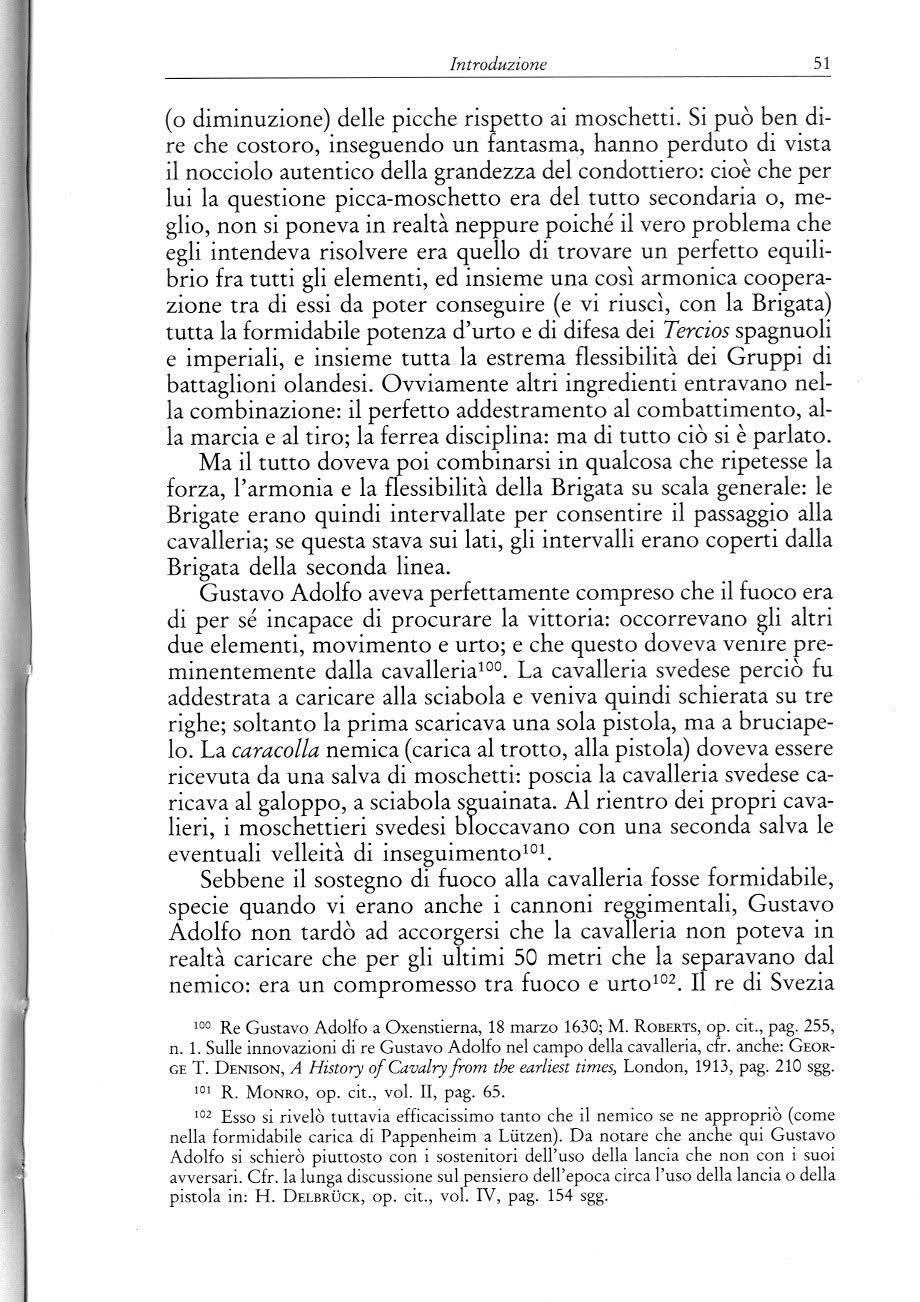
si volse quindi sempre più alla fanteria, ove lo stesso problema, pur esistendo, non era così insolubile. Dopo aver tentato un meccanismo per cui i moschettieri si scavalcavano a due righe per volta (mentre le prime due ricaricavano, le seconde facevano fuoco, ecc.: ventotto piccole scariche continue durate un'ora), successivamente Gustavo Adolfo introdusse le salve di plotone in cui tutti, fusi su tre righe, facevano fuoco simultaneamente: non più che una-due scariche, ma tremende 103 • La salva si combinava così con il fuoco dei pezzi reggimentali. Questo richiedeva però una forte copertura di picche quando tutti i moschettieri (o una buona metà) si trovavano con l'arma scarica: ecco perché la proporzion e di picche tra gli sve desi era più alta che tra gli olandesi, gli spagnuoli o gli imperiali; fu per scarsità di picche che le perdite della fanteria svedese a Li.itzen furono tanto gravi 104 Ma la picca dov eva fornire tale copertura attaccando il nemico sconvolto dalla salva: «Per l'ultima volta», scrive il Roberts, «e proprio quando la vecchia tattica della picca dei Tercios era infine fuori moda, la picca veniva usata come l'arma della vittoria» 105 • Gustavo Adolfo temeva sempre di non avere picche a sufficienza.
Nella tattica dell'artiglieria, il re andò alleggerendo i pezzi e i proiettili allo scopo di ottenere la massima mobilità onde concentrare il fuoco sul punto neces sario ed aumentare la celerità del tiro: ciò gli fu possibile soprattutto con i s uoi pezzi reggimentali.
Tirando le somme, s i può ben concordare con il Roberts che «il contributo fondamentale di Gustavo Adolfo alla tattica... fu la restituzione, sia alla cavalleria che alla fanteria, della capacità per l'azione offensiva; la sua intensificazione della potenza di fuoco di tutte le armi come necessaria premessa a tale azione; la sua insistenza sulla mobilità; ed il suo successo nel risolvere il problema di una soddisfacente interazione tra le varie armi,,. A ciò devesi aggiungere la sua capacità di sviluppare sin nelle più modeste unità lo sp irito di corpo e l'iniziativa : e ciò sia negli ufficia li che nei soldati 106 •
Qui sta la vera grandezza di Gustavo Adolfo, e no n nella presunta pratica di una strategia annientatrice che alcuni studiosi dello scorso secolo e dell'inizio del presente vollero attribuirgli, sotto
ioJ S1R JAMES T u RNER, Pallas Armata · Milùary Essays o[ the Ancient Crecian, Roman and Modem Art of War, London, 1683, pag. 237
10
• M. Ros ERTS, op. cit., pag. 259; T.M. BARKER, The Military lntel!ectual , cit., pag. 189 sgg.
ios M. RosERTS, op. cit., pag 260.
106 M. RoBERTS, op. cit., pag. 261 sg.

l'influsso di un mal inteso clausewitzianesimo secondo il quale sol o un tale tipo di strategia distinguerebbe il grande capitano 107 •
In realtà lo stesso suo principale biografo ammette la debolezza del re di Svezia s ul piano operativo osservando che egli sottovalutò la possibilità di battere il nemico con la manovra108 : ciò che indusse alcuni a scambiare per strategia annientatrice quanto era so lo frutto di uno tra i più gravi difetti del re come condottiero, vale a dire la temerità, la quale oltre a spingerlo talora a dar battagli a precipitosamente e senza aver ben pesato i rischi (Alte Feste , in cui Wallenstein lo batté) lo condusse alla fine ad esporsi in maniera del tutto inutile, rimanendo ucciso sul campo di Lutzen 109
In effetti, Gustavo Adolfo non riuscì mai a sviluppare su l piano operativo una strategia coerente: e non perché non avesse idee 110 , ma perché il pratico fallimento della sua logistica gli rese pressoché impossibile attuarla.
Si è parlato sin qui di organica, di tattica e di strategia: è ora di giungere a questa fondamentale (e spesso sottovalutata) branca della scienza militare: la logistica. Questo fu probabilmente il peggior lato debole di Gustavo Adolfo. Come ha dimostrato Martin Van Creveld, la logistica di Gustavo Adolfo fu pressoché inesistente. Seguendo l'andazzo della sua epoca, egli (come Tilly ecome tanti altri) non riuscì mai a liberarsi da que ll a che lo stesso
107 P er primo il Delbriick vide chiaramente accanto alla strategia annientatrice l ' esistenza di un'altra, che egli chiamò logoratrice (H ANs DELliRUCK, Die Strategie des Perikles erlautert durch die Strategie Friedrichs des Grossen, Berlino, 1980, sp. p ag . 27 sgg.; sulle idee d i Delbriick il più chiar o studio è: GoRDON A. CRA1G, Delbruck: the Military Histo· rian, in: Makers of Modem Strategy - Military Thoug ht from Machiavelli to Hitler a cu r a di E.M. Earle, New York, 1967, pag. 260 sgg.) . Sebbene queSta tesi del Delbriic k peccasse ancora di eccess iv o sche mat is mo (la guerra è un fenomeno infinitamente complesso e non si lascia categorizzare in due tipi) tuttav ia il suo comriburo a distruggere cert e srorture fu enorme. Da notare che la sua tesi gli so llevò contro tu tta la canea degli pseudo teorici mil itari tedesch i del tempo che rit ennero gravemente offensiva la sua designazione di Federico il Grande come un camp ione de ll a strategia di logoramento (il che inv ece, tra parentesi , e ra ve ro) Accanto al Delbriick il nostro Pieri ebb e il merit o immen so di scorgere chi aramente (e di dire senza ambagi) che il modo di far la gu erra d i Gustavo Ado lfo non aveva p roprio nulla della strategia annientatrice (cfr.: PIERO PIERI, Guerra e Politica , cit., pag 87 sgg., n 1). Va detto che Clausewitz (pur most rando chiaramente la sua pred ilezione per la strategia annientatrice: e fu qui che egli fu schematic o e contr i buì a se minare errori ; ma d i ciò si riparlerà più o ltre) è in realtà assai pi ù sfumato.
103 Cfr. : M. RoBERTS, op cit., pag. 265.
109 Secondo i criteri d i Montecuccoli, il r isc hio cu i il re si era espost o non era necessario : cfr. T.M. BARK ER, The Military Intellectual.. . , cit. pag. 141 e 242, n . 41.
11 0 A q u esto proposito, C laus ewitz lo sottovalutò: cfr.: M. RoBERTS, op cit., pag. 267, n. 2.
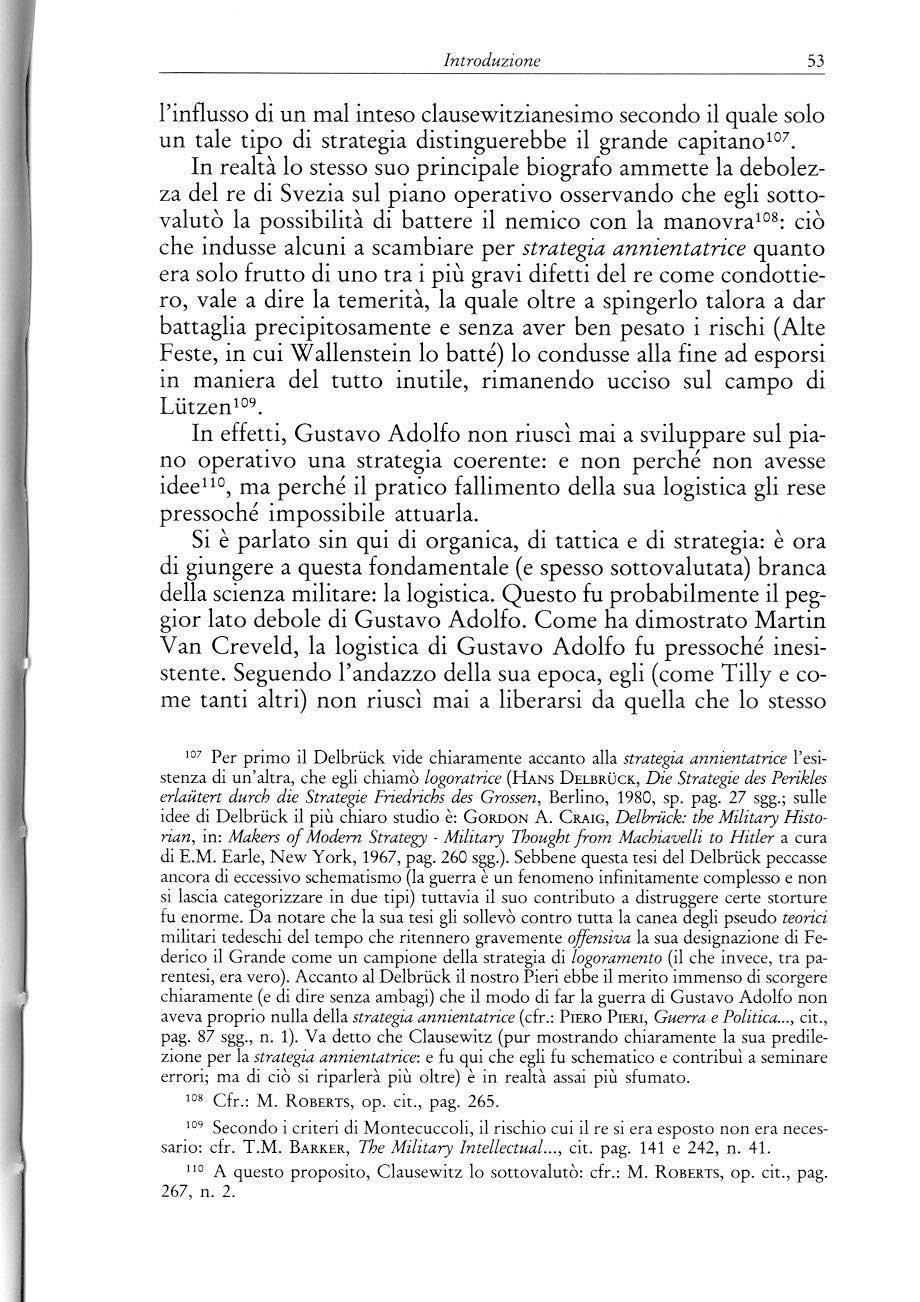
Van Creveld ha in maniera appropri ata definito La tirannia dei saccheggio111. Già al momento d ell a sua avanzata in P o me r an ia eg li si trovò rallentato dal la difficoltà di assicurare adeguati rifornimenti, rinforz~ cibo e denaro per la paga dei soldati 112 . Dop o la vittoria di Breitenfeld, il re aveva t r e possibilità : inseguire il vinto T ill y ; muovere s u Vienna (il ch e avrebbe potuto decidere della guerra); o att raversar e la Bav ier a e la Franconia, ricche di beni ecclesiastici da sacc he ggiare . La s ituazion e logis ti ca lo costrinse a questa terza alternativa: facendo perno su Mago n za, si accinse allo sfruttamento dei territori co n qui stati, allo scopo di manten ere i suoi uomini 1 13 • Ciò gli co n sentì di trasformare le sue for z e da un ' orda di affamati in un esercito ben n utrito 114 • Il sistema co ntinu ò con l 'i nvasi one e la spogliaz ion e de ll a Baviera: ma a questo punto Gustavo Adolfo si trovò contr o un n e mi co c h e, avendo risolto (come si d ir à) il p roblema logist ic o, p o t ev a permettersi il lusso di una strategia sia operativa che globale: ci oè Wallens t ein. Questi, con l a su a mo ssa co nt ro il Circolo d ell a Bassa Sasso ni a, costrinse gl i svedesi a co n vergere d'urge n za ve r so Nord, co nqui stand o co sì su di ess i una grande vittoria strategica. Il r e fu costretto ora a da r battaglia p er ch é il suo grande nemic o lo stava affamando aven do lo attratto in zone or m ai prive di riforni m enti. Fu la sco nfitt a di Alte Feste: da quel momento l'iniziativa strategica passò a Wallen stein 115
In sos tanz a, l'inc ap ac it à de l r e a risolvere il problema logistico incise grave m ent e sull'intero es ito delle su e campagne: in più trasformò gli svedes i in sacc h eggia t o ri , odiati e temuti dall'intera popolazione. La disciplina all'interno r imase ferrea, ma quando il denaro cominc iò a scarseggiare, n on fu più p ossibi le impedire gli eccessi contr o la popolazione, se bb en e il re cercasse, per quanto p ossib il e, di evi tarli 116 • In co nclu s ione, in gran parte della Germania e nell'intera Boemia, gli svedesi, i turchi e il diavolo godevano press 'a poco della stessa reputaz ione •17 •
111 MARTIN V AN CREvE.LD, S11pplying Wa r · Logistics[rom Wallenstein to Palton, Cambridge, GB, 1977, pag. 13 sgg.
112 E A B ELLER, The Thirty Years War, in: New Cambridge Modem History, voi. IV cit., p ag . 384 sgg.
tu E . A. B ELLER, op. cit. , pag. 390.
11
• M. VAN CREVELD, o p. cit., pag. 14.

115 E.A. B ELLER, op. cit., pag 393 sgg.
116 M. RosERTS, op. c it., pag. 2 43 sgg.
117 M. Ros ERTS, op. cit., pag. 245.
La tirannia del sacchep,gio dunque mandò a monte ogni velleità che Gustavo Adolfo potesse avere di sviluppare le sue idee strategiche globali: il suo grandioso piano di convergere su Vienna con cinque (o sette) eserciti rimase una pura utopia 118 • Come si è detto, la grandezza di Gustavo Adolfo è altrove. A parte l'assurdità di voler vedere in lui una strategia annientatrice che non esistette, si è forse esagerata la sua originalità: gli spagnuoli avevano già realizzato la coincidenza tra unità tattiche ed amministrative119; Wallenstein gli fu pari (e addirittura lo superò) come organizzatore; Maurizio di Nassau aveva già introdotto parecchie soluzioni tattiche e accentuato l'uso delle picche nonché l'adde stramento; Stefano Batory introdusse (pare) la cartuccia. Ma Gustavo Adolfo si impadron ì di tutte queste cose che offrivano potenzialmente dei progressi e le combinò, le elaborò, le sviluppò trasformandole in un tutto organico . A differenza degli altri, non praticò una sola innovazione, ma tutte insieme, rielaborandole alla luce dell'esperienza. Come tattico, eg li si erge supremo non solo nella sua epoca, raramente uguagliato, da pochi superato. «In lui», conclude il R oberts, «si incarnò la rivoluzio n e militare che cominciò alla metà del sedicesimo secolo e si completò negli esercit i di Luigi XIV» . Gustavo Adolfo, non Maurizio, portò al trionfo l'ordine lineare e risols e il problema della cooperazione interarma 120 , forse in se stessa la sua più grande realizzazione .
Qu esti furono gli esempi che il pensiero e l 'azione di Gustavo Adolfo posero davanti alla mente speculativa di M ontecuccol i. Il quale seppe vede rne anche i difetti: ma seppe svilupparne così genialmente i lati innovativi che, come si vedrà, pervenne ad eguagliare e superare il Maestro.
Ma un altro Maestro egli ebbe, il quale esercitò su di lui un influsso ancor più grande di quello di Gustavo Adolfo: Albrecht v on Wallenstein, Duca di Friedland 121 • Sebbene, per comprensibili ragioni, il nome di Wallenstein compaia nelle opere di Montecuccoli meno di quello di Gustavo Adolfo, le idee del condottiero

118 Tant o p iù che avrebbe richiesto oltre 200.000 u omini; a p arte il fatto che al re ne manca vano p er lo m eno 90.000, non si vede dove e co me avr eb b e potu t o nutr irli. Cfr.: M. VA N CREVELD, op cic., pag 16.
119 R ENÉ QuATREFAGES, Los Tercios, Madrid, 1983, pag. 123 sgg .
120 M. ROBERTS, pag. 269 sgg
121 La migl io r b iogr afia di Wallenstein è: Gow MA NN , Wallenstein, Frankfurt am Main , 1971 , (trad. it., sfort unatam ente muti lata dell'intero apparato critico: Fire nze , 1981).
boemo furono da lui analizzate ed assimilate, come appare chiaro dalla sostanza dei suoi scritti.
Nato nel 1583 nel castello di Hermanitz in Boemia, Wallenstein aveva studiato a Pado va scienze politiche, matematica, astronomia e astrologia, e là aveva appreso alla perfezione l'Italiano, che scriveva con eleganza 122 . P assato dalla confessione ussita al cattolicesimo romano, Wallenstein cominciò nel 1604 a combattere contro i turchi sotto Giorgio Basta; nella Guerra dei Trent'anni fu alla Montagna Bianca, poscia Colonnello (cioè Governatore mili t are) di Praga. Qui apparvero p er la prima volta le sue tendenze: era nato con il genio dell'organiz zazi one e dell'amministrazione, e tosto propose di mantenere le truppe di occu p azione mediante il s istema razionale di imporre tasse ai nobili anziché continuare con le r equisizioni. Il Cardinale Dietrichstein, G ove rnator e civile, non ne volle sapere: i nobili (e per primo il prelaco) non intendevano pagare 123
Nel frattempo Wallenstein si era d ed icato ad accumulare denaro e ad amministrare le immense sue proprietà e ricchezze, costruendosi un vero stato nello stato. Va detto che le popolazioni civili dei suoi domini ne trassero giovamento: era un saggio ed abile amministratore.

Furono queste qualità c he fecero di Wallenstein il vero creatore della logistica moderna. P er essa egli aveva il genio che Gustavo Adolfo aveva per la tattica. Nella campagna del 1623 lo vediamo già organizzare magazzini per le truppe in movimento, preoccuparsi c he i prezzi siano i migliori : e non limitarsi a dare ordini, ma attento a controllarne l'ese cuzio ne. Da tempo era convinto che la Monarchia absburgica non sarebbe sop ravvissuta senza un esercito regolare permanente: idea preziosa, che sarà ripresa e sviluppata da Montecuccoli. Nel 1625 fece il gran passo: propose all'Imperatore la costituzione di un tale esercito, al suo comando .
Il Supremo Consiglio Aulico rigirò la questione per due mesi: infine aucorizzò la creazio n e di un esercito di 24.000 uomini ed elevò Wallenst ei n a Duca, senza specificarne il grado 124
Ma qui cominciò da parte di Vienna quella diffid e nza che alla fine avrebbe condotto alla rottura con il grande capitano ed alla sua tragica morte: ora la Camera di Corte che amministrava le finanze imperiali sostenne (e la bugia è passat a in molte opere sto122 C fr. la vita di Wallenstein in GuAt.OO PRIORATO, op. cit. 12s G. MANN, op. cit., pa g 182. 12
riche !) di aver supposto che Wallenstein avesse offerto di accollarsi anche il mantenimento dell' esercito. Era un'autentica follia: venti Reggimenti costav ano s ui 10 milioni di fiorini annui ed il Duca, se pure ricchissimo, aveva entrate non superiori ai 700.000 fiorini. Egli in realtà non si era mai offerto di assumersi le spese ma solo di levare ed organizzare l'esercito: e già questo implicava un enorme esborso. Poco di poi, per addolcire la pillola, Vienna lo elevò al grado di Generale in capo 125 .
Co~ì Wallenstein si accinse a risolvere da zero il problema logistico. E stato scritto che egli lo avrebbe fatto lasciando i soldati liberi di saccheggiare a volontà, come per altro facevano quasi tutti i riman enti generali e Gustav o Adolfo più di ogni altro . Ciò è del tutto errato; in realtà Wallenstein fu il primo che spezzò la tirannia del saccheggio, diventando da essa indipendente. Poiché Vienna non intendeva mandar denaro, egli, con uno sforzo sbalorditivo, organizzò il sistema delle contribuzioni forzate, imposte alle città ea alle comunità secondo la loro ricchezza. Sebbene tali contribuzioni fossero più pesanti per le città nemiche, esse, nel complesso, non si potevano definire durissime . Al centro, una perfetta organizzazione provvedeva a tutto: a dividere la zona di reclutamento in circoscrizioni (posto che non vi provvedeva lo stato) affinché gli ufficiali reclutatori non inte rferiss ero a vicenda; a valutare il reddit o delle città ed a negoziare con esse le contribuzioni; ad amministrare il denaro e quindi a provvedere su base razionale al mantenimento dell' esercito: acquisto e magazzinaggio di viveri, vestiario, scarpe, polveri ecc. In compenso le truppe si accampav ano fu o ri dalle mura e veniva risparmiato ai cittadini l'alloggiamento dei soldati; il saccheggio , le violenze, le ruberie erano repressi con drastica severità, puniti spesso con la morte 12 6 •

125 G M AN N, o p. cit , pag 289 sgg
12 6 G. MANN. op cit., p ag 294 sgg Val la p e na d i osse r vare c h e, seco nd o o gni proba b ili t à, la fami gerat a no m ea di orde app ioppata agli ese rci ti d i Wall e nst ei n (ed accet t ata su pi na me nte da p arecchi stud ios i i qual i ev ident e me nte p oco compr end o n o i pro b lemi d ell a sto ri a m ilita re) è pro ba bi l mente de r ivata assa i più dall a t r adiz ione d ei cet i ri cchi - su i q u a li ri c adev a l'o n e re delle co nt r ibu z io n i - c he no n d a i co nt ad in i e d ai p over i, a cu i in vece il sistema di W allenstein r isparm iava sove nte gli orro ri del sacc h egg io e de ll e vessazion i . 1 p ove r i, come s i sa, no n scr ivo n o la stor ia ; e la sc h iacci ante m agg ioranza delle test i m on ia nze t ra ma nd at ec i so n o q uelle dei cet i ricc hi, spec ialm e nte d agli appartenent i alla ricca bo r gh esi a protestante I q uali spess o , ne Jl a loro ira p e r ve nire cos ì salassa ti , d imenticavano che an che a lo r o il sistema di W allenste in ri sp a r m iava be n alt r i o rro r i D el r esto, le t est imo ni an ze ch e ci dà G olo Man n (o p. cit ) sono do ppia m ente inte r essanti: si a p er c h é il M ann n o n si m pa t izza ce rto co n la fig ura e la personali tà di W allenst ei n; sia perc h é egli è di ch iar at a me n t e uno storico non mi l itare. A d og n i modo, uno stu d io serio e pro fondo s u Walle n st ei n co m e ge n er ale, e in part icolare su lla sua logist ica e st r at egia, manca an co r a co mp let a m e nte
Tutto ciò rendeva l'esercito di Wallenstein indipendente ed autonomo; gli consentiva di sostentarsi anche in zone devastate e di spostarsi pressoché soltanto in base alle esigenze operative e strat egiche: una libertà di manovra di cui Gustavo Adolfo non godette mai . Nella campagna del 1626 il Du ca aveva traversato la Slesia a marce forzate percorrendo 800 chilometri e scongiurando la congiunzione di due eserciti nemici; e pure aveva mantenuto e accresciuto un ese rcito senza che il fisco imperiale avesse dovuto sborsare un soldo. Personalmente il generale aveva vigilato a che i contadini e gli altri civili non dovessero subire saccheggi, furti o maltrattamenti: i predoni e i saccheggiatori impararono a temere la sua severità implacabile . Perché Wallenstein aveva sempre un occhio vigile su quelle che oggi si chiamerebbero le pubbliche relazioni, cioè sul lato psicologico e propagandistico della guerra . Statista nato, cercava di mantenere ordine, di proteggere i contadini e le fattorie . Fu una lez ion e preziosa, ch e né Montecuccoli, né altri generali lasciarono andar perduta 127 . Wallenstein era anche sempre attento al benessere ed al morale dei soldati e cercava di risparmiar loro sforzi e sacrifici inutili: soldati riposati, ben armati, abbastanza ben nutriti ... Questo fu il giudizio unanime sulle sue truppe12s.
Organizzare era per lui un piacere, prima ancora che una vocazione . Quando gli venne dato lo stato del Meclemburgo, vi garantÌ pace ed ordin e, t en uti da truppe disciplinatissime, pagate con le cont ribuzioni ; una amministrazione efficiente e scrupolosa; una giustizia pronta ed immediata.
La soluzione del prob lema logisti co gl i consentì di avere ciò che non era mai stato dato ai suoi colleghi ed avversari : un disegno operativo e una strategia. Il pensiero strategico globale di Wallen stein era grandioso, ma avveduto e prudente; non azzardava mai nulla. E sopra og ni altra cosa stava con i piedi sulla terra , non pensando mai a piani che non avesse avuto i mezzi logistici per realizzar e. La Germania doveva gradualment e organizzarsi attorno all'Im peratore; il bastione settentrionale sarebbe stato il Baltico ove egli, con i piedi so lidam ente piantati nel suo dominio di Meclemburgo amministrato alla perfezione, cominciò a gettare le basi di una potenza navale imperiale. Disegn o grandioso e realista: gli strumenti logisti ci e organizzativi per attuarlo, li aveva. Fu Vienna c he non seppe vedere abbastanza in gra nd e e lontano;

e poi Vienna non gravitava verso il Baltico . Il s uo destino fu sempre danubiano e adriatico. Era una strategia nazionale tedesca quella che Wallenstein aveva disegnato e stava attuando. L'intervento della Svezia rimandò tutto; ciò non toglie che la sua strategia globale fosse tutta materiata di realtà, a differenza di quella di Gustavo Adolfo che per la mancanza di una qualunque seria base logistica rimase velleitaria e dopo la sua morte finì per trasformare gli eserciti svedesi in pedine di uno stratega globale ben più lungimirante: Richelieu.
Sul piano operativo, W allenstein aveva una profonda conoscenza d el terreno ed aveva il dono più grande dello stratega: quello di divinar e le intenzioni del nemico 129 . Ciò emerse nella brillante camp agna contro Gustavo Adolfo, ove egli pervenne a sventare la prevista minaccia su Vienna con l'audace invasione de ll a Sassonia. Nettamente superiore al re di Svezia in logistica e strategia, Wallenstein sapeva di essergli inferiore nel campo della tattica. Non aveva quindi esitato a mutuare da lui tutta una serie di idee, dal cannone reggimenta le (che a Liitze n infliss e p erdite terribili agli svedes i), alle cariche di cavalleria (di nuovo a Liitzen, la travolgente carica di Pappenheim), alla diminuita profondità dei quadrati 130 Né va dimenticato che, all'inizio della campagna di Liitzen, Wallenstein dovette ricominciare da zero, ricreare dal nulla un esercito . Egli lo fece: e lo dotò anche di un completo ed organico parco di artiglieria in cui comparivano per la frima vo lta i cannoni reggimentali da 6 libbre (quindi un po' piu pesanti e meno maneggevoli di quelli svedesiJ 131 •
Sul campo di Liitzen Wallenstein aggiunse archibugieri alla cavalleria (circ.a 15 per ala) e mandò avanti un velo di tiratori come gli aggiunti svedesi; schierò la cavalleria su sei righe, la fanteria s u dieci; i battaglioni furono disposti a gruppi di tre, i due laterali più avanti, quello centrale più indietro (il che gli veniva forse ancora dalla scuola di Giorgio Basta) 132 •
La battaglia fu indec isa: la morte di Gustavo Adolfo e di Pappenheim contribuirono all'incerto risultato , anche se al cader della notte Wallenstein sgomberò il campo. Non era riuscito ad eguagliare sul piano tattico il suo grande nemico ora caduto, ma,
129 G. MANN, op. cit , pag. 319; 385
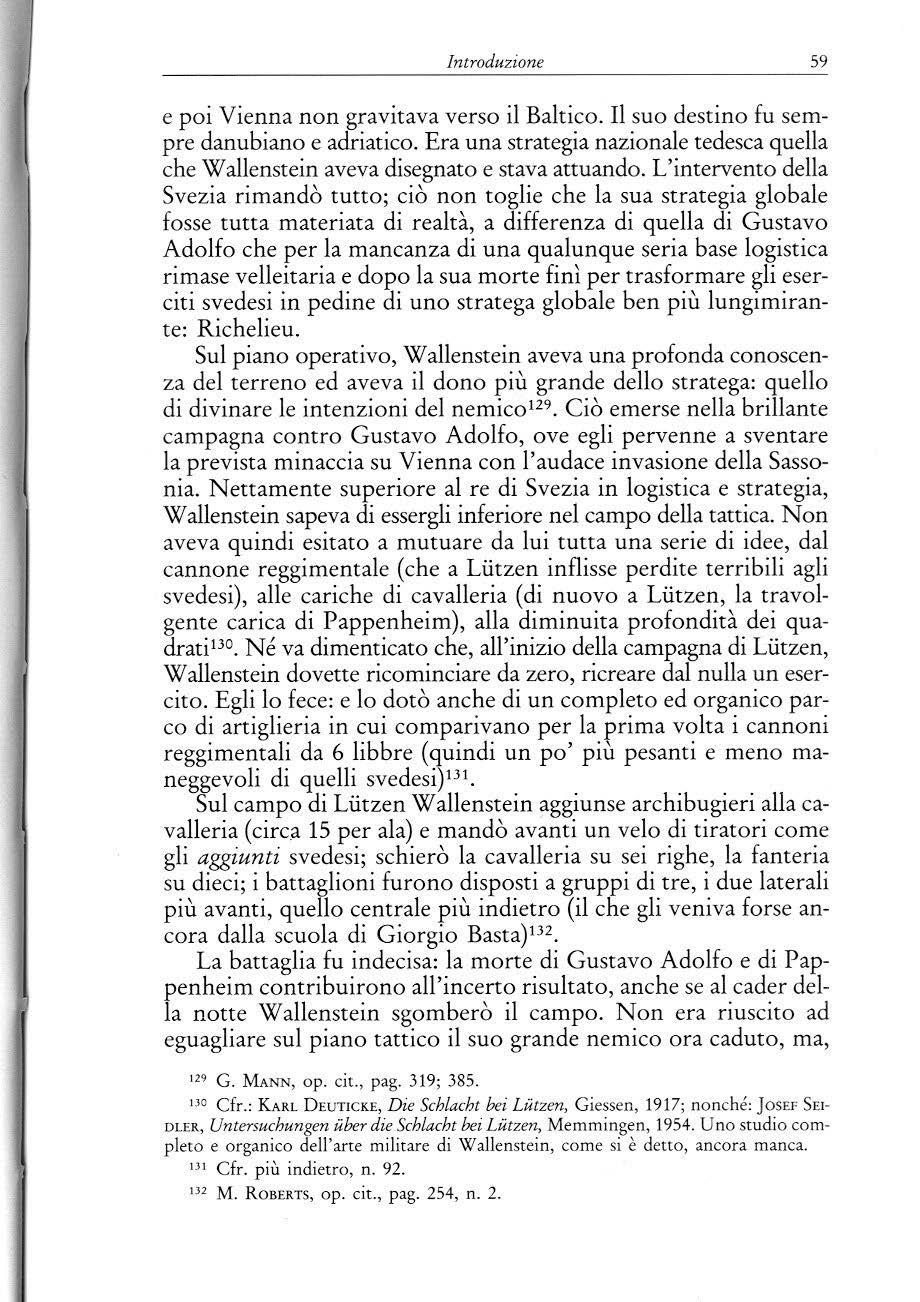
uo Cfr. : KARL D EUTIC KE, Die Schlacht bei Lu tzen, G iessen, 19 17; n onché: JoSEF SEI· DLER , Umersuchunge n uberdie Schlacht beilutzen, Memmingen, 1954. U no stud io co mp leto e organico dell'arte militare di Wallenstein, com e sì è detto, ancora manca
13 1 Cfr. più indietro , n. 92.
132 M. ROB ERTS, op. cit., pag. 254 , n 2.
n el complesso della campagna, lo aveva completam ente supe r ato su qu e!Jo op erativo e strat egico, p er non parlare della logi st ica. In effetti è ben esatto dire che la logisti ca moderna nacque co n Walle nstein. Questi furono due tra i principali ese mpi che, sia p e r le cose positi ve che per qu elle neg ati ve, M o ntecu ccoli ebbe davanti agli occhi e su c ui la s ua mente specu lati va m editò profo ndam ente; ma una attenta analisi delle sue ope re prova in maniera incontrovertibile ch e la tesi sec o ndo la quale egli sarebbe stato il teorizzatore e p e r cos ì dire l'esegeta d ell'arte militare di Gustavo Adolfo è del tutto insosteni bile. Montecuccoli vide chiaramente tutt e le defi cie nze e i lati negativi nell'opera del gran de re , e additò la v ia p er sup erare le une e gli altri; in secondo lu ogo appare evide nte che Wall e n stein lo influenzò assai più profondamente di Gu sta vo Ad olfo, perché se egli studiò e discusse a fondo la tattica dello svedese, fu, nel camp o della lo gist ica, non solo il continuatore, m a il perfezionatore d ell'ope r a del Duca di FriedJand, che anch e qui tuttavia egli trascese e sup erò. E per lo meno due altri co ndottieri egli conside r ò M aestri: il Tilly, di cui ammirò l'abilità nel sap er individuare magistralment e il momento più adatto per dar battaglia nonché le capacità di comandoU3 ; e Matt eo Galasso, con la sua perizia nello sceg liere il terreno.
La verità è c h e Montecuccoli, abilissimo nello stud iare l 'es peri e nza viv e nte d ei grandi co nd ottie ri con cui o co nt ro c ui si trovò a operare, non fu specifica tam ente né il cont inuatore né meno c h e m ai il teori zzatore di alcuno. Cresciuto ad ess ere uno tra i più grandi ge nerali del suo e d i t utti i tempi, ca p o e vi ncit o r e in d ec ine di battaglie, egli espose e te ori zzò la propria dottrina della guerra, in c ui tutte le esperienze, da qu elle di Gustavo Adolfo e di Walle n stein a quelle di Tilly e Gal asso e di altri ancora, furono trascese e s up erate in una visione originale nuova c h e invece di volgersi al passato apriv a la via al futuro.
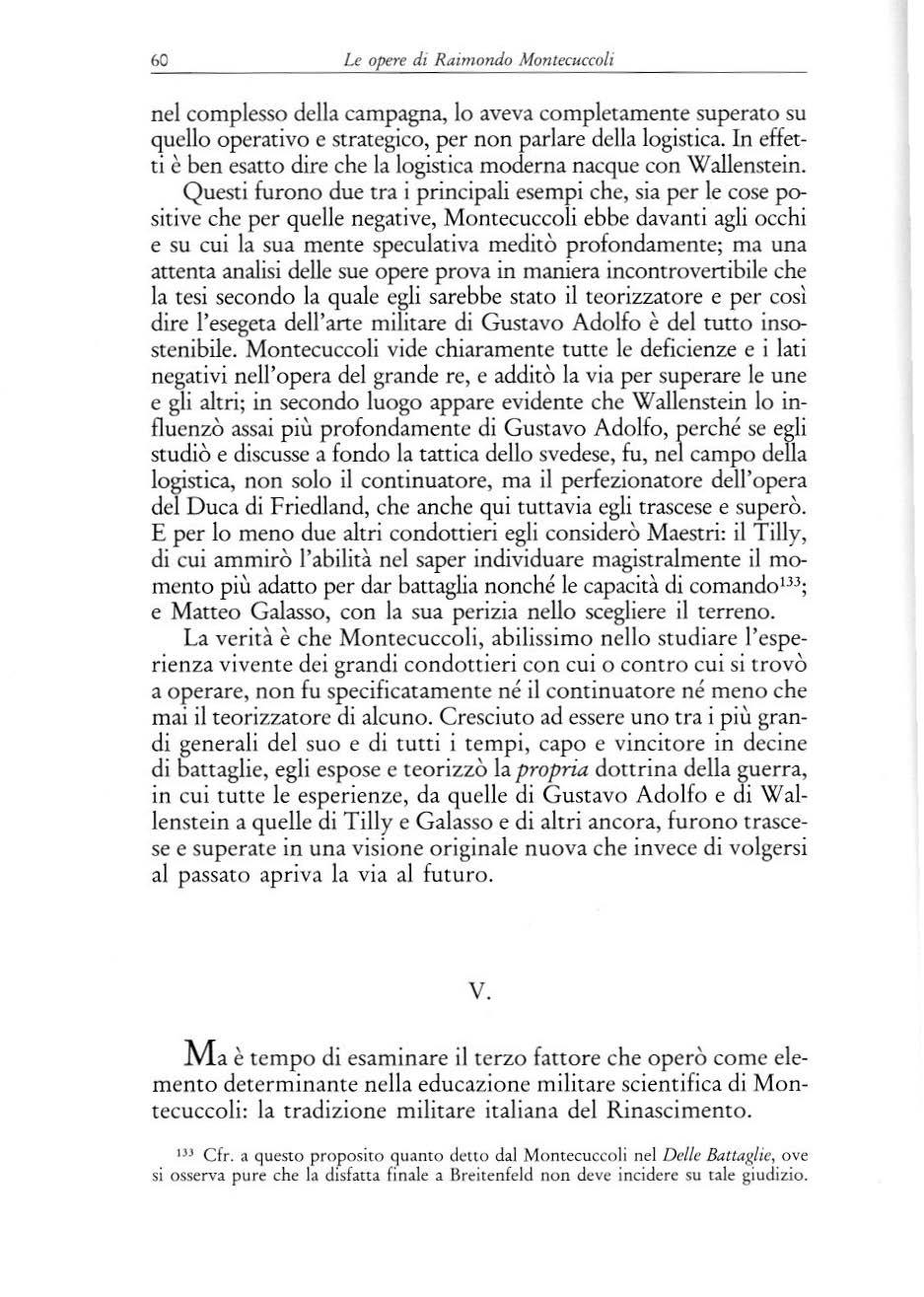
Maè tempo di esaminare il terzo fatto r e che op erò com e elem e nto deter min ante n ella edu caz ion e militar e sc ientifica di Montecuccoli: la tr adiz ione militare italiana del Rinasc i mento .
m Cfr. a qucsro propos ito quanto detto dal Mo ntecu ccoli ne l Delle Battaglie, ove si osserva pure ch e la disfatta finale a Breitenfeld non d eve inc id ere su tale giud izio.
Come in tutti i campi, co me cioè nelle lettere, nelle arti, ne lle scie nze fisico-matematiche , nella filosofia, nella te cnica, l'Italia d el Rinascimento a veva domin ato ed edu cato l'Europa anche in quello dell'arte e della scienza militare. Anche qui era vero che, per tutto quanto essa offriva a chi voleva conoscere, per tutto quanto essa of /riva a chi intendeva contemplare, l'Italia costituiva, per il mondo occidentale, la scuola più alta 134 •
La storiografia nazionalistica italiana dell'Ottocento e del primo Novecento prese a tale proposito uno tra i più grossi abbagli. Convinta che già nel Rinascimento esistesse - se pure divisauna nazione italiana simile a quella nata con le battaglie risorgimentali, essa concluse quindi che la catastrofe, la quale si abbatté sulla P e nisola n el Quindicesimo e nel Sedicesimo secolo, si sarebbe potuta evitare se gli Italiani non fossero stati imbelli e non ave ssero fatto ricorso ai mercenari senza patria e senza principii, i quali avrebb ero impedito una presunta unione della naz ione italiana p er fronteggiare lo straniero 134bis _
Tale concezione, che, incapace di giudicare il passato iuxta pro · pria principia, applicava ad esso strutture, situazioni e mentalità proprie di un'altra era, fu in grandissima parte influenzata dagli scritti del Machiavelli, il quale, sia perché il suo obiettivo era prevalentemente pratico e non già teso alla pura ricerca sci entifica della verità delle cose, sia _per mancanza della n ecessaria prospettiv a, aveva ridicolizzato e infamato il modo di far la guerra degli Italiani allo scopo di raggiungere fini politici precisi e non per una disinteressata ricerca, che del resto nella sua situazione sarebbe stata assurda, mentre il suo metodo (come per altro anche nel Principe) appariva del tutto coerente con i suoi obi ettivi. Ma la sua analisi circa la presunta responsabilità del mercenarismo era (come dice uno tra i maggiori storici militari del Rinascimento, lo Hale) ingannevole135 •
13 4 H EN RI H AUSER· AuGUST IN R ENA UDET , Les Débuts de l 'Age Modern e, Parig i, 194 6, pag 101.
134 bù C irca l'a bbagli o preso da qu a nti vo ll e ro vede re gi à nei secoli precede nt i l' es iste nza di una om oge nea nazione ital iana (c he i n rea lt à si and ò fo r man do so lo ne ll ' O t to· cento) , cf r.: BENEl)E TTO C ROCE, La Storia come pensiero e come azio ne, Bari, 1965 (I ed.: ibi d. , 1938), pag 329 sgg. ; s ulla in cap aci tà degli it ali an i del Ri sorgime nto a capire l' età barocca, BENEDETTO C ROCE, Storia dell'Età Barocca , cit. , pag . 3 sg g. , 489.
135 J.R. H A LE, Diplomacy and War in Western Europe, in: New Cambridge Mo dem Histo ry, cit , vo i. I, pag 360 sgg. Lo stesso può dirsi a pro pos ito del G uicci ardi ni. Veda ns i a nche le acute co nsid erazio ni di FEDERI CO CHABOD, Il carattere e i limiti del pensie· ro di Mac hiavelli, in: Del Prin cipe di Ni ccolò Machia velli, a sua vo lta nel volu me dell o C habo d, Scritti su Machiavelli, To rin o, 1964, pag. 29 sgg. Da t e ner prese mi anch e le gius te osservaz io ni di A NT ONIO GRAMS CI, Quaderni del carcere, a cur a di V Gerr atana, To ri no, 1975 sgg., 4 volumi , passim , o ve è ben pu ntu ali zzat o il car attere d i m an ifesto politico di alc uni t ra gli scr it ti del Machiavelli, come, ne l caso , il Principe.

Altr ettanto falsa era la seconda tesi del Machiavelli, che cioè le battaglie italiane sarebbero state poco cruente: in realtà, la debolezza dell 'I talia non era causata dalla necessità di doversi affidare ai mercenari, n é dal fatto che le sue guerr e assomigliassero più ad un gioco dì scacc hi che a una carneficina; le soldatesche italiane avevano già dimostrato a Crevola, nel 1487, di saper sconfiggere gli svizzeri che av evano allora la miglior fanteria di picchieri d'Europa 136 _
Contribuì an cora una volta a que sto abbaglio degli storici, dì cui si è detto più sopra, l'influsso di certi interpreti del Clau sewitz, i quali avevano assolutizzato la tesi del teorico prussiano (già di per se stess a inesatta) secondo la quale solo la soluzione sangu inosa costituirebbe la vera forma di guerra 137; per cui nelle operazio ni militari italiane del Rin asci m ento (che, per altro, furono spesso quanto mai cruente) si volle r avvisare una specie di deviaz ione dal r etto cammino.
Il primo studioso che vibrò un colpo demolitore a questa leggenda fu il Pi e ri, il quale disse senza ambagì che nel Rinascimento « il fatto più appariscente sembra l'inferiorità militare degli italiani, che si manife sta dalla calata di Carlo VIII in poi, in una serie di dolorosi rovesci. Ma è vano vo ler vedere so lo il fatto militare», continuava egli, «p erché la guerra n o n è che la manife stazione, così come la politica e l' eco nomia, di un più vasto e com pl esso fenom eno» 138 •
La c risi it aliana non fu, cioè, dovuta a fattori militari, ma a fattori sociali e politici; e le sventure dell'Italia furono la inevitabile conseguenza di vi ce nde storic h e ben ind ividuate che vi impedirono il sorgere - come invece avvenne altrove - di un forte stato laico centralizzato: cosa che il Machiavelli ed anche il Guicciardini, sia detto di pass ata, avevano benissimo compreso .
Infine Michael Mallett , con il suo basilare studio sui Condottieri e la gu e rra del Basso Medio Evo e del Rinascimento ha definitivamente liquidato la leggenda della inferiorità militare italiana 139 •
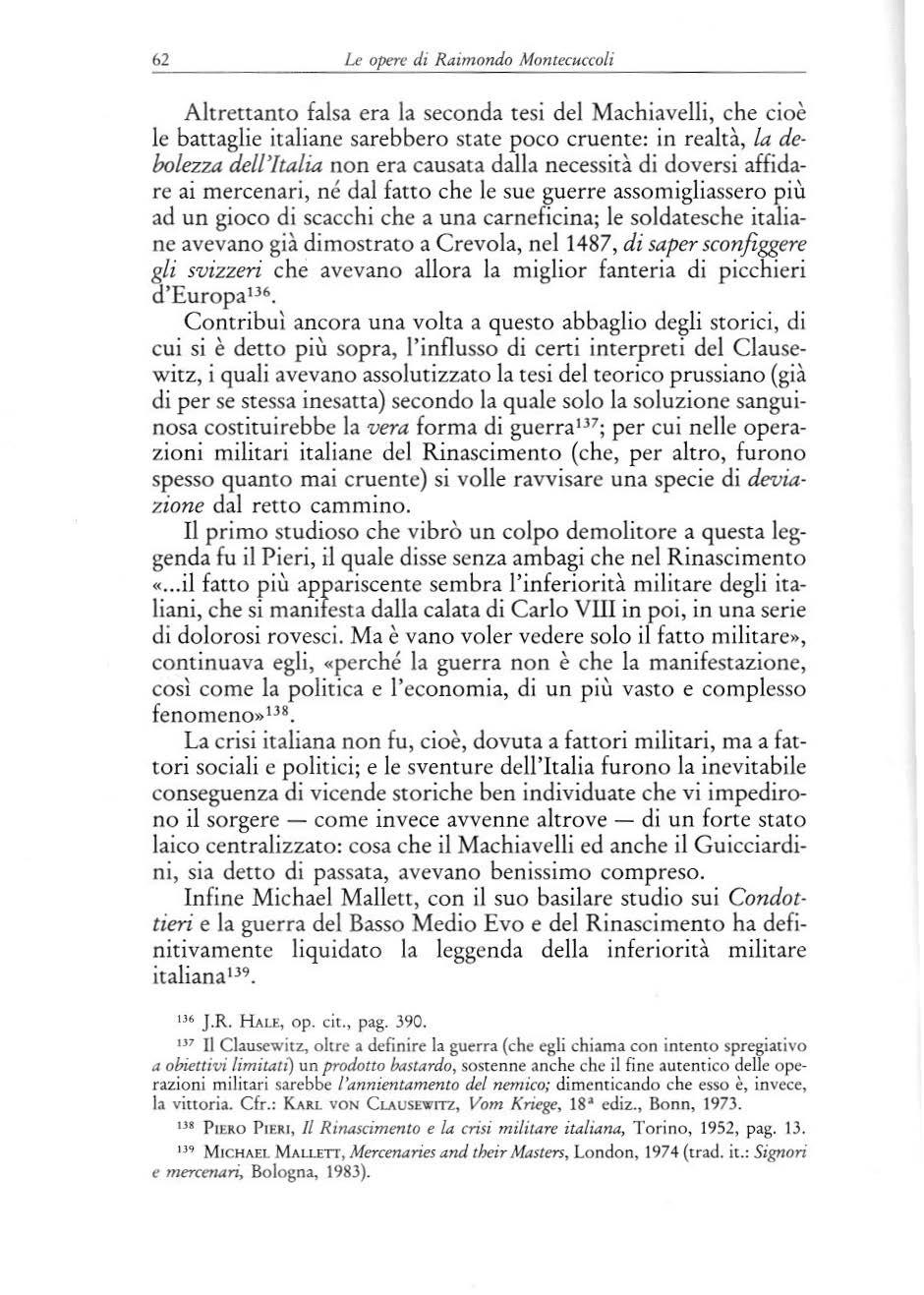
1J 6 J.R. HALE, op. cit., pag. 390.
137 U C lausewitz, oltre a definire la guerra (c he eg li chia ma co n i nte nto spregiat ivo a obiettivi limitali) un prodotto basta rdo , sostenn e a nche che il fine a utenti co delle o perazioni militari sa rebbe l'an nien ta men to del nem ico; dim e nti cand o c he esso è, in vece, la vitt o r ia. C fr .: KARL voN CLAuSEW ITZ, Vom K riege, 18" ediz , Bo nn, 1973
lJ8 P1 ERO P1 ERI , Il Rinasciment o e la crisi militare italiana, Torino, 1952, pa g. 13.
139 M1 C HAEL MALLETI , Mercenaries and their Masters, Lo ndon , 197 4 (trad. it.: Signori e mercenari, Bologna, 1983)
In verità nel Rinascim ento (ed anche oltre) gli stranieri non avevano mai avuto per l'arte e la scienza militare italiana altro che ammirazione. Come esattamente dice il D el bruck, è vero che il passaggio all'età moderna nel campo della guerra consisté nel risorto prestigio della fanteria (ma non si può dimenticare l'avvento delle armi da getto prima, poi da fuoco) 140 ; ed a ciò anzitutto i picchieri svizzeri, poi quelli tedeschi e spagnuoli dettero un contributo che è difficile sopravvalutare; ma è altrettanto vero che nel Cinquecento, se i migliori picchieri erano considerati essere gli svizzeri, gli archibugieri di élite erano e rimasero gli italiani; e se in Italia fu difficile reclutare in massa fanterie armate di picche, ciò accadde perché solo in quei paesi ove esisteva un contadiname povero (ed una notevole quantità di spostati senza mestiere) ciò fu ampiamente possibile. Il livello di vita italiano era troppo elevato; lo stesso accadde per la Francia che, pur essendo all'inizio dell'età moderna la potenza militare dominante, non ebbe mai una fanteria nazionale e dovette costantemente dipendere dai mercenari svizzeri 141 •
Pure, nel Quattrocento gli Italiani - ben guidati - avevano ripetutamente battuto due delle migliori fanterie europee: gli svizzeri ad Arbedo ed al Ponte di Crevola; i lanzichenecchi tedeschi a Calliano 1 42 • Su ciò due brevi considerazioni devono esser fatte. Anzitutto che non solo dai picchieri svizzeri, ma dagli archibugieri italiani stava nascendo la mode rna fanteria che nel Seicento avrebbe fuso in maniera armonica picca e moschetto 143 ; la seconda, che il passaggio dalla pratica militare del Medio Evo a quella moderna stava avvenendo esattamente nel senso contrario a quello auspicato dal Machiavelli: cioè con il sorgere e il consolidarsi
140 H. D ELBR UC K, op. cit., voi. IV, pag. 148.
141 EDUARD FuETER, Geschichte des européiischen Staatensystems von 1492 bis zum 1559, Munchen, Berlin Oldenburg, 1919 (trad. it.: Storia del Sistema degli Stati Europei dal 1492 al 1559, Firenze, 1969, pag. 87 s&g., 135 sgg , 192 sgg.) Gli Italiani ebbero u n li mitato numero di picchieri, per lo piu recl u tati in Val di Lamone, in Romagna: ma le condizioni sociali non ne favorirono mai lo sviluppo Cfr. M MALLETI, op. cit., pag. 185 sgg.
142 M MALLETT, op. cit., pag. 236 sgg.; P . P1ERI, IL Rinascimento... , cit. , pag . 304 sgg., ove si ricorda anche la gr ande vittoria del Colleon i su i francesi a Bosco Marengo.
143 Furono proprio gli italiani Prospero e Fab rizio Colonna a dimostrare, a Cerigno la ed alla Bicocca nel 1503 e nel 1522, come la tattica svizzera dell ' urto puro, sovente senza una sufficiente armonizzazione con il fuoco, fosse destinata alla sconfitta. Cfr. M. MALLETI, op. cit., pag. 254 sgg.; 258 . È normale che gli ita lian i - più evoluti culturalmen te oltre che dotati di un elevato li ve ll o d i vita - si ri vo lgessero a quella specialità della nuova fanteria che furono gli arch ibu gieri (e dove ess i eccelsero), mentre i picchieri si formarono piuttosto tra popo li contadini poveri.

del professionismo militare, di cui proprio gli svizzeri furono un notevole ese mpi o 144 • Ciò per la fanteria. Nel campo della cavalleria pesante gli italiani non temevano confronti 145 mentre la cavalleria leggera veneta (gli stradiotti) era per univ e rsale ri conoscimento la miglior e d'Europa e fu ben tosto imit ata da tutte le potenze. Quanto al l'artiglieria, basti qui ricordare che fu Bartolomeo Colleoni il vero iniziatore dell'uso di essa in battaglia, ossia dei pezzi da campagna; che la famosa artiglieria francese di Ca rlo VIII fu ideata e fusa dal vicentino Basilio Della Scuola; che, infine, fu Alfonso I d'Este, Duca di Ferrara, alla battaglia di Rav e nna che, introducendo la manovra tattica dell'artiglie ria , praticamente acquisì ai francesi la vittor ia 146•
Ma dove la scienza militare italiana era giunta ad ecc ell eree fu e rimase per lunghissimo tempo maestra al mondo - fu nel campo della fortificazione. Francesco di Giorgio Martini, certame nte, oltre ad essere un architetto militare di prim'ord in e, scr isse il primo trattato s ist emat ico in materia di cui s i abbia nozione 14 7 ; ma già prima di lui decine di arc hitetti empirici avevano portato avanti in modo tale la spe rimentazion e da dare all 'Italia una tale maestria nel campo c h e non fu più raggiunta si no ai tempi di Vauban 148 • Ad ogni modo gli ingegneri militari italiani non tardarono a operare in tutta Europa e letteralmente nel mondo intero: da Kiistr in a Spandau, da Anversa alla Boemia, all'Ungheria, alle In die ed alle Am eri che, dovunque le tracce dell'opera loro so no ancora visibili. Un italiano, Battista Antonelli, costruì per Filippo II di Spagna le fortificazioni del Nuovo Mondo; dall'Avana al Mozambico, a Goa, si imposero le opere for tifi cato ri e dovute a ingegn er i militari it alia ni 149 •
144 M. MALLETT, op. cit ., pag. 15 sgg.
14s Vedasi l'episodio di Barl etta: P. PrnRI, op. ci t. , pag . 404.
146 P. PtERI, op cit , pag. 496
147 L'op era, probabi l ment e per motivi di segret o militare, r im ase manoscritta fino alla su a pub b li cazione nel secol o XIX: FRANCESCO or GIORGIO MART1N1 , Trattato di Ar· chuettura Civile e Militare, a cura di Carlo Promis, Torino, 1841; cfr. anche: CA RLO PR O MIS, Dell'arte dell 'i ngegnere e dell'artigliere in llalia dalla s1,a origin e sino al principio del XVI secolo, Torin o, 1841; la prima in ves tigazi o n e cr it ica s ulle origini dell'art e fortificatoria italiana.
143 Si tenga tuttavia conto c he Mome cuccoli, co ntempora n eo di Vauban, gli dispu· tò il pri mat o nell 'arte fort i ficator ia. Su q uesto as petto po c hi ssi m o noto de l ge nio di M oncec uc co li , cfr. più avanti.
149 H. KA UFMANN, o p. cit., pag . 11; cfr. inoltre : J.R . HALE, The early Development of the Bast ion : an lta lian chronology, c. 1450-c.1534, in: R enaissance War Studies, London, 1983 , pag. 1 sgg.
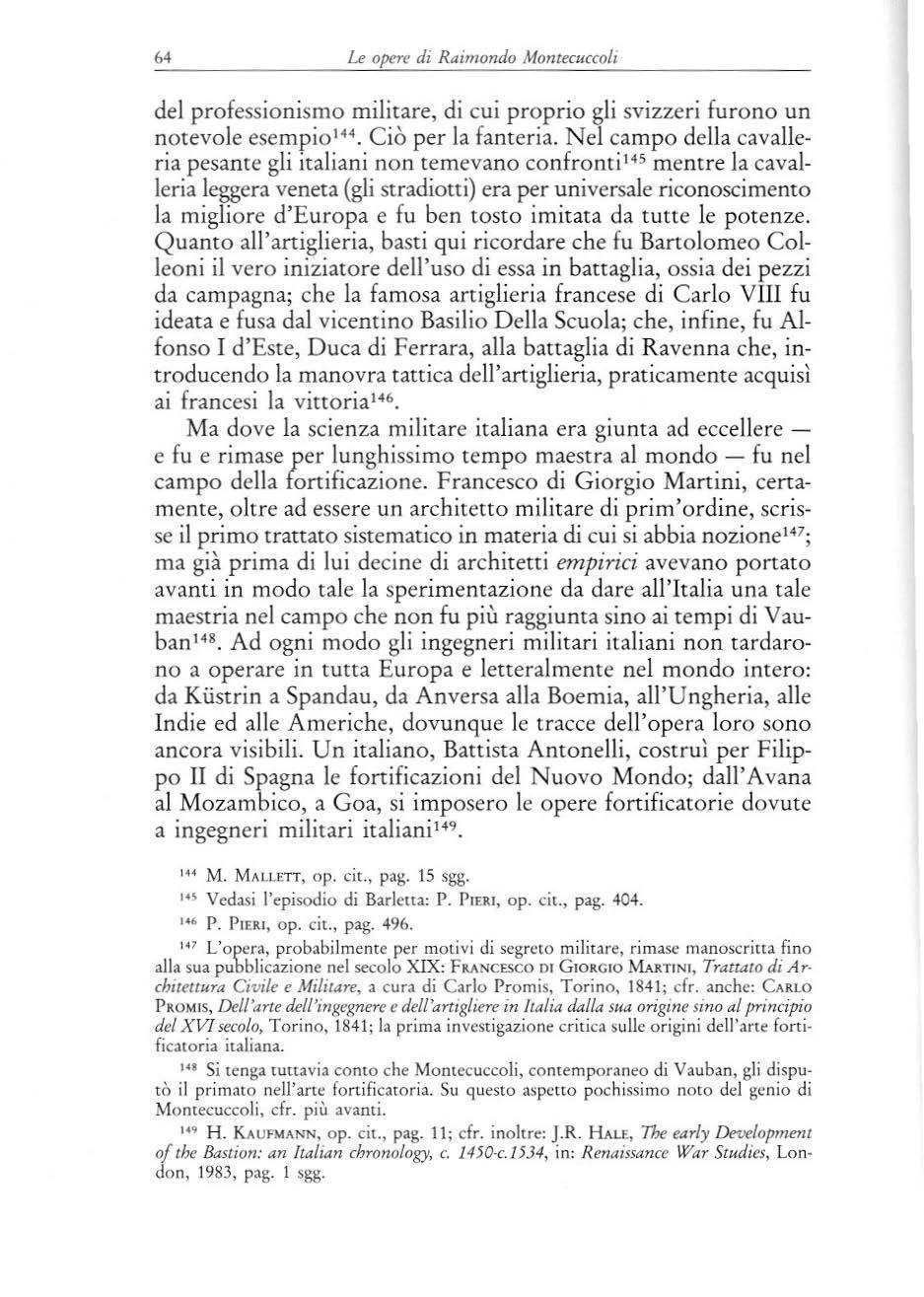
Al livello più alto del pensiero militare, i condottieri italiani che nella prima metà del Seicento ed oltre combatterono al servizio degli Absburgo erano gli eredi di una scienza militare creatasi nelle guerre comunali dei secoli Dodicesimo-Quindicesi mo, imitata dovunque nel Sedicesimo secolo. Tutti i concetti fondamentali dell'art e militare moderna erano stati da loro sp erim entati, sviluppati ed anche t eorizzati: p er raggiunger e la massima economia delle forze, avevano sviluppato la dottrina dell'approccio indir etto cinquecento anni prima ch e Liddell-Hart la formulasse; a questo fine avevano evoluto minuziosamente le teorie della marcia, dell'assedio, della difesa e dello sfruttamento o ttimale di tutt e le armi. Tal e loro strategia si fondava su un accuratissimo sistema di ordini di marcia e di sicurezza in movimento, sull'uso scientifico della fortifica zione campale , su un'attenta alternanza e cooperazione interarma150 • La loro arte militare aveva sostanzialmente due caratterist ic h e . In primo luogo gli italiani erano riusciti a portare nella guerra un distacco da professionisti e conseguentemente cercavano, per quanto possibile, di mantenerla entro li miti uma n i (per questo, e non per esitazione né meno che mai per codardia, tendevano ad evitar e quella str ategia pseudo-annientatrice che s i fo n da sovente sul n o n far economia di vite umane; la qual cosa non significava c he, al caso, non fossero pronti a dar battaglia senza quartiere) ; in second o luogo ess i cercaron o sempre più di distillare il succo delle loro esperienze in principi i razionali; da buon i figli della ci v iltà umanista (molti di essi, com e F ed erico da Montefeltro, lo furono es si stessi) , pres e ro la p e nna e d i ve nn e ro, specialmente dalla metà del Cinqu ece nto in avanti, scrittori militar i . In questo se n so Montecu ccoli non fu c he il tard o e pigono di una inint e rrotta tradizion e c h e da Giulio C es are Brancac cio , Lud ov ico Melzi, Giorgio Basta ed altri ancora , condusse fino a lu i 151 •
Ma gi à prim a di qu esti, gli scrittori militari italiani e ra n o stati i p i ù letti; essi e rano giunti a formular e una d o ttrina del rapport o t ra guerra e politica ben prima di Clausewit z 1 52 ; essi erano an z i-
150 H . KA uF MA NN, op. cit. , pag . 1 1 sgg.
ni H. KAuFMANN, o p cit , pag 12; p ag 82; i l Brancaccio, ge n e ra le e in geg n er e m ilitare, scrisse Della vera disciplina militare e un Disco rso sulla milizia; Lud ov ico Me lz i scrisse R egole militari sopra il governo et servitio pa rticolare della cavalleria, Anversa, 1611 ; Gi o r gio Basta , all ievo di Al ess andro Farnese, scr isse i l Governo della cavalleria leggiera , Ve n ezia , 16 12. C fr. H . KAUFMANN, o p. ci t., p ag. 82, n. 57.
1 s2 J. R. HALE, Diplomacy and War in Western Eu rope in: New Cam bridge Modem History, vo i. I cit ., pag. 360: per j cap i mjJitari it ali an i «la gue rra er a un ingredi ente sco ntato e legi tti m o di ogni negoz iato».
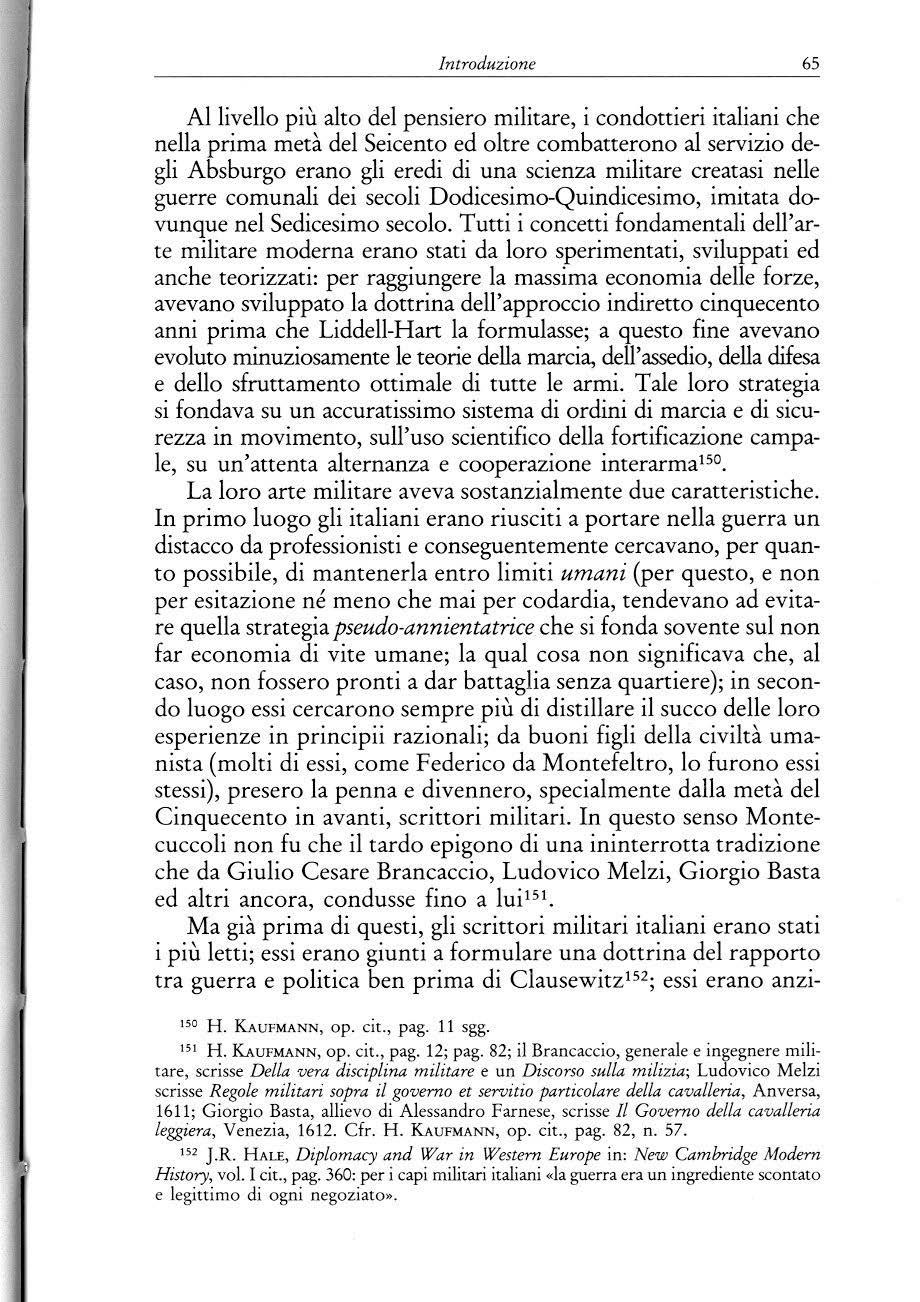
tutto presi dal loro modo scientifico di considerare la guerra. Sebben e 1 taccuini di Leonardo e l'opera di Francesco di Giorgio Martini rimanessero mano scr itti, il De re militari, di Robert o Valturio, fu stampato nel 1472 a Verona e perfezionato nel 1524 da Battista
D ella Valle. Seguirono il Cornazzano da Piacenza, che aveva combattuto sotto Colleoni; Birin gucc io e Tartaglia il quale per la prima vo lta desc ri sse e definì razionalmente non so lo la struttura delle fortificazioni , ma il fuoco difensivo secondo prin cipii r igorosamente matemati ci 153 • Insomma, si può ben concludere co n il Burckhardt che in Italia prima che altrove si hanno una scien za e un 'arte della guerra trattata in modo affatto sistematico e razionale 154 • Era naturale quindi ch e i migliori generali fossero italiani e che ci fosse una gara tra gli stranieri per accaparrarseli. A Gian Giacomo Tri vulz io , primo Maresciallo di Francia, fu dovuta la vittoria di Marignano, così come a Prospero e Fabrizio Colonna quelle di Cerignola e della Bicocca; italiani furono i due più grandi generali della Spagna nelle guerre di religion e e in qu ella dei Trent'anni: Alessandro Farne se e Ambrogio Spinola; italiano il grande ingegnere milit are Federico Giambelli c h e dife se Anver sa contro il suo illustre conterraneo, il Farnese, facendo saltare con una macchina infernale che st upì l 'Europa il grande ponte di barche lungo 750 metri c he gli ingegneri - pur essi italiani - del Farnese avevano costruito 155 • Certo, anche nell'arte e nella scienza milit are come in ogni altra branca del pensiero e dell'azione del Rinascimento prevaleva la tipica tendenza italiana all'universalismo; cos ì che, invece c he ad una ipotetica (e in quel tempo impossibile) rivoluzione nazionale, l'Itali a fornì i quadri migliori all a evoluzione del resto dell'Europa. Ma gli uomini del Rinas cime nto era no cittadini del m<;>ndo; l~ l oro_ coscienza di_ italiani non era div:rsa da _quella per cm oggi c1 se ntiamo europei, mentre una autentica nazione europea è, almeno per il momento, ben lo ntana oltre l'orizzonte.
Uno deiJaesi verso cui i so ldati italiani si dirigevano più volontieri era· Sacro R omano Impero Germanico, cioè la Corte ab-
1s3 N 1cc0Lò TARTAGLI A, Q11esiti et inventioni diverse, Venezia, 1546; cfr .: J.R. H ALE, 1be argument ofsome military title pages of the Renaissance, in: Renaissance War Swdies, cit. , pag. 211 sgg. A proposito del Tartaglia, si deve ancora ricordare c he già nel 1536 egli aveva affrontato il problema della fortificazione (Sul modo di {ortifuare le città rispetto la fonna, Venezia, 1536); n onché il probl e ma matemati co dell'artiglieria (Nova Scientia, Venezi a, 1537).
, sa j ACO B BuR C KHAROT, la civiltà del Rinascimento in Italia, a cura di G. Zippel , Firen ze, 1943, pag. 114.
,s s J.R. HALE, Armies, navies and theart ofwar, in : New Cambridge Modem History, cit., voi. m, pa g. 213.
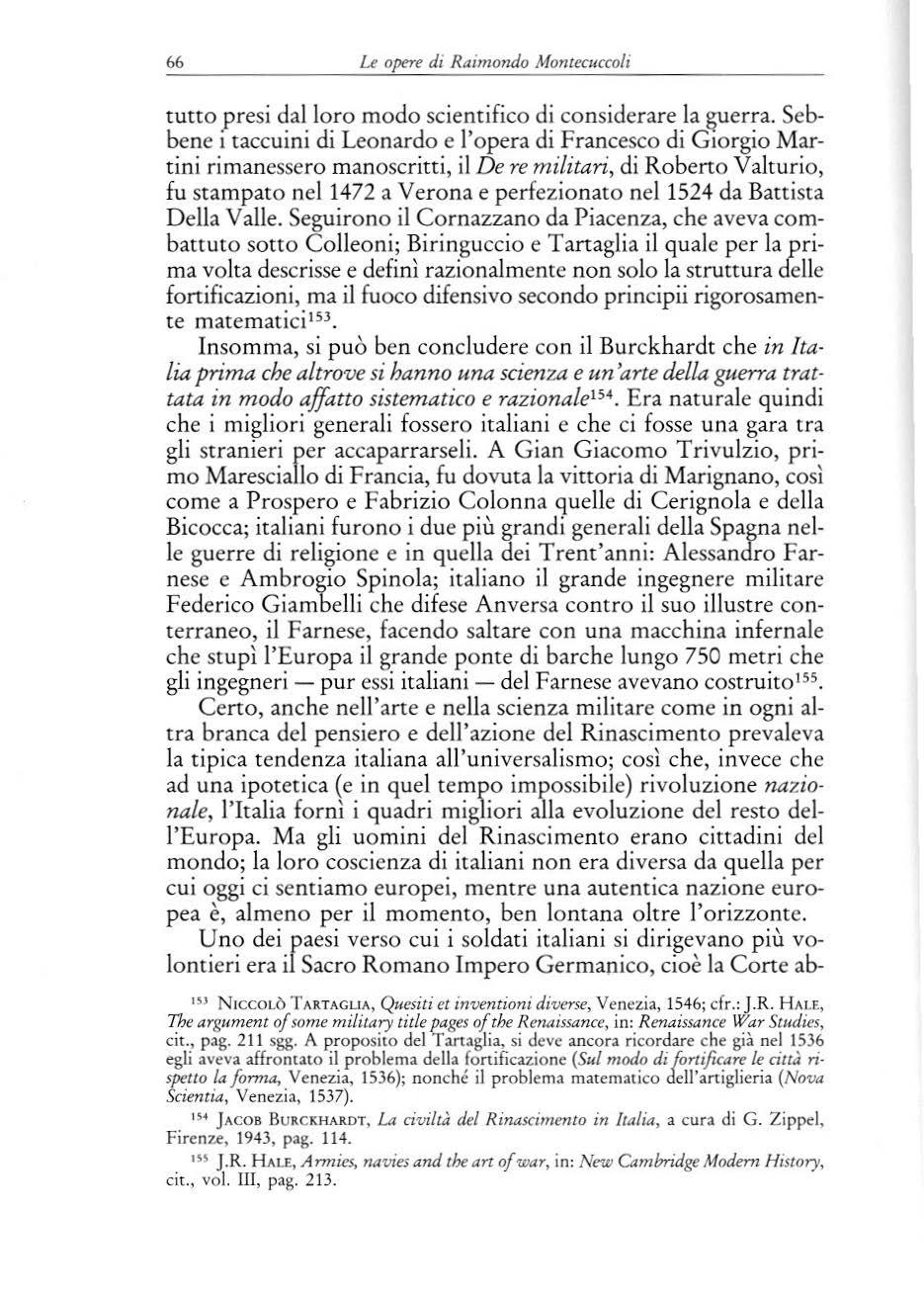
sburgica di Vienna. A parte la vicinanza geografica, dominava a Vienna un cosmopolitismo in cui gli italiani si sentivano a proprio agio , nonché un cattolicesimo che conciliava la fedeltà religiosa co n quella libertà di pensi ero nei confronti delle istituzioni chiesastiche di cui a ragione gli Absburgo andarono sempre fieri. Da Rambaldo di Collalto a Matteo Galasso, da Ernesto Montecuccoli a Rodolfo Giovanni Marazzino, a Ottav io Piccolomini ed a decine di altri, gli italiani formavano una parte sostanziale dell'élite militare absburgica. La lingua italiana (che era in quel periodo la Lingua franca della cultura europ ea) era correntemente parlata a Vienna ed era un idioma di servizio nelle forze armate imperiali 156 • Fu quindi in un ambiente già saturo della tradizion e militar e italiana che il giovane Raimondo Mont ecuccoli e ntrò, quand o si arruolò n ell e forz e armat e d ell'Impero. Questa tradi z ione eracoerentemente con lo spirito della cultura rinascimentale - composta da due poli mirabilmente equilibrati: pensiero e azione; dottrina e professionismo militare fusi in maniera armonica in quel razionalismo che rifuggiva dal praticismo arruffone e artigianesco e tendeva ad elevare ogni valore teorico-pratico al livello dell'arte e della scienza . Dietro tutto ciò vi era lo spirito del razionalismo pratico del Rinascimento, il principio dell'ordine uni_versale che ispirava il tentativo supremo di applicare una controllabilità logica al fenomeno proteiforme della guerra. Logica e matematica. La tradizion e retorica che fin ì più tardi per gravare sulla cultura italiana fece dimenticar e quanto importanti fossero state le scien z e matemati c he p e r l'Uman esimo. L' esist e nza di un U man es i mo matematic o accanto a quello letterario è un fatto non ben noto , ma del tutto reale: non per cas o il culmine della cultura rinascimentale si ebbe in Galilei; grandi matematici erano stati tutti i costruttori ed i t eorici d ell'arch it e ttura militare, da Leon Battista Alberti a Giuliano da Sangallo a Francesco di Giorgio Martini a Luca' Paciotto; Girolamo C atan eo e ra con v into ch e la sci e nza matematica ste sse alla bas e di quella milit are; v i erano bastoni di comandante costruiti come macchine calcolatrici che indica v ano il numero degli uomini i quali pot e vano entrare in un determinato spazi o ; s i mat e matizzav a la scienza d ei r ifornimenti. Si è già detto, poi, di Biringuccio e di Tartaglia 15 7
156 OSK, Wi en , B/ 61 , N r. 16, D ie ltaliener in Osterreich. Eine volkspsychologische Stud vo n O b er st G vo n Hu b ke, hg 19 44; no n ch é: RAI MONDO LuRAGHJ, ltalia ns in H ab· sbourg A rmcd Forces i n: War and Society in East Centrai Europe, vo i. IV, New Yo r k, 198 4, p ag. 21 9 sgg
157 J.R. H ALE, Armies, navies , cit., in : New Cambridge Modem H istory, ci t., vo i. IIl, pag . 220. Gi ro la mo C atan eo , da N ovar a, fu u n o de i più ill ustr i ingegneri militar i nel

L'ufficialità colta era andata sempre più diffondendosi; ma Montecuccoli era, anche tra questa, ai primi posti. La sua disciplina di studio, la profondità della sua mente ne avevano fatto qualcosa di più che non l'erede del pensiero e della pratica militare italiana: per lui l'art e e la scienza militare erano momenti di qualcosa di più vasto, di univ ersale; essi trovavano il loro alimento in una cultura pressoché enciclopedica e straordinariamente profonda. Perché il tentativo supremo di elevare il fenomeno della guerra a scienza razionale fu compiuto da Montecuccoli inserendolo in un quadro infinitamente più vasto, in una visione scie ntifica e filosofica del mondo: non sarebbe quindi possibile tentar di comprenderlo a fondo se nza cercare di capire quanto abbia influito su di lui l'eredità d e lla cultura e della scienza del Rinas cimento nella sua più vasta e universale accezion e.
Già nel momento in cu i (come s i è avuto occasione di dire) il Gi morri definiva Montecuccoli tardo epigono dei grandi Urna· nisti 158 , egli osservava anche acutamente c he è impossibile giudicare il grande capitano modenese senza conoscerne le ide e filosofiche poiché il mondo spiritual e era supremamente importante per lui 159 ; e l' Andreoli, Presidente d ella Sez ion e Storica nel1' Accademia delle Sc ienze di Modena, ebbe più tardi ad o sservare che il m etodo da Montecuccoli applicato era quello spe rimentale della scie nza moderna; il metodo per intenderci di Bacone, Galileo, Newton, Malpighi 16°
Il collegamento profondo tra quella ch e egli definì l'Età Barocca e la grande estate del Rinas ci mento fu acutamente visto e messo in risalto a suo tempo dal Croce, c he sotto lin eò la permanente campo d ell a fortific azion e, a utore di un a mezza dozzin a di trattati sul soggetto, di c ui il piu fam oso è probabilmente Opera nuo11a di fortifu:are, offendere et difendere, Brescia, 1564. A conclusione di qu esta disc ussion e, si pu ò r icordare che l' autorevol e QuENTIN H ucHES, Military Architecture, Londra, 1974, attribui sce definiti vamente l'inve nzi one d el bastione moderno agli i ngegneri italiani (op. cit., pag 77).
158 Cfr. più ind ietro, n. 8.
1s9 A . G IMORIU, o p. cit., pag. lxxx.
160 ln: .Atti del Convegno di St udi su Raimondo MonteCt{ccoli, cit. , pag. 20
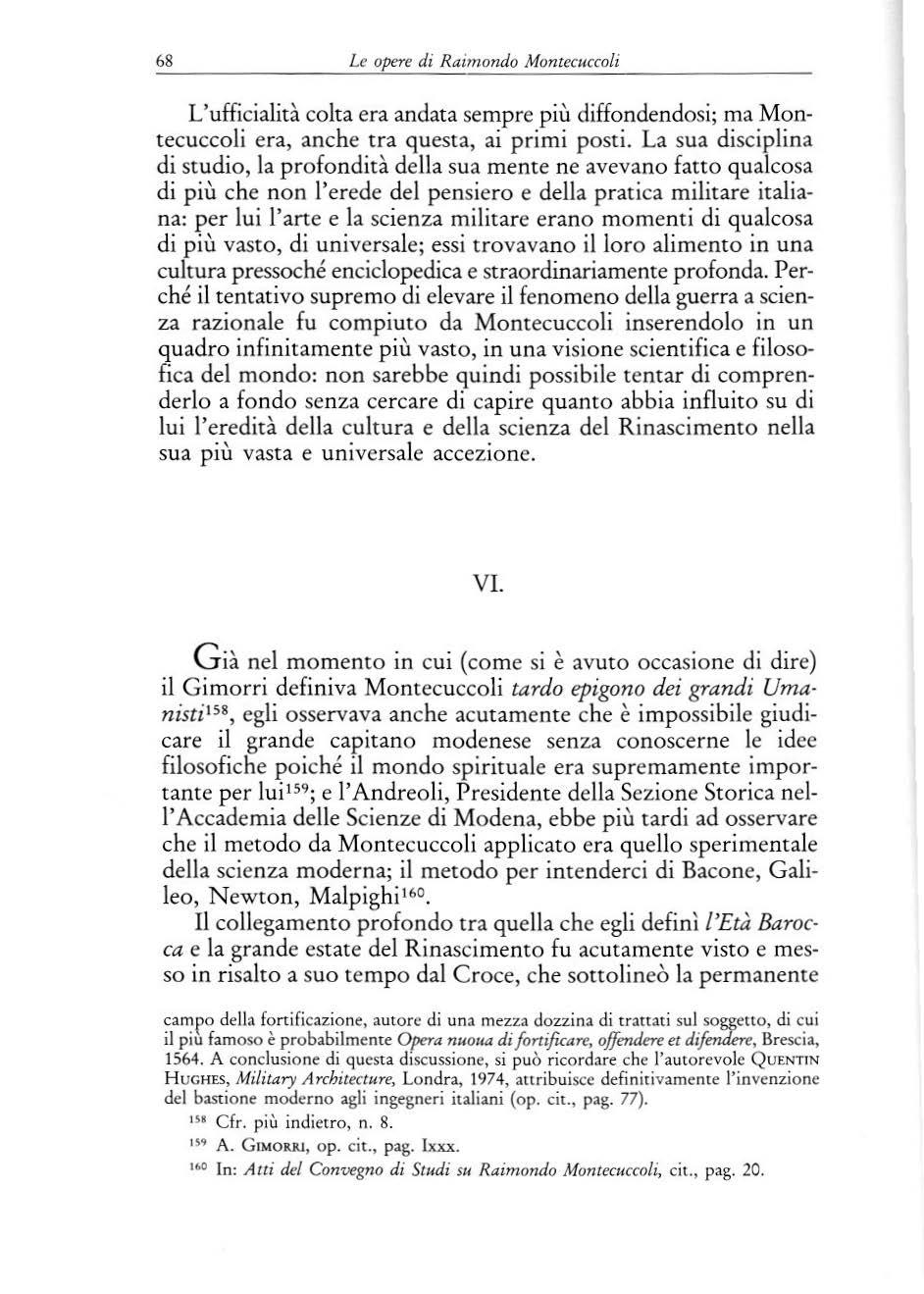
atmosfera umanistica della Controriforma (essa « •..serbò anche gran parte della cultura del Rinascimento, alla qual e la Riforma era stata matrigna, e la buona letteratura e il b ello stile amati dagli umanisti, e l'erudizione filologica e il culto delle arti figurative e architettoniche»)161 e sottolineò che se piccola fu allora la parte recitata dall'Italia sulla sc ena del mondo, grande fu quella che toccò alle sue persona lità 162 • Insomma, un quadro non già di tramonto del Rinascimento ma, al più, di estate indiana: una splendida estate indiana.
Montecuccoli quindi, come ben appare da tutti i suoi scritti, non sentì alcuna soluzione di cont inuità con la cultura del Rinascimento e con la concezione basilare di questa per cui l'uomo - artista, scienziato, soldato, politico, scrittore - era anzitutto uomo integrale: ossia immergeva dialetticamente la propria specifica arte nell'atmosfera universalizzante di una concezione filosofica. Ma se le cose stanno così, e se questo assunto è esatto , a quali pensatori ed a quali orientamenti si richiamava egli specificatamente?
Thomas Barker, con una perspicacia che gli va riconosciuta, fu il primo a indivi duare in lui due filoni: anzitutto, sul piano metodologico e conoscitivo, la capacità - tipicam ente galileianadi calare i prodotti dell'osservazione e dell'esperienza in un cristallino razionalismo; in secondo luogo - e questa vo lta su l piano etico - una ragionata fiducia nel rapporto (anche questo dialettico) tra virtù e fortuna. E ciò lo riallacciava ad un altro scr itto re: il Ma chiave lli 16 2 bi'.
Vi è un terzo pensator e tuttavia che influenzò il Montecuccoli probabilmente più di qualsiasi altro, e il cui insegnamento pervase le sue concezioni e la sua vita in ogni campo: gnoseologico, etico, met o dologico , fisico e metafisico: Tommaso Campanella. Ma di lui, più oltre: il suo influsso su Montecuccoli fu invero tale da richiedere un discorso a parte. Si cercherà poi alla fine di riprendere tutti questi filoni in un insieme organico in modo, o così si spera, da mettere a fuoco la vera essenza del Nostro, in cui la grande eredità della scienza del Rinascim ento brilla ancora di una luce immortale.
Dal Galilei Montecuccoli prese anzitutto il metodo: esso è riscontrabile in tutte le sue opere, permea di sé il suo modo stesso
16 1 B CROCE, Storia dell 'Età Barocca , cit., pag. 15.
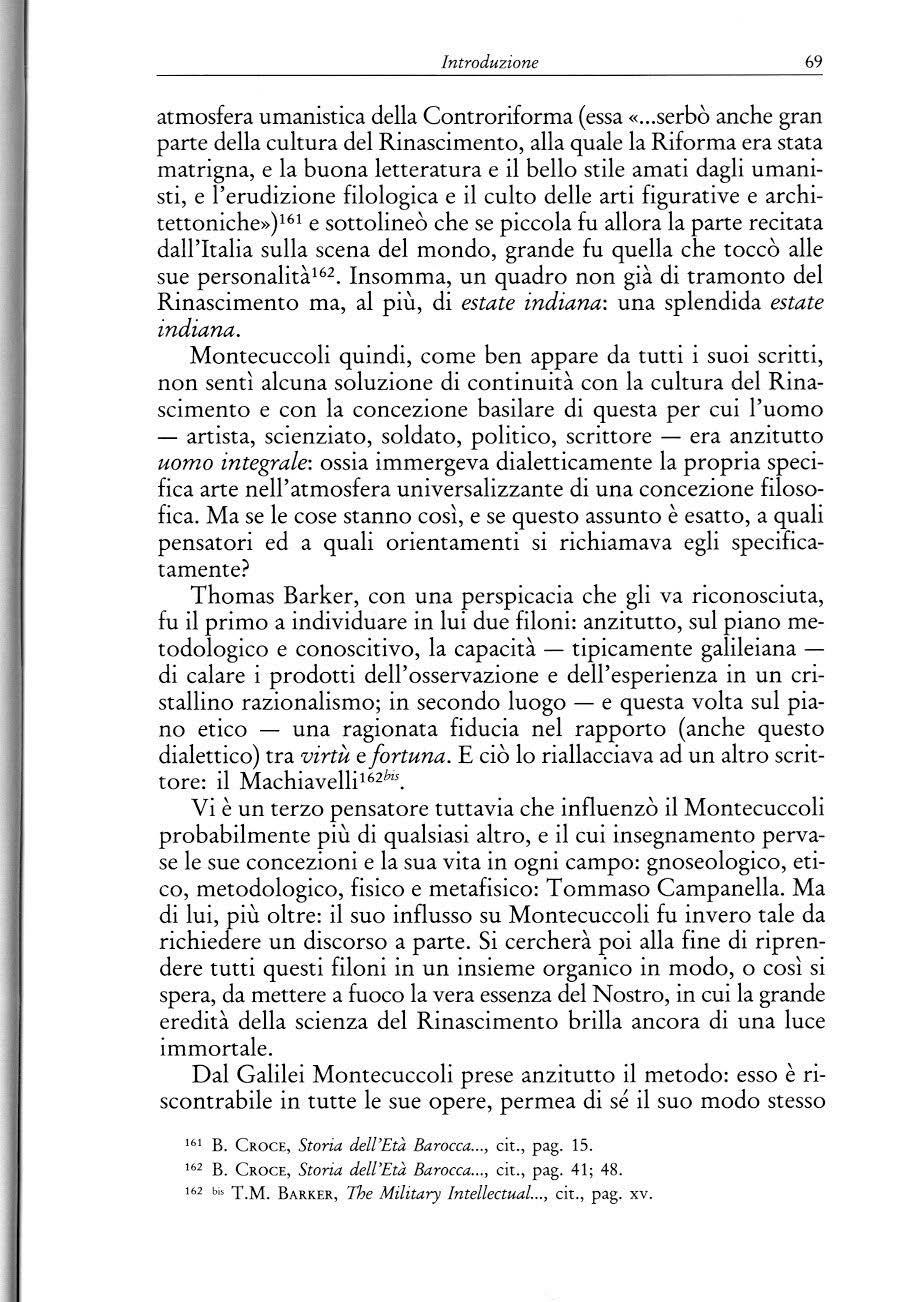
16 2 B. CROCE, Storia dell'Età Barocca... , cit., pag. 41; 48.
16 2 bi, T.M. BARKER, 7he Military lntellectual..., cit., pag. xv.
di ragionare scientificamente. L'empirismo infatti, sebbene Montecuccoli avesse dedicato gran parte del propri o temp o a studiare il pensiero e le opere di Bacone 163, si elevò rapidamente in lui a metodo sperimentale. Nulla rimase in Montecuccoli della tendenza baconiana a logicizzare l'empiria ché, anzi, la sua mentalità profondamente matematica non tardò ad orientarsi verso il metodo galileiano della misurazione del fenomeno e della ri soluzione e sistematizzazione dei dati dell'esperienza in proposizioni un iversali di tipo logico-matematico in cui il metodo analitico e quello sintetico si integrano 1 6 4 • Galilei stesso, nell'introduzione ai Discorsi e dimostrazioni matematiche intorno a due nuove scienze, si era espresso co n parole che devono aver trovato un'eco profonda nell'anima di Montecucc oli: «Largo campo di filosofare agli intelletti speculat ivi parmi che porga la frequente prati ca del famoso arsenale di voi, sisnori Ve nezia ni, ed in particolare in quella parte che m eccanica s1 domanda; attesoc h é q u ivi ogni sorta di strumento e di macchina vien continuamente posta in oper a da nu mero grande di artefici... »; e l'interlocutore, Sagredo, rispondeva ponendo in rili ev o la sua dimestichezza con gli operai specializzati, o maestri, «.. .la conferenza dei quali mi ha più vqlte aiutato nell'investigazione della ragione di effe tt i non so lo mer av igliosi, ma reconditi ancora e qua si inopinab ili »165 •
L'uso de lla matematica come strumento log ico e met odolog ico rimase per l ' int era sua vita una seconda natura in Montecuccoli: ma ciò, si può rite n ere, ci conduce a qu alcos a di precedente il Galilei (ed a cui, in fondo, il Galilei stesso, e così pure Copernico, si r ifann o): il platonismo del Rinascimento. Fu infatti la fisica moderna ad attuare il decisivo passaggio dal concetto di sostanza a quello di funzione: come Plat one, K eplero arriverà a sc oprir e l'armonia dell'anima so lo attraverso l'armonia del cosmo 166 • Siamo qui, da

163 OSK, Vienna, Nach lass Momecucco li, Zibaldone, ove sono dedicat e oltre venti pag. (f. 707 sgg.) all'analis i del pens iero di Sir Francis Bacon.
164 Cfr.: LEONAllD 0LSCHXI, Galilei zmd seine Zeit, Hall e 1927; ALEXANDRE KoYRf. Etudes galiléennes, P arigi, 1939, 3 vo lumi: nonché l' agile volume di Luoov1co GEYMO· NAT, Galileo Galilei, Torino, 1957; gli aspett i più s pecificam e nte fil osofic i del pensiero galileiano sono anali zzati in: HARALD H6Fl'DING, Storia della Filosofia Moderna , Milano , 1944 , 2 volumi, voi. I, pag. 135 sgg Di proposito mi so no servi to della ecce llent e traduzion e italiana dovuta al compia nto Piero Martin etti.
16s Per le ope re di Ga li lei mi sono servito dell' edizione nazionale, a c ura di Antonio Fava.re, Firenze, 1890 sgg., 20 volumi (di c ui un o di indici}.
166 ERN ST CASSIRER, Das Erkenntnisproblem in der Philosophie und Wissenschaft der neueren Zeit, Berli no , 1906 sgg., 4 vo lu mi (trad it.: Storia della filosofia moderna , Torino, 1954 sgg., 4 volumi); voi. I pag. 104 sgg.
un lato, alla concezione del valore conosciti v o-m etodologico della matematica che, come diceva Platone, ha la funzion e di trar l 'anima da ciò che diviene a ciò che è; dall'altro alla tesi platonica per cui, poi , le leggi fisico-matematiche , come il Demiurgo, sono sussume e dominate dalla ragione universale che tutto abbraccia; e la storia consiste nella ragione umana unitaria che si sviluppa e si evolve. Siamo, cioè a Machiavelli, e attraverso lui a Polibio, a Livio, allo Stoicismo ed a tutto il pensiero del Mondo antico. Machiavelli è il secondo pilastro d elle concezioni di Mont ecuccoli. In lui egli vide non solo il fondatore della scienza politica moderna ma - giustamente - il primo teorico militare della nu ova era; ed anche di più. L'analisi delle opere di Montecuccoli mostra chiaramente come due cose influirono sostanzialmente su di lui: il concetto, anzitutto, che il capo militare - così come ciascun individuo - si muove costantemente tra virtù e fortuna, come si è detto: che cioè, lungi dal servo arbitrio di marca luterana, la sua v irtù (non, si badi, la sua volontà, ma qualcosa che la include e la trasc ende) può fino ad un certo punto evitare i guasti d ella fortuna soprattutto con un aspetto della virtù che Montecu ccoli pr iv ilegiò sempr e : la preveggenza.
Ma vi erano molti altri insegnamenti che egli poteva trarre dal Machiav elli. E non tanto, paradossalmente, dal dialogo D ell'arte della guerra, ove molt e ide e , d ettat e d a esig enz e del mom ento , sono caduche; ma da quel vero tesor o del pens iero machiav elliano che sono i Discorsi sopra la prim a de ca di Tito Livio16 7 • Nei Discorsi Montecuccoli poté trovare il principio della immutabilità dell'arte della guerra anche dopo l'avvento delle artiglierie 168; il concetto di una cavalleria moderna, cui siano riservati esplorazione, incursione e inseguim ento 169 ; la precisa definizion e del rapporto tra guerra e politica 1 70 ; persino l'insistenza sulla fluidità delle risposte, cioè - con quattro secol i di anticipo - sul concetto di risposta flessibile 171 ove si sottolinea (insegnamento prezioso) che, non volendo a nessun costo venire a battaglia indipendentemente dalle condizioni, si finisce .per farlo alle condizioni del nemico.

167 P er le o pere di Mach iavell i m i sono se r vito dell a ed iz io n e d i tutt i gli scri tti stor ic i e letterar i a c ur a di Gui do M azzoni e Mar io C asella, F ire nze, 1929
16 8 Discorsi, xv u, in: Opere, cit ., p ag . 162 sgg.
169 Opere, pag. 166 sg.
170 Opere, pag. 169 sg., 175.
17 1 Opere, pag. 2 14 sg., 2 16 sg .
Nei Discorsi Montecuccoli poté trovare ancora altre aut ent ic he co nvinzi oni del Machiave lli: gran de imp o rtanza del buon capo militare; sup erio rità de~li eserciti regolari su ll e moltitudini popo/,ari 172 ; l'i nsist enza sull'unita di comando; il principio della concentrazione; l'ass erz ione che l a difesa è la forma più forte di gu erra , se seguita dal contrattacco (c h e e ra stato, sia de tto incidentalmente, il succo de ll'esperienza militare del Quattrocento italian o) 173 • Fino ad un principio che Mont ec uccoli farà proprio, e che Machiavelli es pone, qu es ta volta, n e l Dell'arte della guerra: la dife sa è indispensabile; per p o t er difend ere i propri sud diti occorre amare /,a pace e saper fare /,a guerra . Se si h a nno intorno o troppi amatori di pace o troppi amatori del/,a guerra si sbaglie rà 174 • Mont ecuccoli l 'avre bb e ricordato durant e l'int e ra sua vita.
Ma è tempo di ve nire al pensatore c h e più di qualunque altro influenzò il Nostro n e lla seconda fase d e lla sua esistenza e d a cui tant i profondi studi e gli dedi cò: Tommaso Campanella 175 •
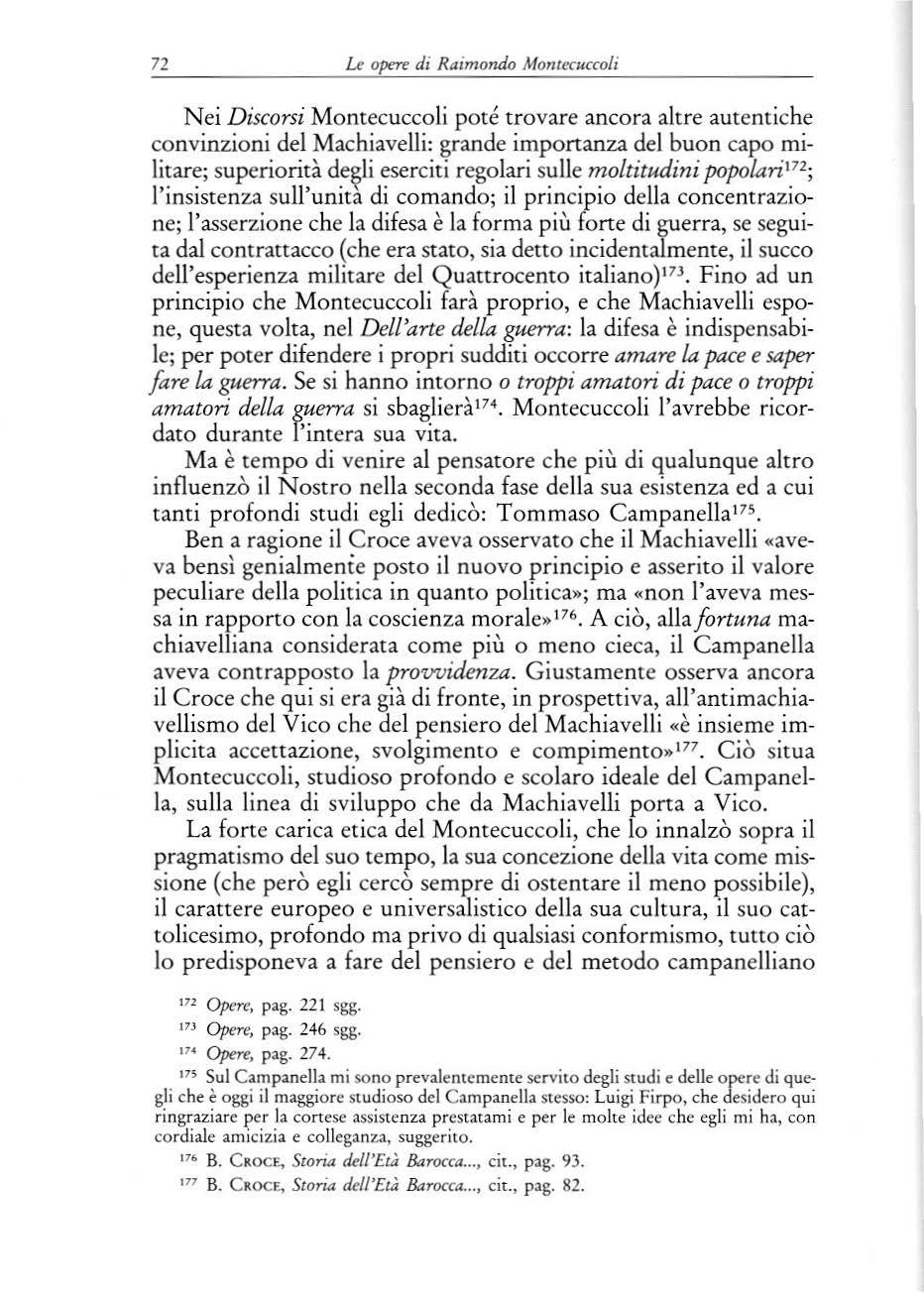
Ben a ragione il Croce aveva osservato che il Ma c hiave lli «aveva bensì genialmen te posto il nuovo principio e asse rito il va lore peculiare d e lla politi ca in quanto politi ca»; ma «non l'aveva messa in rapporto con la coscienza morale »176 • A ciò, alla fortun a mac hiavelliana considerata come più o meno ci eca, il Camp a nella aveva contrapposto l a pro vvidenza . Giustamente o sserva anco ra il Croce che qui si era già di fr o nte, in prospettiva, all'antimachiave llismo del Vic o c h e del p ens ie ro del Machiavelli «è insiem e imp li cita accettazione, svo lgim e nto e com pimento» 177 Ci ò s itua Montecuccoli, studioso profondo e scolaro ideal e del Campanella, sulla lin e a di sviluppo che da Mac hiavelli porta a Vico.
La forte car i ca e ti ca del Montecuccoli, c h e lo innalzò sopra il pragmatismo del suo tempo, l a sua concezio n e della vita come missio ne (che però eg li cercò sempre di ostentare il meno possi bile) , il carattere europeo e unive r sa listico de lla sua cultura, il s uo catt o li cesimo, profondo ma priv o di qualsi as i conformis mo, tutt o ciò lo pre di sp o n eva a fare del pensiero e d e l metod o ca mpan e lli a no
172 Opere, pag . 221 sgg.
173 Opere, pag. 246 sgg.
174 Opere, pag. 274.
i
7 s Sul Campanella mi sono prevalentemente servito degli studi e delle opere di que· gli che è oggi il maggiore studios o d el Cam panella stesso: Lui gi Firpo , ch e desidero qui r ingraz iare per la co rt ese assis te nza pr es tatami e per le molte id ee che egli mi h a, co n co rdiale am icizia e coll ega nza, suggerito.
176 B. CROCE, Swria dell'Età Barocca... , cic ., pag. 93.
177 B. CROCE, Storia dell'Età Barocca... , cit., pag. 82.
il tramite ideale attraverso cui avrebbe assorbito e rielaborato le linfe del Rinascimento e della cultura classica.
Allo studio del Campanella Montecuccoli dedicò anni. Il manosc ritto in cui sono concentrate le sue meditazioni scientifico-fùosofiche attraverso l'esegesi delle fonti del suo pensiero, lo Zibaldone, dedica al Campanella ben 353 pagine. Si parte dalla filosofia universale o metafisica per dedicare la più gran parte del tempo e dell'attenzione alla grammatica (ove è dato rintracciare la fonte della struttura logica dei futuri Aforismi), alla logica, retorica e poetica del Maestro178 •
Per meglio comprendere fino a qual punto la struttura logica del pensiero di Campanella abbia influito su Monte cucco li, occorre ricordare che, dopo la p erdita del manoscritto De universitate rerum (una imponente opera che doveva abbracciare tutto intero lo scibile), sequestratogli a Bologna nel 1592 dall'Inquisizione 179 , il filosofo calabrese, che si era sentito mancar le forze per ricominciare da capo, per lo meno nella forma discorsiva di quel1' opera perduta, aveva deciso di riprendere l'immenso patrimonio colà incluso in una forma nuova, apodittica, la quale concentrasse in proporzioni nitide, definite, l'essenza di una vita di pensiero. Il testo sarebbe stato aforistico, con l' esposizione dell'opinione sua; le dispute sarebbero state aggregate. Per Montecuccoli questa era la forma infine trovata per dare espressione ideale all'immenso patrimonio di meditazioni che egli era andato accumulando; la forma in cui egli scriverà i suoi Aforismi. Perché uno dei grandi problemi che il Nostro aveva cercato per anni di risolvere era questo : una strut-

178 ÒSK, Vienna, Nachlass Momecuccoli, Zibaldone, cit Va anche osservato che nello Zihaldone il Montecuccoli elenca, tra le opere della biblioteca personale su cui aveva fondato la propria preparazione e che si portava in genere seco, ben 18 titoli di opere del Campanella, raggruppati in 11 volumi, e cioè: la Monarchia Hispanù:a, Amsterdam, 1640 (o edizio ne elzevirana nello stesso anno); la Metafisica, Parigi, 1638; il De niedù:inalibus libri septem, Luguduni, 1635; la Apologia pro Galileo, Francoforte, 1623; il Prodromus philosophiae inst.aurantlae, ibidem, 1617; le tre opere Atheismus triumphatus, De Gentilismo non retineru:w e De Praedestinatione, electione, reproba1ione Traaatus, Parigi, 1636; in.fine i tre maggiori tomi: Philosophia rationalis, Parigi, 1638; Philosophia realis, Parigi, 1637 e Astrologicorum libri, pubblicato probabilmente a Lione nel 1629 o 1630 o a Francoforte nello stesso anno . È inutile dire che lo Zibaldone non reca le date e i luoghi di edizione: la ricostruzion e delle varie edizioni carnpanelliane è stata fatta con l'ai uto dell'amico e collega Luigi Firpo, di cui si sono anche costantemente tenuti presenti gli studi bibliografici (cfr : Luigi Firpo, Bib/,iografia degli scntti di Campanella, Torino, 1940).
179 Lu1G1 F!RPO, Rù:erd.Je Campane/liane, Firenze, 1947, pag. 56; inoltre comunicaz. di Luigi Firpo al curatore.
tura adeguata per conferire permanenza e solidità alla espos izione scientifica che gli avesse consentito di concentrare un immenso patrimonio in uno spazio ragionevole, relegando in appendice o in nota i testi di appoggio.
Ad essa era giunto mediante un lungo cammin o . Il primo, completo elenco delle fonti del suo pensiero, posto all 'inizio del Trattato della guerra 18 0 , non cita ancora, del Campanella, che la Monarchia di Spagna, mentre l'influsso del Machiavelli su Montecuccoli appare pervasivo e dominante 181 • Come si dirà, il Trattato (così come forse il Delle battaglie) era stato scritto durante la lunga prigio nia a $tettino: apparteneva cioè alla prima fase del pensiero di Montecuccoli.

Lo Zibaldone (ove, come si è detto, il pensiero del Campanella occupa ormai un posto centrale) è invece opera della maturità, così come lo saranno gli Aforismi.
Tommaso Campanella apportò certamente a Montecuccoli una serie di elementi e di atteggiamenti nuovi. Anzitutto una maggiore, più spiccata insistenza sull'empiria come fonte della conoscenza nonché, verosimilmente, un più profondo interesse per la natura. Non fu per caso che nella seconda fase della sua vita il Nostro mostrò una sempre maggior proclività agli studi di botanica (e vi condusse, nel suo castello di Hohenegg, una serie di esp erimenti), medicina, chimica. Campanella tuttavia gli insegnò anche a fondare la conoscenza non su un ammasso di dati, ma sull'attività discriminante del senso interno il quale deve impedire la commistione fra coscienza ed esperienza, lasciando la prima giudice finale , formatrice del contenuto gnoseologico. G li insegnamenti del filosofo di Stilo, poi (come si è già avuto occasione di osservare), condussero Montec u ccoli sul piano etico a sostituire sempre più la provvidenza (di cui sono almeno in parte individuabili i disegni) alla cieca fortuna . Fu un processo veramente mirabile, che contribuì fortemente a sviluppare in lu i quelle due tendenze che possiamo ben ravvisare e che ancor oggi ci riempiono di stupore e di ammirazione: l'accettazione serena della condizione umana, insieme ad una energia indomabile che lo guidò a non prendere mai, assolutamente mai in considerazione (sia su l piano della vita che su quello militare) la prospettiva della resa.
La meditazione sul pensiero di Campanella fu così per lui una continua scuola. Lo educò alla modestia; gli aperse davanti la
straordinaria prosp e ttiva di un organismo statale ch e - autentica città ideale - si estendesse alle genti più diverse, ov e funzioni, arti, lavori fossero ripartiti in maniera razionale. Da ciò indubbiamente la fedeltà di Montecuccoli all'ideale transnazionale degli Absburgo ricevette nuova linfa, nuove aperture : la filosofia della mitica Città del Sole poteva ben essere quella di un impero che , avvia ndosi al meriggio de ll a sua evoluzio ne , dovesse, come Roma da Augusto in poi , armonizzare e guidare genti diverse in un organismo pacificatore e cosmopolita, ordinatore e paternalista, garante di pace, di giustizia e di saggio governo 18 2 • Ma questo fu talmente importante nel pensiero politico e strategico-globale di Montecuccoli, che vi si ritornerà più oltre.
Ma Montecuccoli non consentÌ mai che la dottrina campane lliana lo portasse in qualche modo a slittare nell'utopia. Perché non certo minore fu l'influsso su di lui dei grandi teorici della ragion di Stato, da Luigi Paruta a Giovan Battista Bote ro , a Scipione Ammirato, a Traiano Boccalini, mentre egli coltivò anche costantemente il diritto (e la filosofia del diritto, ove scrisse un saggio De iure naturali) 183 •

Non vi fu comunque disarmonia tra i vari fi lo ni che nutrirono il suo pensiero: forse il cemento fu dato da una certa qual spiritualità razionalista, di lontana origine averroistico-umanista, sopravvissuta malgrado la Controriforma, che influì su di lui 18 4 .
Se tuttavia non dimentichiamo ch e Raimondo Mont ecuccoli fu e ri mase per l'intera sua vita un professionista d ell e armi e d ella scienza militare, il quesito conclusivo che dobbiamo porci è: come influì il suo vasto e profondo retroterra filosofico sul suo contributo essenziale alla storia ed alla cultura del mondo?
Una cosa è indubbia: Montecuccoli divise con la grande ondata umanistica e tardo-rinascimentale cui, come si è visto, appartenne, la fede nella razionalità dell e conoscen z e umane e nella p e rfe tta conoscibilità d el mondo d ella scienza, sol che il metodo usato fosse quello cor r etto: quindi l'aspira z ione a rifuggire dal vago e dall'approssimato per giungere attraverso l'induzione, riorganizzando razionalmente il materiale raccolto, ad una serie di proposizioni di valore universale. Quindi la sua aspirazione su -
18 2 Su t u t to il p e nsiero d i Cam panella si ve d a la n . 178 . Alc une d i q ueste osservaz ioni, poi , prove n gono da una ser ie di co n versazioni t ra me e L. Fir po.
18 3 OSK , V ie nna, Nac h lass M o nt ec u cco li.
18 4 Sebbe n e Moncecucco li fosse (e r i ma n esse se mpre) u n crede nte t a nt o devo t o d a c hi ed ere all'In q uis izione la dispe n sa p er la lett ura d i li b ri post i all 'Ind ice Cfr.: H. KA VF· MA NN , O P. CIT. , l'AG . 35·
prema fu (ce lo dice egli st esso nel Trattato della guerra) di costruire la dottrina militare come scienza; o meglio (dato che molte cose del s uo tempo, egli lo sentiva, sarebbero state caduche) di fondare i principi i metodologici universalmente val idi della scienza militare. Instauratio magna se mai altra vi fu. Vi riuscì? Il Croc e (pur a mmirandol o) ne dubita 185 • Non va tuttavia dimenticato lo sfo rzo immenso fatto dal Monte cuccoli per matematizz are la guerra . Ma di c iò, più oltre. Qui ci s i limit erà a riservare il giudizio al . ' momento 10 cm sara esammato m mam era maggiormente mmuziosa il pensiero militare del Nostro. Ci si limite r à anche ad osservare che eg li - partendo da Campanella e pre ceden do Vicoera convinto che quanto l'uomo fa può essere oggett o di conosce nza certa; e che ne ll 'opera della sua maturità , gl i Aforismi, inserirà n on solo il ricorso all 'esperienza passata, ma a quella futura, spi ngendo si così, con passi da gigante, oltre la metodologia dello stess o suo seco lo.
VII.
E saminati in tal modo per so mmi cap i gli elementi che sono alla base del pensiero (e dell'a zione) di Montecuccoli non c h é la sua carriera di uomo di guerra e di stato, ci soffermeremo brevemente sulla sua attività di scrittore militare qual e pre me ssa ad un esa me del contenuto della sua dottrina e ad un bilancio della sua figura di so ldato e di pensatore .
P er quanto riguarda gli scritti militari del grande capitano (ci s i tratterrà poi brevemente su quelli letterari), si posso no prende r le mosse dalla rico struzio ne crono logi ca ipotizzata dal Pieri 186 , ali~ q~ale tut~avia occo~rerà apportare alcune indi spensabili correz1om e agg10rnament1.
Il P ier i dunque distinse, nella carriera de l Montecuccoli sc rittore, tre momenti: la prigionia nel castello di $tettino, 1639-1642; gli anni di relativa pace succ ess ivi alla Guerra dei Trent'anni,
185 B CROCE, Storia dell'Età Baro cca , ci t., pag. 156, ove si argo menta ch e le sc ienze morali non possono, senza perdere il carattere loro, dìvencare fisic he ed essere oggetto dì calcolo.
186 P. PlERI, li secolo XVII. Raimondo Montecuccoli, in: Guerra e politica. , cit., pag. 72 sgg.

1648-1652 (verosimilmente, si può aggiungere, a Hohenegg); infine (e nuovamente a Hohenegg) quelli dopo la grande vittoria di San Gottardo, 1665-1670.
In tali periodi, sostiene il Pieri, sarebbero nate le opere teoriche militari di Montecuccoli: e, in linea di massima, ciò sembra grosso modo esatto anche se occorrerebbe subito retrodatare l'inizio del secondo periodo al 1645 e posticipare il suo termine di un anno, al 1653, o meglio ancora spezzarlo in due sottoperiodi: il primo nel 1645 (la sosta forzata a Hohenegg, in convalescenza di una ferita), il secondo dal 1650, dopo il rientro dalle ambascerie all'estero, sino al 1653. Si tenga inoltre presente che la produzione del Nostro fu assai vasta: il Veltzé enumera 46 scritti di soggetto militare, più altri di cui dà il regesto, e ciò sempre escludendo quelli letterari o relativi ad altre branche del sapere 187 •
Il primo periodo dunque in cui il Nostro cominciò la stesura sistematica dei suoi maggiori trattati militari fu quello della seconda prigionia in mano svedese, trascorsa per la grandissima parte nel caste ll o di Stettino ove egli ebbe a disposizione una vasta e ricca biblioteca. Da quanto egli stesso ci dice 188 , la sua produzione in quel periodo si può dividere in due gruppi: a) nove grossi quaderni, rilegati in cartapecora (e detti, pertanto, pecorine), di soggetto militare vario, come poi si vedrà; b) un vero e proprio volume organico, il Trattato della guerra.
I nov e quaderni sono andati perduti eccetto (forse) il nono, che trattava delle battaglie, nonché una sintesi di quanto era contenuto negli altri otto a pr oposito delle fortificazioni 189
Quanto alla materia, sappiamo dall'Autore che i quaderni dall'uno all'otto trattavano di scienza e tecnica della fortificazione, armi, tiro e maneggio dell'artiglieria, artifizi pirotecnici e macc hine varie nonché di gran parte di ciò che oggi formerebbe il patrimonio specifico dell'Arma del Genio . Il nono, come più sopra si è detto, era destinato alle battaglie.
I quesiti che sino a questo punto non sono stati sciolti sono i seguenti: i nove quaderni costituivano una raccolta di materiale preparatorio per il Trattato della guerra o ne formavano piuttosto
187 A. VELTZÉ, o p. cic., p assi m. Nella s ua collezione i l Ve lt zé divide in m anie ra u n p o' arbit r aria gli scritti m ilitar i di Montecucco li in tre gruppi : a) opere t eo riche mi litar i; b) opere stor iche; e) scritti a ca ratt e re vario.
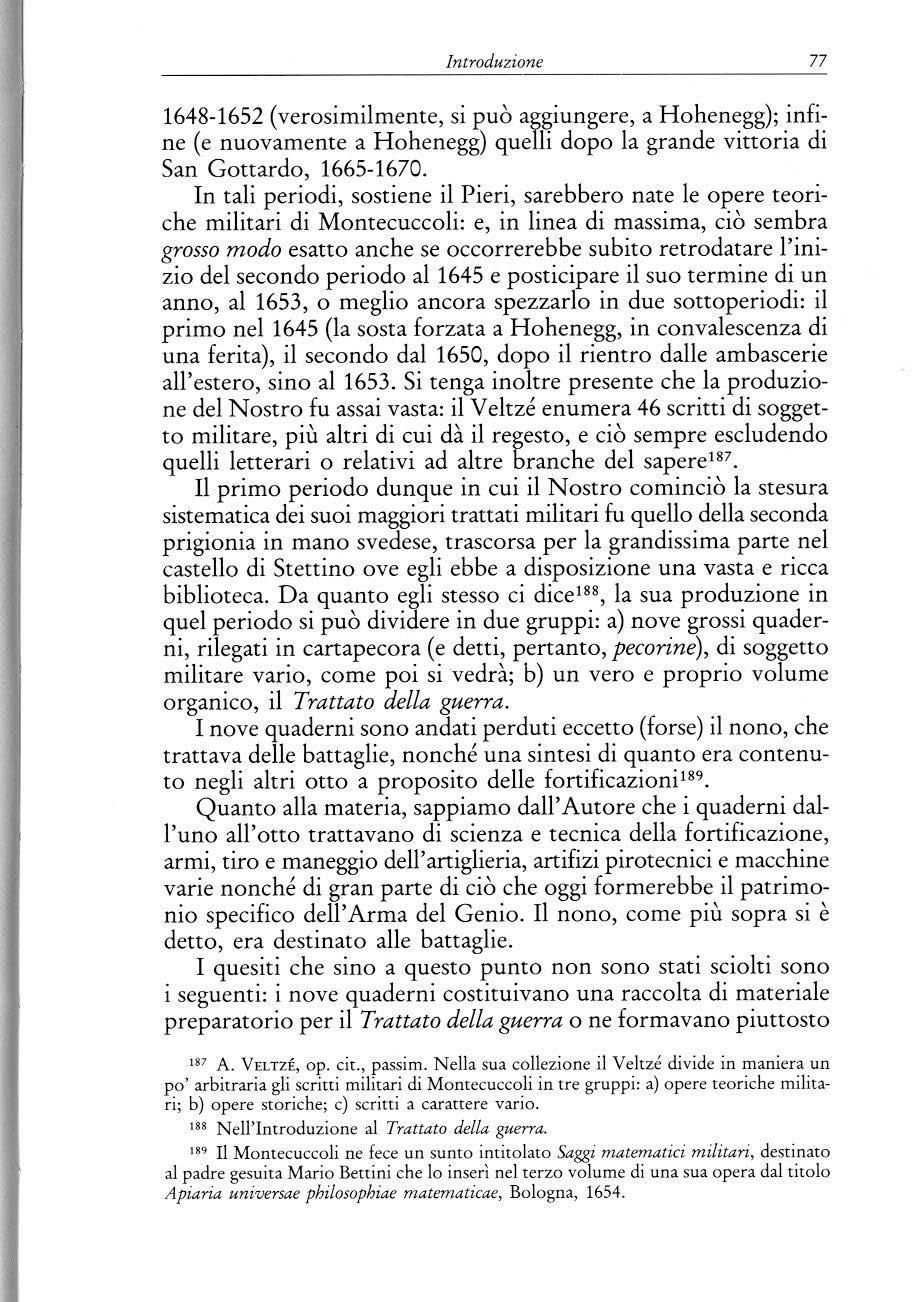
188 Nell'Introduzione al Trattato della guerra.
189 Il Mont ec uccoli n e fece u n sunto int ito lato Saggi matematici militari, d estin at o al padre gesuit a Mario Bett ini che lo inse rì nel terzo vo lu me di u na su a ope ra dal t it olo Apiaria universae philosophiae matematicae, Bol ogn a, 1654.
delle appe ndi ci tecniche? E conseguentemente, il testo che noi oggi possediamo del Delle battaglie, e che è custodito alla Biblioteca Estense di Modena, è o non è quello della nona pecorina? Il Pi eri, appoggiandosi su l fatto che il seco ndo manoscritto del Delle bat· taglie, il quale trovasi al Kriegsarchiv di Vienna, non concorda con il sommario che il Montecuccoli ne dà n e lla introduzion e al Trat· tato della guerra ed è quindi manifestam ente un rifacimento più tardo, rispose affermativamente ad entrambe le domand e 190 • Il P eball invece, cui è dovuto il riordinam ento dell 'i ntera co llezione manoscritta di Montecucco li al Kriegsar c hiv, fece notare che i quaderni appaiono assai più come dei supplementi tecnici al Trattato della guerra che non delle introduzioni; e avanzò dei dubbi sul fatto che, su nove qu adern i , il solo Delle battaglie si fosse salvato, mostrando piuttosto di ritenere che il manoscritto modenesepur fondamentalment e strutturaco come la nona pecorina - ne cost i tuisse però una vers io ne riveduta e forse arricchita 191 •
Do ve stia l a verità, è difficile dire: cert o , dal sunto che il Montecuccoli ne dà e dalla so mmaria descrizione che ne fornisce, i nove quaderni appaiono f iuttosto s uppl ementari che preparatori al Trattato della guerra; i Delle battaglie, quindi, non sarebbe statO scritto prima del Trattato, ma dopo; e la vers i one modenese che ne abbiamo costituirebbe una prima, ampia revisione mentre quella del Kriegsarchiv sarebbe la seconda. P o iché è presumibile che il manoscritto sia stato dal M ontecuccoli offerto a l Du ca di Mod ena in omaggio, insieme al Tra ttato della guerra , la sua stesura non deve esse re troppo tarda, presumibilm en te prece dente la sosta a Hoh enegg del 1645 o ad essa contempo ranea. Nello stesso anno egli attese anche alla prima stesura di un' opera affatto nuova; quell o che possiamo definir e l' Urschrift d elle Tavole militari 192 • Con questi scritti, vere pietre mil iari del pensiero di Montecucco li, termina i l primo periodo. Quando sia iniziato il secondo è diffi c ile dire; nel dic e mbre del 1648, a Praga , egli aveva scritto
190 P . P1 ER1 , Guerra e politica , cit. , pag. 92 sg., n. 1.

19 1 ÒSK, Vi e nn a, Introd. manoscritta di K. Peball alle carte Montecu cco li, pag. 10.
192 L' ipotesi più probabile , se si mantiene l'assunto c he il primo Delle battaglie sia scaco terminat o nel 1645, è che esso sia stato inviato al Duca a seguito del viaggio di Momecuccoli a Modena per assumere il com ando delle forze coalizzate nella guerra di Castro (1642); è addirittura pensabil e che il Mo ntecuccoli abbia ri elaborato e fatt o copiare il nono quaderno proprio in seguito a cale permanenza presso il Duca di Moden a. C iò verrebbe a conforcare l'ipotesi del Peball secondo cui i nove quaderni sarebbero stati scritti dopo il Trattat o; il tono macuro dell' opera, poi, ponerebbc a respingere l'ipotesi del Pi eri che il Delle batta· glie sia sca co scritto addirittura prima dell e alcre otto pecorin.e.
un Discorso sopra le fortezze che si dovriano havere negli stati di S.M Cesarea 193 ; ma fu poi nel sereno ritiro di Hohenegg che la sua attività di studioso e di scrittore ebbe agio di svilupparsi: egli vi scrisse certamente il testo definiti vo, rielaborato e ampliato delle Tavole militari 194 ( ch e il Pieri, seguendo una scelta di titolo per lo meno op inabile del Veltzé, chiama Dell'arte militare); e, sempre secondo il Pieri, anche il rifacimento del Delle battaglie.
Su ciò è necessario soffermarsi, in quanto il Pieri, evidentement e, n o n ebb e campo di esaminare direttam e nte la colle z ion e dell e carte di Montecuccoli a Vienna: e ciò lo condusse all'errata attribuzione dell'ultima opera citata al secondo (o, meglio , terzo) periodo 195. Va anch e sottolineato ch e il manoscritto originale d el trattato che più esattamente conviene indicare con il titolo Dell'arte militare, custodito al Kriegsarchiv, reca chiaramente di pugno di Montecuccoli la data: Salmunster, 29 no v embre 1673, apparti e ne cioè ad un ulteriore periodo: mentre quello cui il Pieri, seguendo il Veltzé, attribui sce tale titolo, è invece il testo ampliato e d efinitivo d ell e Ta v ole mili tari, di cui si è d etto più sopra, scritto nel 1653: e, a nostro avviso, va meglio indi cato con tal e titoJ0 196 .
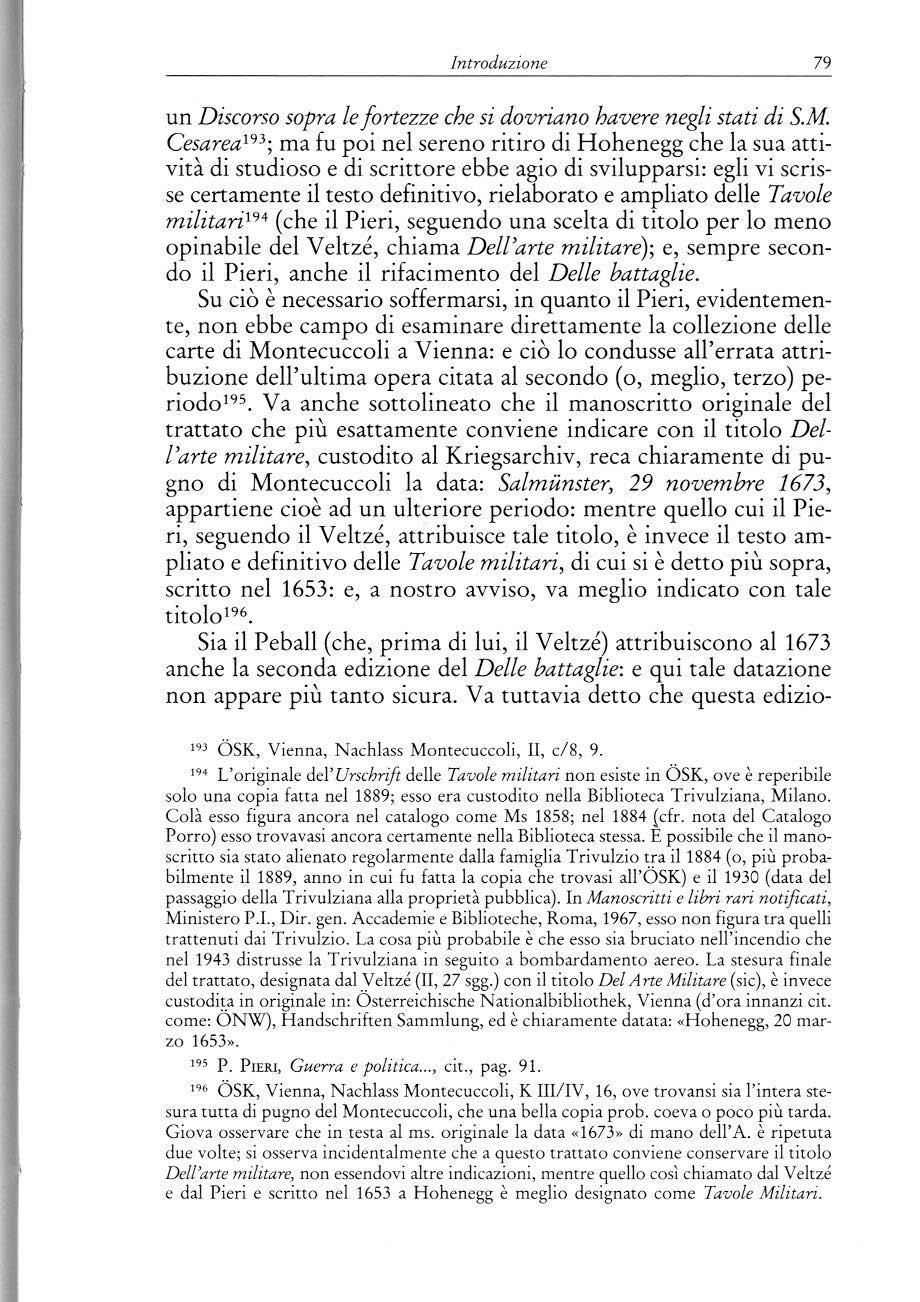
Sia il Peball (che, prima di lui , il Ve ltzé) attribuiscon o al 1673 anche la sec o nda edizione del Delle ba t taglie: e qui tale datazione non appar e più tanto sicura. Va tuttav ia detto che questa edizio-
193 ÒSK, Vienn a, Nach lass Mo nt ecucco li, Il, c/8, 9.
194 L' o ri gi n al e d el' Urs chriji delle Tavole militari n o n esis te i n ÒSK , o ve è repe rib ile so lo una co pia fa t ta ne l 18 8 9 ; esso era cust o dito n ella Bib lioteca T r ivulzi ana, Milano Colà esso fi gura a n cora n el cata logo co m e Ms 18 5 8; nel 1884 {cfr. n ota de l Catal ogo P o r ro) esso t rovavasi an co r a certame nte n ell a Bib liotec a st essa. E p ossib il e che i l m an osc ritto sia sca to ali enato regolarmente dalla fam igli a Triv ulzio ~!a i l 1884 (o, p iù prob ab ilm ente il 1889 , an no in cui fu fa tta la co pi a che tro vas i all 'OSK ) e il 19 30 (data de l passaggio della Trivu lziana alla pro prietà p ub bl ic a) . In Manoscritti e libri rari notificati, M iniste ro P .I., Dir. gen . Accad emi e e Bib lioteche, Ro ma , 1967, esso no n figura tra q uelli trattenut i dai Tr ivu lzio La cosa pi ù pro ba b ile è che esso sia b ruciato nell ' in cendio che ne l 19 4 3 d istrusse la T r ivu lz iana in segu ito a bomb ar d am ento aereo La stes ura finale d el t r attat o , des ig nat a dal .Yeltz é (II, 27 sgg .) co n il t it o lo D el A rte Militare (sic) , è in vece c ustod i~.a in o r iginale in : O ste rreichisch e National bib liot h ek, Vienna (d'o ra in nanzi cit . come: ONW), Handschr ift en Sa mmlun g, ed è ch ia rame nte datata : «H o h enegg, 20 marzo 1653» .
195 P. P1ERI, Guerra e politica ..., cit. , pag . 91.
196 Ò SK , Vien na, Nac h lass M ontec u cco l i, K III/IV, 16, ove t r o van si si a l 'inte r a stesu ra tutta d i pugno de l Moncecucco]i, che u na be lla copi a prob coeva o poco p iù tarda. Gi ov a osserv are ch e in te~'ta al ms o ri gi n al e la data «1 67 3» d i mano d ell' A è ripetu ta d ue vo lt e; s i osse rva inc idental mente che a q uesto trattato conviene conservare il t itolo Dell'arte militare, n on essendov i alt r e ind icazioni , mentre qu ell o così c hi am ato dal Vel t zé e dal Pi er i e sc r itto n el 1653 a H ohenegg è meglio desig na to come Tavole Militari.
ne non può in nessun caso appartenere al secondo (o, a nostro avviso, terzo) periodo (1 650-1653 ), poich é vi figura un ch iaro riferim ento alla ca mpagn a del 1659. Il trattato deve quindi considerarsi posterior e a ta le data 197 • Ma è possibile ricondurlo al 1673? Ritengo di sì, p o iché già il Pieri aveva acutamente oss ervato 198 c h e la dottrina de ll a batta gli a d'al a (di cu i fu quindi Montec u ccoli il p r imo teorico moderno) appare nitida e chiara in due trattati: appunto, il secon do Delle battagli e e il Dell'arte militare, stabilendo tra di essi un'inequivocabile affinità.
Le due o pere vengono quindi insieme ad app art enere ad un quarto (o, se si tien e presente quanto più sopra argom entato, quinto) periodo dell'attività di sc rittore militare di Monte cuccol i, no n contemp lato dal Pieri; esse sono in un cert o sens o il suo testam ento d ott rinale e da qu esto punto di vista acquisiscono una importanza enorm e, invitando ad una completa revis ione de lle co n cezioni r elative alla ev oluzione del suo pensiero mi litare. È anc he di es trema imp o rtan za il fatto che le due op er e furono sc ritte alla fine d el 1673, ossia dopo l'ultima vittoriosa ca mpagna di Monte cuccoli contro Turenne e Condé.
Tra il seco ndo (o terzo) ed il quarto (o quinto) perio do s i ins erì il terzo (o quart o) ( 1665-1670) in cu i il Nostro, nella pa ce se rena di H ohenegg, portò a termin e il s uo cele bre opus tripartitum, oss ia i così detti Aforismi 19 9 •
Il titol o r eale d ell 'opera è Della guerra col Turco in Ungheria; la prima parte è intitolata Aforismi dell'arte bellica in astratto (e non in ritratto, come è detto erroneamente in copie posteriori del ms.); la seco nda, Aforismi riflessi alle pratiche delle gu erre pro ssi me addietro dell'Ungheria; la terza , infine, Aforismi applicati alla guerra possibile col Turco in Ungheria . Il metodo segu ito nella stesura appare in radi cale contrasto con quello del Trattato della guerra. Colà l'illus tre Autore aveva dichiarato es pli citamente c h e avrebbe tralascia to le cit azioni delle fonti poiché scrivev a per se stesso e non per altri; qui, appreso dal Campanella il metodo apo ditti co, egli, co me il M aes tro , r elega in n ote l'intero apparato cri tico co n le citazioni da lui addotte quali pun ti di appoggio o di deriva z io ne (o anche di co ntrasto).
197 L 'argomento addotto dal Pier i contro t ale riferimento, qu e ll o cioè di un a inte rpolaz ion e post erio re , appare poco persu asivo e non sostenu to dall' evidenza interna (cfr.: P. Pieri, Guerra e politica.. , cit., pag. 92 sg., n . 1).

198 P. P1ER1, Guerra e politica , cit., pag. 111 sgg.
199 OSK , Vien na, Nachlass Montecu cco li, K III/IV, 7, Ms B 492/ d / l /7
È quindi del tutto inesatto rimproverare al Montecuccoli (come fecero alquanti studiosi) di aver infiorettato o, peggio, infarcito gli Aforismi di citazioni latine, ne l che si volle vedere un suo presunto barocchismo 200 ; in realtà furono alcuni tardi e maldestri copisti dell'opera sua che inserirono in mezzo al testo quelle citazioni che egli aveva, come si è detto, posto in nota, causando una vera perversione della sua esposizione 201 .
La verità è che nessuno degli studiosi di Montecuccoli si è mai dedicato ad indagare le radici filosofiche e logich e del suo modo di esporre, che vanno, come si è detto, richiamate al Campanella. In que sto senso gli Aforismi costituiscono il clou della sua opera di scrittore militare; né si deve dimenticare che i trattati del 1673 saranno scritti da un uomo già stanco e malato. È per altro interessant e vedere come nel Dell 'arte militare egli rimanga fermo alla forma aforistica, senza però aver più il tempo o la possibilità di aggiungervi il bagaglio critico con la documentazione delle fonti. Giova ancora osserva re che Montecuccoli fu sempre fedele al metodo razionale; da qui la sua continua scomposizione di un concetto più generale in elementi particolari che alcuno volle trovare eccessivame nt e minuziosa e financo pedante, ma che è parte intrinseca dell'impostazione scientifica del suo procedimento.
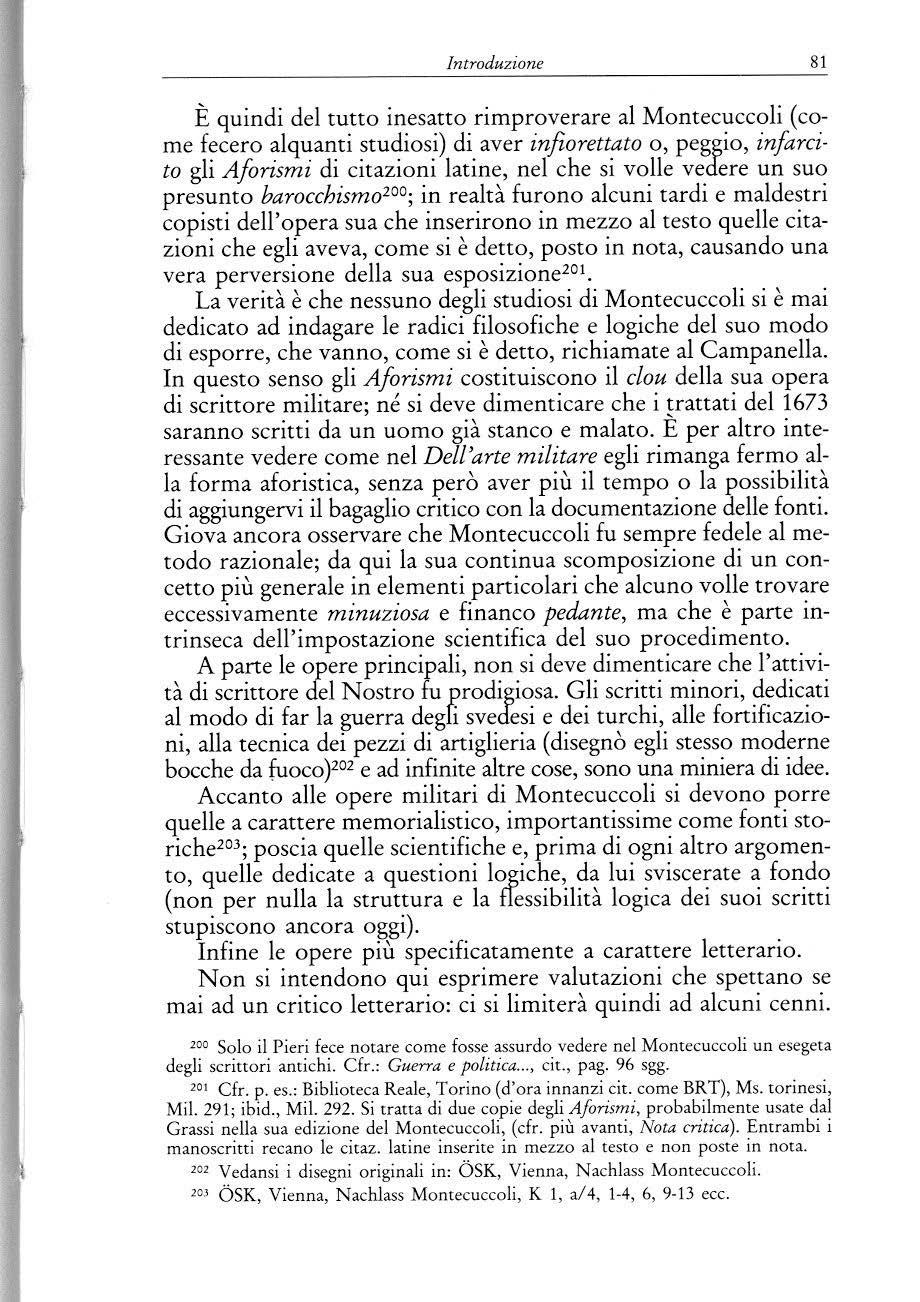
A parte le opere principali, non si deve dimenticare che l'attività di scrittore del Nostro fu prodigiosa. G li scritti minori, dedicati al modo di far la guerra degli svedesi e dei turchi, alle fortificazioni, alla tecnica dei pezzi di artiglieria (disegnò egli stesso moderne bocche da fuoco)202 e ad infinite altre cose, sono una miniera di idee.
Accanto alle opere militari di Montecuccoli si devono porre quelle a carattere memorialistico, importantissime come fonti storiche203; poscia quelle sc ient ifiche e, prima di ogni altro argomento, que ll e d edicate a questioni logiche, da lui sviscerate a fondo (non per nulla la struttura e la flessibilità logica dei suoi scritti stupiscono ancora oggi).
Infine le opere più specificatamente a carattere letterario. Non si intendono qui esprimere valutazio ni che spettano se mai ad un critico letterario: ci si limiterà quindi ad alcuni cenni.
200 Solo i l Pier i fece notare come fosse ass urdo vedere nel M o ntecucco li u n esegeta degli sc rit to ri amichi . Cfr.: Guerra e politica... , cit., pag . 96 sgg.
201 Cfr. p. es.: Bib li oteca R eale, Torino (d'ora innanzi cit. come BRT), Ms. torin es i, M ii. 291; ibid., Mii. 292. Si t r at ta di d ue copi e degli Aforismi, pro babilmente u sate dal Gras si n ella sua edizione del Montecuccoli, (cfr. p iù ava n ti, Nota critica) Entrambi i man oscritt i recano le ci taz . latin e inserite in mezzo a l testo e non po ste i n nota.
20 2 Vedansi i disegni origina li in: OSK , Vienna, Nach lass Montecuccoli
203 OSK, Vi enna, Nac hlass Montecuccoli, K 1, a/ 4, 1-4, 6 , 9- 13 ecc.
Secondo dunque il Gimorri204 si devono a Mont ecuccoli sette sonetti, due ca nzoni , una stanza e quattro ottave 205 ; vi è inoltre la novella autobiografica già precedentem e nte citata. Il Gimorri lo consi derò poeta non volgare, misurato, ricco di una nobiltà e serietà quasi ignote ai poeti del tempo; ed osservò che nel verseggiare Montecuccoli, anche dove appariva freddo, mo st rava tuttavia una consumata perizia2 06

Qui ci si limiterà a concludere che una ripubblicazione integrale dell'opera poetica del Montecuccoli è più che aus pi cabile e che sarebbe opportuno che qualche nostro studioso di letteratura italiana del Seicento vo lesse occuparsene se nza preconcetti e con il desiderio di darci alfine un gi udizio non fazioso né prev en uto circa il valore di tale opera.
VIII.
N on è realmente possibile scindere la dottrina militare di Montecuccoli dalla sua opera di generale . Egli, val bene ripeterlo ancora una volta, non fu mai, come scrittore, l'esegeta di alcuno: il suo pensiero sgorga anzitutto dalla sua propria esperie nza; e se esso si nutrì sia dell'insegnamento dei grandi capitani che egli pot é studiar e dal vivo, s ia dell'eredità del patrimonio culturale e militare del Rinascimento e della civil tà antica, ciò avvenne - come g ià a·mpi amente si è mostrato - per la natura dial ettica e razionale della sua mente, che tutto seppe fondere ed armonizzare in qualcosa di omogeneo e di organico. Monte cuccoli teorico militare e so ldato, quindi, superò in realt à tutti gli scr ittori e i capitani che l'~vevano 1;reced1;1to e di cui era stato testimone, preparando la via verso l'avvenire.
La sua e rudizione nel campo degli scritti militari, così del mondo antico come del Rinascim ento e d ell 'e poca sua, fu imm e nsa, e lo attestano sia l'introduzione al Trattato della guerra che lo Zibaldone e num erosissimi altri sc ritti; ma eg li fu anzitutto e prima
20
• A. G1MORR 1, op. cit., pag. lviii sgg.
ios Le opere letterari e di Momecu cco li so no cust0ditc in: A S. M. e in ONW. Da notare che il Campori (o p. ci t.) ne trascrisse al cune ma con errori di copiatura.
206 A. GIMO RRI, op. cit., pag lxii -lx vi.
di tutto un generale (ed un uomo di stato) e l'insegnamento altrui, come pure le letture, gli servirono solo per aiutarlo ad elevarsi dal livello d ella mera pratica a quello dell'esperienza razionalmente inquadrata.
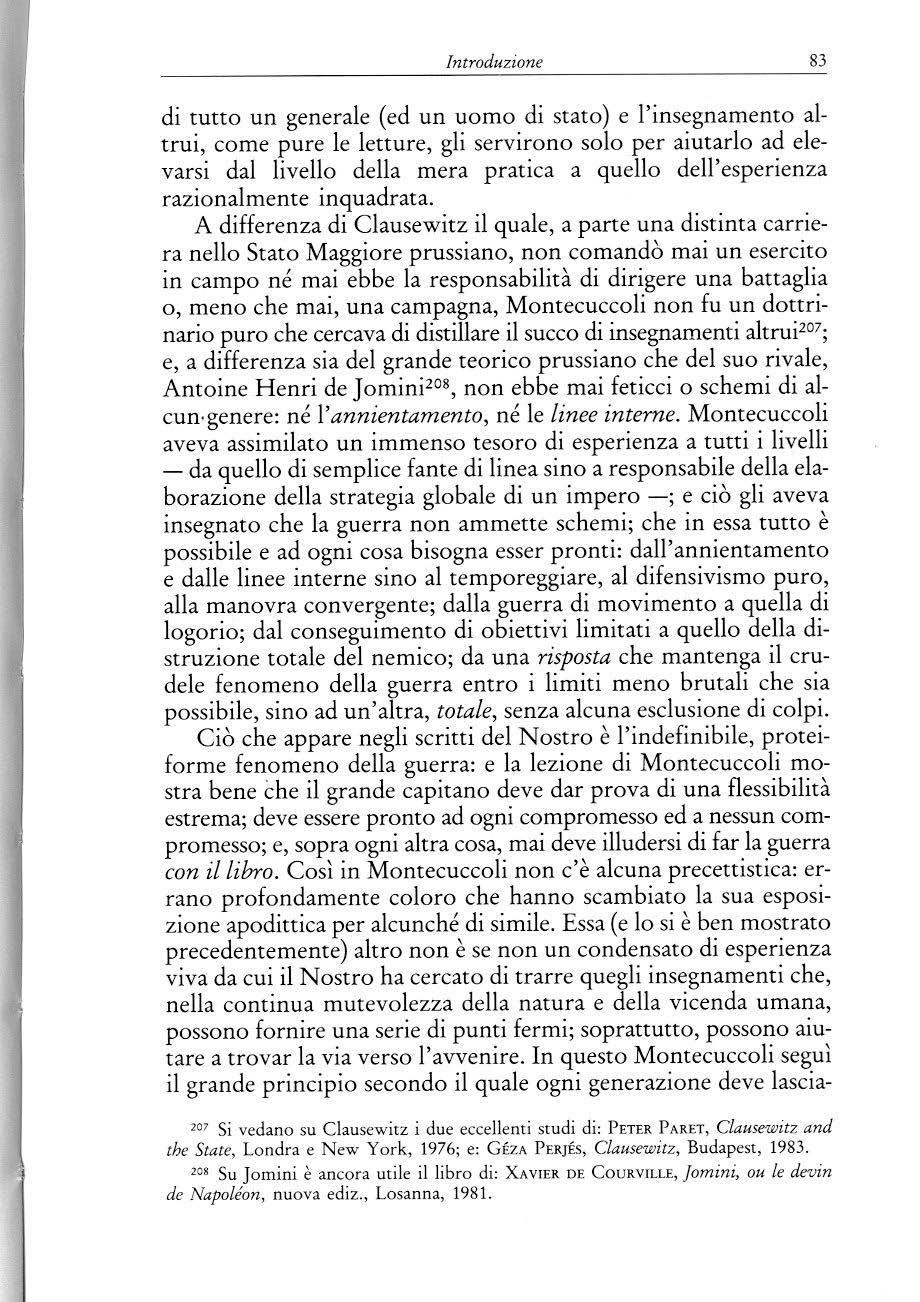
A differenza di Clausewitz il quale, a parte una distinta carriera nello Stato Maggiore prussiano, non comandò mai un esercito in campo né mai ebbe la responsabilità di dirig ere una battaglia o, meno che mai, una campagna, Montecuccoli non fu un dottrinario puro che cercava di distillare il succo di insegnam enti altrui2 0 7 ; e , a differenza sia del grande teorico prussiano che del suo rivale, An t oine H enri de Jomini 2 08 , non ebbe mai feticci o schemi di alcu n ,genere: né l'annientamento, né le linee interne. Montecuccoli aveva assimilato un immenso t esoro di esperienza a tutti i live lli - da quello di semplice fante di linea sino a responsabile della elaborazione della st rat eg ia globale di un impero -; e ciò gli aveva insegnato che la guerra non ammette schemi; che in essa tutto è possibile e ad ogni cosa bisogna esser pronti: dall'annientamento e dalle line e interne sino al temporeggiare, al difensivismo puro, alla manovra convergente; dalla guerra di movimento a quella di logorio; dal conseguimento di obiettivi limitati a quello della distruzione totale del nemico; da una risposta che mantenga il crudele fenomeno della guerra entro i limiti meno brutali che sia possibile, sino ad un'altra , totale, senza alcuna esclusione di colpi.
Ciò che appare negli scritti del Nostro è l'ind efinibile, proteiforme fenomeno della guerra: e la lez ion e di Montecuccoli mostra bene che il grande capitano deve dar prova di una flessibilità estrema; deve essere pronto ad ogni compromesso ed a nessun compromesso; e, sopra ogni altra cosa, mai deve illudersi di far la guerra con il libro. Così in Montecuccoli non c'è alcuna precettistica: errano profondamente coloro che hanno scambiato la s ua esposizione apodittica per alcunché di simile. Essa (e lo si è ben mostrato precedentemente) altro non è se non un condensato di esperienza viva da cui il Nostro ha cercato di trarre quegli insegnamenti che, n ella continua mute vo lezza della natura e d ella vicenda umana, possono fornire una serie di punti fermi; soprattutto, possono aiutare a tro v ar la via verso l'avvenire. In questo Mont ecuccoli seguì il grande principio secondo il quale ogni generazione deve lascia-
20 7 Si veda no su Clausewitz i due eccell enti s cudi d i: PETER PA RET, Clausewitz and the State, Londr a e New Yor k, 1976; e: GÉZA P ERJÉS, Clausewitz, Budapest, 1983.
20 8 Su J o m ini è anc ora ut ile il li bro di : XA VJ ER DE CouRVJLLE, ]omini, ou le devin de Napoléon, n uova edi z., Losanna, 1981.
re a quelle che seguono il tesoro della sua esperienza e dell e sue meditazioni.
Ma vediamo ora in sintesi gli insegnamenti che eme rgon o dalla dottrina e dalla pratica di Montecuccoli, avendo sempre prese nte che quanto proviene dall a prassi è inevitabilmente legato al su o tempo: laddove eg li cercò invece, n ell e sue opere, di di stillare quei dati che (pur nella mut evo lezza della guerra) potevano acquisire valore univ ersa le.
Ed anzi t utto nel ca mpo tattico. Una tra le principali accu se c he qui si vollero fare a Montecuccoli fu di aver sost e nuto caparbiam e nte l'uso della pi cca per la fanteria e della lancia per la cava lleria mentre l'esperienza del suo tempo (ed in particolare l'insegnam ento di Gustavo Adolfo) avr ebbe ro indicato una evoluzione verso il prevale re dell'arma da fuoco individuale. A s ostegno di tal e tesi si soleva portar e l'afferm az ione recisa d ello stess o Montecuc col i negli Aforismi secondo cui la lancia era la regina delle arm i a cavallo, così come la picca di quelle a piedi 209
A ciò si debbono op porr e due conside raz ioni. Anzitutto (come ampiamente discusso in pr ece denza) non è vero c he Gu stavo Adolfo avesse assegnato un ruolo secondario alla picca: ché, anzi, egli ne aumentò piuttosto il numero in proporzion e ai moschetti; fu se mai Montecu ccoli che dett e maggior spazi o alle armi da fuoco portatili 210 Cade quindi la leggenda del Mont ecucc oli passatista di fronte al re di Svezia innovatore (Gustavo Adolfo fu effe ttivam e nte un innovatore, co me si è avuto occasione di dire am piam ente; ma , se mai, per motivi opposti).
Ma vi è un discorso più vasto c he a questo pr oposito si deve fare. II. giudi z io sul tramonto d ella picca nasc e in realtà da una non sufficient eme nte approfondita conoscenza della r eale evoluzione t ec nologica delle armi da fuoco. In effett i, l 'efficacia del moschetto ad anima li scia, data la scarsa velocità iniziale 211 , la modesta forza
209 Vedasi quanto detto da P. Pi er i, Guerra e politica , cit., pag. 100 sgg., n. I; il Pieri però corresse se n sibi lmente il suo gi udizio iniziale in: Ra imondo Montecu ccoli e l'opera sua in: Atti del Convegno di Studi... , cit. , pag. 41 sgg. ove si trovano le pagine piu profonde e mature dedicate dal Pi eri a M o nt ecuccoli
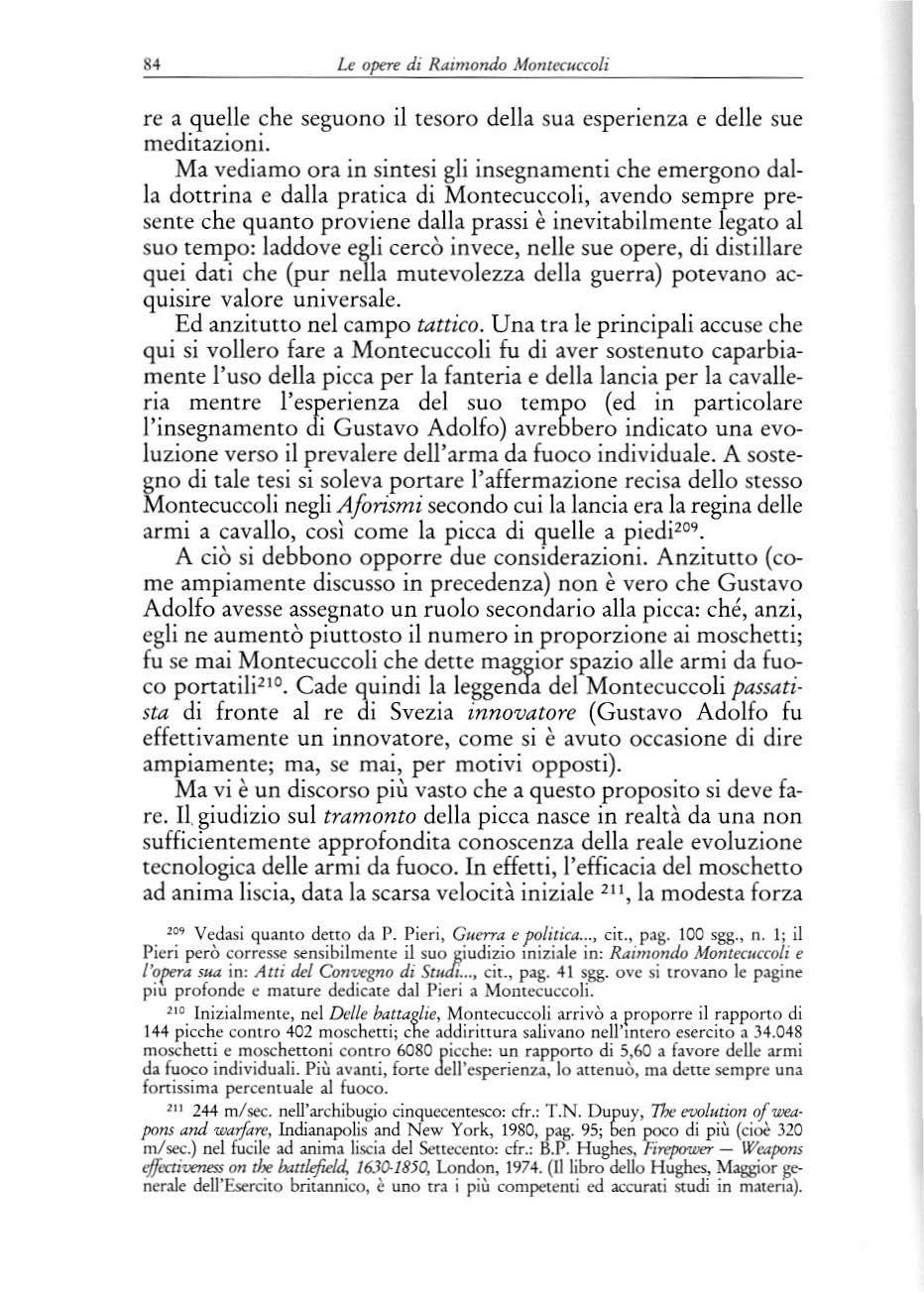
2 10 ln iz ialm e nce, n el Delle battaglie, Mo ntecuccoli a rri vò a pr o p o rre il rapp orto d i 144 picche contro 402 m osc h et t i; che addir ittura sali vano nell'rn tero ese rc ito a 34.0 48 moschetti e moschettoni contro 6080 picc h e: un rapporto di 5,60 a favo re dell e armi da fuoco individuali. P iù avanti, forte d ell 'es perienza , lo attenuò, ma dette sempre una fortissima percentuale al fuoco.
211 244 m/sec. nell'archibugio cinquecentesco: cfr : T.N. D upu y, 7he evolution of wea· pons and warfare, Indianapo li s and New York, 1980,l.ag. 95; ben poco d i pi ù (cioè 320 m/sec.) n el fu cile ad anima liscia del Settecento: cfr.: .P. Hughes, Firepower - Weapons ejfeaiveness on the batt/efìeld, 1630-1850, London, 1974. ( Il libro dello Hughes, Maggior generale dell' Esercito britannico, è uno tra i più competenti ed accurati scudi in materia).
v iva (cioè la ancor più scarsa velocità di impatto e - conseguentemente - la poca forza di p en etraz io n e) 212 , la estre ma imp recisione della traiettoria 213 soggetta anche alla sp inta del ve nt o, era assai limitata e faceva sì che il mo sc hetto seicentesco fosse veramente utile soltanto fino a 50 m; a 80 esso diventava scarsamente efficace. Si pensi che lo stess o fu c il e ad anim a liscia delle guerre nap oleonich e non ave va, oltre i 100 m, qu as i più nessun effetto: come sc risse il gene rale Ulysses Grant, a 200 m un uom o poteva sp ararvi addosso anche per l'i nt er a giornata se n za che voi nemm eno ve ne acco r geste; e il colo nnell o inglese H anger, n el 1814: « quanto a sparare ad un uomo a 190 metri con un n o rmal e fucile ad anima li sc ia, è come tirare alla luna co n la stessa probabilità di colpire il bersaglio» 21 4.
D 'altro cant o, è giusto osservare che il mo schetto del Diciasse ttesim o se colo era, entro certi limiti, un po' più potente del success ivo fucile a pi et ra, in quanto il suo calibro era maggior e (20 mm) e il peso del proietto era di un 'oncia (cioè gr 28,35): da ciò la ne cessità (alla qu ale, come s i è visto, n eppure Gustavo Ado lfo aveva p ot uto sottrarsi ) di sparare su appoggio. Si aggiunga la lentezza d ell e operazioni di caricamento la quale non consentiva di 1 tirare p i ù di un colpo ogni du e minuti e me zzo, ci o è 24 ogni ora (ce lo dice il M ontec uccoli stesso n el suo Trattato della guerra), ed a condizio n e che i mosch ettieri fos sero di prim ' ordine. Tuttav ia il p eso del proi ettile compensa-va in qualch e modo la scarsa velo cità di im patto garant endo una certa quanti tà di en er gia cinetic a2 15. La forza di penetrazione era però scarsissima: due cm e mezzo a 100 m in una tavol a di legno; e tale rim ase sempre, fino all'avvento del fucile rigato , alla metà del Dicianno vesimo seco lo 216 • Gu st avo Adol fo cap ì benissimo tali caratteristich e e le sfruttò al massimo introducendo la sal va di plotone con la qu al e sola i mosc h et ti potevano avere un a qualch e efficacia, ed a condizione
212 La forza di penetrazione e, in definitiva, l'effetto di un proiettile di qualunque genere dipendono dalla sua energia cinetica la quale è pari ad l/2mv2 ; ora, in qualunque arma ad anima liscia la velocità decresce rapi damente e q uella di impatto è pari a 1/3 di quella d i un proi ett il e di ugual pe so lanci at0 a parità d i calibro e carica da un'arma rigata a ll a stessa distanza.
m La t raiettoria ne era eccessivamente curva (a una distanza di 114 m dalla bocca dell'arma il proiettile era già disceso di m 1,52: cfr.: B.P. Hu ghes, op. cit., pag. 26).

214 ULYSSES S. GRANT, Persona! Memoirs, New York, 1885, 2 vo lu mi; voi. I, pag. 95; B.P Hu gh es, op. cic., pag. 26 sgg
m T.N. DuPUY, op. cit., pag. 130 sgg.
216 BERKELEY R. l Ew1s, Small arms and amm1mitiom in the United States seruice, 1716-1865, Smithsonian lnstitucion, Washington, DC, 1960, pag. 93
che fosse sparata quasi a bruciapelo, quando si poteva vedere il bianco degli occhi del nemico: il ch e significava praticamente una sola scarica prima che cavalleria e picchieri avversari arrivassero addosso al s uo schieramento 217 •

Il segret o era quindi di sparar e alla distanza minima e tutti insieme. Per altro già nel secolo precedente sia Consalvo di Cordova a Cerignola che Prospero Colonna alla Bi cocca avevano saputo sfruttare tale tipo di fuoco con effetti devastanti sul nemico. L'arma da fuoco individuale era quindi unicamente difensiva, ed allo stesso modo sarebbe stata usata da Wellington, sia in Ispagna che a Waterloo 218 • Si aggiunga che, come si è mostrato, la sua efficacia anche difensiva era minima fintantoché essa rimase ad anima liscia; ma se la piccca veniva usata offensivamente, allora il bin om io picca-moschetto poteva avere effetti formidabili, come Gu stavo Adolfo e Montecuccoli avevano perfettame nte inteso: il problema, in altre parole, era di fornire alla picca una tale copertura di fuoco che essa non dov esse a sua volta temere il tremendo impatto delle lance e dei picchieri nemici. Fu proprio quindi l'esatta comprensione della funzione offensiva della picca che spinse Montecuccoli ad aument are attorno ad essa il numero dei moschettieri, onde fornirle la più totale protezione. E infatti notorio che l'arm a offensiva non si difende ma, perché possa offendere, deve esser difesa 219 •
L'attacco delle picche, poi, n on aveva altra funzi on e che di fissare le fanterie nemiche per consentire alla propria cavall eria di attaccarle ai fian chi e sulle spalle, e ciò non poteva avvenire con l'inutile, inefficace metodo della caracolla. Gustavo Adolfo aveva adottato la carica a spada sguainata, e dalla Polonia reimparò l'uso della lan cia: da qui la convinzione di Montecuccoli che la lancia fosse la regina delle armi a cavallo. Quanto alla caracolla, egli la scarta definitivamente.
217 In effetti, è stato calcolato che 500 moschettieri schierati su due file su un fron te di 150 m, e capaci di sparare ad un ritmo di 6-10 colpi per mal minuto, potevano, a 100 m di distanza, co!Jocare sul bersaglio, dato da un 9uadrato di fanteria con un fronte di 6 m , il 75% dei loro colpi. Tuno ciò, ovviamente, lfl linea teori ca: all'an o pratico , a 100 m, non più del 50% dei colpi aveva qualche probabilità di andare a segno; oltre tale distanza e fino a 150 m, non più del 40%. Ma ciò ancora non corrispondeva alla real t à, perché supponeva moschenieri perfettamente addestrati e armi senza pecche. Nel concreto , per uccidere sicuramente un nemico occorreva sparargli contro una quantità di piombo pari a sene volte il suo peso e le pallottole che andavano a bersaglio non erano piu del 2-5 per mille. C fr. : B.P. Hughcs, op. cit. , pag. 26 sgg.
213 Cfr.: J AC WE.LI.ER , Wellin gton at Wa ierloo, N ew York , 1967; id. , Wellington in the Peninsula, 1804-1814, Lond on, 1969; P. PtERI, il Rinascimento e la crisi militare , cit., pag. 408 sgg., 542 sgg.
219 E cosl chiaramente Montcc uccoli ne l Delle battaglie.
Tutta la dottrina tattica di Monteccuccoli era in realtà tesa verso l'avvenire : e questo avvenire apparteneva, quasi per altri due secoli, nel campo delle armi individuali, a lle armi bianche, non a quelle da fuoco; la stessa introduzione del fucile co n baionetta non fu, come erroneamente si crede, un a trasformazione della ficca in mo sc hetto: ma del moschetto in picca. Da quel momento i fuoco divenne sempre più impreciso, fino alle fanterie di F eder ico il Grande che avrebbero avanzato a passo cadenzato, l'arma al fianco, scaricando ritmicamente senza quasi mirare, poiché il fucile ad anima liscia era più efficace moralmente per il rumore che atterriva il nemico e per il fumo che dava copertura ai propri movimenti, che non per i suoi ridotti effetti materiali. Alla fine, la decisione sarebbe toccata all'acciaio: la pallottola è pazza, la baionetta è saggia, avrebbe detto il Maresciallo russo Suvorov, ben sintetizzando la filo so fia militare di due secoli.
Ma questa esalt azione della funzion e offensiva dell'arma bianca, che sare bbe , appunto, arrivata a sacri ficare il moschetto per la picca (nella nuova forma della baionetta) sarebbe stata resa possib il e solo dalla evoluzione delle art i~lierie, capaci (come si sarebbe visto bene sotto Federico il Grande) di spezzare preventivamente la resistenza dell e fanterie avversarie: «Il n' y a ri e n de si r edoutable que !es batteri es chargées à cartouches qui font un terrible carnage dans les bataillons ... >> avrebbe detto, appunto, Fed eric o 220 •
Ac canto alla fanteria, la cavalleria si sarebbe sempre più evol uta com e l'autentica arma d'urto (lasciando ai cavall eggeri e ai drago n i l' es plorazione, l'inseguimento e le azioni volanti): era un cammino che avrebbe condotto molto lontano, sino all'u so napoleonico dei corazzieri come vere e proprie truppe di sfo ndamento. T ale epo ca sarebbe durata fino all a Guerra civile am e ricana, in cui l'u so della pallottola Minié, sparata dal fucile rigato , avrebbe capovolto totalmente le premesse tattiche dando la prevalenza alla di fesa sull'attacco e liquidando per se mpr e l'arma bi anca: un altro periodo di un secolo, culminato nelle trince e della Prim a guerra mondiale ed a sua volta terminato più tardi in seguito all'avvento d e] mezzo corazzato 221 •
220 Oeu vres de Fréderic Il, Berlino, 1789, 30 volumi; voi. Ili pag . 355 . Da notare (come avrebbe osservato più cardi il generale Lee) che cale tiro doveva avvenire da non più di 400-600 passi (dr.: R. LURAGHI, Storia della Guerra civile... , cic., pag. 274) .
221 U fuc ile rigato della G uerra civi le americana aveva un tiro utile di 1500 me ad un c hilometro era ancora micidiale; a 700 m poteva perforare uno strato di tavo le di legno di 20 cm. Cfr.: R. LVRAGHr , Storia della Guerra civile americana, Milano, 1985, V edizione, pag. 241 sgg.; BERNARJ) AND FAWN M. BROOr_E, From crossbow to H-Bomb, Bl oomingcon, lnd., 1973, pag. 132 sgg.; B.P. HucHES , op cit., pag. 29; T. DuPUY, op cit., pag. 190 sgg.
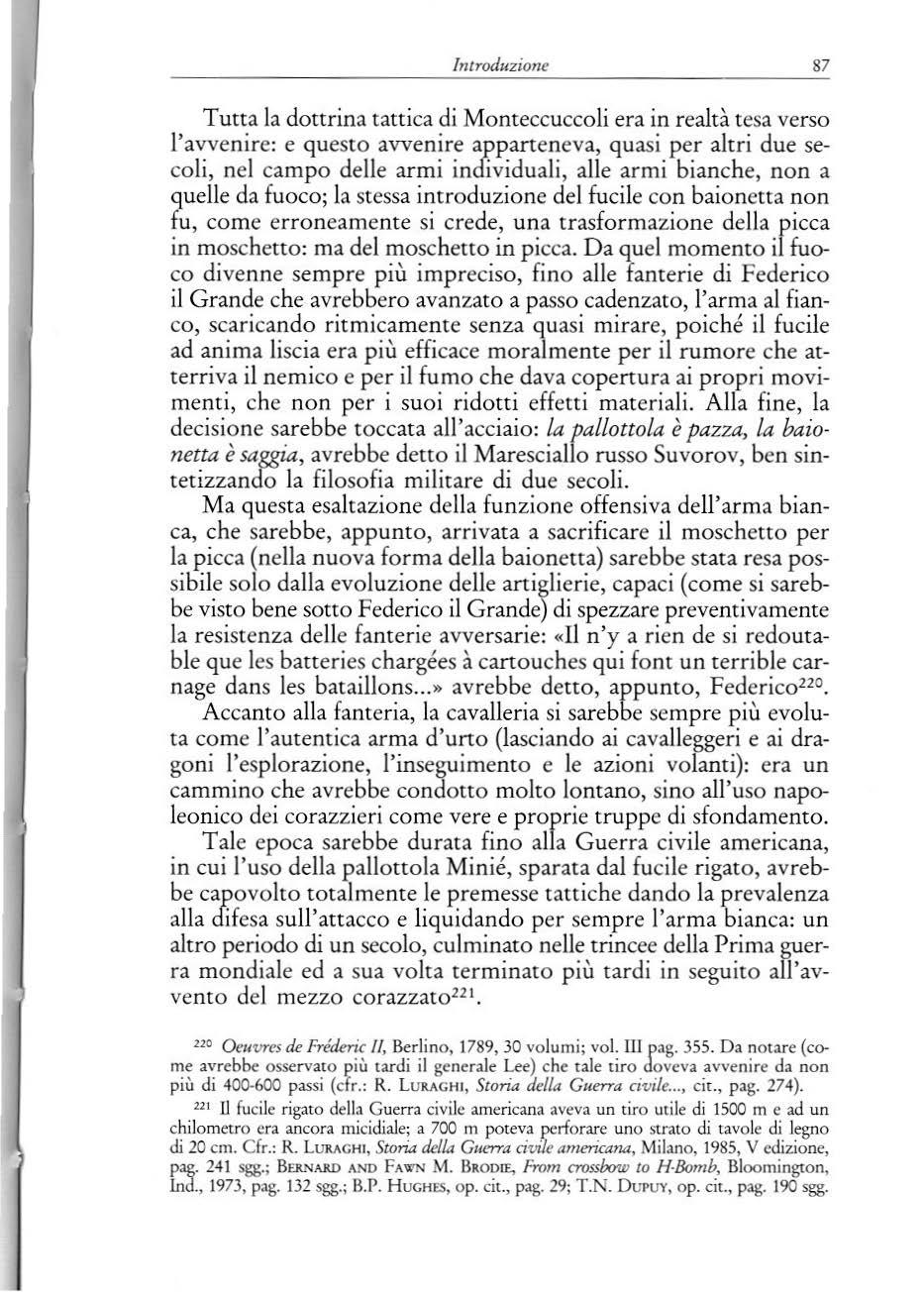
Solo di fronte alla terribile fo rza d i penetrazione ed alla gra nde gittata del micidiale fucile ad anima rigata l'arma bi anca avrebbe perso p er semfre la propria funzione 222 • N el 1878 , a Berlino, Ulysses Grant, gia Generale in capo degli Eserciti am ericani nella Guerra civile ed ex Presidente deg li Stati Uniti, reduce dalla t erribile esperi enza d ei ca mpi di batta glia cl' America, parlando ad un alt o ufficial e tede sco, avr e bbe r eci tato il de profundis della baionetta dicendo senza ambagi che ess a e tutte le armi bianche erano ormai inutili e se n e sarebbe tratt o grand e v an taggi o eliminandole. Né la Germania, né l' E uropa vollero allora co mprendere la lezione , e l'E se rcito tedesco s arebbe entrato nella gu er r a del 1914 con i s uoi reparti di Ulani armati dell' or mai obs oleta lan cia nel1' era della mitragliatrice 223 ; il tutto per non parlare delle folli ec atombi in cui si trasformarono gli attacchi con l' inutil e baion ett a contro trin cee cope rte da reti co lati e irte di armi automatiche.
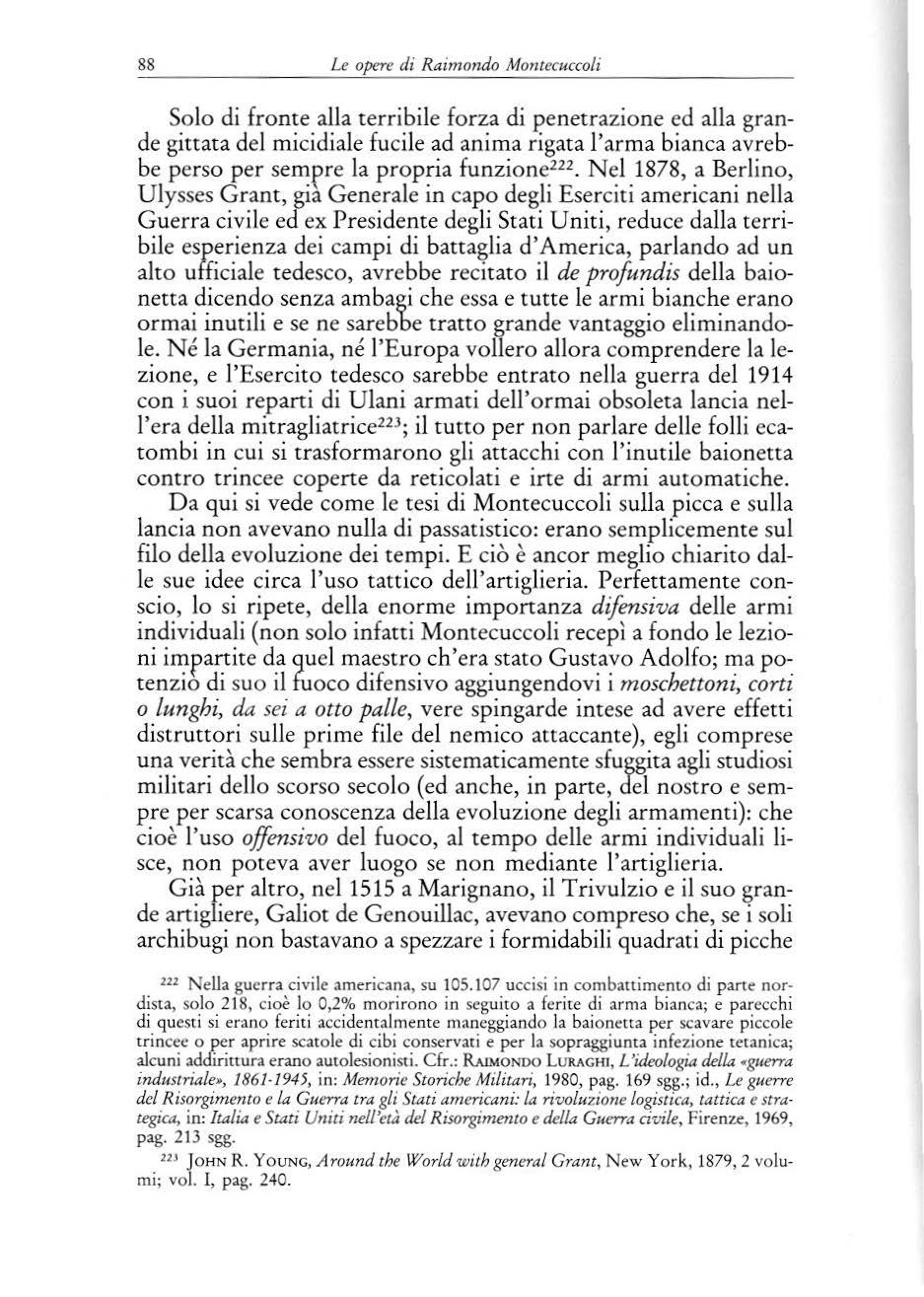
Da qui si vede come le tesi di Montecuccoli sulla picca e sulla lancia non ave vano nulla di pass atis tico: erano se mpli ce ment e s ul filo della ev oluzi o ne dei tempi. E ciò è an cor m eg li o ch iarito dalle sue id ee circa l' uso tattico dell'artiglieria . Perfettamente co nscio , lo si ripete, della en o rm e importan za difensiva delle arm i indivi duali (non solo infatti Mont ec uc coli recepì a fondo le lezi oni impartite da qu el maestro ch' era stato Gustavo Adolfo; ma potenzi o di suo il fuoco di fens ivo aggiungendovi i moschettoni, corti o lunghi, da sei a otto palle, vere sp ingarde int ese ad avere effetti di struttori sulle prime fil e del n e mico atta ccante), egli comprese un a verit à ch e sembra essere s istematicamente sfuggi ta agli studiosi mil itari d ello scorso secolo (ed anche, in parte, del no st ro e se mpre per scarsa conosc enza della evo luzione degli armam enti): che cioè l'uso offensivo del fuoco, al temp o delle armi indi vi du ali lisce, non pot eva aver luo go se n o n m ediante l' artigli eria.
Già per altro, nel 1515 a Mari gnano , il Trivulzio e il s uo gra nde artigl ier e, Galiot de G eno uillac, avev ano compreso che, se i soli archibugi n o n bastavano a spezzare i formidabili quadrati di pi cc he
222 Nella guerra civile americana, su 105.107 uccisi in combattimento di parte nor· dista, solo 218, cioè lo 0,2% morirono in segu ito a fer ite di arma bian ca; e parecc hi d i qu esti si erano fe r iti acc identalme nte maneggiand o la baion etta per scavare piccole trin cee o per aprire scatole di cibi conservaci e per la sopraggiunta infezione tetanica; alcuni addirittura erano autolesionisci. Cfr.: RAIMONDO LURACHI, l'ideologia della «guerra industriale», 1861-1945, in: Memorie Storiche Militari, 1980, pag. 169 sgg ; id., Le guerre del Risorgimento e la Guerra tra gli Stati americani: la rivoluzione logistica, tattica e strategica, in: Italia e Stati Uniti nell'età del Risorgimento e della Guerra civile, Firenze, 1969, pag. 213 sgg.
m jO H N R. YOUNG, A round the World with genera/ Grant, New York, 1879, 2 vol umi; voi. I, pag. 240.
degli svizzeri, l'artiglieria poteva ben farlo 22 4; e specificamente Gustavo Adolfo, con l'introduzione dei suoi pe zzi leggeri da accompagnamento, aveva indicato la via. Montecuccoli stesso aveva v isto sul campo di Breitenfe ld il Reggimento Hohenlohe reggere impavido a qualsiasi carica della cavalleria svedese, per venire poi disfatto a colpi di cannone; ed altri esempi l'avevano confortato in questa sua esatta tesi. Da qui l'inizio dell'evoluzione che avrebbe condotto alla maestria con cui Federico il Grande avrebbe usato sia il cannone da campagna caricato a mitraglia che, sopra tutto, l'obice, specificamente destinato a battere le fanterie, sino alla manovra del fuoco napoleonica 225 •
Anche a ciò avrebbe posto fine l'avvento del fucile rigato , che, costringendo gli artiglieri a star lontani dalla linea del fuoco, avrebbe posto fine all'uso del cannone caricato a mitra glia come arma di accompagnamento, c hiude ndo, anche qui, un'era22 6 Ma dopo aver sgombrato il terreno da una ser ie di false concezioni e di fraintendimenti, è tempo di giungere alla parte più v iva e permanente del pensiero tatt ico di Montecuccoli: le sue idee generali.
Il Pi eri vide in lui - e ben giustamente - il primo tra i grandi teorici d ella battaglia d'ala, ossia delle linee interne; il futuro ordine obliquo di F ederico II appare già del tutto sviluppato e maturo in Montecu ccoli. Teorizzatore della difesa infrofondità, era ad ogni istante pronto a passare dall' ordine sottile a uno più denso qualora le truppe disponibili non fossero state di qualità eccelsa (il che, sia detto di passata, significava aver pienamente compreso la possibilità di co mpensar e, fino ad un certo punto, la qualita con la quantità e viceversa); abilissimo nell'uso dei dragoni (che egli considerava esclusi vamente come fanteria montata), non mostrò mai in tattica alcuno schematismo ma una estrema flessibilità. Del resto il suo geniale concetto dell'unità tattica picca-moschetto co me un vero, omogeneo combat team lo solleva al di sopra di molti capitani, e non solo del suo tempo: e ne fa un artista della difensiva-controffensiva22 7 •
224 Cfr .: Lefeu, Studi e document i de l Serv iz io sto r ico dell'Eserci to Svizzero , Berna, 1982 sg ., amm irab ile studio dovuto alla pe nna del co lo nn ello Daniel Reic hel; I, pag. 3 sgg.
225 C fr.: Vincent J. Es posito, A Military History and Atlas of the Napoleonic Wars, N ew York, 1964
226 Cfr.: R . L u RAGH1, Storia della Guerra civile..., cit., passim.
227 PIERO PIER! , La formazione dottrinale di R aimondo Montecuccoli, in: Revue Inter· nationale d'Histoire Militaire, t. III, n. 10, Roma, 195 1, pag. 92 sgg ; sp pag. 105, 107 sg.; inoltre: id., Raimondo Montecuccoli e l 'opera sua, cit., in: Atti... , cit., sp. p ag. 48 sg. , 55, 57. Giov a d ire ch e l' idea della ba ttagl ia d'a la app ar e già ben dist inta in Monte cu ccoli s in dalla su a pr i ma opera D elle battaglie

Ben a ragione uno tra i suoi più attenti studiosi sottolineò il valore universale d elle idee tattiche del No stro, la loro permanente validità, il fatto che Napoleone (cui furono attribuite da persone male informate) se ne servÌ228 • Gli insegnamenti di Montecuccoli circa la scelta del mom e nto e del luogo per giungere a battaglia, l'importanza di saper sfruttare le caratteristiche del terreno, i fatt ori psicologici militari, il rapporto tra fuoco, movimento e urto, l'armonia e la cooperazione int erarma hanno un valore che non tramonte rà e possono (e debbono) ancora essere studiati utilmente nella nostra era.
S trano a dirsi, alcune tra le più gravi inesattezze circa il pensiero e l'opera di Montecuccoli furono poste in circolazione a proposito di qu elle parti dell'arte e della scie nza militare ov e egli invece eccelse sopra ogni altro suo contemporaneo, compreso Gustavo Adolfo, e dove il suo in segnamento è in r ealtà più valido e duraturo: l'01ga· nica, la Logistica e infine il settore operativo .
Non è necessario trattenersi a lungo sull'immenso contributo di Montecuccoli all ' organica: tutto il presente saggio ne dà testimonianza. Ci si limiterà quindi ad un singolo problema che ha il merito di intr odurci poi direttamente nel successivo dib attito s ull a logistica. Montecuccoli cioè, nel momento forse più maturo del suo pensiero, o ss ia negli Aforismi, fissò la forza massima di un esercito in campo a 50.000 uomini: esattam ente come i suoi due grandi rivali, Turenn e e Zrìnyi il secondo dei quali suggeriva peraltro una cifra lievemente inferiore: 48.000229 .
Ora, Montecuccoli era perfettamente conscio della enorme importanza della superiorità numerica su l nemico. Per qual e ragione sia egli c he due altri illustri capitani del Di ciassettes imo sec olo avevano consigliato un organico apparentemente tanto modesto?
La ragione esisteva, e validissima, ed era, appunto, nella Logistica; e così si stabi liva anch e (sia detto per inciso) il principio second o c ui gli organici dov evano fondarsi sulle possibilità logistic he, cosa
228 G. BANCA u\RJ , o p. cit. , pag. 157, 16 1 sgg
21'1 XA v1F.R Auoou1N, Histoire de l'Administralion de la Guerre, Parigi, 1831 sgg., 4 volu· mi; vol. Il, pag. 244; ZR.iNYl Mnu.6s, Tal:xm kis traaa, in: Zrinyi, Mik16s Hadtudoman,i Munka~ Budapest , 1976, pag 63, sgg. (co n introd. di Géza Perjés).
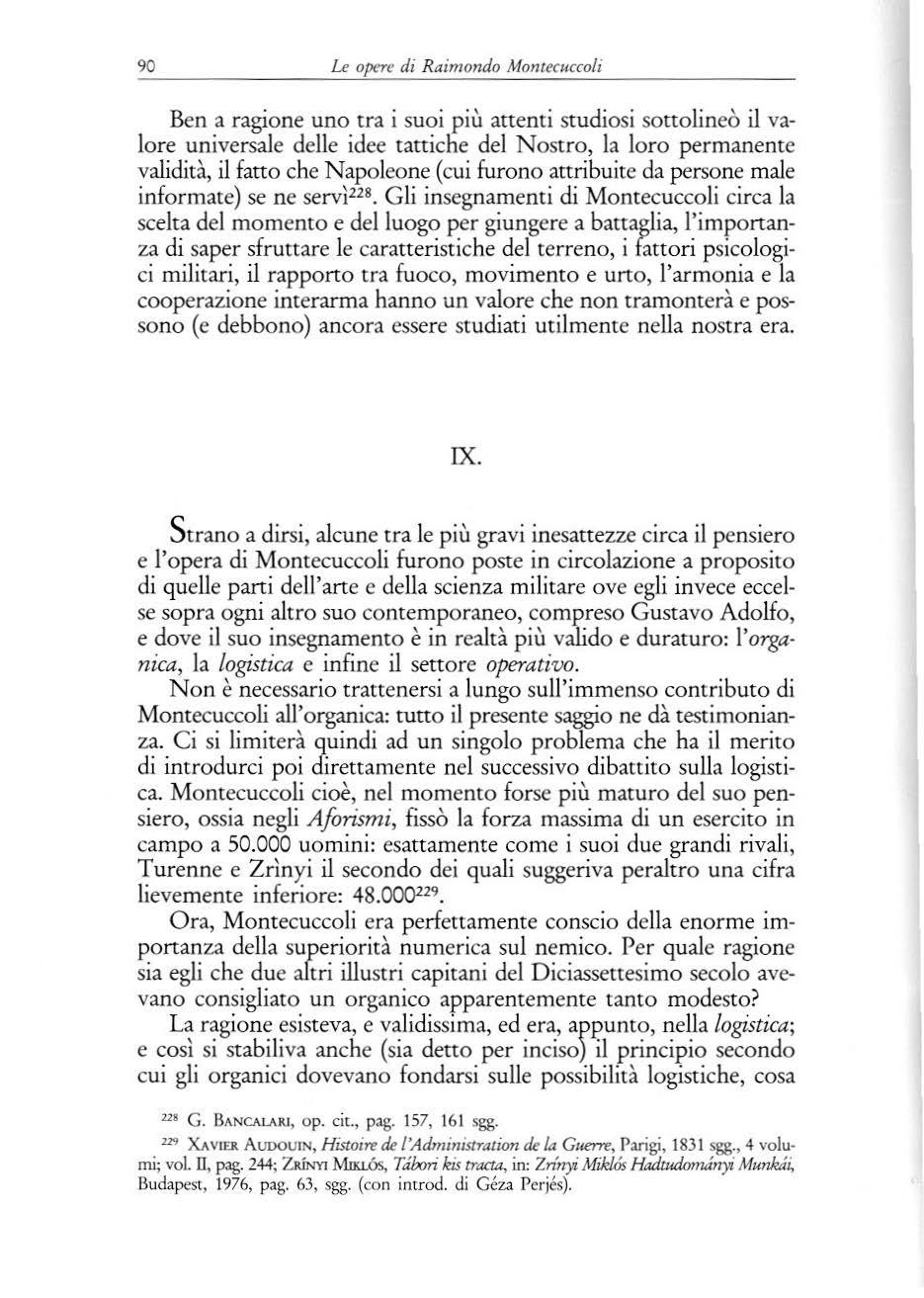
sovente ignorata dai capitani dell'età di Gustavo Adolfo (e dal grande re stesso). Un fenomeno che era stato tipico della Guerra dei Trent'anni, e su cui il Nostro aveva profondamente meditato, era stato il restringimento delle forze svedesi di Banér e T orstensson a piccoli eserciti in rapporto a quelli di Gustavo Adolfo. Il motivo di ciò era stato semplice: il sistema svedese del saccheggio, avendo depauperato la Germania, non consentiva ormai più di nutrir e che poche migliaia di uomini. Le stesse «fulminee)> mosse dei due generali da altro non era no state dettate che dal disperato bisogno di trovare viveri, ed erano state rese possibili proprio dalla leggerezza delle loro unità230 •
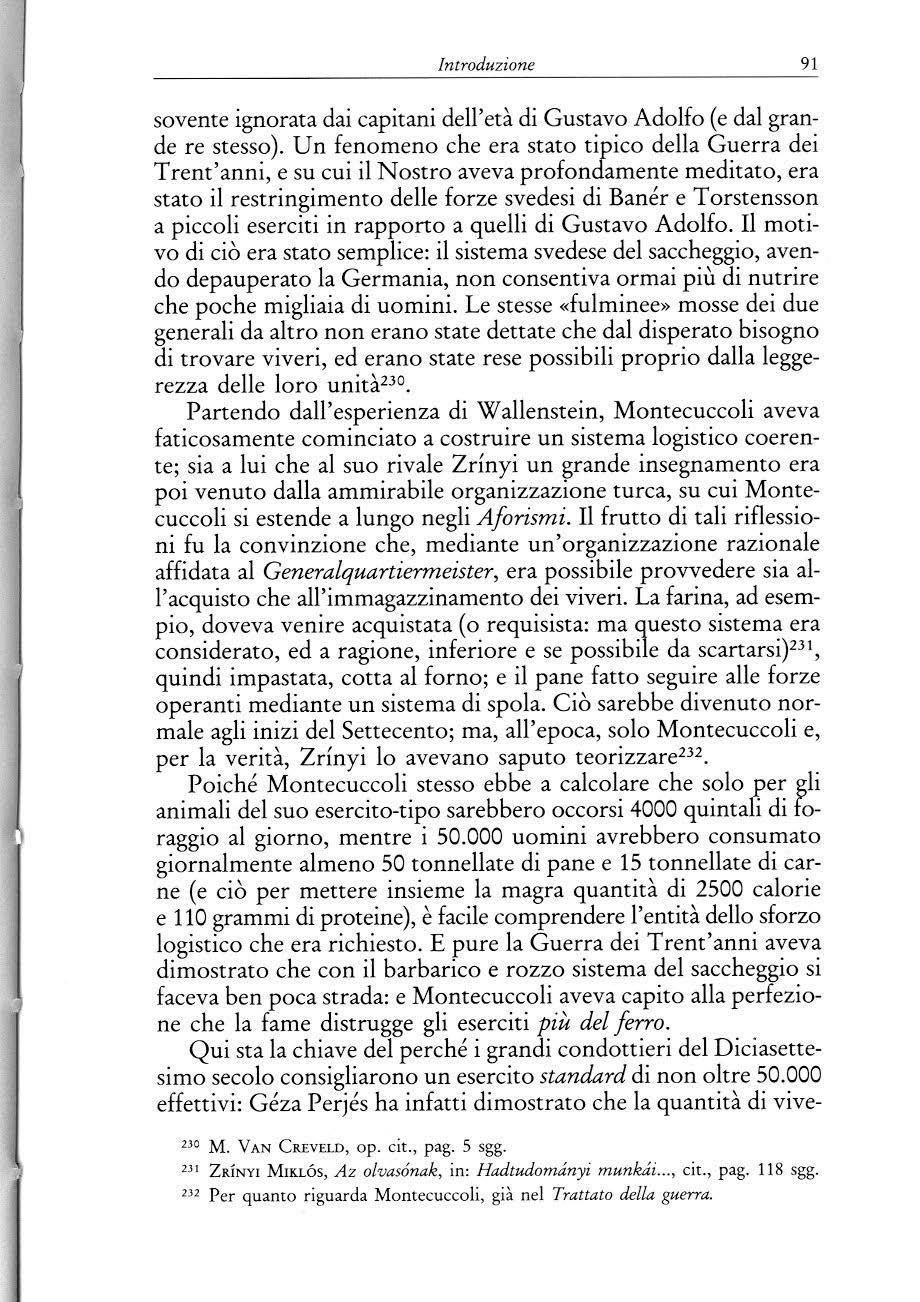
Partendo dall'esperienza di Wallenstein, Montecucco l i aveva faticosamente cominciato a costruire un sistema logistico coerente; sia a lui che al suo rivale Zdnyi un grande insegnamento era poi v enuto da ll a ammirabile organizzazione turca, su cui M ontecuccoli si estende a lungo negli Aforismi. Il frutto di tali riflessioni fu la convinzione che, mediante un'organizzazione razionale affidata al Generalquartiermeister, era possibile provvedere sia al1'acquisto che all'immagazzinamento dei viveri. La farina, ad esempio, doveva venire acquistata (o requisista: ma questo sistema era considerato, ed a ragione, inferiore e se possibile da scartarsi) 231 , quindi impastata, cotta al forno; e il pane fatto seguire alle forze operanti mediante un sistema di spola. Ciò sarebbe divenuto normal e ag l i inizi del Settecento; ma, all'epoca, solo Montecuccoli e, per la verità, Zdn y i lo avevano saputo teorizzare 232 •
Poich é Montecuccoli stesso ebbe a calcolare che solo per gli animali del suo esercito-tipo sarebbero occorsi 4000 quintali di foraggio al giorno, mentre i 50.000 uomini avrebbero consumato giornalmente almeno SO tonnellate di pane e 15 tonnellate di carne (e ciò per mettere insieme la magra quantità di 2500 calorie e 110 grammi di proteine), è facile comprendere l'entità dello sforzo logistico che era richiesto. E pure la Gue rra dei Trent'anni aveva dimostrato che con il barbarico e rozzo sistema del saccheggio si faceva ben poca strada: e Montecuccoli aveva capito alla perfe zione che la fame distrugge gli eserciti più del ferro.
Qui sta la chiave del perché i grandi condottieri del Diciasettesimo secolo consig l iarono un esercito standard di non oltre 50 .000 effettivi: Géza P e rjés ha infatti dimostrato che la quantità di vive-
23 0 M. VAN CREVELO, op. cit. , pag. 5 sgg.
23 1 ZRiNYI M1KL6S, Az olv as6nak, in: Hadtudomanyi munkai ... , cit., pag . 118 sgg. m Per quanto r iguarda Momecuccoli , già ne l Trattato della guerra.
ri che una data area può fornire sia all'acquisto che alla requisizione è proporzionale al numero degli abitanti. Occorrono per lo meno 35 abitanti p er km 2 perché un eserc it o vi possa so pravvivere per alcuni giorni; e al tempo di Montecuccoli solo la Francia, la Re n ania, le Fiandre e la Lombardia raggiungevano tale quota. Fuori da tali zone era impossibi le fare alcu n ch é sen za un accurato sis tema di magazzi ni: ed anche in quelle i viveri si sarebbero esauriti entro pochi giorni. Solo un secol o e mezzo più tardi sarebbe la popolazione europea cresciuta ad un tale livello da poter contribuire a mantenere i più n umerosi eserciti napo leonici 233 .
Montecuccoli non visse abbastanza per dotare l'Impe r o Absburgico di una rete di magazzini militari simili a qu elli che Le Tellier e Louvois d ettero all a Fra n cia di Luigi XI V; ma ne pos e le solide basi.

Nel Diciannovesimo secolo, ispirati da non altri che da Clausewitz234, un a fala n ge di sc rittori m ilit ari, per la quasi totalità tedeschi, si scagliarono co ntro il modo di far la guer r a dei secoli precedenti. Gli strateghi, a partire da Montecuccoli (che ne fu considerato il caposcuo la), vennero derisi e dis prezzat i per esse rsi fat · ti schia v i dei magazzini, il che avre bb e ridotto la loro condotta de ll e operazioni a qualcosa di misero e di meschino, costringendoli in particolare (ecco il feti ccio che rie merge !) a rinunciare ad una strategia annientatrice . Inve ce (così suona la leggenda) nell'età napoleonica questa sare bbe stata resa po ss ibile da una concezion e ampia e audace , fondata su lla rinuncia ai magazzini e sullo sfrutta mento delle risorse dei paesi traversati.
Lasc iamo a parte la questione de ll a mitica strategia annienta· trice, di cui si discuterà a~piamente più oltre, e limitiamoci per o ra al pro blema logistico. E intanto d el tutto falso che gli ese rciti dell'era di Moncecuccoli e dei decenni s uccessivi fossero impediti dal fatto di esser e ancorati ai magazzini. Il Van Creveld ha dimostrato in maniera conclusiva che, ma lgrado ogni sfo r zo, non più dell'll % dei rifornimenti prov eniva da questi; il resto fu sempre acqui sta to o requisito s ul posto: e che fu se mai propri o ciò (vale a dire la preoccupazione di op era re in zone ove si potessero tro-
233 GfzA PERJÉS, Mez6gaulasagi tennelés, népesség, hadseregélelmezés és stratégia a 17. Suizad masodikfelében {1650-1 715), Bud apest , 1963. Q uesta opera, cui si farà sovent e rife r im ento e di c ui è s tato pubblicaro un sumo in in glese (Army provisioning, logistics and strategy in the second Half o/ the 17th Century, in: Acta Historica Academiae Scientiarnm Hun garicae, Budapest, 1970} è il più im portante studio sulla logistica del DiciasseL· cesimo seco lo che sia fin'ora apparso.
m M. VAN CREVE LO , op. cit., pag. 17 sgg .
vare delle risorse) che ostacolò, rallentò e impedì le operazioni. I magazzini, dove c'erano e quando funzionavano, servirono piuttosto a togliere preoccupazioni ai comandanti e quindi ad agevolarne l' azione 235 •
Che poi la celerità delle operazioni napoleoniche fosse dovuta al fatto di essersi l'Imperatore liberato dalla schiavitù dei magazzini, è del tutto falso. Mai in nessuna delle sue maggiori campagne Napoleone si mosse senza essersi organizzata una accurata rete di magazzini, poiché l'esperien za gli aveva dimostrato che senza di ess i egli sarebbe stato costretto a subordinare la sua strategia alle esigenze logistiche, spostandosi là dove avrebbe potuto trovare dei viveri, esattament e come aveva dovuto fare Gustavo Adolfo 23 6 •
In conclusione la logistica dell' I mperatore non fu che lo sviluppo di qu ella dei suoi grandi predecessori, Montecuccoli in testa: solo, la maggiore dens ità della popolazione e la maggior e fertilità delle campagne gli consentirono di operare con eserciti assai più numerosi. Egli stes so però, quando dovette agire in zone sca rsam ente popolate, si ritrovò di fronte ai problemi del Diciassettesimo seco lo: basti pensare alle campagne di Spagna o di Russia 237 • Si aggiunga che il progressiv o ricorso al saccheggio delle truppe francesi (sotto la spinta della necessità) contribuì n o n poco a scatenare le terribili insurrezioni popolari di quei paesi. Lungi cioè dall'essere un progresso, il favoleggiato vivere sul paese era solo un ritorno alla barbarie ed alla tirannia del sacchegg,io e Napoleone cercò di evitar lo per quanto possibile.
Non esiste quind i alcuna divisione tra un vecchio ed un nuovo modo di pro vved ere alle nec essità logistich e, ché, anzi, i grandi scrittori militari del Seicento (Montecuccoli in testa) gettarono le basi delle logistica moderna cui Napoleone si attenne.
Ma come poteron o gli autori militari tedeschi dell'Ottocento diffondere un sì grossolano errore, ove si trovano le basi del discredito e della incomprensione in cu i Montecuc co li finì per ess ere lasciato cadere 238 ? «E fuori qu estion e» , scrive il Van Creveld239 , «c he solo uno scrittore di prim'ordine può ave r dato origine a tali
235 K. voN CLAUSEW ITZ, op cit , pag. 310.
2J6 M. VAN CREVELD, op. cit., pag. 25 .
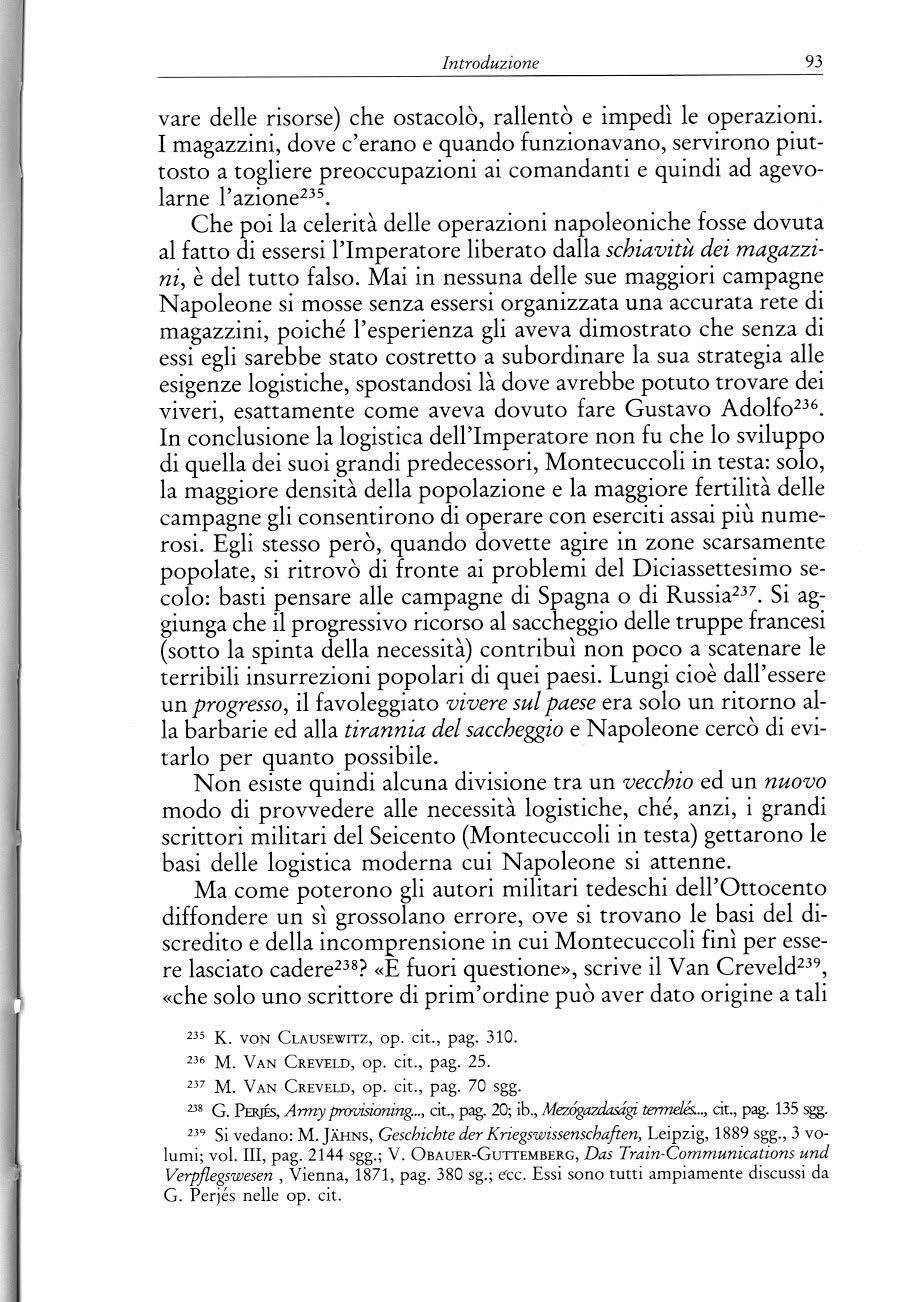
237 M. VAN CREVE LO, o p. cit. , pag. 70 sgg.
238 G. f>ERJÉS, Army prvvisioning , cit., pag. 20; ib., Me7/4,azdasagi t.ermelés. , cit., pag. 135 sgg.
239 Si ved an o : M. JXHNS, Geschichte der Kriegswi ssenschaften, Leipzig, 188 9 sgg., 3 volumi ; vo i. III, p ag 2144 sgg ; V. 0BAlJER- GUTIEMBERG, Das Train-Communications und Verpflegswesen , Vienna, 1871, pag 380 sg.; e"cc Essi sono tutt i ampiamente dis cuss i da G. P erjés nell e op. cit.
errori. I fili della ricerca conducono infatti al maggior critico militare di ogni tempo, Clausewitz. Non è per nulla sorprendente che egli sia stato la fonte di tali er rori, perché l'intera dottrin a prussiana si fondò sull'assunto che la guerra napoleonica fosse qualitativament e diversa e rappresentasse una soluzione interamente nuova>}.
Las cia mo per ora da parte la tesi secondo cui Clausewitz sarebbe da considerarsi il maggior critico militare di ogni tempo, il che è ampiamente discutibile: ma qui è colto il nocciolo del prob lema, così come nelle paro le di un altro studioso del Clausewit z, Géza Perjés: « questa opinione dovette la propria sopravvivenza e il proprio fermo inserimento nella scienza militare del periodo successivo non certo a quegli scrittori (gli studiosi tedeschi dell'Ottocento; n.d. C}. P er poter sopravvivere essa dovette venir sottoscritta da un nome assai più grande. La persona in questione era Clausewitz , il cui pensiero esercitò un influsso formidabile sulla scienza militare. E il prestigio di Clausewitz, la profondità filosofica e la natura metodica dell' opera sua... non solo garantirono una duratura esistenza alle sue verità, ma avvilupparono pure i suoi errori in un invol ucro protettivo la cui rottura avrebbe costituito in quei tempi un compito non solo difficile ma anche ingrato». E lo studioso ungherese prosegue mostrando co me alla base di tali errori vi fosse l'incomprensione che La natura della guerra in ogni epoca è fondamentalmente determinata dalle circostanze economiche e sociali240 • Cosa che, incidental mente, Montecuccoli aveva invece capito alla perfezione.
In sostanza il Nost ro si era r eso chiaramente conto che un comandante, « ..• prima di poter anche solo cominciare a p ensare di manovrare o di dar battaglia, di marciare in qu est a o quella direzione, di p e netrare, cir co ndare, avvolgere, di annientare o logorare, in breve, di mettere in pratica l'intera gamma della strategia, deveo dovrebbe - esser certo della sua capacità di rifornire i propri soldati ~on quelle 3000 calorie al giorno senza le quali cesserebbero ben presto di avere qualsiasi utilità come soldat i»241 • Ha quindi ancora una volta ragi one Géza Perjés di dire che i critici ottocenteschi di Montecuccoli «parlavano e si occupavano di qualcosa che era del tutto estraneo al la sostanza delle cose» 242 • Giustamente asserisce il Barker che l'attività di Montecuccoli nel ca mpo dell'organica e della logistica è ancor tutta da studiare: ma
240 G. PERJÉS, Anny provisioning , cit., pag. 21 sgg
241 M. VAN Ciu::vu.o, op. cic., pag. 1.
242 G. PERJÉS, Anny provisioning , cit., pag. 23.

già sin d'ora se ne possono tracciare alcune grandi linee. E~li stabilì i granatieri come specialità separata; ridusse la quantica delle picche in rapporto ai moschetti; introdusse l'artiglieria leggera reggimentale ad elevata mobilità; nonché una nuova comb inazione tra moschetti a miccia ed a pietra, a scopo sperimentale probabilmente solo nel suo proprio Reggimento. Riordinò sulla base di nuove disposizioni i rifornimenti dei viveri, modificò la frontiera militare con l'Impero Ottomano e riformò radicalmente l'addestramento. E questi non sono che pochi cenni: il Montecuccoli organizzacore ed amministratore militare atte nd e ancor a il suo studioso243.
Maè tempo di iniziare un rapido esame del pensiero e dell'azione di Montecuccoli sul piano operativo e strategico, il quale pure, come ogni altro, fu oggetto di incomprensioni e di deformazioni, sì che non è impresa facile t rarlo alla luce da sotto la mole delle assurdità e degli errori che in proposito sono stati scritti a man salva.
I principali responsabili di ciò furono qui gl i scritto ri ungheresi ott0centeschi, i quali, vedendo in Montecuccoli la longa manus degli odiati Absburgo, tentarono di sminuirne la fama contrapponendogli, come scrittore e t eorico militare, Mikl6s Zdnyi. Questi sarebbe stato fautore di una strategia risolutiva, annientatrice, mentre Montecuccoli veniva invece presentato come un cau to temporeggiatore, che faceva la guerra senza mai giungere ad una soluzione decisiva. Poiché per altro questi nazionalisti ungheresi non avevano il bagaglio intellettuale per espr im ere si mili giudizi, essi pure si rifacevano alle tesi di Clausewitz, che aveva criticato e ridicoliz zato il modo seicentesco e settecentesco di far la guerra definendolo metodismo, vale a dire un procedimento meccanico fondato su regole fisse: il famoso duello Turenne-Montecuccoli sarebbe stato un esempio di tale deteriore metodo, vero minuet-
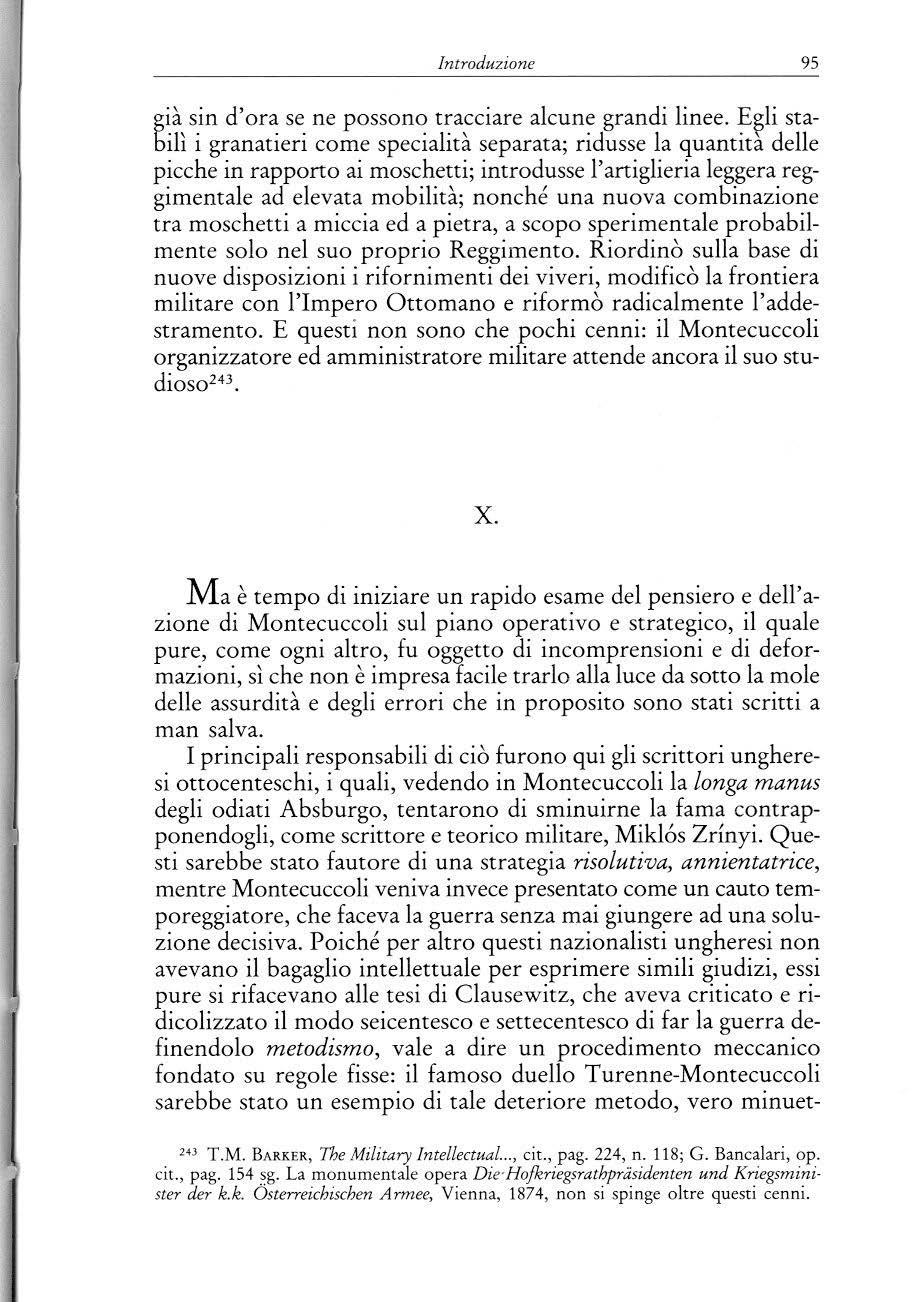
to militare, incapace di giungere ad una soluzione mediante una forzft bruta e un po' rude2 44 •
E stato anche qui il Perjés, cioè proprio un illustre studioso ungherese, a far giustizia di queste fole, dimostrando in maniera incontrovertibile che una anali si dell e opere di Zrfnyi e di quelle di Montecuccoli pone in evidenza la sostanziale analogia e la fondamentale identità del loro pensiero militare: il differente comportamento operati vo durante le campagne contro i turchi nacque dalla sfera più elevata che deve ispirare la condotta della guerra: quella cioè della politica. Mentre infatti Zrfnyi aveva a cuore la causa ungherese come egli la intendeva (ossia in funzione nazionale ed antiabsburgica), Montecuccoli sviluppava la po litica imperiale di cui egli era il massimo stratega ed i cui interessi egli intendeva fare .
Cade così la leggenda che Montecuccoli fosse un esponente del metodizmus e viene rivendicata la sua originalità di generale 245 •
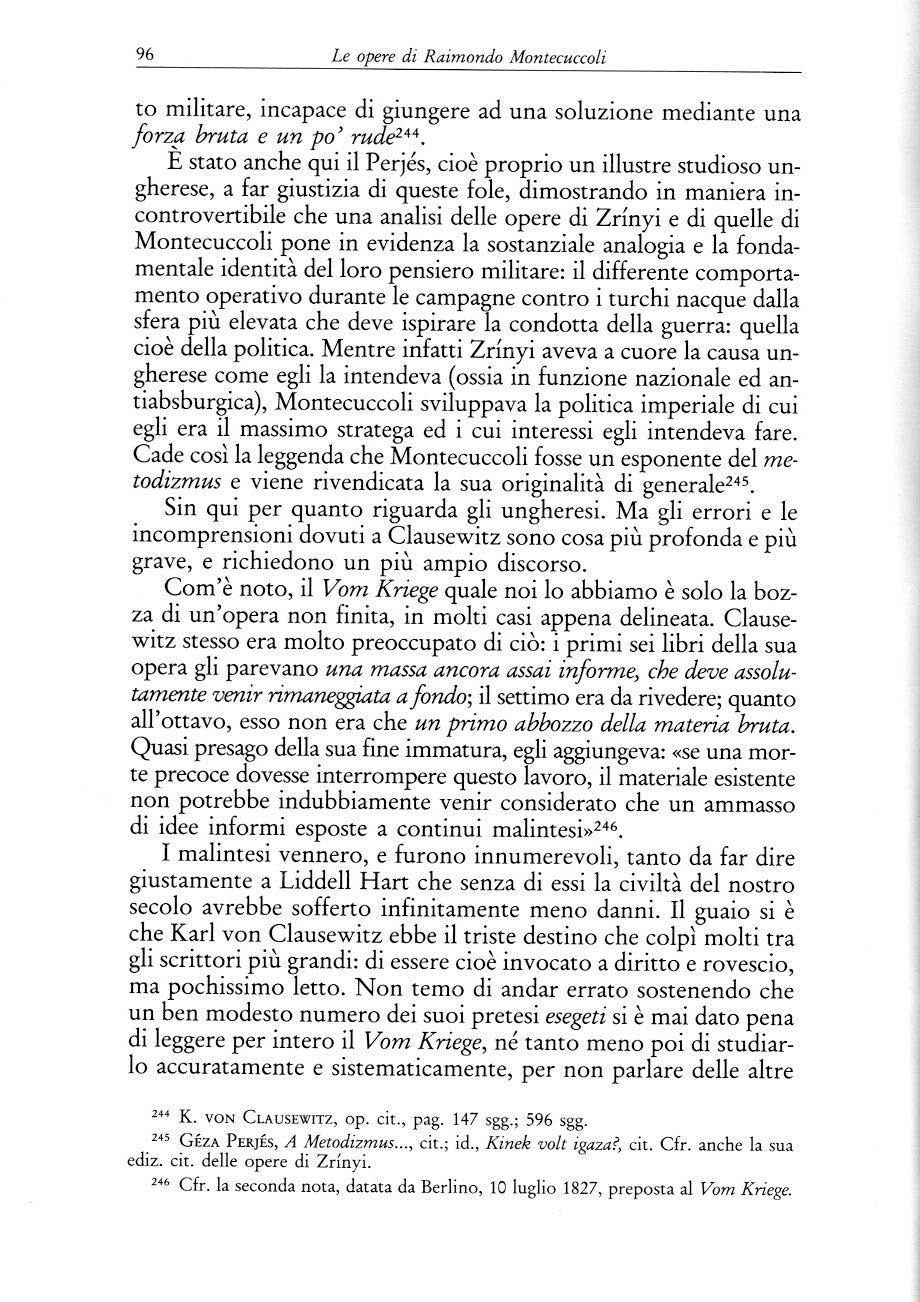
Sin qui per quanto riguarda gli ungheresi . Ma gli errori e le incomprensioni dovuti a Clausewit z sono cosa più profonda e più grave, e richiedono un più ampio discorso.
Com'è noto, il Vom Kriege quale noi lo abbiamo è solo la bozza di un'opera non finita, in molti casi appena delineata. Clausewitz stesso era molto preoccupato di ciò: i primi sei libri della sua opera gli parevano una massa ancora assai informe, che deve assolutamente venir rimaneggiata a fondo; il settimo era da rivedere; quanto all'ottavo, esso non era che un primo abbo zzo della materia bruta. Quasi presago della sua fine immatura, egli aggiungeva: «se una morte precoce dovesse interrompere questo lavoro, il materiale esistente non potrebbe indubbiamente venir considerato che un ammasso di idee informi esposte a continui malintesi» 246 •
I malintesi vennero, e furono innumerevoli, tanto da far dire giustamente a Lidde ll Hart che senza di essi la civiltà del nostro secolo avrebbe so fferto infinitamente meno danni. Il guaio si è che Karl von Clausewitz ebbe il triste destino che colpì molti tra gli scrittori più grandi: di essere cioè invocato a diritto e rovescio, ma pochissimo letto. Non temo di andar errato sostenendo che un ben modesto numero dei suoi pretesi esegeti si è mai dato pena di leggere per intero il Vom Kriege, né tanto meno poi di studiarlo accuratamente e sistematicamente, per non parlare delle altre
244 K. voN C LA USEWITZ, op. cit., pag. 147 sgg.; 596 sgg.
245 GÉZA PERJÉS, A Metodizmus.. ., cit.; id., Kinek volt igaza?, cit. Cfr. anche la sua ediz cic. delle opere di Zrinyi.
246 Cfr. la seconda nota, datata da Berlino, 10 luglio 1827, preposta al Vom Kriege.
sue opere e delle sue lettere. Chi lo facesse, finirebbe per accorgersi che il pensiero di Clausewitz non dìfferisce poi tanto da quello di Montecuccoli: e che le cose più sostanziose e concrete dette dal grande scrittore prussiano non fanno che confermare quanto Montecuccoli aveva già t eor izzato 24 7 •
In realtà si può sostenere che la parte più negativa, il vero caput mortuum del fensiero clausewitziano è proprio ciò che fu, nell'Ottocento e ne primo Novecento, più largamente acclamato, vale a dire tutta l'impalcatura filosofica che egli - allievo del kantiano Kiesewetter - volle dar e alla sua opera 24 8 • In essa egli elabor ò quel concetto della guerra assoluta che, co nc epito da lui come puramente teo rico, doveva dar luogo a tante distorsioni quando fu trasferito in cautament e a li ve llo pratico 249 • Non è tuttavia p oss ibile limitarsi ad accettare la spiegazion e secondo la qual e il pensiero di Clausewitz fu solamente deformato e frainteso: ciò non sarebbe potuto accad ere se non vi fossero state in lui ambiguità, errori di fondo ed incomprensioni che valsero ad aprire la strada al profluvio delle distorsioni.
Ebbene: se si esamina da v icino l 'opera di C lause witz, si può scoprire che l'errore basilare da lui compiuto (insieme a molti altri) è propr io l'essers i voluto avventurare su un t err en o filosofico; è proprio l'aver voluto esaminare il fenomeno della guerra sub specie aeternitatis e nello stesso tempo non ave r saputo rinunciare ad un manuale di carattere pratico e - quindi - contingente. Come ha ben giustamente osservato uno tra i critici più accorti , il Fuller, Clausewitz, dimenticando che la guerra assoluta è, per sua stessa ammissione, un pur o concetto logico (dunque inesist ente actu e non usabile n ella sfe ra pratica), id ent ifica la forma assolu -
247 B H. LlùDELL fu RT , Fore-<11ord, in Sun Tz u, The art ofwar, a cura di S B Griffith, Oxford , 1963, p ag v sgg
248 E owA RD N. LuTTWAK , u no tra i maggio r i e più aut orevo li sc ritto r i di strategia e di scoria militare del nostro tempo, mi confidò mes i addietro di voler preparare una nuova edizione del Vom Kriege in cui avre bb e fatto piazza pulica dell ' intera parte filoso · fu:a perché so lo così, aggiunse, si sarebbe potuto porre in luc e il n occiolo ve r amente so stanzia le e positivo dell 'in segn am ento del gra nd e p ru ssiano . D'alt r a parte già alcun i an ni o r sono un disti nt o u ffici al e d ella Bundeswe hr , il gener al e Ge rd St amp , r ipubb licando i l Vom Kriege per porne gli im mortali insegnamenti in r apporto alle es igenze dell'età nucleare , aveva operato praticamente nella stessa maniera Cfr.: Clausewitz in Atomzeitalter, a cura di G Scamp, Wiesbaden, 1965; trad . it.: Clausewitz nell 'era atomica, M i lan o, 1966.
249 Circa l'i nflu sso de l pensiero di Kant (e d i Schopenhauer?) su Clausewicz, cfr. : R.A 1MONDO LuRAGHI, l 'ideologia della «guerra industriale», 1861 -1945, in: Memorie Storiche Militari, 1980, pag. 169 sgg.
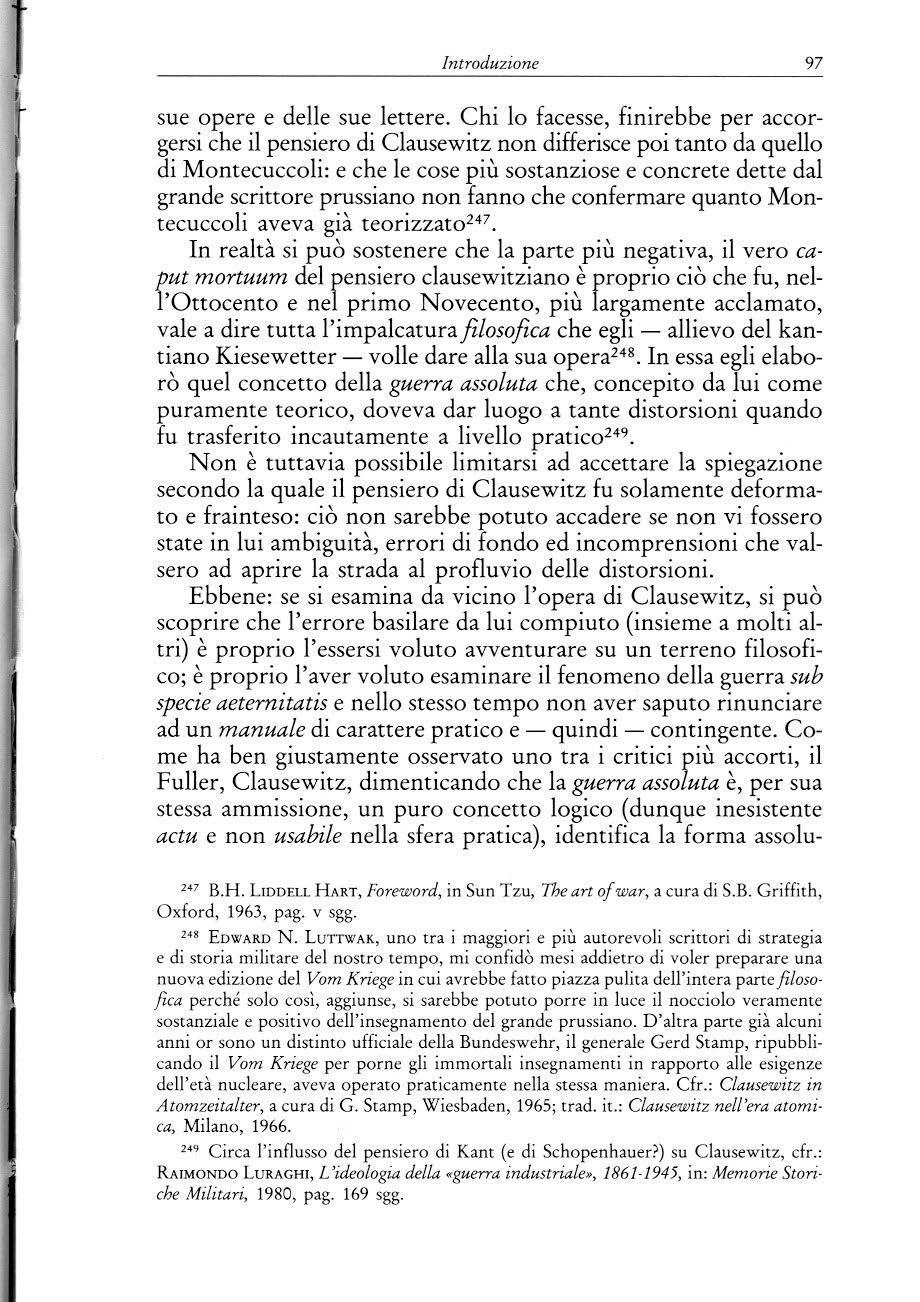
ta della gue rra con la strat egia napoleonica, fenomeno contingent e quant o altri mai 25 0 Ciò fece sì che i suoi seguaci prendessero per buoni alcuni tra i peggiori aspetti della condotta della guerra emersi nel periodo rivo luzio nario e napoleonico e considerassero Clausewitz un apologeta della violenza senza limiti, il che egli non era. Fu così che i s u oi discepoli si attaccarono a ciò che appariva essere la sua tesi per sviluppare la teoria e la pratica della «guerra totale» oltre ogni limite del buon senso 251 •

Da ciò nacque il mito della strategia annientatrice, la quale avrebbe (si supponeva) costituito il segreto napoleonico della vittoria: tesi che Clausewitz formulò essenzialmente per due motivi. Anzitutto perché, contrariamente a quanto si ripete senza beneficio di analisi critica, egli non comprese tutti i multiformi aspetti della strategia napoleonica, né si curò - almeno nel Vom Kriegedi st udiarli a fondo 252 ; inoltre perché, dando scarsa attenzione al1' organica ed all a logi stica, ignorò - come già s i è avuto occasione di dire - gli aspetti sociali ed economici della guerra . Ciò fece sì che egli non capisse che la presunta strategia annientatrice del1'età sua nasceva essenzialmente dall'enorme rivolgimento soc ial e causato dalla Rivoluzion e francese, la quale aveva sostituito agli eserciti professionali dei re assoluti la leva in massa (che aveva consentito ai generali uno spreco di vite umane ap parentementema solo apparentemente! - illimitato), insieme alla sua accompagnatrice inevitabile, la quale sola permetteva di porre le armi in mano ai cittadini e mandarli a combattere e morire: la guerra ideologica e di propaganda che avrebbe risuscitato gli orrori delle guerre di religion e e di quella dei Trent'anni 253
In realtà la strategia annientatrice era antica quanto il mondo; ge n e rali e teorici militari l'av ev ano st udiata e praticata in campagne che andavano da Platea a Leuttra, a Canne, al Metauro, a Zama, a Farsaglia, giù giù sino a San Gottardo. Raimondo Montecuccoli era stato un maestro di tale strategia : il Pi eri giustamente ricorda ch e eg li, già allo spirare della Guerra dei Trent'anni, fermati i franco-svedesi in Baviera, aveva proposto una strategia
250 J F.C. FuLLER, The conduct o/ war, 1789-1961, London, 1962, pag. 62.
25 1 B.H. L1 00ELL HART, Forew ord, cit., pag. v.
252 J.F.C. Fu 1LER, 1he conduct o/ war , c it., pag 75 sgg
m HoFFMAN N1cKERSON, 1he armed horde, 1793 -1939, New York, 1940, passim . L'enorme prob le ma de l sorgere degli esercit i di massa (e de l loro inevitabi le accompagnatore: la propag and a di g uerra) , la sua con nessione con la r ivo lu zione industriale e con il sorgere delle società borghes i, sono qu i trattati a fondo. Nel presente studi o ci si lim ita ad accen narvi.
di radicale annientamento del nemico: sfruttare la posizione centrale, piombare in Boemia, liberare Praga; poi, battuti colà gli svedesi, trasferirsi sul Danubio per l'urto decisivo 254 Lo stesso deve dirsi (è sempre il Pieri che parla) della fulminea duplice campagna per sbloccare Copenhagen nella guerra nordica: campagna la quale dovrebbe infine venir studiata a fondo, cosa che, per lo meno in maniera soddisfacente, non è ancora avvenuta 25 5 .
Che dire poi delle sue oEerazioni (e dei suoi piani di azione militare) contro gli Ottomam? Dopo San Gottardo, solo l'inco erenza e il rapido sfasciarsi della coalizione salvarono Ahmed Kopriilii dal totale annientamento; mentre i piani strategici che il grande capitano aveva preparato per la disfatta finale dei turchi furono alla base delle sfolgoranti vittorie del principe Eugenio di Savoia il quale, è opinione degli studiosi, li pose in pratica256 ; ma non fu senza difficoltà che Montecuccoli pervenne a far accettare la sua audace strategia ed i suoi geniali sistemi operativi. Già Carlo di Lorena, suo immediato successore, avrebbe conquistato contro gli Ottomani ben altri allori, se so lo si fosse data la pena di studiare a fondo la terza parte degli Aforismi; mentre l'idea di Eugenio di Savoia di assumere come base il Danubio era stata da Montecuccoli esposta nel modo più limpido - ma invano - alla Dieta di Ratisbona nel 1664. Eugenio poté applicarla senza chiedere nulla a nessuno: ma egli non e r a più costretto a dipendere da una esitante coalizione, poiché in mano sua stava quello strumento militare affilato ed omogeneo di cui proprio Montecuccoli aveva gettato le in crollabili basi25 7 • Montecuccoli però, come tutti i più grandi condo ttier i prima e dopo di lui, aveva ben compreso che, anzitutto, la strategia annientatrice altro n on è se non una tra le forme di guerra e le possibilità che si offrono al condottiero; e che altresì, in secundum, essa non è superiore n é inferiore ad altre forme in quanto la scelta non dipende, in ultima analisi, dalla volontà del generale ma da una serie di circostanze che egli deve saper valutare realisticam e nte. Altrimenti, invece che la via alla vittoria, essa può essere la strada maestra verso il disastro.
25 ' P. PIER I, Raimondo Montecua:oli e l'opera sua, cit ., in: Atti , cit. , pag. 46.

255 P. P1 ERI , ib id. , pag. 47 e passim .
256 K. PEBALL, Ra imund Furst Mon tecuccoli , cit , pag 301 ; G Bancalari , o p. cit , pag. 163 sg.
257 G. BANCALARI, op. ci t., pag . 163; A. G 1M ORRI , o p. cit ., pag. xLvm; P. PIER!, Guerra e politica , ci t. , pag. 93 sgg.; D EREK McKAY, Prince Eugene òf Savoy, Lo nd ra, 1977, pag 28 (q uesta de l McKay è a tutt'oggi la mig li o re biogra fia di E ugenio come general e} ; Feld zuge des Prinzen Ettgen von Savoyen, a cura dell ' Abte ilun g fiir Kriegsgeschichte del Kr iegsarchiv, Vienna , 1876 sgg , 20 vo lu mi, sp. voi. XVI e XVII.
Oltre venti secoli prima di Montecuccoli, il cinese Sun Tzu - se n z'altro uno dei pochissimi grandi Maestri di arte militare - aveva già visto con assoluta chiarezza che il più grande capitano non è co lu i che annienta il nemico: « •.• vincere cento vittorie in cento battaglie non cost itu isce l'apice della perizia. Superare il nemico senza combattere lo è>> E ancora: «Generalmente in guerra la miglior politica è catturare un paese intatto; distruggerlo è inferiore a ci o; catturare l'esercito nemico è meglio che distruggerlo; prendere intatto un battaglione, una compagnia o anche una squadra di cinqu e uomini è meglio che annientarli» 258 .
In precedenza Sun Tzu aveva elencato le condizioni per la sce lta della strategia: situazione morale, ambiente climatico e geografico, distanze, qualità dell'apparato di comando e, infine, scienza, cioè comando, controllo, organizzazione, situazione logistica e rifornimenti259.
Raimondo Montecuccoli non aveva mai letto Sun Tzu: ma negli Aforismi egli delinea le condizioni che conducono alla scelta della strategia più appropriata, con sorprendenti analogie: l'apparecchio (cioè l'organizzazione e le disponibilità di mat eriali e di finanze); la disposizion e (ossia i rapporti di forze, le condizioni geografiche , i fini che si intendono raggiung ere); infine la fase operativa. Solo in rapporto a ciò, val e a dire alla realtà ed alle possibilità, si possono scegliere gli strumenti operativi e strategici, e non fondandosi su principii astratti, privi sovente di risco ntro con la realtà stessa. Come il suo grande predecessore orientale, Montecuccoli aveva ben ch iar i i tre r equisi ti senza un buon funzionamento dei quali nessuna condotta delle operazioni è possibile: quelli cioè del comando, del cont rollo e delle comunicazioni. L'analisi minuziosa, poi, da lui fatta del tipo di guerra che s i doveva combattere non derivava, co me fu d etto, da pedanteria: ma dal fatto ch e solo l'as soluta chiarezza dei fini può dettare la scelta operativa e strategica, insiem e co n le effettive condizioni dat e dai rapporti di forza, dalla struttura organizzativa, dall'ambiente geografico e climatico, dalle disponibilità di mezzi e di denaro.
Come altrove, anche qui le teori e di Montecuccoli erano il rifl esso della sua esperienza di soldato e di generale: aveva comandato 41 campagne (o v i aveva pr eso parte); av ev a diretto decine
258 SuN T zu, The art of War, cit , p ag 77.
259 Su N T zu, op. cic. , pag. 63 sgg. È interessante osse r vare che, s ia il grande teorico cinese c h e M o nt ec u cco li , dicono in maniera n et t a ch e il fine de lla guerra è la vi ctoria, ind ipendentemente da i mezz i usati .

di battaglie 2 60 senza mai uscirne sconfitto, cosa addirittura eccezionale per un condottiero che per la più parte della sua vita (se non addirittura quasi sempre) si era trovato costretto ad affrontare nemi ci superiori di numero e di mezzi, od a combatterli in condizioni di quasi disperata inferiorità op erati va e strategica.
Ciò era stato possibile graz ie a quella che - tra le numerose sue doti - sembra, a mio avviso, la sua più splendida, quella da cui emana un insegnamento ancora valido e prezioso per l'oggi e il domani: la sua estrema flessibilità, la sua capacità di scegliere, con intuito più unico che raro, la so luzione operativa più adatta ad ogni circostanza. Così giustamente Th o mas Barker lo c ita come un maestro di qu ella che nel linguaggio strategico dell'o ggi si chiama a voidance, oss ia capacità di scansare la disfatta, di evitarla riuscendo sempre a trarre vantaggio da situazioni apparent em e nt e disp erat e26 1 • In ciò lo aiutarono altre du e su e qualità, la cui preziosa esse nza fu da Montecu ccoli distillata nelle sue opere: l'estrema abilità nell'economia delle fo r ze e la capac ità di usare la fortificazione come perno della manovra26 2 •
Tutto ciò derivava ancora dall e su e profonde riflessioni circa l'influsso d ella logistica sulla condotta op erativa: nella terribile Gu erra de i Tre nt'anni avev a b en v isto come ese r c iti disso lti da fam e, dise rzioni, co mbattività foll e, er ano stati r it r asformati in strumenti affilati ed efficaci da organizzatori quali Wallenst ein o Piccolomini; se la esige nza contemporanea di sviluppare una strat egia-logistica h a un antesignano, questi fu Montec ucc o li 2 63 • Così lo vediamo - quando se n e presentav a l'occasio nefautor e di una vera strategia di a nnientam ento ch e egli lucidamente teori zzò 264 ; ma nello stesso tempo, maestro della difen siva-controffensiva2 65; risolutamente innovatore nell'uso dei dragoni che egli concepiva puramente co me fanteria ce lere, precedendo di du e secoli Forrest e di tre le truppe cele r i dell'era contemporanea266 ; teorizzatore
260 C. CAMPORJ, op. c it., pag. 510 n.
261 T.M . BARK f.R, 7he Military !mellectual..., c it., pag . 225.
262 G BANCAURJ, op. cit., pag. 160 sg.
263 H. KAUFMANN, o p c it., pag 18; sulla strategia logistica, cfr.: Rai mondo Lu~hi, LA funzione del comando nella storia e nel presente, lezio ne tenuta nel 1984 al Centro Alti Studi Difesa delle Fori.e Armate Italiane, ora in Rivista Aeronautica, a.61, n. 4, l uglio-agosto 1985, pag. 2 sgg.
26 • P PJERJ, Raimondo Montecuccoli e l'opera sua. , cit. , in: Atti cit., pag SO, 57.
m P PlERI, ibi d , pag 47
266 Cfr. Aforismi. I. Anche: Julius Grossmann, Raimund Montecw:coli: ein &trag -zur Qsterreichischen Geschichte des xvii Jabrhunderts, wmemlich der jahre 1672-1673, in: Archiv far Osterreichische Geschichte, 1878, n. 57, pag. 101 sgg; e: Filippo Luigi Polidori, Appunti per servire alla vùa del Principe Raimondo Montecuccoli: relazione della campagna del 1673 e alcune lettere del/,o scesso, in: Archivio scoruo italiano, 1847, n. 5, pag. 107 sgg.

di un sistema di guerra moderato, come nelle campagne in Occidente contro Turenne, e di un altro capace di spingersi alla lotta più implacabile senza esclusione di colpi, dalla guerriglia al sabotaggio fino all'uso di aggressivi chimici e batteriologici: e ciò (ecco nuova ment e la risposta Flessibile) in dipendenza dalla ferocia e crude ltà del nemico, andando cioè con pii di piombo e mano di ferro. Non e ra quindi Montecuccoli uomo da minuetti militari; e quanto alla battaglia, scriveva egli stesso che l' idea di risolvere le s it uazioni operative senza combattere sà del chimerico; ma tutti gli stru m enti operativi erano in lui, appu nto , strumenti, e non divennero mai fini o, peg~io, miti. Ben a ragione il Pi eri, citando il caso di Carlo XII, mostro dove conduceva la smania svedese del combattere ad og n i costo, che fu la più funesta eredità di Gustavo Adolfo 267
L'in comprensione di Clausewitz fu dunque dovuta alla errata lettura che il grande teorico prussiano fece dell'arte militare napoleonica. Nella sua interpretazio n e volontaristica della storia che so ttovalutava i fattori sociali, economici (e tecnologici!), Clausewitz non seppe vedere come qualmente ciò che a lui pare va una trionfale affermazione del metodo annientatore sul piano operativo e strategico dovunque e semp re, era so lo il prodotto di una rivoluzione più profonda e gravida di conseg u enze di quella stessa di cui, sul piano politico, eg li ed i suoi contemporanei era no stat i testimoni e che, con la democratizzazione della guerra, aveva posto a dispos izione dei capi masse immense, fanatizzate (o, per lo meno , scaldate a bianco) dalla propaganda. Qu ando sarebbe entrato in gioco il terzo fattore, di cu i Clau sew itz, per la brevità della sua esistenza, non riuscì ad essere testimone, cioè la rivoluzione industriale, la strategia annientatrice avrebbe cominciato a porre in mano a quelle masse i più micidiali strumenti di distruzione e la violenza sarebbe salita al parossismo. Malauguratamente, generali e dottrinari de.li' epoca, accecati da una errata interpr e tazione del mito n apoleonico, n on seppero vedere che la nuova tecnologia s ignificava anc he la prevalenza della dife sa sull'attacco.
Le conseguenze apparvero ben chiare nel metodo operativo di uno tra i maggiori generali della storia, Robert E. Lee, e del suo avversario Grant 268 Ben a ragione scrive in proposito Ru sse ll F. Weigley: « Lee era troppo napoleonico. Come Napoleone stesso, con la s ua passione per la strategia annientatrice e la battaglia
267 P. P1ER'. Raimondo Montecuccoli e l 'opera sua , c it., i n: Atti cit., pa g. 50; c fr. a nc he: BEN GT ASHL U N D, Milùary hist ory in the age of the Enlightenmen t: the case of Charles Xli ofSwedl'TI, in: Revue lmemauonale d'Hist oire Militaire, Acta n. 7, 1984 , pag. 90 sgg
168 S uN T zu, The art of War, cit., pag. 77

fondam entale e d ecisi va quale sua espress ion e, egli alla fine annientò non già gli eserciti nemi ci, ma il suo proprio »269 • Napoleon e, infatti - che pure ave v a cercato di salvaguardare le vite dei propri soldati -, usando senza economia in una serie di battaglie decisi v e il suo potenziale umano, se n e era trovat o alla fin e quas i pri v o: e la Francia, stanca, lo aveva abbandonato. E in Europa, o ve nulla si seppe della terribile esperienza della prima guerra indus triale della storia, combattutasi in America, si continuò a teori z zare ed a praticare il metodo operativo annientatore, sino alla follia omicida della Prima guerra mondiale 2 70 •
Certo, Clausewit z non può essere ritenuto responsabile di ciò: il fatto è che le sue dedu z ioni errate circa gli insegnamenti da trarsi dalla strategia napoleonica cal zavano fin troppo ben e con la gu erra democratica , di massa che l'era della rivoluzion e industrial e si appr estava a combattere con mezz i, per la prima volta, pressoché illimitati; così i suoi successori scelsero volentieri di dimenticare tutti i preziosi insegnamenti del grande teorico prussian o, accanendosi su quanto di più errato e caduco era dato ris contrare nel suo abbo zz o di trattato. Solo il suo grande ri vale, Jomini, intra vvid e le funeste conseguenze di tale orientamento, quando , già ottuagenario, previde « una lotta quanto mai insensata tra eno r mi masse munite di armi di poten z a inimmaginabil e . P o t re mmo dover ve der e nuo v ament e scontri di p opoli, co m e qu elli del Quarto secolo; potremmo ess er costretti a v iv ere nuo v amente i tempi degli Unni, dei Vandali e dei Tartari» 27 1 •
Oggi più che mai si impone una rilettura di Clausewitz: solo l'eliminazione di ciò che in lui è morto v arrà a porre in lu ce il grande , vivificant e apporto del suo p ensi ero. Sarà possibile o ss ervare allora quanto egli ripercorra le stesse strade che il genio di Montecuccoli aveva , oltre un secolo prima, esplorato.

269 R usSE LL F WEJ<, LEY , The American way of war · A history of United States military st rategy and policy, N ew Yo r k and London, 1973, pag . 123 .
270 J.F C. FULLER, Th e conduct o/ war..., c it.
271 Cfr.: J. F.C. Fu ll er, Armament and History, New Yor k , 1945 , pag 104; RA1MONoo Lu RAG HI, The Civil Wa r and the modernization of Amer ican society; socia! structure and industriai revolu tion in the Old South be/ore and during the war, in: Civil War History, voi. xv iii, n . 3, 1972, p ag . 230 sgg.; ANTO I NE H ENRI DE }OMINI, Précis de l'art de la guerre, Par ig i, 189 4, 2 vol umi (l ' e d iz. p iù rece nt e , Pari gi , 1977, r ipro d uce q uella del 1855 e n o n ha qu indi le ap pendici in cui son o conte nut i g li interessant iss im i co m ment i d i ] o m ini s u ll a Gue r r a civ ile americana); R. Lu RAGHl , L'ideologia della guerra industriale cit. , pass im.
M a il ca mpo in c ui Mont ec uccoli eccelse com e ben po chi, fu quello della st rategi a globale. P erfet tam en te padrone del rapporto tra politica e guerra 272 , capì a n che tutta la carica di irrazionalità insit a nel fatto bellico; in questo egli - razionalista - fu cert ament e aiutato dai complessi s tudi sull'irrazionale fatti dal suo M aes tr o Campanella, le cui opere M ontecuccoli esam inò profonda me nte nello Z ibaldone. I fattori psi co logici, sociali, religiosi della guerra gli furo no presenti: senza tema di errare, si può dire che Montecucco li comprese che la guerra è anche la continuazione della po liti ca con me zzi differenti; ma anche altro 273 • Già si trovano in lui , ben sviluppat i, tutti i principii della gue rra psicologica e della psicologia militare usata come strum ento bellico; la dinamica, i principii e la metodologia dell e az ioni di com mandos; infin e lo stuaio del terro rismo co me strum ento di stra tegia gl obale n on c hé i principii d ella lotta antiterroristica : ed ac canto a ciò persino la tecnica del co lpo di stato co me stru mento di azione bellica sia inte rna che int e rnazion ale, e qu ella del contro-colpo, analizzate co n un'acutezza che n e fa anche qu i un ant esignan o. Problemi tutti che solo oggi, dopo la Seconda guerra mondiale, gli studiosi mi litari hann o scoperto . Le terribili esp erienze della Gue rra d ei Trent'an ni e d ei co nflitti co ntinui co n 1 turchi incisero profondam e nte su di lui 2 7 4 ; in questo se nso l 'aver vissuto attrav e rso qu ei tempi di ferro gli dette una visio n e d el fen om eno guerra molto più complessa, articolata e disincantata di qu ella che avrebbero avuto poi i grandi p e nsatori militari pr ece denti l a Rivolu z io n e fran cese. Il prin cipale r equis ito della strategia g loba le - una larga vis ione politica - fu il pilastro d el pensiero di Montecuccoli. Aveva i n sos tan za una formidabile capac ità di ve d e re in gran d e, n elle sue co nnessi on i, la poli tica e ur op ea, il che lo portò ad individuare il nodo essenziale dei pro bl emi che riguardavan o la difesa dell' Impero Absburgico: la questione turca; per c ui logicame nt e d ivenne deciso assertore dell a rapida (anche se n on preventiva) elimin azio ne de lla min acc ia tur ca e di qu ell a frances e , co rr ettame nte vista come concomitante con la prima 2 75 •
272 P. P1 ER1 , Guerra e pol itica , ci t. , pag 93 sg ; n. pag. 94 sg.
273 Per cali prob lemi, rima ne indispe nsab il e la monum entale ope ra di QUINcY WRJ G HT, A study o/ War , Chicago, TII ., 1966
m H. KA UFMANN, o p ci t ., pag 18.
275 H . KAU FMANN , op. cit., pag. 25.

Si è ribadito che egli ostegg iò la guerra preventiva che considerava una follia: ma, con sicuro intuito della strateg ia globale, fu un abi le fautore dell'uso della forza potenziale, cioè della minaccia della forza senza il diretto uso di essa: criterio quanto mai attuale e che ne fa uno stratega globale di prima grandezza. U n mode ll o in qu esto senso fu l'abile, continua pressione mediante la minaccia dell'uso della forza che egli mantenne nei confronti dell'Impero Ottomano dopo San Gottardo e che valse agli Absburg'o vent'anni di pace in Ungheria. Solo dopo la sua morte ardirono i turchi muovere nuovamente all'attacco 276
Ma perché l' Imp ero potesse utilmente usare la minaccia della forza, occorrevano due cose, e Montecuccoli vi attese con tutta l'energia della sua v ita: una forza armata p ermanente, e di ciò si è detto; ed un sistema di fortificazioni che lo rendesse praticamente impenetrabile, sottraendolo alla minaccia della forza altrui. Montecuccoli vi si impegnò a fondo. Autore egli stesso di profondi studi sull'arte fortificatoria, e in polemica con altri specialisti277, il Nostro studiò accuratamente il piano delle fortezze destinate a proteggere i territori absburgici. La chiave dell'Impero (e d ell'Europa centrale) egli individuò con suprema acutezza nella Boemia, con i suoi antemurali: la Moravia e la Slesia. Colà do vev ano essere erett e ben 18 d ell e costruende fortezze, fatte in modo da garantirsi vicendevole copertura, laddove per proteggere le terre ereditarie di Casa d'Austria e l'Ungheria tre o quattro per zona potevano bastare 2 78 • Egli aveva intuito che tenendo il massiccio boemo si teneva l'Imp e ro. E la Germania.
Se vogliamo ora dare uno sguardo di insieme alla strategia globale di Montecucco li, una intuizione si affaccia: eg li fu uno degli ultimi difensori di i mperi dell'età modern a 279 Un impero (e Montecuccoli lo intuì: lo si vede chiaramente dalla sua strategia globale) è qualcosa di ben diverso da uno stato n azionale. Esso non è omogeneo; popoli e culture di ve rs e n e fanno part e ed esso è ino l-
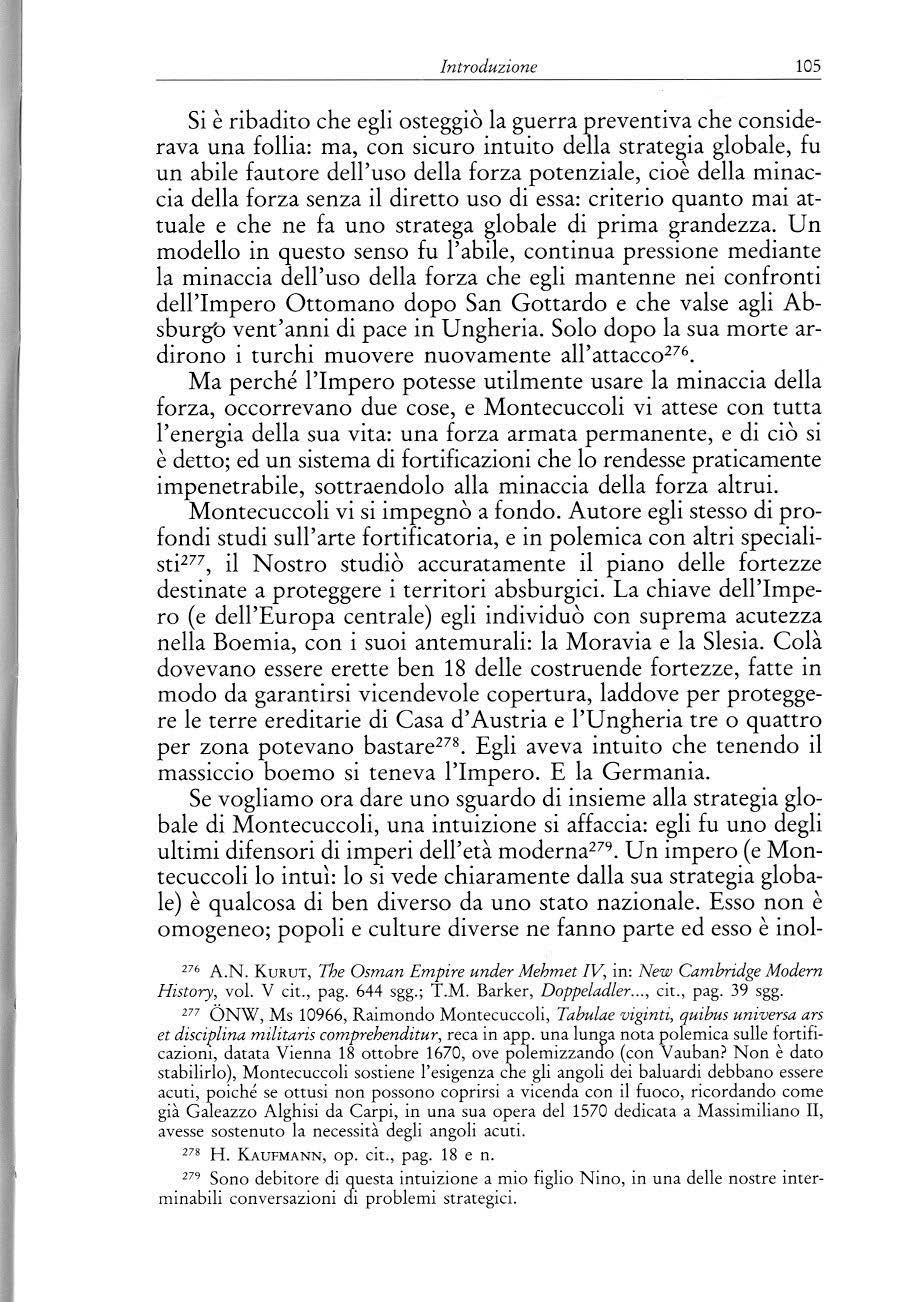
276 A .N . KuRUT , The Osman Empire under Mehmet IV, in: New Cambridge Modem History, voi. V c it ., pag 644 sgg ; T.M. Bark er, Doppeladler , cit., pag. 39 sgg.
2 77 ONW , Ms 10966, R aimondo Montecucc o li, Tabulae viginti, qu ibus universa ars et disciplina militaris comprehenditur, reca in app . u na l u nga nota p olemica su lle fortificazio111, datata Vienna 18 o tt ob re 1670, ove polemiz za ndo (con Vauba n? No n è dato stabi li rlo), Montecuccoli sosti en e l'esigenza ch e gli ango li d ei baluard i de bb ano esse re acuti, poiché se ottusi non possono copr irs i a v ice nda con il fuoco , r ico rdando come già Gal eazzo A lgh isi da Carpi, in u n a s ua opera de l 1570 d ed ica t a a Massimiliano II , avesse sost enuto la necessità degli angoli acut i.
27 8 H KA U FMANN , op cit., pag. 18 e n .
279 _So n o deb itore d_i q_uesta intui z ione a -~ io figlio Nino, in u na delle nostre i ntermmab 1h conve r saz10n1 d 1 pro b lemi st r a teg1c1 .
tre munito di un'ideologia transnazionale che gli dà praticament e un'illimitata forza espansiva28 0 • Secondo Montecuccoli due erano le direttriçi ove l'Imp ero Absburgico (egli lo concepì modernamente cosi: non già come Sacro Romano Imp ero Germanico) doveva cautamente espandere la propria influenza: l'Ungheria e lo spazio tedesco. E là ci si incontrava con la Francia e gli Ottomani. Non ci fu mai ombra di dubbio per il Nostro che la Francia dovesse venir rimandata oltre il Reno, e l'Impero turco spinto fuori dai Balcàni: la campagna militare da lui abbozzata nella terza parte degli Aforismi non lascia dubbi in proposito.
Ma - ed è questa la cosa che trascende ogni altra, e c he richiederebbe uno studio a fondo -, egli riteneva - seco ndo ogni evidenza - che il fine ultimo degli Absburgo dove sse essere difensivo. Allontanata la minaccia turca e neutralizzata quella fran cese, sarebbe stato imprudente spingersi oltre; con la Francia eg li sembrava addi ri ttura pensare ad un compromesso. Il segreto era conservare. Fu così Montecuccoli un o tra i primi - se non il primo artefice - di quella cauta politica europea absburgica che fece dell'Impero di Casa d'Austria un fattore di equilibrio, di st abilità e di pace. E che gli garantì altri due secoli e mezzo di vita. Non ci si può - almeno allo stato attuale degli studi - porre il quesit o di che cosa avrebbe fatto Montecuccoli quando, risolto il problema turco e quello francese, si fosse riaffacciata la vera, grave questione st rat egica globale che sembra rodere alla base l'essenza stessa degli imperi: quella cioè dell'in ev itabil e ripres e ntarsi di una rinnovata minaccia periferica, o di si tuazioni vissute come tali (il che è, sostanzialmente, lo stesso : si pensi, per l'appunto, alla questi one serba) . Qui stette, in ultima analisi, il fato d ell' I mpero Absburgico. Solo lunghe, minuziose ricerche s ull'imm ens o patrimonio delle s ue lettere e dei documenti collaterali che giacciono ancora inesplorati negli archivi potrebbe forse co ndurre a chiarire il suo pensiero su tale basilare problema .
Una osservazione che sembra opportuno fare, è che l'indirizzo strategico globale previsto da Montecuccoli per lo stato absburgico differiva radicalmente da que ll o che a s uo tempo aveva perseguito Wallenstein. La P ace di W estfalia aveva posto fine ad ogni possibile programma tedesco da parte della Corte di Vienna:
280 Sul co nc etto di imper o so no fondamentali: EowARD N. LuTTWA K , The grand stra· tegy of the Roman Empire, Baltimore, Md, and London, 1976 (crad. it.: Milano, 1983); e : id., 7he grand strategy of the SQ'!/Ìet Union, London, 1983 (trad it. con Introd. di R. Luraghi, ove viene analizzato in generale il concetto lunwakiano d i impero: Milan o, 1984) .

e il Nostro ne aveva certamente saputo trarre le conclusioni. Sarebbe anche interessante riuscire a stabilire (ammesso che, con la documentazione esistente, mai lo si possa) fino a che punto non sia stato proprio il programma nazionale tedesco del Duca di Friedland a causarne (o ad accelerarne) la rottura inevitabile con la monarchia absburgica, laddove la strategia globale di Montecuccoli quadrava perfettamente con le aspirazioni di questa .

Si giunge così all'ultima questione. Essa è, in fondo, tanto banale éhe non varrebbe la pena di occuparsene: ma poiché può contribuire a darci una più profonda conoscenza del Nostro, si spenderanno su di essa due parole .
Si tratta dell'accusa lanciata contro Montecuccoli nel Risorgimento di essere stato un transfuga, postosi al servizio dell'Austria. A parte il fatto che durante la Guerra dei Trent'anni 43 Reggimenti di fanteria imperiali su 196 erano comandati da italiani, i quali annoveravano ancora 4 tenenti-generali su 12 e 10 Feldmarescialli su 43 281 , va ricordato che questa tesi (che oggi a noi pare - ed è - assurda) nacque in una temperie ove, come scrisse il Croce, « ... l'Italia si trovava tutta impegnata nelle lotte politiconazionali; e l a storiografia italiana, concorrendo in quelle lott e, si delineava secondo gl'interessi che le movevano e si colorava delle loro passioni)) 282 • E si può quindi, ancora con il Croce, sottolineare che un'Italia quale la sognarono e la realizzarono i patrioti del Risorgimento, ai tempi di Montecuccoli non esisteva: e che italiani, allora, si era affermando i valori universali della cultura che era nostra, ed in ciò Montecuccoli non fu mai secondo ad alcuno. Italiano di lingua, di cultura, di sangue Montecuccoli si sentì sempre; la sua corrispondenza in tedesco è scarsissima; i suoi appunti, i suoi testi, le sue opere, tutto è in Italiano, ed il capitano Veltzé ha dovuto (con opera per altro meritoria) tradurli in tedesco affinché gran parte dell'ufficialità di quell'Esercito, di cui Montecuccoli era stato il creatore, potesse più correntemente leggerli. Si può quindi ben concordare con il giudizio di uno tra i suoi maggiori studiosi, che Montecuccoli, con il suo altissimo livello sia nelle arti della guerra che in quelle dello spirito era il rappresentante ideale della sua nazione, ric ercato, rispettato, lodato in pace come in guerra 283 Soldato e difensore di un Im pero transnazio -
nale, Mont ecuccoli incarnò qu ell'ideal e univers ali stico mitt e le uropeo che r imase ed a ncora è v ivo nella t radi z ion e vie nne se e c he oggi gli stu dio si co min cian o i nfine a valut are co m e il re sidu o di un temp o forse mi gliore e ormai passato.
A ciò lo aiutaron o e lo pr edi sposero anche le s u e enciclopedic h e conosce nze. Se le lingu e so no un o strument o indispensa bile p e r abbracc iare il mo ndo in un ' ampia v isione politi ca, M o nt ec uccoli fu dotato per ciò come po c hi altri. Perfetto conoscitore, oltre ch e d ell'italiano e del ted es co, an c h e del latin o, del fran ces e, d ello sp agnu o lo, padr o neggiav a assai b e n e lo s vedes e, l'un gh e rese, il turco e l'in glese 283 bis .
La sua c ultura universale fu dunqu e la base e il punto di part e nza del suo tenta t i v o, dura t o una vita , di sviluppare la sc ie nza e l'art e d ell a guerra co me una disc iplina es atta, di t ipo ma te matico , e in quanto tal e priva di pr ec ettistica ma fondata su un m etodo dinami co. Profondo conosc itore della teoria neo-stoica dello stato, fu il primo sc ie n ziato militare m o d e rno; ve r sato in sc ie nz a d ella p o li t ica, andò b e n oltre la conce z io n e clausew itziana del legame fra p o litica e gu e rra sin o ad elevars i (giova ripeterlo an cora una volta) ad una vi s ione globale politico-strategi ca in cui l'uomo di stato c h e egli e r a a ppar e altrettanto grande d el ge neral e .
A v ant i ai s u o i te mpi an c h e in ci ò, aveva racco l to tutt e le su e carte in un archivio privato sec ondo un ordine prec iso e raz io nale, conserv andole nella propria biblioteca privata c h e era nella sua cappella 284 • Così a lui dobbiamo an c h e la straord i naria compl et ez za d ella sua eredi tà docum e ntar ia. Essa è, prim a ancora c h e un patrimoni o della t e rra ove div enne grand e e di qu ella che gli dette i natali, un legato all'intera cultura europ ea.
m 1xs il K aufmann, che elenca le lingue parlate da M o ntecuccoli (op . cit., pag. 35), d i mentica l'inglese, il quale invece (come r isul t a dalle fo nt i, da lui elenca te, del Della Guerra) egli sapeva per lo meno leggere e probab il m e nte anch e parlar e, di versame nt e n o n s i sp ieg h erebbe il su o collo qui o co n C romwe ll c he fu chiaram e nte cond otto se nza interpret e Assai p r o ba b ilmente egli co n osce va an c he il gr eco antico : saliva così a dieci lingue il s uo patrimonio.
284 H . Jv. u FMANN, op. ci t., pag . 35 e n. 16, pag . 98.
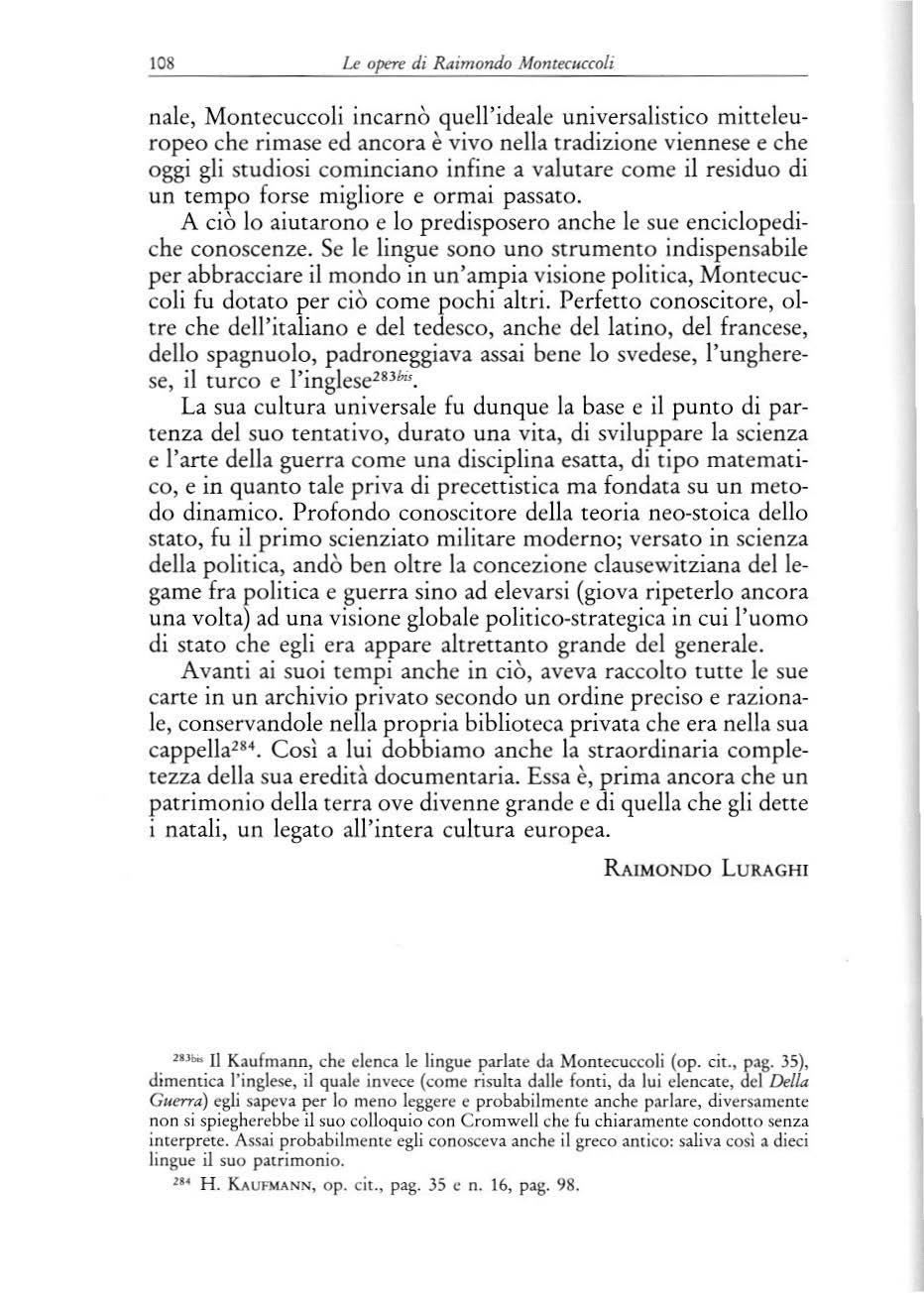
I manoscr itti di Raimondo Montecucco l i so n o sparsi in al meno dodici archivi si tuat i in tre diversi paesi: Austria, Italia e Cecoslovacchia Essi non sono mai stati studiati in modo sistematico, né tanto meno ra ccolti o pubblicati nella loro int erezza e ne l testo originale riveduto criticamente Allo stato di cose attuale, ecco, sommariamente, la loro situazione.

1 - Osterreichisches Staatsarchiv - Kriegsarchiv, Vienna. Esiste qui la più vasta e completa collezione, formata dal lascito delle carte di Montecuccoli così come egl i stesso le aveva ordinate in vita nel suo archivio pe rsonale (Nachlass Montecuccoli}; occorre però tener presente che le grandi dimensioni di questa raccolta hanno sovente fatto dimenticare che in questo stesso archivio altre, fondamenta li cart e di Montecuccoli si trovano nella collezione degl i Alte Feldakten .
Nachlass Montecuccoli.
I manoscritti, riordinati da Kurt Peball , sono raccolt i in se i gruppi, di cu i l'ultimo contien e il carteggio. Trovansi qui tutti i manoscritti originali degli Aforismi, un apografo del Trattato della Guerra nonché il secondo Delle Battaglie e il manoscritto del Dell'arte militare e un apografo tardo (1889) dell'Urschrift delle Tavole Militari il cui originale era a Milano alla Trivul zia na e andò distrutto durante la Seconda guerra mondial e . Degli Aforismi vi è anzitutto lo scheletro, o sommario, di pugno di Montecucco li , il quale reca la data 1670 (Scheletro dell'opera del Principe Raimondo Montecuccoli intitolato Aphorismi della Guerra contro il Turco) . Esso appare zeppo
a)d i var ianti e di ca ncell at u re Segu e poi (se mp re di p ug no d el !' A ) un a stes ura sintetica più corrente; poscia - in un volume rilegato - il manoscritto definitivo (Della Guerra col Turco in Ungheria, 1670) esso pure totalmente di mano del Montecuccoli, con ancora ulteriori cancellazioni e modifiche; i n fi n e il testo fi na le, copiato i n bell a scr it tur a cors iva da un am anu ense (ma con an co ra cance ll azioni e co rr ezioni aut ografe di M ontecucco li ) de l I libro; due alt ri volumi a mano raccolgono le copie dei libri III (con impresso sul dorso il numero II) e infine del II, tutti rivisti e qua e là corretti in autografo da Montecuccoli. Questo è dunque da considerars i i l manosc ri tto ultimo ed autentico d egli Afo· rismi, qu ell o c h e è ripro dotto a stampa nella prese n te edizi o n e (ma ch e è stato cos t antemente riscontrato sulle s t esure preced enti di cui sopra) (ms . K 11I-1v, Ab.dl i , 7).
Il Trattato della Guerra appare chiaramente una copia, né vi sono correzion i di mano d i M ontecuccol i; le var ianti risp etto al testo modenese so n o m in i me, me nt r e ques t'u lt i mo sem b ra più acc ur ato e pos t o i n be ll a co p ia forse sotto il controllo stesso dell' A.; anche il viennese tuttav ia era stato certamente visto da lui, provenendo dal suo archivio personale. L'autenticità è suffragata ancora dalla sosta n ziale identi t à d ei due documenti . Ve ne è poi i n Nachalss Montec uccoli u n a te rza cop ia che appa r e di fatt ura ass ai p i ù t a rd a, p r odotta, a quanto risu l ta, n el 1888 (ms. K 11I-1v, Ab .d/1, 1-2) .
Il manoscritto con la seconda stesura del D elle battaglie, pur non apparendo di mano del Montecuccoli, è però coevo (non si dimentichi mai che tutto questo materiale proviene dalle carte archiviate perso n almente da ll 'A.) e reca a p en na, i n gr afia settecentesca, la dat a «1673» Più c hi ara me nt e (come si è avuto occasione d i dire) il Dell'arte militare reca di mano di Montecucco l i la data «Sa lmiinster 29 novembre 1673» (ms. K 111-1v, Ab.d/1, 10-16).
Il ms . contenente l' Urschrift delle Tavole Militari è del 1889 e, come si è notato, deriva da ll 'origina le p erdut o de ll a Tr ivu lzia na d i M ila n o .
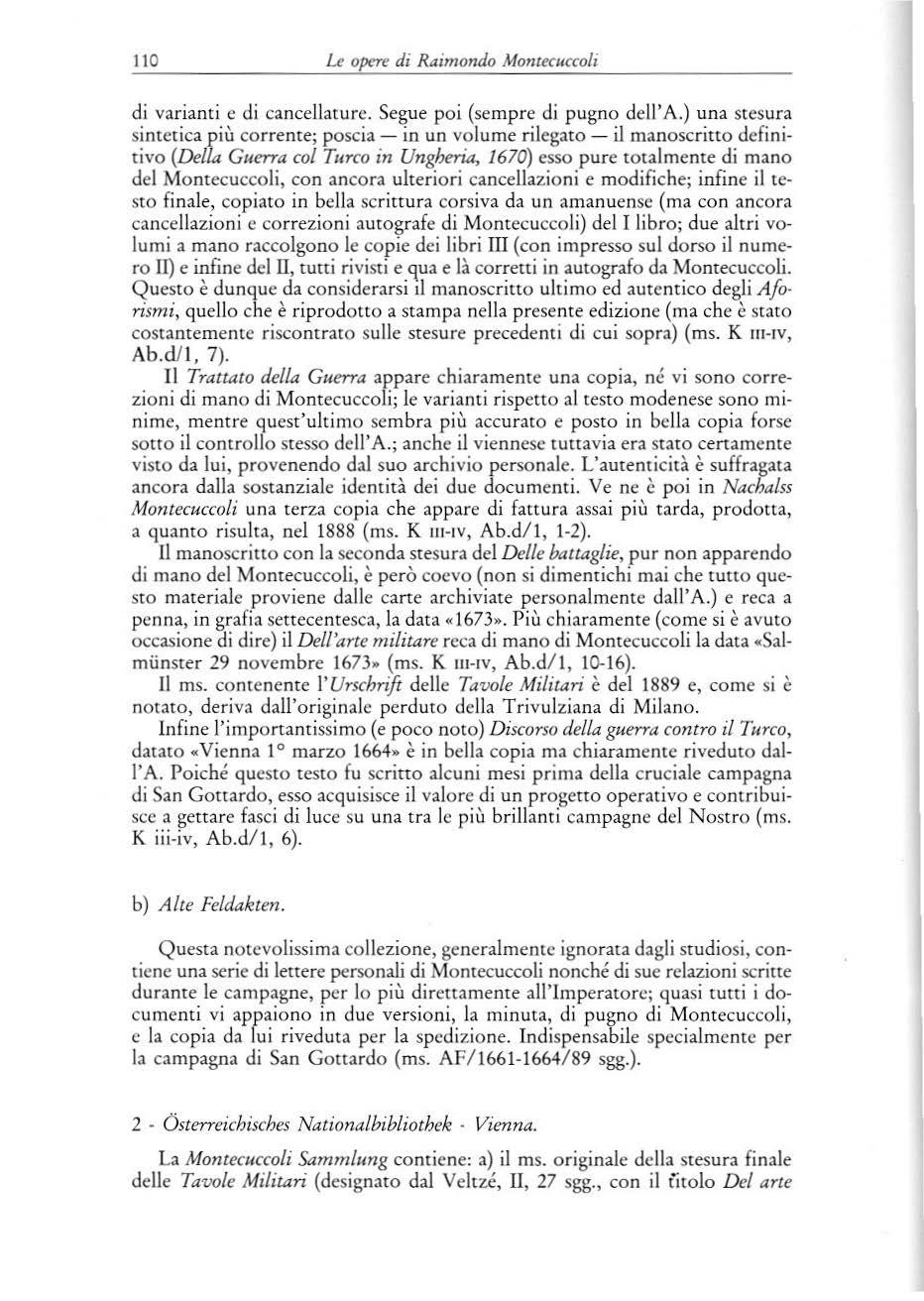
In fi n e l'impo rta nt issimo (e poco noto) Discorso della guerra contro il Turco, datato «V ienna 1° marzo 1664» è in bella copia ma chiaramente riveduto dal]' A. Poiché questo testo fu scritto alcuni mesi prima della cruciale campagna di San Gottardo, esso acquisisce il valore di u n progetto operativo e contribu isce a ge tt ar e fasc i d i lu ce su u na tr a le più bri lla n t i ca mpa gn e del N o stro (ms . K iii-iv, Ab .d/1, 6).
Questa notevolissima co ll ezione, generalmente ignorata dag l i stud iosi, contiene una serie di lettere personali di Montecuccoli nonché di sue relazioni scritte durante le campagne, per lo più direttamente all'Imperatore; quasi tutti i docume n t i vi appaio no in du e versi oni, la m in u ta, d i p ugn o di M o nt ec u cco li , e la cop ia da l u i rived uta pe r la sped izione. Indispensabile special mente per la campagna di San Gottardo (ms. AF/1661-1664/89 sgg.).
La Montecuccoli Sammlung contiene: a) iJ ms. originale della stesura finale delle Tavole Militari (designato dal Veltzé, Il, 27 sgg., con il t itolo Del arte
militare, derivaro, come si è avuto occasione di notare, da un Urschrift del 1645 il cui originale, custodito alla Biblioteca Trivulziana di Milano, fu perduto per eventi bellici tra il 1940 e il '45); r eca la data «Hohenegg, 20 marzo 1653» e l'intitolazione: Tabulae viginti, quibus universa ars et disciplina militari comprehenditur, verosimilmente dovuta al traduttore latino che pu~~licò l'edizione del 1718 e che operò, anche p er gli Aforismi, sui testi oggi alla ONW, mentre l'appendice, in cui trovasi una vivace polemica sull'arte fortificatoria, è assai più tarda, essendo infatti datata «Vienna 18 ottobre 1670» (ms. 10966); b) due apografi degli Aforismi, di data tarda (il seco ndo è senza note, mentre il primo fu con ogni evidenza quello usato dal traduttore in latino) (ms. 10874-10876);
c) una trad. francese dei due primi libri degli Aforismi; d) un ms. i ntiro lato Tabelle assiomatiche di guerra, composro, secondo la dizione, da excerpta methodicae digesta ad uso del Principe Eugen io di Savoia (testimonianza importantissima del come l'illustre condottiero si nutrì della dottrina del suo grande predecessore e Maestro) (ms. 10733); e) diversi ms. di opere poetiche e letterarie di Montecucco li.

3 - Altre fonti archivistiche in Austria e Germania.
Docum enti di Montecucco li (lettere da lui ric ev ute ed anche scritte, quanro mai importanti per ricostruire le vicende della sua campagna di Polonia contro gl i svedesi) furono pubblicati oltre settant'anni or sono in: Briefe an den Feldmarschall Raimund Crafen Montecuccoli - Beitrage zur Geschichte des Nordi schen Krieges in den ]ahren 1659-1660, bearbeitet von Dr. Adalbert Fr. Fuchs, Wien und Leipzig, 1910. Si tratta di 464 lettere e resesti di lettere, scritte e ricevute dal 1° marzo 1649 al 29 settembre 1660, custodite inizialmente a quanto sembra in due archivi: Fiirsdich Porcia'schen Archiv, Spittal, Carinzia (Austria) e Leopoldinischen Akademie, Halle an der Saale (Rep. Dem. Tedesca).
l. - Biblioteca Estense - Modena.
Si tratta, per quanto riguarda le opere teoriche militari di Raimondo Montecuccoli, del più importante fondo dopo quello viennese. Esso contiene:
a) Trattato della Guerra, copia originale, evidentemente da u na minuta (persa), probab il mente opera di un amanuense . La grafia usata ( una bella cance ll eresca ornata, del tipo correntemente riscontrabile attorno alla metà del '600) attesta che non si tratta di copia tarda: nessuno, allo stato di cose attual e, è in grado di dire se non fosse per avventura stata fatta dallo stesso MontecuccoJi durante i lunghi mesi della prigionia Ill ustrata con disegni e cartine (queste ultime assai chiarame nte di mano del Montecucco li stesso) appare verosimilmente destinata ad essere offerta in omaggio a qualche personalità di particolare riguardo, probabilmente il Duca di Modena (ms. a.P.9.15 [ltal. 21]);
b) Delle Battaglie, copia originale, anch'essa secondo ogni evidenza dovuta ad un amanuense che usa una cancelleresca più semplice e, a quanto pare, legger mente più t arda di quella del Trattato della Guerra . A chiu nqu e co nosca per diuturna personale esperienza la grafia d el tutto priva di cu r a, co ntorta , spesso illeggibile, sempre difficilmente decifrabile usata da Montecuccoli nelle sue minute, sembra del tutto improbabile che quest0 ms. (come per altro il precedente) sia la prima stesura di pugno dell ' A.: il qual e, ce rto, o lo copiò da un s uo originale perduto, o per l o meno dovette rived erlo, data la sua re lativa antichità. Esso probabilmente era, come il Trattato, destinato in omaggio al Duca (ms.a.F.6.17 [ltal., 137]);
c) un apog rafo degli Aforismi, di cu i probabilmente il Grass i ebbe notizia ma che non risulta abbia potuto riscontrare personal mente e che, comu nqu e, paragonaco all'originale viennese, appare assai meno attendibile (ms. Ital. 1854);
d) parecchi altri docum. tra cui una trenti.na di lettere autografe nonch é dive rsi docum . vari;
e) un ms. Commentarii in tres Aristotelis libros de Arte Rethorica. Secondo una dichiarazione a firma G. Galvani Vice Bibliotecario, tale ms. è di pugno di Mont ecuccoli.
Ms. e docum. di Mont ecucco li ed a l u i relativi sono qui sparsi un po' dovunque; Gino Boilini ne dà un completo panorama che, sebbene non sia ancora un inventario sis temati co, ne è però, a tutt'oggi, una gu ida preziosa 1 •
La parte più i mportant e di questa doc um ent azione, sparsa per lo meno, seco ndo il Boilini, in cinque collezioni diverse (ma docum. di Montecuccoli si trovano ancora in altre raccolte dello stesso Archivio), sono le lettere, che ancora attendono di esse r e censite in modo davvero soddisfacente. Tuttavia, entro !'«Archivio per materie - Letterati» vi è parecchio material e che fu acqu istato nel 1827 da parte del Du ca di Modena presso quel Giovanni Venturi cui fa cenno il Grassi: in esso anche l'apografo su cui il Venturi riscontr ò per conto del Grassi il testo degli Aforismi, anch 'esso di assai più inc erta lezion e che n on l'o ri ginale vien n ese; nonché un ms. di una t rentina di pagine intit olate L'Ungheria; infine apografi varii, poesie, ecc.
I1 fondo manoscritto che vi è custodito (per altro abbastanza cospicuo) è spec ialm ente importante p er ricostruire le vicende della pubblicazio ne dell e ope re d el Nos t ro: si trovano infatti qui al meno in parte i ms. usati dal Grassi, e studiandoli è facile - nel paragone con gli originali viennesi - rendersi conto di quanto infid o fosse il ter ren o su cui il curatore procede tt e.
1 G. Bo1L1NI , Manoscritti e doc11menti di Raimondo Montecuccoli o a l11i riferentisi conservati nell'A.S. di Modena, in: Accad Naz. di Scienze Lettere e Arti, Modena, Atti del Convegno di Stlldi su Raimondo Montecuccoli nel terzo centenario del/,a battaglia sulla Raab, M odena , 1964, pag. 275 sgg.
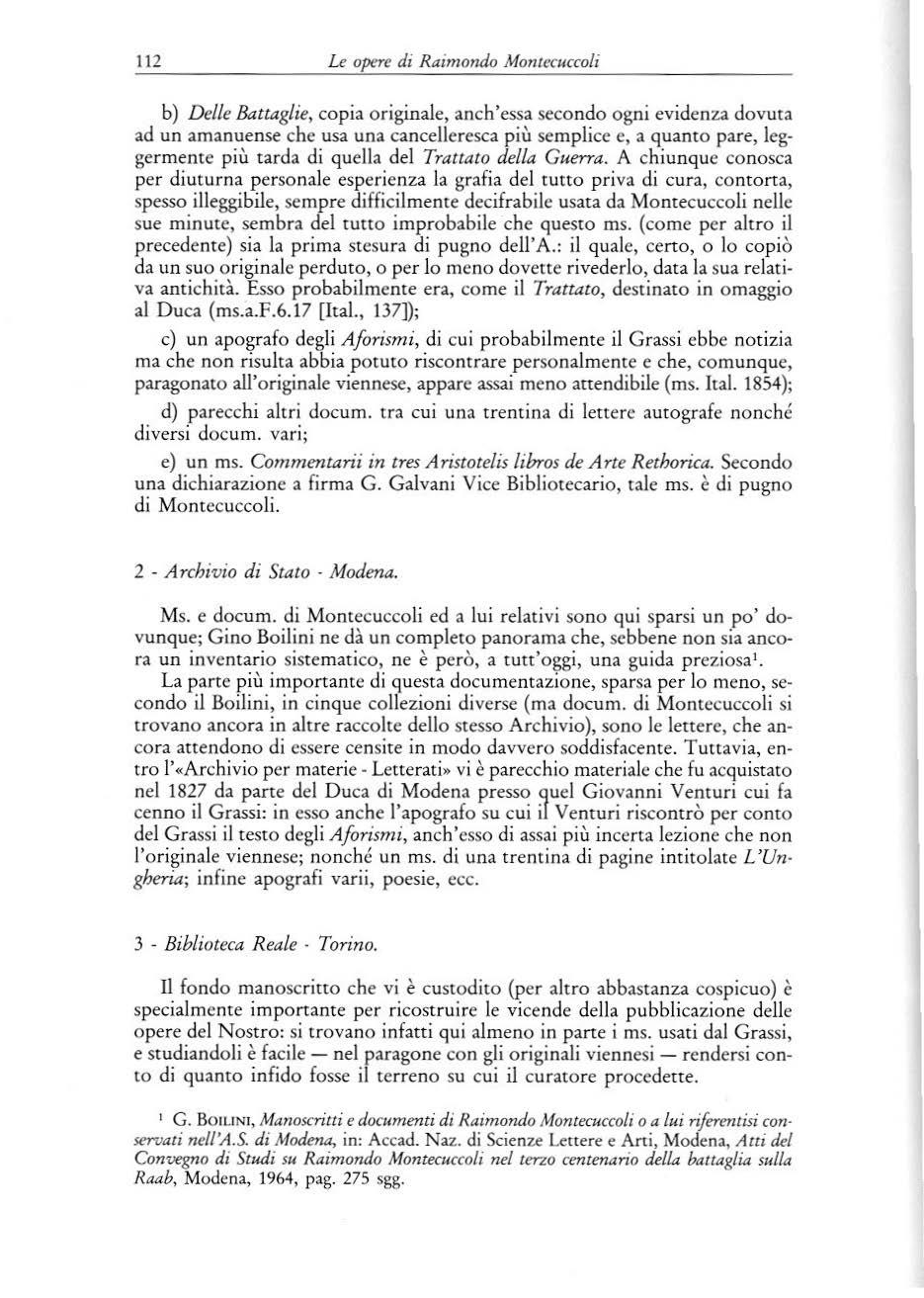
Si tratta dunque di due apografi degli Aforismi . Il primo, apparentemente scri tt o in una cancelle r es ca ornata p iuttosto tarda (lo st esso Grass i d'altronde lo attribuì - se è questo il codice che usò, come sem b ra - alla fine del Seicento), reca la scritta a penna Galeani Napione di Cocconato, poscia cancellata con un tra tto e sostituita da Nomis di Cossi/la; vi sono cor r ezioni a matita d el testo (in part e amputate da una s ucc essiva legatura t ardo-ottocentesca), dovute evidentemente alla mano del Grassi, nell ' evidente tentativo di rettificare, a lume di buon senso, errori di cop iatura (ms. M ii. 29 1)2 •
Il secondo, il quale r eca s u l dorso il t ito lo Montecuccoli - Aforismi militari, non presenta altre indicazioni d i sorta. La grafia è un cors ivo che non pare anteriore al Se tt ece nto . Esso reca correzioni a penna, sp. nelle ci taz ioni latine, evidentemente però non per adeguarlo al primo, in quanto talvolta il correttore a matita ha riportato sul primo alcune correzioni a penna prese dal secondo (ms. M ii. 319)3.
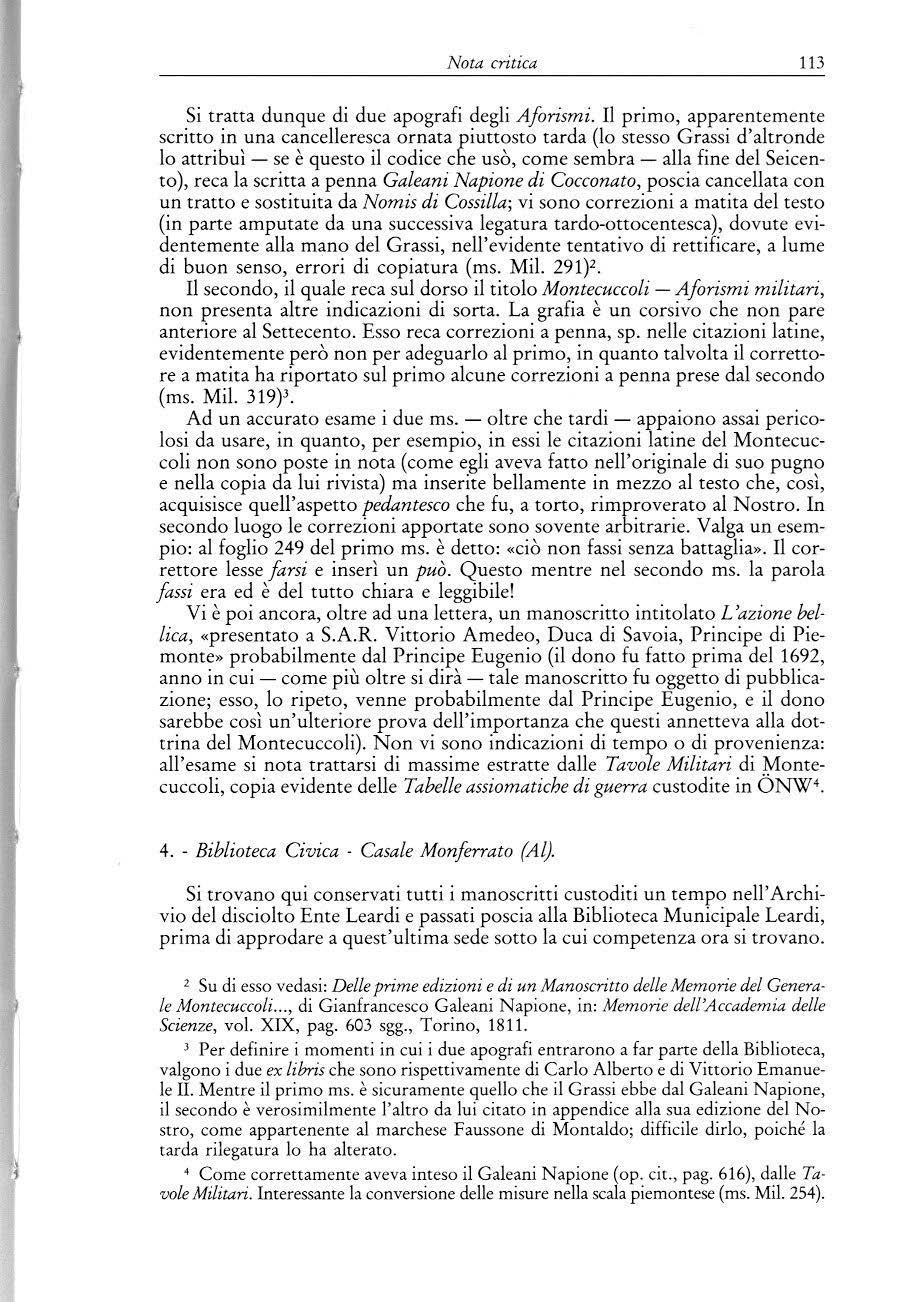
Ad un accurato esame i due ms. - oltre che t ardi - appaiono assai pericolosi da usare, in quanto, per esempio, in essi le citazioni latine del Montecuccoli non sono poste in nota (come egli aveva fa tto nell'o ri ginale di suo pugno e nell a cop ia da lu i rivista) ma inser ite bellamente in mezzo al testo che , così, acqu isis ce quell'aspetto pedantesco che fu, a torto, rimpro verato al Nos tro. In secondo luogo le correzioni apportate sono sovente arbitrarie. Valga un esempio : al foglio 249 del primo ms. è detto : «ciò non fassi se nza battaglia». Il co rre tt ore le sse farsi e inserì un può. Questo mentre nel secondo ms . la parola /assi era ed è del tutto chi ara e leggibile!
Vi è poi ancora, oltre ad una lettera, un manoscritto intitolato L'azione bellica, «presentato a S.A.R. Vittorio Amedeo, Duca di Savoia, P rinci pe di Piemonte» probabilmente dal Principe Eugenio (il d ono fu fatto prima del 1692, anno in cui - come più oltre si dirà - ta le manoscritto fu oggetto di pubbl icazione; esso, lo ripeto, ve nn e probabilmente dal Principe Eugenio, e il dono sarebbe così un'ult eriore prova dell'importanza che questi annetteva alla dottrina del Montecuccoli) Non vi sono in d icaz ioni di tempo o d i provenie nza: all'esame si nota trattarsi di massime es t ratte dalle Tavole Militari di Mont ec uccoli, copia ev ident e delle Tabelle assiomatiche di guerra c ustodite in ONW 4
Si trovano qui conservati tutti i manoscritti custodit i u n tempo nell' A rch iv io del disciolto Ente Lea r d i e passati poscia alla Biblioteca Municipale Leardi, pr i ma di approdare a quest 'u ltima sede sotto la cui com p et enza ora si trovano.
2 Su di esso vedas i: Delle prime edizioni e di un Manoscritto delle Memorie del Genera · Le Montecuccoli ... , di Gianfrancesco Galeani Napione, in: Memorie dell'Accademia delle Scienze, vo i. XIX, p ag. 603 sgg., Torino, 1811.
3 Per definire i momenti in cui i due apografi e ntrarono a far parte della Bib li oteca, valgono i due ex libris che sono rispettivamente d i Carlo A lberto e di Vittorio Emanu ele IL Mentre il primo ms. è sicuramente quello che i l Grassi ebbe dal Gal eani Nap ione, il secondo è verosim ilmente l'alt ro da lui citato in appendice all a sua edizione del Nostro, come appartenente al march ese Faussone d i Montaldo; difficile dirlo, poiché la tarda rilegatura lo ha alterato.
• Co m e cor r etta m ente aveva inteso il Galeani N a pione (op. cit., pag . 616) , dalle Ta · vole Militari. Interessante la conversione delle misure nella scal a piemontese (ms. M ii. 254).
Di ta li ms . esiste un minuzioso catalogo redatto nel 1905 5 • Tra di essi trovasi un apografo degli Aforismi rilegato in pergamena e recante scr itto su lla faccia interna de ll a legatura «Del C.te Carlo Vidua d i Conzano» . Siamo dunque di fronte a u no dei ms. che il Grassi dice di aver usato Esso reca un t i tolo sicuramente es t raneo allo stile del Mont ecuccoli : Affarismi (sic) dell'arte bellica lasciati per eterna memoria dal Gran Generale Principe Montecuccoli . Da un'anal isi della gr afia il ms. appare ch iaramente appartenere al XVIII secolo ed essere sta t o vergato da più mani. E r rori appaiono qua e là: Annibale an zich é Asdrubale e amici invece di numidi; omesse tutte le note con citazioni latine di Mo nt ec uccoli, nonché parecchie annotazion i cronologiche.

5. - Biblioteca Nazionale Braidense - Milano
Vi sono custoditi due apografi degli Aforismi. Il primo reca sul dorso la scritta Aforismi dell'arte militare Si tratta d i u n bel ms , ben r il egato, scritto in chiara ca ncelleresca. Accanto alla ded ica all'Imperato r e la nota a matita: « 1668» (appos t a forse da l G rass i) Il testo però è in accurato, con evidenti, grosso lani erro ri d i copiatura (subi t o al primo paragrafo : «La Guerra è un'azione d 'Esercito (s ic) offendendosi in ogni gui sa» : il che è, t ra l'a ltro, privo di se nso). Il secondo ms. sembra redatto i n una grafia più recente . Reca all'interno, a pe nna, il t ito lo chiarame nt e ottoce nt esco : Memorie del Generale Principe di Montecuccoli per una esatta istruzione dei Generali ed Ufficiali e Massime Polìtiche Il testo sembra più adere nt e ali' origina le d i Montecucco li, senza que ll e innovazio ni arbitrarie di fo r ma (inabilità invece di inhabilità, de/li uomini inv che de gli huomini, azione per attione ecc ) che caratterizzano il primo. In quest o secondo apog rafo le note in latino sono, come nel ms . viennese, poste fuori dal t es t o e indica t e con lettere di richiamo, mentre nel primo sono state semplicente soppresse. Non mancano correzio n i a matita .
Q u anto alla provenienza,l' i nventario della Bib li oteca lo ascr ive ad un Pietro Antonio/i; il Notiziario 6 n onché il Corriere delle Biblioteche 7 attribuiscono entramb i i manoscritti (ed a mio avv iso, fondatamente) al secolo Diciottesimo, classificando li come acquisiti sporadicamente.
Secondo ogni verosimiglianza, il secondo (che è un d isc r et o apografo de l1'originale vie n nese, sebbene non privo d i qualche svarione) è quello ch e il
5 Di queste informazioni sono debitore a l Sig. Andrea Testa, di Casale Monferrato, il quale, diet ro mia richiesta, effettuò cortesemente una ser ie di ricerche nelle carte di Carlo Vid ua, su c ui sta ora conducendo un più vasto studio. Altri, fondamentali ms dj Carlo Vidua trovansi nell'Arc hivio de ll 'Ospedale di Santo Spirito, Casale. Ciò in q uanto l' ulti ma erede dei Vidua, la contessa Clara Cocconito di Momiglio, vedova del conte Cesare Leardi, con suo t est amento in dat a 5 dice mbre 1852, legò tutti i libri, le carte, gli scritti. .. provenienti particolarmente dalla successùme del conte Carlo Vidua all a città di Casale. Nacque così la Bib li oteca Leardi, successiva mente Eme Leardi, recentemente soppresso (per la verità affrettatamente e se nza una motivazione veramente va lida) e riassorbi t o dal la C ivica Biblioteca. Poiché però C lara Leardi aveva legato anche un' importante parte de i suoi beni all ' Ospe dale di Santo Spirito, parecc hi e carte finirono in q uell'Archivio e vi si trovano tuttora. (Cfr.: G1usEPPE OrrOLENGHI, la Biblioteca e l'Archivio leardi in Casale Monferrato, i n: Il Risorgimento Italiano, a.I, 1908, pag. 497 sgg.)
6 In: la Rassegna, xxx i, 1923, 5, pag. 317.
7 In: la Bibliofili,a, xxvi, 1924, pag 150.
Grassi attribuisce al signor Giacinto Bossi. Non è possibile provarlo in maniera definitiva, e meno ancora si può ritenere che il primo sia stato visto dal Foscolo nel suo t entativo di riscrivere l'italiano d i Montecuccoli 7• ;•
Alla Braidense si trova anche, inserito in volume miscellaneo abbastanza chiaramente seicentesco, un ms. coevo, intitolato Battaglia seguita tra il campo Christiano diretto da S. Ecc.za Sig.r Generale Marescial Montecucoli (sic) con quello dell'Ottomano e datato «V ienna 10 agosto 1664», che è forse un condensato delle rela zion i di Montecucco li attua l mente neg li Alte Feldakten .

6. - Biblioteca Nazionale e Archivio Mediceo - Firenze.
Sono qui conservate numerose, imp. lettere di Montecuccoli (360, seco nd o il Gimorri), p er lo più dirette a Mattia de' Medici, mai seriamente censite e studiate.
7 . - Biblioteca Apostolica Vaticana - Roma.
Si trovan o qui (in : Fondo Pat etta Manoscritti 438 (1)): brani sparsi di opere del Montecuccoli che l'Ab ate Serassi aveva segna laro al Foscolo come esist ent i a loro tempo nella Biblioteca Mass imi.
, Il manoscritto comprende la lettera dedicatoria all'imperatore Leopoldo I. E incompleto e s'interrompe al T i to lo secondo de l Libro Terzo " li T urco ne l battagliare - e qualunque altra bocca da fuoco che essi ... " . V i sono le citazioni in latino a pie' di pagina. Si presenta senza cance llature e scritto da una stessa mano M s nr. 300 Sec. xvu, cart., mm. 340x229, ff. 263.
1. - Statni Archiv V Brne
Contiene gl i arch ivi della fam igli a Dietric h stein, da cui proveniva la m ogli e di Montecuccoli. Numerose imp. lettere .
2. - Statni Archiv v Litomeiice (Deéin}.
Carte di Matteo Galasso, con molte lett ere di Montecuccoli
3. - Statni Archiv v Litomeiice (Zitenice}.
Carte di Vaclav L obkovic, parecchie lettere di Montecuccoli.
4. - Statni Archiv v Zamrske.
Carte P iccolom i ni, Collalto, ecc. Molte lett ere di Montecuccoli.
Come tutto il carteggio di Montecuccoli, anche le lettere qui conten ut e non sono mai state oggetto di stu d io sistematico.
7 b;, Mentre dunque uno dei due m s. custoditi alla Braidense è quasi s ic uramente q u ello appartenuto a Giacinto Bossi, l'altro potrebbe essere quello che al Grassi fu mostrato (a quanto egli ci dice) dal «signor Vincenzo Lancetti, direttore dell'Archivio di g uerra» a Milano.
A qu anto appare chiaramente, M ontecuccoli non scrisse mai con l' intenzione di pubblicare le p ropr ie opere. Né per altro, in quell'età, era abituale a ch i non faceva esplicita professione di scrittore, rivo lgersi ad un largo pubb lico. Sovente le opere erano dirette ad una cerchia ristretta di persone o ad una persona sola, ed erano destinate a r i manere man oscritte: i n verità Montecu ccoli indirizzò il suo primo trattato, vale a di re il Della Guerra, a se stesso; uguale destino ebbe il Delle Battaglie nella su a st esura iniziale, nonché gl i altri studi co m p lementar i che sono perduti. Q u ando il p ens iero d el Nostro venne maturando, ed egli fu giunto ai più alti fastigi de ll 'Impero, diresse le proprie ope re all 'Imperatore, all a istruzione pr ivata dei Principi ed ai più alti Ufficiali d elle forze absburgiche ed anc h e al Duca di Modena. Occorre in oltre tener presente che, di conseguen za, molto di quanto Montecucco l i scriveva poteva be n a ragione consid erarsi segreto m il itare. Ciò basta a comprendere perché, lui vivente, nessu na delle sue opere fu pubblicata: né egl i, second o ogni prob abil ità, mai lo avrebbe consentito 8
Ne circolarono tutt avia parecc hi e copie manoscritte: i l D u ca Ca rlo d i Lorena, per esempio, allievo e successore di Montecuccoli, ne aveva seco una cop ia; un'alt r a era i n rossesso de l piemontese genera le d i R uffia , e f u q uella che term i nò in man'o a Galeani Napione9 • Tal i copie era n o per lo più dovute ad amanuensi di lingua tedesca, che mal conoscevano l'italiano (se addiritt u ra non lo ignoravano); d i qui il profluvio dì errori ch e i n fes t ava quegli apografi, i q ual i, per altro, erano i soli a circola re, rimanendo gl i orig i na l i r i nc h iu si nell'Arch ivio privato Montecuccoli a Hohe n egg.
Si dovette at tendere fino al 1704 pe rch é apparisse una prima edizione a stampa de i so l i Aforismi, sot to l' i nesatto tito lo (che da allora per lungo tempo ad essi rimase) di Memorie del Generai Principe di Montecuccoli Essa fu dovuta al tedesco Heinr ich von Huyssen, Consigl iere Militare de ll o Za r d i Russia Pietro il Grande e fu st ampata a Colonia d alla Compagnia de i Librai 10 • Tale edizione fu, secondo lo Huyssen, cond otta sui ms. della Biblioteca Imperiale di Vie nna (che, come sappiamo, non erano gli or iginali, ma degl i apografi); e pe r ò fu fa t ta in ma ni era tanto i n accurata che il Galeani Napione la de fi nì meschina, informe, scorrettissima e mancante11 • Sette anni più tardi apparve in Ferrara una n uova edizione a stampa sempre deg li Aforismi, la qu ale non era in fondo che una cop ia di q uella p recedente di Colonia, recava lo stesso ticolo: Memorie del Generai Principe di Montecuccoli, ed era curata da Bernardino Barb ieri
8 In quel tempo era usuale indirizzare opere, destinate a rimanere manoscritte, direttamente ad alt issimi personaggi: vedasi il caso di Leibniz, il quale scrisse la sua Monadologia pr ivatamente pe r il Principe Eugenio. Cfr. anche : G . GAI.F.ANI NAPIONE, op. cit., pag. 613.
9 G. GALEAN I NAPIONE, op. cit. , pag. 617 e 6 19 .
10 GIROLAMO T1RABOSCH1, Montecuccoli, in: Biblioteca Modenese, voi. III, 1783, pag. 290 . L'abate Tirabosch i fu Prefetto de ll a Biblioteca Estense d i Modena, e profondo conoscitore della bibliografia di Montecucco li.
11 G. GALEANI NAPIONE, op cit., pag. 615 A propos ico dei ms. di cu i si servl lo Huyssen, va detto che THOMAS M. BAllK.ER, lhe Milirary lntellectual... , cit., pag. 217, n. 5, ipotizza che egli possa aver avuto accesso anche ad altr i doc u menti oltre a q uelli della Bib li oteca Imper iale; il VELTZÉ invece, op. cit., vo i. I, pag. xxiii, espl icitamente lo nega. Dall' esame del testo edi t o dallo Huyssen sembra che l'ipotesi del Veltzé sia la più attendibile.

Vero è che il Foscolo, nell'introd uzione alla sua ediz ione d i cui più oltre si dirà, ipo t izzò un'altra edizione erecedente a quella di Colonia, e di cui non si è per ora trovata traccia: probab ilm ente eg li allude all a pubblicazione, avvenuta a Milano nel 1693, i n lingua spagnola, di alcuni excerpta degli Aforismi 12 • Per quanto se ne sa, qu esta fu la prima volta che qualche brano di tale opera apparve a stam pa, sia pure tradotto in lingua stranie ra; precedentemente, solo alcuni estratti o sunt i di due altri sc ritt i avevano veduto la l uce. In primo l uogo, come già si è avuto occasione di dire in precedenza, il Montecucco li st esso aveva fatto un su nto di alcune delle sue Pecorine di $tettino (metà della I, la II, III, IV e V) sulle fortificazioni, con il titolo Saggi Matematici Militari, per il padre gesuita M. Bettini, che lo aveva i nserito i n Apiaria universae philoso · phiae mathematicae, Bo logna, 1654.
Va anche ricordato che nel 1692, in Torino, apparve un libretto in 12° intitola to: L'Attione bellica del conte Montecucoli (sic) Prencipe del Romano Impero, e Luogotenente Generale delle Armi dell'Imperatore... , a cura di Giovan Battista Zappata. Si trattava di pubblicazione a stampa del ms. di analogo titolo giacente alla Biblioteca del Re e costituente, come si è d~~to, la copia di un estratto (impreciso) del ms. Tavole Militari che è ora a Vienna, ONW. Poiché il Foscolo, per sua esplicita dichiarazione, ne ebbe conoscenza, egli potrebbe forse alludere a quest'ultimo.
Nel 1712 apparve in Parigi una traduzione francese degli Aforismi, ad opera di tale Adam . Questa derivava dall'apografo posseduto dal Duca Carlo d i Lorena e già menzionato . Il Principe di Conti, recatosi in Ungheria, vide tale ms. e o tt enne di copiarlo, per farlo, appunto, tradu rre i n francese: tale edizione ebbe par ecchie ristampe, di cu i le migliori sono probabilmente quelle d i Amst erdam (1734) e di Strasburgo (1740).
Nel 1718 a Vienna fu pubblicata una traduzione in latino, sempre degli Afo· rismi accompagnati dalle Tavole Militari nella versione del 1653 (tale edizione latina, preceduta da una parziale nel 1716, fu dunque, come quella in Italiano dello tluyssen, condotta sugli apografi giac enti n ell'al lora Biblioteca Imperiale, oggi ONW); e ne l 1769 il Tur pin de Crissé, studioso e amm ira tore d i Montecuccoli, pubblicò in Parigi (e ripubblicò nel 1770 i n Amst erdam) una nuova edizione in tre volumi della traduzio ne francese, ove però il commento del curatore supera di tre o quattro vo lte il test o del Nostro. Va aggiunto che la traduzione spagnuo la ebbe una ri edizione nel 1746, mentre nel 1736 era apparsa a Lispia una traduzione tedesca verosimilm ent e tratta dalla prima edizione 12 b;, _ Queste erano dunque le fonti che Ugo Foscolo ebbe a disposizion e quando si accinse a preparare una nuova edizione in lingua italiana degli Aforismi (cui aggiunse una sua versione d elle Tavole Militari dandogli il nuovo t itolo di Il sistema dell'arte bellica. Ma di ciò più oltre). L'edizione foscol ia na apparve negli anni 1807-08 13 e risultò subito essere per un verso la migliore di quelle sino allora uscite, sia per l'impegno dell'illustre curatore, sia perché egli compì un'accurata recensio de i testi a l ui disponibili; per un altro verso però essa rappresentò un regresso rispetto alla mutila edizione di Colonia, in quanto il Foscolo, come si d i rà, si prese con la prosa di Montecuccoli delle libertà che a n essun curatore, per quanto illustre, dovrebbero essere leci t e: in p arte, certamente (sia
12 G. GALEANI NAPION E, op. cic. , pag. 615 sg.

120 ;, L'ed i zione francese di Strasburgo fu pubblicata da Doulssecker le Père; quella spagnola del 1746 a Barcellona da Rafae l Figu erò.
13 Opere di Raimondo Mon tecuccoli illustrate da Ugo Foscolo , Mi lano , 1807 sg. , due volumi.
detto a sua giustificazione) per cercar di ovviare alle mend e cd alle lacun e del mat eriale s u c ui doveva lavorare.
L'edizione (spl endida dal punto di vista grafico, sta mpata in folio e costosissima , per cui n e furono tirati so lo 170 ese mplari) era fondata su qu ella di Colo nia, di cui non si ripeteranno qui le man ch evo lezze e le mende , nonc h é in molti casi (per riempire, ci di ce il Foscolo, le lacune di tal e prima pubblicazion e) su una retroversio ne della edizione latina del 1718, cui il Foscolo, non a torto diffidente di qu ella italiana dello Hu yssen, ri co rse sovente, ripon en do in essa una fiducia che, alla prova dei fatti, si riv ela scarsamente giustificata. Né (secondo i l Raimondi) è da escludere che il Fosco lo ricorresse pure alle versio n i francese e s pagnola: 13bi, con qual e accrescimento d ell'imprec isione, è facile immaginare. Vero è che i l Foscolo (eg li s tesso buon specialista di co se militari e studioso attento e int e lligente del M o ntecu ccoli, per lo m en o di quel Montecucc oli che fu a s ua disp osizio ne) tent ò di integrare in qualch e modo l'insoddisfacent e materiale di cui egli poteva di s porre con qualche font e documentaria, servendo si di alcun i brani della Dedica e deUa Prefaz ione agli Aforismi, nonc hé di qualc h e parte delle Tavole Militari, rinvenute dall'Abate Pi e r Antonio $crassi era le carte d ella Biblioteca Massimi in R o ma: ma dovette amm ettere che si trattava di materiale sc orretti ss imo e lacunoso 14 • P e r cui, ond e comp le t are il testo dell e Tavole Militari p e rvenutogli mutilo dal Serassi, egl i ri co rse ad una in co n sc ia contaminatio co mpletand o lo con part i tolte dal manoscritto dello Urscbrifi, da lui visto all a Trivulziana 14bo•
Le fonti dunque di cui il Foscolo si se rvì erano già scarsamente attendibili: ma egli, sven turata ment e, peggiorò la situaz io n e, di fatto decid endo arbitrariam ente di riscrivere l'italian o di Monte c ucco li. Sebb ene infatti nella prefa z i o ne egli ci dica ch e « .•. a' difetti dell'autore s'è portato ri spetto», negando quindi di essere interven uto a correggere l'italiano del Mo nt ec uccoli , poco prim a non aveva mancato di osservare co me egli avesse il m ass imo disprezzo per la pr osa di que l tempo che a lui pareva barocca , in quanto «la lingua era a ll ora adult e rata dalla scuo la d e' secentisti ». Ciò aperse la strada ad una serie di s uoi interventi, sia mediant e la retro versio ne dal latino (e forse dal francese) , nella qual e egli certamente n o n si sforzò più che tanto di ricostruire l'italiano del Monte cu ccoli, dandoci invece degli esempi di bu ona prosa fo sco liana; sia all orché egli c red ette d i dov er raddrizzare ad ultera zion i e interpolazioni dovute ai curatori o ai co pisti di un'era la cui prosa egli tanto sp regiava. Certamente la prosa del Foscolo è degna della sua eccelsa personalita d i scri tt ore : m a la ge nuinit à dcl1'ope ra di M o nte cuccoli se n e va perduta; il suo pensiero militare (e qui egli era immensam e nte superiore al Foscolo) n e viene ulte riorment e distorto e sove n -
u i,., Ezio RA1MOND1, Per un'edizione deUe opere del Monc.ecuccoli, in: Atti del Convegno di Studi s11 Raimondo Momecuccoli. .. , cit. , pag. 235 sgg., seco nd o cui appare ceno c he il Foscolo abbia fatto uso anche d elle trad u z io ni francese e spagnola. Personalmente d ubito che il Fosco lo s i sia servito di que st' ultim a. EgL stesso, nelle sue note, informa di aver usato l'edizio ne fran cese (c iò ev identemente in quanto questa, provenen do dall 'apografo posseduto da Carlo di Lorena e scambiato a quei tempi per un manoscricco originale, gli pareva attendibile); per quella spagn ola egli manifestò sempre diffidenza, per cui mi pare improbab il e che dj essa abbia fatto uso, per lo m en o in mi sura degna di nota.
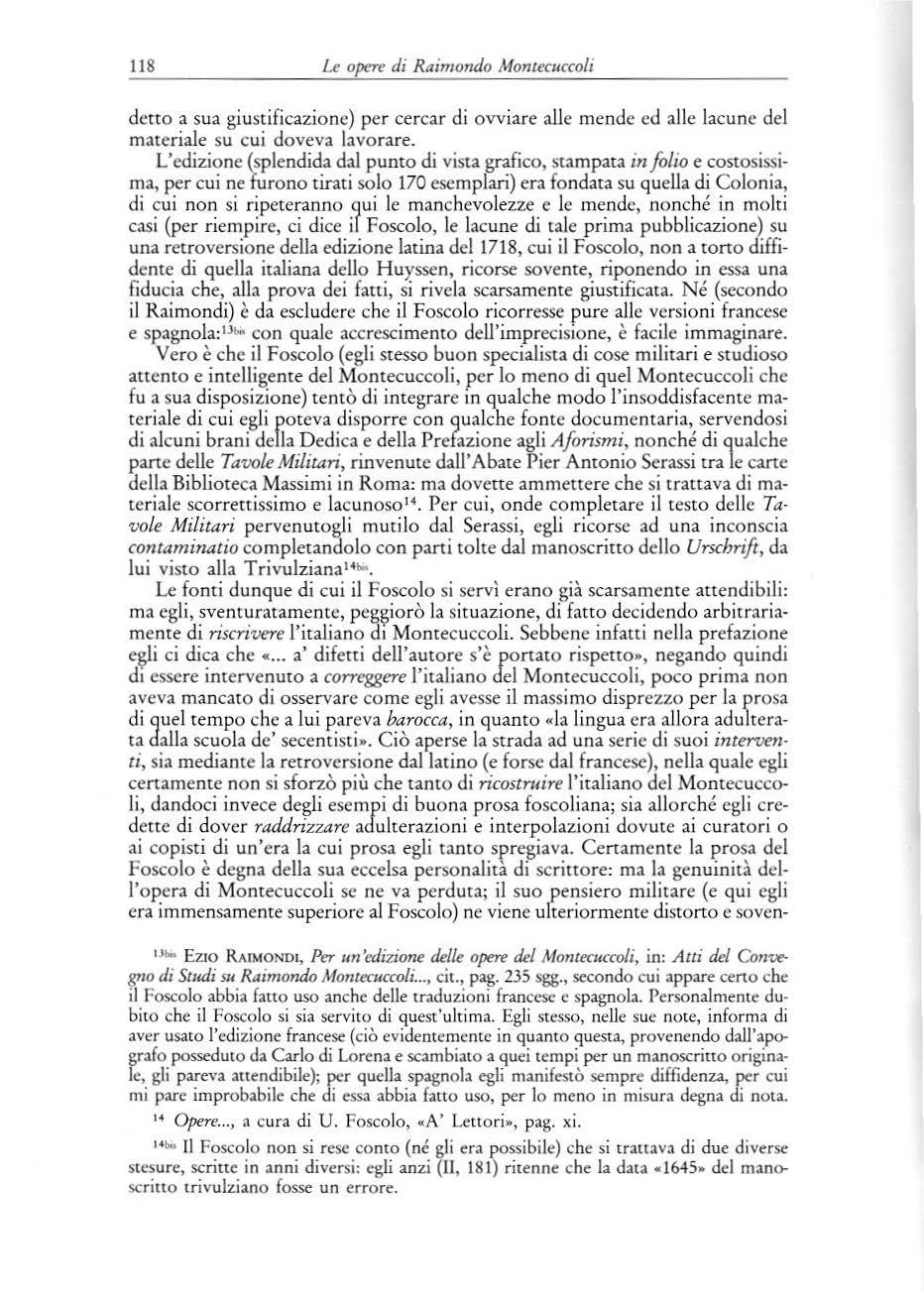
14 Opere..., a c ura di U. Fosco lo, «A ' Lettori», pag. x i.
t 4bis Il Foscol o non si rese co nto (né gli era possibile) c he si tratt ava di due diverse stesure, scritte in anni dj ve r si : eg li anzi (II , 181) ritenn e c he la data «1645,. del manoscritt o trivulziano fosse un errore.
te frainteso; ciò a parte lo scrupolo filo l ogico che dovrebbe animare ogni curatore di una qualunque ediz ione che ambisca all'aggettivo di critica 14 « r
Il pensie r o di Montecuccoli vi si intravede ancora, ma come attraverso una nebbia: esso i n ogni caso bastò ad affascinare il Foscolo che ci dette in proposito dei saggi che sono senza dubbio il suo m i glio r contributo agli stud i su Montecuccoli.
L'ed i zione foscoliana e ra comunque de l tutto inat tendibile: ciò spinse Giuseppe Grassi a tentarne una migliore (e l etterale !) , tanto p i ù che eg li pensava (o si illudeva) di aver fi n almente a disposizione fonti manoscritte super ior i a qu elle di c ui Ugo Foscolo aveva potuto disporre.

I ms. di cu i i l Grassi si servì (e poter fare uso di fonti manoscritte rappresentava già un enorme vantaggio sul Foscolo) furono essenzialmente i due oggi cuscod iti alla Biblioteca Reale di Torino, e, tra di ess i, q uello all ora posseduto dal Ga lean i Napione, il qu al e a quanto risu lt a spronò e so rresse il curatore Il Galeani Napione, i n effetti, aveva pub bl icato nel 1803 un saggio sugli scrittori militari ita l ian i 15; ed aveva lamentato che Montec uccoli, sost an zialmente, rimanesse inedito. Possessore egl i stesso di un apografo degli Aforismi (di cu i si è ampiamente detto più sopra), aveva avuto notizia che un altro apografo era i n poss esso del conte Car lo Vidua di Conza n o, ed aveva potuto pre n derne visione Nel 1817, allorché il Grassi era al lavoro, il Galea n i Napione, tramite l'amico P r ovana, insist e tte pe r c h é il Vidua ponesse il s u o apografo a disposizion e de l nuovo curatore, ma il conte casa lese nicchiava, dicendo: «dell 'A ccad emico Editore non mi fido troppo» 16 •
Infine il ms casa l ese no n fu dato al Gras si, il qua le, contrariamente a qua nto se mbra affermare, ;0on lo vide: 1 7 : egli stesso per altro lasc ia capi re di essersi basato su informazioni a l u i date da Luigi Provana e Cesare Saluzzo circa tale ms Il Salu zzo , per parte sua, mostrò al Grassi un proprio apografo (incompleto), mentre un altro completo il curatore ebbe dal marc h ese Faussone di Montaldo (ed è secondo ogni probabi l ità il secondo dei due custoditi alla Biblioteca del R e di Torino).
Non poté però eg l i p render v is ione dell'apografo oggi custodito ali' A r c h ivio di Stat o di Modena, la cui notizia gli giunse t r oppo tardi, ma l e cui variant i, a lui comunicate dal Venturi, d evono ave r so lle vato nel suo a n imo più di u n dubbio a proposito dell'apografo posseduto dal Galeani Napio n e e c h e quest'u ltimo cons iderava (con scarso fondame n to) come del tutto attendibile 18 •
14'" Il Foscolo ha, a sua scusante, il fatto che dovendo la vorare su un testo mutilo, non pote va fare altrimenti, se desiderava in qualche modo completarlo. Rimane da vedere se un tale procedere debba considerarsi lecite ad un c uratore che intenda perseguire il rispetto filo logico dei testi: a parte poi gli interventi arbitrari di cui s ' è detto, ben analizzati e posti in rilievo dal Raimon di , in un saggio che è un modello di discussione eru dita (E. RAIMO ND I, op cit., passim).
15 G. GALEANI NAPIONE, Notizie de' principali scrittori d'Arte Militare Italiani, in: Memorie dell'Accademia delle Scienze, Torino, 1803, pag. 463 sgg
16 Archivio Leardi, Casale Monferrato, Busta xxxm, filza 11, Carl o Vidua al padre, Milano, 4 novembre 1817
17 Casale Monferrato, Arc hi vio dell'Ospedale di Santo Spirito, cat. ii, cl asse i, busta 11, il padre a Carlo Vidua, Tori no , 12 gennaio 1818.
18 G GALEANt NAP tONE, op. cit., passi m L'edizione de l Grassi apparve nel 1821 in d ue vo lu mi, fu ristampata nel 1831 e poi di nuovo ne l 1852 in un volume, integran dov i le note di qu ella foscoliana e ponendo in fronte il t ito lo: Opere di Raimondo Montecuc· coli annotate da Ugo Foscolo e corrette, arricchite ed illustrate da Giuseppe Grassi.
Il Grassi ci dice tuttavia di essersi servito di un altro apografo, possedu to a Milan o dal signor Giacinto Bossi. Si tratt a - come ebbi occasione di osservare - di uno dei du e oggi c ustoditi nella Biblioteca Braidense: ed an c he sui difetti di questi sembra inutil e ritornare.
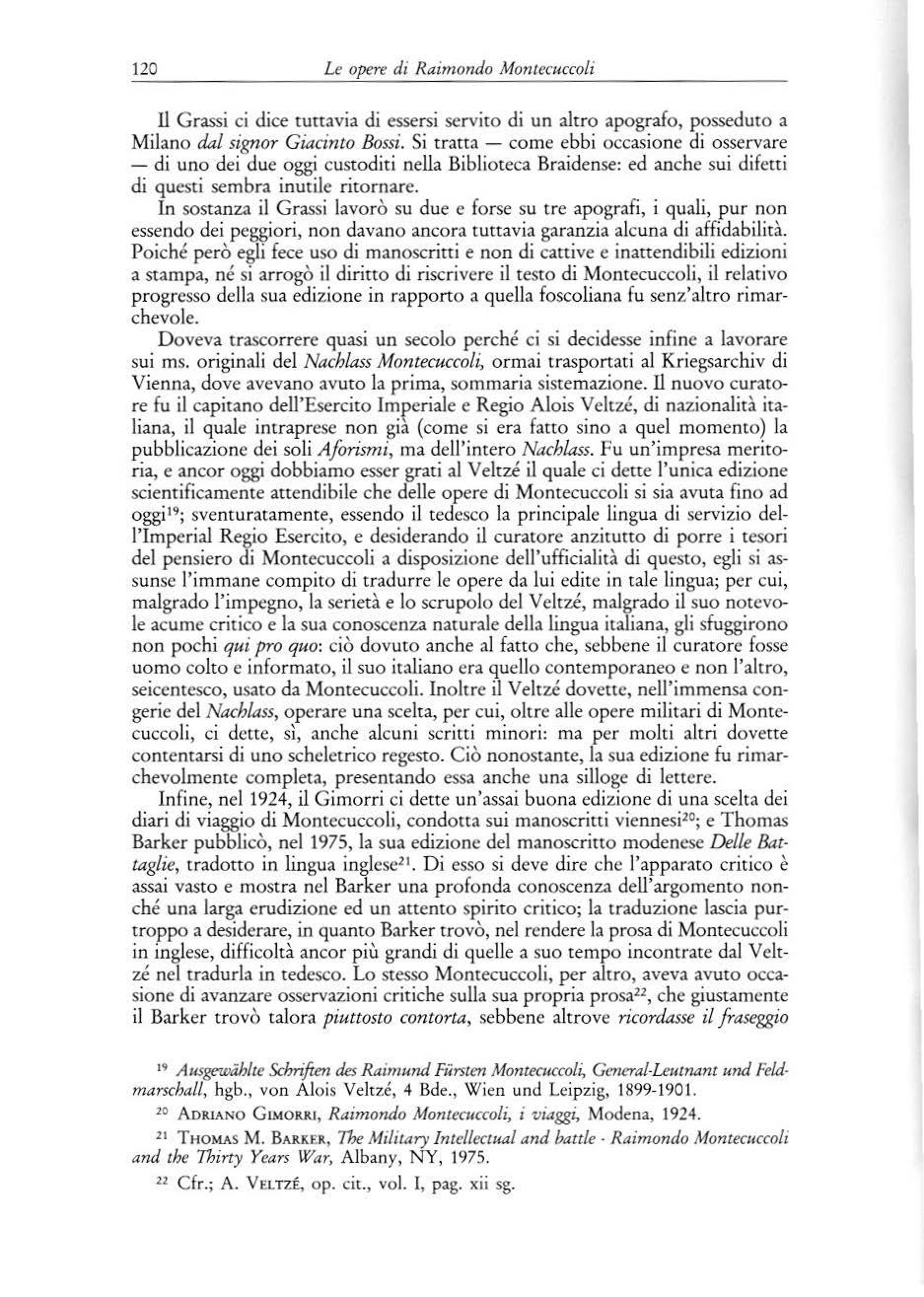
In sostanza il Grass i lavorò s u du e e fo rse su tre apografi, i quali, pur non essendo dei p egg iori, non davan o ancora tuttavia garanzia alc un a di affi dabilit à Poi c hé però egli fece uso di manoscritti e non di catt ive e inattendibili edizioni a stampa, né si arrogò il diritto di riscrive re il te sto di Montecucco li, il relati vo progresso della s ua edizione in rapporto a quella fosco li ana fu sen z'a l tro rimarchev o le.
D oveva trascorrere quasi un secolo perché ci s i decid esse infin e a lav o rare s ui ms. originali del Nachlass Montecuccoli, ormai trasportati al Kriegsarchiv di Vienna, dove avevano avu to la prima, som maria sistemazi o ne. Il nuovo curatore fu il capitan o dell'Esercito Impe rial e e Regio Alois Veltzé, di nazionalità italiana, il quale intraprese non già (com e s i era fatto sino a quel moment o) la pubblicazion e dei soli Aforismi, ma dell'intero Nachlass . Fu un'impresa m e ritoria, e a ncor oggi dobbiamo esse r grati al Veltzé il quale ci dette l'unica edi zione scie ntifi cament e attendibile c h e delle opere di M o ntecu cco li si sia avuta fino ad oggi 19 ; s venturatamente, essendo il t edesco la principale lingua di se rvizio dell'Impe ria! Re gio Esercito, e d esiderando il curatore anzitutto di porre i tesori del pensiero di Mont ecuccoli a disposizione dell 'ufficialit à di qu esto, egli si assunse l'immane co mpi to di tradur re le opere da lui edite in cale lingua; per c ui, malgrado l'impegno, la se rietà e lo scrupo lo del Veltzé, malgrado il s uo notevole acume critico e la sua co no sce nza naturale dell a lingua italiana , gli s fuggirono non pochi qui pro quo: c iò dovuto anch e al fatto c he, sebbene il c uratore fosse uom o colto e informat o, il su o italiano e ra quell o co ntemporaneo e non l'altro, seicentesco, usato da M o ntecuccol i. In o ltre il Ve!tzé do vette, nell'immensa congeri e del Nachlass, op era re una sce lta , per c ui, oltre alle opere militari di Montec uc co li , ci d ette, sì, anc he alcuni scritti minori: ma pe r molti altri dov ette contentarsi di uno scheletrico regesto. Ciò non ostante, la sua edizione fu rimarchevolmence co mpleta, presentando essa anch e una sill oge di let t e re.
Infine, nel 1924, il Gimorri c i dette un'assai buona edi z ione di una scelta de i diari di viaggio di Mont ec ucco li , condotta sui man oscritti viennesi 20 ; e Thomas Barker pubblicò, nel 1975, la s ua edi zion e del manoscrit to moden ese Delle Battaglie, tradotto in lingua ingle se 21 Di esso si dev e dire c h e l'apparato critico è assai vasto e mostra n e l Barker una profonda conoscenza dell'argomento no nché una larga eru dizi one e d un atte nto spirito critico; la traduzione lascia purtroppo a desid erare, in quanto Barker trov ò , nel re ndere la prosa di Montecucco li io ingl es e, diffi coltà ancor più grandi di quelle a s uo tempo incontrate d al Velczé n e l tradurla in tedesco. Lo stesso M oncec ucco li , per altro, aveva avuto occasion e di avanzare osservazioni cri tiche sulla sua prop ria prosa 22 , che giustam e nte il Barker trovò talora piuttosto contorta, sebben e altrov e ricordasse il fraseg,gio
19 Ausgewiihfte Schriften des R aimund Fii rsten Monternccol~ General-Leutnant und Feldmarschall, hgb. , vo n Al o is Veltzé, 4 Bde. , Wi en un d Leipz ig, 1899-1 901.
20 ADRIANO G 1MORJU , Raimondo Montemccol~ i viaggi, Mode na, 1924.
21 THOMAS M. BARKER , 7he Military In tellectual and battle - Raimondo Montecuccoli and the Thirty Years War, A lbany , NY, 1975
22 Cfr.; A. VELTZÉ, op. cit., voi. 1, pag. xii sg.
elegante del Machiavelli 23 Dall'a tt ento stud io degli scritti del gra nd e co ndott iero si trae l' impr essione che egli era in realtà scri tt ore di rara efficac ia , buon prosatore, i ncisiv o, logico, limpido e dotato di un vasto vocabola ri o : ma che sovente i suo i ms. ci sono perv enuti all o stato di stesura in iziale, buttata giù d i getto, senza che il tempo e le cure della guerra e della po litica gli consen t isse r o una sia p ur fu ggevo le rilettura . In effetti quelli redatti per se stesso , come i l Della Guerra, so n o i p iù inaccurati e peggio scritt i: il che non può in vece dirsi degli Aforismi, destinati all'Imperatore e c h e quindi (come si è sotto l in eato) passarono attraverso n um erose revisioni e stesu r e.

Q uesta era la situazione quan do mi accinsi a lavorare alla prese nt e edizione, la pr ima in lingua ita lia na in cui le Opere t eo ri che mi l itari del Grande appa ian o complete e ch e sia stata condotta s u i manoscritti original i, riveduti dallo s t esso Montecucco li.
Per dare i nta nt o s ulla presente ed izi o n e alc un e notizie, dirò anz itutt o ch e l'o b iettivo sa r eb b e di pubb lica re tutt i gli scritti di Mo ntec uccoli: ciò ri chi ed erà anni, e forse l'intero sp az io di una vita uma na (o quelle di più p ersone) Il Nachlass, anzitutto, è enorme, tale da co l m ar e non alcun i, ma mo lt i vol u mi e da ric h iedere un'impresa editoriale di fron t e a cu i più d i una casa editrice darebbe forse indietro. E non basta ancora, ché ali' eno rm e mole del Nachlass si debbono aggiungere i ms. mo denes i, almeno per le due opere principali (i n qu est a ediz io n e, per altro, pu bb li cate n ell a loro i nterezza); le opere poetiche e , so pr a ogni a lt ra cosa le letter e, delle quali si ign ora ancor oggi l'esatto cat al ogo e che sono sparse per og ni dov e: già q uelle più o meno in d ividu at e si trovano in u na decina di archivi d i t r e di versi pa esi (e forse di più che tr e, se, come è possibi le, ve n e sono in Ungheria, Po l o n ia o Svezia) . Di esse non è anco r a nemmeno cominciato un prim o ce n si m ent o Si è quindi deciso - in pieno accordo con l'Uffic io Storico dello St ato Maggi o r e Esercito, cui va il m eri to d i aver osa t o intraprender e la pubblicazio ne d ei presen ti volumi - di limita r e inizialmen t e t ale pubb l ica zi o n e alle opere teor iche militar i, ma di includerle tutte: così ch e i l p en siero di Mo ntec u ccoli appa r isse, già ne i pr imi due vol um i, n ella sua interezza ed attraverso la sua formazio ne ed evol u zione, i n maniera organica e completa. Si sono inve ce r i mandat i ad un fu tu ro che si auspica n on lont ano, ol tre a quegl i sc ri tt i di carattere sto rico, di aristico, ecc ., in ogni caso non appartenenti alla categoria p r esce lta come inizia le, anche qu ell i minori, sovente a carattere occasionale.
Tale escl u sione è stata p articol armente d olorosa. La te nta z ione di inserirne s ubito almeno alcuni era forte : ma ciò avre b be alterato la struttu r a ch e si era deciso di dar e alla prese nt e edizione. Si s p era che cos ì, quando appa rir anno i futuri vol um i, l'opera av rà una maggior siste maticità ed una mig liore coe renza.
Circa i test i, si deve dire che essi sono tali quali il Moncecuccoli ce l i h a las c iati nel la loro s t es ura definit iva L e correz io n i del curato r e sono state ridotte al m in imo indispe n sabil e Mi sono cioè li mitato a riord i n are qua e là la pu nteggiat ur a, ad un iformar e l'u so d elle mai u sco le, a sp ezzare qua lc h e paragrafo eccessivame nt e lungo (soven t e due o tre pag in e di seguito), a far cadere la lette ra «h» muta in parol e come huomini, havere, ecc. ed a sostitu i re la «u » con la «v» qu ando necessario (come in vittoria che gl i amanuens i del tem po solevano scrivere uittoria); infine a uniformare la grafia dei nom i p ropri su quella p iù
co mun e ment e usata o non e rrata (così Wistok, che ric o rre qualche vo lta, è staro regolarizzato in Wittstock; Fridland in Friedland; ecc .) . on mi sono mai preso l'arbitrio di alterare o modificare in qual sias i modo i testi di Montecucco li: quando una qualche parola appariva (sovente per guasti al ms.) del tutto illeggibile, essa è stata semplicemente indicata dalla scritta (illeggibile), né si è tentato d i sostituirla arbitrariamente; quando un' i ntera frase sembrava priva di senso compiu to (sovente per la dimenticanza, forse da parte del copista, di un soggetto o predicato) si sono seg uiti due criteri: a) se la parola era facilmente intuibi le essa è stata aggiunta tra par e ntesi quadre, onde si potesse vedere che non appariva nel ms. originale: si tratta per lo più di pronomi o articoli; b) in caso diverso la frase è st ata data tal quale, e s e ne è tentata u n a s piegazione in nota. Mai ci si è presa, con in testi di Montecuccoli, la minima libertà.
Infine si sono tenute le an not azioni al minimo indispensabile, resistendo alla tentazione di interpretare il Monrecuccoli e lasciando questo al lettore: le note, quindi, sono per lo più semplicemente esplicative e fattuali e sono, ove necessario, di st inte dalla sigl a «N .d.C. ». Le altre so no disti nte dalla sigla <,N.d.A.» e si inte ndon o del Montecuccoli stesso.
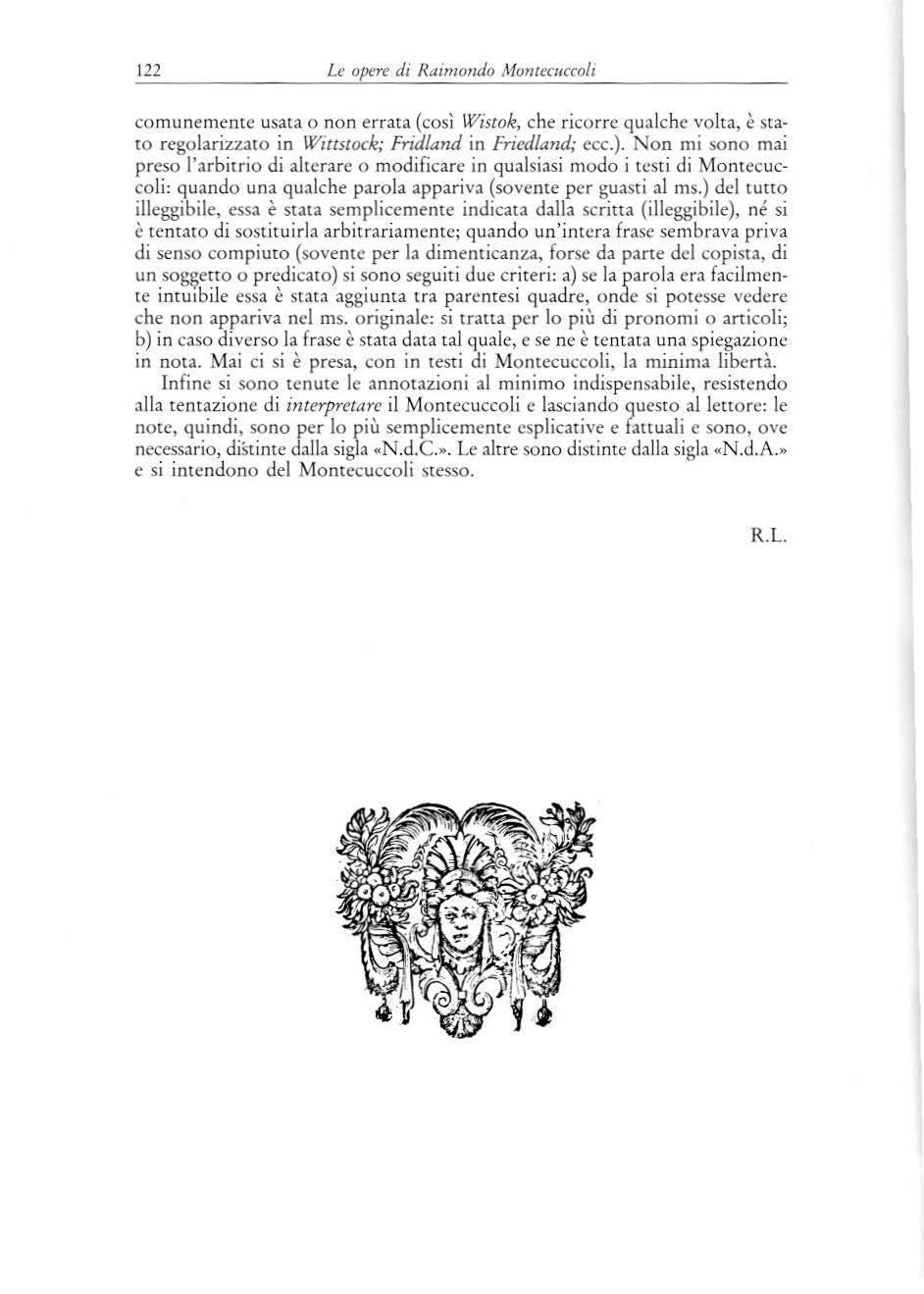


S critto a Steuino nel 1641 durante la prigionia, il Trattato della G ue r ra è la prima grande opera sistematica in cui Montecuccoli esprime per intero il suo pensiero s1-1lla guerra, vista come fenomeno globale, inserita nel contesto stesso della storia e della evoluzione sociale. Non, in altre parole, la guerra come continuazione, sì, della politica ma sosta n zialmen te es t e rn a ad essa. Tale sarebbe stata la concezione clausewitziana, importantissima, geniale e profonda senza alcun dubbio: ma frutto di una società in cui le convenzioni ed i valori, malgrado tutto, ancora conservavano un sostanziale equilibrio fondato su precisi limiti; ciò sebbene i tuoni annunzianti la nuova era si fossero già sentiti in determinati atteggiamenti della Rivoluzione Francese e più ancora della guerra popolare spagnuola o russa contro l'invasore.
Montecuccoli scavalca co n st i va li da sett e legh e tutta la visione otto centesca: e anticipando il futuro ci dà la prima visione globa l e, drammaticamente valida proprio nella nostra era, dominata dagli orrori del terrorismo, della guerra ideologica, inserita nello stesso tessuto sociale, e insomma di ciò che gli strateghi moderni definiscono low intens it y con fl ict, il quale può di colpo balzare all'alta tensione senza un sostanziale mutamento qualitativo.
Forse fu l'atmosfera stessa della guerra di religione permanente del Diciassettesimo secolo che acuì in Montecu ccoli la v i sione: fatt o sta che la sua dott rina dei conflitti non può non sbalordire il lettore di oggi.
Di questa prima, fondamentale opera di Montecuccoli non esiste più il manoscritto originale: contrariamente a quanto credeva il Veltzé che non ebbe campo di vedere i codici conservati nella Biblioteca Estense di Modena, il Ms. Modenese non è l'originale, ma una copia forse {ma è dubbio) riletta dal Montwtecoli stesso; certo, non priva essa pure di errori di trascrizione, in parte facilmente individuabili. Così pu re appare da escludersi che il Ms. Viennese sia una copia del Modenese: le variant i, se pure di modesto ordine, sono più che sufficienti a dimostrare l'erroneità di questa tesi, che il Veltzé avan zò, lo si ripete, solo perché non ebbe occasione di vedere il Ms Modenese
Entrambi dunque i codici appaiono copie di un originale andato secondo ogni probabilità perduto: e la mancanza di quelle correzioni di pugno dell'A. che invece si riscon trano in copie di manoscritti di altre opere, fa sì che la certezza assoluta di una perfetta ricostruzione del testo in ogni minimo particolare sia impossibile: ciò sebbene la illeggibilità o anche solo il dubbio permangano unicamente per pochissime parole o per qualche isolata frase, specialmente là dove i due Ms. presenta · no varianti. Q uanto alla data zione, essa appare del tutto sicura, Jìguran do su entrambi i Ms. Più difficile qualche volta diventa la lettura a causa dello stile af frettato, di opera butt ata giù (l!A stesso ci dice di non aver nemmeno riletto parte di essa). ln qualche caso ciò dà origine ad una prosa contorta e n on chiara: sebbene sia rimarchevole come il Montecuccoli sia riuscito, scrivendo in tal modo sen%a rilettura o rifinitura, a darci nella quasi totalità un'opera leggibile, incisiva, sovente brillante e sempre del più vivo interesse.
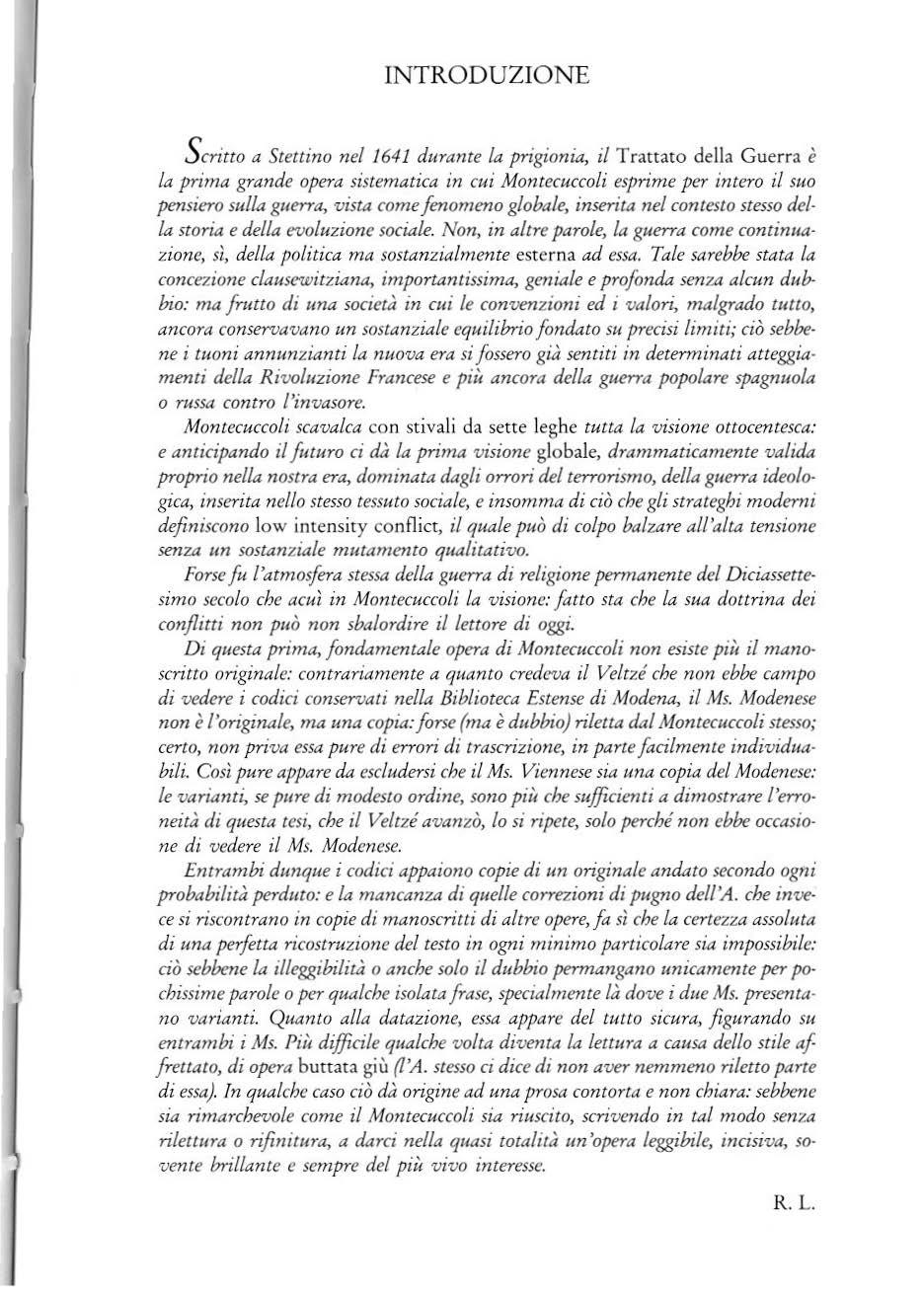

Se qualcheduno s'abbatta a caso a legger e questi fogli, sappia di prima v ista ch'io non gli ho scritti a lui ma a me stesso, e che non avendo avuto altro fine che di piacer e di giovar all'animo mio, ho a questo sc opo solo diretta tutta la forma di quest' opra. L'infortunio d'una lunga prigionia che nell'azione mi tolse dall ' azione, ha svegliato la mente a contemp lar quelle cose che ne la preparin o a sap erle fare, per poterle poi operare quando l' occasione di tempi liberi lo permetta. Per rend ere l'ozio non o zioso e per poter rendere conto di quel ch'io abbia fatto anche nel tempo in che m'era tolto di pot er fare cos a alcuna , mi sono m esso a scrivere qu esto Trattato della Guerra, perché si può dire guadagnato il tempo il quale , perso inti eram ent e per malignità di fortuna, si rubba per industria a cose più infruttuose: né pot end o impiegarlo come si vorreb be, si debb e v olerlo come si può. Molti veramente, antichi e moderni, hanno scritto della guerra, ma la più gran parte di loro non ha trapassato i limiti della teorica; e se qualcheduno ha avuto la pratica congiunta alla specu lativ a, come Basta , Melzi , Rohan, la Noue 1 ecc., o hanno preso a colti-
• G IO RGIO BASTA, da Casa le (1550-1 612), es perto in Cavalleria, combatté alle dipendenze degli Absburgo sia nelle guer re di re lig ione in O lan da che contro i t urc hi in T ransi lvania, e fu autore pr in cip alm ente di due trattat i: Il governo della Cavalleria leggiera, Venezia, 1611, e il precedente Del maestro di campo generale; FRÀ Luoov1co M ELZ I, milanese (1557-1617), ex gener al e e combatte nte n elle Fiandre, pubblicò ad Anversa nel 1611 le Regole militari sopra il governo et servitio particolare della Cavalleria; ENRI CO, DucA DI RO HAN (1579 -1 638) e FRAN ço ,s DE LA NOVE (1531 -159 1) fu rono, o ltre c he illustr i generali ugo n o tti durante le diverse fasi d ell e guer re di religione in Fra nci a, anche d istint i sc r ittor i mi li tari; il primo pubb li cò ne l 163 1 i l t r att ato Le Parfaict Capitaine, un abregé des guerres des Commentaires de Césare, c he , r iconosciuto per una tra le miglior i opere n el cam po, ebbe u n vast issimo successo, una nuova ediz ione (1636), e fu tosto trad otto in inglese. Dopo le guerre d i religione, riconc iliatos i co n L u igi Xli e Ric he lieu , fu in viato, ne l co rs o della Gu erra dei T r ent'anni, a coma ndare le forze francesi nella campagna d i Valtell in a; successiva mente fu sui fronti della Ger mania, ove cadde uc ciso a Rhe1nfelden. La Noue, già ve tera no delle g uerre d'Ita li a, posc ia condott ie ro u gonot to e più tard i st r et t amente assoc iat o ad Enrico IV, combatté t r a l' altro a Jarnac ed a Monco um o ur. Scrisse nel 1587 il trattato D iscours politique et militaire, la cui u lt ima parte fu sovente pubb li cata sep arata sotto il titolo d i Mémoires .

va re una parte so la d i que sto campo spazioso, o s i sono fermati s u le ge ner alità senza discendere all e p art icolarità dell'arti speciali c h e vi si com prendono sotto; e pure, queste sono quell e che formano la p erfe zion e d'un Capitano, perché egli non è mai poss ibile di co mprend ere p e rfettamente un t utto le cui parti, ch e lo co n stit uisco no , s'ig n ora no.
Qui s'è distinta tutt a l'arte d ella gu e rra nelle sue parti, e ciasc una part e di p e r sé co n la maggior br ev it à e co n la ma gg ior diligenza che sia mai stato possi bile .
P osso giurare di av erci consummato più di du e anni co ntinui , non ost ant e o gni ce lerità, assiduità., e studio ch'io v'a bbia contribuito. H o lett o attentamente le istori e prin cipali degli Anti chi et i migliori Autori ch' h anno dato precetti di gu erra, ai quali ho aggiunto gli es empi di quello che l'esperienza di quindici anni co ntin ui mi può aver insegn ato : m'è piaci uto molte volte d'imitar Lipsio 1hu espon endo i miei se nsi co ll e p aro le d egli al t ri, ma però tradotte nella lin gua Italiana: egli è ben vero c he non ho cit ato i lu oghi degli Autori, perc h é avendo sopra iJ tutto studiato alla brevit à, et essend o molti gli Autori ch e dicono una medesima cosa, il notarli tu tti avria fatt o un volume m aggi ore nelle citaz ioni ch e n ella dottrina2 , e t il citarne uno più ch e un altro avria arguito l'escl usion e de' non ci tati; aggiungasi c he il ci tar i luoghi si fa particolarmente per mostrare che la sentenza ch e s i scrive è appo ggi ata a grande aut o rità e eh' ella n on è fal s ificata. Ma io , che scrivo a me stesso, so che gli occ hi miei non m'hanno del uso e p erò so di n on ave r voluto in gannarmi.
H o talora toc cato qualche uso de ll e guerre anti c h e, sì p erché all' imitazione d i quell e si può tal volta destar lo spirito all' inve nzion e d'altra cosa simil e che si p ossa ridurre alla pratica d'oggidì, sì an che p e rché se rva d'erudizione: ne gli esemp i moderni acce nno so lamente il l uogo o le p e rso n e o le azio n i, n é des cri vo p ro lissa ment e le c ircostan ze: per c hé serv end o a me medesimo ch e gli
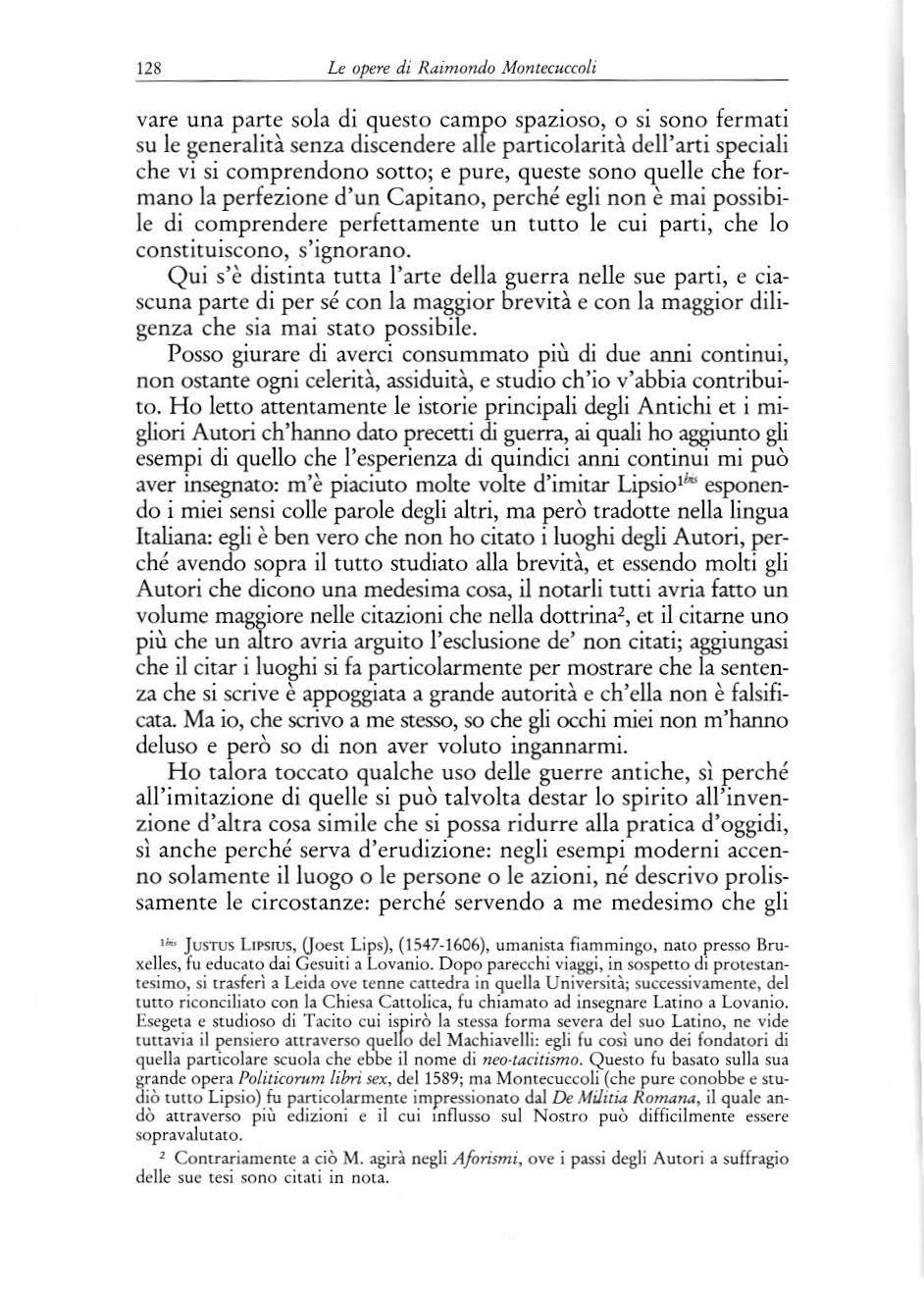
ii.. J us-rus L rPsrus, Qoest Lip s), (1547- 1606), um a n ista fiam min go, nat o presso Bruxe ll es, fu ed ucato dai Ges ui ti a Lovanio . D opo parecc hi viaggi, in sos petto di p rotestantesimo, si trasferì a Leida ove tenne cattedra in quella Università; successiva mente, del tutto rico nc ilia t o con la C hi esa Cattolica, fu chia mato ad insegnare Latin o a Lovanio. Esegeta e st udi oso di Tacito cui is pi rò la stessa forma severa del suo L atino, ne vide tuttavia il pensiero attraverso que ll o de l Machiavelli: egli fu così uno de i fondatori di q uella particolare scuola che ebbe il nome d i neo-tacitismo. Questo fu basato sull a sua gra nde ope ra Polilicorum libri sex, del 1589; ma M on tecuc coli {che pure cono bbe e stu· diò tutto Lipsio) fu panicolarmeote impressionato dal De Mi/.itia Romana, il quale andò attra ve r so più edizio ni e il cui mflu sso sul Nostr o può diffic ilme nte esse re soprava lutat o.
2 Contrariamente a ciò M. agirà negli Aforismi, ove i pass i degli Autori a suffragio delle su e tesi sono citati i n n o ta.
ho visti, basta solo che mi sia fatto risovenire il successo , che subito la reminiscenza discorre da per sé tutti gli accidenti che v'intervennero, i quali se si volessino spiegare minutamente, non bastarebbono i libri inti eri , né però ho volsuto confirmare ciascun precetto cogli esempi ogni vo lta che ho stimato le regole sì approvate da tutti, che non abbiano bisogno d 'esser autenti cate con esempio, non lasciando essere luogo alcuno di dubitazione; massime quando sono state cose le quali s i sogliano praticar giornalmente.
E· bench'io mi sia trovato, come parte e talora come capo, in quasi tutte le azioni successe nelle guerre germaniche ch'io adduco in confirmazione de' pr ecetti, in ogni modo non m'è parso convenirsi alla moralità de' costumi di nominar me stesso né di publicar i miei gesti: sì perché non ho bisogno di ricordar me stesso a me stesso a cui scrivo e che naturalmente ho in odio questi trasoni 2bis , sì anche perché sono stato mos~o dall'esempio di Basta e di Rohan, due Capitani Generali condottieri d'armate altretanto modesti che valorosi, i quali ne' loro scritti non hanno d'alcuna loro azione parlato: e se Cesare l'ha fatto, egli fu Imperatore, fu il maggior Capitano del mondo et il più eloquente, e però inimitabile tanto nello scriver cose degne d'esse r fatte, quanto nel far cose degne d'esser scritte. Oltre al tempo consummato, non è stata leggiera la fatica di ridurre in uno tutti i precetti che toccano l'arte della guerra e di raccozzar insieme quello che sta disperso in più lu oghi et in più libri, sì che questi pochi fogli rappres entano quasi in un'occhiata tutto quello che appena con grande speculazione si può attingere coll'imaginativa e sono come tanti consiglieri, che preferiscono diverse sentenze e vari mezzi per conseguir un intento, de' quali chi opera può facilmente sceglier il migliore et appigliarsi a quello che più si confà alla qualità del suggetto, del t empo e delle c ircostanze che egli maneggia, purché s'abbia qualche giudicio e pratica d 'accommodare gli universali ai particolari, e come dicono i fisici d'applicare gli attivi ai passivi, senza il qual giudicio ogni precetto et ogni esempio riuscirebbe fallace, perché non tornan_o mai le medesime cose individue, se bene elle tornano sempre in ispezie 21 er
La spesa non è anche stata in quest' opra minore che il tempo e che la fatica, perché per sapere esattamente e dal fondamento
21"' La parola è pressoché illeggibi le, s ia nel Ms . Modenese che nel Vienn ese; prob. è d i origine dialettale. Il VELTZÉ (Ausgewahlte Schriften, vol. I) ipo t izza: Grossprecher, cioè millantatori
2"' Notevole concezio ne pre-vich iana di M.

l'arei sub ordina te alla militare, ha bisognato aver ricorso a i maestri che ne fanno le professioni e pagar lo ro con liberalità la fatica, accioché n e mostr ass ino con fedeltà la dottrina, sì co me n ell a fortificazione, nell'artiglieria, n ella fusione d e' metalli e de' cannoni , n e' fuoc hi d'artifizio, n ella mecanica, ecc., che sendo tutt e arti differenti hanno ri c hiesto diversi artifici e diverse spese, n é sono bastati li sa lari d e' mae str i, ma egli è an c h e stato necessario far diverse p rove e fabricare diversi modelli ac cioc h é l'o cc hio vede sse in concreto qu ell o che l'imaginazione si for mava in astratto, partico larm ente n e lla m eca ni ca e n e' fuochi d'artifizio, dov e senza la prat ica si pu ò agevolmente pi gliar errore nella te ori ca .
Lo sti le nel quale ho sc ritt o qu esto Trattato è poco pulito, ed io confesso in ge nuamente che se be ne ho poca attitudine n ello scrivere, avre i non di me n o potuto ornarlo di vantaggio s'avessi voluto usarvi più cu ra, ma io ho più att eso alle cose che all e parole, sì che in molti luoghi si leggono voci non solo to sca ne, ma anch e Italiane, anzi barbare3 : perché il mio disegno era di farmi raccomand evo le lo scritto p e r la sodiz ia dell a materia e non per la vagh ezza degli ornamenti, e mi sarei fatto cos cienza di spendere dietro alla traccia d'un motto puro o pelegrino quel tempo che con più uti li tà si po tea impiegare ne ll 'investigazione de le cose; e que sto dubbio c he l' ozio , il qual ora purtroppo mis e r ab ilment e m'avanza, mi dovesse mancar e, non m'h a anch e permesso d'abbozzar prima la sc rittur a come si su ole, e poi di sc riverla al n etto, ma mi ha spinto a stenderla sub ito com'ella si trova senz'a n che rileggerla, s1 c h e non so lo vi si troveranno vo ca boli barbari ma anc he sollecismi e sensi st r o pp iati, i quali per ciò m eritan o d'essere compatiti; e fors e c he un 'istessa cosa sarà più d'una volta replicata, o sia p e r mancamento di mem oria, o sia fatto a disegno perché ella serva a più cons id erazioni e s'a datti in più luoghi .
Gli Autori di cui mi so n servito sono dissegnati qui appresso, sì come anch e l'ordine e l'indi ce di tutte le cose, p er rinvenirle con minor fatica ogni volta che si de si dera 4 •

D i Stettino, in Pom eran ia, l'Anno del Signore Gesù Cristo 1641.
3 Sovente ne l cesto sono usat i ge rm anism i (provianda p er provvista d i viveri, ecc.).
• Nell'indice, che segue dopo l'e lenco degli Autori, il riferimento alla nume razione dei fogli del Ms. M o denese è sovente inesatto: peggio ancora se ci sì riferisce al Viennese. Nella presente edìz. tale numerazion e è stata lasciata intana: probabilmente essa si rife ri va al l'o r igi n ale, di pu gno del M ., ch e non è ma i st ato ritr ovato.
AGRICOLA, De re metallica; BARCLAY nell'Argenide; BAR LE Due; BASTA, Del Maestro di Campo generale; CAMPANELLA, Della Monarchia di Spagna; CARLOS CoLOMA, Delle storie di Fiandra; CESARE ne' Commentarii; CoMENIO nella Fisica; CuRTIO ne' Gesti d'Alessandro Magno; COMMYNES; DANIEL MoGuNG, Mechanics o/far hung hammers; ELIANO nella Tactica; ENEA, De toleranda obsidione; FAULHABER; FERRETTI; FREITAGj FRONTINO; FROISSART; GIUSTINO; HERODOTO; HONDJUS; JACOPO DI STRADA a Ro sberg; LANGRINI; LIPSIO, De civili doctrina et De militia romana; LORJNO; MALVEZZI nel Tarquinio e n el Romolo; MAC HIAVELLI, nell'Arte della guerra; NEUMAJR, in Das Verbundnis; la NouE; 0NOSANDRO; PATRIZIO, Della milizia romana; Poumo; PouENO; PLUTARCO nelle Vite degli uomini illustri; PRAISSAC; RoHAN, nel Perfetto Capitano; RoBERTUS DE FwcTIBus; SALLUSTJO; ScttòNBORNER, Della politica; SCIPIONE AMMIRATO; SLEIDANUS; THUCIDIDE; VEGEZIO; UFANO; XENOFONTE; WALLHAUSEN 5
Ordine et Indice de' discorsi e delle P eco rine di questo Trattato con i punti che in ciascheduna d'esse si contengon o.
Questo discorso contiene tre libri.
Il PRIMO LIBRO è dell'intraprender la guerra ed ha qu esti capi:
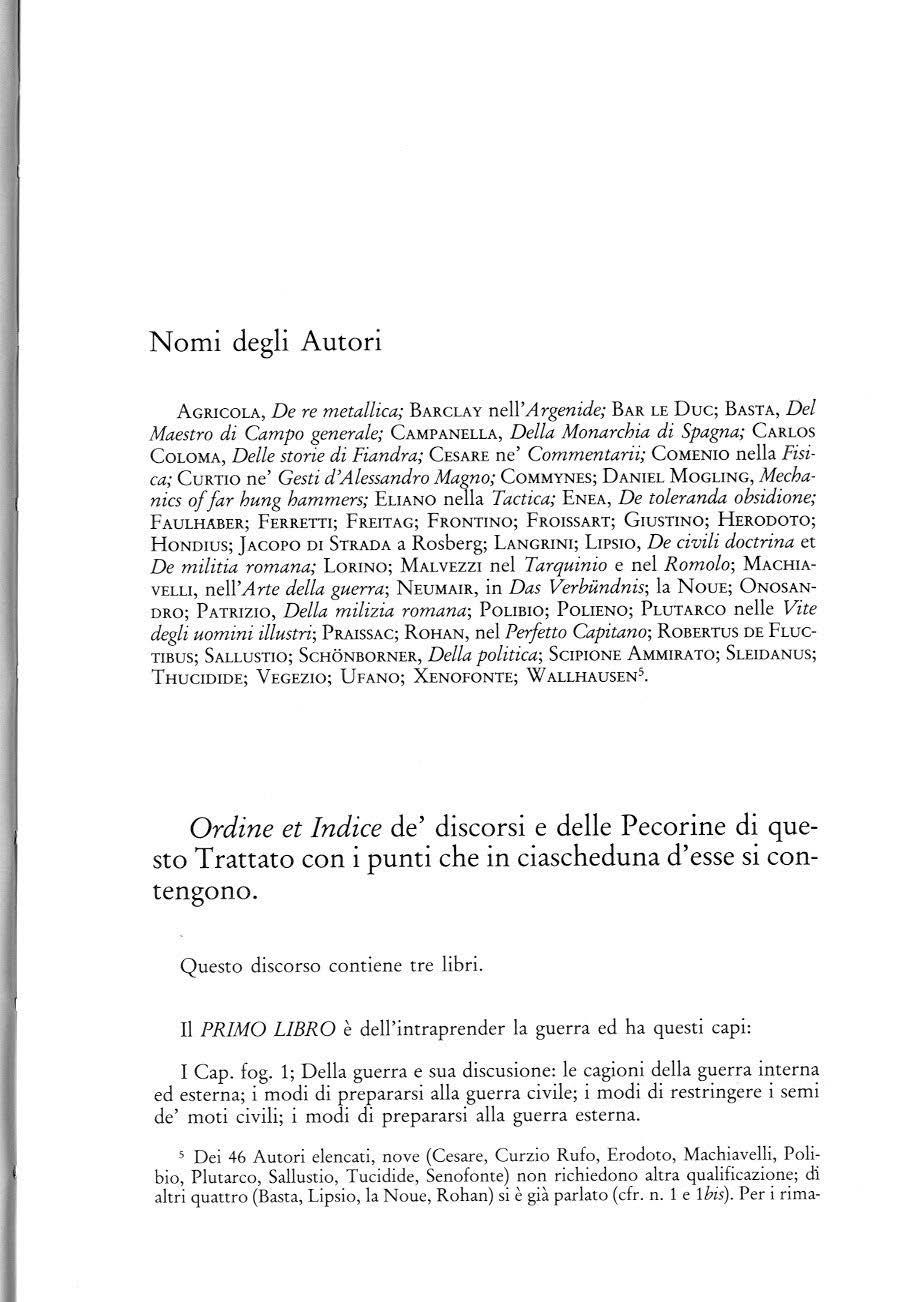
I Cap. fog. 1; Della guerra e sua discusione: le cagio n i della guerra interna ed esterna; i modi di prepararsi alla guerra civile; i modi di restringere i semi de' moti civili; i modi di prepararsi alla guerra esterna.
5 Dei 46 Auto r i elencati, nove (Cesare, Curzio Rufo, Erodoto, Machiavelli, Polibi o, Plutarco, Sallustio, Tucidide, Senofonte) non richiedono altra qualificazione; dì altri quattro (Basta, Lipsio, la Noue, R ohan) si è già parlato (dr. n. 1 e lbis). Per i rima-
II Cap. fog. 8; Delle leghe; co n chi si fanno le leghe; come si proceda diversamente nelle leghe; per qual cagioni si rompano e si disolvano.
III Cap . fog . 10; D ell 'appar ecchio; q uale eg li sia princ i pa l mente; come si dividano gli uomini .
nent i 33 si not i: GEORGIUS AGI\JCOLA (Geo rg Ba uer) , ( 1494-1555), nati vo de ll a Sassonia, noto come il padre della mineralogia, fu umanista, medico, fi sico . Il suo capo lavoro, De re metallica, in 6 libri, pubblicato postu mo nel 1556, fu fondamentale per la metallurgia del suo secolo e del successivo; Jo1-1N BAR CLAY , scozzese (1582-1621), latinista e poeta sa t ir ico, pubb li cò nel 1621 l'Argenis, lungo ro man zo-poem a a chiave, ricco di im plicazioni po liti che, che ebbe su bito diverse traduzioni; BAR LE Due (che T.M . BARKER, The Milir:ary Intellecwal and baule, cit., p. 227, dichiara inidentificabile}, è probabilmente
René de Bar le Due, morto nel 1480, combattente della Guerra dei Cent'anni; TOMMASO C AM PANELLA, il cui nome compare q ui per la pr ima volta, div er rà il pilastro fil osofico del pensie ro del Nostro : di lui per ora M. cita qu i so lo Della Monarchia di Spagna (160 1); DON CAJlLos COLOMA , di Ali ca nte (1573-1637, umani sta, tradusse Tacito in ispagnolo), soldato in Fiandra, Ambasciatore in In ghilterra , Governatore di Cambrésis e di Milano, scrisse Las Guerras de Los Estados-Bajos desde el a. de 1188 hasta el de 1599 (A nversa, 1625); Jo HANN AMos CO MENIUS Qan Amos Komens k y), nato in Moravia (159 2-1 670), educatore , teologo e ultimo Vescovo della Chiesa Morava, oltre alle più no te opere di pedagogia , scrisse tra il 1633 e il 1639 due trattati: una Fisica ed un'Astronomia i qual i, reagendo ad Aristotele ed alla Sco lastica, dovevano gettar le basi per u na fisica "cristiana", in acco rd o con la Sac ra Scr itt ura; P1-1 1L.1P DE Co MMY NES VAN DER CLYTE (14 47 -1511), uomo di stato, mini s tro sotto Luigi XI di Francia, cadde poi in disgrazia durante i regni di Carl o Ville Luigi XII; più vo lte (e infine definitivamente) riabilitato, lasciò nella sua opera Chronique et H istoire... conten.ant les choses advermes durant le régne du roi Louis XI et Charles VIII, abit ual me nte, dal 1552, chia mata Mémoires (l a pr ima edi zio ne comp leta si e bbe ne l 1546) e sc ritta tra il 1489 e il 1498, un ca polavoro ineg uagliat o di storia e di politi ca; AEuAN US T ACTICUS è uno dei quattro com pilatori greci di tattica che M. cita (gli altri sono Aeneas T acti cus, Onosandro e Po lieno). Vissut o a Roma nel II sec d.C , scrisse, forse ne l 106 d C., un tra ttato Taktiké Theoria, dedicato all' Im perat ore Adr ia no; AEN.EAS TA cncus, vissuto nel IV sec. a.C., ide nt ico probabi l mente a quell'Enea di Stimfalo c he Senofonte citò di ce ndo di lui c he combatté a Mantinea , scrisse (o ltre ad altre opere perdute) un trattato sulla difesa delle città; joHANN FAUUiABER (1580-1635), autore di un trattato di geometria pubblicat o nel 1610, si occupò di scien za delle forc ifìcazio n i: a lu i è dovuta l'o pera A rchitectura Martialis (U l ma, 1630), no nché una seco nda, Architectura Universalis (ibid., 1635); DOM.ENICO FERRETTI , fiorentino (1489-1552), fu al servizio di Francesco I e scrisse alcuni trattati politici minori (questa è, per lo meno, la tesi del BARKER, Th e Military Intellectual... , cic., pag. 227; pot rebb e i nvece darsi che i l Ferrett i, cit. da M ., fo sse o Gi ulio Fe rre t t i, raven nate, il q uale pubblicò nel 1562 un trattato di "consigli" militar i, o FRANCESCO FERRETTI, an co netano , che nel 1568 pubblicò un trattato Della osservanza militare) (Cfr.: SrR JOHN HALE, Renaissance War Studies, London, 1983, pag. 431, 465-66); AoAM FREITAG (1602-1664), trattatist a t ede sc o, si occupò di fortifi cazion i; SESTO G,uuo F RONTIN O{c. 35-103 d.C.), so ldato e scritt ore ro mano, pubb li cò un trattat o De re militari, che è pe rduto. Sono invece rimasti gli Stratagematicon libri tres (più un quarto libro, di un o pseudo-Frontino); jEAN FR01SSART, di Valenciennes (1337-1404), sc risse tra il 1371 e il 1404 le Chroniques, c he ne fanno il maggi o r storico della Guerra dei Cent 'a nn i; MAR CO GTUN IANO G1usT1NO , sto r ico roman o, vissuto p rob. nel III sec. d.C., ci dette un' cpit0me dell'opera perduta di Pompeo Trogo, sc ritta al t em po di Augusto sulle monarchie e lleni stiche; HENDRIK HoNDI US (1573-1649), incisore in rame, che ripubbl icò l'opera di Mercatore, si occupò anche di fortificazioni e arte militare, ove scrisse un trattato Horte Beschrijvinge ende afbeeldinge van der generale regeln der Fortificatie, de A rtillerie, Munition ende Vivres...

IV Cap. fog . 17; De ' soldati; come si levino, s'armino, s'ordinino, si facciano passar mostra e giurare, s'essercit i no .
Il SECONDO LIBRO è del far la guerra, et h a questi capi:

I Cap . fog. 18; Della guerra diffensiva: quanto agl i stati piccioli; agli st ati mediocri; agl i stati grandi e potenti.
(I' Aja, 1624), nonc hé una piccola Enciclopedia della guerra in quattro parti; jACOBUS DE STRADA a Rosberg, morto dopo il 1629, storico, scrisse sugli Imperatori Romani; BuoNAIUTO LORINI (c. 1540-1611), veneto, fu ingegnere e costruttore di forti fi cazioni e scr isse il trattato Delle fortificazioni libri cinque, ne ' quali si mostra con le più facili regole la scienza con la pratica di fortificare le città e altri luoghi sopra diversi siti (Ve nezia, 1592); V1RG1uo MALVEZZI, bo lognese ( 1595-1 65 4), storico e politico, consigliere di re Fi li ppo IV di Spagna, scrittore app rezza to e lodato dal Croce , espose le propr ie idee per lo più attraverso lavori biografici, d i cu i M. cit a il Romolo (1629) e il Tarquinio (1632); JoHANN NEUMAIR voN UNO zu R.¼1SLA (1600?- 1650), soldato e scrittore militare, autore di dive rsi trattati, combatté nella Guerra dei Trent'anni agli ordini di Bernardo di Weimar; le sue opere principali furono: Zween Kriegsdiscurs (Francoforte sul M , 1620), sint esi degli scritt i mi litari di Cesare, di Federico da Mo ntefe ltro e di Savorgnano; Vom Krieg, Sonderbarer Tractat Qena, 1641) più a lt ri due trattati sulle alleanze e sulla neutrali tà, apparsi ne l 1620 e 1625; ONOSANORO, t rattatist a greco vissuto nel I sec. d.C., fu autore di u n'opera di tattica vivamente apprezzata dal M., che in gran parte modellò su di essa (in q uanto a strutt ura) il suo Delle Battaglie: l'opera di Onosandro (come già quella di Eliano) è sostanzial mente derivata da quelle , perdute, sulla tattica, di Polibio e Posidon io di Apamea; FRANCESCO PATRIZI , dalmata (1529-1 597), u man ista, filosofo platonico , si occupò anche di po li tica e dell'arte militare antica, ove scrisse d ue trat tati in cui si comparava la prassi mi l itare antica con q uella moderna; PouENo , vissuto c. nel II sec. d.C., fu autore di una co mpi lazio ne di stratagemmi militari, dedicata all'Impe r atore Lucio Vero; i l S1GNORE D1 PRAISSAC, di cui si ha notizia intorno al 16 14, fu autore di un ' imp. opera teorica: les Discours militaires (Paris, 1614); ROBERT\JS Df. F wcTIBUS (Rober t Fludd), nato nel Kem (1574-1637} , fisico, medico, filosofo mistico e alc himista, fu autore di una serie di opere in cui le idee (che potrebbero aver subito l'influsso bru n iano) di microcosmo e macrocos mo si immergono in un'atmosfera fondame nt almen t e irrazio nalis t a; GEORG ScttONBORNER (1579-1637} , fu auto re di parecchi trattati di pol it ica; Sc1P10NE AMMIRATO, nato a Lecce (1531- 1601) e trasferitosi a Firenze, storico e polit ico, pubblicò ne l 1594 un discorso sopra Co rne l io Ta cito che ne fece uno dei sostenitori del neo-tacitismo; nel 1600 apparvero i primi venti li bri delle Storie Fiorentine, da l ui scritte per incar ico del Granduca Cosimo I, mentre i successiv i quindici furono pubblicat i postumi ne l 1641; JoHANNES SLEIDANUS Qo hann Phi lipp i, di Schleiden), (1506-1556), fu il maggiore an nal ista della Riforma, di cui fu anc he attivo partecipante e pensatore; le sue maggio r i opere furono: De statu Religionis et reipublicae Caro/o V Caesare Commentarii, p ùb. nel 1555, e De quattuor summis lmperiis, vasto panorama di storia universale , comparso l' an no della sua morte; FLAv10 VEGEZIO RENATO, vissuto nel IV sec. d.C., so ldato e scr ittore, pubb licò u n trat t ato De re militari, assai utile pe r gl i studiosi , se bbene non per i fi ni pratic i che l' A. si riprometteva, in quanto egli non sembra essersi reso conto della inapplicabilità al suo tempo delle istituzio n i militari antic he che andava st udiando; D 1ECO UFANO (fl. 1613), nato presso Toledo , uffic iale di Artiglieria nelle Fiandre, scrisse un Tratado de la Artilleria (Bruxelles, 1613); JOHANN
jAKOBI voN WALLHAUSEN (fl 1613), progettò un Compendio di scienza mi litare in sei part i autonome, ma pervenne a scrivere solo le pr ime t re: Die Kriegskun st zu Fu.ss (Fr ancoforte su l M., 1615), Die Kriegskunst zu Pferde (ib id , 16 16), A rchilen Kriegskunst (Hanau , 1617); altre s ue opere: Cam era Militaris, oder Kriegskunst Schatzkammer, darinnen
II Cap. fog 22; Della guerra offensiva: se il Paese che s'attacca è largo et aperto; l'azione retta et ob liqua; l'azione delle fortezze
III Cap. fog. 26; Dell'azione nella campagna, come si constri n ga il nemico a battaglia, come si sfugga la battaglia.
IV Cap fog 29; Della disciplina; la conti n enza, la modestia, l'astinenza, li premi e le pene.
V Cap. fog. 34; De' viveri; come si faccia la pr ovvigione, come si distr ibuisca quand'ella è nel cam p o .
VI Cap. fog. 36; De' sp ioni e delle guide .
VII Cap. fog. 38; Del marciare per passar un fiume o qualch e angusto passaggio; per ritirarsi in faccia de l nemico.
VIII Cap. fog. 50; Dell'alloggiare; si va tal'ora coll ' esse rci co ad accamparsi in un paese e perché; quando l'armata vuol soggiornare lungo tempo in un lu ogo; come si disegnino li quartieri in campagna; occorrono molte cose negli alloggiamenti.
IX Cap . fog . 60; Del combattere ; delle battaglie, del combattere particolare, incontri, scaramuccie, sorp rese d i quartieri, d i fo raggieri, ecc .
X Cap. fog. 68; Delie recruite e de' capitani.
Il TERZO LIBRO è del fare la gue rr a, ed ha questi capi :
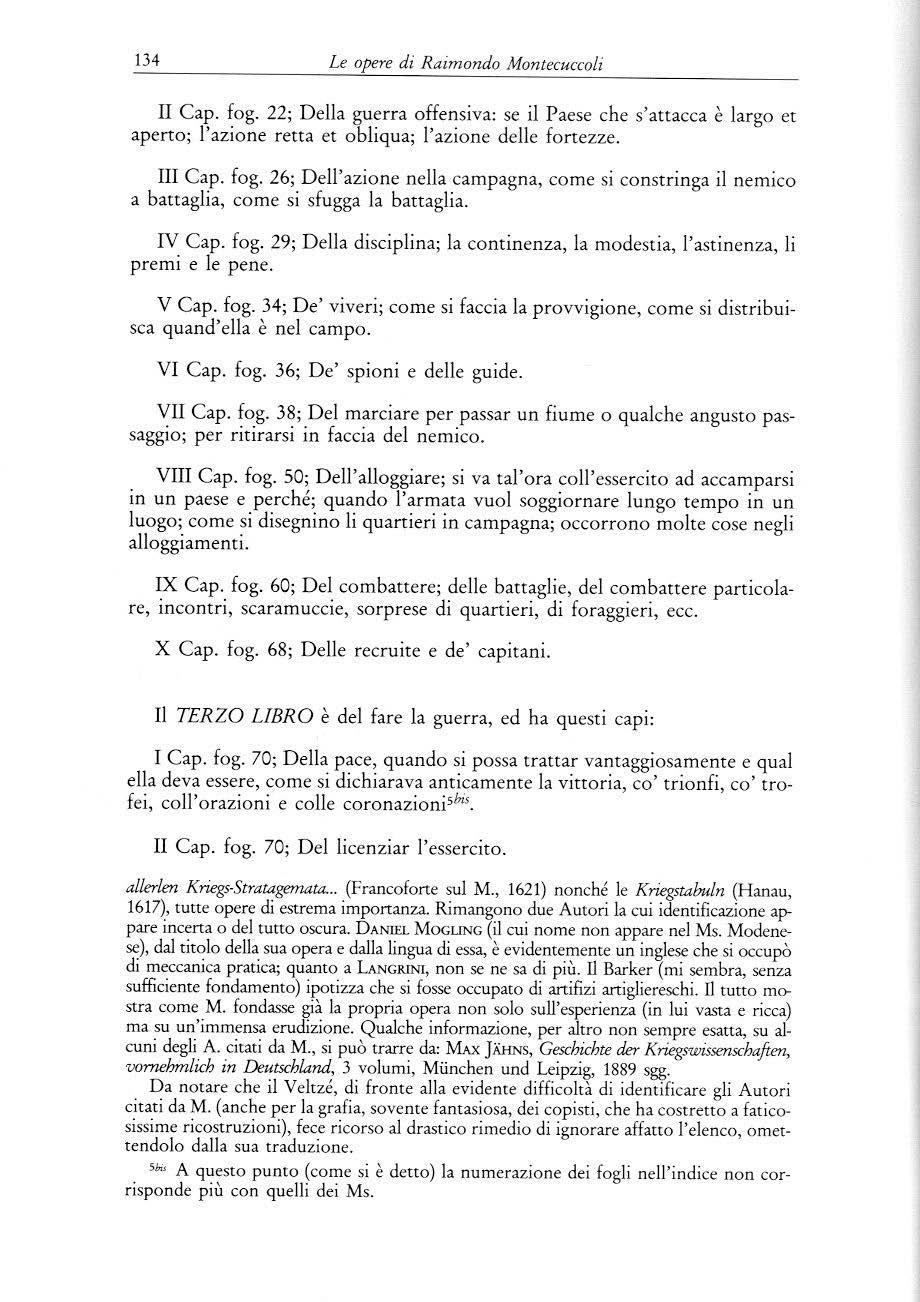
J Cap. fog. 70; Della pace, quando si possa trattar vantagg iosamente e qual ella deva essere, come si dichiarava anticamente la vittoria, co' trio nfi , co' trofei, coli' o r azioni e colle coronazionisbis.
II Cap. fog. 70; Del lice n z iar l'essercito.
allerlen Kriegs-Stracagemata. .. (Francoforte sul M., 1621) nonché le Kriegstabuln (Hanau, 1617), tu t te opere di estrema importanza Rimangono due Autori la cui identificazione appare incerta o del tutto oscura. DANI.EL MoGUNG (il cui nome non appare nel Ms Mode nese), dal tito lo delJa sua opera e dal la lingua di essa, è evi dentemente un inglese che si occupò di meccanica pratica; quanto a LANGRINJ, non se ne sa di più. Il Barker (mi sembra, senza sufficiente fondamento) ipotizza che si fosse occupato di arti6zi artigliereschi. Il tutto mostra come M. fondasse già la propria opera non solo sull'esperienza (in lui vasta e ricca) ma su un'immensa erudizione Qualche informazione, per altro non sempre esatta, su alcun i degli A. citati da M. , si può trarre da: MAX JAHNs , Geschichte der Kriegswissenschaften, vomehmlich in Deutschland, 3 volumi, Miinchen und Leipzig, 1889 sgg.
Da notare che il Veltzé, di fronte alla evidente difficoltà di id entificare gli Autori citati da M. (anche per la grafia, sovente fantasiosa, de i copist i, che ha costretto a faticosissime ricostruzioni), fece ri corso al drastico rimedio di ignorare affatto l'elenco, o mettendolo dalla sua traduzione.
si,;, A q uesto punto (come si è detto) la numera zione dei fog li ne ll 'indice non corrisponde più co n quell i dei Ms.
llI Cap . fog. 71; D el conservare l'acquistato: come si lev i a i popol i lavolontà di rivoltarsi; come si levino loro i mezzi di poterlo fare.
La PECORINA numero I. Tratta della fortificatione, suoi principi e dimostration i.
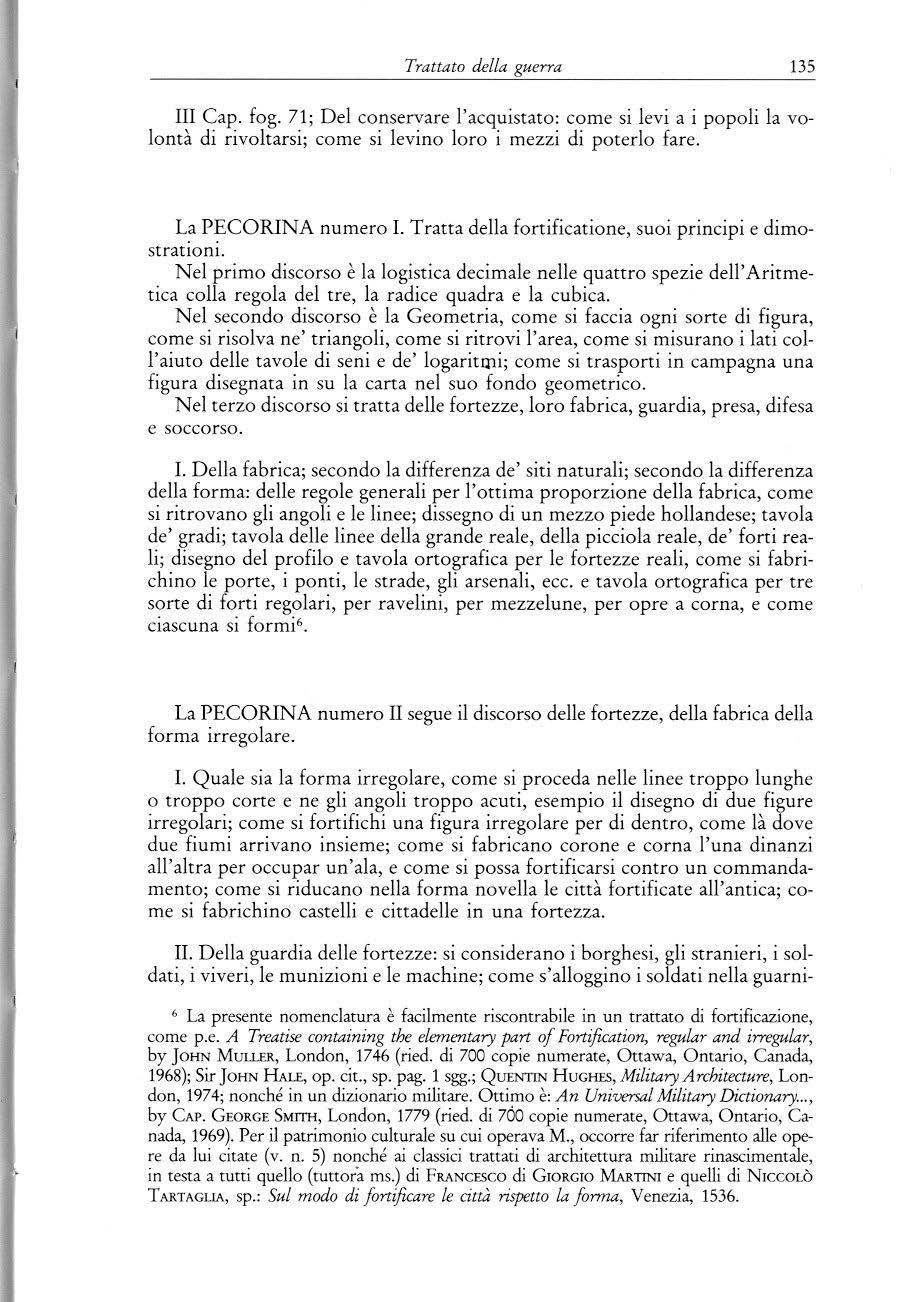
Nel primo discorso è la logistica decimale nelle quattro spezie dell'Ar itmetica colla regola de l tre , la rad ice quadra e la cubica.
Nel secondo discorso è la Geometria, com e si faccia ogni sorte di figura, come si risolva ne' triangoli, come si ritrovi l'area, come si misurano i lati co ll'aiuto delle tavole di sen i e de' l ogaritmi; come si trasporti in cam pagna una figura disegnata i n su la carta nel suo fondo geometrico. Nel terzo discorso si trat t a d elle fortezze, l oro fabrica, guardia, presa, difesa e soccorso .
I. Della fabrica; secondo l a differenza de' siti naturali; secondo la differenza della forma: d elle regole general i per l'o tt ima proporzione della fabrica, come si r itrovano gli angoli e l e linee; dissegno di un mezzo pi ede hollandese; tavola de' gradi; tavola delle linee della grande reale, della picciola real e, de' forti reali; disegno del profilo e tavola ortografica per le fortezze reali, come si fabrichino le porte, i ponti, le st rade, gli arsenali, ecc. e tavola ortografica per tre sorte di forti regolari, per ravelini, per mezzelune, per opre a corna, e come ciascuna si formi 6 •
La PECORINA numero Il segue il discorso delle fortezze, della fabrica della forma irrego lare .
I. Quale sia la forma irregolare, come si proceda nelle linee troppo lunghe o tro ppo corte e ne gli angoli troppo acu t i, esempio il disegno di due figure irregolar i; come si fortifich i una figu r a i rregolare per di dentro, come l à do ve due fiumi arrivano insieme; come si fabricano corone e corna l'una dinan zi all'altra per occupar un'ala, e come si possa fortificarsi contro un commandamento; come si riducano ne ll a forma novella le città fortificate all'antica; come si fabrichino castelli e ci ttadelle in una fortezza.
Il. Della guardia delle fortezze: si considerano i borghesi, gli stranieri, i soldat i, i viveri, le munizio n i e le mac h in e ; come s'alloggino i so lda t i ne ll a guarni-
6 La p resente nomenclatura è facilmente riscontrabi le in un trattat o di fortificazione, co me p. e A Treatise containing the elementary part of Fortification, regular and irregular, by jOHN MutLER, Lo ndon, 1746 (ried. di 700 copie numerate, Ottawa, Ontario, Canada, 1968); Sir JOHN fuu:, op. cit., sp pag. 1 sgg.; QUENTIN HucHES, Military Archùecture, London, 1974; nonché in un dizionario militare. Ottimo è: An Universal Military D ictionary... , by CA P GEORCE SMITH, Lo ndon, 1779 (ried di 700 copie n umerate , Ottawa, Ontario, Canada, 1969). Per il patrimo nio culturale su cui operava M., occorre far riferim ento alle opere da lui citate (v . n. 5) nonché ai classici trattati di architettura militare rinascimentale, in testa a tucti que lJ o (tuttorà ms ) di FRANCESCO di GIORGIO MARTINl e quelli dj NICCOLÒ TAJ\TAGUA , sp . : Sul modo di fo rtificare le città rispeao la forma, Venezia, 1536.
gione, come si mettan o le guardie, come montino; come si guardin le porte , quanti de vo no esser i viveri, come s'a bbiano a v isitare i magazini; deg li stromenti che vi bisognano , de ll e m unizion i.
III Della presa dell e fortezze, consideraz ioni che si devono avere sopra l'assedio, i nnanzi all'assedio , durante l' assedio; dove si tratta d ella circon vallazione, delle trinciere, de' rido tti e delli altri fort i ni per i quali è descritta una tavo la ortografica col d issegno di ste lle e d'alt ri fortini con mezzi balluardi d'approsci; di tra ve rsi , e della fortificazione d'un triango lo equilat ero, e degl i approsci in retta linea et in linea angolar e; come si facciano le batt erie , le gallerie, le mine
La PECORINA numero III. Segue il d iscors o d ell e forte zze nella presa e durante l'assed io.
Come si facciano i se min ell i, come si minino le roccie; come si fanno le capitulazioni quando una città s'arrende; come si diano gli assalti; doppo l'assedio, s'egli s'è costretti a levar lo, o se si guadagna la piazza; la presa d elle fortezze per la via retta diuturna o per obliqu a; la presa per la via retta e subita; la presa p er la via obliqua, detta stratagema e sorpresa per p ettardo, per cattiva guardia d'una porta, per isca lata, p er difetto di muraglia , per intelligenza o tradi m ento.
IV. Della difesa delle fortezze contro l'assedio dove si notano di vers i modi di sc riv er o ccultamente; co m e si distr ibuisca la gente ne' posti, s'impedisca al nemico l'approcciare, s'impedisca il passar il fosso, s'imp ediscan le min e, si facciano le riti r ate, overo trincer am enti generali e p articol ar i, si sostengano gl i assalti, e come si fabricano palizzate, gabbioni, cavaglier i di frisia, t riboli, ecc . e ché si faccia doppo l'assed io; e contro la via r etta diu tu rna: contro la via re tta, e sub ita: contro li strata gemi in generale 7 •
La PECORINA num ero IV Segue il discorso dell e fortezze n ella diffesa contro i stratagemi, in partico lare contro il p ettardo; contro all' int ell ige nza e trad im ento

V . Del soccorso , come si porta apertament e o segre tament e e per istratagema : come s' impedisce.
Nel quarto discorso si tratta d ell e ma ch ine e princ i palmente del cannon e, e de' fuochi d'artificio .
I. Ch e cos a sia mach ina; che tut ta l'artiglier ia usitata è oggidì compresa sotto a due gen eri, cioè cannoni e co lubrine; propor zione che deve aver ogni pezzo n ei s uoi membri, con un can none disegnatovi; che vento si dia alla palla; ta vo la cubica p er formare un (i ll egg ib ile) n on conviene col peso di quel luogo dove altr i si ri trova, com e s'aggi usti; come da ll a proporzione del canno-
7 Cfr. n. prece d ente
ne si tiri la proporzio n e d el s uo letto, messo in dissegno in sieme con la ruo t a e co ll 'asse; come si faccia la prova d ' un can no n e s'egli è b u ono, come si vis it i d i dentro e di fuori; quanto pesi ciasc h edun pezzo be n proporzio n ato, et una tavola circo lare co n una sc a la fatta sop ra u n ci lindro d i metallo per la q ual misurando u n pezzo si può subito sa p ere senza pesarlo quanto sia grave ; quanta polvere s i deve dare alla ca r ica d ' u n pezzo; come si facciano i cucch iari ; come si calibrino le palle; come s'aggiusti il pezzo coll ' uguagl iam ent o e col quadrante; come s'adatt i co n venevolmente il co rpo a caricare e come s'aggiusta un pezzo d i notte t empo; come si ca richi d i dad i, d i pa ll a co ll a stanga, d i palla a for b ice, di p alla a ca t e na; e qu i appartien anche il modo d i caricare le palle i n foca t e, che è d iscr itto ne l fine deg li sc rit t i t edesc h i del cannone 8 •
La PECORINA numero V . Segue il d iscorso delle machin e n el cannone. Pe r qual cagione sco p p ian o i p ezzi; se il c ucchiaro vien a rom p ere, se una palla riman fitta n el pezzo, se il pezzo è inchiodato, s'egli è troppo r iscald ato dal t irar e, se il focone è tro pp o aggran d ito come s'abbia a fa r e; co m e marc i l'artiglieria, con che attir aglio, con ch e gente, per luoghi amici, nemici , pal u dosi, montuosi, dove non possa n o sa lir cavalli, p er un'acq u a ecc.; come alloggi l'artiglieria, che gente si dia a servire a ciascun p ezzo , come combatta l'artiglier ia, come si facc iano le bat t erie, com'ella s'o rd ina i n un giorno d i battaglia; com' ella si fa e traggitta, nel che si conside r a la figura, il mante ll o e il mid o ll o e la c ulatta, p oi come le fo r me si cuocciano e si mett an o dentro alla fossa, e si faccia la fusione, e co me si formino altrame nte i pez zetti piccioli fat t i p er m odello; e come anche si gittino i p ett ardi , i mortari, le gr an ate e le pa ll e di fe r ro; come si facciano altri cannon i appuntuti che si caricano p er di di etro, di cuoio, o alt ramente e co me l'artiglieria si fori e s'acco mm od i doppo essere git tata9 • La PECORINA numero VI. Segue il discorso delle mach in e n ell e minori dove so n o d edott i principi e fondame nt i d ella Mecanica.
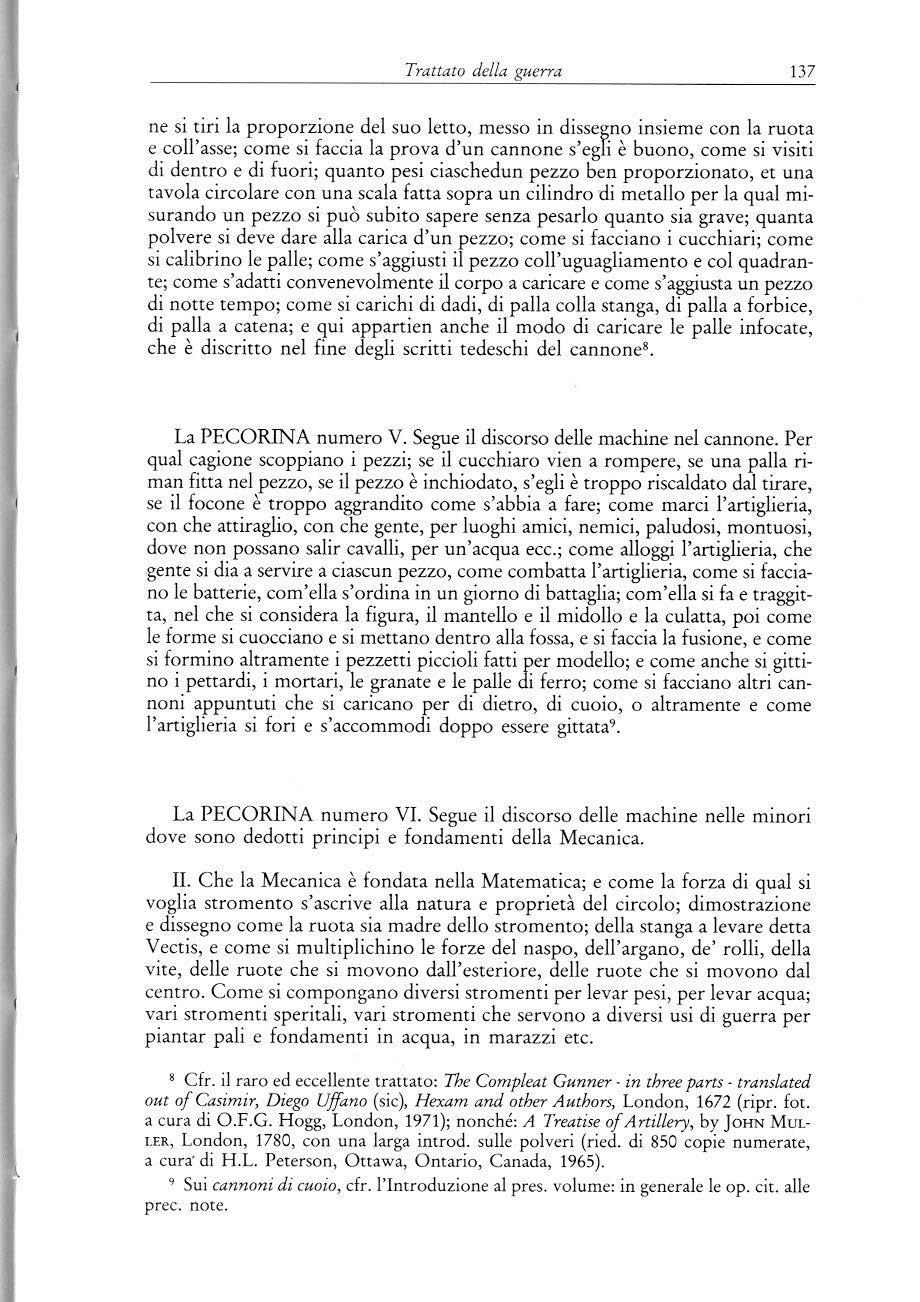
II. Che la Mecanica è fondata nella Matema t ica ; e come la fo r za di q ual si voglia stro m ento s'ascrive alla natura e prop r ietà del circolo; dimostrazio n e e d issegn o come la ruota sia madre dello st r omento; de ll a stanga a levare dett a Vect is, e come si multi p lichi n o le forze del naspo, dell'arga n o, d e' r oll i, de ll a v ite, delle ruo t e ch e si movono dall'esteriore, de lle ruote che si movono dal centro Come si compongano diversi st rome nt i p er levar pesi, per leva r acqua; vari st romenti sperita li, vari stro m enti ch e se r vono a diversi usi di guer r a pe r piantar pali e fondamenti i n acqua, in marazzi etc.
8 Cfr. il raro ed eccellente trattato: The Compleal Gunner · in three parts - translated out o/ Casimir, Diego Ujfano (sic), Hexam and other Authors, London, 1672 (ripr. fo t. a cura d i 0 .F.G. H ogg, London, 1971); nonc h é: A Treati se o/Artillery, by j oHN MuLLER , London, 1780, con una larga introd s ulle polveri (ried di 850 copie numerat e, a c ura· d i H .L. Peterson, Ottawa, Ontario, Canada, 1965).
9 Sui cannoni di cuoio, cfr. l'Intro d uzione al pres. vo lu me: in gene r ale le op . ci t. alle prec note.
La PECORINA numero VII. Segue il discorso d elle machine minori a diversi usi. Per cavar il pantano fuori dall'acque, per rompere l'infanteria del nemico in campagna, per far movere un carretto da per sé per un movimento int erno, per far fortini che vadino a galla e nuotino sopr'acqua; per romper ponti, palizzate e stacchett e; per gettar fuocchi di artifizio; per an dar sott ' acqua. Come si fabrica n o ponti in diversi modi e di materie diverse, come si faccia un vestito di cuoio rigonfiato di vento che sostenga un uomo sopr'acqua; come si fabricano diverse sorte di scale e di molini; che cosa sia il moto, e come semplice, e composto; come si può far movere circolarmente uomini, sfere et altre imagini con contrapesi, con arena, con acqua, con fumo, co n vento ecc.
La PECORINA numero VIII. Segu e il quarto discorso e t ratta de' fuochi d'artifizio. ID - De fuochi d'artifizio compresi in queste proposizioni: I Proposiz ione, fog . I. Della natura e proprietà di tutte le materie ch'appartengono ai fuochi d'artifizio seriosi . II, fog. 13. Come un mortaro si proporzioni in ogni suo membro. III, fog. 15 . Come si preparino le materie squag liate. IV , fog 19. Come si faccia una palla di fuoco con racchette ordinarie, e con racchette mortali 10• V , fog. 39. Come si compongano tutte sorte di Materie per le palle di fuoco bagnate con oglio. VI, fog . 4 . Come si carica n o le palle di fuoco e come s'aggiustino ne l t iro . VIl, fog . 49. Come si fanno le granate co' i cannoncin i che danno fuoco, come si caricano o si ge tt ano. VIII, fog. 57. Come si componga ogni sorta di materia per riem p ire i cannoncini da dar fuoco, sieno lunghi o larghi o st re tti IX, fog. 60. Come si fanno le ghirlande di pece e d'assalto. X, fog. 67. Come si fanno le palle per far buco, o per rischiarare . XI, fog. 69. Come si fanno sacchi, bastoni , pignatte, e botte d'assa lto . XII, fog . 91. Come si proporziona, si carica e si mette il pettardo. XIII, fog. 91. Come si fanno le palle ch ' ardono nell'acqua. XIV, fog. 109. Discrizione delle prin cipali composizioni per le palle ch'ardono n ell 'acqua. XV, fog. 113 . Come si proporzionano le racchette , si riempiono e si fa n no sal ir e 11 • XVI, fog. 140. Delle composizione per ogni sorta di racchette dalle p iù p icciole sin alle più grandi d i 100 l b. XVII, fog. 145. De l salnitro, come si cavi, si purghi e si perfe zioni. XVIII, fog. 159. Come si purg hi il zolfo per i fuoc h i d'artifizio. XIX, fog. 160. Di qual legno, e come si facciano i carboni. XX, fog. 167. Com e si travagli e si dia il grano alla polvere. XXI. Articoli delle persone dell'Artiglieria posti all'altro discorso.

La PECORINA numero IX. Tratta delle battaglie 12 Nel Qu i nto discorso si tratta delle battaglie.
10 Per racchette si intendono razzi di cui si faceva allora cosp icuo uso. Su di essi si veda la classica ope ra di: W 1LL1AM CONGR.EVE, The Details of the Racket System London, 1814 (ried . di 850 copie numerate , Ottawa, Ontario, Canada, 1970).
1 1 Cfr. n precedente.
12 Dal presente sommario de lla P ecorina n 9 appare assai chiaramente come il trattato Delle battaglie sia assai più complesso: il che suffraga l'ipotesi che esso non possa ridursi alla Pecorina n. 9 ma ne sia, al minimo, uno svil uppo ed un ampliamento notevole.
I. Delle considera t ioni innanzi della bat t aglia come si d ee considerare il tempo, i l luogo, l'ordinanza e la figura d'una battaglia ordinata seco n do le rego le dove il sito è spazioso ed un altra dov'eg l i è stretto, e d'una in forma di conio o di mezza lu n a; gli agg i u nt i de ll a ba tt ag l ia come le preghi ere, !'esortazioni, i se gni della pugna.
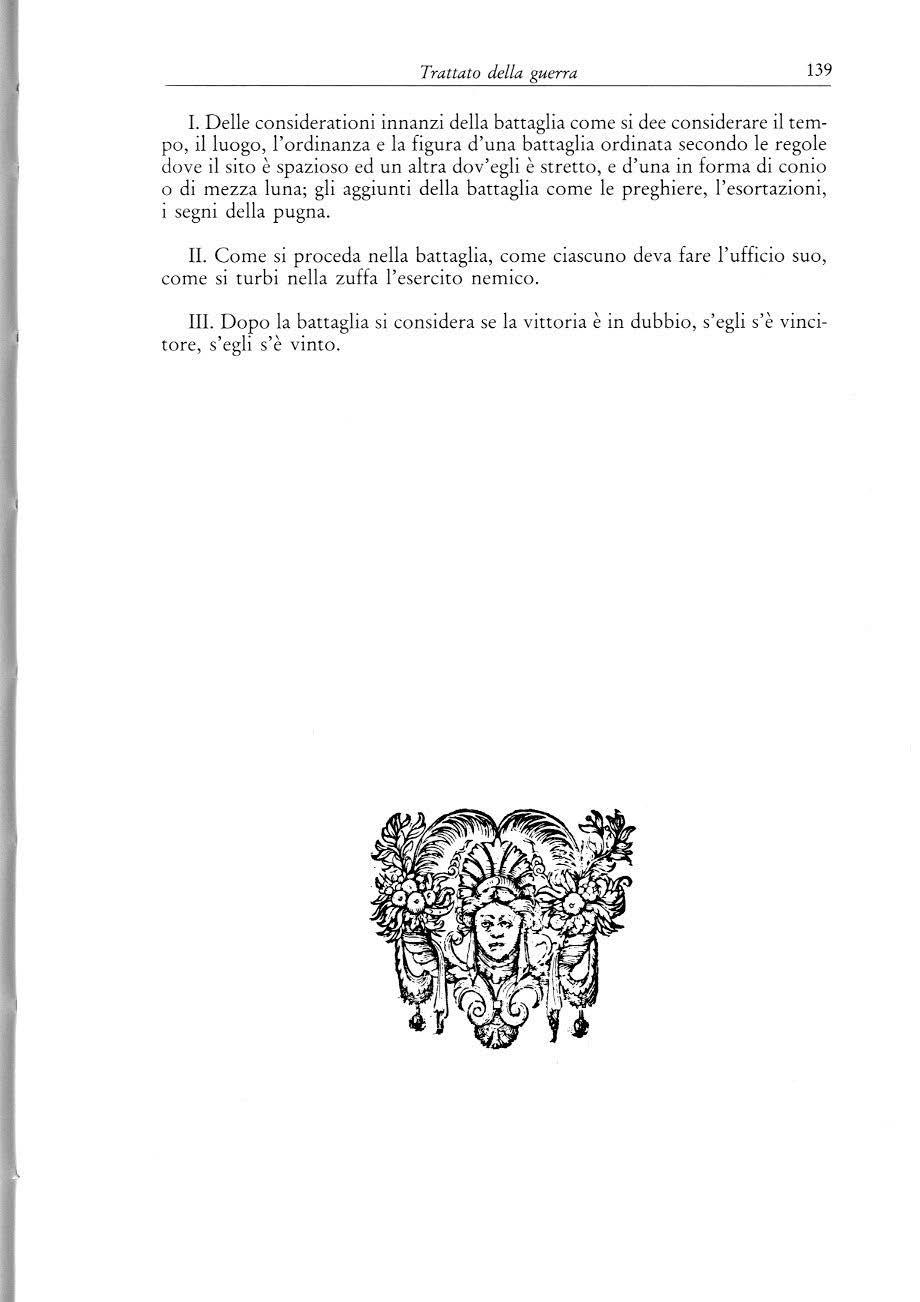
II. Come si proceda nella battag l ia, come ciascu n o deva fare l'ufficio suo, come si turbi nella z uffa l'esercito nem ico
III. Dopo la battagl ia si considera se la v ittoria è in dubb io, s'egli s'è vi n citore, s'egl i s'è vinto.


Della guerra e sua divisione
I. La guerra si fa per mare o per terra, e l'una e l'altra è interna ovvero esterna.
1. La guerra interna o ver civile si defin isce esser l'armi de' sudditi mosse contro al Principe o contro a se stessi.
2. La guerra esterna si definisce esse r la forza e !'arme mosse contra un Principe o contra un popolo straniero.
3. L'Arte della guerra è l'arte di ben combattere per vincere : o diffondendosi, e si chiama guerra diffensiva; o offendendo, e si chiama offensiva; o diffondendo e offendendo, ed è mista.
Quest'Arte è sopra tutte l'altr'arti e senz'essa niuna può aver vita , o uso tranquillo la patria, la libertà, i cittadini; et anche gl'istessi Re si ricoprono nella tutela e nel presidio della virtù guerriera. Tutte !'arti che si ordinano in una civiltà p er cagione del bene comune degl i uomini, tutti li ordini fatti per v ivere con timor delle legge e di Dio, sarebbono vani se non fussino preparate le diffese loro, l e quali, ben ordinate, mantengono quelle anche non ben ordinate. E così, per il contrario, i buoni ordini senza il militare aiuto non altrimente si disordinano che !'abitazioni d'un superbo e regale palazzo, ancor che ornate di gemme e d'oro, quan-
do, senz'esser coperte, non avessono cosa che dalla pioggia le diffendesse.
Le cagioni della guerra interna sono remote o propinque.
I. Sono remote quelle che sono vere e prime cagioni, ma che meno aderiscono all'effetto e meno appaiono, e tali sono il fasto et il lu sso .
1. li fasto in prima, perché dagli eventi di tutte l'età è manifesto che Dio suole quasi solen n emente far ruinar i grandi Imperi per qu esta strada, ed è legge immutabile di natura che ogni cosa perisca, et abbia il suo periodo, e dove una potenza è sì grande c h'una forza esterna non è più capace di moverla o di abbassarla, dovendo cangiare stato, è nece ssario che nascano turbe c ivili che la rend an fievole e stan ca, e conse quent emente preda d'un altro.

2. Il lusso è l 'a ltra cagione, perché da esso nascono i debiti e la po vertà, e quindi le nuove speranze degli impoveriti e indebitati.
II. Sono cagioni propinque le parti o fazioni, la sedizione e la tirannide.
1. Le parti sono un a co ngiunzione di pochi o di molti tra loro ch' hanno dissensione co' gli altri. Nascono da gli odi privati o publichi de' famigliari, o vero dall 'a mbizione, mentre che ciascheduno vuo l e procedere e scavalcar l'altro, et a questo fin e conspirano; si cacciano dunque l'un l'altro come l'onda spinge l' altra onda, e di qui nascon o la co ntenzione, gli odi e la guerra.
2. La sedizione è un movimento subito, evid e nte della moltitudin e co ntr 'al P rincipe o contra al Magistrato. Nasce dall 'oppressione, mentre che si stimano gl'istessi p ericoli rimedi de' pericoli imminenti; o dalla paura, movendo sediz ion e tanto quelli ch'hanno fatto ingiuria temendo il castigo, quanto quelli ch'aspettano l'ingiuria, vo lendo prevenire prim a ch'ella sia fatta; o dall'indigenza soverchia o dall'inopia, mentre che quelli che non hanno cosa alcuna invidiano a i buoni, odiano le cose vecchie, desid eran o le nuove, e per l'odio del lor misero
stato st udiano ch'ogni cosa si muti. O da i capi, ch'eccitano la moltitudine e per contagione la fanno insanire . Questi sono gli uomini ambiziosi che non hanno speranza che p er le discordie, e st im ano di poter conseguir nella republica turbata quegli onori eh' essi disp erano nella quieta; sono gli uomini poveri et indebitati , sono i v ani e viziosi 13 che, non tanti lieti de' premi, de' pericoli stessi, vogliano più tosto le cose nuove, ambigue e dubbie, che le certe e già acq uistat e; sono gli uomini insigni che hanno ric evuto qualche maltrattamento e in gratitudine dalla patria o dal Principe, e vogliono v indicarsi.
3 . La tirannide è l'imperio viol ento d'un solo oltre i costumi e le leggi, ed è v iolento p erché, nel commune odio di tutti, riccorre necessariam ente il tiranno a quest'asilo della violenza, e teme tutti perché si fa temere da tutti, e se nza legge e senza giustizia ama i riportatori, diffende i cattivi, odia i buoni, teme gl'illustri, i dotti, gli scrittori, vive in continuo timore; la potestà sua non dura, è cacciato o morto.
Le cagioni della guerra esterna sono il più delle volte l'ambizion e e l'a vari zia, l'i ra, e l'o dio; sì che la profonda cupidità dell 'i mperio e delle ricchezze e la libidine del dominar e sogliono esse re i motivi del guerreggiare de' Pr incipi che misurano la grandezza della gloria dalla grandezza dell'imperio; e ciò accade più negli animi e nelle nature più grandi, alle quali par bello il ce r ca r e trionfo da ogni occasione .
Quest i ripon gano ogni legge, ogni ragione nell'arm i, stimano ch'ogni cosa sia d ell i uomini forti, cercano l'es ito della guerra e non la causa, e fanno reo e colp evo le il vinto.
I. Qualunque si sia la cagione della guerra, ella è colorita col candore d ella giu stizia e del suo mantello r icoperta, dando pretesto all'armi di guerra gius ta, la quale per esser giusta, dee avere l 'auto re la causa et il fine giusto.
1. L 'autor giusto è il Principe, o quelli che in ciascheduna R epublica tengono luogo di Principi, incorrendo per legge in pena capitale chi p r ivatam ente senza publica approvazione fa pace o guerra.
13 La lezione viziosi non è sicura Il Viennese ha rentosi, che è pr iva d i senso; a meno che n ell'orig. perduto non si leggesse riottosi.
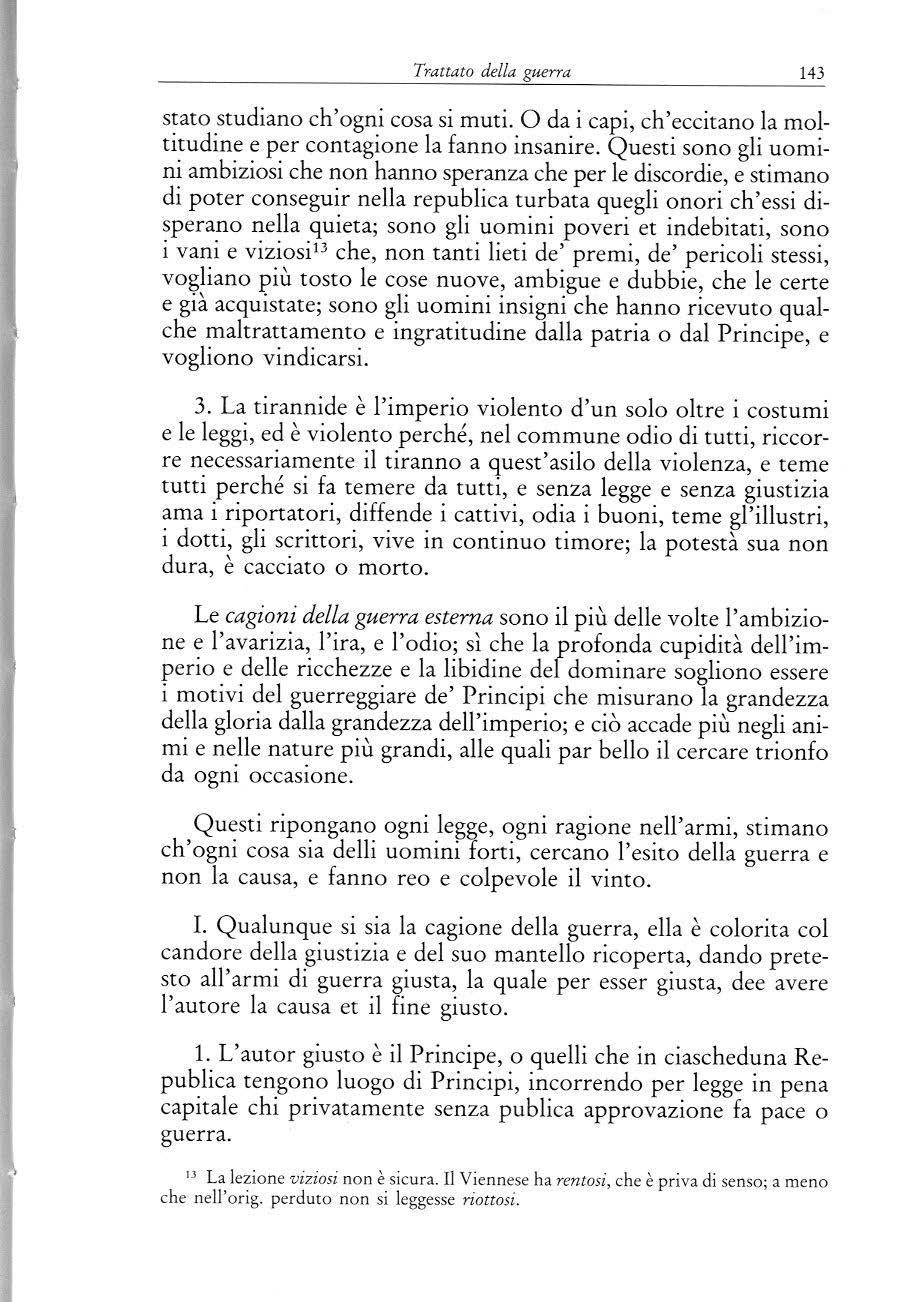
2. La causa giusta è di due sorte, cioè diffensione et invasione. Nella diffensione , chi dubita? Egli è non solamente giusto, ma anche necessario il diffendersi dalla forza con forza; la ragione ha ciò prescritto agli uomini dotti, la necessità ai barbari, il costume alle gente e la natura stessa alle fere che, con qual si s ia mezzo che possano, respingono sempre ogni forza dal corpo , dal capo e dalla vita sua; e non solo si diffende giustamente se stesso et i suoi ricoprendo coll'armi la libertà, la patria e i parenti, ma anche si diffendano giustamente i compagni e gli oppressi, richiedendo l' obligo della fede che s'aiutino quelli co' quali si ha lega e patti d'assistenza, et anche quelli che son'oppressi da qualche gran forza e da un'estrema tirannide, perché a ciò sforza il commune legame della società umana, e chi non diffende né fà resistenza all'ingiuria potendo, tanto è colpevole quanto s'egli abbandonasse i parenti, la patria et i compagni; et è piena di giustizia quella fortezza che diffende gl'infermi, purché con questo pretesto non s'avanzi il piede e la mano e si pigli l'altrui.
L'invasione è ancora lecita e giusta quando si vendica l'ingiuria e si richiede il suo che non vuol' essere restituito; perché, avendosi due modi di contendere, per disputazion e e per forza, et essendo quello proprio degli uomini e questo dell e bestie, si dee ricorrer all'ultimo se il primo non giova; et è giusta quella guerra ~he è necessaria e l'armi a quelli che non hanno altra speranza che m esse .
Anche un'altra invasione pare legitima, benché senz'ingiuria, com e contro a i barbari e contro a gente che ci è totalmente cont r aria di costumi e di religione , principalmente s'essi sono potenti et abbiano fatto, o facciano, invasione nell'altrui, perché questa è coercitione e repressione del male , e si vince utilm ente colui a chi si le v a la licenza dell'iniquità; né quelle gu erre sono peccati che si fanno pe r frenar i cat ivi e per sollevar i buoni.
3. Il fine gi u sto è quello che non ha proposta la vendetta, la gloria o l'imperio, ma solo la tranquillità e la tutela, e così d eves i intraprender la guerra che non paia che si cerchi altra cosa che la pace; per cagion della pace si fa la guerra, e per goder l'ozio si soffre il negozio .
II. Sono parimente alt r e cagioni che fanno intraprender una guerra esterna, benché tutt e si ricoprano col manto della giustizia; e do v e per rossore non si può direttamente mover guerra ad
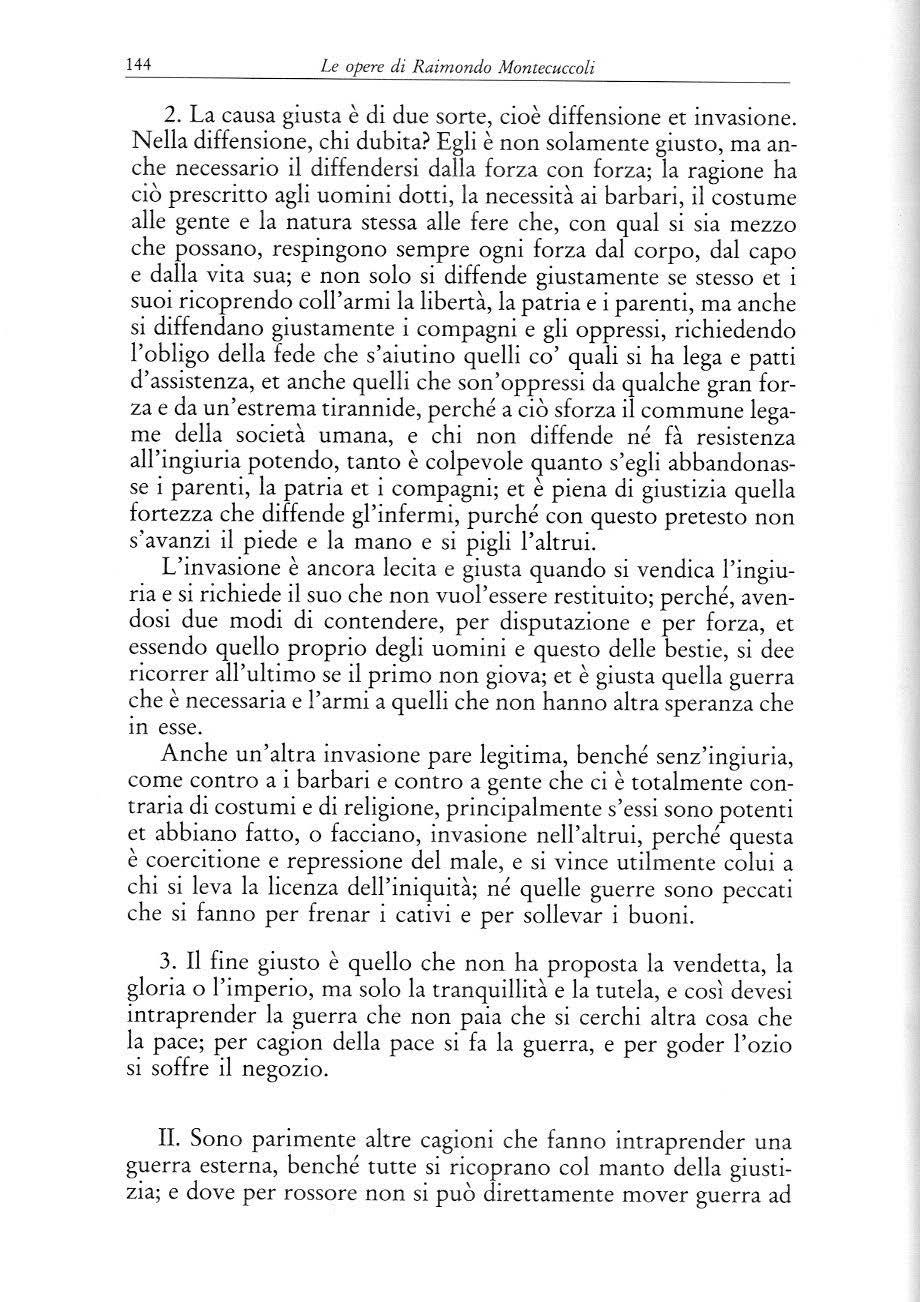
uno contro il quale non s i sa trovare pretesto che vaglia, s'attacca indirettamente assalendo i suoi confederati, sì che sendo obbligato ad aitargli, bisogna necessariamente che muova l'armi; se bene non mancano mai pretesti di colorare onestamente l'impresa contro chi sia, dicendo ch'egli abbia somministrato aiuto a i nostri aversari, come disse il Re di Svezia contro all'Imperatore, ch'avea dato aiuto al Re di Polonia; o ch'ei sia mal'animato contro alla nostra religione, del qual pretesto pur si servì il Re di Svezia contro a Cesare e si servirono i francesi contro a' Barbari, allegando la cagione della guerra essere che i lor maggiori aveano fatto soffrir morte indegna al Salvator del Mondo, aveano escluso il battesimo et aveano giudicato irreverentemente della Vergine Madre13 bis ; o facendo sua propria una lit e ch'un altro ha contro di lui, o entrando in lega co' suoi nemici.
1. Si ha causa di mov er guerra contro un o stato ch'è posto nel mezzo fra tuoi e senza posseder il quale non puoi mantenere né avere communicazione col tuo, e ch'è situato per di là sì che per assicurar questo bisogna conquistar quello. Overo se vi è una città o una provincia molto opportuna al tuo stato, la qual e se tu non occupi sarà occupata da un altro co n danno e timore tuo ete rno, che hai causa di prevenire.
2. Si muove guerra mosso dall'o pportunità de' tempi , come n ella morte d'un Principe , perché i transiti delle cose sono opportuni alle grand'imprese; nelle disunioni e tu rbolenze de' vicini, dove entrato come arbitro o come parte, si vale contro a tutti e si ha occasione di tenere in sequestro la città o la provincia di che d isputano, per levar loro la mat er ia della qu erela; nelle guerre in che un potente è impegnato contro un altro, come il Re di Danima rc a attaccò il Re di Svezi a impedito nella guerra di Moscovia 14; nelle rivolte civili, per le quali è facilitato molto l'entrare ad una nazione forestiera che senza l'appoggio dell'una delle parti non ardirebbe intraprend er d'entrarvi; e così i sve desi coll'appoggio de' protestanti entrarono nell' Al e magna 15
,
3,;,, Pretes ti avanzati dai francesi a giustificazione dell'ottava Crociat a. Il re d i Polo nia cui l'Imp eratore aveva prestato aiuto , er a Sigismondo III, pretendente al trono d i Svez ia, che Gustavo Ado lfo dovette sconfiggere in una serie di campagne.

14 La guerra russo-svedese scoppiò nel 1605 alla m o rte dell'u s urp atore del trono zar ista, Boris Godunov. Sve d es i e polacchi intervennero ne ll a lunga serie di conflitti civili che segu irono, e ciò sebbene Svezia e P o lonia fossero anche in conflitto tra di loro L'attacco danese alla Svezia avven ne nel 1611 e si concluse con la pace di Knarod nel 1613 .
1s Con lo sbarco di G ust avo Adolfo in Pomerania, 4 luglio 1630.
3. S'è incitati alla guerra accioché, sprezzata un'ingiuria, ]'a ltre nazioni non pensino di poter farti l'istesso, et accioché non entri in disprezzo et in opinione d'uom vile, perché nissuno ha ardire di far ingiuria a colui che conosce esser pronto alla vendetta.
4. Si move guerra per non lasciar crescere un vicino in troppa gran potenza, perché val meglio d'offenderlo per impedirlo di mettersi in istato di rovinarti, che di lasciarlo crescere per paura d' offenderlo, essendo cosa sicura ch'egli non si conserva la libertà contro un conquistante con complimenti, ma colla sola forza. O vero per non lasciar venire nella vicinanza un potente straniero, il quale ti possa poi oppr i mere e rovinare come quella cagn a grossa di parto, che chiese in grazia al pastore qualche luogo dov'ella potesse partorire, il che ottenuto, chiese di nuovo ch'ella potesse allevar quivi i canini, ma poi che i canini furono cresciuti, fatta forte del presidio domestico, si usurpò la proprietà del luogo.
5. S'intraprende una guerra straniera per rimediare a una civile, e s'intrattiene fuori per tenervi occupati gli spiriti ambiziosi et inquieti, i q u ali, avendo sempre un inimico a temere e contr'a chi impiegarsi, non abbiano ozio di farsi la gue r ra fra loro nel proprio paese, ma le fantasie de' spiriti bellicosi si scarichino fuori e non dentro, e gli umori depravati delle dissensioni civili siano purgati contro a' stranieri; et anche perché la guerra stra n iera bandisce il l usso, agguerrisce il tuo popolo e ti mantiene in tal reputazione fra tuoi vicini che tu sei l'arbitro di tutte loro differenze.
6. Si movono alcuni Principi alla guerra i n stigati da qualche capo o generale o principale del Regno, il quale, temen d o che in tempo di pace le pensioni, gli stipendi e l'autorità gli manchino, o conoscendo il P rincipe esser di tal naturale che non avendo occupaz ioni esterne ecciti turbolenze in casa, et insomma stima n do che l'ozio del Pr incipe sia contrario alle proprie comodità, procura per tutti i modi di spingerlo a pigliar l'armi per rendersegli necessario e tenerlo in timore, benché a pochi sia riuscito prosperamente di tener in tema il lor Sig n ore . Sono anche furie e fac i di guerra che svegliano un Principe all'armi i nobili, che ne ll a pace hanno servitù più dura et ubbidienza più austera, gl'inqueti, nati per non riposare né per lasciar riposar gli altri, i peregrini e gli esulanti, che mossi dalla speranza o dal t i more e del proprio interesse, spingono all'armi i più tardivi.
Vien anche un Principe instigato alla guerra da un altro Principe il quale, portandogli odio occulto e cercando di farlo rovinare,

l'imbarca in una guerra contr'un nemico molto potente, dal quale è sicuro che quegli sarà consummato, e accioché l'urti, con apparenza d'amicizia gli presta qualche picciol aiuto.
Li modi di prepararsi alla guerra civile sono diversi.
I. La parte che teme d'esser inferiore nel certame domestico, s'applica ad un esterno piuttosto che cedere al cittadino della parte contraria, e cerca d'aver sussidi e leghe di fuori e di ringrossar per di dentro il suo partito, cercando et allettando gli emuli del1' altro, mostrando la necessità dell'armi alla quale s'è indotti dagli insidiatori della sua sal ute i quali sono forti e potenti; né si può vivere sicuro sin che non s'abbiano forze bastanti a lor resistere; e per ciò dimostrare, s'è alcuno volontariamente battuto e laceratosi il corpo, poi, uscito in publico, ha mostrato al popolo le ferite, s'è lamentato della crudeltà della parte contraria dalla quale ha simulato di aver ciò patito: ha aggiunto lagrim e alle parol e e, con orazione invidiosa, ha acceso gli animi della moltitudine credula dalla quale ha ottenuto un numero di satelliti per la guardia del corpo, col qual aiuto ha poi occupato il dominio .
1. Molti similmente hanno mostrato la debolezza della loro parte, et oltre alla guardia del corpo, hanno chiesto qualche luogo munito p er sicurezza ne l qual e cumulando poi giornalmente più gente et avendo un piede sicuro, hanno potuto movere guerra, perché le città forti, potenti, abbondanti e ben sit u ate, sono gli appoggi non so lo dell'armate, ma ançora delle guerre, e, come gran fontane onde scorrono gran ruscelli, possono fornire le commodità necessarie a quelli che non le possono avere d'altrove , servono di bonissima ritirata e sicura in caso di disgrazia o di trattar appuntamento, sono proprie pe r assalire e per diffendersi, assicurano dal castigo e danno agio d'aspettar in sicurezza il tempo di mo ve rsi, quando l'opportunità si presenta.
2. Si attira nella sua parte qualcheduno del sangue del Principe o morto o scacc iato, accioché colla sua voce tiri al partito i principali o il popolo o la maggior parte, sendo che quiv i si ri volge la Maestà R egia dove vien a stare il sangue regio; anzi, c h é alcuni, che hanno avuto similianza nell'effigie e ne' costumi ad un Principe scacciato o morto non manifesta e dubbia, hanno finto d'esser
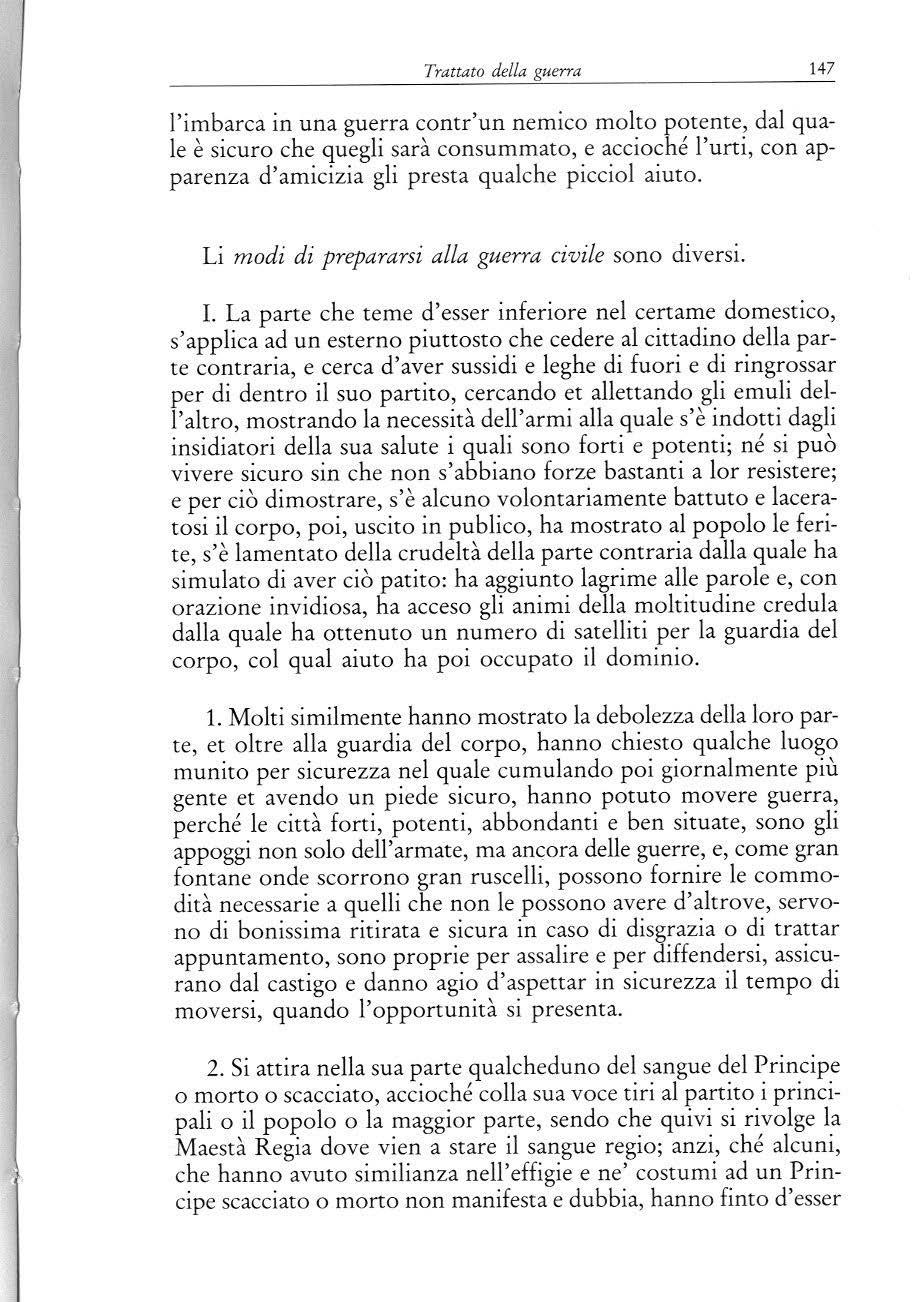
quello stesso, o quello che del suo sangue dovrà giuridicamente succedere, per conciliarsi il favore delle parti.
IL Nelle sedizioni s'incitano gli animi delli imperiti con arte varia, il che anche s'applica tal' ora nelle parti, ne' tradimenti, nell'insidie e nelle congiure.
1. Occultamente e con colloqui notturni o su la sera, quando i migliori si sono ritirati, si aggregano insieme i più dissoluti; quivi s'inseriscono querele, parole ambigue del Principe et altre cose che sogliono commover il volgo; poi, vedendo altri ministri di sedizione pronti et accesi, s'agisce più audacemente, si pub lica il pretesto della libertà, della religione et altri be' nomi e titoli ornati, si ricuoprono i vizi col nome della virtù più vicina nella sua parte, chiamando fortezza la temerità, desiderio di giovar al publico lo studio d'ingrandir se stesso, desiderio di libertà la libidine della dissolutione, né mai fu alcuno ch'ambisse l'altrui dominio che non usurpasse questi stessi vocaboli e non facesse della sua causa particolare una publica, rimostrando ch'egli non vuol pigliar l' armi se non per metter in libertà il popolo, e più atti a persuadere sono i cattivi che i buoni, perché l'improbità discorrendo per i piaceri si serve delle persuasioni di questi, onde molti concorrono nell'ist esso parere, ma la virtù che riguarda all'asprezza et all'erta non è molto potente a trar subito nel suo consenso un parere, massime se vi son altri eh' essortino in contrario alla dilicatezza et al declino. Co' p rimi dunque facilmente concorda il volgo, et in prima i più legg ieri e più creduli, i non provvidi del futuro, i più gonfi di vana speranza; poi, là dove i più sono, concorrono tutti, e quivi ottengon l'imperio i più fe r v idi e più maledici, e quei che, soliti di far invettive contro il Principe, non si riserbano speranza alcuna nell 'avversità, tanto più grati alla ~lebe per esser compagni della colpa e della gl oria ; e quant'uno e più audace, tanto è tenuto più fedele et è in più cre dit o nelle rivolte; e nelle turbolenze anche i malvagi sortis co no onori.
2. Si va con pretesti div ersi per le fortezze e luogh i muniti, e quivi si fanno conviti e festini a i Ma gis trati, e mentre che sono nel fervore dell'all egrezza, s'ammoniscono a non lasciar tradire la publica libertà, et a ricordarsi che sono in un Regno e non sotto una t iran nide; s' aggiungie qualche cosa co nt ra al Re, ma sì am-

Oes Troupes de l' Empere ur, 01v1u' s El'I T OIS UTIU
I Dc f Art lvl,lit ,ut( ("' 'si11lt.1!, J/ Dr/,, Grttrte çQnU( !, Turr Ili. Rt!,:ti?J'I d it /,1 C,u,,p.,gn( de 1664
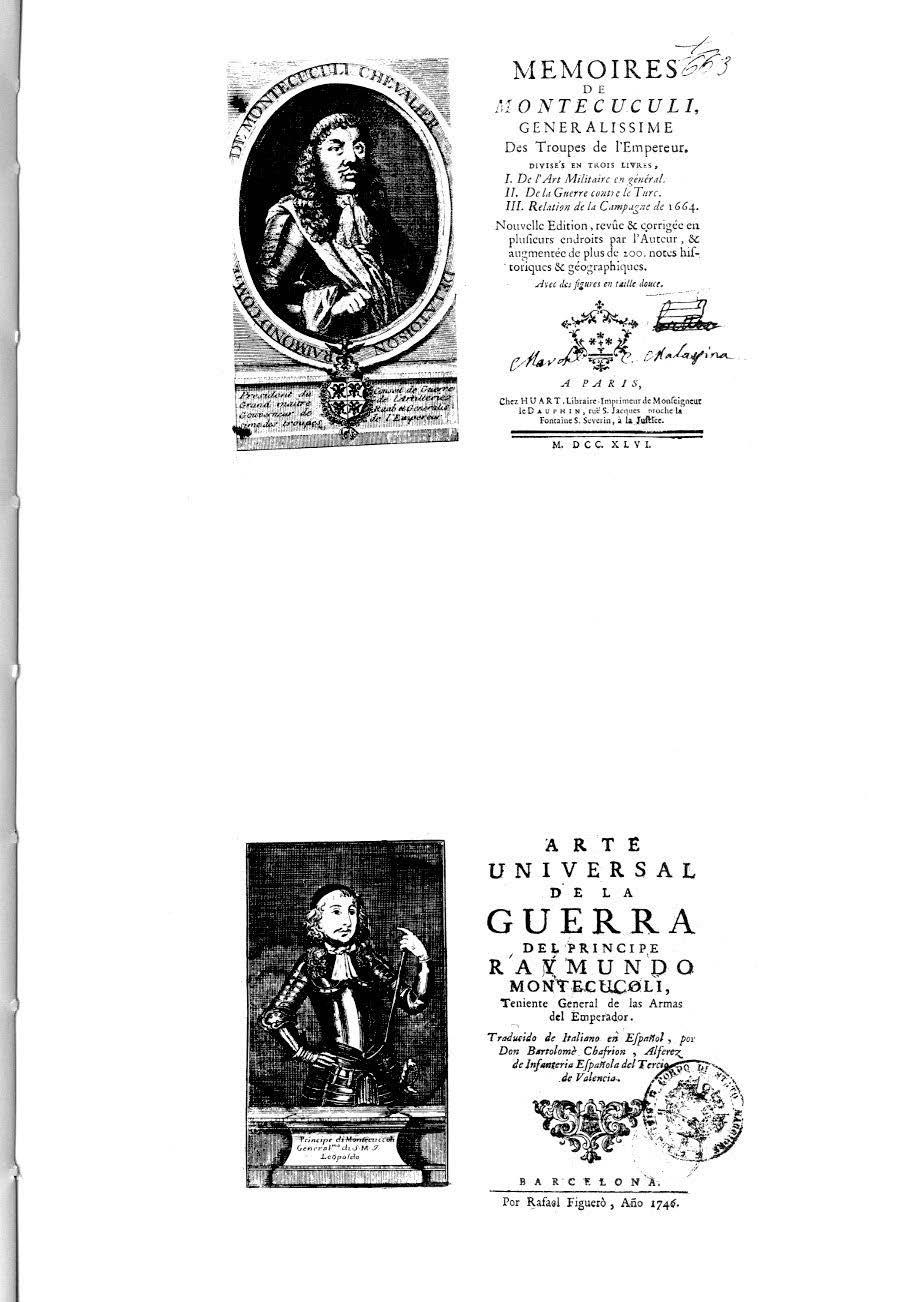
Nou..,dlc Edj ci on. r<:vùc c,o r rigl:c en pl u iic u r5 cn J roits par l 'A utcu r , & ~u1 ~memec dc plus dc 1,00. noti:s b_if•. coriq ucs & s to:;_;raphi t)UCS
A ue d.:4fì:,m, t11 r .,;u, J,11u•
[//(,,,,,,P "·iftf7!. r;tf,.
A P A k I S 0
Che?. li U A ft T, Li bTairc t11.,p, i,.K11 t JcMOà!"cis;t1cat 1t 0 ., 1,1,tc 1 ,r,ri;itS.!1,,111« MOCl1< t..; Fotm1foc $. Si:vain , ÌI '4JWUtc.
M. DCC. XLVL
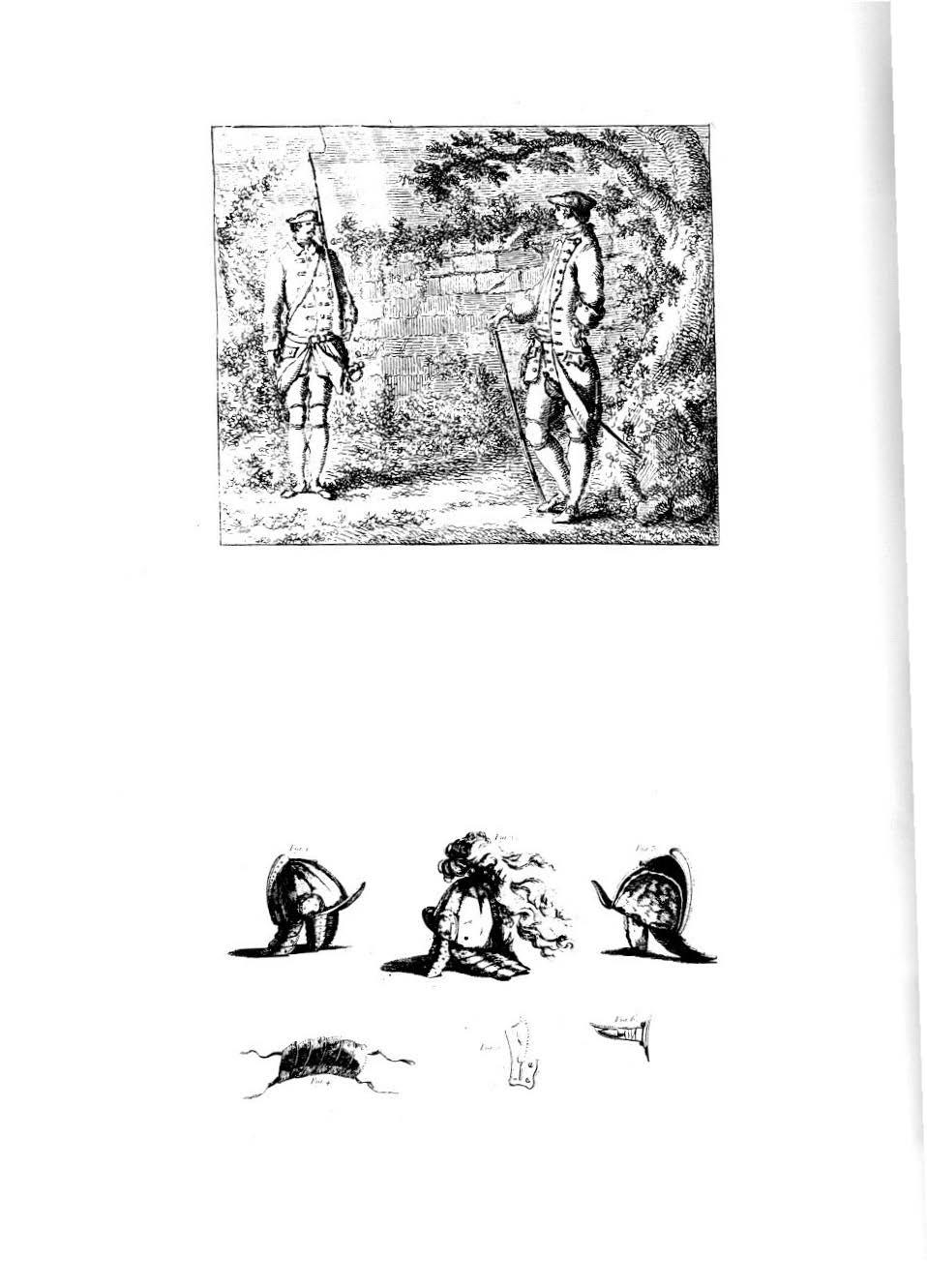
biguo che si possa sempre scusarsi anche alla presenza; e quando si veggono incitati, quasi trattando più famigliarmente, si parla qualche cosa d'imperfetto tra sospiri o publicamente o nell ' orecchio a i principali, quasi paia che con pietosa solicitudine si tema più di quello che si ardisca divulgare.
E quivi si cerca di render il Principe odioso e negletto: odioso, mostrando ch'egli è crudele e ch'egli ha nell'animo di offrir molti a' supplìzi e che solo attende ]'opportunità; ch'egli è avaro, e che vuol augumentar i tributi; che il suo imperio è troppo ristretto e rigoroso senza piacer alcuno; che rompe i privilegi e non osserva le leggi e che, sprezzati i popolari, s'alzano i pellegrini a i primi gradi del Regno et alle cariche publiche; negletto, ch'egli non ha sangue né animo per risentirsi, eh' egli è leggiero e si lascia governare da' min istri; ch'egli è sfortunato, vile e senza fig liuoli; ch'egli è libidinoso, dato al lusso et al vino; ch'egli è vecchio, mal sano e d'aspetto e di presenza indecoroso, insomma ricoprendo la virtù col nome del vizio più prossimo, chiamando ignavia la modestia, nequizia la cautela, viltà la prudenza, superstizione la pietà, astuzia l'accortezza e poltroneria la mansuetudine. Et in questo modo si persuadono al tradimento i governatori delle piazze, nel quale inclinano particolarmente gli avari, che antepongono il loro commodo alla fama, alla fede, et a tutte le cose; gl'instabili e che pendono dalla mutazione de' tempi; i dissimulatori e gli occulti.
3. Si comprano con denari e si corrompono i preti e predicatori che con auguri et auspici inventati predicano mutationi, predicano instare nuovi fati, tempi migliori de' passati et il fine delle miserie; inducono a solevarsi il popolo, persuadendogli che in ogni cosa si debbe servare l'egualità, ch'un uomo non è da più de ll 'alcr'uomo, né il nobile più dell'ignobile, né il ricco più del povero, né il dotto più dell'ignorante; che tutti gli uomini hanno un'istesso principio e devon aver un istesso fine; che sono communi i padri di tutti i mortali, e che que' primi hanno visuto a quel modo senz'osservare differenza alcuna; e che il Creat0re del mondo ha dato il cielo al Signore del Cielo e la terra a i fig liuoli de gli uomini indifferentemente.
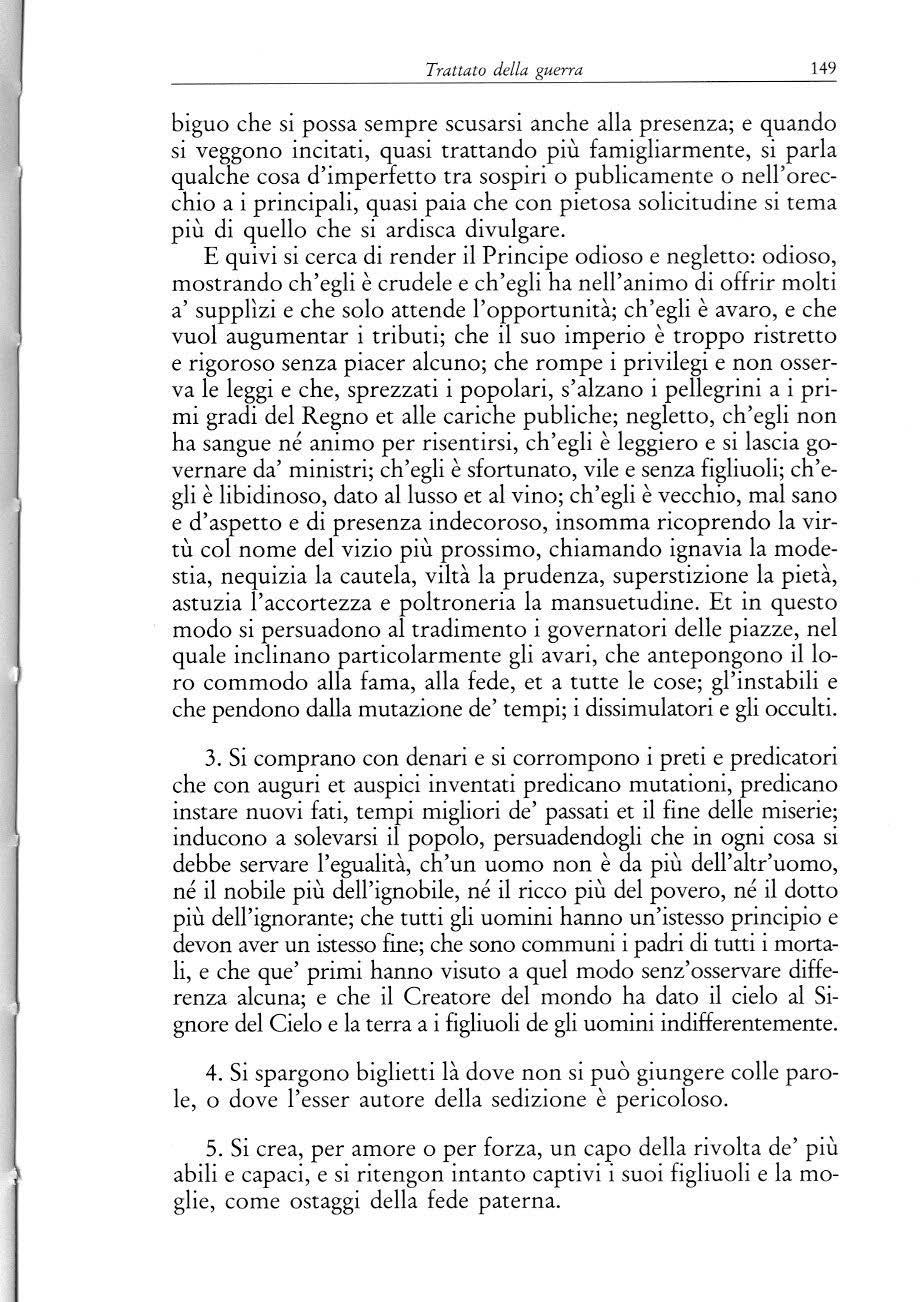
4. Si spargono biglietti là dove non si può giungere colle parole, o dove l'esser autore della sedizione è pericoloso .
5. Si crea, per amore o per forza, un capo della ri v olta de' più abili e capaci, e si ritengon intanto captivi i suoi figliuoli e la moglie, come ostaggi della fede paterna.
6. Mentre che la sedizione è in fervore, si fà commettere qualche sceleraggine et usar qualche tratto irreconciliabile accioché nessuno pensi più all'accordo, né a separarsi dalla rivolta per paura della punizione e del cast igo che gli parrà di aver meritato per il fallo commesso, e che la grandezza de' c rimini escluda la speranza del perdono .
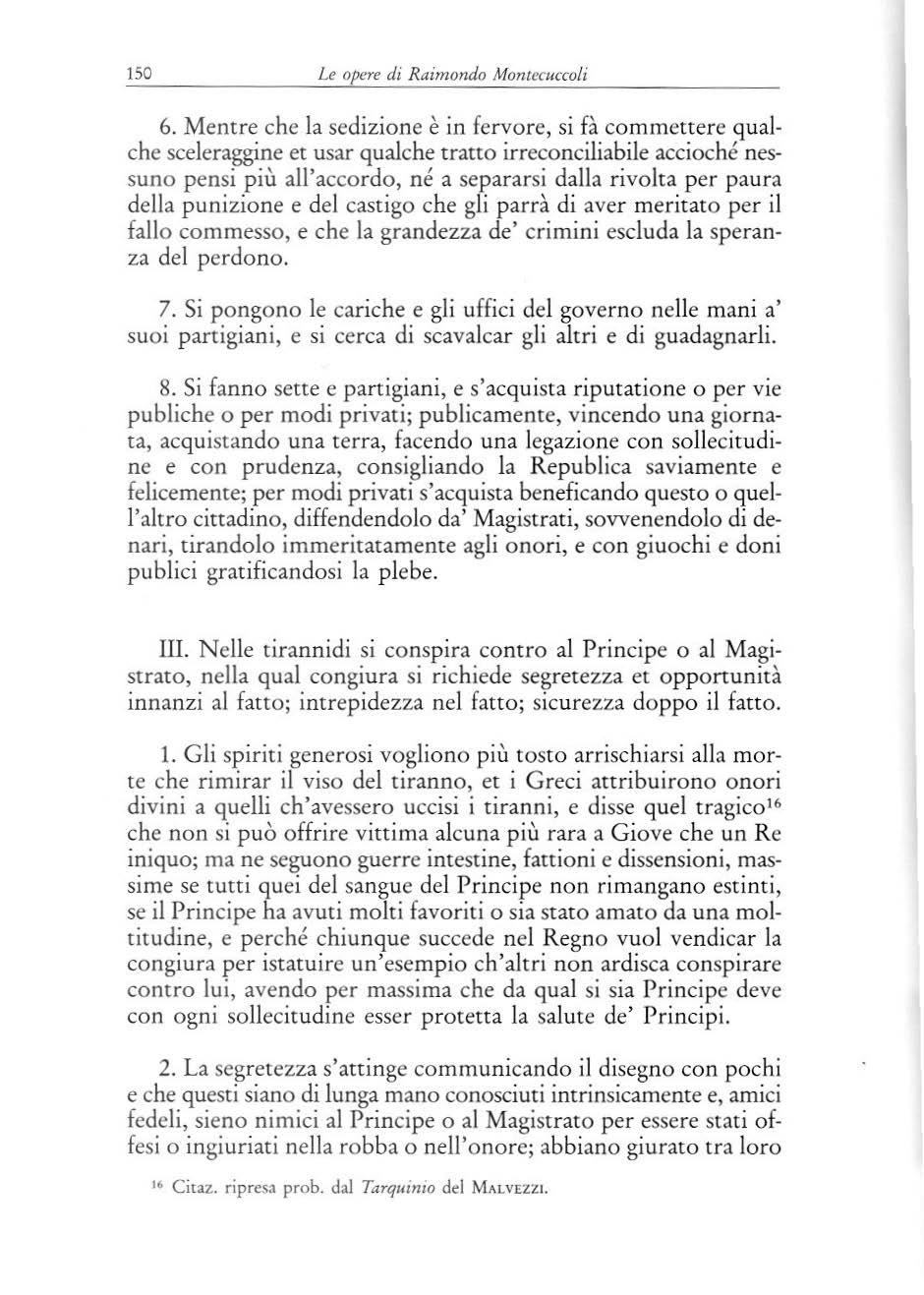
7. Si pongono le cariche e gli uffici del governo ne lle mani a' suoi partigiani, e si cerca di scavalcar gli altri e di guadagnarli.
8. Si fan no sette e partigiani, e s'acquista riputatione o per vie publiche o per modi privati; publicamente, vincendo una giornata, ac qui stando una t err a, facendo una legazione con sollecitudine e con prudenza, consigliando l a Republica saviamente e felicemente; per modi privati s'ac quista beneficando questo o quell'altro cittadino, diffendendolo da' Magistrati, sovvenendolo di denari, tirandolo immeritatamente agli onori, e con giuochi e doni publici gra tificandosi la plebe.
III. Nelle tirannidi si conspira contro al Principe o al Magistrato, nella qual congiura si richiede segretezza et op portuni tà innanzi al fatto; intrepidezza nel fatto; sic urezza doppo il fatto.
1. Gli spiriti generosi vogliono più tosto arrischiarsi alla morte che rimirar il viso del tiranno, e t i Greci attribuirono onori divini a que lli ch'avessero uccisi i tiranni, e disse quel tragico 16 che non si può offrire vittima alcuna più rara a Gio ve che un R e iniquo; ma ne seguo n o guerre intestine, faccioni e dissensioni, massime se tutti quei del sangue del Principe non rimangano est inti , se il Principe h a avuti molti favoriti o sia stato amato da una moltitudine, e perché chiunque succe de nel Regno vuol vendicar la congiura per istat uire un'esempio ch'altri non ardis ca conspirare contro lui, avendo per massima che da qual si sia Princip e dev e con ogni so lle c itudin e esser protetta la salute de' Principi.
2. La segretezza s'attinge c ommunicando il disegno con pochi e che questi siano di lun ga mano conosciuti intrinsicamente e, amici fedeli, si e no nimici a l Principe o al Magistrato per essere stati offesi o ingiuriati nella rob ba o nell'onore; abbiano giurato tra loro
fedeltà con qualche forma di giuramento solenne, e sopra il tutto s'inframetta s ì br eve tempo tra il disegno communicato e l'essecuzione di quello, che non si dia spazio a nessuno di ripentirsi o di scoprirlo: come tal'uno, che, vecchio e senza figliuoli e però senza t emer il rispetto dell'età o d e' pegni, convocati in sua casa i più fedeli amici, gli essortò a liberar la patria dalla tiranide; ma perché quegli indugiavano di finire il publico col privato pericolo, e chiedevano spazio di deliberare, egli , chiamati i servi, comandò che si serrassino le porte e s'avvisasse al tiranno che dovesse mandar gente che pigliasse i congiurati ch'erano appresso di sé, rinfacciando a ciascuno che non p otendo egli essere autore di liberar la patria, v oleva esser autore di vendicarla abbandonata.
Allora gli amici, vedendosi in doppio pericolo, elessero la via più onorata e generosa, e consp iraro no nella morte del tiranno e l'oppressero. E se bene il di segno si communica a pochi, può però ciascheduno di que' pochi aver un seguito di molti de' suoi più amici, i quali sanno in generale di dovergli servire, ma non sanno in che cosa, e sotto diversi pretesti sono r itenuti, o per spezie d'onorevolezza, o p er qualche rissa privata o cosa simile, perché dopo il fatto seguono e di ffendono poi tutti facilmente, secondo il prov erbio cosa fatta capo ha, il che non avriano forse fatto da principio, o, capitato l'uno per qualche accidente nelle mani della giustizia, avria scoperto tutti gli alt ri congiurati, non avendo ognuno la costanza di colui che tormentato dai littori accioché rivelasse i comp lici della congiura, non nominò alcuno de' congiurati, ma dichiarò per complici t utti gli amici del tiranno, fatti morir i quali, e chiesto se vi fosse altri più nella congiura, rispose: egli non r esta più alcuno che io desideri che muoia fuor che l'istesso tiranno; et un altro si rec ise la lingua co' denti, e la sputò nel viso al tiranno 17
3. L'opportunità si ce rca ne' tempi e ne' luoghi dove sia più sicura, più facile e più riusc ibil e, e dove tutti quei del sangue contro a che si co ngiura convengano insieme, accioché non rimanga dopo alcun vendicatore; o se quegli del sangue sono in diversi luoghi, bisog na aver conc ertato che sieno tutti assaliti nell'istess' ora e nell'istesso tempo.
Si possono eseguir le congiure o nel castello, dove il Principe si ritrova , o.ccupate le port e e le guardie; o nel senato, quando tutti sono insieme, o a caccia, dove s'ha commodità di metter imbo1 7 La tradizione attribuisce questo gesto a Zenone di Ele a

scate; o ne' tempi che quello va per la terra a spasso, o ne' conviti, o in qualche pompa e publica festività, dove sotto vari colori si possono ragunare gli amici, o a nozze, o a giuoco, o in chiesa. Si de' disporre, la nott e innanzi, tutto quell o che s'ha da eseguire; ciaschedun o de' congiurati deve sapere distintamente quello che gli tocchi a fare, quale persona in individuo deva ammazzare, quale deve essere il segno dell'operare come per essempio quando si comincia un a tale sonata in un convito, overo in una chiesa quando il sacerdote si communica, o s'alza il sacramento, etc.
Devesi anche conchiudere che se nd o alcuno de' congiurati per qualunque cagione dalla Corte ritenuto, gli altri devano per il mezzo del ferro e de' n emici armati mandar ad effetto il disegno; e però ad ogn'azione devon esser destinate doppie persone, accioché l'una impedita, l'altra possa eseguire.

4. Nel fatto s i richi ede intrepide zz a, perché, se mai in alcuna facenda si cerca l 'animo grande e fermo nella vita, e nella morte per molte esperienze risoluto, è necessario averlo in questa, dove si è assai volte veduto a gli uomini nell'armi esperti e nel sangue intrisi l'anim o mancare; e però devono gli essec utori essere di gran cuore, avere più volte fatto esperienza del coraggio loro, n on s i lasciar addolcir l'animo né intimidire per accidente che arrivi o per sospittione che nasca, et aver già abbeverato l'animo et impresso nella mente l'odio e l'ir a contro a chi si congiura, e sprezzar la vita, perché chiunque sprezza la sua vita è signore di quella d'altrui, e può non istimar alcuno chi non istima la morte.
5. Per la sicurezza bisogna cercare d'estinguere il sangue del Pr incipe, av e r già preparato il favore della moltitudine, aver gente che dopo il fatto seguiti, occupi le porte, le piazze, i luoghi più forti, circuisca con armati la terra e chiami il popolo alla lib ertà et all'armi, benché se il Princip e o Magistrato non è totalmente odiato o negl e tto, spesse volte riesce vano il pensiero che una moltitudine, an c ora che mal contenta, ne i pericoli tuoi ti seguiti o ti compagni, e però bisogna aver forze proprie e rifugi vicini.
6. Le congiure s'eseguiscono c ol ferro o col veleno, e, quando riescono prosperamente, la potenza de' successori ne opprime l'infamia.
Per dar il veleno , o s i mandano in dono cibi avvelenati, o si corrompono i cuochi e t i bottiglieri, o, ridotto il veleno in polve
minuta, se ne fa ve rsare ne' cib i o nella pozione, o si fanno veleni sì potenti che toccandoli co l piede uccidono, e con questi s'ugne una stoffa o se ne sparge come di sabbia un'epistola o un fiore etc. Fu tal donna che per avelenar il ma rit o si servì del mezzo d'un picciolo figliuolino innocente persuadendolo che un tal medicamento, che gli diede, avesse virtù di conciliare l'amore e che secretamente lo dovesse mettere nelle vivande del padre quando e' la vedesse bella, accioché l ' odio di lui si dileguasse e che la benevolenza coniugale si pigliasse fra loro.

Li modi di distinguere i semi de' moti civili sono diversi.
I. Contro al fatto non è rimedio alcuno, non sendo nel potere dell'uomo di svo lgere quello che dal destino è determinato. Ma da questa necessità si deve pigliare argomento di consolazione, perché, non essendo dalla natura conceduto alle mondane cose il fermarsi com'elle arrivano nella lor ultima perfezione, non avendo più da salire conviene ch e scen dino, e similmente, scese ch'elle sono, e per li disordini all'ulti ma bassezza pervenute, di necessità ora, non potendo più scendere, conviene che salgano, e così sempre dal bene si scende al ma le e dal male si sale al bene: perché la virtù partorisce quiete; la quiete, ozio; l'ozio, disordine; il disordine, ruina; e similmente dalla ruina nasce l'ordine; dall'ordine, virtù; da questa, gloria e buona fortuna.
IL Contro al lusso, se si provvede a tempo, è fermo aiuto la censura, ch'è una correzione di que' costumi e di que' lussi che non sono proibiti dalle leggi, né sono ancora degni di castigo, ma negletti e messi in non ca le recano cagione di molti e gran mali , e dalle scuole de' politici s'apprende copiosamente questo rimedio.
ID. Il rimedio contro alle parti è di proibire con leggi severe le fattioni, n é permettere alcun'insegna o differenza di nomi e di vestiti donde possono nascere parti; ma si deve totalmente recidere ogn'i nim icizia e certame ambizioso, e sopra il tutto ogni dissenso di rel igione, ché una apporta unione, e discordia partorisce discordia, perch'è ragionevole che facilmente e prontamente differiscano nelle cose esterne quei ch'anno dissensione nel senso interno e
nella somma istessa della salute: anzi, che volgarmente ne nasce odio quasi contro empi e profani, né temo no di offendere quelli i qual i stimano aver offeso l'i stesso Dio, quindi sorgono sedizioni e ve ngon all'armi, mentre che ciascuno si sforza di anteporre la sua religione all'altre, e ciò è n ecessario, ovvero la religione non è religione , se è cosa fredda né è proseguita con zelo; e così, suscitate le fa zioni, questi o quelli sorgono contr' al Principe s'egli inclina negli uni o negli altri .
E sì come il suscitar fa z ioni in un stato straniero per indebolirlo o nel suo proprio quando non se ne è ancora possessor assoluto o s 'ha pensiero di volergli levar i pri v ile gi o tentar qualche cosa nuova contro di quello, è massima politica, e Carlo Quinto permesse la novità della religione nell' Alemagna per disunir gli Elettori e l'Imperio contro il privilegio de' quali cercava render l'Imperio ere ditario la qual novità è poi stata l'origine di tante guerre civili 18 , così d evons i troncar in erba in un stato nel quale si ha già dominio ass oluto né si cerca d'introdurvi no vità o mutazione alcuna, e nel principio devon si dissipar e le contenzioni de' Magistrati e de' potenti, perché una picciola scintilla negletta eccita sovente volte un grand'incendio e sop rastà sempre gran pericolo in questo genere se si perm ettono congregazioni, concili e consultazioni segrete.
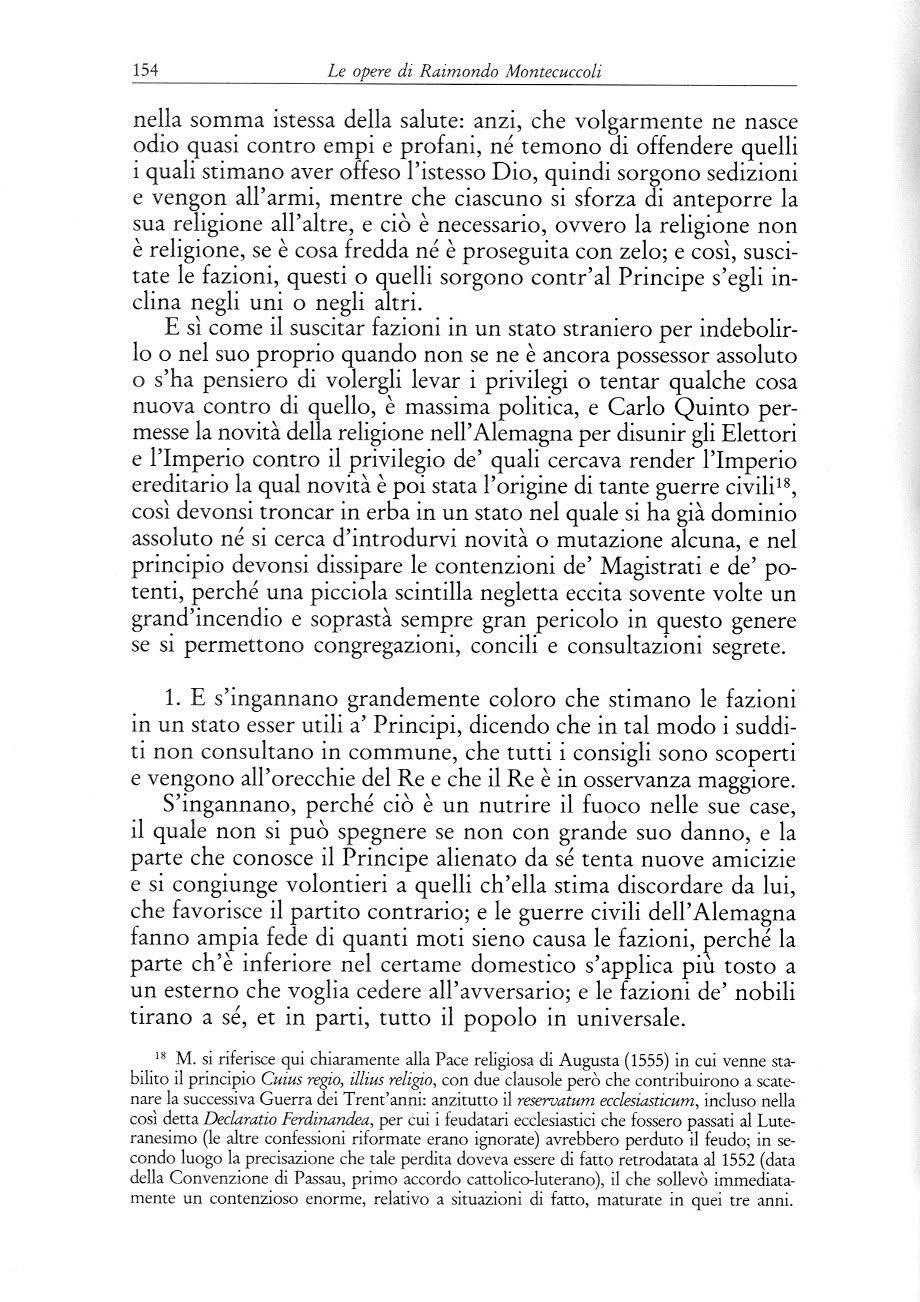
1. E s 'ingannano grandemente coloro che stimano le fazioni in un stato esse r util i a' Principi, dicendo che in tal modo i sudditi non cons ultano in commune, che tutti i consigli sono scoperti e ve ngono all' orecchie del Re e che il Re è in osservanza maggiore.
S'ingannano, perché ciò è un nutrire il fuoco nelle sue case, il quale non si può spegnere se non con grande suo danno, e la parte ch e conosce il Principe ali enato da sé tenta nuove amicizie e s i congi unge volontieri a quelli ch'ella stima discordare da lui, che favorisce il partito contrario; e le guerre civili dell 'A lema gna fa nno ampia fede di quanti moti si eno causa le fazioni, ?erché la parte ch'è inferiore nel certame domestico s 'applica piu tosto a un esterno che voglia cedere all'avversario; e le fa zi oni de' nobili tirano a sé , et in parti, tutto il popolo in uni ve rsale.
18 M. si riferisce qui chiaramente al la Pace religiosa di August a (1555) in cui venne stabil ico i] principio Cuius regio, illius religio, co n due clauso le però che contribuirono a scatenare la successiva Gu erra dei Trent' anni: anzitu tto il reservatum ecclesiasticum, in cluso nella così detta Declaratio Ferdinandea, per cui i feudatari ecclesiast ici che fossero passati al Luteranesimo (le altre co nfession i riformate erano igno rate) avrebbero pe rduto iJ feudo; in seco ndo luogo la precisazione che tale perdita doveva essere di fatto retrodatata al 1552 (data della Conve nzione di Passau, prim o accordo cattolico-luterano), il c he sollevò immediatamente un co ntenzioso enorm e, relativo a situazion i di fatto, maturate in quei tre anni.
2. Egli è ben vero che ei non è inutile ch e di sse ntiscano leggermente fra loro le città confinanti e le provincie, ma leggermente et in risguardo di queste sol bene che non conspirino nel Princip e, e tali p icciole differenze e leggeri odi soliti tra le genti di confine si possono tollerare, ma non già mai quelle vere fationi partico larmente fra nobili .

Possonsi anche seminar astutamente in una famig lia qualche picciole contenzioni e disunione fra servi, se si ha sospetto e si teme la troppa concordia di quelli, e similmente reca gran materia di ridere e di diletto il suscitare tali risse ne gli amori tra le dame, perché non vi è cosa alcuna sì segreta che in questa invidia et emulazione di donne non si risappia; ma l'introdurre tali discordie tra la moltitudine de gli uomini è cosa piena di pericolo.
3 . Aggiungasi che in uno stato tale un Principe viene sprezzato, perché, s'egli minaccia, i vicini, confidati più ne' mali intestini del P rincipe che nella propria forza, si burlano delle minaccie e credono di svegliare fac il mente con piccio lo donativo i suoi sudditi, che lo tengano implicato in una sedizione civile.
Et hanno i popoli ragione di lamentarsi d'un Principe che li tiene involti nelle fazioni. Per comporre questi fatti risguardò già il popolo all a potestà regia, trasferirono nel Re la porpora, il soglio et il ferro, accioché l'ambizione non conquassasse gli ottimati, le fazioni non dividessero una sola gente, non s'avesse a temere da' cittadini quello che sogliono minacciar i nemici. Che, se anche nel regno sono mo lestati da i mali d'una republica, che guadagn o hanno egli!1o d'esser spogliati dell'imperio, e d'aver dato altrui il lor diritto? E del Principe restituir loro la libertà, o procurar loro la quiete domestica per l'amor della quale lasciarono la libertà.
IV. Nelle sedizioni bisogna ripararvi a tempo, perché spesse volte i primi moti si quietano con rimedi mediocri, et ogni male nascente facilmente s'opprime; ma, invecchiato, si fa più robusto. Veggasi dunque che la sedizione che comincia, né ancor è adulta, si volga con migliori consigli. Si mandi chi amonisca, chi persuada e quelli principalmente ch'hanno facondia, autorità, et arte di man eggiar il volgo. Vada tal' ora il Principe stesso in persona, pieno d'ardire, di generosità, d'intrepidezza e di maestà, perché la plebe è tal' ora più feroce a ribellare che a debellare: è di sua natura tener più tosto la libertà, che la difendere .
1. Che se la sedizione è già forte, bisogna adoperare rimedi più forti. Si comprime a forza armandoli contro, ma lentamente, dando spatio di penitenza a' cattivi e di consenso a' buoni, usando vari artifizi: s'offre spera n za, s'accresce il timore, si disgiunge e si separa, e di parti potenti se ne fanno particole minutissime, perch é, quando si vogliono mi sc hiare due co rpi insieme che per la ·loro durezza e contrarietà di natura non possono ricevere mistura l'uno con l'alt ro, si rompono e pestano il più minutamente che si può et allor a per la pico lezza dell e parti si confo ndono meglio insieme, così val meglio divider ancor il popolo tutto in più parti picciole, accioché, gettandosi in altre parzialità, venga a cancellarsi quella principale, la prima fazione essendo divisa e se parata in molte picciole.
2. Si corrompono alcuni e s'attira no con premi occulti; altri si mandano astutamente a' sediziosi, e simulano di vole r essere n el numero e di desid erare le cose medesime, accioché abbiano poi più autorità ne' consigli; s'ingannano con parlar dolce et umano, perché l e parole vag liano molto appresso di loro; e' dicono che ' l lupo non si tiene per !'orecchie, ma che il popolo si de' principalmente menar per !'orecchie; si prom ette ambiguamente, né importa: perché facilmente si fa poi v ano ciò che p e r sedizione hanno forzato, ed è buon inganno, e val meglio ingannarli che farne strage, e se vi è qualche macchia s i lava co lla clemenza e lenità.

3. Se si rimettono al dovere, non s'incrudelisca; la colpa di tutti sia la pena di pochi: basta che gli autori della sedizione lavino col sangue il ma l che com misero , né si ricerchi troppo al sottile, né si faccia inquisizione so ttile de' consapevoli, perché potria essere che troppo grande sarebbe il numero de' colpevoli interessati. Sieno tu.tti sicuri con buona fede; né cercherai, se ben si dica che molt i gli abbiano sosten tati co ll e ricch ezze, o giovani col cons iglio. Odasi il genero so Alessandro che dice: "Assolvo Aminta, et i fratelli, ma v oi giovani amo meglio che vi dimentichiate d e l mio beneficio anzi che vi ricordiate del vostro pericolo. Con quella fede ritornate voi meco in grazia colla quale io con voi ritorn o; s'io non avessi esaminato !'accuse fatte, la mia dissimulazione avria potuto essere molto sosp e tta: ma val meglio che voi siate purgati che sospetti . Pensate che non può esser assoluto se non chi h a confessato il delitto" 19 .
" Assoluto i nte ndasi assolto.
4. Si manda talora ad uccidere il capo della sedizione. Il Principe scri ve di propria mano lettere a i Ministri accioché non seguano il sedizioso né si alterino per la morte di qu ello; mostra d'aver gran confidenza in co lui ch'egli manda ad eseguir l'uccisione, commettendo alla sua fede cosa di grand'importanza, gli ritiene i fratelli o figliuoli in ostaggio mentre ch'esseguisce, gli raccomanda la velocità per prev en ire la celerità della fama e la prestezza tanto nel viaggio che n ell'esecuzione. .

Quasi in tal modo fu tolto di mezzo il Friedland, capo d'una sedizion e contro l' I mperatore 2 0
5. Mandasi talora governatore e capo di sedi z iosi o rib elli un Principe naturale del Paese, accioché non facciano difficultà d'accettarlo , e quegli li volga poi co n destrezza a consiglio migliore.
6. Si di ssi mula talora di sape re la conspirazione per non mette rli in n ecess ito di agir prontamente, ma che per qualch e accidente si se parino e poi si co lgano divisi, e così declinasi la sc eleraggine, non vendicasi, accioché in una sedizione potente non faccia più male la cosa conosciuta che meditata.
7. Si fa pace co' sediz ios i, accioc h é quei che si so no aggregati insieme si spargan o e poi, dispersi, difficilmente si ricongiungano, e s'abbia spazio di mett erli in rissa fra loro o renderli odiosi al popolo, o che sazi dell'inquietudine delle cose nuove essi da per sé r itorni no dalla sed izione alla riveren za della Maestà ; e sì co me i fili sottili e sciolti faci lmen te si rompono, ma se con modo violento s'implicano, quanto più forte si pressa tanto più fort e si stringono e si congiungono in una fune la quale non s'è più bastanti di romp ere , così questi da per sé fatti forse più negligenti delle lor parti , quando si veggono le spade alle gole p er necessitarli ad una forzata e, com'essi stimano, vergognosa penitenza, congiurano talvolta in un nodo furioso, che malamente può esser disciolto.
Sì che co lla pace e coll'ozio, colla felicità del R egn o si devono debe llar e, nel qual tempo non hanno cosa alcuna da i publici latroci ni che possano donare a gli inc ert i e sediziosi ausi liat o ri; né sendo incitati dal fervore degli avversari, raffreddano molt o il loro, e molti d'essi risguardano al Re, dalla cui amicizia pendono
20 Allusione alla cospirazione che condusse, il 24 febbraio 163 4, all'assassinio del Wallenstein, Duca di Fnedland, accusate di organizzare una sedizione (reale o pretesa) cont ro l'lmperat0re.
tutte le cose, nel sereno della quiete, il quale, se no n tanto con odio che con disprezzo perseguiterà il lor partito e la lor disciplina, più efficacemente ch e con qual si voglia guerra forzerà a penitenza l'animo de' nobili, i quali, se mossi da un cattivo rossore hanno penitenza di rinunciar alla loro setta, almeno provederanno a i figliuoli instituendoli in modo che riescano grati alla Corte; e quelli ch'antepongono la pertinazia alle ragioni et agli argomenti, saranno vinti da questo adito degli onori, e cautamente chiusa la speranza delle cariche e degli uffici, particolarmente se queste pene non sieno costituite con leggi pubbliche contro quelli (perché ciò farebbe assai agli adirati per moverli alle lamentazioni, alla congiurazione et ali' armi contumaci) ma con un certo uso lento e coll a destrezza del Principe che in loro non divida i carichi della republ i- . ca, né soffra che scorrino oltre alla licenza che danno le leggi.
E nel resto sia mansueto con essi, e tal volta con parole famigliari paia lor degno a cui essi compiacciano.
E ciò s'intende quando tali sette s'astengono dalla sedizione e dalla ribellione, e possono patir la quiete, e la contagione abbia infetto tanto numero di gente che non possa scriversi chiascheduno fra rei, né citarsi al tribuna! della giustizia .
8. Le virtù et i vizi si devono stimare dal merito e non dal giudizio popolare, dove la consuetudine , la chiarezza de' pe ccatori et i successi nobilitano la colpa, la quale però si dee opprimere e levare, richiamandola pian piano alla viltà de' suoi natali.
E ciò si fa colla disonestà del nome, nominandola tradimento, congiurazione, perfidia, non, come si suole, grandezza d'animo, prudenza, lega e cura del ben publico; e col frangere quei che si divisero dal Principe, almeno coll'umiltà d 'u n chiesto perdono, non udendo leggi né patti con le armate ribelli e dando un so lo rimedio al penitente: di supplicare, deporre l'alterigia e di co nd annare sé e la causa sua.
E sia poi atto della lenità del Principe il perdonare a chi è talment e composto se non ha troppo perniciosamente errato e abbia differito nella necessità la maschera della penitenza; ma perdoni in tal modo che gli rivenga qualche vantaggio in pena: sì che se il ribelle ha avuto·qualche carica dal Principe, gli ne sia levata una parte, se ha avute fortezze, o sue o del P rincipe, in governo, gli ne sia presa una in pegno della fede futura: e guardisi di donar questi rei alle pr eghiere de' parenti che appresso al Principe hanno militato contra di loro, perché non c'è frode più ordinaria che

di questi ottimati, che si dividono nell'armate contrarie non per vero affetto né per vero zelo, ma come per sordidezza: i fratelli, i cugini, i parenti, l'uno sta per il Principe, l'altro co' sediziosi, per essere sicuri nell'una e nell'altra fortuna o colla vittoria o co l favore; e questìy~li dee il Re m~ritamente aver sospetti_e chiar~mente per nem1c1 se troppo ansiosamente pregano per 1 parenti.
9. I governi e le potestà che si danno non durino al più che tre anni, essendo troppo pernicioso l'uso di permettere in un lungo e stabile imperio le provincie, le quali, come ricevono dal Principe un Governatore, subito l'hanno in venerazione, gli s'acostumano, e sì constantemente intendono che egli è prefetto come che il Re è re; anzi: eh' egli è più propinquo a' cittadini, di più presso spinge gli affetti, di più presso condanna e favorisce i contumaci o gli ossequiosi; sì che le stirpi de' nobili particolarmente s'accostano a tali Governatori prese dalla speranza, da' conviti e dalla mansuetudine, in modo che poi esercitano la fede promessa contro l'istesso Re .
Ma se queste cariche si dànno di poco tempo, la forza inveterata non si stabilisce ne' rettori; né i cittadini amarebbono o temerebbono oltre misura coloro che devono esercitar u n breve imperio: oltre che in tal modo si può divider in più persone la liberalità, essendo spesso le cariche vacanti, nelle quali si mettono ora gli uni ora gli altri, secondo i meriti e secondo i tempi .
10 . Non si dee permettere ch'un Principe straniero faccia gran benefizi et oblighi troppo i tuoi sudditi, né chi tiene cani a sua guardia ha caro ch'altri li tratti in modo che più a lui ch e al padrone diventino famigliari, né chi ha bella moglie ama di vedere che altri le compiaccia in modo che se la renda più amica che al marito; così non fa ben eficio colui che dispone in modo i tuoi sudditi che più a lui che a te diventano affezionati .
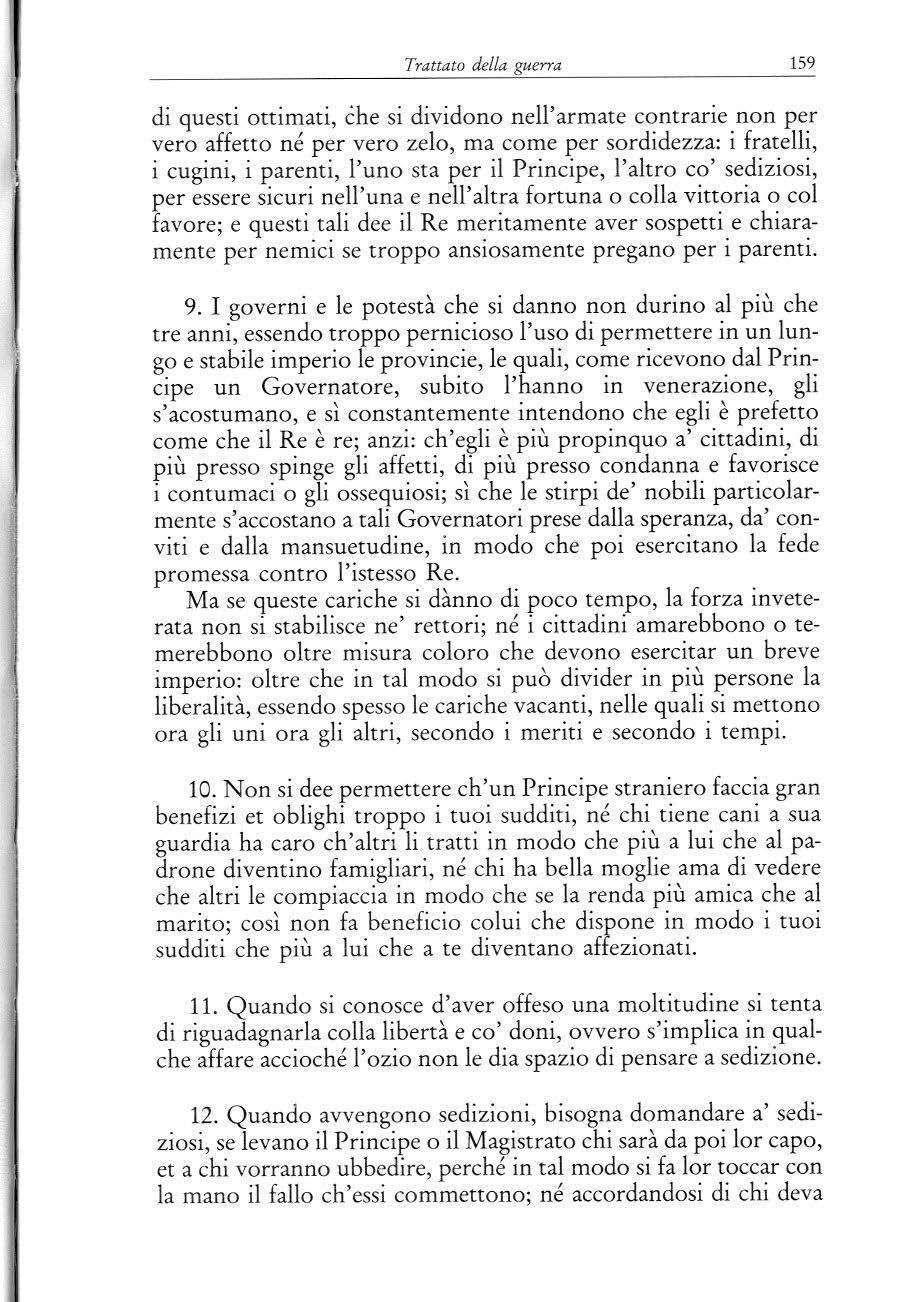
11. Quando si conosce d'aver offeso u n a moltitudine si tenta di riguadagnarla colla libertà eco' do ni , ovvero s'implica in qualche affare accioché l'ozio non le dia spazio di pensare a sedizione.
12 . Quando avvengono sedizioni, bisogna domandare a' sediziosi, se levano il Principe o il Magistrato chi sarà da poi lor capo, et a chi vorranno ubbedire, perché in tal modo si fa lor toccar con la mano il fallo ch'essi commettono; né accordandosi di chi deva
succedere nella carica, la con fus io ne dell' opinioni e delle volontà fa loro riconoscere l'e r rore, perché il più t ollerabile di tutt i i mali è quello c h e è più con osc iuto , né dand osi in questo mondo cosa p erfetta, egli è vero che una moltitudine può sentire qualche m ale da c hi la regge prese nt emente, m a forse che ne sentirebbe un m aggiore se si mutassisi rettori : pe r ché non vi esse ndo chi dia gli ordini , lasciando lo cos tum e ord inario , non facendos i le guardie né oss e rvando gli altri ri ti politici e rappresentando ogni confusione , subito da per sé conosce la moltitudine d'a ve r biso gno di rettor i, all a qu ale se poi si propon e individualmente se quest o o qu ell'altro sarà capace di diffenderla d a ' n emic i, d'acc rescerla n ella pace, di dargli le ricompense, i stip en di, e tc . , fac ilm e nt e si levano qu elle prime impr essioni e bollori di se dizione.
Ha l' Imp eri o Germanico molte volte agitato di trasferir e la corona Imperi ale dalla casa cl' Austria in un'altra, pe rch é contin u ando questa successione l'Imperio di viene quas i ereditario, e perc hé procedono gli Au s tria ci troppo rigorosamente nel fatto della religi one : ma quand o egli ha proposto individualm e nte c hi dev a succedere alla corona, chi possa far resiste nz a alle forze del T ureo , chi possa manten e re con deco ro la di gnità dell ' Imp e rio, c hi viva orn at o di più v i rtù politiche e morali, non ha saputo trovare fami gl ia più degna d'imp erar e ch e quella d'Austria.
Raquetat a la sed izi one, accioché non nasca dissensione per gli atti passa ti, tu tt i s i stringono con giuram e nto so lenne di m ette r in oblio non so lo le di sco rdi e e gli odi, ma anche la menzione delle disc or die e de gli odi.

V. La tirannide dev e v ietarsi da u n Pr incipe et in tal modo sar à s icur o da' tradimenti e dalle cong iur e, le quali so gliono so lo nascere dall 'o dio e dal disprezzo .
Si hanno però que st i rimedi:
1. Si hann o speculato ri e t auriculari e spie c he ti rap p ort ano tutto ciò che fanno e c he dicono i sudditi , massime li più illu stri, p erc h é rade vo lte adivie n e che faccian mal e se non hanno parlato male; e la più pa rte de' congiurati v edrai o aver m al parl at o del Principe, o aver prestate l' orecchie facili a chi lo calu nni ava; e se la congiura è scope rta ella è vinta, e però si dev o no proporre premi e t impunità a c hi la riv ela publica nd one leg i e rinovandole, p e rché tutte le cose so no penetra bili al premio et a torm enti, e
spesso si ritro va costanza minore nel rossore che nella colpa, e senza tormenti, dal co lore del viso e dal moto degli occhi si conosce l'eccesso; e quanto a premi, egli è pur vero che quand'uno si rappresenta nell'animo l'utilità e la potenza, cede il dritto e la salute degli altri, e scuoprono i pegni loro più cari .
Ma in queste delazioni veggasi di dar l' orecchie a tutti ma non la credenza, e credere cautamente, perché molti per isperanza o per odio rapporterano cose false, e chi potrà mai esser innocente se basta l'esser accusato?

Che se sono convinti, si puniscano, ed è il secondo rimedio, né questa è vendetta particolare del Principe, ma è publica, perché nel suo capo consiste la salute di tutti; anzi, che Principi stranieri hanno vendicata la morte vio lent a d'un Principe che non apparteneva loro, stimando utile cosa et onorata il non negligere la vendetta d'una congiura, non solamente per rispetto suo ma per rispetto dell'esempio e per interesse di tutti i Principi.
Tal' ora si danno al supplizio i figli e tutti i parenti e congiunti b enché innocenti accioché non sopraviva alcuno dell'infame casa che imiti la sceleraggine e vendichi la morte de' giustiziati . S'osservi però d'indugiare tal volta alla vendetta, come se la congiura è scoperta in tempo importuno si deve dissimulare , perch'egli è spesso unico rimedi o dell'in sidie il non intendere, e se anche ella è stata ordita da grandi i quali non si possono punir subito, sicuramente devesi prima proveder alla salute che alla vendetta; n é sempre però si de e es cludere il perdono, come se qualche uomo illust re al quale tu e la patria devono molto e sono obligati, sia tolto in tal sceleraggine, che farai? Certo condonerai il castigo se p otrai farlo sicuramente: se no, lo tempererai. Egli è cosa incredibile quanto una tal insigne clemenza ritenga gli altri da simile attentato , o per penitenza, o per v ergogna; perché certo i parenti et i figliuoli di quei che sono giustiziati, gli amici et i propinqui, succedono nel luogo loro, e così fassi un nodo et una catena di cospiranti che non si può rompere se non con questa clemenza e coll'innocenza, che è il terzo rimedio, cioè che, con la spessa offesa degli altri, tu stesso non dia cagione d'esser offeso; et i Principi devono v iver in maniera e farsi in modo riverire et amare che niuno speri potere, ammazzandogli, salvarsi.
2. Alcuni hanno pr eso in prestito un gran somma di denari da quelli da' quali sapevano esser' odiati, accioché per paura di perder il denaro prestato lasciassero di congiurargli contro, e così,
dov e gli altri donano denari per assicurarsi e salvarsi, questi, pigliandone, hanno messo la vita loro in sicurezza .
Ad altri è avvenuto che un pellegrino gli ha detto di volergli insegnare e mostrar il modo di scoprire qual si voglia congiura, e però, trattando appartatamente con lui e fuori dal cospetto degli altri, accioché l'arte non divenisse vulgare, gli ha detto che mostri confidenza e sicurezza di saperlo, e che nissuno ardise più di machinargli contro; il che facendo egli, et onorando d'amplissimi doni tal'uomo, poi publicando d'aver imparato un modo mirab ile di conoscere gli insidiatori, ha fatto che quei l'hanno creduto, né hanno più ardito di ordirgli congiure contro .
Altri, per ingannare gl'insidiatori, ha avuto in uso di fa r spesse volte vestire uno de' suoi corteg iani in quell 'istesso abito eh' egli porta; altri ne' giorni solenni e festivi s'è armato di corazza sotto al giubbone; altri in un giorno di battaglia, sospettando de' suoi so ldati , ha fatto vestir un altro della sua armatura, ed egli n'ha presa segr etamente un'ordinaria. Altri ha fatto compore diverse p erucche e crini di diverse età, poi, mutandole assiduame nt e et anche mutando di vesti to , s'è reso ignoto non solo a quei che lo vedean di rado ma anche a' suoi famigliari .
VI. Se le parti, sedizio ni o congiure sono già tanto accresciute che colla forza solo si possano estinguere, bisogna con tutte le forze del Regno sforzarsi che non portino impuniti l'audacia d'un esempio abominando contro al Magistr ato, e tanto più tosto devesi vendicar la sceleraggine, qu anto più ferocemente essi sog li ono assalir gl' indugiant i interpretando con ispregio la pazienza per debolezza, e devonsi far i preparamenti e procedere nel stesso modo come si fa in una guerra esterna, dalla quale q u esta civile piglia in prestito gran parte delle cose.
1. S'egli è possibile, è ben meglio quietar i moti civili con patti e sapienza che col ferro e colla vittoria . Il tempo fu sempre per i R e, e fra tanto g li animi disvolti si ri uniscono, et a' Principi è sempre dannosa la diuturnità della guerra civile, la quale è intratenuta e fomentata da stranieri che danno aiuto a gl'inferiori e tengono in equilibr io le parti, accioché tale stato non possa intraprendere cos'alcuna fuori di casa, ma si consumi e si logori da per sé, tanto che indebo lit i e stanchi i vinti et i vincitori, sieno gli uni e gli altri cos tretti a sottoporsi al giogo dello straniero che, col fomentare tale dissensioni, quasi da una vendetta insidiò alla libertà di tutti.
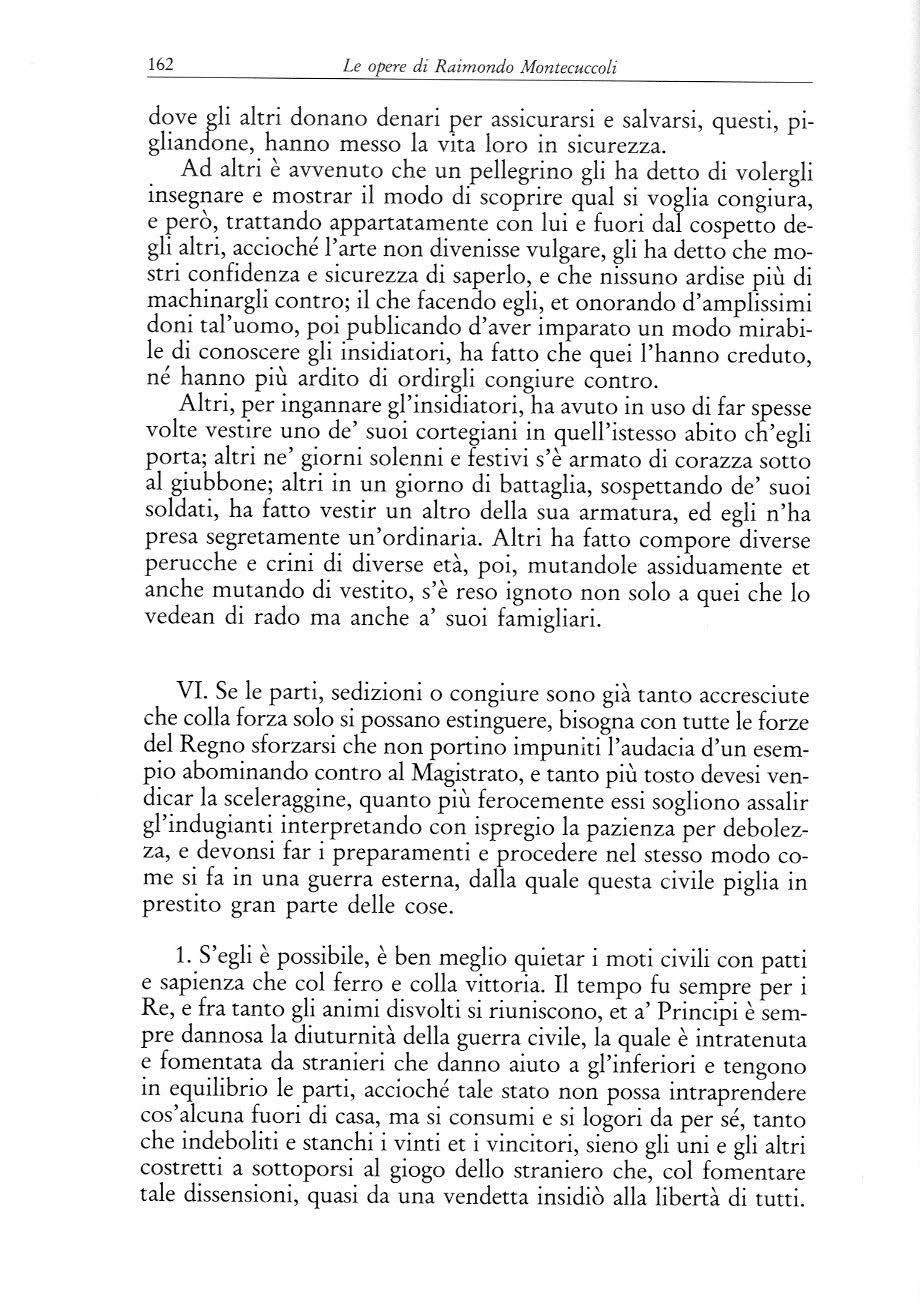
2. Né credasi che le guerre civili sieno scuola alla fortezza et alla milizia, perché spesso n'è più vanità e più minaccie che giusto travaglio . Si ragunano gli armati nelle fortezze e nelle Città suggette e spogliano facilmente il cittadino o il villano sprovvisto, e questa è tutta la somma della fort ezza; non si danno battaglie né si fanno combattimenti p erc hé si placano a tempo e senza provar la fortuna d ell'armi si perdonano; ma quando anche le guerre durino, il soldato non fa che ingrassarsi delle spoglie della Patria e de' beni de' miseri cittadini; più delicato in guerra che in pace, impara più i latrocini che la costanza, la forza e l'arte, sì che poi alla disciplina d'una vera e sobria guerra, e nelle regioni straniere, tal' ora infeconde, è dirotto dal fastidio molle 20bis, e mostra che sono diversissime le fatiche d'un predatore e d'un soldato.
3 . Si levino dunque i semi de' moti, si rel eg hino i cap i sotto spezie d'onori o di cariche, e si tolga il duce e l'autore a chi desidera cose nuove; si rimovano gl'istessi soldati e s i spa rgano per le prov incie, o s ' impieghino in una guerra esterna, la quale ha spesse volte partorito una ferma concordia.

Li modi di prepararsi alla guerra esterna sono diversi .
I. Non bisogna lasciarsi trasportare dalla temerità, perché facilmente si comincia una guerra ma difficilm ente si termina, né sta nel potere del medesimo il principio et il fine . E sì come può uno con agevolezza calarsi in un pozzo ma n o n con agevolezza t irars ene fuori, così può ciascheduno, benché ignavo, cominciar una guerra, ma non finirla, se non quando piace al v incitore.
1. Devesi considerare maturam ente tutto ciò che può arrivare di peggio nella guerra prima d'intrarvi, accioché i cattivi rincontri non sopraprendano, ma quando vi s'è imbarcati bisogna risolversi ad ogni sorta d'evento, et aver la costanza d'andar sin'in capo : per lo qual fine hanno alcuni, nell'uscir di casa per portar guerra nell'altrui paese, messo in fuoco i villaggi, le case et i grani del proprio paese accioché, tolta la spe ranza del ritorno alla patria,
2o1,,, Frase contorta e poco chiar a ed anch e d i difficile leggibi lit à in ent r ambi i Ms. , il cui se n so è che co lu i il qual e non fu avvezzato a ll e d urezze della ve ra guerra, giunto che sia in reg ioni aspre, ne v iene d ist rutto a causa della sua molle zz a.
fossero più pronti a sost entare ogni pericolo: perché altriment e molti hanno l'animo pronto et allegro n ell'intraprendere la guerra, ma l'hanno molle e poco costante nel resister alle calamità, e gli uomini s'inducono con più ardore a pigliar un'impresa ch'a continuarla nell'esecuzione.
2. Si deve esaminar bene, e far un parallelo, delle sue forze e di que ll e de ll 'inimico, e considerare la qualità e quantità dell'armata che si può avere e che può avere quel1o a chi si vuol move r guer r a; la qualità del paese, dell'artiglieria, delle munizion i, dei viveri, de' denari e delle altre cose che fanno stimar un Principe più for t e o più debi le; esaminare se il nemico che si vuol assalire è più forte sopr'acqua o su terr,a, fuori di casa o dentro in sua casa, quali sieno le forze del suo stato, s'egli si governa in Republica o in Principato, e q u ali aiuti, e da chi possa avere assistenza: perché il fine di chi vuole far guerra, almeno offensiva, è potere combattere col nemico alla campagna e potere vincere una giornata, e però quando la potenza d'un Principe ha preso tal'accrescimento ch'ella trappassa la tua, farai da uom saggio di non l'attaccare per paura di non venir a cadere et accelerare i mali de quali ti puoi fac il men t e guar d are, seguendo il tempo, che accomoda ordinariamente gli affari; et i Principi, elevati alla somm ità delle grandezze, lasciano regnare gli altri più volontieri, et Augusto propose per testamento che bisognava serar l'Imper io Romano fra certi termini e mete; sì che se tu dunque rincontri una machina sì grande ch'abbia d i lungo tempo preso accrescimento co' gli anni, farai da uomo saggio di non l'urtare, perch'egli è impossibile che s'ella vien a cader, tu non r esti infranto sotto le rui n e di quest'edifizio.
3 . Lasciò un gran legislatore per ordinanza ch' egli non si dovesser far sovvente guerra co' medesimi nimici, di paura ch e, sendo spesso costretti a pigliar I' arme pe r diffendersi, non n e diventassero alla fine v alenti uomini e buoni combattenti, ma in ogni modo, se bene la pace e la tranquillità si de ve sommamente abbracciare, non di meno non si dee far e cosa alcuna ingiustamente né patirla ignom iniosamente per poter gode r della pace, perché la guerra non si lieva, ma solo con suo danno si differisce .
4. E che sarìa se moderat amente si riguardasse nelle cose di v ine, e col mezzo della Astrologia e d'altre scienze divinatrici s'investigasse che cosa prometta il fato?

Dicesi moderatamente e senza soperstizione. Certo gli Antichi consultavano sempre i loro oracoli, e a nostri tempi ha il Friedland attribuito molto all'Astrologia; ed è cosa sicura che non si muove foglia in arbore che di là sù non dipenda, e che dal punto della fondazione d'una città e dall'oroscopo d'un Principe sovrano si può presso a poco conoscere se il periodo del suo imperio sia vicino o lontano, e s'abbia da avere in guerra la fortuna favorevole o contraria. Sì che non si devono totalmente sprezzare i prodigi e sogni et i presagi delle cose future, perché la benignità del Nume ama d'annunziar con questi modi le cose future, o sia che gli uomini lo meritino o eh' ella sia tocca dalle loro affizioni: et a chi agisce con prudenza a seconda del destino non può mancare prosperità.
IL Prima che si dichiari la guerra bisogna vedere d'occupar con astuzia un luogo che sia di grande importanza e molt' opportuno per far la guerra: o sia sotto pretesto di proteggerlo o di mandarvi soccorso o altramente, come fece il Re di Svezia mandando sua gente in Stralsunda che s'era data alla sua protezione, poi occupando Stettino in Pomerania, et occupando altri siti senz'alcuna denunziazione di guerra o d'ostilità, anzi sempre tenendo sospeso et addormentato Cesare con la speranza e co' trattati d'accomodamento.
E questi luoghi litorali servono meravigliosamente a quelli che intraprendono sopra qualche paese e sono debili dal cominciamento, perché in tal postura si può sostener un gran sforzo et in ogni estremità ritirarsi, avendo un piede in terra e l'altro in mare per poter operare secondo le occasioni per mar e per terra, et in ogni caso non trovarsi rinchiuso 21
1. Si deve confermare la pace e l'amicizia colle città eco' stati propinqui, accioché le sue forze non sieno ritenute in più parte, che mossa la guerra in un l uogo si sia sollevato da tutte }'altre, come solea dire un gran Capitano: ch e chiunque avea tre nemici, dovea cercare con ogni mezo possibile di far pace coll'uno, tregua coll'altro, e buona guerra col terzo, essendo massima di stato che chi ha una guerra non dee intraprenderne un'altra se non ha finito la prima, e così il Re di Svezia fece pace col Moscovita per moversi contro l'Imperatore nella Germania.
21 Mirabile analisi dell'importanza del dominio de l mare e de lle operazioni militari anfibie.
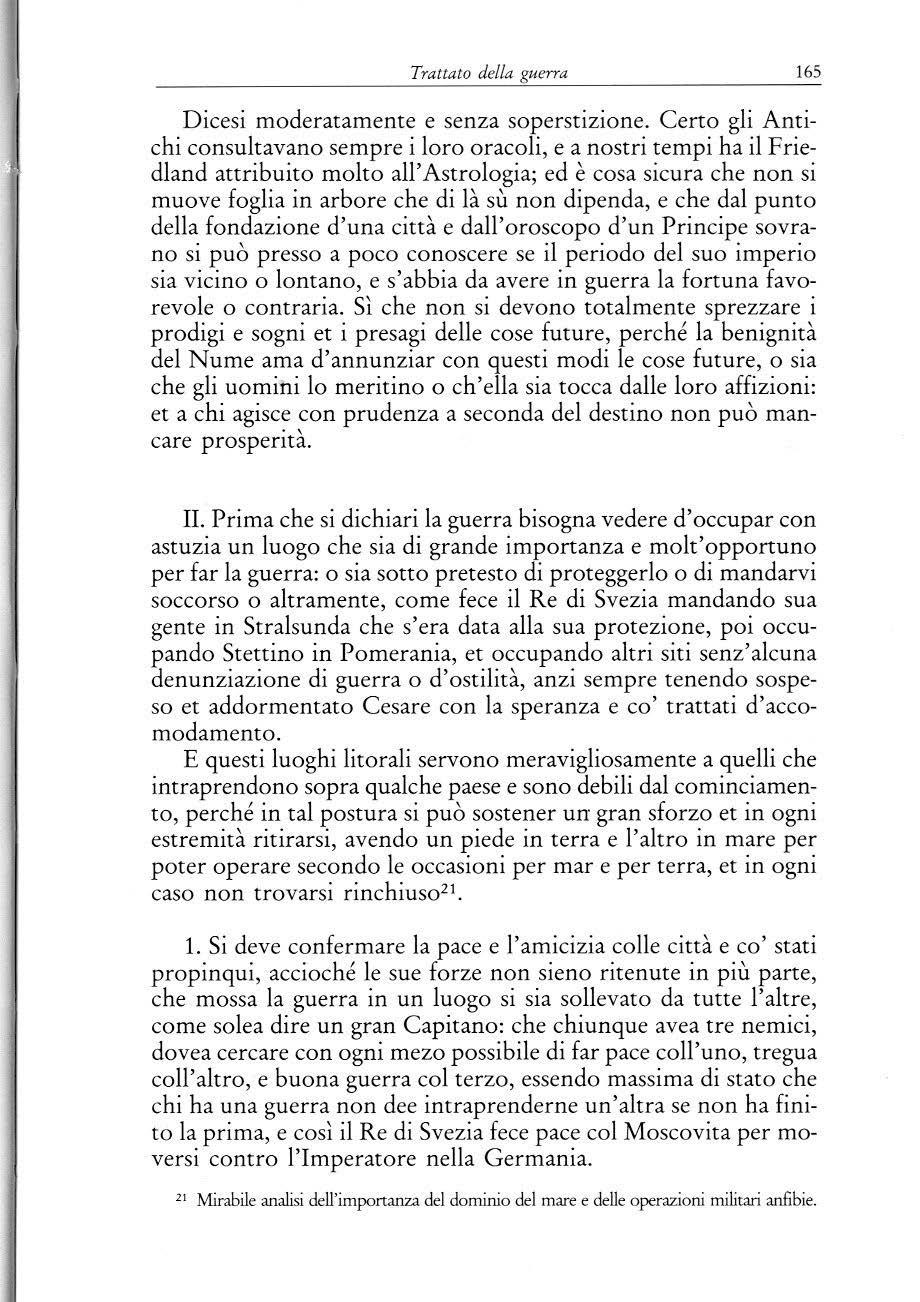
Che se nascono nuove turbol enze bisogna dissimularle et aver riccors o a de gli atti di cortesia per intrattenere gli Am basciatori c h e sono mandati, o vero quietare con celerità e con sorpresa dette turbolenze prima che si muova la guerra.
E dentro allo stato bisogna aver tagliata la ra dic e d'ogni moto civile, perché quando s'ha il n e mi co in casa non si dee cercare di fuori: e se il Princip e esce in persona alla guerra, de ve lasciare Vicario tale nello stato che non lo turbi o non l' occup i, come a volte è successo.
2. Si sollecitano gli altri Principi e si co rr ompono con denari i loro Consiglieri, accioché attacchino dalla loro parte quello stato contro al quale s i m ove la guerra, accioché impedito in diversi l uoghi , non possa far r esistenza .
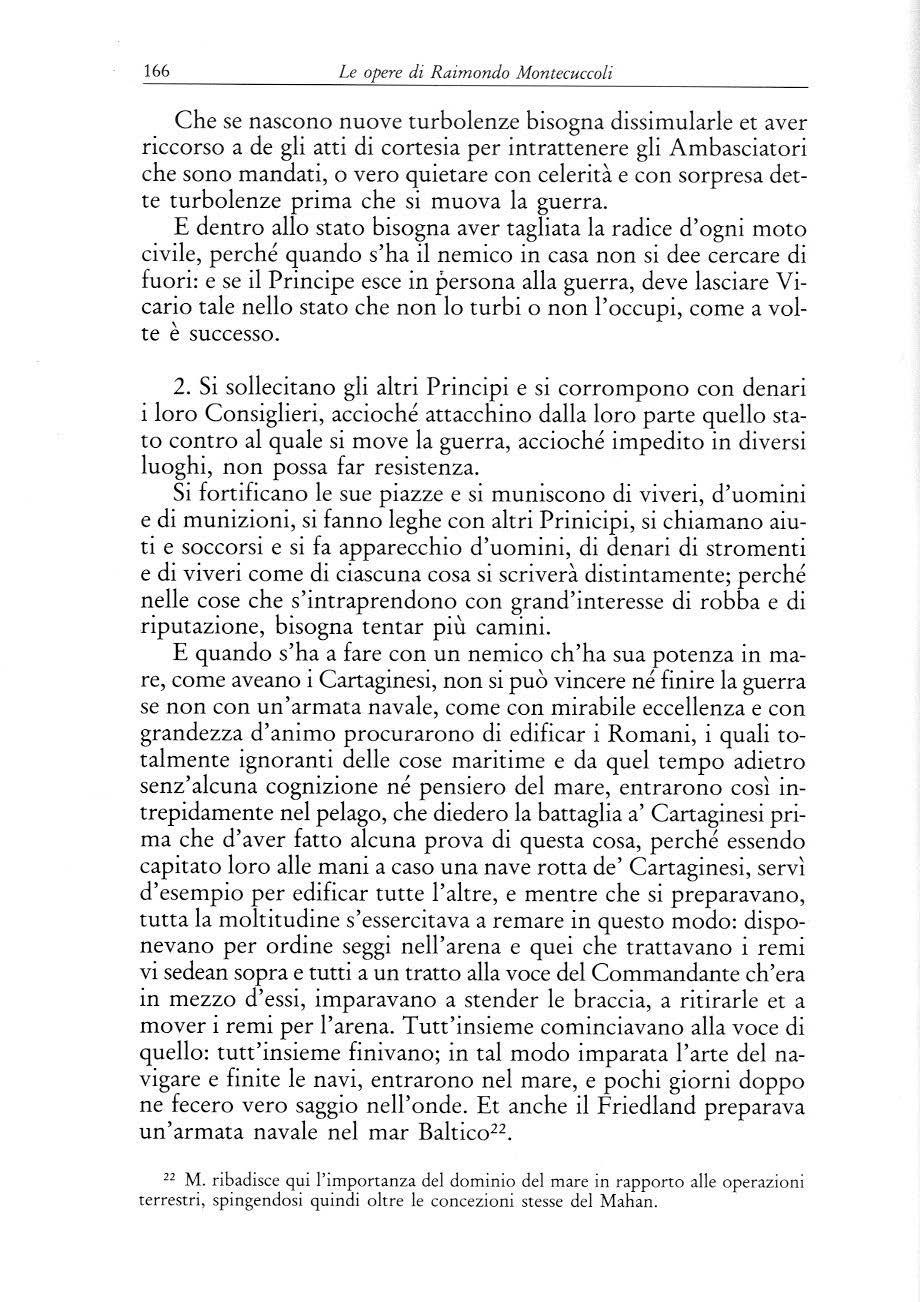
Si fortificano le sue piazze e si muniscono di v ive ri, d'uomi ni e di munizioni, si fanno leghe con alt ri Prinicip i, si chiamano aiuti e soccorsi e si fa apparecchio d'uomini, di denari di stromenti e di viveri come di ciascuna cosa si scriverà distintamente; perché nelle cose che s'intraprendono con grand'interesse di robba e di riputazione, bisogna tentar più camini.
E quando s'ha a fare co n un nemico c h' ha sua potenza in mare, come aveano i Cartaginesi, non si può vincere né finire la guerra se non con un'armata navale, come co n mirabil e eccellenza e con grandezza d'animo procurarono di edificar i Romani, i quali totalmente ignoranti delle cose maritime e da quel tempo adietro senz'alcuna cognizione né pensiero del mare, entrarono così intrepidamente nel pelago, che diedero la battaglia a' Cartaginesi prima che d'aver fatto alcuna prova di questa cosa, perché essendo capitato loro alle mani a caso una nave rot ta de' Cartaginesi, servì d'esempio per edificar tutte l' altre, e mentre che si preparavano, tutta la moltitudine s' essercitava a remare in questo modo: disponevano per ordine seggi nell'arena e quei che trattavano i remi v i sedean sopra e tutti a un tratto alla voce del Commandante eh ' era in m ezzo d'essi, imparavano a stende r le braccia, a ritirarle et a mover i r em i per l'a rena. Tutt'insieme cominciavano alla voc e di quello: tutt'insi eme finivano; in tal modo imparata l'arte del nav igare e finite le na vi , entrarono nel mare, e pochi giorni doppo ne fecero vero saggio nell'onde. Et anche il Fried la nd preparava un'armata nava le nel mar Baltico22 •
3. Se l'impresa et il movimento d ella guerra ha da essere segreto, non si denunzia la guerra, si fa l'apparechio occultamente, si levano le genti in diversi luoghi e sotto diversi colori e diverse occasioni, si tiene gente appresso a quel Principe contro a chi si è risoluto di moversi, che lo distomi da tutti i sospetti eh' ei potria concepire, se gli scrive lettere umilissime e si danno attacchi e s'accusano degli altri, dandoli quasi a intendere che 'l suo corruccio sia contr' essi, accioché gli paia che tutta la gelosia deva voltarsi quivi et egli resti addormentato .
III. Si publicano le cause e la necessità della guerra per manifesti che si mandano in istampa, e per uomini eloquenti che le spengono evidentemente in diversi luoghi, accioché tutti giudichino che le sue ragioni sono giustissime e che però s'abbia più faci le il popolo a contribuir i stipendi et a soffrir i carichi della guerra, s'abbia maggior concorso di soldati, ch'hanno maggior confidenza dov'è maggiore la bontà della causa, né si offenda la sua fama e riputazione, quasi che si operasse contro le legge divine o l'umane, perché quando i Re et i Principi sovrani hanno differenze fra loro per ingiurie o danni fatti né queste controversie posson esser composte con l'opra e l'intervento d'altri Pr incipi prima che rompano in una guerra aperta, non possono allo r a riccorrere ad un foro competente che pigli ad essaminare le loro azioni e le definisca per sentenza e per giudizio, perché essendo tutti d'un istessa Maestà, e sovrani, l'uno non s'accommoda alle legge dell'altro sendo che l'uguale non ha imperio sopra l'uguale.
E però, accioché i Re et i Principi non fossero di peggior condizione che i privati, i quali possono riaver il loro per la sentenza del giudice, il diritto e ius delle genti ha supplito a questo diffetto, et ha ritrovato un mezzo col quale s i definiscano Je controversie de' Re e de' Principi e questo e la guerra, l'armi. E la spada colla quale si scioglie qu esto nodo gordiano, e ciò è abbracciato da Re e da i Principi in quella usitata forma di sc r iv ere ch'ei non riconoscano superiore nissuno se non Dio e la spada, perché le loro controversie non si finiscono col mezzo de' Canoni, ma con quello de' cannoni.
1. Sono alcuni che stimano, quando hanno buona causa, eh' ella si manifesterà di per sé a ciascuno, il che li fà negligenti a publicare cio che n'è, nella qual cosa essi errano, perché, se bene le cose

giuste e vere mostrano sempre col tempo la loro chiarezza in ogni modo , in molte occorrenze egli è necessario d'anticiparla e che si conosca subito quel che non lasciarebbe d'esser conosciuto più tardi, ma non ne arriverebbe tanto frutto; e sì come l'erbe cative soffocano le buone se non si svelgono, così chi non rintuzza le calunnie eh' ordinariamento gli avversari mettono in obiezione a rincontro di ciò ch'è buono, senza dubbio si vedrà spesse volte oppresso. Il Re di Svezia publicò per cause della sua venuta in Alemagna le private ingiurie ricevute dall'Imperatore p er gli aiuti mandati in Prussia al Polacco, gli Ambasciatori non ammessi contro al diritto delle genti, la libertà prostrata della Germania, la r eli gione oppressa, il Ducato di Meklemburgo ingiustamento preso e ritenuto, il titulo del Wallenstein di Gener alissimo del Mar Baltico, le provincie maritime occupate: in so mma, la gloria di Di o, la libertà della Germania e la conservazione del proprio stato.
2. Per dar più colore alla giustizia della causa si cerca d'aver dalla sua parte un Principe del Sangue dello stato contro il quale si muo ve la guerra, spiegando le sue in segne, dicendo di v olerlo rimetter in stato s'egli n'è stato cacciato o s'egli n'è erede o s'egli ha qualch e propinquità disputabil e nella successione, et in tal modo s'ha anche maggior concorso di soldati e maggior affezione degli uomini del paese.
3. Si denunzia la guerra, il qual atto fu detto da' Lat ini clarigazione , ed è com'il principio della guerra, e prima della quale non si do v ria dar luogo né a insidie, né a guerra aperta: ma poco osservata n e ' m o derni tempi , come s'è detto del Re di Svezia, e come fecer anch'i francesi ch'andavano avanzando nell' Alemagna senza vo ler dichiarar la guerra benché di ciò anche richiesti per un trombetta mandato a loro dal Conte Galasso.

Li riti delle clarigazioni sono vari. I Cartagines i volendo dichiarar la guerra a' Romani , mandarono un'asta a Roma, e li Romani osservarono l'istesso quando dichiararono la guerra a' Latini .
Il Feziale, detto oggidf Araldo, e da' Tedeschi Herold, solea portar un'asta ferrata o insanguinata a i confini de' nemici, et alla presenza di tre giovanetti per lo meno, solea dire: che i Latini hanno fatto e mancato contro i Romani, e che il popolo ha commandato che sia guerra co' Latini e che il Senato l'ha acconsentito e determinato, perciò io et il popolo Romano faccio e dichiaro la guerra a' Latini, e ciò detto gettava l'asta ne' confini di quelli.
Gli stromenti della clarigazione sono il feziale e le lettere. Il fezial e , o Araldo è un publicatore mandato dal Principe a denunziare la guerra al nemico , e gode del dritto de gli Ambasciatori, né può esser violato: le lettere di clarigazione si chiamano in Tedesco Feinds - und A bsagebriefe2 3 , e si sogliano mandare per un giovine nobile con un trombetta.

Il loro formulare è d'esplicare le cagioni della guerra, le ingiurie ricevute e le loro pretensioni giustissime, e che però voglion e ssere scusati dinnanzi a Dio et agli uomini del mondo di tutte le calamità che nasceranno dalla guerra, e che la colpa è tutta del nemico; rinunziasi all'amicizia o all'obbedienza se si è suggetto, mostrando eh' avendo egli contravenuto alle leggi di patronanza, non merita d'esser riconosciuto per Signore, e che però non si saria stato ubbligato di denunziare la sua volontà contro di lui, ma s i fà p e r maggior caut e la, e che p erò publicame nt e e con uso sol e nne s e gli dichiara la gu erra; e s' e gli è superiore, o si las cia fuori d ella le tt e ra il nom e d e lla sup e riorità, o vi si mett e con aggiunta di putativo, e suolsi anche dire che intraprendendosi la guerra per la cosa publica non saria stato bis ogno d'alcuna significatione della s ua v olontà, ma in ogni modo accioché non gli sia ignoto, se gli professa la guerra .
Al giovine nobile che apporta la lettera suolsi rispondere che il suo Principe ha rotta la fede et egli procede ingiustamente; che venga pure, e si vedrà ciò eh' ei sappia far e , e donandogli qualch e moneta d'oro si rimanda; ma se la guerra è denunziata da un suddito al Sign o re, non s i rice v e la lettera e si commanda a chi la porta di ripportarla a chi l'ha scritta sotto pena della vita, si minaccia della forca chiunque verrà più mandato da quello , e se gli dà la tavola del bando e della prescrizione, cornmandandogli gravemente che la ricapiti al suo Signore.
Soglionsi queste lettere di clarigazione mandare quando s'è già in c ampagna coll' ess ercito unito e s'è in procinto d'attacar il nemico. U n ess e mpio se n e ve d e n e ll e l ettere ch e i Protestanti mandarono a Carlo V Imperatore l'anno 1546, de scritte dal Sleidano, lib. 17; e [che] Ferdinando Re de' Romani e Mauri z io Elettor di Sass o nia mandarono ad Alberto Marchese di Brandenburgo l'anno 1553 , pur descritte dal Sleidano , lib. 25
23 C io è let t ere di d ichi araz ione di i ni m icizia.
24 La pr ima d ic hi ar azione d i guerra, fatta dalla così detta Lega di Smal kalda, condu sse alla dis fa t t a d ei Prote stant i a Mu h lbe r g, il 24 a pri le 1547: la seco nda all a batta gli a d i Si eve rsh ause n , n el 1553, in c ui morì M a urizio d i Sasso n ia: ed entr amb e all a Pace di A ugusta .
4. Quando viene minacciata la guerra da un Principe che richiede il suo e desidera sodisfatione overo il cimento dell'armi e che non s'è ancora apparechiato alla diffesa o all'offesa, s'intratt engono i suoi am basciatori con buone parol e, se ne mandano de' suoi dall'altra parte, s'entra in tratto d ' accomodamento e si ce rca ogni mezzo di guadagnar tempo per avere spatio di mettersi su l'armi.
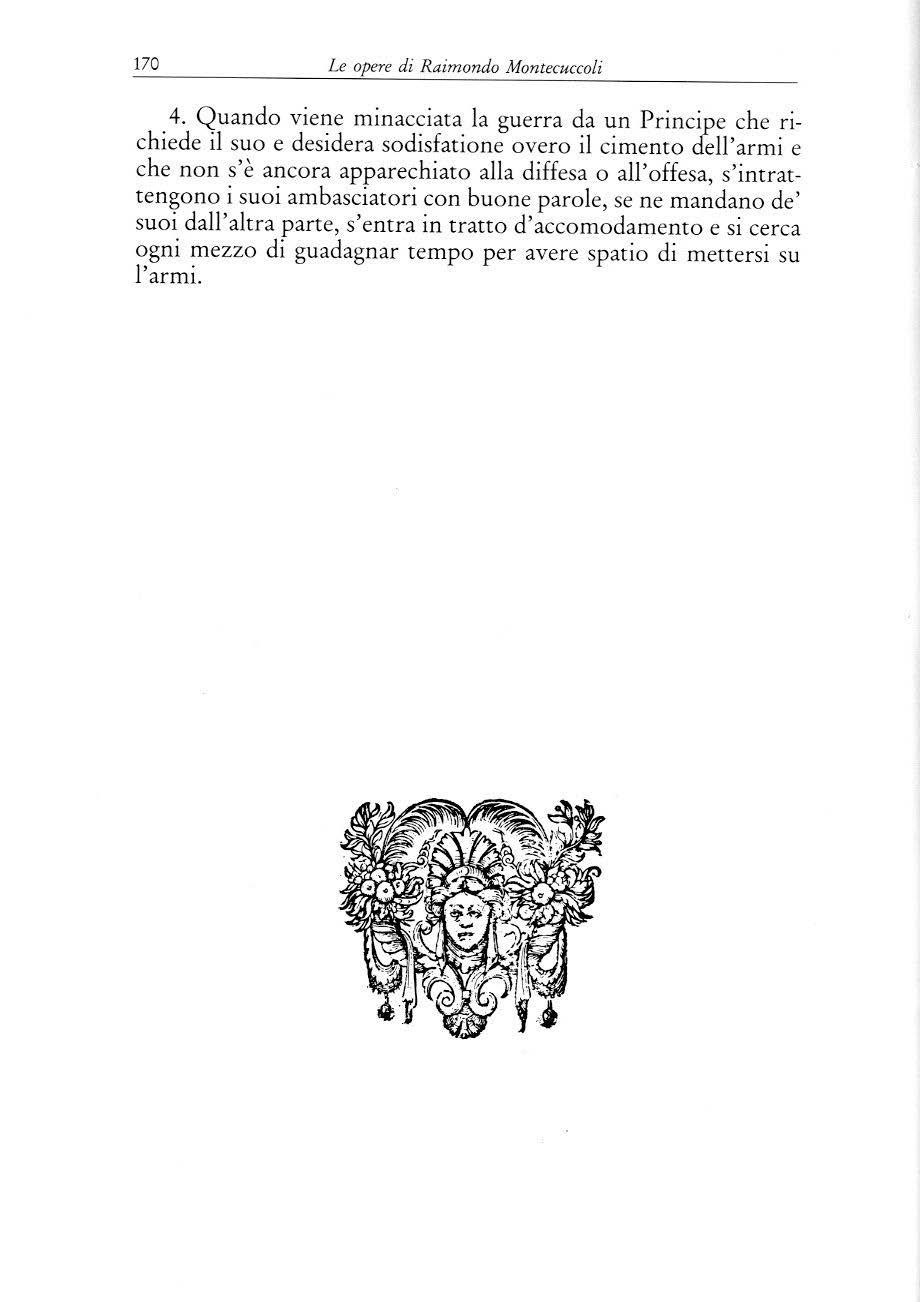
Delle leghe

Le leghe si fanno o non si fanno con uno per diversi rispetti; e' s'intraprendono contr'uno per diverse ragioni, e per diverse si continuano e si procede in esse, e per diverse si rompono e si dissolvono.
Si fanno le leghe con quelli donde ne nasce onore, forza e riputazione.
I. T ai sono quelli che vugliono, di non mediocre potenza e che abitano da vicino, e che però possono essere utili per la qualità delle forze e per l'opportunità del luogo, perché, a che fine congiungersi co' gl'infermi e con miseri et appoggiarsi ad un parete caduco? Se non fusse tal'uno la cui ruina ti dovesse tirar seco al precipizio, perché allora senz'altro rispetto ti collegherai, o l'aiterai, o vero astutamente entrerai scopertamente nell'amicizia dell'uno e con segretezza e fedeltà inclinerai e favorirai più l'altro. Difficil nodo quando discordano fra loro duo vicini potenti, che non possono vincere né esser vinti senza tuo pericolo perch' egli è cosa pericolosa unirsi ad uno più potente di se, ed è pur necessaria, non potendosi sfuggire d'aver l'uno o l'altro per compagno o per nemico: né quivi ha luogo la via del mezzo della neutralità, perché sempre sarai preda del vincitore, come quegli che non avrai grazia stabile in alcun luogo avendo aspettato l'evento per applicar alla fortuna i tuoi consigli. Devesi dunque gettar la carta et entrar in lega con l'uno de' due: col migliore, s'ei sono eguali di potenza; col maggiore, s' ei sono ineguali: mentre eh' ei non vi sia rispetto d'altra opportunità o utilità, alle quali si deve sommamente avere riguardo.
1. Si fan n o le&h e per mant ener e diffender la religi o ne, per l'utile, per la lib erta commune, p er diffendersi da un commun nemico o da una potenza ch e cresce troppo, ad opprimere la qual e concorrono tutt'i minori com'ad estinguere un incendio commune, temendo d'esser tutti soggiogati l'uno doppo l'altro, e che quella gran potenza avendo domati i più propinqui con accrescim ento di forz e, passi più fort e a gli altri e serv endosi di ciascuna prossima vittoria per istrumento della seguente, venga finalmente a soggiogar tutti. E qu este ragioni moss e ro i Principi e le Città protestanti della Germania ac;l unirsi in lega contro all'Imperatore25 •
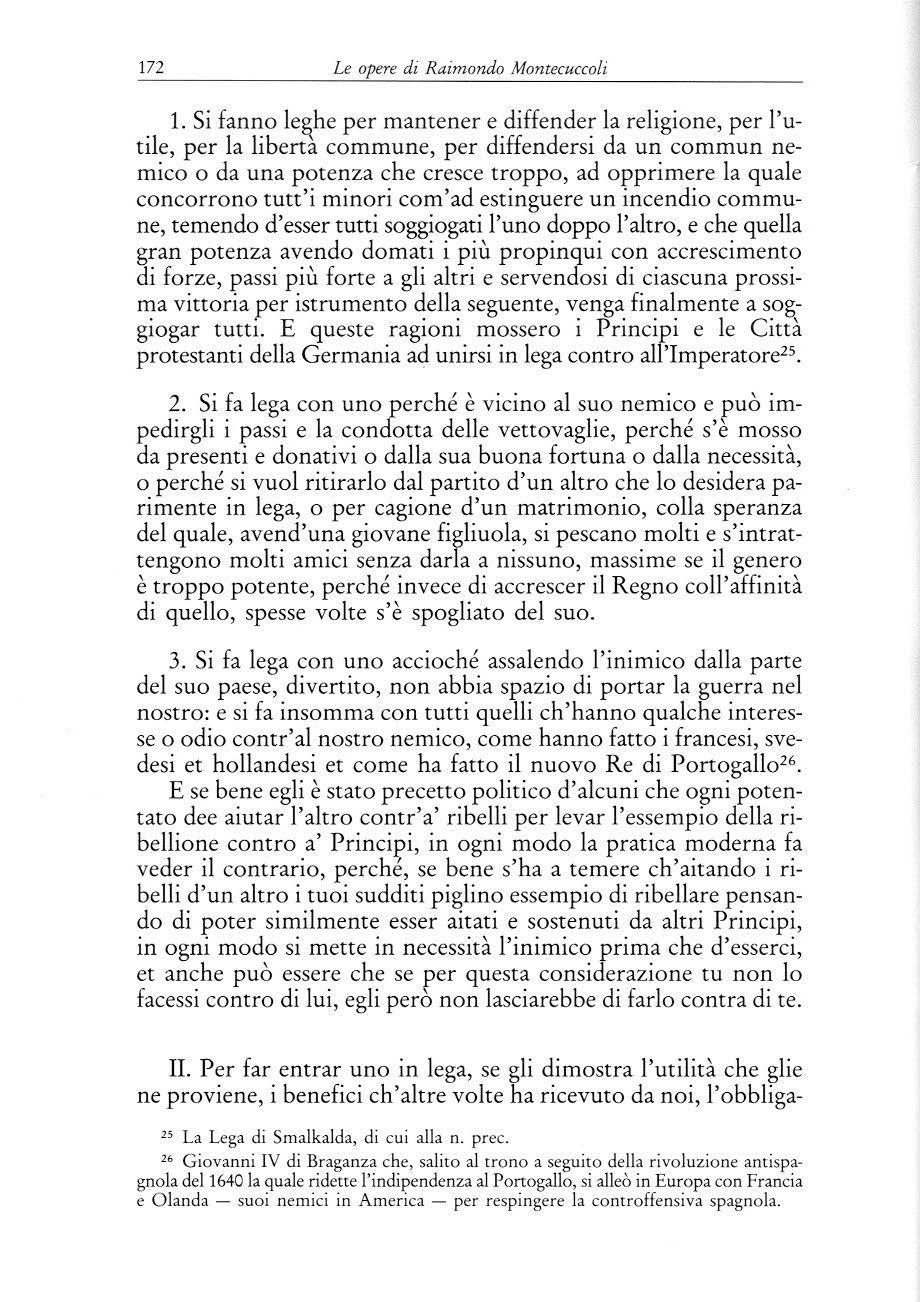
2. Si fa lega con uno perché è v icino al suo n emico e può impedirgli i passi e la condotta delle v ettovaglie, perché s'è mosso da presenti e donativi o dalla sua buona fortuna o dalla necessità, o perché si vuol ritirarlo dal partito d'un altro che lo desidera parimente in lega, o per cagione d'un matrimonio, colla speranza del quale, av end'una giovane figliuola, si pescano molti e s'intrattengono molti amici sen za darla a nissuno, massime se il genero è troppo potente, perché invec e di accrescer il Regno coll'affinità di quello, spesse volte s'è spogliato del suo.
3 . Si fa lega con un o accioché assalendo l'inimico dalla parte del suo paese, divertito, non abbia spazio di portar la guerra nel nostro: e si fa insomma con tutti qu elli ch'hanno qualche int er esse o odio contr'al nostro nemico, come hanno fatto i francesi, svedesi et holl andesi et come ha fatto il nuovo Re di Portogallo 26 • E se bene egli è stato precetto politico d'alcuni ch e ogni potentato dee aiutar l'altro contr'a' ribelli per levar l'es sempio della ribellione contro a' Principi, in ogni modo la pratica moderna fa v eder il contrario, perché, se bene s'ha a tem er e ch'aitando i ribelli d'un altro i tuoi sudditi piglino essempio di rib ellare pensando di poter similmente esser aitati e sostenuti da altri Principi, in ogni modo si mette in necessità l'inimico prima che d'esserci, et anch e può ess er e ch e se p er qu esta consid erazion e tu non lo facessi contro di lui, egli però non lasciarebbe di farlo contra di te.
II. Per far entrar uno in lega, se gli dimostra l'utilità che glie ne proviene, i benefici ch'altre volte ha ricevuto da noi, l'obbliga-
25 La Lega d i Sm al kald a , di c ui alla n prec
2 6 Giov ann i IV d i Braganza che, salit o al t ro no a seguito della ri vo lu z io ne ant isp agnola del 1640 la q u ale r id ette l ' indi pende nza al P ortogallo, si alleò in E uropa con Francia e Ol anda - s uoi n emic i in Am eri ca - per resp in gere la co ntroffensiv a sp ag nola
zione che glie n'avremo; o almeno, che la lega non gli è inutile, che può guadagnar qualche cosa sul paese del nemico, fertile, abbondante, ricco; che de' congiungersi a far ostacolo ad una grande potenza la quale aspira alla monarchia, che si può facilmente impedirla aitato dal destino, nel quale è stabilito e rivelato per l' Apocalisse che non debba esser al mondo la quinta monarchia ma debba finire nella quarta de Romani (doppo la prima degli Assiri, la seconda de' Persi, la terza de' Greci) la quale deve di giorno in giorno andar diminuendo e smembrandosi sin all'estremo: come già si vede che ormai le potenze sono talmente disposte e quasi in equilibrio, che non si trova quasi popolo al quale Dio non abbia eccitato un emulo o un aversario: a i Galli oppose gl'Inglesi, i Scozzesi, etc.27.
1. Si corrompono i suoi Consiglieri con denari, con onori, con promesse et anche avendo con essi famigliarità impudica et attirando quelli ch'hanno autorità e credito col Principe o col popolo, e usurpano anche l'inse?ne et il titolo di quello contro a chi si muove la guerra, accioche i suoi popoli liberi e sciolti dal giuramento prestato, possano entrar seco in lega, come i popoli della Pomerania dicono d'esser collegati con la Corona di Svezia senza macchia d'infedeltà, perché quella si dice Principe della Pomerania sin ad altra dichiaratione, et essi hanno giurato al Pr incipe della Pomerania, non a Paolo o a Pietro in individuo 28
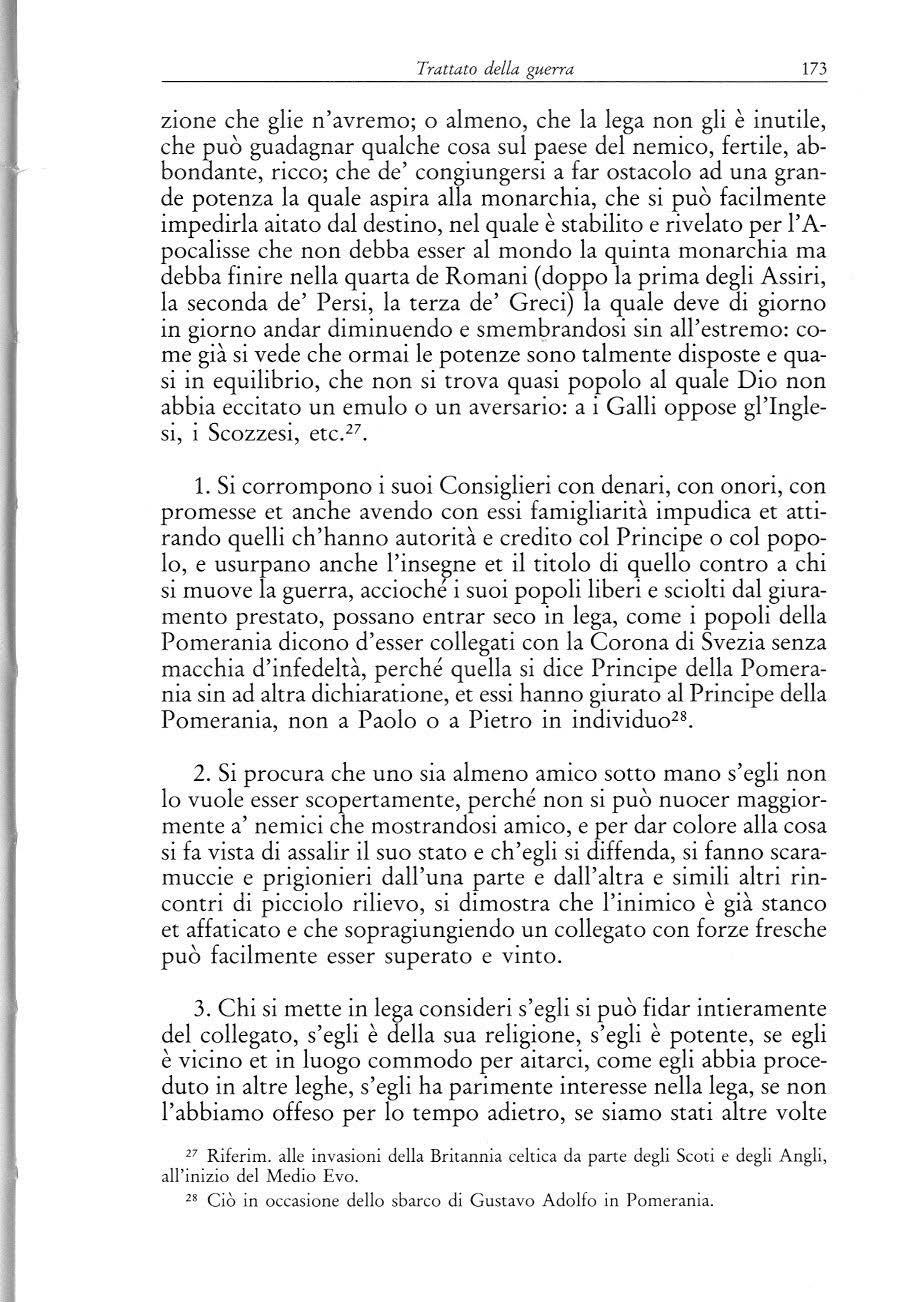
2. Si procura che uno sia almeno amico sotto mano s'egli non lo vuole esser scope rtam ente, perché non si può nuocer maggiormente a' nemici che mostrandosi amico, e per dar colore alla cosa si fa vista di assalir il suo stato e eh' egli si diffenda, si fanno scaramuccie e prigionieri dall'una parte e dall'altra e simili altri rincontri di picciolo rilievo, si dimostra che l'inimico è già stanco et affaticato e che sopragiungiendo un collegato con forze fresche può facilmente esser s uperat o e vinto .
3. Chi si mette in lega consideri s'egli si può fidar intieramente del collegato, s'egli è della sua religione, s'egli è potente, se egli è vicino et in luogo commodo per aitarci, come egli abbia proceduto in altre leghe , s'egli ha parimente interesse nella lega, se non l'abbiamo offeso per lo tempo adietro, se siamo stati altre vo lte
2 7 Riferim. alle invasioni de lla Britannia ce lti ca da parte degli Scoti e degli Angli, all 'in izio del Medio Evo 28 Ciò in occas ione dello s barco di Gustavo Adolfo in P omera n ia
in lega con lui, o noi o i nostri antecessori, e s'egli ha prestato fedelmente aiuto.
Chi si mette in lega chiamato al soccorso d'un paese, domanda che gli sia data una o più piazze nelle mani per sicurezza della ritirata, e così il R e di Svezia domandò Spandau all'Elettore di Brandenburgo29. Chi ha anche pensiero e disegno d'intraprendere sopra un paese straniero, abbraccia volentieri l'occasione d'entrar in lega e di mandar soccorsi a quelle Città che vi so no guerreggiate e travagliat_e, p~rché ciò è come fabricarsi poco a poco un ponte per potervi poi passare con una grossa e potente armata.
III. Quando un Principe sa che si fa, o s'è fatta, una lega contro di lui, dee cercare di far una contro lega, o d'impedi r e la lega de' nemici con una diversione o coll'eccitar loro un potente nimico addosso, o di romperla s' ella e già fatta.
1. Alcuno, per ingannar~ due collegati, ha fatto credere all'uno che l'altro trattasse seco di pace, sì che il primo, per prevenir il compagno, ha conchiuso realmente seco la lega.

IV. Gli articoli delle leghe devon'esser chiari, mettendo pena a chi non la tiene fedelmente, perché i Principi raramente mantengono la fede e di lor natura non han no alcuno per amico né per nemico ma dal commodo loro misurano le amic izi e e le inimicizie, e però s'altri non si prevale subito nel principio del calor delle leghe, svanisce presto, perch' egli è difficile che fra tanti capi non nasca dissensione e di scordia, sì che è natura delle leghe d isfarsi per ogni poco d'incommodità de' collegati se non vi si provede prima molto accuratamente.
1. E però, quando si vede una guerra di più potentati contro un solo, si de' far giudizio che quel solo avrà l'avantaggio se ha solamente tanta virtù in lui che possa sostenere li primi sforzi, e temporeggiando usi de' mezzi co n venevoli per separarli e dividerli; et un solo, il quale ha in suo potere 10.000 uomini, s i de' più temere che dieci confederati, ciascuno de' quali abbia 6.000 uomini, perché fra loro non è un'autorità singulare e precipua, e giornalmente vengono molte cose in disputazione, e prima ch'una cosa sia determinata l' occasione è passata.
Egli è noto quante grosse leghe si siano fatte contro l'Imperatore e la Casa d'Austria, ma egli è anche noto come si sieno sempre disfatte, et ultimamente come la più gran parte de' Principi dell' Alemagna si distaccarono da' Svedesi doppo la battaglia di Nordlingen30.
2. Gli articuli della lega tra Francia e Svezia furono 31 : Che fra loro fusse una lega per la diffesa de?li amici communi, per la sicurezza del mare, per l'uso libero de commerci, per rimettere nelle pristina libertà gli stati oppressi dall' Alemagna;
Che, poiché la parte contraria non si poteva disporre per intercessioni a soddisfar all'ingiurie e danni fatti, si dovesse cercar coll'armi il buono stato degli amici communi, e a tal fine dovesse il Re di Svezia condurre et mantenere in Alemagna, a sue spese, un'armata di 30.000 fanti e di 6.000 corazze; Che il Re di Francia dovesse contribuir ogni anno (400.000 talleri) pagando la metà della somma alli 15 di Maggio e l'altra metà alli 15 di Novembre in Parigi o in Amsterdam, in Olanda, secondo il piacer del Re di Svezia, a' suoi deputati;
Che le levate de' soldati e la condotta de' Vasalli e d'altre cose di guerra fussino libere nell'uno e nell'altro Regno, ma proibite al nemico;
Che quei che commetessero qualche delitto nell'armata fossero castigati secondo l'uso militare, e i fuggitivi fossero resi e messi nelle mani del lor signore per essere puniti;
Che se Iddio desse prosperi successi et avanzamenti al Re di Svezia, egli dovesse comportarsi ne' luoghi occupati secondo le leggi e le constituzioni dell'Impero , e dov'egli ritrovasse l'essercizio della Romana Cattolica Religione , ve la lasciasse, né la riformasse;

Che se volessino entrar in questa lega altri Principi o stati di Germania o d'altri paesi, do vess ino esser ricevuti, ma con questa
30 A Nordlingen, il 6 settembre 1634, le forze svedesi-protestanti, guidate da Gustavo Horn e da Bernardo di Weimar, durante un fallito tentativo di sbloccare la città assediata dalle truppe spagnole del Principe Ferdinando, fratello di re Filippo IV e Cardinale (detto quindi il Cardinale Infante) e da quelle Imperiali di Ferdinando d'Ungheria (erede al trono dell'Impero) e da Matteo Galasso, furono disastrosamente battute F u la più bella vittoria degli Imperiali e fece perdere agli svedesi molti dei loro alleati . (Cfr.: OscAR FRAAs, Die Nordlingen Schlacht am 27 August 1634, Nordlingen, 1869, repr 1983; GusTAV AnoLF ZrPPERER, Nordlingens Schicksalstunde, 1634 · Sie Schlacht bei Nordlingen, s.l., 1984; di G.A. ZIPPERER è anche da vedere la storia della città, che abbraccia l'i nte ro per iodo della G uerra dei Trent'anni relativo ad essa: Nordlingen, No rdli ngen, 1979, pag . 113 sgg.).
31 L ' all eanza tra il re di Svezia, Gustavo Adolfo, e la Francia fu stipulata il 23 gennaio 1631, con il Trattato di Barwalde.
promessa e cauzione: che né occultamente né apertamente, in lor nome o sotto nome d'altri, terranno mano alla parte contraria o saranno d'impedimento al Re di Francia o di Svezia o al ben publico; anzi, che più tosto dovranno contribuire in favore di questa guerra la lor quota e interesse, per quanto porterà la lor conditione;
Che si dovesse tener amicizia, o al meno neutralità, col Duca di Baviera e colla lega cattolica dell'Imperio in caso eh' essi facessino l'istesso;
Che in caso si venisse a trattati d'accomodamento si dovessino far i trattati col commune consiglio e cooperazione di tutti i confederati; e che nissuno senza il sapere e senza il consenso dell'altro potesse conchiudere la pace o accordar cosa alcuna;
Che la lega do vesse dal dì d el trattato d ell'Anno 1631 durar c inque anni, cioè sin al prim o di Marzo stilo vecchio dell'anno 1636 32 ;
Che se in questo tempo non fusse conchiusa la pace, dovesse esse re prolungata e prorogata secondo il parer comune de' collegati .
E gli articoli della lega tra Svezia et i Prin cipi della Germania furono 33 :
Che i Principi suddetti e gli altri somministrassero i danari e che il Re di Svezia somministrasse i soldati;
Che quando il Re fosse entrato nella Germania i Principi gli dessero ogni assistenza;
Che de' paesi ch'egli acquistarebbe ritenesse per sé quelli che fossero de' Cattolici e restituisse al loro Signore quelli che fossero della religione protestante.
3. Un Principe de' però sempre tener ambasciatori appresso i s uoi confederati per mantenerli constantemente nella fede e prevenire ad ogni cativa pratica.
Si procede diversamente nelle leg he e tutto l'ordine del procedere s'esprime chiaramente negli articoli delle convenzioni.

J 2 La riforma d e l calendario giuliano ad ope r a di Papa Gregorio XITI nel 1582 fu immediatame nte accettata dai p aesi ca t tolici; i protestant i e gli ortodossi , tuttavia, non lo adot t arono che assai più tardi : i Principi te deschi nel 1700 (Dieta di Ratisbona) e così pure la Danimarca; l 'Inghilterra lo adottò nel 1751; la Svezi a nel 1753 e la Russia solo dopo la presa d el potere da parte dei Bolscev ichi nell'o t tobre de l 1917 (la q ual e, così, fu datata al 7 no vem bre) . Quando si parla quindi di stilo vecchio ci si riferisce al calendario giuliano ancora in vigore, mentre i l computo d el t empo i n base al calendario gregoriano è detto nuovo stile.
33 Si tratta dell'alleanza di Heilbronn, stipulata ne l marzo-aprile 1632.


I. Tal' ora si concerta ch'ognuno de' collegati attacchi l'inimico commune dalla sua parte, e ciò che ciascuno occupa di per sé gli rimanga.
1. Tal' ora che se uno occupa qu ello ch'è stato prima d'uno de' confede rati, sia obligato di restituirglielo ma con soddisfar alle spese della guerra o col pagar una determinata quant ità di danari.
2. Si determina dunque la quantità dell'armata, le spese per intrattenerla, i l fine a che è dire tta la guerra, il modo di condurla, la distribu z ione de' pa es i acquistati.
3 . Si fa tal' ora una lega difensiva, accordandosi che se l'uno de' collegati vien'attacato, tutti gli altri sieno obligati a mandargli assistenza d'una quantità di gente determinata, o di munizione, o di viveri, o di denari, e se son'attaccati tutti insieme, ognuno faccia la guerra da per sé.
4. Ma sop ra il tutto s'ha risguardo che non entri disunione fra collegati, c h'è l'uni ca p este delle leghe, e però accordano principalmente di non far guerra o pace se n on communemente, né l'uno senza la saputa dell'altro.
5. S'accorda ancora che se i sudditi dell'uno de' collegati ribellano, sieno dichiarati inimici di tutt i, et in somma che si sia amico degli amici et inimico de nemici, di sorte che se un Principe ha sudditi ne' quali egli poco si fidi, collegandosi ad un potente trova qualche sussidio contro alla ribellione.
6. Se un Princip e è molto ricco, piglia a far solo le spese che dovriano fare tutti i confederati in sieme, poi in discanto ritiene per sé solo un paese acquistato.
II. La lega offensiva si fa contr'uno per torgli lo stato il quale vo gliono i confederati divider tra l oro; o p er spegner un tiranno che ci estorsiona con dazi e con gabelle, ci rompe i privilegi e ci fa altre ingiurie n e lla vita, nella robba e nell 'on ore e nella religione.
1. Non s'entra tal 'or in lega con uno per l'accordo e convenzion e che s'ha con un altro di n on intraprendere leghe, o perché
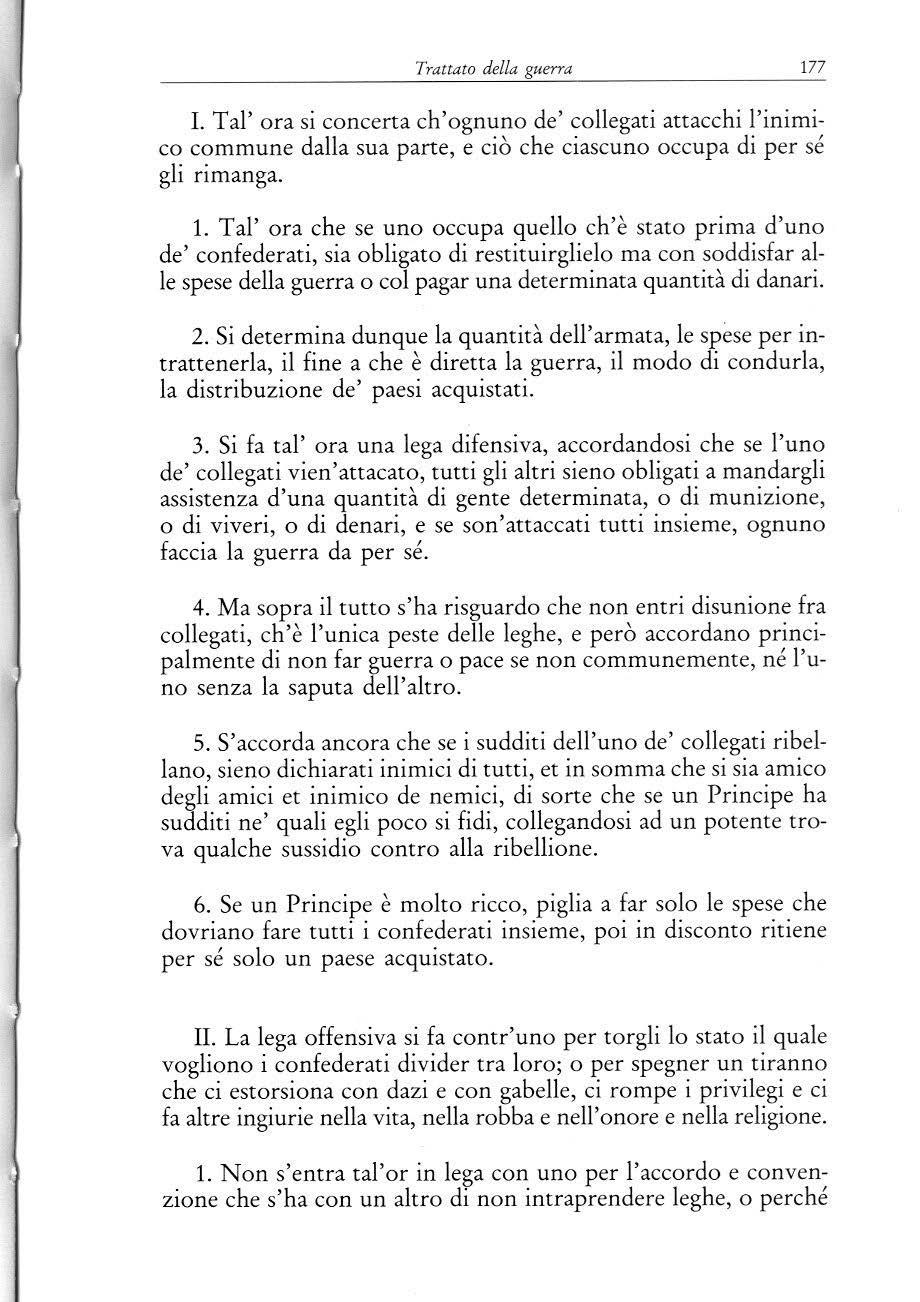
la lega è inutile et intolerabile rompendo i traffichi della mercantia; o perché il collegato non ha forze a diffendersi, o può ariva r e qualche accidente che non ci possa recar aiuto.
2. Non s'entra in lega con uno perché egli è troppo potente e dubitiamo d'esser finalmente assuggettati da lui o eh' egli solo abbia la fama dell'imp rese e noi li aggrav i e le spese, o che bisogni far per amor della lega cose che non si fanno vo lonti eri.

Si rompono e si dissolvono le leghe:
I. Quando il tempo della lega è spirato; quando i nostri confederati la rompono i primi; quando siamo stati forzat i ad entrar in lega né l'abbiam fatte spontaneamente; quando s'è operato contro gli articoli della lega; quando sono passate le ragioni e le circonstanze che ci aveano persuasi alla lega, perché a volere che un uomo sia tenuto di fare quel che promise, si richiede che tutte le cose rimangano immutate, altrimenti né egli fu mendace nel promettere , perché promise quello ch'avea nell'animo sotto intesesi le debite condizioni, neanche è in fede le non adempiendo quello eh' ei promise perché quelle medesime condizioni non sono più.
1. Si rompono quando viene a morire il capo della lega: quando dubitiamo che i co nfed erati diventino troppo potenti perché la discordia è un male assiduo fra gli egua li, e quei che furono prima confederati contro un terzo, debellato quello, muovono tra loro la guerra; quando i confederati sono stati vinti dal nemico, e noi per paura lasciamo il partito e ci voltiamo contro di loro.
2. Si rompono quando s'è abbandonato da' confederati e che nella necessità non si riceve soccorso, perché all'ora s'è scusato di rinunziar alla lega, e però quando non si può mandar aiuto a i collegati non si lascia tuttavia di prometterlo giornalmente e di dar apparenza e verisimiltudine alle promesse, acciochè, riempiti di speranza, sieno ritenuti nel dovere della società.
II. Nel soccorrer un confederato bisogna considerare diverse cose.
1. Se il suo paese è congiunto al tuo, e che nulla t'impedisca d'assisterlo con tutte le tue forze unite, tu non puoi aver altra scusa di
farlo se non che terni il suo nemico e non lo vuoi offendere, la quale è una ragione vile e non giudiciosa, perché per -tale scusa tu non scampi il pericolo che la perdita del tuo vicino ti porta, sendo molto meglio di r esister insieme che di lasciarsi disfare l'uno doppo l'altro .
2. Se il confederato è separato da te per altri Principi e p er altri stati, e che si rincontrino grandi difficultà per pen e trar e sin dentro al suo paese, bisogna vedere che se gli stati che sono fra mezzo ti negano il passaggio, e che bisogni che tu li combatta prima che potere assistere il co n federato, v'ha dubbio che tu non lo potrai soccorrer a tempo.
C h e se il tuo vicino, o per paura tua o di quello ch'attacca il tuo collegato , t'offre il passaggio, tu non lo puoi accettare s icurament e ch'e' non ti metta nelle mani i luoghi neces sa ri per assicurar il tuo ritorno, il che sendosi rifiutato, tu non devi passar innanz i, ma per manifesti in istarnpa publicar la tua scusa; così il R e di Svezia, volendo soccorrere Magdeburgo e dovendo passare per il paese di Brandenburgo, domandò Berlino, Kustrin e Spandau con prov ianda e con lo stipendio d'un mese, ubbligandosi di renderli doppo il soccorso , et aggiungendo ch'egli. non li chiedeva perché dubitasse della fede d ell'Ele ttore, ma perché ave va per sospetti i suoi ministri e commissari . Espugnò anche Alt Brandenburg, tenuto da' Cesariani, per non lasciar il nemico doppo di sé. E con ogni modo non avendo soccorso Magdeburgo mandò manifesti in istampa per purgarsi3 4 •
3. Se il nemico del tuo confederato ha de' stati vicino a te e che tu possa attacar facilmente, bisogna farlo con ogni v igor e, et il soccorso che si può dare per diversione è il piu sicuro e che riesce il meglio, perché tu lo fai con tutte le tue forze e cornrnodità e p erc hé ordinariamente quello che tu attacchi non è b en provisto, sendo che colui ch'attacca un altro staro suol condurre seco i migliori capitani e migliori soldati eh' egli abbia .
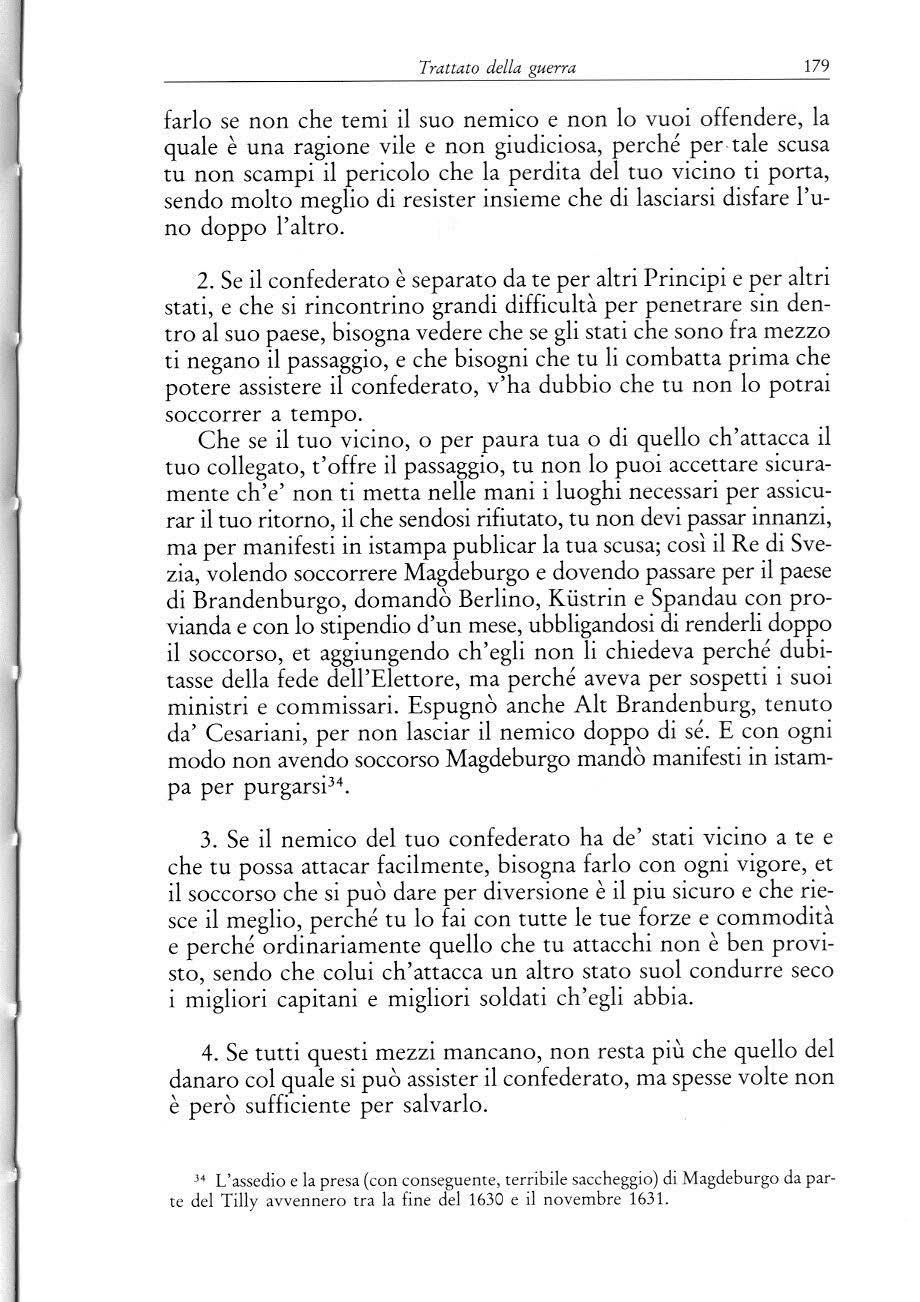
4. Se tutti questi mez zi mancano , non resta più che quello del danaro col quale si può assister il confederato, ma spesse volte non è però sufficiente per salvarlo .
34 L'assedio e la presa (con conseguente , terribile saccheggio) di Magdeburgo da parte del Tilly avvennero tra la fine de l 1630 e il novembre 1631.
Risoluco si il Principe d'intraprendere guerra sia per attac ca r o per diffe nders i, dev e fare tal apparecchio d'uomini, di strom enti, di denaro et di viveri qual egli co no scerà esse rgli necessario per la sua impresa, e sì come il buon marinaro prima che sc iol ga dal porto suol d'ogni cosa necessaria e d'ogni a rma provveder lanave, cos ì il provvi do Capitano de' preparare tutte le cose n ecessarie all'uso della guerra prima che di comme ttersi alla fortun a, perché nell'istesso atto della guerra l'apparecchio riesce incomodo, e tardi, et anche impossioil e perché l'inimico non ti dà tempo, e se ben e per int erceder e spazio di m e ttersi i n armi si danno buone parole agli ambasciatori del nemico, si c hi ede qu alc he giorno a deliberare e s'appuntano, che tornino per la risoluzione ad un tempo prefisso, in ogni modo quest'accortezza non riesce sempre felicemente e l'armi che sono in pro nto sos tengano più le guerre che le levate violenti, le quali difficil m ente si possono far così subito o se si fanno sono poco utili; ma una v olta l'app ar ecchiate non solo servo no a far gue rra ma anche ad impedire, [sì] che non s ia gue rra; che nissun o ard isce di provo care o far in giuria a que l Regno o p opo lo il qual conosce essere sped ito et in pronto a vendicarsi, e chi desidera la pace prepari la guerra .
L'apparecchio principale è d'armate form idabili e grosse, c hé non si possono far gran cose se non con forza, né s' intende però ch'un eccessivo num ero di gente faccia un so l corp o, perch é n o n si devono passar li 40 o 50 mila sold at i, perché più fanno confusione, né lasciano osservare la disciplina e gli ordini impartiti, né servo no che a fa r morire l'armata di fame, perché è facil cosa co l ritrincierarsi schivar la battaglia e Pi rro usava dir e che con 15 mila uomini voleva assalire il mondo, né in Alemagna si sono mai

viste armate insieme che passano questo num ero benché Friedland da una parte, et il Re di Svez ia co' Prin cipi protestanti35 dall'altra hanno avuto di poderosissimi eserci ti: p erché, sì come dove sono più uomini insieme che confidano, s'accresce loro l'animo et il coraggio, così, dove temono, quanto più sono, tanto più sono sbigottiti, perché l'uno accresce il timore dell 'altro, e fra tanti egli è impo ss ibile che non si trovino de ' vili.

Ma s'intende d'aver numero infinito di gente di guerra, ma distinto in più ese rciti; perché gli uni si mandano a far testa ne' passaggi, gli altri attendono ne' piani, con altri si rinforzano le guarnigioni delle piazze, et un altro si tiene libero e non impiegato, accioché in ogn i inopinato che arrivi si possa mandare dove il bisogno richiede. E gli ese mpi d el t empo moderno hanno fatto vedere che se bene sono state rotte molte armate ora dell'Imperatore, ora del Re di Spagna et ora del Re di Francia, sub it o si sono riempite quelle rotture con nuo vi eserciti eh' erano già apparecchiati, sì che chi guadagnò la battaglia non guadagnò per questo la guerra.
I. Una milizia ben ordinata dev'essere composta di Cavalleria e d'Infanteria ch'abbiano una certa convenienza fra loro, perché l'una senza l' altra non può combattere in tutti i luoghi né in tutt'i tempi. I Romani si fidavano totalm ente nell'Infanteria, la quale ricoprivano da i lati con pochiss ima Cavalleria ma quando vo ls ero tener questa regola fuori d'Europa contro i Barbari potentissimi di Cavalleria, non poterono far loro resistenza e furono rotti e disfatti 3 6
Poi venne in uso di metter tutte le forze nella Cavalleria il quale errore ha cagionato la perdita di molti stati in Italia perché la Cavalleria non può combatter in tutt i i lu ogh i né fa r e altre fazioni che appartengono all'Infanteria, oltre che non disputa sì ostinatamente un combattiment o come la Fanteria che vi è condotta dalla necessità di non pot er fuggire; e però s'è trovato esser regola infal~ibile p er 1~ vittoria il comporre l'armata dell'una e dell'altra spezie proporzionatamente.
1. La proporzione quale de va essere non si può assolutame n t e determinare, perché ella v aria secondo il suggetto e secondo i pae-
35 Ne lla campagna che si concluse con la battagli a d i Liitzen.
36 All ude alla d isfatta romana di Carre , ove i P art i, fortissi m i in Cavaller ia, dist russero l' esercito di Crasso (53 a.C.).
si dove si p e n sa voler menar la g uerra e seco ndo !'imprese c h e si vogliono fare.
In Alemagna la Cavalleria suo l esser ' un terzo dell' Infant eria, e tal'ora an c he piu d'un terzo, et il cann one si calcula un p ezz o ad ogni 1000 uomini di piede e 300 cavalli: ma di questa proporzio ne si dirà a ncora nel libr o seco ndo.
Il. De' viveri poi che se ne deve far provigioni conti nuamente n on solo nell'intrapre ndere la guerra ma anche nel farla e cont inuarla se ne parlerà nel libro sec ondo, cap. V.
ID. D egli stromenti che si pigliano qui larga ment e per ogni so rt e di machina da guerra , come nave , ponti , ca nnoni co n palle, polvere, sue munizioni e fuocchi d'artifizio, pale, badili, vangh e et ordigni da lavo rar terra, se n' è discorso nella pecorina n° 4-5 dove si tratta de fuochi d'artifizio .
1. S'aggiunge che , in generale, s' h anno a pigliare queste cose segue nti col ca mpo [e s' hanno anche a prov eder magaz ini] 37 , cioè : polve, mic cia, piombo, forme p er palle da mo schetti a 12 bu chi 38 ; co perte di pelo per co prir la polve, vele vecchie p e r co prir e mosc hetti, forchettoni, bandolieri, archibugi , picche, m ez ze pi cc h e, armatur e alla prova , piastroni, casc hetti , cavaglieri di frisia, co rt e paliss ate con punte di ferro, magli di legno per cacciarle in terra, martelli di fer ro per ferra r le palissate, ponti d'assalto, graffi lunghi e curti, forche, pale, molini da acqua , ferri p e r far gazoni 39, fu oc hi appa r ecc hia ti, c hiodi grandi e piccioli, lant e rn e, torchi, pece, calce viva in tonni ben serrata 40 , cord e tavole, p ertiche, panieri, ga bbion i, ponti di g ionco, di tela, secchie di cuoio, seghe, e se 'l paese dov e s'ha da guer reggi a r e ha molte piccole acque, b a r che su le carr a e carri per c hiudere il ca mp o e far un Wagenburg4 °bts ,
J 7 Le paro le tra p arentes i quadre m an ca no nel M s. Viennese.
38 Si intenda: forme capaci di consentire la fusione di 12 pall otto le da moschetto contem poraneamente.
J 9 Secondo G. s ~uTH, An Unive rsal Military D ictionary cic., pag. 112, i gazons erano zo ll e di terra co perte d'erba, t agli ate a c uneo, lungh e circa un pi ede e spesse m ez zo, fissate con pio li di leg n o a r ivest im ento es te rno dei bastion i in terra battuta.

• 0 P er tonni inte ndansi bari li o botti.
V •o... Il Wagenburg, usat o con estrema efficac ia dapprima dal condottiero boem o Jan 7. i~ka durame le Gue rre hu ssite ( 141 9- 1436), era una s pecie di fortilizio fatto mediante i
se bene il bagaglio si de' riformare al più picciolo piede che sia possibile, e questo coli' esempio del Capitan genera le, e si potesse introdurre che chi volesse aver carri, avesse a portar qualche cosa per l'utilità publica, come scure e pali di ferro etc ., e di poi se altro potessino a commodità loro, sarebbe un gran vantaggio del1'essercito .
2. Per v ietar ogni fraude, che i so ldati quando travagliano non cambino i lor materiali co' i rotti de' Maestri dell' opra del campo e facciano il lor profitto, e' si fa che gli stromenti degli ovraggi affidati a' Maestri sieno marcati d'un ferro caldo, per poterli discernere41.
IV. Egli è trita sentenza che i denari sono il nervo della guerra, perché sì come i medici negano che l'uomo possa caminare senza nervi, così lo negano i politici della guerra senza denari, perché ella non consiste solamente nell'armi ma anche nelle spese col mezzo delli quali l'arm i sono rese utili et efficaci, e per mancamento di danari si perdono molte vo lte di bellissime occasione .
1. Un gran politico ha avuto opinio n e che gli uomini e non il denaro siano il nervo della guerra, perché, diceva egli, gli uomini armati possono sempre trovar danari ma il danaro non trova sempre uomini 42 • Si può usare questa distinzione: che la parte principale della guerra sta posta nella virtù d e gli uomini, ma l'instrumentale nel danaro, e quando si dice che il danaro è il nervo della guerra, s'intende a condizione che la guerra abbia tutte le sue altre circonstanze requisite, come il corpo umano non è solamente composto di nervi, d'ossa, di carne e di sangue; e sì come un braccio, benché pien d'ossa, di carne e di sangue, non potria fare il suo ufficio se qualche n ervo l'impedisse, così un'armata, benché carri, il quale co n se nti v a a forze relativamente deboli n el setto r e della cavall er ia di ad ottare una tattica d i fens iva-controffens iva, respingendo dapprima l' att acco nem ico e poi contratt accand o lo. Lo stesso venne usa to, su scala ass ai più ridotta, da i pionieri america ni nell' Ov est p er resistere agL attacchi del la cava ll eria pe ll erossa
41 Questo per iodo , a bbastanza co ntorto, pone in guar d ia contro l' usanza da parte dei sol dati di scamb iare i loro attrezzi campa li nuovi contro q ue lli guas t i de ll e m aestra nze (ch e facevano allora le funzioni de l Gen io) , riceve nd o ne un a so mma d i den aro. Successivamente i so ldati denu ncia vano i loro att r ezzi come g uas ti e se li faceva no cambiare grati s, te n en dosi il p rofi tt o intascato. Il m archio avrebbe reso impossibile tutto ciò.
4 2 Tagliente polem ica contro la tes i en unciata dal MACHIAVELLI (Discorsi, li, 10), essere gli uo m ini e non il denaro il nerbo de lla guerra.

fornita d'uomini di guerra, che sono gli ossi, e d'armi, che tengono luogo di carne, sarebbe inutile, struppiata e immobile da una parte e d'a ltra, se il dan aro , che n'è il n ervo, ven isse a mancargli.
N é so lo dalla quantità del paese, ma anche dalla quantità del danaro si fa stima d ' una potenza: e questo deve esser già in pronto e non ave rl o a ce rca re nel punto del bisogno, e devesen e avere gran quantità, perché le spes e d e lla guerra no n si possono misurare né diffinire.
H a detto un gran politico moderno che la guerra non è ordinariam e nte bu ona mercant ia p er fars i ricco , ma b en per farsi gr ande43; e gl i è vero ch'elle cos tano assai e c he in que l punt o c he si fa la guerra più tosto impoveriscano c h e altr im e nti, com e si conosce c h iaram e nte al giorno d'o gg i in qu e ' P rincip i che me nan o la guerra, perché bisogna impiegarvi del suo, et i tes o ri riservati di molti anni.
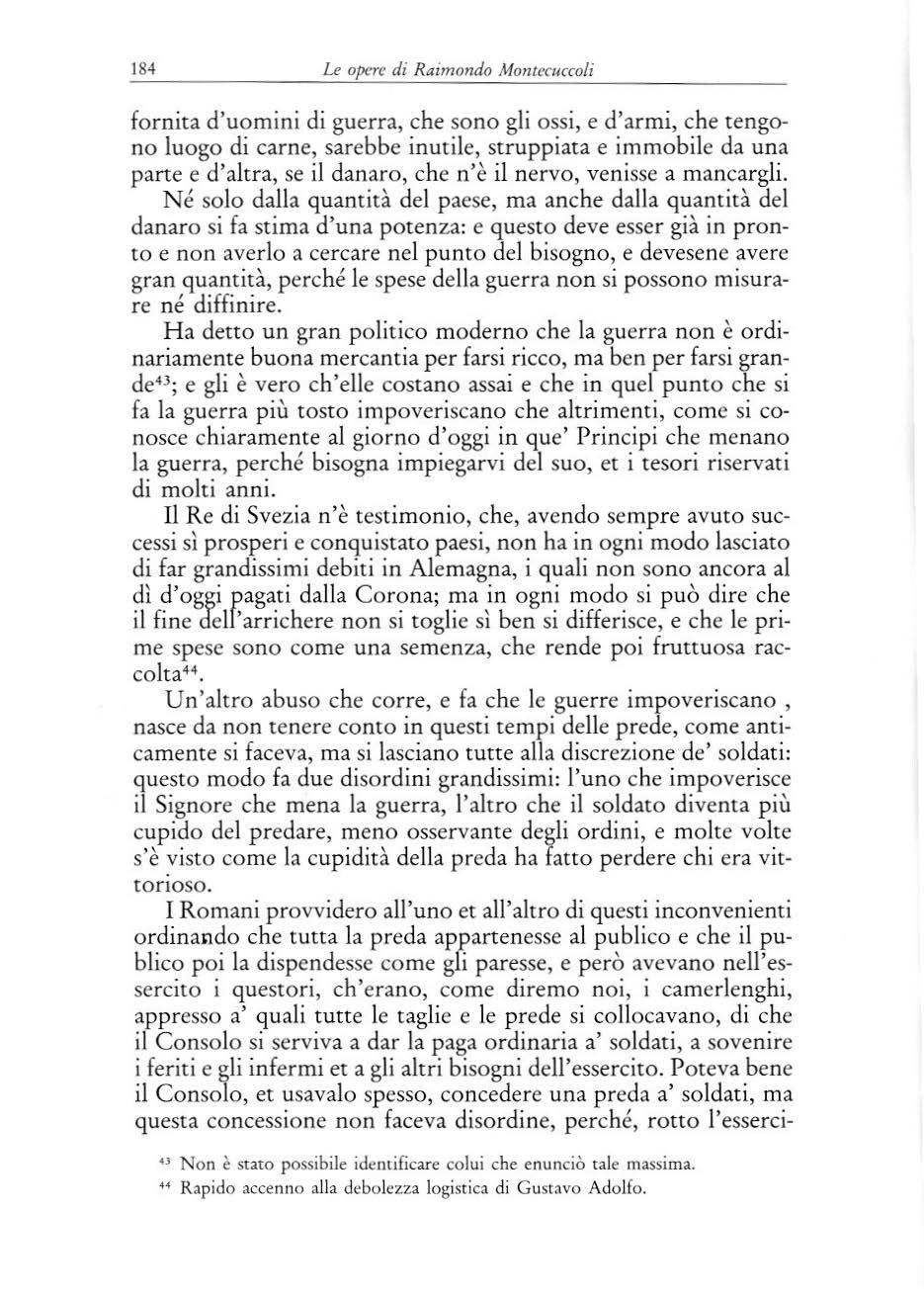
Il R e di Svezia n'è test imoni o, che, av e ndo semp re av uto su ccess i sì prosperi e co nqui sta to paesi, non ha in ogni modo lasciato di far gran dissimi debiti in Alemagna, i quali non so no anco ra al dì d'oggi pagati dalla C o r o na; ma in ogni mod o s i può dire che il fin e dell'arrichere n on si togli e sì ben si differi sce, e che le prime spese so n o co me una semenza, che r e nde p oi fruttuosa racco lta44.
Un'altro abuso che co rre, e fa che l e guerr e impoveriscano , nasce da non tenere conto in questi tempi delle prede, come antica mente si faceva, ma si lasciano tutte alla discrezione de' sol dati: q ue sto modo fa due di sord ini grand is simi: l'u no c h e im poveris ce il Signore c he mena la guerra, l'alt ro che il soldato div enta più cupido del pr eda re, m eno osservante de gli ordini , e molte volte s'è :'isto come la cu pid ità della pre da ha fatto perdere chi e ra vittorioso.
I R omani provvidero all'uno et all'altro di qu esti inconven ient i or din a ndo ch e tutta l a pre da apparten esse al publi co e che il publico poi la dispendesse co me gli paresse, e per ò avevano n ell'e ssercito i qu estori, ch'erano, come dir emo noi , i camerlengh i, ap pr esso a' qu ali tutt e le tagli e e le pr ede si coll ocavan o, di ch e il Conso lo s i serv iv a a dar la paga ord in aria a' so ld ati, a sove nir e i feriti e gli infermi et a gli altri bisogni dell'essercito. P oteva bene il Conso lo, et usavalo sp esso, conce dere una pr eda a' soldati, m a questa co ncessi o ne non faceva disordin e, perch é, rotto l' ess er ci-
to, tutta la preda si metteva in mezzo e distribuivasi per testa secondo la qualità di ciascuno, il qual modo faceva che i soldati attendevano a vincere e non a rubbare, e le Legioni romane vincevano il nemico, e non lo seguitavano 45 , perché mai non si partivano dagli ordini loro; solamente lo seguivano i cavalli con quelli armati leggermente.
Che se le prede fossero state di chi le guadagnava, non era possibile né ragionevole tenere le Legioni ferme e portavasi molti pericoli. Di qui nasceva per tanto che il publico arrichiva, et ogni Consolo portava con li suoi trionfi n ell'erario assai tesoro, il quale era tutto di taglie e di prede.
2 . Un'altra cosa facevano gli antichi bene considerata: che del sol do che davano a ciascuno soldato, la terza parte volevano che si deponesse appresso quello che della sua battaglia portava la bandiera, il quale mai non gliene riconsegnava se non fornita la guerra. Questo facevano mossi da due ragioni. La prima perché il soldato facesse del suo soldo capitale, perché essendo la maggiore parte giovani e trascurati, guanto più hanno tanto più senza necessità spendono; l'altra parte perché, sapendo che il mobile loro era appresso alla bandiera, fossero sforzati d'avere più cura e con più ostinazione diffenderla, e così questo modo gli faceva massai e gagliardi.

3. I denari si cavano da i Campi publici, dalle spoglie de' nemici, da i donativi degli amici, dalle pensioni de' collegati, dalla mercantia, dalle gabelle delle cose che si portano dentro e fuori del paese e dai tributi de' sudditi; straordinariamente si cavano imponendo nel paese tanto per testa, per camino o per casa, incaricando gli uomini ecclesiastici e constringendo i ricchi ad andare personalmente alla guerra o a pagar tanto vendendo i beni, gli onori, le cariche, le dignità; pigliando in prestito anche da' Capitani istessi dell' esserc it o, nel che si fanno due profitti: che col pegno in mano s' obligano gli animi di quei Capitani che hanno prestato, e col pagare i soldati si riguadagnano le vo lontà loro; mettendo la mano a i tesori sacri e profani, affittando il paese, vendendo o ranzionando i capti v i46 e facendo preda sopra il nemico; nelle
•s intendi: non si b uttav ano alla r infusa per arraffare la preda: ché, anzi, i R o m ani er ano maestri nell ' inseguimento impl acabile del n em ic o battu to, ma mediante le truppe adatte, co m e nota M. più o ltre , e in buon o r dine .
' 6 Ranzionando: francesismo (d a rançonner) . Signifi ca esige re u n riscatto .
contribuzioni del paese occupato; facendo moneta falsa et alchimia dorata, overo facendone di materia non vali da, ma coniata in modo che si possa rico noscere, accioché in tempo di pace o d'altra commodità si riccatti con buon argento.
4. Per persuadere un popolo a una contribuzione bisogna mostrarne la necessità, impiegarvi i predicatori e che i capi ne diano buon esempio col contribuire i primi la loro propria argenteria. Egli è anche bene di far mettere i tributi grandissimi per de' Commissari e Ministri, accioché scemandoli da poi il Signore acquisti grazia appresso de' tributari, i quali paghino vo lontieri quel che rimane quasi che avessino ricevuto gran benefizio dal Signore che gli ha diminuiti. S'onestano anche con be' titoli le azioni poco grate: chiamate contribuzioni le taglie, guardie le guarnigion i, magione la prigione, amica la puttana. Alcuni Principi, per aver danari da' sudditi, preparano fintamente la guerra contro a qualche potentato per aver apparente necessità di chieder fOntribuzione; poi, in capo a breve tempo, licenziano le truppe. E detto vulgare de' populi della Germania negl'Imperatori Austriaci che, quando vogliono chieder danari a qualche Dieta, fanno subito correr avv isi et imprimer gazette e venir lettere d'Ungheria che il Turco si muove con armate formidabili e poderose, per assaltare la Cristianità dalla parte d'Ungheria.
5. Per distribuir bene il danaro nell'armata, non bisogna che passi per le mani di molte persone, perché tanto più diminuisce; e la quantità d e' Pagadori e Commissari nella Fiandra fa che non si ritrova la metà del denaro ch'è pagato dal Re per l'esercito 47 • U n politico ecclesiastico propone che il danaro dovrebbe esser dato nelle mani di persone ecclesiastiche, che ne facessino la distributione come persone integerrime, e che fra l' ecclesiastici si dovriano elegger quelli che fanno maggiore professione di povertà e che hanno minor affetto al danaro, com'è l'ordin e de' Cappuccini.
6. Annibale, invidiato per le s ue grandi ricchezze, pose anfore piene di Riombo nel tempio di D iana quasi presìdi della sua fortuna, e cosi, quella città, non punto sollecita di lui perché teneva come in pegno le su e ricchezze, egli viaggiò altrove avendo infu so l'oro suo dentro alle statue che portava seco, accioché le ricchezze v iste non fussero di nocumento alla vita sua 48 •

4 7 Allude alla pessima amministrazione del le truppe spagno le in Fia ndra.
• 8 Intendasi: la città (C apua) credeva di tenere in pegno le sue ricchezze
Gli uomini si dividono in: consiglieri; Generali e capi, artefici e soldati .
I . I consiglieri devono sopra tutte le cose esser qualificati di fedeltà e di esperienza: questa fa che sappiano che dire per giovamento della Republica o del Principe, quella, che vogliano dirlo senza lasciarsi vi nc er e dalla passione né corrompere dal denaro. Ed è necessario udir più pareri, p erché se non sono dette diverse sentenze, non si può eleggere la migliore ma bisogna servirsi di quella che è stata detta alla prima; ma quando ne sono state proferite parecchie, si può sceglierne una come oro puro, e quello che non si potria disc~rnere da per sé solo, si discerne nella comparazione d'un altro. E ben vero che spesse volte la quantità delle v oci prevale alla qualità della migliore, né i troppo acuti consiglieri sono sempre i migliori, perché vogliono parer più sapienti delle leggi e per trapassar gli altri vogliono sempre recar qu alch e cosa di nuovo; molte volte ancora i migliori consigli, se vengono da persona straniera, sono contrariati da i favoriti del Principe, i quali non considerano l'utilità della cosa, ma temono che, approvato il consiglio di colui, egli occupi il primo luogo nella gratia del Signore, sì che viensi a cadere in quell'infelicità dove chi più sa ha minor potenza; e tal ' ora, anche se il Principe farla il primo nella consultatione e dimostra il suo senso, con ta pregiudicato vien a perire la libertà di quelli che temono d'opinare cose contrarie al Re, o credono di dissuaderlo. Invano Solone, per non mancar al bene della Republica tacendo e per non metter se stesso in pericolo parlando, finse una subita pazzia, col perdono della quale non solo era per dire, ma anche per fare le cose proibite.
1. Egli è vero che in tutte le cose, massime nella militare, può la fortuna, e eh' ella può apportare casi inopinati, e che i più gran capi non devono attrib ui r troppo alla lor prudenza nella condotta degli affari tanto publichi che particolari, perché se b en ella è un instrumento necessarissimo, in ogni modo ella è qualque volta come bendata, non potendo, fra tante vie e tanti procederi, conoscere quale sia la migliore per sostenersi quando soprarrivano queste tempeste inopinate, e ciò succede accioché ella s'umilii e vada a cercare fuori di se stessa la cagione de buoni successi . Si deve anche di qui imparare a non perdere mai la speranza benché l'uom si trovi in grandi difficultà, perché non bisogna che un accidente favorevole per disimbarazzarlo, il quale però segue ordinariamente quelli che s'avvalorano e fuggie quelli che s' avviliscono.

2. Disse ottimamente quel politico 49 che la metà delle nostre azioni sta nelle mani nostre e l'altra metà nelle mani della fortuna, e però per condur a fine imprese grandi è necessario lasciar qualche parte delle azioni raccommandate alla fortuna, perché chi vuol pensare a tutte le cose non si risol ve mai a nissuna, perché gli accidenti et i singolari non cadono tutti sotto all'imaginazione. La varietà della fortuna è tale che i Pri ncipi ora si veggano Re, ora essulanti, e poco intervallo di tempo colloca gli uomin i in un eccelso fastigio e ri conduce i medesimi ad una estrema miseria e calamità: però non bisogna fidarsi delle cose a venire come già fatte, né collocar la speranza in quelle cose che possono succeder altramente, ma bisogna riserbar continuamente qualche parte a quegli accidenti che possono succedere oltra la speranza in tutte le cose umane, ma molto più nelle belliche . Chi si dà però tutto alla fortuna disimpara la natura e la perpetua felicità e consolatione della temerità.
3. Ma non ostante la parte che ha la fortuna nelle azioni, non bisogna lasciar la prudenza, che ne ha la parte maggiore. Un sol buon consiglio può vincere una gran mano di soldat i, e gli accidenti che paiono avversi si possono colla prudenza emendare, et accommodando li alle sue cose, renderli utili.
Egli è vero che più facilmente si può conoscer il male che cacciarlo colla medicina, eh' egli è più utile ubbidire che recar consiglio, perché qui vi si va del pari co' gli altri: qui si fa il pericolo suo proprio; che i consigli di coloro che consigliano a se stessi sono torbidi: mentre che gli uni sono impediti dal timore il quale toglie la mente a gli uomini et il consiglio e debilita i membri, gli altri sono impediti dalla cupidità e dal natural amore di quelle cose che s'imaginano, il qual fa che ciò che noi vogliamo e crediamo e sentiamo volontie ri, speriamo che gli altri anche lo sentano, e nelle cose avverse l'uno getta sempre la colpa sopra dell'altro, benché tal vo lta s'abbia più suggetto di lamentarsi del caso.
Ma non per questo si dee lasciare di consigliare al ben publico per quanto si estende l'umana capacità, la quale dipende per lo più dall'esperienza.
4 L'uso è maestro di tutte le cose, et ordinariamente c'è differenza fra quello che presuppone la teoria e quello che presuppo-
49 MACHIAVELLI (Discorsi, II, 1). M. aderì sempre al concetto mach iavellico secondo cui le az ioni umane sono dominate dalla v irtù e dalla fortuna (in senso lat ino) .

ne la pratica, et il consiglio richiede velocità perché l e cose d ella guerra son punti et ore, né si dee dar nome di prudenza alla tardanza, perché le occasioni sono precipitose.

Non si deve già sempre pigliar p er danaro conta nt e tutto quello ch'è scritto nell'Istorie, perché molte vo l te le cause che hanno prodotto gli effetti sono ignorate o falsificate, e sì come una scarpa non convien ad ogni piede, così un fatto non s i può appropriar a tutti i paesi, e bisogna ben conoscere tanto la natura delle cose c he delle persone prima d'accommodargliele, overo s'entra in pericolo di cadere in errore.
Né si posson anche fabricar regole sopra gli esempi che la necessità ha prodotti se non v'è la medesima ragione che vegnano all'ora: ma si può servirsene accommodandoli a i tempi, a i luoghi et alle persone, e sì com'egli è atto di profana superbia lo sprezzare da per tutto la prudenza delli Antichi, così anche è un genere absurdo di riverenza il l egarsi perpetuamente a i loro instituti, e bisogna procurare le cose secondo il genio del secolo e secon d o la diversità de' tempi ne' quali altri si ritrova. L'uso delli esempi è dunque pericoloso in questo: che le persone e i luoghi sono spesse vo l te diversi benché gli eventi paiano simili; ma ogni volta che l'esempio s i giunge a l precettn che si trova uniforme in quelli che hanno scritto d'una professione, all'ora non bisogna metter in dubbio che non se ne tiri una massima, l'imitazione della qua l e deve esser proposta a tutti in generale; et ogni scienza ha le sue gene rali tà .
5. In t u tte le nostre deliberazioni et imprese bisogna avvisare da qual lato v'è manco pericolo, e pigliar quello per miglior partito, perché tutto netto, tutto senza sospetto non si trova mai, e negli estremi pericoli non bisogna essere troppo intendenti, ma adoprare rimedi estrem i.
Se ti occorresse che assai uomini e assai popoli avessi n o a far u na cosa che fosse a te di u tile et a loro di danno gr ande, come sarebbe, o disfare le mura delle loro Città, o mandar in essilio molti di l oro, ti è necessario o inganarli in modo che ciascuno non creda che tocchi a lui, tanto che, non sovenendo l' uno all'altro, si trovino poi oppressi tutti senza rimedio, overo a tutti commandare quello che devono fare in uno medesimo giorno, accioché credendo ciascuno essere solo a chi sia il commandamento fatto, pensi ad ubbedire e non a' rimedi, e così fia senza tumulto da ciascuno il tuo commandamento esseguito.
II. I Capi dell'armata sono di due sorti : primari e secondari, cioè il Principe stesso che mena la guerra, come il Re di Svezia, o Generalissimi, com'era il Friedland, o persone general i subordinate, come i Marescialli di Campo, Generali del Cannone, Sergenti Generali di battaglia, etc.: o altri capi minori, come colonnelli, capitani, alfieri, etc. 50 • ·
Delle qualità, che appartengono ad un generalissimo, di quelle che appartengono a gli altri capi subordinati e delle loro funzioni, della riputazione d ' un capitano e se è meglio che un gran Principe faccia la guerra in persona, o per luogotenenti, n'hanno discorso diffusamente Lipsio, nel libro V della Politica, cap. 14-15; Preissac, nel cap. 14 degli Uffi zi delle genti di guerra; Rohan nel Trattato della guerra, cap. 17, 22, 23 51
1. Oltre alle v i rtù assegnate da gli scrittori sudetti, si può dire succintamente che le parti d'un capitano devon'esser tali che sappia fare tutte quelle cose che sono discorse nel libro 2°, «D el far la guerra)); né anche bastarebbono, quando non ne sapesse trovare da. sé, perché niuno senza invenzione fu mai grande uomo del mest1ero suo .

2. Deve il Generale esser sommamente curioso d'acquistare l' affezione de' soldati, il che si fa coli' esser loro lib e rale, qualche vo lta indulgente, coll'esser provido nel procurar loro le vettovaglie necessarie, i medici e le m edicine per i malati; col conoscere i soldati per il loro proprio nome, perché se in ogni arte sordida ciascuno conosce i nomi dell'istrumenti dell'arte sua, ben li dev e anche sapere il capitano di coloro de' quali si serve per istrumenti; e per atterrire e per onorare egli è molto convenevole il chiamar ciascheduno col proprio nome: ché quelli che ve ggono d'esser conosciuti dal capita no, desiderano più di farsi vedere a fare qualche bella azione et ad asteners i dalle viltà, oltre c h e se si commanda in genere vada qualcuno ad attingere acqua, vada qualcuno a tagliar legna, l'uno riguardarà l'altro in viso, né nissuno si moverà, perché niuno arrossirà o temerà per ta l causa, perché si dovrebbono accusar tutti e niuno pensa che il commandamento sia fatto a lui; col chiamar i soldati ora commilitoni, cioè compagni di guerra, et ora fratelli, o altri simili titoli di onorevolezza; col tener
50 Per Maresciallo di Campo si inten da il Fe ldm aresc iallo ; Generale del cannone era il Gran Maestro dell'Artiglieria, Sergente Generale di Battaglia era il General e di Brigata.
51 Su Lipsio, Preissac e Ro h an si vedano le n 1, 2 e 5.
tavola e far mangiar e bere seco quelli ch'ei vuol onorare; col metter la mano all' opra, et esser in parte de' i travagli e delle fatiche e de' disagi che i soldati sopportano, perché l'onore rende più lieve a lui le tatiche, particolarmente perché sa che ciò eh' egli fa è nella vista degli uomini; coll'essere giudice non parziale ne gli affari particolari; col mostrar sempre alacrità e letizia nella fronte, fierezza ne' vest iti e nelle parole, temendo il nemico col pensiero e col!' ordine: ma con le parole e con !'altre estrinseche dimostracioni mostrando di srreggiarlo, perch é quest'ultimo modo fa che i soldati sperano piu d'aver vittoria, qu ell'altro fa il capitano più cauto e meno atto ad esser ingannato.
Per acquistare però la benevolenza non bisogna perdere l'autorità, e bisogna temperare l'una e l'altra in modo che restino ne' termini della virtù, perché molte virtù degenerano i[n] vizi, e, quello ch'è più, vedrai spesse volte i medesimi effetti, secondo la sorte de te mpi , ora essere virtù, ora vizi.

3. D evon i capitani esser fortunati, ma, perché la fortuna non dura semp re in un sol uomo, però si dee mandare successori a i generali quando si vede che la felicità non gli arr id e. Ma se il capitano è fortunato, vegga che la troppa felicità non lo sommerga nelle voluttà o non lo precipiti nell'immodestia. A molti sono stati dati i commandi degli esercit i per esporli al pericolo et accioché, sotto spezie d'onore , fossero ammazzati nelle zuffe quelli che per altra v ia non si potevano levar di mezzo : così fu mandato in Germania et in Francia Giu liano, che fu poi Imp eratore et Apostata; così Giasone secondo racconta Giustino, etc.
Molti Principi son'anche dell'umor di Alessandro, vogliono che i nemici sien vinti, ma si sdegnano che un loro capitano gli abbia vinti, stimando che sia scemata alla loro ciò che ridonda ali' altrui gloria. Non si lascino dunque ab bagliare dall'alterigia, ma si servano modestamente della fortuna, la quale non è dubbio di grande riputazione; e la fama del nome è di grandissimo momento nella guerra: et ebbe a dire colui 52 : "piaccia al Cielo che anche gl'In di mi credono Dio"; perché le guerre si fanno colla fama e spesse volte quello ch'è ancor falsamente creduto ottien luogo di verità.
4. Risplenda sopra il tutto nel capitano la fortezza, ma la vera e pura, non mascherata e falsa.
Gl i uomini forti sprezzano più la morte che non odiano la vita; spesse volte anche i vili sono spinti ad aborir la vita per lo tedio della
s2 A lessa n dro il Macedone
fatica, ma la virtù non lascia cosa alcuna d'inesperimentato: bisogna ess ere audace, ma con ragione , non come alcuni a i quali l'ignoranza reca fiducia e la ragion e ritegno; si conoscano le cose aspre, si conoscano le gioconde, ma non per l'amor di queste o p er sfuggir quelle; si sottragga un animo grande da i pericoli, an zi per l'onestà li rincontri: non però senza suggetto si m etta il capitano ne' rischi, e, in quello che può ess eguir per un altro , non azardi se stesso, sì come fu biasrnato di t emerità il Re di Sve z ia che, per leggier causa di riconoscer il Campo imperiale, uscì da $tettino con poca gente , e nel ritorno gli fu quasi tagliato il passo, perché il riconoscer e tali alloggiament i pot eva esser fatto da qualch'altro, e forse poteva riconoscerli meglio che il Re ist esso 53
5 . Tenga il generale cons iglio nelle cose di rilievo, o siano consiglieri apposta appresso di lui, o chiami a Consiglio i gen erali s ubordinati et anche tal' ora i colonnelli dell'esercito, come fece il Duca di Sassonia et Hatzfeld prima d ella battaglia di Wittstock 5 4; p erché più occhi veggono più; et i cartaginesi crucifiggevano que' capitani ch e senza consulta avessero amministrata qualche impresa bellica: benché con prospero evento si tiene però anche tal' ora consiglio più per l'approbazion e di quello che si v uol fare che per avere l'avviso de' consiglieri.
Ne' consigli dov ' è inconveniente da tutte e due le parti, bisogna appligliarsi al partito più generoso, e nell'azioni pericolose bisogna sempre servirsi di quelli che s'offrono a farle.
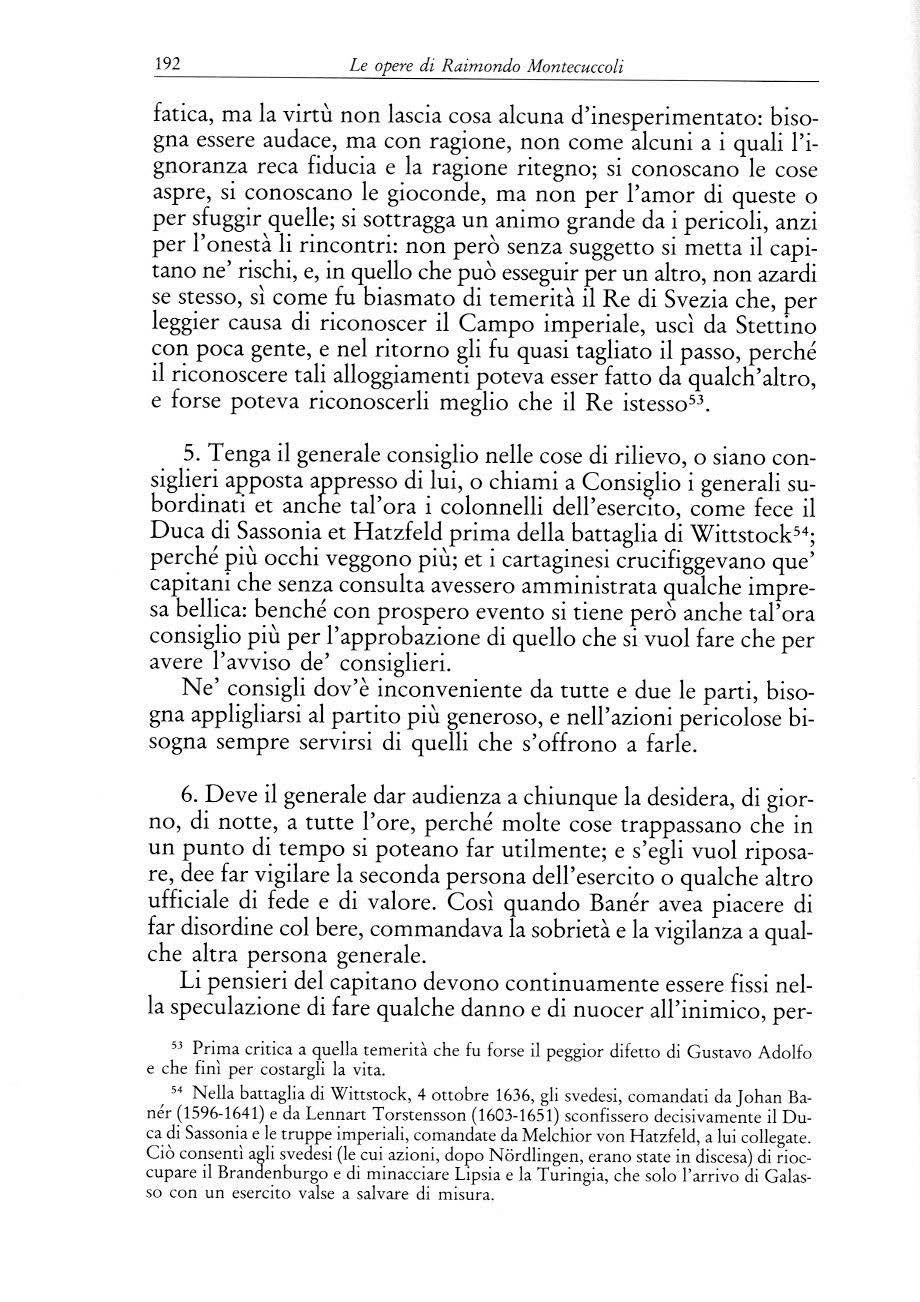
6. Deve il generale dar audienza a chiunque la desidera , di giorno, di notte, a tutte l'ore, perché molt e cose trappassano che in un punt o di tempo si poteano far utilmente; e s'egli vuol riposare, dee far vigilare la seconda persona dell'e sercito o qualch e altro ufficiale di fede e di v alore. Così quando Banér avea piacere di far disordine col ber e, commandav a la sobrietà e la vigilanza a qualche altra persona general e .
Li pensieri del capitano d ev ono continuamente ess ere fi ss i nella sp ecula zione di fare qualche danno e di nuocer all'inimico, per-
53 P r ima critica a q ue ll a te m er ità che fu forse il peggior dife t to di Gustavo Adolfo e che fi nl p er costar gli la vita.
54 Nella b atta glia di W ittst oc k , 4 ottobre 1636 , gli svedesi, co m andati d a J o h an Banér (1596- 1641) e da Le nn art T ors tensson {1603 -1651 ) sconfissero decisivamente il Duca d i Sasso nia e le t ruppe imper ial i, com and at e d a Melchi or von H atzfeld , a lui co ll egate C iò con se nti agli svedes i (le cu i azioni, do _p o N or d linge n , eran o st ate in d iscesa) di r ioccupare il Bra nden b urgo e di mi nacciar e Lip si a e la Turing ia, c he so lo l'arr ivo d i G alasso con u n esercito vals e a salvare d i m is ura
ché una cogitazione somministra l' altra , et entrando d'una imaginazione in un'altra s'affacciano all'intelletto cose che a prima vista non sariano mai cadute nel pensiero; e dove colla prudenza umana non può arrivare a concepir il futuro, può mediocramente aitarsi colle scienze divinatrici, e Friedland faceva grandissimo capitale dell 'Astrologia55 •
Non dee anche il generale ingiuriare di leggieri qualcuno, se non è che lo castighi col mezzo consueto della giustitia di guerra e delle leggi, perché quanto maggiore è chi fa l'ing iuria, tanto più gravemente duole a colui a chi ella è fatta, perché ella è più publica e più nota, et il Barone di Vinermondl fu ammazzato nel mezzo di Colonia mentre usciva di Chiesa da un sergente maggiore ch'era una volta stato tocco da lui d'un bastone nel servizio d ell'esercito Cesareo 5 6
7. Quand'un generale desidera ottener qualche cosa da un'altra non deve (se l'occasion lo soffre) dargli tempo di deliberarne, ma fare in so rt e eh' essi ve ggano necessità di pronta deliberatione, la quale occorre quando colui che è richiesto conosce ch e dal rifiuto o indugio ne può nascer contro di lui un'indignazione subita e pericolosa; sì come fece il Re di Sve zia qu ando domandò d'entrar a Stettino57 •
8. I Pr incipi o le Republiche devono fare l'autorità lib era a i generali, perché non si può a tempo dar consiglio degli accidenti ch'arri vano ad ogni momento, e la distanza de' luoghi fa che i consigli s'apportano doppo le cose .

La moltitudin e di più Capitani generali di egual'autorità è cosa p erniciosissima in un esercito e cagiona mille incon v enienti e mille confusioni, perché i pareri sono diversi, nissuno vuol ceder all'altro, et l'uno guasta quello che fa l'altro o per l' invidia della gloria o per volervi la parte o in qu alch'altra maniera e lo divertisce n e' consigli o non gli assiste colla forza.
55 Il M. era c hiaramente scettico nei co nfronti dell'as t r ologia, pur n o n r ifiut and o la del tutto; del res to, oggi presso i p iù potenti esercit i del mo nd o si stud ia il p ossibi le u so delle fo r ze paranor m ali per la g uerra. Siamo lontan i d al rigido razionali smo del Sette-O ttocento e po ssia mo forse megli o compre nd er e la menta lit à se ice ntesca . Da n o· tare co me M. sottoli nei se mpre l'esigenza per il condottiero di consu ltarsi, ma anche il fatto che a lui spetta l' un ic a e sola r es pon sab ili tà de lla decision e final e. P er nessu n a r agion e M. approvò qu ei co nsigli di guerra che non combattono mai.
56 Si tratta in du bbiamente del barone Johann Vir m ond von der N eers, ucciso n el 1632.
57 All' inizi o dell e operazioni svedesi n ella G uer r a dei Trent'anni
Nell'Armata Imperiale, in quella di Spagna, di Svezia e d'Olanda, il generale non ha compagno di pari auttorità, e se i francesi hanno usato il contrario qualche tempo, addesso non l'usano più, e forse anche all'ora furono mossi per vietar un male maggiore, né avendo ferma certezza della fedeltà de' lor generali .
9 . I Principi della Germania collegati e congiurati contra l'Imperatore non elessero un capo fra loro, perché l'emulazione era . fra i pari, né l'uno si sottomettev a volontieri all'imperio dell'altro, oltre che dubitavano che se colui che avevano fatto generale avesse voluto diventar tiranno, non avevano rimedio alcuno di proibirglielo, essendo della istessa nazione né mancandogli parenti e fautori per sostenerlo: però elessero per capo il Re di Svezia, per dignità e per grado tale che nissuno si sdegnava d'ubbedirgli, e per essere di paese straniero non così facile a poter occupar la tirannide, non avendo tanti aderenti quanti era per avere un allemano.
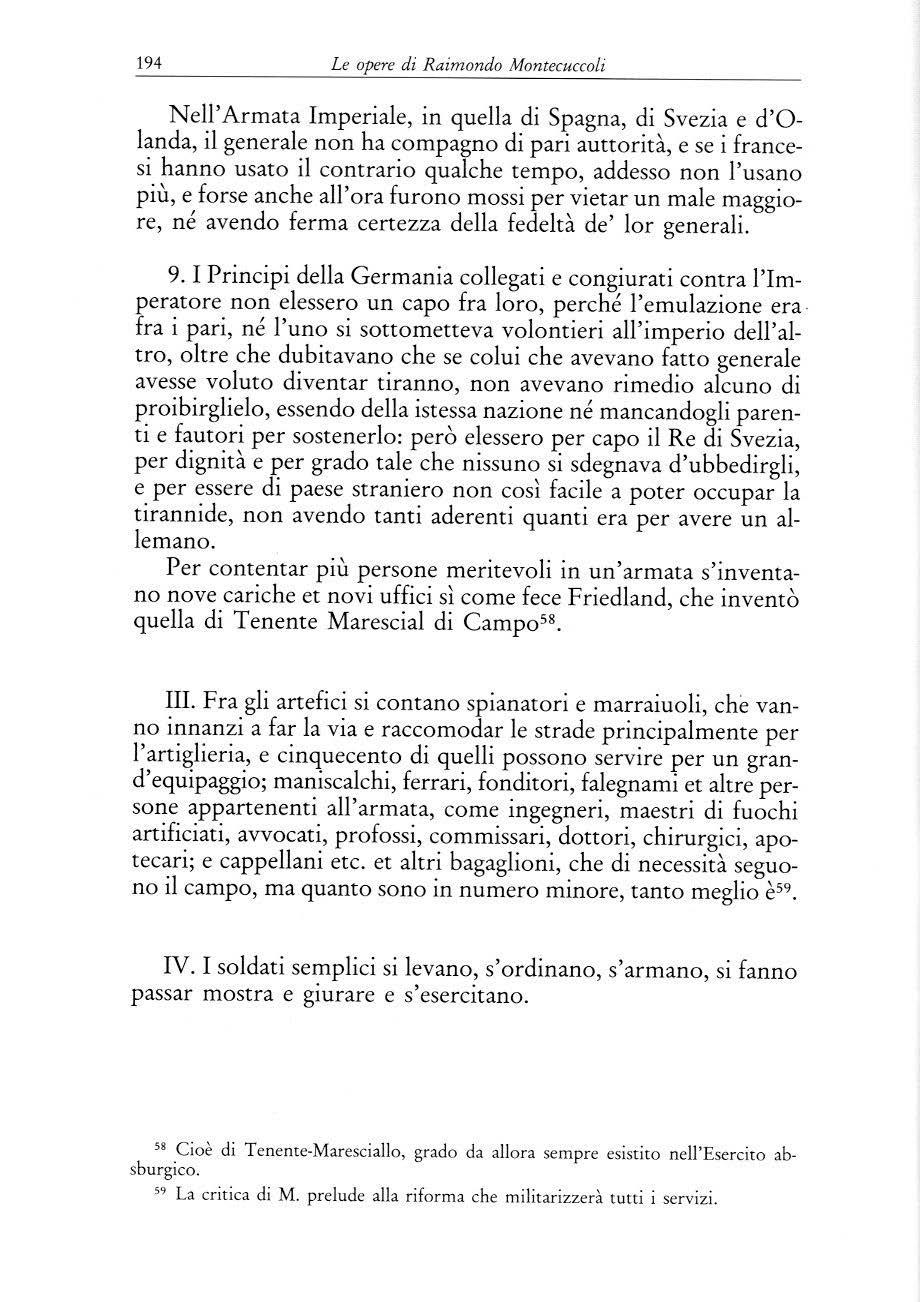
Per contentar più persone meritevoli in un'armata s'inventano nove cariche et novi uffici sì come fece Friedland, che inventò quella di Tenente Marescial di Campo 58 •
III. Fra gli artefici si contano spianatori e marraiuoli, che vanno innanzi a far la via e raccomodar le strade principa lme nte per l'artiglieria, e cinquecento di quelli possono servire per un grand 'equipaggio; maniscalchi, ferrari, fonditori, falegnami et altre persone appartenenti all'armata, come ingegneri, maestri di fuochi artificiati, avvocati, profossi, commissari, dottori , chirurgici, apotecari; e cappellani etc. et altri bagaglioni, che di necessità seguono il campo, ma quanto sono in numero minore, tanto meglio è59 •
IV. I soldati semplici si levano, s 'ordi nano , s'armano, si fanno passar mostra e giurar e e s'esercitano.
58 Cioè di Ten e nt e- Maresci allo , gr ad o da all o r a sem pre es istito n ell' Eserc it o abs burg ico .
59 La crit ic a di M. prelude alla r ifo r ma c h e m ili tarizzerà t utt i i se rvi z i.
D e' sold at i
Li soldati semplici nella milizia terrestre sono a piedi o a cavallo et anticamente anche alcuni su le carra. Se la Fanteria generalment e si deve preferire alla Cavalleria, ne discorre Lipsio nel libro V dell e Politiche, cap. 7 e deg li uffici del soldato tratta Preissac nel cap . 1460 • C esare desiderava nel soldato non meno la modestia e la continenza che la v irtù e la grandezza dell'animo. Egli dev'essere ben complessionato e sano, armare la spalla61 di fuori per sicurezza, difesa e maestria di buona prospettiva (si usa però in molti luoghi di portar sempre il moschetto su la spalla sinistra per la comodità di tirarlo a basso o apprestarsi); portar la banda del colore del suo Principe; non andar da una compagnia all'altra, e saper nuotare 62
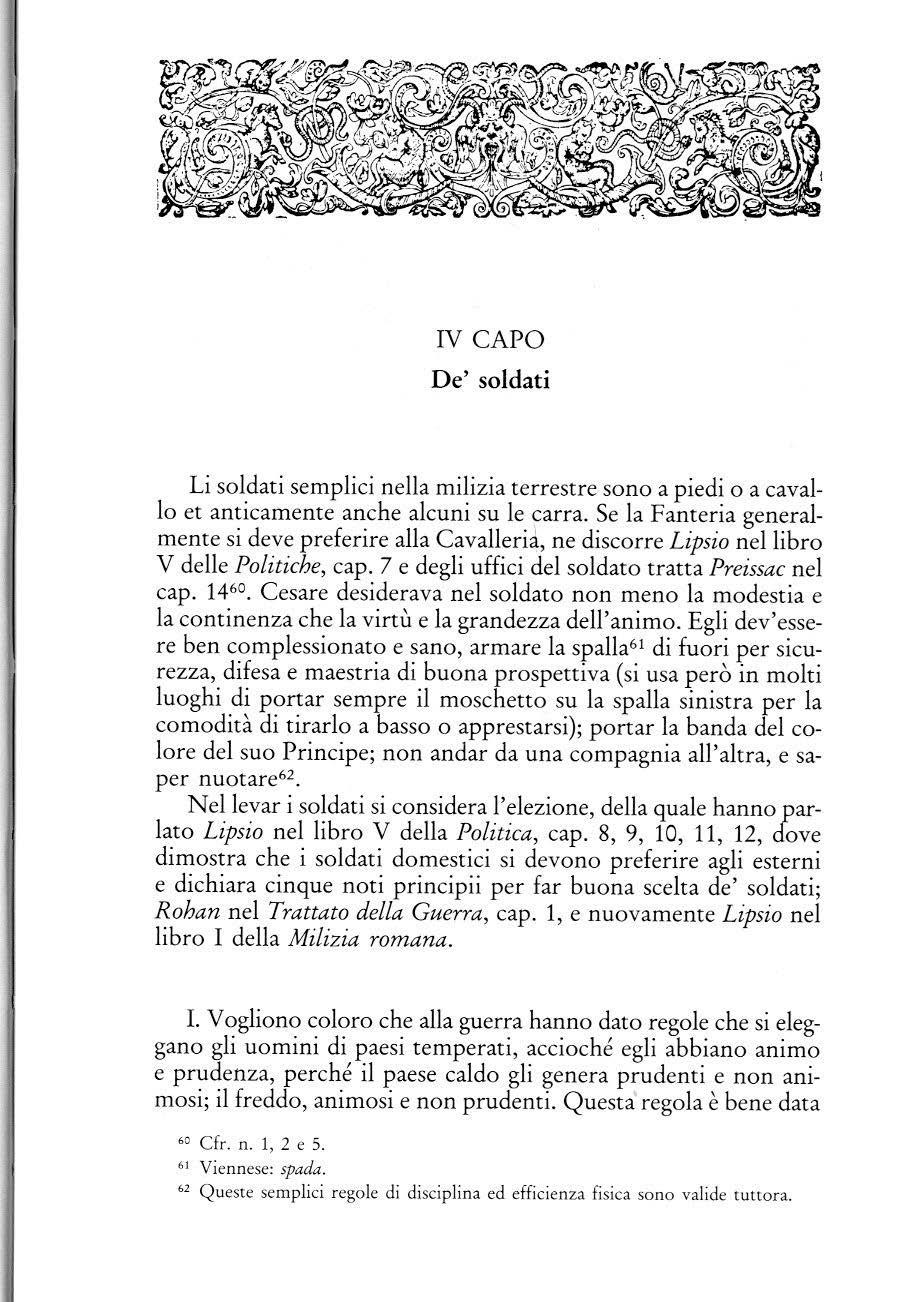
Nel levar i so ldati si considera l'elezione, della quale hanno parlato Lipsio nel libro V della Politica, cap. 8, 9, 10, 11, 12, dove dimostra che i soldati domestici si devono preferire agli esterni e dichiara cinque noti principii per far buona scelta de' soldati; Rohan nel Trattato della Guerra, cap. 1, e nuovamente Lipsio nel libro I della Milizia romana.
I. Vogliono coloro che alla guerra hanno dato regole che si eleggano gli uomini di paesi temperati, accioché egli abbiano animo e prudenza, perché il paese caldo gli genera prud enti e non animosi; il freddo, animosi e non prudenti. Questa regola è bene data
6° Cfr. n 1, 2 e 5.
61 Viennese: spada
62 Ques te sem p lici r egole di di sciplina ed efficien za fisica sono va lid e t uttora.
a uno c h e sia Principe di tutto il mondo [e] per questo gli sia lecito trarre gli uomini di quelli lu oghi che a lui v errà bene; ma volendo dare una regola che ciascun possa usarla, conviene dire che ogni republica et ogni regno debba scernere i soldati de' paesi suoi, o caldi o freddi o temperati che si siano, perché si vede per gli esempi come in ogni paese con l'esercizio si fa buoni soldati, perché dove manca la natura supplisce l'industria, et allegandosi [che ] in altri luoghi non si può chiamar diletto, perché dil etto vuol dire tòrre i migliori di una provincia et avere potestà di eleggere quelli che non vogliono come quelli che vogliono militare: non si può pertanto fare questo diletto se non ne ' luoghi a te sottoposti, perché tu non puoi tòrr e chi tu vuoi ne' paesi che non sono tuoi , ma bisogna prendere quelli che vogliono 63 .
1. Gli u omini che si conducono alla milizia per commandamento del Principe, vi hanno a ven ire né al tutto forzati, né al tutto volontari: perché la tutta volontà fa che quelli che si presentano non sono de' migliori , anzi sono de' più cattivi d'una provincia, perché se alcuni vi sono scandalosi, oziosi, senza freno, senza religione, fuggitisi dall'imperio del padre, bestemmiatori, giuocatori, in ogni parte mal nutriti, sono quelli che vog liono militare; i quali costumi non possono esse r più contrari ad una vera e buona milizia. E quando di tali uomini ti se ne offeriscono tanti che te ne avanzi al numero che tu hai disignato, tu puoi eleggerli, ma send o la materia catti va non è possibile che il diletto sia buono. Ma molte volte interviene che non sono tanti ch'egli adempino il numero di che tu hai bisogno , talché, sendo forzato a prenderli tutti, ne nasce che non si può più far diletto, ma soldar e fanti 64 •

La tutta forza partorisce ancora cattivi effett i; p erò si d eve prendere una via di mezzo dove no n sia né tutta forza né tutta volontà, ma siano tirati da un rispetto ch'egli abbiano al Principe, dov'essi temano più lo sdegno di quello che la presente pena; e sempre occorr er à ch' ella sia una forza in modo mescolata con la vo lontà che non n e potrà nascere mala co nsist enza che faccia mali effetti .
2. Non si fanno ogg idì sempre questi diletti , perché molti Principi non hanno privilegi di poter man dare alla guerra chi v ogliono
63 P er diletto (lati ni smo : delectus) si intend e non già la lev a i n m assa m a q uello che oggi si ch iama serv iz io selett iv o .
64 Il M. ha u na marcata ripugnanza p e r l'arruolamento i n massa
de' loro sudditi; altri hanno i paesi sì spopolati che non possono mandar fuori i paesani loro propri ma assoldano gente mercenaria o ausiliaria; altri temono di armar i loro popoli e però si serv ono de' soldati est erni.
Il Ream e di Svezia ha quasi ordinata la sua milizia nel medesimo modo che avevano i Romani, secondo riferisce Messenio, istorico intrattenuto da quella Corona 65 •
Tutti gli uomini del Regno che hanno più di 17 e meno di 50 anni sono obbligati di farsi scriver al ruolo, et accioché li censori non sieno ingannati, il pastore o predicatore di ciascuno luogo è obbligato in coscienza di dare in nota con giuramento tutte !'anime della sua Parr occhia. Ogni due anni si fa la scelta, che i romani chiamavano diletto e fra gl'italiani si dice cernita o ordinanza; e di ogni 10 di quelli già scritti se ne elegge e se ne ord in a uno il quale si scrive sul ruolo l della guerra e se gli tagliano i capelli per riconoscenza; e questi scelti sono obbligati a tenersi in pronto per uscir alla guerra, o civile o straniera, ogni volta et in ogni tempo ch'egli piaccia al R e. Questi tali si tengono però alle case loro e travagliano nel lor consueto esercizio e guadagnano il vitto. Sono però distinti in reggimenti e compagnie et ad ogni tre o quattro villaggi più o meno, è dato un capo eh' è pagato dalla Corona, il quale li fa ragunar insieme et esercitare nel maneggio dell'armi e negli altri esercizi ogni terzo giorno, sì che hanno due giorni di lavoro domestico et un giorno d'esercizio; et in questo giorno quei 1~ da' quali fu eletto quest'uno, sono tenuti a somministrargli il VlttO.
Vengono talora questi tali mandati nelle guarnigioni delle città da una parte e dall'altra per fabricare e fortificare le piazze, eriger valli e far altri travagli, et allora il Re li mantiene di vitto .
Quando escono dal paese e sono mandati fuori, è obbligata ciascuna decina donde quell'uno fu eletto, dargli con seco per due mesi di vitto e poi nell'altro tempo il Re li paga.
I Gentiluomini sono esenti da farsi scrivere nel Ruolo, ma sono obb_ligati se~o~do la proporzione dell'entrata loro a mantenere tanti corazz1en.
II. I soldati propri sono i migliori di tutti, e se bene un popolo bellicoso difficilmente si lascia reggere, in ogni modo [uno] non
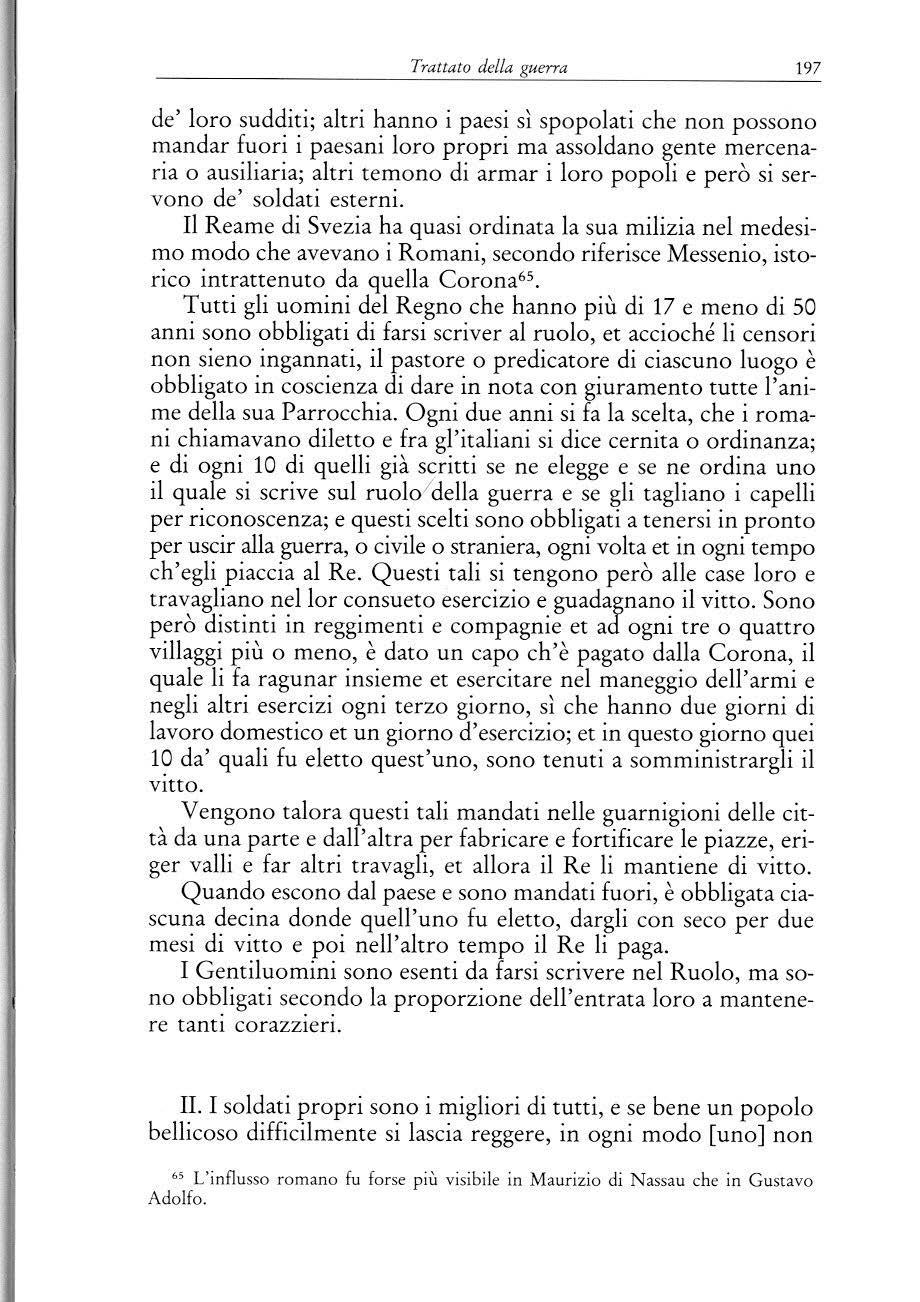
bellicoso si lascia vincere dal primo stranie ro che viene attaccarlo: e però di due mali si dee eleggere il minore .
I soldati ausiliari sono i più perico los i di tutti perché il Principe che gl'impiega nel suo affare, non ha autorità alcuna sopra di quelli, ma l'ha colui che li invia, perché una Republica o Principe ambizioso non sapr e bbe augurarsi più grande occasione di occupare una città, Signoria o provincia che quando vien richiesto di mandare un suo esercito per la difesa di quella.
I soldati mercenari corrono dove si dà maggior soldo.
1. È vero che da' paesi moll~ escono uomini molli; e [c h e gli uomini] che sogliono esser più forti ne' luoghi lontani dal culto e dall'umanità e dove non capitano mercadanti che vi portino cose che vagliano ad effemmina r gli animi, perché dove gli uomini sopportano gran male, amano meno la vita e temono meno la morte, ma dove entrano le dilizie, anche i popoli più vigoros i perdono la virtù. Similmente que' popoli che sono in continui combattimenti co' confinanti diventano forti; e quando hanno perso l 'emulazione si ammolliscono e divengono effemminati.
2. L'instituzione però può far in ogni clima buona milizia perché egli è grande la _differenza nello stimar molto la virtù e nello stimar poco la vita. E ben vero che la virtù militare ha bisogno del vigore e della forza del corpo e che dove gli uomini nascono più grandi e più robusti sono più atti ad esser instituiti. Ma si instituisce un popolo alla fortezza colle leggi, colla educazione, coll' assuet udine, colla religione, col consiglio, con gli onori, con le lodi, colle vittorie, colla poesia, colle pene, co' i spettacoli e colla conversazione.
3. I popoli bellicosi hanno bisogno di qualche esercizio per moderar il lor calore; quindi hanno alcuni pe rm esso il du ello: e per div ertire la gioventù da i pensieri di novità, hanno alcuni perm esso le cortigiane, altri hanno sempre somministrato qualche guerra al suo confederato per purgar il suo paese di spiriti inquieti.

III. Per far presto una levata, ha il Papa usato di publicar la crociata e concedere la remission e di tutti i peccati a chi avesse militat o .
1. Hanno alcuni per aver gente fatti festini e spettacoli dove, essendo concorsa la gente, l'hanno arrestata, né rilasciata se non
condizionatamente, et in questo modo hanno anche rapite le vergini le quali, in penuria d'altre donne, hanno poi maritato agli uomini del paese per avere prole.
2. Altri hanno publicato che si va a buttinare qualche luogo ricco, et hanno fatto correr voce eh' egli era tradimento nel paese eh' essi voleano attaccare; e così molti soldati sono convenuti insieme volontieri pensando di andare più alla preda che alla pugna.
3 . Si fanno facilmente quando s'abbatte in congiunzione che un altro Principe licenzia il suo eserci ; o, sì come la maggior parte delle prime levate del Re di Svezia e de' Principi protestanti furono fatte di soldati licenziati dall'Imperatore.
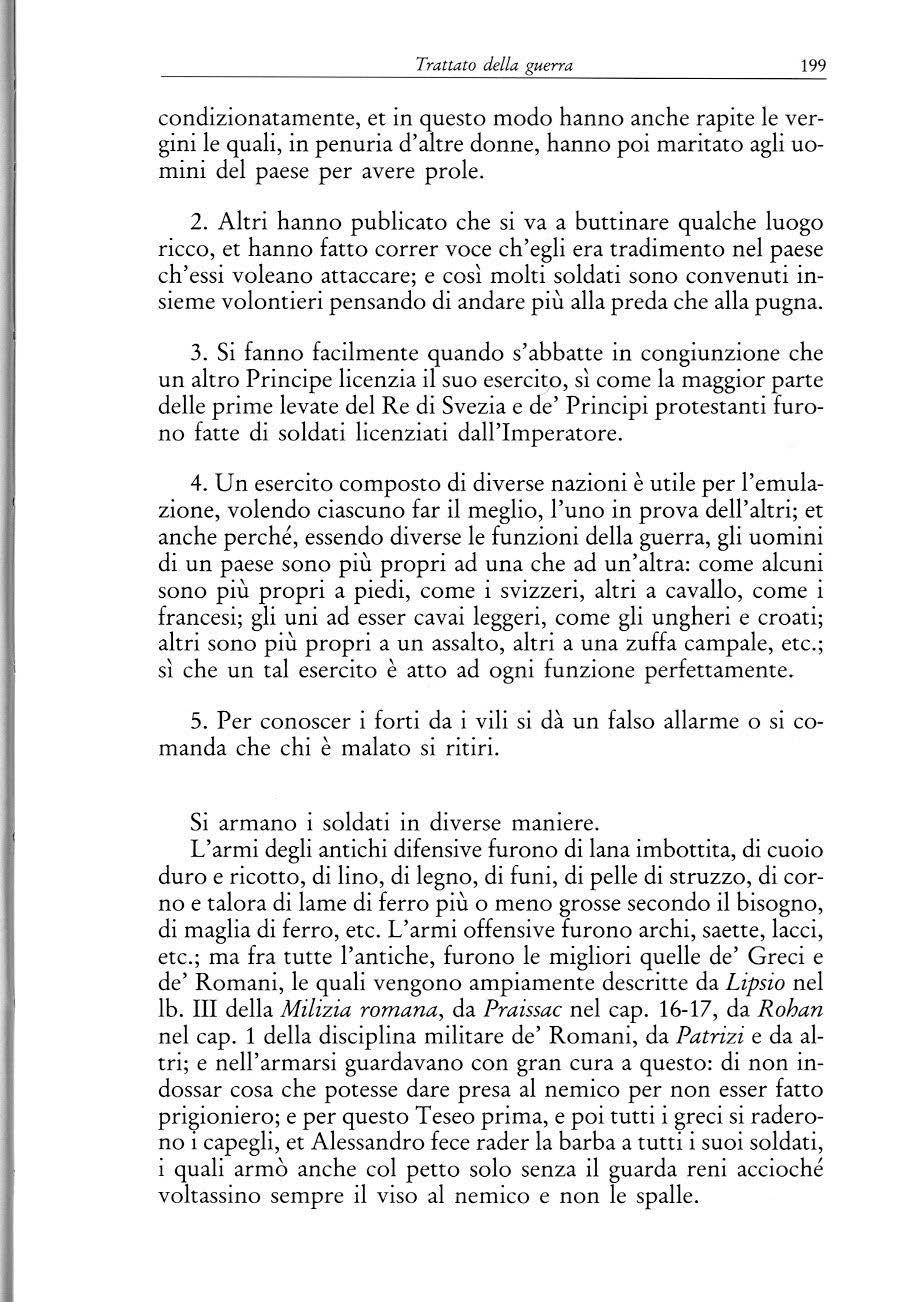
4. Un esercito composto di diverse nazioni è utile per l'emulazione, volendo ciascuno far il meglio, l'uno in prova dell'altri; et anche perché, essendo diverse le funzioni della guerra, gli uomini di un paese sono più propri ad una che ad un'a ltra: come alcuni sono più propri a piedi, come i svizzeri, altri a cavallo, come i francesi; gli uni ad esser cavai leggeri, come gli ungheri e croati; altri sono più propri a un assalto, altri a una zuffa campale, etc.; sì che un tal esercito è atto ad ogni funzione perfettamente.
5 . Per conoscer i forti da i vili si dà un falso allarme o si comanda che chi è malato si ritiri.
Si armano i soldati in diverse maniere. L'armi degli antichi difensive furono di lana imbottita, di cuoio duro e ricotto, di lino, di legno, di funi, di pelle di struzzo, di corno e talora di lame di ferro più o meno grosse secondo il bisogno, di maglia di ferro, etc . L'armi offensive furono archi, saette, lacci, etc.; ma fra tutte }'antiche, furono le migliori quelle de' Greci e de' Romani, le quali vengono ampiamente descritte da Lipsio nel lb. III della Milizia romana, da Praissac nel cap. 16-17, da Rohan nel cap. 1 della disciplina militare de' Romani, da Patrizi e da altri; e nell'armarsi guardavano con gran cura a questo: di non indossar cosa che potesse dare presa al nemico per non esser fatto prigioniero; e per questo Teseo prima, e poi tutti i greci si raderono i capegli, et Alessandro fece rader la barba a tutti i suoi soldati, i quali armò anche col petto solo senza il guarda reni accioché voltassino sempre il viso al nemico e non le spalle.
I. Oggidì sono l'armi migliori tanto offens iv e quanto difensive per cagione della polvere che dà sì gran forza.
S'usano fra la ca v alleria la Lancia che è stimata la parte pr incipale, e si arma tutta alla pro v a; et oltre alle pistole e alla spada ha anche la lancia con la quale investisce di carriera [le] truppe6 6 , e debb e ess er m o ntata s ovra un cavallo bonissimo; ma perché l'intrattenerla costa assai, né per combattere trovano sempre il terreno proporzionato, i Principi n e mantengono poche o ni ssuna.
1. La Corazza è armata tutta intieramente, si serve delle pistole e più d ella spada, carica in grosso di passo o di trotto e dee avere un cavallo alto 15 mani larghe67 ; e perché queste armi sono molto incomode e bisogna risparmiarl e troppo, né servono quasi se non in un giorno di battaglia, si son o tro vate le Mezz e corazze le qual i non hanno se non il petto e la schiena et il caschetto, ma tutti alla prova di pistola. Queste Corazze sogliono in qualche occasion e d'assalto metter pié a terra e combatter tra fanti, e si potriano anche far combattere così a piedi in altre occasioni , come si legge d e ' catafratti degli antichi.
2. Qualche numero di Carabine son anche molto util i in un esercito perché, occorrendo v i di verse funzioni, si richieggono anche di vers e sorte d'armi, et gli u o mini gravemente armati non possono, per la grav ezza dell'armi, seguire quei che combattono fugg endo, e p erò sono men atti ad azzuffarsi con un nemico di questa sort e, né son anche capa c i d i far altre cos e ch e fanno le Carabine, inventate propriamentte per servir alla Ca valleria sia ne' quartieri o allo scoperto, o a pigliar lingua 6 8 , o in un combattimento per far una discarica in fianco , o in una ritirata per mol estar il nemico ch e è perseguitato, o per impedir d ' esserlo quan do il n e mi co perseguita.
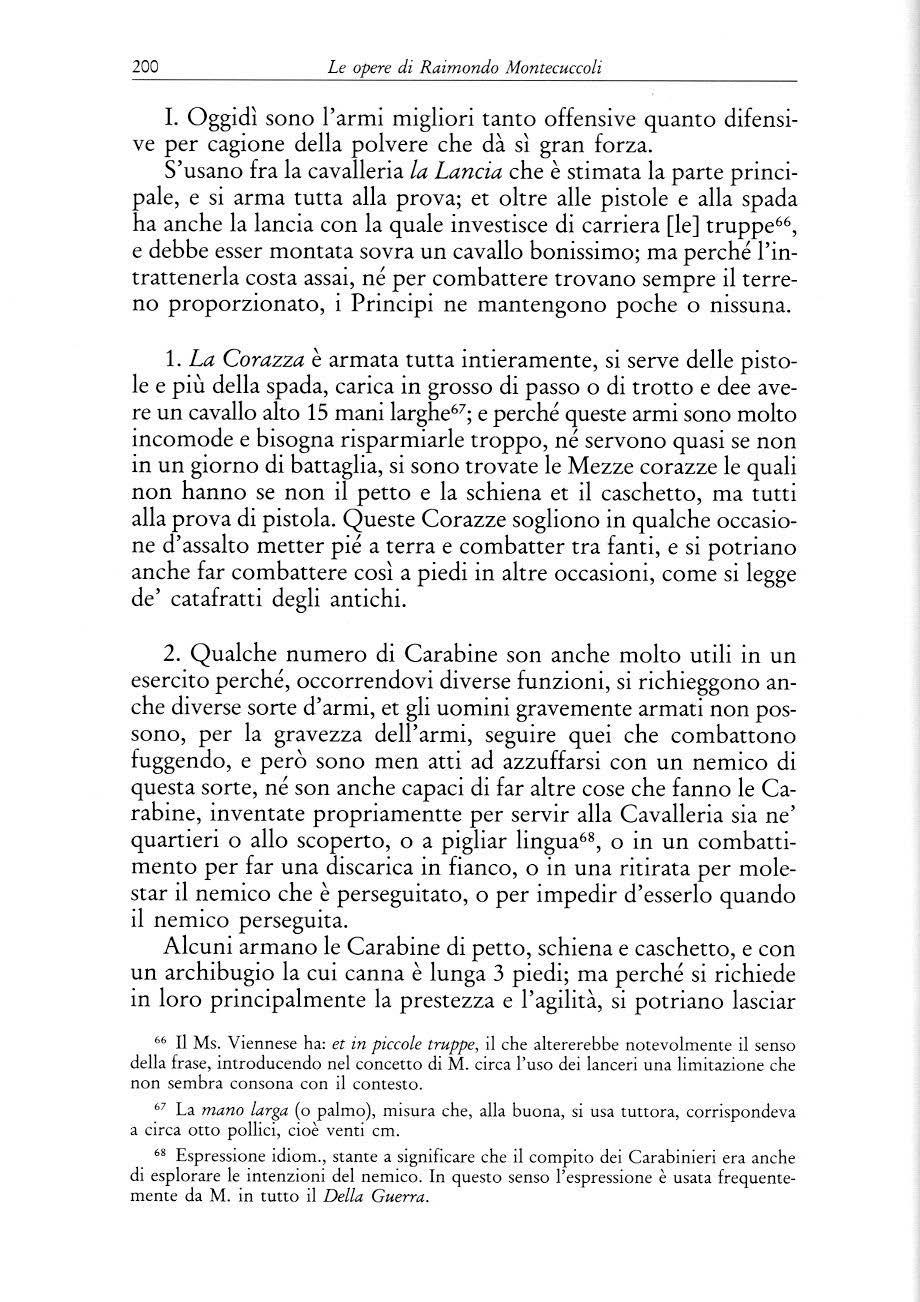
Alcuni arman o le Carabine di petto, schiena e caschetto, e con un archibugio la cui canna è lunga 3 pi edi; ma per ché si ri chi ed e in loro principalmente la prestezza e l'agilit à, s i potriano lasciar
66 Il Ms . Vi en nese h a: et in piccole truppe , il che a lt er er e bbe notevolm ente il sen so d ell a frase, int ro d u ce nd o nel concetto di M. ci rc a l'uso de i lan cer i una li m itazione che non sembra conso n a con il contesto.
6 7 La m ano larga (o pal mo) , mi s ura ch e, alla b uo n a, si usa t utt or a, co r r ispon dev a a c ir ca o tto po lli ci , cioè vent i cm.
68 Es pressi o ne idio m ., sta nt e a signific are ch e il comp ico dei Carab ini e r i e ra an c he d i esp lorare le intenz ioni de l n em ico. In q uesto senso l' esp r ess io ne è usata fr eq uentem ente da M . i n t u tto il Della Guerra.
disarmati di difensiva e porr e in questo se rvizio gente leggera come croati, ungheri etc., de' quali s'è parlato nel discorso delle battaglie.
3. I Dragoni non sono che fanti a cavallo, che portano la picca e il moschetto, ordinati c o me l'Infanteria, e sono di gran serv icio per guadagnar passaggi e per trasferirsi subitamente in un luogo 6 9 .
4. Le spade lunghe a cav allo sono di grandissimo effetto come chiaramente si vide nella battaglia di Wittstock; e se bene s'è fortemente pressati nella mischia, rimane sempre tanto spazio ch e occupa la lunghezza del cavallo, che non s' è impediti a mane ggiarla et a ferire di punta.
II. Fra l'Infanteria si usano oggidì le picche, regine dell'armi, propriissime per resistere alla cavalleria, perché parecchie giunte insieme fanno un corpo solidissimo e difficilissimo ad ess e r r o tto per la testa, e la Moschetteria senza picche è come braccia e gambe senza corpo. S'armano di petto, schiena e caschetto e portano
una picca lunga 18 v. 70 • Alcuni non si armano di armi difensive e chiamansi picche secche. La proporzione ch'elle hanno con la Moschetteria è di versa; molti hanno più picche che moschetti perché in un giorno di battaglia d o ve si viene alle mani il numero delle picche dà molto
69 È interessa nte no t are co me t ale uso de i Drago ni (c he e ra perfett ame nte corretto ed efficace) cad de, nel la seco nda metà de l Sette cent o, ed anche pr ima, in dis uso: cosicch é, per esem pi o, ne ll 'Esercito nap ol eo ni co la funzio ne dei Drago ni fu q ue lla di una C avalle ria legger a. Fu so lo durame la Gu e rra C ivile Ame rican a ( 1861-186 5) che il genio del ge ne rale N at han Bedfo rd Forrest, i ndubb iam ente un o t ra i maggio ri leaders di truppe celeri dell a sto ria, riscoprì tale funzione e ne fece uso co n i mmensa efficacia: ma, c ur iosame nt e, senza de si gnare i suoi re part i come Dragoni , ment re tal e nome rimase a i repa rti di Cav alle ria legge ra. (Cfr : RAIMONDO LuRA GHI , Storia della Guerra Civ ile America na, V. ediz. , Milano, 1985; Ro BERT S. H EN RY , First with the most, Forrest , Jnd ianapo li s & Ne w Yo rk , 1944; Eo wrN C. BEA RSS, Forre st at Brice's Cross R oads, Dayto n , Oh io , 1979 , p ag 134, o ve è c it ato il s iudi zio es presso dal Feld maresc iallo Lo RD WOLSE· LEY in United Services Magazine, cxvii, apr ile -maggio 1892, pai; . 1- 14 e 113-124, r iportate in: As they saw Fo rres t - Some recollet ctions and comments oj contemporaries, a cura di R.S. H ENRY, Jackso n, T en nessee , 1956, pag. 24, in cui è det to t ra l' alt ro, di Fo rrest e di alc uni altri generali della G uerra Civile: " they we re th e fi rst ge nerals who in modem days have taught us what Ture nn e and Montecuccoli knew so we ll, namely, t he use of t he t rue Dragoon , th e ri fleman on ho rse back, but who fro m be in g mo unted, has aJl t he mobility of che horse sol di er" Da osser vare che nello st esso saggio Lo rd Wolseley riporta
(ibid. , pag. 22) il giu dizio del Maresci al lo Marmont il quale diceva che all ' inizio i D ragoni erano solo Fanteria montata, e c he avrebbe ro dovuto sempre rimanere tali).
70 Verghe. Si tratt a q ui evidentemente di piedi e no n di verghe t edesc he, come p iù oltre.
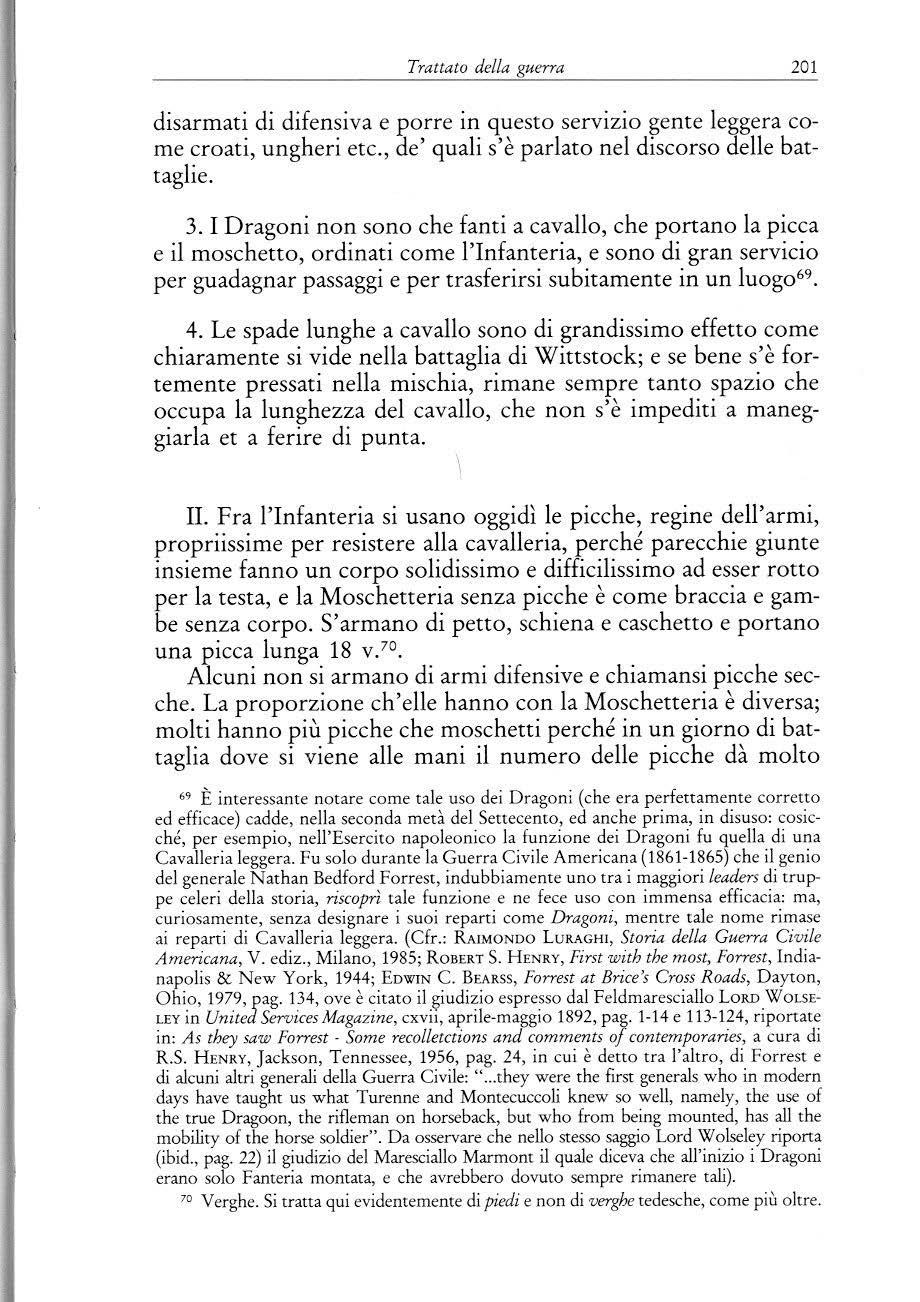
vantaggio sopra quello de' moschetti; altri ripartiscono egualmente le picche et i moschetti, ma in Alemagna s'usa d'avere più moschetti che picche avendo ne' reggimenti due terzi di moschetti et un terzo di picche: perché, non dandosi se non di rado battaglia e facendosi molto più spesso assedi et altre funzioni dove il moschetto è più richiesto, è molto necessario aver più moschetti che picche 71 •
1. I Mo schetti sogliono portare un caschetto; per offesa hanno la spada et il moschetto forato con una calibra a 12 palle per libbra; et è molto utile che in un reggimento sieno tutti i moschetti d'una istessa calibra accioché quando l'uno manca di palle l'altro possa accomodarlo delle s u e.
2. La rondaccia, o targa all'imitazione de' romani, sarebbe anche un'arma molto utile da adoperarsi, perché tutte l'armi che passano di lunghezza due braccia n elle sc ritture sono inutili, e quando s'è giunti addosso alle picche elle non possono più offendere, anzi, che si legge di un capitano antico che combattendo contra a' n em ici armati di sarisse, ordinò nelle prime file del suo battaglione soldati co ll e mani vuote, con ordine che subito attestati insieme, dessero di piglio alle sarisse e le tenessero sin ch e gli altri assalissero il nemico ne' fianchi, il che successe; e però quando le picche sono rese inutili si richieggono gli scudi che disfacciano il nemico. Un gran politico li loda; dicesi che Maurizio Principe di Orange aveva voglia di introdurli, et un gran capitano moderno gli approva 7 1bi<
3. L e bandiere e stendardi devono serv ire per guida e per riordinare, perché ciascun soldato, ferma che è la bandiera, deve sa-
7 1 Questo passo è tra q ue lli ch e sme ntiscono la leggenda secondo cui M. avrebbe dato la prevalenza alla picca sul moschetto e, l'altra, secondo cu i sare bbero stati gli svedesi a fare uso di m oschetti i n numero m aggiore dell e picc h e.
7 ib., Maurizio di Nassau, Pr inc ipe d i Orange (1567- 1625), nato a Dillenb urg, figl io di G u gli elmo il Taciturno, fu Statholder de ll e principali Provinc ie Unite (e v irtualment e d ell'intera repubb li ca olandese). Oltre che statista f u uomo di guerra notevolissi mo. Profondo studioso de ll e dottrine militari dei C lassici, cercò di introdurr e riforme di organica e di t attica che gli consentiro no d i riorganizzare scie ntificamente le fo rze olan desi il che gli consentì di conq ui stare parecchi s uccessi mi litari sugli spag noli, tra c ui il più r i marchevo le dal punto di vista mi lit are fu quello di N ieuwpoor t {2 lug lio 1600) in cui batté l' Arciduca Alberto. Le sue riform e furono assai stu d iate si a da Gustavo Ado lfo che d a M.; sebbene però tutti ne ri co n oscessero i l valore di esempio, esse furono forse t rop po inficiat e da pregiudizi t eorici, i quali fecero sì che le vere innovazioni ne l campo t att ico d ovesse r o ven ire dall e as sa i più equilibrate r iforme di Gustavo Adolfo (in particolare, i l re d i Svezia, come si è già avuto occasione di dire, respinse l'eccessiva riduzione delle p icche a fa vo r e dei mosc hetti , introdotta da Maurizio).

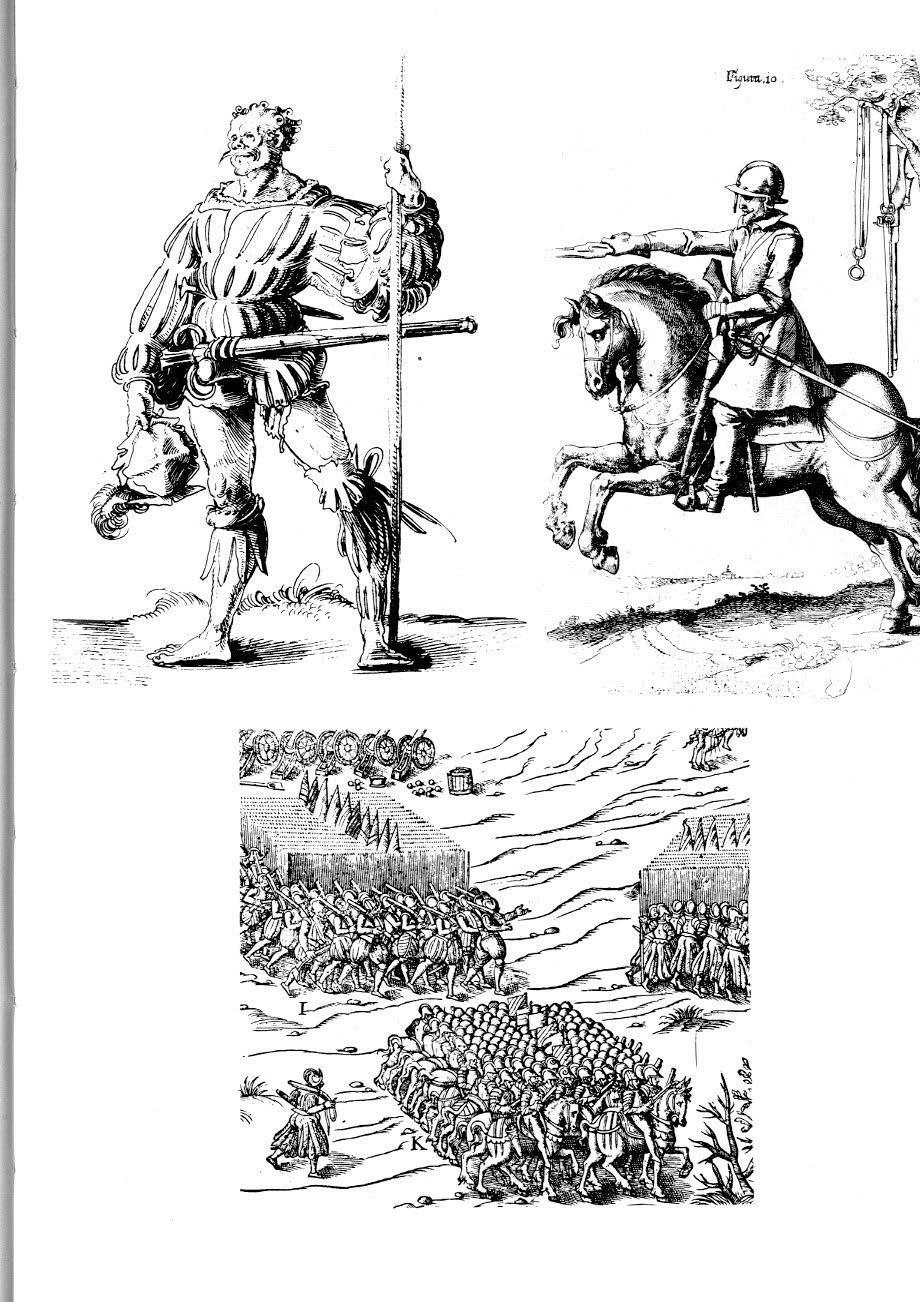

per il luogo suo. Esse debbono variare co' campi o col segno, accioché si conoscano l'una dall'altra. Si usa nell'armata imperiale che lo stendardo della compagnia [a] cavallo sia di color bianco e gli altri di altri colori.
Le bandiere si fanno benedire. Oltre alle bandiere si dà anche il suono il quale, ben ordinato, comanda all'esercito, che andando con i passi c h e rispondono a' tempi di quello, aita a servare facilmente gli ordini, onde che gli antichi avevano suffoli, pifferi e suoni modulati perfettamente. Oggidì si hanno fra la cavalleria le trombette et i timballi e fra l'infanteria i pifferi et i tamburi, e con questi suoni si dà il segno di raccogliersi, di marciare, di combattere, d'un allarme, di far fascin~, di pregare, di ritirarsi negli alloggiamenti, etc.
S'ordinano i soldati e si distinguono in diverse maniere et ogni nazione nell'ord ine degli uomini suoi alla guerra ha fatto nel1' esercito suo, ovvero nella sua milizia, uno membro principale il quale hanno variato col nome et anche qualche poco nel numero degli uomini. Questo membro da i romani fu chiamato legione, da' greci falange, da' francesi caterv a e questo membro hanno poi diviso in diverse battaglie et a suo proposito ordinato, e però devesi sapere ch'è necessario in un esercito ch e vi siano assai corpi et ogn i corpo abbia i suoi membri; perché avendo questo, conviene eh' ~gli abbia assai animo e per conseguenza assai v irt ù, e sia libero da ogni confusione e dis o rdine .
Dell'ordine de' soldati greci ha parlato Preissac nel cap . 16; di quello de' soldati romani ha parlato detto Preissac nel cap. 17 e Lipsio nel II libr o della Milizia romana.
I. Oggi si distingue l'armata in brigate; le brigate in reggimenti, li reggimenti in compagnie, le compagnie in isquadre e le squadre in capi di fila detti rottmeister.
l. I soldati devono imparar a conoscersi fra di loro, e stimularli all'emulazione l'uno dell'altro.
2. I Romani so lean o dare due centurioni a ciascuna centuria accioché, venendo a mancar l'uno, l'altro ave ss e potuto comandare; ma nell'armata cesarea si dà u n t e n ente al c ap itan o , il qu a le fa quest'uffizio di subentrare in lu ogo del capitano che mancas se.

3. Usasi al piede allemano di far le compagnie di cavalli di 100 uomini et i reggimenti di 1000. Sono 10 compagnie; e di fare le compagnie di fanteria di 300 uomini et i reggimenti di 3000, che sono pure 10 compagnie. Altri Principi fannq_ le compagnie di fanti di 200 uomini, altri di 124, altri altrimenti. E vero che dove sono più compagnie vengono anche ad esserci più uffiziali, e però s'è meglio serviti, oltre che non essendo il numero de' soldati sì grosso, non può il capitano mandar sì facilmente soldati fuori a rubbare e lasciarli absentari dalla bandi era, perché in poco numero si conosce subito all'occhio la diminuzione, la quale non si può sì ben osservare nel gran numero. Ma in ogni modo dove sono più uffiziali vien anche il soldo a crescere di vantaggio, oltre che essendo le compagnie sì de bili, ogni poco di soldati che manchino per esser malati o comandati fuori o altrimenti, a gran pena si possono coprire e difendere le bandiere .
II. Per conformarsi dunque all'uso allemano, si potria distinguer l'ordine di un esercito a questo modo:
1, sia un'armata di 32.000 uomini fra quali sono 24 .000 fanti et 8000 cavalli; siano dunque 8 reggimenti a piedi, ciascheduno di 3000 fanti, et 8 reggimenti di cavalleria, ciascheduno di 1000 cavalli;
2, fra la cavalleria sieno 1000 cavai leggeri, 3000 corazze intiere e 3000 mezze corazze;
3, ogni reggimento abbia 10 compagnie di 100 cavalli l 'una et ogni compagnia abbia 3 squadre di 33 cavalli ciascuna;
4, una compagnia di fanti abbia 300 uomini con questa proporzione d'armi; cioè siano 76 picche, 12 moschettoni, 12 scudi e 200 moschettieri che fanno in tutto 300 uomini, e con facilità grandissima s'ordinano da per sé et accompagnati. Da per sé nel marciare vanno 100 moschettieri a 6 di fronte e 8 di fondo, e fanno due squadre che contengono 96 moschetti eri e ne avanzano 4, che è poco, perché posson esser malati o esser fuori o si tengono a parte per poterli commandare quando il bisogno richiede, o si metton dietro all'ultima fila dello squadrone o ne' quattro canti, che poco importa. Dopo li 100 moschettieri su detti, seguono 6 scudi nella prima fila, 6 moschettoni nella sec onda e 36 pie-
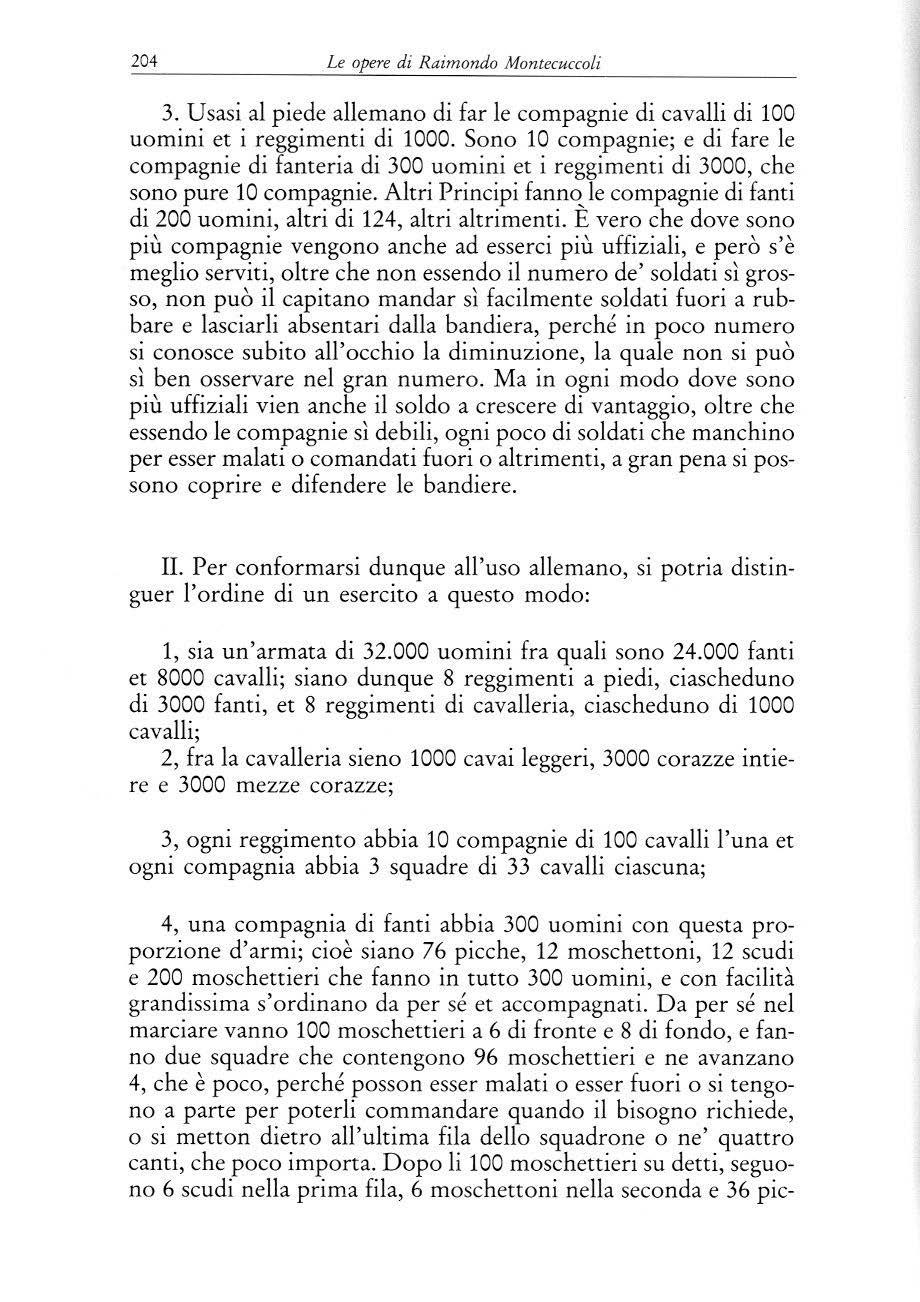
che nell'altre sei, che viene similmente ad essere una squadra di 48 uomini che ha 6 [ di] fronte e 8 di fondo.
A questa squadra ne segue un'altra simile pure di scudi, moschetto ni e picche, e fanno tutte le due squadre 96 uomini, et avanzano 4 picche, eh' è po ca cosa: e se non sono malati e sie no presenti, si possono far marciare dietro agli altri e poi mettere ne' canti dello squadrone, accioché se il battaglione ha da far faccia da tutte le parti, i canti, che rimangono altrimenti scoperti, siano co p erti da queste picche; ovvero si possono tener a parte per commandare dove il bisogno richieda 1
Dopo le picche seguono li altri 96 moschettieri 72 in due squadre come i primi, et avanzano pure 4 moschettieri.
Nel m etters i in bat taglia le due prime squadre de' moschettieri si attestano su la mano ritta e fanno la fronte di 12 et il fondo di 8, ch'è di 96; alla mano manca de' moschettieri si attestano l e due squadre di picche che fanno pure la fronte di 12 [e il fondo] di 8, che dà 96 e l e 4 picche di resto si mettono su i canti. Su la mano manca delle picche s'attestano le due ultime squadre de' moschettieri che similmente fanno la fronte di 12 et il fondo di 8, e li 4 moschettieri che avanzano si possono mettere nel l ato di fuori di ciascuna ala. Nel combattere si pigliano due file dell'ala dritta e si mettono dietro alle picche e queste servono a tenersi sempre al l 'ordine per tirare di sopra la testa delle picche quand' elle s'azzuffano col nemico e che s'abbassano curvandosi su l e ginocchie; e servon anche a rinforzare il battaglione il quale viene in questo modo ad ave r 10 uomini di fondo; poi si pigliano due altre file dell'ala m anca e si mettono dinanzi a gli scudi accioché di pie' fer mo tirino sempre e bersaglino l 'inimico sinché viene a lla zuffa et alle mani, perché allora si ritirano a dietro gli intervalli.
L 'a l tre 6 file che rimangono a ciascheduna ala vanno continuamente tirando una fila dopo l'alt ra e ricaricando, gi ustamente nel modo come si fa l'esercizio; se si deve comandare qualche moschettiero altrove, essendo il numero delle file e de' ranghi pari, egli è facilissima cosa di co mman darli et anco r istaurar subito le file et i ranghi: come, se si hanno a commandare 12 moschettieri, si può l evare una fila di dietro alle picche ovvero una dinanzi agli scudi, et è fatto. Se se ne vogliono cavar 20, similmente una delle file suddette e gli 4 moschettieri che sono di più in ciascu n a ala , li danno. Se se ne vogliono cavar 50, si levano due file dell'ala manca

e due file dell'ala dritta73 , e l'ali rimangono con 4 uomini di fondo, che è sufficienza per andar continuamente traccheggiando; e se si vogliono pur avere di 5 di fondo, si possono rannodarvi le due file che furono messe dietro alle picche accioché infestino continuamente il nemico co' tiri sinché si venga alle mani, nel qual caso si ritirano di nuovo dietro alle picche e quivi nuovamente scaricano per di sopra la testa di quell e; e così ogni poco d'accortezza e di pratica basta per restaurar i luoghi della gente che si commanda;
5, due compagnie raccozzate insieme formano un battaglione perfetto, che ha: 24 scudi, 24 moschettoni, 144 picche, che fanno il fronte di 24 et il fondo di 8; et avanzano 8 picche delle quali si può far un rango se non si vogliono commandare altrove, o mettere ne' cantoni del battaglione.
Della Moschetteria d'una compagnia s i formano due maniche su l'ala dritta del battaglione avendo prima due file di 24 l'una messe dietro alle picche; e ciascheduna manica ha 12 soldati di fronte e 6 di fondo, e gli 8 moschettieri che avanzano si possono impiegare a far un rango di più a una manica, se si vuole.
Della Moschetteria d e ll'altra compagnia si fanno due altre simili maniche su l'ala manca, l e quali si v anno secondando e rilevando nel tirare, avendo prima messe due file di 24 l 'una dinanzi agli scudi; e degli 8 moschettieri che qui ancora avanzano si può far un rango di più a una manica.
Se si vogliono commandar fuori moschettieri, si cavano giustamente nel modo come si fa nella compagnia semplice, come se, p er ese mpio, s i v oglio no aver fuori 100 mosch ettieri, si pigliano 8 ranghi della prima manica dell'ala destra che fanno 48 moschettieri, e se ne pigliano 2 degli 8 ch'erano di più, che fanno giustamente 50: e nell'istesso modo si proce de nell'ala sinistra, e si hanno fuori li 100 mosc hettieri.
Ora quei quattro ranghi c he restano della prima manica, et anche un altro rango che si fa di 6 moschettieri eh' erano di soprappiù, s' aggiungono a canto alla seconda manica, e v iene detta manica ad avere 17 uomini di fronte e 6 di fondo; e così anche procedesi nell'ala sinistra, sì com e si può vede r e nel Discorso delle battaglie nella Pecorina numero 9;
7 J T utto il passo presenta qualche d i ff icoltà , per cui i l VELTZÉ (I, 104) ha cr ed ut o be n e di integrarlo, ac cresce ndo la confusion e" ... will man 50 (nehme n ), so z ieht man zwei Glieder vom r echte n und zwe i vom lin ken Fl i.igel vorne und h inten hera u s, die 48 geben , nimmt zw eit von jenen dazu , di e i.ibrigb leibe un d hat dann 50 Musket ier. .. " Il passo, lasc iat0 così com'è n el Ms., appare assai più p lausibile.
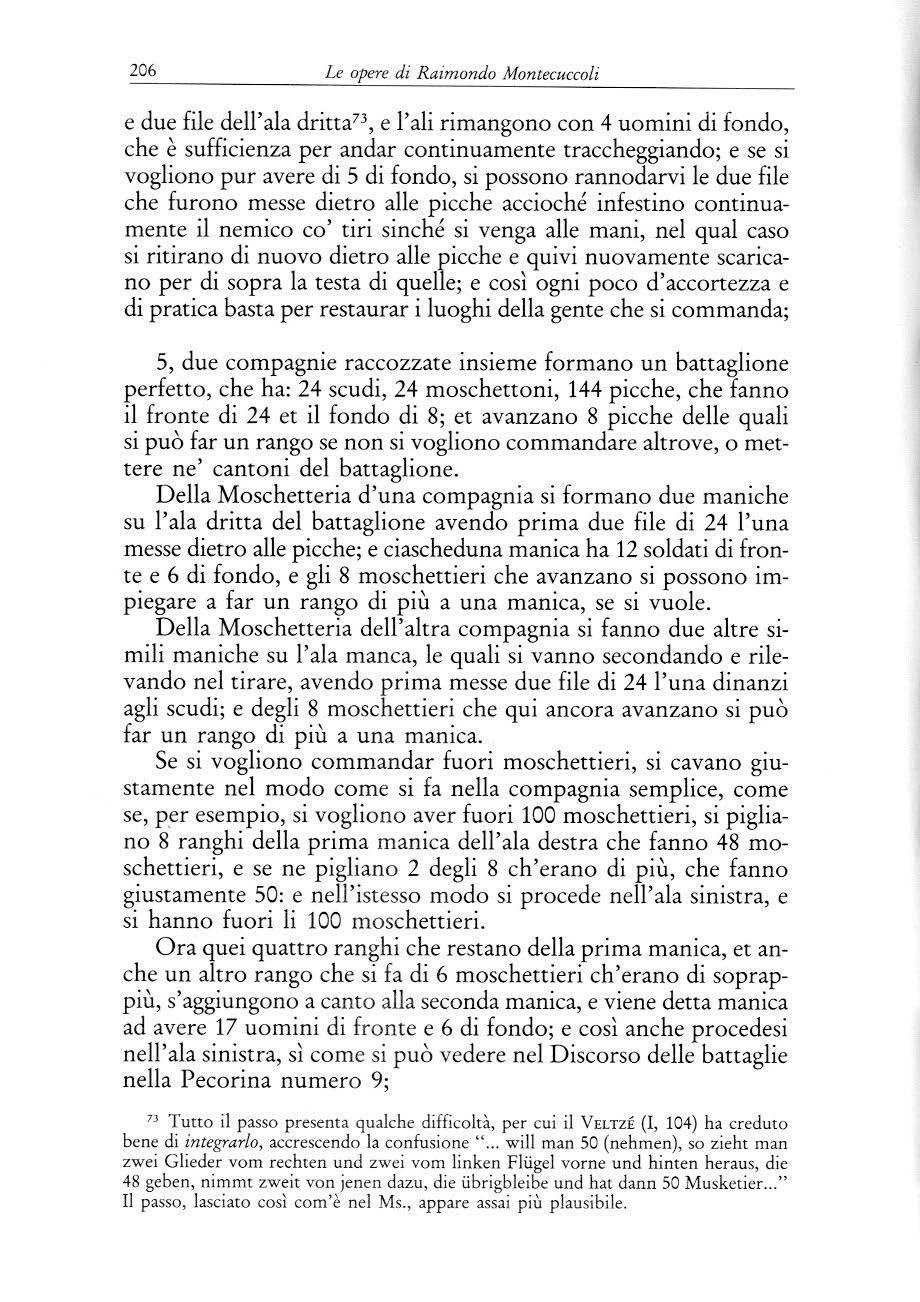
6, du e co mpagni e hanno 152 picche, 24 scudi, 24 moschettoni e 400 moschettieri; fanno in tutto 600 uomini c he formano un perfetto battaglione colle sue ali e maniche;
7, un reggimento ha 10 compagnie: fanno 3000 uomini, cioè 706 picche, 120 scudi e 120 moschettoni; e fanno S battaglioni di due compagnie l 'uno;
8, otto reggimenti fanno un'armata di 24.000 fanti che si distinguono in 40 battaglioni e co mpre n dono 6080 p icche, 960 scudi, 960 moschettoni e 16.000 moschettieri 74
Si fanno passar mostra e giu rare i soldati alla presenza di un Commissario, il quale scrive nel ruolo quelli che ritrova atti a milita r e, e gli inabi li cass a e non riceve.
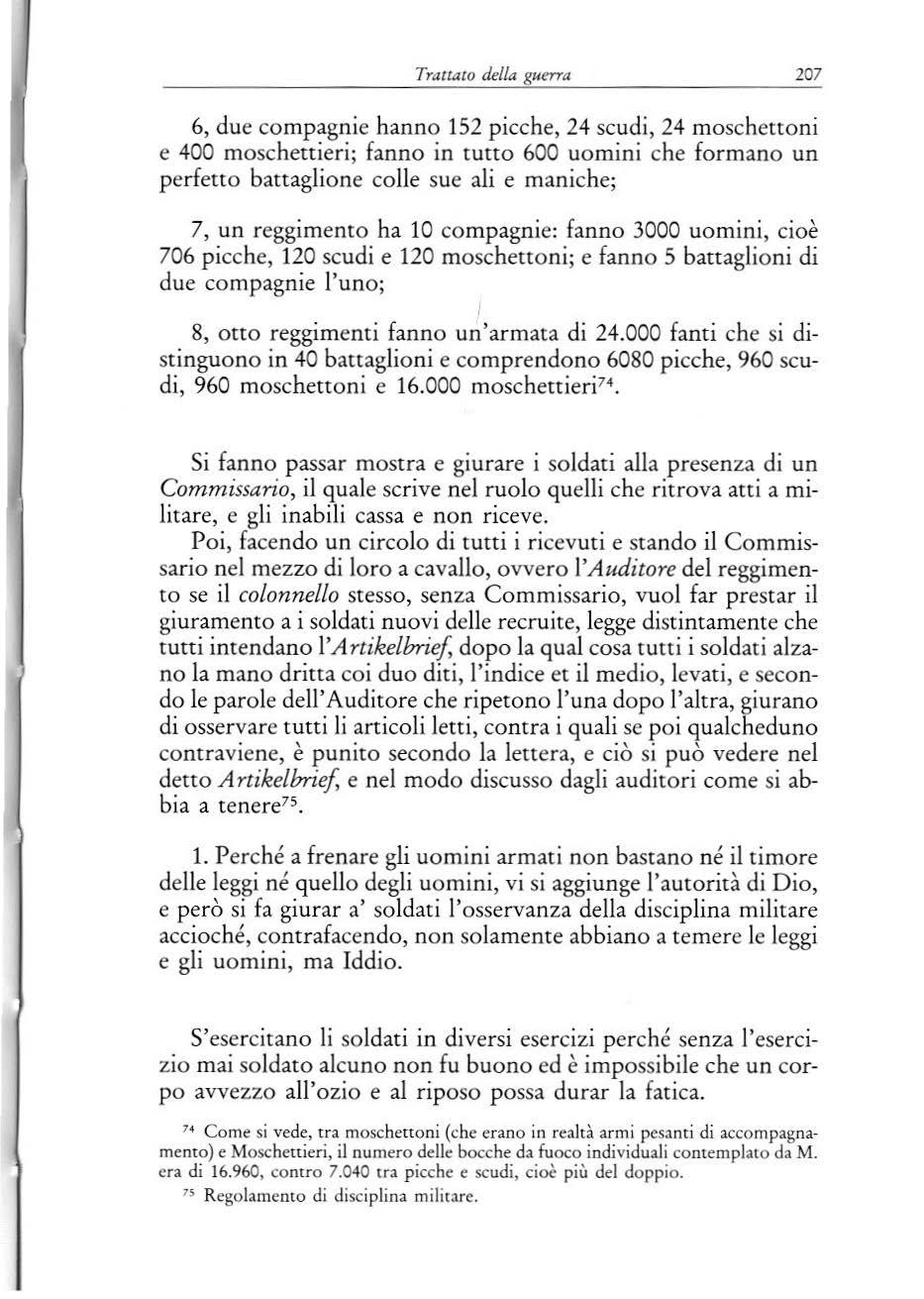
Poi , facen do un circolo di tutti i ricevuti e stando il Commissario n el mezzo di loro a cavallo, ovvero !'Auditore del reggimento se il colonnello stess o, senza Commissario, vuol fa r prestar il gi uramento a i soldati nuovi delle recruit e, legge distintamente che tutti intendano l'A rtikelbrief, dopo la qual cosa tutti i soldati alzano la mano dritta coi duo diti, l'indice et il med io, levati, e seco ndo le par ole dell' Auditore che ripetono l'una dopo l'altra, giurano di osservare tutti li arti coli letti, contra i quali se poi qualcheduno contraviene, è punito secondo la lettera, e ciò s i può vedere nel detto Artikelbrief, e nel modo discusso dagli auditori come si abbia a tenere 75 •
1. P erché a frenare gli uomini armati non bastano né il timore de lle leggi né quell o degli uomini, vi si aggiu nge l 'autorità di Dio, e però si fa giurar a' so ld ati l'osse rvanza della disciplina militare accioché, con trafa cendo, non solamente a bbiano a temere le leggi e gli uomini, ma I ddio.
S' esercitano li soldati in diversi esercizi perché senza l'esercizio mai so ldato alcuno non fu buono ed è impossibile che un corpo avvezzo all'ozio e al riposo possa durar la fatica.
74 Come si ved e, tr a moschettoni (che erano in real tà armi pesant i di accompagnamento) e Moschettieri, il numero delle bocche da fuoco individuali contemplato da M. era di 16.960, contro 7.040 tra picche e scudi, cioè più del doppio.
7 s R egolamento di disciplin a militare.
I. Devono essere, questi esercizi, tripartiti:
1, l'uno p er indurar il corpo e farlo atto a' disagi e più veloce e più destro, al che appartiene il portar pesi, come il cibo, gli ut ensili, il vallo e l'armi; et il travagliar e mover la terra, del che ha trattato diffusamente Lipsia nel V libro della Milizia romana e nel V libro della Politica, cap. 13;
2, l'altro per imparar ad adoprar l'armi, il che è osservato da Lipsia nei luoghi suderei e diffusamente specificato da Preissac n el cap . 1, tanto per l'infanteria che per la cavalleria, e da Montgomery nel cap. 3 d ella parte IF6;
3, il terzo per imparare ad osservar gli ordini nell'esercito, così nel camminare come nel combattere o nell'alloggiare; il qual esercizio di più soldati insieme è descritto ampiamente da Preissac nel cap. 6 della Milizia de' Greci e da Montgomery nel luogo sudetto, e tutto presso dalla Tattica di Claudio Eliano, di movimento in movimento.
S'aggiunge che quando si fanno abbassar le p icche, i soldati le devono abbassar per ordine una fila dopo l'altra, cioè [la] prima, poi la seconda e dopo la t erza, e così conseguentemente sino all'ultima; il che non so lamente è bello a vedere, ma anche più commodo che se si abbassano le picche l'una fra l'altra. Le due branch e della punta del ferro della picca d evon o essere lunghe per lo meno cinque gran palmi, accioché né cavaliere né pedon e possa con la spada tagliar la picca.
Qui s'intende che qu ei soldati che sono sul tuo lato dritto o sul sinistro, sieno della tua fila, e un rango sia quello ch e è dinanzi o dietro a te in linea r etta, sì che la fila si stende in linea retta sui lati, et il rango si stende i n lin ea r etta dinanzi e di dietro, ma i. francesi l'intendono tutto il contrario.
Il Sergente Generale di battaglia dell'armata d ella lega Lindelau77, fac ev a fare alla Cavalleria tutti gl'iste ss i esercizi di punto in
76 Non cit. n e ll 'e lenco d egli A.; si tratta p rob ab il me nte de l co nte Gabrie l de M ontgommery, ge n erale fr anco-ugo n otto , il q ual e il 24 agos t o d el 1569 respin se un'invasion e realist a de lla Nava rra, d isfacendo il gene r ale de T e rr ide. (C fr.: T uRENNE à M.me de T urenne , 29 sette mbre 1659, i n: Lettres de Tu ren ne extrait.es des A rchives Rohan-Bouillon , a cu ra d i S. o'H u ART, Paris, 1971, p ag 578 e n ); oppure del soldato e t ratt ati sta Lms DE MoNTGO MM ERY, Signore d i Co ur bo uso n e A utore dell ' oper a La Mi/ice Française, re· du ite à l 'ancien ordre et di scipline militai re des Legions: telle et comme la soulouyent observ er !es anciens Fra nçois à l'im ication des R omains et des Macedoniens (Pari s, 1602; II ed. r ived uta e a u mentata , ibid , 16 10)
77 VELTZÉ, I, 107: Lindelaw .

punto che si usano per l'Infant eria; faceva tirar i so ldati ora per file ora per ranghi, e dopo che l'una fila aveva tirato, si divideva in due parti ciascuna delle quali marciava lungo de' lati dell'ordinanza e così rimettevasi nell 'or dine; e ciò si cominciava or dietro or dinan z i e se le file e rano di numero dispari una parte nel dividersi restava pari all'altra dispari, che punto non importava.
Per fare che i tiri di un battaglione d'infanteria non vadano fallaci, suppongasi che a, b, c, d sia un o squadrone nella fig. 1 posto in linea retta contro un altro e, f, g, h. Ora, quand o la fila e, f piglia tutta la mira, nel dar fuoco, all'uomo di me zzo dell a fila, dico i tiri si ripartiscono così ben e che difficilmente possono ir vuoti , co me si vede dalla figura.
II. Lo squadron eggiare, detto assai impropriamente per ordinare i b attag lioni in qualsiasi forma che si voglia, apparti e n e anche all'esercizio. E perché tutte le figure so no quadrate o triangoli o circolari 78 , perch é tutte quelle di più angoli tanto regolari come irregolari si risolvono in triangoli, sì come s'è appreso nella geometria: però che congiunge l 'ar itmeti ca alla geometria, e fa da un lato della figura venir in cognizione degli altri lati e poi di tutto
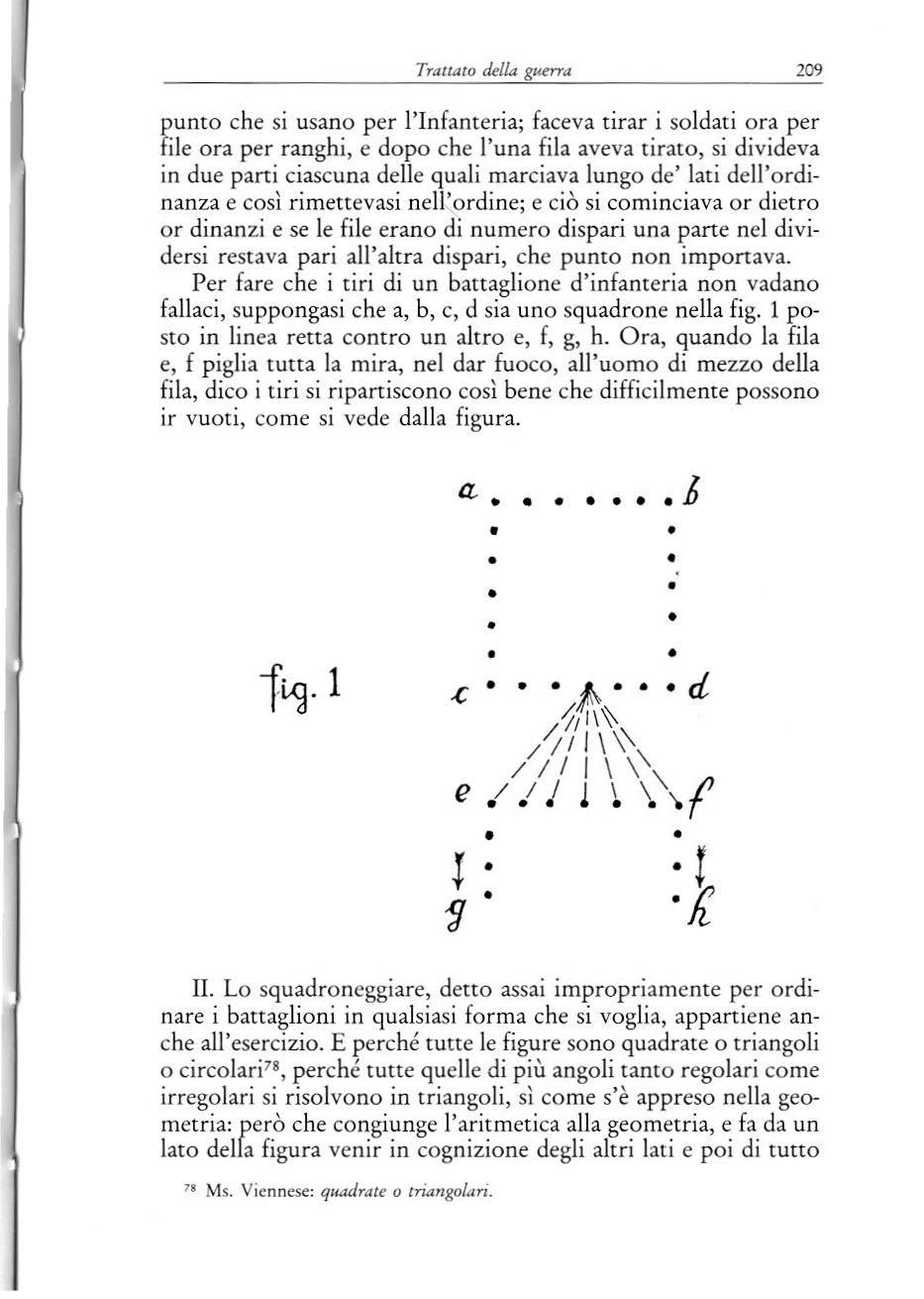
il contenuto della figura, può facilmente formare ogni sorta di battaglione in qual si voglia figura che uomo possa immaginare.
1. Quanto alle figure quadrate, se n'è diffusa m ente t r attato nel Discorso delle battaglie. Resta solo a dire c he di un quadro perfetto si fa un rombo solo col fare che le file del battaglione, dopo ch ' è posato, si torcano un po' sulla mano manca o sulla destra, secondo che si vuole si pieghi il rombo, né vengano gli uomini a st are direttamente l'un dietro all'altro, ma che l'una fila venga a risguardare gli intervalli di 9.uella che gli sta din anzi o poco meno, secondo si vogliano gli angoli del rombo più o meno obliqui, come si vede nella figura 2 .

E nel medesimo modo di un quadrato oblungo si fa un romboide e la forma che tiene la distanza ch ' è fra li 4 so ldati più vicini, è tenuta anche da tutta la figura per la relazione che ha la parte al tutto: e' si suppone che per far l'esercizio si dieno 6 v . D ad o gni soldato e per combattere 3 v. D.
2. Per far una punta, basta metter sempre un uomo di meno nella fila che s'attesta, o sia che gli uomini si collochino uno a canto all' altro, o s ia che si risguardino tra gli intervalli, come si vede nella fig . 3.
Ma quando gli uomini stanno in linea ritta l'uno a canto all'altro e l'uno dietro all'altro, tutta la forma vien a dar un angolo retto, perché la distanza è presa dalla linea laterale e non diagonale; ma quando la distanza si piglia su l a linea diagonale e che i soldati si risguardino fra gli intervalli, allora la figura dà un angolo acuto . Sapendo quanti uomini vanno in un lato del triangol o , si sa subito il contenuto di tutta la figura in quest o modo. Ho per esempio 12 uomini sul lato de lla figura sudetta, ch'è num e ro pari; multiplico il num ero per la s ua metà, ch'è 6, e mi dà 72 a' quali aggiungendo il m o ltiplicante cioè 6, mi viene 78 pel num e ro di so ldati di tutto il triangolo. E se il numero de' soldati del lato è dispari, come 11, lo moltiplico per 6 che è il numero intiero più propinquo sopra la sua met à, e mi dà 66 per gli uomini di tutto il triangolo.
Ora , s'io ho un numero di so ldati i quali voglio ordinar e in forma di triango lo, e però desidero di saper il suo lato che s i può dir diagonale come se fussin o 50 soldati, raddoppi o il num e ro e mi viene 100. Da questo cavo la radice quadrata e mi viene 10 per il lato del triangolo; ma bisogna osservare che quando non ava nza niente so pra la radice come in qu esto esempi o di 100, il lato 10 è troppo per porvi sopra il triangolo di 50 uomini per ché detto lato di 10, secondo la r ego la precedente, dà il continuo di 55: e la ragione di questo errore è che nel quadrato la diagonale se rve ad amendue i triangoli, ma qui non c'è che un triangolo so lo, e in ogni modo ha la diagonale intiera come se fus sino due , del che s'è anche parlato nel Discorso delle battaglie trattando di battaglioni a 8 facce .
Per proceder dunque con giustizia, dopo av e r cavata la radice quadra che serve di lato di un triangolo, bisogna far la rip rova per la regola antecedente se il numero de' so ldati basta adempir il triangolo sopra tal l ato; e s'ei non basta, bisogna scemare un'unità al lato.
3. P er far una figura circolare, bisogna aver alla mano la tavola circolare discussa n e lla Pecorina n. 4; e l'area, che significa il numero delli uomini che si hanno per disporre nel battaglione tondo, dimostra subito il diametro che de e avere; e la tavola si s tende si n a 50 di diametro pigliando le minu zie per inti eri, il qual diametro dà un'area di 1963 .

Come per esempio se io ho 19 soldati e li voglio disporre in ordinanza orbicolare, la tavola mi dà 5 per il diametro come si ve de nella fig. 4.
Ma più mecanicamente, si fa il circolo formando una funga ordinanza di molte file, poi cominciando a marciar attorno e ristringendosi sempre, vengono a raddoppiare per di dentro le file e si vanno attestando verso il centro sin che il capo, che conduce l' ordinanza, si trova t]JttO attorniato. Ovvero si fermano i sergenti nel mezzo, di mano in mano che le file arrivano le dividono col manico dell'alabarda, che la metà gli passi su un lato e la metà su l'altro; e se le file sono dispari in numero di uomini, su la mano dove girò la metà pari della prima fila, gira poi la metà dispari della seconda, poi la pari della terza, e così successivamente sinché tutte le file hanno attorniato i sergenti e fatto il circolo.
In qu esto modo si può anche formar una mezza luna co l calcio dell'alabarda dopo che l'ordinanza è formata in una fronte eguale e poi si fa incentrare nel mezzo.

Altrimenti, in tempo di notte, si può porre un regulo in giro con corde e pali, il quale faccia sta r e a segno le prime genti che arrivano, e diano la forma al battaglione.
4. Per fare di più squadroni un grosso, bisogna ordinare le compagnie in tante file, quante si vuo le che il fianco dello squadrone abbia cavalli; poi bisogna giu ng ere le compagnie fianco a fianco. La distanza de' ranghi de v 'essere tanta per la lunghezza del cavallo che per lo spazio fra loro di 6 passi; quella delle file 1 passo.
5. Si giungono l'ali a un'insegna in diversi modi nel mezzo, sui canti e come si è mostrato nel Discorso delle battaglie.

Della guerra difensiva
I. Il modo di far la guerra è l'istesso nella civile che nell' esterna, e però da questo s'impara quello.
Nella guerra difensiva bisogna considerare le forze e la situazione degli Stati secondo eh' essi sono piccioli, mediocri o grandi.
Gli Stati piccioli sono di natura tale eh' ei non hanno sussistenza se non per la gelosia che hanno i lor vicini gli uni sopra gli altri, perché se gli uni voglion attaccar uno Stato debile, gli altri lo difendono . Nondimeno questa·è una condizione instabile e malsicura perché se l'uno si trova in istato di attaccarlo, l'altro non si troverà forse in istato di difenderlo, oltre che qualche volta si accordano insieme a divider la preda; talmente che tal natura di piccioli Stati che non hanno la forza in loro medesimi di difendersi, è sempre in pericolo, e bisogna loro una gran distanza per levar ogni pretesto a' lor vicini di intraprender sopra di loro.
I. Il sol mezzo che resta loro, è d'aver una piazza o due molto ben fortificate et armi e denari a sufficienza per ben difenderle, accioché si dia tempo di soccorrerti a quelli che non vorranno permettere l'accrescimento di colui che ti attaccherà, perché:
1, s'egli non si ha alcun mezzo di resistere, il tuo paese sarà preso prima che s'abbia avuto t empo di soccorrerti;
2, la facilità che si giudica a poter conquistarti, mette voglia di attaccarti;
3, tu troverai più persone disposte a soccorrerti ch e a riconquistare il tuo paese, perché l'uno è facile con egual forza, e l'altro è molto più difficile senza av ere più gran forze;
4, dicono alcuni che egli è buono di avere i paesi senza fortezze , perché, se bene si possono prendere facilissimamente, in ogni modo s i possono con la medesima facilità riacquistare, particolarmente quando si ha l'aiuto e l'affezione de' sudditi; ma la ragione non vale, perché se bene non vi sono fortezze nel paese, può l'inimico dopo averlo acquistato farne a spese sue, sì che entrerai nelle medesime difficoltà per riguadagnarlo mettendovi prima l'inimico. Né possono i Principi porr e tutto il loro fondamento nella fedeltà de' vassalli, perché gli animi degli uomini si cambiano con i tempi, molti sono desiderosi di veder cose nuove e si compiaceriano delle mutazioni; e tutti fastidiscono i calamitosi, sì che chi pone molto nella misericordia de' suoi, non sa quanto presto s'.asciugano le la~rime: e la pratica di tutti gli Stati moderni aut enuca questa massima;
5, aggiungasi che sovente volte c'è tanto pericolo che colui ch e racquista il tuo paese come tuo amico non lo ritenga per sé, come quegli che l'avea pr eso come tuo nemico; o se te lo rende, lo fa con condizioni sì dure ch e non si possiede più che l'ombra di una sovranità; e ben felici sono quelli che rincontrano Principi sì buoni e generosi che li ristabiliscono ne' loro Stati perduti con la medesima autorità e libertà con che li godevano prima, perché gli esempi ne sono molto rari. Anzi: che molte volte chi tu chiami al soccorso ti caccia e ti leva egli stesso il paese, come hanno fatto gli Svedesi, chiamati dal Brandenburgo in Alemagna; né l'Imperatore ha voluto ricever i soccorsi che il Turco gli ha più volte offerto.
II. Questa piaz zafort e de' piccioli Stati può essere la residenza del Principe, dentro a cui si ritira per difendersi tutto ciò che si può del paese, accioch é, venendovi l'armata nemica, non abbia vi-

veri da soggiornarvi; e può essere situato o nel mezzo del paese, o nelle frontiere, o dove il sito è più favorevole, perché vi sono de' luoghi che la natura li difende da se medesma, e li rende più inespugnabili che tutta l'arte del mondo, come una rocca inaccessibile, un marazzo, un lago, né tal piazza è posta per diffendere tutto il paese, ma solo per guadagnar tempo, ovvero se vi fosse un passaggio per lo quale l'inimico dovesse nece ssariamente passare, quivi si potria fabricare. _
1. Prima devesi anche aver risguardo di farla grande o picciola secondo la qualità del nimico contro di cui ella si ordina, perché se per esempio si vo lesse far picciola contro al Turco, ella non si diffenderebbe lungo tempo, perché la forza del nimico che l'assalirebbe sar ia troppo gagliarda, et anche secondo le sue forze; perché se non s'è sufficiente a tenerla ben guarnita, il vicino potente, che la conosce opportuna al suo stato e che teme se non l'occupa d'esser prevenuto dal suo emulo, te la chiede e te la leva o apertamente o sotto pretesto di mandarvici o di pagarvici la guarnigione che tu non sei bastante ad intrattenere, e tal occupazione in tal caso è anche approvata per giunta da alcuni teologi.
2. Come si abbiano a fabricar le fortezze secondo le migliori regole della fortificazione si è diffusamente trattato nella P ecorine numero I in qu anto alla forma regolare e nella P ecorina n. II in quanto alla forma irregulare, nella quale è anche ampiamente descritto il modo di guardarle e come si abbiano a difendere contro gli assed i sleali; e contro li st ra tagemi in genere si è discorso nella P ecorina numero III e contro li stratagemi in ispezie, nella Pecorina numero IV.
3. Si può però aggiungere nella diffesa reale che le sortite servono ad inchiodar i cannoni al nimico, abbruggiarli la polve, riempirli le trinciere et a levare v ia e disfare ciò che reca imped im ento. Che nelle sort ite non bisogna caricars i molto di prigionieri, perché essendo molti, non si possono ben guardare durante l'assed io , né si possono rilasciare, che non abbiano osservato o inteso qualche mancamento della piazza; che nelle trinciere si sogliono lasciare tonnelletti di polve con un cannoncino da respirare dentro a cui è una miccia accesa, eh' esce un mezzo piede fuori del tonnello, e si ricoprono leggermente di ter r a, accioché quando il nimico vien a ricominc iare il travaglio delle trinciere, la polve

s'accenda e l'uccida; che il fosso, quando è secco, si può anche difendere per le sue casematte portatili, dette coffani, attorniate di piccioli fossati e di palizzate per impedir l'abordo, che si mettono in diversi luoghi del gran fosso per difenderlo, e per n on esser visto dal cannone dell'assalitore .
4. N elle diffese contro i stratagemmi s'aggiunge che, quando la controscarpa è di scesa agevole nel fosso, ch'è secco, vi si mettono pali d'assalto orizzontalmente, che riguardano verso la fortezza, sì come è fatto a Stettino; che sopra il ramparto 79 devono sempre esserci picche et arme corte, accioché, se l'inimico ti assalisse in tempo piovoso, quando i moschetti non pigliano fuoco e sono resi inutili, possano i moschettieri gettarli e dar di piglio all'armi corte per difendersi, essendo che per simile diffetto fu soprapresa la piazza di Tri ebe nse e dalli Svedesi8 0 ; che si raddoppiano le guardie nei giorni di fiera o di mercato, durante la raccolta e particolarmente la vendemmia, perché si spia vo lontieri simili tempi per formar un dissegno; che si formi istesso le intraprese doppie, fingendo di disgustare un officiale o semplice soldato o abitante, il quale andandosi a rendere all'inimico, gli faccia intraprendere un disegno verisimilmente facile, perché oltre al profitto che si ha d'acchiappare i più arditi, tu ne tiri ancor questo vantaggio, che il tuo nimico non ne medita alcun altro, tanto eh' egli spera in questo, perché sempre s'intraprende quello che si crede dover riuscire più sicuramente.
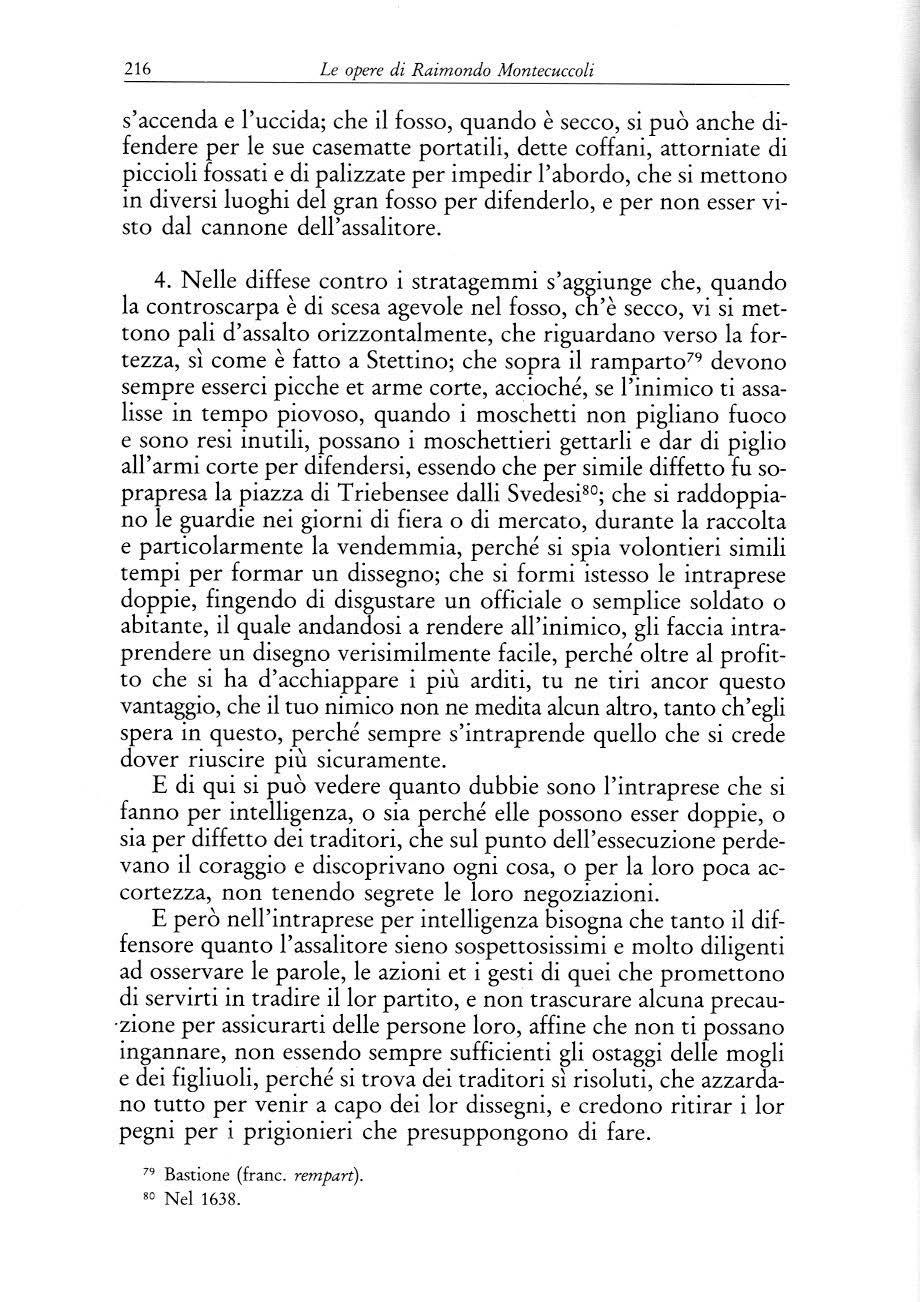
E di qui si può ve dere quanto dubbie sono l'intraprese che si fanno per intelligenza, o sia perché elle possono esser doppi e, o sia per diffetto dei traditori, che sul punto dell'essecuzione perdevano il coraggio e discoprivano ogni cosa, o per la loro poca accortezza, non tenendo segrete le loro negoziazioni .
E però nell'intraprese per intelligenza bisogna che tanto il diffensore quanto l'assalitore sieno sospettosissimi e molto diligenti ad oss ervare le parole, le azioni et i gesti di quei che promettono di servirti in tradire il lor partito, e non trascurare alcuna precau·zione per assicurarti d ell e persone loro, affine che non ti possano ingannare, non essendo sempre sufficienti gli ostaggi dell e mogli e dei figliuoli, perché si trova dei traditori sì risoluti, che azzardano tutto per venir a capo dei lor dissegni, e credo no ritirar i lor pegni per i prigionieri che presuppongono di fare.
79 Bastio ne (frane. rempart).
80 Nel 1638.
Gli Stati mediocri s'intendono qui per un Principe o una Republica che per sua diffesa può intratener un 'Ar mata di 20.000 uomini di piede, e 3000 cavalli con tutto l'equipaggio necessario.
1. Se il suo paese è d'accesso difficile e che non vi si possa entrare se non per certi passaggi e montagne guardate e fortificate, c'è un grand'avvantaggio, ma coloro, che vi si sono fidati troppo et addormentati et hanno trascurate l' altre diffese, si sono ingannati, e si sono perduti là dove pensavano d'essere più sicuri.
2. S'egli è circondato dal mare, egli è un bel fosso, ma in ogni modo il più potente troverà mezzo di far la sua discesa nell'iso l a.
3. S'egli è circondato da marazzi e da riviere, si trova ancor mezzo di passare particolarmente in questo tempo, che s'ha del1' artiglieria per favorire tali passaggi.
I. Talmente che il più sicuro è fondarsi sopra le proprie forze, cioè sopra una buona Armata e sopra buone fortezze, e dicesi le due giunte insieme, perché l'Armata senza le fortezze sendo debole e non avendo ardire d'azzardar cosa alcuna, lascia al nimico i viveri della campagna et i mezzi di sussistere a tue spese, e finalmente di rovinarti. E le fortezze senza Armata non si possono conservare se non tanto tempo per quanto avrai fatto magazzini dentro di quelle, e chiunque si mette intieiamente sulla diffensiva rinchiudendosi dentro alle piazze bisogna (senza un soccorso str-aniero) c h e alla lunga perisca, perché due o tre anni di guasto d e l fa campagna riducono le città a ll a fame e fann o lor conoscere che la tua debolezza non le può salvare, onde amano meglio di rendersi al tuo nimico che d i perdersi; ma queste cose sendo proporzionate con giudizio, si può fare una grande resistenza .
1. Ma egli è cosa egual mente pericolosa l'aver più fortezze di quelle che si posson guardare, et il non ne aver punto, perché in questo caso, quand'anche s'avesse un'armata forte , una peste nel tuo essercito, o una battaglia persa, si dà perso tutto lo stato, e però s'è trovata l'invenzione d'opporre de' luoghi forti a conquistatori per fermare con poche genti la lor prima furia e rovinar le loro armate . Nell'a ltro caso bisogna perir sicuramente senza poter sperare altra cosa che d'allungar la sua perdita; perché la gelosia

che tu hai di conservare tutte le tue fortezze lasciandovi grosse guarnigioni, ti leva il mezzo di tener un'armata alla campagna, et allora il guasto di due o tre raccolti ti costringe a renderti.
2. Aggiungasi, che le fortezze sono principalmente inventate per il più debile, accioché i pochi possano resistere contr'a i mo lti, e se tu hai sì gran numero di fortezze e di gran guardia, come sono le gran città fortificate, ti bisogna più numero di soldati che non avrà colui che v iene per attaccarti, altrimenti tu non sapresti provederle tutte di guarnigione sufficiente per conservarle da un assedio; e se tu sei il più forte, senza alcuna piazza conserverai il tuo paese tenendo la campagna.
3. Ed evvi ancora un altro inconveniente nel fortificare le gran città, ch'è che tu le rendi sì superbe che a pena vogliono riconoscere il lor sovrano, et alla minima incommodità che ricevono in una guerra gli abitanti amano meglio cangiar di Signore che di vedere rovinar il lor bene.
4. Concludasi dunque che bisogna aver sì poche fortezze ch'elle non t'impediscano il tener la campagna, essendo sicuro che, per conservar il suo paese contro una maggior forza che la sua (dando ordini che non si manchi di viveri), si può fare campeggiando e ritrincerandosi fortemente, perché tal essercito è una fortezza mobile e che si trasporta dove il bisogno richiede. E se ben alcuni si fondano sopra questa ragione, che quando tutte le piazze principali di uno stato sono fortificate vi si ritirino dentro tutt'i viveri della campagna, nella quale v enendo un'Armata nimica, s'ella vi soggiorna ella si muore di fame, e s' ella non fa che passarvi, ella non vi fa gran male, di sorte eh' egli è quasi impossibile d i potervi far la sede della guerra, in ogni modo s'è già risposto che le fortezze sono principalm ente in ventate p er il più debi le e si son aggiunte altre ragioni contro la troppo gran quantità di quelle. E le fortezze che si hanno bisogna fortificarle e munirle sì bene ch'elle possano far una gran resisten za, e collocarle sì bene, eh' elle tengano in briglia le gran città; e eh' elle assicurano le frontiere, accioché il nimico faccia difficultà di lasciar dietro a sé una piazza che possa incommodar i viveri e che per intelligenza o altramente non possa impadronirsi d'una città principale che li serva di sede per intrattener la guerra dentro al paese .

IL Le fortezze ben intese, ben situate fanno l'ufficio d'un essercito in campagna, perché combattono col nimico, gli fanno resistenza, l'intratengono, gli fanno perder il tempo e danno commodità al lor Principe di metter insieme le sue forze per soccorrerle o per di verti re e portar la guerra in un altro luogo, et alcuni castelli in Italia che si opposero ai gran progressi di Annibale diedero spazio ai Romani di rimettersi in armi e di mantener la libertà, mentre ch'egli fu costretto perder il tempo intorno a quelli per espugnarli.
1. I luoghi più propri per collocarvi fortezze sono quelli di dove si può coprire un gran pezzo del paese dall'attacco del nimico; se gli può levare e tagliare ogni vantagg io e commodità d'offendere, o almeno fargli il maggior impedimento e causargli la maggior difficultà che sia possibile; e per contrario se gli può entrar nel paese e fargli qualsivoglia danno et offesa .
2 . Per tal raggione è meglio situar le fortezze nelle frontiere e nei co nfini che nel mezzo del paese, perché se le frontiere non sono fortificate , il nimico ha il passo aperto per far scorrerie nel paese e sacc heggiarlo a suo piacere, ma se pel contrario i luoghi di confine sono assicurati con forti e piazze gagliarde, non può il nimico entrar nel paese s' ei non ha prima guadagnato le fortezze, le quali, se bene non possono totalmente resistere contro un essercito di real forza, nondimeno trattengono e danno t empo al tempo finché la parte assalita si risolve di trattare di tregua, d'accordo o di pace con lo assalitore, ovvero procura di far previsioni tali che sieno sufficienti alla sua diffesa o a soccorrere la frontiera assalita; e quanto alle picciole scorrerie che può far il nimico colle partite, elle son impedite dalle guarnigioni di cavalleria che si possono tenere dentro a queste piazze, se ve n'è bisogno.

E per quest e ragioni sono fortificate le frontiere d'Ungheria contr'al Turco.
3. Se un paese giace al mare , bisogna fortificar gagliardamente l'isole vicine et i porti di mare, accioché 'l nimico non le occupi, perché occupandole può poi faci lm ente entrar nel paese e conquistarlo, avendo commodità di pot er ricevere senza impedimento soccorso abbastanza di gente, di munizioni, e di v ive ri, e potendo avanzare nel paese, e ritirarsi secondo ch'ei vuole; e nelle guerre
imperiali contro lo Sveco81 , la perdita dell'isola di Rligen e di qualche porto, fa perdere tutto il paese all'Armata Cesarea.
4. Si fabricano anche fortezze sulla ripa de' grandi fiumi e navigabili, per avervi un passo sicuro et aperto per potervi sempre ricever soccorso, e pe'l contrario per impedire che 'l nemico non passi il fiume sì facilmente, né possa condurre con agevolezza i cannoni per acqua al luogo dov' ei desidera, intendendosi che la fortezza sia situata in modo che quando un'armata ha da cercar il passo per acqua, sia forzata a passarvi necessariamente a canto.

5. Dove sono passaggi stretti fra roccie e monti è similmente buono fabricare forti e piazze gagliarde, perché in tali passi e chiuse \ s1 puo sostenere e nspmgere un esserc1to mttero.
6. Nel situar le fortezze bisogna aver rispetto all'aere, che sia buono, puro e sottile, alla fertilità del terreno all'intorno per poter raccogliere grani et altre vettovaglie per lo mantenimento della guarnigione, all'acqua ch'è un elemento necessario alla vita degli uomini, alla sicurezza, accioché ella non sia soggetta a commandamento nissuno di colle o di montagne, e che da vicino non v i sia bosco folto o cavern e o fo ss e dentr'all e quali po ss a il nimico segretamente nasconders i et all'improvviso sorprendere la piazza.
7. Si trovano talora dei siti favorevoli che la natura senza l'arte rende da per sé inespugnabili, come una roccia in e spugnabile, un marazzo o un lago; ma ogni agio ha il suo disaggio, e radamente tali siti si rincontrano a luoghi di frontiera, o sopra qualche passaggio importante, o capaci di contenere una guarnigione assai forte per dar gelosia al nimico che vuole entrare dentro un paese, ovvero si trovano sì facili ad esser bloccati che 500 uomini di fuori ne assedieranno 500 dentro, e però servono più per ricoverarsi dentro in caso di necessità e salvarsi le cos e migliori, ch e p e r offende r il nimico.
bisogna riguardare qual nimico t'attacca 82 ; s'ella è una potenza unita di confederati insieme, ella è più facile a disunire che quando ella dipende da un solo,
81 Sved ese.
8 2 M s . V ie nn ese: s'attacca : il c h e è ch iar am e nte un er rore , t rattandos i di di fe n siv a, e non ha senso nel co ntest o .
et in questo caso gli è molto buono di far nascere diffidenza tra loro, fingendo d'aver intelligenza con qualcheduno de' confederati, al quale mostrando più rispetto e meno animosità si dà gelosia agli altri; come ancora procurando una diversione sopra il paese d'uno degli altri, sendo cosa molto difficil e che più potenze sovrane sieno lungo tempo collegate insieme senza che vi nascano disgusti, invidie et anche inimicizie, a cagione della diversità de' lor umori e de' lor interessi,. talmente che la potenza che dipende da uno stato solo, è molto più da temersi.
1. Si fanno al nimico sospetti i suoi uomini, ne ' quali confida, col riguardare le cose loro, com'è conservare nella guerra le sue genti, e le s u e possessioni, rendendoli i figliuoli o altri suoi necessari senza taglia.
2. Mettello avendo l'essercito contr'a Iugurta, tutti gli oratori che de Iugurta gli erano mandati erano richiesti da lui che li classino Iugurta prigione, et a quelli medesimi scrivendo di poi della medesima materia lettere, operò in modo che in poco tempo lugurta insospettÌ di tutti i suoi consiglieri et in diversi modi li spense .

3. Essendo Annibale riffuggito ad Antioco, gli oratori romani lo pratticavano tanto domesticamente, che Antioco, in sospettito di lui, n on prestò di poi più fede a' suoi consigli. Ed è quasi aver ottenuta metà della vitto ria quando si può far cacciar dall'armata nimica un gran capitano, o dallo stato un gran consigliere. Né i Principi dell' Alemagna seppero usare artificio maggiore contro la potenza dell'Imperatore, che di far in modo nella Dieta di Ratisbona che Wallenstein fosse rimosso dal generalato e che l'Armata fosse lic enziata, perché in tal modo la maggior parte de' soldati, disgustata nel licenziamento, passò a' servizi del nimico, et il Wallenstein, capitano di condotta mirabile e che aveva resi all'Imperatore serviz i egregi, divenne per la ricevuta ingiustizia sì mal affezionato, come gli eventi di poi hanno fatto vedere 83 • Ma coloro, ai quali sono stati conservati i beni dal nimico hanno obviato all'odio popolare e si sono levati di sospetto facendo presente delle sue ter r e al Principe o alla republica, overo vendendo le, e co n quel danaro pagando la ranzione 84 e riscattando i prigionieri, o facendo qualch'altra opera in beneficio del Principe, o della repub lica.
Interessante e
4. Alcun capitano riconoscendo l'austerità del capitano nimico, ha usato modi umanissimi e cortesi, accioché i soldati fossero mossi ad abbandonare la tirannia del nimico e ricorressino a rendersi a lui, ch'avea fama di dolce e di pietoso. Quando il Conte Galasso entrò nella Pomerania e nel Mecklenburgo e spinse Banér al mare, offerse perdono a tutti i tedeschi che venissero rendersi alla parte Imperiale, e Cesare fece un mandato avocatorio publicato in istampa contro tutti i tedeschi che servissero a svedesi, se in un tempo prefisso non rinunciassero al servizio; le quali cose cagionano ch'alcuni lasciano il servizio, altri sono resi sospett i a lor Principi o generali, i quali procedono con essi con diffidenza; e da questa nasce poi un vero rimorso, e cattivo volere in colui che conosce che la sua fedeltà è messa in dubbio.
5. Per metter dissensione fra collegati, si tratta cogli ambasciatori degli uni disgustati, e si fa, che qualcheduno degli altri alla porta intenda segretamente quello, che i primi rapportano di mal contentamento e di disgusto .
6. Si chiamano gli ausiliari del nimico con lettere sparse ne lu oghi, o intagliate negli arbori, dove l'armata nimica de' capitare, perché o si separeranno o si renderanno sospetti .

7. Si manda gente sotto spezie d'ambasciatori, che dissolva una gran potenza, dando il ius di sovranità a ciascheduna città di per sé, accioché più facilmente sien poi forzate all'ossequio.
8. Si lasciano i prigionieri degli ausi liari de' nimici liberi e senza taglia, e quelli propri de nimici si ritengono in angustie.
9. Et in detto modo s'usa ogni arte di mettere divisione tra nimici, non perdonando a spesa né a fatti ca nissuna, subornando i Principi stessi, i loro famigliari e le città alla ribellione.
Né s'attaccano durante la dissensione, massime se non è altra considerazione che il mutinamento solo, ma devi fomentar l'un partito tanto che puoi per rovinar l'altro, et alla fine assugettire ancor questo, e devi sempre favorire la parte più debole e de' vinti, accioché rendendola uguale a' nimici, si consumino le forze del v incitore; perché altrimenti attaccandogli s'accorderebbono contro al commune nimico, come dimostrò colui che fece condurre due cani furiosi, che subito s'azzannarono insieme, e cominciarono a
mord e rsi, poi fece condurre un lupo appresso di quelli, et allora i cani si lasciarono per gettarsi sopra il lor nimico commune, il quale strangolorno, e lor due furono amici.
10. Se non si può guadagnare con premio il consigliere o capitano che mena la guerra, si cerca di farlo morire, di mandar qualche traditore che l'uccida, et a questo tale si fa qualch'ingiuria e qualche oltraggio in pubblico, affinché egli abbia qualche colore di far il malcontento, e di passar ali' armata nimica, o si fanno sparger biglietti nel campo nimico che promettono gran taglia a chi l'uccid e, o si cerca di subornare qualch eduno che osservi la commodità e scopra il modo di farlo prigione, come fece un certo Quintino di nazione tedesca, che scoprì a Torquato Copti84 w, generale dell'Imperatore, l'occasione cl' acchiappar il Re di Svezia, eh' era uscito di $tettino per riconoscere il campo Cesareo, la qual cosa non fu trascurata dal Conti, ma commandando una partita di cavalleria in imboscata, poco mancò, che non tagliasse al Re il passo del ritorno a $tettino, e non lo facesse prigioniero; o si cerca di renderlo odioso mostrando che la guerra è fatta per causa sua e per suo puro interesse, eh' egli attribuisce tutta la gloria delle cose fatte a se stesso e non al Principe, et in somma subornando qualche favorito o amico del Principe che gli riempia sempre l' orecchie di calunnie contro di quello, dissimulando la cagione dell'.ira, accioché abbia maggior credito l'autorità del calunniatore e segretamente senza testimoni lo renda sospetto accusandolo ora cl' avarizia, ora di tradimento, e se per sorte ha ricevuto dal Signore grazia della vita, dicendo, che noi odiamo certi benefici, ch'ei si vergogna di confessare d'aver meritato la morte, e che vuole che più to sto paia ch'egli abbia ricevuto ingiurie che la vita, e che però il Principe deve con lui contendere della salute e disputare la v ita. E queste frodi dee l'amica ess e rci tar e negli atti di Venere, ogni volta che vede l'amor d e l Principe acceso in lei, perché l' animo \ . \ . e piu c o ncitato.
11. Si corrompe anche il capo dell'inimico, trattando con lui segretamente di v olerli assistere ad occupar il Principato del suo Principe o della sua Republica, promette ndoli una sua figlia in matrimonio; e facendo uccidere tutti coloro ch e servono da me zani e d'internun~i a trattare, accioché per la loquacità lo ro il tradime nto non sia scop e rto.

8
• 1,,; Epi so d io no n meglio no t o . Il Co nti e ra un o dei cant i It al iani al serv iz io de ll'Imp ero e fu a lui ch e t occò l ' i ngrat o co mp ito di fr o nteggiare G ustavo A d o lfo s ubit o d opo il su o sbar co in P ome rani a (v. più avanti )
12. Si manda anche un soldato di grand'abilità sotto spezie di fuggitivo e transfuga nel servizio del nimico, il quale de' mostrar segni verisimili d'esser stato maltrattato e disgustato e fra 'l nimico de' mostrar segni di fedeltà rendendo qualche buon servizio di non troppo gran conseguenza, accioché avendo preso autorità e credito nell'esser.cÌto, ti serva poi in quello a che lo mandasti.
13. Che se un corpo di soldati nimici vien a rendersi e a passar nel tuo campo, devi esser cauto nel riceverli, né assicurartene, che non abbiano prima fatto nel partire qualche gran danno al nimico, o abbiano portata la testa di qualche capo per giunger cari, o diano in potestà e prigioniero il capitano del nimico per obligarti, sì come dopo la battaglia di Leipzig passando il Tilly per Halle in Sassonia fu pensier d' alcuni borghesi di pigliarlo prigione, e delivrarlo nelle mani del Re di Svezia per obligarlo; o sia che avendoti prima ingiuriato, vogliano con un gran beneficio cancellar un'offesa, o sia che prima con te s'avvisino per assicurarsi che tu li riceva, come colui che scrisse a Cesare: "Se tu mi doni la vita, poiché son abbandonato da Pompeo, quale sono stato verso di lui, di tale v irtù e di tale costanza sarò verso di te", al che rispose che egli era Cesare, e che manterrebbe la fede. E quando un paese vuole rendersi a te per esserti grato e rendersi irrecon ciliabil e col nimico, taglia a pezzi in un'istessa ora tutti i presidi dell'avversario che sono in esso.
14. Quanto al divider le genti nimiche non c'è il più certo modo che far assaltar il paese da parte di quelli (avendoli suscitato qualche nimico), accioché essendo costretti andar a diffender quello, abbandonino la guerra, e la lega venga a disunirsi o a raffredarsi.
IV. Se tu sei attaccato con forze che non sono troppo disproporzionate alle tue, puoi conservar il tuo paese senza disertarlo, e con la tua armata e le tue forze puoi consummar il nimico incommodandogli i viveri o ritrincerandoti sempre e campeggiando per luoghi montuosi e difficili, sì vicino a lui che tu gli impedisca di fermar il piede in alcun luogo d'importanza, perché se un conquistatore non avanza, ei ricula, e gli è impossibile di sussistere dentro un paese ch'ei vuol conquistare, se d'abordo non piglia piede e non vi si stabilisce per qualche presa considerabile; e simil campo, che ritien il nimico di far progressi nel paese dov' e&li è entrato, si può chiamar un campo vo lante, poiché non puo mai star

fermo, ma bisogn a che si r egoli seconda il nimico, e se quel marcia, bisogna che tu ancora marci per seguitarlo, e quand' ei sia fermo, bisogna che tu ancora t i fermi per essergli sempre adosso e levargli ogni commodità di far progressi, procedendo però con tal cautela che tu non sia ridotto a combattere contro tua voglia, perché la perseverazione fa più che la forza, e molte cose inespugnabili a chi pensasse forzarle tutt' a un colpo, col tempo si lasciano prendere quando vi si va poco a poco, perché la cont inuazione è invincibile, per la lun gh ezza della quale non è forza sì grande che il temp o alla fine non consumi 85 , come dimostrò Sertorio al suo essercito con qu est' esse mpio: fece condurre due cavalli, l'uno molto debile e vecch io, l'altro grande e forte, che av ea la coda meravigliosamente bella e folta; dietro al cavallo magro fece mettere un grand'uomo robusto, e dietro al caval forte ne fece metter un altro piccolo e debile, poi ad un segno or dinato, l'uom forte prese a due mani la coda del caval magro e la tirò con tutta la sua forza come per strapargliela, e l'altro uom debile si mise a tira r a pel o a pelo la coda del caval forte; or quando l'uom gagliardo ebbe travagliato lungo tempo e sudato in v ano, l'altr'uom d eb il e avea già pelato con poca fatica et in poco tempo tutta la coda del suo.
1. Quando s'intende che il nimico vien e, si visitano le pi azze, si rinforzano di nuov i travagli, di gente, di munizione, di viveri, si fortificano i passaggi e particolarmente quelli dove s i stima che il nimico voglia tentare, si serrano co ll 'inon dar il paese come fecero nel paese di Bremen, e co ll 'abbatte r i boschi, come più volte s'è fatto nella Boemia, s'oppone l'armata al nimico ai passaggi delle riviere, come Tilly s'oppose al R e di Svezia al passaggio del Lech e il duca Bernardo a Galasso nel passaggio del Reno, il Banér al Galasso nel passaggio della Pe na, e Galasso al Banér nel passaggio d ell'Elba86 • S'oppone ai di st r ett i [?] dell e montagn e, d e' boschi e de' marazzi, perché s'ha qu es to vantaggio, che ro chi uomini possono resistere a molti; s'intratiene e si stanca i nimico, e nell'ind ugiar , sendo tu nel tuo paese puoi aver miglior commodità di viveri . E se alcun dicesse che sendoci diversi passaggi egli è impossibile di guardarli tutti, si rispond e che ciò si deve intender de' luoghi dove si giud ica a poco presso che il nimico debbia passare, e cos ì

85 In questo mirabile passo sono icasticamente descri cti: il principio che l' actacco si esaurisce progred endo; la difesa manovrata; il cedere spaz io per guadagnare t empo e la capacità di un'a bile difensore di sfru ttare a danno del nemico l'illusione dell a guerra breve
86 li primo episod io avvenne i l 5 apri le 1632; il seco nd o nel Mar zo del 163 5; il terzo nel 1637 ed il quarto presso T orgau nello stesso an no .
s'abbattono i ponti de' fiumi, si rompono i guadi né si lascia nissu n luogo spovvisto, accioché occupandolo il nimico, non abbia poi un piede fermo nel paese .
2. Che se il nimico non può più esser impedito ne' passaggi, o nel metter pie' a terra ne' luoghi littorali, bisogna ritirarsi ne' l u oghi mediterranei 87 , muniti e vicini l' u no all ' altro, accioché le forze non sieno distratte e ritenute in l u oghi, a quali non si possa portar facilmente soccorso, sì come fece Torquato Conti, doppo che vide che il R e di Svezia avea occupato più p orti, né che si poteva più proibirgli il metter pie' a terra, il quale non ritenne luogo alcuno al mare se non Rostok, Wismar, Colberg e Greifswald, e si ritirò coll' essercito, bisognando sopra il tutto guardarsi d i divider la forza quando s'è inferiore all'avversario.

3. Opporsi anche in campagna coll'armata al nimico, ma ritrin cerandosi fortemente, e campeggiando ne' siti avantaggiosi per i mpedir li ogni progr esso e consumarlo per la lunghezza del tempo, leven d oli i grani, l'acqua et i foraggi e cercando d'affamarlo per riportar la vittoria senza effusione di sangu e. Un fiume, e tal ora un bel muro dietro a cui l'a r mata stà in avantaggio et aspetta il b eneficio del tempo accioché vengano soccorsi da confinanti, che l'ardore del conquistatore s'intiepidisca, che il soldo venga a ma n carg li e c h e la natu r al e i mpazi enza della sua gente, o ch'è compos t a l a maggior p arte di volontarie e d'avventu ri eri, s i disparga; e bisogna con ogni diligenza osserva r e di non dar agio al nimico di formar un assedio, o prevenendolo, e gettando gente di rinforzo nella piazza ch'ei pensa di occupar o essendolisi posto adosso, ch'ei non possa provedersi di foraggi e delle cose necessarie all'assedio; et anche bisogna osservare c h 'e i non pig li alcun posto d'impo rtanza per in te ll igenza, e però se in una città son parti e dissensio ni , bisogna q uietarle, perché la parte che meno confida nelle sue forze suol chiamare il soccorso del nimico e se con qualche sortita potesse far danno al ni mico, lascia di farlo per tema d'esse r serrata fuori della città nel suo ritorno.
87 È qui esposto il pr in cipio d i ritirarsi n e ll' interno ("luoghi m edit erra n e i") ri nu ncia nd o a co ntes t are il l itorale ad un nemico il quale abbi a il dominio del mare, come m ancò invece di fare il Feldmaresciallo R o m me l nel 1944 , p er controbattere lo s bar co
A lleato i n No rmandia (ma cfr. : D1ETER 0SE, Entscheidung im Westen, 1944 · Die Oberbefehlshaber West und die Abwehr der allierten lnvasion, Stuttgart, 1982). La cosa riuscl invece per fe t tamente al generale Lee nel 1862 in Carolina Merid iona le e Georgia, dur ante la Guerra C ivi le Ame ri ca na (Cfr .: R . LuRAGHI, Storia della Guerra Civile... , cit ., passi m).
4. S'invigila di danneggiar il nimico ne' passaggi quando egli ha una parte delle genti da un lato e il resto dall'altro e quando marcia disordinatamente, o che si mette a spog liar il paese e si divide, ovvero s'egli è entrato inconsideratamente dentro al paese senz'ass icurarsi le spalle, si cerca di richiuderlo e serrarlo a dietro, per proibirgli che li sieno somministrati i soccorsi de v ive ri, delle genti e de' danari; ovvero si cerca d'attirarlo incautam e nte in luoghi scabrosi, difficili et atti all'imboscata per il vantaggio che si ha della notizia del paese; ovvero si gitta un nervo di cavalleria dentro alle piazze fra le quali il nimico è accampato, accioché li tengano l'armata in travaglio, facciano intraprese sopra li quartieri , rompano i convoi, né la lascino viver in riposo o sicura; ovvero si cerca d'impigliar il nimico in qualche opra difficile, come nell'assedio di qualche piazza della quale non possa facilmente impadronirsi o in altra cosa, per aver poi tempo di soccorrer intanto e far impressione la dove nissuno o pochi facevano resistenza, essendo temerità il commetter la somma delle cose alla sorte d'una battaglia potendo vincer più sicuramente benché più lentamente, né dovendosi punto azzardare quando il pa ese è mal affezionato, e che al successo d'una disgrazia potria sollevarsi e ribbellarsi apertamente.

5. Hann o alcuni, per dividere le forze del nimico, lasciatolo entra r nel paese suo et in prova lasciatogli pigliar di molte terre, accioché mettendo in quelle guardie, diminuisse le sue forze: e per questa via avendolo fatto debole, assaltatolo e vinto. Altri, essendo assaliti, non hanno voluto ire a trovar il nimico ma sono iti ad assalire il paese suo e costrettolo a tornar a diffendere la casa sua, il che molte volte è riuscito bene perché i tuoi so ldati cominciano a vinca re ad empirsi di preda e di confidenza, quelli del nimico si sbigottiscono parendo loro di vi ncitori diventare perditori, in modo che a chi ha fatta questa diversione molte volte è riuscito bene: ma solo si può fare per colui che ha il suo paese più forte, perché, quando fosse altrimenti, andarebbe a perdere; Holck, Maresciallo di campo dell'Imperatore, non s'oppose all'Arnheim, che coll'Armata di Sassonia era entrato nel Regno della Boemia, ma stimando di non esser forte abbastanza per rispigne r l'inimico, quasi per richiamarlo a diffonder il suo proprio entrò nella Misnia, dove espugnò Zwickau, Plan en, Horst et altri luoghi di quella Provincia88
88 Al Velczé (I, 133) non è riuscito di legge r e le parole che seguono, da Et ogni volta sino a nel paese del nimico, per c ui le ha sa ltate .
Et ogni volta che si può gli è molto meglio portar la forza et la sede della guerra nel paese del nimico che averla nel suo, e far a lui quel che da lui si patisce, perch' altrimenti si fà la guerra in casa et altrimenti fuori, in casa s'hanno solamente quegl'aiuti che le forze della patria somministrano, fuori si vince il nimico anche con le proprie forze di lu i, distaccandosi da quello i confederati e sollevandosi i malcontenti, i quali per odio del diuturno imperio e per desiderio di novità, riguardano agli aiuti stran ieri .
6. Devesi sopra il tutto metter in opra ogni sorta di stratagema e <l'intraprese, quando non s'è bastante a combattere apertamente a giornata né a fare assedio reale .

V. Se tu sei attaccato con forze che sono totalmente sproporzionate alle tue, in tal caso bisogna disertar la campagna et abbrugiar tutti i viveri che t u non puoi contenere dentro alle tue fortezze, e parimenti tutte le città e villaggi che tu non puoi guardare, perché val meglio conservarsi in un paese rovinato, che conservarlo per il tuo nimico 89 • Et è in questo, ch e un Prin cipe per acquistarsi il nome di pietoso pr esso il suo popolo (che in tali occasioni gli volta le spalle) diventa crudele a se medesimo; ma gli è piuttosto vizio d'irresoluzione e di debolezza di coraggio ch'ei ritiene, che una vana compassione che abbiamo del male altrui . Ma sì come nissuno bene pubblico può essere senza qualche pregiudizio ai particolari, così un Principe non può disintrigarsi d'un'impresa perico lo sa s'ei vuol compiacer a tutti, et i più grand i et i più ordinari falli che commettiamo in materia di Stato e di guerra, provengono dal lasciarsi portare da questa compiacenza della quale vien pentimento quando non vi si può più rimediare.
1. Si renda dunque inutile tutto ciò che può serv ir al n1mico per sostentamento di mangiare e di bere e per coperto, e l'acque sta~nanti del paese si sono molte volte corrotte col ve len o, perche si può debellare coll'inopia facilmente quel nimic o il quale no n ha altro che quello, che egli occupa con la rapina. Si bruggiano anche tutte le città e villaggi che non si possono guardare, accioché non servano a' tuoi di recettacolo a sfuggir la milizia, e servano al nimico di posto e di magazzino.
E ~uesto disertar la campagna si chiamano i muri della Liv onia, gia propri delle città della Germania, le quali si recavano a
grandissima lode l'aver all'intorno deserti grand issimi dato il guasto a confini, stimando proprio del valore che i confinant i, cacciati dai loro campi, cedessino, né alcuno ardisse di star loro vic ino, et anche stimandosi più sicure, tolto via il timore delle incursioni r epentine.
2. Ciò non si dee però fare se non qu ando non si può altramente diffendere il paese o che ci è un'apparenza grandissima di dover in tal modo rovonar il nimico, perché altrimenti ella è rabbia e non grande zza militare, come fece il Banér, il quale fece abbruggiar da 6 o 7 leghe tutt'all'intorno di Praga, forse per imp ed ir gli Imp er iali di potersi mantenere dentro al suo campo e campeggiarl i contro ; m a perché ess i poteano aver viveri ab bastanza dai paesi ereditari ch'erano loro alle spalle, et anche perché il Banér istesso non avea disegno di fermarsi in Boemia ma di ritirarsi alla giunta degl'Imperiali, si come l'ev ento dimostrò venne in qu ell'atto ad acquistar poca lode 9 0 •

3. E quando tu stimi che in qualunque vantaggio di posto tu fossi, il nimico verrebbe a forzarti, bisogna allora che tu abbandoni la campagna e venga a dividere le tue genti per le città e per le fortezze, acc ioch é il lungo assedio che bisognerebbe eh' ei tenesse dinanzi alle piaz~e e la l unga espugnazione di quelle , lo venga a stancare et annoiare.
E quando non si possono guardare tutte le piazze d'un paese, se ne guardi una sola, la migliore, per non perderle tutte, perché se il paese t'è affezionato e la fortezza nella quale ti r itiri sia per natura e per arte quasi inespugnabile e fornita di viveri a molt'anni, bisogna che il nimico tenga sempre necessariamente un'armata in piede dentro al paese per paura della ribellione, alla quale invigilano i sudditi che confidano tuttavia nel P rincipe, e nella città principale veggono salva; sì ch e avendo a mantener sempre un essercito, c'è speranza ch'ei non lo possa durare a lungo, che deva patire di penuria di viveri e di denari, sì ch e, distruttosi da se medesimo, sia faci le il cacciarlo con poche forze.
Gli Stati grandi e potenti sono quelli che senza aiuto d'altri hanno arme e denari e di che intraprender sempre la guerra, e di questi ve ne sono pochi e non hanno a guardarsi che da lor medesimi, perché un so l nimi co non è assai forte per attaccarli ed è cosa dif-
90 Il M. ind ic a molto esattame nte la d iffere n z a tra la st r at egia d ella terra bruciata e le i n u t il i d e vastazion i.
ficile che le leghe di diversi Principi si possano tutte accordar ad un segno tale, né sussistersi longamente insieme.
Li grandi Stati sono tutti rammassati insieme o sparsi in diversi luoghi.
Qu ei ch'hanno le lor forze tutte unite possono attaccare e diffendersi più potentemente che quei che sono separati, perché portano tutte le lor forze dove il biso gno richiede con più diligenza e più facilità e con meno spesa. Gli altri mettono in allarme e gelosia più mondo, perché fanno frontiera a più gran numero di stati. Nondimeno se gli uni o gli altri sono attaccati, devono servirsi delle diffese proposte di sopra .
1. Non devono però avere fortezze se non buone e in picciol numero, e so lamente sopra le frontiere e nissuna nel cuor dello Stato, perché avendo essi più a temere le guerre civili che le straniere, e se n za le quali non s'attaccherebbe giammai un grande Imperio, si toglie loro la radice principale che le fa intraprendere e sussistere, perché non fotendo un Capo di sedizione tenersi alla campagna, ha sempre i riffuggio e la ritirata in una buona piazza della quale dev'essere sicuro prima di muover l'armi, et essendo la piazza grande, forte e ben situata, come sopra il litto del mare, in un paese abbondante di viver i e pieno d'assai ri cch i mercanti e buoni artigiani, può sempre tirare le commodità che sono necessarie per il mantenimento delle genti di guerra, sì come servì la R occella a quei de la Reli gion Riformata nell e guerre civili della Francia 91 ; et è cosa sicura che i luoghi forti danno occasione a molti di procedere licenziosamente, confidati in que' castelli dove hanno ricov ero con qualche compagn i armati.

2. Contro i nimici esterni bastano dunque le fortezze di frontiera, le quali coprono il paese et intratengono tanto [fin] ch'egli si ha un essercito formato in piedi, sì che, se il nimico vien a passar questi argini, è ricevuto dall'armata che l'affronta; ma nel cuore dello stato servono alla ribellione, non essendosi mai visto moto civile che non sia uscito da quei claustri o che non vi abbia avuto ricovero.
~- N~ i governamenti si devono perpetuare alle famiglie, né meno m vita.
4. Ma il principal ripiedio contro la guerra civile è l'intrattener la guerra straniera. E ben vero che questa massima non è buona ad osservare che alli stati di quest'ultima spezie, perché sì come a loro è necessaria così ella è dannosa alli stati piccioli che devono temere ogni sorta di guerra, perché non essendo essi assai forti p er profittarn e, corrono rischio d'essere preda del più potente.
5. Il Turco non costuma di fortificar molte piazze, perché nissuno ardirebbe intraprender d'andar assalire alcuna delle principali che non avesse subito sulle braccia un'armata potentissima la quale lo faria ben ritirare. Oltre che quando ei dubita che se ne voglia assalir qualch eduna, vi getta dentro otto o diecimila soldati, e così non si cura d'altra fortificazione.

Chiunque attacca il primo 92 il nimico nelle sue terre e si mette su l'offensiva, bisogna necessariamente che sia il più forte, o vegga de disordini nello stato e h' egli attacca e vi sia chiamato per una delle parti, altrimenti ella sar ia un'impresa temeraria.
I. Chi ha il suo paese situato tal mente che confidi molto nella fortezza della natura del luogo , come il paese de' Svizzeri circondato dalle montagne et il Regno di Svezia separato dalla Germania col mar e et inaccessibile dalla parte di te rra per i boschi e per i monti coperti di n ev i perpetue, può faci lmente uscir a far la guerra offensiva, non avendo da temere ch'altri gli attacchi il paese m e ntre eh' è fuori di casa.
1. Chi vuol acquistar un paese d'altri bisogna necessariamente che faccia guerra offensiva. Ma se ad uno viene denunciata la guerra, chiedesi s'egli debba aspettarla nel suo paese o andarla a rincontrare nel paese d el nimico.
2 . N el paese del nimico s'hanno questi vantagg i: che qu ell o diventa il teatro della miseria e la sede della guerra, e non il suo, perché è spogliato, ruinato, abbruggiato tanto dal nimico, quanto dalle sue proprie genti; le terre vanno in ruina, i paesani sono cacciati, le città spogliate, li borghesi occupati per le guarnigioni 93 o per l'inimico, o abbandonate o smantellate o suggette a contri-
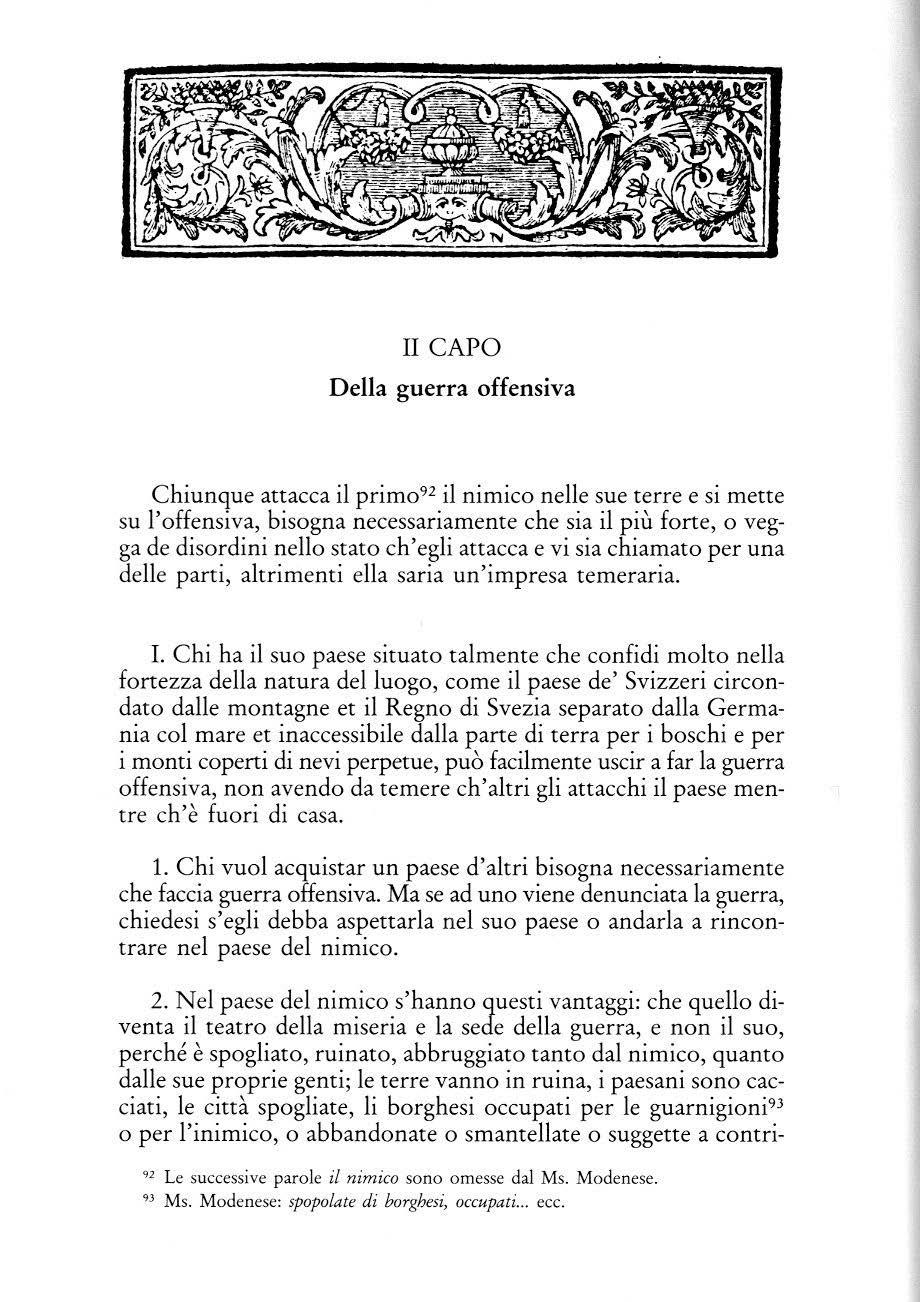
92 Le succ ess ive p aro le il nimico sono omesse dal Ms . Modenese.
93 Ms M odenese: spopolate di borghesi, occupati ecc
buzioni; che si mantiene meglio l'onore, la riputazione e la fama delle sue armi attaccando il nimico in casa sua; che si possono tirare al suo partito molt e città e malcontenti che non aspettano se non l'occasione d'esser sostenuti per sollevarsi, né si sollevarebbono se non vedessino un'armata nimica sul lor paese che li appoggia; che si combatte con maggior prudenza e con maggior ostinazione fuori che dentro al proprio paese, perché i soldati sono tanto più coraggiosi quanto meno hanno di rifuggio, sendo costretti dalla necessità di vincere o di morire, oltre che ordinariamente il coraggio è più grande in colui che attacca che in colui che si diffonde . Che si vinca il nimico colle sue armi, colle sue forze et a sue spese: e ch i non và in casa del nimico a seccarli la fonte delle sue forze , s'inganna per appunto nel modo, come s'ei volesse derivar i fiumi non dalla sorgente de' fonti, ma volesse seccarli e svolgerli nella parte dove sono ammassate gran moli d'acqua.
3. Nel proprio paese s'hanno questi vantagg i: che si può armar e più quantità di gente alla diffesa del suo e gli uomini hanno il coraggio più rilevato di combattere per la libertà, per la patria, per i beni e per la religion e; che il favore delle città, del paese e delle riviere sono per noi, possedendone tutte le\ ommodità le quali si levano al nimico, che è costretto a ricovrare tutte l e provigioni d'altrov e, il che si può fare per qualche tempo ma difficilmente può durare; che combattendo in casa, s'è fra gli amici che aiutano d'uomini, di viv eri, di denari, d'armi, di cavalli e di ritirata là dove il nimico è combattuto da tutte l e incommodità; che il nimico guerregiando ne l nostro paese non può fidarsi alle spie del pa ese, né hanno i suoi buona cognizione della regione sì che il più sovente non può penetrare i nostri cons igli, là dove i suoi sono scopert i e traditi.

4. Stimasi che il Principe che ha il suo popolo armato e stilato alla guerra deva attendere nel suo reame una guerra forte e pericolosa; ma il Princip e che ha i suoi soggetti disarmati e mal agguerriti deva allontanarla il più che può dalla sua Terra, poiché la sua virtù consiste nel denaro e non negli uomini, e però quando la via del tuo soccorso ti fia impedita, tu rimani senza poter far resistenza, né c'è cosa alcuna che tanto ti possa chiudere questo passo quanto questa guerra quasi domestic a.
Ma in questo non si può dare regola certa, bisognando variarla secondo la varietà del suggetto e secondo le circostanze del luogo e del tempo.
L'azione nella guerra si fà intorno alle fortezze, o nella campagna. Qui si considera in generale.
I. Subito che l'armata è giunta insieme, bisogna impi egarla e metterla in azione senza perder tempo, perché nell'induggio sempre si varia e diminuisce qualchecosa del bell'apparecchio, e s'egli è incommodo e molesto il nutrire un sol uomo ozioso è anche più molesto il ~utrir ~na famiglia intiera e molestissimo il nutrir tutto un esserc1to ozioso.
1. L'essercito dev'essere riconciliato a Dio, p erché chi b en comincia ha la metà dell' opra, né si comincia bene se non dal Cielo, ed è assai che si creda che l'aiuto divino assista et accompagni in qualunque azione, perché questa speranza fà gli animi coraggiosi et invitti.
E si conduce fuori l' essercito quando l' erbe sono fuori et i frumenti vicini a maturarsi, ch'è ordinariamente al principio di maggio, o più tardi conforme alla qualità del paese dove si guerreggia, perché la cavalleria deve trovar in campagna di che pascersi, sendo difficil e eh' ella possa esser intrattenuta da magazzini.
2. I Romani facevano più battaglie che assedi perché vedevano che per una rotta dell'armata nimica guadagnavano un Reame in un giorno et a espugnare per assedio una città ostinata cons ummavano gli anni, sì che anticamente le principali azioni della guerra si decidevano in campagna, da che procedevano gli subiti acquisti o la subita perdita de paesi; ora si fà la guerra più da volpe che da lione, e l'azioni consistono più a sorprendere, assalire e diffender piazze che a combatter a giornata. Nondimeno i Turchi et i Persi anche oggidì decidono la più parte delle lor guerre per battaglie e fra Cristiani se ne sono date parecchie in Alemagna in poch' anni: fors e perché le piazze forti non vi sono sì frequenti che nell'Italia e nella Germania inferiore.
Egli è ben sicuro che un'armata ben disciplinata e c he non teme la battaglia ha un maraviglioso avantaggio in tutti i s uoi dissegni contro qu ella che la teme 94
3. Egli è cosa ordinaria che l'azioni si cominciano con più ardore ch'elle non si proseguiscono e che dal principio l'assalitore è focoso, ardito, e coraggioso, ma co l tempo si rende vile, stanco,
94 Tesi la quale mostra come M. apprezzasse appieno il va lore d ell 'in iziativa e della battaglia .
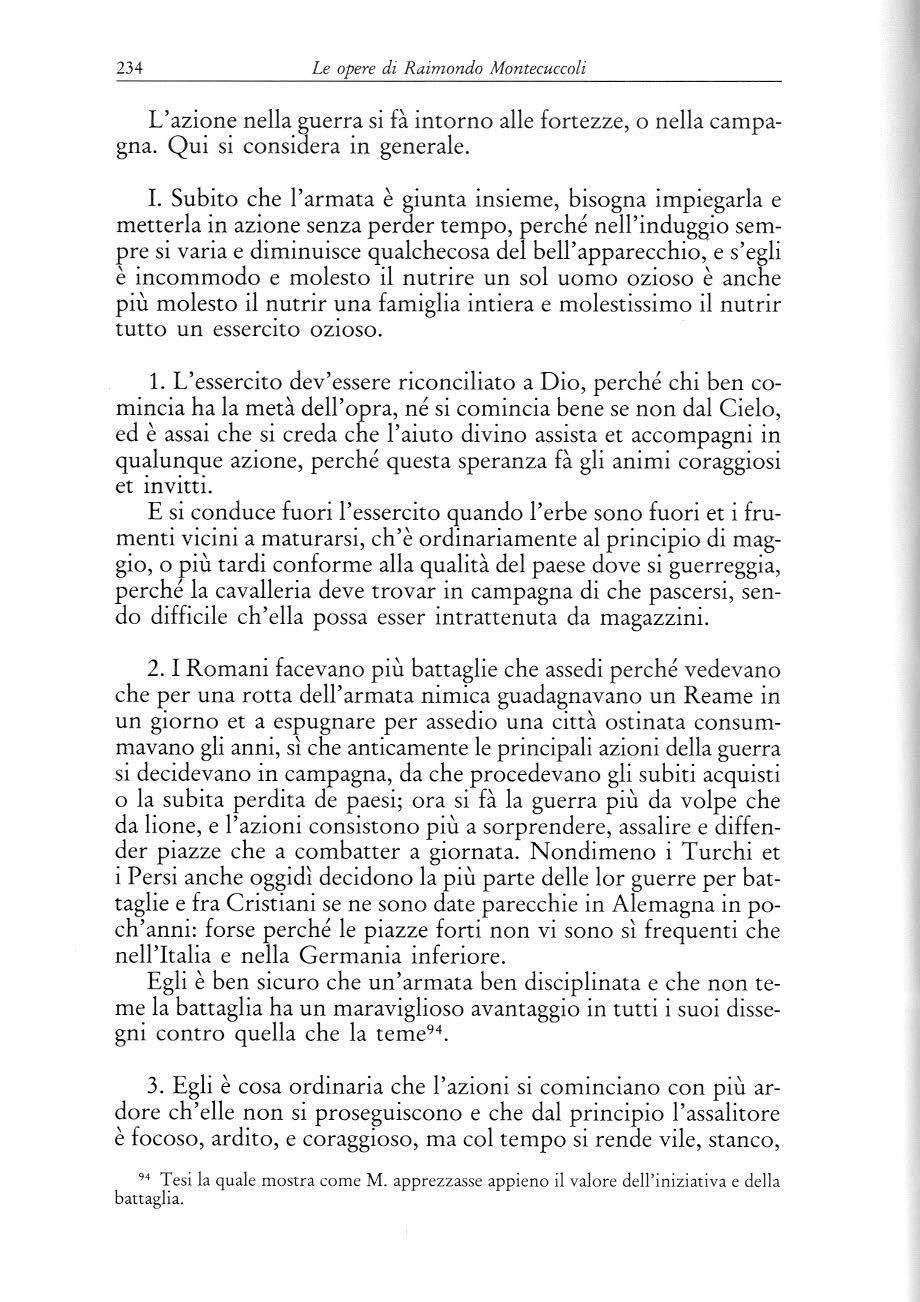
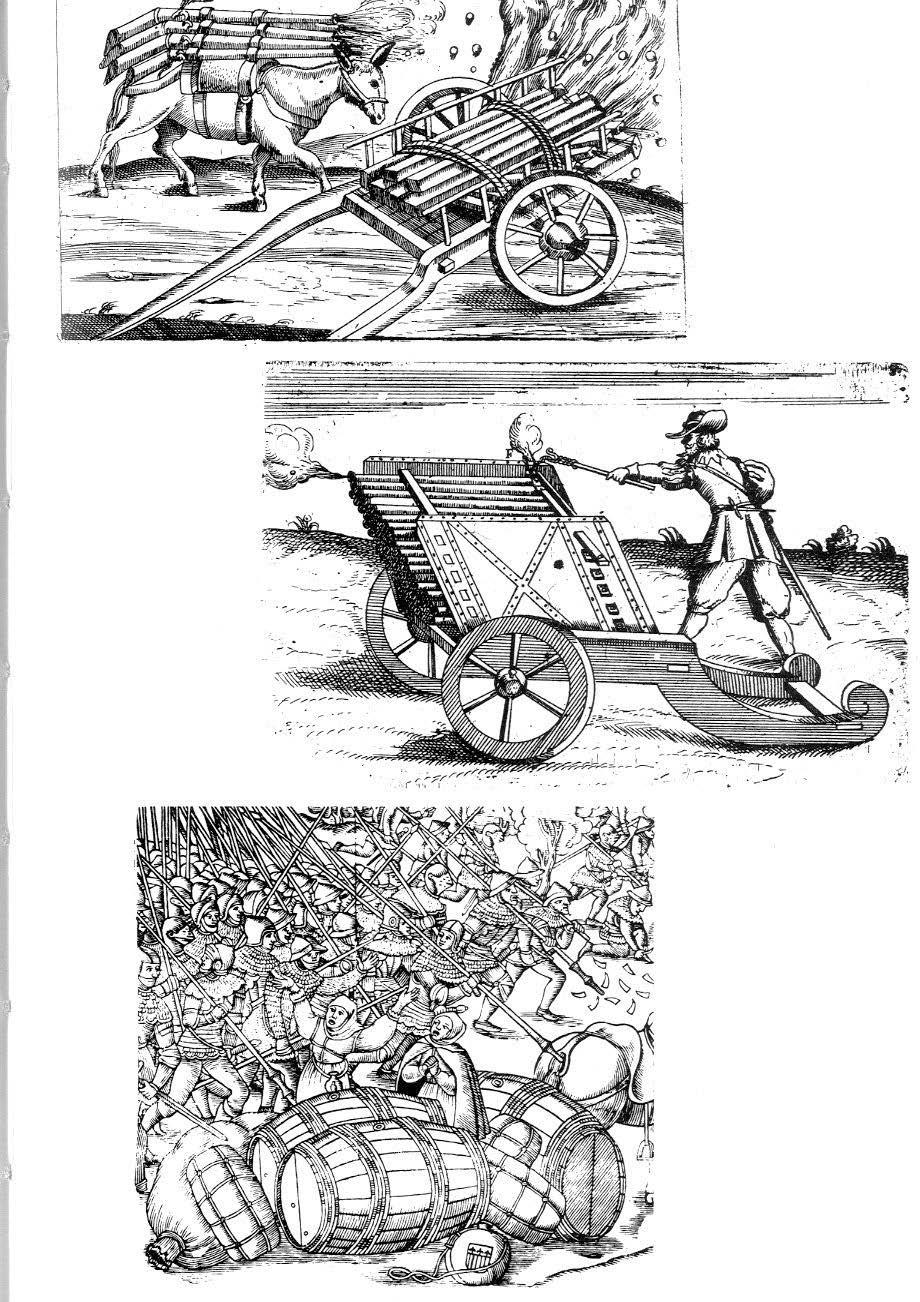

debole e pieno di malattie. E fu un tal Re d'Inghilterra che, portando la guerra in Francia e dubutando o desiderando di ritornarsene presto, prese con seco da 12 cittadini di Londra, e d'altri luoghi del Regno, uomini ricchi, grassi, corpulenti et avve zzi a vita molle e delicata, i quali erano in credito appresso alla moltitudine et avevano sopra tutti gli altri persuasa l'impresa di Francia; ora se ben questi avevano nelle tende e nell' essercito ogni sorta di commodità, in ogni modo non essendo avvezzi a quel genere di vita, subito ne furono startchi e tediosi, né mancò il Re di accrescere la loro noia accioché con tanta maggior veemenza fossero urg enti nella pace e lo sincerassero e pugnassero quand'egli tornass e a casa se per so rte il popolo fusse adirato del suo presto ritorno.
4. La scienza della guerra consiste principalmente a non combattere se non quando si vuole, et a quest'effetto bisogna dar buon ordine ai viveri, essercitar bene i suoi soldati al maneggio delle lor armi et ali' osservanza di tutti gli ordini, e sap er ben fare i suoi ritrinceramenti 9 5 •
Il. Si cerca d'occupar prima i paesi confinanti o circonvicini o che sono fra mezzo e contingui per servir a passar in un altro paese lontano dov' abbiamo de stinato di portare la guerra, e fa cendo correr grido di voler portar la guerra in un luogo si porta in 0pinatamente nell'altro ch'è più a proposito e più opportuno ad avanzar le nostr'armi essendo occupato; e, non essendo occupato, ei può essere più infesto, ed è ricco e util e ed ei può recare maggiore utilità vincendolo che danno p erdendo.
Così il Re di Francia ha cercato d'occupar la Lorena prima che dichiarar guerra all'Imp erator e e per far progressi nell'Italia cerca di possed er la Sav oia et il Piemonte 96 •

1. Alcuni, volendo andar in una pro v incia, hanno finto di v olern e assaltar un'altra et usata tant'industria che subito entrati in qu ella dove e' non si dubitava eh' egli entrassero, l'hanno prima vinta che il nimico sia stato a tempo a soccorr erla: perché il nimico tuo non essendo certo se tu sei per t o rnar indietro al luogo
9 5 Si ribad is ce l'esigenza d i co nser vare se mpre l'inizi at iv a.
96 Ne l 1631 , co n i l T ra ttat o di C h er asco, i Du ch i di Savo ia dovet te r o ceder e la piazza d i Pi nero lo a.Ila F ranci a, co n che si dava prat ic am ente a q uest a il co ntrollo mi l it are dello St ato Subalp in o.
prima da te minacciato, è costr etto non abbandonare l'uno luogo e soccorrere l'altro, e così spesso non diffende né l'uno né l'altro.
2. Gli stati e l'armate si devono tenere in grande riputazione: e per non la perdere, anzi per acquistarla, dovria un essercito nuovo cominciare per cose facili, perché bisogna instare alla fama, la quale segue nell'altre cose secondo il successo delle prime azioni, e Friedland, [era] come un furioso torrente il quale passa per tutto, porta via tutto col suo corso né trova ostacolo che lo ritenga97
E quando c'è qualche verità nelle prosperità de' successi, egli è poi cosa agevole l'aggrandir l'opera con le parole e la ver ità con l'apparenza.
3. L'azione si tenga segreta, ma si facciano i preparamenti necessari ne' luoghi dove si deve agire e s'impedisca per quanto si può la congiunzione dell'armate e forze nimiche, e si tenga sempre divertito e imbaraz zato un gran capo di guerra per rompere il corso de suoi dissegni, perché quando gli s i dà tempo di partorir e quello che il suo intendimento ha concepito, non solamente egli riconsolida l e vecchie ferite, anzi dà nuovamente forza ai membri c h 'avean languito .
Et il tempo che il Re di Svezia diede al Friedland dopo la battaglia di L eipzig, li causò la sua ruina. E quello , che il Tilly diede all'Elettor di Sassonia dopo la presa di Magdeburgo fu parimenti cagione delle sue perdite 98 , sì che devesi con ogni diligenza osservare di tagliar in erba e spegner in faville i dissegni e l e prime levate del nimico.

4. Per la sicurezza d'una grande armata si tiene sempre avanti ad un'ora o due un buon corpo di gente che la copra, che pigli lingua del nimico che mandi sempre fuori partite, e ch'avisi tutto ciò che passa, la qual cosa usava sempre di fare il Conte Galasso.
III. Quando l'armata è molto forte, ella si divide in più corpi per far più azioni in un istesso tempo, attaccando una città in un luogo, dando il guasto al paese in un altro, cercando l'inimico in
97 Il Walle nste in, cioè, spargeva il t im o r e co n il suo stesso nome ta lc h é nessuno osava opporglisi.
98 Viene ribadita l'esigenza di in calzare i l nem ico vinto senza concede r gli t regu a, e la si sost ien e con gl i esempi di errori commess i da due pur grand i cap itani.
campagna col terzo per non avere l' essercito inutile e perché non paia ch'egli si stia ignavamente sotto una città so la.
E colla virtù della celerità hanno Cesare et Alessandro condotto a fine la più bella parte delle lor imprese, e con essa hanno ritenuto in fede gli amici, raffermati i dubbiosi, indotti i nimici a condizioni di pace; e, sorpresoli colle cavalcate veloci, ora lasciando adietro l'Infant eria e marciando colla Cavalleria sola, ora mettendo l'Infanteria a cavallo e facendone Dra goni, ora su le carra, o~a in groppa di cavaglieri e marciando tutta la notte e tutt'il giorno.

Et il Banér soleva dir e che, in prova di chiunque si fosse, egli volea marciare et operare velocemente con l'essercito, la qual velocità e separazione d'armata si dee però temperar e colla prudenza, accioché non arrivi come all'istesso Banér, che , loggiatosi a Cham, Neuburg et all'intorno in faccia del Danubio dove }'Imperiali potevano passare per tutto , senza accamparsi e mandando a far scorrerie nella Boemia, nella Moravia et altrove, fu colto sì all'improvvisi dagl'Imperiali, c he con perdita di più di 4000 uomini si ritirò in confusione e più a similitudine di fuga che di ritirata99 , sì che val talora meglio non andar così presto e sapere dov e si và, che esser ubbligato a fuggir vergognosamente o a perire.
1. Chi và con un'armata in soccorso d'un altro, domanda pa esi e città per salari e spese di guerra, e così i Svedesi chiegono la Pomerania, e qualche luoghi del Mecklenburgo .
2. Chi ha un'armata non troppo forte deve cercare d'impadronirsi di poche piazze ma che sieno d'importanza, accioché pigliandone molte egli no n s ia costretto a disfar l'armata per gua~darle o a riperderle p er non aver armi suff ici enti a soccorrerle. E ben vero che per ottenere la pace bisogna portar la guerra presso la città capitale del nimico, perché i colpi c he minacciano la testa danno gr and 'ap prensione e sono causa di far avanzar i trattati, vedendo il Principe et i ministri la sede d ella guerra nelle case loro; e fu opinione d' alcuni Principi d' Alemagna che pe r aver la pace dall'Imperator e, bisognava portar la guerra nei paesi ereditari di quello .
3. Si espugna talora una città del paese che si assalta prima che avanzar più innanzi, e talora si fà subito impeto ne luoghi medi-
terranei per non da·r tempo al nimico di resistere né di proveder alle cose necessarie alla diffesa di quello; talora si fà accozzare tutta l'armata insieme per fare un grande sforzo, e talo r a si tien separata a diverse imprese, accioché convenendo insieme i capitani non abbia a nascere dissensione fra loro la quale faccia tralasciar la cura di perseguitar i nimici, anzi dia facultà a nimici d'opprimerle.
Tal dissenzione s'è vista più volte ne ll 'Armata di Cesare 100
4. Per fare che i soldati non sieno presi dalla cupidi t à di rit ornar al paese, si fà che piglino moglie ne paesi acquistati e che abb iano con loro ne l campo una certa imagine della sede domestica, e che le fatiche della milizia sien rese p i ù molli con le dolcezze delle mogli. E volendo fa r il soldato ostinato alla zuffa , non si de' permettere che ne mandino a casa alcuna loro facoltà 101 , ma la depongano in alcun luogo a ciò determinato, infino ch'egli è terminata la guerra, accioché intendano che se il fuggire sa lva loro la vita, egli non salva loro la roba, l'amor della quale non suole meno di quella rendere ostinati gli uomini alla diffesa .
Se il Paese , che si attacca è largo et aperto, si deve cercare dal cominciamento d'azzardar la battaglia o qualche gran combattimento, accioché per la riputazione delle sue armi si spaventi i IllmICl.
I. Se il paese è serra t o di montagne o tagliato di riviere e di fosse o coperto di foreste o pieno di fortezze, egl i è cosa difficile di forzar l'inimico a battaglia, et in tal caso bisogna venir agli assedi e far l'acquisto piede a piede, come fanno gli Hollandesi 102 •
1. Ora, colui che vuol far progresso per questa strada deve avere per lo meno due corpi d'armata, accioché con l'uno tenga in iscacco il nimico e con l'altro possa agire se n za essere impedito, perché egli è cosa difficilissima di far il dissegno d'un assedio tanto ch e tu hai una buon'armata campata presso di te, la q uale ti taglierà i viveri. Così il general Galasso facea testa con l'Armata al Banér nella Pomerania e nel Meck lenburgo, e con un corpo
100 Intendasi: del Sacro Romano Imperatore.
10 1 Intendasi: propried persona le.
10 2 Mediant e l' in vest imen to me t odico

di gente dal Klitzingen 103 fece pigliare Domitz,' Havelberg, Rathenau et altre cittadelle.
2. Se il paese è tale che l' ent rata vi sia difficile e che vi sieno pochi passagi per ent rarvi, bisogna forzarne uno prima che passar oltre e fortificarvisi, et assicurare sì bene il cammino de' s uoi viveri che non s'abbia a patire quando il nimico av esse abbruggiat0, o ritirato, dentro alle sue fortezze, quelli 104 del suo paes e .

E se bene si potria forse da per sé trovare o far un nuovo passaggio e fortificarlo, in ogni m odo non r ecano tai passi quei vantaggi che si hanno ne luoghi di passaggio già fatti, perch é s on per lo più già fortificati , né s'ha da fare di perder il tempo in fortifica rli1 05; so no colti 106 da copia d'abitanti c he somministrano la coltura ai cam pi et ogni servizio in casa, dove gli altri sono vuoti d'abitatori; levano la commod ità di qu el passo al nimico, il quale vi potrebb e tener forse guarnigione, restarti alle spalle massime se il paese è stretto e se que' luoghi che r estano a dietro poss ano far gran nocumento; né [è facile] ch e poss ano se rrarsi et imbrigliarsi coll'alzarvi dinanzi un forte, come fece il Galasso dinanzi a Demmin benché poco accortament e et infruttuosamente 107 , o col lasciarvi dinanzi un corpo di gente c h e li tenga blocati; e sì b ene bisogna ce rcar d'o cc uparli, p er tanto più facilmente e sicuramente poter avere le munizioni et i viveri; in ogni modo n on bisogna sprezzare di condisce nd ere a condizioni facili et onorevoli quando si vogliono arrender subite, accioc hé queste picciole occupazioni non facciano perder il tempo dell'azione di maggior acquisti.
Il R e di Svezia domandò subito Gartz e Gr eifswal d al Duca di Pom erania, luoghi posti su l'Oder 108 , per fortificarli et impedir ag l'Imperiali quel transita, et ave r egli il passaggi o libero dall ' una all'altra provincia.
3. P er divertire e t e nere di stratte le forze del nimico in più luoghi, si cerca di passa r in più ve r s i, e, passato , si munisce e si forti-
10 3 H an s Kaspar vo n Klitzingen , ge neral e impe riale, mort o nel 1644.
• 0 • Inte nd asi : i v iveri.
ios Turc o il passo è co ntono e si presta ad equivoci Il Ve_lczé ( I, 146) ha aggirato la difficoltà mediante una ricostruzione d el tutto arbitraria . E com unqu e chiaro che il M. elen ca i va ntaggi ch e lo stesso invasore ha tr aversa ndo passaggi già normalmente percor si.
106 Intendasi: colt ivaci.
101 Di cembre 1637.
103 Al tempo della sua avanzata verso il cuore della Germani a.
fica ben il luogo prima d'avanzarsi, perché egli è cosa piena di pericolo l'intrar molto inanzi in un paese nimico, massima se si hanno a passar fiumi e luoghi stretti senza aver alle spalle luoghi muniti ne quali si possa aver ricovero se si è forzato dai tempi, et il Re di Svezia, quando azzardò la battaglia di Leipzig, volse aver prima nelle mani dal Duca di Sassonia la città di Wittenberg per sicurezza della sua ritirata, né si può sempre lasciar adietro un corpo che tenga blocato o assediato i luoghi del nimico che restan o alle spalle accioché non si diminuisca tanto l'armata che non si possa poi essere mastro della campagna.
II. Se tu sei chiamato nel paese per una fazione, tu ne tiri grande avantaggio perché tu sei instrutto della situazione del paese e de' diffetti che si rincontrano alle piazze che vi sono fortificate, tu non hai mancamento di spie né d'esser puntualmente avvertito di ciò che si passa tra nimici.
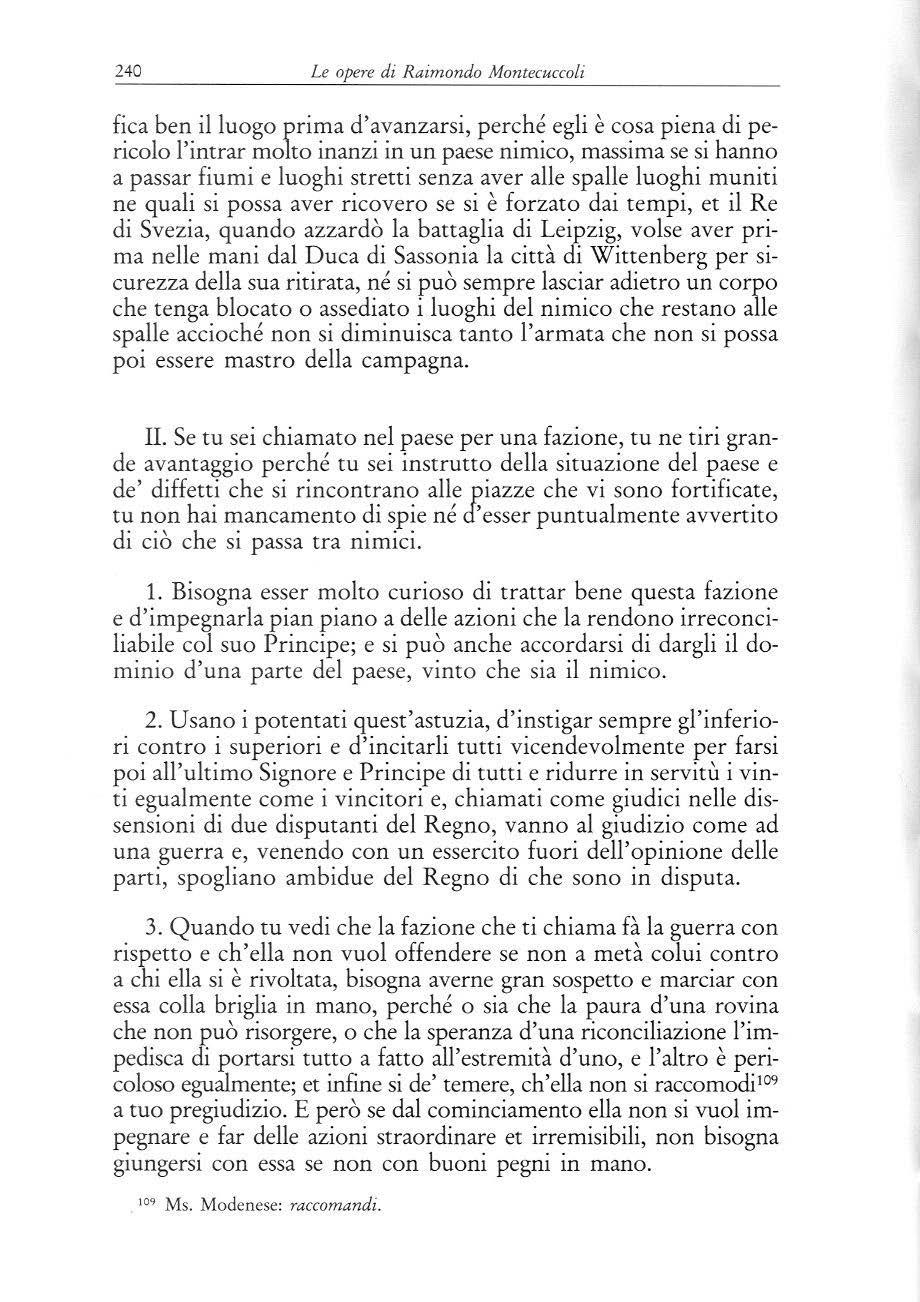
1. Bisogna esser molto curioso di trattar bene questa fazione e d'impegnarla pian piano a delle azioni che la rendono irreconciliabile col suo Principe; e si può anche accordarsi d i dargli il dominio d'una parte del paese, vinto che sia il nimico .
2. Usano i potentati quest'astuzia, d'instigar sempre gl'inferiori contro i superiori e d'incitarli tutti vicendevol m ente pe r farsi poi all'ultimo Signore e Principe di tutti e ridurre in servitù i vinti egualmente come i vincitori e, chiamati come giudici nelle dissensioni di due disputanti del Regno, vanno al giudizio come ad una guerra e, venendo con un essercito fuori de ll 'opinione delle parti, spogliano ambidue del Regno di che sono in disputa.
3. Quando tu vedi che la fazione che ti chiama fà la guerra con rispetto e eh' ella non vuol offendere se non a metà co l u i contro a chi ella si è rivoltata, bisogna averne gran sospetto e marciar con essa colla briglia in mano, perché o sia che la paura d'una rovina che non può risorgere, o che la speranza d'una riconc iliazione l' impedisca di portarsi tutto a fatto all'estremità d'uno, e l'altro è pericoloso egualmente; et infine si de' temere, eh' ella non si raccomodi 109 a tuo pregiudizio. E però se dal cominciamento ella non si vuo l impegnare e far delle azioni straordinare et irremisib ili, non bisogna giungersi con essa se non con buoni pegni in mano.
109 M s Mod en ese : raccomandi.
4. Bisogna ancor trattar con ogni umanità, clemenza e liberalità quelli che volontariamente si rendono a te, e molta severamente quelli che ti resistono, perché la benificienza agli uni e la severità agli altri sono i due mezzi principali che ti danno l'ubbidienza. Una città presa a forza e maltrattata, o una che si rende di buona volontà e ch'è favorita, apre la porta a una dozzina d'altre, come per lo contrario una città presa a forza e risparmiata, o una che si rende di buona volontà e ch'è mal trattata, la serra a molte altre. Onde si ha a concludere che un conquistatore deve far valere la sua parola tale quale egli l'ha promessa, sia in clemenza o sia . . ' m seventa.
Né si può credere quant' affezione si acquisti in un paese nuovo con un grand'atto di umanità usato a proposito e diffendendo un popolo dall'ingiurie e dall'insolenze de' soldati: molt'altri s'arrendono, che è un grande effetto d'un essercito ben disciplinato, della qual disciplina si discorrerà qui appresso, et è grande stimolo a' popoli d'arrendersi quando veggono che quei che s'aggiungono alla tua amicizia godono miglior condizione et imperio più dolce che gli altri, onde fra gli assiomi militari non si dee trascurare di farsi amici gli abitatori di quella Pr ov incia dove si mena la guerra110•
5. Quando si può vincer il nimico senza pugna e senza ferite, avendolo ridotto in luoghi angusti dove si gli tagliano i viveri, per- I ché azardar un combattimento nel quale benché prospero, si perde sempre qualcheduno de suoi? E perché tentar la fortuna?
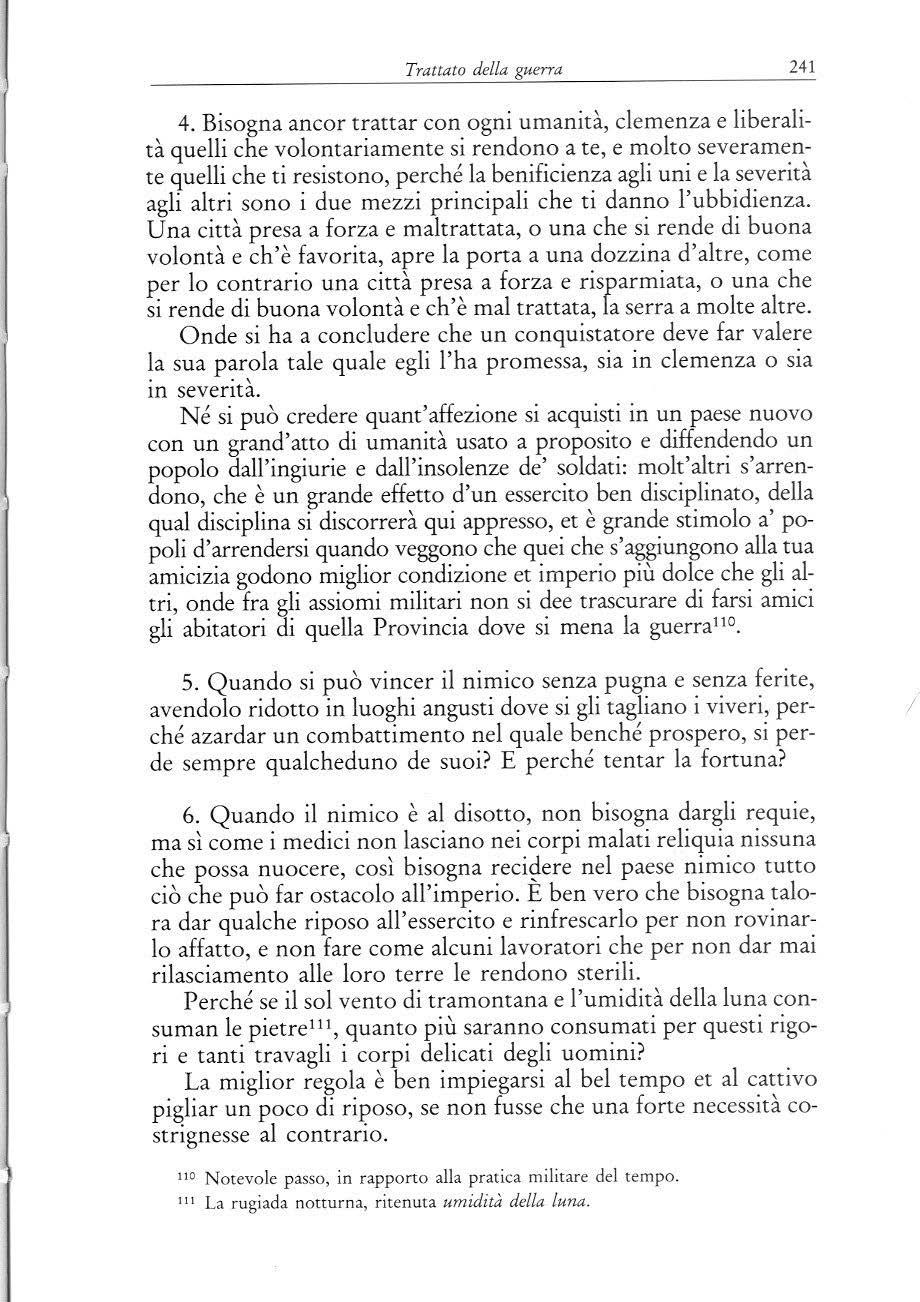
6. Quando il nimico è al disotto, non bisogna dargli requie, ma sì come i medici non la sciano nei corpi malati reliquia nissuna che possa nuocere, così bisogna reci1ere nel paese nimico tutto ciò che può far ostacolo all'imperio. E ben vero che bisognatalora dar qualche riposo all'essercito e rinfrescarlo per non rovinarlo affatto, e non fare come alcuni lavoratori che per non dar mai rilasciamento alle loro terre le rendono sterili.
Perché se il sol vento di tramontana e l'umid ità della luna consuman le pietre 111 , quanto più saranno consumati per questi rigori e tanti travagli i corpi delicati degli uomini?
La miglior r egola è ben impiegarsi al bel tempo et al cattivo pigliar un poco di riposo, se non fosse che una forte necessità costrignesse al contrario.
110 Notevole passo, in rapporto alla pratica militare del tempo .
111 La rugiada notturna, ritenuta umidità della luna.
Così faceva il Duca di Friedland, e così vuol la ragione, perché di verno tempo non si possono mantener gli ordini, sì che tutta la fatica che s'è messa in disciplinar bene un essercito riesce frustratoria, l'armata sta semp re in pericolo e si consuma senza poter fare gran danno al nimico, perché assedi d'importanza non si possono intraprendere, non potendosi travagliar in terra et essendo suggetto a molte altre incommodità, né si può anche attaccar il nimico, perché si suppone eh' egli sia loggiato sì bene e sì avantaggiosamente che con poco suo patimento ti possa resistere e cagionarti grandissimo disaggio.
E se il R e di Svezia era solito di guerreggiar anche il verno, l'affezione commune di tutto il paese che l'aiutava per tutto dove egli arrivava, la paura che col tempo s'intefidisce l'ardore col quale la lega de' Protestanti era cominciata et i furore straordinario di una fortuna prospera per la quale la temerità istessa gli ri ven iva in gloria, n'erano in causa, le quali cagioni rincontrandosi in un conquistatore, se ne può seguire l' essemp io 112 •
L'azione è retta, ovvero obliqua. L'azione retta è quella che và per la via piana e militare, l 'azione obliqua è qu ella che và per la via occulta e per i vicoli deile fraudi e dell'astuzia detta stratagema. L'una e l'altra si fà intorno alle fortezze o nella campagna.

I. L'azione delle fortezze considera la loro fabrica, guardia, presa, diffesa e soccorso, di che distintamente s'è trattato nella Pecorina I, II, III, IV. E si può aggiungere:
1. Che nella guardia delle piazze, trovandosi mancamento di sale, se ne può fare dall'urina dell'uomo, sì come intendono i distillatori, et avendosi mancamento di acqua si può attrarre l'aere con una cucurbita e farla risolver in acqua, ovvero metter il sale di tartaro in un luogo umido, che si solverà tutto in acqua, poi distillandolo. L'acqua s'est rae dolce, et il sa le rimane asciutto nella quantità di prima, ma in tutte queste cose si richiede grandissima quantità di legna per abbruggiare e far fuoco.
2. Nella presa s'è molte volte astretto a cingere d'assedio una città per impedire le sortite della guarnigione che recano troppo
112 M. elenca rapidamente le condizion i per c ui, sostanzialmente, i l tempo lavora va contro il r e di Svezia.
danno et inquietano l' essercito, et attaccata una volta una piazza non s'abbandona facilmente l'attacco per non render di minor peso la sua fama, con la quale si vince e si opera tal'ora più che coll'armi e per non lasciar un luogo ch'è quasi testimonio che tu puoi esser vmto.
Si procura d 'att irare nel suo partito la città principale o la metropoli d ella provincia, accioché l'altre minori, mosse poi dall'essempio, la seguano, e s'è desiderato in una città per avervi molti debiti, perché i creditori bramano il tuo ritorno et augurano che le tue facultà sieno grandissime, e così il Re di Spagna tiene impegnata G enova nella sua protezione; ovvero s'è desiderato per la consuetudine e per la conoscenza che hai avuto per l'innanzi con le donne di quella città, le quali movono facilmente i mariti a commiserazione e le nità .
Talora si occupano all'improvviso le piazze meno forti e meno munite e si togl iono con celerità al nimico che non vi pensa, poi, occ upate che si hanno, si fortificano, e si muniscono gagliardamente che n on possano essere ricuperate; e ne luoghi più forti e men esposti ai stratagemi, se si possono comprar i Governatori con denari, si devono dar e lib eralissimam ente né spavantarsi per alcun prezzo, perché s'avanza il tempo et anche la spesa dell'assedio.
Tal' ora si attacca la città più debole, accioché espugnata facilmente, dia essempio all'altre più forti di rendersi; e s ' ella ha commesso qualche atto infame di ribellione o d'altro crime atroce, bisogna coll'essempio del s uppli zio spaventare gli altri, come Cesare, il quale fece ·tagliar le mani a tutti quelli di Cadenae ch'avean portato armi e donò loro la v ita, accioché tanto più fosse testificata la pena degli improbi; e se non si vogliono castigar tutti , conoscendo eh' essi temono per la cosc ienza del misfatto, per lib erare tanto più presto la città dalla paura si chiede al supplicio il principale della sceleragine et il concitatore della ribellione, e questa è una crudeltà detta da un gran politico ben usata, che s' eseguisce in un tratto e poi lascia gli animi liberi dal timore e gli addolcisce co' b enefici che si vanno ins t illando poco a poco.
E molte volte la moltitudine degli oppidani non aspetta la forza, ma tradendo fuori tutte le cose sacre con la religione delle quali sogliono pregare gli offesi et irati animi dei Re, vanno a rincontrare il capitano e se gli rendono; così uscirono tutti i consuli da Stuttgart a rincontrare il Re d'Ungheria, chieder perdono e consegnargli le chiavi della città, e così le Principesse e dame di Berli -

no uscirono incontro al Re di Svezia eh' avea piantato i cannoni contro alla città per placar il suo animo 113 •
3. Non si pensa a un assedio prima che di aver pensato alla prov igione de' viveri, i quali si d evono tirar dentro al campo fortificato per tanto tempo quanto si st ima che l'assedio deva durare, o che il nimico possa impedir il foraggiar alla campagna, e chi è mandato innanzi, se per qualche accidente si trova in tal stato che tema la sortita di quei di dentro, deve mandar dentro qualcheduno che tratti di condizioni di pace, d'accordo o d'altro, accioché mentre essi deliberano, il tempo si passi, e se non bastano i primi se ne mandano anche dopo degli altri ovvero se si hanno ostaggi della città si mandano quelli a trattare, il quale stratagema si usa anche tal volta da quei di dentro , come fece il Marescial di Campo Horn a Bamberg, che, attaccato dal Pappenheim , fece toccar il tamburo chiedendo parlamentare quasi volesse rendersi, e mentre gli Imperiali erano trattenuti nei trattati, messe le cose più care su le mani, passò colla gente in battaglia oltre il R eno per di là della città 114 .
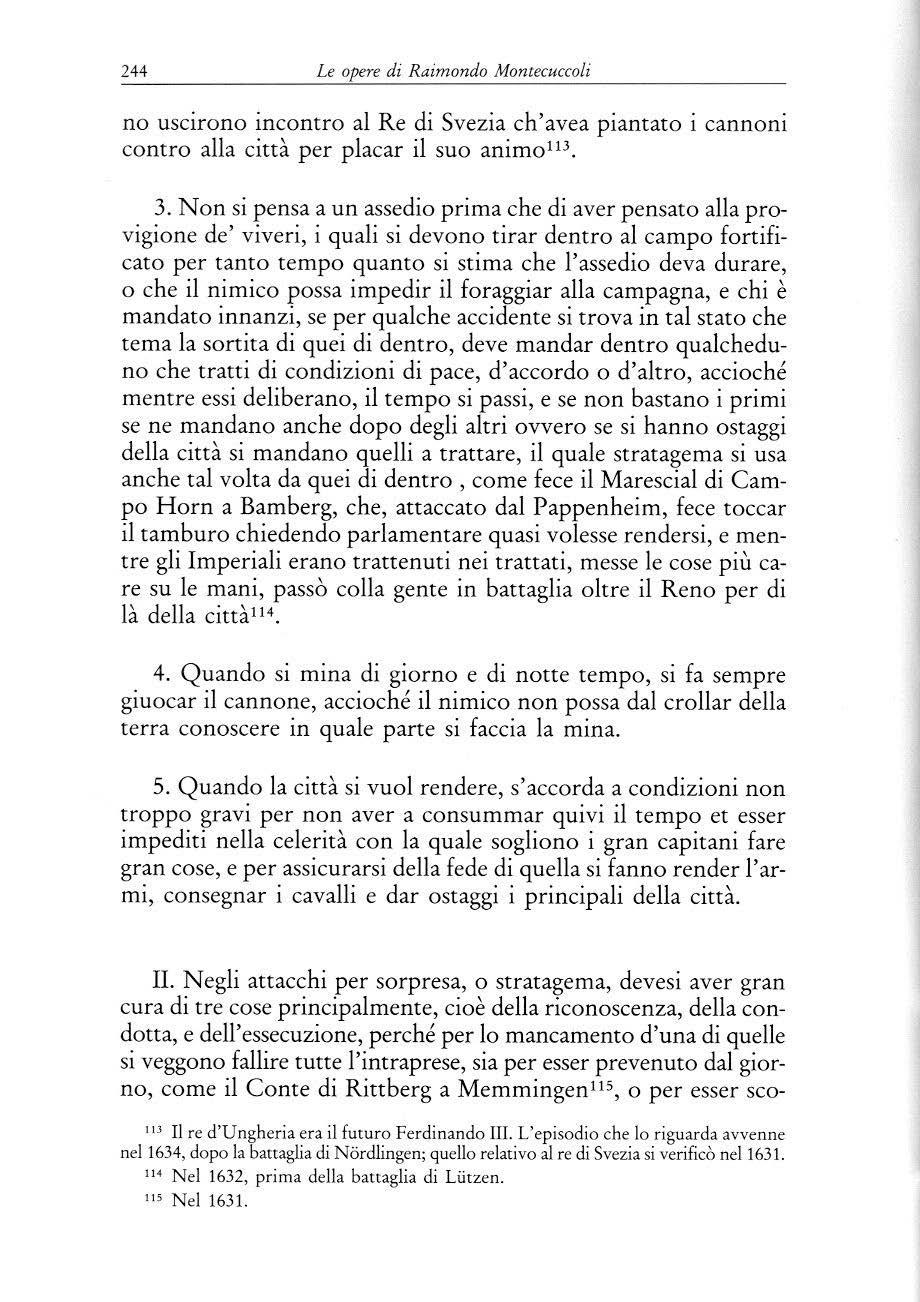
4. Quando si mina di giorno e di notte tempo, si fa sempre giuocar il cannone, accioché il nimico non possa dal crollar della terra conoscere in quale parte si fa ccia la mina.
5. Quando la città si vuol rendere, s'acco rda a condizioni non troppo gravi per non aver a consummar quivi il tempo et esse r impediti nella celerità con la quale sogliono i gran capitani fare gran cose, e per assicurarsi della fede di quella si fanno render l' armi, consegnar i cavalli e dar ostaggi i principali della città.
II. Negli attacchi per sorpresa, o stratagema, devesi aver gran cura di t re cose principalmente, cioè della riconoscenza , della condotta, e dell'essecuzione, perché per lo mancamento d'una di quelle si veggono fallire tutte l'intraprese, sia per esser prevenuto da] giorno, come il Conte di Rittberg a Memmingenm, o per esser sco-
1 13 Il re d'Ungher ia era il fut uro Ferdinando III . L'episodio che lo riguarda avve n ne nel 1634 , dopo la baccaglia di Nordlingen; qu ello relati vo al re di Svezia si ve rifi cò nel 1631.
ii< Nel 1632, prima della battaglia di Uitzen.
m N el 1631.
perto troppo a buon ora, o per mancare di qualche petardo o scala o altro stromento, o nell' essecuzione per nascervi disordine.
l. Quanto alla riconoscenza, bisogna che quei che vi son impiegati s'informino esattamente della forma della guarnigione e del numero di borghesi e della loro affezione, e che osservino benissimo le porte, i ponti, le mura, il fosso, li di fuori, le palizzate, i corpi di guardia, le barriere e tutti gli impedimenti che vi sono dopo la campagna sino dentro alle città, e come tutte queste cose si servano, bisogna riconoscer il cammino che si vuol tenere dopo il luogo dove si parte sin a quello che si attacca, e sì da osservare un luogo proprio a mezza lega dalla piazza che si vuol attaccare, per metter pie' a terra, distribuir i petardi et altri stromenti, insomma si deve ben considerare lo stato delle genti e delle cose necessarie per superar tutti gl' ostacoli che si troveranno.
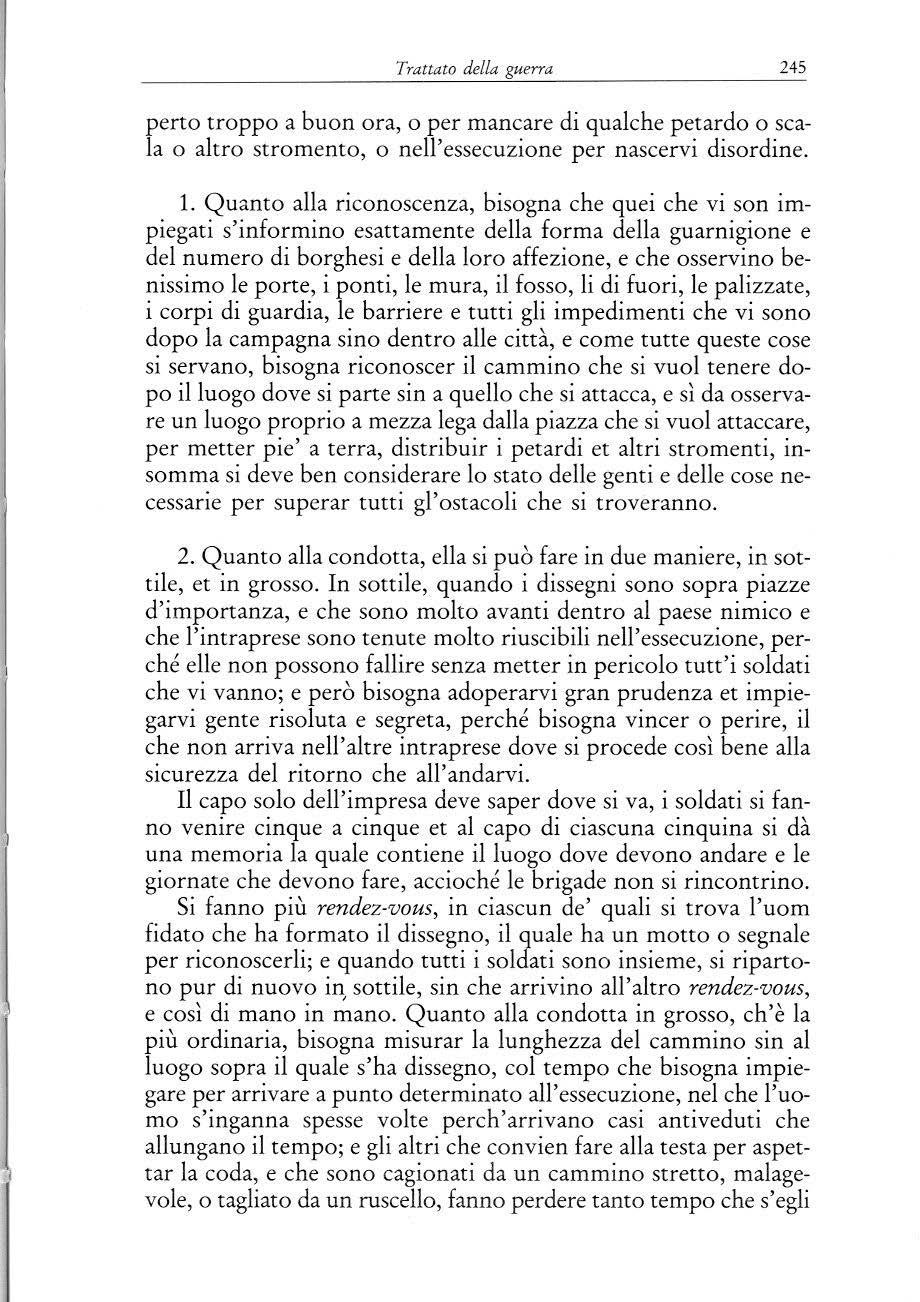
2. Quanto alla condotta, ella si può fare in due maniere, in sottile, et in grosso. In sott il e, quando i dissegni sono sopra piazze d'importanza, e che sono molto avanti dentro al paese nimico e che l'intraprese sono tenute molto riuscibili nell'essecuzione, perché elle non possono fallire senza metter in pericolo tutt'i so ld ati che vi vanno; e p erò bisogna adop erarvi gran prudenza et impiegarvi gente risoluta e segreta, perché bisogna vincer o perire, il che non arriva nell'altre intraprese dove si procede così bene alla sicurezza del ritorno che all'andarvi.
Il capo solo dell'impresa deve saper do v e si va, i soldati si fanno venire cin qu e a cinque et al capo di ciascuna cinqui na si dà una memoria la quale contiene il luogo dove devono andare e le giornate che devono fare, accioché le brigade non si rincontrino.
Si fanno più rendez- v ous, in ci as cun de' quali si trova l'uom fidato che ha formato il diss egno , il quale ha un motto o segnale per riconoscerli; e quando tutti i soldati sono insieme, si ripartono pur di nuovo in, sottile, sin che arrivino all'altro rendez -vous, e così di mano in mano . Quanto alla condotta in grosso, ch'è la più ordinaria, bisogna misurar la lunghezza del cammino sin al luogo sopra il quale s'ha dissegno , col tempo che bisogna impiegare per arri v are a punto determinato all'essecuzione, nel che l'uomo s'inganna spesse volte perch'arrivano casi antiveduti che allungano il tempo; e gli altri che co nv ien fare alla testa per aspettar la coda, e che sono cagionati da un cammino stretto, malagev ole, o tagliato da un ruscello, fan n o perdere tanto tempo ch e s'egli
non si ha fatto riconoscer il cammino e previsto a tutte le cose, non s'ha mai tempo abbastanza 116 •
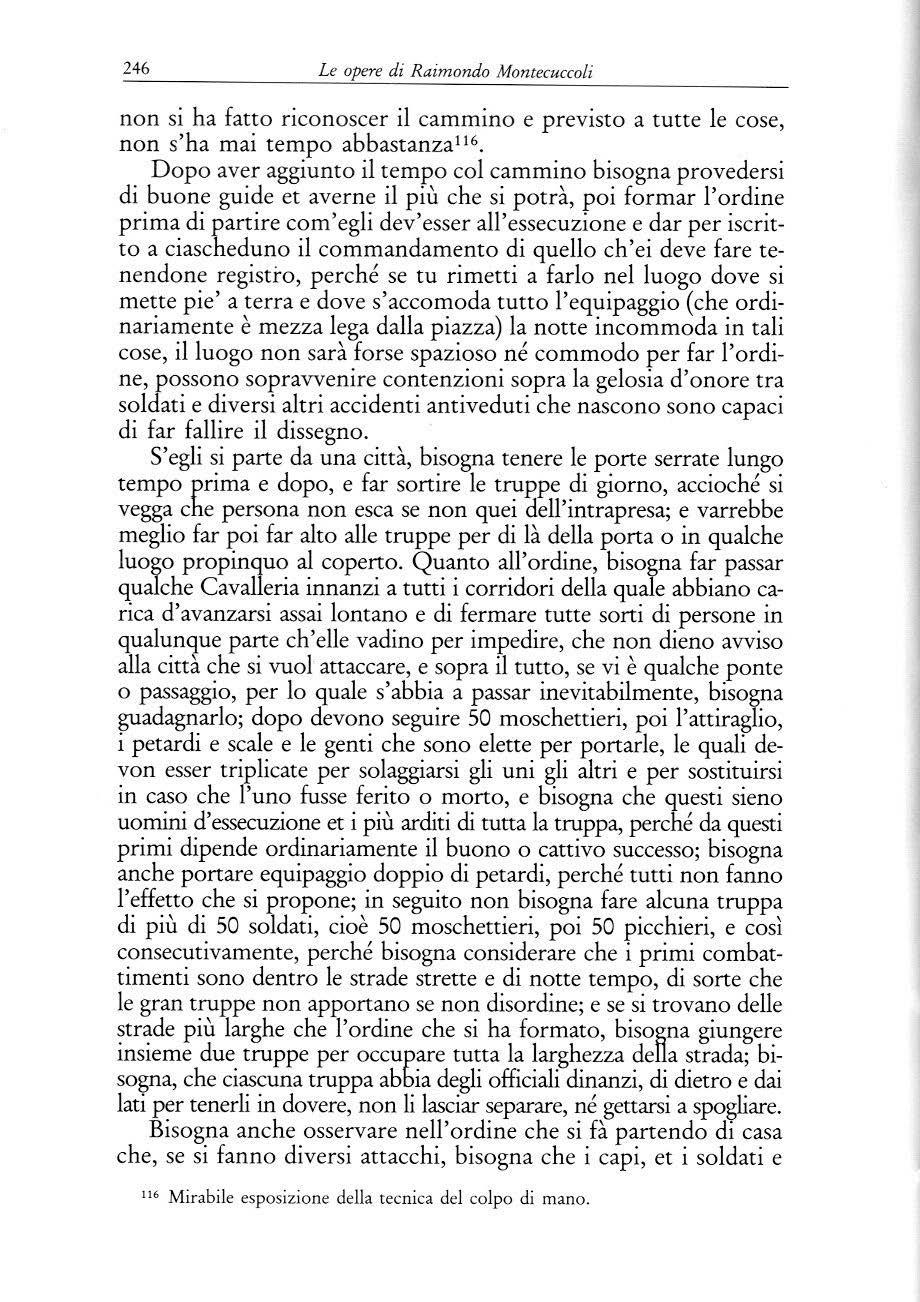
Dopo aver aggiunto il tempo col cammino bisogna prevedersi di buone guide et averne il più che si potrà, poi formar l'ordine prima di partire com'egli dev'esser all'essecuzione e dar per iscritto a ciascheduno il commandamento di quello ch'ei deve fare tenendone registro, perché se tu rim ett i a farlo nel luogo dove si mette pie' a terra e dove s'accomoda tutto l'equipaggio (che ordinariamente è mezza lega dalla piazza) la notte incommoda in tali cose, il luogo non sarà forse spazioso né commodo per far l' ordine, possono sopravvenire contenzioni sopra la gelosia d'onore tra soldati e diversi altri accidenti antiveduti che nasc ono sono capaci di far fallire il dissegno.
S'egli si parte da una città, bisogna tenere le porte serrate lungo tempo prima e dopo, e far sortire le truppe di giorno, accioché si vegga che persona non esca se non quei aell'intrapresa; e varrebbe meglio far poi far alto alle truppe per di là della porta o in qualche luogo propinquo al coperto. Quanto all'ordine, bisogna far passar qualche Cavalleria innanzi a tutti i corridori della quale abbiano carica d'avanzarsi assai lontano e di fermare tutte sorti di persone in qualun9ue parte ch'elle vadino per impedire, che non dieno avviso alla citta che si vuol attaccare, e sopra il tutto, se vi è qualche ponte o passaggio, per lo quale s'abbia a passar inevitabilmente, bisogna guadagnarlo; dopo devono seguire SO moschettieri, poi l'attiraglio, i petardi e scale e le genti che sono elette per portarle, le quali devon esser triplicate per solaggiarsi gli uni gli altri e per sostituirsi in caso che l'uno fusse ferito o morto, e bisogna che questi sieno uomini d'essecuzione et i più arditi di tutta la truppa, perché da qu esti primi dipende ordinariamente il buono o cattivo successo; bisogna anche portare equipaggio doppio di petardi, perché tutti non fanno l'effetto che si propone; in seguito non bisogna fare alcuna truppa di più di SO soldati, cioè SO moschettieri, poi SO picchieri, e così consecutivamente, perché bisogna considerare che i primi combattimenti sono dentro le strade strette e di notte tempo, di sorte che le gran truppe non apportano se non disordine; e se si trovano delle strade più larghe che l'ordine che si ha formato, bisogna giungere insieme due truppe per occupare tutta la largh ezza della strada; biso~na, che ciascuna truppa abbia degli officiali dinanzi, di dietro e dai lati per tenerli in dovere, non li lasciar separare, né gettarsi a spogliare. Bisogna anche osservare nell'ordine che si fà partendo di casa che, se si fanno diversi attacchi, bisogna che i capi, et i soldati e
l'equipaggio sieno distinti in tante truppe quanti si faranno attacchi e ch'elle marcino secondo l'ordine ch'elle devono attaccare. A tutte l'intraprese, e principalmente a quella dove la ritirata è pericolosa e lu n ga, bisogna far più conto de' buon uomini che della quantità, perché una picciola truppa può partire di p iù lontano, marc iar più segretamente e ritirarsi con meno pericolo e confusione, che una grossa.

U n a picciola truppa con molte genti di commandamento è nell'essecuz1one più ubb1ruente e genera manco disordine che una grossa; con una picciola truppa nell'intraprese di notte si spaventa tanto il nimico quanto con una grossa, perché questa è una massima: che quei che sono sorpr esi et attaccati combattono in timore presupponendo sempre ch'altri gli attacchi con forze sufficienti. Se tu vinci con una picciola truppa, tu n'hai più gloria che con una grossa . E se tu sei battuto tu n'hai meno disonore.
3 . Quanto all'essecuzione, tutto l'ordine si deve dar per iscritto accioché nissuno di quelli ch'hanno qualche commandamento nell'intrapresa si possano scusare d'ave r mal inteso. Quando s'è presso al luogo dove l' ess ecuzione si de' fare, s i distribuisce a ciascheduno quello ch'ei deve portare, e per non s'imbarazzare si fa tal'ora m arciare innanzi a piedi 10 uomin i d'arme per riconoscer se il n imico non è sull'avvenuto, poi seguono tre uomini che portano di buone rondacci e per coprire fra gli altri i petardieri, poi marciano quelli che portano i petardi et altri attiragli, li quali s aranno seguiti da SO moschettieri condotti da un capitano p er tirar alle diffese , s'egli è bisogno, con gros si pallini.
Quando il nimico domanda chi và là, bisogna affrettar il passo; allora il petardiere piglia il primo petardo con esso lui , e bisogna che gli altri seguino molto da vicin o, accioché quando il primo petardo avrà giuocat o , il seco ndo sia vicino a mettere nelle sue mani .
Li 10 cavaglieri ch'avranno marciato dinanzi all'equipaggio sin là, n o n avanzeranno più ch e il tiro d'una pistola dalla prima barriera, poi si ritireranno col capitano che conduc e li SO mosch ettieri. Avendo giuocato il primo petardo, l'ufficia le farà mettere le sue genti a dritta et a sinistra per dar passaggio al secondo petardo, poi quell'ufficiale farà l'ist esso p er dar passaggio al terzo; poi quello al ponte a gettare e quelli ai petardi et altri stromenti e cons egu entemente tutt o il resto; e bisogna che quei che sono discaricat i assistino gli altri senza far romore; gli ufficiali devono av er cura che il petardiere sia servito incontin ent e e ch e tutto si faccia senza rumore e senza confusione.
Essendo fatta l'apertura, bisogna che quei che saranno comandati per la prima punta sieno pronti a entrare e forzare ciò che farà loro resistenza; e così anche quei che devono seguitarli e conseguentemente tutti quelli ch'hanno a esseguir qualche cosa; e quando s'è dentro non bisogna che i primi entrati si sbandino molto avanti dentro la città (sin tanto, che saranno ancor deboli) sia in seguitando i nim:ici o sia in non trovandoli : ma bisogna fare due grossi, l'uno per agire, l'altro che si deve solamente metter in battaglia per sostenere; e fatto questo bisogna marciar in buon ordine, gli uni a forzar quello a che sono ordinati, gli altri ad andare a mettersi in battaglia alle strade e piazze, che si ha risolto di pigliare et occupare sopra il piano e disegno della piazza, sul qua le tutto l'attacco deve esser stato dissegnato; perché sebene qualche volta egli è riuscito di seguitare prontamente i nimici per poca gente che si sia dentro, in ogni modo questa non è la via più sicura, perché posson essere ributtati da pochi uomini, il che ha fatto sovente fallire delle intraprese.
Bisogna anche aver un terzo corpo il quale resti fuori in battaglia durante l' essecuzione, accioché se quei che sono entra ti dentro fussino ributtati, li sostenga, ovvero rimedi agli accidenti che potranno sopravvenire di qualche truppe nimiche che per azza rdo arrivassino in questo luogo. S'egli s'è totalmente ributtato, questa truppa da di fuori farà la ritirata e resterà ferma in battaglia, sin che s'abbia raccolto o messo in ordine le truppe rispinte. Ma se quelli che sono entrati si rendono padroni della piazza, il detto battaglione di fuori si separerà all'entrate di quella per guardarle; fatto questo bisogna disarmar gli abitanti prima che deporre l'armi.
Et essendosi ben assicurato di tutti i corpi di guardia e piazze commode, bisogna ripartire le case, accioché ciascuno abbia la sua parte del butino non essendo permesso di buttinar per altr' ordine, e bisogna punire severamente quelli che comincieranno a spogliare; in questo modo si possono ripartire le case migliori a quelli che l'avranno acquistato meglio e far il resto per la sorte, nella quale nissuno non s'ha da lamentare che della sua disgrazia . S'egli è bisogno, ai luoghi che si attaccano per iscalata si disporranno truppe di moschettieri, che tireranno continuamente ai fianchi, e vi s'applicherà se si può lancie a fuoco; e quei, che tireranno conti1'.-ua:Y1ente sopra delle scale, cesseranno quando le lor genti cominc1eranno a montare.

Nell'azione d e lla campagna, o si cerca d'attaccare e costringere il nimico a dar battaglia, o s i cerca di t e mporeggiare e sostenerlo che non faccia progressi, e vincerlo senza battaglia.
I. Si deve cercar la battaglia quando s'ha un altro essercito alle spalle, sì che arrischiando il primo, non si viene per questo ad arrischiar tutta la fortuna, né tutto il paese u7;
1. Quando il t e mpo v à accrescendo le forz e al nimico e ch'egli aspetta un soccorso, che non li è ancor giunto;
2. Quando si stima n ecessario di ribatter un po' della gloria che i nimici pensano d'aver acquistata, mostrando loro che non s'ha p e rso il cuore né la speranza, e presentandosi in battaglia per dar cuore a i s u o i e torlo al nimico;
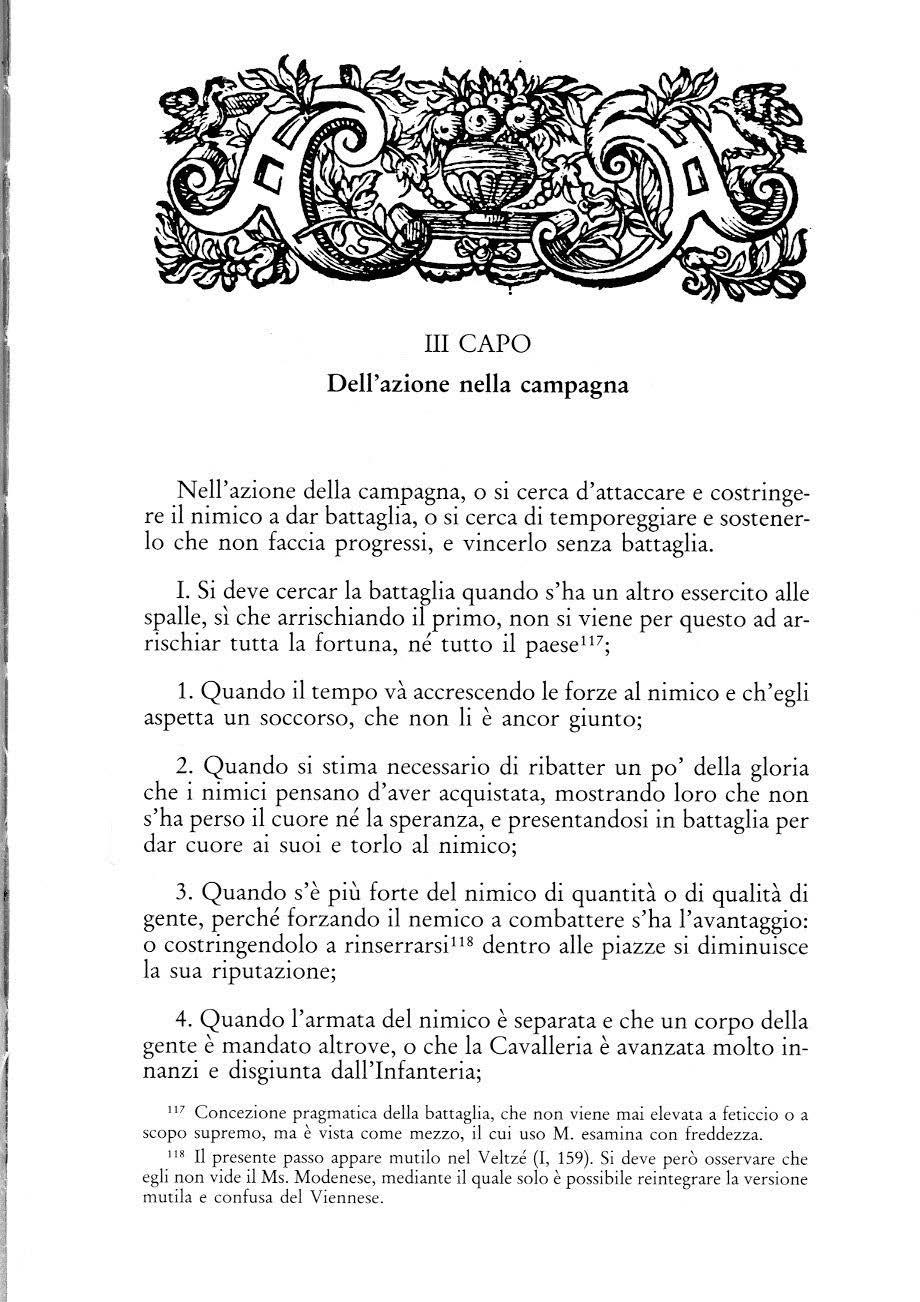
3. Quando s'è più forte del nimico di quantità o di qualità di gente , p e rché for z ando il nemico a combattere s'ha l' a vantaggio: o costringendolo a rinserrarsi 118 dentro alle piazze si diminuisc e la sua riputazione;
4. Quando l'armata del nimico è separata e che un corpo d ella ge nt e è mandat o altrove, o che la Cav alleria è avanzata molto innanzi e disgiunta dall'Infant e ria;
117 Concez ione pragmatica d ella b attag li a, c h e n on vie n e m ai elev ata a fe ti ccio o a sc op o supre mo , m a è vist a co m e mezz o, i l cui u so M . esa m in a co n fredd ezza.
118 Il prese nte p asso app are mu tilo ne l Ve ltzé (I, 159) Si d eve pe r ò osservar e ch e egli non vide il M s. Mo de n ese , mediante il q uale solo è p oss ibi le rei n tegra re la versio n e mut ila e confus a del V ien n ese
5. Quando l'armata è molto forte e che l'inverno è imminente e che 'l paese guasto da suoi propri e da quei del nimico, non può supplire gli alimenti a tanta moltitudine, che fu anche una delle cagioni che mossero l'Elettor di Sassonia ad avventurare la battaglia di Leipzig contro agli Imperiali, allegando che tenendo il nemico la parte migliore del suo paese, il resto non potea fornir di vivere abbastanza 119 alla sua armata et a quella del Re di Svezia;
6. Quando si conosce che il suo essercito è riscaldato di speranza, perché allora bisogna servirsi degli animi e del fervore;

7. Quando il guadagno può esser maggior della perdita;
8. Quando s'è in disperazi9ne, e che 'l nimico t'ha tagliato i viveri, e eh' egli ingrossa giornalmente di numero e di forze e che tu diminuisci;
9. Quando, giudicando senza passione e senz'affetto de l suo essercito e di quello del. nimico, si trova d'esser superiore al nimico in molte cose, avendo prima fatto saggio della virtù dei suoi con scaramuzie e zuffe leggiere, accioché si possa poi guerregiare seconde che si ritrova il nimico, e sendo egli inferiore s'affretti la giornata, essendo superiore s'indugi;
10. Quando si può dar la battaglia in luogo molto opportuno e che si ha alle spalle un paese amico e forte, nel quale senza pericolo si può aver facile ricovero in caso di disgrazia;
11. Quando l'essercito nimico è già stato rotto una volta e che gli animi impauriti della prima fortuna hanno poco vigore a diffendersi;
12. Quando mancano i stipendi o che i confederati si vogliono ritirar dalla lega o che è arrivato qualche altro accidente disavantaggioso, il quale risaputosi da soldati, potria diminuir lor animo e farli mutinare, sì che prima che lo risappino si cerca di venir a giornata. Come anche prima che il sinistro accidente, che si prevede, succeda, mentre che la fede de' confederati è intiera, l'essercito nimico è novizio e bisognoso, et il lor capitano è ferito o malato o absente, e la sua propria armata è fresca et agguerrita;
11 9 Anche questo passo, per la ragio ne cit. alla n. precedente, appare ne l Velt zé (I , 160) confuso e muti lo.
perché a chi conduce un essercito per l'altrui paese e cerca di conquistare, resta un sol modo di salute, cioè ritener in fede gli amici e temere sopra ogni altra cosa di consummar il tempo in far nul- . la, perché se un Conquistatore non avanza, ei ricula.
E così anche quando s'ha rammassato un essercito di ventura di malcontenti e di ribelli; perché, sapendosi di non potere durare nell'imperio se non tanto quanto essi durano nell'insania, mentre çhe la cosa è in fervore e che il timor delle leggi o la riverenza del loro Re o consiglio migliore non occupa ancor loro la mente, bisogna tentar la fortuna della battaglia.
13. Insomma si cerca di far giornata quando s'ha vantaggio, ovvero quando s'è necessitato.
Il v antaggio nasce dal sito, dall 'or dine, dall'aver più, o miglior gente. La necessità nasce quando tu vegga non combattendo dover in ogni modo perdere come e che sia per mancarti denari, e per questo l'ess erc ito tuo s'abbia in ogni modo a risolvere; che sia per assaltarti la fame; ch'il nimico aspetti d'ingrossare di nuova gente. In questi casi sempre si dee combattere ancora contro disavanta:ggio, perché egli è assai meglio tentar la fortuna dov' ella ti possa favorire che non la tentando veder la tua certa ruina; et è così grave peccato in questo caso in un capitano il non combattere, com'è l'aver occasione di vincere e non l'ave r o conosciuta per ignoranza o lasc iata per viltà, e bisogna molto ben considerare se la lunghezza del t empo, la quale si stimava dover minare e consummare le forze del nimico, non abbia piuttosto finito di consumm ar e distrugger te stesso; perché in tal caso bisogna combattere, né far l'errore che commettono i medici paurosi per non ardire di rimediar virilmente alla malattia mentre ch'egli è tempo, stimando che la consummazione delle forze sia dim in uzione della malattia 120 •
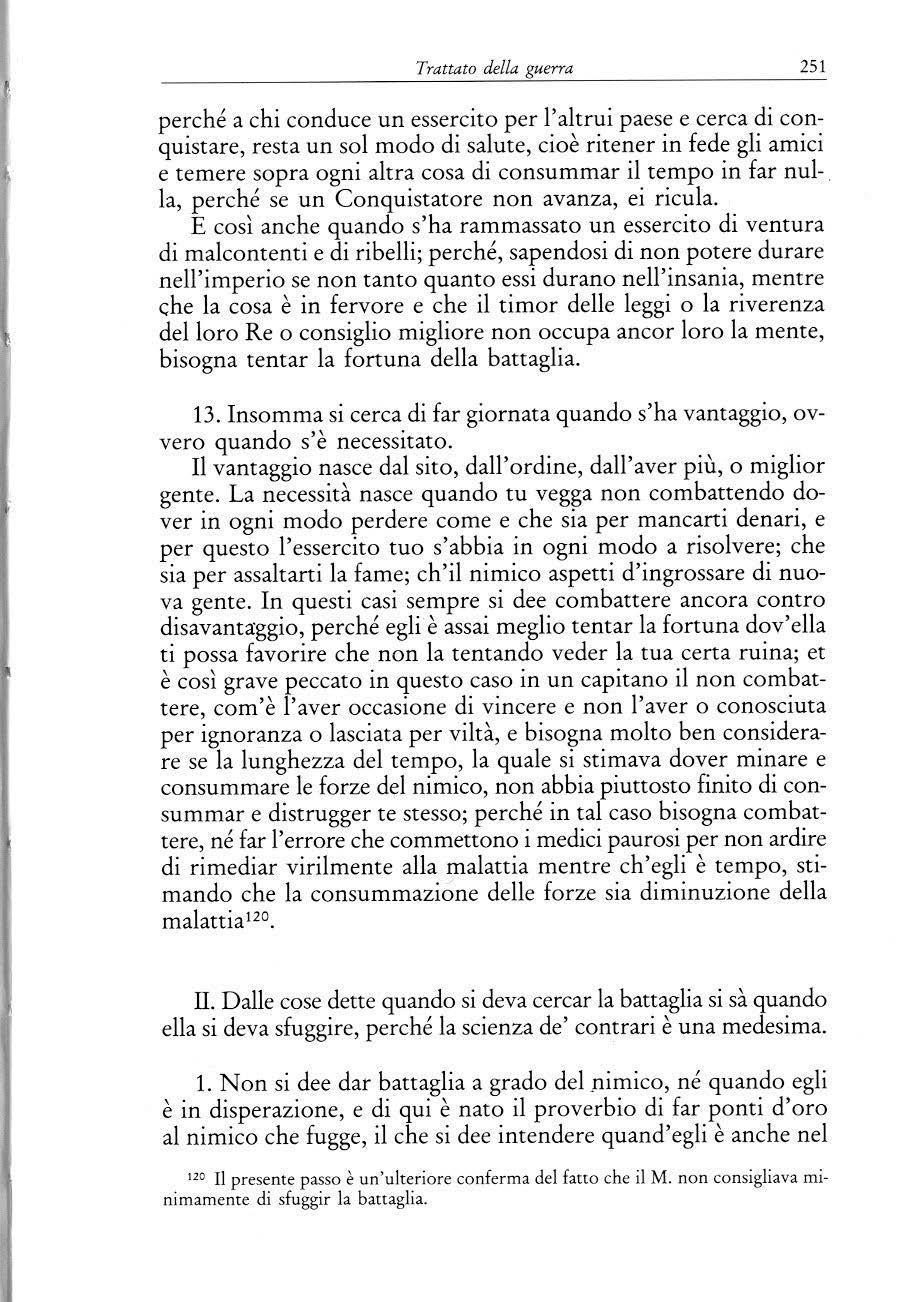
II. Dalle cose dette quando si deva cercar la battaglia si sà quando ella si deva sfuggire, perché la scienza de' contrari è una medesima.
1. Non si dee dar battaglia a grado del .n imico, né quando egli è in disperazione, e di qui è nato il proverbio di far ponti d 'oro al nimico che fugge, il che s i dee int en d ere quand'egli è anche nel
120 Il presente passo è un 'u lteriore conferma del facto che il M. non consigliava minimamente di sfuggir la battagli a.
suo intiero, perché in tal caso vale il consiglio di Aristide e di Temistocle di non romp er a Serse il ponte dello stretto dell ' Ellesponto, anzi piuttosto di fabbricargliene un altro se si potesse, accioché uscisse tanto più presto fuori dell'Europa.
2. Non si dà battaglia quando la perd ita può esser maggi o r e del guadagno e che si viene a porre incontro al poco et incerto il certo e 'I molto, né bisogna l asciarsi trasportare dalla passione di que lli che perdono la pazienza, veggendo distruggersi il lor paese dinanzi a l or occhi, perché gli arbori tagliati rimettono in poco tempo, ma egli è impossibile di ricupe r ar gli uomini quando sono perduti una volta: eh' ei vogliono 30 o 40 anni a far un soldato; né bisogna anche lasciarli trasportare dalle parole ingiuriose che sogliono dir i soldati contro ai capitani, che differiscono e sospendono l a battaglia, accusandoli di _poltroneria o di tradimento o di mancamento di coraggio, perche si mostra d'esser ancor più codardo lasciandosi svolgere dal suo proponimento per paura di parole piccanti e di scorno, non essendo vergogna l'aver timore per il ben pubblico e per l a salute de ll a pat r ia, ma all'o pp osito esse ndo ben disonorevole turbarsi per la stima e per il grido del volgo; e moversi per }'improperi e calunnie degli uomini communi no n è atto di personaggio degno di una gran carica, anzi piuttosto d'uomo servo et ubbidiente a quelli a clii egli dovria comandare e ch'ei dovria governare, perché non son saggi.
Il Conte Galasso sosteneva in simili calunnie l a persona di Fabio Massimo, e rimanendo ne ll e sue deliberazioni, solea dire che sono ridicoli quei capitani che per mostrar gran cuore azzardano ogni dì mal a proposito l'armata e si vogliono farsi credere animosi alle spese dell'altrui vita, che se avessino vero st i mo l o d'animosità dovriano trovar modi e rincontrar occasioni d'arrischiare e far prova de ll a l oro persona, e non d i quella degli altri; egl i è vero, che anche le persone più accorte e più saggie non lasciano qualche volta di calunniar i gran capi perché si fermano sull'apparenza delle cose e giudicano secondo quella, né sapendo le vere considerazioni che ha un generale, fondate sulla verità e non su l'apparenza, giudicano sinis t ramente della sue intenzioni, sì che per isbrigarsi da queste calunnie potria il capo avere per ottimo rimedio l o scoprire le vere cagioni c h e l o inducono a proveder in modo tale, perché i calunniatori ne rimarrebbero appagati né sapriano in che cosa incolparlo; ma la segretezza che si richiede ne grandi affari non permette sempre di palesare le cause del suo procedere, e però non può sempre un generale sfuggire la ma ledicenza.

3. Si dee sfuggir di combattere quando l'armata nimica è composta di soldati agguerriti, vittoriosi et essercitati in più zuffe, e ch'ella è fra piazze che tu tieni ben munite e fortificate et hai speranza che si estingua da se medesimo il vigor delle sue truppe, ch'è come un fuoco di paglia e come una fiamma accesa in una materia di poca durata.
4. Si de' differir la battaglia quando s'aspetta qualche soccorso, per esser poi più forte nella giornata; né bisogna lasciarsi trasportare dall'ambizione di voler avere la gloria tutto solo, come fece Tilly a Leipzig, il quale non ebbe pazienza d'attender il soccorso dell' Aldringen 121 , che veniva d'Italia con 15.000 uomini vittorios i e vecchi soldati, e che non era che tre giornate da lui; e come fanno que' capitani che con ugua l autorità comandano a vicenda, aspettando il giorno ch e tocca a loro il commando, poi senza risguardo d'alcuna opportunità avv enturano la battaglia (che è fra gli altri un disordine ordinario a qu ell'armate che hanno due capi di pari autorità) o aspettano che il collega sia absente o malato o per paura, che sia loro mandato un successore o ch e venga un altro generale di maggior grado , stimulati dall'ambizione, s'affrettano a commetter soli la giornata mal a proposito.
5. Si sfugge il combatter quando s'ha un'armata di soldati nuovi che col tempo si và essercitando, e che quella del nimico è di gente leggiere e infida, che presto lo può abbandonare, o ch'è composto di ribelli o mutini, che promettendo loro perdono si fuggono, il che si fà col spinger innanzi una truppa che con sembiante di vo ler scaramucciare grida altamente che il Re fa gra zia del passato furore a chi ripentito della ribellione si ridurrà innanz i sera ne' suoi alloggiamenti, e che colla sua fede pubblicamente assicura quest o perdono, e di questo tenore si spargono moltissim i biglietti sul campo , poi si accampa l'essercito in luogo avantaggioso vicino al nim ico accioché si possa faci lmente ricevere quei che vogliono rifuggire; e quei ch e rifugono, depongono l'armi alle prime guardie, si lodano, s i premiano e si ha l'occhio sopra di loro, accioché sotto nome di riconciliazione non machinino cose peggi o ri.
6. Quando la sua armata è ben provvista di tutte le cose necessarie p er att endere il tempo e che l'armata del nimico è compo-
12 1 Nella battag lia d i Breitenfeld (17 sette mbre 1631) in cu i T illy, co n sigliato d a P app e nheim, combatté co n tro Gustavo A d o lfo sen za att end ere l' ar r ivo d ei ri nforzi del1' A ldr in ge n e fu graveme nt e sco n fi tt o
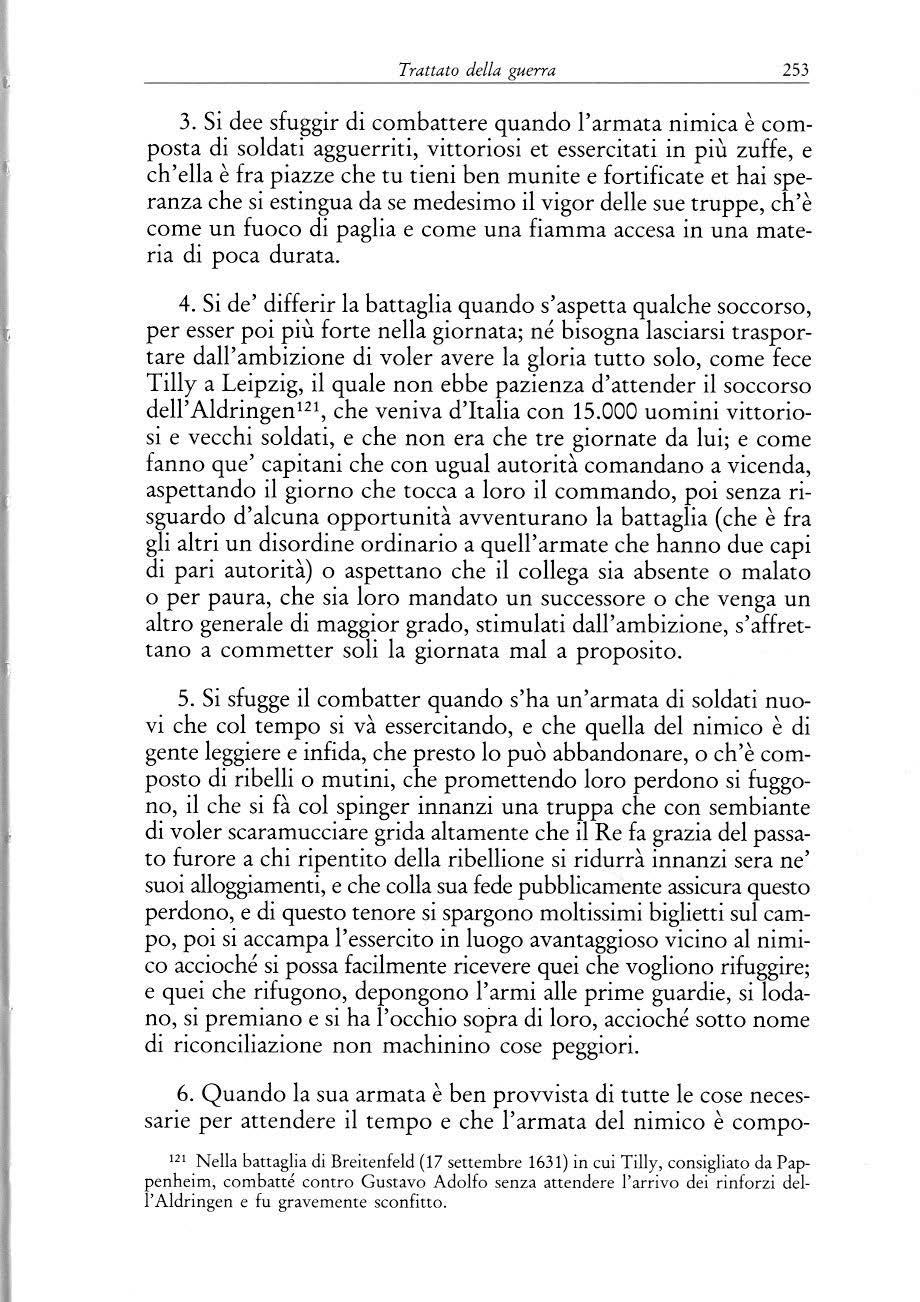
sta di uomini valorosi per un giorno di battaglia, ma che non possono soffrir le fatiche né gli incommodi del campeggiare; o che qualche malatia contagiosa s'è messe fra loro, o si spera si deva metter per il cambio del clima o de cibi, o che hanno mancanza di denari o di viveri.
7 . Quando il nimico è troppo forte di quantità di gente, e s'ha grand' opinione della sua virtù e si vuol prima far saggio con scaramuccie, partite, rincontri e zuffe leggieri, che ardire egli abbia e che ardire abbiano i nostri.
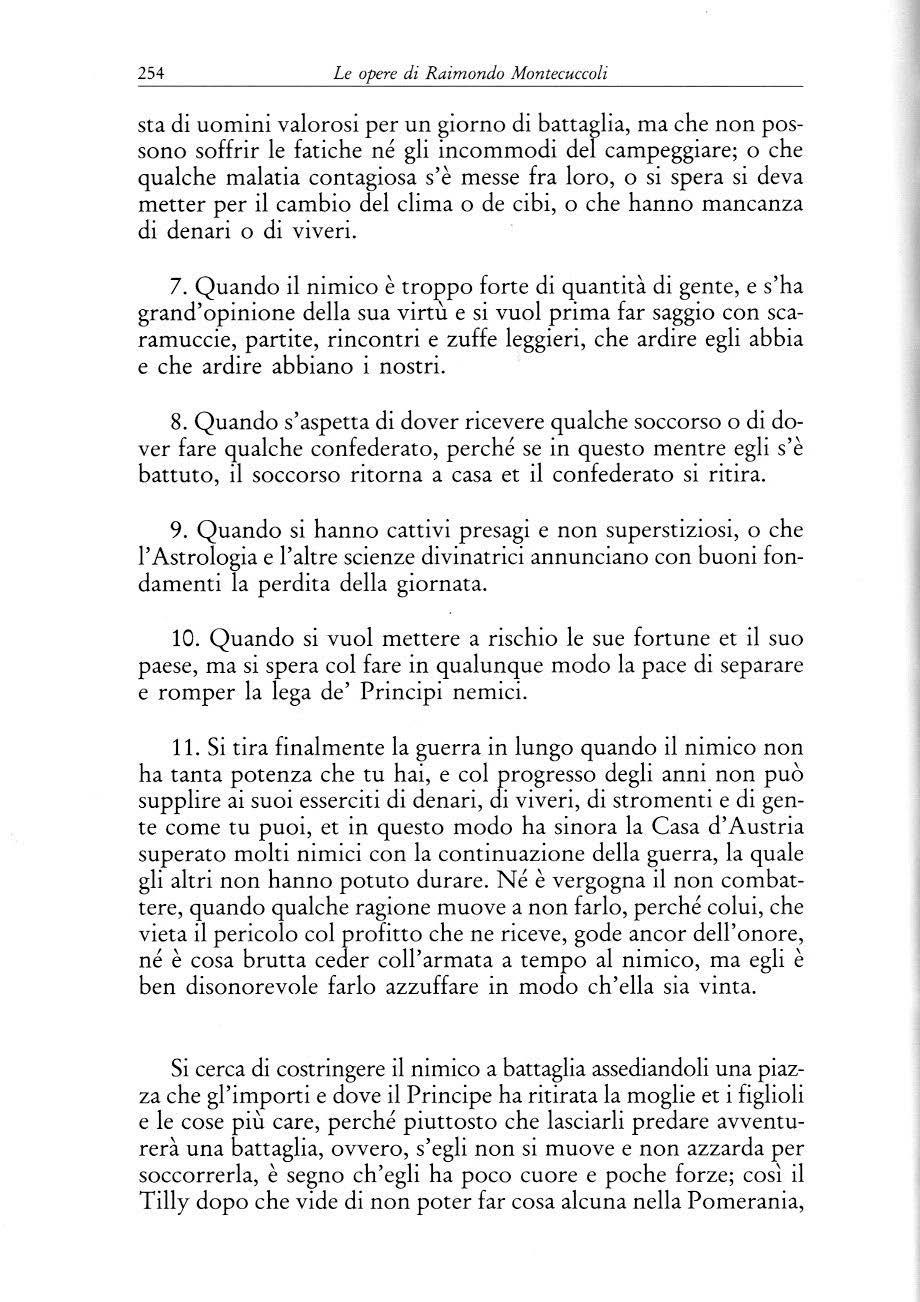
8. Quando s'aspetta di dover ricevere qualche soccorso o di dover fare qualche confederato, perché se in questo mentre egli s'è battuto, il soccorso ritorna a casa et il confederato si ritira.
9. Quando si hanno cattivi presagi e non superstiziosi, o che l'Astrologia e l' altre scienze divinatrici annunciano con buoni fondamenti la perdita della giornata.
10. Quando si vuol mettere a rischio le sue fortune et il suo paese, ma si spera col fare in qualunque modo la pace di separare e romper la lega de' Principi nemici .
11. Si tira finalmente la guerra in lungo quando il nimico non ha tanta potenza che tu hai, e col progresso degli anni non può supplire ai suoi esserciti di denari, di viveri, di stromenti e di gente come tu puoi, et in questo modo ha sinora la Casa d'Austria superato molti nimici con la continuazione della guerra, la quale gli altri non hanno potuto durare. Né è vergogna il non combattere, quando qualche ragione muove a non farlo, perché colui, che vieta il pericolo col profitto che ne riceve, gode ancor dell'onore , né è cosa brutta ceder coll'armata a tempo al nimico, ma egli è ben disonorevole farlo azzuffare in modo eh' ella sia vinta.
Si cerca di costringere il nimico a battaglia assediandoli una piazza che gl'importi e dove il Principe ha ritirata la moglie et i figlioli e le cose più care, perché piuttosto che lasciarli predare avventurerà una battaglia, ovvero, s'egli non si muove e non azzarda per soccorrerla, è segno ch'egli ha poco cuore e poche forze; così il Tilly dopo che vide di non pot er far cosa alcuna nella Pomerania,
essendo occupato e munito dal Re di Svezia ogni passaggio si volse all'assedio di Magdeburgo per attirare il Re ch'egli stimava non dover mancare al soccorso in luoghi avantaggiosi, lungi dagli aiuti propri, dove fosse ubbligato alla battaglia.
1. Arrivando improviso sopra il nimico colla Cavalleria e co' Dragoni, et intrattenendo tanto che l'Infanteria giunga .e si costringa a battaglia; e ciò si fà marciando giorno e notte grande spazio di paese con celerità e segretezza, e così Banér assalì improviso Marazzino e lo disfece.
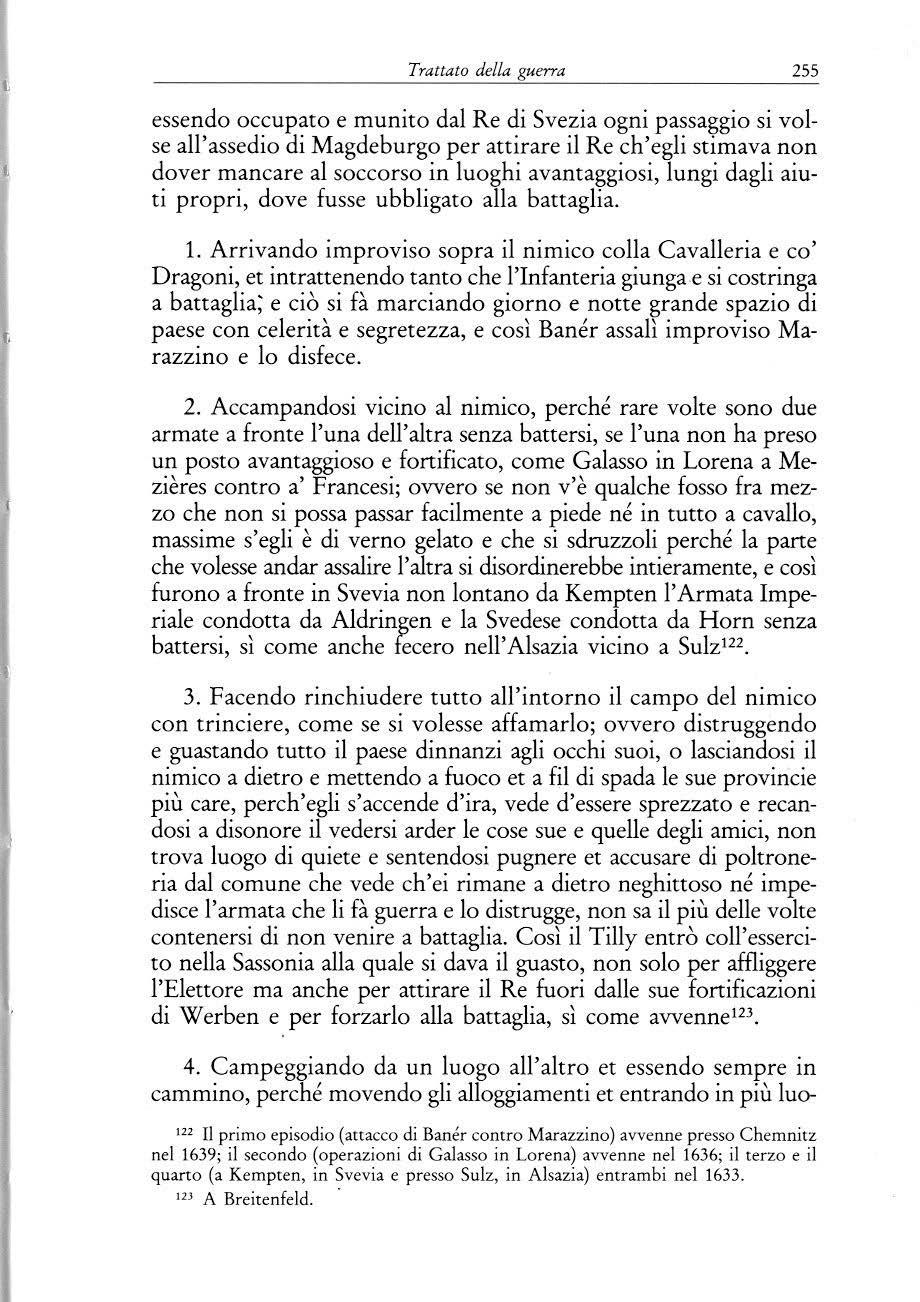
2. Accampandosi vicino al nimico, perché rare volte sono due armate a fronte l'una dell'altra senza battersi, se l'una non ha preso un posto avantaggioso e fortificato, come Galasso in Lorena a Mezières contro a' Francesi; ovvero se non v'è qualche fosso fra mezzo che non si possa passar facilmente a piede né in tutto a cavallo, massime s'egli è di verno gelato e che si sdruzzoli perché la parte che volesse andar assalire l'altra si disordinerebbe intieramente, e così furono a fronte in Svevia non lontano da Kempten l'Armata Imperiale condotta da Aldringen e la Svedese condotta da Horn senza battersi, sì come anche fecero nell'Alsazia vicino a Sulz122 •
3. Facendo rinchiudere tutto all'intorno il campo del nimico con trinciere, come se si volesse affamarlo; ovvero distruggendo e guastando tutto il paese dinnanzi agli occhi suoi, o lasciandos i il nimico a dietro e mettendo a fuoco et a fil di spada le sue provincie più care, p erch'egli s'accende d'ira, vede d'essere sprezzato e recandosi a disonore il vedersi arder le cose sue e quelle degli amici, non trova luogo di quiete e sentendosi pugnere et accusare di poltroneria dal comune che vede ch'ei rimane a dietro neghittoso né impedisce l'armata che li fà guerra e lo distrugge, non sa il più d ell e volte contenersi di non venire a battaglia. Così il Tilly entrò coll'essercito nella Sassonia alla quale si dava il guasto, non solo per affliggere l'Elettore ma anche per attirare il Re fuori dalle sue fortificazioni di Werben e per forzarlo alla battaglia, sì come avvenne 123 •
4. Campeggiando da un luogo all'altro et essendo sempre in cammino, p erché movendo gli alloggiamenti et entrando in più luo-
122 U p ri m o episo dio (att acco di Banér c ont r o Marazzino) avve n ne p resso C hem ni t z nel 1639; il seco nd o (o per azio ni di G alasso in Lorena) avvenne n el 1636; il terzo e i l quart o (a Ke mpte n , in Svev ia e presso Sulz, in Alsaz ia) ent r a m b i n el 1633.
12 3 A Brei tenfeld. ·
ghi tu vieni ad aver più commodamente i viveri e nella marcia puoi rincontrare qualche occasione di combatter il nimico, il quale se ha un essercito non avvez zo alla fatica, si consuma ne' viagg i quotidiani.
5. Cercando di condurre il nimico in un paese stretto, picciolo, povero di commercio, o del quale tu tenga le piazze, i passaggi e le riviere, accioché tagliandoli i viveri e tenendolo serrato et assediato, sia costretto di venir a battaglia o di rovinare. Et in questo punto mancò Galasso dopo aver cacciato Banér dall'Elba e proibitoli l'entrar nella Pomerania, perché se il Galasso avesse dato allora il guasto alla Pomerania di dietro (facil cosa a mett er in essecuzione, perché Demmin non era fortificata e potea pigliarsi subito) poi fosse ripassato l'Oder, entrato nel Mecklenburgo ecostretto Banér a ritirarsi nella Pomerania di dietro rovinata, gli Svedesi erano affamati 124 •
6. Andando a ricontrar il soccorso che dee venir al nimico, per veder di romperlo prima che giunga , ovvero impedirgli la congiunzione, ovvero rivo ltarsi sopra il nimico che vorrà farsi seguitar a farli spalla e combatterlo, ovvero restando con l' esse rcico accampato contro al nimi co e mandando segretamente un corpo di gente a rincontrar improvvisamente il soccorso che li viene et a disfarlo, perché è forzato il nimico a combatter quando se gli attacca un nervo della sua gente, la quale p er riputazione è ubbligato a soccorrere.
7. Quando si cerca di costringere il nimico a battaglia bisogna che il generale si sia prima prefinite diverse forme d'ordinanze e · di campi, accioché possa poi tanto meglio e più splendidamente formar la battaglia e sc hierare l'essercico quando il bisogno ric hi ede . Si usa di averne il disegno in carta e vede rlo spesso e medita~lo; et alcuni capitani usano di fa r semp r e metter in battaglia l'esserciCO ad og ni rendez-vous dove i reggimenti s'accozzano, accioché tutti gli Ufficiali e i soldati sappiano meglio il loro posto e sappiano presso a qual gente abbiano a combattere, a chi devano r ecare , e da chi devano aspettare soccorso.
I . Quando si dà il guasto al paese per superar quelli che si difendono fuggendo e ritirandosi ai luoghi inaccessib ili, bisogna os-
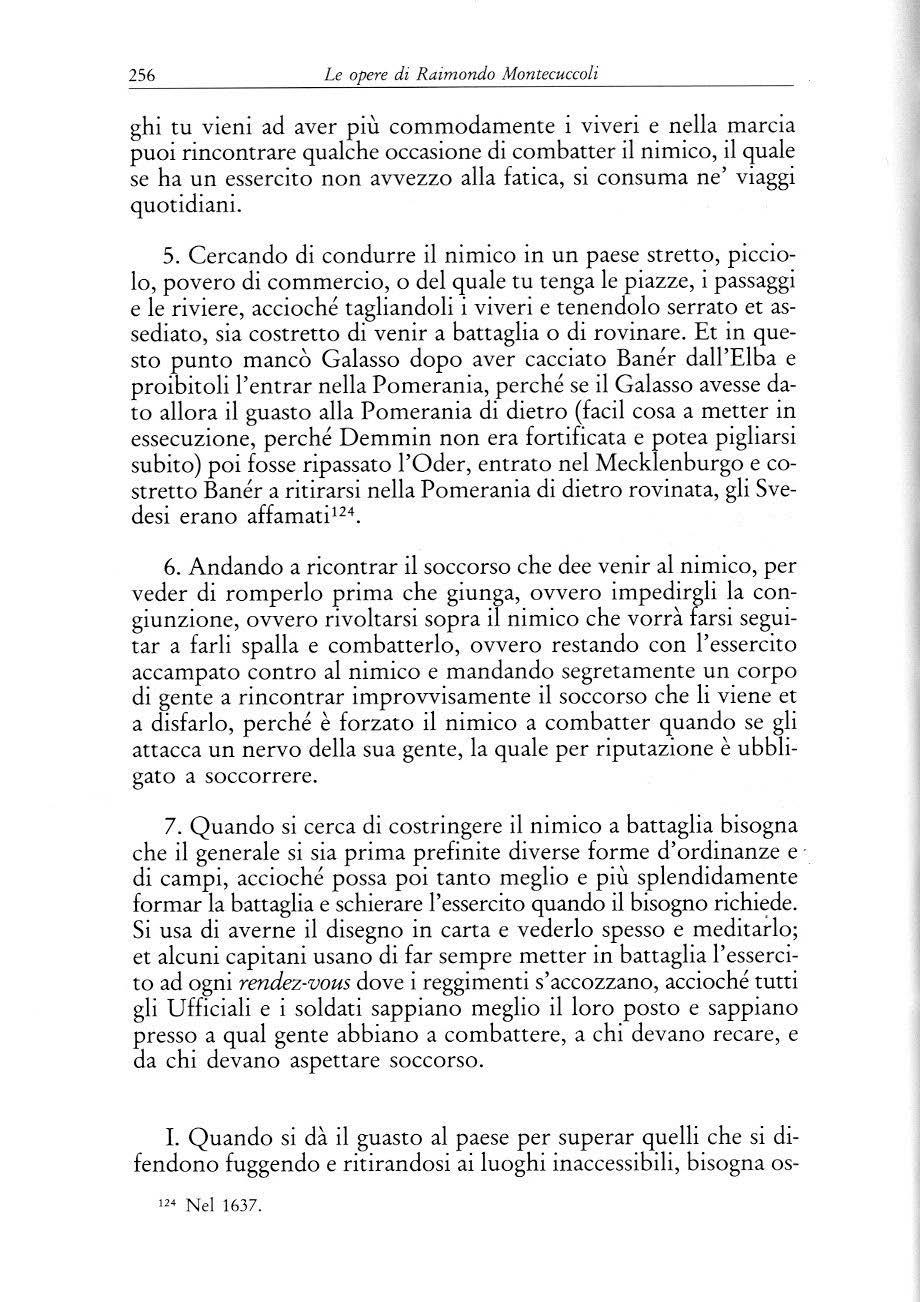
servare tre cose principali, cioè prevenirli talmente con una gran diligenza, c h e sieno so rpr esi prima che possano ritirare né essi né i viveri loro dentro le fores t e, perché a questo modo gli un i sono costretti a rendersi, gli altri a morir di fame; separar la sua armata in due, tre o tante parti, che si può fare sicuramente non avendo ostacolo d'alcun essercito formato, accioché attaccando u n paese in diversi indirizzi tutt'a un tratto, gli abitant i di que ll o non sappiano da qual lato pot er ritirarsi; impedire che i suoi soldati non si sband in o senz' ordine per andar a butinare, di paura che non sieno morti dai nimici nascosti dentro alle selve e ne marazzi, com' è più volte successo ai soldati imperiali.
1. Si lascia talora di dar il guasto a un paese per tirarne una somma di denari che viene pagata dal Signore di quello per ricomprarne la distruzione, e si lascia anche quando si pensa di posseder e il p aese, perdonandogli come a cosa sua propria, né vo lendo struggere quello che si viene per possedere perché in tal modo s' egli s i vince si possono aver più trib uti , e se la guerra è tirata in lungo si ha il vitto copioso e tetti per ricoprirsi e, quello ch e è più, s'acquista la benevolenza degli abitanti.
2. Si suo l dare il guasto al paese stimando che deva succedere l'un de' due, cioè o che 'l nemico sia costretto a venir a battaglia, o che appaia universalmente che tu sei padrone della campagna e che 'l nemico non ha ardire di azzuffarsi teco, ma si tiene rinchiuso ne' suoi ri trinceramenti, per lo che molte volte le città della provincia sbigottite ti si rendono e la fama ti reca grande vantaggio.
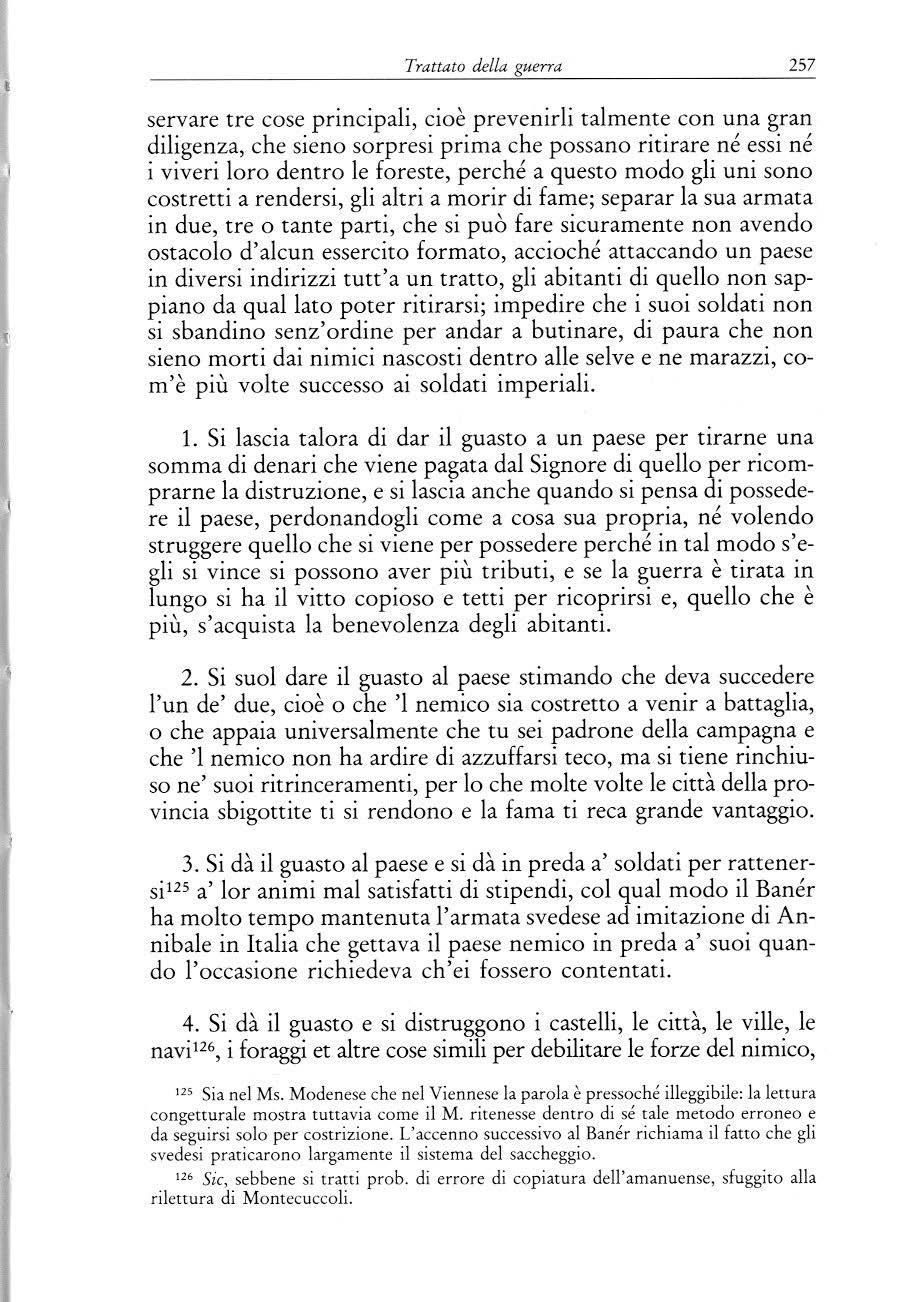
3. Si dà il guasto al paese e si dà in preda a' soldati per ratten ersi 125 a' lor animi mal satisfatti di stipendi, col qual modo il Banér ha molto tempo mantenuta l'armata svedese ad imitazione di Annibale in Italia che gettava il paese nemico in preda a' suoi quando l'occasione richiede v a ch'ei fossero contentati .
4. Si dà il guasto e si distruggono i castelli, le città, le ville, le navi 126 , i foraggi et altre cose simili per debilitare le forze del nimico,
125 Si a n e l Ms Mode n ese ch e nel Vie n nese la p ar o la è pr ess oché ill eggib ile: la lett ura conge tt urale mo stra t utta via co m e il M. r itenesse d ent ro di sé tale metod o erroneo e d a segu irsi solo p er cos tr iz io ne. L ' acce nn o s uccess iv o al Banér richiam a il fa t to c h e gli sve d esi pr at ica ro no lar gam e n t e il sist e m a del saccheggio
12 6 Sic, se b bene si tra t t i pro b. d i er r o r e di cop iat ura dell' amanue n se , sfuggit o alla r il et tur a d i M o ntec ucco li
come fece Banér intorno a Praga; o per confermar et accrescer le sue. Ma non si devono già distruggere quelle cose che non recano emolumento a se stesso né detrimento al nemico , come sono i templi, le statue, le antichità e cose simili, perché quello è permesso a ciascheduno dalle leggi e dalla ragion della guerra, questo è atto di uomo rabbioso et insano.
5. Nel dar il guasto veggasi d'aver sempre insieme un corpo di gente sobrio et unito per sostener le partite che, distribuite a' diversi uffici, sono mandate di qua e di l à a bruggiare, a spogliare, ad occupar parecchi luogh i 12 7 , accioché se il nemico, benché rotto e debole, si raccogliesse e ripigliasse animo, non abbia occasione e potere di menarti captivo nel tuo trionfo.
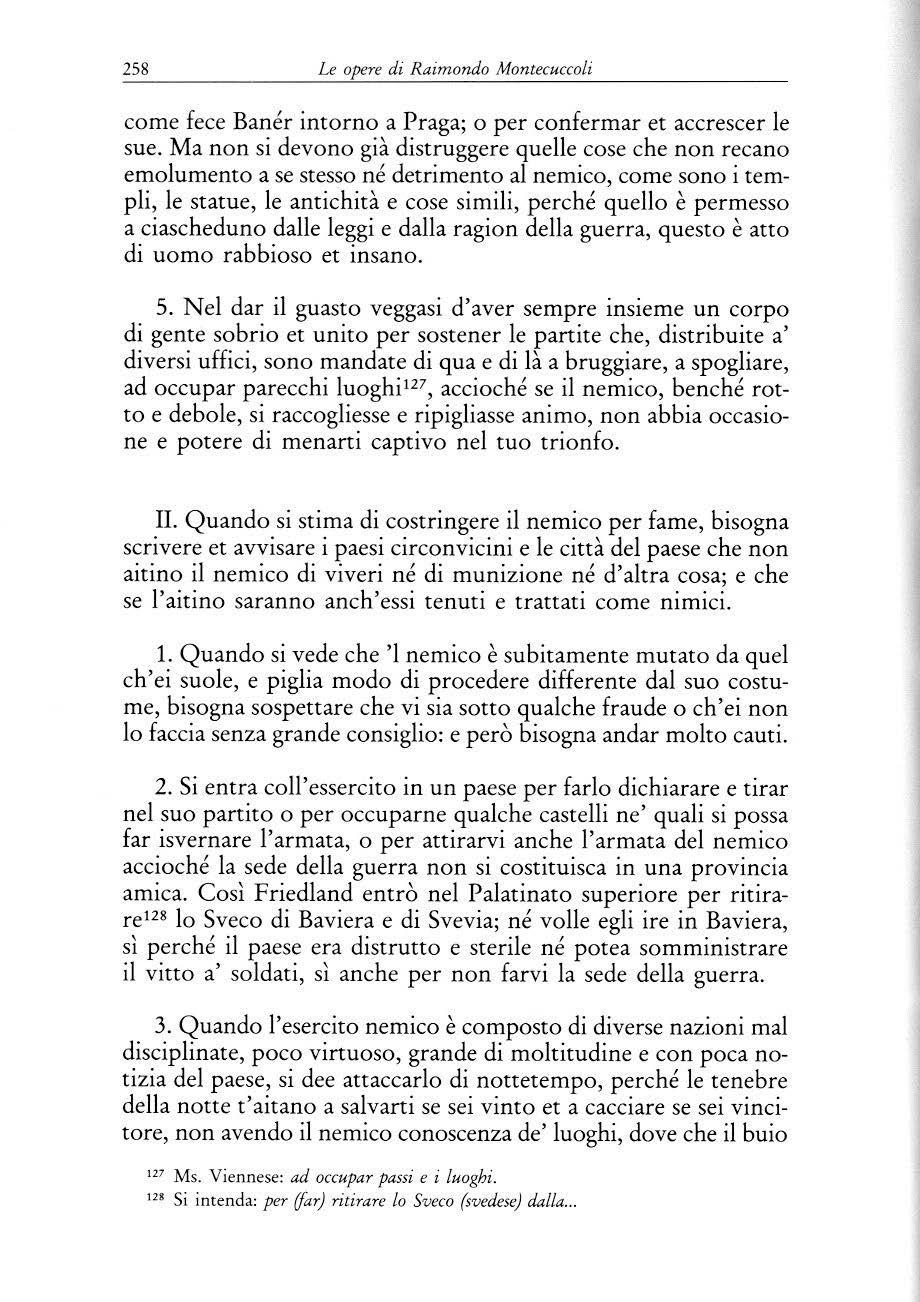
II. Quando si stima di costringere il nemico per fame, bisogna scrivere et avvisare i paesi circonvicini e le città del paese che non aitino il nemico di viveri né di munizione né d'altra cosa; e che se l 'ai tino saranno anch'essi tenuti e trattati come nimici.
1. Quando si vede che 'l nemico è subitamente mutato da quel eh' ei suole, e piglia modo di procedere differente dal suo costume, bisogna sospettare che vi sia sotto qualche fraude o eh' ei non lo faccia senza grand e consiglio: e però bisogna andar molto cauti.
2. Si entra coll' essercito in un paese per farlo dichiarare e tirar nel suo partito o per occuparne qualche cast elli ne' quali si possa far isvernare l'armata, o per attirarvi anche l'armata del nemico accioché la sede della guerra non si costituisca in una provincia amica. Così Friedland entrò nel Palatinato superiore per ritirar e 12 8 l o S veco di Baviera e di Svevia; né volle egli ire i n Baviera, sì perché il paese era distrutto e sterile n é potea somministrare i l vitto a' soldati, sì anche per non farvi la sede della gu erra.
3. Quando l'esercito nemico è composto di diverse nazioni mal disciplinate, poco virtuoso, grande di moltitudine e con poca notizia del paese, si dee attaccarlo di nottetempo, perché le tenebre d e ll a n o tte t'aitano a salvarti se s ei v into et a cacciare se sei vincitore, non ave ndo il nemico conoscenza de' luoghi, dove che il buio
127 M s . Vie nn ese: ad occupa r passi e i luoghi .
123 Si i nte nda: per (far} ritirare lo Sveco (svedese) dalla
mette confusione fra i molti e mal disciplinati, copre alla vista de' tuoi la quantità del nemi co che vista di giorno potria sbigottirli, e fa che 'l nemico, poco virtuoso, cede alla paura e fugge, là dove la luc e del giorno lo ritiene talvolta col freno della vergogna.
4. Quando si va per combattere il nemico, ,s'uniscono insieme tutte le forze che si possono avere, perché la difficoltà che nasce nelle troppo grosse armate consiste nel campeggiare, non nel combattere, nel quale si possono sempre moltiplicare li fronti della battaglia per rinnovar e tante più volte il combattimento 129 ; e dir di non voler azzardare ad un colpo di fortuna tutte le forze del Regno, si dee intendere di non l evare le guarnigioni dai luoghi forti per arrischiarle in campagna, né dai passaggi, né dalle fortezze; ovvero servirsi di un'armata novizia, la quale, sì come è buona a guardare le spalle et è in atto prossimo di rendersi co n poco tempo agguerrita, così saria perderla a bello studio facendola azz uffare così alla prima et imperita.
Ma del resto devonsi avere le forze accozzate insi eme, né credere a qu alched uno poco fedele e corrotto con mercede dal nemico che vorria divider le truppe per essere a parte e pendere dall'avvento de' successi, ovvero [che] per ambizione cerca di aver un commanda m e nto a parte, ovvero p er inesperienza lo consiglia. Sì come anco erano quelli che avendo occasione di attaccare il nemico che non è ancor tutto insieme (come quando la Vanguardia è molto troppo avanzata oltre la battaglia) aspettano c h' ei sia unito accioc~é nissuno possa salvarsi, e vengo no a lasciar il certo per l'incerto. E ben vero che si può differire il combattimento per aspettar il nemico in sito disvantaggioso per lui, o vero tanto lontan o dalle sue fortezze e dal suo paese amico che, sen do battuto e poco pratico delle strade e d e' passaggi e per il grande intervallo della ritirata, possa poi essere intieramente disfatto nella fuga.
5. Si deve sempre intraprendere qualche cosa sopra il nemico, eh' è una massima ecce ll ente per dar cuore a' suoi et anche per assicurar se stesso dalle sorprese 130
Né si deve, se non con -grande n ecessità, rincular con l'armata, perché si viene a lasciar il paese in preda al nemico; e c hi si ritir a par che ei fugga, e la gue r ra sta nella fama: e sì come egli è cosa
129 Ammirevole esposizione de l principio oper ativo di marciare di vis i e concentrars i posc ia per co lpire.
00 Esigenza d i mantenere l 'iniziat iva
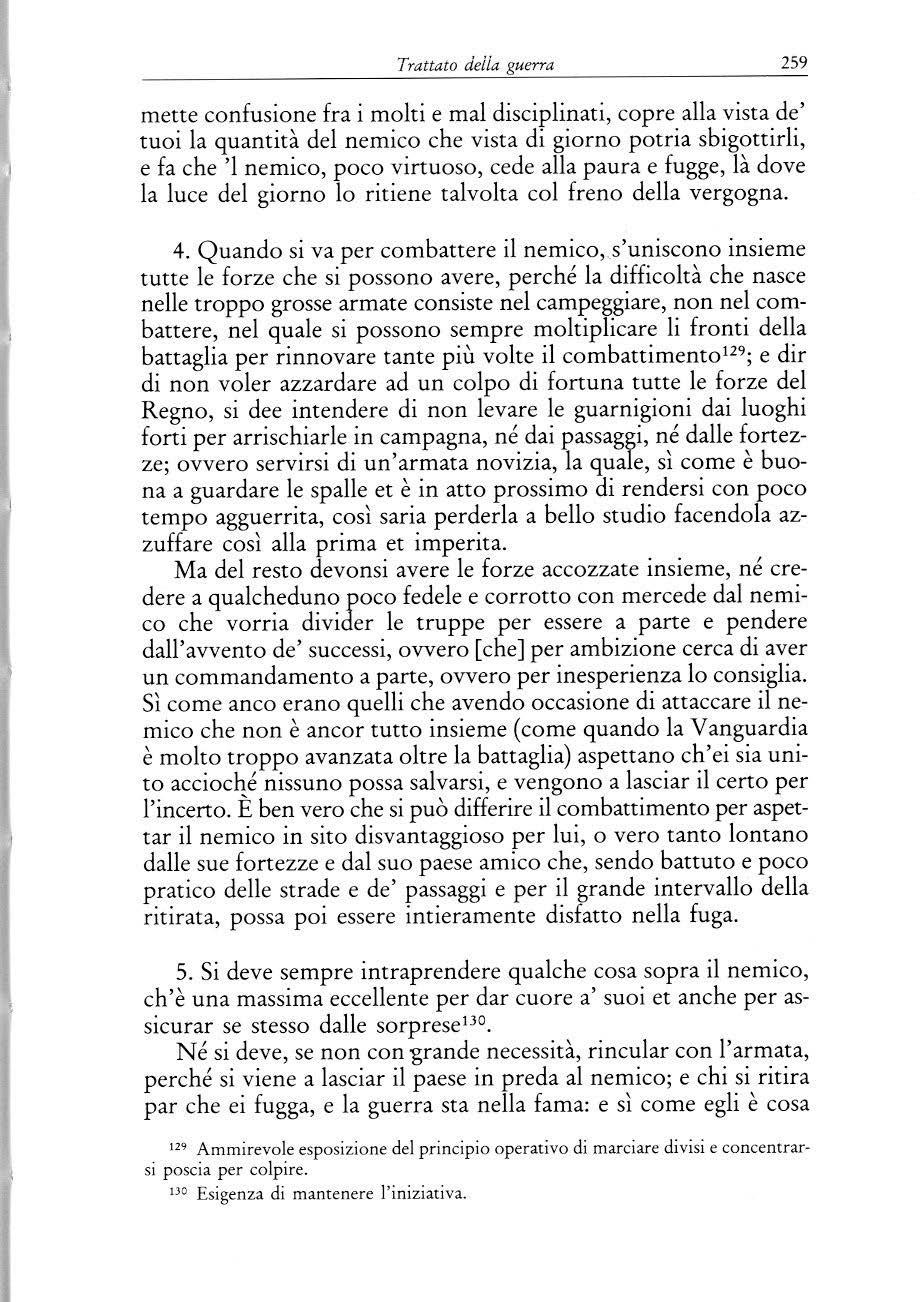
dubbiosa il vincere , così è sempre cosa certa che si può morire onoratamente e con gran laude.
6. Si presenta talora l'esercito in battaglia dinanzi al campo del nemico per forzarlo co l cannone a lasciare gli alloggiamenti, com e provò di fare Banér contro a Piccolomini a Saalfeld 13 1 e Tilly contro il Re di Svezia a Werben 132 ; overo per dar più cuore a' suoi e per render più timidi i nemici, come fece Banér a Perleberg 133 contro Hat zfel d, o a Praga contro a Galasso , ecc. 134 • Talora non si presenta [l'esercito], perché, rimirandoti il nemico da lu ogo sicuro e senza timore, poi vedendoti partire senza far nulla e misurando e contando le tue forze che forse saranno inferiori alle sue, ne diventa più ardito e piglia animo di assaltarti un'altra vo lta con più coraggio, sì che s i può far mostra delle sue forze quando si ha più o miglior gente del nemico , ma non quando se ne ha meno, o di peggior qualità.
Si cerca di fuggire l a battaglia in più modi .
1. Si va sempre campando in luoghi forti et alti sopra le montagne fuori del pericolo della Cavalleria del nemico, s' ei ne è più forte; e si costeggia sempre, in modo che, quando il nemico si ferma in qualche luogo, tu ancora ti fermi, e s'ei si muo ve, lo segui alla traccia e giri all'intorno di lui senza mai allontanar le montagne, né avvicinandoti tanto che tu possa esser costretto di combattere se non vuoi, però essendogli sempre alla coda, avendo viveri abbondanti alle spalle, tenendo sempre i soldati insieme uniti n el campo, perché in questo modo tutte le cose si sono sicure e tieni il nemico in continuo timore e suggezione, perché, se qualcheduno si divide dal suo esercito per foraggiare o spog liare, lo fai prigione o lo uccidi.
Tal modo tenne Fabio Massimo contro Annibale per diminuire poco a poco le forze di quello e per avvezzare con le piccole vittorie i soldat i sbigottiti dalle rotte passate a ripigliar cuore et a confidarsi nella virtù e nella fortuna.

Ma questo modo non si può sempre tenere, perché bisogna che 'l sito aiuti e che la tua armata sia sì virtuosa che il nemico non abbia ardire di venir ad assalirti ne' tuoi vantaggi; né si può dire che Fabio fuggisse la giornata, ma c h e la vo lesse e cercasse a suo vantaggio 135 • E certo un'armata di 30 o 40.000 uomini, ben agguerriti e disciplinati, può con pazienza ritrincerandosi e ben alloggiando dissipare le armate numerosissime le quali, per mancamento di viveri, si distruggono da per se medesime, e s' elle combattono (purché si eviti di esser circondato da tutte le parti), li disordini e la confusione le rovinano, mentre che non abbiano . \ pan v1rtu.
2. Ma quando tu credessi che il nemico ancor ne' luoghi forti ti v enisse a trovare, né avessi animo di poterti difendere, bisogna partirsi dalla campagna e dividere le ge nti per le tue terre 136 , accioché il tedio dell'espugnazione di quelle lo stracchi o lo consumi, perché altrimenti egli è cosa molto diffici le che quello che sta alla campagna possa fuggir la giornata quando egli si ha un nemico che la voglia combattere in ogni modo, et andarlo a trov are in tutti i luoghi dove egli alloggia 137 ; et il rimedio di porsi coli' esercito suo discosto cinque o sei leghe dall'avversario, con tener fuori bonissime spie p e r esser sempre a tempo a le v arglisi dinanzi quando l'avess e a trovare, è soggetto a molti p e ricoli , abbandona il paese allo spoglio del nemico, né è sicuro di non esser colto alla fine. Il Mansfeld ha m e nato qualche tempo la guerra a qu esto modo scorrendo da un paese a un altro, e sempre entrando in quello dove non trovava ostacolo né avversario 137 bis
3. Quando il paese lo permette, il miglior modo di sfuggir e la battaglia è di mettersi al l uogo, e dietro una buona rivi e ra, perché, aitati da tal fosso, possono i pochi sosten e r e i molti et avendov i uno o più ponti assicurati da forti o da buone piaz ze, se il nemico passa da un lato della riviera tu passi dall'altro né gli dai agio di trovarti; e se il fiume è grande o il fondo è cattivo o le rip e sono paludose, come è la terra del Mecklenburgo, si può to-
us A pp are q ui be n de fin ito il pr in cipi o di M. d ella dife ns iva-co ntroffe nsi va .
136 Int endasi: citt à fort i ficate .
137 O per affre tta t a stesur a, o per erro r e del copista sfu gg ito all 'A , q ues t a frase sembr a no n av er senso; dovr eb b e legge rs i: anche and and oti a t ro v are in tutti i lu oghi d ove t u alloggi .
!37/,., Il co nte E rnst Von M ansfe ld, ge n era le p rotest ante, cond usse t al i o p erazio ni d ur ant e il Per io d o Boemo della Guer r a dei T rent ' an n i (161 8- 1625) .

talmente impedir il passo al nemico et opporsegli su la ripa contraria. In questo modo sfuggiva il Re di Svezia al Tilly passando con navi dalla Pomerania nel Mecklenburgo e dal Mecklenburgo nella Pom erania; et in questo modo l' Aldringen si serviva del Danubio per non venir alle mani con Horn, passando la riviera ora a lngolstadt ora a Regensburg, secondo che il nemico era da una parte o dall'altra, di sotto o di sopra 138 •
Così anche si mise l'armata di Bav iera dietro la Saale contro al Re di Svezia, se bene non poté sostenere il passaggio e fu costretta a ritirarsi ad Ingolstadt 139 ; così il Duca di Weimar al Reno; così il Banér a Torgau sopra l'Elba passava ora di qua ora di là della riviera secondo li tornava comodo et sempre poteva ritirarsi o a Erfurt nella Turingia o nella Pomerania 140 • Ciò avvenne nella campagna successiva alla morte di Gustavo Adolfo, secondo che gl'Imperiali gli avessero tagliata o l'una o l'altra ritirata, perché m tal caso o bisogna che 'l nemico abbia due armate ciascuna delle quali sia più forte della tua (altrimenti tu batteresti l'una dopo l'altra), o bisogna ch'egli dia totalmente il guasto ad una parte della riviera [e] pervenga a serrarti dall'altro lato per affamarti; il che pro v ò di fare Hatzfeld contro a Banér 141 ; ma ella è cosa lunga e tu puoi fare tanta provvigione nel campo che possi godere del beneficio del tempo.
4. Dietro la Pe ene si resse anche coll'esercito Banér dopo essersi ritirato da Torgau 142 , e per fuggir la battaglia si campò anche sotto alla città di Stettino: e l'accamparsi tra le piazze che servono di favore e di spalla 143 , è anche un modo di sfuggir la battaglia; et è necessario porsi in simili posti sicuri quando s'aspetta il soccorso, perché è certo che l'inimico farà allora ogni sforzo di attaccarti prima che il rinforzo ti arrivi, ovvero cerc h erà di rincontrar il soccorso e batterlo prima che tu ti congiunga; e però tu d ev i talora andarlo a rincontrare e marciare verso di lui, ma cautamen-
13s Il primo esempio si r ifer isce alla campagn a che prece d ette l ' urto d i Breitenfeld; il secondo a q uel la s uccessiva in Fra ncon ia e Baviera. Lo Horn avrebbe dovuto esse r e scamb iato con M al tempo d ella sua prigionia, ma la cosa non ebbe seg uito.
139 In tale occasione Ti ll y fu fe r ito e mo rì.
140 Il cors ivo è di M .; lo scr ittore evidentemente inte nde far notare come Banér mantenesse coscancemence ap erta la lin ea di comunicazione con la su a b ase s tra tegica che era, appunto , la Pomerania. Ciò avven n e n ell a ca mpa gn a successiva alla morte di Gustavo Adolfo

141 Nella camp agna d i Wittstock.
142 Sempre nella ca mp agna de l 1637.
143 Si intenda: che sono favorevo li e coprono le spalle
te; e talora aspettarlo in un posto avantaggioso e fortificato perché possa arrivarti senz'impedimento . .
Taluno, aspettando un soccorso e udendo il nemico ire ad incontrarlo, acciò non andasse diede voce per tutto il suo ese r cito di vo ler l'altro giorno far giornata co' nemici: per lo che questi, per non diminuire le loro forze, non andarono ad incontrare quel soccorso, e per questa via ei si condusse salvo. La congiunzione dell'armata e de' soccorsi si fa con l'abbondanza di allegrezza, mettendo l'armata in battaglia 143 bis, dando fuoco a' cannoni e facendo tre saluti con tutto l'esercito; così fu fatto quando l'armata del Cardina le In fante di Spagna si congiunse con quella del Re di Ungheria, quando Hatzfeld si congiunse col Gotz, Banér co' frances i e con Liineburg 14 4.
Il. L'azione della campagna consiste in tre capi principali, cioè nel marciare, nell'alloggiare e nel combattere . Perché in ciascheduna di queste operazioni è necessaria la disciplina per regolarsi, i viveri per mantenersi, gli spioni per sapere i disegni del nemico e secondo quelli deliberare di marciare, di alloggiare o di combatte~e, però di ciascheduna di queste cose di per sé si discorrerà distmtamente.
143bis Si intenda: schierando la in ordine d i battagli a.
144 Ferdinando, Arcivescovo di To led o e Cardinale Infante di Spagna, e il futuro Imperatore Ferdinando lll, re di U n gheria, si congiunsero nella campagna che, come già si è detto, p ortò alla vittoria imp erial e di Nordlingen, 1634; Hatzfeld con Gotz nel 1636 e Banér con i francesi e col Duca Giorgio di Bru n sw ick-L iineburg nella c ampagn a del 1640.


Egli s'intende qui per disciplina le leggi che frenano i costumi de' soldati, che risguardano la continenza, la modestia e l'astin enza, e gli esempi che risguardano al premio et alla pena. Non si de' mai lentar la briglia alla severità della disciplina militare e benché i soldati se n'adirano, bisogna più tosto contentargli per ogni altra sorte di strada che per questa, e quando essi vedranno che i loro capitani son a parte con loro de' pericoli e delle fatiche della guerra, le sopporteran no allegramente, perché si legge bene che per l'osservazione esatta della disciplina militare molti capitan i hanno superato grandi difficoltà et hanno acquistato vittorie gloriose, e che molti altri, per averla sprezzata, sono stati vergognosamente disfatti: ma non s'è mai letto che l'osservazione di quella sia stata causa della perdita d'una battaglia o della rovina d'una impr esa, e s'osserva mille volte una cosa accioché una sol[a] volta renda profitto .
La continenza si dee osservare nel cibo e ne' piaceri di Venere, cioè che i so ldati non siano dati a i con v iti et all' ebrietà et alla parte turpissima del corpo perché l'una e l'altra cosa snerva e coll'uso delle voluptà degenera il soldato dal vigore e dalla virtù. Quel1' esercito d'Annibale, indomito fra le nevi e fra l 'A lpi, fu snervato dalle delizie di Capua; invitto con l'arme, fu vinto da i vizi; e quel grande che l'arme de' P ersi non ruppero, vinsero i vizi, né alcun luogo nocque mai tanto al suo esercito quanto la diliziosa città di Babilonia. Ben è prudente chi col negozio sa spegnere i vizi dell' ozio145.
14; Alessa nd ro il Mac ed o n e1. I soldati, abbandonati e carichi di pr eda desiderano più di godere delle cose acquistate che di faticarsi per acquistarne delle altre, e però solea dire il Re di Sve zia che i soldati si d evono sempre tener poveri, et in vero la sua armata, pov erissima, ha in molte occasioni operato meglio di quella dell'Imperatore, commoda et opulenta.
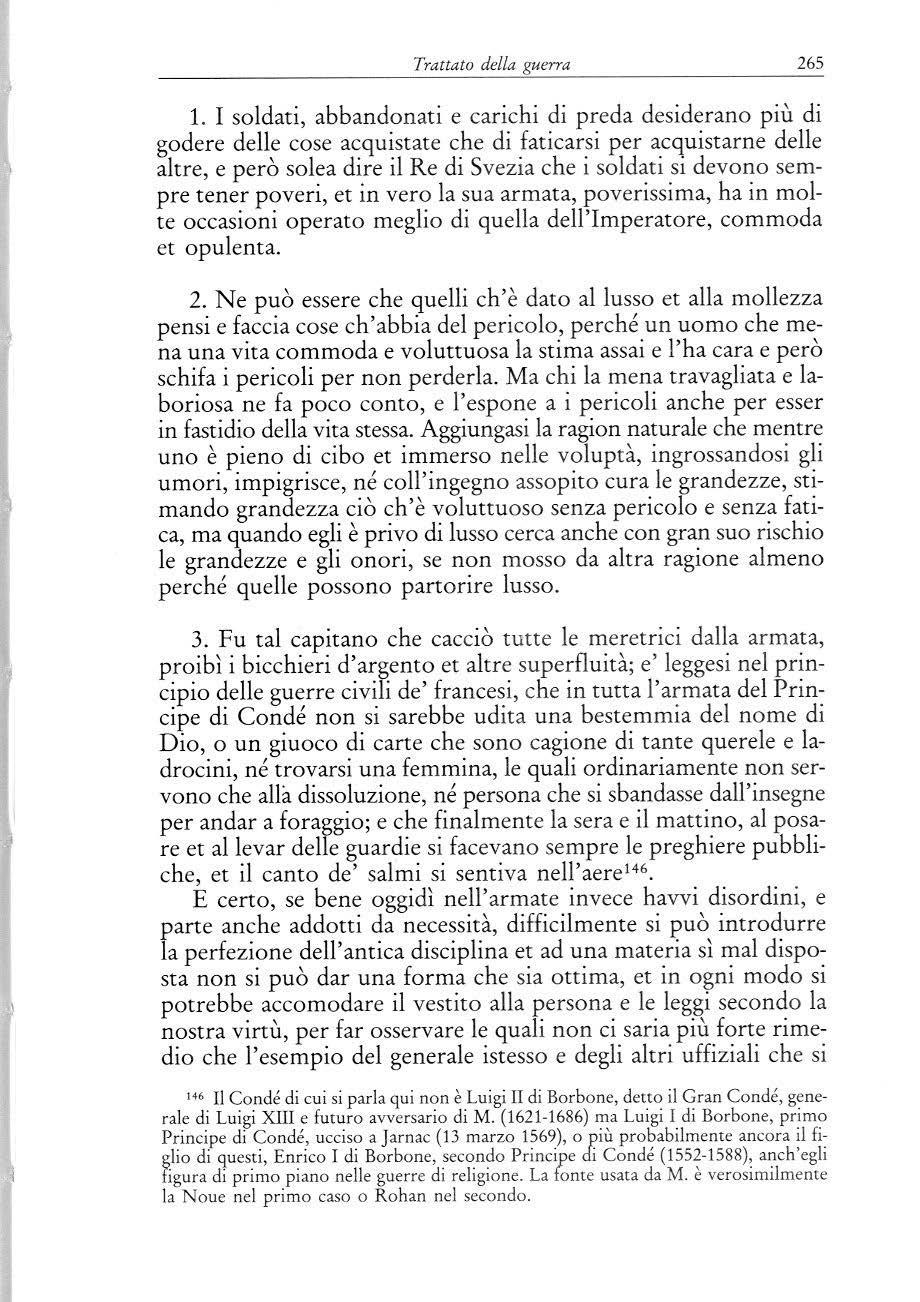
2. Ne può essere ch e quelli ch'è dato al lusso et alla mollezza pensi e faccia cose ch'abbia del pericolo, perché un uomo che mena una vita commoda e voluttuosa la stima assai e l'ha cara e però schifa i pericoli per non perderla . Ma chi la mena tra v agliata e laboriosa ne fa poco conto, e l'esp o ne a i pericoli anche per ess er in fastidio della vita stessa. Aggiungasi la ragion naturale che mentre uno è pieno di cibo et immerso nelle volupt à , ingrossandosi gli umori, impigrisce, né coll'ingegno as sopit o cura le grandezze, stimando grandezza ciò eh' è voluttu o so senza pericolo e senza fatica, ma quando egli è privo di lusso cerca anche con gran su o rischio le grandezze e gli onori, se non mosso da altra ragione almeno perché quelle possono partorire lusso.
3. Fu tal capitano che cacciò t ut t e le m er et r ic i d all a arm ata, proibì i bicchieri d'argento et altr e sup erflu ità; e' leggesi nel principio delle guerre civili de' francesi, ch e in tutta l'a r mata del Principe di Condé non si sarebbe udit a una b est em mi a del n o me di Dio, o un giuoco di carte ch e sono cagi o ne di tante querele e ladrocini, né trovarsi una femmina, le quali ordinariamente non se rvono che alla dissoluzione , né persona che si sbandasse dall'insegn e per andar a foraggio; e che finalment e la sera e il mattino, al posare et al levar delle guardie si faceva n o sempre le preghiere pubbliche, et il canto de' salmi si sentiva ne1l'aere 146 • E certo, se bene oggidì nell'armate invece havv i disordini, e parte anche addotti da necessità, difficilmente si può introdurre la perfezione dell'antica disciplina et ad una materia sì mal disposta non si può dar una forma ch e s ia ottima, et in ogni modo si potrebbe accomodare il vestito alla pers ona e le leggi second o la nostra vi rtù, per far osservare le quali non ci sa ri a pill fort e rimedio che l'esempio del generale istesso e degli alt ri u ffiziali ch e si
146 Il Co nd é d i cui si p arl a q ui non è Lui gi II di Bo rb one, detto il Gran Con dé, general e di Lui gi XIII e fu t uro avversar io di M. (1 621 - 1686) ma L u igi I di Borbone, pr i mo P r incipe di Co ndé, ucciso a J arnac ( 13 m arzo 1569) , o p iù p rob abi lm ente anco ra il figlio d i questi, Enr ic o T di Bo rbo n e, secondo Prin cip e di Condé (1552- 1588), a nch'egli figura di pr im o pia n o nelle gue r re d i religione. La fonte usata da M. è verosimilmente la No u e ne l pr im o caso o Ro h an ne l secondo.
mostrassero continenti e virtuosi, perché sin tanto che il capitano si imbriaca ogni giorno, cerca ogni esquisitezza del cibo, ogni sontuosità di servizio e conduce col suo bagaglio ogni sorta di commodità, come vorranno i soldati patir sete e gli ufficiali minori non imitarlo, condurre seco le sue puttane, vestiti, argenteria et simili impedimenti, vedendo ch'ei s'acquista tanta gloria da un bel convito quanta da una partita battuta, e tanto s' e ntra in estima per rovesciar il suo compagno bevendo che per abbatter il suo nemico combattendo, e tanto s'acquista la benevolenza e l'applauso de' superiori e degli eguali trattandoli diliziosamente e sontuosament e a un desinare e facendo loro cena intiera, quanto intraprendendoH 7 sopra un quartiere del nemico o formando un disegno e facendo qualche altra valorosa azione militare?
II. Da questa continenza nasce la pietà et il timore di Dio, perché dove si sta sempre immersi e sepolti nel fango de' piaceri si spegne quel lume il quale è necessario sopra tutte le cose e il fondamento di ogni virtù, il principio di ogni sapienza, l'origine d' ogni unione, d'ogni buon ordine e d'ogni buona fortuna.
1. Li nemici tramano ad ogni ora in s idie gli uni a gli altri nel tempo della guerra et ordiscono inganni e drizzano imboscat e , le quali non è alcuna prudenza umana sì sagace e sì circonspetta che poss a scoprirle tutte prevedendole, e provedervi; né cadono tutti i stratagemmi singolari sotto l'imagina z ione d'un uomo né vi è persona che possa mostrar il modo d'avvedersene se non i Dei che sanno tutto e predicono tutto cogli augurii, colle rivelazioni , co' rumori , co' sogni; o ra egli è cosa verisimil e che i D ei sian o in tali cose per consigliare e pro v eder molto più a coloro i quali non s olamente quando sono nel bisogno ricorrono a gli oracoli accioch é sappiano quello che devono fare: ma che ancora nelle cose prospere li z:iveriscono e gli hanno in venerazione.
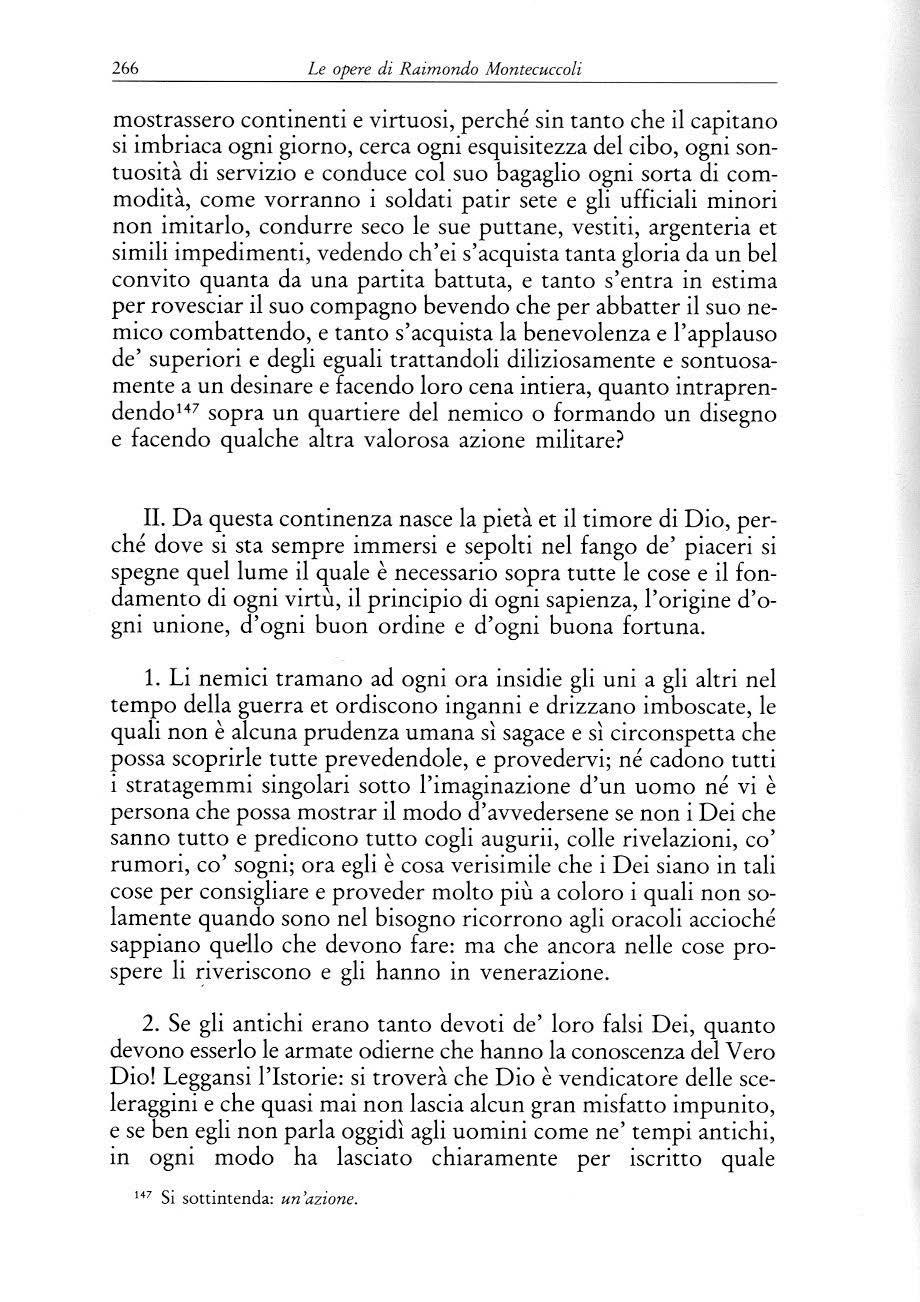
2. Se gli antichi erano tanto d evoti d e ' loro falsi Dei, quanto devono esserlo le armate odierne che hanno la conosc enza del Vero
Dio! Leggansi l'Istorie: si troverà che Dio è vendicator e dell e sceleraggini e che quasi mai non lascia alcun gran misfatto i mpunito, e se ben egli non parla oggidì agli uomini come ne' tempi antichi, in ogni modo ha lasciato chiaramente per iscritto quale
147 Si sott intenda: u n'azione.


sia il suo perpetuo commandamento e che cosa ei vuole che non facciamo: di sorte che non vi è alcuno che possa aver luogo di scusa. La causa di tanta licenza e di tanta pravità ne' nostri eserciti è l'incredulità, perché se determinassimo certamente che vi è Dio che non lascia impunito alcun misfatto, che vi sono le pene perpetue e sempiterne colle quali sono afflitti gli empi, egli è credibile che non vi saria alcuno il quale procedesse con lussuria, con violenza, con avarizia e con crudeltà.
3. E però, per mantener i soldati nella pietà e nella divozione è lode vo lissimo instituto che ciaschedun Reggimento abbia il suo Cappellano che medichi le passioni dell'animo e con sermoni quotidiani riprenda i tristi e procuri che ogni giorno si facciano almeno due volte pubbliche preghiere a Dio il che, grand' onta delle armi cattoliche, è puntualissimamente osservato nelli eserciti luterani i quali, disposto il Reggimento in battaglia, cantano per rime le preghiere come hansi nella loro lingua volgare, dal che non si potria credere quanto ardore concepiscano gli animi.
E potriasi anche facilmente introdurre fra [i] cattolici accioché, dopo la celebrazione della Messa, si cantasse qualche orazione nel1'idioma del Paese il quale, inteso da tutti, ha forza molto maggiore di penetrare negli animi che non inteso. Nissuna cosa, disse un antico, regge più efficacemente la moltitudine ch e la superstizione; per sfrenata, crudele, mutabile che sia, presa eh' ella è dalla religione che l'invasa, meglio ubbidisce a i miti che a' propri duci.
III. Questo è un altro buon effetto della pietà e d ella divozione: cio[è] che credendo fe rmament e il soldato d'esser accompagnato dal favore e protetto dallo scudo di Dio, conscio della purità della sua conscienza, è prodigo della vita, né teme pericolo alcuno perché qual possanza può mai nocere a chi è difeso dall'omnipotenza di Dio? E questa confide nza si d ee anche accrescere nel soldato con ogni mezzo politico:
1. Facendo predicar a i ministri della parola di Dio (comprati a qu esto effetto con denari o stimolati per altro mezzo) che Dio promette la vittoria all'esercito, ch e nell' Apocal issi le è stato denonziato l'imperio del mondo, ch e chi vien a perire per causa sì giusta goderà la glor ia sempiterna, e provando ingegnosamente ogni cosa co' gli esempi e co' detti della Scrittura;
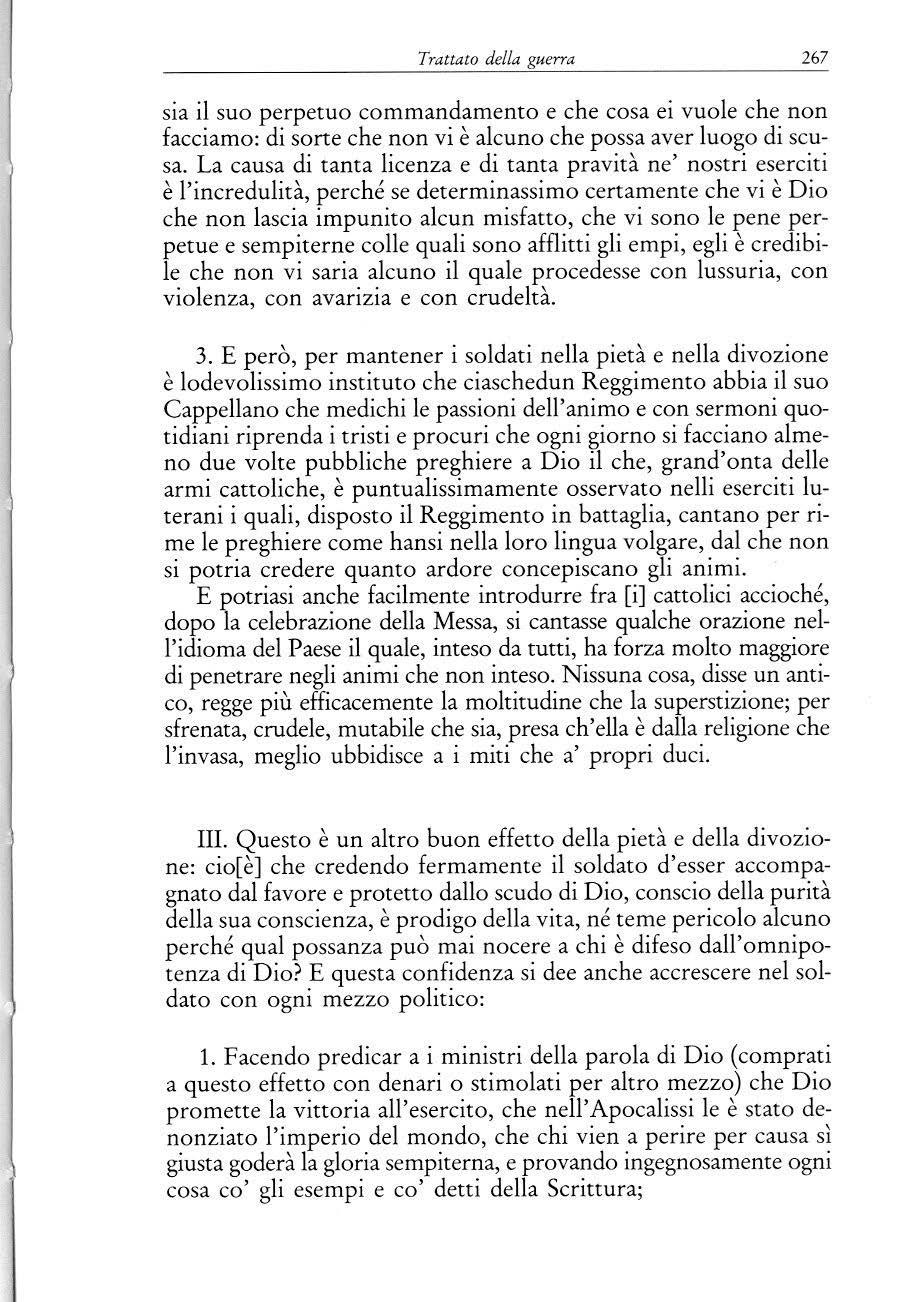
2. Celando le cattive nuove all'armata, et i rincontri infelici, ovvero diminuendo il male: anzi, facendo correre grido tutto co ntrario, siccome ottimamente sanno fare i svedesi i quali, giudicando che non si possa tener totalmente segreto il rumore di quello ch'è passato, stimano chè non bisogni negar l'atto ma ben sì travestirlo e fargli cambiar di faccia in m odo che di perditore si paia vincitore, come più v olte a Stet tino hanno fatto dal pulpito render grazie solenni a Dio et annunciar le vittorie dov'erano le perdite , perché verament e le cose della guerra son ore e punti, et essendo ogni minuto di tempo nelle cose umane suggetto a gran mutazioni, va le assai di tener gli animi de' popoli e de' soldati animosi e confidenti sin che si può;
3. Spargendo voc i di qualche soccorso che viene a rinforzo, del1' a iu to e del fa v ore di molti P rincipi e repubbliche , ancora che non sia; ch e s 'ha intercetto qualche avviso d'importanza al nemico; facend o anco talora allegrezza con artiglieria e con fuochi di sera, con proposito di artificiosi avv isi e facendo anco venir corri eri con lettere finte, o mostrando talvolt a ardir di vo ler assalire li nemici di notte all'improvviso con incamisciati 148 ; nel che devesi però osservare che s1come nissuna cosa rende gli uomini più all eg ri et arditi che la speranza di buoni success i, così se alcuno, proponendo loro frequentemente aspettazioni di bene, gl' in ganni, questo tale non potrà pers uader e neanche allora che ciò eh' egli rivela è vera speranza, e sicura;
4. No n divul gando mai la morte di qualche capo nell'occasione, neanche de' semp li ci soldati, per non atterrire gli altri, sì com e il Wangler castigò rigoro sa mente un uffiziale che sotto N eubr anden burg disse ad alta voce ch'un tenente era morto; et il Conte Mosti fece adirare gravemente il Piccolomini sotto a N ordlingen avendo detto che il fosso era pieno di morti de' soldati imper iali 149 • Alessandro denuntiò 150 la morte a coloro ch'erano ritornati da un combattimento se avessero divulgata la strage ricevuta. Scrivesi de gli amichi france si ch 'aveano per legge se alcuno
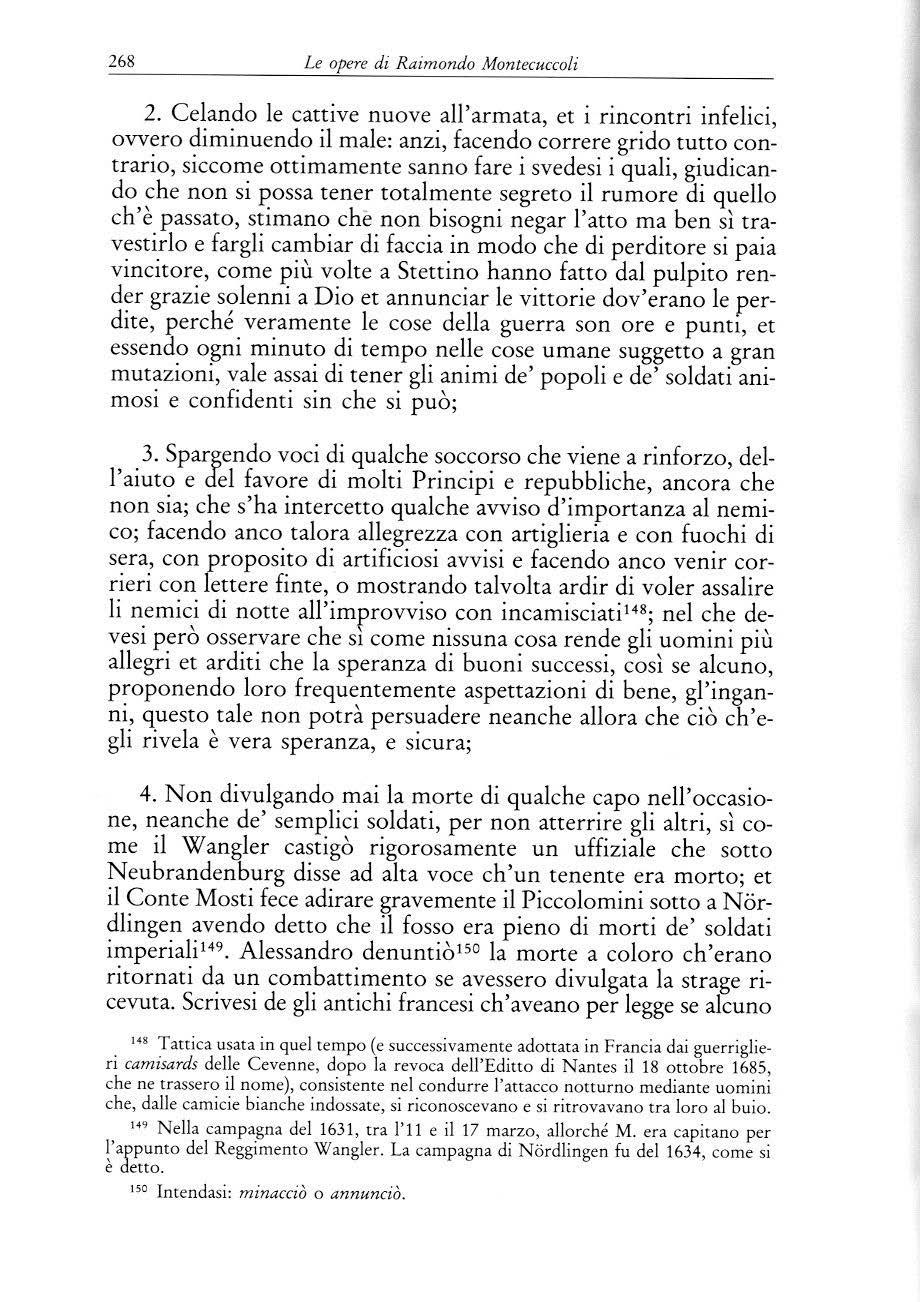
148 Tattica usata in q uel tem po (e successivamente adottat a in F rancia dai gu er r iglier i camisards delle Ceve nn e, dopo la revoca dell'Editto d i Nantes il 18 ottobre 1685, che n e trassero il n o m e), consistente n el con d urre l 'att acco notturno mediante uomini che, dalle cam icie bi anc h e indossat e, si r iconoscevano e si r it rovavano tra loro al buio
14 9 Nella campagn a d el 1631, tra 1' 11 e il 17 ma rzo, all orché M. er a capit ano per rappunto de l R eggimento Wangler . La ca mpagna di Nordlingen fu de l 1634, co me si e detto
150 Intendasi: minacciò o annunciò.
avesse inteso per fama e per rumore dai confinanti qualche cosa della repubblica, che la rapportasse al Magistrato né la communicasse con alcun altro avendosi conosciuto che spesso molti uomini temerari et imperiti s'atterriscono per falsi rumori, sono spinti a cose nuove e pigliano consiglio dannoso; ma il Magistrato tien occulto quello che gli pare e scuopre alla moltitudine quello che stima esser bene eh' ella sappia is obis ;
5 Scoprendo anche talora spontaneamente le cose successe a i soldati, acciò che la fama non accresca la cosa più di quello eh' ella è o non atterrisca l'animo de' soldati colla novità del successo151 o vero per conoscere come siano animati e pigliar poi consiglio secondo il loro movimento.
l'ubbidienza del soldato e la sicurezza dalle mutinazioni, perché non può temere gli uomini del mondo chi non teme Dio, et alla troppa indulgenza del capo segue disordine e gran dissoluzione de' soldati che divengono troppo arditi, et essendo pieni di ricchezze et accostumati alle dilizie, ne divengono pesanti per soffrir i travagli della guerra, né volendo più altro che riposarsi ad ogni poca cosa si mutinano, sì che è falsa regola di pensar di rimediar alla sedizione col permetter a' soldati di vivere licenziosamente: perché anzi questo ne è il cominciamento, cioè dando principio a perdere il rispetto a' maggiori.
1. Nascono le sedizioni per le dilizie, per i stipendi ritenuti, per la volubilità de' soldati che si voltano a seguir la parte del nemico quando la fortuna lo seconda, per l'emulazione quando il generale ha l'esercito composto di varie nazioni e ch'egli fa più stima de' forestieri che de' suoi propri e dà sempre loro la punta verso il nemico, li mette in presidio e si regge secondo il loro consiglio; per l'ambizione e superbia dopo una vittoria acquistata, e che son tenuti tutti insi eme in un corpo; per l'ozio sendo che non impiegandosi i soldati a bene, essi s'impiegano a male.
2. I rimedi dunque sono, oltre agli descritti nel primo libro delle discordie civili 151 bis, tener pagati i soldati, non tenerli insieme
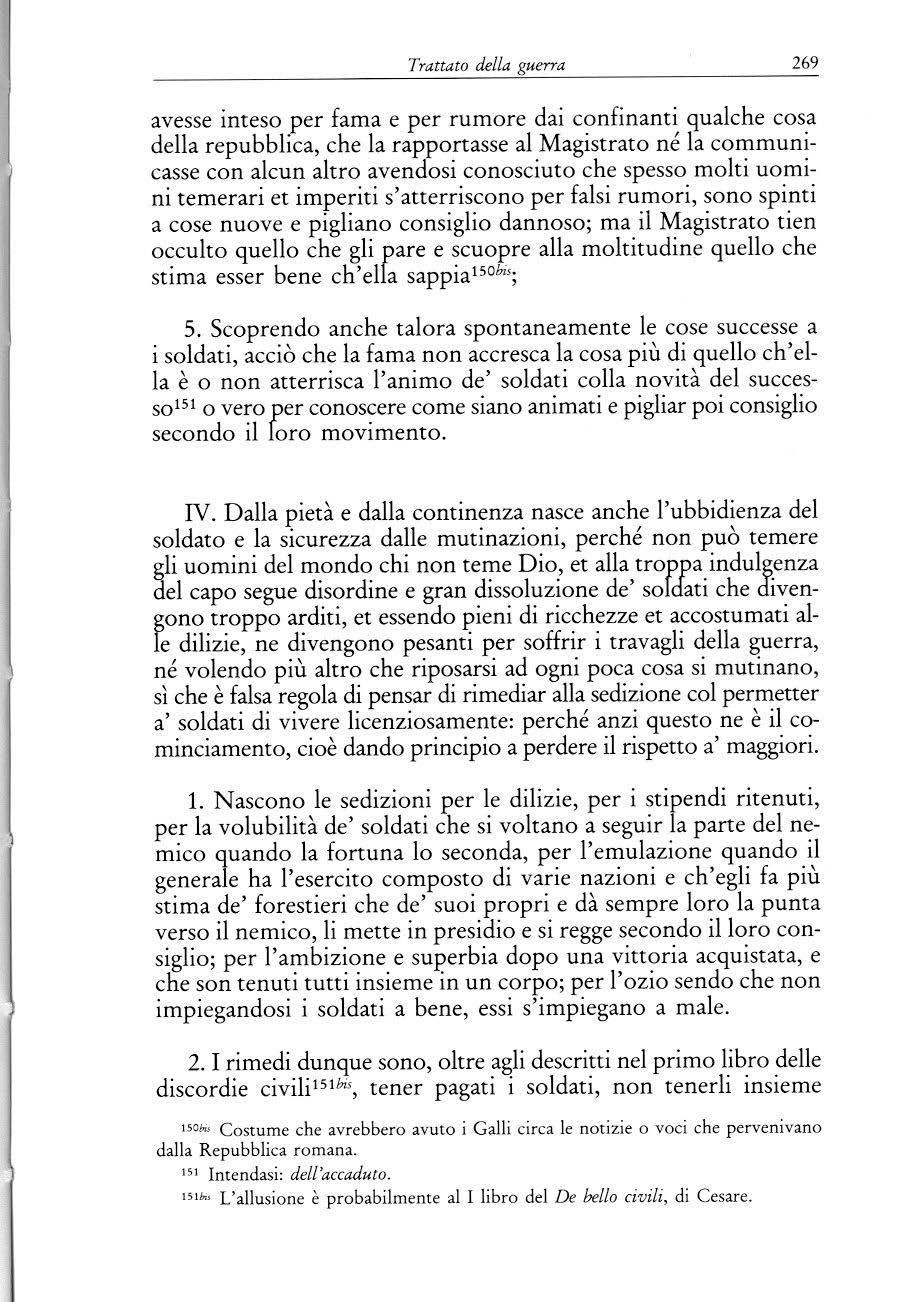
1sobù Costume che avrebbero avuto i Galli c irca le notizie o voc i che perve niv ano dalla R epubbl ica romana ,s , Intendasi: dell'accaduto .
1 5 1 ,,,.. L'allusione è probabilmente al I libro del De bello civili, d i Cesare.
quando non sono in azione, tenerli in azione quando sono insieme, et imprimer loro giusta credenza che la principa le virtù richiesta in essi è il sapere ben ubbidire ciascuno al suo superiore.
3 . Si può anche spegnere con arti una sediz ione o discordia nata tra soldati col castigare i capi degli errori, ma farlo in modo che tu gli abbia prima oppressi ed essi se ne siano potuti accorgere il modo e si sono discosti da sé 152 non chiamando solo i nocitori, ma ins ieme con loro tutti gli altri, accioché non credendo che sia per cagione di punirgli, n on diventino contumaci ma dieno commodità alla punizion e. Quando sieno presenti, si dee farsi forte con quelli che non son in colpa e mediante l'aiuto loro punirli; et è costume ordinari o che quando si mette la guardia ad un co lpevole arrestato si adoprano so l dat i d'altre compagnie, accioché per il commercio avuto insieme la contagione de ll a disubbidienza non s'attacchi anche a quest i. Quando ella fosse discordia tra loro, il miglior modo è presentargli al pericolo, la qual paura gli suole sempre render uniti, o far dare un falso all'arme, i l qua l modo è stato anco usato per divertir i so l dati dallo spoglio d'una città; ma quello che sopra ogni altra cosa tiene l 'esercito unito è la riputaz ione del capitano la quale solamente nasce dalla virtù sua perché né sangue né autorità la dette mai senza la virtù.
4. A voler che i capi non facciano d isordine, è necessario aver cura che non acquistino sopra i soldati troppa autorità, la q u ale s'acquista o per natura o per accidente: e quanto alla natura, conviene provvedere ch e chi è nato in un luogo non sia preposto a gli uomini descritti 153 in quello, ma sia fatto capo di q u elli l uoghi do ve non abbia alcuna naturale conveni e nza; quanto all 'accidente, si debbe ordinare la cosa in modo che ciascun anno i capi si permutino dal posto a governo, perché la continua autorità sopra i medesimi uomini genera tra loro tanta unione che facilmente si può convertire in pregiudicio del Princ ipe.

5. Nelle sedizion i si castigano gli ufficial i ancorché senza colpa, accioché abbiano meg l io l'occhio su gli andamenti de' loro so ldati; sono però qualche accidente ne' quali 154 bisogna traveder1 55
m Si intenda: che ess i si siano pot ut i re nd er conto di aver fallito la sed izione e se ne siano allontanati per loro iniziat iva
1s, Si intenda: arruolati.
1s• Vi è però qualche caso in cu i.
155 Trascurare.
il castigo, o per non verificare la colpa 156, o per non tingersi nel sangue perché i mutini cast igati con editti troppo rigorosi vann o al n emico, et alcune nature si lasciano piuttosto guadagnare dalla piacevolezza che dal rigore. Fabio ebbe indicio che un suo soldato valente di sua persona e di nobil casato aveva tenut o discorso con altri soldati di andarsi rendere al nemi co, né però li fece peggior accoglienza che prima, anzi, chiamando[lo] a sé gli disse eh' ei confessava che non era stato tenuto tal conto di lu i qual'ei meritava: della qual cosa, disse egli, ne biasimo sinora i capitani particolari che vanno distribuend o le grazie e gli o nori per favori e non per merito, ma d'ora innanzi ne darò la co lpa a te medesimo se tu non parli quache volta a me e non mi dici in privato le tue necessità quando tu avrai bisogn o di qualche cosa. Et avendogli dett e q ueste parol e gli fece presente di un cavallo e l'onorò d'altre grazie delle quali si costuma di ricompensar i bravi uomini; il che fece che dopo tal giorno il sol d ato diventò fe de li ss imo et affezionatissimo al serv izio de' Romani, perché egli parve a Fabio che non vi fosse ragio ne alcuna che i domatori, i cavallerizzi et altri che fanno professione di domare le b estie irrazio nali, levasse ro loro la fierez za salvatica e la ferocia che le hanno di natura colla diligenza, colla costanza e con la cura del loro nutrimento piuttosto c he col batterli a colpi di sferza, e che qu ello che piglia a governare degli uomini non usass e più pazienza, dolcezza e clemenza che ruvidezza per correggerli.
6. Che se la dolcezza non vale, né si può con sicurezza usare il rigor e apertamente, tentasi di co nseguir con la frode quello che non s i può con la forza, e nel fu rore della battaglia s i fanno uccidere da i suoi medesimi.

7. Amilcare, vedendo che i fra n cesi su oi ausiliari passavano frcquantemente al servizio de' Romani , subornò i suoi più fedeli a simulare di andar a rendersi, i quali tagliarono a pezzi i Romani ch'erano iti a rincontrarli per riceverli, fa qu al astuzia non so lo giovò ad Amilcare nel presente successo, ma fece anche nell'avvenire c he i tr ansfughi ve ri fossero sospetti a' Romani. Annone, Capitano de' Cartaginesi nella Sicilia, aven do trovato che circa 4000 francesi ausiliari avevano conspirato di andar a rendersi a' Romani perché non avevano ricevuto lo stipendio d'alcuni mesi, n é avendo ardire di castigarli p er paura di sedizione, promise di ricompensare con gran liberalità l'ingiuria della dilazione, p e r lo che, rendendo grazie i frances i e date in tempo opportuno le cose p romesse, mandò un suo
IS6 Perché non sempre appare opportuno andare troppo a fondo.
tesoriero fedelissimo a Otacilio, Console de' Romani, il quale, come se fosse fuggito per non aver potuto render conto della cassa, avvisò che nella notte seguente si potevano acchiappare 4000 francesi ch e erano stati mandati a foraggiare.
Otacilio non diede s ubito credito al fuggitivo, et anche giudicando di non dover sprezzar l'impresa mise in imb oscata una mano di gente scelta de' suoi, dalla quale colt i i francesi satis fecero doppiamente al consigl io d' Annone: batterono i Romani et essi furono tutti tagliati a pezzi.
Annibale, sapendo che alcuni de' suoi soldati vo li ano passar la notte seguente al nemico e che nel suo campo si trovavano spioni del nemico, pubblicò apertamente che non si dovevano chiamar fuggitivi soldati diligentissimi i qual i per suo commandamento uscivano ad intendere i consig li del nemico, le qual cose furono subito dalle spie rapportat e ai suoi. Allora i Romani presero i transfughi e, tagliate loro le mani, li rimandarono.
Ificrate, essendo fuggiti ai Lacedemoni soldati suoi mercenari, mandò lettere occulte ai loro capi, avvisandoli che si riunissero nel tempo previsto nel quale s'aspettava anche aiuto d'Atene, sapendo che le lettere sarebbero capitate ne ll e mani delle guardie del nemico . Ora dopo che le guardie portarono queste lettere ai Lacedemoni, essi vollero fare imprigionare i transfughi i quali cercavano novamente di fuggirsi, essendo stati perfidi alli Ateniesi · in effetto, et ai Lacedemoni solo in apparenza.
Con simile astuzia, il Co lonnello de Cordova a Frankental fece impiccare presso al nemico due soldati che gli erano sfuggiti 1 57 .
La modestia si richiede nelle parole , ne' vestiti e ne' fatti .
I. Nelle parole, accioché i soldati non siano vani, gonfi di bocca e, come si dice, fanfaroni e t rasoni 158 , che , nei conviti e nei circoli, quando si parla dei nemici appena possono ritener le m~ni, ma quando li veggono in viso appena ne soffrono l'aspetto. E di sicuro che i più poltroni ed i più vili ed i meno arditi nel pericolo
_
157 L'episodio di Ificrate si verificò nella G uerra del Peloponneso (460-404 a.C.); quello di Gonsa lvez de C6rdoba (generale spagno lo, da non confondere con i l "Gran Capitano"), nel 1621.
15 8 Termine già usato ne lla prefazione (cfr. n. 2 bis) Tutto il passo nel su ccessivo par. II viene dal Veltzé (I , 188) presentato in una t r aduzione im prec isa . Da notare ch e l'episodio attribuito al Tilly non è documentato.
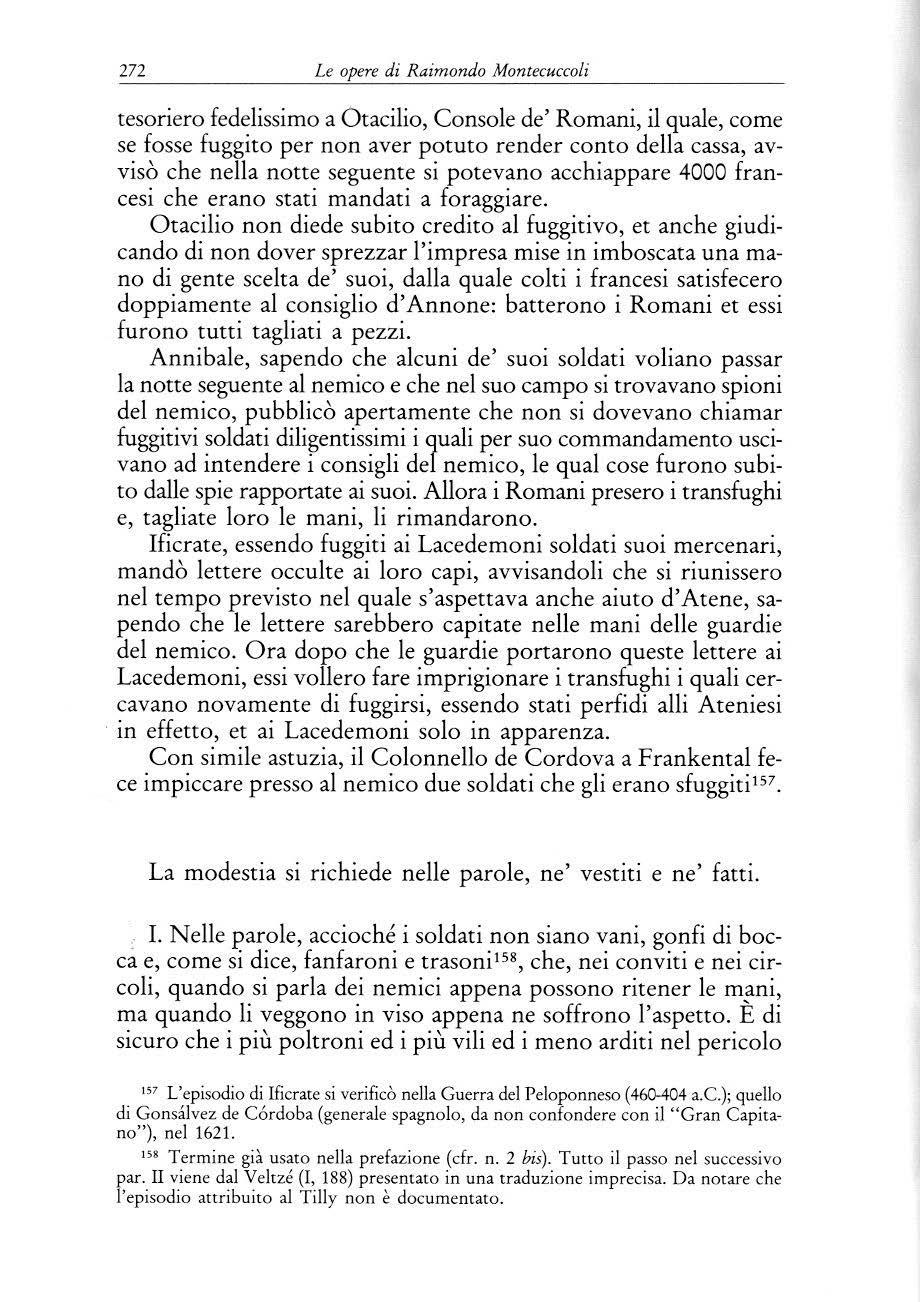
sono i più eccessivi nelle parole ed i più feroci nella lingua, perché cane che latra non morde, e gli uomini forti sono veri nell' opere, et innanzi all'opera placidi e quieti, perché il loro petto pieno d'animo e di sdegno tacito differisce tutta la ferocia nell'istesso atto della zuffa.
II . N elle vesti, perché il soldato dev' esser orrido, non intagliato d'oro e d'argento, ma fortificato di ferro e d'animo. Il Tilly riprese publicamente il Bernstat con parole ignominiose perché egli era vestito d'un abito troppo sontuoso e delicato. Ogni luogo, ogni tempo ha la sua differenza; altri è il cortigiano, altri è il soldato, e fra le dame stà bene un vestito che fra le schiere non conviene; il campo non sopporta le delicatezze della corte . Schifi il soldato le robe di seta, gli ornamenti donneschi et altre superfluità che pare non possano star insieme con la ferocia dell'armi e col peso della corazza, ma nel resto sia il vestito fiero e bizzarro, ornato di piume, sciolto e di novella usanza.
III. Ne' fatti , accioché i soldati siano ubbedienti non solo ai commandi, ma anche ai cenni del capitano, né vogliano piuttosto interpretare che eseguire i suoi ordini, perché sono divisi gli uffici fra i capi e fra i soldati: questi abbiano armi et animo, a quelli si lasci il consiglio et il reggere la virtù loro; la milizia sta più nell'ubbi dire che nel perscrutare gli ordini de' capi. Queste cose fanno buona milizia: volere, temere, ubbidire.
I. L'astinenza è pur richiesta parimente, accioché 1 soldati s'astengano dalla forza e dalle rapine et abbiano le mani p1::1re. Non si permetta che i soldati siano insolenti ai possessori: vivano coi provinciali col retto civile, né insolentisca l'animo che si sente armato, perché quello scudo del tuo essercito deve procurare il riposo ai villani. Niuno rapisca l'altrui pollo, né tocchi l'altrui pecora, né svelga l'uva, né guasti i grani, né chiega l'olio, sale , legna. Sia contenuto del suo commesso e passi in modo che si possa dire che non solo le mani, ma neanche il vestigio abbia nociuto 159
1 s9 Imp o rtantissimo p asso d a cui appare la cura pos ta da M. nei rappo rt i co n la p opolazione civ ile, specialm ent e c on i co ntadin i Sebben e egli avesse pr o b ab ilm ent e appreso ta li principi dal W al le nst ein, egli appare i l p rim o c h e li a bb ia formu lati sis t e m at icam e nte e che n e abbi a fatto un fonda mento de lla s u a do t t r in a

1. Furono alcuni onorati come D ei perché diedero sì bu on ordine a tutte le cose, eh' essendo la loro armata alloggiata in una città, non fu fatto torto né dispiacere a persona, sì come appartiene di far a quelli che hanno la carica di alcuna cosa, i quali devono vigilare diligentemente per la conservazione di quella.

2. T. Quint io Flaminino , sendo avvisato che Fi lippo, passando per la Tessaglia, come fuggendo di paura avea fatto uscir gli ab itanti fuora delle città, ritirarli alle montagne e poi mettere il fuoco nelle case abbandonando a spogliar ai suoi soldati quello che gl i abitanti vi lasciavano di lor beni perché essi non potevano portarli via a causa della gravezza o della quantità, talmente che parea che eg li abbandonasse già il paese ai Romani, ebbe l'occhio, et avvisò le sue genti di passarvi senza farvi alcun danno come in paese che era già a loro tutto quanto ceduto dal nemico . Né stettero guarì a sentire quanto avea loro giovato quest'astinen za, perché subito che entravano nella Tessaglia le città si resero loro volontariamente, et i Greci medesimi a bitanti per di là del passaggio Termopili desideravano singolarmente di veder Tito, non domandando altra cosa che darsi a lui. Quei dell' Acaia similmente rinunziarono alla lega che avevano con Filippo e, quello che è più, determinarono nel loro consiglio di fargli la guerra in compagnia de' Romani. Non si può dire quanto app lauso acquistasse il R e di Svezia entrando in A lemagna e quando aitasse alle sue cose l'aver subito frenata la l icenza dei soldati, con i detti suoi proibendo che non abbruciassero né pigliassero per forza più di quello che era stato ordinato, et aggiungendo molte altre cose accioché i soldati non fossero gravi ai popoli, perché non solo guadag n ano la benevolenza e gli animi degli abitanti, avvezzi prima all'esto r sione dei so ldati cesarei; ma anche ritrasse n el detto e nella disciplina 'militare l'esercito, perché se egli avesse concesso il paese all'arbitrio dei soldati, spogliate le case et i troni, avrebbero portato seco ogni cosa, onde ne sarebbe nato u n gran bagaglio e grande impedimento all'armata, et il so ldato sarebbe passat o dalla disciplina alla dissoluzione et al lusso 160
3. Nell'astinenza si comprende anche la purità dal furto, il quale è gravemente proibito e punito, né la preda stessa è lasciata libera
160 Sebbene agl i inizi la condotta d i Gustavo Adolfo potesse venir citata ad esemp io , successivamente, per la deficienza logist ica delle forze svedesi, egli do vette sempre più acquiescere alle estors io ni nei confronti della popolazione.
ai soldati, ma si mandano per manipoli, per coorti e per legioni accioché facciano preda nel paese nemico e la portino, ma con legge che essa sia comune. Onde i Romani, per raffrenar l'avarizia e l'ingiustizia che gli è compagna, facevano portare tutta la preda al questore che la vendesse, e del d enaro pagavano il so ldato sì che la preda per lo più apparteneva al pubblico, e s'ella era talora concessa ai soldati per riunirsi i lor animi e per farli più probi nelle cose ardue e difficili , questa concessione era ancora sotto legge e norma di divisione.
Qualche volta si mutavano ogni giorno i soldati che restavano e che andavano a buttinare, qualche volta non si mutavano, ma una volta so la si separavano, come a dire di ciascheduna legione cinque coorti erano mandate a buttinare e cinque rimanevano alle bandiere, ma la preda raportata era egualmente divisa e vi interveniva anche la sorte et il gioco quando dividevano le cose, e non il denaro, la qual cosa s i osserva anche oggidì fra i reggimenti, nel mandar a foraggio in partita dove la parte tocca anche a quei che rimangono alli stendardi e l e parti si dividono per sorte, né è lecito a nisuno della partita il nascondere cosa alcuna in particolare, ma tutto si deve collocare e mettere in mezzo, e però usan o i soldati, quando escono per andare in partita, che ciascuno mostri e palesi quello che egli ha appresso di sé, accioché poi dopo il buttino si sappia che tutto ciò che egli avrà di più di quello c h e e bbe prima appartiene in comune.
Il. P er tenere questo buon ordine in un esse rcito egli è prima necessaria la sicura numerazione degli stipendi, perché di che altro può v i ve r un so ldato se non dello stipendio o della rapina? E co l pretesto di prendersi delle cose n ecessarie al vitto fanno mille altri disordini, ma, pagati, non hanno pretesto alcuno d'andar fuori, e se vi vanno , sieno castigati duramente. Tale è il secondo rimedio, ma qualunque volta manca il pagamento conviene che manchi la punizione, perché tu non puoi castigare un so ldato che rubi se tu non lo paghi, né qu ello, volendo vivere, si può astenere dal rubare; ma se tu lo paghi e non lo punisci diventa in ogni modo insolent e perché tu diventi di poca stima.
1. I Romani militarono da principio più di trecento a nni senza soldo, mantenendosi a proprie 'Spese, il che non era loro molto difficile perché in quel tempo non facevano guerra molto lontano

da Roma. Ai soldati a cavallo però si dava il cavallo del pubblico, et erano assegnate vedove che somministravano il foraggio per esso. Ma quando cominciarono a uscir d'Italia fu necessario di dar la paga la quale dal cominciamento era molto picciola, poi ella crebbe con la grandezza dell'Impero Romano. Era lo stipendio di tre sorte: in denaro, in formento et in vestiti.
2. Il denaro fu da principio molto poco, perché era somministrato il vitto del soldato e nei trionfi erano spesso i donativi; poi v'era no le promozioni, e per la virtù salivano a gradi maggiori e perciò a stipendi migliori, sicché nonostante la scarsezza del soldo molti erano pronti alla milizia. I soldat i a cavallo aveano tre volte più soldo che quelli a piedi sia perché essi erano di condizioni più nobili, sì perché aveano ad aver più travaglio, e con più difficultà manteneano il cavallo . Gli ufficiali aveano proporzionatamente più che i soldati. Oggidì si dà 15 talleri al mese al soldato in corazza e 5 talleri al mese al fantaccino, come più chiaramente si può vedere nel Bestallung 161 dei Colonnelli dell'Imperatore.

In penuria di denari hanno alcuni chiesto in prestito al pubblico il denaro delle gabelle dell'anno seguente e dato alle città le gabelle pubbliche in pegno del prestito. A ltri hanno accordato coi colonnelli dell'esercito che ciascuno desse un mese o due di paga ai suoi ufficiali e ai suoi soldati, promettendoli ad un certo t empo rimborso e ricompensa dall'Imperatore. Ovvero se ciò non potessero , hanno accordato che i colonnelli, i capitani e gli altri ufficiali fossero contenti di restar senza paga e ch e il soldo fosse tocco solamente dai semplici soldati, il che si è usato molte volte nel1' Armata imperiale.
In qualunque modo si sia, bisogna che la paga sia proporzionata talm ente che il soldato se vi possa ben intrattenere.
3. Il formento, i vestiti, l'armi e le tende per i so ldati e l'orzo per i cavalli era anche fornito dai magazzini (ribattendo le cose sopra il so ldo dei sol dati): sa le, legumi e carne salata. Il che è buon ordine e totalmente necessario per far sussis t ere un'armata, perché, oltre che vi è sempre la più gran parte dei soldat i cattivi economi e s'egli non vi si provvede si troveranno sempre mal nutriti e mal vestiti, ancora egli è cosa impossibile che il soldato trovi per tutto pane a comprare, e che possa portare tutto quello che
gli è necessario. Quand o l'armata svedese è stata nei paesi litorali del Mar Baltico, l'hanno saputa intrattenere molto economicamente con aringhe, cascio e simili companatici.
III. Quando i soldati ricevono le cose necessarie, si usano diverse diligenze per tenere buon ordine.
1. Si mandano ordinanze e si pubblicano a suon di trombe o di tamburi e si fanno gride che sotto pena della v ita persona non esca fuori del quartiero o si parta dallo standardo senza licenza e passo segnato dal colonnello; et il generale, quando acchiappa qualcheduno che contravviene agli ordini, incarica il colonnello del cui reggimento è il soldato, a risponderne; il colonnello si piglia al capitano et il capitano al caporale della cui squadra è il soldato, accioché ciascuno sia obbligato ad aver lo occhio vigilante sopra i soldati, che non facciano disordine.

2. Si manda fuori il Rumormeister 161 b is accompagnato dal carnefice e servito da una compagnia che si tie ne a questo effetto nel1'esercito ovvero che si commanda di tutti i reggimenti dell'esercito, accioché possa subito far impi ccar agli alberi chiunque troverà fuori senza passo. Et accioché i colpevoli non possano far difesa, è obbligato l'ufficiale che è comandato a guidar li soldati di far darli n ell e mani del Rumormeister ovvero egli è obbligato rispondere per i colpevoli.
3. Quando le persone dissolute sono molto forti, si suole anche mandare un colonnello con mille cavalli comandat i, accompagnato dal prefetto o dal Rumormeister, accioché batta, castighi e faccia impiccare tutte queste partite, e i co lonnelli vanno di mano in mano secondo l'ordine uno dopo l'altro, e ciò usava di far l' Aldringen in Baviera .
4. S'egli è di necessità il foraggiare, si comanda che ciaschedun colonnello mandi a foraggio in buon ordine, cioè mandi un capitano con 50 o 60 soldati e con passaporto sufficiente e che detto capitano sia obbligato di tener i foraggieri insieme, vedere che non si piglino se non quello che è di necessità per il vitto e di rispondere per tutto quello che fanno, e, dopo il ritorno, di rendere su-
16
Ufficia le adde tto alla disciplina.
bito minuta relazione di tutto quello che è passato del luogo dov' egli ha foraggiato e della qualità e della quantità del foraggio che ha portato.
I premi e le pene sono totalmente necessarie per incitare i virtuosi a far bene e ritener i viziosi dal far male . Il mestiero che ha più bisogno di tali aiuti è quello della guerra, dove, per il semplice soldo col quale appena si può vivere e col quale il minimo artigiano non si contenterebbe, il soldato s'abbandona a tutte le sorti di pericoli e di fatiche.
I. I Romani avevano proposto premi per ogni egregio fatto, dal qual sperando il soldato in promozioni, onori e ricchezze, combatteva con molto più amore. Ed è noto che quivi sottentra il pericolo e la fatica, donde si spe ra onore et emolumento, e nessuna cosa. è desiderata da alcuno il cui frutto egli non abbia prima prev isto.
1. Essi dunque lodavano pubblicamente alla presenza di tutti gli altri soldati quelli che avevano fatta qualche az ione va loro sa e straordinaria. Et inoltre si donava a colui che avesse ferito il nimico nelle scaramucce e nei piccoli combattimenti e che vo lontariamente era ito ad attaccarlo, un dardo. A colui che l'avesse morto e spogliato, s'egli il percussore era uomo a piedi, uno scudo, e s' egli era uomo a cavallo un arnese da cavallo . A chi prima saliva sopra il muro delle terre nemiche in un assalto, una corona murale. A chi combattendo salvava la vita ad un suo concittadino, la corona ci vica che gli era posta sulla testa da colui eh' era stato salvato, il quale per tutto il tempo di sua vi ta lo rispettava et onorava come un padre. A chi primo ent r ava nelli alloggiamenti dei nemici, la corona castrense. Al capitano che liberava una città dal1' assedio, la corona ossidiona le . E quelli che conseg uivano doni per alcuna di queste cose , oltre alla glo ri a et alla fama che ne acquistavano tra i soldati, poiché egli erano tornati nella patria, con solenni pompe e con gran dimostrazione tra gli amici e parenti le dimostravano 162 •

I capi aveano ancor loro la sua parte degli onori per i di versi trionfi che essi ottenevano, seco ndo la grandezza delle loro azioni e la felicità delle loro vittorie.
162 Intendasi: le esib iv an o.
Ne importarebbe punto servirsi oggidì delle loro medesime rimunerazioni, bastando che fossero equipollenti a quelle per riceverne la medesima utilità, cioè di eccitare i buoni uomini nelle belle azioni. Secondo la costituzione di reami o di repubbliche, si deve usar tal modo che l'onore di que generali che hanno fatte belle azioni e resi gran servizi, non sia diminuita o sprezzato, perché l'animo più generoso che scuserà facilmente ogni mancamento d'altra ricompensa alla sua servitù, non soffrirà mai d'esser frustrato dell'onore dovuto alle sue belle azioni, e si disgusterà piuttosto di questo rifiuto d'onore che d'ogni altra cosa, dal che sovente sono nati gran mali.
2. Una sorta di ricompensa è anche il distribuir un buttino ai soldati, il dar un buon quartiero d'inverno ad un reggimento; l'Imperatore suole premiare molti con i beni confiscati dei ribelli e con l 'avanzamento delle cariche che accrescono gli onori ed i profitti.
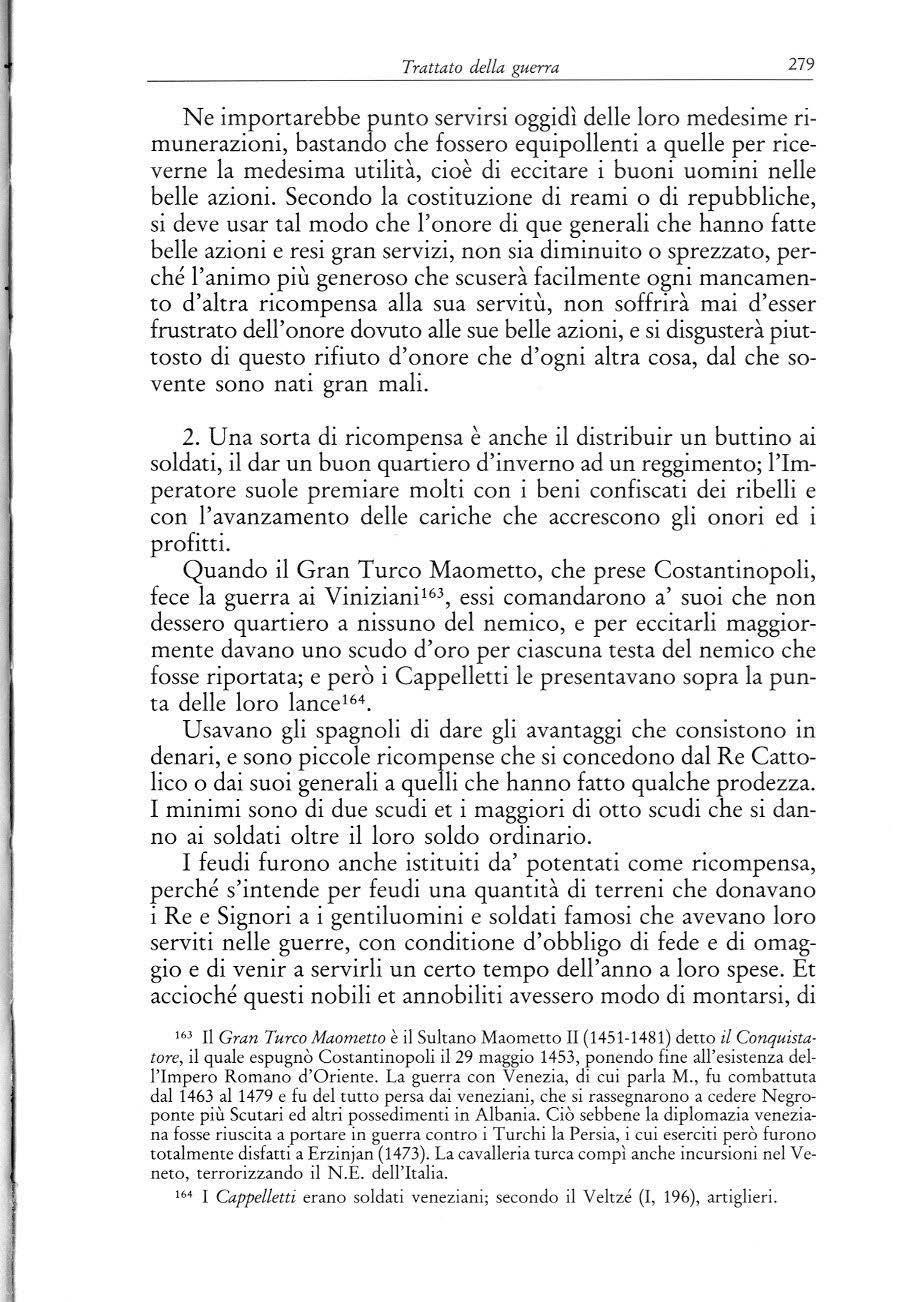
Quando il Gran Turco Maometto, che prese Costantinopoli, fece la guerra ai Viniziani 163 , essi comandarono a' suoi che non dessero quartiero a nissuno del nemico, e per eccitarli maggiormente davano uno scudo d'oro per ciascuna testa del nemico che fosse riportata; e però i Cappelletti le presentavano sop ra la punta delle loro lance 164
Usavano gli spagnoli di dare gli avantaggi che consistono in denari, e sono piccole ricompense che si concedono dal Re Cattolico o dai suoi generali a quelli che hanno fatto qualche prodezza.
I minimi sono di due scudi et i maggiori di otto scudi che si danno ai soldati oltre il loro soldo ordinario.
I feudi furono anche istituiti da' potentati come ricompensa, perché s' intende per feudi una quantità di terreni che donav ano i R e e Signori a i gentiluomini e soldati famosi che avevano loro serviti nelle guerre, con conditione d'obbligo di fede e di omaggio e di venir a servirli un certo tempo dell'anno a loro spese. Et accioché questi nobili et annobiliti avessero modo di montarsi, di
16 J Il Gran Tu rco Maometto è il Sultano Maometto II (1451-1481) detto il Conquistatore, il quale es pugnò Costanti n o poli il 29 maggio 1453, ponend o fi n e all'esistenza dell' Impero Romano d'Oriente. La guerra con Ve nez ia, di cui par la M , fu combattuta da l 1463 al 1479 e fu del tutto persa dai veneziani, che si rassegnarono a cede r e N egroponte più Scutar i ed altri posse di menti in Albania Ciò sebbene la diplomazia veneziana fosse r iuscita a portare in guerra contro i Turchi la Persia, i cui ese rcit i però fu rono totalment e disfatti a Erzinjan (1473). L a cavalleria turca co mpì anche incursion i nel Vene to , terrorizzando il N.E. dell'Italia.
t M I Cappelletti erano soldati veneziani; secondo il Veltzé (I, 196), artiglieri.
intramettersi e di intrevenirsi, permisero loro di dare le loro terre a dei paesani a diritto di rendita, et anche concessero loro alta giustizia mezzana e bassa sopra i loro uomini e vassalli , essendo le appellazioni di quelle giustizie riservate alla loro giurisdizione sovrana . Di qui ve ngono gli arrier-bans di Francia 165
Sarebbe anco lodevol cosa che sacerdoti o altre persone incorrotte tenessino un libro nel quale scrivessino ogni atto egregio di ciaschedun sol dato e poi lo riferissero all'Imperatore al tempo della rimunerazione, perché questa è la cagione che molti non hanno poca e punta [voglia] di operar cose straordinarie, e che molti nobili e cavalieri non vogliono anche servire in guerra, perché ciascuno dice: " Il mio R e non vi è in presenza, che possa vedere le mie azioni valorose, né voglio anche sottomettermi alla relazione di un capitano che forse mi sarà inimico, o invido, o poco grazioso".

Fra le ricompense de' soldati sono anche i privilegi che hanno , cioè che sono esenti dai gravami, non possono essere messi in prigione per debiti, non possono essere messi alla tortura, qu ello che acquistano in guerra è talmente loro proprio che il Re non v i ha autorità nissuna, sono scusati dall'ignoranza del dritto, possono far testamento senza le so lennità, ecc. Alcuni principi proveggono anche di stipendi i soldati, che durano tutto il tempo d ella loro vita, benché dalla vecchiezza o dalle ferite o da altro accidente siano resi stroppiati et inutili; il che fa che combattano con molto coraggio . Altri continuano anche i stipendi ai figliuoli pupilli dei soldati che moiano in guerra, il che fece Alessandro.
il presente amore dell'esercito specioso, ma poco a poco et occultamente diminuiscono la disciplina militare, però sono anche necessarie le pene, accioché il rigore del supplicio ritenga i cattivi dal mal fare; e la disciplina militare ha bisogno d'un aspro genere di castigo, perché le forze stanno nell'armi, le quali, se si sviano dalla strada
16S L'arrier-ban, istituzione mi litare fe udal e le cui origini risalivano a Carlo Magno , consisteva nelJ'obb li go di tutti i vassalli d i accorrere a difen dere in armi il sovrano, organizzati secondo la gerarch ia feudale. Ogni uomo libero era te nuto ad armarsi ed a forn ire il cavallo a propr ie spese. I re ricorsero sempre meno all'arrier-ban, prefer e ndo i propri eserciti persona li , assai più efficienti e sicu n. L'arrier-ban finì per diventare una specie di mi lizia, assai poco valida ed a cui si r icor re va so lo in caso di emergenza. (Cfr.:
S1R CHARLES OMAN, A History of the Art of War in the Middle Ages, New York, 1924, due volumi, voi. I, pag . 79 sgg.; HANS DELBRUCK, Geschichte der Kriegskunst im Rahmen der politischen Geschichte, Berlino, 1920 sgg , 6 volumi, voi. III, pag. 79 sgg.).
diritta, opprimono se non sono oppresse. La pena e il timore correggono i soldati nei quart ieri, nell' espressione 166 la speranza et i premi li fanno migliori.

1. I Romani punivano di pena capitale chi manc ava nelle guardie, chi abbandonava il luogo che gli era dato a combattere, ch i portava cosa alcuna di nascosto fuori delli alloggiamenti, se alcuno dicesse avere fatto qualche cosa egregia nella zuffa e non la avesse fatta, se alcuno avesse combattuto fuora del comandamento del capitano, se alcuno avesse per timore gettato via l'a rm e, se avesse detto falso testimonio, se avesse abbandonato il suo corpo all'impudicità o se fosse ricaduto tre volte nei mini mi errori, perché st imavano un tal di natura cattiva fatto a peccare cont umac e, e che peccasse quasi per ischerno e sprezzo della legge; sì come anche era punito capitalmente l'alfi ere c he abbandonava l'ins egna. E quando li occorreva che una coorte o una legione intera avesse fatto simile e rr ore di fuggire o di mutinar si, per non li fare morir e t utti, li imborsavano tutti e ne traevano la decima parte, e quelli morivano; la qual pena e ra in modo fatta che se ciascuno non la sentiva ciascuno nondimeno la temeva; e talora ne traevano la ventesima parte, talora la centesima. La qual cosa è molto necessaria per imprim ere questa credenza nei soldati: c h e per fuggir e v ilm e nt e non scam pano la morte, ma solamente cambiano una morte gloriosa che avriano conquistato combattendo valentemente con una morte infame e vituperos a.
2. Avevano anche pene più dolci d'ignominia, come dar orzo in vece di formento, accioché paressero indegni del commun cibo dei soldati ma fossino rigettati ed eguagliati ai giumenti; ritener loro lo stipendio, farli dormire fuori del campo, disarmarli, scriverli da un ordine di milizia più degno in uno più basso, cacciarli dall'essercito, frustarli: il che usano anche oggi i Turchi et altri Orientali; [o] farli cavare un fosso.
Altri crucifigevano chi fuggiva nella zuffa e portavano i soldat i a vin cere o a morire, il qual rigore usava anche il Re di Svez ia con gli Svedes i, e cavavano gli occhi a chi avesse dormito in sentinella.
Altri non davano, ma riserbavano il castigo ai soldati, accioché tanto più valorosam en te combattessero, dovendo cance llare
166 Parola di i ncerta lett ura. Il Velczé (I, 197) se la cava sos t it uendo a lu me di naso: im Felde, in ca mpo, vo cabolo ch e certamente non si può r intra ccia re , nem meno per analogi a, nei Ms .
un peccato insigne con qualche atto di fortezza similmente memorabile et insigne. Et il cont e di Bouquo y 167 soleva a questo essempio riserbare qualche condannato alla morte per impiegarlo in qualche azione pericol os issima e quasi sicura della morte.
3. Nelle nostre guerre la giustizia militare è nelle mani del Marescial di campo; i colonnelli d'Infanteria l'hanno nel loro reggimento, ai colonnelli di Cavalleria viene disputata.
La maniera di procedere n el tener processo sopra la vit a di un delinquente et il modo di punirlo e per qual cagione, è diffusamente descritt o nelli articoli di guerra, secondo il contenuto dei quali i soldati prestano giuramento .
Si hanno molti essempi che quei che hanno reso una piazza senza potersi giustificare d'essere stati costretti da una estrema necessità, sono stati decapitati, come quel colonnello s assone che rese il confine al co lonn ello Montecuccoli 168 e poi fu fatto decapitare dal Re di Svezia a N euburg; e cos ì anche fu fatto decapitare dall'Imperatore Fahrenspach, il comandante che rese Cham al Banér, ecc . 169 •
Similmente Cratz e Schaffgotsch furono decapitati, l'uno a Vienna, l'altro a Rati sbona per aver usato tradimento; la Chapelle per esser fugg it o all'inimico; il governatore di Wesel chiamato Lo zanus, per aver lasciato sorprender la piazza dagli Olandesi fu decapitato in Anversa, e sono infiniti i casi dei castighi ai quali giornalmente si puniscono i delinquenti d ell'armata1 70 •
167 Il conte C harl es de Boucqu oy (o Bucquoi), generale i mp eriale, batté il 10 giugno 1610 a Sablat il Mansfeld durante i l Periodo Boemo della Guerra dei Tre nt' anni (Cfr : PETER BROUCEK, Feldmarschall Bucquoy als Armeekommandant, 1618 bis 1620, in : Der Dreissigjiihrige Krieg, Wien, 1976, pag. 25 sgg.).

168 Si tratta di Ernesto Montecuccoli, cugino anz iano d i Raimondo, e l'episodio avve nne a Ra in am Lech, nel settembre 1632.
169 Tutto il passo è poco le ggibi le i n entr ambi i Ms. Il Veltzé (I , 199), congettura: " ... den Fahrensp ach und den Com m andante n, der Cham an Bern hard iibe r gab ... ", cercando cioè di leggere il testo origi nale in Italiano come segue " ... il Fahrenspac h ed il comandante che rese Cham a Bernardo ... ". E ffettiv am ente il conte di Fahrenspac h fu decapitato il 19 maggio 1633 a Ratisbona; ma poic h é la resa di Cham avven n e n e l n ovembre dello st esso anno, la congettura sembr a da respingersi: e l'episodio deve essere u n altro , n on m egli o precisato.
170 Il generale capo delle guardie Cratz ed il Conte Schaffgotsch furono messi a morte nel 1635, il seco nd o per sospette complicità con Wal lenstein; il T. colonnello la Chapelle lo fu nel 1633; il Governatore spagnolo di Wesel, Franz Lozanus, fu decapitato nel 1629: tutti p er va ri casi di tradimento e diserzione.
I viveri sono sì. necessari nell'armata che senza quelli non si può vivere nonché vincere, e chi non li prepara a tempo è vinto senza ferro . Nelli altri casi si può aver aiuto dal tempo: e i foraggi e le proviande non hann o rim edio nella necessità se non sono prima provvisti. Devons i prevedere in duplicato uso, cioè per i presidi nelle fortezze e per i soldati nel campo.
Quanto a viveri per le guarnigioni, se n'è parlato abbastanza nella Pecorina num ero III. Quanto ai viveri del campo, devonsi avere molte considerazioni, perché la mendicità ch iama gli armati ad ogni disperazione et un essercito digiuno non può osservare la disciplina, il che purtroppo si sperimenta in questa guerra, e più armate sono state distrutte per la fame che per le zuffe. Banér rovinò l'armata svedese a Torgau, Galasso l'Imperiale all'Elba 171 •
Per quest'effetto , il Commissario Generale dei Viveri, o Generale di proviand meistar, deve essere un uomo d'autorità, fidele, vigilante et attivo. E questa carica era sempre commessa dai Romani a qualche persona segnalata, perché ella è di tale importanza che, secondo che ella è bene o mal amministrata, fa sussi. . ster o rovmar un esserc 1to .
La provigione dei grani si deve fare di buon'ora, né aspettar a farla nella carestia, ma quando si è in abbondanza si deve provvedere alla penuria, perché allora mentre che non pare che se n'abbia un est remo bisogno si otterrà più facilmente da quelli i quali devono darla n é si verrà accusato d'improvvido da' suoi soldati.
171 Dur issima critica a co mandant i che pure il M. stimava molt issimo: ma egli era estremamente severo con le deficienze logi st iche, ché per lui la logistica era i l p ilast ro della guerra.

Ella deve anche essere sufficiente in luogo comodo per condurla al campo e fatta di buon grano, perché non bisogna sempre fermarsi sulla speranza che si ha di trovarne in campagna né ai luoghi dove si v u ol andare, perché il nemico li potea aver richiusi o abbrugiati e ti troveresti ingannato. Un ammiraglio di Francia so leva dire che, quand'egli era questione di far un corpo cl' armata, bisogna cominciar dal ventre a formar questo mostro, perché ogni altra cosa nella ~erra si può col tempo vincere, questa sola col tempo vince te , ne sarà mai alcuno tuo nimico il quale ti possa superar:e colla fame, che cerchi di vincerti col ferro, perché se la vittoria non è sì onorevole, ella è più sicura e più certa.
I. Le provvigioni di viveri per l' essercito sono fa rina , biscotti, sale, cascio o butirro salato, i companatici devono essere asciutti e salati, perché satollano di più; e per i cavalli orzo, segale, avena, fieno ecc.
Per ché si debba ordinare l'essercito suo più spedito che sia possibile , e togliere tutte quelle cose che gli aggiungono carico e gli fanno difficili !'imprese, e tenere l' essercito provvisto di vino e di pane cotto: e però gli antichi al vino non pensavano né cuocevano il pane nei forni, ma prevedevano le farine e di quelle ogni soldato a suo modo si soddisfaceva; avevano per l'ordinario branchi di bestiame grosso e minuto che seguiva lo essercito, il quale per non avere bisogno d'esser portato non dav a molto impedimento .
Negli esserciti moderni si cuoce il pane ne' forni, perché egli è molto necessario per mant en ere i soldati in servitù, ma la provianda non si distribuisce se non all'Infanteria e molto di rado alla Cavalleria se non in estrema necessità, presupponendosi eh' ella ne trovi laddove trova il foraggio per i cavalli.
Quanto al vino et alla birra, non si proibisce il berne, o che ne venga all'essercito condotto dai mercanti, ma non si usa industria né fatica alcuna per averne fra le altre provvigioni e per distribuirlo per commesso, se non molto di rado. Tuttavia se l'essercito fosse in lu ogo che se ne potesse aver facilmente e che la condotta fosse agevole, non è dubbio che il vino o la birra, distribuito moderatamente, ristorasse molto gli spiriti e la salute dei corpi dei so ldati.
1. Le provvigioni si fanno comprandole o tassando i v icini amici che giornalmente ne proveggano, o distribu endo i villaggi e le cit-

tadelle del paese a ciaschedun r eggimento, accioché guardandole con salvaguardia sia fornito di viveri et i luoghi siano conservati, essendo ubbligato a risponderne il reggimento a cui sono assegnate; o loggiando la Cavalleria separata nei buoni villaggi se si può fare sicuramente, et imponendo a ciascun reggimento una certa somma di provianda ch ' ei debba subito inviare al corpo dell'Infanteria, tenendo per quest'effetto buoni commissari i quali, oltre ai carri che hanno con essi loro, tengano ancora in ciascuna cornetta di Cavalleria un fornaio e due cavalli da soma che subito arrivati al quartiero si mettano a fare il pane e poi lo mandano all 'Infanteria .
Ancora si fanno le provvigioni pigliando e conservando le picciole città del paese e facendo inventario di tutte le provvigioni per distribuirle parcamente, minacciando le altre cittadelle dove non si ha guarnigione d'abbruggiare una lega intorno d'esse s'elle non mandano munizione, et al contrario promettendo loro buon trattamento se conducono provvigioni e vettovaglie et altro n ecessario al campo; e s'elle sono nel mezzo fra il tuo paese e quello del nemico, si può fare et accordare di non le mol estare e lasc iar coltivare i campi purché contribuiscano ad ambe le parti, come fanno li Svedesi all ettando le genti del paese et i mercenari con doni , con guadagni e con onori a venir a vendere nel campo; infine mandando grosse partite a foraggiare sopra il nemico, i quali foraggi si distribuiscono poi fra tutto l'esercito.
2. Bisogna far i magazzini in diversi luoghi, accioché non si possano perdere tutti in una volta e, se ne fosse preso uno dal nemico, s'abbiano gli altri . Bisogna farli nelle città e nei castelli più vicini e comodi per la condotta delle provvigioni nell'armata e dove si pensa di volere campegiare o si ha disegno d'intratenersi come ha fatto Horn a Bautzen e Crossen, Banér a Torgau, ecc. 172 • Secondo il sito del paese bisogna proveder carri o muli o navi per portarle al campo dove si deve sempre avere un magazzino per quindici giorni, al quale non si tocca se non all'estremità o per qualc he impresa straordinaria. E però bisogna guardarsi di non entrar co ll 'essercito in u n luogo dove non sieno prima stat i fatti i magazzini, ovvero che non vi si possino condurre i viveri dai magazzini già fatti dietro di te, perché, sebbene s'è trovato che i soldati si sono nutriti dell'erbe della terra, delle radici, delle frondi e delle cortecce degli alberi o dei frutti o del pesce dei fiumi o dei

canali e dei giumenti di bagaglio e poi di quei di servizio e finalmente dei corpi umani, mangiandosi fra di loro, il che spesse vo lte è successo in questi esserciti, in ogni modo le armate non possono sussistere l ungo tempo in tal modo e muoiono o si indebiliscono o entrano malattie contagiose e la tota! rovina dell'armata.
Alessandro, avendo disegno di condur l'armata per un paese secco e senz'acque, mandò innanzi gente che scavassero dei pozzi, et egli intanto si fermò coll' esse rcito aspettando la primavera, perché chi è sì forte e sì robusto, ch e possa combattere contro la fame e contro la sete ?
IL La co ndotta non si deve fare se non con buoni convogli, e mai a giorno prefisso per impedire che altri non s'apparecchi a levarlo in camino; e però i lu oghi per dove hanno da passare i viveri e le munizioni si denno fortificare e guardare le strade e le vie assicurare, accioché i mercanti v iva ndi eri et altre persone che portano v iver i al campo non siano spogliati e r esi paurosi e malmenat i, pun endo rigorosam ente chi intraprende di smontarli o di assalir li per istrada.
Con le proviande, si devono anche avere molini per macinare il grano, forni/er cuocere il pane e munai che sappiano adoperarsi. Il Friedlan ordinò che ogni reggimento avesse un mulino o due nella campagna, il che ritornò in gran utile d el!' essercito 173 •
1. Si costringono talora i v illani del paese a portare la provianda in collo dietro dell'armata, e talora la pigliano e portano gl'istessi soldati sopra le loro spalle per vari giorni, secondo il bisogno.

2. Si conta che un commune molino da cavallo possa macinare in 24 ore 96 sacchi con 9 cavalli pigliando 4 sacchi in un'ora, e t re cavalli travagliando insieme; questi cavalli sono da eleggere fra i cavalli de l cannone.
Quanto ai molini a vento , non se ne può far conto per l'inc ertezza dei venti, ma con buon vento si può con u n mulino co mune macinar in 24 ore 128 sacchi . Un sacco pesa 160 libbre presupponendo di buona segale, e 28 sacchi si contano per un carico, il qual pesa 4480 libbre, sì che si puoi far e s ubito il conto quante carra ci vog li ono per carreggiare i grani, pigliando ordinariamente per un car ro 1000 o vero 1200 libb re al più, secondo la
173 Si noti - q ui come altrove - l'uso del germanismo provianda per rifornimenti o pro1,'Viste. Degno di osser vazione anche l'accenno alla prevegge nza logistica di Wallenstein
condot t a e sec o ndo che il c amino è buono o cattivo; quando il grano è macinato, si mette dentro a tonni in farina , dandogli il tempo d'infredarsi prima che di rinserrarla. Si me tt ono 200 libbre per t onno, e per il peso de ' tonni aggiuntos i quello della far i na si conta n o 5 carra per u n carico da carreggiare; e pe r carri car il gr ano su le navi da 20 a 29 Schiffs-Lasten non se ne può carricare p iù di 50 carri, se si deve ris~armiare lo spazio n ecessario per maneggiare il carico . Il p es o e se c o n d o il p es o di Olanda, dove 200 libbre non fanno ch e 30/ libbr e del p e so d i Norimb e rga dove una libbra fa 6 ,6 [o lande s i].
3. U n forno lungo 6 pi e di, largo 4, alt o 1 pi ed e , può cuocere u n sacco di segala p er volta in pani tondi e piatti , ciascheduno pesant e 4 l i bbre . Ma [se ] s i sogliono cuocer pani lunghi di 6 libbre c om e si costuma di fa r cuocere per l'armata, all'ora se ne può quasi c u o cere 2 sacchi o un po ' meno . Cuocendo dunque pani lu n gh i di 6 libbre, si cuocerà facilmente 5 volte, contan d o 6 ore pe r la prima volta: e per l' altre 4 vo lte seguesi ri scaldandol o ciascuna vo lt a di 4 ore almeno; talmente che un forno può cuocere 10 sac c hi in 24 ore, il c h e port e rà 2000 libbr e p e r la crescita e h' e i pi g lia, sì che, dandon e a ciascun soldat o 1 1/2 libb re , o vero 24 o ncie per giorn o, un fo rno c o ce rà giornalm e nt e p e r 1333 soldati; e bisogna sap e r c h e qu e sto pan e d e ve p es are tanto quando egli è cotto, perché 2000 l i bbre di pane in pasta e crudo per essere infornato, pes a da 2222 l ibbre 173bi,
•· I campi rendono più o meno secondo la grandezza Ordina r iamente in Pomerania sogliono rendere 12 per uno, sì che un Sc heffel sem inato dà 12 Sc h effeln di raccolta, 4 Scheffe l n fanno un sacco Si seminano da 3 Sch effeln in un Mo rgen Un Hufe è 30 M orge n. Un Morgen contiene 300 piedi quadri; un Morge n di Pomerania contiene 168 piedi quadri. Un piede di Pomerania è più corto di uno di Olanda di tanto: (N. d. A.}.
173 1,,, Il sistema di pesi e mis ure usato d a M è piutt ost o com p osi t o, att i ngendo eg li sia da q uell i in vigo r e in Francia e in Ispagna, c h e ne i var i Stat i italia n i, in q uelli t edesc hi e in Olanda. Come mis ura d i lunghezza egli adotta us ua lmente la verga o pass9 mode nese, p ar i a m. 1,25, da lui in d icata con "v"; q u ando fa uso de ll a ve rga r ena na (o Ruthe), d i m . 3, 77, lo d ice esp li citame nte (cfr. n . 214). Come sottomult ipl o, egli usa norma lmente il piede , la cui l un g hezza vari av a da cm . 52 (piede mo de n ese), a cm . 3 3 (pi ed e di Par igi), a cm. 32 (pie d e di V ienn a), a c m. 31 (piede di P o m er an ia e piede renano), a cm. 29 (pi ede di No r imberga), a cm. 2 8 (p ied e o landese): no n è dat o q uasi mai st a b ilire co n es attezza d i q uale specifico p iede eg li stia parlan d o sal vo c he eg li st esso lo indich i, sebbe n e, ch iar am ente, egli si atte nga i n ge n er e ad u n a misura che osc illa semp r e attorno ai 30 c m. (co n var iazion i m inim e, u na de ll e q uali è q ui in di cata dal M. stesso) ; come m u lti p lo, egli usa il mi glio , che , secondo le di ver se localit à var iava da m . 1569 (Modena), a m. 7420 (No r im b er ga), a m . 774 6 (P o m e rani a), a m . 10.689 (Sve z ia) . Dal

Quando la provianda è nel campo, bisogna soprattutto dispensarla con diligenza, dandone ogni giorno a ciascuno una ragionevo le misura, et osservare in modo questa parte eh' ella non si disordini, p erch é non può fuggire la fame quell'es ercito che non è osservante di giustizia e che licenziosamente consuma quello che gli pare, perché l'uno disordin e fa che la vettovaglia non vi viene; l'altro, ch e la venuta inutilme nt e si consuma. Devesi comunemente osservare e proibir e, dov e il paese è abbondante, che nessuno faccia m ercanzia né mandi fuori a vendere grani o vini o bestiam e, perché qùesto è il vero modo d'affamar subit o l'esercito nel miglior paese che mai possa esse r e .
I. De ve il generale farsi fare spesse v olt e un conto puntuale ragguagliato dal Commissario generale, dal Proviandmeister e dal prefetto di quanta vettovaglia ha nel campo, quanto se ne consumi giornalmente e quanto bisogna averne; accioché egli sappia come l'esercito sia forn ito .
Questo commissario dei v iv eri, o sopraintendente, tanto per gli uomini che per i cavalli, ha la cura particolare sopra i v iv eri, tanto di quelli che sono invia ti dal paese nell'armata quanto degli altri che so n o condotti da' mercanti e v ivandi er i per ven d e rli a' soldati.
1. Accioché la vettovag lia sia distribuita e non dissipata, egl i è nec essario che di otto in otto giorni il commissario generale dei contesto è difficile capire di q ual e miglio di volta in volta si tratt i, sal vo che il M. lo dica esp li citamente. Come misura di superficie, egli ut ili zza il piede quadro, anc h' esso con m i nime var ianti da lu ogo a luogo. D iversa e assai più comp li cata la si tuaz io n e p er le misure agricole, la cui unità era il Morgen, pari (i n Ola nda) a 300 pi edi quadri, o ( in Pomer ania) a 168 piedi (di Pome r ania) quadri; mult ipl o del Morgen era lo Hufe, p ar i a 30 Morgen. Le mis u re di capaci tà e di peso (ove la commist ione t r a le differenti scal e sale al massi m o), q ui usate per le granagli e e la farina so no : anzi t utto lo Scheffel, o staio, par i in O landa (ove era de tto Shepel) a litri 28, in P ome r ania a I. 55 e a No r imberga a I. 222; i ndi la libbra, che osci llava da assai meno di mezzo s ino a circa 1 kg.; qui M. dice di usare la misura o landese (che si può - con mo lta app rossimazione - ca lc o lare intorno a g. 850), p oscia il sacco (160 li bbre) e il tonno, o bari le, di 200 libbre più la tara. La stazza de lle navi da carico ven iva calc olata in Schi/js- Lasten, pari in Olanda a li tri 3004 (d'acq u a: cioè a 3 tonnellate) e ne ll e zone balt ic h e d ella Germania a I. 3298 (ossia meno di 3 tonnellate e mezza). Calcolan d o secondo il peso di Olanda, le navi da carico di cui par la M. sta zzavano dalle 60 alle 87 tonne ll ate. (Cfr.: ANGELO MARTIN!, Manuale di Metrolo gia, ossia Misure, Pesi e Monete in uso attualmente e anticamente presso tutti i popoli, To rino, 1883, ove però parec ch i dati non sono del tutto esatt i, sp ecia lmente perc h é in a lq uant i casi l ' A. dà come antiche le mis ure i mmed iatamente preced ent i l'adozione del sis te ma met r ico, o addirittura quel le ottocentesche, senza citare le p iù antiche, o confondendo le var ie scal e).

v ive ri abbia il ruolo o lista esatta di quelli che si trovano nell'armata, segnata dal gen er ale, per regolare la distribuzione del pane secondo quella, perch é se s i crede ai sergenti ne pigliano sempre ~er due volte più di qu ello che hanno soldati nella sua co mpagma.
Si usa nell'Armata Cesarea che il generale domanda ai colonnelli la lista dei loro reggimenti, i quali sono ubbligati a darla sotto alla fedeltà del loro onore e del loro giuramento, giustamente sottoscritta di propria mano e suggellata dal loro suggello . Sicché, q uando si distribuisce la vettovaglia alla I n fanteria od alla Cavalleria, lo si fa secon d o la volontà del generale dell' esserc ito e quanto ciascuno debba avere in sua parte sopra le ricevu te è scritto del colonnello o quartiermaestro del reggimento o forrieri delle compagnie, le quali sono passate dal Proviandmeister e suoi conduttori, poi sono date al commissario che fa le paghe per rac conciliarle al reggimento; la distribuzione dell'avena alla Cavalle ria è similmente ribattuta nel soldo come i viveri.
2. L'ordine del comesso è che si doni ad ogn i soldato libbr e 1 1/2 di pane per t esta e 1/2 libbra di formaggio, et ad ogni 100 uo mini un tonno di birra di due franchi, il che si può scemare od accresce re secondo che le provigioni vi possono fornire .
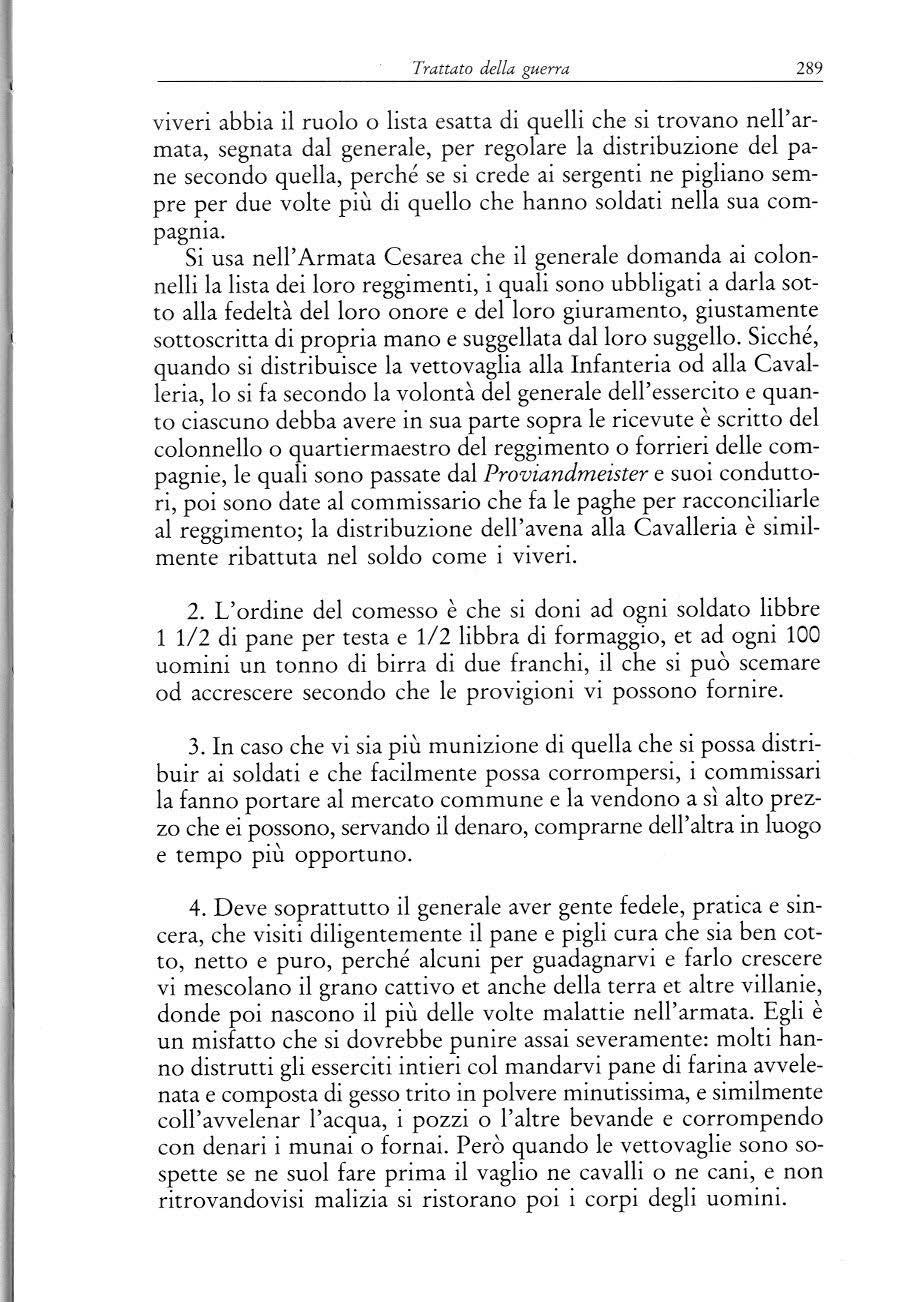
3 . In caso che vi sia più munizione di quella che si possa distribuir ai soldati e che facilmente possa corrompersi, i commissari la fanno portare al m e rcato commu n e e la vendono a sì alto prezzo che ei possono, servando il denaro, comprarne dell'altra in luo go e tempo più opportuno.
4. Deve soprattutto il generale aver gente fedele, pratica e sincera, che v isiti dilig e ntem e nte il pane e pigli cura che sia ben cotto, netto e puro, perché alcuni per guadagnarvi e farlo crescere vi mescolano il grano cattivo et a n c he della terra et altre villanie, donde poi nascono il più delle volte malatti e nell'armata. Egli è un misfatto che si dovrebbe punire assai seve ramente: molti hanno distrutti gli esserciti in tieri col mandarvi pane di farina avvelenata e composta di gesso trito in polvere minutissima, e similmente coll'avvelenar l'acqua, i pozzi o !'altre bevande e corrompendo con denari i munai o fornai. Però quando le vettovagli e sono sospette se ne suol fare prima il v aglio ne cavalli o ne cani, e non ritrovandovisi malizia si ristorano poi i corpi d egli uomini.
II. Né solamente nella bontà dei v iveri consiste la sanità del1' essercito, ma ancora in altre cose le quali si devono con somma accuratezza osservare, perché tanta lode s'acquista a conservar il suo essercito quanto a rompere quel del nemico, e leggesi che Fabio ottenne il titulo di Massimo e Scipione di Magno e che Scipione chiedesse a Massimo donde venia che col conservar l' essercito avesse acquistato il nome di Massimo, laddove egli, avendo combattuto coi nemici e disfatto Annibale in battaglia, non avea se non il titulo di Magno. Rispose Fabio: "Se non t'avessi conservato i soldati, tu non avresti avuto con che vincere".

1. Per fuggire le infirmità, non bisogna accamparsi in luoghi paludosi o esposti a venti nocivi, il che si riconosce non tanto dalle qualità del sito, quanto dal viso degli abitanti: se si veggono male colorati o bolsi o d'altra infezione ripieni.
Non bisogna far disordinare l'essercito, ma operare che i so ldati dormano sotto le tende, che si alloggi dove siano arbori che facciano ombra, dove sia legname da poter cuocere il cibo. Bisogna anco curare che l' essercito non cammini per il caldo, e però bisogna trarlo dell'alloggiamento inanzi de la state, e di verno guardarsi che non camini per la neve e per i ghiacci senz'avere comodità di far fuoco e non manchi del vestito necessario e non beva acque malvage; egli è un abuso evidente volersi ostinare a certare col rigore del tempo se non vi si è spinto da qualche grand' occasione, perché se l e cose durissime ne sono rotte e trite, tanto più bisogna che l'uomo, che è sensibile, vi ceda.
2. Quelli che ammalano a caso, si devono far curare da dottori, perché uno capitano non ha rimedio quando egli ha a combattere con le malattie e col nemico, e se qualche compagnia o soldato ha mal contagioso , subito si deve loggiare a parte e lontano dal1' essercito, accioché non l'infetti.
Egli è anche molto utile et salutare il mutare spesso il campo da un luogo all'altro, perché i naturali e necessari escrementi, rammestati sempre in un istesso l uogo, spirano aliti gravi e fetidi, e finalmente corrompono coll'odore l 'aere ambiente. Et in tai luoghi giova molto il lavarsi spesso e tenersi netto, perché la lozione frequente rende i corpi vegetanti e li conserva da quei mali che suol generar l'immondizia; e però nell'Infanteria allemanna ilfuhrer ha questa carica, di visitar ogni mattina i soldati nelle brande e costringerli a lavarsi. Le città assediate dove si può rilevare e rin-
frescare la guarnigione ogni due o tre mesi si conservano molto più sane e per conse&uenza si mantengono molto più, perché nei lunghi assedi la meta dei presidi è resa inutile dalle malattie.
3. Ma niuna cosa è tanto utile a mantenere l'essercito sano quanto l' essercizio, dal che si vede quanto ei vaglia, perché negli alloggiamenti si fa sano e nelle zuffe vittorioso. E Ciro solea dire eh' egli procurava di non si saziare mai mangiando, poiché la sazietà è difficile e grave, e di consumare con la fatica tutto quello che avea mangiato, perché si conservava più sano e ne diventia più robusto.
III. Le vettovaglie che non appartengono al commisso, ma vengono portate al campo da vivandieri e mercanti, sono trattate secondo la giusta convenevolezza dal Proviandmeister, ovvero Commissano generale, col consiglio e commando del generale, senza il cui consentimento e saputa non si deve far cosa alcuna di conseguenza nel campo; e la designazione n'è data al prefetto il quale la fa poi sapere ai venditori.
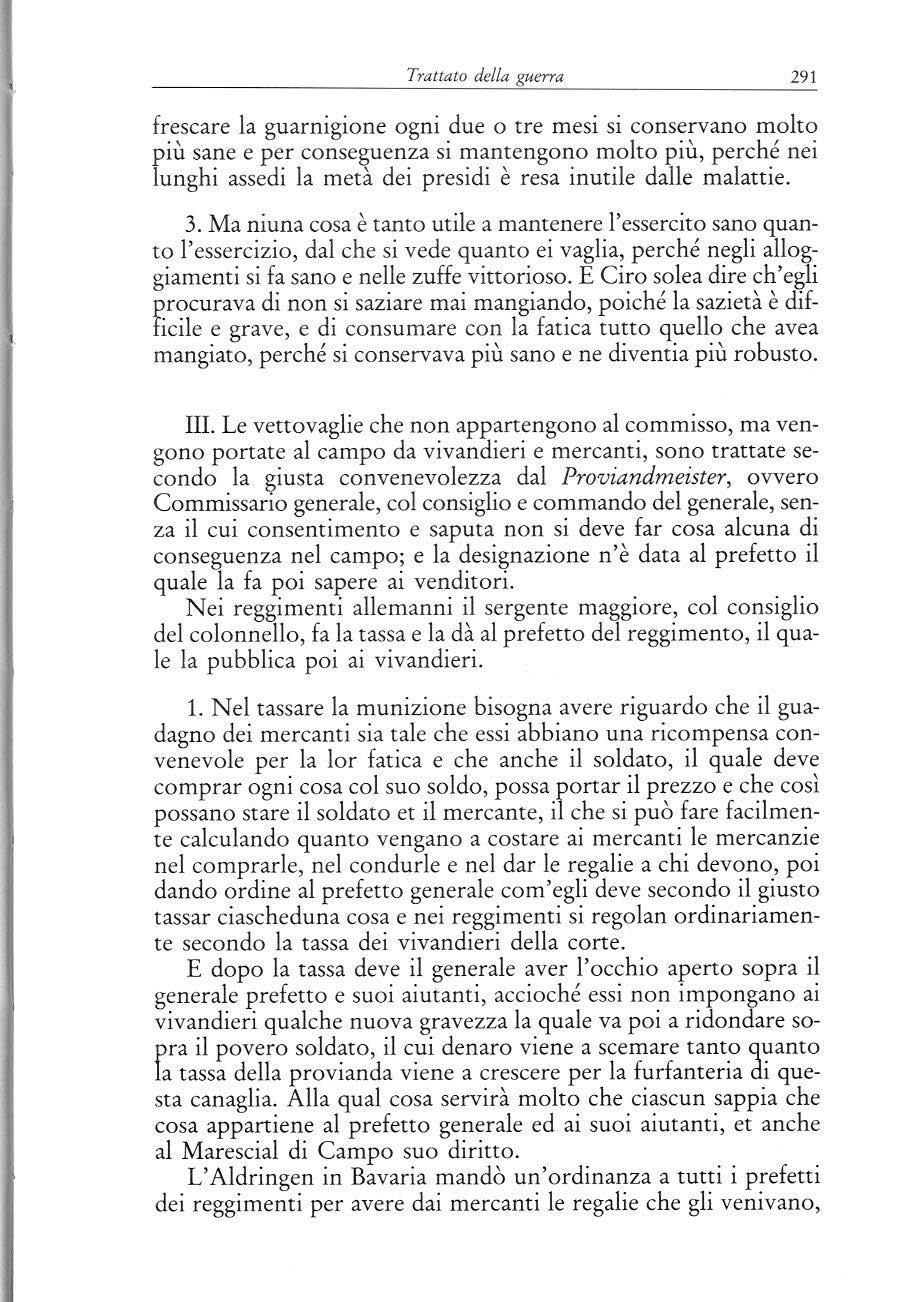
Nei reggimenti allemanni il sergente maggiore, col consiglio del colonnello, fa la tassa e la dà al prefetto del reggimento, il quale la pubblica poi ai vivandieri.
1. Nel tassare la munizione bisogna avere riguardo che il guadagno dei mercanti sia tale che essi abbiano una ricompensa convenevole per la lor fatica e che anche il soldato, il quale deve comprar ogni cosa col suo soldo, possa fortar il prezzo e che così possano stare il soldato et il mercante, i che s i può fare facilmente calculando quanto vengano a costare ai mercanti le mercanzie nel comprarle, nel condurle e nel dar le regalie a chi devono, poi dando ordine al prefetto generale com'egli deve secondo il giusto tassar ciascheduna cosa e nei reggimenti si regolan ordinariamente secondo la tassa dei vivandieri della corte .
E dopo la tassa deve il generale aver l'occhio aperto sopra il generale prefetto e suoi aiutanti, accioché essi non impongano ai v iva ndieri qualche nuova gravezza la quale va poi a ridondare sopra il povero soldato, il cui denaro viene a scemare tanto quanto la tassa della provianda viene a crescere per la furfanteria di questa canaglia . Alla qual cosa servirà molto che ciascun sappia che cosa appartiene al prefetto generale ed ai suoi aiutanti, et anche al Marescial di Campo suo diritto.
L' Aldringen in Ba varia mandò un'ordinanza a tutti i prefetti dei reggimenti per avere dai mercanti le regalie che gli venivano,
come ai Mar escial di Campo, ma i colonnell i non la vollero intende r e, perché, mancando oggidì i stipendi all'armata, non si può più mantenere la puntualità degli ordini che sariano necessari in questa et in ogni altra cosa.
Soliano anc h e i colonnelli avere qualche cosa dai vivandieri, e similmente il sergente maggiore et il prefetto. Da queste tasse interessate, particolari et irragionevoli, nasce anco grosso disordine, che mercanzie vecchie, guaste e cattive sono vendute per buone, che s'adoperano pesi e misure non giuste e che si cerca ogni sorte d'inganno accioché il mercante, il quale non è di dovere ch'abbia a servire per nulla, venga sopra il suo.
Ma quando la tassa è acquistata e fatta convenevolmente e senza inganno , allora si può tanto meglio punir senza .alcun pregiudicio gli inganni avvantaggiosi di venditori. E però il Proviandmeister ha i suoi subordinati e aitanti, i quali pigliano minuta e diligente informazion e di tutto ciò ch'appartiene alla provianda et al benessere dell' essercito, e questi osservano diligentemente che non v i scorra inganno o malizia alcuna, e, se ve n'è, n e castigano anche l'ist ess i commissari.
2. Il generale tassa tutte le altre mercanzie, cioè panni a vestire o d'altra necessità; il che però non si può sempre fare, per la differenza che vi si t ro va , ma in ogni modo, è molto utile di mettervi un ordine et una misura prefissa, per quanto si può; et accioché il prezzo trattato sia meglio ritenuto, si fa pubblicare a suon di tromba e di tamburo la tassa, poi si fa affi 9gere sopra la piazza commune accioché si sappia dapp ert utto ne alcuno abbia pretesto d'ignorarla.

3. Bisogna anche osservare che sotto colore di venire a vendere qualche cosa nel campo, molte spie vi si intromettono, e però deve il generale farsi diligentemente specificare ogni giorno e far essaminare le genti che vanno e che vengono, di qual luogo siano, che cosa portino, quanto tempo siano stati nel campo e quanto pensino dimorarvi, perché in tal modo non solo si vie ne facilmente in cognitio n e se qualcheduno ha qualche cattivo disegno, ma molti anche sono atterriti né ardiscono di m etters i a simil rischio.
P er la qual cosa sarebbe di molto servizio, e servirebbe anche ad alleggerire in parte l'incommodità dei carriaggi, che alla piazza commune s'ordinasse e si permettesse solo un certo e conosciuto numero di mercanti, ciaschedun dei quali avesse la sua patente
particolare dal generale, et a questi dovrebbero gli altri mercanti straordinari lasciare e vendere le loro mercanzie e subito partire dal campo a pigliarne dell'altre, così restarebbe la piazza sempre fornita e vi sarebbe condotta ogni giorno fresca provisione. Non si dovrebbe però proibire il mercato ai paesani et alle donne dall'intorno, ma piuttosto privilegiarle in qualche cosa e lasciarle vendere quello che portino al meglio che potessino, sì perché elle non vengono in troppo grande quantità e portano giornalmente robba fresca, sì anche perché, ricevendo esse il maggior danno anche da un essercito ben disciplinato e ragionevole, che godino anche un poco di profitto.
Ma tutto ciò si potrebbe molto meglio esseguire quando s'avess ino una, due o più persone determinate le quali, sopra un giusto guadagno che fosse loro concesso, pigliassino sopra di loro e comprassino tutte le vettovaglie all'ingrosso, e che poi gli altri mercanti ven issino a pigliarle da essi e ne portassino a tutti gli altri qua rtieri, sì come ad ogni quartiero dovriano esser ordinati i suoi mercatanti particolari.
4. Occorre tal volta che viene penuria nel campo e che la provianda non basta; et in tal caso bisogna mettere ordine che i ricchi non comprino ogni cosa, sì che poi i poveri abbiano a soffrir mancamento, e ciò si fa facendo portar insieme tutta la provianda nella casa della munizione e quivi facendo egualmente distribuire secondo il bisogno .
IV . Ma perché la fame nasce principalmente in un'armata per la soverchia quantità di bagagliame, egli è sommamente necessario di ridurre il bagaglio al più picciolo piede che si possa e di farne una revista tutti i mesi, perché egli cresce a vista d'occhio, e finché sarà tollerato in u n essercito questo abuso, che i soldati abbiano tante femine, garzoni, carri e cavalli, egli non sa rà mai capace di fare cos'alcuna di buono, perché siccome in una battaglia colui che può conservare in ultimo delle truppe che non abbiano ancora combattuto, guadagna la vittoria: così anche colui che mantiene in ultimo la sua armata sana, completa et accostumata alla fatica, fa l'istesso; e ciò non si può ottenere se i soldati sono sì delicati che non possono portare il loro bagaglio, oltre ch e, come s'è detto, la malizia e la fame non nascano nell'armata se non per questa canaglia di bagaglioni . E questa cosa è di tale importanza,

eh' ella è il più delle volte la disperazione d elle più floride et anche delle più vittoriose armate.
1. Egli è ben vero che, facendosi oggidì la guerra in paesi distrut t i dove i foraggi si hanno a cercare molto lontano, né dandosi gli stipendi ai soldati né tenendosi i magazzini dell' essercito ben provvisti, bisogna necessariamente permetter un po' più d i bagaglio di quello che un ordine esatto richiederebbesi, per portare più quantità di viveri con seco , sì anche per poter mandare a foraggio i garzoni, e che i soldati et i cavalli di servizio rimangano agli stendardi.

2. In ogni modo bisogna ritrinciare e riformare tutto ciò che si può d'inutile o di superfluo, ma bisogna che il generale istesso e gli altri capi servano d' essempio e si spoglino delle superfluità et anche di qualche commodità che non è assolutamente n ecessaria. Alessandro, vedendo che il suo essercito per la moltitudine delle bagaglia e per la grandezza del bottino era ta r do e lento, fece fare un monte nel mezzo prima delle sue, e appresso delle robbe di tutta l'armata, essendo già i carri caricati, et eccettuarne le cose necessarie, poi fece appicare il fuoco, prima alle sue, et appresso alle bagaglia degli altri, così rimase il suo essercito leggiere dalla turba e dagli impedimenti, attento ai cenni nonché ai comandi del capitano, et il luogo bastava agli alloggiamenti e la vettovaglia al1' armata.
Si soliano concedere 4 carra per compagnia senza il carro del vivandiere e senza quei del comando, e quando s'è car ico di bottino o di cavalli superflui, si fanno vendere alle città più vicine .

Sì come egli è cosa impossibile che un capitano si possa risolvere a qualche impresa buona e sicura senza prima sapere benissimo lo stato del nemico et averne minuto ragguaglio, così non può mai esseguire cosa fruttuosa s'egli non tien celati e segreti i suoi disegni, e per contrario non usa ogni diligenza e spesa per avere buoni spioni, pratichi e fedeli, per la cui opera sia avvisato non solo di quello che passa ne' quartieri del nemico, ma anche di quello eh' ei consulta nel consiglio di voler tentare, ed è cosa di tal utilità che un Principe o capitano non d eve risparmia re cosa alcuna, in questo sendo il mezzo più potente che si possa avere per intraprendere belle azioni o per schifare grandi rovine, perché gli spioni avvisano gli andamenti dell'avversario e secondo il rapporto loro o tu intraprendi sopra di lui, o ti guardi dai suoi disegni. Si deve tener per certo che il generale che saprà meglio maneggiare questa parte, o meglio servirsi dei spioni, avrà sempre vantaggio sopra il nemico.
Gli spioni s'i ntrattengono fra il nemico et anche nella propria armata per conoscere li animi et i sentimenti dei suoi so ldati; e siccome non si può fidare questo mestiero ad ognuno, né ad ognuno s'acco nviene il farlo, così bisogna occuparvi persone che siano fideli, perché dando fa lsi avvisi possono far cadere in grave pericolo; e sì come bisogna guardarsi dalla doppiezza loro, così anche è n ecessar io guardarsi da quei del nemico, il quale bisogna presupporre che avrà spie nel tuo campo sì come tu ne hai nel suo .
I. Le spie d evon' essere molte in numero, perché spesso si impiegano diversi sp ioni alla conoscenza di una sola cosa, né devono conoscersi fra di loro né saper l'uno dell'altro accioché non ab-
biano a star in paura l'un dell'altro di essere traditi, et anche perché non s'accordino o per guadagno o per malizia a dar falsi messaggi, perché in questo modo, esaminandoli appartatamente gli uni dagli altri, per la concordanza o discordanza delle lor relazioni si può giudicare s'elle sono buone e per la verificazione di quelli che dicono il vero et il falso tu riconosci chi ti tradisce o chi ti serve bene.
1. Non devono anche esser conosciuti da persona alcuna, sì perché non temano d'esser scoperti dal nemico, sì anche accioché parlando con i soldati non palesino molti disegni, e però nissuno deve conoscerle se non quello che gli impiega, ovvero deve il generale ordinare una persona accorta e giudiziosa e ben pagata alla quale siano rac co mandate le spie, sì per donar loro largamente e trattarle bene, sì anche per dar loro le istruzioni convenevoli e necessarie; et a costui fanno le spie la loro relazione, per restare esse tanto più segrete, il che non potria succedere così bene quando si conoscesse che esse, come persone di bassa considerazione, entrassino molto dal generale. Deve però talora il generale udirle egli stesso et interrogarle secondo che gli pare; il conte Enrico di Berg sapea con somma destrezza maneggiarle, facendole sedere appresso di lui, e mangiando e bevendo con esso loro 17 4 •
2. Gli spioni passano al campo del n emico sotto co lor e d'altri affari, e per potersi intrattenere qu ivi lungo tempo fanno sembiante di cercar servizio o lo pigliano anche per un t e mpo sin che veggono la comodità di tornare, o vero mentre che sono nel servizio portano gli avvisi in un luogo concertato, sia arbore o pietra od altra cosa, o mandano gli avvisi per garzoni o femine. Altri fingono d'esser stati maltrattati e vanno come fuggiaschi nel campo n emico, e per dar colore alla finzione si fanno ferite in sul corpo da loro stessi o mostrano qualche altro segno verisimile dell'ingiuria recente e di disgusti. Prima di fuggire fanno anche sparger voce nel proprio esserc ito di esser malcontenti accioché poi non siano traditi, e per acquistar maggior fede riferiscono qualcosa di vero al nemico di quello che tu fai o che hai disegno di fare, et essendo effettivamente mandati in essiglio hanno molto più agio di poterlo fare.
174 Seco ndo dunque il M ., il co m anda nte d eve egli stesso mantenere i co ntatt i co n gli informatori Sano principio , ch é si ev ita i l per ico lo che q u alche intermediario possa essere a sua volta u n agente nemico.

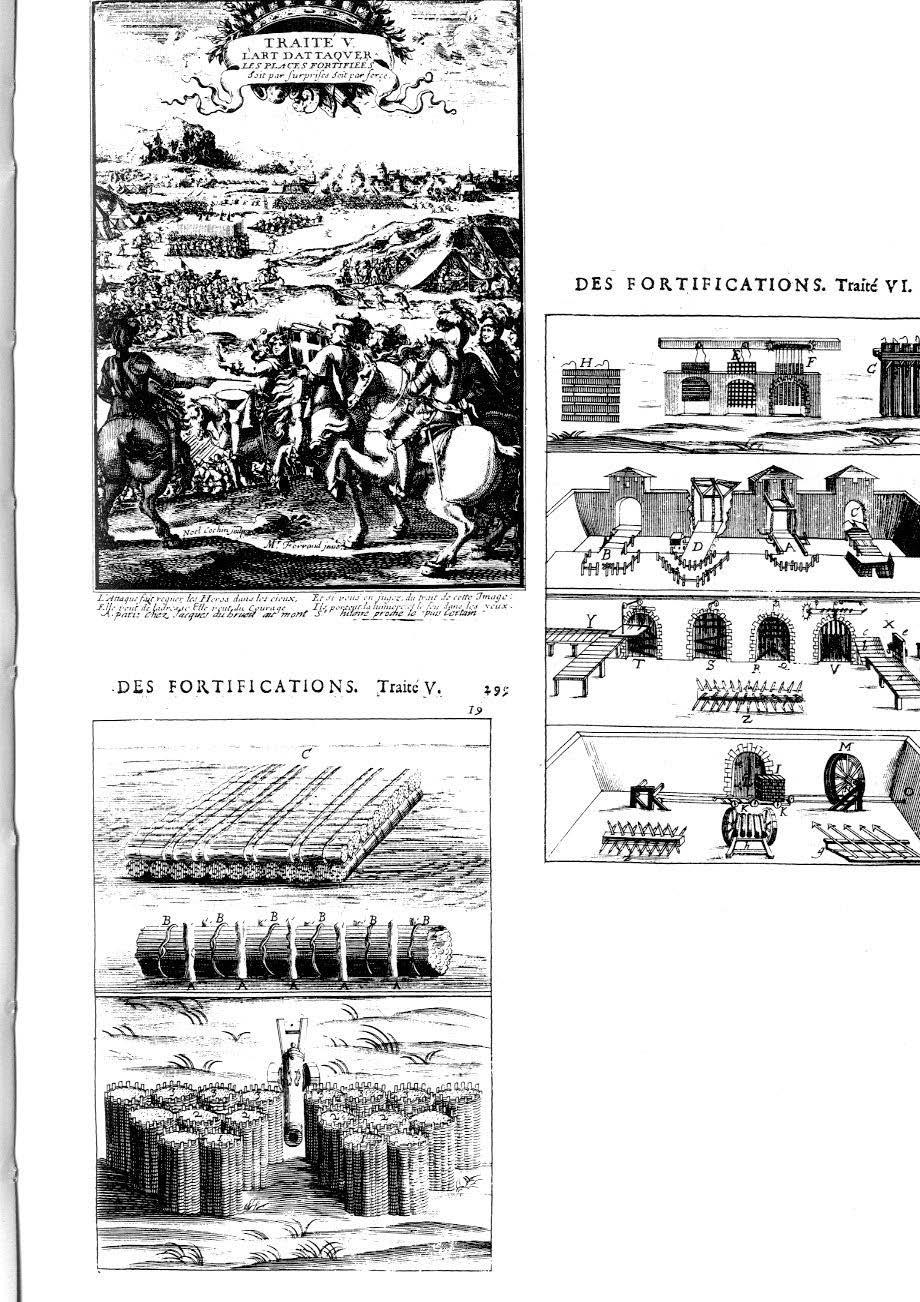
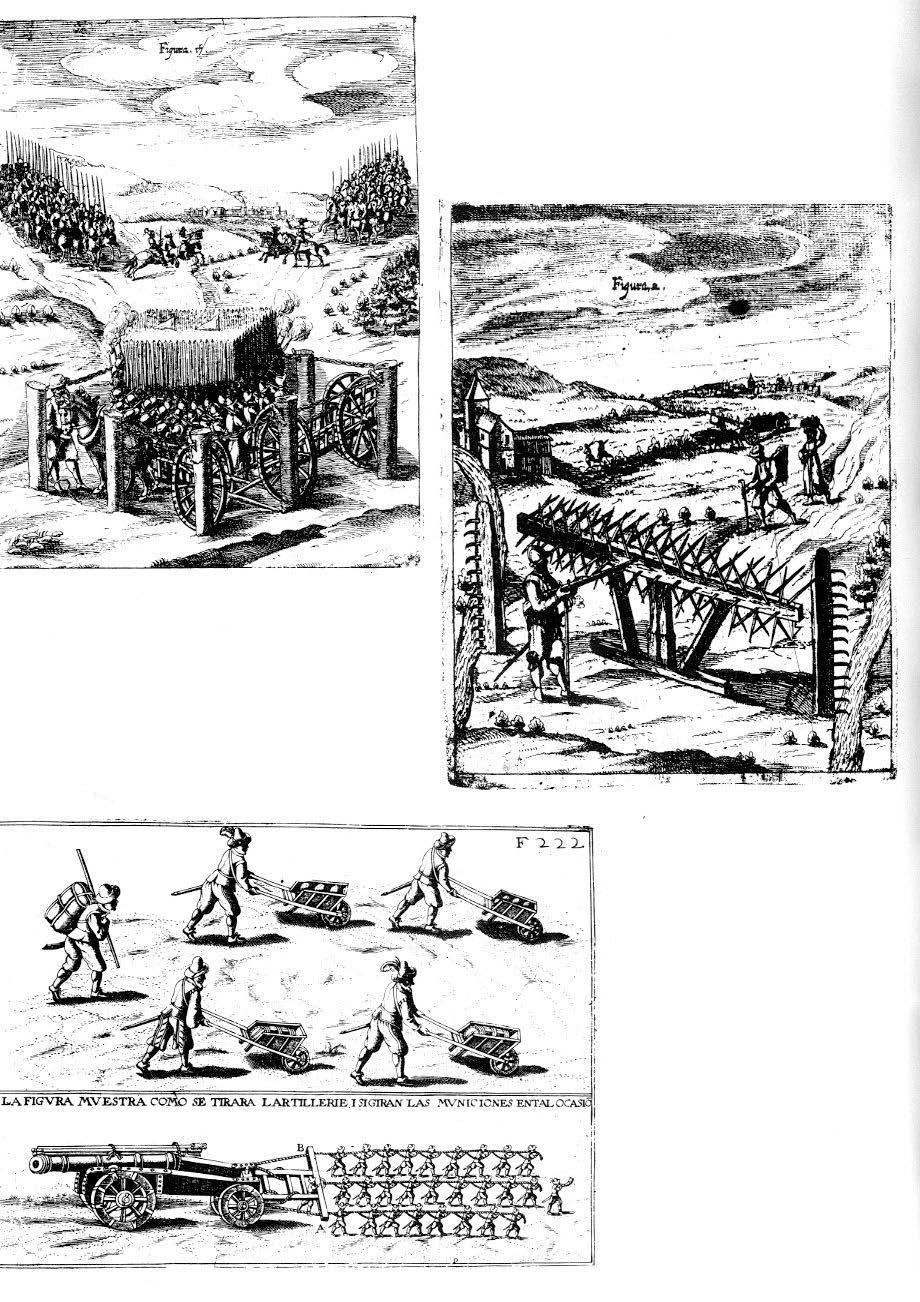
Alcuni si fanno vivand ieri e mercanti et ent rano nei quartieri del nemico a vendere e trafficare. Altri che sono soldati, e come del paese, si travestono in paesani e servendo di guida ai nemici spiano i loro andamenti.
Alcun capitano cerca di corrompere le spie del nemico e tirarle alla sua affezione e nella sua parte perché, siccome il modo essenzia le d'esser ben servito da questa specie di gente è d'esser loro molto liberale trattarle benissimo e cacciarle con lo sprone d'oro accioché non si disgustino e con doppiezza vi nuocciano, così anche questo è l'unico rimedio di guadagnarsi quelle de l nemico, perché sono sempre più fideli a chi loro dona più.
Si corrompano anche con donativi segretari e famigliari del nemico accioché avvisino i loro segreti e gli ordini suoi . Qualcosa altro intendesi anche quando a quest'effetto si pigliano prigioni del suo essercito .
3 . Ma egli non è sempre ben fatto di mandar a spiare indifferentemente nel campo del nemico ogni villano o soldato o persona cogn it a, perché tali genti non si arrischiano molto indentro, come il bisogno richiede, avendo essi sempre paura, sicché o non si informano della qualità e dello stato delle cose o vero se si azardano assai innanzi, sono in ogni modo sì ignoranti che non capiscono bene nissuna cosa, onde le loro relazioni sono molto incerte e molte volte false, né si può fare alcun fondamento sopra di quelle.

E perché le spie ordinarie non possono rapportar se non quelle cose che sono quasi note a tutti, hanno alcuni usato mandare ambasciatori al nemico, e con quelli, sotto veste di famigli, uomini peritissimi in guerra i quali, presa occasione di vedere l'esser cito nemico e considerare l e forze e debolezze sue, gli hanno dato occasione di superarlo, di penetrare i suoi cons igli e di specu lare i suoi apparecchi, perché nessuno spione per provvido e fidele ch'egli sia può avere facultà di conoscere tante cose come simili ambasciatori, i quali, essendo due o tre o più, non può essere che non odorino qualche cosa, e però si devono mandare spesse volte al nemico sotto spec ie di tregua o di trattar pace e principalmente nei giorni festivi o nelle solennità e nei tempi di spettacoli, perché, concorrendovi a gara la moltitudine, si può facilmente conoscere la forza e la quantità dell' essercito.
E similmente sotto altri pretesti si mandino feciali, tamburi, trombette ecc ., che osservino quello che si fa. Ma per contrario, non potendosi far di meno di non ricevere anche et intendere gli
ambasciatori del nimico, et è cosa piena di pericolo l'averli in casa, bisogna udirli quanto prima e spedirli subito, in modo però che non abbiano occasione alcuna di lamentarsi d'inospitalità, e nel tempo che si fermano bisogna deputare appresso a loro alcuni uomini idonei da quali siano trattati e serviti, perché ciò appartiene alla cortesia et anche giova per conoscere che cosa facciano, con chi parlino e che sia i loro famigliari, e per impedire che gli uomini leggieri, sediziosi e malcontenti non abbiano adito né accesso alcuno ad essi, perché tali collusioni sono sempre pericolosi e recano particolarmente gran danno a quello che per essere inferiore di forze, perché egli è cosa naturale fra gli uomini il desiderare d'accrescere e di diffonder il loro, e però facilmente s'accostano ai più potenti, massime se incontrano u n Principe liberale che intenda l'arte di guadagnarsi gli animi. Quando si mandino o si ricevano simili ambasciatori bisogna prima aver avuto e dato salvacondotti e passaporti per la sicurezza del viaggio e delle persone.
II. Per far sapere qualche cosa al campo nemico, si fanno rilasciar sotto mano qualche prigionieri alla presenza dei quali s'è tenuto espressamente, mostrando però che sia successo inopinatamente e senza studio, quei discorsi che si vuole che siano rapportati.
1. Alcuni hanno fatto spargere biglietti nel campo nemico, scritti di quello che si vuol far risapere, ma il generale del nemico vi ha rimediato fingendo di aver egli stesso fatto spargergli apposta per far prova delli animi della sua gente, nella qual cosa ha ritenuto allora in fede quelli che vacillavano et ha promesso all'avvenire che, occorrendo più simil cosa, i soldati tenessero per fermo di non essere corrotti dal nemico ma d'essere tentati dal loro capitano .
2. Narra Daniel Schwenter nella Steganologia, autoritato da Gustavo Seleno, e Cardano De subtilitate, lib. 4°, e De rerum varietate, li b. 13°, e pur anche Schwenter, lib. 3°, n. 12 , citato da Gustavo Seleno 175 , che si può far sapere la sua intenzione ad un altro in
175 DANtEL SCHWENTER, nato presso Norimberga (1585-1636), bibliotecar io e mat emat ico, scrisse un trattato intitolato Steganologia et Steganographia nova, sull'arte di leggere e scrivere segretamente; Gustavus Selenus (cioè il Duca Augusto di Braunschwe ig, 1579-1666), f u studioso di alchimia; GIROLAMO CARDANO, di Pavia, (1 501-1576) , fu matematico, fis ico , medico e astrologo . Il suo trattato Artis magnae sìve de regulis algebricis libri fece fare progressi fondamentali all'algebra; il suo Liber de ludo aleae presentò una t eoria del calcolo delle probabilità un secolo avanti Pascal e Fermat. Il De subtilitace rerum , citato da M., è u n a si ll age di invenzioni ed espe r ime nt i di fi sica.

grand~ssima lontananza colla calamita, co' specchi e col sangue suo propno.
III. Per assicurarsi delle spie del nemico, servono molto le pene rigorose et acerbe con le quali si fanno morire quei che sono colti, accioché gli altri che si lasciano adoperare in simil servizio sieno sbigottiti.
1. Serve anche molto la segretezza, la quale in tutte l'azioni e dissegni fu sempre utilissima, et un capitano, domandato che cosa volesse fare l'altro giorno, rispose che se la camicia sua lo sapesse, l'arderebbe, et un altro , domandato quanto manerebbe l'essercito, rispose: «Credi tu essere il solo a non sentire le trombe?».
2. È anche rimedio contro ai spioni il non lasciar venire nel campo persona alcuna oziosa et incognita, et il proibire agli ufficiali, i quali tengono servitori e ragazzi, che nissuno tenga appresso di sé persone che non sieno ben conosciute, e particolarmente quei che sono in gran carica e consiglieri, nelle stanze et alla mensa dei quali spesse volte si tengono discorsi ch e saria meglio tacerli e che con gran pregiudi z io sono poi pubblicati da simil sort e di gente.
Si proibisce anche che nessuno alberghi nel suo quartiero alcun forestiero senza saputa e cons enso del genera le . Quando talvolta si viene ad accorgersi che vi sono molti stranieri, si fa all'improvviso un comandamento che ciascuno si ritiri al suo quartiero e t al suo alloggiamento, e così rimangono gli stranie ri insieme sopra la strada dove son acchiappati dal prefetto et essaminati di quello che facciano quivi.
3. Quando tu presentissi che fosse nel tuo essercito alcuno che tenesse avvisato il tuo nemico dei tuoi dissegni come un tuo spione traditore , non puoi far meglio, a vo lerti valere de l suo malvagio animo, che fingere di crederlo fidele e communicargli quelle cose che tu non vuoi far e e quelle che tu vuoi fare tacere, e dire di dubitare delle cose che tu non dubiti e quelle di che tu dubiti nascondere: il che farà fare al nemico credendo sapere i disegni tuoi, dove facilmente tu lo potrai ingannare. Et in tal modo potrai anche ingannare le spie del nemico, pubblicando sordamente di avere un'impresa totalmente contraria a quella che hai in

animo di voler eseguire, e ciò succede molto meglio quando si fa alla presenza di gente che sono sospette, come quando trombetti o tamb u ri sono dal nemico mandati nel tuo campo per qualche affare e partico l armente quando si fa vista di non conoscerli o di non badare che siano quivi, p erché allora s i può dire molte cose di un dissegno al quale non s i è mai pensato, accioché lo riferiscano ess i al nemico .
4. Egli è anche talvolta utile cosa il far intendere ad una persona sospetta che si sa bene ch'egli è mandato dal nemico co me spione ma che per un'affezione particolare che si ha verso di lui non si vuole castigare, anzi che si gli vuo l far ogni bene secondo eh' egli meritarà, et in tal maniera ve ngono talora d isviate le spie del nemico in guisa che più servano a noi che al nemico che le ha mandat e, e queste si chiamano spie doppie con le quali bisogna però procedere con gran cautela.
E se queste o qualche fuggitivo verrà dal nemico per significarti l 'opportunità di assalirlo o di far un'impresa, tu devi condurlo teco legato et assicurarlo purché egli narri il vero e che consigli cose utili alla salute dell' essercito et alla vittoria, eh' eg li avrà non solo la libertà, ma anche gran doni e ricompense, ma s'egli fingendo cose vane inganni e macchini tradimento, che nel medesimo punto che l'impresa cominciarà a mancare e pericolare ch'egli sarà strangolato ne' ceppi.
5. L'entrare e l'u scire di tamburi e di trombettieri è anche una parte che non si de ve trascurare, e sì come non se ne deve lasciar andar alcuno al nemico senza un passo del generale , il quale non può esser dato senza sua saputa e consentimento, così anche non si deve ric eve rne alcuno né lasciarlo entrare nel campo, ma dopo eh' egli ha fatto la sua chiamata deve esser fermato dalle sen tin elle della Cavalleria finché venga qrdine del capitano generale eh' ei sia lasciato passare, e se si teme che possa riconoscere cosa alcuna che riferendola fosse di pregiudizio, se li fanno bendare gli occhi et in quel modo condurre a traverso le guardie sin al campo dove se gli dà udienza, e poi mentre si delibera che risposta se gli ha da dare, il prefetto lo piglia in sua custodia, accioché non possa parlare con alcuno né punto né poco; o vero si mette in un loggiamento con una guardia, o se si vuo l trattare più cortesemente e che non sia pericolo n e l luogo, se li dà in compagnia una trombetta fedele che lo faccia b ere e che abbia le orecchie sopra di lui,

e dopo ch'egli è spedito si fa ricondurre nel mede simo modo con gli occhi bendati sin fuori dell'ultime guardie.
6. Quando s'acchiappano spie del nemico si sogliono fare impalare o impiccare e far morire rigorosamente, ma talvolta, quando le forze del suo essercito sono superiori a quelle del nemico e che la sua armata è ben fornita di qualità e di quantità di uomini e di capi valorosi e di buon equipaggio, allora si può far mostra dell'essercito ai spioni e rimandarli illesi, perché risapendo i nemici che s i è loro superiori concepiranno timori e diverranno vili; et in simil caso se ne fa anche mostra ai prigioni e si rilasciano, come fece il Friedland a Norimberga 176
IV. Per conoscere gli animi et i sentimenti dei suoi soldati hanno alcuni fatto spargere fama d'essere stati uc cis i o d'essere altrimenti morti, e dalla letizia o mestizia loro hanno argumentato la qualit à dell'affezione.
1. Altri ha fatto chiamare a sé le meretrici sotto colore di trastullo, poi con pr emi o con tormenti ha da quelle risap uto i discorsi che di lui si tengono nei congressi amorosi.
2 . Altri, per conoscere la fede d 'alc un i, mandò a loro lettere aperte e suggellate, e nelle aperte scriveva che non aprissero le suggellate se non a tal tempo; et innanzi a quel tempo ridomandandole e trovandole aperte conobbe la fede loro non essere intiera.
3 . Alessandro avv isò ch 'egli spediva un corriero in Mac edon ia e chi voleva mandar lette re ai suoi si servisse dell'occasione; ciascuno scrisse semplicemente ai parenti et agli amici qu ello eh' ei sentiva, ad alc uni era grave, ad altri era grata la milizia. Ora, dopo che il corriero fu partito a due o tre miglia, gli mandò dietro e fecelo richiamare, et aprendo tutte le lettere conobbe l'animo di ciascuno. Ora, quelli che avevano scritto male del re, o che furono stimati male affezionati, furono ridotti insi eme in una corte o per essere consumati o per esse r mandati in colonie nell'ultirne terre.
Il R e di Svezia solea mandare i primi negli assalti ed esporre ai maggiori pericoli quelli che, essendo stati presi prigionieri, ave-

vano preso servizio nel suo essercito e dei quali perciò poco si fidava, perché in tal maniera faceva danno al nemico, risparmiava i suoi fideli e consumava quelli che li erano sospetti.
Le guide sono necessarie sommamente all'essercito . Esse danno la conoscenza del paese, de' camini e dei passaggi dove bisogna che tu passi o per dove il nemico può venir a te. Bisogna eh' esse sieno fideli, perché guidando maliziosamente tu puoi cadere in gran pericoli, e bisogna averne molte p erché soprattutto marciando di notte ciascuna grossa truppa ha bisogno della sua, o almeno ciascun corpo, e prima di partir devono essere tutte d'accordo della strada che vogliono tenere.
I. Nei Paesi Bassi egli è usanza di avere un capitano delle guide, uomo di spirito vigilante e che [sì] ha cura di riconvitare di luogo in luogo, il qual subito che con le trombette si tocca la marcia, comparesse con la sua gente in una piazza assegnatagli dove vengono poi distribuite secondo il parere del generale; altrimenti si danno alla custodia del prefetto ch e ne ha sempre un buon numero e che va pigliando gli abitanti delle contrade dove si passa e i villani. Elli sono particolarmente utili al proposito in questo servizio, come quelli che hanno ottima conoscenza di tutta la campagna con tutte le sue qualità e circostanze, e la lo ro quantità serve quando si marcia di not te o che si marcia per diverse strade facendo più corpi dell'armata, o che, conferendoli insieme, si viene meglio a notizia di tutte le qua lità e siti del paese, le qual particolarità non si possono sempre avere dalle carte geografiche .
Un mugnaio che mostrò al Banér un guado dell'Elba vicino a Melnik 177 fu cagione che 6 reggimenti di Cava lleria imperiale furono battuti e la più gran parte degli ufficiali prigionieri. Tanto importano le buone guide et il riconoscere bene .
177 Nel 1639 Banér, che si era r itirato l' anno pr i ma in Pomeran ia , si avanzò attraverso la Sassonia respingendo Galasso. Tra il 19 e i l 29 maggio egl i forzò il fiume sorprendendo (come d ice M., co n l'aiuto di un mugna io) il comandante imper iale, Tenente-maresciallo Georg Lo ren z F reiherr von Hofkirch tra Meln ik e Brandys. L o stesso Hofkirch cadde prigionie r o, e con lui M. Quest i, che in un precedente consiglio si era opposto al piano di Hofk.irch, gi udi ca ndo lo inutilm ente risch ioso, gli rimprovera più oltre di aver mandato av anti la Cavalleria contro forze di gran lunga superiori. Sembra {ma non è s icuro) che ciò abbia portato durante la prigioni a ad u n duello tra M. e Hofkirch, durante il quale l'italiano ebbe partita vinta, di sarmando l'avve r sario. (Cfr.: J.B. ScH EE LS, Momecuccoli, in: Osterreichische Militarische Zeitschrift, lV, 1818, pag . 64 sgg .; nonché: T.M. BARK.ER, The Military lntellectual..., cit., pag 38 , 221 , 222).

1. Oltre alle guide che sono stipendiate et altre che sono prese dal prefetto, se ne trovano anche che da loro stessi e di libero arbitrio vengono ad offerir il loro servizio di guida, ma a questi tali non bisogna fidarsi intieramente perché potriano esser stati mandati dal nemico per condurre un essercito in luoghi malagevoli, in imboscate et in istrade pericolose . Ma quando si ricevono e si vuol serv irsi di loro non bisogna tenerle altrimenti che quelle che sono ritenute per forza, o almeno bisogna assicurarsi di loro con una buona guardia acc ioché non fugga no per malizia o p er timore in caso di allarme quando si ha più bisogni di loro.

2 I mercanti sono anche il caso a mostrar i camini, perché sono semp r e sulle strad e e per viaggio e si può meglio fidarsi di loro se non per altro almeno per cagione del lor interesse, perché oltre alla sicurezza che ricavano di far il lor cammino accompagnati, ricevono anche donativi e ricompensa.
3. Insomma, il capitano d eve avere descritto e dipinto tutto il paese per il quale egli cammina in modo che egli sappia i luoghi, il numero delle distanze, le vie, i monti, i fiumi, le paludi e tutte le qualità loro; et a fare di sapere questo conviene, oltre alle carte geografiche stampate, averne delle particolari fatte dal quartiermastro o dall'ingegnero; e conviene anche abbia a sé diversamente et in div ersi modi qualche genti luomo del paese e quegli che sanno i luoghi e dimandargli con diligenza, e riscontrare il lor parlare e secondo i riscontri notare. E deve mandare inn anzi cavalli e con loro capi prudenti non tanto a scoprire il nemico quanto a speculare il paese per vedere se riscontra col disegno e con la notizia ch'egli ha avuto da quello.
Del ma r ci ar e Bisogna fare diverse considerazioni sopra il marciare di una armata, bisognando regolarsi secondo l'intenzione che ha il generale, come d'andar a conquistare un paese, soccorrer una piazza assediata, dar una battaglia, passar attraverso un paese nemico o far una ritirata, e secondo i tempi s'egli è di giorno o di notte, di state o di verno, e secondo i luoghi se egli si ha a marciare per paese largo o stretto, montuoso o selvoso, amico o nemico e passar fiumi, ecc.
I. Si dee generalmente osservare che, avendo fatto tutti gli apparecchi necessari per la guerra, risoluta l'azione che si vuol intraprendere, riempiti i magazzini e provvisti i viveri ch'è la cosa principale , s'elegge una città per fare lo stato delle munizioni, per drizzarvi l'attirag lio dell'artiglieria e per farvi la mostra dell'armata, tanto d'Infanteria che di Cavalleria e di Artiglieria, et ordinare l'armata in battaglia giustamente come se in quel giorno si dovesse combatter il nemico .
1. Il modo di metter l'armata in battaglia è stato ampiamente descritto nella Pecorina numero II, e quest'ordinanza dipende da quello che il generale ha intenzione di vo ler esseguire e dalla qualità del paese per dove si ha da passare, dovendosi pigliare questa massima genera le: c h e la perfezione dell'ordine del marciare consiste in questo, cioè che le truppe sieno disposte in modo che volendo possano subito senz'indugio schierarsi nella forma della battaglia che si ha proposta; e que ll 'ordinanza di marciare dalla
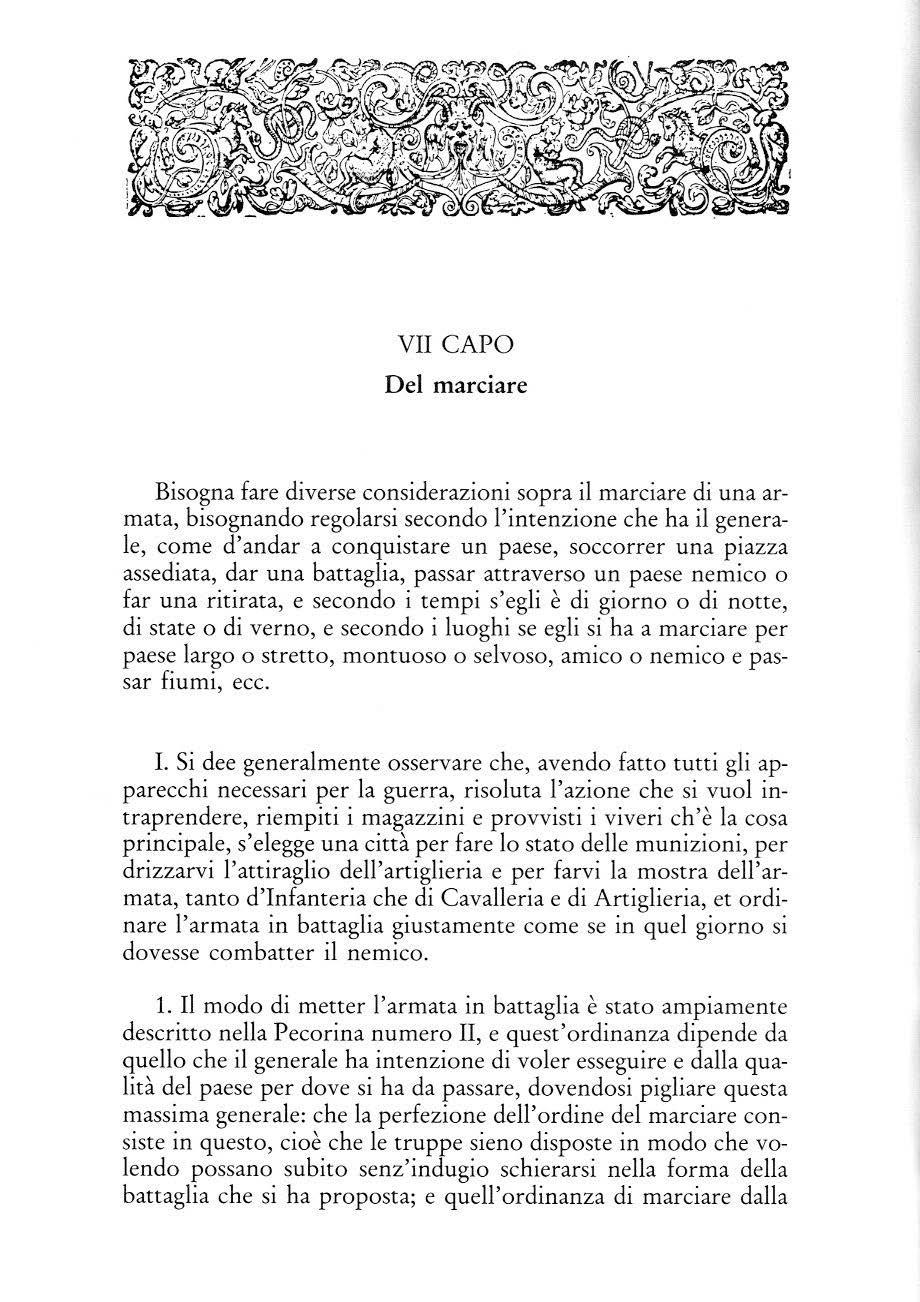
quale si potrà prima e con maggiore celerità iniziare nell'ordinanza di battaglia, sarà sempre la migliore 178 •
2. Se il paese per do ve si passa è sterile, bisogna far portar dei viveri, e s'è regione arida e secca, bisogna anche portar acqua negli otri caricati sopra carra o giumenti o camegli, ma s'egl i è abbondante si può sgravare l'armata da questo bagaglio, massime se l'espedizione richiede celerità, perché allora si suo l lasciar adietro il bagaglio in qualche luogo forte e sicuro, e similmente se si marcia sopra il paese del nemico per andarvi a viveri e per conservare il suo dall'estreme ruine ch e fanno le armate.
3 . Se si ha diss egno di soc correr e una piazza assediata e gettarvi dentro soccorso, e per questo si vuol forzar un quartiero non si devono stendere molto le ali dell'armata, ma si terrà serrata e rinforzata. Se si ha intenzione di dar battaglia al nemico e che il paese vi sia propizio, si stenderà il fronte dell'armata il più che si potrà. E se si vuol attraversar un paese nimico si deve sempre far alloggiare l' essercito in corpo e campare senza mai disunire alcuna parte e marciare in battaglia cercando i luoghi discoperti, piani et uguali e portando le sue muni zioni per tanto tempo che tarderà a passare, et occupare qualch e buon posto per mettere piede a terra, se si marcia da luoghi marittimi. E se si passa per paese indifferente, che pregato concede il passaggi o , si danno ostaggi dall'una parte e dall'altra; quei che concedono il passo danno ostaggi per sicurezza che non l'impediranno, quei che passano li danno per sicurezza che non faranno danno al paese.
II. Avendo l'armata fatto mostra al luogo del rendez-vous, si fa partire di là e marciar in battaglia fino al luogo dove deve essere alloggiata la sera, se il paese lo permette, per insegnarli com'ella deve marciar in battaglia, che s'ella non lo può fare per l'asprezza del paese, bisogna che i spiana t ori e marraiuoli accomodino diversi cammini riempiendo fossi, romp endo le siepi e fabricando ponti di barche o d'altro sopra i fiumi et i ruscelli.
1. Nel camino di m ezzo passan o l'artiglieria, le munizion i et il bagaglio; alle lor ali, una parte dell'Infanteria, marciando in fila
178 È q uesto il pr incipi o - c h e sarà ampiam ente p r at icat o da N ap ole on e - di marciare in o r d i ne d i b attagl ia; M. ne farà uso con gr andi ss i m a eff icaci a ne lla m ar cia alla battaglia di San Go t tard o (1664)

di tre a tre o di cinque a cinque; alle ali di questa fanteria, qualche archibugiere; li due terzi delle Corazze alla testa dell'armata e l'altro terzo alla coda; le lancie marcieranno avanti alle corazze dinnanzi a tutta l'armata con qualche archibugiere e qualche altro alla coda.
L'Infanteria deve marciare al camino di mezzo distinta in avanguardia, battaglia e retroguardia.
2. Si cercherà di alloggiarsi di buon'ora, per avere tempo di fare i trinceramenti del campo, ripartir i quartieri, posar le guardie, mandar a foraggio, far fare le baracche, discoprire le azioni del nemico et ovviare a mille inconvenienti che la notte apporta, disponendo il tutto secondo il luogo e secondo il tempo, se non fosse che si volesse marciar innanzi giorno, né alloggiar mai se non di notte accioché la gente del paese non vedesse la debolezza del1' esserc it0 ovvero accioché il nemico non potesse aver la lingua del quartiero 178 b is e venisse a sorprenderlo, il che fu gran tempo usato dall' Aldringen.

3. Si ha da temere la Cavalleria, contro alla quale bisogna oppor le picche per sostenere e la moschetteria e pezzetti di campagna per impedirli l'approssimarsi, e dal lato dove si teme la Cavalleria si possono schierare le carra guarnite di moschetteria e serrate assieme, che servano di riparo e di argine, come fece il Pappenheim quando andò a levare v ia la guarnigione di Magdeburgo, il quale facea condu r re da ambedue i lati delle truppe una schiera d i carri riempiti d i letame, con le loro feritoie 179 • Ovvero si possono trascinare sui lati dell' essercito catene, che in un subito si possono alzare, come s'è diffusamente detto nella pecorina delle battaglie.
Se il paese è malagevole, pieno di fossi, paludoso e selvoso, egli è suggetto all'imboscate e sorprese e difficilmente vi si possono formare le battaglie; s'avanza poco camino e la moschetteria ha il vantaggio perché ella trova sempre qualche cosa che la favorisce di tirar al coperto.
4. Insomma bisogna considerare se nella marcia si può esser assalito dinanzi, di dietro, dai lati o per tutto, se si può marciar in battaglia o disporre le genti a mettervisi prontamente tenendo -
17sbis Intendasi: venire a sapere la località dell'acquartieramento.
179 Facendo cioè una specie di wagenburg mobile.
si sempre pronto a ricever l' inimico, perché in questo modo riscontrandolo non ti troverai mai sorpreso, massime se marci in tal ordine e ti tieni su le tue guardie giustamente come se tu avessi il nemico in vista, perché, avendo a disposizione le genti per tal essecuzione, non resterà più che a metterle in opera. E per non trovarsi in alcuna parte impro v isto, soleano gli antichi capitani andare con l' essercito quadrato, che essi così chiamavano questa forma, non perché ella fosse del tutto quadra ma perché era atta a combatter da quattro parti, e diceano che andavano parati al cammino et alla zuffa, perché se avenia che l' essercito fosse assalito in cammino da fronte o da spalle, essi facevano d'un tratto ritirare tutti i carriaggi in su la destra o in su la sinistra secondo I' occorrenza, o che meglio rispetto al sito si potea, e tutte le genti insieme, libere da quegli impedimenti, facevano testa da quella parte donde il nemico venia; s'erano assaltati di fianco, si ritiravano i carriaggi verso quella parte che era sicu ra , e dall'altra faceva testa, e così erano sicuri che né i paesani né l' essercito nemico li potea offendere, perché non occorre mai che qu este genti tumultuarie vengano a trovarsi al tiro della spada o della picca, sendo che le genti inordinate hanno paura delle ordinate, e sempre si vedrà che con le grida e con i rumori faranno un grande assalto senza appressartisi, altrimenti a guisa di cani piccoli attorno ad un mastino. Se viene che tu sia assaltato da un esserci to ordinato, ques to assalto non può nascere s ubito , perché un essercito ordinato viene col passo suo, tanto che tu sei a tempo a riordinarti alla giornata e ridurti tutto in quella forma che ti hai proposto, non avendo a far altro che far voltar il viso a tutto l 'essercito ve r so quella banda dove il nemico v iene ad affrontarti, che s'egli vie ne 'da te da quattro bande è necessario o che tu o che esso manchi di prudenza, perché se tu sarai savio tu non ti mettera i mai in lato che il nemico da tre o da quattro bande con gente grossa et ordinata ti possa assaltare, perché a v olere che sicuramente ti offenda, convien e che sia sì grosso che da ogni banda egli ti assalti con tanta gente quanta abbia quasi tutto il tuo essercito; e se tu sei sì po co prudente che tu ti metta nelle terre di un nemico il quale abbia tre volte gente ordinata più di te, non ti puoi dolere se tu capiti male se non di te stesso. Ma se il nemico non ha molta più gente di te, e voglia per disordinarti assaltarti da più bande, sarà stoltizia sua e ventura tua, perché conviene che a far questo egli s'assottigli in modo che puoi facilmente volta rn e una banda e sostenerne un'altra et in breve tempo minarlo.

5. Se si marcia per un paese amico né s'abbia sospetto del nemico, si può far marciare dopo ciascun reggimento il suo bagaglio per la commodità dell'armata, ma dove si è in un paese sospetto il bagaglio dev' esser interamente separato dalla gente di guerra, lasciando solamente alla sua coda qualche poche truppe per guardia e p er impedire che non si sbandi, perché se ad un allarme ciascun corpo ha il suo bagaglio dietro di sé, egli reca una gran confusione et impedisce che i soldati non si possan rannodare né soccorrer gli uni gli altri; ma s'egli è a parte, le truppe assaltate possono sostenere tanto il nemico, che l'altre vengano al soccorso et a formar la battaglia.
Similmente in paese amico si dà il rendez -vous a tutte le truppe ad una tal ora precisa nel luogo più comodo per la distribuzione degli alloggiamenti, e di là ciascuna s 'incamina ai suoi quartieri, et andando in questo modo per diversi cammini, la diligenza è grande a chi la vuol fare, e molte volte ancora non si fa rendezvous ma il generale manda il nome del quartiere ai reggimenti accioché marcino direttamente con prestezza e senza incommodo da un quartiere all'altro. E se l'essercito è grande e nel paese è penuria di viveri, si divide in tre o più parti e si fa marciare per strade diverse, accioché non gli manchino le vettovaglie.

Ma se si marcia con sos petto, bisogna far marciare l'armat a in corpo, dargli un rendez-vous sopra il cammino che si vuol tenere, del quale, se il nemico ha lingua assai a tempo per trovarvisi il primo o per a zzardo vi si abbatte, fa correre gran rischi ad una armata la quale viene al suo rendez-vous a diversi tempi e per diverse strade. I migliori modi di guardarsi da un tal accidente, è di tener il suo rendez-vous molto segreto, di avere buoni spioni fra li nemici e di mandare molti corridori a pigliar lingua.
Quando s i campa non si è suggetto a questo pericolo perché l'armata è sempre insieme. Se si marcia in gran pianure si può andar quasi sempre in battaglia, o almeno coi battaglioni e coi squadroni formati, sì ch'eg li è facile di mettersi prontame nte in istato di ben combattere, perché non si fa troppo lunga fila. Ma quando si marcia per un paese stretto che non si può andare se n on pochi di front e, allo r a bisogna ragguagliare l e incommodità del cammino et il tempo che vi va a farlo al numero dei so ldati di che l'essercito è composto, p e rché 8000 fanti marciando 10 a 10 e mille cava lli filando 5 a 5, col più legger bagaglio che possano avere, e 10 cannoni con l'equipaggio, portando ciascun pezzo 100 colpi, occupano di cammino circa 28000 v. di lungh ezza. Quando dunque grandi armate si trovano in un cammino sì malagevole,
bisogna di necessità far di versi corpi che vengon l'un dopo l'altro et alloggiano separatamente, ovvero farli veni re per diversi camini qualche lega discosti gli uni dagli altri, ovvero in ogni caso far dei camini attraverso i campi per far marciar e la gente di guerra, lasciando la strada reale et ordinaria al canno n e et al bagaglio. Se po i è un fiume a passare dove non si possa fare che un pont e solo, o qualche passaggio di montagna o marazzo o foresta che non si possa fare diverse strade, allora bisogna passare gli un i dopo gli altri et in diversi giorni.
III . Sonvi altre osservazioni general i.
1. Ne' gran caldi si tira fuori l'essercito innanzi giorno e si marcia in modo che s'arrivi al quartiere prima che il sole s'avvicini al meriggio, e suolsi marciare con tutta l'armata in corpo una lega o due, il che però varia secondo i Iu og h i, secondo la gente e secondo il sospetto che si ha .
2. Per t e ner la marcia di una navigazione segreta, fu taluno che diede al capitano di ciascuna nave un'ordinanza serrata, con ordine che se navigassino insieme non rompessino il suggello né aprissino l'ordine, ma se fossero distratti dai ve nti , allora aprissero l'ordinanza e drizzassero il corso al luogo che vi fosse dentro n otato.
3. Quando si conduce l'armata per luoghi malagevoli e che il squallore dei luoghi et i deserti atterrisca no il soldato strano che crede di vedere il fine delle umane cose et attonito rimira ogni cosa orrida senz'alcun vestigio di culto umano e pensa di voler tornar adietro prima che la luce e il cielo gli manchi, non c'è cosa più efficace per ritenerlo che l' essemp io del capitano il quale se scendendo da cavallo comincia a marciar a piedi per la neve e per i ghiacci, arrossiranno di non seguirlo prima gli am ici e i favoriti, poi i capitani e gli ufficiali, e finalmente i soldati . E se con le sc ure, rompendo egli stesso il ghiaccio, s'apre il cammino, tutti poi imit a rann o il suo essempio.
Se l'avanguardia è giunta al quartiero, si fanno far fuochi sull'altezza dei monti , acc io ché quelli che seguono con fatica conoscano di non essere lontano dall'alloggiamento e ripigli no animo, e dopo che quei che sono arrivati i primi si sono rinfrescati, si fan riempire vasi pieni d'acqua e portarli per rinforzamento agli
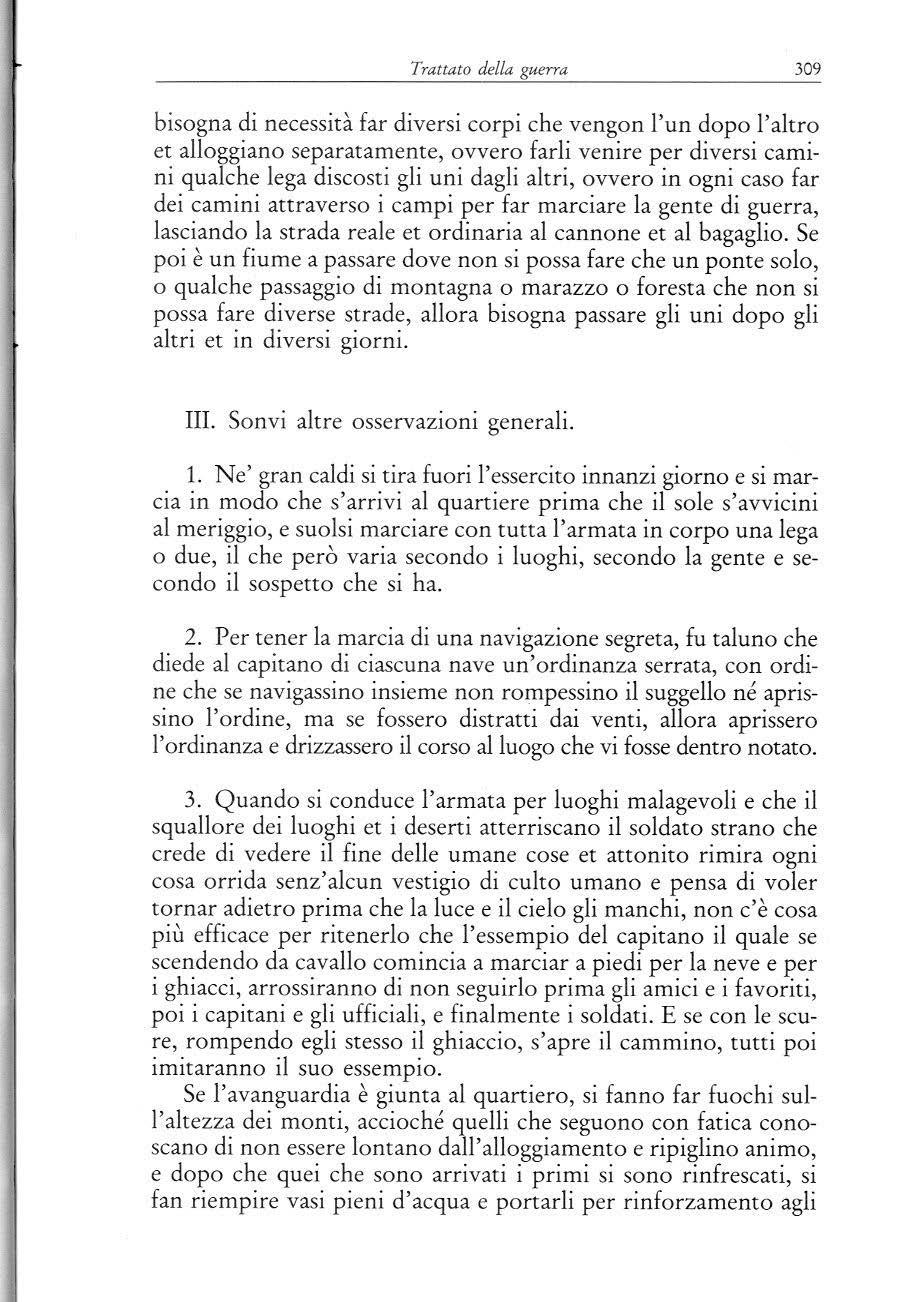
altri guardandosi che i cavalli stanchi e riscaldati non ne bevano troppo intemperatamente, accioché, intercluso lo spirito, muoiano.
4. Quando si sia per attaccare un paese del nemico che sia fertile et aperto si può marciare senza molto bagaglio, perché se si è v into ogni cosa è superflua, se si vince si trova abbondanza di ogni cosa, se il paese che si vuo le assalire non fosse però tale che il nemico lo potesse metter sott'acqua rompendo gli argini di qualche riviera per imp edirvi la marcia o che per altra maniera potesse il nemico tenerti a bada di venir a battaglia.
IV. Quando si ha risoluto di voler marciare e si ha determinato il giorno, la sera innanzi si danno gli ordini necessari per iscritto accioché nessuno si possa scusare di non aver ~en inteso e nelli ordini si nomina l'ora at il luogo del rendez-vous nel qual ciascuno deve comparire, e ciò s'intende quando la Cavalleria o anche l'Infanteria è alloggiata in diversi quartieri, perché s' ella è accompagnata in corpo, non si sogliono dar gli ordini per iscritto ma solo si avvisa la sera innanzi per i sergenti maggiori che vanno a pigliar la parola che l'altra mattina alla tal ora si deve marciare e che ciascuno si tenga in ordine . Si usa fra l'lnfanteria alemanna, quand'ella è nei quartieri, far pubblicar a suon di tamburo e con la grida del tamburino la sera innanzi che tutti i soldati si tengano all'ordine per marciare l' altra mattina, che se occorresse che il nemico fosse vicino né si volesse eh' ei sapesse che si voglia marciare, non si lascia toccar alcun tamburo all'Infante r ia e la Cavalleria tocca solamente in sordina. Due ore innanzi alla marcia si tocca il buttasella, col qual segno si dà la biada, s'accomodano e si sellano i cavalli et i corazzieri s'armano di petto e schiena e si suol anche incominciar ad incamminare il bagaglio; e similmente l'lnfanteria, prima che di toccare la marcia, tocca due altri segni, cioè il mettersi l'ordine e poi la raccolta che corrispondano giustamente ai tre segni delli antichi, al primo dei quali disfacevano i padiglioni e componevano le some, non essendo però lecito né disfare né rizzare la tenda ad alcuno prima che quella dei tribuni e del capitano, al secondo segno s'imponevano i bagagli sulle bestie et al terzo bisognava che andassero avanti i primi e che si movesse tutto il campo.
1. La mattina, subito ch'egli è giorno o l'ora destinata a marciare, si tocca a cavallo e si suona la raccolta et il generale col Quar-

tier mastro generale, il capitan delle guide et altri ufficiali che ne dipendano, si trova alla piazza d'arme, dove dopo aver visitato la gente sua e trovato eh' ella è insieme secondo l'ordinamento dato, sendo costume di assignar e nell'ordine a ciascun reggimento il posto che deve prendere al rendez -vous et accanto a qual altro reggimento sia disposto accioché l' essercito venga sempre disposto in battaglia e così s'assuefacciano gli ufficiali et i soldati all' ordinanza, se bene altri usano fare che i primi reggimenti eh' arrivano alla piazza d' arme ·si collochino sulla mano dritta, e gli altri che di mano in mano vanno venendo si collochino nella man manca dei primi, tutti d'un fronte, perché ci è maggior facilità, si fa più presto, con meno carracolli e si fanno anche più diligenti i r eggimenti a comparire; il generale dunque dà ordine che la avanguardia cominci a marciare.
Se si ha da uscire da un campo fortificato subito che la più gran parte della gente è alla piazza d'arme, il generale comincia a farne spianare le trinci ere che fasciano il campo, accioché senz'impedimento si possa uscirne con gli squadroni et i battaglioni intieri; e spianate ch'elle sono, fa avanzare la avanguardia tanto lontano dalla piazza d'arme qu anto gli pare convenevole, poi manda dietro la battaglia e poi la retroguard ia, in ragionevole distanza et ordinanza.
L'essercito si ripartisce in questi tre corpi principal mente, cioè l'avanguardia, la battaglia e la retroguardia, e sebbene si suol ch iamar avanguardia la metà d ella Cavalleria che marcia per ordinario su l'ala dritta, e l'Infanteria, che marcia tutta insieme , è detta corpo o battaglia m entre l'altra metà della Ca va lleria, che marcia sull'ala manca, è detta retrogua rdia, in ogni modo essendo la perfezione del marciar e come s'è detto il pot ersi in un subito ordinare nella forma della battaglia che si è proposto, però egli è molto meglio che la gente tanto a piedi quant o a cavallo sia ripartita nei tre co rpi s uddetti, e ch e ciascuno di essi sia come un picciolo essercito da per sé e possa sostenere ogni sforzo et assalto dal n emico .
L'avanguardia suo l essere guidata dalla seconda persona generale e la retroguardia dalla t erza, ma il generalissimo suol condurre la battag lia ch'è come il cu ore di tutta l'armata dal qual e t utti gl i altri membr i pigliano forza e vit a . Alcuni generali non tengono posto fisso ma corrono or al campo, or nel mezzo, or"a alla coda, vanno dai la t i sopra i monti e sopra le colline per ve der tutto et osservar tutto tanto nell' essercito qu anto nella qualità del paese et ogni altra cosa.
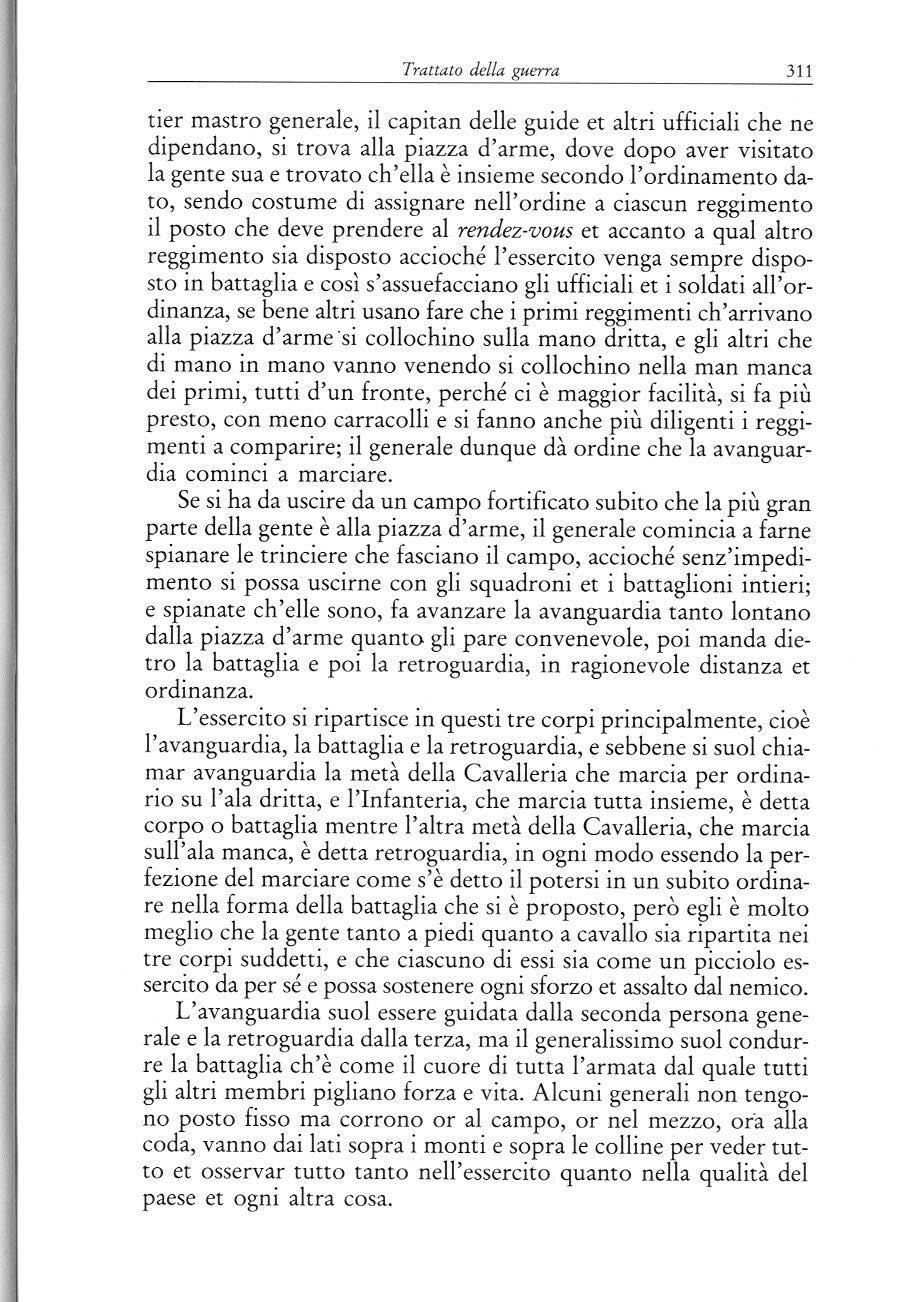
2. Usano alcuni generali che questi tre corpi suddetti si cambino ogni giorno a vicenda, cosicché quello che ha oggi la vanguardia marci domani nella retroguardia et il dì seguente nella battaglia, e così in tre giorni va attorno e nel quarto dì torna di nuovo nella vanguardia. Quella parte si tiene per vanguardia la quale sta più vicina al nemico e gira il fronte verso di lui, e però chi condusse ieri la battaglia e dovria condurre oggi la vanguardia si mette di nuovo nella retroguardia quando il nemico si è voltato e postosi contro la coda dell'essercito . Questo modo si osserva perché, se bene queste due estremità son le più pericolose, in ogni modo sono richieste da tutti come parti dove il pericolo e la fatica sono ricompensati da grande onore, et anche affinché della commodità della acquazione e della frumentazione tutti ugualmente comunichino permutando sempre l'ordine dell'andar avanti, perché i primi arrivano quasi sempre al quartiero di giorno e per tempo , e però possono meglio accomodarsi dell'acqua, degli strami e delle biade; quest'ordine usavano anche i Romani, fra i quali un dì il destro corno e l'altro il sinistro andava innanzi, tramutandosi anche le legioni loro vicine nel medesimo modo.

Questa tramutazione ha molto luogo in un essercito dove sono più generali di pari autorità, come s'è visto parecchie volte nell'armate francesi dove la suprema autorità gira col girar dei posti e si fa che il generale a cui tocca l'avanguardia abbia anche il comando quel giorno. Alcuni assegnano a ciascun corpo il suo posto, il quale mantiene poi sempre senza mutarlo né si muta anche chi lo conduce, il che è molto meglio perché l'essercito marcia più speditamente, li pri vati affetti e le private passioni non vi hanno tanto luogo e venendosi a giornata improvvisamente le genti ritengono nella battaglia i posti secondo che nel disegno di quella s'è determinato .
Ben è vero che in ciaschedun corpo di per sé si usa che i reggimenti di una medesima generazion d'armi passino vicendevolmente dalla vanguardia alla retroguardia e poi come per una scala vadano salendo sin alla vanguardia di nuovo, e questo modo osservano anche le compagnie di ciaschedun reggimento di per sé.
3. Si deve intendere che quando non si vuol ordinare la gente in ~atta9lia, al rende z -'?014:s ella s_i ~uol ordinare tutt~ in u? fro1_1te, acc1oche cavalcandovi dmnanz1 il generale possa m un occhiata scoprirla tutta, e se ci è qualche rialzo nella campagna, quivi viene schierata facendo fronte verso la parte donde si puol aspettar il
nemico, o se non si ha a temere il nemico, vérso la parte dove si vuol pigliare la marcia. Invece d ' una fronte ugua le, si suol talvolta schierare la gente in una fronte disuguale, a foggia di corno vuoto dentro, accioché le truppa possano esser viste e possano mostrare non solo l a fronte ma anche il lor fianco.
4. Per regolare ciascuno di questi corpi egl i è molto a proposito di considerare la forma che si vuol dare alla battaglia e secondo quella fare l a ripartizione della gente nei tre corpi. Alla vanguardia si consegnano le guide, innanzi a ll a q u al e si mandano i corrido r i e i battitori di strada che scuoprano e riconoscano tutto il paese all'intorno e sono guardie di tutto l'essercito finché ei marcia, né però s'avanzano mai tanto lontano che non possano essere visti, ma riconoscono per tutto s' ei non vi fosse qualche imboscata et avvisano la vanguardia di tutto ciò che scuoprono o che rincontrano.
Il generale del cannone ordina l'artigl ieria et il prefetto ordina il bagaglio. Innanzi alla vanguadia si fa anche marcia r e qualche truppe di Cavalleria leggiera et anche qualche moschettieri, che guardino et assicurino i guastatori che vanno facendo le vie accioché possino marciare almeno 10 uomini in fi l a e che si possa servirsi delle strade ordinarie e rea l i per la marcia del canno n e e dei bagagli, se non si può altrimenti. Nella vanguardia si conducono ordi n ariamente qualche pezzi di campagna, e questa vanguardia si rinforza con più o meno Cavalleria et Infanteria, s iccome si fa anc h e l a battag l ia o l a retroguardia secondo che s'ha più sospetto che l'uno o l'altro di quei corpi sia assalt ato dal nemico.
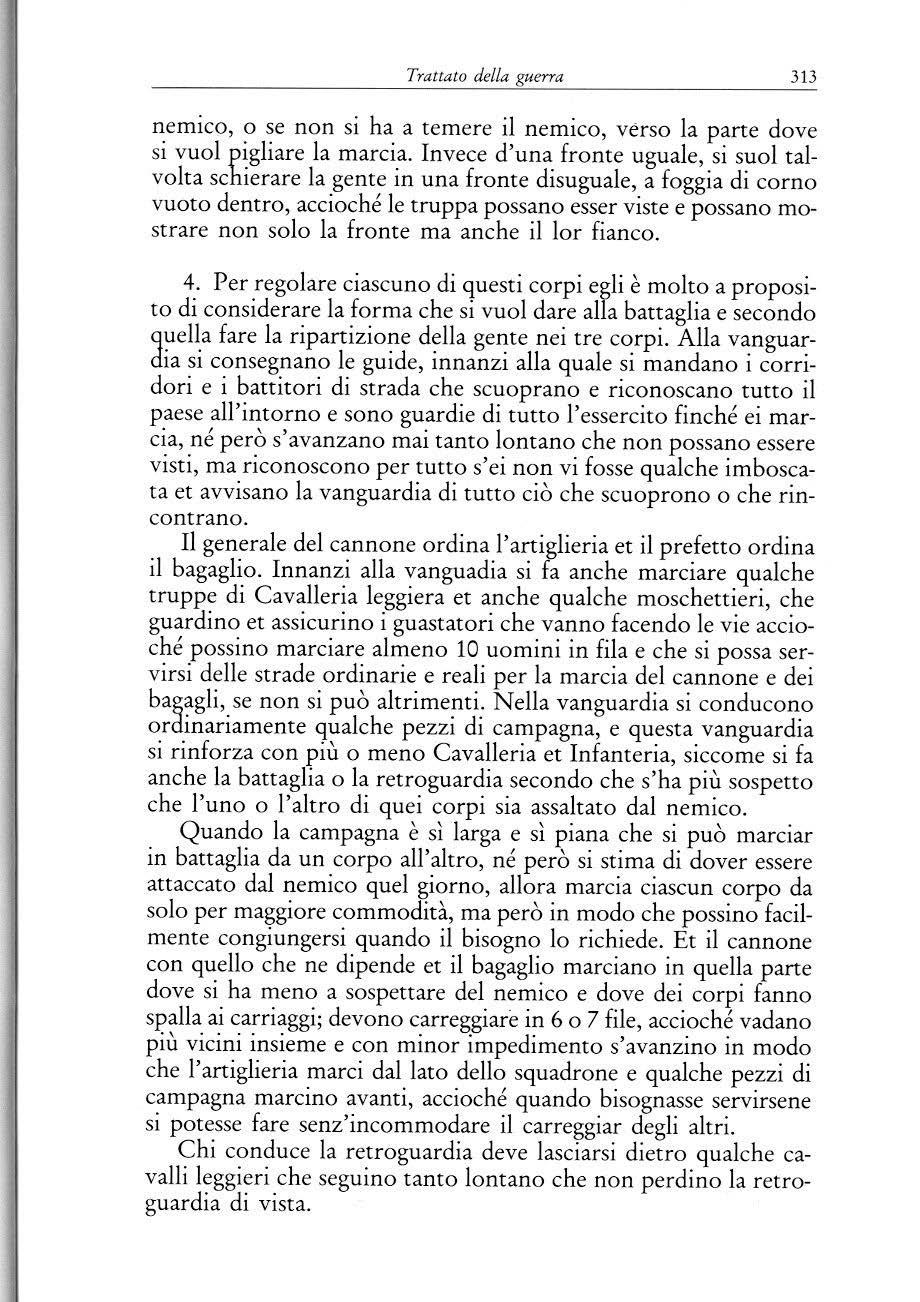
Quando la campagna è sì larga e sì piana che si può marciar in battaglia da un corpo all'altro, né però si stima di dover essere attaccato dal nemico quel giorno, allora marcia ciascun corpo da solo per maggiore commodità, ma però in modo che possino faci lmente congiungersi q uando il bisogno lo richiede. Et il cannone con quello che ne dipende et i l bagaglio marciano in quella parte dove si ha meno a sospettare del nemico e dove dei corpi fanno spalla ai carriaggi; devono carreggiare in 6 o 7 file, accioché vadano più vicin i ins ieme e con minor impedimento s'avanzino in modo che l'artig lieria marci dal lato dello squadrone e qualche pezzi di campagna marcino avanti, accioché quando bisognasse servirsene si potesse fare senz'incommodare il carreggiar degli altri.
Chi conduce la retroguardia deve lasciarsi dietro qualche cavalli leggieri che seguino tanto lontano che non perdino la retroguardia di vista.
Quando il paese è montano et i battito ri di strada d evono sempre tenersi sui colli e sui rialzi, accioché il nemico non li pigli, o vi venga, o di là possa scoprire l'ordinanza nella quale si marcia. In una campagna o cammino stretto si rinforza ordinariamente la vanguardia coll'Infanteria secondo che più o meno ·si teme il nemico, e se gli dà qualche pezzo da campagna quando la strada lo comporta. La retroguardia si rinforza anche in simil maniera e la battaglia si riparte in modo che l'Artiglieria con ciò che ne dipende, il bagaglio e la più gran parte della Cavalleria, poiché quivi non si può servirsi di essa gran fatto, sia messa nel mezzo. Ma se la strada fosse sì stretta che i carriaggi facessero una fila sì lunga che la retroguardia non potesse facilmente soccorrere la vanguardia, si devono far marciare alcune truppe accanto al bagaglio le quali sieno disposte in modo che si possano aitare l'una l'altra e si possa tanto più facilmente venire a soccorrere o l'una o l'altra part e quando fa bisogno.
In tal sito e strettezza di paese e di strada, occorre talvolta che vi s'incrocicchiano viottoli che vengono dai boschi o da valle, et in tal caso quando si teme che il nemico possa per essi occultamente venir addosso si deve far fermare quivi un nerbo d'Infanteria, il quale li guarda sinché tutto il bagaglio è passato e fuori di pericolo, e poi detta Infanteria si va a porre nella retroguardia. Poiché la moschetteria è del più comune servizio, massime in contrade strette dove prestamente può essere trasferita d'un luogo in un altro e collocata secondo che richiede il bisogno per occupare prestamente o per guardar un passo, o per copr ir e e favorire in qualche modo la Cavalleria, egli è molto a proposito che dinanzi ai battaglioni di picche della vanguardia sieno comandate alcune truppe di moschetteria di 100 moschettieri per truppa e non più, perché in ogni modo rimangano moschettieri assai per guarnir i battaglioni delle picche, in considerazione che questi corpetti a parte in un bisogno sono più alla mano, e più facilmente senza disordine e fatica si possono subitamente impiegare dove si vuole che se s'avessero primieramente a separare e levare dalli altri corpi.
Questi moschettier i potrebbero essere Dragoni, sì come l' Aldringen usava sempre di farli marciare innanzi tutta la vanguardia. Questi servono per coperta della Cavalleria quando i corridori fossero rispinti, et anche marciano innanzi di quella quando si ha da occupare un posto stretto e lo teng ono finché le truppe di Cavalleria siano passate et aspettano poi quivi che arrivino le picche, dinnanzi alle quali si pongono poi nuovamente nell'ordine di pri -
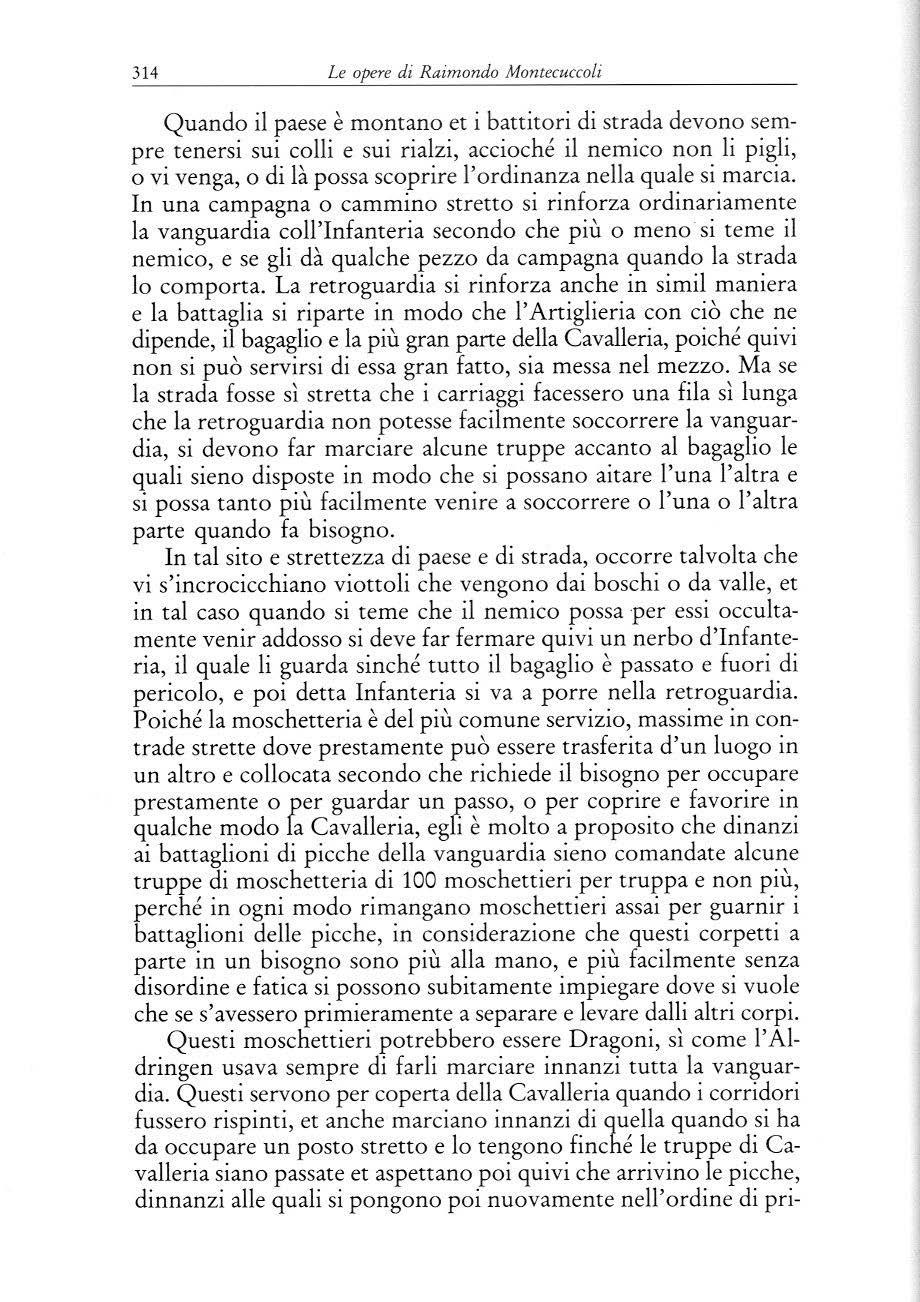
ma . Nella retroguardia si procede all'opposto ad un passo stretto e pericoloso, dovendo lasciar passare innanzi la Cavalleria eh' è dietro a loro, seguirla finché ella è passata, dove ella fa poi altro sinché i moschettieri tornano nuovamente dinnanzi al loro posto di prima, et in questa ordinanza non si può facilmente essere sorpreso e danneggiato, perché il nemico che vuol intrattenere un essercito che marcia manda dietro la sua Cavalleria solo per attaccare e molestare la coda.
5. Insomma, si possono fare queste osservazioni: che la parte dove si terne di più sia rinforzata con i migliori fanti e con i migliori cavalli; che gli impedimenti sieno messi nella parte che si stima più sicura; e se si teme per tutto sieno messi nel mezzo; che si consideri la qualità dell'azione e la natura delle truppe, perché per far subita impressione sul nemico sono più le lance, la moschetteria, la Cavalleria leggera e le mezze corazze, per sostenere l'impeto del nemico vagliano di più le corazze intere e le picche; quelle in un cammino stretto possono esser rovesciate, e se sono poste dinnanzi possono rincular sopra gli altri e metter ogni cosa in disordine, massime di nottetempo; queste sostengono con un corpo solido e fermo il nemico sintanto che le truppe che sono dietro hanno tempo di gettarsi sui lati e guadagnar la campagna, o avanzarsi et ordinarsi secondo il disegno.
Così anche se vi sono cammini cupi e profondi, egli è pericoloso il passarvi, in ogni modo si forzano con i picchieri armati e con gli scudi, avendo la loro moschetteria alle due ali sopra l'alto del cammino; che se le corazze hanno messo pié a terra per guardar il passaggio, bisogna tener la campagna per aver luogo per collocare la moschetteria all'ale delle picche, che banderà queste corazze. S'egli s'è costretto di passar allo stretto, bisogna che i picchieri vadino avanti e che la moschetteria seguiti di presso, et i picchieri occuperanno tutta la larghezza del camino fuori che per il passaggio di un sol uomo da ciascun lato, l'uno per dove la moschetteria vada a tirare al fronte dei picchieri e l'altro accioché dopo ella possa ritirarsi dietro di quelli.
Nei luoghi angusti preceda l'ala dritta e di mano in mano v adano seguendo le genti che so110 più verso la sinistra e nel camminare l'una parte dell ' essercito non si spicchi dall'altra o per andare l'uno tosto e l'altro adagio l'essercito non si assottigli, le qual cose sono cagionè di discordia e fanno che se il nemico è accorto e risoluto può assaltarne una parte e batterla, perché per la distanza non potrà essere assai a tempo soccorsa dalle altre.

Dove s 'intoppano più strade massime di nottetempo, si lascino dalle prime truppe due soldati indietro su la croce della strada che avvertiscano quelli che seguono del cammino che devono pigliare per seguir gli altri e non isbagliare; questi due soldati devono essere rilevati da due altri delle seconde truppe e questi pur di nuovo dalle truppe che seguono, e così di mano in mano sin all'ultime della retroguardia.
Quando il generale non può condur seco quantità bastante di vettovaglie, abbia almen cura di avere sul lato dell'armata qualche fiume navigabile o qualch e provincia opulenta o castello alle spalle donde possa commodamente aver i viveri, e però vegga c h e marciando con l'essercito non si lasci qualche luogo nimico alle spalle, massime vicino ai fiumi, accioché quelli ch'apportano i viveri non siano intercettati. O ccorrendo che l' essercito abbia a marciare vicino ad una guarnigione del nemico, si commandi verso di quella un nerbo sufficiente di Cavalleria e di Fanteria, il qual possa ritener dentro la guarnigione et impedirgli le sortite, et abbia ordine di fermars i quivi sinché tutta la gente e tutto il bagaglio sia fuori pericolo.
Quando s i è v icino al luogo dove si ha dissegno di loggiare, vada innan zi il Quartier mastro generale con quei dei reggimenti e coi furieri delle compagnie e con tanti soldati commandati quanti li bisognano per sicurezza, per riconoscere e veder il campo e per ripartir i quartieri; talora ci va il capitan generale ist esso, o da qualche rialzo scoprendo il paese distribuisce ad occhio i quartieri e commanda dove abbia ad alloggiare la Fanteria, e dove questa e quell'altra Cavalleria. Così faceva spessissime volte il Banér, perché molto meglio si può giudicare della commodità della piazza d'armi, della sicurezza dei quartieri, dei foraggi della campagna e della qualità del sito per un combattimento, vedendo cogli occh i propri che udendo relazioni degli altri.
Pr ima di entrar nei quartieri si faccia metter l'armata in battaglia e posar le guardie e poi si faccia alloggiare truppa a truppa senza permettere che alcuno vada ad alloggiarsi se non per commandamento, facen do intanto fare la discoperta da tutti i lati perché il tempo dell'alloggiamento è anche un'ora pericolosa di esser attaccato, trovandosi l'armata stanca ed avan zandosi ciascuno in disordin e al quartiero per voglia di alloggiarsi presto. E ciò devesi anche osservare con un reggimento solo e con una compagnia, per l'analo gia che vi è.
L'armata si assomiglia ad un corpo umano, dove i battaglioni delle picche rappresentano il petto e il ventre, perché siccome in
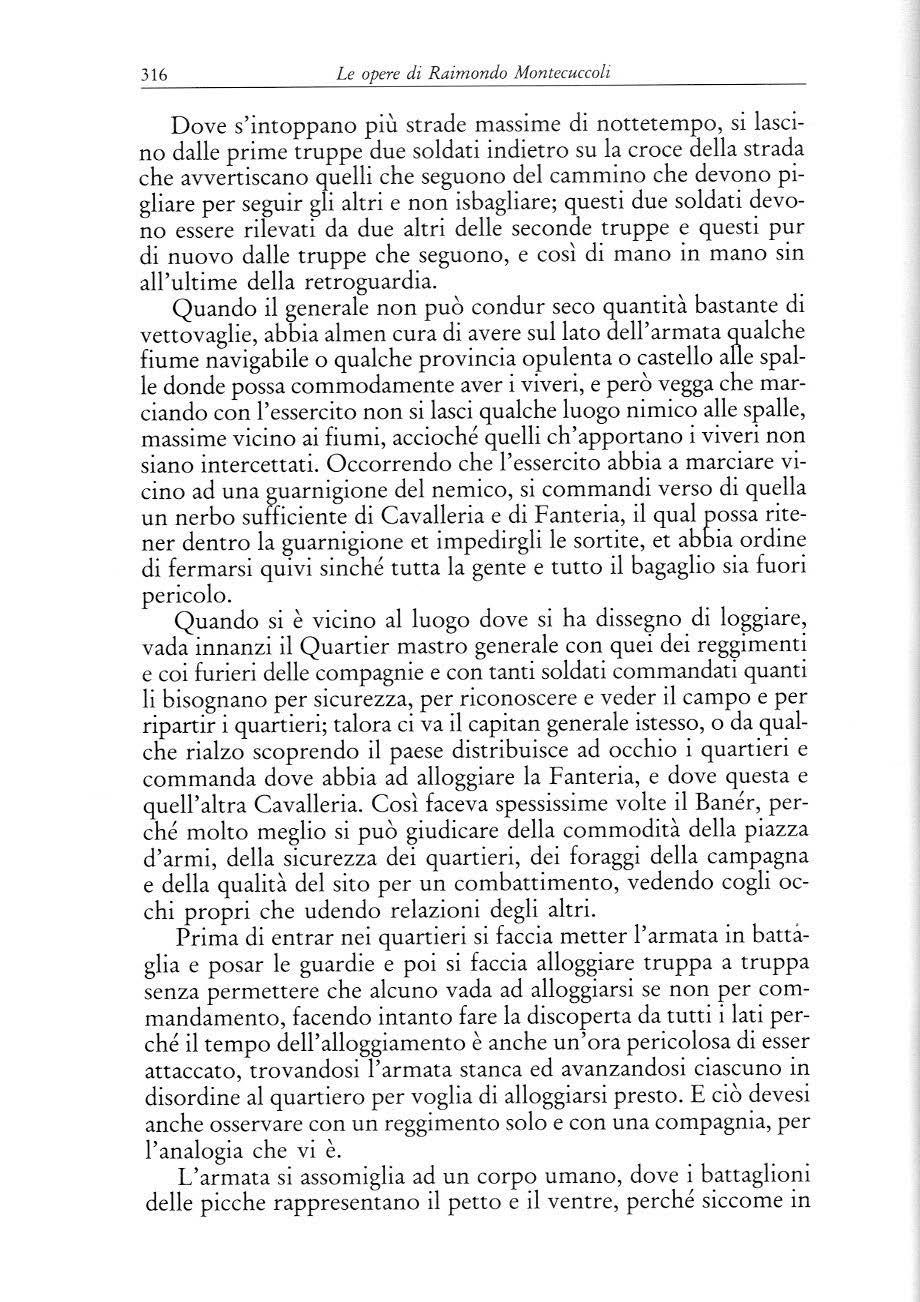
questi consiste la principal virtù, vigore e forza dell'uomo, così in questa parte dell' essercito si deve colloca re la spera nz a maggiore della vitto ri a, le maniche e l'ali formate di moschettieri rappresentano le braccia, i guastatori che marciano davanti s i comparano ai denti dell'uomo, perché siccome i denti preparano gli alimenti accioché il loro transito non sia impedito al ventricolo, così anche i pionieri preparano la via e levano ogni impedimento dal quale il viaggio dell' essercito possa esse r e turbato. Li squadroni dei cavalli leggeri che vanno innanzi ai guastatori si assomigliano all'immaginazione dell'uomo, perché preveggono gli incommodi a ve nire essendo sempre pronti a diffondere la fronte dell'essercito e le squadre dei guastatori et a rispingere le ingiurie dei nemici; i corr id ori, che sono cavalli leggeri et osservano, spiano gli andamenti del nemico, si paragonano agli occhi il cui uffizio è governare b ene e regere la mole di tutto il corpo . Ma più distintamente ancora dovesse dire qualche de' corridori dell'artiglieria e del bagaglio.
di ogni altra cosa, mentre che camminano con l'esercito guardarsi dagli agguati nei quali si incorre in due modi: o camm inando tu entri in quegli, o con arte del nemico vi sei tirato dentro senza che tu gli presenta.
1. Al primo caso volendo ovv iare, è necessario mandar innanzi corridori, i quali secondo il bisogno s i mandano duplicati e triplicati da tutti i lati e sono la pupilla dell' essercito, e battendo la strada in buon numero dinnanzi e di dietro e d'ambe i due lati scoprono il paese, e tanto maggior diligenza vi si deve usare quanto più il paese fosse adatto per gli agguati, come sono i paesi selvosi e montuosi, perché per l'ordinario si mettono o in una selva o dietro a un colle, e come l'agguato non lo prevedendo ti rovina, così prevedendolo non ti offende. Questi co rridori sono i cavalli leggeri, et osservano tutta la co ntrada, le strade reali, i vioto li et ogni cammino, perché talvolta un essercito che marcia è assaltato dai lati dal nemico imboscato, il quale avendo avuto lingua della tua marciata si sarà venuto a porre in agguato s ulla strada che dev i pigliare, siccome fece il Banér, quando lo Hatzfeld marciava coll'armata ad Eilenburg 180 ; e non solo vengono fatti prigionieri e amazzati da quel lato i soldati che non possono seguire il campo o che marciano fuori dell'ordinanza: l'essercico medesimo è assa-
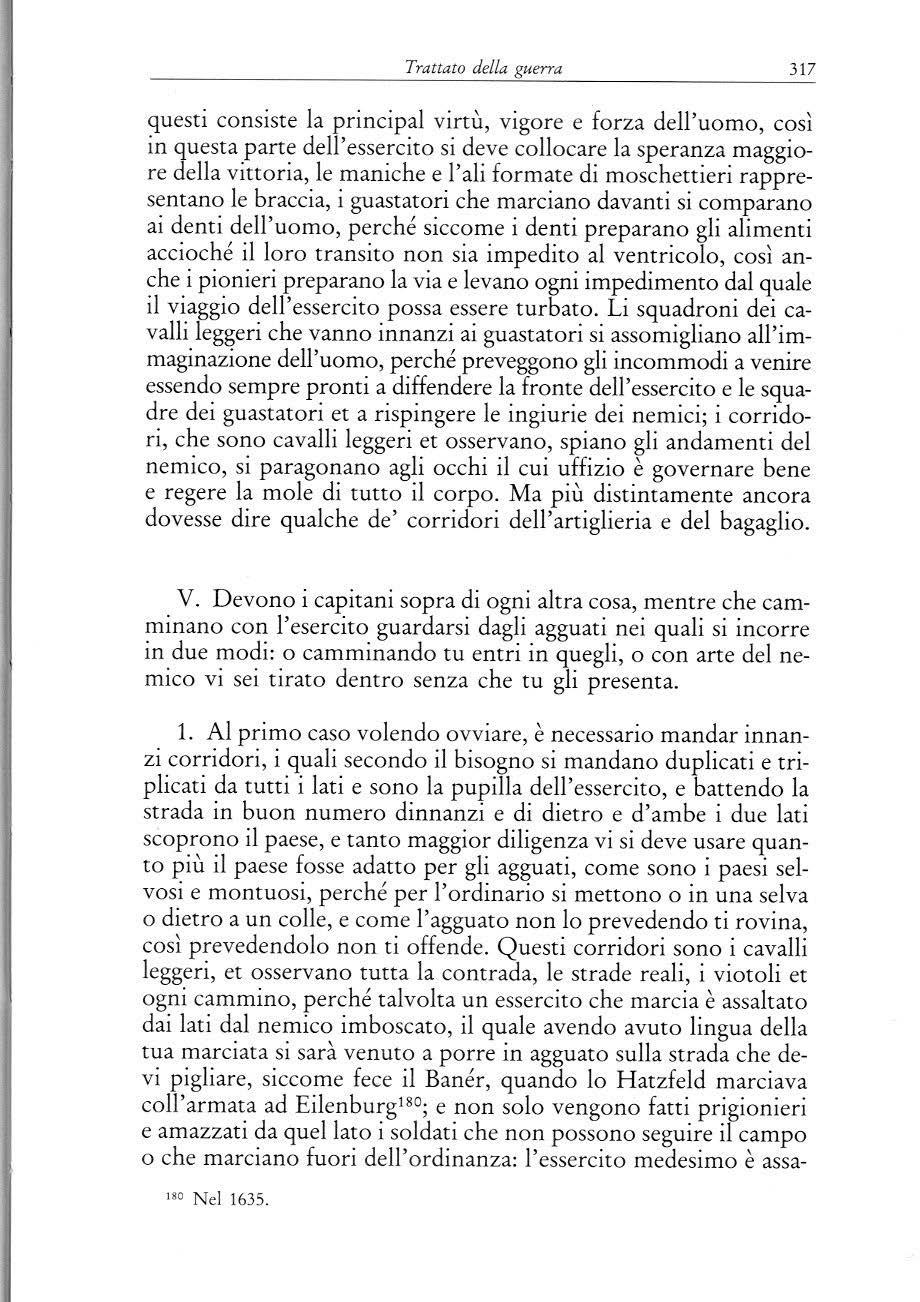
lito, onde quand'anche il nemico non facesse gran danno nella gente, fa in ogni modo qualche prigionieri, dai quali può aver lingua di ogni particolarità dell'essercito con danno dell'armata e con iscorno del generale. E però egli deve dar ordine rigoroso e far pubblicare gride che nessuno marciando esca dall'ordinanza, ed incaricar gli ufficiali di prenderci cura particolare, e deve anche ordinare s ulle ale squadroni di archibugieri a cavallo, che ricoprano e diffendano quelli che vi marciano dentro.
Hanno gli uccelli o la polvere molte volte scope rto il nemico, perché sempre che il nemico ti venga a trovare farà polvere grande, s'egli è d'estate, che ti significherà la sua venuta: così molte volte un capitano, vegge ndo n ei luoghi donde egli de ve passare levarsi colombi o altri di quelli uccelli che volano in schiera, et aggirarsi e non si porre , ha conosciuto esser quivi l'auggurio dei nemici, e mandato innanzi sue genti e conosciuto quello, ha salvato sé et offeso il nemico suo. Hanno anco scoperto il nemico il fumo o il fuoco eh' egli fa nei quartieri, o i cavalli eh' egli ha lasciato andar alla pastura o i foraggeri eh' egli ha mandato a tagliar erba o grani. Subito che i corridori hanno scoperta qualche simil cosa, lo devono immantinente avvisare al generale o a chi conduce la vanguar dia o quel corpo che è più vicino al lato dove il nemico è scoperto.
2. Quanto al secondo caso, d'esservi tirato dentro, devi star accorto di non credere a quelle cose che sono poco ragionevoli eh' elle siano, come sa rebbe se il nemico ti mettesse dinnanzi una preda, devi credere che in quella sia l'amo e che vi sia dentro nascosto l 'inganno; se gli assai nemici sono cacciati dai tuoi pochi; se pochi nemici assalgono i tuoi assai e fanno una rapida fuga e non ragion evole: sempre devi in tali casi temere inganno, e non hai a creder mai che il nemico non sappia fare i fatti suoi e ti deve esser_ sospetta non solo la fraude dei luoghi ma anche quella del nemico.
3. Il bagaglio è il principale impedimento ch'a un essercito nel marciare, perché non solo eg li è un grave peso dal quale il movimento dell'armata viene grandemente impedito e ritardato, ma egli è anche cosa difficilissima il poterlo condurre in buon ordine sicché sia totalmente sicu ro ch'egli non rechi gran pregiudicio a tutto il corpo o vero che non bisogni lasciarne qualche pezz o adietro con iscorno, e però si deve ridurre al più picciolo piede che sia

possibile, rinunciando ad ogni superfluità, perché chi vuole esse r soldato si deve conten tare nella vita di soldato, e pubblicata questa riforma bisogna farla osservare con castighi rigorosi e tener se mpre in buon ordine le bagaglie che restano nell'essercito facendo commandamento al prefetto di impiccar i garzoni eh' egli trova fuori d'ordine e fare spogliare i carri che trova fuori delle loro fila, e quando questo sarà stato esseguito due o tre volte non e' è dubbio che gli altri cercaranno di tenersi negli ordini, e servirà anche molto che il generale istesso vada talora girando or intorno ai lati ora intorno alla fronte e alla coda dell' essercito e con qualche colpo di pistola uccida et intimorisca i soldati che marciano fuori dell'ordinanza, siccome hanno usato di fare Pappenheim, Fiirstenberg, Montecuccoli ecc. 181 •
La sera pr ece dente il giorno che si deve marciare, deve il generale non solo dare gli ordini, come si è detto, ma anche questo per iscritto, dove ciascuno sotto alla s ua banderuo la abbia a posare i carri suoi et i bagaglioni, e come abbiano a marciare, e d1 questi ordini deve avere una copia il prefetto generale il quale ha anche una banderuola particolare di tela turchina, accioché sia differenziata da tutte le altre, e tutti gli altri prefetti dei reggimenti devono accozzarvisi con le loro e col bagaglio che guidano dove ciascheduno secondo il dato commanda mento , e poi ordinato e mostrato il suo posto dal prefetto generale.
4 . Quando un esse r cito marcia, si tiene sempre questo ordine: che i carri e le bagag lie s' inca mminano prima che le bandiere e gli stendardi, e però egli è molto a proposito quando il sito del luogo lo permetta di far il rendez-vous, dove la gente si deve incontrar insieme, un tiro di moschetto o più lontano dall'insegue, accioché fra gli alloggiamenti dentro ai quali sta tutta via il campo e detta piazza, sia spazio abbastanza dove le bagaglie possano contenersi, s inché elle sieno ordinate assieme in buon ordine; et il prefetto generale d eve stare coi suo i aitanti appresso alle dette bagaglie accioché nissun a parte di quelle si muova dal suo posto ordinato . Ma perché non si può sempre aver tale comodità di sito, egli è necessario per il mentenimento del buon ordine che sia pubb licata una grida che sotto pena della vita n essuno s i muo va col suo bagaglio prima che quello del generale sia in marcia, doppo il quale segui ranno poi tutti gli altri, ciascuno nella sua ordinanza.
is i Gottfried H eirich vo n Pappen h ei m (159 4- 1632) , il più ab ile comandante di Cavaller ia Imperiale; Fr iedr ich Rudo l f von Furste nb er g-Shtulingcn (1 602 -1665) , generale bavarese; Montecuccoli è, ancora u na volta, Ernesto M .
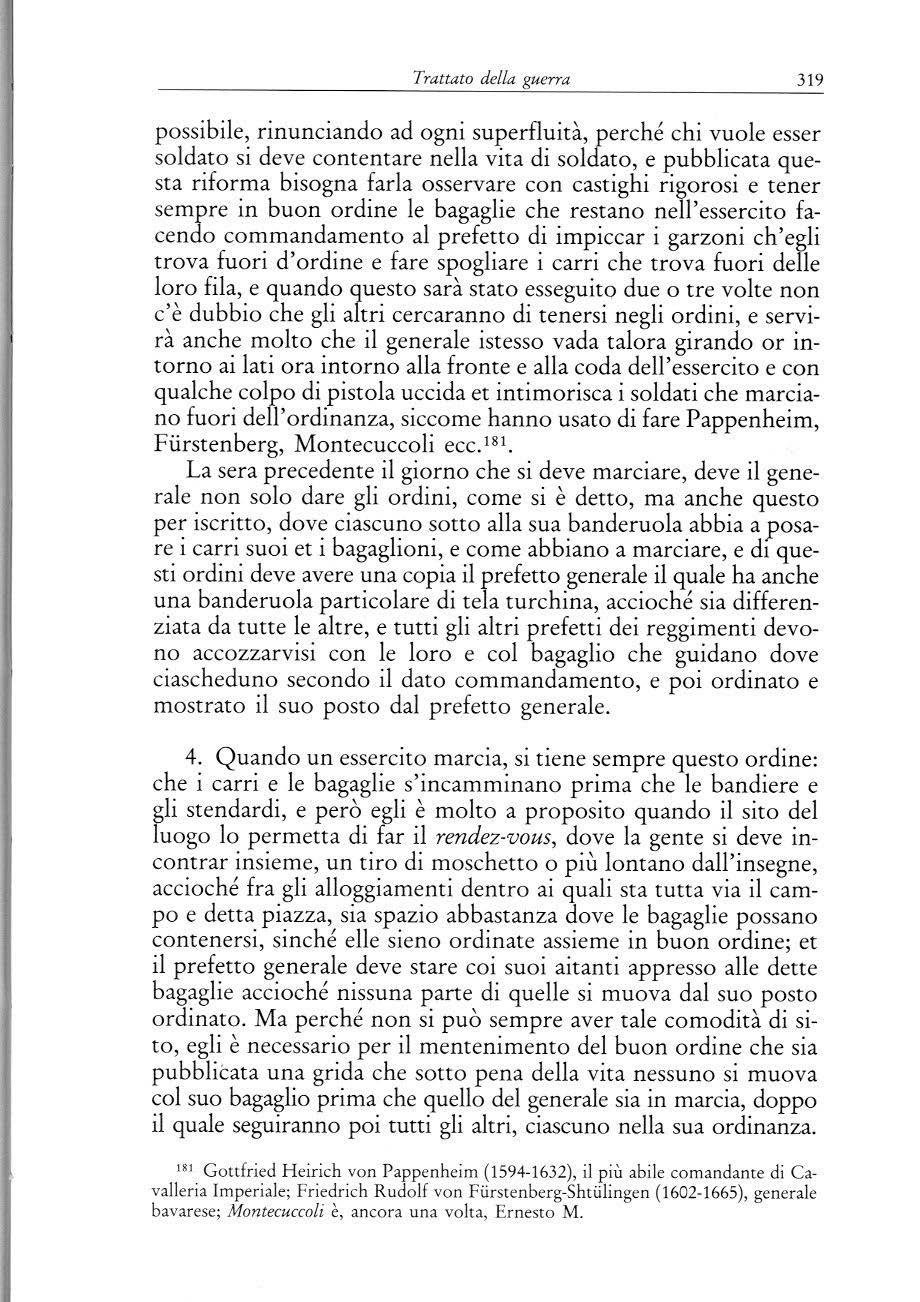
5. L'ordinanza viene disposta in questo modo: l'Artiglieria con tutto ciò che ne dipende marcia davanti e con essa hanno anche il loro posto i guastatori, né è permesso che vi si mischi alcun carro che sia di chi che sia, e <lessa è disposta in bell' ordine. Primi eramente si conduce un carro carico di zappe, badili, vanghe, picconi e simili stromemi per lavorar la terra dinanzi, poi ne segue uno st romento particolare col quale è segnato una striscia, detta daflgleis, sopra la strada che si deve tenere marciando, quando il cammino è rincontrato tr oppo stretto, e che l'Artiglieria non ci potria passare, accioché subito i guastatori l'allarghino; poi seguono i pezzi piccoli e leggeri, sulle loro Lafetten 182 ; poi l'artig lieria più grossa, la quale, quando non s'ha sospetto del nemico , è condotta sop ra le carra dette Stuckwagen 183 , ma quando se n'ha sospetto, è condotta anch'ella sopra i suoi letti, perché n'andria troppo tempo se nelle occasioni e quasi in pr esenza del nemico si volesse levar dalle carra e metterla su le Lafetten. Doppo l'artiglieria seguono le carra sopra di cui si fa legnami et i maniscalchi hanno i loro stromenti caricati. Poi le carra cariche di polvere e di piombo, poi quelle delle merci, poi quelle che conducono le picche, poi seguono finalmente i carri carichi di palle. Dopo questi seguono i carri del generale dell'artiglieria e quelli ch e appartengono ai suoi ufficiali e dopo seguono tutti gli altri carri carichi di munizione appartenenti al cannone, e poi i carri della provianda e lo spita le , cioè qu elli sopra cui si conducono i malati et i feriti. Dopo questi seguitano i carri con i quali si dà principio al bagaglio, cioè quelli del genera le, poi quelli della Cavalleria e dell'Infanteria i quali sogliono esser ordinati dinnanzi o di dietro conforme al posto che tengono nel marciar e le truppe alle quali appartengono.
Se il bisogno richiede che per tema di qualche assalto del nemico si facciano marciare fuori di qu est'ordinanza qualche pezzi d'artiglieria dinnanzi o in altra parte, allora si manda con essi anche tante carra con polvere, palle et altre munizioni necessarie quanto si stima che facciano di bisogno. Quanto al bagaglio, si deve tener questa massima, che quando si teme il nemico dinnanzi, quello si ordina tutto dietro alla retroguardia dove si fa guardare con num ero convenevole d'infanteria e di cavalleria secondo il bisogno accioché anche quivi non sia assalito; e quando il nemico marcia di dietro, allora si ordina il bagaglio dinnanzi, come s'è detto, con la guardia necessaria, e la gente fa alto sopra il rendez-

vous fintanto che egli sia avanzato un buon pezzo di strada. Per passare un fiume o qualche ingrato passaggio, devonsi apportare diverse considerazioni, perché un fosso, un marazzo, una riviera od altro passo stretto fa sì che il generale non può avanzarsi sì speditamente, e quando il nemico lo presente et è vicino, può occupare et impedire il passo o per lo meno attaccare l'essercito che passa dietro o dinnanzi, dov' egli è più debole, con suo grande avantaggio, et i buoni capitani cercano con ogni industria di pigliare per i capegli simili occasioni . Si usa però di COfl:durre barche e pontoni sopra i carri con un essercito, accioché tanto più speditamente si possa passare un'acqua, e quelle sono pr-ovviste di funi, d'ancore, di remi e d'ogni altra appartenenza accioché non s'abbia a perdere tempo nel far piantar i pali o far altre fatiche che intrattengono l'essercito, ma si possono gettar subito le barche sull'acqua, et in poche ore fare un ponte. Dei ponti si è discusso diffusamente nella meccanica, nella Pecorina numero VII.
I. Quando ci s'abbatte ad un ponte, e che il nemico è vicino, bisogna assicurarsi in due punti.
1. Bisogna che il generale consideri quanto lontano è il nemico da lui e misuri bene il tempo, che non gli arrivi sopra innanzi che sieno finiti i travagli necessari del ponte, perché sebbene si danno molti precetti per passar tali passi cattivi in vista del nemico, in ogni modo quando si vien all'essecuzione pochi se ne sbrigano bene se son bene attaccati, sicché il modo migliore è di pigliare sì bene le sue misure che si sfugga a questo rincontro.

2. Bisogna gettar il ponte colla maggio r celerità che si può, et accioché il nemico non impedisca il passo si deve far alzare una trinciera in forma di mezza luna dinnanzi alla stretta del passo o vero del ponte, e se il sito non lo permette si deve alzare uno o più baluardi secondo il bisogno, dai quali si possa, con l'artiglieria e la moschetteria, tenere adietro il nemico s' ei venisse.
Quando si ha il nemico alle spalle si deve far passare il bagaglio con l'artiglieria grossa che vi marcia dinnanzi e subito dev'esser piantata per di là, sull'altra ripa del fiume, contro al nemico, et i piccioli cannoni si ritengono da questa parte di qua nei baluardi per tenir adietro il nemico et impedirlo che anch'egli non pianti il suo cannone; ma quando si ha il nemico innanzi, dopo aver
alzato qualche baluardo contro di lui, si deve tener il bagaglio di qua sino all'ultimo e piantarv i l'artiglieria e farla giocare contra al nemico fintanto che tutta la gente sia passata nell'altra parte di là, et allora segue finalmente il bagaglio e l'artiglieria grossa dopo, senza pericolo.
Ma, accioché l'artiglieria eh' è piantata di qua per favorire il passaggio o la fabrica del ponte possa tirar meglio e con i tiri incrociati rinchiudere per di là maggior spazio di luogo, e sia capace di [coprire] più gente di guerra quand'ella passa 18 4, si deve aver cura di eleggere un luogo del fiume dove egli faccia una curvatura et un angolo in dentro dalla parte di qua, dove alzando poi le batterie nei lati dell'angolo, si può con tiri di quelle tener coperta nell'altra ripa e netta una gran piazza capace di disporre l'armata, artifizio usato dal Re di Svezia nel passare il Lech, in Baviera, il qual e rincontrò anche questo altro vantaggio, d'un picciol colle eh' era vicino alla fronte del ponte ripieno di folti virgulti, il quale egli occupò subito e fortificò, e di mano in mano che la gente andava passando la schierava in ordinanza di due parti, di sotto e di sopra del ponte, il quale era lasciato fra le du e battaglie, e spazio per ricevere de' soldati che andavano venendo, e perché si fortificavano di mano in mano, non potevano quei di Baviera né col fare girare la cavalleria leggera tentare d'assalir i Svedesi alle spalle e tagliar loro il ponte e separarli dagli altri, perché le loro fortificazioni erano congiunte al fiume, né caricarli impetuosamente di fronte, perché le batterie ch'erano disposte nell'angolo della ripa opposta del fiume venivano a batterli crudelmente nel fianco. Usò anche il Re d'impedire a quei di Baviera la vis ta, accioché non vedessino ciò che particolarmente travagliasse et accioché i lavoratori non fossero impediti nell'opera del ponte, e però faceva tirare continuamente con i cannoni et abbrugiar pece e simili materie fumose ch e riempivano l'aere di nebbie scurissime e ricoprivano il lavoro et i la voratori .
3. Fra i vantaggi che si de v ono eleggere d'un sito di una ri v iera è anche questo, che nella ripa opposta e dove si vuole passare siano folti cespugli o fossi o marazzi o altra cosa simile, dove la Cavalleria non possa adoperarsi, perché subito facendo portar di là in un tratto una barcata di fanti, aitati dal v antaggio del luogo possono con un po' di travaglio in brev issimo tempo far il posto
184 C on tale acco r gim e nto avr e bb er o i Turc hi, ventit r é an ni d o po, fo rzat a la Raa b a San Gottard o

sì forte che, sopravvenendo il.nemico, non possono più esse r rispinti, ma favoriscono il passaggio degli altri, p erché se il nemico è negligente e trascurato nel guardar il passaggio, o perché tu abbia fatto vista di non voler tentar cosa alcuna, e p erò tu o ti sia ritirato e distribuito fintamente l' essercito nei vi llaggi, poi in una notte oscura e piovosa improvvisamente marciando, e tramesso di là una barcata di fanti che più facilmente si trasportano che i cavalli, o perché il nemico non possa guardar sempre tutto il tratto della riviera, o perché tu abbia separato l'essercito in più parti e facendo dimostrazione in più versi di passare dove non hai dissegno costringi anche il nimico a separar le sue forze in diverse truppe, e però passi la notte et all'improvviso con un nerbo di fanti a guadagnar nell'altra ripa un posto come s'è detto, in tutti questi casi tutto quello che può far il nemico che non è presente per impedire che tu non passi affatto avendo lingua che tu abbia cominciato a passare, è di venire con celerità per rispingere quelli che sono passat i prima che le forze ingrossino; ma perché la sua Fanteria non potrà marciar così in fretta, ei verrà solo con la Cavalleria, e tu avrai preso posto proporzionato ai fanti e non ai cavalli, però potrai sostenere il nemico tanto che vai ingrossando e passando tutte le tue forze nell'altra parte .
Banér passò in quest o modo l'Elba vicino a M elnik. Egli fece gran dimostrazioni il giorno prima di vole r passare a forza a Brandys e dall'altra ripa della riviera si vedea marciar a quella volta con tutta l'armata et il bagaglio, e gli Imperiali ridussero qui tutta l'Infanteria e la Cavalleria ch ' era comandata a guardar la riviera per opporsi allo sforzo, ma perché dubitorno che il nemico facesse una finta, e most rando di voler forzare Brandys andasse improvvisamente a passar altrove, separarono i reggimenti tutto lungo la riviera in diversi posti, accioché avessero l'occhio sopra il nemico con le guardie e con le pattuglie continue et occorrendo che un posto fosse attaccato tutti vi concorressero per difenderlo; né fallì l'aspettazione, perché una notte Banér si levò segretamente da Brandys et accioché gli Imperiali non se ne accorgessero lasciò le micce accese attaccate nei gabbioni e nelle trincee che avea alzate, e portatosi rapidamente presso a Melnik passò una barcata di fanti che presero subito posto sulla ripa del fiume, impedita di arbori, di fossi e di virgulti, e cacciò una guardia di Cavalleria imperiale, la qua le non vi poteva maneggiare né impedir il passaggio, e sebbene l'[all]arme fu subito dato a tutti gli altri posti et a gran trotto tutti i reggimenti alloggiati quivi a lungo corsero per

rispingere il nemico in ogni modo, prima che vi fossero giunti egl i era già molto ingrossato e il sito, malagevole per i cavalli, non lasciava caricarlo, sicché, avendo anche la Cavalleria svedese ritrovato un guado, passò in breve tempo tutto l' essercito e disperse le truppe imperiali 18 5
Dal che si può tirare questa massima, che quelli che non è estremamente curioso, diligente e previdente a guardar il passaggio d'una rivi era o quello d'una montagna, è quasi sempre prevenuto, perché chi la guarda s'addormenta sopra il vantaggio del luogo, e chi lo vuole passare cerca ogni espediente, e finalmente lo trova, per superare ogni ostacolo.
4. Un altro vantaggio è un'isoletta che sia posta nel mezzo del fiume, perché guadagnandola si è come al coperto, per forzar poi di quivi quello che vi resta di passaggio, siccome con tal commodità passò il Galasso il Reno vicino a Germ ershause n, con dispetto dell'armata del Weimar che lo difendeva, avendo fatto sbarcare un nerbo di fanti ai quali, messi a terra sull'altra riJ?a, si fecero discostar le barche accioché i soldati fossero tanto piu necessitati a combattere finché ne fossero stati trasportati degli altri.
5. Per passar dunque quando si teme il nemico in fronte, si pianta tutta l'artiglieria sulla ripa e si aggiusta a mirare il luogo che si vuole occupare dall'altra parte, poi si cominciano a metter le barche, o a far altri travagli nell'acqua per fabbricare il ponte, sul quale si vanno mettendo i moschettieri che con tiri tengono lontano il nemico , e subito che il ponte è fatto si fa passare qualche cavalleria leggera, se il sito lo comporta, qualche pezzetti d'artiglieria con qualche carra di munizione e con fanti e guastatori, accioché i soldati si possano subito fortificare sull'altra ripa per la difesa del ponte, e se si teme anche da questa parte il nemico nella retroguardia bisogna anche fortificarsi quivi, accioché gli ultimi soldati dietro che chiudono la ritirata siano fuori dal pericolo.
E questo modo che si tiene con un'armata si tiene anche proporzionalmente con una partita, regolandosi conforme alla natura dell'armi, accioché sieno adoperate nel lor avantaggio, come se c'è qualche ruscello a passare e s'abbia il nemico dinnanzi, si fa passare la metà della moschetteria e s'ordina l'altra metà da questa parte lungo la ripa, per far tener lontano il nemico, e quando quella moschetteria è passata, ella s'ordina al bordo di là del ruscel-

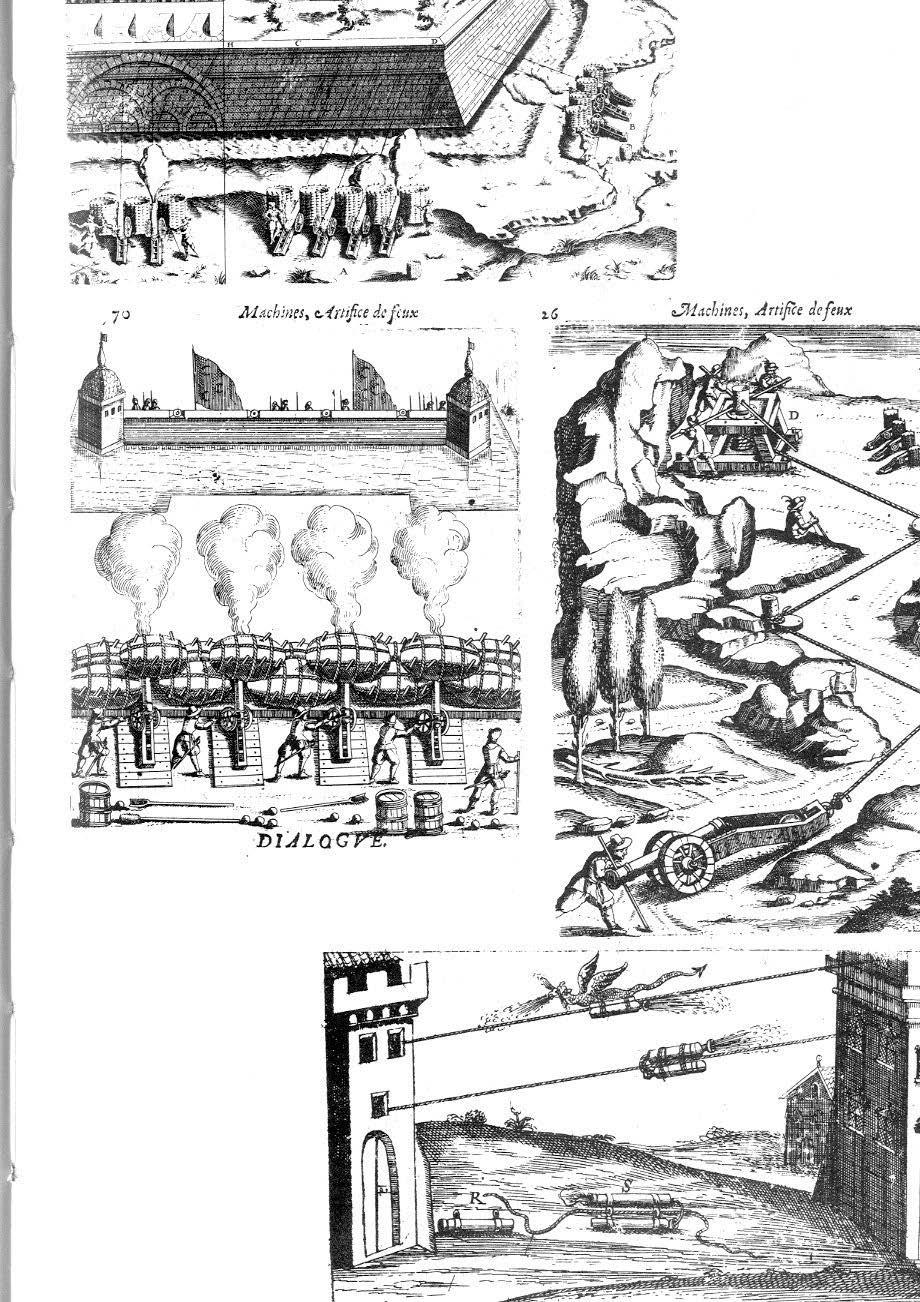
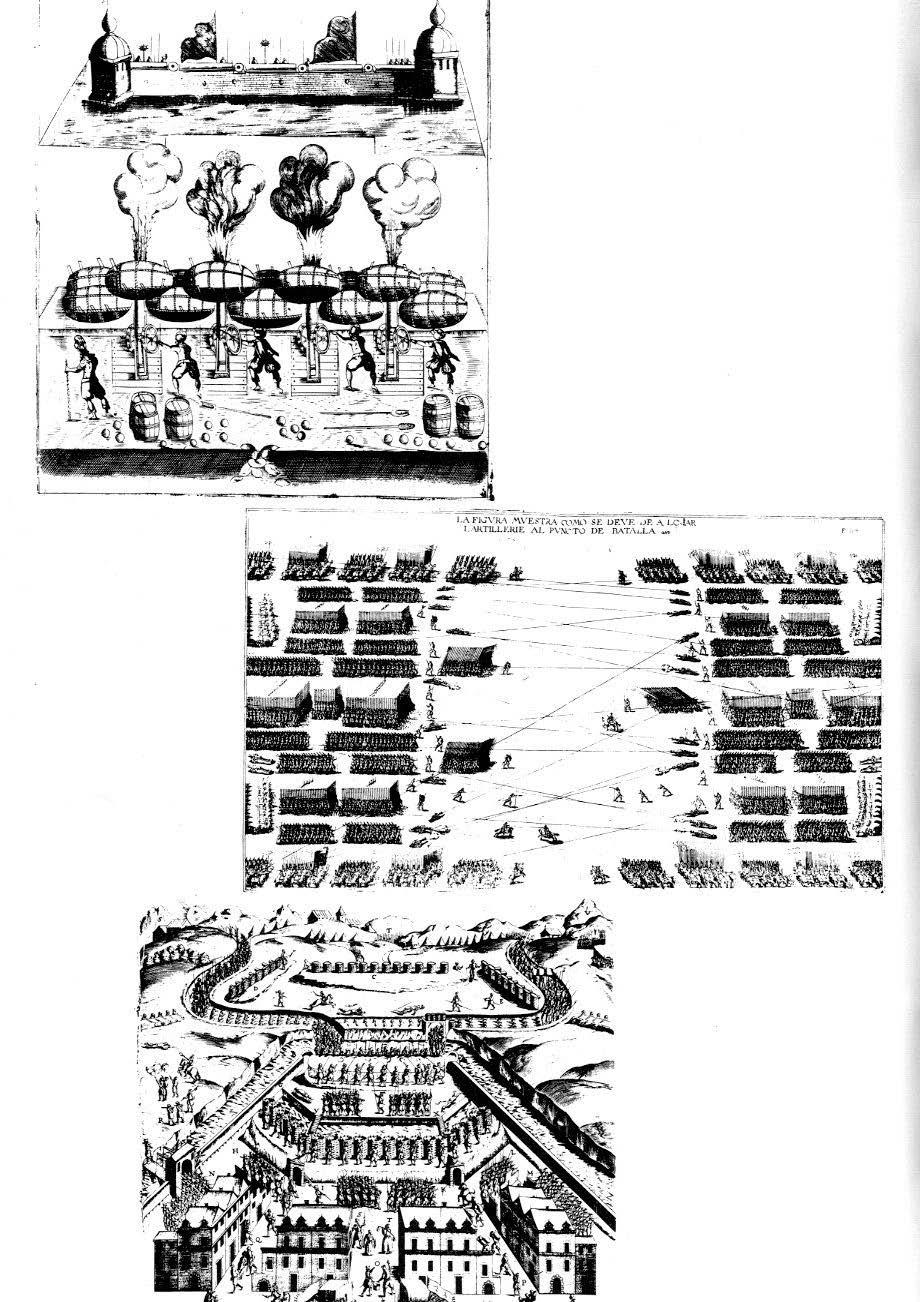
lo e comincia subito a tirare. Dopo si fanno passare tutte le picche che si mettono in battaglia a proporzione che elle passano, et alla fine segue il re sto della moschetteria. E se il nimico è di dietro si cambia il modo, facendo passare la metà della moschetteria mentre che l'altra tira, poi facendo passare l'altra metà, mentre che la già passata tirerà, e, sendo tutta passata, tirerà continuamente sendo ordinata sopra i fianchi delle picche. S'ella è una riviera che bisogni passare con barca, s'aspetta la notte e si fanno passare prima le picche, che iJ nemico non se ne avvegga, e dei moschettieri si fanno passare quelli che non sanno nuotare, ma si fanno tirare gli altri continuamente accioché il nemico non conosca che si passi, poi si passano alla fine ancor questi.
S'egli bisogna forzar una porta di città o passar un pont e di riviera, s'armano le due o tre file di picchieri a prova di moschetto e si fanno passar prima le picche, e se il ponte è molto largo si mettono due fi l e di moschettieri a ciascheduna ala, che si ritireranno dietro tra le file dopo aver tirato .
II. Alcuni, per passare un fiume non avendo ponte, lo hanno derivato, et una parte tiratasi dietro alle spalle e l' altra di poi divenuta più bassa, [fu] con facilità passata.
1. Quando li fiumi sono rapidi, a volere che le fanterie passino più sicuramente si mettano i cavalli più possenti dalla parte di sopra che sostengano l'acqua, et un'altra parte di sotto che soccorra i fanti se alcuno dal fiume nel passare ne fosse vinto, ovvero i cavaglieri pi gliano i fanti sulla groppa dei cavalli quando il fiume non è molto cattivo . E per conoscer i guadi s'ha questa regola: sempre il fiume in quella parte la quale è tra l'acqua che stagna e la corrente, che fa a chi riguarda come una riga, là è meno fondo et è luogo più atto ad esser guadato che altro ve , perché sempre in quel luogo il fiume ha posto più et ha tenuto più in c o lle di quella materia che per il fondo trae seco. E se occorresse che il fiume avesse sfondo il guado, perché i cavalli non affondassero bisognerebbe far dei graticci di legname e metterl i nel fondo dell'acqua e far passarvi sopra i cavalli .
E certo quando si fa tastare per tutto una rivi era, si trovano talvolta come miracolosamente de i guadi dove non c'è memoria d'uomo che mai alcu no v'abbia passato, come quando Banér trovò un guado propinquo a Melnik mostratogli da un mugnaio, che
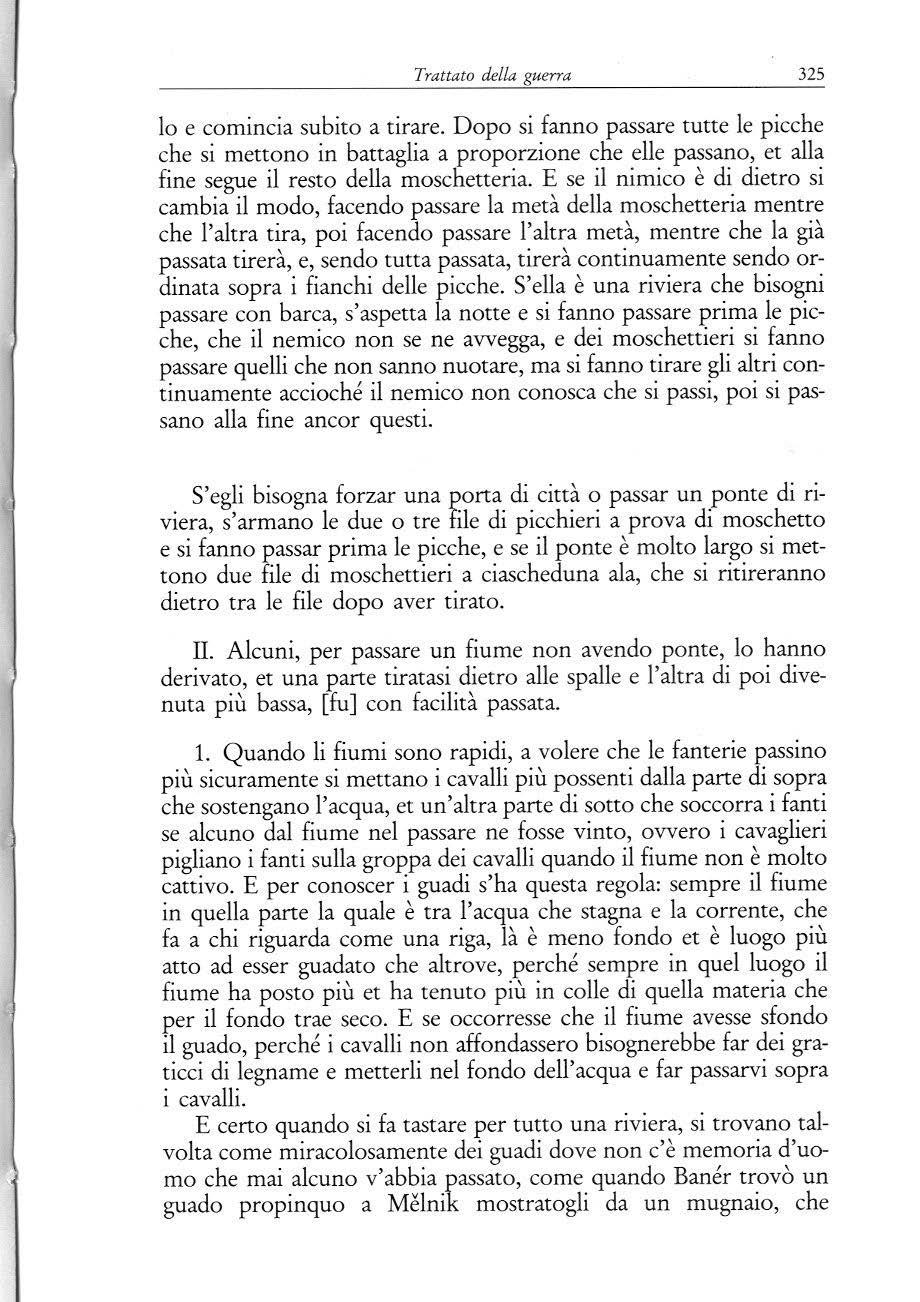
nessuno nell'armata imperiale, né di quei di Praga abitanti nel paese non ne avevano la minima notizia. Sicché l'esperienza ha sempre fatto conosc er e che un'armata potente è difficilmente tenuta in briglia per un fiume che gli si opponga, perché se ella non lo passa al favore di un luogo av antaggioso o dell'artiglieria, ella vi arriva per astuzia, intrattenendo il n emico da una parte e gettando i suoi ponti e facendo i suoi sforzi da un'altra.
2. Cesare, avendo l' esserci to suo alla riva di un fiume et essendogli impedito il passare dal nemico il quale dall'altra parte aveva le sue genti, caminò più giornate lun go il fiume, et il simile faceva il nemico, et avendo fatto Cesare un alloggiamento in un luogo selvoso et atto a nascondere gente, trasse da ogni legione tre coorti e fecele fermare in quello luogo, commandando loro che subito che fosse partito gettassero un ponte, e rifaces sero un pont e che era stato abbattuto ma vi erano restati i travi fondamentali, e lo fortificassero, et egli con l' altre sue genti seguitò il cammino, donde che il nemico, vedendo il numero delle legioni, credendo che non ne fosse rimasta parte adietro, seguì ancor egl i il camminare, ma Cesare quando credette che il ponte fosse fatto se ne tornò indi etro e trovato ogni cosa ad ordine passò il fiume senza difficoltà.
Così il generale Galasso marciò con tutto l'essercito da Malche n come se disperasse di poter passare la Peene, dall'altra parte della quale il Wrangel, Marescial di Campo svedese, aveva le su e genti, [e] volesse gire nella Pomerania o nella Marca e lasciò indietro [illeggib.] con un nerbo di gente, onde il nemico, pensando che non fosse rimasta parte alcuna delle truppe adietro, rallentò la diligenza della guardia, sicché Breda[?] ebb e agio di passare vicino a loro con l'aiuto di un del nemico che era venuto a rendersi, e Galasso, ritornando con l'armata e trovando il passo occupato 186 , passò poi con tutt e le forze, e si loggiò nel Meklemburgo.
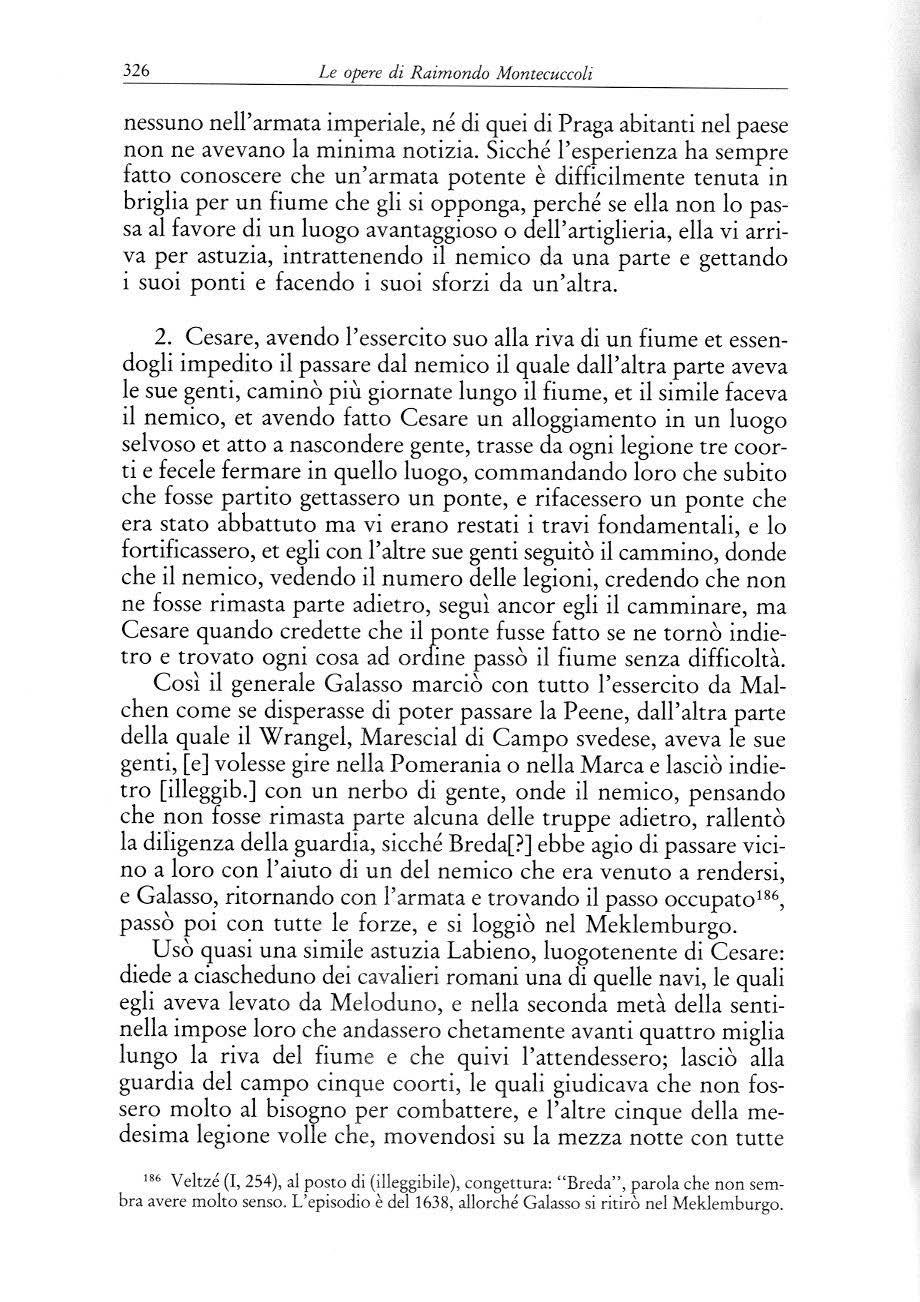
Usò quasi una simile astuzia Labieno, luogotenente di C esare: diede a ciascheduno dei cavalieri romani una di quelle navi, le quali egli aveva levato da Meloduno, e nella seco nda metà della sentinella impose loro che andassero chetamente avanti quattr o miglia lungo la riv a del fium e e che quivi l'attendessero; lasciò alla guardia del campo cinque coorti, le quali giudica va che non fossero molto al bisogno per combattere, e l'altre cinqu e d ella medesima legione volle che, move ndosi su la mezza notte con tutte
186 Veltzé (I, 254), al p osto di (illeggib ile) , congettura: "Breda", parola che non sembra ave re mo lt o senso. L'episodio è d el 1638, all orché Galasso si rit irò ne l Meklemburgo.
le bagaglia, ne andassero contra il corso del fiume, facendo tutta volta grandissimo rumore; fece cercare etiamdio di molte barchette e mandolle verso la medesima parte, con far gran rumore nel batter dei r emi nell'acqua, et egli uscito fuori poco dopo chetissimmamente con tre legioni andò colà dov' egli aveva prima fatto fermare le navi e tutto l'essercito fu passato di là dal fiume con molta prestezza .
3. Alcuni hanno armato un elefante, messovi sopra una torre piena di guer r ieri e mandatolo a passar il primo; poi dietro a quello e sotto la sua coperta hanno passato gli altri soldati.
Oggidì si fanno navi che, dalla parte opposta alla ripa do ve sta il n emi co, hanno parapetti di tav ole alla prova con feritoie. Si tendono anche funi dall'una nell'altra ripa, con le quali aitati, i pedoni passano e co l petto solo sop ravvanzano fuori dall'acqua. Alcuni hanno fatto passare i fanti armati nella parte più profonda dell'acqua, accioché la maggior parte del corpo fosse nascosta sotto al fiume e quello che sopravanzava fosse ricoperto dello scudo. E così anco passando con navi si dispongono gli armati nell' estremità opposta al nemico e gli altri disarmati stanno a ginocchioni al riparo d ei primi, et i cavaglieri dalla poppa tirano per le redini i cavalli nuotanti lungo il battello. Altri hanno gettato grandi arbori tagliati, che con la lungh ezza toccassino l'una e l'altra ripa, poi gettatovi subitamente sopra della terra hanno passato il fiume. Altri hanno preso il tempo di passare le riviere quando elle sono gelate; e leggesi de' Traci che essi non passano i fiumi o i laghi gelati se non all'andar e cornare della vo lpe, avendosi osservato ch e ella , t enendo l'orecchio al ghiaccio, congettura la grossezza di quello. Alessandro, avendo a passare con l' essercito il T igri che arrivando co n l ' onde alla sommità del petto ne portava v ia molti, per resistere alla violenza del fium e ordinò che tutti i soldati s'acchiappassino gli uni agli altri per le mani e constrignessero ins ieme quasi una mol e fortissima di corpi.
E se l'essercito è copioso e s'abbia commodità di farvi più ponti, per l'un o si fa passare la gente di guerra e per l'altro le bagagl ia per guadagnar tempo, e se dopo che s'è passato si vuo l mantenere il pont e, bisogna assicurarlo nell'una e nell'altra part e, secondo l'a rt e della fortificazione e lasciarvi buono e forte presidio.
4. Così chi guarda i l passo d'una riviera, benché faccia minar tutti i ponti, metta presidi et altre trinciere dove so no i guadi , fac-

eia piantare ac ut e palizzate nella ripa et anche sott'acqua, coperte dal fiume, e si metta con l'essercito alla difesa, non può però assicu rarsi che, se nd o il nemico più forte, non venga finalmente per for za o per stratagema in capo del suo dissegno, perché sebbene la natura de' passaggi è ta le che ella è vantaggiosa a chi li guarda, perché i primi che si mettono a passare sono impediti e gli altri aspettano freschi, ordinat i e sc iolti, in ogni modo l'artiglieria oggidì favorisce molto i passaggi, et alle finte non si ha quasi rimedio perché una parte che n e passi se gretamente in qualche luogo assalisce improvvisamente alle spalle quei che guardano il passo e li batte, poi commodamente dà agg io di far ponti per passar tutto l'e sse rcit o, e ciò s'intende dei luoghi dove possano aversi più passaggi in più versi come sopra un fiume, perché dove il passaggio è unico egli è soprattutt o cosa necessarissima di opporsi quivi al nemico acciò non passi, il c he dal H atzfeld fu trascurato nella battaglia di Witt stoc k 187
E per lo contrario, quando un capitano ha a condurre l'esserci to p er luo ghi angusti, scoscesi e difficili deve mandar innanzi alcu n e partite che preoccupino le cime dei monti e le fauci del!' angustie, accioché se il nemico ven isse ad esservi prima non impedisse il passaggio.
III. Quando un'armata ha da marciare per un gran bosco, si deve ordinare qualche Cavalleria che pigli il bosco e marci attraverso di quello accanto alla strada per la quale marcia l' essercito e lo ricopra da tutti due i lati; e quando si riscontrasse nel bosco un piano eguale, come talvolta occorre, allora deve la Cavalleria fermarsi per ass icur are la strada sinché il bagaglio sia passato, dopo il quale elJa segue subit o e l'Infanteria dietro di lei. E quando si viene fuori del bosco e vi è una campagna piana et aperta, devono gli archibugieri fermarsi n ell'uscita di quello finché la Cavalleria h a preso coi suoi squadr oni la campagna, ovvero le al tezze se il luogo è montuoso.
Scrivesi d'alcuni popoli che, antivedendo che il nemico doveva passare per un a gr an selva, segavano una gran parte degli arbori nella parte inferiore in modo però che potessino anche star dritti : e quando videro l'essercito nemico tutto dentro alla selva spinsero abbasso gli arbori estremi del bosco addosso agli altri eh' erano dentro alla selva, i quali venendo a cadere oppressero con la ruina loro tutto l'essercito.

1. Nell'angustie de' passi bisogna marciar cautamente, perché i l nemico si tiene talvolta quieto a bello studio e fa il timido per attirarti nelle strettezze e per opprimerti.
2. Per passar in dispetto del nemico, hanno alcuni commandato segretamente gente dell'armata e fatto fare nel campo i medesimi fuochi accioché il nemico non s'accorgesse che fosse quivi diminuito l'essercito, anzi con iscaramuzie et altre apparenze l'hanno tenuto a bada, poi, tentato all'improvviso con la gente commandata un altro passaggio, o l'hanno guadagnato prima che il nemico se ne sia accorto e gli sono venuti alle spalle avendone dato segnale al campo con fuochi, con fumi e con insegne, ovvero s'egli se n'è accorto e vi è corso per impedirlo, il campo intiero ha fatto impr essione al primo luogo, e, trovatolo voto o debole di diffensori, ha forzato il passaggio .
Altri, avendo trovato una punta d'una roccia quasi inaccessibile che commandava il passaggio, l'hanno presa o intagliando gradi e stalloni nella roccia e salendovi come per una scala, o aitandosi con ferri acuti e graffi attaccati alle mani, alle ginocchia et ai pi edi; e così, essendo a commandamento di quelli che guardavano il passo, li hanno sbigottiti e cacciati e guadagnato il passo. Altri hanno aspettato che faccia gran v ento favorevole, poi messo il fuo co in una selva che era dirimpetto del passo che guardava il nemico, e' l'hanno cacciato col fumo e colle fiamme, poi in tal parte è passato l' essercito. Et altri col favore d'un simil vento hanno sparso nell'aere sabbia o cenere che, ferendo il viso dei nemici, impedendogli le narici et impede ndo loro la respirazione, li hanno forzati ad abbandonar il passaggio . Altri hanno dato all'arme in un luogo, avendovi mandato molti trombetti e tamburi, poi hanno fatto lo sforzo in un altro. Alcuni hanno finto d'alloggiare o di ritirarsi o di separare l' esserc ito o di partire di l à, et in qu es to modo dato suggetto al nemico di rall e ntar e le guardie; poi assalitolo improvvisamente hanno superato il passaggio o l'hanno trovato in luoghi difficili dove il nemico non avea mai pensato, con l'aiuto di qualche paesano o cacciatore .
Annibale, per guadagnare astutamente i passi delle montagn e guardat i dalla gente di Fabio fece pigliare 2000 bo vi e fece attaccar loro a ciasc h edun corno dell e facelle, ovvero dei fasci d i salce e di sarmenti, et ordinò a quelli che n'avevan la carica che la nott e , quando al zarebbe l o r o un segno nell'aere, mettessino il fuoco in questi fasci e cacciassero i bovi all'insù delle coste ve rso i passi e

gl'indritti che i nimici avevano occupati; mentre che ciò si preparava egli dal suo lato ordinò la gente in battaglia, poi, quando la notte fu venuta, la fece marciare a picciol passo . Ora i bovi, tanto che il fuoco che ardeva, quello che essi avevano attaccati alle corne, fu picciolo, camminavano pian piano all'insù dov'erano cacciati; onde i pastori et i bifolchi, che erano sopra le cime delle coste, si maravigliavano molto di vedere così delle fiamme e dei fuochi attaccati alle corna di questi bovi come se fosse stata un'armata che marciava in ordinanza al lume di torchi; ma quando le corna vennero ad essere abbrugiate sino alla radice, e che il sentimento del fuoco fu passato sin alla carne viva, cominciarono i bovi a dibattersi et a scuotere le teste, e ciò facendo si coprirono via più di fuoco gli uni gli altri, né caminarono più piano et in ordine: anzi, per la paura che avevano e per lo dolore che sentivano, cominciarono a correre di qua e di là attraverso le montagne, portando fiamme alle corna et alle code, onde mettevano il fuoco nei boschi e nei cespugli per i quali passavano. Ciò parea ben st rano a vedere e sbigottiva i Romani che guardavano il passo delle montagne, perché credevano che fussino uomini che corressino cos ì di qua e di là con delle torchie in mano, per lo che ne erano sbigottiti e turbati pensando che fussino i nemici che corressino a quel modo contro di loro per circondarli da tutti i lati, talmente che non ardirono fermarsi quivi ai passaggi dov'erano stati ordinati, anzi abbandonando gli stretti si misero a fuggire verso il loro gran camp o; e subito i corridori di Annibale, armati leggermente, s'impossessavano di quei passi in modo che tutto il resto dell'armata ebbe tempo di marciare fin là a suo agio senza timore e senza pericolo.
3. Alcuni, volendo impedir un passo stretto al nemico, né potendo arrivar a tempo ad occuparlo prima di lui, hanno mandato un lor fidato sotto spezie di spia e di fuggitivo che ha avvisato il nemico che essi avevano già occupato i passi. Egli, o credendolo o stando sospeso, ha perso il tempo di marciare et essi l'hanno guadagnato di occupare effettivamente i passaggi.
4 . Se la malagevolezza dei camini non lascia marciar l'armata con la celerità che si vorrebbe per arrivar presto a portar soccorso ad un altro tuo essercito che è alle strette col nemico, bisogna mandar innanzi tre o quattro mila cavalli senza bagaglia, spediti e leggieri, accioché, se qualche necessità stringesse prima del tuo arrivo, possano render rinforzo e servizi.
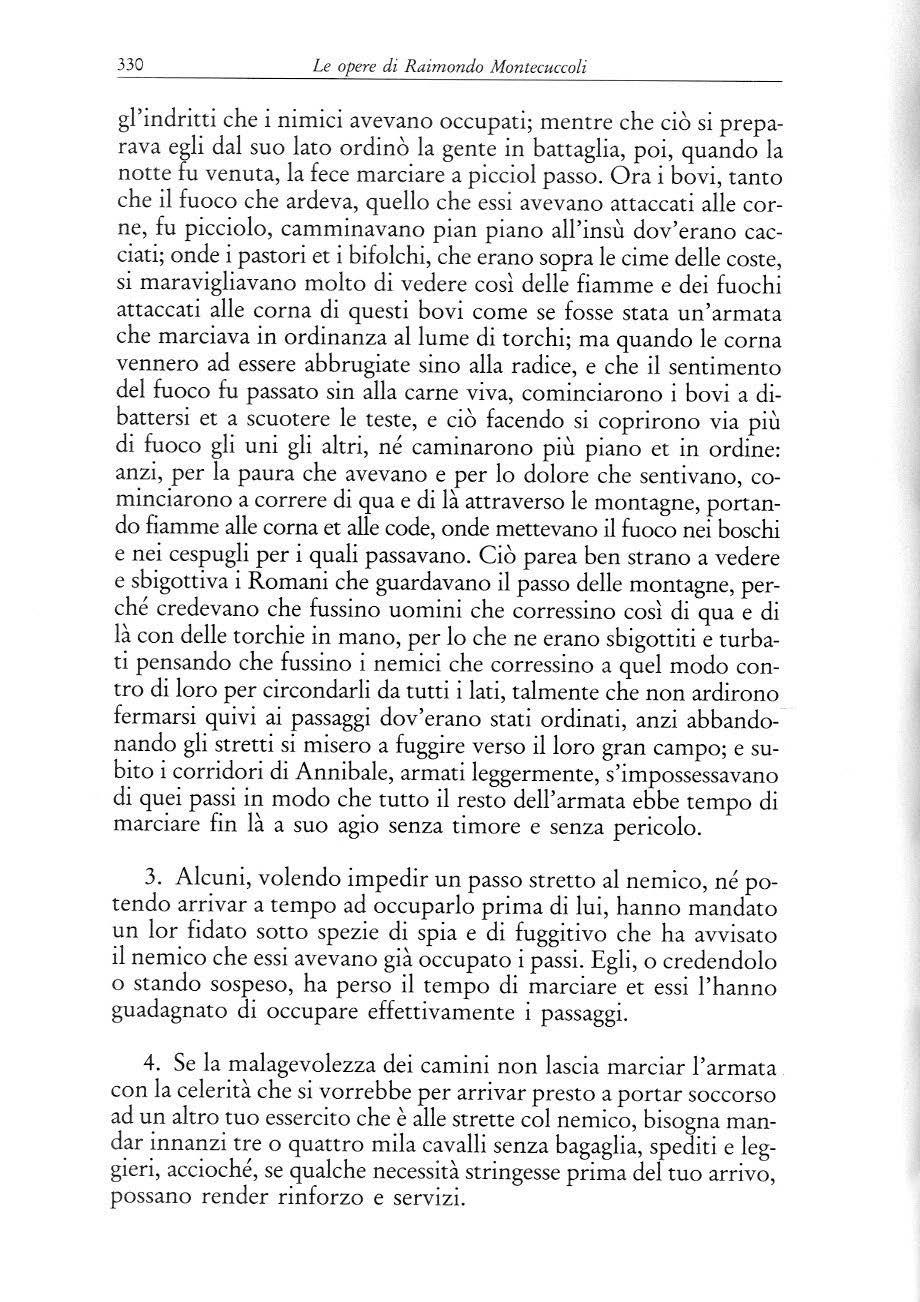
5. Nel marciare, bisogna che i sergenti et i caporali osservino che fra l'Infanteria vi siano sempre miccie accese, almeno una per ciascuna fila, e marciando di nottetempo si deve osservar silenzio e servirsi più degli orecchi che degli occhi e soprattutto conservar gli ordini, perché di notte egli è più facile il confondersi che di giorno et il remediarvi è più difficile e, volendo marciare segretamente, bisogna far alto il giorno con la truppa in qualche fondo cope:1:0 di bosco e marciar la notte per strade non battute né cogmte.
IV. Per marciar propinquo al nemico e non esser forzato a battaglia bisogna farlo seguire con un nerbo di Cavalleria tanto forte quanto si stima nec essario per esser sicuro come e dove egli pigli la marcia; e quando egli è in gita bisogna sempre tenersi da lontano dietro di lui e spedirgli all'intorno più e più truppe di corridori i quali possano sempre avvisare lo stato del nemico.
1. Sintantoché il nemico marcia a questo modo, chi conduce la Cavalleria commandata deve diligentemente osservare il campo di quello, come e dove egli alloggi, et avvisarne il generale e sempre seguitarlo a quel modo; e così l'inimico stesso gli mostrerà di luogo in luogo dove ei debbia fermarsi: e' deve però frattanto star molto all'erta che sempre resti in vantaggio e deve regolarsi secondo le relazioni che frequentemente egli ha del nemico, accioché non sia ingannato e che il nemico, dopo avere fatto lungo tempo vista di andarsene, non si volti ad un tratto all'impro vv iso e con disvantaggio non lo forzi in battaglia, dal che si deve ben guardare et usar diligenza che quando il nemico si rivolta con impazienza lo trovi sempre in vantaggio.

2. Così può il generale accompagnarsi sempre con l'essercito a una mezza o a un quarto di lega, secondo che si trova la commodità, dietro al nemico per ritenerlo in briglia e che non ardisca di allargarsi troppo, ma sia sempre da lui tenuto in paura e tanto più quando gli ha sempre addosso un nerbo di Cavalleria.
3. Il conte Galasso aveva sempre questo costume: di tener e continuamente una grossa partita innanzi all'armata, la quale ricopriva l'essercito et osservava gli andamenti del nemico .
Le ritirate in faccia del nemico sono piene di pericoli, e sì come l'intraprenderle senza necessità mostra una va na presunzione del capitano, così il saperle fare bene quando il bisogno richied e è il capo d'opra e la pietra di paragone d'un buon generale 188 •
Si parla quando si vuol ritirarsi senza venir a battaglia e che si ha da fare con un nemico che è buon soldat0 e risoluto a dar un attacco, principalmente se la ritirata è lunga e la campagna larga et aperta, perché in una breve distanza et in un sito stretto nel quale si può forse marciare con i lati coperti et intrattenere il nemico d'un passaggio all'altro, può bene talvolta succedere: ma dove la strada è lunga e la campagna aperta egli è cosa difficilissima potersi ritirare in buon ordine senza essere costretto a combattere, perché il voltare le spalle dinnanzi al nemico ha questo in sé, che allora il soldato lascia ogni p e nsiero di combattere e perde la sua forza; e la cosa in se stessa è di tal condizione che quand'anche egli volesse non può nell'istesso tempo difendersi e ritirarsi tutt'a un tratto, e quando il soldato sa ch'ei si deve ritirare non vorrà mai restar l'ultimo, in modo che non si può tener ordine nessuno, particolarmente quando s'ha da passare un ponte o qualche luogo stretto e pericoloso nel quale uno impedisce l'altro, e mischiandosi tra di loro s'affollano e causano confusione tale che ogni ruina ne procede.
1. Per render sicura la ritirata e per vietar il disordine, bisogna farla di buon'ora e sì per tempo che non si sia ubbligato a combattere. E però se si è in vista del nemico, si può fare segretamente di notte eh' egli non se ne avvegga; né però de ve un capitano stimar d'offender e il s uo onore nel ritirarsi così alla sorda, perché la presunzione e l'ignoranza sono due cattivi consiglieri alla guerra, e spesse volte, per fermarsi e mant ene re la riputazione in apparenza, ella si perde in effetto, ch'è un punto al quale devono pensare qualch e vo lta i giovani et i vecchi soldati.
E, sebbene la notte non lascia d'avere le sue difficultà, p e rché le tenebre di loro natura sbigottiscono, fanno parer il pericolo maggiore di quello eh' egli è e levano ai soldati la vergogna et il rossore di fuggire, sì che queste ritirate notturne imprimono paura a
188 E in tale diffici li ssima arte, g iova ricordare, M. s i sarebbe rivelato un maest ro : basti q ui ricordare come egli sa lv ò l'Eserci to Impe ri ale dopo la disfatta di Zusmarshau· sen, i l 17 maggio del 1648, guadagn andos i le lodi del suo grande avversar io, Turenne.
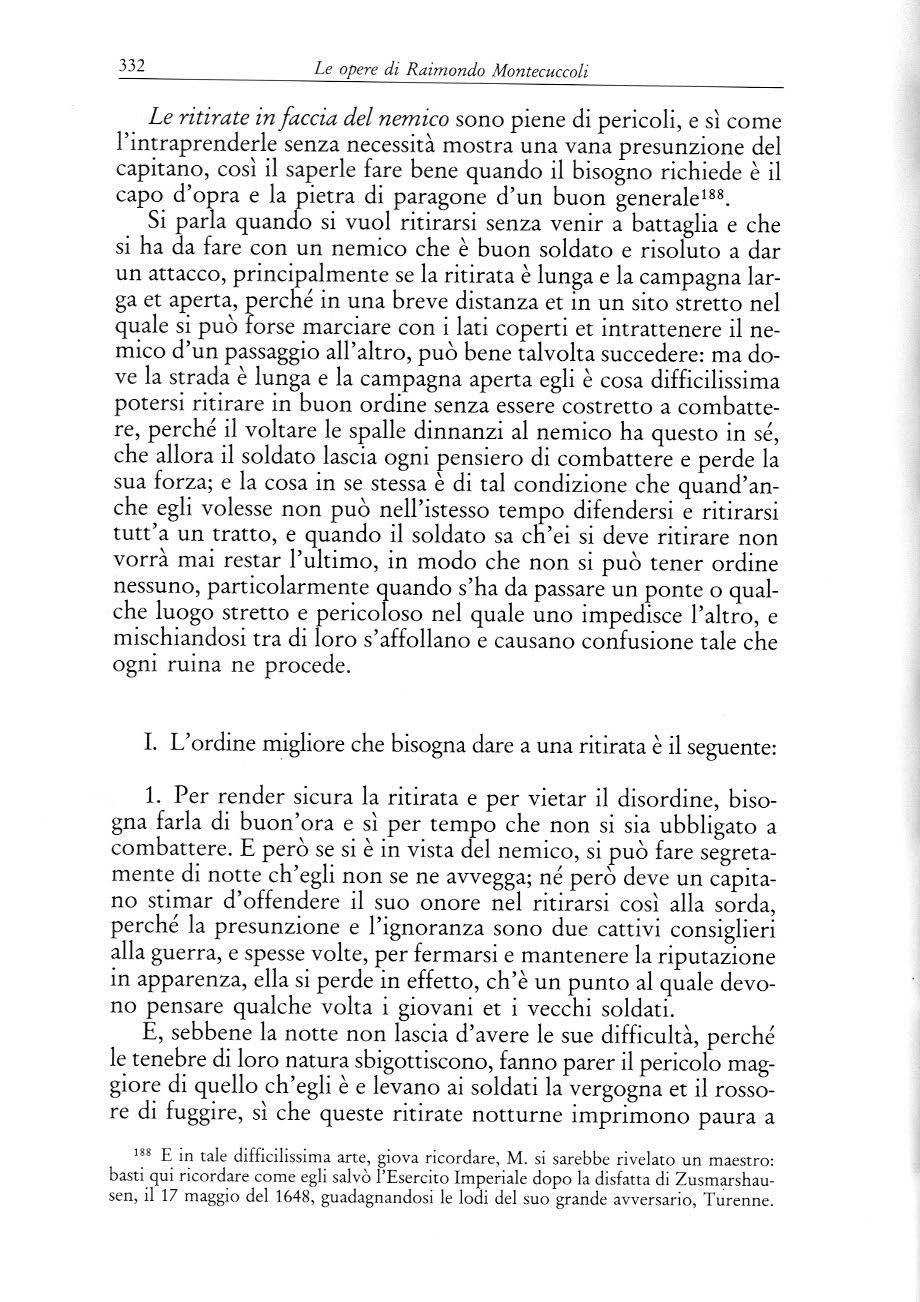
quelli che le fanno, diminuiscono la riputazione e danno audacia ai nemici, in ogni modo non può il nemico accorgersi sì presto quando tu cominci a marciare, sì che hai tempo di guadagnar qualche montagna, passaggio o luogo sicuro prima ch' ei se ne avvegga e cominci a seguirti: oltre che un saggio capitano non s'imponga molto a seguir un'armata di notte, perché egli è difficile il guardar s i di non cadere in qualche imboscata . Così ritirossi di notte il Pappenheim dopo la battag lia di Leipzig. Così Hatzfeld dopo la battaglia di Wittstock, così la Valetta dopo aver rispint o il giovane Colloredo 18 9
2. Prima di levar il camp o per ritirarsi si mandano ad occupare e fortificare i passi ch e sono sulla strada che si vuole marciare, come s'è d etto di sopra nel marciare per l uoghi angusti, e se si ha da marciare per un bosco si fanno tagliare et abbatter gli alberi per renderlo malagevole, come fece Banér quando si ritirò da Torgau, perché guadagnandolo prima chi si ritira, se il nemico lo seguita, intrattenuto dalla malagevo lezza del luogo et anche da qualche soldati che lo difenderanno, tro v a doppio ostacolo e perde tanto tempo che quello che si ritira ha già tanto vantaggio di strada ch'avrà già guadagnato un altro passo, perché chi si ritira non trova altra difficoltà che quella del passo, e, p erché si suppone che la sua armata sia men fort e che quella del n emico, lo pass a in più breve tempo; ma chi perseguita non solo trova la difficultà del passo, ma anche quella dei difensori che vi sono lasciati e m ette più tempo perché ha da passare più gente .
E se il passo è tale che il nemico possa venir a tagliarl o dai lati, è ben v ero che ne caccerà presto i defensori, i quali forse anche non attaccherà di front e, o se gli attacca sarà forse per tenerli a bada fintantoché le truppe che nel medesimo tempo egli avrà mandato a passar su i lati ve ngono loro alle spalle , o col fare sembiante
.1 39 L ouis de Nogaret, D uca de la Valette, C ar din al e ( 159 3-1639 ), comandav a le fo rze frances i co nt ro qu elle Imper iali c he ne l 1635 aveva n o invaso la Lo r ena, gu id at e da G alasso I n settemb re egli, arr iva ndo sul camp o do po ch e i fran ces i avevano r ipiegat o in direzio ne d i Met z, r esp inse le fo rze d i C avaller ia Imper ia le com anda te d a Giro la m o di C olloredo, getta tesi scr iteri at am e nt e a ll ' i nsegui mento do p o il cader d ella n o tte Gir olamo d i Co ll o r edo ( 158 3- 163 8) non è da confon dersi co n il p iù g iov an e (e assai p iù ab i le) fratello, il F e ld marescia ll o conte R o d o lfo di C olloredo (1 58 5-1 657) . Ent r amb i app artenevano ad un a ill ustre famiglia ital ia na (Cfr .: Gsterreichisches Militarlexikon, W ien , 18 5 1, p ag . 73 2 sg.) . A proposito de ll a r it ir ata di Hatzfeld d o p o la sco nfitta d i W ittstoc k , va detto che essa fu co nd o t t a sotto la co p ert ur a e la protezione di q uatt ro R eggi ment i d i C avalleri a comandat i da M ., che in questa o cc asion e compì u n o d ei suoi c apo la vo r i, sal van d o il battuto Eser cito Imperiale dalla fi nal e catast r ofe .

d i ven irv i li sb igottisc a n o e li fa cc ia no a b band o n ar il p os to, com e gli Svedesi mentr e c he P appenh eim si ritirava dopo la battag lia di Leip z ig et av e va las ciato Hat zfe ld a gu a rdar un p asso, passaron o altro ve e v enn ero a cari carlo alle spalle e lo fece ro prigioni e ro; nel medesimo mod o Bané r vinse Wildb e rg, ch e s ' e ra m esso ad un p asso a du e legh e da Pe rl e b e r g 190 •
M a se il p asso è cale ch e il nemi co abbi a nec ess ariam e nte a p assar p e r di quivi p e r se guir e, sarà fac il cosa che , la sciand ov i un ne rb o d i gent e alla d ifes a, so ste n ga n o tanto il n e mi co c h e tu ab b ia guadagnato un gran tratt o di pa ese e poi essi an cora si ritirino ultim a ment e se nza d anno , p e rch é p ar e nd o forse c he il ne mi co trascu rerà di segu irl i appunt o nel m o me nt o che ess i p art ano, non se n'accor ge ndo e' perderà temp o, o se ben li se gu e, n ell'ist ess o m ome nt o ave ndo ess i sp az io ap ert o di a ndar di gran fr o nt e e dovend o il n e mi co fil a re p e r passar e, guad ag neranno tempo in o gni mod o ; ma d e vono però esse r ge nt e a cava llo, ch e possa no ritira rsi sì p resto qu a nto pr es to s i p u ò il ne mico segu irl i, co m e so no i Dragoni e Cav alleria leg giera, o anch e qualche cora zz a ben montata. E p erc hé il Bané r t e nn e q uesto mod o di ritir ar s i da T orgau i n tutt i i passi, non fu m ai possib ile ch e il co nte di Puchh ei m, commandaco a se guitarlo , potess e mai giunger e quei ch e facev a no la ri t irata, p e rch é faceva n o testa ai pass i fi n c h é avevan o dat o spazio all a lor o arm at a di a va nzarsi, p o i s i ritiravano, e prima c he il Pu c hheim ave sse fatto filar la sua ge n te e rannodat ala per di là insie me , era n o già lo nt a n i, o aveva n r ip r es o qualch e alt ro pass o a vantaggio so 191 .
E quand o an c h e il passo fu sse del primo ge n e re , ci oè ch e p ot esse ess er t ag liat o dai la t i, in o gn i mo d o non bisogn a trasc ura r e di la sciarvi qualch e truppa alla difesa, p e r c hé sendo tut t o ciò fatto a di seg no di far guad agn ar t e mp o all'arm ata ch e s i r i tir a e di fa rlo
190 Ph ilip p vo n W i ld be rg, co lo n ne ll o impe r ial e. L'e pi so d io avve nn e il 24 settembre 1636. Entrambi gli episodi citati pongono in guardia contro il feticismo della posizione naturalmente fone.
191 Ha n s C hr is t oph Reichsgraf vo n P uch h e im (1605- 165 7), di ven n e Feld marescia ll o imperiale e collaborato re d i M nella di ffi ci lissima campagna fi nale della Guerra dei T re nt'anni. Tra i due tuttavia non corse buon sangue: M. stimava assai poco Puchheim, al quale più tardi avrebbe rinfacciato una p esante responsab i lità nella d isfatta subita da ll e fo r ze imper ia li de ll ' Arcid uca LeoP.oldo Guglie lmo e di O ttav io Pi ccol o m in i il 2 novembre 1642 nella seconda b attaglia di Breitenfeld, ad o p era di Lennart Torstensson . {Cfr.: PETER BRoucEK, Der Scbwedenfeldzug nach Ni-ederosw-reich, 1645 -1646, Wien, 1967; nonché: MA TIHIAS K ocH, Geschichte des Deutsches R eiches unter der R egierrmg Ferdinand des Dritten, W ie n , 1865, sg., 2 vol umi , vo i. r, pag. 370 sgg ) Co me s i vede, già ora il giudizio di M. su Puchheim è negativo .

perdere a quella che perseguita, non c'è dubbio che se il nemico vuol forzar il passo direttamente perde tempo nell'espugnazione, e se lo vuole tagliare andando dai lati vi perde tempo nel girare, perché la li nea obliqua è più lunga che la retta, et in questo è incolpato Marazzino, che, volendosi ritirare a Chemnitz per non essere attaccato dal Banér, non oppose gente alcuna ai passaggi, ch'eran dei molti, il che avria dato spazio all'armata di guadagnar i boschi o le montagne. E se bene si corre gran rischio in tal caso di perdere gli ultimi che fanno la ritirata, in ogni modo questo danno è ricompensato con l'utilità pubblica dell'esercito intiero 192 •
3. Si manda innanzi il bagaglio con gente sufficiente sul cominciar della notte, accioché non sia d ' imbarazzo fra la soldatesca, perché, oltre al tempo ch'egli fa perdere, nel marciare difficilmente si può diffondere e se, astretto da necessità, si vuole pigliar consiglio d'abbandonarlo in quel punto, i soldati perdono la speranza et ai nemici accresce l'ardire al combattere, parendo a loro che ciò non sia fatto se non per sommo timore e per disperazione, oltre che molti abbandonano !'insegne per affrettarsi a gire a ripigliar dal bagaglio le cose più care, et i bagaglioni riempiono di gridi e di pianto ogni cosa . Se il nemico è saggio, non si darà per questo a sbandarsi intorno alle spoglie, ma ordinarà che nessuno parta dal suo posto, ché la preda è già loro , e che ad essi si riserba tutto ciò che gli altri lasciano adietro, e però stimino che ogni cosa è posta nella vittoria.
Né basta solo mandarlo innanzi, ma bisogna anche rinforzarlo e ridurlo nella minore quantità che sia possibile, e se il paese è montuoso si deve caricare sulle some l'artiglieria grossa e si deve lasciare nelle piazze circonvicine, se vi se n'ha, e l'Infanteria si deve mettere a cavallo, pigliando tutti quelli che si J?OSsono avere dal paese. Quando Banér ebbe dissegno di ritirarsi da T orgau, alcuni giorni prima tutti gli ufficiali facevano fare delle some et abbruggiavano i carri, et egli montò una gran parte dell'Infanteria; e quando la V aletta fece la ritirata da W orms a M etz, lasciò dietro due grossi pezzi di cann o n e 19 3
Et in tal caso, quando non s i possino condurre, o si giettano n elle riviere o nei pozzi o nei mara zzi o s'interrano, accioché il
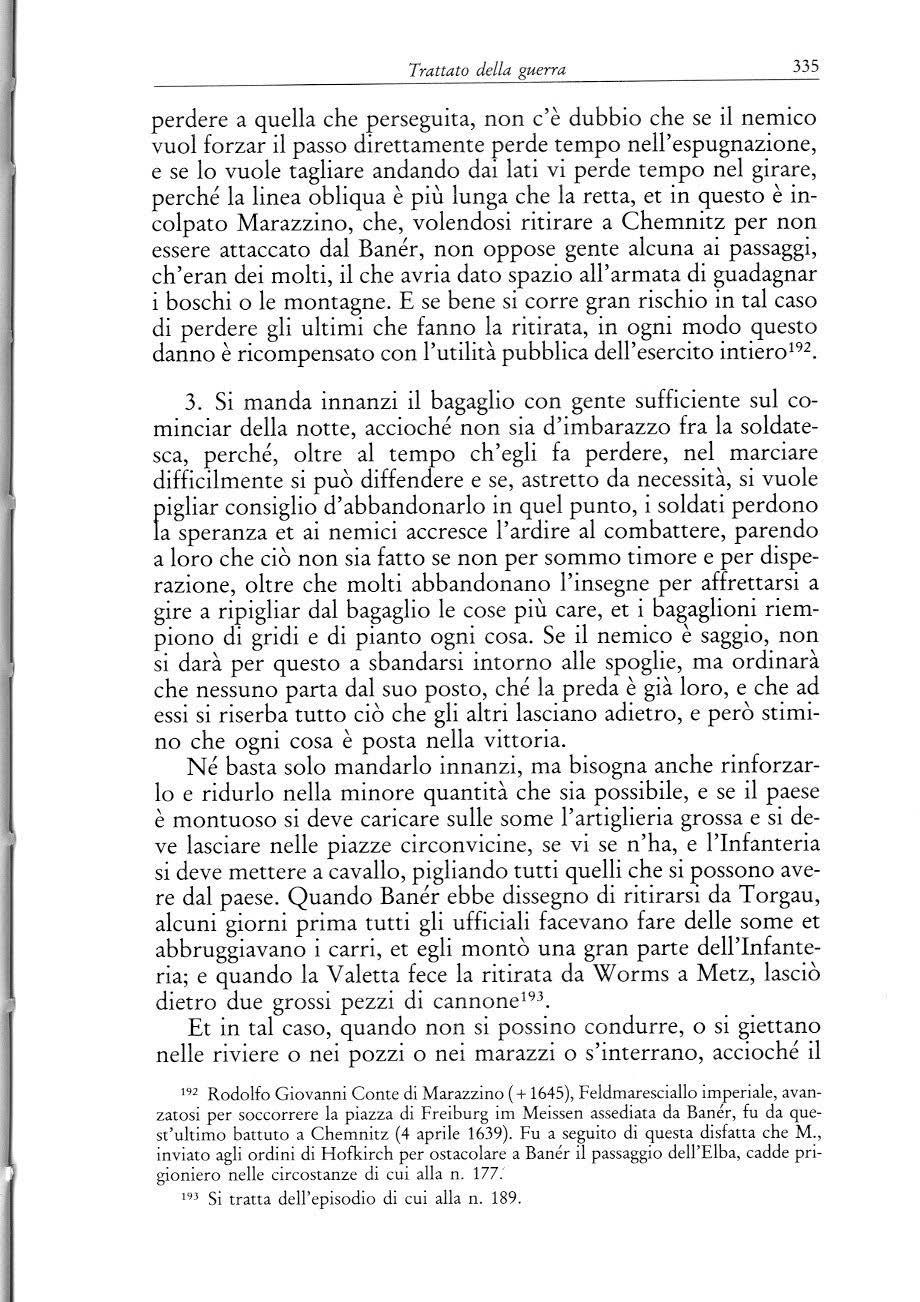
19 2 Ro d o lfo Gio vanni C onte d i M arazzino ( + 1645), Feldmar esci allo imperiale , av anz aco si p er soccorrer e la piazza di F rei b urg im Meissen asse diata da Banér, fu da qu est 'ulti m o b att uto a C h e mni tz (4 a p r ile 1639). Fu a se gu ito di q ues ta disfatta che M., inviato a gli ordini d i H o fkirch p er o stacol are a Ban ér il passaggio dell ' Elb a, cadd e pr igio niero n elle ci rc o stanze d i c ui all a n 177.'
193 Si t r atta de ll'e piso dio d i cui alla n. 189.
nemico non li trov i, o vero si fanno scoppiare caricandoli con soverchia polve, o mettendo qualche cosa vacua tra la polve e la palla, ovvero si riscaldano con gran fuoco e poi a gran colpi di. martello si fanno in pezzi, i quai pezzi si ripartiscono su diversi carri per non lasciarli adietro e poterli rifondere, sì come ha fatto u ltimamente Banér ritirandosi da Cham 194 ; ovvero, se non si può far altro, si inchiodano e si guastano, accioché il nemico non possa servirsene, e così s' abbruggiano le lafette, i carri, le proviande e le municioni che si è costretto a lasciar adietro.
Ovvero si fa marciare il bagaglio per un cammino e l'essercito per un altro, ma bisogna farlo sì occultamente che il nemico non lo presenta, o inviarlo sì per tempo che non lo possa raggiungere, o mandarlo per qualche paese neutro nel qua le il nemico non ardirebbe attaccarlo, come fece il Banér che, ritirandosi da T orgau, lo mandò per la Polonia.
4. Su la mezanotte si manda innanzi l'Infanteria e qualche Cavalleria che l'accompagni, poi alla punta del giorno si parte con la Cavalleria che è rimasta e co' Dragoni, e con questa gente si fa la ritirata, la quale si fa meglio con una parte dell'armata che con tutta l'armata intiera, perché come s'è già detto le pocche truppe passano più presto che le molte se si riscontrano passi, et ogni poco che la campagna sia aperta le pocche truppe trovano facilmente luoghi capaci di riceverle schierate insieme e marciano del pari do ve molte difficilmente rincontrano campagna sì spaziosa, e però, avendo a fare più fronti et a marciare l' une dopo l'altre, mettono più tempo framezzo, e le pocche posson essere tutte a cavallo, perché si pigliano tutti i Dragon i che rimanendo adietro o fa perder il campo, o tutta la retroguardia che le vuol aspettare.
Questa retroguardia di Cavalleria rinforzata da fanti, cioè da Dragoni, e che dev'esser composta delle truppe migliori e meglio montate accioché non si sbigotiscano del nemico ma quando è tempo carichino vigorosamente, poi marcino di nuovo con celerità, sbrigata dall'impedimento e dalla parte più grave dell'armata, può, se vuole, per mostrar fierezza e animosità dar il segno della marcia con qualch e tiro di cannone, come fece il Banér partendo da Torgau, o se non si fida di resister a chi perseguiterebbe, può andarsene chetamente.
Tutto lo scopo di chi si ritira è d'accelerar il viaggio e non lasciarsi intrattenere dal nemico il quale ordinariamente manda la cavalleria alla coda che t'intrattenga sintanto che egli sopraggiun-

ga co n l'Infanteria e colla part e più grande dell'armata e ti costringa a fermarti e a dar battaglia contro voglia, come provò Galasso di fare. con la Valetta, facendolo attaccar in coda due ·volte dal Colloredo e dal Rittberg195 , e come si usa di far sempre, perché la Cavalleria che perseguita può facilmente ritardar un'armata che si ritira, per ragione che chi perseguita va sempre innanzi in linea retta; ma chi si ritira, quando scuopre il nemico che gli viene alle spa ll e, per potersi diffondere è ubbligato a vo ltar faccia, e questo voltar faccia non solo l'intrattiene dall'andar innanzi in lin ea r etta , ma anche fa tornar adietro in linea circo lare, che è la più l unga di tutte le oblique; e dopo essere tornato adietro, se v uole rimettersi su la marcia, bisogna di nuovo che girando faccia un'altra linea obliqua per venir su la retta, il che cagiona perdita grande di tempo e tanto maggiore quanto più grossi sono gli squadroni che devono girare o qu anti più sono in numero, perché per mettersi in battaglia per ricever il nemico l'uno aspetta il girar dell'altro finché son tutti insieme voltati e questo aspettar fa pur perder tempo, come se un squadron e con A , che farà per essempio un fronte di 20 passi e l'avrà volto verso la ritirata , vorrà volgerlo verso il nemico in B e farà il caracollo alla mano manca sopra il centro C con la più grande strettezza che possa farlo, ve rrà a ca-

minare per lo meno 60 passi, e quivi, se va diritto per azzuffarsi contro al nemico, torna indietro quello di più. Poi, quando vuol tornare a voltarsi per rimettersi sulla linea retta delle ritirata, bisogna che faccia nuovamente 60 passi di caracollo, che vengon ad esser 120 passi ch'egli ha perso di strada e che l'inimico ha guadagnato; senza contare che il caracollo non si può fare sì stretto, che la fronte d'un squadron grosso ha più di 20 passi e che più squadroni mettono più tempo a girare. Sì che in 7 od 8 volte che i l nemico, presentandosi dietro a tal squadrone, lo stringa a voltar faccia, gli avrà già fatto perdere da 1000 passi di strada, né può essere che col tempo non lo raggiunga col gr osso dell'armata e lo costringa a combattere o a fuggire in disordine (fig. 5) .
Un'altra ragione che fa perdere tempo a chi si r it ir a è che chi perseguita va di gran passo o di trotto e talora di galoppo, perché ogni celerità è imputata a voglia d'azzuffarsi e desta i spiriti e sveglia il coraggio nei soldati, ma chi si ritira non suol andare se non di passo, perché il galoppo sarebbe interpretato a voglia di fuggire e farebbe perdere il coraggio ai soldati.
5. Or il far una retroguardia che marci spiccata dal resto del1' armata, che va innanzi come s'è detto, è buono rimedio per non perdere il tempo della ritirata, perché, quando anche il nemico si mostra di dietro, questa retroguardia sola è quella che volge il viso al nemico se bisogna, e lo carica e lo sostiene, sì che il co rpo dell'armata ha commodità di andare sempre innanzi in linea retta, e quel vantaggio di strada che egli si è preso da principio lo ha sempre conservato, perché non ha occasione nissuna che glie lo faccia perd ere, anzi l'accresce sempre più, perché si suppone che sia più leggiero e sgravato et abbia minor numero di gente che l'armata del nemico.
Quanto alla retroguardia, ella deve esser ordinata con qualche proporzione e risguardo della gente del nemico che si crede; deve essere commandata innanzi per ritardarla e per r i mediar al ritardamento s'hanno questi rimedi, di non girare né voltarsi adietro se non astretto da necessità, perché se ogni volta che si scuopre il nemico da lontano le truppe che fanno la ritirata si voltano, che cosa altra è questa se non volere a bello studio perdere tempo, ch'è contro allo scopo di chi si ritira, e volerlo dare al nemico di raggiungerti, ch'è il suo intento? Perché se il nemico si accorge che tu pigli ombra dal vede rlo, non si avvicinerà mai tanto che tu possa venir alle mani, ma aspetterà d'ingrossare tanto che ti sia di gran

lunga superiore, perché il suo disegno è di fermarti, né pretende altro che di intrattenerti, e tu ti fermi di per te solo per la sola gelosia di vederl o . Quando il Banér ruppe il Marazzino, e che s'avanzò colla Cavalleria pensando di voler intrattener tanto con essa che l'Infanteria potesse arrivare, vide che le truppe di Marazzino si voltavano ogni poco e si mettevano in battaglia, e giudicò subito che non avevano potuto ritirarsi senza combattere o fuggire perché perdevano il tempo, il che successe appunto com'egli avea predetto 196 • Un altro rimedio sarebbe di aver i soldati disciplinati a girare ciascun di per sé nel suo luogo, giustamente com'è l'essercizio dei fanti; perché i soldati non cambino di piazza, si fa in un subito né si perde tempo né strada, e si potrebbe aspettare che il nemico fosse vicinissimo, il che non si può far coi caracolli, perché, richiedendo essi spazio, bisogna cominciarli tanto tempo innanzi che si possa essere piantato prima che il nemico sia addosso, n e l che si perd e assai tempo come s'è detto; ma girando ciascun cavagliere di p e r sé , s'aspetta che il nemico sia molto vicino, poi voltandosi sopra di lui si carica nel medesimo tempo, e subito caricato si rivolta e s'avanza strada, come fecero i Francesi, che, vistosi Rittberg che li perseguitava molto vicino alle spalle, si ri vo lsero ad un tratto, e senza metter tempo in mezzo lo caricorno e ruppero e subito ripr eser il loro cammino 197 • N é bisogna far girare più truppe di quello che è necessario, ma lasciar sempre avanzar le altre, il cui v oltar faccia non fa di bisogno perché o rdinariam ente quei che perseguitano in sì gran fretta e di galoppo vengono disuniti e sono per lo più volontari e gente che non tien ordine né corpo, et un nerbo di 15 o 20 cavallieri uniti insieme che si rivolti sopra di loro li ricaccia subito, né per questo è necessario far perdere tempo all'altre truppe, errore troppo ev identemente commesso dal Hofkirch, che, vegge ndo assaliti i Croati da gente sbandata che col far volgere il viso a una truppa sola potevano essere rispinti, non solo fece fermare i reggimenti della retroguardia, ma fece anche ritornare tutte le truppe che avevano più di mezz' o ra d'av anzo di strada né potevano più esser giunte dal nemico , sì che, perdendo il tempo di ritirarsi, furono miseramente disfatte 19 8 •

196 Ne ll a r it irat a occo r re dunque evitare l'agganciamento.
197 Alla battaglia di Chemnitz, d i c ui alla n. 192
198 Cfr. n. 189
Un altro rimedio è d'affrettar il passo se si vede d'esser perseguitato, perché se il nemico ti segue di trotto e che tu vogli riti_:rarti di passo, certa cosa è ch'egli voglia sforzarsi, verrà s1 disord inato e disunito che non accostandosi tu non ne pigli gelosia alcuna ne lass i ritardarti, ma vai avanzando tua strada, et accostandosi, puoi con p oche truppe che si rivoltino caricarlo su b ito e r omper lo e subito rimetterti a m ar ciar e. E tanta osservazione si deve fare in questo punto di non perdere tempo a volta r si mal a proposito, ma solo nel momento di caricar il nemico e non prima, che Jean de Werth ha in usanza, dopo aver battuto un quartiero199, di ritirarsi subito alla sfilata senza voltars i mai adietro per accidente che sia e senza lasciar alcuna retroguardia, il che però no n è intieramente imitabile perché, sebbene quando le truppe del nemico vogliono perseguitare ordi n ate et unite non possono più raggiungere, in ogni modo la retroguardia è fatta solo contro a certi arditi che sciolti e sbandati vengono a tutta corsa per attrappar qualche cosa, i quali rincontrando il minimo nodo di cavalli uniti insieme, ritengono briglia e lasciano di perseguitare, e senza ques t o intoppo metterebbero più terrore di quello che convenga alle loro debili forze.

E nell ' affrettar il passo bisogna vedere di t en er le truppe ben serrate insieme , che non si d isord inino e che guardino la distanza ordinata fra loro accioché non ne nasca confusione, e sapendo i soldati che l'intento non è di fuggire ma di rivoltarsi subito che l'inimico si approssimi, non perderanno il cuore, et acciocché anche il nemico non possa veder sì bene che tu marci con tanta fretta e di là pigli ardire, puoi raddoppiare il passo solo nei fondi dove non può vedere e ne ll 'a ltezza andar più adagio; e se bisogna salire qualche montag n a, il sito naturale facilmente diffende gli ultimi dal pericolo, perché quelli ch e sono saliti i primi, e possono esser Dragoni, stando in alto tirano contro gli avversari e possono esser addestrati a tirare con giustezza a cavallo, e coprono i suoi, et anche solo col mostrare il viso fanno tener briglia al nemico ch e non è forse tutto assieme .
E se il sit o è piano, si marcia sempre de l pari in battaglia, accioché in caso di necessità possano voltarsi le truppe tutte a un tratto in un tempo istesso, né s'abbiano a scostar punto per soccorrer l'ultime, e se vi sono dei passi stretti, si manda innanzi ad occuparli come s'è detto sopra, e se il nemico premesse tanto che acchiappasse di qua del passo, sc h ierandosi a lungo del passo si sarebbe in
199 Nuov a, dura critica a l contegno di Hofkirch, che causò la cattura propria e di M.
qualche modo coperto da' tiri della moschetteria c h e fosse messa alla difesa di quello, poi dopo la scarica si caricherebbe risol utamente sopra al nemico il quale, se è venuto con la medesima ce lerità con la qu ale tu hai marciato, non avrà potuto con d urre più forze delle tue, né avrà vantaggio sopra di te nell'appiccars i: anzi [per] ricuperare l'avanzo di strada che tu avrai , avrà bisogno c h e tanto più s'affretti a marciare, e però tanto più disunito e concitato sarà giunto.
6. Egli si può anche far ritirar l'armata tutta in sieme, ma distinta nei suoi corpi e ben ordinat a, e che l'ultimo corpo sia sì ben rinforzato che se l'avanguardia del nemico si accosta troppo et in disordine , sia abile a rivoltarsi e appiccarsi con essa, ma dopo averla rispinta non bisogna che la perseguit i, ma che si rimetta subito nella marcia per non perder tempo, come s'è detto di sopra; e qu esto corpo fa l'ufficio della gente spiccata che suol fare la ritirata, et in questa forma marciò l'armata della Valetta ritirandosi da Worms et un si mil corpo batté il giovane Colloredo, che lo volle assalire alle spalle con un nerbo di cav all eria. Perché avendo tu già preso avanzo di strada, se il nemico ti seguita con tutta l'armata, no n ti giungerà mai, perché egli ha da fare la medesima strada che tu fai, né ha, in questo, vantaggio alcuno più di te, e si suppone che i tuoi uomini possano camminare quanto i suoi; ma s'egli ti seguita colla Cavalleria sola e, per la fretta con che v ien e, forse anche mal serrata i nsieme, tu, che hai le tue forze unite, cioè Fanteria, Cavalleria e cannone insieme, puoi facilmente appiattart i in u n fondo in ordinanza di battaglia e riceverlo all'improvviso e romperlo, come il Mansfel1 ruppe una volta il Tilly che lo perseguitava a q uel modo 200 • Es' egli di lontano si ferma per aspettar la sua gente eh' è dietro che venga a mettersi insieme, tu segui il tuo viaggio né ti lasci in alcun modo t en er a bada, e quando il nemico non è risoluto in alcun modo di dar b attaglia ma so lo far seguitar la tua ar mata quasi per complimento e per riputazione o per valersi de ll 'occasioni della tua ignoranza se tu marcia ss i senz' ordine e lasciassi part e della tua gente adi e tro p e r le strad e, quando vedrà che av rai la tua armata serrata insi e me non t'assalterà mai per non imp egnarsi , et in tal modo Weimar et H orn si ritirarono da Nord lingen dopo averla soccorsa di gente, né Piccolomini che li segui t ava con la Cavalleria , poté far loro alcu n danno 20 1

200 Battagli a di M i n gol sh ei m, i l 27 apr il e 1622. Batte nd o Ti ll y, Man sfeld r itard ò il co ng iun gi m e nt o di q uest i con le forze sp agno le d i G o n sa lv ez de C 6 rd ob a.
20 1 L ' ab ile r it ira t a d eg li sve d esi e de i sasso ni pr ivò in part e gli Imp eria li d ei frutt i d ella b ell a v itto r ia d i N o r dli nge n del 6 sette mbre 1634.
7. Ma quello che s'è detto d'una armata intiera si deve anche osservare in un solo squadrone, cioè di non azzardarlo mai tanto innanzi che bisogni di poi farlo ritirare alla v ista del nemico; il che se fosse stato osservato dal Hofkirch che potea molto bene ritirar si prima che tutto il nemico fosse [sic] passato l'Elba poiché in ogni modo non si potea più impedirgli il passo, non sarebbe seguita la rovina di molti bravi uomini 202 . Deve però adoperarsi il giudicio et essaminar bene ogni cosa e riconoscer ben il luogo e ponderar fra se stesso, in caso che il nemico vi venisse, se si sarebbe bastante a riceverlo, perché avanzarsi et aspettar il nemico e poi volersi di nuovo ritirare, non solo è cosa poco onorata, ma anche è un negocio il più pericoloso eh' esser mai possa. E fu giudicato atto di grande imprudenza quello di Banér che sapendo di non poter resistere all'Armata Imperiale, si trattenne in ogni modo tanto tempo a Torgau che il Galasso gli arrivò addosso, e senza la trascuratezza di quei dell'Elettore di Brandenburgo di guardar il passaggio dell'Oder, lo disfaceva intieramente 203 •
IL Occorrono diversi accidenti ad un'armata che si ritira, ai quali bisogna cercare di rimediare con ogni costanza e generosità .
1. Se, per avvisi falsi ch'un capitano ha avuto del nemico, egli tocca d'essersi ritirato mal a proposito e senza suggetto, per salvare la sua riputazione e per non isbigottire i soldati che concepiscano opinione di dover temere il nemico, deve simulare qualche cagione apparente e dire d'aver marciato in quel paese non per ritirarsi dal nemico, ma per altre caus e urgenti che toccano quel paese dov'egli s'è messo.
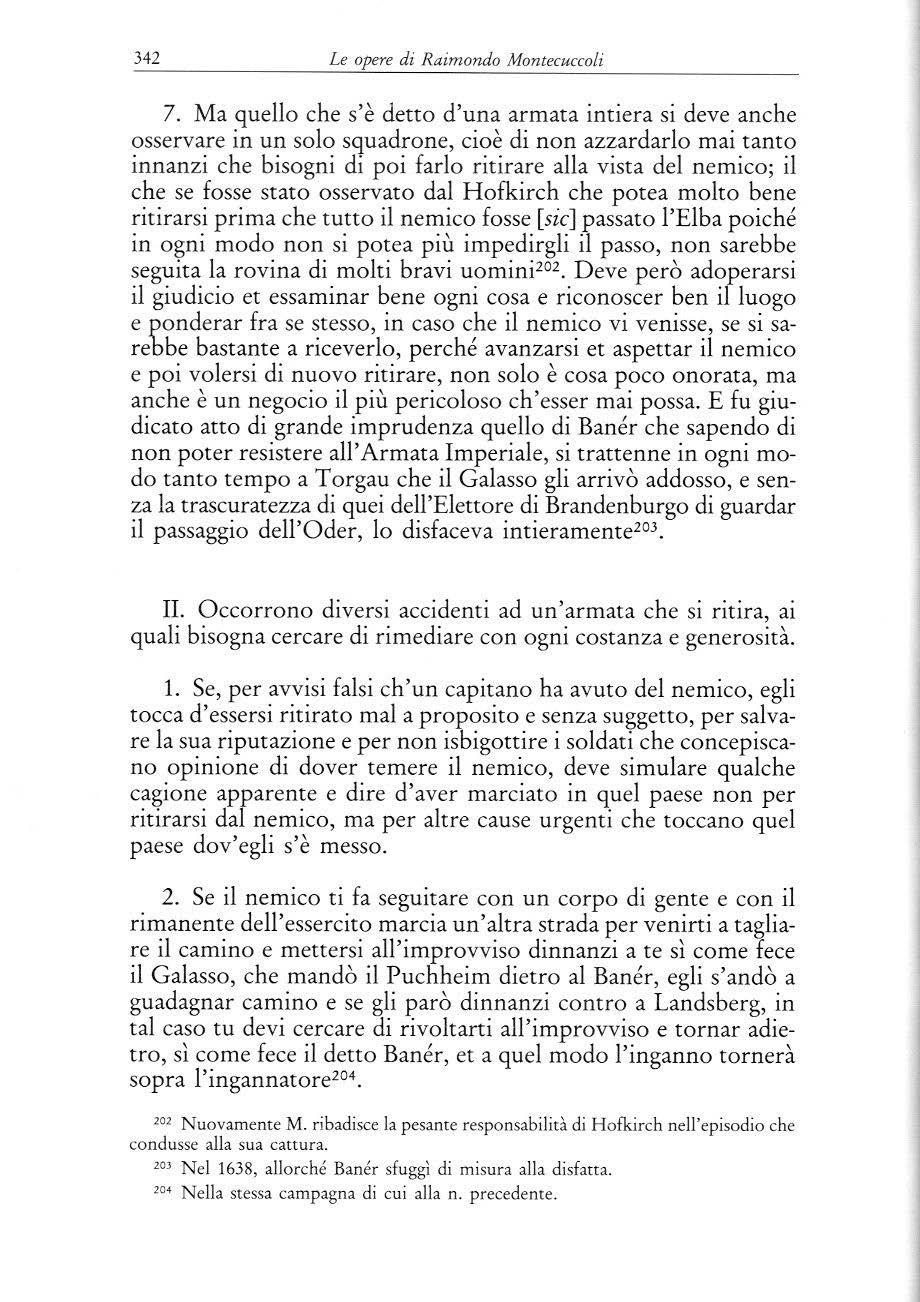
2. Se il nemico ti fa seguitare con un corpo di gente e con il rimanente dell'essercito marcia un'altra strada per venirti a tagliare il camino e mettersi all'improvviso dinnanzi a te sì come fece il Galasso, che mandò il P uchh eim di etro al Banér, egli s'andò a guadagnar camino e se gli parò dinnanzi contro a Landsberg, in tal caso tu devi cercare di rivoltarti all'improvviso e tornar adietro, sì come fece il detto Banér, et a quel modo l'inganno tornerà sopra l 'ingannatore 204
202 Nuo vam ente M. r ibad isce la p esant e responsab il ità di Hofkirc h n ell 'episod io c he cond usse a lla sua catt ur a.
20 3 Ne l 1638, all orché Banér sf uggì d i m isur a alla disfatt a .
20
• Nella stessa campag n a d i cui al la n. prece dente
Ma per sap e re se la gente che ti perseguita è solo una partita ovvero tutta l'armata, bisogna aver buone spie, ovver fare qualche prigionieri di quei che ti perseguitano, perché da essi potrai forse avere lingua, se bene l' istessa partita non sa molte volte che gente segua dopo di lei; ma per far prigionieri il modo consiste nell'ardire e nella celerità che alcuni dei tuoi si spicchino a tutta carriera, e gettandosi fra i nemici ne acchiappino qualcheduno, ovvero sotto spezie di amici o di far altra cosa girino loro alle spalle e I.i sorprendino, e promettendo qualche somma di denari a chi ti condurrà un prigioniero, s i trovano sempre degli arditi che si arrischiano di farlo.
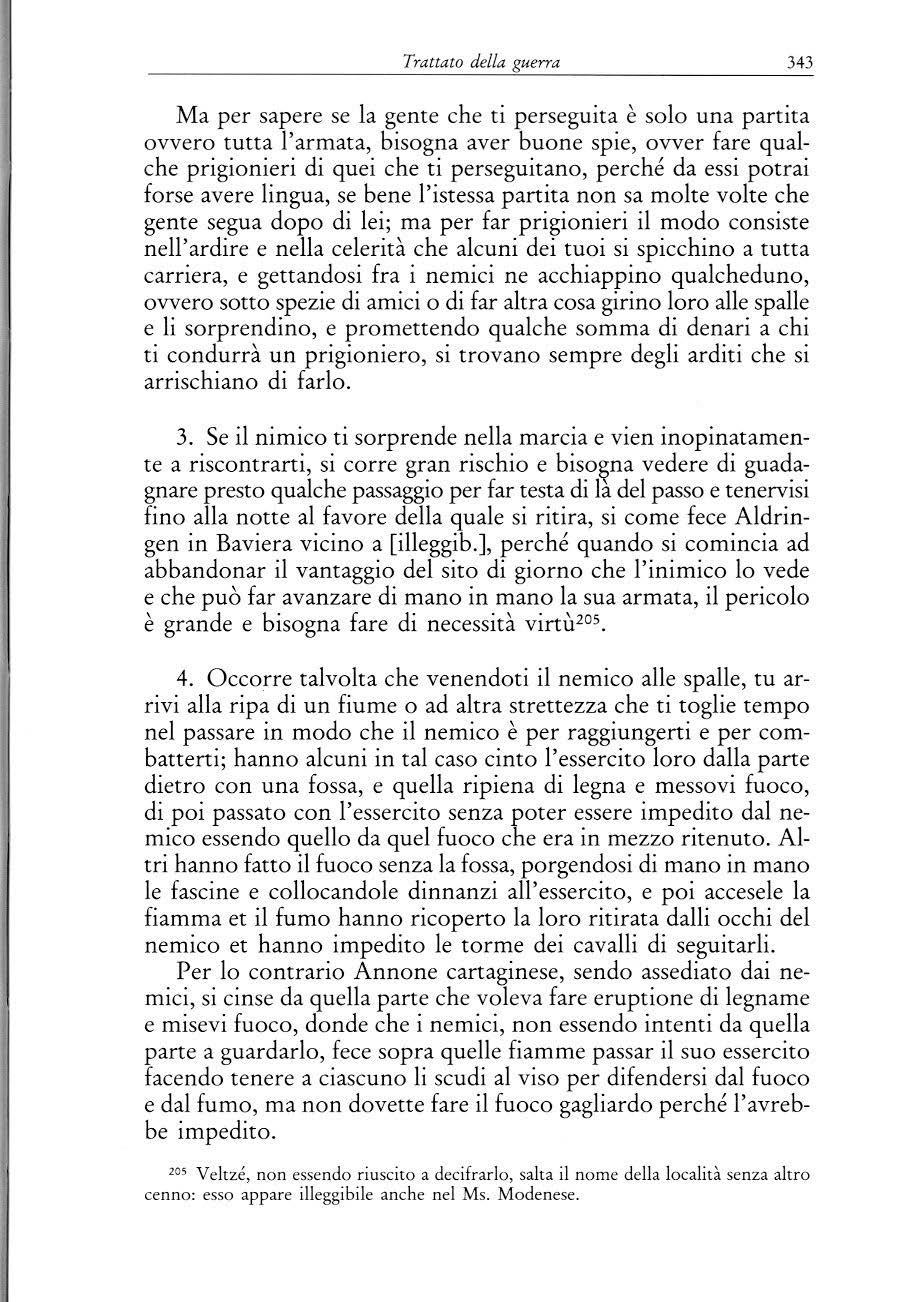
3. Se il nimico ti sorprende nella marcia e vien inopinatamente a riscontrarti, si corre gran rischio e biso~na vedere di guadagnare presto qualche passaggio per far testa di la del passo e tenervisi fino alla notte al favore della quale si ritira, si come fece Aldringen in Baviera vicino a [illeggib.], perché quando si comincia ad abbandonar il vantaggio del sito di giorno che l'inimico lo vede e che può far avanzare di mano in mano la sua armata, il pericolo è grande e bisogna fare di necessità virtù 205
4. Occorre talvolta che venendoti il nemico alle spalle, tu arrivi alla ripa di un fiume o ad altra strettezza che ti toglie tempo nel passare in modo che il nemico è per raggiungerti e per combatterti; hanno alcuni in tal caso cinto l'essercit o loro dalla parte dietro con una fossa, e quella ripiena di leg na e messovi fuoco, di poi passato con l' essercito senza poter essere impedito dal nemico essendo quello da quel fuoco che era in mezzo ritenuto. Altri hanno fatto il fuoco senza la fossa, porgendosi di mano in mano le fascine e collocandole dinnanzi all' essercito, e poi accesele la fiamma et il fumo hanno ricoperto la loro ritirata dalli occhi del nemico et hanno impedito le torme dei cavalli di seguitarli.
Per lo contrario Annone cartaginese, sendo assediato dai nemici, si cinse da quella parte che voleva fare eruptione di legname e misevi fuoco, donde che i nemici, non essendo intenti da quella part e a guardarlo, fec e sopra quelle fiamme passar il suo essercito facendo tenere a ciascuno li scudi al v iso per difendersi dal fuoco e dal fumo , ma non dovette fare il fuoco gagliardo perché l'avrebbe impedito.
0 5 Ve ltzé, n o n esse ndo riu sc ito a dec ifrarl o , salta il nom e de lla loca li tà senza al tro cen no: esso appare illeggibi le anc h e n el Ms . Modenese .
Nabide spartano, sendo assediato in Sparta dai Romani, messe fuoco in parte della sua terra per impedir il passo ai Romani i quali erano di già entrati dentro, e mediante quelle fiamme non solamente impedì loro il passo, ma li ributtò fuora. Alcun i, non avendo altro legname in pronto, hanno messo insieme le carra dell'essercito e fatto come un wagenburg, e poi accesele.
5. Alcun capitano che si è trovato assaltato da gran moltitudine di nemici, si è ristretto insieme e dato al nemico facoltà di circondarlo tutto, e di poi da '}uella parte ch'eg l i ha conosciuto più debole ha fatto forza e per quella via si ha fatto fare luogo e salvatosi. Altri, per divertir il nemico che lo seguitava, ha fatto girar alcuni pochi cavalli con molte trombe alle spalle del nemico e quivi datogli l'[all]arme: sì che egli, sospettando di qualche imboscata, s'è fermato di perseguitare e l'altro ha guadagnato tempo d'avanzare strada.
Altri, molestati nella retroguardia da' tiri del nemico, vi hanno messo i prigionieri accioché servissero di scudo e che il nemico non tirasse per non ammazzare i suoi propri. E in una partita è successo che, avendo ella fatto prigione un capo del nemico d i grande stima fra i suoi, et essendo poi perseguitata, né potendosi più ritirare, ha minacciato di voler uccidere quel prigione se non l asciavano di perseguitare, o l'hanno fatto commandare per quel capo istesso prigioniero e questa minaccia o commandamento ha fatto fermare il nimico e salvare la partita.
6 . Alcuno, conduttosi fra due monti, né avendo se non due vie a salvarsi, o quella dinnanzi o quella di dietro, e quelle essendo dai nemici occupate, ha fatto dalla parte di dietro una fossa grande e difficile a passare e ha mostrato al nemico di voler con quella ritenerlo per potere con tutte le forze, senza avere a temer di dietro, fare forza per quella via che davanti resta aperta, il che credendo i n emici si fecero forti di verso la parte aperta et abbandonarono la chiusa, e quello allora gittò un ponte di legname a tale effetto ordinato sopra la fosse, e da quella parte senza nessun impedimento passò e liberossi dalle mani del nemico.
7. Alcun capitano ha finto di voler alloggiare in un luogo et ha fatto far fosse e rizzar alcun padig l ione e mandato la Cavalleria a foraggio, facendola però rientrare segretamente nel campo, tanto che credendo i nemici che egli alloggiasse, ancor essi allog-
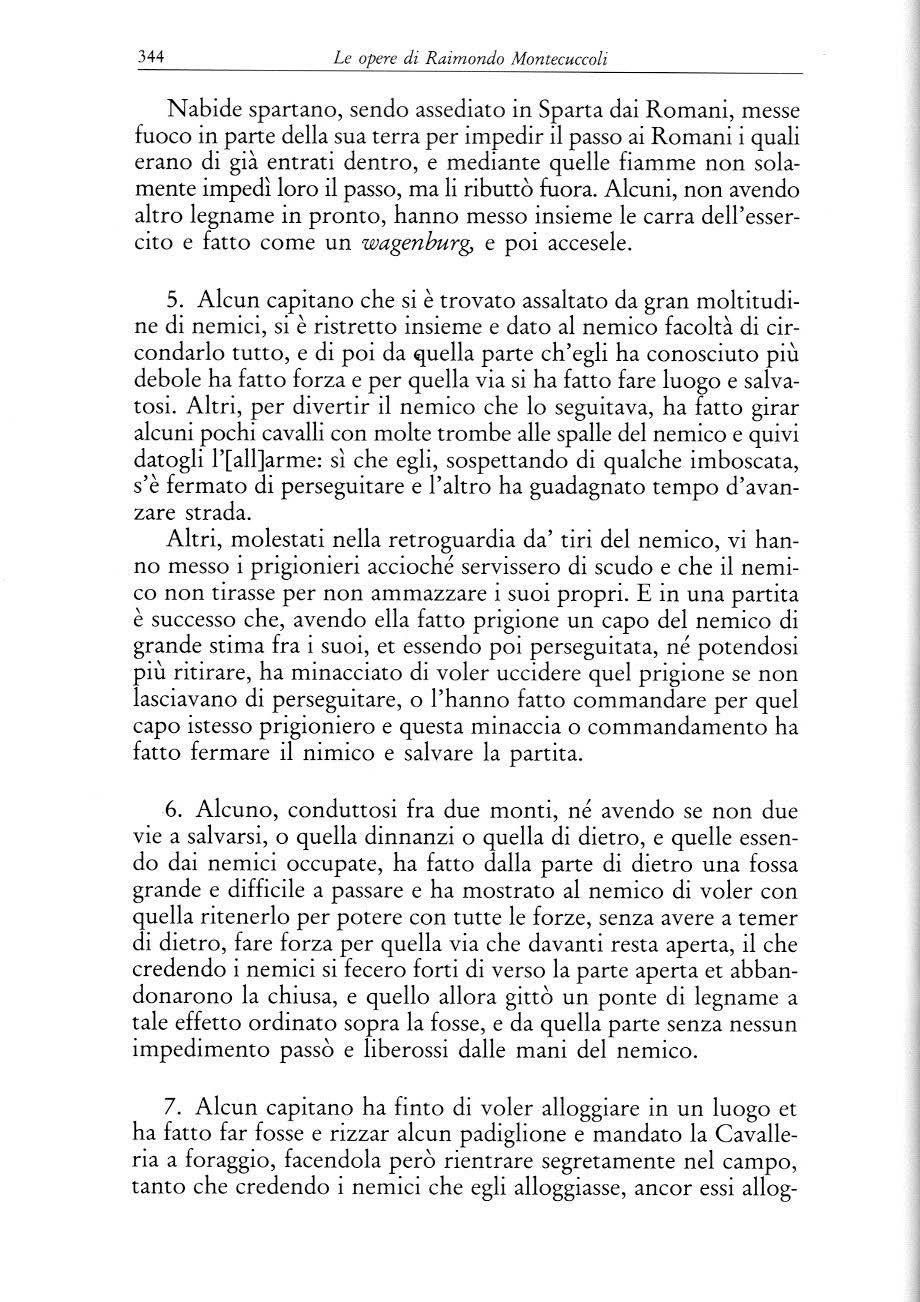
giorno, e mandarono davvero la Cavalleria fuori a prender viveri, di che essendosi quello accorto, ha marciato senza che i nemici potessino perseguitarlo. Altri hanno aspettato la notte, poi al favore delle tenebre ha nn o mandato via la gente pian piano e spicciolata, acc ioché il nimico non se n'accorgesse, o hanno lasciato qualche trombetta adietro nel campo e qualche padiglioni e fuochi e miccie accese , o s'egli è stato verso il giorno, h anno messo il fuoco in legna secche, poi sopra le secche hanno messo legna verde, acc ioché fatto l'aria nuvolosa e densa gli occhi d ei nemici fossero ottenebrati.
8. Alcuno ha mosso pratica d'accordo e fatto triegua col nemico per alcun giorno, il che ha fatto i nemici più negligenti in ogni loro azione, ta le che va l utosi della negligenza loro ha avuto occasione di uscire loro dalle mani.

Giova ancora a liberarsi dalle forze del nemico far qualcosa che lo tenga a bada. Questo si fa in due modi, o assaltarlo con parte delle forze accioché intento a quella zuffa dia commodità al resto delle tue genti di potersi salvare, o fare surgere qualche nuovo accidente che per la novità della cosa lo faccia maravigliare e per questa cagione stare dubbioso e fermo, come fece Annibale contro a Fabio come s'è detto di sopra.
9. S' egl i si ritira con qualche confusione sopra d elle barche per passare una rivi era, bisogna guardarsi di non caricarle tanto ch'elle affondino, il qual caso preve d en do una vo lta Cesare, si gettò a nuoto e si salvò.
10. Accioché il nemico non prevegga se tu v uoi ritirarti da un paese et abbandonarlo, s i fa travagliare nella fortificazione del campo e di altri luoghi, si scrive ai luoghi circonvicini che egli si è risoluto di svernar quivi e che però facciano provigione di viveri e d'ogni altra sorte di munizione necessaria pe r passarvi il verno, e così il nemico, non avendo l'occhio sopra la tua partenza, ti darà il tempo di partir inopinatamente e di guadagnare grande spazio di cammino prima che possa m ette rsi insieme per seguitarti.
III. S'egli s'avesse a ritirare un nerbo d'Infanteria sola, in campagna rasa, contro della Cavalleria, il miglior ordine sarebbe di disporla in due battaglioni accioché si favorissino e fiancheggias -
sino l'un l'altro, come si vede per la figura dissegnata qui sotto, perché non marciando più discosto l'uno dall'altro che 80 passi B D 4
e costeggiandosi, ne segue che la testa del battaglione segnato A difficilmente può essere caricata, stante che il lato dell'altro battaglione, segnato 3, la fiancheggia, come parimenti la detta testa fa il medesimo effetto in favore del detto fianco, per la medesima ragione l'una delle teste del battaglione segnata 2, et il fianco dell'altro segnato D si soccorrono vicendevolmente per la mosch etteria, di sorte che il pericolo è grande alla Ca valleria d'attaccar e per tai versi che si fiancheggiano a vicenda. Ma si potria dire che, ancorché i due battaglioni non possano essere assaliti ciascuno che per due l ati , perché non varrebbe m eglio farne un solo il quale non potrebbe esser attaccato per più versi di qu esti, parendo che la resistenza eh' egli farebbe saria più gagliarda stant e che la forza eh' è unita è ben più grande che quella ch'è separata? Ma in questo caso non bisogna risguardar tanto alla grossezza o picciolezza de' battaglioni, quanto alla difficoltà et impedimento che ci è quando un battaglione si trovi attaccato per più lati, perché egli è grande ventura s' egli non arriva qualche disordine quando un corpo deve far testa in quattro luoghi. Ma non avendo a farla ch e in due, gli uomini vi si dispongono con molto maggior ordine e maggiore facilità.

1. Non si fanno anche più battaglioni perché siccome le picciole truppe sono più proprie per attaccare e per agire prontamente da una parte e dall'altra, così le grosse e che non vogliono che diff~~dersi sono più difficili a rompersi e si diffendono meglio in una ntirata.
2. Quanto alla disposizione de battaglioni, le picche sarebbono nell'estremità in 6 file per ogni lato coperte dagli scudi se ve n e fussino, e dietro alle picche sarebbe una parte de' moschetti eri e nel m ezzo di quelli le bandiere, e quando la carica si presentasse non farebbono altra cosa, dopo essersi fermati, se non fare un mezzo giro e si troverebbono tutti nel lor ordine, la faccia voltata verso il nemico; li moschettieri ch'avanzassino sarebbono distribuiti in quattro parte per tenersi come sbandati dinnanzi alle picche, e venendo la carica andrebbono a schierarsi sotto le prime file delle picche dai quattro lati del battaglione.
3. Quando la Cava ll e ria si tenesse lontana, bisognerebbe che i battaglioni avanzassino cam ino, e vedendola preparata per venirli a caricare bisognerebbe che si fermassi no per meglio disporsi in buon ordine per sostenere l'assalta a pié fermo; e perché i quattro canti del battaglione, ben eh' egli s i serri insieme, restano qualche poco aperti e di debile diffesa la qual apertura potria servire d'entrata alla Cavalleria, bisognerebbe rimediarvi collocandovi le picche ch e avanzassino e co ll'ordinare ai soldati della quarta, quinta e sesta fila propinqui dei luoghi d"ètti di vo ltare le picche per sostenere, se vedessino farvi uno sforzo, ovvero vi si potriano collocare quattro coni di picche, in modo che i battaglioni diventassino ad 8 facce, sì come s'è mostrato nel discorso «Delle battagli e)), nella Pecorina n. IX.
4. Il più gran pericolo per la suddetta Infanteria sarebbe alle due prime cariche della Cavalleria, dovendosi presupporre ch' elle sarebbono gagliarde, ma avendole sostenute dovrebbe pigliar buona speranza avendo ammortato la prima furia dei nemici, e marciar sempre in buon ordine per la campagna gettando sempre 140 passi dai battaglioni qualche moschettieri sbandati per tener la Cava lleria più discosta e vedendo la venire a lui in giro fe r marsi.
5 . Egli è vero che facendo le genti a cavallo le loro cariche per picciole truppe, cioè in luogo di uno squ adrone di 300 cavalli far -
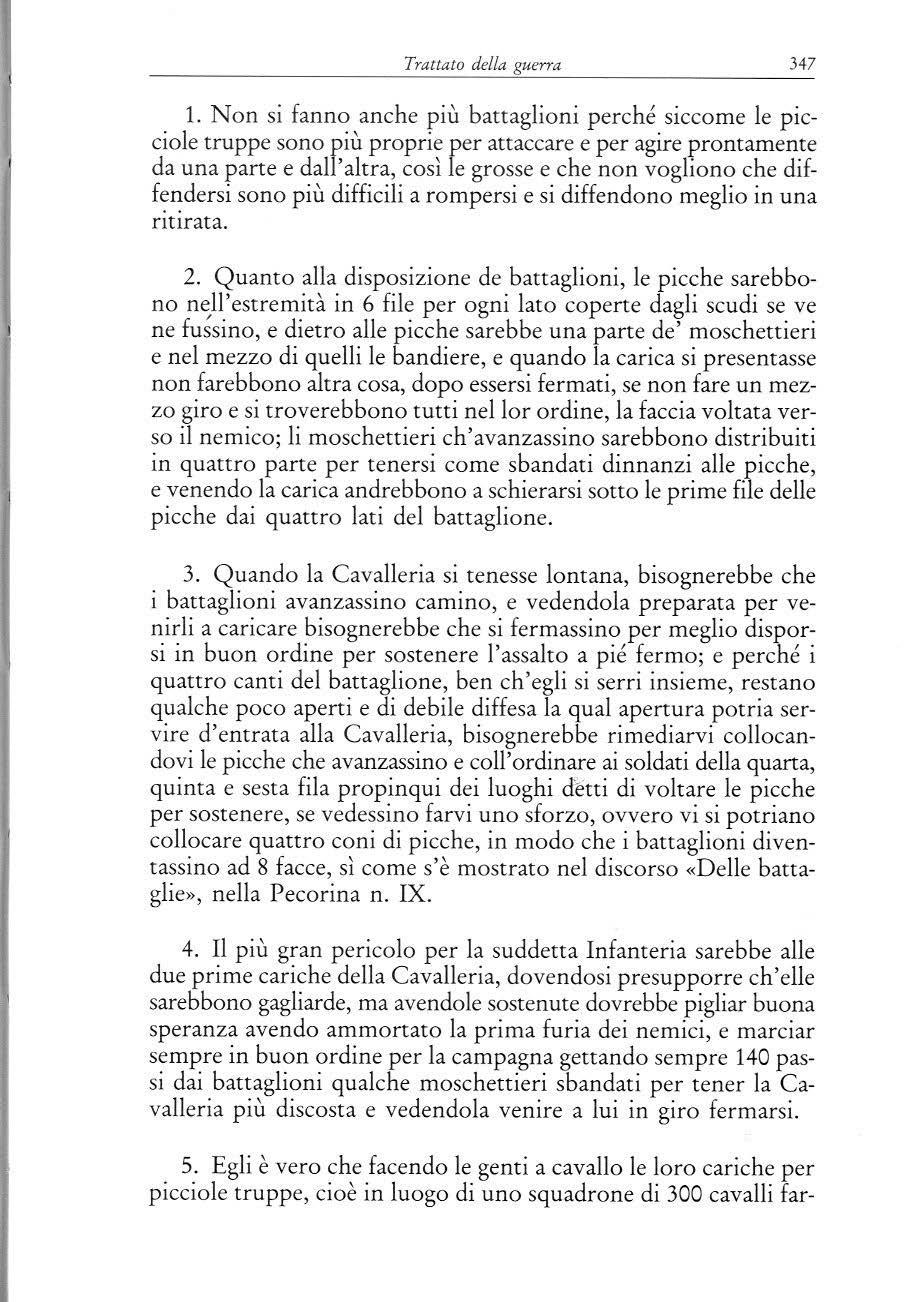
ne tre c i as cheduno di 100 ch e caricassero gli uni dopo gli altri, questo crollerebbe molto il battaglione perché, avendo la moschetteria scaricato so pra i primi, ch e non si può negare che non ne fussino grandemente danneggiati, li due altri squadroni venendo dopo avrebbero un gran vantaggio essendo esenti da una tal offesa, e c'è qualche apparen z a che la moverebbero perché questa maniera di attaccare è molto buona. Ma c'è in ogni modo rimedio, perché qualcuno dei moschettieri che sarebbono sotto alla prima fila delle picche potrebbono aver ricaricato prima che la seconda truppa de' cavalli avesse choccato; poi, non assaliti che dai due lati o da uno, si farebbono avanzare de' moschettieri per soccorrere il lato che fusse attaccato e qualcuno di quelli che sariano in mezzo al battaglione potrebbono anch'essi tirare, e così le picche verrebbono a ricevere continuo favore dalla loro mosch etteria perché senza questo la loro diffesa sarebbe un po' fredda.
6. Chi volesse dare una diffe sa maggiore a questi battaglioni, si potrebbono formare in guisa di baluardi e farne 4 o 5 o più a seconda della gente che s'avesse, ma quanto più fossino tanto più capace di gente sarebbe l'angolo interiore che nella fortificazione si chiama angolo di baluardo, ma bisognerebbe che le picche fossino di molto maggior numero che i moschetti.
IV. In somma, s'inganna il nemico che non perseguiti col simular d'accamparsi, col prepararsi alla pugna e far vista di voler dar battaglia accioché egli tenga la sua gente insieme né la mandi innanzi ad occupar i passi et a tagliarti le strade; col farlo assalire da una parte della gente facendo intanto ritirare il resto; collo scrivere lettere finte , e far sì che capitino nelle mani del nemico nelle quali tu mostri un dissegno tutto contrario a quello che hai; col dividere l'essercito e trasmetterlo per più parti; col simulare d'aver avuto nuovi rinforzi o una vittoria o simulare pace, tregua o dedizione; col fingersi gente del nemico servendosi delle sue insegne; col favore della n e bbia, del fumo, della notte, coll'opporre fuoco , acqua o fortificazione; colla cel erità, lasciando le bagaglia e la preda; col mettere innanzi al nemico gli D e i eh' egli onora et i suoi captivi, la preda, le bagaglia e i denari; col simulare di pigliare un camino e marciar per l'altro, e s'egli è di notte, commandando per quest'effetto gente che vada facendo fuochi e posta per quella strada che non pigli.

L'alloggiamento dell'armata si fa in campagna o nei vi llaggi e quando si fa nei villaggi, o l'Infanteria sola si campa e la Cavalleria si manda al coperto, ovvero tanto l'Infanteria che la Cavalleria si separa nei villaggi; e quando si fa in campagna o la Cavalleria e l'Infanteria campano tutte insieme in un campo fortificato ovvero l'Infant eria campa in un luogo e la Cavalleria in un altro, come in un bosco, in un fondo ecc., per maggior commodità.

I. Si alloggia ai villaggi quando il nemico è discosto tanto che si possa aver il tempo di mettersi in battaglia nella piazza d'arme prima c h'egli possa arriva re sopra le braccia.
1. Quando v i s'è cost r etto per la commodità dei v iveri e per essere al coperto e per ripararsi dall'ingiuria del ve rno, senza il qual so la ggiamento non si pup quasi sussistere in tal stagione
2. Questo è però un cattivo modo di alloggiare, né si deve mai costumare in paese che non è totalmente sicuro se non è per qualche grande necessità, perché si può esser facilmente sorpreso nonostante qualunque vigilanza e che si battino le strade giorno e notte, come successe ai reggimenti di Montecuccoli, Holche e Bernstein sorpresi tutti e tre a un tratto dal Re di Svezia vicino a Tangermi.inde, benché non avessino mancato in punto alcuno di ben guardarsi, et a tre reggimenti svedesi che alloggiavano a T angerm i.ind e sorpresi dal Hatzfeld, ed al colonnello svedese Sperrenter,
sorpreso più volte da Jean de Werth, et a Damiz, colonnello svedese, sorpreso dal colonnello di Bruay 205b is
L'armate che alloggiano separate in questo modo cadono in inconvenienti che la suffizienza dei capi mig liori non può divertire.

Né per una partita fa anche sicuro soggiornar molto se egli non è in un luogo forte dinanzi una gran possanza di Cavalleria nemica, perché, senza che vi si pensi, si trovi sorpreso come d'un cattivo tempo che arriva all'improvviso, et ella ti è sulle braccia tanto presto quanto le tue sentinelle, vedette e battitori di strada, perch'ella marcia con sicurezza non temendo cosa alcuna e sempre d ice ai primi: «Attacca, carica e segui tutto ciò che troverai», sì che in tali affari i più avveduti e che aprono meglio gli occhi non lasciano qualche volta di esservi colti, come successe al colonnello Munster206 •
E però, se una partita di cavalleria è commandata dietro ad una armata per pigliar guardia ai suoi andamenti, cercar di sorprendere qualcuna delle sue truppe alloggiate, far danno ai foraggieri, rompergli i viveri e tenerla spesso in arme, non bisogna loggiarsi in villaggi (che fu un punto principale deposto contro al detto Munster ne ll o Standrecht20 7 tenuto sopra di lui) ma tenersi in campo serrato insieme e cambiar spesso piazza, accioc h é il nemico non possa aver lingua dove tu sei ma vi formi sopra dissegno.
3. Anche nei quartieri di verno , se l'armate sono in guarnigione in diversi luoghi possono così separate esser disfatte in tutto o in parte per una congiurazione e per un Vespro Siciliano, oltre che le delicie delle città corrompono ogni disciplina militare et avviliscono ogni coraggio generoso.
II. Quando si alloggia ai villaggi separatamente e la Cavalleria e l'Infanteria si alloggia in uno o due corpi, si pigliano i villaggi più vicini accioché un quartiero possa dar la mano all'altro, e quando sopravviene all'arme, la Cavalleria si va rendere al detto corpo dei fanti, e se un quartiero separato è attaccato e se sia coll'essercito più forte del nemico, si va incontinente a soccorrerlo, e però con le cornette si mette a loggiare un buon numero di archibugieri a cava ll o o di Dragoni che diffendano la Cavalleria dalle sorprese di notte, alle quali sono particolarmente suggetti i quartieri ch'hanno in vicinanza città o castelli dove vi sono guarnigioni ne -
2o51r.s Episod i tutti verificatisi int orno al 1631.
206 Chr is t ian von Miinster, colo nn ello imperiale, sorpreso nel 1638 dal nem ico. M. sembra assolverlo.
207 Corte marziale .
miche, e così, frammischiando i Dragoni colla Cavalleria, sono sempre preparati a diffendersi tanto nei paesi larghi che nei coperti, e quando s'è arrivato al quartiere si fortificano molto bene le avvenute e spesso s i piglia posto nei templi e nei castelli, per potersi tenere due ore aspettando il soccorso; e se l'Infanteria è accampata in corpo, per assicurar la Cavalleria dalle sorprese si alloggia al coperto dell'Infanteria, ma s'anche l'Infanteria è separata allora la Cavalleria deve coprire con i suoi quartieri quelli dell'Infanteria. E quando al rendez-vous si distribuiscon i quartieri, si ordina ancora a ciaschedun reggimento verso qual parte abbia principalmente da far battere le strade e mandar le partite e donde s'abbia soprattutto da guardare dal nemico et in caso di allarme dove s'abbia da ritirare; e se il generale non ha dissegno di voler soccorrere i quartieri che per sorte venissero attaccati, non s'ha a fare di alloggiar colla Cavalleria fanti o Dragoni ma è meglio tener fuori una grossa partita commandata di tutto l'essercito la quale ricopra i quartieri.
Simil mente quando non si può tenere il verno l'armata insieme ma s'è costretto di farla svernare in diversi luoghi per farla vivere più facilmente e tirare in contribuzione il suo pagamento e che un luogo solo non patisca troppo danno, bisogna farlo giudiciosamente, che i luoghi dov' ella viene loggiata non siano discosti gli uni dagli altri, che non si possino soccorrere né sì vicini che non contengano diversi popoli; dove che ella abbia dinnanzi a sé qualche riviera o buone fortezze che la coprino; e però Friedland, volendo aquartierare l'essercito nella Misnia, dissegnò prima d'occupare Ha ll e in Sassonia perché era luogo propinquo alli altri quartie r i, i quali dovevano essere sì vicini gli uni agli altri e forti di gente e di tutto, che, se una parte fosse stata assalita dal Re di Svezia, avessero gli Imperiali potuto resistere sin che avessino avuto sussidio dai quartieri circonvicini; ma questo dissegno fu poi mutato perché il Pappenheim, che fu mandato per occupare Halle, prima che avesse il castello fu richiamato per la battaglia di Liitzen. Ovvero che una partita grossa di tutta l 'armata sia commandata a tenersi in corpo all e venute del nemico, mentre che il resto de ll ' esserc i to riposa, sì come fece Galasso, che lasciò il Salis con una compagnia di 50 cavalli effettivi di ciaschedun reggimento su le venute del nemico, et egli s'aquartierò col resto.
1. Devono dunque i quartieri essere difficili a forzare et ad assaltare almeno all 'improvviso, facili ad esser soccorsi e però pro -

pinqui, fortificati, trincerati e ben guardati. La piazza d'arme sarà in fronte del nemico eminente e commandante, all'interno capace per mettere tutta l'armata in battaglia, fortificata d'arte e dinatura commoda per le entrate e per le sortite delle truppe senza confusione; eh' ella non possa essere assalita senza gran disavantaggio del nemico, propinqua ai quartieri, ben diffesa dall'artiglieria e ben guardata di corpi di guardia tanto d'Infanteria che di Cavalleria.
Alcuni, temendo di essere assaliti di notte, hanno fatto mettere alla testa della lor piazza di battaglia su l'avvenuta cinque o sei mucchi di fasci con molta paglia di sotto, per farvi mettere il fuoco se si andava ad attaccarli, accioché alla chiarezza di questo lume si potesse tirare tre o quattro co lpi d'artiglieria il che avrebbe grandemente danneggiato gli assalitori, e se bene c'è tali che sdegnano simile inventione, non di meno elle possono servire qualche volta.
2. I quartieri particolari e separati devono stare molto all'erta perché il nemico tenta sovente d'attaccarli potendo l o fare senza azzardar un combattimento generale, nel che la sola guardia ordinaria qualunque essa si faccia non è sufficiente di rimediar a un tale accidente, perché ella non può dare l'allarme se non di troppo presso, e che spesso non si ha tempo di mettersi in stato di combattere, e però bisogna esser diligente in far battere la strada tutte le notti per più picciole truppe l e quali, se fanno bene il lor debito, non permetteranno che tu sia sorpreso perché un'armata o una grossa truppa capace di levar un quartiero dell'armata non può passare sì segretamente che non se n'avvegga.
E quando si ha da fare con un nemico svegliato e si temono tali attacchi di notte, non è cosa alcuna sì buona che di prevenirl o, se non per davvero, almeno darli tutta le notti dell'arme, accioché sia più impedito a guardarsi che ad attaccarti. Né si deve mai omettere cosa alcuna per assicurare il suo quartiero benché si creda di esser molto lontano dall'inimico, perché, oltre al profitto che si tira di accostumar la gente a far il suo debito, vi arriverà una volta una tal occasione che ciò sarà la salute di quella, della tua vita e della tua riputazione.
3. Le piazze d'arme dei quartieri particulari si assegnano di giorno nella fronte degli alloggiamenti per dar tempo al bagaglio di ritirarsi et ai quartieri di dietro di mettersi in arme mostrando baldanza contro al nemico, ma di notte s'assegnano in uno dei lati, il
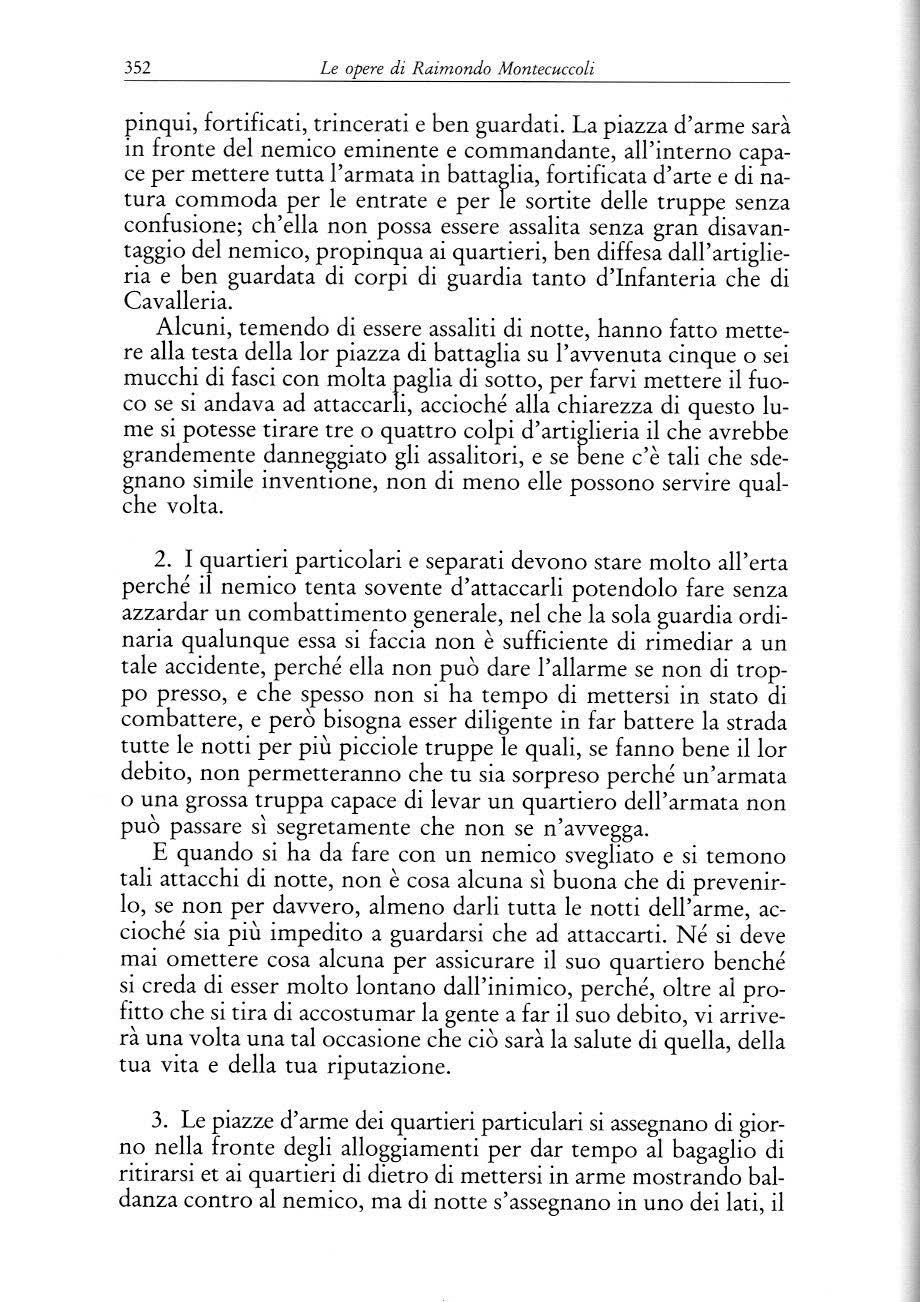
più sicuro, per esser più pronto a dar la mano agli altri quartieri. Le strade communi e battute che vengano dentro al quartiero, si serrano, si barriccadano o si traversano con fossi, poi s'aprono nuov e uscite per i giardini e per le siepi accioché venendo il nimico per attaccarti non possa entrare nel quartiero per le vie ordinarie né abbia notizia delle nuove.
I quarti eri s'assicurano con i corpi di guardia, colle sentinelle, colle ronde, colle pattuglie e colle partite. I corpi di guardia si conducono al loro posto prima ch e le truppe entrino nel v illaggio per alloggiarsi e si fanno più o meno forti secondo che più o meno s'ha sospetto del nemi co, perché se si pon gono a questo fine che abbiano a far testa al n emico e sostenerlo sintanto che quei del quartiero abbiano tempo di montar a cavallo, devono esser più forti, e se bene si tiene che fra l'Infanteria la terza parte della gente deva far guardia ogni notte sì che ella abbia due notti buone e fra la Cavalleria la quinta part e, sì eh' ella abbia quattro notti buone, in ogni modo bisogna regolarsi secondo il bisogno. E se i corpi di guardia si pongono solo per fornire le sentinelle e le pattuglie, bisogna calculare quante sentinelle s'abbia n o da posare e che ogni posto sia mutato di sentinella per lo meno tre volte per notte, e quant e pattuglie s'abbiano a mandare, e si somma la quantità del corpo di gua rdia.
Il corpo di guardia si suol mettere su la venuta del nemico, in luogo dove non possa essere tagliato fuora del quartiero, sotto a qualche arbore o d entro a qualch e siepe di giardini per la comodità dell'ombre, e legare i cavalli che possa usci r subito in campagna e trasferirsi se fa di bisogno al luogo dell 'arme, e però si fa talora nel mezzo del villaggio quando si sospetta egualmente da tutti i lati, o si fanno due o più corpi di guardia quando vi sono più avvenute p ericolos e; e se vi sono archibugieri o Dragoni, guardano a piedi le strade barricadate e le fatte di nuovo.
P er esser più pronti a montare a cavallo usano alcuni di far toccare il buttasella alla mezza notte ovvero un'ora innanzi giorno e fingono di aver avuto lingua del nemico accioché ogni uomo sia all'erta; della qual simu lazi o ne si serviva spessissime volte l' Aldringen mandando quasi sempre ordinanze et avvisando ai colonnelli che il nemico era fuori con partite in dissegno di dare sopra a qualch e quartiero.
Il colonnello et ogni capitano ha anche una guardia picciola alla. s ua casa dove tiene lo sten dardo, il qual e qualcheduno tiene n ella camera altri lo ti ene piantato sulla strada dinnanzi alla casa, in mezzo della guardia per assicurarlo più dal fuoco; altri metto -

no tutti gli stendardi insieme alla casa del colonnello, altri li fanno tenere alle case delle cornette.
Alcuni usano di non accendere fuoco di notte negli alloggiamenti, ma innanzi alli alloggiamenti, accioché per la luce essi possano ricever quei che vengono né pensando esser visti da loro; altri accendono il fuoco dietro alli alloggiamenti per ingannar il nemico, il quale cade nelle mani delle guardie stimando di esser anche molto lontano da loro.
Le sentinelle, dette da sentire, non possono vegliare tutta la notte, però a ciascun posto devono per lo meno essere assegnati tre uomini che si rilevano, sì che a ciascheduno vengano a toccare quattro o re di sentinella per tutta la notte, ma non devono stare le quattro ore tutte in un pezzo, anzi devono essere rilevate ogni ora et anche più spesso se il freddo è grande o il posto pericoloso accioché per la lunghezza non si addormentino o tramino qualche misfatto.

Le sentinelle devono essere poste in lu ogo che possano scoprire il più lontano che sia possibile, però di giorno si mettono sopra i colli, nelle torri dei templi, sugli arbori e dove più strade vengono insieme, e di notte nei fondi e luoghi bassi perché mirando di basso in alto l'aere è più chiaro e perché s'ode meglio per il bombo della concavità; dove sono certe campagne aperte si mettono attorno al quartiero a guisa di corona e vanno cavalcando l'una contro l 'alt ra accioché nissuno possa passar fra mezzo che non l o veggano o non l'odano, Si posano un po' lontano dalla st rada, accioché qualcheduno del nemico sotto specie di viandante non le sorprenda et a quest'effetto devono essere in luogo coperto il più che sia possibile accioché non siano viste, come dietro ad un arbore o in un grano ecc.; et al tempo della neve possono mettersi una camiscia indosso e di notte star in un fondo e non lasciar accostarsi persona né lasciar uscire o entrare di notte tempo persona dal quartiero, ma farla fermare a 30 o 40 passi sin che quello che commanda la guardia l'abbia riconosciuta.
Di giorno si mettono più lontane dal quartiero e dal corpo di guardia e di notte più vicine e doppie, a 200 o 300 passi dal corpo di guardia, e fra questo e quelle se ne mette una o due altre secondo la distanza che ci è, accioché la prima osservi quella di mezzo e quella di mezzo vegga e senta le due estreme, e tutte sono senza celata, accioché tanto più facilmente possano udire ogni strepito. La sentinella doppia estrema avvisa- ogni cosa a quella di mezzo e questa al corpo di guardia, sia che si sia, o che vegga gente o che
vegga fuochi o che scuopra micce o che oda latrati di cani o che vegga venir il nemico, nel qual tempo si ritira pian piano al corpo di guardia, dopo che l'una per più chiaramente riconoscere s'è spinta contro di lui, e se ha ricevuto l'allarme dai battitori di strada anche l'avvisa, ma sta nel suo posto finché vegga il nemico.
Le ronde si fanno dagli ufficiali del reggimento e dal colonnello istesso, il qual suole fare la prima, e si chiama ronda capitale, e distribuisce l' altre assegnando a ciascuno l'ora sua accioché sieno sempre fuori ronde, che è propriamente ufficio del sergente maggiore. La ronda visita le sentinelle, s'informa di quello ch'elle hanno visto o udito, osserva s' elle et il corpo di guardia fanno il debito loro e cavalca attorno al quartiero con silenzio e fermandosi di luogo in luogo per ascoltare il latrato dei cani, il nitrir dei cavalli et ogni strepito; vanno tre o quattro cavalli insieme e s'avanza tanto per di là le sentinelle quanto è la distanza delle sentinelle dal quartiere.

L e pattuglie vanno a cinque, a sette o più cavalli battendo le strade verso il nemico ad una lega o più o meno, e si mandano pattuglie per tutte le avvenute e queste devon essere ordinate in modo che prima che l'una ritorni l'altra sia in istrada, accioché abbattendosi il nemico di venire mentre eh' ella torna indietro non la seguisse alle spalle e non entrasse con essa lei nel quartiere, come si fece nel dar sopra il quartiero di tre reggimenti svedesi che alloggiavano a Tangermiinde.
Non devono cavalcar tutti insieme per sospetto di non esser acchiappati tutti a un tratto dal nemico e che non rimanga nessuno che porti l'allarme, ma devono andare due innanzi, poi uno, poi altri due o in altra maniera similiante, et avvertir bene di conoscer ogni cosa per non esser colti da qualche imboscata; quando scoprono il nemico che viene corrono di carriera al quartiero a dare allarme e vicino alle sentinelle tirano le pistole, et anche, per guadagnar tempo, se ci è qualche casa per istrada vi mettono il fuoco, avendo concertato in quel modo col commandante d el quartiere. Chi conduce la pattuglia ha un segnale col quale è riconosciuto nel ritorno da chi commanda il corpo di guardia.
Se vi è qualche passaggio lontano dal quartiere sull'avvenuta del nemico la pattuglia, in arrivando quivi, può fermarvisi sin che sia rilevata da quell'alt ra che viene dopo; ovvero si può anche ordinar quivi dal quartiere un altro corpo di guardia, sì come anche si fa alla punta di un bosco, la qual guardia avanzata contribuisce molto alla sicurezza di un quartiere; ma bisogna eh' ella sia molto
all'erta e che il sito l'aiuti a non esser sorpresa o tagliata fuori dal nemico che gli venga alle spalle .
I migliori avvisi che talvolta si hanno vengono dai foraggieri e da quelli che vanno a rubba, i quali, spandendosi per tutto come mosche, rincontrano ordinariamente i nemici, e qualcuno viene a portare novelle perché questa sorte di gente corrono come lepri quando bisogna fuggire, ma quando vanno a scroccare qualche preda volano; e quest'utilità s'ha talvolta fra tanti mali che questa gente cagiona, ché non vi è male che non rechi qualche bene.
Le partite sono truppe più grosse, di 40 o 50 cavalli, che si commandano verso al nemico per intraprendere sopra di lui, per pigliar lingua o per dargli ail'arme e divertirlo d'intraprendere sopra di te.
Della guardia si è anche parlato nella Pecorina n. II.
Ciaschedun quartiero di cavalleria deve tenere due soldati al1'ordine al quartier generale e talora vi si manda anche un caporale con essi, accioché se l'uno è spedito con ordinanza l'altro aspetti quivi, se succedesse qualche altra cosa di nuovo da commandare.
Quando il quartier generale ha l'alla rme, dà il segno l'Infanteria con tre colpi di cannone e fra i Svedesi con due, et allora tutti i reggimenti che sono nei quartieri separati vanno subito a rendersi alla piazza d'arme la quale suol essere d'ordinario al quartier della Corte, dove giunta la gente non deve più partirne anzi l'ordine del generale.
4. I quartieri dell'Infanteria separata s'assicurano quasi nel medesimo modo. S' ella alloggia in un villaggio, ella assicura con corpi di guardia le porte e muraglie, se ve n'è, se no ella elegge una piazza d'arme che ella barricada, o sia chiesa o cimitero, o sia che pertugi le case dall'intorno e si loggi nella più forte, e posa le sue sentinelle a lungo, non tanto che le possa perdere, o le mette tali che conosce non poter recar pregiudicio essendo prese, sia per la lor risoluzione o per la lor ignoranza. S'ella alloggia alla campagna, cerca qualche casa o grangia o bosco o campo circondato di siepe o impedito di fossi. Ma ella viene coperta dai quartieri della Cavalleria pesante e questa dai quartieri della Cavalleria leggera.
Quando l'Infanteria forma in tempo di notte un battaglione, deve avere ciascuna sorte d'arme divisa da per sé, per vietare la confusione e per potersi perfettamente servire di quella quantità di gente appunto che il bisogno richiede.

III. S'alloggia in campagna quando s'è vicino al nemico p er essere pronto a combattere d'un ora all'altra, e quando s i fa qualche assedio, come fece il Tilly a Magdeburgo et il Re di Ungheria a Ratisbona, e quando si acca m pa presso il nemico, come il Re di Svezia a W erben, F riedland a Bern burg, Galasso a Mezières in Lorena ecc., o quando la peste costringe a fuggir il contatto o che il paese è deserto d' abitaz ioni 20 8 •
1. S'assicura l'alloggiamento fortificandolo tutto intorno e face n dolo b en guardare per buoni corpi di guardia e sentinelle di dentro e di fuori, né si può abbastanza esprimere l'utilità che si rit r ae dal loggiar in corpo, che è infinita. E soleva Cesare, quando ritirandosi da' paesi nemici aveva messo a fuoco i campi, i villaggi e gli edifici, r idurre l' essercito nei quartieri di verno, ma accamparlo insieme, i quai campi fortificati serv ivano ai paesi intier i di br iglia come le cittadelle alle città, e travagliandosi accuratamente diedero l'origine a molti nobili castelli; e p er questo mezzo mantennero li Romani sotto la loro ubbidienza tanti popoli conquistati, perché più facilmente si tenta qualche cosa contro una picciola truppa che contro una grande, come provò l'istesso Cesare ch e, separata una volta l'armata in varie guarnigioni, diede cuore ai Francesi di voler intraprendere d'assalirle tutte in un medesimo giorno, accioché una legione non potesse venire al soccorso di un'altra. E t oggi ancora si potrebb e alloggiare in corpo a q uel modo , et assegnare a ciascheduno un reggim e nto e s uoi quartieri, nei quali si mandano i soldati a piedi e i mal mandati, et i forieri facessino venire i v iver i et il soldo.
2. Chi ha il suo campo unito e fortificato è sempre in istato di intraprend ere sopra il nemico a tutte l'ore, secondo le occasioni che se ne presentano. Può sfuggi r e il combattere contro un'armata eh' ei teme, può rassicurarn e una sbigottita e può ridurre all a fame una più forte che la sua, perché egli è un'impresa quasi t em eraria di attaccar un essercit o loggiato in corpo in un campo tr inci erato .

Il R e di Svezia attaccò Friedland a Norimberga, ma ci guadagnò poca gente e poca gloria. Tilly, capitano ardentissimo, non osò di attaccar il Re a Werb en nel suo campo fortificato. Il Duca di W eimar et Horn attaccarono il Re d' U ngheria a Nordlingen, ma riuscì loro male 209 . Se si dovess e attaccare , o biso gnerebbe far -
208 N elle campagn e de l 1631 , 163 2 e 1636.
209 M. po n e in gu ar d ia co n t r o l' attacco a posizio ni fo r t ifica te .
lo subito, prima eh' egli avesse il tempo di trincerarsi e di mettersi in vantaggio, o rincontrare qualche occasione che la Cav alleria fusse partita o che il campo fosse debile per qualche altra opportunità.
3. In somma, un campo fortificato fa che un'armata attaccata può combattere con gran vantaggio, solleva d'una gran fatica pe rché s'hanno da fare molta meno guardie e men faticose principalmente la Cavalleria, la quale quando alloggia nei villaggi aperti è costretta per sicurezza d'esser a cavallo quasi tutta la notte, contiene l'armata come dentro una città serrata, donde tu puoi partire secretamente con tali truppe che ti piace per esseguire ogni sorta di dissegni, lasciando il bagaglio in sicurezza; impedisce al nemico di costringerti a combattere se non quando ti piace, ti fa stare senza pericolo alla testa dell'armate più formidabili; ti fa pigliare delle città potenti alla barba d'armate più potenti che la tua; finalmente, un campo fortificato s'infetta meno che i villaggi dove s'alloggi, perché s'elegge un sito sano, et il villaggio bisogna pigliarlo come si rincontra, e anche perché egli è più arioso e gli allogg iam enti vi sono meglio compartiti.
Si va talora con l'esercito ad accamparsi in un paese per far qualche lega, per assistere i collegati et impedire le invasioni che potrieno farsi sopra di loro , per aspettar rinforzo, per affamare , far contribuire e dare il guasto al paese do ve si è o che è v icino, per forzar qualche piazza, per attirare l'armata nemica in un luogo dove l'aere, il paese, il tempo, le incommodità dei viveri, alloggiamenti, foraggi et acque la dissipino, o per allontanare l'armata nemica da un luogo dove si facilita ai suoi collegati il modo d'ammassar gente e far quivi qualche sforzo.
I. Si v a a menar il cam po propinquo al nemico tra il suo campo et il luogo donde li vengono i viveri per impedirglieli e tagliarglieli, e si cerca anche di rinchiuderlo di trinciere et assediarlo, massime se vi è l'opportunità di vantaggio di sito come colline d'accesso difficile o passaggi che inducano a tal dissegno. E se il nemico è più forte di Cava ll eria che tu non sei, perché in questo modo Ii è impedita la commodità di foraggiare, ell a è resa inutile a tutte le funzioni della guerra. Poi si diminuisce la riputazion e del nimico e si accresce la tua quando si dice che tu tieni assediato il nemico e ch'egli non ardisce combattere, il che è di grande utili-

tà perché d'ordinario gli uomini si voltano sempre dal lato del più forte .
È memorabile l'atto di Friedland che aveva assediata l'armata del R e di Svezia a Norimberga, se Pappenheim avesse ubbedito ai suoi ordini e fusse venuto a congiungersi col suo essercito invece di portar infruttuosamente il soccorso a Maastricht 210 • Ma ogni volta che si fa questo bisogna essere disposto di fare la giornata qualunqu e volta il nemico voglia, ma pe rò con tuo vantaggio, cioè s'egli t'attacca nei tuoi trincieramenti, et essere così forte, o più forte che l'inimico, perché in tal caso non ci è perico lo se non ordinario quando anche il nemico ti attaccasse prima d'esserti accampato, perché le due parti dell'essercito si ordinano a fare la giornata e l'al tra parte fa e fortifica gli alloggiamenti.
1. In questo modo ponsi anche il campo più alto che quello del nemico sopra un fiume per impedirli la discesa dei viveri e delle munizioni o per guadagnar commodità d'occupargli i suoi magazzini o di rompergli il suo ponte o, avendo il passaggio da una parte e dall'altra d ell'a cqua, di dar il guasto al paese di donde tira le vettovagli e, e poi di stringerlo come fecero Hatzfeld e Gotz contro a Banér, ch'era lo ggiato a Torgau sopra l'Elba.
2. Campasi anche propinquo al nemico quando hai speranza ch e molti soldati dei suoi debbiano passar nel tuo campo e che non aspettano se non l'opportunità di poterlo fare. Ma ciò facendo bisogna ben pigliare cura di poter anche sussistere con la propria armata nelle vettovag li e e che no n si venga a patire quello che s i vuol far patire al nemico.
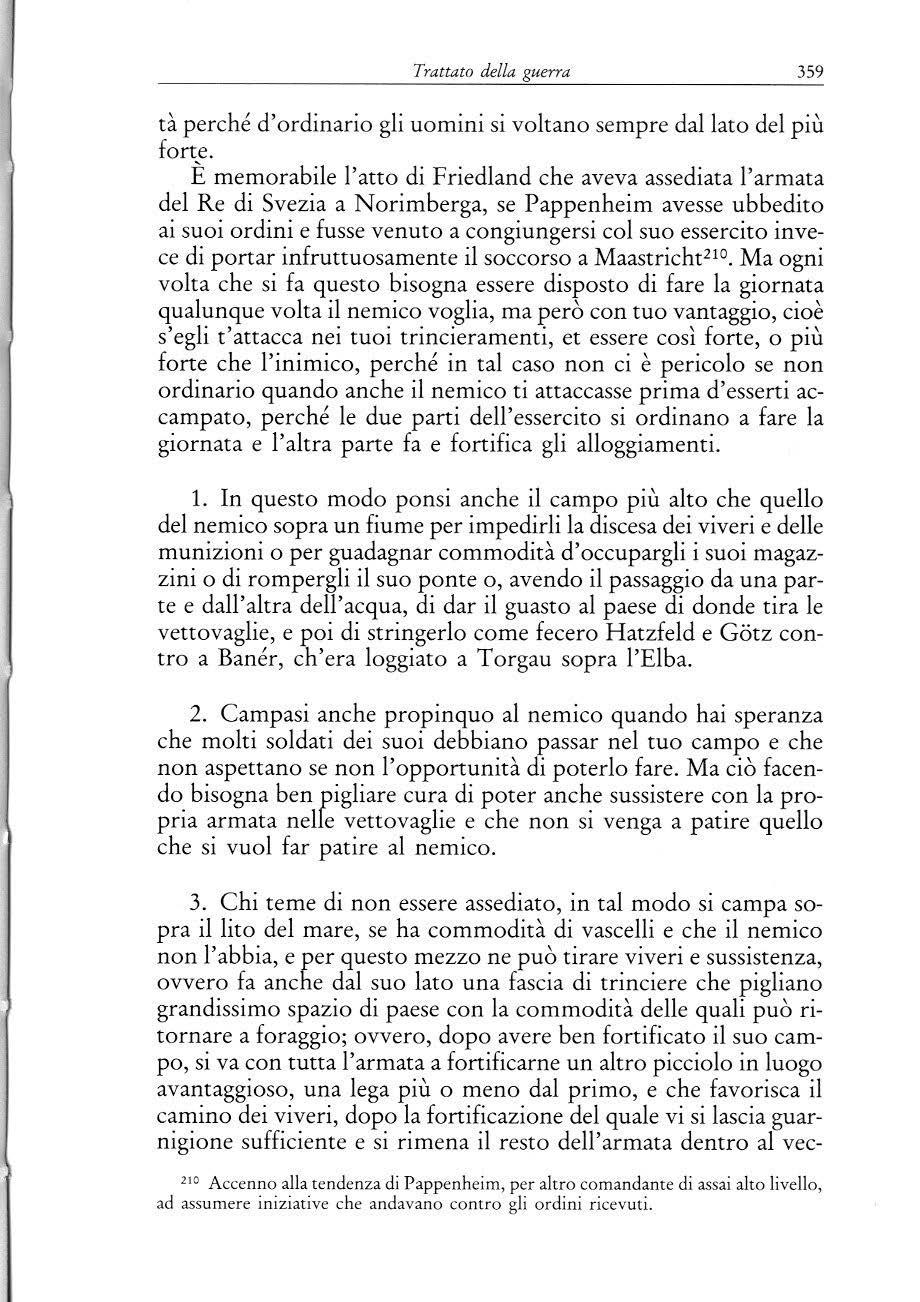
3. Chi teme di non essere assediato, in tal modo si campa sopra il lito del mare, se ha commodità di vascelli e che il nemico non l'abbia, e per questo mezzo ne può t irare viveri e sussistenza, ovvero fa anche dal suo lato una fascia di trincie r e ch e pigliano grandissimo spaz io d i paese con la commodità dell e quali può ritornare a foragg io; ovvero, dopo avere ben fortificato il suo campo, si va con tutta l'ar mata a fortificarne un alt r o picciolo in luogo avantaggioso, una lega più o meno dal primo, e che favorisca il camino dei viver i, dopo la fortificazione del quale vi si lascia guarnigione sufficiente e s i rimena il resto dell'armata dentro al vec-
2 10 Acce nno alla t e nd e nz a di Pappe n h ei rn , per altro co ma nd an te di ass ai alto li ve llo , ad ass umere iniz iat ive c he an d avan o co ntro gli o r din i r ice vu t i.
chio campo, e così son favoriti i viveri, e se il picciolo campo è attaccato la v icinanza dell'alt ro lo soccorre, ma si suppone ch e, marciando così in faccia del nemico, si sia forte quanto lui né si tema la giornata, o si pigli posta prima che il nemico se n'avvegga.
4 . Suolsi ordinariamente campare lungo un fiume, perché un lato d elli alloggiam enti è as sicurato dall'acqua e dalla natura del luogo, s'ha una parte e l'altra del paese libera per i foraggi e se il nemico è dall'una parte si ha l'altra parte sicura, e quello che rimane adietro può fornire alle necessità dell 'essercito le quali si possono commodamente fare condurre per acqua, a seconda se il nemico è alloggiato di sotto; senza azzardar nulla si può tirar in lungo la guerra, perché potendo essere ora da una parte, ora dall'altra del fiume, si suppone che non abbiano a mancar viveri, et avendo fortificato il ponte e gli alloggiame nti, lasciandovi poca gente a guardarli si può col resto dell' essercito uscire sicurament e ai foraggi et all'imprese che si presentano essendo il campo diffeso dalle fortificazioni medesime.
Così s'accampò il Re di Svezia, prima a $tettino, sopra l'Oder, poi a Werben sopra l'Elba; così anche Banér a Worms e a T orgau sopra l'Elba e cos ì Galasso a Dyhrenfurt sopra l'Oder, ecc. 211 •
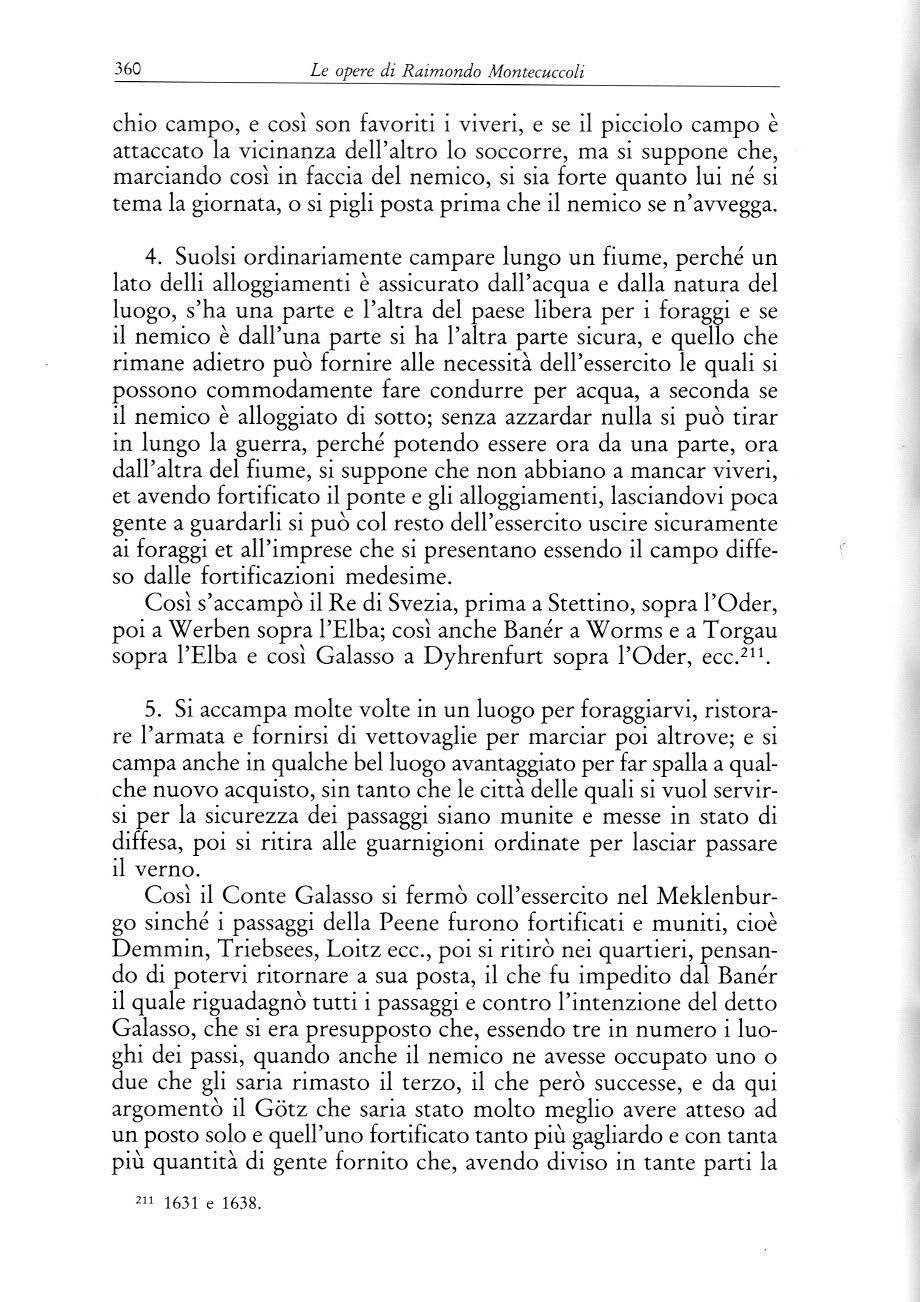
5. Si accampa molt e v olte in un luogo per foraggiarvi, ristorare l'armata e fornirsi di v ettovaglie p er marciar poi altro ve; e s i campa anche in qualche bel lu ogo avantaggiato per far spalla a qualche nuovo acquisto, sin tanto che le città delle quali si vuol servirsi per la sicurezza dei passaggi siano munite e messe in stato di diffesa, poi si ritira all e guarnigioni ordinate per lasciar passare il verno.
Così il Conte Ga lasso si fermò coll' essercito nel Meklenburgo sinché i passaggi della Peene furono fortificati e muniti, cioè Demmin, Triebsees, Loitz ecc., poi si ritirò nei quartieri, pensando di potervi ritornare a sua posta, il che fu impedito dal Banér il quale riguadagnò tutti i passaggi e contro l'intenzi o ne del detto Galasso, che si era presupposto che, essendo tre in numero i luoghi dei passi, quando anche il nemico ne avesse occupato uno o due che gli saria rimasto il t erzo, il che però successe, e da qui argom e ntò il G o tz che saria stato molto meglio avere atteso ad un posto solo e quell'uno fortificato tanto più gagliardo e con tanta più quantità di gente fornito che, avendo diviso in tant e parti la
fortificazione, la diligenza e la gente, aver indebolito le forze e la resistenza2 12 •
II. Ma, per qualunque ragione si campi, si deve nell'alloggiare avere due considerazioni principali, l'una di porsi in luogo sano, l'altra di porsi dove il nemico non ti possa assediare e torti la via dell'acqua o delle vettovaglie, per lo che conviene considerare la natura del luogo, do v e son posti gli amici e dov e i nemici, e da questo fare una congett ura se tu puoi esser assediato o no, e però conviene che il capitano sia peritissimo dei siti dei paesi et abbia intorno assai che ne abbiano la medesima perizia.

1. Ma sono di due sorte di campi, cioè per allorggiarvi solo una o poche notti, come quando si marcia, o vver per dimorarvi lungo tempo come occorre in un assedio, in un quartiero di verno, o in altre simili occasioni dove si deve usare più diligenza, più fatica e maggiore cautela.
2. Nelli alloggiamenti che durano poco, detti castra temporanea, si ha risguardo a cercare qualche luogo avantaggioso e forte di natura che abbia un lato coperto da un bosco, da un fiume, da un precipizio o da cosa simile, e partico larmente se si marcia in paese nemico e si manda da principio innanzi una partita di Cavalleria col quartiermastro generale per riconoscere puntualmente ogni qualità del luogo dove si vuol accampare quella notte, che dev'essere in campagna piana al possibile, pe r non esser dominato all'intorno, e quando vi s'è arrivat o (i l che dev'essere sempre per tempo e di giorno, accioché i soldati abbiano tempo di fare le loro baracche e d'accomodare i loro cavalli e di non mettersi in pericolo del fuoco, coi lumi, se non c'è qualche considerazione particolare di vo ler alloggiare di notte, come s'è detto nel capitolo del marciare), si ripartiscono i quartieri nei villaggi circon v icini che vi sono e si avanza la Cavalleria nei luoghi che si giudicano sospetti, et il corpo dell'Infanteria si fascia con una trinciera alta 6 v. e 3 v. grossa, p er non esser totalmente nuda in caso che il nemico tentasse una intrapresa sopra il campo, e nei luoghi dove per sorte sia marazzo o altro vantaggio, per avanzar il travaglio si possono chiudere insieme cavalli di frisia o piantarvi palizzate, le quali poi marciando si gettano novamente sopra i carri e si con-
2 12 N e lla ca mpagna del Mecl emburgo , 163 8. M. pone in r isalto il gravi ssi m o pe r icolo d i di vid er le forze p er voler tutto coprir e .
ducono seco, e se il pericolo non è grande invece di trinciera si può chiuder il campo con le carra disposte in giro detto wagenburg o con altre serrature di campo.
3. Quando le trinciere sono all'ordine, si mettono li soldati a fare le lor o baracche con alcune stanghe e con paglia, o in mancanza d'esse si pigliano i padiglioni dai carri e si stendo no accioché la gente sia coperta et abbia il suo riposo, e sia più gagliarda per marciar più i nnanzi. I carri dell'artiglieria, munizione e provianda si mettono nel mezzo del campo fasciati d'una trinciera particolare; e qualche pezzo di cannone con ciò che li appartiene si pianti verso quei luoghi dove si pensa che il nemico potrebbe tentar un attacco.

4. Dopo di ciò si fanno montare in guardia le gente necessarie, non fidandosi sempre nella difficultà del sito, massime delle montagne, perché si trovano alle volte sentieri non battuti et ignoti per i quali il nemico ti viene alle spalle, come successe a Fernemont nel Tirolo 213 • Si mandano truppe di cavalli a batter la strada et a riconoscere verso il nemico e se vi è qualche ruscello o passaggio non molto lontano, vi si mandano guardie d'Infanteria e di Cavalleria accioché se l'inimico venisse per attaccar il campo, sia arrestato quivi per forzar il passo, et intanto s'abbia l'allarme e s'abbia tempo di mettersi in battaglia e di mandar anche rinforzo ai passaggi per tanto più intrattenere il nemico.
5. Dopo le guardie montate, il resto della gente si m e tte ariposare e l'altra mattin a allo spuntar del giorno si dà il segno della marcia e si spianano le trinci ere, accioché il nemico non trovi vantaggio alcuno in caso che egli perseguitasse l'armata.
6 . Ma quando si marcia ancora nel paese amico e s'è abbastanza sicuro che il nemico non può per allora dar attacco al quartiero, non è necessario di trincierarsi in questo modo , ma la gente si ripartisce nei villaggi ci r convicini accioché abbia maggio r commod ità, massime la Cavalleria, perché una notte cattiva, fredda e piovosa è bastante a rovinar un cavallo che non abbia coperto .
Quando l'armata vuole soggiornare e campare lungo tempo in un luogo, si deve considerare alla commodità di 6 cose, cioè di viveri, dell'acqua, del foraggio, della legna, del sito e della fascia del campo, delle quali cose, e massime del sito, s'è discusso nella Pecorina n. II dove si tratta dell'accamparsi sotto una città per la presa d'assedio.
1. S'ha risguardo alla sicurezza dei viveri e delle munizioni non allontanandosi troppo né lasciando alcuna città nemica all'ali che possa tagliar et impedire loro il corso.
2. Si cerca la commodità delle riviere per servirsi dell'acqua a bere, a barcheggiare et assicurarne l'uno dei lati del campo, non sendo possibile di vivere senz'acqua, la quale deve anche essere buona, e però si devono fuggire i luoghi imminenti e le valli , quelli per lor mancamento che hanno d'acqua, queste per la cattività loro et anco per l'incommodità dei fanghi e per il cattivo aere ch'ei causano; ma dagli arbori freschi e verdi si congettura buon'acqua.
3. S'ha risguardo all'abbondanza, commodità e sicurezza d'aver dei foraggi, perché la Cavalleria ne fa un guasto incredibile, oltre che ne bisogna molto per lo coperto e per il dormir dei soldati.
4. Bisogna aver molta legna per i fuochi dei corpi di guardia e per far le baracche .
5. Bisogna che il luogo dove si vuol piantare il campo sia piano, uguale e sabbioso, se si può trovare, lontano da ogni commandamento, o se ve n'è bisogna occuparlo e rinserrarlo dentro i trincieramenti per discoprir e commandar la campagna . Quando si rincontra un colle che non è dominato da nissun altro commandamento, s'ha un gran vantaggio piantando il campo sotto di quello et ordinando la piazza d'arme in modo che, quando il nemico voglia salire, appena possa vedere la prima fronte o le prime file. Se vi è qualche bosco vicino bisogna servirsene e guardarlo, allontanando un poco il trincieramento, lasciando una piazza fra due per ischifare le imboscate che il nemico potrebbe farvi dentro.
6. La forma de' quartieri è diversa e si regola per lo più secondo la commodità del luogo, la loro grandezza si ordina secondo la quantità dei reggimenti che vi hanno a loggiare, accioché non

sieno così stretti che non si possa dar ai soldati et alle piazze il loro spazio convenevole e neanche sieno sì larghi et ampi che quando si volesse rinchiudervi ogni cosa per non lasciare vantaggio al nemico la gente sia troppo faticata nel fortificar il campo e nel f~re le guardie convenevoli, e così vengono le forze ad essere disumte e separate.
7. L'alloggiamento di un essercito che deve durar lungo tempo è di grande importanza, il generale istesso lo riconosce coi propri occhi, et essendo a 2 o 3 leghe dal posto dove vuol campare, s' avanza con le guardie ne cessarie, col quartiermastro generale, col generale ingegnero e con altre persone generali, e dopo aver riconosciuto puntualmente tutte le circostanze e qualità dei luoghi, le fa mettere in piano et ordina come i quartieri devono essere ripartiti.
I. Prima che si parli del ripartimento dei luoghi che sono assignati particolarmente a ciaschedun reggimento per quartiero, bisogna prima mostrare quanta piazza debba avere una bandiera di per sé, e poi di quivi si può calcu lare quanta se ne deva ordinare per un reggimento, il quale è composto di più bandiere.
1. Ciascheduna bandiera di fanteria giace in lunghezza (il che sem pre si ritiene senza alterazione o cambiamento alcuno) 300 v. renane 214 ; la larghezza è diversa secondo la diversità della bandiera, s' ella è forte di gente o debile; sia qui per essempio una compagnia di 100 uomini, alla quale per ordinatamente alloggiarla si dà un parallelogrammo di 300 v. di lungh ezza e di 24 v . di larghezza; della lunghezza di 300 v. se ne dà al capitano 40, sì che il suo all oggiamento abbia uno spazio di 24 v. di larghezza e di 40 v. di lunghezza. Poi fra il loggiamento del capitano et il principio delle baracche dei soldati si lascia uno spazio lungo 20 v . e largo quanto è la larghezza di tutta la bandiera; quivi incominciano le baracche dei so ldati, per le quali si pigliano 200 v. di lunghezza, fra il qual spazio devono stare le baracche, e la larghezza s'è già detto essere 24 v., dove vengono due file di baracche con una strada in questo modo.

2. La larghe zza di 24 v. si ripartis ce in tre parti eguali, e la parte di mezzo è la strada, 8 v. fra le due file di barac c he , che sono
2 14 La p aro la bandiera , per battaglione, è di tradi z ione spag n ola. Sec. Veltzé, I, 302, la verga re nana era di m. 3,77.
poste da tutti e due i lati della strada, e nissuna baracca vi e n e ad esser più larga di 8 v., la qual larghez z a non deve nissuno poter accrescere e diminuire né dinnanzi né di dietro, accioché l'ordine non sia turbato. Nella lunghezza si danno 4 v. per uomo, ma quando 4ue so ldati giacciano insieme in una sola tenda non si dà loro 8 v . di lunghezza, ma solamente 6 v ., accioché quelli che hanno le mogli possano avere un po' più spazio che un soldato solo, e se v i avanza anche qualche spazio di più si dà a quelli che non ne hanno di bisogno.
Ora, fra questi termini accennati s'alzano le tende dei soldati, e sono ripartite in modo che tanta gente venga a giacere da un lato quanta dall'altro . E perché non si p ermette che i so ldati tengano fuoco nelle baracche, né che anco cuociano quivi, però dietro ai so ldati si dà una piazza ai mercanti e ai vivandieri. Si misura un spazio di 20 v . di lunghezza, cominciando dall'ultima baracca dei so ldati; la qual piazza riman vuota e senza fabrica alcuna, tra i soldati e le baracche dei vivandieri, accioché il fuoco non possa far danno alle baracche dei soldati, in caso eh' ei s'appigliasse fra i vivandieri ch'hanno sempre fuoco e le cui cucine fumano sempre. Dopo questi 20 v. di spazio s i rizzano le baracche dei vivandieri, alle quali si dà 10 v. di lunghezza, e poi anche si dà loro 10 v . di sovrappiù per il loro focolare e cucina, accioché l e baracche dei soldati siano tanto più sicure dal fuoco. L e port e delle baracche sono ordinate in modo che abbiano tutte l 'usc ita verso la strada, sì che una fila delle baracche abbia le s ue porte a dirimpetto di quelle dell'altra fila; le due prime baracche hanno la porta che risguarda verso la piazza eh' è lasciata fra il capitano e i soldati, e di queste du e l'una è del tenente, l'altra dell'alfiero; così anche l'ultime due baracch e non riguardano come l e altre verso la strada di mezzo, ma hanno le loro porte verso le tende dei vivandieri, e queste due ultime baracche si danno ai sergenti della compagnia. Le porte delle baracch e dei vivandieri stanno verso le baracche dei soldati, accioché vi si possa andare dirittamente senza girare.
3. Questo è il ripartim ento di una compagnia di fanti, quando ella è forte di 100 uomini, che s'ella fosse di 120 o di 150, allora gli s'aggi ungerebbe una fila di baracche, sì che una tal bandiera v i e ne ad avere tre file e due strade, pigliando ciascheduna fila e ciascheduna strada di 8 v. di larghezza, senza alcun ca mbiamento , e così la larghezza di questa bandiera sarà di 40 v ., la quale sarà anche la larghezza dell'alloggiamento del capitano, e se la ban-
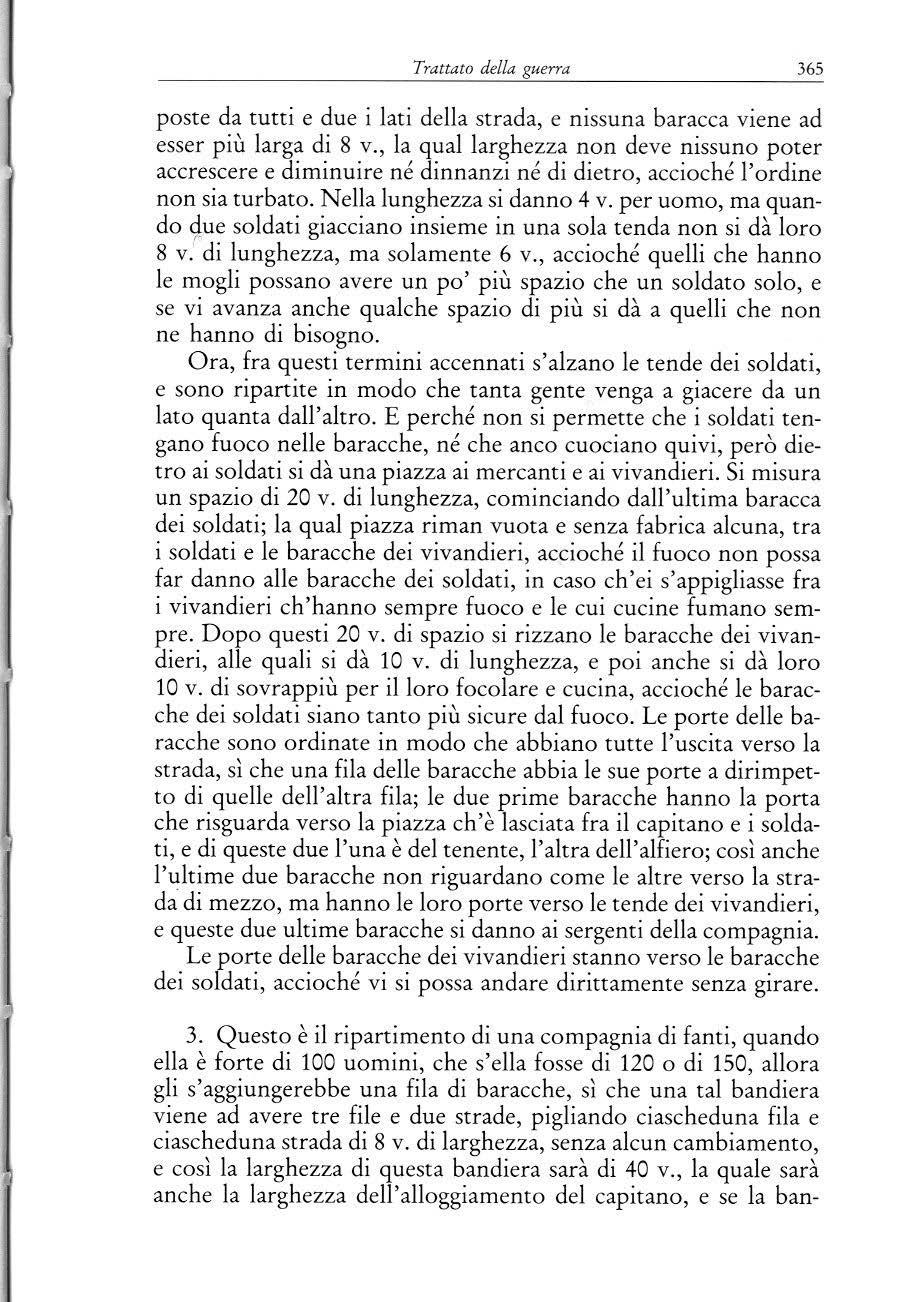
diera è forte di 180 o 200 uomini , gli si danno 4 fila di baracche, che fanno 56 v., e s'è forte di 250, gli si daranno 5 fila e 4 strade, che faranno 72 v. di larghezza, et allora anche l'alloggiamento d el capitano guadagna la medesima larghe zza, ma la lunghezza di 300 v . resta sempre la stessa senza cambiamento alcuno, giustamente come in una compagnia di 100 uomini.
Per lo passato si conducevano sulle carra tende e padiglioni per gli ufficiali e per i soldati, i quali eran o poi stesi n el luogo dove si campava, ma ora sono riformati, perché vi si trovan o molte incommodità, e particolarmente questa, che sotto tali t ende i soldati non s i potevano ben diffendere dalla pioggia e dal freddo, e però in luogo di tende si fanno baracche, le quali ciascun soldato fatica di per sé, e bisogna che i paesani dei luoghi circonvicini somministrino la legna e la paglia per farle. Nel fabbricar le baracche bisogna osservare che non si tocchino insieme, ma vi sia intervallo fra l'una e l'altra, accioché tutte le baracche non abbiano a correr pericolo in caso che per disgrazia o per negligenza venisse un fuoco, perché qu ando le baracche che abbruggiano sono separate dall' altre si posson o sub ito tirare a basso e disfare e spegn er il fuoco che resta, ma quando }'altre sono congiunte a quelle che ardono, può facilmente il fuoco attingerle tutte insieme nell'ordine che stanno, sendo che senza questo la paglia è facile assai a concepire il fuoco.
I capitani hann o anche avuto per lo passato i loro propri padiglioni ma poiché trovano più utilità nelle baracche gli hanno riformati e fanno fabricare baracche per loro et adoprano i padiglioni per cuci na e per gli stalli dei cav alli.
4. Il piano d'una compagnia di 100 uomini è qui rappresentato nella figura A, dove A-B e C-D è la lun ghezza della compagnia, 300 v.; A-Ce B-D, 24 v., è la larghezza, e fra questi confini alloggia la gente. Da A sino a G e da C sino ad H l'allogg iame nto del capitano, lungo 40 v. e largo 24 v.; da G sin in a e da H sin in d è una strada libera di 20 v. , tra il capitano e le baracche dei soldati. Da a sin b e da d sin e sono 200 v., dove sono fabbricat e le baracche de i soldati, le quali hanno due file, la loro larghezza è ae fd bn oc, ciascuna 8 v.; fra le baracche è una strada ef no , larga 8 v., fra le baracche dei soldat i e quelle dei vivandieri è uno spazio di ck lungo 20 v., largo be ik 24 v.; le baracche dei vivandieri stanno fra il km, la qual piazza è lunga 10 v.; 1B mD sono anche 10 v., il qu al luogo è lasciato per la cucina dei vivandieri 215
Il Vel tzé salta l' intero par. 4


5. Ora, quando si s a quante compagnie ha un reggimento e quanto forte sia ciascheduna compagnia, si può, dalle cose dette d'una bandiera, facilmente calculare quanta piazza bisogni dar in larghezza ad un reggimento intiero, perché, se il reggimento ha molte compagnie e ch'elle sien forti, ha necessariamente da far più file e p erò gli bisogna maggior piazza; ma s'egli è de bile fa manco file e gli bisogna minor piazza. Ma sia un reggimento tanto forte o tanto de bile eh' egli si vogl ia, non si dà mai ad alcuno in lunghezza più di 300 v., ma la larghezza si va cambiando secondo che il reggimento è più forte o più debole, come s'è detto.
Al colonnello tocca il suo quartiero nel mezzo del reggimento s uo, et ha da tutti e due i lati numero eguale di compagnie quando il reggimento è composto di compagnie in numero pari, ma s' elle sono di s.pari, bisogna nec essa riamente che da un lato sia una compagnia piu che dall'altro. La larghezza del suo quartiero è 68 v. e la lunghezza è 40 v., come qu ella dei capitani ordinari, poiché la strada trasversale de ve essere lasciata per tutto eguale e la lunghezza di 300 v. rimaner sempre immutabile come più volte s'è detto. Fra l'alloggiamento del colonnello et il luogo dov e incominciano le baracche dei soldati si lascia nell'ordine già cominciato la strada di 20 v ., poi rimane uno spazio lungo 200 v. eguale alla lunghezza do ve stanno le baracche dei soldati e largo 68 v. ; que sto spazio si divid e in due parti eguali, ciascheduna di 100 v .; la parte dinnanzi è occupata dall e baracche necessarie fabbricatevi, ma la parte di dietro è lasciata libera p er i carri di bagaglio del colonnello e d'altri ufficiali. Nella parte dinnanzi, a canto alla quale incominciano le baracche dei soldati, si dà al tenente colonnello uno spazio largo 68 v. e lungo 40 v. come al colonnello, et il restante di detta parte innanzi si dà all'altre persone dello stab2 16 , ma che però tra il lor alloggiamento e quello del tenente colonnello sia lasciata una strada di 10 v . Le compagnie si pongono parallele l'una accanto all'altra e fra di loro è lasciata una strada larga 8 v. su la quale però non riguarda porta nissuna, ma le baracche stanno quivi colle spalle voltate l'una contro dell'altra, accioché le compagnie sieno p er detta strada separate e divise d'insieme. Fra il padiglione del colonnello e quelli dei capitani, sì come anche fra il t enente colonnello e le baracche dei soldati, è lasciata d'ambe due i lati una strada di 8 v., et anche i capitani fra loro vengono separati similmente da una strada larga 8 v. Le baracche dei vivandieri non hanno alcuna strada nella lunghezza, ma giac-

ciono parallele alla larghezza di tutto il reggi mento nella distanza già accennata di sopra.
6. Sia per essempio nella figura A il piano di un reggimento di sei compagnie, e ciascheduna compagnia di 100 uomini, che faranno in tutto 600 uomini. Per loggiarla secondo la regola data si conta primieramente che cosa debba avere questo reggimento in largh ezza, perché la lunghezza è già cognita, e senza mutazione si ritiene di 600 v . Ciascuna compagnia occupa in larghezza, con le baracche e con la strada, 24 v. ; sei vo lte 24 fa 144 v. Oltre di questo, si deve fra ciascheduna compagnia far una strada larga 8 v ., sì come anche vi è una strada fra le baracche del colonnello e del tenente colonnello e fra qu elle dei capitani e dei soldati, ciascheduna larga 8 v. da ciascun lato, sì che vengono ad essere sei strade, che fanno in tutto 48 v., ai quali aggiunta la larghezza degli alloggiamenti del colonnello, 68 v., ne viene BO AN la larghezza di tutto il r eggime nto: 260 v. Li sei quadrati segnati 9 significano i padiglioni o baracche dei capitani, D è la strada fra l'alloggiamento dei capitani e quello dei so ldati, nella quale si usa di piantar le insegne in linea retta e di drizzar lunghe stanghe che stiano in piedi e trasversali, alle quali possano i soldati appoggiar le lor arme, cioè picche e moschetti, e sotto a queste stanghe, alle quali stanno appoggiate le picche, si fanno pozzi per attinger acqua21 7 •
7. Il quartiero dei vivandieri, i quali fanno le loro baracche e cucine lungo il reggimento, né v i lasciano strada alcuna fra mezzo. E la strada fra detti v ivandieri e le baracche dei soldati ( 0 ); e il quartiere del colonnello, largo 68 v . (E), e il quarti ere del tenente co lo nne ll o, dell'istessa lungh ezza, e largh ezza (G). Qui sono alloggiate le altre persone dello stab (H), e un luog o vuoto per le ca rra di bagaglio del colonnello e degli altri ufficiali (F) 218 •

II . Per la cavalleria si fanno ordinariamente quartieri particolari a parte, per ovviare a molti inconvenienti che sogliono nascere quando ella alloggia insieme con l'infanteria.
1. A ciaschedu na cornetta di cavalleria s i dà 300 v . di lunghezza e la larghe zza si varia secondo che la cornetta è forte o debile

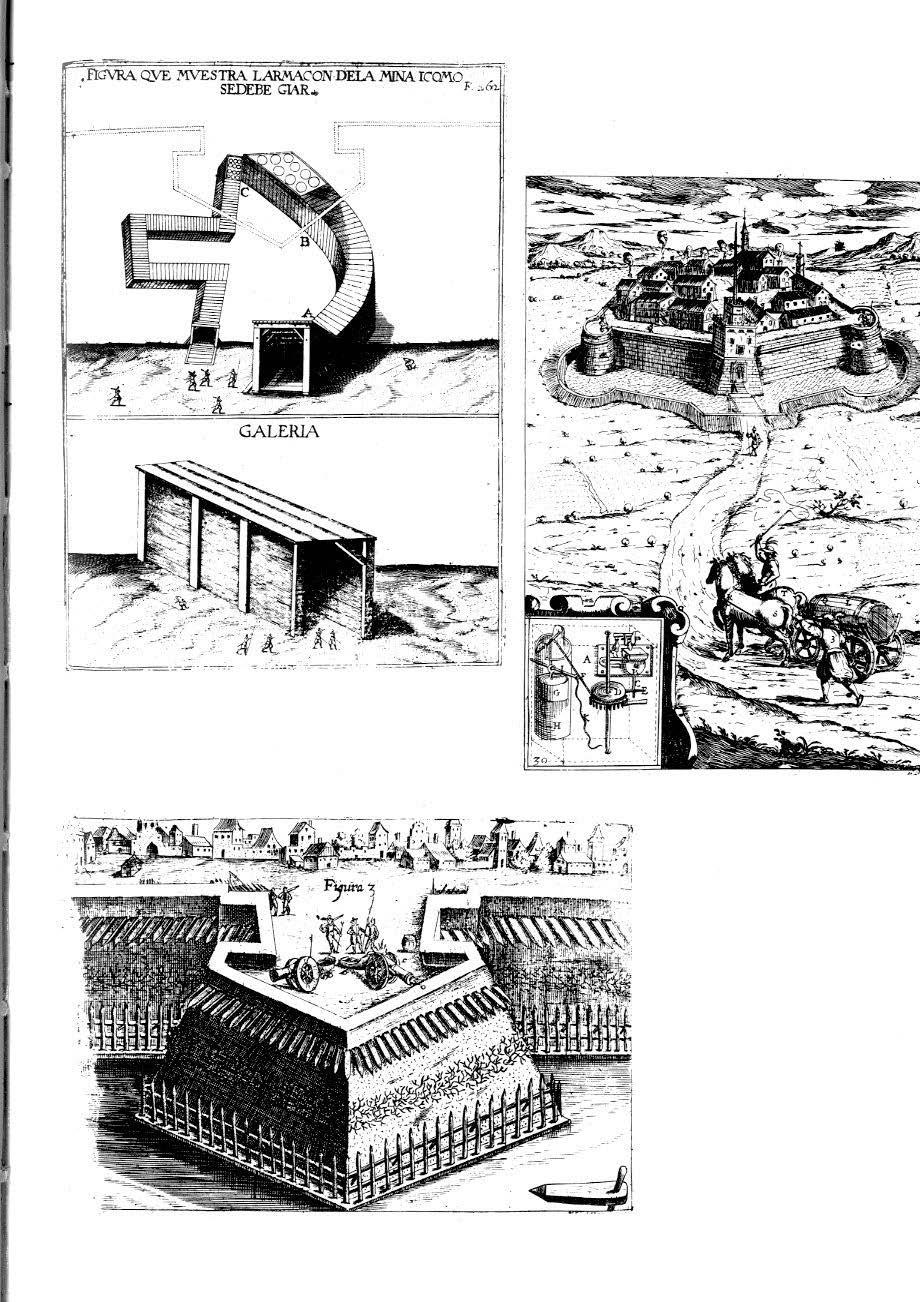
di gente; quando ella è forte di 100 uomini, se gli dà una lunghezza come detto et una larghezza di 10 v., nel qual e spaz io devono alloggiare questi 100 uomini. Al capitano si dà per sua piazza 10 v. di larghezza e 40 v. di lunghezza, la quale si misura e si ribatte dalla lunghezza di 300 v.; fra il capitano et i soldati re sta una strada di 20 v. Poi si ripartiscono le baracche dei cavaglieri, per i quali è lasciata una lunghe zza di 200 v . dove sono ordinati in due file, per cui è data la larghezza di 20 v.; da ciaschedun lato si danno 10 v. per la larghezza delle baracche, poi rimane una picciola v ia di 5 v. dove i cavaglieri posson9 uscire dalle baracche. Poi si danno da ciaschedun lato 10 v . per i cavalli, sì che viene anche a restar nel mezzo una st rada larga 20 v., e poiché la cornetta è forte di 100 uomini, vengono ad esse re ogni lato 50 cavalli, e così viene ciaschedun cavallo ad avere per sua stalla 4 v. di lunghezza e 10 di larghezza, e tal piazza ha anche ciaschedun cavagliere.

Fra i soldati et i vivandieri è lasciata vuota una piazza di 20 v . per le medesime ragioni che si danno nell'infanteria, poi seguono le baracche dei v iva ndieri, per le quali si dà una piazza della larghezza di tutta la cornetta, cioè larga 20 v. e lunga 10. La lunghezza che rimane, di 10 v., è per la cucina, e così questa compagnia occupa in lunghezza 300 v. et in larghezza 70.
Quando una compagnia è più forte di 100 uomini, fino a 140 se gli dà in larghezza una fila di più, sì che vengon ad essere tre file di baracche , ma quest'ultima fila si aggiunge all'altre così che fra !'alt re baracche e i cavalli di questa nuova fila sia lasciata una strada di 10 v., poi s i dà come prima 10 v . per questi cavalli, 5 v. per la picciola v ia e 10 per le baracche dei soldati, e così una cornetta di 140 uomini verrà ad avere 105 v. di larghezza, perché prima le due file hanno avuto ?O v ., et ora vi si aggiungono 10 v . per una strada e 5 per l'altra picciola, e per i cavalli e per i cavaglieri insieme 20 v., che fanno 35, i quali aggiunti ai 70 fanno 105 v. la larghez za di tutta la cornetta; ma la lunghezza rimane la medesima.
I cavalli si fanno stare con le teste verso le baracche dei soldati, accioc hé i soldati possano subito avere alla mano il cavallo quando bisogna, né abbiano a far gran giro. Quando c'è spazio abbastanza, ché la compagnia non è totalmente completa, non solo si lascia un po' d'intervallo fra ciascheduna baracca, ma anche fra ogni cin que o sei baracche si lascia una strada larga 6 od 8 v., per la quale si può camminare per la larghezza di tutto il reggim ento. Le baracche che qui si fabbricano non hanno gran differenza con
quelle dell'infanteria, solo che queste hanno 8 v. di larghezza, e quelle ne hanno 10, perché si danno 2 v. in più ai cavaglieri per cagione dell'armatura, che occupa più spazio di quella dei fanti . . Dell e due baracche dinnanzi, una ne piglia il tenente e l'altra la cornetta, e delle due dietro una ne piglia il quartiermastro e l'altra un caporale . Fra le baracche e la picciola via si fanno greppie per i cavalli, le quali si fanno con tavole connesse insieme, ovvero, prima che si possano avere le tavole, si piantano pali in terra, e da un palo all'altro si stendono drappi di tela, che si chiamano drappi da greppie, et accioché i cavalli non si battano nella greppia n é si mordano o facciano danno si separano con stanghe ch e si mettono di traverso fra loro.
Quando si pianta un campo che si stima dover rimaner lungo tempo, si fanno anche baracche per i cavalli accioché non stiano sotto il cielo scoperto, massime quando piove o fa gran caldo o gran freddo, e queste si fanno di paglia come la baracche dei cavaglieri, ma però aperte dinnanzi e di dietro accioché possano uscire e che i cavaglieri dalle loro baracche possano sempre vedere i cavalli et averci l'occhio sopra; e sono coperte di sopra e dai lati, ovvero si fanno di tela doppia di quella [con] che si usano fare i padiglioni.
2 . Il piano di una cornetta di cavalleria sta nella figura (j tra i confini segnati ABCD, AD v s è la piazza del capitano, larga 70 v. e lunga 40; vasg è la strada fra il capitano et i soldati, abgi è la lunghezza, dove stanno le baracche dei cavaglieri, 200 v., ak bEpGhi è la larghezza delle baracche dei cavag li eri , 10 v ., kfe doplh è la picciola via fra le baracche dei cavaglieri, larga 5 v , mngr è l a strada di tutta la compagnia fra i cavalli, larga 20 v., buti è la strada fra i cavaglieri et i vivandieri, larga 20 v., tBCu è la piazza per i vivandieri, lun ga 20 v., l a metà della quale più propinqua alle baracche dei cavaglieri è per l e baracche dei vivandieri , e l'altra metà è per la cucina21 9
3. Quando si sa come ha da loggiarsi una compagnia di cavalli, si sa anche come s'abbia da ordinare la piazza per un reggimento intiero, osservando solamente che ciascheduna cornetta di cavalleria dev'essere separata dall'altra con una strada larga 20 v ., e ch'elle devono esse r e collocate tutte l'una accanto all'a ltra parallele. _ Al colonnello non si dà piazza maggiore che ad un semplice capitano .

(Intendi nel servizio degli olandesi, dalle cui regole come dalle migliori e che hanno grandissima similitudine con quelle degli antichi Romani, s'è tirata questa castramentazione, la quale se si vuole ridurre ai colonnelli di gente allemanna, si può assignar loro piazza molto maggiore che ai capitani, sì come s'è mostrato per i colonnelli della fanteria, perché egli non vien nominato colonnello per il soldo che se gli dia più che ad un altro capitano, ma solo per la carica che gli è imposta durante la campagna, cioè d'avere sotto al suo comando tre o quattro o più cornette, per poter tenere miglior ordine, ma in questo egli è differenziato dagli altri, che gli si dà il posto di mezzo come più onorato).
4. Sia per essempio nella figura tJ rappresentato -un reggimento di cavalleria che ha tre cornette, e ciascuna cornetta di 100 cavalli, quivi sono fra ciascheduna cornetta le strade che le separano, ciascuna larga 20 v.; ora, ciascuna cornetta ha 70 v. in larghezza, che fanno insieme 210 v., ai quali se si aggiungono le due strade che separano le compagnie, ciascheduna di 20 v., verrà il reggimento ad essere secondo le date regole immutabili AFBE 250 v. in larghezza, et ABFE 300 in lunghezza 220 •
III. Vengono ancora più luoghi e più quartieri speziali daripartirsi nel quartiero generale, come è il quartiero del capitano generale, quello del generale dell'artiglieria, quello dei carri, dei forestieri et altri.
1. Al capitan generale si dà una piazza quadrata, come s'è detto dei reggimenti, la quale ha 300 v. di lunghezza e 600 di larghezza, dove i padiglioni e le baracche per il generale e per la sua gente sono ripartiti secondo il bisogno.
2. Il generale dell'artiglieria ha una piazza lunga 300 v. e larga 480, nella quale si collocano tutte le cose necessarie et appartenenti ali' arsenale, et anche gli ufficiali del cannone .

3. Per la polve e per altre materie da fuoco che facilmente s'accendono, si fabbricano gran ridotti quadri ovvero oblunghi, e questi si ricoprono con coperte di setole, le quali servono contro alla pioggia e contro al foco, perché non sono sì accendibili come la paglia e la tela.
22o Il Velt zé sal ta l' inte ro par. 4.
4. Per gli ufficiali di tutto il campo, i quali non costumano d'alloggiar appresso i reggimenti, si dà una piazza lunga 300 v. e larga altrettanto.
5. Le carra si collocano anche in un luogo a parte, accioché non sieno d'impedimento nel caìnpo, e se gli dà 300 v. in lunghezza e la larghezza si regola secondo la quantità delle carra.
6. Al mercato, cioè dove alloggiano mercanti, osti, artigiani, macellari e fornari, si danno 300 v. in lunghezza e 400 in larghezza, e questo si tiene vacuo nel mezzo, sì come appartiene ad una piazza di mercato, ma nei lati si ripartiscono baracche e strade, e vi sono ordinariamente 8 file di baracche, quattro delle quali si collocano da un lato e quattro dall'altro, e per ciascheduna baracca si danno 10 v. di larghezza, e poi si lascia una strada fra le due file larga 20 v. Le due prime file più propinque alla piazza del mercato si danno ai mercanti di seta e d'altre mercanzie di valore, le seconde si danno agli osti e tavernieri, le terze agli artigiani, le quarte ai macellari e fornari .
7. Si ritiene anche sempre una piazza v uota per le persone forestiere che arrivano, le quali si possono alloggiar quivi; questa non ha misura alcuna determinata, e si cambia facendola più grande o più picciola secondo che la commodità e che il bisogno richiede.
E questa è la descrizione del quartier gen e rale in particolare, e degli altri quartieri speziali in genere, e si de ve sapere che tutti i reggimenti e quartieri speziali non si mettono insieme indifferentemente e senz' ordine, ma ci è una misura determinata che li separa et ordinariamente si lascia sempre una strada di 50 v. fra ciaschedun reggimento et anche fra ciaschedun quartiero speziale.
IV. Prima che si pianti il ca~po in campagna è necessario:
1, avere misurato la piazza dove si deve accampare l'essercito.
2, av er dissegnato sopra la carta il suo piano e la sua situazione.
3, sapere tutti i quartieri che vi si vogliono fare, non solo in genere, ma anche in spezie la grandezza di ciaschedun reggimento tanto a piedi quanto a cavallo, cioè quante compagnie abbia un reggimento e quanto forte sia cias cheduna compagnia.

4. saper quanto grande vuol il capitano generale aver il suo quartiero e quanto il generale dell'artiglieria e quante altre persone generali vi sieno, et in somma bisogna prima avere ordinatamente descritto e sopra la carta specificato ogni pezzo et ogni pa rte che si vuol avere nel campo, e datola al quar tiermastro, ovvero ingegnero generale, che ha la carica di ripartire e di piantar i quartieri . Dopo, l'ingegnero rapporta tutti i quartieri sulla carta e d issegna tutto il campo giustamente nella forma siccome deve essere pianta t o nella campagna .

Ma quando non si potesse misurar innanzi la piazza et il sito della campagna per cagione del pericolo o d'altro impedimento, bisogna aver dissegnato sopra la carta va r ie forme di campi, accioché poi da quelle secondo la qualità del luogo si possa eleggerne una che vi si accomodi al meglio, né abbia per questo a nascere alcun impedimento o disordine quando si vuole trasportare in campagna.
V . S'ab bi a per essempio da formar un campo composto di 6 reggimenti a piedi et un reggimento di cavalli, nel quale si hanno an che a r ipartir tutti gli altri quartieri speciali .
1. Bisogna calcu lar la piazza di ciascun reggimento e d i ciaschedun quart iero d i per sé in questo modo: il reggimento A h a 8 compagnie, fra le q u ali ciascheduna delle 7 ha 100 uomini, e la ottava ne ha 150; così viene ad avere in lunghezza 300 v . et in larghezza 349 v. Il reggimento B ha dieci bandiere, ciascuna di 100 uomini, e però contiene 300 v. in lunghezza e 388 v. in larghezza. Il reggimento C ha 12 bandiere ciascuna di 150 uom in i, e però ha 300 v. d i lunghezza e 644 di larghezza. Il reggimento D ha 7 bandiere, ciascuna di 100 uomini, e però ha 300 v . in lunghezza e 292 in larghezza. Il reggimento E ha 8 bandiere ciascuna di 100 uomini, e però ha 300 v. in lunghezza e 324 in larghezza. Il reggimento F ha 16 bandiere ciascuna di 100 uomini, e però ha 300 v . in lunghe zza e 580 in larghezza. Il reggimento di cavalli G ha 4 cornette ciascuna di 100 uomini, e però ha 300 v . in lunghezza e 340 in larghezza . Il cap itan generale ha il suo quartiero H largo 600 v . e lungo 300. Il generale dell'artig lieria ha il suo quartiero I largo 480 v. e lungo 300. Il mercato K è largo 400 v . e lungo 300 Il quartiero degli ufficiali L è largo 332 v. e lungo 300 Il quartiero dei forestieri e gente che arriva N è largo 400 v. e lungo 300. Il quartiero delle ca r ra M è largo 298 v. e lungo 300.
2. Dopo che ciò è sc r itto e notato in q u esto modo, bisogna disegnar sulla carta il piano di tutto il campo, per poter poi rapportar e piantare in campagna, e però, presa una scala grande o picciola secon d o che si vuol avere i l dissegno, si dissegnano sopra la ca r ta alcùne linee morte parallele, così che le due prime siano tirate in distanza 300 v . l 'una dall'altra, poi sotto se ne tira un'altra parallela in distanza di 50 v., e sotto questa, u n'altra i n d istanza di 300 v., e dopo un'altra parallela di 50 v ., e così l'una dopo l'altra, e la distanza di 300 v . denota la lunghezza dei quartieri, e li 50 v. denotano la st r ada che si lascia fra u n reggimento e l'altro, e fra un quartiero e l' altro, come si vede dalla figura 1:. Fatto q uesto , si disseg n a anche sopra una carta particolare ciascun reggimento e ciascun q u artiero spezia l e di per sé giustamente, secondo la scala conforme alla quale si son tirate le linee parallele, e poi si tag l ia l a carta nella lunghezza e la r ghezza che deve avere il reggimento o il quartiero dissegnatovi (s'avviene meglio che questa carta sia soda, come cartone o carta incollata o carte da gi u ocare), e sopra q ueste cartucce misurate scrivesi la lunghezza e larghezza et il nome del reggimento o del quartiero che ciascheduna denota e ciò si fa con tutti i quartieri, poi si mettono questi quartieri tagliati e queste parti fatte sopra la carta dove sono state ti r ate le l inee parallele, e si rimira com'elle vi s'adattino e vi si aggiustino; quivi si lasciano giacere, e se la forma del campo venisse a cadere troppo sparuta e sproporzionata, come troppo lunga o troppo co r ta, v i si può facilmente rimediare coll'allargare o col ristringere divers i quartieri, come quello del cap itan generale, del generale dell'artiglieria, del mercato, delle carra, dei forestieri ecc., e così anche de ll e strade t rasversali che dividono i quartieri nei fianchi, accioché il campo pigli forma convenevole, non essendosi sì strettamente ubbligato ad una prefissa larghezza dei suddetti quartieri e st r ade trasversali che n on si possa qualche poco accrescere o scemare con discrezione, ma per lo contrario i quartieri del l 'infanteria e della cavalle r ia devono necessariamente ritenere la grandezza loro invariabile, né si devono mai alterare .
3. Devesi anche osservar questo nell'accomodare i quartieri tagliati sopra le linee parallele, che i l quartiero del capitan generale venga o r dinariamente ad essere nel mezzo del campo, e che sempre gli si lasci fuori d el quartiero una piazza assai capace dinnanzi e dai lati, come si vede nella figura Il , dove il capitan generale ha il suo alloggiamento in H e rimane alla piazza Q larga 342 v. e lunga


340, e dai lati rimane la piazza O, larga 200 v . da ciascuna parte. Che gli ufficiali generali, forestieri e compagn ie di guard ia sieno alloggiati a canto a lui e dai lati, e dietro a lui vengano ad essere il quarti ero d e ll'arti glie ria, il mercato e l e carra. Che int orno a queste sia l ogg iat a la cavalleria, e nella parte est r ema l'infanteria. Che i quartieri sieno se parati con una strada di 50 v., la q uale si fa anc h e t alora del doppio, come è qui P fra il mercato e la piazza che è la scia t a per gli avventurieri.
4. Applicati che si hanno tutti i quartieri tagliati sopra le linee paralle le, si misura tutta la lunghezza e tutta la larghezza del quartier generale, e si not a; qui nell 'essempio tutta la lun g hezza di detto quartiere è quattro vol te 300, e tre strade ciascuna di 5 0 v., che fanno insieme 135 0 v . d i l unghezza e 1656 di larghezza.

VI. Ora, quando si vuol fo rmar e in ca mpagn a e piantare un tal ca mp o, il qual è disseg n ato, co me s'è detto, sopra la carta, con tutti i suoi quart ieri e le sue parti, si può fare fac ilissimamente co n l'aiuto di una cate n a da misu rare ripartita in pi edi, e d'uno st rumento ordinario p er pigliar gli angoli u sa to n e lla forti ficazi one, ovve ro d'una semplice squadra o del trian&olo pitagorico (poiché tutto vien a cadere in angolo retto) e di piu bastoni da quarti ere, che sono lun gh i da 9 o 10 v., signati di colo ri e di sopra hanno una band er uola.
1. Qu ando s'è arrivato n el luogo dove il quartiere deve esse re piantato, si fa primi e ramente il ci rcuit o univ ersale del campo e de l quarti er general e con le quattro lin ee estreme, sì che in ciasc h edun canto del quartiero venga un angolo retto; ora, mentre c he qu este quattro linee estrem e sono mi surate, si piantano in capo a quell e quattro bastoni ordinar i da quartiere, e poi si procede a piantarvi di mano in man o a ciaschedun quartiero a part e, nel modo ch'egli è stato dissegnato sopra la cart a, ma accioché non si erri o si sbag li nel piantar i bastoni, si sc rivono numeri sop ra le ca rtu cce di ciascun quartiero sp e zial e, e quei m edesi mi numeri s i dipingono o s'int ag liano sopra i bastoni c he serrano i confini di detto quartiero, ed è ben fatto che sempre s'abbiano insieme quattro e quattro bastoni di un medesimo numero, i quali si possono ·anch e poi di scerne re per l a banderu ola quand o fossero di un medesimo colore. Tutto questo si vede nella figura c•, dove i punti rappresentan o i bastoni dei quartieri, i quali so no dissegnati in piano nella figura 1) .
2. Quando tutto ciò è fatto e ciaschedun quartiere speziale e reggimento ha i suoi confini, allora ciascun quartiermastro lo ripartisce al suo reggimento secondo il piano dissegnato nella figura A, ma però secondo la quantità delle compagnie, e per ciò s'adoprano lunghe corde l e quali s'an nodano nei quattro bastoni del quartiere, dinnanzi in due, e dietro in due. A lungo di queste corde si misura (secondo il dissegno del piano) la larghezza per le baracche e per le strade, sempre di 8 v. in 8 v., et in ciascun capo degli 8 v. si piantano corti pali in terra, e ciò si fa da tutte due le parti, e così il colo nn ello viene a giacere nel mezzo, come dimostra il dissegno del piano . Ma detti pali non si piantano nelle linee estreme del reggimento; ma prima è misurata e battuta dal quartiermastro dinnanzi e di dietro la distanza della piazza che appartiene ai capitani, la distanza della strada che è fra i capitan i et i soldati, e finalmente quella che è fra i soldati e i vivandieri, e poi si piantano i pali.
3 . Quando il quartier mastro ha fatto questo, allora egl i dà il ripartimento delle baracche ai sergenti o furieri, i quali legano corde nei pali piantati e fra quelle ripartiscono le baracche e le strade, e ciascheduna baracca ha ancor ella i suoi confini i quali sono terminati e dimostrati con quattro legn etti piantativi; e così si ripartisce tutto il reggimento. Con gli altri quartieri della cavalleria, dell'artiglieria e degli ufficiali si procede nel medesimo modo.
4. Int orno al generai quartiero si lascia da tutte le parti uno spazio parallelo largo 200 o 250 v., che si chiama la piazza d'arme, dove i soldati si possono radunar e mettersi in battaglia, et oltre di questo si pigliano ancora 6 o 7 v . di più, sopra il qual sp azio si l eva una trinciera o circonvallazione, c h e fascia il quartiero.
5. Il quartiere si fortifica attorno attorno con ridotti et altri travagli della fortificazione, secondo che si giudica necessario ecome s'è diffusamente discorso nella fortificazione regolare et irregolare nella Pecorina n. I e n. Il, e s i deve osservare d'occupare e di pigliare tutti i vantaggi che sono presentati del sito, perché spesse volte occorre che si ha da vicino un fondo o un fosso o un rialto o cos'altra simile che non si stima, dove in ogn i modo è di molta importanza il levarla al nemico.
E dove la natura del sito è manchevole, bisogna supplire col1' arte . Si lasciano anche aperture nelle trinciere sì larghe che 5 o 6

cavalli vi possano uscire di fronte, le quali però si ricoprono coi lor ravelini, e ciò si fa particolarmente verso la piazza d'arme della cavall eria, nei fianchi, non molto lontano dalla fronte, siccome la cavalleria fa per lo più la sua maggior forza nei fianchi.
La fronte verso il nemico deve essere la prima ad essere fortificata, e per sicurezza maggiore (perch é il nemico potria intraprendere di impedir il travaglio), quando la vanguardia arriva nel cam po ella deve tenersi quivi in batt aglia sin che giunge il co rpo, il quale poi de ve anc he far alto sin che arrivi la retroguardia, e qu esta novamente si ferma in battag li a sin che il trinc1eramento e all'ordine et il campo messo in difesa. Per far il fosso et alzar il parapetto intorno al ca mpo non s'assolda nissun lavoratore forestiero, ma i sol dati stessi devon o senza pagamento alcu no trincierar il quartiero, poiché questo v iene a loro proprio servizio, i quali possono come dietro ad un muro star sicuri et in riposo.
Il travaglio che essi devono fare è assegnato a ciaschedun r egg imento a parte, ac cioché l'un o non sia più aggravato dell'altr o, e si fa co sì: s i misura tutta la circonferenza del quartiero con tutte le sue parti e si conta n o anche tutti i reggimenti insieme quante ce ntinaia d'uomini fa nno, poi si procede per la regola del tre. Tutta la somma dei reggimenti deve trincierare la circonvallazione di tanti piedi; cosa ha da trincierare il reggimento NN che ha tanti uomini? E quando ciò è calculato, si conducono i reggimenti al travaglio, il quale si ha in qu esta mani era perfezionato in bre ve tempo, poiché ciascuno è dili gente di far presto per poter fabbricare una baracca p er se stesso. E così usasi anche nel servizio dell'Im peratore, contro l'opinione di quelli che st im ano che il campo dovria fortificarsi da i guastatori e non dai soldati, il che, oltre alle altre incommodità, richiederebbe tempo lunghissimo.
6. Le regole suddette di questo ripartimento dei quart ieri son o tirate dalla mani era che si osserva in Ollanda, la quale è st imata la migliore e più puntuale; in Alemagna non si osservano tante minuzie, ma solo dopo che il generale ha mostrato al quartiermastro generale il lu ogo dove vuol camparsi e quanti quartieri si debbano far e, il quartiermastro generale, colla sperienza che ha, giudica sub ito se una piazza è troppo larga o troppo stretta per alloggiarsi e, riconoscendo il sito, proporziona la qualità del luogo alla qualità della gente accioché la cavalleria non ve nga m essa in un lu ogo ineguale e sca broso dove non si possa ben manovr are, né il cannone in un fondo dove si potrebbe aver in un rialto, et accomoda il tutto al meglio che sia possibile.
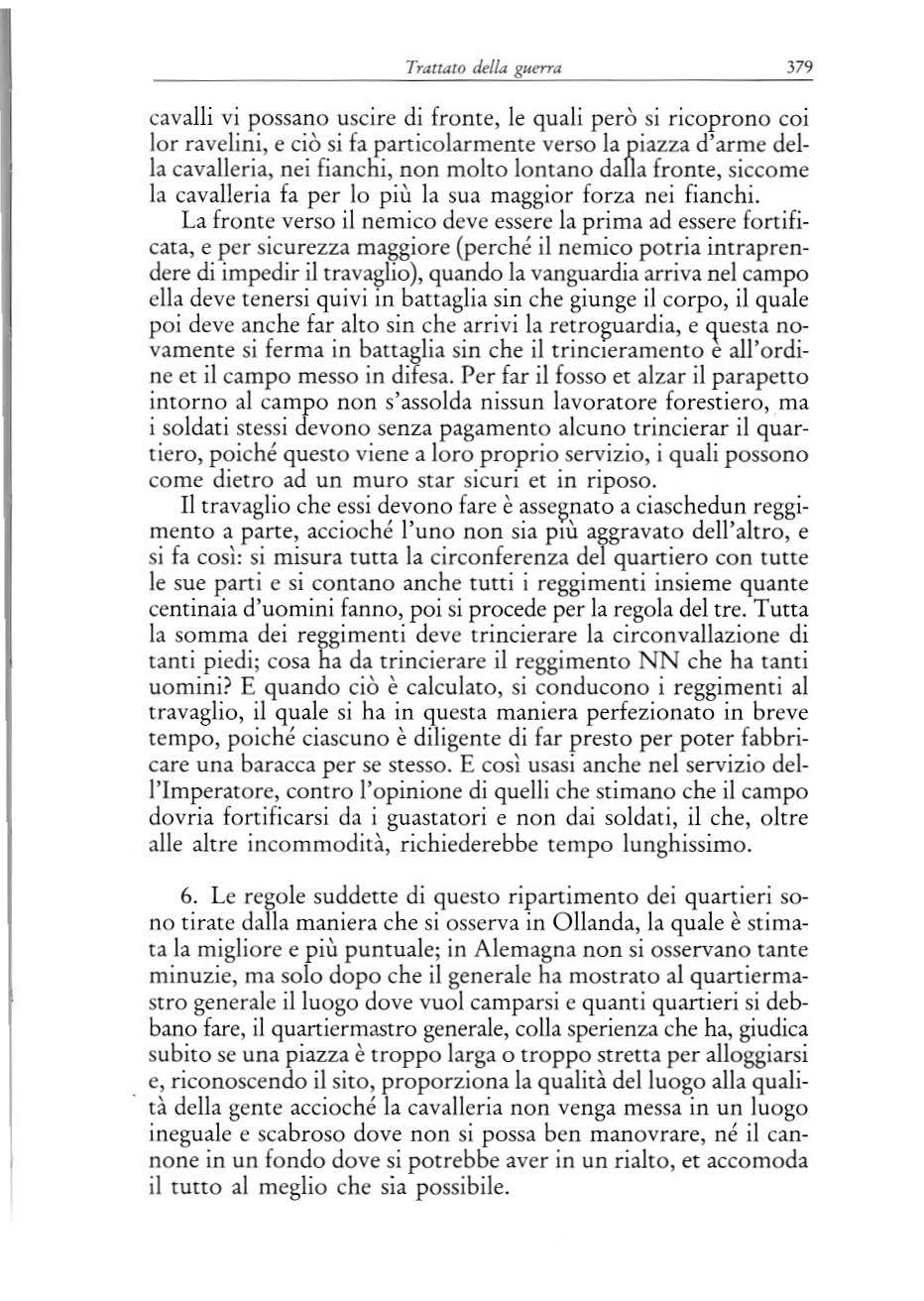
Ha con seco i quartiermastri dei reggimenti, e questi hanno i furieri delle compagnie alle quali fa la ripartizione del piano non già con l'accuratezza olandese, misurandolo con verghe e piedi, né ritenendo sempre una medesima lunghezza et alterando sol la larghezza, ma solo osserva che le insegne vengano a collocarsi dinnanzi in linea retta tutte in una fronte eguale, poi misura la piazza con passi e dà ordinariamente a ciascuna bandiera di fanteria di 300 uomini 20 passi di fronte, ovvero anche 30 quando la larghezza del sito è grande assai, ma quando ella è piccola bisogna anche che si contentino di 15 passi, come fu dato dal Friedland nel campo di Norimberga e da Hatzfeld a Magdeburgo, ecc .; et allora se gli dà più spazio di fondo, che è ordinariamente di 200 passi, perché ordinano di dietro il bagaglio e l'infanteria si alloggia sempre dinnanzi alla fronte verso il nemico, come quella che è più presta e che può essere prima alla difesa delle trinciere se venissino improvvisamente assaltate dal .µemico. La cavalleria s'alloggia dietro all'infanteria, non più lungo che alla metà dei lati, accioché sia in qualche modo coperta, e si danno a 1000 cavalli 300 passi di fronte (che vengono ad essere 30 passi ogni 100 cavalli) e 120 passi di fondo, e dove sono diverse nazioni, le più conosciute si alloggiano insieme. E qualche pezzo di cannone si colloca anche nella fronte e nei fianchi dove si ha sospetto che il nemico potrebbe assaltare, e con essi si mette qualche barile di polvere e qualche palle per poter ricaricare in caso di bisogno.
Occorrono molte cose negli alloggiamenti alle quali si deve por cura.
I. Quanto alle guardie, se n'è già discorso, e si può sol aggiungere che, mentre s'accomodano i quartieri, che la gente vien avanzando, il generale deve fra tanto aver riconosciuto tutto il sito all'intorno e spedite diverse partite e corridori verso il nemico e stabilito dove s'abbiano a posarsi i corpi di guardia e le sentinelle, e guadagnar tempo accioché il campo sia assicurato secondo il bisogno con ogni diligenza possibile.
1. Ai capi si danno tutti li ordini necessari, come e dove si abbiano a mettere in ogni caso d'allarme, che tutti i posti sieno ben reparti e vietata ogni confusione che la notte suol cagionare.
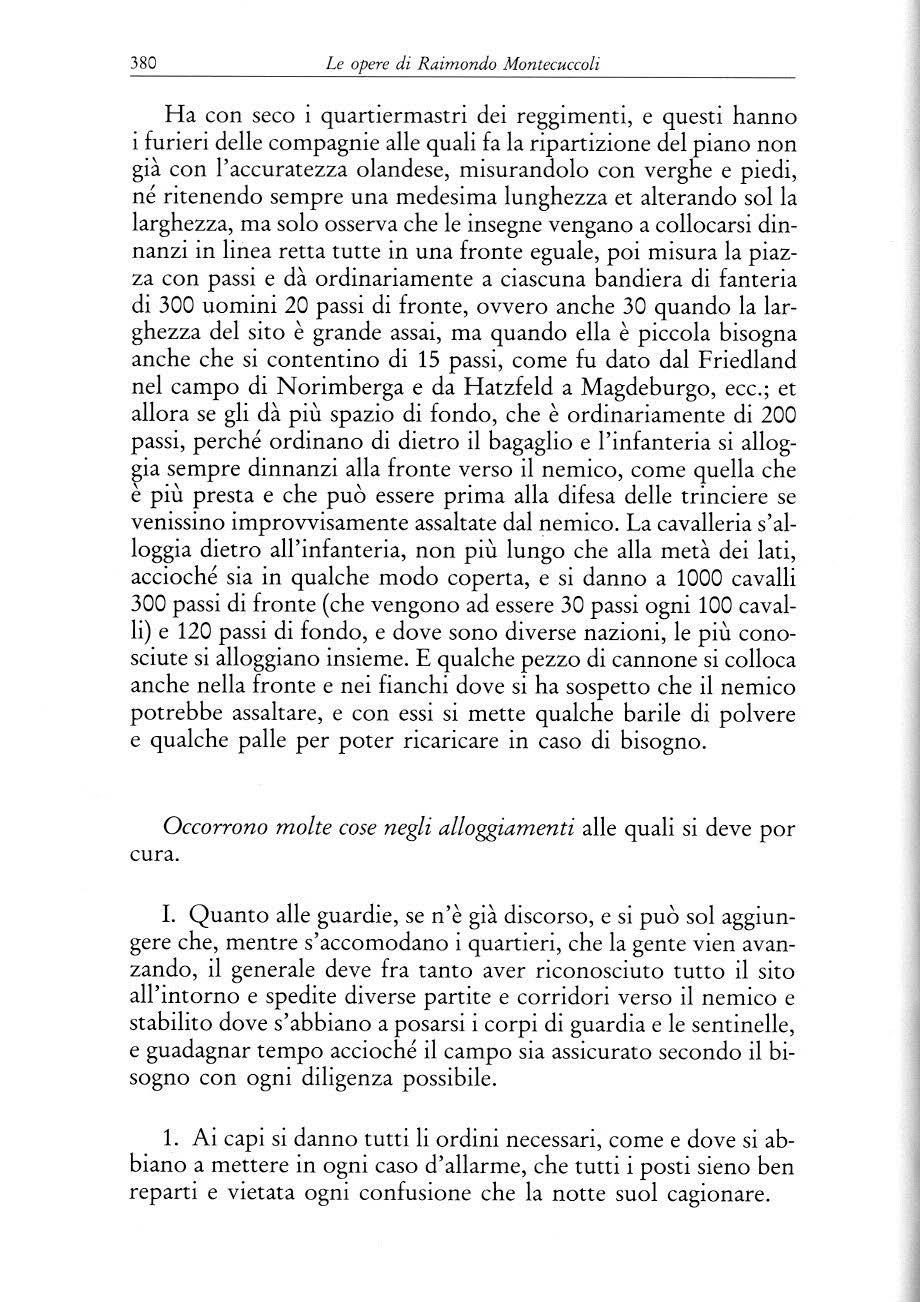
2. Di notte tempo deve tenersi gran s ilenzi o in tutto il campo, e per vietar ogni rumore devesi proibire il bere nell'andare a dormire, e mettere un'ora determinata ai vivandieri dopo la quale non possano più tirar vino.
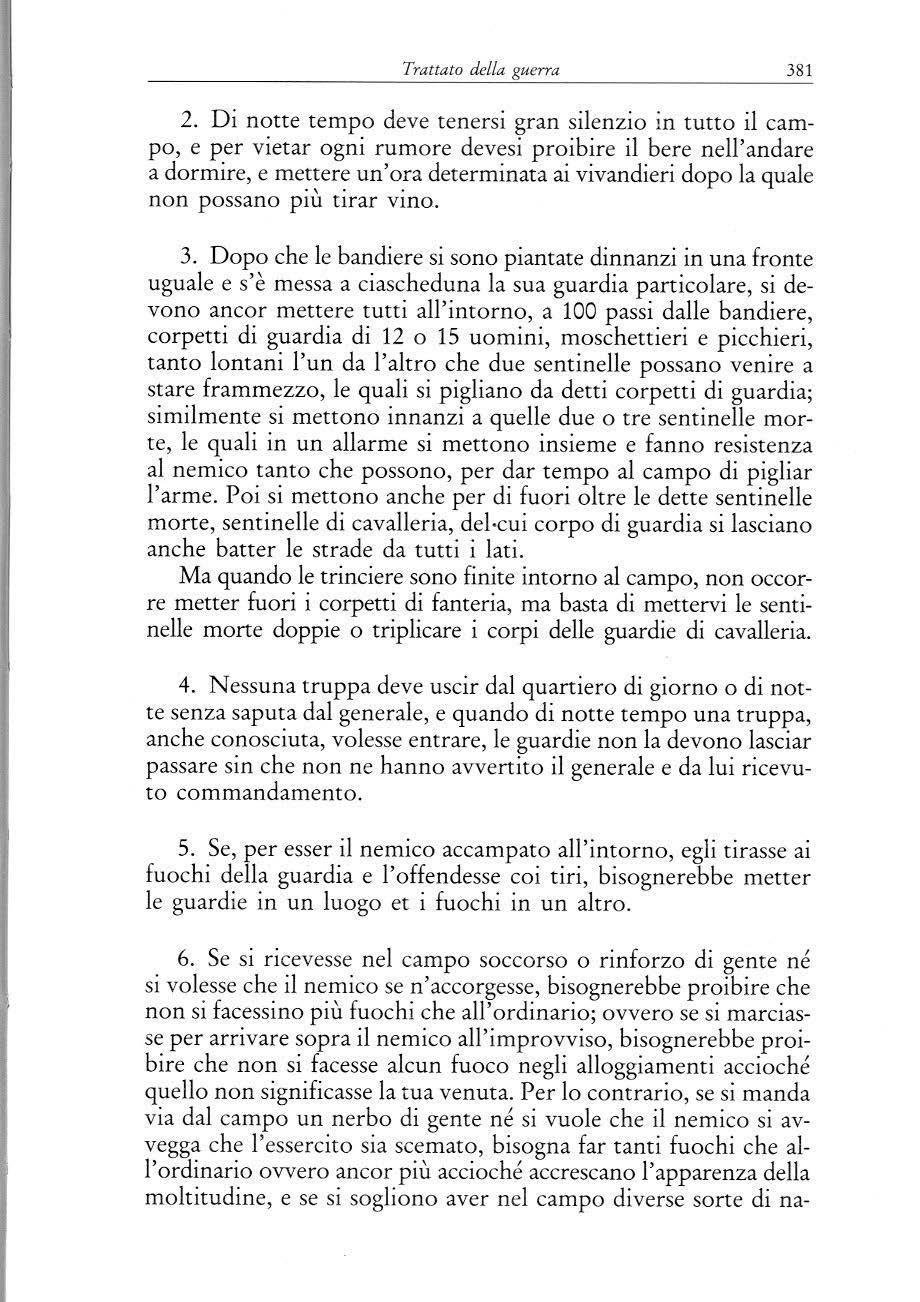
3. Dopo che le bandiere si sono piantate dinnanzi in una fronte uguale e s'è messa a ciascheduna la sua guardia particolare, si d evono ancor mettere tutti all'intorno, a 100 passi dalle bandiere, corpetti di guardia di 12 o 15 u omini, moschettieri e picchieri, tanto lontani l 'un da l'altro che due sentinelle possano venire a stare frammezzo, le quali si pigliano da detti corpetti di guardia; simi lm ente si mettono innanzi a quelle due o tre sentine ll e morte, l e quali in un allarme si mettono insieme e fanno resistenza al nemico tanto che possono, per dar tempo al campo di pigliar l'arme. Poi si mettono anche per di fuori oltre le d ette sentinelle morte, sentinelle di cavalleria, del-cui corpo di guardia si las ciano anche batter le strade da tutti i lati.
Ma quando le trinciere sono finite intorno al campo, non occorre metter fuori i corpetti di fanteria, ma basta di mettervi le sentinelle mort e doppie o triplicare i corpi delle guardie di cavalleria.
4. Nessuna t rupp a deve uscir dal quartiere d i giorno o di notte senza saputa dal generale, e qu an do di notte tempo una truppa, anche conosciuta, volesse entrare, l e guardie non la de vono lasciar passare sin che non ne hanno avvertito il genera le e da lui ricevuto commandamento .
5. Se, per esse r il nemico accampato all'intorno, egli tirasse ai fuoc h i della guard ia e l 'offendesse coi tiri, bisognerebbe metter le guardie in un luogo et i fuochi in un altro.
6. Se si ricevesse nel campo soccorso o rinforzo di gente né si volesse che il nem ic o se n'accorgesse , bisognerebbe proibire che non si facessino più fuo chi che all'ordinario; ovve r o se si marciasse per arrivare sopra il nemico all'improvviso, bisognerebbe proibire che non si facesse alcun fuoco negli alloggiamenti accioché quello non significasse la tua venuta. Per lo contrario, se si manda via dal campo un nerbo di gente né si vuole che il nemico si avvegga che l' essercito sia scemato, bisogna far tant i fuochi che al1' ordinario ovvero ancor più accioché accrescano l'apparenza della moltitudine, e se si sogliono aver n e l campo diverse sorte di na-
zioni che battono le casse o le trombette differentemente, bisogna far battere e toccar nel medesimo modo che sogliono far le genti che mancano, accioché paia che tutto il grosso sia insieme; ma bisogna intanto proibire che persona non si sbandi e che non si combatta se non per diffendersi , per paura che il nemico non facciaci qualche prigioniero il qual scopra la verità , e si fanno anche montar le guardie all'ingrosso et in più numero di quello che è bastante poter tenere, le quali si ritirano poi occultamente dopo esser montate apparentemente. E questo stratagemma si usa anche per ritirarsi di notte in faccia al nemico, eh' eg li non segua, p erché non sapendo la tua debolezza non istima che tu abbia pensiero di ritirarti, e però no n prevedendo a questo, tu marci via sull'oscurità della notte, che non se ne avved e, e quando se n'avvede tu hai già guadagnato molto cammino. Anzi che tal' ora, diloggiando per ritirarsi, si può tirare coll'artiglieria nel campo nemico per mettergli apprensione che si voglia far giornata, accioché intento a mettersi in battaglia e ad occupar i siti vantaggiosi et ad ordinar la gente al combatte re, non sia così presto a seguitarti o a mandar innanzi a tagliarti i passi, sospettando che tu l'atti_ri in sito disavantaggioso o che tu lo voglia cingere o altramente mgannare.
II. Per la conservazione del campo deve il prefetto generale e sue genti pigliar guardia particolare che la piazza d'arme e tutte l'altre piazze dei quartieri sieno tenute nette, e così deve fare ogni prefetto di reggimento. Le necessità corporali si de vono far fuori del campo o a 200 passi dalle bandiere. Gli antichi Romani di nott e tempo , quando non potevano uscire dal campo, le facevano in vasi che portavano poi di giorno a vuotar fuori dalli alloggiamenti.

1. Quando sono molini, castelli o picciole città all'intorno dove si piazza il campo, non molto lontano, bisogna metterv i salvaguardie scritte che li conservino, e se si campa sotto qualche luogo serrato, v i si m ette pur qualche ufficiale di salvaguardia e guar die alle porte, accioché non . lascino entrar alcuno della soldatesca né lascino far ingiurie agli abitanti.
2. Se l'armata è ve nuta per mare, si fanno tirar le navi a terra e si rinchiudono n el campo, accioché sieno sicure né la tempesta possa rovinarle.
3. Qualche volta si dà simulatamente specie di timore co l non uscire alle scaramucce e vietar ogni combattimento, col ritirarsi sempre negli alloggiamenti, col fortificarsi più del solito, col mostrare d'aver poca gente nel campo, col mandar una spia doppia che affermi che il tuo essercito è in disperazione e che dissegna fuggirsene, e co l mandar ambasciatori al nemico facendo vista di vo ler parlamentare di potersene ritornare coll'esercito salvo accio ché il nemico ti pigli in disprezzo, né stimandoti punto venga incautamente e senza ordine quasi più a predare che ad assalirti negli alloggiamenti, et affaticato nel corpo, assottigliato in più parti, impedito dalle fascine e materie che porta per riempir il fosso, ti dia commodità di far una fu rio sa sort ita improvvisa et a tempo fuori di tutte le parti del campo sopra di l u i e di romperlo; ovvero, stimandosi in altra maniera sicuro e stando senza guardie, ti porga pur occasione di andar improvvisamente ad assaltar lui e di romperlo.

4. Per far bene queste sortite improvvise, si fanno venir al campo tutte le forze che si possono avere, ma occultamente e di notte, e s'ordina ai suoi soldati che, ·messi in fuga i nimici, tutti cerchino il generale del nemico e nisuno ferisca o uccida persona prima che lo vegga morto detto capitan generale, accioché stando a bada con gli altri, egli non trovi spazio di fuggirsene, e si promettono anche premi a chi ne riporterà la testa, perché morto il generale si fa poi maggior mercato del resto dell' essercito.
Ma tutta la scienza consiste nell'indurre il nemico a questa negligenza e quest'opinione, eh' egli ti sprezzi né t i tema, e sia reso orgoglioso come co lo ro che, appropinquatisi al campo di Cesare, fecero pubbliche gride che se qualche Francese o Romano vo lesse passare nel loro campo prima dell'ora terza, gli sarebbe commesso senza pericolo, ma che dopo tal tempo non ci saria più stato quartiere; ma non durò guarì l'orgoglio, perché avendo disordinatament e assaltat i gli alloggiament i, furono da una sortita di Cesare disfatti.
III. La cura principale che si deve avere quando si è campato è di sapere mandar a foraggio, nella qual cosa si hanno queste regole:
1. Non deve la soldatesca andare alla spicciolata di qua e di là, errando per il paese, e far preda, accioché non incorrano in qualche st ra ge, perché quella turba disordinata, grave di guadagni
e carica di buttini, non può aitarsi dell'armi n é socc o rrersi scambievolment e , e però chiunqu e v a a foraggio s en z a li c enza dev ' esser punito. Ma quando il general e v i manda, deve mandare coi garzoni e coi foraggieri convuoi di cavalli e di fanti i quali non devono occuparsi n é punto né poco della preda, ma sempre ordinati devono diffendere i foraggieri accioché possino ritirarsi sicuri colla preda al campo.
2. Quando non bastano i con v uoi ordinari pe r assicurar i foraggieri, vi si p o ssono mandare sino l e due parti dell'armata e che la terza rimanga per custodire gli alloggiamenti e p er spalla ai foraggi e ri, ma ciò si de v e fare quando s ' ha il foraggio v icino com e al tempo del mi etere e c he presto si vuol ridurre gran quantità di vi veri nel campo e che non si è tanto discosto dagli alloggiamenti che si possa essere sfor z ato dal n e mic o a combattere contro sua v oglia. Nel Meklenburgo il Princ ipe Mattia di Toscana andava con tutta la cavalleria per conviar i foraggieri 221 •
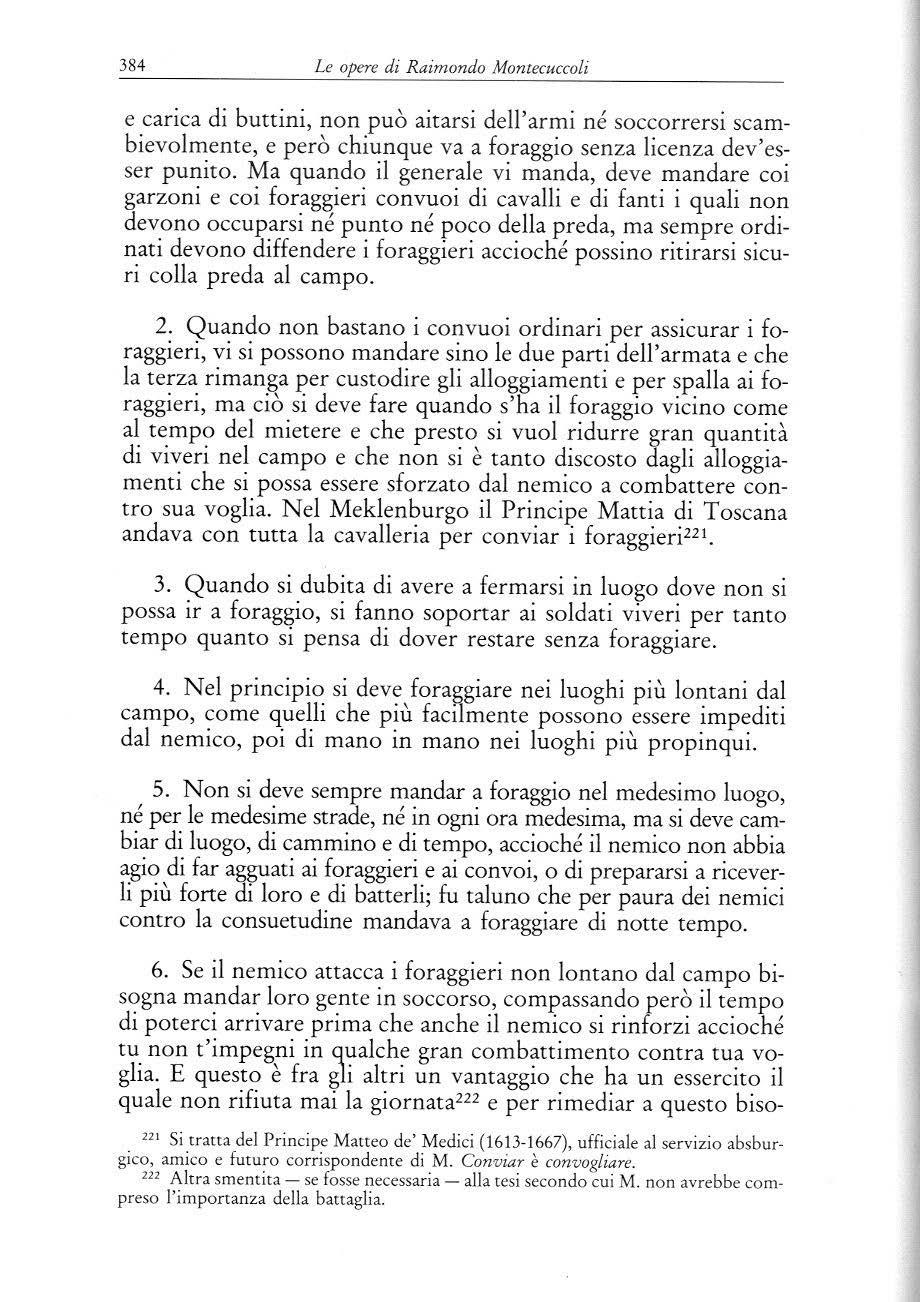
3. Quando si dubita di avere a fermarsi in luogo dove non si possa ir a foraggio, si fanno soportar ai soldati v iv eri per tanto tempo quanto si pensa di do v er restare senza foraggiar e.
4. Nel principio si dev e foraggiare nei luoghi più lontani dal campo, come quelli che più facilmente posson o es sere impediti dal nemico, poi di mano in mano nei luoghi più propinqui.
5. Non si deve se mpre mandar a foraggio nel medesimo luogo, né per le medesime strade, n é in ogni ora medesima, ma si deve cambiar di luogo, di cammino e di tempo, accioché il nemico non abbia agio di far agguati ai foraggieri e ai convoi, o di p r epararsi a riceverli più forte di loro e di batterli; fu taluno che p er paura dei nemici contro la consuetudine mandava a foraggiare di notte tempo .
6. Se il n e mico attacca i foraggieri non lontano dal campo bisogna mandar loro ge nte in soccorso, compassando per ò il tempo di poterci arrivare prima che anche il nemico si rinforzi accioché tu non t'impegni in qualche gran c ombattime nto contra tua voglia. E questo è fra gli altri un vantaggio che ha un essercito il quale non rifiuta mai la giornata222 e p e r rim e diar a questo biso-
22 1 Si tratta del Pr incipe Matteo de ' Medici (1613 - 1667) , ufficiale al serv iz io absbur · gico , am ico e futuro co r risp o nde nte di M . Conviar è convogliare .
222 A lt ra smenti t a - se fosse necess ari a - alla tesi secondo cui M non avrebbe compreso l'im po rtanza della batt agl ia.
gna astenersi di foraggiar in quei luoghi dove il nemico può venir più forte di te, ma foraggiar in quelli dove il viaggio è a lui pericoloso e tener sempre nel campo cavalleria apparecchiata e pronta (ogni volta che è fuori qualche convoi) per poterla subito senza perdere tempo mandar al soccorso se il bisogno richiede .
7. E perché talvolta occorre che la cavalleria che va di convoi, per la consuetudine diviene negligente, il che per lo più suole accadere nelle cose diuturne, il nemico suol pigliare occasione di osservare dov' ella foraggia e con che forza e con che ardire, poi disponendo in agguati le forze maggiori, la tira nell'imboscata e la batte. Che se da qualche spia o fuggitivo s'ha lingua di tal imboscata, si ha bella occasione di attaccarla nei suoi propri agguati e rovinarla o disporre contro di lei una nuova imboscata e mandando il convoi ordinario et i foraggieri ordinari, marciar dopo con forze molto maggiori accioché venendo il nemico per dar sopra ai foraggieri, dia inopinatamente nel grosso e sia battuto.
8. I garzoni, i foraggieri e le carra non si devono mischiar mai col convoi per vietar confusione in caso di allarme, e quando si va a foraggiare lontano dal campo si deve lasciar qualche truppe in guardia fra il campo et il luogo dove si va a foraggiare, perché impediscano che il nemico non venga improvvisamente alle spalle, et accioché servano a potersi ritirare sopra di loro in ogni caso che i primi fossero attaccati; e dove sono avvenute strette per dove può venir il nemico, quivi si lasciano truppette di cavalli e di fanti che guardino.
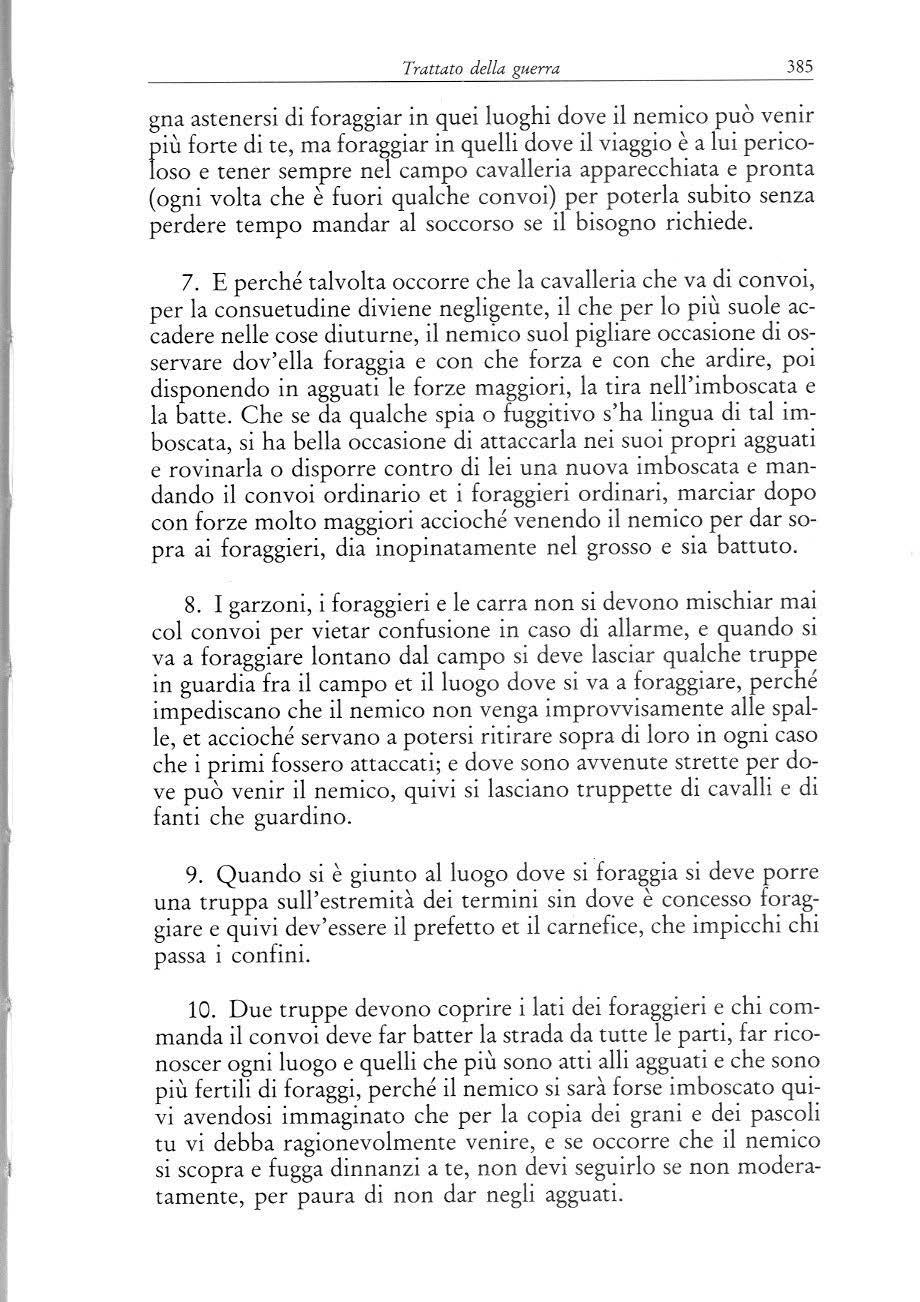
9. Quand o si è giunto al luogo dove si foraggia si deve porre una truppa sull'estremità dei termini sin dove è concesso foraggiare e quivi dev'essere il prefetto et il carnefice, che impicchi chi passa i confini.
10. Due truppe devono coprire i lati dei foraggieri e chi commanda il convoi deve far batter la strada da tutt e le parti, far riconoscer ogni luogo e quelli che più sono atti alli agguati e che sono più fertili di foraggi, perché il nemico si sarà forse imbo scato quivi avendosi immaginato che per la copia dei grani e dei pascoli tu vi d ebba ragionevolmente venire, e se occorre che il nemico si scopra e fugga dinnanzi a te, non devi seguirlo se non moderatamente, per paura di non dar negli agguati.

Del combatt ere
Due sono l'occasioni del combattere. L'una è particolare, c he occorre all e picciol e truppe et anche all e partite gro sse, ma c he tutta l'armata non è insieme, come sono i rin cont ri c h e si fanno il più sovente per accidente e qualche volta di dissegno delib e rato, e co m e so no l e scaramucce c h e si fanno ordinar i amente per attirare, p er intratt ene r e o per riconoscer il nemico . L'altra è general e, che è quando, ven e ndo un 'a rmata a rin co ntrar l'altra, e ll e si danno battaglia ovvero quando un'arm ata imi era attacca per ist ratagemma l'alt r a che non è intiera, o s'ella è intiera, non lascia però di so rpr e nderl a, et arri sc hia ge neralmente tut te l e sue forze .
1. Nel co mbatt e re, sì co me in tutt e l e altre azioni della guerra, eg li è gran d'an alogia fr a le picciole truppe e l e gro sse e fra un nodo di gente e l 'esse r c ito intiero, perché si può dire c h e una squadra non è alt ra cosa c h e una compagnia picciola, et una com pagnia non è a ltro c h e un a grand e squadra; un a co mpag nia è un picciol reggi ment o, un reggimento è u na g ran co mpagnia , un reggim en to è una pi ccio la bri gata, e una bri ga ta è un gran reggime nto; fina lm ente, un a brigata è un a picciol'armata, et una armata è una g ran bri gata. Dalla qual analogia segue che t utto ciò c he s'osserv a nel m arc iare, nell'alloggiar e e nel co mbatt e re di un essercito si pu ò applicare al marciare, all'alloggiare e t al com batt ere di una partita, et anche co ntra, pur che il giudicio di che com manda sappia variare nella varie t à d e l suggetto, e sì com e in un a giorn a ta egli s'è dett o c h e, ve nend o il n emico a caricare, egli è st rata ge mm a di far cede re la parte di mez zo dell a battaglia e qu as i aprirla et int anto, facendo avanzar i corni, cingier il n em ico n ei fianchi,
così anche in una partita quando il nemico viene a caricare si può aJ?rire la truppa sua e pigliarlo nel mezzo a similitudine della forbice contro al conio, il che sanno fare mirabilmente i Svedesi. E siccome in una giornata il rimedio di non esser cinto è di far avanzare i sussidi et i squadroni di riserva in quel lato et contro a quella gente che il nemico ha mandato per attorniarti, così anche in una partita per non esser preso nel mezzo dalla truppa che si apre o bisogna aver una truppa dietro che subito nella carica si spinga sull'ali e l'impedisca, o avendo lo squadrone tutto in un pezzo bisogna che le prime tre file entrino e l'altre tre si fermino a sostenere, ché il nemico non possa girar nei fianchi, il che riuscirà sempre a grande suo disvantaggio, poi che si va già preparato al suo aprirsi; il qual modo si usa anche contro l'Infanteria, perché le prime tre file dello squadrone sostengono la discarica e danno occasione ai moschettieri di scaricar tutti in un tratto sopra di loro, pensando l'Infanteria che sia un squadrone solo; poi, fatta la scarica, l'altre tre file dello squadrone che s'erano fermate hanno b ell' agio di sfondare, e questo vien anche usato da uno squadrone di corazze che carica contro uno squadrone di carabi n e223 • O bisogna che gli squadroni, secondo quello che carica, gli vadino sì attaccati ai fianchi, che glie le guardino, o bisogna che lo squadrone che carica sia già preparato e concertato ad aprirsi in due parti quando vede che il nemico s'apre, per gettarsi da amendue le parti sopra di lui.
Sì che dai precetti che si sono dati dell'azioni di un essercito inti ero si possono facilmente tirare regole per le azioni delle truppe particolari, e contra.
2. Hanno usato alcuni di combattere con armi avvelenate, con palle false ramate, di stagno, quadrate ecc., con fuochi d'artifizio pestiferi e velenosi, ch'infettano l'aere dove s'accendono, le qual cose fra le guerre cristiane sono proibite, e per legge di guerra ai soldati che si servono di palle false non si dà quartiero, o se si dà non si tiene, sì come scrivesi sia successo nuovamente a Zwickau, città presa dal generale di battaglia Borri. E i maestri dei fuochi d' artifizio, nell'insegnare la composizione dei fuochi velenosi, fanno far giuramento che chi gli impara non se ne debba in modo alcuno servire se non contro il nemico commune dei Cristiani, il Turco 22 4.
223 La lentezza di tiro delle ar mi d el tempo non consentiva più di una scarica prima dell 'assalto nem ico.
m Zwick au fu presa nel 1641 dal marchese Alessand ro del Borro, Feldmaresciallo imper iale.
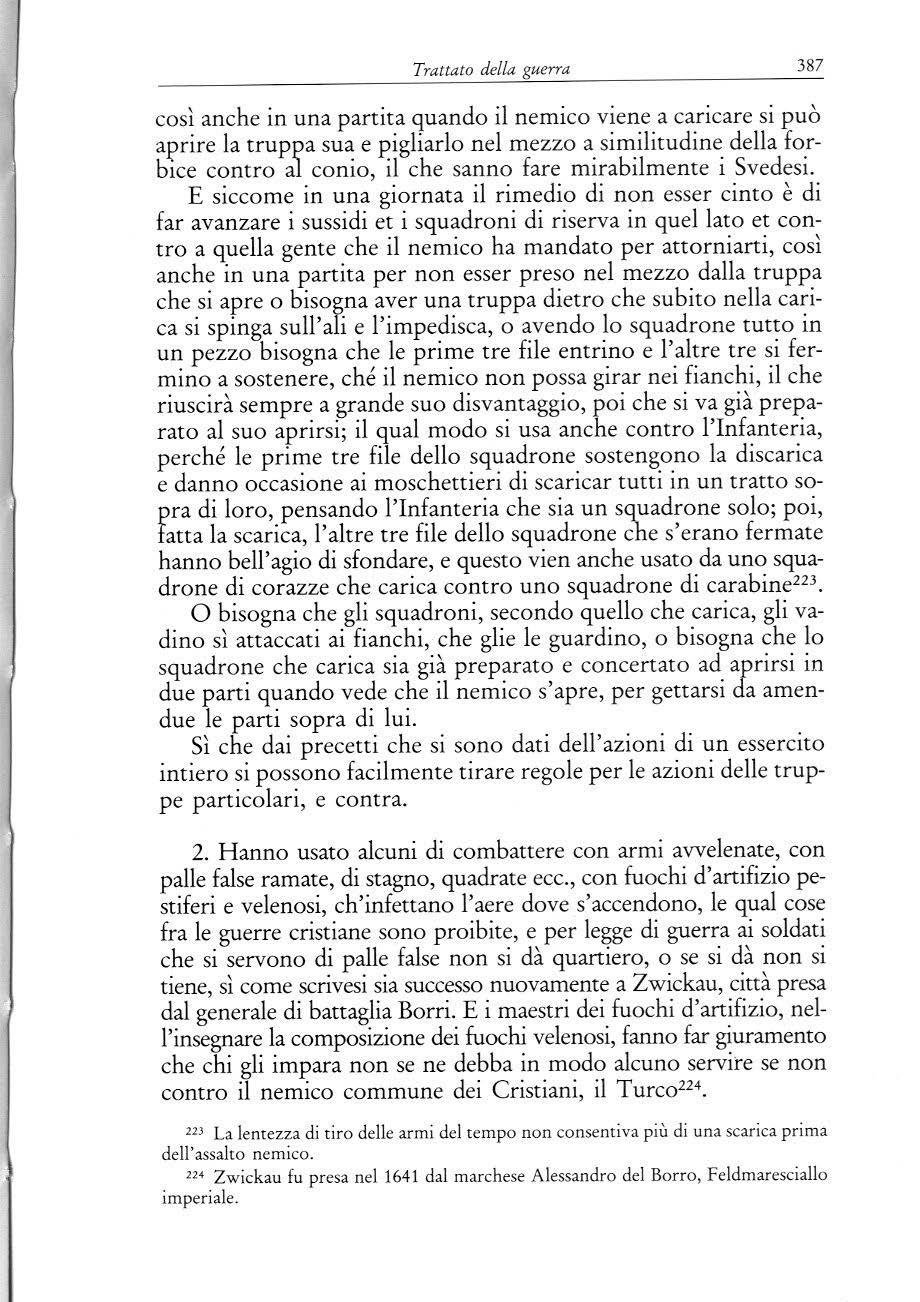
3. li combattere si fa più con gli animi che coi corpi22 5, e però non sempre giova la moltitudine, e bisogna ben porre cura che le prime genti che s'azzuffano sieno valorose, perché se i primi combattenti danno inizio alla fuga, facilmente col fuggir loro sbigottiscono e levano l'animo agli altri, se non fosse che già sapessino essere ciò fatto a bello studio e per stratagema, per attirar il nemico fuori dei suoi vant aggi e per dargli suggetto di seguire in discordie.
4. Quando un nerbo di tue genti è impegnato con tutta l' armata nemica e chiede soccorso, o bisogna che tu ci vada con tutto l'esserci t o se ti trovi capace di azzardar la giornata, o non bisogna mandarvi persona, perché il soccorso non so lo non disimpegnerà i primi, ma impegnarà ancora se stesso .
Delle battaglie si è diffusamente discorso nella pecorina n. IX, e qu i s'aggi ungerà solamente che di tutte le azioni della guerra la più gloriosa e la più importante è di dar battaglia, perché il guadagno d'una o di due acquista o rovescia gli imperi intieri, e però un essercito che non teme la giornata ha un meraviglioso avantagg io in tutti i suoi dissegni contro a quello che la teme 226 •

1. Chi guadagna la giornata non so lo guadagna la campagna, ma anche un gran pezzo di paese, e chi va al di sotto perde il paese, il coraggio e la riputazione e spesse volte i suoi migliori amici, e però chi sa bene presentare al nemico una giornata gli altri errori che facesse nel maneggio della guerra sarebbero sopportabili, ma chi manca di questa disciplina, ancora che nelli altri particolari valesse assai, non condurrà mai una guerra ad onore, perché una giornata che tu vinca cancella ogni tua mala azione, così medesi mamente perdendola restano vane tutte le cose bene da te avanti operate.
2. Egli era costume d egli antichi d i sfidarsi a battaglia con l' armate e di assignare luogo e giorno prefisso per la giornata, il che ai nostri tempi non si usa se non per complimento o per mostrar bizzarria. Il Duca di Parma Al essa ndro, fu da Enrico il Grande sfidato a battaglia, ed egli rispo se che il suo Re di Spagna l'aveva
m La resi che nella guerra l e forze morali sian o predominanti è esattamente uguale a quella che s arà soste nuta due seco li più tardi dal Clausewitz.
226 M. ribadisce l'estrema, prem in ente importanza del dare battaglia. Ciò rnosua l'insussiStenza delle resi di coloro secondo i quali egli avreb be ign o raro la strategia " annienta· trice": unicamente, M. pensava che la si dovesse usare quando possibile, e non in assolut o .
mandato in F ranc ia pe r socco r rere la Lega Cattoli ca, e che se avess e stimato c h e la via pi ù breve d'esseguire questo co m manda mento e d'ottenere il suo mt ent o fus se quella d'un fatto d'arm e, egli non l'avria sfugg it o, ma c h e, non esse nd o, egli non aveva occas ion e di venirvi 227 •
Altri capita ni hann o rispo sto ai n em ici che non dav a no le battaglie a grado d e ll'avve r sa r io, ma a suo. Altri ha provocato il nemico dice nd o: «S e tu sei un gran cap it ano, perché non vieni a batt ag lia?» Et il nemi co ha ri sposto : «Se tu pure se i gran ca_p itan o, perc n é non mi costringi a venirci?» Ultimamente Banér sfi dò per trombetta il P icc ol omini a un fatto d'a rm e quando le du e armat e erano ~~c a1:1p~te presso di Saalfeld, e le lin ee di questa disfida sono p o i 1te m 1stampa.
Egli e ra anche in uso il du ello appresso agli antichi avant i il comin ciame nto de lla battaglia, e facevano azzuffarsi insiem e un prigioni ero della parte avversaria, preso in qualunque modo avessin potuto, con un effetto dei suoi popolari, e ciascuno armato dell'armi accostumate nel suo esser cito; poi la vittoria dell'uno o dell'altro era presa come auspicio dell' eve nto della gu erra o dell a pugna.
3. Quando due armate unit e assieme non s'accordano nei pareri, e c h e l 'una vuo le dar b attaglia e l'altra non vuole, e siano a fr o nte al n e mico, se l'una com inci a ad appi cca rsi bisogna c h e l'alt ra a n co r a, benché cont ro a s ua voglia, venga a combatte r e necessaria me nte, sì p er non pare re co darda e t rad itrice, sì anc he perché, s' e lla las cia batt ere il coll egato, sarà foi preda an che ella d e l nemico; partito che non seppe p r endere i Du ca di Feria quand o, unit o co ll' Aldringen, stava in battaglia co ntro ai Svedesi , a So ulz, e deside rand o so mmam e nte di dar gi ornata, non potev a tirare n el s u o parere detto Aldrin ge n, che aveva ord in e co ntrario dal Friedland , perché s'eg li avesse cominciato a co mbatt e re col corno destro della ba t tag lia ch'eg li formava colla armata spagnu o la, avria biso gnato a forza ch e l'ar mat a imperiale e di Baviera avessi no segui to il combatti m ento.

4 . Quand o s i ha a dare un co mbattim e nto gene ral e in un p aese che n on è s uo ma d'un confederato, si domandano da lui pegni
227 A lessandro Farnese, Duca di Parma ( 1545-1592), u no tra i più grandi co nd ottieri di ogni tempo, Governatore ge nerale d ei Paes i Bassi e co mandante sup remo delle forze spagnole nelle Fiand re. Di lui basta ricordare la spettaco losa marcia su Parigi durante le guerre di religione (1 590-92). La risposta data a Enrico I V tende a sottolineare che non sempre il più abile ca pit ano è colui che dà battaglia, ma sovente colui che la rifiuta quand o l'avversar io ne ha d ispe ratam ente bisogno.
et ostaggi, sì come il R e di Svezia prima di venir alla battaglia di Leipzi$ negò di mettere il suo esserc ito a pericolo se l'Elettore di Sassoma non ubbligava pubblicamente la fede sua di volere impiegare i beni, le fortune et il sangue per diffendere la religione e la libertà, e non gli dava nelle mani la città di Wittenberg sopra l' et il suo figliuolo primogenito in pegno, e se no n pagava al1' essercito suo tre mesi di soldo.
5. Quanta munizion e faccia di bisogno in un giorno di battaglia non si può facilmente determinare, perché bisogna regolarsi seco nd o la quantità d'armi da fuoco che si ha, secondo il tempo c he dura il combattimento e secondo la strettezza o larghezza del s ito nel quale s'impiega più o meno moschetteria ad un tratto. Si suppon e che un moschettiero, tirando con agilità e prestezza, possa tirare in un'ora 24 colpi, quanti co lpi possa tirare in un'ora qual si sia pezzo di cannone n'è discorso nella pecorina numero V. Quanto alla Cavalleria ch'a dopra le pistole, si può supporre che le mezz e corazze abbiano a caricare 5 o 6 volte e che le corazze intiere non adoprino pistole, o se l'adoprino, non sia c h e la prima vo lta, e c he carabine non vi siano, o che si possano adoprar poco quando la battaglia si viene a ristringere e di qui si può calcolare la quantità della polvere e delle palle che saranno necessarie.
6. Quando o fame o alcra naturale necessità o umana passio ne ha condotto il nemico tuo ad un'ult i ma disperazione e cacciato da quella venga per combattere teco, devi starti adentro ai tuoi a lloggiamenti, e per quanto è in tuo potere fuggire la zuffa.
I. Tutti gli stratagemmi con i quali assalire il nemico si riducono a qu ello che tu apparecchiato assalti il nemico non pr epa rato; armato et unito l'assalti disarmato e disunito; vigilante e non visto l'att acc hi che dorma; e che si vegga, e stando in posto s icuro, attacchi lui nella difficilità dei luoghi constituito. Ed è facil cosa cogliere il nemico in qualche errore, perché bisogna n ecessariamente che egli e tu ne p organo molte occasioni, e però c hi è più vigilante sop ra l'avversario, quegli ha più vantaggio perché bisogna nec essa riam e nte andare a foraggio, bisogna necessariamente dormire e riposare, e nel marciare bisogna necessariamente andare per le st rade e per l e ca mpagn e, quali che siano, né si possono far a suo gusto, le qual cose tutte bisogna rivolgere nell'animo, e

dove tu conosci essere più debole, quivi hai da usare maggior cautela, e dove vedi il nemico più facile ad essere colto, quivi devi particolarmente assalirlo.
1. Chi inganna i nemic i può ritro varli incauti, avendo messo nel1'animo loro sicurezza e fiducia col trattar una pace o col far una tregua per qual ch e giorno, nel qual tempo attaccarli è astuzia più praticata che apRrovata; o coll'aver simu lato timore o debolezza o con altra via puo renderli disordinati e turbati, dando loro facultà di seguir lui che fugge e qu ivi attaccarli e batterli, et a queste cose non solo bisogna por cura e servirsene, ma bisogna anche inventarne e specularne sempre dell' altre, et essaminata la natura del nemico ordir !'insidie approppriate al suo modo di fare, come l'uccellatore sorge di notte a pigliar gli uccelli e prima che essi si sieno mossi v'ha tese le panie, e le tende in modo che non si veggano e se mosse qualche ramo o qualche altra cosa la raccomanda come non mossa, et ha altri uccelli ammaestrati che servono di zimbe llo et ingannano gli altri uccelli della medesima specie, et egli sta rinchiuso et appiattato in modo che vede gli uccelli e n on è visto da quelli; e così anche il cacciatore, poiché il lepre si pasce di notte tempo e fugge di giorno, nutris ce cani che lo trovano col fiuto e co ll 'o dorato , e perché egli co rre velocemente, tien altri cani che, dopo ch'egli è trovato, gli corron o dietro per pigliarlo, che se si salva anche da questi, conosciuto il suo passaggio et il bosco dove si suol ritirare, vi tende reti difficili da esser viste ne lle quali venendo a dar il le pre col suo corso veemente, s'annoda e si lega da per se stesso.
2. Il mezzo più proprio per far riuscire ogni impresa e stratagemma è la velocità e prestezza, virtù attribuita sopra tutte le alt re ad Alessandro et a Cesare, i quali, stimando che l'indugio portasse sempre danno e deterrimamento a colui che è apparecc hiato e che classe il tempo d'apparecchiarsi, di mettersi in ordine e di star su ll e guardie all'avversario, movevano quasi fu l gore addosso ai nemici 228 E sebbene Cesare non aveva talvolta tutte le forze presso di sé, cominciava con quelle che si tro vava attorno dando ordine all'altre c h e lo seguissino con diligenza, così col poco disordinava il n emico sp ro veduto e col molto che gli veniva dietro l'abbatteva e ' l mandava in ruina, perché sì come la nat ura ha dato ai pesci le teste acute con le quali rompono l'acqua e la strada al rimanente dei corpi loro fanno, e siccome l'arte aguzza

le frecce et i cogni per aprir e per passar i corpi e col resto poi rompe successivamente e fracassa ciò che incontra, così Cesare entrando con le forze che si trovava improvviso nell'impresa, scompigliava e confondeva il nemico che poi atterrava e rovinava col grosso della sua gente; così egli era sempre superiore all'avversario perché nel principio, sebbene egli aveva poche forze, l'avv ersario o ne aveva meno, o, spaventato dalla subita venuta di lui, perdeva il giudicio e l' an imo col quale potesse valersi del suo vantaggio; nel mezzo poi e nel fine, restava superior e per l'ag grossamento e raddoppiamento delle genti che gli sopraggiungevano e per l'acquisto ch'egli faceva spesse volte delle forze apparecchiate contro di lui. E ora dell'opinione che il nemico aveva di forze maggiori, ora della r eal tà di esse forze si valeva, e così con sei legioni cominciò l'i mpresa della Gallia, la continuò con otto, la finì con dieci; diede principio alla civ il e con una legione, arrivò a Brindisi con sei, passò il mare contra P ompeo con 15000 fanti e 500 cavalieri, proseguì la guerra e la finì con 22000 fanti e 1000 cavalli; cominciò la guerra Alessandrina con 3200 fanti, la continuò e condusse a buon fine con 5 o 6 legioni; cominciò l'Africana con sei, la finì con otto.
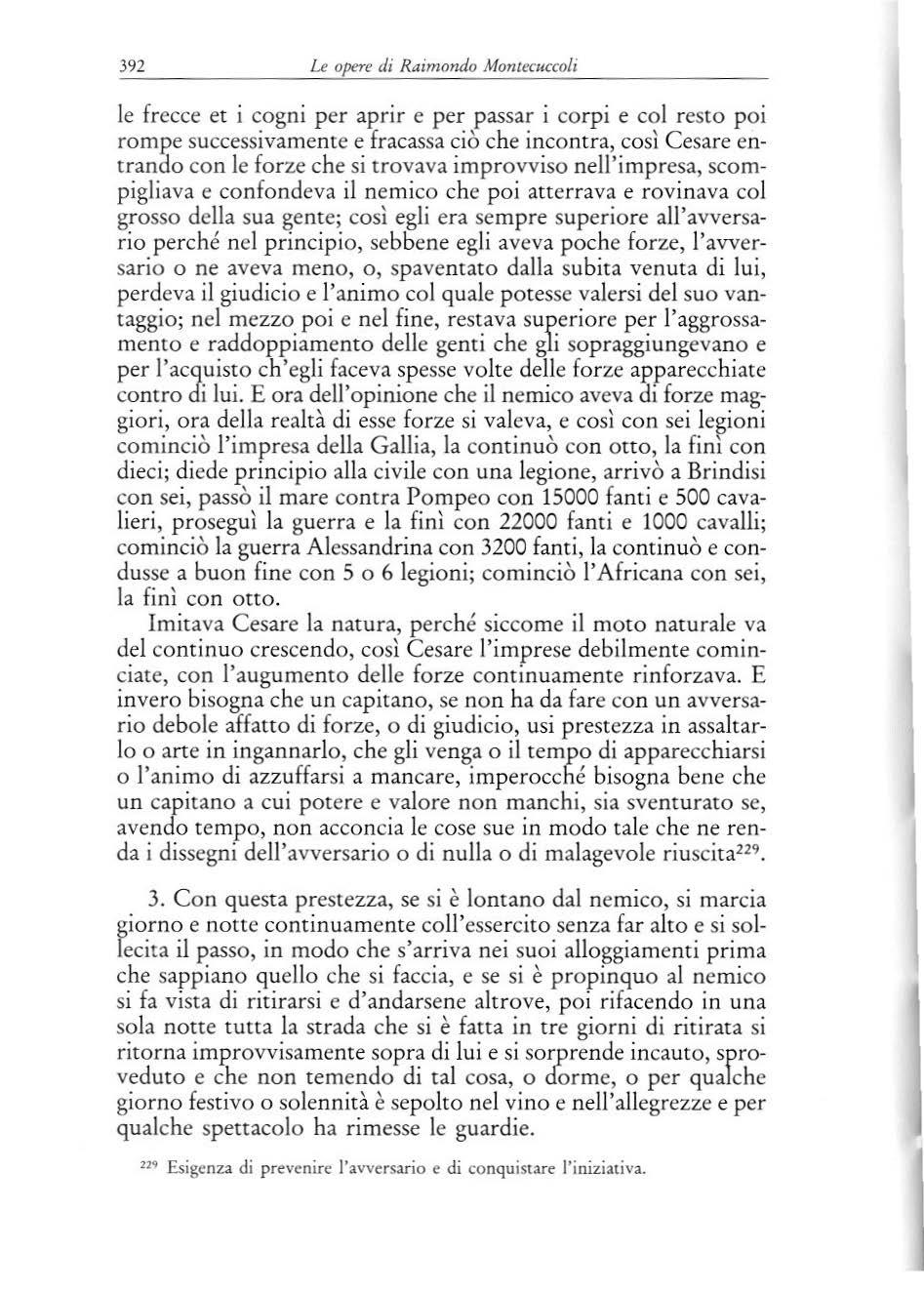
Imitava Cesare la natura, perché siccome il moto naturale va del contin uo cresce ndo, così Cesare )'imprese debilm ente comi nciate, con l'augumento delle forze continuamente rinforzava. E invero bisogna che un capitano, se non ha da fare co n un avversario debole affatto di forze, o di giudicio, usi prestezza in assaltarlo o arte in in gannarlo, che gli venga o il tempo di apparecchiarsi o l'animo di azzu ffarsi a manc are, im perocch é bisogna bene che un capitano a cui potere e valore non manchi, sia sventurato se, avend o tempo, non acconc ia le cose su e in modo tale c he ne renda i dissegni dell'avversario o di nulla o di malagevole riuscita22 9 •
3. Con questa prestezza, se si è lontano dal nemico, si marcia giorno e notte continu amente co ll' esserc ito senza far alto e si so llecita il passo, in modo che s'arriva nei suoi all o ggiament i prima che sappiano quello che si faccia, e se si è propinquo al nemico si fa vista di ritirarsi e d'andarsene altrov e, poi rifacendo in una sola notte tutta la str ada che si è fatta in tre giorni di ritirata si ritorna improvvisamente sopra di lui e si sorpre nde in ca uto , sproveduto e che non temendo di tal cosa, o dorme, o per qualche giorno festivo o solennità è sepolto nel vino e nell'ailegrezze e per qualche spettacolo ha rimesse le gua rdi e.
m Esigenza di prevenire l'avversario e di co nqu istare l'i niz iativ a.
4. Né basta di rifare con diligenza gran camino, ma bisogna pigliarlo per vie ignot e, per boschi, per colli scoscesi, per il m ezzo delle nevi, per dirupi e per guadi incogniti, et in somma per quelle st rad e che, non sendo punto sospette, non sono anche guardate, et aitano ad arrivar improvviso sopra il nemico, dove distribuendo la Cavalleria ad attaccare in più parti in un medesimo tempo et a dilatarsi il più eh' ella può, reca sbigottimento straordinario al_ 1:en:iico, il quale non sa da quale parte voltarsi né dove mettersi insieme.
E con questa celerità si opprimono i soccorsi che devono venir al nemico prima che giungano, congi unti si cerca di districarli facendo vista di voler fare impression e in diversi luoghi, poi distratti e separati si assaltano. Molti hanno vinto il nemico a quelle facultà di mangiare e bere fuori d i modo, similando di avere paura e lasciando gli alloggiamenti suoi pieni di vino e di armenti, dei quali sendosi riJ?ieno il nemico sopra ogni uso naturale, sono improv v isamente ntornati sopra di lui e l'hanno assaltato e v into . Alcuni hanno con mandragora o con altro avvelenato o vin i o altre cose da cibarsi, per potere più faci l mente vincerli .
5. La celerità e gli im p eti rep ent ini i quali si fanno subitamente fuori dell'opinione, atterriscono le truppe del nemico benché valorose et in copia maggiore degli assalitori, perché il disavantaggio di essere so rp reso most r a una perdita ev id e nte di colui che si lascia sorprendere, il quale [è] sproveduto et atterrito; eg li è cosa incredibile a dirsi come siano più i soldati presi che quei che pigliano, e come il terrore invasa gli animi e toglie ogni senso, sì che chi è sorpreso non possa vedere abbastanza la sua moltitudine e la poca quantità di chi lo assa le; ma se si dà tempo al nemico di raccogliere i spiriti e riguarda,r le sue forze e deliberarne, può facilmente ripigliar animo e spezzare l'assalitore e farg li testa, ovvero ne ll 'indugiare può cambiare lo stato di quelle cose delle quali s'ha avuto lingua e trovarlo tutto differente da quello che si era presupposto; possono crescere le forze al nemico, può rinforzare le guardie e costudire le avvenute, ferché il tempo dà sempre di giorno in giorno miglior notizia de l uogo dove si è, et in somma non essendo preven u to et avendo lingua di dover essere assalito, può radunare le forze distratte, mettersi insieme e rovinarti l'impresa
6. Servono alla celerità il mandare la Cavalleria innanzi e i Dragoni, proibendo loro di far alcun fuoco dove fanno alto per levare
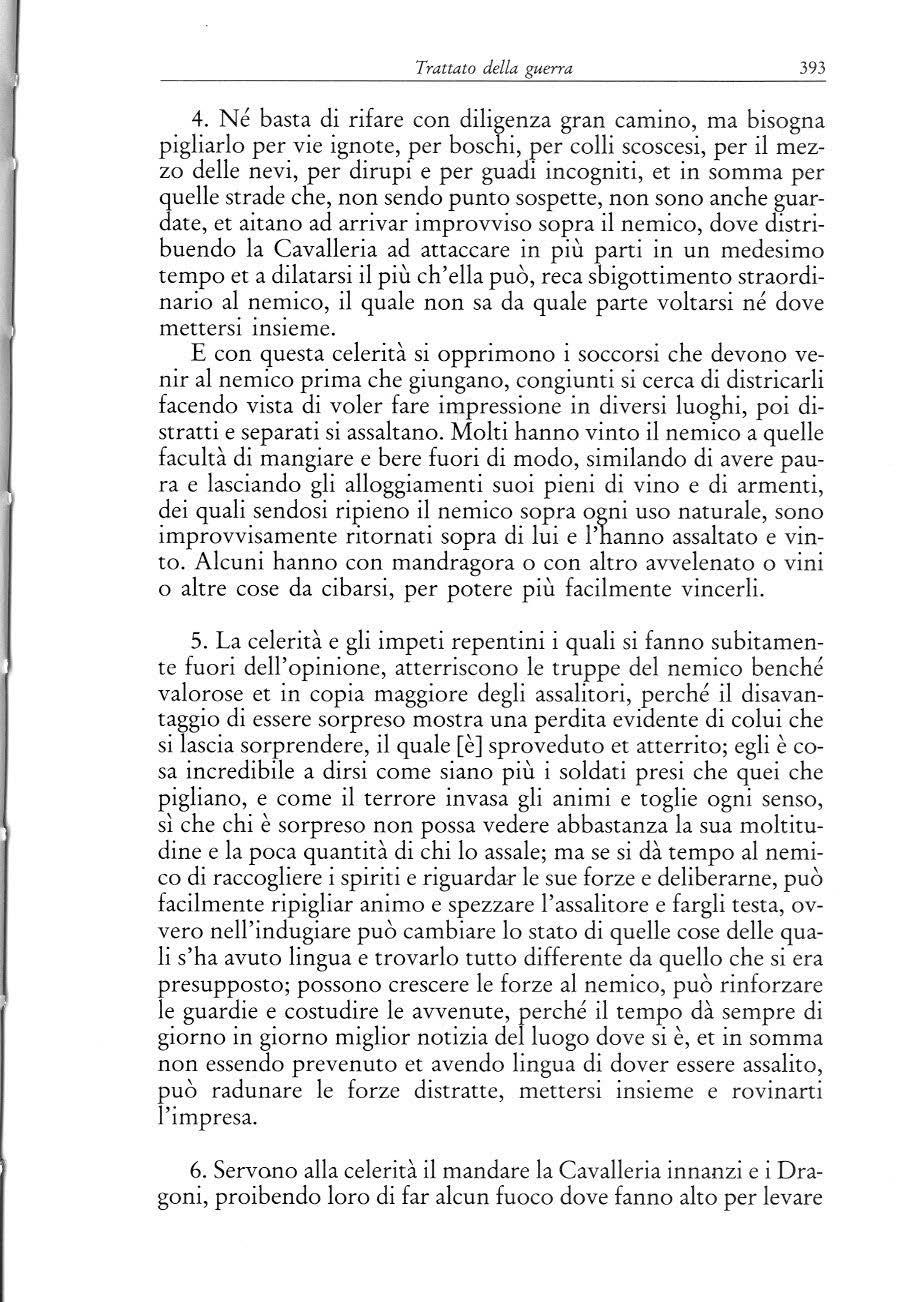
la conoscenza della venuta loro; serve il marciare senza bagaglio, perché ella è una cosa di grandissimo impedimento in una espedizione dove la diligenza è richiesta; serve la segret ezza, che è sopra tutto ne cessaria in qual si voglia impresa, al che giova il tempo oscuro e piovoso et il serrare l'armata in un campo chiuso accioché nissuna spia esca a portar lingua al nemico; serve il raccozzare la gente, s'ella non è prima insieme, in luogo segreto et a un rendezvous che denota marcia contraria a que ll a che vuoi pigliare e sotto altro pretesto, come di convocare qualche gran principe o di far passar mostra o di far caccia; serve il mandare innanzi qualche cav alli leggieri e sciolti c he prendono e fermino chiunque su la strada, o dei paesani o d'altri, accioché qualcheduno non iscappi e corra innanzi ad avvisare la tua venuta, e quei che non possono pigliare, li perseguitano accioché n on possano apertamente vedere tutte le forze che seguono ma stimino che sia una picciola partita; serve il marciare diligentemente la notte et arrivare alla di ana sopra il nemico, perché di giorno ne può essere avvisato, se non dalle guardie, almeno dai suoi foraggieri, et è molto util e prendere il tempo d'assalirlo quando qualche suo cap o principale è asse nte dall'essercito e che le sue truppe alloggiano molto separate, o ch'egli ha mandato gran parte della gente a foraggio o ch'egli è nel punto di e ntrar in quartiere ess e ndo impedito per gli alloggiamenti.
E sebbene ordinariamente non si vede molti dar dell'incarnisciati all'armate, in ogni modo tanto più facilmente possono riusc ir e per ché altri se ne guarda di meno, et al rendez-vous si fanno vestir e i soldat i di camiscie per riconoscersi fra loro, ovvero con un fazzoletto bianco si cingo n o il cappello, benché il nemico può facilmente imitar que sto segna le 23 0
Serve soprattutto il marciar presto e diligentemente, massime dove il paese è piano e se si può fare, perché non può essere che, mettendo spazio fra mezzo, il nemico non riceva qualche odore della tua venuta; e scrivesi c h e il P rincipe di Condé co n 2000 cavalli prese il gran galop po a sei leghe d'Orl éa ns, né mai si fermò sin che non fu giunto alla porta e sorpresa la città 231 •

Usavano ordinariamente i Svedesi quasi la medesima prestezza nel marciare a qualche sorpresa, e così suol fare an che J ea n de Wert, al qual e è riuscito sempr e prosperamente fuori che una voi -
z,o Su gli incamisciat i cfr. n 148
m Si tratta di Lu igi I di Bo rbone , Principe di Condé; la presa d i Orléans fu nel 1562, all'inizi o d elle gu er re di reli gio n e (C fr . n 146)
ta in Baviera, che avendo seco il reggimento dell'Aldobrandino , il nemico, avuta lingua della sua venuta, s'era messo insieme in campagna e l'aspett ò di pié fermo, e trova ndolo mal unito e poco ord in ato per la celerità della marcia, lo rincontrò e ruppe, si ché Friedland, mal contento che le corazze dell' Aldobrandino fossero state consumate a quel modo, ordinò all' Aldringen che commandava l'armata in Baviera che non de sse più corazze a condurre a J ean de Wert, ma solo cavalli leggi eri 232 • Dal che si può considerare che il modo d ' andar sì veloce è ve ram ente molto più suggetto a disgrazie se si trova il nemico all'erta, che andando posatamente et aspettandosi l'un l'altro, perché i cavalli e la gente non si stanca tanto et arrivano sopra al nemico più serrati e più freschi; ma egli è ben anche ve ro che , marciando adagio, si dà tempo al nemico di m ettersi all'ordine p er la minima n uova che abbia dai suoi corridori, guardie e spioni, laddove marciando presto tu arrivi insieme coi corridori del nemico e coi suoi spioni e gli sei addosso prima che ne sia avvertito, e però, sì come nelle cose umane non si dà partito nessuno tutto netto e tutto puro e sicuro, così anche in questo non si può avere il bene che proviene della prestezza e sfuggire intieramente il male che l'accompagna.
Ma si può moderare in qualche modo. Ché, dove la campagna è aperta, si marci velocemente, perché !'ultime truppe non patiscono più che le prime, e dove sono passaggi si marci un po' meno ve loce, ma non troppo, perché il tempo che perdono !'ultime truppe nel passar in luogo stretto mentre che stanno ferme finché le prime siano passate lo riguadagnano poi in arrivando ad un altro passo, dove le prime si fermano nuovamente a sfila re e l'ultime marciando vengono appunto ad arrivarvi quando l'altre finiscono di passare né hanno queste più a fermarsi . Dove si rincontrano le partite nemiche è necessario affrettar il passo per giungere con esse loro sopra al nemico, e quand'anche convenesse all ' ultime truppe di galoppar qualche poco, non p er questo si rovina un cavallo p er galopparlo, e sebbene non tutti i cavalli hanno galoppo uguale, non essendo il galoppo troppo grande tutti in ogni modo il pareggiano, né però per questo vengono a diradarsi le truppe; che se non si giudicasse a proposito l'affrettar tanto tutte le trupp e, si può far spiccare un numero delle prime per non perdere l'opportunità della prestezza, nella quale è tant'importanza, come si vede a Tangermiinde quando furono sorpres i tre reggimenti svedesi. Et avventurarle all' azzardo mettendole come per-
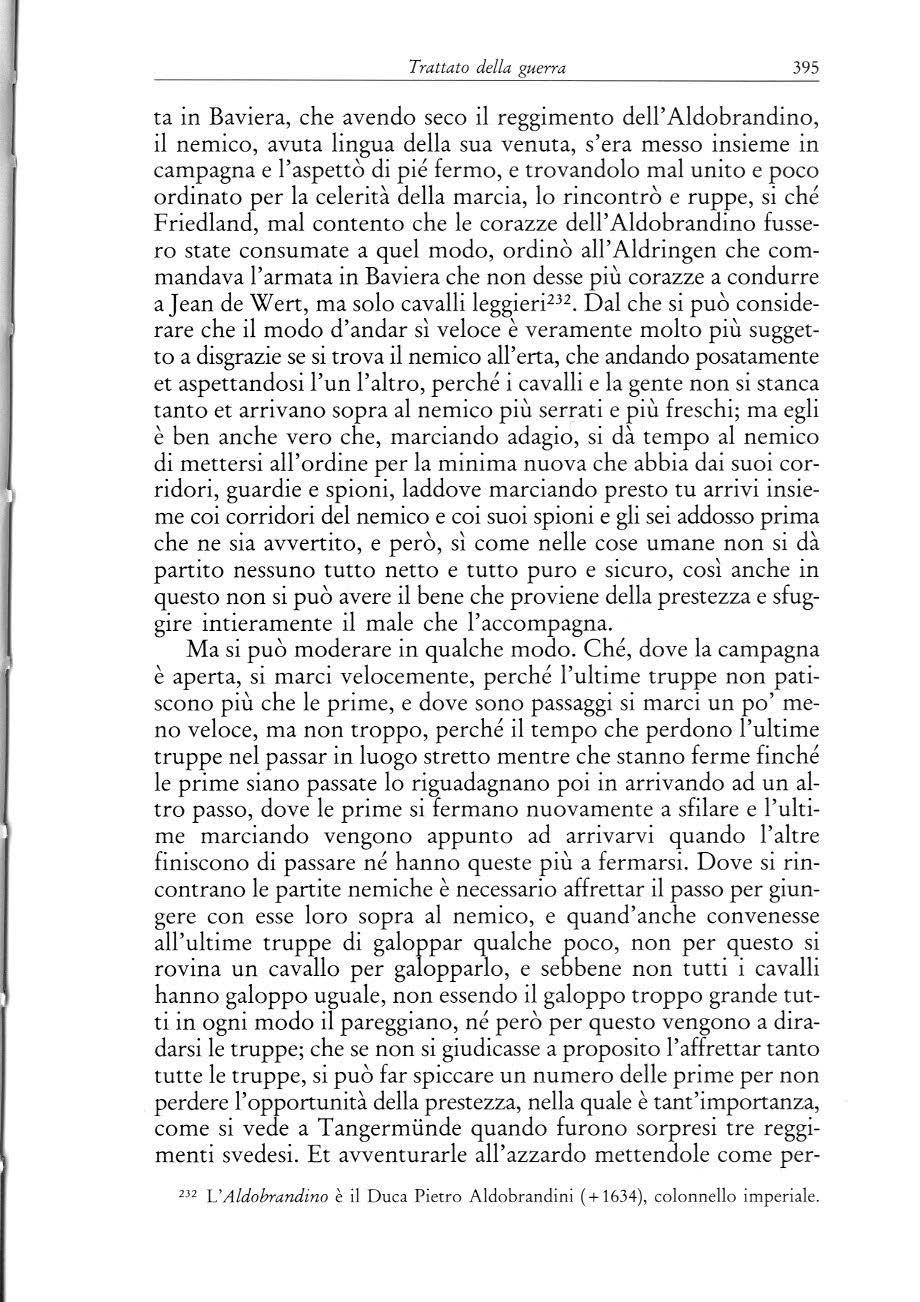
se, poi seguitare più mod e ratamente col re sto sopra il qual grosso s i possono sempre ritirare le prime trupp e in ogni caso di disgrazia e che trovassino il nemico che le attendesse, il qual però non saprà forse pigliar subito la risoluzione di rincontrarle non sapendo ancor bene la loro forza, o se le rincontra non le perseguitarà molto, massime di notte tempo, per dubbio di dare nell'imboscate.
Serve, dopo essere giunto sopra al nemico, di far parere le truppe in numero maggiore di quello che esse sono per più sbigottirlo; e per farle parere maggiori si fanno fare strepiti e grid i nelle cavi tà delle caverne e dei boschi dove l'eco raddoppia e triplica le voci, la qual cosa usata primieramente da Pan diede il nome ai terrori panici. Si mandano truppette di cavalli in diversi luoghi che accen dan o fuochi, danno fa lse all'arme, fanno toc car in varie parti molte trombette e tamburini e fingo no di vo ler aggirare il nemico alle spalle e si distinguono in truppe i bagaglioni, che rappresentano s quadroni armati.
7. L'ordine che fu dato per combattere in un ' incamis ciata di un'armata francese che presupponeva di sor prender i nemici negli alloggiamenti, fu tale. Marciavano alla testa 800 lancie, c he dovevano rovesciare tutta la cavalle ri a nemica che avessino rincontrato in arme, d opo seguitava no 1200 archibugie r i in quattro truppe con ordine di attaccare i co rp i di guardia dell'infanteria nemi ca, poi dare dentro al lor quartiero; dopo marciavano 800 archi bu gieri per occupare l'artigli eria, seguitati da due gran battaglio ni di picche; poi veniva il capitan generale co n più di 1000 cavalli in quattro squadroni e col r es to d'archibugien. Ma le guide, che fallirono la strada, fecero fallire l'intrapresa .
Se vi so no più strade che vadano al nemico, o ch 'egli sia allo ggiato in più quartie ri, si attacca per diverse avvenute e si commandano tante trupp e quante si stimano necessarie all'attacco di ciascun qua rtiero o di ciascun'avvenuta, ma bisogna ben osservare che sieno s1 ben concertate c he l'attacco segua da tutte le parti in un medesi mo punto; e se qualche truppa arriva prima dell'altra faccia alto se può, e si ten ga seg ret a, sinc h é si dia il segnale con qualche tuono di canno n e o co n qualche fuo co o con altra cosa accioché tutte assalgano il nemico ad un tratto. Et il grosso tien guardata la campagna in luogo atto a mandar rinforzi e soccorsi da tutte le parti dove bisogni et a distribuire gli aiuti et anche a fare spalla a chi fusse respinto, il qual ordine si osserva anche n el dar il guasto ad un paese, perché facendo un corpo di fanti in luogo sicuro

e sito avantaggioso, si manda la Cavalleria a spogliar in diversi indirizzi, la quale ha sempre quivi la sua ritirata. E prevedendo in qual parte il nemico abbia più propinquo, più ragionevole et apparente rifugio, quivi si può commandare qualche gente che ne occupa i luoghi sì come prima che si dia la caccia alle fiere s' occupano i boschi. E quelli che sono ordinati a tali entrate si tengono occulti per non divertir e le cacciate fiere che da per loro vanno a dar nelle reti.
Ma se non s i ha notizia della natura del luogo e si è nuovi nel paese, non bisogna perseguitare i fuggitivi se non moderatamente, massime se i nemici hanno fatto corpo, per non cadere in qualche inconveniente.
II. C he se per lo contrario si viene sorpreso dal nemico, bisogna subito cacciar innanzi la Cavalleria e la gente che si ha pronta alla mano, la quale anche col favore delle guardie sostenga e faccia testa al nemico tanto che s'abbia tempo di metter in arme il resto della gente, come fece il Galasso a Nordli ngen che, assaltato dai Svedesi nel punto che l'armata era ita a riposare nel quartiero, oppose allo sforzo loro i r eggimenti di Gonzaga, dell' Aldobrandino, di San Martino e de La Tornetta, i quali sostennero tanto il nemico c he il resto dell'armata si raccozzò e si dispo se in battaglia 232 bis .
1. E quando anch e s'avesse voglia di ritirarsi, bisogna in ogni modo far testa per guadagnar tempo di m ett e rsi in ordine, ma in caso di sorp re sa non ci è più tempo di ritirarsi senza confusione e però bisogna risolversi a combattere per perdere piuttosto valorosamente che senza avventurarsi fuggir vilmente, e bisogna che i primi facciano buon viso et appare nze fiere accioché il nemico non rimarchi in loro segno alcuno di timore e però vada più lento. Se possono, devono occupare alcun posto vantaggioso o qualche rialto per levare al nemico la vis ta dell a v alle, accioché non riconosca e per fargli pensare ch e ci sia nas cos ta dietro gran Cava lleria e grand'Infanteria, e ciò si può fare anche in un bosco facendo apparire solamente le prime file, e così la buona contenenza nasconde la propria d e bolezza, e facendo sembiante di voler combattere forse la notte sopravverrà, che favorirà poi la riti rata o recherà partito migliore o tempo di trincierarti, sì come fece Ba-
232 "" Si noti ch e i co m andami erano tutti italian i .

nér a Freiberg che, soprapreso da Marazzino, si messe in ordine di battaglia di là da un picciolo ru scello e si tenne fino alla notte, al favore della qual e si ritirò se nza danno 233 • Ma quei primi c he si mettono a sostenere il nemico bisogna che siano capitani esperti e soldati va lorosi, accioché per poca accortezza non s'impegnin o senz' occasione e stuzzichino il nemico ad avanzare, né per viltà e timore si fuggano e raddoppino il coraggio al n emi co.
2. Quando anche hai lingua che il nemico marcia alla volta tua et h ai l' essercito tuo separato, per guadagnar tempo di metter le tue forze insieme puoi andare all'incontro di lui co n poca gente, scierre un posto molto avantaggioso e far accendere fuochi in grandissima quantità, accioché l'inimico pensi che lì sia tutta la tua armata, e però si fermi o si ritiri pensando che tu sia avvisato del suo dissegno: et intanto hai tempo di metter dietro a te la tua gente insieme.

III. Quando il nemico s'è piazzato in qualche sito avantaggioso s i cerca di farlo levar di là a forza di colpi d'artiglieria e per attacchi di moschett e ria e di picchie ri , dopo i quali seguono i cavalli per sostenere e s pinger innanzi i fanti e premerli che avanz ino e ritenerli se rinculano, e se vi è qualche rialto intorno al campo nemico sono molto a proposito per tirarvi di là granate dentro e fuoco d'artifi z io, massime se gli alloggiame nti sono coperti di paglia e che sp iri qualche vento che dilati le fiamme per tutto, e dei fuo c hi d'artifizio s'è diffusamente discorso nella Pe cor in a n. VIII. E s e non si può cacciar il nemico fuori dal campo e che il soggiorno sia nocevole e che venga no a mancare la polvere e le munizioni, si può ritirarsi in luogo dove si possa rimunirs i delle commodità necessari e e ricominciar altra impresa.
1. Ovvero bisogna mandar occ ultam ente un nerbo di ge nte per qualch e luogo difficile alle spalle del nemico che lo sbigottisca, e tu col r es to dell'armata l o attacchi dinnanzi, ovve ro al favore della polvere c he alza in aria la Cavalleria o del fumo del can n one o fatto in altra maniera, si toglie la vista al nemico e s'occupano . . . . . ' . . mtanto 1 sm pm avantagg1os1.
2. Volendo tirare in d ei luoghi forti l'es serc it o nemico, fu tale che mandò uno so tto colore di fuggiasco c he affermava come il m Nel 1636.
s uo essercito era in discordia e che la maggior parte di quello si partiva, e per dar fede alla cosa fece girare in prova certi tumulti fra gli alloggiamenti donde che il nemico, pensando di poter rompere, assalt ando fu rotto.

3 . Altri, per attirar il nemico a combattere hanno pubblicamente testimoniato di temerlo sapendo che nella propria armata erano spie che l'avrebbero avv isato et hanno dato ordine segretamente che si dovessero ritirare con gran rumori e come avendo gran paura, donde il nemico, esse ndo avvertito, ha creduto di non dover perdere l'occasione che se gli offriva e però s'è avanzato in disordine come a v ittoria sic ura, donde quelli si sono ri vo ltati in buon ordine e disfattolo. Ma tale stratagemma sarebbe pericoloso a tentarsi con soldati nuovi che il più delle volte si spaventano quando veggono il nemico venir sopra di loro correndo e senz' ordine, il che per lo contrario assicura quelli che sono esperimentati nei combattimenti. In sim il modo s'è ritirato alcuno dal nemico fingendo d'esservi costretto da penuria di viveri, poi a una lega o due da là s'è messo in imboscata con tutto l' essercito in luogo atto et occulto, onde il nemico seguitandolo, se bene ha mandato innanzi corridori per riconoscere, non ha potuto sc hivare che almeno le prime truppe dei corridori istessi non sieno entrate negli agguati e sieno state prese et uccise, dopo che colui che stava in agguati ha conosciuto che l'imboscata era già scoperta e che l'essercito nemico si era fermato sicché, non potendo sperar altra cosa, s'è contentato delle prime truppe.
Quando il Tilly si ritirava da Werben dove era accampato il Re di Svezia, il Pappenheim, Marescial di Campo, prese una gran partita di Cavalleria e s'imboscò sopra a un lato della strada a due leghe da Werben, pensando che il Re manderebbe dietro ali' Armata della Lega qualche truppe per riconoscer la sua marcia e che egli dopo che fussino state passate l'imboscata, avrebbe potuto uscire e venir loro alle spalle e tagliar loro il ritorno : ma il Re avvedutamente non mandò persona alcuna a segu itar manco di lontano il Till y 234
4. Si può anche mettere l'imboscata di notte, poi si manda la mattina a far sembiante di voler guadagnare un posto avantaggioso; il nemico, per non lasciarlo guadagnare, combatte le tue prime truppe, tu rinforzi i t uoi, egli rinforza i suoi, sinché attiri tutta
la sua armata negli agguati, ovvero facendo sembiante di f'uggire colle prime truppe, dai facultà al nemico di seguir sinché l'imboscata che li fu messa di notte alle spa lle se la vede bella et esce ad attaccarlo di dietro, mentre che tu ti rivolti e l'attacchi dinnanzi, e così lo pigli nel mezzo.
5. Quando anche tu prevedi per dove abbia a passar il nemico che marcia, tu metti in imboscata una parte della gente e coll'a ltra ti appiatti dietro a qualche colle o monte, accioché quando il nemico giunge a quei colli tu improvvisamente l'assalti dinnanzi, e nel frattempo l'imboscata, che era situata in lu ogo che il nemico l'ha trapassata, l'assalti di dietro e lo metta in confusione. Si possono anche far l'imb oscate duplicate e triplicate, i n più e più luoghi, di dietro, dinnanzi e dai lati, e ciascuna doppia se la commodità del sito lo permette, sì perché il nemico, vedendosi im- . provvisamente assalito da tante parti e come attorn iat o e cinto, è sbigottito né può in un subito smemb rare le sue truppe per opporle ai diversi attacchi, sicché facilmente viene messo in confusione, sì anche perché, se il nemico viene a scoprire un agguato o due, pensa già di avere scoperto ogni cosa e però, fatto trascurato e non '?adando più, è pur improvvisame nte assaltato a su o disavantagg10.
6. Nel mettere imboscate bisogna sopra tutto osservare che il nemico n on ne abbia lingua, perché altrimenti si corre gran rischio, esse ndo facile al nemico di assalirti con forze maggiori di quelle che tu hai messo in agguati, se l'ha risaputo, et anche con armi avantaggiose, perché nelli agguati si mett e ordinariame nte la Cavalleria et i luoghi degli agguati sono ordinariament e scabrosi e più propri per la Fanteria, sicc hé se il nemico l'ha risaputo ti può opprimere nella tua propria imboscata, oltre che può prevenirti, et occupando i luoghi degli agguati con gente, nel mentre che tu vieni può con altre truppe attaccarti da un'altra parte ecosì pigliarti nel mezzo, ovvero, trovando le tue forze distratte in piu imb oscate, può con le sue unite venir a ciò preparato e combatterti con suo gran vantaggio.
7 . Tutto l'effetto dell'imboscata sta in questo, che si lascino passare l e truppe nemiche o s'attirino a passare o col mandar a spogliare il pa ese, accioché seguitino le partite che spogliano, o col far vista di fuggire, poi quando sono passate s'esca dall'imboscata e s'assaltino nei fianchi e nelle spalle, come s.i leg ge [di] To-
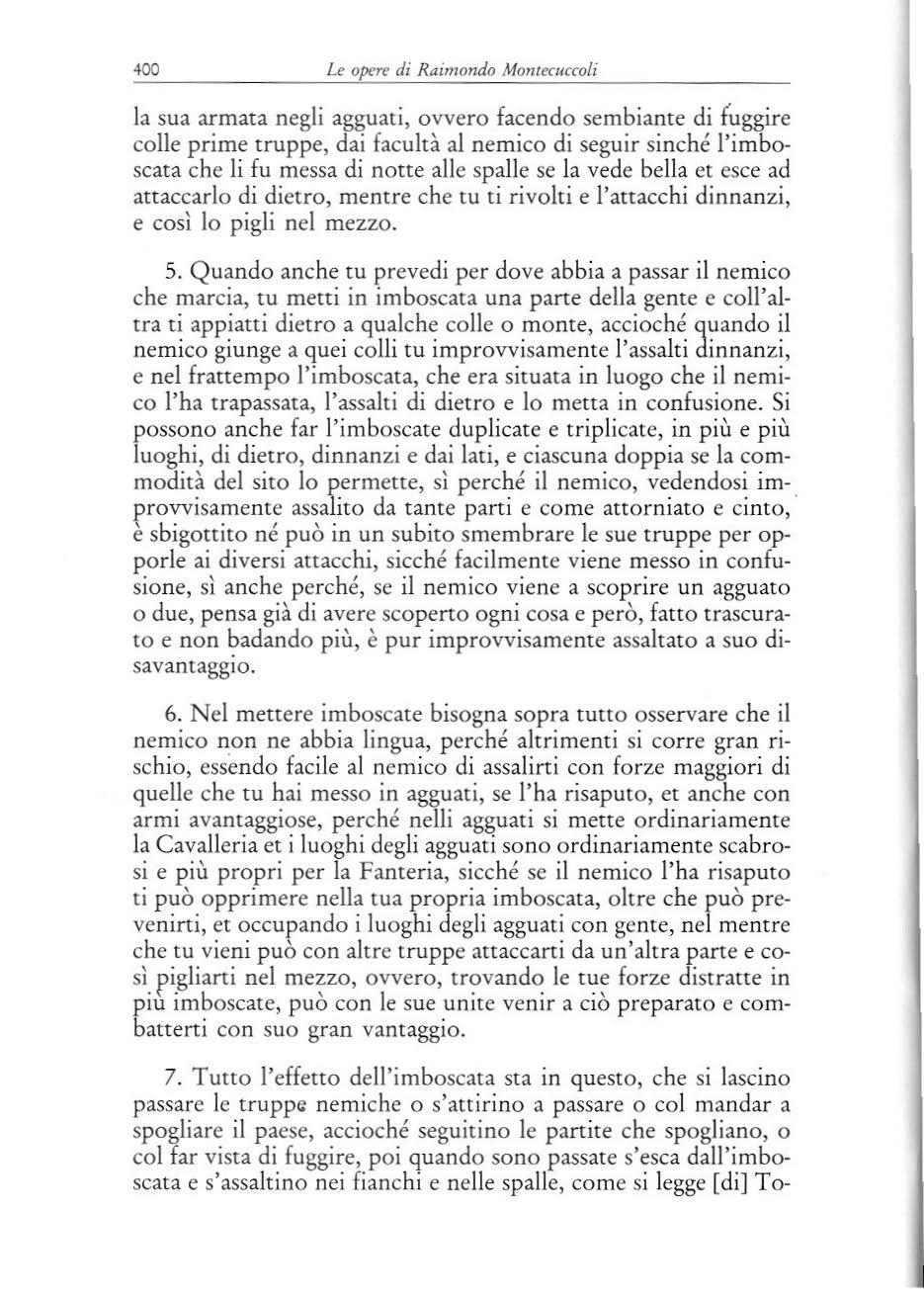
miri 235 , che attirò Ciro col suo essercico in certi luoghi angusti, dove avendo messi. agguati nei monti, tagliò a pezzi lui e il suo esercito di 20000 Persiani; nella qual vittoria leggesi anche questo di memorabile, che non ne rimase v ivo pur u no so lo per portar le nuove di tanta strage .
Ma devesi osservare che l'impressione sull'inimico si faccia da tutte le parti in un medesimo tempo, sì per isb igottirli maggiormente, sì per non darli tempo di ordina r si o di ripartire l 'opposizioni o di battere una partita di gente dopo l'altra, il che gli potr ia riuscire se fosse attaccato successivamente e non da tutte le parti in un colpo, e però bisogna usar somma diligenza nel computar bene il tempo e n el concertarsi. E chi segue un inimico che fugge no n essendo ancora stato battuto e disfatto, deve farlo cautamente, facendo riconoscer bene per tutto e lasciando guardie nei passi, nei luoghi angusti, nelle fauci e nelle cime dei monti et in ogni l uogo pericoloso, per assicurar il ritorno.
8 . Se tu avessi sospetta la fede di alcun popolo, e volessi assicurartene et occuparlo all'improvviso per potere colorire il dissegno tuo più facilmente, non puoi fare meglio che communicare con quello alcuno tuo dissegno, richiederlo d'aiuto e mostrare di voler fare altra impr esa e d'aver l'animo alieno di ogni pensiero di lui, il che farà che non pensarà alla diffesa sua non credendo che tu pensi ad offenderlo, e ti darà commodità di poter facilmente soddisfare al tuo desiderio .
9. È stato anche utile ad alcuno capitano, avendo l'essercito propinquo all'essercito nemico, mandare la sua gente con l'insegne nemiche a rubbare et ardere il suo paese proprio, donde che i nemici hanno creduto che sieno gente che vengono loro in aiuto e sono ancor essi corsi ad aiutare a far loro la preda e per questo disordinatisi e dato facoltà all'avversario loro di vincerli.
10. Alcuni, sapendo che il nemico aveva un corpo della sua gente separato dall' essercito, hanno cercato, sotto colore di far altra cosa, come d'occupare qualche luogo all'intorno per mettervisi in quartiero, di escludere intieramente e di tagliarli il ritorno, il che provò di fare il Re di Svezia ment r e che il P appenheim con un corpo di gente era loggiato intorno a Burg, e che il Tilly era a Magde-
m Tomir i, R egina dei Massageti, siti lungo la valle del lo Tassane (Sy r Dar'ja). Ciro il Grande, re di Persi a, fu ucciso nel 530 a.C. d urante una campagna contr o di essa. D a nocare che il Ve ltzé (I, 344 sg.) non essendo riuscito a leggere il nome d i Tom iri, lo salta , rendendo il brano pressoché inco mprensibi le.

burgo col resto dell'essercito, ma il Pappenh eim se n'avvide e si ritirò per ternpo 2 36
11. Per attirare il nemico a battersi hanno alcuni mostrato al principio solo una parte delle loro forze, accioché credendo il nemico che non ne seguissino altre, s'impegnò a combattere; ovvero hanno co llocato la gente loro sopra un monte in tal forma che nissuno potesse riconoscere tutto il numero delle truppe sicché essendo molte migliaia siano parse poche agli esploratori, e però attaccati dal nemico l'hanno rotto.
12 . Né so lamente i bosch i e le caverne sono luoghi atti agli agguati, m a talo ra anc he le pianure sono più idonee a ricoprire e diffender e gl'insidiatori, poiché più di lontan o si posson o vede re i nemici che vengono, et hanno anc he i nascondigli necessari perc h é un rio secco e co n ripe basse, una bussa in fondo, un grano, un canneto , erbe palustri ecc. non solo possono ricoprire i fanti ma anche i cavalli, mettendo il pié a terra e nascondendo il fulgore de ll' armi.

IV. Nel com battere, oltre agli artifizi accennati nel Discorso delle battaglie, si può usar questo: che se il nemico carica la tua va nguardia con la sua Cavalleria, tu non vada a socco rrere i tuoi, ma vada ad attaccare il co r po della battaglia del n emico, c he avendo i fianchi nudi di Cavalleria può facilmente essere battuto, e dopo s i viene alle spalle di d etta sua Cava ll eria che s'e ra avanzata et in qu es to modo è sta to una volta battuto il Duca di Lorena dai Fr ancesi.
1. Si può anche aver concertato fra la sua gente e disposta la ordinanza in modo c h e le prim e trupp e tue che s'azzuffano ve ngano nelle prime ca riche a porsi di dietro e qu elle di dietro si avanzino nei primi luoghi, la quale novità può turbare molto i nemici perché, vedendo ritirar i p rimi , si disordinano, po i vedendoli piantar si di nuo vo, vedendosi venir gl i ultimi nei fianchi, so no assaliti dallo spavento e dalla confusione perché in questo modo tu fai a dissegno e con ordine quello c h e essi vengono a fare a caso e con disordine.
2. P er mettere pr est o in disordine il nemico del quale s i è più forte e torgli ogni mezzo d'indugio e di ritira ta , si fanno assalt are nel medesimo tempo tutti li suoi squadroni, tanto quelli che egli ha dinnanzi quanto gli altri che ha sui lati e di dietro di sostegno assegnando a ciascuna truppa lo squadrone in particolare che ella deve caricare e facendole marciare direttamente ciascheduna ve rso il suo opposto, senza por cura che le truppe che vanno a caricare gli ultimi squadroni si lascino qualche nemico dietro le spalle perché appunto questo è quello che mette spavento nel nemico, vedendo che alcun e truppe gli girano alle spall e e c he non ha più a sperare socco rso né sostegno dai squadroni che egli aveva posto di dietro a quest'effetto perché ess i ancora sono caricati et hanno da fare per loro med es imi, né pur anche girarsi coi primi squadroni per andar alla groppa d ell e truppe che vanno per caricar gli ultimi , perché n el lev artisi di presenza e nel girare ti ve rrebbe a mostrare le spalle lui stesso et a darti facultà di batterlo senza alcun rischio.

3 . Le truppe che tu fai mettere di lontano ovvero tenersi ferme da un lato del n emico, lo tengono in briglia et ass icurano di caricar e più vivamente con le altre che tu hai in fronte, perché quando anche tu fossi respinto, il nemico non ardisce seguitarti per non offrire le spalle a quelle truppe che si vede collocate verso il fianco o per non venire ad urtare in quelle lontano che gli mostrano il viso, e però hai tempo di rilegarti e di far nuov amente testa.
E l'ultimo Marescial di Biron 237 so le va dire che, quando anche non avesse av uto che 100 cavalli, li avrebbe ripartiti in tre truppe, l'una delle quali non si fo sse mai azzuffata se non p e r grandissima nece ss ità ma fosse rimasta ferma e t immobile verso la mano diritta accioché ella av es se potuto tenere il nemico in maggior suggezione. Se bene un buon capitano può rimediar a tale suggezione, ordinando nell ' istessa maniera un'altra truppa di forza eguale o superiore contro a quella che sta ferma , né lasciandola muovere se non al moto di quella, poi col r esto procedendo a combattere sì come egli ha determinato di vo ler fare.
237 Charles de Goncaut, Duca di Biron (1562 -1602} , figli o d i Armand, b arone d i Biro n , Maresciallo di Francia, si baccé val orosame nte ad Arques e lvry. Fat t o a sua volta Maresciallo da E nri co IV nel 1594 per il su o contributo alla campagna contro il Farnese, no mi nato Pari di Francia nel 1598, conqu istatore di Bourg, si lasciò t r asc in are in intr ighi con Carlo Emanuele I, Duca di Savoia, posc ia en t rò in una ver a e pro pr ia cospirazi one contro Enrico IV. Arrestato a Foncainebleau, r is ultò che aveva i nvi ato al Duca di Savoia p ian i segreti delle Forze Armate francesi. Processato, fu decapit ato alla Bast igli a.
4. La risoluzione che si deve pigliare subito che si scopre il nimico, di combattere in un modo o in un altro, tosto o tardi, sostenendo o facendo impress ion e sopra di lui, dipende dall'aver lingua sic ura della qualità sua, s'egli è forte o debile, se seguita più quantità di gente o se non segue, se le prime truppe sono molto avanzate dall'altra o non so no, se vi è qualche passaggio fra i primi e gli ultimi o no, e che sorte di gente sia quella che si vuol combattere , perché dal ri con os cer male si capita talvolta in grandissimi disordini e credendo che i molti sieno pochi s'impe gna male a proposito e disavantaggiosamente a combattere, si come arrivò al Pappenhei m che alla battaglia di Leipzig, riconoscendo l' Armata svedese per una so la partita, cominciò prima a scaramucciare, poi a caricare con compagnie e con reggimenti intieri, s in che ebbe tutta la Cavalleria impegnata ad un combattimento generale fuori dei vantaggi del campo e senza ordinanza di battaglia e senza dar tempo a tutti i reggimenti d'esser presenti, e sì come anche fu quasi per occorrere presso Pegau, dove una partita imperiale attaccò quasi t utta l' a rmata di Banér, immaginandosi che non fu sse se non bagaglio con qualche convoi 238 • Così anche cr edendo che i pochi sieno molti si perdono molto belle occasioni .
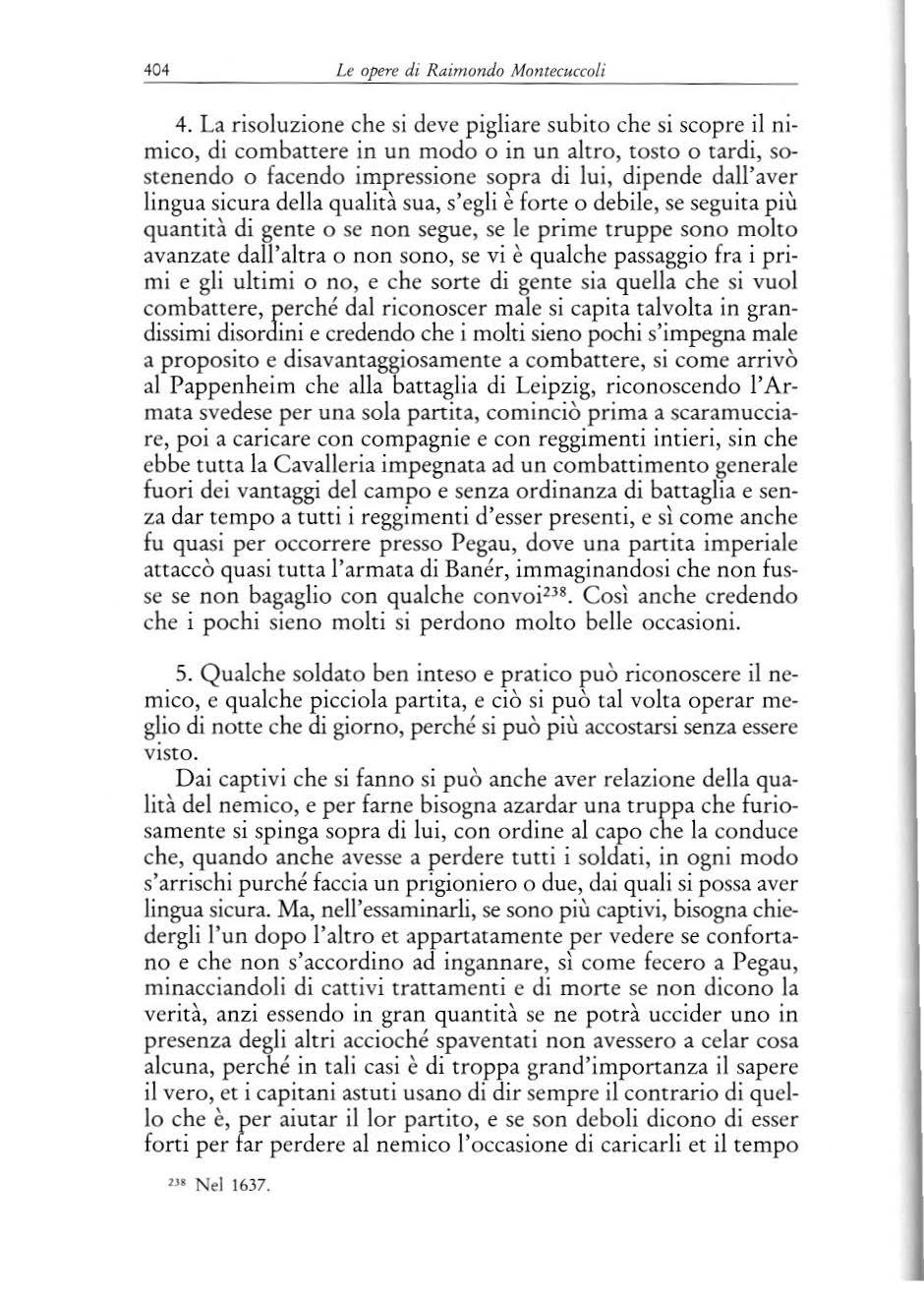
5. Qualche soldato ben inteso e pr atico può riconoscere il n emico, e qualche pic cio la partita, e ciò s i può tal volta op era r meg~io di notte c he di giorno, perché si può più accostarsi sen za essere visto.
Dai captivi c he si fanno s i può anche aver relazione della qualità del nemico, e per farne bisogna azardar una truppa che furiosa ment e s i spinga sopra di lui, con ordine al cap o che la co ndu ce c h e, quando a nch e avesse a perdere tutti i soldati, in ogni modo s'arrischi purché faccia un prigioniero o due, dai qu ali si p ossa aver lingua sicura. Ma, nell'essaminarli, se sono più captivi, bisogna chiedergli l'un dopo l'altro et appartatamente per vedere se co nfort ano e che non s'accordin o ad ingannare, sì come fecero a Pegau , mi na cciandoli di cattivi trattamenti e di morte se non dico no la verità, anzi essen do in gran quantità se ne potrà uccider uno in presenza degli altri accioché spaventati non avessero a celar cosa alcuna, perché in tali casi è di troppa gra nd 'im portanza il sapere il vero, et i capi tani astuti usano di dir sempre il contrario di quello che è, per aiutar il lor partito, e se son deboli dicono di esser forti per far perdere al nemico l'occasio ne di caricarl i et il tempo zJs
di batterli prima che ringrossino, e se so no forti di co no di esser deboli per far perdere al nemi co l'occasione di ritirars i e di salvarsi.
Si ricono sce anch e il nemi co dalla contenenza che tiene e dalla maniera con che sta, perché se manda v ia gli stendardi e se li mett e in un mucchio , o se non osserva le di stanze e s i confonde, o se va cambiando di posto se n za stabilità e senza va ntaggio, o s i ve dono i ste ndardi vacillare, si può far giudicio c h 'e gli sia pr es o dal timore e dalla confusione ne abbia c u ore di com battere vigoro sa ment e . E sebben e non s'approssima oggidì sì presso gli uni degli altri co me n ei tempi passa ti per cagione dell'artiglieria, in ogni mod o i capitani esperti si se rvono ultimamente di tali giudici, e giudicando che il nemico s ia intimorit o non bisogna in alc un modo perd e re l'occasio ne di combatterlo, e se non s i può arrivargli sì presto addo sso con tutte le truppe p e r dubbi o di non vi arriva re troppo sconcertato e disunito, non bisogna p e rò tras c urare di dar all'azardo e commettere alla fortuna qualche gente co mmandata c h e d'imp eto e di fortuna lo pigli, come s i suol dire, a pi é levato, n é gli dia tempo di st abilirsi, s1 come riuscì mirabil me nt e a T angermiinde contro i Svedesi, perch é quando anche della ge nte com mandata fosse battuta, non v i sar ia gran mal e perché s'è già presupposto ch e possa essere, né s' ha fatto il suo fondamento sopra di quella ma sopra l' altre truppe che si tengo~o insieme, e in ogni modo può essere che ella sola atterri sca di sorte il nemi co che è già confuso ch 'ei si metta totalmente in rotta vedendola venire sopra di lui sì impetu osa mente; e questa è la ragione c he quando uno si ritira al la prese n za del nemico, quand o bene n on volesse in alcun modo co mbattere, deve in ogni modo comman dare qualche truppa che faccia la ritirata, non già per sostene re totalmente il nemico s'ei viene sopra di lei, perché egli sarebbe cosa imp oss ibile, ma per far arrestare e fermare qu este truppe sci olte che alla sbandata si sogliono mandare avanti dai saggi capitani a perseguitare, o c he spontaneamente vi vanno, perc hé si suppone che il grosso non possa seguitare così velocemente se nza disordinarsi, co nfondersi e disunirsi .
Il combattere parti co larm ente riguarda genera l mente i rin co ntri che si fanno il più sove nt e p e r accid e nte e con qualche p artit a dell' esserc ito , e ri sguarda in spec ie principalmente le sc aramu cci e, l'i mboscat e, le sorprese dei qu artier i, d ei for aggieri e delle guardie.
I. Nel co mbatter e s i oss erva ge ner almente, oltr e a quello c he si è detto nelle Battaglie, c he qualc h e generatione d'armi è più propria per o ffe ndere come le lan cie, le carabine, e qualcuna per dif-

fendersi e sostenere come le corazze e le picche. Le lancie investiscono di corso le trupp e nemiche e le rompon o, le carabine, o in luogo di quelle i moschettieri a cava llo, c he si chiamano Dragoni (questi solion o o rdinariamente combattere a piedi , ma se anche fossero essercifati a saper com battere e tirar giusto a cavallo tanto meglio sarebb e, perché in molte occasioni nelle parti non hann o tempo di mettere pié a terra), assal tano con tiri il nemico e lo perseguitano.
1. Le lanci e combattono in una sola fila o a l più in due, con picciole truppette, perché investendo di co rso n o n posso no avere tutti i cava lli galoppo uguale , e però sia per essempio un a truppa di lanci e di 64 uomini per assalir un nodo di fanti o di cava lli n emici, si può ordinare in più modi, come in 4 file ciascuna di 16 uomini e con distanza co nvene vole una dall'altra, ovvero in fronte, qu attro file come le prime, ma disposte in due file, e ciascuna delle file raddoppiata, ovvero sono disposte ad attaccar il nemico in quattro lati , o vero ad attaccarlo ne i lati e nei canti; e se si vuole ordinare questa truppa di lan cie non per investire ma pe r diffendere, s i pu ò dargli la forma quadrata , la qual e fa fronte da tutti e quattro i lati.

2. Le carabine, o moschettieri , o archibugieri, fanno l a loro discarica per ranghi o per file nel modo che fa fare l'esserciz io all' In fanteria, e dopo c he una fila o un rango ha tirato, va caracolla nd o a rimetter s i o dietro o sul lato dell o squadrone, cio è a dire a rifare fila o rango, et in quel mentre che piglia il ca racollo, ricarica l'archibugio, et in questo mod o può scaricare sulla fronte e su un fianco del nemico.
3. Le corazze servono prin cipalmente a sostenere, e si possono formar a squadroni quadrati, Riù solidi di fondo e più larghi di fronte secondo che si trova piu a proposi to, e se temes si d'es ser assalito da tutti i lati , si potriano ridurre in forma rotonda e sferica diffensiva, in due o tre file circolari, sì co me è )'Ile d'Eliano 23 9 • Per offendere, si possono ordinare le corazze in più trupp ette picciole che si ano disposte o a guisa di cogno o in una ordinanza dritta falcata o in m ezza luna o come altramente si voglia, pur ché sempre si osservi che qualche truppa più ma ss iccia sia sempre ordinata a n o n caricare, ma a sos tenere e a servire alle tru ppe che hanno caricaco di coperta, per rillegarsi dietro di lei.
4. I Dragoni, che di lor natura devono combattere a piedi, si ordinano come l'infanteria, cioè le picche nel mezzo et i moschettieri sull'ali, e sul punto del combattere devono guadagnare i vantaggi che l'occasione fornisce, come d'una siepe, d'un fosso, d'un bosco o d'una vigna dove s i getterà qualche moschetteria, d'un ruscello per coprirsi da un lato, ecc ., e nel combattere si soccorreranno i battaglioni commessi con quelli che non sono ancora venuti alle mani e si darà lor luogo di ritirata per rifarsi fra gli altri intieri rammassando, rannodando e riordinando i soldati rotti.
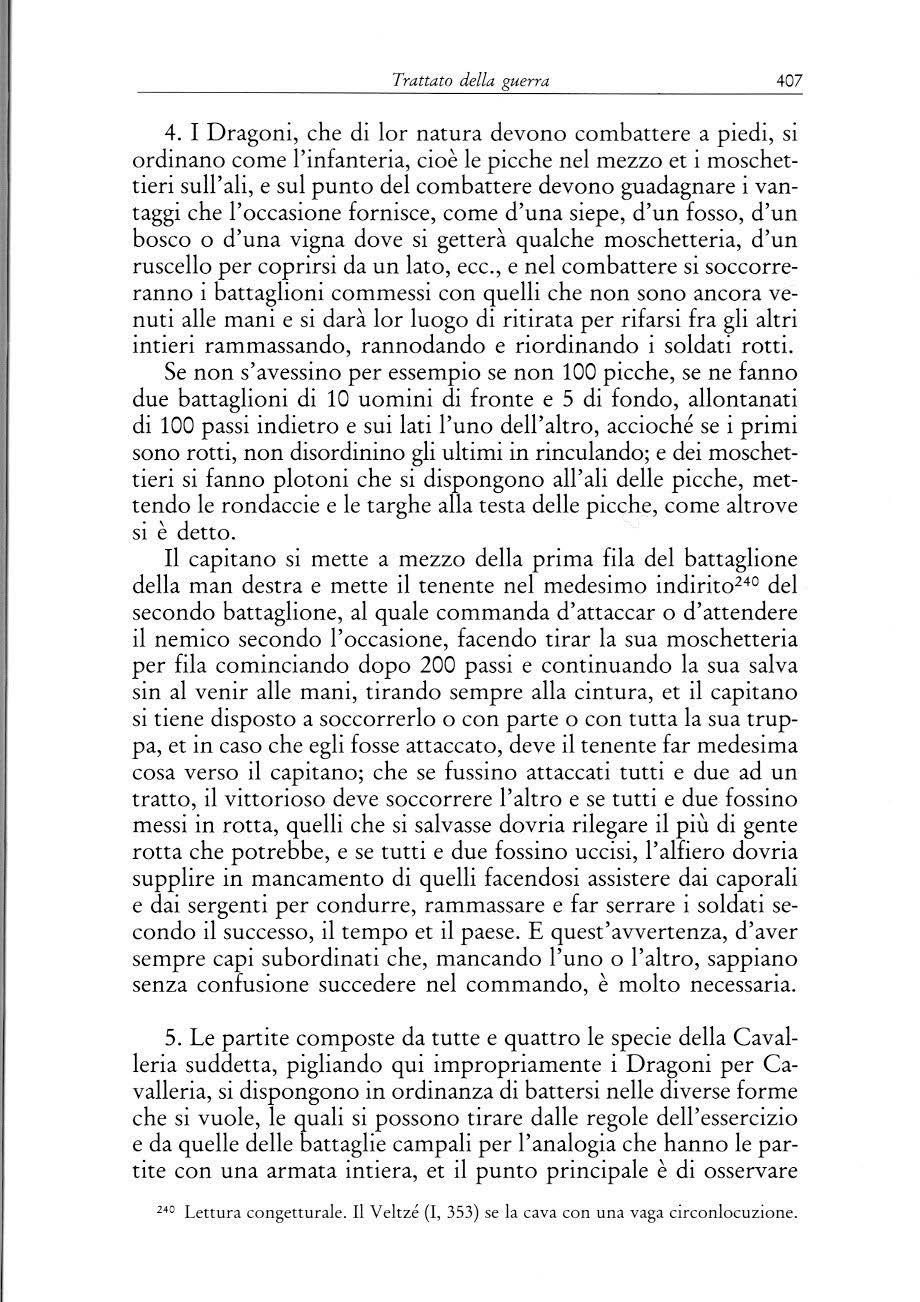
Se non s'avessino per essempio se non 100 picche, se ne fanno due battaglioni di 10 uomini di fronte e 5 di fondo, allontanati di 100 passi indietro e sui lati l 'uno dell'altro, accioché se i primi sono rotti, non disordinino gli ultimi in rinculando; e dei moschettieri si fanno plotoni che si dispongono all'ali delle picche, mettendo le rondaccie e le targhe alla testa delle picche, come altrove si è detto.
Il capitano si mette a mezzo della prima fila del battaglione della man destra e mette il tenente nel medesimo indirito 24 0 del secondo battaglione, al quale commanda d'attaccar o d'attendere il nemico secondo l'occasione, facendo tirar la sua moschetteria per fila cominciando dopo 200 passi e continuando la sua sal va sin al venir alle mani, tirando sempre alla cintura, et il capitano si tiene disposto a soccorrerlo o con parte o con tutta la sua truppa, et in caso che egli fosse attaccato, deve il tenente far medesima cosa verso il capitano; che se fussino attaccati tutti e due ad un tratto, il vittorioso deve soccorrere l 'altro e se tutti e due fossino messi in rotta, quelli che si salvasse dovria rilegare il più di gente rotta che potrebbe, e se tutti e due fossino uccisi, l' alfiero dovria supp lir e in mancamento di quelli facendosi assistere dai caporali e dai sergenti per condurre, rammassare e far serrare i soldati secondo il successo, il tempo et il paese. E quest'avvertenza, d'aver sempre capi subordinati che, mancando l'uno o l'altro, sappiano senza confusione succedere nel commando, è molto necessaria.
5. Le partite composte da tutte e quattro le specie della Cavalleria suddetta, pigliando qui impropriamente i Dragoni per Cavalleria, si dispongono in ordinanza di battersi nelle diverse forme c h e si vuo le, le quali si possono tirare dalle regole dell' essercizio e da quelle de ll e battaglie campali per l 'analogia che hanno le partite con una armata intiera, et il punto principale è di osservare
che ciascuna arma sia collocata in sito e luogo proporzionato alla sua natura e dov' ella possa ben fare l'ufficio s uo. Et i cavalli dei Dragoni s i lasciano dietro all'ordinanza, nudi, con due o tre uomini che li guardino, essendo la briglia dell'uno attaccata nel pomo della sella dell'altro perché non fuggano o si movano. Quando nei tempi passati la CavaJleria soleva per lo più co mbattere caracollando e la maggior part e erano archibugieri, come fanno anche quasi oggidì gli Spagnoli e come scri vesi che fac ea no gli Italiani che solevano co mbattere compagnia contro compagnia, gli uni dopo gli altr i, di so rte che spesso durava tutto il giorno il combattimento se nza vantaggio o senza gran danno dell'una parte o dell'altra, erano i precetti e le regole di quei tempi assai buone, et a nche le forme dell'ordinanza to llerabili, come quella di Melzi, ch e distribuisce la Cavalleria in quattro corna o vertici oblunghi, et altre . Ma ora c he si carica di fronte e si urta e si sfo nda senza caracollo e c he si us ano poche carabine (perché il caracollare e tornar adietro quando è fatt o da molte truppe biso gna necess ariamente che ge neri co nfu sio ne, tolga l'animo ai suo i e l'accresca al nemico che s i vede voltar le spalle) bisog na andarvi co n regole più so de e co n meno movimento, e perché in ogni modo da quelle r eg ole si possono pur anche o sse rvar molte cose che vengono appunto an c he in questa maniera di combattere che si usa in Alemagna, purché si mutino in qu ello che tocca la variazione dell'arm e, poi nel resto si osservi il medesimo scopo.
Si dirà che i pass ati capitani ripartivano la Cavalleria in tanti corpi, ciascheduno di 1000 cavalli, e ciasc hedun corpo era ripartito in centurie, cioè, si può dire, in 10 co mpa gnie, delle quali due erano di corazze e l' altr e otto di mos che tti o di carabine; o vero tre di corazze e !'altre sette di carab in e, e nel com batt e re le disponevano come si vede in 0, aggi ungendo picciole truppe nei lati, neJla front e e nel tergo, rappre se ntate p er la lettera T, et in questa maniera in ciasch edu n corpo era come una solida mol e di corazze con per tutto all'intorn o truppe di cavalli leggie ri, e se un co rpo venisse in co mb attere ad ess er rotto, il resto d ella battaglia rimane però indietro, sendo c he ciasc un corpo è di stinto da per sé né confuso agli altri, et i corpi turbati facilmente si posso no instaurare e riordinare sos tent ando gli altri la pugna, il che non si può fare bene quando tutta la Cavalleria è ammassata in grossi sq uadroni; ed è verissimo c h e, quanto più distinta è la battaglia e di più parti com posta, tant o più facile ella è a chi secondo il bi sog no vuol ripartire le truppe o congiungerle.
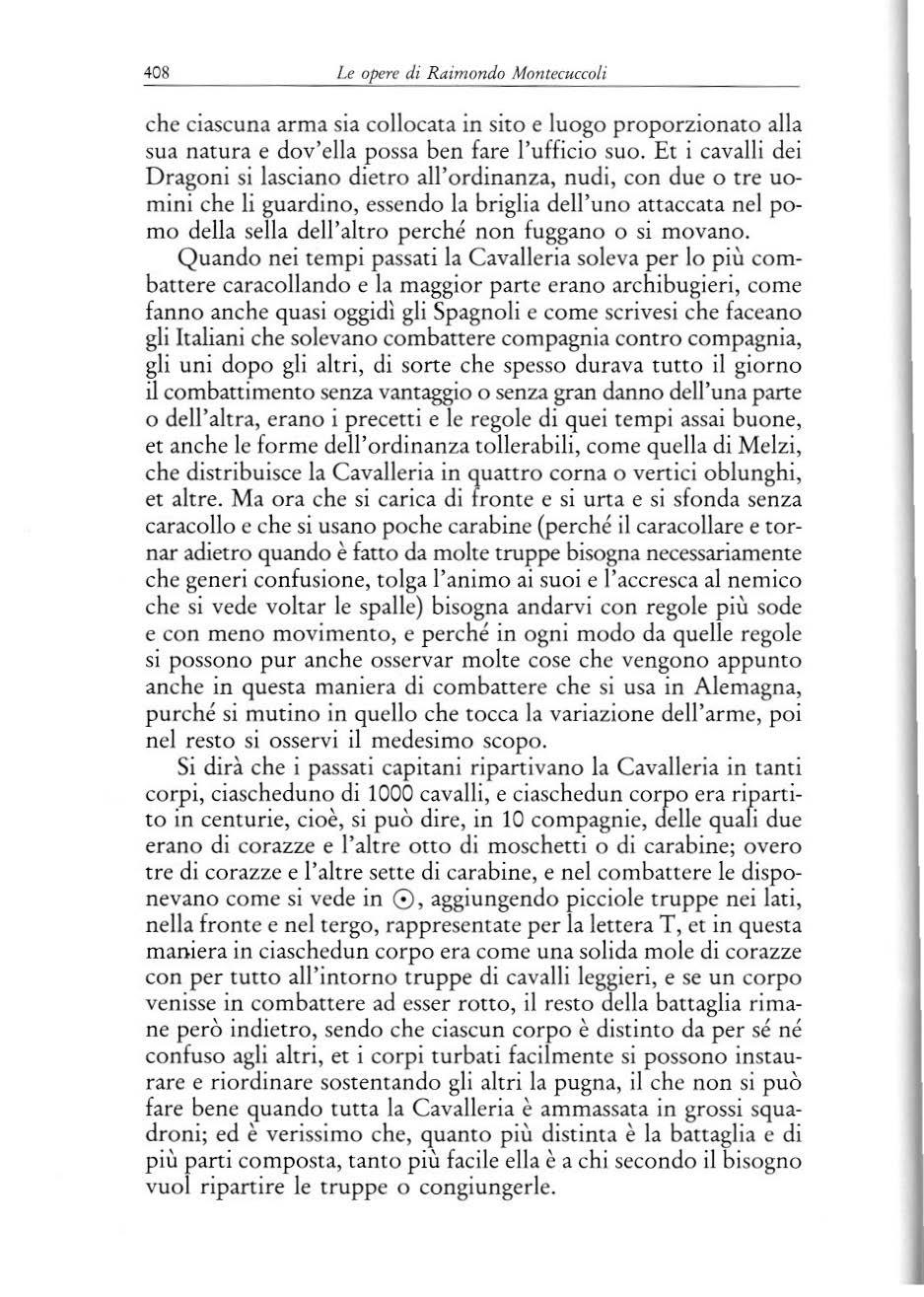
Si possono 24 1 anche disporre questi corpi in alt r e figure, come in ordinanza fallata, il che si vede rappresentato in ì) la q ual ordinanza fallata è che si parte il suolo in due gioghi c h e alternatamente si riguardano, dove nel primo giogo sono lasciati intervalli per i quali possono passare le truppe del secondo giogo, perché ell a non ha corpo e non ha se non una fronte duplicata, sicché se viene investita nei lati può faci lm ente essere presa alle spalle. In 9 si rappresenta un corpo ordinato a foggia di cogno in due maniere, e nella prima maniera la truppetta A è senza stendardo presa da tutte !'altre truppe, et è l'undecima; negli altri corpi e l'altre ordinanze non hanno se non dieci truppe. In si rappresenta un'ordinanza lun a re , la quale è migliore di quella che è so lo formata da due giogh i, ché tutta la forza [è] in una fronte sola nonostante che bisogna esser preparato in tutti i versi contro !'astuzie del nemico.
Ora colla disposizione di questi corpi così ordinati si deve combattere in tal modo . Prima le truppette di cavalli senza stendardo devono attaccare i fianchi del nemico, accioché i fianchi dei loro corpi non sieno da quelli importunati; girando le truppette h anno da scaricare i lor archibugi, ca r acollaranno alle spa ll e del corpo et in luog o di quelle che erano nella fronte succederanno l'altre truppette che stavano su l'ali e su l'ali verranno quelle che erano poste a tergo; l' altr e centur ie di cavalli (eccettuatone le corazze) entrano in zuffa una fila alla volta, né mai tutta la truppa caricherà se la battaglia nimica non è in rotta o s' ella non ha speranza sicura di penetrare. Nell'andar alla carica e nel venirne bisogna aver cura di non urtare ne ll e truppe dei compagni, e per contrario bisogna procurare colla celerità delle cariche e collo st esso respin ger il nemico che [l e] truppe dell'avversario correndo a vicenda si confondano. Le due o tre truppe di corazzier i devono sta r immote a guisa di muro o di machma, se non è caso che la fronte o i fianchi di tutto il corpo siano in pericolo, il che si vede rappresentato in ~ , dove le tre A, B, C fanno il primo giogo, in luogo delle quali, rimanendo ferme le due truppe di corazzieri, succedono D, E, H, poi F, G co rrono nel l uogo di D, E, ma le tre prime A, B , C ri tornano da tergo nel di H, F, G.
6. Se si rincontra improvvisamente il nemico, eg li è cosa molto utile il pigliar subito colle truppe qualche sito occulto dal qual si possa vedere e non esser visco, come un bosco, un alto, un fondo ecc. , perché se si conosce poi d'esser più forte del nemico si

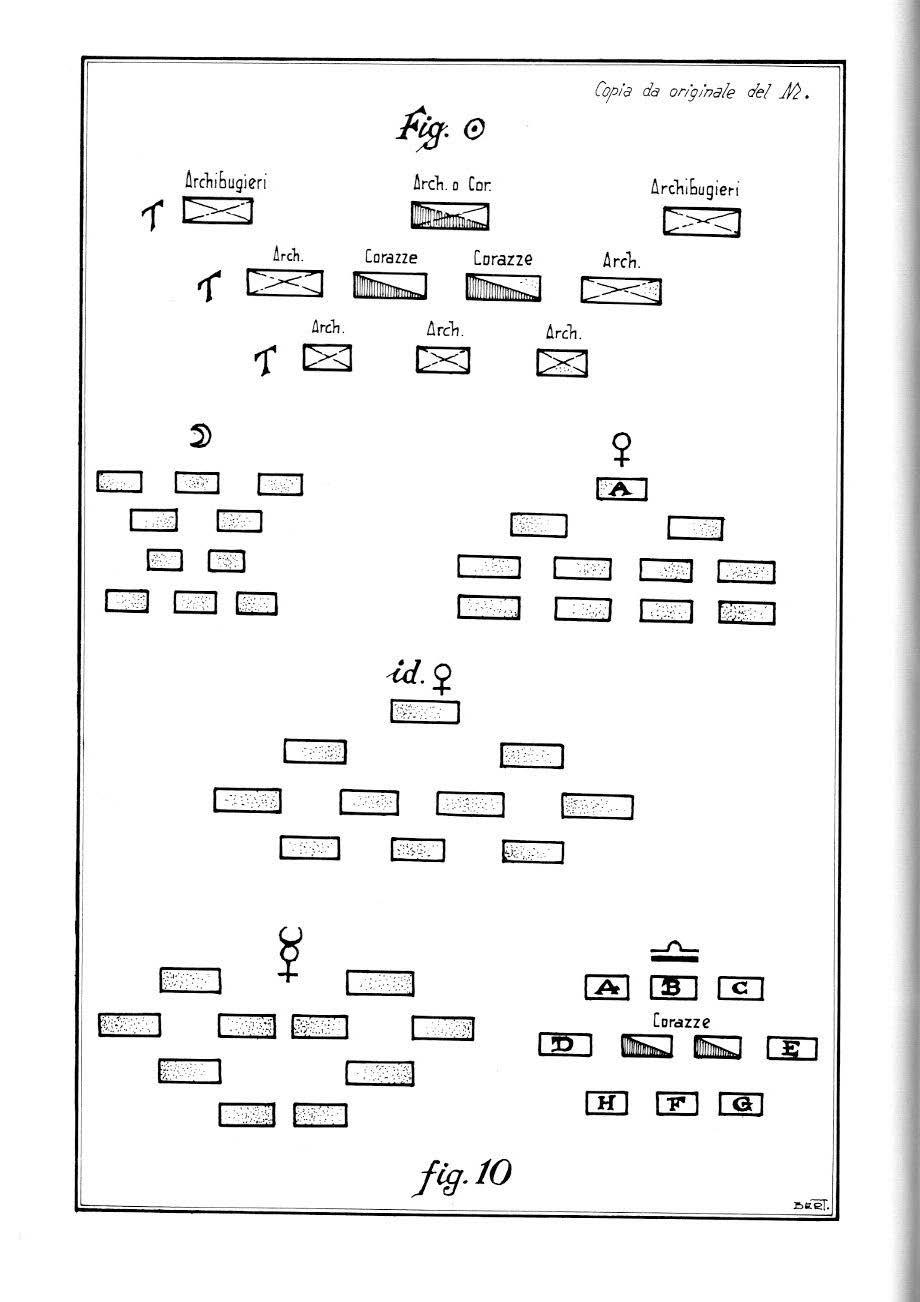
può risolutamente attaccarlo, e se si conosce d'esser più debole, o si può ritirarsi prima che il nemico ti scopra o se ti scopre, non potendo in ogni modo sapere quanto forte tu sia dentro al bosco e temendo di qualche imboscata, ogni poco di buon'apparenza che tu fai vedere o col stendere tutta la truppa in una sola fila (quando però non si possa scerner il fondo) o in altro modo, non ardirà d'attaccarti.
7. Herate in Tracia aveva fatto molti prigionieri, ma incalzandolo gagliardamente il nemico nella ritirata, espose i captivi nudi con le mani legate dietro alle spa lle ai dardi et alle frecciate del nemico , il quale, temendo d'offender i suoi propri, lasciò di tirare. Se si avesse fatto qualche prigioniero di qualità, si potria ben far desistere il nemico di perseguitare annunciandogli che se perseguita si leverà la vita al captivo, e si potria fare che il prigioniero istesso, per paura di essere ucciso, commandasse lui medesimo a quelli che venissino per liberarlo a forza di lasciar l'impresa.
8. Riesce alcuna volta nel combattere di far vista di fuggire e di pigliar veramente la carica, accioché il nemico seguisse disordinato, si stanchi e scarichi le sue armi: poi, quando le ha scaricate, si rivolta tutto in un tratto e ben serrato contro di lui e si rompe, e certo egli è gran vantaggio di aspettare a pié fermo che il nemico faccia la prima scarica e poi investirlo, perché occorre quasi sempre che il soldato che ha già la pistola vuota, non sapendo più come diffondersi, perda l'animo e si metta a fuggire e l'altro che ha avanzato il suo tiro urti con più sicurezza e più coraggio, e però non devono le co razze combattere se non con la spada, o, se pigliano la pistola alla mano, dev'essere la prima fila che deve nel medesimo tempo tener già la spada pronta nella mano della briglia, né deve scaricare se non a brugia giubbone per fare effetto, e non far come alcuni che si contentano di fare scoppio e pensano di spaventare in quel modo il nemico.
9 . Alcune partite portano le bande e l'insegne doppie, cioè quelle del lor colore e quelle del color d el nemico, per esser conosciute fra i loro et in caso di bisogno passare fra il nemico non riconosc iute, cingiendo or l'una or l'altra banda, conforme al bisogno .
G li Svedesi fanno talora belle imprese pigliando vestiti alla croata e passando fra gli Imperiali senza essere riconosciuti sendo stati presi per Croati, e similmente molti reggimenti tedeschi hanno

mandato i so ldati a rubare e spog li are il paese avendoli fatto vestire da C roati, accioché la colpa del misfatto fosse attribuita a qu elli di che avevan o preso ad imitar il vestito .
10. In caso che il n e mico abbia cinto una parti ta tutto all'intorno, né vegga[si] altro rim edio di salvarsi, bisogna accrescer il coraggio, serra rsi insieme e, fa ce ndo imp eto nella parte più d e bol e, aprirsi l a via tra il ferro e tra li mort i, perché la fortuna a ita sove nt e gli aud aci e se ne cade qualcuno m o lti si sal va no , ladd ove procede nd o timid ame nt e tutt i si perdono.
11. Nel mandare grosse partit e fuori d e ll'esserc ito a comb at t ere o in altra funzion e, bisogna procedere co n gran ca utela, e ve dere di mandarle ad i mprese sicure o con t anta provvid e nza che quasi non possa l o ro succedere male, perché sicco me di ceva il ge n e rale Galasso, se una tal grossa part ita è rotta o perché il n e mico la ri ncontri c on t utta l' armata o per qualche alt ro accidente, il tuo essercito r imane sì ind ebolito che tu non puoi più far testa al nemi co e. resti qu asi nel m edesi mo st ato come se tu avessi perso una giornata.
Sieno dunque le partite c h e si mandan o non tanto grosse, c he se gli succede disgr azie tutto l 'esse rcit o non ne s ia r eso inabile a m e nar la guerra avv e nturando tutta la fortuna e n o n tutte l e fo rze; o vero s i mandin o co n tal di sc rezion e c he si sia quasi s i curo d i bu on avenime nt o, perché altrimenti, qu ando si può e che si va a l n emico, eg li è m olto bene andarvi più forte di lui per no n fa llir e (diceva un Marescia l di Fran c ia) la sa l vat icina 242 •
II. L e scaram uccie s i fanno ordina riam ente, com e s'è detto, per riconoscer il nemico et averne lingua fa ce ndo qualch e prigi o niero, p e r far saggio di sé a l nemi co co n animo d'as sagia r anch e lui , p er attirarl o in qualche im b oscata, p er intrattenerlo acc io c h é non cam mini a suo piac ere o accioch é, ca mm inan do tu, non dann egg i l e tue genti e bagagli e e per guadag nar qu alc he sito.
1. Nelle scaramu cc ie l'arte e l 'astuzia ci è altrettanto neces sa r ia quanto l'imp e tuosit à, perché se i l paese è un poc o coperto si può preva lersi di molti vantaggi, m a se mpre profitta m o lto d' ordinar e l e sue ge nti per pi cc io le trupp e, assalire per fianco all'impro-
242 Intendasi: selvaggina.

viso, collocar bene la truppa che sostiene la quale dovria essere d'arme d'asta fra la Fanteria e di corazze fra la Cavalleria, occupando con essa qualch e sito vantaggioso, e finalmente venir determinatamente ai colpi della spada, rinfrescando i stanchi coi freschi, sostentando gli oppressi et ingrossando o diminuendo la fazione coll'ispigner innanzi e col ritirare una o più truppe dopo che i pr~mi più espediti avranno provoc ato il nemico e si saranno attaccati.
2. Quando non si vuol molto ingrossare la fazione, possono le truppe andare scaramuzzando per fila, siccome si fa nell 'essercizio, rimettendosi sempre le prime file dopo aver scaricato dietro dell'altre, e quando si vogliano ritirare i scaramucciatori si può spignere alla fazione una banda di gente fresca accioché ciascuno si ritiri con facilità e sicurezza e si trattenga l'impeto dei nemici, se pur venisse loro voglia di farlo.

3. Non si deve permettere mai, o di rado, che uomini segnalati né ufficiali né signori famosi si pongano in questa fazione a scaramucciare, ma sì bene a r eggerla e governarla prudentemente, perché senza proposito si vengono a perdere i bravi uomini e nella scaramuccia non possono effettuare niente più di quello che farebbe un soldato semplice, anzi che corrono molto maggior rischio perché non scaricano di lontano come gli altri ma, come obb li gati a fare qualche cosa più del comune, portano i loro tiri sì presso, che vog li ano avere il loro uomo sicuro, per lo che spesse volte vi rimangono; oltre che può facilmente un colpo di lontano e d'azzard o tirato da qualcheduno che contro le leggi della parità dell'arme si servirà d'una canna lunga o rigata, portar via una persona principa le, come successe al figlio del Re di Danimarca, ucciso in una scaramuccia attaccata con il Piccolomini.
I II. Nell'imboscate si usa principalmente la Cavalleria, la quale, s'è inferiore a quella del nemico, non bisogna mai metterla tutta intera in agguato, perché il nemico più forte potria similmente venirvi con tutta la sua Cavalleria e romperla; ma se la tua è più forte, poi adoperarla una volta o due tutta intiera i n imboscata, accioché dopo quando t'imboschi con qual si sia picciola partita il nimico abbia a temere che tutta la tua Cavalleria vi sia, e così per lo sospetto suo potranno le tue picciole partite effettuare ogni gran cosa. L'Infanteria si mette anche in agguato in posto avan-
taggioso per sostenere la Cavalleria in ogni caso ch'ella ne avesse bisogno, ma nell'imboscata si devon osservar alcune cose:
1. Elle devono essere occultissime al nemico, si devono mandare attorno cavalli per riconoscere se il nemico non avesse occupato i luoghi dell'imboscata e non fosse in agguato vicino a detto luogo; le sentinelle si devono porre sopra cima degli arbori o giacenti e carponi nei rialti di terra accioché veggano e non sien viste, le truppe che si menano all'imboscata devono tirarsi fuori del campo di notte tempo et arrivar negli agguati avanti l'aurora; le truppe che stanno negli agguati devono essere poste coi loro giusti intervalli acc ioch é non si confondano nell 'usc ir e o se per azzardo venissero ad esser caricate qui dentro; i corridori cercheranno di attirar il nemico o andando a rubare sot to una città dell'avversario dove sia dentro sua guarnigione o predando altramente sopra il suo paese o levandogli un quartiero o battendogli una guardia o mandandoli un fidato che, sotto specie di fuggitivo, gli dia qualche impresa sopra di te, perché in questi casi è credibile che egl i d eva seguitare i tuoi corridori e le tue prime partite per ritrarre loro la preda o per aver vantaggio sopra di loro, et in tal modo l'attireranno nell'imboscata già fatta o vero quella partita stessa che ha predato, dopo aver mandato innanzi la preda et i soldati imbarazzati nel buttino, si terrà col resto ali' ordine e rinfrescata, e quando arriverà il nemico stanco, disordinato e distratto, potrà improvvisamente investirlo e batterlo.
Nissun dei corridori e dell e partite che vanno innanzi per attirar il n emico (fuori che il capo che guida) deve saper cosa alcuna d e ll'imboscata. Devono le trupp e aguatate so rtire et investirlo determinatamente nei fianchi o nelle spalle.

2 . Alcuni hanno fatto vestire in abito di donne soldati sbarbati, poi mandatoli a passare propinquo a qualche guarnigione nemica, di dove potevano esser visti; o mandano sotto spetie di fuggitivo il loro fidato, ch'avvisassi che tali donne andavano qua o là; il nemico è uscito con poca gente per pig liarl e ed è stato battuto. $aria meglio farli vestire in abito di garzoni e di foraggieri, con la falce e coi sacchi e con ]'arme coperte.
IV. Le sorprese dei quartieri richiedono gran valore e grand'arte; si sog liono attaccare i quartieri sul fare della notte, prima che siano
dati gli ordini, poste le guardie e collocate le sentinelle, e che il nemico, essendo poco prima giunto, è impedito e distratto nel cercar i foraggi e nell'accomodare gli alloggiamenti; o allo spuntar del giorno, quando il nemico si ritira a dormire e riposare dopo l'aver vegliato la notte, o di bel mezzo giorno, quando la più gran parte dei soldati nemici è fuori a foraggio e che la qualità dell'ora li fa più sicuri e meno guardinghi, o finalmente poco dopo la mezza notte per avere almeno due ore di notte d'avan z o per favorire la sua ritirata in ogni caso che l'intrapresa venisse a mancare.
1. Le truppe che vogliono attaccare un quartiero possono commodamente essere distinte in cinque corpi, dei quali il primo con impeto affettato perseguita i corridori del nemico e le sue sentinelle subito che da quelli è scoperto e penetra con loro costantemente fin nel quartiero et investisce il corpo di guardia, il secondo seguita il primo con eguale velocità e si riparte e occupa varie strade degli alloggiamenti accioché il nemico non possa rammassarsi e far corpo, il terzo segue un po' più adagio e ben serrato et occupa la piazza del quarti ero. Il quarto passa attra ve r so del quartiero, né stimando necessario l' entrarvi si di v ide in più trupp ett e ch e circondano per di fuori il villaggio et occupano l'entrate e l'uscite accioché sia serrata ogni fuga al nemico e chi n ' esce sia tagliato a pezzi. I garzoni hann o cura di pigliar i cav alli che si guardano 24 3 alla mano accioché i soldati non siano imbarazzati, et aiutano anche a mettere il fuoco nelle cas e e nei quattro canti del villaggio quando si vuole, accioché il nemico non si metta alla difesa di qualche alloggiamento o che gli ufficiali non si nascondino per non esser fatti prigionieri.
2. N ell'andar alla sorpresa d'un quartiero si cerca di pigliar una strada che venga a riferir sui fianchi o alle spall~ di quello per arrivargli sopra ben all'improvviso, supponendosi che quelle parti non sieno così diligent e mente guardat e co me la front e ; o che venga da un altro quartiero d el n emico che si lascia non attac cato, o vvero si asp etta ch e i battitori di strada di d etto quarti ero ritornino indietro e poi si ma r cia non osservati dietro di quelli; ovvero si fa un'imboscata a detti battitori di strada e tagliandoli fuori s'impediscono di ritornar a dar lingua al quartiero; o si sorprendono le sentinelle o con altra maniera si sorprende la guardia, dandosi fuora per gente del nemico, parlando la sua propr ia lingua, simu-
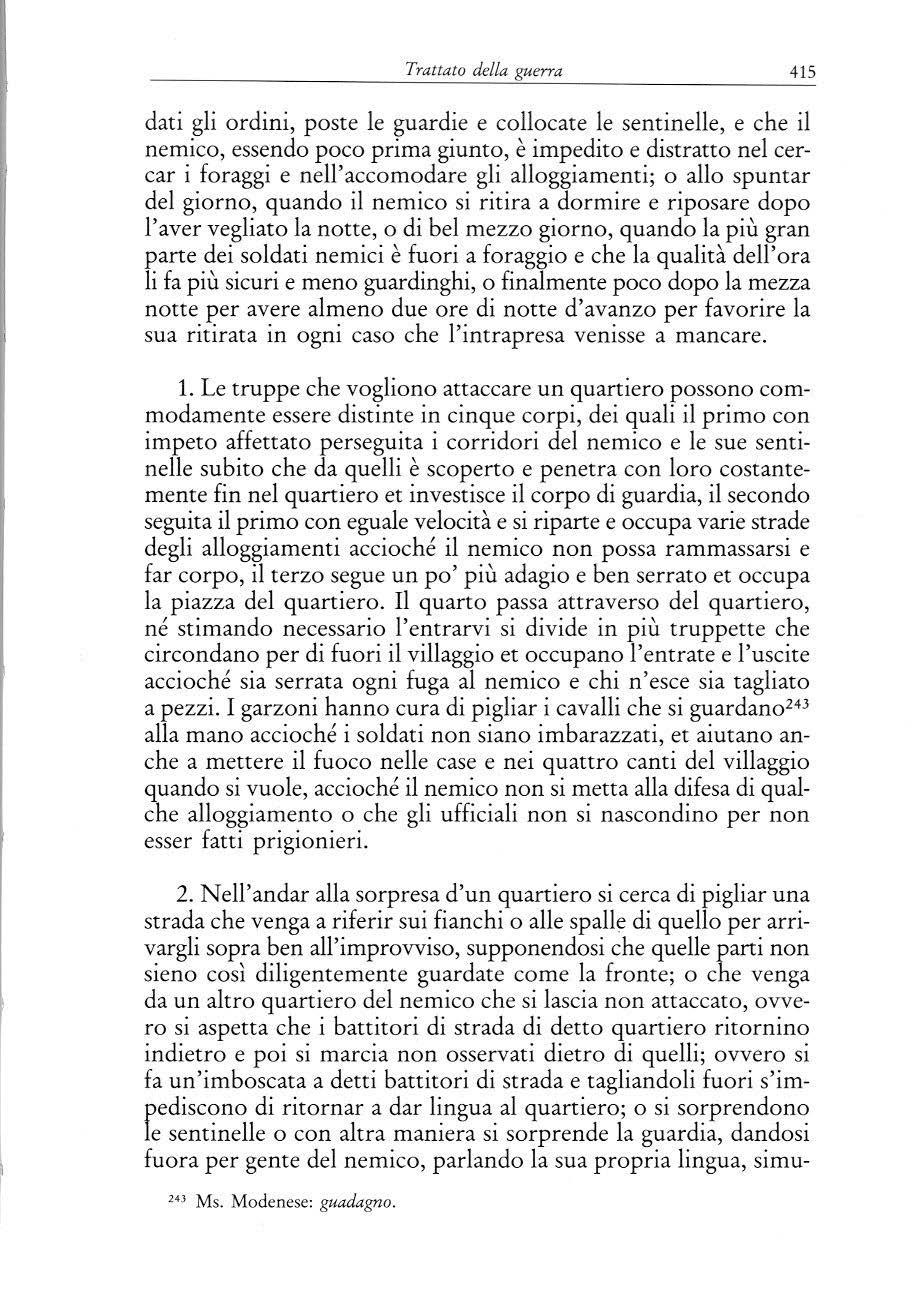
lando d'esser una delle sue partite che si sa esser fuori, massime se si hanno fatto dei suoi prigionieri che si costringono a parlare per far fede all'inganno, o se si hanno guadagnato le sue insegne, le sue armi, le sue vesti, le sue navi, se il quartiere è sul mare o su qualche fiume, nelle quali tu metti dentro i tuoi soldati e gli introduci nel quartiero sotto colore dei soldati istessi del nemico che ritornano, o se in qualche modo per mezzo di spioni, di fuggitivi o di prigionieri se gli è rubato il nome e la parola.
3. Quando s'intraprende sopra un quartiere bissogna ben compassare e confrontar il tempo nel quale si può avere fatto l'effetto e ritiratosi , e quello nel quale i soccorsi degli altri quartieri possorio arrivare, per non incorrere in qualche disgrazia; e quando si teme del soccorso che non è molto lontano da] luogo sopra il quale si vuole intraprendere, è bello stratagemma, nel medesimo tempo che si dà nel quartiere che d eve essere levato col grosso della partita, di mandare qualche numero di Cavalleria al quartiero di donde si sospetta che venga il soccorso, facendo grande fanfare di trombette e grida di battaglia accioché il soccorso pensi che se ne vog_lia a lui? et in tal sorte tenerlo a bada sintanto che l'intrapresa s1 essegmsce.
4. Se tu hai lingua che il nemico ti voglia dare sul quartiero, puoi sul far della notte leva r la gente dagli alloggiamenti e condurla quivi vicino in qualche valle o bosco dove stia nascosta, lasciando però il bagaglio dentro al quartiere, accioché mentre il nemico e intento a spogliar quelle e distratto, tu possa arrivargli sopra improviso e batterlo.
V. I foraggieri del nemico si combattino o assalendoli all'improvviso e distratti, o attirandoli in imboscata fingendosi della lor gente o facendo come sopra s'è detto dei quartieri , cioè presentarsi con l' armata in battaglia dinanzi al campo del nemico, poi di là mandar la Cavalleria leggiera ad attaccare i suoi foraggieri, il che usò Banér contro Hatzfeld eh' era alloggiato a Perleberg all'Elba243 bis, perché il nimico non può dar battaglia (supponendosi che egli sia più debile, e anche perché egli è indebolito per l'absenza dei foraggieri) né può recare aiuto né soccorrere i suoi soldat i sparsi nei campi.
2 • 3w N el 1636. T utta la parte più sopra delinea con str ao rdin aria lucidità q uelle che oggi si defin iscono operazion i di commandos.

1. Il portar v ia una guardia riesce talvolta non molto difficile, massime quando si ha lingua ch'ella è situata lontana dal campo e molto avanzata, perché si può tagliarla fuori, si può venirgli addosso dalla parte ch'ella stima la più sicu ra e sorprenderla, massime essendo pochi quei che hanno la guardia in rispetto della partita che li assalta, ch'è composta di molti. E prima che quei del campo abbiano tempo di montar a cavallo, la vanguardia è di già battuta e la partita che l'ha fatto è ritirata, si come fece Be nigfarisz quando Galasso e ra accampato a Mezieres in Lorena.
2. Ma perché anche nei combattimenti e nei rincontri prosperi s i vanno consumando le proprie forze, né si ha tanta fede nei soldati delle genti domate qu anta s i ha nei domestici, però egli è necessario che chi vuole continuare la guer r a, sia vinto o vincitore, pensi con ogni studio ai rinforzi et alle recruite le quali devono venire spessissime volte all'armata de' soldati propri, sì come manda il Re di Spagna n ei Paesi Bassi e sì come mandano i Svedesi in Alemagna, e perché anche durando la guerra si fanno molti prigionieri da una parte e dall'altra, proprio di questi due punti si tratt e rà nel capitolo seguente .

Delle recruit e e de ' capt iv i
Chi vuol acquistar gran paese, ha di tanti amici affezionati e divoti bisogno che non so lam ente il resto de lla gente sogg io gato contrappesino, ma gli restino anche superiori, e però, conoscendo Cesare che se n za molta gente non si può cosa grande imprendere, si provvide d'un esse rcit o grosso e numeroso, percioché egli ebbe nella Gallia dieci legioni che con gli aiut i non faceva no meno di 60000 co mbatt ent i, si valeva dei Galli e di Alemani a suo piacere e s'ubbligava le cit tà e i Principi con grossi presenti e co n aiuti d'arm e e di soldati che loro mandava.
E se bene una troppo grossa armata è inuti le, sì come s'è detto, in ogni modo ciò non si deve intendere della quantità della gente, la quale non è mai dannosa, perché non si tiene tutta in un corpo, ma se n e fanno d iverse armat e che assaltano da diver se parti il nemico, ovvero mentre che l'una arrischia una battaglia l'altra si tiene sui confini del paese per opporsi al nemico in ogni caso di disgrazia, o vero si rilevano vicendevolmente nel travaglio, guerreggiando l'una la state e l'altra il verno, ovve ro con l'una che sta n egli agi e sen za combat t ere si va di mano in mano rinforzando quella c he guerreggia e che anche nelle cose prospere va necessariament e scemando per le malattie, per le morti, per le st ragi e per l'infed e ltà di que lli c h e fuggono.
I. E molto importa alla reputazione di un Prin cipe che m e na guerra che il paese dov'ei guerregg ia vegga c h e non so lo può s ustituire subitamente una nuova armata ad un'altra distrutta, ma farla anco maggiore et accrescere di forze.
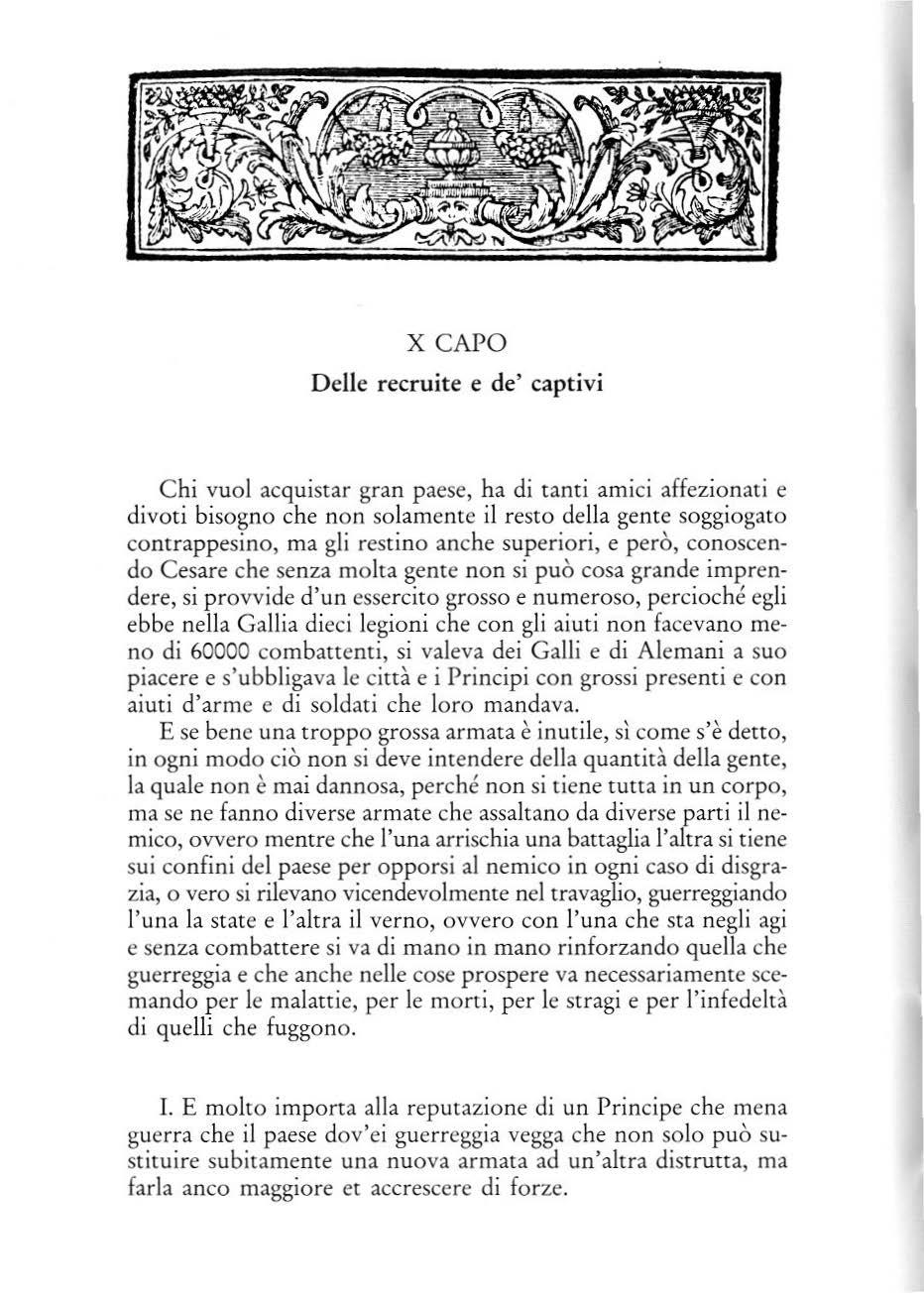
1. Come si possa sempre abbondar di soldati fedeli ne ha discorso assai bene Tomaso Campanella nel cap . XV della Monarchia Spagnola, e per tenere sempre l'armata completa, salvo se non succedesse una rotta generale, hanno alcuni Principi pagato sempre una squadra di più a ciascheduna compagnia, la quale si chiama la truppa persa, e con essa si ristauravano sempre i luoghi di quelli che mancavano o per esser morti o malati o per essere fuori a foraggio, e così la compagnia veniva sempre per qualsivoglia accidente ad essere piena, né pativa alcuna alterazione nell'ordinanza del marciare, dell 'al loggiare o del combattere. Altri hanno pagato alcune piazze morte dette passavolanti, cioè ad ogni dieci uomini una piazza morta, ai ca pti vi, col qual denaro d'avanzo essi capitani erano obbligati, quando la lor compagnia scemava, di [illeggibile] e di tenerla sempre completa sin all'intiero licenziamento di quella.
Il Conte di Collalto faceva pagar i reggimenti per completi quando entravano nei quarti er i di verno , benché non fussino, accioché del denaro di sovrappiù ciascun capitano fosse ubbligato all'uscir dei quartieri di condu rr e fuori la sua compagnia completa, sotto pena d'esser cassato e spogliato e disonorato.

Nell'Armata Imperiale s'è talvolta usato di far nuov e levate della gente del paese, poi distribuirla fra tutti i reggimenti e compagnie tanti uomini per compagnia, accioché i soldati novamente levati e bisogni imparassino dai vecchi fra i quali erano misti. Altre volte non si sono dati i quartieri di verno se non per la gente effettiva, ma s'è dato denaro di recruitti per riempire le compagnie che suo l essere 1000 talleri o 1000 fiorini più o meno per compagnia, secondo la necessità e secondo la volontà del signore . Invece di denari di recruitte si soglio no talora assegnare piazze di recruitte .
2. Le recruitte si fanno talora di soldati del nemico captivi che si costringono a pigliar servizio o eh' escono da una guarnigione che si rende a discrezione, o si fanno dei garzoni dei soldati i q u ali sono già avezzi fra l'armi ai disagi et a governar i cavalli, o si fanno come le prime levate, mandando attorno ufficiali conosciuti e liberali che gli persuadano a pigliar so ldo e servicio et in questo modo si conservano gli esserciti si può dir immortali, perché i vacui sono sempre turati con nuovi soldati .
II. I captivi erano nei tempi passati di condiz ion e miserabile, sendo astretti ad ogni servizio più vile et a supplici più acerbi di
qual sia morte. Sesostri forzò quattro re prigionieri a tirar il carro, Tam erlano trattò Baizette miserabilmente 243 ' " , Basilio II, vittorioso di Samuele R e dei Bulgari, fece cavar gli occhi a 15000 captivi, li Sciti usavano di ber il sangue dei prigionieri, poi del crani o farne una scudella da bere, e delle cuoia cucite insieme si servivano come del cora me d'altre bestie, e chi più aveva di tali cuoi e di tali scode lle era stimato più valoroso. Altri espo nevan o i prigionieri in preda alle fiere, et altri, instando il tempo di una battaglia et avendo molti prigionieri, commandò sotto pena della vita c he ciascuno ammazzasse il suo, accioché mentr' essi erano occupati nel combattere, quelli, scioltisi dai legami, non ripigliassino l'armi; altri hanno fatto tagliare ai prigionieri il dito grosso della man de stra, accioché non potessino più man eggiar la picca ma serv ir al remo schiavi, dove mancavano la lor vita miseramente, sì che spaventati gli uomini da questo timore, tenevano gli essercizi militari vivi, combattevano ostinamente et onor avano chi era ec cellente in quegli; i Romani ranzionavano di rado i loro captivi, sti mand oli di poco cuore.
1. Al tempo d'oggi la Cristiana R eligione ha colto questa tirannia e per conseguenza questa paura è in maggior parte perduta, perché dei vinti pochi se n 'a mmazzano, et i prigionieri con facilità si liberano, sì che di qu i procede in gran parte la ignavia di molti e ch e non si combatte più sì ostinatamente come dianzi, e se ben e c hi vin ce ha un pieno ius nel vinco captivo, in ogni modo risovenendosi i capitani della fortuna lubrica et instabile e che possono incorrere nel medesimo caso d'esser fatti prigioni, hanno introdotto di dar quartiere per i quali è lecito a chi si sia, quando non si può più diffendere o per esser ferito o per esser portato per terra o per essere abbandonato dagli altri, il ren der si al nemico dal quale poi ottiene in qua lche tempo la libertà. Egli è ben vero che, se un Principe conoscesse di poter mantener la guer ra più che il suo avversario e d'avere più abbondanza d'uomini, potrebbe proibire che non si dassino ne ricevessino quartieri, nel qual modo sare bbon o estinti i nemici fin dall a radic e.

2. Nelle guerre ben r egolate si sogliono riscattar i prizionieri co n la ranzione 244 che suol essere la somma di un mese d1 sol do.
W rn D o po la b att ag li a di Ank ara, 20 lug li o 1402, in cu i T ame rl a no sconfisse e fece prigi o n ie r o il Sultan o Bajazet I.
2 44 Come prec., riscatto (da rançon).
Nelle guerre che mena l'Imperatore non c'è cartello stabilito coi suoi nemici, perché non è della Maestà di Cesare il trattarsi egualmente con altri, né fu trovato buono il cartello che lo Hatzfeld vo leva stabi lir e col Banér quand'egli era a Torgau, ma i prigionieri si riscattano chi più e chi meno secondo la faco l tà loro, ovvero si cambiano con altri captivi della medesima ca ri ca, e se il prigioniero è di gran qualità si può chieder in ricatto qualche città o castello; talvolta si minaccia il nemico di mettergli a fuoco il paese se non rende i capti v i, dalla qualcosa spaventato li rimanda senz'altra ranzione, sì come il Baner minacciò ultimamente l'Elettore di Brandenburgo, e si riscattano anche alle volte i cadaveri degli uomini di condicione, rendendo loro in questo modo la sepoltura.
3. Se i captivi sono naturalmente vassalli del Principe che li piglia si possono far giustiziare come ribelli, et altri che sono indifferenti si lasciano liberi a condizione che giurino di non se r v ir mai più contro il Principe che gli ha avuto prigioni, o vero si fa loro tanti onori e si praticano tanto famigliarmente che si rendono sospetti dalla parte loro.
4. Fra l'Armata Imperiale e la Sv ed ese i prigionieri di qualità sono trattati molto co rt ese m e nte et i generali si piccano di magnanimità e gentilezza; Banér ha tenuto un pez zo gli ufficiali appresso di lui a tavola franca, poi mandatoli in altre parti si è contentato di aver parola da loro da cavaglieri che non se ne andassino se non con sua licenza e passaporto, né tentassino cosa alcuna contro di lui finché sono prigionieri; e così senza guardia alcuna gli ha lasciati andare per tutta la città e praticare con chi essi volevano, et anche qualche volta fuori della città a spasso, con licenza però del governatore e del commandante del luogo il quale solea mandar fuora con loro un ufficiale o due sotto colore di servire e di tener compagnia; le lettere si scrivevano e si sogettavano a sigillo volante 2 45 , le quali erano lette dai segretari a ciò de putati prima di essere sp edite, sì come anche quelle che venivano d' altrove ai prigionieri erano prima lette, poi cortesemente consegnate. Se qualche trombetta veniva mandato ai prigionieri dalla lor armata, era messo in un alloggiamento co n guardia, né si lasciava parlare ai prigionieri se non con la licenza del commandante et alla presenza di qualche ufficiale; simile cortesia ha anco fatto usare l'Imperatore coi prigionieri svedes i.
245 Lettu r a co n gett ur ale; q uesro p asso n arra pro b abi lm e nt e le esp e r ie n ze person ali di M. d ura nt e la prigionia. Il sigillo volante era tale da c o nse ntire la lett ura d a p arte d ei ce n so r i.
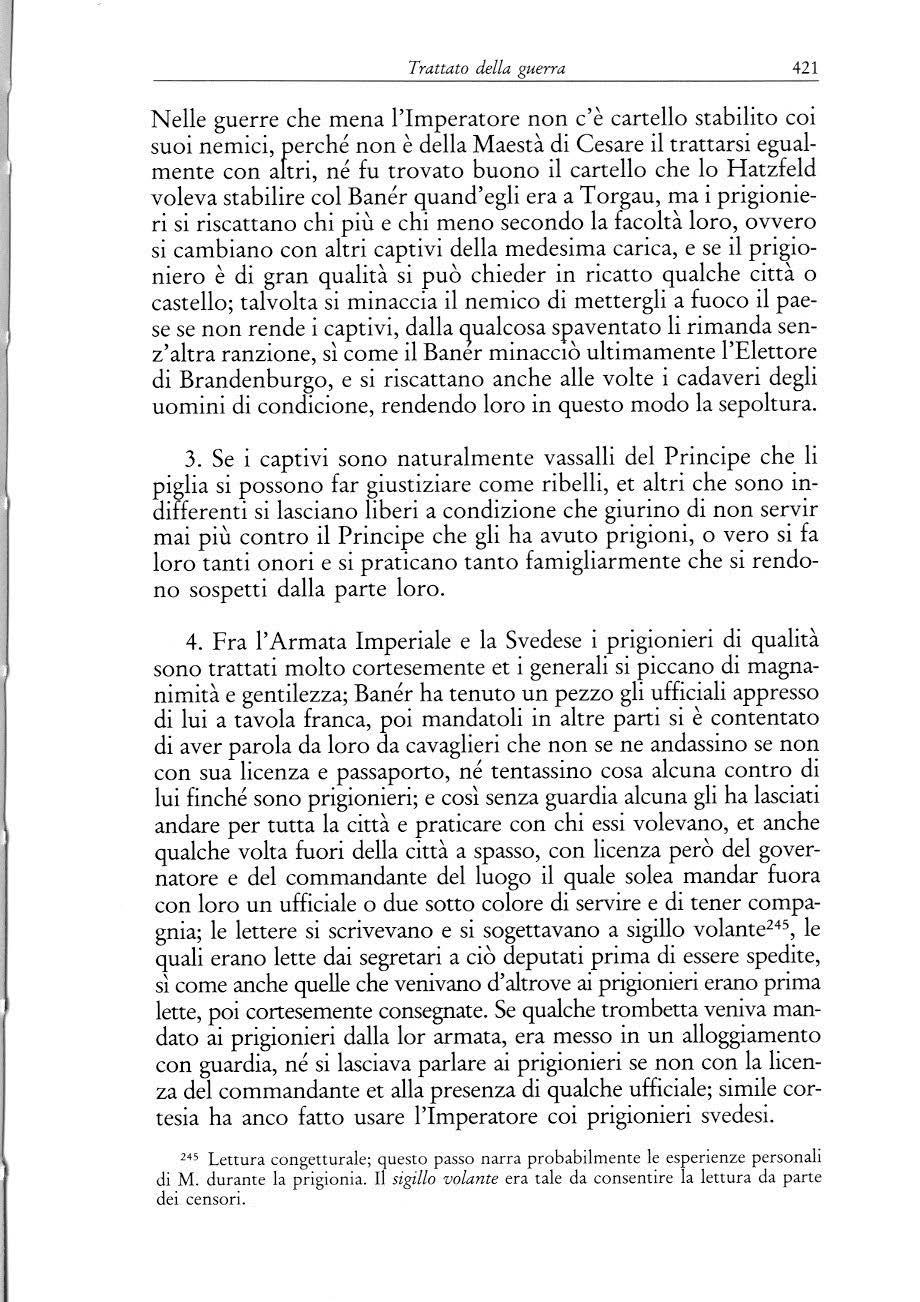
5. Il Banér so leva dire che non ci e ra guardia più forte per ass icurarsi di un cavagliere che la sua parola , perch é quando egli è lecit o a d uno tentar di fug gire senza offendere il suo onore, cerca tante vie e tante strade che finalmente ne trova una, come fece Arnh e im, guar dat o sì rigorosamente in Svezia, il colonnello di Bruay, guardato a W edell, il colonnello Slang, guard ato a Dresda246 , ec c. Alcuni s i sono sa lvati ca landosi dall e fene stre, altri si sono s alvati per un cesso, altri h ann o co rrotto le guardie o fatto b ere v ino alloppiato et addorm e ntatol e, altri so tto spezie d'ir a caccia e far vo lare hanno finto di seguit are il falcone, e poco a poco togliendosi dall a vista delle guardie s i sono smarriti. Altri hanno finto di essere fort ement e malati, sì che solda ti fuori d'ogni sosp e tto hanno allontanato la guard ia e per tal m ezz o datogl i commodità di fuggire, altri han no pertugiato un muro nella parte la meno sospetta e passati da un tetto all'altro si sono tenuti nascosti tr e o quattro giorni in qualche luogo occulto, sin che il nemi co, perduta la speranz a di rit rov arl o, non l'ha più cerc ato ed e gli travestito ha avuto agio di andarsene e per nasconder il p e rtugio del muro l'ha fatto di etro a qualche quadro o tapezzeria; altri si è salvat o dentro a un car ro di paglia, in un a botte, in un battello ecc. Altri ha m ess o il suo servitore nel letto ch e rappresentasse il suo simulacro et egli n ei vestiti del servi tore si è salvo, o in vece del servitore vi ha me sso qua lc h e altr o simulacro c he, rappresentando un c he d o rme, ha fatto c he l e g uardie hanno custodito qu ello; ovvero vi ha messo la moglie et egli nei vest iti donn esc hi è uscito; e mo_lti si s ono sa lv~ti. in abito da frate o di pr~t<:, di. paesano o d'arteg1ano, radendosi 11 pelo e· contrafacendos1 11 viso.
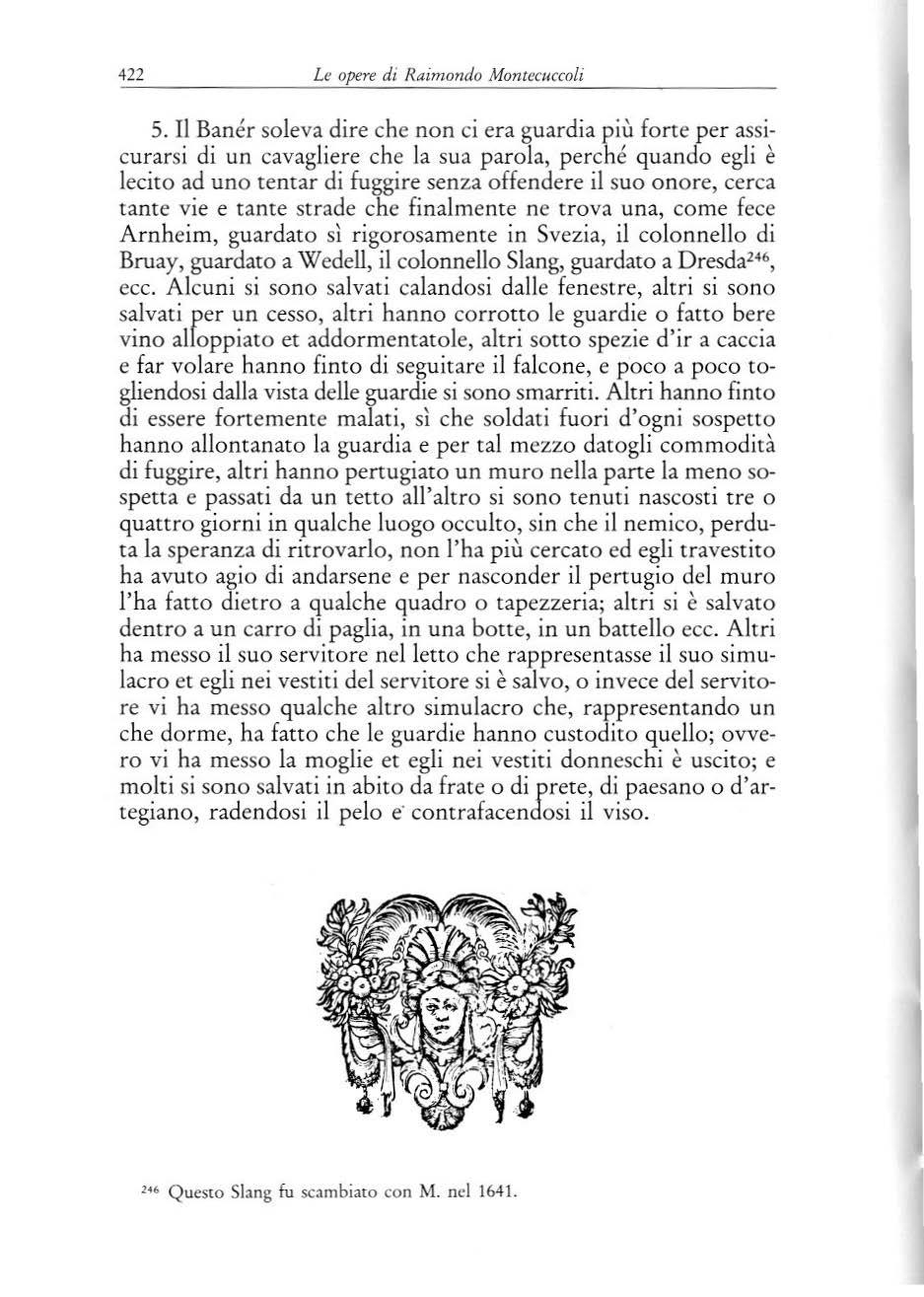
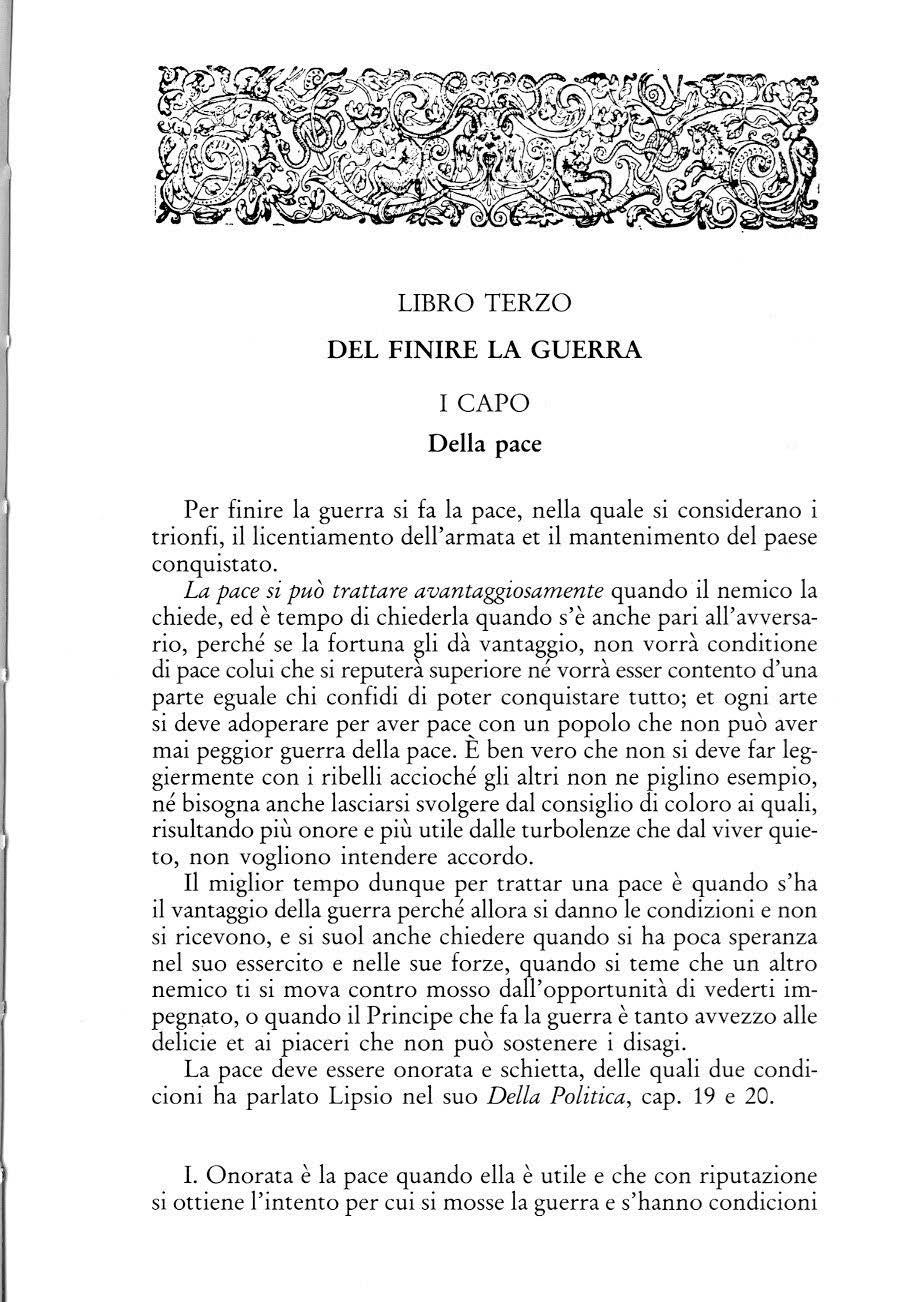
Della pace
Per finire la guerra si fa la pace, nella quale si considerano i trionfi., il licentiamento dell'armata et il mantenimento del paese conquistato.
La pace si può trattare avantaggiosamente quando il nemico la ch iede, ed è tempo di chiederla quando s'è anche pari all'avversari_o, perché _se la ~ortuna ~li dà ~antagpio, ~on vorrà condit~one d1 pace colui che s1 reputera supenore ne vorra esser contento d una parte eguale chi confidi di poter conquistare tutto; et ogni arte si deve adoperare per aver pace, con un pop o lo che non può aver mai peggior guerra della pace. E ben vero che non si deve far leggiermente con i ribelli accioché gli altri non ne piglino esempio, né bisogna anche lasciarsi svolgere dal consiglio di coloro ai quali, ri sultando più o nore e più utile dalle turbolenze che dal viver quieto, non vogliono intendere accordo .
Il miglior tempo dunque p er trattar una pace è quando s'ha il vantaggio della guerra perché allora si danno le condizioni e non si ricevono, e si suol anche chiedere quando si ha poca speranza nel suo esserci to e nelle sue forze, quando si teme che un altro nemico ti si mova contro mosso dall'opportunità di vederti impegnato, o quando il P rincipe che fa la guerra è tanto avvezzo alle de li cie et ai piaceri che non può sostenere i disagi .
La pace deve essere ono rata e schietta, delle quali du e condicioni ha parlato Lipsio nel suo Della Politica, cap . 19 e 20.
I. Onorata è la pace quando ella è utile e che con riputazione si ottiene l'intento per cui si mosse la guerra e s'hanno condicioni
avantaggiose, come se si ha guadagnato c h e ciasche dun o ritenga ciò ch'ei possiede, c he si faccia di sarmar il n e mico e gi urare di non assistere ai tuoi n em ici né direttamente né indiretta mente sotto qual pret es to si s ia, e che dia quartiero alla sua armata d entro al · suo paes e, condiz ion i alle quali fu astretto il Du ca di Wiirttemb e rg n ell'accordo fatto con l'Armata I mperiale che uscì d'Italia sotto il co mmando del capitano Egon di Fiirstenberg, e c h e s i ritenga n o qualche pi azze d'importanza n e ll e mani e che sia pagata una somma di d ena ri e c he siano dati ostaggi p e r sicurez za.
1. Qu a ndo un re è in prese n za e l'altra [parte] non vi ha che ambasciatori, app a rtiene agli amb asc iatori di cominciar i primi a trattare.
IL Schietta è la pace quando e lla è sicura e ch e non vi è so tto qualche artificio , co me d'i sviar i soldat i d e l partito co ntrari o o di riaver i suoi prigionie ri c h e molto si st iman o o di far parer al mondo che il nemico sia implacabile e c agione so la di tut t e l e t urbole nze et incomodi che r eca la gu erra, o di acquistare nell e mani piazze per s icurezza che diano p oi se mpr e adi to qu a ndo si vuo l e n el paes e del n em ico .
1. D urante l a tregua bisogna fa r migli or guardia che mai per non incorrere in qualche disordine.
2. P er sicu r ezza della pace si danno piazze nell e mani a quelli che senz' esse non ne possa no esser e sicuri , ma con co ndizion e che sia determinata la quantità del presidio ch e vi hann o a ten er dentro, acci oc hé sott o colore di pres idio non v i ragunino tropp e forze co n l e quali, preso il lor tem po, facciano invasio n e .
3. Si ass icura anc he l a pace facendo giuramento di osserva re la capitula zio n e, e recat o in m ezzo il libro del Vangelo et a ltre cose reli giose , tutt i e du e i Principi vi m etta no sopra la m a no e promett ano col santissimo giuramento di voler osse rvare ogni cosa co n buon a fede. S'usa anche di segnare gli acco rdi co ll ' int erve nto d'altri Principi e re pubbli c he, per sicurezza ma ggio re .
4. Si d an no anche ostaggi per confi rmare la pace o per osservare la tr egua; si sogliono dare dall 'infe riore e ricev ersi dal s up e riore, e sono person e principali o d el popolo, ma in gran num e ro; se

quei che danno li ostaggi mancano nell'osserv anza della fede, gli ostaggi sono fatti morire. I Volsci ruppero la fede data et i Romani decapitarono 700 ostaggi dei Volsci.
5. Si può credere che l a pace sia t rattata ingenuamente quando il nemico ha causa di farlo.
Con trionfi, con trofei e colle ovazione e colle coronazione si dichiarava già la vittoria ottenuta, e solevano !'antiche e ben ordinate repubbliche nelle vittorie loro riempir d'oro e d'argento l 'era rio, distribuir doni nel popolo, rimetter ai so l dati tributi, e con giochi e solenni feste festeggiarli
1. Nel trionfo si conducevano avanti al carro i re captivi e gli altri prigionieri, né solo questi, ma anche tutta la preda fatta in guerra si conduceva in trionfo, }'insegne dei nemici, le spoglie, l'oro e l'argento . Nel carro trionfale sedeva il carnefice che, tenendo in mano una corona d'oro ornata di gemme, ammoniva il vincitore.a riguardarla, cioè accioché pro vvedesse al rimanente della vita, né gonfio di quell'onore insuperb isse; erano anche attaccato al carro le fruste et i sonagli, per dimostrare che egli poteva cadere in ta l calamità che fosse frustato e decapitato, perché quelli che per qualche misfatto eran fatti morire, solevano portar i sonagli accioché nell'andare nissuno si contaminasse nel toccarlo.

2. I trofei si chiamano le spoglie affisse ai tronchi, e di qui si cominciò ad er igere monimenti della vittoria di marmo e di sassi nelle cime dei monti e nei luoghi più rilevati, sottoscrivendovi i nomi delle genti vinte e l'immagin e del combattimento.
3. Le ovazioni differiscono dal trionfo in tanto che i tr ionfanti entravano nella città sopra a un carro e gli ovanti entravano a piedi, cinti d'una corona di mirto; gli ovanti si servivano talora di un sol cavall o et erano condo t ti dai plebei e dai cavalli romani nel Campidoglio dove sacrificavano con pecore, dette dai Latini oves, da che aveva il nome l'ovazione. I trionfato ri erano condotti da quattro cavalli bianchi e precedendo il senato sacrificavano in Campidoglio con tori.
4. Le coronazioni presso i Romani facevano fede di qualche opera illustre fatta in guerra, e di queste corone si è già parlato nel libro superiore.
Del licenziar l 'essercito

Fatta la pace s i licenzia l' essercito facendo i lor di sconti ai soldati e pagandoli, dando lor passaporti e mandandoli fuora del paese, massime se s ono stra nieri , accioché non m ova no sed izione né faccia no latrocinii; né bisogna essacerbar i loro animi col ritener loro le debite pagh e o co l disgustarli altramenc e, accioché n on passino all'inimi co e lo svegli no co ntro di te, come fecero i so ldati imperiali licenziati sì mal a proposito e con sì cattiva maniera dai commissari quando il Friedland fu dimesso dalla carica di generale, c he passarano tutti al servizio del R e di Svez ia e delli Elettori protestanti.
Ovv ero accioché non si mettano assieme et alzando una bandiera di ve ntura , avvezzi alle rapine et all e prede, si diano a spogliare e metter a sacco il paese ora in un luogo ora in un altro.
I. Per obviare a questo disordin e si tratta anche con un altro Principe che sia in guerra accioché pig li a sé la gente au ssil iaria, o s'opprime affatt o e toglie ad esso con la ge nt e di guerra c he resta in piedi, o si cerca altro modo di ridurla fuori, non licenziandola tutta in un luogo né tutta in un temp o e così all'improvviso che chi è licenziato non lo prevegga né creda che abbia a toccare a lui.
Il Non si de ve licenziar tutto l'essercito ma tener sempre in piedi qualche numero di gente di guerra più o m e no secondo la qua li tà dello stato, perché bisogna avere sempre in pronto arme
spe dite in ogni caso che possa succedere e p er la guardia dei confini , altrimenti si è sempre in pericolo di essere assaltato e spogliato prima che si sieno fatte levate. Egli è ben v ero che i Principi sono di siffatta natura che poco a poco cresce in loro l'ambicione e la cupidità e quante più forze hanno alla mano tanto più facilmente pigliano occasione di dissidi e d 'i nimicizia con altri, ma ciò occorre quando il Prin cipe è imp e rito o lascia figliuoli piccioli , et allora queste genti d'armi nuocono anziché giovino alle provincie alla diffesa delle quali sono destinate, perché altrimenti, quando elle sono rette dall 'a utorità di qualche principe prudente, possono recare grandi servizi .
1. I corpi dei reggimenti devono essere sempre in piedi, accioché l'arte milita r e non si dimentichi, non in teoria, anzi in pratica, e anche per conservare molti uomini di commandamento , e le compagnie posson essere la metà forti del lor piede ordinario, perché quando l'occasione occorre d'augumentarle, gettando in ciascheduna il compimento delli uomini, in due mesi saranno formati per ben servire, tanto per la diligenza dei buoni capi quanto per la virtù delle buon e regole, il che non succede nei reggimenti nuovi che si levano perché se il colonnello è di poca esperienza fa catti va elezione di capitani, e questi di soldati; poi, governandosi gli uni e gli altri più secondo le fantasie loro che secondo gli ordinamenti militari, maraviglia non è se ne riesce cattiva milizia. Il fine dunque è per aver sempre un magazzino di so ldati vecchi apparecchiati per il bisogno 247 •
2. Un essercito sempre in piede è il mantenimento degli stati, tiene i cittadini in fede e gli stranieri in amicizia, s i spe ngono le sedizioni in favilla, ed è gran differenza fra un esse r cito vete rano et un fatto novellamente, che non combatte con quella fede né con quell'ardore come fanno i vecchi soldat i i quali, inveterata l'affezione, non più in guisa di soldati che in guisa di famigliari diffondono il Principe avve zzo a dar loro gli alimenti e quasi lo spiri to et al quale li ha congiunti non solo quella guerra ma anche la fortuna di tutta la vita . Aggiungasi che a molti uomini manca la sanità , a molti l'animo, i quali diffetti si possono conoscere in questo tirocinio d'una perpetua milizia, ma non già n elle levate repent ine, nelle quali, pigliando tutto ciò che vien ad offrirsi, non si sa
247 Com inci ano a co mp a rire le idee su c ui M. fonderà il suo progetto futuro di Esercito i mper iale perm anente .

spesse volte s'egli s'arma un uomo o una statua. Né la spesa deve parer grave al paese, considerando il danno molto maggiore che v i fa il nemico entrandovi per non ritrovarvi ostacolo.
3. Si potria dire che questa gente armata potria fare sollevazione, che il generale potria cacciare il Principe, che questo corpo saria come una repubblica di per sé, che se non si tiene insieme e si vuol ripartire, accioché i soldati non si conoscano insieme né facciano ribellione, le città dove saranno ripartiti non saranno sicure et essi non saranno essercitati, e così verrassi a perdere il frutto dell 'essercito veterano. Ma si risponde che, sì come gli esserci ti troppo grandi in tempo di pace sono nocivi, così un nerbo di gente moderato, oltre i presidi, è molto utile e di questa gente la metà deve sempre accompagnare il re, sì che il soldato stia sei mesi al1' anno in casa e l'altra parte nelli alloggiamenti campali, e così disgiunti non avranno forza a far sedizione gagliarda né lunga soverchia dimora nelle case li divezzerà dall'abito di soldat0. Che gli stipendi devono essere pagati puntualmente e larghi; e [che] tanto più rigida è la legge da ubbidire, castigando [sì] severamente la protervia e i furti, da [non] altri che dal re medesimo 248 •
248 Tutto il passo è scarsamente leggibile in ent r amb i i Ms. La r icost ruzion e è con· gettura le (come pure qu e lla del Veltzé).
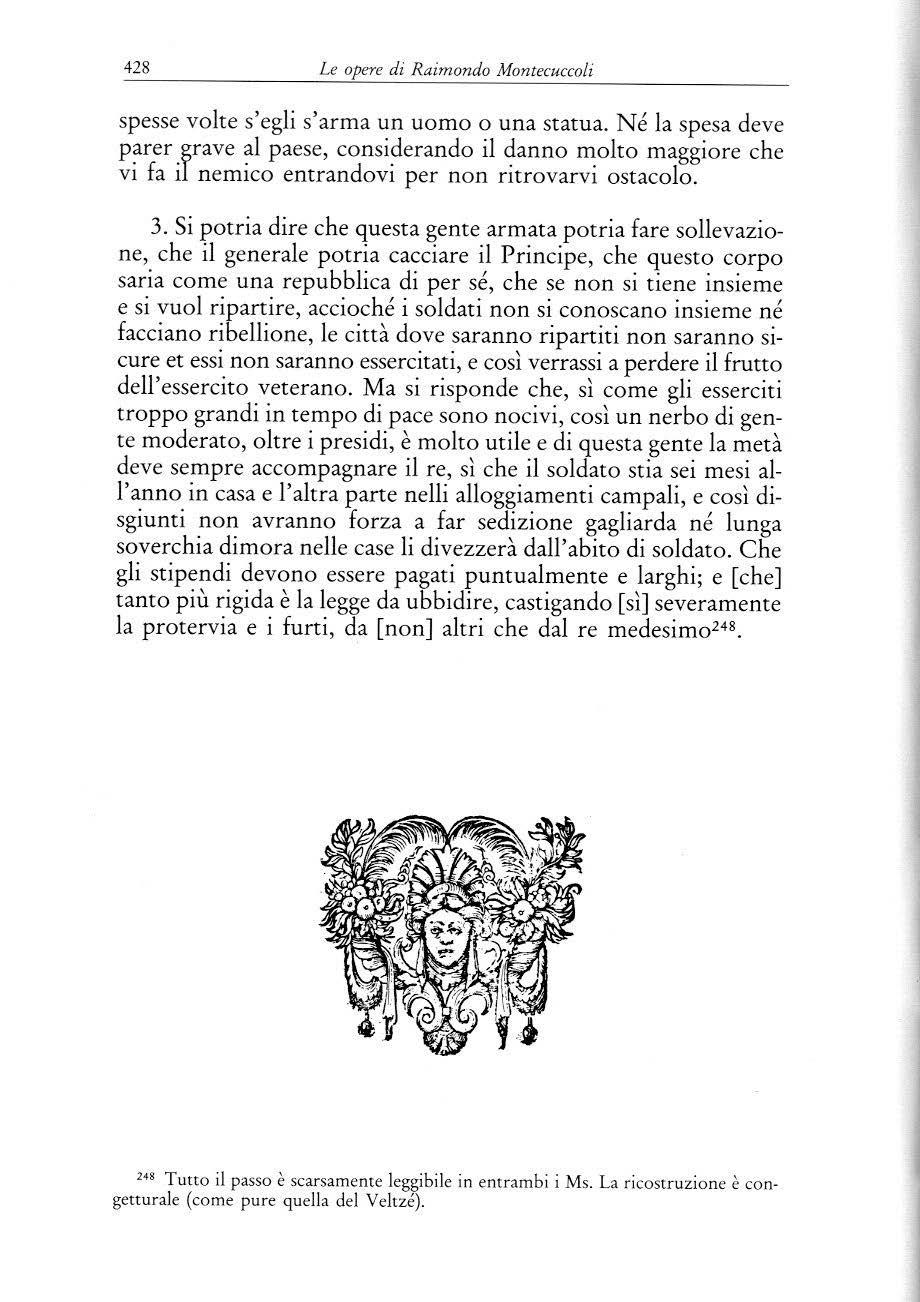
Del conservare l 'acquistato
Hanno i politici trattato sì accuratamente questa parte del conservar l'acquistato, re golando differentemente i precett i secondo la differenza dei governi dei paesi, che qui se ne parlerà succintamente. Egli è ben necessario usarvi gr and'a rte, p erc h é non si trova nazione alcuna che vog lia soffrir vo lentieri d'esser dominata da uno st rani ero b e nch é sia più gra nde e più for t e che ciaschedu n altro, e quand'anche governi bene e commandi n on di meno, essen d o differente di costumi e di natura né potendo p erò rappresentare quella benevolenza verso il popolo come s'egli fosse nativo del paese, quindi è c h e nascono faci li occas ioni di dissensioni, sì che avviene che quegli , per diffender il principato e le sue fo r ze, faccia ve nir d' a ltro ve soldati e forze esterne per farsi forte col lor presidio, i q uali, accresciuti poi singolarme nt e da lui con onori e b enefic i, gli eccitano contro grand'odio e mal 'affezione della moltitudine, sì che ri chiede si destrezza grande n el governare un popolo st rani ero; e sebbene la necessità di natura in segna che c hi è superato in guerra dev'esser anco dominato nella pace et è lege di guerra che chi v inc e esserciti l'imp erio nei vinti sì come gli piace, in ogni modo si trova spesse volte maggior difficultà n el co n se rvare che nell 'acqui stare, e però si richiede non minor virtù in que llo che in questo. Ma tutte le mas sime per ben assicurar un acquisto si riducono a questi due punt i, cioè di levar la volontà di rivoltarsi a quelli che tu hai co nquist ati e di levar loro il mezzo di poterlo fare .
I. La volontà di rivoltarsi si leva più facilmente a un stato avvezzo a vivere sotto un Prin cipe c h e a qu e ll o che è avvezzo a viver libe ro, perché a questo non si può togliere il desiderio di rimet-

te rsi in libertà, massime durante la vita di quelli che hanno vissuto liberi, e che mettono facilmente in oblio ogni beneficio che non ristabilisse in tieramente la libertà; ma quello, non avendo se non a cambiar di signore, amerà meglio di restar sotto l'auttorità di quello che lo tratterà più umanamente .
1. Però bisogna sempre cominciar per la via dolce e stabilire una condizione a quelli che tu hai conquistat i che sia sicu ra e per la vita e per i beni, e però deve il Principe far regnar la giustizia essatta, sostener l'oppresso nella sua ragione, astene r si eg li medesimo da ogni violenza sia nell'onore delle donne o sia nella robba pe~ché senza questo egli è impossibile d'addomestica r e gente conquistata.
2. Bisogna anche mantenerli il più che si può nella forma del suo governo e non escludere alcuni di quelli di poter pervenire alle cariche, dignità e t onori eh' ess i possono possedere senza pr egiudicio alla sicurezza.
3. O si possono lasciar totalmente nello st ato di prima, contentandosi dei tributi annuali d'uomini e di denari.
4. S'egli è un Principe ch'abbia fatto l'acquisto, il modo d'assicurarsene è d'andarvi ad abitare colla sua corte il più che si potrà, perché la sua presenza impedisce molti disordini e lo splendore della sua corte impone una certa venerazione nello spirito dei popoli e fa guadagnare gli artigiani et i borghesi dove risiede. Ma s'egli è un re che non può cambiar e la sede del suo imperio, bisogna che quelli che egli vi manderà per governare vi sieno con isplendore, perché i popoli s'attaccano qualche volta più all'apparenza che alla r ea ltà. Si conciglia il favore del popolo rilasciando per un tempo determinato di due o tre anni, più o meno, i tributi e facendoli essenti dalla milizia, e per acquistare riputazione si rovinano i templi, le statue e le memorie degli antichi signori del paese conquistato accioché il nome di nisuno sia più venerabile che quello di colui che li conquista.

5. Sotto pretesto di scuole pubbliche e di beneficio s'intrattiene la gioventù più nobile dentro una città tua dimora, come ostaggi.
6. Un Principe nuovo può anche far tutte le cose nuove in un paese conquistato, come fece David nell'entrata nel suo regno, di
cui si scrisse: "Esurientes implevit bonis, et di v ites dimisit inanes", accioché tutti quelli che vi tengono gran stato, uffizi o altro bene lo riconoscano tutto da lui.
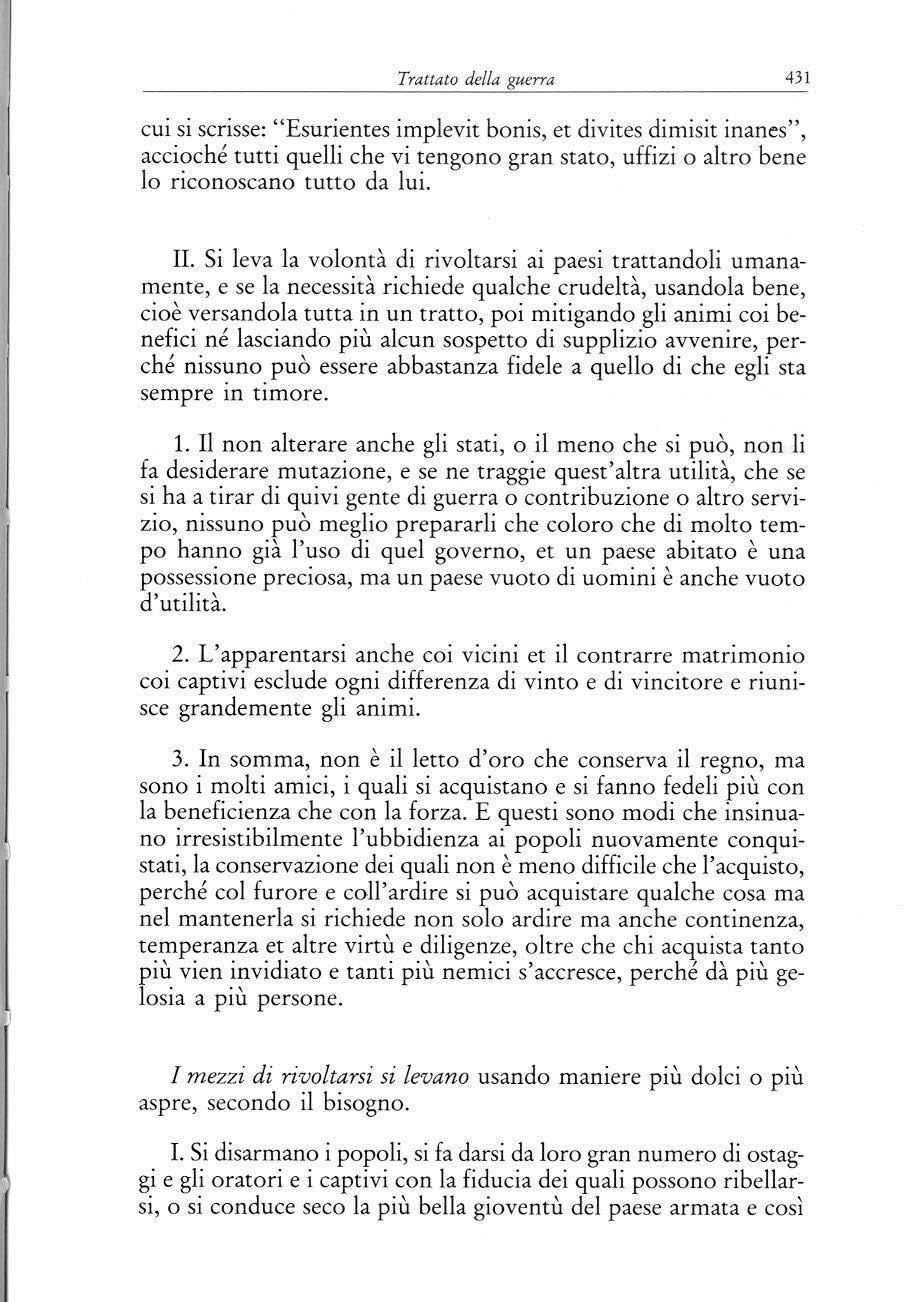
IL Si leva la volontà di rivoltarsi ai paesi trattandoli umanamente, e se la necessità richiede qualche crudeltà, usandola bene, cioè versandola tutta in un tratto, poi mitigando gli animi coi benefici né lasciando più alcun sospetto di supplizio avvenire, perché niss1;1no_può essere abbastanza fidele a quello di che egli sta sempre m timore .
1. Il non alterare anche gli stati, o il meno che si può, non li fa desiderare mutazione, e se ne traggie quest'altra utilità, che se si ha a tirar di qui vi gente di guerra o contribuzion e o altro servizio, nissuno può meglio prepararli che coloro che di molto tempo hanno già l'uso di quel governo, et un paese abitato è una possessione preciosa, ma un paese vuoto di uomini è anche vuoto d'utilità.
2. L'apparentarsi anche coi vicini et il contrarre matrimonio coi captivi esclude ogni differenza di vinto e di vincito re e riunisce grandemente gli animi.
3. In somma, non è il letto d 'oro che conserva il regno, ma sono i molti amici, i quali si acquistano e si fanno fedeli più con la beneficienza che con la forza. E questi sono modi che insinuano irresistibilmente l' ubbidien za ai popoli nuo va ment e conquistati, la conservazione dei quali non è meno difficile che l'acquisto, perché co l furore e coll'ardire si può acquistare qualche cosa ma nel mantenerla si richiede non solo ardire ma anche continenza, temperanza et altre virtù e diligenze, oltre che chi acquista tanto più vien invidiato e tanti più nemici s'accresce, perché dà più gelosia a più persone.
I mezzi di rivoltarsi si levano usando maniere più dolci o più aspre , secondo il bisogno.
I. Si disarmano i popoli, si fa darsi da loro gran numero di ostaggi e gli oratori e i captivi con la fiducia dei quali possono ribellarsi, o si conduce seco la più bella gioventù del paese armata e così
si ha in essa soldati et ostaggi tutti insieme, ovvero si mena seco tutti i principali della provincia conquistata dando loro provisione, et ai popolari di quella si prepongono uomini vili, e così i Principi si fanno contenti pagandoli, et i populari quieti non avendo capi che l'inquietano.
1. Si infiacchiscono i popoli ad una v ita oziosa e molle, accioché perdano ogni scienza e meditazione militare, la qual arte è stata mostrata dagli Dei agli uomini come instrumento della libertà e della felicità; ma s'ammo llisce un popolo feroce co lla religione, con le feste, con le cerimonie, con la vita rustica, con gli st udi delle lettere, col levargli l'armi, i cavalli et i vestiti siolti et ogni essercito fiero, et invece di quelli introducendo suoni, canti, balli e conviti, et abiti gravi e donneschi .
2. Si leva v ia tutto il senato e si manda nei tuoi domini antichi, overo gli s'aggiunge un consiglio fedele d ei tuoi antichi soggetti, overo si costituiscono i primi magistrati dei tuoi vassalli vecchi e gli altri inferiori si forniscono della gente nativa del luogo.
3. Si spegne il sangue del Principe antico e tutti quelli che possono pr etender e allo stato o che son atti a far ribellione, e se v i è donne della stirpe regia s'impedisce loro il matrimonio accioché non abbiano prole, o si fanno monache accioché sotto colore d' onore sia nascosta l'ingiuria, et in somma tutti quelli che eccedono di potenza o di valore o d'industria o di credito e gli autori delle fazioni, si troncano e si levano di mezzo se ti si sono opposti o s'hanno favorito le tue parti li trasporti nei tuoi domini antichi, dove dai lor o signorie e ricompense, né mai si lasciano nei luogh i loro i capi delle genti che hai soggiogato.

II. Si levano i mezzi di rivoltarsi smantellando le città soggiogate che non si possa guardare accioché nulla possa r es iste r alle tue genti di guerra che , sendo sempre insieme, s'oppongono ad ogni le ga di congiurazione, e non lasciando in piedi alcuna città o castello fuori che le tue forze di guarnigione che possa s uffrire cento colpi di cannone.
1. Fabbricando fortezze nei siti opportuni e necessari e rocche nelle città come freni delle genti domate e presidiandole di soldati esterni e fedeli o delli antichi domini.
2. Tenendo in piede un essercito nel paese vinto per soffocare nella culla le sollevazioni, separandolo nelle guarnigioni delle piazze o tenendolo insieme in un campo fortificato eh' è molto meglio, o facendone più corpi o tenendolo in diverse parti del paese e nei confini accioché le città non possano congiungere assieme le forze in una ribellione.
3. Mandandovi colonie e trasportando i popoli d'un paese all'altro, il che è una gran briglia per tener in debito un paese conquistato e per il qual mezzo si ricompensano anche parecchi soldati che ti hanno ben servito. Quest'ordine è quello che fa gli imperi più sicuri et i paesi mantiene copiosamente abitati. La sicurtà nasce perché quella colonia, la qual è posta dal Principe in un paese nuovamente occupato da lui, è come una rocca et una guardia a tener gli altri in fede. Non si può oltre di questo una provincia mantenere abitata tutta, né perseverare in quella gli abitanti bene distribuiti senza questo ordine, perché tutti i luoghi in essa non sono generativi o sani, onde nasce che in questi abbondano gli uomini e negli altri mancano, e se non vi è modo di trarli donde gli abbondano e porgli dove mancano, quella provincia in poco tempo si guasta perché una parte di quella diventa per i pochi abitanti deserta, un'altra per i troppi povera, e perché la natu r a non può a questo disordine supplire, è necessario supplisca l'industria, perché i paesi mal sani diventano sani per una mo l titudine di uomini che ad un tratto gli occupi, i quali con la cultura sanifichino la terra e con i fuochi purghino l'aria e che la natura non potrebbe mai prevedere, i l che dimostra la città di Vineg ia, posta in luogo paludoso et infermo, nondimeno i mo l ti abitatori che ad un tratto vi concorsero la renderono sana. Sendo mancato per tanto quell'ordine del mandar le colonie, i paesi vinti si tengono con maggior difficultà, et i paesi vòti mai non si riempiono e quelli troppo pieni non si alleggeriscono.


Questi indici sono stati compilati da Antonio BR UGI0Nl che si ringrazia
 R.L.
R.L.
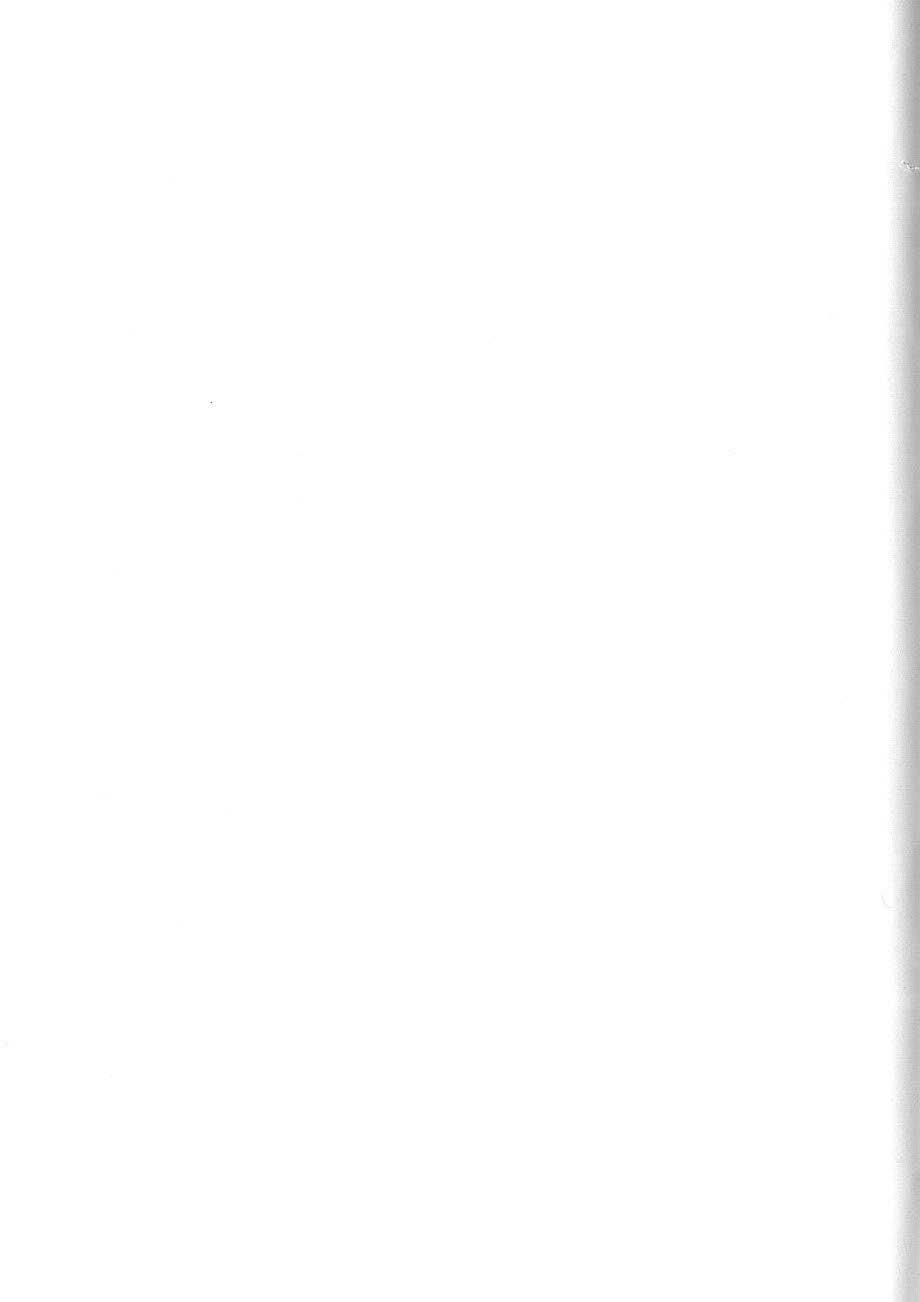
ACHILLE, eroe della mitologia greca, 36.
ADAM, a utore di una trad uzione francese degli «Aforismi» di R . Montecucco li, 117.
ADRIANO, imperatore romano, 132 nota 5.
AELIANUS Tacticus, scrittore greco , 45, 131, 132 nota 5, 133 n ota 5, 208, 406, 406 nota 239.
AENEAS Tacticus (probabi l mente Enea di Stimfalo), scrittore greco , 131, 132 nota 5.
AGRICOLA Georgius (BAUER Georg), 131, 132 nota 5.
ALBERTI Leon Battista, 67.
ALBERTO d' Absburgo, arciduca e governatore dei Paesi Bassi cattolici, 202 n ot a 71bis
ALBERTO di Brandenburgo, margravio di Kulmbach-Bayreuth, 169.
ALDOBRANDINI Pietro, 395, 395 nota 232, 397.
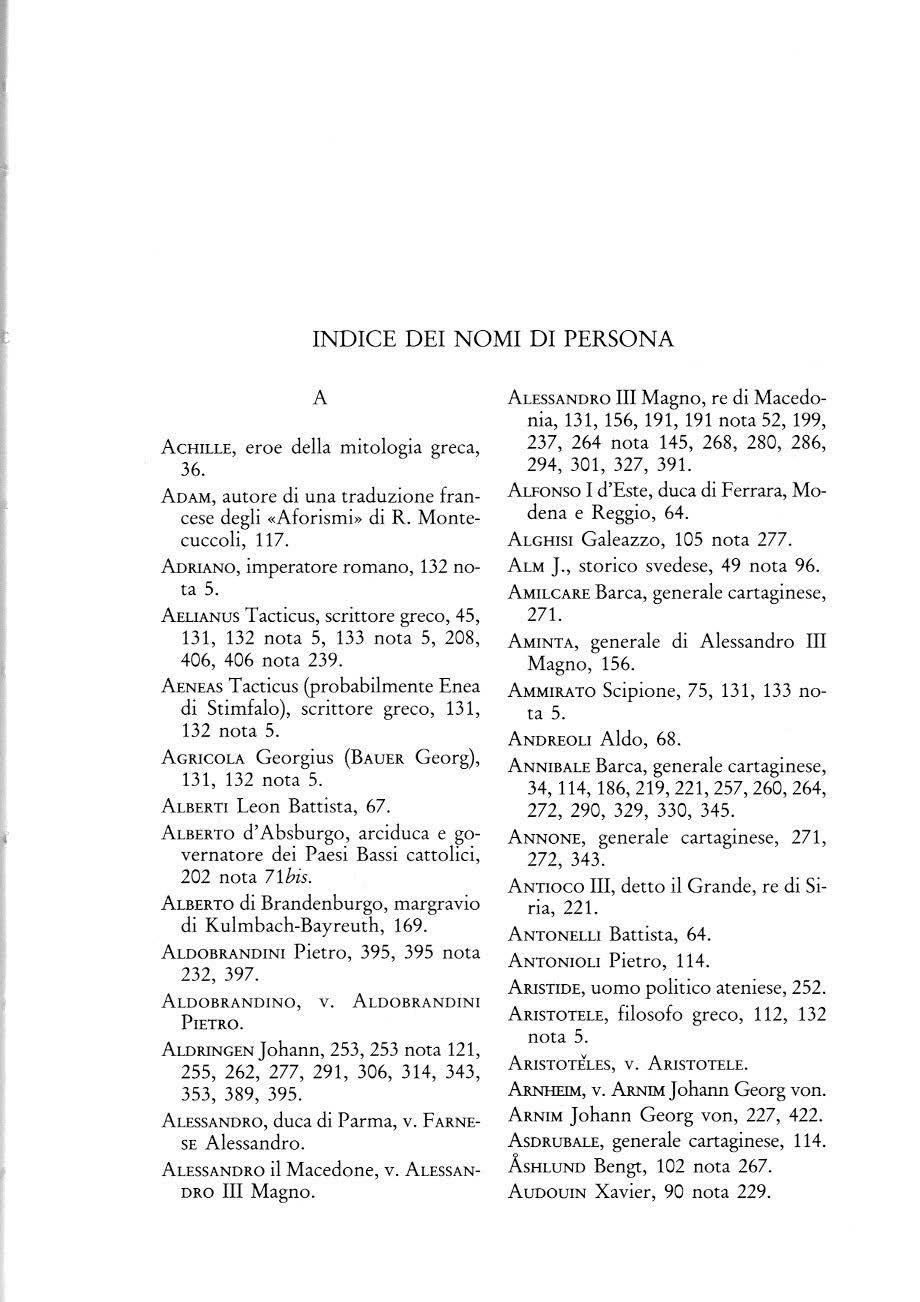
ALDOBRANDINO, V . A LDO BRANOINI PIETRO.
ALDRINGEN Johann, 253, 253 nota 121, 255 , 262, 277, 291, 306, 314, 343, 353, 389, 395.
ALESSANDRO, duca di Parma, v . FARNESE Alessandro .
ALESSANDRO il Macedone, v ALESSANDRO III Magno.
ALESSANDRO III Magno, re di Macedonia, 131,156,191, 191 nota 52, 199, 237, 264 nota 145, 268, 280, 286, 294, 301 , 327, 391.
ALFONSO I d'Este, duca di Ferrara, Modena e Reggio, 64 .
ALGHISI Galeazzo, 105 nota 277.
ALM ]., storico svedese, 49 nota 96.
AMILCARE Barca, generale cartaginese, 271.
AMINTA, generale di Alessandro III Magno, 156.
AMMIRATO Scip ione, 75, 131, 133 nota 5.
ANDREOLI Aldo, 68.
ANNIBA LE Ba r ca, gene r ale ca r taginese, 34,114,186,219,221,257,260,264, 272, 290, 329, 330, 345.
ANNONE, generale cartaginese, 271, 272, 343.
ANTIOCO III, detto il Grande, re di Siria, 221
ANTONELLI Battista, 64.
ANTONIOLI Pietro, 114.
ARISTIDE, uomo po litico ateniese, 252 .
ARISTOTELE, filosofo greco, 112, 132 nota 5.
ARISTOTELES, V. ARISTOTELE.
ARNHEIM, v. ARNIM Johann Georg von .
ARNIM J ohann Georg von, 227, 422
ASDRUBALE, generale cartagi n ese, 1 14
ÀsHLUND Bengt, 102 nota 267.
Auoou1N Xavier, 90 n ota 229
Auc usTO Caio Giulio Cesare Ottaviano, 75, 132 nota 5, 164.
BA CON Francis, v. BACONE Francesco.
BACONE Francesco (BACON Francis), 68, 70, 70 nota 163.
BADEN Wilhelm marchese di, 28 nota 37.
BAIZETTE, v BAJAZET (o BAYAzm) I.
BAJAZET (o BAYAZID) I, sultano ottomano, 420, 420 nota 243ter.
BANCALARI Gustav, 10, 10 nota 9, 19, 90 nota 228, 95 nota 243, 99 note 256-257, 101 nota 262
BANÉR]ohan, 17, 91, 192 nota 54,222, 225, 229, 237, 238, 255, 255 nota 122,256,257, 257 note 125-126, 258, 260, 262, 262 nota 140,263,263 nota 144, 282, 283, 285, 302, 302 nota 177, 316, 317, 323, 325, 333, 334, 335, 335 nota 192, 336, 339, 342, 342 nota 203, 359, 360, 389, 397, 404, 416, 421, 422 .
BARBIERI Bernardino 116.
BARCLAY Jhon , 131, 132 nota 5.
BARKER Thomas M ., 7, 10, 10 nota 4, 16, 41 note 64-65 -68, 42 nota 71, 52 nota 104, 53 no ta 109, 69, 69 nota 162bis, 74 nota 181, 94, 95 nota 243, 101, 101 nota 261, 105 nota 276, 116 nota 11, 120, 120 nota 21, 121 nota 23, 132 nota 5, 134 nota 5, 302 nota 177.
BAR LE Due René de, 131, 132 nota 5.
BASILIO II, detto il Bulgaroctono, imperatore d'Oriente, 420.
BASTA Giorgio, 14, 14 nota 16, 56, 59, 65, 65 nota 151, 127, 127 nota 1, 129, 131, 131 nota 5.
BATORY Stefano, 55.
BAUER Georg, v . AGRICOLA G eorgius.
BEARSS Edwin C., 201 nota 69.
BEAUVEZÈ, de, genera le francese, 32.
BELLER E.A., storico inglese, 54 note 112-113-115.
BENIGFARISZ, 417.
BERENGER Jean, 25 nota 34.
BERG E nrico conte di, 294.
BERNARDO di Weimar, duca di SassoniaW eirnar, 133 nota 5, 175 nota 30, 225, 282 nota 169, 324, 341, 357.
BERNARDO, duca, v BERNARDO di Weimar.
BERNHARD, v . BERNARDO di Weimar.
BERNSTAT, 273.
BERTINARIA P ierluigi, 7.
BETTINI Mario, 77, 117.
B1c1 Anna, 12 .
BIRINGUCCIO Vannoccio, 66, 67.
BIRON Armand de Gontaut barone di, 399 nota 237.
BrRON Charles de Gontaut duca di, 403, 403 nota 237.
BocCALJNI Traiano, 75.
B01LINI Gino, 112, 112 nota l.
BOLOGNESI Ottavio, 16, 16 nota 17, 19 nota 22.
BONAPARTE Napo leone, poi Napoleone I, imperatore dei francesi, 10, 11, 49 nota 93, 83 nota 208, 90, 93, 102, 103, 228 nota 89, 305 nota 178 .
BORIS Godunov, zar della Russia, 145 nota 14 .
BoRRI, v . BORRO Alessandro del.
BoRRO Alessandro del, 387, 387 nota 224.
Bossi Giacinto, 115, 115 nota 7bis, 120.
BoTERO Giovan Battista, 75.
Boucquoy (o Bucquo 1) Charles de, 282, 282 nota 167.

Bouq uoY, conte di, v . BouCQUOY (o Bucqu01) Charles de.
BouRNONVILLE Alexandre Hyppolite principe di , 38
Bov10 Or este, 7.
BRANCACCIO Giulio Cesare, 65, 65 nota 151.
BRAUNSCHWEIG Augusto duca di, v . SELEN US Gustavus.
BREDA, 326, 326 nota 186.
BRODIE Bernard , 87 nota 221.
BR0D1 E Fawn M., 87 nota 221.
BROUCEK Peter, 7, 282 nota 167, 334 nota 191.
BRUAY, colonnello di, 350, 422.
BRuNSW ICK -LDNEBURG Giorgio di, 263, 263 nota 144.

BuRCKHARDT Jacob, 66, 66 nota 154.
CHAPELLE, la, T. colonnello, 282, 282 nota 170.
CHARLES VIII, V. CARLO VIII .
CHARLES XII of Sweden, v. CARLO XII.
C1Ro il Grande, re di Persia, 291,401, 401 nota 235 .
CLAUD IO El iano, v. AELIANUS Tacticus.
CAMPANELLA Tommaso, 13, 18, 69, 72, 72 n o t a 175, 73, 73 nota 178, 74 , 75 nota 182, 76, 80, 81, 104, 131, 132 nota 5, 419.
CAMPORJ Cesare , 12, 12 n ota 12, 14 nota 16, 15, 16 nota 17, 17 nota 19, 20 , 20 nota 23, 24 nota 32, 35 nota 50, 40 nota 62, 41 nota 69 , 82 nota 205, 101 nota 260.
CAPRARA Enea Silvio, 38.
CARDANO Girolamo, 298, 298 nota 175.
CARLO V d ' Absburgo, imperatore del Sacro Romano Impero, 133 nota 5, 154, 169 .
CARLO V, duca di Lo r ena, 39, 40, 99, 116, 117, 118 nota l3bis.
CARLO VIII di Valois, re di Fra ncia, 62, 64, 130 nota 5.
CARLO X G ustavo, re di Svezia, 22, 49.
CARLO XII, r e di Svezia, 102, 102 nota 267.
CARLO ALBERTO, re di Sardegna, 113 nota 3.
CARLO EMANUELE I, duca di Savoia, 40 3 nota 237.
CARLO MAGNO, imperatore, 280 nota 165
CAROLUS V, v . CARLO V d'Absburgo.
CASELLA Mario, 71 nota 167.
CASIMIR, v. SEMENOWYCZ Cas i mir.
CASSIRER Ernst, 70 nota 166.
CATANEO Girolamo, 67, 67 nota 157.
CAVIGLIA Pao lo, 29 n o ta 40 .
CESARE Caio Gi u lio, 44 , 127 nota 1, 129, 131, 131 nota 5, 133 nota 5, 19 5,224,237,243,269 nota 151bis, 326, 345, 357, 383, 391, 392, 41 8.
CESARE d'Este, duca di Modena e Reggio, 13, 13 nota 14.
CHABOD Federico, 61 nota 135.
CLAUSEWITZ Ka rl von, 10, 11, 53 note 107-110, 62, 62 nota 137, 65, 83, 83 n ota 207, 92, 93 nota 235 , 94, 95, 96, 96 nota 244, 97 , 97 note 248-249, 98, 102, 103, 388 nota 225.
CoccoNITO 0 1 MoNT1Guo C lara, 114 n ota 5.
COLE H.M ., storico americano, 49 nota 93 .
CouGNY-SALIGNY J ean de, 23, 32, 34 nota 47
COLLALTO Rambaldo co nt e di, 14, 67, 115, 419
CoLLEON1 Bartolomeo, 63 no t a 142 , 64, 66.
CoLLOREDO Girolamo di, 333, 333 nota 189, 337, 341.
COLLOREDO Rodolfo di, 333 nota 189.
CoLOMA Don Carlo, 131, 132 nota 5.
COLONNA Fabrizio, 63 nota 143, 66.
COLONNA Prospero, 63 nota 143, 66, 86.
CoLONNETTI Laura, 29 n o t a 40.
CoMENJo, v. CoMENIUsJohann Amos.
CoMEN1us Johann Amos (K OMENSKY Jan Amos), 131, 132 n ota 5.
COM MYN ES VAN OE R CLYTE P h ilip de, 131, 132 nota 5.
CoNDÉ Enrico I di Borbone principe di, 265 nota 146.
CoNDÉ Luigi I di Borbone princip e di , 265, 265 no t a 14 6, 394, 394 nota 23 1.
CoNDÉ Luigi II di Borbone principe di, d etto il Gran Condé, 38, 39, 40, 40 nota 61, 80, 265 nota 146.
CoNGREVE William, 138 nota 10.
CoNSALvo d i Cordova, v. FERNANDEZ DE C6ROOBA Gonzalo.
CONTI Louis-Armand de Bourbon principe di, 117.
CONTI Torquato, 223, 223 nota 84bis, 226.
COPERNICO Nicola, 70 .
C6RDOBA Gonsalvez de, generale spagno lo, 272, 272 nota 157, 34 1 nota 200.
CoRòovA, Colonnello de, v. C6RooBA Gonsalvez de.
CORNAZZANO Antonio, 66.
CORNAZZANO da Piacenza, v. CoRNAZZANO Anton io.
CosIMO I de ' Medici, granduca di Toscana, 133 nota 5
CouRVILLE Xavier de, 83 nota 208.
CRA1G Gordon A., 53 nota 107.
CRASSO Marco Licinio, 181 nota 36.
CRATZ voN ScHARFFERSTEIN Johann Phi lipp, 282, 282 nota 170.
CRISTINA di Svezia, regina di Svezia, 11, 21, 22.
CROCE Benedetto, 10, 10 nota 7, 61 nota 134bis, 68, 69 note 161 -162, 72, 72 note 176-177, 76 nota 185, 107, 107 nota 282, 133 nota 5.
CROMWELL Oliver, 11, 21, 108 nota 283bis.
CRuccu Rinaldo, 7.
CuRTIO, v. CuRz10 R uFO Quinto.
CURZIO RUFO Quinto, 131, 131 nota 5
D IETRICHSTE IN Margarethe vo n, 22.
DouLSSECKER Jean Renauld, le Père, 117 nota 12bis .
DuPUY Trevor N., 84 nota 211, 85 nota 215, 87 nota 221.
EARLE Edward M., 53 nota 107. EccLEs Wi ll iam J., 29 nota 40.
ELIANO Claudio, v. AELIANUS Tacticus.
EKBERG Cari J., 37, 37 nota 54, 38 nota 57-58.
EMANUELE FILIBERTO AMEDEO, princip e di Savoia-Carignano, 29 nota 40

EMER ICO, padre confessore, 42.
ENEA di Stimfalo, v. AENEAS Tacticus.
ENRICO il Grande, v. ENRICO IV di Borbone.
ENRICO IV di Borbone, re di Francia, 127 nota 1, 388, 389 nota 227, 403 nota 237
ENRICO XIV, re di Svezia, 44, 45, 46.
ERBERTO Pio, marchese di Savoia, 32.
ERODOTO, storico greco, 131, 131 nota 5.
ESPOSITO Vinc ent J., 89 nota 225.
Es TE Alfonso cl', cardina le, vescovo di Reggio nell'Emilia, 13.
EuGEN von Savoyen, v. EuGENIO di Savoia.
EucENE of Savoy, v. EUGENIO di Savoia.
EuGENIO di Savoia, generale, 99, 99 nota 257, 111, 113, 116
DAMIZ, Colonnello sve dese, 350.
DAVIO, V. DAVID E.
DAVIDE, personaggio biblico, secondo re d'Israele , 430.
D ELBRUC K Hans, 44 nota 77 , 46 nota 84, 47 nota 87, 50 n ota 99 , 51 nota 102, 53 nota 107, 63, 63 nota 140, 280 nota 175
DELLA ScuOLA Basilio, 64.
DELLA VALLE Battista, 66
DENISON George T ., 51 nota 100.
DEUTICKE Karl, 59 nota 130.
DIETRICHSTEIN Franz vo n, 56.
FAB IO MASSIMO Quinto, detto il Temporeggiatore, 252, 260, 261, 271, 290, 329, 345.
F AHRENSPACH, co nte di, 282, 282 nota 169.
F ARNESE Alessandro, principe e poi duca di Parma e Piacenza, 65 nota 151 , 66, 388, 389 nota 227,403 nota 237.
FAULHABER Johann, 131, 132 nota 5. fAVARO Antonio, 70 nota 165
FEDERICO da Montelfeltro, duca di Urbino, 65, 133 nota 5.
FEDERICO Enrico, principe di OrangeNassau, 15.
FEDERICO Il, il Grande, re di Prussia, 10, 53 nota 107, 87, 87 nota 220, 89.
FEJtDINANDO d'Ungh er ia, re d'Ungheria, v. FERDINANDO III d' Absburgo.
FERDINANDO, principe e cardinale, detto il Cardinale Infante, 175 nota 30, 263 nota 144.
FERDINANDO, re dei Romani, v. FERDINANDO I d'Absburgo.
FERDINANDO Id' Absburgo, imperatore del Sacro Romano Impero, 169.
FERDINANDO m d' Absburgo, imperatOre del Sacro Romano Impero, 21, 22, 41, 175 nota 30, 244 nota 113, 263 nota 144.
FERIA G6mez A lvarez de Figuero y C6rdoba duca di, 389.
FERMAT Pierre de, 298 nota 175.
FERNANDEZ DE C6RDOBA Gonzalo, detto il Gran Capitano, 86, 272 nota 157.
FERNEMONT Johan n Franz Freiherr Barvitz vo n, 362, 362 nota 213.
FERRETII Domenico, 131, 132 nota 5.
FERRETTI Francesco, 131, 132 nota 5.
FERRETII Giulio, 131, 132 nota 5.
F rGUERÒ Rafael, 117 nota 12bis.
FILIPPO II, re di Spagna, 64.
FILIPPO IV, re di Spagna, 133 nota 5.
FILIPPO V, re di Macedonia, 274.
F1RPO Lu igi, 72 nota 175, 73 note 178 -179, 75 nota 182.
FLAMININO Titò Quinzio, 274.
FLAMININO Tito Quincio, v FLAMINI· NO T ito Quinzio.
FwcnBus Robertus de (Fwoo Robert), 131, 133 nota 5.
FLUDD Robert, v. FwCTrnus Robertus de.

FOLARD J ean Charles de, 10.
FORREST Nathan Bedford, 101,201 nota 69.
FoscoLO Niccolò Ugo, 115, 116, 117, 117 nota 13, 118, 118 note l3bis-l4-l4bis, 119, 119 note l 4 ter-18.
FRAAs Oscar, 175 nota 130.
FRANCESCO I de' Medici, granduca di Toscana, 132 nota 5.
FRÉDERIC II, v. FEDERICO II, il Grande.
FREITAG Adam, 131, 132 nota 5 .
FRIEDLAND, duca di, V. w ALLENSTEIN Albrecht Eusebius Wenzel von .
FRIEDRICH der Grosse, v. FEDERICO II, il Grande.
FROISSART J ean, 131, 132 nota 5.
FRONTINO Sesto Giu lio, 45, 131, 132 nota 5.
FucHs Adalbert Fr., 111.
FuETER Eduard, 63, nota 141.
FULLER John Frederick Charles, 44 nota 77, 50 nota 99, 97, 98 note 250 -252, 103 note 270-271.
FORSTENBERG Egon di, 424.
FORSTENBERG-SHTULINGEN Friedrich Rudolf von, 319, 319 nota 181.
GALASSO Matteo, 17, 19, 60, 67, 115, 168, 175 nota 30, 192 nota 54, 222, 225, 236 , 238, 239, 252, 255, 255 nota 122, 256, 260, 283, 302 nota 177, 324,326,326 nota 186,331,333 nota 189, 337, 342 , 351, 357, 360, 397, 412, 417.
GALEANI NAPIONE G ianfrancesco, 113, 113 note 2-3-4, 116, 116 note 8-9 -11, 117 nota 12, 119 , 119 note 15-18.
GALILEI Galileo, 13, 18, 67, 68, 69, 70, 70 note 164-165, 73 nota 178.
GALVANI G., vice bibliotecario nella biblioteca estense di Modena, 112.
GARNEAU François X ., 29 nota 40.
GASSION, de, generale francese, 29.
GENOUILLAC Galiot de, 88
GERRATANA Valentino, 61 nota 135
GEYMONAT Ludovico, 70 nota 164.
GIAMBELLI Federico, 66.
GIAMBERTI Giuliano, v. SANGALLO Giuliano da .
GIASONE, figura della mitologia greca, 191.
GIMORRI Adriano, 10, 10 nota 8, 22 nota 26, 40 nota 63, 41 nota 70, 42 nota 72, 68, 68 nota 159, 82, 82 note 204-206, 99 nota 257, 115, 120, 120 nota 20.
GIOVANNI GIORGIO, principe elettore di Sassonia, 17.
GIOVANNI IV di Braganza, re di Portogallo, 172 nota 26.
GIUGURTA, principe di Numidia, 221.
GrUUANO Flavio Claudio, detto l' Apostata, imper atore romano, 191.
GIUSTINO Marco Giuniano, storico r omano, 131, 132 nota 5, 191.
GoDUNOV Boris, v. BoRis GoDuNov .
GoNZAGA Annibale, principe, 28 nota 37.
GoTZ, 263, 263 nota 144, 359, 360.
GRAMSCI Antonio, 61 nota 135.
GRANT Ulysses S., 85, 85 nota 214, 88, 88 nota 223, 102.
GRASS I Giuseppe, 81 nota 201, 112, 113, 113 nota 3, 114, 115, 115 nota 7bis, 119, 119 nota 18, 120.
GREGORIO XIII (Ugo Boncompagni), papa, 176 nota 32
GRIFFITH Samuel B., 97 nota 247.
GROSSMANN Julius, 101 nota 266.
GUGLIELMO I d'Orange, detto il Taciturno, duca di Orange, 202 nota 71bis.
Gu IBERT Jacques Antoine Hippolyt e de, 10.
Go ICCIARDINI Francesco, 61 nota 135, 62.
GusTAvo I VASA, re di Svezia, 44.
145 note l3bis-l5, 173 nota 28, 175 nota 31, 184 nota 44, 192 nota 53, 197 nota 65, 202 nota 71bis, 223 nota 84bis, 253 nota 121, 262, 262 nota 140, 274 nota 160.
GusTAvus ADOLPHus, v. GusTAVO II ADOLFO. H
HALEJohn R., 61, 61 nota 135, 62 nota 136, 64 nota 149, 65 nota 152, 66 note 153-155, 67 nota 157, 132 nota 5, 135 nota 6.
HANGER, colonnello inglese, 85.
HATZFELD Ma lchiorre vo n, 17, 23, 192, 192 nota 54,260, 262,263,263 nota 144,317,328,333, 333 nota 189, 334, 349, 359, 380, 416 , 421.
HAUSER Henri, 61 nota 134 .
HENRY Robert S., 201 nota 69.
HERATE, 411.
HERODOTO, V. ER ODOTO.
HExAM, tecnico dell 'artiglieria, 137 nota 8.
HITLER Adolf, 53 nota 107, 228 nota 89.
HoFFDING Harald , 70 nota 164.
HO FKJRC H Georg Lorenz Freiherr von, 302 nota 117, 335 nota 192, 339, 340 nota 199, 342, 351 nota 202 .
HoGG O.F.G., 137 nota 8.
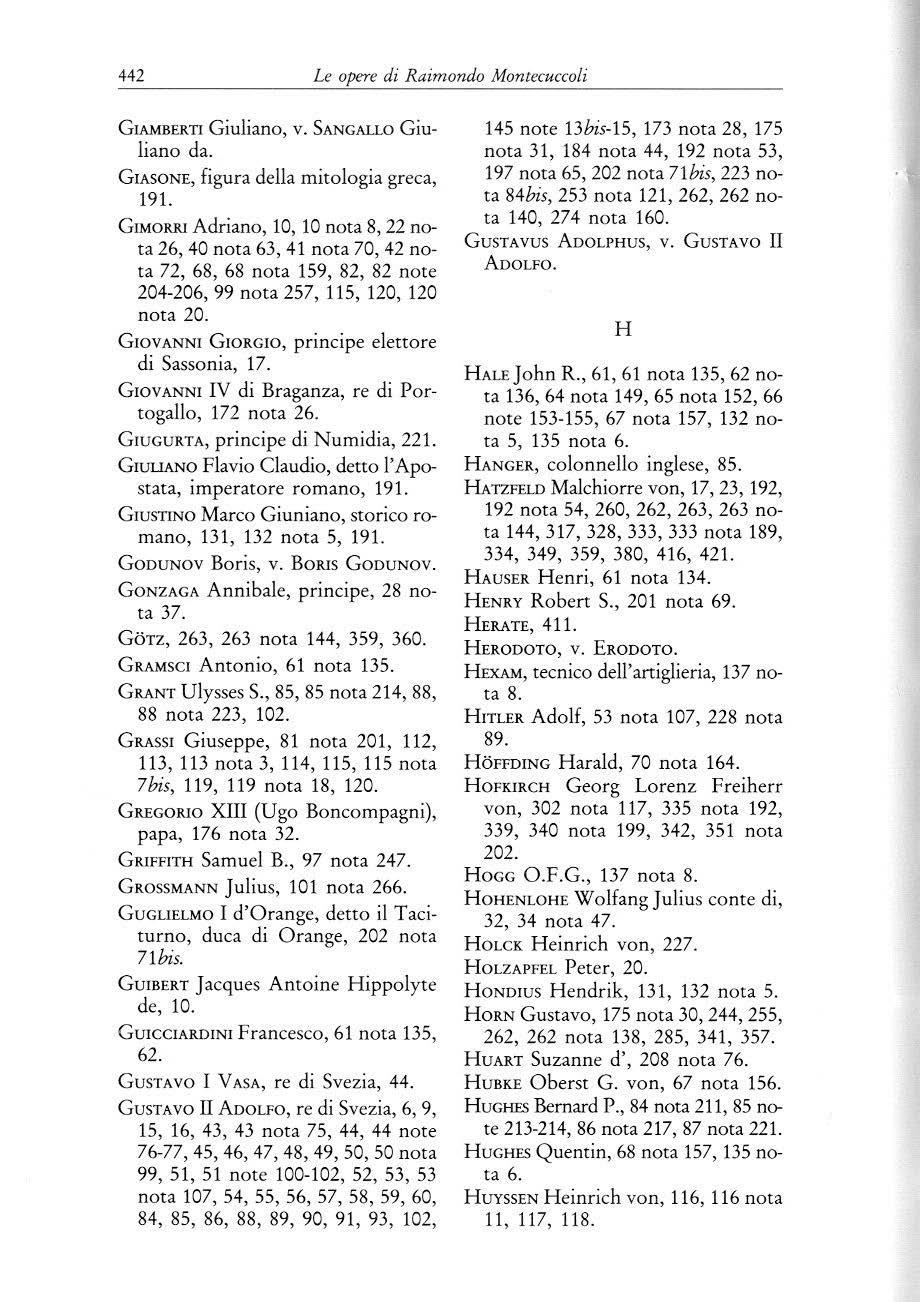
HoHENLOHE WolfangJu lius conte di, 32, 34 nota 47.
HoLCK Heinrich von, 227.
HoLZAPFEL Peter, 20.
H0No1us Hendrik, 131, 132 nota 5.
HoRN Gustavo, 175 nota 30, 244, 255, 262, 262 n o ta 138, 285, 341, 357
HuART Suzanne d ', 208 nota 76.
HusKE Oberst G. von, 67 nota 156.
GusTAVO II ADOLFO, re di Svezia, 6, 9, 15,
n o te
, 93, 102,
H uGHES Bernard P., 84 nota 211, 85 note 213-214, 86 nota 217, 87 nota 221.
HoGHES Quentin, 68 n ota 157, 135 nota 6.
HUYSSEN Heinrich vo n, 116, 116 nota 11 , 117, 118.
lFICRATE, generale ateniese, 272 . l uGU RTA , V. GIUGURTA.
JXHNS Max, 93 nota 239, 134 nota 5.
]OMINI Antoine Henri de, 83, 83 nota 208, 103, 103 nota 27 1.
KANT Immanuel, 97 nota 249 .
KAuFMANN Harms, 10, 10 nota 2, 22 nota 27, 23 nota 29, 41, 41 nota 66, 64 nota 149, 65 note 150-151, 75 nota 184, 101 nota 263, 104 note 274-275, 105 nota 278, 107 note 281-283, 108 note 283 bis-284.
KEPLERO Johanne s, 70.
KIESEWETTER Johann Gottfried, 97.
K1szuNG Rudolf, 10, 10 nota 10.
KLrrzINGEN Hans Kaspar von, 239,239 nota 103.
KocH Matthias, 334 nota 191.
KoMENSKY Jan Amos, v. CoMENJUS Johann Amos.
KoNIGSMARK H ans Christoph von, 19
KoPRULU Ahmed, 24, 28, 29, 31, 34 , 99 .
KovRÉ Alexandre, 70 nota 164.
KuRUT A.N., storico turco , 105 nota 276
LEIBNIZ Gottfried Wilhel m von, 116 nota 8.
LEONARDO da Vinci, 66.
LEOPOLD I, v. LEOPOLDO Id' Absburgo.
LEOPOLDO GUGLIELMO, arciduca d'Austria, 18, 22, 334 nota 191.
LEOPOLDO I d'Absburgo, impera tore del Sacro Romano Impero , 24 , 38 nota 57, 115.
LE TELLIER Miche !, 92.
LEWIS Berkeley R., 85 nota 216.

LJODEL-HART Basi! Henry, 65, 96, 97 nota 247, 98 nota 251.
L1NOELAU, generale, 208, 208 nota 77.
LINOELAW, V. LINDELAU.
L1Ps Joest, v. L1Ps10 Giusto.
L1rs10 Giusto (L1Ps Joest), 45, 128, 128 nota lbis, 131, 131 nota 5, 190, 190 nota 51, 195, 199, 203, 208, 423.
L1PS1us Justus , v. LIPSIO Giusto.
L1SK Jill, 23 nota 28.
Lrv10 Tito, 45, 71
LOBKOVIC Vaclav, 36, 115.
LOR INI Buonaiuto, 131, 133 nota 5
LORINO, v. LORINI Buonaiuto.
Loms XI, v Lu1G1 XI.
Louvois François-Michel Le Tellier marchese di, 36, 36 no te 52-53, 37 nota 56, 92.
LOZANUS Franz, 282, 282 nota 170.
Luc io VERO, imperatore romano, 133 nota 5.
LUIGI Xl, re di Francia, 132 n ota 5.
Lu1G1 XII, detto Padre del Popolo, re di Francia, 132 nota 5.
Lmc1 XIII, detto il Giusto, re di Francia, 127 n ota 1, 265 nota 146.
Lu1G1 XIV, re di Francia, 25, 29 nota 40, 36, 38, 55, 92.
LUIGI FILIPPO di Borbone-Orléans, re dei Frances i, 37 nota 55.
LABIENO Tito, genera le romano, 326.
LA FEUILLADE François, 29, 32 .
LANCETTI Vincenzo, 115 nota 7 bis.
LANGRIN I, 131, 134 nota 5.
LEARDI Cesare, 113, 114 nota 5, 119 nota 16.
LEARDI Clara, v. CoccoNITO 01 MoNTIGLIO Clara.
LEE Robert Edward, 87 nota 220, 102, 226 nota 87.
LONEBURG Giorgio di BRUNSW ICK, v. BRUNSWICK-LONEBURG Giorgio di.
LuRAGHI Nino, 105 nota 279.
LuRAGHI Raimondo , 7, 9, 49 nota 93, 67 nota 156, 87 note 220-221, 88 nota 222, 89 nota 226, 97 nota 249, 101 nota 263, 103 nota 271, 106 n o ta 280, 108, 122, 125,201 nota 69, 226 nota 87, 435.
LUTTWAK Edward N ., 97 not a 248 , 106 nota 280.
M., v. MoNTECUCCOLI Raimondo.
MACHIAVELLI Niccolò, 13, 44, 45, 53 nota 107, 61, 61 nota 135, 62, 63, 69, 71, 71 nota 167, 72, 74, 121, 128 nota lbis, 131, 131 nota 5, 183 nota 42, 188 nota 49.
MAGALOTTI Lorenzo, 41.
MAHAN Alfred-Thayer, 166 nota 22.
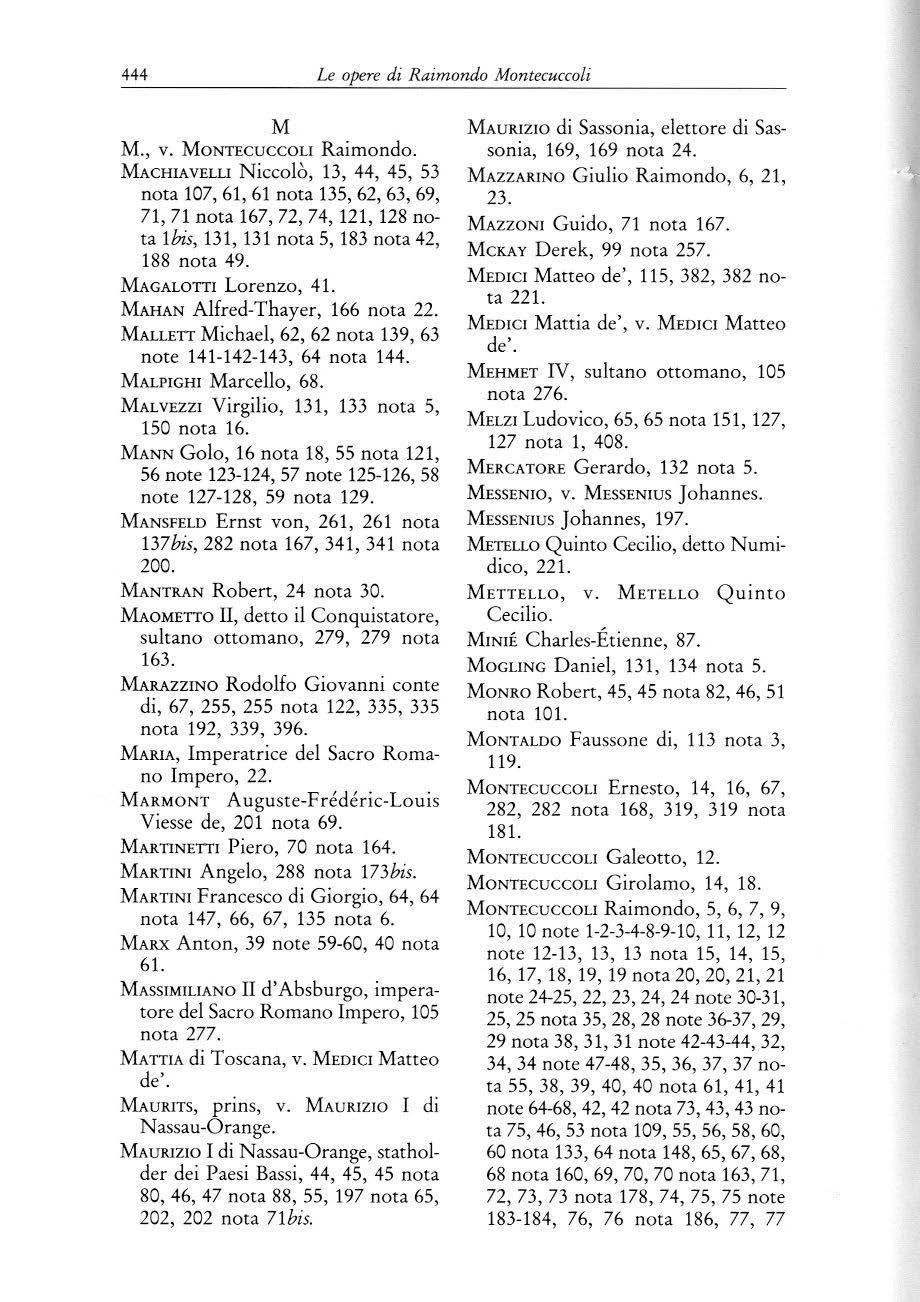
MALLETT Michael, 62, 62 nota 139, 63 note 141-142-143, 64 nota 144.
MALPIGHI Marcello, 68.
MALVEZZ I V irgi li o, 131, 133 nota 5, 150 nota 16.
MANN Golo, 16 nota 18, 55 nota 121, 56 note 123-124, 57 note 125-126, 58 note 127-12 8, 59 nota 129.
MANSFELD Ernst von, 261, 261 nota 137bis, 282 nota 167, 341, 341 nota 200.
MANTRAN Robert, 24 nota 30.
MAOMETTO II, detto il Conqu istarore, sultano ottomano, 279, 279 nota 163.
MARAZZINO Rodolfo Giovanni conte di, 67, 255, 255 nota 122, 335, 335 nota 192 , 339, 396.
MARIA, Imperatrice del Sacro Romano Impero, 22 .
MARMONT Auguste-Frédéric-Louis Viesse de, 201 nota 69.
MARTINETTI Piero, 70 nota 164.
MARTIN! Angelo, 288 nota 173bis.
MARTIN! Francesco di Giorgio, 64, 64 nota 147, 66, 67, 135 nota 6.
MARX Anton, 39 note 59-60, 40 nota 61.
MASSIMILIANO II d' Absburgo, imperatore del Sacro Romano Impero, 105 nota 277.
MATTIA di Toscana, v. MEDICI Matteo de'
MAURITS, prins, v. MAURIZIO I di Nassau -Orange.
MAURIZIO I di Nassau-Orange, statholder dei Paesi Bassi, 44, 45, 45 nota 80, 46, 47 n ota 88, 55, 197 nota 65, 202, 202 nota 71bis.
MAuRiz10 di Sassonia, elettore di Sassonia, 169, 169 nota 24.
MAZZARINO Giulio Raimondo, 6, 21, 23.
MAzzoNr G u ido, 71 nota 167.
MCKAY Derek, 99 nota 257.
MEDICI Matteo de', 115, 382, 382 nota 221.
MED1c1 Mattia de', v. MEorc1 Matteo de' .
MEHMET IV, sultano ottomano, 105 nota 276.
MELZI Ludovico, 65, 65 nota 151, 127, 127 nota 1, 408.
MERCATORE Gerardo, 132 nota 5.
MESSENIO, v. MESSENIUS Johannes.
MESSENIUS Johannes, 197.
METELLO Quinto Cecilio, detto Numidico, 22 1.
METTELLO, v M1::rELLO Quinto Cec i lio.
M1NIÉ Charles-Étienne, 87.
MocLING Daniel, 131, 134 nota 5.
MoNRO Robert, 45, 45 nota 82, 46, 51 n ota 101.
MoNTALDO Faussone di, 11 3 nota 3, 119 .
MoNTEcuccou Ernesto, 14, 16, 67, 282, 282 nota 168, 319, 319 nota 181.
MoNTEc u ccoLI Galeotto, 12.
MONTECuccoLI Girolamo, 14, 18.
MoNTEc u ccou Raimondo, 5, 6, 7, 9, 10, 10 note 1-2- 3-4-8-9 -10, 11, 12, 12 note 12-13, 13, 13 nota 15, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19 nota 20, 20, 21, 21 note 24-25, 22, 23, 24, 24 note 30-31, 25, 25 nota 35, 28, 28 not e 36-37, 29, 29 nota 38, 31, 3 1 note 42 -43 -44, 32, 34, 34 note 47-48, 35, 36, 37, 37 nota 55, 38, 39, 40, 40 nota 61, 41, 41 note 64-68, 42, 42 nota 73, 43, 43 nota 75, 46, 53 not a 109, 55, 56, 58, 60, 60 nota 133, 64 nota 148, 65, 67, 68, 68 nota 160, 69, 70, 70 nota 163, 71, 72, 73, 73 nota 178, 74, 75, 75 note 183 -184, 76, 76 nota 186, 77, 77
MONTEC
o, v MONTEcuccou Raimondo.
MONTGOMERY, V. MONTGOMMERY.
MoNTGOMMERY Gabriel d e, 208, 208 nota 76.
MONTGOMM ERY Luis de, 208,208 nota 76.
Mosn, co nce, 268
MuLLERJohn, 135 nota 6, 137 nota 8.
MuNSTER Christian von, 350, 350 nota 206.
NABIDE, re di Sparta, 344.
NAPOLÉON, v. BONAPARTE Napo leone.
NAPOLEONE I, imperatore dei francesi, v BONAPARTE Napoleone
NEUMAIR voN UNO zu RAMsLA J ohann, 131, 133 nota 5.
NEWTON Isaac, 68.
NrCKERSON Hoffman, 98 nota 253.
NoUE François de la, 127, 127 nota 1, 131, 131 nota 5, 265 nota 146.
0BAUER-GUTTEMBERG V., scrittore mil itare austriaco, 93 nota 239.

0LSCHKJ Leonard, 70 nota 164.
OMAN Cha rl es, 280 nota 165.
ONOSANDRO, trattatista greco, 131, 132 nota 5, 133 nota 5
OsE Dieter, 226 nota 87
0TACIUO, console romano, 272 .
0TTOLENGHI Giuseppe, 114 nota 5.
OxENSTIERNA Axel Gustafsson, 46, 47, 51 nota 100.
PACIOTTO Luca, 67 .
PAPP EN HEIM Gottfried Heinri ch von, 51 nota 102, 59,244,253 nota 121 , 306, 319, 319 nota 181, 333, 334, 351, 359, 359 nota 210, 399, 401, 402, 404.
PARET Peter, 83 nota 207.
PAR UTA Luigi, 75.
PASCAL Blaise, 298 nota 175.
PATRIZI Francesco, 131, 133 nota 5, 199.
PATRIZIO, v. PATRIZI Francesco.
PATTON George Smith, 54 nota 111.
PEBAL L Kurt, 7, 9, 10, 10 note 1-5, 11 nota 11 , 24 nota 33, 25 nota 35, 28 not a 36, 32 nota 46, 34 nota 47, 35 nota 49, 78, 78 note 191- 192 , 79, 99 nota 256, 109.
PERETTI, cardina le, 13, 13 nota 14.
PERICLE, uomo politico ateniese, 53 nota 107.
PERIKLES, V. PERICLE.
PERJÉS Géza, 7, 11, 24 nota 31, 83 nota 207, 90 nota 229, 91, 92 nota 233, 93 not e 238-239, 94, 94 note 240-242, 96, 96 nota 245.
PETERSON Harold L., 137 nota 8.
PHILIPPI Johann, v. StEIDANUS Johanne s.
P1ccoLOM1N1 Ottavi o, 16, 16 nota 18, 67, 101,115,260, 268, 334 nota 191, 341, 389, 413.
Prnru Piero, 6, 10, 10 note 3-6, 43 nota 75, 46 nota 84, 53 nota 107, 62, 62 nota 138, 63 nota 142, 64 note 145-146, 76, 76 nota 186, 77, 78, 78 note 190-192, 79, 79 note 195- 196, 80, 80 note 197-198, 81 nota 200, 84 nota 209, 86 nota 218, 89, 89 nota 227, 98, 99, 99 note 254-255-257, 101 note 264-265, 102, 102 nota 267, 104 nota 272.
PIETRO I, il Grande, zar di Ru ssia, 116.
PIRRO, re dell'Epiro, 180.
PLATONE, filosofo greco, 70, 71.
PLUTARCO, storico e moralista greco, 131, 131 nota 5.
Pous10, storico greco, 45, 71, 131, 131 nota 5, 133 nota 5.
Potrooru Filippo Luigi, 101 nota 266.
PouENO , sc rittore greco, 131, 132 nota 5, 133 nota 5.
POMPEO MAGNO Gneo, 224, 392.
PosrooNJO di Apam ea, fi losofo e sc ienziato greco, 133 nota 5.
PRAISSAC (o PRE1SSAC), Signore di, teorico militare, 131, 133 nota 5, 190, 190 nota 51, 195 , 199, 203, 208.
PRIORATO Galeazzo Gualdo, 12 nota ·12, 13, 13 nota 15, 35 nota 51, 49 , 56 nota 122
PRO~us Carlo, 14 nota 16, 64 nota 147.
PRO VANA Luigi, 119.
PucHHEIM Hans Christoph Re ichsgraf von, 334, 334 nota 192, 342.
QuATREFAGES Ren é, 55 nota 119
QUINTINO, 223.
R. L., v. LuRAG HJ Raimondo.
RAIMoNDI Ezio, 118, 118 nota 13bis, 119 nota 14ter.
RAK.6czv Gyorgy, 19, 23.
RAuscH Wilhelm, 42 note 73-74.
REoucH Oswald, 38 nota 57.
RE1cH EL Daniel, 89 nota 224.
RENA UDET Augustin, 61 nota 134.
RICHELIE U Armand-Jean du Plessis de, 59, 127 nota 1, 230 nota 91.
RicHTER Siegfried, 7.
R.irrsERG Ernst Ch ri stoph conte di, 244, 337, 339.
RoBERTS Michael , 44 , 44 note 76-77 -78 , 45 note 79-81, 46 note 83-84, 47 note 86-87-88, 48, 48 note 89-90-91 -92, 49 note 93-94-95, 50, 50 note 97-98 -99, 5 1 nota 100, 52, 52 not e 104-105-106, 53 note 108-110, 54 note 116-117, 55, 55 nota 120, 59 nota 132.
ROHAN Enrico duca di, 127, 127 nota 1, 129, 131, 131 nota 5, 190, 190 nota 51, 195, 199, 265 nota 146.
ROMMEL Erwin Johannes, 226 nota 87.
RossELLJ Alberto, 7.
RUFFIA , conte di, generale piemontese, 11 6. s
SAL1s Hans Wolff von, 351.
SALLUSTIO Gaio Crispo, storico romano, 131, 131 nota 5.
SALuzzo Cesare, 119.
SAMUELE, r e dei Bulgari, 420.
SANDONNINl Tommaso, 12, 12 nota 12.
SANGALLO Giuliano da (G1AM BERTI Giuliano), 67.
SAVORGNANO Giulio, 133 nota 5.

ScttAFFGOTSCH Hans-Ulrich conte di, 282, 282 nota 170.
SCHARNHORST Gerhard von, 10.
ScttEELS Joahann B., 302 nota 177.
Sctt6NB0RNER Georg, 131, 133 nota 5.
ScttOPENHAUER Arthur, 97 nota 249.
ScttwARZENBERG Adolph pri ncipe di, 41.
ScHWENTER Daniel, 298 , 298 nota 175
SCIPIONE AFRICANO Publio Cornelio, 29 0 .
SEIDLER Josef, 59 no ta 130.
SELENO Gustavo, v. SELENUS Gustavus.
SELENUS Gustavus (BRAUNSCHWEIG Augusto, duca di), 298, 298 nota 175.
SEMENOWYCZ Casimir, 137 not a 8.
SENOFONTE, storico greco, 131, 131 nota 5, 132 nota 5.
SERASSI Pier Antonio, 115, 118.
SERSE I, re di Persia, 252.
SERTORIO Quinto, uomo politico romano, 225.
SIGISMONDO III VASA, re di Polonia e di Svezia, 145 nota 13bis.
SLANG Erich, 422, 422 nota 246.
SLEIOANO, v SLEIDANUS Johannes.
SLEIDANUS J ohannes (PHILIPPI Johann), 131, 133 nota 5, 169.
SMITH Ca p. George, 135 nota 6, 182 nota 39.

SouMANO Il, sultano ottomano, 25.
SOLONE, uomo politico ateniese, 187.
SouLT Nicolas-Jean de Dieu, 37 nota 55.
SPANHEIM, 45.
SPERRENTER, colonnello svedese, 349.
SPINOLA Ambrogio, 14, 66.
SroNTONE Ciro, 14 nota 16.
SroRCK Johannes von, 31, 34.
STAMP Gerd, 97 nota 248.
STOLLER F ., storico austriaco, 21 nota 24.
STRADA Jacobus de, 131, 133 nota 5.
STRADA Jacopo di, v. STRADA J acobus de.
SuGAR Peter, 24 nota 30.
SuN Tzu, 97 nota 247, 100, 100 note 258 -2 59, 102 nota 268.
SuvoRov o SuvARov Aleksandr Vasilevic, 87.
TACITO Publio Cornelio, storico romano, 128 nota lbis, 132 nota 5, 133 nota 5
TAMERLANO, sovrano turc o dell 'Asia cent rale, 420, 420 not a 243ter.
TARTAGLIA Niccolò , 66, 66 nota 153, 67, 135 nota 6.
TEMISTOCLE, uomo politico e generale ateniese, 252.
TERRIDE de, generale, 208 no ta 76.
TESEO, eroe della mitologia greca, 199.
TESTA Andrea, 114 nota 5, 115.
TESTI Fu lv io, 11, 16, 17.
THUCIOIOE, V TUCIDIDE.
T ILLY Johan Tserclaes de, 15, 53, 54, 60, 179 nota 34, 224, 225, 236 , 253, 253 nota 121, 254, 255, 260, 262, 262 nota 139, 272 nota 158, 273, 341, 341 nota 200, 357, 399, 401.
TIRABOSCHI Girolamo, 116 nota 10.
ToMIRI, regina dei Massageti, 400, 401 nota 235.
TO MMASO , principe di Carigna n o, 29 nota 40.
ToRSTENSSON Lennart, 18, 20, 48, 91, 192 nota 54, 334 nota 191.
TRIVULZIO Gian Giacomo, 66, 88.
TROGO Pompeo, storico latino, 132 nota 5.
TUCIDIDE, storico greco, 131, 131 nota 5.
TURENNE Charlotte de Caumont de la Force M.me de, 208 nota 76.
TuRENNE Henri de la Tour d' Auvergne de, 6, 10, 19, 20, 21, 36, 36 note 52-53, 37, 37 note 54-55-56, 38, 39, 40, 80, 90, 95, 102, 201 nota 69, 208 nota 76, 333 nota 188.
TuRNER Sir James, 52 nota 103.
TuRPIN DE CrussÉ, conte, generale, 117.
UFANO Diego, 131, 133 nota 5, 137 not a 8.
UFFANO Diego, v. UFANO Diego.
URBANO VIII (Maffeo Barberini), papa, 18.
Louis du ca de la.
V ALETTE DE NoGARET Louis duca de la , cardinal e, 333 , 333 nota 189, 335 , 337, 341.
VALTURIO Rob erto, 66.
VAN CREVELD Martin, 53 , 54, 54 note 111-114 , 55 nota 118 , 91 nota 230, 92, 92 nota 234 , 93, 93 no te 236-237 , 94 nota 241.
V AUBAN Sébastien Le Prestre marchese di, 64 , 64 nota 148, 105 nota 277.
VEGEZIO RENATO Flav io, 44, 45 , 131, 133 nota 5.
V ELTZÉ Aloi s, 5, 6 , 21 nota 25, 41 note 64-67, 77, 77 nota 187, 79, 79 note 194-196, 107, 110, 116 nota 11, 120, 120 note 19-22, 125, 129 nota 2bis, 134 nota 5, 206 nota 73, 208 nota 76, 227 no ta 88, 239 nota 105, 249 nota 118, 250, 272 nota 158, 279 nota 164, 281 nota 166, 282 nota 169, 326 nota 186, 343 nota 205, 364 nota 214, 366 nota 215, 369 note 217-218 , 371 nota 219, 372 nota 220 , 401 nota 235, 407 nota 240, 409 nota 241, 42 8 nota 248.
VENTURI Giovanni, 1 12 , 119.
Vi co Giambattista, 5, 72, 76.
VmuA Carlo, conte di Conzano, 114, 114 nota 5, 119, 119 note 16-17.
V1LLARS Claude-Louis-He cto r duc a di , 37 nota 55.
VINERMONDL, barone di, V. VIRMOND VON DER NEERS Johann.
V1RMOND voN DER NEERS J o h ann, 193, 193 nota 56.
V1TTORJO AMEDEO II, duca di Savoia, princip e di Piemonte , 113.
V1TTORIO EMANUELE II, re di Sard eg na e, dal 14 marzo 1861, re d'Italia, 113 nota 3.
ta 92 , 53, 54, 54 nota 111, 55, 55 nota 121, 56, 56 nota 122, 57, 57 nota 126, 58, 59, 59 nota 130, 60, 91, 101, 106, 107, 157, 157 nota 20 , 165, 166, 168, 181, 190 , 193, 194, 221 ,221 nota 83, 236, 236 nota 97, 242, 258, 273 nota 159, 282 nota 170, 286, 286 nota 173, 301, 351 , 357, 359, 380, 389, 395, 426.
WALLHAUSEN Johann Jakobi von, 131, 131 nota 5.
WANGLER Jo hann, 268 , 268 nota 149
W EIGLEY Russell F. , 102, 103 n o ta 269.
WEIMAR, v. BERNARDO di Weimar.
W ELLE R Jac, 86 nota 218 .
WELLINGTON Arthur We ll esley duca di , 86, 86 nota 218.
WERTH (o WERT) Jean de, barone, 340, 350, 394, 395.
WrLDB ERG Philipp von, 334, 334 n o t a 190.
W IJN J .W. , st orico olandese, 45 nota 80, 46 no ta 84.
W1TTENBERG Arfwid von, 20.
WoLSE LEY Sir Garnet Joseph , Lord, 201 no ta 69.
W RAN GEL Karl Gustav vo n, 20, 21, 326.
WREDE Alphons von, 41 n o ta 65.
WRIGHT Quincy, 104 nota 273.
W u RMHANDT Melkior, 48 n ota 90.
W AGNER Georg, 25 nota 35, 28 nota 36, 31 note 41 -45, 34 n ota 47.
W ALLENSTEIN Albrech t Euse bius Wenzel von, duca di Friedland, 6 , 9 , 14, 15, 16, 16 nota 18 , 17, 36, 48 no-
YouNG John R. , 88 nota 223
ZAPPATA Giovan Batt ista, 117.
ZENONE di Elea, filosofo greco, 151 nota 17.
Z1PPEL Giorgio, 66 not a 154.
Z1PP ERER Gustav Adolf, 175 nota 30
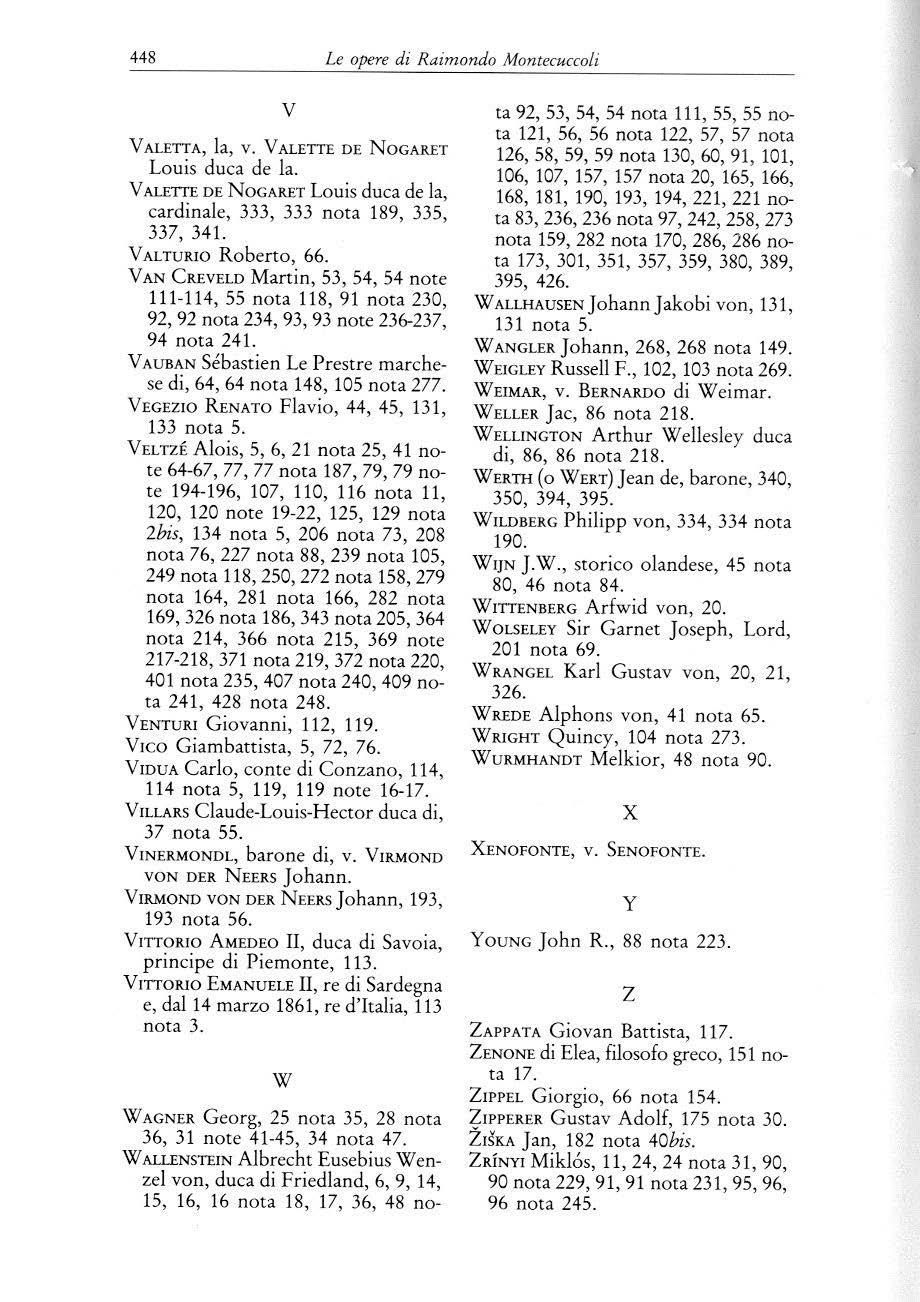
ZISKA Jan, 182 nota 40bis.
ZRfNY I Mikl6s, 11, 24, 24 nota 31, 90, 90 n ota 229, 91, 91 nota 231, 95, 96, 96 nota 245.
Acaia (Grecia), 274.
Albania, 279 nota 163.
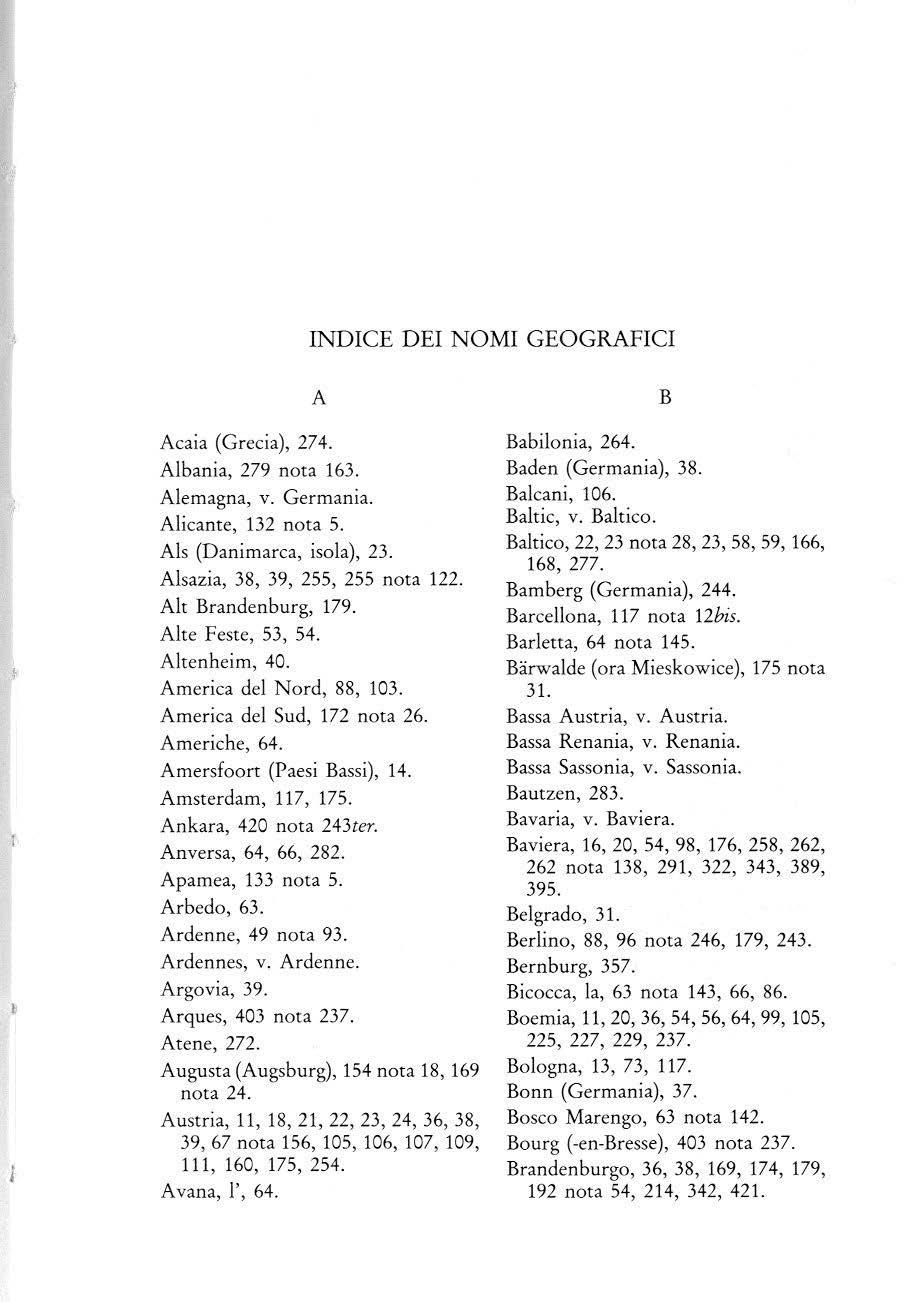
Alemagna, v. Germania.
Alicante, 132 nota 5.
Als (Danimarca, isola), 23 .
Alsazia, 38, 39, 255, 255 nota 122.
Alt Brandenburg, 179.
Alt e Feste, 53, 54.
A !ten h eim, 40.
America del Nord, 88, 103.
America del Sud, 172 nota 26.
Americhe, 64.
Amersfoort (Paesi Bassi), 14.
Amsterdam, 11 7, 175 .
Ankara, 420 n o ta 243ter.
Anversa, 64, 66, 282.
Apamea, 133 nota 5.
Arbedo, 63.
A rd enn e, 49 nota 93.
Ardennes, v. Ardenne.
Argovia, 39.
Arques, 40 3 nota 237.
Atene, 272 .
A u gusta (Augsburg), 154 no t a 18, 169 nota 24.
Austria, 11, 18, 21, 22, 23, 24, 36, 38 , 39, 67 nota 156, 105, 106, 107, 109, 11 1, 160, 175, 254 .
Avana, l', 64.
Babilon ia , 264.
Baden (German ia) , 38.
Balcani, 106.
Baltic, v. Baltico.
Baltico, 22, 23 nota 28, 23, 58, 59, 166, 168, 277.
Bamberg (Germania), 244 .
Barcellona, 117 nota 12bis.
Barletta, 64 nota 145.
Barwalde (ora Mieskowice), 175 nota 3 1.
Bassa Austria, v. Austria.
Bassa Renania, v. Renania .
Bassa Sassonia, v . Sassonia.
Bautzen, 283.
Bavaria, v . Baviera.
Baviera, 16, 20, 54, 98, 176, 258, 262, 262 nota 138, 291, 322, 343, 389, 395.
Belgrado, 3 1.
Berlino, 88, 96 nota 246, 179, 243.
Bernburg, 357.
Bicocca, la , 63 nota 143, 66, 86.
Boemia, 11, 20, 36, 54, 56, 64 , 99, 105, 225, 227, 229, 237.
Bologna, 13, 73, 117.
Bonn (Germania), 37.
Bosco Marengo, 63 nota 142.
Bourg (-en-Bresse), 403 nota 237.
Brandenburgo, 36, 38, 169, 174, 179, 192 nota 54, 214, 342, 421.
Brandys (nad Labem), 302 nota 177 , 323.
Brege n z, 39
Bre isgau, 39 .
Breitenfeld, 15, 50, 54, 60 nota 133, 89, 253 nota 121, 255 nota 122, 260 nota 132, 262 not a 138, 334 nota 191.
Brema, 225.
Bremen, v. Brema.
Brindisi, 392.
Britan n ia, 173 nota 27.
Brne, 115.
Brno, 20.
Bruxelles, 128 nota lbis.
Burg (bei Magdeburg), 401.
Cadenae, 243.
Ca lli àn o (Tre nto), 63.
Ca mbrésis, 132 nota 5.
Cambridge (Inghilterra), 46 nota 84, 54 nota 112, 61 nota 135, 65 n ota 152, 66 nota 155, 67 nota 157, 105 nota 276.
Canada, 29, 29 nota 40.
Ca ndia (Creta), 25.
Ca nne, 34, 98
Capua, 186 nota 48, 264.
Ca rignano, 29, 29 nota 40.
Carinzia, 111.
Carolina Meridionale, 226 nota 87.
Carpi, 105 nota 277 .
Carre, 181 nota 36.
Casale Monferrato, 14, 113, 114 nota 5, 115 , 119 note 16-17, 127 nota 1.
Castro, ducato di, 18, 78 nota 192.
Cecos lova cc hia , 109, 115 .
Cerignola, 63 nota 143, 66, 86.
Ceve nne, 268 nota 148 .
C ham (Ge rmania), 237, 282 , 282 nota 169, 336.
C hemnit z (ora Karl-Marx-Stadt), 255 nota 122, 335, 335 nota 192, 339 n ot a 197.
Cherasco, 235 nota 96.
Coblenza, 37.
Cocconato, 113.
Colberg, 226.
Colonia (Kéil n), 36, 37, 116, 117, 118, 193.
Cop enhage n, 99.
Costantinopo li, 279, 279 n ota 163.
Co urb ouson, 208 nota 76.
C racovia, 23.
C revol a (d'Ossola), 62, 63.
Croazia, 24.
Crossen, 285.
Danimarca, 23, 38, 145, 176 nota 32, 413

Danubio, 25, 99 , 237, 262.
Decin, 115.
Demmin, 239, 256, 360.
De utschla nd , v. Germania.
Dillenburg, 202 nota 71bis.
Domitz, 239.
Drava, 25, 28.
D res da, 422.
Dy hrenfurth (ora Brzeg Doln y), 360 .
rstadt, 37.
Ei lenburg, 317.
Eis enstadt, 34 nota 47.
Elba (fiume), 225, 256, 262, 283, 302, 323, 335 nota 192, 342, 359, 360, 416.
Elea, 151 nota 17.
Ellesponto, 252.
Ensisheim, 16 .
Enzh eim, 38 .
Erfurt, 262.
Erzinjan, 279 nota 163.
Esseg, 25.
Es tad os-Bajos, v. Paes i Bassi.
Eu r ope, v. Europa.
Europa, 6, 13, 15, 21, 24 nota 30, 25, 35, 41, 48, 61, 61 nota 135, 62, 64, 65 nota 152, 66, 67 not a 156, 88, 103 , 105, 172 nota 26, 181 , 252.
Farsaglia (o Farsalo), 98.
Ferrara, 64, 116
Fiandra, v. Fiandre.
Fiandre, 21, 92, 127 nota 1, 131, 132 nota 5, 133 nota 5, 186, 186 nota 47, 389 nota 227.
Firenze, 115, 133 nota 5.
Fontainebleau, 403 nota 237.
Francia, 19, 21, 23, 29, 29 nota 40, 36, 37, 37 nota 55, 38, 63, 66, 92, 103, 106, 127 nota 1, 132 nota 5, 172 nota 26, 175, 175 nota 31, 176, 181, 191, 230, 235, 235 nota 96, 268 nota 148, 280, 284, 287 nota 173bis, 389, 403 nota 237, 412 .
F rancoforte (Frankfurt am Main), 39.
Franconia (Germania), 19, 37, 39, 54, 262 nota 138.
Fra nkenta l (ora Frankenthal), 272.
Frei berg (Sassonia), 398.
Freiburg im Meissen, 335 nota 192.
Fr idland, v. Friedland in Bohmen.
Fr iedland in Bohmen (ora Frydlant-v Cechach), 16, 36, 55, 60, 122, 157 nota 20.
Frignano, regione dell'Emilia, 12 .
Fyn, 23. G
Gallia, 392, 418
Gartz, 239.
Genova, 241.
Georg ia (U .S.A.), 226 nota 87.
Germania, 11, 19 nota 22, 25 , 36, 38, 39, 39 nota 59, 44, 45 , 48, 49 , 54, 58, 88, 91, 105, 111, 127 nota 1, 134 no-
ta 5, 145, 154, 165, 168, 172, 174 no-
ta 29, 175, 176, 180, 182, 184, 186, 191, 194, 202, 214 , 221, 228, 232, 234, 237, 239 nota 108,274,288 nota 173bis, 379, 408, 417.
Germershausen , 324.
Gle iss, 9.
Goa, 64.
Graz, 25.
Greifswald, 226, 239.
Giins (ora Koszeg), 25.
Gyor, 23. H
Hafnerbach, 7, 42 nota 73.
Hagenau, 40.
Haindorf, 9.
Halle (an der Saale), 41, 111, 224, 351.
Halle (Sassonia), 15.
Havelberg, 239.
Heilbronn, 176 nota 33.

Hermanitz, 56.
Hohenegg, 7, 9, 18, 19, 19 nota 22, 22, 36, 42 nota 73, 74, 77, 78, 79, 79 note 194-196, 80, 111, 116.
Hohenem s, 39.
Holstein (Germania), 23.
Horst (Pomerania), 227.
lassarte (Syr Dar'ja), 401 nota 235.
Indie , 64.
Inghilterra, 23, 132 nota 5, 176 nota 32, 235.
lngolstadt, 262.
Iso nzo, 49 nota 93.
Ispagna, v Spagna.
Italia, 10 nota 7, 11, 14, 18, 61, 62, 63, 64, 64 nota 147, 66, 66 nota 154, 69, 88 nota 222 , 107, 109, 111, 127 nota 1, 181, 234, 253,257,276, 279 nota 163, 424.
lvry (-la -Bataille), 403 nota 237.
Jarnac, 127 no t a 1, 265 nota 146.
Jutland , 23 .
Kaiserlautern, 17.
Kemp t en, 255, 255 nota 122 .
Kent (Inghilt erra) , 133 nota 5.
Kitzingen , 37.
Knarod, 145 nota 14.
Kollbus, 15.
Ko r mcnd, 28, 29.
Kiistrin (o ra Ko strzyn), 64, 179.
Lahn, 37.
Landsberg (Sassonia), 3 42 .
La Roche ll e, 230, 230 nota 91.
La Sall e, 7.
Lecce, 133 nota 5.
Lec h (fiume), 225, 322
Leida, 128 nota lbis.
Leipzig, v. Lipsia.
Lendva, 28.
Le utt ra (ora Leuktra), 98
Linz, 42, 42 nota 73.
Lipsia, 117, 192 nota 54,224,236,240, 250, 253, 333, 334, 390, 404.
L itomericc, 115.
Livonia, 228.
Loitz, 360.
Lombardia, 92 .
Lo ndra, 21, 235.
Lorena (Francia), 39, 235, 255 , 255 nota 122 , 333 nota 189, 357, 402, 417.
Lovanio, 128 nota lbis.
L ut zen, 16, 5 1 nota 102, 52, 53 , 59, 59 nota 130, 181 n o ta 35, 244 n. 114, 260 nota 131 , 351.
M
Meklemburgo, v . Meclemburgo.
Melnik , 302, 302 nota 177 , 323, 325.
Meloduno, v Me lod u num
Me lodunum (ora Me l un), 326.
Memmin ge n , 244.
Meno, 36, 37.
M e tauro, 98.
Metz (Francia), 333 nota 189, 335.
Mézièr es, 255, 357, 417.
Milano, 79 nota 194, 109, 110, 111 , 114,1 15 not a7bis, 117,1 19 nota 16, 120, 132 nota 5.
Mingolsheim, 341 nota 200.
Misnia, 227, 351.
M itteleuropa, 35.
Modena , 7, 12, 13 , 13 nota 14, 14, 15, 16, 17, 19 nota 22, 25 n ota 35, 68, 74 nota 180, 78, 78 n ota 192,111, 112, 112 no t a 1, 11 6, 116 nota 10, 119, 125, 287 nota l73bis
Mogersdo rf, 24 n ota 33, 25 nota 35, 32, 34 nota 47 .
Mo ncounto u r, 127 no t a 1.
Mons (Belgio), 38.
Montag na Bianca , 14, 56.
Montecu cc ol o , 12.
Mo r avia (Cecoslovacchia), 105, 132 nota 5, 237.
Moscovia , 145.
Mosel (fiu m e), 40 nota 61.
Mozambi co, 64.
Miihlb erg, 169 nota 24.
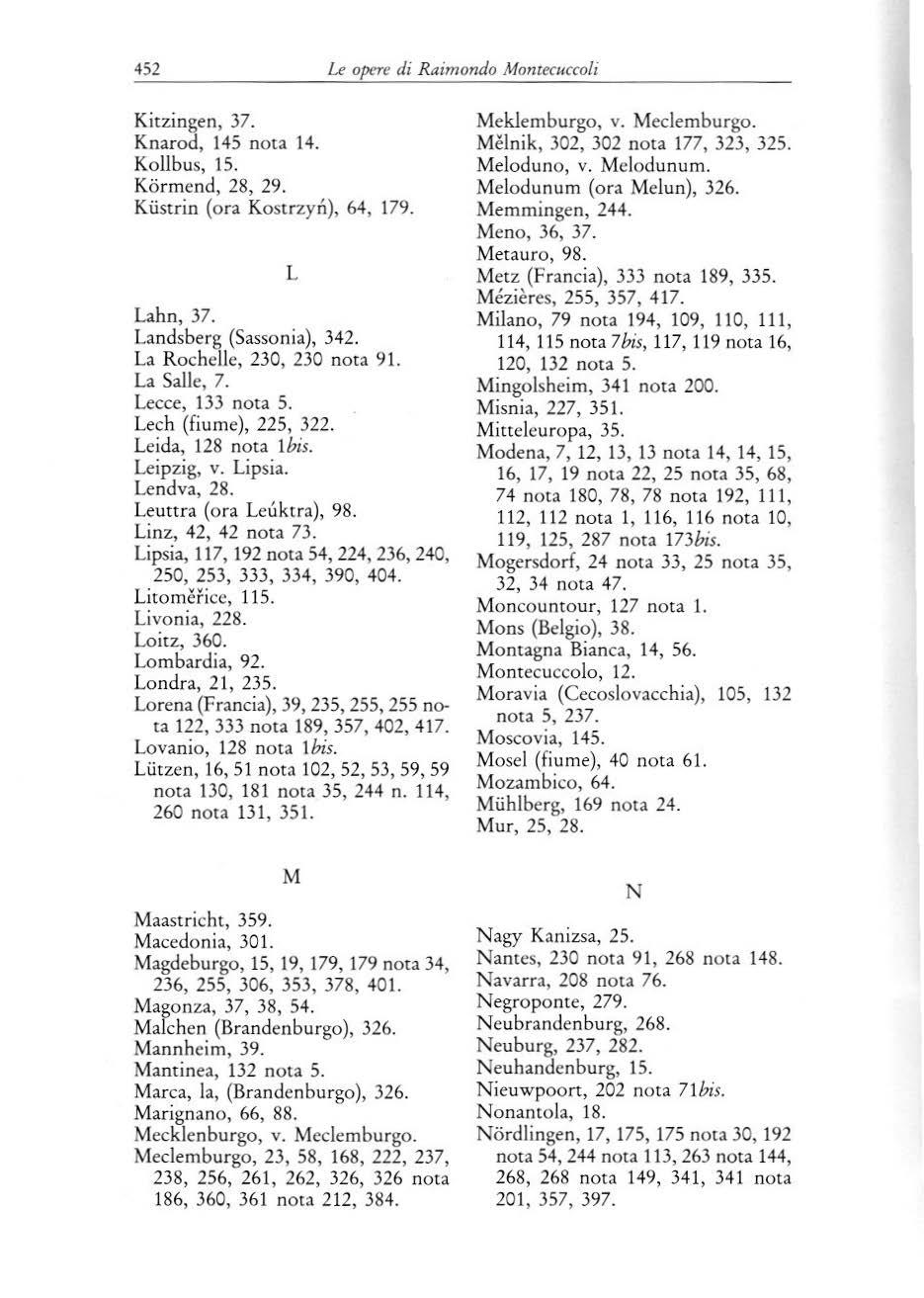
Mur, 25, 28
Maastricht, 359 .
Macedonia, 30 1.
Magdebur go, 15, 19 , 179, 179 nota 34 , 236 , 255, 306, 353, 378, 401.
Magonza, 37, 38, 54 .
Malc h en (Bra ndenburgo), 326.
Mannheim, 39.
Mantin ea, 132 nota 5.
Marca, la, (Brandenburgo), 326 .
M arignano, 66, 88.
Mecklenburgo , v. Meclemburgo .
Meclemburgo, 23 , 58, 168, 222, 237, 238 , 256, 26 1, 262, 326, 326 n ota 186, 360, 361 nota 212, 384.
Nagy Kanizsa, 25.
Nances, 230 nota 91, 268 nota 148.
Navarra, 208 not a 76.
Negroponte, 279.
Ne u branden bu rg, 268 .
Neuburg, 237, 282.
Neuhand enb urg , 15.
Nieuwpoort, 202 nota 7lbis.
No n anto la, 18 .
Nordlingen, 17, 175, 175 nota 30, 192 nota 54, 244 nota 113, 263 nota 144, 268, 268 n ota 149, 341, 341 n ota 201 , 357, 397.
Norimberga, 287, 287 nota 173bis, 288 nota 173bis, 298 nota 175, 301, 357, 359, 380
Normandia , 226 nota 87.
Novara, 67 nota 157.
Polonia, 9, 22, 23, 86, 111, 121, 145, 145 note 13bis-14, 336.
Pomerania, 18, 23, 54, 130, 145 nota 15, 165, 173, 173 nota 28, 222, 223 nota 84bis, 237, 238, 239, 254, 256, 262 nota 140, 287, 287 nota 173-bis, 288 nota 173bis, 302 nota 177, 326 .
Ponte di Crevo la, v. Crevo la.
Po rtogallo, 172, 172 nota 26

Oder, 239, 256, 342, 360 .
Offenb urg, 39.
Olanda, v. Paesi Bassi.
Oldenb urg, 25.
Oliva (Polon ia), 23.
Ollanda, v. Paesi Bassi.
Orange (Francia), 202, 202 nota 7lbis.
Orléans (Francia), 90, 394 nota 231.
Osterburg (Germania), 9.
Osterreich, v. Austria .
Ostrande des Wechsels, 25 p
Padova, 56.
Paesi Bassi, 14, 15, 23, 36, 45, 127 nota 1, 132 n ota 5, 172 nota 26, 175, 194 ,287,287 nota 173bis, 288 nota 173bis, 302,379,389 nota 227,417 .
Pa latinato, 38, 258
Par igi, 29 nota 40, 36 nota 52, 40, 11 7, 175, 287 nota 173bis, 389 nota 227.
Paris, v. Parigi
Parma, 389 nota 227.
Passau, 154 nota 18.
Pavia, 298 n ota 175.
Pavullo nel Fr ignano, 22 nota 26, 25 nota 35.
Peene, 225, 262, 326, 360.
Pegau, 404.
Pena (fiume), v. Peene.
Perleberg, 260, 334, 416.
Persia, 279 nota 163, 401 nota 235.
Philippsbourg, 37, 38, 39.
Piacenza, 66 .
Piemonte, 29 nota 40, 233
Pinero lo, 235 nota 96.
Planen, 227 .
P latea, 98.
Poznan, 23.
Praga , 56, 78, 99, 229, 258, 260, 326.
Provinc ie Unite, 202 nota 71bis.
Prussia, 168. R
Raab (fiume), 23, 25, 25 nota 35, 28, 29, 31, 112 nota 1, 322 nota 184.
Raab (regione), 9 .
Rain am Lech, 282 nota 168.
Rathenau, 239.
Rati sbona, 17, 25, 99, 176 nota 32, 221, 282 nota 169, 357.
Ravenna, 64.
Regensburg , 262 .
Reggio nell'Emilia, 13.
Renania, 36, 92 .
Reno, 16, 36, 37, 38, 39, 40, 40 nota 61, 106, 225, 244, 262, 324.
Rhein, v. Reno.
Rheinfelden (Germania), 127 nota l.
Roccella, la, v. La Rochelle .
Roma, 13, 75, 1 15, 118, 132 nota 5, 168, 276.
Romagna , 63 nota 141.
Rostock, 226.
Rostok, v. Rosto ck.
Rosb erg, 13 1, 133 nota 5.
Riigen, 220.
Russia, 93, 116, 176 nota 32. s
Saale, 262.
Saalfe ld, 260, 389.
Sablat, 282 nota 167
Sa li sburghese, 39.
Sa lm iinster, 79, 110.
San Gottardo, 9, 24 nota 33, 25, 25 nota 35, 28, 28 note 3 6-37, 29, 29 n ot a 40, 3 1, 34 nota 47, 38, 77, 98, 99, 105, 110, 305 nota 178, 322 nota 184.
Sassbach, 40.
Sasso ni a, 10, 19, 37 n ota 55 , 54, 59, 132 n ota 5, 169, 192, 192 nota 54 , 22 4, 227, 236, 240, 250, 255, 302 nota 177, 35 1, 400.
Savoia, 23 5, 235 nota 96,403 nota 237.
Sch leide n, 133 n ota 5.
Scutari, 279 nota 163.

Seneffe, 38 .
Sicilia, 271.
Sieve rshau sen, 169 nota 24.
Sinsh e im , 38.
Slesia, 18, 58, 105.
Sma lk a lda, 169 not a 24 , 172 n ota 25 .
Soviet Union, v. Unione Sovietica.
Sp agn a, 36, 46 not a 84, 66 , 74, 86, 93, 131, 132 n ota 5, 133 nota 5, 181, 194, 243, 263, 263 nota 144, 287 nota l73bis, 38 8, 41 7 .
Spain, v. Spagna.
Spa nd a u , 64, 174, 179.
Spart a, 344.
Spittal, 111.
Stati Unit i d'America, 49 nota 93, 85 nota 2 16, 88, 88 nota 222, 103 nota 26 9.
$tettino, 18, 21, 22, 74, 76, 77, 117, 125, 130, 165, 192, 19 3, 216 , 223 , 262, 268, 360.
St. Gotthard, v. San Gottardo.
Stilo, 74 .
Stin falo, 132 nota 5.
Stoccarda, 243.
Stoccolma, 21, 44.
St ralsu nda, 165.
Strasburgo, 38, 39, 117, 117 nota 12bis.
St ugga rt, v. Sto ccca rda
Su lz (o Soulz), 255 , 255 nota 122, 389.
Sve ri ge, v . Svezia.
Svev ia, 39 , 255, 255 not a 122, 258.
Svezia, 15, 22, 44 , 44 note 76-77, 46, 47 , 48, so, 51, 53, 59, 84, 121, 145, 145 no t e 13bis-14, 165, 168, 173, 174 , 175, 175 n ota 31, 176, 176 nota 32, 179, 181, 184, 190, 192, 193, 194 , 197 , 199,202 not a 71bis, 223, 224 , 225, 226, 232, 236, 239, 240, 242, 242 nota 112 , 244, 244 nota 113 , 250, 25 5, 260, 262 , 265 , 27 4, 281, 282, 287 n ota 173bis, 301, 322, 349 ,3 51 , 35~ 359, 36~ 39~ 399, 401 , 422, 426.
Sv izze ra , 39.
Swede n , v. Sve zi a.
Sy r Dar'ja, v. lassarte. T
Tangermiinde, 349, 355, 395, 405.
Te r mop ili , 27 4.
Tessaglia, 274.
Ti gri, 327.
Tir olo, 39, 362 .
Toledo (Spagna), 133 n ota 5, 263 nota 144.
T orgau, 225 nota 86, 262, 283, 28 5 , 333, 33 4 , 33 5, 336, 342 , 359 , 360, 421.
Torino, 7, 29 nota 40, 81 not a 20 1, 11 2, 117, 119, 119 nota 17 .
T r ac ia, 411 .
T ra nsilvania, 14 nota 16, 23, 127 nota l.
Trieb ensee, 2 16.
Trieb l, 20.
Triebsees, 360.
T ro ppau, 18 .
Turckheim, 38.
T urin gia, 192 nota 54, 262. u
Ulm (Germa nia), 38
Ungh eria , 11, 14, 19 , 36, 41, 64, 80, 105, 106, 110, 11 2, 117, 121 , 186, 219 ,2 43, 244 n ota 113 ,263, 263 not a 144, 353.
Unione Sovietica od Unione de ll e Repubbliche Socialiste Sovietiche (U.R.S.S .), 106 nota 280.
Un ited States (of America), v. Stati Uniti di America
Water loo (Belgio), 86, 86 nota 218.
Wedell, 422.
Weimar (Germania), 262.
Werben, 255, 260, 357, 360, 399.
Wesel, 282, 282 nota 170.
Westfalia, 20, 21, 106.
Wetzlar, 37
Val di Lamone, 63 nota 141.
Valenciennes, 132 nota 5.
Valtell in a, 127 nota 1.
Vasvar, 35.
Veneto, 279 no ta 163.
Venezia, 25, 279 nota 163, 433.
Verona, 66.
Vienna, 7, 16 nota 17, 20, 21, 22 nota 26, 23 , 25, 25 nota 34, 28, 28 nota
37, 31, 35, 36, 38 , 39, 40, 42, 42 no -
ta 73, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 67, 67
nota 156, 70 nota 163, 73 nota 178, 75 nota 183, 78, 78 nota 191, 79, 79
note 193- 194-196, 80 nota 199, 81

note 202-203 , 105 nota 277, 106, 109, 110, 11 1, 115, 116, 117, 120, 282, 287 nota 173bis.
Vinegia, v. Venezia.
Wien , v. Vienna .
Wiener-Neustadt, 25 .
Wisma r (Germania), 226
Wistok, v. Wittstock.
Wittenberg (G erm ania), 240, 390
Wittstock, 17, 122, 192, 192 nota 54, 201, 260 nota 133, 262 nota 141, 328, 333, 333 nota 189 .
Worms, 335, 341, 360.
Wiirtt emberg, 39, 424 .
Wiirzburg, 37, 38.
Zama, 98.
Zamrske, 115 .
Zitenice, 115.
Zusmarshausen, 20, 332 nota 188.
Zwickau, 227, 387, 387 nota 224.

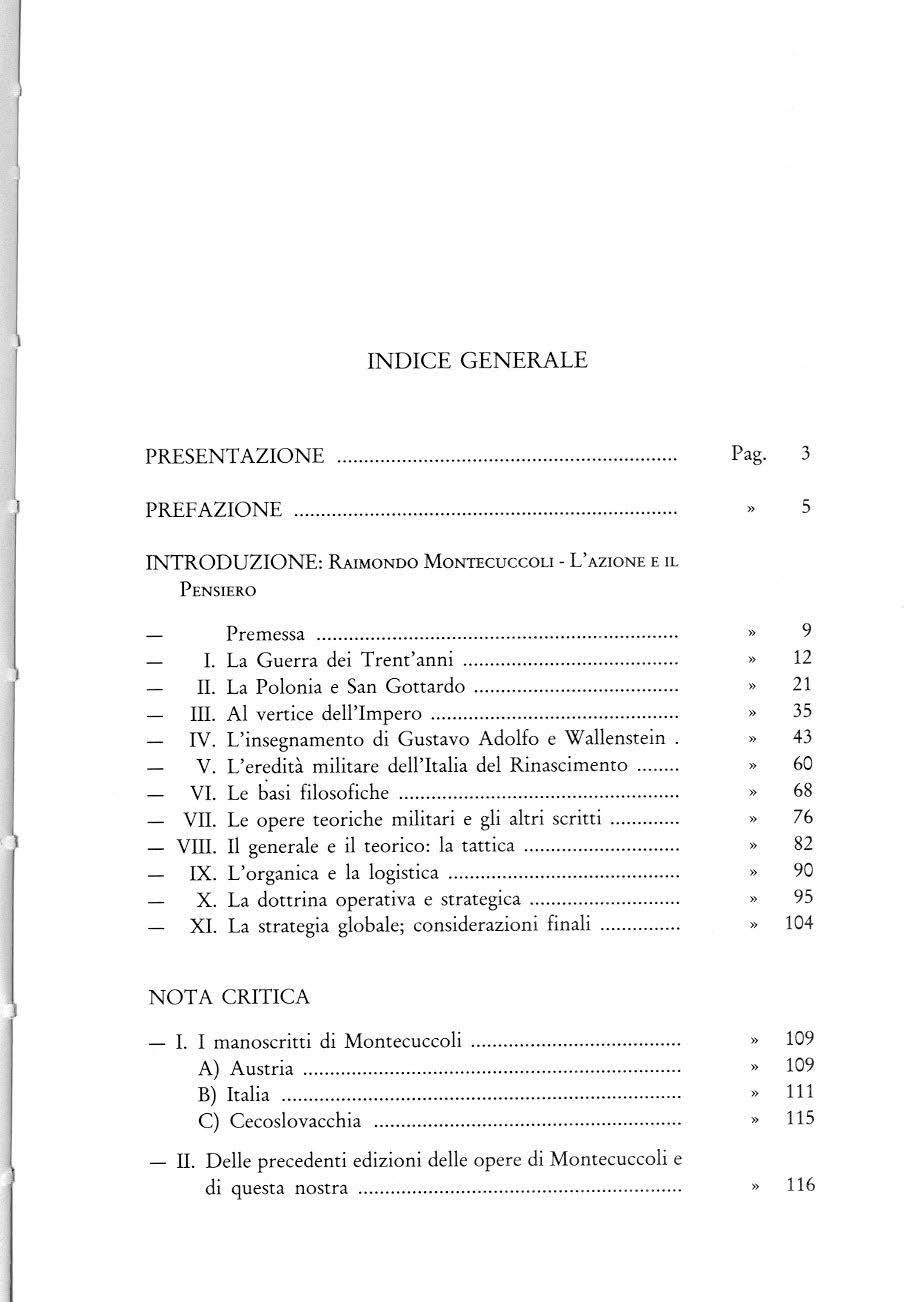
INTR ODUZIONE: RAIMOND O MoNTEcucco u - L'AZIONE E IL P ENSIERO
I. La G u erra dei Tr ent 'anni .......
fl. La Polonia e San Go tt ardo ........ .
III. Al vertice dell'Impero
IV. L'insegna m ento di G ust avo Ado lfo e Wall enstein
V. L 'eredità militare dell' Italia del Rinasc i me nt o ... .... .
VI. Le basi filosofic h e .......... .... .. ..... .... ..... .. .. ..... . ... . ....... .
VII. Le opere t eo ri che militar i e gli altri scr itti ............ .
vm. Il ge n erale e il te ori co: la tattica . ........ .. .. ... .. ..........
IX. L'organica e la lo gistica .... ..... .
X La do ttr i na operativa e stra t egica
X I. La strategia globa le; considerazioni finali
- II. D elle preceden t i edizioni delle opere di Montecuccoli e di
-
- Nomi d egli Autori .. ..... ......... . .......................... . ................
LIBRO PRIMO : Dell'intraprendere la guerra
I Capo - Della guerra e sua divisione ....................... .
n Capo - Delle leghe ... .. .. .......... ............................ ... .. .
III Capo - Dell 'a ppare cc hio
IV Capo - De ' soldati
LIBRO SECONDO: Del far la guerra
I C apo - Della guerra difensiva .. ..... .......... .. .. ......... ... .
II Capo - Della guerra offensiva .................... ...... ....... .
III Capo - Dell'azione nella campagna ... ...... ......... ......
IV Capo - Della disciplina .............. . .......... ....
V Capo - Dei viveri
VI Capo - Dei spioni e delle guide

VII Capo - Del marciare ......... ....
- VITI Capo - D ell'alloggiare
IX Capo - Del combattere
LIBRO TERZO: D el finire la guerra
I Capo - D ella pace
Il Capo - Del licenziar l'esserc ito
III Capo - Del co nservare l'a cquistato
