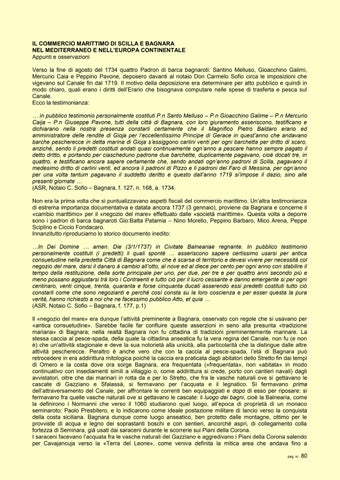IL COMMERCIO MARITTIMO DI SCILLA E BAGNARA NEL MEDITERRANEO E NELL’EUROPA CONTINENTALE Appunti e osservazioni Verso la fine di agosto del 1734 quattro Padron di barca bagnaroti: Santino Melluso, Gioacchino Galimi, Mercurio Caia e Peppino Pavone, deposero davanti al notaio Don Carmelo Sofio circa le imposizioni che vigevano sul Canale fin dal 1719. Il motivo della deposizione era determinare per atto pubblico e quindi in modo chiaro, quali erano i diritti dell’Erario che bisognava computare nelle spese di trasferta e pesca sul Canale. Ecco la testimonianza: … in pubblico testimonio personalmente costituti P.n Santo Melluso – P.n Gioacchino Galime – P.n Mercurio Caija – P.n Giuseppe Pavone, tutti della città di Bagnara, con loro giuramento asseriscono, testificano e dichiarano nella nostra presenza constarli certamente che il Magnifico Pietro Baldaro erario ed amministratore delle rendite di Gioja per l’eccellentissimo Principe di Gerace in quest’anno che andavano barche pescherecce in detta marina di Gioja s’essiggono carlini venti per ogni barchetta per dritto di scaro, anziché, sendo li predetti costituti andati quasi continuamente ogn’anno a pescare hanno sempre pagato il detto dritto, e portando per ciascheduno padrone due barchette, duplicamente pagavano, cioè docati tre, in quattro, e testificano ancora sapere certamente che, sendo andati ogn’anno padroni di Scilla, pagavano il medesimo dritto di carlini venti, ed ancora li padroni di Pizzo e li padroni del Faro di Messina, per ogn’anno per una volta tantum pagavano il suddetto deritto e questo dall’anno 1719 si’impose il dazio, sino alle presenti giornate … (ASR, Notaio C. Sofio – Bagnara, f. 127, n. 168, a. 1734. Non era la prima volta che si puntualizzavano aspetti fiscali del commercio marittimo. Un’altra testimonianza di estrema importanza documentativa e datata ancora 1737 (3 gennaio), proviene da Bagnara e concerne il «cambio marittimo» per il «negozio del mare» effettuato dalle «società marittime». Questa volta a deporre sono i padron di barca bagnaroti Gio:Batta Patamia – Nino Morello, Peppino Barbaro, Mico Arena, Peppe Sciplino e Ciccio Fondacaro. Innanzitutto riproduciamo lo storico documento inedito: …In Dei Domine … amen. Die (3/1/1737) in Civitate Balneariae regnante. In pubblico testimonio personalmente costituti (i predetti) li quali sponté … asseriscono sapere certissimo usarsi per antica consuetudine nella predetta Città di Bagnara come che è scarsa di territorio e devesi vivere per necessità col negozio del mare, darsi il danaro à cambio all’otto, al nove ed al diece per cento per ogni anno con stabilire il tempo della restituzione, della sorte principale per uno, per due, per tre e per quattro anni secondo più e meno possano aggiustarsi trà loro i Contraenti e tutto ciò per il lucro cessante e danno emergente si per ogni centinaro, venti cinque, trenta, quaranta e forse cinquanta ducati asserendo essi predetti costituti tutto ciò constarli come che sono negozianti e perché così consta su la loro coscienza e per esser questa la pura verità, hanno richiesto a noi che ne facessimo pubblico Atto, et quia … (ASR, Notaio C. Sofio – Bagnara, f. 177, p.1) Il «negozio del mare» era dunque l’attività preminente a Bagnara, osservato con regole che si usavano per «antica consuetudine». Sarebbe facile far confluire queste asserzioni in seno alla presunta «tradizione mariana» di Bagnara; nella realtà Bagnara non fu cittadina di tradizioni preminentemente marinare. La stessa caccia al pesce-spada, della quale la cittadina anseatica fu la vera regina del Canale, non fu (e non è) che un’attività stagionale e deve la sua notorietà alla unicità, alla particolarità che la distingue dalle altre attività pescherecce. Peraltro è anche vero che con la caccia al pesce-spada, l’età di Bagnara può retrocedere in era addirittura mitologica poiché la caccia era praticata dagli abitatori dello Stretto fin dai tempi di Omero e la costa dove ora sorge Bagnara, era frequentata («frequentata», non «abitata» in modo continuativo con insediamenti simili a villaggio o, come addirittura si crede, porto con cantieri navali) dagli avvistatori, oltre che dai marinari in rotta da e per lo Stretto, che fra le vasche naturali ove si gettavano le cascate di Gazziano e Sfalassà, si fermavano per l’acquata e il legnatico. Si fermavano prima dell’attraversamento del Canale, per affrontare le correnti ben equipaggiati e dopo di esso per riposare: si fermavano fra quelle vasche naturali ove si gettavano le cascate: il luogo dei bagni, cioè la Balnearia, come la definirono i Normanni che verso il 1060 studiarono quel luogo, all’epoca di proprietà di un monaco seminaroto: Paolo Presbitero, e lo indicarono come ideale postazione militare di lancio verso la conquista della costa siciliana. Bagnara dunque come luogo anseatico, ben protetto dalle montagne, ottimo per le provviste di acqua e legno dei soprastanti boschi e con sentieri, ancorché aspri, di collegamento colla fortezza di Seminara, già usati dai saraceni durante le scorrerie sui Piani della Corona. I saraceni facevano l’acquata fra le vasche naturali del Gazziano e aggredivano i Piani della Corona salendo per Cavajancuja verso la «Terra del Leone», come veniva definita la mitica area che andava fino a pag. nr.
80