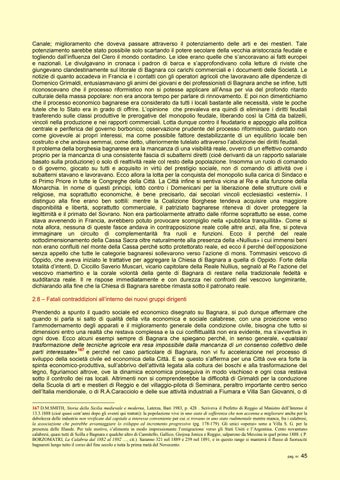Canale; miglioramento che doveva passare attraverso il potenziamento delle arti e dei mestieri. Tale potenziamento sarebbe stato possibile solo scartando il potere secolare della vecchia aristocrazia feudale e togliendo dall’influenza del Clero il mondo contadino. Le idee erano quelle che s’ancoravano ai fatti europei e nazionali. Le divulgavano in cronaca i padron di barca e s’approfondivano colla letture di riviste che giungevano clandestinamente sul litorale di Bagnara coi carichi commerciali e i documenti delle Società. Le notizie di quanto accadeva in Francia e i contatti con gli operatori agricoli che lavoravano alle dipendenze di Domenico Grimaldi, entusiasmavano gli animi dei giovani e dei professionisti di Bagnara anche se infine, tutti riconoscevano che il processo riformistico non si potesse applicare all’Ansa per via del profondo ritardo culturale della massa popolare: non era ancora tempo per parlare di rinnovamento. E poi non dimentichiamo che il processo economico bagnarese era considerato da tutti i locali bastante alle necessità, viste le poche tutele che lo Stato era in grado di offrire. L’opinione che prevaleva era quindi di eliminare i diritti feudali trasferendo sulle classi produttive le prerogative del monopolio feudale, liberando così la Città da balzelli, vincoli nella produzione e nei rapporti commerciali. Lotta dunque contro il feudatario e appoggio alla politica centrale e periferica del governo borbonico; osservazione prudente del processo riformistico, guardato non come giovevole ai propri interessi, ma come possibile fattore destabilizzante di un equilibrio locale ben costruito e che andava semmai, come detto, ulteriormente tutelato attraverso l’abolizione dei diritti feudali. Il problema della borghesia bagnarese era la mancanza di una visibilità reale, ovvero di un effettivo comando proprio per la mancanza di una consistente fascia di subalterni diretti (cioè derivanti da un rapporto salariale basato sulla produzione) o solo di reattività reale col resto della popolazione. Insomma un ruolo di comando o di governo, giocato su tutti e acquisito in virtù del prestigio sociale, non di comando di attività ove i subalterni stavano e lavoravano. Ecco allora la lotta per la conquista del monopolio sulla carica di Sindaco e di Primo Priore in tutte le Congreghe della Città. La Città infine si sentiva vicina al Re e alla funzione della Monarchia. In nome di questi principi, lottò contro i Domenicani per la liberazione delle strutture civili e religiose, ma soprattutto economiche, è bene precisarlo, dai secolari vincoli ecclesiastici «esterni». I distinguo alla fine erano ben sottili: mentre la Coalizione Borghese tendeva acquisire una maggiore disponibilità e libertà, soprattutto commerciale, il patriziato bagnarese riteneva di dover proteggere la legittimità e il primato del Sovrano. Non era particolarmente attratto dalle riforme soprattutto se esse, come stava avvenendo in Francia, avrebbero potuto provocare scompiglio nella «pubblica tranquillità». Come si nota allora, nessuna di queste fasce andava in contrapposizione reale colle altre anzi, alla fine, si poteva immaginare un circuito di complementarità fra ruoli e funzioni. Ecco il perché del reale sottodimensionamento della Cassa Sacra oltre naturalmente alla presenza della «Nullius» i cui immensi beni non erano confluiti nel monte della Cassa perché sotto protettorato reale, ed ecco il perché dell’opposizione senza appello che tutte le categorie bagnaresi sollevarono verso l’azione di mons. Tommasini vescovo di Oppido, che aveva iniziato le trattative per aggregare la Chiesa di Bagnara a quella di Oppido. Forte della totalità d’intenti, D. Ciccillo Saverio Muscari, vicario capitolare della Reale Nullius, segnalò al Re l’azione del vescovo mamertino e la corale volontà della gente di Bagnara di restare nella tradizionale fedeltà e sudditanza reale. Il re rispose immediatamente e con durezza nei confronti del vescovo lungimirante, dichiarando alla fine che la Chiesa di Bagnara sarebbe rimasta sotto il patronato reale. 2.8 – Fatali contraddizioni all’interno dei nuovi gruppi dirigenti Prendendo a spunto il quadro sociale ed economico disegnato su Bagnara, si può dunque affermare che quando si parla si salto di qualità della vita economica e sociale calabrese, con una proiezione verso l’ammodernamento degli apparati e il miglioramento generale della condizione civile, bisogna che tutto si dimensioni entro una realtà che restava complessa e la cui conflittualità non era evidente, ma s’avvertiva in ogni dove. Ecco alcuni esempi sempre di Bagnara che spiegano perché, in senso generale, «qualsiasi trasformazione delle tecniche agricole era resa impossibile dalla mancanza di un consenso collettivo delle 167 parti interessate» e perché nel caso particolare di Bagnara, non vi fu accelerazione nel processo di sviluppo della società civile ed economica della Città. E se questo s’afferma per una Città ove era forte la spinta economico-produttiva, sull’abbrivo dell’attività legata alla coltura dei boschi e alla trasformazione del legno, figuriamoci altrove, ove la dinamica economica proseguiva in modo vischioso e ogni cosa restava sotto il controllo dei ras locali. Altrimenti non si comprenderebbe la difficoltà di Grimaldi per la conduzione della Scuola di arti e mestieri di Reggio e del villaggio-pilota di Seminara, peraltro importante centro serico dell’Italia meridionale, o di R.A.Caracciolo e delle sue attività industriali a Fiumara e Villa San Giovanni, o di 167 D.M.SMITH, Storia della Sicilia medievale e moderna, Laterza, Bari 1983, p. 428 . Scriveva il Prefetto di Reggio al Ministro dell’Interno il 13.3.1888 (cioè quasi cent’anni dopo gli eventi qui trattati): la popolazione vive in uno stato di sofferenza che non accenna a migliorare anche per la debolezza delle industrie non vivificate dal capitale a interesse conveniente per cui si trovano in uno stato rudimentale mentre manca, fra i calabresi, la associazione che potrebbe avvantaggiare lo sviluppo ed incremento progressivo (pg. 178-179). Gli unici «operai» sono a Villa S. G. per la presenza delle filande. Per tale motivo, s’alimenta in modo impressionante l’emigrazione verso gli Stati Uniti e l’Argentina. Cento novantuno calabresi, quasi tutti di Scilla e Bagnara e qualche altro di Cannitello, Gallico, Giojosa Jonica e Reggio, salparono da Messina in quel primo 1888. ( P. BORZOMATRI, La Calabria dal 1882 al 1892 …, cit.). Saranno 321 nel 1889 e 259 nel 1891, e in questo range si manterrà il flusso di fuorusciti bagnaroti lungo tutto il corso del fine secolo e tutta la prima metà del Novecento. pag. nr.
45