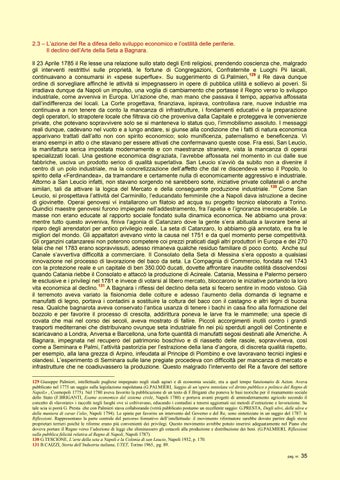2.3 – L’azione del Re a difesa dello sviluppo economico e l’ostilità delle periferie. Il declino dell’Arte della Seta a Bagnara. Il 23 Aprile 1785 il Re lesse una relazione sullo stato degli Enti religiosi, prendendo coscienza che, malgrado gli interventi restrittivi sulle proprietà, le fortune di Congregazioni, Confraternite e Luoghi Pii laicali, 129 continuavano a consumarsi in «spese superflue». Su suggerimento di G.Palmieri, il Re dava dunque ordine di sorvegliare affinché le attività si impegnassero in opere di pubblica utilità e sollievo ai poveri. Si irradiava dunque da Napoli un impulso, una voglia di cambiamento che portasse il Regno verso lo sviluppo industriale, come avveniva in Europa. Un’azione che, man mano che passava il tempo, appariva affossata dall’indifferenza dei locali. La Corte progettava, finanziava, ispirava, controllava rare, nuove industrie ma continuava a non tenere da conto la mancanza di infrastrutture, i fondamenti educativi e la preparazione degli operatori, lo strapotere locale che filtrava ciò che proveniva dalla Capitale e proteggeva le convenienze private, che potevano sopravvivere solo se si manteneva lo status quo, l’immobilismo assoluto. I messaggi reali dunque, cadevano nel vuoto e a lungo andare, si giunse alla condizione che i fatti di natura economica apparivano trattati dall’alto non con spirito economico; solo munificenza, paternalismo e beneficenza. Vi erano esempi in atto o che stavano per essere attivati che confermavano queste cose. Fra essi, San Leucio, la manifattura serica impostata modernamente e con maestranze straniere, vista la mancanza di operai specializzati locali. Una gestione economica disgraziata, l’avrebbe affossata nel momento in cui dalle sue fabbriche, usciva un prodotto serico di qualità superlativa. San Leucio s’avviò da subito non a divenire il centro di un polo industriale, ma la concretizzazione dell’affetto che dal re discendeva verso il Popolo, lo spirito della «Ferdinandea», da tramandare e certamente nulla di economicamente aggressivo e industriale. Attorno a San Leucio infatti, non stavano sorgendo né sarebbero sorte, iniziative private collaterali o anche 130 similari, tali da attivare la logica del Mercato e della conseguente produzione industriale. Come San Leucio, si prospettava l’attività del Carminillo, l’educandato femminile che a Napoli dava istruzione a decine di giovinette. Operai genovesi vi installarono un filatoio ad acqua su progetto tecnico elaborato a Torino. Quindici maestre genovesi furono impiegate nell’addestramento, fra l’apatia e l’ignoranza irrecuperabile. Le masse non erano educate al rapporto sociale fondato sulla dinamica economica. Ne abbiamo una prova: mentre tutto questo avveniva, finiva l’agonia di Catanzaro dove la gente s’era abituata a lavorare bene al riparo degli arrendatori per antico privilegio reale. La seta di Catanzaro, lo abbiamo già annotato, era fra le migliori del mondo. Gli appaltatori avevano vinto la causa nel 1751 e da quel momento perse competitività. Gli organzini catanzaresi non poterono competere coi prezzi praticati dagli altri produttori in Europa e dei 270 telai che nel 1783 erano sopravvissuti, adesso rimaneva qualche residuo familiare di poco conto. Anche sul Canale s’avvertiva difficoltà a commerciare. Il Consolato della Seta di Messina s’era opposto a qualsiasi innovazione nel processo di lavorazione del baco da seta. La Compagnia di Commercio, fondata nel 1743 con la protezione reale e un capitale di ben 350.000 ducati, dovette affrontare inaudite ostilità dissolvendosi quando Catania riebbe il Consolato e attaccò la produzione di Acireale. Catania, Messina e Palermo persero le esclusive e i privilegi nel 1781 e invece di votarsi al libero mercato, bloccarono le iniziative portando la loro 131 vita economica al declino. A Bagnara i riflessi del declino della seta si fecero sentire in modo vistoso. Già il terremoto aveva variato la fisionomia delle colture e adesso l’aumento della domanda di legname e manufatti di legno, portava i contadini a sostituire la coltura del baco con il castagno e altri legni di buona resa. Qualche bagnarota aveva conservato l’antica usanza di tenere i bachi in casa fino alla formazione del bozzolo e per favorire il processo di crescita, addirittura poneva le larve fra le mammelle; una specie di covata che mai nel corso dei secoli, aveva mostrato di fallire. Piccoli accorgimenti inutili contro i grandi trasporti mediterranei che distribuivano ovunque seta industriale fin nei più sperduti angoli del Continente e scaricavano a Londra, Anversa e Barcellona, una forte quantità di manufatti segosi destinati alle Americhe. A Bagnara, impegnata nel recupero del patrimonio boschivo e di riassetto delle rasole, sopravviveva, così come a Seminara e Palmi, l’attività pastorizia per l’estrazione della lana d’angora, di discreta qualità rispetto, per esempio, alla lana grezza di Arpino, infeudata al Principe di Piombino e ove lavoravano tecnici inglesi e olandesi. L’esperimento di Seminara sulle lane pregiate procedeva con difficoltà per mancanza di mercato e infrastrutture che ne coadiuvassero la produzione. Questo malgrado l’intervento del Re a favore del settore 129 Giuseppe Palmieri, intellettuale pugliese impegnato negli studi agrari e di economia sociale, era a quel tempo funzionario di Acton. Aveva pubblicato nel 1775 un saggio sulla legislazione napoletana (G.PALMIERI, Saggio di un’opera intitolata «il diritto pubblico e politico del Regno di Napoli» , Cosmopoli 1775). Nel 1780 aveva favorito la pubblicazione di un testo di F.Briganti che poneva le basi teoriche per il risanamento sociale dello Stato (F.BRIGANTI, Esame economico del sistema civile, Napoli 1780) e portava avanti progetti di ammodernamento agricolo secondo il concetto di «lavorare» i raccolti negli luoghi ove si coltivavano, educando i contadini a tenersi aggiornati sui metodi d’estrazione e lavorazione. Su tale scia si porrà G. Presta che con Palmieri stava collaborando (verrà pubblicato postumo un eccellente saggio: G.PRESTA, Degli ulivi, delle ulive e della maniera di cavar l’olio, Napoli 1794). Le spinte per favorire un intervento del Governo e del Re, sono sintetizzate in un saggio del 1787: le Riflessioni. Rappresentano la parte centrale del percorso formativo dell’intellettuale: il movimento riformatore sarebbe dovuto partire dagli stessi proprietari terrieri poiché le riforme erano più convenienti dei privilegi. Questo movimento avrebbe potuto inserirsi adeguatamente nel Piano che doveva portare il Regno verso l’adozione di leggi che eliminassero gli ostacoli alla produzione e distribuzione dei beni. (G.PALMIERI, Riflessioni sulla pubblica felicità relativa al Regno di Napoli, Napoli 1787). 130 G.TESCIONE, L’arte della seta a Napoli e la Colonia di san Leucio, Napoli 1932, p. 170. 131 B.CAIZZI, Storia dell’Industria italiana, UTET, Torino 1965,. pg. 89. pag. nr.
35