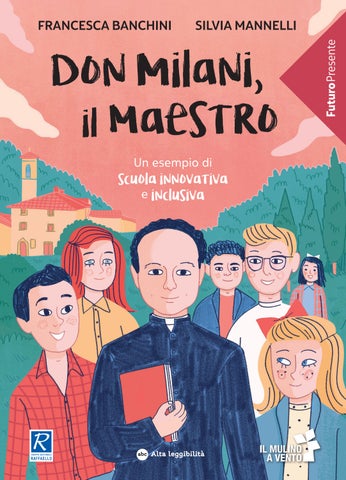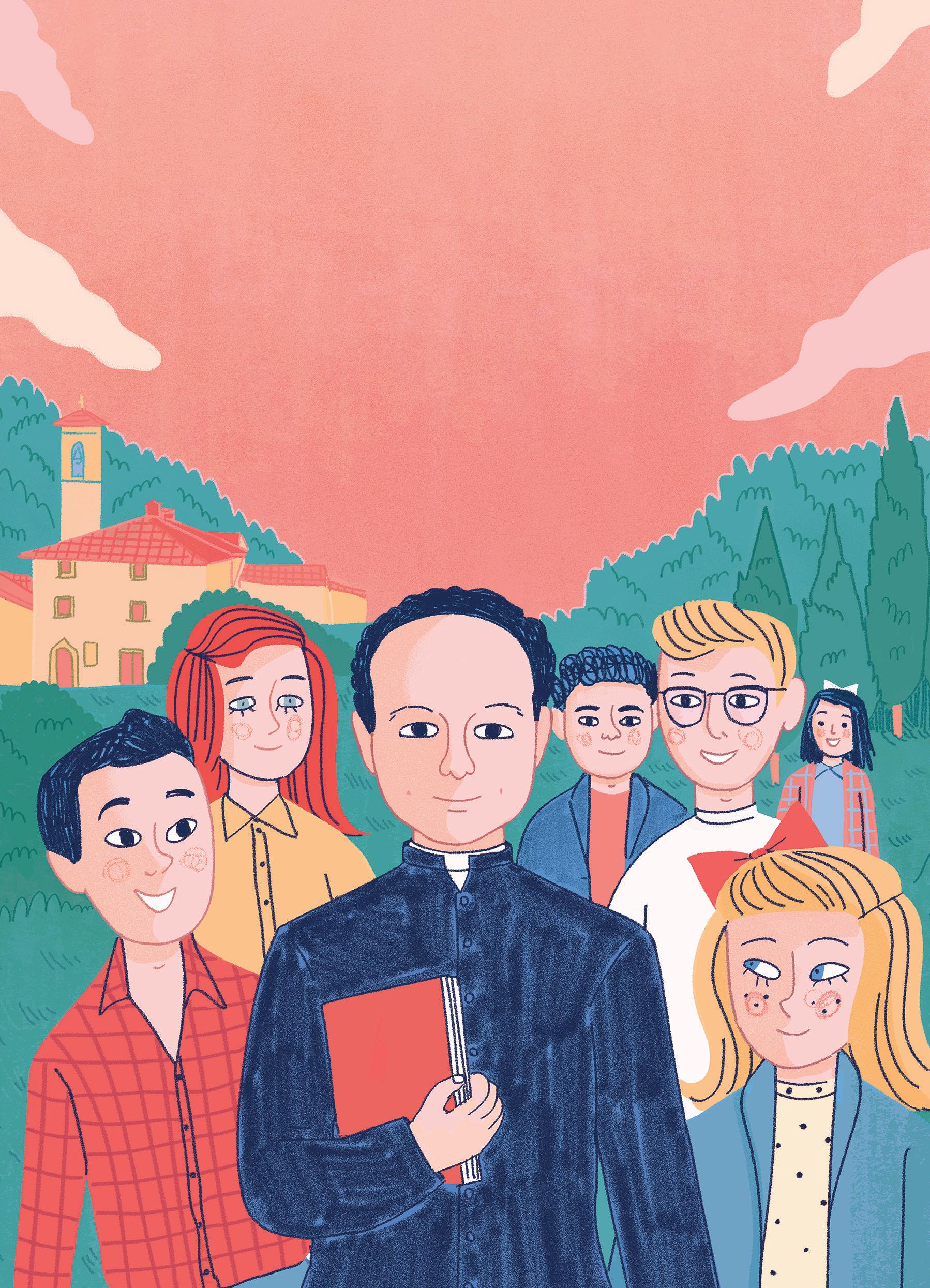
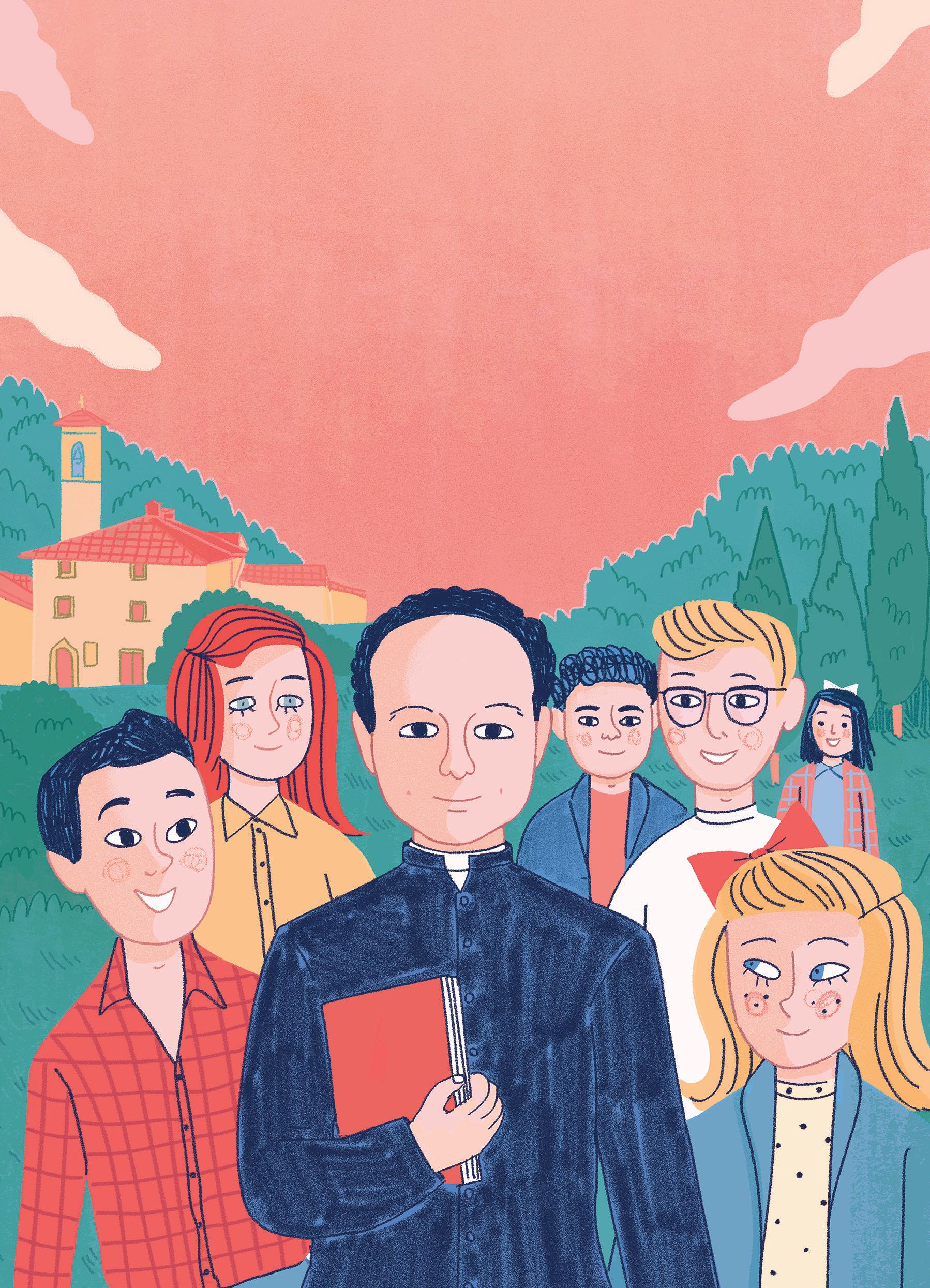
Don Mi l ani, i l maestro
Un esempio di scu o l a innovativa e in c l usiva
Futuro Presente
Editor: Francesca Lombardo
Consulente: Patrizia Ceccarelli
Coordinamento redazionale: Emanuele Ramini
Coordinamento grafico: Mauro Aquilanti
Autrici: Francesca Banchini, Silvia Mannelli
Team grafico: Raffaella De Luca, Valentina Mazzarini
Illustrazioni: Veronica Carratello
Font alta leggibilità Leggimi © Sinnos
I Edizione 2022
Ristampa 7 6 5 4 3 2 1 0 2028 2027 2026 2025 2024 2023 2022
© 2022 Tutti i diritti sono riservati
Raffaello Libri S.p.A.
Via dell’Industria, 21 60037 - Monte San Vito (AN) www.grupporaffaello.it
info@ilmulinoavento.it www.ilmulinoavento.it
Printed in Italy
È assolutamente vietata la riproduzione totale o parziale di questo libro senza il permesso scritto dei titolari del copyright.
L’Editore è a disposizione degli aventi diritto con i quali non è stato possibile comunicare, nonché per eventuali omissioni o inesattezze nella citazione delle fonti.
FRANCESCA BANCHINI
SILVIA MANNELLI
Don Milani, il maestro
illustrazioni di Veronica Carratello
Agli insegnanti che possono cambiarti la vita. Agli studenti disposti a farsela cambiare.
INTRODUZIONE
Questo romanzo è un omaggio a don Lorenzo Milani, il prete di Barbiana, colui che ha fatto del motto I care (Mi importa), il centro della propria esistenza. A don Lorenzo importavano i suoi ragazzi, poveri e senza futuro, che trascorrevano la vita su un monte nemmeno segnato sulle carte geografiche, dove non c’erano né acqua corrente né elettricità, dove era stata persa la speranza.
Grazie all’intervento di questo parroco, mandato là in esilio perché considerato scomodo dalla Chiesa, tanti di loro hanno scoperto cosa fosse la vera istruzione e hanno avuto la possibilità di diventare cittadini attivi e consapevoli.
Ma chi era veramente don Lorenzo Milani? E ciò che ci ha insegnato è ancora attuale? In queste pagine, seguendo Michele, un alunno di terza media che scopre la storia del parroco, conosceremo le azioni intraprese da questo prete rivoluzionario. Don Milani è un esempio di giustizia e premura per i più deboli e dimenticati; è un uomo che ha impiegato la sua vita per dare senso a quella degli altri. Ma don Milani non è sempre stato don Milani, da bambino e da ragazzo era il signorino Lorenzo, figlio di una famiglia colta e benestante.
Fino a oggi, i biografi hanno raccontato la sua vita adulta, le azioni e i pensieri che hanno fatto davvero la differenza per chi l’ha conosciuto.
Com’era, però, Lorenzo Milani prima di diventare prete? Cosa l’ha portato a compiere la scelta che poi ha dato senso al suo percorso?
Ricercando e studiando i suoi scritti e le scarse notizie biografiche sulla prima parte della sua vita, abbiamo immaginato di poter dare voce a Lorenzo Milani bambino e ragazzo. Leggendo le pagine di diario all’interno di questo libro, scritte da noi ma fedeli agli eventi storici e biografici, si può di sbirciare nei pensieri di un giovane Lorenzo che, ancor prima di decidere di andare in seminario, mostrava già i segni di una profonda insofferenza verso il mondo istituzionale e le disuguaglianze sociali; questa insofferenza lo porterà a fare della sua vita una battaglia a favore dei diritti dei più deboli.
Ci auguriamo che la storia di questo indimenticabile uomo del Novecento possa essere di ispirazione per tutti coloro che desiderano fare, nella realtà in cui operano, la differenza.
Le autrici
Si ringraziano Sandra Gesualdi, Guido Carotti e Mileno Fabbiani per aver condiviso con noi ricordi, racconti, esperienze e per aver sostenuto la nascita di questo libro.
PARTE PRIMA
Una nuova professoressa


capitolo uno
Afa
Fa davvero molto caldo, oggi. In televisione hanno detto che da almeno vent’anni non c’era un maggio così torrido e, anche se il mio bisnonno non fa che ripetere che nel 1935 era peggio, la cosa non mi consola. Chissà poi se è vero, che nel 1935 l’afa era peggiore: ci sono poche persone, ormai, in grado di smentire fatti avvenuti tanti anni fa.
Comunque, in questi giorni ho un problema più scottante del caldo e non ho molto tempo per risolverlo: devo scegliere l’argomento della tesina per l’esame e poi mi devo mettere a scriverla in fretta. L’orale si avvicina e io sono ancora qui, in mezzo ai miei dubbi. – Pensate a qualcosa che vi ha appassionato in questo anno scolastico e partite da lì – ci hanno consigliato i professori. Sembra facile. Continuo a sfogliare il quaderno di italiano alla ricerca di un’idea: un argomento che mi permetta di scrivere qualcosa, di collegare qualche materia, e soprattutto di evitare una figuraccia. Lancio uno sguardo a Spike, sdraiato sul pavimento di marmo della mia camera: mi ricor-
da il tappeto di pelle di mucca che avevano i nonni nella casa in montagna; boccheggia e ansima sotto il suo mantello peloso, cercando un po’ di refrigerio sul fresco del pavimento. Gli tiro una pallina di carta, ma ottengo solo un brontolio annoiato. Non ho scuse. Non ho tempo. Devo tornare al mio quaderno. Ho bisogno di trovare qualcosa di originale, o almeno di passabile per affrontare questo famigerato orale. Il problema è che in tutti i mesi passati nella 3F non posso proprio dire di essermi interessato a un argomento in particolare. Forse però, a pensarci bene, ci sarebbe quella lezione… A dire il vero un’idea ce l’avrei, ma non so se ho ancora le fotocopie. Scartabello in fretta il quaderno e alla fine trovo quello che sto cercando: il pacchetto di fogli che la professoressa aveva distribuito quella mattina.
Mordicchio la penna bic e mi chiedo: andrà bene? Continuo a leggere qua e là fra le pagine e ritrovo alcune frasi che mi ero appuntato durante la lezione. Incredibile quante cose riesca a ricordare anche se sono passati già dei mesi! Faccio scorrere l’indice sul cellulare per controllare le notifiche e intanto mi dico che sì, certo, questo è l’argomento giusto: è stato interessante, mi ha appassionato, me lo ricordo bene. Basta concentrarsi un attimo, ripensare a quella lezione, raccogliere le idee e iniziare a scrivere.
capitolo
due
Come è giusto che sia
Era il 4 novembre, una data che ricordo bene per due belle notizie. La prima è che proprio in quel pomeriggio Spike è arrivato dal canile, la seconda è che quella mattina la verifica di grammatica è saltata e così ho evitato di prendere l’ennesimo votaccio.
Mi piace la professoressa Cattaneo, ma mi piaceva ancor di più il fatto che fosse inciampata scendendo le scale e si fosse fratturata una caviglia; e allora, addio compito in classe.
Quando la custode entrò a darci la notizia, la classe esplose in un boato di gioia che la fece indignare. Indignata, andò a chiamare la vicepreside che, indignata a sua volta, venne a brontolarci. Ci disse che eravamo proprio degli insensibili e degli irresponsabili, che gioire delle disgrazie altrui è qualcosa di molto brutto e che avremmo dovuto cambiare atteggiamento. Soprattutto, ci disse che stavano già cercando un supplente e che, quando sarebbe arrivato, ci avrebbe pensato lui a farci fare la verifica di grammatica, “come è giusto che sia”.
Alla vicepreside questa frase deve piacere tanto perché non fa che ripeterla ogni volta che ne ha l’occasione. Come quando hanno sospeso il mio compagno Giorgio Acciaioli che aveva scritto nel bagno offese contro la preside. Lui provò a far notare che parole simili, e perfino peggiori, erano immortalate anche sul muro della palestra e vicino al cancello esterno, ma non c’era stato niente da fare, la vicepreside lo aveva zittito:
– Quelle non sappiamo chi le ha scritte. Di queste invece siamo sicuri, visto che hai ammesso di essere stato tu; quindi, la sospensione non te la toglie nessuno, come è giusto che sia.
Tanto giusto a Giorgio non era sembrato e neanche a noi a dire la verità, ma poi sul muro esterno della scuola, proprio sotto la ringhiera di confine, apparvero delle ingiurie anche contro la vicepreside e quella cosa ci sembrò giusta. Non del tutto, ma un po’ sì, ecco. O almeno sembrò giusta a me. A Giorgio non so, perché non ne abbiamo più parlato.
Comunque, la vicepreside è una professoressa di matematica, per fortuna non in classe nostra. A noi matematica la insegna il Trikis che è di origine greca e infatti, anche se vive in Italia da tanto tempo, si sente ancora bene l’accento straniero. Si chiama Alessandro, ma noi l’abbiamo soprannominato Ulisse, un po’ perché è greco e un po’ perché parla sempre dell’Odissea e cita
continuamente un poeta che ha scritto un’opera che si intitola Itaca. Anche quando non c’entra nulla, come per esempio quando ci interroga e magari non sappiamo rispondere, lui ci guarda fisso e comincia a recitare:
– Itaca tieni sempre nella mente…
A chi non lo conosce può sembrare strano, ma noi tutto sommato gli vogliamo bene, soprattutto perché non è severo. Invece la vicepreside sì, è molto rigida. Lo dicono tutti, anche quelli bravi; lo posso confermare anch’io, perché una volta, a causa di una supplenza, divisero la classe e capitai da lei che stava spiegando scienze. Non volava una mosca, tutti stavano zitti e ascoltavano. Pensai che se lei fosse stata la nostra professoressa, forse saremmo stati buoni anche noi, almeno nelle sue ore.
Quel lunedì mattina comunque l’avevamo fatta proprio arrabbiare con le nostre urla di gioia e, mentre ci rimproverava, continuava a ripetere che avremmo dovuto riflettere, così l’accontentammo. Qualcuno rifletteva su quanti giorni di malattia il dottore avrebbe dato alla professoressa per farla guarire: bisogna stare attenti. Le caviglie, si sa, sono delicate e ci vuole il tempo che ci vuole. Qualcun altro rifletteva su come poteva aver fatto, la Cattaneo, a scivolare: era sempre attenta, vestiva in modo sportivo e non indossava mai le scarpe con i tacchi.
Qualcuno rifletteva sulla fortuna che avevamo avuto: la verifica di grammatica faceva paura proprio a tutti. In fondo non le era capitato niente di grave, che male c’era a cogliere anche l’aspetto positivo?
La vicepreside continuava a farci la predica e ripeteva che, anche se con qualche difficoltà, il supplente l’avrebbero trovato; il problema era che a novembre le cattedre erano già assegnate e un incarico così breve non faceva gola a nessuno. Fu a quel punto, più o meno, che intervenne il mio compagno di banco, Martino Archimede. Nessun cognome poteva essere più adatto per lui che è in assoluto il più geniale della classe (e infatti non lo chiamiamo quasi mai per nome; per tutti noi lui è semplicemente Archimede). Il mio amico non si smentì nemmeno in quell’occasione:
– Scusi, se non trovate il supplente, può darsi che ci salti anche la verifica di storia di giovedì?
capitolo tre
Appello
In realtà non era stato tanto difficile recuperare un supplente, visto che già la mattina successiva si presentò in classe una nuova professoressa:
– Buongiorno ragazzi, sono qui per sostituire la vostra insegnante di lettere, mi chiamo Giulia Strada. Cominciamo con l’appello, almeno vediamo di conoscerci un po’.
Non c’era nessun dubbio, quindi. L’avevano trovata. E pure in fretta. Tutti i nostri sogni di libertà erano svaniti. Sospirammo rassegnati, senza il coraggio di chiedere se avremmo recuperato la verifica di grammatica proprio quella mattina. Se sì, eravamo spacciati o almeno, io lo ero di sicuro.
Quando conosci un nuovo insegnante, i primi attimi sono i più importanti: lo devi studiare subito per capire che tipo è, questo lo sanno tutti. Il silenzio che c’era in quei minuti nella nostra classe poteva essere scambiato per educazione e interesse, ma in realtà era solo il frutto di venti menti che stavano prendendo le misure
per capire in fretta che cosa dovessimo aspettarci da lei. Ho detto venti menti, anche se noi siamo venticinque in classe, ma Martina, Sofia e Laura non devono essere considerate, perché loro sono sempre le preferite di ogni insegnante: non combinano mai niente fuori dalle regole, non fanno battute, non scherzano, alzano la mano, rispettano i turni e, soprattutto, studiano sempre. Secondo me non sono molto intelligenti, però si danno un gran daffare e i professori le premiano anche per il loro impegno, come ci ripetono sempre. Io invece, stando a quello che gli insegnati dicono ogni volta a mia madre in occasione dei colloqui, sarei pure intelligente, ma siccome non mi applico per niente, colleziono un’insufficienza dietro l’altra. Nel conteggio non va preso in considerazione nemmeno Michael Hoti, perché non l’abbiamo ancora capito fino in fondo visto che è arrivato alcuni mesi fa dall’Albania: parla poco (eccezion fatta per le parolacce che gli abbiamo insegnato) e a volte abbiamo l’impressione che per lui un professore valga l’altro. Per me no, invece. La Cattaneo, per esempio, a me piace, perché ci fa leggere in classe e ci fa anche scrivere parecchio e io sono bravo a inventare trame e personaggi. La professoressa lo ripete sempre a mia madre che nella scrittura sono uno dei più bravi e che se solo studiassi di più farei grandi cose; purtroppo, i miei genitori si concentrano solo sull’ultima parte del discorso e così non fanno che lamentarsi.
E poi c’è Giovanni Sartori, un vero mago nell’arte dello studio degli insegnanti: in pochi minuti ne fa un ritratto completo e veritiero. Applica una sua tecnica ormai divenuta infallibile: osserva e aspetta qualche secondo, poi, con un sorriso educato e sicuro, se ne esce con una battuta travolgente o con un versaccio e fa esplodere tutta la classe in una risata scomposta. Ecco, in quel preciso momento si vede di che pasta è fatto il professore e tutti capiamo se e quanto ci possiamo divertire e fino a che punto è lecito spingerci. Ma Giovanni Sartori, purtroppo, quella mattina era assente.
La professoressa Strada era giovane, o forse lo sembrava solamente: poteva essere scambiata per una coetanea di mia sorella Flavia, anche se non le assomigliava affatto. Mi persi dietro a questo pensiero, di come sarebbe stato buffo vedere Flavia seduta dietro alla cattedra, con le sue unghie tutte mangiucchiate, ed era una cosa molto divertente e strana da immaginare, tanto che non mi accorsi che l’appello era andato avanti rapido e che era arrivato il mio turno.
– Frosini Michele non c’è? – stava ripetendo la professoressa, mentre tutti si voltavano verso di me.
– Sì, sono io.
– Ah, bene, sei dei nostri allora! – esclamò.
Quando un’occasione ti si presenta, devi coglierla, questo avevo capito dopo tre anni di scuola media pas-
sati a osservare le gesta dei miei compagni. Decisi che era arrivato il mio momento e le risposi, sorridendo: – Scusi, mi ero addormentato.
Su un sottofondo di commenti soffocati, si sentì distintamente Giorgio sghignazzare dall’altra parte dell’aula. Ci lanciammo uno sguardo complice che forse non sfuggì alla professoressa. E così la partita era ufficialmente cominciata. Il primo passaggio, però, era andato a vuoto: da parte sua non ci fu nessuna reazione alla mia battuta; infatti, continuò a fare l’appello come se non avessi parlato. A volte lo fanno, gli insegnanti: provano a ignorarti e sperano che tu la smetta da solo, ma se questo non accade, si arrabbiano e possono arrivare anche a metterti una nota, ma a quel punto tu sei già diventato l’eroe della classe, almeno per un giorno.
La nostra supplente sembrava proprio incamminata su quella strada, ma io non avevo nessuna intenzione di espormi troppo, comunque non prima di aver capito di che pasta fosse fatta. Tornare a casa con una sanzione ricevuta dalla nuova professoressa avrebbe peggiorato i rapporti, non proprio idilliaci, con i miei genitori. Decisi perciò di restarmene in disparte a studiare la situazione, ma poi si presentò un’altra occasione su un piatto d’argento e certo non mi tirai indietro.
capitolo quattro
Uno strano guizzo
– Bene, ragazzi – esordì la professoressa dopo aver finito l’appello. – Oggi avreste avuto un’ora di storia. Chi di voi sa dirmi a che punto siete con il programma?
Il suo tono era piuttosto incerto, come se non sapesse bene cosa dire e aspettasse da noi un appiglio per andare avanti.
Era la mia occasione, Giovanni Sartori sarebbe stato fiero di me.
– Abbiamo appena finito il Rinascimento – esclamai sicuro con un sorriso innocente, mentre da diversi punti della classe sentivo nascere risatine beffarde. Mi guardai intorno fingendo stupore per quelle reazioni, come se non capissi a cosa fossero dovute.
La professoressa inarcò le sopracciglia, sfogliò rapidamente il libro che aveva di fronte, poi alzò la testa e mi si rivolse in modo dolce e rassicurante. Un po’ troppo, a ripensarci ora.
– Forse volevi dire Risorgimento, Michele, vero? Bene, visto che hai rotto il ghiaccio, che ne dici di parlarmene un po’? Cosa sai del Risorgimento?
Il sorriso si congelò sul mio volto mentre tutti gli altri tirarono fuori il libro e aprirono il quaderno. Martina, Sofia e Laura mi lanciarono uno sguardo di pietà e commiserazione, il mio compagno Archimede cominciò a scartabellare nel quaderno alla ricerca di un salvagente da lanciarmi. Quanto avevo ancora da imparare da Giovanni Sartori! Inoltre, con la professoressa Strada le cose funzionavano al contrario: era lei che stava prendendo le misure a me e non viceversa.
Comunque, qualcosa devo aver risposto, anche se non ricordo esattamente cosa. Di sicuro i miei cioè e i miei dunque la convinsero che era meglio passare la parola ad altri e non infierire su di me. Mi misi a disegnare sul quaderno: un po’ ascoltavo, un po’ scarabocchiavo, un po’ sbadigliavo. Era tutto come sempre, insomma. Non sapevo che di lì a poco la lezione avrebbe preso una piega davvero imprevista.
Cominciò tutto con un intervento di Martina che, ovviamente, non perdeva occasione per dire la sua; stavamo parlando delle condizioni dell’Italia nell’Ottocento e lei esordì così:
– Io so che l’analfabetismo era un problema prima dell’Unità d’Italia. Molte persone non sapevano né leggere né scrivere e solo i ricchi andavano a scuola.
– È vero – rispose la professoressa.
– Ma questo è rimasto un problema per molto tempo.
Pensate che anche dopo l’Unità d’Italia, avvenuta nel 1861, la legge prevedeva che fossero obbligatori solo i primi due anni di istruzione e le famiglie che non mandavano per niente i figli a scuola erano numerose. C’era un tasso altissimo di analfabetismo, più del 90% fra i ceti più umili.
– Anche la nonna del mio babbo non aveva finito le elementari – intervenne allora Valentina senza alzare la mano. – Ma lei è vissuta nel Novecento – precisò poi sistemando il ciuffo biondo dietro all’orecchio.
Io e Archimede ci guardammo stupiti: come diavolo faceva Valentina a sapere che scuola aveva fatto la sua bisnonna? Scuotemmo la testa: probabilmente aveva tirato a indovinare per mettersi in mostra. Tipico suo.
– Sì, certo – rispose la professoressa accalorandosi un po’. – Anche nel Novecento l’analfabetismo è stata una vera piaga del nostro Paese. L’istruzione è diventata obbligatoria lentamente, ma nella realtà erano tanti i bambini che non andavano a scuola, soprattutto le femmine. Mancavano soldi e mezzi e la mentalità era molto diversa da quella di oggi: chi nasceva povero, insomma, difficilmente poteva sperare di cambiare la propria situazione.
La professoressa si alzò, fece qualche passo, si appoggiò alla cattedra e riprese:
– Non sono argomenti così lontani da noi, sapete? Provate a chiedere ai vostri nonni che scuola hanno
fatto loro o i loro genitori e scoprirete che in pochi finivano le elementari anche a metà del secolo scorso.
– I ricchi no, però – intervenne di nuovo Valentina.
A questo punto pensai che la discussione avrebbe preso una piega del tutto prevedibile, con l’inevitabile conclusione che noi siamo fortunati, visto che possiamo avere accesso all’istruzione, mentre nel mondo c’è ancora gente cui è preclusa! Niente di nuovo, insomma. Le discussioni in classe sono sempre così, pensavo mentre compilavo su un foglietto la classifica del fantacalcio per farla arrivare ad Archimede: una gara per mettersi in mostra agli occhi dei professori, che sono sempre contenti di sentirci dire quello che si aspettano e di avere conferma delle loro stesse idee.
– No, certo – rispose la professoressa tornando a sedersi. – Le persone dei ceti sociali più elevati avevano molte possibilità per i propri figli: maestri privati, collegi, formazione di qualità. Ma per arrivare a un’istruzione obbligatoria garantita per tutti ci sono voluti decenni.
Fu più o meno a quel punto che la professoressa si guardò intorno con uno strano guizzo negli occhi. Sembrava indecisa su come continuare e alla ricerca di qualcuno da far intervenire. Alla fine, il suo sguardo si posò di nuovo su di me.
In quel momento stavo cercando di applicare la tecnica dell’opossum della Virginia che, in caso di mi-
naccia, entra in una specie di coma, si immobilizza e simula la morte. Sono sempre stato appassionato di animali e spesso queste conoscenze mi hanno salvato la vita a scuola: infatti, se stai completamente fermo, con lo sguardo fisso di fronte a te e non muovi nemmeno un muscolo è più facile che il professore ti ignori e si concentri su qualcuno che sembra vivo. Forse però la professoressa Strada era troppo inesperta e non conosceva bene come funzionano le cose, non sapeva che è ingiusto accanirsi contro uno studente che si finge morto, o magari era così giovane da ricordare benissimo questi trucchetti. Fatto sta che appoggiò i gomiti sulla cattedra, il mento sui palmi delle mani e mi chiamò in causa un’altra volta:
– Michele, tu lo sai cosa significa la parola scuola?
capitolo cinque
Tempo libero
No. Non lo sapevo. Del resto a scuola ci vai, non ti chiedi cosa significa. È un po’ come il panino: lo mangi, ma non ti stai a domandare tante cose su di lui. Le parole si usano perché ci servono per parlare, come la macchina ci serve per viaggiare. Quando mettiamo in moto non iniziamo a pensare a come funziona il motore: partiamo e basta. Con le parole è lo stesso: ce ne sono alcune di cui sai spiegare l’origine e altre no. Per esempio, io sapevo che Lombardia significa terra dei Longobardi e che penna deriva dal latino pinna, che era la piuma con cui scrivevano gli antichi, non ricordo se l’avevo letto da qualche parte o qualcuno me l’aveva detto; comunque, non avevo proprio idea di cosa volesse dire scuola e a dire il vero nemmeno mi interessava particolarmente. Mi guardai intorno per scrutare le reazioni dei miei compagni e lessi in alcuni sguardi lo stesso pensiero che aveva attraversato la mia mente: se quello era un modo per allungare la discussione ed evitare di farci assegnare delle pagine da studiare, eravamo tutti pronti a dare il nostro contributo.
– Luogo dove si studia? – provai.
– No – rispose la professoressa, – ma grazie di aver partecipato al nostro gioco – scherzò fingendo di suonare un campanello inesistente sulla cattedra.
– Edificio? – intervenne Giorgio titubante.
– Nemmeno – ribatté la professoressa, invitando con un gesto tutti gli altri a fare silenzio.
Michael, accorgendosi di un certo fermento, fece cenno di voler capire cosa stesse succedendo e Valentina gli suggerì sottovoce:
– Scuola. Sai cosa vuol dire scuola?
– Compiti! – esclamò a voce alta facendoci ridere tutti.
– No, mi dispiace, nemmeno questa è la risposta giusta. Sembrava che la prof Strada si stesse divertendo.
Le ipotesi si accavallarono una sull’altra: libri, insegnare, imparare, studio. Il tentativo più originale, come al solito, era quello di Archimede:
– Posto dove si sta insieme.
La professoressa continuava a scuotere la testa, finché decise che era arrivato il momento di darci la risposta. Si alzò, appoggiò le mani sulla cattedra, inarcò leggermente il busto in avanti. In classe era tornato il silenzio: ormai si trattava a tutti gli effetti di una gara e volevamo arrivare alla soluzione.
– Tempo libero.
Qualcuno cominciò a ridere. Io pensavo che ci stesse prendendo in giro e aspettavo la risposta vera.
– Tempo libero! – ribadì lasciando girare uno sguardo divertito fra la nostra incredulità. Sembrava contenta di essere riuscita a destare il nostro interesse, come se lei stessa non ci avesse sperato. – Deriva da una parola greca, scholé, che vuol dire, per l’appunto, tempo libero – precisò subito, quasi temendo che l’attenzione calasse. – Il suo corrispondente in latino è una parola che vi stupirà ancora di più: otium, ozio in italiano. Strano vero? La scuola è il luogo del tempo libero e, addirittura, dell’ozio!
In classe c’era un silenzio attento e lei proseguì:
– Ma se ci pensate bene, non è così difficile: a scuola, infatti, ci possiamo andare quando non dobbiamo lavorare. Per noi la parola ozio ha un valore negativo, significa pigrizia, ma per gli antichi non era così: indicava quel tempo della vita che una persona può destinare allo studio, e che di solito corrisponde alla giovinezza. Quando poi uno diventa adulto ha mille compiti da svolgere, in famiglia, al lavoro e ha molto meno tempo per sé: finché si è ragazzi, invece, possiamo dedicare all’istruzione il nostro tempo libero perché non abbiamo preoccupazioni di altro tipo.
– Però secondo me non è giusto! – Valentina disapprovò con vigore. – Ogni persona dovrebbe decidere da sola come usare il proprio tempo.
– Secondo me – prese la parola Martina, – ci dovrebbe essere un periodo di scuola obbligatorio per tutti, perché va bene che tutti imparino qualcosa, ma poi una persona dovrebbe decidere liberamente se continuare a studiare oppure no.
– Tanto se uno non ha voglia rallenta solamente gli altri – le fece eco Laura.
– Guardate che funziona già così! – rispose piccato
Archimede, – a sedici anni puoi smettere. Mio fratello, infatti, non va più a scuola.
– Sì, ma fino a sedici anni devi andarci per forza –affermò di rimando Valentina. – È troppo tempo, se la scuola non ti interessa.
Io non dissi niente, ma osservavo di sottecchi la professoressa che ascoltava attenta la discussione. Sembrava incerta se intervenire o no, sicuramente si capiva che era molto interessata. Decisi che il fantacalcio poteva aspettare: misi le braccia conserte sul banco e trovai una posizione comoda per non perdermi il seguito.

"Quando avete buttato nel mondo d’oggi un ragazzo senza istruzione avete buttato in cielo un passerotto senza ali".
FuturoPresente
Questa è una delle frasi più importanti di don Milani, l’uomo che ha fatto del motto I care (“Mi prendo cura”) il suo principio. Era un maestro, don Lorenzo, oltre che un prete. Un maestro che ha accompagnato i suoi ragazzi con amore e serietà in quella che è stata una scuola di vita. Un maestro a cui stavano a cuore i suoi allievi: il suo obiettivo era infatti farli crescere cittadini liberi. A Barbiana, piccolo borgo nei pressi di Firenze, non si studiava per ottenere un voto, ma per realizzare in pienezza il proprio progetto personale.
Don Lorenzo Milani rappresenta ancora oggi un esempio per fare scuola in modo innovativo e inclusivo.
Alta leggibilità abc
Caratteristiche grafiche che favoriscono l'accessibilità al testo.
9,50