


Promosso da: https://www.urbesmagazine.it/ https://healthcityinstitute.com/






Promosso da: https://www.urbesmagazine.it/ https://healthcityinstitute.com/


di Federico Serra
L’indimenticabile Anna Magnani, per tutti “Nannarella” è stata un’icona del cinema italiano e mondiale.
Vincitrice dell’Oscar nel 1955 per la sua interpretazione nella “Rosa tatuata”, rappresentava l’anima più popolare e genuina del cinema italiano. Lei di origini egiziane, ma romana verace di Porta Pia, ha rappresentato l’immagine di donna che piaceva e lei raccontava la bellezza con la tipica ironia romana.
«Ce metti una vita intera per piacerti, e poi, arrivi alla fine e te rendi conto che te piaci. Che te piaci perché sei tu, e perché per piacerti c’hai messo na vita intera: la tua. Ce metti una vita intera per accorgerti che a chi dovevi piacè, sei piaciuta… E a chi no, mejo così. Ce metti na vita per contà i difetti e riderce sopra, perché so belli, perché so i tuoi. Perché senza tutti quei difetti, e chi saresti? Nessuno. Quante volte me sò guardata allo specchio e me so vista brutta, terrificante. Co sto nasone, co sti zigomi e tutto il resto. E quando la gente me diceva pe strada “bella Annì! Anvedi quanto sei bona!” io nun capivo e tra me e me pensavo “bella de che?”. Eppure, dopo tanti anni li ho capiti. C’ho messo na vita intera per piacermi. E adesso, quando me sento dì “bella Annì, quanto sei bona!”, ce rido sopra come na matta e lo dico forte, senza vergognarmi, ad alta voce “Anvedi a sto cecato!”».
A Nannarella vogliamo dedicare questo editoriale, nel numero di URBES dedicato alla longevità e agli anziani, partendo da una frase celebre che Anna Magnani disse al suo truccatore.
«Lasciami tutte le rughe, non me ne togliere nemmeno una. Le ho pagate tutte care. C’ho messo una vita a farmele!». Una frase che porta con sé la saggezza di chi invecchiando sa che le rughe non sono solo il segno di un
tempo che intacca l’aspetto di una persona, ma la traccia dell’evoluzione di chi, donna o uomo, fa nella sua vita.
Le rughe sono la bellezza del tempo che scorre e che racconta la nostra storia e la nostra evoluzione, che è ricca delle esperienze fatte, delle gioie avute, dei dolori e dei torti subiti, delle lotte quotidiane, dei successi e degli insuccessi. Tutto questo è la bellezza di chi invecchia, con il proprio bagaglio unico di esperienze da consegnare alle generazioni future.
Oggi siamo consapevoli che essere anziani ha un significato differente di prima., la stragrande maggioranza degli adulti in tutto il mondo può aspettarsi di vivere decenni oltre l’età pensionabile. Il numero di anziani raddoppierà fino a raggiungere una stima di 1,6 miliardi entro la metà del secolo, segnando uno dei più profondi cambiamenti demografici nella storia umana.
Questa è una vera rivoluzione demografica e sociale, nella quale ognuno di noi deve essere coinvolto e protagonista per comprendere che invecchiare è una risorsa e non un problema.
La lotta all’ageismo parte proprio dalla consapevolezza che quelle rughe esprimono un patrimonio sul quale puntare per costruire una società migliore, anche nell’ottica di un patto sociale e intergenerazionale.
Richard Weissbourd, uno psicologo che insegna alla Harvard Graduate School of Education, ritiene che i giovani e gli anziani si sentirebbero meno isolati se avessero più contatti tra loro.
“Gli anziani hanno così tanto da condividere con i giovani: la saggezza sull’amore, il lavoro, l’amicizia, la mortalità e su molte altre cose”, dice Weissbourd. “E i giovani hanno
così tanto da condividere con gli anziani su un mondo in rapido cambiamento: non solo la tecnologia, ma nuovi e importanti modi di pensare sulla razza e sul razzismo, sulla giustizia, sulla sessualità e sul genere e suu altre questioni critiche”.
E allora quelle rughe vanno in qualche maniera protette e coltivate e la partecipazione sociale degli anziani e non il loro isolamento è la strada da seguire, sviluppando strategie di coinvolgimento attivo attraverso le quali, gli stessi possono soddisfare molti dei fattori che influenzano la loro salute, dal trovare uno scopo, al connettersi con gli altri, al rimanere attivi a trasmettere serenità alla generazioni dei più giovani ad esempio nel contesto di difficoltà e paure che oggi i giovani vivono.
Nelle società tradizionali, le nonne e i parenti più anziani si prendevano cura dei bambini mentre i loro genitori andavano a cacciare, raccogliere e curare i campi. Gli anziani erano anche i cantastorie, che tramandavano le tradizioni. Ma il mondo moderno separa le persone in istituzioni esclusive per l’età, come scuole e college per i giovani e comunità di pensionati per gli anziani. I social media spesso dividono ulteriormente le generazioni in silos auto-selezionati dei propri coetanei. In larga misura “ le due generazionali hanno smesso di incontrarsi”.
Ma forse qualcosa sta cambiando, ed è particolarmente significativo un racconto tratto dal New York Times nel periodo della pandemia del COVID.
Sam Cozolino, 14 anni, di Los Angeles, ha approfittato della pandemia per conoscere meglio la storia della sua famiglia attraverso il racconto della nonna. Ispirato dalla serie televisiva “Finding Your Roots” condotta da Henry Louis Gates Jr., Sam, ha trascorso decine di ore alla ricerca della sua storia ancestrale, incluso il contatto con parenti perduti da tempo in Italia, con l’obiettivo di creare un albero genealogico.
Sam ha passato ore parlando al telefono con sua nonna paterna, che gli ha raccontato delle sue lotte per crescere povera in America durante la seconda guerra mondiale.
“Le sue paure durante la guerra sono simili alle mie paure di uscire durante la pandemia”, ha detto. “Ma sicuramente non è così male come dover fare due lavori e non avere mai abbastanza soldi. Parlare con lei ha messo davvero in prospettiva quello che sto passando”.
Questo racconto è emblematico di come gli anziani con le loro esperienze possono trasmettere non solo i ricordi e le esperienze, ma anche garantire serenità alle generazioni future.
Aveva ragione Nannarella quanto diceva che le sue rughe le aveva pagate care, ma le voleva tutte.





EDITORIALE F. Serra
AGORÀ A. Lenzi
ZIBALDONE F. Greenhouse IN PUNTA DI PENNA F. Mazzeo
CITTADINI A. Gaudioso
FOCUS ON L. Serra SOCRATIC DIALOGUE
Three Bees Inner Circle
HEALTH CITY MANAGER ALUMNI M. T. Riccardi
RECENSIONI F. Policastro
TAKE AWAY
CITIES SPEAKING F. Greenhouse
CITIES+ F. Greenhouse
NEWS DA HCI Redazione
NEWS DALLA ReCUI C. Spinato MONOGRAFIA
Anziani & Città
AA. VV., a cura di HCI & Edra
URBES DIALOGUE
41° ASSEMBLEA ANCI TORINO 2024: intervista a Roberto Pella, Presidente f.f. ANCI C. Spinato
Lettera Aperta ai Sindaci Italiani in occasione della 41^ Assemblea Nazionale ANCI HCI
Nasce Science for Cities, una grande alleanza scientifica sull'urban health F. Serra
Dieci anni di Cities Changing Diabetes: il ruolo di HCI e dell'Italia Redazione
Aree interne: potenziare la sanità territoriale, obiettivo di Governo e Parlamento F. Serra
Deborah Visconti, Presidente unione comuni montani "Montagna aquilana"
L. Serra
URBES AWARD 2024
Redazione
Mauro Armelao, Sindaco di Chioggia: l'HCM e l'impegno della città per più salute C. Spinato
Luciano Fregonese, Sindaco di Valdobbiadene: le passeggiate con il sindaco per promuovere salute e cittadinanza C. Spinato
Marco Innocenti, Sindaco di Tivoli: intervista al sindaco che candida la città a Capitale della Cultura 2028
L. Serra
G7 Italia
G7 Salute: una roadmap sulla salute globale L. Serra
L'extra G7 di Ancona
M. Caucci
ANCI Marche per l'extra G7 Salute: il ruolo dei territori per la salute dei cittadini Redazione
Speciale PARIGI 2024
Incontrando Anne Hidalgo, la Sindaca di Parigi
L. Serra
In che modo le Olimpiadi hanno cambiato il volto della città
L. Serra

In che modo le Olimpiadi hanno cambiato il volto della città
L. Serra
Parigi torna a nuotare L. Serra
CALEIDOSCOPIO
In giro per il mondo Redazione VIII
URBAN HEALTH COLUMNS
Caregiver, è la (s)volta buona?
I. Mori, Cittadinanza Attiva
Intervista a Fabrizio d'Alba, nuovo Presidente Federsanità T. Bonacci, Federsanità
Rigenerazione urbana in chiave one health E. Massari, Fondazione The Bridge
L'AI da possibile minaccia a migliore amica della salute
M. C. Logiudice, Responsabile Area Cyber Security & AI KeyPartner
Salute e benessere al centro!
F. Ascoli, Urban Eco Mobility Trend
Vivere insieme in pari dignità
AA.VV., FareRete InnovAzione BeneComune APS
FOCUS ON SPORT
L'esercizio fisico in ricetta medica
D. Sbrollini, Senatrice
Daniela Sbrollini nuova Presidente dell’Italian Wellness Alliance-IWA Redazione
SportCity Day 2024
F. Pagliara, Fondazione Sport City
CITTA, SALUTE, CULTURA, AMBIENTE E BENESSERE
Firenze al vertice della classifica mondiale delle walkable cities L. Serra
La Via Appia entra nella lista del patrimonio mondiale UNESCO Redazione
Allergie respiratorie: presentato il Manifesto per rafforzare i diritti, l’accesso alle cure e l’assistenza Redazione
Congresso EASD 2024: un semplice esame del sangue può predire il rischio di cancro nel diabete di tipo 2 Redazione
Cinque anni di EUDF: il documento d’impegno della comunità diabetologica rivolto ai membri del Parlamento Europeo Redazione
Benessere degli oncologi, un aspetto fondamentale per il futuro della cura del cancro
S. G. Ciappellano
Salute degli anziani: l’impegno di Cuore Nostro e Fondazione Longevitas sulle malattie delle valvole cardiache Redazione
ADVERTISINGaI

Andrea Lenzi, Presidente Health City Institute, Presidente del Comitato Nazionale per la Biosicurezza, le Biotecnologie e le Scienze della Vita (CNBBSV) della Presidenza del Consiglio dei Ministri



In occasione della Giornata Nazionale dei Nonni e degli Anziani dello scorso 28 luglio il Santo Padre ha voluto sottolineare il ruolo che gli stessi devono avere nella società odierna, indicando però come oggi vi è una solitudine che colpisce gli anziani dovuta a tante cause.
In molti Paesi, soprattutto i più poveri, gli anziani si ritrovano soli perché i figli sono costretti a emigrare, oppure nelle situazioni di conflitto molti anziani rimangono soli perché gli uomini – giovani e adulti –sono chiamati a combattere e le donne, soprattutto le mamme con bambini piccoli, lasciano il Paese per dare sicurezza ai figli. Nelle città e nei villaggi devastati dalla guerra rimangono tanti vecchi e anziani soli, unici segni di vita in zone dove sembrano regnare l’abbandono e la morte. In altre parti del mondo, poi, esiste una falsa convinzione, molto radicata in alcune culture locali e legate a credenze ancestrali, che genera ostilità nei confronti degli anziani, in cui questi sono addirittura sospettati di fare ricorso a espedienti per togliere energie vitali ai giovani; così che, in caso di morte prematura o di malattia o di sorte avversa che colpiscano un giovane, la colpa viene fatta ricadere su qualche anziano. Questa mentalità va combattuta ed estirpata.
Se ci pensiamo bene, quest’accusa rivolta ai vecchi di “rubare il futuro ai giovani” è molto presente, in realtà, ovunque e la stessa permea e si riscontra, sotto altre forme, anche nelle società più avanzate e moderne. Ad esempio, si è ormai diffusa la convinzione che gli anziani fanno pesare sui giovani il costo dell’assistenza di cui hanno bisogno e, in questo modo, sottraggono risorse allo sviluppo del Paese e dunque ai giovani. Si tratta di una percezione distorta della realtà. È come se la sopravvivenza degli anziani mettesse a rischio quella dei giovani.
Ma gli anziani sono invece energia vitale per i giovani. Non sorprende
suoi coautori abbiano concentrato la propria attenzione sugli anziani e abbiano scoperto che avere uno scopo nella vita e sviluppare connessioni significative con gli altri sono tra i fattori più importanti per rafforzare la salute in tutto il mondo.
L’analisi del McKinsey Health Institute (MHI) mostra che gli anziani sono più felici e più sani quando si impegnano di più nella società, e aiutarli a farlo potrebbe giovare all’economia.
Ma qual è il più forte predittore di salute e felicità in età avanzata? Molte ricerche suggeriscono che la risposta sta nelle buone relazioni. Si tratta di relazioni che trasmettono un senso di scopo e di connessione significativa, tra loro e con la società tutta.
L’indagine del MHI, condotta su adulti di età pari o superiore a 55 anni in 21 Paesi, ha, infatti, confermato che avere uno scopo nella vita e connessioni significative con gli altri sono tra i fattori più importanti per rafforzare la salute degli anziani in tutto il mondo. Gli intervistati hanno spesso citato la realizzazione personale e la connessione sociale come motivazioni primarie per il lavoro o il volontariato. Sono stati ritenuti importanti anche l’apprendimento permanente e la partecipazione a organizzazioni o attività comunitarie. Questi risultati sono tutti in linea con il concetto di “partecipazione sociale”, definito da MHI come il “coinvolgimento costante in attività deliberate che portano a un impegno significativo con la propria società e comunità”. Questo è in linea con le attività che gli anziani possono svolgere nelle loro comunità, come lavorare, fare volontariato, sostenere la formazione dei più giovani o partecipare ad attività comunitarie. Attraverso queste attività, gli anziani possono soddisfare molti dei fattori che influenzano la loro salute, dalla ricerca di uno scopo al connettersi con gli altri e rimanere attivi.
Il tema della partecipazione sociale sta diventando sempre più rilevante sia a livello globale che locale ed è spesso discusso come una componente fondamentale per i programmi di invecchiamento sano. Il Decennio dell’Invecchiamento in Buona Salute delle Nazioni Unite elenca la “capacità di contribuire alla società” come uno dei cinque domini di abilità funzionali necessari per un invecchiamento in buona salute. Allo stesso modo, la Global roadmap for healthy longevity della National Academy of Medicine, delinea otto obiettivi a lungo termine a cui aspirare, quattro dei quali riguardano la partecipazione sociale degli anziani.
La partecipazione sociale può essere, quindi, molto positiva per la salute degli anziani. Tra gli intervistati nel sondaggio MHI, coloro che hanno partecipato ad attività sociali hanno avuto un aumento del 4-8% della salute generale percepita rispetto a coloro che non hanno partecipato ma avrebbero voluto. Questo risultato è in linea con la letteratura esistente. MHI ha analizzato, inoltre, più di 70 recenti studi accademici peer-reviewed sulla partecipazione sociale degli anziani e ha riscontrato benefici tematici per la salute: riduzione dei tassi di mortalità; ridotta disabilità cognitiva; minore disabilità e fragilità funzionale; diminuzione della solitudine e della depressione; aumento dei livelli di attività fisica e miglioramento del significato e della qualità della vita.
Alcune delle prove più forti fino ad oggi provengono dallo studio decennale di Harvard sullo sviluppo degli adulti. “Le persone che erano più felici, che rimanevano più sane mentre invecchiavano e che vivevano più a lungo erano le persone che avevano i legami più caldi con le altre persone”, ha detto Robert Waldinger, direttore dello studio di Harvard e autore di The Good Life: Lessons from the World’s Longest Scientific Study of Happiness (Simon & Schuster, gennaio 2023) in un’intervista per la serie Author Talks di McKinsey. “In effetti”, ha detto, “le buone relazioni erano il più forte predittore di chi sarebbe stato felice e in salute quando sarebbe invecchiato”.
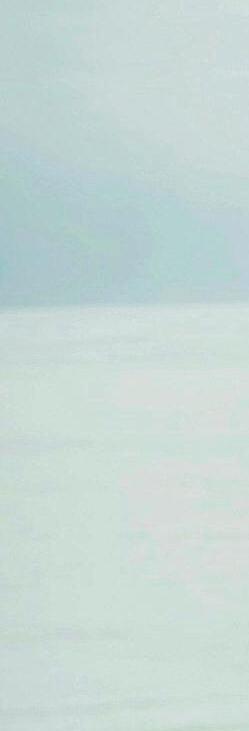
Oltre alle relazioni forti e al senso di scopo – beni inestimabili in sé e per sé – c’è un beneficio economico nella partecipazione della società. MHI stima quasi 6,2 trilioni di dollari il valire annuale di PIL, nei 21 paesi esaminati nella Global Healthy Aging Survey. Ciò equivale a un aumento medio pari a circa l’8% se potessimo consentire agli anziani che hanno dichiarato di voler lavorare, di rientrare nella forza lavoro, ma non lo stanno facendo. Per i soli Stati Uniti, questo si traduce in un’opportunità di 1,7 trilioni di dollari (pari al 7,2% del PIL del 2021). L’impatto potenziale sulle economie nazionali potrebbe essere sostanziale e questo senza nemmeno prendere in considerazione i contributi dei lavoratori più anziani di oggi: il 21% della forza lavoro totale nelle economie a reddito più elevato oggi è costituito da lavoratori di età pari o superiore a 55 anni
Le stime demografiche prevedono che, entro il 2050, il numero di persone di età superiore ai 65 anni crescerà dal 9,4 al 16,5% della popolazione totale del mondo. A livello locale, i divari tra zone rurali e urbane porranno sempre più i Paesi di fronte alla sfida di bilanciare esperienze di invecchiamento eque. Risolvere il problema della partecipazione alla società nelle nostre città e comunità locali sarà essenziale per costruire una società futura in cui l’invecchiamento sano prosperi, indipendentemente dal luogo in cui si vive.
Investire nella felicità e nelle relazioni non farà solo bene agli anziani, ma contribuirà a rendere migliore la società dove viviamo.




Le città italiane diventeranno più sostenibili grazie allo sviluppo tecnologico. Il binomio composto da sostenibilità e transizione digitale fa parte della missione di TIM Enterprise, la business unit del Gruppo TIM, guidato dall’Amministratore Delegato Pietro Labriola. Con il suo patrimonio di tecnologie e professionalità TIM Enterprise mette a disposizione di pubbliche amministrazioni e grandi clienti la propria offerta di connettività fissa e mobile, abbinata al cloud, all’Intelligenza Artificiale, alla cybersicurezza e all’Internet delle cose. Tutti strumenti che contribuiscono alla costruzione della smart land, ovvero di un territorio più sicuro e più vivibile grazie all’utilizzo delle tecnologie.
Un quadro chiaro delle potenzialità della trasformazione digitale dei nostri territori viene fornito dai dati del Rapporto del Centro Studi TIM che stima che entro il 2027 in Italia il mercato delle smart city raggiungerà un valore di 1,6 miliardi di euro con evidenti effetti anche sul piano della sostenibilità ambientale: una riduzione di 6,5 miliardi di euro dei costi legati al traffico e di 405 milioni di euro legati all’inquinamento, per 650 mila tonnellate in meno l’anno di emissioni di CO2.
Per TIM Enterprise, guidata da Elio Schiavo, Chief Enterprise and Innovative Solutions Officer di TIM, il modello di smart land
è già una realtà, attraverso l’utilizzo di TIM Urban Genius, la piattaforma di intelligenza urbana che integra le migliori tecnologie proprietarie e i contributi di startup, scaleup, e del mondo dell’innovazione. TIM Urban Genius è a disposizione delle istituzioni locali per realizzare il modello di città evoluta, sostenibile e sicura, analizzando i dati e gestendo le aree urbane in tempo reale, per far sì che queste soluzioni tecnologiche, insieme all’AI, siano capaci di rispondere alle esigenze dei cittadini.
Il digitale applicato alle realtà urbane è anche un abilitatore straordinario per accrescere l’attrattività turistica e per questa ragione TIM Enterprise ha sviluppato un ecosistema di tecnologie unite all’impiego della rete 5G, capaci di innovare i modelli di business e sviluppare nuove esperienze all’interno di spazi digitali e virtuali in cui è possibile rafforzare l’offerta culturale.
Lo sviluppo delle smart city, con la loro portata tecnologica, non può prescindere dall’analisi degli aspetti legati alla cybersicurezza. La nuova Direttiva europea NIS2 cui anche molte piccole e medie imprese dovranno presto adeguarsi, rende particolarmente attuale il tema. TIM Enterprise anche nell’ambito della cybersicurezza è in grado di rispondere alle rinnovate esigenze di aziende e pubblica amministrazione.

di Frederick Greenhouse
Quando qualcuno contempla l’invecchiamento, lo fa probabilmente con un desiderio di indipendenza fisica e finanziaria, attraverso attività gioiose e coinvolgenti, in buona salute e con la vicinanza dei propri cari. Che si tratti di svolgere attività ludiche, quali il ballo, le attività sportive, l’andare in giro per musei e teatri, o fare del turismo, molte di queste attività abbisognano di un buono stato di salute ed economico, come anche lavorare part-time o correre dietro ai nipoti. La grande domanda è come ogni adulto che invecchi e diventi anziano, indipendentemente dal paese o dallo status socioeconomico, possa godere della sua vita futura.
Troppo spesso la società e gli individui accettano il declino della salute come inevitabile e il passare del tempo porta al deterioramento fisico. Un obiettivo importante per molte società potrebbe essere quello di chiedersi: “Cosa ci vorrebbe perché più della metà delle persone di età pari o superiore a 80 anni riferisse di essere in una buona salute nel prossimo decennio? Cosa ci vorrebbe per espandere ciò che significa essere in buona salute all’età di 60, 70, 80, 90 anni e oltre? Come un quadro urbano sano si collega alle capacità degli anziani di rimanere attivi, accedere alle cure e rimanere in contatto con altri membri della propria comunità?”
Tutte domande alle quali bisogna non solo dare risposte concrete, ma che necessitano di una visione complessiva su cosa significa essere anziani oggi.
L’invecchiamento in buona salute inizia anche con azioni individuali, come ad esempio una persona che segue comportamenti che hanno dimostrato di migliorare la salute, supportata da un ambiente che li rende accessibili a tutti. È un viaggio che dura tutta la vita e non è mai troppo tardi per intraprendere la strada per invecchiare bene.
Ma la vecchiaia inizia sempre più tardi, soprattutto se si chiede alle persone interessate. Uno studio pubblicato dall’American Psychological Association ha sco-
perto che gli adulti di mezza età e gli anziani di oggi credono che la vecchiaia inizi più tardi di quanto i loro contemporanei pensassero decenni fa. Anche più tardi di quanto hanno detto gli stessi partecipanti. Essere vecchi non è più inteso come una volta. Lo studio riflette i cambiamenti biologici, ma suggerisce anche molto sul modo in cui ci relazioniamo con l’invecchiamento. “C’è una tendenza storica sorprendentemente forte verso un rinvio soggettivo o un inizio più tardivo della vecchiaia”, spiega Markus Wettstein, psicologo dell’Università Humboldt di Berlino e autore principale dello studio. “E ancora non capiamo appieno perché”.
Negli ultimi anni l’aspettativa di vita e la qualità della vita sono aumentate. Questo è andato di pari passo con i cambiamenti nella società: le fasi chiave della vita ora avvengono più tardi, come il matrimonio e la genitorialità. E in molti Paesi anche l’età pensionabile, la porta d’accesso ufficiale alla vecchiaia, è stata posticipata. Il concetto diffuso di vecchiaia potrebbe essere stato posticipato di alcuni anni a causa di questi cambiamenti, suggeriscono i ricercatori. O forse, in una società ageista, nessuno vuole percepirsi come vecchio.
Ma cosa significa esattamente essere vecchi? A partire da quale età si è oggettivamente anziani? Gli intervistati hanno risposto alla domanda, da una a otto volte, in un periodo di 25 anni. Hanno cambiato la loro risposta con l’avanzare dell’età, citando un’età sempre più avanzata con l’avanzare dell’età. Alla fine, l’età più citata è stata di 70 e 71 anni. Secondo Wettstein “é difficile definire [la vecchiaia] perché vediamo sempre nella nostra ricerca quanto sia tremendamente eterogeneo il gruppo degli anziani”.
In generale, le donne tendono a dire che la vecchiaia inizia in età più avanzata rispetto agli uomini. Questo è stato visto in ricerche precedenti ed è stato confermato con il nuovo studio, dove c’è una divergenza di 2,4 anni. “Le donne tendono a vivere più a lungo degli uo-
mini, il che potrebbe spiegare questa differenza nella percezione dell’inizio della vecchiaia”, afferma Wettstein. Lo studio, che ha utilizzato i dati di 14.000 cittadini tedeschi, ha analizzato come i termini età biologica, età cronologica ed età soggettiva siano cambiati dal 1988 a date più recenti. “Se l’aspettativa di vita è più lunga, la percezione dell’inizio della vecchiaia potrebbe essere posticipata in una certa misura”, riflette Wettstein. “Qualcuno che ha 60 anni potrebbe essere stato considerato vecchio in passato, ma oggi può aspettarsi di vivere 20 anni o più”.
Bruno Arpino, sociologo dell’Università di Firenze specializzato in invecchiamento, va oltre e parla di un’età prospettica. “Normalmente, l’età si misura guardando indietro al momento in cui si è nati. Una prospettiva totalmente diversa, che alcuni ricercatori propongono, consiste nel guardare al futuro, cioè a quanti anni una persona può aspettarsi di vivere. In questo contesto, essere più grandi non dipende solo da quando si nasce, ma anche da dove. L’aspettativa di vita del paese determinerà ciò che intendiamo per anziani”
Ma la vecchiaia non è un numero, ma un concetto soggettivo, che cambia a seconda della società. “In uno studio condotto nei paesi europei, sono state osservate grandi differenze tra i paesi, fino a 10 anni”, afferma Wettstein, che spiega che questi cambiamenti si basano sulla “partecipazione degli anziani al mercato del lavoro, sulla percentuale di anziani all’interno di un Paese e sulla percezione culturale della vecchiaia e degli anziani”.
Lo studio sostiene che “l’età soggettiva di un individuo potrebbe essere un fattore importante” quando si parla di vecchiaia. L’età soggettiva si riferisce all’età che una persona sente, rispetto all’età effettiva. E in generale, gli adulti tendono a pensare a sé stessi come molto più giovani. Secondo uno studio del 2006, gli adulti sopra i 40 anni si percepiscono, in media, come il 20% più giovani di quanto non siano in realtà. La differenza tra età cronologica ed età soggettiva inizia ad allargarsi lentamente, ma inesorabilmente, all’età di 25 anni, e continua ad allargarsi da quel momento in poi. Come spiegano gli autori di uno studio dell’Università della Virginia sull’ageismo:”L’invecchiamento soggettivo ci fa diventare marziani, dove su Marte un decennio terrestre equivale a soli 5,3 anni marziani”.
Questo è ciò che dicono le persone anziane su cosa significhi essere più anziani, ma cosa dice la scienza? C’è qualche supporto per questa percezione soggettiva? La risposta breve è sì. Ma Wettstein preferisce dare una risposta più lunga: “Grazie ai progressi della medicina, gli anziani sono in una certa misura più sani di quanto non fossero 10 o 20 anni fa, e questo potrebbe spiegare perché credono anche che la vecchiaia inizi più tardi”. Quindi
questo fenomeno non è solo psicologico, ha una vera e propria base scientifica.
Uno studio del 2021 condotto in Finlandia ha suddiviso questo dato in numeri. I ricercatori hanno somministrato a uomini e donne di età compresa tra i 75 e gli 80 anni una serie di test fisici e cognitivi. Hanno salvato questi risultati e quando sono passati 28 anni, hanno ripetuto gli stessi test su un altro gruppo di uomini e donne di quell’età. Il nuovo turno di senior ha ottenuto voti migliori in tutte le aree. Camminavano più velocemente tra i 20 e i 40 centimetri al secondo, erano in grado di afferrare con una forza maggiore tra il 5% e il 25% e potevano alzare la gamba tra il 20% e il 47% in più rispetto al gruppo che aveva fatto questi test 28 anni prima di loro. Inoltre, avevano almeno il 14% in più di capacità polmonare e una migliore fluidità verbale, ragionamento e memoria di lavoro.
Questo studio posticipa l’inizio della vecchiaia e i suoi autori sostengono che si tratta di una tendenza solida. Ma non tutti i gerontologi la pensano allo stesso modo.
Come era essere anziani nel passato?
Non abbiamo dati affidabili, tuttavia informazioni interessanti possono essere ottenute dai testi di poeti, scrittori e storici. Ad esempio, l’antico poeta greco Mimnermo scrisse: “Vorrei che il destino della Morte mi raggiungesse senza malattie o tribolazioni a sessant’anni”, intendendo 60 anni. Attualmente, l’età in cui una persona inizia ad essere definita anziana è intorno ai 60 o 65 anni, ancora però abile per il mercato del lavoro e pienamente inserito nel tessuto sociale.
Provate a chiedere a un 60enne se si sente anziano. Vi risponderà che non lo è affatto e molte delle sue attività, il suo modo di vestire, i suoi hobby evidenzieranno questo pensiero.
Oggi siamo in un’epoca di convenienza utilizzata anche da organizzazioni internazionali come le Nazioni Unite, dal mercato del lavoro, dalla società nel suo insieme, dove definire le persone anziane è una convenzione. Quindi le cose non sono cambiate molto. Diversi studi possono parlare di anziani più sani e più forti, ma ciò non significa che non siano più anziani per la società. Sessant’anni sono i nuovi 50, ma solo per le persone che hanno 60 anni e non per il contesto nel quale vivono. E questo la dice lunga sulle forme di stigma associate alla vecchiaia e a quando inizia. Nel corso della storia, la percezione di come l’invecchiamento sia cambiato è maggiore di quanto non pensiamo e oggi essere anziani è diventata una dinamica demografica con implicazioni sociali.
di Fabio Mazzeo
Giornalista e divulgatore scientifico
Parto da una considerazione personale condita con qualche aneddoto per entrare nel merito. Sono nato nel 1967 e quando questo articolo andrà in stampa avrò compiuto 57 anni. Quaranta anni fa, quando stavo per completare il liceo, mio padre aveva 47 anni. Ai miei occhi, nonostante fosse in buona forma fisica, lui era già un anziano signore che aveva enormi difficoltà a capire come il Festival di Sanremo potesse ospitare Vasco Rossi, perché le serate in discoteca cominciassero alle 23 e aveva un rapporto di diffidenza col Commodore 64, il primo tra i computer a sfondare nel mercato di massa.
Giocava a tennis quando poteva ma si sarebbe fatto uccidere piuttosto che andare a una cena indossando scarpe da ginnastica (nel vocabolario di allora la parola sneakers non era ancora stata introdotta).
Sì, il mondo è cambiato; perché siamo cambiati noi. Con mio figlio ho giocato alla playstation provando sempre a vincere, insieme a lui ho fatto migliaia di chilometri per assistere a eventi sportivi e musicali. Ci capita di fare sport insieme, e provo ancora ad esserne all’altezza con risultati che vanno dal modesto al disastroso; ma non mollo mai.
I comportamenti sono cambiati, e molto è dovuto al tempo in più che ci viene concesso.
Quaranta anni fa l’aspettativa di vita degli italiani era di 74 anni, oggi è di 83.
Una differenza enorme, ottenuta grazie a vaccini e altri farmaci, alla cronicizzazione di malattie prima incurabili, livelli stratosferici raggiunti dalla chirurgia, dalla diagnostica. E nella mia esperienza agli Istituti Scientifici Maugeri ho visto come la buona riabilitazione può portare a risultati straordinariamente positivi anche in soggetti particolarmente fragili. Mediamente lavoriamo in ambienti più sicuri, ci nutriamo meglio, abbiamo colto l’importanza dell’attività fisica. Il contributo della buona comunicazione è stato quello di divulgare corretti stili di vita. Dalla terza, nell’ultimo decennio siamo arrivati a discutere di quarta età. E oggi c’è chi pone per gli ultranovantenni le questioni legate alla gestione della quinta età.
Il 60% degli over 65 usa quotidianamente Internet, ha un account social dove esprime opinioni, rimane in


contatto con tutti gli amici, ne cerca di nuovi. Oggi il 53% degli uomini e il 42% delle donne tra i 60 e i 69 anni sono ancora sessualmente attivi. Dopo i 70 anni queste percentuali scendono ma il 43% degli uomini e il 22% delle donne nutre ancora interesse.
Insomma, il progresso, con le sue quotidiane scoperte, non solo ha allungato la vita ma, per dirla come Luciano De Crescenzo, ha trovato anche il modo di allargarla, riempiendo l’esistenza di contenuti felici. “Vecchio sarai tu!” è oggi una frase che può stare sulla bocca di una persona di qualsiasi età. Sono una serie di fattori a offrire non un elisir di eterna giovinezza ma una serie di pratiche di buona vita quotidiana a ogni età.
Nutrizione e attività fisica hanno programmi sempre più sofisticati in grado di guidare la base dell’efficienza fisica. Ma questo deve corrispondere a una società in grado di accogliere tale efficienza, con programmi di integrazione che rendano utili tutte le persone. Altrimenti prende spazio la malinconia, e con essa le malattie generate dalle sensazioni di chi crede di non essere più né utile né gradito.
Proprio il diffuso invecchiamento mitiga l rischio, tra vecchi ci riconosciamo, ma il benessere emotivo dipende soprattutto dal livello di indipendenza e autonomia che il singolo soggetto riesce a ottenere ed esprimere.
La tecnologia viene in soccorso, offrendo per le abitazioni strumenti in grado di rendere più agevoli tutte le questioni domestiche. Gli smartwatch rappresentano una risposta al controllo di tutta una serie di parametri sanitari, ma presto entreranno sul mercato sistemi di controllo in grado di monitorare costantemente la salute della persona. Pensate, molti di questi dati potranno essere restituiti ogni mattina dal water! A distanza di quasi 500 anni dall’invenzione dello scarico da parte di Sir John Harington, un cortigiano inglese al quale viene attribuita l’invenzione di un dispositivo che usava l’acqua per eliminare i rifiuti dalla tazza, capiterà che le nostre urine, prima di sparire nell’impianto fognario verranno analizzate in modo domestico. Incredibile, no?! Come sempre accade per le innovazioni, per qualche anno sarà roba da ricchi, poi arriverà a tutti. Ma la vera questione rimane di na-
tura psicologica. Chi col tempo perde un po’ di brillantezza e sopravvive a tanti amici e familiari, ha bisogno di un modello di città che lo accolga nella sua nuova dimensione, quella di chi si muove ma più lentamente, di chi è attivo ma fino a certe attività. Di chi si sente solo. Bisogna preparare nuovi luoghi e nuovi modelli, strade e parchi accessibili a ogni livello di mobilità e nuovi modelli di residenza, andando dalle case di riposo alle coabitazioni, dove gli anziani autosufficienti possano trovare indipendenza in luoghi dove condividere servizi, dalle cucine al medico o all’infermiere per controlli periodici. La comunicazione qui deve investire su un doppio impegno, illustrando a una popolazione che invecchia e a un decisore che sbanda con
conti pubblici che devono supportare pensioni e malattie croniche, che ci sono strade percorribili, esigenze che è possibile soddisfare. Facendo attenzione e costruendo ponti di sostenibilità, andiamo avanti. Proprio 40 anni fa raggiunse un successo planetario una bellissima canzone degli Alphaville, tornata prepotentemente di moda. Nel ritornello la voce struggente cantava “Forever young, I want to be forever young”. Beh, nessuno può rimanere giovane per sempre e con questo dobbiamo farci i conti individualmente. Però possiamo tutti insieme generare una società nella quale a qualsiasi età la vita vale la pena di essere vissuta perché è bello essere al mondo.

Il rendiconto annuale dell’ISTAT descrive l’Italia tra i Paesi con la più alta percentuale di anziani con un’aspettativa di vita in aumento. Per molti anni, gli anziani sono stati considerati principalmente un onere economico e sociale relegati ad una condizione da gestire piuttosto che essere riconosciti come una risorsa potenziale, soprattutto in economie e contesti sociali in continua evoluzione.
Il progressivo allungamento della vita impone alla società di assicurare agli anziani di vivere il più a lungo possibile in buona salute. L’OMS definisce l’invecchiamento attivo come il processo di ottimizzazione delle opportunità di salute, partecipazione e sicurezza per migliorare la qualità della vita delle persone che invecchiano; il recente dibattito innescato da Monsignor Paglia sul tema riflette la necessità di un cambio di paradigma sociale per considerare gli anziani come una risorsa per il sostegno della struttura socioeconomica del paese. Il loro contributo può essere determinante per la stabilità economica e lo sviluppo attraverso ruoli e funzioni che stanno emergendo e consolidandosi nella società.
La Legge 33/23 promuove la gestione dell’invecchiamento attivo, spostando la percezione degli anziani da peso a risorsa economica e sociale. Valorizzare la condizione degli anziani attraverso azioni preventive, garantendogli buona salute, non solo contribuisce allo sviluppo economico e sociale, ma riduce anche il carico sui sistemi di welfare rendendone necessario un ripensamento e adottando una gestione integrata che unisca aspetti sociali e sanitari. Investire nella prevenzione e nella qualità dei sistemi sociosanitari migliora la salute della popolazione anziana e libera risorse che possono essere reinvestite per far crescere l’economia. Lo schema di decreto legislativo per le persone anziane, pur essendo focalizzato prevalentemente sulle tematiche sanitarie e assistenziali, include disposizioni per la partecipazione degli anziani ad attività di lavoro dipendente o autonomo; Negli anni, si è spesso discusso della condizione degli anziani anche in termini di conflitto tra generazioni da prevenire e gestire. In questo contesto, è essenziale promuovere un nuovo patto intergenerazionale che riconosca la trasformazione radicale della struttura socioeconomica e del mercato del lavoro sviluppando una visione strategica e definire


come supportarla dal punto di vista delle risorse, poiché innovazione e riforme richiedono inevitabilmente investimenti. Occorre inoltre, avviare un dibattito pubblico che superi gli stigmi culturali, spesso causa di contrapposizioni tra generi e generazioni.
In questa fase storica, si assiste ad una significativa carenza di competenze nel mercato del lavoro, con milioni di posti vacanti che non soddisfano le esigenze economiche e sociali. Al contempo, molte persone che escono dal mercato del lavoro si trovano abbandonate a sé stesse, nonostante le loro competenze siano state cruciali per l’economia fino a prima del pensionamento. Questo scenario evidenzia una mancanza di strategia a lungo termine riguardo la gestione degli anziani nel nostro paese
Dunque, la politica non dovrebbe lasciar cadere le questioni affrontate nella L.33, che hanno suscitato un dibattito pubblico importante ma sviluppare ulteriormente questi temi attraverso nuovi provvedimenti normativi che consolidino i concetti espressi nella legge, offrendo all’arena politica l’opportunità di superare l’isolamento concettuale, spesso presente nel dibattito politico, rispetto alla realtà vissuta dalle persone.
Se consideriamo questa come un’opportunità con benefici potenziali, come dimostrato da numerosi dati, per la crescita economica e sociale è necessario sviluppare una capacità di investimento a lungo termine che include investimenti nel mercato del lavoro, nel trasferimento intergenerazionale delle competenze e nei sistemi sociali e sanitari. Tali investimenti non solo aiutano a gestire i problemi, ma anche a sfruttare le opportunità, garantendo che la popolazione anziana possa godere di buona salute il più a lungo possibile. In questo contesto diventa fondamentale elaborare una strategia lungimirante e stimolare un dibattito pubblico che coinvolga il mondo del lavoro, le università, la società civile e il terzo settore. Questo approccio permetterebbe di governare l’innovazione sociale anziché subirla. È ciò che ci si aspetta in un Paese normale, dove ciascuno ha il dovere di contribuire alla discussione. Inoltre, l’Italia potrebbe cogliere l’opportunità di essere all’avanguardia su tematiche ormai strettamente interconnesse con la nostra quotidianità.

Per Snam l’ascolto e il dialogo con il territorio, le relative comunità e i rispettivi stakeholder sono elementi essenziali nella conduzione della propria attività. In qualità di primo operatore europeo nella gestione del trasporto del gas naturale, dello stoccaggio e della rigassificazione, nella sola Italia Snam gestisce una rete di oltre 33.000 chilometri, che diventano oltre 38.000 considerando l’estero.
Cecilia Gatti Executive Director Institutional Affairs
La rete di infrastrutture di Snam costituisce una vera e propria spina dorsale composta da gasdotti, impianti come centrali di compressione e di stoccaggio e asset costieri o in mare: i rigassificatori. La presenza capillare su tutto il territorio nazionale, non solo delle infrastrutture ma anche del personale, non può prescindere da un coinvolgimento attivo e partecipato di istituzioni (centrali e territoriali), associazioni e organizzazioni, considerati stakeholder di primo piano per il Gruppo sia nella fase di realizzazione di nuovi impianti sia nella gestione o nell’ammodernamento di quelli in esercizio,
nell’ottica di una sempre maggiore collaborazione e trasparenza con i territori.
“La realizzazione di nuovi progetti prevede una fase prodromica di presentazione alle istituzioni competenti, in virtù del successivo iter autorizzativo. Si passa quindi alla condivisione dei dettagli realizzativi con le istituzioni e gli enti locali coinvolti: Regioni, Comuni e altri stakeholder istituzionali che rappresentano gli interessi del territorio nel confronto con chi realizza le opere. Obiettivo di questo approccio è garantire l’ascolto delle istanze delle comunità locali, soddisfacendo il legittimo desiderio di informazione tramite la condivisione delle scelte principali dell’intervento infrastrutturale, la sua localizzazione, le eventuali varianti e le misure compensative”, afferma Cecilia Gatti, Executive Director Institutional Affairs di Snam.
Un confronto costante, che si basa su rapporti consolidati nel tempo, quello tra Snam e i territori e che si traduce in un’attività di divulgazione, volta a spiegare il perché

di determinate opere, la finalità delle stesse e, soprattutto, le informazioni sulla localizzazione che interesseranno le singole aree.
“Presentare i nostri progetti alle istituzioni è un atto doveroso che ha anche l’obiettivo, mediante l’ascolto e il dialogo preventivo con le comunità locali, di favorire la cosiddetta public acceptance delle opere e limitare l’esposizione alle potenziali resistenze dei territori. Proprio per questo è necessario implementare i momenti di condivisione e raggiungere percentuali sempre più elevate di popolazione, al fine di far comprendere l’utilità intrinseca dell’opera, accogliendone
i valori. Prendiamo per esempioaggiunge Gatti - la Linea Adriatica. Riconosciuta come progetto di interesse comune dall’Unione Europea e inserita, con riferimento alla sua fase 1, nella revisione del Pnrr, la Linea Adriatica è strategica per la sicurezza energetica del Paese e dell’Europa, consentendo di eliminare i colli di bottiglia dalla direttrice sud-nord di trasporto del metano - diventata strategica dopo la forte contrazione del gas importato dalla Russia - e abilitando anche l’export verso nord. I 425 chilometri di metanodotti di nuova realizzazione previsti nell’ambito del progetto sono, inoltre, hydrogen ready: pronti cioè a veicolare non soltanto metano e biometano ma anche, appunto, idrogeno, abilitando così la transizione energetica e la decarbonizzazione perseguite da Snam (con questo e altri progetti), dal Paese e dall’Unione Europea. Da ciò si evince il contributo che ogni territorio può dare rispetto a una dimensione che va ben al di là della propria area geografica di interesse, ma che guarda al sistema-Paese e oltre”.
UNA GIORNATA DI CONDIVISIONE NELL’IMPIANTO DI MASERA
A proposito, Snam ha, di recente, promosso e realizzato dei veri e propri “Open Days”. Delle giornate di “porte aperte” il cui concetto di fondo è cercare di avvicinare sempre di più, in un’ottica di trasparenza, le istituzioni e la cittadinanza alle infrastrutture del Gruppo. “La giornata di porta aperte organizzata a ottobre nell’impianto di trasporto di Masera, nella provincia piemontese del Verbano Cusio Ossola, ha dato modo alle istituzioni locali e ai cittadini di avere la possibilità di essere guidati dal personale dell’azienda alla scoperta dell’impianto e delle sue caratteristiche e di approfondire il reale impatto sul territorio, andando a costituire un momento di confronto attivo e partecipativo che – spiega la direttrice delle relazioni istituzionali di Snam - può essere intesa come una best practice sulla quale il Gruppo investe molto per rendere partecipe delle nostre scelte una quota sempre più ampia di stakeholder ”.


L’Accademia Reale Svedese delle Scienze ha spiegato che i tre studiosi “hanno contribuito a una ricerca
innovativa su ciò che influisce sulla prosperità economica dei paesi”. Il loro lavoro evidenzia il ruolo critico delle istituzioni politiche ed economiche nell’influenzare l’evoluzione degli standard di vita.
di Ludovica Serra
I vincitori del premio Nobel per l’economia di quest’anno hanno fornito nuove intuizioni sul perché ci sono così grandi differenze di prosperità tra le nazioni. Una spiegazione importante sono le persistenti differenze nelle istituzioni sociali. Esaminando i vari sistemi politici ed economici introdotti dai colonizzatori europei, Daron Acemoglu, Simon Johnson e James A. Robinson sono stati in grado di dimostrare una relazione tra istituzioni e prosperità. Hanno anche sviluppato strumenti teorici in grado di spiegare perché le differenze nelle istituzioni persistono e come le istituzioni possono cambiare.
Il 20 per cento più ricco dei paesi del mondo è ora circa 30 volte più ricco del 20 per cento più povero. Inoltre, il divario di reddito tra i paesi più ricchi e quelli più poveri è persistente; Anche se i paesi più poveri sono diventati più ricchi, non stanno raggiungendo i più prosperi. Perché? I vincitori di quest’anno hanno trovato prove nuove e convincenti per spiegare questo divario persistente: le differenze nelle istituzioni di una società.
Fornire prove a sostegno di ciò non è un compito facile. Una correlazione tra le istituzioni di una società e la sua prosperità non significa necessariamente che l’una sia la causa dell’altra. I paesi ricchi differiscono da quelli poveri in molti modi – non solo nelle loro istituzioni – quindi potrebbero esserci altre ragioni sia per la loro prosperità che per i loro tipi di istituzioni. Forse la prosperità influisce sulle istituzioni di una società, piuttosto che viceversa. Per arrivare alla loro risposta, i vincitori hanno utilizzato un approccio empirico innovativo.
Acemoglu, Johnson e Robinson hanno esaminato la colonizzazione europea di gran parte del globo. Una spiegazione importante per le attuali differenze di prosperità sono i sistemi politici ed economici che i colo-
nizzatori introdussero, o scelsero di mantenere, dal XVI secolo in poi. I vincitori hanno dimostrato che questo ha portato a un’inversione di fortuna. I luoghi che erano, relativamente parlando, i più ricchi al momento della colonizzazione sono ora tra i più poveri. Inoltre, hanno usato, tra le altre cose, i dati sulla mortalità dei colonizzatori e hanno trovato una relazione: maggiore è la mortalità tra i colonizzatori, più basso è il PIL pro capite di oggi. Perché? La risposta è che la mortalità dei coloni – quanto fosse “pericoloso” colonizzare un’area – ha influenzato i tipi di istituzioni che sono state istituite.
I vincitori hanno anche sviluppato un quadro teorico innovativo che spiega perché alcune società rimangono bloccate in una trappola con quelle che i vincitori chiamano istituzioni estrattive, e perché sfuggire a questa trappola è così difficile. Tuttavia, dimostrano anche che il cambiamento è possibile e che si possono formare nuove istituzioni. In alcune circostanze, un paese può liberarsi delle sue istituzioni ereditate per stabilire la democrazia e lo stato di diritto. A lungo termine, questi cambiamenti portano anche a una riduzione della povertà.
Come possiamo vedere le tracce di queste istituzioni coloniali ai giorni nostri? In una delle loro opere, i vincitori usano come esempio la città di Nogales, al confine tra Stati Uniti e Messico.
Nogales è tagliata a metà da una recinzione. Se ti trovi vicino a questa recinzione e guardi a nord, Nogales, Arizona, USA si estende davanti a te. I suoi residenti sono relativamente benestanti, hanno una vita media lunga e la maggior parte dei bambini riceve un diploma di scuola superiore. I diritti di proprietà sono sicuri e le persone sanno che potranno godere della maggior parte dei benefici dei loro investimenti. Le elezioni libere offrono ai residenti l’opportunità di sostituire i politici di cui non sono soddisfatti.
Se invece guardi a sud, vedi Nogales, a Sonora, in Messico. Anche se questa è una parte relativamente ricca del Messico, i residenti qui sono in generale considerevolmente più poveri che sul lato nord della recinzione. La criminalità organizzata rende rischiosa la creazione e la gestione di imprese. I politici corrotti sono difficili da eliminare, anche se le possibilità che ciò accada sono migliorate da quando il Messico si è democratizzato, poco più di 20 anni fa.
Perché queste due metà della stessa città hanno condizioni di vita così diverse? Geograficamente si trovano nello stesso posto, quindi fattori come il clima sono esattamente gli stessi. Le due popolazioni hanno anche origini simili; storicamente, l’area settentrionale era in realtà in Messico, quindi i residenti a lungo termine della città hanno molti antenati comuni. Ci sono anche molte somiglianze culturali. Le persone mangiano cibo
simile e ascoltano più o meno lo stesso tipo di musica da entrambi i lati della barricata.
La differenza decisiva non è quindi la geografia o la cultura, ma le istituzioni. Le persone che vivono a nord della recinzione vivono nel sistema economico degli Stati Uniti, il che offre loro maggiori opportunità di scegliere la loro istruzione e professione. Fanno anche parte del sistema politico degli Stati Uniti, che conferisce loro ampi diritti politici. A sud della recinzione, i residenti non sono così fortunati. Vivono in altre condizioni economiche e il sistema politico limita il loro potenziale di influenzare la legislazione. I vincitori di quest’anno hanno dimostrato che la città divisa di Nogales non fa eccezione. Invece, fa parte di un modello chiaro con radici che risalgono all’epoca coloniale.

Una analisi americana della USC Leonard Davis School of Gerontology della South California cerca di dare risposte su come promuovere un buon
Come saranno gli anni d’oro dei tuoi nonni? Gli anziani di domani avranno stili di vita molto diversi?
Sono alcune delle domande che ci poniamo e che grazie ai progressi nella salute, nella tecnologia, nell’istruzione e altro ancora, trovano alcune risposte. Diversi esperti della USC Leonard Davis School of Gerontology hanno condiviso quelli che ritengono saranno i progressi più importanti per la vita quotidiana in futuro.
A seguito dei successi nel trattamento del cancro, con interventi geneticamente personalizzati, siamo all’apice di nuovi entusiasmanti fronti nella lotta contro altre malattie dell’invecchiamento, con interventi personalizzati basati sulla genomica, afferma Pinchas Cohen, Preside della USC Leonard Davis School. La capacità di capitalizzare le informazioni su grandi set di dati ci consente di iniziare a prevedere chi potrebbe essere a rischio per determinate malattie e di indirizzare di conseguenza gli sforzi di trattamento e prevenzione.
Inoltre, la scoperta di microproteine, comprese quelle codificate nel genoma mitocondriale più piccolo, ha introdotto nuove possibilità per i trattamenti per il diabete, l’obesità e altro ancora.
“Se si pensa a tutto ciò che si sa sulla biologia, la scienza ha cercato in passato di spiegare [tutto] con l’esistenza di 20.000 geni, che è ciò che la gente credeva fino a poco tempo fa fosse il numero di grandi geni nel genoma”, dice Cohen.
“In effetti, le microproteine rappresentano centinaia di migliaia di nuovi geni aggiuntivi recentemente riconosciuti, che rimodelleranno il modo in cui comprendiamo la scienza”.
Comunità: promuovere una vita intergenerazionale
“Le comunità esclusivamente per anziani sono sempre più viste come obsolete. Perdono i numerosi vantaggi di comunità vivaci e diversificate per età”, afferma Paul Irving,
studioso in visita dell’USC Leonard Davis e senior fellow presso il Milken Institute.
“Che tipo di società stiamo costruendo: una società che incoraggia la comprensione, la collaborazione e l’apprezzamento degli altri, o una società che rafforza le divisioni che già sfidano l’America?” Ha chiesto Irving in un’intervista con Rethinking65.com. “Direi che mettere insieme americani più anziani e giovani migliora la vita di entrambe le fasce d’età e, nel mix, aumenta la probabilità di collaborazione, comprensione reciproca e apprezzamento”.
Le comunità intergenerazionali e a misura di anziano promuovono l’interazione tra giovani e anziani, secondo Irving. Le relazioni che ne derivano possono ridurre la solitudine e l’isolamento sociale per entrambe le fasce d’età e migliorare l’intera comunità.
“Credo fortemente nel valore degli ambienti diversi. La diversità è stata la grande forza dell’America, e lo è ancora”, dice Irving. “Sappiamo che la diversità nelle comunità e nelle istituzioni ha un grande potenziale. Ed è tempo di includere l’età nella matrice della diversità. Sono entusiasta di vedere sempre più leader illuminati fare proprio questo: progettare, costruire e pianificare in modo che si integrino diverse razze, culture e coorti di età”.
Risorse finanziarie: tenere conto dell’invecchiamento
Con le persone che non solo vivono più a lungo, ma che lavorano anche più a lungo, e forse intraprendono carriere bis, la pianificazione del proprio futuro finanziario dovrà essere conformata dalla realtà dell’invecchiamento. È qui che entra in gioco la gerontologia finanziaria.
Cynthia Hutchins MAG, direttore della gerontologia finanziaria presso Bank of America, ha dichiarato in un’intervista a Financial Advisor che i gerontologi finanziari sono addestrati a “porre le domande giuste ai loro clienti, le domande più approfondite e personali che
sono al di fuori del regno della finanza”. Ha osservato che prendono in considerazione i problemi di salute, dove loro vogliono vivere, se vogliono continuare a lavorare part-time o come vogliono trascorrere il loro tempo libero.
Attraverso un programma di certificazione lanciato nel 2015 con Bank of America, la USC Leonard Davis School ha insegnato finora questa prospettiva olistica a quasi 1.300 consulenti finanziari. Maria Henke, Senior Associate Dean dell’USC Leonard Davis, ha spiegato a Financial Advisor che i gerontologi finanziari qualificati sanno come esplorare le questioni più profonde riguardanti l’invecchiamento e le finanze, dal chiedere informazioni sui desideri di caregiving al notare potenziali indicatori di demenza o abuso finanziario.
“Quando si consiglia sulle opzioni pensionistiche, come risparmiare trasferendosi in un’altra comunità, un gerontologo finanziario prende in considerazione fattori come il rischio di isolamento sociale, l’accesso all’assistenza sanitaria o le opportunità di un impegno significativo, oltre agli impatti finanziari”, ha detto Henke.
Cibo: diete su misura per la longevità
La crescente spinta per la personalizzazione della medicina basata sulle caratteristiche individuali probabilmente un giorno includerà la nutrizione, consentendo alle persone di imparare quale tipo di dieta si adatta meglio alle loro esigenze specifiche, compresa la loro genetica, afferma il Professor Sean Curran.
“Penso che tutti conoscano qualcuno che ha fatto una dieta alla moda e che ha avuto risultati sorprendenti – e poi allo stesso modo ha provato quella dieta da solo o conosce qualcuno che ha fatto la stessa identica dieta, solo per scoprire che non ha funzionato affatto”, dice Curran. “Il motivo per cui i risultati sono stati diversi è la composizione genetica dell’individuo. Quindi penso che questo sia un nuovo modo di pensare alla medicina personalizzata, ma dal punto di vista della dieta personalizzata. Piuttosto che prescrivere una dieta valida per tutti, [stiamo] osservando la composizione genetica di un individuo e poi un giorno saremo in grado di prescrivergli i tipi di cibo da evitare, o di cui aumentare il consumo su base giornaliera”.
Abbiamo imparato di più sulle caratteristiche generali della dieta ottimale per la longevità, che include parti della dieta mediterranea e di Okinawa e che incorpora una finestra temporale giornaliera di 12 ore per mangiare e raccomanda anche diete periodiche e brevi che imitano il digiuno una manciata di volte all’anno, secondo il professor Walter Longo. Queste raccomandazioni possono essere facilmente adattate agli individui in base al sesso, all’età, allo stato di salute e alla genetica,
aggiunge. Ad esempio, per contrastare la fragilità e la perdita di massa magra, le persone di età superiore ai 65 anni potrebbero aver bisogno di aumentare non solo l’assunzione di proteine, ma anche la varietà di alimenti di origine animale che consumano.
Per le persone che stanno cercando di ottimizzare la loro dieta per la longevità, Longo afferma che è importante lavorare con un operatore sanitario specializzato in nutrizione per personalizzare un piano incentrato su piccoli cambiamenti che possono essere adottati per tutta la vita.
“La dieta della longevità non è una restrizione dietetica destinata solo a causare la perdita di peso, ma uno stile di vita incentrato sul rallentamento dell’invecchiamento e sulla riduzione al minimo della fragilità, che può integrare l’assistenza sanitaria standard e, presa come misura preventiva, aiuterà a evitare la morbilità e a sostenere la salute in età avanzata”, afferma Longo, Professore di Biogerontologia e Direttore dell’Istituto sulla Longevità a USC (University of Southern California) –Davis School of Gerontology di Los Angeles,
Connessione: Realtà virtuale per la socializzazione, l’assistenza sanitaria e altro ancora
Non è solo per i videogiochi: la realtà virtuale e il metaverso potrebbero un giorno avere una miriade di applicazioni importanti per gli anziani.
Il concetto di metaverso è stato reso popolare nel romanzo di fantascienza Snow Crash, di Neal Stephenson, dove il termine si riferisce a un universo digitale a cui è possibile accedere attraverso la realtà virtuale. Questo ambiente digitale può dare agli utenti la sensazione di essere presenti con qualcuno che non è fisicamente non lo sia, qualcosa che ha un’immensa possibilità per gli anziani che stanno vivendo l’isolamento sociale, afferma Dean Pinchas Cohen.
Oltre a dare alle persone la possibilità di incontrare o “viaggiare” con amici e familiari nel metaverso, la ricerca indica che la realtà virtuale ha un potenziale terapeutico per l’ansia, il dolore, la solitudine e altro ancora, afferma Cohen. Se abbinato all’uso di sensori o tecnologia indossabile, può anche creare un ambiente più coinvolgente per l’esercizio cerebrale e la terapia della reminiscenza e può aumentare i servizi di telemedicina.
“Per gli anziani che affrontano sfide di mobilità e perdita di connessioni sociali, la realtà virtuale e il metaverso potrebbero diventare un metodo chiave per rimanere coinvolti con la loro rete sociale e mantenersi mentalmente attivi”, afferma Cohen.
Per gli anziani e la tecnologia, l’accesso è fondamentale
Contrariamente agli stereotipi, gli anziani stanno abbracciando la tecnologia. L’aumento dell’uso di smartphone, tablet e app da parte degli anziani legato alla pandemia è continuato nel 2021, secondo un rapporto sulle tendenze tecnologiche dell’AARP. I dispositivi portati in tasca, indossati al polso e installati nelle case stanno aiutando gli anziani esperti delle tecnologie di oggi a mantenere le connessioni, prevenire le cadute, rimanere attivi, rilevare malattie, ottenere passaggi, ordinare cibo e altro ancora.
Ma l’accesso e l’accessibilità economica impediscono ancora a molti di beneficiare delle innovazioni tecnologiche. La professoressa Kate Wilber sta lavorando per colmare questo divario digitale. Guida un team che valuta gli sforzi del governatore della California Gavin Newsom per espandere l’adozione della tecnologia tra gli anziani. Sta anche esaminando l’uso della telemedicina tra gli anziani a casa e nelle strutture infermieristiche qualificate. Ecco cosa ha imparato finora: la banda larga è essenziale.
“Le persone non solo hanno bisogno di avere un qualche tipo di dispositivo, ma hanno anche bisogno di avere la banda larga, e questa deve funzionare. Abbiamo visto che c’è una mancanza di accesso alla banda larga in alcune
parti degli Stati Uniti, soprattutto nelle aree rurali. Questo è un servizio essenziale e dobbiamo fare un lavoro migliore per fornirlo in tutta la nazione”.
L’hardware non è sufficiente.
“Se dai a qualcuno una scatola con dentro un computer e dici: ‘Ecco, ora navigherai in rete con gli altri’, non lo fa. Come aiutiamo le persone a imparare? Dobbiamo fare un lavoro migliore per aiutare le persone a imparare, compreso il miglioramento delle competenze culturali richieste per i formatori. Dobbiamo anche essere sensibili a una varietà di usi diversi che le persone desiderano. Ciò significa essere centrati sulla persona e coinvolgere le persone che saranno gli utenti finali e capire cosa è più efficace per loro”. Il futuro è luminoso.
“Ci sono così tante innovazioni entusiasmanti che stanno emergendo. Dobbiamo basarci su ciò che stiamo imparando e renderlo migliore e più efficace per aiutare coloro che si trovano dalla parte sbagliata del divario digitale a connettersi”.
* “THREE BEES INNER CIRCLE” ha sede a Washington DC ed è formato da un gruppo chiuso di policy maker internazionali che, attraverso il dialogo socratico, animano il dibattito ed elaborano orientamenti e strategie in merito alle questioni più rilevanti per la società e la politica.

a cura di Emoticon
Mentre le città accettano la sfida delle palestre a cielo aperto offrendo nuovi spazi e infrastrutture per praticare outdoor fitness, c’è chi cerca di valorizzare questa nuova opportunità per la salute, supportando i cittadini nel migliorare i propri stili di vita attraverso l’utilizzo di una app.
È il partenariato del progetto “EMOTICon-NetStakeholders engagement per la creazione di un intervento personalizzato di promozione dell’attività fisica mediato da tecnologia digitale, per un assessment dei bisogni di salute finalizzato alla programmazione sanitaria” finanziato dal Centro nazionale per la prevenzione e il controllo delle malattie del Ministero della Salute e composto da: Agenzia Regionale Strategica per la Salute ed il Sociale - Puglia (Partner coordinatore); Ospedale Specializzato in Gastroenterologia “S. De Bellis”- Castellana Grotte (BA); UOSD Coordinamento Screening - Dipartimento Prevenzione - ASL Roma 2; Sezione di Igiene, Dipartimento “Scienze della Vita e Sanità Pubblica” - Università Cattolica del Sacro Cuore (RM); ATS Città Metropolitana - Milano - UOVR Promozione Salute - DG Welfare.
La app “EMOTICon-Net”, acronimo di “Every Move On Track: I CONnect!”, è al momento nella sua fase di start-up e si basa sul presupposto, comprovato scientificamente, che l’attività fisica agisce come fattore protettivo per numerose malattie non trasmissibili, migliorando il nostro stato di salute dal punto di vista fisico e psicologico.
L’applicazione sarà disponibile entro la fine del 2024 negli store ufficiali. Il suo obiettivo è promuovere uno stile di vita attivo fornendo ai cittadini un programma di allenamento personalizzato e una mappatura di spazi e servizi per consentire di svolgere attività fisica nella propria città, in autonomia e liberamente, in spazi pubblici più o meno attrezzati e dotati di servizi, o in occasioni più strutturate.
L’idea di proporre una app per supportare l’attività fisica outdoor non sarebbe una soluzione così originale, se non fosse che “EMOTICon-Net” ha molte caratteristiche che la rendono unica. Innanzitutto è di proprietà del Ministero della Salute, sviluppata secondo le regole di tutela della privacy e gli standard previsti per le app della Pubblica Amministrazione. In secondo luogo, si attiene agli standard (minuti a settimana) dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) per adulti e anziani. Infine, non solo consente al citta-
dino di muoversi nel proprio territorio compiendo liberamente “un’attività fisica possibile” (quando, dove, come è possibile!), ma offre anche occasioni di attività fisica in compagnia, guidata da professionisti riconosciuti e/o volontari abilitati (i coach).
La nuova app sarà accessibile ai cittadini che avranno compiuto 18 anni, senza limitazioni funzionali e in possesso di SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale). Al suo interno, gli utenti troveranno schede di attività fisica elaborate da professionisti e personalizzate in base alle evidenze scientifiche, video dimostrativi, la mappatura di strutture, servizi per l’attività fisica e attività, mediante la digitalizzazione dell’offerta esistente nei territori delle Unità Operative di Progetto.
Ma come si può valutare e apprendere grazie ad una app come “EMOTICon-Net”? La risposta risiede nel progetto di ricerca associato all’applicazione che mira a ridurre il livello di sedentarietà della popolazione e nello studio che, previa valutazione etica, permetterà di analizzare, in forma anonima e nel totale rispetto della privacy, le abitudini degli utenti riguardo al movimento, così come gli eventuali miglioramenti compiuti verso uno stile di vita più attivo rispetto ad una situazione di partenza indagata con un questionario iniziale.
Gli aspetti misurati riguarderanno: lo Stile di vita (quante persone hanno migliorato il proprio stile di vita?); l’Obiettivo OMS (quanti minuti in più gli utenti hanno fatto movimento rispetto al loro stile di vita iniziale?); l’Auto-valutazione utente (quanti utenti hanno percepito un cambiamento nel proprio stile di vita?); e l’Equità di accesso (siamo riusciti a raggiungere ed includere tanti utilizzatori o abbiamo promosso una app solo per “pochi”?).
L’analisi dei dati collezionati tramite app alimenterà, tra coloro che si interessano di Salute Pubblica, la riflessione sugli interventi necessari a promuovere nella popolazione generale uno stile di vita attivo, attribuendo l’importante connotazione programmatoria allo studio epidemiologico del progetto di ricerca. I risultati ottenuti, infatti, forniranno informazioni utili per lo sviluppo di modelli proattivi di prevenzione e per aumentare la fruibilità degli strumenti a disposizione per una più accurata misurazione degli esiti di salute della popolazione.

Il tema del Planetary Health è di stringente attualità e viene discusso in molti ambiti: politico, sociale, economico, ambientale e, certamente, in quello che riguarda la sanità, la salute e il benessere individuale e collettivo.
Prendendo in prestito le parole di Tanya Steel, direttrice del WWF che dice che “siamo la prima generazione a sapere che stiamo distruggendo la Terra e l’ultima che può fare ancora qualcosa”, sottolineiamo l’urgenza di passare dall’ottica del dire a quella del fare, dando risposte concrete e supporto alle Istituzioni per affrontare in maniera sinergica e concreta il tema del Planetary Health all’interno del nostro Paese.
L’opera di Federico Serra, Direttore Generale del Planetary Health Inner Circle, vuole contribuire e ampliare il dibattito ospitando contributi di pregio di ben 44 esperti e la prefazione del Ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica Sen. Gilberto Pichetto Fratin e del Ministro della Salute Prof. Orazio Schillaci.
Vorrei prendere in prestito le parole di Tanya Steel, direttrice del WWF, la quale afferma: “siamo la prima generazione a sapere che stiamo distruggendo la Terra e l’ultima che può fare ancora qualcosa”. Questo sottolinea l’urgenza di passare dall’ottica del dire a quella del fare, fornendo risposte concrete e supporto alle Istituzioni per affrontare in maniera sinergica e concreta il tema del Planetary Health all’interno del nostro Paese.


L’obiettivo principale di questo libro, è quello comprendere al meglio come le sfide ambientali, quali la crisi climatica, la perdita di biodiversità, l’inquinamento e la deforestazione, possano avere un impatto sulla salute umana, e trovare soluzioni sostenibili per affrontare queste sfide. La salute planetaria si basa sull’idea che la salute delle persone è intrinsecamente legata alla salute dell’ambiente in cui si vive, e quindi è importante adottare un approccio integrato per affrontare le sfide globali che minacciano entrambi.

Salute planetaria: Riflessioni per un futuro sostenibile di Federico Serra Editore LSWR EDRA
Nel marzo di quest’anno, il segretario generale delle Nazioni Unite António Guterres, in occasione della pubblicazione del sesto Rapporto IPCC, era stato inequivocabile chiaro: “In tempi rapidi, il nostro pianeta ha bisogno di un’azione risoluta per il clima, da attuarsi su tutti i fronti –ovunque, e rapidamente”. Ma, chi realizzerà questa azione?
Per Guteress l’umanità è come se fosse seduta su una lastra di ghiaccio sottile – e quel ghiaccio si sta sciogliendo rapidamente, e come spiega il rapporto dell’Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), e gli esseri umani sono responsabili di quasi tutto il riscaldamento globale degli ultimi 200 anni.
Il tasso di aumento della temperatura nell’ultimo mezzo secolo è il più alto degli ultimi 2.000 anni e le concentrazioni di anidride carbonica sono ai massimi da almeno 2 milioni di anni a questa parte.
Dobbiamo essere consapevoli che la bomba a orologeria climatica rapidamente avanza ede è pronta ad esplodere se non facciamo qualcosa di concreto.
Il rapporto dell’IPCC è una guida pratica per disinnescare questa bomba a orologeria climatica, è una guida di sopravvivenza per l’umanità e ci mostra che il limite di 1,5°C è raggiungibile. Ma ci vorrà un salto di qualità nell’azione dei governi e di ogni singolo individuo su tutti i fronti: tutto, ovunque, tutto in una volta.
Il nostro mondo sta affrontando il momento più cruciale e precario da generazioni. Le persone vengono colpite da un cambiamento climatico incontrollabile. Entro il 2050, la popolazione mondiale si avvicinerà ai dieci miliardi. L’azione, o l’inazione, di tutti i Paesi determinerà se ogni membro della nostra famiglia umana potrà vivere in modo sostenibile e pacifico, su un Pianeta sano.
Incremento demografico e crisi climatica, possono diventare una miscela esplosiva in grado di produrre effetti devastanti sul nostro futuro. L’innalzamento delle temperature, dovuto a politiche ottuse da parte di alcuni membri del G20, ovvero le più forti economie del mondo, potrebbe portarci a vere catastrofi naturali e sociali, da dove tornare indietro sarebbe difficile.
Un Pianeta a differenti velocità dove i Paesi più ricchi generano il problema e quelli più poveri ne patiscono le conseguenze.
Nove dei dieci Paesi più vulnerabili dal punto di vista climatico sono nell’Africa subsahariana, la cui popolazione dovrebbe raddoppiare entro il 2050 e dare vita a fenomeni di migrazione climatica incontrollabili e devastanti sui sistemi socio-economici e sulla salute degli individui.
Quando si ragiona di Planetary Health, bisogna essere consapevoli che l’impegno non può essere delegato ma deve coinvolgere tutti noi nell’ottica del bene comune.
A Margaret Mead, grande antropologa americana del novecento, durante una lezione una studentessa le chiese quale fosse secondo lei il primo segno di sviluppo culturale in una civiltà. Probabilmente tutto il pubblico si aspettava che la risposta fosse uno strumento per approvvigionare il cibo, come un amo da pesca o un’arma di pietra per la caccia.
Margaret invece disse che l’origine di una civiltà era in-
dicata dal ritrovamento di un osso fratturato e poi rinsaldato, segno di cura e di attenzione per gli altri.
Tra gli animali una zampa fratturata significa la morte, perché un individuo non può più cacciare, né fuggire da un predatore. Nessun animale, perciò, sopravvive abbastanza a lungo per permettere a un arto di rinsaldarsi.
Al contrario, un femore o un altro osso che è guarito è la prova che un altro individuo ha assistito chi si è infortunato, lo ha aiutato a curare la ferita, l’ha portato in un luogo protetto e lo ha accudito fino alla guarigione.
Quindi il primo segno di una civiltà è l’aiuto reciproco nelle difficoltà.
Dobbiamo imparare da questa osservazione per considerare che il “femore rotto” oggi è la perdita di biodiversità, l’innalzamento delle temperature, il mancato accesso alle cure in molte parti del modo, l’aumento delle zoonosi, tutti fattori che rendono fragile il sistema sociale e che necessitano di una risposta comune.
Il concetto di One Health e la connessione tra mondo umano e quello animale, non è un concetto astratto, ma un fatto concreto che fa si che il contesto dove viviamo è un sistema connesso e globale.
Deve fare riflettere quanti pubblicato recentemente dalla stampa internazionale riguardo uno studio pubblicato su Scientific Report da ricercatori del Development and Evolution of Cognition Research Group, Max Planck Institute of Animal Behavior di Konstanz assieme ai colleghi del Department of Biology, Graduate Program, Faculty of Biology and Agriculture, Universitas Nasional, Jakarta,
Lo studio fa riferimento a quanto osservato da loro nel giugno 2022, quando il team di ricercatori notò un comportamento mai osservato prima nel mondo animale: un orango di Sumatra di nome Rakus si è autocurato una ferita utilizzando una pianta medicinale.
Nel Parco Nazionale Gunung Leuser, una riserva della foresta pluviale sull’isola indonesiana occidentale di Sumatra, gli scienziati hanno sentito dalle cime degli alberi una serie di “lunghi richiami”, un comportamento che di solito rileva nei primati comportamenti di dominanza o aggressività maschile. Il giorno successivo, videro Rakus con una ferita aperta sulla guancia destra, appena sotto l’occhio, segno di una lotta avvenuta all’interno di una colonia di Oranghi.
Giorni dopo, il team ha osservato Rakus mettersi al lavoro, raccogliendo e masticando gli steli e le foglie di










































Akar Kuning ( Fibraurea tinctoria ), o radice gialla. La pianta è una vite rampicante originaria della regione che la popolazione locale utilizza per le sue qualità medicinali per trattare condizioni come il diabete, la dissenteria e la malaria.
Anche se non è certo un alimento base della dieta degli oranghi (il team ha notato che la radice gialla viene mangiata solo lo 0,3% delle volte), Rakus la consumava comunque. Lo masticò anche lui, senza deglutirlo, poi ne sparse i succhi e l’impiastro sulla ferita, dove avevano cominciato ad accumularsi alcune mosche. Rakus tornò alla pianta e la mangiò il giorno successivo, e presto la sua ferita fu completamente guarita.
Isabelle Laumer, autrice dello studio, commentando con National Geographic quanto notato su Rakus, ritiene che questa sua la prima osservazione di un animale selvatico che tratta la sua ferita proprio con una pianta medicinale.
Ci sono voluti cinque giorni dopo il trattamento perché la ferita si chiudesse e gli scienziati non hanno riscontrato segni di infezione dopo un mese. La ricerca sulla chimica della radice gialla ha dimostrato che la pianta ha “proprietà antibatteriche, antinfiammatorie, antifungine, antiossidanti, antidolorifiche e anticancerogene.
E’ difficile comprendere da dove Rakus abbia imparato a curarsi e a riconosce i benefici di una pianta medicinale nel curare la propria ferita e se è qualcosa tramandata all’interno degli esemplari del gruppo.
Quello che colpisce è osservare l’esatta percezione che il primate ha avuto delle proprietà curative della pianta e della tecnica da utilizzare e come curare e prendersi cura non fa parte solo della componente umana.
Allora bisogna comprendere al meglio come le sfide ambientali, quali la crisi climatica, la perdita di biodiversità, l’inquinamento e la deforestazione, possano avere un impatto sulla salute umana, e trovare soluzioni sostenibili per affrontare queste sfide. La salute planetaria si basa sull’idea che la salute delle persone è intrinsecamente legata alla salute dell’ambiente in cui si vive, e quindi è importante adottare un approccio integrato per affrontare le sfide globali che minacciano entrambi.
La Dichiarazione di San Paulo sul Planetary Health del 2021, dice che ogni persona, in ogni luogo, con ogni vocazione, ha un ruolo da svolgere nella salvaguardia della salute del pianeta e delle persone per le generazioni future.
Un invito che raccogliamo e che questo libro, che ha
coinvolto politici, esperti, accademici e ricercatori, vuole trasformare da pensiero in azione, consapevoli che come dice Marshall McLuhan
«Non ci sono passeggeri sulla Nave Terra, Siamo tutti parte dell’equipaggio»
DELL’AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA
Gilberto Pichetto Fratin, Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica
Perché in questo momento storico sentiamo il bisogno, in qualità di accademici, comunicatori, giornalisti e politici, di riflettere su un argomento da cui può dipendere la sopravvivenza della nostra specie e il futuro della vita sul pianeta?
Perché di questo confronto c’è bisogno e ampliare il dibattito sul tema del Planetary Health ospitando contributi di pregio provenienti dal mondo della politica, della medicina, dell’ingegneria e delle scienze ambientali è il modo giusto per guardare alle sfide che abbiamo davanti.
Questo libro accompagna il lettore in un viaggio attraverso le varie fasi che hanno portato alla nascita del tema ambientale sui tavoli internazionali: dalle prime conferenze sul clima fino ad arrivare ai più vicini effetti della globalizzazione, alle abitudini di consumo, il problema dei rifiuti, l’inquinamento nelle grandi aree urbanizzate e i rischi per la salute dei cittadini, la perdita di biodiversità.
Temi complessi, raccontati con un linguaggio semplice e con un approccio multidimensionale che non vuole generare allarmismi, ma lascia al lettore lo spazio per una valutazione autonoma e consapevole del processo di analisi e degli interventi di “problem solving” esposti dai relatori.
L’umanità ha ancora la possibilità di modificare il trend degli ultimi decenni in quanto dispone dei mezzi necessari per fermare l’aumento delle temperature e avviare il processo di decarbonizzazione, come sottolineato durante la “COP28” di Dubai nel 2023 alla presenza delle maggiori potenze energetiche mondiali e ribadito dalla firma della Carta di Venaria durante il “G7 Clima, Energia e Ambiente” di Torino ad aprile 2024.
Per concentrarsi sui pericoli reali legati al cambiamento climatico e all’inquinamento è necessario che tutti i
Paesi mettano da parte le idee del passato che dividevano il mondo in confini politici e interessi economici, adottando un modello di sviluppo sostenibile globale che riduca le emissioni di CO2 e il volume dei rifiuti prodotti grazie all’economia circolare.
Non possiamo permetterci di perdere tempo, perché in gioco c’è la salute dei cittadini e dell’ambiente dove viviamo, quindi la sopravvivenza stessa dell’umanità.
Il Governo ha affrontato questi temi, con la responsabilità di prendere delle decisioni in un momento delicato per il nostro Paese e per la Comunità europea. Da poco usciti dalla pandemia da COVID-19, il rapido peggioramento della crisi in Ucraina scoppiata con l’invasione russa ha portato insieme alle sanzioni internazionali un pericoloso aumento dei prezzi del gas e delle materie prime strategiche, bloccando così le tradizionali vie di approvvigionamento energetico e mettendo in difficoltà l’economia.
Abbiamo diversificato le forniture consolidando i rapporti con nuovi partner commerciali nell’area del Mediterraneo e fatto dei passi importanti verso una transizione energetica che includesse il solare e l’eolico, energie rinnovabili viste non più come semplici alternative al fossile ma come risorse su cui fare affidamento, insieme all’idrogeno e al potenziale ritorno dell’energia prodotta dalle nuove tecnologie legate al nucleare.
In conclusione, questi avvenimenti ci hanno insegnato quanto può diventare fragile l’economia di un Paese, che seppur inserito in un contesto globalizzato ma non mettendo in atto strategie di sviluppo sostenibile nel proprio territorio, avrà difficoltà a rimanere in piedi in caso di necessità.
Su questo punto, l’Italia ha dato dimostrazione di grande resilienza e volontà supportata anche da un uso intelligente dei fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e dalla cooperazione con i partner europei al fine di indicare un percorso verso un futuro sostenibile ed esportare anche un modello semplice da replicare per altri Paesi e realtà extra UE, come stiamo facendo con i Paesi africani nel “Piano Mattei”.
La salute del pianeta, il progresso e il benessere della nostra comunità nazionale non sono cose diverse e separate, ma viaggiano assieme. Questo libro aiuta a vedere quanto sia unica e alta la sfida che dobbiamo sostenere e come ciascuno di noi possa dare il proprio contributo per costruire un domani migliore.
Orazio Schillaci, Ministro della Salute
Come la salute della Terra sia connessa in modo indissolubile alla salute dell’uomo è un tema recentemente conquistato al dibattito pubblico. Allo stesso modo, fa parte della storia degli ultimi anni il modo in cui lo strettissimo rapporto esistente fra la salute umana, quella animale e l’ambiente è diventato il fulcro di quella visione One Health, indicata ormai a livello internazionale come l’approccio integrato necessario per tutelare non solo il nostro benessere, ma la nostra sopravvivenza.
L’evidenza di questi temi, e l’urgenza delle questioni da affrontare alla luce di questa nuova consapevolezza, oggi sono tali da far dimenticare spesso come questo cambiamento culturale sia avvenuto in un tempo tanto ristretto.
Il senso di responsabilità nei confronti delle nuove generazioni e la necessità di costruire la sostenibilità futura del mondo che abiteranno – nonché del servizio sanitario su cui potranno contare – ci chiamano a un impegno forte per modificare le tendenze degli ultimi decenni e per contrastare in modo efficace i rischi per la salute che derivano dall’inquinamento, dalle scelte legate alla produttività e ai consumi, dall’uso inappropriato di farmaci e da stili di vita da correggere. Mai come oggi si è avvertita l’urgenza di un approccio olistico che punti concretamente a una salute globale e che adesso deve trasformarsi da “visione” a vera e propria “strategia”.
Lo stesso concetto di One Health, coniato durante la Conferenza di Manhattan del 2004, quando la Rockefeller University vide riuniti leader mondiali, società civile ed esperti di sanità pubblica, è stato a lungo concepito quasi esclusivamente in termini di connessione tra salute umana e animale. Bisognerà arrivare fino al 2019 perché i “12 Principi di Manhattan” siano aggiornati e ampliati, e poi alla pandemia da COVID-19 che con il suo impatto spingerà ad allargare ulteriormente gli orizzonti.
Questa nuova sfida, di enorme portata, si accompagna al bisogno di un dibattito aperto, in grado di rafforzare le sinergie indirizzate verso una salute circolare. A tale riflessione questo volume fornisce un apporto di idee ampio, con contributi autorevoli provenienti dal mondo della politica, della scienza, della medicina, in un’ottica multidimensionale. Si tratta di una riflessione che oggi può estendersi anche alla pianificazione ur-

bana, territoriale, produttiva e dei trasporti, e che deve interrogarsi su come sfruttare al meglio il potenziale tecnologico e informatico per salvaguardare l’integrità del pianeta.
In questo percorso il Ministero della Salute ha avuto un ruolo quasi pionieristico, affiancando fin dalla sua istituzione la tutela della salute umana e quella veterinaria. Oggi l’approccio One Health sostanzia tutte le nostre politiche e a esso è stata improntata la stessa riorganizzazione del Ministero, che ha previsto l’istituzione di un “Dipartimento per la salute umana, la salute animale e dell’ecosistema (One Health)”. E ancora, è su una visione One Health che si concentra il Piano Nazionale della Prevenzione 2020-2025 così come la Missione 6 Salute del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.


La partita non è però una di quelle che si giocano da soli. Quest’anno, nel corso della Presidenza italiana del G7, l’Italia ha fatto perno su una visione One Health per sollecitare tutti gli Stati su tre priorità di sanità pubblica, connesse al cambiamento climatico, all’inquinamento e alla perdita di biodiversità, all’invecchiamento attivo e alla lotta all’antimicrobico-resistenza. Nel frattempo, progettiamo di strutturare una prima “Survey nazionale One Health” per analizzare l’implementazione delle azioni poste in essere per l’interfaccia salute, ambiente e clima.
Sia a livello nazionale sia internazionale il lavoro è avviato, ma la riflessione deve restare aperta e oltrepassare anche le linee fin qui stabilite, finché non sia raggiunto l’obiettivo della “Salute in tutte le politiche pubbliche”.

Il Piano nazionale integrato per l’energia e il clima (PNIEC) individua gli obiettivi che il nostro Paese dovrà raggiungere al 2030 anche in tema di mobilità sostenibile, definendo, tra i vari target, la percentuale di energia rinnovabile utilizzata nel settore trasporti.
La transizione dei trasporti, pubblici e privati, verso una mobilità sostenibile è complessa. Il GSE promuove lo sviluppo della mobilità sostenibile attraverso diversi meccanismi di supporto che sostengono la riconversione efficiente del parco veicoli, la realizzazione di impianti per la produzione di biocarburanti come il biometano, la realizzazione di infrastrutture di ricarica pubbliche e l’agevolazione alla ricarica dei veicoli elettrici in luoghi non accessibili al pubblico.

Riconosciuto in sede europea come un importantissimo vettore energetico, il biometano sarà nei prossimi anni un attore primario della decarbonizzazione dei settori industriali “Hard to Abate” e del settore dei trasporti. Il D.M. 2 marzo 2018 ha stimolato la realizzazione di 170 nuovi impianti (di cui 104 già in esercizio) per una potenziale capacità produttiva annua di 1,06 miliardi standard metri cubi. In seguito, il D.M. 15 settembre 2022 ha messo a disposizione 1.930 milioni di

euro, gestiti dal GSE attraverso cinque procedure competitive (l’esito della 4^ procedura sarà pubblicato a fine di ottobre), dedicati dal PNRR alla realizzazione di impianti di produzione di biometano (di nuova costruzione o per interventi di riconversione di impianti esistenti a biogas) ricavato da FORSU o da scarti agricoli. L’obiettivo della misura è quello di accrescere la produzione di biometano sostenibile, entro giugno 2026, di ulteriori 2,3 miliardi di metri cubi e garantire al nostro Paese una maggiore indipendenza energetica.
Per supportare la diffusione della mobilità elettrica, grazie ai fondi dedicati dal PNRR alla realizzazione di nuovi punti di ricarica pubblici per veicoli elettrici, nel corso del triennio 2023-2025, il GSE erogherà 744 milioni di euro di incentivi con l’obiettivo di realizzare, entro il 2025, oltre 21 mila infrastrutture di ricarica sulle strade extraurbane e nei centri urbani. Attraverso la prima procedura competitiva sono stati assegnati fondi per la realizzazione di oltre 4.700 nuove infrastrutture di ricarica veloce per veicoli elettrici nei centri urbani italiani. I risultati della seconda procedura saranno pubblicati entro il prossimo 22 novembre.
Sempre in ambito mobilità elettrica, sono stati invece circa 4.500 (duplicando in 8 mesi il numero di richieste pervenute durante la prima fase) gli utilizzatori di un veicolo elettrico che hanno usufruito, grazie alla sperimentazione ARERA-GSE, dell’incremento gratuito di potenza, fino a 6 kW, dell’utenza domestica nella fascia oraria notturna e nei giorni festivi.
Con l’obiettivo di mettere a disposizione degli utenti un censimento completo delle infrastrutture pubbliche di ricarica dei veicoli elettrici, a marzo 2024 è stata inoltre messa online la Piattaforma Unica Nazionale (PUN) dei punti di ricarica sul territorio nazionale promossa dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e realizzata in collaborazione con il GSE e RSE.
La Piattaforma, che in futuro potrà essere integrata anche con i punti di rifornimento di biometano, biocarburanti e idrogeno, geolocalizza i punti di ricarica per i veicoli elettrici distribuiti sul territorio nazionale accessibili al pubblico, fornisce informazioni sulla loro localizzazione, la tipologia di alimentazione, la potenza massima erogabile, il gestore dell’infrastruttura e lo stato del punto di ricarica. La Piattaforma, oltre a garantire un’unica mappatura delle infrastrutture per gli utenti, costituisce un utile strumento per le amministrazioni locali nella pianificazione territoriale e permette uno snellimento del processo autorizzativo di nuove installazioni; per questo è stata messa a disposizione di comuni, province e regioni un’area riservata nella quale è possibile trovare dati, informazioni e indicatori utili a comprendere lo stato della mobilità elettrica. È prevista inoltre l’introduzione di nuove funzionalità, tra cui la possibilità per i Comuni di pubblicare le richieste di installazione di nuovi punti di ricarica.
Le aziende e le Pubbliche amministrazioni che investono nella sostituzione delle flotte aziendali con veicoli a combustione interna alimentati a biometano o a propulsione elettrica possono accedere al meccanismo dei Certificati Bianchi; titoli negoziabili che certificano il conseguimento di risparmi negli usi finali di energia attraverso interventi e progetti di incremento dell’efficienza energetica.
Il GSE si impegna a fare la differenza non solo attraverso la gestione dei meccanismi incentivanti ma anche attraverso la promozione e l’assistenza a cittadini, imprese e PA viaggiando per il territorio italiano a bordo di una macchina a biometano messa a disposizione dal comparto associativo di settore. Ogni spostamento con la macchina a biometano è un passo avanti verso un futuro più sostenibile e un esempio concreto del “si può fare”.
L’impegno comune verso innovazione, inclusione e sicurezza costruendo insieme il futuro

Nel panorama in continua evoluzione della società digitale si dimostra sempre più urgente la trasformazione di cittadini e imprese in attori consapevoli del futuro tecnologico, in linea con le Direttive Europee per l’inclusione e la sostenibilità tese a rendere sempre più efficienti e accessibili i servizi della Pubblica Amministrazione attraverso soluzioni innovative e progetti mirati.
Il Programma Strategico per il Decennio Digitale definisce gli obiettivi concreti per guidare la trasformazione digitale dell’Europa entro il 2030, dove l’80% della popolazione tra i 16 e 74 anni dovranno avere competenze digitali almeno di base.
Le finalità strategiche comprendono:
• una popolazione digitalmente qualificata e inclusa;
• infrastrutture digitali efficienti, sicure e in grado di connettere tutti i cittadini;
• una trasformazione digitale delle imprese per
prendere decisioni migliori, interagire con i propri clienti e migliorare i processi aziendali;
• una modernizzazione della Pubblica Amministrazione con servizi e procedure digitali.
Le aree principali sulle quali si concentra il Programma Europeo riguardano competenze e infrastrutture digitali, digitalizzazione delle imprese e dei servizi pubblici, l’adozione di soluzioni AI per migliorare efficienza, trasparenza, accessibilità e qualità dei servizi offerti a cittadini e imprese, garanzia di elevati standard di sicurezza e affidabilità.
“L’Europa mira a dare maggior forza alle imprese e ai cittadini in un futuro digitale incentrato sulla persona, sostenibile e più prospero.”
(Decennio Digitale Europeo 2030)
Un futuro, quindi, teso al miglioramento della connettività attraverso l’innovazione tecnologica e un accesso inclusivo e sostenibile
Al termine di questo percorso il mondo digitale si baserà su valori comuni, dove tutti i cittadini avranno acquisito le competenze digitali nella vita quotidiana e le imprese utilizzeranno le nuove tecnologie per prendere decisioni aziendali migliori, interagire con i propri clienti e migliorare i processi aziendali.
In questo contesto, per noi è fondamentale continuare ad affiancare i Comuni italiani per contribuire alla costruzione di un ponte con la cittadinanza, migliorando la fruibilità dei servizi attraverso soluzioni digitali avanzate. In un’epoca in cui le città si trasformano sempre più in “Smart City” - territori intelligenti dove i servizi vengono gestiti digitalmente - ci impegniamo nella creazione di una governance più trasparente e partecipata, promuovendo una cittadinanza digitale attiva, inclusiva, consapevole, sicura e in continua evoluzione.

“I cittadini hanno il diritto di accedere a tutti i dati, i documenti e i servizi di loro interesse in modalità digitale.”
(Carta della Cittadinanza Digitale, Legge 07/08/2015, n. 124)
L’Identità Digitale è la chiave per connettersi al futuro: nelle città del 2030 i cittadini accederanno ai servizi pubblici da pc o da device tramite app, effettueranno ogni tipo di pagamento online, potranno apporre la propria firma digitale e ricevere comunicazioni, documenti e atti in modalità digitale. Noi continuiamo a contribuire attivamente alla creazione di una società che garantisca a tutti i cittadini l’accesso, equo e senza ostacoli, alle tecnologie digitali e alle infrastrutture. Privacy, sicurezza informatica e protezione dei dati acquistano sempre maggiore rilevanza in questo percorso: alla base di tutto c’è l’obiettivo di voler promuovere un comportamento etico che preveda l’uso responsabile e rispettoso del digitale al fianco dei Comuni e dell’intera Pubblica Amministrazione.


Chongqing è una città nel sud-ovest della Cina, è la città più grande della regione, con una popolazione di 18 milioni di abitanti nell’area metropolitana. Tecnicamente, la città è la più grande del mondo per il fatto che è anche un comune che racchiude una vasta area rurale. In totale, ospita più di 30 milioni di persone e offre molte cose da vedere e da fare.
La città è costruita sulle colline accanto al fiume Yangtze, densamente affollata con una grande quantità di grattacieli, ancora in continuo sviluppo. Data la limitata disponibilità di suolo, gli urbanisti e gli architetti di Chongqing hanno progettato e inventato molti nuovi modi per risolvere il problema della scarsità di terreno. In questa città molti concetti futuristici sono diventati realtà.
Se fai una passeggiata a Chongqing, troverai molte scene spettacolari che ti sorprendono, molte di queste scene di solito possono essere viste solo nei film o in opere d’arte che raffigurano il mondo futuro.

Una serie di edifici imponenti, tra cui il complesso di Raffles City, hanno attirato l’attenzione negli ultimi anni. Questo famoso complesso è stato progettato dall’architetto di fama mondiale Moshe Safdie e dispone di: 8 torri; 230.000 mq di centro commerciale; 1.400 appartamenti residenziali; 160.000 mq di uffici; 1 hotel di lusso; 1 ponte sospeso di 250 metri soprannominato Crystal.
Lo sviluppo del complesso di Raffle City è costato circa 3,8 miliardi di dollari e si ispira alle tradizionali imbarcazioni a vela cinesi, tracciando un segno impressionante nello skyline di Chongqing. Si trova al centro dell’area urbana della città, arroccato all’incrocio dei due fiumi come una barca ormeggiata.
Mentre la Cina passa dal perseguire una crescita ad alta velocità ad ogni costo a un modello di crescita incentrato su sostenibilità, inclusività ed efficienza, città
come Chongqing sono una parte fondamentale di questa nuova strategia di urbanizzazione.
Un nuovo rapporto della Banca Mondiale intitolato “Chongqing 2035: Spatial and Economic Transformation for a Global City” fornisce un quadro di cinque pilastri strategici per la tr asformazione della città: struttura spaziale, connettività, innovazione, inclusività e crescita verde.
Chongqing deve affrontare molte sfide nel perseguire il nuovo modello di crescita, una delle quali è la sua struttura spaziale e la sua forma urbana sempre più inefficienti. L’urbanizzazione ad alta intensità di consumo di suolo degli ultimi 20 anni ha impoverito l’asset strategico di Chongqing, la sua riserva di terra e ne ha ridotto la densità economica e l’efficienza.
Il rapporto utilizza 30 indicatori per confrontare Chongqing con le città globali secondo quattro dimensioni: 1) struttura spaziale e tessuti urbani, 2) competitività economica, 3) sostenibilità ambientale e 4) inclusione sociale. Gli Scenari di Crescita Urbana sono stati condotti per prevedere le conseguenze del proseguimento delle politiche attuali rispetto all’adozione di un modello di sviluppo compatto e orientato al transito (TOD).
Secondo l’analisi, se Chongqing continua con lo stesso modello di espansione urbana, la sua preziosa riserva di terra di quasi 800kmq potrebbe esaurirsi nei prossimi 20 anni. Tuttavia, un nuovo modello di sviluppo territoriale, se adottato, potrebbe far risparmiare una quantità significativa di terreni, costi infrastrutturali, uso di energia ed emissioni di carbonio.
Di seguito sono riportate alcune delle viste più futuristiche di Chongqing.
IL TRENO PASSA ATTRAVERSO UN CONDOMINIO
Il condominio sottostante non sembra molto particolare per il suo aspetto generale, ma ha un treno che lo attraversa: questa è una caratteristica molto futuristica che di solito si trova solo nei film di fantascienza o nelle opere d’arte. È un metodo efficace per fare spazio al percorso del treno in una città ad alta intensità abitativa. Questo insolito binario ferroviario è costruito direttamente attraverso il 6°-8° piano dell’edificio residenziale di 19 piani, il binario fa parte del Chongqing Rail Transit No.2, e l’edificio ha anche una fermata di transito lì, conosciuta come Liziba Station, i residenti dell’appartamento possono comodamente salire sul treno da lì.
PONTI PEDONALI COLLEGATI AD EDIFICI RESIDENZIALI
Si tratta di un ponte pedonale a 40 metri di altezza da terra, molto più alto dei normali ponti pedonali, non collega due lati di una strada ma può portare i pedoni da un lato di una strada direttamente al 13° piano di un edificio residenziale.
PONTI SOSPESI STRALLATI
CHE COLLEGANO DUE EDIFICI
I ponti strallati non sono sempre sospesi sui fiumi, qui a Chongqing vengono utilizzati per collegare due grattacieli ad alta quota. Questi due ponti strallati si librano ad un’altezza di 68,5 metri, i ponti stessi sono lunghi 23 metri ciascuno e larghi 4 metri. Collegando il 22° piano di un edificio e il tetto dell’altro edificio, sono stati costruiti per la comodità dei residenti e degli inquilini degli uffici.
Le funivie sono solitamente viste in alcuni tipi di attrazioni turistiche come le montagne, qui a Chongqing vengono utilizzate nel trasporto pubblico. Soprannominata Sky Bus, le funivie di Chongqing viaggiano dal distretto di Yuzhong al distretto di Nanan, passando attraverso il fiume Yangtze, la distanza totale è di 2110 metri. Ogni giorno, più di 10 mila persone in città vengono trasferite con questo speciale trasporto.
Nel distretto di Nanan a Chongqing, il tetto di un edificio di 5 piani viene utilizzato come strada, si possono vedere le auto che ci corrono sopra. Il concetto di strade sui tetti degli edifici è stato presentato per la prima volta in una delle opere d’arte visionarie di Hugh Ferriss che raffigurano le città del futuro.
Nell’area di Marble Rock, nel distretto di Nanan, un grande parco giochi è costruito sul tetto di un centro commerciale. Il parco giochi ha una superficie di 17.000 metri quadrati ed è aperto al pubblico gratuitamente.
I grattacieli sono una delle parti più indispensabili del mondo futuro e Chongqing è una città di grattacieli. A partire dal 2021, la città ha quasi 60 grattacieli che superano i 200 metri, 6 dei quali sono superalti (edifici di altezza superiore a 300 m).
Il più singolare di questi grattacieli è un complesso di edifici chiamato Raffles City sul lungofiume Chaotianmen, è composto da 8 torri, due delle quali più alte sono alte 355 metri, le quattro torri adiacenti sono alte 265 metri ciascuna, la caratteristica più significativa è un ponte sospeso super lungo proprio sopra quelle quattro torri.
Il ponte sospeso è lungo 300 metri, collega le torri tra loro, è considerato il ponte sospeso più alto che collega il maggior numero di torri. Il ponte sospeso è progettato per essere curvo e a forma di fisarmonica, comprende un ponte di osservazione, giardini sospesi, piscine e ristoranti. La costruzione dei grattacieli del progetto Raffles City è stata completata nell’agosto 2019 e ha aperto al pubblico nel settembre 2019.
STRADA SUL TETTO DELL’EDIFICIO


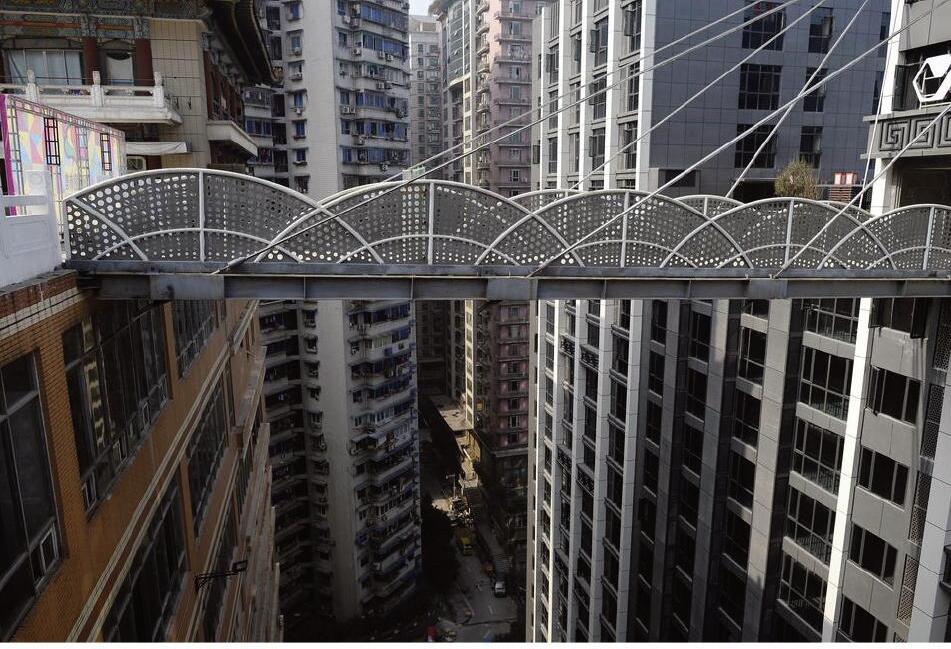


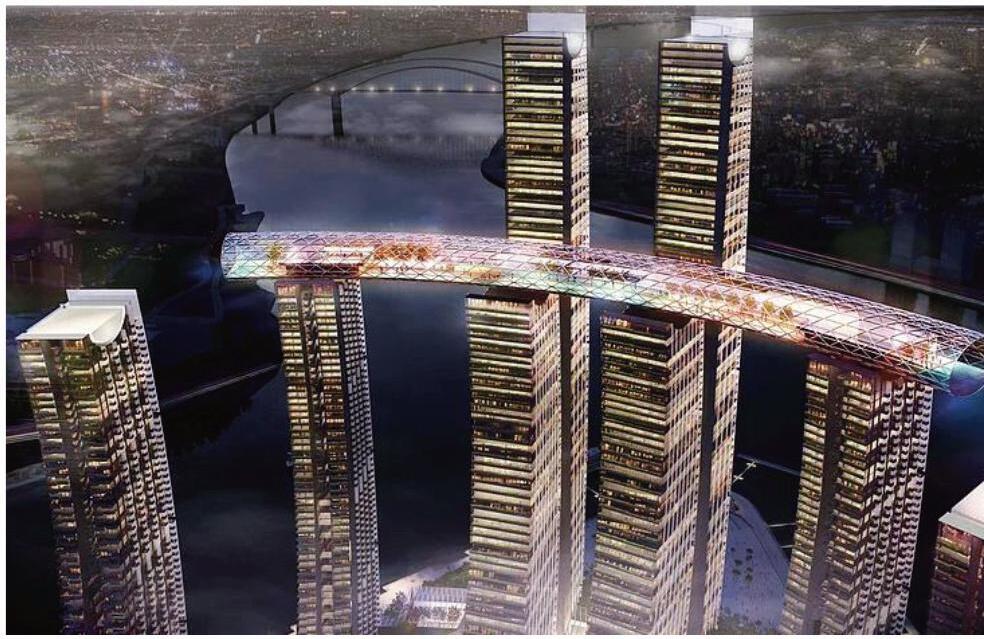


I leader mondiali, riuniti a New York al Palazzo di Vetro delle Nazioni Unite, hanno adottato lo scorso 22 Settembre il Patto per il Futuro - PACT OF THE FUTURE, una dichiarazione storica che si impegna ad agire concretamente per un mondo più sicuro, più pacifico, sostenibile e inclusivo per le generazioni di domani.
I Capi di Stato e di Governo – che rappresentano i popoli del mondo – con il PACT OF THE FUTURE hanno assunto 56 impegni d’azione volti a proteggere i bisogni e gli interessi delle generazioni presenti e future in mezzo ai cambiamenti climatici, alle crisi e ai conflitti che attualmente attanagliano il globo.
Nei primi mandati del Patto, l’Assemblea si è impegnata a intraprendere azioni coraggiose, ambiziose, accelerate, giuste e trasformative per attuare l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile e a porre l’eliminazione della povertà al centro degli sforzi in tal senso.
In altri termini, i leader mondiali si sono impegnati a colmare il divario di finanziamento dell’Obiettivo di Sviluppo Sostenibile (SDG) nei paesi in via di sviluppo, a garantire che il sistema commerciale multilaterale continui a essere un motore per lo sviluppo sostenibile e ad accelerare la riforma dell’architettura finanziaria internazionale per rafforzare la voce e la rappresentanza dei paesi in via di sviluppo. L’Assemblea si è inoltre impegnata a riformare il Consiglio di sicurezza, riconoscendo l’urgente necessità di renderlo più rappresentativo, inclusivo, trasparente, efficiente, efficace, democratico e responsabile. Il Patto contiene anche termini relativi all’uguaglianza di genere e all’emancipazione di tutte le donne e le ragazze, nonché l’impegno a promuovere, proteggere e rispettare i diritti umani di tutti i giovani.
Inoltre, il patto ha due allegati, il primo dei quali, il Global Digital Compact, delinea gli obiettivi di colmare tutti i divari digitali; promuovere uno spazio di-
gitale inclusivo, aperto, sicuro e protetto che rispetti, protegga e promuova i diritti umani; e il rafforzamento della governance internazionale dell’intelligenza artificiale. Nel secondo allegato – Dichiarazione sulle generazioni future – l’Assemblea ha adottato una serie di principi guida, impegni e azioni per promuovere la stabilità, la pace e la sicurezza internazionali e per garantire società pacifiche, inclusive e giuste, affrontando nel contempo le disuguaglianze all’interno e tra le nazioni e le esigenze specifiche dei paesi in via di sviluppo, nonché delle persone in situazioni vulnerabili.
“Il nostro futuro è nelle nostre mani”, ha sottolineato Philémon Yang (Camerun), Presidente dell’Assemblea Generale alla sua settantanovesima sessione, dopo l’adozione del Patto. Il documento rappresenta un impegno ad affrontare le crisi immediate e a gettare le basi per un ordine globale sostenibile, giusto e pacifico per tutti i popoli e le nazioni. Sottolineando la necessità di garantire un futuro in cui la pace trascenda la mera assenza di conflitti e sia fondata sulla giustizia, l’inclusione e l’equità, ha affermato che un progresso significativo richiede che tutte le voci siano ascoltate e che tutte le nazioni, indipendentemente dalle dimensioni o dalla ricchezza, abbiano un posto al tavolo.
António Guterres, segretario generale delle Nazioni Unite, ha poi osservato di aver invocato il Vertice del Futuro “perché il nostro mondo sta andando fuori dai binari” poiché “le risorse che potrebbero portare opportunità e speranza sono investite nella morte e nella distruzione”. Affermando che la comunità internazionale ha “aperto la porta” adottando il Patto e i suoi allegati, ha esortato: “Ora è nostra responsabilità comune attraversarlo”. Alla fine, tuttavia, “ci reggiamo e cadiamo non adottando accordi, ma con le nostre azioni e il loro impatto sulla vita delle persone che serviamo”, ha concluso.
Le cinque grandi aree di interesse del Patto includono:
sviluppo sostenibile; la pace e la sicurezza internazionale; scienza e tecnologia; giovani e le generazioni future e la trasformazione della governance globale.
Approvando il Patto, gli Stati membri delle Nazioni Unite si sono impegnati, tra l’altro, a:
Ad accelerare gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDG) e all’Accordo di Parigi sui cambiamenti climatici, due accordi fondamentali del 2015 che hanno visto arrestare i progressi e mancato le tappe. Ascoltare i giovani e coinvolgerli nel processo decisionale, a livello nazionale e globale. Costruire partenariati più solidi con la società civile, il settore privato, gli enti locali e regionali e altro ancora. Raddoppiare gli sforzi per costruire e sostenere società pacifiche, inclusive e giuste e affrontare le cause profonde dei conflitti. Proteggere tutti i civili nei conflitti armati. Accelerare l’attuazione dei nostri impegni in materia di donne, pace e sicurezza.
Patto digitale globale
Il Global Digital Compact segna il primo vero accordo mondiale sulla regolamentazione internazionale dell’intelligenza artificiale (AI) e si fonda sull’idea che la tecnologia debba andare a vantaggio di tutti.
Delinea gli impegni per garantire che le tecnologie digitali contribuiscano allo sviluppo sostenibile e ai diritti umani, affrontando nel contempo rischi come i divari digitali, la sicurezza informatica e l’uso improprio della tecnologia.
Il patto mira a colmare il divario digitale e a garantire che le tecnologie di IA siano utilizzate in modo responsabile, promuovendo la cooperazione globale sia sulle capacità di IA che sulle minacce alla sicurezza. I governi sono inoltre obbligati a formare un gruppo scientifico mondiale imparziale sull’IA e ad avviare un dibattito internazionale sulla governance dell’IA all’interno delle Nazioni Unite.
Dichiarazione sulle generazioni future
La Dichiarazione sulle generazioni future si concentra sulla garanzia del benessere delle generazioni future, sottolineando anche la necessità di includere i loro interessi nei processi decisionali.
Sottolinea inoltre l’importanza di proteggere l’ambiente, promuovere l’equità intergenerazionale e garantire che siano prese in considerazione le conseguenze a lungo termine delle azioni odierne.
di Federico Serra
Un grande riconoscimento per l’Health City Institute è stato comunicato dall’University College of London, con la pubblicazione, come case study globale, nel report HEALTH INCLUSIVITY IN ACTION il progetto italiano che riguarda l’Health City Manager, sviluppato da HCI, con ANCI, grazie al sostegno del Dipartimento per le politiche giovanili del Governo.
Nel 2022 vi è la prima pubblicazione da parte di Economist Impact dell’Inclusivity Index (Indice di inclusività sanitaria). L’Indice è il primo benchmark globale al mondo che valuta gli sforzi dei governi per garantire che una buona salute sia accessibile a tutti.
Nel 2022, FASE UNO ha esaminato la politica sanitaria nazionale e le infrastrutture di 40 paesi per valutare l’inclusività dei loro sistemi sanitari, concentrandosi su tre aree politiche: salute nella società, sistemi sanitari inclusivi e persone ed empowerment della comunità.
La seconda fase, pubblicata nel novembre 2023, ha evoluto la metodologia di ricerca e include le informazioni di oltre 42.000 persone per comprendere meglio le loro barriere ed esperienze durante l’ottenimento dell’assistenza sanitaria, prima di confrontarle con la valutazione delle politiche stabilita nella prima fase.
Per raggiungere un mondo più sano ed equo, l’inclusività sanitaria è diventata un principio fondamentale sul quale puntare. Mentre la lotta per l’assistenza sanitaria e per le risorse che promuovono la salute persiste in tutti i paesi e le comunità, alimentata da una miriade di sfide socioeconomiche, culturali e strutturali, il report evidenzia storie che illustrano il potere dell’azione creativa e cooperativa per superare anche le disparità sanitarie profondamente radicate. Il casebook 2024 intreccia narrazioni provenienti da tutto il mondo, evidenziando come le varie sfide dell’inclusività sanitaria siano state affrontate con creatività, determinazione e unità. Utilizzando spunti tratti dall’Health Inclusivity Index di Economist Impact, come misura completa dell’accessibilità e della reattività del sistema
sanitario, questi casi di studio forniscono una comprensione dettagliata delle complessità nel raggiungimento dell’equità sanitaria. Ogni studio è un faro che illumina soluzioni tangibili ed efficaci strategie che hanno smantellato con successo le barriere all’inclusività sanitaria. Dalle innovative iniziative sanitarie basate sulla comunità agli interventi politici trasformativi, queste storie stimolanti esemplificano i diversi approcci e gli sforzi collaborativi essenziali per creare sistemi sanitari inclusivi. È importante sottolineare che il casebook va oltre la semplice documentazione: offre raccomandazioni politiche attuabili basate sulle lezioni apprese e sulle revisioni di risultati e impatto. Basate su esempi di vita reale e guidate dai principi di equità, le raccomandazioni forniscono una tabella di marcia per i decisori politici, i professionisti sanitari e le parti interessate per apportare cambiamenti significativi a livello locale e globale. Per raggiungere l’inclusività sanitaria è necessario un approccio olistico che affronti i determinanti sociali della salute, promuova l’inclusività nell’erogazione dell’assistenza sanitaria e favorisca le partnership intersettoriali. Condividendo queste narrazioni, i loro successi e le sfide, si punta a raggiungere l’aspirazione di avere una equità sanitaria reale.
L’inclusività sanitaria non è un gioco che non porta a niente di concreto; in realtà, è esattamente l’opposto. Promuovere una migliore cura di sé e per più persone, guida la resilienza dei sistemi sanitari, migliorala produttività e rafforza il contratto sociale. Comprendendo meglio le esperienze vissute da parte di coloro che cerchiamo di aiutare, possiamo superare i pregiudizi e diventare agenti per l’inclusività sanitaria.
Sebbene le stime varino, è ampiamente accettato che l’accesso all’assistenza sanitaria rappresenti solo circa il 10% della salute di una popolazione, mentre il resto è influenzato da fattori socioeconomici più ampi.
L’esperienza di salute di ogni individuo è profondamente modellata dalle sue circostanze uniche quindi
dobbiamo prima riconoscere e comprendere le barriere esistenti alla salute e al benessere, siano esse fisiche, socioeconomiche o sistemiche, prima di lavorare attivamente per smantellarle. Le barriere ben definite includono disabilità, età, razza, etnia, genere e sessualità, mentre fattori meno visibili come solitudine, limiti di tempo, assistenza o disabilità nascoste, hanno anch’essi un impatto sulla salute.
Questo riconoscimento per Health City Institute costituisce la pietra angolare del nostro approccio alla promozione dell’inclusività della salute in un mondo in cui la salute e l’accesso all’assistenza non dovrebbero essere determinati dall’identità, dai privilegi o dalla situazione di vita di una persona. Per comprendere e promuovere veramente l’inclusività della salute, dovremmo affrontare questa complessità con sfumature, riconoscendo che non è un gioco a somma zero, ma piuttosto un viaggio collaborativo in cui tutti possono guadagnare. Tutti possono, da una prospettiva sociale, economica o sanitaria, diventare vulnerabili, come abbiamo imparato durante la pandemia di Coronavirus. Tuttavia, bisogna agire per rimuovere le barriere personali, sociali, culturali e politiche che impediscono a individui e alle comunità di godere di una buona salute fisica e mentale e di una vita pienamente realizzata, può significativamente mitigare tali vulnerabilità nel lungo periodo.
Promuovere l’inclusività della salute va oltre l’affrontare le disparità; si tratta di riconoscere la ricchezza della diversità umana e il suo contributo al nostro benessere collettivo. L’inclusività sanitaria è cosa significhi chiedere uguaglianza e agire in modo equo, ma insiste an-
che sul fatto che questi obiettivi siano sempre mediati da una comprensione di chi è, e chi non è, incluso nella condivisione delle risorse, nei processi decisionali, nell’implementazione delle politiche, e così via. Questo approccio è sia giusto che pragmatico, poiché non possiamo migliorare la salute e il benessere della comunità e della società senza includere tutti i membri dove si trovano, al contrario di dove pensiamo che dovrebbero essere.
Pensare in modo inclusivo è un impegno continuo - è un percorso segnato da progressi incrementali.
Pensare in modo inclusivo accetta e considera le esperienze vissute e ci invita non solo a chiederci cosa colma il divario tra le differenze nelle nostre realtà biologiche e socioeconomiche, ma a comprendere e affrontare come le persone vengono escluse, perdono i diritti connessi alla salute e diventano invisibili nel processo. Dando vita al concetto di inclusività sanitaria attraverso esempi globali come “punti luminosi”, si spera di garantire rilevanza, suscitare interesse e mobilitare l’azione, e contribuire a rendere l’inclusività sanitaria una realtà per tutti.
Una inclusività sanitaria applicata, uno strumento per ispirare il dialogo politico e l’azione verso sistemi sanitari più inclusivi a livello globale, l’indice di inclusività sanitaria di Economist Impact affronta l’assenza di dati assemblando una base di prove internazionale per aiutare i decisori politici, gli enti regolatori, gli accademici e altri professionisti a lavorare verso una maggiore inclusività sanitaria per tutti.

Trasformare la conoscenza per il Futuro dell’Africa
Il Prof. Patrizio Bianchi, portavoce della rete delle Cattedre UNESCO in Italia (ReCUI), ha partecipato al Forum “ Transforming Knowledge for Africa’s Future”, che si è tenuto ad Addis Abeba dal 30 settembre al 2 ottobre 2024.

Il Forum, organizzato dall’Unione Africana insieme all’UNESCO, ha coinvolto principalmente le novecento Cattedre UNESCO presenti in tutto il mondo, tra cui le 45 Cattedre UNESCO italiane, con l’obiettivo di rinforzare la ricerca interdisciplinare e collaborativa in Africa e il partenariato di ricerca tra i Paesi del sud e tra questi e il resto del mondo.
L’evento è stato aperto dalla Presidente della Repubblica di Etiopia, Sahle-Work Zewde, che ha ricordato il vantaggio per il mondo intero di uno sviluppo economico e democratico dell’Africa, che può avvenire però solo sulla base di un rapporto paritario con gli altri Paesi, senza nuove sudditanze o nuovi colonialismi. Lo stesso vale per la ricerca scientifica, troppo a lungo dominata dalle istituzioni del Nord globale.
Il Prof. Bianchi nel suo intervento ha presentato il grande lavoro che le Cattedre italiane, riunite in ReCUI, stanno compiendo in Africa da molto tempo e che è stato raccolto nel volume “Empowering higher education in Africa”, la cui presentazione è prevista il prossimo 18 ottobre a Roma. Bianchi ha anche ricordato che le Nazioni Unite hanno indicato il prossimo decennio come Decennio internazionale della Scienza per lo Sviluppo Sostenibile. Richiamando la forza dell’educazione per trasformare il mondo, filo con-


delle Nazioni Unite, e la nuova Racco, ha evidenziato l’urgenza di impegnarsi non genericamente in direzione di una Decade della Scienza, ma più efficacemente in una Decade of Science for Peace, e ha auspicato infine una convergenza fra Unione Africana ed Unione Europea, per stabilire un asse diretto sui temi della pace, della democrazia e dello sviluppo
G7 Meeting on Research Cooperation AfricaG7 di Trieste


Il 2 ottobre il Prof. Patrizio Bianchi, Portavoce ReCUI, ha preso parte al primo tavolo di discussione a Trieste sulle politiche pubbliche per lo sviluppo e la cooperazione fra G7 e l’Africa nel campo della ricerca. Lo stesso 2 ottobre si è tenuto il G7 dedicato ai rapporti in materia di ricerca ed alta formazione fra i paesi africani ed Italia, Francia, Germania, il Regno Unito, Stati Uniti, Canada e Giappone, che ancora si definiscono Grandi Economie.
Nella sua relazione ha portato con sé – essendo il solo fra i presenti che aveva partecipato anche alla riunione di Addis Abeba - non solo i risultati dell’incontro Unione Africana-Unesco, ma soprattutto i sentimenti di un’Africa che non vuole rimanere schiacciata fra la crescente pressione cinese ed il monopolio digitale americano, e contestualmente la richiesta all’Europa di giocare un ruolo propositivo, assumendosi le responsabilità di una cooperazione effettiva e paritaria per costruire un percorso reale di pace e sviluppo.
Proprio le università europee, i centri di ricerca pubblici e privati, le scuole possono oggi giocare il ruolo di piattaforma di quel dialogo con l’Africa, che diviene tanto più necessario in una fase in cui si stanno ridisegnando i rapporti globali. Tuttavia, l’Unione Europea deve investire di più in ricerca, educazione e cooperazione scientifica internazionale.
Anche a Trieste è stato ricordato che la ReCUI sta lavorando intensamente per esplicitare in tutte le sue forme una dimensione etica dello sviluppo, proprio perché così profondamente impegnata nel presentare percorsi di pace e di educazione alla pace, dando così corpo e sostanza alle Raccomandazioni Unesco all’educazione alla pace che lega la costruzione della pace ai diritti umani, alla comprensione fra nazioni, alla sostenibilità ambientale, sociale ed umana dei processi di crescita, che altrimenti rischierebbero di rimanere un rilevante dichiarazione di principio, ma non quella guida allo sviluppo su cui si é tanto lavorato.
giorno per giorno
La sfida per raggwiungere la neutralità climatica entro il 2050 si gioca e si vince nelle città. Queste ultime sono cresciute in maniera consistente: il 2007 è stato l’anno in cui, a livello mondiale, la popolazione urbana ha superato per la prima volta quella rurale. In particolare, dal 2007 al 2024 i residenti nelle aree urbane sono saliti ulteriormente, raggiungendo il 58,3%, con la previsione che tale quota si attesti a circa il 70% entro il 2050: una percentuale che in Italia potrebbe essere ancora più alta, superando l’80%. Il futuro della popolazione sembra quindi essere legato alle città ed è proprio qui che risiede la più grande opportunità di intervento per contribuire alla transizione ecologica, come evidenziato dal Position Paper “Sostenibilità Urbana. Decarbonizzazione, elettrificazione e innovazione: opportunità e soluzioni per città future-fit” realizzato da TEHA Group in collaborazione con A2A e con il contributo scientifico di ASviS.
Questo trend di urbanizzazione crescente comporta una sfida cruciale: bilanciare la crescita economica con la sostenibilità ambientale e il miglioramento della qualità della vita dei cittadini. Le città svolgono infatti un ruolo di catalizzatore economico e sociale, considerando che i 112 comuni capoluogo italiani oggetto dello studio – che coprono il 7% della superficie nazionale – consumano il 29% del totale energetico nazionale ma generano il 60% del PIL nel Paese.
Grazie alla loro densità e alla loro efficienza intrinseca, nelle città si creano economie di scala che le rendono ecosistemi ottimali alla lotta contro il cambiamento climatico. Le emissioni di CO2 nei capoluoghi del Paese possono essere più che dimezzate attivando alcune leve attualmente disponibili, come l’installazione di impianti fotovoltaici, la mobilità elettrica, le pompe di calore , il teleriscaldamento, il relamping, l’uso circolare dei rifiuti e il verde urbano. Un pacchetto di soluzioni che prevede un fabbisogno di investimenti annuali pari a 10 miliardi di euro, per un totale di 270 miliardi fino al 2050: questi fondi possono arrivare da un mix in parte di investimenti pubblici, in parte dalle utility e in parte dai privati. I grandi player industriali, come A2A, hanno in questo contesto un ruolo chiave come partner abilitatori, contribuendo a rendere possibili questi interventi.
Nello studio sono state inoltre individuate sette città in cui si stanno già portando avanti progettualità per accrescere la qualità della vita e il livello di sostenibilità: Milano, Brescia, Messina, Bergamo, Varese, Cremona e Cosenza. Questi esempi concreti mostrano come le città italiane possano essere protagoniste di una trasformazione verso una maggiore sostenibilità. Un processo che, come evidenziato dal Gruppo e da TEHA, richiede uno sforzo coordinato tra tutti gli stakeholder – amministrazioni pubbliche, operatori privati e cittadini – con l’obiettivo comune di creare città future-fit, in grado di garantire una migliore qualità della vita per tutti i cittadini.
Il percorso verso città sostenibili è quindi già avviato, ma c’è ancora molto da fare: solo attraverso investimenti consistenti, innovazione tecnologica e collaborazione a livello nazionale e internazionale sarà possibile ridurre significativamente le emissioni e contribuire in modo decisivo agli obiettivi di neutralità climatica previsti entro il 2050.


di Paolo Ciani
Deputato, Presidente dell’Intergruppo parlamentare sull’invecchiamento attivo
La nostra società, rispetto alla media degli altri Paesi europei, presenta una forte tendenza all’invecchiamento demografico ormai sempre più evidente. Gli ultimi dati ci dicono che l’Italia sia uno dei paesi in Europa più colpiti da questo trend: il 23% degli abitanti ha più di 65 anni, collocando il nostro Paese ai vertici dell’Europa per età media della popolazione, molto più alta di Germania e Francia. Inoltre, assistiamo non solo all’invecchiamento della popolazione ma anche ad un forte calo della natalità: nel 2022 abbiamo raggiunto il tasso di natalità più basso della storia, con meno di 7 nati per 1.000 abitanti.
Questo scenario non può non imporre una riflessione sociale e politica sul ruolo degli anziani nelle nostre società, una riflessione urgente che ponga gli anziani al centro di un dibattito che non li identifichi come soggetti passivi e inutili.
La nostra società sembra valutare le persone, le loro esperienze e competenze, solo sulla base della produttività economica che ne può conseguire: non appena si conclude il periodo di attività lavorativa, si pensa che concluda così anche la vita e il contributo sociale delle persone stesse. Si tratta di una forma di “mercificazione” che porta a vedere gli anziani esclusivamente come un peso sulle spalle del nostro sistema di welfare, piuttosto che come risorse attive imprescindibili del nostro tessuto sociale.
Dal 2008, durante gli anni di crisi, gli anziani sono stati il primo ammortizzatore sociale per sostenere le famiglie, i giovani e i nipoti. Sono anche la nostra memoria storica, la testimonianza di anni difficili, di guerra e povertà, che è fondamentale tramandare alle giovani generazioni. La scomparsa prematura di migliaia di anziani durante la pandemia da Covid-19 ce lo ha drammaticamente ricordato insieme alla necessità di tutelare le parti più fragili della nostra società, senza cedimenti a logiche di altro tipo.
Una società a prova di anziano è infatti una società a prova di tutti. Per questo è fondamentale avere cura anche della fragilità che si manifesta in tante forme nell’età anziana o, ancora meglio, nell’età “grande” come l’ha definita mons. Vincenzo Paglia per indicare quella parte di vecchiaia avanzata che i geriatri indicano come “quarta età”.
Invece di abbandonarci alla cultura dello scarto, così definita da Papa Francesco, dobbiamo investire in un cambiamento politico che valorizzi il ruolo degli anziani nella comunità e che permetta loro di continuare a contribuire con la propria esperienza e competenza.
Per questi motivi è nato l’intergruppo parlamentare sull’invecchiamento attivo, di cui sono Presidente; la vecchiaia non deve essere interpretata come un momento di declino e isolamento: l’invecchiamento attivo considera l’anzianità come una fase della vita in cui non solo è possibile continuare a mantenere un ruolo attivo nella società ma è necessario per prevenire future situazioni di isolamento, marginalizzazione e solitudine, garantendo una buona qualità della vita. Tutto ciò nel più totale rispetto dalla persona e delle sue libere determinazioni, che è necessario salvaguardare. In questa prospettiva gli stessi fondamentali aspetti sanitari e assistenziali vanno considerati solo come una parte delle politiche verso la terza età, evitando quindi di essere l’unica dimensione in cui l’anziano viene considerato.
In questo senso, le città rappresentano un ottimo ambiente di riferimento per mettere in pratica attività di prossimità e promuovere l’invecchiamento attivo. Proprio quest’anno, il cohousing ‘Casa Nino’ di Roma Capitale ha compiuto due anni; un progetto virtuoso di coinvolgimento attivo di anziani con fragilità, per contrastare la solitudine e dare loro la possibilità di vivere una buona socialità e convivenza. In questa sede gli anziani non sono abbandonati a sé stessi ma coinvolti in attività quotidiane, dalle pulizie alla preparazione dei pasti. Oltre a rappresentare una alternativa alle resi-

denze sanitarie assistenziali, alle case di riposo e all’istituzionalizzazione in generale, i cohousing come Casa Nino rappresentano un valido modello di assistenza residenziale sociosanitaria. L’Assessorato alle Politiche Sociali di Roma Capitale è stato autore di importanti attività a sostegno degli anziani anche grazie alla collaborazione con gli sportelli sociali di Farmacap, tra cui le visite culturali sul fiume Tevere, durante l’estate appena trascorsa, che hanno coinvolto 400 anziani; gite che per molti di loro hanno rappresentato l’unico momento di vacanza e di socialità durante i caldi mesi estivi.
Gli anziani non sono uno scarto sociale, non vanno isolati e abbandonati, sono una risorsa e in quanto tali vanno protetti e ascoltati. L’invecchiamento attivo fornisce una nuova chiave di lettura dell’anzianità; una chiave di lettura necessaria nel contesto di calo demografico e invecchiamento della popolazione in cui ci troviamo. Le città sono e saranno sempre di più in futuro il contesto in cui rendere concreto il concetto di invecchiamento attivo, attraverso azioni di prossimità e buone pratiche per promuovere il benessere degli anziani e il loro coinvolgimento – i progetti di Roma ce lo dimostrano – e costruire società e comunità più coese, inclusive e meno individualiste. Ne abbiamo bisogno tutti.

di Marco Trabucchi
Presidente
dell’Associazione
Italiana di Psicogeriatria
Il titolo, che incorpora il concetto di “suoi” nell’affrontare da parte dalla città le debolezze che frequentemente accompagnano la vita della persona anziana, dichiara apertamente un criterio di appartenenza privilegiata di chi non è più giovane ad una comunità di cura, colta, attenta, curiosa, accogliente, generosa, concreta.
La città è un insieme complesso di dinamiche umane che interagiscono e che nel loro insieme creano vita; però è anche il luogo dove tanti non riescono ad entrare nella ricchezza di ciò che si muove e restano testimoni desolati di quello che avviene attorno a loro. Povertà, solitudine, malattie, non autosufficienza creano le condizioni per cui alcuni cittadini non riescono a restare a galla rispetto alle dinamiche umane ed economiche. Sono bisognosi di cura da parte della città attenta alla sofferenza profonda di chi richiede cure delicate, costanti, impegnative.
Da non molti anni le collettività hanno preso coscienza della responsabilità verso le persone anziane, in particolare quelle sole, che rappresentano larga parte di chi non è più giovane e verso la loro sofferenza psicologica e somatica. Contemporaneamente è anche cresciuto il livello di attenzione della medicina, che guarda alle conseguenze sulla salute degli eventi psico-sociali, perché ha compreso che la cura è tale solo se si rivolgere allo stesso tempo al dolore della carne e a quello dello spirito. La città che cura deve quindi costruire progetti che aiutino la crescita di una convivenza di attenzioni reciproche.
L’individualismo diffuso rallenta le possibilità di un intervento collettivo in favore della persona che hanno
bisogno del calore e della concretezza degli atti di cura. Inoltre, le più moderne tecnologie della comunicazione non facilitano la formazione di relazioni significative, concentrando l’attenzione su rapporti privi della possibilità di incidere nel profondo. In questa realtà faticosa la città che cura deve creare ponti tra i cittadini, andando a scoprire in particolare le nicchie di sofferenza silenziosa. Una città deve essere curiosa: la curiosità è premessa indispensabile per un vero approccio di cura. Talvolta la privacy è un ostacolo a chi vuole avvicinare l’altro per prendersene cura, ma la città deve costruire ambienti e atmosfere dove si riducono le barriere, le ritrosie, la mancanza reciproca di fiducia. Le persone anziane spesso si curano poco di sé stesse, perché ritengono inutile qualsiasi tentativo di migliorare la propria condizione; hanno uno stile di vita scostante, chiuso, polarizzato su sé stesse, senza desideri e speranze di cambiamento. La città si dovrà occupare di questi aspetti, impostando cure generose, fatte di accompagnamento, sollecitudine verso i problemi di ogni giorno, lenendo, ove possibile, la mancanza di speranza. Una città che non voglia essere solo un agglomerato di individui chiusi nelle loro case, impauriti per un domani incomprensibile, non abbandona gli anziani che da soli non sono in grado di uscire dalla loro condizione, spesso disperata. Però oggi vi sono anche segnali positivi; nelle città si muovono individui e gruppi impegnati per ridurre la sofferenza e la solitudine di tanti anziani. Le città incominciano a comprendere che devono essere incubatrici benevole di queste generosità, che a loro volta le rendono più umane.
Capolongo S, Rebecchi A, Mangili S, Design & Health Lab, Dipartimento ABC, Politecnico di Milano
L’invecchiamento della popolazione è un fenomeno globale che sta rapidamente trasformando la demografia delle città. Entro il 2050, si prevede che oltre il 34% della popolazione italiana sarà composta da persone di età superiore ai 65 anni. Parallelamente, l’urbanizzazione continua a crescere: già oggi oltre il 55% della popolazione mondiale vive in aree urbane, e questa percentuale è destinata ad aumentare fino al 70% nel 2050. Queste due tendenze impongono una riflessione profonda su come le città dovranno evolversi per garantire che l’ambiente costruito risponda ai bisogni di una popolazione sempre più anziana. L’età media della popolazione è in forte aumento, ad oggi gli over 65 rappresentano il 23,5% della popolazione, ma entro il 2050 potrebbero arrivare fino al 34,9%.
Le città, tradizionalmente progettate per una popolazione giovane, attiva e sana, devono ora affrontare nuove sfide. In primo luogo, l’architettura e l’urbanistica devono adattarsi per promuovere l’invecchiamento attivo. Questo significa creare spazi che non solo siano accessibili, ma che stimolino anche la partecipazione sociale e il benessere psicofisico degli anziani. Le barriere architettoniche devono essere fortemente ridotte: aree pedonali, parchi, edifici pubblici e trasporti devono essere facilmente fruibili da chi ha ridotte capacità non solo motorie ma anche sensoriali, cognitive e psichiche.
L’ambiente costruito gioca un ruolo cruciale nella salute pubblica. Una città ben pianificata può prevenire l’insorgenza di patologie legate all’invecchiamento, come le malattie cardiovascolari, il diabete e la depressione. Spazi verdi accessibili e sicuri, percorsi pedonali adeguati e la disponibilità di servizi sanitari di prossimità sono elementi fondamentali. Inoltre, l’integrazione della tecnologia smart e dell’intelligenza artificiale nei contesti urbani offrirà sempre più soluzioni innovative: la digitalizzazione consentirà il monitoraggio della salute degli anziani e l’integrazione con sistemi di
emergenza rapidi e intuitivi.
Un altro aspetto fondamentale è rappresentato dalle condizioni abitative. La maggior parte degli anziani abita in unità immobiliari di proprietà, con più di 50 anni (il 54,9%) e spesso con impianti non adeguati in materia di sicurezza e con barriere architettoniche. Pertanto, le città devono promuovere modelli abitativi flessibili e adattabili, come le senior housing dotate di tecnologie che facilitano la vita quotidiana e migliorano la sicurezza. Allo stesso tempo, la progettazione di quartieri intergenerazionali, dove giovani e anziani possano convivere e sostenersi reciprocamente, può contribuire a creare un tessuto sociale più coeso e solidale.
La pianificazione urbana deve anche affrontare la questione dell’isolamento sociale, un problema che colpisce molti anziani e che può avere gravi ripercussioni sulla loro salute mentale. Le città del futuro dovranno promuovere l’inclusione attraverso la creazione di spazi di incontro, la promozione di attività culturali e ricreative e il rafforzamento delle reti di supporto sociale.
Guardando al futuro, l’equilibrio tra densità urbana e qualità della vita diventerà sempre più delicato. La sfida sarà quella di conciliare la crescita urbana con la necessità di creare ambienti salutari e inclusivi per tutti i cittadini, indipendentemente dalla loro età. Questo richiederà un approccio integrato, che coinvolga architetti, urbanisti, esperti di salute pubblica e la comunità stessa. L’invecchiamento della popolazione urbana può essere visto anche come un’opportunità per ripensare le nostre città, attraverso una pianificazione attenta e inclusiva, che crei ambienti che non solo rispondano ai bisogni degli anziani, ma che promuovano una società più equa, sana e sostenibile per tutti. Le città del futuro dovranno essere luoghi in cui l’età non rappresenta una barriera, ma un elemento di forza e coesione.
di Eleonora Selvi
Presidente Fondazione Longevitas
La trasformazione demografica in atto sta rapidamente modificando il volto delle città moderne. Entro il 2050, il numero di persone di età superiore ai 60 anni dovrebbe raddoppiare, raggiungendo i 2,1 miliardi a livello globale, secondo i dati delle Nazioni Unite. Questo cambiamento richiede un ripensamento del design urbano per rispondere alle esigenze della popolazione anziana, promuovendo il concetto di città “agefriendly”. Il concetto di città age-friendly si basa sull’idea di creare ambienti urbani che non solo siano accessibili e sicuri per gli anziani, ma che promuovano anche il loro benessere e la partecipazione sociale. L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha lanciato nel 2007 il “Global Age-Friendly Cities Project”, un’iniziativa volta a incoraggiare le città di tutto il mondo a sviluppare infrastrutture e servizi che rispondano alle esigenze degli anziani. Attualmente, l’OMS coordina la Rete Globale di Città e Comunità Age-Friendly, che comprende più di 1.000 città in 41 paesi. Tra le caratteristiche chiave delle città age-friendly secondo l’OMS vi sono: la disponibilità di spazi pubblici accessibili, il trasporto pubblico inclusivo, il supporto alla partecipazione sociale e culturale, e servizi sanitari adeguati. Diversi esempi di buone pratiche emergono da città che hanno adottato il modello agefriendly. New York City, ad esempio, ha implementato il programma “Age-Friendly NYC”, che include iniziative come la creazione di spazi pubblici sicuri e facilmente accessibili, l’adattamento delle abitazioni per renderle più sicure per gli anziani e la promozione di attività sociali e culturali per la popolazione anziana. In Europa, Copenhagen è stata riconosciuta come una delle città più avanzate nell’implementazione di politiche age-friendly. La città ha investito nella costruzione di piste ciclabili sicure e nell’accessibilità del trasporto pubblico, rendendo più facile per gli anziani muoversi autonomamente. Inoltre, il programma “Co-
penhagen Aging Society” prevede la creazione di spazi comuni e iniziative sociali che favoriscano l’inclusione degli anziani nella vita comunitaria. Tokyo, che affronta una delle sfide demografiche più significative con una popolazione anziana in rapido aumento, ha sviluppato il piano “Tokyo Vision 2020”, che mira a rendere la città più accessibile attraverso la modernizzazione delle infrastrutture e l’integrazione di tecnologie intelligenti, garantendo la presenza di ascensori in ogni stazione della metropolitana e introducendo persino l’uso di robot assistenti per aiutare gli anziani nelle attività quotidiane. Alcuni elementi che possono apparire trascurabili a uno sguardo poco attento ma che invece rappresentano punti cardine per la vivibilità di una città da parte delle persone più anziane o con particolati esigenze di salute, possono apparire in tutta la loro significatività solo coinvolgendo i gruppi e le popolazioni interessate nella progettazione degli spazi urbani. Ad esempio la disponibilità di toilette pubbliche pulite e accessibili è un elemento cruciale per la vivibilità di una città, soprattutto per la popolazione anziana. A Tokyo, per citare uno dei casi più noti, l’impegno per garantire toilette moderne e ben mantenute in luoghi strategici migliora significativamente l’autonomia e la qualità della vita degli anziani. Queste strutture non solo offrono un servizio essenziale, ma riducono anche l’ansia legata alla possibilità di trovare servizi igienici adeguati, facilitando la partecipazione degli anziani alla vita sociale e permettendo loro di muoversi liberamente per la città. La stessa Tokyo, tuttavia, così all’avanguardia su tanti fronti, appare fortemente deficitaria su un altro fronte, con la sua pressoché assoluta mancanza di panchine. Queste, ove presenti, sono strutturate con braccioli di separazione per far sì che le persone non possano sdraiarsi. Si tratta di un classico esempio di “architettura/design ostile”, ovvero finalizzato a rendere impossibile la permanenza dei senzatetto, come parte



Siamo una multinazionale farmaceutica fondata nel 1923 in Europa, con sede a Copenaghen e presenti in Italia dal 1981.
La nostra mission è guidare il cambiamento per sconfiggere le malattie croniche non trasmissibili basandoci sulla nostra solida esperienza nel campo del diabete. Lo facciamo promuovendo la ricerca scientifica e l’innovazione, lavorando per prevenire e curare tali malattie.




Nel 2024 Novo Nordisk ha ampliato e rafforzato l’impegno per la promozione della Salute urbana lanciando il programma Cities for Better Health.
L'iniziativa promuove un approccio olistico alla Salute e al Benessere della popolazione attraverso lo sviluppo di soluzioni innovative e sostenibili volte alla promozione di stili vita sani, dell’attività fisica e di una alimentazione corretta: tutti elementi cruciali nella prevenzione e gestione delle malattie croniche.




Il progetto vede coinvolti 23 milioni di cittadini, il 40% della popolazione Italiana
Città partner
Aree metropolitane
Focus regionale

8 città global partner
14 Città metropolitane + di 70 comuni

di una strategia di una società quale quella giapponese, diventata sempre più dura nei confronti dei suoi membri più vulnerabili. Questa strategia impatta in modo molto negativo sulla possibilità di spostamento delle persone più anziane, ma anche di altre categorie, come i disabili, le donne incinta, le persone con particolari esigenze di salute, generando una contraddizione in una società peraltro attenta alle esigenze degli anziani come quella giapponese. Sono, in conclusione, molteplici i bisogni di cui tener conto nella progettazione di una città “lenta”, amica, ed age-friendly, ovvero di un contesto che, come dimostra lo studio condotto dalla Harvard University e pubblicato sul Journal of Urban Health, risulta atto non solo a migliorare la qualità della vita degli anziani, ma anche la salute e il benessere generale della popolazione urbana. Il rapporto evidenzia che infrastrutture accessibili e opportunità di partecipazione sociale riducono l’isolamento e migliorano la salute mentale degli anziani. Un altro studio significativo proviene dall’University College London (UCL), che ha pubblicato su The Gerontologist un’analisi comparativa delle politiche age-friendly in diverse città europee. Lo studio indica che le città che adottano politiche integrate, coinvolgendo attivamente gli anziani nella pianificazione urbana, ottengono risultati migliori nel miglioramento della qualità della vita per i loro cittadini anziani. Le città age-friendly offrono dunque un quadro per promuovere inclusione, sicurezza e benessere, assicurando che le città non siano solo luoghi di residenza, ma anche spazi di partecipazione attiva e vita comunitaria, spazi vivibili e sostenibili non solo per le persone di età più avanzata, ma per tutte le generazioni.
Harvard University. (2018). Age-Friendly Cities and Communities: A Global Perspective. Journal of Urban Health
Buffel, T., Phillipson, C., & Scharf, T. (2019). Ageing in urban environments: Developing age-friendly cities. The Gerontologist, 59(4), 667-678.
World Health Organization (WHO). (2007). Global Age-friendly Cities: A Guide. Geneva: WHO Press.
Chi si prenderà cura degli anziani? Dall’Italia al Giappone spazio ai robot, Il Sole 24 ore, 6 giugno 2024

di Johann Rossi Mason
Per la prima volta nella storia dell’umanità convivono insieme 5 o 6 generazioni contemporaneamente, tanto da aver reso necessario definire vere categorie anagrafiche: dai grandi anziani ai boomers, sino alle generazioni successive indicate con X, Y, Z e Alfa. Un arco temporale che supera spesso gli 80 anni e che pone questioni di risorse, sopravvivenza e mentalità. Generazioni che sembrano chiudersi in sé stesse ed erigere muri per difendere diritti e doveri, che parlano linguaggi differenti, si alimentano e vivono in modo diverso e non hanno contatti significativi se non quelli più strettamente familiari.
Eppure, qualcosa sta cambiando: si è compreso che solo il dialogo tra le generazioni può abbattere le barriere e mettere a fattor comune conoscenze ed esperienze. Un dialogo necessario e prezioso, riconosciuto anche dall’ONU come utile a conseguire due obiettivi dell’Agenda 2030: lavoro dignitoso e crescita economica (obiettivo 8) e riduzione delle disuguaglianze (obiettivo 10).
Il segreto? Adottare la ‘circolarità’ nelle relazioni e superare la logica della competizione per le risorse, la conoscenza, i posti di lavoro. Una collaborazione al centro di progetti come C*Gens acronimo di Circular Generations che ha l’obiettivo di creare reti umane sostenibili. Siamo abituati a ‘gettare’ le conoscenze e le competenze nel momento della pensione, come se non servissero più. Mentre possono essere ‘riutilizzate’ e messe a disposizione delle nuove generazioni.
Uno scambio bidirezionale, perché le società non possono fare a meno dell’apporto dei giovani per crescere anche grazie al pensiero creativo, alla capacità di innovare, allo sguardo non contaminato sul mondo. Giovani

che scontano un divario demografico se pensiamo che a causa dei trend negativi di natalità, gli adulti in Europa sono tre volte più numerosi degli under 25. Questo sta portando ad un mondo sempre più ‘adultocentrico’ dove i giovani sono considerati inadeguati e gli anziani ormai inutili. E in cui un nucleo di adulti detiene il controllo e le redini del mercato e della politica. Ha contribuito alle ‘ostilità’ la disparità a livello occupazionale e contrattuale tra generazioni, la crisi del sistema pensionistico, il passaggio da un mondo caratterizzato da contratti a tempo indeterminato al precariato.
Nello stesso luogo di lavoro convivono persone che hanno raggiunto posizioni, privilegi e status quo che non vogliono cedere e giovani a cui viene rinfacciata una fisiologica mancanza di esperienza. Ma ad entrambi manca qualcosa: ai più grandi l’aggiornamento tecnologico, la flessibilità mentale e ai ragazzi l’esperienza che acquisiranno sul campo. Anche se va detto che i giovani del 2000 sono mediamente più preparati e istruiti con competenze in ambito digitale che li rendono ‘appetibili’.
Il capitalismo ha acceso una competizione sfrenata per le risorse disponibili, ma anche la società è cambiata: le famiglie sono sempre più nucleari e i nonni sono sempre più impegnati o lontani. La continuità di rapporto tra generazioni e lo scambio continuo tra di esse non è più quotidiano ma occasionale. Eppure, in passato le generazioni avevano un continuo scambio di informazioni e competenze e uno scambio di esperienze che servono esattamente a accorciare le distanze culturali e storiche.
54
Già nel 2021 la Commissione Europea pubblicava il Libro verde sull’invecchiamento demografico con l’intento di promuovere la solidarietà e la responsabilità tra le generazioni. L’approccio adottato considera l’intero ciclo di vita, data la crescente flessibilità tra istruzione, lavoro e pensione. “È necessario trovare un equilibrio tra sostenibilità del sistema di protezione sociale e rafforzamento della solidarietà intergenerazionale per affrontare l’invecchiamento della popolazione. La demografia è diventata una priorità per l’UE e, nel 2020, la Commissione ha evidenziato i cambiamenti demografici concentrandosi sul potenziamento di invecchiamento attivo e apprendimento permanente” scrivono.
Un invecchiamento fatto di realtà diverse tra loro, da un lato il numero di persone anziane in buona salute è ad un record storico. Più persone rispetto al passato restano attive per più tempo, prolungano la carriera lavorativa e partecipano ad attività sociali dopo il pensionamento. Grazie a stili di vita più sani e ai progressi della medicina (miglioramento della prevenzione, della diagnosi e della cura delle malattie), la maggior parte dei pensionati è in forma e può scegliere il modo in cui trascorrere il proprio tempo (dati Eurostat Ageing Europe 2019). Queste nuove realtà cambiano la percezione dell’invecchiamento, facendo luce sull’importante contributo che gli anziani apportano alla società e all’economia attraverso l’apprendimento e la coesione intergenerazionali.
Ma nello stesso gruppo anagrafico un over 65 su 4 ha almeno due malattie croniche all’attivo. Ciononostante, gli anziani rappresentano una risorsa per la società: il 28% è attivo nel fornire aiuto a familiari e amici, il 17% è un caregiver, il 31 % delle donne presta attività di volontariato. Solo il 10% riferisce che la propria salute
vada ‘male’ o ‘molto male’ e un altro 10% accusa limitazioni a causa di problemi psicologici e uno su 4 ha un problema sensoriale con limitazione di vista, udito o masticazione. Sono, comprensibilmente, preoccupati dalla vulnerabilità che può precedere la perdita di autonomia (interessa il 32% degli over 85).
Ma le vere malattie sono la solitudine e l’isolamento: il 16% non ha avuto alcun contatto con l’esterno (neppure telefonico) nella settimana precedente e il 75% non frequenta luoghi di aggregazione (dati Passi D’Argento, ISS). È quanto diffuso in occasione della Giornata Mondiale delle persone anziane che si celebra il 1° ottobre di ogni anno. “Quasi un anziano su 7 vive isolato” ha dichiarato il Presidente dell’ISS Rocco Bellantone “un cerchio di solitudine che è necessario interrompere anche per migliorare salute e qualità della vita”. Una condizione che risente di determinanti sociali: l’isolamento sociale infatti è più frequente tra chi ha un basso livello di istruzione (24% rispetto al 10% dei più istruiti) e maggiori difficoltà economiche (27% rispetto all’11% di chi ha redditi superiori).
Lo scambio intergenerazionale non deve essere inteso solo come utile al mondo del lavoro, ma alla cultura e ad una società più nuova e inclusiva che abbia al centro la varietà dei punti di vista e le visioni. Una idea? Creare Biblioteche umane che facciano parlare le generazioni e favoriscano lo scambio al di fuori dei social network. Iniziative che potrebbero essere valutate come crediti formativi per gli studenti e bonus per l’assistenza informativa e il superamento del ‘digital divide’ agli anziani, in un circolo virtuoso che avvantaggi tutti ma soprattutto la comunità.
di Francesca Romana Gigli
giornalista scientifica e co - CEO di Leeloo Informazione e Comunicazione con il supporto scientifico del Prof. Giovanni Fabbrini, Direttore del Dipartimento di Neuroscienze Umane di Sapienza Università di Roma
La Malattia di Parkinson è una patologia neurodegenerativa che colpisce prevalentemente la popolazione anziana, causando difficoltà motorie e cognitive, oltre a influenzare profondamente lo stato psicologico del paziente. E’ caratterizzata dalla perdita di neuroni dopaminergici nella substantia nigra, una parte del cervello che controlla il movimento. Il Parkinson non solo può provocare tremori, rigidità muscolare e difficoltà nel movimento, ma influisce anche sull’equilibrio psicologico e sulla qualità della vita dei pazienti. Con l’età avanzata, la malattia tende a progredire più rapidamente, intensificando i sintomi fisici e l’impatto psicologico, rendendo particolarmente difficile mantenere una vita attiva e socialmente connessa.
Le persone anziane affette da Parkinson non affrontano solo le difficoltà motorie, ma anche una serie di sintomi psicologici e demenza. Studi hanno evidenziato che una percentuale significativa dei pazienti sviluppa depressione, ansia e apatia, che aggravano ulteriormente il loro stato di salute fisica e mentale. La depressione è spesso sotto-diagnosticata nei pazienti, ma rappresenta una delle complicanze più debilitanti, influenzando la motivazione e la capacità di affrontare la malattia.
L’isolamento sociale è un altro fattore chiave che peggiora lo stato psicologico. La perdita progressiva di mobilità rende difficile partecipare ad attività sociali, portando molti pazienti a ritirarsi dalla vita comunitaria. Questo isolamento può aumentare il rischio di patologie psicologiche, creando un circolo vizioso che indebolisce ulteriormente il paziente.
Difficoltà Quotidiane
Le sfide quotidiane che i pazienti anziani con Parkinson incontrano sono numerose. Tra queste, la difficoltà nel camminare, la rigidità muscolare e i tremori rendono complesse anche le attività più semplici come vestirsi, mangiare o spostarsi autonomamente.
L’instabilità posturale può portare, inoltre, a cadute aumentando così la paura di uscire di casa impedendo alla persona con Parkinson la partecipazione ad attività all’aperto.
Le difficoltà cognitive, la bradicinesia e i deficit di attenzione, possono ostacolare la capacità di pianificare o risolvere problemi, aumentando la dipendenza dai caregiver o dai familiari. Il deterioramento cognitivo, se presente, aggrava ulteriormente lo stato di salute psicologica, rendendo il paziente sempre più vulnerabile.
Potenziale dei Luoghi Pubblici per il Supporto
Creare situazioni di incontro nei parchi o in luoghi pubblici può rappresentare una risorsa importante per il benessere psicologico e sociale dei pazienti anziani con Parkinson. La possibilità di incontrare altre persone, specialmente se affrontano la stessa condizione, offre un’opportunità unica di supporto reciproco e scambio di esperienze. La partecipazione ad attività all’aperto o gruppi di cammino potrebbe aiutare a migliorare non solo la salute fisica, ma anche a combattere il senso di isolamento e solitudine.
Interventi sociali che incoraggino la creazione di gruppi di supporto informali nei parchi o luoghi pubblici favoriscono una rete sociale più forte, riducendo i sentimenti di esclusione e favorendo l’interazione tra pazienti, caregiver e comunità. Le attività all’aperto possono migliorare l’umore, ridurre l’ansia e aumentare la motivazione a mantenere uno stile di vita attivo.
La gestione della Malattia di Parkinson negli anziani, quindi, non può limitarsi al trattamento farmacologico. È necessario un approccio olistico che includa supporto psicologico e sociale. Creare spazi d’incontro e promuovere attività all’aperto può ridurre il senso di isolamento e migliorare la qualità della vita. Gli sforzi collettivi per sviluppare iniziative pubbliche che integrino i pazienti con Parkinson nella vita comunitaria sono essenziali per affrontare le sfide della malattia.
di Lucio Corsaro e Gianluca Vaccaro

Introduzione
Nel cuore di una rivoluzione tecnologica senza precedenti, due mondi apparentemente distanti si stanno incontrando in modo sempre più significativo: quello degli anziani e quello dell’intelligenza artificiale (IA). Questa convergenza non è solo un fenomeno interessante da osservare, ma rappresenta una delle sfide più cruciali e potenzialmente trasformative del nostro tempo. Da un lato, abbiamo una popolazione che invecchia rapidamente in molte parti del mondo, portando con sé sfide uniche in termini di assistenza sanitaria, inclusione sociale e qualità della vita. Dall’altro, abbiamo l’ascesa vertiginosa dell’intelligenza artificiale, una tecnologia che promette di rivoluzionare ogni aspetto della nostra esistenza, dalla medicina alla mobilità, dalla comunicazione all’intrattenimento.
L’intersezione di questi due mondi solleva domande fondamentali: Come può l’IA migliorare la vita degli anziani? Quali sono i rischi e le preoccupazioni etiche da considerare? Come possiamo garantire che questa
rivoluzione tecnologica sia inclusiva e benefica per le generazioni più anziane?
Per dare risposta a queste domande ed esplorare in profondità queste questioni, in questo articolo riportiamo alcuni dei dati rilevati tramite l’Osservatorio Scenario Salute di BHAVE . Esamineremo le applicazioni pratiche già in uso, le potenziali innovazioni future e le considerazioni etiche che abbiamo rilevato. Inoltre, discuteremo le politiche necessarie per garantire che questa rivoluzione tecnologica sia veramente al servizio di tutti, indipendentemente dall’età.
Nel corso di questa esplorazione, diventerà chiaro che il rapporto tra anziani e IA non è semplicemente una questione di adattamento tecnologico, ma un profondo riesame di come vogliamo invecchiare come società e di quale ruolo vogliamo che la tecnologia giochi in questo processo. È una conversazione che riguarda tutti noi, poiché tutti aspiriamo a invecchiare con dignità, indipendenza e un senso di connessione con il mondo che ci circonda.
1OSSERVATORIO SCENARIO SALUTE di BHAVE, raccogliamo ed analizzato un enorme mole di dati quali-quantitativi relativamente ai comportamenti di tutti coloro che gravitano intorno al sistema sanitario (cittadini, operatori sanitari, pazienti, payor, politici, stakeholder, etc…) per cogliere i diversi contributi utili a comprendere il tema di come evolverà il sistema sanitario italiano, oltre a rilevare la conoscenza e percezione degli italiani relativamente al proprio stato di salute e delle diverse patologie correlate. Sulla base dei dati che raccogliamo utilizziamo l’intelligenza artificiale per integrare le informazioni a disposizione con lo scopo di comprendere le problematiche connesse alla salute. Infine, attraverso l’analisi comportamentale e sociale individuiamo il framework concettuale alla base delle scelte di salute degli stakeholder e degli italiani. Specificatamente nel periodo Maggio-Settembre 2024, anche attraverso la somministrazione di un questionario sia online sia telefonico (della durata di 20-30 minuti), abbiamo rilevato informazioni e dati relativamente al livello di conoscenza, percezione e relazione degli italiani nei confronti dell’Intelligenza artificiale. La dimensione del campione era 2.455 casi. Il campionamento per quote rileva che 29% dei rispondenti rientrava nella fascia di età over 65 anni, in questo articolo riportiamo l’analisi di alcuni dei dati emersi relativamente a questa fascia di età.
Mentre ci imbarchiamo in questo viaggio di scoperta, è essenziale mantenere una prospettiva equilibrata, riconoscendo sia il potenziale trasformativo dell’IA sia le legittime preoccupazioni che accompagnano il suo rapido sviluppo. Solo attraverso un dialogo informato e inclusivo possiamo sperare di plasmare un futuro in cui la tecnologia arricchisca veramente la vita di tutte le generazioni.
Il contesto demografico: l’invecchiamento della popolazione
Il mondo sta invecchiando a un ritmo senza precedenti. Secondo le Nazioni Unite, entro il 2050, una persona su sei nel mondo avrà più di 65 anni, rispetto a una su undici nel 2019. Questo cambiamento demografico, noto come “invecchiamento della popolazione”, sta ridisegnando il tessuto sociale ed economico delle nostre società, portando con sé sfide significative ma anche opportunità uniche. L’invecchiamento, purtroppo, spesso porta con sé una serie di fragilità che possono compromettere significativamente la qualità della vita:
1. Fragilità fisica: Con l’avanzare dell’età, il corpo diventa più vulnerabile a malattie croniche, problemi di mobilità e declino cognitivo. Molti anziani si trovano a dover gestire condizioni multiple, che richiedono cure costanti e spesso complesse.
2. Fragilità economica: Nonostante i sistemi pensionistici, molti anziani si trovano in difficoltà economiche, specialmente in paesi con sistemi di welfare meno sviluppati. L’aumento dei costi sanitari e l’aspettativa di vita più lunga possono esaurire i risparmi di una vita.
3. Fragilità sociale: La perdita di ruoli sociali, il pensionamento e la scomparsa di amici e familiari possono portare a un restringimento della rete sociale degli anziani, aumentando il rischio di isolamento.
4. Fragilità psicologica: La combinazione di cambiamenti fisici, perdite personali e cambiamenti nel ruolo sociale può portare a problemi di salute mentale come depressione e ansia.
La solitudine: una pandemia silenziosa
Tra tutte queste fragilità, la solitudine emerge come una delle sfide più insidiose e pervasive. Spesso descritta come una “pandemia silenziosa”, la solitudine tra gli anziani ha raggiunto livelli allarmanti. Il 38% degli anziani intervistati si sente regolarmente solo. La solitudine (e il senso di solitudine) è associata a un aumento del 50% del rischio di demenza e a un aumento del 30% del rischio di malattie cardiache e ictus. L’isolamento sociale può accelerare il declino cognitivo e aumentare il rischio di mortalità prematura. Le cause della solitudine sono molteplici: la perdita del partner
(61% dei rispondenti), la distanza geografica dai familiari (82%), la ridotta mobilità (49%), la mancanza di opportunità di socializzazione (27%) e, sempre più spesso, il divario digitale che può escludere gli anziani da forme moderne di connessione sociale (39%). Degno di nota è che il 66% degli anziani intervistati dichiara di avere un account Facebook, il 29% Instagram ed il 23% tiktok.
Il 100% degli intervistati possiede un cellulare, di cui il 21% possiede un IPhone 9 o superiore.
Il 67% utilizza il computer con regolarità (una o due volte al giorno).
Il 47% vede al meno un film o un episodio di una serie in streaming online, di cui il 56% direttamente su cellulare.
Il 39% vede almeno 3 ore di televisione al giorno.
Il potenziale dell’IA nel contrastare fragilità e solitudine
È in questo contesto di vulnerabilità e isolamento che l’intelligenza artificiale emerge come una potenziale alleata. L’IA, con la sua capacità di processare grandi quantità di dati, apprendere e adattarsi, offre soluzioni innovative per affrontare molte delle sfide legate all’invecchiamento:
1. Assistenza sanitaria personalizzata: Sistemi di IA possono monitorare costantemente i parametri vitali, prevedere potenziali problemi di salute e personalizzare i piani di cura, riducendo la fragilità fisica. Il 9% degli intervistati dichiara di avere in casa assistenti virtuali tra questi il più diffuso è il tele salvavita Beghelli.
Caso di studio: IBM Watson Health e Assistenza agli Anziani
IBM Watson Health ha collaborato con diverse organizzazioni sanitarie per migliorare l’assistenza agli anziani. Un esempio notevole è la partnership con Avamere Family of Companies, un fornitore di assistenza agli anziani negli Stati Uniti.
- Implementazione: Watson analizza dati provenienti da cartelle cliniche elettroniche, sensori ambientali e dispositivi indossabili.
- Risultati: Il sistema è in grado di prevedere il rischio di cadute, identificare primi segni di infezioni del tratto urinario e altre condizioni comuni negli anziani.
- Impatto: Riduzione del 60% delle cadute e diminuzione del 50% delle ospedalizzazioni non pianificate.
2. Supporto cognitivo: Applicazioni basate sull’IA possono stimolare l’attività mentale, aiutare nella gestione della routine quotidiana e fornire assistenza per com-
piti complessi, contrastando il declino cognitivo. Ciò non di meno tra gli intervistati gli strumenti più diffusi per mantenere in attività la mente sono il cruciverba (60% degli intervistati), la lettura di libri cartacei (il 35% degli intervistati ha letto un libro nell’ultimo anno), dedicarsi ad un attività come la pittura, suonare un strumento musicale o scrivere (il 27% degli intervistati), il 22,5% degli intervistati usa app per mantenere attiva la mente in particolare app relative alla meditazione (tra le più citate Smiling Mind e asana rebel, che offrono sessioni di “Invecchiamento consapevole”)
Caso di studio: Piattaforma di realtà virtuale Rendever
Rendever è una piattaforma di realtà virtuale progettata per anziani in case di cura e comunità di pensionamento.
- Tecnologia: Utilizza la realtà virtuale e l’IA per creare esperienze immersive personalizzate.
- Applicazioni: Gli utenti possono “visitare” luoghi del loro passato, partecipare a eventi familiari a distanza o esplorare nuove destinazioni.
- Risultati: Studi hanno mostrato una riduzione del 40% nei sintomi depressivi tra i partecipanti e un aumento significativo delle interazioni sociali.
3. Connessione sociale: Chatbot avanzati e assistenti virtuali possono offrire compagnia, stimolare la conversazione e facilitare la connessione con familiari e amici, combattendo la solitudine. Il 38% utilizza regolarmente Gemini per conversare e avere informazioni sul tempo, le ricette, la propria squadra, etc… solo il 4% usa chatbot dedicati (es. Copilot, CompanionBot, MemoryLane, etc…).
Caso di studio: Chatbot ElliQ
ElliQ è un assistente robotico sociale sviluppato da Intuition Robotics, progettato specificamente per gli anziani che vivono da soli.
- Funzionalità: ElliQ può iniziare conversazioni, ricordare appuntamenti, suggerire attività e facilitare videochiamate con familiari e amici.
- Tecnologia IA: Utilizza il natural language processing e l’apprendimento automatico per personalizzare le interazioni in base alle preferenze e alle abitudini dell’utente.
- Risultati: Studi pilota hanno mostrato una riduzione del senso di solitudine e un aumento dell’engagement sociale tra gli utenti anziani.
4. Sicurezza domestica: Sistemi di domotica basati
sull’IA possono rendere le case più sicure e confortevoli, permettendo agli anziani di vivere in modo indipendente più a lungo. Il 59% degli intervistati dichiara di avere in casa elettrodomestici domotici, tra cui più diffuso è l’aspirapolvere 61%, a seguire robot da cucina 59% (frullatori, friggitrice, etc…), tapparelle elettriche 32%, lavastoviglie 22%, lavatrici 21% ed in ultimo frigoriferi 13%. Il 31% ha installato in casa sistemi di sicurezza antintrusione.
Caso di studio: Sistema di monitoraggio domestico Canary Care
Canary Care è un sistema di monitoraggio non invasivo che utilizza sensori e IA per monitorare le attività quotidiane degli anziani che vivono indipendentemente.
- Funzionamento: Sensori wireless posizionati in casa rilevano movimento, temperatura e utilizzo di porte e apparecchi.
- Analisi IA: L’IA analizza i dati per identificare cambiamenti nei pattern di comportamento che potrebbero indicare problemi di salute o sicurezza.
- Impatto: Ha permesso a molti anziani di vivere più a lungo nelle proprie case, fornendo tranquillità ai familiari e riducendo la necessità di assistenza residenziale.
5. Supporto emotivo: L’IA può essere utilizzata per rilevare cambiamenti nell’umore e nel comportamento, segnalando potenziali problemi di salute mentale e facilitando interventi tempestivi. Il 27% usa smart watch per monitorare la propria salute (la quasi totalità sono uomini).
Caso di studio: Assistente vocale personalizzato SnorkelAI
SnorkelAI ha sviluppato un assistente vocale personalizzato per anziani, adattando la tecnologia esistente alle esigenze specifiche di questa popolazione.
- Personalizzazione: L’IA apprende le preferenze individuali, il vocabolario e le routine dell’utente.
- Funzionalità: Oltre ai compiti standard come impostare promemoria o controllare dispositivi smart home, può monitorare sottilmente il benessere dell’utente attraverso l’analisi del parlato.
- Impatto: Ha migliorato l’aderenza alla terapia farmacologica del 30% e ha aumentato l’engagement sociale attraverso suggerimenti di attività personalizzate.
È chiaro che siamo di fronte a un’opportunità unica: utilizzare una delle tecnologie più avanzate del nostro tempo per affrontare alcune delle sfide più antiche dell’umanità - la fragilità e la solitudine che spesso ac-
compagnano l’invecchiamento. Il modo in cui riusciremo a bilanciare l’innovazione tecnologica con i bisogni umani fondamentali determinerà non solo la qualità della vita degli anziani di oggi, ma anche il tipo di società che stiamo costruendo per il futuro. Dalle analisi condotte dall’Osservatorio Scenario Salute di BHAVE si rileva che, l’applicazione dell’IA per gli anziani richiede considerazioni specifiche:
1. Usabilità: Le interfacce e le interazioni devono essere progettate tenendo conto delle possibili limitazioni fisiche e cognitive degli utenti anziani. La personalizzazione è cruciale: le soluzioni più efficaci sono quelle che si adattano alle esigenze e preferenze individuali degli utenti anziani.
2. Accettazione tecnologica: È necessario superare potenziali barriere psicologiche e culturali all’adozione della tecnologia. L’accettazione e l’adozione da parte degli utenti rimangono sfide significative, sottolineando l’importanza di un design centrato sull’utente e di programmi di formazione adeguati.
3. Integrazione con l’assistenza umana: L’IA dovrebbe complementare, non sostituire, l’assistenza e l’interazione umana. L’implementazione di successo richiede spesso un approccio multidisciplinare, coinvolgendo esperti in gerontologia, etica, design e tecnologia.
4. Privacy e dignità: Le soluzioni IA per gli anziani devono bilanciare attentamente il monitoraggio e l’assistenza con il rispetto della privacy e dell’autonomia individuale. Molte di queste soluzioni sollevano questioni etiche e di privacy che devono essere attentamente considerate e gestite.
5. Equità e accesso: L’accessibilità economica rimane un ostacolo per l’adozione diffusa di alcune di queste tecnologie avanzate. Inoltre, il divario digitale può escludere alcuni gruppi di anziani dai benefici dell’IA ed il rischio di bias negli algoritmi che potrebbero portare a discriminazioni basate su età, genere, etnia o status socio-economico.
È fondamentale che lo sviluppo e l’implementazione di soluzioni IA per gli anziani siano guidati non solo dall’innovazione tecnologica, ma anche da una profonda comprensione dei bisogni, delle preferenze e dei valori degli anziani stessi. Ciò richiede una collaborazione stretta tra sviluppatori di tecnologia, professionisti sanitari, politici, eticisti e, soprattutto, gli anziani e le loro famiglie. Inoltre, è cruciale riconoscere che l’IA non è una panacea, deve essere vista come uno strumento per potenziare e complementare, non sostituire, l’assistenza umana e le relazioni interpersonali che rimangono fondamentali per il benessere degli anziani.
Raccomandazioni per sindaci e comuni: Promuovere l’inclusione digitale degli anziani attraverso l’IA
L’indagine condotta dall’Osservatorio Scenario Salute di BHAVE mirava ad identificare possibili suggerimenti e raccomandazioni specifiche per sindaci e amministrazioni comunali su come implementare e gestire l’uso dell’intelligenza artificiale per migliorare la vita degli anziani nelle loro comunità. Queste raccomandazioni mirano a promuovere l’inclusione digitale, garantire l’equità nell’accesso alle tecnologie IA e massimizzare i benefici per la popolazione anziana locale.
1. Valutazione delle esigenze e pianificazione strategica
Raccomandazioni:
- Condurre un censimento tecnologico degli anziani per comprendere il livello attuale di alfabetizzazione digitale e accesso alla tecnologia.
- Istituire un comitato consultivo composto da anziani, esperti di gerontologia, specialisti di IA e rappresentanti della comunità per guidare le iniziative locali.
- Sviluppare un piano strategico quinquennale per l’implementazione dell’IA a beneficio degli anziani, con obiettivi chiari e misurabili.
Esempio pratico: Il Comune di Bologna potrebbe lanciare il progetto “Bologna Digitale Senior”, iniziando con un sondaggio capillare sulla familiarità degli over 65 con la tecnologia, per poi elaborare un piano d’azione mirato.
2. Infrastruttura e accessibilità
Raccomandazioni:
- Investire in infrastrutture di connettività a banda larga in tutte le aree del comune, con particolare attenzione alle zone con alta concentrazione di anziani.
- Creare “hub tecnologici” nei centri anziani e nelle biblioteche pubbliche, dotati di dispositivi e assistenza per l’uso di tecnologie IA.
- Implementare un sistema di trasporto pubblico intelligente che utilizzi l’IA per ottimizzare percorsi e orari in base alle esigenze degli anziani.
Esempio pratico: Il Comune di Padova potrebbe avviare il progetto “Padova Connessa”, installando punti di accesso Wi-Fi gratuiti in tutti i parchi e le piazze frequentate dagli anziani, e fornendo tablet in comodato d’uso con app IA preinstallate per l’assistenza quotidiana.
3. Formazione e supporto
Raccomandazioni:
- Organizzare corsi gratuiti di alfabetizzazione digitale per anziani, con focus sull’uso di applicazioni IA per la salute, la socializzazione e la vita quotidiana.
- Istituire un programma di “tutor digitali”, coinvolgendo volontari giovani per assistere gli anziani nell’uso delle tecnologie IA.
- Creare una help line telefonica dedicata per il supporto tecnico agli anziani nell’uso di dispositivi e applicazioni IA.
Esempio pratico: Il Comune di Firenze potrebbe lanciare l’iniziativa “Nonni 2.0”, con corsi settimanali nei centri civici e un servizio di assistenza a domicilio per l’installazione e l’uso di dispositivi smart per la casa.
4. Servizi comunali potenziati dall’IA
Raccomandazioni:
- Implementare chatbot IA sul sito web del comune per assistere gli anziani nella navigazione dei servizi online.
- Sviluppare un’app mobile comunale che utilizzi l’IA per personalizzare informazioni e servizi in base alle esigenze specifiche di ogni anziano.
- Utilizzare l’IA per ottimizzare la gestione dei servizi di assistenza domiciliare, migliorando l’efficienza e la qualità del servizio.
Esempio pratico: Il Comune di Torino potrebbe creare “TorinoSenior”, un’app che utilizza l’IA per ricordare appuntamenti medici, suggerire attività sociali basate sugli interessi dell’utente e fornire informazioni in tempo reale su servizi comunali rilevanti per gli anziani.
5. Salute e benessere
Raccomandazioni:
- Collaborare con le ASL locali per implementare sistemi di telemedicina potenziati dall’IA, facilitando le consultazioni remote per gli anziani.
- Installare sistemi di monitoraggio ambientale basati sull’IA nelle abitazioni degli anziani a rischio, con il loro consenso, per prevenire incidenti domestici.
- Utilizzare l’IA per analizzare i dati sanitari aggregati e anonimi per identificare tendenze e migliorare i servizi di prevenzione per gli anziani.
Esempio pratico: Il Comune di Bari potrebbe avviare il progetto “Bari Salute Smart”, fornendo dispositivi indossabili connessi a un sistema IA centrale per il monitoraggio della salute degli anziani, con alert automatici ai familiari o ai servizi di emergenza in caso di
anomalie.
6. Inclusione sociale e partecipazione civica Raccomandazioni:
- Creare una piattaforma di social networking locale potenziata dall’IA per connettere gli anziani con interessi simili e facilitare incontri e attività di gruppo.
- Implementare un sistema di democrazia partecipativa online con interfacce adatte agli anziani, utilizzando l’IA per analizzare e categorizzare i feedback dei cittadini.
- Utilizzare l’IA per personalizzare la comunicazione del comune verso gli anziani, assicurando che ricevano informazioni rilevanti in formati accessibili.
Esempio pratico: Il Comune di Palermo potrebbe lanciare “PalermoInsieme”, una piattaforma che utilizza l’IA per suggerire attività di volontariato agli anziani basate sulle loro competenze ed esperienze, promuovendo l’invecchiamento attivo e il contributo alla comunità.
7. Monitoraggio e valutazione
Raccomandazioni:
- Istituire un sistema di monitoraggio continuo dell’impatto delle iniziative IA sugli anziani, utilizzando metriche quantitative e feedback qualitativi.
- Condurre valutazioni annuali dell’efficacia dei programmi IA, coinvolgendo direttamente gli anziani nel processo di revisione.
- Utilizzare l’IA per analizzare i dati raccolti e identificare aree di miglioramento o nuove opportunità di intervento.
Esempio pratico: Il Comune di Verona potrebbe implementare “VeronaAscolto”, un sistema che utilizza l’analisi del sentiment basata sull’IA per valutare la soddisfazione degli anziani rispetto ai servizi comunali potenziati dall’IA, permettendo aggiustamenti rapidi basati sul feedback.
L’implementazione di queste raccomandazioni richiederà un impegno significativo in termini di risorse, pianificazione e collaborazione intersettoriale. Tuttavia, i potenziali benefici per la qualità della vita degli anziani e per l’efficienza dei servizi comunali sono sostanziali. I sindaci e le amministrazioni comunali hanno una posizione unica per guidare questa trasformazione digitale in modo inclusivo ed etico. Attraverso un approccio centrato sull’utente, una pianificazione attenta e un monitoraggio continuo, i comuni possono sfruttare il potenziale dell’IA per creare comunità più age-friendly, migliorando significativamente la vita dei
loro cittadini anziani.
È fondamentale ricordare che l’obiettivo ultimo di queste iniziative non è la tecnologia in sé, ma il miglioramento tangibile della qualità della vita, dell’indipendenza e del benessere degli anziani. Con una leadership illuminata e un impegno costante, i comuni possono essere in prima linea nella rivoluzione dell’IA per gli anziani, creando un modello di inclusione digitale che possa ispirare altre comunità in tutto il paese.
Impatto su tecnologia e vita quotidiana: I bias comportamentali degli anziani I bias comportamentali sono tendenze sistematiche nel comportamento e nel pensiero che possono influenzare le decisioni e le azioni di una persona. Gli anziani, come tutti gli altri gruppi demografici, sono soggetti a vari bias comportamentali. Questi possono avere un impatto significativo sul loro rapporto con le nuove tecnologie, l’IA e la vita quotidiana in generale. Ecco alcuni dei principali bias comportamentali osservati negli anziani: 1. Bias dello status quo: Tendenza a preferire che le cose rimangano come sono o che cambino il meno possibile. Impatto: -Resistenza all’adozione di nuove tecnologie o cambiamenti nelle routine quotidiane.- Preferenza per metodi e strumenti familiari, anche quando esistono alternative più efficienti. 2. Bias di conferma: Tendenza a cercare, interpretare o r icordare informazioni in modo da confermare le proprie convinzioni preesistenti. Impatto:Rafforzamento di opinioni negative preesistenti sulle nuove tecnologie.- Difficoltà ad accettare evidenze dei benefici dell’IA o di altre innovazioni. 3. Effetto di ancoraggio: Tendenza a fare affidamento eccessivo sulla prima informazione offerta quando si prendono decisioni. Impatto:- Difficoltà a rivalutare il valore o l’utilità di nuove tecnologie dopo una prima impressione negativa.- Resistenza a cambiare opinione su questioni tecnologiche o sociali. 4. Bias di disponibilità: Tendenza a sopravvalutare la probabilità di eventi di cui si ha un ricordo vivido o recente. Impatto:- Eccessiva preoccupazione per rischi tecnologici ampiamente pubblicizzati (come violazioni della privacy).- Sottovalutazione di rischi meno “sensazionali” ma potenzialmente più rilevanti. 5. Bias di negatività: Tendenza a dare maggior peso alle esperienze o informazioni negative rispetto a quelle positive. Impatto:- Focalizzazione sui potenziali rischi delle nuove tecnologie piuttosto che sui benefici.- Tendenza a ricordare e condividere più facilmente esperienze negative con la tecnologia. 6. Illusione di controllo: Tendenza a sovrastimare il proprio grado di influenza sugli eventi esterni. Impatto:- Resistenza a sistemi automatizzati o IA che potrebbero ridurre il senso di controllo personale.- Preferenza per metodi manuali anche quando meno efficienti o sicuri. 7. Bias
di abilità decrescente: Tendenza a sottovalutare la propria capacità di apprendere nuove competenze con l’avanzare dell’età. Impatto:- Riluttanza a intraprendere l’apprendimento di nuove tecnologie.- Sottostima delle proprie capacità di adattamento al cambiamento tecnologico. 8. Nostalgia bias: Descrizione: Tendenza a ricordare il passato in modo più positivo di quanto fosse realmente. Impatto:- Resistenza al cambiamento basata su una visione idealizzata del passato.- Difficoltà a riconoscere i miglioramenti apportati dalle nuove tecnologie. 9. Bias di gruppo sociale: Tendenza a conformarsi alle opinioni e ai comportamenti del proprio gruppo sociale di riferimento.Impatto:- Adozione o rifiuto di tecnologie basati sulle norme percepite del proprio gruppo di coetanei.- Difficoltà ad abbracciare innovazioni se non supportate dal proprio ambiente sociale.Raccomandazioni a comuni e sindaciComprendere questi bias comportamentali è cruciale per sviluppare strategie efficaci per l’integrazione degli anziani nel mondo digitale e dell’IA. Riconoscere questi bias può aiutare a:1. Progettare interfacce e prodotti tecnologici più intuitivi e adatti alle esigenze degli anziani.2. Sviluppare programmi di formazione e supporto che affrontino specificamente questi bias.3. Creare campagne di comunicazione più efficaci per promuovere l’adozione di nuove tecnologie tra gli anziani.4. Implementare politiche che favoriscano l’inclusione digitale, tenendo conto delle particolari sfide cognitive e comportamentali affrontate da questa fascia demografica.Riconoscendo e affrontando questi bias, possiamo creare un ambiente in cui gli anziani si sentano più a loro agio nell’esplorare e adottare nuove tecnologie, migliorando così la loro qualità della vita e il loro coinvolgimento nella società digitale.

L’YMCA, pur nascendo come organizzazione con un focus sui giovani, nelle proprie politiche e programmi, punta a creare un ambiente favorevole per la crescita psicofisica di persone di tutte le età. YMCA vuole creare nuove connessioni tra le persone, coinvolgere i nuclei familiari, promuovere il dialogo intergenerazionale e non solo quello del singolo individuo, consapevoli che la socializzazione, il divertimento contribuisce a migliorare la salute e la qualità di vita , il tutto puntando su programmi che si adattano alle varie esigenze e stili di vita. Questa è parte fondante delle politiche di YMCA HEALTH, che punta alla scoperta di nuove forme di fitness e wellness per gli anziani.
Con l’avanzare dell’età, si aiuta la persona anziana a creare una serie di obiettivi di fitness che vuole raggiungere, come migliorare l’equilibrio psicofisico e la propria motricità. Con il programma Enhance®Fitness ci impegniamo ad aiutare gli anziani a rimanere fisicamente e mentalmente sani e proattivi.
Negli Stati Uniti, dove il programma è stato creato, oggi un numero crescente di YMCA offre Enhance®Fitness, come programma di esercizi di gruppo creato per gli anziani, che utilizza movimenti semplici e facili da imparare, che motivano le persone (in particolare quelle con artrite) a rimanere attive per tutta la vita.
Ecco alcuni dei cambiamenti che i nostri partecipanti hanno notato:
Più energia, migliore equilibrio psicofisico, aumento
della forza muscolare sia nella parte superiore che inferiore del corpo, maggiore flessibilità e libertà di movimento.
Inoltre i partecipanti sottoposti ad una survey hanno riferito che riescono a dormire meglio, hanno maggiore swnsazione di felicità, maggiore senso di indipendenza.
L’obiettivo che YMCA dichiara è quello di aiutare gli anziani a sentirsi meglio a livello psicofisoco Ogni sessione di lezione include esercizi cardiovascolari, di forza, di equilibrio e flessibilità e la promozione di forti relazioni sociali tra i partecipanti. Enhance®Fitness come detto è rivolto agli anziani, ma soprattutto quelli con una condizione cronica, come l’artrite.
Enhance®Fitness è stato riconosciuto a livello nazionale dal Centers for Disease Control and Prevention (CDC), dal Dipartimento della Salute e dei Servizi Umani degli Stati Uniti, e dall’Amministrazione degli Stati Uniti sull’invecchiamento e dal National Council on Aging. Il CDC raccomanda Enhance®Fitness come un efficace intervento di gestione dell’artrite. Il programma Y’s Enhance®Fitness è orientato a sostenere coloro che lottano cotro l’artrite, ma il programma può essere adatto a qualsiasi adulto più anziano, indipendentemente dall’esperienza di fitness iniziale. Secondo il CDC, l’artrite colpisce 54,4 milioni di adulti statunitensi, più di un soggetto su quattro.
I partecipanti a Enhance®Fitness seguono un programma specifico che li porterà ad avere una buona condizione fisica.
I punti salienti del programma sono:
• Corso di esercizi di 16 settimane, per gruppi composti da 12-25 partecipanti (i nuovi partecipanti possono iscriversi in qualsiasi momento in base alla disponibilità).
• Il gruppo si riunisce tre volte a settimana per 60 minuti ciascuna.
• Valutazione dell’esercizio eseguita all’inizio e alla fine delle 16 settimane per monitorare i progressi.
• Ai partecipanti viene data un’iscrizione gratuita “Famiglia” all’YMCA per tutta la durata del programma.
• Creazione di clima che favorisce l’interazione sociale, parte vitale della salute e del benessere dell’individuo.
• Per la partecipazione non è richiesta l’iscrizione all’YMCA perché il programma è interamente finanziato dalle autorità locali e governative.
Uno dei partecipanti riferisce che “Le donne e gli uomini del gruppo sono un ottimo sistema di supporto per mantenermi motivato a continuare ad allenarmi. EnhanceFitness è diventato un elemento necessario nella mia vita” a conferma di un programma che ha fatto breccia negli anziani.
Sentiment che viene confermato dai dati e dai risultati ottenuti:
• 35%
dei partecipanti a Enhance®Fitness ha riportato un miglioramento del funzionamento fisico
• 53%
dei partecipanti ha riportato tassi ridotti di depressione
• $945/GIORNO
meno costi sanitari all’anno rispetto ai non partecipanti
• 35,000 ANZIANI
I partecipanti all’attività di fitness
Ora il programma, attraverso YMCA HEALTH, è pronto per essere implementato in Italia, in collaborazione con palestre, società scientifiche e autorità sanitarie, per garantire ai nostri anziani una “longevità” attiva e in salute.

giorno per giorno

Sviluppo economico e valore sociale: i sindaci al centro del più grande piano di trasformazione
Il Gruppo FS è la principale stazione appaltante d’Italia e il principale attuatore dei finanziamenti PNRR, con quasi 25 miliardi di euro assegnati. Nei prossimi dieci anni, saranno investiti circa 120 miliardi di euro nelle infrastrutture ferroviarie per migliorare la mobilità e i servizi, ridurre il divario Nord-Sud e collegare il Sud all’Europa. Di questi, una buona parte servirà a riqualificare centinaia di stazioni e a concretizzare interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria per ammodernare l’infrastruttura e innalzare gli standard di efficienza, affidabilità e sicurezza della rete, anche dal punto di vista tecnologico.
Questa fase rappresenta un’opportunità che trasformerà il funzionamento del Paese. Siamo immersi nella più grande opera di trasformazione infrastrutturale che l’Italia abbia mai vissuto.
Se pensiamo al tanto citato Piano Marshall del dopoguerra, la Penisola fu allora interessata da investimenti in opere per quasi 14 miliardi di euro attualizzati, utili per ricostruire le infrastrutture danneggiate dalla guerra, comprese le ferrovie. Grazie a quei fondi, furono riparati 4.800 km di linee ferroviarie, ricostruiti ponti strategici e stazioni distrutte, e rinnovati locomotori e vagoni, garantendo la ripresa dei collegamenti. A seguire, durante gli anni ’60 e ’70, in pieno boom economico, vi furono altri numerosi investimenti, con la creazione di nuove linee e l’elettrificazione di molte tratte. Si pensi ad esempio all’Autostrada del Sole, la cui costruzione iniziò ufficialmente nel 1956 e fu completata in otto anni, nell’ottobre del 1964. Parliamo di una linea lunga circa 760 km, che collega Milano a Napoli, attraversando alcune delle città e regioni più industrializzate d’Italia.

Tuttavia, tali investimenti, pur significativi, risultavano frammentati e meno coordinati rispetto a quelli di oggi.
Il grande salto si ebbe con l’introduzione dell’Alta Velocità all’inizio degli anni 2000, che richiese uno sforzo economico pari a circa 30 miliardi di euro. Questo progetto ha rivoluzionato i collegamenti tra le principali città italiane, come Milano, Roma e Napoli: si concentrava sulle aree urbane più popolose e non prevedeva ancora una copertura capillare sul territorio nazionale. In seguito, negli anni precedenti al PNRR, gli impegni di spesa si sono poi focalizzati sul completamento delle linee AV e su interventi di manutenzione e sicurezza, tra cui l’implementazione di tecnologie avanzate come il Sistema di Controllo Marcia Treno (SCMT) e il Sistema di Segnalamento ERTMS.


Ciononostante, mancava ancora un approccio integrato per modernizzare l’intera rete stradale e ferroviaria.
Gli investimenti attuali, al contrario, sono più estesi e strategici. Non solo toccano le principali tratte nazionali, ma coinvolgono anche un ampio spettro di aree regionali e locali, contribuendo a colmare il divario infrastrutturale che storicamente separa il Nord dal Sud del Paese.
Oggi, infatti, anche grazie agli interventi passati, arriveremo presto al completamento della tratta AV/ AC della Napoli-Bari, parte integrante del Corridoio ferroviario europeo TEN-T Scandinavia – Mediterraneo, finanziata anche con fondi PNRR. Il valore complessivo dell’opera è di circa 5,8 miliardi di euro e consentirà, entro il 2028, di velocizzare gli spostamenti dalla Puglia verso Napoli e Roma: sarà quindi possibile andare da Bari a Napoli in 2 ore, fino a Roma in 3 ore e collegare Lecce e Taranto alla Capitale in 4 ore. Prima del 2028 sono comunque previste progressive riduzioni dei tempi di viaggio, grazie all’apertura per fasi dei nuovi tratti di linea, a partire dal nuovo collegamento diretto che sarà attivato il prossimo anno e che consentirà anche di incrementare progressivamente il traffico delle merci su ferro.
Il lavoro attuale non si limita dunque a un singolo progetto, ma mira a modernizzare l’intero sistema infrastrutturale, rendendolo più efficiente, sostenibile e integrato nel contesto europeo. Il potenziamento del trasporto su ferro consentirà di aumentare la capacità e la connettività, sia per i passeggeri che per le merci, e a promuovere azioni di sostenibilità ambientale e sociale, con l’obiettivo di creare una rete più rispettosa dell’ambiente e in linea con gli obiettivi di una transizione equa anche sul piano sociale.
È così in corso una ridefinizione generale delle infrastrutture strategiche, che si estende su tutto il territorio nazionale. Questo processo rappresenta un vero e proprio lavoro di ricucitura territoriale, volto a creare valore economico e sociale e a favorire lo sviluppo delle diverse aree geografiche. L’obiettivo è offrire collegamenti più frequenti, veloci e affidabili, incrementando la sicurezza e la resilienza delle infrastrutture e rispondendo così alle mutevoli esigenze della domanda di mobilità.
Lavoriamo per garantire una rete capillare, solida, affidabile, moderna. Per generare un nuovo valore condiviso sui territori.
Per fare l’Italia, giorno per giorno.
City Green Light, un approccio integrato verso la transizione energetica e digitale delle Pubbliche Amministrazioni.
Intervista ad Alessandro Visentin, CEO City Green Light

City Green Light in 7 anni è passata dall’essere il principale player privato di illuminazione pubblica in Italia, a diventare un operatore di servizi integrato specializzato nella fornitura di servizi energetici e soluzioni smart per le comunità a 360˚. Come è avvenuta questa evoluzione?
City Green Light ha iniziato a operare agli inizi degli anni 2000 come business unit del servizio di pubblica illuminazione di una nota realtà italiana, dalla quale è diventa indipendente nel 2017. Il core business è sempre stato l’efficientamento, la riqualificazione e la gestione degli impianti di illuminazione pubblica, attività che comportano un alto presidio sul territorio e che, grazie all’avvento delle tecnologie di rete, ha permesso di ampliare la proposta aziendale anche a tutti i prodotti e i servizi legati alle smart city. “Città intelligenti” perché sostenibili, che necessitano insieme alla pianificazione urbanistica anche una pianificazione energetica. Questo è stato il percorso che ci ha portato a diventare un operatore di servizi integrati: dall’illuminazione agli interventi di efficientamento energetico per gli edifici pubblici. Dallo smart parking alla diffusione e gestione delle comunità energetiche, dalla sensoristica alla videosorveglianza AI based, fino alla e-mobility. Oggi City Green Light è un’eccellenza nazionale che accompagna Pubbliche Amministrazioni e imprese nel percorso di transizione ecologica, energetica e digitale, operando in oltre 300 Comuni italiani, con un fatturato cresciuto da 50 milioni di euro del 2018 a oltre 150 milioni di euro del 2023.
Quali sono le principali sfide che un’azienda come City Green Light deve affrontare in un contesto in cui la transizione energetica è sempre più urgente e in che modo le state affrontando?
C’è prima di tutto la necessità di coniugare innovazione tecnologica e sostenibilità economica per rispondere alle esigenze sempre più complesse delle Pubbliche Amministrazioni e delle imprese, con soluzioni personalizzate e integrate. L’obiettivo è di anticipare la crescente domanda di sistemi per la razionalizzazione dei consumi, la flessibilità energica e la riduzione dell’impatto ambientale. Il nostro punto di partenza è stato intuire che il presidio territoriale e la gestione dell’illuminazione pubblica rappresentassero anche una rete diffusa per la raccolta di dati, ma per poter ampliare la gamma di soluzio-

ni e gli ambiti di intervento è stato necessario dotarsi di nuove competenze, anche attraverso l’acquisizione di realtà con esperienza sull’efficientamento degli edifici e sulla gestione tecnologica degli smart parking. A questo proposito, nel 2024 abbiamo integrato nel nostro Gruppo Termotecnica Sebina, specializzata nella progettazione, realizzazione e manutenzione di impianti, e Smart Parking Systems, che realizza tecnologie per la gestione del parcheggio e dello spazio pubblico, con un’esperienza nella gestione di oltre 15.000 stalli in più di 80 realtà tra Comuni e aziende.
del binomio innovazione e sostenibilità nella strategia aziendale è evidente. Come si concretizza questo impegno?
Innovazione e sostenibilità per noi sono concetti collegati, che caratterizzano il modo di operare di City Green Light. Per questo abbracciamo l’approccio dell’Open Innovation, collaborando con università, centri di ricerca e startup per dare vita a reti intelligenti in grado di rispondere in modo agile e innovativo ai fabbisogni dei territori. Costruendo, insieme ai nostri partner e agli stessi clienti, ampi progetti di smart city, sostenuti economicamente dall’efficienza energetica e dei servizi locali. Per esempio dalla collaborazione con iSImob, spin-off dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, è nato il progetto LightAnalytics. Un modello che, sfruttando i dati di traffico e le potenzialità dell’intelligenza artificiale, consente una progettazione illuminotecnica tarata sulle effettive esigenze urbane, riducendo l’impatto energetico delle infrastrutture e garantendo al contempo una migliore gestione della sicurezza stradale. Grazie al supporto dell’AI è inoltre possibile realizzare sistemi di illuminazione con sensori che allertano le forze dell’ordine, favorendo interventi veloci e mirati. Quanto ai risultati in termini di riduzione dell’impatto ambientale, i progetti di efficientamento energetico realizzati da City Green Light insieme alle strutture tecniche delle Pubbliche Amministrazioni ha permesso di raggiungere l’obiettivo di 92.000 tonnellate CO2 annue risparmiate grazie agli investimenti in efficientamento energetico effettuati nel periodo 2011-2023.
Quali servizi offre City Green Light per migliorare la gestione del territorio?
Operiamo principalmente in quattro aree: illuminazione intelligente, mobilità sostenibile, efficientamento degli edifici e soluzioni per le smart city.
Nell’ambito dell’illuminazione pubblica, oltre a progettare e implementare sistemi di illuminazione stradale, monumentale e urbana e a gestire impianti semaforici e pannelli a messaggio variabile, sviluppiamo soluzioni avanzate di video analisi e intelligenza artificiale per l’elaborazione automatica di flussi ed eventi, migliorando sicurezza ed efficienza della gestione del traffico e dei servizi cittadini. Ci occupiamo anche di efficientamento energetico degli edifici pubblici, come uffici, scuole e strutture sportive anche di grandi dimensioni, con proposte innovative per ridurre i consumi, ottimizzare la gestione e creare CER. Inoltre, offriamo servizi di smart parking, installazione di colonnine di ricarica per veicoli elettrici e soluzioni di micromobilità in sharing. Siamo quindi in grado di offrire soluzioni articolate, costruite sulle esigenze reali di ogni Comune, un supporto completo alle amministrazioni locali, permettendo loro di concentrarsi sullo sviluppo di servizi innovativi. Per città più vivibili, sostenibili e resilienti ai cambiamenti climatici.
Affianchiamo i Comuni nel loro percorso di trasformazione digitale, offrendo soluzioni per rispondere a bisogni reali in tema di sicurezza urbana, gestione dei rifiuti, mobilità e trasporto pubblico locale, politiche sociali, valorizzazione dei luoghi di cultura e potenziamento del turismo, efficientamento energetico. Il tutto garantendo una solida sostenibilità economica e finanziaria.
14.000 DIPENDENTI 45 SEDI IN ITALIA
500 COMUNI SUPPORTATI
Il Gruppo Engineering mette a fattor comune competenze tecnologiche e conoscenze di business per supportare aziende e amministrazioni attraverso progetti che abbiano impatti importanti sulla protezione dell’ambiente, sulla salvaguardia delle comunità e sul disegno e creazione di modelli sociali più inclusivi.
Mettendo le politiche di sostenibilità al centro delle nostre strategie aziendali, eleviamo la tecnologia a strumento capace di ottimizzare l’uso delle risorse naturali, incentivare la produzione di energie rinnovabili, creare ecosistemi sociali più inclusivi, portando di fatto benefici reali a tutte le persone, supportando un modello di progresso in cui convivano innovazione tecnologica, salvaguardia dell’ambiente e benessere
sociale. Nell’ultimo anno, attraverso il nostro Piano Strategico di Sostenibilità 2024-2026, abbiamo tracciato un percorso di medio-lungo periodo per essere sempre più resilienti e competitivi sul piano della sostenibilità grazie a prodotti e soluzioni digitali che, nel supportare i partner nel raggiungimento di target ESG, siano essi stessi green e sostenibili.
Ad esempio, abbiamo definito azioni concrete per ridurre le emissioni dirette e indirette. Tra i principali risultati del 2023, sono state abbattute del 50% le emissioni di CO2 legate ai consumi elettrici grazie al processo di efficientamento e ad una nuova diminuzione dei consumi del Data Center di Pont-Saint-Martin (AO).
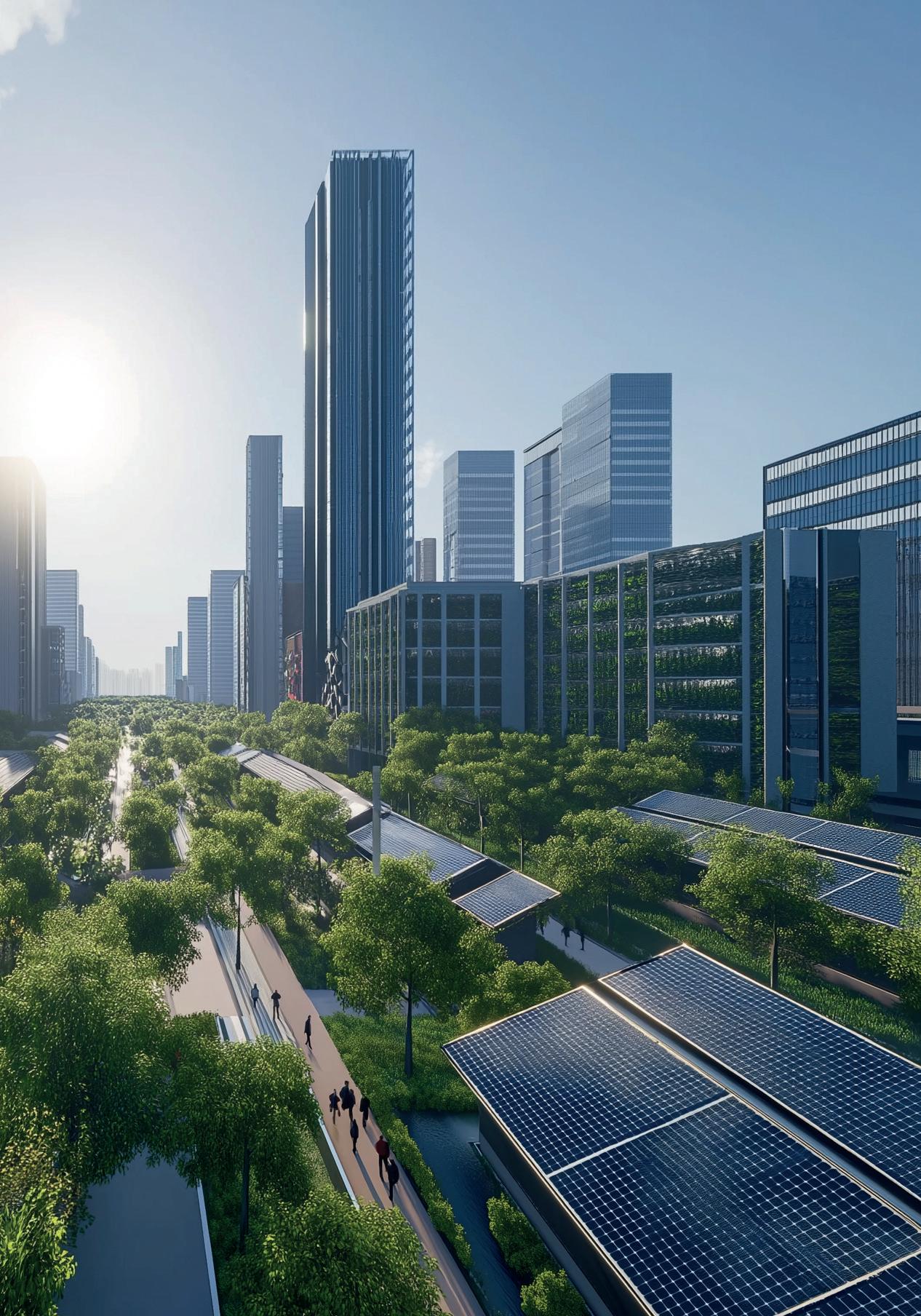


Engineering è presente alla 41ª
Assemblea annuale dell’Anci di Torino allo stand “O” Area Main Partner Vieni a trovarci per assistere in diretta alla registrazione di podcast tratti dalle interviste ad ospiti e personaggi istituzionali.
Sarà un’occasione per confrontarsi e raccogliere opinioni autorevoli su come l’innovazione tecnologica sta impattando sulla società, facendo evolvere le città e i servizi pubblici. Scopri come l’Intelligenza Artificiale può migliorare, in modo
etico e responsabile e attraverso la cooperazione tra imprese, istituzioni e organizzazioni, la qualità delle nostre vite, potenziando lo sviluppo economico e culturale.
Allo stand si potrà assistere anche ai nostri Tech Talk, che racconteranno in modalità divulgativa gli aspetti interessanti dell’AI, e sarà possibile sperimentare alcune Virtual Reality Experience.
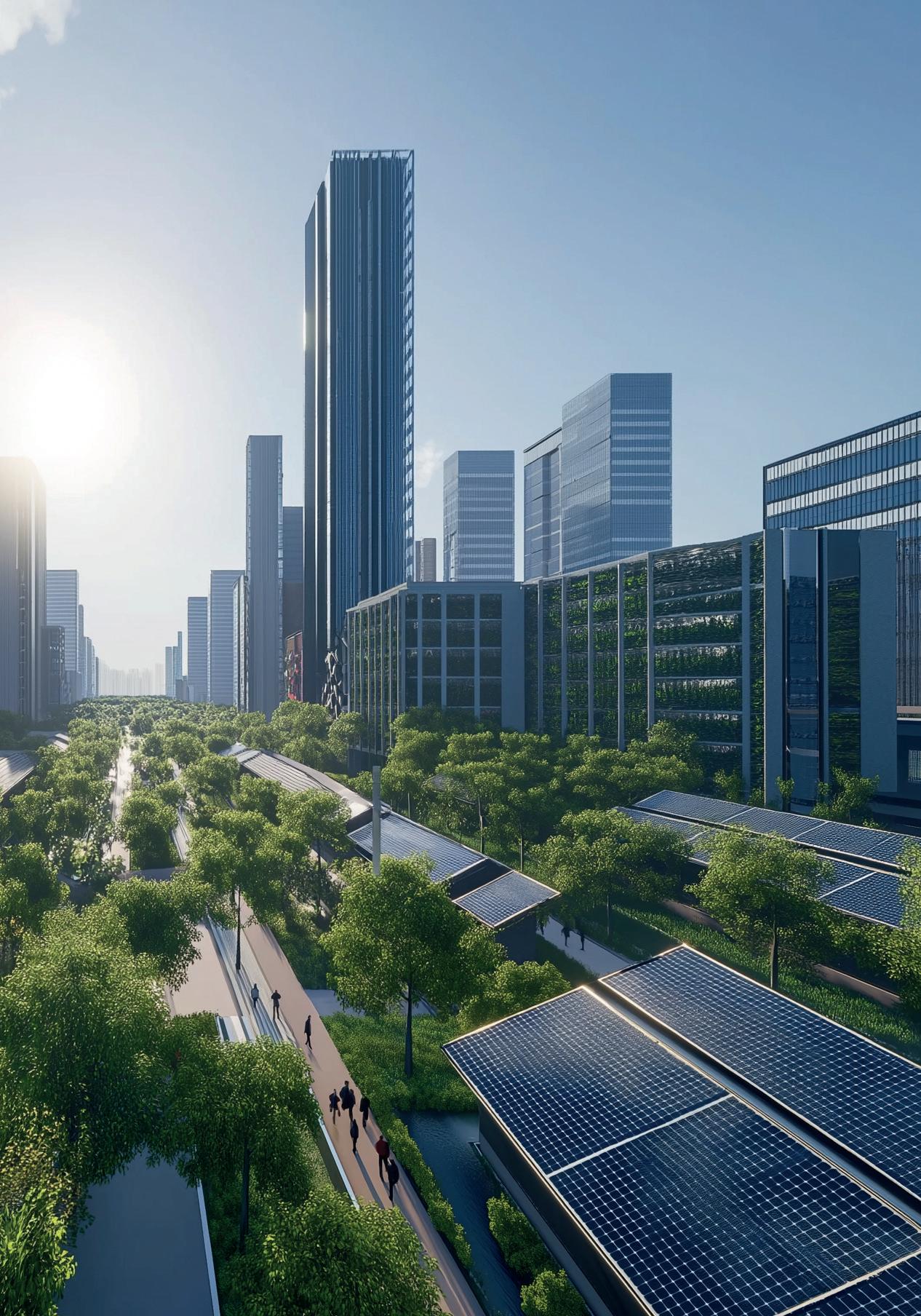
Ascolta i nostri podcast dedicati alle Augmented Cities per saperne di più sulle opportunità di finanziamento disponibili, sul Partenariato Pubblico-Privato, su come realizzare i progetti in tempi certi e senza gravare sui conti pubblici, migliorando la qualità della vita delle persone e assicurando la crescita economica e sostenibile del territorio.
Uno studio di ENGIE e Politecnico di Milano identifica nell’efficienza energetica del patrimonio immobiliare pubblico una leva chiave per accelerare i percorsi di decarbonizzazione.
La pubblica amministrazione svolge un ruolo chiave nel raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione previsti sia dalle diverse normative europee che dal Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC) predisposto dal governo italiano e confermato recentemente anche dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica nella relazione “La situazione energetica nazionale nel 2023”. Per consentire a comuni ed enti locali di contribuire concretamente alla transizione energetica, occorrono, però, strumenti normativi e regolatori ben precisi, capaci di mettere tali enti nella condizione di abbattere i consumi e, di conseguenza, i costi a carico dei cittadini.
Nello studio “Roadmap 2030: scenari e indicazioni di policy alla luce dei nuovi target di decarbonizzazione” ENGIE e il Politecnico di Milano hanno analizzato il ruolo strategico che il patrimonio immobiliare gestito dalla pubblica amministrazione può rivestire nel supportare la transizione verso fonti energetiche più sostenibili. Secondo l’analisi effettuata, attualmente gli enti pubblici gestiscono un patrimonio immobiliare di 300 milioni di metri quadri, pari al 10% del patrimonio immobiliare nazionale. La riqualificazione energetica di tali edifici (incluse scuole e ospedali) genererebbe enormi benefici economici, ambientali e sociali.
Un aumento al 4% annuo del tasso di riqualifica della PA centrale genererebbe notevoli risparmi energetici per circa 300 milioni di euro l’anno.
Le stime indicano che circa il 10% dei risparmi energetici cumulati, previsti nel PNIEC, siano proprio ascrivibili al patrimonio pubblico. Tuttavia, se prendiamo come riferimento il periodo 2014-2021, il tasso di riqualificazione energetica della PA centrale è stato del 2,7%, al di sotto del target del 3% annuo previsto dal PNIEC. Dalla relazione del MASE, sopra citata, nel periodo successivo, tra il 2022 e il 2023 emerge un

significativo aumento degli investimenti in efficienza energetica effettuati da parte della Pubblica Amministrazione, in particolare sostenuti dal meccanismo del Conto Termico, che sono passati da 169 milioni di euro nel 2022 a 327 milioni di euro nel 2023.
È un segnale molto positivo, basti pensare che un aumento al 4% annuo del tasso di riqualifica della PA centrale genererebbe notevoli risparmi energetici per circa 300 milioni di euro l’anno, con investimenti compresi tra 1 e 2 miliardi.
Anche il settore residenziale può offrire un contributo rilevante nella riduzione dei consumi. In questo ambito è fondamentale il contributo del teleriscaldamento, che, grazie alla produzione centralizzata, comporta una maggior efficienza energetica, nonché un possibile maggiore impiego di fonti rinnovabili per la generazione del calore. La Commissione Europea stessa, nel diffondere i risultati delle valutazioni effettuate sulle proposte di aggiornamento dei PNIEC, ha sottolineato la necessità di migliorare la chiarezza e l’efficacia del quadro di implementazione del principio “efficienza energetica al primo posto”, confermando la centralità dell’efficienza per raggiungere gli obiettivi fissati al 2030.
e potenziando gli strumenti oggi in vigore, per aumentare l’attrattività degli investimenti privati, come le formule contrattuali dell’Energy Performance Contract e del Partenariato Pubblico Privato.
l’alleanza pubblico-privato, implementando e potenziando gli strumenti oggi in vigore, per aumentare l’attrattività degli investimenti privati.
Tutto questo mette in luce una certezza: per affrontare le sfide e i costi della transizione energetica bisogna agire e accelerare. Due sono le strade principali da percorrere. Da un lato avere un quadro normativo e regolatorio che supporti una visione di lungo periodo e nel quale le risorse siano tra di loro coordinate e razionalizzate, continuando nel processo di semplificazione degli iter amministrativi. Dall’altro lato, occorre rafforzare l’alleanza pubblico-privato, implementando
ENGIE è un operatore di riferimento nel comparto energetico e ha realizzato in Italia progetti di decarbonizzazione del patrimonio pubblico, grazie a un modello integrato lungo l’intera filiera energetica. La combinazione tra efficientamento energetico e produzione di energia rinnovabile consente di realizzare soluzioni adatte anche in contesti caratterizzati da patrimoni immobiliari di enorme valore storico. Molti sono i progetti avviati per efficientare e ridurre i consumi di scuole, palazzi storici e musei grazie alla presenza di ENGIE in oltre 350 comuni italiani. Un caso particolarmente virtuoso è quello di Aosta, dove ENGIE ha realizzato un modello integrato di gestione energetica che, attraverso la rete di teleriscaldamento alimentata dal recupero del calore di scarto di Cogne Acciai Speciali e l’efficientamento della pubblica illuminazione, contribuisce a ridurre le emissioni, valorizzare le risorse locali e promuovere la sostenibilità nei settori residenziale, pubblico e industriale. Il Paese ha tutte le potenzialità per essere il laboratorio della decarbonizzazione. Definire una pianificazione energetica di medio-lungo termine, sostenuta da strumenti normativi abilitanti, e puntare sulle giuste leve strategiche di concerto con le istituzioni, rappresentano le basi per costruire il sistema energetico carbon neutral, sicuro e accessibile di cui l’Italia e l’Europa hanno bisogno.

Laila Perciballi, Garante dei diritti delle persone anziane del Comune di Roma

L’isolamento e la solitudine sono le piaghe più profonde del tessuto urbano e generano anche depressione e malattia; per questo era ed è necessario intraprendere un percorso di promozione e valorizzazione dell’invecchiamento mettendo al centro la persona. E’ necessario mettere in campo un profondo ripensamento dell’assistenza socio-sanitaria dato che l’isolamento sociale impatta in modo importante sulla salute fisica e mentale, sulla qualità della vita, sui costi sociali e coinvolge in egual misura uomini e donne: ma è più frequente tra chi ha un basso livello di istruzione e maggiori difficoltà economiche. Ed ancora, l‘isolamento è associato anche a maggiore disabilità e ospedalizzazione. Il problema, dunque, non riguarda solo il benessere individuale perché coinvolge l’intera società, ed è per questo che è necessario adottare iniziative inclusive, puntare sulla prevenzione e sulla gestione dell’isolamento sociale. Su questa via si può garantire un maggior benessere agli anziani e si possono ridurre i costi sociali associati a questa sfida crescente. Le persone sole, poi, sono più vulnerabili e sono “facili” vittime dei truffatori. È fondamentale mettere in campo tutti gli accorgimenti per evitare truffe e raggiri nella quotidianità e azionare strumenti di solidarietà, sussidiarietà e responsabilità per garantire un’ esistenza dignitosa agli anziani, dal punto di vista patrimoniale, sociale e (digitale), sanitario ed economico. Del resto, il compito della Repubblica, e quindi di tutti i cittadini – come prescrive l’art. 3 della Costituzione italiana – è rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana, anche della terza età. La politica è, infatti, tenuta a rimuovere le barriere architettoniche, digitali, culturali e a tutelare la salute della persona anziana nella sua “totalità unificata”, e garantire il suo “benessere fisico, mentale, spirituale, sociale e ambientale”, consentendole di realizzare il suo
diritto di invecchiare con dignità. Del resto, l’Italia (Art. 2 Costituzione) “riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo” e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale”. E dunque è dovere della politica combattere la solitudine, l’emarginazione e l’abbandono degli anziani.
Inoltre, è davvero importante restituire forza alla relazione tra le persone di ogni età attraverso la potenza dell’educazione, è fondamentale che gli anziani siano trattati con gentilezza, che gli sia data la speranza, che si tenga conto dei loro progetti di vita (residua) e che gli sia consentito di sognare e di svolgere le attività che amano (una gita al mare, una visita al museo, una passeggiata al parco, un giro di danza).
In questo senso la legge 33/2023 “deleghe al Governo in materia di politiche in favore delle persone anziane” è rivoluzionaria in quanto restituisce nuova dignità alla terza età promuovendo l’autonomia, l’inclusione sociale, l’invecchiamento attivo e la prevenzione della fragilità. Riprendendo le parole di monsignor Paglia, questa legge ha attuato un profondo cambio di paradigma, ponendo come obiettivo quello di prendersi cura di tutti gli anziani attraverso un “continuum assistenziale” centrato sul cohousing, su centri diurni polifunzionali e lungodegenze temporanee, in modo che nessuno sia lasciato solo e senza cure. Il cohousing è stato indicato da monsignor Paglia come un punto chiave per favorire una nuova alleanza tra generazioni e contrastare il fenomeno dell’isolamento sociale. Questo modello non solo permette agli anziani di vivere insieme in un ambiente comunitario, ma favorisce anche una maggiore coesione sociale e civile. Inoltre, i centri diurni polivalenti non solo forniscono assistenza e cura, ma anche una serie di servizi e attività che offrono opportunità di socializzazione, stimolazione mentale e fisica, contribuendo così al benessere com-
plessivo degli anziani e al sostegno delle loro famiglie. La legge raccomanda la promozione di una trasformazione positiva di un modello sanitario incentrato sugli ospedali a un modello basato sulla comunità, distribuito sui territori, proattivo e dotato di tecnoassistenza, dalla telemedicina al telemonitoraggio e così via. Socialità e supporto reciproco contro solitudine e abbandono sono i principali punti di forza del cohousing per anziani, un modello abitativo virtuoso che negli ultimi tempi si sta diffondendo anche nel nostro paese. Vivere con altre persone rappresenta un notevole vantaggio per la popolazione non più giovane; alcuni studi condotti negli Stati Uniti, dove questo modello è abbastanza diffuso, stimano che le persone anziane che vivono in strutture di cohousing siano in g r a d o di essere autosufficienti in media per 10 anni in più rispetto a quanti vivono da soli. Oltre al risparmio in termini di costi, la coabitazione permette a chi è rimasto solo di tornare a stare in compagnia, in una sorta di comunità solidale, organizzando attività condivise e sviluppando nuovi rapporti basati sul reciproco aiuto. Inoltre, il supporto di professionisti dedicati riduce il peso dell’assistenza sul resto del nucleo familiare, dai figli ai nipoti, ed è un modo per rendere più autonomi gli anziani sia nella gestione della vita quotidiana, che nell’avvio di progettualità nuove per guardare in modo diverso al futuro. Nel decreto legislativo n. 29 del 2024, entrato in vigore a marzo scorso, ci sono alcune risposte sul punto focale della “coabitazione solidale domiciliare (senior cohousing) e coabitazione intergenerazionale (cohousing intergenerazionale)”. Il decreto pone all’articolo 16, “criteri e prescrizioni per la realizzazione di progetti di coabitazione mediante rigenerazione urbana e riuso del patrimonio attuati sulla base di atti di pianificazione o programmazione regionale o comunale e di adeguata progettazione, tenendo conto di una serie di criteri quali la mobilità e accessibilità sostenibili, la ristrutturazione ed efficientamento energetico del patrimonio immobiliare pubblico e privato e la rigenerazione delle periferie urbane. In tal senso l’articolo 17 incentiva lo sviluppo di “progetti pilota sperimentali” di coabitazione, con priorità per gli interventi di rigenerazione urbana e di riuso del patrimonio costruito, tenuto conto di quanto realizzato dagli ambiti territoriali sociali (Ats). Il limite del decreto, come spesso avviene in Italia, sta nella previsione normativa che dispone che dall’attuazione di questo articolo “non derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che siano le amministrazioni interessate a provvedere agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili.” Ovviamente questo ne rallenta l’attuazione per quanto
ci sono sempre più esempi virtuosi da Milano a Roma, passando per Firenze e Bologna, e sono già diversi gli esempi di questa convivenza tra anziani che prende il nome di senior o silver cohousing. Tutti puntano a rispondere a un’esigenza prima di tutto sociale, oltre che economica. Certo, il nostro paese è in ritardo rispetto al Nord Europa, specie rispetto alla Danimarca ed alla Svezia, ma finalmente, anche grazie a queste innovazioni normative, qualcosa cambia anche in Italia. Molto si deve ancora fare perché sono davvero tante le potenzialità di questa modalità di vita. Secondo le più recenti stime, a regime si può ottenere un risparmio fino al 10-15% sulla spesa media mensile delle famiglie che abitano in cohousing, a seconda di cosa hanno deciso di condividere e di come hanno deciso di organizzarsi. Come detto, e come si sta facendo, è una realtà molto interessante specie in Italia, secondo paese più anziano al mondo e primo in Europa. Inoltre, dati i costi degli affitti e del prezzo delle case e delle utenze, le persone che possono beneficiare di questo modello sono estremamente numerose. Nel programma di Garante delle persone anziane di Roma sono state visitate alcune realtà. Di particolare interesse è “Casa Nino”, una comunità alloggio del Comune di Roma, realizzata anche con i finanziamenti europei, che ospita anziani fragili, con disagio economico e a rischio di solitudine. Questa “casa” è anche espressione della legalità, dato che si tratta di una vil letta ristrutturata sottratta da Roma Capitale alla criminalità organizzata in via Kenia, nel quartiere dell’Eur. La struttura oggi è abitata da 8 anziani e vi è un’equipe formata da una coordinatrice, un’educatrice professionale, un assistente sociale, uno psicologo e un operatore socio sanitario. Un ottimo esempio di modello abitativo che sostiene la terza età. Vi sono anche strutture di cohousing privato che concretizzano grandi realtà di convivenza della terza età con coppie di ultra novantenni, intenti a conversare, giocare a carte, pranzare insieme. La strada intrapresa, e meglio delineata dalla legge 33/2023 e dai decreti attuativi, sembra essere quella giusta dato che mette in campo un percorso di “promozione e valorizzazione dell’invecchiamento” in chiave pragmatica. Si vuole, finalmente, puntare sul valore degli anziani come risorsa, sulla modernità di una città che li renda visibili, attivi, partecipi della vita economica e sociale dei quartieri, promotori di gentilezza e saggezza attraverso strumenti di solidarietà, sussidiarietà e responsabilità.
Chiaramente il cohousing non risolve tutti i problemi della terza età e della società, ma per tutto quanto detto – e molto altro – il cohousing ha la forza di trasformare la fragilità in opportunità dando nuova dignità alla terza età.
Viviana Kasam, Presidente BrainCircle Italia
La generazione dei baby boomers nell’ultimo decennio ha iniziato, lenta ma inesorabile, a raggiungere l’età della pensione. Portando nel panorama scientifico-economico-commerciale la consapevolezza di nuove esigenze e di un nuovo mercato di grande potenziale.
I baby boomers spesso dispongono di possibilità economiche: sono vissuti durante gli anni del boom, hanno privilegiato il risparmio, come allora era costume, non hanno più figli da mandare a scuola e genitori anziani da mantenere. Hanno spesso una abitazione di proprietà, almeno in Italia, e preoccupazione prioritaria è di mantenersi in salute, vivere più a lungo e se possibile in forma, usufruire di ciò che il mercato offre loro. E il mercato offre moltissimo: integratori, prodotti di bellezza, cliniche di longevità, trattamenti innovativi di ogni tipo, per non parlare di viaggi, crociere, vacanze low cost…
E’ la silver economy, bellezza, spesso “d’argento” più per chi la propone che per chi ne usufruisce. Parliamo di un mercato stimato solo in Italia a circa 600 miliardi. Secondo uno studio della Commissione UE, se la Silver economy fosse uno Stato sovrano, si posizionerebbe alle spalle solo di Stati Uniti e Cina, con una crescita annua del 5%, ben di più della maggior parte delle economie del mondo. Quanto di tutto ciò abbia basi scientifiche comprovate, e quanto sia invece abile marketing è difficile giudicarlo, anche perché mancano sperimentazioni di lunga durata e parametri condivisi di misurazione. Una cosa è certa. L’aspettativa di vita degli italiani era all’inizio degli anni 50 di circa 64 anni, all’inizio degli anni ’60 di 70, oggi è di 85. A questo hanno contribuito scoperte farmacologiche, come la penicillina e gli antibiotici e antivirali, vaccini, sistema sanitario pubblico, attenzione alla prevenzione, migliori condizioni igieniche e abitative. Ma a fronte di un aumento della durata della vita (il cosiddetto life span) non è aumentata analogamente la durata della vita in salute (il health span). E questo comporta un peso insostenibile per il sistema sanitario e assistenziale, ma anche per le famiglie e gli individui, che si trovano spesso ad affrontare lunghi anni in condizioni di fragilità psicofisica.
Il miglioramento del health span è diventata quindi una priorità a livello mondiale, tanto che le Nazioni Unite nel 2021 ha istituito la Decade dell’invecchiamento sano (Decade of Healthy Ageing) con l’idea di promuovere consapevolezza e comportamenti volti a migliorare la salute degli individui. Comportamenti che sono alla portata di tutti, perché, come insegnano i centenari delle Blue Zone i segreti della longevità sana sono esercizio fisico costante, cibo a chilometro zero e prodotto in modo sostenibile, socializzazione, buon sonno, comunità coese affettivamente e allenamento del cervello.
Su questa consapevolezza si basa un progetto all’avanguardia nel mondo, che farà di Milano, tra il 21 e il 30 marzo 2025, la prima metropoli a offrire gratuitamente ai suoi cittadini una serie di “laboratori” dove apprendere e sperimentare i segreti per vivere a lungo in salute, cominciando da giovani. Organizzato da BrainCircleItalia con il Patrocinio del Comune di Milano, il MilanLongevitySummit 2025, “Esercizi di longevità” offrirà a tutti i milanesi la possibilità di apprendere come nutrirsi e cucinare in modo sano, che tipo di attività fisica prediligere, come imparare a dormire meglio, a difendersi dalle truffe, a investire in modo previdente i propri risparmi, a mantenere agile il cervello, a progettare per il benessere l’ambiente in cui si vive, a diventare cittadini digitali, e anche scoprire le possibilità di impegnarsi in attività di volontariato (un campo in cui Milano eccelle, con una rete vastissima di associazioni e fondazioni).
Sul modello del Fuori Salone, gli organizzatori del Summit invitano chiunque desideri condividere gratuitamente le proprie competenze di benessere a patrocinare un laboratorio, che verrà a far parte del calendario del Summit, purché rientri nei parametri di serietà e gratuità che sono la base della manifestazione.
Accanto ai laboratori, il Summit offrirà anche un importante contributo scientifico, grazie a conferenze e lectio magistralis di alcuni tra i più prestigiosi scienziati nel panorama internazionale. Per informazioni www.milanlongevitysummit.org e www.braincircleitalia.it

LETTERA APERTA ALLE ISTITUZIONI E AI SINDACI
DELLA 41a ASSEMBLEA NAZIONALE ANCI PER UN PATTO SULLA SALUTE E IL BENESSERE PER IL FUTURO DELLE CITTÀ LE CITTÀ SONO I CONTESTI IDEALI PER

di Federico Serra
Verrà presentata il prossimo 4 Dicembre in presso la Sala Zuccari di Palazzo Giustiniani, Science for Cities, un’alleanza scientifica, promossa dall’Health City Institute, costituita da oltre 100 qualificati e riconosciuti soggetti scientifici, come associazioni e società scientifiche, fondazioni, comitati scientifici, gruppi di ricerca, interessati ad agire sui determinanti sociali della salute nelle città, nelle metropoli, in ambito urbano e nelle aree interne marginali, montane e nelle isole minori.
Una alleanza che intende operare attraverso la collaborazione con partner qualificati quali, il Ministero della Salute, l’ANCI, il Comitato delle Regioni e delle PA, l’Istituto Superiore di Sanità, il CNBBSV della Presidenza del Consiglio, le città metropolitane, le regioni, le provincie, i comuni, le università, i servizi sanitari e di assistenza delle ASL, network come CITIES+, il mondo delle imprese, le organizzazioni che promuovono l’attivismo dei cittadini, le associazioni di volontariato, religiose e comunitarie, del terzo settore e altre istituzioni pubbliche e private, interessate ai temi dell’urban health e alla salute nelle città come bene comune.
L’Organizzazione Mondiale della Sanità, coerentemente con l’art.32 della nostra Costituzione, considera la salute diritto fondamentale dell’individuo e interesse della collettività, ritenendola anche un formidabile fattore competitivo per le Nazioni. In questo senso la salute è considerata indissolubilmente legata alla sanità di cui rappresenta un fondamentale, ancorché ovviamente non unico determinante, che trova nelle città la culla delle opportunità e dei problemi che assieme sindaci, autorità sanitarie, accademici, ricercatori ed esperti sono chiamati ad analizzare, condividere, affrontare e risolvere.
L’esponenziale sviluppo urbano, cui il mondo ha assistito ha modificato profondamente lo stile di vita della popolazione e seguita a trasformare il contesto ambientale e sociale in cui viviamo molto rapidamente.
L’urbanizzazione crea nuovi problemi: riduce l’equità, genera tensioni sociali e introduce minacce per la salute
delle persone. La configurazione attuale delle città e, più in generale l’urbanizzazione, presentano per la salute pubblica e individuale tanti rischi ma anche molte opportunità.
Se infatti le città sono pianificate, ben organizzate e amministrate coscientemente, si può dare vita ad una sinergia tra istituzioni, cittadini e professionisti in grado di migliorare le condizioni di vita e la salute della popolazione.
Questo nuovo concetto di salute, dunque, non si riferisce meramente alla sopravvivenza fisica o all’assenza di malattia ma si amplia, comprendendo gli aspetti psicologici, le condizioni naturali, ambientali, climatiche e abitative, la vita lavorativa, economica, sociale e culturale. Nel considerare ciò non è più possibile trascurare il ruolo delle città come promotrici di salute.
A tal proposito l’OMS ha coniato il termine “healthy city”, che non descrive una città che ha raggiunto un particolare livello di salute pubblica, piuttosto una città che è conscia dell’importanza della salute come bene collettivo e che, quindi, mette in atto delle politiche chiare per tutelarla e migliorarla.
La salute non risulta essere più solo un “bene individuale” ma un “bene comune” che chiama tutti i cittadini all’etica e all’osservanza delle regole di convivenza civile, a comportamenti virtuosi basati sul rispetto reciproco.
Il bene comune è dunque un obiettivo da perseguire sia da parte dei cittadini, sia dei sindaci e degli amministratori locali e anche del mondo scientifico, che devono proporsi come garanti di una sanità equa, facendo sì che la salute della collettività sia considerata un investimento e non solo un costo.
L’organizzazione della città e, più in generale, dei contesti sociali e ambientali, è in grado di condizionare e modificare i bisogni emergenti, gli stili di vita e le aspettative dell’individuo, fattori che dovrebbero, dunque, essere considerati nella definizione ed orientamento delle politiche pubbliche.
Si stima che nei prossimi decenni la popolazione urbana rappresenterà il 70% della popolazione globale.
In Italia il 37% della popolazione risiede nelle 14 Città Metropolitane e il tema della salute sta diventando una priorità di azione amministrativa da parte dei Sindaci. La città può offrire grandi opportunità di integrazione tra servizi sanitari, servizi sociali, servizi culturali e ricreativi.
Il futuro della sostenibilità dei sistemi sanitari nel mondo non può, però, prescindere dallo studio dei determinati della salute nelle grandi città, tema al quale il mondo scientifico deve e può contribuire.
aggrega entità scientifiche di riconosciuta integrità e di comprovato merito che si uniscano all’organizzazione per un sentimento civico comune di contributo al miglioramento della salute nel nostro Paese e delle nostre città;
Science for Cities è apartitico ed indipendente e non persegue particolari dottrine economico-sociali o scuole di pensiero politico, economico, sociale e clinico: l’obiettivo è fare proposte per migliorare la salute in Italia e partendo dalle Città come aggregazione delle esigenze locali dei cittadini in tema di salute; Science for Cities, intende coinvolgere la società civile traducendo in un linguaggio comprensibile l’impatto sociale delle proprie proposte in tema di miglioramento della salute negli ambienti urbani;
Il dialogo e confronto di Science for Cities con le Istituzioni è leale, trasparente, coinvolgente, aperto e costruttivo.
L’azione dell’alliance si ispira al Manifesto della salute nelle città come bene comune.
Il Manifesto delinea i punti chiave che possono guidare le città a studiare ed approfondire i determinanti della salute nei propri contesti urbani e a fare leva su di essi per escogitare strategie per migliorare gli stili di vita e lo stato di salute del cittadino. Ogni punto del Manifesto contiene le azioni prioritarie per il raggiungimento di questo obiettivo, promuovendo, a partire dall’esperienza internazionale, partenariati pubblico–privato per l’attuazione di progetti di studio sull’impatto dei determinanti di salute nei contesti urbani; L’azione dell’Health City Institute si ispira ai 10 punti qualificanti dell’azione sulla salute urbana espressi nel Manifesto.
Il Manifesto è stato realizzato grazie al contributo di un board di esperti e ha come primi firmatari il Ministro della Salute e il Presidente dell’ANCI e viene adottato dalle parti interessate e aderenti a Science for Cities.
Alla stesura e
SALUTE NELLE CITTÀ COME BENE CO-
MUNE hanno contribuito 208 esperti e 36 tra Istituzioni, enti, università, società scientifiche, associazioni pubbliche e private.
Il Manifesto è stata la base ed ha ispirato, il parere del Comitto delle Regioni dell’Unione Europea, NATVI/016 approvato nella 123° sessione plenaria dell’11 e 12 maggio 2017 “La salute nelle città: bene comun”, la risoluzione Roma Urban Health Declaration presentata e firmata in occasione del G7 il 11 Dicembre 2017, l’Urban Diabetes Declaration, adottata da 46 città a livello mondiale e documenti governativi, ministeriali e di riferimento per le amministrazioni comunali.
Il Manifesto è stato edito nel luglio del 2016, con una prima revisione febbraio 2021 e una seconda revisione marzo 2023
OBIETTIVO GENERALE DI SCIENCE FOR CITIES
Aggregare la comunità scientifica sullo studio dei determinanti della salute nelle citta per ridurre le disuguaglianze di salute e costruire. A tal fine, le Parti Interessate che partecipano all’Alliance si impegnano a contribuire a creare le condizioni che permettano di progettare, approvare e attuare soluzioni riguardante la salute in ambito urbano che affronti i determinanti socio-sanitari della salute nelle città.
OBIETTIVI SPECIFICI DURANTE I PRIMI DUE ANNI DI ATTIVITÀ DI SCIENCE FOR CITIES
Per il raggiungimento dell’Obiettivo Generale, le Parti Interessate, considerando la propria esperienza e campo di azione, si impegnano a contribuire al raggiungimento di uno o più degli Obiettivi Specifici elencati di seguito entro i primi due anni di attività:
1) Partecipare a iniziative di comunicazione/formazione su buone pratiche ben documentate e organizzate da Science for Cities.
2) Potenziare l’impatto di Science for Cities attraverso il coinvolgimento di ulteriori Parti Interessate.
3) Progredire nella capacità di monitoraggio dei determinati di salute nelle città il cui risultato atteso dipenderà dalla situazione iniziale di ogni territorio e dei dati al moment disponibili.
4) Progredire nella capacità di sviluppare almeno un intervento pilota sui determinanti della salute in ambito urbano e di valutare il suo impatto o di valutare l’impatto di interventi locali già svolti sia di matrice socio-sanitaria che non sanitaria.
5) Migliorare le sinergie e la collaborazione con le entità istituzionali, accademiche, scientifiche esistenti sul Territorio che si occupano di urban health.

Fondamentale il ruolo giocato sin qui dall’Italia, con la partecipazione delle 14 Città metropolitane e di ben 1.300 comuni di ogni dimensione e il coinvolgimento di una larga fetta della popolazione: 23 milioni di persone, ovvero il 40 per cento dei cittadini italiani
Dopo 10 anni, il progetto si rinnova e amplia, diventando “ Cities for Better Health”. Con una visione olistica della salute, si propone di dare priorità alla prevenzione e all’equità sanitaria nelle città, con l’ambizione di risolvere le cause alla radice delle malattie croniche non trasmissibili
È stato celebrato a Roma lo scorso 25 Settembre, il 10° anniversario del progetto Cities Changing Diabetes, l’iniziativa nata da una partnership tra Novo Nordisk, l’University College of London e Steno Center di Copenaghen per evidenziare il rapporto tra urbanizzazione e patologie croniche, con l’obiettivo di promuovere iniziative per salvaguardare la salute dei cittadini e prevenire l’insorgere di tali malattie. In 10 anni di attività, l’Italia ha giocato un ruolo chiave con la partecipazione di 14 Città metropolitane e 1.300 comuni, con il coinvolgimento di ben 23 milioni di persone, ovvero il 40 per cento dei cittadini italiani, tanto che è stata scelta la città di Roma come sede dell’evento celebrativo, alla presenza dell’Ambasciatore di Danimarca Anders Carsten Damsgaard e di autorevoli esponenti delle Istituzioni Italiane.
Il programma si fonda su tre elementi interconnessi che consentono alle città di mappare i fattori associati a obesità e diabete, condividere approfondimenti e aspetti chiave e fornire strumenti in grado di accelerare l’azione locale territoriale. Dal suo lancio nel 2014 con cinque città partner, le dimensioni e la portata della rete è cresciuta fino a raggiungere a livello globale oltre 200 partner in 46 città e in 24 Paesi, con una popolazione complessiva di quasi 250 milioni di abitanti coinvolti. In Italia, dove il progetto è coordinato dall’-
Health City Institute, in collaborazione con Anci –Associazione nazionale comuni italiani, e autorevoli rappresentanti delle Istituzioni e della comunità scientifica e supportato da Novo Nordisk, sono state coinvolte 8 città come partner - Bari, Bologna, Genova, Milano, Napoli, Roma, Torino, Venezia - 12 città advocate - Brindisi, Cagliari, Cremona, L’Aquila, Livorno, Novara, Palermo, Pescara, Ravenna, Reggio Calabria, Siena, Varese, - sei città follower - Catania, Cremona, Empoli, Firenze, Messina, Varese, la rete dell’hinterland milanese e torinese - e una regione: Le Marche.
«Una buona salute è alla base dello sviluppo sociale ed economico di un paese. Questa fondamentale correlazione implica che tutti gli Stati Europei dovranno presto ripensare ai servizi sanitari per renderli più sostenibili e durevoli, nonché alla necessità di creare collaborazioni trasversali tra pubblico e privato – necessarie per realizzare un sistema sanitario davvero virtuoso», afferma Anders Carsten Damsgaard, Ambasciatore di Danimarca in Italia. «Il programma CCD, realizzato con il supporto di Novo Nordisk, è un eccellente esempio di come sia possibile contribuire insieme per salvaguardare la salute dei cittadini, promovendo azioni volte alla prevenzione di gravi malattie croniche, con un particolare focus ai contesti urbani a misura d’uomo».
«Ormai più della metà della popolazione mondiale è concentrata in ambienti urbani e, secondo le stime, questo numero è destinato a crescere ulteriormente. Se da un lato le città sono motore di crescita economica e innovazione, dall’altra sono alla base di disuguaglianze di salute, influenzando il modo in cui le persone vivono, mangiano, si muovono. Vivere in città spesso comporta lavori sedentari, scarsa attività fisica e alimentazione scorretta, tutti fattori che hanno un impatto sul rischio di sviluppare malattie croniche come diabete e obesità», spiega Andrea Lenzi, Presidente di Health City Institute e del Comitato nazionale per la biosicurezza, le biotecnologie e le scienze per la vita della Presidenza del Consiglio dei
ministri.
«Il successo del Progetto Cities Changing Diabetes sta, innanzitutto, nel potente messaggio di consapevolezza che ha saputo radicare in tutti i comuni italiani, a partire dalle città partner, rispetto ai fattori di rischio presenti nei contesti urbani e nell’attuale tassonomia della popolazione e rispetto all’importanza che le politiche pubbliche messe in campo dai decisori locali rivestono», commenta Roberto Pella, Presidente f.f. ANCI, Deputato e Presidente Intergruppo “Qualità di Vita nelle Città”. «Aver squarciato questo velo grazie al progetto e alle profonde sinergie attivate ha fatto sì che, in questi primi dieci anni, l’Italia abbia visto nascere piani di azioni e metodi di lavoro condivisi per promuovere la salute e il benessere dei cittadini. E di questo la nostra Associazione è molto orgogliosa, convinta che sia essenziale continuare a impegnarsi su questo fronte», conclude.
Visto il successo e l’ampia portata raggiunta, dopo 10 anni è stato deciso di rinnovare il progetto e intensificare l’impegno per la promozione della salute urbana: sotto la bandiera di Cities for Better Health, con una visione olistica della salute, il progetto vuole dare priorità alla prevenzione e all’equità sanitaria nelle città con l’ambizione di risolvere le cause alla radice delle malattie croniche, riunendo attori in diverse discipline e settori, con un focus particolare sulle popolazioni più vulnerabili, come le comunità con basso livello socioeconomico e i bambini, attraverso la prevenzione dell’obesità infantile. In particolare, i tre temi al centro del progetto sono creare ambienti alimentari favorevoli, garantendo l’accessibilità di cibi sani, rendere l’attività fisica più facile e piacevole, e mobilitare finanziamenti sostenibili per la prevenzione primaria.
«Siamo molto orgogliosi della portata e dei traguardi raggiunti finora dal progetto a livello internazionale e, ancora di più, nel nostro Paese, dove grazie alla collaborazione di numerosi partner di valore, abbiamo creato la rete più estesa di città aderenti», dice Alfredo Galletti, Corporate Vice President & General Manager di Novo Nordisk Italia, che aggiunge «nonostante i tanti sforzi già compiuti, c’è ancora molto da fare per creare città più sane e sostenibili in grado non solo di contrastare le malattie croniche, ma anche di garantire un equo benessere socioeconomico, fisico e mentale che, in sintonia con la natura, il rispetto dell’ambiente, il minor spreco di energia, dia valore aggiunto alla salute. Per questo motivo non solo continua, ma si intensifica il nostro impegno con il progetto Cities for Better Health».
I sindaci e le città intese come comunità hanno un enorme potenziale per creare ambienti vivibili e sani per i propri cittadini. Sono motori dell’innovazione economica, sociale e tecnologica, e ormai sempre di più le persone scelgono di vivere nelle città, attratte dalla possibilità di lavoro, di poter avere servizi in termini sanitari e di istruzione per i giovani. Ma nelle città gli ecosistemi non sono sempre favorevoli o si coniugano alla buona salute.
Il benessere e la vita di città possono portare a disuguaglianze di salute, con alcune persone che hanno meno opportunità di mantenersi in salute, che diventano più vulnerabili e fragili e con maggiori rischi di sviluppare patologie croniche.
La pandemia di COVID-19 ha evidenziato ad esempio l’importanza di affrontare le malattie croniche non trasmissibili (NCD) in generale e in particolare l’obesità e il diabete di tipo 2, perché le stesse rappresentano delle zone di vulnerabilità sociale e clinica. L’evoluzione pandemica ci ha evidenziato in maniera chiara, che le persone che convivono con le NCD hanno maggiori probabilità di avere forme gravi di COVID-19 e spesso con conseguenze gravi in termini di salute, ma ha anche rivelato le nette diseguaglianze in termini di salute tra le varie fasce di popolazione e tra i vari livelli culturali, sociali, economici anche nell’ambito della stessa comunità. La pandemia ha dimostrato in maniera chiara che alcuni gruppi sono più vulnerabili e questo in ragione di dove vivono.
Periferie e le zone suburbane hanno mostrato maggiori problemi in termini di accesso alle informazioni, alle cure e alla prevenzione.
Cities Changing Diabetes è un programma globale che da dieci anni guida il cambiamento attraverso partenariati locali per promuovere la salute come priorità nelle agende cittadine e co-creare iniziative che mirino a migliorare la salute della popolazione, attraverso lo studio dei determinanti sulla salute relativamente al diabete e all’obesità. Dal suo lancio nel 2014 con cinque città partner, le dimensioni e la portata della rete è cresciuta fino a raggiungere oltre 200 partner in 47 città e in 24 Paesi, con una popolazione complessiva di più di 250 milioni di abitanti coinvolti.
Una rete unica che vuole affrontare in maniera sinergica lo stretto legame tra urbanizzazione e malattie croniche non trasmissibili
In questo l’Italia ha voluto giocare un ruolo chiave coinvolgendo con vari livelli di impegno ben 21 città, di cui 8 partner del progetto globale, e una regione, con l’idea di attivare un network nazionale in grado di studiare una parte significativa della popolazione con diabete che vive nelle città italiane.
Una forte alleanza costruita con il Parlamento, il Ministero della Salute, l’ANCI, le Regioni, le Province, il Comitato per la Biosicurezza, le Biotecnologie, le Scienze della Vita della Presidenza del Consiglio dei Ministri, l’Istituto Superiore di Sanità, il CONI, Sport
e Salute, Cities+, la Fondazione SportCity, l’Osservatorio permanente sullo sport e ben 21 Università italiane. Un primato all’interno del progetto globale del quale siamo orgogliosi.
Di pari passo con la crescita del progetto è aumentata anche la sfida, ma abbiamo compreso che solo coinvolgendo nelle città non solo le amministrazioni comunali, ma anche le università, le aziende sanitarie locali, i centri di ricerca, le strutture diabetologiche, le associazioni pazienti, la società civile e gli esperti, che il progetto potesse avere una forte identità sociale e culturale e dare risposte concrete ai cittadini. Globalmente, la prevalenza dell’obesità e del diabete di tipo 2 continua aumentare e avere un impatto su milioni di vite ogni anno, questo avviene soprattutto nelle aree urbane e anche l’Italia riflette questa situazione. I dati ci dicono che è solo bloccando la curva di crescita di malattie come il diabete di tipo 2 e l’obesità, che si possono raggiungere risultati significativi in tema di prevenzione del rischio clinico e di riduzione dei costi sanitari dovuti alle complicanze. Oggi anticipare il problema è essenziale, e questo significa puntare sulla prevenzione, sulla corretta informazione e sulla promozione di stili di vita salutari, fattori che necessitano di ampie sinergie e il superamento di silos organizzativi e culturali.
Le città sono in prima linea per sviluppare l’azione necessaria per contrastare l’evoluzione pandemica del diabete a livello urbano e i sindaci, i leader delle comunità scientifiche e accademiche delle città hanno una posizione privilegiata per poter apportare quei cambiamenti che possono migliorare in maniera significativa la salute e il benessere della popolazione. Migliorare la salute e raggiungere i vari settori della società civile e i cittadini a più alto rischio di sviluppare obesità e diabete, ma questo richiede collaborazione, conoscenza e coordinamento.
Nessuno può affrontare questa sfida da solo, e crediamo che le partnership, la raccolta e condivisione dei dati e le azioni concrete, create all’interno della nostra rete, serviranno come ispirazione per chiunque sia desideroso di unirsi a noi nel contribuire a creare quel cambiamento di cui abbiamo bisogno per città più sane e comunità più consapevoli di investire sulla salute come bene primario. Dopo dieci anni, Cities Changing Diabetes sta intensificando il suo impegno per promuovere la salute urbana sotto una nuova bandiera: Cities for Better Health
Come promotori del progetto Cities Changing Diabetes e di Cities for Better Health ci auguriamo che il nostro appello venga accolto da un numero sempre maggiore di amministratori locali, di clinici, di accademici, di sociologi, di economisti e di esperti per costruire assieme un futuro migliore per le nostre città.
Andrea Lenzi, Presidente di Health City Institute
Roberto Pella, Presidente ANCI e Presidente dell’Intergruppo Parlamentare Qualità di Vita nelle Città
Mario Occhiuto, Daniela Sbrollini, Presidenti dell’Intergruppo Parlamentare Qualità di Vita nelle Città
Angelo Avogaro, Presidente SID
Riccardo Candido, FeSDI e AMD
Alfredo Galletti, Corporate Vice President & General Manager di Novo Nordisk Italia

Costituiscono oltre il 60 per cento del territorio nazionale: 4.000 comuni con 13 milioni di abitanti, il 22,7 per cento della popolazione italiana, spesso carenti e distanti dai servizi essenziali, a partire da quelli sanitari. Lo sviluppo della sanità territoriale previsto dal PNRR rappresenta un’opportunità fondamentale. Presentato l’Intergruppo parlamentare sulla prevenzione e le emergenze sanitarie nelle aree interne.
“La nuova sanità territoriale, le emergenze e le aree interne”, è questo il titolo del Convegno che si è svolto il 18 luglio presso la Sala Zuccari del Senato della Repubblica, su iniziativa del Sen. Guido Quintino Liris. Un’occasione importante per riflettere sulle necessità delle aree interne, che rappresentano una parte molto consistente del nostro Paese, anche alla luce di quanto previsto nel PNRR rispetto allo sviluppo della nuova rete di sanità territoriale. Un punto questo su cui è importante richiamare l’attenzione di tutti gli attori coinvolti, a partire dalle istituzioni, affinché il tema si ponga fermamente quale priorità dell’agenda politica. Il Convegno è stato l’occasione per la presentazione dell’Intergruppo parlamentare sulla prevenzione e le emergenze sanitarie nelle aree interne. Presidenti dell’Intergruppo sono il Sen. Guido Quintino Liris, Membro della 5ª Commissione permanente del Senato (Bilancio) e la Sen. Daniela Sbrollini, Senatrice, Vice Presidente 10ª Commissione permanente del Senato (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale).
Una parte preponderante del territorio italiano si connota per un’organizzazione spaziale fondata su “centri minori”, spesso di piccole dimensioni. Per “aree interne” si intendono i territori del paese più distanti dai servizi essenziali (quali istruzione, salute, mobilità), una realtà che riguarda oltre il 60 per cento del territorio nazionale, 4.000 comuni con 13 milioni di abitanti, il 22,7 per cento della popolazione italiana, territori a forte
rischio di spopolamento demografico, con una mobilità giovanile elevata e una ridotta natalità, e dove la qualità dell’offerta dei servizi è spesso limitata, con una popolazione non nativa digitale e con fragilità formativa. Dal punto di vista dell’istruzione questi territori incontrano spesso forti problematiche, che acuiscono la tendenza allo spopolamento. L’offerta educativa è compromessa dalle difficoltà di spostamento e dalla tendenza alla forte mobilità degli insegnanti. Oltre l’80 per cento dei comuni nelle aree interne non ha nessuna scuola superiore statale e il 39 per cento non ospita neanche una scuola media.
Nella definizione di aree interne marginali si comprendono anche realtà montane e le piccole isole, che risultano poco connesse con i centri di erogazione dei servizi primari.
Le aree interne marginali vivono spesso una situazione di isolamento in termini di accesso ai servizi essenziali. Per poter definire quali comuni ricadono nelle aree interne marginali, si identificano i comuni “polo”, cioè realtà che offrono contemporaneamente (da soli o insieme ai confinanti), un’offerta scolastica secondaria superiore articolata (cioè almeno un liceo – scientifico o classico – e almeno uno tra istituto tecnico e professionale), almeno un ospedale sede di d.e.a. I livello e una stazione ferroviaria almeno di tipo silver. Nella classificazione delle aree interne (aggiornata dal Cipess nel 2022) i comuni che distano meno di 27,7 minuti dal polo più vicino si definiscono “cintura”; quelli che distano oltre i 27,7 minuti rientrano nelle aree interne, che si suddividono a loro volta in 3 categorie, sempre in base alla distanza dal polo: comuni intermedi (che distano tra 27,7 e 40,9 minuti), comuni periferici (tra 40,9 e 66,9 minuti), comuni ultraperiferici (oltre 66,9 minuti).
La mancanza di opportunità spinge spesso la parte più intraprendente della popolazione ad andarsene e questo rende i territori marginali sempre meno interessanti, sempre più abbandonati a sé stessi. A restare sono
soprattutto gli anziani e coloro che più faticano a trovare alternative. Nei comuni periferici e ultraperiferici oltre un residente su 4 ha almeno 65 anni. Si calcola che nelle aree interne marginali risiedono circa 1,5 milioni di cittadini con diabete. Di conseguenza, cresce in questi territori il bisogno di Stato sociale, mentre diminuiscono le risorse per darvi risposta. I territori abbandonati diventano più fragili, e il loro dissesto diventa causa di calamità e di emergenze, specie oggi con gli eventi estremi sempre più frequenti (es. piogge torrenziali, inondazioni e frane, siccità e incendi). Guardando questi territori, abbiamo conferma del fatto che ascoltare il grido della terra significa ascoltare il grido dei poveri e degli scartati, e viceversa: nella fragilità delle persone e dell’ambiente riconosciamo che tutto è connesso, che la ricerca di soluzioni richiede di leggere insieme fenomeni che spesso sono pensati come separati. In questi territori l’esistenza di presidi sanitari diffusi è un punto cruciale, che si collega alle politiche di prossimità legate alla difficoltà dei collegamenti, alla lontananza dai servizi essenziali e al progressivo invecchiamento della popolazione e delle malattie croniche non trasmissibili.
«Il PNRR identifica nello sviluppo della nuova rete di sanità territoriale un punto di sostegno alle politiche di riqualificazione dei tessuti urbani più vulnerabili –dichiara il Sen. Guido Quintino Liris, Presidente dell’Intergruppo parlamentare sulla prevenzione e le emergenze sanitarie nelle aree interne, Capogruppo della 5ª Commissione permanente del Senato (Bilancio) - Il nuovo scenario emergente si basa sulla concezione della spesa sanitaria non più come costo, ma come investimento, scardinando un preconcetto che ritiene la spesa stessa incompatibile con gli equilibri finanziari del Paese. L’identificazione delle sfide finanziarie nel perseguire gli obiettivi di sanità territoriale deve essere assicurata in combinato disposto con la qualità delle cure e la prevenzione in ognuno dei singoli territori. Prevenzione, territorio e prossimità diventano, quindi, le parole chiave per costruire una Sanità sempre più vicina e aderente ai bisogni della popolazione, in un contesto di progressivo invecchiamento della popolazione e contestuale aumento delle aspettative di qualità di vita. Risulta strategico, pertanto, lavorare per potenziare la Sanità territoriale nelle aree interne, affrontando il tema in termini di investimenti in ricerca, assistenza e cura del paziente. I bisogni sanitari e la popolazione cambiano, ma il paziente resta al centro dell’attenzione insieme al suo sistema familiare in una condizione circolare di benessere e di qualità di vita la migliore possibile; tutto ciò è realizzabile attraverso la telemedicina, la teleassistenza, l’assistenza domiciliare integrata, le Case e gli ospedali di
comunità. In quest’ottica assume rilevanza strategica la medicina di prossimità, che si realizza sul territorio prevenendo per quanto possibile l’ospedalizzazione. Assume, quindi, centralità il ruolo del medico di medicina generale in quanto in possesso di informazioni preziose sui singoli pazienti attraverso le quali il sistema di assistenza territoriale può diventare una realtà di eccellenza».
«Nelle aree interne oltre la metà (52 per cento) delle case di comunità previste col PNRR sarà spoke (contro una media nazionale del 34 per cento) e il 23,3 per cento dei futuri ospedali di comunità sarà realizzato con nuove costruzioni o ampliamenti, in linea con la media nazionale – dichiara la Sen. Daniela Sbrollini, Presidente dell’Intergruppo parlamentare sulla prevenzione e le emergenze sanitarie nelle aree interne, Vice Presidente 10ª Commissione permanente del Senato (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - L’obiettivo centrale degli investimenti del piano nazionale di ripresa e resilienza è costruire una rete di servizi sanitari di prossimità, con ospedali e case della comunità diffuse sul territorio, con punti facili di digitalizzazione, con un ruolo alla telemedicina, alle farmacie dei servizi, ai medici di medicina generale e ai pediatri di libera scelta, in modo da non creare fenomeni di digital divide e promuovere una effettiva equità socio-sanitaria per la popolazione in tutto il paese, tanto nelle città maggiori quanto nelle aree interne marginali, nelle comunità montane e nelle piccole isole».
«Ai circa 13 milioni di italiani che vivono nelle aree interne – spiega il Ministro della Salute, Orazio Schillaci - dobbiamo dare la possibilità di curarsi vicino casa, senza più dover percorrere lunghe distanze, e anche a domicilio. Penso soprattutto agli anziani e ai più vulnerabili, che hanno bisogni sociali, accentuati da una condizione di solitudine, e sanitari legati all’insorgenza di patologie croniche e di comorbilità che vanno intercettati in strutture sanitarie di prossimità. In questo scenario, la realizzazione nelle aree interne del 30 per cento delle case di comunità e di più del 20 per cento degli ospedali di Comunità previsti dal PNRR permetterà di rafforzare anche in queste zone la capacità di risposta del Servizio Sanitario Nazionale. Senza contare che con la rimodulazione del Piano abbiamo aumentato di 250 milioni le risorse destinate all’assistenza domiciliare e di 500 milioni di euro le risorse per la Telemedicina».
Le aree interne sono i territori del paese più distanti dai servizi essenziali (quali istruzione, salute, mobilità). Parliamo di circa 4.000 comuni, con 13 milioni di abitanti, (oltre il 22% della popolazione italiana), a forte rischio spopolamento (in particolare per i giovani), e dove la qualità dell’offerta educativa risulta spesso compromessa.
La maggior parte degli abitanti delle aree interne (8,8 milioni di persone) vive nei Comuni intermedi distanti dai 20 ai 40 minuti dal polo più vicino. 3,7 milioni abitano in comuni periferici, mentre 670mila vivono in aree ultra-periferiche (cioè comuni distanti almeno 75 minuti dal centro più vicino)
Fonte: Agenzia per la Coesione territoriale
Le aree interne sono i comuni italiani più periferici, in termini di accesso ai servizi essenziali (salute, istruzione, mobilità). Per definire quali ricadono nelle aree interne, per prima cosa vengono definiti i comuni “polo”, cioè realtà che offrono contemporaneamente (da soli o insieme ai confinanti): un’offerta scolastica secondaria superiore articolata (cioè almeno un liceo – scientifico o classico – e almeno uno tra istituto tecnico e professionale); almeno un ospedale sede di d.e.a. I livello; una stazione ferroviaria almeno di tipo silver. Un comune è considerato di cintura se si trova entro 27,7 minuti dal polo più vicino Tra 27,7 minuti e 40,9 è intermedio.
Tra 40,9 e 66,9 è periferico.
Oltre i 66,9 minuti è ultraperiferico.


Capire le sfide e i problemi dei comuni montani italiani è fondamentale per comprendere meglio la complessità e la diversità del nostro paese. Comuni, infatti, rappresentano un patrimonio culturale e storico insostituibile, e che svolgono un ruolo chiave per l’economia, in particolare per il settore dell’agricoltura. IFEL e l’Unione nazionale delle comunità e degli enti montani, nel loro report , sviluppato con Symbola, nel 2020, aveva fatto una fotografia precisa delle sfide che questi comuni affrontano, tra desertificazione demografica, invecchiamento della popolazione, mancanza di infrastrutture e servizi. Sfide che necessitano di risposte. Su come affrontare queste sfide URBES lo ha chiesto a Deborah Visconti, Presidente dell’Unione Comuni montani “montagna aquilana”
Sono 3.850 i comuni montani nel nostro paese, ben il 43,7% del totale delle amministrazioni comunali. In Abbruzzo si arriva ad una percentuale del 66%. Si tratta di quei Comuni classificati come montani che presentano una forte spopolamento. Lei oggi è Presidente dell’unione dei comuni montani “montagna aquilana”, un territorio complesso e fragile. Quali sono le sfide che una Comunità montana come quella da lei presieduta deve affrontare e cosa occorre?
In qualità di Presidente dell’Unione dei Comuni Montani “Montagna Aquilana” ci tengo ad evidenziare come la principale sfida per le nostre comunità interne e montane sia rappresentata dal continuo declino demografico, aggravato dall’esodo giovanile verso le città, determinato dalla carenza di opportunità lavorative e di servizi essenziali. Questo invecchiamento della popolazione rende urgente ripensare l’offerta socio-sanitaria e incentivare il ritorno o la permanenza delle famiglie nelle aree montane. Per far fronte a questo problema, l’Unione dei Comuni Montani “Montagna Aquilana” può avvalersi di alcune strategie chiave. Prima fra tutte, il rafforzamento dei servizi socio-sa-
nitari per rispondere alle esigenze di una popolazione sempre più anziana, ma anche la creazione di opportunità economiche che possano attrarre nuove generazioni. Lo sviluppo di iniziative legate al turismo sostenibile, all’agricoltura di qualità, alle energie rinnovabili e alla valorizzazione del patrimonio culturale e paesaggistico rappresenta una strada da seguire per ridare vitalità a queste comunità. Tuttavia, ciò richiede una pianificazione concertata e una volontà politica forte, capace di unire risorse regionali, nazionali ed europee per investire nel futuro di questi territori.
Il forte invecchiamento della popolazione pone l’attenzione su come assicurare i servizi socio-sanitari necessari. Piano delle cronicità, infermieri di comunità, farmacie dei servizi, elisoccorso per il volo notturno verso elisuperfici adeguate nei Comuni montani, Case della salute, servizi dell’Agenda digitale, trasporti “a chiamata” verso studi medici e centri polifunzionali sono altri punti chiave di una riorganizzazione del sistema nei comuni montani. Come assicurare questa offerta di servizi che appaiono indispensabili in termini di equità socio-sanitaria?
La garanzia di un’equità nell’accesso ai servizi sanitari è una delle questioni più urgenti per i comuni interni. Il diritto alla salute, che deve essere garantito a tutti i cittadini, indipendentemente dal luogo in cui vivono, viene spesso messo in discussione nelle aree più remote, dove la mancanza di strutture ospedaliere, di medici e di trasporti crea diseguaglianze difficili da colmare. Come Presidente dell’Unione dei Comuni Montani, ritengo cruciale un piano di riorganizzazione sanitaria che comprenda figure come gli infermieri di comunità, farmacie dei servizi, ospedali di comunità. La disponibilità di trasporti sanitari a chiamata, unita all’utilizzo di servizi digitali come la telemedicina, potrebbe ridurre le distanze fisiche e compensare la mancanza di personale medico qualificato. In questo senso, un mo-
dello di sanità “di prossimità” potrebbe essere la soluzione ideale per garantire assistenza anche nelle aree più isolate. Figure come gli infermieri di comunità possono diventare centrali nel nuovo assetto organizzativo, professionisti capaci di fornire cure domiciliari, monitoraggio costante e interventi tempestivi direttamente nelle case degli anziani o delle persone con difficoltà motorie, riducendo la necessità di spostamenti verso strutture sanitarie lontane. Le farmacie dei servizi possono giocare un ruolo simile, offrendo, oltre alla distribuzione di farmaci, un supporto per la prevenzione e la gestione delle patologie croniche. Un altro punto fondamentale è l’integrazione della telemedicina che, sfruttando le tecnologie digitali, permette di effettuare consulti a distanza e di monitorare i pazienti senza che debbano recarsi in ospedale. Questo tipo di soluzione potrebbe rivelarsi particolarmente efficace per le aree montane, dove le distanze sono un ostacolo rilevante. Tuttavia, l’introduzione di questi servizi richiede un potenziamento delle infrastrutture tecnologiche, in primis la diffusione della banda larga o della fibra ottica in tutte le zone, e la Regione Abruzzo già da oltre cinque anni sta operando in tal senso, con la messa a terra di investimenti importanti. Solo così si può garantire una connessione stabile e affidabile per le nuove soluzioni digitali.
Lo spopolamento dei comuni montani è un fatto che sembra inarrestabile. Lei è una giovane sindaca di un comune, Sant’Eusanio Forconese, che ha solo 365 abitanti. Ha scelto di spendersi per rilanciare non solo il suo Comune, ma tutta la zona montana aquilana, nota per le sue bellezz e naturali, ma anche per le sue fragilità territoriali. Come incentivare, in un comune montano come il suo, i giovani a rimanere e favorire nascite e nuove residenze?
Il problema dello spopolamento dei comuni montani, specialmente quelli più piccoli come Sant’Eusanio Forconese, è una delle sfide più ardue da affrontare. Le ragioni che spingono i giovani ad abbandonare questi luoghi sono molteplici: mancanza di lavoro, infrastrutture inadeguate, carenza di servizi sociali ed educativi. Tuttavia, il territorio montano presenta anche delle potenzialità che, se adeguatamente sfruttate, possono diventare il motore della rinascita locale. Per contrastare lo spopolamento dei piccoli comuni interni e montani e incentivare i giovani a rimanere, dobbiamo promuovere un piano di sviluppo incentrato sulle opportunità lavorative legate alle risorse naturali e culturali del territorio. In particolare, il turismo sostenibile, le energie rinnovabili e l’agricoltura biologica rappresentano settori strategici per creare nuovi posti di lavoro e attrarre giovani imprenditori. Un altro aspetto fondamentale è
la riqualificazione del patrimonio edilizio e la ristrutturazione di immobili abbandonati. Questo piano edilizio, unito al miglioramento dei servizi dedicati alla famiglia, come asili nido e scuole attrezzate con tecnologie digitali, potrebbe rendere i comuni interni e montani più attrattivi per le giovani famiglie, favorendo così un aumento della natalità e la permanenza dei residenti. Il rafforzamento dei servizi educativi e sociali rappresenta un tassello indispensabile per garantire un futuro alle comunità montane.
Collegati fin dai tempi antichi da piccoli sentieri e tratturi, i borghi della provincia aquilana rappresentano la testimonianza di secoli e secoli di storia abruzzese, pastorale, contadina e montanara. Costruiti nella maggior parte dei casi in epoca medievale, divennero in buona parte dei villaggi fortificati, protetti da castelli e mura di cinta. A distanza di secoli, ancora oggi conservano intatti i connotati di quell’architettura: case-mura strette e alte, con le finestrelle a feritoia che servivano a difendere l’abitato; in cima, i ruderi dei castelli o delle antiche torri, le rocche e le fortezze, che rappresentavano il fulcro delle autorità locali. Come valorizzare questo patrimonio unico e attirare le nuove forme di turismo molto attento al benessere psico-fisico coniugato alla natura?
I borghi montani della provincia aquilana custodiscono un patrimonio storico e culturale inestimabile, testimoni di secoli di storia abruzzese. Per valorizzare questi tesori e attrarre nuovi flussi turistici diventa cruciale un piano integrato che combini investimenti infrastrutturali, incentivi e sgravi fiscali. Migliorare le infrastrutture, come le strade e l’accesso a internet ad alta velocità, è essenziale per ridurre l’isolamento delle aree montane e facilitare la mobilità. Parallelamente, è importante migliorare la qualità della vita attraverso la creazione di spazi pubblici ben progettati, eventi culturali e servizi pubblici di qualità, che contribuiscano al benessere della comunità. Infine, la valorizzazione delle risorse naturali e culturali, anche attraverso un turismo sostenibile e rispettoso dell’ambiente, può rappresentare una leva importante per attrarre visitatori interessati al benessere psico-fisico, promuovendo un modello di sviluppo che unisca natura e cultura. Servizi pubblici di qualità e spazi pubblici ben progettati favorirebbero il benessere comunitario ed eventi culturali per rafforzare l’identità locale. In sintesi, un approccio integrato è essenziale per affrontare le sfide delle aree montane, garantendo un futuro prospero e preservando l’identità di queste comunità.


Urbanizzazione, Benessere e Salute rappresentano un trinomio sempre più centrale e prioritario per i sindaci e gli amministratori locali del nostro Paese, convinti che investire sul territorio per una migliore qualità di vita dei propri cittadini sia la chiave di volta per un futuro migliore.
Per questa ragione il motto che anima il premio è “Noi non abbiamo ereditato il mondo dai nostri padri, ma lo abbiamo avuto in prestito dai nostri figli e a loro dobbiamo restituirlo migliore di come lo abbiamo trovato.”
Il dibattito sulla promozione del benessere degli individui, della comunità e del tessuto urbano in cui si sviluppa, riscuote una crescente attenzione anche all’interno del dibattito pubblico, e come ha recentemente affermato l’architetto Renzo Piano “Un architetto e un sindaco hanno molte cose in comune. Innanzitutto, la città. L’architetto ne pensa gli spazi, ma è il sindaco che li riempie”: ebbene, molte delle intuizioni per la creazione di nuove città o per soluzioni innovative all’interno delle stesse, dello sviluppo del benessere e della qualità di vita, si devono a sindaci che hanno immaginato il futuro e hanno lavorato in una dimensione temporale che guarda alle generazioni future,
È sulla base di tale impegno e investimento che URBES assegna annualmente un riconoscimento alle politiche intraprese dalle città, dalle Fondazioni, dagli Enti di ricerca, dalle Società Scientifiche, dalle organizzazioni dello sport e del terzo settore, dai giornalisti, dagli esperti e ricercatori , che con il loro impegno e attività, investono per la tutela e promozione della salute e il benessere dei cittadini per rendere la salute nelle città un “bene comune”
Il premio, promosso dalla rivista URBES, in collaborazione con l’Health City Institute e il network CITIES+, e con il patrocinio dell’Intergruppo Parlamentare
Qualità di Vita nelle Città, giunto alla terza edizione, viene assegnato annualmente da una giuria di professioniste ed esperte nell’ambito della salute e della promozione del benessere, presieduta da Ketty Vaccaro, Responsabile Area Welfare e Salute Fondazione CENSIS, e così composta: Adriana Bonifacino (Fondazione IncontraDonna), Raffaella Bucciardini (Istituto Superiore di Sanità), Novella Calligaris (Associazione Nazionale Atleti Olimpici e Azzurri ITALIANI), Roberta Crialesi (ISTAT), Annalisa D’Amato(ANCI), Fernanda Gelona (Confindustria DM) , Francesca Roma Gigli (Giornalista), Veronica Grembi (Università Roma Sapienza), Francesca Romana Lenzi (Università Roma Foro Italico), Frida Leonetti (Università Roma Sapienza) Anna Lisa Mandorino (Cittadinanzattiva), Eva Massari (Fondazione The Bridge), Teresa Petrangolini (ALTEMS Università Cattolica Sacro Cuore Roma), Roberta Silquini (Università di Torino) Giulia Sormani (Politecnico di Milano), Chiara Spinato (HCI), Simona Tondelli (Università di Bologna).
I premiati vengono selezionati, per categoria, dalla giuria sulla base delle segnalazioni delle candidature pervenute da qualificati esperti del mondo accademico, sociale, economico, dello sport, della comunicazione, della salute e del benessere.
Un premio giornalistico viene assegnato in memoria di Mario Pappagallo, indimenticato giornalista del Corriere della Sera, divulgatore scientifico, scrittore e rimo Direttore Responsabile di URBES.
Il premio viene consegnato, in occasione della Assemblea ANCI, quest’anno il 21 Novembre alle ore 15 a Torino, nel corso di una cerimonia presso la Sala Azzurra del complesso fieristico del Lingotto.
Premio URBES CITTA’ DEL BENESSERE E DELLA SALUTE città metropolitane e di grandi dimensioni da 200.000 abitanti in su
VERONA – Promozione della salute attraverso la creazione del Planetary Health Festival
Premio URBES BENE COMUNE
città capoluogo di provincia e di media e grande dimensione da 50.000 a 200.000 abitanti
MONZA – Per la promozione della salute attraverso progetti per rendere la città “viva e sportiva”
TIVOLI – Promozione della salute attraverso lo sviluppo dei percorsi termali e della cultura
CUNEO – Promozione della salute attraverso progetti di mobilità attiva
Premio URBES COMUNITA’ DEL BENESSERE piccoli e medi comuni sino a 50.000 abitanti
CHIOGGIA – Promozione della salute attraverso la creazione della figura dell’Health City Manager
SAN GIOVANNI IN FIORE - Promozione, sviluppo e benessere del territorio e della comunità in un’area montana
VALDOBBIADENE – Promozione della salute attraverso l’esempio e la partecipazione pubblica
RICONOSCIMENTI URBES
FONDAZIONI DI RICERCA SCIENTIFICA - FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI PAVIA – Promozione della salute e ricerca
SPORT - ASSOCIAZIONE FITWAKING SALUZZO – Promozione della salute e degli stili di vita attraverso il cammino
ENTI DI RICERCA SOCIALE - BHAVE – Promozione della salute attraverso l’analisi predittiva, semiotica, intelligenza artificiale
ENTI DI RICERCA DI OPINIONE - ISTITUTO PIEPOLI – Promozione della salute attraverso le ricerche di marketing e di opinione
FORMAZIONE – VIRTUAL TRAINING
Per la promozione di attività innovative di formazione medico-sanitaria per la prevenzione e la salute dei cittadini
SPORT - LEGA CICLISMO PROFESSIONISTICO – Promozione della salute attraverso l’attività sportiva professionistica
IMPRESE - FONDAZIONE CONAD – Per la promozione della salute nelle città attraverso progetti specifici di sostegno finanziario
SOCIETÀ SCIENTIFICHE - SOCIETÀ ITALIANA DI MEDICINA GENERALE – Per la promozione della salute attraverso i programmi di prevenzione primaria
FONDAZIONI SOCIALI - FONDAZIONE ONDA – Per la promozione della salute nelle donne
SOCIALI - FONDAZIONE LONGEVITAS – Per la promozione della salute negli anziani
SPORT- MANAGER SPORTIVI ASSOCIATI – Per la promozione della salute attraverso la gestione dello sport
PREMIO RICERCATORI PER LA SALUTE NELLE CITTÀ
GIUSEPPE NOVELLI – Università di Roma Tor Vergata
STEFANO CAPOLONGO – Politecnico di Milano
PREMIO GIORNALISTICO MARIO PAPPAGALLO
ELENA MELI – Corriere della Sera

Mauro Armelao
Sindaco
Marangon Sandro
Assessore
Griguolo Perini
Se chiedi alla stragrande maggioranza dei veneti, e non solo, dove ha trascorso l’infanzia d’estate ti verrà risposto: “A Sottomarina!”
Da sempre la località del Comune di Chioggia è nota per le sue proprietà benefiche per chi soffre di patologie respiratorie e non solo. L’aria ricca di iodio è un toccasana in particolare per bambini e anziani, consigliata da pediatri e specialisti, mentre la spiaggia di sabbia ricca di quarzo rappresenta un gradevole sollievo per chi ha problemi articolari o ossei in generale.
Da un luogo con queste caratteristiche naturali non poteva che nascere una particolare propensione per il benessere a 360 gradi, tradotto dall’attuale Amministrazione comunale in una particolare propensione alle esigenze dei cittadini e al miglioramento della qualità della loro vita.
Dall’istituzione della figura dell’Health City Manager ai massicci investimenti nel verde pubblico fino alla promozione dei corretti e sani stili di vita con eventi collettivi come la Festa dello Sport. Sono varie le iniziative portate avanti dal Comune per promuovere il benessere dei propri cittadini.
Mauro Armelao, Sindaco di Chioggia: “ Quella della tutela del benessere dei nostri cittadini è per noi una scelta di indirizzo. Anche le pubbliche amministrazioni devono impegnarsi affinché i cittadini possano fare scelte consapevoli a tutela della propria salute. L’Health
City Manager lavorerà a stretto contatto con i vari assessorati per pianificare azioni che durino nel tempo e che vadano proprio in questa direzione, mentre destinare i fondi del PNRR per recuperare e rivitalizzare tante aree verdi pubbliche come abbiamo deciso di fare qui a Chioggia è un segnale forte che sottolinea quanto questi luoghi possano essere determinanti. Da sedi di incontro per soggetti fragili, per lo svolgimento di attività di promozione culturale, per la didattica e per le attività ricreative, quante cose possono ruotare attorno ai parchi pubblici. Non ultimo un evento come la Festa dello Sport che abbiamo riportato in auge propone la scoperta di tanti enti e associazioni che a vario titolo si occupano di sport”.
Chioggia, arriva l’Health City Manager
Creare una coscienza diffusa sul territorio sull’importanza della salute, un bene fondamentale di cui quasi sempre ci accorgiamo quando non lo abbiamo. E’ questo il primo obiettivo dell’ Health city Manager, figura di cui si dota anche Chioggia e ruolo previsto dal più ampio progetto di Segretariato sociale (vedi comunicato allegato).
Sandro Marangon, Assessore alle Politiche sociali del Comune di Chioggia: “Si tratta di una figura che trova la sua naturale collocazione all’interno del progetto di Segretariato sociale e che risponde a quella che secondo noi è un’esigenza forte e cioè che la salute sia un bene collettivo, che non riguarda solo il singolo. All’Health City Manager spetta il compito di indirizzare tutti verso le buone pratiche per uno stile di vita sano”.
Mauro Armelao, Sindaco di Chioggia: “Si tratta di una scelta di indirizzo, anche le pubbliche amministrazioni devono impegnarsi affinché i cittadini possano fare scelte consapevoli a tutela della propria salute. Questo professionista lavorerà a stretto contatto con i vari assessorati per pianificare azioni che durino nel tempo e che vadano proprio in questa direzione”.

L’Health City Manager esiste dal 2017, da quando l’Health City Institute, associazione con sede a Roma, ne ha ideato la figura che ruota attorno ad un concetto base: la salute è un bene comune.
Si tratta di una figura che ha competenze gestionali, nel caso dell’ente Comune, in staff al sindaco o ad un assessorato, e che coniuga i bisogni di salute espressi dalla popolazione con le azioni messe a terra dell’ente pubblico, o dall’azienda, facendo rete tra tutti gli attori coinvolti.
Il percorso formativo dell’Health City Manager viene erogato dall’ Health City Institute con la collaborazione dell’università La Sapienza, Anci e Dipartimento per le Politiche Giovanili del Ministro per lo Sport e i Giovani. Ad oggi sono circa 300 i Manager formati in tutta Italia e che trovano collocazione sia negli enti pubblici che privati che nel terzo settore.
“La figura, spiega Chiara Spinato dell’ Health City Institute, vuole superare i silos dei singoli settori per arrivare con azioni concrete in tema di accessibilità, sostenibilità ambientale, mobilità sostenibile, inclusività, sport, aree verdi, sostegno delle fasce più fragili, solo per citarne alcuni. Attualmente grandi città come Genova e Palermo hanno un Health City Manager, e anche centri più piccoli come Bergamo e Imola lo hanno sperimentato. La sensibilità in questo senso dimostrata dal Comune di Chioggia merita un plauso. Significa avere una visione futura di tutela del cittadino a 360 gradi”.
Gilberto Stival è l’Health City Manager di Chioggia: “Il primo passo sarà quello di raccogliere i dati sulla popolazione e le sue problematiche e potenzialità puntando anche alla preziosa collaborazione con il mondo dell’associazionismo, molto vivo e attivo in città. Poi indirizzeremo la nostra attività su alcuni temi come l’importanza del cammino collettivo, i benefici dello sport e l’educazione stradale vista in chiave di mobilità sostenibile. Il mio ruolo sarà quello di trovare soluzioni
nuove, di mettere a fattore comune quelle che arrivano da altre realtà e soprattutto portare le esperienze di Chioggia anche agli altri”.
Al via la riqualificazione di 4 aree di verde pubblico Chioggia, 4/12/2023 - Sant'Anna, Valli, Isola Verde e le zone in prossimità dell’Arena Duse di Sottomarina, saranno queste le 4 aree della città interessate dai lavori di riqualificazione presentati stamattina in Municipio. Un imponente progetto di riqualificazione urbana con una spiccata propensione per l’inclusione sociale e il risparmio energetico, così come previsto dal PNRR.
Mauro Armelao, Sindaco di Chioggia: “Si tratta di un ampio progetto che ci ha visti impegnati in un gioco di squadra, un lavoro congiunto tra servizi sociali, lavori pubblici, urbanistica e ambiente per il quale ringrazio tutti. Una risposta importante che daremo a tre frazioni e al cuore di Sottomarina. Utilizzeremo questi fondi del PNRR per recuperare e rivitalizzare tante aree verdi pubbliche, per destinarle in parte a luogo di incontro per soggetti fragili e in parte allo svolgimento di attività di promozione culturale, per la didattica e per le attività ricreative. Fondamentale, come dico sempre, il rispetto degli arredi che verranno posizionati, delle giostrine, dei giochi inclusivi. Sarebbe un’enorme spreco, oltre che un profondo dispiacere, vederli rovinati. Colgo l'occasione per ringraziare il sindaco della Città Metropolitana, Luigi Brugnaro, per aver coinvolto i comuni del territorio per la compartecipazione al programma”.
Serena De Perini, Assessore all’Ambiente del Comune di Chioggia: “Sono davvero orgogliosa di presentare questo progetto che vedrà la piantumazione in totale di circa 250 nuovi alberi. L’importanza del recupero delle aree verdi è un capitolo importante di questo intervento così sfaccettato che, ad esempio, a Valli, includerà anche una zona per “sgambamento” cani. Un lavoro di squadra reso possibile grazie al prezioso
impegno di tutti i Servizi del Comune”.
Sandro Marangon, Assessore alle Politiche sociali del Comune di Chioggia: “La riqualificazione comprende anche spazi per anziani, per persone con disabilità. Una delle finalità del progetto, infatti, era proprio il recupero di aree degradate da destinare all’inclusione. Da qui è stata condotta una sorta di survey anche con le associazioni del territorio dalla quale sono emerse le esigenze di giovani, famiglie proprio sulla creazione di spazi pubblici di aggregazione e per fini terapeutici, basti pensare agli anziani con patologie neurodegenerative. Il progetto prevederà proprio questa aree.”
Progetto definitivo ed esecutivo delle aree verdi a Chioggia: H&A Associati – Venezia. Gruppo di lavoro coordinato da: architetti Matteo Cibin, Seihyung Cho e paesaggista arch. Lorenzo Ortolani.
Il progetto
L’intervento è finalizzato al recupero di aree pubbliche ad oggi in stato di degrado da trasformarsi in luoghi di aggregazione e socializzazione per la promozione di attività e servizi scolastici, socio educativi, culturali e sportivi.
La proposta progettuale è stata elaborata dall'Ente secondo le linee guida ministeriali in tema di PNRR e gli indirizzi della Città metropolitana di Venezia, avente oggetto: “Intervento finalizzato al recupero, quali luoghi di aggregazione e socializzazione, di aree pubbliche ad oggi in stato di degrado per la promozione di attività e servizi scolastici, socio educativi, culturali e sportivi”.
Il progetto clodiense si inserisce in un intervento più complesso e articolato, denominato “Bosco dello Sport”, presentato dalla Città Metropolitana di Venezia, in qualità di capofila. Sono stati inseriti 28 comuni della Città Metropolitana, tra cui il Comune di Chioggia, al quale, sulla base del numero degli abitanti e indice di vulnerabilità IVSM, risultano assegnati € 5.234.288,10. Di questi, 3.300.000 verranno impiegati per il progetto di riqualificazione delle 4 aree verdi in questione. Ogni Comune ha sviluppato la propria idea progettuale, ma il filo conduttore di tutti gli interventi è costituito dalla manutenzione per il riuso e rifunzionalizzazione ecosostenibile di aree pubbliche e strutture edilizie destinate allo sport, al tempo libero, alle attività ludico ricreative e di inclusione sociale.
I lavori partiranno a breve, dopo che la ditta che realizzerà l’intervento, Il Germoglio, avrà stilato il cronoprogramma in base alle ricognizioni che farà proprio in questi giorni. Il termine dei lavori, in base ai dettami del PNRR, deve essere necessariamente il 30 giugno 2026 ma molto probabilmente la durata sarà più breve. Il progetto prevede anche il primo anno di manutenzione del verde a carico dell’impresa che realizzerà i lavori. Fanno parte dello stesso progetto anche la riqualificazione energetica del Centro Fitness che si trova all’interno dell’area interessata dal principale intervento (Arena Duse) del costo di 450.000 euro e il recupero edilizio degli Esagoni che si trovano all’interno dell’area di pertinenza dell’ex colonia della Croce Rossa del costo di 250.000 euro.
E’ più che positivo il bilancio della Festa dello Sport 2024 che domenica 6 ottobre ha inondato di allegria Corso del Popolo a Chioggia. Tantissima gente ha passeggiato tra gli stand delle circa 30 associazioni che hanno aderito, a testimonianza di quanto lo sport e più in generale l’attività fisica, siano una priorità della nostra città. Ormai tutti sappiamo quanto fare regolare esercizio fisico sia un investimento per la nostra salute, il benessere e anche il buonumore, e la ricca offerta in termini di palestre e associazioni che propone Chioggia permette di diversificare gli interessi dei cittadini.
Un ambito, quello dei corretti stili di vita, che sta molto a cuore all’Amministrazione comunale.
Avv. Riccardo Griguolo, Assessore al Turismo, Sport, Eventi del Comune di Chioggia: “Una giornata oltre le aspettative! Questo dimostra quanto i cittadini di Chioggia siano attivi e desiderosi di condividere momenti di aggregazione come questo. Un ringraziamento speciale va a tutti i volontari, le associazioni sportive e gli sponsor che hanno reso possibile questa meravigliosa festa.
Appuntamento al prossimo anno, con la promessa di rendere la Festa dello Sport ancora più grande e coinvolgente”.
La Festa dello Sport è stata anche l’occasione per rendere merito ad alcune eccellenze sportive della città, atleti che si sono distinti, anche in ambito internazionale, in molteplici sport e discipline.
Lo ha iniziato a fare nel suo Comune, Valdobbiadene, per unire due necessità: cominciare a prendersi cura della sua salute, promessa fatta in occasione della recente ri-elettura per il terzo mandato amministrativo, avendo accumulato 50 chili di peso in 10 anni, e al tempo stesso rispettare il consueto il ricevimento dei cittadini.
E così, dalle iniziali 45 persone che si sono presentate il primo giovedì, si è arrivati progressivamente a quota 215, dai 7 agli 80 anni, più 12 cani. “In famiglia mi incitavano da tempo a fare qualcosa per il mio peso, passato dai 90 kg ai tempi del primo mandato agli attuali 140 - racconta Fregonese - Ho sempre avanzato la scusa degli impegni da primo cittadino, quando poi un amico mi ha proposto di andare a camminare con lui chiedendo alle persone di fare il ricevimento settimanale durante la nostra passeggiata a passo sostenuto”.
Il sindaco decide, così, di pubblicare la proposta su Facebook per aprire la partecipazione a tutti e da quel momento sempre più uomini e donne si sono uniti per incitarlo, per parlare delle necessità del territorio, ma soprattutto per muoversi in compagnia
“Visto che il giovedì ricevevo in Comune i cittadini ho chiesto loro di unirsi a noi ed in soli due mesi dallo scorso 20 giugno siamo passati da 45 a 215 persone che camminano ogni settimana insieme a me”. Luciano Fregonese, 47 anni, sindaco di Valdobbiadene, alla guida di una lista civica di centro destra, spiega con estrema naturalezza la genesi dell’iniziativa che ha portato il centro trevigiano, famoso per il Prosecco, sulle copertine della stampa internazionale. “Per il peso raggiunto avevo problemi di salute e dovevo fare qualcosa, ed alla fine ho onorato la promessa, ma questa iniziativa è cresciuta in poco tempo con il passaparola. I cittadini potrebbero anche scegliere il ricevimento del martedì ma moltissimi – spiega – preferiscono la camminata ‘collettiva’, alcuni per stare in compagnia, altri per diverse motivazioni non necessariamente per il ricevimento”.
La camminata del giovedì non ha soltanto aiutato il sindaco a ‘provare’ a rimettersi in forma: “Se non fosse stato per i cittadini, mi sarei già fermato al secondo giovedì”, riconosce Fregonese. Ma ha soprattutto cambiato l’approccio del primo cittadino ai problemi della sua comunità: “I problemi rimangono ma condividere ‘la fatica’ della camminata mi aiuta ad affrontarli con uno spirito diverso e costruttivo”.
D’altronde, proprio nel 2018 Valdobbiadene è stato uno dei primi otto Comuni in Italia bandiera azzurra della Fidal come Città del Cammino, un riconoscimento in collaborazione con ANCI per la promozione della vita all’aria aperta. Sono in tutto, infatti, 300 i km di percorsi e sentieri che la cittadina veneta vanta, tra il Piave e le montagne, comprendenti ippovie e ciclabili. Proprio l’anno scorso è stato inaugurato il Cammino delle Colline del Prosecco, 51 km in 4 tappe, che si è andato ad aggiungere all’anello del Prosecco Superiore.
Da qui l’auspicio del sindaco veneto di allargare questa esperienza positiva alle altre amministrazioni comunali. “Il mio Comune insieme a quello di Valdengo è stato tra i primi, già nel 2008, ad avere ottenuto la Bandiera Azzurra che su iniziativa di Anci e Fidal viene assegnata annualmente alle “città del cammino e della corsa” che si impegnano favore di migliori stili di vita con attività podistiche all’aperto a garanzia di benessere e salute dei loro cittadini. “Sarebbe bello che molti traessero spunto da questa esperienza per cogliere l’opportunità di conoscersi meglio coi propri cittadini attraverso il cammino in comune”, sottolinea il sindaco veneto.




di Ludovica Serra
Due siti patrimonio Mondiale dell’Umanità UNESCO e un terzo candidato ad esserselo, un sito termale antico, una città più antica di Roma e un territorio importante dal unto di vista economicoproduttivo, che si candida a diventare “Capitale italiana della cultura 2028”
Tutto questa è Tivoli, conosciuta in tutto il mondo, una gemma che si affaccia sulla valle dell’Aniene e incastonata tra la catena dei Monti Lucretili, i Monti Tiburtini e Monti Prensetini.
Di questa prestigiosa candidatura ne abbiamo parlato con il Sindaco Marco Innocenzi.
Sindaco il 4 Ottobre è stato presentato il progetto per la candidatura di Tivoli come Capitale della Cultura 2028. Cosa ha ispirato questa candidatura?
Basta guardare il nostro patrimonio storico-naturalistico per comprendere il perché Tivoli possa essere Capitale Italiana della Cultura 2028. Abbiamo ben due patrimoni Unesco e una storia pluri-millenaria, ancor più antica di Roma. Tivoli è un attrattore turistico anche nel settore gastronomico, termale, artistico e letterario. Proporre, all’interno del mio programma elettorale, questa candidatura è stato un per corso spontaneo e oserei dire, necessario.
Quali saranno gli elementi qualificanti della candidatura che va presentata entro il 2026?
Innanzitutto una programmazione lungimirante e che riesca a valorizzare tutti i nostri punti di forza. Ci aiuterà a realizzare eventi di rilievo nazionale ed internazionale che possano coprire l’intero anno, coinvolgendo i nostri principali siti, senza trascurare quelli meno noti e visitati.

Un altro elemento portante sarà quello di rendere l’intero territorio Tiburtino Capitale della Cultura. C’è la necessità di aumentare le possibilità di aver accesso a spazi ed eventi culturali, con attività che possano coinvolgere tutte le realtà territoriali.
Una candidatura che è una sfida importante nel nome di che riguarderà tutto il territorio, infatti Tivoli e della sua vasta area di riferimento che comprende i comuni di Guidonia Montecelio, Ciciliano, Casape, Castel Madama, San Gregorio da Sassola, San Polo dei Cavalieri e Poli che hanno già deliberato nel merito. Come costruire sinergie con gli altri comuni?
Creare sinergia con questi Comuni è importantissimo per l’intero territorio. Dalla nostra candidatura a Capitale Italiana della Cultura 2028 sono certo che tutti i paesi circostanti potranno trarne vantaggio. L’aumento di afflusso turistico che ne potrebbe conseguire avrà un effetto a catena in tutte le zone confinanti, portando i turisti ad innamorarsi non solo di Tivoli, ma anche di tutti i meravigliosi comuni che lei ha citato. Inoltre ritengo che sarebbe buona idea proporre alcune iniziative, nel caso diventassimo Capitale, anche in questi territori, rendendoli tutti protagonisti diretti di un’esperienza che porterebbe lustro e garantirebbe flussi turistico-economici importanti. Tivoli à una città patrimonio dell’umanità con ben due siti UNESCO, Villa Adriana e Villa d’Este, e ora punta ad inserire anche Villa Gregoriana. Come questi siti di straordinaria bellezza possono aiutare la candidatura di Tivoli?
Sono due nostri fiori all’occhiello, come dimostrano i numeri. I dati diffusi dal Mic hanno sottolineato il boom di presenze nel 2023. I visitatori sono stati 748,656 (37,74% di accessi in più rispetto al 2022), posizionando le due ville tra i primi dieci siti italiani statali più visitati in assoluto. Però è importante ricordarsi come Tivoli offra molto altro: Villa Gregoriana, il Tempio d’Ercole Vincitore,
la Rocca Pia, l’Anfiteatro di Bleso, il Tempio della Tosse,il nostro Centro Storico Medievale e le terme. L’eterogeneità del nostro patrimonio, non solo quantitativa ma soprattutto qualitativa, è la nostra più grande ricchezza e il nostro maggior aiuto per la candidatura. Tivoli ogni anno attrae quasi un milione di visitatori e come capitale della cultura, questi numeri potrebbero lievitare ulteriormente. Una sfida per tutto il territorio e una grande opportunità che va costruita. Cosa serve a Tivoli per sfruttare questa grande occasione?
E’ necessario creare un’atmosfera creativa, dove tutti i Cittadini possano essere parte attiva e portare il loro contributo nel proporre idee, avere spazi creativi e sviluppare progetti che possano essere di supporto alle strategie già messe in campo dall’Amministrazione. Vogliamo rendere Tivoli un laboratorio innovativo di idee, rendendo tutti i quartieri un contenitore di qualità che possano essere risorse di tutti e per tutti.
Essere capitale della cultura significa mettere in mostra, per il periodo di un anno, i propri caratteri originali e i fattori che ne determinano lo sviluppo culturale, inteso come motore di crescita dell’intera comunità. Quali sono i fattori identificativi di Tivoli in tal senso?
I nostri fattori identificativi saranno lo sviluppo di eventi letterari, artistici e culturali, che possano interessare tutte le fasce d’età, diversificando le proposte in modo da attrarre sensibilità e interessi diversi. Tutto ciò rimanendo legati alle nostre tradizioni: il Carnevale, la Fiera di San Giuseppe, il Natale di Tivoli, il Settembre Tiburtino e la Sagra del Pizzutello, per dirne alcuni, possono trovare in questa candidatura un elemento espansivo per aumentare il proprio bacino d’utenza e garantirsi una pubblicità che vada oltre i confini nazionali.
Oggi nella zona di Tivoli Terme sono presenti le famose Terme Acque Albule, un ulteriore aspetto identificativo della città. Come collegare il rilancio delle Terme con la candidatura?
Il rilancio delle Terme rientra proprio nel discorso di garantire che anche le zone non facenti parte del Centro Storico possano avere le risorse, le opportunità e gli stimoli che in passato sono venute meno. Dobbiamo valorizzare lo sfruttamento delle risorse termali, valutando congiuntamente con la Regione Lazio e Acque Albule S.p.a. la realizzazione di un Parco Termale che possa essere
volano per lo sviluppo imprenditoriale e turistico di Tivoli Terme e di tutta la Città. Ovviamente senza dimenticarsi che questo sviluppo passa anche per il miglioramento di tutti i settori fondamentali per il territorio.
Cultura può significare anche rilancio dell’economia tiburtina?
Certamente. La cultura non è solo un volano per migliorare il benessere immateriale della Città, ma costituisce anche un fondamentale sostegno al tessuto economico. Per farlo serve una programmazione forte, garantita dall’interazione fra questo settore con tutti gli elementi portanti della società. Penso, in particolar modo, all’ambiente, alla sicurezza, le infrastrutture, la viabilità e la mobilità. In tal modo si potrà garantire un miglioramento del livello della qualità della vita sociale, con ricadute positive anche per l’occupazione e nella soddisfazione dei nostri Cittadini.
Come costruire sinergie coinvolgere la popolazione attorno a questa candidatura?
Facendola sentire partecipe. Come accennavo prima è fondamentale che si senta parte integrante di questa candidatura coinvolgendola nel processo di organizzazione, specialmente a livello creativo. L’Amministrazione ha il compito di incanalare tutte le migliori energie cittadine, permettendo che da questa sinergia si realizzi questo importante cammino, senza criticità aprioristiche o barriere ideologiche.
Conoscendo il carattere, la compattezza e l’amor cittadino dei Tiburtini, sono consapevole che sarà così.
Tutti conoscono Roma, la città eterna, unica per storia e bellezza, ma non tutti sanno che a poco più di mezz’ora di macchina, esiste una città ancora più antica: Tivoli, l’antica Tibur.
L’antica città latina, chiamata Tibur, si sviluppò in età arcaica sulla riva sinistra dell’Aniene come luogo di confluenza di popolazioni locali per attività commerciali. Situata ai piedi dei Monti Lucretili, è incorniciata da una natura di str aordinaria bellezza, ideale per passeggiate ed escursioni.
Nell’epoca del Grand Tour, la città era meta privilegiata di romanzieri, pittori, poeti, musicisti, che completavano la loro formazione culturale e cercavano
ispirazione dalle sue opere d’arte, dai suoi monumenti e dal suo paesaggio.
Tivoli città d’arte, storia, cultura e monumenti, ricca di siti di interesse di inestimabile valore, come le Terme di Acque Albule e le tre magnifiche Ville che la rendano una meta per quasi il milione di visitatori che ogni anno vengono a vedere la spettacolare Villa d’Este e l’archeologica Villa Adriana, entrambe Patrimonio Mondiale dell’Umanità UNESCO, e Villa Gregoriana gestita dal FAI (Fondo Ambiente Italiano).
Tivoli è una città che vanta un primato che condivide solo con Pechino, con ben due siti patrimoni dell’umanità dell’UNESCO, Villa Adriana e Villa D’Este, al quale si spera di poter affiancare prossimamente anche Villa Gregoriana.
Queste sono le premesse per la candidatura delle città a Capitale della cultura 2028
Oltre alle celebri ville, inserite dall’UNESCO tra i siti dichiarati patrimonio dell’umanità, Tivoli ospita splendidi edifici di culto, come la Chiesa di Santa Maria Maggiore, la Cattedrale di San Lorenzo, duomo cittadino, la trecentesca Chiesa di San Biagio, la Chiesa di San Pietro alla Carità in stile romanico e la Chiesa di San Silvestro del XII secolo. Fuori dal centro storico si trova il suggestivo Santuario della Madonna di Quintiliolo, dedicato alla sacra immagine della Vergine Maria, la cui icona del XIII secolo è tuttora venerata dai cittadini.
Nei pressi della cattedrale, si trova la Mensa Ponderaria, che anticamente costituiva l’ufficio di controllo dei pesi e delle misure situato all’interno del Foro. Da non perdere una passeggiata lungo via della Sibilla per ammirare le vestigia dei Templi di Vesta e della Sibilla.
Nella zona si segnalano inoltre le famose Terme Acque Albule, così dette perché alimentate da una sorgente naturale di acque sulfuree dalle proprietà antinfiammatorie.
È uno dei più importanti complessi di architettura romana del mondo, situato a poca distanza da Roma. La Villa fu fatta costruire dall’Imperatore Adriano intorno al 126 d.C. come sua residenza ufficiale. Successivamente lasciata in abbandono e oggetto di razzie durante le invasioni barbariche, fu recuperata grazie a interventi di restauro straordinari a partire dall’Ottocento.
Un piacevole percorso permette di esplorare l’area e i vari edifici che componevano nel loro insieme una piccola città. Si inizia dalla piscina del Pecile per raggiungere i diversi impianti termali caratterizzati da vari ambienti pensati per ospitare vasche con acqua a differente temperatura. Il cuore della villa è il magnifico ninfeo del Canopo, ideato per i banchetti durante le calde giornate estive, e il vicino Museo dove sono conservati i reperti più importanti. Proseguendo con l’itinerario si incontrano i palazzi dove risiedeva la famiglia imperiale, così come gli alloggi per gli schiavi e per i pretoriani.
Dopo un lungo intervento di messa in sicurezza, è stato riaperto il cosiddetto Teatro Marittimo, un edificio circolare circondato da un canale d’acqua a formare una sorta di isolotto che veniva utilizzato probabilmente per spettacoli all’aperto.
villae.cultura.gov.it https://www.turismoroma.it/it/luoghi/tivoli-e-le-sueville
Costruita per volere del cardinale Ippolito II d’Este, nominato Governatore di Tivoli alla metà del XVI secolo, la Villa è un eccezionale esempio di architettura rinascimentale ed è realizzata su due piani con stanze affrescate dai migliori pittori manieristi.
La visita inizia dagli ambienti del piano nobile, caratterizzati dagli stemmi di famiglia e da scene mitologiche legate alle origini e alla storia della città di Tivoli. Al piano inferiore si trova l’ambiente più fastoso, il Salone della Fontana, utilizzato per feste e banchetti, affrescato da Girolamo Muziano e decorato con una vera fontana in stile rustico.
Uscendo nel giardino all’italiana, inizia il percorso all’aperto, alla scoperta delle numerose fontane monumentali che caratterizzano lo spazio. Grazie all’innovativo progetto ingegneristico di Pirro Ligorio, la villa fu collegata a una sorgente d’acqua sotterranea che alimentava le fontane senza congegni meccanici ma sfruttando solamente la gravità e la pendenza del terreno. Seguendo i viali delimitati dalle siepi di bosso, ammirate il Bicchierone, la Fontana dell’Ovato e quella dei Draghi, oltre le Cento Fontanelle e la spettacolare Fontana dell’Organo che vi incanterà con melodie rinascimentali.
villae.cultura.gov.it https://www.turismoroma.it/it/luoghi/tivoli-e-le-sueville
Voluta da Papa Gregorio XVI intorno al 1834, Villa Gregoriana è un affascinante parco naturalistico costellato da evidenze archeologiche e architettoniche di varie epoche, con cascate naturali e artificiali, grotte, terrazze e scorci panoramici.
La proprietà è gestita dal FAI (Fondo Ambiente Italiano) che, dopo aver diretto il lungo e complesso progetto di recupero dell’area, si occupa della sua continua manutenzione. Da marzo a dicembre la villa apre al pubblico i suoi suggestivi percorsi, offrendo l’imperdibile occasione di ammirare uno scenario tipico della cultura romantica ottocentesca. Vengono organizzate visite guidate per adulti e bambini, oltre a un ricco programma di eventi culturali. La visita è adatta a tutte le età, con una durata media di circa un’ora e mezza, e all’interno del parco si trovano servizi, caffetteria e bookshop.
Info: fondoambiente.it https://www.turismoroma.it/it/luoghi/tivoli-e-le-sueville
Sull’antica acropoli della città, si trovano i due celebri templi di Vesta e della Sibilla.
Sul ciglio roccioso che domina la valle delle cascate, sorge il tempio di Vesta, un piccolo tempio a pianta rotonda risalente al I secolo a.C.
Era dedicato probabilmente a Vesta, dea del focolare, il cui culto era affidato alle Vestali, o a Tiburno, l’eroe che avrebbe dato il nome alla città. Conserva dieci delle 18 colonne corinzie dell’ambulacro anulare; nella cella centrale, è stata aggiunta nel medioevo una piccola abside. Nel corso dei secoli, è stato il soggetto maggiormente ritratto dagli artisti che arrivavano a Tivoli per il Grand Tour.
Situato sul punto più alto dell’acropoli della Tibur Superbum, l’attuale Tivoli, il Tempio della Sibilla è un edificio con una caratteristica forma rettangolare, che conserva due delle originarie quattro colonne ioniche sul fronte. Costruito intorno al II secolo a.C., oggi offre un panorama mozzafiato, sia dalla Piazza del Tempio di Vesta sia dal Ponte Gregoriano, suggestiva “passerella” architettonica, in travertino con un’arcata unica.
https://www.turismoroma.it/it/luoghi/tivoli-e-le-sueville
Insieme a quelli di Gabii e Palestrina, faceva parte dei grandi santuari con teatro-tempio laziali, ed era uno dei più importanti complessi sacri dell’architettura romana di epoca repubblicana.
Edificato nel II secolo a.C., era dedicato al dio protettore dell’antica Tibur. Si trattava di una struttura scenografica di dimensioni imponenti, realizzata con una serie di terrazzamenti a picco sul fiume Aniene, lungo un antico percorso di transumanza divenuto in seguito la via Tiburtina. La strada, che venne di fatto inglobata nel complesso, lo attraversava in una monumentale galleria in muratura (la c.d.Via Tecta).
Il santuario, a pianta rettangolare (188 x 140 m), misurava 3000 m2 e si articolava in tre edifici principali: il teatro, che sfruttava il naturale declivio del terreno e poteva contenere fino a 3.600 spettatori, un’ampia piazza delimitata da portici e il tempio stesso. I terrazzamenti, i portici e i colonnati formavano una maestosa scenografia intorno al tempio che si innalzava su di un alto podio.
La vita del santuario continuò fino al IV sec. d.C., ma l’abbandono definitivo risale alla prima metà del VI secolo, quando, durante la guerra greco-gotica, Tivoli venne conquistata da Totila, re degli Ostrogoti. Il tempio, in stato di abbandono, divenne gradualmente una cava di materiali e si trasformò in terreno agricolo. https://www.turismoroma.it/it/luoghi/tivoli-e-le-sueville



Architettura sanitaria, prevenzione, One Health, lotta all’antimicrobico resistenza, invecchiamento attivo e intelligenza artificiale
di Ludovica Serra
La riunione dei Ministri della Salute del G7 si è svolta ad Ancona il 10 e 11 ottobre. A presiedere l’incontro sarà il Ministro della Salute, Orazio Schillaci. Tra i partecipanti i ministri degli Stati membri del G7, il commissario europeo per la salute e la sicurezza alimentare e i ministri della salute dei paesi ospiti: Albania, Brasile, India, Sudafrica e Arabia Saudita, insieme a rappresentanti di organizzazioni internazionali come FAO, OMS e OCSE.
I principali argomenti di discussione erano su tre pilastri:
1. architettura sanitaria globale e prevenzione, preparazione e risposta alle pandemie;
2. Invecchiamento sano e attivo attraverso la prevenzione e l’innovazione lungo tutto l’arco della vita; 3. Un approccio “One Health”, con particolare attenzione alla resistenza antimicrobica.
L’obiettivo è stato quello di individuare strategie che affrontino efficacemente le crisi e le sfide attuali che comportano costi sociali ed economici significativi, combattendo nel contempo le disuguaglianze e promuovendo la salute come valore fondamentale e punto di forza delle nostre società.
I ministri si impegneranno a migliorare i sistemi sanitari e a garantire un accesso equo a cure e contromisure sicure, accessibili e di alta qualità, in particolare nei paesi a basso e medio reddito. Ciò sarà realizzato attraverso un maggiore coordinamento a livello nazionale, regionale e globale per garantire la sicurezza sanitaria globale e raggiungere la copertura sanitaria universale.
L’agenda ha affrontato anche il tema della prevenzione lungo tutto l’arco della vita, a partire dalla fase prenatale, passando per le strategie di prevenzione e la promozione di stili di vita sani. Al centro della due giorni c’è la necessità di adottare modelli alimentari sostenibili per combattere l’obesità e le malattie cronico-degenerative, affrontando contemporaneamente la malnutri-
zione nei paesi in via di sviluppo. La Presidenza italiana incoraggerà inoltre l’utilizzo di soluzioni innovative come la telemedicina e l’intelligenza artificiale, volte a migliorare sia la qualità della vita che i servizi alla comunità attraverso un approccio moderno incentrato sulla persona.
Il dibattito ha riguardato l’approccio One Health, che riconosce l’interconnessione tra salute umana, salute animale ed ecosistemi, con l’obiettivo di limitare le future emergenze sanitarie derivanti dai cambiamenti climatici, dall’inquinamento e dalla perdita di biodiversità. I ministri e le organizzazioni internazionali si concentreranno in particolare sulla resistenza antimicrobica e sull’importanza di promuovere l’uso prudente e responsabile degli antibiotici sia in campo umano che veterinario, sostenendo al contempo la ricerca e lo sviluppo di nuovi antibiotici e l’accesso a quelli esistenti, soprattutto in contesti vulnerabili.
I Ministri della Salute del G7 hanno concluso la riunione firmando un comunicato in cui si impegnano ad affrontare le principali sfide sanitarie per garantire una vita sana per tutti. Inoltre, adotteranno un documento programmatico sulle opportunità offerte dall’intelligenza artificiale sia per gli operatori sanitari che per i pazienti. A novembre, una “Implementation Conference” sulla resistenza antimicrobica concluderà l’agenda delle riunioni del G7 italiano della Salute.
FOTO
Molte applicazioni dell’IA nei sistemi sanitari sono già in uso e ci sono prove crescenti della capacità dei sistemi di IA di avere un impatto significativo sulle stra-
G7 Policy brief sull’intelligenza artificiale: opportunità e sfide per il settore sanitario L’implementazione dell’intelligenza artificiale (IA) nel settore sanitario rappresenta una grande opportunità per i professionisti sanitari, i pazienti, i decisori politici e altri stakeholder per migliorare l’efficienza operativa e i risultati sanitari.
tegie diagnostiche e terapeutiche, compresi i metodi decisionali dei professionisti sanitari, la relazione medico-paziente e le strategie di prevenzione delle malattie e di promozione della salute. Ciò richiede una forte governance per affrontare considerazioni scientifiche, tecnologiche, infrastrutturali, normative, legali, di sicurezza, etiche e barriere e sfide culturali per realizzare il pieno potenziale dell’IA in un modo che sia sicuro, protetto e affidabile. L’accesso equo alle tecnologie digitali, incluso l’affrontare il divario digitale di genere ed età, nonché l’affrontare questioni etiche e potenziali pregiudizi nei sistemi di intelligenza artificiale, deve essere prioritario per evitare di aumentare le disuguaglianze. Questi sforzi devono includere la garanzia del supporto ai professionisti sanitari, ai pazienti e ad altri stakeholder dei sistemi sanitari per acquisire le conoscenze, le competenze e le infrastrutture necessarie per trarre pieno vantaggio da questi recenti progressi. È inoltre necessario bilanciare la sicurezza dei dati e la privacy con la promozione dell’innovazione. I pazienti e i professionisti sanitari devono rimanere al centro delle decisioni mediche e garantire che le normative non siano eccessivamente complesse e allineate con gli approcci esistenti nei settori correlati, quando possibile. La capacità dell’IA di utilizzare una vasta quantità di dati e prove cliniche potrebbe aiutare i professionisti sanitari a migliorare in modo efficace ed efficiente la diagnosi, ottimizzare i percorsi di cura e il trattamento da una prospettiva di medicina personalizzata, ridurre gli errori medici, migliorare la qualità dei servizi, compresi i servizi di prevenzione delle malattie e promozione della salute, facilitando risultati sanitari positivi attraverso un approccio basato sulle prove, che rispetti gli standard e le linee guida internazionali. Esistono opportunità per semplificare il flusso di lavoro e ridurre l’onere amministrativo per i professionisti sanitari, e fornire più tempo per l’interazione con i pazienti. L’IA potrebbe dare potere agli individui e promuovere la personalizzazione delle cure fornendo maggiori approfondimenti sulle loro condizioni e facilitando la comprensione di documenti e informazioni sanitarie. Inoltre, la capacità dell’IA di elaborare rapidamente grandi quantità di dati può sbloccare valore da risorse attualmente inutilizzate per il processo decisionale. Potrebbe anche promuovere e accelerare le attività di ricerca e sviluppo (ad esempio, la scoperta di farmaci) e informare la ricerca sulla salute pubblica. L’intelligenza artificiale può anche essere uno strumento prezioso in termini di rafforzamento della sicurezza: può proteggere l’infrastruttura sanitaria rilevando attività di rete insolite, identificando malware e prevedendo potenziali violazioni della sicurezza informatica. Per quanto riguarda la sicurezza dei pazienti, gli algoritmi di intelligenza artificiale potrebbero essere utilizzati per monitorare i prodotti medici.
Pertanto, in quanto Stati membri del G7, esprimiamo
la nostra determinazione a promuovere l’uso dell’intelligenza artificiale nell’assistenza sanitaria al suo pieno potenziale, per migliorare la qualità e i risultati della salute individuale, della popolazione e pubblica e alleviare l’onere per i professionisti sanitari di ripristinare il tempo per le cure e le interazioni umane e ridurre le disuguaglianze e le disparità nell’accesso alle cure o la disponibilità di dati che rispetti i problemi di sicurezza e privacy è il primo requisito per qualsiasi sistema di intelligenza artificiale. Infatti, non si tratta semplicemente di raccogliere dati in repository dedicati, ma di avere dati disponibili in modo organizzato, classificato e standardizzato. Sono necessari dati completi e adatti all’uso per ottenere output algoritmici di qualità superiore con meno distorsioni, poiché dati incoerenti e incompleti possono amplificare inavvertitamente i pregiudizi esistenti nei dati sanitari.
Nello sviluppo dell’intelligenza artificiale per l’assistenza sanitaria, incoraggiamo gli sforzi di cooperazione internazionale verso la standardizzazione e l’armonizzazione dei dati poiché questo processo è essenziale per i) la formazione, la messa a punto, il test e la convalida dei modelli di intelligenza artificiale attraverso set di dati completi e rappresentativi per garantire accuratezza, affidabilità, pertinenza e buona generalizzabilità; ii) garantire l’efficienza negli studi multicentrici riducendo la complessità e il tempo necessari per l’aggregazione e l’analisi dei dati; iii) l’applicabilità oltre i confini. Inoltre, un solido sistema di catalogazione per i dati aperti è essenziale per supportare lo sviluppo dell’intelligenza artificiale. Per un uso sicuro, protetto e affidabile dell’IA, le iniziative sui dati aperti, così come le iniziative basate sui principi FAIR (per dati che sono reperibili, accessibili, interoperabili e riutilizzabili), forniscono ai ricercatori l’accesso a grandi set di dati per addestrare, sintonizzare e testare modelli di IA, e la ricerca applicata dovrebbe essere promossa per stimolare l’innovazione e la collaborazione tra ricercatori e sviluppatori. Rendere i dati disponibili, standardizzarli ed armonizzato non è semplice a causa di sfide tecniche e culturali legate alla governance, accountability, data literacy, trust, compliance con le norme sulla protezione dei dati e problemi di sicurezza; tutti questi aspetti sono cruciali per la tutela dei diritti dei pazienti e per l’accettazione da parte dei pazienti delle nuove tecnologie. Riconosciamo inoltre gli elevati costi opportunità che i pazienti devono sostenere se il potenziale dei loro dati sanitari non viene sfruttato. Pertanto, ci impegniamo a lavorare attivamente sull’armonizzazione delle politiche e delle normative sui dati laddove possibile, anche sfruttando gli sforzi a livello regionale e internazionale.
È fondamentale che ci impegniamo affinché l’uso dell’IA nell’assistenza sanitaria venga distribuito in modo equo e con un accesso equo. Riconosciamo i vantaggi dell’uso dell’IA nel settore sanitario, ma anche i rischi
che può comportare, in particolare per quanto riguarda le popolazioni sottorappresentate. I modelli di IA devono essere addestrati su dati rappresentativi delle popolazioni per cui saranno utilizzati, con l’obiettivo di ridurre al minimo i pregiudizi discriminatori che possono complicare l’accesso all’assistenza sanitaria. Hanno anche bisogno di trasparenza nel loro processo decisionale, per interpretare o fidarsi della validità dei risultati ottenuti. Per superare queste sfide, ci impegniamo a considerare tutti i mezzi per promuovere un accesso equo e un uso dell’IA nell’assistenza sanitaria, in particolare promuovendo modalità per ridurre al minimo i rischi di discriminazione e pregiudizi. Inoltre, riconosciamo l’importanza di monitorare i pregiudizi e valutare l’impatto degli strumenti di intelligenza artificiale per le applicazioni sanitarie e di assistenza sanitaria durante la loro implementazione per garantire che gli strumenti abbiano un beneficio netto per le popolazioni e i casi d’uso per cui sono intesi.
Ribadiamo l’impegno, assunto dai leader del G7 nel 2023, di promuovere ulteriormente il Quadro politico globale del processo di intelligenza artificiale di Hiroshima, inclusa l’implementazione dei principi guida internazionali e del codice di condotta internazionale per le organizzazioni che sviluppano sistemi di intelligenza artificiale avanzati per guidare lo sviluppo e l’adozione delle tecnologie di intelligenza artificiale, anche nel settore sanitario. Notiamo l’importanza di rispettare i diritti umani e proteggere i dati personali e la privacy. Lo sviluppo della ricerca sull’intelligenza artificiale nei sistemi sanitari dovrebbe essere effettuato nel rispetto della protezione dei dati, della sicurezza dei dati e della proprietà intellettuale. Per il bene della ricerca e della pianificazione sanitaria, l’uso dell’IA per elaborare dati sanitari dovrebbe essere incoraggiato e perseguito secondo le leggi e le normative nazionali e internazionali. Ci impegniamo quindi a incoraggiare attivamente un dialogo tra professionisti sanitari e regolatori a diversi livelli, comprese le agenzie di regolamentazione e i DPO (Data Protection Officer) locali, per promuovere la condivisione dei dati, la sicurezza dei dati e la protezione dei dati per garantire che possiamo sfruttare appieno il potenziale dell’IA nell’assistenza sanitaria.
Gli aspetti etici dell’uso dell’IA dovrebbero essere presi in piena considerazione con particolare riguardo a: i) rispetto e protezione dell’interesse pubblico; ii) inclusione, emancipazione e ottimizzazione della forza lavoro sanitaria, senza disperdere le sue tradizionali competenze o capacità decisionali; iii) servizi equi e accessibili per le persone; iv) rispetto della privacy, incluso il consenso del paziente (nel processo decisionale) e chiari obiettivi di gestione dei dati e regole di protezione dei dati.
Le considerazioni etiche sono fondamentali per l’uso dell’IA poiché la supervisione umana degli strumenti
di IA rimane una considerazione chiave per aiutare a identificare e correggere i pregiudizi, garantendo al contempo raccomandazioni giuste ed eque. A questo proposito, accogliamo con favore il “G7 Toolkit for Artificial Intelligence in the Public Sector” prodotto dal G7 Digital & Technology WG. Poiché l’interazione paziente-medico è profondamente influenzata dall’IA, le considerazioni legali sulla necessità e sui metodi di informazione dei pazienti in merito all’uso dei sistemi di IA e, soprattutto, sugli aspetti della responsabilità legale in caso di errore dell’algoritmo dovrebbero essere approfondite. Riconosciamo la necessità di promuovere l’istruzione sia dei professionisti sanitari che dei pazienti, nonché la consapevolezza dei reali vantaggi e dei limiti meno noti dei sistemi di IA, per migliorare la trasparenza ed evitare controversie in futuro. La digitalizzazione e la condivisione dei dati hanno inoltre portato all’emergere della criminalità informatica nell’ambiente sanitario. Riconosciamo l’importanza di investire fondi e risorse professionali adeguati nella sicurezza informatica, inclusa la promozione di corsi di formazione a diversi livelli, tra cui l’assistenza sanitaria professionale. Sosteniamo inoltre il rafforzamento dei meccanismi di cooperazione e l’armonizzazione, ove possibile, delle normative nazionali e internazionali.
Lo sviluppo e l’implementazione incontrollati e non regolamentati di sistemi di intelligenza artificiale in ambito sanitario possono comportare gravi rischi per i professionisti sanitarie i pazienti. Questo è il motivo per cui i quadri giuridici sono stati aggiornati o sviluppati e incorporano i principi di intelligenza artificiale dell’OCSE, che promuovono l’uso di un’intelligenza artificiale innovativa e affidabile e che rispetti i diritti umani e i valori democratici. Sosteniamo lo sviluppo e l’uso di sistemi di intelligenza artificiale sicuri, trasparenti, tracciabili, incentrati sull’uomo, affidabili, non discriminatori e rispettosi dell’ambiente; l’incorporazione dei principi di valutazione delle tecnologie sanitarie per la validazione dell’intelligenza artificiale dovrebbe essere promossa e promuovere le agenzie HTA affinché siano meglio preparate a valutare l’uso delle risorse pubbliche nelle applicazioni dei sistemi di intelligenza artificiale all’assistenza sanitaria. Riteniamo inoltre che un attento monitoraggio e sorveglianza della sicurezza post-commercializzazione siano essenziali, considerando la natura specifica intrinseca del software basato sull’intelligenza artificiale.
Il “divario digitale” dei professionisti sanitari e della popolazione generale per quanto riguarda i sistemi di intelligenza artificiale è probabilmente dovuto a una combinazione di scarsa conoscenza delle tecnologie dovuta a rapidi sviluppi, mancanza di comprensione delle possibili applicazioni e mancanza di incentivi e supporto per implementare soluzioni digitali. e sfiducia nella tecnologia. Accogliamo con favore iniziative edu-
cative per i professionisti sanitari, gli enti di regolamentazione, i ricercatori e sviluppatori per migliorare la conoscenza e le competenze nel campo dell’intelligenza artificiale e aumentare l’affidabilità nei sistemi di intelligenza artificiale. Questi programmi dovrebbero coprire argomenti interdisciplinari, tra cui scienza dei dati, apprendimento automatico, sistemi sanitari e quadri normativi. Supportiamo il lancio di campagne di comunicazione dedicate alla popolazione generale sull’uso dell’intelligenza artificiale nell’assistenza sanitaria attraverso i media tradizionali e i social media. Per superare la sfiducia tecnologica, supportiamo attivamente la trasparenza dei dati, l’imparzialità, l’equità, la governance dei dati, la privacy, la responsabilità, la sicurezza e le iniziative di sostenibilità ecologico-ambientale.
Allo stesso modo, riconosciamo la necessità che le persone aumentino la loro alfabetizzazione in materia di intelligenza artificiale, comprese le conoscenze e le competenze necessarie per consentire ai pazienti di trarre vantaggio dalla tecnologia dell’intelligenza artificiale nell’assistenza sanitaria con programmi educativi che siano culturalmente sensibili e rispettino i diversi background



di MANUELA CAUCCI
In occasione del G7Salute, tenutosi ad Ancona dal 9 al 10 ottobre scorso, l’Amministrazione Comunale ha deciso di coinvolgere la cittadinanza organizzando “ExtraG7Salute - Il festival del vivere bene da ogni punto di vista”, con l’obbiettivo di divulgare e sensibilizzare al concetto di salute così come è definito dall’OMS “uno stato di completo benessere fisico, mentale e sociale e non semplice assenza di malattia”.
Il mio Assessorato, insieme al Capo di Gabinetto ed in collaborazione con l’Azienda Ospedaliera Universitaria delle Marche, l’Ast, l’INRCA e l’Università Politecnica delle Marche ha creato un format che è arrivato a contare oltre 50 appuntamenti e dal 3 al 13 ottobre hanno preso vita meeting, spettacoli ed eventi in esterna ed in prestigiose location situate nel centro della nostra città: il suggestivo Teatro delle Muse, la gotica Loggia dei Mercanti, Il Museo Archeologico delle Marche che si trova nel cinquecentesco palazzo Ferretti, lo Studentato Buon Pastore all’interno dei locali dell’Ex convento “Buon Pastore” ristrutturato di recente, la Sala del Consiglio Comunale, la sede della Facoltà di Economia Giorgio Fuà nella ex Caserma Villarey di Piazza Martelli ed infine per le esterne, due delle quattro piazze principali del centro storico ovvero Piazza Roma e la significativa Piazza Cavour che segna la congiunzione tra i rioni ottocenteschi e quelli del Novecento e sorge lungo la passeggiata “da mare a mare”.
Per affrontare un tema così vasto come quello della Salute, che è cosa ben diversa dalla Sanità pubblica, abbiamo deciso di creare quattro filoni tematici: Società e Salute che ha voluto fare focus su conoscenza e trattamento di specifiche patologie, Benessere e Stili di Vita rivolto alla promozione di sane abitudini, Territorio e Sanità che ha voluto fare rete tra Istituzioni, enti e cittadinanza ed infine Futuro Sano che ha rivolto l’attenzione su natalità, giovani, intelligenza artificiale e comunicazione.
Per la realizzazione del festival è stato fondamentale puntare sulla “qualità” e sul “fare rete”, tanto che gli
Assessore ai Servizi sociali, Welfare, Politiche dell’integrazione, Politiche sociosanitarie, Rapporti con aziende ospedaliere sanitarie e INRCA, Ciclo idrico integrato, Rapporti con Viva Servizi S.p.A. del comune di Ancona
ospiti scelti sono state figure autorevoli provenienti sia dall’Italia che dall’estero e soprattutto non solo professionisti sanitari e sociali, ma anche rappresentanti delle professioni e del terzo settore “operanti nell’abito salute”. Naturalmente hanno partecipato anche esponenti politici di rilievo come la Dott.ssa Lucia Albano – Sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze e Marcello Gemmato – Sottosegretario di Stato alla Salute. Ai diversi eventi hanno preso parte il Sindaco Daniele Silvetti, il Presidente regionale Francesco Acquaroli, Filippo Saltamartini Assessore regionale alla Salute e la sottoscritta in qualità dell’Assessore alle politiche sociosanitarie del Comune di Ancona. Il Festival è stato costruito con eventi di altissimo carattere scientifico, ma sempre con un carattere anche divulgativo, il cui elenco può essere reperito nella pagina che rimarrà dedicata all’ExtraG7salute nel sito del Comune di Ancona, ma ci tengo ad evidenziarne alcuni che hanno avuto un notevole riscontro di pubblico:
“Stile di vita marchigiano: un modello salutare” evento curato dalla dottoressa Marina Taus, Dirigente Medico SOD Dietetica e Nutrizione Clinica, Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche di Ancona che ha celebrato l’esempio marchigiano proprio come modello da seguire visto che L’ISTAT ha riconosciuto che “grazie alla forte vocazione rurale della regione, i marchigiani consumano cibo salutare, a filiera corta ma soprattutto di qualità” e che i nostri territori sono fondati su una tradizione olearia e vinicola di eccellenza.
“Dare priorità alla salute del cervello: un imperativo globale per la salute pubblica” evento organizzato da SIN, la Società Italiana di Neurologia e con la Strategia Italiana per la Salute del
Cervello, che ha consentito di condividere tramite
Ancona l’esperienza Italiana con Norvegia, Svizzera, Finlandia, Canada e tutti gli altri paesi in cui la salute del cervello è stata definita con piani nazionali perché ogni paese ha la responsabilità di proteggere, prevenire e curare la salute del cervello dei propri cittadini, così come evidenziato dal Professore Alessandro Padovani, Presidente della SIN. Durante il Convegno che ha visto insieme diversi relatori esteri tra cui Vladimir Hachiniski Past President della Federazione Mondiale di Neurologia e relatore per il Canada ed illustri relatori nazionali come Giovanni Leonardi Direttore del Dipartimento ‘One Health’ del Ministero della Salute e Matilde Leonardi - Iniziative per la salute del cervello dell’OMS, Europee e a livello internazionale, EAN - European academy of neurology ha premiato il Sindaco Daniele Silvetti riconoscendo la nostra città non solo quale luogo dal buon modo di vivere, ma anche Capitale europea per la salute del Cervello per l’anno 2024.
“Intelligenza artificiale in sanità – stato dell’arte e progetti applicativi per una migliore cura della popolazione” evento organizzato dall’Azienda Ospedaliera Universitaria delle Marche che ha evidenziato l’importanza dei nuovi strumenti che la tecnologia e la ricerca ci mettono a disposizione.
L’intelligenza artificiale (IA) in sanità sta trasformando la diagnosi, il trattamento e la gestione delle malattie e può essere utilizzata esattamente come stanno facendo altri Paesi Europei e non, così come ci hanno documentato e “fatto toccare con mano” i relatori internazionali dagli Stati Uniti e dalla Gran Bretagna, come il Prof. Marco Mazzanti illustrando i principi fondamentali dell’IA e presentando progetti concreti che utilizzano l’IA per migliorare la cura della popolazione.
“Il ruolo dei territori per la salute dei cittadini” convegno organizzato da ANCI nella giornata dell’otto ottobre che si è tenuto al Ridotto del Teatro delle Muse ove si è parlato di Accessibilità, continuità e prossimità dei territori e di strumenti di integrazione sociosanitaria nei territori marchigiani alla presenza di Gian Luca Gregori Magnifico Rettore dell’Università Politecnica delle Marche, Marco Fioravanti Presidente ANCI Marche, Giovanni Stroppa Direttore Generale AST Ancona. Oltre la sottoscritta sono poi intervenuti Maria Capalbo in rappresentanza di Federsanità, la responsabile Welfare, Politiche Sociali e Salute ANCI Annalisa d’Amato, il Capo Dipartimento per le politiche sociali, del terzo settore e migratorie, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Alessandro
Lombardi ed infine il Direttore Generale dell’Unità di Missione per l’attuazione degli interventi del PNRR, Ministero della Salute Alessio Nardini e ancora i direttori delle Ast territoriali di Ascoli Piceno, Fermo, Macerata e Pesaro Urbino ed i primi cittadini di Ascoli Piceno, Fermo, Macerata, Camerino e di Pesaro ed infine i rappresentanti degli ATS della Regione Marche. La salute, il territorio ed il suo sviluppo i temi al centro del dibattito, un momento di confronto e di vero arricchimento.
Mi piace anche evidenziare che gli eventi hanno riguardato non solo i temi classicamente riconducibili alla salute, ma ci si è indirizzati altresì al benessere fisico, psicologico e mentale coinvolgendo anche Enti ed Istituzioni che a prima vista potevano sembrare anche non attinenti al tema “Salute”.
Ad esempio, la natalità si conferma sempre più la nuova questione sociale e sanitaria, per questo motivo la Fondazione per la Natalità, in collaborazione con il Comune di Ancona, con il patrocinio di ERDIS Marche – Ente Regionale per il Diritto allo studio, ha organizzato sabato 12 ottobre presso l’Istituto Buon Pastore l’evento dal titolo “Più giovani, più futuro. Per la salute del Paese”.
E non solo, sono state introdotte tematiche importati come l’ “Ascolto dei ragazzi sulle risposte emotive agli eventi relazionali e analisi dei riflessi in materia di salute” organizzato dal Presidente del Tribunale per i Minorenni delle Marche Dott. Cutrona che ha coinvolto numerosi giovani delle scolaresche che hanno lavorato tramite dei quesiti e con il sussidio di strumenti multimediali a formulare percorsi utili a superare situazioni stressanti, che ovviamente coinvolgono anche la salute dei nostri ragazzi.
Sempre i giovani sono stati parte attiva nel laboratorio che si è svolto durante l’evento “Circles activities e autismo: il benessere come chiave di comunicazione” a cura e con la partecipazione del musicista Albert Hera, cantante definito “narratore di suoni” e la docente e musicista Claudia Carletti che hanno presentato il progetto di sperimentazione e ricerca su le circles activities e l’ autismo con i loro risultati e benefici verso tutti coloro che sono affetti da questa sindrome, fenomeno purtroppo in crescita. L’incontro è stato emozionante ed empatico ed ha dimostrato come la musica possa essere ricompresa non solo tra le arti, ma anche tra le scienze come vera e propria “terapia”.
L’attenzione è stata posta non solo sui più giovani, ma anche sulla cosiddetta “Silver Age”. La longevità e l’innovazione sono i capisaldi dell’attività di AC75 SA in collaborazione con il Comune di Ancona, IRCCS
INRCA, Camera di Commercio delle Marche e con il supporto di Fondazione Marche, hanno lanciato “Ancona Longeva: l’innovazione per vivere più a lungo e meglio”, iniziativa che ha previsto tre momenti di intervento. Il primo con l’attivazione di sperimentazioni di tecnologie innovative con un campione di cittadini anziani anconetani. Il secondo con lo svolgimento di 4 giornate di incontri in Piazza Roma in cui hanno avuto luogo talk divulgativi, laboratori ed attività come lo yoga della risata o la pittura artistica. Terzo ed ultimo momento, l’incontro conclusivo dal titolo “Innovazioni e startup per vivere più a lungo e meglio” svoltosi al Museo Archeologico il 5 ottobre in cui si è fatto un bilancio delle sperimentazioni poste in essere e si è evidenziata la volontà di trasformare la città di Ancona nella capitale italiana della Silver Economy. Vi sono stati anche momenti musicali e teatrali sempre riconducibili al tema salute, come con l’esibizione di Opus 1 Big Band, orchestra formata da 18 elementi che hanno eseguito un repertorio jazzistico interpretando brani famosi di artisti come Duke Ellington, Count Basie, Burt Bucharach, ove la maggior parte dei componenti della Band sono professionisti della medicina con una forte passione in comune che hanno dato più volte vita a raccolte fondi a sostegno di organizzazioni benefiche.
Ugualmente il tema della salute mentale è stato trattato anche in maniera artistica dal duo comico Ale e Franz al Teatro delle Muse che sono stati i protagonisti di un’intervista-spettacolo. L’evento è stato promosso da Lundbeck Italia, azienda farmaceutica specializzata nelle neuroscienze che, per il suo 30° anniversario di attività nel nostro Paese che ha voluto riportare all’attenzione del grande pubblico questo prioritario tema. La serata è stata patrocinata dal Comune di Ancona e si inserisce nel progetto nazionale Everyone4mental Health ideato da Rete Città Sane Nazionale OMS di cui il Comune stesso fa parte, un progetto che nasce per dare priorità alla salute mentale e combattere lo stigma e l’isolamento delle persone più fragili. Infine, nella giornata del 13 ottobre a conclusione del palinsesto, si è dato spazio agli “STATI GENERALI DELLE PROFESSIONI
DEL SISTEMA SALUTE” ove, alla presenza del Presidente della Regione Francesco Acquaroli, i rappresentanti delle Federazioni, Consigli e Commissioni di Albo nazionali delle professioni sanitarie e sociali, hanno analizzato ciascuno dalla sua prospettiva il do-
cumento redatto durante il G7 e firmato dai ministri della salute. Momento conclusivo di grande confronto e reciproca condivisione.
La sinergia fra i numerosi partner che hanno partecipato è stata sicuramente l’arma vincente ed ogni singolo evento è stato un arricchimento per gli uditori oltre che per la sottoscritta, che ha avuto così modo di approfondire numerosi temi di grande rilevanza sociale dai quali non si può prescindere per una concreta programmazione di servizi per i nostri cittadini.
Non solo, ciò che è stato evidente è che mettendo a stretto contatto fra loro anche gli addetti ai lavori che si occupano quotidianamente della nostra salute, possono scaturire nuove idee e nuovi progetti che potranno sicuramente migliorare la vita di ciascuno di noi. Molto spesso nel “mondo salute” gli stessi attori non sono a conoscenza di quello che altri stanno facendo e quindi il ritrovarsi a parlare di temi a tutti cari è stata una reciproca conoscenza delle proprie competenze e professionalità, che, mi sia consentito, nelle Marche sono di altissimo livello.
Invero, i cittadini hanno potuto finalmente comprendere l’enorme lavoro che hanno fatto e continuano a fare tutti gli operatori del mondo della Salute e della Sanità, con grande professionalità e profonda responsabilità tanto da far essere la nostra regione fra i primi posti a livello nazionale per l’offerta dei servizi sanitari ed al tempo stesso il contenimento dei costi.
E’ stata una bellissima esperienza e mi auguro vivamente che “Extra Salute” divenga un format che possa identificare la nostra città come un punto di riferimento per studio, approfondimento e divulgazione di temi così cari a tutti e fondamentali per il nostro futuro e quello dei nostri figli.
Focus sugli strumenti di integrazione sociosanitaria proposto da Anci Marche nell’ambito
tra G7 Salute.
Domicilio come primo luogo di cura e telemedicina. Ecco le due parole chiave legate al Pnrr in riferimento anche al lavoro che l’Unità di Missione per l’attuazione degli interventi del PNRR sta portando avanti emerse dall’evento inserito nel programma di ‘Extra G7 Salute – il festival del vivere bene da ogni punto di vista’ svoltosi dal 3 al 13 ottobre, accompagnando il G7 Salute ad Ancona. L’evento con tanti relatori qualificati ha voluto rappresentare un momento di dialogo volto a promuovere l’integrazione sociosanitaria nella Regione.
L’apertura dei lavori è stata a cura di Francesca Bedeschi, Direttore di Anci Marche che ha rappresentato le motivazioni per le quali Anci Marche ha inteso organizzare l’iniziativa per toccare due tematiche fondamentali con due tavole rotonde distinte, l’una legata ‘Accessibilità, continuità e prossimità dei territori dopo il 2026’ e l’altra legata agli ‘Strumenti di integrazione sociosanitaria nei territori marchigiani’. Su questi concetti si sono sviluppati, ciascuno per le proprie competenze i saluti del Sindaco di Ancona Daniele Silvetti che ha dato il benvenuto a tutti i presenti rivendicando l’orgoglio che la città stia meritando la fiducia della Regione Marche e del Governo che ha scelto Ancona per il G7. Gian Luca Gregori, Magnifico Rettore dell’Università Politecnica delle Marche ha rimarcato l’impegno dell’Università per formare professionisti sul territorio incrementando l’offerta di corsi di laurea che afferiscono alle materie sanitarie. Marco Fioravanti, Presidente ANCI Marche ha sottolineato il ruolo dei territori e la necessità di fornire servizi a tutti i cittadini ma che, grazie al percorso strutturato, dà una evidente centralità ai sindaci, Francesco Acquaroli, Presidente della Giunta Regione Marche ha illustrato il percorso che si sta compiendo e la visione politica.
Alla tavola rotonda sul tema ‘Accessibilità, continuità
e prossimità dei territori dopo il 2026’ sono intervenuti l’Assessore alla Salute del Comune di Ancona Manuela Caucci, Maria Capalbo in rappresentanza di Federsanità, il Direttore Generale M6 PNRR Alessio Nardini del Ministero della Salute, moderati da Francesco Caroli, portavoce Rete Città Sane OMS e da Federico Serra, Segretario generale Health City Institute e Cities+.
La seconda parte, incentrata sugli ‘Strumenti di integrazione sociosanitaria nei territori marchigiani’ ha previsto il dialogo fra i direttori delle Ast territoriali ed i primi cittadini moderato da Chiara Spinato, Ufficio Integrazione Sociosanitaria di Anci. L’integrazione sociosanitaria resta un tema particolarmente attenzionato sia dai cittadini che dai sindaci e da qui la necessità del confronto proposto da Anci Marche con i rappresentanti delle istituzioni regionali e nazionali che si occupano ogni giorno dell’accessibilità e della continuità dei servizi sociosanitari erogati. L’evento è stato organizzato in collaborazione con Morandi Group, Domina Audi Zentrum Ancona, Rotary Club Ancona.


“Nel nostro mondo sempre più urbanizzato, ci sono così tante opportunità per le città, che sono già responsabili del 70% delle emissioni globali di gas serra, di guidare la lotta globale. Il sindaco Hidalgo è una leader visionaria, il tipo di leader che dimostra come l'azione locale possa risolvere la crisi climatica.”
(Time - Le 100 persone più influenti del 2020)
Al Gore, Premio Nobel per la pace, ex vicepresidente degli Stati Uniti e fondatore e presidente del Climate Reality Project
di
Ludovica Serra
Dieci anni fa Anne Hidalgo ha fatto la storia diventando la prima donna sindaco di Parigi. Nel suo discorso inaugurale aveva indicato, che non poteva immaginare il futuro della città senza una “vera transizione energetica e ambientale”. Un decennio dopo, è innegabile che Hidalgo abbia completamente trasformato la capitale francese, ma questi cambiamenti hanno avuto un costo politico considerevole.
Dieci anni di mandato sono altrettanti anni di azione al servizio di Parigi e dei parigini. Dal 2014 Anne Hidalgo e la maggioranza comunale riunita hanno avviato un cambiamento ecologico radicale per affrontare una sfida importante: l’adattamento del patrimonio cittadino al cambiamento climatico consentendo ai parigini di trovare un alloggio, e programmare fiorire nella loro vita. Ecologia e solidarietà sono le due bussole che hanno orientato l’azione comunale. L’uno non va senza l’altro.
Gli ultimi 10 anni sono stati segnati da grandi crisi che hanno dovuto essere affrontate: la crisi dell’accoglienza dei rifugiati, gli attentati del 2015, le conseguenze della crisi climatica, COVID-19. Ogni volta Parigi ha resiste, soprattutto grazie ai parigini e ai suoi servizi pubblici.
Parigi ha fatto la scelta consapevole di continuare a investire, più di 16 miliardi di euro dal 2014, anche se l’ultimo decennio è stato quello di un massiccio disimpegno dello Stato nei confronti del bilancio della città.
Un dato lo dimostra chiaramente: per tre anni, la dotazione operativa complessiva (DGF) di Parigi ammonta a 0 euro, contro 930 milioni di euro del 2015. Questo però è la partecipazione principale dello Stato ai bilanci degli enti locali. Nello stesso tempo, la spesa richiesta a Parigi per finanziare la solidarietà territoriale ha continuato ad aumentare crescere fino a raggiungere i 777 milioni di euro nel 2024, rispetto ai 456 milioni di euro del 2015
Parigi deve inoltre assumersi la responsabilità esclusiva del pagamento delle indennità o dell’assistenza sociale, vale a dire 3 miliardi dal 2014, non compensati dallo Stato
Queste sono state le premesse che ha introdotto Anne Hidalgo il 23 marzo, nell’evento celebrativi i dieci anni della sua sindacatura, aprendo le porte dell’Hotel de Ville ai cittadini e mostrando loro e ai media cosa è stato fatto in questa decade di governo di Parigi.
Un open day al quale abbiamo avuto la fortuna di essere presenti come URBES, per vedere come una grande capitale cambia il suo volto.
Una sindaca che amministra una delle città più iconiche del mondo, ed è responsabile di oltre due milioni di cittadini, di un bilancio di 10 miliardi di euro e di un organico comunale che supera le 50mila persone e di una città che per vocazione unisce il turismo, con i grandi musei, con la moda, la vitalità artistica e culturale in grado di creare nuove tendenze, ma che è anche diversità sociali e culturali, tra il centro dai boulevard e le banlieue delle periferie.
“Sono 10 anni che, con tutta la squadra comunale che ho l’onore di guidare, noi perseguiamo una politica ambiziosa per trasformare la nostra città, sempre al servizio di tutti Parigini e tutti i parigini- ci dice Anne Hidalgo- 10 anni di lavoro collettivo per adattare la nostra città al riscaldamento globale mentre si fa vivere quotidianamente la solidarietà. 10 anni durante i quali, è vero, abbiamo attraversato grandi crisi, ma anche vissute magnifici successi, come la vittoria dei Giochi Olimpici e Paralimpici per il quale ho lottato e che accelererà la trasformazione della nostra città.
Oggi i numeri ci sono.
40%: questa è la riduzione dell’inquinamento della nostra città in circa dieci anni. Perché l’inquinamento uccide, meno inquinamento significa meno morti. Ecco come proteggiamo la salute dei nostri bambini, degli anziani e dei
Come abbiamo raggiunto questo obiettivo? Assumendo una rottura importante e radicale: la fine delle auto come principale mezzo di trasporto.
Lo sono i 1.300 chilometri di piste ciclabili che si estendono da un capo all’altro della nostra città testimoni concreti. La bicicletta è entrata nella vita dei parigini che, per niente al mondo, tornerebbe indietro. Siamo riusciti a riconquistare la Senna con passeggiate sulle rive e, presto, nuoto! Anche la natura ha riconquistato i suoi diritti 45 ettari di nuovi parchi e quasi 150.000 alberi piantati dal 2014. Questo è tutto la nostra città che si è trasformata, e in particolare quella che vogliamo piccola Parigini e piccoli parigini, con più di 130 cortili oasi e più di 200 strade con scuole. Continueremo.”
Ma l’impegno della Sindaca nella vivibilità, sostenibilità, nel sostegno alle fasce sociali più svantaggiate. Nella lotta alle diseguaglianze e nell’inclusione include altre iniziative.
“Un’altra cifra illustra da sola la nostra politica sociale: 13 centesimi – continua la Hidalgo - Si tratta del primo prezzo per un pasto in mensa, un prezzo che non è mai cambiato dal 2014 nonostante l’inflazione e le varie crisi che abbiamo attraversato. Perché ce l’abbiamo voluto in questo modo.
Di fronte alle disuguaglianze che crescono ovunque nel pianeta e che minacciano le nostre vite democratico, con il mio team miriamo ad essere il più vicino possibile a quelli e chi più ne ha bisogno e per mantenere quotidianamente vivo il servizio pubblico comunale. È il senso del mandato che per due volte mi è stato affidato.
Questa è la politica che perseguiamo in materia di alloggi, con 700.000 parigini e i parigini vivono oggi in alloggi costruiti su iniziativa del Comune. Anche questo è vero sul fronte della prima infanzia con 4.720 nuovi posti negli asili nido realizzati dal 2014, che oggi fa di Parigi la città più dotata della Francia. Lo dobbiamo alle famiglie.
Questa valutazione è anche quella di un cambiamento nelle nostre pratiche democratiche.
In 10 anni abbiamo ridato voce ai parigini per decidere le loro scelte future. Continueremo.
Con i voti dei cittadini, hanno sostenuto la riconquista delle loro strade votando contro la fine dei monopattini self-service e per la triplicazione delle tariffe dei parcheggi per i SUV.
Ogni anno, grazie al bilancio partecipativo, i parigini sono sempre di più sempre più numerosi a partecipare e votare per sempre più ecologia, con più strade dentro scuole, piste ciclabili, percorsi nelle oasi, parchi ma anche per una maggiore solidarietà con servizi pubblici ovunque per accedere alla cultura, all’istruzione, allo sport, alla sanità e al tempo libero. Trasformare Parigi per prepararla alla sfida climatica, questa immensa sfida che ci mobilita in ogni momento, dando vita alla solidarietà, cioè stando accanto ai più vulnerabili, preservando ciò che rende la bellezza unica al mondo della nostra città, questo è ciò che mi anima ogni giorno come sindaco di Parigi.
Un mandato che esercito da 10 anni, ogni giorno con questo immenso orgoglio che mi guida e mi obbliga: quello di essere al servizio di Parigi, quello di essere al servizio dei parigini e Parigini”
Ma Anne Hidalgo è anche la paladina della città dei quindici minuti, una sindaca che difende l’idea che puoi trovare tutto vicino a casaciò che è essenziale per la vita: fare la spesa, lavorare, divertirsi, imparare, fare sport, trattare... Tutto in 15 minuti a piedi. Ciò implica, tra le altre cose, dare una posizione centrale alla scuola, avere una politica per promuovere e difendere il commercio locale, riunire la cultura degli abitanti, garantendo la loro tranquillità in un ambiente pulito e curato.

+ 550 CHILOMETRI
nuove piste ciclabili, ovvero come andare da Parigi a Brest
+155.000
alberi piantati
+131
cortili ristrutturati
+205
strade con scuole, 56 delle quali già con percorsi paesaggistici e verdi
+5420
nuovi posti negli asili nido
700.000
Parigini che vivono in alloggi sociali a Parigi nel 2024
13 CENTESIMI
il primo prezzo per un pasto in mensa, invariato dal 2014
OLTRE 5 MILIONI
visitatori dei musei della città di Parigi nel 2023, un record!
OLTRE 16 MILIARDI DI EURO
investito dal 2014 sul futuro per Parigi
3.200
progetti realizzati grazie al bilancio partecipativo
45 nuovi ettari di verde pubblico
+300
edifici pubblici ristrutturati per far fronte ai cambiamenti climatici
di Ludovica Serra
“Andiamo nel cuore della città e lasciamo gli stadi”, ha detto Pierre Rabadan, vicesindaco di Parigi responsabile dello Sport e dei Giochi Olimpici e Paralimpici. Si tratta di un cambio di modello per le Olimpiadi, il cui centro di gravità è stato a lungo uno stadio principale e degli impianti satelliti, spesso in periferia.
“Una volta che saremo nel centro della città, sarà speciale perché quello è un campo di gioco e nessun’altra città lo ha fatto”, aveva spiegato il direttore esecutivo dei Giochi Olimpici del Comitato Olimpico Internazionale (CIO), Christophe Dubi.
“I Giochi si adattano alla città e alla regione e non il contrario” è stato il motto delle Olimpiadi di Parigi.
Le Olimpiadi sono state sempre uno spettacolo televisivo con un pubblico globale di miliardi di persone, ma a Parigi i Giochi hanno cambiato il loro volto, con un coinvolgimento ampio della città, facendola diventare un impianto a cielo aperto.
“Quando lo guarderai in TV, saprai che è a Parigi. Non ci saranno dubbi che questi siano i Giochi di Parigi, che si tratti dei colori che si usano o dell’architettura che si vede, si capisce immediatamente di essere a Parigi”, aveva dichiarato Lambis Konstantinidis, Direttore Esecutivo del Coordinamento e della Pianificazione del comitato organizzatore (COJO).
E così è stata, rappresentando un modello di riferimento anche per i Giochi delle prossime edizioni, La cerimonia di apertura è stata lungo la Senna e non all’interno dello stadio e i nuotatori e i triatleti di lunga distanza si sono dati battaglia lungo il fiume dal ponte dorato Alexandre III di fronte agli Invalides e a Place de La Concorde, entrambe sedi di gara, passando per il Grand Palais, un’altra sede vicino alla Torre Eiffel e al parco del Trocadero. Altri due siti di competizioni olimpiche.
Il numero di progetti di costruzione necessari per qualsiasi Olimpiade presenta sfide logistiche, ma la creazione di una serie di sedi temporanee nel cuore di una città, ha presentato sfide particolari.
“Concorde, Champs de Mars, Invalides, Pont Alexandre III, Trocadero - quattro Stades de France in numero di posti”, ha detto Rabadan, il cui staff ha stimato di aver partecipato a “più di 30” incontri pubblici per placare i malumori emersi nei parigini.
Più di 20 stazioni della metropolitana sono state chiuse per la cerimonia di apertura e tre, nel cuore della città, per tutti i Giochi, ma non prima della vigilia della cerimonia di apertura.
Alcune strade intorno alle sedi sono state bloccate, per i Giochi, altre corsie VIP, riservate alla famiglia olimpica e ai loro ospiti, hanno limitato il traffico.
Tutte difficoltà inizialmente poco comprese dai parigini, ma alla fine apprezzate che hanno permesso di raggiungere l’obiettivo di rendere le Olimpiadi di Parigi più aperte, più urbane, più giovane, più equilibrate, più generose, proiettando l’immagine di una città in tutto il mondo.
La cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Parigi ha offerto uno spettacolo straordinario. Migliaia di atleti hanno navigato lungo la Senna mentre più di 400.000 persone erano allineate lungo le rive per godersi tutto, mentre le riprese televisive proiettano in tutto il mondo le immagini di Parigi.
Assumendo una nuova veste, la sfilata degli atleti si è tenuta sulla Senna con imbarcazioni per ogni delegazione nazionale. Queste barche erano dotate di telecamere per consentire agli spettatori televisivi e online di vedere gli atleti da vicino. Snodandosi da est a ovest, i 10.500 atleti hanno il centro di Parigi, trasformato il campo di gioco generale per i Giochi, nel quale gli atleti hanno gareggiato per 16 giorni. La sfilata è
giunta alla fine del suo percorso di 6 chilometri davanti al Trocadéro, il tutto arricchito da una serie di esibizioni artistiche.
Dopo aver attraversato in lungo e largo la Francia, la fiamma olimpica invece è stata accesa nel Jardin des Tuileries, tra il Palais du Louvre e Place de la Concorde, ed è stata la per tutta la durata dei Giochi Olimpici di Parigi 2024. Il luogo scelto è diverso da quello ipotizzato inizialmente. Originariamente infatti il progetto denominato “Projet Ariane” prevedeva l’installazione del braciere olimpico nella Cour Carrée del Louvre, al centro dell’omonimo museo. Braciere olimpico, opera del designer Mathieu Lehanneur, sospeso in cielo a una mongolfiera. Era stata presa in considerazione anche la Tour Eiffel ma alla fine è stato scelto il Jardin des Tuileries per la sua facilità di accesso al pubblico. Questa scelta riflette la volontà degli organizzatori e del Comune di Parigi di rendere le Olimpiadi accessibili a tutti.
Cerimonia di apertura, accensione della fiamma olimpica, maratona, urban sport e gare di equitazione nel centro della città, triathlon e nuoto nella Senna, facevano parte di una scommessa e di un nuovo concetto di Olimpiadi.
I mega-eventi sportivi internazionali sono stati criticati per il loro impatto ambientale.
Tutte le parti coinvolte insistono sul fatto che concentrare così tanta azione nel centro della città ha contribuito a rendere i Giochi del 2024 “sostenibili”.
Le Olimpiadi, aveva detto Konstantinidis, devono essere “sostenibili sia dal punto di vista ambientale, ma anche da un evento che non alimenti quella che chiamiamo l’inflazione di riferimento”.
I Giochi di Parigi hanno combattuto la tendenza di “sempre di più e di più e di più e sempre più grande e sempre più grande”.
Tra le novità vi è stato il divieto delle bottiglie usa e getta. Coca Cola, uno dei “partner olimpici”, ha installato 700 fontane di soda automatizzate appositamente sviluppate.
La città ha pianificato di utilizzare questo come precedente e rendere permanente il divieto di imbottigliamento. Piuttosto che restituire le corsie VIP lungo la circonvallazione di Parigi all’uso generale, la città le riserverà ai veicoli a più occupanti.
E il recupero della Senna alla balneazione era uno degli obiettivi che gli organizzatori volevano raggiungere.
“I Giochi Olimpici e Paralimpici ci hanno anche permesso di vincere una serie di battaglie per accelerare queste trasformazioni in un tempo davvero molto più breve del solito”, ha detto Rabadan.
Mentre i Giochi potrebbero trasformare realmente Parigi, guardando avanti al 2028 e al 2032, si è più cauti sull’impatto a lungo termine sulle Olimpiadi.
Per Christophe Dubi, che in qualità Direttore Esecutivo dei Giochi del CIO, ha supervisionato la gestione e il coordinamento di tutti gli aspetti dei Giochi Olimpici sin dalla fase di candidatura nel 2015 “Il sapore locale, la cultura locale è ciò che rende le Olimpiadi ogni volta più ricchi”.
“Non cercate di replicare la cultura di Parigi a Los Angeles- ha detto Dubi- Non cercate di replicare Hollywood e il potere delle star di Los Angeles a Brisbane”.
LA TORRE EIFFEL SIMBOLO DEL CONNUBIO DELLA CITTÀ CON I GIOCHI OLIMPICI

Anche la Torre Eiffel decorata con i cinque anelli, è stato il simbolo dei giochi all’interno della città
I cerchi, chiamati anche “Spectaculars” da Parigi 2024, sono i protagonisti dello show grazie al loro formato gigante: 29 metri di larghezza, 13 metri di altezza e circa 30 tonnellate. Ogni anello ha un diametro di 9 metri.
Con l’installazione degli anelli olimpici, la Torre Eiffel è diventata ancora di più parte integrante delle Olimpiadi e Paralimpiadi di Parigi 2024: è stata inclusa nelle medaglie olimpiche e paralimpiche, nel design del podio, nella cerimonia di apertura, e trovava anche all’intersezione tra alcuni stadi e siti olimpici essenziali (Parc des Champions, Champ de Mars Arena, Ponte Iéna). È anche sulla valuta: da giugno 2024, la Torre è stata coniata su 24 milioni di monete commemorative da 2 euro, messe in circolazione dalla Zecca di Parigi



Dalle prime fasi della candidatura ai Giochi, Parigi 2024 ha voluto incoraggiare lo sviluppo degli sport urbani lontano dagli stadi e nel cuore della città, nel loro ambiente naturale. Quest’idea è stata perfettamente rappresentata dalla trasformazione temporanea del Palazzo della Concordia in un’arena all’aperto. Questo sviluppo dimostra anche i grandi cambiamenti proposti e attuati dal consiglio cittadino parigino per riadattare il monumento in modo sostenibile.
Nel 2014, il CIO ha lanciato l’Agenda Olimpica 2020, invitando i comitati organizzatori per i Giochi ad aggiungere temporaneamente nuovi sport ed eventi ai loro programmi. Parigi 2024 ha deciso di aggiungere diversi sport moderni e contemporanei come breaking, il surf, lo skateboard (in strada e al parco) e l’arrampicata sportiva. In linea con l’approccio moderno, alcune altre discipline sono state incluse nel programma di Parigi 2024, come il basket 3x3, lo sport urbano numero uno al mondo; BMX freestyle, una variante acrobatica delle gare BMX. BMX freestyle, breaking, skateboard e basket 3x3 hanno nella La Concord, una località unica al centro di Parigi 2024, per la durata dei Giochi. Il parco urbano ha ospitato i quattro sport non-stop da sabato 27 luglio a domenica 10 agosto.
Ospitando gli sport urbani nei loro habitat naturali, nel centro cittadino, Parigi 20204 ha offerto un’esperienza indimenticabile per tutti, promuovendo un concetto innovativo che ha unito sport moderni con uno spettacolare luogo storico.
L’allestimento de La Concorde è stato temporaneo e ha ospitato quattro sport condividendo le risorse di un solo impianto, e facilitandone l’istallazione e i rifornimenti nell’area, in un luogo facilmente raggiungibile grazie alla rete di trasporti pubblici già esistente nella zona. Come per ogni impianto Olimpico, è stata posta particolare attenzione alla mobilità delle persone con capacità motorie ridotte.
Con la fine delle Olimpiadi 2024, è lecito chiedersi: quale «eredità» resterà per la città di Parigi? Anche perché, per la prima volta, la voce «eredità» figurava nel budget iniziale del progetto «Parigi 2024» (stimato in 50 milioni di euro su 4,4 miliardi, che però sono più che raddoppiati) e perché le ambizioni degli organizzatori in materia di «sostenibilità» erano alte. L’eredità, materiale e immateriale, andrà molto al di là della fiaccola olimpica. Uno degli obiettivi degli organizzatori era di evitare i «mostri edilizi» che sfigurano il paesaggio una volta concluso l’evento, come accadde ad in altre Olimpiadi. L’idea era quindi di privilegiare infrastrutture smontabili e modernizzare quelle esistenti, costruendo da zero solo strutture utili a riqualificare alcuni quartieri, in particolare la città di Saint-Denis, nella popolare periferia a nord. Il nuovo Centre Aquatique Olympique, costruito vicino allo Stade de France, sarà destinato ai giovani e alle scuole, mentre il Villaggio degli atleti, un «ecovillaggio» di 31 edifici, diventerà un quartiere residenziale. Un altro obiettivo era che il 100% dei siti olimpici fossero raggiungibili con i trasporti pubblici e in bici: sono stati realizzati quindi più di 100 chilometri di piste ciclabili e sono state prolungate diverse linee, tra cui la 14 interamente automatica, che collega l’aeroporto di Orly a Saint-Denis. Il progetto «Parigi 2024» inoltre prevedeva inoltre di valorizzare il patrimonio storico cittadino, attraverso cantieri di restauro attivi da anni, compreso quello del Grand Palais che ha permesso di ospitare le prove di scherma e taekwondo. Sono stati completati anche i restauri della Chiesa della Madeleine e della facciata di Saint-Eustache, oltre che di celebri fontane come la Fontaine des Innocents e la Fontaine Stravinsky, a Les Halles.
Parigi spera di incrementare i flussi turistici a lungo termine, sfruttando i vantaggi della splendente immagine da cartolina della città che è stata diffusa in mondovisione e della piacevole esperienza per i turisti, sottolineata anche da diversi media internazionali, per il buonumore che si è respirato in città e l’efficienza dei trasporti e dell’accoglienza dei visitatori Il bilancio definitivo di queste Olimpiadi si potrà fare solo tra diversi mesi o anni. Intanto l’Ufficio del Turismo di Parigi ha pubblicato i primi numeri sull’affluenza: 11 milioni di visitatori in due-tre settimane, a cui si vanno aggiunti 4 milioni per le Paralimpiadi, in linea dunque con le previsioni.
L’esperienza di Parigi rilancia il concetto di balneabilità dei fiumi delle grandi città e un nuovo modo di vivere i corsi fluviali delle nostre città
di Ludovica Serra
In occasione delle Olimpiadi di Parigi, il movimento dell’Urban swimming, ha avuto il suo più grande successo, quando la televisione ha mostrato a tutto il mondo che atleti di tutto il mondo si tuffavano nella Senna per il triathlon per le gare di nuoto di fondo. Lo spettacolo televisivo dei nuotatori che si facevano strada a stile libero attraverso Parigi, fiancheggiati da ponti in stile Beaux-Arts, ha offerto uno scorcio di come potrebbero apparire anche in tutti i nostri corsi d’acqua urbani, e aperto un dibattito su come le città possano riappropriarsi di un bene così prezioso come sono i fiumi.
Queste preziose arterie fluviali, troppo spesso inquinate, potrebbero rinascere come i grandi spazi pubblici? Un giorno, un tuffo nel Tamigi, nell’Hudson o nel Tevere potrebbe essere comune quanto una passeggiata al parco?
Quello di Parigi non è stato solo un esperimento di natura sportiva, ma un chiaro esempio di riqualificazione ambientale e urbanistica, cercando di far sì che i cittadini si riappropriassero della Senna, attraverso un investimento di 1,4 miliardi euro.
Nel XVII secolo, i parigini nuotavano spesso nella Senna, spesso nudi, fino a quando le autorità non vietarono la pratica. Nel 1923, tutti i bagni urbani nella Senna furono vietati per motivi di salute e sicurezza a causa dell’aumento del traffico fluviale a Parigi. Un secolo dopo, nell’estate del 2025, tre siti nel cuore di Parigi apriranno gratuitamente ai nuotatori esperti. Queste sedi saranno a Bras Marie, tra i ponti Sully e Marie vicino al Marais sulla riva destra; a Bras de Grenelle, vicino alla Torre Eiffel sulla riva sinistra, tra il porto di Grenelle e l’Île aux Cygnes; e a monte a Bercy, intorno alla passerella Simone de Beauvoir tra i ponti Tolbiac e Bercy.
I Giochi Olimpici di Parigi hanno accelerato il progetto a lungo termine del Municipio di rendere balneabile la Senna. Un totale di 110 triatleti e 55 nuotatori maratoneti hanno partecipato a cinque eventi in acque libere svoltisi nel fiume, nonostante le sessioni di allenamento siano state cancellate e il triathlon maschile sia stato posticipato a causa delle forti piogge che hanno degradato la qualità dell’acqua e con molte polemiche, alla fine lo spettacolo è stato assicurato e la Senna è tornata ad essere balneabile.
Il sindaco di Parigi Anne Hidalgo si è tuffata nella Senna il 17 luglio per dimostrare che la qualità dell’acqua soddisfaceva gli standard olimpici, dimostrando sicurezza nel progetto portato avanti e sottolineando come tra i suoi impegni durante la campagna elettorale c’era stato proprio quello di rendere balneabile la Senna dopo cento anni di divieto
Del resto gli sforzi per migliorare la qualità dell’acqua della Senna risalgono agli anni ‘80. Oggi, 34 specie di pesci prosperano nella Senna, rispetto alle sole due di 40 anni fa.
Il successo delle Olimpiadi ha rafforzato la determinazione dello Stato, della città di Parigi e di altri, a rendere il nuoto nella Senna una realtà entro luglio 2025 durante gli eventi estivi di due mesi di Paris Plages.
Paris Plages trasformerà le rive della Senna e due località dei canali in un’oasi estiva, offrendo varie attività gratuite, sedie a sdraio e ombrelloni.
Con l’aumento delle ondate di calore, l’iniziativa di Parigi di aprire i suoi corsi d’acqua alla balneazione è una risposta sostenibile al riscaldamento globale e al caldo estremo.
I tre futuri punti di balneazione fluviale, insieme ai due siti esistenti sul canale, forniscono una tregua tanto ne-
cessaria contro l’afa estiva per una capitale con oltre due milioni di residenti.
L’apertura della Senna ai bagnanti durante l’estate è un progetto da 10 milioni di euro, soggetto a una stretta supervisione da parte delle autorità prima di essere considerato sicuro.
Antoine Guillou, vicesindaco di Parigi responsabile dei servizi igienico-sanitari, ha dichiarato che sono in corso discussioni con la Prefettura Regionale e l’Agenzia Regionale per la Sanità per l’attuazione del piano.
“La città di Parigi – dice il vicesindaco-presenterà un dossier nei prossimi mesi a entrambe le istituzioni. L’ultima parola spetta alla Prefettura regionale. È l’istituzione che deciderà quali saranno le condizioni per nuotare nella Senna nel 2025”.
Una volta approvato, Guillou ha detto che verranno condotti regolarmente due tipi di test.
Il primo è un test di laboratorio per valutare i livelli di batteri E. coli ed Enterococchi - che indicano l’inquinamento delle acque reflue o delle feci nel fiume - con risultati disponibili entro 24 ore. Il secondo prevede l’utilizzo dello strumento ColiMinder o Fluidion per monitorare i livelli di batteri nella Senna, in tempo reale.
Le zone di balneazione della Senna saranno diverse dalle quattro piscine esistenti nel canale, a Bassin de la Villette.
Nel canale, l’acqua scorre naturalmente nelle piscine attraverso i fori sui lati. Le piscine, di profondità variabile, sono chiuse da galleggianti piatti sul fondo.
Nella Senna non ci saranno piscine chiuse; L’esperienza di nuoto vuole essere il più “naturale” possibile, con bagnini in servizio per garantire la sicurezza delle persone.
I galleggianti segneranno i confini per i nuotatori, proteggendoli dal consueto traffico fluviale nella sede di Bercy. Le sedi di Bras Marie e Bras Grenelle saranno chiuse al traffico fluviale mentre saranno aperte per il nuoto.
Quella di Parigi è una strada già intrapresa da altre città che dopo aver ignorato le arterie fluviali, stanno imparando ad amare di nuovo i loro fiumi. In tutto il mondo, mentre il riscaldamento globale fa salire alle stelle le temperature estive, le persone hanno necessità di trovare refrigerio nelle acque dei propri fiumi e laghi.
A Copenaghen, all’ora di pranzo, le mura del porto sono gremite di corpi abbronzati che si abbronzano su ponti a più livelli e si lanciano in acqua da piattaforme di legno predisposte dagli amministratori comunali. Gli impiegati si fermano per un tuffo veloce tra una riunione e l’altra, mentre i traghetti navigano. Dopo il lavoro a Vienna, le rive erbose del Danubio si affollano di nuotatori che si rilassano all’ombra degli alberi del fiume, appena cambiati nelle torri degli spogliatoi a più piani che il comune ha previsto, mentre un treno della metropolitana passa su un ponte vicino.
“Quello che è successo a Parigi rappresenta un cambio di testimone generazionale”, afferma Matt Sykes, un architetto paesaggista australiano e promotore della Swimmable Cities Alliance, una rete globale di sostenitori del nuoto urbano che si impegnano per rendere le scene sulla Senna una realtà quotidiana per tutti noi. “Con il cambiamento climatico, le città sono costrette ad adattarsi. L’accesso al nuoto diventerà una parte inevitabile del vocabolario del design urbano. La prossima generazione è pronta: i bambini guarderanno il triathlon olimpico in TV e chiederanno: “Perché non possiamo nuotare nel nostro fiume?”“


Città giovani e in crescita dovrebbero creare ricchezza e opportunità, ma riusciranno a fronteggiare le sfide sociali dell’urbanizzazione?
Cosa rende una città la potenza economica di domani? Si tratta dell’innovazione, degli investimenti globali o della resilienza dei suoi cittadini? Mentre il mondo guarda al 2035, i paesaggi urbani dell’Africa sono destinati a subire cambiamenti sismici nelle loro fortune economiche.
Secondo il rapporto redatto dall’Economist Intelligence Unit, sei città africane avranno più di 10 milioni di persone entro il 2035, con una popolazione giovane e in forte espansione nel continente africano, che rende lo stesso come la regione con la più rapida urbanizzazione al mondo.
La capitale dell’Angola, Luanda, e il polo commerciale della Tanzania, Dar es Salaam, si uniranno alle metropoli del Cairo, Kinshasa, Lagos e Greater Johannesburg con popolazioni di oltre 10 milioni, ha affermato l’Economist Intelligence Unit nel suo rapporto sulle città africane.
Secondo il rapporto, entro la metà degli anni 2030 le prime 100 economie urbane dell’Africa ospiteranno quasi 400 milioni di persone, circa il 21% della popolazione del continente. Queste città, che comprendono sia mega-popolazioni che capitali più piccole come Libreville, Cotonou e Port Louis, genereranno oltre il 60% del PIL dell’Africa.
Città giovani e in crescita dell’Africa sono viste come una fonte sconfinata di creatività e innovazione, ma molte sono state anche al centro di ondate di proteste quest’anno tra corruzione, aumenti delle tasse, mancanza di lavoro e classi politiche che sono spesso considerate inadeguate a gestire le stesse.
Questa urbanizzazione frenetica, che porterà più della metà degli africani a vivere in città e paesi entro il
2035, dovrebbe creare ricchezza, dinamismo e opportunità di business, afferma il rapporto, ma aggiunge anche che con tutta questa crescita arrivano sfide significative. Le città dovranno fare i conti con il sovraffollamento, le abitazioni informali, l’elevata disoccupazione, i servizi pubblici sottosviluppati, i servizi pubblici tesi e la crescente minaccia del cambiamento climatico. Affrontare questi problemi sarà fondamentale per sbloccare il pieno potenziale economico del panorama urbano in evoluzione dell’Africa. Entro il 2035, oltre alle sei megalopoli, il continente avrà 17 aree urbane con oltre 5 milioni di persone e circa altre 100 con oltre 1 milione.
Delle 100 città più grandi entro il 2035, si prevede che Addis Abeba crescerà a un tasso medio annuo del 10,6%, seguita da Kampala, Dar es Salaam e Abidjan a un tasso superiore o vicino al 9%.
Si prevede che la popolazione urbana del continente raggiungerà quasi 1 miliardo entro il 2035, rispetto ai circa 650 milioni dell’anno scorso. Si prevede che l’Africa orientale sarà la regione con la popolazione urbana in più rapida crescita, seguita dall’Africa centrale e dall’Africa occidentale.
L’EIU ha affermato che le “megalopoli in divenire” includono un tratto di 370 miglia (600 km) di costa dell’Africa occidentale da Abidjan, in Costa d’Avorio, verso est attraverso Ghana, Togo e Benin fino a Lagos, in Nigeria, che “potrebbe diventare uno dei più grandi corridoi urbani del mondo entro il 2035”, con oltre 50 milioni di persone.
Linee guida del Governo cinese per incoraggiare gli anziani a fare volontariato nei servizi comunitari e ad aiutare le aree sottosviluppate,
La popolazione anziana della Cina sta crescendo rapidamente. Nel 2023 i cittadini di età pari o superiore a 60 anni hanno raggiunto i 297 milioni, pari a oltre il 21% della popolazione, mentre quelli di età pari o superiore a 65 anni sono stati 217 milioni, pari al 15,4%.
La Cina sta spingendo la sua popolazione anziana a fare volontariato nei servizi comunitari mentre la nazione è alle prese con una popolazione che invecchia e una forza lavoro in diminuzione.
Il National Committee on Ageing (Comitato Nazionale per l’Invecchiamento) ha pubblicato venerdì 20 settembre nuove linee guida per promuovere l’iniziativa Silver Age Action, un programma lanciato due decenni fa per sostenere il lavoro di volontariato dei cittadini più anziani, secondo quanto riportato dal South China Morning Post.
L’iniziativa mira a promuovere la partecipazione dei volontari anziani nelle regioni sottosviluppate, con particolare attenzione al miglioramento di servizi come l’assistenza all’infanzia, l’assistenza agli anziani, l’assistenza ai disabili e il sostegno ai bambini svantaggiati, secondo una dichiarazione del Ministero degli Affari Civili.
Le autorità locali sono state esortate a integrare Silver Age Action nei piani di cooperazione regionale tra le province orientali e occidentali. Le linee guida sottolineano l’arruolamento di anziani istruiti per contribuire con la loro esperienza nelle aree meno sviluppate, sostenendo ulteriormente lo sviluppo economico e sociale della Cina.
Le nuove linee guida propongono anche di riservare una parte delle posizioni di volontariato ai grandi eventi per gli anziani e incoraggiano la creazione di una piattaforma online per abbinare i volontari anziani alle esigenze della comunità.
Il comitato prevede di istituzionalizzare ulteriormente il programma entro il 2026, con l’obiettivo di renderlo un “Key brand” riconosciuto entro il 2028 per i cittadini più anziani che desiderano rimanere attivi e contribuire con le proprie competenze.
La spinta a coinvolgere i volontari anziani arriva in mezzo a sforzi più ampi per gestire gli effetti dell’invecchiamento della popolazione cinese. La scorsa settimana, la massima legislatura del paese ha approvato un piano per aumentare l’età pensionabile fino a cinque anni entro il 2040.
A partire da gennaio, l’età pensionabile aumenterà gra-
dualmente di alcuni mesi all’anno. Inoltre, entro il 2030 il periodo contributivo minimo richiesto per la pensione di base passerà da 15 a 20 anni.
UNO STUDIO DELLA WASHINGTON UNIVERSITY RIVELA COME I LOCKDOWN PER IL COVID HANNO CAMBIATO IL CERVELLO DEGLI ADOLESCENTI
Secondo lo studio gli effetti del lockdown COVID19 suggeriscono che vi sia stata una maturazione accelerata sulla struttura cerebrale degli adolescenti
Le misure restrittive introdotte tra il 2020 e il 2021 hanno svolto un ruolo importante nel frenare la diffusione del coronavirus SARS-CoV-2. Tuttavia, questi lockdown hanno avuto un costo: l’interruzione della routine quotidiana e delle attività sociali. Si ritiene che queste interruzioni siano state particolarmente dannose per gli adolescenti, che si affidano alle interazioni sociali per sviluppare il loro senso di identità e controllo di sé.
“Pensiamo alla pandemia di COVID-19 come a una crisi sanitaria, ma sappiamo che ha prodotto altri profondi cambiamenti nelle nostre vite, soprattutto per gli adolescenti”, ha detto Patricia Kuhl, autrice senior del nuovo studio e co-direttrice dell’Institute for Learning & Brain Sciences (I-LABS) dell’Università di Washington.
Nel 2018, Kuhl e i suoi colleghi dell’Università di Washington hanno intrapreso uno studio longitudinale con 160 adolescenti di età compresa tra 9 e 17 anni per valutare i cambiamenti nella struttura cerebrale durante l’adolescenza tipica. In particolare, il team ha deciso di esplorare i cambiamenti nello strato esterno del cervello chiamato corteccia cerebrale, che è noto per diventare più sottile con l’avanzare dell’età.
Tuttavia, nel 2020 è diventato chiaro che le esperienze adolescenziali di questi partecipanti sarebbero state tutt’altro che “normali”.
“Una volta che la pandemia era in corso, abbiamo iniziato a pensare a quali misure cerebrali ci avrebbero permesso di stimare ciò che il blocco della pandemia aveva fatto al cervello”, ha detto in una dichiarazione Neva Corrigan, autrice principale dello studio e ricercatrice presso I-LABS. “Che cosa significava per i nostri adolescenti essere a casa piuttosto che nei loro gruppi sociali, non a scuola, senza fare sport, senza uscire?”
È noto che lo stress cronico e gli eventi negativi della vita accelerano l’assottigliamento corticale, che è collegato a un aumento del rischio di sviluppare disturbi di salute mentale, in particolare tra le giovani donne. Quindi, quali effetti potrebbe avere una pandemia glo-
bale su questi cambiamenti nella struttura del cervello?
Utilizzando i dati originali del 2018, il team ha creato un modello per mostrare la traiettoria prevista dell’assottigliamento corticale per questi adolescenti. I partecipanti sono stati poi sottoposti a una seconda scansione cerebrale nel 2021 per confrontare come i loro cervelli erano effettivamente cambiati durante questo periodo.
In media, il cervello degli adolescenti ha mostrato un assottigliamento corticale significativamente accelerato, con effetti particolarmente pronunciati nelle femmine. Mentre i ragazzi mostravano assottigliamento corticale solo nella corteccia visiva, le ragazze mostravano assottigliamento in tutto il cervello.
I ricercatori ritengono che questa disparità di genere possa essere dovuta alle differenze nel modo in cui le ragazze e i ragazzi tendono a socializzare e allo stress sociale che possono provare a causa dei social media.
“Gli adolescenti stanno davvero camminando sul filo del rasoio, cercando di rimettere insieme le loro vite”, ha detto Kuhl. “Sono sotto una pressione tremenda. Poi arriva una pandemia globale e i loro normali canali di rilascio dello stress scompaiono. Quei punti vendita non ci sono più, ma le critiche e le pressioni sociali rimangono a causa dei social media.
“Quello che la pandemia sembra davvero aver fatto è isolare le ragazze”, ha detto. “Tutti gli adolescenti sono stati isolati, ma le ragazze hanno sofferto di più. Ha colpito il loro cervello in modo molto più drammatico”.
Kuhl ha detto che mentre è possibile che questi adolescenti possano vedere un certo recupero, come un assottigliamento più lento nel tempo, è improbabile che la corteccia cerebrale diventi di nuovo più spessa. Tuttavia, questo studio presenta alcuni grossi difetti. Per cominciare, mentre i lockdown globali sono stati associati all’assottigliamento del cervello per questi adolescenti, durante questo periodo si sono verificate molte altre variabili che potrebbero aver contribuito a questi cambiamenti cerebrali.
“Lo studio mostra che i cervelli femminili post-lockdown hanno dimostrato complessivamente un assottigliamento corticale maggiore del previsto, ma non che le misure di blocco abbiano effettivamente causato l’assottigliamento”, ha detto Rebecca Sheriff, consulente psichiatra e ricercatrice clinica senior presso l’Università di Oxford, in una dichiarazione.
Ha detto che lo studio ha escluso una percentuale piuttosto ampia di giovani a causa della loro storia di salute
mentale.
“I partecipanti sono stati esclusi se era mai stato loro diagnosticato un disturbo dello sviluppo o psichiatrico, il che, dato che fino a un adolescente su cinque ha un probabile disturbo mentale, sembra piuttosto un’omissione. Inoltre, non riporta altre fonti di stress, quindi non possiamo dire se ci sono altre possibili ragioni per i cambiamenti cerebrali”, ha detto Sheriff.
Secondo Richard Bethlehem, assistente professore di neuroinformatica presso l’Università di Cambridge, è difficile applicare questi risultati alla popolazione generale.
“In primo luogo, i campioni sono piuttosto piccoli, quindi dobbiamo essere cauti per non generalizzare questi risultati a tutti gli adolescenti”, ha detto in una dichiarazione.
“In secondo luogo, non c’è un’enorme quantità di informazioni su questi campioni oltre al fatto che sono stati raccolti in momenti diversi durante la pandemia, quindi non possiamo presumere che sia sicuramente il lockdown la causa di questi cambiamenti segnalati nel cervello.
“Ad esempio, molte altre cose potrebbero essere accadute durante il periodo della pandemia, come l’infezione da covid o un numero di infezioni. Ci sono molti fattori che non sono modellati o documentati in questo documento che potrebbero potenzialmente spiegare questi risultati al di là dei blocchi stessi”, ha detto Bethlehem.
Chiaramente, è necessario più lavoro per confermare se i lockdown stessi siano direttamente responsabili di questi effetti, ma lo studio si aggiunge alla nostra comprensione della fragilità del cervello degli adolescenti.
“La nostra ricerca introduce una nuova serie di domande su cosa significhi accelerare il processo di invecchiamento nel cervello”, ha detto Kuhl. “Tutte le migliori ricerche sollevano nuove e profonde domande, e penso che sia quello che abbiamo fatto qui”.
Riferimento
https://www.pnas.org/doi/10.1073/pnas.2403200121
Una singola casa in bilico precario nel bel mezzo di un cantiere può sembrare una struttura condannata e fragile. Ma in Cina, queste residenze sono diventate un potente simbolo di resistenza. Conosciuti come “dingzihu” in cinese – che può essere tradotto come “casa dei chiodi” o “casa dei chiodi” – edifici come que-

sto rappresentano coloro che, come chiodi testardi, sfidano gli sfratti e le demolizioni ordinate dallo stato rifiutandosi di lasciare le loro proprietà.
Le case dei chiodi hanno attirato l’attenzione globale in immagini spettacolari pubblicate in vista dei giochi olimpici del 2008 a Pechino. Ma la pratica è iniziata prima, quando ai proprietari di case in Cina sono stati concessi diritti inviolabili sulla loro proprietà privata a seguito di due importanti modifiche legali nel 2004 e nel 2007.
Le case di chiodi hanno assunto un significato speciale in un paese che percepisce l’urbanizzazione come un progetto politico, economico e ideologico vitale. Le economie locali dipendono fortemente dagli investimenti in infrastrutture ed edifici, e la crescita dei consumi della classe media è vista come il prossimo motore dello sviluppo economico della Cina. Inoltre, i cittadini urbani sono considerati più civilizzati, o hanno un livello più elevato di “suzhi” (realizzazione culturale), e hanno un migliore accesso ai servizi pubblici come l’istruzione, l’assistenza sanitaria e l’alloggio.
Ma la costruzione e l’espansione delle città richiedono grandi tratti di terreno libero per sviluppi su larga scala. Ciò si traduce nella demolizione di case, quartieri e villaggi esistenti, che non si adattano alla visione del Partito Comunista Cinese (PCC) di un futuro urbano.
Il risarcimento per le famiglie le cui case sono sull’orlo della demolizione è sempre una delle principali fonti di controversia. Le offerte si basano sulle valutazioni attuali degli immobili, che probabilmente saranno di gran lunga inferiori a quelle di qualsiasi residenza che li sostituisce. Ciò significa che lo sfollamento è spesso inevitabile, portando a comunità distrutte e danni psicologici dovuti a stress e violenza e costringendo le famiglie a chiedere un risarcimento finanziario.
Le petizioni dei residenti hanno un successo limitato in tribunale. La forte presenza del PCC in ogni sfera della vita sociale ed economica rende estremamente difficile per i residenti presentare rivendicazioni di successo contro lo stato. Le decisioni dei tribunali sono raramente prese contro i governi, soprattutto nelle aree in cui gli aspiranti governi locali hanno rimosso le barriere normative e fisiche allo sviluppo.
Così, invece, le famiglie chiodate subiscono interruzioni di corrente, servizi limitati e minacce di sfratto forzato e demolizione, al fine di ottenere il maggior risarcimento possibile dal governo o dai costruttori, per garantire la propria sopravvivenza in una società sempre più diseguale. Le famiglie che resistono sono spesso stigmatizzate come “egoiste” perché cercano di proteggere i propri interessi, a scapito di un bene più grande per i loro vicini e per il pubblico in generale. Le autorità governative alimentano questa percezione
anche con manifesti, come questo di Guangzhou, che recita: “Per proteggere gli interessi dei proprietari di case, non arrendetevi mai alle case dei chiodi”.
Eppure questo tipo di impasse non è inevitabile. Le famiglie dei chiodi potrebbero non adottare misure così estreme se fossero consultate e fornite loro scelte informate per migliorare le loro case e i loro quartieri, senza demolizioni. Le famiglie non diventano famiglie di chiodi da un giorno all’altro. Né una casa di chiodi è il risultato di un qualche “egoismo” intrinseco da parte dei manifestanti.
Piuttosto, le famiglie spesso subiscono molestie e violenze a lungo termine e soccombono alla disperazione quando non sono in grado di risolvere le controversie. Molti residenti iniziano conducendo negoziati persistenti con i governi locali o gli sviluppatori, diventando “embrioni di nail house”. Nel tempo, i sentimenti si induriscono e i residenti diventano più determinati, fino a quando non sono disposti a intraprendere azioni estreme per mantenere le loro case.
Gran parte di questo può essere attribuito al processo. Quando un quartiere è destinato alla riqualificazione, i residenti devono affrontare un’estrema pressione per trasferirsi: il governo locale responsabile organizzerebbe vari uffici – tra cui uffici di pubblica sicurezza, pianificazione e propaganda – per lavorare a stretto contatto con i leader del quartiere, per far rispettare lo sfratto tempestivo dei residenti locali. Vari incentivi finanziari, così come le minacce dirette e la pressione dei pari, sono progettati per accelerare il processo di sfratto.
In questo contesto, le case dei chiodi simboleggiano la disuguaglianza e l’ingiustizia prevalenti nella Cina contemporanea. Tuttavia, una maggiore consapevolezza dei diritti di proprietà tra i cittadini urbani potrebbe rafforzarli in modo che non siano più soggetti ai capricci dello stato autoritario e delle imprese a scopo di lucro. Una maggiore consapevolezza dei diritti consentirebbe loro anche di chiedere una maggiore partecipazione ai processi di pianificazione urbana che spesso escludono le voci dei cittadini.
Se i governi, gli sviluppatori e gli altri cittadini cinesi riuscissero a riconoscere la difficile situazione delle famiglie con unghie, piuttosto che rifiutarle e alienarle, ciò potrebbe portare a un sistema più equo per tutti. Allora, le case dei chiodi non saranno più le imponenti lapidi per le comunità scomparse.


di Isabella Mori
Responsabile area tutela di Cittadinanzattiva
Sono otto milioni e mezzo le persone, soprattutto donne, che svolgono il ruolo di caregiver familiare, ossia si prendono cura – per lo più in ambito domestico - di un altro soggetto malato, anziano o disabile. Il profilo del caregiver è stato delineato normativamente per la prima volta dalla Legge di Bilancio 2018 (articolo 1, commi 254-256, Legge n. 205 del 2017), che al comma 255 lo definisce come “persona che assiste e si prende cura di specifici soggetti”. La figura del caregiver familiare viene anche definita in particolare nell’articolo 39 del Decreto Legislativo 15 marzo 2024, n. 29 “Disposizioni in materia di politiche in favore delle persone anziane”. Entrambi i provvedimenti hanno il “merito” di aver delineato la figura del caregiver come soggetto autonomo, destinatario di diritti individuali indipendenti da quelli riconosciuti alla persona di cui ha cura.
Dal 17 gennaio 2024, su iniziativa del Ministro per le Disabilità Alessandra Locatelli e del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali Marina Calderone, si è insediato il “Tavolo tecnico per l’analisi e la definizione di elementi utili per una legge statale sui caregiver familiari”. Sempre nel 2024 sono stati depositati, presso la Camera dei Deputati e incardinati presso la Commissione affari sociali, nove disegni di legge già oggetto di specifiche audizioni informali e che subiranno, in queste settimane, un accorpamento utile alla definizione di un testo base che sembrerebbe dover terminare il suo iter in Parlamento entro la fine dell’autunno. Dopo anni d’attesa, siamo dunque ad un passo dall’approvazione di una legge statale che potrebbe finalmente definire la figura del caregiver familiare e riconoscerne i diritti individuali, indipendentemente da quelli della persona che ha in cura.
Nella formulazione di una legge statale auspichiamo che vengano superati limiti e definizioni legati ad una visione della società oramai non più attuale. Ci auguriamo che si superi il vincolo della parentela in senso stretto, così come quello della convivenza, perché non
è necessario che il caregiver viva sotto lo stesso tetto per prendersi cura di una persona cara. Altro punto fondamentale è che l’assistito possa prestare personalmente o attraverso l’amministratore di sostegno o il tutore il consenso alla scelta e la nomina del proprio caregiver informale. Infine, una Legge al passo con i tempi dovrebbe riconoscere la centralità e il ruolo attivo del caregiver anche nel progetto di vita della persona di cui ha cura.
Molte di queste richieste emergono a gran voce anche dai circa 600 caregiver familiari che Cittadinanzattiva ha coinvolto in una recente indagine online. Oltre il 29% è caregiver da più di 5 anni, un ulteriore 25% da più di dieci anni; quasi la metà dedica oltre 12 ore al giorno alla cura ed assistenza del proprio caro/a. Emerge dunque chiaramente che il lavoro di caregiver è svolto per lunghi o lunghissimi periodi di tempo, spesso da una stessa e unica persona. Le conseguenze? Quasi il 45% si sente poco realizzato personalmente e più della metà (55,8%) dichiara di aver poco tempo per la sua sfera personale, anche se pensa di essere molto utile (55,8%) nei confronti della persona di cui ha cura. Nell’ultima sezione della survey abbiamo chiesto ai caregiver familiari di esprimersi in merito ad una serie di temi “dirimenti” per il riconoscimento del ruolo che dovranno essere oggetto della Legge statale. In premessa specifichiamo che “riconoscimento del ruolo del caregiver familiare-informale” significa che viene riconosciuta e valorizzata l’importanza del lavoro svolto dai caregiver familiari-informali, cioè le persone che forniscono assistenza e supporto a familiari o amici malati, anziani o disabili, senza essere professionisti e senza ricevere una retribuzione formale per il loro impegno. Questo riconoscimento può includere aspetti come il riconoscimento legale, il sostegno economico, l’accesso a servizi di supporto e la protezione dei diritti.
I caregiver che hanno risposto alla survey ritengono, con un’ampia maggioranza, che il ruolo debba essere
riconosciuto a tutti i caregiver, siano essi conviventi o meno (78,8%) e a prescindere dal vincolo di parentela (71,4%).
La quasi totalità (92%) ritiene che la legge debba garantire nuove tutele e diritti di tipo “crescente”, cioè ad una maggiore intensità di cura e impegno dovrebbero corrispondere maggiori tutele. Inoltre il 91% vorrebbe avere un ruolo “attivo” nella stesura del progetto di vita individuale: ricordiamo che. La Legge n. 328/00 prevede la predisposizione di un progetto individuale per ogni “persona con disabilità fisica, psichica e/o sensoriale, stabilizzata o progressiva che abbia come obiettivo la piena integrazione scolastica, lavorativa, sociale e familiare dell’individuo”.
Un Manifesto appello per una Legge inclusiva e di equità sociale
In questo contesto, Cittadinanzattiva e CARER (Associazione Caregiver familiari) hanno presentato, lo scorso 15 ottobre in una conferenza stampa alla Camera dei Deputati, un Manifesto/Appello rivolto a tutti i soggetti istituzionali a vario titolo coinvolti nel processo di definizione della proposta di legge, nonché ai singoli cittadini e alle altre organizzazioni civiche e di pazienti, affinché i contenuti della norma siano ispirati a principi di inclusività e di equità sociale.
Il Manifesto ”Caregiver: per una Legge inclusiva e di equità sociale” è disponibile sul sito www.cittadinanzattiva.it, nonché sulla piattaforma Change.org per rendere possibile la sottoscrizione anche da parte di singoli cittadini.
Chiediamo anche ai Comuni di sottoscriverlo (già molti quello che lo hanno fatto), inviando una mail a v.condo@cittadinanzattiva.it.

di Teresa Bonacci
Quali sono le principali linee di mandato?
Federsanità è una realtà con ancora un grande potenziale da esprimere sia in termini di presenza ed attiva partecipazione a tavoli istituzionali, sia in termini di sviluppo di nuove ed originali iniziative su base nazionale e regionale. Il potenziale da sviluppare si poggia su una ampia e solida base associativa che oggi deve condividere linee di sviluppo strategico su cui orientare le proprie azioni, adeguando la propria struttura, organizzazione e i propri modelli all’attuale fase storica che chiede, a tutti gli attori qualificati, sforzi straordinari ma necessari per garantire al nostro servizio sanitario e socio sanitario di vincere la sfida della sostenibilità senza intaccare i propri principi, primo fra tutti l’universalità. I valori e lo scopo della nostra Associazione rappresentano oggi un elemento distintivo nel panorama nazionale associativo e delle rappresentanze istituzionali. Lo sviluppo dei servizi si cura e assistenza è quello che dobbiamo realizzare attraverso strumenti, strategie e modelli organizzativi, confrontandoci con le dinamiche evolutive del SSN e adottando ogni iniziativa, sia a livello politico che culturale che scientifico, volta a tutelare i principi cardine della nostra Carta costituzionale in materia di tutela della salute.
A che punto siamo con l’avanzamento delle riforme previste dal PNRR, che riformano anche il SSN nel suo complesso?
Dal report pubblicato dalla Corte dei Conti, a maggio scorso, sull’attuazione della Missione 6 Salute del Piano, gli obiettivi per il 2023 risultano raggiunti, anche se su Assistenza domiciliare e digitalizzazione ci sono ancora alcune criticità attuative. In realtà non dobbiamo perdere di vista l’obiettivo principale e che sta sopra ogni azione o progetto realizzato ovvero ridare equità all’intero sistema di presa in carico. Abbiamo di fronte a noi anni fondamentali per il nostro servizio sanitario nazionale, e, più in generale, per il modello di welfare del nostro Paese.
Non riuscire a garantire che gli investimenti finanziari e
di “pensiero” del PNRR, e quelli allo stesso collegati, producano i risultati attesi determinerà la necessità di rivedere in maniera “importante” il nostro modello di assistenza e di presa in carico, minando i valori di universalità, l’uguaglianza e l’equità che lo rendono unico.
In questa “partita” Federsanità ci sarà da protagonista, contribuendo alla elaborazione delle soluzioni e, soprattutto, alla realizzazione delle iniziative.
Solo mediante l’iniziativa di chi quotidianamente vive le organizzazioni sanitarie ed i territori ciò sarà possibile; solo mediante la messa a fattor comune delle esperienze, energie ed intelligenze si potrà permettere al sistema Paese di procedere compatto, senza aumentare le differenze e le disuguaglianze.
Come Asl e Comuni possono rafforzare l’alleanza per la salute nei territori e costruire reti di prossimità?
L’integrazione non passa soltanto dalle azioni messe in atto e dalle iniziative progettate e realizzate nei territori, ma si realizza realmente attraverso l’integrazione delle conoscenze sui bisogni di salute, attraverso l’integrazione delle competenze e delle risorse. Federsanità è, costitutivamente, il luogo per promuovere momenti di dialogo strutturati tra i distinti livelli istituzionali, la governance della sanità e gli enti locali, per un vero cambio di paradigma. Per integrare veramente servizi dobbiamo essere disponibili a lasciare ognuno parte del proprio spazio e mettersi in ascolto, creando “momenti” in cui le persone si confrontano con chi, quotidianamente, affronta gli stessi problemi e lavora per i medesimi obiettivi.
Piccoli comuni e aree interne: quale il ruolo della digitalizzazione, strumenti come telesoccorso e teleassistenza o teleconsulto serviranno veramente a colmare i divari territoriali?
Le strutture territoriali previste dal Pnrr, case e ospedali di comunità, e centrali operative territoriali (COT), così

come la digitalizzazione sono una straordinaria opportunità per trasformare i servizi che mettiamo a disposizione dei cittadini, porre in discussione una volta per tutte le logiche prestazionali, ripensare i modelli di presa in cura e puntare con decisione sulla medicina di iniziativa, sulla integrazione dei percorsi e sulla appropriatezza. L’innovazione tecnologica sta cambiando il modo in cui viene fornita l’assistenza sanitaria: l’intelligenza artificiale, la robotica e la realtà virtuale sono solo alcune delle tecnologie emergenti che stanno reinventando le modalità di interazione tra medico e paziente. Gli strumenti digitali stanno diventando sempre più sofisticati e user-friendly, consentendo a pazienti di tutte le età di gestire autonomamente la propria salute. Questa trasformazione sta avvenendo nel contesto di un cambiamento culturale più ampio che vede i pazienti diventare sempre più attivi nel gestire la propria salute. Questo annulla le distanze territoriali e, se ben messe a sistema, anche le distanze sociali, favorendo la continuità di cure ed assistenza, soprattutto per le cronicità. La digitalizzazione può rivelarsi strategica, quindi, per favorire l’orientamento del Ssn ad una governance integrata, sistemica, efficace e tempestiva, rendendo obsoleti e fuori contesto riflessioni e approcci per compartimenti stagni. Il management della sanità italiana può svolgere su questo terreno un ruolo insostituibile di cerniera tra bisogni, visione strategica proiettata sul futuro e territori.
di Eva Massari
Centro Studi Fondazione The Bridge
La rigenerazione urbana è un processo fondamentale per ridare vita ai territori, che punta al miglioramento della qualità della vita degli abitanti e preserva il patrimonio edilizio esistente. Questo percorso di riqualificazione, riuso e recupero degli edifici non si limita alla dimensione fisica degli spazi, ma coinvolge anche la comunità e il contesto ambientale in cui si inseriscono. La sostenibilità, concetto centrale in questo ambito, deve essere economica, sociale e ambientale, poiché solo un approccio integrato può garantire benefici duraturi per la collettività.
Un elemento chiave risiede nel recupero del patrimonio edilizio, spesso abbandonato o in disuso, per trasformarlo in risorsa: attraverso interventi di riqualificazione, si creano spazi più funzionali e sicuri, capaci di rispondere alle nuove esigenze abitative e sociali. Tuttavia, è essenziale che questo processo avvenga con un approccio sostenibile, che riduca l’impatto ambientale, favorendo il riuso dei materiali e promuovendo soluzioni tecnologiche innovative a basso consumo energetico.
Ma non è sufficiente parlare di recupero, occorre guardare anche alla rivitalizzazione del tessuto sociale, spesso frammentato: spazi abbandonati e servizi insufficienti portano all’isolamento degli individui, alimentando povertà e disuguaglianze, tra cui quella educativa, che penalizza soprattutto le nuove generazioni. Un percorso di recupero urbano efficace deve dunque mettere al centro le persone, promuovendo nuove forme di relazione tra la comunità e il territorio. In questo senso un ruolo cruciale viene svolto dalle iniziative partecipative e locali, che possono essere sviluppate nei contesti in fase di riqualificazione. Attraverso il coinvolgimento diretto degli abitanti nei processi decisionali e nella gestione degli spazi, si favorisce la coesione sociale, fondamentale per ricucire le fratture e affrontare le criticità del territorio. Questo approccio partecipativo stimola la nascita di nuove dinamiche di solidarietà e condivisione, contribuendo a ridurre le di-
suguaglianze e a migliorare il benessere generale. E allargando ancora di più lo sguardo la rigenerazione urbana è uno strumento di salute pubblica cui concorrono ambienti riqualificati e vivibili che favoriscono il benessere psicofisico degli abitanti, migliorano la qualità dell’aria, riducono il rumore e creano spazi che incentivano stili di vita più attivi e salutari. In ottica one health promuove l’inclusione sociale e la riduzione delle disuguaglianze in un territorio che integra servizi – non ultimi quelli sociosanitari - spazi culturali e aree verdi accessibili a tutti, e che contribuisce a migliorare la qualità della vita di tutte le fasce dalla popolazione garantendo un accesso equo a risorse fondamentali per il benessere collettivo; questo riduce le disparità sociali, economiche e educative, favorendo una maggiore coesione comunitaria.
Solo un intervento che tenga conto della salute dell’intero ecosistema potrà affrontare le sfide future in modo sostenibile ed equo.
Oggi l’impatto delle esperienze di rigenerazione urbana in Italia varia in base ai contesti; in alcuni casi, si sono ottenuti risultati significativi, come la riduzione del degrado urbano, la riqualificazione degli spazi pubblici e l’aumento della partecipazione civica. In altri, l’impatto è stato limitato, spesso a causa di difficoltà burocratiche o mancanza di risorse. Tuttavia, queste esperienze hanno innescato processi di innovazione sociale, rafforzando il senso di appartenenza dei cittadini e creando nuove opportunità di inclusione, evidenziando il potenziale di questa pratica come strumento per costruire città in salute. Nel contesto urbano, le diverse aree sono infatti spesso epicentri di sfide sanitarie complesse, che coinvolgono non solo gli esseri umani, ma anche gli animali, l’ambiente e le risorse naturali. L’integrazione dei principi di One Health nelle politiche urbane può portare a soluzioni più sostenibili e resilienti. È una sfida che dobbiamo essere pronti a cogliere.
di M. C. Lo Giudice
Associate Consultant - Responsabile Area Cyber Security & AI KeyPartners
©L’Intelligenza Artificiale (AI) è emersa come una delle tecnologie più dirompenti nel settore sanitario, con il potenziale di ridefinire profondamente il modo in cui vengono erogate le cure. Da molti vista con sospetto e considerata una possibile minaccia, l’AI sta progressivamente conquistando un ruolo da protagonista nel miglioramento della qualità dell’assistenza e nell’efficienza dei processi. L’evoluzione tecnologica e l’adozione di strumenti di analisi avanzati stanno spingendo il settore sanitario verso un modello più integrato, personalizzato e sostenibile, dove l’AI gioca un ruolo centrale.
Il cambiamento più significativo si osserva nella capacità dell’AI di gestire e analizzare grandi quantità di dati clinici. Ogni giorno vengono raccolti miliardi di dati riguardanti la salute dei pazienti, dai risultati dei test di laboratorio alle immagini diagnostiche, fino alle cartelle cliniche elettroniche. L’AI, con i suoi algoritmi di apprendimento automatico e di deep learning, riesce a processare questi dati in modo rapido ed efficiente, permettendo ai medici di ottenere analisi dettagliate in tempi molto ridotti rispetto ai metodi tradizionali. Questo significa che diagnosi complesse, come quelle legate al cancro o a malattie degenerative, possono essere effettuate con una maggiore accuratezza e precocità, aumentando notevolmente le possibilità di successo dei trattamenti.
Non si tratta solo di diagnosi, ma anche di trattamenti personalizzati. L’AI è in grado di studiare le caratteristiche genetiche e cliniche di un paziente e suggerire terapie mirate, ottimizzando l’efficacia delle cure. Questo approccio personalizzato rappresenta un’evoluzione fondamentale rispetto ai protocolli standardizzati, che, pur essendo validi, non tengono conto delle specificità di ogni individuo. L’oncologia di precisione è uno degli ambiti che ha beneficiato maggiormente di queste innovazioni, con terapie costruite su misura per i pazienti in base alle loro caratteristiche genetiche e molecolari.
La capacità dell’AI di prevedere gli esiti di un trattamento è un altro aspetto rivoluzionario. Grazie all’analisi predittiva, è possibile prevedere come un paziente risponderà a una terapia o identificare potenziali complicazioni in anticipo. Questo è particolarmente utile in contesti come la chirurgia e i trattamenti a lungo termine, dove la prevenzione degli imprevisti può fare la differenza tra la vita e la morte. L’uso di strumenti basati sull’AI nelle sale operatorie e nei reparti di terapia intensiva è in costante crescita, contribuendo a ridurre i rischi e a migliorare i risultati clinici.
Un altro settore chiave che beneficia dell’AI è la gestione delle risorse sanitarie. Negli ultimi anni, la pressione sui sistemi sanitari di tutto il mondo è aumentata drasticamente, a causa dell’invecchiamento della popolazione e della crescente complessità delle malattie croniche. L’AI offre soluzioni innovative per ottimizzare la gestione delle risorse, riducendo i costi e migliorando l’accesso alle cure. Grazie agli algoritmi di machine learning, è possibile ottimizzare l’allocazione del personale, prevedere i picchi di domanda nei servizi di emergenza e migliorare la gestione delle scorte di medicinali. Questo rende il sistema sanitario più reattivo e in grado di adattarsi rapidamente ai cambiamenti nelle esigenze della popolazione.
Inoltre, la telemedicina e il monitoraggio remoto dei pazienti, due aree cresciute esponenzialmente durante la pandemia di COVID-19, sono strettamente legate all’AI. I sistemi di monitoraggio intelligente permettono di seguire i pazienti a distanza, raccogliendo costantemente dati sui loro parametri vitali e segnalando eventuali anomalie in tempo reale. Questo riduce la necessità di ricoveri ospedalieri e visite ambulatoriali, migliorando l’accessibilità delle cure, soprattutto per le persone che vivono in aree remote o che hanno difficoltà a spostarsi.
Nonostante i grandi benefici, l’adozione dell’AI nel
settore sanitario non è priva di sfide. Una delle principali preoccupazioni riguarda i bias algoritmici. Gli algoritmi di AI sono addestrati su set di dati che, in molti casi, non riflettono adeguatamente la diversità della popolazione. Questo può portare a pregiudizi nei risultati, con un impatto negativo sui gruppi di pazienti sottorappresentati, come le minoranze etniche o le persone con basso reddito. È quindi fondamentale sviluppare tecnologie inclusive, che tengano conto delle differenze tra i pazienti e garantiscano equità nell’accesso alle cure.
Inoltre, la questione della privacy e della sicurezza dei dati è cruciale. L’AI, per funzionare correttamente, ha bisogno di un’enorme quantità di dati personali sensibili, che devono essere protetti da accessi non autorizzati e da eventuali cyber attacchi. Le normative sulla protezione dei dati, come il GDPR in Europa, giocano un ruolo fondamentale nel garantire che i dati sanitari siano gestiti in modo sicuro e rispettoso della privacy dei pazienti. Le aziende e le istituzioni sanitarie devono quindi investire in soluzioni di cybersecurity all’avanguardia per proteggere le informazioni sensibili.
Un altro ostacolo all’adozione diffusa dell’AI è la necessità di formare il personale sanitario. Medici, infermieri e altri operatori devono acquisire competenze tecnologiche per utilizzare al meglio gli strumenti di AI. Questo richiede investimenti in formazione continua e l’adozione di nuovi modelli organizzativi che integrino le tecnologie digitali nel lavoro quotidiano degli operatori sanitari. La collaborazione tra il settore pubblico, privato e accademico è essenziale per garantire che il personale sanitario sia adeguatamente preparato per affrontare le sfide del futuro.
In Italia, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) offre un’opportunità unica per accelerare la trasformazione digitale del sistema sanitario. Il PNRR prevede ingenti investimenti in innovazione e digitalizzazione, con l’obiettivo di rendere il sistema sanitario più efficiente e accessibile. Le aziende e le istituzioni sanitarie italiane devono sfruttare appieno queste risorse, adottando un approccio strutturato e integrato che allinei gli obiettivi clinici e scientifici con le opportunità offerte dal PNRR. In particolare, è essenziale che vengano create sinergie tra le priorità terapeutiche e tecnologiche, promuovendo l’innovazione e la collaborazione all’interno dell’ecosistema sanitario.
Guardando al futuro, è chiaro che l’AI continuerà a svolgere un ruolo sempre più importante nel settore sanitario. Le tendenze globali indicano un’accelerazione dell’adozione di queste tecnologie, con un focus crescente sulla sostenibilità e sull’integrazione tra as-
sistenza sanitaria fisica e virtuale. Gli ospedali del futuro saranno sempre più digitali e personalizzati, con modelli di assistenza che superano i confini tradizionali delle strutture fisiche, portando le cure direttamente nelle case dei pazienti. Questo non solo migliorerà la qualità della vita dei pazienti, ma contribuirà anche a ridurre l’impatto ambientale del settore sanitario, rendendolo più resiliente e responsabile.
In conclusione, l’Intelligenza Artificiale ha il potenziale per diventare la migliore amica della salute, offrendo soluzioni innovative per migliorare la qualità delle cure, ridurre le disuguaglianze e garantire un futuro più sostenibile. Tuttavia, per realizzare appieno questo potenziale, è necessario affrontare le sfide legate ai bias tecnologici, alla sicurezza dei dati e alla formazione del personale sanitario. Solo così l’AI potrà davvero trasformare il settore sanitario, portando benefici concreti a pazienti, medici e alla società nel suo complesso.

di Federica Ascoli

Il vertice del G7 ha posto l'accento su tematiche cruciali per il futuro del pianeta, tra cui l'interconnessione tra salute umana, animale e ambientale. In particolare, il concetto di One Health è emerso come una priorità assoluta, con un focus specifico sul ruolo delle smart cities nella promozione di un approccio olistico alla tutela della salute, del benessere e dei correte stili di vita. I leader delle principali economie mondiali hanno riconosciuto l'importanza di un'azione coordinata per affrontare le sfide globali, come le pandemie, la resistenza antimicrobica e i cambiamenti climatici. In questo contesto, il modello delle smart cities è stato presentato come un'opportunità unica per integrare tecnologie innovative e soluzioni sostenibili, al fine di migliorare la qualità della vita dei cittadini e proteggere l’ambiente. Sono emersi interessanti punti chiave. I partecipanti al vertice, infatti, hanno sottolineato la necessità di sviluppare sistemi di sorveglianza integrati per monitorare in tempo reale le minacce alla salute, sia a livello locale che globale. L'uso di dati provenienti da diverse fonti, come sistemi sanitari, veterinari e ambientali, consentirà di identificare precocemente i focolai epidemici e di attivare tempestivamente le misure di contenimento. Si è discusso anche delle infrastrutture verdi. Le smart cities del futuro saranno caratte-
rizzate da infrastrutture verdi che promuovano la biodiversità e migliorino la qualità dell’aria. Parchi, giardini e spazi verdi urbani non solo contribuiscono al benessere psicologico dei cittadini, ma svolgono anche un ruolo fondamentale nella regolazione del clima e nel controllo della diffusione di patogeni. Altro tema caldo: la mobilità sostenibile. La promozione della mobilità sostenibile, attraverso l'utilizzo di mezzi di trasporto pubblici efficienti e a basse emissioni, è un altro elemento chiave per la realizzazione di smart cities a misura d’uomo. Ridurre l'inquinamento atmosferico e acustico significa migliorare la salute respiratoria e cardiovascolare dei cittadini. Una efficace gestione dei rifiuti è essenziale per prevenire la diffusione di malattie infettive e proteggere l'ambiente. Le smart cities saranno in grado di ottimizzare la raccolta e il trattamento dei rifiuti riducendo al minimo l'impatto sulla salute umana e sull’ecosistema. Il G7 Italy dunque ha lanciato un messaggio chiaro: la tutela della salute è un bene comune che richiede un approccio integrato e interdisciplinare. Le smart cities rappresentano una via promettente per realizzare questo obiettivo, offrendo soluzioni innovative e sostenibili per affrontare le sfide del prossimo futuro.
Giuseppe Assogna, Anna Maria Pitizolu, Elisabetta Campus, Sabrina Rosiglioni, Nicola Mele, Anna Maria Innocenzi, gruppo di lavoro FareRete InnovAzione BeneComune APS“Inclusione e giustizia sociale”
Nel mondo contemporaneo, il divario tra chi ha accesso alle risorse e chi ne è privato è sempre più evidente. Le disuguaglianze sociali, economiche e ambientali impongono alla società una riflessione critica e un impegno collettivo per garantire a tutti le stesse condizioni di partenza e opportunità per crescere e contribuire allo sviluppo della società.
In questo contesto, il Gruppo di Lavoro “Inclusione e Giustizia Sociale” di FareRete InnovAzione BeneComune APS, si impegna a promuovere riflessioni e azioni concrete per abbattere le barriere che ostacolano il pieno sviluppo della persona umana, puntando su politiche inclusive e sostenibili in grado di garantire equità e giustizia sociale.
Inoltre, vengono presentati esempi concreti di attivismo sociale nati proprio nei contesti periferici, come la Comunità Energetica e Solidale di Napoli Est, i Giardini di Pitagora di Crotone, e la rete dei “Numeri Pari”, che dimostrano come le iniziative di collaborazione tra istituzioni, scuola e comunità locali possono creare nuovi modelli di sviluppo incentrati sull’inclusione e la giustizia sociale. Questi progetti sono la prova che, attraverso una progettazione collaborativa, è possibile promuovere contesti sociali sostenibili e inclusivi in grado di evolversi e di avviare innovazioni
L’impegno del Gruppo di Lavoro è volto a promuovere una coscienza critica sulle disuguaglianze, favorire lo studio e la formazione, e avviare politiche inclusive per ridurre le barriere linguistiche, di genere e di opportunità. Lo scopo è far sì che ogni persona, indipendentemente dalla sua condizione economica o sociale, possa
sentirsi valorizzata e contribuire con i propri talenti allo sviluppo della comunità e al progresso collettivo, promuovendo un futuro più equo e inclusivo per tutti.Il principio di uguaglianza rappresenta uno dei valori fondamentali della Costituzione repubblicana, insieme con il dovere di solidarietà, e la sua tutela impone allo Stato la rimozione degli ostacoli di ordine economico e sociale che la limitano di fatto, impedendo il pieno sviluppo della persona umana.
L’azione politica del dopoguerra è stata progressivamente volta a garantire condizioni di uguaglianza sostanziale e pari opportunità per tutti, anche in presenza di situazioni economiche e sociali assai differenti.
Lo sviluppo economico che ne era seguito aveva consentito di ridurre ai minimi termini la povertà e l’analfabetismo, consentendo il miglioramento delle condizioni di vita.
Una errata concezione della ideologia liberista, che si è diffusa a partire dagli anni ’90, ha cambiato radicalmente il quadro dei valori dettati dalla Costituzione.
Lo sviluppo della persona umana ed il dovere di solidarietà sancito dall’art. 2 della Costituzione, che costituiva lo scopo dell’azione politica, è stato sostituito da una visione individualistica, incentrata unicamente sul profitto. I lauti guadagni ottenibili dallo sviluppo dell’attività finanziaria drenavano risorse dalle attività produttive e frenavano gli investimenti necessari per la stabilità dell’impresa nel lungo periodo. Le imprese, che prima costituivano il punto di riferimento di un territorio e dei suoi cittadini, venivano delocalizzate sulla base di meri vantaggi contabili, troppo spesso fon-
dati sulla minore tutela accordata da altri Paesi ai lavoratori e all’ambiente. L’avvento della tecnologia sta rendendo obsolete le conoscenze in tempi assai rapidi e creando nuove forme di povertà per coloro che sono espulsi dal circuito produttivo o che non sono in grado di utilizzarle. Nella sanità la delegazione di funzioni ha aumentato in maniera esponenziale i costi, a svantaggio della qualità del servizio, ed ha creato una disparità di trattamento tra coloro che possono ricorrere all’assistenza privata e coloro che non possono permettersela. La formazione, che dovrebbe rappresentare la chiave di volta per l’integrazione tecnologica, ha un costo elevato. Aumentano i cd. working poor, lavoratori che percepiscono compensi insufficienti al loro mantenimento. A tutto ciò si aggiunge una imposizione fiscale che grava quasi integralmente sulle attività produttive e sui lavoratori.
Le condizioni di disuguaglianza ambientali e sociali sono ancora più evidenti nelle periferie urbane, ora come ai tempi della Rerum Novarum, sulle quali devono essere concentrate le azioni politiche di inclusione e di sviluppo che superino la mera assistenza e comprendano interventi strutturali volti a promuovere contesti sociali sostenibili e inclusivi, in grado di evolversi e di avviare innovazioni incentrate sulla giustizia sociale .
Una progettazione collaborativa fra istituzioni, volontariato, scuola, imprese, sanità ed assistenza consentirebbe di rimodulare e rendere più efficaci gli interventi e più produttive le risorse già disponibili, certamente da integrare.
L’impegno è quello di incrementare una coscienza critica sulle disuguaglianze e sulle discriminazioni, favorire lo studio e la formazione, avviare politiche inclusive e attente alla disparità in ambito linguistico e di genere e ridurre le barriere, affinché tutti possano sentirsi apprezzati e contribuire con i propri talenti allo sviluppo della società. Sono necessari anche interventi rivolti ai giovani che consentano di collegare la loro formazione scolastica alle richieste delle imprese, creando reti che possano superare la disoccupazione o sottooccupazione.
Virtuosi esempi di attivismo sociale nati proprio nei contesti periferici: dalla Comunità Energetica e Solidale di Napoli Est ai Giardini di Pitagora di Crotone, dal progetto Piazza dei Mestieri a La rete dei “Numeri pari”, fino a La Fondazione Charlemagne e al lavoro della Rivista Impresa Sociale e del Welforum.it. Per usare uno slogan: “Vivere insieme in pari dignità”.



di Daniela Sbrollini
Senatrice della Repubblia
Nei Paesi industrializzati la sedentarietà è divenuta il secondo più importante fattore di rischio per la salute, dopo il fumo di tabacco. Esiste una stretta relazione tra l’inattività fisica e le patologie cronico-degenerative, che rappresentano circa il 75 per cento delle cause di mortalità nei Paesi industrializzati.
Gli effetti positivi dell’attività fisica sulla patologia cronica non trasmissibile, da quella cardiovascolare, al diabete, all’obesità, alla osteoporosi e ad alcune patologie neoplastiche quali il cancro del colon e della mammella, sono solidamente documentati in diversi studi internazionali.
Al riguardo appare opportuno evidenziare le «Physical Activity Guidelines Advisory Committee Report 2008 – U.S. Department of Health and Human Services», pubblicate nel maggio del 2008, che rivoluzionando la letteratura internazionale in materia, riassumono le principali evidenze sull’efficacia dell’esercizio fisico nelle diverse condizioni patologiche e forniscono le indicazioni per l’uso corretto di questo nuovo strumento nella pratica clinica.
L’attività fisica appare, pertanto, un efficace strumento di prevenzione e come tale rientra nella strategia di intervento nei confronti di persone sane o affette da svariate patologie, al punto che l’esercizio fisico dovrebbe essere inserito nel normale iter terapeutico per il trattamento di diverse patologie. Tuttavia, questa tipologia di intervento appare ancora largamente sottovalutata in ambito di Sistema sanitario nazionale.
Di pari passo è fondamentale che le città e il governo promuovano un’urbanizzazione focalizzata sulla cura e sulla salute dei cittadini. Si deve spor-
tivizzare le città così da garantire a tutti la possibilità di svolgere moto e attività fisica. Spesso sono proprio le barriere architettoniche come l’assenza di parchi o la cattiva illuminazione a rendere difficile una passeggiata o una corsa. Si deve agire insieme per far sì che le città siano strutturate a misura di sport.
Lo sport è ampiamente riconosciuto come elemento cardine per la promozione e diffusione di comportamenti e stili di vita sani; eppure, dall’adolescenza in poi la percentuale di popolazione che svolge attività fisica diminuisce in modo drastico. Secondo gli ultimi dati del 2021, nella fascia di età tra gli 11 e i 14 anni il 46 per cento pratica sport in modo continuativo, tra i 15-17enni diminuisce al 42 per cento, con valori più alti tra i maschi (47% dei maschi contro il 37% delle donne), percentuale che scende ulteriormente dai 18 ai 59 anni, in cui il 31 per cento degli uomini pratica sport, mentre tra le donne la quota si ferma al 23 per cento. Occorre attuare programmi di diffusione e sensibilizzazione in tutte le fasce di età, facendo emergere i fattori di rischio legati alla sedentarietà.
Grazie alla ricerca e all’innovazione, l’aspettativa di vita si è allungata oltre gli 80 anni, ma per usufruire di una buona qualità di vita è necessario preparare il nostro organismo con attività fisica costante e continuativa. È importante che nella realtà di oggi siano messi in atto interventi di prevenzione mirati a sensibilizzare la popolazione a svolgere attività sportiva fin dalla giovane età. Lo sport, oltre a rappresentare valori importanti come lo spirito di gruppo, la solidarietà, la tolleranza e la correttezza, contribuisce all’invecchiamento attivo, fondamentale per aspirare quanto più possi-
bile ad un invecchiamento in salute della popolazione.
Svolgere attività fisica vuol dire fare una scelta a favore della propria salute. Infatti, ha importanti effetti sul fisico e sulla mente, contribuisce a migliorare la forza, la resistenza e la salute ossea, allo stesso tempo permette di mantenere il peso sotto controllo, contrastare la depressione e prevenire diverse malattie non trasmissibili come ictus, ipertensione, iperglicemia, iperlipidemia, cancro al colon e al seno ma anche diabete e obesità. A questo proposito già nel 2020 l’Organizzazione Mondiale della Sanità aveva pubblicato le Linee Guida sull’attività fisica e il comportamento sedentario per fornire raccomandazioni, basate su evidenze e studi scientifici, che i governi dovrebbero adottare nelle loro politiche nazionali, così da sostenere un aumento dei livelli di attività fisica nella popolazione.
Lo scopo del disegno di legge “Disposizioni recanti interventi finalizzati all’introduzione dell’esercizio fisico come strumento di prevenzione e terapia all’interno del Servizio sanitario nazionale” è, dunque, quello di definire princìpi e criteri generali al fine di introdurre una strategia complessiva relativamente alla «prescrizione dell’attività fisica». La stessa, infatti, deve riguardare sia persone che presentano fattori di rischio, quali ad esempio ipercolesterolemia, obesità, sia persone affette da condizioni patologiche, quali, a titolo esemplificativo cardiopatia ischemica, sindrome metabolica; entrambe queste condizioni, infatti, possono trarre sicuro giovamento attraverso un esercizio fisico correttamente prescritto, nonché svolto in modo controllato.
Un approccio integrato in materia sarebbe, inoltre, funzionale ad una reale implementazione del documento programmatico «Guadagnare salute», di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 aprile 2007, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 117 del 22 maggio 2007, che tra le diverse ipotesi di intervento prevede interventi «volti ad affermare una concezione dell’attività sportiva che va al di là della mera attività fisica agonistica, divenendo invece un momento di benessere fisico e psicologico che coinvolge tutti i cittadini, giovani e meno giovani. Da qui, un’idea di sport come momento
di aggregazione sociale, nonché come attività formativa ed educativa dell’individuo»
Occorre, pertanto, che gli interventi di prevenzione mirati alla promozione dell’attività motoria, i programmi di sorveglianza sulla diffusione tra la popolazione dei fattori di rischio per malattie croniche, nonché la prescrizione controllata dell’attività fisica nei pazienti a rischio rientrino nei livelli essenziali di assistenza (LEA).
Gli interventi di prevenzione individuale, da implementare sul singolo o su piccoli gruppi omogenei, sono destinati a soggetti che presentano fattori di rischio o affetti da condizioni patologiche sensibili all’esercizio fisico.
Particolare attenzione deve essere diretta alla patologia cardiovascolare ed a quelle correlate. Infatti, l’inattività fisica influisce non solo sullo sviluppo della patologia conclamata, ma anche sulle condizioni predisponenti, quali l’ipertensione, la dislipidemia, l’obesità, la sindrome metabolica e il diabete di tipo 2. Altre condizioni che possono giovarsi dell’esercizio fisico includono le patologie osteo-articolari, la depressione, l’osteoporosi e alcune patologie tumorali.
In relazione tutto questo, appare di tutta evidenza la rilevanza del ruolo svolto dal medico di medicina generale e dal pediatra che sono il primo filtro di valutazione clinica della popolazione interessata. Essi possono farsi carico di interventi di prevenzione primaria su individui con livello di rischio basso e molto basso. Avendo identificato o sospettato la necessità di interventi su livelli di rischio più consistenti, essi devono poter indirizzare il paziente verso una rete di strutture specialistiche, che a seconda dei livelli di rischio e delle modalità organizzative previste dalle singole regioni, possono essere dei centri territoriali all’uopo istituiti. Queste sono strutture ambulatoriali collegate all’assistenza sanitaria di base e si rivolgono a pazienti con livello di rischio fino a medio-alto, sia clinicamente silenti, ma portatori di fattori di rischio, sia con patologia già conclamata.
I centri territoriali opereranno in rete sul territorio regionale. Il disegno di legge intende configurarli in maniera tale da farli coincidere con le strutture di medicina dello sport destinate, secondo i mo-
delli organizzativi in atto nelle diverse regioni, al rilascio delle certificazioni di idoneità alla pratica sportiva agonistica ricomprese nei LEA, all’evidente scopo di utilizzare al meglio la professionalità e l’esperienza che già operano nell’ambito dei Servizi sanitari regionali.
Nella loro opera le predette strutture si possono anche avvalere della collaborazione di nutrizionisti, chinesiologi, psicologi e laureati in scienze motorie.
Il 31 luglio il DDL stato sottoscritto ieri da tutti i partiti in X Commissione (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale). Un Disegno di legge, che è al centro di un’importante battaglia per promuovere il ruolo dell’attività fisica come volano per la salute, ha come obiettivo quello di rendere l’esercizio fisico prescrivibile proprio come un farmaco da parte del medico di medicina generale, pediatra di libera scelta e specialisti, per incentivarlo come strumento di prevenzione e di cura. Ora, con la sottoscrizione del Ddl da parte di tutti i partiti, si avvia un iter legislativo, già avviato in commissione, che nel suo ambito potrebbe essere veramente rivoluzionario
Lo sport, come esercizio fisico, è un “farmaco” che non ha controindicazioni e fa bene a tutte le età - Il Disegno di legge che ho presentato intende dare la possibilità a pediatri, medici di medicina generale e specialisti di inserirlo in ricetta medica rossa, così che le famiglie possano usufruire delle detrazioni fiscali. La speranza è che, recuperando attraverso il 730 parte dell’investimento, le persone siano incentivate a impegnarsi in attività positive per la propria salute.
I numeri evidenziano che l’esercizio fisico, nonostante sia un fattore determinante per la salute degli individui, è infatti ancora troppo poco praticato
I dati dell’Eurobarometro dicono che nell’Unione europea il 45 per cento delle persone afferma di non fare mai esercizio fisico o praticare sport e una su tre ha livelli insufficienti di attività fisica. La conseguenza è l’insorgere di milioni di casi di malattie non trasmissibili che peggiorano la salute delle persone e gravano sulle economie dei singoli paesi. Il rapporto congiunto dell’OMS e dell’OCSE “Step up! Affrontare il peso dell’insuffi-
ciente attività fisica in Europa” evidenzia che, con un aumento dell’attività fisica a 150 minuti a settimana, si eviterebbero in Europa 11,5 milioni di nuovi casi di malattie non trasmissibili entro il 2050, tra cui 3,8 milioni di casi di malattie cardiovascolari, 1 milione di casi di diabete di tipo 2, oltre 400.000 casi di diversi tumori. In Italia il costo dell’inattività fisica è stimato a 1,3 miliardi di euro nei prossimi 30 anni. Da qui l’importanza di un’iniziativa legislativa che consenta finalmente di prescrivere l’esercizio fisico esattamente come un farmaco.
Una battaglia quella per sostenere il binomio tra sport e salute, che è importante portare avanti su più fronti, che come Presidente dell’Intergruppo Parlamentare Obesità, diabete e malattie croniche non trasmissibili, a fianco delle società scientifiche FeSDI, SID e AMD, la Sen. Sbrollini ha promosso negli ultimi anni molte iniziative, tra cui la firma di importanti protocolli d’intesa con il CONI e con Sport e Salute, finalizzati alla promozione dell’attività sportiva come corretto stile di vita e come forma di prevenzione per il diabete e l’obesità, con il coinvolgimento del mondo dello sport, consapevoli che lo stesso sia uno strumento per investire sul miglioramento del Paese. È importante portare avanti un lavoro comune che consenta il riconoscimento del valore formativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell’attività sportiva, ponendo la cura e la prevenzione delle malattie croniche al centro dell’agenda politica e dell’azione legislativa. Un ringraziamento va dato a tutti i senatori della Commissione Sanità del Senato per il sostegno a questo Disegno di legge, e con l’auspicio, che con l’impegno comune, e in sintonia con il Ministro Schillaci e il Ministro Abodi e i loro dicasteri, la prescrizione dell’esercizio fisico come un farmaco possa divenire presto una legge.
L’IWA è l’organizzazione italiana rappresentativa a livello internazionale nella NCD Alliance. Rinnovati gli organismi direttivi: nuovo Vice Presidente Vicario il Prof. Paolo Sbraccia, Presidente del Comitato Scientifico sarà il Prof. Andrea Lenzi.
È la Sen. Daniela Sbrollini la nuova Presidente dell’Italian Wellness Alliance-IWA , organizzazione creata nel 2012 e operativa su un piano internazionale, nata in accordo con la strategia globale dell’OMS e, in particolare, della NCD Alliance (Non-Communicable Diseases Alliance). Obiettivo fondamentale dell’IWA, che è l’organizzazione italiana rappresentativa a livello internazionale nella NCD Alliance, è quello di contrastare la diffusione di alcune malattie come il diabete, le malattie cardiovascolari, il cancro e le malattie respiratorie croniche.
Ad affiancare la neo-Presidente Sbrollini, ci saranno, in qualità di Vice Presidente Vicario, il Prof. Paolo Sbraccia e, in qualità di Presidente del Comitato Scientifico, il Prof. Andrea Lenzi. A comporre il nuovo Consiglio Direttivo di IWA ci saranno figure di primissimo piano provenienti da ambiti professionali diversi a testimonianza di una straordinaria varietà di competenze. Nuovo Direttore Generale di IWA sarà il Dott. Federico Serra.
Ideare e realizzare interventi, con sostenibilità economica, che supportino l’adozione di corrette abitudini alimentari e la riduzione della sedentarietà, sono il fine ultimo per favorire e mantenere lo stato di benessere del singolo individuo, della collettività e dell’ambiente. Già in età infantile, un eccesso di peso può essere associato a una serie di comorbidità e soprattutto può costituire un fattore di rischio precoce per morbilità e mortalità nella vita adulta. Non solo: lo scenario globale dell’invecchiamento della popolazione, che vede la popolazione anziana predominare su quella giovanile, con un’aspettativa di vita allungata, rende necessario nella società moderna un concomitante miglioramento della qualità di vita. A maggior ragione già nel 2012, anno designato dall’Unione Europea come l’anno dell’Invecchiamento Attivo e della Solidarietà Intergenerazionale, è stata sviluppata questa alliance che mette il benessere al centro delle azioni da

promuovere. Obiettivo, anzitutto, quello di migliorare una cultura del benessere individuale e collettivo
«Grazie alla creazione dell’Italian Wellness Alliance, anche l’Italia ha potuto contribuire, e continuerà a contribuire, alla crescita e alla diffusione della cultura della prevenzione delle malattie croniche non trasmissibili, contrastandone la ormai ben nota diffusione epidemica e il significativo impatto sociale ed economico – dichiara la neo-Presidente Sen. Daniela Sbrollini –Quella del contrasto alle cronicità e della promozione dei sani stili di vita, della corretta alimentazione, dell’attività fisica, è una battaglia fondamentale per la nostra società e per la sua tenuta. Sono onorata, e ringrazio, per l’incarico che mi è stato assegnato, il mio impegno sarà rivolto alla promozione di un lavoro comune che coinvolgendo ambiti molto diversi fra loro contribuisca a mettere la cultura del benessere al centro del nostro sistema e degli stili di vita».
A far parte del Consiglio direttivo sono stati chiamati alla Presidente, Sen. Daniela Sbrollini, il Prof. Paolo Sbraccia quale Vice Presidente Vicario e la Dott.ssa Ketty Vaccaro quale Vice Presidente e come componenti la Prof.ssa Carmen Bizzarri, la Prof.ssa Adriana Bonifacino, la Dott.ssa Roberta Crialesi, la Dott.ssa Cecilia Cristaudo, Dott.ssa Francesca Romana Gigli, Prof.ssa Valeria Guglielmi, Prof.ssa Francesca Romana Lenzi, Prof.ssa Frida Leonetti, Dott.ssa Annalisa Mandorino, Dott.ssa Eleonora Selvi, la Dott.ssa Chiara Spinato, Dott.ssa Simona Clivia Zucchet.
La Repubblica del Movimento si è trasformata in un universale
Confederazione dello sport e del benessere
Il vociare festoso e l’energia del popolo del benessere psicofisico e della pratica sportiva destrutturata, sono tornate a riempire domenica 22 settembre 2024, dall’alba al tramonto, le strade, le piazze, i parchi le strutture sportive urbane di tutta Italia per la più grande festa del movimento d’Europa. Si tratta dello Sportcity Day, quarta edizione dell’evento clou promosso da Fondazione Sporticity che dal 2020 opera sul territorio nazionale promuovendo uno stile di vita attivo grazie alla collaborazione di Enti, Istituzioni locali, nazionali ed europee, come ad esempio la Rappresentanza in Italia della Commissione Europea, Associazioni sportive e nuovi stakeholders. L’iniziativa, che coincide con la Giornata Nazionale per la Salute e il Benessere delle Città, è stata presentata il 18 Settembre in una conferenza stampa in Senato, su iniziativa della Sen. Daniela Sbrollini, in collaborazione con Osservatorio Permanente sullo Sport, Intergruppo parlamentare Qualità di vita nelle città, Health City Insitute, e CITIES +
Quest’anno l’evento ha ottenuto l’adesione record di oltre 163 città che, insieme, hanno lanciato ‘La Repubblica del Movimento’, un’idea che si è concretizzata grazie alla presenza attiva di oltre 600.000 persone in tutta Italia pronte a testimoniare quanto sia possibile alimentare il benessere psico-fisico dei cittadini semplicemente offrendo spazi urbani per praticare attività fisica e cominciare a trasformarli in vere e proprie Hub della Salute. Sono state oltre 90 le attività proposte in tutte le regioni, con più di 700 realtà associative coinvolte e oltre 1500 operatori del movimento qualificati che hanno fatto vivere ai cittadini di ogni età e condizione fisica una giornata all’insegna del benessere.
La Repubblica del Movimento si è trasformata in un universale Confederazione dello sport e del benessere. Tutta l’Italia, oggi, si è trasformata dalle 10 al tramonto in un’unica palestra a cielo aperto dove oltre 600.000 persone hanno potuto vivere insieme l’emozione di
praticare le attività più amate e di conoscere nuove discipline sportive. Dai 3 ai 90 anni, sono sati tutti protagonisti della 4^ edizione dello Sportcity Day, l’evento ideato, promosso ed organizzato dalla Fondazione Sportcity con il sostegno di Enti Locali, Federazioni Sportive, Enti di Promozione, ASD e con l’USSI.
163 città, da nord a sud della penisola, capoluoghi e piccoli borghi, grandi città e realtà di provincia, protagoniste in egual misura in una la domenica che ha voluto regalare ai cittadini una giornata da ricordare. Piazze e centri storici, periferie e parchi, palestre e spiagge sono diventate location ideali per saltare giù dai divani, mettersi in moto, socializzare e divertirsi, per poi tornare a casa con un senso assoluto di benessere fisico e mentale. Una giornata straordinaria che è andata addirittura oltre le previsioni degli organizzatori.
Dai 17 comuni che aderirono alla prima edizione del 2021 alle 163 di quest’anno, dalle 30 mila persone del 2021 alle 600 mila nell’appuntamento del 22 settembre: sono numeri che fanno capire come la linea tracciata da Fondazione Sportcity si sia rivelata vincente in poco tempo. I Comuni che hanno aderito, sono stati pronti ad offrire scenari sempre più suggestivi e aggreganti come sede dell’evento, e il coinvolgimento delle associazioni del territorio si è ormai espanso a macchia d’olio.
E’ tornato anche quest’anno l’appuntamento con Agos, il main partner dello Sportcity Day. A Milano, Roma, Lucca, Padova, Lecce e Catania l’evento si è svolto nei Parchi Agos Green&Smart, zone presenti nelle città e riqualificate con il supporto di Brand for the City nelle dimensioni “green”, “smart”, “sport” ed “art”, per offrire alla collettività sul territorio qualcosa in più di una semplice area verde.
Tra le novità di questa edizione, è spiccata l’iniziativa “Se corri doni”, un momento dedicato all’interno della giornata che si pone l’obiettivo di sensibilizzare sui
temi dell’educazione tramite lo sport e del ruolo sociale che tale attività riveste. Iniziativa che si è svolta in molte città italiane nell’ambito dello Sportcity Day grazie al fondamentale sostegno e alla collaborazione nata con Fondazione Conad ETS e il supporto organizzativo di Csportmarketing. Il progetto produrrà dei voucher per la pratica sportiva per consentite ad alcuni ragazzi una pratica sportiva gratuita. Un modo concreto per lasciare una legacy volta al benessere e ai sani stili di vita.
Così come è confermato è stato l’impegno del Ministero dell’Ambiente e della Sostenibilità ambientale, al fianco dell’evento dal 2023, che sta valorizzando lo sport come strumento per diffondere una nuova cultura dell’educazione ambientale in tutte le fasce della popolazione. Un obiettivo sul quale il MASE sta puntando forte, tanto che per la prima volta nella storia ha affidato una delega allo sport, nello specifico al Sottosegretario Claudio Barbaro.
Altra novità è la partnership con la ‘Settimana europea della mobilità’. La giornata del 22 è stata quella conclusiva dell’evento europeo e sarà incentrata sul park(ing) day, un evento annuale portato avanti in Italia da FIAB, Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta, per convertire temporaneamente aree occupate da parcheggi in spazi pubblici di socialità.
Una giornata, quella del 22 settembre, che è stata anche raccontata nello Sportcity Talk, una diretta video di 8 ore trasmessa sui canali social di Fondazione Sportcity e su decine di canali di associazioni partner dell’evento. Una talk show con ospiti in studio, collegamenti dalle città e video messaggi di personaggi del mondo dello sport e delle istituzioni.
“Non mi interessa – ha sottolineato al termine della lunga e impegnativa giornata il Presidente di Fondazione Sportcity Fabio Pagliara – guardare ai numeri ed affidare a freddi resoconti quello che abbiamo vissuto oggi. Ho negli occhi il gioioso entusiasmo, il meticoloso impegno organizzativo di tutte le associazioni coinvolte e la soddisfazione dei partecipanti e questo è il vero successo ottenuto dallo Sportcity Day. . Questo ripaga un anno di duro lavoro e ci proietta con forza verso un futuro che non potrà che seguire le linee guida che ormai non sono solo le nostre ma di un vero e proprio movimento che cresce ogni giorno di più. L’appuntamento è per la quinta edizione in programma il 21 settembre 2025“.

Claudio Barbaro, Sottosegretario del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica
“Sportcity è indubbiamente un’iniziativa molto intelligente di cui condividiamo la filosofia e le finalità . Molto c’è ancora da fare, nonostante lo sport sia stato inserito in costituzione, è difficile costruire una cultura sportiva negli italiani e strapparli alla sedentarietà. Nonostante l’aumento della richiesta di pratica sportiva ancora si fa fatica ad intercettare tutti coloro che vorrebbero fare sport. Ma siamo all’inizio di un percorso. Le vittorie internazionali dei nostri atleti, delle quali ci siamo beati, sono state importanti per far accrescere la voglia di sport degli italiani ma non hanno fatto compiutamente da traino ad aumentare il desiderio di fare sport. La pratica sportiva per tutti potrebbe avere ripercussioni e benefici sul settore sanitaria ed abbiamo il dovere di permettere che sempre più persone pratichino sport nel nostro Paese.. Venendo all’aspetto ambientale abbiamo messo in moto un circolo virtuoso che le vittorie dei nostri atleti a Parigi hanno fatto crescere. I nostri medagliati, nominati ambasciatori dell’ambiente, hanno fatto da cassa da risonanza alle tematiche ambientali che perseguiamo, sarà un importante punto di partenza. Sportcity risponde al massimo ai requisiti di sostenibilità e il Ministero ne ha sposato in pieno la filosofia ed il percorso sin qui compiuto “.
Daniela Sbrollini- Senatrice Vice Presidente della X Commissione Permanente del Senato
“Ringrazio il Presidente della Fondazione Fabio Pagliara con il quale stiamo lavorando fattivamente per riuscire a far diventare legge in disegno che vuole permettere ai medici di prescrivere l’esercizio fisico come alternativa ai farmaci e come cura. Questa quarta edizione si basa su solidarietà e amicizia valori che sono alla base degli enormi risultati raggiunti fino ad oggi. Il movimento è destinato a crescere e altre iniziative sono in programma grazie al sostegno di tante componenti che hanno interagito pro-
ficuamente con la Fondazione Sportcity “.
Andrea Lenzi, Presidente del CNBBSV della Presidenza del Consiglio dei Ministri e Presidente dell’Health City Institute
“ E’ evidente che fare attività motoria in un ambiente sbagliato è davvero deleterio per la nostra salute. I problemi di inquinamento delle città molto spesso rendono impossibile praticare sport in strada o in piazza. Lo Sportcity può essere la terapia per la salute delle città. L’attività sportiva deve e può essere terapia che può sostituire i farmaci, anche se come ogni terapia deve essere personalizzata. L’uomo è fabbricato per camminare, lo dimostrano i popoli del passato che erano sempre in movimento per reperire le risorse alla propria sopravvivenza.”
Paolo Pilotto, Sindaco di Monza
“ Leggere le città che aderiscono a Sportcity è un come fare un meraviglioso viaggio sportivo lunga tutta la penisola. Monza ha aderito già da due anni perché crediamo nella funzione pedagogica dello sport e di eventi come questo. Sono numerose le iniziative che vengono svolte in città dedicate ai bambini e ai ragazzi. Lo Sportcity Day sarà preceduto sabato dalla Festa dello Sport è dalla 10k Liberi di Correre, gara podistica in notturna, che a Monza ormai ha una grande tradizione sportiva. Fra gli obiettivi che ci riproponiamo è quello dell’abbattimento delle barriere architettoniche nello sport e di realizzare eventi inclusivi e dedicati al settore paralimpico, perché lo sport deve essere davvero di tutti “.
Sabrina Gastaldi Responsabile Istruzione e sport ed edilizia scolastica di Anci
“Siamo stati vicino a questa iniziativa sin dalla prima edizione perché la filosofia che persegue è molto vicina a quella di Anci. Ci riconosciamo nella finalità di permettere a tutti i cittadini di fare sport perseguendo non il risultato bensì il benessere perso-

nale. Crediamo fermamente che questa iniziativa possa permettere la valorizzazione delle città coinvolte. Anci sta ovviamente lavorando per il miglioramento dell’impiantistica sportiva e per dare l’opportunità ai giovani di praticare attività in ogni angolo della penisola. Fra le nostre tante iniziative quelle dello sport nei parchi, soprattutto quelle dedicate ai giovani in età 4/14. Abbiamo stipulato inoltre protocolli d’intesa con FIP e Federgolf, per la realizzazione di 100 play ground di basket in tutta Italia e per lanciare, anche fra i giovani lo sport del golf“.
Paolo Pilotto, Sindaco di Monza -
“ Leggere le città che aderiscono a Sportcity è un come fare un meraviglioso viaggio sportivo lunga tutta la penisola. Monza ha aderito già da due anni perché crediamo nella funzione pedagogica dello sport e di eventi come questo. Sono numerose le iniziative che vengono svolte in città dedicate ai bambini e ai ragazzi. Lo Sportcity Day sarà preceduto sabato dalla Festa dello Sport è dalla 10k Liberi di Correre, gara podistica in notturna, che a Monza ormai ha una grande tradizione sportiva. Fra gli obiettivi che ci riproponiamo è quello dell’abbattimento delle barriere architettoniche nello sport e di realizzare eventi inclusivi e dedicati al settore paralimpico, perché lo sport deve essere davvero di tutti “.
Antonio Marco Appella, Generale di Brigata comandante Centro Sportivo Fiamme Gialle-
“ Le Fiamme Gialle guardano sempre alla promozione dello sport, aprendo le porte ai bambini, organizzando manifestazioni ed di carattere sociale. Parteciperemo allo Sportcity Day mettendo a disposizione in tutti i nostri centri sportivi per recitare un ruolo importante per tutta la cittadinanza e dare impulso importante alla diffusione della pratica sportiva ad ogni livello “
Maria Cristina Alfieri, Direttrice Fondazione Conad ETS
“Siamo orgogliosi come Fondazione Conad ETS di sostenere la più grande festa sportiva d’Europa con un progetto che abbina attività fisica e solidarietà. In occasione dello Sportcity Day, chi parteciperà all’iniziativa ‘Se corri doni’ regalerà un anno di attività sportiva a migliaia di giovani in difficoltà economica. Un modo concreto per far bene a se stessi e agli altri, dimostrando che lo sport può anche essere uno straordinario strumento di inclusione sociale”.
Susanna Venisti ,Responsabile Corporate Sustainability
Agos-
“Agos cercava una progettualità che ci permettesse di essere vicino al territorio e per dare vita al nostro progetto di rigenerazione urbana all’interno delle città. La visione di Fondazione Sportcity si sposava perfettamente alla nostra che viaggia su quattro direttrici “Green” per diffusione del verde in città e l’educazione alla sua cura; “Smart”, ovvero l’innovazione attraverso la tecnologia e il digitale a disposizione della comunità; “Sport”, ovvero la diffusione della pratica sportiva in città come fattore di salute, benessere e socialità; “Arte” con un focus sulla street art e le altre
forme di espressione artistica urbana. Lo Sportcity sarà ospitato anche nei sette parchi Agos di Torino, Milano, Padova, Lucca, Roma, Lecce e Catania per certificare il meglio la sinergia che è stata costruita “.
FABIO PAGLIARA, PRESIDENTE DELLA FONDAZIONE SPORTCITY
“Il vento non si ferma con le mani, grandi città e piccoli comuni sono pronti per una giornata che trasformerà la penisola in un’enorme palestra diffusa. Il processo di sportivizzazione che abbiamo messo in moto ha convinto tutti, dalle istituzioni al mondo dell’associazionismo e ovviamente ai cittadini, sempre più numerosi nella partecipazione all’evento. La Repubblica del Movimento, dunque, è un’idea lanciata da noi che si sta trasformando in realtà: progressivamente, infatti, sta cambiando l’idea dello sport nel nostro paese. Pervicacemente porteremo avanti il nostro progetto in quanto convinti dai fatti che in molti ci seguiranno. Insieme sconfiggeremo la sedentarietà e la dipendenza dal cattivo utilizzo dei device“.


Il report di Insider Monkey premia la città toscana come la destinazione più percorribile a piedi al mondo
di Ludovica Serra
Non c’è niente di meglio che camminare in una città, per assorbire la cultura locale e imbattersi in gemme nascoste, luoghi fantastici e ricchi di storia e il tutto è meglio se nel contempo respiriamo aria non inquinata. Quali sono le città più percorribili a piedi al mondo? Un nuovo rapporto ha le risposte a questa sfida per rendere le città più attrattive non solo a livello turistico, ma anche ambientale, promuovendo nel contempo la mobilità attiva.
All’inizio di quest’anno, il sito web-finanziario Insider Monkey ha condiviso in un report la sua lista delle città più percorribili a piedi al mondo, che ha creato utilizzando fonti come Tourlane e WalkScore. Ha quindi preso questi punteggi, ha mappato la distanza tra le prime cinque attrazioni turistiche di ciascuna destinazione e ha controllato la qualità dell’aria utilizzando i dati IQAir e gli indici di criminalità e sicurezza per garantire ulteriormente la pedonabilità.
La classifica della qualità dell’aria di IQAir assegna un punteggio più alto alle città con una scarsa qualità dell’aria e un punteggio inferiore alle città con una buona qualità dell’aria. Un punteggio compreso tra 0 e 50 si traduce in un’eccellente qualità dell’aria, tra 51 e 100 si traduce in una qualità dell’aria moderata e qualsiasi valore superiore a 100 inizia a muoversi verso una qualità dell’aria malsana.
Dopo aver esaminato tutte le informazioni, ha nominato Firenze come la migliore walkable city.
Firenze è una città che offre storia rinascimentale e una struttura urbanistica unica, che il coinvolge visitatore incontra ad ogni passo. La pedonabilità di Firenze è particolarmente esaltata nel suo centro storico, dove stretti vicoli conducono a monumenti come il Duomo e Ponte Vecchio. I suoi principali punti di riferimento, tra cui la Galleria degli Uffizi, Ponte Vecchio, Piazza della Signoria, Piazza del Duomo e la Cattedrale di Santa Maria del Fiore, si trovano tutti a 0,5 miglia
l’uno dall’altro, il che rende facile raggiungerli tutti a piedi in 10 minuti.
Insieme a Firenze in cima alla lista c’è Riga, in Lettonia, al secondo posto, con le sue principali destinazioni turistiche tutte nel raggio di 1,5 miglia; Amburgo, Germania, al terzo posto con i suoi punti entro due miglia; e Porto, in Portogallo, al quarto posto, con le sue migliori attrazioni nel raggio di 2,2 miglia.
A completare la top five c’è Madrid, dove i viaggiatori troveranno tutte le migliori attrazioni nel raggio di 2,2 miglia. La città ha un indice di qualità dell’aria leggermente inferiore a quello del Portogallo, scendendo solo di un posto più in basso nella lista. Tuttavia, è un luogo che il team nota che vale la pena visitare.
L’Europa ha dominato la lista, conquistando i primi cinque posti: Riga, la capitale della Lettonia, è arrivata seconda, seguita da Amburgo, in Germania; Porto, Portogallo; e Madrid, Spagna. Con 17 città (tra cui Istanbul, che si trova a cavallo dell’Asia), l’Europa ha anche il maggior numero di località di qualsiasi altra regione. Gli Stati Uniti, il Regno Unito e il Canada avevano ciascuno tre città nell’elenco. Ce n’erano due in Australia, uno in Asia e uno in Medio Oriente.
Una città diventa percorribile a piedi quando ci si può spostare comodamente da un luogo all’altro senza bisogno di un veicolo. Si tratta di creare spazi in cui le persone possano passeggiare per visitare i monumenti, o per il tempo libero, lo shopping, il lavoro o l’esercizio fisico. Ma cosa rende esattamente una città percorribile a piedi?
n una città percorribile a piedi, troverai aree libere dalle auto e vicino ai siti turistici, alle strutture sanitarie e scolastiche. Questi luoghi favoriscono la comunità e rendono la vita quotidiana conveniente. I piccoli isolati creano un ambiente urbano più intimo, che aumenta anche la pedonabilità della città.
Secondo l’American Institute for Cancer Research, a livello globale, una persona media cammina circa 5000 passi al giorno, il che è buono ma non abbastanza, secondo NIH. Il National Institute of Health ha studiato e scoperto che gli adulti che camminavano solo 4.000 passi al giorno erano più inclini a morire di malattie cardiache o cancro rispetto a quelli che camminavano 8.000 o più passi al giorno.
Camminare è un esercizio con molti benefici per la salute, tra cui un minor rischio di diabete, ictus, malattie cardiovascolari, obesità e ipertensione, oltre a migliorare la salute mentale. Inoltre, l’AICR rileva che essere fisicamente attivi per 30 minuti riduce il rischio di sviluppare tumori del colon-retto, dell’endometrio e della mammella.
Sebbene camminare prevenga molti problemi di salute ed è incoraggiato dagli operatori sanitari di tutto il mondo, non molte città sono percorribili a piedi o dispongono di infrastrutture pedonali. Secondo il World Economic Forum, le 35 più grandi aree metropolitane degli Stati Uniti hanno solo l’1,2% di superficie percorribile a piedi o pedonale. Ancora più scioccante, questa piccola percentuale di terra percorribile genera quasi il 20% del PIL degli Stati Uniti, mostrando una relazione positiva tra buone infrastrutture pedonali e l’economia sotto molti aspetti (vedi: 15 città più percorribili a piedi negli Stati Uniti).
Un’infrastruttura pedonale aumenta il valore dei terreni e delle proprietà rendendola più desiderabile e attirando la classe ricca nella zona. La stessa ricerca del WEF che abbiamo linkato sopra rileva che a partire dal 2021, le aree urbane percorribili a piedi hanno avuto un significativo sovrapprezzo rispetto alle aree urbane percorribili in auto. Per premio di prezzo si intende la percentuale di cui il prezzo di vendita supera il prezzo base. Nel 2021, il premio di vendita o di affitto nelle aree urbane pedonali è stato del 35-45% per uffici, affitto, vendita al dettaglio e case in vendita.
Inoltre, le città percorribili a piedi attirano investimenti da parte di aziende private e imprese in quanto trovano le aree pedonali più attraenti dal punto di vista economico. CNU presenta un esempio del centro di Lancaster, in California, dove il governo di Lancaster ha speso 11,5 milioni di dollari per un progetto per migliorarne la pedonabilità. Lancaster ha attratto 130 milioni di dollari di investimenti privati entro quattro anni dal progetto e ha generato 273 milioni di dollari di produzione economica.
Le città percorribili a piedi tendono ad avere una migliore qualità dell’aria anche perché ci sono meno auto
sulla strada che producono gas nocivi come il monossido di carbonio. Una buona qualità dell’aria promuove una migliore salute mentale e fisica e, quando le persone sono in buona forma e mente, tendono ad essere più creative e produttive e contribuiscono all’economia. Infine, le città percorribili a piedi incoraggiano un maggior numero di venditori locali sul marciapiede, il che si aggiunge all’attività economica complessiva dell’area, attirando allo stesso tempo i turisti.
Sebbene le infrastrutture pedonali nelle aree urbane siano importanti per l’economia, non molte città in tutto il mondo soddisfano tale standard. Per sbloccare il pieno potenziale economico delle loro città, i paesi devono lavorare per migliorare le infrastrutture e renderle più adatte ai pedoni e costruire percorsi di trekking urbano.
Firenze è in cima alla lista come la città più percorribile a piedi al mondo. Conosciuta per la sua storia rinascimentale e la sua straordinaria architettura, i principali monumenti della città, come la Galleria degli Uffizi, Ponte Vecchio, Piazza della Signoria, Piazza del Duomo e la Cattedrale di Santa Maria del Fiore, sono tutti facilmente raggiungibili a piedi. Un altro punto forte, secondo Insider Monkey: “Firenze dà la priorità alla pulizia, evidente nelle sue piazze ben tenute e nelle rive del fiume Arno.
2. Riga, Lettonia
Questa capitale medievale situata sul Mar Baltico è un luogo delizioso per i pedoni. Le sue attrazioni più popolari, la Cattedrale di Riga, il Mercato Centrale di Riga, la Casa delle Teste Nere, il Parco Bastejkalna e il Giardino Vērmanes, si trovano tutte a 1,5 miglia l’una dall’altra. Oltre al centro storico pedonale, Insider Monkey consiglia di visitare il quartiere di Vecrīg, patrimonio dell’umanità dell’UNESCO, che descrive come “il centro storico di Riga”.
3. Amburgo, Germania
Le vibrazioni marittime e i siti culturali di Amburgo, come l’Hamburg Dungeon e il Miniatur Wunderland, si trovano a meno di due miglia l’uno dall’altro. L’efficienza dei trasporti pubblici e i siti panoramici della città contribuiscono alla sua elevata percorribilità a piedi.
4. Porto, Portogallo
Porto combina strette strade acciottolate, perfette per esplorare, e monumenti famosi, come il ponte Dom Luís I e la Livraria Lello. Le strade pulite della città e i parchi ben curati ne migliorano la pedonabilità. “La qualità dell’aria di Porto è influenzata dalla sua posizione costiera”, osserva il rapporto.
5. Madrid, Spagna
Con le principali attrazioni come il Palazzo Reale e il Museo del Prado non lontani l’uno dall’altro, Madrid è facile da esplorare a piedi. “La pedonabilità di Madrid è più evidente nelle zone centrali come la Puerta del Sol e il Parco del Retiro, che sono entrambi punti di riferimento storici”, secondo gli autori di Insider Monkey.
6. Edimburgo, Scozia, Regno Unito
Edimburgo è nota per i suoi parchi puliti e i suoi monumenti storici, che la rendono un’ottima destinazione per gli escursionisti. Inoltre, le sue principali attrazioni, come il National Museum of Scotland e il Castello di Edimburgo, si trovano nelle immediate vicinanze.
7. Tallinn, Estonia
La struttura compatta e il fascino medievale di Tallinn la rendono una città ideale per passeggiare. Il rapporto descrive Tallinn come dotata di un “layout compatto, che rende ideale camminare a piedi”. Attrazioni come Piazza della Libertà e il Municipio di Tallinn offrono un ricco mix di tradizione e cultura.
8. Stoccolma, Svezia
Stoccolma offre una delle migliori qualità dell’aria al mondo per i pedoni. Le principali attrazioni della città, tra cui il Palazzo Reale e il Museo Vasa, si trovano nel raggio di 2,3 miglia, il che la rende facile da esplorare a piedi.
9. Sydney, Australia
I monumenti iconici di Sydney, come la Sydney Opera House e il Royal Botanic Garden, sono facilmente raggiungibili a piedi l’uno dall’altro. Il suo fattore di pulizia è uno dei suoi tratti distintivi: secondo il rapporto, “Sydney ha una pulizia notevole, anche sulle spiagge e negli spazi pubblici”. Il tutto è arricchito da un efficiente sistema di trasporto pubblico, nel caso in cui abbiate voglia di alzarvi dai piedi.
10. Boston, Massachusetts
Il fascino storico di Boston e i parchi ben curati la rendono una città altamente percorribile a piedi. Le principali attrazioni, tra cui il Museum of Fine Arts e il Boston Common, si trovano nel raggio di 2,9 miglia. Secondo il rapporto, “Boston ha una qualità dell’aria decente e la brezza del porto spesso abbellisce la città”.
HEALTHY WALKABLE CITIES DI CITIES CHANGING DIABETES
In Italia con il progetto Cities Changing Diabetes si è realizzata, grazie al campione olimpico Maurizio Damilano e il suo TO WALK IN THE CITIES LAB, una prima rete di healthy walkable cities con 523 percorsi suddivisi tra tutte le regioni ed in 217 città diverse: per un totale complessivo di 2.666 km.
CONTEXT ROMA
Roma è la città in Italia che registra il più alto numero di turisti, la città più estesa e la città con il più alto numero di abitanti; è stata una sfida l’inserimento nelle HEALTHY WALKABLE CITIES, una sfida vinta.
E’ infatti la città in cui è stato proposto il maggior numero di percorsi pedonali, sono presenti sull’applicazione oltre 60 percorsi 22 dei quali presenti anche sul Passaporto e 18 sulla Mappa, per complessivi 360 Km circa che fanno di Roma la prima walkable city in Europa.
Sono percorsi pensati appositamente per il cammino, uniscono le diverse anime di Roma, coinvolgono infatti l’intera città metropolitana con proposte diversificate che vanno dall’itinerario storico teso alla scoperta dell’immenso patrimonio architettonico ed artistico a quello naturalistico più inaspettato tra pinete e parchi secolari a pochi passi dal centro. Sono tutti ideali da percorre a piedi e sono “per tutti i piedi”, ci sono infatti i percorsi più sportivi che meglio si prestano al cammino veloce e ad un approccio più allenante e quelli in grado di ritemprare la mente e lo spirito grazie alla bellezza nella quale sono immersi.
CONTEXT BARI
La città di Bari ben si presta ad una fruizione pedonale, è un centro urbano a misura d’uomo che ha nell’affaccio sul mare il suo punto di forza. La maggior parte dei percorsi proposti ha infatti questo denominatore comune, o si sviluppano sul lungo mare oppure collegano centro e mare in un costante dialogo tra i due elementi, tra città nuova e città vecchia.
Il lungomare di Bari, tra i più vasti di Europa con i suoi 16 Km, attraversa la città fiancheggiando tutta la costa, è stato recuperato recentemente alla piena fruizione dei cittadini per la pratica di esercizio fisico e sport, è un punto di incontro importante per tanti sportivi e meta prediletta dei podisti cittadini, ben si presta alla pratica del cammino sia veloce che sotto forma di passeggiata quotidiana.
CONTEXT MILANO
Milano è la città italiana che più guarda alle grandi metropoli internazionali, attenta e ricettiva verso gli stimoli nuovi ha ben saputo cogliere l’opportunità di
proporsi come città “per e da camminare” proponendo itinerari nell’intera città metropolitana.
I percorsi proposti spaziano infatti dal centro cittadino, ai parchi più conosciuti e frequentati come l’Idroscalo ed il Parco Sempione, ai nuovi quartieri ridisegnati grazie all’impulso dell’Expo 2015 come City Life e Porta Nuova, sino ai comuni dall’Alto Milanese al Magentino Abbiatense, da Nord a Sud della città sino alla Martesana. L’elemento che li collega tutti è il cammino inteso sia come mezzo per muoversi all’interno della città in combinazione magari con l’auto o con i mezzi pubblici che come strumento alla portata di tutti per tenersi attivi. Milano sarà città olimpica nel 2026 e punto di riferimento ideale per sviluppare un progetto di maggiore sostenibilità dell’eredità olimpica attraverso l’ideazione delle “OLYMPIC ROADS FOR HEALTH”, percorsi inseriti nel contesto delle aree olimpiche perché divengano patrimonio della città per l’esercizio fisico, sportivo e salutistico dei cittadini.
CONTEXT TORINO
Torino per la sua storia industriale è la città dell’auto per definizione questo non le ha però impedito di essere una delle città con più aree verdi a livello nazionale. Questa apparente dicotomia ha rappresentato la base di partenza per la proposta dei percorsi individuati inizialmente nei grandi parchi cittadini come il Valentino, le Vallere, il Parco Pellerina, il Parco Dora, il Parco della Tesoriera ed il Parco di Piazza d’Armi e successivamente in tutta l’area non solo urbana. E’ stata infatti coinvolta anche in questo caso l’intera città metropolitana dal centro, con un connubio tra storia, tradizione e leggenda che vuole Torino una città esoterica, sino ai comuni suburbani che lambiscono le valli montane a nord ovest e la pianura a sud est.
Torino conferma inoltre la sua vocazione di città dell’innovazione e laboratorio, è infatti il riferimento, tanto da essere inserita nel nome di “TO Walk in the City Lab”. Anche Torino come Milano e Roma è città olimpica in Italia, e come per le altre sedi di Giochi Olimpici nel Paese si identifica come riferimento per lo sviluppo del progetto “Olympic Roads for Health” pensato dal TO Walk in the City Lab”.
OUTCOMES & ACTIONS ROMA
In sinergia con il Comune di Roma sono stati progettati 52 percorsi di walking urbano e di percorsi nei parchi urbani, arrivando a una rete di più di 300 Km utilizzabili per attività motoria a costo zero, che pongono Roma la prima walkable city europea. I percorsi sono stati scelti pensando ai cittadini e alla quotidianità di utilizzo, ma anche rivolti ai turisti, dedicati alla visita della Città, dei suoi luoghi simbolo, così come di parti meno note ma che presentano altrettanto fascino e bellezza e percorsi di tipo naturalistico, ambientale o più decisamente sportivo. Una parte importante è dedicata ai percorsi delle periferie per favorire lo sviluppo sociale delle stesse. In totale i per-
corsi coinvolgono cica 1,5 milioni di cittadini e 1,2 milioni di popolazione insistente quali lavoratori temporanei, studenti fuori sede e city user
OUTCOMES & ACTIONS BARI
In collaborazione con il Comune di Bari e della Città Metropolitana sono stati sviluppati 15 percorsi per un totale di 44 Km che si sviluppano non solo nella valorizzazione del lungomare e del centro storico, ma anche delle periferie e dei quartieri a più alta densità abitativa. Il progetto trova un forte link con la progettualità del Comune di Bari che rende fruibili 43 impianti sportivi per la promozione della salute in tutte le fasce della popolazione.
OUTCOMES & ACTIONS MILANO
Sono stati realizzati 43 percorsi urbani per uno sviluppo di 210 km per promuovere il movimento dei cittadini e in particolare la camminata come sana abitudine nella prevenzione delle malattie croniche non trasmissibili, come diabete e obesità.
Entro il 2026 (anno delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina) entreranno nel passaporto e nel progetto “OLYMPIC ROADS FOR HEALTH” tutti i 103 comuni dell’hinterland milanese con almeno un percorso per camminare in ciascuno.
OUTCOMES & ACTIONS TORINO
Il progetto nasce in Piemonte nel 2008 in Piemonte dall’esperienza del campione olimpico di marcia Maurizio Damilano. Per testarlo al meglio si è svolta nel triennio 2009 – 2011 una fase pilota in Piemonte che ha visto coinvolte 47 città e la partecipazione di circa 500 mila cittadini. Oggi solo nella città di Torino sono stati sviluppati 20 percorsi per un totale di 90 Km, che si sviluppano nei contesti verdi della città.
Grazie agli sforzi delle Associazioni pazienti e delle autorità sanitarie locali, attualmente utilizzano i percorsi circa 32 gruppi di camminatori (circa 600 persone con diabete).
STRUMENTI DI CONNESSIONE TRA LE CITTA’
- IL LABORATORIO “TO WALK IN THE CITY LAB” è la realizzazione dell’idea di mettere insieme specialisti della salute, del movimento fisico, dell’urbanistica, dell’organizzazione cittadina, dello sport per sviluppare proposte e suggerimenti per come muoversi nella direzione di città più attive e in salute. Il Laboratorio vuole poter sostenere il lavoro degli amministratori cittadini e di chi lavora nel mondo della
salute e delle attività motorio e sportive, fornendo idee, studi e progettualità legate al sistema camminare all’interno delle città, e alla città che diviene luogo per camminare. Tra le prime proposte suggerite dal laboratorio vi è l’ampio lavoro da realizzare sul tema della mobilità sostenibile a piedi nelle città. Un caposaldo nel sistema che guarda alla città del futuro, una città a dimensione di cittadino e che unisce in una nuova stretta alleanza le esigenze di innovazione urbanistica e di ricerca di una miglior qualità dell’ambiente urbano e del suo sviluppo green, con quelle di benessere e di salute delle persone.
- L’APPLICAZIONE “CITTÀ PER CAMMINARE E DELLA SALUTE” è lo strumento che propone itinerari adatti al cammino indicandone le caratteristiche, i punti di interesse presenti e le informazioni utili. E’ lo strumento, insieme alle mappe, che “fa vivere il percorso” passando dalla proposta alla pratica. Attivando l’applicazione viene indicato il risparmio in termini di CO2 un ulteriore elemento di attenzione verso i temi della sostenibilità ambientale e dello spirito green che pervade le nuove città ed oggi al centro delle politiche di tutte le istituzioni, nazionali, regionali e mondiali.
- LE MAPPE E I PASSAPORTI insieme all’applicazione, sono lo strumento che rende immediatamente fruibili i percorsi localizzandoli all’interno della città e dandone una descrizione breve ed efficace.
I passaporti permettono di identificare le caratteristiche dei percorsi, le difficoltà degli stessi, la fruibilità, le facilties (parcheggi, presenza di fontanelle dell’acqua, trasporti…) e i luoghi di interesse turistico e pubblico
- I GRUPPI DI CAMMINO “WALKING FRIEND GROUPS” nascono come elemento operativo ed attivo per una maggiore fruibilità regolare di uno o più percorsi proposti e suggeriti. I gruppi sono condotti da un Walking Friend Chief specificatamente formato che conduce il gruppo di cammino con costanza e determinazione con l’obiettivo di rendere l’esercizio fisico ed il cammino una costante, una salutare abitudine da praticarsi con continuità. Nato per facilitare lo sviluppo dell’attività fisica in pazienti diabetici e per la prevenzione della malattia ha nelle Associazioni pazienti e nelle strutture sanitarie specialistiche gli alleati principali.
In conclusione, le parole di Enrique Peñalosa, sindaco di Bogotá in Colombia: “Dio ci ha fatto pedoni. Come un pesce ha bisogno di nuotare, un uccello di volare, un cervo di correre, noi uomini dobbiamo camminare; non per sopravvivere, ma per essere felici”. Lui, in quanto sindaco, ha chiuso il centro di Bogotà alle auto una volta a settimana. Un giorno in cui ci si muove solo a piedi e in bici.
In fin dei conti, l’uomo è stato creato per camminare e tutti gli eventi della vita grandi e piccoli si sviluppano quando camminiamo tra le altre persone, in contatto diretto con chi ci cammina intorno.
Maurizio Damilano, Presidente Associazione Fitwalking e Campione Olimpico di Marcia
Il fitwalking è “l’arte del camminare”, è una forma di praticare il cammino che ne evidenzia tutte le potenzialità e va oltre il semplice camminare. Il termine inglese significa letteralmente “camminare per la forma fisica”; è il denominatore comune per tutte le attività di cammino che escono dalla normale locomozione quotidiana e diventano attività motoriosportiva , per il tempo libero e per il relax, per il divertimento, per il fitness, per la salute, per il benessere, ma che mantengono la comune radice del CAMMINARE BENE.
“L’arte del fitwalking” sta proprio nella scoperta che non è sufficiente camminare per fare al meglio la passeggiata, il trekking, lo sport, il tour culturale e turistico o l’attività salutistica, ma è necessario camminare bene, ossia camminare osservando una corretta meccanica del movimento, acquisita conoscendo e praticando la tecnica del fitwalking. Una tecnica semplice ma indispensabile per trasformare il normale camminare in forma sportiva ed adatta a tutti.
Il fitwalking è quindi anche una filosofia che accompagna la vita quotidiana, per renderla più viva, più equilibrata e ritmata. E’ un modo di vivere che permette di entrare nel quotidiano al passo giusto, al ritmo corretto, in equilibrio assoluto tra noi e ciò che ci circonda. FITWALKINGSe si pensa alla frenesia della vita di ogni giorno ben si capisce l’importanza di inserire nella nostra giornata un momento in cui tutto rallenta e dove il rapporto tra tempo e spazio prende una dimensione assolutamente diversa e si conquista un’efficienza fisica nuova e un senso di libertà assoluta. La libertà di muoversi dove si vuole ed alla velocità desiderata, di lasciare vagare i pensieri, di soffermarsi a scrutare l’orizzonte o di tirare dritto con passo deciso e sicuro.
Fare fitwalking con regolarità è un po’ come tornare indietro nel tempo, quando camminare era l’unica vera forma di locomozione che permettesse a tutti di muoversi per lunghi tragitti o di spostarsi per brevi tratti e compiere le normali azioni del vivere quotidiano.
Un insieme così vasto di concetti e situazioni ha però bisogno di una sintesi che ne limiti i contorni in modo più chiaro.
Il fitwalking si distingue, pur riconoscendosi nella sua radice, dal normale camminare, dal farlo per turismo, per arte, per cultura, ambientalismo o amore per la natura.
Ecco perché il fitwalking al suo interno si caratterizza in 3 categorie, o famiglie, che, per comodità, includono tutti i diversi modi di intendere il fitwalking, e nelle quali ognuno potrà individuare la più corrispondente alle sue mire ed esigenze di camminatore.
l sito “Via Appia. Regina viarum” è stato iscritto lo scorso 27 luglio nella Lista del Patrimonio Mondiale UNESCO, durante la 46a sessione del Comitato del Patrimonio Mondiale, in corso di svolgimento a New Delhi in India.
Tracciata per esigenze militari dal censore Appio Claudio nel 321 a. C. per collegare Roma a Capua e successivamente estesa fino a Brindisi, l’Appia divenne subito strada di grande comunicazione commerciale e di primarie trasmissioni culturali, in quanto concepita fin dall’inizio come via publica, percorribile gratuitamente da tutti perché realizzata su terreni espropriati allo scopo dallo Stato romano. La strada fu ampliata nel corso del tempo, per questo il sito Patrimonio Mondiale comprende anche la variante al tracciato originale, fatta costruire da Traiano nel 109 d.C.
La via Appia costituisce la testimonianza eccezionale di una tradizione culturale o di una civiltà vivente o scomparsa in quanto modello per la viabilità dell’epoca, che contribuì alla diffusione della civiltà urbana e all’unificazione culturale di tutte le genti del mondo romano. La via fu la prima delle grandi strade che attraversavano l’impero, costruita con tecniche ingegneristiche innovative, e costituisce un esempio straordinario di una tipologia edilizia, di un insieme architettonico o tecnologico capace di illustrare una fase significativa nella storia umana, come stabilito dal criterio iv della Convenzione UNESCO per la Protezione del Patrimonio Mondiale e Culturale del 1972. Inoltre, le prime 12 miglia della strada, caratterizzate da famosissimi monumenti, costituiscono uno dei tratti dell’itinerario più celebrati nell’arte attraverso i secoli; in quanto materialmente associata opere artistiche o letterarie, presenta caratteristiche che soddisfano il criterio vi della Convenzione del 1972.
Il sito non comprende solo il tracciato stradale, ma un’ampia gamma di tipologie di manufatti che erano funzionali alla viabilità dell’epoca o strettamente legate
ad essa, in particolare quelle riferibili al periodo 312 a.C.- IV d.C. in coerenza con la fase storica cui si riferisce il sito candidato: opere ingegneristiche necessarie alla realizzazione della via, infrastrutture di servizio, insediamenti, monumenti funebri, luoghi di culto, evidenze monumentali, porti e approdi, centuriazioni, elementi scultorei ed epigrafi, che costituiscono espressioni tangibili della storia e delle tradizioni riferite al lungo ed ininterrotto uso della antica via, da millenni luogo della memoria e crocevia di culture.
Con l’iscrizione della via Appia, l’Italia raggiunge il numero di 60 siti iscritti nella prestigiosa Lista del Patrimonio Mondiale, della quale continua a detenere il primato.
Via Appia è la prima e più importante delle grandi strade costruite dai Romani, conosciuta anche come regina viarum. Fu costruita verso la fine del IV secolo a.C., nel 312, per garantire una comunicazione rapida e diretta tra Roma e Capua. Secondo lo storico romano Livio, fu costruita dal censore Appio Claudio Cieco, al quale deve il suo nome.
Il progetto rivela una concezione sorprendentemente moderna, che prevedeva soluzioni ingegneristiche all’avanguardia: ponti, viadotti, gallerie che hanno assicurato un percorso assolutamente rettilineo e rapido per i tempi, attraverso distese d’acqua, paludi e montagne; molte di queste opere sono ancora oggi praticabili. Fino ad allora le strade erano poco più che sterrate e diventavano impraticabili per i veicoli a ruote ad ogni pioggia. I Romani concepirono fondi stradali, innovativi per stabilità e drenaggio, pavimentati con lastre di basalto rivestito, garantendo così la praticabilità con tutte le condizioni meteorologiche. Questa sapienza costruttiva ha permesso loro di realizzare una vasta rete di oltre 120.000 km, che è rimasta intatta per secoli ed è ancora la spina dorsale dei sistemi stradali di tutti i paesi dell’area mediterranea.

Anche lo status giuridico di queste strade è veramente innovativo, perché la strada fu concepita come via publica, quindi non soggetta a pedaggio e destinata a servire la popolazione rurale e urbana. Tutte le strade avevano marciapiedi e pietre miliari che indicavano le distanze principali ed erano previste stazioni postali a intervalli regolari che fornivano il cambio dei cavalli e l’alloggio. Questo sistema stradale altamente efficiente fu utilizzato dal cursus publicus, il servizio postale romano per lo scambio di messaggi tra le province e la capitale dell’Impero. Per tutte queste ragioni, la Via Appia fu tramite di propagazione della civiltà romana e crocevia di diverse culture.
Il tracciato della Via Appia fu esteso più volte, in corrispondenza con l’espansione dell’influenza romana sulla Penisola, prima fino a Benevento, intorno al 268 a.C., poi attraverso gli Appennini fino a Venosa e di nuovo fino a Taranto. Infine, nel II secolo a.C., raggiunse Brindisi, principale porto per le navi dirette in Grecia e in Oriente. Nel corso degli anni, il tracciato originario da Benevento a Brindisi fu gradualmente sostituito da un percorso più breve e agevole attraverso la Puglia fino a quando, all’inizio del II secolo d.C., l’imperatore Traiano promosse un vero e proprio itinerario alternativo, che porta il suo nome e che raggiungeva Brindisi in 13-14 giorni per un totale di 365 miglia, poco meno di 540 km.
Grazie alla costante manutenzione, la via Appia rimase in perfetta efficienza per diversi secoli, fino al Medioevo, quando la strada attraversò un periodo di abbandono. Nel XIV secolo divenne nuovamente la principale via di accesso al Sud Italia. Completamente restaurata dai Papi e dai Re di Napoli, la strada fu inclusa da Napoleone tra gli itinerari che considerava essenziali per le sue attività politiche e militari.
Inoltre, la Via Appia svolge un ruolo unico nel quadro della rete viaria romana in quanto ha indotto lo sviluppo di siti, idee, opere, testimonianze e memorie che, nel corso di oltre 2300 anni di storia, hanno costituito un ambiente culturale complesso, universalmente riconosciuto come tale da scrittori, pittori, poeti e viaggiatori europei e americani.
Le allergie respiratorie costituiscono una problematica di rilevanza mondiale e comportano un consistente onere sociale ed economico per i sistemi sanitari nazionali. Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità e i dati presenti in letteratura circa 350 milioni di persone soffrono in tutto il mondo di malattie connesse alle allergie respiratorie (quali la rinite e l’asma bronchiale) con carattere di cronicità, che influenzano pesantemente la qualità di vita con grandi implicazioni sociali, economiche e cliniche. La comparsa e la ricorrenza dei sintomi (soprattutto tosse e difficoltà respiratoria) richiedono una gestione impegnativa, con visite specialistiche regolari, urgenti e anche ricoveri per la gestione dei casi più severi. Da qui l’esigenza di un “Manifesto dei diritti e dei doveri delle persone con allergie respiratorie”, presentato lo scorso 2 ottobre in una conferenza presso la Camera dei Deputati e sottoscritto da 15 organizzazioni rappresentative del mondo medico-scientifico, dei pazienti, delle istituzioni.
«Sono molto contento di essere qui oggi, la presentazione del “Manifesto dei diritti e dei doveri della persona con allergie respiratorie” rappresenta una tappa fondamentale del percorso che stiamo facendo grazie all’attività svolta dall’Intergruppo parlamentare sulle ‘Allergie respiratorie’, di cui sono presidente insieme alla Sen. Sbrollini, con il supporto di un grande team di tecnici ed esperti che si sono messi a disposizione per questo progetto. Il Manifesto vuole essere uno stimolo ed una roadmap che possa far crescere e potenziare il sistema di accesso alle cure per le persone affette da allergie respiratorie», ha dichiarato l’On. Paolo Ciani, vicepresidente gruppo PD-IDP e Segretario della XII Commissione Affari Sociali alla Camera dei Deputati, Presidente Intergruppo parlamentare sulle Allergie respiratorie.
Il National Institute of Health degli Stati Uniti ha riconosciuto l’ipotesi che l’aumento del livello di igiene e l’esposizione a sostanze inquinanti, tipici delle società più avanzate del mondo, influiscano sulla risposta immune favorendo sensibilizzazione allergica. A quello
ambientale si aggiungono altri fattori di rischio individuali, genetici e legati alla familiarità, comportamentali e relativi a stili di vita inadeguati. Nel nostro Paese si stima che ogni anno circa dieci milioni di persone si ammalano di allergie respiratorie per l’esposizione ad allergeni di pollini, muffe, acari e animali domestici e si calcola che circa il 15-20 per cento della popolazione italiana soffra di allergie, fenomeno in crescita, soprattutto tra i più giovani e le donne.
«A fronte di una situazione epidemiologica e clinica di estrema rilevanza, l’assistenza allergologica versa in una situazione spesso preoccupante. Con la dismissione di strutture in ambito ospedaliero, come purtroppo avvenuto in questi ultimi anni per incomprensibili e infruttuose politiche di tagli lineari, si è drammaticamente ridotta la possibilità di intervenire su malattie gravi e potenzialmente fatali e che necessitano di un setting assistenziale complesso e realizzabile solo in ambienti protetti e da personale a questo dedicato e specificatamente addestrato. Inoltre credo sia opportuno inserire l’immunoterapia specifica e gli NPP tra i trattamenti autorizzati da parte di AIFA, come unica terapia in grado di modificare la storia naturale delle allergie, una terapia che riesce a desensibilizzare progressivamente l’organismo nei confronti di specifici allergeni, inducendo con il tempo una tolleranza verso gli inalanti interessati», ha dichiarato la Sen. Daniela Sbrollini, Presidente Intergruppo parlamentare sulle Allergie respiratorie e Vice Presidente della 1Oa Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) del Senato.
I costi diretti dell’asma, derivanti dall’uso dei farmaci e dei servizi sanitari, rappresentano circa l’1-2 per cento della spesa sanitaria, mentre quelli indiretti (per assenteismo scolastico e riduzione dei giorni di lavoro dei genitori per l’assistenza al figlio), nei casi più gravi, costituiscono oltre il 50 per cento dei costi complessivi, arrivando a incidere, in termini economici, più di patologie quali tubercolosi e infezione da HIV combinati. A fronte di una situazione epidemiologica rilevante, l’assistenza allergologica appare fortemente ridimen-
sionata a livello nazionale e regionale e le malattie allergiche spesso non vengono considerate appieno per la loro gravità clinica e le implicazioni sulla qualità di vita delle persone, sia in età evolutiva sia in età adulta. Non è sempre garantito l’equo accesso all’impiego delle terapie più avanzate per il trattamento delle allergie respiratorie, incluse le terapie desensibilizzanti e le NPP (“Named Patient Products”) disciplinate dall’art. 5 della Legge n. 94/1998, in linea con i principi di appropriatezza terapeutica, della sostenibilità per il sistema sanitario nazionale e dell’equità di accesso alle cure in tutte le regioni. «È importante sollecitare l’intervento della politica sul tema delle allergie respiratorie e promuovere le azioni per contrastare l’impatto di queste malattie, come il monitoraggio aerobiologico di pollini allergenici e spore fungine attraverso siti di misura, disposti a rete, diffusi su tutto il territorio nazionale. Le malattie allergiche sono strettamente correlate all’inquinamento e alla immissione di nuove sostanze chimiche nell’ambiente di vita. Gli effetti dell’inquinamento atmosferico hanno un impatto significativo, rispetto alle allergie, particolarmente nei contesti urbani. Questo significa che il carico assistenziale sarà destinato ad accrescersi ulteriormente nel tempo e con esso i costi sanitari che potrebbero invece essere ridotti con l’adozione di politiche pubbliche orientate alle buone pratiche della prevenzione», dichiarato Andrea Lenzi, Presidente Comitato Nazionale per la Biosicurezza, le Biotecnologie e le Scienze della Vita (CNBBSV) della Presidenza del Consiglio dei Ministri e Presidente dell’Health City Institute. «Le malattie allergiche comportano un grande carico assistenziale, avendo raggiunto ormai una prevalenza nella popolazione generale del 20 per cento, ed è ulteriormente preoccupante il loro continuo incremento –ha sottolineato Mario Di Gioacchino, Presidente Comitato scientifico dell’Intergruppo parlamentare sulle Allergie respiratorie e Presidente Società Italiana di Allergologia, Asma e Immunologia Clinica (SIAAIC) - A fronte di questo scenario, è grave la mancanza di ogni riferimento alla definizione di una rete clinica dedicata all’allergologia, a differenza di quanto previsto per numerose altre discipline a minore impatto epidemiologico ed assistenziale. È anche indispensabile che la formazione medica preveda in ogni Università un Corso specifico di Allergologia ed Immunologia Clinica, che attualmente è presente solo in alcuni Atenei». Il “Manifesto dei diritti e dei doveri delle persone con allergie respiratorie” vuole essere uno stimolo a tutelare i diritti e l’accesso alle cure della persona con allergie respiratorie e a potenziare e razionalizzare l’assistenza favorendo la crescita di ampie strutture specialistiche in costante e dinamico collegamento con il territorio.
Il Manifesto, sviluppato da BHAVE, ha visto il coinvolgimento oltre delle società scientifiche, anche di Cittadinanzattiva, Respiriamo Insieme e ALAMA. Il documento si focalizza su molti temi cruciali, quali i diritti della persona con allergie respiratorie, le aspettative e responsabilità della persona con allergie respiratorie e dei suoi familiari, l’associazionismo responsabile, la prevenzione delle allergie respiratorie, la remissione e controllo delle allergie respiratorie, l’impegno nella ricerca, l’educazione continua della persona con allergie respiratorie, il dialogo medicopersona, le allergie respiratorie in età evolutiva e nell’anziano fragile, e il rapporto delle allergie respiratorie col fenomeno dell’immigrazione e col territorio. Il Manifesto, che viene presentato a un anno dal lancio del Patto di legislatura sulle allergie respiratorie, è controfirmato da 15 organizzazioni, ovvero: Intergruppo parlamentare sulle Allergie respiratorie, AAIITOAssociazione Allergologi Italiani del Territorio ed Ospedalieri, ALAMA-APS - Associazione Liberi dall’Asma, dalle Malattie Allergiche, Atopiche, Respiratorie e Rare aderente a FederASMA e ALLERGIE Federazione Italiana Pazienti Odv, Associazione Respiriamo Insieme, Cities+, Cittadinanzattiva, EAACI - European Academy of Allergy and Clinical Immunology, Federsanità, Health City Institute, Planetary Health Inner Circle, SIAAIC - Società Italiana di Allergologia, Asma e Immunologia Clinica, SIAIP - Società Italiana di Allergologia e Immunologia pediatrica, SIMRI - Società Italiana di malattie respiratorie infantili, SIMG - Società Italiana Medicina Generale, SIP - Società Italiana di Pediatria. «La mancata definizione, ad oggi, di un modello assistenziale reticolare a complessità crescente (Hub, Spoke e primo livello) rispetto alle malattie allergologiche, impedisce una loro gestione integrata che consenta al paziente di essere inserito in un percorso assistenziale coordinato tra i diversi livelli a crescente complessità, a partire dal proprio medico di famiglia. Occorre su questo un intervento urgente. È importante, inoltre, che a livello di casa della comunità, di livello Hub, sia espressamente prevista la figura dello specialista allergologo e garantita un’assistenza di qualità. È infine importante sottolineare l’assoluta disomogeneità di assistenza ed accesso alle cure a livello nazionale rispetto alle allergie respiratorie, con disuguaglianze a livello regionale, quale una delle massime priorità di intervento», ha dichiarato Lorenzo Cecchi, Presidente Associazione Allergologi Italiani del Territorio ed ospedalieri (AAIITO). «Con il Manifesto presentato oggi vogliamo richiamare l’attenzione sull’impegno a porre le allergie respiratorie al centro dell’agenda istituzionale – ha evidenziato Stefano Del

Giacco, Past President European Academy of Allergy and Clinical Immunology (EAACI) - Occorre potenziare e razionalizzare l’assistenza alle persone che soffrono di queste malattie, aumentare i fondi per la ricerca, implementare la gestione integrata, promuovere campagne di sensibilizzazione rivolte ai cittadini e assicurare il pieno accesso alle cure e ai trattamenti in maniera omogenea su tutto il territorio nazionale. Si tratta di un impegno importante per il contrasto a malattie che rappresentano un costo significativo sia sociale sia economico, nell’interesse e a tutela di tutti i cittadini che ne sono colpiti». «In Italia circa il 10 per cento dei bambini al di sotto dei 14 anni soffre di asma e l’80 per cento di essi è allergico – ha aggiunto Michele Miraglia del Giudice, Presidente Società Italiana di Allergologia e Immunologia pediatrica (SIAIP)Le allergie respiratorie sono la causa dell’asma nell’80 per cento dei casi, per questo è fondamentale agire sulla prevenzione. È nei primi anni di vita spesso l’origine di molte malattie polmonari croniche dell’adulto, tra cui l’asma, che purtroppo registrano tassi di morbilità e mortalità ancora preoccupanti. L’auspicio è che il Manifesto presentato oggi sia uno stimolo all’adozione di strumenti adeguati per il contrasto a queste malattie a tutte le età, da quella pediatrica a quella anziana».



Un semplice esame del sangue potrebbe permettere di comprendere quali pazienti con diabete di tipo 2 sono più a rischio di sviluppare un cancro. È questo quanto emerge dalle evidenze di uno studio scientifico danese che è stato presentato in occasione dell’EASD (European Association for the Study of Diabetes) Annual Meeting, svoltosi a Madrid dal 9 al 13 settembre. È noto che le persone affette da diabete di tipo 2 presentano un rischio più elevato di sviluppare tumori associati all’obesità (tumori OR), tra cui il tumore al seno, ai reni, all’utero, alla tiroide e alle ovaie, nonché tumori gastrointestinali, tra cui il tumore del colonretto e del pancreas, e il mieloma multiplo. Si ritiene che l’infiammazione cronica di basso grado, prevalente sia nell’obesità che nel diabete di tipo 2, svolga un ruolo significativo nello sviluppo del cancro in entrambe le condizioni.
Mathilde Dahlin Bennetsen dello Steno Diabetes Center Odense, Odense University Hospital, Odense, Danimarca, e i suoi colleghi hanno studiato se le differenze nei livelli di citochine proinfiammatorie, proteine del sistema immunitario che aumentano l’infiammazione, potrebbero aiutare a identificare gli individui con diabete di tipo 2 particolarmente a rischio di tumori OR.
«Comprendere quali sono i pazienti diabetici più a rischio ci potrebbe consentire di mettere a punto un monitoraggio più mirato ed efficace, migliorando potenzialmente l’esito mediante interventi precoci e trattamenti personalizzati», afferma Mathilde Dahlin Bennetsen, che ha guidato la ricerca.
Livelli elevati di interleuchina (IL) 6 sono associati a un rischio aumentato di tumori correlati all’obesità nei pazienti a cui è stato recentemente diagnosticato il diabete di tipo 2, consentendo potenzialmente l’identificazione di individui a rischio più elevato attraverso un semplice esame del sangue. I ricercatori hanno studiato se i marcatori dell’infiammazione IL-6, il fattore di necrosi tumorale alfa (TNF- ) e la proteina C-reattiva ad alta sensibilità (hsCRP) possano fungere da biomarcatori predittivi per i tumori correlati all’obesità
nei pazienti a cui è stato recentemente diagnosticato il diabete di tipo 2.
Sono stati identificati pazienti con diabete di tipo 2 di recente insorgenza e senza una storia pregressa di cancro che partecipavano allo studio del Centro danese per la ricerca strategica sul diabete di tipo 2. All’inizio dello studio, i livelli plasmatici di IL-6 e TNF- sono stati misurati utilizzando test Meso Scale Discovery, mentre i livelli sierici di hsCRP sono stati misurati utilizzando test immunofluorometrici.
Tra i 6466 pazienti idonei (40,5% donne, età media 60,9 anni), 327 hanno sviluppato tumori correlati all’obesità nel corso di un follow-up mediano di 8,8 anni. Ogni incremento SD nei livelli di IL-6 trasformati in logaritmo aumentava del 19% il rischio di tumori correlati all’obesità. I ricercatori non hanno trovato una forte associazione tra TNF- o hsCRP e tumori correlati all’obesità. L’aggiunta dei livelli basali di IL-6 ad altri noti fattori di rischio per i tumori correlati all’obesità ha migliorato le prestazioni di un modello di previsione del cancro da 0,685 a 0,693, il che si traduce in un piccolo, ma importante aumento della capacità di prevedere se un individuo svilupperà uno di questi tumori.
In futuro, un semplice esame del sangue potrebbe identificare i soggetti a più alto rischio di cancro, afferma Mathilde Dahlin Bennetsen: sono necessarie ulteriori ricerche per determinare se i test migliorerebbero la diagnosi precoce e la gestione di questi tumori. E aggiunge Bennetsen «Capire che livelli più elevati di infiammazione possono indicare un rischio maggiore di alcuni tumori evidenzia l’importanza di controlli regolari e di una gestione efficace del diabete».
«Mantenere uno stile di vita sano e attenersi ai piani di trattamento può potenzialmente aiutare a gestire l’infiammazione e ridurre il rischio di cancro», conclude Bennetsen.
Lo studio condotto presso lo Steno Diabetes Center Odense, è stato pubblicato online il 27 agosto come anticipazione dell’Annual Meeting EASD 2024.
Ha compiuto 5 anni lo European Diabetes Forum (EUDF), realtà di primissimo piano in Europa nel contrasto al diabete, che anche quest’anno ha promosso un importante livello di attività in occasione dell’EASD (European Association for the Study of Diabetes) Annual Meeting, svoltosi a Madrid dal 9 al 13 settembre. L’European Diabetes Forum è stato fondato da EASD, l’Associazione Europea per lo Studio del Diabete, per riunire più parti interessate provenienti da tutto il panorama del diabete in Europa, incluse le organizzazioni, le persone affette da diabete e i loro caregiver. Il Forum raccoglie tutte le voci a livello europeo affinché l’azione politica possa essere indirizzata verso una migliore cura del diabete, proponendo ai sistemi sanitari soluzioni possibili per far fronte a questa pandemia.
Da questa vocazione di EUDF, nasce il Documento d’impegno della comunità diabetologica, rivolto ai membri del Parlamento Europeo, per aiutare con atti concreti i 32 milioni di persone che soffrono di diabete nell’Unione europea e le loro famiglie, creando un solido quadro politico UE a sostegno dei piani di intervento nazionali rispetto a questa malattia. Sono oltre 686.000 le persone che muoiono ogni anno in UE a causa del diabete o di patologie correlate, una ogni 46 secondi. Ad oggi sono 31,6 milioni le persone nell’UE affette da diabete, l’equivalente della somma delle popolazioni di Paesi Bassi, Portogallo e Croazia. Con l’aumento di questa pandemia silente, si prevede che il numero di persone con diabete aumenterà fino a 33,2 milioni entro il 2030. Nell’area europea sono 295.000, un numero in crescita, le persone giovani con diabete di tipo 2 e adolescenti con diabete di tipo 1, e ammonta a 104 miliardi di euro (dato del 2021) il costo complessivo correlato al diabete a carico dei sistemi sanitari dell’UE. Il 75 per cento di questi costi è imputabile a complicanze potenzialmente evitabili; questo significa che le politiche che promuovono una diagnosi precoce e una buona gestione della malattia possono favorire un notevole risparmio sui costi e contribuire alla resi-
lienza e sostenibilità dei sistemi sanitari. Il documento d’impegno promosso da EUDF e sviluppato da un’ampia coalizione di associazioni impegnate nel settore del diabete, contiene le 15 raccomandazioni politiche concrete per migliorare la vita delle persone con questa malattia e dei soggetti a rischio in tutta Europa. Le raccomandazioni indirizzate al Parlamento Europeo evidenziano le leve sulle quali agire, articolandosi in quattro aree tematiche prioritarie, identificazione precoce, cure eque di elevata qualità, valorizzazione delle persone, sostegno a scienza e tecnologia.
«I decisori politici europei hanno prestato maggiore attenzione al diabete negli ultimi anni: nel 2022, un secolo dopo la scoperta dell’insulina e 33 anni dopo la Dichiarazione di Saint Vincent in cui sono stati definiti gli obiettivi per la prevenzione e la cura del diabete, il Parlamento Europeo ha adottato una delibera storica in materia di prevenzione, gestione e cure migliori per il diabete nell’UE, invocando piani di intervento nazionali per il diabete nei 27 Stati Membri. Quell’impegno rappresenta lo spunto affinché sempre maggiore salute e qualità di vita venga garantita alle persone affette da diabete, facilitando la prevenzione della malattia e delle sue complicanze, garantendo un’accessibilità alle cure uniforme in tutti i Paesi membri, sostenendo la ricerca scientifica e la tecnologica in ambito diabetologico. Ai membri del Parlamento Europeo, EUDF, attraverso un intenso lavoro che ha visto la partecipazione di tutte le principali associazioni, suggerisce 15 azioni pratiche, percorribili, necessarie affinché donne, uomini di ogni età, dal bambino all’anziano, possano affrontare con crescente serenità il loro quotidiano impegno a garanzia di salute duratura e di una vita normale e piena», dichiara il prof. Stefano Del Prato, Presidente EUDF. Il documento d’impegno è stato al centro dell’EUDF Italia Forum 2024 “Act now in diabetes care. Una roadmap per il diabete in Europa: le riflessioni italiane”, svoltosi a Roma lo scorso 19 settembre. L’evento orga-
nizzato insieme da European Diabetes Forum Italia (EUDF Italia) e da EUDF, in collaborazione con Intergruppo parlamentare Obesità, diabete e NCDs e Intergruppo parlamentare Sanità digitale e terapie digitali, si è svolto presso Spazio Europa, sede gestita dall’Ufficio del Parlamento europeo in Italia e dalla Rappresentanza in Italia della Commissione europea. Fra gli obiettivi dell’evento, quello di diffondere la consapevolezza e l’adesione rispetto ai temi del documento d’impegno anche a tutta la comunità scientifica e al mondo delle associazioni dei pazienti affinché il suo contenuto possa essere patrimonio comune e, attraverso la condivisione, rafforzare l’impegno nel contrasto al diabete.
Muovendo dall’esperienza dello European Diabetes Forum, EUDF Italia si configura come think tank nazionale di ispirazione internazionale nel quadro di un vasto coordinamento europeo. Un network europeo indipendente di discussione e proposta che opera in stretta collaborazione con le parti interessate del mondo del diabete e delle malattie metaboliche in Italia (società scientifiche, associazioni di pazienti e di cittadini, operatori sanitari, amministratori, politici, industrie del farmaco ecc.), per favorire la traduzione dei risultati della ricerca in azioni politiche per una migliore cura del diabete a livello nazionale.
L’evento del 19 settembre ha visto anche la presentazione dei documenti programmatici di EUDF Italia su “Integrated care”, “Data & register”, “Selfcare, technology e digitalization”, “Type 1 diabetes”, elaborati dai rispettivi tavoli di lavoro. Nel contesto attuale emerge l’importanza di interventi operativi per assicurare una piena integrazione assistenziale: occorre adattare la storia dell’assistenza integrata ai bisogni dei professionisti sanitari, dei diversi gruppi di persone e all’organizzazione di una rete assistenziale efficace, omogenea ed efficiente, preservando il ruolo dei centri di diabetologia, eccellenza del SSN, e armonizzandolo al meglio con quello dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta. I registri offrono molti vantaggi nel panorama del diabete per migliorare i risultati dell’assistenza e ridurre il rischio di complicanze: l’istituzione di un registro nazionale, come obiettivo a lungo termine, richiede alcuni passi fondamentali come l’iniziale realizzazione di registri regionali; esiste già in alcune regioni (ad es. Marche, Umbria, Lazio) una cartella diabetologica unica regionale, che consente l’accesso ai dati clinici del paziente da qualsiasi centro diabetologico della regione; la cartella regionale consentirebbe un monitoraggio e miglioramento continuo delle cure erogate dai centri specialistici. Il documento “Selfcare, technology e digitalization” sottolinea i passi opportuni per sfruttare fino in fondo le potenzialità dell’innovazione tecnologica, accompagnandola una ri-
progettazione dell’intera organizzazione, attuando un reengineering dei modelli assistenziali che permetta di affrontare in modo strutturale la crescente domanda di assistenza e la riqualificazione dei professionisti, delle loro prestazioni e dei servizi sanitari; l’assistenza dovrebbe essere erogata preferibilmente a distanza, riducendo di conseguenza le visite in presenza e potenziando l’analisi automatica dei dati tra le visite. Infine, il documento “Type 1 diabetes” sottolinea come lo screening per il diabete tipo 1 in età pediatrica sia realizzabile e pienamente giustificato anche nella popolazione generale e come abbia mostrato efficacia nella prevenzione della DKA (diabetic ketoacidosis) nei bambini; l’Italia ha una posizione di avanguardia grazie alla Legge n.130/2023, che ha la finalità di definire un programma di salute pubblica di diagnosi tramite screening destinato alla popolazione in età infantile e adolescenziale, individuata nel range di età dagli 1 ai 17 anni, per identificare i soggetti a rischio sviluppo di diabete di tipo 1; un risultato questo che va assolutamente implementato attraverso il coinvolgimento di tutti gli attori necessari alla sua realizzazione.
«Una diagnosi precoce e un accesso paritario a cure di elevata qualità possono consentire ai diabetici di continuare a condurre una vita appagante e di fornire il loro pieno contributo alla società. Un’efficace prevenzione e gestione del diabete può offrire una maggiore resilienza e sostenibilità dei sistemi sanitari. Le tecnologie innovative e i servizi ad esse associati possono contribuire a invertire la tendenza attuale del peggioramento degli esiti sanitari per le persone con diabete - dichiara il prof. Agostino Consoli, Coordinatore di EUDF Italia - L’Italia si è impegnata sin dal primo momento nell’implementazione del documento di impegno contenente le priorità della comunità diabetologica sul diabete e rivolto ai membri del Parlamento Europeo. L’adesione a questo documento, con la promessa di impegno a sostegno della comunità diabetologica, da parte di molti parlamentari italiani appartenenti trasversalmente a tutti gli schieramenti, dimostra l’attenzione della politica italiana al tema del diabete e all’urgenza di sostenere con atti concreti le persone che vivono con questa malattia, i loro familiari e, allo stesso tempo, la sostenibilità del sistema sanitario».

giorno per giorno
Le tonnellate di rifiuti di imballaggio riciclate in Italia sono 10 milioni e 470mila, pari al 75,3% dell’immesso al consumo. Superati gli obiettivi europei al 2030.
Lo annuncia CONAI nella nuova Relazione generale. Risultati trainati dalla crescita dei rifiuti di imballaggio riciclati dalle raccolte urbane, diventate vere miniere metropolitane. 696 milioni di euro dal sistema consortile ai Comuni italiani.

“Nel 2023 l’Italia ha riciclato il 75,3% dei suoi rifiuti di imballaggio: 10 milioni e 470mila tonnellate su un totale di 13 milioni e 899mila tonnellate immesse al consumo. Una percentuale di riciclo in forte crescita rispetto al 71% circa del 2022, anche per via di una riduzione dei pack immessi al consumo in Italia. Ad annunciarlo è CONAI nella sua Relazione generale.
«Numeri incoraggianti per l’Italia» commenta il direttore generale CONAI Simona Fontana «I quantitativi di materia riciclata crescono, e confermano il settore del riciclo degli imballaggi come strategico per l’economia circolare nazionale.
I risultati 2023 superano i target UE previsti al 2030 nonostante un contesto generale difficile per le imprese italiane.
Balzo in avanti del riciclo incoraggiante, seppur in un contesto di produzione industriale in frenata.
Ora devono aumentare anche le percentuali di intercettazione degli altri rifiuti per rendere sempre più circolare la nostra economia
Simona Fontana
Direttore generale CONAI
Il balzo in avanti della percentuale di riciclo è risultato di una crescita delle quantità di rifiuti di imballaggio riciclati a fronte della contestuale riduzione dei quantitativi di packaging immessi sul mercato nazionale nel 2023. Il tessuto imprenditoriale, infatti, ha fatto ricorso alle scorte di imballaggi e prodotti imballati accumulate nel 2022, producendo uno sfasamento temporale fra la produzione degli imballaggi, il loro uso e il momento in cui sono diventati rifiuti».
Nel dettaglio, sono state riciclate 418mila tonnellate di acciaio, 59mila di alluminio, 4 milioni e 674mila di carta, 2 milioni e 164mila di legno, 1 milione e 55mila di plastica tradizionale e circa 44mila di bioplastica compostabile, 2 milioni e 46mila di vetro


E se alle cifre del riciclo si sommano quelle del recupero energetico – ossia l’uso dei rifiuti di imballaggio come combustibile alternativo per produrre energia – il totale di imballaggi recuperati e non finiti in discarica arriva a 11 milioni e 804mila tonnellate, ossia l’85% dei pack immessi al consumo. Numeri resi possibili anche dal lavoro portato avanti da CONAI e dal sistema consortile con i Comuni italiani tramite l’accordo nazionale con ANCI, in accordo con i Consorzi di filiera. Nel 2023 sono stati 7.242 i Comuni che hanno stipulato almeno una convenzione con il sistema consortile, con una fetta di popolazione servita pari al 96% degli Italiani.
E oltre 15 milioni sono gli abitanti del Centro-Sud coinvolti in progetti territoriali speciali volti a far crescere le raccolte per il riciclo nelle aree ancora in ritardo.
Per coprire i costi di ritiro dei rifiuti di imballaggio in modo differenziato, nel 2023 CONAI ha versato ai Comuni italiani 696 milioni di euro: risorse che provengono dalle imprese produttrici e utilizzatrici di imballaggi che si fanno carico dei costi da sostenere per gestire il fine vita degli imballaggi che immettono sul mercato.
I risultati di riciclo 2023 permettono all’Italia di rimanere in una posizione solida nel quadro europeo.

«Gli obiettivi complessivi di riciclo chiesti dall’Unione al 2030, quando ogni Stato dovrà riciclare almeno il 70% dei suoi rifiuti di imballaggio, sono ormai ampiamente superati» spiega Simona Fontana. «Secondo gli ultimi dati Eurostat, l’Italia è leader per riciclo pro-capite di imballaggi in un testa a testa con la Germania, staccando di diversi punti il più piccolo e gestibile Lussemburgo. Non è un caso che lo scorso anno la Commissione Europea abbia inserito il nostro Paese fra i nove non a rischio per il raggiungimento degli obiettivi di riciclo, nella sua relazione di segnalazione preventiva sull’attuazione delle Direttive sui rifiuti. Non è il momento di fermarsi, però. Il nuovo Regolamento europeo chiederà tassi di intercettazione dei pack sempre più alti: dobbiamo continuare a lavorare per aumentare quantità e qualità delle raccolte differenziate degli imballaggi, anche attraverso lo strumento delle raccolte selettive, ove opportune. Per migliorare ancora saranno importanti le innovazioni a monte, nella progettazione di imballaggi sempre più riciclabili e rigenerabili, e a valle, nelle tecnologie di riciclo in grado di recuperare materiale dalle frazioni oggi ancora più difficili da riciclare».














Edison Next, è la società del gruppo Edison al fianco di aziende, pubblica amministrazione e dei territori nel percorso di decarbonizzazione e transizione ecologica mettendo in campo una piattaforma integrata di servizi, tecnologie e competenze che spazia dall’autoproduzione e ottimizzazione dell’energia, ai green gas, a soluzioni per la mobilità sostenibile e di circular economy, fino ad arrivare allo sviluppo di progetti per la rigenerazione urbana e la smart city. Edison Next, inoltre, sostiene lo sviluppo delle Comunità Energetiche Rinnovabili, virtuoso esempio di condivisione dell’energia prodotta localmente, promuovendo un modello che genera benefici ambientali ed economici per i territori.
Edison Next gestisce oltre 1,3 milioni di punti luce in importanti città come Venezia, Perugia, Napoli e Salerno. Quest’anno ha avviato con il comune di Trieste un percorso di riqualificazione energetica
e tecnologica dell’illuminazione pubblica di cui godranno circa 200.000 cittadini. Tra i principali interventi, l’efficientamento a LED di oltre 20.000 punti luce, l’abbellimento di 1.100 corpi illuminanti, la gestione di tutti i 26.000 punti luce cittadini e l’installazione di sistemi di illuminazione adattiva, oltre a servizi smart e per la mobilità sostenibile. A questi si aggiungono soluzioni per la valorizzazione del patrimonio storico-artistico di alcuni siti simbolo della città, come Piazza Unità d’Italia e il Castello di San Giusto. I numerosi interventi garantiranno un risparmio energetico annuo di oltre il 70%, evitando l’emissione in atmosfera di circa 3.900 tonnellate di CO₂*.
Inoltre, Edison Next in Italia gestisce più di 800 strutture sanitarie e oltre 400 edifici scolastici ed è impegnata nella riqualificazione energetica di edifici pubblici, come ospedali, scuole, carceri. Un caso concreto è il percorso avviato per la riqualificazione e l’efficientamento energetico del Policlinico di Bari, una struttura complessa che si estende su un’area di circa 230.000 m2. Tra i numerosi interventi, è prevista l’installazione di sistemi di trigenerazione e di impianti fotovoltaici, oltre alla sostituzione di circa 12.000 punti luce con tecnologia a LED e all’introduzione di soluzioni digitali. L’obiettivo è garantire comfort e sicurezza e ridurre l’impatto ambientale, arrivando ad abbattere i consumi energetici del 15,5% annuo e le emissioni di CO₂ di circa 3.100 tonnellate all’anno**.
Infine, Edison Next è impegnata nello sviluppo di progetti in cui l’energia rappresenta il motore per lo sviluppo dei territori, anche dal punto di vista sociale. Un esempio è il nuovo modello che ha sviluppato per far diventare la scuola sempre più un polo di riferimento per quartieri e città.

Edison Next ha sviluppato un modello per far evolvere una realtà chiave per il futuro dei nostri territori e per la crescita delle nuove generazioni: la scuola. Questo modello, in particolare, si propone di trasformare gli edifici scolastici da luoghi chiusi e poco utilizzati in centri innovativi, sicuri e polifunzionali, aperti anche alle famiglie e alla comunità, in grado di rispondere alle nuove necessità del modello di famiglia attuale, in cui entrambi i genitori lavorano.
Edison Next propone un modello innovativo di scuola che valorizzi e ottimizzi gli spazi esistenti generando opportunità per studenti e comunità, preservando la coerenza con il sistema didattico attuale e la piena proprietà da parte dei comuni. Per riuscire a raggiungere questo obiettivo sarebbe necessario prima di tutto estendere l’orario di apertura degli edifici scolastici, coprendo le fasce pomeridiane e serali
e in parte il periodo estivo, massimizzando così l’utilizzo di un’infrastruttura che oggi è utilizzata solo per il 20% del suo tempo. Inoltre, sarebbe necessario prevedere interventi infrastrutturali e di efficientamento energetico, oramai inevitabili considerando che gli edifici scolastici sono alla fine del loro ciclo di vita e hanno in media un’età di 56 anni. Questi interventi comprenderebbero la riqualificazione e la creazione di spazi didattici, sportivi e polifunzionali, oltre a soluzioni di riqualificazione energetica come l’installazione di impianti fotovoltaici da associare allo sviluppo di Comunità Energetiche Rinnovabili. Queste azioni consentirebbero di ridurre i consumi energetici della scuola fino al 25%, liberando risorse per 250 milioni di euro all’anno ed evitando l’emissione in atmosfera di circa 630.000 tonnellate di CO₂ annue. Gli investimenti complessivi necessari sarebbero pari a 13 miliardi di euro, che potrebbero essere coperti fino al 50% da investimenti privati.
A trarne beneficio sarebbe l’intera comunità: gli studenti, che potrebbero crescere in un ambiente educativo funzionale, sicuro, confortevole e contare su un’offerta extra-didattica erogata da esperti nei diversi ambiti; le famiglie, che potrebbero godere di un servizio di prossimità aderente alle esigenze attuali e in grado di semplificare le complessità logistiche legate alla gestione dei figli; le amministrazioni che vedrebbero diminuire consumi, costi di gestione ed emissioni degli edifici.
Un modello, quello della scuola del futuro di Edison Next, che vede questa realtà evolversi, aprirsi alla comunità e diventare sempre di più un polo di riferimento per quartieri e città.
di Silvia Gabriella Ciappellano
Il burnout, ossia la sindrome da stress cronico associato al contesto lavorativo che porta a un esaurimento emotivo e psichico, rappresenta sempre più un’emergenza globale nell’ambito delle professioni sanitarie. In Europa, questo fenomeno ha un’alta prevalenza e riguarda i medici, così come le altre professioni sanitarie associate, senza distinzione di specializzazione o di livello di carriera. Se consideriamo questo ambito professionale, alla base del burnout troviamo la compassion fatigue, l’esposizione ripetuta alla morte, il crescente burden per gli incarichi amministrativi, i vincoli finanziari e un inadeguato bilanciamento vita-lavoro.
Secondo un’indagine condotta dalla European Society of Medical Oncology (ESMO) tra il 2013 e il 2014, questo fenomeno riguarda più di due giovani oncologi europei su tre. Questi risultati trovano conferma in tre indagini globali condotte nel corso della pandemia di Covid-19 che hanno evidenziato proprio le difficoltà degli oncologi nell’affrontare le crescenti pressioni della loro vita professionale. Da questo parte l’appello all’intera comunità oncologica lanciato durante l’ultimo Congresso della European Society of Medical Oncology (ESMO) 2024: lavorare per migliorare il benessere di tutti gli operatori sanitari che operano in questo settore.
Di recente la Task Force sulla Resilienza dell’Esmo ha pubblicato delle raccomandazioni per la gestione dei rischi psicosociali, la garanzia del benessere e la riduzione del burnout degli oncologi. “Il paper dell’ESMO traduce i risultati delle tre indagini globali, che hanno ricevuto complessivamente un totale di oltre 3.700 risposte, in raccomandazioni concrete basate su quanto riportato dai professionisti di oltre 100 Paesi”, ha dichiarato l’autore Jonathan Lim, The Christie NHS Foundation Trust, Manchester, United Kingdom,
membro della Task Force sulla Resilienza dell’Esmo. “In qualità di oncologi sul campo, vediamo ogni giorno che il morale è basso e che la forza lavoro è in crisi: la nostra speranza è che queste raccomandazioni rappresentino una base che possa servire da leva per promuovere un cambiamento all’interno delle Istituzioni, prendendo ciò che è più di valore e praticabile a seconda dei Paesi, culture e ambiente lavorativo.”
Le raccomandazioni si focalizzano su tre aree molto importanti per il benessere degli operatori sanitari, ossia: l’informazione e la formazione per supportare lo sviluppo e il lavoro degli oncologi, le strategie e risorse per salvaguardare la loro salute fisica e psicofisica, l’attivismo e il supporto per la disciplina oncologica e il benessere della forza lavoro in questo settore. Le misure proposte includono, per questo, una maggiore formazione e mentoring individualizzati per supportare i medici e riportare un senso di controllo sullo sviluppo della loro carriera, permettendo di avere carichi di lavoro gestibili e offrendo maggiore flessibilità sul posto di lavoro, con la creazione allo stesso tempo di un ambiente lavorativo piacevole, con dotazioni adeguate e che consenta di avere tempo e spazio per comunicare con i colleghi, riducendo così l’isolamento.
In un contesto dove un oncologo su quattro riferisce di pensare a un cambio di carriera, gli investimenti per mantenere la forza lavoro e le strategie per attrarre più persone in questo settore sono essenziali per garantire la sostenibilità dei servizi oncologici. Inoltre, sono necessarie misure personalizzate per supportare in modo specifico determinate categorie che si sono mostrate più a rischio di stress e burnout durante la pandemia, quali donne e giovani, o gli oncologi senior che potrebbero scegliere di anticipare il pensionamento dall’attività clinica in caso di condizioni lavorative poco
soddisfacenti.
Susana Banerjee, oncologa presso il Royal Marsden NHS Foundation Trust e professoressa presso l’Institute of Cancer Research di Londra, Regno Unito, ha dichiarato: “Troppe persone che lavorano in oncologia soffrono di burnout e questo si ripercuote sulle Istituzioni e sui pazienti. Ci auguriamo che le raccomandazioni formulate per istituzioni, società e singoli individui contribuiscano a modificare alcuni comportamenti e le priorità di questo settore, riducendo il burnout dei professionisti, migliorando l’efficienza degli ospedali e mantenendo eccellente l’assistenza ai pazienti”.
Il direttore delle politiche pubbliche dell’ESMO, JeanYves Blay, ha sostenuto che le azioni intraprese da tutti i Paesi per aumentare il numero di operatori sanitari formati ogni anno devono andare di pari passo con le disposizioni per garantire la salute e il benessere della forza lavoro. “Non aumenta solo il carico di lavoro per i professionisti dell’oncologia, il cui numero è già in-
sufficiente in tutto il mondo e che devono affrontare un’incidenza annuale del cancro che si stima aumenterà del 75% tra il 2022 e il 2050, ma anche la pressione associata al lavoro sta crescendo a causa della rapida espansione del volume di conoscenze nel nostro campo. Parallelamente, stiamo assistendo allo stesso cambiamento sociologico di altri settori economici, dove le nuove generazioni di medici si aspettano un migliore equilibrio tra lavoro e vita privata per affrontare una carriera decennale in oncologia”, ha spiegato Blay.
Se non si apportano i cambiamenti necessari, ha avvertito Blay, la qualità delle cure peggiorerà in tutta Europa e, associata all’aumento del nomadismo medico, ci sarà un inevitabile aumento delle disuguaglianze sanitarie. “Tutti questi fattori potrebbero avere un forte impatto sulla qualità e sull’equità delle cure oncologiche. Non si tratta di misure cosmetiche, ma di misure fondamentali per il futuro delle cure oncologiche”, ha sottolineato Blay.

L’Italia è il Paese più anziano d’Europa, con il 24,1 per cento della popolazione che supera i 65 anni, percentuale che si prevede supererà il 30 per cento entro il 2050. Questo cambiamento demografico, oltre a comportare l’esigenza di prevedere un miglioramento della qualità della vita delle persone che accompagni l’aumento quantitativo degli anni di vita, pone la sfida al contrasto di alcune malattie che colpiscono maggiormente gli anziani. In questo scenario, le malattie valvolari cardiache si prefigurano come la prossima epidemia cardiaca nel nostro Paese. In Italia le malattie delle valvole cardiache sono particolarmente diffuse, e colpiscono annualmente il 13 per cento degli individui di età superiore ai 65 anni. Lo studio Prevasc (PREvalenza delle malattie cardioVASColari) condotto dalla Società Italiana di Cardiologia Geriatrica (SICGe) sugli over 65, ha rivelato che su oltre 800 persone esaminate, il 7 per cento di chi aveva più di 80 anni era affetto da stenosi aortica, il 10 per cento da insufficienza mitralica, il 15 per cento da fibrillazione atriale o scompenso cardiaco.
Le persone quanto conoscono queste patologie? Quali barriere ostacolano la diagnosi tempestiva e il trattamento? Cosa si può fare per una reale presa in carico dei pazienti?
Queste le domande a cui istituzioni, medici e pazienti hanno voluto rispondere, lo scorso 18 settembre, durante un convegno in Senato, realizzato su iniziativa della Senatrice Daniela Sbrollini, Vicepresidente della 10ª Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) del Senato, Presidente dell’Intergruppo Parlamentare Qualità di Vita nelle Città, con la collaborazione scientifica di Cuore Nostro, partendo dalle criticità rilevate sui ter-
ritori, identificando opportunità di azione e soluzioni, per il benessere delle persone e la sostenibilità del Sistema Sanitario Nazionale. L’evento si è svolto in occasione della Settimana di sensibilizzazione sulle malattie delle valvole cardiache (16-22 settembre), promossa nel nostro paese dall’Associazione Cuore Nostro, insieme a Fondazione Longevitas, in collaborazione con il Global Heart Hub. All’evento ha partecipato lo schermidore Daniele Garozzo, Campione Olimpionico e medico. «È fondamentale che le Istituzioni ascoltino le associazioni dei pazienti, supportandole nei loro percorsi per migliorare la qualità della vita delle persone, ed è per questo che sono al fianco di Cuore Nostro nell’impegno al contrasto delle malattie valvolari cardiache. – ha dichiarato la Sen. Daniela Sbrollini - Le istituzioni possono essere vicine alle persone che soffrono di patologie valvolari cardiache e alle loro famiglie in modo concreto, soprattutto lavorando per un più rapido accesso alla diagnosi, abbattendo le liste d’attesa anche per gli interventi e lavorando assieme alle associazioni dei pazienti e alla comunità medico scientifica per diffondere la consapevolezza rispetto a queste malattie in tutte le sedi. È un obiettivo importante ed è per questo che il mio impegno è rivolto a portare questo tema alla dovuta attenzione delle Istituzioni e della politica».
Le malattie delle valvole cardiache possono manifestarsi in modi diversi, ma i segni più comuni includono vertigini, stanchezza e affanno. Sintomi che possono sembrare banali, ma che spesso sono, invece, un segnale d’allarme che il cuore potrebbe non funzionare correttamente. Con una diagnosi precoce e un trattamento adeguato, molte di queste malattie sono curabili e gestibili: da qui l’importanza della campagna promossa
per la Settimana di sensibilizzazione di quest’anno. Una delle chiavi per il riconoscimento precoce delle malattie delle valvole cardiache è un controllo regolare con lo stetoscopio da parte del medico di medicina generale. Questo semplice esame può rivelare eventuali anomalie nelle valvole cardiache e fare la differenza nella vita delle persone, consentendo un trattamento tempestivo che può migliorare la loro qualità di vita e prevenire complicazioni gravi. In occasione della #settimanadellevalvole2024, Cuore Nostro ha promosso il messaggio #ascoltailtuocuore e ha presentato inoltre le attività del progetto #valorizzailtuocuore, che prevede iniziative di informazione, sensibilizzazione e screening, con 13 giornate di monitoraggio della salute del cuore nel 2024 promosse da Fondazione Longevitas e Cuore Nostro. Nel mese di settembre, in occasione della Settimana di sensibilizzazione, ai 13 eventi previsti, se ne sono aggiunti altri 5 di auscultazione cardiaca nei centri anziani di diverse regioni italiane: Frosinone 17 e 18 settembre, Roma 19 e 20 settembre, Tolve in Basilicata il 21 settembre. Entro la fine del 2024 si terranno eventi informativi e di screening a Civitanova Marche, Nuoro, Bassano del Grappa, Padova. Tutti sono stati invitati a sostenere la campagna sui social media utilizzando gli hashtag #ascoltailtuocuore, #settimanadellevalvole2024 e #valorizzailtuocuore, a condividere informazioni importanti, storie personali di chi ha affrontato una malattia valvolare, per diffondere la consapevolezza sulle malattie delle valvole cardiache e il loro impatto sulla vita delle persone. I progetti di Cuore Nostro sono realizzati grazie al contributo non condizionato di Edwards Lifesciences.
«Le persone spesso non conoscono le malattie valvolari cardiache o associano sintomi come stanchezza e fiato corto al semplice processo di invecchiamento. - ha dichiarato la Presidente di Cuore Nostro e di Fondazione Longevitas, Eleonora Selvi - Con le iniziative messe in campo per la Settimana di sensibilizzazione e con il progetto #valorizzailtuocuore vogliamo aiutare le persone a riconoscere segni e sintomi, ascoltare i bisogni di chi sta vivendo l’esperienza della malattia, dare voce alle testimonianze di coloro che l’hanno superata, e soprattutto promuovere il monitoraggio e la diagnosi precoce, che rappresentano la chiave per poter affrontare tempestivamente e adeguatamente queste malattie».
L’evento del 18 settembre è stata occasione anche per presentare storie e progetti di successo. Nell’ambito dell’accordo quadro per collaborazione per fini di ricerca e didattica tra l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù e l’Università dello Sport-Foro Italico stipulato nel settembre 2023, ad aprile 2024 è iniziato un pro-
getto di ricerca sull’Attività Motoria Preventiva e Adattata (AMPA) nei bambini e ragazzi affetti da cardiopatia o da altre malattie rare croniche. La ricerca è finanziata dalla ONLUS La Stella di Lorenzo (Presidente Ing. Maurizio Fabbri) ed è sotto la guida del Dr. Fabrizio Drago, Direttore della UOC di Cardiologia S. Paolo, Palidoro-S. Marinella e Aritmologia, che ha illustrato l’iniziativa nel corso dell’evento, e del Rettore dell’Università, Prof. Attilio Parisi. L’obiettivo della ricerca è quello di far svolgere ai pazienti, dopo accurata valutazione medica, un programma di addestramento fisico della durata di 3 mesi svolto negli spazi dell’Università, per il miglioramento della capacità aerobica, della forza, dell’elasticità e della mobilità articolare per poi valutarne l’efficacia. Tale attività motoria adattata e monitorata, che potrebbe poi essere prescritta come terapia, permette di spostare al di fuori del percorso Ospedaliero il trattamento a lungo termine del paziente, portandolo in un contesto meno “medicalizzato” e favorendo il superamento della percezione di malattia e un miglioramento del grado di socializzazione.
«I dati di Real Life relativi all’incidenza delle malattie valvolari cardiache, emersi dallo studio Prevasc, sono più alti rispetto alla letteratura scientifica attualmente disponibile. Da qui la necessità di uno screening cardiologico differenziato per età, in modo da poter disporre di dati aggiornati su cui basare le politiche per un piano nazionale cardiologico – ha dichiarato Alessandro Boccanelli, cardiologo, Vice Presidente SICGe, Professore di Medicina Narrativa presso l’Università Unicamillus e componente del Comitato Scientifico di Cuore Nostro - La valenza davvero unica dello studio Prevasc è quella di aver fatto emergere vizi valvolari latenti che, se non diagnosticati precocemente e seguiti nel tempo, nel 10 per cento dei casi rischiano di evolvere, nell’arco di 4-5 anni, in forme gravi che possono diventare fatali nella metà dei pazienti. Tutto questo ha gravi conseguenze, con una stima di 150mila decessi evitabili grazie all’adozione di programmi strutturati di screening “salvavita” come per i tumori mammario, colon-rettale e della cervice uterina. Ciò permetterebbe un aumento del numero delle diagnosi dall’attuale 25 per cento al 60 per cento, consentendo di intervenire precocemente in modo da aumentare la probabilità di sopravvivenza».



