Scalare il tempo
70 anni di Trento Film Festival




70 anni di Trento Film Festival



70 anni di Trento Film Festival
a cura di
Luana Bisesti - Alessandro de Bertolini - Rosanna Stedile - Sara Zanatta - Laura ZumianiIn copertina
Un collage di immagini degli anni sessanta provenienti dall’Archivio fotografico del Trento Film Festival, dove è ritratto il teatro Sociale all’interno (gremito di persone) e all’esterno (la scritta luminosa), in occasione della 14a edizione della rassegna
Quarta di copertina
Un’immagine, tratta dal primo exhibit espositivo della mostra «Scalare il tempo. 70 anni di Trento Film Festival», allestita a Le Gallerie di Trento (Galleria Bianca)
A cura di Luana Bisesti, Alessandro de Bertolini, Rosanna Stedile, Sara Zanatta, Laura Zumiani
Grafica ed impaginazione
GrafArt - Trento
Stampa
Litografica Editrice Saturnia - Trento
Editore
Montura Editing - Montura Srl
Via Trento, 138 - 36010 Zané (Vi)
ISBN: 9791280802095
Copyright © Montura Editing 2023
Finito di stampare nel mese di marzo 2023
I progetti legati alle celebrazioni del 70° anniversario del Trento Film Festival (1952-2022) sono stati sostenuti da:
Testi, fotografie, materiale grafico, appartengono ai legittimi proprietari. La riproduzione totale o parziale, in qualunque forma (compresa la fotocopia e la scannerizzazione), su qualsiasi supporto e con qualunque mezzo è proibita senza autorizzazione scritta dell’editore e dell’autore e costituisce violazione degli articoli 171 e seguenti della legge sul diritto d’autore (n.633/1941) e successive modificazioni
Questo volume è pubblicato da Montura Editing in collaborazione con la Fondazione Museo storico del Trentino e con il Trento Film Festival
Questo prodotto è realizzato con materia prima di foreste gestite in maniera sostenibile e da fonti controllate.
- Il sindaco di Trento
Franco Ianeselli pag. 9
- Il presidente generale del Club Alpino Italiano - CAI
Antonio Montani pag. 11
- Il sindaco di Bolzano
Renzo Caramaschi pag. 12
- Il presidente del Trento Film Festival
Mauro Leveghi pag. 14
- Il presidente della Fondazione Museo storico del Trentino
Giorgio Postal pag. 16
01. Pensare il Festival pag. 19
- Realtà e finzione: le narrazioni di un Festival pag. 22
Di Enrico Camanni
- Trento 1952: intorno all’idea del Festival pag. 30
Di Elena Tonezzer
- Da un fax al VOD: 20 anni con il Trento Film Festival pag. 38
Di Sergio Fant
- Con la cultura non si mangia pag. 46
Di Isabella Bossi Fedrigotti
- Una «fontana di giovinezza» pag. 50
Di Roberto Bombarda
- Compagni di cordata: la città alpina e il Trento Film Festival pag. 56
Di Alessandro de Bertolini
- La narrazione delle montagne: tra incontro e condivisione pag. 62
Di Luana Bisesti
- Paolo Cognetti, scrittore pag. 185
- Mauro Corona, alpinista e scrittore pag. 188
- Franco De Battaglia, giornalista pag. 192
- Erri De Luca, scrittore pag. 196
- Roberto De Martin, già presidente generale del CAI pag. 199
- Fausto De Stefani, naturalista e alpinista pag 203
- Kurt Diemberger, alpinista e documentarista pag. 208
- Anna Facchini, presidente della SAT pag. 212
- Nicoletta Favaron, regista pag. 216
- Alessandro Garofalo, manager pag. 220
- Maurizio Giordani, alpinista pag. 224
- Heidi Gronauer, direttrice ZeLIG pag. 228
- Giovanni Paolo Iuriatti, volontario pag. 233
- Tamara Lunger, alpinista pag. 237
- Milo Manara, fumettista pag. 242
- Sergio Martini, alpinista pag. 245
- Bernadette McDonald, scrittrice pag. 250
- Nives Meroi, alpinista pag. 253
- Reinhold Messner, alpinista pag. 258
- Maurizio Nichetti, regista pag. 261
- Cecilia Perucci, direttrice editoriale pag. 266
- Ingrid Runggaldier, scrittrice pag. 270
- Sandra Tafner, giornalista pag. 275
- Maurizio Zanolla Manolo, alpinista pag. 278
Postfazione
Di Leonardo Bizzaro pag. 285
L’immenso Walter Bonatti riteneva che «le grandi montagne hanno il valore degli uomini che le salgono, altrimenti non sarebbero altro che un cumulo di sassi». Per me questa frase così perentoria non ha solo un significato «alpinistico». Io ci leggo pure una presa di distanza dalle montagne da cartolina e da copertina, viste da lontano e dunque false, fredde, senza contraddizioni, senza umanità. Anche il racconto che il Trento Film Festival ha dipanato in questi 70 anni è stato di tutt’altra natura: ha avuto come protagonisti donne e uomini che hanno affrontato la vita di montagna non solo per sport, non come un’attività ginnica, non solamente con l’immancabile coraggio e l’indispensabile preparazione. Attraverso la montagna e le loro imprese, alpinisti, arrampicatori, camminatori (ma anche contadini, artigiani...) hanno fatto crescere il loro valore umano, la loro statura che è diventata stra-ordinaria, esemplare e dunque degna di ammirazione, in grado di illuminare anche la nostra quotidianità di cittadini e cittadine di pianura. Se nel nostro inconscio, e anche nel senso comune, la montagna – la vita di montagna, la cultura di montagna, l’economia di montagna – rappresentava una realtà minoritaria, perdente, un mondo arretrato che andava modernizzato ispi-
randosi al modello urbano vincente, grazie al Festival oggi non è più così. Le storie raccontate in questi 70 anni hanno contribuito infatti a costruire una narrazione autentica della resistenza delle terre alte, tanto che più volte, soprattutto riguardo agli aspetti ambientali e alla difesa delle culture minoritarie, abbiamo dovuto constatare che noi urbanizzati abbiamo molto da imparare da chi in montagna vive, produce, fa cultura.
Dunque, il Festival ci ha educato e ha plasmato la nostra sensibilità: e questo è solo il primo motivo di riconoscenza. Ci ha anche aperto al mondo, ha avvicinato destinazioni lontane e mostrato l’alterità irriducibile di luoghi vicini. Il Festival ha portato in città personaggi eccezionali, famosi oppure sconosciuti, che difficilmente avremmo avuto modo di apprezzare in altri contesti. Ha valorizzato la Trento migliore, quella legata alle proprie radici e insieme curiosa, che sa essere autentica e accogliente, essenziale e colta.
Questa Trento «migliore» il Festival l’ha fatta conoscere a latitudini un tempo impensate, contribuendo a costruire e a dare sostanza a un’immagine nuova di città: non più depressa e grigia come negli anni cinquanta, ma dinamica, all’avanguardia e culturalmente vivace.
A 70 anni dalla prima edizione i meriti del Trento
Film Festival sono evidenti e tuttora attuali. Perché la formula della manifestazione non è invecchiata, ma ha saputo interpretare il cambiamento e raccontare le nuove emergenze del terzo millennio senza snaturare l’idea originaria dei fondatori, il vicepresidente del Club Alpino Italiano (CAI)
Amedeo Costa e il sindaco di Trento Nilo Piccoli.
A loro, a chi ha raccolto il testimone nel corso dei decenni, all’attuale presidente del Festival Mauro Leveghi, alla direttrice Luana Bisesti e al responsabile del programma cinematografico Sergio Fant va la gratitudine della città. Lunga vita al Film Festival!
A volte certi eventi che segnano la storia, anche quelli più significativi, nascono da particolari all’apparenza secondari, come quello della messa in produzione di una certa cinepresa dalle dimensioni ridotte, che poteva essere riposta nella tasca dello zaino. La storia gloriosa del Trento Film Festival nasce da lì. Siamo nel 1952 e gli alpinisti, da pochi anni, possono contare su un vero gioiello della tecnica: il «passo ridotto». Vale a dire cineprese leggere, maneggevoli, che al momento giusto possono essere impugnate standosene in bilico sulla parete ventosa per riprendere il compagno nell’azione dinamica della scalata. Sembra poco, ma è una vera rivoluzione. «C.A.I. FILM - Primo Concorso Internazionale della Cinematografia Alpina a passo ridotto. Trento 14-18 settembre 1952», recitava la locandina della prima edizione del Trento Film Festival. Il «passo ridotto» avrebbe comportato un passo enorme nella diffusione della cultura delle alte quote. Finalmente, l’atto misterioso degli alpinisti protesi verso le cime poteva emergere non solo dalle fotografie o dai racconti scritti, ma addirittura sul grande schermo! Il mistero era svelato. Grazie a quel prodigio della tecnica e all’intuizione geniale dell’imprenditore trentino Amedeo Costa nasceva uno degli appuntamenti culturali sulla montagna più importanti del mondo. Gli alpinisti passavano in
breve tempo da essere dei personaggi misteriosi che tornavano da un mondo inaccessibile, a vere e proprie stelle da applaudire. Dal buio della sala, eccoli svelarsi nella bufera, il viso stravolto dalla fatica, un passo dopo l’altro nella neve profonda, l’appiglio sempre più piccolo col passare degli anni, a volte un volo trattenuto dalla corda. Ogni anno, Trento diventerà una passerella per scalatori, registi, esploratori di fronte a platee sempre più numerose. Dopo i divi dei primi anni, Lionel Terray, Cesare Maestri, Hillary, Bonatti, Cassin, Maraini, e lo sherpa dei record Tenzing Norgay, tutti i più importanti nomi internazionali legati alla montagna, come è puntualmente descritto in questo volume, sono passati dalla passerella di Trento. Nessun alpinista di punta, fino ai giorni nostri, si è fatto mancare l’applauso del pubblico consapevole e appassionatissimo del Festival. Alle scalate, si è poi aggiunta l’esplorazione e lo sguardo indagatore dell’etnografo, che riscopre ogni volta i segreti delle terre alte. Il CAI è stato, con la Città di Trento, il socio fondatore di questa scatola magica che ogni anno ci sorprende. E continuerà a essere sostenitore con lo stesso entusiasmo di sempre. Perché la vita in quota produce cultura, e il Trento Film Festival è la macchina ideale per trasmetterla al mondo.
Nel corso degli anni novanta, ho lavorato come direttore di Ripartizione presso il Comune di Bolzano, e la discussione in città su come valorizzare la cultura della montagna era accesa.
Trento vantava il Trento Film Festival, uno dei più antichi festival cinematografici italiani. Dal 1952 con il Club Alpino Italiano (CAI), la città di Trento promuoveva la cultura dell’alpinismo internazionale affiancando ad essa le tematiche dell’esplorazione e anticipando di decenni quella sensibilità ambientale così radicata nel nostro territorio.
A partire dalla seconda metà degli anni novanta, i contatti e gli scambi tra Trento e Bolzano si sono rafforzati per instaurare una convinta collaborazione istituzionale. Si è partiti inizialmente con alcune proiezioni e allestimenti di MontagnaLibri, vetrina internazionale dell’editoria di montagna, di viaggio e di esplorazione.
Nel 1998 il Comune di Bolzano ha formalizzato la sua adesione diventando socio del Festival. A partire da questa data, oltre ad avere un proprio rappresentante nel Consiglio direttivo, Bolzano ha promosso il fascino della montagna con una serie di incontri alpinistici e letterari, mostre fotografiche e una edizione «personalizzata» delle proiezioni del Trento Film Festival.
Vagando nei ricordi, ho ancora impresse nella mente le immagini dei vertiginosi cieli himalaya-
ni che si stagliano sullo schermo durante la proiezione del film Himalaya - L’infanzia di un capo (Himalaya, l‘enfance d‘un chef, Francia, 2000) di Éric Valli, vincitore della Genziana d’oro nel 2000, o la potenza del volo degli uccelli, trasportati dal mutare delle stagioni, raccontati da Jacques Perrin nel documentario Il popolo migratore (Le peuple migrateur, Francia, 2001), vincitore della Genziana d’oro nel 2002. Solo per citare alcune delle immagini più forti e note che hanno portato il Festival all’attenzione del pubblico internazionale.
Dal 2006 viene istituito anche un premio Genziana d’oro Città di Bolzano per il miglior film di esplorazione o avventura, vinto in quell’occasione dal film Jenseits von Samarkand (Germania, 2005), regia di Thomas Wartmann e Lisa Eder: la narrazione del sogno di una storia d’amore visto attraverso gli occhi di una diciassettenne uzbeka, Zümbüla. Risuonano ancora nelle mie orecchie, di appassionato di musica, gli yodel, i gorgheggi e i mormorii del vincitore del 2008 Heimatklänge (Paesi Bassi, 2006), per la regia di Stefan Schwietert, un vero e proprio viaggio sonoro attraverso le Alpi.
Il contributo importante dell’adesione bolzanina al Trento Film Festival è stato quello di avere promosso una serie di attività di approfondimento
della cultura di montagna e della storia dell’alpinismo, dando in tale modo il proprio contributo al rafforzamento del Festival trentino.
Tra le iniziative più importanti, realizzate anche talvolta in partnership con Trento oltre che con il CAI, ricordo la serie di mostre L’alpinismo acrobatico, una serie di fotografie storiche di fine
Ottocento che raccontano le Dolomiti e l’invenzione dell’arrampicata; la bellissima mostra Tien
Shan di Stefano Torrione, una raccolta di immagini realizzate ripercorrendo lo storico viaggio del 1900 (finanziata dal principe Scipione Borghese)
di Brocherel e Borghese in Asia Centrale verso il confine fra Kyrgyzstan e Cina; e più recentemente la mostra Gasherbrum IV - 1958. Verso la Montagna di Luce, che racconta l’avventura di Walter Bonatti, Carlo Mauri, Riccardo Cassin, Toni Gobbi, Donato Zeni, Giuseppe De Francesch, Giuseppe
Oberto e Fosco Maraini verso la vetta che, con i suoi 7.925 metri, è una delle più maestose e impervie cime del pianeta.
E poi gli incontri con Walter Bonatti, ospite a Bolzano, e con Simone Moro, Florian Riegler e Andy Holzer, con i protagonisti della storia dell’alpini-
smo e con coloro che stanno scrivendo la contemporaneità dell’arrampicata. Ricordo con suggestione lo stile di Catherine Destivelle, icona dell’alpinismo femminile, che ha sviluppato un percorso di ricerca di sempre nuove sfide: non dimenticherò mai quelle immagini in cui la scalatrice francese, aggrappata con una mano alla roccia, affronta il vuoto immenso e straordinario del Verdon. Così come non dimentico il film Au delà des cimes (Francia, 2008) di Rémy Tezier, vincitore della Genziana d’oro del CAI nel 2008, che ne racconta la vita e ci delizia gli occhi con i paesaggi sontuosi del monte Bianco e le vertiginose riprese dall’alto o dal basso delle pareti di granito.
L’adesione della Città di Bolzano al Trento Film Festival è stata una scelta convinta perché il Festival ha saputo offrire occasioni uniche d’incontro con i protagonisti del cinema, della scena alpinistica e letteraria più attuale, che accrescono il mito della montagna con un approccio rispettoso e consapevole dei limiti dell’uomo e della natura.
Succede spesso, in occasione delle feste di compleanno, di sedersi in compagnia a sfogliare gli album di famiglia, rivivendo emozioni ed evocando ricordi che sembravano svaniti. Ogni anno che passa quelle immagini, apparentemente sempre uguali, in realtà mutano davanti a noi e sembrano raccontarci una versione differente della nostra storia. Siamo noi che le guardiamo con occhi diversi, con un anno in più sulle spalle, con un’esperienza nuova e nuovi modi di vedere, conoscere e capire il mondo. Nel 2022 al Trento Film Festival abbiamo fatto proprio questo: aperti gli scatoloni dell’archivio, sono riemerse immagini, parole e suoni di 70 anni di cinema e culture di montagna. Non è la prima volta che il Festival rilegge la sua storia: negli anni si sono susseguiti importanti lavori di analisi sull’evoluzione del Festival nel contesto più generale della cinematografia di montagna e nella specificità territoriale di Trento e del Trentino. Ma, non dimenticando mai l’insegnamento crociano per cui la storia è sempre contemporanea, abbiamo sentito l’esigenza di aggiornare lo sguardo sul nostro passato, anche se forse sarebbe più corretto parlare di «sguardi», usando un plurale che mai come in questa occasione è giusto e necessario.
È stato infatti un lavoro corale, quello svolto nel corso del 2022, che ha coinvolto decine di perso-
ne, legate a doppio filo alla montagna e alla sua cultura. E anche qui, come orgogliosamente rivendichiamo nel pay off del nostro logo, meglio usare il plurale: montagne e culture.
Il Festival d’altronde è plurale fin dalla sua nascita, frutto dell’incontro tra la solida tradizione del Cai e la tenace volontà di un piccolo comune alpino, Trento, che sulle macerie della seconda guerra mondiale stava cominciando a costruire il suo futuro, consapevole che sarebbe stato luminoso solo nella misura in cui lo sguardo non si fosse fermato sull’orizzonte delle montagne di casa ma, al contrario, si fosse aperto al mondo.
Quello che all’epoca si chiamava Concorso Internazionale della Cinematografia Alpina contribuì a portare il mondo a Trento, prima ancora che Trento nel mondo. Non fu una semplice operazione di marketing territoriale, ma un grande investimento nel capitale sociale di questo territorio, attraverso un elemento fondativo della sua identità.
Per intere generazioni di trentine e trentini il Festival è stato una finestra sul mondo: immaginate cosa potesse significare nel 1957 veder arrivare in stazione a Trento Tenzing Norgay, l’alpinista nepalese che insieme a Edmund Hillary nel 1953 raggiunse per primo la vetta dell’Everest, accolto da una fiaccolata e dai gagliardetti della Società Alpinisti Tridentini (SAT). Le stesse fiaccole festose
che nel 1954 accolsero i protagonisti della «conquista» italiana del K2. Ai tempi delle comunicazioni in tempo reale, sembrano ricordi sfocati e un po’ naif: ma non possiamo dimenticare che all’epoca le opportunità di conoscenza e informazione erano ben diverse, e il Festival è stato per migliaia di persone che vivevano in Trentino l’unica possibilità di conoscere il mondo attraverso il racconto di chi lo aveva esplorato.
Il Festival ha rappresentato un modello virtuoso dell’Autonomia che si andava costruendo in questo territorio alpino: fortemente incardinato sulle specificità territoriali, ma aperto al mondo; capace di leggere i cambiamenti sociali, economici e culturali, talvolta perfino di anticiparli; soggetto creatore di capitale sociale, attraverso la cultura e la conoscenza.
Ma quali sono gli elementi chiave delle culture delle montagne del mondo? L’esperienza di questi
70 anni ne indica almeno tre, che sono al contempo valori circolari e strategie per il futuro: identità territoriale, intesa in senso aperto, inclusivo e in continua evoluzione; responsabilità individuale e collettiva, per la costruzione di un’economia del bene comune; sostenibilità, nel significato più pieno che i francesi racchiudono nel termine durabilité, e quindi un intreccio tra sostenibilità economica, sociale e ambientale, condizione necessaria per costuire il domani basandosi su una diffusa e convinta cultura del limite. Sono tematiche che il Trento Film Festival ha messo al centro della sua strategia, diventando qualcosa di più di una rassegna cinematografica e definendosi ormai come un progetto culturale sulle montagne del mondo e sul loro futuro, che si sviluppa nel corso di tutto l’anno promuovendo, a Trento e in tutta Italia, la globalizzazione delle differenze.
Fin dagli esordi, il respiro internazionale del Trento Film Festival, le sue rassegne, i suoi convegni e i suoi incontri hanno saputo proiettare Trento e il Trentino ben al di fuori dei propri confini. Occorre riconoscere che Trento in particolare, proprio grazie al Festival, ha goduto di ampia eco, affermandosi come città alpina sul vasto palcoscenico della cinematografia e della cultura di montagna. Se volgo il mio sguardo al passato, restano indelebili nella mia memoria immagini che porto scritte nella mente e nel cuore: quelle relative alla scena del film Italia K2 (Italia, 1955), a cui assistetti, nella quale il rientro a valle della salma di Mario Puchoz, morto durante la spedizione italiana al K2, veniva accompagnato da un sottofondo tanto coinvolgente quanto emozionante di canzoni valdostane di montagna, magistralmente eseguite dal Coro della SAT. Da un lato, quelle armonie conferivano alle immagini che si susseguivano grande solennità, partecipazione, vorrei dire un’aura di autentica sacralità. Dall’altro, testimoniavano la circolazione di una cultura di montagna del Trentino legata non soltanto al nome di Trento e delle sue montagne, ma anche a un insieme di valori fortemente radicati sul territorio e alimentati per lungo tempo dall’associazionismo locale. Non va certamente dimenticato, a questo proposito, il ruolo sempre imprescindibile svolto dalla SAT.
In quegli anni, con il successo della spedizione italiana al K2, raccontata dai suoi protagonisti e largamente ripresa dal Festival della montagna, la città di Trento si candidava a diventare il centro del mondo alpinistico, con un decisivo rafforzamento della sua vocazione e della sua identità alpina. Una città che cercava lentamente di uscire dagli anni difficili del dopoguerra, e che, sotto la guida di uomini e istituzioni lungimiranti, voleva crescere nell’apertura al mondo. Dunque anche il Festival, con la sua offerta culturale, alimentata da un orizzonte di visioni e di relazioni ampio e penetrante, ne doveva costituire uno strumento particolarmente corroborante. Vari sono stati i registri sui quali, nel corso degli anni, il Festival ha saputo giocare, dalla dimensione ideale della montagna alla sua dimensione reale, storica, economica e politica, sempre comunque all’interno di una cultura della montagna capace di percepire i cambiamenti in corso e nel contempo di mantenere saldi i valori costitutivi, senza il timore delle contaminazioni che, per il vero, hanno costituito il sale del suo messaggio culturale. Un’epica capace di raccontare e raccordare il mito con la fatica del vivere in montagna o con la sfida alle più alte vette, dove la montagna vissuta e la montagna rappresentata hanno potuto trovare un felice punto di incontro.
In effetti, lungo la strada, il Festival, ha dovuto fare i conti, decennio dopo decennio, con i grandi passaggi dell’alpinismo (fino al free climbing) e nel contempo con le grandi mutazioni che hanno coinvolto la vita della montagna. Molte cose sono cambiate e tuttavia a me pare che sempre, anche nei momenti di difficoltà, ha saputo mantenere intatto lo spirito delle origini. Molto è cambiato anche per la città di Trento. Il sentimento della sua comunità verso la «Trento città alpina» si è, a mio avviso, largamente affievolito, sotto la spinta delle omologazioni provenienti dalle pianure. E questo in un tempo nel quale ritengo assolutamente essenziale che la dimensione alpina della città debba essere permanentemente recuperata e valorizzata come fondamento identitario della nostra comunità. In occasione dei suoi 70 anni, auspico quindi che il
Trento Film Festival possa continuare a perseguire le finalità che lo hanno contraddistinto, rinnovando e potenziando ancora di più quel ruolo di promotore di una cultura della montagna che lo vide protagonista fin dalle prime edizioni. Con il pieno e convinto supporto delle istituzioni provinciali e della politica locale.
La vocazione alpina della città di Trento appartiene alle specificità culturali e identitarie di questo territorio. È su questi presupposti che la Fondazione Museo storico del Trentino e il Trento Film Festival hanno potuto collaborare in occasione del 70° del Festival, nella condivisione di un percorso comune che pone al centro della riflessione sul futuro il significato della storia, come strumento di conoscenza, e le politiche culturali, come modalità concreta per operare sul presente.
I festival sono crocevia di flussi culturali. Spazi tutt’altro che «neutri», non si limitano al ruolo di cornice organizzata e organizzante di spettacoli ed eventi, ma contribuiscono alla promozione di una città, all’identità di un territorio, alla produzione di valore attraverso idee e messaggi, alla costruzione di forme di «cosmopolitismo». I festival sono rituali sociali: aggregano le persone in situazioni di compresenza fisica; si rivolgono a target ben definiti, per quanto ampi, che formano una comunità provvisoria; concentrano l’attenzione di chi partecipa su un medesimo oggetto (la visione di un film, un’esperienza musicale, una competizione sportiva); danno alle emozioni individuali un’intensità collettiva. Come oggetto di studio – per la verità piuttosto recente – i festival si prestano poi a molteplici letture: l’analisi del contesto storico, la riflessione critica dei contenuti, la ricognizione degli archivi, spesso frammentari e disordinati, lo studio dei principali cambiamenti istituzionali, e in filigrana l’andamento generale delle politiche culturali. Questo significa «pensare» un Festival. Riavvolgere il nastro, e ripercorrerlo criticamente seguendo tracce e rivoli, anche molto distanti tra loro. I testi di questa sezione si collocano a metà strada tra il saggio e la testimonianza autobiografica. Perché a scriverli sono addetti ai lavori, professionisti che hanno incrociato il Trento Film Festival e lo «ri-pensano» oggi con le lenti dello studio del territorio, dei processi culturali, della cinematografia, dello sport, della letteratura, della politica.
Alpinista, giornalista e scrittore, è stato direttore di varie riviste di cultura alpina (tra le principali la Rivista della Montagna, Alp e L’Alpe) e ha collaborato con numerosi quotidiani e periodici tra cui Airone, Il sole 24 ore, La Stampa, Panorama, L’Unità, Meridiani e Il Manifesto. Già direttore della Scuola Nazionale di Scialpinismo SUCAI di Torino, è autore di importanti volumi ed è tra gli osservatori più attenti del mondo alpino in Italia e all’estero. In 40anni di attività pubblicistica e di ricerca si è occupato di storia delle Alpi e delle problematiche dell’ambiente alpino, con particolare attenzione all’aspetto umano, unendo più discipline e competenze.
Ho cominciato a frequentare il Festival a 19 anni, nel 1977, quando ero un piccolo redattore della Rivista della Montagna. Che meraviglia: avrei pagato per immergermi una settimana intera nel buio elettrizzante del teatro Sociale di Trento, e invece mi ci mandavano! Era l’apoteosi della scoperta, un’indigestione di cime, alpinisti e avventure senza limiti di lingua e geografia. Mi perdevo completamente dentro quello schermo quasi sempre acceso che ci portava più lontano del sogno.
Alla fine degli anni settanta il mondo era già completamente cambiato, anche quello dell’alpinismo, ma a Trento si respirava ancora un’atmosfera d’altri tempi, un po’ provinciale, iniziatica e impenetrabile. I miti miei e degli altri spettatori si aggiravano silenziosamente in città, quasi di nascosto, li vedevi appena, ne percepivi la presenza. Tutti si conoscevano ma molti si davano del lei, ossequiosi, formali, e noi giovani avvertivamo la distanza generazionale. Il Festival proponeva un grande spettacolo, ma era come se non si dovesse sapere al di fuori del recinto perché l’alpinismo e la montagna non andavano urlati, solo sussurrati. C’era ancora tanta deferenza verso i presunti «grandi» e il mistero si nutriva d’informazione sommaria. Giusto quella essenziale, se non eri del giro.
«Amo l’odore del napalm la mattina. Ha il profumo della vittoria» re-
citava negli stessi anni, negli altri cinema, il colonnello Kilgore di Apocalypse now (Stati Uniti, 1979) di Francis Ford Coppola, ispirandosi a Cuore di tenebra di Joseph Conrad. Il film di Coppola poteva essere ambientato in Vietnam e ovunque. L’allegoria della giungla, la cavalcata wagneriana degli elicotteri, la follia di Bill Kilgore e le sfrontate fughe di guerra sulla tavola da surf parlavano una lingua universale. Il monologo di Walter Kurtz-Marlon Brando svelava al mondo occidentale il suo violento marchio di fabbrica e la patetica, inarrestabile volontà di potenza. Con linguaggio ipercontemporaneo il film colpiva due generazioni, e chi aveva meno di 40 anni anni usciva dalla sala con il nodo allo stomaco, il napalm in gola e l’urlo dei rotori che picchiava in testa. Letta con gli occhiali di oggi la bolgia di Coppola era la nuova giungla economica dell’occidente, una profetica anticipazione dell’edonismo reaganiano degli anni ottanta, e anche della successiva globalizzazione. Credevamo di essere alla fine del vecchio decennio e invece eravamo già scivolati in quello nuovo, ci eravamo già dentro fino al collo, e il mercato aveva ripreso il controllo sociale. Non c’era più spazio per l’utopia, il dialogo e la solidarietà. Comandava sfrontatamente il denaro, senza dubbi né vergogne. Comandava il privato. In tre anni successe tutto. Nel 1977 sbarcarono in Italia i televisori a
colori e le serie televisive, e nel primo episodio di Happy days (Stati Uniti, 1974-1984) Richie ebbe un appuntamento con Mary Lou lasciando credere a Fonzie di essere andato «fino in fondo». Niente di straordinario, oggi succede mattina e sera su almeno 20 canali digitali, ma Richie e Fonzie erano dei miti controrivoluzionari perché arrivavano alla fine del decennio più duro e impegnato della storia italiana. Le serie americane sdoganavano una nuova scala di priorità, somministrando allo spettatore distrazioni, spot e disincanto. Il Festival della Montagna di Trento sembrava immune da questi sconvolgimenti, al riparo dagli spifferi esterni della società, difeso e protetto nel suo rifugio gentilmente dissimulatore, riparato da quel buio silenzioso e denso che aleggiava nel teatro Sociale dove solo i film avevano diritto di parola. Era il cinema a comandare su tutto e non si parlava ancora di ecologia, riscaldamento climatico, difesa dell’ambiente; oltre all’etnografia montana e alla diffusa retorica del «lassù gli ultimi», esistevano solo i film di alpinismo e arrampicata, che allora corrispondevano a un concetto unico e, quasi sempre, alla «conquista» di una cima – i termini bellici imperavano – e a un viaggio alpino o himalayano. Credo di aver visto almeno cento marce di avvicinamento all’Everest e ad altri Ottomila, con portatori e tende, tra pie-
di nudi e scarponi, del tutto simili nelle immagini e nei commenti, sempre in cerca di una vetta liberatrice. Qualche volta le spedizioni finivano in tragedia, ma anche quando non si verificava la tragedia i registi se la inventavano con qualche suspense e aleggiava sempre l’ombra del dramma sullo sfondo, perché l’alpinismo era una liturgia dura, pura e sacrificale. Per questo, quando sbarcavano a Trento dei film speciali come Solo (Stati Uniti, 1973) di Mike Hoover
o Die Wand (Germania, 1974) di Lothar Brandler, quei film facevano scalpore perché ci dicevano che in montagna ci si poteva anche divertire, che era lecito scherzarci sopra e soprattutto era possibile fallire e tornare indietro da una scalata e raccontarlo ai propri simili con la forza delle immagini, un buon dialogo e una giusta sceneggiatura, senza il timore di passare per dei miserabili vigliacchi. Al contrario, capimmo che il «fallimento» poteva essere più interessante del successo perché era vero. Fu questa la rivoluzione dell’alpinismo e dell’arrampicata sul ventoso spartiacque tra gli anni settanta e ottanta del Novecento, che inevitabilmente cambiò anche il Trento Film Festival, le sue pellicole e i suoi protagonisti. E noi cronisti, è ovvio.
A dire la verità ci fu un film che anticipò la percezione del cambiamento: El Capitan (Stati Uniti, 1978)
di Fred Padula. Lito Tejada Flores, Gary Colliver, Richard McCracken e Glen Denny, che aveva girato la maggior parte delle immagini, incrociavano le fantastiche scene di arrampicata con dialoghi da noi mai sentiti in parete, forse neanche immaginati. Sul muro più alto della valle di Yosemite andava in scena la reinvenzione della scalata, del tutto scevra dai condizionamenti eroici nostrani, tanto ineccepibile professionalmente quanto spontanea, ispirata e poetica. Tutti andammo a dormire con in testa quella luna più grande dello stesso Capitan e quegli scalatori piccolissimi, vigorosi e antiretorici. In una parola, nuovi. Capimmo che il futuro dell’alpinismo (si chiamava ancora così) e del cinema di montagna era smisurato.
Il direttore che prima e più di tutti raccolse la sfida del cambiamento fu Emanuele Cassarà, brillante e incontenibile giornalista di Tuttosport. A metà degli anni ottanta, Cassarà fu l’ideatore e il promotore con Andrea Mellano e Marco Bernardi delle prime gare di arrampicata a Bardonecchia e portò a Trento la stessa carica eversiva, intenzionato a seppellire i vecchi miti e a fare chiarezza su tutto, sezionando ogni contenuto ed esponendolo alle luci della ribalta. Da direttore della nuovissi-
ma e sbrigliata rivista Alp gli fui numerose volte complice, imbastendo dibattiti infuocati e atipici, coinvolgendo personaggi poco allineati come
Ambrogio Fogar, il conduttore della trasmissione Jonathan - Dimensione avventura (Italia, 19841991), che fino a quel momento erano stati ritenuti estranei al cenacolo alpinistico e invece portarono sguardi e parole nuove e dimostrarono che non eravamo un’élite impenetrabile. Furono gli anni del dibattito e del confronto continuo – con almeno un decennio di ritardo sulla società –, le stagioni dei grandi reportage, delle grandi inchieste e della mutazione radicale delle immagini; fu il tempo in cui tutto moriva e rinasceva in forme inedite, a cominciare dagli abiti degli scalatori e dai loro exploit fantascientifici, liberati dagli antichi tabù, frutto di allenamento metodico e di una visione laica della montagna e sportiva dell’alpinismo. Nonostante alcune diversità di vedute, condivisi con Cassarà l’idea di fondo: dovevamo imparare a scrivere, filmare e raccontare le avventure come si sarebbe fatto con una riunione politica, un matrimonio, una partita di calcio, la lite di condominio. Era ora di anteporre la capacità narrativa alla retorica di genere. Pensare al lettore e allo spettatore, non all’autore o al regista: sarà contento? Non lo sarà? Privilegiare la forza espressiva. Rinunciare al sacerdozio dell’informazione. Lavorare per farsi capire da tutti, compresi quelli che non conoscevano la montagna e ne ignoravano i segreti.
La trasformazione del cinema di settore non è stata da meno del giornalismo di genere. Penso a film come Cumbre (Svizzera, 1986) di Fulvio Mariani, girato sul Cerro Torre, che in meno di 40 minuti, seguendo la gioiosa corsa solitaria di Marco Pedrini sulla via del Compressore, ci restituì tutta quella leggerezza e quella poesia che avevamo perso in decenni di alpinismo disumano; penso al lungometraggio Cinque giorni un’estate (Stati Uniti, 1982) del maestro Fred Zinnemann, il più fortunato incontro tra la montagna e il cinema, dove un ispirato Sean Connery scala le pareti ghiacciate del Bernina senza improvvisare un solo gesto tecnico, impeccabile; o ancora, su una via intermedia, penso al coraggioso La face de l’Ogre (Francia, 1987) di Bernard Gireaudeau, sulle pene di una donna legata a un grande alpinista, tratto dal racconto di Simone Desmaison, la moglie di René.
Presto si passò dal buio misterioso e iniziatico del teatro Sociale agli spazi aperti e collettivi del Santa Chiara, dove tutti – i famosi e i non – si incon-
travano al Campo Base nell’ora di pranzo: veniva meno il distacco generazionale e si smorzava quello tecnico alpinistico, favorendo lo scambio amichevole e disincantato. Il Festival diventò una
festa in città: la festa di primavera. Negli anni novanta, il nuovo direttore Toni Cem-
bran si concentrò sull’aspetto culturale che avrebbe dovuto fare da cornice alla rassegna cinematografica. Nel 1998 commissionò a Pietro Crivellaro e a me, in quanto storici dell’alpinismo e giornalisti a loro agio in varie discipline espressive, la prima grande serata multimediale del Film Festival. S’intitolava «Sognando la Patagonia: storie di uomini e montagne alla fine del mondo». Fu un’esperienza intensa, molto impegnativa, perché provammo ad affiancare – oggi direi con successo – il grande cinema a quello specializzato, la grande letteratura a quella alpinistica, la musica alle immagini, le parole ai suoni, e portammo in sala i protagonisti dell’alpinismo patagonico, tra cui Cesare Maestri e Casimiro Ferrari. Erano tutti senza parole, completamente presi dall’atmosfera della pampa che si creò al Santa Chiara, appesi visivamente ed emotivamente agli scudi di granito del Cerro Torre e del Fitz Roy, sospesi tra la fascinazione e il mistero. La nostra era una formula ambiziosa e complessa, ma ci permise di portare la Patagonia a Trento per una sera. Una vera magia. Una quindicina di anni dopo scrissi con Maurizio Nichetti la serata dedicata ai 150 anni del Club Alpino Italiano (CAI) e trovai un Festival e un pubblico di nuovo assai cambiati. Un po’ li aveva cambiati lo stesso Nichetti, che da uomo di cinema e anche da appassionato di montagna, guardava
molto più all’aspetto sociale dell’alpinismo che ai grandi exploit. Di fatto anche la nostra serata fu una storia sociale del CAI, totalmente mischiata, «contaminata» avrebbe detto qualcuno, con la storia d’Italia dall’Unità a oggi. Scegliemmo le canzoni che segnavano le varie epoche e gli eventi che le definivano, incrociandoli con l’evoluzione dell’andare in montagna. Fu una serata allegra e demistificatrice, che piacque alla platea vasta e forse deluse i seguaci degli exploit, ma non era un problema perché ormai al Festival c’era spazio per tutti e tutti avevano un po’ di quello che cercavano, compresi i loro miti sempre meno mitici e più avvicinabili di una volta. Dal Centro Santa Chiara il Festival usciva per le strade e le piazze, coinvolgendo la città in una kermesse culturale e ricreativa tenuta insieme dalla montagna. Finalmente nel 2016 sono ritornato a Trento solo per guardare i film in concorso. Uno per uno, da bravo giornalista, come quando avevo 20 anni e da inviato della Rivista della Montagna mi annegavo per una settimana nello schermo, scalando pareti vicine e lontane, sognando e soffrendo con i miei eroi. Ma a quel tempo ignoravo che non erano le imprese a far battere il mio cuore, bensì
i loro racconti, e non sapevo ancora che la storia dell’alpinismo è una straordinaria narrazione, la ripetizione infinita di un racconto codificato, più
o meno come l’epopea cinematografica del Far West oppure come quei polizieschi in cui succedono sempre le stesse cose ma stai comunque inchiodato per vedere come va a finire. E ogni volta ci ricaschi perché è bello fingere che sia vero, che assomigli alla vita. I frequentatori assidui del Festival lo sanno molto bene, perché anche il racconto d’alpinismo funziona così: comincia sempre con un progetto e una sfida, poi vengono le difficoltà, gli imprevisti, a volte il dramma, e infine la liberazione. Con o senza vetta, poco conta, ormai. Non è indispensabile arrivare in cima, ma bisogna perdersi per ritrovarsi. Bisogna affrontare la parete, o il viaggio, giocarsela e tornare a casa. È proprio il ripetersi dello schema narrativo a farci emozionare, perché ricalca il gioco e lo schema del romanzo classico: si entra nei sogni e nelle storie dei protagonisti e ci si smarrisce nei loro guai, aspettando appassionatamente di salvarsi con loro.
Il film d’alpinismo è narrazione, ripetizione e metafora di vita. Senza la narrazione esisterebbero le scalate, non i sentimenti. Le emozioni sarebbero riserva dei pochi che le hanno vissute, e anche loro si sentirebbero incompresi e soli senza un pubblico. Per questo l’alpinismo è un immenso e ossessivo groviglio di racconti, come se la penna, la cinepresa o la camera digitale contassero più
della piccozza. A dispetto di chi vorrebbe farne una disciplina quasi scientifica per documentare la «verità», l’alpinismo è da sempre narrazione e finzione, fin dal giorno in cui è stato inventato. Individuata la sceneggiatura, ogni alpinista ripete con passione la medesima storia, che non è quella dell’ultima scalata ma quella della sua vita. Henri Beraldi, il grande bibliofilo francese, sosteneva che un alpinista esiste veramente solo se scrive, oltre ad arrampicare. O se filma e riprende se stesso con l’obiettivo, aggiungo io. In assenza di regole e testimoni (l’alpinismo è fondato su regole non scritte e mutevoli secondo la cultura del tempo), l’unica certificazione della scalata sta nella sua narrazione. E così, tornando finalmente a Trento a vedere una rassegna completa di film del terzo millennio, ho trovato del cinema di ottima qualità dal punto di vista tecnico. C’erano buoni film e buoni autori, talvolta impeccabili, quasi perfetti, ma, forse ancora più di una volta, difettavano le storie e le sceneggiature. Ormai si arrampicava in diretta con la GoPro sul casco e il drone sulla testa, la finzione era sempre più esplicita. Quasi oscena. Tutto era mostrato e si era sempre più nudi davanti alla videocamera. Si soffriva e gioiva pubblicamente, si moriva nudi e nudi ci si salvava, tutti allo stesso modo, senza pudore. Era l’ambigua democrazia del digitale.
Una scena del film El Capitan, vincitore della Genziana d’oro nella 26a edizione del Trento Film Festival.
Alla fine della mia immersione cinematografica, senza rimpiangere i brutti film di una volta, frutto di molti stereotipi e poca professionalità, ho pensato che la perfezione sia un’arma a doppio taglio e possa essere molto pericolosa. Siamo scivolati in un’epoca in cui ci si può fotografare e filmare con la leggerezza di un respiro, senza dire niente. Il racconto è diventato determinante e lo sarà sempre di più. Proprio perché possiamo vedere tutto e tutto ci è svelato, abbiamo un bisogno quasi vitale di ritrovare il senso e la narrazione di quello che facciamo, e anche di quello che vediamo. Per sciogliere qualche mistero, per emozionarci davvero, ci servono più che mai le ombre, i chiaroscuri, le pieghe nascoste e imperfette, perché troppa luce acceca e alla fine non si vede più niente. Sarà questo il Festival di domani?


Ha conseguito un dottorato in studi storici all’Università di Trento ed è attualmente ricercatrice alla Fondazione Museo storico del Trentino. Qui è responsabile del settore della storia della città di Trento, a cui ha dedicato diversi saggi, mostre e programmi televisivi.
Il primo febbraio 1952, la cronaca di Trento del quotidiano L’Adige presenta questo titolo a quattro colonne: «Sette cittadini ogni cento escono di casa dopo le 20», e l’occhiello specifica che «si balla poco e si riposa molto».
L’articolo, sotto forma di inchiesta, tra il serio e il goliardico dipinge una vita notturna cittadina a dir poco inesistente: poche persone in giro, quasi nessun locale aperto dopo cena. L’Adige è il giornale di proprietà della Curia e del partito conservatore che in quegli anni amministra il Comune di Trento, la Regione, anche lo Stato: la Democrazia Cristiana. Un quotidiano che, al di là del tono canzonatorio dell’articolo, probabilmente condivide e asseconda l’idea di vivere in una città tranquilla, quasi letargica.
Nel 1952 a Trento non ci sono né l’Università, né l’autostrada; il centro storico della città è ancora in parte ingombro delle macerie della guerra, finita da appena sette anni. Il censimento nazionale del 1951 certifica poco più di 62.000 abitanti (erano 56.000 prima della guerra). Chi arriva alla stazione dei treni si trova davanti uno scenario molto segnato dalla catastrofe dei bombardamenti, in piazza Dante vede le macerie del palazzo su cui ora si erge la sede della Regione, intorno a torre Vanga ci sono i resti degli edifici distrutti della Portela.
I danneggiamenti del sistema viario rendono ancora molto difficili e lenti i collegamenti tra i centri maggiori e le valli. Il Consiglio comunale è costantemente impegnato nel risolvere problemi concreti, eredità pesanti: le macerie, gli edifici pubblici danneggiati, la mancanza di materie prime, le scuole da riaprire…
Il 6 giugno 1951 si insedia la quarta amministrazione dalla fine della dittatura: il primo sindaco era stato Gigino Battisti, figlio di Cesare, morto in un incidente ferroviario nel 1946; il secondo il democristiano Tullio Odorizzi; in seguito alle dimissioni di Odorizzi, che si candida alle elezioni regionali, il 19 ottobre 1948 è eletto sindaco Dino Ziglio. La tornata elettorale del 1951 porta alla nomina di Nilo Piccoli che guida una giunta quasi interamente democristiana, l’unica eccezione al monocolore DC è il liberale Gino Marzani, assessore agli Affari generali; per la prima volta nella storia del municipio siede in Giunta anche una assessora, Ottilia De Nicolò, nominata all’Assistenza. Il sindaco è fratello di Flaminio Piccoli, direttore del quotidiano
L’Adige e segretario della DC locale fino al 1957.
Nell’anno di nascita del primo festival della montagna di Trento, il Consiglio comunale della città
è dunque impegnato a ridare dignità alla vita di centinaia di famiglie e nei primi timidi passi verso uno sviluppo che si immagina subito anche turi-
stico. Il 22 maggio di quel 1952 viene inaugurato il palazzo in via Oriola che ospita il nuovo passaggio a piazza Lodron, una piazza nuova, non voluta ma risultata proprio dalle macerie dei palazzi che vi si trovavano fino alla seconda guerra mondiale. L’anno successivo si completa la copertura dell’Adigetto, il fiumiciattolo che ancora correva in via Alfieri, interramento che fa perdere l’ultima traccia visibile del vecchio corso del fiume Adige.
Il pendolo in cui oscilla l’attività municipale è compreso tra la ricostruzione del passato e il rilancio verso il futuro. A gennaio il Consiglio comunale inizia a discutere la proposta dell’Azienda autonoma del turismo di costruire un lido nella zona della Bolghera, allora aperta campagna, su un terreno di proprietà comunale. È il luogo dove poi vengono costruite le piscine Fogazzaro (ora Manazzon): lo si immagina per turisti, per gli abitanti della città e per ospitare una colonia elioterapica per bambini. Se il Lido risponde a bisogni nuovi, di ben altra natura è la richiesta che arriva pochi mesi dopo dalla popolazione del quartiere di Piedicastello, di poter usufruire di un lavatoio pubblico, dato che le abitazioni sono in gran parte sprovviste di acqua corrente.
Nel verbale del 17 marzo 1952, nella discussione che riguarda il contributo alle istituzioni culturali, educative e musicali, il consigliere Bauer deplora che
questa voce, che dovrebbe avere un’importanza anche turistica ed economica, indichi un importo modesto. Nel suo intervento cita l’importanza che può avere la Società degli Alpinisti Tridentini (SAT) rispetto al turismo trentino e indica ad esempio le mostre di funghi e flora alpina realizzate dalla Società Operaia della Societa degli Alpinisti Tridentini (SOSAT), che sono state visitate da numerose comitive venute anche da fuori provincia. La discussione continua di mese in mese tra sprazzi di modernità e momenti di crudo realismo; alla riunione del Consiglio comunale del 29 maggio, l’assessora Ottilia De Nicolò tiene un lungo e articolato discorso per illustrare le difficilissime condizioni abitative in cui versano centinaia di famiglie: «il problema degli alloggi non si può limitare a una sola zona della città: abbiamo alloggi inabitabili negli scantinati di via Grazioli, dove meno si crederebbe, alla Cervara, nei ruderi della scuola media di via Esterle, negli interrati delle caserme Battisti, nei nostri sobborghi, abbiamo un sovraffollamento veramente impressionante in molti alloggi, con conseguenze inevitabili ai fini della salute e della morale. Convivenze strane create dal dopoguerra, che rovinano famiglie e la gioventù. Qui alla sede del comune arrivano ogni giorno vere invocazioni per un alloggio meno malsano, per una difesa fisica e morale di crea-
ture costrette a vivere in ambienti umidi e senza luce. Insegnanti, medici e sacerdoti denunciano la gravità del fatto. […] Il recente censimento ha dato numero di 106 famiglie con 264 persone abitanti in 98 «grotte», ossia locali senza finestre, senza servizi igienici, veri e propri antri».
Tra le macerie spuntano comunque anche le gru dei nuovi quartieri, progetti che culminano nella costruzione delle chiese che ospitano i parrocchiani e le parrocchiane. Quasi tutte le chiese storiche sono danneggiate dai bombardamenti –quella di San Martino è completamente distrutta – e gli edifici di culto edificati sono il suggello della costruzione di interi quartieri. È il caso ad esempio della chiesa di Cristo Re, la cui conclusione è annunciata come imminente dal giornale L’Adige il 20 giugno del 1952 e le foto ci mostrano in una selva di cantieri.
Il tema della carenza di abitazioni continua e ritorna più volte in Consiglio: sempre De Nicolò, invitata a intervenire il 29 settembre dell’anno successivo, sottolinea che «oltre cento famiglie con 4-5 figli vivono ancora in un’unica stanza senza alcun servizio igienico. Per l’assegnazione degli alloggi di via Giusti furono presentate 680 domande e di queste ben 480 rispecchiavano alla lettera situazioni di autentica inabitabilità. Il Comune di fronte a tante domande, ha potuto mettere a disposizio-
ne soltanto 54 alloggi, altri 19 alloggi saranno presto a disposizione mediante sopraelevazione del fabbricato comunale in via Bronzetti, 24 alloggi saranno presto assegnati a altrettanti dipendenti comunali, nel prossimo anno sorgeranno due altre case per senza tetto in località San Bartolomeo».
In questo contesto fatto di molti scuri e di qualche luce, il congresso del Club Alpino Italiano (CAI) previsto per la metà di settembre è indicato come un punto di riferimento nel calendario del 1952 già nel consiglio comunale del 12 marzo. Il sindaco Piccoli lo presenta ai colleghi dicendo che «si terranno in città quest’anno varie manifestazioni come il Congresso del CAI, della deputazione di storia patria… ci vuole un minimo di decoro per Trento, che deve essere presentata con una certa sobrietà e dignità».
Il congresso nazionale del CAI, coincide con gli 80 anni della SAT e con il nuovo progetto di cinematografia alpina, che però non viene citato nel verbale del Consiglio comunale. L’attenzione per questo evento, in un calendario cittadino segnato quasi solo dalle feste religiose, trova ragione anche nella matrice irredentista della SAT, un carattere che viene sottolineato nei commenti della stampa con una forza che travalica anche la natura di sodalizio sportivo dell’associazione. Il 16 maggio 1952, L’Adige comincia a pubblicare una
serie di articoli dedicati alla storia della SAT con un saggio edito anche sul Bollettino del Museo del Risorgimento. L’impegno del Museo per il congresso è anche espositivo e si annuncia l’apertura nel castello del Buonconsiglio di una sala temporanea «dove troveranno per il momento decorosa sede tutti i cimeli della gloriosa società che riguardano il suo passato irredentista a tutti noto». Il tono del discorso politico è ancora fortemente segnato dal nazionalismo, la retorica irredentista non sempre si distingue dalla mentalità respirata nei decenni della dittatura fascista. Nella seduta del Consiglio comunale del 29 maggio, il sindaco ricorda la recente scomparsa «del patriota trentino Ettore Tolomei», e l’assessore Marzani tiene un discorso ai colleghi, che lo ascoltano in piedi, in cui rammenta che «dopo le solenni onoranze, che per disposizione dell’onorevole De Gasperi, le furono ieri tributate a Roma, a spese dello Stato, la salma di Ettore Tolomei è transitata a Trento e ai piedi del monumento a Dante fu salutata con elevate parole dal nostro sindaco». Tolomei è stato l’artefice del processo di nazionalizzazione forzata della popolazione di lingua tedesca dell’Alto Adige/Südtirol, e viene ricordato da Marzani per «la sua vasta opera di studioso, predominantemente dedicata alla geografia e alla storia delle terre al confine settentrionale della patria. […] I problemi
dell’Alto Adige egli li vide da Roma e non dal Trentino e ripetutamente i suoi criteri e i sui propositi furono in aperto contrasto con i nostri e ne sorsero polemiche e dissensi». Applauso della sala. Già il 20 maggio viene pubblicato su L’Adige il programma del convegno del CAI previsto dal 14 al 21 settembre: vengono resi noti gli appuntamenti che si susseguono quasi ora per ora di ogni giornata, con una precisione da cronoprogramma. Le liturgie più importanti, quelle che coinvolgono le autorità, riecheggiano lo stile delle manifestazioni sportive filoitaliane dell’inizio del Novecento – quando Trento era parte dell’Impero austroungarico – con l’aggiunta dei luoghi che ricordano la Grande Guerra, già sacralizzati durante la dittatura conclusa da pochi anni. Il primo giorno comincia con il vermouth d’onore – il brindisi – in municipio, continua con l’omaggio sul dos Trento a Cesare Battisti, il banchetto ufficiale e la prima sessione del congresso, annunciata nella prestigiosa sala del Consiglio comunale. Alle 20.30 è programmato uno spettacolo all’aperto e dalle
21.30 viene annunciata la proiezione di film alpinistici nei locali cittadini. In una città abituata ad andare a dormire presto, viene spontaneo chiedersi quali siano questi bar, quale il pubblico e soprattutto cosa è proiettato, con quali tecnologie... purtroppo le cronache giornalistiche e gli archivi
non soddisfano questa curiosità.
La lettura della cronaca cittadina più spiccia, gli annunci degli eventi, aiuta a capire però che la scelta del cinema di montagna, in una città come Trento, ancora impegnata a risolvere i problemi più vistosi della ricostruzione, si poggia su un terreno quantomeno fertile.
Il 6 febbraio 1952 il quotidiano Alto Adige segnala che nella sede della SOSAT si tiene la proiezione per i soci di film di montagna. Anche la SAT organizza pochi giorni dopo una proiezione nei suoi «giovedì culturali»: il 13 febbraio nella sede di Trento, Sandro Conci tiene una conferenza con una proiezione dedicata al tema «8.000 metri, nuovo capitolo nella storia dell’alpinismo» Nella stessa settimana L’Adige comunica che l’associazione
Pro Cultura ospita Leonardo Ricci, dell’Istituto geografico universitario di Venezia, che interviene con una relazione dedicata ai ghiacciai, anche in questo caso corredata da una proiezione. Ma non c’è solo la montagna. Il 4 giugno 1952, L’Adige annuncia che il Circolo Al Caminetto aveva organizzato pochi giorni prima a palazzo Roccabruna il terzo convegno dei documentaristi trentini, che – si capisce dalla cronaca – si trovano ogni settimana per discutere di problemi tecnici. Gli autori dei cortometraggi a 8 mm sono Martino Alchner, Mario Albertini, padre e figlio, e Renzo Zampiero; in
quell’occasione sono proiettati anche documentari sonori 16 mm. Purtroppo non è stato possibile trovare altre informazioni di questo sodalizio, ma non si tratta dell’unica realtà del genere esistente. Sullo sfondo si muove anche il trentino Giuseppe Šebesta, che negli stessi anni inizia a produrre i primi innovativi cartoni animati e film.
Sempre dalla lettura de L’Adige si scopre che esisteva il Centro cinematografico trentino: il 22 marzo si tiene la proiezione al teatro di San Pietro di un film del regista francese Marcel Carnè, mentre vengono date per imminenti le pellicole Monsieur Verdeux di Charlie Chaplin (Stati Uniti, 1947) e Achtung! Banditi! di Carlo Lizzani (Italia, 1951); il circolo cittadino del cinema, proietta il 4 maggio, sempre al San Pietro, alcuni film di Jean Vigo «per la prima volta in Italia attraverso il circuito dei cine-club». Purtroppo anche per queste associazioni non sono stati trovati documenti capaci di illuminare maggiormente la loro esistenza. Sembrerebbero legate all’Associazione Universitari Cattolici Trentini, fondata in epoca asburgica e formalmente assorbita dalla FUCI, ma neppure le sparute pubblicazioni espressione di questo mondo hanno fornito informazioni utili sui loro gruppi dirigenti o sulle attività in ambito cinematografico. Queste tracce potrebbero indurre a credere che ci fosse in città un buon interesse per l’arte cine-
matografica in genere, una curiosità diffusa, un pubblico e anche qualche competenza tecnica e produttiva. Due anni dopo, alla fine del 1954, il presidente della giunta provinciale Remo Albertini invia a tutti i sindaci del Trentino una lettera in cui sollecita la raccolta di informazioni precise circa la presenza di locali per spettacoli, sale cinema industriali e parrocchiali, teatri. Il lungo elenco contenuto nella risposta del Comune di Trento comprende il cinema teatro Sociale (1.070 posti), i cinema Modena e Vittoria (rispettivamente 770 e 712 posti), il cinema Italia (580), Roma (650), l’Astra (800), il cinema-giardino in via Santa Croce aperto solo in estate (650), il Dolomiti (379 posti per tre giorni a settimana), il cinema San Marco, legato all’oratorio di San Bernardino (300), il cinema oratorio di Santa Maria Maggiore (280), il cinema teatro San Pietro (290) e il teatro oratorio del Duomo (290), questi ultimi definiti di carattere «parrocchiale, educativo e ricreativo». A queste sale si aggiungono tutti gli spazi dei sobborghi, dove le parrocchie dispongono di sale capaci di ospitare in media un centinaio di persone ciascuna (Fonte: Archivio storico del Comune di Trento, II.g.83/a 1954).
Le cronache de L’Adige e dell’Alto Adige descrivono un immediato entusiasmo nel pubblico per l’esperienza delle proiezioni del concorso cinema-
tografico della montagna del 1952, tanto che nei giorni seguenti compaiono su entrambi i quotidiani commenti positivi che invitano a continuare anche nei prossimi anni, auspicando sempre più la partecipazione internazionale. Gli articoli non descrivono purtroppo da chi era composto questo pubblico, se da anziani o giovani, se solo maschile o anche femminile, se di città o proveniente anche dai paesi limitrofi.
In un contesto urbano in cui la chiesa e i partiti politici assorbivano gran parte delle energie intellettuali presenti, e dove i cenacoli culturali erano poco numerosi e latamente controllati dall’occhio del parroco o del dirigente dell’Azione cattolica o della FUCI, quelle serate poco o niente segnate da una adesione politica o religiosa possono essere state delle vere boccate d’aria.
Il gruppo dirigente democristiano, capeggiato dal sindaco Nilo Piccoli, continua a tenere saldamente la maggioranza del consenso a Trento fino alle elezioni del 1964. I dati elettorali che vanno dal 1951 al 1964 descrivono una città controllata dal partito democristiano, supportato da maggioranze schiaccianti, che si ripetono anche a livello provinciale e nazionale. Nilo Piccoli è il protagonista della trasformazione di Trento da piccola e semidistrutta città tradizionale a città che inizia a giocare la carta del turismo, del terziario e a porre le
basi dell’università. Con le sue giunte, Piccoli cerca di mantenere il difficile equilibrio tra mutamento e continuità. Lo Statuto speciale di autonomia sottoscritto nel 1948, ha fissato in Trento il capoluogo della Regione. In un opuscolo edito dal municipio nel 1960, Memorie di Trento, dedicato a ricordare gli ultimi 10 anni della vita della città, si legge che lo status di «capitale» di una regione complessa per passato e composizione etnica, impone alla città un «dovere di responsabilità per un ideale di rappresentanza degli interessi regionali», «un capoluogo di Regione deve sostenere iniziative come quelle del Festival del film della montagna e dell’esplorazione».
Gli anni cinquanta trentini oscillano «tra slanci e diffidenze»: in cui si muovono la componente cattolica animata in larga parte da uno spirito difensivo, quando non clericale o antimoderno; l’AUCT (poi FUCI) e le ACLI, che avevano una più chiara distinzione tra il piano teologico e quello politico, più aperti e culturalmente rilevanti; il poco che rimane intorno alla galassia cattolica soffriva di una mancanza di autonomia dai partiti politici laici. In questa cornice, a tratti claustrofobica, si colloca la nascita della rassegna dei film di montagna, tra i pochi eventi «non allineati», che, dopo l’entusiasmo suscitato con la piccola edizione del 1952, diventa rapidamente sempre più importante an-
che a livello internazionale. Con il cinema documentario, il Festival traghetta la montagna nella modernità; fino a quel momento la montagna era stata quella dell’Alpenstock, del «vecchio scarpone» e dell’irredentismo. Quel territorio alpino che all’inizio del Novecento era stato dotato di un senso nazionale anche grazie alla SAT, rafforzando l’identità locale in opposizione al nazionalismo tirolese, che dopo l’annessione all’Italia aveva trovato nuovo significato nel repertorio dei cori alpini rielaborato da Luigi Pigarelli e Arturo Benedetti Michelangeli, ora, dopo la seconda guerra mondiale, poteva essere rilanciato verso il mondo esterno grazie alla competizione documentaristica. Si guarda al futuro ma con i piedi ben saldi nel cuore dell’identità locale, che continua a basarsi anche sulle vette, sui rifugi, sulle imprese dei campioni dell’alpinismo, ma che deve trovare un’interpretazione contemporanea, legata al nuovo tempo libero delle gite in Lambretta e soprattutto al turismo, anche internazionale. Oscilla tra conservazione e temerarietà anche la discussione che alla fine degli anni cinquanta anima le riunioni della Democrazia Cristiana relativamente al progetto di istituire l’università a Trento. All’interno del partito di maggioranza è consolidata l’idea di istituire una facoltà di agraria, capace di formare un’élite locale che potrebbe impiegare
le conoscenze pratiche acquisite per migliorare la produzione delle valli, senza allontanarsi troppo dal campanile. Nel già citato opuscolo Memorie di Trento, si legge che è in corso «con una Università italiana, la pratica per la istituzione a Trento di una laurea in scienze forestali ed economia montana, che risponde certamente a una esigenza vivissima dell’economia locale». Il progetto inaspettatamente tramonta, sostituito nel decennio successivo da quello più azzardato e sperimentale della facoltà di sociologia, propugnata e realizzata da Bruno Kessler. Il 24 aprile 1955, commemorando il decennale della fine della seconda guerra mondiale, su L’Adige si legge che «benché siano passati dieci anni, tutti si sentono più giovani, perché, solo che lo vogliano, possono ancora credere e sperare». Anche il Festival della montagna entra nelle speranze di una città che cerca nuovi modi di definirsi, di ritrovarsi e di conoscere il mondo attraverso lo schermo e gli ospiti che arrivano a Trento durante quelle giornate. «Città della montagna e dell’alpinismo – si legge ancora in Memoria di Trento – nell’esaltazione dei valori poetici, letterari, artistici e sportivi della montagna – di cui sono cospicue espressioni anche il festival del film di montagna, la Biennale del libro di montagna […] – Trento potrà anche coltivare il calore e la sobrietà di chi vive più vicino alle vette imbiancate».
Programmatore e consulente per diversi eventi cinematografici, tra cui il Trento Film Festival. Ha ideato e curato i programmi per il Cinema Ritrovato di Bologna, la Festa del Cinema di Roma, la Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, il Festival di Locarno; dal 2019 partecipa al comitato di selezione della Berlinale. Ha cofondato e dirige CineAgenzia, piattaforma di programmazione e distribuzione cinematografica. Vive tra l’Italia e la Germania.
La ricostruzione tra archivi personali e online delle origini del mio rapporto con il cinema di montagna mi porta all’amara constatazione di una coincidenza: né il cinema Astra di Trento, la sala dov’è nato il Festival nel 1952, nè l’Edison di Belluno, dove nel 1999 ho programmato le mie prime proiezioni «cine-alpine», esistono più. Non il più incoraggiante degli inizi per questo testo, ma indispensabile a ricordare quanto sia cambiato il panorama culturale, sociale e tecnologico in cui inquadrare la storia recente del Trento Film Festival: in questi due decenni sono passato dal preoccuparmi che tutti i rulli della copia di un film muto venissero sdoganati senza intoppi e arrivassero sani e salvi a destinazione per venire proiettati nell’ordine giusto su un proiettore modificato appositamente da un elettricista specializzato, a far apparire con un paio di clic i film che gli abbonati alla piattaforma InQuota vedono sui loro schermi. Pausa, e rewind, con un po’ di nostalgia: da bellunese folgorato dal cinema sulla via di Bologna, per la precisione del Dams e della locale Cineteca, il festival «Oltre le vette» nella mia città natale era stata l’occasione di riannodare i pezzi di una vita «fuorisede», condividendo i primi frutti della mia esperienza cinefila e cinetecaria bolognese nella sala che avevo frequentato nelle (rare) serate dedicate all’essai.
Pur di andare a caccia di film e copie, assistere un proiezionista insofferente, dare il benvenuto al pubblico e spegnere le luci osservando l’effetto dal fondo della sala, qualsiasi scusa era buona: anche la montagna!
Ritrovo online titoli e registi di quelle prime programmazioni, tra il 1999 e il 2001: Maciste alpino di Luigi Romano Borgnetto e Luigi Maggi (Italia, 1916), Intrigo internazionale di Alfred Hitchcock (North by Northwest, Stati Uniti, 1956), Narciso nero di Michael Powell e Emeric Pressburger (Black Narcissus, Regno Unito, 1947), Nosferatu il vampiro di Friedrich Wilhelm Murnau (Nosferatu, eine Symphonie des Grauens, Germania, 1922), I proscritti di Victor Sjöström (Berg-Ejvind och hans hustru, Svezia, 1918), Mariti ciechi di Erich von Stroheim (Blind Husbands, Stati Uniti, 1919), Due sorelle (Die Bergkatze, Germania 1920) e Lo scoiattolo (Kohlhiesels Töchter, Germania, 1921) di Ernst Lubitsch, le vues dei fratelli Lumière e i travelogues alpini di inizio Novecento... Saranno stati quelli a far ricordare a qualcuno a Trento che in un cassetto c’era il fax che lo stesso aspirante film programmer aveva inviato un paio di anni prima, dopo aver scoperto a Riminicinema nel 1996 il cinema «alpino» di Luc Moullet, per proporre al Festival una retrospettiva dedicata al regista e critico, figura unica e defilata del cinema francese?
È nel segno di Moullet, timidamente suggerito nel 1997 e finalmente accolto di persona nel 2022, che si dipana la mia storia con il Trento Film Festival, anche se in realtà la collaborazione inizia solo qualche tempo dopo: in una fase di ripensamento e rilancio della manifestazione fu Augusto Golin a chiedermi se mi occupassi ancora di cinema, se giravo sempre per festival, e potevo suggerire qualche titolo (non strettamente alpinistico, di quelli ce n’erano abbastanza) per una selezione che necessitava spunti e nuova linfa. La prima edizione in cui trovo traccia di almeno due cortometraggi che sono abbastanza certo di aver proposto, nel ruolo di consulente, è quella del 2004, l’anno della Genziana d’oro a La morte sospesa di Kevin Macdonald (Touching the Void, Regno Unito, 2003): sono Solo un cargador di Juan Alejandro Ramírez (Perù, 2003), scoperto a Rotterdam, allora tappa fissa dei miei percorsi festivalieri, e Portrait (Portret, Russia, 2002) di Sergei Loznitsa, regista che da allora ne ha fatta di strada, e nel 2022 ha portato ben due nuovi lungometraggi ai festival di Cannes e Venezia. Ma tra serata di apertura ed eventi speciali di quell’edizione ritrovo anche il proseguimento dell’interesse per il cinema muto e classico, che ora può godere di un palcoscenico come quello dell’auditorium Santa Chiara: l’impressionan-
te Grass di Merian Cooper ed Ernest Schoedsack (Stati Uniti, 1925), e una memorabile proiezione del musical Sette spose per sette fratelli di Stanley Donen (Seven Brides for Seven Brothers, Stati Uniti, 1954).
Citare il Santa Chiara a proposito di questa mia prima esperienza trentina è importante, perché proprio in quel 2004, a eccezione di questi eventi, per la prima volta il cuore cinematografico della manifestazione si sposta dalla grande (spesso troppo…) sala che dal 1988 ospitava le celebri proiezioni a ciclo continuo del Festival, divise semplicemente in fasce mattutina, pomeridiana e serale. Si inizia a usare la bella, pratica e ben attrezzata multisala Modena, i cui tre schermi, con relative platee di capienze diverse, permettono di iniziare ad articolare tra sezioni e orari diversi una programmazione sempre più ampia e variegata. Siamo in una fase di rapide trasformazioni, grazie a una presidenza e direzione dinamiche, aperte a nuove ipotesi, strategie e anche alla perplessità che un assiduo frequentatore di festival come me inizia a condividere, di fronte a certe abitudini: perché ad esempio non iniziare a programmare le proiezioni per fasce orarie, permettendo di scegliere un film e individuarne l’inizio, come si fa normalmente al cinema? Gli habitué sono spaesati (ma come, non basta più un unico biglietto per
passare tutto il giorno in sala?!), ma un pubblico nuovo si avvicina alle proiezioni, scoprendo che è possibile trovare film per gusti e interessi diversi, e addirittura capire quando poterli vedere!
L’anno successivo anche la tradizionale, prolissa, denominazione di Filmfestival Internazionale Montagna Esplorazione Avventura viene aggiornata, resa più pratica ad uso dei media e del web, negli anni in cui si diffonde internet: dal 2005 la manifestazione prende il nome attuale, Trento Film Festival. Quell’anno, ricostruendo il mio contributo alla 53a edizione, mi rendo conto che ero già molto più coinvolto: curo con Roberto Bombarda la retrospettiva polare «Ombre bianche»; invitiamo l’ex-Monty Python Michael Palin, attore comico, regista e viaggiatore, che presenta al pubblico i suoi documentari himalayani e l’esilarante Life of Brian (Regno Unito, 1979); proiettiamo (in pellicola!) due capolavori restaurati come Raining in the Mountain del regista King Hu (空山靈雨, Hong Kong-Taiwan, 1979) e Terra lontana di Anthony Mann (The Far Country, Stati Uniti, 1954); e in concorso e tra i premiati trovo titoli frutto di missioni e scoperte in giro per festival, arrivati a Trento come succederà sempre più spesso in anteprima italia-
na: La storia del cammello che piange (Die Geschichte vom weinenden Kamel, Germania-Mongolia, 2003), The Devil’s Miner (Berg des Teufels,
Germania, 2004) o il geniale mediometraggio In the Beginning Was the Eye (Im Anfang War Der Blick, Austria-Lussemburgo, 2003).
Quest’ultimo, film sperimentale realizzato dalla regista Bady Minck con tecniche miste che propone una illuminante lettura critica e visionaria del paesaggio alpino, premiato con una menzione speciale dalla giuria, è legato a un ricordo di quell’edizione, emblematico della fase che il Festival attraversava: al termine della proiezione, tra i tanti volti sorpresi, perplessi o entusiasti per la visione totalmente inattesa, anche quello particolarmente minaccioso di qualche spettatore che, individuatomi fuori dalla sala, mi affronta a muso duro protestando (ricordo addirittura un ombrello agitato… pioveva o la mia memoria esagera!?): «questi non sono film da Trento», «non è più il film festival di una volta», «non ci metterò più piede»… Che dire? Aveva ragione: il Festival stava cambiando, per «colpa» di Augusto Golin, di Maurizio Nichetti, e un po’ anche mia. Non fu l’unica occasione in cui ricordo vigorose lamentele, in nome di una presunta smarrita anima del festival, ma altrettanto ricordo facce nuove sempre più numerose, più donne e giovani in file ogni anno più lunghe, e commenti sorpresi, divertiti, talvolta entusiasti, all’uscita dalle proiezioni dello stesso Festival che tanti a Trento si erano
abituati a considerare un appuntamento solo per specialisti.
Il percorso intrapreso allora, e che dal 2010 mi vede nel ruolo di responsabile della programmazione cinematografica, è proseguito con l’obiettivo di elevare qualità e prestigio del programma e quindi lo status del Festival, a livello sia nazionale che internazionale, e di continuare ad ampliare lo spettro delle proposte, tenendo al centro la montagna, interpretata e raccontata attraverso il cinema non solo come scenario di sfide, drammi e conquiste alpinistiche, ma sempre più come ambiente complesso dal punto di vista sociale, ambientale, climatico, politico, culturale, umano. Tra la seconda metà degli anni zero e gli anni dieci molte proposte si sono confermate: oltre alla rinnovata centralità e ambizione del concorso, si sono ripetuti gli appuntamenti con il cinema muto e la musica dal vivo, con film come La febbre dell’oro (The Gold Rush, Stati Uniti, 1925), La signorina Else (Fraulein Else, Germania, 1929), Il gigante delle Dolomiti (Italia, 1927), The Great White Silence (Regno Unito, 1924), Visages d’enfants (Francia-Svizzera, 1925), e con il cinema classico, rigorosamente in versioni restaurate.
Allo stesso tempo si è cercato di fare spazio a nuove proposte e percorsi, come la vetrina di «Orizzonti vicini» pensata per dare visibilità al ci-
nema realizzato e prodotto in Trentino-Alto Adige/ Südtirol, dove sempre più attive sono state negli anni le film commission provinciali; o con le proiezioni cult a tarda sera di film di genere più o meno misconosciuti, come Il grande silenzio (Die grosse Stille, Germania-Francia-Svizzera, 2005), La montagna sacra (La montaña sagrada, Messico-Usa, 1973), Dead Mountaineer’s Hotel (Hukkunud Alpinisti hotell, Estonia, 1979), o quelli evocati nel giocoso format ibrido tra proiezione e presentazione
Le folli notti del Dottor Tyrol.
Ma la novità più corposa, duratura e apprezzata è stata la sezione «Destinazione», introdotta nel 2010 con un programma dedicato alla Finlandia, che da allora ha proposto con crescente successo un palinsesto di film, incontri ed eventi dedicato alla scoperta di un paese o territorio affini al Festival, invitando il pubblico a viaggiare con immagini, suoni, parole e sapori verso Russia, Turchia, Messico, India, Cile, Giappone, Islanda, Marocco, Georgia e Groenlandia.
Strategico nell’ampliamento del bacino di pubblico, e per la varietà e prestigio della selezione, è stato il consolidamento della sezione «Anteprime», con la sua proposta fuori concorso di lungometraggi di fiction selezionati dai maggiori festival, minoritaria per numero di titoli all’interno di ogni edizione, ma essenziale per poter includere
nel programma nomi e volti di grandi protagonisti del cinema internazionale.
Sono stati proprio i lungometraggi più attesi, le proiezioni evento (come i diversi film di Werner Herzog regolarmene passati a Trento), i sempre più spettacolari film di alpinismo e documentari naturalistici, a dimostrare a inizio anni dieci che anche la sala più grande del cinema Modena non era più sufficiente a soddisfare la domanda: dal 2014 si inizia così a utilizzare anche il cinema Vittoria, monosala d’altri tempi, ma restaurata per offrire il massimo comfort, che si afferma come lo spazio ideale per ospiti e occasioni speciali e per accogliere, con i suoi quasi 500 posti, un pubblico sempre più numeroso e partecipe.
Tra tanti film in concorso e no, premiati o delusi, amati o discussi, dal territorio o dagli angoli più remoti del pianeta, troppi per ricordarli qui, arriviamo all’edizione da record del 2019, che registra oltre 22.000 ingressi al cinema: sono affollate perfino le proiezioni proposte per la prima volta al mattino, l’occupazione dei posti totali disponibili sfiora l’80%, facendo immaginare che presto possa essere necessario aggiungere un nuovo schermo, e altre repliche, per soddisfare la richiesta e continuare a crescere.
Ma siamo al 2020: le tradizionali date tra aprile e maggio, in piena esplosione della pandemia di
Covid-19, costringono al primo spostamento del Festival da quando nel 1973 era stato ricollocato dall’autunno alla primavera, saltando l’edizione 1972. La corsa del Trento Film Festival, come quella di tutto intorno, inevitabilmente si arresta: la 68a edizione viene posticipata tra fine agosto e inizio settembre, pochi affezionatissimi e preziosi spettatori tornano per l’occasione in sala «fuori stagione», l’esperimento delle proiezioni all’aperto mitiga solo in parte l’effetto della disabitudine ai cinema, chiusi da mesi.
In nome della lunga storia del Festival, durante la quale gli schermi non si sono mai spenti, malgrado tutte le difficoltà non si rinuncia alle proiezioni, ma inevitabilmente ci si attrezza per ricorrere in parallelo allo streaming, proponendo l’intera selezione cinematografica anche online, per i tanti che ancora non se la sentono di tornare a partecipare, o che venivano a Trento da lontano, e ora non possono farlo.
Scopriamo così che il pubblico non è scomparso, anzi si è moltiplicato: spuntano migliaia di spettatori in tutta Italia, che conoscono e seguono il Festival e non vedevano l’ora di poterlo vivere, ma a cui le distanze, gli impegni, gli orari non avevano mai permesso di partecipare. Il momento più difficile, mentre intorno le sale chiudono e l’intero sistema cinema entra in una crisi che ha nella
pandemia l’ultima e forse più letale delle cause, si trasforma per il Trento Film Festival in occasione di speranza e rilancio progettuale, proprio alla vigilia del 70° anniversario.
L’ulteriore successo della programmazione in streaming anche nel 2021, questa volta affiancata a proiezioni più partecipate nelle date tradizionali, conferma che entrambe le strade possono essere percorse, ma anche che il vero Festival è nelle sale e nelle piazze della città, e nessuna tecnologia può replicare l’immersione in un evento, in un luogo, in un momento, insieme agli altri partecipanti, agli ospiti in presenza. Appena festeggiata la 70a edizione, con un festival più che mai ricco e di nuovo interamente dal vivo, e presenze che tornano a ricordarci l’affluenza a cui eravamo piacevolmente abituati, ci mettiamo al lavoro per lanciare insieme al CAI un servizio inedito per il mondo dei festival cinematografici italiani, e pionieristico anche a livello internazionale: InQuota.tv è una vera e propria piattaforma SVOD interamente dedicata al cinema di montagna, attiva tutto l’anno, che risponde alla richiesta di tantissimi appassionati e offre rinnovata visibilità ai film presentati al Festival, contribuendo al riconoscimento anche economico dell’impegno di registi e produttori. Non un «festival online», ossimoro che abbiamo imparato avere pochissimo
senso, ma un servizio che contribuisce a rendere il nostro lavoro sempre più rilevante tutto l’anno, a ragionare in modo necessariamente innovativo su fonti di finanziamento e modalità di coinvolgimento del pubblico, a immaginare come in futuro l’evento in presenza possa beneficiare dell’impatto che il Festival genera online.
Ero partito da Luc Moullet, il desiderio e la promessa di presentare i suoi film a Trento mi hanno accompagnato durante questi 20 anni, e con lui dunque chiudo: abbiamo scoperto che da giovane critico era venuto due volte al festival, nel 1963 e 1964, e che dopo la prima visita aveva pubblicato sui leggendari Cahiers du Cinéma gialli, palestra critica della nouvelle vague, un corposo e illuminante resoconto in forma di saggio su cinema e montagna. In occasione della 70a edizione abbiamo invitato il cineasta e montagnard francese di nuovo a Trento per un meritato tributo e abbiamo tradotto per la prima volta quel testo in italiano: si intitolava Nécessité de Trento. Credo, crediamo, che quel titolo allora profetico sia più che mai valido; lavoriamo, lavoreremo, perché continui a restarlo.
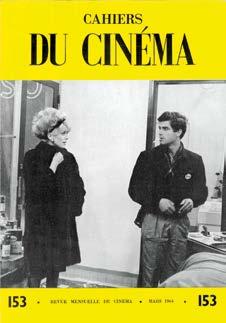
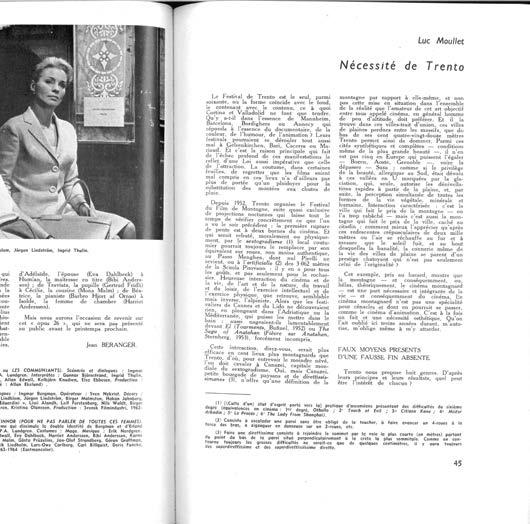
Scrive per il Corriere della Sera. Ha esordito nella narrativa nel 1980 con Amore mio uccidi Garibaldi, seguito nel 1983 da Casa di guerra e nel 1991 da Di buona famiglia con il quale ha vinto il Premio Campiello. È del 2021 un suo libro di racconti, Tutti i miei uomini. Tiene una rubrica settimanale sull’edizione milanese del Corriere e un forum di conversazione («Così è la vita») sul Corriere on line. È presidente del Bagutta, il più antico premio letterario italiano.
E sono 70. Gli anni di Festival. Della sua storia non parlerò perché altri lo hanno fatto (e lo faranno). In questi 70 anni è cambiato il Festival, è cambiata Trento, siamo cambiati noi e sono cambiate le montagne, sulle quali, tanto per fare un esempio del cambiamento, la neve cade molto più raramente che 70 anni fa. Ecco, vorrei parlare delle montagne, della cultura delle montagne cui è dedicato questo Festival e perché questa cultura ci deve essere cara e preziosa: preziosa, anzi preziosissima anche dal punto di vista economico.
Dario Franceschini ha scritto un libro intitolato Con la cultura non si mangia?, seguito da un punto di domanda, interrogativo retorico ovviamente, quasi una risposta a quello che un ministro per l’economia categoricamente aveva affermato qualche anno prima: con la cultura non si mangia, e la frase era seguita da un punto fermo. Frase che a molti di noi sembrò un controsenso, l’annuncio di una sconfitta, di una rassegnazione all’autogol perché in un Paese come l’Italia che dell’intreccio tra arte, bellezza, storia, paesaggio ha fatto da secoli un tratto della propria identità, la cultura può e deve essere non solo una leva di crescita civile e democratica, ma un fattore strategico per uno sviluppo economico sostenibile, una chiave possibile, in particolare ora, dopo la pandemia e le sue con-
seguenze sanitarie e sociali, per iniziare a scrivere il dopo, con uno sguardo lungo, dotato di respiro. «Investire in cultura non è soltanto un dovere sociale ma anche, insieme, un’opportunità economica» afferma l’ex ministro, ma noi gli crediamo e vorremmo che a credergli fossero numerosissimi tra gli uomini che possono decidere, dagli amministratori locali fin su ai parlamentari e ai ministri. Essendo la cultura, è oggetto fragile, delicato che, e affinché renda – e mi scuso per la volgarità del termine –, va trattato con precauzione dovendo fare i conti con il livello di scolarizzazione del pubblico, oltre che della situazione economica dei luoghi. È di sicuro più facile far rendere un’arena sportiva che non un museo, una località sciistica che non un sito archeologico. Per fare sì che la cultura diventi anche un volano economico bisogna studiare, lavorare, inventare vie nuove, anche inaspettate: e viene in mente il direttore degli Uffizi che in giorno di chiusura ha invitato la regina delle influencer, Chiara Ferragni, a visitare le sale per il grande scalpore di molti. Risultato? Gli Uffizi sono stati nello scorso anno il museo più visitato d’Italia, superando perfino i Musei Vaticani. Con la cultura si può mangiare. Chiediamolo a Mantova il cui festival letterario ha dato fama alla città attirando tra le sue mura turisti di tutto il mondo, anche quelli che di letteratura sanno poco o nul-
la, e il tutto grazie all’iniziativa di un libraio pieno di passione per il suo lavoro. Chiediamolo a Bilbao che prima del museo Guggenheim era una cupa, triste e povera città di provincia mentre ora, grazie al gran numero di visitatori del museo, ha cambiato faccia, restaurato i suoi palazzi e aperto ristoranti: da anni visitarla è diventato un must Chiediamolo a Salisburgo il cui festival musicale ha una straordinaria forza di attrazione, tale da far accorrere tutto l’anno non soltanto fedeli appassionati di musica.
E chiediamolo anche a Trento che nel suo piccolo sperimenta la stessa realtà: e cioè che con la cultura si può mangiare. L’università di Trento è risultata anche nel 2022, per la ricerca, la migliore d’Italia. Ovvio che questo risultato non potrà che far crescere la città perché verranno nuovi studenti e nuovi professori che faranno ulteriore nuova ricerca, valanga che rotola e si ingrossa. E poi c’è il nostro Festival del quale possiamo osservare la crescita, la notorietà, la forza d’attrazione, capace di trasformare la nostra città tradizionalmente percepita come sonnolenta e chiusa, in un centro vitale e vivace, luogo di visioni e riflessioni sulle terre alte del pianeta e palcoscenico di grandi imprese sportive e umane. Con anche un importante merito politico: essere riuscito a coinvolgere Bolzano, il nostro per lo più separatissimo
capoluogo gemello, che da anni ormai ospita una sezione del Festival.
Cosa abbiamo in comune noi cugini delle due Province? Moltissime cose ovviamente ma una in particolare, impossibile da negare o bypassare: le montagne, la cultura delle montagne, cultura da tenere cara, da coltivare, da salvare là dove è minacciata, e minacciata purtroppo lo è. Non è un caso se il Club Alpino Italiano ha da poco lanciato l’allarme sui megalavori programmati per le olimpiadi invernali del 2026, Milano Cortina. La nostra regione ne sarà forse risparmiata ma lo sfruttamento fino all’osso della montagna, l’oblio della sua secolare cultura, riguarda anche noi e da molto vicino. E proprio su questo tema mi è stato chiesto di scrivere sul Corriere della Sera, segno che la minaccia comincia a farsi sentire e che c’è più bisogno che mai del nostro Festival che da tempo non si limita più a celebrare le grandi imprese di scalatori ed esploratori ma affronta sempre più di frequente necessarissimi temi ambientali.
Le montagne sono la nostra vita: il panorama di bellezza che ci accompagna dalla nascita, l’imprinting che ci caratterizza, il luogo dell’avventura, ma anche risorsa e protezione, ombra ora benevola ora rischiosa, sempre prezioso deposito di fiabe e leggende.
Allo stesso tempo siamo noi che possiamo decre-
tarne la morte, o se non proprio la morte almeno la decadenza, l’imbastardimento, l’impoverimento. La strada per riuscirvi si è fatta breve negli ultimi anni, forse addirittura brevissima, e il vitello d’oro cercato, corteggiato, adorato è lo sfruttamento turistico, vena aurifera intorno alla quale ci si affanna in modo spasmodico, rischiando di perdere di vista cosa il turista davvero desideri, il turista di domani fondamentalmente, quello dal quale dipendono le stagioni a venire.
Di nuovo viene in mente la cosiddetta «riminizzazione» della montagna della quale si era già parlato negli inverni del pre-covid, e cioè di quella smania di trasformare le piste in parchi del divertimento con rifugi che sparano musiche a mille e festeggiano happy hour di massa, dove lo sport diventa quasi secondario, dove il silenzio delle cime è soltanto un bel ricordo, dove la montagna e il suo incanto sembrano ridursi a una semplice questione di dislivello e poco altro.
La domanda che sorge è quanto tempo ci metterà il turista a disamorarsi dei luoghi. E quando sarà stufo di sentirsi tradito, turlupinato, sia pure, almeno da principio, consenziente? Quando si deciderà di mandare al diavolo il parco giochi, la musica a mille e gli happy hour in quota e tornerà a cercare (altrove) quel silenzio, quel raccoglimento, quell’incanto che la montagna gli aveva
promesso? La scommessa verte su questi tempi che potranno essere lunghi o brevi ma che, anche favoriti dai due anni di pandemia, prima o poi probabilmente arriveranno. E ci toccherà pensare alla favola della cicala e della formica. Rischia di succedere lo stesso nella stagione estiva più che mai dedicata ai grandi appassionati di montagna, scalatori ed escursionisti a piedi o in bicicletta. Ecco i resort di superlusso che promettono qualsiasi felicità: e fin qui va benissimo, poi però un poco si resta sconcertati dalla decisione di piantare palme e scavare un lago artificiale destinato a evocare atmosfere tropicali, quasi volessero far dimenticare il panorama vero che attende fuori. Ed ecco i rifugi che, bisognosi di ristrutturazione, rischiano di finire sfigurati, del tutto fuori contesto rispetto all’ambiente in cui sorgono. Succede un po’ lo stesso in certi quartieri di città dove le archistar costruiscono sensazionali palazzi futuribili, senza tenere conto del circondario, magari formato da un insieme di villette liberty Ovvio che non si vuole un palazzone nel medesimo stile, però ne piacerebbe uno che in qualche modo richiamasse i caratteri della zona alla quale vuole appartenere.
Normale, comprensibile e anche benvenuto il
desiderio di mettersi al lavoro, di osare percorsi inediti dopo due anni difficili per il turismo, ma di nuovo, come per la «riminizzazione» invernale, si deve temere per quella estiva. Oltre ai resort con atmosfera tropicale e ai rifugi di vetro e cemento vengono in mente le allucinanti code di automobili lungo i passi delle nostre due province, guidate da turisti per forza di cose più impegnati a evitare tamponamenti che a godere dell’abbagliante panorama offerto dalle cime. E ancora una volta è difficile evitare la domanda che sta in agguato: fino a quando tutto questo piacerà al turista che cercava la montagna, il suo silenzio, la sua maestà, la sua misteriosa forza di attrazione? Fino a quando, anche, piacerà a noi che le montagne intorno abbiamo sempre chiamato «nostre» heimat come dicono nella provincia gemella. Non è una questione di passatismo, di nostalgia per i bei tempi andati, con la pace di tutti il «vecchio scarpone» è definitivamente fuori servizio. Quello che, tuttavia, si vorrebbe evitare è che le nostre montagne si trasformino in quinte di cartone o, meglio, in video proiezione senza più vita né realtà, da servire ai turisti come sfondo insapore delle loro vacanze. Sarebbe questa una strada breve e senza via d’uscita.
Geografo, giornalista e professionista della montagna, dal 2016 responsabile della comunicazione di Montura e delle attività culturali (libri/film/eventi) e sociali di Montura Editing. Già consigliere regionale del Trentino Alto Adige/Südtirol e già membro del Comitato delle Regioni dell’Unione Europea. È stato consigliere e direttore organizzativo del Trento Film Festival.
Può capitare che una persona incontri e alle volte intrecci il proprio destino con quello di un’associazione, o di un’istituzione. A me è capitato per 40 anni con il Trento Film Festival. Quando avevo circa 20 anni, quello che all’epoca si chiamava «Festival internazionale della montagna, esplorazione, avventura» si materializzò davanti ai miei occhi come una sorta di «fabbrica dei sogni». A quell’età, come ha scritto anche Manolo, ci si sente immortali e qualunque attività appare possibile. Figurarsi che cosa può accadere quando un giovane montanaro, appassionato di geografia, incontra il gotha dell’alpinismo mondiale, miti in carne e ossa, e film che uniscono l’adrenalina con lo spettacolo. Tempi nei quali il Festival era per me l’appuntamento atteso per l’intero anno; la tessera dei film che si otteneva a metà prezzo grazie all’università veniva interamente bucherellata; e non c’era appuntamento importante che non mi vedesse seguirlo trasognante. Parliamo dell’inizio degli anni ottanta: la corsa alla collezione degli Ottomila era nel vivo, Reinhold Messner aveva appena salito l’Everest da Nord senza ossigeno dando alle stampe il meraviglioso Orizzonti di ghiaccio; in Patagonia, gli italiani salivano in estate e in inverno il Grido di Pietra; Arco e Bardonecchia accoglievano le prime competizioni di arrampicata, mentre Patrick Edlinger e Patrick Berhau-
lt danzavano sulle falesie francesi del Verdon; a Trento Emanuele Cassarà promuoveva incontri su incontri per discutere se i vocaboli avventura ed esplorazione avessero ancora un senso, mentre Ulisse Marzatico costruiva con «Traudi» De Concini lo straordinario contenitore di MontagnaLibri, poi sviluppato da Luana Bisesti. Bolzano affiancava Trento e il Club Alpino Italiano (CAI) nella compagine sociale e io avrei aggiunto anche Innsbruck e le rispettive università. Che anni formidabili, con i film di Herzog, Dickinson, Diemberger, Mariani… Pochi anni dopo, forse intuendo il mio entusiasmo per un evento che portava il mondo in Trentino, proiettando a sua volta questa piccola terra ovunque – «per parlare a tutte le montagne della Terra», come scrisse Mario Rigoni Stern – Roberto De Martin, all’epoca presidente del CAI, propose il mio nome per il consiglio direttivo. Risposi: «A disposizione!». Non era mia abitudine rispondere così, tanto che mi chiesi subito se avessi dato l’impressione di essere uno yesman, un militare, o un gesuita in partenza per la Cina. Tant’è. All’epoca ero poco più che trentenne e credo di essere stato per un po’ di tempo uno dei consiglieri più giovani della storia del Festival. Furono anni molto interessanti e impegnativi, al fianco di presidenti, consiglieri, direttori molto esperti che mettevano grande impegno per mantenere Trento sul piedistallo raggiunto, facen-
do i salti mortali per far quadrare i conti. Era ancora un festival, mi si permetta il termine, «artigianale», con tutte le accezioni positive di questo termine. Ma anche con i limiti che questo assetto avrebbe potuto comportare in una dimensione internazionale.
Con questa vettura arrivammo nel 2002 alla 50a edizione, in contemporanea con le celebrazioni per l’Anno internazionale della montagna proclamato dall’ONU. Fu un’edizione giustamente memorabile, che portò a una profonda riflessione sul futuro. Io ero all’epoca nella cosiddetta «età di mezzo», quando si dovrebbe essere sicuri di se stessi, trasmettendo la stessa sicurezza agli altri. Io non mi sentivo proprio così: ma in un momento di difficoltà del Festival, di ritorno da un viaggio in Patagonia accettai la richiesta di Italo Zandonella Callegher per guidare pro-tempore il festival nella 51a edizione. Per la seconda volta rispondevo: «A disposizione!». Questa volta avrei potuto essere più consapevole delle conseguenze della decisione, vista l’età più matura. Posto che la 50a edizione era stata dura come doppiare Capo Horn, la 51a si dimostrò come quello che segue al superamento del limite meridionale del Sudamerica: si entra nell’Oceano Pacifico, che come sanno i navigatori è tutt’altro che «pacifico». Davanti c’è l’infinito, le forze naturali sono immani e ci si sente piccoli e sperduti. Ecco,
io mi sentivo più o meno così, alla faccia della sicurezza che avrei dovuto trasmettere agli altri. Ma siccome dalla famiglia, di secolare civiltà contadina, ho ricevuto il talento di saper piegare la schiena con pochi lamenti, mi misi all’opera in piena sintonia con il consiglio e con due «fratelli maggiori» come Italo Zandonella ed Elio Caola, quest’ultimo all’epoca vicepresidente, creando una cordata affiatata e affidabile. Così portammo a casa anche la 51a – per la cronaca vinse il Gran premio Alberto Iñurrategi con il poetico Your Himalayas (Spagna, 2003), dedicato al fratello Felix – ponendo le basi di uno sviluppo che negli anni seguenti avrebbe visto il Festival uscire in parte dalla strettoia delle infinite diatribe tra avventura ed esplorazione, tra città e montagna, per diventare ancor più di prima un luogo dedicato a raccontare il mondo, con i suoi patrimoni di natura e cultura.
Anche quell’edizione fu indimenticabile, come per certi versi lo sono state tutte: io serbo un ricordo indelebile di una giuria di giganti, presieduta da Spiro Dalla Porta Xydias, e della serata del primo maggio 2003 con Reinhold Messner, dedicata ai 50 anni dalla prima salita dell’Everest. Se la ricordano probabilmente anche le 500 persone che non trovarono posto all’Auditorium Santa Chiara di Trento (situazione che dall’anno successivo portò a una radicale riorganizzazione delle serate), ma io stavo comunque peggio di loro: trascorsi infatti la notte
in ospedale… Da quell’anno Messner inanellò una serie di serate che avrebbero illuminato come le perle di una preziosa collana la storia del Festival. Dopo alcuni anni di incomprensioni, il suo fu un grande ritorno, propiziato da Loris Lombardini che organizzò a castel Juval un piacevole incontro. Aggiungo un altro aneddoto (il Festival è ricchissimo anche in piccole storie): Reinhold rinunciò al proprio cachet per destinare l’importo a un progetto di solidarietà in Equador.
Fu proprio in seguito alla 51a edizione che si attivò la convenzione con la Provincia autonoma di Trento, ridefinendo anche le modalità del sostegno dei soci fondatori: per la prima volta il Festival diventava anche «imprenditore», assumendo in proprio il personale – alcune figure, oggi fondamentali per l’attività del Festival, come Rosanna Stedile, Tommaso Gabrielli e Laura Zumiani entrarono nello staff proprio nel 2003 – impostando diversi contratti e collaborazioni, individuando nuovi filoni di interesse per il pubblico. Ricordo quando, davanti a un fumante piatto-Pedavena, io e Michele Andreaus proponemmo a Michele Kettmaier, innovatore del web che all’epoca collaborava a Milano con Maurizio Nichetti, di chiedere al regista la disponibilità a entrare in giuria, dopo che negli anni precedenti era stato giurato a Berlino e Cannes, portando così una visione del cinema ancor più aperta e internazionale e non propriamente legata
ai contenuti della montagna. Insomma, forse non ce ne rendevamo conto, ma stavamo proiettando il Festival nel nuovo millennio. Saranno i posteri a giudicare se questo sia stato uno dei momenti di svolta nella storia del Festival. L’epoca di grande trasformazione era data anche dalla prorompente diffusione di internet, rete destinata a cambiare tutte le organizzazioni, tanto che con una mia piccola rivista online, Born to walk, offrii a mie spese per un paio di edizioni un nuovo premio, la «Negritella d’oro» (per restare in tema con le «genziane» del concorso cinematografico e con i «ranuncoli» un tempo assegnati al concorso fotografico) al «miglior sito internet dedicato alla montagna». Un’esperienza purtroppo esauritasi forse per eccessivo anticipo sui tempi... Con un altro fulmine a ciel sereno avvenne poco tempo dopo la mia elezione nel Consiglio regionale/provinciale di Trento. Per effetto di una norma che io nemmeno immaginavo si palesò la cosiddetta «incompatibilità» tra i due ruoli. Ciò non mi impedì di programmare l’edizione del 2004, poi condotta egregiamente in porto dal collega consigliere Augusto Golin. Ma negli anni successivi avrei potuto assistere solo da spettatore, non mancando mai nei momenti più importanti e contribuendo ad assicurare, per quella che era la mia funzione, il sostegno pubblico a un Festival che anno dopo anno usciva dagli schemi dell’appuntamento an-
nuale per assumere la statura di una vera e propria istituzione, operante tutto l’arco dell’anno. Di quegli anni ricordo, tra gli altri, i progetti per una versione on-line del concorso cinematografico e la mia proposta per l’ingresso nella compagine sociale delle Camere di Commercio di Trento e di Bolzano, per coinvolgere anche l’imprenditoria privata della regione nello sviluppo del Festival. Ma pure un format che anche oggi sarebbe particolarmente attuale come «Montagne di Pace», contenitore di eventi ideato dall’allora assessora comunale alla Cultura di Trento, Micaela Bertoldi. L’ultima tappa di questo mio viaggio, che s’intreccia con quello del Festival, ha il nome di un’azienda, originale e rivoluzionaria come il suo fondatore, Roberto Giordani. Parlo di Montura, leader nel settore dell’outdoor, che da 15 edizioni sostiene il Festival e che è diventata anche uno dei main sponsor. Questa volta non fu necessario manifestare la «disponibilità», poiché per lavoro ho avuto anche il compito di affiancare il Festival fin dalle fasi preparatorie di ciascuna edizione, cercando di portare contributi per arricchire la già ampia offerta festivaliera.
Nel frattempo la Trento «città del Concilio» è diventata la «città dei festival», uno più interessante dell’altro: dall’economia allo sport, dal vino spumante al teatro. Ma un Festival, per me, vale ancora sopra tutti. Quello che un tempo si chiamava
il «Festival della montagna»: forse perché entrato ormai nel sangue di tanti appassionati, forse perché si occupa dal 1952 di temi particolarmente affini con le caratteristiche del territorio e cari alla popolazione locale.
Il Festival non è più quello di 70, 50, o 30 anni fa. Non è cambiato solo il cinema: sono cambiati anche il modo di viaggiare e di scoprire il mondo; ma anche come raccontarlo, nei film, sui libri, nel web o tramite i canali social. Sarà così anche in futuro, tra 20, 30 o 50 anni. Il Festival vive continuando a rinnovarsi, a inventare nuove formule, a presidiare culturalmente nuovi territori. E se vi è un senso, una missione che il Festival ha sempre avuto e dovrà mantenere è senz’altro quella dell’incontro tra le persone, di diversa età, provenienza ed esperienza. Perché un festival è soprattutto conoscenza e condivisione. Come scriveva 30 anni fa Franco de Battaglia nel libro In cima al mondo: «L’importante è che il Festival torni a essere punto di incontro delle esperienze singole, composizione delle lacerazioni e degli individualismi, momento di denuncia anche. Una cordata di esperienze, uno stare insieme. A costo di lasciar andare per la loro strada chi non ci sta… La montagna ha bisogno di visioni corali». Corale è senz’altro l’International Alliance for Mountain Film, che ho visto nascere e alla quale auguro lunga vita, perché dalla cooperazio-
ne non possono che uscire vincenti tutti i soggetti aderenti. Europeista convinto, avrei visto volentieri anche la nascita di un progetto europeo per una rete forte dei festival dei Paesi UE. Ma lasciamo fare al tempo e alle persone di buona volontà… Quale futuro attende il Festival e quale sarà il mio rapporto con esso, dopo gli anni da spettatore, dirigente, sostenitore, rappresentante dello sponsor? Per il futuro mi piacerebbe vedere un Festival impegnato ancora di più nella sua veste educativa, rivolta in particolare alle giovani generazioni. Come una “scuola” vera e propria. Il festival arriverà ai 100 anni e oltre. È il mio auspicio. Ma i traguardi temporali ai quali le istituzioni possono ambire spesso non si addicono alla natura umana e per me sarebbe già un sogno poter festeggiare tra alcune edizioni, al Campo Base, i miei decenni di Festival, anche da semplice spettatore. Nei prossimi anni potrei quindi completare la mia esperienza chiedendo al Festival di potermi unire ai volontari, visto che mi sono sempre trovato a mio agio in mezzo ai giovani. Forse perché, prendendo a prestito il titolo del libro pubblicato da Eugen Guido Lammer proprio 100 anni fa, ora che sono prossimo ai 60 anni il Festival rimane per me, così come per molti dei miei coetanei, un’inesauribile «fontana di giovinezza».

Ricercatore presso la Fondazione
Museo storico del Trentino, si occupa dello studio del paesaggio come fonte della storia, con attenzione particolare alle trasformazioni che hanno interessato il Trentino e l’Arco alpino. Su queste tematiche ha scritto diversi libri e saggi, curato mostre e format televisivi. Con Sara Zanatta ha curato la mostra Scalare il tempo. 70 anni di Trento Film Festival. Giornalista pubblicista, gira il mondo in bicicletta e scrive dei suoi viaggi.
Compagni di cordata: così, dopo un sodalizio che celebra i 70 anni, si presentano il Festival della montagna e la città di Trento. Negli anni cinquanta, il Festival nasce come manifestazione e si afferma gradatamente come istituzione, contribuendo a fare di Trento la capitale locale e internazionale della cultura e del cinema di montagna.
Fin dalle origini – era il 1952 – il Festival e la città si sostengono l’un l’altra. La cordata che li unisce è anche un’alleanza politica e culturale per gettare ponti tra il passato, il presente e il futuro dell’alpinismo. La cordata, quella che crea atmosfere, ha il profumo delle strade cittadine e il magnetismo che si respira quando la rassegna entra nel vivo nelle sale e nelle piazze. L’alleanza, quella che fa politica e cultura, assume invece i caratteri della geografia e della storia. Da una parte la geografia umana, che mette in relazione i luoghi con le popolazioni che li hanno abitati. Dall’altra la storia delle comunità, nella consapevolezza che, per agire sull’ambiente, l’uomo si pone in dialettica con l’ambiente stesso.
Così si scopre il rapporto tra la città di Trento e il Festival della montagna: la città con le sue «geografie» e il Festival con le sue «storie». Due riferimenti, uno di un geografo e l’altro di uno storico, aiutano a spiegare questo rapporto. Il primo è di Edward Relph, paesaggista e
geografo canadese contemporaneo, maestro nel sottolineare l’apporto delle azioni culturali dell’essere umano nei processi di attribuzione di senso ai luoghi: «I luoghi possono diventare significativi attraverso le relazioni sociali, ma i luoghi speciali aiutano a creare anche relazioni significative». La seconda è dello storico Lucien Febvre, tra i fondatori della scuola degli Annales, caposaldo della storiografia del secolo scorso: «nelle relazioni tra le società e l’ambiente l’uomo prende e restituisce al tempo stesso, l’ambiente dà ma riceve anche». Con queste coordinate storiche e geografiche è cresciuto il Festival in un racconto lungo 70 anni, affermandosi come luogo di incontro tra persone e Paesi differenti. Dal 1952 a oggi, il Festival della montagna è stato, al tempo stesso, interprete e destinatario di queste narrazioni storiche e geografiche. Quelle del passato e del presente. Ma anche quelle del futuro. Ne è nata una manifestazione/istituzione che ha saputo innovare, esplorare nuove tendenze e nuovi scenari, anticipare i cambiamenti, promuovere la cultura dell’ambiente e del mondo alpino a 360 gradi mediante l’uso di diversi linguaggi e sensibilità: l’alpinismo, l’arrampicata, l’avventura, l’esplorazione, il cinema, la fotografia, l’arte e l’editoria di montagna.
La capacità di cogliere molteplici sguardi, di restituirli e di valorizzarli, tematizzarli e anticiparli, ha
fatto del Festival un luogo di riflessione sulla montagna e ha fatto della città di Trento un punto di incontri e di confronti.
In tutte le edizioni del Festival, Trento ha svolto un ruolo centrale: non solo una questione di superficie, dato che il nome della città si trova nel nome della rassegna, ma anche una questione più sostanziale, poiché legata al rapporto tra i luoghi e le persone e alle profondità di tale rapporto. Le relazioni tra il luogo e gli individui che lo popolano contribuiscono a costruire le caratteristiche con cui il luogo stesso si presenta. L’aspetto dei luoghi, infatti, è una caratteristica importante di tutti i paesaggi.
Nelle giornate della rassegna, Trento si cambia d’abito e si «veste a festival». L’abito che indossa, fatto anche di atmosfere, non è casuale e fornisce la prova tangibile della concentrazione di una serie di attività umane geograficamente riconoscibili che esprimono intenzioni, volontà, propositi e aspettative. Ricco di significati, quell’abito rispecchia lo spirito della rassegna e alcune peculiarità della città. In filigrana, potessimo stendere le giornate del Festival come tante veline al sole, ci ritroveremmo alcuni tra i principali elementi identitari di Trento. E fra di loro, la vocazione alpina del capoluogo, in «conversazione» continua con il Trento Film Festival.
La reciprocità di relazioni tra la città e il Festival si esprime attraverso la duplice valenza fisico-naturalistica e storico-culturale del territorio e il loro rapporto, come una porta a doppio ingresso, incontra le aspettative della geografia umanista. Invitandoci a riflettere sui legami tra i luoghi e le popolazioni, David Lowenthal, tra i fondatori di questa disciplina, ci ricorda l’importanza delle «relazioni tra il mondo esterno e le sue immagini contenute entro le nostre teste». Lo studioso americano, storico e geografo, si esprimeva così nel 1961, in un articolo dal titolo Geography, experience and imagination: towards a geographical epistemology
C’è una domanda che descrive il significato di questi studi, caratterizzata da una grande attenzione allo «spazio vissuto» in contrapposizione con lo «spazio neutro»: l’attaccamento a un luogo, sia per coloro che lo abitano sia per coloro che amano frequentarlo occasionalmente, è determinato più da fattori di tipo sociale e personale o più da fattori di tipo materiale, cioè le caratteristiche fisiche che quel luogo possiede? Almeno per quanto riguarda la «nostra» storia festivaliera, potremmo rispondere che l’identità alpina della città di Trento si nutre del Festival e viceversa. Pensiamo alla frase, solo apparentemente banale: «Trento città del Festival».
Nei confronti dei tanti che giungono a Trento nelle giornate del Festival, coloro i quali si trovano in città per vedere il Festival, oppure vi inciampano incidentalmente, ma pure nei confronti di coloro che abitano la città, la rassegna ha esercitato una profonda influenza sulle modalità con cui il territorio è stato percepito e viene percepito. Il territorio, incarnando i percorsi di vita e le aspirazioni di una comunità, porta con sé l’insieme di simboli, di segni e di valori che quella comunità esprime. E ciò nonostante, tale simbologia può necessitare dell’intervento di un «intermediario» per essere meglio compresa. Il Festival, partendo da alcune caratteristiche date dalla «Trento città alpina», ha svolto esattamente questo ruolo. Grazie anche alla portata internazionale della manifestazione, il Festival ha contribuito a valorizzare alcuni elementi identitari del territorio che, già parte integrante del tessuto connettivo culturale della popolazione, hanno trovato una vasta eco e un’ampia diffusione fuori dal Trentino.
Promuovendo un messaggio di internazionalità e conciliazione, il Festival ha incoraggiato e favorito «geografie comuni» e «storie comuni», anche in momenti difficili, quando la polarizzazione degli anni della guerra fredda divideva il mondo in blocchi contrapposti. Nel nome della cultura del cinema di montagna e della montagna, le tante
bandiere presenti al Festival, dalle prime edizioni fino alle più recenti, raccontano di una rassegna che si è spinta oltre il significato dei film proiettati, diventando una finestra sul mondo. Nel ruolo di precursore, il Festival ha posto al centro queste evidenze. Come quando, in passato, ha puntato i riflettori sulle politiche della tutela dell’ambiente e della sostenibilità, per una montagna che possa sopravvivere alla cultura dell’eccesso. O come quando ha posto l’attenzione sulla montagna al femminile. O quando, ancora, ha spostato l’accento sulla complessità del mondo alpino e sulle vite dei montanari, le economie di montagna, l’isolamento alpino, lo spopolamento e più in generale il volto delle terre fragili, dalla cultura materiale a quelle orale e letteraria. Un ragionamento aperto sulla montagna e sulle montagne, sull’alpinismo e sugli alpinismi, sul cinema e sulla fotografia, sul bisogno di raccontare e di documentare.
L’alpinismo è rimasto il cuore del Trento Film Festival, ieri come oggi; con le grandi imprese di un tempo, le prime ascensioni di vette inviolate, l’epopea degli Ottomila ma anche la scoperta delle profondità sotto gli oceani o l’esplorazione dell’orizzontale nei deserti, la ricerca di vie di salita sempre più difficili e, in tempi più recenti, le nuove sfide dei concatenamenti con il cronometro alla
mano e la corsa ininterrotta verso il superamento di ogni record. Eppure, a fianco di questi fili narrativi, la montagna è emersa al Festival a tutto tondo, a tutte le sue quote, a tutte le sue latitudini e longitudini, protagonista di antropologie, filosofie, sociologie, economie. Protagonista, più semplicemente, di storie di vita e di soggettività. Protagonista, in un mondo sempre più globalizzato, di una storia di territorio che conserva ancora le proprie radici nella città di Trento.
Da alcuni decenni – va pur sottolineato – il Festival, non per inadeguatezza ma poiché la società è diventata estremamente più complessa e diversificata, esercita un impatto minore sull’opinione pubblica locale ed è meno incisivo nel portare avanti quella politica di sensibilizzazione culturale verso temi legati alle specificità identitarie del territorio trentino. Negli anni cinquanta e sessanta c’era solo il Festival che parlava di montagna. Poi, le fonti di informazione, diffusione e produzione di contenuti culturali sulla montagna si sono enormemente moltiplicate e decentrate fino all’esplosione di internet, dei social e delle web tivù.
Peraltro, va altresì evidenziato che la rassegna ha saputo ulteriormente rafforzare il suo ruolo a seguito della crisi che ha recentemente interessato l’editoria di montagna in campo alpino. In ambito bibliografico, abbiamo assistito alla progressiva
scomparsa di quasi tutte le riviste di settore e la sensibile riduzione delle piccole case editrici di editoria alpina. Luogo di confronto prediletto per discutere dell’alpe e delle Alpi, il Festival di Trento è diventato così ancora più prezioso nell’esercitare quel ruolo da protagonista che, fin dagli esordi, lo ha visto impegnato in un’ampia riflessione sul mondo alpino. Questo, non soltanto in relazione alla straordinaria crescita che ha conosciuto la rassegna dell’editoria MontagnaLibri, ma anche per quanto riguarda la capacità del Festival di creare momenti di dibattito sulle Alpi attraverso linguaggi differenti: il cinema, il cineforum, gli incontri con il pubblico.
In tutto questo, la montagna è emersa come un «topos culturale», non soltanto come un «topos geografico». Tanto più che oggi, nella società iper-positivistica in cui viviamo, dove tutto è misurabile, la montagna ha assunto confini topografici sempre più precisi, ma si sta perdendo il senso di ciò che è la montagna, di quello che in montagna si può fare e di quello che non si può fare. Ciò che
In piazza Dante a Trento nel 1960 (foto di Flavio Faganello; Soprintendenza per i beni culturali della Provincia autonoma di Trento).
manca, sempre più spesso, è la consapevolezza dei significati della montagna, delle sue rappresentazioni e dei limiti dell’azione umana nei suoi confronti.
L’Ottocento e il Novecento sono stati i secoli che ci hanno fatto scoprire le montagne: le abbiamo viste, scalate, bombardate, filmate, abitate, abbandonate e raccontate. Nel tempo che viviamo ci resta invece di capirle meglio e di comunicarle. Questa è la responsabilità a cui siamo chiamati ora. Non soltanto in ragione delle sfide climatiche che ci attendono, ma anche e soprattutto per la progettazione di un futuro della montagna che tenga conto dei bisogni veri delle comunità che le abitano, dei loro diritti all’autodeterminazione e del rapporto tra di esse e la città. A 70 anni dalla nascita del Festival, ci si aspetta e ci si augura che questa manifestazione e la sua città possano ancora e per lungo tempo continuare a svolgere questo loro compito: essere luogo privilegiato di dibattito per comunicare la montagna.

LUANA BISESTI
Dopo diversi anni passati a Milano, dove ha ricoperto ruoli organizzativi e di insegnamento presso il Politecnico, è rientrata a Trento, sua città natale, e ha cominciato a collaborare con il Trento Film Festival occupandosi della rassegna MontagnaLibri. Nel 2002 ne è diventata la curatrice e dal 2011 ha assunto il ruolo di direzione dell’intero Festival. Dal 2013 fa anche parte della giuria del Premio Itas del Libro di Montagna.
Quasi per caso cominciai a lavorare al Festival 25 anni fa, seguendo la segnalazione di una conoscente secondo cui l’ente era alla ricerca di una persona appassionata di libri e scrittura per la Rassegna internazionale dell’editoria di montagna. Ammetto che non avevo mai frequentato la manifestazione prima di allora. La conoscevo poco e soprattutto attraverso i racconti di mia nonna Giuseppina, che mi aveva narrato il «suo» Festival, ovvero la rassegna degli anni cinquanta: la trepidante attesa della città, la mobilitazione di tanti volontari impegnati nell’organizzazione, i trionfali arrivi degli ospiti, le bandiere estere in piazza Dante, le automobili con le targhe straniere, le sfavillanti serate al teatro Sociale, le gite fuori porta, il clima di scoperta e curiosità, la consapevolezza che Trento diventava una finestra sul mondo. Un quadro frizzante, di eleganza e internazionalità, che avrei ritrovato nelle foto di cronaca esposte nella sala riunioni del Festival che ancora oggi, come numi tutelari, ci fanno sognare e ci ispirano durante ogni incontro.
A fine gennaio del 1995 arrivai così negli uffici del Festival per incontrare l’allora direttore Gianluigi Bozza; in un’atmosfera apparentemente disordinata, vivace e informale si stava lavorando alla 43a edizione.
Al termine di un breve quanto rilassato colloquio, uscii dalla sede del Festival con la testa piena di immagini, quelle colorate dei poster e quelle in bianco e nero di Mario Fantin appese in segreteria, e soprattutto con la convinzione che quello fosse uno dei pochi luoghi della città in cui, all’epoca, si respirava un’aria cosmopolita, lavorando con tutto il mondo.
Avrei affiancato Wolftraud de Concini nell’organizzazione della 9a Rassegna editoriale: all’allestimento, al contatto con gli editori, alla raccolta e catalogazione dei libri per il catalogo trilingue, italiano-inglese-tedesco. L’appuntamento editoriale era ormai diventato un importante punto d’incontro per quanti si occupavano del binomio montagna-libro e aveva trovato una sua identità e autonomia evidenziata non solo dal catalogo, utile strumento bibliografico editato fino al 2008, ma anche da una locandina concepita ad hoc per la sua promozione.
La «Prima Mostra Internazionale del libro di Montagna e di Esplorazione» si era tenuta nel 1956 nel palazzo Pretorio di Trento, organizzata dal comitato ordinatore. La seconda edizione, che la configurò come manifestazione biennale di contorno e di integrazione al Concorso cinematografico internazionale dei film della montagna e dell’esplorazione, vide la luce nell’autunno del 1960 e fu
allestita presso l’università popolare di Trento. Nel 1962, la terza edizione, sempre all’università popolare, introdusse la peculiarità della mostra, ovvero quella di esporre solo le novità editoriali pubblicate negli ultimi 15 mesi dagli editori di tutto il pianeta. Nel 1987, dopo oltre 20 anni di interruzione, ricompare la mostra editoriale allestita nello spazio foyer del centro culturale Santa Chiara con il nome di «1a Rassegna Internazionale dell’Editoria di Montagna».
700 volumi provenienti da editori europei ed extraeuropei, raccolti all’ombra dello schermo del più importante Festival al mondo del cinema di montagna, la storia dell’alpinismo e delle montagne raccontata dai libri, dopo essere stata narrata per 35 anni attraverso la pellicola.
I libri sono tanti, più delle cime del mondo, non tutti capolavori, non tutti sinceri: guide, manuali, studi, monografie, libri fotografici, reportage e diari, romanzi, libri per ragazzi, biografie e autobiografie; moltissime pagine da leggere, per chi è interessato a capire cosa succede «in alto».
La rassegna vuole dimostrare che la montagna non è fatta solo di cime da conquistare, pareti rocciose da scalare, sentieri da percorrere, tramonti e fiori e animali da fotografare, ma è un mosaico composto da tante tessere, piccole e grandi, in cui trovano posto pubblicazioni che a un primo
sguardo sembrano lontane dalla gloria delle cime vittoriose e dalla retorica dei monti ma si occupano del macrocosmo «montagna». Un universo ricchissimo di sfaccettature, quello presentato nella mostra editoriale, una montagna che va ben oltre i molti cliché, limitati e ripetitivi, in cui molto spesso è costretta.
La rassegna continua a crescere negli anni, il suo palinsesto si arricchisce con mostre tematiche, la presenza delle librerie antiquarie della montagna e un programma di incontri con l’autore e di presentazioni di libri sempre più ricco e articolato. Semplifica il suo nome in MontagnaLibri e, nel 2002, per la 50a edizione del Festival, concomitante con l’anno internazionale delle montagne, si presenta con il record di libri ed editori partecipanti. Siamo alla 16a edizione, e io, sostituendo Wolftraud de Concini, ne divento la curatrice e, per tutti, la «signora dei libri» che cerca, seleziona, raccoglie, custodisce e accompagna la mostra nel suo tour delle cittadine alpine, tra cui Bolzano, Belluno e Briga.
Mentre MontagnaLibri si conferma come una fucina di idee e proposte per una profonda e corretta conoscenza della montagna e della sua realtà culturale, cresce anche il mio ruolo, sempre più autonomo, organizzativo e programmatico. La mia presenza negli uffici del Festival, da sporadica
e limitata a pochi mesi, diventa costante e continuativa. Aumenta la conoscenza della struttura, dei suoi tempi, dei suoi ritmi, dei suoi preziosi archivi, delle persone che vi lavorano: Daniela, Stefano, Giorgio, Laura, Annarosa, Alberto, Beatrice, Rosanna e tanti altri e altre. Ho conosciuto e lavorato sempre proficuamente con i direttori che si sono succeduti, Gianluigi Bozza, Antonio Cembran, Roberto Bombarda, Maurizio Nichetti, e con molti presidenti, Claudio Visintainer, Italo Zandonella Callegher, Egidio Bonapace, Roberto De Martin e Mauro Leveghi.
Con Egidio Bonapace, mi viene proposta la direzione del Festival. Cerco di mettere a frutto quanto, da interna, ho appreso sull’organizzazione: le sue risorse umane, il suo patrimonio culturale, i suoi valori, le sue potenzialità ma anche le sue fragilità. Coltivando relazioni, passioni, entusiasmi, credendo nei giovani e nella loro crescita e investendo sulle professionalità, si è via via strutturato uno staff che si è evoluto assieme alla rassegna, condividendo con essa la filosofia della partecipazione, della riflessione e della sperimentazione. Da sempre il Festival non si è limitato a raccontare e conoscere le montagne solo attraverso il mezzo cinematografico, ma si è consolidato come un luogo di incontro tra le persone e tra le culture. Relazioni che vanno ben al di là di tutto ciò che viene
proposto dal programma e diventano stimoli attorno ai quali creare discussioni e partecipazione per parlare di presente ma anche di futuro.
Senza dubbio il Festival mi ha cresciuta tanto, professionalmente e umanamente, e mi ha dato l’opportunità di confrontarmi con storie incredibili, emozionanti, spesso estreme, e di conoscerne i protagonisti, il loro lato umano ancor più di quello pubblico. Riccardo Cassin, Mario Rigoni Stern, Cesare Maestri, Reinhold Messner, Catherine Destivelle, Erri de Luca, Walter Bonatti, Lynn Hill, Kurt Diemberger, Mauro Corona, Philippe Daverio, Tommy Caldwell, Alex Honnold, Nives Meroi, Hervé
Barmasse, Tamara Lunger, Simone Moro e numerosi altri nomi, tutti grandissimi, ma pur sempre uomini e donne come noi, come me.
Importanti anche gli incontri con gli artisti del manifesto del Festival, passaggio creativo per eccellenza ma anche segnale di inizio di una nuova edizione. Ogni artista è sempre riuscito a stupirmi per come ha rappresentato il Festival: Gianluigi Rocca, Guido Scarabottolo, Philip Giordano, Albino Rossi, Gianluigi Toccafondo, Milo Manara, per citare solo gli ultimi nomi della prestigiosa e lunga galleria delle affiche festivaliere. Ciascuno, con l’originalità del proprio linguaggio, ha dimostrato grande sensibilità e profonda empatia verso la rassegna sia interpretandone l’essenza sia cogliendone il tratto
più contemporaneo o innovativo. Il Festival è un «laboratorio», un luogo culturale di narrazione delle montagne, delle terre alte ed estreme del pianeta, dove vanno in scena i grandi cambiamenti, molto più evidenti che in pianura o in città. Uno spazio in cui esplorare nuovi scenari, nuovi immaginari ma anche in cui cercare e sperimentare nuove forme di linguaggio, di dialogo e di condivisione con il pubblico per creare umanità e vivere esperienze uniche da ricordare, assaporando le «mode» e anticipando le nuove tendenze. Tanto tempo è passato dal 1952 quando nacque il Festival, grazie alla lungimirante idea del Club Alpino Italiano e del Comune di Trento di portare in una piccola e decentrata città alpina la possibilità di scoprire il mondo attraverso il cinema e, attraverso il cinema, farsi scoprire. Una grande intuizione quella di pensare a un Festival tematico, tutto dedicato alla montagna e alle sue storie, incardinato all’identità e al territorio trentino ma sorprendentemente «avanti» nel volersi aprire al mondo. Il linguaggio cinematografico venne scelto come mezzo per raccontare e conoscere le montagne, quelle vicine e quelle lontane; il cinema, inteso come spazio, divenne luogo e momento di ritrovo, di condivisione e di discussione ma anche di scoperta e di conoscenza di altre culture.
L’editoria di montagna è protagonista al Festival del 1962.
Il trovarsi assieme davanti al grande schermo, uniti per vivere un’unica esperienza, idealmente come in un «campo base», è divenuto nel tempo un modo per creare gruppo, fare comunità.
Il Festival, ieri come oggi, è sempre riuscito ad attrarre numeroso pubblico nei suoi luoghi simbolo: i cinema Astra, Modena, Vittoria, i teatri Sociale e Auditorium, e gli spazi della convivialità come Cantinota, Forst, Pedavena e il «mitico» Campo Base. Intercettando generazioni diverse, tramandando di padre in figlio l’abitudine a esserci, è riuscito a creare una «comunità della montagna» unita nei valori e negli interessi.
Grazie al cinema, alla letteratura, alla fotografia, all’arte, alla musica e al teatro, ha documentato l’evoluzione tecnica, cinematografica e alpinistica, ha esplorato nuovi scenari, nuovi immaginari, ha promosso la sostenibilità e la cultura dell’am-
biente, ha anticipato cambiamenti e temi sempre attuali, raccontando di natura e di popoli, di montagne come luoghi di vita e di vite.
Il Festival è simbioticamente cresciuto con la città di Trento diventandone elemento identitario, un appuntamento annuale che l’ha consacrata internazionalmente come capitale della cultura di montagna. Nel tempo si è trasformato da manifestazione a istituzione basandosi su un progetto culturale di ampio respiro e sulla sua grande duttilità nell’affrontare le tematiche della montagna, sapendo anche intercettare prontamente le esigenze di socialità e la voglia di conoscenza del pubblico.
In 70 anni molto è cambiato, ma la centralità del Festival di essere luogo e momento di incontro e confronto tra persone, culture e paesi differenti è rimasta intatta.

Studioso ed esperto di cultura delle montagne, autore di numerosi saggi sul settore e curatore di oltre 200 pubblicazioni. Direttore del Museo Nazionale della Montagna «Duca degli Abruzzi» di Torino dal 1978 al 2018. Dal 2000 al 2018 ha coordinato l’International Alliance for Mountain Film (IAMF).
Nella primavera del 1980 i periodici del Club Alpino Italiano (CAI) annunciavano, come ogni anno, il «rito» del Festival che sarebbe iniziato da lì a poco. «Anche quest’anno una settimana da non perdere!» scriveva Lo Scarpone sul numero del 16 marzo 1980. «Ancora non sappiamo niente dei titoli dei film presentati, ma basta una scorsa al programma delle diverse manifestazioni per vedere che ce ne sarà di tutti i gusti». Sulla copertina del notiziario CAI, campeggiava il manifesto di quell’anno, sicuramente inusuale, che portava a dimensione affisso una notissima figurina commerciale Liebig del 1897: il soggetto Wanderung in Thal, della serie Eine Bergparhtie. Il cartellone scelto era il segno di una positiva dimensione vissuta dalla manifestazione trentina, un continuo rimando tra il cinema, la comunicazione della montagna e il collezionismo colto, naturalmente oltre agli exploit alpinistici e alle tematiche di settore. Tutte doti che si rispecchiavano nel direttore Piero Zanotto, giornalista raffinato dai poliedrici interessi.
A quell’edizione – io che non mi ero mai cimentato con un festival – arrivai in rappresentanza del Museo Nazionale della Montagna di Torino, che dirigevo da appena due anni, con l’esposizione temporanea Arte e architettura del Nepal, accompagnata dal primo cahier Museomontagna, una collana che avrebbe in poco meno di
quattro decenni, sotto la mia guida, raggiunto i 190 titoli. Per me si aprì un mondo nuovo, tanto che da allora i miei ritorni annuali, senza assenze, si susseguirono con regolarità, e continuano ancora oggi. Piero Zanotto divenne un amico e un «fedele» collaboratore del Museomontagna e io, passo dopo passo, cominciai a «respirare l’aria» del Festival. Tra le collaborazioni di Zanotto ricordo il cahier, Le montagne del cinema, del 1990, che aprì nuove visuali alla documentazione storica del settore. Con il Museo a Trento, per quasi 40 anni, presentai mostre e libri, partecipai a eventi e incontri, ma non è questo il luogo per elencarli. Soprattutto, cercai sempre di osservare e di capire la portata e il significato di ciò che stava accadendo. Con il trascorrere del tempo mi occupai sempre di più del settore – fino ad arrivare alla cura del monumentale Dizionario Museomontagna, Cinema delle Montagne, 4000 film a soggetto (UTET, 2004) – e iniziai a «vagare» tra i diversi festival. Nelle manifestazioni a cui presi parte, incontrai esperienze diverse e tentativi di affermazione che guardavano a Trento, ma cercavano anche nuove strade. Ovunque la rassegna trentina era vista come un riferimento e come un’esperienza ineguagliabile, e tutti andavano ad assistere al «rito» annuale, come se si trattasse di un pellegrinaggio. Inoltre c’erano già Autrans, Banff, Les Diablerets, San Sebastián,
Telluride, Teplice nad Matují, per citare solo quelli già nati all’inizio degli anni ottanta. In seguito, nel corso dello stesso decennio, si aggiunsero i festival di Antibes, Kendal, Torelló. Poi arrivarono tutti gli altri, mentre alcuni, per varie ragioni, cessarono la loro attività; questa cronologia è pubblicata in IAMF Portrait, appendice nel volumetto Una Storia di passione 2000-2020, stampato per i 20 anni dell’IAMF.
Grazie al mio ruolo di direttore del Museomontagna, ai contatti internazionali e all’attenta «produzione» di esposizioni (anche itineranti) – oltre a eventi e iniziative di diverso tipo –, venni via via coinvolto da molti festival. Per alcuni di essi collaborai anche alla nascita e all’affermazione. Ma questo dettaglio è poco importante, ai fini di questo contributo scritto. La cosa che mi preme sottolineare, invece, è che, partecipando in prima persona alle varie manifestazioni, respiravo l’aria delle diverse realtà, capivo i loro interessi e le loro aspettative, acquisivo nuove aperture. Comunque mi resi sempre conto che tutti guardavano al Festival di Trento come a un evento ineguagliabile, in alcuni casi solo per sentito dire e senza aver mai partecipato.
I festival si rivolgevano al Museo per semplici consigli o ci coinvolgevano con maggiore energia, e a poco a poco ci accorgemmo che stava nascendo
in maniera spontanea una rete (non codificata) di scambi e di collaborazione. Grazie a questa reciprocità di interessi, chi scrive ha fatto parte di oltre 15 giurie, nel 1996 è stato nominato consigliere del Banff Centre for Mountain Culture – struttura di riferimento del locale festival canadese – e per un breve periodo ha anche fatto parte della Commissione Cinematografica del CAI. Parallelamente, ebbi modo di collaborare con le principali emittenti televisive europee, che in quegli anni ospitavano regolari trasmissioni sulla montagna e sull’alpinismo; ho anche vissuto la felice stagione delle sedi regionali RAI, ricche di produzioni e nuove esperienze. Tutti evidenti segni di reciprocità e di apertura.
A Trento, parallelamente, cominciai a riscontrare delle piccole incertezze: dietro la dichiarata (e reale) dimensione internazionale appariva sempre anche l’altra faccia della medaglia, spesso un po’ troppo locale. Il mio è un giudizio che si basa solo su sensazioni e sulle esperienze vissute quale spettatore. A Trento, infatti, non ho mai ricoperto ruoli ufficiali, non ho mai fatto parte delle annuali giurie internazionali; solo dopo aver lasciato la direzione del Museomontagna, per un mandato, dal
2018, ho fatto parte del direttivo.
Questo aspetto, con ogni probabilità, per me è stato un bene: mi ha permesso di osservare l’evolversi
del Trento Film Festival con un occhio distaccato, senza lasciarmi condizionare da coinvolgimenti diretti. Così, ho potuto assistere al cambio dei direttori e dei presidenti con la dovuta distanza, anche se in alcuni casi con rincrescimento. Pertanto, credo di aver avuto modo di comprendere bene le potenzialità e le criticità della kermesse trentina. Il Festival di Trento, a mio giudizio, ha sempre avuto grandi potenzialità internazionali, che tuttavia non sono state sfruttate del tutto; anzi, per anni dall’interno non sono state considerate come avrebbero meritato. Per fare un esempio, solo negli ultimi vent’anni i direttori o i presidenti si sono confrontati con gli «altri mondi» degli altri festival. E, guarda caso, quando le cose sono cambiate, i risultati non sono mancati. Nel momento in cui si è registrata la giusta apertura verso l’esterno, il successo non si è certo fatto desiderare. Un esempio che va sottolineato con forza, a questo proposito, è stata la nascita di un progetto di grande respiro, quello dell’International Alliance for Mountain Film. Un’iniziativa che delineò davvero un orizzonte nuovo, ampio e importante. In quell’occasione, da un lato io operavo a Torino, dall’altro Antonio Cembran, allora direttore, si muoveva a Trento, ed ebbe un ruolo fondamentale.
In poco più di 20 anni, l’IAMF ha cambiato il modo di confrontarsi, di coinvolgersi. Ma, come nei primi
anni della sua storia, è rimasta una rete di «amici», rispettosi delle prospettive di ciascuno, sempre pronti a sostenere gli altri nei momenti di difficoltà. Anche se la recente pandemia ha creato insormontabili blocchi nei contatti diretti riducendo la presenza fisica e creando (forse) qualche cambio di indirizzo.
Dal momento della fondazione dell’IAMF si sono susseguiti quattro presidenti: Antonio Cembran fu il primo, seguito da Mireille Chiocca, da Joan Salarich e ultimo, da poco riconfermato, Javier Barayazarra; e ci sono stati due coordinatori; prima lo scrivente e, oggi, Marco Ribetti. Hanno aderito 31 realtà (alcune delle quali non fanno più parte dell’Alleanza), in rappresentanza di 5 continenti (per gli elenchi e le cronologie rimando al già citato IAMF Portrait). Una grande macchina costruita in pochi anni grazie a basi consolidate nel tempo. «Le premesse risalgono al 1999. Per un anno furono lanciati segnali, idee appena abbozzate che un po’ alla volta presero forma e diventarono sollecitazioni», ricorda Sandra Tafner in Una storia di passione, volume ufficiale dell’IAMF – scritto avvalendosi dei ricordi di Aldo Audisio, Antonio Cembran, Mireille Chiocca, Joan Salarich, e di altre testimonianze –, a cui farò riferimento riportando varie citazioni (il volume Una Storia di passione 2000-2020, Torino 2020, con il testo di Sandra Tafner e le crono-
logie a cura di Aldo Audisio, è consultabile online. In quell’anno «il presidente Claudio Visintainer e il direttore Toni Cembran pensarono di promuovere una riunione […] per parlare delle rispettive esperienze e dei problemi organizzativi. Un modo di riflettere ad ampio raggio […]. Viene inviata una lettera per un incontro informale». Vengono anche raccolte molte manifestazioni d’interesse per creare qualcosa – l’idea non era ancora chiara. «In quell’occasione a Trento dunque si parla di tutto, di quello che si poteva fare, di quello che si doveva fare. Non vengono prese decisioni, alla fine, se non quella di risentirsi. Toni Cembran commenta ‹Ci lasciammo con la sensazione che ognuno di noi non sarebbe più rimasto chiuso […] e facendo squadra con altri avrebbe costruito qualcosa destinato a dare nuovi e grandi risultati›». L’idea del presidente e del direttore e l’azione del Trento Film Festival erano state da tutti valutate positivamente. Poco meno di un anno dopo, c’è un cambiamento di scena, da Trento ci si sposta a Torino: il 4 e 5 febbraio 2000 su mio invito, in accordo con Antonio Cembran, convergono al Museomontagna al Monte dei Cappuccini i direttori dei principali Festival, accompagnati da altri rappresentanti. Per Autrans (Francia) Mireille Chiocca e il presidente Jean-Pierre Jodon; Bernadette McDonald per Banff (Canada); Valeriana Rosso per Breuil-Cer-
vinia; Robert Schauer per Graz (Austria); Marco Grandi per Lugano (Svizzera); Pierre Simoni per Les Diablerets (Svizzera), Joan Salarich per Torelló (Spagna); Antonio Cembran con il presidente
Claudio Visintainer e Antonella Cicogna per Trento; e infine lo scrivente, con Angelica Natta-Soleri e Marco Ribetti, per l’Italia, con il Museo Nazionale della Montagna di Torino. Un bel gruppo per un inizio promettente. Il 5 febbraio viene ufficialmente costituita l’IAMF. «C’è una foto di quell’incontro in cui si vedono sorridere i rappresentanti delle nove istituzioni che per prime si legarono a quella cordata a cui, anno dopo anno, si sono aggiunti molti nuovi partecipanti.
Oggi i membri sono 28, il numero si è triplicato, ma l’obiettivo comune rimane quello di allora: promuovere, valorizzare e conservare la cinematografia di montagna».
Il sogno iniziato con grande impulso a Trento si era concretizzato, una dichiarazione d’intenti univa realtà di diversi nazionalità di cui era presidente Antonio Cembran e coordinatore lo scrivente (che affiancherà tre presidenti e sei consigli direttivi).
L’evoluzione fu rapida e il 7 dicembre 2001, ad Autrans, con il rafforzamento di nuove adesioni, venne depositato l’atto di formale costituzione davanti a un notaio di Villard-de-Lans: la sede legale venne costituita a Autrans, quella organizzativa a
Torino. «Firmando i documenti davanti al notaio in Francia», racconta Cembran, «mi rendevo conto dell’importanza di quello che avevamo fatto. Non era più un patto tra amici ma qualcosa che ci impegnava fino in fondo».
Poco dopo a Trento cambiarono gli scenari e i grandi entusiasmi verso l’IAMF cominciarono progressivamente ad affievolirsi. Per questioni legate allo stato giuridico-associativo – difficili e poco interessanti da riassumere in poco spazio – dopo tante discussioni, nel 2005 il Trento Film Festival uscì dall’Alleanza tra lo stupore e il dispiacere di tutti, comunque in piena libertà di scelta. «Un disastro» ricorda Chiocca, ormai diventata presidente, «facevamo un passo indietro perdendo questo socio, ma noi continuammo […], anche se non pochi furono i momenti di tensione».
Nel 2006 l’Assemblea decise di dotare l’Alliance di uno statuto, le sedi legali e operativa vennero unificate a Torino e il 24 luglio con Mireille Chiocca firmavo il nuovo atto costitutivo e lo statuto davanti a un notaio torinese, dopo il voto unanime raccolto a Breuil-Cervinia il precedente 22 luglio.
Intanto a Trento si risolsero i dubbi e si chiarirono
le posizioni, e nel 2007 il Festival presentò formalmente la richiesta di rientrare e di venire riammesso mantenendo il privilegio di socio fondatore.
Da quella data Trento è di nuovo parte fondamen-
tale dello sviluppo dell’associazione, luogo privilegiato di incontri e contatti. Oggi nessuno torna più alle vicende del passato. Ciononostante, fervente sostenitore dei valori e delle potenzialità del Festival trentino, ho sempre cercato di programmare un’apertura sul mondo. Non sarebbe stato corretto fare di Trento la sede «fissa» delle assemblee; pur nelle difficoltà sarebbe stato bene muoversi su sedi diverse, tant’è che per un terzo degli anni di vita dell’IAMF, si sono svolte assemblee anche in altre località italiane o estere. Non certo per un’azione politica contraria alla rassegna trentina ma per la necessità di far sentire tutti parte di una grande avventura e farla condividere da tutti. Nulla resta da aggiungere al valore dell’idea dell’Alliance nata a Trento e formalizzata a Torino. Ormai in qualità di membro d’onore, mi sento di dare il consiglio di rivolgere sempre grande attenzione politica alle aree geografiche, alle proposte da condividere. Oggi in queste scelte è garanzia Roberto De Martin, che da poco ha iniziato il secondo mandato di vicepresidente dell’IAMF, appunto in rappresentanza del Trento Film Festival. In questi giorni ho letto il numero di Montagne360
di agosto 2022, al cui interno compare il portfolio Ciak, si scala! Cinema di alpinismo e arrampicata dedicato alla mostra presentata a Trento in occasione dell’edizione del 70°. Il percorso espositivo prende spunto dal libro omonimo, curato da Roberto Mantovani. Un volume importante, un progetto non casuale, che dimostra il grande ruolo svolto dall’International Alliance for Mountain Film nel promuovere la capacità di associarsi, di aprirsi, di confrontarsi. Ricordo, infatti, la proposta mia e di Angelo Schena il 30 ottobre 2017 all’assemblea IAMF a Banff (Canada). Tra qualche perplessità, l’idea di realizzare un nuovo libro con il CAI, Museomontagna e IAMF venne accolta e ridiscussa il successivo 1° marzo 2018 a Domžale (LubianaSlovenia). Ci mise mano Roberto Mantovani come autore, si fecero nuove valutazioni in varie occasioni, si definirono i contenuti – nel frattempo io lasciai il Museo e cambiarono i vertici IAMF –, il progetto editoriale e grafico si concluse, il libro venne presentato a Trento ed è diventato una mostra, ancora nella stessa località, e poi a Torino. Come sarebbe stata possibile un’operazione simile senza l’International Alliance for Mountain Film?
Sociologa, lavora presso la Fondazione Museo storico del Trentino come ricercatrice e divulgatrice. Si occupa di storia dei media, comunicazione della storia e processi culturali local, attraverso mostre e installazioni, programmi televisivi, progetti educativi. Con Alessandro de Bertolini ha curato la mostra Scalare il tempo. 70 anni di Trento Film Festival
Gli uffici del Trento Film Festival, oltre a essere un luogo di lavoro, sono un piccolo museo. Vi si conserva la storia dell’istituzione – nata come appendice d’intrattenimento al 64° congresso del Club Alpino Italiano (CAI) – e, al tempo stesso, la si esibisce con inconsapevole garbo ai tanti e tante che passano di qui. «La collezione – scriveva Italo Calvino – nasce dal bisogno di trasformare lo scorrere della propria esistenza in una serie di oggetti salvati dalla dispersione, o in una serie di righe scritte, cristallizzate, fuori dal flusso continuo dei pensieri» (Collezione di sabbia, 1984). Nella sede operativo-amministrativa di via Santa Croce troviamo entrambe le modalità, mescolate con la vita quotidiana, che in certi periodi dell’anno si fa decisamente affollata e frenetica. Vetrinette con genziane di forge diverse e gadegt dal gusto rétro, totem di mostre disallestite, un vecchio iMac azzurro, i «mitici» manifesti incorniciati, i cataloghi ben impilati delle rassegne cinematografica e letteraria; e ancora, raccoglitori verdi con i verbali del consiglio direttivo, quaderni ingialliti scritti a penna e album fotografici ordinati per edizione.
Per un anno ho frequentato con assiduità questi spazi, per raccogliere e selezionare i materiali che hanno trovato forma pubblica in questo libro-catalogo e, prima ancora, nella mostra Scalare il
tempo, percorso scenografico site specific diventato anche allestimento itinerante. Ho aperto cassetti e armadi, mi sono aggirata per i corridoi con curiosità, ho chiesto conto di oggetti dimenticati o mai visti, ho scattato centinaia di foto a documenti e articoli. E in queste pagine proverò a stilare un catalogo ragionato della collezione (quasi) involontaria del Festival. Si possono inventariare cinque tipi di materiali: gli appesi, gli «ufficiali», i tecnologici, la «credenza della nonna» e i caduchi. Gli appesi. La collezione a muro, esibita e stratificatasi nel tempo; quella per cui ci si prende la briga di trovare posto, cornice e chiodi. È ciò che il Festival ama ricordare e mostrare di sé: la faccia pulita, o meglio la «ribalta», per usare la felice metafora teatrale del sociologo canadese Erving Goffman, nel suo celebre lavoro La vita quotidiana come rappresentazione (The Presentation of Self in Everyday Life, 1959). Lo spazio pubblico dove «la facciata diventa ‹rappresentazione collettiva› e realtà a sé stante», il luogo dove si valorizza la propria attività secondo le regole del «decoro» e della «cortesia». Tre tipi di affissioni fanno da scenografia visibile del Festival: gli scatti cinematografici, le foto della manifestazione, i manifesti. In corridoio, le immagini dei film vincitori del premio più importante, intitolato alla «Città di Trento» dalla seconda edizione e associato alla Genzia-
na d’oro solo dal 1977, l’anno in cui vince Belyj Parochod (Urss, 1976). Sono foto di scena che consentono di fare il giro del mondo in pochi passi, attraverso diverse fasi della cinematografia di montagna e del gusto delle giurie specializzate. Fino alla narrazione contemporanea da cui emerge uno spazio montano complesso e vario, luogo ora di denuncia (Metamorphosen, Germania, 2013), ora di poetica sospensione (Samuel in the Clouds, Belgio, 2016) e di diversità (Señorita María, la falda de la montaña, Colombia, 2017), ora di personaggi improbabili (Gaucho Americano, Cile, 2021) e leggerezza estiva (La Grand-messe, Francia-Belgio, 2018).
Passando in sala riunioni, troviamo appese e accostate una sopra l’altra, una vicina all’altra, decine di stampe fotografiche, bianconero e a colori. Come si fa in famiglia con gli scatti più iconici, divertenti o emotivamente significativi; ricordi che sono un po’ anche tuoi che quei momenti non li hai mai vissuti. Così quei volti diventano riunione dopo riunione presenze amiche, benevole, inco-
raggianti: la faccia divertita dell’ex Monty Python Michael Palin con Maurizio Nichetti, i sorrisi di tre generazioni di «uomini di montagna» (Reinhold Messner, Hervé Barmasse e Adam Ondra), il tempo che passa – insieme alle sue vite, quella alpinistica e quella politica – sul volto di Pierre Mazeaud, ri-
tratto con Walter Bonatti durante una gita sul lago di Garda negli anni sessanta e con Lothar Brandler in una «rimpatriata» del 2011; fino alle immagini nuove delle edizioni più recenti, come lo scatto colorato di Tamara Lunger con il presidente Mauro Leveghi nel 2022.
Infine, i manifesti sparsi su diverse pareti, vicini ma senza soluzione cronologica, in un patchwork di rappresentazioni della montagna e di una certa idea di Festival. Così nei primi anni sembra importante insistere sugli elementi che contribuiscono a definirne l’identità (pellicole, catene montuose, bandiere e le «torri» della città), per poi lasciare spazio alle persone che «fanno cose» in quota, e infine in anni recenti al senso, anche astratto, che assumono le vette. A vederli appesi, insieme, è impossibile non notare le tante arti di riferimento, dalla pittura alla pubblicità, dall’illustrazione alla fotografia, e le tante diverse mani creative. Se possiamo azzardare che i poster rimasti nel cassetto siano quelli considerati meno riusciti, altri invece guadagnano potenza espressiva inseriti nello spazio informale di lavoro. Uno dei più belli, a mio avviso, è il manifesto del 1989 firmato dal fotoreporter Vittorio Giannella: un’immagine silente con una natura «rugosa» in primo piano e un legame primitivo, profondo, tra uomo e animale. Finalmente dal 2022 ha trovato posto anche Milo
Manara con la sua ondina totalmente immersa in acque torbide, parziale compensazione all’ormai famoso manifesto censurato. I due lavori svelano peraltro il gioco tra scena e retroscena delle collezioni: all’orgogliosa esposizione del manifesto della 70a edizione corrisponde la storia meno in vista del 1997. Non più semplicemente la facciata pubblica, ma quel che avviene a porte chiuse e resta agli atti. Veniamo così alla seconda categoria di materiali.
Gli «ufficiali». Ovvero i documenti che il Festival ha consapevolmente conservato e che costituiscono il patrimonio documentario fondamentale per chiunque volesse studiare con approccio scientifico la storia di questa organizzazione culturale. I verbali, le rassegne stampa, la corrispondenza ci restituiscono infatti punti di vista inediti, e ancora poco esplorati, sulla rassegna. Torniamo alla questione dell’ondina e prendiamo i verbali del 1997: Manara viene proposto in quanto nome di spicco del fumetto italiano e già autore di un manifesto per la Mostra del Cinema di Venezia, il consiglio accoglie la proposta «riservandosi comunque preventiva visione dell’opera». Cosa che avviene nella seduta successiva con una discussione che si intuisce piuttosto accesa: da una parte, c’è chi non apprezza «la presenza del nudo femminile» o «considera il manifesto non in linea con le tradi-
zioni del Film Festival», dall’altra, c’è chi sottolinea che «la bocciatura contrasta con una visione laica della cultura di montagna» e «non ritiene l’opera lacerante». In quella stessa sede viene proposta una soluzione alternativa: usare un’altra illustrazione di Samivel, la terza presa dagli archivi del museo etnografico di Ginevra, oppure «l’opera di Adolf Vallazza raffigurante un cineoperatore stilizzato con sfondo di montagne». Sappiamo che passa la prima opzione, ma l’affaire lascia degli strascichi: in una riunione successiva Claudio Visintainer torna a sottolineare che «la discussione sul manifesto Manara testimonia il disagio esistente all’interno del Festival», che dovrebbe invece ambire a «essere capitale della cultura di montagna», «occasione di incontro, di uomini e di culture», ma per fare ciò è chiaro che il Festival «culturalmente va reimpostato, amministrativamente va rivisto». I verbali dunque sono una fonte preziosa per ricostruire il dibattitto interno a un’organizzazione, le problematiche ricorrenti e le soluzioni proposte, le idee emergenti e mai realizzate (mi ha fatto sorridere la proposta di far realizzare un orologio Swatch per l’edizione numero 40).
Dalle lettere, telegrammi, preventivi contenuti nell’archivio della corrispondenza emergono altri rivoli di storie perdute e piccoli aneddoti di colore. Pesco stavolta dalla prima edizione del Festival: la
stanza al Grand Hotel occupata dal primo vincitore, Samivel, per 1.300 lire a notte più 900 lire di mezza pensione giornaliera; una missiva «riservata» con le ilari proteste per un menù troppo modesto («alle nostre richieste siamo poi riusciti ad avere una mela e qualche d’uno un pezzo di formaggio»); la lettera del sottosegretario alla presidenza del Consiglio dei ministri, Giulio Andreotti, in risposta alla richiesta fatta al presidente del Consiglio, Alcide De Gasperi, che invia una medaglia d’argento per uno dei film premiati; il comunicato con cui la Società degli Alpinisti Tridentini (SAT) invita la cittadinanza a ritirare presso l’Azienda Turismo gli inviti per assistere alle proiezioni dei film ma anche a «porgere ai graditi ospiti il più cordiale, alpinistico benvenuto» dimostrando così che «la riconoscenza e l’ospitalità affettuosa sono sentimenti innati nella nostra gente». E ancora, i tanti biglietti di apprezzamento alla chiusura della manifestazione, compresi i ringraziamenti per il «magnifique voyage en Italie», per la «perfetta cordialità d’ambiente» e «il godimento intenso e veramente completo nel ritrovar[s]i tra le montagne amiche», fino al commento ficcante di Gaspare Pasini, fondatore della rivista Lo Scarpone, che ad Amedeo Costa scrive: «preso nota della ripetizione del Festival, che avevo già appresa dai giornali locali; il buon seme darà copiosi frutti, ad
edificazione degli scettici del CAI che non avevano ancora capito l’importanza del cinema per l’alpinismo…».
Dalla stampa – fino a inizio anni settanta tutti gli articoli sul Festival venivano ritagliati e incollati su appositi album divisi per stampa italiana/estera e periodo dell’anno – non solo emergono fatti ed episodi che arricchiscono la cronistoria della manifestazione (deliziosa la rubrica Pepe sul Festival di Fulvio Campiotti per il Corriere della Sera) ma si coglie anche come la manifestazione venisse percepita a livello mediale (che fosse un «festival senza dive» era opinione diffusa), quanto si discutesse della (a volte mancata) qualità cinematografica del concorso, come non siano mai mancate polemiche sui vincitori o sulle fughe in avanti dell’alpinismo.
70 anni sono una vita. Per la tecnologia ancora di più: sono ere geologiche. Così nelle collezioni del Festival entra di diritto la strumentazione cinematografica. In bacheca si scorge un film su nastro di Fulvio Mariani: Los Cueveros (Svizzera, 2000), Genziana d’argento come miglior film di esplorazione nell’edizione 2002. Ma al Festival si sono visti davvero tanti supporti, dalle pellicole 16mm e 35mm fino all’immaterialità dei file che ha semplificato uno dei passaggi cruciali dei festival cinematografici, ovvero il recapito dei film per la selezione
e il concorso. Il cambiamento tecnologico è ben visibile anche nella strumentazione ordinaria che ha senza dubbio facilitato la macchina organizzativa. Se negli scantinati sono conservati alcuni modelli di macchina da scrivere e un vecchio ingombrante ricevitore di cassa, negli uffici fanno bella mostra due oggetti del «mondo della Mela» – il computer arrotondato di plastica traslucida e uno dei primi portatili.
Non sono passati tanti anni, ma quasi non si riesce a immaginare cosa volesse dire inviare tutto per posta (regolamento, schede di iscrizione, inviti, programmi), gestire la corrispondenza con le veline e i telegrammi, fare i comunicati stampa col ciclostile del Comune, dettare gli articoli giornalistici al telefono, e così via. Me ne sono resa conto grazie a uno dei ritrovamenti più interessanti, di tipo «pre-tecnologico». Pile di quaderni organizzati come fogli excel, con griglie per tenere nota degli ospiti e delle notti di pernottamento in alberghi o campeggi, e quadernetti di «spese piccola cassa» con annotati i costi di francobolli, telegrammi, rotoli di nastro adesivo. Si tratta di «scritture popolari», al pari dei libri dei conti e dei quaderni di scuola, che nella loro sobrietà rivelano non solo informazioni economiche sui primi 15 anni di Festival, quelli di un Trentino entrato tardivamente nella fase di sviluppo socioeconomico, ma an-
che pratiche culturali (la mancia all’operaio per le spedizioni e le telefonate in teleselezione) e organizzative (la divisione negli alberghi per categorie: alpinisti, giornalisti, ecc.).
E così abbiamo aperto anche la «credenza della nonna». Dai mobiletti, di solito quelli in alto e molto in basso, può uscire o il servizio buono della festa o quello sbeccato che non si usa più. Così anche negli uffici di via Santa Croce, dove oltre ai quaderni ho trovato ad esempio un sacchetto di spillette vintage con la scritta «ospite», antesignane dei moderni badge. E gli album fotografici: foto attaccate per i lembi con lo scotch, foto volanti e buchi neri di foto mancanti, spesso corredate da didascalie scritte a penna. Sono quasi tutte digi-
talizzate e indicizzate ma sfogliare questi libroni ha un altro sapore, quello della nostalgia. Concludo con i miei preferiti: i «caduchi», ovvero gli oggetti dalla durata effimera, breve, che non verranno musealizzati. Penso ai due cartelloni, lunghi diversi metri: qui nei mesi che precedono il Festival prende forma la programmazione degli eventi e dei film. Li ho visti bianchi solo con le colonne dei giorni e le righe dei luoghi, tabule rase che arrivano a riempirsi di post-it colorati. Credo vengano buttati alla fine di ogni edizione mentre si conserva il programma a libretto. Chissà, potrebbe essere uno spunto per l’installazione del Centenario…
Docente universitario, regista, giornalista pubblicista e autore di diversi libri, è anche maestro di sci ed esploratore. Ha all’attivo spedizioni alpinistiche e scialpinistiche in tutti i continenti e ha pubblicato articoli e fotografie su tutte le più prestigiose riviste di outdoor italiane, francesi, spagnole, norvegesi, australiane e statunitensi. Amante del mare, negli anni settanta e ottanta ha compiuto lunghe traversate in barca, da cui ha preso spunto per alcuni dei suoi libri.
Tre sciatori con zaini disumani sulle spalle mirabilmente filmati da un quarto sciatore che nel film non appare mai. È il regista tedesco
Gerhard Baur, pluripremiato al Trento Film Festival per tanti film di alpinismo, che si è portato sulle spalle anche una pesante cinepresa da 16 mm per tutta la traversata di 12 giorni, in totale autonomia, delle aspre montagne della Corsica. In Das Gebirge im Meer-mit Skiern durch Korsika (Germania, 1980), girato nel febbraio 1980 e presentato al Festival del 1981, si ritrova il vero spirito della traversata con gli sci «by fair means», interpretato da un regista-operatore di alta professionalità che è anche un eccellente scialpinista. Rivedere film di sci di questo spessore è un invito a ripercorrere, attraverso tutti quelli presentati al Festival, gli ultimi 70 anni di storia di quel meraviglioso gioco che è lo scivolare sulla neve. Una storia affascinante, ricca di momenti importanti, di cambiamenti epocali. Una storia che, per motivi anagrafici, ho vissuto interamente, avendo imparato a sciare prima che a camminare. La mia passione per la neve non si è infatti mai affievolita, neanche in tempi difficili come gli attuali, in cui si evocano inverni sempre più «liquidi» (mi preme qui ricordare il volume Inverno liquido, di Maurizio Dematteis e Michele Nardelli, Comunità concrete, 2022) e le belle nevi «perdute» (in riferimento a Nevi perdute, di Aldo Audisio,
Società Storica delle Valli di Lanzo, 2023). Ripercorrerla oggi permette di riscoprire valori mai venuti meno. Che poi si tratti di film di sci o di sci nei film, parafrasando la distinzione fra film di montagna e montagna nei film condotta da Bernard Germain nel suo autorevole ultimo volume Dico Vertigo (Dictionnaire de la montagne au cinéma en 500 films, Guérin 2019), direi che poco importa. Negli anni cinquanta, quando è nato il Festival, lo sci era sostanzialmente ancora quel gioco bellissimo dell’età d’oro degli anni fra le due guerre, quando l’ebrezza di scivolare attraverso le meraviglie della montagna bianca era privilegio di élites, quando gli impianti di risalita erano slittoni, manovie, skilift e traballanti seggiovie monoposto. Oppure treni perfettamente inseriti nell’ambiente alpino, unici mezzi di trasporto per raggiungere località montane. Le discese avvenivano fuori pista o su piste di neve naturale, battute dagli stessi sciatori, che seguivano la morfologia della montagna e che non impattavano sull’ambiente come quelle attuali. Era lo sci immortalato nei capolavori cinematografici di Arnold Fanck (Wunder des Schneeschuhs, Germania, 1920) e di Luis Trenker (Liebesbriefe aus dem Engadin, Germania, 1938), presentati non a caso per la loro godibilità in retrospettive del Festival. Nel dopoguerra questo sci gioioso e ben inserito nella montagna invernale
iniziò a interessare un numero crescente di cittadini delle classi medie, favorendo così la trasformazione di molti paesi di montagna in stazioni invernali e la creazione di nuove stazioni in quota ex novo, dando il via allo sviluppo dello sci di massa. Uno sci destinato a incidere sempre più profondamente sull’ambiente e sulla cultura alpina, soprattutto dopo l’invenzione americana della neve artificiale.
I film in concorso nei primi anni del Festival celebrarono con numerosissime opere questa epopea dello sci e la sua insostituibile centralità nell’evoluzione degli sport invernali. Nella prima edizione del 1952 i film di sci rappresentarono il 28% dei film in concorso, con opere come il delicato Etna, Mare e Neve (Italia, 1952) di Fosco Maraini, in cui si univa al piacere di sciare sulle pendici del vulcano quello di nuotare nel mare sottostante, il tutto nella stessa giornata. Il Gran Premio andò quell’anno a Cimes et Merveilles (Francia, 1952) di Samivel, che nel celebrare le bellezze della montagna nelle quattro stagioni ci propone lo sci in quella migliore, la primavera. Una giovane coppia di sciatori effettua un’ultima curva su di una lingua di neve primaverile per poi stendersi al sole su di un prato puntellato di crocus, per celebrare la meraviglia del tutto.
Nel 1953 la percentuale di film di sci fu sempre alta,
oltre il 20%, con La grande descente (Francia, 1953) di Lionel Terray, prima opera di sci estremo con la discesa della Nord del Bianco. Anche negli anni successivi l’interesse per i film di sci si mantenne molto elevato, con parecchie opere che ben figurerebbero in una retrospettiva. Da ricordare in particolare Primavera in Sci (Italia, 1955) firmato da Mario Fantin, Le ski alpin di Bruno Lötsch (Austria, 1954), Ski melody dell’Arcangelo delle nevi Hans Nöbl (Italia, 1955), Sinfonie in weiss di Oskar Kühlken (Austria, 1957), Skis et abîmes (Svizzera, 1957) e Ciels, rocs et glaces (Svizzera, 1959) di un cantore delle Montagne bianche (titolo del suo famoso e raro volume) come Denis Bertholet. Una menzione particolare in quel periodo d’oro merita un altro grande interprete della montagna invernale come Jean Jacques Languepin, regista di molti film sul neonato sport di massa in tutte le sue forme, dal fuori pista alla competizione. Suo e di Jacques Ertaud il documentario sulle Olimpiadi di Grenoble presentato al Festival del 1969. Suo anche Neiges (Francia, 1955) presentato al Festival del 1956, un documento perfetto sullo sci di quei tempi, anche se un po’ enfatizzato. Eccezionali in questo film le riprese della elegante tecnica dei grandi campioni francesi di quei tempi, da Henry Oreiller a Emile Allais. Ricordiamo che Languepin ha anche vinto il Gran Premio nel 1954 con Himalaya, passione
crudele (Francia, 1953) e ha co-diretto opere con Marcel Ichac (La Clef des champs, Francia, 1947) e con Gaston Rebuffat (Des hommes et des montagnes, Francia, 1953).
Va fatto notare che fino agli anni settanta la qualità cinematografica di molti film ammessi al Festival non era eccelsa, venivano infatti accettate opere magari discretamente montate ma di imprese ed escursioni per le quali la documentazione cinematografica aveva caratteristiche amatoriali. Il forte interesse per lo sci si mantenne comunque vivo con pellicole di valore anche negli anni sessanta, attraverso opere che ne tratteggiavano forme particolarmente mature come lo sci delle grandi traversate, uno sci che troverà nel film di Baur (citato all’inizio) la sua massima espressione. Da ricordare a tale proposito Haute route (Svizzera, 1963) di Willy Fah, presentato nel 1964, e Innsbruck-Grenoble (Svizzera, 1965), di Denis Bertholet, presentato nello stesso 1965, in cui vengono unite sci ai piedi le città sede delle Olimpiadi invernali del 1964 e del 1968. Da notare che in quell’anno la Genziana d’oro venne attribuita, per la prima e ultima volta, a una fiction sullo sci, il cortometraggio Schuld an allem ist der Schnee/ Ski-grotesk (Germania, 1965) di Wolfang Gorter.
Nel 1966 le emozioni dello sciare si manifestarono in Ski-Faszination (Germania, 1966), uno dei primi
film di successo di Willy Bogner, a cui ne seguirono tanti altri del noto regista-sciatore-imprenditore tedesco. Fra di essi non si può non ricordare il lungometraggio a soggetto Fuoco, neve e dinamite (Germania, 1990), che tanto successo ebbe nelle grandi sale. Un film spettacolare ma del tutto inconsistente, una sorta di parodia sulla neve della saga di James Bond. Negli anni settanta il Festival fu l’importante testimone del periodo d’oro dello sci estremo. Aprì la serie Victoire à ski sur l’Eiger di Sylvain (Svizzera, 1970), lo sciatore dell’impossibile. Lo stesso Saudan ottenne il premio UIAA nel 1974 con Ski aux limites de l’oxigène (Svizzera, 1973). Seguirono nel
1976 Dalla parete est del Cervino con Toni Valeruz (Italia, 1975), di Ermanno Chasen, e, nelle edizioni 1978/1979, film diventati di culto: come Peuterey la Blanche (Francia, 1977) e El Gringo eskiador (Francia, 1977) di Patrick Vallençant, entrambi in concorrenza con quelli dell’amico-rivale Jean Marc Boivin, conosciuto per i suoi diabolici concatenamenti in giornata immortalati in Au vent des cimes (Francia, 1977), presentato al Festival nel 1979, e in Aventure au Cervin (Francia, 1980), presentato al Festival nel 1981, in cui si vede Boivin nella discesa della Est, nella salita in solitaria della Nord e, dulcis in fundo, nella discesa in deltaplano dalla cima. Quest’ultima opera fu premiata con la seconda e
ultima Genziana d’oro a un film di sci nella storia del Film Festival. Gli anni settanta non furono però solo sci estremo. A tale riguardo ricordiamo, ci sia concesso dire «con nostalgia», il delicato 50 ans ou la vie d’un skieur (Francia, 1972) di Marcel Ichac, che ottenne il Premio della giuria nel 1973. Nel 1980 il già citato Bernard Germain, regista, guida alpina ma soprattutto poeta della montagna, presentò Annapurna premier 8.000 à ski (Francia, 1979) sulla prima discesa in sci da un Ottomila effettuata da Yves Morin. Yves purtroppo la interruppe a 6.000 metri, dove morì, stremato dalla fatica. Per questo motivo l’impresa non gli fu riconosciuta, anche se aveva sceso più volte con gli sci l’ultimo tratto di discesa durante la salita ed è stato uno dei pochi sciatori himalayani a portarsi tutto sulle spalle dal campo base, senza l’aiuto di portatori, su di un itinerario tutto fuorché banale. «Spettatore, questo non è un resoconto di spedizione come gli altri, simili a racconti di imprese coloniali», ci avverte Bernard Germain nel presentare il suo film. Si tratta infatti di un’opera da valorizzare non solo come testimonianza di un’eccezionale performance ma anche dal punto di vista della qualità cinematografica e dei contenuti. Un film sensibile alla cultura dei luoghi e al significato delle spedizioni, con spunti innovativi e pregevoli metafore purtroppo
passate inosservate. Anche i film in cui lo sci è protagonista possono avere insomma risvolti sociali, culturali e ambientali importanti.
Negli anni ottanta continua l’epopea dello sci estremo, con Fall line (Usa, 1981), presentato da Robert Carmichael e Greg Lowe al Festival dello stesso anno. In esso si vede una spettacolare (e vera) caduta dello sciatore Steve Shea durante la discesa dal Grand Teton. Segue Victoire à ski sur l’Himalaya (Svizzera, 1983), presentato al Festival del 1984 sulla discesa di Sylvain Saudan dall’Hidden Peak, omologata come prima discesa da un Ottomila. Senza dubbio da segnalare La parete che non c’è (Italia, 1985) di Michele Radici, presentato nel 1986 sui nuovi traguardi per lo sci estremo di Stefano De Benedetti su pareti di roccia normalmente «insciabili». Descentes (Francia, 1987) di Jean Afanassieff è un altro film fondamentale per vivere le pazzie dello sci estremo di quegli anni. Presentato al Festival del 1988, documenta il terzo incredibile concatenamento di 5 discese estreme in 24 ore da parte di Jean Marc Boivin nel massiccio del Bianco.
Anche lo sci di traversata continua a essere presente in quegli anni, con opere di valore come Across the main divide (Nuova Zelanda, 1984) di Howard Moses, un documentario in cui le Alpi neozelandesi vengono presentate in tutto il loro po-
tenziale per uno scialpinismo di vera avventura (presentato al Festival nel 1985).
La «glisse», ossia il piacere fine a se stesso di scivolare nella neve polverosa, fa negli anni ottanta prepotentemente la sua apparizione al Festival con i numerosi documentari di Didier Lafond, fra i quali non si può non ricordare Apocalypse snow (Francia, 1986), presentato fuori concorso al Festival dello stesso anno. Si trattò di una fiction destinata a fare storia, con la prima consacrazione sullo schermo dell’eleganza delle discese con lo snowboard (a coda di rondine!) di Régis Rolland, inseguito da bande di goffi monosciatori. Una parodia dei film di James Bond, o forse sono stati proprio questi film ad attingere dalla dirompente fantasia (e simpatia) di Didier Lafond… Una fantasia che non ha più freni: nel 1988 Michele Radici, su di una sceneggiatura dello sciatore estremo Stefano De Benedetti, presenta la fiction The time machine (Italia, 1987), un film diventato di culto che ha favorito la rinascita del telemark, con la prima e unica discesa estrema della Nord delle Jorasses a talloni liberi effettuata dal norvegese Morten Aass con l’attrezzatura minimalista di allora.
Concludiamo questa breve analisi dei film di sci presentati al Festival negli anni ottanta con un’altra opera preziosa di Gerhard Baur. Il professionista tedesco, dopo la presentazione nel 1981 del film
sulla traversata della Corsica citato in apertura, venne premiato nel 1985 con la Genziana d’argento per il miglior film di montagna con la pellicola di sci estremo Die Entscheidung (Germania, 1985), un documentario di soli 10 minuti sul tema della rinuncia di un’intensità e sensibilità unica, oltre che di ottima qualità cinematografica. Saper rinunciare è una qualità di fondamentale importanza anche quando si fa dello sci estremo, questo il messaggio del film. La decisione dovrebbe pertanto essere visto dai numerosissimi adepti attuali dello sci ripido, spesso esaltati dalle eccezionali performance dei migliori sciatori dell’ultima generazione.
Passando agli anni novanta, nell’ultimo decennio del secolo scorso sono stati presentati 62 film di sci (pari al 6,5%) a dimostrazione dell’importanza che veniva ancora data a questo genere. Notiamo ancora tante opere sullo sci e sullo snowboard estremi che raccontano le gesta di grandi sciatori come Pierre Tardivel, con il pregevole Le skieur du vide (Francia, 1989) di Alain Tixier, e Tardivel (Italia, 1992) di Michele Radici, presentati rispettivamente al Festival nel 1990 e nel 1993; come Dominique Perret, con C’est tout bon (Francia, 1989) e Go east (Francia-Svizzera, 1992) di Didier Lafond, presentati al Festival nel 1990 e nel 1994; e come Toni Valeruz con Toni Valeruz - I sogni verticali (Italia, 1990) di
Fulvio De Martin e l’originale Uno slalom speciale (Italia, 1996) di Giorgio Balducci, presentati al Festival nel 1991 e nel 1997.
Una menzione speciale merita Face to Face di Michele Radici e Anthony Hofman, su di un’altra brillante idea di Stefano De Benedetti. Presentato al Festival 1990, in esso il campione norvegese di telemark Morten Aass si trova inseguito dal suo sosia in pazze discese, fino a superare i fantasmi delle sue paure. Il film documenta anche la prima discesa con lo snowboard del Couloir Couturier nel massiccio del Bianco da parte di Denis Bertrand. Un documento fondamentale per capire lo sci estremo himalayano è La discesa pazza (Italia, 1991) di Wolfgang Thomaseth, sulla eccezionale performance di Hans Kammerlander sul Nanga Parbat, con discesa integrale in sci del versante del Diamir. L’attrezzatura, è importante precisarlo per poter valutare l’impresa, era quella leggera da scialpinismo, poco performante in discesa. Ottima la qualità cinematografica delle riprese di un professionista come Thomaseth, che ha portato le pesanti attrezzature fino a quota 7.000. Un altro film da ricordare, perché premonitore di uno sci di massa mordi e fuggi svuotato di contenuti, è stato senza dubbio Dérapages japonais (Francia, 1990) di François Dom, presentato al Festival del 1991. Lo sci a talloni liberi ebbe momenti
di gloria anche in questo decennio con Il passo in curva (Italia, 1993) di Carlo Rossi, Premio FISI 1993, e con No man’s land di Enrico Verra (Italia, 1995) presentato al Festival nel 1996, un’opera importante che indaga sui significati profondi del viaggio durante un’inedita traversata delle montagne del Libano effettuata da 5 sciatori-viaggiatori a talloni liberi di diversa nazionalità, sulle tracce di un mito dello sci errante come Michel Parmentier.
Concludiamo con la «chicca» di questo decennio, un decennio importante per i film di sci al Festival, passata quasi inosservata: Die Grosse Ekstase des Bildschnitzers Steiner (Germania, 1974) di Werner Herzog, presente al Festival nel 1996, un lungometraggio sul sogno romantico e visionario dello scultore-saltatore Steiner, un’opera appassionata e appassionante sui significati profondi del salto con gli sci.
Il passaggio al nuovo secolo vede una progressiva diminuzione delle opere oggetto di questa analisi. Si passa dal 3,5% di film di sci nel decennio 20002009 al 2,9% degli ultimi 12 anni. Si nota però un netto miglioramento nella qualità cinematografica. In particolare l’utilizzo del drone permette negli ultimi anni risultati prima impensabili per il film di sci, con registi e operatori non necessariamente alpinisti e sciatori. Sarà forse per questo che, a fronte di tali miglioramenti, è ricorrente in questi
ultimi anni una carenza di contenuti preoccupante. O forse perché tutto lo sci, influenzato dalla tecnologia di quello rinchiuso nei luna park bianchi, non permette più slanci creativi.
Per fortuna le eccezioni, anche se rare, non mancano. Ad esempio vanno ricordate le opere di denuncia sui danni ambientali e culturali provocati dallo sviluppo dello sci di massa, in particolare Struktur - Die Skipur in der Kulturlandschaft (Austria, 2017) di Hanna Mackowitz, presentato al Festival nel 2019, girato nelle stazioni dell’Arlberg. Anche le performance sportive certamente non mancano e lo sci estremo nel nuovo secolo è presente soprattutto con discese in Himalaya. I grandi sponsor di queste imprese fanno però spesso apparire le opere che le documentano direttamente in internet, senza presentarle prima nei film festival. Così è avvenuto per il film sulla prima discesa dalla cima del K2 di Andrzej Bargiel del 2018, un’impresa tanto assurda quanto pericolosa, ripresa con grande abilità dai droni che il fratello di Andrzej pilotava dal campo base. Presente invece al Festival nel 2002 Ski Everest 2000 (Slovenia, 2000) di Janez Stucin, sulla prima discesa del versante Sud del tetto del mondo: anche in questo caso il protagonista Davo Karnicar venne pilotato dal fratello fra i seracchi della Icefall con un drone.
Nel 2005 Bertrand Delapierre presenta al Festival
Marco, étoile filante (Francia, 2004), un lungometraggio sulla vita fuori dalla norma di Marco Siffredi, lo snowboarder di Chamonix che con le sue discese da visionario, fra le quali la Nant Blanc nel gruppo del Bianco e il Canalone Norton dalla cima dell’Everest, è diventato un mito. Il telemark e il viaggio con gli sci rimangono protagonisti in Il diritto e il rovescio (Italia, 2012) di Alberto Sciamplicotti, girato sulle montagne dell’Armenia, presente al Festival nel 2013.
Il vero protagonista del nuovo secolo risulta però essere il freeride nelle sue versioni estreme, diverse come tecnica e come filosofia dallo sci estremo.
Capostipite di questo nuovo modo di vivere lo sci è stato il lungometraggio Into the mind (Canada, 2013) di Dave Mossop e Eric Crosland, presentato nel 2014, un film diventato di culto fra gli adepti del freeride, sponsorizzato da The North Face. In esso si nota l’ostentazione di uno sci altamente adrenalinico e pericoloso come esperienza mistica necessaria per raggiungere una spiritualità profonda, con ampi riferimenti alle filosofie orientali e in particolare al Lamaismo.
Senza inoltrarci oltre nei contenuti di questo film di ottima qualità cinematografica, dobbiamo notare che purtroppo lo sci negli ultimi anni è spesso presente al Festival in opere che potremmo definire di «falsa esplorazione con gli sci». Si tratta in
genere di performance su montagne remote e sconosciute raggiunte e vissute in modi non proprio «leali» e/o con attrezzature poco adatte, come quelle pesanti da freeride da stazione o eliski. Film di buona qualità cinematografica che evidenziano una certa inesperienza dei protagonisti nell’affrontare una vera spedizione. Così Onekotan-The lost island (Austria, 2015) di Simon Thussbas, al Festival nel 2016, un film di una tristezza assoluta. Così The white maze (Austria, 2016) di Matthias Mayr, al Festival nel 2017, seppur con una discesa ripida da manuale del remoto monte Pobeda in Siberia, raggiunto facendo ampio uso di motoslitte per trasportare pesanti attrezzature fino al campo base. Matthias Mayr, sciatore di eccezionale bravura, trova però totale assoluzione con Auf den Spuren der Erstern (Austria, 2017), presentato al Festival del 2018. In esso Matthias ripete con l’amico Matthias Haunholder la discesa del canalone Pallavicini al Grosslockner e quella della parete Nord dell’Hochferner con gli sci e gli scarponi degli anni sessanta, per poi effettuare le stesse discese, riprese ovviamente con un drone, con i moderni pesanti sci larghi e poter riflettere sui cambiamenti epocali di stile e di mentalità nello sci con i protagonisti di allora.
Anche gli ultimi due anni del Trento Film Festival presentano pochi film di sci, oltre che di scarso
valore. Segno forse della crisi epocale che sta vivendo il mondo dello sci, a causa di inverni sempre più caldi, dell’artificialità dello sci luna park e dell’agonismo sempre più presente nello scialpinismo in tutte le sue declinazioni. Anche i nuovi criteri di selezione delle opere in concorso possono aver influito in qualche modo sulla scarsità di film di sci in questi ultimi anni. Inoltre, la prassi di far apparire i film direttamente in internet senza presentarli prima ai festival non ha aiutato: ad esempio un film come Vanishing lines, prodotto nel 2022 dall’americana Patagonia per promuovere uno sci più rispettoso della montagna e per difendere quel poco che rimane dei ghiacciai alpini, non è stato presentato al Festival. È pur vero che in opere del genere il «green washing» è sempre in agguato e il Trento Film Festival non ha bisogno di cadere in queste trappole. Comunque sia, le opere di sci presenti nel 2021 e nel 2022 sono risultate non solo poche ma oltremodo deludenti. Across emptiness (Italia, 2022) di Luca Albrisi vuole far vivere una traversata attraverso le stazioni deserte delle Dolomiti durante la pandemia: idea brillante e ridotta però ad alcune sciate «costruite» in zone ben circoscritte, con un falso bivacco a scopo puramente cinematografico in una moderna stazione di partenza deserta di una cabinovia e alcune esibizioni di puro freeride. Forse una rivi-
Una scena del film La liste, everything or nothing presentato alla 70a edizione del Trento Film Festival.
sitazione del film di Bauer del 1981 sulla traversata della Corsica avrebbe permesso di far di meglio. Deludente anche, malgrado il titolo, The Traverse (Francia, 2021), una corsa non stop sulla classica Chamonix-Zermatt, a dimostrazione di come ormai l’agonismo sia presente e vincente anche nello sci di traversata, uno sci che ha ben più profondi contenuti. Unico film di sci godibile del 2022, fuori concorso ma con la sala stracolma, è stato La liste, everything or nothing (Canada, 2021) di Eric Crosland, con i bravissimi Jérémie Heitz e Sam Anthamatten. Un film visibile in internet, come tutti quelli sponsorizzati da Red Bull, ma certamente più apprezzabile sul grande schermo. Quello che risulta oggi difficile per far vivere una nuova primavera ai film di sci è, da un lato il saper recuperare valori e storie dimenticate e dall’altro saper riflettere senza preclusioni ideologiche su di un difficile futuro. Non bastano le riprese con i droni e le folli linee di discese precostruite. L’organizzazione di qualche retrospettiva potrebbe indubbiamente aiutare. Senza dimenticare i cartoni animati di Bruno Bozzetto, da Il Signor Rossi va a sciare (Italia, 1963) a Ski Love (Italia, 1991), storia esilarante di un paio di sci che si innamora di una bella ragazza incontrata sulla funivia che dal passo dello Stelvio porta al Livrio. Senza amore e passione vera poco rimane. Anche nel mondo dello sci.

Si è occupato di politica fin da giovanissimo. È stato sindaco di Trento dal 1990 al 1998, presidente della Provincia autonoma di Trento dal 1999 al 2012 e parlamentare dal 2013 al 2018.
Chi ha avuto il privilegio di essere sindaco di Trento ha potuto abitare la città in tutte le sue pieghe, anche le meno note; sentirne l’anima e il respiro profondo; viverne da vicino le esperienze collettive. Questa è la natura unica e irripetibile dell’essere sindaco. E sindaco di Trento, in particolare.
È sulla base di questa premessa che accolgo con piacere l’invito a raccontare il mio rapporto con il Trento Film Festival che celebra i suoi 70 anni.
Prima di essere sindaco, conoscevo ovviamente la manifestazione e, come tutti i cittadini, ne apprezzavo la storia, il ruolo, il significato. Dal 1990 in poi, però, ho scoperto ancora più a fondo la valenza di questo gioiello che la città può vantare. Ho potuto vedere da vicino ciò che gli spettatori e le spettatrici – anche quelli più affezionati – non possono vedere: il grande lavoro tecnico, scientifico, ma anche e soprattutto di relazione e di «pensiero» che sta dietro l’evento.
Si, perché le relazioni e il «pensiero» contano più di tutto. Più ancora della pur riconosciuta e pregevole qualità tecnica. Le «relazioni». Ricordo le occasioni di incontro informale (anche al Campo Base) tra alpinisti, donne e uomini della montagna, operatori dei rifugi, responsabili delle associazioni: popolo della montagna in senso lato.
I film sono sempre stati importanti, certo: ma questo contorno di umanità e di rapporti non era, in realtà, «contorno», ma piatto principale di uno straordinario menú, fatto di valori, di passioni, anche di liti e di polemiche, ma sempre con la cifra della lealtà e della sincerità.
Erano occasione di sintesi tra spiccate individualità (i mitici protagonisti delle imprese alpinistiche, con le loro capacità e anche con le loro innate vocazioni da «protagonista») e robusta dimensione comunitaria. Laddove quest’ultima non si banalizzava mai in passivo fanatismo. In un tempo nel quale il fanatismo acritico, in tutti i campi, sembra prevalere, questa caratteristica del popolo del Festival mi pare essere un buon esempio, un segnale di resistenza rispetto alla deriva del consumismo leaderistico.
Il «pensiero». Mi pare che il Festival sia stato – e continui a essere – un luogo di riflessione condivisa alla ricerca di un «senso». Senso della montagna, del verticale, dell’avventura e dell’esplorazione. Senso della scoperta di esperienze nuove e inedite. Senso del voler andare «oltre».
La nostra epoca è sempre più dominata dalla «cultura dell’orizzontale». Cambiamenti antropologici, culturali e tecnologici hanno cambiato i connotati del tempo e dello spazio. E il rischio è che tutto si appiattisca. Un rischio che la stessa
montagna sta vivendo, quando importa e sopporta modelli culturali, e anche economici, tipici delle grandi pianure. È proprio la «cultura del verticale» – che abita nella montagna vera - che può salvarci rispetto a questa deriva. Il Festival è stato – e rimane – un presidio importante da questo punto di vista; una sorta di giacimento di riflessioni, sensazioni, relazioni e pensieri che ci possono aiutare a recuperare il sentiero smarrito nella nebbia. E Trento è il luogo ideale per questo percorso.
Perché è, assieme, città e montagna. È «città alpina». Vive la complessità urbana dell’orizzontale e la natura alpina del verticale. Mi vengono in mente a questo proposito le belle iniziative che Trento aveva messo in campo, quando ha fondato e guidato per tanti anni l’associazione «Città delle Alpi», diretta per tanti anni dal compianto Ettore Bonazza, non a caso grande amico del Festival. Rimane questa, ancora oggi, la pista da seguire, per Trento e per il Trentino. L’unica che può aiutarci a ritrovare il senso della nostra identità, senza inutili nostalgie e pericolose paure dei cambiamenti epocali che stiamo vivendo, ma anche senza banalizzazioni e omologazioni.
La storia settantennale del Trento Film Festival si deve alla lungimiranza dei suoi fondatori e al generoso impegno di chi ci ha lavorato, a tutti i livelli
e con diverse responsabilità: è stata e rimane una grande comunità di lavoro, che merita la riconoscenza delle istituzioni e della cittadinanza.
Da sindaco di Trento ho avuto modo di conoscere e apprezzare in particolare chi ha lavorato per il Festival durante il periodo dei miei mandati, dal 1990 al 1998. Nella fase iniziale e in quella finale, ho apprezzato i presidenti Giacomo Priotto e Goffredo Sottile (quest’ultimo grande servitore delle istituzioni statali, per un periodo anche commissario del Governo per la nostra Provincia, che ha sempre amato e rispettato, nel suo ruolo, la nostra speciale autonomia e che il CAI aveva indicato come presidente).
Nei lunghi anni intermedi, ricordo con affetto la presidenza di Claudio Visintainer, mio compagno di strada nella amministrazione comunale, che ha sposato, sostenuto e fatto crescere il Festival con un impegno che andava molto al di là dei doveri amministrativi: riguardava, appunto, i valori e l’identità stessa della nostra comunità cittadina. Il
Sui tetti di Trento: una scena del documentario La città delle Dolomiti (Italia, 1954) di Carlo Pacher.
direttore in quegli anni era Gianluigi Bozza. Lui e Claudio Visintainer sono stati a lungo una coppia vincente, capace di accreditare la rassegna nei circuiti internazionali, ma sopratutto di radicarla nella comunità trentina. Gianluigi con la sua riconosciuta competenza tecnica e con la sua curiosità intellettuale; Claudio con l’entusiasmo politico e il carisma umano che lo connotava.
Il Comune di Trento e il CAI – ricordo per tutti Roberto Demartin e la qualità della sua dedizione alla causa – hanno dunque investito seriamente e con convinzione sul nostro Festival, oggi guidato sapientemente da Mauro Leveghi.
È una storia che continua e che trova di giorno in giorno nuovi motivi per proseguire. Una sorta di radar che abbiamo la fortuna di avere, per non perderci nella nebbia sul sentiero difficile che dobbiamo percorrere. Possibilmente in cordata. Una cordata consapevole e solidale. Viva il Film Festival.

Scalare il tempo. 70 anni di Trento Film Festival è il titolo della mostra ospitata nello spazio de Le Gallerie a Trento. Un percorso scenografico che ha voluto raccontare il Festival, la sua storia, i suoi linguaggi e le sue voci. Non attraverso una narrazione cronologica ma tematica, scandita in tre capitoli – Montagna, Festival e Cinema – e 15 parole chiave. In queste pagine le ripercorriamo, assieme alle immagini dello scenografico allestimento: quattro grandi strutture di legno che svettano fino a sei metri d’altezza, una sala di proiezione per rivedere i film più amati, premiati e discussi, una lunga parete colorata di rosso con tutti i manifesti, un’area sonora con i ricordi, gli aneddotti e le emozioni del Festival, un tavolo di romanzi e saggi sulla montagna, la volta trasformata in un climbing wall verbovisuale, e infine tre grandi pedane con gli oggetti della cinematografia di montagna e di una grande spedizione italiana.


Nel 1865 l’intellettuale Douglas William Freshfield, mentre cercava di scalare la Presanella, scriveva così, a proposito di un dialogo con gli abitanti della zona: «Oh sì – disse il nostro ospite – un signor professore tedesco di Vienna ha tentato di scalare la montagna, un anno o due fa, e l’ha trovata impraticabile. La sommità finale è come la stufa in questa camera e tutta di ghiaccio». «Ebbene –dissi io – ma la stufa è facile. E salii in cima alla stufa». Ve lo immaginate Douglas Freshfield che si arrampica sulla stufa? Nel gesto, di una spontaneità sorprendente, si scorgono il primato della volontà e la forza delle intuizioni. Che cosa porta un essere umano verso la montagna? Cosa lo spinge a scalarla, conquistarla, viverla, filmarla, descriverla nelle pagine di un libro di montagna o semplicemente contemplarla? Un’infinita varietà di motivazioni, di alpinismi e sguardi differenti sono alla base di questa spinta. Dal 1952 a oggi, il Festival è stato, al tempo stesso, interprete e destinatario di queste sensibilità. Quelle del passato e del presente. Ma anche quelle del futuro. La capacità di cogliere questi sguardi, di restituirli e di valorizzarli, tematizzarli e anticiparli, ha fatto del Festival luogo di riflessione e incontri sulla montagna.
Il Festival della Montagna di Trento esordisce come rassegna di cinematografia alpina e si caratterizza come momento di confronto internazionale sui molteplici significati della montagna: anticipa e interpreta tendenze, segna il passo e precorre i tempi. In principio sono il cinema e l’alpinismo i due paradigmi di riferimento. Presto si aggiungono l’attenzione all’ambiente e all’educazione per uno sviluppo sostenibile, l’interesse per le tematiche etnoantropologiche e culturali legate alle genti e ai popoli di montagna, gli sguardi verso il futuro e sulle grandi sfide contemporanee, dalla crisi climatica ai conflitti. Dalle prime edizioni a oggi, il Festival cresce e diventa grande. Riprendendo un auspicio del 1987, espresso dall’allora presidente del CAI, Leonardo Bramanti, il Festival «esce dalla cronaca cittadina per entrare nella storia».
ALPINISMI
La parola «alpinismo» non basta. La si deve per forza declinare al plurale: «alpinismi». L’evoluzione tecnica e tecnologica ha trasformato il modo di andare in montagna nel corso del tempo. Ma
non sono solo l’evoluzione dei materiali e i gradi di difficoltà che cambiano. A fare la differenza sono state soprattutto le motivazioni: quei processi di formazione e di rappresentazione identitari, non di rado in contrasto fra loro, che fanno dell’alpinismo l’espressione di una volontà individuale o di
un piccolo gruppo, di una comunità o di una nazione, di una tendenza o di una stagione. Mutando in continuazione, l’alpinismo non somiglia mai a se stesso. Lo definiscono il tempo, cioè la Storia, lo spazio, quindi la Geografia, e le modalità di narrazione, attraverso una moltitudine di soggettività.

ALPINISMO COME ESPRESSIONE DI
UNA VOLONTÀ INDIVIDUALE

Le biografie di alcuni tra i più grandi alpinisti di tutti i tempi, come Reinhold Messner e Walter Bonatti, Jerzy Kukuczka, Kurt Diemberger o Hermann Buhl, più volte protagonisti al Trento Film Festival, sono l’esempio di una straordinaria determinazione individuale verso il superamento dell’impossibile: una volontà di ferro che risponde a una forza interiore eccezionale.
ALPINISMO COME ESPRESSIONE
DELLA VOLONTÀ DI UN GRUPPO
La spedizione trentina del 1957 al Cerro Torre, in Patagonia, celebrata al Trento Film Festival nel 1959, mostra la caparbia di un gruppo di alpinisti determinati a raggiungere la vetta: una volontà maturata nel contesto sociale, storico e alpinistico del Trentino degli anni cinquanta.
La spedizione trentina del 1971 al Nevado Caraz, in Perù, coinvolge direttamente il Comune di Trento, che la sostiene con grande impegno, e la Società
degli Alpinisti Tridentini, che celebra in quell’anno i 100 anni dalla fondazione. Nel 2021 il Trento Film Festival ha ricordato la spedizione in occasione del 50° anniversario.

La conquista dell’Everest nel 1953 a opera di Edmund Hillary e Tenzing Norgay, finanziata dall’Inghilterra e affidata al colonnello britannico John Hunt, incarna la volontà di una nazione di affermare se stessa mediante il raggiungimento di una vetta. La notizia della conquista della cima fu data durante la cerimonia di incoronazione della regina Elisabetta II, il 2 giugno 1953. Negli anni successivi il Festival di Trento accolse proprio Tenzing, in visita in Trentino.
Kurt Diemberger, tra i più grandi alpinisti di tutti i tempi, porta il cinema in alta quota alla fine degli anni sessanta. Con Julie Tullis forma il «film team più alto del mondo». Negli anni ottanta, Diemberger e la Tullis girano importanti documentari sulle vette più alte del pianeta. Grazie alla sua capacità di raccontare e documentare, nel 1989 Diemberger fu protagonista assoluto del Trento Film Festival, vincendo sia il premio per il miglior film (Genziana d’oro) sia il premio per il miglior libro (Premio Itas del Libro di Montagna).

La montagna come punto di incontro: una «geografia in comune» su cui cercare un confronto al di là delle barriere linguistiche, nazionali e belliche. Quando il Festival nasce, nel 1952, la Guerra di Corea è giunta all’apice e contribuisce a esacerbare gli equilibri della Guerra Fredda. Il clima geopolitico internazionale divide il mondo in due blocchi contrapposti e porterà presto alla costruzione del
Muro di Berlino. Il cinema di montagna si stringe attorno a Trento e il Festival diventa luogo di incontro tra mondi, promuovendo un messaggio di internazionalità e conciliazione. Fin dalle prime edizioni, nel periodo del Festival vengono esposte in piazza Dante le bandiere dei Paesi presenti alla manifestazione. La rassegna va oltre il significato dei film che vengono proiettati e diventa una finestra sul mondo.
IL FILM: Una cordata europea (Lothar Brandler, Germania 1964) vince a Trento il Gran premio Città di Trento e porta alla ribalta un nuovo alpinismo: senza frontiere. Finita la stagione dei nazionalismi, molte pellicole selezionate al Festival veicolano un messaggio di pace e fratellanza.


Come Ulisse, che ha avuto bisogno di raccontare il suo viaggio per renderlo reale, così anche alpinisti e viaggiatori raccontano le loro avventure, per fissarle nel tempo e nello spazio. Ma davvero la scrittura conferisce una maggiore credibilità ai fatti? Sicuramente attribuisce loro più forza e rende le esperienze più facilmente trasferibili. È questa la magia della narrativa di montagna.
Alla prima Mostra Internazionale del Libro di Montagna, nel 1956, promossa a Trento a cornice del Festival, erano presenti 99 case editrici con 667 opere. Quattro anni dopo, nel 1960, le case editrici sono 132 e i volumi presenti 759. L’iniziativa, rinnovata successivamente nel 1987, con la nascita della rassegna MontagnaLibri, si caratterizza oggi come la principale vetrina internazionale dedicata all’editoria di montagna: richiama centinaia di autori e di titoli ogni anno ed è tra i maggiori appuntamenti del Trento Film Festival.

Il 31 luglio 1954 gli italiani Lino Lacedelli e Achille Compagnoni sono i primi uomini a calpestare le nevi della vetta del K2, a 8.611 metri, che raggiungono grazie alle bombole di ossigeno portate da Walter Bonatti fino al IX campo, il più avanzato, a 8.100 metri.
La spedizione è sostenuta dallo Stato italiano, con l’impegno esplicito di Giulio Andreotti, allora sottosegretario del Governo De Gasperi. Patrocinata dal Club Alpino Italiano e guidata da Ardito Desio, la conquista della vetta è un successo internazionale e contribuisce a battezzare il K2 come la «Montagna degli italiani».
Nel 2022, il Trento Film Festival si è aperto con la prima proiezione assoluta di Italia K2 (Marcello Baldi, Italia 1955) con un filmato amatoriale inedito del ritorno della spedizione italiana a Karachi. Il restauro è stato realizzato dalla Cineteca di Bologna presso il laboratorio L’Immagine Ritrovata, in collaborazione con il Centro di Cinematografia e Cineteca del CAI e con il sostegno del Ministero della Cultura.
Collezioni Museo Nazionale della Montagna – CAI Torino Tenda da campo Ettore Moretti. Cassa per il trasporto. Piccozza con la scritta «A. Desio» incisa nella parte alta del manico. Tuta beige, composta da: giacca con cappuccio, cerniera in metallo e bottoni, bretelle interne, guanti, pantaloni con bretelle e due tasche, calzari. Moffole King Manufacturing Company Inc., modello Mittens Arctic 1952. Zaino di tela di colore rosso. Bandierine triangolari: Italia, CAI, Pakistan

Le esperienze dei luoghi possono generare senso di appartenenza negli individui e nelle comunità, assumendo un ruolo decisivo nei processi di formazione delle identità personali e collettive. «Il sentire di un posto – è stato scritto – richiede tempo per essere acquisito ed è fatto di esperienze ripetute giorno dopo giorno nel corso degli anni. Una miscela di immagini [istantanee], suoni, odori, armonie uniche di ritmi naturali e artificiali». L’identità alpina della città di Trento si nutre del Festival della montagna e viceversa. I luoghi del Festival e le atmosfere – i cinema, i teatri, la sala stampa, le vie, i ristoranti – simbolizzano contesti
che si ripetono nel tempo, diventando situazioni familiari per la popolazione e per la comunità di alpinisti, cineasti, fotografi, turisti e semplici appassionati. Questa geografia umana della città alpina racconta il rapporto tra le persone e i loro spazi di vita. Così il Trento Film Festival ha caratterizzato un territorio e si è identificato con esso, favorendo lo sviluppo di una continuità storica legata alle identità alpine e di montagna. Come osservato sulla stampa, nelle cronache del 1952: «si voleva fare una manifestazione di contorno e invece il Festival si è imposto»... 365 giorni l’anno.

MONTAGNA DI FATICA E BELLEZZA
Dal 14 al 18 settembre 1952 si svolge a Trento il 1°
Concorso Internazionale della Cinematografia
Alpina a passo ridotto. Nasce così il Festival della Montagna, nel momento in cui si tengono a Trento il 64° Congresso nazionale del CAI, in concomitanza con le celebrazioni per gli 80 anni di fondazione della Società Alpinisti Trentini (SAT). Nel suo proclama, il sindaco Nilo Piccoli saluta così l’iniziativa: «La montagna è per i trentini una scuola di fatica e di bellezze alla quale si sono formate le generazioni». Attraverso la manifestazione, che si afferma nel tempo come appuntamento annuale

per la cittadinanza, Trento si scopre e si conferma capitale della cultura di montagna, sia locale sia internazionale.
Con la nascita del Trento Film Festival, alcuni luoghi della città si affermano e ne diventano, essi stessi, espressione. Il linguaggio cinematografico, che trova nelle sale la propria rappresentazione, favorisce i momenti di incontro e di ritrovo, di discussione e condivisione: dai principali cinema cittadini (Cinema Astra, Dolomiti, Vittoria, Modena) al teatro Sociale, dal Centro Santa Chiara
al palazzo del Municipio fino ai più noti ristoranti del tempo (La Cantinota, Forst, Roma, Caffè degli Specchi, Caffè Europa). Le relazioni sociali della comunità internazionale degli appassionati di montagna (registi, alpinisti, scrittori, semplici curiosi) e le peculiarità della città di Trento (il paesaggio, la montagna, perfino le vie del centro) si influenzano reciprocamente conferendo al luogo un’identità alpina riconoscibile.
«Sette cittadini ogni cento escono di casa dopo le 20»: si legge a febbraio del 1952 sul quotidiano L’A-

dige. Eppure la città dove «si balla poco e si riposa molto» assisterà, di lì a pochi mesi, al «sorprendente e inatteso successo» del 1° Concorso Internazionale della Cinematografia Alpina a passo ridotto.
Sì perché una delle manifestazioni di contorno del 64° congresso del CAI diventa – come annota ancora la stampa locale – «il motivo centrale delle quattro giornate alpinistiche». La scelta di Trento si lega alla convinzione personale di Amedeo Costa, imprenditore trentino e vicepresidente del CAI, e al sostegno entusiasta dell’amministrazione comunale, che vede forse in questo appuntamento unico per la città una boccata d’aria fresca negli anni non facili del dopoguerra.
Negli anni sono nati sempre più festival del cinema, anche a tema montano e alpinistico. La manifestazione trentina, che nel frattempo ha cambiato nome in Trento Film Festival, è andata dilatandosi nel tempo, con iniziative lungo l’intero anno solare, e nello spazio, con una rassegna di avvicinamento sul territorio provinciale, con un’edizione bolzanina e con la costituzione di un’associazione internazionale di cinema di montagna (International Alliance for Mountain Film – IAMF).

Le atmosfere più autentiche del Trento Film Festival, ieri come oggi, perpetuano lo spirito delle prime edizioni. Un duplice viaggio. Quello più esplicito, della sete di scoperta e di avventura per il nuovo, per le terre mai viste, per le montagne mai scalate, per le difficoltà mai superate. E quello più nascosto, di memoria proustiana, che non consiste nel cercare nuove terre ma nella capacità di guardarle con nuovi occhi. Fin dalle prime edizioni, il Festival ha trovato nell’esplorazione il tema centrale, dalle vette più alte alle profondità dei mari, dai deserti di sabbia alle distese di neve e ghiaccio.
LA RASSEGNA IN COLONNA
Cuore pulsante di ogni festival: è il luogo degli incontri, dei gossip, dei pronostici. Che sia ai piani alti del teatro Sociale o sotto a un tendone in piazza Fiera, da qui passano giornalisti accreditati, registi, scalatori, donne e uomini di montagna. Da qui prende forma la rappresentazione ufficiale del Festival che raggiunge poi le testate locali e nazionali, le riviste di settore, le radio e televisioni,
fino alle nostre bacheche virtuali. Le cronache, e le tecnologie usate per documentarle, ci restituiscono l’eco del tempo e lo spirito autentico di una manifestazione che, per scelta, non ha mai avuto il suo red carpet.
PER OGNI SCATTO UN ANEDDOTO
I compleanni sono sempre l’occasione per scorrere l’album dei ricordi e riscoprire come eravamo.
Gli archivi del Festival custodiscono migliaia di fotografie, in bianco/nero e a colori: sono immagini in cui la ripetizione di rituali di premiazione, platee affollate e gite in Paganella si giustappone agli scatti rubati del dietro le quinte e ai servizi fotografici con vip di passaggio.
Un affresco corale che, visto in prospettiva, ci restituisce momenti indimenticati, aneddoti divertenti, piccoli gesti lontani.

È un rapporto quasi dialettico quello che si esprime tra gli oggetti e le persone, come se gli oggetti avessero una biografia da raccontare, dove dialogano mondi diversi: le storie di vita e le storie delle cose. Queste cineprese sono testimoni della quotidianità di coloro che le utilizzarono in spedizione, tra mille difficoltà, fatiche, delusioni, aspettative, drammi, conquiste. Le immagini che hanno catturato gettano un ponte tra le montagne scalate e i film realizzati, passando per le mani, le casse e gli zaini di quanti se le portarono appresso. Questi oggetti, che mostrano l’evoluzione tecnologica delle macchine da presa usate in alta quota tra gli anni sessanta e ottanta del secolo scorso, sono stati chiesti in prestito alla Cineteca del Club Alpi-
no Italiano durante il secolo scorso da alpinisti e cineasti in partenza per le spedizioni. Hanno viaggiato, filmato, vissuto. Molte sono ritornate, alcune sono rimaste sulle montagne, perdute. La selezione in mostra è stata curata dalla Cineteca del Club Alpino Italiano (proprietaria dei materiali) con la Fondazione Museo storico del Trentino e il Trento Film Festival. Il lungo lavoro di ricerca storica e di documentazione, che ha permesso di raccogliere le notizie che collegano le cineprese alle spedizioni, agli alpinisti e ai film prodotti è opera di Antonio Massena e Pamela Lainati, rispettivamente autore e curatrice del libro La memoria della luce – La Cineteca del Club Alpino Italiano tra storia e attualità, edito nel 2022 dal CAI: un volume originale, che restituisce pagine di storia affascinanti, disvelando le memorie che le cineprese raccontano. Le ricerche si sono basate sulla consultazione degli archivi ma anche sull’utilizzo delle fonti orali della storia: gli alpinisti viventi o i loro discendenti.
Collezioni Cineteca del Club Alpino Italiano
Cinepresa Bell & Howell «Magazine» 200EE
Cinepresa Bell & Howell «Magazine» 200
Cinepresa Paillard H16 Bolex

Cinepresa Bell & Howell «Magazine»
Cinepresa Bell & Howell 200 «Magazine»
«La bellezza della montagna è fatta di realtà immediata, come il cinema. Si impone, senza l’interpretazione richiesta da altri spettacoli» scrive lo studioso Pierre Leprohon. La montagna, come il cinema, è ritmo, una questione di movimento. Un connubio naturale per un genere dalle molte sfumature: dai film di conquista ai drammi biografici, dalle opere poetiche sulla montagna alle imprese di arrampicata estrema, dai reportage etnografici ai documentari naturalistici. Quando il cinema di montagna sbarca a Trento ha cambiato pelle rispetto alle origini: la montagna viene racconta-
ta in modo più realistico, in linea con la corrente del cinema vèritè francese. Inizia così la stagione documentaristica della conquista degli Ottomila, che segna gli anni in cui la rassegna diventa un punto di riferimento internazionale. Con lenti retrospettive guardiamo come il Festival ha comunicato visivamente la montagna, con i suoi manifesti e le pellicole passate da Trento, non solo le più acclamate o discusse, quelle che hanno vinto i premi più prestigiosi, ma anche quelle minori che hanno portato alla ribalta tutta la fatica creativa della regia di montagna.

«Pioggia di premi», si legge spesso sulla stampa a chiusura del Festival: negli anni si assegnano
Genziane, Nettuni, Rododendri, Genzianelle, Trofei delle Nazioni, Menzioni Speciali. Il primo anno il miglior film vince ben 150 mila lire e, su pressione del pubblico, l’Azienda turismo organizza una serata
di proiezione dei film premiati. Il riconoscimento più importante viene intitolato alla «Città di Trento» già a partire dalla 2a edizione, mentre viene associato alla Genziana d’oro dal 1977. I film vincitori sono a volte trionfi annunciati, altri inaspettate sorprese, altri ancora detonatori di scaramucce e polemiche, come in ogni festival che si rispetti.

L’ARTE DI GIRARE IN MONTAGNA
Nei film di montagna spesso cineasta, operatore di ripresa, fotografo e alpinista si confondono. Se li guardiamo nelle foto di scena mentre trasportano ingombranti cavalletti e pesanti cineprese a manovella, o riprendono con telecamere in analogico, o indossano leggerissime GoPro, vedremo sfilare davanti ai nostri occhi la storia della tecnologia del XXI secolo.
RETROSPETTIVE
IL CINEMA DELLE ORIGINI
Il cinema di montagna è più anziano del Festival di mezzo secolo, quasi coetaneo all’invenzione dei Fratelli Lumière. I cineoperatori di inizio Novecento, armati di macchine da presa rudimentali, raccontano una montagna già piena di fascino, a volte comica, solo più tardi tragicamente epica. Per recuperare le radici del genere, a Trento vengono organizzate retrospettive e proiezioni speciali sul

cinema di Luis Trenker, sull’opera del grande cineasta Marcel Ichac, sui film d’esplorazione di Robert Flaherty, sui film muti italiani, fino ai cartoon a tema montano, da Walt Disney ad Antonio Rubino.
COMUNICARE UNA FILOSOFIA
È la carta d’identità di un grande evento. Nei suoi 70 anni il Festival ha scelto artisti e studi grafici diversi per interpretarne lo spirito attraverso la propria visione artistica. Il risultato è un viaggio di suggestioni: poster fotografici giustapposti a illustrazioni, collage, geometrie, fotogrammi di film; vette che cedono il passo a nastri di pellicola, attrezzi da ripresa o da scalata, animali, bandiere e mondi. Ma è anche una corsa nella storia di questa particolare forma di comunicazione pubblicitaria.




Una storia lunga 70 anni non passa inosservata. Per 70 volte, dal 1952 a oggi, il Trento Film Festival si è ripresentato ogni anno nelle vie e nelle piazze della città, nelle sale cinematografiche e nei ristoranti. C’è tutta una ritualità che lo caratterizza: l’accoglienza degli ospiti, l’arrivo dei grandi alpinisti e dei cineasti, le premiazioni, l’osservanza dei cerimoniali, i momenti ufficiali e quelli conviviali, che riservano autentiche sorprese. È la città intera che si anima. Ma non solo. Per mostrare agli ospiti il Trentino, le gite in montagna e le escursioni al lago hanno portato il Festival fuori dalle mura cittadine, in un clima da vacanza dove si respiravano atmosfere leggere. Gli archivi fotografici del Trento Film Festival raccontano questa storia e custodiscono un tesoro. Direttamente dalle raccolte fotografiche, in queste pagine viene proposta una selezione di 70 scatti, perlopiù inediti, che percorre dal 1952 al 2022 alcuni tra i momenti più memorabili della rassegna e del suo rapporto con il territorio.

Il «papà» (ideatore) del Festival Amedeo Costa (secondo da sinistra) durante un’escursione (1953).




Cesare Maestri fa il baciamano all’attrice greca
Yvonne Sanson (1955).
Walter Bonatti con Gaston Rébuffat (1955).



Il
Escursioni al lago di Levico tra le gite per gli ospiti del Festival (1956).


Cesare Maestri, Norgay Tenzing e Lionel Terray quasi in cima alla Paganella (1957).
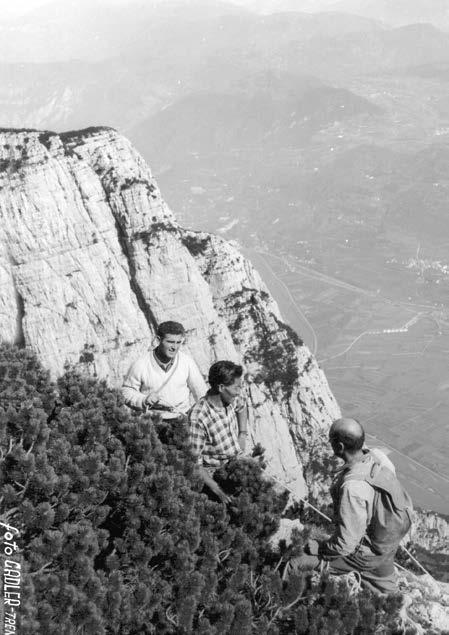
Norgay Tenzing e Achille Compagnoni: un incontro da film (1957).

In piazza Dante, fiaccolata in onore dei conquistatori del Gasherbrum IV, Walter Bonatti al centro (1958).





Gita in Paganella: si riconoscono
Cesare Maestri, Rolly Marchi, Gaston Rébuffat e Marino



Il regista Lothar Brandler ed Evi Soldà, figlia dell’alpinista

Gino Soldà (1960).
La regista Micheline Rambaud e Gino Soldà durante una gita sul lago di Garda (1960).

Sul lago di Garda l’alpinista Edmond Denis e la regista Hélène Dassonville (1960).

Uno sguardo dall’alto per una foto di gruppo con gli ospiti del Festival: si riconoscono tra gli altri Walter Bonatti, Cesare Maestri, Carlo Mauri, Pierre Mazeaud, Riccardo Cassin, Gaston Rébuffat, Rolly Marchi, Marino Stenico, Yvette Vaucher (1961).

Al teatro Sociale nelle giornate più attese della rassegna (1961).



Il giornalista Rolly Marchi si esibisce davanti agli alpinisti Walter Bonatti, Marino Stenico, Kurt Diemberger e Pierre Mazeaud (1962).

Escursione in Paganella: in seggiovia il regista Jean Jacques Languepin (1962).

Gita al lago di Garda, si riconoscono (da sinistra) Pierre Mazeaud, Toni Hiebeler, Kurt Diemberger, Walter Bonatti e Bepi Defrancesch (1962).

A castel Madruzzo, gli ospiti del Festival al concerto d’organo (1967).





Alla mostra Montagna da salvaremontagna da vivere, a palazzo Pretorio (1970).
Il sindaco di Trento Edo Benedetti consegna il distintivo in memoria della spedizione trentina al Nevado Caraz (1971).


Il




In piazza Dante sventolano le bandiere dei paesi partecipanti al Festival (1976).
In visita dall’estero per partecipare alla rassegna cinematografica (1977; foto di Flavio Faganello Soprintendenza per i beni culturali della Provincia autonoma di Trento).


Studenti e studentesse dopo una proiezione al teatro Sociale (1978).

Consegna del Chiodo d’Argento a Kurt Diemberger e Julie Tullis presso la casa della SAT - Società degli Alpinisti Tridentini (1980).

Una mattina per le scuole al cinema Dolomiti (1982).

Serata al teatro Sociale con le glorie dell’alpinismo: Walter Philipp (1982).

La commissione di selezione composta da Gianluigi Bozza, Piero Zanotto, Ulisse Marzatico, Achille Gadler (1982).
Cerimonia di premiazione del Premio ITAS del Libro di Montagna con Mario Rigoni Stern (in primo piano), Piero Zanotto, Aldo Matassoni, Alessandro Pietracci e Edo Benedetti (1982).





Reinhold Messner a un incontro tra alpinisti a castel Juval (1987).

Foto di gruppo: si riconoscono Maurizio Zanolla (Manolo), Alessandro Gogna, Luisa Jovane, Riccardo Cassin, Heinz Mariacher, Jean Marc Boivin, Eric Escoffier, Jean Afanassieff, Franco Perlotto, Reinhold Messner, Jerzy Kukuczka (1987).


Un dettaglio festivaliero (1988; foto Flavio Faganello Soprintendenza per i beni culturali della Provincia autonoma di Trento).



Manolo (Maurizio Zanolla) a Palazzo Trentini per l’incontro «40 anni di Film Festival - 40 anni di alpinismo» (1992).

Cesare Maestri (da destra) con Ermanno Salvaterra, Marco Furlani e Maurizio Giarolli (1992).









Il Festival attivo durante la pandemia Covid-19


Evento del Festival al parco dei Cappuccini di Bolzano (2022).

Il murales dedicato a Cesare Maestri nel quartiere di San Pio X, a Trento, realizzato dall’artista Umberto Rigotti con Tiziano Beber (2022).

In città il manifesto della 70a edizione firmato da Milo Manara (2022).




Le persone hanno fatto il Festival. Sono state loro, protagonisti e spettatori, gli interpreti e i destinatari della rassegna. Una storia, quella del Trento Film Festival, passata per le singole biografie e per i vissuti personali di tanti volti noti e meno noti. Gli sguardi soggettivi, le testimonianze e le percezioni restituiscono una coralità di voci che raccontano il Festival e il rapporto che essi hanno avuto con la manifestazione e con la città. Sono le voci degli alpinisti, eroi delle scalate in montagna, e degli esploratori, interpreti dei grandi viaggi. Sono le voci dei registi, per la cinematografia di settore, e degli scrittori, per letteratura di montagna. Sono anche le voci dei giornalisti, che hanno seguito il Festival attraverso le lenti della cronaca. E le voci dei produttori, che hanno lavorato per promuovere la categoria del cinema di montagna. Sono le voci, infine, di coloro che hanno organizzato il Trento Film Festival, dai direttori artistici ai membri delle giurie, dai selezionatori ai volontari. Abbiamo raccolto alcune di queste testimonianze per fissare sulla carta nuove tessere preziose del grande puzzle sulla storia e la memoria del Trento Film Festival.
Palma Baldo ha iniziato a scalare alla fine degli anni sessanta negli ambienti dalla Società degli Alpinisti Tridentini (SAT) sulle montagne di casa sua, in Trentino, per spostarsi poi sulle pareti più famose e difficili delle Alpi. Negli anni settanta scopre la California e con Giovanni Groaz scala la parete del Capitàn, nello Yosemite, diventando la prima donna europea a compiere l’impresa. Umile, generosa e appassionata, è tra le alpiniste trentine più forti di sempre.
È stata la prima guida alpina donna del Trentino, Palma Baldo. Praticando un alpinismo completo su roccia e ghiaccio, ha firmato numerose prime femminili assolute e italiane nelle Dolomiti, nei gruppi del Monte Bianco e delle Alpi Pennine. Negli anni settanta è tra la generazione di alpinisti che scopre la valle del Sarca, emblema di una rivoluzione che segna un punto di svolta per l’arrampicata moderna nelle Alpi. Poi, alla fine degli anni settanta si lascia appassionare dalla Yosemite Valley, la nuova frontiera dell’arrampicata, dove erano puntati gli occhi degli scalatori più forti al mondo. Ci arriva nella primavera del 1979 assieme a Giovanni Groaz. Con lui, compagno di cordata e nella vita, scala la via del Naso (The Nose) a El Capitan, scrivendo una pagina memorabile di storia dell’alpinismo. Sulla grande Big Wall della California è

la prima donna europea a salire la vetta. Nel 2022, dopo 50 anni di alpinismo, diventa socia onoraria del Trento Film Festival.
Cosa hai pensato quando ti hanno proposta come socia onoraria?
Quando mi ha raggiunta la telefonata del presidente del Festival, Mauro Leveghi, stavo andando ad arrampicare. Rispondo al telefono, ascolto quello che mi vuole dire e sul momento penso che si stia sbagliando. Io, socia onoraria del Festival della Montagna? Non mi sembrava possibile e non ci potevo credere. Socia onoraria, come Sergio Martini e altri grandi interpreti dell’alpinismo... Ho provato subito una grande felicità. Che cosa è stato e cosa rappresenta il Trento Film Festival per te?
Quando mi sono avvicinata all’alpinismo c’erano pochissime riviste, la televisione non era quella che conosciamo oggi, non c’era internet e non c’erano i telefoni portatili. Il Festival rappresentava per noi una finestra sul mondo. Era l’unico modo per conoscere altri alpinisti di valore e le montagne lontane. Era un’occasione di scambio e di conoscenza. Ed era praticamente l’unica possibile. Ho seguito il Film Festival come spettatrice e appassionata di montagna, assieme al pubblico variegato.
Poi ti hanno invitata come ospite.
C’è stato anche quell’aspetto, che coinvolgeva tutti noi alpinisti e professionisti della montagna. Quale?
L’invito al Festival. Noi tutti lo aspettavamo come fosse un premio alla fine di ogni stagione alpinistica. Quando toccava a te, era un grandissimo riconoscimento. Ricordo ancora quando ricevetti la prima lettera di invito: ero emozionatissima. Molti alpinisti lo hanno vissuto allo stesso modo. Il Festival ha sempre richiamato i protagonisti più importanti del settore; mi riferisco sia all’alpinismo sia all’arrampicata. In tutti questi anni ho potuto conoscere persone indimenticabili. Per esempio?
Oltre ai nostri più noti scalatori trentini, ho incontrato Renato Casarotto, Gian Carlo Grassi, Giorgio Bertone e Jim Bridwell. E molti altri nomi dell’alpinismo mondiale.
Bridwell, Grassi, Bertone: i principali «scopritori» della Yosemite Valley, in California. Proprio così, fu grazie al Festival – quando cominciai a frequentarlo, nei primi anni settanta – che venni a sapere dello Yosemite. La molla per partire per il Nord America è scattata al Festival. Prima di allora non immaginavo neanche che esistessero, quelle montagne californiane.
Che cosa riuscisti a scoprire, al Festival, dello Yosemite?
Nel 1978, a Trento, il film El Capitan (Stati Uniti, 1978) vinse la Genziana d’oro. Andai ad assistere alla proiezione e ne rimasi affascinata. Il regista, Fred Padula, mostrava la salita di quattro scalatori californiani su una parete di granito di 1.000 metri che si chiamava El Capitàn. Le immagini restituivano sapientemente il carattere alpinistico di quell’impresa, la tecnica e la bravura dei protagonisti, il fascino di quegli ambienti naturali, dando vita a uno spettacolo cinematografico indimenticabile.
Dopo aver visto il film, era così tanta la voglia di vedere quei posti, di scalare quelle montagne, di scoprire quel mondo lontano, che non potemmo resistere. Nella primavera dell’anno successivo, io e Giovanni partimmo insieme per la California; fu così che ci trovammo ai piedi della Sierra Nevada ancora bianca di neve, nella Yosemite Valley. Era il 1979 e volevamo salire l’immensa parete di El Capitàn che ci stava di fronte: un’esperienza che ci cambiò la vita.
Che cosa avete trovato?
Un mondo nuovo, in tutti i sensi. Sia dal punto di vista sociale, sia culturale; era il tempo del nuovo sogno americano, pochi anni dopo il Vietnam, e gli scalatori locali che incontrammo nella mitica Valley vivevano con una mentalità e uno sti-
le molto differenti dai nostri. Anche da un punto di vista sportivo: imparammo a confrontarci con un nuovo tipo di arrampicata, nuovi attrezzi, movimenti sconosciuti. A Yosemite, i ragazzi del luogo salivano su quelle fessure di granito con una tecnica e uno stile diversi dai nostri. Noi eravamo legati a un’interpretazione più classica. Persino l’abbigliamento era differente: loro non portavano pantaloni alla zuava, mettevano scarpette lisce al posto degli scarponi e indossavano vestiti comodi e fantasiosi. Restammo affascinati anche da quegli orizzonti sconosciuti: foreste a perdita d’occhio, rocce vertiginose, altissime cascate imponenti. Incontrammo una generazione di scalatori che ci insegnò a guardare le cose da una diversa prospettiva, senza ideologie competitive o eroiche. Fu questo che portammo a casa: un’esperienza di viaggio straordinaria.
Ritrovaste anche Jim Bridwell, simbolo di quella generazione?
Certo, lo incontrammo nella sua Yosemite Valley come un re nel suo castello, e diventammo subito amici.
Ma è tutto vero quello che si dice su di lui?
Ci sono molte leggende su Jim Bridwell. A Yosemite era venerato come un profeta. Un personaggio eccentrico, completamente fuori dal comune. Uno scalatore fortissimo, non soltanto sui graniti di Yo-
semite, ma anche in giro per il mondo, dall’Alaska alla Patagonia, dalla Cina all’Himalaya, su misto, roccia e ghiaccio. Autore talvolta di imprese ai limiti dell’umano. Un maestro dell’alpinismo. Tanto era poco impegnato nella vita di tutti i giorni, quanto era rigoroso, impeccabile in parate. Negli ultimi anni, prima che ci lasciasse, lo accompagnammo varie volte per conferenze alpinistiche in giro per l’Italia, dove aveva molti estimatori.
Quando siete tornati in Trentino, dopo la conquista del Capitàn, come sono cambiate le vostre vite?
Abbiamo cercato di portare nell’arrampicata alcune cose di quanto avevamo imparato in California.
Avete scoperto così la Valle del Sarca?
In Valle del Sarca, che già avevamo iniziato a frequentare alcuni anni prima, abbiamo trovato il modo per sperimentare a casa nostra alcune tecniche che avevamo appreso nello Yosemite. Fu un momento di svolta, il passaggio da un tipo di alpinismo a un altro.
L’alpinismo tradizionale, quello che avevamo conosciuto fino a quel momento, poneva in primo piano una sorta di dimensione eroica, legata al raggiungimento della vetta. Per noi, dopo l’esperienza americana, erano diventate altre le priorità, specie a bassa quota. Non c’era soltanto la neces-
sità eventuale di arrivare in vetta, ma contavano soprattutto le modalità con le quali si scalava. Mi riferisco alla bellezza del gesto atletico. Cercavamo di salire le pareti privilegiando una dimensione estetica. Senza dimenticare una giusta etica. Anche la società stava cambiando. In Europa stavamo attraversando una fase di profonda transizione. Cambiava lo stile di vita e cambiava la società. La ventata di freschezza degli anni della contestazione, il Sessantotto, cominciò a modificare anche il mondo dell’alpinismo, soprattutto verso la fine degli anni settanta. Allo stesso tempo, l’attrezzatura tecnica migliorava velocemente. La mia generazione scalava con gli scarponi da montagna e, all’inizio, senza l’imbracatura. Poi, proprio all’inizio degli anni ottanta, anche grazie alla rivoluzione californiana, cominciarono a diffondersi le scarpette e la magnesite. Io e Giovanni abbiamo vissuto tutti questi cambiamenti sulla nostra pelle. Parli sempre di Giovanni Groaz, il tuo compagno. Quanto è importante la vostra cordata?
Giovanni è un sognatore, a volte un po’ troppo. Il nostro legame, in più di 40 anni di vita in comune, è sempre stato forte. Abbiamo fatto tutto insieme e lo abbiamo fatto spontaneamente. In montagna, nella vita, con nostra figlia: i momenti insieme, nonostante qualche attrito, sono solitamente
sereni. Mi è difficile immaginare quello che ho fatto senza la nostra complicità.
E nei momenti di tensione?
Quando ci sono tensioni… Allora andiamo ad arrampicare insieme e passa tutto. Lo abbiamo fatto sempre e continuiamo a farlo ancora.
Avete condiviso ogni cosa, anche le paure?
Il timore, in montagna, è giusto che ci sia. Deve rimanere una presenza controllata. È indispensabile per tenere l’attenzione alta.
Come quando eravate sullo Yosemite?
Sì, ma non solo. Ci siamo trovati varie volte in situazioni difficili. Abbiamo avuto fortuna, siamo sempre tornati a casa. Ma in quei momenti, quando non sapevamo se ne saremmo usciti, la forza di poter contare sulla nostra cordata è stata fondamentale per me e Giovanni. Ricordo una nostra scalata, sul Cervino. Eravamo in parete, quando cominciò a grandinare. Non vedevamo vie di uscita, cadevano sassi. Mi spostai dalla sosta e subito dopo venne giù tutto. Sarebbero bastati pochi secondi. Poi Giovanni mi passò davanti e disse che avremmo potuto salire in obliquo per uscire sulla cresta sommitale. Andò bene. Ancora oggi, quando ci penso, mi rendo conto che l’elemento più importante in quella situazione, così come in molte altre, fu la reciproca fiducia, il rapporto di solidarietà e l’amore che ci univa.
Sei stata la prima guida alpina donna in Trentino. Hai trovato resistenze in un mondo tipicamente maschile?
Non mi sono mai posta il problema di essere donna. Sono stati gli altri che me lo hanno spesso evidenziato. Non è stato facile. Ho dovuto subire situazioni, commenti, giudizi che non avrei mai voluto vedere e sentire. Cose che, oggi, non accetterei più. E in ogni caso, la mia vita alpinistica si è svolta principalmente con Giovanni. Con lui, tutte queste cose sono passate in secondo piano. Dopo il 1979, quando avete scalato il Nose, siete più tornati nella Yosemite Valley?
Giovanni è tornato lì a più riprese, per arrampicare con Bridwell. Io ci sono stata ancora un paio di volte, all’inizio degli anni novanta e poi una decina di anni fa. Nonostante sia trascorso molto tempo, la Yosemite Valley non è cambiata molto. Anche se alcuni americani hanno impostato ultimamente un tipo di arrampicata estremamente competitiva e rischiosa. Certo, oggi è più turistica di un tempo, ma i limiti imposti dal parco nazionale impediscono stravolgimenti. Le atmosfere che abbiamo respirato allora sono ancora quelle. Orsi e procioni sono ancora lì, tra le sequoie, ad aspettarci.
Bruno Bozzetto è animatore, disegnatore e regista. A 20 anni realizza il primo cortometraggio Tapum! La storia delle armi (Italia, 1958) e a 22 fonda la Bruno Bozzetto Film. Coi suoi lavori vince numerosi premi internazionali, oltre a una candidatura agli Oscar. Nel 2014 il Walt Disney Family Museum di San Francisco gli dedica la retrospettiva Animation, Maestro!. Al Festival di Trento partecipa con sette opere tra il 1963 e il 1992. «Una delle cose peggiori della nostra civiltà è che manca il silenzio. Perfino in ascensore c’è la musica! Io ho bisogno del silenzio: aiuta a riflettere. La montagna per me è una camera di decompressione; le più belle idee mi sono venute camminando». Bruno Bozzetto ha la passione per la montagna fin da ragazzo, grazie al padre Umberto che a Madonna di Campiglio ha aperto un sentiero sulla dorsale del Monte Zeledria e costruito casa a metà anni sessanta. Mentre si racconta in videochiamata, fa capolino sullo sfondo il ritratto di uno dei suoi personaggi più noti, quell’italiano medio vestito di rosso che ci ha strappato più di un sorriso.

C’è una foto con il tuo signor Rossi anche nell’archivio del Festival: l’avevi disegnato sulla lavagna della sala stampa al Grand Hotel Trento.
Ho fatto pochi film sulla montagna. Quello che è passato più volte al Festival è sicuramente Il Signor Rossi va a sciare (Italia, 1963), che è completamente diverso dai documentari di montagna classici, soprattutto quelli del periodo. Perché vuole far divertire: è una presa in giro della montagna e dello sci. Come anche … E il settimo giorno riposò (Italia, 1963), la mia prima partecipazione al Festival. Era un documentario girato con una Paillard Bolex 16 mm andando a rubare le scene sulle piste da sci a Campiglio. Mi son preso anche qualche insulto, perché riprendevo tutte queste cadute con gli slittini e prendevo in giro quelli che non sapevano sciare, allora ce n’erano tanti! Questo film è diventato un cimelio storico, perché fa vedere quanto siano cambiati Madonna di Campiglio, l’abbigliamento, lo sci, le piste, tutto. La chiave ironica nel genere del cinema di montagna era inusuale al tempo, non meno della scelta di fare animazione per adulti. Ho cominciato subito a parlare dell’uomo, soprattutto della stupidità umana. Nel mio primo film, La storia delle armi, mi chiedevo perché gli esseri umani non pensano ad altro che inventare armi
e fare guerre. È chiaro che non era il solito film coi tre porcellini rivolto all’infanzia, ed essendo diverso come argomenti ha suscitato più interesse anche nella critica.
Anche se hai fatto pochi film a tema montano, la montagna è importante per il tuo lavoro?
La montagna mi ha aiutato sicuramente molto. Mi ricordo camminate di ore con questo passo quasi ipnotico, sempre uguale, di mio padre. Uno dei miei film più belli nasce dallo stare dietro a lui per ore e ore: Mister Tao (Italia, 1988; Orso d’oro al Festival di Berlino 1990). Vedere questo passo che avanza sempre, avanza e continua a salire, mi ha fatto nascere l’idea che la vita fosse tutta lì: non la conquista di una meta, ma un avanzare anche senza una destinazione nota. Poi, se si sale in una maniera «umana», il cervello funziona, il sangue circola, si è molto più vivi nel creare. Per questo mi piace andare anche da solo e registro le idee che mi vengono: un microfono in tasca e un posto meraviglioso sono il massimo per creare. Una volta mentre salivo al Brentei ho incrociato cinque finanzieri che vedendomi parlare con questo aggeggio chissà cosa avranno pensato!
Questa dimensione solitaria sembra così lontana dal mondo cinematografico…
In realtà è il motivo per cui ho iniziato a fare animazione. A me piaceva il cinema, ma mi ero reso
conto che era difficile fare i film dal vero, richiedeva un’organizzazione. Io invece ero un’aquila solitaria, cioè avevo un’idea e cercavo di realizzare il film. Quindi visto che disegnavo sempre, ho provato a fare tanti disegni su block notes, ricalcandoli da una pagina all’altra e cambiando dei particolari; poi li fotografavo con una 8 mm e vedevo che si muovevano. È stato un periodo molto eroico, entusiasmante ma faticoso perché non c’erano libri su cui imparare né strumentazione. Meno male che mio padre, oltre a portarmi in montagna, era un grande tecnico: il mio primo film d’animazione l’ho fatto sull’asse da stiro di mia mamma, modificata da mio padre in una macchina da ripresa.
Montagna e cinema, Madonna di Campiglio e Trento.
A Madonna di Campiglio ci sono i posti del cuore: le Bocchette, il Tuckett, il rifugio Brentei. Ma è tutto il mondo della montagna che mi affascina: la natura, gli animali, la nebbia, i boschi. E quindi Trento per me rappresentava il condensato – in maniera diversa, attraverso i film, i libri, ecc. – di tutte le cose che stimo siano le più belle e le più importanti. Poi al Festival uno va anche per distrarsi, è una cosa un po’ mondana. Ho conosciuto tante persone. Però non sono un fan degli alpinisti. Li ammiro, li capisco. Ma anche quando leg-
go un libro di Maestri, che conoscevo benissimo, mi paralizzo quando vedo che rischia la pelle per fare certe cose. La mia è una passione tranquilla, di godimento poetico. Loro invece lo fanno per raggiungere o battere dei record. La montagna è sempre una zona vittoriosa per me.
Al Festival hai partecipato non solo coi tuoi film, ma anche con una sigla realizzata ad hoc per l’edizione del 1980.
C’è una storia curiosa dietro a quella sigla. Erano gli anni di Piero Zanotto alla direzione del Festival. Piero era un mio carissimo amico: con lui conoscevo il dietro le quinte dei film, mi piaceva perché entravo nell’intimo della manifestazione. Forse anche per questo mi chiese di fare la sigla. Io non ne avevo mai fatte e sono partito con una idea strana: la storia di un ciclista che fa sosta in un prato, tira fuori dallo zaino un panino, questo gli sfugge, lui lo insegue finché arriva in cima alla montagna… e qui il panino si sollevava in aria e appariva il nome del Festival. Il problema è che quando inizio a girarla, la storia cresce e diventa un cortometraggio. Per cui per la sigla mi sono inventato un’altra cosa, e mi trovo con un film in mano, per caso. Ed era talmente surreale e divertente che ha avuto un successo strepitoso, è perfino diventato una serie per la televisione svizzera (Sandwich, Svizzera, 1984).
Il modo in cui parli della montagna e del linguaggio cinematografico che usi per esprimerti, mi fa pensare a cosa saresti stato se non avessi fatto questo mestiere…
Sicuramente sarei rimasto nel campo dell’invenzione. Quando mi dicevano «devi fare un film di un minuto, senza parole, sull’empatia», io mi esaltavo.
Per fare un film ci metto il 90% del tempo a pensarlo e il 10% a farlo. Questo è il rapporto giusto se vuoi fare un discorso di comunicazione. Oggi c’è una rincorsa all’effetto speciale, ci sono film perfetti in ogni dettaglio tecnico ma senza una storia. Io sono un po’ contro questa tendenza, perché penso che sia il messagio a dover arrivare e a dover
arrivare nella maniera giusta. E credo anche che se uno fa un film non debba scegliere argomenti troppo di moda, ma temi universali che anche tra 20 anni siano ancora validi.
Hai vinto anche un premio alla carriera al Trento Film Festival nel 2005…
Mi han dato credo 33 premi alla carriera, quindi ho perso il conto. Dovrei essere già morto 33 volte, perché ogni volta che mi danno un premio alla carriera io penso «è l’ultimo!». Però in quegli anni al Festival c’era Maurizio Nichetti come direttore artistico, che aveva lavorato con me e ha continuato la tradizione di farmi andare a Trento. In cambio gli ho insegnato a sciare!
Francesca Braito lavora per l’associazione di promozione sociale Carpe Diem e il Forno Sociale Migola. Grande appassionata del Festival, ne è diventata reporter per caso: prima con le recensioni dei film sulla sua pagina Facebook e poi con la rubrica «Grazie per la domanda» sul quotidiano Il Dolomiti. «Quando vedo i film del Festival mi sento un po’ a casa». È originaria della val di Fiemme e ha cominciato a frequentare le sale di proiezione per una ragione affettiva. «Le serie sulle piattaforme sono sature di imput visivi e sonori, io preferisco la lentezza delle immagini e la lentezza di stare seduta al cinema per ore. Il primo ricordo del Festival è un corto sul ritorno dall’alpeggio di una comitiva di mucche. Erano tutte inquadrature di occhi di mucca, schiene di mucca, code di mucca… l’ho trovato meraviglioso!».

Il Festival non è un appuntamento solo per uomini e donne di montagna, alpinisti, scrittori e filmmaker che a Trento si danno appuntamento ogni anno. Tu come ti prepari alla rassegna?
La rassegna Avvicinamenti è un po’ il mio calendario dell’avvento. Poi il Festival combacia con le mie feste preferite, il 25 aprile e l’1 maggio, e mi dà quella sensazione di ritorno alla vita tipica della primavera. Quando esce il programma io mi gaso. E ho tutta
una mia routine: faccio una lettura integrale delle sinossi che ci sono sul cartaceo e mi affido solo a quelle. Non guardo trailer, né mi informo online. Faccio un cerchio intorno ai film che voglio vedere e un asterisco vicino a quelli assolutamente imperdibili. Poi incrocio il calendario delle proiezioni. Negli anni d’oro sono riuscita a vedere anche 25/30 film.
E quali storie ti attirano di solito?
Tendenzialmente scelgo storie di comunità montane, documentari di ricerca antropologica, non tanto su chi la montagna la sfida, ma più su chi la vive tutti i giorni. La mia sezione preferita è «Terre alte». La gente di montagna in qualche modo si assomiglia, perché la montagna ti mette davanti alla stessa fatica. Vado a vedere anche film che sulla carta sembrano noiosissimi: di solito l’espressione «di ampio respiro intimistico» mi fa capire che le parole pronunciate saranno in totale 12.
Poi c’è da dire una cosa, non so quanto casuale: io non vedo praticamente nessuno dei film premiati. Ormai ne faccio un vanto.
Allora ti chiedo di assegnare la tua personale Genziana…
Non sono forte coi titoli, ma mi ricordo molto bene le storie. Tra le mie preferite: La Grand-Messe (Belgio-Francia, 2018), che ha vinto la Genziana d’oro, su un gruppo di appassionati di ciclismo sulle sa-
lite del Tour de France; il viaggio epico dei polacchi col kayak durante la guerra fredda [Godspeed, Los Polacos!, Stati Uniti-Polonia-Perù, 2020]; e la storia commovente di questa signora sulle montagne turche, lei e le sue mucche, una forza d’animo incredibile [Beloved, Iran, 2018]. Ho pianto sempre.
Hai anche un posto feticcio in sala?
Assolutamente sì. Posto laterale, fila L o M, tendenzialmente a sinistra, con un posto libero davanti per appoggiare le ginocchia. Se li trovo prenotati un po’ mi girano...
Raccontami come scrivi le recensioni.
Ci tengo a precisare che non sono un’esperta, per cui le mie recensioni sono spontanee; e così anche le valutazioni che assegno in calici di vino (da uno a cinque). Di solito scrivo di getto appena esco dal cinema; infatti le recensioni contengono tutte quattro-cinque refusi: ti potrei dire che è una scelta di stile, per far vedere che il commento è in presa diretta! Mi rendo conto che mi fisso spesso su un particolare e finisco per non parlare per niente del film. Non so ad esempio, una volta un regista esordisce dicendo «Non ho molto da dire»: presentava un documentario di 25 minuti e ha parlato per 32! L’ho trovato tenerissimo. Oppure, capita che un film sia molto lento e succede qualcosa che ti tira all’improvviso giù dalla sedia.
Una volta, non smettevamo più di ridere. Era un film con un alpinista rumeno, un’impresa epica, l’uomo solo contro la montagna. Quando arriva in cima, tira fuori dalla tasca dei fogli A4 spiegazzati con scritto una roba del tipo «carrozzeria da Gianni».. E li mostra alla telecamera. C’era una tale distanza tra la narrazione di prima e questi foglietti che ci ha stesi. Non siamo riusciti a smettere di ridere per il resto della proiezione.
Il pubblico spesso diventa vittima delle tue recensioni.
In generale al cinema mi piace osservare le persone, ascoltarne i commenti, vedere le facce. La mia categoria preferita di spettatori del Festival sono quelli che si emozionano quando ci sono gli animali sullo schermo. C’è sempre qualcuno che annuncia la comparsa dell’animale, di solito un cucciolo, gridando «Vara l’agnelot!». Io ho poche certezze nella vita, ma questa non mi abbandona da anni.
Come hai vissuto il Festival su piattaforma, conseguenza della pandemia Covid-19?
Ero contenta che il Festival non si fosse fermato, la selezione dei film è rimasta altissima però l’esperienza è diversa. In sala uno può fare anche tre proiezioni filate: mi ricordo giornate al cinema dalle 15 alle 23 con grande scioltezza. A casa è un altro approccio, meno totalizzante: metti in pausa, ti cade la coperta, fai uno spuntino. E poi manca lo scambio: la pausa sigaretta in cui ti chiedi cosa hai visto, cosa ti è piaciuto, anche perché io rubo i commenti degli altri!
Chiudi gli occhi ed esprimi un desiderio per il Festival del futuro.
Vorrei tantissimo che tornassero le proiezioni notturne. Richiedo a gran voce lo spettacolo delle 23. Un anno ho visto un film di zombie coi Lederhosen e non mi sono mai più ripresa [Attack of the Lederhosenzombie, Austria, 2016]! E poi che il Festival continui a essere attento a quello che gli succede intorno, a livello di linguaggi e di tematiche. E che ci sia sempre questo clima rilassato, accogliente, che si respira in città quando c’è il Festival.

Billy Choi ha lavorato per molti festival in Corea del Sud, tra cui il Jeonju International Film Festival, l’International Film Festival of Women Seoul e l’Ulju Mountain Film Festival, di cui è stata per molti anni direttrice della programmazione oltre che volto internazionale della rassegna. Ha fatto parte del Korean Film Council e del comitato Korean Barrier Free Film.
«Ho un grande senso di gratitutine verso Trento, è il primo posto che abbiamo visitato per imparare a fare il nostro festival di Ulju». Durante la videocall intercontinentale Billy Choi scherza spesso sul suo «rapporto particolare con la montagna» ma rispetto al festival che ha organizzato con passione nelle prime edizioni non ha dubbi. «Lo considero il più grande successo della mia vita. All’inizio non avevamo molto credito, la produzione nazionale era scarsa… ho pensato spesso a cosa deve essere stato iniziare un festival negli anni cinquanta».
Quando sei venuta a Trento la prima volta?
Era il 2014 e facevo parte di una sorta di task force incaricata di organizzare una rassegna di cinema di montagna a Ulju, una contea di Ulsan in Corea del Sud. Sapevamo che Trento era il festival di montagna più antico al mondo e volevamo conoscerlo da
vicino. Così una delegazione di sette persone è partita per Trento: abbiamo conosciuto Rosanna [Stedile] e Luana [Bisesti] che già lavoravano al Festival da diversi anni. Ci hanno fatto davvero da balia! Il presidente, Roberto De Martin, diceva che il festival era «bambino» [ride pronunciandolo in italiano]. Ma ci fece anche arrabbiare parecchio… Perché?
Ricordo che a un certo punto disse che eravamo il Festival delle piccole colline [little hills]. Per noi fu uno shock, perché siamo così orgogliosi delle nostre montagne! Non sono alte come le Alpi o l’Himalaya ma sono bellissime, hanno una vegetazione fiorente, bellissimi fiori... Insomma ce l’eravamo un po’ presa. Poi ho capito che non voleva certo insultarci. Anche perché davvero le nostre montagne sono «piccole»... Siamo sotto i 2.000 metri!
Come sei arrivata a lavorare per un festival di cinema di montagna?
Per caso. Quando ho iniziato a lavorare a Ulju per me le montagne erano solo montagne! Sono una donna di cinema, venivo dal mondo dei festival, le montagne erano qualcosa a cui non prestavo attenzione, non mi piaceva neanche camminare in montagna. Poi è cambiato tutto. Mi sono innamorata del cinema di montagna, ho cominciato perfino ad arrampicare…
E a camminare?
Non esageriamo! Mi piace guardarle, dalla finestra di casa mia. Mi danno il senso del tempo che passa.
Hai «rubato» qualcosa dal Festival?
In generale per preparare la prima edizione a Ulju, ho dovuto copiare da diversi festival di montagna in giro per il mondo. Di Trento ho cercato soprattutto di replicare l’equilibrio nella programmazione tra film di alpinismo, pellicole che raccontano la cultura di montagna e lavori più sperimentali. Quando abbiamo lanciato il nostro festival, il film di montagna era un genere nuovo per il pubblico sudcoreano, quindi la lezione di Trento è stata utile per abituare le persone e per dare a tutti – alpinisti, appassionati di cinema, curiosi – qualcosa che potesse soddisfarli.
Ti ricordi qualche film in particolare?
Il nostro Festival era in settembre, quindi per me Trento era Cannes! Un mercato dove venire a scegliere i film da proiettare al mio festival. Ho passato non so quante ora nella saletta di visione, ho scelto tantissimi film a Trento. Uno di quelli che ricordo di più, perchè poi è stato un grandissimo successo da noi, è The Dawn Wall (Stati Uniti-Austria, 2017), la storia drammatica di Tommy Caldwell e poi l’impresa ai limiti dell’impossibile con Kevin Jorgeson.
Immagino non fossi l’unica a passare ore in sala visione a Trento…
Mi piaceva vedere come ognuno di noi pensasse al pubblico del proprio Festival, a cosa poteva interessarlo. Ci sono sempre state due scuole: chi preferisce i film di alpinismo a prescindere e chi giudica prima l’estetica cinematografica. Questa
è una delle discussioni più ricorrenti, anche nelle giurie a cui ho partecipato. All’inizio era un dibattito che non riuscivo a capire. Poi ho cercato di imparare il più possibile del mondo alpinistico…
E cos’hai concluso?
Che un buon film deve avere entrambi: l’eccellenza filmica e i valori dell’alpinismo.
Come ti trovi quando vieni a Trento?
Dal 2014 ci sono venuta tutti gli anni fino alla pandemia. È diventata una delle mie città preferite, assomiglia un po’ a Ulju, nel senso che anche la città in cui vivo è circondata dalle montagne. Non è grande nè rumorosa, come Roma o Milano. E le
persone mi sembrano diverse dall’immagine che abbiamo degli italiani: i trentini sono pacati e abbastanza silenziosi.
Hai anche dei posti preferiti?
Il mio posto preferito in assoluto è il Campo Base, mi piace per il cibo, buono ed economico, e per la gente. È il posto in cui incontri tutti; da straniera non è sempre facile ordinare ma lì tutti erano amichevoli. E poi mi piacevano anche alcune gelaterie e… i negozi di scarpe! Non me ne sono mai andata da Trento senza aver comprato almeno tre paia di scarpe.
Fai un augurio al Festival.
Innanzitutto, voglio fargli un grande applauso [batte le mani]. Penso che 70 edizioni siano un risultato incredibile. Io associo il Trento Film Festival alle persone: il gruppo secondo me è la forza di questo Festival. Per cui l’augurio che posso fare è che resti la passione di innovare e rinnovarsi anno dopo anno.
Paolo Cognetti è uno scrittore di romanzi, racconti e saggi. Nel 2017 ha vinto il Premio Strega con Le otto montagne, da cui è tratto il film omonimo con Luca Marinetti e Alessandro Borghi. Vive tra Milano ed Estoul, un paesino della Valle d’Aosta dove ha costruito e gestisce un rifugio culturale. Dal 2018 al 2022 ha fatto parte della giuria del Premio Itas del Libro di Montagna. «Tutte le scene en Plein air che ci sono nei miei libri sono state scritte ‹dal vero›. Mi porto sempre un quaderno quando vado a camminare, mi piace sedermi lì su un sasso e provare a scrivere una scena con quel lago, quel ghiacciaio, quel torrente come se fosse una pittura». Mentre si racconta, Paolo Cognetti è seduto per terra, con il suo inseparabile cane Lucky, in un altro habitat familiare: una libreria di Milano. «Da bambino ho scalato l’Everest più volte con i libri». E cita subito Reinhold Messner…
Com’è stato incontrarlo di persona? Pensa che il primo ricordo che ho del Festival è quando ho incrociato Messner per strada. Era uno dei miei miti, è stato come incontrare una rockstar! Ma non l’ho fermato né niente… non sono quel tipo di fan: mi basta guardarlo da lontano e pensare che siamo stati vicini per qualche secondo.

È stato il primo di una serie di incontri. A Trento ho conosciuto Enrico Camanni, per me fondamentale, perchè è stato il primo che ho letto a definire la montagna come luogo politico, spazio di ribellione e di eresia, come rifugio per diversità di ogni tipo. E quest’idea mi è entrata dentro. Anche di Mauro Corona ero un grandissimo lettore e incontrandolo ho scoperto tutta la sua umanità. È raro incontrare una persona famosa, così accogliente e calorosa – sicuramente sempre
esuberante, però è uno degli scrittori più generosi che abbia incontrato. Poi Trento è un po’ l’ombelico del mondo nei giorni del Festival. Una città così intrisa di cultura è rara in montagna. Da valdostano un po’ vi invidio questo fermento. La dimensione internazionale soprattutto. Nel 2018 in giuria ero l’unico italiano. E poi il territorio ha la capacità di essere un catalizzatore di esperienze: a Trento ho conosciuto storie di ripopolamento alpino, creazione di luoghi d’incontro e sperimentazione. Ti sembra che anche la narrazione della montagna stia andando in questa direzione?
L’alpinismo contemporaneo mi sembra sempre più vuoto di contenuti. Mi spiace dirlo, ma sono grandi prestazioni sportive, non ci vedo più il senso umano e di avventura dell’alpinismo classico. Di conseguenza, i libri e i film di alpinismo per me hanno perso un po’ di valore. Di contro, la narrazione più interessante oggi riguarda la vita in
montagna, di chi va a viverci e delle ultime civiltà di montagna in giro per il mondo. Non so perché ma mi è rimasto impresso un film che ho visto al Festival qualche anno fa sui raccoglitori di miele nepalesi: The Last Honey Hunter (Stati Uniti, 2017). Una scheggia di bellezza.
C’è un altro ricordo cinematografico che racconti spesso. Dopo aver visto Into the Wild, il giorno del tuo 30° compleanno, hai affittato una baita per tre mesi e hai deciso di ricominciare a vivere la montagna. Cosa rappresenta per te? Forse la felicità. Nei miei racconti c’è sempre una montagna felice, fatta di persone che lì si ritrovano, si connettono con una dimensione primordiale di sé, e si prendono cura l’una dell’altra, persone gentili. Sono quasi sempre tutti buoni nei miei libri. Altri scrittori vedono la maestosità del paesaggio, l’avventura, la prestazione sportiva. Io ci vedo l’infanzia. Ho iniziato ad arrampicare a sette anni e ancora oggi quando sono su una crestina – di quelle facili, non dove bisogna arrampicare, ma semplicemente mettere giù le mani, saltare da un sasso all’altro e avere sotto il vuoto – mi sento di nuovo un bambino, sono felice e mi rendo conto che quella è la mia infanzia che torna alla luce. Però vorrei che la mia montagna fosse completa. Prima o poi dovrò affrontare la montagna della violenza, della rabbia, dell’alcool, la montagna dell’alienazione insomma, quella di cui scrive
Mauro Corona. Mi aspetta un po’ di lato oscuro... E come farai?
Con pazienza, cercando di mantenere la calma. Negli ultimi anni pratico tanto yoga, che assomiglia all’andare in montagna. Perché c’entra molto con il respiro, con lo stare dentro alla fatica, in una posizione scomoda che ti sembra che ti romperai da un momento all’altro e ne vuoi uscire immediatamente. Invece stai calmo, respiri e alla fine addirittura ti sembra di stare quasi comodo. La fatica diventa una bellissima sensazione, anche quando scrivi. Mai come in montagna mi capita di esplorare il limite della fatica: quando ti sembra di non farcela più e poi trovi dentro di te una riserva di energie non fisiche ma mentali. Quando lo scopri è bellissimo e ti aiuta anche in altre situazioni della vita. Lo dicevano anche Primo Levi scrivendo della vita nel lager («in montagna ho imparato la pazienza, l’ostinazione, la sopportazione») e Mario Rigoni Stern delle sue esperienze in guerra. Per me la montagna è anche una sorta di meditazione, uno di quei pensieri-rifugio che evochi quando hai bisogno di calmarti. Chiudi gli occhi, respiri… … e pensi a qualcosa di bello.
Mi interrogo spesso sul fatto che tutto quello che mi sembra brutto viene dall’uomo mentre dalla natura non viene niente di brutto: un albero anche distrutto dai fulmini è sempre bello! Anche l’uomo è capace di bellezza certo, ma mediamente pro-
duce del brutto, cose di cattivo gusto che feriscono lo sguardo. In montagna questo non succede: se cammini in un bosco sei circondato dalla bellezza e questo mi mette dentro una grandissima pace. Mi cambia l’umore. L’ho anche sofferta la montagna intendiamoci, non è solo un paradiso. Ho sofferto tanto la solitudine. Ogni tanto ci sono quei momenti in cui non ne puoi più di te, dei tuoi soliti difetti e delle tue solite depressioni. E allora questo poi lo associ al posto dove sei che diventa un inferno. Però lo lego più alla casa, non tanto ai boschi: quando sono triste o mi sento solo, la medicina è sempre uscire di casa e andare a fare un giro, perché lì mi passa il senso di solitudine. Una «medicina» che fa bene anche a chi ti legge e a chi decide di fare una residenza creativa al tuo rifugio Fontane.
Faccio parte di un nuovo filone di letteratura di montagna che sta influenzando le scelte di ragazzi e ragazze, che arrivano in montagna con occhi diversi rispetto a tempo fa. Cercano la loro avventura, una vita più radicale. Io spero che non sia un fenomeno passeggero ma che produca qualcosa di buono per la montagna, che ha un bisogno enorme di nuova linfa umana, dei desideri delle persone e della loro voglia di realizzarsi. E mi auguro che il Festival continui a cambiare insieme alla montagna e a essere sempre così contemporaneo.

Mauro Corona è artista e alpinista, scrittore e scultore. Nasce in Trentino a Baselga di Pinè nel 1950. Successivamente la sua famiglia decide di tornare a Erto, il paese di origine, in Friuli Venezia Giulia.
Mauro Corona è legato al Trento Film Festival da una lunga storia. Prima come spettatore e appassionato, poi come protagonista, dagli anni novanta diventa una stella della rassegna. Nel 1995 è interprete e protagonista della pellicola selezionata al Film Festival L’uomo di legno (Italia, 1994), per la regia di Fulvio Mariani e Paolo Gobetti. Nel 1997 espone le sue sculture di legno alla mostra Il bosco scolpito, a Trento, nello Spazio Foyer, che si trasforma durante le giornate della rassegna in una galleria d’arte ricolma di gente. L’anno successivo, nel 1998 vince il Cardo d’Argento per la saggistica al Premio Itas del Libro di Montagna con Il volo della martora, Vivalda Editori. E nel 2008 bissa il successo aggiudicandosi il Cardo d’argento con l’opera Cani, camosci, cuculi (e un corvo), edito da Mondadori. Dopo tanti anni e tanti successi, Mauro Corona coltiva ancora un rapporto profondo con il Trento Film Festival: le origini trentine di Corona contribuiscono a rinverdire questo legame, così come i ricordi legati ai suoi esordi in campo letterario e artistico.
Che cosa è il Trento Film Festival per Mauro Corona?
Devo molto al Festival. Diciamo, senza ipocrisie, che la mia notorietà è cominciata al Festival di Trento molti anni fa.
I primi ricordi?
Avevo 19 anni quando costruivo appartamenti in Trentino. A quei tempi ero impegnato in una ditta di costruzione di Erto, che ottenne alcune commesse a Trento per realizzare delle palazzine in via Bolognini, vicino alla Fersina. Lavoravo come manovale, e tale sono rimasto nonostante la notorietà. Il Festival, cominciai a frequentarlo in quell’occasione. Ci andavo da spettatore, per vedere i film di arrampicata. Ero io quello che andava a vedere gli altri, poi sono diventato quello che veniva invitato. All’inizio seguivo il Festival da appassionato. Poi continuai ad andarci anche per vanità.
Per vanità?
Non nascondiamoci. Quando diventi qualcuno, lavori anche per vanità. Per quale motivo, altrimenti, vai al Festival a fare le serate? Ci vai per raccontare le tue cose, le tue esperienze, le tue storie. Ci vai perché davanti a te troverai un pubblico che ti ascolta. Per questo, dico, vanità… Ma non è una cosa per forza negativa. La vanità è lo specchio delle nostre paure, delle nostre fragilità.
Cerchiamo di essere qualcuno e vogliamo farlo sapere agli altri. Tutto qua. Ti fa paura, la montagna?
No, al contrario, la montagna mi attrae. Mi ha attratto in passato e continua ad attrarmi oggi. Uscirei subito da questa porta, anche adesso, per andare a vivere la montagna, a scalare, a camminare, a respirare. Non ho avuto un’infanzia facile. Quando ero ancora un bambino sono stato abbandonato. Sono cresciuto con il nonno, che seguivo nei boschi. Lui andava a camosci. Un giorno, con un otre di vino, il nonno si fermò a riposare. Decisi di salire da solo sulla cima della montagna, il monte Citta, nei pressi di Erto. Da solo, nei boschi, imparai a cercare lì l’affetto che non trovavo tra la gente. Nel bosco vedevo spiriti e folletti. Mi sentivo circondato da voci. Stavo così bene, ero come per aria. Quando raggiunsi la vetta, pensai che là dietro ci fosse la pianura e invece trovai altre salite e altre montagne. Capii che la vita è fatta di cime e imparai che, quando arrivi lassù, puoi solo tornare in basso per poi risalire ancora. In montagna, come nella vita, non ci sono solo le conquiste ma anche gli ostacoli.
Ne hai superati tanti, soprattutto quelli della vita. Vedi, la vecchiaia ha un vantaggio. Cerchi di fare meno errori, perché quelli che hai già fatto ti ricordano chi sei e ti si parano davanti.
Frequenti il Trento Film Festival da quasi 50 anni. Quali sono stati gli incontri più importanti? Sono così tanti… Come una valanga che scende giù e mi porta via.
Per esempio?
Ricordo le mie serate con Roberto Bassi e con Manolo, li incontravo sempre con grandissima emozione. Ma anche le lunghe chiacchierate con Cesare Maestri o con Riccardo Cassin, nel tendone del Campo Base, nei pressi del centro culturale
Santa Chiara. Quel ragnetto formidabile, Cassin, ci spiegava i suoi passaggi sulla via alla Torre Trieste (che aveva aperto nel gruppo del Civetta) con movimenti tanto realistici da illuderci che fosse lì. Ma penso anche alle ore trascorse al ristorante Pedavena con Jim Bridwell; lui, che era il re dell’arrampicata libera. Più tardi, lo rividi in una foto, nei suoi ultimi giorni di vita, con le mani ridotte a semplici ossicini; quelle stesse mani che avevano salito le rocce e i graniti delle montagne più importanti al mondo. Ricordo poi i festeggiamenti con Andrea Gobetti e Fulvio Mariani, registi del film
L’uomo di legno
Presentaste il film al Festival nel 1994. La pellicola raccontava la tua storia e tu eri il protagonista. Che effetto ti fece?
Non avrei mai pensato che, da semplice spettatore quale ero, mi sarei trovato un giorno dalla parte
dei protagonisti. Quella sera festeggiammo a lungo con Gobetti e Mariani per le vie di Trento. Fu una serata memorabile. Alzammo decisamente il gomito, oltre ogni limite.
In quell’occasione partecipasti al Festival per il tuo film. Negli anni successivi anche come scrittore e scultore.
Ricordo ancora quando mi chiamarono per dirmi che avevo vinto il Cardo d’argento per la saggistica al Premio Itas del Libro di Montagna. Mi presentai alla cerimonia tutto gongolante con la mia famiglia. C’erano anche mia moglie e i miei figli. Ci arrivai facendo lo spaccone. Mario Rigoni Stern si stupì che non indossassi una camicia e si offrì di prestarmene una. Devo moltissimo a Rigoni Stern. Tra l’altro, fu per merito suo se riuscii a esporre le mie sculture di legno a Trento nell’ambito del Festival.
Cioè?
Un giorno Rigoni Stern, dopo averne viste alcune, mi chiese se avessi altre sculture da mostrare. Io risposi che ne avevo una settantina. E così nacque l’idea di esporre a Trento la mostra Il bosco incantato, allestita nello spazio foyer del Santa Chiara. Tante esperienze, come dici tu, una valanga di ricordi. E il più bel Festival che hai visto? Un’edizione in particolare, un’annata speciale…
Le edizioni più belle del Trento Film Festival sono
quelle che ho vissuto coi miei figli, quando hanno cominciato a crescere e si sono appassionati alla montagna. Venivamo al Festival insieme e dormivamo sempre all’hotel America. Sono stati questi, per me, i Festival più belli. A 70 anni dalla sua nascita, cosa dovrebbe essere il Festival di oggi e cosa dovrà essere il Festival del futuro?
Il Festival – luogo di riflessione sulla montagna – ha questa grande opportunità: farsi carico di denunciare i problemi che affliggono i popoli di montagna e sforzarsi nel tentativo di trovare nuove risposte. È urgente e necessario aprire dibattiti e discussioni su questi problemi se vogliamo salvare la montagna. Mi riferisco alla montagna vera, quella dove non nevica firmato. Mi riferisco alla montagna povera, afflitta dalle difficoltà e dallo spopolamento. Mi aspetto un Festival, quindi, che sappia svolgere sia una funzione di denuncia sia una funzione propositiva per trovare soluzioni utili, innovative e interessanti. Un Festival che possa essere cartina di tornasole delle società montane.
Questo atteggiamento – la volontà di denunciare i problemi della montagna per cercare di risolverli – contraddistingue già il Festival di oggi. Ma, in futuro, dovrà diventare sempre più determinante per caratterizzare il Festival di domani. Penso quindi a un Festival capace di mostrare e raccon-
tare la montagna, ma anche e soprattutto a un Festival capace di salvarla. Una grande responsabilità – mi rendo conto – per il Festival di domani.
Tornerai al Trento Film Festival?
Tornerò con l’animo di quando ero ragazzo, senza speranza e senza disperazione, ma con grande curiosità.
Ci rivedremo al Festival, allora.
Ci rivedremo al Festival: dove verrò per metter via memoria.
In che senso?
La memoria è importante, perché quando ritorna si ripresenta nel futuro per aiutarti e sostenerti. Ma per metter via memoria devi andare nei luoghi giusti.
E quali sono?
Quelli dove la memoria ti viene incontro. Tu sei giovane ma io non lo sono più. Quando vengo al Festival ritrovo tanti amici e tanti luoghi cari. Molte persone che ho conosciuto non ci sono più. Perciò, mi piace ricordare come una carezza la nostalgia positiva delle cose che ho fatto, cercando di andare incontro a quelle che devo ancora fare.
Chiedendomi del Festival, mi hai colto alla sprovvista e mi è venuta una dolcezza che non ti so più raccontare.
Franco De Battaglia è giornalista, scrittore, saggista ed editorialista, tra i più attenti osservatori del dibattito culturale attorno alla montagna. Classe 1943, ha iniziato la sua carriera al quotidiano Alto Adige, diventando prima caporedattore alla redazione di Trento e poi direttore responsabile della testata (Bolzano e Trento), aprendo nel 1994 il Corriere delle Alpi a Belluno.

Si fermava lungo la strada per guardare i manifesti dei film in programma, appesi alle vetrine del cinema Astra, che aveva appena aperto le sale all’inizio degli anni cinquanta. Sono questi i primi ricordi del Festival di De Battaglia, giornalista e scrittore, tra le voci più autorevoli nel dibattito culturale sulla montagna trentina, più volte nel consiglio direttivo del Trento Film Festival, voce critica e memoria storica della manifestazione.
Che significato avevano quei manifesti?
Erano un modo per aprirci gli occhi e la mente verso il mondo. Si scoprivano le montagne del passato e quelle del futuro. Tornando a casa da scuola osservavo quelle immagini e volavo con la fantasia. Il Festival fu un elemento di sorpresa e di grande apertura per tutta la cittadinanza. Erano altri tempi: il dopoguerra, gli anni cinquanta, non era la città di oggi. Trento aveva bisogno di un fe-
stival per farsi conoscere e il Festival aveva bisogno di una città alpina su cui appoggiarsi. Un’intesa perfetta. Il cinema fece il resto. In che senso?
Se, nell’Ottocento, il linguaggio dominante era stato quello della letteratura, nel Novecento si fa largo il cinema. Si capiva che sarebbe diventata una forma di espressione prevalente. Cominciava la stagione dei Cineforum. Andavamo alle programmazioni del Festival per vedere i film e per parlare, riflettere e discutere. Serviva un Festival di cinema e montagna per spiegare la vocazione alpina del capoluogo?
Trento è sempre stata una città alpina. Ma il Festival le permise di uscire dalla sua dimensione localistica – una dimensione alpina e dolomitica – per confrontarsi con il mondo e diventare capitale dell’alpinismo. Fu questo il vero cambiamento. Non è un caso che il Festival nasca in quegli anni. Si era appena aperta la stagione degli Ottomila. I francesi conquistano l’Annapurna (8.091 metri) nel 1950. In quella spedizione era presente anche Lionel Terray, tra i miei miti dell’alpinismo, quello che mi ha maggiormente appassionato. E nel 1954 gli italiani raggiungono la vetta del K2 (8.611 metri).
Quelle imprese diventano i soggetti di una nuova epopea e di una nuova narrativa.
Certamente. Anche perché gli Ottomila dovevano essere conquistati due volte. La prima, con le lunghe marce di avvicinamento, che potevano durare giorni e settimane, veri e propri viaggi d’avventura. La seconda, con il tentativo di scalata alla vetta. Non saprei dire quale tra questi due aspetti mi affascinava di più. Forse il primo.
A proposito di Lionel Terray: ma è proprio vero, riprendendo la sua più celebre espressione, che gli alpinisti sono «i conquistatori dell’inutile»?
Andare in montagna è sempre utile. C’è un aspetto comunitario nell’andar per monti che non dobbiamo dimenticare. Qualcosa che comincia da lontano, dal significato stesso di una cordata. Qualcosa che attraversa gran parte del lessico di montagna, passando anche per la coralità dei Cori della SAT (Società degli Alpinisti Tridentini). Un aspetto, questo, che si è fatto interprete di un forte senso di condivisione, di comunanza e di avvicinamento.
La cordata come elemento che unisce e accomuna. Tra persone o anche tra culture differenti? Soprattutto tra culture differenti. Non dimentichiamoci che, quando nasce il Festival della montagna, si era appena conclusa la seconda guerra mondiale e andavamo incontro alla guerra fredda. Ci trovavamo nel pieno della guerra di Corea
e correvamo il rischio concreto di una terza guerra mondiale, con il generale statunitense Douglas McArthur che voleva fare uso della bomba atomica. In quei momenti delicati, il Festival lanciava un messaggio diverso. Un messaggio di conciliazione. Il Festival si apriva al mondo e scommetteva non soltanto sulle cordate di conquista, per raggiungere una vetta, quanto sulle cordate di pace, per avvicinare popoli e nazioni differenti nel segno dell’alpinismo e della cultura di montagna. La rassegna cinematografica di Trento nasceva prima di tutto come un festival internazionale, che richiamava personalità di tanti Paesi diversi. In una fase di grandi pregiudizi nazionalistici, il Festival univa mondi contrapposti, politicamente distanti e in conflitto fra di loro.
Un modo per superare i confini e le barriere. Ricordo, ancora oggi, le bandiere dei Paesi che partecipavano al Festival: venivano issate, le une accanto alle altre, a Trento, in piazza Dante. Accadeva tutti gli anni, nelle giornate della manifestazione, in segno di accoglienza: la Cina, l’Unione
Sovietica, gli Stati Uniti, la Germania… Non parliamo, quindi, solo di alpinismo e di alpinismi. Ma raccontiamo un Festival che ci ha condotto verso tematiche molto più grandi.
Anche il rispetto dell’ambiente naturale e l’amore verso la montagna?
Eccome, fin dagli inizi. Pensiamo al 1952, alla prima edizione del Festival, quando il primo premio venne assegnato a Cimes et merveilles (Francia, 1952) del regista Samivel, un vero e proprio inno alla bellezza e alla libertà della natura. Allora non esistevano ancora le sensibilità ecologiste. Ma il Festival portava già avanti quei valori, anticipandoli. Precorrendo i tempi, la manifestazione ha sempre sottolineato l’importanza dell’ambiente, fin dagli esordi.
Parli del Festival come di un’istituzione, ben oltre il significato intrinseco della rassegna di cinematografia alpina.
Infatti. Il Festival non è soltanto cinema. Per quanto mi riguarda, l’ho vissuto e continuo a viverlo come uno strumento civile per un impegno concreto in favore di alcuni valori internazionali come la pace e la tutela dell’ambiente. Mai come oggi le montagne sono in fiamme, pensiamo alla quantità di guerre in corso, dalla Russia all’Afghanistan. Mai come oggi siamo chiamati e dare risposte concrete all’emergenza climatica, con le sfide che ci pone dinnanzi.
Problemi globali e situazioni locali che chiedono più attenzione per la montagna e politiche di governo del territorio lungimiranti. Dobbiamo porre un freno agli eccessi di turismo?
Il Festival è chiamato a intervenire anche su que-
sti temi. La montagna non può diventare un capriccio stellato. Non è fatta per i grandi ristoranti in quota, per gli eccessi, per la meccanizzazione. Va ripresa una progettazione di lunga durata – lontana dal mordi e fuggi – che sappia presentare la montagna come un’esperienza vera, distante dai luoghi comuni.
Occorre ragionare anche sul rapporto tra città e montagna, tra centro e periferia?
Vedi, la montagna ha qualcosa di speciale, che riguarda tutti noi. Voglio dire… Se vuoi governare la città, devi salvare la montagna. Non puoi dividere i due ambiti: da una parte la città, come terminale tecnologico e strumento di lavoro, e dall’altra la montagna, come parco giochi e luogo esclusivo del divertimento. Così non funziona. Montagna e città devono stare in equilibrio per trovare un contrappunto tra il vivere urbano e il vivere naturalistico.
Hai spesso parlato del Festival come di un «libro di testo», qualcosa da cui prendere esempio. Cos’altro ti ha fatto scoprire, il Festival?
Mi ha fatto scoprire l’arrampicata, la montagna, il mondo della montagna e perfino i fondali degli oceani. L’arrampicata la scoprimmo con Monologo sul sesto grado (Italia, 1953), tra i primi film premiati al Festival con il Rododendro d’argento. Il documentario, regia di Enrico Pedrotti, illustra-
va la ripetizione in solitaria (in salita e in discesa) della via Preuss al Campanil Basso, compiuta da Cesare Maestri. Per molti di noi, i trentini della mia generazione, quel film fu una scuola di roccia: ti insegnava come arrampicare, dove mettere i piedi, dove mettere le mani. Ci iscrivemmo ai corsi di roccia della SAT dopo aver visto quel film. Ben oltre l’arrampicata, però, il Festival mi ha fatto scoprire i vasti orizzonti culturali legati alla nozione di montagna in senso ampio, gli aspetti geologici e naturalistici ma anche quelli antropologici ed etnografici, storici linguistici, economici e sociali. E non solo. Mi ha fatto scoprire anche il «sesto continente», dal titolo di un film di Folco Quilici (Sesto continente, Italia, 1954). Fu quella una delle pellicole che mi impressionò maggiormente, mostrandomi per la prima volta con le riprese sottomarine ciò che stava sotto l’acqua. Dopo quel film, ricordo che, con mia madre, andammo insieme al Voltolini, il negozio di sport che c’era allora, a Trento, per comprarci le pinne e la maschera…
Una grande apertura: dagli Ottomila ai fondali degli oceani, dal sesto grado alla cultura di montagna.
Credo che il Festival abbia avuto questo merito. Liberare, in un certo senso, l’alpinismo dalle sue esasperazioni e gli alpinisti dalla loro specializzazione.
Erri De Luca è scrittore, poeta, giornalista e traduttore. Il suo primo romanzo è Non ora, non qui (1989). La montagna fa parte della sua vita e dei suoi racconti, che ha presentato anche al Festival. Nel 2005, dopo aver partecipato a una spedizione himalayana con l’amica Nives Meroi, pubblica Sulla traccia di Nives. «Le mie montagne preferite sono le Dolomiti in estate». Erri De Luca ama la roccia e si definisce un «praticante di alpinismo». Perché preferisce ripetere le vie che hanno già una storia, «sapere di mettere mani e piedi su appigli che sono stati toccati da generazioni di alpinisti prima». Aprire una via invece, non lo ha mai interessato. «Mai battuto neanche un chiodo. Quel gesto di lasciare il segno, in montagna non ce l’ho. In editoria sì».

Come entra la montagna nelle tue storie? È tutta questione di una camminata e un taccuino?
Ci sono cose che mi sono successe in montagna che ho organizzato in forma narrativa. Io posso scrivere solo storie che conosco, che mi sono passate per il corpo. Per cui scrivo storie ambientate in montagna perché una parte della mia esperienza fisica si è svolta in montagna. Scrivo a penna su quaderno, niente computer. E mi sono accorto che camminare in montagna mi fa affiorare
ricordi, mi lascia delle suggestioni. Per esempio, Impossibile (2019) è una storia che mi è venuta in montagna: mi sono ricordato di una cengia «scorbutica» che ho dovuto percorrere tanto tempo fa e così lì ho ambientato una storia. Oltre a ritornare sulle vie che hai percorso attraverso il ricordo, ti capita di fare ritorno sulle tue «vie» letterarie?
Ci son tante cose belle da leggere, non mi metto certo a rileggere me stesso. La lettura è un’attività più entusiasmante della scrittura. Da lettore ho frequentato delle vette letterarie gigantesche. E sul mondo della montagna, che tipo di libri ti piacciono?
Sono stato un ammiratore dell’alpinista Paul Preuss, allora c’era una biografia scritta da Severino Casara [Preuss l’alpinista leggendario, 1970] che mi è piaciuta molto. Casara scrive per ammirazione e l’ammirazione è una misura che permette di rispettare la distanza. Alcuni scrittori vivono la scrittura anche con ansia, senso di fatica, paura. Tu come vivi l’atto di scrivere?
Mi spiace per loro! Io se fosse una sofferenza facevo ‘naltra cosa! [sorride] È un’attività abbastanza comoda, oltre che lieta. Quando cominci un racconto è come se dovessi aprire una via: sei alla base della parete e puoi scegliere qualunque tipo
di percorso. Devi cercare la tua linea in quella vastità. Più sali, più la montagna si restringe. E così la scrittura: all’inizio puoi andare dappertutto, poi più vai avanti più il percorso si restringe e arrivi alla fine che non hai più spazio intorno. Eppure sei un uomo di mare…
Quello con il mare è un rapporto genetico. Appartengo a quella specie botanica che cresce solo a favore di esposizione solare: crescevo solo al mare, nei mesi estivi, in città non aumentavo di un centimetro. Il mare è anche il luogo in cui ho cominciato a capire che quella che chiamiamo natura è un posto che non è fatto per noi, è così gigantesca e indifferente a noi che mi fa considerare sempre un ospite non invitato nei suoi spazi. Di inviti al Trento Film Festival ne hai ricevuti diversi, forse non tutti graditi. Sono venuto diverse volte a presentare libri. Se c’è Mauro Corona, siamo amici, capita che bazzichiamo insieme. Ma ho anche un ricordo un po’ spiacevole. Avevo scritto un racconto che si svolge in montagna tra un vecchio cacciatore di frodo e un camoscio, Il peso della farfalla (2009). Questo libro piacque a Mario Rigoni Stern, presidente della giuria letteraria. I premi funzionano così: gli editori mandano i libri alle giurie, e queste decretano il vincitore. Il mio editore, per mia espressa raccomandazione, non manda libri miei a nessun
premio letterario. Perché preferisco che li vincano quelli che li desiderano i premi letterari, a me non importa. Però Mario Rigoni Stern decise che doveva premiare quel libro. Per cui io di fronte al fatto compiuto, decisi di rifiutarlo e feci questo sgarbo, del tutto involontario. Quindi venni a Trento a presentare il libro ma non ritirai il premio. Che atmosfera c’è? E com’è la città nei giorni del Festival?
Quella tipica di un importante festival cinematografico. Mondana, appariscente, forse si prende meno sul serio di altri. Perché c’è più sobrietà da parte dei protagonisti, che sono persone che si sono fatte le ossa in montagna. Per la città è un’occasione per mettere fuori il vestito buono, poi si rimette in armadio. È come dire quanto è importante il Festival di Cannes per Cannes? È importante per quel periodo dell’anno, poi Cannes è una città tranquilla.
A Trento si intrecciano letteratura e cinema di montagna. Che rapporto c’è tra questi due linguaggi?
Il cinema ha bisogno di storie e le prende spesso dalla letteratura, ha un enorme bacino a disposizione. Il cinema però è un riassunto generale delle arti: c’è dentro la musica, la fotografia, la pittura. L’ultima delle arti è quella che le riassume tutte. La letteratura è una delle arti dentro le quali il cinema
pesca. D’altra parte uno scrittore si trova una propria storia al cinema ingrandita, e la trasposizione cinematografica ingrandisce anche il suo nome. Pensiamo al cinema neorealista: tutta la generazione di scrittori di quell’epoca sognava e scriveva per il cinema. Pasolini se non avesse fatto cinema, sarebbe stato semplicemente un poeta e uno scrittore di qualche libro. La fatica della montagna e la fatica del lavoro… C’è una disciplina che mi è stata trasmessa dai mestieri manuali che ho fatto, da quell’attività fisica intensa e logorante. È una disciplina che ritrovo anche quando faccio delle attività liete, come andare in montagna e scalare. Però si parla spesso del coraggio di andare in montagna. Ecco io posso dire che il coraggio vero è di chi i rischi se li deve prendere per forza, non per gusto o per scelta. L’attività in fabbrica, nei cantieri, ecc. ha bisogno di coraggio. Lì il rischio ti tiene compagnia per tutta la giornata di lavoro, basta guardare i dati degli incidenti sul lavoro in Italia che sono impressionanti. Quello lo chiamo coraggio, un coraggio obbligatorio. Mentre quello di fare una via slegato, quello ha a che vedere con la tua felicità fisica.
Roberto De Martin è un dirigente d’azienda. Originario di Corteno Golgi, un paesino in Val Camonica, si appassiona di montagna durante le estati in Cadore. È stato presidente generale del Cai dal 1992 al 1998, e successivamente del Club Arc Alpin, la federazione dei Club alpini europei. Attualmente è vicepresidente dell’International Alliance for Mountain Film. Al Trento Film Festival ha ricoperto il ruolo di presidente dal 2011 al 2017. «Il geografo Paul Guichonnet ha sostenuto che noi delle Alpi Orientali siamo fortunati perché abbiamo gli altipiani che incrociano linee verticali con linee orizzontali arrivando a dare più luce, più fascino, più opportunità di coltivazioni», una visione che Roberto De Martin ha trasferito anche al Festival negli anni in cui ne è stato presidente, trovando la giusta miscela tra tradizione, alpinismo e attualità. Una visione che trae linfa dai suoi primi ricordi della rassegna trentina.

Da quando frequenti il Festival?
Il primo ricordo va ben più indietro della mia presidenza ed è legato al Festival di 30 anni fa. È un ricordo tripolare, se si può dire, e ha a che fare con il primo incontro con l’istituzione, con il grande alpinista e con lo scienziato al Festival. Prima ho scoperto come il Festival non limitasse la sua azione ai film in concorso ma in effetti
fosse una realtà poliedrica, articolata su tante iniziative, anche poco note ma meritevoli di essere meglio conosciute. La retrospettiva d’autore con le gesta in montagna dei comici Stanlio e Ollio mi fece trascorrere in sala un pomeriggio quasi solitario con Catherine Destivelle, allora arrampicatrice sportiva che ha saputo poi essere alpinista a tutto tondo (bravissima anche nel mondo del cinema di montagna, non a caso presente nelle mie relazioni alle assemblee dei delegati CAI).
Poi Riccardo Cassin, semplicemente autorevole, che afferma proprio a Trento con convinzione e capacità di convincimento che l’alpinismo nasce quando si fanno i primi passi nel bosco. Non è un caso che la montagna-terapia sia diventato uno dei temi del Festival. E infine, Paul Guichonnet, il geografo delle Alpi per eccellenza, che ci faceva appunto scoprire come fossimo dei privilegiati a poter frequentare facilmente gli altipiani. Che rapporto hai maturato con la città di Trento durante i giorni del Festival?
Trento è un crocevia. Un crocevia per chi pensa di venire a imparare, per chi vuole vedere film e rilassarsi dopo le fatiche della salita, per chi ha voglia di farsi ispirare a salire. Più che nei giorni del Festival, il mio rapporto con Trento si è costruito nei mesi dedicati alla preparazione, alle scelte, alle selezioni. È un rapporto che costitu-
isce un patrimonio, perché frutto di un lavoro che si sedimenta con l’andare del tempo e che diventa un interlocutore ricco di storie e, alla fine, una bella storia. Anche l’esperienza fatta nelle assemblee dei soci è stata positiva perché ha dato sempre dei frutti di conoscenza reciproca, per certi versi inaspettatamente profondi. Legittimo quindi l’orgoglio personale per aver convinto – da presidente di uno dei due soci storici, il CAI – l’allora sindaco Giovanni Salghetti a valutare l’ingresso del Comune di Bolzano, come entrambe le Camere di Commercio salutate come giusto allargamento di compagine in chiave regionale. Nei giorni del Festival poi, ricordo la serenità delle ore passate al Parco dei Mestieri.
Mi racconti l’istituzione negli anni della tua presidenza?
Devo dire che l’ho trovata robusta, in quanto fondata e formata da esperienze ultradecennali. Anche tranquilla, per alcune sistemazioni amministrative operate dai miei due predecessori (Italo Zandonella Callegher ed Egidio Bonapace) con il supporto di Tommaso Gabrielli: a loro va senz’altro un doveroso ricordo e tanta riconoscenza. Non ho mai creduto alle presidenze collegate a un nome; le presidenze vere che funzionano sono quelle che riescono a far lavorare una squadra, è un lavoro di armonizzazione. Il cambio di passo che si è regi-
strato negli anni della mia presidenza va ricercato nell’incremento a due cifre della partecipazione di pubblico e nell’efficace contributo del nuovo ufficio stampa animato da Rosario Fichera. Il legame «internazionale» poi – il Festival nacque attribuendosi tale aggettivo nel lontano 1952! – è stato particolarmente seguito sia tramite l’International Alliance for Mountain Film sia con attività straordinarie quali quelle di «balio-istruttore» per nuovi festival come quello di Ulju nella Corea del Sud.
Saper alimentare questa linfa che guarda lontano, dalla Terra del Fuoco argentina alla Nuova Zelanda, rimane sfida aperta anche per il futuro.
C’è un film a cui sei legato che hai visto al Festival?
Ce ne sono diversi che evidenziano un aspetto riconosciuto dalle giurie degli ultimi anni. Mi riferisco allo scandagliare l’animo dei protagonisti, impegnati su scenari meravigliosi, con capacità di indagine psicologica non comune. Penso, solo nella mia ultima edizione da presidente, a Dirtbag: the legend of Fred Beckey (Stati Uniti, 2017) che ho visto per la prima volta al festival di Bansko; Bonington mountaineer (Regno Unito, 2017); Hansjörg Auer – No turning back (Italia, 2017); Oltre il confine, la storia di Ettore Castiglioni (Italia-Svizzera, 2017); e la Genziana d’oro di quell’anno Samuel in the Clouds (Belgio, 2016). Ma anche alle donne
curde di Gulîstan, Land of roses (Canada-Germania, 2016) e a quel dialogo profondo fra padre e figlio sulla Cima Ovest di Lavaredo di Panaroma (Spagna, 2015). E poi Jeff Lowe’s Metanoia (Stati Uniti, 2014) che mi spinse a scrivere nel settembre 2017 un articolo dal titolo «Le impronte dei grandi» sulla rivista Montagne360. E da ultimo vorrei citare Verso Dove (Italia, 2014) di Luca Bich su Kurt Diemberger, alpinista e cineasta, non a caso anche socio onorario del Festival.
Rispetto alle tue numerose esperienze, qual è oggi il ruolo dei festival legati ai temi della montagna?
Parto da una constatazione positiva che viene anche dalla felice esperienza di «Trento Film Festival 365». Molto del lavorio collegato all’edizione di un film festival finisce per alimentare e animare iniziative sparse sul territorio in misura sempre crescente. Basta pensare a quanto è stato recuperato dai webinar dell’Unione Nazionale Comuni comunità Enti Montani (UNCEM) o da iniziative collegate all’Università della Montagna di Edolo per confrontarsi sul futuro dei territori. Si sta sempre più realizzando una rete a somma positiva che desta meraviglia perché un effetto moltiplicatore si può pronosticare per gli anni a venire. La legge per la Montagna non ancora approvata [il Consiglio dei ministri del 10 marzo 2022 ha
approvato in esame preliminare il disegno di legge «Disposizioni per lo sviluppo e la valorizzazione delle zone montane»] e il 101° Congresso del Club
Alpino Italiano ne potranno certamente usufruire. Anche perché c’è una ricorrente constatazione negli ultimi film premiati con la Genziana d’oro: si è passati dall’esaltazione di exploit alpinistici all’approfondimento dei temi esistenziali che toccano la gente di montagna.
Che cosa può rappresentare la montagna – e la cultura di montagna – in questo momento storico, così drammaticamente segnato da guerre, conflitti e rapporti internazionali delicati?
Qualche anno fa l’alpinista Paola Gigliotti era intervenuta in un incontro a Perugia parlando delle guerre in montagna. Mi ricordo di essere rimasto stupito dal numero di guerre contemporanee e di aver pensato quanto le creste siano ancora confini molto più che cerniere. Allo stesso tempo, credo che i valori di semplicità, i rapporti diretti che sono
più facili da realizzarsi nelle terre alte, potrebbero portare a rapporti diplomatici diversi. Ma questo per ora è più un auspicio che la realtà.
70 anni di Festival. Qual è il segreto di una tale longevità?
Uno. Il livello della selezione cinematografica che si è andato alzando sempre di più. Due. La capacità di indagare non solo il mondo squisitamente montano ma anche le pertinenze. Attraverso ad esempio il paese ospite che permette un’indagine approfondita anche di chi non abita le vette ma vive un territorio che sulle vette ha costruito la sua identità. Tre. Qui ritorno al titolo di un incontro di qualche anno fa «Da Solda ad Amatrice e Rigopiano» con don Josef Hurton, a lungo a capo del Soccorso alpino nazionale e creatore della scuola dei cani da valanga. Mi sembra una finestra importante: un messaggio che va oltre la tecnica alpinistica. Il futuro del Festival non potrà che continuare a essere poliedrico.

Succede di aver bisogno di un esempio, un modello da seguire, qualcuno a cui ispirarsi. E succede anche, nella grande confusione che caratterizza oggi il nostro tempo, di trovarne sempre meno. Fausto De Stefani fa eccezione. Tra tanta confusione, è l’esempio che può succedere di incontrare. Fai fatica a scovarlo, perché non ama parlare di sé, tanto spesso lontano dai riflettori. Ma se hai la fortuna di scoprirlo, ti senti piccolissimo vicino a lui. Fausto nasce ad Asola, in provincia in Mantova, nel mese di febbraio del 1952 e proprio come il Trento Film Festival ha compiuto 70 anni nel 2022. È stato il secondo alpinista italiano dopo Reinhold Messner ed il sesto al mondo ad aver scalato tutti i quattordici Ottomila. Ma soprattutto, ambientalista e fotografo naturalista, ha mostrato al mondo come si possa fare della solidarietà internazionale una ragione di vita.
Hai l’età del Festival. Qual è il tuo primo ricordo della rassegna? Avevo circa vent’anni, forse meno. Erano i primi anni settanta e venivo a Trento per incontrare i protagonisti dell’alpinismo internazionale. Per le giornate della rassegna, si davano appuntamento al Festival. Mi colpiva il fatto che tutte queste persone giungessero a Trento dall’Italia e dall’estero.
Qualche incontro speciale?
Ricordo Jerzy Kukuczka, lo conobbi negli anni ottanta. Insieme a lui, ne incontrai molti altri. Ma non era solo questo. Cercavo qualche cosa di diverso al Festival, non soltanto i protagonisti dell’alpinismo.
Cos’altro?
Leggevo.
Andavi al Festival per i libri?
Proprio per i libri. Trascorrevo ore e ore a leggere pagine su questioni naturalistiche, botaniche e ornitologiche. Le mie grandi passioni. Nutrivo per la natura una enorme curiosità e avevo tanta fame di sapere.
Come per la montagna, per le cime, per le scalate.
Dico la verità, prima che un alpinista mi sento un naturalista nel senso più intimo del termine: un grande innamorato di natura. Credo di aver iniziato ad andare in montagna per la curiosità di vedere quello che c’era più in alto.
La Natura?
Sì, la bellezza della Natura. Cercavo i papaveri azzurri in Himalaya e stavo lì fermo a osservarli. Dove gli altri andavano avanti, passando oltre, io mi fermavo per restare in silenzio ad ammirare.
Come per i papaveri, così con la pernice bianca dell’Himalaya. Quanta meraviglia! Scoprivo un
mondo attorno a me. Era uno spettacolo che mi affascinava e che si rinnovava ogni volta. Parlo di un mondo straordinario che vivevo come un’esperienza speciale attraverso i mei occhi, i miei sentimenti, le mie emozioni.
Ma avevi anche voglia di salire in cima.
Vedi, quando sei giovane ti prende la passione. Hai la tendenza a considerarti invulnerabile e ti senti immortale.
È stato anche questo, il tuo alpinismo?
Se l’alpinismo è qualcosa di tuo e di personale, come l’ho vissuto io, avverti la necessità di farlo.
Soprattutto se hai vicino alcuni amici veri, come ce li ho avuti io. Quando si verificano queste due circostanze – sali in montagna per rispondere ai tuoi bisogni soggettivi e hai la fortuna di poterlo fare con degli amici veri – l’alpinismo diventa uno stato d’eccezione e ti si presenta come il massimo delle emozioni possibili. È vero, è inutile; l’alpinismo
è inutile. Ma è straordinariamente bello e le emozioni che provi ti rimangono dentro.
Sei arrivato così sugli Ottomila?
È stato un percorso lungo e graduale. Ho vissuto la maggior parte delle mie esperienze alpinistiche prima di salire gli Ottomila. Il vero alpinismo, io l’ho fatto negli anni settanta. Poi, all’inizio degli anni ottanta, decidemmo di metterci in gioco sulle montagne più alte della Terra. Eravamo io e Ser-
gio Martini. Le persone che salivano lassù erano tutti professionisti della montagna. Per noi era diverso. Io facevo il carrozziere e Sergio l’insegnante di educazione fisica. Decidemmo di salire il K2 dal versante Nord. Era il 1983. Partecipammo a una spedizione trentina che durò 4 mesi. La montagna mi apparve per la prima volta dietro una curva, sul sentiero, durante l’avvicinamento. La guardai e ricordo di aver pensato: “Ma dove vogliamo andare, come si fa a salire lassù”.
E poi?
Proseguimmo umilmente, cercando di metterci a disposizione senza risparmiarci e senza tirarci indietro. Nei pressi della vetta, fummo costretti a bivaccare a 8.450 metri senza ossigeno, senza tenda e senza sacco a pelo. Solo con una persona come Sergio Martini lo puoi fare. Così arrivammo in cima. E quando fummo sul tetto del mondo, sul K2, capimmo che si poteva fare. Di colpo abbiamo realizzato che era tutto vero. Avevamo capito che quelle montagne ci avevano accettato. Dopo il K2, il tuo primo Ottomila, arrivarono anche tutti gli altri.
La passione degli Ottomila è esplosa perché per me erano emozioni più complete. Non c’era solo la vetta, ma anche e soprattutto l’avvicinamento. C’era il contatto con persone diverse, uomini e donne che non conoscevi. C’era il contatto con le
comunità dell’Himalaya. Ancora oggi, non smetto di pensarci. Se vogliamo confrontarci con loro… Non siamo credibili. In che senso?
Penso agli Sherpa, ai Baltì, agli Hunza. Lo dicevo trent’anni fa e non mi stanco di ripeterlo. La nostra forza e la nostra determinazione fanno ridere in confronto a quelle che hanno loro. Quando vidi gli sforzi e le fatiche che erano capaci di sopportare, capii che quelle popolazioni erano di un altro pianeta. Ricordo uno di loro, un omino da 50 o 60 chili, che trasportava da solo in salita tre grosse travi per 1.000 metri di dislivello. Cercammo di sollevarne una, di lato, e non ci riuscimmo. Restammo lì a discutere su quanto potessero pesare, fino a scoprire che raggiungevano i 190 chili. Quasi due quintali, cose da non credere. Quelle persone avevano due o tre marce in più. Ma gli alpinisti che salivano le vette non volevano che si venisse a sapere. Nelle spedizioni, talvolta, fermavano gli sherpa poco prima della cima; perché, se anche loro avessero conquistato la montagna, si temeva che l’impresa potesse perdere di valore. Sembrano cose impossibili, ma accadevano davvero.
Hai compiuto 70 anni. Un tempo venivi al Festival come spettatore, oggi sei tra i protagonisti più autorevoli. Cosa si prova?
Sensazione di imbarazzo.
Perché?
Da un lato, penso ai tanti alpinisti più forti di me, che non hanno vissuto abbastanza per compiere grandi imprese e per venircele a raccontare.
Dall’altro, perché sento che il pubblico cerca di identificarci come dei supereroi. Ma io non sono un supereroe. Non lo sono oggi e non lo sono mai stato. Non posso e non voglio dare questa soddisfazione al pubblico del Festival. È una delle poche certezze che mi sono rimaste.
E le altre… Quali sono le tue certezze?
Da giovane ne avevo tantissime. Straripavo di certezze. Ma non solo. Guardando al futuro, pensavo che con il tempo ne avrei avute ancora di più. Invece, è accaduto l’opposto. Quasi tutte le mie certezze sono scomparse e i dubbi che avverto ora aumentano quotidianamente. Ma almeno una, anche una soltanto. Ti è rimasta una certezza?
Ho imparato ad ascoltare i bambini. Agli adulti ci credo poco. Questa è una certezza che ho maturato.
Perciò hai ideato e realizzato la «Collina di Lorenzo»? Il luogo a Castiglione delle Stiviere, in provincia di Mantova, dedicato ai bambini «da 0 a 100 anni», dove potersi muovere in mezzo alla natura.
È visitata ogni anno da oltre 20.000 ragazzi e stu-
denti. I bambini hanno questo di speciale: che hanno conservato la capacità di stupirsi e di meravigliarsi. E poi assorbono tutto. Mi riferisco, per quanto riguarda la Collina di Lorenzo, alle nozioni relative alla parte naturalistica, che cerchiamo di promuovere e di insegnare sul posto.
Alla Collina, tutte le attività per i bambini sono completamente gratuite. È lo stesso spirito di gratuità che ti ha spinto a creare il progetto “Rarahil” in Nepal, che offre un percorso di formazione scolastica ai bambini e ai ragazzi di Kirtipur, una cittadina vicina a Kathmandu.
Dopo più di vent’anni di lavoro (istituimmo la Fondazione Senza Frontiere Onlus nel 1998 per questo scopo) abbiamo creato oggi un polo scolastico, la Rarahil Memorial School, che si presenta come un piccolo paese: ci sono una scuola primaria e una scuola secondaria, una scuola professionale per accompagnatori ecoambientali, un istituto d’arte e una scuola di musica, un poliambulatorio, un convitto e un refettorio, dove si distribuiscono circa 1.200 pasti ogni giorno.
Al teatro Sociale di Trento, gremito di persone, nel mese di maggio del 2022 è andata in scena
al Trento Film Festival la serata-evento Anche i sogni impossibili. Il quindicesimo Ottomila di Fausto De Stefani. Lo spettacolo era interamen-
te dedicato alla tua vita: una storia straordinaria di impegno nella solidarietà. Sì, la rappresentazione a cui ti riferisci è stata ideata e prodotta da Montura Editing, con i testi scritti e interpretati da Mattia Fabris e Jacopo Maria Bicocchi, della Compagina degli (S)legati.
Sono emerse le tue vere vocazioni, l’altruismo e la gratuità, che ti hanno contraddistinto fin da tuoi primi passi.
Ho sempre vissuto in questo modo. Anche prima del progetto della Rarahil e della Collina di Lorenzo.
Eri stato in Africa, dove avevi costruito un pozzo. Hai lavorato e lavori ancora nelle carceri, per portare sostegno ai detenuti. Cosa ti spinge verso tutto questo?
Ci chiediamo per quale motivo siamo al mondo, quale sia il senso autentico delle nostre esistenze e cosa possiamo fare per dare significato alle nostre vite. Di fronte a queste domande, ciascuno di noi dà risposte differenti. Per me, il senso profondo della vita sta nel cercare di aiutare gli altri. Voglio continuare a farlo e lo farò finché avrò fiato, finché sarò vivo. Come tutti, sono solo in prestito su questa Terra. Sono solo di passaggio. Mi spiego… Ho passato i 70 anni e trovo che le mie energie se ne stanno andando. Le guardo: e mentre le osservo vedo che si sciolgono come la neve al sole. Non voglio vivere dei miei ricordi alpinistici. Che senso avrebbe? Non è questo che desidero. Per quando non ci sarò più, voglio lasciare qualcosa a chi ne ha più bisogno.
Kurt Diemberger è tra gli alpinisti più importanti e carismatici di tutti i tempi. Autore di imprese eccezionali sulle montagna più alte della Terra, è stato tra i primi uomini a raggiungere gli Ottomila e ha saputo unire alle capacità alpinistiche quelle del cineasta. Nel 2013 è vincitore del Piolet d’Or alla carriera, la massima onorificenza internazionale nel mondo della montagna. Kurt Diemberger è salito dove nessuno prima di lui aveva mai osato: ha raggiunto la vetta di sei Ottomila, ma è l’unico alpinista, assieme a Hermann Buhl, ad averne scalati due in prima assoluta: il Broad Peak (nel 1957, senza portatori e senza bombole d’ossigeno) e il Dhaulagiri (nel 1960, senza bombole d’ossigeno). Carismatico e gentile, affabile e ostinato, pieno di cultura e di culture, Diemberger è anche un sopravvissuto. Vide per l’ultima volta Hermann Buhl, che scomparve nella nebbia mentre i due alpinisti scalavano insieme nel 1957 il Chogolisa. Vide per l’ultima volta Julie Tullis, sua compagna di scalate, quando rimasero coinvolti nel 1986 nella tragedia del K2. Julie Tullis perse la vita nella notte tra il 6 e il 7 agosto mentre Diemberger riuscì a sopravvivere subendo l’amputazione di alcune dita delle mani e dei piedi. Con Julie Tullis, Diemberger costituì «Il film team più alto del mondo»: insieme, lavorarono per anni come cineasti, realizzando documentari sulle
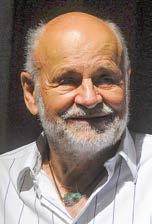
vette più alte della Terra. Con le sue avventure e con i suoi racconti, Diemberger è stato tra i protagonisti più importanti del Trento Film Festival, che frequenta da lunghi anni. Sono numerosissime le sue partecipazioni con alcune note di merito che ne illuminano la carriera. Nel 1989 Diemberger è il campione assoluto della rassegna, centrando una doppietta storica: conquista la Genziana d’oro per il miglior film, sua la regia del documentario che vince il Festival (K2 - Traum und schicksal, Germania, 1988), e si aggiudica il Premio Itas del Libro di Montagna con K2. Il nodo infinito. Nel 1989, il Trento Film Festival celebrò così quell’uomo venuto dalla Carinzia, nelle Alpi austriache, bagnate dalla Drava. Classe 1932, di Villach, Diemberger vive oggi in Italia sui colli bolognesi ed è un’icona dell’alpinismo di tutti i tempi. Nell’anno del 70° del Trento Film Festival, il 2022, Kurt Diemberger ha compiuto 90 anni.
Quale è il tuo primo ricordo del Festival?
Sono passati troppi anni. Ho visto così tante edizioni, ho partecipato così tante volte al Festival. Il primo ricordo, dico la verità, non me lo ricordo. Ma non dimentico la prima volta che ho visto Trento. E quando è stato?
Il Festival della Montagna non era ancora nato. Prima del Festival? Erano gli anni quaranta.
Quando giunsi a Trento per la prima volta ci arrivai in bicicletta. Con una vecchia bicicletta di mio nonno. Continuai a pedalare fino a sera, quando decisi di fermarmi al lato della strada per passare la notte in un campo sotto un albero. Era un albero di pere. Allungai la mano e ne presi una, ma non era la stagione buona. La trovai così acida. Ricordo ancora il sapore persistente che non mi lasciava. Prima di fermarmi per la notte, la visibilità era scarsa e si vedeva poco. Continuavo a leggere sui cartelli stradali «Attenzione a Trento», ma Trento non arrivava mai. Perciò decisi di fermarmi con il buio. Quando mi alzai, il mattino dopo, ripresi a pedalare e incontrai nuovi cartelli. Che, in effetti, si trovavano sempre nei pressi dei binari della ferrovia. Allora li lessi meglio: c’era scritto «Attenti al treno». Poi ha conosciuto il Festival.
Ci venivo ogni anno, come faccio ancora. Capii subito che il Festival della Montagna era un grande punto di incontro per alpinisti. Ma non solo. Al Festival c’erano anche gli alpinisti che sapevano fotografare. Ero interessato alle persone che avrei potuto incontrare. E queste persone si interessavano a me. Mi dicevano: «Kurt, tu non sai solo scalare. Tu sai anche fotografare». Fu così che iniziai a partecipare con le mie immagini e con i mei film. Per esempio?
Tra i miei primi film, sicuramente Monte Bianco.
La grande cresta di Peuterey (Austria, 1962), premiato con la Genziana d’oro del CAI (Club Alpino Italiano). Nel film raccontavo la lunga ascesa con Franz Lindner alla vetta del Bianco, seguendo la cresta di Peuterey. Ci vollero cinque giorni per raggiungere le vetta.
Hai sempre inseguito le vette e hai sempre cercato di filmarle. È più grande la passione per la montagna o per la fotografia?
Queste due dimensioni sono sempre rimaste unite. Volevo scalare le montagne ma allo stesso tempo desideravo mostrarle agli altri. Per questo usavo la cinepresa. Anche adesso, che non cammino più tanto bene, mi è rimasta la stessa passione. Ora sono io quello che va a vedere i film degli altri, sperando che con le loro cineprese mi mostrino ancora le montagne. Venire al Festival significa anche questo. Poter guardare nuovi film e ritrovare gli amici di una volta.
Ci vieni spesso?
Tutte le volte che posso. Rivedo qui gli amici di un tempo e incontro quelli nuovi. Ritrovo a Trento i miei ricordi. Come vedi, ci sono sempre buoni motivi per tornare.
Ripensi anche ai tuoi film, alle tue pellicole, quelle passate per il Festival? Hai voglia di rivederle?
Soprattutto quelle a cui sono più affezionato. Pen-
so al film K2 - traum und schicksal (Germania, 1988), che realizzai con Julie Tullis.
Hai girato con Julie riprese in altissima quota, portando la telecamera oltre quota 8.000, dove nessuno era mai arrivato. Quanta fatica costa?
Ci si abitua. È come portare gli occhiali. Li indossi e non ci pensi più. Così è anche con la cinepresa, anche se è molto più pesante.
Quanto conta programmare le riprese, scrivere un soggetto; e quanto invece saper improvvisare, cogliere il momento che non ti aspettavi?
Durante il mie scalate avevo già un soggetto nella testa, ma la sua apparenza si formava e si concretizzava durante la spedizione.
Per fare un buon film, è importante la collaborazione dei propri compagni di scalata?
È estremamente importante. Ricordo una spedizione con un gruppo di americani. Ci fecero firmare un contratto in cui si specificava che non avrei avuto aiuto da nessuno, durante la salita. E invece, grazie ai rapporti di amicizia che fummo capaci di costruire durante la spedizione, alcuni componenti del gruppo mi furono di grande aiuto. Grazie a loro riuscii a girare le riprese. Ai miei tempi, con l’attrezzatura che avevamo, per girare bene un film occorreva che almeno cinque persone, in una spedizione di 20, fossero disposte ad aiutarti sempre e costantemente.
La presenza della telecamera influenzava il clima del gruppo?
Sicuramente sì. Per questo, per la riuscita delle riprese, bisognava fare come se la telecamera non ci fosse.
Sono più le cose che la montagna ti ha dato oppure sono di più quelle che la montagna ti ha tolto?
Sono di più le cose che la montagna mia ha dato. Ma non solo. Son di più anche le cose che la mon-
tagna mi può ancora dare. Se c’è qualcuno che mi porta via qualcosa… Quella non è la montagna, ma è il tempo che passa. Sono gli anni che mi portano via quello che ho. Mi stanno portando via anche i muscoli. Non ho perso la voglia di andare in montagna ma ho perso le mie capacità. Perciò torno al Festival sempre volentieri. Una ragione di più per venire a Trento: il Festival non perde i suoi muscoli, si rinnova sempre. Ed è proprio questo il più bel regalo che mi fa.

Anna Facchini, di Trento, vive tra la città e la montagna. Oggi abita a Moena in val di Fassa. Dal 2018 è la prima donna alla guida della SAT (Società degli Alpinisti Tridentini), dopo 150 anni dalla nascita del sodalizio. Nel 2021 è stata riconfermata alla presidenza per un altro triennio.
Anna Facchini è nata e cresciuta a Trento dividendosi tra la città e l’amore per la montagna, che ha sempre frequentato in tutte le stagioni dell’anno e in quelle della sua vita. Costantemente presente nella promozione della conoscenza e della cultura di montagna, ha alle spalle una lunga esperienza nella pianificazione e nel governo dei territori montani e delle aree protette, per tradurre in azioni concrete l’impegno nei confronti della natura e di un modo etico di valorizzare l’ambiente. Il suo è uno sguardo attento, critico, di chi ha riflettuto molto sul rapporto tra le città di fondovalle e i paesi di mezza montagna. Assieme alla bellezza delle cime, che la affascinano, è interessata soprattutto alla cultura dell’alpe, che pone continui interrogativi sui modelli di sviluppo sostenibile in un tempo di grandi cambiamenti. Diplomatasi a Trento al liceo classico, ha frequentato il Trento Film Festival quando era giovanissima, fin dagli anni settanta.
Qual è il tuo primo ricordo del Festival?
Ho iniziato a guardare i film di montagna quando andavo scuola, probabilmente l’età in cui io e le mie coetanee ottenevamo i primi permessi per uscire di casa dopocena. Erano gli anni settanta. Ho finito il liceo nel 1976. Cercavo con gli amici i film delle grandi scalate, dei grandi alpinisti e delle grandi arrampicate. Inseguivamo ancora una rappresentazione di montagna che si identificava con la conquista della vetta e che mostrava luoghi allora sconosciuti come l’Himalaya, il Sudamerica, la Patagonia, gli altipiani indocinesi. Terminata la proiezione, le serate proseguivano alla Cantinota (ristorante di Trento) per tirare tardi con gli ospiti del Festival. Sono questi i miei primi ricordi della rassegna.
La Cantinota è stato per anni uno dei simboli del Festival e del suo rapporto con la città di Trento. Le atmosfere che si respiravano facevano la differenza. In quelle giornate, c’era profumo di Festival. Erano anni di grandi trasformazioni.
Cominciava ad affacciarsi la pratica del free climbing ed eravamo affascinati da alcune figure che caratterizzavano quel periodo: Luisa Iovane, Heinz Mariacher, Hans Kammerlander. Ovviamente anche i fratelli Messner, con tutta l’epopea che hanno narrato. Il significato della montagna e dell’esplorazione veniva associato ai grandi nomi
dell’alpinismo, declinati in avventure e grandi spedizioni. Una nota di costume: grazie all’arrampicata sportiva cominciammo a vestirci anche noi con le canottiere e i fuseaux coloratissimi. C’era anche la fascettina sulla fronte, la indossavamo per fermare i capelli, emulando gli alpinisti che scoprivamo al Festival: erano quasi nostri coetanei. Sono stati anni speciali e noi eravamo così giovani. Poi cosa è cambiato?
Abbiamo iniziato a lavorare e siamo diventati grandi… Abbiamo preso strade differenti, ciascuno i propri percorsi. Ci siamo un po’ staccati dal Trento Film Festival per poi riscoprirlo in età adulta, con grande sorpresa e tante differenze.
Quali?
Non c’era più solo la scalata, ma c’era anche molta rappresentazione di culture, paesi e luoghi diversi. Non più soltanto la montagna, ma il mondo di montagna. Non più soltanto l’impresa e l’avventura, ma anche, in modo ben più raffinato, la volontà di riflettere su tematiche importanti legate all’ambiente, all’etnografia e alla cultura delle genti di montagna. Tutti aspetti che identificano ancora il Festival di Trento.
Certamente. Sono proprio le prerogative che meglio esprimono la rassegna e sono anche gli elementi che mi interessano di più.
Una bella amicizia, quella tra te e il Festival: lo hai incontrato negli anni del liceo, poi te ne sei allontanata e infine lo hai riscoperto con altri occhi e con una nuova pelle. Ci sono altri capitoli di questa storia?
Nel 2015, mentre ero impegnata all’interno della SAT come volontaria nella Commissione Tutela ambiente montano e nella Commissione cultura, vengo designata dal CAI (Club Alpino Italiano), di cui la SAT è sezione, come membro del Consiglio direttivo di Trento Film Festival. Così ho potuto entrare dentro la macchina organizzativa di questa realtà, per scoprirne un grandissimo grado di efficienza insieme alla eccezionale qualità delle persone che vi lavorano, a tutti i livelli.
Al timone della SAT, il tuo rapporto con il Festival è cambiato un’altra volta diventando, se possibile, ancora più stretto. La SAT ha un legame fortissimo con il Festival.
Il Festival nasceva a Trento nel 1952 quando la SAT compiva 80 anni. E nel 2022, mentre il Festival festeggia il suo 70° compleanno, la SAT celebra il 150° anniversario. Alla base di tutto vi è una storia comune: le stesse passioni per la montagna, le stesse culture di montagna. Nel 2022 si festeggiano inoltre i 70 anni della nascita del Soccorso alpino, ideato dal satino Scipio Stenico. Nella concomitanza degli anniversari e in oc-
casione della tua presidenza, avete promosso nuove forme di collaborazione con il Festival?
Per esempio, abbiamo organizzato con lo staff del Festival dei piccoli momenti di cineforum presso lo spazio alpino della SAT, andando a scegliere, tra i film premiati o anche solo apparsi in concorso, quelli che trattavano argomenti affini alle tematiche presenti di anno in anno nei congressi della SAT. A causa del Covid, questi appuntamenti si sono interrotti nel 2020 e nel 2021, per poi ripartire proprio quest’anno, nel 2022. Ricordi anche qualche evento o qualche incontro favorito dall’alleanza tra il Trento Film Festival e la SAT?
Ricordo Reinhold Messner, ospite in città per il Trento Film Festival, che fece visita alla SAT, recandosi personalmente presso la sede centrale di via Manci. Affascinato dai volumi della nostra Biblioteca (Biblioteca della Montagna della SAT), lo vidi sinceramente colpito dalla ricchezza documentale del nostro archivio storico. Era di passaggio. Aveva pochi minuti a disposizione e il suo staff premeva affinché ci salutassimo, per condurlo verso gli impegni successivi. Ma Reinhold volle fermarsi più a lungo a guardare i nostri libri. Li sfogliava – ricordo, alcuni libri di vetta – con tanto garbo e delicatezza. Mi colpì moltissimo. Pensare che quelle mani avevano scalato rocce e ghiacci
sugli Ottomila di tutta la Terra! Senza questa felice collaborazione tra SAT e Trento Film Festival non avrei mai potuto vivere quel momento di persona. A proposito di libri, che rapporto c’è tra le vostre raccolte e la bibliografia di montagna legata al Festival?
La SAT custodisce tutti i libri che vengono proposti a MontagnaLibri. Ogni anno, al termine dell’edizione del Festival, i titoli vengono depositati alla SAT in un fondo librario dedicato – appunto, il «Fondo MontagnaLibri» – che si alimenta continuamente. Tramite i linguaggi della letteratura e del cinema – quelli più frequentati dalla rassegna – ma anche tramite l’arte, quali temi vorresti ritrovare al Trento Film Festival di domani?
Il Festival ha sempre avuto la capacità di anti-
cipare i tempi, introducendo nuove riflessioni e nuovi dibattiti, dalla cultura per il rispetto dell’ambiente alla sensibilità di genere. In questo senso, ha costruito ininterrottamente momenti di incontro, magari non sempre esaurienti, ma sempre capaci di porre interrogativi e di fornire alcune risposte. Se penso a un dibattito che non avrà mai fine – che necessita ancora di tanto confronto e riflessione – penso al rapporto tra la città e la montagna. O meglio, tra gli abitanti della città e quelli della montagna. I punti di vista sulla montagna sono spesso differenti, per questo è importante cercare una composizione tra interessi diversi nell’interesse di tutti gli attori in gioco. E, non ultimo, nell’interesse della montagna.

Nicoletta Favaron è regista, storyteller e fondatrice della Bread & Dreams Video Productions. Ha firmato diversi documentari in ambito montano, tra i quali Ciapin. Passi scolpiti nel vento con Maurizio Camponovo (Italia, 2012), Prese libere (Italia, 2015), Prima il dovere (Italia, 2016) e #storiadiunagoccia (Italia, 2017). Suo è anche il video promozionale Oltre l’orizzonte (Italia, 2017) che racconta la montagna vista dal Club Alpino Italiano (CAI). Dal 2017 è vicepresidente del Trento Film Festival e dal 2022 anche del Centro di Cinematografia e Cineteca del CAI
«Ho portato la mia prima figlia al Festival di Trento quando aveva appena 9 mesi». Così la storia personale intreccia quella istituzionale. Nicoletta Favaron, vicepresidente del Festival, si dice «onorata per l’opportunità offerta, e insieme molto consapevole delle responsabilità che comporta un ruolo di tale importanza».
Se torno con la memoria indietro negli anni, ho ancora viva l’immagine di me alle prese con uno dei primi lavori come assistente alla regia. Fresca di università, mi sono imbattuta in un lavoro industriale all’estero. Mentre condivido ore e giorni con Pino, il mio «datore di lavoro», mi arriva all’improvviso la proposta di fare la
giurata per un premio del CAI al Trento Film Festival. Trento è una leggenda per noi amanti della montagna e dell’alpinismo! Per me in particolare, considerato che sono nata a Lecco e che per anni ho condiviso i banchi di scuola con Marta Cassin, nipote di Riccardo, circondata da quelle Grigne che sono state, ieri come oggi, palestra di allenamento di tanti Ragni e alpinisti lombardi e dove mosse i primi passi in verticale anche Walter Bonatti.
E poi cosa successe dopo quella prima chiamata?
Ovviamente sono al settimo cielo e chiedo a Pino qualche informazione in più: sono giovane, ho tanta voglia di fare, ma sono anche consapevole della mia inesperienza. Ma non è tanto quello l’ostacolo insormontabile: la prima condizione per accettare è essere soci CAI. E io non lo sono. Nonostante fossi una frequentatrice della montagna, non avevo mai sentito l’esigenza di tesserarmi al Club Alpino Italiano: per monti andavo con un gruppo più piccolo, l’Unione Operaia Escursionisti Italiani (UOEI) di Lecco e mi era andata bene così. Quindi mi tocca rinunciare. E vado avanti col mio percorso…
In generale che rapporto hai con la montagna? La parte più tecnica dell’alpinismo non mi ha mai particolarmente interessata, ho sempre preferito
la dimensione naturale della montagna, come luogo di vissuto umano, dove si compiono storie personali dentro cui mi piace entrare per raccontarle a un pubblico più ampio. Mio marito Pietro, lecchese doc e grandissimo appassionato e cultore dell’alpinismo e della sua storia, ha passato serate intere a tentare di insegnarmi i nodi più importanti e i rudimenti della progressione su roccia. Senza grandi risultati, però! La montagna comunque è la nostra passione tanto che poi mi sono avvicinata anche al CAI. Prima nella sezione di Lecco, dove inizio a occuparmi di documentari in ambito montano, legati soprattutto alla storia del territorio. E così scopro che esiste una Commissione Cinematografica all’interno del Club Alpino Italiano, che è poi quella di cui il famoso Pino dei miei inizi era stato presidente a inizio anni duemila: Pino è Giuseppe Brambilla. Decido di presentare la mia candidatura per quella commissione e qui inizia la mia storia nel CAI centrale. E com’è stato entrare nel mondo CAI?
Dopo l’elezione, mi ritrovo a collaborare con un bel gruppo di donne, ostinate, tenaci e decise a cambiare alcune regole che avvertono come aliene e superate, non più in linea con la direzione che sta prendendo il mondo, tantomeno quello del cinema. Ad avviare questo nuovo corso è Renata Viviani, referente per la Cineteca e componente del
Consiglio centrale. Renata mi ha insegnato tanto, soprattutto a non demordere e a lottare per cambiare in meglio. Valori che mi erano certamente già noti, ma che forse solo allora ho interiorizzato davvero, proprio grazie alla testimonianza quotidiana di una persona che ha realmente incarnato questo ideale all’interno del CAI, mentre lottava con una malattia sempre più invalidante. La cinematografia è stata storicamente uno strumento importante per il CAI per comunicare l’alpinismo e per conservarne memoria, attraverso quello che oggi è un ricco patrimonio filmico. Da regista, come è cambiato il rapporto tra CAI e cinema di montagna?
Il CAI, fin dalla costituzione della sua Cineteca, non ha mai smesso di acquisire nuovi titoli a catalogo per prestarli alle Sezioni, ma, come successo per il Festival, ha dovuto accettare che col tempo «montagna» non significava più solo alpinismo in senso stretto. Questo cambiamento culturale, inizialmente critico, è stato vincente e ha traghettato il sodalizio nella contemporaneità, aprendolo a un pubblico molto più ampio, grazie a temi all’inizio ritenuti lontani e invece oggi considerati priorità. Penso in prima battuta a quelli legati alla preservazione dell’ambiente montano o alle conseguenze del cambiamento climatico sulle popolazioni che ci vivono, ma anche alla montagnaterapia. Per un
regista credo sia ancora più stimolante occuparsi di cinema di montagna oggi, potendo spaziare in un campo semantico così vasto e ricco.
Attraverso il CAI hai di nuovo intrecciato la via del Festival di Trento, entrando a far parte anche del consiglio direttivo.
Lascio immaginare l’emozione provata sedendomi per la prima volta in consiglio! Agitatissima, mi presento con Angelo Schena, mio presidente alla commissione cinematografica e uomo di grande esperienza caiana. Dopo le presentazioni, Roberto De Martin, che è stato presidente del CAI ed è in quel momento il presidente uscente del Festival, introduce Mauro Leveghi, proposto come suo successore. Accolta la sua nomina con favore unanime, vengo proposta io come vice presidente. Sono stati cinque anni di crescita personale e professionale, in seno al Festival ma anche in seno al CAI, la cui prima richiesta è stata quella di creare più spazi ed eventi dedicati ai soci, per coinvolgerli sempre di più in una manifestazione storica per il Club, che ne è fondatore. Abbiamo iniziato a ideare progetti comuni rivolti anche al pubblico dei soci, per rinsaldare la nostra collaborazione e renderla sempre più concreta. Un percorso che ha trovato il suo coronamento nel 70° del Festival, quando si è deciso di aprire l’edizione con la proiezione al teatro Sociale del film di Marcello Baldi
Italia K2 (Italia, 1955), nella versione restaurata in 4k. E chi conosce il CAI sa quanto conti quel film nella sua storia, oltre che in quella del cinema di montagna!
Se dovessi dire cos’è per te il Festival…
Trento Film Festival oggi per me è una seconda famiglia, fatta di persone che uniscono una grande umanità a un alto livello di competenza professionale. È un ambiente in continua crescita, che si sa adattare ai tempi che cambiano. Un esempio concreto è stata la sfida del 2020, quando la pandemia di Covid-19 ci ha costretti a una chiusura forzata. Non potendo fare praticamente nulla, per via delle numerose restrizioni volte a evitare assembramenti, come appunto si creano dentro a una sala cinematografica, sarebbe stato
facile scegliere di saltare l’edizione di quell’anno. Invece il Festival ha resistito. Anzi, ha rilanciato con una versione online creata da zero. Non è stato semplice convincere i vertici del CAI che si trattava di una buona idea, ma Vincenzo Torti, allora presidente generale, si è fidato della nostra scelta. Col senno di poi, una scelta vincente, fonte di un successo incredibile che ci ha proiettato nel futuro. Pensando alla rassegna trentina, faccio mie proprio le parole di Vincenzo Torti che lo ha definito «un Festival che ha saputo divenire nel tempo, testimone di una cultura che, dalle immagini del passato, sa proiettare luce sul futuro sempre più attento e consapevole del valore della montanità in ogni sua espressione, umana e ambientale».
Alessandro Garofalo è fisico e fondatore di Garofalo & Idee Associate Srl, dal 1995 laboratorio per aziende nell’ambito dello sviluppo di nuovi product concept e nella formazione innovativa. Ha esperienze lavorative nell’area ricerca e sviluppo in industrie del settore meccanico ed energia.
«Quando si innova si ricombinano e si mescolano fattori già esistenti, si parte dal materiale che abbiamo, lo si rovescia su un tavolo, si individua una trama di indizi per ipotizzarne gli sviluppi». Il tavolo in questione è quello di Alessandro Garofalo e i pezzi sparsi raccontano il Trento Film Festival. Con gli occhi di un creativo che ha la passione per le mappe e gli elenchi puntati».

Da dove cominceresti per affrontare il tema della creatività applicata al Trento Film Festival?
Partirei dalla 68a edizione, forse una delle più difficili, nel primo anno di pandemia: è stata un’edizione speciale con lo slittamento della data tra fine agosto e inizio settembre, un programma che si sviluppava sia in città che in altri centri provinciali e poi era diffuso in tutta Italia, con film disponibili on line per sette giorni e 500 visioni. Quella è stata davvero una rivoluzione, organizzativa e digitale. In generale, la pandemia ha accelerato un’evoluzione
che era già in atto nell’industria cinematografica. Faccio qualche esempio. Il Sundance Film Festival, festival dedicato al cinema indipendente negli Stati Uniti, si è tenuto interamente on line: ogni film era accompagnato da una sessione question and answer (Q&A) via Zoom, mentre chi era interessato all’aspetto più social del festival si ritrovava nella cosiddetta «Spaceship»,, un hub virtuale destinato alle conversazioni a margine delle proiezioni. Il rapporto del pubblico con i film sta dunque mutando: multiplex e home theatre sono usati agevolmente, ma cambia la relazione coi registi che perdono l’opportunità di vedere la reazione degli spettatori durante la proiezione in sala. Serve una stanza, una piattaforma dove centinaia di persone possano parlare del film visto. In futuro si dovrà puntare su festival ibridi come suggerisce Angela Watercutter nel pezzo «Film Festival Are Evolving for the Better», apparso su Wired a gennaio 2022. La sala deve mutare in polo aggregativo culturale, che dialoghi con la città: matinée, nuovi orari notturni, film cult riproposti per i giovani, proiezioni in lingua originale; insomma un’offerta adatta a diverse fasce di pubblico.
Un po’ di sano benchmarking sulle altre realtà culturali, italiane e non, risulta salutare alla creatività che un Festival può attivare. Non c’è dubbio. Suggerirei anche di analizzare
le segnalazioni di Artribune nella sua imperdibile newsletter: alcune realtà culturali propongono palinsesti originali che sono ottimi spunti, come la Galleria d’arte contemporanea di Bergamo, il Dipartimento educativo di Pirelli HangarBicocca, il benchmarking a Prato, il Museo tattile Omero di Ancona. Personalmente, ho realizzato un contest sul futuro del cinema all’Università di Verona nel corso in Marketing e comunicazione d’impresa. Ne do una sintesi a uso di una certa idea di Trento Film Festival del futuro che mi frulla nei pensieri. Qui mi scuserete, ma ricorro a una delle mie famose liste.
1. Istituire un servizio per consentire agli spettatori di vivere l’esperienza del cinema ovunque essi vogliano, anche da casa, con un visore, potendo anche condividere l’esperienza con altri amici abbonati in sale private. Lo spettatore è totalmente immerso nell’ambientazione del film.
2. Installare al soffitto delle sale una serie di bolle trasparenti, fatte con materiali di riciclo. Nelle bolle vengono immessi aromi e fragranze coerenti con le scene del film, variate le temperature, creati piccoli movimenti per aumentare l’ingaggio durante la visione.
3. Mantenere il cinema tradizionale ma innovare la poltrona, dotandola di tutti i comfort e ren-
dendola simile a un oggetto di design quasi spaziale.
4. Trasformare la tradizionale sala in sei maxischermi disposti a esagono con sei cupole indipendenti e relativi percorsi per incanalare il pubblico. Catering con nastri trasportatori e un’app per permettere il dialogo tra spettatori, attori e registi.
5. Creare una struttura trasparente per guardare in notturna un film incorniciato da un cielo stellato distesi su pouf, con apertura da due lati per consentire ricircolo continuo dell’aria.
Davvero idee interessanti, per chiunque lavori nel mondo della cultura live. Dai tuoi appunti degli incontri con lo staff del Festival ritrovi alcuni di questi elementi?
Emergono molti elementi «risonanti» che ritengo sia utile diffondere per far lavorare l’intera comunità sul futuro di questo tesoro culturale al suo 70° anno. Ad esempio: l’arricchimento dell’offerta a tutta la gamma della multisensorialità, ovvero i cinque sensi devono essere stimolati ed essere veicoli di emozioni (non solo assaggi di vini e cibo di montagna ma anche proiezioni sotto le stelle, sound logo, conoscenza di alberi, foglie e cortecce); la creazione di uno spazio/piattaforma per gestire idee a partecipazione emergente dal basso, soprattutto sui temi della sostenibilità
ed economia circolare; la capacità di parlare in modo appropriato alle cinque generazioni che abitano la nostra società. E ancora, è emersa la necessità di interpretare il festival come ambiente di vera e sana coesione sociale ma anche come come punto estremo di disconnessione e detox. Poi naturalmente ho raccolto le idee più varie, anche bizzarre: raccogliere le storie dei negozianti e i loro ricordi del festival, fare collegamenti a sorpresa del regista con il pubblico, organizzare i Giochi senza frontiere a tema montano o il drive in per alcune proiezioni.
E se dovessi aggiungere una personalissima lista a questi spunti?
Il WWF da poco diffonde una raccomandazione bellissima basata su azioni da fare per mantenere una relazione con la natura sin da piccoli: si intitola «Le 50 cose da fare prima degli 11 anni». Sono suddivise tra divertimento, scoperta, esplorazione, ricerca e avventura e spaziano da «giocare sotto la pioggia» a «raccogliere tutte le sfumature di colore delle foglie d’autunno», fino ad «arrampicarsi sui massi» o semplicemente «camminare nella neve». A leggerle bene sono tutte attività perfettamente in sintonia con comportamenti di rispetto del nostro pianeta e coerenti con i valori del Trento Film Festival. Il Festival può divenire il naturale promotore di tali azioni educative per aumentare
il rispetto della Terra. Una seconda considerazione la farei a partire da Antonio Lampis, già direttore generale della Direzione Musei del Ministero dei Beni Culturali, che afferma: «non dimentichiamo che l’innovazione avviene maggiormente in quei paesi nei quali larghe fasce di popolazione sono abituate a frequentare attività culturali. I consumi culturali diffusi sono il principale fattore che aiuta le istituzioni di ricerca, le università e gli incubatori di impresa a non divenire cattedrali nel deserto o occasioni di presenza mordi e fuggi da parte di docenti di varia provenienza e scarsa qualità e consentono viceversa a tali istituzioni di innestarsi positivamente nel territorio come investimento utile per tutta la collettività». Credo molto in questa affermazione, come pure nelle teorie sulla creatività dei territori formulate dall’economista
Richard Florida (in The Rise of the Creative Class, 2022) attraverso il modello delle tre T: tecnologia, talento e tolleranza sono attivatori di creatività.
Tre parole che suonano come un auspicio.
Vedo anche il futuro Trento Film Festival come catalizzatore di innovazione verticale, montagna, sport, tecnologia e sostenibilità e, aggiungo, co-
operando con l’Alto Adige. A proposito di territori e cultura mi ha colpito una riflessione di Elena Granata sul significato di culture maker e placemaker, gli inventori dei luoghi che abiteremo. La specializzazione funziona se gli specialisti sanno lavorare come squadra a «intelligenza collettiva», spesso invece non hanno la consapevolezza di essere parte di un insieme. Mi auguro che le strade future di questo «giovane settantenne» (il Festival) portino alla interdisciplinarità dei saperi, ancorandolo al territorio dove è nato ma interprete planetario di tutte le comunità montane della nostra terra.
Ti concedo un’ultima provocazione. Ultima provocazione, lo prometto. Il Trento Film Festival potrebbe avere ogni anno un brand ambassador nel mondo, proveniente da campi completamente differenti dal core della montagna. Ho già in mente il primo: l’astronauta e alpinista Maurizio Cheli. Mi sembra perfetto quando dice: «sognavo di raggiungere la vetta dell’Everest, sin da quando la guardavo dallo spazio, sullo Shuttle: guardavo quella montagna da lassù con ammirazione e speravo, un giorno, di arrivare in cima».
Maurizio Giordani è Accademico del Club Alpino Italiano (CAI) e fa parte del Groupe de Haute Montagne francese. Guida alpina dal 1989, ha all’attivo più di 80 spedizioni in tutto il mondo, numerose solitarie e prime salite di vette inviolate. La sua esperienza spazia dalle alte difficoltà della falesia alle alte quote dell’Himalaya con più di 1.000 salite in roccia e ghiaccio, spesso oltre il sesto grado, alle quali si aggiungono centinaia di vie nuove, decine di prime invernali e solitarie, tutte di difficoltà estrema.
Il primo ricordo del Festival? Giura di non ricordarselo, tanti ne ha passati, vissuti, seguiti, raccontati. Roveretano, classe 1959, Maurizio Giordani ha scalato due Ottomila e vanta un’enorme esperienza su roccia, neve e ghiaccio. Tra i maggiori interpreti dell’alpinismo trentino, ha dedicato parte della sua vita alla Marmolada, dove ha aperto vie di altissima difficoltà, pubblicando diversi volumi che le illustrano. Ama soprattutto l’avventura e considera l’alpinismo «quasi un pretesto per partire in spedizione», mettersi in viaggio, scoprire il mondo. E forse è proprio questo che lo avvicina maggiormente al Trento Film Festival, incarnandone lo spirito autentico di esplorazione e di ricerca.

Che cosa cerchi nella montagna?
Territori selvaggi e pareti che non conosco. Sono molto curioso e voglio scoprire quello che non so, vedere quello che non ho mai visto, raggiungere luoghi dove nessuno ha mai messo piede.
E la cima?
La cima conta, eccome. È importante raggiungere la vetta. Ma non è l’unica priorità. Quello che sta attorno è più importante. Voglio dire: parti per scalare una montagna ma è l’esperienza globale, di vita e di viaggio, che fa la differenza. Il vero richiamo verso l’avventura si nasconde proprio in ciò che costruisci prima, durante e dopo la conquista della vetta.
La voglia di avventura; così non sei schiavo della cima.
Il desiderio di raggiungere la vetta è una molla che motiva la partenza. Ma se lo consideri l’unico obiettivo, non va bene. Sia perché sei meno disposto alla rinuncia, e quindi corri più rischi. Sia perché tendi a escludere il resto del viaggio: l’avvicinamento, gli incontri, la voglia di scoperta, che sono il valore aggiunto della tua esperienza. Mi considero soprattutto un appassionato di avventura e di avventure, ancor più che di alpinismo. Ma come si pianifica l’avventura?
Non si pianifica.
Cioè?
Se vuoi vivere pienamente l’esperienza della co-
noscenza non puoi pianificare ogni cosa. Il mio muoversi in spedizione e in montagna ha sempre avuto questa caratteristica: non mi sono mai informato completamente su ciò che mi aspettava, non ho mai preparato tutto a tavolino. Solo così riesci a vivere davvero l’avventura mano a mano che l’affronti e che ti si presenta. Ho fatte tante spedizioni. Partivo, prendevo il volo aereo e il mio piccolo bagaglio. Molte cose le sapevo, molte altre non le conoscevo. L’avvicinamento, il percorso, la salita… A volte, perfino la cima che avrei scalato non era stata predeterminata. Giunto sul posto, guardavo le pareti e cercavo le più promettenti. Ho scoperto così montagne straordinarie. Mettere le mani e i piedi dove nessuno è stato mai. Sembra la luna. Cosa si prova?
Oggi è sempre più difficile. Il mondo è più piccolo e scoprire posti inviolati diventa quasi impossibile. Ma quando ci riesci e torni a casa: beh, ti porti dentro una sensazione ineguagliabile. Ho raggiunto posti dove nessun uomo, non solo gli alpinisti ma nemmeno le popolazioni locali, era mai stato, perché le vie di accesso non erano percorribili, se non superando enormi difficoltà alpinistiche. Ho raggiunto così terre inesplorate, valli, cime, altipiani. Un’esperienza di grandissimo valore umano ed emotivo, che non puoi dimenticare. Oggi i luoghi inesplorati si stanno esaurendo. Nelle Alpi, questa
dimensione non esiste più da molto tempo. Sono stato fortunato a poterla vivere.
Somiglia molto alla libertà: quello che cerchi e quello che hai provato.
È una mia scelta. Ancora oggi, se parto, lascio tanta parte al caso. La bellezza dell’alpinismo è anche questo, che puoi decidere tu. È la tua liberta. Puoi scegliere cosa fare e puoi decidere a cosa rinunciare, che tipo di esperienza vuoi vivere e cosa vuoi portarti a casa. Nessuno te lo fa fare e nessuno ti obbliga. L’alpinismo è questo, una scelta di libertà. Anche la rinuncia?
Se devi rinunciare agli obbiettivi che ti eri posto, poco male. La rinuncia ti serve per trovare nuovi stimoli e per ripartire. Fa parte del gioco e devi sempre potertela permettere. La libertà individuale di rinunciare a una vetta non può mai venire meno, per non superare il limite dell’azzardo. Come si fa a capire dove sta il limite, il confine da non oltrepassare?
C’è una percentuale di rischio e di pericolo che non è eliminabile. Intendiamoci, non arrivi in cima facilmente. E non puoi nemmeno essere predisposto alla rinuncia. Quando è così, non vai da nessuna parte. Devi saper stringere i denti nel momento giusto e devi stringerli forte per arrivare lassù. Ho scalato montagne molto difficili in ambienti molto severi dove non ci sono sconti. Ogni passo te lo
devi guadagnare, tenendo duro. Ma c’è sempre un filo sottile che separa l’azzardo dalla sicurezza. Cerchi di restare sul confine, dalla parte giusta. In tanti anni di frequentazioni, prima da semplice curioso e appassionato, poi da protagonista, cosa ti ha dato il Festival di Trento?
Un ambiente speciale dove incontrare persone, alpinisti e mondi differenti. Oggi la rassegna ha allargato i suoi orizzonti e si occupa di cultura di montagna, oltre che di alpinismo. Ma, un tempo, prevalevano l’arrampicata e l’alpinismo. Ricordi qualcuno in particolare?
Conobbi al Festival Jim Bridwell, che giunse fin qui dalla California. Andammo a scalare insieme sulle falesie di Arco, dove lo accompagnai personalmente. Ripetemmo la via «Nuovi orizzonti». Lui era un mostro su certi tipi di arrampicata, sulle fessure a incastro. Ma qui occorrevano tecniche diverse per ambienti e rocce differenti. Ci confrontammo sui nostri modi di arrampicare e imparammo l’uno dall’altro. Fu un’esperienza indimenticabile. Legarsi in cordata con Jim! Lui, californiano, un mito del suo tempo, ieri come oggi.
Alpinisti di scuole, nazionalità e generazioni differenti si incontravano a Trento.
Alcuni anni fa trovai al Festival Matteo Della Bordella, molto più giovane di me. Davanti al cinema Vittoria nacque l’idea di andare in spedizione
insieme. Situazioni come questa erano all’ordine del giorno. Ciascuno di noi aveva i propri sogni e qualche progetto in tasca. Li tiravi fuori al momento buono. Scambiavi due parole e così si partiva per una nuova avventura. Anche con Hervé Barmasse – ci si incontrava al Festival – ho fatto due spedizioni, una in Patagonia e una in Pakistan. Oggi è molto più facile avere contatti con altri alpinisti e maturare nuovi rapporti di amicizia e professionali. Ci sono i telefoni, internet, i social. Ma un tempo il Festival rappresentava una tra le pochissime occasioni per potersi confrontare, sicuramente la più importante di tutto l’anno. Ci misurava con scuole alpinistiche differenti e con mentalità distanti dalla nostra. Per esempio?
Prima della caduta del Muro di Berlino, incontravamo al Festival generazioni di alpinisti che provenivano dall’Est. Sul palco dell’auditorium Santa Chiara ho conosciuto Jerzy Kukuczka. Quelle persone esprimevano un tipo di alpinismo profondamente diverso dal nostro. Noi occidentali eravamo più liberi e indipendenti nelle scelte. Potevamo organizzare la nostra spedizione decidendone modalità e destinazione. Loro no. Le spedizioni alpinistiche dell’Est avevano un’impostazione quasi militare. Dovevano chiedere il permesso di espatrio per poter uscire dal Paese, fissare la conquista
di un grande obiettivo, accettare di perseguirlo come fine irrinunciabile, adempiere a tutta una serie di impegni formali, politici e istituzionali. Per loro, portare a casa il successo della spedizione diveniva condizione indispensabile. Questo comportava molti rischi. Noi occidentali eravamo diversi. Ho scoperto l’alpinismo e l’avventura tra gli anni settanta e gli anni ottanta, un momento di grande innovazione e libertà.
Che anni erano?
Eravamo ambiziosi e avevamo voglia di viaggiare. C’era grande fermento. L’arrampicata sportiva esplodeva proprio in quel periodo, introducendo nuovi strumenti e nuove tecniche. L’esperienza che maturavi sulle nostre montagne te la portavi dietro in spedizione, per raggiungere nuove vette e terre inesplorate. Gli anni ottanta sono stati una stagione d’oro nell’alpinismo, una fase di evoluzione e di crescita importantissima, un momento magico, che ho vissuto in prima persona. Poi, l’alpinismo e l’arrampicata si sono specializzati sempre di più, prendendo strade separate.
Quando partirai per la prossima cima?
La cima è solo una scusa, un pretesto per cominciare un nuovo viaggio e nuove avventure. Ho ancora tante idee, tanti progetti, che aspettano di essere realizzati.
Heidi Gronauer, direttrice della ZeLIG dal 1990, si dedica allo sviluppo dei vari progetti e produzioni, legati al documentario, realizzati dalla scuola. Dal 2004 è responsabile anche del progetto europeo ESoDoc – European Social Documentary, indirizzato a filmmaker impegnati nella creazione di progetti di documentario e cross-mediali su tematiche di rilevanza sociale. Collabora con l’Associazione documentaristi italiani doc-it/Italian Doc Screenings, il Trento Film Festival, il Fondo per il cinema in Alto Adige IDM ed altri enti. È membro della EFA (European Film Academy).

Quale è il tuo primo ricordo del Trento Film Festival?
Sono arrivata in Trentino nel 1986 nell’ambito di un gemellaggio tra le città di Trento e Berlino-Charlottenburg che, in quell’anno, celebrava il 20° anniversario. Nel 1987 cominciai a lavorare per un progetto dedicato alla colonna sonora nel cinema che si chiamava «Trento Cinema-Incontri internazionali con la musica per il cinema»: si trattava di un festival che si svolgeva in quegli anni, a Trento, oltre al Film Festival Internazionale di Montagna ed Esplorazione Città di Trento (così si chiamava allora il Trento Film Festival). Per gli «Incontri internazionali con la musica per il cinema» seguivo i rapporti internazionali e mi occupavo della
programmazione delle scuole di cinema. La cosa divertente è che ho conosciuto il Trento Film Festival perché, nell’ambito del mio lavoro, quando chiamavo esperti e incontravo registi o giornalisti, tutti associavano il nome di Trento al Festival del cinema di montagna e non al giovane festival della colonna sonora «Trento Cinema», di cui mi occupavo io.
Poco dopo hai cominciato a lavorare per la ZeLIG. Quanto è stato importante, per voi, il rapporto con il Trento Film Festival?
Grazie alla mia attività a Trento ho potuto conoscere anche le altre realtà che, nelle vicinanze, ruotavano attorno al mondo del cinema. Bolzano
è molto vicina a Trento e non ci è voluto molto che mi avvicinassi anch’io a quella realtà, appena nata, che allora si chiamava «ZeLIG Scuola di Cinema di Bolzano». Nel 1990 ne diventai la direttrice. La ZeLIG è sempre stata una scuola molto pratica, con studenti che provenivano da tutta Europa e che, nel corso della loro formazione, dovevano produrre il loro film di diploma. Le diverse origini dei nostri studenti e delle nostre studentesse hanno sempre portato alla ZeLIG punti di vista e prospettive narrative diverse e questo si rispecchiava anche in uno sguardo specifico e unico sulla nostra regione, allora location privilegiata delle produzioni realizzate durante la formazio-
ne. Forse fu per questo che molte produzioni venivano invitate dal Trento Film Festival, vincendo anche premi significativi. Come primo premio importante mi ricordo il documentario Keine will hoch hinauf (Italia, 1998), di Michaela Pabst, che vinse il premio del Museo degli usi e costumi di San Michele, assegnato all’opera cinematografica che, cito testualmente: «con rigore antropologico, meglio sa rappresentare gli usi e i costumi delle genti della montagna». Fu per noi una grande soddisfazione. Il film (titolo in italiano Nessuna vuole salire lassù - vivere nei masi di alta quota in Val Sarentino) narra della difficile situazione dei contadini di alta montagna di «trovare una moglie». Fu un riconoscimento davvero importante, che ci fece capire che il progetto formativo della ZeLIG era sulla buona strada. Negli anni successivi avete sviluppato anche forme di collaborazione comuni e progetti condivisi con il Festival?
Tra la ZeLIG e il Trento Film Festival sono nate negli anni successivi delle straordinarie sinergie. Ricordo che nel 1999 vennero a Bolzano Toni Cembran e Claudio Visintainer, rispettivamente direttore e presidente del Trento Film Festival, proponendoci di organizzare un convegno sulla cinematografia di montagna. L’intenzione era di riflettere su come le montagne vengono rappresentate nei film e
su come, questi film, vengono distribuiti dopo la loro uscita nelle sale. Il titolo del convegno era «Dopo la conquista: immagini cinematografiche della montagna del 2000». L’iniziativa fu promossa dal Festival assieme alla ZeLIG e si tenne proprio a Bolzano, presso la vecchia sede della nostra scuola. Vi collaborò anche l’Accademia internazionale per le arti e le scienze dell’immagine dell’Aquila, presente in quel momento con Antonio Massena. Fu quasi un’impresa realizzare quel convegno, due giornate piene di incontri, con tanti relatori stranieri provenienti da contesti e Paesi diversi. Fu necessario ricorrere a un sistema di traduzione simultanea in più lingue. Le giornate ebbero un ottimo successo, vi parteciparono personalità importanti come Kurt Diemberger, Mario Brenta, Lothar Brandler, Ermanno Comuzio e molti altri, gente di montagna e gente di cinema. Fu un’occasione per affrontare anche temi che non erano esplicitamente in programma, ma che evidentemente erano importanti, ed erano nell’aria. Tra questi, anche un’impressione abbastanza
condivisa: che, spesso, i film di montagna curavano poco l’estetica e la drammaturgia cinematografica, trascurando le sensibilità legate alla bellezza filmica. Alla base del convegno vi era la volontà di promuovere il film di montagna anche in un’ottica di qualità filmica, con uno storytelling
efficace, capace di affascinare ed emozionare. Un’iniziativa di grande significato, quindi, che ha lasciato un segno negli anni successivi.
Certamente, negli anni successivi il Trento Film Festival cominciò a dedicare una particolare attenzione a questi aspetti. Ad esempio, mise a disposizione delle scuole di cinema dell’Aquila e della ZeLIG una borsa di studio per gli studenti che realizzavano film sui temi di montagna. I nostri rapporti si intensificarono proprio nella ricerca di possibili collaborazioni utili a sostenere e a favorire la qualità del film di montagna. Negli anni successivi, durante la direzione artistica di Maurizio Nichetti, furono sviluppate diverse idee che si concretizzarono nel progetto «Raccontare l’avventura», proposto nell’ambito delle varie edizioni del Trento Film Festival dal 2006 al 2015. «Raccontare l’avventura» veniva proposto come un’iniziativa rivolta a filmmakers che volevano perfezionare le proprie conoscenze sulla scrittura, sullo sviluppo e sulla presentazione di un progetto di un film documentario. Al termine del percorso formativo i progetti venivano presentati in un pitching pubblico con esperti del settore e decision makers in grado di offrire reali opportunità di mercato. Fu un corso al quale parteciparono diversi giovani autori o aspiranti tali. Per molti di loro fu l’inizio di un’importante carriera. Per molti dei progetti
sviluppati fu il trampolino di lancio di prestigiose produzioni. Ma fu, soprattutto, un momento di incontro e di aggregazioni dal quale si svilupparono interessanti collaborazioni. Per Trento, tutto ciò offrì l’opportunità di allargare l’apertura verso il mercato della produzione e distribuzione dei film di qualità. Penso che un festival debba essere anche questo: non solo il luogo per far vedere i film, ma anche un luogo di incontro per gli amanti del cinema oltre che delle tematiche proposte. Un luogo di incontro per tutti gli addetti del settore, a vari livelli della filiera produttiva, dove, soprattutto gli autori, possano trovare reali momenti di contatto con l’industria dell’audiovisivo.
Anche le case di produzione trentine, così, avevano modo di scoprire nuovi film e nuovi autori. Il legame fra la portata locale e internazionale del corso «Raccontare l’avventura» ha rappresentato il suo più grande potenziale. Ha favorito non solo lo sviluppo e la qualità dei film con tematiche legate a quelle del Festival, ma anche la loro collocazione sul piano della produzione e del mercato. Un contesto che le case di produzioni locali hanno potuto sfruttare, prima di altre, come una grande opportunità.
È stato difficile far passare nel film di montagna un tipo di narrazione che non fosse legata strettamente all'impresa sportiva o tecnica,
ma, più in generale, al mondo di montagna e alle culture di montagna?
Il linguaggio narrativo del documentario è cambiato molto negli ultimi trent’anni. Ed è in questo più ampio contesto che anche il film di montagna ha adeguato il suo linguaggio, puntando anche alla qualità narrativa, includendo maggiormente il punto di vista dell’autore e lo sguardo individuale di chi affronta la montagna. L’audience si è allargato. Il genere del documentario è molto cambiato. Non è più un genere di nicchia e il grande pubblico del Trento Film Festival lo dimostra. Chi guarda un film di montagna, oggi, non è più solo colui che è interessato alla montagna o al gesto atletico, ma, più in generale è colui o colei che ama le buone storie, i buoni racconti e i buoni film. Questo passaggio non è stato facile. Proprio per questo abbiamo promosso iniziative come «Dopo la conquista» e «Raccontare l’Avventura», che rappresentavano un tentativo di sostenere questo cambiamento di orizzonte, cercando di aiutare gli autori nei loro percorsi di crescita e formazione.
Nel favorire questo cambiamento, credi che il Trento Film Festival e la scuola di documentario ZeLIG abbiano avuto un ruolo determinante?
Non so se è stato determinante, sicuramente posso dire che abbiamo dato il nostro contributo. C’è
stata una forte capacità di anticipare i tempi e di intraprendere il cambiamento. Per esempio, con il corso di formazione «Raccontare l’avventura»
abbiamo lanciato un segnale chiaro: un Festival che non si occupa solo di film una volta finiti, ma è attento anche al loro sviluppo e a offrire il proprio contributo per aumentare la loro qualità.
A 70 anni dalla sua nascita, qual è oggi il significato più importante del Festival e che ruolo credi che debba avere la rassegna?
Il significato più importante del Festival è il fatto che esso rappresenta un vero momento di dialogo tra il film e il pubblico, tra film e il suo impatto sulla società. Questa sua vocazione come festival – mostrare film di alta qualità artistica, che creano emozioni e che fanno conoscere persone e realtà nella loro diversità e complessità – questo dialogo intellettuale ed emotivo, questa comunicazione, devono rimanere anche in futuro le prerogative principali.

Giovanni Paolo Iuriatti è un giovane volontario del Trento Film Festival. Assieme a molti altri giovani, come lui, rende possibile ogni anno la realizzazione della rassegna, mettendosi a disposizione dell’organizzazione durante le giornate del Festival. Ogni anno, puntuali, sul sito del Trento Film Festival aprono le iscrizioni per quanti vogliono partecipare alla rassegna come volontari e volontarie: «Si cercano giovani tra i 18 e i 35 anni disponibili ad affiancare lo staff in tutte le attività di organizzazione logistica e nei servizi di accoglienza e informazioni per il pubblico. I luoghi in cui verranno coinvolti i volontari sono le sale cinematografiche, il salone espositivo di MontagnaLibri, l’area dedicata alle attività per scuole e famiglie, e tutti quei luoghi che ospiteranno gli eventi dell’edizione, come ad esempio musei, teatri e palazzi storici di Trento». Giovanni Paolo Iuriatti è uno di loro. A lui, come a tutti i suoi colleghi e colleghe, è rivolta la gratitudine dell’organizzazione, che sente di sopravvivere anche grazie «all’entusiasmo di centinaia di volontarie e volontari che non hanno mai mancato di portare la loro energia e le loro competenze per realizzare un Festival, che dal 1952 fa di Trento la capitale internazionale del cinema e delle culture di montagna».
Hai letto anche tu l’annuncio sul sito?
Ho visto che cercavano volontari e ho scritto subito al Festival. Stavo visitando la pagina web come semplice appassionato. Mi pare di aver cliccato sulla voce «fai parte di noi» o qualche cosa di simile. Non ricordo bene. È già passato un po’ di tempo. Faccio il volontario da quattro anni e certamente sarò presente anche l’anno prossimo. Come hai scoperto il Trento Film Festival?
Poco per volta. Ogni anno, tra la fine di aprile e l’inizio di maggio, vedevo che si animava la città di Trento e ritrovavo traccia della rassegna sulla stampa. Mi accorgevo della sua presenza ma all’inizio non avevo le idee chiare. Non ero interessato al Festival della montagna e non lo conoscevo. Capivo che accadeva qualcosa di importante anche se non mi soffermavo sugli eventi. Non ne sapevo molto: mi chiedevo se vi fossero attinenze con il Festival dell’economia...
E poi?
Poi ho capito che la parola Festival non era abbastanza per associare le due rassegne. Quindi, se mi stai chiedendo come sono arrivato al Trento Film Festival: beh, ci sono arrivato punto e basta. Perché era in città e perché animava la città. Perché la riempiva di gente e di atmosfere. Perché vivevo il Festival ogni primavera senza sapere cosa fosse. Era come una presenza. Ti ci ritrovi dentro,
poi capisci cosa è, quindi ti appassioni e ci ritorni l’anno dopo.
Dimmi se ho capito bene, non eri un appassionato di montagna?
Esattamente, non ero un esperto del settore e la montagna non mi appassionava in modo particolare.
E il cinema?
Neanche quello. Nemmeno il cinema era tra le mie priorità.
E quindi?
Mi sono ugualmente innamorato del Festival e ora continuo a ritornarci. Questa è la grandezza del Festival. Che appassiona anche chi non è specializzato del settore. Ogni anno, un’esperienza entusiasmante.
Dopo aver compilato il form sulla pagina del sito, cosa è successo?
Mi hanno contattato subito. Guardo la posta e ricevo una mail con scritto: «Ok, ti aspettiamo». Mi fissano ora, data e luogo. Ci vado in compagnia di un’amica che, assieme a me, aveva fatto richiesta. Non sapevamo proprio che cosa aspettarci. Come è andata?
Non sapevo nulla di montagna. Invece la mia amica era un’appassionata; lei avrebbe saputo rispondere ad alcune domande sul tema. Io ero invece preoccupato come per un’interrogazione
sui banchi di scuola. Avevo appena finito le superiori. Non avevo idea di che cosa avrebbero potuto chiedermi. Si entrava in una stanzetta due per volta. Attesi il mio turno, in fila, finché mi chiamarono.
Dentro c’era Lia (Merli, coordinamento staff volontari) che faceva le selezioni. Mi chiese conferma di quanto avevo scritto nel modulo, verificò la mia buona volontà e le mie disponibilità. Poco dopo, cominciò così il mio primo Festival da volontario.
Poi il secondo, il terzo, il quarto.
E niente più interrogazioni.
Infatti. Negli anni successivi, pur continuando ad aderire al bando, che viene sempre rinnovato sul sito del Festival, mi recavo direttamente al secondo giorno delle selezioni, saltando il primo di colloquio.
Quindi dovete iscrivervi ogni anno?
Sì, dobbiamo rinnovare sempre l’iscrizione. Abbiamo anche un gruppo social – un gruppo di amici – dove partecipano i volontari che, come me, hanno già qualche edizione alle spalle. Il primo che nota la pubblicazione del nuovo bando sul sito del Festival scrive al gruppo e avverte tutti gli altri. Spesso, molti di noi si ripresentano. È un bel modo per stringere amicizie e rapporti di fiducia. Per chi ha già partecipato, poi, la procedura è più snella. E Lia ci conosce tutti quanti, tutti per nome, uno per uno. Non le sfugge nulla.
C’è proprio un Festival nel Festival: il Festival dei volontari.
È
così. Ogni anno aspettiamo l’annuncio con l’apertura delle iscrizioni. Scatta la corsa e poi partiamo. Alcuni volontari sono fissi e lavorano al Festival per tutto il giorno nel periodo della rassegna.
Altri sono presenti su chiamata, in giornate e in orari stabiliti, in base alle loro disponibilità. Chi siete?
Soprattutto studenti, ma non solo. Tantissimi giovani. Una parte sono ragazzi di Trento e del Trentino, come me. Ma il maggior numero è composto da persone che giungono da fuori. Non soltanto da altre città d’Italia ma anche dall’estero. Ogni anno incontro gente nuova, pronta a misurarsi con il Festival. Molti di noi non hanno la passione per la montagna o per il cinema. Per tutti, ciò che conta è partecipare al Festival. E la cosa più bella è che ci sentiamo parte dell’organizzazione. In che senso?
Ho partecipato ad altre manifestazioni come volontario, ma è difficile trovare un clima come questo, dove ti senti valorizzato. Al Trento Film Festival è diverso. I volontari sono considerati un vero elemento della rassegna. Non mi riferisco solo al fatto che ti danno un pass per andare a vedere tutti gli eventi, le serate, i film e gli appuntamenti a calendario; sono gli stessi membri dello staff del
Festival che ci incoraggiano ad andare agli spettacoli, dopo aver svolto il nostro lavoro. Ma penso anche al clima che respiri: ti senti parte dell’organizzazione, ti senti dentro l’evento, ti senti «uno di loro» prima, durante e dopo il Festival. Siamo coinvolti già dalle settimane precedenti e poi fino alle giornate che seguono la conclusione degli appuntamenti a calendario. Alla fine del Festival, lo staff organizza per noi – solo per i volontari – una festa per ritrovarsi tutti insieme. Quando il Festival
è terminato, ci coinvolgono infine nel disallestimento degli spazi, dove l’attenzione è posta al recupero delle strutture per riutilizzare tutto ciò che è possibile l’anno successivo. Anche i manifesti cartacei, dove possibile, vengono riconvertiti così da non buttare via nulla. C’è una grande attenzione alla sostenibilità: comportamenti che, noi giovani, tendiamo a dare per scontati, ma che non si ritrovano così frequentemente.
E il vostro pass? Avete troppo lavoro, durante la kermesse, oppure riuscite a utilizzarlo?
Ci riusciamo eccome. Entriamo in contatto con i grandi alpinisti e con i grandi registi. Il tutto in un clima piuttosto informale. Essere volontari ci aiuta. Incontriamo i protagonisti della rassegna durante il nostro orario di lavoro. Ma poi riusciamo a recarci alle serate, seguendo direttamente chi ci piace di più. Molti dei film che trovi al Festival li puoi vedere solo al Festival. Ho potuto apprezzare così molti «nomi» importanti della montagna e del cinema di montagna, che prima non conoscevo, e che seguo tutt’ora. Anche questo è il bello della manifestazione: la vicinanza con gli autori dei libri, con gli scalatori, con i cineasti. Quando termina la proiezione in sala, gli autori non scappano via ma restano a dialogare con la gente, rispondono alle domande. Stanno con il pubblico come se fossero tra il pubblico. Ricordo questi atteggiamenti fin dai miei primi passi al Festival. Una disponibilità al dialogo che ti lascia la voglia di tornare. Speriamo che continui a rimanere questo il Festival del futuro.
Campionessa di scialpinismo ed esploratrice sudtirolese, Tamara Lunger è tra le alpiniste italiane più note e più vivaci, un’icona nel panorama internazionale. Classe 1986, ha scalato negli ultimi 15 anni alcune delle montagne più alte e più difficili della Terra, legando il suo nome a imprese senza tempo, come il tentativo di raggiungere la vetta del Nanga Parbat in invernale.
Nel 2006 e nel 2008 Tamara Lunger è campionessa italiana di scialpinismo e nel 2010, a 23 anni, diventa la donna più giovane a raggiungere con l’ausilio dell’ossigeno la cima del Lhotse, 8.516 metri. Negli anni successivi sale il K2 (8.611 metri), la vetta del Cho Oyu (8.210 metri), del Broad Peak (8.047 metri) del Kangchenjunga (8.586 metri) e altre cime sopra i 7.000 e i 6.000 metri. Con Simone Moro prova la salita in invernale del Manaslu (8.163 metri), del Nanga Parbat (8.126 metri) e del Gasherbrum e si dedica con successo alla ascesa in invernale del Pik Pobeda (3.003 metri), in Siberia, in uno dei luoghi più freddi della Terra.

Sei nata nel 1986: il Trento Film Festival ha quasi il doppio dei tuoi anni. Qual è il tuo primo ricordo del Festival?
Pochi anni fa: era il 2014 o forse il 2015. Andai a un appuntamento del Festival per seguire una serata di Simone Moro e rimasi a
bocca aperta. Fu strepitoso. Mi accompagnò a quella serata Marianna Zanatta, la manager di Simone, che poi divenne anche la mia manager. In quell’occasione conobbi inoltre il viaggiatore Francesco Russo, con cui poi divenni molto amica. Progettammo e realizzammo un bellissimo viaggio in Mongolia.
E prima? Non ci eri mai stata?
A dir la verità no, non lo avevo mai frequentato. Sono una persona riservata che se ne sta lontana dai riflettori. Preferisco passare il tempo con poca gente, nella mia pace, a casa mia. Ho sempre avuto la testa impegnata nei miei progetti, nei miei allenamenti. Sono spesso rimasta fuori dal mondo, con la mente occupata a seguire i miei pensieri.
Hai conosciuto altre persone, al Festival?
Molti alpinisti noti, nomi famosi nell’ambiente della montagna. Alcuni di loro li avevo già incontrati. Altri li ho visti per la prima volta al Festival. Sono nate amicizie, nuove conoscenze, belle chiacchierate. Dopo le serate si finiva sempre a bere una birra al Pedavena. Conservo sempre bei ricordi. Mi piace la rassegna, come è organizzata, gli eventi. Ma poiché non amo la città, ci vado raramente. Ma ci
sono appuntamenti che considero irrinunciabili: quando li trovo nel programma, allora mi metto in macchina e vado al Festival.
La conoscevi già, la città di Trento?
Ci ero stata poco. Non la conoscevo bene. Quando vado al Festival, mi piace ancora girare per la città, dove mi perdo ancora per le vie del centro. È
sempre stato così: faccio fatica a orientarmi tra i palazzi mentre tra le montagne sono subito a mio agio. Ho bisogno delle mie montagne per ritrovare la pace.
Qual è il tuo rapporto con la montagna?
Sono convinta che le montagne abbiano un’anima. Perciò cerco sempre una connessione con loro. Una lunga conversazione, la vostra, che comincia da lontano.
Sono nata in montagna, ci sono cresciuta e ho scelto di rimanerci. Vivo in un piccolo paesino in Sudtirolo che amo moltissimo. Ci sono il sole, le stelle, le montagna e nulla più. Stiamo tutti nella stessa casa: io, i miei genitori, mia sorella, i miei nonni. A mezzogiorno ci troviamo per pranzare e quando io arrivo in ritardo, di fretta, indaffarata tra tanti pensieri, i miei familiari mi dicono: «Va bene, adesso fermati, rilassati e prenditi il tempo per mangiare».
Quali sono le «tue» montagne?
La montagna è entrata nella mia vita quando i miei genitori presero in gestione il rifugio Croce di Lazfons, in val d’Isarco. Con le mie sorelle salivamo lassù per fare la stagione. Eravamo piccole. Ogni
sera guardavo le Dolomiti che cambiavano colore e indossavano un vestivo diverso. Erano meravigliose. Ogni volta un film più bello: le vedevo avvolte nelle nebbie oppure tra le stelle, con le luci del tardo pomeriggio e poi con quelle del tramonto. Quando, in autunno, finiva la stagione, ricordo che piangevo. Non volevo che finisse. Me ne stavo in camera, guardavo lassù e dicevo: «Voglio tornare tra le nuvole», dove mi sembrava di vivere un sogno. È stata così importante la tua famiglia?
Importantissima. Eravamo tre sorelle. Mamma e papà ci hanno sempre cresciute libere. Potevamo correre, andare, venire. Potevamo esprimerci nei boschi, sempre fuori, sempre in giro, a piedi o con la bicicletta. Facevamo tutto quello che facevano i maschi. Siamo cresciute senza questi limiti. E allo stesso tempo eravamo sempre insieme, molto uniti, soprattutto quando lavoravamo in rifugio ma anche durante gli altri mesi dell’anno. Tutti i sabati e le domeniche si stava in famiglia. È stato un rapporto molto stretto e intenso. Anche quando abbiamo attraversato la fase dell’adolescenza non ci siamo allontanati. Cercavamo, certo, i nostri gruppetti di amici. Ma stavamo spesso tra di noi, proprio come ora.
Quando parti per le spedizioni, fai fatica ad allontanarti?
Guarda, quando ero piccola, ero una di quelle
bambine che non voleva mai andare via da casa. Avevo nostalgia. Partecipai ai campionati italiani di atletica leggera e mi dissi: «Speriamo di non vincere i regionali, altrimenti devo partire per andare lontano a fare altre gare in Italia». Mi classificai seconda nel lancio del disco. Così evitai la partenza…
Quindi facevi atletica leggera. Quando hai cominciato a scalare e come ci sei arrivata?
Probabilmente, all’inizio, le scalate più difficili sono stati i pendii e gli alpeggi dietro il rifugio Lazfons. Il mio è stato un percorso lento e graduale, spontaneamente condiviso con la mia famiglia e con le mie montagne. Crescendo, poi, ho intrapreso il mio percorso e ho fatto le mie scelte. Quali sono state quelle più importanti? Le scelte, intendo dire, che ti hanno portato a essere Tamara Lunger?
Ho sempre desiderato fare fatica e ho sempre cercato le cose più difficili. Ho iniziato facendo sport, tutto quello che mi piaceva, cambiando spesso discipline. Prima la corsa, poi l’orienteering, poi il lancio con il disco. Ma non mi bastava: volevo girare, conoscere, vedere, scoprire. Volevo salire le montagne. Così sono passata allo scialpinismo. Ho chiesto al mio papà di portarmi, ma non sapevo sciare. Mi ricordo i primi sci, erano lunghissimi: un metro e 92 centimetri. Seguivo il mio papà, che
mi ha portato la prima volta sul Corno Nero nei pressi della val d’Ega. Mi piaceva così tanto. Volevo far fatica e non accettavo mai di rimanere in traccia. Uscivo da quella di papà per battermi la mia. Poi, a scendere, ho fatto ancora più fatica. Papà mi insegnava e ricordo di aver pensato: «Ok, questo è il mio sport». Poi, dopo aver imparato a sciare, ho cominciato a iscrivermi alle competizioni e a viaggiare nelle Alpi. Sono entrata subito nella squadra nazionale e ho iniziato a vincere le gare. Eppure…
Eppure? Ti mancava qualche cosa.
Sì, mi mancava di vivere la montagna. Le gare, le competizioni: erano belle ma contavano solo i tempi all’ordine di arrivo e il colpo di pistola nel punto di partenza. Quello che stava intorno e quello che stava in mezzo – la montagna – passavano in secondo piano. A me non stava bene. Nel frattempo avevo lentamente maturato il desiderio di salire un Ottomila. Ero attratta dal grande fascino delle montagne più alte della Terra.
Poi hai conosciuto Simone Moro.
Quando Simone mi disse che sarei potuta andare con lui; è stato il giorno più bello della mia vita. Ho cominciato a gridare e tremare dalla felicità e la mia mamma mi disse: «Adesso sei andata completamente fuori di testa».
Erano più le paure o gli entusiasmi?
Non lo so. Sicuramente ho bruciato le tappe. Ho fatto spesso così nella mia vita. Voglio dire, non mi sono domandata se fosse stato meglio avvicinarmi a quella quota per step, facendo prima un 5.000, poi un 6.000 e così via. Non me lo sono chiesto. Ho accettato la sfida senza paura. Soprattutto, senza timore di affrontare le fatiche fisiche. Quelle non mi hanno mai spaventato. Ho sempre trovato così tanta forza dentro di me.
Insieme alla tua forza, quello che colpisce è anche la tua allegria: forza e allegria sono un binomio straordinario. Negli ultimi 12 anni hai scalato sulle montagne più importanti del mondo, hai conosciuto il successo e sei stata a un passo dalla morte. Quanto è cambiata la tua vita?
È cambiato tutto. Quando sono arrivata per la prima volta in cima a un Ottomila mi sentivo come una regina. Poi, quando ho visto la morte da vicino, ho provato sentimenti opposti. Ora sto cercando un equilibrio. Vedi, ti dico una cosa… Nella mia stanza ho scritto una frase alla quale sono molto affezionata, che tengo come una bussola. La frase recita così: «Una persona grande e libera è solo quella che è capace di tenersi il suo cuore da bambino». Ecco, vorrei sempre essere così. Vorrei essere onesta come un bambino, continuare a vedere le cose come le vedono i bambini.
Ma è difficile. Mano a mano che andiamo avanti perdiamo questa capacità, facciamo esperienze negative, viviamo delle delusioni, conosciamo le paure. Più il tempo passa e più diventa difficile tenere fede a quel bambino che portiamo dentro di noi. Cerco di tenerlo più stretto che posso. Anche se so di averlo un po’ ammazzato, con le esperienze negative e brutali che ho vissuto. E quindi, che programmi hai?
Sto lavorando molto su me stessa. Vivo un momento di transizione. È forse la prima volta nella vita che Tamara rallenta un po’, senza grandi ob-
biettivi a breve termine. Certo, ho tanti progetti. Ma non un Ottomila all’orizzonte. Nei momenti di difficoltà, dove trovi conforto?
Nella mia famiglia e in Dio. È un sentimento molto forte che mi accompagna sempre. Non soltanto in montagna ma anche nella vita. Auguro a tutti di avere una forza così che ti aiuta, che ti guida. Non necessariamente il mio dio, ma una forma di spiritualità, ciascuno la propria.
Tornerai al Festival a raccontare queste cose? Sicuramente sì. Ho tanto da raccontare.

Milo Manara è un fumettista e disegnatore. Tra le sue storie più note: le avventure di Giuseppe Bergman (1978-2004), Il gioco (1982-2001), Il profumo dell’invisibile (1985). Ha pubblicato su riviste italiane ed edizioni internazionali, come Dc Comics e Marvel; ha collaborato con Hugo Pratt, Federico Fellini, Pedro Almodovar e molti altri. Per il Trento Film Festival ha realizzato il manifesto della 70a edizione.
«Ho una visione piuttosto radicata della montagna, che mi viene dai libri di Karl Felix Wolff che mi leggeva mia sorella da piccolo e dai miei primi ricordi di queste montagne che a volte sembrano spettri e altre esplodono di colori». C’è il sapore dell’infanzia nelle parole di Milo Manara, anche quando descrive la sensazione che ancora gli procura la vista di «certe vette dolomitiche, il Cristallo o le Tofane: non riesco a reggerne la visione per più di pochi secondi alla volta, come quando da bambino vedevi delle scene terribili e ti nascondevi gli occhi».
Che rapporto ha quindi con la montagna l’adulto Milo Manara?
La mia è la visione di un contemplativo. Non mi sono mai sognato di scalarla, di «violarla». Per me le montagne hanno una loro sacralità. Mi ricordano le cattedrali gotiche. Anche Dino Buzzati le
vedeva così. Per cui non sono mai stato attratto dall’impresa eroica. Non mi piace neanche l’idea di vederle dall’alto.
Intendi dire che sei un contemplativo della montagna dal basso?
Per me è il punto di osservazione migliore. Io al massimo arrivo alla base delle Tre Cime di Lavaredo. E mi danno quasi fastidio le figurette che le scalano, perché me le riportano a una dimensione troppo umana. Mentre io di fronte alle montagne sono colpito spesso da una sindrome di Stendhal. Mi capita anche se sono in macchina, di dovermi fermare perché rischio davvero incidenti. Mi perdo a guardarle ma sono anche preso da un grande turbamento. Stendhal si riferiva ai capolavori dell’arte, ma penso che possa colpire anche di fronte a certi spettacoli della natura. Ci sono cose talmente straordinarie ed enormi che non credo si possa assistervi con animo sereno. Questo turbamento l’hai portato anche nei due manifesti che hai realizzato per il Festival?
Nei manifesti avevo pensato di ricorrere alle leggende di Wolff, contenute nei suoi libri I Monti pallidi (1929) e Il regno dei Fanes (1932). Qui ritornano spesso personaggi mostruosi: il più impressionante era Spina de mul, un mulo che ha la metà anteriore intatta mentre quella posteriore è uno scheletro. In mezzo a tanti personaggi minacciosi
e terribili, c’era anche l’ondina, una figura dolcissima e malinconica che esce dai laghi dove abita e canta queste canzoni sul far della sera. Per cui visto che mancava una rappresentazione leggendaria della montagna negli altri cartelloni, pensai di disegnare l’ondina in contemplazione di questo anfiteatro dolomitico. Per non correre il rischio di scandalizzare nessuno, la inquadro da dietro. Il direttivo del Festival si spacca, e ti viene chiesta una revisione al bozzetto…
Mi è stato detto che era troppo scandalosa. Lei aveva già i capelli lunghissimi che diventavano delle alghe, e io ho provato ad aggiungerne ancora di più. Ma non sono bastati [ride]!
Te la sei presa?
Sono rimasto abbastanza sorpreso perché l’ondina per me non era così erotica, mi pareva solamente bella. Però riconosco pienamente il diritto di rifiutare un disegno che non piace. Perché l’erotismo è una componente importantissima della vita di ognuno di noi, ma la linea che definisce il comune senso del pudore è un terreno molto delicato. Quando per la 70a edizione mi è stato chiesto nuovamente di fare il manifesto, mi sono riferito di nuovo a quel personaggio. Ma stavolta per non correre nessun rischio, si vede a malapena la testa dell’ondina! E ha un’espressione piuttosto sorpresa o diffidente, sicuramente non gioiosa.
Anche la natura intorno è completamente cambiata.
Pensando anche alla tempesta Vaia, ho pensato di dedicare il manifesto più agli alberi che alle vette. L’acqua è tutta scura, perché sta riflettendo le montagne. La foresta è tutta nera. In generale il manifesto è molto meno celebrativo della bellezza, molto più malinconico. D’altra parte riflette la mia sensazione di oggi. Mi pare che sia tutto così fragile, precario, effimero. L’impressione è che questo mondo lo stiamo rovinando, e al tempo stesso perdendo. E quando ci estingueremo il pianeta ritroverà il suo equilibrio. Il problema non è tanto salvare il pianeta quanto salvare per noi stessi la meraviglia di questo pianeta. Ma ti avevano già rifiutato dei lavori?
Lavori su commissione così importanti non mi pare. Una volta mi avevano chiesto una rappresentazione di Louise Brooks, la modella a cui si è ispirato Guido Crepax per Valentina. L’avevo fatta in una posa molto più erotica e mi hanno chiesto di rifarla. La prima versione però la comprò Sergio Bonelli, ce l’aveva appesa nel suo studio.
La montagna ha sempre ispirato i linguaggi dell’arte, non solo il cinema e la letteratura, ma anche fotografia, pittura, musica. Anche nei tuoi fumetti è stata la cornice di diverse storie. Un fumetto in particolare L’uomo delle nevi (1978) era ambientato sull’Himalaya in un monastero tibetano. Ma anche nelle storie di Giuseppe Bergman ho raccontato un po’ di montagna, sia l’Himalaya che le Dolomiti, sempre a partire dai racconti di Wolff. Avendo questo pallino ho fatto alcune illustrazioni sui personaggi delle leggende dolomitiche che sono esposte al Museo ladino di Fassa. Ovviamente in spiaggia risulta più facile spogliare i personaggi, ma c’è un episodio del mio fumetto erotico più fortunato, Il gioco (1983), ambientato in montagna tra gli sciatori. Al Festival però non sei mai stato? No. Devo dire che non mi piacciono molto i film di montagna. A parte (Seven Years in Tibet, Stati Uniti, 1997), uno dei più bei film di montagna, dove la montagna è davvero una protagonista. Ecco, se lo proiettassero, pur avendolo visto diverse volte, verrei volontieri.
Sergio Martini, trentino di Lizzanella (Rovereto), è tra i pochi uomini al mondo ad aver scalato tutti gli Ottomila ed è tra i pochissimi ad averlo fatto da non professionista. Dopo gli studi, ottiene il diploma ISEF e lavora come insegnante di educazione fisica alle scuole medie, portando avanti parallelamente il suo alpinismo. A soli 17 anni, nel 1966, sale lo spigolo Nord del monte Agner (nella valle Agordina) e 19 anni sale come capo cordata il pilastro Micheluzzi della Marmolada. Dopo l’apertura di nuove vie nelle Dolomiti, a partire dagli anni settanta si dedica alle spedizioni extraeuropee. Lontano, lontanissimo dalle telecamere. Eppure così vicino, suo malgrado, alla popolarità. Nel mondo dove tutti cercano di apparire, Sergio Martini è campione di modestia e di umiltà. La sua è una storia silenziosa, quella di uomo cocciuto e determinato, che insegna, con la volontà di ferro, che i fatti contano di più delle parole e che i sogni sono obbiettivi possibili: 14 Ottomila conquistati in 24 anni, tra il 1976 e il 2000. Settimo uomo al mondo a esserci riuscito e secondo italiano, dopo Reinhold Messner. Tutto qua? Sì, per Sergio Martini è tutto qua. Come se fosse normale. Nessuna ostentazione, niente mostrine. «Mi hanno invitato spesso al Trento Film Festival ma credo di non essermi mai seduto in prima fila», dice.

Sei un’istituzione per il Trento Film Festival. Dal 2014 anche socio onorario della manifestazione. Non credo di essere stato un assiduo frequentatore del Festival, anche se hanno cercato spesso di coinvolgermi. Considero un privilegio esserne socio onorario. Penso che mi abbiano nominato come segno di gratitudine nei miei confronti, quando, molti anni fa, li aiutai a visionare alcuni filmati che erano giunti in un vecchio formato, che loro non riuscivano ad aprire.
Non sarà stato anche perché sei tra i più forti alpinisti himalayani di tutti i tempi?
Resto nelle retrovie. Non lo dico per modestia. Quando ho potuto evitare il palcoscenico, l’ho sempre evitato. Anche se, talvolta, questa scelta mi è costata qualche giudizio negativo.
E la tua forza, le tue imprese, la tua notorietà?
Se qualcuno mi considera popolare mi fa certamente piacere e gliene sono grato. Ma non è il mio spirito.
Hai scelto la tua strada: l’alpinismo e non il palcoscenico.
Proprio così. Ho fatto le mie scelte e ho deciso il mio percorso. Prima di tutto, un discorso legato alla montagna. Di alcune scelte sono contento, di altre meno. Qualcosa sono riuscito a fare e va bene così. Avrei voluto fare molto di più, ma penso sia normale. Ciascuno di noi ha i propri desideri.
Che cosa hai amato maggiormente del Festival?
Restavo affascinato dai volti degli alpinisti. Ero molto giovane, quando frequentavo la rassegna le prima volte. Mi colpivano i visi abbronzati, con il segno bianco degli occhiali, erano chiaramente gente di montagna. Mi conquistava il loro aspetto. Ti appassionavano le persone, insieme alle montagne. Amavo gli incontri. Se ho frequentato il Festival, l’ho fatto non solo e non tanto per vedere i film, ma per incontrare i protagonisti delle scalate e delle spedizioni importanti. Compagnoni, Lacedelli e altri. Soprattutto Reinhold Messner ma anche Walter Bonatti. Ecco, Bonatti. Credo di averlo visto l’ultima volta alcuni anni fa, poco prima che ci lasciasse, al Festival di Trento.
Lo avevi incontrato anche in altre occasioni, Bonatti?
Sì, probabilmente legate al Festival. Ricordo che Reinhold Messner mi invitò a castel Juval, in Sudtirolo, per gli ottant’anni di Walter. C’era anche Simone Moro. Era il 2010 e, a quel tempo, era stato realizzato un calendario con le fotografie dei miei Ottomila. Mi chiesero se avevo una copia per Bonatti, andai a prenderla. Mi invitarono a consegnargliela, gliela portai. Appartenevamo a due generazioni diverse. Ebbi con lui un breve scambio di battute e gli dissi: «Walter, quando tu hai smes-
so di fare alpinismo estremo io ho cominciato le mie salite himalayane». Bonatti aveva chiuso la sua carriera nel 1965 con un’impresa eccezionale, aprendo in cinque giorni una via nuova in solitaria in invernale sulla parete Nord del Cervino. Walter prese il calendario e mi rispose: «Vedi Sergio, come gli artisti, quando esauriscono la loro vena creativa, così anche io, a 35 anni, avevo esaurito la mia spinta di fare imprese».
Una delle peculiarità del Festival è stata proprio questa: la sua capacità attrattiva. Portare a Trento le stelle dell’alpinismo internazionale favorendo momenti di incontro fra di loro e con il pubblico. Ne ricordi altri?
Come Bonatti, non posso dimenticare Kurt Diemberger. Uno di quei personaggi che guardavo dal basso verso l’alto. Un marziano: sia per le vicende legate al suo profilo biografico, alle sue imprese, sia per essere stato compagno di cordata di Hermann Buhl, l’ultimo uomo ad averlo visto vivo. Più tardi, ho avuto la fortuna e il piacere di andare in spedizione con Kurt; sull’Everest nel 1980, sul K2 nel 1983. Non faceva solo alpinismo. Diemberger aveva anche l’ambizione di girare film. Era assolutamente caparbio nel suo lavoro. Noi, i suoi compagni di scalata, eravamo sotto la sua direzione e sotto le sue regole. Non era facile. Voglio dire… Finché sei nelle valli, a bassa quota, puoi anche
accettare di tornare indietro più volte per rifare la stessa scena. Le riprese dovevano essere perfette. Ma quando sali a 7.000 o 8.000 metri, andare su e giù per ripetere le immagini poteva essere pesante. Poi Kurt voleva la sua attrezzatura, le macchine da presa, gli obbiettivi, il cavalletto. Voleva quel cavalletto lì e non un altro, che pesava 10 chili, tutto in legno, perché era stabile. E lo voleva lassù, a 8.000 metri. Questo era Kurt Diemberger. Uno che dimostrava di saperci fare, un uomo fuori dal comune, tra i più grandi registi in alta quota. Lo penso spesso. È molto che non ci sentiamo più. Adesso ha più di 90 anni.
Dici che vedevi questi uomini come marziani, capaci di imprese estreme. Ma tu sei diventato uno di loro. Hai mai pensato, anche tu, di raccontarti? Un libro sulla vita di Sergio Martini, un film sulle sue conquiste: lo devi ancora fare. Ammiro la capacità di chi sa esprimere con la scrittura il racconto di una salita o la conquista di una vetta. Reinhold Messner, per esempio. Ho apprezzato moltissimo i suoi libri, in particolare Noi, gente di montagna (2021). Io non sono mai riuscito a farlo. Lo devo ammettere.
E quando leggi qualche articolo che parla di te?
A volte succede, ti racconto una cosa. Sono un accademico, appartengono a questo Club (Club Alpino Accademico Italiano - CAAI) da molti anni.
Entrai a farne parte per merito dell’alpinista trentino e mio amico Marino Stenico. Alcuni mesi fa, sul gruppo WhatsApp degli accademici, un socio condivise un articolo scovato sulla Rivista della Sezione Ligure del CAI (Club Alpino Italiano) del primo semestre del 1976. L’articolo titolava così: «Prima invernale alla Castiglioni-Gilberti sulla Cima Buzazz». Tre pagine, in bianco/nero, a firma di Gianni Costa, raccontavano la scalata che avevo fatto con alcuni compagni di cordata sulla via Castiglioni-Gilberti nel gruppo del Civetta. Facevo parte di quella cordata, avevo 26 anni. Eravamo io, il genovese Gianni Costa e i miei amici trentini Franco Gadotti e Marcello Rossi. Non avevo mai visto quell’articolo. L’ho letto, mi sono emozionato e poi mi sono detto: questa non è certamente tra le mie imprese più impegnative. E se avessi raccontato anche le altre? Sarebbe stato magnifico. Il fatto che qualcuno abbia scritto di quella scalata ha permesso di ricordarla. Sono molto grato a Gianni Costa e agli accademici che hanno portato questo pezzo di passato nel mio presente. La volontà di fissare i ricordi nel tempo ha molto a che fare con il linguaggio del cinema e della letteratura, con il Trento Film Festival, con Montagnalibri.
Come nei film, una vicenda può essere valorizzata se c’è qualcuno che riesce a raccontarla, a
trasmetterla, a figurarla. Chissà quante scalate, che non hanno goduto di questo privilegio, sono state dimenticate. Viceversa, alcune vicende sono rappresentate in modo così realistico da lasciarci senza parole.
Per esempio?
Ricordo un film che narrava la tragedia avvenuta sull’Everest nel 1996, quando diversi alpinisti persero la vita. Avevo visto il film a Trento, in occasione del Festival. Quando assistetti alla scena del distacco della valanga mi spaventai e tolsi lo sguardo dallo schermo. Sono situazioni che ho vissuto personalmente. Sembrava che tutto mi venisse addosso.
Hai mai avuto paura?
Tante volte. Fa parte del gioco. La paura è una di quelle cose con cui ti devi necessariamente confrontare in alta montagna. Hai la consapevolezza che i pericoli sono oggettivi e che ci sono. Ciò che fa la differenza è la percezione del pericolo, che cambia con l’età. Quando ero giovane avevo una percezione del pericolo spostata molto più avanti. Come posso spiegarlo: pensiamo al libro di Manolo, Eravamo immortali (2018), dove questo concetto emerge benissimo. Poi vai avanti con gli anni e il pericolo si palesa sempre di più. Per questo le grandi imprese le fanno i giovani. Ma, in tutti i casi, il pericolo è un dato che non puoi eliminare.
Genera paura e determina anche la possibilità di insuccesso, che è necessaria.
Cosa intendi?
Credo che l’incertezza sia una delle motivazioni più forti che stanno alla base dell’alpinismo. Non puoi essere sicuro che arriverai in vetta. Se fosse così, verrebbe meno il significato stesso della scalata.
Cosa è oggi per te la montagna?
Un richiamo, un ambiente dove mi trovo ancora a mio agio. Dove vado a camminare, a sciare. Dove continuerò ad andare finché potrò farlo.
La sogni, la montagna?
Se la sogno… Certo, i sogni li abbiamo tutti. Quando ti poni un obiettivo, prima o poi, hai bisogno di giustificarlo come un sogno per poterlo inseguire e realizzare. Se invece ti riferisci al sogno notturno, quello è diverso. A volte sogno la montagna, ma sotto forma di incubi dovuti alle preoccupazioni delle giornate passate in alta quota. Un modo per scaricare la tensione, che riemerge come angoscia, nella notte.
E adesso, i tuoi prossimi obbiettivi?
Tornare in Nepal. Tornare là per camminare. Non per raggiungere le vette. Ma per camminare e incontrare le persone che conobbi anni fa.
Bernadette McDonald è una scrittrice canadese specializzata in storia e cultura della montagna. Direttrice per 20 anni del Banff Mountain Film Festival, crea nel 1994 anche il Banff Mountain Book Festival e ricopre il ruolo di vicepresidente del Mountain Culture Centre. A Trento è stata più volte ospite da delegata, giurata o in concorso.

«La vita per me è come un libro, è fatta di capitoli» afferma Bernadette McDonald, dopo aver ripercorso le pagine dei suoi esordi da musicista, la sua esperienza al festival di Banff prima da volontaria e poi da direttrice, quando «il lavoro era uno stile di vita», fino alla nuova vita di scrittrice, «un’attività più intima, solitaria, lontana dalle giornate di ordinaria follia che capita di vivere quando sei dentro alla macchina organizzativa di un festival».
Quando hai cominciato a frequentare il Trento Film Festival?
Dal mio primo anno come direttrice a Banff. Era il 1988. I miei colleghi mi hanno detto che sarei dovuta andare a Trento per cercare di sviluppare una collaborazione con il più antico e rinomato – «l'originale» – festival della cinematrografia di montagna. Ero abbastanza intimidita, per me è stata un’esperienza travolgente. Una specie di corso accelerato introduttivo ai nomi più noti
dell’alpinismo mondiale e alle figure chiave della cinematografia di montagna. Da allora Trento è entrata nel mio calendario annuale, era strano se un anno mancavo all’appuntamento.
E che ricordo hai della città?
La città era magica, e lo è ancora per me. Certe facciate, i sanpietrini, piazza Duomo. Credo di essermi persa un centinaio di volte i primi anni. Poi alla fine avevo provato tutti i ristoranti! Una sera eravamo a cena con Sir Edmund Hillary in un ristorante di lusso. Era tutto perfetto: il cibo delizioso, i camerieri sembravano dei modelli di Hugo Boss, la nostra accompagnatrice faceva di tutto perché non ci mancasse niente. E Hillary a un certo punto dice: «Secondo voi, qui fanno le patatine fritte?». E lì c’è stato un gran via vai dalla cucina. Mezz’ora dopo gli hanno portato queste patatine rosolate, e lui era soddisfatissimo. Insomma siamo stati anche viziati dalla città.
Che cosa è cambiato maggiormente dalla fine degli anni ottanta?
Il Festival è cresciuto tantissimo. La programmazione è migliorata, in numeri e qualità. Io da professionista ho sofferto la crescita, perchè mi ha complicato un po’ la vita. I primi anni sapevo chi stava in quale albergo, la sala stampa era un posto dove ci si trovava senza darsi un orario, poi sono aumentati i luoghi degli eventi ed è diven-
tato più difficile incontrarsi. Una cosa l’ho sempre apprezzata: la saletta riservata per vedere i film senza apettare la programmazione in sala. Un servizio che noi addetti ai lavori abbiamo utilizzato tanto. Sei stata un’osservatrice privilegiata non solo dei film e degli eventi ma anche del dietro le quinte del Festival. Assolutamente. Ho avuto la possibilità di entrare in contatto con molte persone che poi sono venute a Banff o che mi hanno coinvolta nei loro festival: ad esempio nella mia prima edizione trentina ho legato subito con gli alpinisti Royal Robbins e Allen Steck; e Mireille Chiocca mi invitò subito in giuria del Festival di Autrans. Ma soprattutto a Trento ho imparato l’importanza di avere una struttura dinamica, uno staff che funziona e lavora bene, dove viene immessa continuamente energia fresca e c’è un turn over regolare ai vertici. È così che ho capito che forse la mia visione a Banff iniziava a essere ripetitiva e che era arrivato il momento di lasciare la macchina in buone, nuove, mani.
A quel punto è iniziato un nuovo capitolo della tua vita, che ha sempre a che fare con la montagna.
Ho deciso di scrivere di storia dell’alpinismo. E ho iniziato a farlo con un approccio diverso, credo. La mia prospettiva vuole mettere al centro le persone,
non le imprese. Certo la conquista è importante, ma è la soggettività che conta, le motivazioni individuali, il gruppo di supporto, la famiglia, il retroterra politico-culturale. Conoscere gli alpinisti, entrare in connessione con la loro visione, è al tempo stesso straordinario e straziante. Quello che mi appassiona è svelare ciò che di solito resta in ombra nella storia dell’alpinismo. Narrativamente diremmo la backstory di un personaggio. Qual era la situazione politica del Paese alla partenza?
Chi è rimasto a casa ad aspettare? Com’è stato il rientro dopo una spedizione? C’è tutta una zona «invisibile» e poco raccontata. Nei tuoi libri indaghi sul passato, ma ti sarai fatta un’idea anche sul futuro dell’alpinismo. Penso che sarà più orientato alla tecnica, e forse ci si concentrerà sui 7.000 che sono fantastici e difficili. Molti alpinisti poi preferiscono scalare d’inverno perché le vie sono meno affollate; quindi immagino squadre più piccole. Naturalmente questo avrà un impatto anche sul racconto alpi-
nistico, scritto e filmato. Da scrittrice sei tornata come protagonista di MontagnaLibri.
Sono venuta nel tendone di piazza Fiera a presentare il mio lavoro sulla storia dell’alpinismo sloveno [Alpine Warriors | I guerrieri venuti dall’est, 2015] e la biografia di Voytek Kurtyka [Art of Freedom | L’arte di essere libero, 2017]. Insieme a me c’era Silvio Karo che mi ha aiutato a entrare in contatto con tantissimi scalatori, soprattutto a passare una giornata con l’altro «moschettiere» Francek Knez. E poi sono stata ospite nel 2021: ho presentato Winter 8.000, un libro su cui ho lavorato per tre anni. Sono felicissima perché a Trento ha vinto la sezione Alpinismo e sport di montagna. Ovviamente ero in collegamento dal Canada. E per quanto ci siamo abituati a gestire anche le presentazioni dei libri da remoto, nulla può sostituire il cameratismo che un Festival come quello di Trento offre. È davvero qualcosa di speciale.
Nives Meroi è nata in provincia di Bergamo nel 1961 e da oltre 30 anni risiede in Friuli Venezia Giulia, dove ha conosciuto il marito, Romano Benet. Con Romano, ha scalato tutti i 14 Ottomila. La loro passione per la montagna è fatta anche di falesie, cascate di ghiaccio, sci estremo. Le sue imprese l’hanno consacrata come una tra le più autorevoli alpiniste di sempre. Quando pensi all’alpinista italiana più grande di tutti i tempi, anche se lei non ama sentirsi chiamare così, stai pensando a Nives Meroi. Su wikipedia è «tra le maggiori alpiniste della storia», poiché, assieme a suo marito Romano Benet, ha scalato tutti i 14 Ottomila e ha saputo fare della montagna, assieme all’amore per Romano, la favola della sua vita. Senza usare l’ossigeno, hanno scalato in coppia le 14 montagne più alte della Terra. E soprattutto, anteponendo al desiderio di conquista la forza della solidarietà, hanno insegnato al mondo dell’alpinismo il principio che uno vale uno, ma due vale molto, molto di più.
È proprio così? In montagna si vince e si perde insieme?
L’alleanza fra esseri umani è la forza più formidabile che esiste in natura. Lassù, a quelle quote, ti permette di arrivare sulla cima e di tornare al campo base. Ovviamente bisogna essere autosuffi-

cienti psicologicamente e fisicamente. In un certo senso, siamo sempre soli. Ma due solitudini, come le nostre, procedono unite verso un obiettivo comune, diventando assieme qualche cosa di diverso e di più grande. Perciò sono convinta che la cordata esprima prima di tutto un forte desiderio di amore e di alleanza.
È vero che vi siete sposati perché, con il viaggio di nozze, avreste avuto il tempo per organizzare una spedizione?
Andò più o meno così. Il nostro è stato un matrimonio di interesse… Scherzi a parte, ci siamo sposati nel 1989. Quanto tempo è passato. Era il secolo scorso. Avevamo entrambi una grande curiosità. Desideravamo vedere e scoprire il mondo, terre lontane, nuove montagne. Quell’anno ci dedicammo al Sud America. Poi, poco per volta, spostammo l’attenzione sugli Ottomila. Sali una montagna, ne raggiungi un’altra, quando torni da una spedizione ti dai subito da fare per la successiva e continui su questa strada, verso nuovi percorsi. È stato così. È stata la nostra vita.
Le hai raccontate, le vostre vite, al Trento Film Festival?
Ci sono stata nel 2000. Fu la prima occasione, quando mi invitarono. Poi sono tornata altre volte. Il Festival mi è rimasto, come posso dire, nel cuore. Mi sono ritrovata in mezzo a tanti alpini-
sti e appassionati, i protagonisti delle serate e le molte persone che assistevano, uniti tutti da una passione comune. A ogni Festival ho vissuto esperienze intense a stretto contatto con la città. Il fatto che ci si sposta a piedi, tra le vie del centro, lega fortemente la manifestazione con la città di Trento.
Qualche luogo, in particolare?
Al tendone del Campo Base – ti posso dire – ci si sentiva come ai campi base delle spedizioni: un luogo dove conoscersi e riconoscersi, incontrarsi e raccontarsi.
Adesso, che compie 70 anni, cosa augureresti al Trento Film Festival?
A una leggenda vivente, come mi piace definire il Festival, auguro altrettanta longevità. Lo considero un esempio di vivacità e di apertura culturale. Il Festival ha raccontato non soltanto la montagna, la conquista degli Ottomila, il mondo dell’alpinismo, ma anche l’ambiente naturale e il mondo delle montagne.
Il tuo primo Ottomila?
La mia prima esperienza su un Ottomila è stata dal versante Nord sul K2, il lato nascosto della montagna. Ci piaceva l’idea di ficcare il naso nella parte più sconosciuta della vetta. Il 1994 fu per noi l’anno del primo tentativo, lungo una via in parte nuova. In quell’occasione eravamo membri di una
spedizione organizzata da don Arturo Bergamaschi e quel giorno, come «cordata d’avanscoperta», eravamo in tre: Romano, Filippo Sala e io. Arrivammo fino a 8.450 metri e poi fummo costretti a fermarci. Tornammo sul K2 alcuni anni dopo, nel 2006, per tentare nuovamente la cima. In completa solitudine, salimmo e scendemmo la vetta in cinque giorni, mentre tutte le altre spedizioni erano ferme al campo base. Scalammo il collo di bottiglia in cordata come una via alpina, perché le corde fisse arrivavano fino a 6.800 metri. Dal 2004, nessuno era più salito. Abbiamo affrontato la salita con le nostre forze, come potevamo, cercando di allontanare la paura di fallire. Lo abbiamo fatto in due e siamo arrivati in cima in due. Il nostro K2, il nostro «K in 2», tentato due volte dal suo lato nascosto e poco conosciuto. Ero talmente emozionata quando raggiungemmo la vetta, così felice. Anche per Romano fu la stessa sensazione. Eravamo in cima, noi due da soli, su tutta la montagna. Fu come vivere un secondo viaggio di nozze. E il tuo Ottomila più difficile?
Il 15°.
Cioè?
La malattia di Romano. Nel 2009, mentre salivamo sul Kangchenjunga, che doveva essere il nostro 12° Ottomila, attorno a 7.500 metri di quota Romano iniziò a stare male, manifestando i sintomi del-
la malattia che, di lì a breve, avrebbe comportato anni di ospedale, terapie, trapianti. Decidemmo subito di rinunciare alla vetta e di tornare a casa insieme. Ci vollero alcuni anni prima che Romano guarisse. Fu la nostra vittoria più grande: il nostro 15° Ottomila.
Quando decidesti di rinunciare alla vetta, nel 2009, avresti potuto essere la prima donna al mondo a raggiungere tutti gli Ottomila.
Sì, eravamo in piena corsa femminile per conquistare quel primato. Eravamo in tre, ci facevamo concorrenza. In quel momento, tutte e tre con 11 Ottomila alle spalle: pronte per il rush finale. Sul momento, la scelta di rinunciare alla vetta del Kangchenjunga poté sembrare un fallimento. Ma non per me. Sapevo quello che stavo facendo e il tempo mi dette ragione. La decisione di tornare giù dalla montagna, insieme a Romano, fu il successo più grande delle nostre vite.
Otto anni dopo, infatti, la vostra rivincita: quando raggiungesti con Romano la vetta dell’Annapurna, siete diventati la prima coppia nella storia a conquistare insieme le 14 montagne più alte della Terra.
Come vedi… A volte nascono più opportunità dai fallimenti che dalle vittorie. Ciò che può sembrare un fallimento spesso non lo è. Se riesci a cambiare punto di vista, la prospettiva può essere diversa.
È stato questo il vostro modo di vivere l’alpinismo?
Credo di aver vissuto con Romano un alpinismo onesto, cercando di trovare il tempo per le spedizioni tra un periodo di lavoro e l’altro, con tanta passione, basando tutto sulle nostre capacità e sulle nostre forze. Accettando anche le sconfitte, quando necessario. Ci consideriamo esperti nell’arte della fuga e abbiamo imparato a farlo senza vergona. Siamo giunti spesso sulla vetta. E spesso abbiamo fallito. Credo che ciascuno di noi sia in questo senso la sintesi delle nostre conquiste e dei nostri fallimenti, la sintesi dei nostri dritti e dei nostri rovesci, dei sì e dei no che abbiamo detto, delle nostre paure e del nostro coraggio. Come vi dividete i compiti, tu e Romano?
Siamo diversi. In cordata, ciascuno di noi ha il proprio ruolo e non interferisce con l’altro. Romano è tecnicamente e fisicamente più forte di me. Quando, ogni tanto, lo costringo a stare dietro, quando batto traccia io, lui sbuffa e mi dice che sono troppo lenta. Aumenta il passo e passa avanti. Romano ha anche più fantasia. Io sono quella che pianifica e che programma, sono più per l’organizzazione. Forse questo ci ha aiutato: ciascuno si è assunto delle responsabilità e dei compiti precisi, senza cercare di sovrastare l’altro, in base alle proprie capacità.
Avete mai avuto paura?
La paura è una compagnia costante a quelle quote. È una cosa positiva, finché non degenera nel panico. Ti aiuta ad affrontare le difficoltà e a valutare le decisioni da prendere nei momenti di pericolo. Non siamo fatti per vivere lassù, dove le nostre vite sono estremamente piccole e fragili dinnanzi al freddo, il vento, le bufere e la mancanza di ossigeno. Ti capita spesso di rimanere bloccato in tenda in alta quota. Una volta, sul K2, siamo rimasti fermi in parete per quattro giorni, chiusi in tenda senza poter uscire, a 6.600 metri. Dopo un po’ era diventato perfino difficile capire quanto tempo era passato. Ecco, in quelle situazioni impari il significato della parola “pazienza”. Che non significa rassegnazione. Ma è l’attesa del momento per poter ripartire. Lì, in quella circostanza, era fondamentale mantenere la calma, non abbandonarsi alla disperazione, non perdere la speranza e non aggrapparsi a qualche aiuto ultraterreno. L’unica cosa da fare era curare la pazienza, in attesa del momento propizio per scappare via. Per affrontare queste difficoltà, che cosa occorre? Una motivazione forte, la voglia di superare i limiti?
La curiosità ci ha spinti a fare ciò che abbiamo fatto, assieme alla passione per l’ambiente e per la montagna, i luoghi dove si è svolta tutta la no-
stra attività. Ho sempre sentito il bisogno di ritrovare in montagna la naturalità e la bellezza che c’è in ognuno di noi, riscoprendo l’essenzialità del gesto e del pensiero. Questo, vale più del desiderio di fare un’impresa o di conquistare una vetta. La voglia di superare i limiti è importante. Ma mi sono resa conto di non essere abbastanza forte per andare incontro al limite e sfondarlo, come fa un guerriero. Ho troppa paura per farlo. Preferisco avvicinarmi lentamente, un passo per volta, considerandolo come un filo da superare. I limiti sono importanti perché ci definiscono rispetto agli altri e definiscono la nostra identità. Non riesco però a considerarli come muri da abbattere, ma come soglie da oltrepassare. La sogni, la montagna?
Di notte no, non la sogno. Preferisco sognarla a occhi aperti. Fortunatamente, la realtà che abbiamo vissuto è stata per noi il sogno più bello. Abbiamo ricevuto dalla montagna molto di più di quello che avevamo chiesto. Hai ancora sogni nel cassetto, montagne da scalare, orizzonti da curiosare?
Una volta ho dato questo titolo a una mia conferenza: «Io sono le montagne che non ho scalato». E quali sono?
Le sto ancora cercando. Abbiamo tanti sogni legati ai nostri viaggi. Anche se, ti devo dire, ora siamo tranquilli. Viviamo in montagna ai margini del bosco, le ultime case del paese. Badiamo ai nostri asini, che non escano dal recinto. A volte, quando scappano, andiamo a recuperarli fino in paese.
Nel 2022 Reinhold Messner è stato nominato socio onorario del Trento Film Festival. In occasione dei 70 anni della rassegna (19522022), il modo migliore per ripercorrerne la biografia è leggere la motivazione espressa durante la cerimonia del 31 maggio 2022, quando Mauro Leveghi, presidente del Festival, gli conferisce l’onorificenza. Presente con loro, quella sera, anche l’alpinista trentina Palma Baldo, invitata a ricevere lo stesso prestigioso premio. I loro nomi si sono aggiunti alla lista degli altri soci onorari, dove figurano alcuni tra i più importanti protagonisti dell’alpinismo di tutti tempi: Erich Abram, Armando Aste, Romano Benet, Walter Bonatti, Sir Chris Bonington, Riccardo Cassin, Bruno Detassis, Kurt Diemberger, Cesare Maestri, Sergio Martini, Pierre Mazeaud, Nives Meroi, Roberto Sorgato, Goretta Traverso Casarotto. «Reinhold Messner –si legge nella motivazione – oltre ad essere uno dei più grandi alpinisti della storia, un celebre esploratore, scrittore e divulgatore, è un altrettanto grandissimo innovatore. Una qualità, questa, che lo accomuna, per molti aspetti, al Trento Film Festival, che nel corso dei suoi 70 anni di vita si è sempre rinnovato, sperimentando nuovi mondi e modi di raccontare e scoprire la montagna. Socio onorario e medaglia d’oro del Club Alpino Italiano, il suo spirito innovativo si è anche espresso attraverso la fondazione e la gestione del

complesso museale Messner Mountain Museum, sperimentando un modo originale di raccontare le culture delle montagne del mondo. Storico dell’alpinismo, sceneggiatore e conduttore di serate-evento tra le più attese del Trento Film Festival, Reinhold Messner ha aperto in questi ultimi anni una nuova pagina della sua eclettica vita, diventando regista e produttore di film di montagna. Un amore per il cinema, il suo, attraverso il quale entra nella più intima essenza degli uomini, degli alpinisti e delle popolazioni delle montagne del mondo, così come avviene per il Trento Film Festival, laboratorio di idee ed esploratore di nuove strade sulle quali incamminarsi verso continui, nuovi orizzonti».
Non ho vissuto tutta la storia del Festival perché sono stato invitato la prima volta a metà degli anni sessanta. Ma posso dire che questa manifestazione, dall’inizio fino a oggi, si è affermata come il leading Festival sulla montagna a livello mondiale.
Pur con alcuni alti e bassi, è sempre stato un festival molto forte. Penso alla presenza dei grandi alpinisti di un tempo, che hanno conquistato le cime
più alte del mondo, quando si saliva sull’Everest per la prima volta… Molti di loro sono venuti con grande entusiasmo al Festival di Trento, attirando
un grande pubblico. Poi, negli anni, la rassegna è diventata sempre più un festival sul film, rivolto a tutta la popolazione e non soltanto agli alpinisti. Ho tanti bei ricordi legati al Festival e alle serate a cui ho partecipato.
Nel corso del 70° sei stato protagonista di una serata dal titolo «Messner e le sempreverdi (1952-2022)», in cui hai scelto sette grandi scalate – una per decennio, dalla nascita del Festival a oggi – e le hai presentate insieme agli alpinisti e alle alpiniste che le hanno ripetute. Naturalmente la serata è stata sold out. C’è qualche altra serata che ricordi in modo particolare?
Ho partecipato molte volte a serate importanti. Tra le più significative, quella sulla vicenda legata alla conquista del K2 da parte della spedizione italiana del 1954. Io, conoscendo bene la storia, ho usato questo momento per ribadire che i fatti si svolsero esattamente come li aveva riferiti Walter Bonatti. Quella sera, abbiamo avuto la fortuna di avere sul palco tutti i protagonisti di quella vicenda, a eccezione di Walter Bonatti. Anche gli storici dell’alpinismo hanno poi confermato quello che dicevo io.
È più «bello» il Festival quando partecipi da protagonista? Oppure il Festival quando partecipi raccontando le imprese degli altri?
Oggi preferisco raccontare le storie degli altri. Lo faccio continuamente nelle mie conferenze. È chiaro che tutto è anche legato alle mie esperienze. Per esempio, posso raccontare di Bonatti sul K2 perché anch’io sono stato lassù. Lo sforzo che dobbiamo fare è quello di narrare le storie da punti di vista nuovi e differenti, senza dimenticare che la natura selvaggia è più forte di noi. In questo senso, sono anche la geografia, il vento e i cambiamenti climatici che ci raccontano le storie dell’alpinismo tradizionale. Raccontarle da punti di vista sempre nuovi è una delle responsabilità del Festival di Trento. Più diventiamo vecchi e più capiamo di essere niente nei confronti del tempo e dello spazio, nei confronti della montagna. Per questo sono venuto molte volte a Trento a raccontare le storie dei grandi successi alpinistici, per ricordare che l’alpinismo non è soltanto quello che si fa oggi, ma è anche la storia e la cultura del passato. Per questo cerco di raccontare la montagna sul palco di tutto il mondo… E vorrei farlo anche con un mio festival. Vorrei andare in Australia, in Sud America, in America. La formula è quella della grande conferenza con un’ampia discussione.
Ormai, da qualche anno, il Trento Film Festival fa tappa anche a Bolzano. Il Comune del capoluogo sudtirolese è socio del Festival dal 1998. Che cosa ne pensi?
Credo che chi è veramente interessato ai temi del Festival e alla manifestazione continui comunque ad andare a Trento, senza aspettare Bolzano. Con questo non voglio certo togliere ai bolzanini la possibilità di avere anche loro il Festival, forse andrebbe inventato qualcosa di nuovo, di diverso. Una formula specifica come quella dei miei musei [Messner Mountain Museum è un circuito museale diviso in sei sedi: in una di queste, a castel Firmiano, si è svolta l’intervista.
E se dovessi fare un augurio al Festival… Da 30 anni a questa parte, l’alpinismo è cambiato ed è diventato sempre più uno sport. Oggi il 99% di chi arrampica lo fa in palestra, oppure va sulle vie attrezzate. Ormai puoi comprare un viaggio fino in cima all’Everest: è turismo! Noi, con il Festival di Trento, dobbiamo portare avanti, e difendere almeno parzialmente, alcuni valori dell’alpinismo tradizionale, che proprio a Trento ha avuto la sua massima espansione dagli anni cinquanta agli anni ottanta. Secondo me bisogna preservare quella tensione fra montagna e natura umana, non solo sportiva, una dimensione umana che è specialmente spirito dell’avventura. Come il Festival.

Maurizio Nichetti è regista, sceneggiatore, attore e produttore. Dal 2005 al 2010 ha ricoperto la carica di direttore artistico del Festival. Autore di successo, nel 1979 firma la regia di Rataplan (vincitore del Nastro d’argento come Miglior regista esordiente) e negli anni successivi produce Ladri di saponette (1988, vincitore del Nastro d’argento come Miglior soggetto originale), Volere Volare (1990, vincitore del David di Donatello per la Miglior sceneggiatura) e Luna e l’altra (1995, vincitore del Nastro d’argento come Miglior film italiano).
Ha cambiato il Trento Film Festival. Il primo a esserne consapevole è proprio lui, Maurizio Nichetti. Così come ne sono consapevoli tutti gli appassionati della rassegna, che, dopo la sua direzione artistica, non è stata più la stessa. Nuova pelle, nuovi orizzonti, nuove prospettive. Con Maurizio Nichetti – erano gli anni duemila – il Festival si apre al pubblico e diventa una festa per tutta la città, anche per i bambini: non soltanto un appuntamento per alpinisti e frequentatori di montagne.
La tua direzione artistica del Festival ha segnato il passo, stabilendo un «prima» e un «dopo Nichetti» nella storia della manifestazione.
Ricordo con emozione quegli anni. Incontrai a Trento un gruppo di persone e di professionisti appassionati che lavoravano al Festival con grande impegno e dedizione. Mettevano tanta passione nel portare avanti le loro idee. E anche nel difenderle.
Come arrivasti a Trento?
L’anno precedente, era il 2004, mi invitarono a partecipare come giurato. Conobbi così il Festival e la città di Trento. Fu un’esperienza intensa che ho molto apprezzato. Un sentimento ricambiato.
Direi sì, visto che l’anno successivo mi proposero nel ruolo di direttore artistico. Ricordo anche le parole di quella telefonata. Mi chiamò il presidente Italo Zandonella, e mi disse: “Nichetti, guardi, lei è stato presidente di giuria l’anno scorso, ci è sembrata un buona esperienza… Vorremmo proporle la direzione artistica del Film Festival”. Io, senza saperne quasi nulla – quale fosse la struttura degli uffici, con quali persone avrei lavorato, perché cercavano un direttore nuovo (tutte cose che bisognerebbe sempre chiedere) – accettai immediatamente. Così mi ingaggiarono per tre anni. Attore, registra, produttore e sceneggiatore di fama. Avevi già vinto numerosi premi e riconoscimenti per i tuoi film. Cosa ti spinse a venire a Trento?
Sono dell’idea che se una cosa mi incuriosisce e mi piace, vale la pena provare. Certo, immaginavo che vi fossero dei problemi, altrimenti non mi avrebbero proposto la direzione artistica, ma allo stesso tempo accolsi la sfida per risolverli. Inoltre, dico la verità, attraversavo un periodo particolare da un punto di vista professionale. Da alcuni anni mi ero allontanato dal cinema e da Roma. Era forse giunto il momento di cambiare. Il cinema che facevo era un cinema di effetti speciali. Ma dai primi anni duemila si imposero le nuove tecnologie. Se eri ricco, potevi comprartele. Quando ho capito che gli effetti speciali te li vendevano con i software, che bastava avere i soldi, che tutti li potevano acquistare: mi è scappata la voglia di farli. In che senso?
Come dire: se io faccio una gara tra chi è più ricco, la perdo sempre. Se faccio una gara tra chi ha più idee, allora è diverso e mi diverto ancora. Se mi avessero chiesto di dirigere il Festival qualche anno prima, quando ero nel pieno della mia fantasia cinematografica, gli anni di Volere volare o Ladri di saponette: probabilmente non sarei venuto a Trento a dirigere una rassegna cinematografica sulla montagna. Invece, in quel momento, fu una folgorazione. Conoscevi la montagna e il cinema di montagna?
Conoscevo il Trentino perché ci venivo in vacanza,
avevo una casa a Pinzolo. Non conoscevo invece il cinema di montagna, che però mi affasciava. Mi sono calato in questa realtà, che non mi apparteneva, e mi ci sono immerso. Il mio percorso era diverso, provenivo dal cinema comico, di fantasia, i cartoni animati, la virtualità. Di colpo mi sono trovato travolto da filmati veri, storie reali, dove l’unico «effetto speciale» era il coraggio che le persone mettevano nel compiere imprese impossibili sulle montagne.
Che situazione hai trovato, che impressione ti fece il nuovo ambiente? Non deve essere stato semplice affrontare un settore per te inedito e molto specialistico.
Quando vai a un Festival trovi un contesto estremamente stimolante, entri in contatto con tanti autori, tanti artisti, tanti film. Ho partecipato a molte giurie, da Cannes a numerosi altri contesti internazionali. Il clima è sempre quello: un luogo di grande creatività che facilita gli incontri e la nascita di nuove idee e nuovi progetti. È accaduto anche a Trento. Quando arrivai in città, mi accorsi subito che il Trento Film Festival godeva di una forte considerazione in tutto il mondo. Eppure c’era tanto da lavorare. Si poteva migliorare.
Da dove cominciare?
Il Festival si rivolgeva a un pubblico di appassionati di montagna e di specialisti del settore. Io ero
convinto che si potesse fare molto di più. Che il Festival potesse diventare una festa per tutta la città. È stato difficile spiegarlo ai tuoi interlocutori, in una città di montagna, a un pubblico di alpinisti?
Mi rivolsi a loro e dissi: «Avete un’età importante. Questa rassegna ha più di 50 anni. Siete conosciuti in tutto il mondo e avete un marchio che vale. È un peccato tenere in piedi tutta questa macchina pensando che possa interessare solo a poche migliaia di persone, chi arrampica, chi va in montagna». Pensavo, insomma, che il Festival, date le sue caratteristiche, fosse sottovalutato e che vi fossero molti margini di miglioramento. Bisognava uscire dagli spazi ordinari per invaderne altri. Così, durante la tua direzione, sono state introdotte tante innovazioni. Solo per ricordarne alcune: il rapporto con il Museo degli usi e costumi delle gente trentina di San Michele, che apriva al cinema etnografico, il Parco dei Mestieri, che guardava ai bambini e alle famiglie, e il Salvanel, la mascotte del Festival nata dalla fantasia dell’illustratore Andrea Foches.
Sì, furono tutti tentativi di portare il Festival fuori dal Festival. Costruimmo una rassegna dal programma fittissimo, decine e decine di eventi con un’offerta molto ampia. Che suscitò anche delle critiche. Come si fa – mi si chiedeva – a vedere tutti gli
appuntamenti che proponete a calendario? Non è necessario vedere tutto, rispondevo. Come con i canali televisivi, ciascuno sceglierà il proprio palinsesto, individuando ciò che più lo interessa e lo incuriosisce. I numeri ci dettero ragione. In pochi anni, i frequentatori del Festival raddoppiarono, triplicarono, decuplicarono. In un certo senso, fu anche una sfida culturale. Sicuramente. Penso ad alcuni eventi ed episodi in particolare: come quando, nel 2007, decisi di dedicare la serata inaugurale del Festival alla proiezione del film muto di Charlie Chaplin La febbre dell’oro (Stati Uniti, 1925). Cosa c’entra, mi chiesero, il film di Chaplin con la montagna? Forse nulla. Ma il film è ambientato in montagna e rappresenta un patrimonio cinematografico eccezionale. Le musiche del film, composte dallo stesso Chaplin, le facemmo eseguire dall’Orchestra regionale Haydn di Bolzano e Trento. Fu una serata memorabile dove registrammo il tutto esaurito. Il giorno prima la facemmo anche per le scuole. Fu un evento capace di uscire dai confini di una comunità e di trovare un’eco nazionale sui principali quotidiani: il Corriere della Sera, la Repubblica.
Come questa, ricordo altre serate speciali. Penso a «Montagne Migranti» – un grande spettacolo per il quale curai la regia teatrale con la direzione musicale e artistica di Carlo Casillo e Miscele d’aria
– che raccontava le esperienze in montagna dei migranti di tutto il mondo. Un tema di eccezionale interesse, capace di attirare un pubblico eterogeneo, non soltanto di alpinisti. Fu un successo. Lo spettacolo venne poi più volte ripetuto anche al di fuori del Festival iniziando un suo tour in Trentino. Hai trovato resistenze nel proporre questi cambiamenti, introducendo idee nuove, aprendo il Festival a nuovi linguaggi e nuove tematiche?
Eccome, era inevitabile. Da un lato, perché non provenivo dall’ambiente dell’alpinismo e mi attirai le critiche di chi si domandava che cosa avessi a che fare, io, con la montagna. Dall’altro, perché mi confrontavo con persone appassionate, che credevano in quello che facevano. A volte avevano il carattere duro. Gli uomini di montagna sono dei duri.
Per esempio?
Nelle sedute della giuria, ricordo la discussione che ebbi con un forte alpinista. Uno che saliva gli Ottomila. Non ci trovammo d’accordo su alcune questioni. Aveva un carattere talmente forte che mi aggrediva, non mi lasciava parlare. Dettava ordini. Più tardi mi spiegò che a 8.000 metri, dove faceva il capocordata, non c’era tempo per le discussioni. Io lo capivo. Applicava quel metodo anche in giuria.
Altre serate difficili? Momenti particolari o tematiche delicate?
La serata sul Cerro Torre: una serata da incubo. Lo dico con ironia, perché riuscimmo incredibilmente nell’impresa e l’evento fu un successo. Quell’anno, era il 2009, condussi io la serata. Il Torre era un argomento delicato e fortemente divisivo. Cadevano i 50 anni dalla spedizione di Cesare Maestri e sembrava opportuno occuparsene. Maestri era trentino, un’icona dell’alpinismo, e con la sua spedizione sul Torre aveva fatto discutere il mondo. Ragionammo così sul da farsi, fino a quando, un giorno, ricevemmo una lettera dall’Inghilterra, che ci diffidava dal fare la serata sul Torre. Non so se mi spiego: mi arriva una lettera dalle istituzioni della montagna inglesi che ci dicono che non
possiamo agire liberamente in casa nostra. Ecco, questa è stata la cosa che mi ha fatto convincere: mi sono convinto che, non solo dovevo fare la serata, ma dovevo essere io a condurla. Mi tenevano d’occhio, aspettavano tutti che dicessi qualche cosa di sbagliato. Il tema era delicatissimo, ma questo non mi impediva di parlare di quanto accaduto.
A più di dieci anni di distanza – hai lasciato il Festival nel 2010 – conservi ancora qualche ricordo, qualche cosa, qualche oggetto del Festival, i «tuoi» souvenir?
E come no... Tutta una libreria di cataloghi, fotografie, libri, brochure. Certe serate le ho in pellicola. E poi ho tutto il Salvanel, una delle cose che mi divertivano di più.
Cecilia Perucci è nata a Roma nel 1962 e si è laureata in Lettere moderne a Pavia. Lavora nell’editoria dalla fine degli anni ottanta e dirige la casa editrice Corbaccio dal 1994. Ha una passione per la montagna, la natura e il silenzio. Vive in campagna, vicino a Pavia, e frequenta il Festival da più di 20 anni.

«Ho più che altro sensazioni e luci di quella serata: il ristorante, la tovaglia color avorio e Mauro Corona, in canottiera, già seduto al tavolo, che mi accolse con una frase che non posso dimenticare e alla quale non seppi rispondere nulla: ‹La morte ti taglierà le lunghe gambe›. Cecilia Perucci inizia così il ricordo delle sue prime giornate trentine, nella primavera del 1998.
Come mai era venuta a Trento per il Festival?
Ero stata invitata dal Premio Itas del Libro di Montagna per la serata di consegna dei premi. Facendo una eccezione, dato che il libro era uscito nello stesso anno, la giuria del premio aveva deciso di assegnare il Cardo d’oro ad Aria Sottile di Jon Krakauer. Partecipavo alla serata con mio marito, Roberto Santachiara, che avrebbe ritirato il Cardo in rappresentanza dell’autore, cliente della sua agenzia letteraria. Ricordo che cadeva una pioggerella sottile e che diretti al luogo della premiazione incontrammo l’amica Mirella
Tenderini con la quale dividemmo la strada. Ero molto emozionata: la presenza dell’amico e autore per la casa editrice Corbaccio, Gino Buscaini, le belle parole di motivazione della giuria, lette dal suo presidente Mario Rigoni Stern, e la pesantissima aquila, che tuttora troneggia nel mio ufficio, che mi venne messa in mano e subito tolta per paura che me la lasciassi cadere sui piedi! Che meravigliosa idea quella di premiare non solo l’autore ma anche l’editore! Riconoscendo – ed è cosa rara – che l’uno non esiste senza l’altro.
E come continua questa storia?
Fu l’inizio luminoso di una amicizia, la mia e della Corbaccio, con il Festival di Trento, che si è intensificata con gli anni, con i tanti libri, con gli autori e autrici, con i premi vinti e con la partecipazione mia o dei miei colleghi a quasi tutte le edizioni del Festival negli anni successivi. Un appuntamento al quale iniziamo a pensare mesi prima quando decidiamo che libri mandare al premio, quali i titoli da esporre nella bella libreria sotto il tendone in piazza Fiera e che autori presentare. Per arrivare al 2022, quando il Trento Film Festival ha festeggiato i suoi 70 anni ma anche, con la generosità e l’inclusività che gli è propria, i 50 anni della collana Exploits, collana di montagna della Corbaccio che ho curato con passione, con fascinazione e con incanto per quasi tre decenni. E poi in questa
edizione il festival ci ha offerto uno spazio per una piccola mostra che illustrasse la collana, le evoluzioni della sua grafica, la ricchezza del catalogo e i premi vinti e ci siamo resi conto più che mai del cammino percorso insieme. In questo viaggio della memoria immagino siano tanti gli incontri…
Non c’è dubbio. Ho ripensato che dopo Krakauer avevamo ricevuto premi per Hans Kammerlander, Giovanni Capra, Maria Coffee e Joe Brown. Sono venuta a incontrare Tommy Caldwell, ad ascoltare Reinhold Messner, Stefano Ardito, Mirella Tenderini, Kurt Diemberger, Carla Perrotti e altri ancora, sempre con quel senso di sospensione dell’essere ospite – quasi clandestina – tra tante persone competenti ed esperte. E con quell’allegria che essere a Trento, circondata da appassionati di montagna, mi ha sempre trasmesso. E poi l’incontro con Luana Bisesti, per tanti anni alla guida della rassegna: non ricordo la prima volta che ci siamo incontrate ma ricordo bene che mi è piaciuta subito con la sua forza, la sua energia, il suo equilibro, la sua magica capacità organizzativa, la sua simpatia e il calore che emana. Fa sembrare
l’immenso lavoro di programmazione, organizzazione, inseguimento (letteralmente!) di alpinisti talentuosi ma disorganizzati, un gioco da ragazzi. Ho sempre pensato se ci avesse messo mano lei,
sarebbe riuscito tutto bene. E non mi sbagliavo! La coincidenza dei due anniversari «tondi», i 70 anni del Festival e i 50 della vostra collana di montagna, è stata anche l’occasione per una collaborazione diversa.
Abbiamo deciso di organizzare una serata comune dal titolo «Estremi narrativi» nella meravigliosa piazza del quartiere di Piedicastello, mai utilizzata prima dal Festival. La serata, in una cornice mozzafiato con la silhouette della chiesa di Sant’Apollinare a catturare continuamente lo sguardo, è stata ricca di contributi. Prospettive diversissime di scrittura e di narrazione si sono confrontate sotto le stelle: dal racconto autobiografico al giornalismo, passando dal blog fino alla recensione via podcast. Perché raccontare l’avventura, vissuta in prima persona o solo osservata, passa attraverso tante forme di linguaggio, alcune classiche e sempre rinnovate, altre nuove e altrettanto efficaci. Modalità adatte a momenti diversi, non necessariamente a pubblici diversi. C’erano più di 300 persone quella sera. Tra i protagonisti Mauro Corona, costretto ad assentarsi per parte della serata per il suo «appuntamento con la Bianchina»; abbiamo tutti riso del sublime scambio finale tra lui e Kurt Diemberger, a proposito di una promessa di tanti anni prima riguardante una scultura in legno che tuttora troneggia nel laboratorio di
Corona ma che dovrebbe essere invece a casa Diemberger. Nella mia ingenuità ho pensato che, dopo le firme sui libri, la serata fosse conclusa, ma mi sbagliavo. Non poteva mancare la tappa al bar degli Alpini che ci hanno offerto vino, formaggi e salame in quantità. Se il detto in vino veritas vuol dire qualcosa, dico solo che i miei compagni di serata mi hanno stupita. Non si dovrebbe mai credere di conoscere gli altri fino in fondo!
Come ti è sembrato questo compleanno del Trento Film Festival?
Quest’anno mi sono concessa qualche ora in più per «guardare» il Festival. Ho visitato la mostra Senza posa dedicata a Mario Fantin, ho guardato un meraviglioso – per la sua essenzialità e intensità emotiva – cortometraggio sulla tempesta Vaia, ho ascoltato i registi presentare i film del giorno, ho passeggiato per la città perdendomi – ma io mi perdo sempre! – e ho respirato un’atmosfera che per me resta magica. Ho anche potuto ammirare la splendida mostra celebrativa dei 70 anni dal titolo Scalare il tempo sempre a Piedicastello. E sono rimasta incantata dallo spazio de Le Gallerie – dalla sensazione di entrare nel cuore, freddo!, della terra – e dall’esposizione di tutti i manifesti delle diverse edizioni. Alcuni li ricordavo ma di molti mi hanno colpita la modernità, il simbolismo, i colori. In realtà solo vedendoli così, tutti insieme
su quella lunga parete, ho percepito fino in fondo l’ampiezza del progetto, il suo valore storico, la modernità dell’idea e la capacità sempre nuova e sempre al passo con i tempi dell’organizzazione. Un festival che è stato il primo a portare al pubblico il cinema di montagna ed esplorazione ed è tutt’ora il primo per importanza e rilievo nazionale e internazionale. Per me il Trento Film Festival è un momento importante dell’anno; un momento per portare a un pubblico di appassionati i nostri libri di montagna, un momento per incontrare amici e
colleghi, un momento speciale. Tutta la città vibra dell’energia del Festival, risuona delle attività e si anima al passaggio di persone ormai di casa ma famose come Messner, Diemberger, Corona, Barmasse e tanti altri. Alcuni ospiti regolari e altri di passaggio. In quei giorni Trento diventa il Festival. Non c’è angolo della città che non abbia un segno della manifestazione a conferma del fatto che la città ha sposato il Festival con entusiasmo e partecipazione.
Ingrid Runggaldier è nata a Bolzano nel 1963 e cresciuta a Ortisei in val Gardena. Ha studiato lingue e letterature straniere all’Università di Innsbruck e dal 1997 lavora come traduttrice presso l’ufficio Questioni Linguistiche della Provincia autonoma di Bolzano. Autrice di programmi radiofonici e reportage televisivi, nel 2011 ha pubblicato il libro sulla storia dell’alpinismo femminile Frauen im Aufstieg. Auf Spurensuche in der Alpingeschichte. È stata consigliera del Trento Film Festival dal 2003 al 2014. Cresciuta in un ambiente dove l’alpe era di casa – il padre era una guida alpina della val Gardena in Alto Adige e capo del Soccorso alpino – Ingrid Runggaldier si è dedicata soprattutto alla scrittura di montagna, «un modo – dice – per ordinare quello che sta nella mia testa», appassionandosi alle bellezze delle Dolomiti e alla storia dell’alpinismo femminile, i temi letterari che predilige. Scrittrice, traduttrice e libera pubblicista, oggi vive a Bolzano e parla correntemente il tedesco, l’italiano e il ladino. Un trilinguismo, quello di Ingrid, specchio della ricchezza culturale del Tirolo, terra di confine, dove è nato Trento Film Festival.

Conoscevi Trento, prima di frequentarla per il Festival?
Frequentavo poco la città. È stato grazie al Festival se l’ho conosciuta da vicino. I sudtirolesi che, come me, erano coinvolti nella manifestazione, venivano a Trento durante le settimane della rassegna. Sono stata tante volte alla biblioteca della montagna della SAT, in via Manci, dove andavo a fare le mie ricerche bibliografiche. Ricordo anche il rifugio Bindesi, dove si andava a cena per parlare e confrontarsi dopo gli incontri nelle sale cinematografiche. C’era una forte empatia. Erano i luoghi del Festival, in quelle giornate di montagna e di montagne. Noi, di Bolzano, vivevamo il Festival come se fosse anche un po’ nostro. Il Festival come esperienza comune tra due provincie differenti?
Soprattutto da quando, nei mesi di settembre e ottobre, la manifestazione si svolge anche a Bolzano, nella versione autunnale. Del resto la città di Bolzano è entrata a far parte dei soci del Trento Film Festival negli anni novanta, aggiungendosi al Comune di Trento e al Club Alpino Italiano, i due soci fondatori. È vero. Ma anche prima degli anni novanta il Festival ha promosso un avvicinamento tra le due città. I punti di contatto tra le provincie di Trento e Bolzano sono così tanti, eppure qualche volta
ci sembra di essere lontani. Il Festival ha rappresentato una vera occasione d’incontro culturale. Prerogativa che lo contraddistingue, non solo per quanto riguarda i rapporti tra le due provincie. Ti riferisci alla sua internazionalità?
Quando ho cominciato a frequentare il Festival ho aperto gli occhi sul mondo e mi sono accorta che è fatto di montagne. Tantissime montagne oltre alle nostre. Le Alpi, i Pirenei, le catene del Nord e del Sud America, l’Himalaya… Le immagini del Festival mi affascinavano come una scoperta. Ho frequentato tanti altri festival ma nessuno è così internazionale come Trento. È un punto di ritrovo. Anche se non hai appuntamento con qualcuno, sai che vai lì e farai un incontro speciale. Forse dipende anche dalla città, non troppo grande, raccolta, misurata. Durante la rassegna, cammini sempre sulle stesse strade, quattro o cinque vie. Le strade del Festival.
I tuoi incontri?
Persone eccezionali. C’erano i volti più famosi, Reinhold Messner, Kurt Diemberger. E le nuove leve, ricordo in particolare Alex Honnold. Generazioni di alpinisti e scalatori che si incontravano nelle vie del Festival. Poi anche i loro familiari, le persone che stavano vicino agli alpinisti, che li accompagnavano. Penso alla moglie di Hermann Buhl, la ricordo bene. Dall’altra parte dello schermo
stavano i registi. Anche quegli incontri erano molto intensi, legati più al mondo del cinema che a quello dell’alpinismo: Giuliano Montaldo, Maurizio Zaccaro, Sabine Derflinger sono i primi che rammento. Li incontravi per caso e in pochi istanti si consolidavano rapporti di fiducia e reciproca stima. Con alcune persone c’era subito feeling, nascevano amicizie. Come con John Porter, lo vedo ancora tutti gli anni. Di che cosa parlavate?
Si discuteva di cinema, montagna, avventura e letteratura. Una grande apertura di visione e di sguardi. Il Festival, da quando lo conosco, è sempre stato questo: non solo un ritrovo di alpinisti e registi di montagna, ma luogo di riflessione sulla cultura di montagna. Si respiravano nuovi stimoli e c’era aria di nuove riflessioni, nuove strade, nuovi percorsi non soltanto per il cinema di settore ma verso il cinema in generale.
Quale è la tua idea di cinema e di cinema di montagna?
Ho sempre dato importanza alla qualità del cinema. Il tema che viene affrontato in una pellicola è importante, ma conta moltissimo la qualità del lavoro registico che lo narra. Perciò ho personalmente inteso il Festival come un vero e proprio festival del cinema. A prescindere dall’argomento affrontato, cercavo la qualità dell’esecuzione ci-
nematografica. A Trento – ricordo – mi appassionavano anche le vecchie pellicole restaurate e mi stupiva la bravura di quei cineasti. C’era davvero grande emozione nel vedere i film del passato, di cui talvolta avevi sentito parlare. Era straordinario poterli ritrovare. Ti succedeva solo al Festival. Avevo poi interesse per i film sull’ambiente. Anche questi li trovavo a Trento. Il Film Festival ha avuto un grande merito: sensibilizzare il pubblico sulle tematiche ambientali, il cambiamento climatico, il problema dei rifiuti lasciati in montagna, il turismo eccessivo ma anche l’abbandono delle terre alte.
E il tuo rapporto con la montagna, qual è?
Come ti dicevo, è una storia di famiglia. Sono cresciuta tra persone che praticavano la montagna. A differenza di mio padre, non ne ho fatto una professione. Ma la considero come la mia casa, un luogo dove vivo, vado, vengo e torno sempre volentieri. Trascorro le estati nella mia baita sul monte Seceda, in val Gardena, dove facciamo il fieno e passiamo il tempo con la famiglia e con gli amici. La montagna è parte di me e quando posso ci ritorno, ogni volta che posso. Non ho mai fatto nulla di impegnativo o di pericoloso, non sono un’alpinista ma abito la montagna e faccio escursionismo.
Un modo per prendersi il bello dei paesaggi alpini, senza il rischio di chi scala o di chi cerca l’impresa.
Non ho mai cercato le difficoltà in montagna. Li ho scritti nella mente i rischi che comporta. In che senso?
Crescere con un papà guida alpina e capo del Soccorso alpino significa vivere accanto ai pericoli della montagna. A casa nostra si trovava la centrale del Soccorso alpino. Quando si verificava un incidente eravamo sempre i primi a saperlo. Se moriva qualcuno, i parenti delle vittime si recavano da noi. I genitori arrivavano da lontano, spesso le vittime erano turisti, anche stranieri. E la mia mamma, anche lei membro volontario del Soccorso alpino, stava lì con loro, con i familiari di quei ragazzi. Li consolava, offriva qualcosa, una tazza di tè, qualche parola. Abbiamo conosciuto anche questo aspetto, quello doloroso, gli incidenti che accadevano e che gettavano nella disperazione. Quando si è giovani non si pensa che possa toccare a te. È per questo che i nostri genitori non ci hanno mai incoraggiato ad andare in montagna. Come sei arrivata alla scrittura?
Ho iniziato con lo studio degli alpinisti del passato e poi la mia attenzione si è concentrata sulle figure femminili, le donne di montagna. Un tema che mi appassiona ancora molto, a cui ho dedicato
uno dei miei libri più importanti: Frauen im Aufstieg (Donne in ascesa). Recentemente mi sono appassionata alle Dolomiti, cercando di capire come sono state considerate nella letteratura; un argomento vasto e suggestivo. È una ricerca che mi ha arricchito tanto e mi ha fatto pensare che il modo in cui noi guardiamo le montagne dipende molto dalle letture che facciamo, dagli autori che abbiamo letto, dalle immagini di montagna che ci sono state presentate.
Come scegli i tuoi temi letterari?
Qualche volta ho l’impressione che siano loro a scegliere me. Sono molto curiosa, ho sempre avuto un grande bisogno di sapere. Ma sento anche la necessità di condividere le cose che leggo, che trovo, che imparo. Di qui la volontà di scrivere libri. È sempre un’emozione immergermi nei miei argomenti. Quando lo faccio, il resto del mondo sembra scomparire. Entro in una dimensione psicologica affascinante che continua a meravigliarmi. E la montagna al femminile? Cosa ti ha spinto a raccontarla?
Mi incuriosiva il fatto che quasi tutte le storie di alpinismo fossero riferite a figure maschili. Ho quindi messo mano agli archivi di montagna per cercare storie femminili e ho scoperto che ce ne sono tante, purtroppo sconosciute. Ho voluto dare voce a queste biografie per non dimenticarle.
Dopo tante ricerche e diversi libri, che hanno caratterizzato la tua attività di autrice e appassionata, hai qualche sogno nel cassetto? Non soltanto letterario.
Un desiderio ce l’avrei: una specie di trekking… Una camminata lunga un anno per attraversare le Alpi e gli altri monti d’Italia, dall’Alto Adige fino alla Sicilia, senza avere pressioni di tempo, con calma, recuperando la lentezza, rallentare un po’ sulla mia
vita e sentire il tempo che passa andando a piedi. Vorrei camminare a lungo su queste montagne per coglierne non soltanto l’altezza ma, diciamo così, anche la dimensione della distanza. Prendo spunto da quella generazione di alpinisti vittoriani che, nella seconda metà dell’Ottocento, giunse nelle Alpi e le percorse in lungo e in largo, zigzagando, come facevano i viaggiatori di un tempo.
Sandra Tafner, studi umanistici e laurea in lettere classiche, giornalista professionista. Ha seguito le vicende politiche e sociali per il quotidiano l’Adige. Attenta ai problemi ambientali che ha sviluppato in collaborazioni Rai, nella sede di Trento. Ha firmato volumi sulle tradizioni e l’identità trentina.

«In quegli anni in Trentino non era così facile fare la giornalista in un quotidiano. Quantomeno non era scontato». Sandra Tafner parla così dei suoi esordi di giornalista. Era la metà degli anni sessanta quando insieme al collega Enrico Goio curava per l’Adige la rubrica «Sottovoce» durante il Festival, che allora si chiamava ancora Festival Internazionale della Montagna e dell’Esplorazione.
Allora il Festival si svolgeva al teatro Sociale.
Sì, via Oss Mazzurana era piena di gente, ci si trovava a parlare davanti al teatro anche un’ora prima delle proiezioni, così si poteva vedere chi entrava e si parlava, si discuteva. Ai giornalisti era assegnata la barcaccia e non era una grande idea metterci tutti insieme, perché eravamo piuttosto indisciplinati. I primi anni si proiettavano quasi soltanto documentari delle spedizioni e il mio amico Flavio Faganello, grande fotografo, scherzava sempre fingendo di essere stato ogni anno a Katmandu: «hai visto come hanno dipinto
quelle case lì in fondo?» diceva, perché le spedizioni partivano sempre da lì e quindi sembrava di conoscere tutta la città.
Vi conoscevate tutti?
Era un clima molto familiare. Un giorno mi hanno chiesto perfino di doppiare un film slavo perché mancava la doppiatrice femminile. Un’esperienza nuova, fatta con una certa incoscienza. E cosa succedeva una volta usciti dal teatro?
Eh, quella è una cosa irraccontabile [ride]. C’era il dopofestival, andavamo alla Cantinota che restava aperta solo per noi e Gianni, il proprietario del ristorante, ci accoglieva sfregandosi le mani «risottino, signori?». Lì facevamo mattina e gli alpinisti ci raccontavano di tutto, venivamo a sapere un sacco di cose.
Ci fai qualche nome?
C’erano nomi grossi, tanti inviati, ma la maggior parte degli alpinisti li trovavamo durante il giorno.
Incontravi Walter Bonatti per strada «ciao Walter, come va?». Oppure Kurt Diemberger, persona straordinaria. E i trentini, Armando Aste, Sergio
Martini, Palma Baldo, Bepi Defrancesch che andava e veniva ogni giorno dalla val di Fassa durante il Festival. Cesare Maestri poi era di casa. Io lo conoscevo da sempre e sono contenta di avergli fatto l’ultima intervista, pochi mesi prima della sua scomparsa. Abbiamo ricordato i vecchi tempi.
Guardava dalla finestra, nella sua casa di Campiglio, guardava la pista dello Spinale che stava proprio lì di fronte e si commuoveva.
La stampa di allora lo definiva spesso «il festival senza dive». Confermi?
C’è stata una piccolissima parentesi mondana della quale per la verità sono stata responsabile insieme a Mario Cristofolini. Abbiamo organizzato le giornate dell’equipaggiamento e dell’abbigliamento di montagna con tanto di passerella e di sfilata. Avevamo ingaggiato perfino quattro indossatrici di Milano.
Da giornalista ricordi qualche fatto di cronaca che abbia segnato l'andamento del Festival?
Ne ricordo uno che riguarda la storia locale. Era l’edizione del 1967, la 16a, e noi eravamo tutti a pranzo al castello di Pergine. A un certo punto arriva una telefonata, alla stazione di Trento era scoppiata una bomba. Era il 30 settembre ed erano morti due poliziotti, Filippo Foti ed Edoardo Martini, vittime di un’esplosione legata al terrorismo altoatesino. L’anno seguente invece la contestazione studentesca ignorò completamente il Festival, mentre durante altri eventi culturali (alla Scala di Milano e alla Mostra del Cinema di Venezia) si erano verificati episodi di boicottaggio e accese proteste.
Quella che racconti è soltanto una delle stagioni del Festival.
Certo e direi che ora è cambiato moltissimo dai primi anni in cui ho iniziato a frequentarlo. Innanzitutto la stagione, dall’autunno alla primavera, poi la sede, dal teatro Sociale all’auditorium Santa Chiara. A quel punto è cambiato anche l’approccio al Festival: il tendone, chiamato Campo Base, diventò il naturale luogo d’incontro, creando una continuità tra prima, durante e dopo la visione dei film. Negli ultimi anni invece è un po’ più difficile individuare un luogo di ritrovo comune, anche perché c’è più gente e un’offerta maggiore in città. Il Festival ha trattato tematiche di attualità rispetto al mondo della montagna, credi che ne abbia anticipate?
Sicuramente ha anticipato il dibattito sull’ecologia: già negli anni settanta nei convegni si parlava di salvaguardia dell’ambiente. E poi le tematiche di genere: ricordo Silvia Metzeltin, alpinista e giornalista, coordinatrice di una tavola rotonda dedicata alla donna in montagna e nel cinema di montagna. Ma prima ancora, le donne alpiniste che passavano dal Festival non mancavano di sottolineare quanto fosse difficile questo mondo per loro. Annetta Stenico mi raccontò che quando andava in parete con Marino, partiva in bicicletta con la gonna e si portava i pantaloni in un sac-
chetto, perché le donne non potevano andare in montagna vestite come gli uomini e si cambiava lontana da sguardi indiscreti.
Anche il cinema di montagna è una cartina di tornasole dei tempi che cambiano. Ricordo soprattutto due film che hanno fatto discutere. Solo di Mike Hoover (Stati Uniti, 1972), nell’edizione del 1973: era un film che mostrava la montagna come terreno di gioco, come divertimento, non solo sofferenza e confronto con se stessi come era invece nella retorica del vecchio alpinismo. Dopo l’annuncio della vittoria (Gran premio Città di Trento), nell’atrio del Sociale si era scatenata la fazione di quelli che dicevano «questo non è alpinismo» e «questo tradisce la tradizione del Festival». Qualcosa di simile è successo cinque anni dopo, quando viene premiato El Capitan di Fred Padula (Stati Uniti, 1978), un’opera che apre la strada cinematografica all’alpinismo californiano, un altro modo di andare in montagna.
Hai conservato qualche ricordo materiale dei tuoi anni al Festival?
Ricordo il tovagliolo di carta firmato da Raymond Peynet, l’illustratore francese autore di un manifesto del Festival. Eravamo seduti vicini al ristorante e non ho resistito: gli ho chiesto un disegno e in un secondo mi ha fatto lo schizzo dei suoi fidanzatini.

Maurizio Zanolla è guida alpina e alpinista, tra i pionieri dell’arrampicata libera in Italia e nel mondo. Classe 1958, tra la fine degli anni settanta e gli anni novanta sposta i limiti di questo sport raggiungendo confini mai immaginati. Personaggio di fama mediatica, è diventato un’icona per generazioni di scalatori.
Maurizio Zanolla, uomo dell’impossibile, è una stella assoluta dell’arrampicata di tutti i tempi. Per tutti Manolo, il Mago, ha da poco compiuto 65 anni (nel 2023) e conserva con il Trento Film Festival un rapporto di lungo corso: «Ho quasi l’età del Festival», dice. Nel 2012 vince il premio Genziana d’oro del CAI alla 60a edizione del Trento Film Festival con Verticalmente démodé (Italia, 2012), un film dove racconta le proprie emozioni sulle pareti «a metà strada tra i luoghi dove sono nato e i luoghi dove sono vissuto». Poi, nel 2019 si aggiudica il Premio Itas del Libro di Montagna per «la miglior opera non narrativa» con il volume Eravamo immortali (Fabbri editore). Dopo tanti anni alle prese con il vuoto, oggi continua a vivere in Primiero, tra le sue montagne, in una baita che ha costruito con le sue mani: «Se sono ancora qui – prosegue – è perché sono un sopravvissuto. Tanta fortuna. Sono fatto così e ho imparato ad accettarmi». Una vita al limite, quella di Manolo. La vita di chi ha incontrato il successo senza averlo cercato.
Dici di essere diventato famoso per un orologio…
È vero. Sono diventato popolare grazie alla pubblicità della Sector. Un insieme di circostanze fortunate mi ha portato su quella strada. Che ho vissuto con imbarazzo. Ricordo ancora quando mi fermavano per strada e mi riconoscevano: ero in imbarazzo, come quando mi rivedevo in televisione. Lo sponsor mi ha dato grande popolarità ma sono rimasto ciò che ero. Lo vedi, vivo qui, in 100 metri quadrati in una casa che ho costruito da solo. Siamo in quattro, io e la mia famiglia, ai margini del bosco. Ci sono nato, ai piedi di queste montagne, dove la vita è dura. Diversa da come te la fanno vedere in cartolina.
Sei un’icona dell’arrampicata, in Italia e all’estero. Sei stato un simbolo mondiale di questo sport tra gli anni ottanta e novanta. Come hai vissuto questa condizione?
Come ti dicevo, sono rimasto quello che ero. Ho vissuto senza un numero sulla schiena e senza inseguire la competizione. C’è chi è competitivo anche a pelare le patate. Io non lo sono. Ho inseguito la mia passione per la montagna e l’unica competizione che ho avuto è stata con me stesso.
Dopo tanti anni, dico che è stata dura, non è facile gareggiare con sé stessi.
Ricordi la tua prima partecipazione al Festival?
La prima volta ero un ragazzo, ricordo poco, avevo meno di 20 anni. Presentavano un film sull’Eiger e desideravo vederlo assieme a un amico. Così scendemmo a Trento. Negli anni a seguire non fui un assiduo frequentatore del Festival. Mi interessava. Ma preferivo la montagna alle sale cinematografiche.
Poi sei diventato il grande protagonista del Festival: ti invitavano per le tue imprese, una volta anche come giurato.
Certo me lo ricordo bene. Quell’anno, assieme ai colleghi della giuria, passai una settimana segregato in casa, chiuso dentro, a guardare film. Meglio praticarlo, l’alpinismo, che guardarlo al cinema.
Preferisco stare all’aria aperta. Faccio fatica a esprimere giudizi sui film che guardo e a coglierne le peculiarità. Mi colpisce di più la fotografia: che sia il mare, il deserto o una montagna. Ecco, nei film mi colpisce il modo con cui il regista gestisce questo aspetto. In alcuni momenti della vita ho perfino avuto interesse per la fotografia, la voglia di fermare un attimo o un momento. Ma è durato poco.
Perché?
Sono nato in un’epoca in cui non si facevano fotografie.
La prima macchina fotografica?
Probabilmente l’ho vinta a una lotteria o qualcosa di simile, non ricordo bene. Era una fotocamera di plastica, scattava solo qualche immagine. Ricordo di essere partito con il mio compagno di cordata per una scalata. Arriviamo all’attacco della via e scattiamo la prima foto. Poi scaliamo per circa 1.000 metri e alla fine della via facciamo la seconda foto. Il mio compagno si girò e mi disse: «Ma quante foto vuoi farmi oggi?» Abbiamo messo la macchina nello zaino e lì è rimasta. Più avanti cambiai idea. C’è stato un periodo in cui mi piaceva fotografare le mie scalate. O quando viaggiavo, specie in Himalaya. Preferivo il bianco/ nero. Ma mi sono stufato presto, forse ero troppo esigente o forse pensavo che quell’attività rubasse troppe energie.
Ora ti manca quella documentazione, le foto che non hai fatto?
Non ci penso. Sono rimasto tale e quale. Oggi come ieri. Non faccio le foto nemmeno col telefonino.
Cosa ti ha dato e cosa ti ha tolto la montagna?
Non ci sarei dovuto nemmeno essere, sulle montagne. Nessuno faceva l’alpinista nella mia famiglia e nessuno mi aveva mai parlato delle montagne. Non conoscevo neanche il nome delle vette dietro casa. Neppure quello della montagna da cui scendeva il ruscello che bagnava i piedi della
casa di mio nonno. Dal basso, quando le guardavo, vedevo solo pietre e sassi. Tutto un disordine, un grande caos. Poi, la prima volta che sono arrivato in cima a una vetta ho visto il mondo dall’alto e tutto mi sembrato in armonia. Un’armonia assoluta e irraggiungibile.
Eri arrivato lassù, poi non hai più smesso.
L’alpinismo mi ha insegnato a vedere il mondo in modo diverso. Un viaggio straordinario ma anche doloroso. Andando in montagna ho imparato quello che nessuno mi aveva insegnato a scuola.
L’alpinismo non è soltanto sassi. Ci sono le vittorie e le sconfitte, le conquiste e le rinunce, il coraggio e la paura. La paura del vuoto. Ma davvero Manolo ha paura del vuoto?
Certamente – e per fortuna. Per quanta spavalderia e incoscienza io abbia messo nel fare ciò che ho fatto, ho sempre avuto paura delle montagne e del vuoto. Questo mi ha permesso di anteporre al mio protagonismo la responsabilità e il rispetto nei confronti della vita, degli altri e dell’ambiente naturale. Devo a queste paure la capacità di adattamento alle regole che la montagna mi ha imposto. Se non le rispetti, queste regole, non torni a casa. Il timore del vuoto mi ha costantemente accompagnato, mi ha fatto riflettere su ciò che facevo, mi ha insegnato ad accettare le sconfitte, mi ha dato la forza per andare avanti. La paura
del vuoto e della montagna mi ha costretto a ridimensionarmi. L’ambiente che ci circonda – dove ho praticato il mio alpinismo – è troppo grande e ci chiede rispetto. Dobbiamo entrarci in punta di piedi e sperare di uscirne vivi. «Sperare di uscirne». È solo questione di fortuna?
Sicuramente no, ma ci vuole anche quella. Occorrono tanto talento e tanta determinazione. Sono sopravvissuto perché ero bravo. Ma anche perché sono stato fortunato; una fortuna immensa, senza la quale non sarei qui a raccontare. Bravura e paura, talento e fortuna. Che rapporto hai con il superamento del limite?
Quando iniziai a scalare, qualcuno aveva posto il limite sul sesto grado. Nella mia ignoranza, mi domandavo chi mai potesse essere stato così arrogante da aver chiuso le possibilità umane in sei gradi. Si sentiva parlare di settimo grado, è vero, ma solo come qualche cosa di impossibile e di irraggiungibile. Dovevo provarci. Aspettare non era sufficiente. Bisognava fare per capire, fare per vedere, fare per scoprire nuovi orizzonti. Poi diventi sempre più bravo, aumenti il livello, ti poni obbiettivi sempre più grandi fino quando ti trovi a scalare sul settimo e poi sull’ottavo grado. Ecco fatto, avevo superato il limite. Ma i limiti continuano a cambiare. Quando li superi te ne ritrovi altri e
poi altri ancora. Oggi ci si è spinti molto oltre. Non avrei mai immaginato, quando ho cominciato ad arrampicare, di contribuire a spostare in avanti i limiti di questo sport, aprendo la strada a nuovi confini e nuovi scenari. E la paura del vuoto, l’hai più superata? Vincere la paura del vuoto è stata un’impresa enorme. Quando vincevo un piccolo vuoto ne trovavo un altro e un altro ancora. Ho lottato per questo fino a che, a un certo punto della mia vita, ci sono riuscito: ricordo esattamente quel momento, quando il vuoto diventò per me un punto di appoggio. Fu una cosa incredibile. Una presa d’atto e una presa di coscienza per me necessarie. Il vuoto era il posto dove volevo essere e dove volevo stare. Scalavo slegato e continuavo a farlo su qualsiasi difficoltà. Così raggiunsi l’apice. Che non è durato molto. Non potevo continuare a lungo. Infatti, poco dopo, il vuoto si è ripresentato a rimettermi paura e a restituirmi una misura, a farmi capire che non puoi arrampicare slegato, cadere e aprire le ali per non ammazzarti. Non funzionava così. Bisogna tornare ad avere paura, timore, usare la testa, saper rinunciare, mettere nello zaino la voglia di rientrare assieme a quella di partire. Arrivare in cima non significa niente se non riesci a tornare a casa. Mi resi conto, insomma, che il superamento del vuoto era stata un’esperienza li-
mitata nel tempo, dalla quale ero fortunatamente uscito vivo. Quando riapparvero le paure, le montagne tornarono a essere di nuovo grandi come prima, quando ero bambino. L’alpinismo è qualcosa di veramente impegnativo. Oggi devo ammetterlo, anche se un tempo non la pensavo così. E oggi, lo segui ancora questo sport? Non riesco a guardare il filmato di una persona che arrampica slegata nemmeno per un secondo. Anche se so come va a finire, che finisce bene, che lui non cade. Oggi non ci riesco. So quanto è delicata quella situazione. A volte, arrampicando
legato, mi si sono rotti appigli che non avrei mai pensato potessero saltare. Se sono vivo è perché, quel giorno, avevo la corda. Non voglio immaginare le cose che fanno oggi i migliori specialisti di questa disciplina, i limiti che superano, le difficoltà estreme. Al solo pensiero sento male alle dita, ai muscoli, alla testa. Sono pieno di acciacchi. Mi rendo conto che la carta di identità non mi permette più di fare certe cose. Ma non mi mancano, perché ho scalato tanto da non poterne più. Oggi sto bene. Non sono diventato un maniaco della scalata.
Giornalista e scrittore, esploratore e alpinista. Già responsabile delle pagine di cultura e spettacolo di la Repubblica, ha scritto per le più importanti riviste di cultura alpina. Spesso con gli sci, ha salito e disceso molte montagne del mondo, dall’Himalaya all’Africa, dalle Montagne Rocciose nordamericane alle Alpi Scandinave, compiendo anche la traversata di grandi ghiacciai. Per molti anni ha fatto parte del direttivo del Trento Film Festival.
Mi meravigliavo sempre, tornando a Trento, di non trovare scritto a chiare lettere sui cartelli stradali «città del Festival» (la lacuna è stata oggi colmata con la posa di una targa in largo Porta Nuova in occasione del 70° anniversario della rassegna). Lo dico perché quando sono in giro e dico che sono nato e ho vissuto a Trento diversi anni, immancabile arriva, se appena uno sa qualcosa di montagna, il riferimento alla seconda più antica rassegna cinematografica d’Italia, e la terza in Europa. Trento è mille cose, dallo spumante dei Lunelli all’orchestra Haydn, dal MUSE (Museo delle scienze) ai rimandi del Concilio e di un effervescente Sessantotto, dalla Società degli Alpinisti Tridentini (SAT) al Monte Bondone. Ma è soprattutto la sede di un Festival che vanta quasi 30 tentativi di imitazione, a contare solo i membri dell’International Alliance for Mountain Film. Trento è il Festival della montagna, e viceversa, anche prima che il nome della città subentrasse in primo piano nella sua denominazione. E dappertutto, dove il camminare e l’alpinismo e tutta una cultura delle terre alte sono patrimonio comune, si guarda quassù, poco oltre il 45o parallelo, per capirne le possibili evoluzioni.
Frequentare il Festival, anche senza lavorarci o averci collaborato, è sempre stato un passaporto nelle spedizioni verso qualche
montagna del mondo. Una sorta di certificazione che ti faceva accettare nelle comunità arrampicanti. Arrivi da lì e dunque qualcosa devi saperne. E magari c’è il caso che tu in cambio mi ospiti, se vengo a vedere le proiezioni, a viverlo, e mi fermo qualche giorno. Il Festival è stato per molti anni, finché sono sopravvissuti l’Unione Sovietica e il patto di Varsavia, una zona franca dove approdavano i formidabili himalaysti polacchi certi di trovare un porto sicuro – e magari anche uno sponsor per gli obiettivi a venire – o i climber dalla Boemia che estraevano dallo zaino, furtivi come si trattasse di diamanti da contrabbandare, le viti da ghiaccio forgiate con il titanio dell’industria missilistica russa. Le scambiavano al Mountain Shop (negozio di articoli sportivi della città) con qualche pezzo di attrezzatura da loro altrimenti introvabile, o più semplicemente con una stanza e un pranzo al ristorante.
Quando nel 1968 cinque personaggi che faranno molta strada nel mondo della montagna – tra loro, il fondatore di Patagonia Yvon Chouinard e quello di North Face Doug Tompkins – partono da Ventura, California, per raggiungere El Chaltén, Patagonia, su un cigolante furgone Ford, hanno solo una scadenza nel loro viaggio di ritorno: arrivare in tempo per partecipare al Festival di Trento con il film che racconta l’avventura e la salita
della via americana al Fitz Roy. Il regista Lito Tejada-Flores termina di montare appena in tempo Fitz Roy, First Ascent Of The South-West Buttress (Stati Uniti, 1969), per salire su un aereo e raggiungere trafelato l’Italia: vincerà il Gran premio dell’edizione 1969.
A metà anni ottanta chi arrivava da Trento era accolto come ospite d’onore alla bellissima e assai frequentata rassegna, tramontata purtroppo, che a San Sebastian veniva dedicata al cinema di montagna. E gli organizzatori facevano poi a gara per venire in Italia su una scassata Land Rover a consegnare le pizze dei film, nonostante per molti di loro una certa contiguità con gli indipendentisti baschi facesse rischiare ogni volta sequestri e qualche giorno di prigione, al passaggio del confine. Ma che importava? Si veniva dove era cominciato tutto, dove si era capito che i temi della montagna potevano diventare un evento di spettacolo e cultura fin dal lontano 1952 e anche per loro, gli alpinisti baschi, era l’esempio perfetto da imitare. Lo stesso accadeva a Banff, nella Columbia britannica, o a Telluride, in Colorado. Oggi succederebbe lo stesso a Kathmandu o Ushuaia, sedi di manifestazioni analoghe. Quel che ha sempre affascinato gli spettatori, qui, è l’intreccio tra cultura e azione. Dopo le proiezioni, la notte – un tempo davanti al Sociale, poi
al Santa Chiara – si allunga nella scelta di una meta per la gita scialpinistica, l’uscita in Dolomiti o, dagli anni Ottanta, le più vicine pareti di Arco e della Valle dei Laghi. Una cordata internazionale in perpetuo movimento tra le iniziative cittadine e le attività en plein air, fosse anche una ferrata o un’escursione sul Calisio.
«Necessità di Trento» titolavano nel marzo 1964 i Cahiers du Cinéma una corrispondenza di Luc Moullet, redattore della rivista di critica francese e poi regista con la passione per la montagna (l’articolo lo ha ritrovato Sergio Fant e ne ha fatto una bella copia anastatica in occasione della 70a edizione). Per quella che era stata la culla della nouvelle vague, palestra privilegiata delle teorizzazioni filmiche di Jean Luc Godard e François Truffaut, l’allora Festival Internazionale Film della Montagna e dell’Esplorazione «Città di Trento» valeva qualsiasi altra, ben più mediatizzata, rassegna internazionale. Moullet scriveva tra l’altro che «dal 1952 Trento organizza (…) una serie di proiezioni quasi esclusivamente serali che lascia tutto il tempo di verificare nel concreto quello che si è visto sullo schermo il giorno precedente: il primo pendio è a due chilometri da casa. (…) I festivalieri di Cannes o di Venezia non sono altrettanto fortunati: tuffarsi nell’Adriatico o nel Mediterraneo non li aiuta certo ad immergersi nell’atmosfera».
E Trento è sempre stata così. Quando arriva Tenzing, dopo la vittoria sull’Everest, Cesare Maestri lo porta in Paganella ad arrampicare (e la leggenda racconta che il “ragno delle Dolomiti” gli abbia insegnato uno slogan contro la Democrazia Cristiana, per salutare in vetta il sindaco Nilo Piccoli). D’altronde il primo Concorso Internazionale Cine-alpinistico CAI-FISI, nel settembre 1952, è nato non solo per l’alzata d’ingegno d’una congrega di cinefili, ma in occasione d’un congresso del Club Alpino Italiano (CAI), il 64o, che coincideva con l’80o anniversario della SAT. Uomini di montagna, dunque, e però senza dimenticare la storia della settima arte. È sempre stato un privilegio del Festival il recupero di pellicole dall’immenso magazzino del cinema dimenticato. Fin dall’inizio, con le retrospettive dedicate a Trenker, Fanck, Riefenstahl, Flaherty. E ancora i cartoon, rivalutati dalla direzione di Piero Zanotto ben prima che si riconoscesse alla cultura bassa la stessa valenza di quella alta, o i manifesti assai spesso firmati dai grandi maestri dell’illustrazione e del fumetto, fino a quello di Milo Manara del 2022, fortemente voluto dall’attuale presidente Mauro Leveghi e dalla direttrice Luana Bisesti (dopo un precedente, nel 1997, stritolato dalla censura). I western «nevosi» e più in generale ambientati in montagna, rivisitati dal direttore Gianluigi Bozza. E, nel corso del
tempo, le tante pellicole restaurate e musicate dal vivo, spesso in collaborazione con la Cineteca di Bologna e le Giornate del Cinema Muto di Pordenone.
Ma gli abitanti che per più di una settimana si trovano e si sono trovati la città invasa dai multicolori protagonisti delle cronache alpinistico-arrampicatorie (ma se riguardate le fotografie degli anni cinquanta e sessanta, erano tutti in giacca e cravatta), che feeling hanno avuto con questo mondo? E quale è stato il rapporto con le amministrazioni, gli organi d’informazione? Non sempre in perfetta sintonia, quest’ultimi. Talvolta in contraddizione, i primi. L’entusiasmo degli ospiti non ha sempre contagiato i locals. Il red carpet davanti alle sale non attira le folle. Yvonne Sanson, bellezza greca arrivata in città nel 1955 a presentare Il prigioniero della montagna (Flucht in die Dolomiten, Germania-Italia, 1955) con il regista Luis Trenker, ha attirato più gli obiettivi dei fotografi che gli sguardi dei passanti. E le altrettanto affascinanti star dell’arrampicata anni ottanta e novanta, da Catherine Destivelle a Lynn Hill e Isabelle Patissier, si sono sempre mosse nelle vie di Trento senza richieste di autografi né – se già fossero stati possibili - di selfie. A incontrare Messner ti davi di gomito, ché il suo volto è impossibile confonderlo, finito com’è sui cartoni del latte
e sui biglietti del tram. Ma già Bonatti nelle sue ultime apparizioni lo riconoscevano solo i più agée, quelli che ricordavano di averlo letto sulle pagine di Epoca. E di Manolo e Adam Ondra che parlano fitto a un tavolo del Pedavena – è accaduto più di una volta – si accorgevano in pochi, nonostante siano l’attualità e la storia dell’arrampicata, come si bevesse una birra di fianco a Usain Bolt e Marcell Jacobs. Trento è così, un understatement che a volte sconfina nella ruvidezza.
L’attenzione di quotidiani e periodici (dei commercianti anche, e di politica e amministrazioni), è spesso stata a corrente alternata. Evento internazionale per definizione, al Festival non sempre si è data l’attenzione dovuta. Questione di sensibilità giornalistica, talvolta: il riflesso sulle pagine è legato in gran parte alla presenza o meno in redazione di caporedattori, cronisti e collaboratori sensibili ai temi della montagna e dell’outdoor. È accaduto spesso che prima, dopo e durante si accendessero appassionate discussioni, a volte polemiche, su certe fughe in avanti della rassegna o sulla sua capacità d’essere testimone, a volte anticipatrice, del progresso nelle discipline della montagna (gli anni dell’artificiale e delle superdirettissime, la rivoluzione che arrivava dallo Yosemite, il cambio d’abito dell’himalaysmo, la nascita dell’arrampicata sportiva, le
gare…). E però in altre occasioni c’è stata grande disattenzione. Un esempio: il debutto di Ezio Bosso in regione risale al 2004, proprio al festival di Trento. Con Giacomo Agazzini e Stefano Genovese realizzò una composizione originale, frutto di mesi di lavoro, per musicare il rutilante Grass: a Nation’s Battle for Life (Stati Uniti, 1925), opera prima di Merian Cooper e Ernest Schoedsack,, futuri autori di King Kong (Stati Uniti, 1933). Ma a parte i fortunati spettatori di una serata indimenticabile, pochi se ne accorsero: i giornali locali gli dedicarono poche righe. Quando Bosso tornò, nel 2013
per i «Suoni delle Dolomiti», i titoli a piena pagina si sprecarono. Poco importa, il Festival è oltre e anche la città ha capito ormai quanto possa contare e quale ruolo possa avere nel futuro. Alberghi e ristoranti sono affollati in quei giorni, gli appuntamenti si distendono da una periferia all’altra, gli spettatori in sala arrivano da fuori come dalla cinta daziaria, senza più distinzioni. Hanno capito tutti che l’evento forse più antico di Trento – fatta salva la festa del patrono – ha radici più profonde, e contenuti, di qualsiasi altra invenzione degli ultimi decenni.
Oltre 80 film co-prodotti o sostenuti, con sponsorship o product-placement. Opere che hanno partecipato a festival, che in parte sono ora presenti su piattaforme o sul sito aziendale. E decine di altri film, serie e programmi tv sostenuti con fornitura di prodotti.
Più di 100 libri editi come Montura Editing o sostenuti da Montura, con oltre 250 mila copie distribuite gratuitamente in 20 anni, sempre in cambio di una donazione “libera e responsabile” a favore di progetti di solidarietà.
More than 80 films co-produced or funded through sponsorships or product placement. Films that have been featured at festivals, some of which are now available on the company website and various platforms. And dozens more films, series and TV programmes supported by the supply of products. montura.it
More than 100 books published by Montura Editing or backed by Montura, with over 250,000 copies distributed free of charge over 20 years, always in exchange for “free and responsible” donations to charity projects.
Montura Editing è il laboratorio creativo e la “casa editrice” di Montura, il brand italiano leader nell’abbigliamento e nelle calzature per la montagna e per l’outdoor. Nel corso degli anni l’azienda ha sviluppato un percorso di comunicazione originale, in linea con il motto “Searching for a new way”: sostegno alla produzione cinematografica e letteraria; edizione diretta di alcune opere; supporto di festival culturali, mostre d’arte, rassegne musicali. Di particolare significato è il sostegno allo sviluppo di alcuni luoghi di valore artistico ed ambientale. L’attività di Montura Editing si completa con alcuni interventi di solidarietà, a livello nazionale ed internazionale.


Decine di pubblicazioni tra libri e cataloghi, disponibili nei negozi o scaricabili gratuitamente dal sito. Dozens of books and catalogues available in stores or as free download from the website.

Più di 80 film co-prodotti e/o sostenuti in vario modo, vincitori di numerosi riconoscimenti. More than 80 films co-produced or backed in various ways and recipients of numerous awards.






Un’accurata rappresentazione del territorio per descrivere cammini, itinerari, percorsi di gara


Accurate representation of the territory in descriptions of trails, routes and competition courses.



Importanti progetti di solidarietà e cooperazione allo sviluppo in Nepal, Mongolia, Perù e Italia.


Major charity and development cooperation projects in Nepal, Mongolia, Peru and Italy.












Molteplici attività al sostegno dei giovani e di iniziative sociali e culturali: festival, concerti, mostre, teatro

Multiple youth support programmes and social and cultural initiatives: festivals, concerts, exhibitions, theatre

Il territorio e i luoghi d’eccellenza da conoscere e tutelare


The region and its outstanding places to know and protect.
 Finito di stampare nel mese di marzo 2023
Finito di stampare nel mese di marzo 2023
“I luoghi possono diventare significativi attraverso le relazioni sociali, ma i luoghi speciali aiutano a creare relazioni significative”.

 Edward Relph, geografo
Edward Relph, geografo
