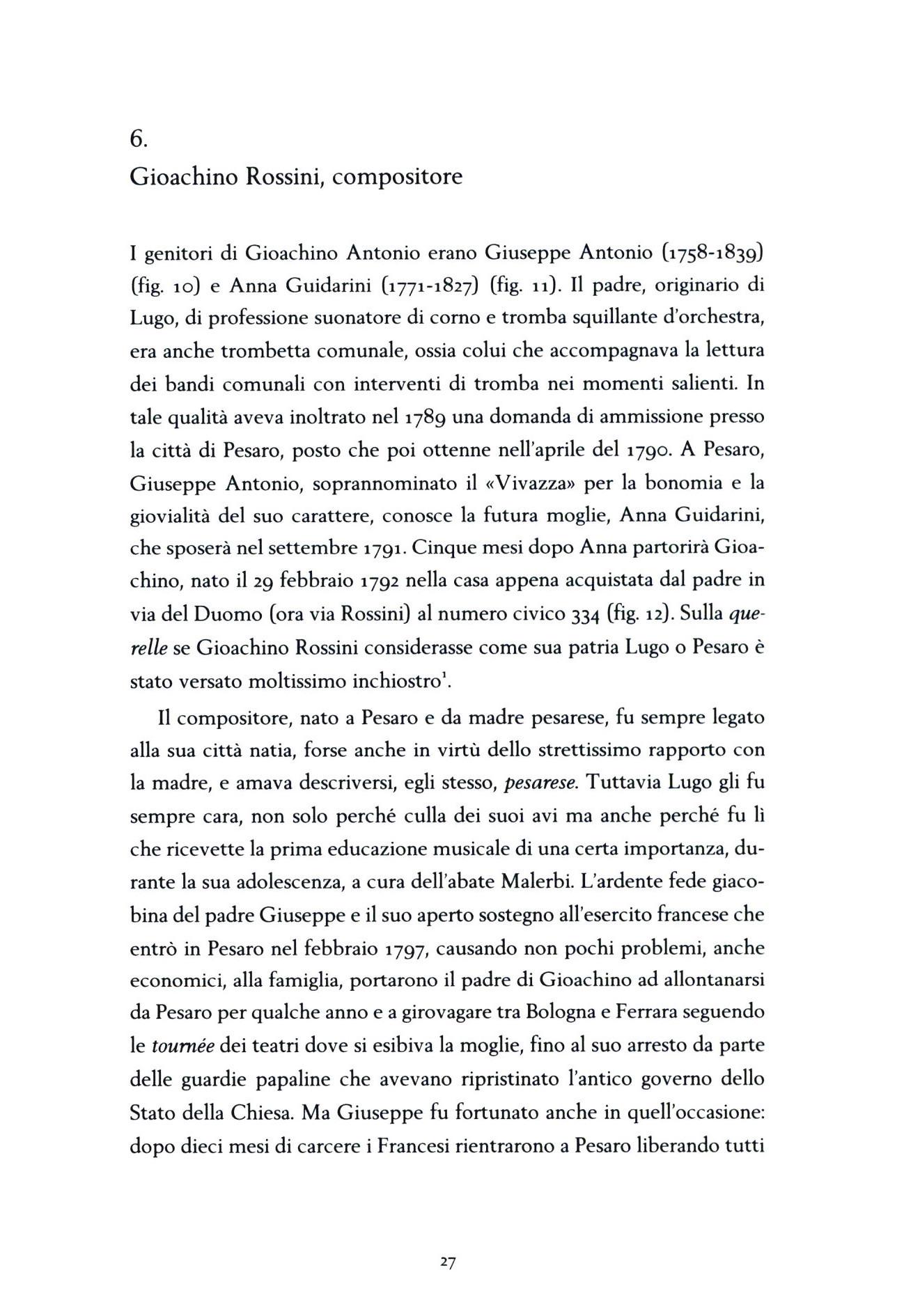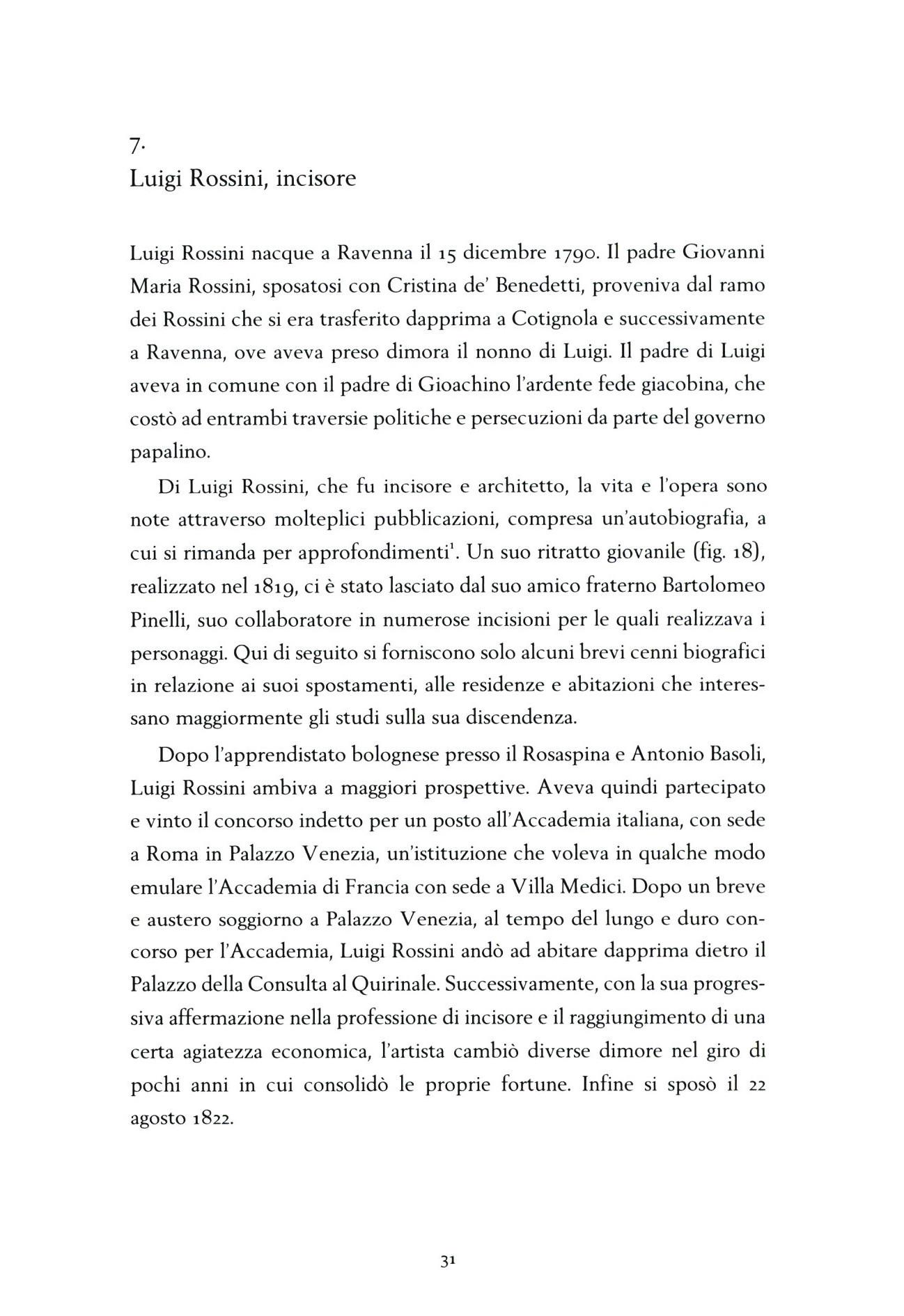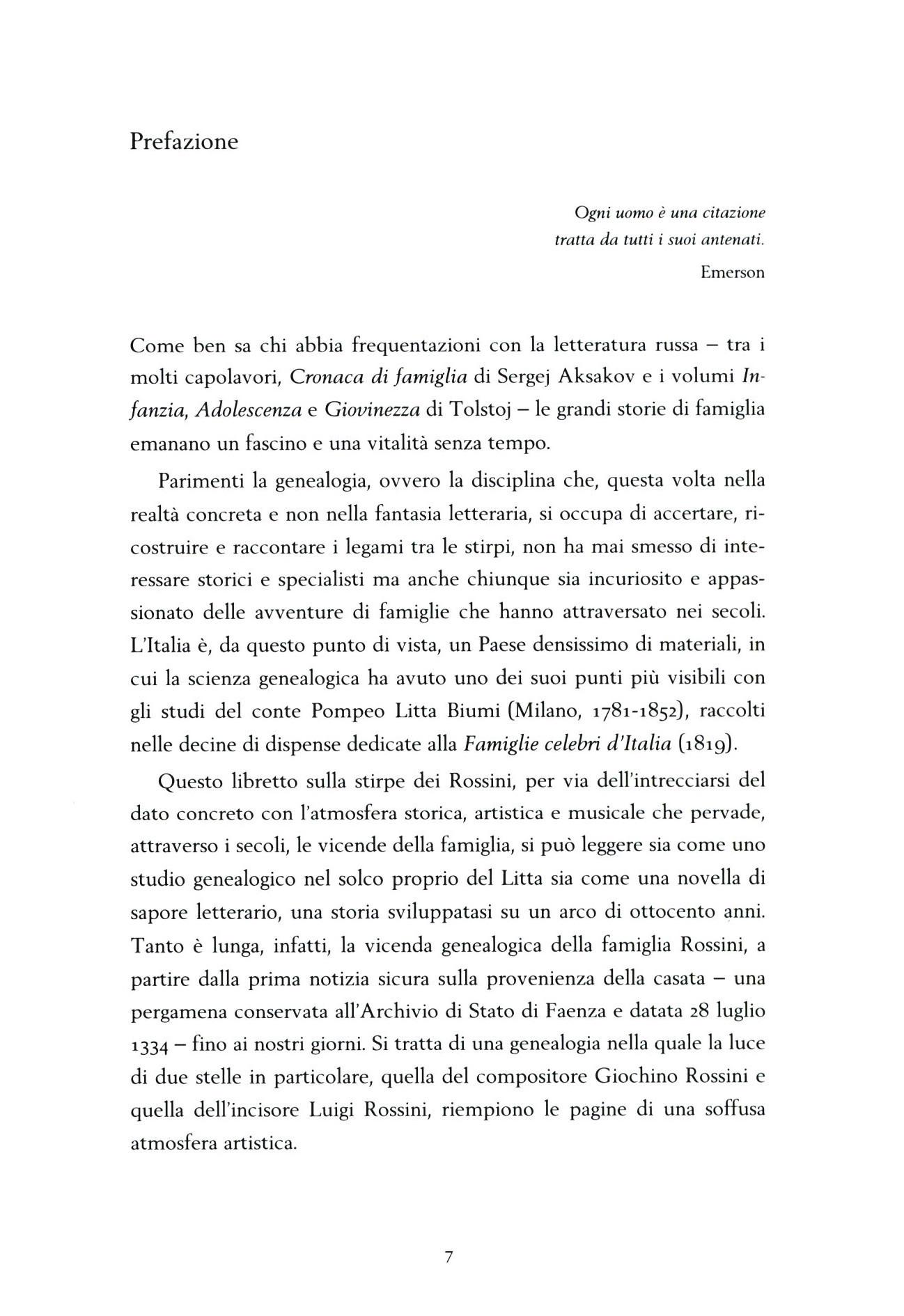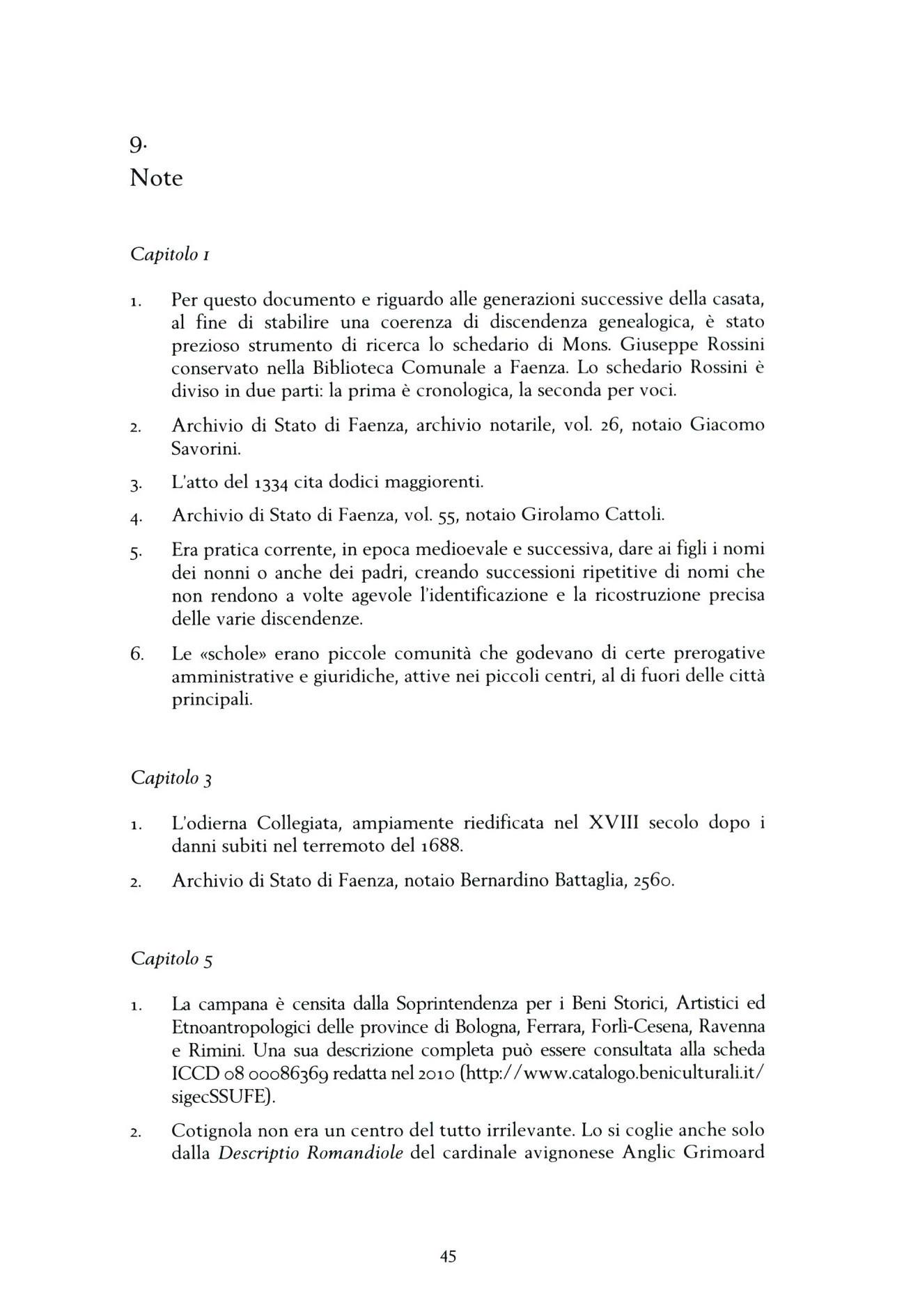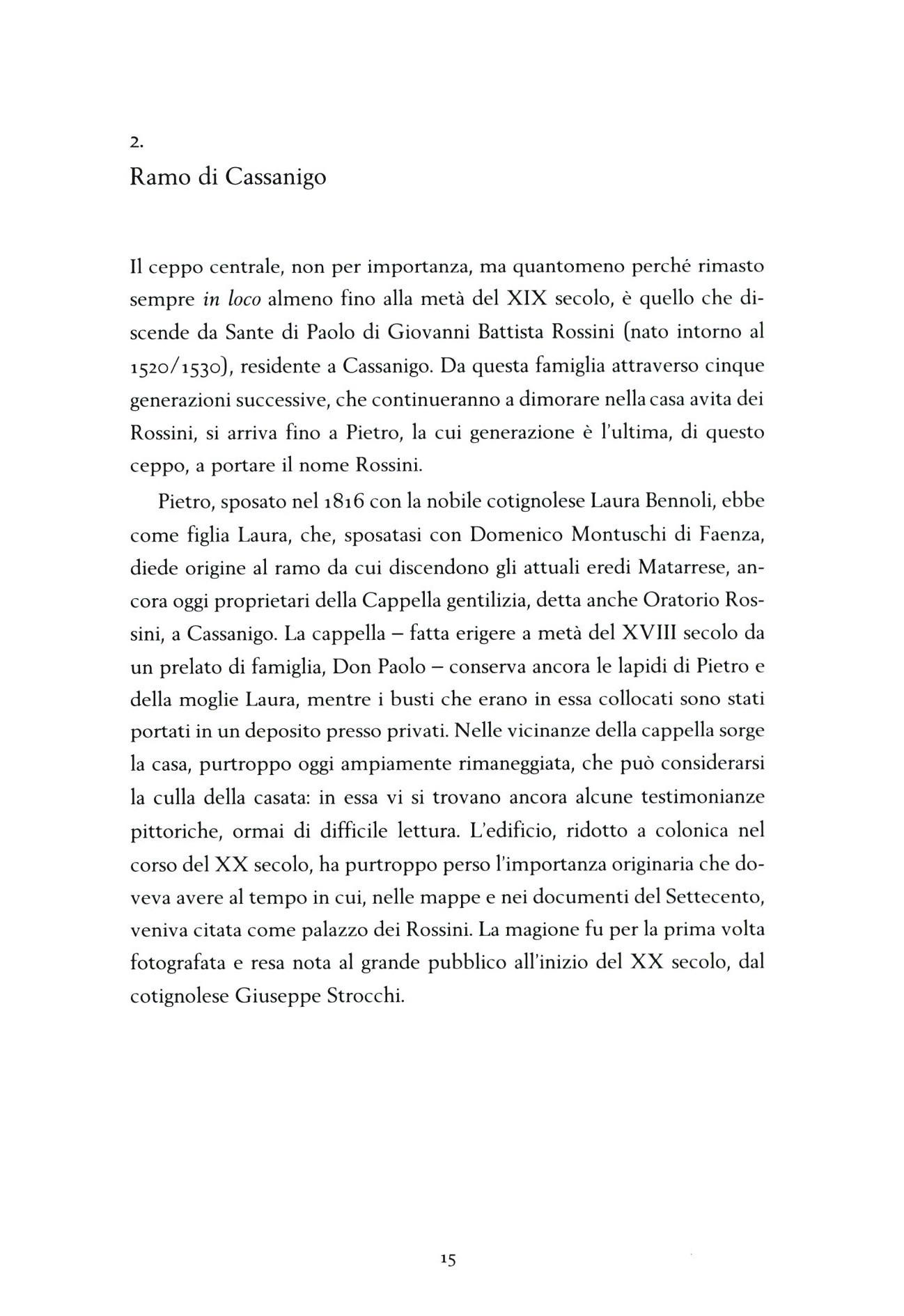8 minute read
8. Discendenza di Luigi Rossini
8. Discendenza di Luigi Rossini
Se dalla parte di Gioachino non si hanno discendenti diretti né prossimi indiretti, non avendo egli avuto né figli, né fratelli o sorelle, dalla parte di Luigi abbiamo invece una vasta discendenza solo in linea diretta, essendo i suoi numerosi fratelli e sorelle tutti morti alla nascita o in età infantile. L'incisore, vinto il concorso di architettura e aggiudicatosi il premio Canova dell'Accademia di San Luca, si stabilisce definitivamente a Roma, dove si sposa nel 1822 con Francesca Mazzoni (1795-1882) (fig. 24), figlia dello speziale di Genzano, dalla quale ebbe appunto sei figli, ai quali fu per tutta la vita legatissimo (fig. 25).
Molto probabilmente è in previsione del matrimonio che Luigi acquistò, con un acconto dato come dote dal futuro suocero, il grande immobile di via Felice (oggi via Sistina), dove nacquero tutti i suoi figli e dove impiantò il proprio studio e risiedette tutta la vita. Il primogenito Alessandro (del quale purtroppo non è stato possibile recuperare una foto), nato nel 1823 e divenuto, giovanissimo, ispettore delle Antichità pontificie, era il figlio nel quale il padre aveva riposto le maggiori speranze, destinate, però, a essere colpite da una sventura. Un incidente alla carrozza sulla quale Alessandro stava viaggiando di ritorno da un sopralluogo per effettuare dei rilievi al Mausoleo di Cecilia Metella gli causò un'infezione molto grave ad una gamba, portandolo a morte in pochi giorni, all'età di soli 31 anni nel 1851.
La secondogenita Cristina (7 marzo 1824-13 luglio 1895) (fig. 26) sposò il pittore Franz von Rohden (Roma, 1817-1903), figlio del pittore Johann Martin von Rohden (Kassel, 1776-Roma, 1868), uno dei più importanti paesaggisti tedeschi attivi a Roma tra la fine del XVIII e la prima metà del XIX secolo. Anche la sorella di Johann, Marianne V on Rohden, e sua figlia Susette Hauptmann erano pittrici, e di Susette è
giunto fino a noi il trittico che rappresenta tre generazioni di artisti Von Rohden (fig. 27).
Franz seguì il padre nell'attività pittorica. Rientrato in Italia dopo gli studi artistici in Germania, condotti ali' Accademia di Kassel dal 1827 al 1831, fu introdotto nell'ambiente nazareno e si avvicinò a J. A. Koch e poi a J. F.Overbeck, nel cui studio completò la propria formazione, non abbandonando più quell'indirizzo pittorico, tanto da essere considerato l'ultimo in ordine di tempo del gruppo dei pittori chiamati «Nazareni».
Dipinse importanti pale per le chiese di Sant' Antonio di Padova in via Merulana, di Santa Maria in Aracoeli, di Sant'Alfonso de' Liguori (1885) e del Sacro Cuore a Castro Pretorio, e la «Madonna con angeli» (1885) ora presso la Pinacoteca Vaticana. Un'«Immacolata Concezione» (1867) è conservata in una chiesa di Tuscania (Viterbo). Altre opere sono conservate in Germania e in Inghilterra, delle quali vanno ricordate in particolar modo la «Crucifixion of Our Lord with the Virgin Mary, St John and Mary Magdalene» (1854) all'Ushaw College (Durham).
Il nome «Nazareni» si riferisce a un gruppo di pittori tedeschi attivi a Roma. Ribelli al classicismo accademico, essi aspiravano ad un'arte rinnovata su basi religiose e patriottiche. La loro arte assunse negli anni un carattere arcaicizzante, con un forte accento lineare e un uso del colore crudo steso con pennellate uniformi. Il modello a cui si ispiravano i Nazareni era un preciso gruppo di artisti italiani del Quattrocento, da Beato Angelico a Filippo Lippi, da Luca Signorelli al Perugino, e soprattutto il primo Raffaello. Del loro stile i Nazareni tentarono una ricomposizione formale, quasi filologica. Altri artisti del gruppo si rifecero anche a Dtirer e all'antica pittura tedesca.
Franz e Cristina ebbero cinque figli: Raimondo (1847), Maria (1849) 1 Albert (1850-1924) 1 Carlo (1852) e Federico (1855). Di questi, Albert ebbe una figlia naturale dalla famosa pianista Giulia de Cousandrier (Roma, 1848-1933, sposata Cerasoli), alla quale era sentimentalmente le-

gato. Alla morte della musicista - che fu allieva di Franz Liszt e protagonista della scena musicale postunitaria a Roma - un'importante collezione di disegni di Johann Martin, di proprietà di Albert, rimase alla figlia naturale di Giulia e Albert, Margherita, sposata Contini, venendo in seguito esposti in varie mostre.
La terzogenita Michelina, nata il 12 maggio 1827, (fig. 28) era la figlia femmina più giovane e rimase più a lungo presso la casa paterna insieme ai genitori: aiutava infatti il padre nelle varie contabilità della casa e dello studio. Nel testamento viene menzionata come custode degli averi paterni e a lei viene destinata in dote la cospicua somma di 4000 scudi, ossia il doppio di quella destinata alla sorella Cristina. A vendo Michelina dedicato la propria giovinezza alla famiglia, il padre si preoccupò di assegnarle una dote più importante, affinché non avesse problemi dopo la sua morte, anche per trovare marito. Michelina, infatti, si sposerà con Antonio Graziali e il 10 novembre 1861 avrà un figlio, Raffaele. La loro casa è in via Belsiana ma dopo la morte prematura del marito Michelina ed il figlio tornano alla casa paterna in Via Sistina, a vivere con il fratello Filippo, che non si era sposato e che in precedenza aveva abitato in via della Vetrina. Anche la mamma Francesca, dopo la morte del marito Luigi, si trasferisce nell'appartamento di Filippo, un'abitazione dotata di ingresso laterale su via dei Cappuccini al numero 9, lasciando il grande appartamento dove aveva vissuto con la famiglia e i sei figli al secondo piano di via Sistina.
Il quartogenito Filippo, nato il 1 agosto 18281 fu pittore. Di lui ricordiamo un pregevole ritratto del padre, in età matura, conservato presso l'Accademia di San Luca (fig. 29). Recentemente è stato ritrovato un altro ritratto di Luigi, inedito, dove appare ritratto con i baffi, del pittore belga Alexandre Robert (1817-1890) (fig. 30). A Filippo il padre destinò in lascito la sua importante biblioteca con le stampe, i quadri e gli altri oggetti da lui raccolti, definiti nel testamento «museo universale». Filippo non si sposò e non ebbe discendenza.

Gli ultimi due figli di Luigi, entrambi maschi, Teofilo e Narsete, risulteranno i più prolifici e la loro discendenza continua fino ad oggi.
8.1. Ramo di Narsete
Narsete, penultimo figlio di Luigi e Francesca Mazzoni, fu battezzato nella parrocchia dei SS. Vincenzo ed Anastasio a Trevi il 31 maggio 1832 (fig. 31) e cresimato il 30 ottobre 18431 occasione in cui gli fece da padrino il fratello Alessandro Rossini. Narsete dovette essere ben considerato dal padre se nel suo testamento quest'ultimo gli assegnò in lascito il palazzo di via della Vetrina, acquistato dall'incisore dai marchesi Tanari e dal principe Spada come investimento al prezzo di 6.000 scudi.
In un appunto manoscritto tra le carte di famiglia che ci sono pervenute si trova la menzione che Narsete era «il più bello di tutti» e probabilmente la bellezza dovette fargli gioco, dato che Narsete sposò Luigia Spadoni una donna di notevole avvenenza della quale abbiamo un ritratto ad olio a figura intera di pregevole fattura. In esso è ritratta in un elegante abito di gala e con indosso importanti gioielli (fig. 32). Il quadro si trova tuttora presso il nipote di Narsete, Mario Rossini, nell'appartamento che pervenne per divisione ereditaria a suo padre Riccardo, figlio di Narsete.

Si tramanda in famiglia un aneddoto secondo cui l'autore del quadro si fosse innamorato della bellissima fanciulla e che, scoperto a non lesinarle le sue attenzioni, venisse cacciato dalla dimora patrizia lasciando il quadro parzialmente incompiuto. La storia potrebbe non essere priva di fondamento, come si nota dal particolare della mano destra guantata della fanciulla lasciata incompleta.
Luigia Spadoni fu battezzata il 31 maggio 1844 nella Chiesa di SS. Salvatore in Lauro e cresimata il 2 maggio 1852. Le fu madrina Anna Delfini. Era la sola figlia di Antonio Spadoni, di Ancona, e di Agata Paradisi, di Roma, che risultano essere inquilini dello stabile di proprietà Rossini in Via della Vetrina, abitanti al quarto piano. In questo contesto,
probabilmente, Narsete conobbe la bella fanciulla. I due si sposarono il 12 gennaio 1861 ed ebbero sette figli, tre maschi e quattro femmine, continuando ad abitare sempre al quarto piano (fig. 33).
Gli ultimi due figli, Cristina e Guido non hanno avuto discendenza. Delle figlie femmine, la maggiore, Emma (1870) sposò Paolo Marulli; Elvira (1872) si sposò con Ernesto Khiestaller, mentre Enrica (1874) si congiunse a nozze con Uberto Meriggiali. Tutte hanno avuto figli con una discendenza che prosegue ai nostri giorni.
Elvira (fig.34)1 sposò un ufficiale delle armi pontificie, Ernesto Khiestaller, figlio di Carlo (Fig. 35) 1 la cui famiglia era originaria della Baviera o forse dell'Austria, zone che tradizionalmente fornivano personale all'esercito e all'amministrazione pontificia. Purtroppo Ernesto venne presto a mancare, lasciando sola Elvira con l'unico figlio, Lamberto. Fortunatamente i due poterono contare sull'affetto delle sorelle di Elvira, e in particolare di Emma e dei suoi figli con i quali avevano trascorso insieme alcune estati nella loro villa di Grottammare presso Ancona.
Ma le preoccupazioni per Elvira non erano finite; Lamberto, sebbene «figlio unico di madre vedova», fu uno dei giovani tenenti richiamati per la Grande Guerra, arruolatosi come sottotenente e disperso sull'altipiano della Marcesina, battaglia per la quale venne insignito della medaglia di Bronzo alla memoria. Possiamo immaginare in questo contesto quali siano state le angosce di Elvira e la gioia finale nel vedere il figliolo ritornare a casa dopo la fine del conflitto. Lamberto conobbe quindi, e poi sposò, Anita, figlia - il nome è eloquente -del garibaldino Ernesto Ariani. Ernesto, fiorentino, era fuggito di casa ancora minorenne per arruolarsi con Garibaldi: tanta era la sua passione per la causa che mentì persino sulla propria età durante il reclutamento. Anita e Lamberto si sposarono negli anni Venti ed ebbero una sola figlia, Anna Maria, che la nonna Elvira, grande appassionata di cinema e collezionista dei rotocalchi cinematografici dell'epoca, portava tutti i giovedì ad assistere a una