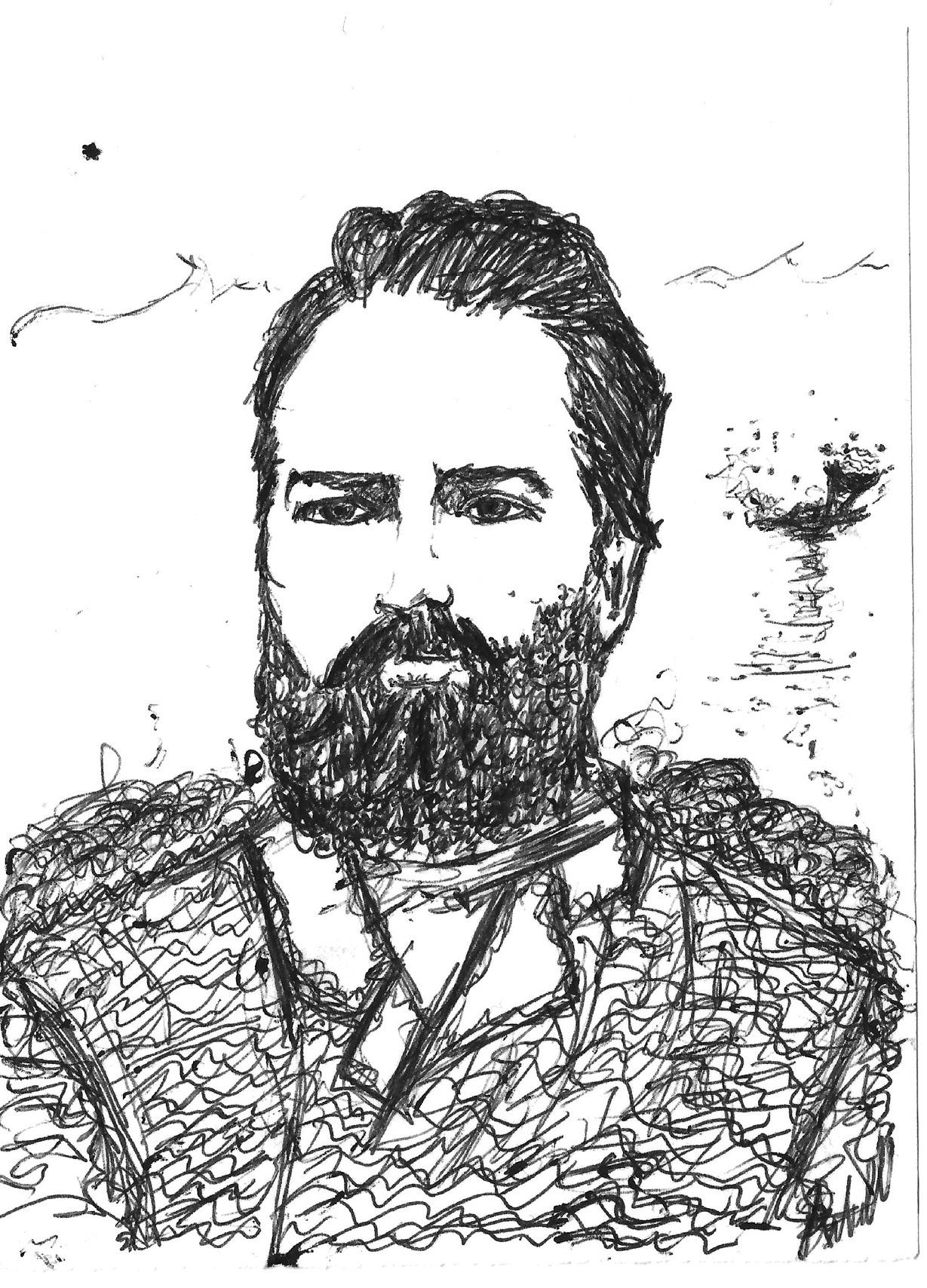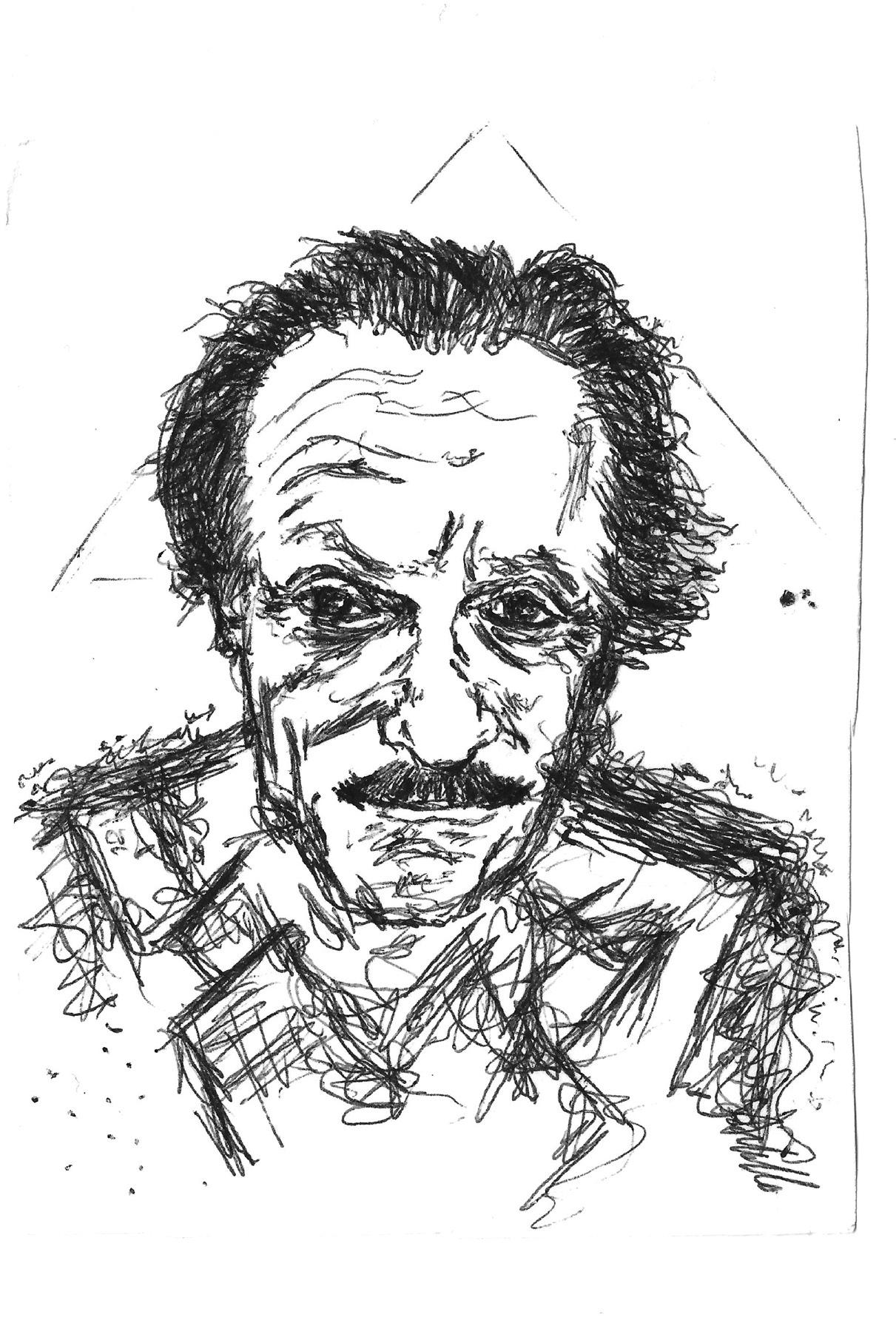KAFKA NON L’AVREBBE MAI FATTO
Sogni con uomini e donne straordinari
1
Jacques Lacan
Lacan è nel suo studio, è seduto su una enorme poltrona di pelle verde che sembra respingerlo più che accoglierlo. Noi riusciamo a vedere anche quello che sta scrivendo su un enorme quaderno marrone scuro, non ha mai usato taccuini, anche se tutti hanno sempre detto il contrario. Noi riusciamo a leggere le frasi seguenti “Giunge alla nostra osservazione il 12/5, sbaglia per tre volte il palazzo, si siede sul marciapiede e comincia a regalare pacchi di caramelle agli astanti. Nonostante la temperatura mite, o forse proprio per quello, indossa una pesante giacca di fustagno marrone scuro, maglione ocra a collo alto, gilet di pelliccia di castoro, cappello di pelo e mantella di cotone ignifugo. Un paio di occhiali a specchio da elicotterista romeno, parole sue, completano il quadro. Beve 7 caffè freddi che chiede di travasare in un decanter di acciaio, che porta con sé legato alla schiena. Diffusa presenza di tic primari, movimento incontrollato dell’astragalo, un tatuaggio posticcio a forma di tacchino sul mento. Concordiamo l’inizio di un percorso terapeutico. prima di uscire estrae dalla tasca della giacca una fetta di fontina e la lascia cadere sulla scrivania. Giunge alla nostra osservazione il 24/6, sbaglia per due volte lo stabile, infrange con la testa la vetrina di un ristorante cinese. Entra in studio con un uramaki al sesamo appeso all’orecchio destro. Denota una singolare iperattività psicomotoria, compulsa con frenesia il cellulare, chiede un caffè con nove bicchieri d’acqua. Rimane in silenzio per una decina di minuti, accavalla e disaccavalla le gambe seguendo una sua persona-
lissima coreografia mentale. Episodi di derealizzazione, si vede come “un granchio che su uno scoglio tenta di afferrare l’infinito e ha voglia di una birra”. Lamenta che il tema è un altro ma non specifica di quale tema si tratti. Lancia delle freccette immaginarie contro un bersaglio immaginario urlando MENO MENO. Arrovescia gli occhi prima di parlare; dal torace emergono sessantasette fili colorati, la carcassa di un tacchino, delle matite colorate. Curiosamente ha un paio di occhiali sulla schiena. Si decide l’inizio di un ciclo di sedute terapeutiche con, per il momento, una modesta assunzione di agrifoglio in barrette. Uscendo dallo studio svelle la porta dai cardini e si giustifica dicendo che è povero e che a casa la utilizzerà come tavolo da pranzo. Da rivedere con urgenza. Paziente seguito personalmente da un semestre. Ingegno brillante, con saltuari tratti di ipervigilanza, ipotonia vagale derivante da assunzione di pinoli tostati come snack. Si presenta alla nostra osservazione con un occhio giallo e un orecchio verde, il destro. Al collo ha sette macchine fotografiche, sei delle quali prive di obiettivo: la settima, gialla, è di legno. Fotografa la maniglia della porta sostenendo che la macchina fotografica che sta usando è stata fatta a Nervi e non ha bisogno di obiettivo. Parla diffusamente di una condizione di disagio derivante da una sconfitta subita a ping pong nel luglio del 1987, pare per eccesso di scorrettezze da parte dell’avversario. Rappresenta il desiderio di tingersi i capelli di blu e di usare della colatura di alici per deodorare le parti intime, usanza, lui dice, tipica dei popoli amerindi, di cui si ritiene uno dei massimi cultori liguri. Si inizia una terapia farmacologica a base di suppose di passiflora e crema di asparagi.
Preso in carico il 12/5, ritorna alla Nostra osservazione in data odierna. Tono dell’umore migliorato, leggera disti-
mia ipovagale, afferra delle inesistenti lucciole che sostiene volteggiargli davanti senza ucciderle: non visto, finge di inghiottirle repentinamente. Indossa un loden verde dal collo di pelo di foca per ripararsi dal vento di origine baltica che è sceso in questi giorni (parole sue). Invitato a sedersi, preferisce restare in piedi per proseguire i suoi esercizi di contrazione dei glutei. Ha con sé uno zaino giallo, capacità cinquantasei litri, dal quale estrae due torroni, quattro fette di pandoro, un panettone Motta, un tronchetto della felicità vaniglia e pistacchio mangiato a metà, delle caramelle gommose al rabarbaro, sette paia di occhiali da sole, un costume da spiaggia con vistose applicazioni in cashmere, tre barbe finte, un paio di cuffie da alta montagna, 6 sciarpe, un cappotto in finta pelliccia di lapin, 5 paia di stivali texani di produzione cipriota, un flauto traverso rotto, un pettine. Rimette tutto a posto e mangia le gommose al rabarbaro dopo essersi messo la cuffia. Si prescrive un blando ansiolitico in supposte da 65 mg. Riaggiorniamo la seduta. Prima di uscire butta nel vaso di fiori una rana, che aveva tenuto in tasca per tutto il tempo.
Torna alla nostra attenzione dopo un lungo periodo di latenza da lui trascorso, dice, in Bassa Sassonia ad allevare tortore da riporto. Alla nostra osservazione relativa alla possibilità molto elevata che le tortore da riporto non esistono scuote la testa, che osserviamo essere molto piccola e dalla curiosa forma a triangolo isoscele e dice ad alta voce IN SASSONIA È PIENO DI TORTORE DA RIPORTO. SE LEI NON SI MUOVE MAI DALLO STUDIO NON È COLPA MIA.
Alla fine richiude il taccuino che non è un taccuino e si accende un sigaro, mentre afferra un libro dalla copertina rossa, ma il fatto fondamentale è stato che noi siamo riusciti a leggere tutto.
Ho sognato Dio. Era molto gentile, molto alto, molto luminoso. Sembrava indaffarato. Mi ha detto di non prenderla sul personale ma che era molto impegnato, e che doveva andare via. Mi ha suggerito una dieta povera di grassi e ricca di fibre. Era abbronzato. Molto abbronzato, forse troppo, ma non mi era sembrato opportuno dirglielo, in quanto Dio.
A un certo punto si è alzato per poi risedersi subito, sono ovunque e comunque, non ho bisogno di andare in nessun posto per essere in quel posto, quindi non ho alcun bisogno di alzarmi da questa sedia. In quanto Dio, i miei bisogni esistono solo se voi li avvertite, se no non ci sono.
Proclo. Forse a Costantinopoli, ma non ne sono sicuro, nei sogni i contorni delle persone sono slabbrati e i nomi della città sono coperti dai contorni slabbrati, quindi non posso esserne del tutto sicuro. Era una città, c’erano delle strade e dei carretti, questo signore con una barba molto lunga era seduto su un carrello e stava scrivendo. Gli ho chiesto il nome di una via che adesso non mi ricordo più, è strano che abbia chiesto a questa persona che non conoscevo il nome di una via di una città che non conoscevo, è stato molto gentile e mi ha detto “Strano che tu mi chieda il nome di una via di una città che non conosci, ma sono cose che possono succedere. Questa città è Atene, io mi chiamo Proclo Licio Diacono, dirigo l’Accademia di Atene, e so già quando morirò, il 17 aprile del 485. Tu non lo sai, quindi vivi leggero, cammina molto, guarda spesso il cielo e non raccogliere i fiori, perché è come se li uccidessi.”
Con un cenno del capo mi ha salutato e si è avviato dalla parte opposta rispetto alla mia. Poco dopo mi sono svegliato, ho guardato il cielo e ho versato molta acqua alla base del vaso di Nelumbo nucifera vicino alla finestra, augurandole una buona giornata.
4
Charles Darwin e Senofonte
Darwin era sdraiato sull’erba davanti a un cottage col tetto di paglia e le pareti rosa, tre pareti rosa e una rossa, forse le pareti erano originariamente tutte rosse e il sole dello Shropshire, dopo tre secoli, le aveva scolorite fino a farle diventare rosa. Charles Darwin era disteso tra due alberi, parzialmente coperto dalle foglie, e stava fissando con intensità dei fili d’erba, vicini a lui. Sapevo per antica e ormai consunta esperienza che sarebbe meglio evitare di disturbare chi osserva dei fili d’erba così da vicino ma ero pur sempre in un sogno, il mio sogno, e sentivo di potermi prendere delle libertà sconosciute alla vita di chi non sta dormendo. Ma non sapevo che Darwin era collerico, molto collerico, e all’arrivo di Senofonte ho deciso di svegliarmi, Darwin e Senofonte nello stesso sogno era troppo anche per me.
Bertolt Brecht
C’era Brecht in fondo a una strada, non sapevo come facevo a sapere che fosse Brecht ma lo sapevo, in qualche modo lo avvertivo, sapevo che quella persona in fondo alla strada era Brecht e che era uno che scriveva, di solito commedie, e immaginavo che fosse in fondo a quella strada perché passare la propria vita a una scrivania a scrivere parole che poi diventano frasi, più o meno complesse, tutto il giorno, tutti i giorni, fosse una attività sfiancante, una cosa che ti divora lentamente il cervello, un a tenia che era appostata sulla sella turcica, che avrebbe usato come scivolo. Nel sogno il mio pensiero era questo, era un pensiero sdoppiato, aveva un dito che puntava verso Brecht, in fondo alla strada, e un secondo dito che mi toccava la tempia e mi faceva pensare alla mia sella turcica, che doveva essere senza tenia o piccioni o altri animali perché io, in quel momento, non stavo pensando a niente. Volevo, però, fare qualcosa, in quel sogno, e ho deciso di avvicinarmi alla persona che sapevo essere Brecht e ho deciso di chiedergli cosa stesse facendo, in piedi, in fondo alla via, il tutto usando il linguaggio universale dei sogni, metà polacco e metà ungherese.
“Sono uscito a prendere un gelato al pistacchio”, mi rispose Brecht, con un forte accento francese.
Graham Greene I
Era su una spiaggia in giacca. Fumava. Non sapevo cosa chiedere a uno che fuma in giacca in spiaggia. Sotto indossava un paio di pantaloni corti gialli. Dopo aver visto i pantaloni mi sono svegliato. Poi mi sono riaddormentato, per essere certo che i pantaloni fossero veramente gialli e non bianchi, ad esempio. Se c’è una cosa che nei sogni non funziona molto bene sono i colori, che sono sempre molto diversi da come appaiono da sveglio. La veglia definisce, il sonno slabbra. Da sempre. Anche nel caso dei pantaloni di Graham Greene.
Benny Goodman
Non tutti i clarinetti vanno a vapore, quello di Benny Goodman sì. I clarinetti a vapore non si differenziano dagli altri che per poche, trascurabili inezie ma è nelle inezie che si nascondono i diavoli, e quindi dobbiamo osservarle con attenzione. Il clarinetto a vapore emetterà sbuffi laterali a intervalli sapientemente irregolari, in modo tale da ingenerare confusione e senso di crescente fastidio nell’ascoltatore, fino al punto da condurlo a una specie di stordimento dei sensi, che verrà risolto non appena il vapore sparirà, essendo controllato con perizia consumata dal clarinettista. Si distingueranno nettamente tre tipi diversi di sbuffi di vapore, ossia uno sbuffo basso, uno medio e uno acuto. Lo sbuffo basso ha la caratteristica di durare più a lungo di tutti gli altri, si accende e prenda vita soprattutto quando il clarinettista avverte il desiderio insopprimibile di aggiungere vita alla sua interpretazione, e considera questo sbuffo basso un elemento propulsore della sua creatività: essendo però ad oggi ancora incomprensibile il significato di elemento propulsore, molti clarinettisti si tengono lontani da questa variabile pericolosa, non ben definita, ancora inserita nell’alveo dell’ignoto, e preferiscono usare un più comodo sbuffo medio. Lo sbuffo medio può essere usato sia in ambiente chiuso che aperto, molto utile nella musica da camera soprattutto quando chi dice che dirà due parole prima del concerto avrà già parlato per cinquantasei minuti e emessi 78.976 parole; in queste situazioni un robusto, centrato sbuffo medio porterà l’orrendo individuo affetto da logorrea sulla terra, dove ver-
rà prima denudato e poi cosparso di pece. In ambienti aperti lo sbuffo medio potrà essere motivo di sorpresa per grandi, piccini e medi, ossia uomini o donne di altezza compresa tra il metro e ventitré centimetri e il metro e settantaquattro centimetri. Come elemento di ricchezza interpretativa se ne consiglia l’utilizzo nelle Elegie, pezzi notoriamente mortali, e nelle trascrizioni di brani operistici, che conducono gli ascoltatori a un distacco dal proprio corpo e a un inizio di derealizzazione psichica. Lo sbuffo acuto è territorio infido, appannaggio esclusivo dei virtuosi dello strumento, soprattutto se biondi senza barba. Vera prova di forza che tenta di trascendere le caratteristiche tecniche dello strumento, che pure sono molto ampie, può ricordare il suono delle buccine romane, che venivano regolarmente distrutte dai legionari a cui capitavano sotto le mani; essendoci oggi una relativa penuria di legionari possiamo affermare come lo sbuffo acuto sia invece di straordinaria utilità in ambito agricolo, laddove la collocazione di un clarinettista particolarmente versato in questa tecnica può aumentare in modo sensibile la presenza di uova fresche rilasciate sul terreno da galline terrorizzate dal suono. Molto usato da Hindemith che non era una gallina. Esisterebbe, e il condizionale è d’obbligo, uno sbuffo intermedio, che si situa tra quello basso e quello acuto, ma come tutte le cose intermedie viene poco praticato perché guardato con ingiustificato sospetto. Non che esso non abbia la ventura di avere conosciuto il brivido pertinace dell’esistere, ma l’intermedio non viene praticato se non in pochi, controllatissimi casi. Collocato in una zona di tregua uditiva, l’intermedio non funziona per chi abbia in uggia il sovracuto proprio in quanto intermedio, cioè non completamente espresso, né incontrerà i favori di chi abbia in pancia l’amore per i suoni gravi perché essi sono, appunto, inter-
medi: c’è però una grazia sottile nel suono mediano, come quella di un pascolo con ancora poche mucche, che deve essere sorvegliata con attenzione, perché è possibile che le mucche possano aumentare. Il suono mediano non venga mai confuso col suono mediocre, che è cosa ben diversa, quasi antitetica, se non si avesse paura di scrivere antitetica. Questo è quello che mi è apparso nel sogno dei clarinetti a vapore, che erano più di uno. Benny Goodman ha tenuto lo smoking per tutto il tempo.
Piersandro Pallavicini
Viaggio tranquillo, poca gente, un paio di orette, non ore, per il professor P. le ore erano solo quelle di lavoro, quando non era in università le ore diventavano orette, e il lucido aeromobile con scritto British Airways sulle fiancate atterrava a Heathrow in perfetto orario. Piccolo bagaglio a mano, un impermeabile appoggiato con disinvoltura consumata sul braccio destro, all’altezza della articolazione del gomito, come aveva sempre visto fare a David Niven, scarpe non completamente lucide ma con piccoli aloni opachi all’altezza delle caviglie, calze rosse con piccole aragoste gialle, occhiali da sole dalla montatura in finta tartaruga, il professor P. era pronto a salire sulla metro per Londra quando, improvvisamente, la borsa in vitellino spazzolato cominciò a gonfiarsi, a sibilare, sfuggì dalle mani di un professor P. terrorizzato, volò in alto, rimase in aria per una decina di minuti, e quando atterrò non c’era più la borsa ma al suo posto era apparso un fenicottero gonfiabile rosa, altro circa due metri. “Devo aver preso la borsa sbagliata” pensò il professore, prima di svenire, con eleganza, su un divanetto in sala d’attesa.
Quando si riprese, un paio di minuti dopo, aveva entrambi i polsi tra le mani di due persone, un uomo e una donna: l’uomo era un dentista madrileno che avrebbe poi scoperto chiamarsi Miguel, una fantasia sfrenata per i nomi devono avere a Madrid, pensò il professore, mentre al termine del braccio che finiva con il polso femminile c’era Renate, tedesca, oftalmologa in viaggio per lavoro. “Anche gli
oftalmologi viaggiano” pensava il professore. Dietro di loro si intravedeva una sagoma rosa, era ancora lì, era il fenicottero, stavolta il professore riuscì a resistere al successivo mancamento.
«NON È MIO, non capisco che cosa possa essere successo ma non è MIO»
«Ma non si preoccupi» disse in un italiano quasi perfetto ma dalla strana cadenza veneta il dentista madrileno «no deve preoccuparsi, su, non è un problema. Tutti abbiamo bisogno di qualcosa che ci sostenga, la vida es complicata.
Lei sembra una persona molto impegnata sì? Un professore, sembra. Sono uscite alcune carte col suo nome sopra, con degli articoli scientifici».
«Carte?» disse con una voce ancora timida il professore “carte?”
«Sì carte nel senso di papers, in inglese si capisce meglio, articoli scientifici, sono dentista e non ho capito quasi niente ma sembrano formule chimiche. Comunque non deve preoccuparsi, le abbiamo recuperate tutte io e questa signora. Sono tutte sistemate sotto il culo del fenicottero».
La testa del professor P. si girò verso il viso della oftalmologa tedesca, se gli avessero detto solo 24 ore prima che si sarebbe trovato seduto sul divanetto di una sala di attesa dell’aeroporto di Heathrow insieme a un dentista spagnolo e a una oftalmologa tedesca impegnato a cercare di spiegare disperatamente che quel fenicottero rosa alto due metri non era suo non ci avrebbe mai creduto, ma la realtà come spesso accade supera anche i nostri sogni, in questo caso incubi, più arditi, ed era proprio lì, tra uno spagnolo, una tedesca e un fenicottero rosa.
La tedesca non parlava, fissava prima lui e poi il fenicottero e poi ancora lui con un viso sul quale il disprezzo
lottava con la sorpresa, e con un movimento della mano che forse significava Tutto bene, ora me ne vado disegnava dei piccolo cerchi davanti a sé. Miguel, il dentista, si era rimesso lo giacca e stava andando verso la banchina della metro. «Tutto a posto, si è ripreso, del resto con i fenicotteri non si scherza, si sarà spaventato» disse con un osceno, così parve al professor P., movimento dello zigomo destro, e dopo avergli stretto con forza la mano era già sparito. La tedesca si era smaterializzata, era passata da uno stato fisico a uno plasmatico, l’unico che era rimasto al suo posto era il fenicottero. Deciso a uscire da quella situazione non tanto spiacevole quanto folle, e continuando a chiedersi cosa ci facesse un fenicottero gonfiabile nella sua borsa di vitellino, in mezzo ai suoi lavori scientifici, e continuando a ripetere a sé stesso, come in un mantra QUESTO FENICOTTERO ROSA NON È MIO, NON HO NIENTE CONTRO I FENICOTTERI ROSA
MA QUESTO NON E’ MIO E SE LO FOSSE LO AVREI ALMENO SCELTO BLU, si sistemò, si rialzò dal divanetto come se nulla fosse, tolse i suoi lavori scientifici da sotto il culo del fenicottero, preso l’animale di gomma per il becco, attraversò l’atrio seguito dallo sguardo tra il sorpreso e il preoccupato di due agenti di polizia, e si diresse ai bagni. Qui giunto, estrasse un mazzo di chiavi, prese quella a stella della baita di St. Moritz, si era sempre chiesto cosa farsene di una baita a St. Moritz e ora lo capì, impugnando la chiave a stella cercò la giugulare del fenicottero di gomma, la colpì con fredda determinazione, il fenicottero si sgonfiò e cadde tra le sue braccia, proprio mentre una comitiva di olandesi entravano nei bagni. Visto il professor P. con tra le gambe la pelle di un fenicottero, rosa, di due metri, gli olandesi fecero quello che fanno sempre gli olandesi, mangiarono una aringa e lo salutarono.
Qui viene citata, per completezza oniromantica, la lettera che il professor P. scrisse all’addetto dei bagagli dell’aeroporto di Luton, nel quale fece scalo al ritorno
«Carissimo Eward, tra gli anfratti e le forre del tuo aspro girovagare, hai per caso scorto qualche traccia, anche filamentosa, del mio fenicottero rosa di gomma? Esso, come ricorderai, aveva una calotta di brillantini in zircone nano e una scritta in latino sul culo. I fenicotteri hanno culi piuttosto vasti. Mi accontenterei anche di filamenti, come ti scrivevo sopra, perché ho ormai sviluppato una strana capacità di tipo manuale, tu mi dai un filamento e io ti realizzo in pochi minuti un fenicottero, verde, il colore rosato sopraggiunge al terzo anno di utilizzo. Ho una grande fiducia nei filamenti, ingiustamente sottovalutati: uno legge filamento e pensa a una cosa di poco conto, irrilevante, quale errore marchiano, figlio di una cultura che schiaccia verso il basso questo nobile e misterioso materiale! Peraltro, ti è mica rimasto anche del lievito bio che devo fare una torta di mele senza mele?»
9 Thomas Mann
Era una montagna molto strana, per essere una montagna. In primo luogo era bassa, piatta, piena d’erba, non si è mai sentito di una montagna bassa, le montagne sono alte oppure non sono montagne, avevo sempre creduto che le montagne per essere tali dovessero essere alte, avere una altezza congrua, ma non avevo mai capito che cosa volesse dire congruo, era un termine che non avevo mai posseduto e se i termini non li possiedi, non li invadi, non li soggioghi, in qualche modo ti sfuggono e non sono più tuoi, se mai lo sono stati. Quindi c’era questa montagna che non sembrava una montagna perché era bassa, almeno da come la vedevo io, e c’era questo signore molto distinto, molto alto, o forse sembrava alto solo perché la montagna mi sembrava bassa e faceva diventare alto lui, portava con la disinvoltura di chi è nato disinvolto un paio di baffetti molto curati, un completo grigio, una camicia bianca col colletto duro e fumava in continuazione. Per tutto il tempo in cui sono stato in sua compagnia continuava a fumare, sempre la stessa sigaretta, senza avvertire il bisogno di accenderne altre. Camminava, fumava, e parlava, faceva uscire dei fonemi pasticciati, a volte tronchi, a volte citava dei nomi, sono sicuro di avere sentito Friedemann, che dovrebbe essere un cognome, e poi Paul, che dovrebbe essere un nome, seguito subito dopo da Ehrenberg, che era invece un cognome, e intanto continuava a fumare la solita sigaretta, e a torcersi il mignolo della mano destra, che impugnava la sigaretta che non aveva intenzione, apparentemente, di esaurirsi. Poi, improvvisa-
mente, come era apparso scomparve, camminando oltre la linea dell’orizzonte imitando il passo di un’anitra selvatica. (Thomas Mann Mann amava anche recitare nei suoi anni giovanili: quando Ernst von Wolzogen mise in scena L’anitra selvatica di Ibsen, Thomas interpretò la parte del commerciante Werle. Non è importante, o forse sì).
Herman Melville
Entrando in quella sala bassa e di forma conica, sempre che una sala possa avere una forma conica, cosa di cui non siamo affatto certi, ci si ritrovava, dopo essersi persi in un piccolo dedalo noto come dedalino o dedaluccio, in un vestibolo largo, dal soffitto opprimente e tutto storto, anch’esso insicuro della sua forma come lo era la sala, rivestito di vetusti pannelli di legno che ricordavano, a un ubriaco, le murate di qualche vecchio legno cassato dai ruoli. A un sobrio non avrebbero ricordato niente. Da un lato era appeso un quadro a olio, di dimensioni incongruamente generose, talmente scurito dal fumo di tabacchi passati dalle bocche di così tante persone e sfigurato in tanti modi, che a guardarlo in quella luce debole, proveniente da più parti, forse si poteva arrivare a capirne il senso soltanto con un esame accurato, attraverso una serie di ispezioni sistematiche, unite a una grande pazienza, a un occhio, almeno uno, che vedesse e soprattutto prescindendo dalla domanda delle domande, la metadomanda, la domanda iniziale; perché devo capire un quadro e non posso invece limitarmi a guardarlo. Sulla tela si alternavano in modo ineguale masse così difficilmente comprensibili di ombre alternate a un buio fitto seguito da piccoli intervalli ocra chiaro, tendente a un altro colore che non era però rimasto sulla tela, in una tale cacofonica serie di peti cromatici che veniva quasi naturale pensare che un pittore giovane e ambizioso, probabilmente magro e con un neo sul mento, probabilmente mezzo francese e mezzo polacco, avesse tentato, senza riuscirci, di rappresentare il
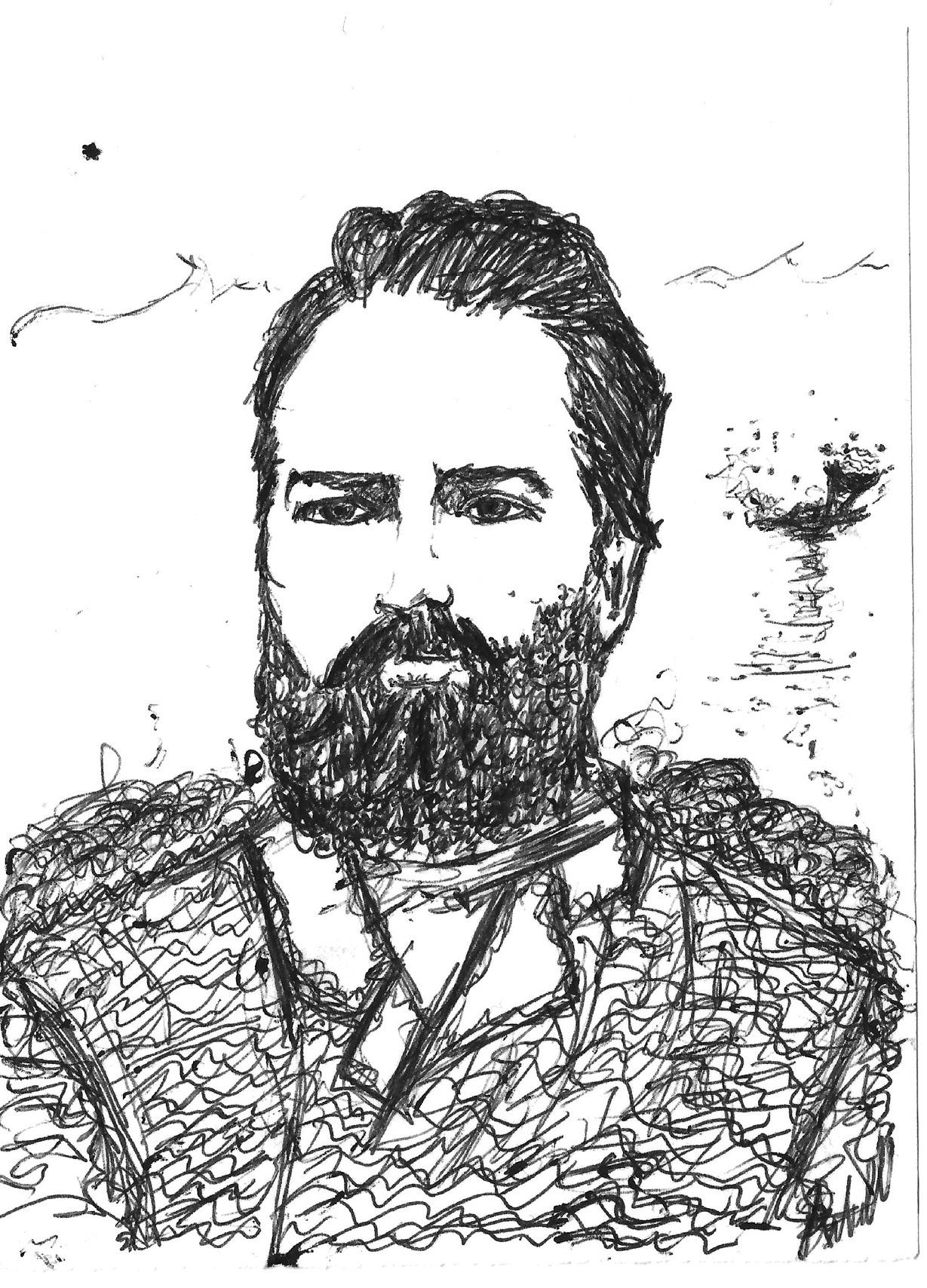
momento esatto in cui l’ordine avrebbe avuto il sopravvento sul Caos, in ciò sbagliando grossolanamente perché l’Ordine non vince MAI sul Caos. Ma era un pittore, aveva un neo sul mento, ed era anche magro. Ci sentiamo di perdonarlo, e lo invitiamo a farsi rimuovere chirurgicamente quel neo. Purtuttavia lasciando tutti i nostri pregiudizi in portineria, con la promessa che saremmo passati a riprenderceli ben presto, questa idea, per quanto sconcertante, poteva non essere completamente infondata, solo che ci eravamo dimenticati di quale idea stavamo parlando, essendo troppo impegnati a pensare al neo. I nei, soprattutto quelli sul mento, distraggono. Di tanto in tanto un’idea brillante ma ahimè ingannevole vi saettava per la mente: “È una tempesta notturna nel Mar Nero. No, nel mar Nero non ci sono tempeste notturne, ci sono solo di giorno. Di notte al massimo piove. No, è la lotta mostruosa dei quattro elementi primordiali. Ma siamo sicuri che fossero solo quattro ? Essendo primordiali magari erano cinque, o sei, o sette. Forse è una brughiera devastata, come solo le brughiere devastate sanno essere. Un inverno artico. Freddo. Essendo artico e essendo inverno deve essere per forza freddo. È lo spezzarsi dei ghiacci con fragore nella infinita serie dei giorni che formano il Tempo”. Ma alla fine tutte queste fantasie erano sconfitte da quel non so che di misterioso in mezzo al quadro e dalla necessità di orinare al più presto, possibilmente non vicino al quadro. Una volta spiegato quello, tutto il resto sarebbe stato chiaro. Un momento! Non somiglia vagamente a un gigantesco granchio? Forse a un avanotto, anch’esso gigantesco? Non era, quindi, un pesce, bello grosso? C’era una cosa che lasciava ammollare il cervello di chi guardava quella tela più di altre, quello che ingenerava una confusione senza speranza la lunga, intermittente, poderosa massa similbluastra di qualcosa di
grosso che si estendeva al centro del quadro, come si estende una mucca svizzera quando non si trova in Svizzera, essendo la Confederazione Elvetica molto rigorosa in fatto di mucche: un vago senso di nausea afferrava la vista quando la si impegnava cercando di identificare alcune sottoforme più piccole di quella al centro, lontanamente e confusamente perpendicolari, che ondeggiavano in mezzo a un fermento indefinibile, che abbiamo però appena definito. Un quadro melmoso, fradicio, serpigno, da fare perdere la testa a un nevrastenico, che essendo nevrastenico qualche problema già se lo porta dietro. Eppure, in esso, c’era una specie di sublimità indefinita, di tenerezza inespressa. Alla fine è arrivato Melville con un capodoglio di plastica in mano, e io mi sono svegliato.
Leonardo Fibonacci
È così inappropriato. È sempre tutto così inappropriato. E inutile. Ero pieno di vergogna, zampillavo vergogna, mi vergognavo della mia stessa vergogna per il fatto che fosse una vergogna. Così sono fuggito dalla stanza e mi sono chiuso in bagno, e per fortuna avevo con me quel piccolo libretto sulla meditazione che mi avevate dato l’ultima volta, quello in cui c’è scritto che meditare è meglio di curare e che se anche la lettura delle parole che ci sono scritte sopra non è sufficiente, è possibile iniziare un percorso terapeutico personalizzato, si paga anche col POS ma sarebbe meglio in contanti. Mi feci una doccia fredda. Nel bagno dell’appartamento dove davano la festa. Gli altri invitati tempestavano di pugni la porta, e intanto, sotto la doccia fredda, io pensavo: “Sto facendo la cosa giusta, sto facendo la cosa giusta”. E ne sono fiero! Ho raccontato questa storia alla mia terapista la settimana scorsa e lei mi ha suggerito di scrivere una lettera ad una delle donne che io mi immagino quando, diciamo, tendo a masturbarmi, cosa che faccio abbastanza spesso. L’ho fatto e lei mi ha detto che dovevo leggerla ad alta voce nella mia sessione di gruppo, in piedi. Più o meno, eccola.
Caro Leonardo, prima di tutto io non so se tu ti chiami realmente Fibonacci, ma io ti chiamerò così. Forse un giorno ci incontreremo e io imparerò il tuo vero nome.
Forse ti vedrò camminare per strada, o ti incontrerò sulla metropolitana, o forse ci troveremo seduti vicini in un cinema. Spero che ciò accada così avrò l’occasione di chiederti scusa per tutto il male che ti ho fatto, non capendo se tu eri
veramente Fibonacci o no. Voglio chiederti scusa, anche se non c’è un motivo vero per chiederti scusa, quindi ne userò uno falso. E vorrei anche chiederti quella storia del ragno, Se un ragno ogni giorno si arrampica lungo un muro per un certo numero di passi e ogni notte scivola indietro di un numero fisso di passi, quanti giorni gli ci vogliono per arrivare in cima al muro? Ma non sono sicuro se sia una cosa che può essere chiesta a chi non è di Pisa, o meno. Non so se i ragni ci sono ovunque, ecco. Poi, mi sveglio.
Francesco Bacone
Bacone che sogna Bacone che sogna ancora Bacone che riesce a dire che stava sognando un pinguino. Francis Bacon, gran cancelliere di Inghilterra, barone di Verulamio, visconte di Sant’Albano, alfiere della scienza e della filosofia moderna. Sognare i pinguini non è una cosa molto normale, i pinguini non sono quasi mai protagonisti dei sogni, per il semplice e imprescrittibile motivo che un pinguino ha una vita di una tale noiosa ripetitività che anche nei sogni, anzi soprattutto nei sogni, uno si annoia e tende a svegliarsi subito. Solo che c’era un problema, Francesco Bacone era un originale e aveva questa spiccata propensione a dormire, come tutti, e a sognare i pinguini, come pochi. Ogni piccolo assopimento, ogni momento di sonno che appulcrava la sua vita da sveglio era immancabilmente punteggiato da pinguini, di ogni forma e misura, che saltellavano da una parte all’altra del suo spazio di sogno. Erano, a tutti gli effetti, dei pinguini saltellanti. Bacone aveva tre obiettivi ben precisi nella vita, scoprire la verità, servire il suo paese e servire la sua chiesa, e fare l’avvocato sembrava soddisfare tutte e tre gli scopi che aveva assegnato alla sua esistenza, per poter ottenere i quali doveva anche riposare, ogni tanto, e quando lo faceva gli apparivano in sogno questi pinguini saltellanti. Non camminavano, non strisciavano, non stavano fermi, ma saltellavano in continuazione. Di giorno Bacone si pronunciava a favore della unione di Scozia e Inghilterra, ascoltava i sermoni, seri e puritani, di William Travers in compagnia della madre, e di notte sognava pinguini saltellanti, appa-
rentemente muti, non emettevano alcun suono: c’è da dire che, da sveglio, Bacone rifletteva sul fatto che anche qualora questi suoi pinguini, ormai li considerava suoi, avessero parlato con molta probabilità non li avrebbe capiti, perché non parlava il pinguinese ma solo l’inglese. Bacone sarebbe morto dopo avere eviscerato un pollo e averlo riempito di neve, per vedere quanto avrebbe resistito da congelato; nel fare ciò avrebbe contratto la polmonite, ed è piuttosto singolare che una persona che aveva passato tutta la sua vita da addormentato a sognare pinguini, sia morto per vedere quanto avrebbe resistito un pollo congelato artigianalmente.
Questo, mentre sognava i pinguini, non gli era venuto in mente.
William Shakespeare
C’era un ampio prato verde, di forma circolare, con alcuni fiorellini bianchi che seguivano il perimetro del prato, tutti perfetti, forse troppo perfetti per essere veri, infatti erano di plastica anche se sembravano veri. In mezzo al prato cìè una persona che cammina in cerchio, poi si ferma, continua a camminare e poi si ferma ancora. Capisco che è Shakespeare perché indossa abiti moderni, anzi per meglio dire non indossa abiti ma solo una t-shirt bianca con scritto sopra Shakespeare a caratteri cubitali, lettere gialle se vedo bene. Non sono sicuro che siano gialle perché sono abbastanza lontano e non mi sembra gentile né avvicinarmi né, tantomeno, una volta avvicinatomi, vedere che tipo di caratteri hanno deciso di usare per la t-shirt. È pur sempre Shakespeare e io, anche se sto sognando, mi immagino tenuto ad osservare quello che credo sia un codice di condotta. Però, questo bisogna dirlo, i codici di condotta nei sogni sono molto diversi da quelli da sveglio, e decido di avvicinarmi lo stesso. Si gira, io mi giro, ci giriamo quasi nello stesso momento e uno sembra dire all’altro qualcosa ma nessuno parla, è come se volessimo parlare ma è come se ci fosse qualcosa o qualcuno che vuole impedircelo, anche se non si capisce perché, sarebbe utile, molto utile sapere se questa nostra impossibilità di parola sia voluta o imposta, sia nostra o di qualcuno che non vuole che comunichiamo, arriva una nuvola, prima a piedi, è una strana nuvola con alcune piccole gambette, quasi delle zampe, nessuno aveva mai visto una nuvola con le zampe, nemmeno Shakespeare, che la fissa a lungo e sembra volere
dire qualcosa ma non riesce, forse pensa che sia Marlowe che assumeva spesso la fattezza di una nuvola, poi la nuvola si alza in cielo e si colloca esattamente sopra le nostre teste, io nel frattempo mi ero avvicinato pur sentendomi in colpa e in ansia, nel sogno c’era molta colpa e altrettanta ansia ma non in parti uguali, la colpa sovrastava l’ansia di alcune misure. Appena arrivata sulle nostre teste, forse più su quella di Shakespeare che sulla mia, la nuvola si ingrossa, diventa scura, e comincia a piovere. A quel punto Shakespeare parla, guarda la nuvola e dice “Tu dici che ami la pioggia, ma quando piove apri l’ombrello”. Poi si gira verso di me, mi guarda, mi dice Hello, fa una capriola all’indietro e se ne va.
Adriano Olivetti
Non una caffettiera, una macchina del caffè; il sogno postfordista dell’archetipo era questo, una macchina del caffè che potesse soddisfare ogni sua esigenza di caffeina lungo le ventisette ore che caratterizzavano la sua giornata, le tre ore in più erano state guadagnate grazie a un salto quantico che lo aveva imprigionato nella tarda primavera del 1983, da allora tutte le sue giornate erano fatte di ventisette ore, non ventiquattro. Nel suo intimo Adriano Olivetti detto Mamo dalla domestica cubana di colore, che nel sogno in cui c’era anche la macchina per il caffè continuava a tagliare banane in fette perfette di due millimetri di spessore, avrebbe voluto inventare la macchina per il caffè ma si era dovuto accontentare di alcuni blandi strumenti di scrittura, che non erano in grado di fare il caffè. Per questo sognava spesso di sognare di essere sognato, anche se faceva molta fatica a rendersene conto.
Ennio Flaiano
Ennio Flaiano stava passeggiando in zona EUR, strascicando leggermente il piede destro. Questa piccola e quasi impercettibile zoppìa rendeva la sua camminata incerta, simile a quella di un piccolo animale da tana che cerca di scappare da un suo predatore, anche se non lo vede. La città era immersa in un silenzio pieno di suoni fatto di qualche piatto che cadeva per terra, il rumore di un motorino, i palazzi con alcune finestre illuminate che sembravano fluttuare con una rapinosa leggerezza, come se fossero palloncini sospesi in aria, con tutti i loto abitanti che guardavano verso il basso. Mentre camminava, Flaiano notò la porta di una antica libreria, con una insegna a forma di oca, o di anatra, o di entrambe. Mentre cercava di capire se fosse un’oca o un’anatra Flaiano spinse la porta prima con la punta delle scarpe e solo in un secondo momento con le mani, lui praticava da sempre una gerarchia degli arti quando doveva aprire una porta, e si ritrovò in un salone molto grande, con pareti azzurre e rosse e con centinaia di libri che svolazzavano per la stanza, pronti per essere letti o ignorati, essendo questo il destino dei libri, l’attenzione o la dimenticanza. Al centro della stanza, su un tavolo di legno molto scuro con sole tre gambe, anch’esse a forma di oca o di anatra, c’era un libro aperto, fatto di più di trecento pagine bianche che cominciarono a riempirsi di parole solo quando Ennio si avvicinò, e solo dopo aver superato un momento di sbalordimento Flaiano si rese conto che quelle parole non gli erano per niente estranee, anzi, le conosceva benissimo, erano quasi tutte
parole e frasi che aveva già usato nei suoi libri, solo alcune di esse, pur non essendogli sconosciute, seguivano sentieri diversi che si componevano all’istante sulla pagina, anche se non tutte si comportavano allo stesso modo. Le parole che finivano in a erano più veloci, si disponevano all’inizio e alla fine della pagina, quelle che terminavano in e erano più sfuggenti, più inquiete, apparivano, davano l’impressione di volersi collocare comodamente al centro del foglio e poi fuggivano, trasformandosi spesso in verbi irregolari, al centro campeggiava un verbo scritto in stampatello ESACERBARE, e Flaiano non lo riconosceva, lui non aveva mai scritto esacerbare in nessuna delle pagine che aveva pubblicato fino ad allora, forse nelle recensioni teatrali, no, neanche in quelle, nessuna delle commedie a cui aveva assistito lo aveva propriamente esacerbato, forse annoiato, quello sì, ma esacerbato no, quel verbo gli aveva creato uno stato d’animo che il suo amatissimo Swift non avrebbe esitato a definire di “bewilderment”, di stupore improvviso e imprevisto. Il silenzio della libreria venne interrotto dalla terza Variazione Goldberg di Bach, Flaiano la riconobbe immediatamente, e giratosi vide un uomo di piccola statura, molto magro al limite della cachessia, vestito con un frac molto elegante ma estremamente consumato, che la stava eseguendo con una apparente svogliatezza. L’uomo sollevò lo sguardo e sorrise a Flaiano, invitandolo a sedersi accanto a lui. “Quelle sono le tue parole, tutte le tue parole, ci sono quelle che hai già detto e quelle che hai scritto, quelle che non hai ancora detto e che dirai, i verbi che sono dentro di te e non sono ancora usciti perché non era ancora il loro momento, le nuvole, so che a te piacciono molto le nuvole, che stazionano sopra la tua testa e che non hai ancora visto perché camminando, giustamente, guardavi in basso. Il che non è sbagliato, ma
blocca un po’ le cose, a volte.” Mentre Flaiano ascoltava, sia la musica che le parole, cercava di non fissare troppo negli occhi quell’ometto che sembrava stare insieme per errore, che eseguiva quella musica celestiale con delle manine piccole, ossute, con le falangette percorse da mille venuzze bluastre, ecco gli guardo le mani e non guardo le nuvole, pensava Flaiano, per poi correggersi immediatamente, sono in una sala non posso vedere le nuvole, dovrei uscire, tornare in strada, sapeva perfettamente cosa avrebbe dovuto fare ma non ci riusciva, la musica e il piccolo uomo che suonava il pianoforte lo avevano soggiogato, e mentre avvertiva questa sua condizione di mollezza degli arti la musica si fece più forte, tutto attorno a lui iniziò a dissolversi, come se fosse fatto di fumo e che sia lui che il pianista fossero dentro un sigaro che veniva fumato da qualcuno molto più grande di loro. Con un sussulto, Flaiano si svegliò, giusto in tempo per spegnere un sigaro che aveva dimenticato, acceso, tra le lenzuola.
Nora Ephron
Il collo no. Il collo, decisamente, no. Non va bene. Su tutto il resto possiamo raggiungere un compromesso, metterci d’accordo in qualche modo, ma sul collo no. Il collo deve restare grinzoso, flaccido, l’abbronzatura deve fare esaltare le rughe che devono rimanere bianchicce e sudate, perché il collo è la sola parte del corpo umano femminile che resta attaccato alla verità dopo la chirurgia estetica. Voi le avrete viste, quelle donne alte, bionde, sottili e algide come la loro dieta low carb, che quando girano di scatto il collo alzano la gamba destra perché il chirurgo ha toccato qualche nervo e ormai quello che tira da una parte finisce da quella opposta? Guardate con discrezione il loro collo, è un disastro. Un macello. Sembra una fermata della metropolitana abbandonata da 5 anni, che è il tempo medio di riformazione di una ruga di espressione dopo il passaggio della mano del chirurgo. Non so se lo avete notato, ma i chirurghi hanno spesso delle mani con dita enormi, fanno una certa impressione. Si avvicinano con quelle chele e manipolano a pagamento dei corpi che dopo qualche anno ritorneranno ad essere peggio di come sono prima della loro manipolazione, costosa come tutte le manipolazioni. Il collo no, il collo è intoccabile, o meglio loro lo toccano ma il risultato è completamente fallimentare, e le loro dita, quando lo vedono, si bloccano. È il crampo del collo, succede a tutti i chirurghi plastici, si sbloccano solo dopo aver rifatto un paio di tette o aver aspirato del grasso in eccesso da un gluteo. Una volta ebbi uno scambio di mails con un chirurgo, del New England ma di
origine siriana, mi scrisse una mail in piena notte, essendo insonne leggo immediatamente le mails che mi arrivano in piena notte, e questa mail diceva “Per favore”, “Devo vederla”. L’umlaut del mio computer non funziona. Ho un congresso in Svezia. Lei è la sola persona che può aiutarmi.” Ma dove in Svezia? In che città della Svezia ? Perché proprio io avrei dovuto aiutarlo, forse per via del collo. Il mio collo con le rughe mi aveva assegnato una rispettabilità che non avevo mai avuto. Non c’era modo di sapere in che città della Svezia avrebbe dovuto partecipare al congresso, soprattutto se uno non è mai stato prima in Svezia. Sapevo, lo avevo appena letto sull’iPad, che in Svezia esistono città come Gröndal, Södermalm, Hornsgatan, che si poteva bere un caffè di soia a Bellmansgatan e cercare un tipico bistrot svedese a Brännkyrkagatan, e che i nomi delle persone che avrebbero partecipato al congresso sarebbero state Sandberg, Gullberg, Holmberg, Niedermann e Nieminen, questi forse cugini, e poi ancora la serie dei Jonasson, Fredriksson, Mårtensson, Torkelsson, Svensson, Johansson, Svantesson, Fransson, e una città che si chiamava Svavelsjö dalla quale era necessario passare per arrivare a Södertälje che era prima di Ekström e subito dopo Strängnäs, la richiesta di una umlaut era quindi del tutto pertinente, ma io non avevo nessuna umlaut pronta, né avrei avuto la possibilità di averle in futuro, e, pur sentendomi in colpa, ignorai la sua lettera, muovendo il collo in su e in giù per recuperare un po’ della elasticità perduta.
C’era una volta un piccolo uomo, magro e con le gambette storte, piccole ed esili ombre che si proiettavano sulle strade come zampette offese di un grillo dalla sessualità incerta. Questo individuo era solito insidiare alcune delle menti più illustri del suo secolo, che per pura avventura aveva avuto modo di conoscere, con interrogativi banali e privi di senso, quali dove poter trovare un polpo morto in collina, come vedere film porno senza pagare, come aggiustare di sale un piatto di fritto misto scroccato alla mensa del fratello, come cuocere un uovo sodo mantenendo una consistenza adeguata perché se no gli faceva schifo. Il tenore delle domande rifletteva con drammatica nettezza la disarmante sordidezza di questo orrido individuo, che girava per le città italiane chiedendo a tutto SCUSI LEI COME FA LE UOVA SODE? Lui non era molto interessato alle uova sode, voleva solo sapere come venivano preparate quelle degli altri perché avrebbe voluto rubare tutte quelle che trovava sulla sua strada e tenerle tutte per sé. Era un uomo divorato da una avarizia incontenibile. Tutto questo andava avanti da anni, in mezzo alla noja degli interrogati e alla colpevole indifferenza delle strutture di contenimento coattivo di tale immenso rompicoglioni. Fino a quando, un bel giorno, tutto, improvvisamente, tacque; basta domande, basta uova, basta vocine sibilanti da donnetta, basta pretesti inani per attaccare bottone. L’omino era stato portato in campagna, buttato in una buca profonda 18 metri, e poi ricoperto di vitello tonnato bio senza grassi. Davanti alla buca
un tavolo in frassino anticato accoglieva alcune delle menti migliori della nostra generazione, intente a mangiare una frittata di cipolle. Un enorme uovo di plastica, a centro tavola, era illuminato.
Lui, mentre cadeva nella buca, aveva detto che avrebbe voluto essere ricordato col nome di Molière perché Jean-Baptiste Poquelin gli sembrava, a ragione, troppo lungo.
Bix Beiderbecke
La casa di Bismarck Beiderbecke, Bix non era altro che la contrazione di Bismarck, anche se forse non era proprio così, era in fondo alla strada e dalle finestre spalancate sul giardino, negli afosi pomeriggi dell’estate dell’Iowa tra quelle nuvole dense di afa e di aria immobile le prime note della tromba di Bix cominciavano, a fatica, a farsi largo. “Non ho niente contro le fotografie ma non ho neanche qualcosa di particolare a favore, i fotografi fanno rumore, parlano troppo e ti puntano addosso quella specie di fucile che spara luce spargendo polvere dappertutto. Io sono amante del buio perché così nessuno ti può vedere, anche se guarda. Il vantaggio inarrivabile del buio è, molto semplicemente, quello di poter evitare di essere visti anche se uno, o una, sta fissandoti. Alla luce per non essere visto devi cercare di scappare, al buio puoi stare fermo, tranquillo, immobile, e nonostante questo non ti vedono. Certo, sì, c’è il problema del respiro, come dice sempre Adrian (Rollini), ma lui suona il sax basso che non è esattamente uno strumento musicale ma piuttosto uno stato d’animo, di uno incazzato, quindi deve respirare molto e spesso, io suono la cornetta, e posso usare solo un soffio, leggero, e la musica esce lo stesso.” “Quella storia dell’organo a canne del battello? Quando dissi di saperlo suonare per potermi imbarcare? Tutto verissimo, solo che avevo dodici anni e sapevo suonare solo le prime tre battute di una canzoncina scandinava che avevo ascoltato un pomeriggio dalle finestre spalancate dei nostri vicini di casa. A Davenport era pieno di tedeschi, svedesi, scandina-
vi, per essere precisi, tutta gente bionda con la pelle bianco latte e gli occhi azzurri e inespressivi. Gli occhi azzurri sono talmente trasparenti che non riescono a bloccare quello che c’è dietro. Sono delle porte aperte. Io odio le porte aperte, ho sempre preferito quelle chiuse. Ma torniamo alla storia dell’organo, ci avevo provato perché sapevo che i musicisti suonavano sulle barche e potevano mangiare tutto quello che volevano. Purtroppo non mi hanno preso e mi hanno rispedito a casa, al 1934 di Grand Avenue, praticamente vicino alla curva, in quella casetta tutta bianca dentro e fuori che a me piaceva solo per via del giardinetto sul retro, dove davo la caccia alle lucertole. Poi un giorno vidi questa cornetta. Era settembre, credo, gli alberi stavano sicuramente perdendo le foglie perché mi ricordo che quando arrivai a casa con la valigetta dello strumento quasi scivolai sulle foglie bagnate, pensando SE CADO GLI FACCIO SCUDO
COL MIO CORPO. Fortunatamente il mio corpo non dovette fare lo scudo a niente perché riuscii a stare in piedi, tenendo la scritta Conn-Victor, la marca della cornetta, perfettamente parallela alla mia gamba destra. Un tatuaggio sulla mia gamba destra CONN-VICTOR CORNET. Trentacinque dollari pagabili a rate, senza dirlo a mio padre, non dicevo quasi mai niente a mio padre.” “Non la comprai subito, la cornetta. Questo no. Ci volle un po’ di tempo prima che decisi di farmela comprare a rate. Ero poco convinto che fosse la scelya goista, non mi sembrava uno strumento adatto a me, avevo le mani troppo piccole e non avevo capito come tenerla in mano, mi sembrava una specie di teiera con i tasti. La prima cornetta che vidi era ammaccata, nerastra, non era di nessuno, appoggiata sul fondo di un armadio nella palestra della scuola; non appena la presi in mano mi successe una cosa molto strana, vidi il perimetro. Vidi lo spazio
dentro il quale potevo muovermi, vidi che in quello spazio ancora vuoto avrei potuto muovermi senza che nessuno mi dicesse cosa o come fare o perché farlo. Era uno spazio in cui avrei potuto fare quello che volevo, e io volevo suonare quel pezzo di ottone annerito dal tempo e dall’abbandono. E cominciai a farlo, spesso di notte, davanti al grammofono, cercando di seguire quello che faceva Nick La Rocca con la Original Dixieland Jazz Band: all’inizio, però, fu una tragedia. Non usciva niente di sensato, solo sibili, rumori metallici, mi graffiavo le labbra e non riuscivo a fare niente di quello che mi girava in testa, ma non smettevo. Non avevo preso in considerazione l’ipotesi di smettere, per nessun motivo al mondo lo avrei mai fatto, e quindi andavo avanti, seduto, in piedi, sdraiato sul letto, allungato sul pavimento, infilavo i piedi sotto al letto e spingevo, soffiavo dentro quella cornetta come un indemoniato perché io sapevo, io lo sentivo, io avevo un ingombro, dentro, che doveva uscire, e la sola strada che poteva seguire era quella della cornetta che avevo tra le mani.”
Alfred Hitchcok
Poi c’è stata quella volta in cui Hitchcock voleva ammazzare Hitchcock. Sapeva che era già morto, ammazzare un morto è una impresa inutile, essendo impossibile, ma voleva vedere come sarebbe morto una persona che in tutta la sua vita aveva ammazzato decine di persone. Le aveva ammazzate per finta, solo nei suoi film, ma anch’io lo avrei ammazzato per finta, diceva, essendo già morto. Era solo per vedere come ammazzare uno che non si sarebbe mai aspettato di essere ammazzato; per una volta si sarebbe trovato dalla parte opposta della macchina da presa. Il primo problema che gli si era presentato era decidere se farlo soffrire o meno. Si trattava di una uccisione simbolica, non priva di una sua etica, il pensiero di fare soffrire la vittima sarebbe stato insostenibile, quindi si doveva pensare a una morte innocua. Un meccanismo letale ma dolce. Si poteva pensare a una torta avvelenata, ma sembrava troppo banale. Poi che torta? Che veleno? Se si fosse sbagliata la quantità di sostanza velenosa e la torta non fosse stato in grado di ucciderlo al primo colpo? Se il risultato fosse stato quello di avere un altro Hitchcock solo catatonico ed egualmente flaccido e non morto? Se, in una situazione di progressivo indebolimento delle sue facoltà mentali, ottenebrato nelle sue capacità registiche, si fosse messo a scrivere romanzetti rosa? Che responsabilità immensa sarebbe stata quella di aver creato un mostro del genere? Il più celebrato, iconico, imprescindibile maestro del cinema giallo che, per colpa di un omicidio mal riuscito, si mette a scrivere di palpitazioni cardiache di signorine in
corrisposte? Non andava mica bene. No. Anche come vaneggiamento sarebbe stato tremendo. Ci voleva un metodo più sicuro. Incidente d’auto? Hitchcock non guidava. Coinvolgere nella uccisione anche l’autista? In qualità di complice o di malcapitata vittima non prevista ma necessaria per portare a termine il progetto? Troppi rischi. Troppe possibilità di errore. Il modo forse c’era, e lo avevamo sotto gli occhi, e proprio per quel motivo non lo avevamo ancora preso in considerazione. Bisognava fare morire l’altro Hitchcock di indigestione. Uomo di appetito insaziabile, bastava una cena ad altissima intensità calorica per eliminarlo. Ucciso da due chili di tacchino con carote seguito da una torta a sette piani di fragole e panna seguita a sua volta da un doppio set di fagianelle arrosto con patate al burro e verdure miste. Le verdure ripassate in pastella, diversamente sarebbero state troppo salutari e odiosamente inutili. L’idea era buona, il progetto stava prendendo corpo, ma all’improvviso Hitchcock decise di non ammazzare l’altro Hitchcock perché sapeva che era già morto, è inutile ammazzare un morto per il semplice fatto che è già morto. Per quella cautela che ti afferra quando non serve a niente essere cauti, dopo essermi svegliato e aver sognato di uccidere sé stesso per indigestione Hitchcock, per postrema cautela, quella mattina non fece colazione. Solo un caffè. Senza zucchero.
Nel mese di giugno del 2016, ed è di quella volta che vogliamo parlare, senza applicare il possente maglio della censura, le persone devono sapere, senza distinzione di censo o razza, e, laddove possibile, non commettere gli stessi errori. Il 6 giugno 2016 Graham Greene si era svegliato molto presto, nonostante fosse morto, per i suoi standards, sovrapponibili a quelli di un sauropode del Giurassico inferiore, intorno alle 11.26 del mattino, e dopo aver consumato una colazione frugale, una banana capitozzata perché le punte lo impaurivano, una tazza di caffè solubile scaduto nella primavera di sette anni prima, e del latte di soia con vistose gore di muffa, si vestì per andare in banca, dopo reiterate telefonate da parte del direttore della filiale che chiedeva ulteriori approfondimenti su un bonifico di 2340 euro a favore di una ditta denominata Pussies Kingdom, Jamaica, New York, indossando quello che caratterizzava il suo abbigliamento estivo, nell’ordine 1) boxer in finto cashmere con carta da forno sui testicoli, soffriva di geloni epididimiali, tre canottiere di lana, due camicie da finto boscaiolo, un maglione girocollo da donna, un maglione a collo alto da bambino, un reggiseno a balconcino per i dolori intercostali che lo affliggevano dopo aver fatto jogging per 2 minuti tre settimane prima 2) giacca a vento gialla con toppe di vero coniglio, loden color merda senza una manica e 3) due paia di pantaloni da sci, un paio di pantaloni da vela rosa fucsia, un tuta da saldatore e una gonna plissettata vinta, barando, a tombola. In testa un colbacco con piuma gialla a destra.
Graham Greene (II)
La giornata era fresca e non voleva rischiare colpi di freddo. Così vestito fece le scale in un balzo, atterrò sul barboncino colitico della signora Thuram, sua vicina di casa novantenne, lo rialzò appoggiandolo alla parete salutando la signora con calore eccessivo, e cominciò a cercare la sua macchina. Dopo tre ore di ricerca infruttuosa, non ricordava né il colore né il modello, nella sua teca cranica modestamente popolata cominciava a farsi strada il sospetto di non possedere una macchina, decise di andare a piedi, essendo la banca a 130 metri da casa sua e essendo la signora Thuram, quella del barboncino colitico, la madre del direttore della banca, che si chiamava Emerenziano, come il barboncino, e che dal cane aveva ereditato una intensa motilità intestinale, parossistica quando vedeva Graham Greene. Arrivato alla banca cercò di aprire la porta al contrario per un paio di volte e dopo aver incastrato il colbacco davanti alla fotocellula riuscì ad entrare, dopo essersi acceso una sigaretta. Il direttore era alla sua scrivania, in fondo alla stanza, la testa collocata esattamente davanti ai testicoli del toro del quadro appeso alle sue spalle, aveva la stessa dimensione di quello destro: Graham Greene stava per sedersi davanti a lui, che già lo fissava con occhi dilatati dalla congiuntivite nervosa che insieme alla colite lo perforavano quando vedeva Graham Greene quando quest’ultimo si fermò, improvvisamente, facendo cadere la cenere della sigaretta sulla testa di una signora colombiana nana che lo precedeva: alla sua destra aveva visto una porta a soffietto, una enorme porta a soffietto bianca, che lo fissava minaccioso ondeggiando come una anaconda sui suoi cardini laschi. In pochi minuti vide tutta la sua vita passargli davanti, mentre la nana colombiana stava prendendo fuoco; le vacanze in campeggio, la sua elezione truccata a capo manipoli dei giovani esploratori, la
volta in cui si rinchiuse in ascensore per cercare una larva di zanzara e venne poi liberato dai pompieri che lo picchiarono per sette ore di fila, la prima settimana bianca in cui si presentò per errore con una tavola da surf perché aveva letto male l’annuncio, tutto questo era lì, davanti a lui, un mosaico di azioni e pensieri composto come una pala d’altare su quella porta a soffietto bianca. Rimase fermo ancora per qualche minuto, le nocche delle mani erano bianche per la continua tensione muscolare che vi imprimeva, la nana colombiana era ormai un tizzone ardente, quando, improvvisamente, anni di PNL e di altre cazzate del tipo È TUTTO OK TU SEI A POSTO sono solo gli altri che sbagliano affiorarono alla luce, vennero spinte come un razzo dai suoi precordi e fu un attimo, il corpo si fece freccia di un arco tenuto non si da chi e si avventò con la furia primigenia di un berserker vichingo contro la porta a soffietto, prendendola a calci urlando fino a divellerla dai suoi cardini. La porta cadde a terra, dietro di essa apparve la segretaria del direttore vestita di un delizioso completo intimo malva, il direttore urlò dalla parte opposta della stanza e dopo aver afferrato un rotolo di carta igienica si precipitò in bagno che però era occupato risolvendosi quindi a defecare dietro una pianta di plastica a foglie lanceolate, Graham Greene si accesa una seconda sigaretta e chiese alla segretaria in completo intimo color malva cosa usasse per le doppie punte, che vedeva perfettamente e sapientemente contrastate da una hennè al sapore, e al profumo, di banana.
Joris-Karl Huysmans
Huysmans e la nebbia sono sempre stati una cosa sola, dove finiva uno cominciava l’altra, dove finiva la nebbia apparivano subito le gambette rachitiche e ipotoniche di Huysmans, solcate da reticoli di venuzze bluastre, segno evidente dei suoi stravizi alimentari, della sua pinguedine cerebrale, che copriva tutta la zona amorfa della sua scatola cranica, della sua incapacità di fare più di 387 metri in linea retta senza avvertire il bisogno di chiamare un taxi, che non sarebbe stato in grado di pagare. Per questo amava la nebbia, che gli impediva di vedere e anche di essere visto, fino a quando, un giorno, in apparenza uguale a tanti altri giorni, andò a sbattere contro uno stenditoio di zinco, e si accorse che la nebbia poteva essergli di aiuto per molte cose ma non per evitare gli stenditoi di zinco.
Erri de Luca
Erri non aveva mai posseduto pentole, aveva solo un piatto verde rotto al centro e riparato con la malaccortezza che lo accomunava a un cirripede e tre posate, due cucchiai sottratti a una festa dell’Unità con la faccia di Occhetto e un coltello peruviano rubato alla presentazione di un libro di Erri De Luca, che poi era lui, di cui non si ricordava il titolo anche se sarà stato sicuramente troppo lungo; non riusciamo a capire per quale motivo fosse presente un coltello peruviano alla presentazione di un libro di Erri De Luca ma non capiamo neanche i libri di Erri De Luca come non li capisce lui che li ha anche scritti quindi su questo particolare di folklore armeno non ci soffermeremo, ma sulla pentola a pressione sì, perché di ritorno dalla presentazione del suo libro Erri, che indossava ancora un poncho in materiale plastico donatogli dalla psicologa del consultorio, trovò davanti alla porta di casa una scatola di cartone, la aprì, era diventato velocissimo ad aprire con i denti le scatole di cartone, e dentro trovò una pentola a pressione, nuova, intonsa, riccamente avvolta da una pellicola trasparente che rendeva ancora più lucido quello che c’era dentro. Mentre cercava di togliersi il poncho senza strangolarsi aveva anche pensato di liberarsi della pentola e tenere solo la pellicola, che gli sarebbe tornata utile per foderare l’interno del frigorifero che lasciava sempre aperto per avere più fresco in casa, ma colto da uno dei suoi rapinosi momenti di esaltazione, durante i quali pensava di essere un epistemologo omosessuale esperto di teologia della forma, decise non solo di tenerla ma anche di
usare la pentola a pressione per cucinare un piatto che era in cima alla sua lista di priorità imprescindibili alimentari, il polpo con patate e pomodorini confit. Il pomodorino confit avrebbe conferito nobiltà al polpo, sottraendolo al suo ineluttabile destino di eterna gommosità, di plasticità ininterrompibile, di masticabilità complessa. Il confit era la pietra angolare della possibilità, per il polpo, di ascendere al livelli di sarago, addirittura di trota, forse anche di salmone, e tutto questo Erri lo sapeva molto bene.
Claudio Monteverdi
Arrivato in Lapponia Claudio Monteverdi cercò subito una sedia, era stanco, e del succo di mirtillo, era assetato. E cominciò subito a chiedersi cosa ci facesse, in Lapponia. L’unione della sedia col succo di mirtillo sarebbe stato perfetto ma poiché la perfezione non è di questo mondo decise di bere il succo in piedi, non avendo trovato nessuna sedia. Staranno sempre in piedi in Lapponia, pensava, mentre irrorava la sua epiglottide con ruscelli di mortella di palude, uno degli altri nomi del mirtillo rosso insieme a mirtillo rosso, appunto, o mirtillo palustre. In quel momento non era in una palude ma davanti alla fermata di un bus lappone, segnalata da un cartello di fermata in lappone, aspettando un bus lappone che lo portasse in albergo, anche se non si ricordava in quale albergo dovesse andare. Questo è un problema che risolverò quando sarò sul bus, pensò, mentre finiva di stillare le ultime, disperate e transeunti particole di liquido ancora presenti nella bottiglia; C. M. era alto, molto alto, e per raggiungere tutte le parti del suo corpo, anche le più remote, il succo doveva fare un viaggio lunghissimo, punteggiato di varie, imprecisate fermate, alcune prevedibili, altre meno. Mentre il liquido stava facendo il suo lavoro, era arrivato il bus lappone: bianco, con alcune scritte rosse sulle fiancate, una diversa per fiancata, era guidato da un autista nano con un paio di enormi baffi a manubrio e una giacca blu, la divisa degli autisti lapponi pensava C. M., che gli tirava tremendamente sul torace, con un bottone centrale pronto a schizzare a velocità supersonica verso gli occhi del
primo malcapitato: fortunatamente la giornata di sole aveva invitato con perentorietà C. M. a indossare un paio di vistosi occhiali da sole gialli con delle piccole perle, finte, ai lati, che lo metteva al sicuro da eventuali, improvvide partenze verso Sirio del bottone centrale dell’autista; la partenza improvvida avvenne poco dopo, seguita da un rumore secco, improvviso, una detonazione, col bottone che fendeva come una lama di Toledo un panetto di burro il vetro anteriore dell’automezzo, creando una enorme crepa a forma di ano di struzzo al centro del vetro, che pochi minuti dopo andava in frantumi, tra le grida di stupore dei passeggeri: tutti erano preoccupati non tanto per la rottura del vetro quanto per la comparsa, sia pure provvisoria, del culo di uno struzzo sul vetro che stava per andare in frantumi. Mentre tutto questo si srotolava sotto il sole che avvolgeva la città di Inari, dove stava succedendo tutto questo, C. M. si era seduto in un posto in terza fila, accanto al finestrino, non si era tolto gli occhiali e dopo aver soffiato sul vetro di sua pertinenza, dopo aver dato pietosa sepoltura ai cadaveri di tre zanzare ivi presenti dalla primavera di sette anni prima, aveva disegnato un pentagramma sul vento opacizzato dal suo fiato e stava componendo un pezzo, intitolato Fattish Ostrich, ossia lo Struzzo grasso. Dopo tre curve affrontate con baldanzosa sicumera, C. M. arrivò davanti al suo albergo, circondato da siepi di eucalipto e alcune ortensie, tutte verdi. Senza farsi notare C. M. afferrò tre ortensie e le mangiò, insieme al loro gambo, che considerava la parte migliore del fiore; fin da piccolo aveva sviluppato una forte, incontenibile passione per i gambi di ortensia, e quando gli capitava di vederne uno non riusciva a controllarsi. C. M. quando mangiava le ortensie attivava la sua mente musicale, gli appariva un brano tra le commessure cerebrali, in questo caso l’Orfeo
di Monteverdi, che era lui, quindi era giusto che sognasse qualcosa di suo, non stava rubando niente a nessuno, e quello era il brano che canticchiava mentre saliva nella sua camera, la 345897689, lato sud.
Sonny Rollins
Il poliedro è un solido geometrico, con un numero finito di facce piane poligonali. Quando questa persona si avvicina al suo strumento, con una circospezione avvertita, non casuale, programmata, il poliedro comincia a prendere forma dietro la sua testa, essendo le teste delle persone uno dei luoghi di elezione dei poliedri. Suona uno strumento a fiato, questa persona, gli strumenti a fiato sono strani perché prima che una persona ci soffi dentro, o attraverso, sono materiale inerte, sono volute di ottone, pezzi di ebano con delle ghiere e delle chiavette che, quando sfiorate, fanno un piccolo rumore di posata caduta a terra. Poi, quando uno, o una, si avvina a questo manufatto silenzioso la quiete e l’abbandono precedente diventano un suono, due suoni, 60 suoni, dipende dal tempo e dal fiato. Questa persona, quella che si avvicina al suo strumento con circospezione, comincia a suonare ben prima di prendere in mano il suo strumento, in questo caso un sax tenore, e segue delle idee che gli girano tra i lobi parietali da qualche ora prima. Poi lo afferra, con la circospezione di cui parlavamo più sopra, e comincia a fare uscire dei globi di note, dei frattali con dei suoni che gli girano dentro, che fluttuano un po’ nell’aria e che poco dopo, ordinatamente, senza nessun obbligo apparente, diventano dei piccoli, succosi poliedri, fatti di immagini, con le note che sono, in questo caso solo un tramite necessario. Un poliedro diventa una nuvola, poi si accartoccia, una delle sue facce cambia direzione e diventa una freccia, che prima va molto in alto, poi in basso, poi si ferma per diventare un
albero, uno di quei faggi racemosi, coi fiori messi in cerchio, sempre che i faggi abbiano dei fiori, ma in questo caso non è così importante. Poi arriva il mare e il blu e il bianco e il suono dell’acqua che va a sbattere sugli scogli, questo perché l’acqua ha un suono, anzi più di uno, e questa persona ha la speciale abilità di riuscire a trovare anche i suoni che non esistono, che diventano tali dopo che li ha scoperti lui. Si sente un rumore diverso per ogni diversa goccia d’acqua che cade sullo scoglio, poi scivola via ma il suono resta sempre dentro la testa di chi lo guarda. Poi c’è lo sguardo, che è quello che afferra il suono che non esiste ancora e che dopo arriva a esistere con una stoica, indomita petulanza; non esiste suono più forte, più imponente, più gloriosamente contento di esistere di quello che prima non c’era. È tutto così, alla fine: è silenzio e poi suono, suono e poi silenzio, brusio e chiacchiera netta, gerundio invasivo e piccolo, nascosto condizionale, e ti accorgi, se hai la curiosità sufficiente per farlo, che sta arrivando un suono nuovo quando questa persona schiaccia leggermente, in un modo avvertito forse solo dal suo nervo zigomatico, l’occhio destro, forse per vedere meglio il mare. Alla fine di tutto si volta verso di te e scopri che è Sonny Rollins.
Richard Feynman
Giova sapere che Feynman aveva elaborato un metodo, cristallizzato in alcune slides di presentazione che aveva catalogato sotto la sigla Donuts fractals o D. F. contenute in una cartellina di colore giallo che campeggiava al centro del computer del suo laboratorio, proprio al centro della bocca dello squalo morto che utilizzava come salvaschermo, per mangiare in modo soddisfacente le ciambelle, odiando la differenza e l’invarianza nella serialità. In tale metodo veniva chiarito, senza possibilità di errori, che la ciambella infrasettimanale deve avere un diametro non superiore ai 9 mm, non deve presentare bruciacchiature o commessure sulla superficie, deve essere cotta in modo uniforme e contenere un numero massimo di tre bolle di cottura: alla mancata corrispondenza di uno di questi elementi il manufatto dolciario deve essere smaltito con l’umido. Se il prodotto soddisfa tutte le caratteristiche appena descritte, può passare alla fase di degustazione, che si strutturerà a sua volta in due sottofasi successive, fase 1 collocazione della ciambella sul piattino, di colore bianco, con una inclinazione di cinquantaquattro gradi rispetto all’asse radiale del piattino stesso, e fase 2, utilizzo di una forchettina da dolce in wolframio anticato, con sottile impugnatura in bachelite, non trattata, con la quale praticare sette incisioni a uguale distanza sul lato destra e altre sette sul lato sinistro, in ognuna della quali verrà versato del succo di ribes appena spremuto. La nota penuria di ribes da spremere non fermerà il nostro Feynman, che creerà una spuma di ribes col cascame di lavorazione del pesce palla,
particolarmente gustosa. Feynman piaceva alle donne in modo estremo. Non è che piacesse alle donne in quanto donne singole che poi tutte insieme non cessano di essere donne ma sicuramente non sono più singole, ma viene adorato da esse in modo parossistico, lo stesso vertiginoso aumento del ritmo cardiaco che prova chi deve comprare una marmellata di arance ma si ritrova alla cassa con della marmellata di ribes perché nel momento della scelta ha sperimentato un subitaneo e significativo abbassamento della vista, avendo appena visto passare Feynman, avvolto da una camicia bianca con ascelle intonse e asciutte, nonostante i cinquanta gradi all’ombra. Egli non cammina come i suoi mortali compagni di camminata ma scivola su un tappeto di gomma che lo tiene a 6 centimetri di distanza rispetto al suolo, e non prova nessuna fatica affrontando camminate di centinaia di chilometri; se deve andare a comprare degli insaccati, che adora, si reca nel punto più lontano rispetto a quello in cui si trova quando ha pensato che doveva comprare degli insaccati, e una volta arrivato, emanando un delizioso profumo di menta e rodio, numero atomico 45, dopo aver rivolto la parola alla commessa sarà testimone dello svenimento della poverina, che dopo essersi riavuta scoprirà di aspettare un figlio da lui, che chiamerà Omicron. Nell’avvicinarsi al fornello Feynman venne assalito da una marea di dubbi angosciosi, era il suo fornello, era quello del vicino di casa, come era possibile adottare un metodo scientifico che permettesse ai fornelli di essere riconosciuti come tali e, soprattutto, come sarebbe stato possibile collegare ogni singolo fornello al suo proprietario, partendo dall’assunto che ogni fornello avesse un solo proprietario, cosa ancora da verificare? E come era possibile partire da un assunto senza muoversi da casa? Questo angoscioso interrogativo, unito a lievi, intermittenti
fitte al trillice del piede sinistro occupavano una parte significativa delle circonvoluzioni cerebrali di Feynman, alcune migliaia, che stava chiudendo la porta di casa con una chiave magnetica di sua invenzione. Questa chiave magnetica, da lui chiamata Magnetochiave perché era un amante delle parole complesse, era il risultato finale di un progetto che, iniziato alcuni mesi prima, lo aveva visto trionfare alla fiera del mobile componibile di Lima col suo comodino a frattali, che si scomponeva e ricomponeva seguendo l’umore del possessore, e arrivare terzo alla fiera campionaria di Lubecca con il suo prototipo di bici senza pedali, la sua pedaless bike, con la quale il sindaco di Lubecca si era schiantato contro un furgoncino che consegnava banane bio, in divieto di sosta. La chiave era molto efficiente, funzionava anche da grandi distanze, e se non fosse stato per la lunghezza, sette metri, e il peso, 156 chili, sarebbe stata un sicuro successo, ma queste sue caratteristiche così evidenti avevano obbligato Feynman a farne un uso di eminente domesticità. La lunghezza e il peso avevano infatti fatto nascere forti dubbi negli angeli investitori del progetto che avevano preferito aderire a una richiesta, arrivata da una multinazionale finlandese del sesso a pagamento, di un apparecchio trasparente a forma di triangolo isoscele che avrebbe dovuto fornire orgasmi a comando dietro il versamento di un piccolo obolo in denaro che avrebbe dovuto essere inserito nel manufatto in monete di plastica dal valore traslazionale, ossia deciso dal singolo utente. A dieci orgasmi consecutivi scattava di ufficio la possibilità di averne tre gratis, ma nella maggior parte dei casi l’utente era svenuto e doveva essere trasportato via di peso dalla struttura, che i finlandesi avevano chiamato Orgasmikone.
Honorè de Balzac
Dopo essere arrivato in Giappone senza essere certo di volere andare in Giappone, e dopo avere preso in locazione un appartamento di diciassette metri quadrati senza avere mai avuto l’intenzione di farlo ma ormai era lì, Honoré de Balzac, nome che significava Honoré de Balzac, appoggiò le borse a terra, tre, si tolse il giaccone, si sedette sulla tazza del cesso, e vide subito davanti a sé una serie di luci verdi, poi gialle, poi ancora verdi, poi arancioni mentre un braccio telescopico alla fine del quale era innestato in pennello in pelo di martora che visitava con una gentilezza seconda all’ostinazione i suoi testicoli. Aveva conosciuto il famoso cesso giapponese, o della tazza autopulente. Sapeva, dopo aver esperito nei lunghi giorni che precedevano la partenza del suo primo vero viaggio dopo ventisette anni, che il Giappone era lontano, che mangiavano un pesce velenoso e che in quel Paese la tazza del cesso faceva tutto da sola ma un conto è leggere queste cose su una guida al Giappone stampata male su carta riciclata, un altro conto è sentirsi i testicoli vellicati da un braccio meccanico azionato da un pulsante che non volevi premere che agisce in modo coordinato su entrambi. E’ tutto molto diverso. Dopo aver aspettato che finisse questa pratica criptoerotica, dopo aver pensato e aver deciso che no, non era il caso che si fumasse una sigaretta né che chiedesse al cesso se aveva un nome e se tutte le volte sarebbe successa la stessa cosa o doveva considerare quello che era successo un evento del tutto straordinario, con i testicoli perfettamente puliti e profumati si alzò per uscire
dalla stanza, angusta, dove era ospitato il piccolo trono della peristalsi. Nel farlo non poté sottrarsi a un’occhiata furtiva ai testicoli coi quali conviveva da alcuni decenni, e gli parvero entrambi perfettamente rotondi, senza quelle ostentate differenze di volume e posizione che aveva sempre notato: effetto della pulizia intratazzale, rifletté, o forse semplice suggestione, riflettè sulla precedente riflessione. Honoré era un maestro della riflessione doppia, prima pensava a una cosa, poi a una cosa diversa, quindi tendeva a dimenticarle entrambe. Uscito dal bagno, andò a schiantarsi contro un comodino rettangolare con gli spigoli in titanio, sopra il quale era appoggiato un cavallo di plastica blu, una deità che, in teoria, avrebbe dovuto proteggere la stanza e i suoi occupanti, che però cambiavano spesso quindi doveva essere più che altro legato alla stanza che agli occupanti, essendo un cavallo azzurro un Dio animale abbastanza inaffidabile, almeno in apparenza. I diciotto metri quadrati dell’appartamento erano occupati da un bagnetto di 3,5 metri, una cucina a cubicolo di due metri, uno spazio vuoto che occupava i metri restanti e una scala in legno di faggio che portava a un soppalco sopra il quale c’era un futon, tipico, scomodissimo, insensato letto giapponese e il poster pubblicitario di una birra alla ciliegia con la parte destra piena di numeri di telefono, per lo più illeggibili. Dopo aver strappato il poster si sentì subito meglio ma poco dopo si sentì subito peggio perché il poster copriva il disegno fatto probabilmente da qualche ubriaco ipovedente di un topo, presumibilmente giapponese anche se aveva tutte le caratteristiche di un topo europeo, che cercava di mangiare quello che restava di un piatto di ramen. Prese quindi quello che restava del poster e lo rimise sopra al topo. Ora aveva fame. Probabilmente il topo ricoperto gli aveva messo fame, in qualche modo
doveva cercare di mangiare qualcosa, se possibile di commestibile anche per un non giapponese. Dopo un ultimo, fuggevole sguardo al topo ormai ricoperto, uno sguardo che non si sapeva se descrivere meglio come appunto fuggevole o trasognato, uscì da quella che sarebbe diventata la sua casa per il prossimo anno e subito inciampò in un gatto di gomma rosa con una zampa che andava su e giù in modo inconsulto. Non era tanto il fatto che fosse di gomma rosa, dava per scontato che in Giappone ci fossero molti gatti di gomma rosa, ma che si muovesse da solo, cosa che un gatto di gomma di regola non dovrebbe fare, gli fece nascere una fuggevole perplessità, che era però già scomparsa quando arrivò davanti a una banca, e non cercava una banca, e poi a un bar, e non cercava un bar, infine davanti a quello che cercava, un locale di sei metri per tre, con le pareti rosso ciliegia, che gli era stato consigliato da Flaubert, il suo amico esploratore artico che era però diventato famoso come scrittore, anche se la sua vera passione era esplorare l’artico senza muoversi da casa, che dopo avere esplorato migliaia di chilometri di ghiacciai si era trasferito a Tokio da due anni, senza muoversi da Bordeaux. Avrebbe dovuto incontrarlo nei prossimi giorni, se riusciva a trovare il biglietto giallo sul quale aveva segnato la via in cui avrebbero dovuto vedersi: un francese, morto due secoli prima, e un islandese a Tokio, un bel titolo per un romanzo, pensò, che non avrebbe letto nessuno, pensò ancora, tanto nessuno legge più niente, pensò per la terza volta. Quando arrivò la quarta volta non stava già più pensando e stava svegliandosi.
Francesco Petrarca
Gli armadi ad ante scorrevoli sono in tutto e per tutto identici agli armadi senza ante scorrevoli, con la sola preziosa differenza che hanno un numero imprecisato di ante scorrevoli. Quelli che le hanno, gli altri no. Dentro uno di questi armadi in noce, si capiva che era legno di noce per via delle nervature molto evidenti, dicevo che dentro uno di questi armadi in noce era seduto un uomo, di aspetto serio ma non troppo, era Francesco Petrarca. Delle ante sappiamo infatti che scorrono ma non sappiamo quasi mai quante sono, se in numero pari o dispari, se sono pesanti o leggere, se allo scorrimento fanno rumore o meno, se gettano chi le sta per utilizzare in un gorgo buio o in mulinello chiaro, se petrarchescamente “Ché non poss’io cangiar teco vïaggio?”, ma è altamente probabile, laddove non quasi certo, che Petrarca non possedesse armadi ad ante scorrevoli, forse neanche armadi, ma a questo riguardo Egli, ormai morto da secoli, è sempre stato sfuggente. Anche sulla pizza non ha mai fornito informazioni, e questo ci appare eccessivo. Esulando per un momento dalla infrascritta questione sulle ante scorrevoli, perché, in relazione a chi o a cosa, per quale motivo il Petrarca non parla MAI di pizza, dove risiede la scaturigine della sua ostinata deflessione dall’affrontare l’argomento, che dobbiamo supporre essere stato per lui spinoso? Irto, quindi, degli aculei della verità urente? Come mai non c’è pizza in Petrarca? Questa domanda ci interroga, in quanto domanda, e si fa largo nei recessi più nascosti della nostra ragione, mentre poco o niente possiamo dire dei recessi del-
le ragioni degli altri, a ogni recesso fa capo una sola ragione, che non può essere sempre la stessa, come è facilmente immaginabile. Prendiamo, a titolo di esempio, questo passo del lamento di Magone del Petrarca, appunto “O qual è il traguardo dell’alta sorte! / Quanto l’anima (è) cieca davanti alle fauste imprese! Ecco la follia dei potenti, godere delle altezze vertiginose”, ebbene, dove possiamo collocare la pizza? In che modo viene adombrata ? forse tra le follie dei potenti possiamo mettere una marinara ? una quattro formaggi ? una boscaiola ? sono le “follie dei potenti” una ardita, immensa metafora della pizza? È quindi la poetica petrarchesca nella sua essenza più intima GLUTEN FREE? O non esiste nessuna poetica petrarchesca ? come facciamo a capire se c’è o mene, quando la sola persona che potrebbe dircelo, Petrarca stesso, si è richiuso nell’armadio?
Ettore Sottsass
Un armadio al centro di una stanza. Un grosso, affidabile e squadrato armadio borghese. Quattro ante, scene di caccia su tutte e quattro. Cani che corrono con dei fagiani morti in bocca. Entra un uomo. Ha la barba, ha una giacca marrone, alcuni lo salutano, altri no, ad alcuni risponde, ad altri no. Uno lo chiama Ettore, lui non si lamenta, quindi molto probabilmente deve essere il suo nome. Fa alcuni passi, gira su sé stesso, si gira prima verso il pubblico senza dire niente, poi verso l’armadio, lo fissa per qualche secondo, scuote la testa, si gira di nuovo verso il pubblico e comincia a parlare, con voce chiara e squillante; durante il suo monologo muoverà molto entrambe le mani e alzerà spesso gli occhi al cielo. “Devo dirvelo, prima che possiate pensare chissà cosa: questo non è il mio armadio. Non voglio che nessuno di voi, voi seduti qua davanti e voi seduti lì dietro, in fondo, tutti voi che mi guardate con i vostri sottili occhi indagatori possiate pensare che questo affare qui dietro, alle mie spalle, sia il mio armadio. IN SESSANTA ANNI DI VITA IO NON HO MAI POSSEDUTO UN ARMADIO. Mi danno fastidio, gli armadi. Bisogna riempirli di vestiti, di magliette camicie cravatte se uno ha delle cravatte calze canottiere cappelli sciarpe fazzoletti e mutande ecco le MUTANDE soprattutto le mutande; a voi moltitudine silenziosa con tutti quegli occhietti indagatori, signorina i suoi lo sono in modo particolare, sì dico a lei, seconda fila terza da destra, le sue pupille indagano forse senza volerlo ma indagano, a voi sembra normale che una persona di sesso maschile,
sessantenne, che ha nel corso della sua vita consumato diciamo 1390 mutande? Corretto? Prendiamolo per buono; vi dicevo uno che ha superato la boa dei 60 anni sia tenuto a conservare le sue mutande nuove in un parallelepipedo di legno di faggio, questo qui alle mie spalle pare che sia di legno di faggio, insieme alle sue camiciole sgargianti, a me piacciono le camiciole sgargianti, mi sono sempre piaciute le camiciole sgargianti, a voi no? AMEN. PAZIENZA. A me sì, mi mettono allegria: ora vi sembra quindi logico giusto e soprattutto NECESSARIO che uno debba mettere le sue mutande insieme alle sue camicie? No, assolutamente no, fortissimamente no. Poi lo avete visto questo affare? Questo termitaio potenziale? Gli armadi sono per le termiti quello che sono gli strudel per i diabetici, un sogno proibito che proprio in quanto proibito ti impegni tantissimo per sognarlo ora IO LO FACCIO ANCHE PER DARE UN SEGNO FORTE AI DIABETICI CHE VOGLIONO MANGIARE LO STRUDEL; io faccio a meno dell’armadio, voi accontentatevi di qualche scarna e disadorna confezione di biscotti similindustriali a forma di saponetta. Poi le avete visto queste ante (si gira, armeggia con le chiavi inserite nell’armadio, tocca con un disgusto molto evidente la coda del cane da caccia inciso sull’armadio) questi due cani? Fermi? Bloccati? Con in bocca un fagiano morto? Potrei mai dico io mettere le mie mutande, da quando ho compiuto sessant’anni compro solo mutande molto belle, eleganti, mi venisse un colpo sono in ordine, ho solo ceduto in un momento di stanchezza all’acquisto di 16 mutande gialle di produzione cinese, non le ho ancora indossate perché di notte si illuminano da sole, potrei mai mettere le mie mutande in un contenitore facile preda di termiti affamate e guardato a vista da due cani con due fagiani morti in bocca? Che poi, a guardare bene, anche
i due cani non sono messi benissimo perché non si muovono mai? NO. Io le mutande le lascio sul letto, le camiciole sgargianti sulla sedia e i pantaloni in bagno, accuratamente ripiegati sulla lavatrice. A carica manuale, dall’alto. Le calze sono ancora un punto interrogativo, ma ci sto pensando. Comunque, e adesso vi lascio perché mi ha aperto la banca, questo armadio, questo alle mie spalle, NON È IL MIO. Ha capito, signorina dallo sguardo indagatore?
Achille Succi
Gira questa storia secondo cui io vorrei essere come Achille Succi detto Achille Succi o Sire o re del mirtillo e di tutte le terre emerse comprese quelle semiaffondate e così via: niente di più falso, io non vorrei essere COME Achille Succi per il semplice motivo che io vorrei essere proprio LUI, togliendo il come. I motivi? Svariati, inutili, per lo più privi di senso e per questo ancora più validi. In primo luogo per come cammina, un passo elastico, ronfante, quasi erratico, da gatto soriano che ha appena mangiato 780 croccantini al pollo o all’aragosta o al mango, nel caso di gatto vegan, che son rari però, e che si guarda intorno soddisfatto e satollo, con benevola indulgenza verso le miserie umane che anche un gatto satollo non può fare a meno di vedere. Un passo cadenzato, diciamo un 5/4 con improvvise, inaudite folate di 128esimi che si arrampicano sulle spalle di quelli che lo precedono e scendono davanti a loro per poi ritornare indietro. Un passo morbido come un paio di pantaloni di velluto marrone scuro che si allacciano perfettamente anche se manca qualche bottone. In secondo luogo per come parla, per quelle vocali aperte come il becco di un cigno (volevo scrivere oca ma mi sembrava brutto) che allunga il collo in tutta la sua estensione fino a fare uscire dal becco che nel caso di Achille è una bocca ma qui siamo nel regno della metafora assoluta una inesorabile teoria di vocali perfettamente e sapientemente rotonde, solo Succi riesce a vocalizzare l’aria fino a farla diventare rotonda, con delle OOOO che sembrano dipinte da Giotto e delle AAA che sembrano
delle OOO che a un certo punto hanno deciso di fermarsi prima: ma c’è una cosa, su tutte, che mi fa ardere come una pietra focaia resa incandescente dall’uso protratto, una sola, magnifica cosa che mi fa impetrare con tutte le mie modeste forze di essere Achille Succi, la sua valigiona degli strumenti. Un parallelepipedo nero, con una grossa maniglia, di lunghezza variabile tra i cinque e i trentaquattro metri, dal quale numerosi attendibili testimoni hanno visto estrarre, nel corso degli anni: un clarinetto basso, un clarinetto medio e un clarinetto piccolo, uno scoiattolo di plastica, uno scoiattolo vero, 456 bustine di tè alla pesca, sessantacinque di camomilla e 560 wafer alla nocciola, un quartetto d’archi boemo persosi a Modena e prontamente infilato dal Succi nel parallelepipedo, alcune pizze salsiccia e funghi, due scatole di mandorle denocciolate, e qui qualcuno deve avergli fatto uno scherzo perché le mandorle non hanno i noccioli, un giocatore di badminton samoano troppo piccolo per giocare a rugby, un coniglio rosa, un sax contralto, una confezione di pasta pronta al sugo di capriolo, un capriolo irritato per essere stato messo in un sugo, una minicar della Subaru, dell’aceto balsamico, una foto con dedica di Max De Aloe usata come sottobicchiere, alcune noci e due gemelle ginnaste praghesi Per queste, e per molte altre cose che qui non sto a scrivere perché devo fare il bagno, vorrei essere Achille Succi ma sono nano, troppo peloso e sottilmente patetico, quindi mi accompagna la ragionevole certezza che non lo sarò mai. Adesso basta, che mi sveglio.
Oliver Sacks
Il cinquantaseienne che compra la Harley dopo aver compiuto i cinquantasei anni è persona che dentro di sé coltiva con delicatezza e in segreto, se no lo coltiverebbe fuori di sé, un oscuro sogno di morte e di politraumatismi di vario genere, solo parzialmente lenito e convenientemente rallentato dall’avere guidato uno di quei terrificanti scooteroni monomarcia che sembrano enormi caffettiere pronte a scoppiare. Dopo avere accantonato per un sessennio una serie di fondi neri depositati presso una cassa rurale e artigiana diretta dal suo ex compagno di banco del liceo, tacendo tutto alla moglie che ne era egualmente a conoscenza essendo l’amante del suddetto compagno di banco, il nostro cinquantaseienne che chiameremo convenzionalmente Gamete, un solatio giorno di radiosa primavera, si reca dalla concessionaria più lontana da casa sua, per non destare sospetti. Dopo essersi inventato un viaggio di lavoro in Gambia arriva a Roma ed entra nella enorme sede della Ardenne Motors, concessionaria multimarca, e dopo aver cercato infruttuosamente di scendere da solo da una Harley Davidson Electra Glide Purple Heart Brazen Leg di 1780 cavalli di cilindrata viene soccorso pietosamente da un addetto alla vendita, che lo deposita, con le membra irrigidite da un crampo alla schiena bassa, davanti a uno dei venditori. La motocicletta pesa 6 tonnellate e ha un costo di 98mila euro, senza optionals; essendo previsto tra gli optionals anche il motore Gamete decide di farlo mettere, senza pare che fosse
difficile farla partire, e dopo questa aggiunta la cifra raggiunge i 125 euro, che è esattamente il doppio della cifra che aveva accantonato. Colto tuttavia da un raptus, con la caviglia destra che cominciava visibilmente a tremare, il Nostro decide per l’acquisto, andando però a sbattere contro il vaso di fiori in cristallo della scrivania in un eccesso di svolazzo nella firma del contratto di vendita. Comincia a sanguinare copiosamente ma si tampona la ferita con una copia di Class e una di Le Ore che trova sul tavolino, affetta una residuale indifferenza, si alza piangendo in silenzio e si avvicina alla sua Harley, e solo in quel momento si accorge che è rosa metallizzata con le ruote bianche. Sviene, e poco prima di perdere i sensi vede, confusamente, la sagoma della moglie entrare in concessionaria con una motosega da giardinaggio tra le mani. Poi, il buio. Poi, gli appare Oliver Sacks, il neurologo, che cavalca una elegante BMW nera degli anni ’50, quel modello con le frecce ai lati delle manopole, molto cool con un giubbotto di pelle nera che gli sottolinea il torace ampio; Sacks non dice niente, fissa il cinquantaseienne, scuote l’indice da destra a sinistra facendo segno di NO, la testa da sinistra a destra facendo segno di NO, e riparte rombando senza mettersi il casco.
Johann Sebastian Bach
Potete sfiorare la guancia di vostra moglie, se proprio ci tenete, quella della vostra amante, e qui vi vedo già più convinti, ma non dovrete mai sfiorare i tasti di un clavicembalo, dovrete premerli. Non tutti insieme, possibilmente, se non quando espressamente indicato dall’autore, cioè da me. Johann veniva da me quasi tutti i giorni, una volta si è presentato con un pasticcio di rognone, cosa che ho molto apprezzato, invero, e notavo dei miglioramenti costanti ma sempre lievi, appannati, era come se suonasse sotto una coperta di lino, immateriale ma presente. Si chiamava anche lui Johann ma la cosa al momento non mi ha preoccupato, è un nome abbastanza comune, non mi ero infastidito, forse stupito, ma non tanto, solo un po’. Esercito di rado l’arte della stupefazione perché la trovo, mediamente, inutile. Io usavo spesso il metodo della coperta di lino per nascondere la tastiera, ma nel suo caso era come se questa coperta ce l’avesse direttamente sulla testa, rendendo tutto ovattato. Per questo motivo ho deciso di dargli una mano, scrivendo qualche variazione che partisse da un tema. Semplice il tema, abbastanza complesse, anche se non tanto, le variazioni, tutte fattibili da un essere umano di grado medio e di intelletto modesto anche se le mani, che dovrebbero essere due, sono coperte da una sottile striscia di lino bianco. Su questa storia del lino bianco si è innervata, come dite in italiano innervata adesso non mi viene in mente, nella mia lin-
gua comunque è verschneit, una storia più piccola dell’altra nella quale si racconterebbe che il lino bianco non servirebbe a niente perché essendo bianco è trasparente e essendo trasparente le mani si vedono lo stesso ma questo poco o nulla c’entra, le mani si possono anche vedere, uno sa di averle, di solito, lo scopo era quello di renderle meno visibili a chi le stava usando, trasformandole semplicemente nella parte terminale dei suoi pensieri, che avrebbero dovuto seguire la mia musica. Oltre a questa esiste l’altra storiella, quella principale, secondo la quale le avrei scritte per allietare le notti insonni di un angeberischer Angeber, un nobilastro sfaccendato che non riusciva a dormire, col povero Goldberg nella stanza accanto che gliele suonava per fargli prendere sonno, ma io non scrivo musica per fare addormentare la gente, piuttosto per fare il contrario, per tenerla sveglia e farle scoprire qualcosa che non sa. Fare scoprire alle persone cose che non sanno, questo dovrebbe essere uno degli scopi principali della musica, della mia come quella di altri. Se non impari niente di nuovo ascoltando della musica o sei completamente tonto, il che può anche essere, o il compositore ha fallito. Nel mio caso siete sempre tonti voi, è chiaro.
Thelonius Monk
Era già sera molto avanzata, le sere avanzano senza che noi possiamo farci niente per diventare notti, quando il piccolo sognato corpo di Thelonious Monk che ballava seguendo una musica tutta sua che nessuno poteva ascoltare attraccò e prese possesso della mia mente, che fino a quel momento era stata sgombra e quieta. Quel giorno non era successo niente che potesse farmi solo pensare che la notte mi avrebbe portato Thelonious Monk in sogno, io mi sarei aspettato qualcosa di più semplice, una ballerina ipercinetica, una campagna assolata o con la pioggia, uno di quegli arabeschi di pensieri che di solito vengono sognati dalle persone che sognano, una mandria di trichechi e di balene, non Monk che vestito di grigio ballava su un palco illuminato. Inizialmente pensai al palco, pensando come si può pensare quando si sogna, in modo intermittente e casuale, pensai che quel palco era troppo grande per un uomo solo, e che era strano che questo uomo fosse da solo su un palco, che era ancora più strano che fosse vestito di grigio chiaro, che avesse una cravatta e che avesse in testa un colbacco. Era però un sogno nel quale stavo sognando di sognare quindi feci finta di ignorare la questione spinosa del colbacco e quella meno spinosa del completo grigio, nei sogni le spine sono stondate e si sentono meno. Quello che continuava a farmi divisare inquietudini era il ballo, questa danza solitaria che seguiva una musica che io non sentivo, ma che con ogni evidenza sentiva lui, Thelonious Monk. Girava le spalle a destra e a sinistra, alzava le mani disegnando qualcosa nell’aria, disegnare nell’aria è una attività molto complicata perché se
sbagli non puoi correggerti, è già volato via tutto, muoveva il bacino come se dovesse cacciare via, allontanare con grazia indomita qualcuno o qualcosa che gli stava troppo vicino, e teneva gli occhi rivolti verso l’alto, guardava il colbacco, probabilmente, faceva molta attenzione al colbacco, sembrava più interessato al colbacco che alla musica ma io non potevo saperlo, perché non sentivo nessuna musica, all’inizio del sogno, ma ero anche caritatevole con me stesso e con Thelonious che aveva deciso di visitarmi, e decisi di aprire bene le orecchie, per cercare di sentire quello che stava sentendo lui, e qualcosa cominciò ad arrivare, da lontano, un suono, due suoni, cinque suoni, all’inizio tenui e poi più sfolgoranti, bassi e poi alti, angolosi e strani, avvolti da una bellezza appariscente ma nascosta, nei sogni si può essere nascosti ma anche appariscenti, e cominciai, sempre nel sogno, ad elaborare un codice, una curiosa esegesi onirica che mi aiutava a capire quello che stava succedendo: quando alzava le braccia andava in alto, quando girava il bacino andava in basso, quando si spostava di lato con dei graziosi, piccoli e leziosi passetti da gufo stava per dare l’attacco a un nuovo pezzo, e andando avanti a sognare mentre Thelonious danzava divenne tutto più chiaro, quello non era un palco ma era il ponte di una nave e io mi stavo avvicinando sempre di più alla parte centrale del ponte e cominciavo a vederne le vele, che si stavano gonfiando, sempre di più, mentre la danza di Monk continuava sotto di esse e diventava quasi frenetica e la musica aumentava, di intensità e bellezza, e spingeva sempre più aria verso le vele, che erano diventate gonfie ed enormi, e le vele erano delle braccia aggiuntive a quelle che avevo visto mulinare fino a poco tempo prima, e in fondo al ponte apparve un pianoforte, aperto, dal quale si alzò un altro Monk, che mi salutò. Dopo poco mi svegliai e cominciai a ballare anch’io, senza colbacco.
33 Sigmund Freud
Le rose sono rose, non sono fiori che possono essere altro che fiori, non sono come le margherite che sono quasi sempre anche altro, sono dei fiori che non riescono a uscire dalla loro condizione di florealità. Spesso sono rosse o gialle, mai verdi. Nel sogno Sigmund, di cognome Freud, le osservava, le guardava da vicino e poi da lontano e poi ancora da vicino, addomesticava la sua curiosità avvicinandosi all’oggetto osservato e poi allontanandosene in modo subitaneo, e sogghignava. Sogghignare non vuol dire propriamente ridere, vuol dire pensare di dover ridere senza darlo a vedere, alzando la parte superiore del labbro senza muovere il resto della faccia, Freud in questo era un maestro, dimmi che sto ridendo anche se non sto ridendo. Nel sogno aveva un completo grigio con un panciotto rosso, a 5 bottoni, con due taschini. Da quello di destra occhieggiava la pupilla dilatata di un piccolo topolino bianco, che, come Sigmund, sogghignava. Alcun anni prima Freud, che oltre a osservare le rose aveva codificato quella strana, curiosa professione che consisteva nell’ascoltare persone con problemi di vario genere simulando un interesse nei loro confronti e fingendo di aiutarli a risolverli, aveva pubblicato un caso clinico, la Bemerkungen über einen Fall von Zwangsneurose, cioè le Note su un caso di nevrosi ossessiva, l’anno era il 1909, e riguardava una persona non fortunatissima nella sua esistenza psichica che sentiva un relativo sollievo solo torturando i topi con i quali veniva in contatto; quindi, a parziale saldo del debito che Freud sentiva di avere nei confronti di questi animalet-
ti, forse non fascinosi ma destinatari dello stesso diritto alla vita che poteva avere un cavallo o un coniglio, ne portava sempre uno con sé, nel taschino del panciotto, e insieme a lui osservava intensamente le rose. Il coniglio a un certo punto si stufò di guardare quello che stava guardando e cominciò a cercare una carota.
34
Duke Ellington
Era su un letto di ottone, con la spalliera alta, e fissava il soffitto. Il soffitto era alto, a cassettoni, al centro c’era una incisione sul legno, sembrava un pavone, almeno, a Duke Ellington sembrava che fosse un pavone. Un pavone inciso, inserito in un soffitto di legno che sembrava dovesse sbattere le ali e invece rimaneva fermo, immobile. Duke scriveva note su un pentagramma, prima poche, due, tre, poi gruppi di sette o otto infine maree di note, per poi ritornare a lasciare riposare la carta. C’era una finestra, una persona piccola e gentile con un paio di occhiali dalla montatura leggere si era affacciata e aveva dato a Duke un piccolo foglio di carta, un lacerto piccolo di qualcosa di molto più grande, senza dire una parola, nessuno diceva niente, e il sole entrava dalla finestra senza essere fermato dalle tende. Il pavone, forse, si mosse, ma nei sogni è molto difficile riconoscere il moto dalla stasi, forse era solo un riflesso delle tende. Forse non era un pavone, certo non era nemmeno un gatto, era una donnola che sembrava un pavone che fingeva di essere un gatto, ma era tutto così dannatamente impreciso da sembrare irreale, un sogno, appunto. A un certo punto è arrivato un altro uomo, nero, è apparso l’uomo nero, aveva con sé una borsa molto grande, si chiamava Harry, Duke Ellington lo ha chiamato Harry, e dopo essersi detti qualcosa è uscito, lasciando a Duke un paio di chiavi. Il pavone, che forse non era un pavone, continuava a stare al suo posto, con la sua tipica espressione lignea.
Mozart era seduto al tavolo di una locanda poco frequentata, c’era poca luce e poca gente, le poche persone sedute agli altri tavoli stavano facendo molto rumore, chi urlava, chi ruttava, chi faceva entrambe le cose contemporaneamente, chi contava in silenzio i cerchi bagnati lasciati dai calici di birra sul tavolaccio in legno, che traballava vistosamente. Indossava la sua giacca rossa, quella che usava per i concerti, con un paio di vistose macchie di sugo ai lati. Mozart giocava con una forchetta senza uno dei rebbi, mancava quello centrale, sembrava la dentatura incompleta di una vecchia, pensava Mozart, e la cosa, come spesso gli capitava, gli portava alle labbra un riso incontenibile, tutto quello che vedeva e che faceva lo divertiva, e cercava sempre di controllarsi, perché le persone non apprezzavano molto questo suo comportamento. Allora, per evitare di infastidire i suoi coetanei, che vedeva così diversi da lui, ogni tanto fingeva di essere come loro, rideva alle loro battute, che non lo facevano ridere, apprezzava le loro musiche, che non apprezzava, beveva le loro birre, che invece apprezzava. Sapeva che sarebbe stato solo di passaggio, e usava spesso il passo del lupo, il wolf gang, per passare attraverso quelle persone che gli sembravano ombre, mai dire a uno che sembra un’ombra che sembra un’ombra, quindi rideva e tirava dritto.
Aristotele è seduto su una bicicletta, non in modo elegante, ha uno dei glutei parzialmente in evidenza, in parole povere gli si vede bene un pezzo di culo, abbondante, la bicicletta è gialla, con due adesivi piccolini sulla canna, uno con una banana e l’altro con una pera a fette piccole, Pedala controvento, ha i capelli spettinati, e fuma un sigaro, con la difficoltà provata da chiunque tenti di fumare un sigaro col vento che fa di tutto per impedirglielo. Mentre pedala, Aristotele suda, mentre suda, pensa. Proseguendo, si trova in una città utopica, forse l’Atlantide dei suoi racconti, dove le strade sono perfettamente ordinate e i cittadini vivono in armonia. In questo luogo, Aristotele riflette sulla giustizia e sull’organizzazione ideale della società, osservando come ogni individuo contribuisca al bene comune con dedizione e saggezza. Poi si avvicina a una grotta oscura. In un attimo, comprende di essere arrivato alla famosa caverna del mito del suo collega di scopone scientifico, Platone. Scende dalla bicicletta e si avventura all’interno, dove vede le ombre danzare sulle pareti, proiettate da un fuoco invisibile. Ricorda le sue parole sul mondo sensibile e il mondo intelligibile, comprendendo ancora una volta l’importanza della conoscenza e dell’illuminazione, soprattutto quando c’è buio. Mentre si avvicina all’uscita della grotta, la luce del giorno si fa sempre più intensa, lo acceca, scivola e cade. Dopo essersi rialzato Aristotele torna sulla sua bicicletta e pedala verso il sole, simbolo della verità e del bene. Si sveglia poco dopo, con
una nuova chiarezza nei suoi pensieri e un sorriso sul volto, consapevole di aver viaggiato, anche solo in sogno, attraverso i principi fondamentali della sua filosofia.
Platone è seduto su una bicicletta, non in modo elegante, ha uno dei glutei parzialmente in evidenza, in parole povere gli si vede bene un pezzo di culo, abbondante, la bicicletta è gialla, con due adesivi piccolini sulla canna, uno con una banana e l’altro con una pera a fette piccole- Pedala controvento, ha i capelli spettinati, e fuma un sigaro, con la difficoltà provata da chiunque tenti di fumare un sigaro col vento che fa di tutto per impedirglielo. Mentre pedala, Platone suda, mentre suda, pensa. Proseguendo, si trova in una città utopica, forse l’Atlantide dei suoi racconti, dove le strade sono perfettamente ordinate e i cittadini vivono in armonia. In questo luogo, Platone riflette sulla giustizia e sull’organizzazione ideale della società, osservando come ogni individuo contribuisca al bene comune con dedizione e saggezza. Poi si avvicina a una grotta oscura. In un attimo, comprende di essere arrivato alla famosa caverna del suo mito. Scende dalla bicicletta e si avventura all’interno, dove vede le ombre danzare sulle pareti, proiettate da un fuoco invisibile. Ricorda le sue parole sul mondo sensibile e il mondo intelligibile, comprendendo ancora una volta l’importanza della conoscenza e dell’illuminazione, soprattutto quando c’è buio. Mentre si avvicina all’uscita della grotta, la luce del giorno si fa sempre più intensa, lo acceca, scivola e cade. Dopo essersi rialzato Platone torna sulla sua bicicletta e pedala verso il sole, simbolo della verità e del bene. Si sveglia poco dopo, con una nuova chiarezza nei suoi pensieri e un sorriso sul volto, consapevole
di aver viaggiato, anche solo in sogno, attraverso i principi fondamentali della sua filosofia. Che è come quella di Aristotele che aveva usato una bicicletta diversa.
36 Mario Soldati
La città potrebbe essere Torino, c’è la nebbia, questo non basta a farci pensare che sia Torino ma potrebbe esserlo, è vero che la nebbia c’è anche a Tokio, anzi se vogliamo o dobbiamo essere precisi forse c’è più nebbia a Tokio che a Torino ma a Tokio è improbabile trovare Mario Soldati, quindi pensiamo di poter essere a Torino, probabilità resa vieppiù certa dai cartelli stradali, che sono scritti in italiano e non in giapponese, e questi ci fa propendere nettamente per l’Italia. Soldati non ha ancora i baffi ma ha già un sigaro in bocca, un sigaro più piccolo di quelli che fumerà più avanti, quando avrà anche i baffi, e sembra essere più piccolo, con un ciuffo di capelli folto al centro del cranio, e una camicia bianca con una enorme cravatta rossa Sta parlando fittamente con un signore molto distinto, che profuma di acqua di colonia, lo chiama per nome, il nome è Lionello, il signore è Lionello Venturi col quale studierà e poi si laureerà in storia dell’arte, alcuni anni più tardi. In quel momento stanno parlando fittamente, il vero Lionello Venturi nella sua forma attuale e presente e una ipotesi progettuale di quello che sarà l vero Mario Soldati, nella sua forma futura e ipotizzata. La sola, grossa differenza col Mario di vent’anni dopo sarà che il sigaro non si accenderà più da solo, come in questo caso, ma avrà bisogno di una mano e di fuoco. Per il resto, tutto uguale.

Charles Mingus
Non è vero che Mingus fosse sempre arrabbiato, non è vero che sentisse sempre soffiargli sulla faccia il vento della rabbia, non è vero che picchiasse tutti quelli che incontrava, ogni tanto, qualche volta, una di queste cose poteva succedere, certo, ma non sempre e non tutte insieme. Il vento, quello, c’era sempre, insieme all’inquietudine. C’era una rabbia qualitativa e una quantitativa una che sapeva nominare e una che poteva solo subire una che lo avvolgeva e una che lo dominava, e quando se ne sentiva dominata cominciava a chiamare la rabbia con un nome che inventava lui, maschile o femminile, perché aveva capito che il primo passo per cercare di controllare le cose, le persone, gli animali e gli stati d’animo era quello di chiamarli per nome, e quando chiamava per nome il vento freddo che gli tagliava la faccia sentiva che diminuiva quasi subito.
Thelonius Monk
Era già sera molto avanzata, le sere avanzano senza che noi possiamo farci niente per diventare notti, quando il piccolo sognato corpo di Thelonius Monk che ballava seguendo una musica tutta sua che nessuno poteva ascoltare attraccò e prese possesso della mia mente, che fino a quel momento era stata sgombra e quieta. Quel giorno non era successo niente che potesse farmi solo pensare che la notte mi avrebbe portato Thelonius Monk in sogno, io mi sarei aspettato qualcosa di più semplice, una ballerina ipercinetica, una campagna assolata o con la pioggia, uno di quegli arabeschi di pensieri che di solito vengono sognati dalle persone che sognano, una mandria di trichechi e di balene, non Monk che vestito di grigio ballava su un palco illuminato. Inizialmente pensai al palco, pensando come si può pensare quando si sogna, in modo intermittente e casuale, pensai che quel palco era troppo grande per un uomo solo, e che era strano che questo uomo fosse da solo su un palco, che era ancora più strano che fosse vestito di grigio chiaro, che avesse una cravatta e che avesse in testa un colbacco. Era però un sogno nel quale stavo sognando di sognare quindi feci finta di ignorare la questione spinosa del colbacco e quella meno spinosa del completo grigio, nei sogni le spine sono stondate e si sentono meno. Quello che continuava a farmi divisare inquietudini era il ballo, questa danza solitaria che seguiva una musica che io non sentivo, ma che con ogni evidenza sentiva lui, Thelonius Monk. Girava le spalle a destra e a sinistra, alzava le mani disegnando qualcosa nell’aria, disegnare nell’aria è una attività molto complicata
perchè se sbagli non puoi correggerti, è già volato via tutto, muoveva il bacino come se dovesse cacciare via, allontanare con grazia indomita qualcuno o qualcosa che gli stava troppo vicino, e teneva gli occhi rivolti verso l’alto, guardava il colbacco, probabilmente, faceva molta attenzione al colbacco, sembrava più interessato al colbacco che alla musica ma io non potevo saperlo, perché non sentivo nessuna musica, all’inizio del sogno, ma ero anche caritatevole con me stesso e con Thelonius che aveva deciso di visitarmi, e decisi di aprire bene le orecchie, per cercare di sentire quello che stava sentendo lui, e qualcosa cominciò ad arrivare, da lontano, un suono, due suoni, cinque suoni, all’inizio tenui e poi più sfolgoranti, bassi e poi alti, angolosi e strani, avvolti da una bellezza appariscente ma nascosta, nei sogni si può essere nascosti ma anche appariscenti, e cominciai, sempre nel sogno, ad elaborare un codice, una curiosa esegesi onirica che mi aiutava a capire quello che stava succedendo: quando alzava le braccia andava in alto, quando girava il bacino andava in basso, quando si spostava di lato con dei graziosi, piccoli e leziosi passetti da gufo stava per dare l’attacco a un nuovo pezzo, e andando avanti a sognare mentre Thelonius danzava divenne tutto più chiaro, quello non era un palco ma era il ponte di una nave e io mi stavo avvicinando sempre di più alla parte centrale del ponte e cominciavo a vederne le vele, che si stavano gonfiando, sempre di più, mentre la danza di Monk continuava sotto di esse e diventava quasi frenetica e la musica aumentava, di intensità e bellezza, e spingeva sempre più aria verso le vele, che erano diventate gonfie ed enormi, e le vele erano delle braccia aggiuntive a quelle che avevo visto mulinare fino a poco tempo prima, e in fondo al ponte apparve un pianoforte, aperto, dal quale si alzò un altro Monk, che mi salutò. Dopo poco mi svegliai e cominciai a ballare anch’io, senza colbacco.
Lina Sotis
La signora Lina Sotis, milanese ma romana di nascita, aveva un appuntamento con la signora bresciana in un sushi bar in zona duomo ma era in considerevole ritardo perché il nuovo smalto organico cruelty free arrivato in settimana dalla Thailandia faceva una fatica estrema ad asciugarsi, forse in Thailandia c’è più sole, si chiedeva la signora, ma il ritardo si stava facendo imbarazzante, la bresciana la stava aspettando e nel concilio forense delle sue amicizie la bresciana era nota per la puntualità e per la tendenza a rimarcare per tre lustri chi, poverino, fosse arrivato in ritardo ad un appuntamento, emettendo una bolla di scomunica che avrebbe segnato a fuoco le carni della malcapitata: poiché alle sue carni teneva molto, non fosse altro per i soldi che aveva speso per mantenerle così turgide, la signora milanese, effettuando un salto concettuale che le avrebbe sicuramente creato una cefalea tensiva per le successive 48 ore, aveva abbandonato a malincuore l’idea di indossare uno dei suoi ottantanove sandali pitonati e si era decisa a offrire una possibilità alle sneakers Powerball Ranger Suntan 600, che avevano il non trascurabile particolare di essere scarpe chiuse, con le dita e le conseguenti unghie dei piedi al coperto. Comprimendo una fitta di dolore che le dilagava nello sterno rimise a posto i sandali nella scarpiera con le ante in onice, emise un grosso sospirò ed infilò i piedi nelle Suntan 600, e solo in quel momento capì che 600 era il peso delle calzature, ed era espresso in chilogrammi. Dopo averle allacciate tentò di alzarsi, riuscì fortunosamente a raggiungere una posizione semieretta ma
la scarpe la trascinavano inesorabilmente verso il basso, riusciva a fare solo dei piccoli, brevi passi con le gambe rigide e le rotule scricchiolanti: nel sedersi per cercare un momentaneo sollievo aveva avuto una fascicolazione improvvisa alla gamba destra che era scattata innaturalmente in avanti proprio mentre i due carlini nani, Edo e Eda, si stavano avvicinando allo specchio della cabina armadio per guardarsi. Animali orrendi, dotati di piccole zampette vestigali e una monoespressione di orripilante idiozia, non si aspettavano in alcun modo che la loro amorevole padrona potesse colpirli direttamente con una scarpa dal peso unitario così elevato, e in pochi secondi i loro corpi vennero prima proiettati verso la parete est, poi verso quella sud, quindi verso quella nord per poi arrivare a fine corsa nell’acquario in titanio che conteneva Osiride, un piranha di 2 anni ipovedente. Seguendo il rumore dell’acqua che si increspava in seguito alla caduta dei due corpi canini, Osiride pensò che fosse già ora di cena e fece quello che avrebbe fatto un piranha in un caso del genere, aprì le mandibole e le richiuse per 32 volte di fila, ricavandone una certa soddisfazione. La signora milanese con l’arto ancora in estensione arrovesciò entrambi gli occhi verso l’alto e con le sclere ormai bianche cadde al suolo, svenuta, emettendo un piccolo rantolo, tipo un ruttino.
Una mattina, era presto perché era mattina, il signor C. si alzò e dopo essersi alzato decise di ritornare a letto perché non aveva niente da fare tutto il giorno, a parte chiudere la tazza del cesso retroilluminata, giallo canarino deceduto, ma non aveva voglia di mettere le enormi chele sul freddo pavimento di cotto, e lasciò la tazza del cesso aperta. Totalmente aperta, con una certa, conseguente oscenità. Dopo quarantasei minuti ebbe ancora voglia di alzarsi ma riuscì ancora ad evitarlo: era un uomo di forte tempra etica, il dominio della volontà sull’azione era totale.
Cochi Ponzoni
Bud Powell
Bud Powell camminava sempre storto. Sempre. Mai fatti più di 140 metri senza andare storto. Non seguiva mai linee rette. Tutti glielo facevano notare, glielo dicevano, e lui di rimando li premiava con uno dei suoi sguardi acquei, fissi e trasparenti, come se la cosa non lo riguardasse affatto. A lui sembrava di camminare dritto. Drittissimo. Come un razzo. Gli piacevano i razzi, quei missili argentati con le alette che erano i protagonisti dei suoi amati racconti di fantascienza. Era un lettore vorace di quelle storie e in quei momenti il carico insopportabile della sua vita gli appariva più lieve. Sorrideva, pensando ai piccoli alieni verdognoli che osservavano con disprezzo i prodi e biondi esploratori lunari, si era sempre sentito dalla loro parte, dalla parte degli indiani, dalla parte sbagliata insomma. Anche quando suonava e si lanciava in quelle sue scorribande sulla tastiera del pianoforte, quando ingaggiava una lotta che sapeva persa in partenza con i suoi demoni si sentiva dalla parte sbagliata, della musica e del mondo. Lo sapeva che lui stava dalla parte buia e che la parte chiara del mondo non lo voleva. Ne era perfettamente consapevole. Però era felice lo stesso, e si sentiva anche lui un piccolo marziano. Capitato sul pianeta sbagliato.
Paolo Sorrentino
Una veloce disamina delle sue prossime fatiche cinematografiche.
1. Le foche corrono sui rulli, un accorato, denso apologo sulla solitudine di una foca alla periferia di Denver, la sola attività del mammifero carnivoro sarà quella di correre su un rullo, per circa tre ore e dieci minuti
2. Il saprofita intelligente: il film, con sottotitoli in iraniano, racconta della esistenza solitaria e innervata di dubbi di Paek, un giovane orfano che abbandonato dagli zii in una biblioteca di Patrasso ne diventa il direttore e scrive saprofita in tutte le lingue su tutti i muri dell’edificio. Alla fine muore soffocato da un gamberetto. Durata tre ore.
3. Il professore e lo sparafoglie che viene dallo spazio. La pellicola, liberamente ispirata alla figura archetipale del professor Piersandro Pallavicini detto Pally con accento sulla y, ci consegna con graziosa gentilezza il vivido ritratto di un fascinoso professore universitario di mezza età, di vasta erudizione e dilagante eleganza, che viene perseguitato nei sogni da un enorme sparafoglie alieno condotto da un nano di colore, tale Juan. Ossessionato da questa presenza onirica, il professore tiene vicino al letto un alano arlecchino di cashmere, che abbraccia ogni volta che si sveglia in preda al terrore. Una sera la donna delle pulizie originaria della DDR ed ex discobola si dimentica di collocare Rufus, questo è il nome che il professore ha dato all’alano, vicino al letto. Quando nel cuore della notte il professore si sveglia per il suo consueto incubo non lo trova e per la disperazione si
lancia nella piscina a forma di asfodelo. Dissolvenza, il cuore è uno zingaro di Nicola di Bari in sottofondo, urlo del professore. Durata sette ore, di cui cinque di titoli di coda.
4. L’amante dell’avvocato. In tutti i film francesi della nouvelle vague troviamo una coppia di intellettuali di sinistra che si sono dimenticati perché sono intellettuali di sinistra e si comportano come dei notai di destra. Lei indossa solo cappotti di tre misure più larghi, il colore preferito è il verdegiallorossoarancio mentre lui, che si chiama Philippe o Armand ma che viene chiamato sempre Lolò con l’accento grave sulla seconda O ha tre giacche di velluto verde a coste, che indossa spesso una sull’altra. Vivono in un appartamento all’ultimo piano di rue des Escargots malades, al numero 21, e convivono con due gatti e tre pesci rossi; dopo un po’ i pesci rossi diventano due e uno dei gatti ha una espressione molto felice. Lei è laureata in storia medievale con una tesi sulla omosessualità nei Catari e aspetta che il suo professore, con il quale intrattiene corposi rapporti sessuali nel suo studio, le confermi una nuova borsa di studio, cosa che purtroppo non accadrà perchè durante uno dei loro amplessi furibondi il tomo del Levinas-Cressisky di 8.900 pagine sulla guerra franco-prussiana cadrà sul collo del suddetto professore, rompendoglielo. Lei rimetterà a posto il libro e chiamerà i soccorsi, che una volta arrivati potranno solo constatare il decesso accidentale del famoso cattedratico, già bluastro per il rigor mortis. Lui, Lolò, avvocato praticante nello studio Pressebosque di places des Vosges 23-26-28-3032-34-36-38, ha da tre anni una relazione con madame Dussolier-Yringuette, la moglie del suo capo, che nel tentativo di deglutire un pesce rosso ancora vivo nel corso di un gioco erotico si soffocherà, non riuscendo più a espellere il carassio dorato. Entambi si ritroveranno improvvisamente senza
amanti e col il frigorifero rotto, perché un malheur n’arrive jamais seul, come dice Lolò fissando il ghiaccio che cola dall’elettrodomestico.
Alla fine di tutto arriva Renè Clair e dice a tutti qualcosa in francese, senza che nessuno capisca niente.
44
Cannoball Adderley
Julian Edwin (CHE PRECISIONE) Adderley suonava il sax contralto, solo in qualche rarissimo caso il sax soprano, era nato in Florida e aveva dentro di sé il sole, che faceva esplodere ogni volta che suonava. Tutti gli esperti sanno che CANNONBALL era una storpiatura del nomignolo CANNIBAL, datogli perché lasciato solo avrebbe mangiato anche le gambe del tavolo ma queste sono bagatelle inutili, per esperti, appunto. Musicista dalla articolazione strumentale prodigiosa, ogni volta che suonava irrideva i limiti tecnici del suo strumento perché per lui, fortunato, non esistevano limiti tecnici. Aveva portato un bel malloppo di blues nel gruppo di Miles Davis ma per una questione di sopravvivenza fisica non posso scrivere Miles Davis senza che arrivi Merlino a dirmi a che ora si tagliava le unghie, quindi evito. Voglio solo parlarvi, con un severo esercizio di retorica e di contenimento, di tre pezzi di Julian Edwin, scelti ubbidendo a una selvaggia, incoercibile etica personale, per me sono i più rappresentativi, per il resto del mondo non lo so perché non lo conosco tutto.
1. Stars fell on Alabama, dal disco Cannonball Adderley Quintet in Chicago, pubblicato dalla Mercury Records nel 1959 (quante notiziole inani, nevvero?), disco che uscirà, identico, anche nel 1964 col titolo Cannonball & Coltrane, perché c’era anche Coltrane che in questo brano, bontà sua, non suona. Questo non è un pezzo, non è un assolo, ma è una enciclopedia di suoni, di ritmo, di invenzione musicale: è una scalata verso le stelle, forse per evitare che cadano tutte al suolo, che Cannonball fa usando il suo sax contralto, piegandolo, con-
torcendolo, imprimendogli un ritmo accelerato, fermandosi, inserendo del sangue blues, per poi tornare alla felina calma iniziale. Se le stelle fossero cadute che so a Bergamo probabilmente non sarebbe stata la stessa cosa.
2. Waltz for Debby, registrato con Bill Evans il 13 marzo 1961. Inizia come un acquerello, a metà cambia ambito espressiva diventando quasi una statua, poi torno a essere un acquerello: Bill Evans, lo sanno tutti, suonava il pianoforte, lo sapevo anche Edwin che non essendo uno sprovveduto se lo era scelto come pianista in questa incisione. Il pezzo, di Evans, è delicato, leggiadro, a tratti etereo, e il sax contralto entra in punta di piedi, come quelle scarpe a punta che si infilano nelle porte socchiuse; una volta entrato si guarda intorno, dilaga con eleganza, e con la stessa eleganza con cui era entrato se ne va. La porta la apre e la chiude Bill Evans, un privilegio spesso accordato ai pianisti.
3. A little taste, contenuto nel primo album di Julian Cannonball Adderley, pubblicato dalla Savoy Records nel 1955. Dovrebbe essere un medium tempo, ma di medium, qui, non c’è niente. Dopo l’esposizione del tema all’unisono con la cornetta del fratello Nat, comincia a entrare in campo il suo contralto, dapprima con qualche nota rugosa e pienotta nel registro grave, e poi comincia la danza. Pur cercando di trattenersi, come le sue mani fossero controllate da qualche filo invisibile agli altri ma non a lui, come se si dicesse QUI PIANO SE NO
SI SPAVENTANO, in nuce c’è già tutto quello che poi diventerà, una esplosione cosmica di gioia, luce, suono e colore. Se avete una cosmogonia personale Julian Edwin “Cannonball” Adderley dovrebbe essere messo più o meno al centro; se non ce la avete, peggio per voi. Il tutto mentre lui era in cucina, a preparare un piatto di deliziosi tortellini con abbondante panna e abbondante piselli, tutto in lui era abbondante.
Philippe Daverio
Il giorno 25 dicembre dalle ore 17.45 visita guidata per un numero massimo di trentadue persone, se arriviamo al numero di trentacinque le tre eccedenti verranno messe nel bagagliaio di una Skoda in attesa della prossima visita, alla casa-studio-casa di Porrentruy di Ugoberto Obvaldo, un imagista del diciottesimo secolo. Sarà possibile prendere visione della ricchissima biblioteca del professore, toccare la sua sedia Orinoco in midollino con il caratteristico cuscino a sostegno lombare, la piccola piscina coperta esagonale mantenuta sempre a una temperatura di venticinque gradi, la scrivania in bambù Takeo con i fenicotteri rosa che muovono il collo quando nella stanza si pronuncia la parola SESQUIPEDALE, la stanza dei cocktails con le pareti rivestite di pasta di mandorle, la raffinata collezione di tostapane appartenuti a Charles Lennox, duca di Richmond, improvvidamente deceduto per la esplosione di uno di essi. A discrezione del professore, persona di grande umanità e incoercibile gentilezza, sarà possibile farsi autografare le copie in vendita di un suo racconto giovanile mai giunto alle stampe, il romanzo erotico “Vibratili vibrisse che vibrano”, con sette vibrisse fuori testo. Per contatti vi prego di scrivermi a comunicazionepercloruropertutti@gmail.com. Poi, il risveglio.
Il problema dell’asola è che aspetta il bottone, e a volte il bottone non arriva. L’asola si contrae, si distende, si prepara, ma non arriva niente, nessun bottone. E l’asola resta lì, inerte, come un tronco senza un nido di cutrettole. In pratica il bottone è una cutrettola. E non lo sa. Il bottone non sa di essere una cutrettola e la cutrettola non sa di essere un bottone, entrambi, forse, sanno di non sapere non sapendo di non sapere senza capire che sapendo di non sapere forse sanno, ma uno è un bottone, l’altro è una cutrettola, e soprattutto è un sogno.
Lo struggente racconto di un ritorno alla natura Madre che tutto avvolge, il rapinoso turbamento che ti prende davanti a un mandorlo robusto e odoroso, i campi che ti circondano e ti rimandano, oltre che un generoso odore di merda, afrori di tiglio e cinnamomo, ma non hai campo sul tuo iPhone e non riesci a farci sapere quanto è bello stare in campagna, nel mentre una simpatica oca di nome Lotaria tenta di possederti con trasporto indomito. Tu non puoi opporti all’oca Lotaria perché in essa vedi il futuro e il passato e il presente del mondo, quindi ti accomodi e speri che non ti veda.
Isaac Asimov
Svegliato alle 5 del mattino dall’automa Felpyn1, un vero idiota che non ha ancora capito che la sveglia deve essere non prima delle 10.48: preso l’automa e sbattutolo contro il muro, continuava a funzionare dicendo ogni quattro minuti EZIANDIO. Uscito per recarmi al lavoro, ricordo che dopo la deliberazione astrale 2345789754213456 il lavoro è stato abolito e al suo posto è stato creato un monte ore di non ozio da impiegare in attività socialmente inutili, io ho scelto di allevare microbi. Scendo in serra e incontro il simulacro di Begoña~67, modellato sul corpo di un mentecatto troppo pasciuto del secolo scorso. Accendo la macchina ma non parte, sono in debito di idee creative e ho il serbatoio vuoto. Mi girano leggermente i lobi delle orecchie, essendo stati aboliti i coglioni perché tendevano a cedere. Mi risveglio in un lago alpino di sudore.
George Simenon
Stava tentando di accendere una Peterson Magnun Huge Bore acquistata a Londra per fare colpo sulla commessa, che si era poi rivelata essere un travestito ceco, travestito bene ma sempre un travestito e Simenon, che in quel sogno non lo sapeva ma era pur sempre un liberal di scuola habermasiana, in certe occasioni avvertiva una eccessiva sensazione di pienezza: si era quindi tenuto la pipa e se la era riportata a casa, e fino al giorno prima era rimasta appoggiata sul lato destro della scrivania in noce, vicino al dizionario dei sinonimi e dei contrari del Petissier. Dopo averla vista, ancora avvolta nella sua carta rosa, si era risolto a lacerare la carta e a mettere a nudo il contenuto, che consisteva in una pipa di sette chili di peso con un fornello iridescente con alcune pietre dure a formare la scritta London is London. Dopo averla appoggiata delicatamente sull’osso del cranio di un crotalo, che usava abitualmente come leggio, la tenne in posizione con l’indice della mano sinistra e cominciò a tentare di accenderla. In quel momento entrò la sua commercialista. Era alta più o meno come un comodino ma nonostante questo aveva una grande influenza su Simenon, essendo la persona che si frapponeva tra i suoi soldi e la possibilità di non pagare le tasse con una parte di essi; una qualità che Simenon apprezzava grandemente. Simenon non amava la fontina, diceva che era un formaggio troppo levigato, senza buchi. Per lui i formaggi dovevano essere aspri, corrosi dalle mani di chi li aveva maneggiati prima, pieni della storia dei loro polpastrelli: non avrebbe mai mangiato un formaggio che
non avesse impresse le orme di chi lo aveva preparato, voleva vedere i dermatoglifi. Se no, niente. Quando, invitato a un convegno di dossografi in alta val Badia, gli venne portata una enorme, intonsa, lucida fetta di fontina ebbe quasi un mancamento, si perforò l’indice con uno stuzzicadenti in faggio che portava sempre con sé dai tempi di Darmstadt e chiese, con voce flebile ma autoritaria, se avesse potuto togliergli da davanti quella cosa o, in subordine, se potesse buttarla direttamente nella indifferenziata. Solo dopo essere tornato da quel convegno, solo in quel momento, gli venne in mente che la fontina non doveva essere così male, e venne trafitto, improvvisamente, da acute fitte di nostalgia, che sono fitte molto peggiori delle altre perché si sa quando arrivano ma non si sa mai quando se ne vanno.
Fred Astaire
La stanza era rosa ma avrebbe potuto essere anche di un altro colore, forse gialla o rossa ma probabilmente si trattava di una stanza rosa, un rosa tenue e insidioso. Non c’erano mobili, il che era una fortuna perché lo scopo principale dei mobili è quello di impedire alle persone di muoversi liberamente negli spazi che si sono autoassegnate, comprandoli. C’era solo una vecchia poltrona verde con i braccioli consumati fino al loro telaio, sembrava un dente cariato alla radice più che una poltrona, mentre la seduta appariva perfettamente intonsa, intoccata da culi di ogni origine e censo. Fred girava per la stanza, accennava a piccole piroette leggiadre, si sedeva, si alzava, si sedeva nuovamente, si metteva esattamente al centro della stanza e muoveva i piedi in un silenzio assoluto e assordante e disegnava dei grandi cerchi di dimensioni crescenti. Per tutta la sua vita aveva disegnato lo spazio con le sue gambe, i suoi piedi erano stati le sue matita e la sua tela era stato tutto quello su cui si era avvicinato col suo corpo, aveva seguito flotte, era sceso a piedi da grattacieli, aveva grattato nuvole con le sue mani, aveva stretto con gentile e inscalfibile fermezza i fianchi delle donne che avevano disegnato questi cerchi con lu, soprattutto uno, che non era nel sogno, non era nella stanza, non era con lui in quel momento. C’era solo quella poltrona con i braccioli esausti e la seduta intonsa e a Fred venne in mente di fingere che sulla poltrona ci fosse proprio quella donna che lo aveva accompagnato nella sua ricerca delle nuvole, e che, diversamente dalle altre, era anche riuscita ad affer-
rarle. Ed ecco che i cerchi, che prima sembravano seguire un ordine casuale, cominciarono a ridursi di numero e ad aumentare di precisione, divennero convergenti, più ampi, allargarono il loro perimetro per avvicinarsi sempre di più alla poltrona, la circondarono di una danza gentile, e solo dopo averne eseguiti almeno una decina Fred decise che era arrivato il momento di sedersi sulla poltrona, ma sui braccioli, o su quello che rimaneva dei braccioli, perché il resto era occupato.
Jerome David Salinger
Una mattina, saranno state le dieci, al massimo le dieci e sette minuti, un uomo di altezza media, con una faccia media, un cappotto medio e delle scarpe medie entrò nello zoo del Bronx, a New York, con in mano una fetta di pizza coi peperoni e una bottiglietta di acqua naturale sgasata. L’acqua non era stata comprata sgasata, era diventata sgasata nel suo Divenire. La pizza con i peperoni era stata ordinata per posta.
L’unica nota di colore di questo uomo medio erano gli occhiali, color rosso squillante, che non portava appoggiati sul naso, come sarebbe lecito attendersi da chi porti un paio di occhiali per diletto o necessità, ma mollemente appoggiati sulla testa, solcata in modo ineguale da alcune ciocche di capelli color stoppa, spugnosi, piccoli arcipelagotti di pelo sulla lucida superficie del cranio, già sudata nonostante l’aria pungente della mattinata. Dos Passos una volta aveva scritto che l’aria pungente di New York si trova solo a New York, il che ci è sempre sembrato abbastanza naturale perché non stava parlando dell’aria di Lisbona che siamo sicuri che deve pungere in un altro modo. Il cappotto medio svolazzava qua e là tra i viali ancora lucidi della pioggia della notte, si fermava davanti agli alberi dai quali scendevano scoiattoli che dopo aver visto gli occhiali dell’uomo di altezza media scappavano spaventati, fino a quando le gambe che imprimevano aria al cappotto si fermarono proprio di fronte a uno dei custodi al quale venne rivolta, con un inglese percorso dal seme quasi maturo del dubbio, WHERE IS THE ORTOTTERI CAGE? Ortotteri, nello zoo del Bronx, non
ce n’erano. Questa fu la risposta lapidaria del custode, accompagnata da un gentile e imprevisto colpetto della mano sulla spalla destra dell’uomo medio, che si stava leccando le dita in un modo che stava a metà tra il voluttuoso e lo schifoso ma forse più schifoso perché la voluttà era parecchio ipotetica, dopo aver terminato di mangiare la fetta di pizza ai peperoni, verdi, anche se lui li aveva chiesto giallo, il primo di una lunga serie di incidenti che culmineranno nel suo inseguimento DA PARTE DI UN ENORME ORSO ROSA che probabilmente non era aggressivo, ma era pur sempre un orso. Ma tutto questo dopo, molto dopo. Ma Jerome David Salinger, questo era il nome dell’uomo che era entrato nello zoo, non ne era affatto sicuro e aveva preferito risalire sulla sua jeep e andare a cercare un posto più tranquillo, magari intorno a un laghetto di Central Park, sperando che non ci fossero troppe papere.
Giorgio Manganelli
Era un sogno in cui conobbi Manganelli nel 1961, era estate se non ricordo male, una afosa e immobile giornata di agosto; credo che fosse un giovedì, verso le 6 del pomeriggio, ma poteva anche essere stato un giorno diverso, forse erano le 3 e 27, i miei ricordi sono opacizzati dalle ingiurie del tempo; ricordo però nettamente, con una vividezza retinica che mi percorre solo quando sto per tagliare la prima di una serie di fette asimmetriche di anguria, che davanti a me camminava questo strano individuo, un poncho multicolore sulle spalle, un paio di sandali di plastica verde, uno dei quali slacciato, capelli corti e adesi perfettamente a un cranio inderogabilmente ovale, un forte sentore di assenzio e un alone di frittura di totanetti che lo circondava come un sudario invisibile. Camminava a piccoli passetti isterici, le gambette segaligne e quasi sefardite, evitando di calpestare le fessure che trovava tra un pezzo del piancito e l’altro, mulinando le braccia in senso antiorario facendosi passare una sigaretta accesa da una mano all’altra con una abilità da scimpanzè, fino a quando, distratto dal passaggio di una ragazza con i capelli rossi, perse il ritmo e fece cadere la sigaretta accanto a un distributore di benzina, accanto al quale sostava un gruppo di frati circassi in gita, che presero fuoco in pochi minuti. In mano aveva una cartella di cuoio, la maneggiava con molta circospezione, quasi che potesse esplodere, ed è possibile che forse fosse veramente una cartella esplosiva, c’erano state esplosioni in serie negli anni precedenti. A quel punto ritenni doveroso cambiare strada, vidi
solo con la coda dell’occhio il corpicino ossuto che saltellava sulla pira, cercando di spegnere il fuoco con i suoi sandaletti di gomma, che si erano sciolti e avevano composto la scritta PIRLA sul marciapiede. La scritta era rosa, dello stesso colore dei sandaletti disciolti.
Cary Grant
Cercare di essere Cary Grant è operazione complessa e fastidiosa, in particolare per chi abbia la sventura di assistervi, ma inevitabile, e nei sogni riesce meglio. È necessario saldare il conto con il fato senza avere alcuna speranza di sottrarsi all’agone, come diceva il conte di Pannigody, ormai deceduto. Per iniziare bisogna iniziare dall’inizio quindi dall’alto, quindi dalla testa, quindi dai capelli. I capelli di Cary Grant non sono una opzione ma uno stato dell’anima, un secondo principio della termodinamica, un piatto di ceci servito su un pavimento di cotto, una condizione dello spirito disagevole nelle forme ma dotata di intima letizia nei contenuti, uno slancio gridato verso il cielo. I capelli di Cary Grant devono essere divisi in tre fasi, neri, grigio scuro, grigio chiaro: in nessuna di queste fasi assistiamo a un mutamento delle forme, che restano perfettamente adese al cranio, senza alcuna possibilità di introduzione di una covarianza pilifera. Sottolineano con sapienza la perfetta forma del cranio, girano intorno alle orecchie con grazia, occhieggiano sulle tempie e si ricongiungono al lobo frontale atterrando sulle sue anse primeve, per annunciare al mondo quanto tale lobo frontale sia perfetto. Chiunque decida, quindi, di iniziare il processo di “carygrantizzazione” deve tenere in accesa considerazione queste caratteristiche, soprattutto se è privo di una sede del lobo frontale di tale perfezione; si dovranno quindi seguire percorsi alternativi, con una attenta smerigliatura manuale delle tempie, da effettuare con adeguate quantità di acqua di colonia, e prevedere
dei linimenti adeguati per contenere l’inevitabile rossore dermico che si propagherà per tutta la pelle del viso, rendendolo più simile al mantello di una razza che a quello di un essere umano. Pertanto, sarà necessario procedere con cautela e senza alcuna fretta, che è notoriamente cattiva consigliera. Il capello dovrà essere perfettamente stirato, aderente, tenuto in perfetta tensione da una serie di piccoli, invisibili esseri presumibilmente alati che ne curino la tensione cranica. In mancanza di detti esseri alati potrebbe essere sufficiente anche un pettine, in corno, con rebbi ravvicinati ma non troppo, dei rebbi che potremmo definire medi: uno dei principi cardine del carygrantismo è la bellezza del non visto che si fa vedere solo quando serve. La pettinatura procederà in parallelo ad una cura intensa della pelle del viso, con alcuni interventi cosmetici a base di cenere himalyana e vibromassaggi indotti da appositi apparecchi che stimolino la cute senza indebolirla in modo eccessivo. Dopo il capello e la cura del viso si arriverà in corpore vili, ossia all’indumento da indossare prima di presentarsi davanti al folto pubblico di ammiratori e ammiratrici, essendo il carygrantismo un culto rigorosamente gender free e pet friendly. Per le prime ore della giornata, quelle che possiamo identificare dalle 7 alle 9 del mattino, i due capi imprescindibili saranno un pigiama con giacca ampia e bottoni di almeno 7 cm. di diametro e una robe de chambre in lino o seta lavorata a triplo filo, tipicamente a righe, con colori vivaci, tendenzialmente contrastanti: con questo abbigliamento sarà possibile avvicinarsi al tavolo della colazione e aspettare che essa venga servita. Colazione che potrà sembrare casuale, banale, provvisoria, ma sarà invece coordinata al colore della tovaglia e in simmetria con l’apertura delle finestre che inonderanno di sole a stanza, collocata sempre ad est, qualora la struttura del
building non lo permettesse sarà collocata egualmente a nord. Nel caso in cui la stanza sia collocata a sud bisognerà andarsene immediatamente e trovare riparo in albergo o a casa di conoscenti perché in nessun caso in nessun modo e per nessun motivo si potrà fare una colazione a sud; la colazione deve essere fatta in un ambiente anodino, colori freddi, alteri, quasi neutri, il sud è troppo intenso, quasi livido, e sarà dispiegato in tutta la sua importanza al momento della cena. L’espressione usurata di “abbigliamento di tutti i giorni” non ha alcuna ragione di essere, l’aspirante Cary Grant avrà un abbigliamento suddivisibile per cromia del tessuto, non certo per funzione, egli si vestirà, non si coprirà, e vivrà del rumore fragrante della pochette di seta che si infilerà nel taschino della giacca con una irredimibile volontà penetrativa. Il rumore della pochette sarà fragrante perché avrà il sapore del pane appena uscito dal forno, che di solito non esce da solo, ci vuole sempre qualcuno che lo tiri fuori ma questo sempre non vale per il finto Cary Grant che, come quello vero, se lo troverà davanti, sulla tovaglia del tavolo rotondo della colazione, già servito a fette delicatamente imburrate dalla parte giusta. La colazione sarà ordinata, gentile, raffinata e preziosa, allietata da alcune ghirlande di fiori di lavanda, tazzine di caffè nero, forte, fumiganti, le già ricordate fette di pane imburrato, marmellate di varia e in taluni casi esotica origine, un ananas a centro tavola pronto per essere consumato, alcune banane messe di lato, verso est, nella parte del tavolo rotondo meno visibile. L’aspirante Cary Grant si presenterà docciato, pettinato, vestito, profumato, deodorato, poi nuovamente pettinato e riprofumato. In effetti i capelli aderiranno con perfezione tenace al sottostante cuoio capelluto e ci sembra brutto, inadeguato ed eccessivo usare il verbo pettinati, essi seguiranno spontaneamente la
via della perfezione e si deporranno con cura, volontariamente, senza bisogno di pettine o spazzole o di altro strumento coercitivo sul cranio, in tutta la sua estensione. Resta ora da esaminare uno degli aspetti primari della colazione, ossia l’abito scelto per celebrarla. La preferenza andrà a completi grigio antracite con giacca a spacco unico posteriore, che permetterà al colazionante di sedersi senza incorrere in strappi improvvisi dei pantaloni: la seduta sarà elastica e flessuosa, con la coscia destra che saggerà la consistenza della sedia facendosi scivolare sopra, con noncuranza, come un panda che scivoli con un bamboo in mano, e prepari l’arrivo della seconda gamba, che chiuderà il movimento iniziale con un soffio di vento e un ribollire estuoso di stoffe. Se possiamo fare un paragone acustico-uditivo, sarà come sentire le zampe di un gabbiano che raspano con gentilezza uno scoglio bagnato, anche se di solito il gabbiano poi scivola e cade in mare, qui, fortunatamente, di solito non cade nessuno. La colazione non verrò consumata, solo guardata, questo è ovvio. Dopo aver abbandonato tutto quello che c’è sul tavolo il quasi Cary si alzerà, bacerà castamente la moglie e si dirigerà verso la porta, per recarsi al lavoro. Il lavoro si dipanerà in tre macrosettori: agenzia pubblicitaria, libera professione legale o paralegale, dirigente di istituto bancario. Tutti gli uffici saranno un florilegio di boiseries e segretarie imbullonate alle sedie, con alcune piante, apparentemente finte, a fare da divisorio tra una stanza e l’altra. Di diversa altezza, saranno piante grasse che fingono di essere piante magre per non essere troppo grasse. Il finto Cary Grant indosserà un cappello a tesa molto ampia, talmente ampia e larga da rendere quasi invisibile il cadavere di un piccione, morto due anni prima e mummificatosi in loco. Solo dopo averlo lanciato con supremo gesto atletico sulla
spalliere della poltrona per la settantanovesima volta la piccola mummia del piccione cadrà a terra con un tonfo sordo, facendo sfracellare ciò che resta del corpicino del volatile ai piedi della prima segretaria, che cadrà a terra svenuta. Il finto Cary Grant darà una energica scrollata ai trapezi, che indoviniamo tesi sotto la giacca, e entrerà nel suo ufficio, per la prima riunione della giornata. Le riunioni sono sempre inutili, in tutto il mondo occidentale la riunione sancisce la totale e irrefragabile inutilità della persona che decide di organizzarla, e questo lo sa anche il nostro finto C.G. che, tuttavia, portando il sia pure finto nome che porta, riuscirà a deflettere dal consueto mugugno dei riunendi e riuscirà a volgere la situazione a suo esclusivo vantaggio: alla proiezione dei primi dati di vendita, già sorpassati da quelli più recenti ma i grafici erano stati preparati la settimana prima, esibirà una reazione di genuina sorpresa, si produrrà in una meravigliosa distensione dei muscoli orbicolari e dirà, a voce tenue NOTEVOLE, picchiettando sul tavolo con una stilografica Pelikan verde smeraldo, sapendo perfettamente che quello che ha appena visto sarà del tutto inutile ma avrà riempito un’ora della sua giornata lavorativa, poco prima che che il proiettore, collegato al portatile, della manager che ha organizzato la riunione si blocchi sull’immagine dell’ultimo acquisto su Amazon della signorina, un oggetto blu con tre punte appuntite, soprattutto quella al centro, deputato a riempire le ore di solitudine della impegnatissima organizzatrice di riunioni. Il suo utilizzo viene spesso accompagnato da un video motivazionale coreano riprodotto in coreano per lasciare sempre un pizzico di sintomatico mistero. A questo punto, né prima né dopo, esattamente a questo punto, C.G. si alzerà, si sistemerà il bavero della giacca, perfetto ma essendo un bavero si sarà autoincrespato per
permettere ai polpastrelli di Cary di strofinarlo, e saluterà tutti con un inarcare timido della gota sinistra, mentre la destra rimarrà perfettamente immobile. Dopo essersi alzato, la sedia andrà al suo posto da sola, i braccioli gemeranno in silenzio per la mancanza, e nella sala si effonderà un delizioso odore di tiglio.
Giulio Mozzi
Alcune proposte atte a non essere seguite in quanto oggettivamente irrealizzabili
1. Cercare di pubblicare un romanzo - racconto - storia in cui lui non lasci lei e lei si senta lasciata da lui senza che lui abbia capito fino in fondo perché ha lasciato lei in cui i protagonisti NON VIVANO in una di quelle case carine con i mattoni rossi (sarebbero case in arenaria di fine ‘800 caratterizzate dal fatto di essere rossicce ma il romanziere ha nella sua faretra terminologica solo “casa carina con i mattoni rossi”) con sette cani di vario colore e dimensione e ventisette gatti di varia nazionalità e sesso, che rappresenteranno uno dei problemi fondamentali del post separazione, nel senso di chi tiene chi. Alcuni verranno lasciati davanti alle porte dei vicini di casa, che avranno contezza della esplosione della coppia che gli viveva accanto.
2. Se uno dei due è architetto è del tutto irrealistico che giri in bicicletta perché gli architetti non sanno pedalare perché la bicicletta è un mezzo tecnicamente perfetto, massimo risultato col minimo sforzo, e l’architetto non può tollerare che qualcosa funzioni per un periodo di tempo superiore ai 7 minuti; una della prime modifiche che apporterebbe al progetto BICICLETTA sarebbe quella di dotarla di tre paia di pedali triangolari in titanio, saldati tra di loro, non funzionanti, ma secondo lui/lei/essi belli da vedere. Quindi, un architetto che pedali per più di tre minuti è un assurdo logico, se succede è una illusione ottica o non è un architetto.
3. La scelta del tipo di valigia o borsone nel quale lancia-
re, in preda a un attacco di rabbia che non riesce ad essere sopito, le maglie i maglioni le calze e gli intimi, perché ne avremo più di uno, che hanno caratterizzato gli ultimi anni di vita a due. La borsa, spesso di colori sgargianti e vivaci, al netto del possibile daltonismo di uno degli interessati, sarà abbandonata sul letto, completamente spalancata come la bocca di un portatore di molari cariati dal dentista, e attenderà fiduciosa che quasi sempre la lei la riempia di biancheria intima alla rinfusa, fatta volare nella stanza per permettere all’abbandonato di apprezzare per l’ultima volta quello che sta per non vedere mai più, con una panoplia tissutale di reggiseni a balconcino con ferretto centrale, l’interruttore di tanti amplessi consumati sul parquet di pino che ne reca ancora vistose ecchimosi, e vistosi tanga giallo limone e verdi.
4. Non parlare mai, per nessun motivo, delle cipolle di Bruges: sono poco digeribili e a Bruges non le conoscono.
5. Non parlare mai della sedia Thønne componibile, che poteva diventare sia una margherita che una pera che un icosaedro. La Thønne veniva venduta in un comodissimo kit di montaggio, settantotto sacchi di iuta perché la ditta produttricåe era da sempre molto attenta all’ambiente, identificati da un numero progressivo svedese; essendo fortunatamente i numeri progressivi svedesi uguali agli altri numeri progressivi, il professor P. non aveva avuto alcuna difficoltà a metterli in ordine sul pavimento, creando un ardito collage che poteva ricordare la Opus 2 del famoso collagista norvegese Ratte Foråm, che aveva ottenuto un anticipo di 2 milioni di dollari per la Opus 3, che sarebbe consistita, secondo le sue parole, nella Opus 2 senza la s finale, quindi la Opus 3. Non è un argomento che può interessare un essere umano per più di sei minuti. Ricordati sempre che i libri, se nel caso, li comprano gli esseri umani e che gli animali,
tanto superiori agli umani, non riescono a pagare col bancomat o a curarti la carie. Evita le storielle edificanti dei labrador che portano tanta gioia e serenità in famiglia perché poi devi chinarti a raccogliere la sua corposa merda. Di seguito, alcune ipotesi di soggetti di trame per erigendi romanzi, in ordine decrescente di rilevanza.
1. Dente
2. Parcheggio occupato
3. Necessità fisiologica in un supermercato
4. Suonano alla porta, con insistenza, una volta aperta non appare nessuno
5. Fisiologia del cane da passeggio, che porta a spasso il padrone
6. Voglia di esotismo e pressione bassa
7. Sole, mare e mancanza di sesso pur in presenza di sole e mare
8. Cappotto troppo corto
9. Cappotto troppo lungo
10. Lisbona come luogo dell’anima di un altro
11. Ratisbona perché avevo detto Lisbona ma la signorina dell’agenzia di viaggi ha capito male
e il biglietto era già stato pagato
12. Invecchiamento e protesi mobili
13. Tennis e grugniti agonistici
14. La ricerca dell’anima dopo le 17 del pomeriggio di venerdì
15. Saltare o stare fermi senza ragione
16. Il Giappone visto da un treno ad alta velocità coi finestrini bloccati
Gianni Rodari
Molte delle storie che si raccontano sul granciporro sono sbagliate o inventate, il che, a ben vedere, è la stessa cosa: ci fu la diaspora dei granciporri marinati, che dalla costa orientale degli Stati Uniti volevano andare in quella occidentale ma furono fermati da una tempesta di neve, la prima dal 1876, e da un complesso problema legale relativo allo status di granciporro nel Maryland, che ha una legislazione molto severa sul granciporro, ci fu, anche se ormai quasi nessuno ne parla, la Grande Guerra Dei Granciporri Stufati che, in apparente contrasto con quelli cotti al brandy, avevano tentato di marciare verso il centro cittadino ma il granciporro è lento e ha zampette piccole e fragili, e vennero falciati senza pietà non appena arrivarono sulla ss 345, che era chiusa, per la verità, ma si suicidarono tutti in massa perché pensavano che fosse aperta. Inoltre il clima della costa orientale degli Stati Uniti non è bellissimo, e il granciporro soffre l’umidità. Tutte queste storie sono state raccontate da Gianni Rodari che sognava sé stesso che raccontava queste storie pur non avendo mai visto un granciporro, da sveglio.
Alessandro Bergonzoni
Le attività ad alto contenuto sociale che ti compaiono in sogno quando dormi, non solo in sogno quando non dormi anche se ci sono persone che sognano anche quando non dormono.
- determinazione del sesso dell’ornitorinco mediante osservazione diretta della cauda plagalis, se c’è è maschio, se non c’è è meglio;
- creazione e commercializzazione di una tazza da té senza manico con piccoli inserti in cashmere con scritte in gaelico che raccontano sinteticamente perché il PD sia il PD pur non essendolo;
- stesura di un agevole pamphlet su diritto all’eleganza, diritto a mangiare aglio e poi baciare chiunque, diritto a pensare che la pizzica sia una totale e devastante orlatura forzosa ai testicoli;
- riaffermare con burbanzosa e tracotante sicumera che Cesare Pavese non si è ammazzato per permettere a te di mettere sulle tue vezzose bacheche i suoi libri dei quali hai forse letto i titoli;
- stampare sei poster di cinque metri per dodici sui quali scrivere IL TOFU FA CAGARE ANCHE I PICCIONI;
- bere spesso, soprattutto tra un congiuntivo e l’altro, il che ti permetterà di idratarti e di ricordarti dei congiuntivi;
- se hai i capelli molto lunghi, applica alle punte un balsamo rigenerante alla mela verde, di solito è abbastanza infiammabile e puoi concludere il tuo discorso cercando di bruciarti superficialmente le punte più lunghe: crea un forte
effetto di sorpresa tra gli astanti e sparge in sala un gradevole aroma di pelle di pollo bruciata nel caminetto; - fissare sempre negli occhi la persona più alta seduta in sala, lei o lui o loro si sentiranno in imbarazzo per te e usciranno poco dopo
- ricordare sempre che la prima cosa da fare viene sempre dopo la seconda cosa da fare che è comunque uguale alla prima, ed è quindi inutile farla per evitare inani doppioni. I doppioni sono sempre inani.
Luciano Bianciardi
In una insopportabilmente radiosa giornata primaverile, piena di odiosi volatili cinguettanti, di piccoli, inutili merli che avevano alonato di piccole cacche di merlo il balconcino fatiscente della casa occupata abusivamente in una via abusiva di una città abusiva Luciano (Bianciardi) detto il Non Mi Alzo Da Questo Divano Per Nessun Motivo (NMADQDPNM) o più semplicemente Luciano, si alzò dal pagliericcio ricoperto di sigarette spente e di riviste pornografiche degli anni ’40, ne avevano pubblicate solo un paio, con tutti i prezzi tagliati, l’individuo raggiungeva l’eccitazione solo leggendo i numeri, il resto non lo capiva, e decise che aveva voglia di caffè. Non potendo scendere al bar perché non c’erano bar nel raggio di settantacinque chilometri, decise di farselo da solo, dimenticando di essere completamente incapace di muoversi in modo autonomo avendo il sistema propriocettivo di una rana gravida, e per prima cosa andò a sbattere contro una scarpiera, quindi si tirò in testa un olio di Enea Salmeggia detto il Talpino, da lui rubato sei anni prima, si bruciò la lingua tentando di spegnere una sigaretta rimasta accesa, e alla fine trovò una vecchia caffettiera, della fine degli anni ’50 del secolo scorso, nascosta sotto una scrivania priva di cassetti, e tentò di aprirla con uno spazzolino da denti elettrico, non riuscendovi, soprattutto perché lo spazzolino elettrico non era stato ancora inventato, ma il sogno presuppone una certa alea di incertezza e imprecisione. Non pago di questi tentativi destinati a un sicuro fallimento, tentò di aprirla gettandola contro il muro, sperando in un effet-
to esplodente dell’intonaco della abitazione, ancora intriso di polvere nera in quanto vecchia dimora di briganti, ma ottenne solo di abbattere una parete e di colpire una pecora del vicino alpeggio, che venne subito incamerata e nascosta sotto il povero giaciglio che egli insisteva a chiamare letto. Con la caffettiera ancora bloccata, si risolse a ordinare su Amazon (che non esisteva) una confezione di cioccolato senza zucchero per partorienti, che avrebbe consumato senza estrarle dalla scatola, come era solito fare con le pizze surgelate. Poco dopo, si vestì con tre cappotti, nessuno dei quali di sua proprietà, e uscì nei ventiquattro gradi della giornata.
Alvar Aalto
Arrivato in Lapponia A.A. cercò subito una sedia, era stanco, e del succo di mirtillo, era assetato. L’unione della sedia col succo di mirtillo sarebbe stata perfetta ma poiché la perfezione non è di questo mondo decise di bere il succo in piedi, non avendo trovato nessuna sedia. Staranno sempre in piedi in Lapponia, pensava, mentre irrorava la sua epiglottide con ruscelli di mortella di palude, uno degli altri nomi del mirtillo rosso insieme a mirtillo rosso, appunto, o mirtillo palustre. In quel momento non era in una palude ma davanti alla fermata di un bus lappone, segnalata da un cartello di fermata in lappone, aspettando un bus lappone che lo portasse in albergo, anche se non si ricordava in quale albergo dovesse andare. Questo è un problema che risolverò quando sarò sul bus, pensò, mentre finiva di stillare le ultime, disperate e transeunti particole di liquido ancora presenti nella bottiglia; A.A. era alto, molto alto, e per raggiungere tutte le parti del suo corpo, anche le più remote, il succo doveva fare un viaggio lunghissimo, punteggiato di varie, imprecisate fermate, alcune prevedibili, altre meno. Mentre il liquido stava facendo il suo lavoro, era arrivato il bus lappone: bianco, con alcune scritte rosse sulle fiancate, una diversa per fiancata, era guidato da un autista nano con un paio di enormi baffi a manubrio e una giacca blu, la divisa degli autisti lapponi pensava A.A., che gli tirava tremendamente sul torace, con un bottone centrale pronto a schizzare a velocità supersonica verso gli occhi del primo malcapitato: fortunatamente la giornata di sole aveva in-
vitato con perentorietà A.A. a indossare un paio di vistosi occhiali da sole gialli con delle piccole perle, finte, ai lati, che lo metteva al sicuro da eventuali, improvvide partenze verso Sirio del bottone centrale dell’autista; la partenza improvvida avvenne poco dopo, seguita da un rumore secco, improvviso, una detonazione, col bottone che fendeva come una lama di Toledo un panetto di burro il vetro anteriore dell’automezzo, creando una enorme crepa a forma di ano di struzzo al centro del vetro, che pochi minuti dopo andava in frantumi, tra le grida di stupore dei passeggeri: tutti erano preoccupati non tanto per la rottura del vetro quanto per la comparsa, sia pure provvisoria, del culo di uno struzzo sul vetro che stava per andare in frantumi. Mentre tutto questo si srotolava sotto il sole che avvolgeva la città di Inari, dove stava succedendo tutto questo, A.A. si era seduto in un posto in terza fila, accanto al finestrino, non si era tolto gli occhiali e dopo aver soffiato sul vetro di sua pertinenza, dopo aver dato pietosa sepoltura ai cadaveri di tre zanzare ivi presenti dalla primavera di sette anni prima, aveva disegnato un pentagramma sul vento opacizzato dal suo fiato e stava facendo lo schizzo di un sanatorio che avrebbe poi chiamato sanatorio. Un edificio molto bello e molto luminoso perché A.A. pensava che per costruire degli edifici fosse sufficiente afferrare la luce che c’era al loro interno, e farla uscire con gentilezza. Dopo tre curve affrontate con baldanzosa sicumera, A.A. arrivò davanti al suo albergo, circondato da siepi di eucalipto e alcune ortensie, tutte verdi. Senza farsi notare A.A. afferrò tre ortensie e le mangiò, insieme al loro gambo, che considerava la parte migliore del fiore; fin da piccolo aveva sviluppato una forte, incontenibile passione per i gambi di ortensia, e quando gli capitava di vederne uno non riusciva a controllarsi. A.A. quando mangiava
le ortensie attivava la sua mente musicale, gli appariva un brano tra le commessure cerebrali, in questo caso l’Orfeo di Monteverdi, che canticchiava mentre saliva nella sua camera, la 345897689.
Herman Melville
Entrando in quella sala bassa e di forma conica, sempre che una sala possa avere una forma conica, cosa di cui non siamo affatto certi, ci si ritrovava, dopo essersi persi in un piccolo dedalo noto come dedalino, in un vestibolo largo, dal soffitto opprimente e tutto storto, anch’esso insicuro della sua forma come lo era la sala, rivestito di vetusti pannelli di legno che ricordavano, a un ubriaco, le murate di qualche vecchio legno cassato dai ruoli. A un sobrio non avrebbero ricordato niente. Melville si guardava intorno con una sicurezza che poteva tracimare nella sicumera, e non riusciva a rendersene conto del tutto. Aveva un cappotto blu perfettamente allacciato e un grande, minaccioso fiocco che dava alla sua cravatta l’apparenza di qualcosa di terribile, anche se era solo una cravatta. Pur camminando senza problemi, ogni tanto simulava una zoppìa patologica, come se la gamba destra decidesse improvvisamente di non funzionare più. La barba era vistosa e molto curata. Da un lato era appeso un quadro a olio, di dimensioni incongruamente generose, talmente scurito dal fumo di tabacchi passati dalle bocche di così tante persone e sfigurato in tanti modi, che a guardarlo in quella luce debole, proveniente da più parti, forse si poteva arrivare a capirne il senso soltanto con un esame accurato, attraverso una serie di ispezioni sistematiche, unite a una grande pazienza, a un occhio, almeno uno, che vedesse e soprattutto prescindendo dalla domanda delle domande, la metadomanda, la domanda iniziale; perché devo capire un quadro e non posso invece limitarmi a guardarlo. Sulla
tela si alternavano in modo ineguale masse così difficilmente comprensibili di ombre alternate a un buio fitto seguito da piccoli intervalli ocra chiaro, tendente a un altro colore che non era però rimasto sulla tela, in una tale cacofonica serie di peti cromatici che veniva quasi naturale pensare che un pittore giovane e ambizioso, probabilmente magro e con un neo sul mento, probabilmente mezzo francese e mezzo polacco, avesse tentato, senza riuscirci, di rappresentare il momento esatto in cui l’ordine avrebbe avuto il sopravvento sul Caos, in ciò sbagliando grossolanamente perché l’Ordine non vince MAI sul Caos. Ma era un pittore, aveva un neo sul mento, ed era anche magro. Ci sentiamo di perdonarlo, e lo invitiamo a farsi rimuovere chirurgicamente quel neo. Purtuttavia lasciando tutti i nostri pregiudizi in portineria, con la promessa che saremmo passati a riprenderceli ben presto, questa idea, per quanto sconcertante, poteva non essere completamente infondata, solo che ci eravamo dimenticati di quale idea stavamo parlando, essendo troppo impegnati a pensare al neo. I nei, soprattutto quelli sul mento, distraggono.
60
Pelham Grenville Wodehouse
Wodehouse era in vestaglia, una vestaglia rosa con piccole nuvolette bianche alternate a caprette che sembravano volere saltare sulle nuvolette, stava in piedi con le spalle alla grata vuota – poiché era estate e le grate dei condotti di areazione in estate sono vuote – e osservava con occhio pseudoitterico la rimozione scrupolosa di quello che restava della sua colazione.
«Signora Poppertrotter», disse.
«Signore?»
«Vi creerebbe un grosso e inestricabile problema se la cosa diventasse autobiografica?»
«Signore?»
«Non importa. Non più di tanto, perlomeno. Voglio solo abbozzare a vostro esclusivo beneficio una parte della storia della mia vita. Alle undici di ieri sera sono andato a letto e sono subito sprofondato in un sonno senza sogni. Circa quattro ore dopo c’è stato un baccano inaudito sulle scale che ha scosso la casa come una mano che tocca tremolante il piattino che ospita quello che resta di un pudding che non può più fare niente perché è scomparso. Era il signore della camera di sopra – non ricordo il suo nome – che tornava a casa a dormire. Stava canticchiando una canzone patriottica.
Una disgustosa canzone patriottica, di quelle fatte tutte di stivali fango cavalli cariche e qualcuno che muore per motivi poco chiari. Poco dopo ho sentito un paio di colpi potenti, ritmati. Si era tolto gli stivali. Tutto questo mentre frammenti della canzone patriottica mi arrivavano attraverso il soffit-
to della mia camera da letto. Verso le quattro e mezzo ci fu una tregua, e riuscii a riaddormentarmi. Vorrei che quando vede quel signore, signora Medley, gli facesse i miei complimenti e gli chiedesse se potesse abbreviare il programma della sua esibizione in modo rilevante, se deciderà di fare un bis. Potrebbe eliminare la canzone patriottica, tanto per cominciare».
«È un giovanissimo gentiluomo, signore», disse la signora Poppertrotter, in una forma di vaga difesa dell’ospite.
«Ed è altamente improbabile», disse Wodehouse, «che invecchierà mai, se ripete la sua performance di ieri sera. Non ho alcun desiderio di spargere sangue in modo inutile e gratuito, ma ci sono momenti, rari ma importanti, nei quali bisogna mettere da parte i propri pregiudizi personali e agire per il bene della specie. Un uomo che canticchia canzoni patriottiche alle quattro del mattino non mi sembra rientrare in alcun modo nel grande progetto della felicità universale. Quindi gliene parlerete, vero?»
«Molto bene, signore», disse la signora Poppertrotter, placidamente.
Forte del fatto che scriveva per i giornali e aveva pubblicato ben due romanzi aventi come protagonista una capra ipovedente che cerca di accoppiarsi con una mucca, la signora Poppertrotter considerava il signor Wodehouse come un individuo eccentrico che doveva essere assecondato, come bisogna sempre fare con le persone di quella categoria. Qualunque cosa facesse o dicesse la riempiva sempre di un incontenibile voglia di sorridere. Riceveva le sue arringhe quotidiane con lo stesso spirito con cui una nutrice ascolta gli sfoghi del bambino di famiglia. Si sorprendeva quando lui diceva qualcosa di abbastanza sensato, cosa che succedeva molto raramente, da permetterle di capire.
La sua tavola era libera dai resti della colazione, abbondante senza eccesso, e la sua stanza era libera da influenze che potessero nuocerle, e in quel preciso istante la modesta euforia provocata dalla chiacchierata con la padrona di casa abbandonò il signor Wodehouse. La vita gli sembrava molto grigia. Era un giovane coscienzioso, e sapeva che avrebbe dovuto sedersi a lavorare. D’altra parte, il suo cervello si sentiva più o meno come un cavolfiore, e non riusciva a pensare a cosa scrivere, essendo noto che i cavolfiori non sono grandi scrittori. Questa è una delle cose che inaspriscono il giovane autore più di quanto non facciano quelle lunghe buste che decorano con tanto gusto il suo tavolo la mattina.
In quel momento si sentiva particolarmente inadatto a scrivere qualunque cosa, a parte la lista della spesa, pur figurandosi non pochi problemi anche con essa. La mattina non è il momento adatto al lavoro creativo, c’è troppa luce. Un articolo può essere rifinito, riletto con attenzione e magari addirittura finito, un racconto può forse trovare un modo elegante per decidere di finire ma è un dato di fatto che le 11 del mattino, come orario, si sposa malissimo con qualsivoglia sforzo di creatività.
Pelham Grenville Wodehouse vagava senza pace nel suo salotto. Raramente gli era sembrato così noioso e deprimente, pur avendo già provato in passato una sensazione simile. Le fotografie sulla mensola del camino lo irritavano. Erano sempre uguali: non che una fotografia potesse cambiare nel corso del tempo, ma fissare sempre gli stessi occhi esoftalmici dilatati nel vedere qualcosa che probabilmente non c’era più era irritante.
Gli sembravano l’espressione solida, concreta, definita della noia. Il suo occhio fu catturato da un quadro che pendeva dalla parete, attaccato a un chiodo pigro. Lo scosse da
un lato, e l’effetto peggiorò. Lo scosse di nuovo, e il quadro sembrò appeso alla parete da un alcolizzato cronico, astigmatico, in una giornata buia, anzi meglio con una luce talmente fioca da essere inutile. Cinque minuti di tira e molla lo collocarono in una posizione solo un po’ meno storta, ma poco, di quella in cui l’aveva trovato, e a quel punto la sua inquietudine era cresciuta come una torta di mele in forno, senza mele.
Guardò fuori dalla finestra. La luce del sole giocava a nascondersi sulla casa di fronte. Guardò le sue scarpe. A questo punto la sua coscienza lo pungolò quasi dolorosamente.
“Non lo farò, non continuerò a perdere tempo”, mormorò con una ferocia inaudita, “lavorerò. Tirerò fuori qualcosa da queste pagine, anche se fosse la peggiore porcheria che io abbia mai scritto”.
Con questo ammirevole sentimento recuperò la sua boccetta di inchiostro, era affezionato a quello viola (la signora Poppertrotter ne trovava uno nuovo ogni giorno), lo afferrò, prese una penna e si sedette a scrivere.
Ci fu un tonfo provenire dall’alto, e poco dopo una sottile voce tenorile si fece sentire sopra un vigoroso schizzo di acqua del bagno. Il giovane signore dell’ultimo piano si era svegliato. Come faceva tutti i giorni, peraltro; era molto affezionato al suo ciclo sonno-veglia-sonno, e lo ripercorreva tutti i giorni con una perfezione ammirevole, o stomachevole, dipende dai punti di vista. Dopo aver tolto il suo corpo dal letto che lo aveva accolto fino a pochi minuti prima, lasciando il soffice materasso di piume d’oca orbo del calore dei suoi glutei, si era alzato di scatto solo per andare a sbattere con la testa contro un orologio a cucù di marmo rosa, un vecchio dono di una vecchia zia ormai morta, probabilmente, del quale non riusciva in alcun modo a liberarsi. Poi il sogno era svanito.
Luciano Canfora
Luciano, in una radiosa giornata di un inverno che sembrava volere cedere il passo a una primavera incipiente, anche se poi nessuno sapeva cosa volesse dire incipiente e quindi aveva cominciato a nevicare, aveva deciso, dopo aver terminato la stesura di un pamphlet sulla sinistra hegeliana e la cottura dell’uovo sodo di struzzo, di uscire a delibare un gustoso, imperiale cappuccino di soia, accompagnato da uno stinchetto di maiale farcito di merluzzo, un doveroso omaggio alla cucina maya, di cui era cultore fanatico. Aveva scritto un piccolo pamphlet sull’argomento, anni addietro, a lui piaceva moltissimo scrivere ADDIETRO perché si sentiva Quintiliano. Dopo aver indossato un prestigioso cappottino blu, aver drappeggiato intorno al collo taurino una sciarpa rossa con la scritta PORTA LI SEMI COSÌ DOMANI SE BECCAMO in greco antico, regalo di una vecchia fidanzata dei tempi delle scorrerie sul litorale di Ostia, e aver scelto un comodo paio di sneakers viola scuro, era sceso dalle scale saltando i gradini a tre per volta, investendo una ottuagenaria, ex dipendente di un primario istituto di credito (dentro di lui ardeva ancora incandescente la fiamma della rivoluzione), un corriere che non si era accorto di niente e che, una volta svegliatosi, si sarebbe espresso solo in spagnolo del XV secolo, e una studentessa di veterinaria, che stava rientrando nel suo appartamento con in mano un coniglio morto, per motivi di studio. Atterrato davanti alla sua bicicletta, una Pergolesi blu scuro con cambio a 45 marce e sella Webern in pelle di scroto di babbuino, si era reso
conto di non avere con sé le chiavi del lucchetto: poco male, disse tra sé e sé, e ruppe la catena, originariamente usata per l’ancoraggio delle petroliere al Cairo, con la sola stretta della sua mano destra. La sinistra reggeva quattro cellulari alimentati da una batteria che portava agganciata dietro le scapole. Dopo essere salito con un balzo ghepardesco sul mezzo, affrontava con una spinta belluina degli arti inferiori la salitella che lo separava dal cancello, di quindici chilometri. Per lui, semplice riscaldamento. Arrivato sulla strada, la pedalata diventava più lenta, rasserenata, quasi pacificata, interrotta solo dal respiro quieto di Luciano Canfora e dalla sua tendenza, incancellabile, a schivare con troppo zelo conigli bianchi che vedeva solo lui.
John Keats
Caro John (Keats) stamattina mi sono svegliato con questa cosa in testa, un ammasso di stoffa con alcuni ricami fatta da una sarta bizantina una sera di maggio, in ossequio al noto fatto che se sei una sarta, per di più bizantina, lavori solo nelle sere di maggio perché a giugno comincia a fare troppo caldo e ricamare col caldo è troppo indaginoso, troppo smagante, il dito scivola, il pollice suda, la capocchia si stacca e cade a terra con un numinoso fragore, ti buchi il palmo sudato e, in sostanza, ti rompi i coglioni. Non che mi dispiaccia, nelle more di queste giornate color ocra, avere qualcosa in testa, ma mi prefiggevo qualcosa di più sobrio, anche se prefiggere è cosa che poco è attigua al mio ánemos, che tende invece, fatalmente, a posporre. Bello sarebbe se sotto di esso riuscissi a celare a occhi indiscreti quella opima spoglia di grana che mi porto appresso dal 1898 ma, pare, che anche in questo caso ciò non sia possibile. Adesso, fino a che sono aperti, vado al bar. Che non sono stati ancora inventati, temo, ma ci vado lo stesso Tuo Lord Byron

Carl
Gustav Jung
In una stanza entra una persona con un impermeabile, blu. Questa persona ha un paio di baffi bianchi, perfettamente tenuti, pettinati con cura ai lati, con la parte centrale molto più folta. Fuori dalla stanza, nel mondo, non piove, il sole svetta alto nel cielo, non c’è traccia di pioggia, ma questa persona che entra in questa stanza ha un impermeabile. Color crema. Prima era blu ma adesso è diventato color crema. E un giornale infilato nella tasca del giornale. In questa stanza ci sono due sedie. Entrambe bianche. Che strano delle sedie bianche anche se non siamo in ospedale, pensa la persona con l’impermeabile. Accenna a un piccolo sorriso, si siede senza togliersi l’impermeabile, prende il giornale che ha nella tasca e inizia a leggerlo. Dopo pochi minuti entra una seconda persona nella stanza. Non ha un impermeabile, non ha un giornale, ha una giacca blu. Vede le due sedie bianche. Non accenna mentalmente al fatto che sono bianche, la cosa sembra non interessarlo. Si siede sulla sedia rimasta libera e guarda fisso davanti a sé.
«Scusi lei sa se questa è la stanza giusta?» chiede l’uomo senza impermeabile.
«Come dice? La stanza giusta? Non saprei proprio, guardi. Non so se questa sia la stanza giusta perché non so che cosa intenda lei per la stanza giusta. Io sono entrato e mi sono seduto perché ho visto una sedia vuota. Se sia la stanza giusta o meno io lo ignoro».
«Ah capisco. Pensavo che lo sapesse. Per la verità volevo anche chiederle perché si è seduto senza togliersi l’imper-
meabile e, a dirla tutta, e gliela dico tutta, perché lei giri con l’impermeabile, dato che fuori c’è il sole. Ma temevo che lei mi considerasse troppo curioso, quindi ho lasciato perdere e mi sono concentrato solo sulla stanza giusta. Che però lei sembra non sapere se lo sia, la stanza giusta».
«Non deve farsi questi problemi, può farmi tutte le domande che vuole, vede io giro con l’impermeabile anche quando c’è il sole per una mia, diciamo, innocua fissazione; temo sempre che il tempo possa cambiare improvvisamente e per non farmi cogliere impreparato giro sempre con l’impermeabile: è molto comodo anche per mettersi il giornale in tasca, e se dovesse mettersi a piovere sono già pronto. Vede ? tutto spiegato. Piuttosto, mi dica lei a questo punto, cosa intende per stanza giusta? Cosa intendeva dire quando prima mi ha chiesto se questa è la stanza giusta? Non riesco a capire».
«La stanza giusta per vedere i muli nani, credevo fosse ovvio. Siamo tutti qui per vedere i muli nani.»
Una espressione di profonda sorpresa apparve sul viso dell’uomo con l’impermeabile.
«Muli nani? Ma caro signore mi scuserà, la prego, se questa cosa mi fa sorridere, non è mia intenzione offenderla, ma io sono qui per un appuntamento col mio medico, non sono venuto a cercare dei muli nani. Che poi, mi scusi ancora, ma io non ho mai sentito parlare di muli nani. Di pesci rossi sì, ho sentito parlare. Di gatti persiani. Anche di quelli ho sentito parlare. Qualche volta, forse, devo anche aver visto un mulo, ma escludo che fosse nano. A questo punto mi manca qualcosa.»
«Non deve preoccuparsi, non è un fatto raro: quasi nessuno vede i muli nani, sono animali molto timidi, piccoli, veloci, timorosi, non deve sentirsi in difetto se non ne ha mai visti, è una questione di concentrazione più che di visione.
I muli nani si vedono solo se si pensa a loro con intensità, si vedono con gli occhi della mente. I muli nani sono quelle persone che lei vede per strada e che non saluta perché hanno delle facce che a lei sembrano strane, i muli nani sono quei ragazzini che le hanno chiesto l’ elemosina in quella via del centro illuminata a giorno, è comprensibile che lei non li abbia visti, c’era troppa luce e loro venivano dal buio. I muli nani sono quelle persone che in questo momento, mentre io e lei stiamo parlando seduti su queste sedie bianche, stanno morendo in qualche parte sconosciuta del mondo per dei motivi che non sapranno mai perché moriranno prima di saperlo. Questi, tra gli altri, sono i muli nani. Tuttavia mi permetta di darle un piccolo consiglio; ogni tanto, non sempre per carità ma ogni tanto, si tolga l’impermeabile, non abbia paura di bagnarsi, alzi gli occhi dal suo giornale e provi a concentrarsi. Glielo dico perché sa, tra una pioggia e l’altra, quasi senza accorgersene, può diventare un mulo nano anche lei».
Franz Kafka
Dopo una notte serena, accompagnata da galli che non cantavano e suoni di organo con alcuni tasti rotti, il signor K. si svegliò nel proprio letto, allungando le braccia per distendere i muscoli dopo il profondo sonno notturno. Qui si presentò il primo problema, gli sembrava che le braccia gli fossero diventate improvvisamente piccole, minuti opercoli di ossa e muscoli che facevano fatica ad arrivare al comodino sulla sinistra del letto: in tutte le sue camere da letto, questa era la sessantacinquesima, il comodino era sempre sul lato sinistro del letto, essendo il lato destro sempre occupato da una chitarra. Il signor K. si era svegliato a forma di vasetto di yogurt. Niente più di quello che componeva prima il suo corpo era presente; niente piedi, trasformatisi in due piccole appendici verdi che muoveva con disinvoltura per essere delle appendici, niente più sedere, trasformato in un pezzo di vasetto con scritto sopra OPEN HERE, niente più braccia, come abbiamo già ricordato, e sopra a tutto questo sterminio, a questa visibile ordalia di arti e di parti del corpo non c’era più la testa, la sua testa era scomparsa e al suo posto era comparsa una minuscola testolina da marionetta, con due piccoli e inespressivi occhi neri e un ricciolo finto di capelli finti di legno. Era diventato un vasetto di yogurt, ai mirtilli, per la precisione. Il signor K., dopo un iniziale stato di sbigottimento, cominciò a pensare che stava sognando, tuttavia non era del tutto convinto che potesse trattarsi di un sogno perché lui sentiva tutto, sentiva le lenzuola che tiravano sotto il suo corpo che non c’era più ma che era diventa-
to un vasetto, vedeva il suo comodino sulla sinistra, vedeva la sua chitarra sulla destra, tutto gli appariva assolutamente e radiosamente reale, e c’era il fondatissimo sospetto che lo fosse: ora, non è che se uno si risveglia a forma di vasetto di yogurt deve dare per scontato e assolutamente certo che si trattava di un sogno, i vasetti esistono, lo yogurt pure, qualcuno dovrà pur farlo. È vero, altresì, al signor K. piaceva molto pensare la parola altresì, fin da piccolo era una delle sue parole preferite insieme a epigenetico, che fino al giorno prima era un uomo, di altezza non indifferente, con alcuni giubbotti di pelle nell’armadio, una moto, alcune paia di occhiali, della pasta scotta in frigorifero, un essere umano con tutte le caratteristiche dell’essere umano, ma oggi, a quanto pare, era diventato un vasetto di yogurt. Aveva preso in considerazione, è vero, la possibilità di darsi un pizzicotto al braccio, cosa che aveva visto fare a un attore americano che nuotava da una piscina all’altra cercando non si sa cosa, ma permaneva il piccolo siccome trascurabile particolare che le braccia non le aveva, essendo un vasetto, se non si volevano considerare braccia quei filamenti carnei che gli spuntavano ai lati che terminavano, è vero, con delle mani, ma così piccole e lucide da renderle quasi inutili, sembravano delle manine messe lì per bellezza, per aiutare le persone ad afferrare il vasetto per aprirlo, perché questo era uno dei problemi che cominciavano a visitare la sua teca cranica, il fatto che i vasetti di yogurt la gente li apre per mangiare quello che c’è dentro, e una prospettiva del genere, pur essendosi scoperto vasetto da pochi minuti, non gli sorrideva affatto. La prima cosa da fare, però, era trovare il modo per uscire dal letto. Come fa un vasetto ad alzarsi dal letto? Bisognerebbe chiederlo a un vasetto, ma era ormai acclarato in modo definitivo, pare, che il vasetto fosse lui, quindi o si rispondeva
da solo o trovava un modo per alzarsi dal letto senza dare troppo nell’occhio. Scivolare di lato? Possibile ma poco praticabile, essendo rotondo avrebbe rischiato di sfracellarsi al suolo sporcando dappertutto e spargendo ovunque yogurt ai mirtilli, rischiando, forse, di morire, sempre che i vasetti muoiano: il signor K. cominciava ad apprezzare questo della sua nuova condizione, il fatto che qualunque cosa principiasse a fare sollevava immediatamente un dilemma filosofico, e a lui piacevano sia i dilemmi che la filosofia. Adesso però doveva decidersi, o scivolare cercando di non ammazzarsi o rotolare con cautela somma verso il comodino, al quale appoggiarsi per poi decidere come continuare la sua nuova vita da vasetto di yogurt. Decise di optare per questa seconda soluzione e mentre, con estrema cautela, stava procedendo in direzione del comodino sul quale erano appoggiato alcuni fogli un torsolo di mele e un portachiavi a forma di anatra, ebbene in quel momento sentì una voce, che proveniva dall’anatra.
Eric Rohmer
Rohmer è sul set e fa un sogno nel sogno, nel senso che è chiaro che Rohmer sogna sé stesso che sta sognando di sognare sé stesso. In questo sogno del sogno c’è Frédéric, piccolo, con una camicia bianca sbottonata, che sta tutto il giorno seduto al tavolino di un piccolo cafè francese e sogna di fare sesso devastante con tutte le ragazze che passano davanti al cafè in oggetto, ragazze che lo mandano sistematicamente a fare in culo. Il film termine con il vaffanculo d Elodie, che indossa una gonna a quadretti marroni. L’assunto del grande regista è quello di non fermare mai una ragazza con una gonna a quadretti marrone.
Stieg Larsson
Sull’automobile viaggiavano due uomini, vistosamente depressi. Solo che uno era una donna che non sapeva di esserlo. Il primo era alto, capelli rossi, tempie pulsanti e un braccio più lungo dell’altro, il secondo era basso, senza capelli ad eccezione di un piccolo ciuffo di peli al centro del cranio, che formava un mulino a vento. Entrambi canticchiavano un motivetto insulso che finire con la parola “badile”. Il sole che stava tramontando illuminava il parabrezza della vecchia Volvo azzurra e feriva le loro cornee. Era la fine dell’estate e il probabile inizio dell’autunno ma gli alberi erano ancora pieni di foglie e sembrava che nessuna di queste avesse la minima intenzione di staccarsi dai rami, coltivando un loro sogno di anarchia personale. Lungo la strada asfaltata solo a tratti il paesaggio svedese scorreva sotto i loro sguardi sottilmente vacui, e nessuno dei due riusciva a cedere una parte della sua attenzione alla bellezza della sera, che forse non era bellissima. Erano due giornalisti, lavoravano entrambi per l’edizione svedese di Case e casali, Hus och Stugor, e coltivavano il loro praticello di cinismo e infelicità in modo diverso ma costante; superata la cinquantina, ormai stabilmente insediati dalla parte opposta dei sogni e delle illusioni, erano sposati, fortunatamente con due donne diverse, delusi con efficacia, traditi con l’efficienza tipica della donna nordica, convivevano con una vasta serie di disturbi digestivi e una scelta molto eterogenea di problemi quotidiani. Avevano appena smesso di argomentare ad alta voce, quindi di litigare, per decidere se era meglio rien-
trare a Uppsala o passare la notte a Visby, dove uno dei due sosteneva di avere una vecchia amica; non avendo risolto la questione in nessun modo, non si erano più rivolti la parola, lasciando al caso e al silenzio la possibilità di decidere al loro posto. Chiusi in loro stessi con la profonda pertinacia tipica degli svedesi che sanno essere decisi solo quando devono affrontare problemi secondari lasciando che la loro vita vada più o meno dove capita, sembravano attraversavano lo splendore di quella sera estiva immersi nei loro 3 pensieri, la testa incassata tra le spalle, senza accorgersi di quanto vi fosse di squallido in quel loro guidare fissando solo la strada davanti a loro. Viaggiavano con indifferenza e abitudine consunta e slabbrata.
Henning Mankell
La rettitudine morale del commissario capo del nuovo giallo di Mankell comincia dalla nettezza e precisione del suo nome, che sarà Olle Lasse o Lasse Olstrum o Neva Lorkum o Guido Nostrøm, anche se in quest’ultimo caso si tratterà di immigrato di terza generazione, irregolare. I delitti sui quali indagherà saranno particolarmente efferati, con corna di renna lasciate davanti alla porta del cottage dell’indiziato principale, teste mozzate male perché nel Nord Europa i coltelli tagliano male, lettere minatorie scritte in braille per cercare di impedire al perito grafologo di fare il suo dovere. Il kommissionär Olle sarà divorziato ma penserà sempre con intensità alla ex moglie che, scopertasi lesbic# al compimento del cinquantesimo anno di età, dopo avere abbandonato Olle avrà iniziato una convivenza con una graziosa pediatra dell’ospedale cittadino, conosciuta a un torneo di badminton, ignorando che la pediatra era un sollevatore di pesi che a quarantacinque anni aveva scoperto di essere donna, e da cinque anni era in terapia ormonale: quel rigonfiamento che ha sulla schiena è una terza tetta che gli è cresciuta per sovradosaggio di farmaci. Olle vivrà in un bilocale che affaccia su una piscina artificiale piena di pesci di plastica gialla nella quale, alle 9 e 47 di un sabato mattina, verrà scoperto il tronco di un uomo con un vistoso tatuaggio a forma di banana sul petto, chiaro segno di una affiliazione a una società segreta. Il corpo verrà scoperto dall’astuto e insonne nano Adrian, di origine serba, vecchio amico di infanzia di Olle che lo usava come scrittoio quando frequentava
la facoltà di legge a Lund. Il tutto avverrà mentre la pioggia si trasformerà in neve e cadrà incessante per sessantasette giorni, il periodo della inchiesta di Olle, che verrà a capo del mistero dopo avere mangiato un piatto di ramen avariato all’Infoated hjort (Il cervo infoiato), il ristorante giapponese della sua nuova compagna.
Humphrey Bogart
Humphrey Bogart e la nebbia sono sempre stati una cosa sola, dove finiva uno cominciava l’altra, dove finiva la nebbia apparivano subito le gambette rachitiche e ipotoniche di Bogart, che era alto poco più di un metro e sessanta, solcate da reticoli di venuzze bluastre, segno evidente dei suoi stravizi alimentari, della sua pinguedine cerebrale, che copriva tutta la zona amorfa della sua scatola cranica, della sua incapacità di fare più di 387 metri in linea retta senza avvertire il bisogno di chiamare un taxi, che non sarebbe stato in grado di pagare. Per questo amava la nebbia, che gli impediva di vedere e anche di essere visto, fino a quando, un giorno, in apparenza uguale a tanti altri giorni, andò a sbattere contro uno stenditoio di zinco, e si accorse che la nebbia poteva essergli di aiuto per molte cose ma non per evitare gli stenditoi di zinco.
Italo Calvino aveva fame. Probabilmente il topo ricoperto di una sostanza oleosa non meglio identificabile che aveva visto in giardino gli aveva messo fame, in qualche modo doveva cercare di mangiare qualcosa, se possibile di commestibile. Dopo un ultimo, fuggevole sguardo al topo ormai ricoperto, uno sguardo che non si sapeva se descrivere meglio come appunto fuggevole o trasognato, uscì da quella che sarebbe diventata la sua casa per il prossimo anno e subito inciampò in un gatto di gomma rosa con una zampa che andava su e giù in modo inconsulto. Non era tanto il fatto che fosse di gomma rosa, dava per scontato che a Parigi, in pieno agosto, ci fossero molti gatti di gomma rosa, ma che si muovesse da solo, cosa che un gatto di gomma di regola non dovrebbe fare, gli fece nascere una fuggevole perplessità, che era però già scomparsa quando arrivò davanti a una banca, e non cercava una banca, e poi a un bar, e non cercava un bar, infine davanti a quello che cercava, un locale di 6 metri per 3, con le pareti rosso ciliegia.
Il locale era accogliente, secondo gli standards parigini, anche se era un ristorante cinese, che conoscono solo i cinesi di Parigi, e nemmeno tutti, e consisteva in una lunga stanza di forma rettangolare con al centro un lungo tavolo anch’esso rettangolare, con tre sedie da una parte e due dall’altra, per dare movimento alla stanza, pensò, che cosa me ne faccio di una stanza che si muove, pensò di nuovo, ma io nono sono cinese e a loro le stanze che si muovono. Forse, piacciono, pensò nuovamente, poi smise di pensare, aveva
Italo Calvino
fame, e si sedette dal lato con le tre sedie, gli sembrava più educato. Dopo pochi minuti arrivò una cameriera, graziosa ma molto minuta, non raggiungeva probabilmente il metro e 30 centimetri, che dopo averlo salutato salì su un cubo di plastica, che portava legato alla cintura, per arrivare almeno con la faccia al tavolo. La faccia era rotonda, abitata in modo improvvido da un paio di occhi neri, uno semichiuso, e sormontata da una sottile coltre di capelli color pancia di anatra cinese. L’anatra cinese ha la caratteristica di vivere in Cina. Ne ha anche altre, ovviamente, ma essendo cinese tende ad una riservatezza che ha una inesorabilità che non può essere scalfita da nessuno. Forse solo da un’altra anatra, ma esiste una scarsissima comunicazione intraspecifica. Dopo aver appoggiato la faccia al tavolo, con una insospettabile agilità mandibolare, essendo anche la mandibola appoggiata al tavolo insieme al resto della faccia, la gentilissima signorina, che si chiamava Kumiko, snocciolò con inappuntabile efficienza asiatica il cibo disponibile quella sera, aggiungendo alcuni risolini di approvazione, due, o di vera estasi, quattro, di commento alle proposte, impiccandosi con la lingua sul tonkatsu ai fiori di mirtillo, piatto di origine giapponese, ma facciamo finta di niente. Il resto del menu era illeggibile, non solo perché era scritto in cinese ma soprattutto perché i caratteri tipografici che erano stati utilizzati transitavano da 1.5 mm a 3 mm nel caso dei titoli della sezione, che campeggiavano sulle pagine gialline in uno svettante rosso intenso, con alcune screziature ocra che si vedevano solo se ci si avvicinava al menu a distanza di naso, come aveva appena fatto Calvino, in ciò impedito da un naso di dimensioni insolitamente generose per uno scrittore italiano, che solitamente nasce con seni paranasali appena accennati e passa buona parte della sua vita a vergognarsene: Calvino dispo-
neva invece di un perfetto e imponente naso attico, con una struttura da tempio greco, compreso il pronao. Era arrivata l’acqua, in una caraffa a forma di giraffa. Era una giraffa strana, o meglio era una caraffa strana a forma di giraffa strana, e aveva una coda lunghissima dalla quale veniva fatta uscire l’acqua che avrebbe trovato alloggio nel bicchiere che Calvino si era messo davanti, bicchiere che non abitava forme strane, era un semplice bicchiere a forma di bicchiere, solo che era nero. Pece. Intenso. E essendo nero non si poteva vedere quanta acqua ci fosse e quanta fosse ancora necessario aggiungere, e Calvino, fin da piccolo, aveva sempre detestato i bicchieri neri e le cose che hanno un colore che ti impedisce di vedere quello che c’è dentro. Cose inutili, aveva sempre pensato. Poi, sbattendo con il piede contro la testata del letto, si era svegliato.
Gli armadi ad ante scorrevoli sono in tutto e per tutto identici agli armadi senza ante scorrevoli, con la sola preziosa differenza che hanno un numero imprecisato di ante scorrevoli. Delle ante sappiamo infatti che scorrono ma non sappiamo quasi mai quante sono, se in numero pari o dispari, se sono pesanti o leggere, se allo scorrimento fanno rumore o meno, se gettano chi le sta per utilizzare in un gorgo buio o in mulinello chiaro, se petrarchescamente “Ché non poss’io cangiar teco vïaggio?”, ma è altamente probabile, laddove non quasi certo, che Petrarca non possedesse armadi ad ante scorrevoli, forse neanche armadi, ma a questo riguardo Egli, ormai morto da secoli, è sempre stato sfuggente. Anche sulla pizza non ha mai fornito informazioni, e questo ci appare eccessivo. Esulando per un momento dalla infrascritta questione sulle ante scorrevoli, perché, in relazione a chi o a cosa, per quale motivo il Petrarca non parla MAI di pizza, dove risiede la scaturigine della sua ostinata deflessione dall’affrontare l’argomento, che dobbiamo supporre essere stato per lui spinoso? Irto, quindi, degli aculei della verità urente? Come mai non c’è pizza in Petrarca? Questa domanda ci interroga, in quanto domanda, e si fa largo nei recessi più nascosti della nostra ragione, mentre poco o niente possiamo dire dei recessi delle ragioni degli altri, a ogni recesso fa capo una sola ragione, che non può essere sempre la stessa, come è facilmente immaginabile. Prendiamo, a titolo di esempio, questo passo del lamento di Magone del Petrarca, appunto “O qual è il traguardo dell’alta sorte!/Quanto l’anima
Francesco Petrarca
(è) cieca davanti alle fauste imprese! Ecco la follia dei potenti, godere delle altezze vertiginose”, ebbene, dove possiamo collocare la pizza? In che modo viene adombrata ? forse tra le follie dei potenti possiamo mettere una marinara ? una quattro formaggi ? una boscaiola? sono le “follie dei potenti” una ardita, immensa metafora della pizza? È quindi la poetica petrarchesca nella sua essenza più intima gluten free o addirittura cripto vegana? Non basta un solo sogno per rispondere a tutto questo, e infatti la risposta, adesso, non c’è.
Glenn Miller
A chiunque venga chiesto, in assenza di ogni altra attività significativa, cosa sia un trombone, la risposta sarà evasiva, sfuggente, imbarazzata. A Glenn Miller, che prima di essere morto era vivo, apparve in sogno un piccolo decalogo, che si fermerà al nono punto, perché nove punti per un trombone sono fin troppi e perché, arrivato al nono punto, Glenn Miller si sveglierà.
1. Il trombone è uno strumento grosso. Senza dubbio, esso non è piccolo ma non è nemmeno enorme. Si situa in una confortevole e praticata area di dimensione medio-grande, impegnativa ma non annichilente, dalla voce piacevolmente robusta ma non invadente. Essendo composto anche di una parte mobile assolutamente essenziale per la produzione del suono e quindi per essere utilizzato come strumento musicale, consigliamo una adeguata zona di rispetto all’interno della quale è meglio non mettere gatti vivi, vasi di fiori, merendine parzialmente consumate, succhi di frutta al mango, indumenti intimi che potrebbero essere fortuitamente raccolti dalla parte mobile dello strumento e quindi esposti al pubblico ludibrio. Per il resto il suo utilizzo non comporta cautele particolari.
2. Abbigliamento consigliato per lo studio e l’utilizzo in concerto del trombone. La differenza tra studio e utilizzo in concerto del trombone è fondamentale dal punto di vista vestimentariooutfit. Pur avendo alcune caratteristiche comuni (eleganza trattenuta del capo, sua praticità, caratteristiche
traspiranti) la policy di scelta è del tutto diversa. Se per lo studio consigliamo una comoda sahariana declinata nei toni del blu cobalto/verde mela con ampi tasconi che permettano al trombonista praticante di nascondervi pinzette per i peli del naso o banane mignon di importazione cilena, per l’utilizzo in concerto la scelta andrà su camicia multilayer color cremisi con garofani veri applicati, pronti per essere lanciati al pubblico in visibilio. Qualora il pubblico non sia in visibilio, i garofani verranno lasciati dove si trovano. Un paio di pantaloni di velluto a costa grossa con toppe a contrasto in cashmere completeranno l’abbigliamento del trombonista in concerto. In assenza di toppe si useranno borse in plastica tenute assieme da spille in acciaio.
3. Idratazione durante l’esecuzione. Il trombonista abbisogna di una idratazione abbondante nel corso delle esecuzioni pubbliche, in particolare quando tali esecuzioni hanno luogo in ambienti secchi e con scarso riciclo di aria. Solitamente una spremuta di ananas rappresenta una delle soluzioni migliori, apportando una giusta quantità di sali non disgiunta da una aliquota gustativo-olfattiva non indifferente. Il corpo esausto dell’ananas, in una ottica di riciclo totale e di adesione a tematiche ambientali che ogni trombonista segue con zelo inesausto, può essere utilizzato come sordina o come pratico astuccio per gli occhiali.
4. Predisposizione interiore o di animo del trombonista. Questo punto è da considerarsi esaurito in quanto il trombonista medio è privo di ogni forma, anche residuale, di interiorità.
5. Il trombonista e il ramen, Il trombonista è attratto ferocemente da tutto ciò che è oriente o allontanamento dal codice comportamentale occidentale, e il ramen esercita su di lui un potere di attrazione al limite dell’ossessione. L’uovo
che occhieggia al centro del piatto viene sfiorato dalla coulisse del trombonista che con pochi, leggeri colpi di polso lo priva del suo albume e ne raggiunge il tuorlo, che si getta in bocca con una fretta proditoria. Il tutto mentre titilla il suo strumento con affettata noncuranza. In mancanza di un ramen, opta per un toast, ma con una tristezza che gli affiora dal fondo dell’animo.
6. Il punto SEI vuole rimarcare con intensità ancora maggiore quello che è stato detto al punto CINQUE, ossia che il trombonista non ha una vera interiorità ma solo fugaci e incostanti flessioni dell’animo.
7. Il trombone e i tappeti. I tromboni amano i tappeti e i tappeti non amano i tromboni, e come tutti gli amori incorrisposti si tratta di un sentimento vero, forte, inscalfibile dai venti dell’abitudine: questo perché le macchie derivanti dalla salivazione del trombonista sul tappeto sono sempre diverse, e l’abitudine in questo caso non trova ricetto. Alcune macchie sono rotonde, altre trapezoidali, altre ancora sembrano la cartina geografica della Rhodesia ma tutte, nessuna esclusa, hanno in comune il fatto di essere bagnate.
8. Il trombone di plastica. Per rispetto ai tromboni non di plastica chiediamo tre minuti di silenzio. Se vi stufate ne bastano anche due.
9. Il vero trombonista non sa di essere un vero trombonista e a volte se ne vergogna, ma è un sentimento temporaneo, transitorio, di solito passa subito. Quando non passa bisogna passare alla terapia farmacologica.
Daniele Del Giudice
C’era una stazione, avevo letto da qualche parte che esisteva, su questa terra, una stazione dei treni, ma questa era una stazione particolare perché i treni non c’erano. Daniele ci era arrivato per caso. Che era poi come dire che non c’era neanche una stazione, perché una stazione senza treni è come un cavallo senza coda, che penso che anche a voi sia capitato di rado di vedere un cavallo senza coda, di solito ce l’ hanno. Dietro, che a volte è un po’ difficile da vedere perché appunto stando dietro è complicato accorgersene ma se guardi bene la trovi. Quindi dicevo che c’era questa stazione, senza treni, proprio neanche uno.
Allora ad un certo punto, data questa drammatica penuria di treni, è stato deciso di togliere i binari, che servono a fare avanzare i treni ma se non c’è nessun treno che avanza, o che indietreggia, che è lo stesso, non servono neanche i binari (per esempio, a nessuno è mai venuto in mente di togliere la coda a un cavallo, questo dimostra che serve, la coda, principalmente al cavallo e poi a chi osserva che senza una coda il cavallo sta male).
Quindi si era arrivati ad un dato momento a decidere di togliere anche i binari lasciando questa stazione senza treni anche senza binari, perché sembrava la cosa più logica: era scritto così sul documento che avevano tra le mani quelli che avevano tolto i binari: LA COSA PIÙ LOGICA. Però dopo un paio di giorni che alla stazione erano stati tolti i binari non vuoi dire che è arrivato un treno? E poi un secondo? E poi anche un terzo? Che però si sono fermati in aperta cam-
pagna, mooolto lontani dalla stazione perché mancavano ormai i binari e quindi non sono riusciti ad andare avanti.
Poi è tutto finito, i treni sono stati svuotati, abbandonati, lasciati in mezzo al nulla e senza binari intorno; adesso ci sono sempre dei cavalli che gli girano intorno; li guardano e scuotono la coda. Forse ridacchiano ma non so esattamente se sia così perché non si capisce mica quando un cavallo ride.
Oscar Wilde
Stava tentando di accendere una Peterson Magnun Huge Bore acquistata a Londra per fare colpo sulla commessa, che si era poi rivelata essere un travestito ceco, travestito bene ma sempre un travestito e Oscar, pur essendo un liberal di scuola habermasiana, in certe occasioni avvertiva una eccessiva sensazione di pienezza e sapeva riconoscere al primo sguardo un travestito ceco: si era quindi tenuto la pipa e se la era riportata a casa, e fino al giorno prima era rimasta appoggiata sul lato destro della scrivania in noce, vicino al dizionario dei sinomino e dei contrari del Parker-Roberts. Dopo averla vista, ancora avvolta nella sua carta rosa, si era risolto a lacerare la carta e a mettere a nudo il contenuto, che consisteva in una pipa di sette chili di peso con un fornello iridescente con alcune pietre dure a formare la scritta London is London and Croydon is Croydon. Dopo averla appoggiata delicatamente sull’osso del cranio di un crotalo, che usava abitualmente come leggio, la tenne in posizione con l’indice della mano sinistra e cominciò a tentare di accenderla. In quel momento entrò la sua commercialista. Era alta più o meno come un comodino ma nonostante questo aveva una grande influenza su Oscar, essendo la persona che si frapponeva tra i suoi soldi e la possibilità di non pagare le tasse con una parte di essi; una qualità che Oscar apprezzava gtandemente. Allo stesso tempo Oscar non amava la fontina, diceva che era un formaggio troppo levigato, senza buchi. Per lui i formaggi dovevano essere aspri, corrosi dalle mani di chi li aveva maneggiati prima, pieni della storia dei
loro polpastrelli: non avrebbe mai mangiato un formaggio che non avesse impresse le orme di chi lo aveva preparato, voleva vedere i dermatoglifi. Se no, niente. Quando, invitato a un convegno di dossografi nel Sussex, gli venne portata una enorme, intonsa, lucida fetta di fontina ebbe quasi un mancamento, si perforò l’indice con uno stuzzicadenti in faggio che portava sempre con sé dai tempi di Darmstadt e chiese, con voce flebile ma autoritaria, se avesse potuto togliergli da davanti quella cosa o, in subordine, se potesse buttarla direttamente nella indifferenziata. Non capì mai perché proprio lui, Oscar Wilde, fosse stato invitato a un convegno nel Sussex, regione dell’Inghilterra che pensava fosse più uno stato d’animo che un luogo geografico.
Francis Scott Fitzgerald
Il lago era molto grande, si faceva fatica a vedere una riva dall’altra, e anche se era molto azzurro aveva dovuto lasciare spazio a alcune masse intricate di alghe di lago, che sono diverse da quelle marine perché hanno un colore molto più intenso nella parte centrale per poi digradare cromaticamente verso l’esterno, e la piccola imbarcazione bianca con le assi azzurre al centro sulle quali era seduto in punta di gluteo il rematore si era incagliata in uno di questi viluppi. Francis, il nome, Scott Fitzgerald il doppio cognome, era uscito molto presto di mattina sia per fare attività fisica sia per pensare a come finire il terzo capitolo del suo nuovo romanzo, per il quale, contrariamente al solito, non aveva ancora scelto il titolo. Questo era uno dei motivi per i quali remava quasi tutte le mattine, cercare di capire perché non riuscisse più a pensare ai titoli dei libri che scriveva, come faceva una volta. Il titolo lo confortava, lo spronava, lo tranquillizzava, sapere di avere un titolo gli dava sicurezza e senso, sapeva che con un titolo in mano tutto era già pronto. Ma questa volta era diverso, non aveva un titolo, non aveva quasi niente, aveva, forse, un cognome, Gatsby, e aveva quella piccola barchetta sulla quale remava con poca voglia e molti dubbi tutte le mattine, alla barchetta era riuscito a dare un nome, l’aveva chiamata Zelda. Il laghetto era nel Connecticut, ed era relativamente isolato, a parte qualche turista che berciava sulle rive e un leggero odore di bacon fritto con grasso di sugna che gli creava un piccolo senso di vomito, che riusciva a controllare deglutendo a vuoto, come
se dovesse digerire qualcosa che non aveva mangiato. Queste sue remate solitarie non lo avevano aiutato a trovare il nome del suo nuovo romanzo fino a quando una mattina, verso le nove, forse le nove e mezza, abbandonò un attimo i remi per accendersi una sigaretta, abbandonando per un istante la piccola imbarcazione alla sua corrente, e vide che il lago la condusse prima verso destra, poi dalla parte opposta, quindi la cristallizzò in una andatura da crociera quasi impercettibile, e in quei momenti, mentre si sentiva sospinto, ebbe la sensazione che qualcosa stava aprendosi nella sua testa, e gli venne in mente un altro nome, Daisy, e una città, e una grossa villa biancheggiante, e una luce verde, e pensò distintamente a un futuro che non era davanti a lui ma che era dietro le sue spalle, e pensò che forse sarebbe stato sufficiente solo allargare di più le braccia, inarcare più la schiena, dilatare ancora di più gli occhi e gli venne da scrivere, una volta arrivato alla sua scrivania, che il futuro orgiastico indietreggia davanti a noi, e che per cercare di afferrarlo domani andremo più in fretta, allungheremo di più le braccia, e una bella o brutta mattina, questo dipenderà dal punto di vista, continueremo a remare, sempre controcorrente, risospinti senza sosta nel passato. Finì la sigaretta, riprese in mano i remi, si aggiustò il cappello e remò verso casa, col titolo stampato in mezzo alla testa. Poi, cominciò a piovere.
Gianni Celati
Camminare, camminare e solo camminare per cristallizzare il tempo e contare con calma tutte le conchiglie che erano appoggiate sul comodino, nessuna esclusa. È inutile chiedersi da dove vengano le conchiglie, bisogna solo contarle per capire quante sono, non perché sono lì piuttosto che da un’altra parte, solo capire quante sono. E’ inutile affrontare l’ontologia della conchiglia, bisogna solo guardarla. Bisogna camminare e raccontare, tenendo bene a mente che camminare è raccontare senza dire niente, o forse è un niente che vale più di un tutto, non lo so, nessuno lo sa, diffidare sempre da chi dice di sapere le cose, se le sa non ha alcun bisogno di dirlo e se lo dice, di solito, non le sa. Mentre si cammina, insieme a Celati, che di solito non parla molto perché preferisce guardarsi intorno, pensare anche al Paradiso, cristiano o laico, e ricordarsi di quello che diceva Elsa Morante, altra grande camminatrice, “se pensi che andrai in paradiso, andrai in paradiso, ma se hai qualche dubbio, allora c’è qualche dubbio.” Quindi fare andare le gambe con una certa forza, guardarsi di lato, dall’alto sarebbe troppo faticoso e stiamo pure camminando, per passare al ruolo di quello che guarda fuori dalla sua finestra e vede due persone che camminano e pensa toh, guarda, due persone che stanno camminando, laddove la camminata, soprattutto in questi ultimi tempi, è un atto bello eversivo. Come nei romanzi di Gianni, che sta camminando con noi, nei suoi romanzi dove dice meglio quello che non voleva dire, oppure una di quelle lunghe e inesorabili camminate nella
campagna inglese, seguendo quei sentieri pieni di ricci e di vecchie Range Rover azzurre col tetto di tela, con un passo che segue l’altro che ha fame di un altro passo, che fa dei piccoli mulinelli nella terra per affrettarsi a seguire sé stesso perché ha paura che possa svenire, e tutte le camminate sono avvolte da una polvere azzurrognola, sbiadita, eterea ma che, volendo, si può toccare con le mani, ed è la polvere azzurra che ti ricorda che lei c’era prima di te e ci sarà dopo di te e che oltre alle conchiglie bisogna fare attenzione anche ai ricci. Quindi, come diceva Gianni, quando decideva di parlare durante le sue camminate, non farsi mai dei complimenti inutili, non pensare a rappresentazioni di sé stessi e, nel caso, non farle sapere a nessuno, non monumentalizzare né il sé né gli altri, ma continuare a camminare e a pensare, finché ci si riesce. Poi, a un certo punto, ci si siede.
Eduardo de Filippo
A Napoli pioveva, e Eduardo De Filippo era a casa sua, in una stanza rettangolare piena di salami appesi. Eduardo guardava tutti quei salami e non capiva perché fossero appesi, ma era stanco dopo una lunga giornata di prove e aveva deciso di sdraiarsi sul divano, chiudendo un occhio, mentre con l’altro controllava che i salami non cadessero a terra. A un certo punto quello che paventava accadde, un salame si staccò di netto dalla corda alla quale era appeso e cadde sul pavimento, sul quale cominciò a camminare perché era un rarissimo salame con le gambe, non zampe proprio gambe, che Eduardo aveva letto fosse molto diffuso nel Gabon. Ma qui non siam nel Gabon, siamo a Napoli, prima pensò e poi disse ad alta voce De Filippo, rivolto a uno degli altri salami non ancora caduto a terra, sperando che non si muovesse. Quello non si mosse ma strizzò un occhio, essendo un ancora più raro salame con gli occhi, di origine maya. Ma dico, diceva a sé stesso Eduardo, ho due lauree in lettere, una me l’hanno data gli inglesi, che in fatto di lettere sono pure scrupolosi, sono una persona abbastanza colta, ho sempre visto salami in tutta la mia vita, li ho maneggiati a volte con cura a volte con colpevole corrività e ora, d’un tratto, non riesco a capire la differenza tra un salame con gli occhi e uno con le gambe, anzi gambette, perché sono molto piccole. Non è una bella cosa, per niente, ed è meglio che chiuda entrambi gli occhi, aspettando che passi la nottata, che è ancora giovane.
Sofonisba Anguissola
Se siamo armate e addestrate siamo in grado di convincere gli uomini che anche noi abbiamo mani, piedi e un cuore come il loro; e anche se siamo delicate e tenere, ci sono uomini delicati che possono essere anche forti e uomini volgari e violenti che sono dei codardi. Le donne non hanno ancora capito che dovrebbero comportarsi così, in questo modo riuscirebbero a combattere fino alla morte; e per dimostrare che ciò è vero, sarò la prima ad agire, ergendomi a modello. Tutto questo prima di andare alla mia tela, per fissarvi un pezzo di vita.
Giacomo Leopardi
A torto, Giacomo Leopardi era giudicato noioso. A torto, perché a farci brillare e a farci essere qualcosa di diverso da noi non è mai la nostra natura che sconfessiamo spesso come incapiente a sé stessa e non adatta in alcun modo a descriverci ma la mano, ossuta, di una regia invisibile, un ambiente che occupa tutta la scena fino a diventare esso stesso la scena che ha contribuito a edificare. Leopardi non era un conversatore brillante né un uomo di mondo, incapacitato in ciò dalle dimensioni e dalla lentezza immacerabile degli arti inferiori, secchi e minutamente innervati, in mezzo agli altri si lasciava pervadere, come la goccia di un liquore all’assenzio che poco a poco prende possesso dell’intero bicchiere, dalla timidezza e dalla ritrosia di lessema, e ne era paralizzato; ma la stessa, preclare, immaginosa timidezza e una percezione piccola e diamantifera della propria superiorità avvinta da un suggello irrefragabile alla certezza che non sarebbe mai stato capace di esprimerla lo rendevano regale e impietosamente sarcastico. Per dare il meglio di sé, Leopardi aveva bisogno della solitudine e di un gelato al pistacchio. Il cicaleccio, la fatuità, la esibizione molle e insensata della carne, di tutti i tipi, viva o morta, da cui era affascinato e che amava secondo l’immagine che inseguiva di sé e non secondo la propria natura, lo ingannavano, perché gli suggerivano un’idea sbagliata della futilità, della corrività, dell’attimo transeunte, come se la futilità non fosse una realtà conchiusa ma un oggetto che appare desiderabile, impetrato, e il cui desiderio ci fa sentire sciocchi e colpevoli
ma solo se siamo in compagnia di qualcuno, perché la colpa ha bisogno di testimonianza. Chi lo ascoltava, si distraeva imbarazzato; e le ragazze, passata la curiosità per un torace che dilagava nella categoria del nulla e stravagava in un torso da anemone, tornavano a chiedersi su quale altro bipede ansante sarebbe stato saggio e opportuno fare riposare le loro lunghe gambe dorate e lucide, per farsi portare prima di mezzanotte verso il centro del mondo, cioè un posto che non esisteva. Giacomo Leopardi si eclissava con le infinite ellissi delle sue gambe verso la sua domus nova, disparaissant come i personaggi di esergo alla sua narrazione, e solo dentro quel sericeo perimetro di mura cenava, da solo. Lo ritrovavo a notte fonda, o poco prima di giorno, quando appariva un suo messaggio, tipicamente sinottico, di poche cellule vocaliche, ondeggiando come una piroga semantica tra “io nel pensier mi fingo, ove per poco il cor non si spaura” o il maggiormente interlocutorio “e mi sovvien l’eterno”, sempre intimamente sperando che nessuna abbia agio o desiderio alcuno di muoversi.
Haruki Murakami
Murakami è appena tornato da una corsa sulla spiaggia di Kamakura e ancora sudato in ogni distretto corporeo, conosciuto e non, si ferma in mezzo alla stanza e spiega, con voce ferma, come affrontare il ramen, “Una delle cose più importanti da fare quando ci si avvicini, per la prima volta, al ramen, è creare dentro di sé un fittizio sentimento di disperazione, un vago presentimento di morte, una indotta mollezza dello spirito e della carni che faccia desiderare con spasmi crescenti un uovo ammollato in mezzo a un brodo scuro con della carne di origine indefinita. Questo è, in sintesi, il ramen. Una accozzaglia indebita di alimenti che nella vita di tutti i giorni farebbero fatica a salutarsi e che calati nella magica tazza del ramen sembrano fatti l’uno per gli altri. La tradizione culinaria del periodo Edo ci ricorda, e ce lo ricorda in giapponese del periodo Edo, che il ramen va consumato bollente, e il brodo deve essere risucchiato con la veemenza di un capro albino che si trovi improvvisamente da solo in alta montagna. Non si danno attestazioni di capri albini nel periodo Edo e come alta montagna dobbiamo accontentarci del Fuji, ma la storia è piena di smagliature e cortocircuiti logici. Questa sembra più una smagliatura, a ben vedere. Una volta fatto cadere nella tazza l’uovo comincia a fare cose strane, si distende, sembra osservare con attenzione tutto quello che lo circonda, l’albume è un occhio obeso che si protende verso il nulla e all’altro capo del nulla ci siete voi che state per mangiarlo. Un sabba oftalmologico. Poi arriva la carne, a fettine sottili, una dopo l’altra, fatta
cadere con maestria dalla mano del cuoco che come dice Hiroshi Osaki, uno dei più grandi esperti di ramen giapponesi, devono sembrare ali di farfalla che cadono su un campo fiorito. Sullo stesso campo fiorito andranno a cadere anche i cipollotti verdi e un ettolitro di salsa marroncina. Shaken, not stirred. Il ramen deve essere trattato come un Martini, tutti gli elementi devono fare amicizia ma non troppa, mescolarsi ma non troppo, mantenere la loro ontologia ma non troppo. È del tutto evidente che anche un uovo ha la sua ontologia, ma non lo sa: l’ignorarlo è quello che rende l’albume del ramen un terzo occhio, da divorare con cura.”
Paolo Nori
Mi sono sempre chiesto cosa spinga certa gente a suonare. Per di più il basso tuba. Cioè il basso TUBA non è uno strumento. Non PUÒ essere uno strumento. È troppo grosso e emette dei suoni mediamente sgradevoli. Capisco che in certi casi possa anche essere utile, soprattutto se il suonatore, per ora non lo chiamo ancora musicista ma opto per il più neutro termine di SUONATORE, ossia di emettitore di suoni privi di senso, è timido. Non ama farsi vedere. Uno ha voglia di suonare, gli piace suonare, ma è pure timido; questo rappresenta un problema apparentemente insormontabile ma ecco che in questo caso il bassotuba ti viene in soccorso; tu, suonatore timido, tu introverso esecutore di melodie che apprezzi solo tu e qualche tuo congiunto sino al secondo grado, ti siedi e ti metti davanti al corpo questo ammasso scomposto di ottone che ti nasconde quasi completamente e suoni, emetti rumori, allinei note che paiono provenire dal pavimento, avrei potuto dire cielo ma data la gravità delle stesse il pavimento mi sembra più indicato, senza che nessuno se ne accorga; ebbene questo è sommamente utile. Un pensiero accorato vada allo sfortunato violinista timido che non ha alcuna possibilità di nascondersi ma deve offrire al pubblico tutta la bellezza della sua arte o all’ancora più sfortunato pianista che, pure seduto, può giusto abbassare il capo fino a sfiorare la tastiera ma poco o nulla può contro lo sguardo goloso del pubblico. Ebbene questi due sono molto più sfortunati del suonatore di basso tuba, non possono fare nulla se non fingere di essere contenti di essere lì. Il che non
è che non accada mai, ma a volte vorrebbero forse essere a casa a bersi una tisana alla malva. Soprattutto i pianisti. Statisticamente i pianisti hanno una irredimibile passione per le tisane alla malva. In tazza piccola. Ma torniamo al basso tuba: non è infatti tutto bassotuba quello che luccica, c’è una parte oscura del basso tuba, e siamo qui per spiegarvela. La parte oscura è quella che sta dietro e che a volte si muove, è un oscuro in movimento, è quello che lo suona, la persona spesso di aspetto fisico opinabile, che gonfia le gote, inspira, ammassa l’aria dentro di sé, poi espira, la getta fuori, e la convoglia dentro il suo strumento e dal suo strumento verso il mondo. In pratica vuole farci sapere che è vivo e che sta respirando per continuare a rimanerci, vivo.
Nina Simone
Nina Simone è in un grande appartamento di New York, anche se non ama molto New York e preferisce appartamenti più piccoli perché riesce a vedere meglio dove finiscono. Nell’appartamento c’è un pianoforte lucido, perfetto, un Bechstein tirato a lucido per lei, probabilmente hanno pulito anche tutti i tasti perché sono ancora umidi, il sol dell’ottava centrale è claudicante, esce un sol che scappa subito sul la che è li vicino, e Nina piega il dito per rendere più fluido il passaggio, facendo assumere alla falangetta del suo dito medio una posizione affatto innaturale, quasi impressionante ai suoi occhi, ma quando suona Nina smette di essere Nina, esce da quel corpo che suda davanti a quegli 88 tasti e ritorna ad essere Eunice Kathleen Waynon, coi nomi delle sue zie e il cognome di suo padre e si vede a Tyron, un piccolo paese sabbioso della Carolina del Nord, mentre va a lezione di pianoforte e i ragazzini bianchi le urlano parole che lei capisce bene, molto bene, e cerca vanamente di non capire e si fa scivolare addosso come il succo di mela che sa che avrebbe trovato a casa, sul tavolo rosso della cucina. Eunice non aveva i soldi per fare niente, le lezioni le venivano pagate dalla comunità, era brava, ripeteva le canzoni ad orecchio e aveva scoperto che alcuni secoli prima un signore con i capelli strani aveva scritto dei pezzi bellissimi, meravigliosi, aerei, per quello strumento che sembrava un armadio orizzontale con quegli ottantotto tasti. Lei avrebbe voluto imparare solo quelle musiche, scritte da quel signore con quel cognome strano, Mozart, e poi un altro signore dal
cognome ancora più corto, Bach, anche lui con una pettinatura strana, lui assomigliava al signor Tucker, era grasso come lui, anche lui scriveva dei pezzi meravigliosi, Eunice metteva le mani sulla tastiera e gli occhi sulla partitura e suonava si alzava si sedeva si alzava nuovamente senza mai muoversi, non sentiva il caldo non sentiva le voci dei ragazzi non sentiva l’odore della polvere, i bianchi non lo sentono ma i neri sentono subito l’odore della polvere, fin da piccoli, ma le era stato detto No cara, sei brava, molto brava, forse anche bravissima ma sei nera come un pezzo di carbone, non puoi suonare queste musiche in pubblico, sono musiche da bianchi, ci vogliono affusolate dita bianche che percorrano con grazia la tastiera, le tue dita sono lunghe, questo è vero, ma sono nere, non sono fatte per questo tipo di musica, lascia perdere. Allota Eunice non disse niente, non parlava molto, preferiva suonare e cantare, e decise che quelle musiche le avrebbe tenute per sé, le avrebbe suonate per sé, con le sue lunghe dita nere che arrivavano alla fine di mani nere di braccia nere, e decise che si sarebbe chiamata Nina, usando il soprannome datole dal primo fidanzato, Niña, Piccolina, e Simome come una attrice francese dalla faccia triste che recitava come lei viveva, parlando poco, Simone Signoret, ed ecco apparire Nina Simone. Nina Simone non avrebbe suonato Bach ma cantato My Baby Just Cares For Me, suonato I Loves You Porgy, composto Old Jim Crow, sarebbe diventata amica di Martin Luther King e nemica dell’FBI, avrebbe girato il mondo, sarebbe andata in Egitto, in Turchia, in Belgio, alle Barbados, avrebbe suonato sempre in tutti i suoi concerti quel Mississipi Goddam pensando alle 4 ragazze saltate per aria in una notte nera dell’America più nera, sarebbe diventata inspiegabilmente ricca grazie alla sua My Baby Just Cares For Me usata da Chanel per una pub-
blicità televisiva, avrebbe riso molto pensando come tutte quelle donne bianche avessero comprato quei prodotti pubblicizzati dalla canzone di una donna con le mani nere che non avrebbero potuto suonare Bach e Mozart. Eunice sarebbe anche morta, insieme a Nina Simone, e avrebbe chiesto che le sue ceneri venissero sparse in varie zone dell’Africa, terra di origine dei suoi antenati. Ma tutto questo sarebbe successo dopo, o prima, o forse doveva ancora succedere. Adesso, in mezzo a una luce ovattata, Eunice era da sola, in questo grande appartamento di New York, con tre poltrone, due quadri con scene di caccia e un terzo quadro, più grosso degli altri, rettangolare, con una signora molto elegante che la fissava, tenendo tra le mani un cagnolino dallo sguardo assente e un grande e lucido pianoforte che la aspettava. Si sedette davanti al pianoforte, si ricordò dei tasti ancora umidi e di quel sol che tendeva a diventare un la e come quasi tutti i giorni della sua vita pensò a quei buffi, per la Eunice decenne, signori che avevano scritto quelle musiche meravigliose che non la avevano mai abbandonata e che le avevano fatto compagnia anche mentre il suo primo marito tentava di violentarla e Martin Luther King veniva ammazzato con tre colpi di pistola, e le sue lunghe e affusolate mani nere incominciarono a suonare la prima delle Variazioni Goldberg di quel signore con la faccia rubizza che assomigliava tanto al signor Tucker, che, aveva scoperto, si chiamava Johann Sebastian Bach e non si sarebbe opposto a vedere dita nere sul suo clavicembalo, e cominciò a volare, sorridendo.
Lina Wertmüller
Bambina dotata di una naturalissima floridezza di carni e di ingegno vivace, a soli tre anni Linam, che si chiamava Arcangela Felice Assunta era già in grado di leggere tutta la Divina Commedia al contrario, lei la pronunciava al anivid aidemmoc con un forte accento romano, mangiare due banane per volta senza sbucciarle e recitare A Zacinto in piedi sul tavolo ovale del soggiorno, senza mettere le calze perché gli stringevano troppo i polpacci, di dimensione invero generose e dalla perfetta forma a goccia. A quattro anni, alta già un metro e due centimetri, per lei era molto, chiese di andare da sola a Stoccolma a piedi, pensava che andare a Stoccolma a piedi potesse essere una bella idea, ma spesso succede che le belle idee non sono mai belle e arrivata a soli duecento metri da Anzio una improrogabile esigenza di pipì la costrinse a ritornare a casa essendo ancora non del tutto autonoma nel togliersi e mettersi il pannolino da sola. A quattro anni e mezzo conobbe Enrico, il suo primo fidanzatino, un rubizzo e gioioso bimbetto dagli occhi chiari e dall’appetito insaziabile, soprattutto di mortadelle, e in una notte di luna quasi piena, una luna di tre quarti e un quarto, uscì con Enrico su un tandem rosso con le rotelline che garantiva ad entrambi una maggiore stabilità, e nonostante la acquisita stabilità sfondò di testa la vetrina della premiata mortadelleria Centofanti, senza sapere che il signor Centofanti era in laboratorio a legare le zampe a un maiale appena arrivato. Dopo averlo visto Enrico scappò, da solo, sul tandem con le rotelline, pare che abbia smesso di pedalare solo sette anni
più tardi, mentre Arcangela Felice Assunta detta Lina rimase esanime per una decina di minuti per poi alzarsi di scatto e battere la testa contro una scatola di tonno Imperatore, di importazione messicana, che la fece svenire nuovamente e poi ricadere in un sonno placido e pieno di sogni di tonni a pinna gialla di Caracas che pedalavano su tandem gialli sulla strada di Cortina; arrivata a Cortina si risvegliò e la prima cosa che vide fu il signor Centofanti con un coltello da pesce in una mano e la testa di un pesce senza il resto del pesce nell’altra. Sorrideva, il signor Centofanti, non il pesce. Era senza testa, il pesce, non il signor Centofanti.
Margaret Thatcher
Margaret Thatcher, per molto tempo, girò per tutte le città d’Inghilterra con un basco in testa. Non un basco di particolare prestigio o ardita foggia, ma una semplice frittella di tessuto di colore indefinito, con vistosi segni di usura ai lati, una frittella di patate di tela, per gli anglofili una hash brown da testa. Questo perché Margaret Thatcher aveva una testa di dimensioni oltremodo generose, con uno spiccato prognatismo parietale. In pratica, un testone. Tutto procedeva senza intoppi, Margaret non era tipa da intoppi, se trovava un intoppo sulla sua strada lo prendeva a calci o la lanciava addosso a chi lo precedeva, che spesso tornava a casa con un intoppo non suo, e nella peggiore delle ipotesi lei non riconosceva quell’intoppo come quello che aveva preso a calci. Il tutto mentre sulla sua testa restava agganciato questo basco, come lo zola nella polenta, che in Inghilterra si trova a fatica. Un corpo unico, un copricapo che era fondamentale per il capo che lo sosteneva. Un giorno successe una cosa. Ci sono dei giorni in cui succedono delle cose e questo era uno di quei giorni. Margaret Thatcher. Andò a pranzo con dei colleghi di partito nel ristorante al numero 6 di Downing Street. Lei ama quel ristorante perché aveva le tovaglie a quadretti che la tranquillizzano, la nostra Margaret ha bisogno di ordine interiore per poter pranzare con calma e adeguata voluttà, e il quadretto la tranquillizza. Entrata nel ristorante, dopo essersi seduta e avere incrinato in modo irrimediabile la cassapanca, si tolse il basco e lo appoggiò accanto a un vassoio di fritto misto: Margaret era affetta da uno specifi-
co disturbo del comportamento che la faceva sempre sedere vicino a un vassoio di fritto misto, un fenomeno noto come tropismo dell’anello di totano. Seduta accanto a questo vassoio, con la mano destra parzialmente coperta da sguardi estranei dal fedele basco, cominciò a titillare con l’indice il contenuto del vassoio, arrivando a ingurgitare quarantanove anelli di totano in cinque minuti netti. Magra, ma di famelicità inquieta. Poco dopo arrivò il resto del pranzo di lavoro, due capretti un fagiano delle patate novelle al forno torta con 890 mele caffè ammazzacaffè e ammazza dell’ammazza caffè, conto, basco rimesso in testa per travisarsi e uscita dal ristorante dalla porta posteriore. Dopo qualche ora cominciò a verificarsi uno strano fenomeno, Margaret Thatcher avvertì la costante presenza di un odore di fritto misto, molto persistente, quello che in psichiatria viene definita cacosmia soggettiva o presenza dell’odore fantasma. Tuttavia, in questo caso, l’odore non era affatto fantasma, era causato dalla attiguità forzata, durata per tutta la durata del pranzo frugale descritto sopra, del basco con il vassoio di fritto misto. Il basco era diventato un anello di totano. Un enorme, soffice, morbido anello di totano da portare in testa. Da quel giorno la vita di Margaret Thatcher non fu più la stessa, e nelle sere di autunno, dietro un larice, spesso la si vedeva cospargere il basco di sale, una specie di aspersione laica, novella san Colombano del fritto misto.
Yasmine Reza
Chi deve apparecchiare la tavola. Atto unico.
Protagonisti – variabili.
Presenze fisse – un tavolo lungo, anzi oblungo, che indoviniamo essere di forma ovoidale, con un adeguato numero di sedie disposte tutto intorno.
La scena è un appartamento alto borghese, la città è a vostra scelta così come i nomi e le professioni delle persone che andranno a sedersi al tavolo. In scena ci sono 3 coppie, tra le professioni imprescindibili e insostituibili, che non possono mancare in nessuna delle rappresentazioni di questo atto, ci deve essere un avvocato, una mercante d’arte, un professore universitario di filosofia. Il resto è variabile. La mercante d’arte si finge lesbica, come fanno spesso le mercanti d’arte per vendere più vassoi.
Che freddo
Freddo?
Sì freddo. Non te ne sei accorto? Piove da 4 giorni e oggi mi sembra che la pioggia sia gelata…
Stalattiti.
Come hai detto scusa?
Ho detto stalattiti.
Stalattiti?
Sì. La pioggia. Gelata. Delle stalattiti, dei dardi gelati che cadono, senza ferirlo, sul tuo corpo infradiciato (dice tutto questo senza alzare gli occhi dal giornale che sta leggendo, girando le pagine in modo rumoroso).
Bello. Sì sì. Bello. Ai tuoi allievi, poveri sfortunati, propo-
ni tutti i giorni queste cazzate da intellettualucolo dei mie santi coglioni? Anzi delle mie SANTE ovaie, i coglioni sono fortunata a non averli. Mi passi la salvietta da mettere sotto i piedi? Sto allagando il salotto.
Uhh che risposta fulminante. Mi sento inerme. Eccoti la salvietta. In effetti stavi inondando il parquet con le tue acque reflue. A che ora arrivano i commensali? Che non ho ancora capito chi sono, se non che verranno a cena a casa nostra. Ho visto movimento in cucina, essendo un raffinato intellettuale ho inferito, ti piace questo termine, INFERITO che stasera ci fosse qualcuno a cena, la cuoca non si ferma mai durante la settimana.
I soliti. Vengono i soliti. Saremo in sei. Ci sarà il pollo coi peperoni. So che ti piace tanto, il pollo coi peperoni.
In sei. I soliti sei. Il pollo coi peperoni. Ho capito. Mi ingozzerò di pollo fingendo di ascoltarvi. Se alzo il sopracciglio destro sono disposto a piccoli, telegrafici dialoghi di non più di cinque minuti, se lo lascio inerte non voglio parlare con nessuno. Stasera guardami il sopracciglio.
... Ma certo. Non aspettavo altro. Il sopracciglio. Vado a cambiarmi che tra poco arrivano.
Che tette.
Eh? Tette?
Le tue. Che tette. Non me le ricordavo. Se non sapessi che sono all’80 percento di materiale plastico potrei ancora provare un brivido di eccitazione ma la plastica mi abbatte. Mi deprime.
All’inizio non avevi questo tipo di problemi. Anzi. La plastica ti piaceva, eccome. Con quello che le ho pagate ci mancherebbe pure che non fossero uscite così. Senti dopo cena parliamo delle mie tette, se vuoi, ma adesso vado a cambiarmi. È tardi. Saranno qui a momenti.
Ok ok. Le ho solo viste ballonzolarmi davanti, un rinnovamento della libido, sia pure intermittente, è cosa gradita.
MA NON È CHE CI SARÀ ANCHE LEI ?
(La risposta arriva da dietro la porta del bagno) certo che ci sarà anche lei. È mia amica da vent’anni. C’è sempre lei. Ti ho detto che ci saranno i soliti sei.
Mio Dio ma è una cretina assoluta. Uno degli esempi più eclatanti di come la psicologia faccia male, in primo luogo, agli psicologi. L’ultima volta mi ha detto di spostare il cesto della frutta verso est per rispettare la sua vita interiore. Della frutta. Io devo spostare un cestino di frutta perché una con una laurea in psicologia presa non si sa come mi ha detto di rispettare la vita interiore degli ananas. Ti do una notizia, e stasera, nel caso, la darò anche a lei. Io sono totalmente disinteressato alla vita interiore degli ananas. Sono disinteressato alla vita interiore di chiunque, a ben vedere.
Vedremo di non parlare di ananas, se la cosa ti tranquillizza.
Speriamo, l’ananas torna sempre. Il grande ciclo vichiano dell’ananas.
L’ananas sarebbe vichiano ?
Certo. Poi te lo spiego, anche se sarà inutile.
Si sente suonare il citofono.
Il citofono. Qualcuno ha suonato al citofono.
Ho sentito. Io devo finire di cambiarmi. Apri tu.
Così, immediatamente, senza neanche un attimo di pausa, subito.
Senza neanche riflettere con maggiore attenzione sulla vita interiore dell’ananas. Ok vado a sentire. Tu fai con calma. Cosa te li dico a fare poi (comincia a parlottare tra sé e sé). Tu fai sempre con calma. Tutto.
Sì? Ah siete voi, certo. Sì. Siamo in casa. Io dovevo partire
per l’Antartide ma ho rimandato. No no scherzo. Ci vado la prossima primavera in Antartide. Intanto salite. Quarto piano. C’è l’ascensore. Io non lo prendo mai ma voi potete prenderlo. Ecco fatto. Ho aperto. Non ho capito a chi ma ho aperto. Una voce di donna credeva che dovessi partire per l’Antartide. Io scherzavo ma questa ci ha creduto. Deve essere la tua amica psicologa. Quella degli ananas.
… Certo che anche tu, dire cose del genere... al citofono... Beh e perché no? Sarò mica io? Io dico una cosa idiota e quella ci crede, a occuparsi troppo di vita interiore degli ananas.
Ti prego, almeno questa sera…
Niente. Sto zitto. Per ora. In ogni caso le ho detto che partiremo per l’Antartide più avanti. Questa primavera. Hai visto mai che magari ci crede.
Suonano alla porta. La moglie del professore va ad aprire.
Sulla soglia due persone. Un cinquantenne alto, abbronzato, vestito in modo fintamente trasandato, giacca blu, pantaloni rossi, un paio di mocassini con nappina blu. Accanto a lui
una donna un poco più giovane, capelli tagliati a caschetto, un trucco leggero, vestita in modo etno chic con zoccoletti con calze corte ai piedi, un cappello a larga tesa in testa, un cigarillo alla vaniglia spento in bocca. Spento da poco perché la brace arde ancora.
Eccovi, tutto a posto? Avete fatto fatica a trovare la via?
Ma noo figurati. Ciao tesoro. Certo se lui avesse finito prima di fingere di lavorare in studio Io non stavo fingendo di lavorare. Ho avuto tre riunioni, una peggiore dell’altra, e…
Tutte inutili, le solite riunioni inutili, fatte per vellicare l’ego di chi decide di organizzarle, che sceglie anche il colore dei pennarelli da mettere accanto ai fogli, bianchi, pieni del nitore accecante delle decisioni, inutili, da prendere.
Franca Valeri
Alla finestra, poi in casa, poi ancora alla finestra che da su Corso Monforte a Milano. Franca Valeri indossa un abito rosso e fuma senza particolare convinzione. Fuori si sente il rumore di una macchina che accelera all’improvviso. “Eccone uno, sarà il terzo o il quarto questa mattina. La gente ha sempre fretta, fretta, fretta, ansia di arrivare e poi di non sapere cosa fare una volta arrivata. Ma andate con calma, vi dico, cosa vi serve affrettarvi per non sapere cosa fare quando siete arrivati dove pensavate, tapini, di essere attesi. Nessuno aspetta più nessuno, oggi. Nessuno. Tutti da soli a credere di essere indispensabili, e per questo corrono, hanno fretta, sbavano. Del resto, gli uomini, una certa noia, sapete. Nella vita di un uomo ci sono sempre molte donne, almeno tre, e di solito non si conoscono tra di loro, sono distanti, l’uomo pensa di essere psicologo ma è, al massimo, sociologo, ne sceglie una facoltosa, una lavoratrice e una che viaggia molto, anche se alla fine non sceglie un granché perché sono queste tre disgraziate che accettano, per noi o per gioco, la piccola corte del lombrico. Il lombrico chiama, si organizza la giornata, e dalla sua organizzazione discende la fretta, il dover essere nel posto giusto al momento sbagliato, che la donna caritatevole finge che sia quello giusto. E il lombrico, essendo lombrico, non capisce. E mentre non capisce lui deve andare di fretta, non pensare, perché mai dover pensare, è così faticoso, siamo realisti almeno per una volta, che basta e avanza, non si può chiedere a un lombrico un pensiero complesso, forse anche un solo pensiero, delle
motivazioni, uhh che noia le motivazioni, è chiaro che un lombrico non avrà che motivazioni puerili e superficiali, meglio correre, correre, andare senza sapere dove andare e soprattutto perché, ma andare per il gusto di andare. Sembra la moda del momento, mentre io ho sempre preferito i pesci rossi, che sanno di essere venuti al mondo per non fare nulla di più che muoversi con calma, guardarsi intorno, e vedere tutti gli altri pesci più grandi che si agitano per un nonnulla. Calma, tranquillità e finestre chiuse, come farò io tra poco. Le finestre chiuse aiutano molto”.
Agatha Christie
Un treno fermo in una stazione giapponese, uno di quei treni superveloci a forma di supposta, che sembrano dovere entrare in un culo immenso che li aspetti da qualche parte. Seduta al centro di tre sedili vuoti c’è Agatha Christie, che mangia un melonpan e gioca con una tazza di tè verde, che probabilmente non berrà mai. “Vi devo dire alcune cosette, con la preghiera di dimenticarvene subito. La vita ha spesso una trama pessima, e non vedo perché la vostra debba essere diversa, e ad essa, alla vita, io preferisco di gran lunga i miei romanzi, che so come fare iniziare e, con un po’ più di fatica, anche come fare finire. In essi troverete alcune verità scomode, vi verrà naturale pensare che una verità è quasi sempre scomoda, e, segnatevelo da qualche parte, un indizio è un indizio, due indizi sono una coincidenza, ma tre indizi fanno una prova. Ora gradirei un caffè, può andare bene anche un caffè giapponese, potrei verificare in prima persona se anche in Giappone, come in Inghilterra, il caffè ha sempre il gusto di un esperimento chimico venuto male. A proposito del male, saprete, vero, che il male non rimane mai senza punizione, e che se qualche volta può sembrare che questo sia successo, ebbene è solo perché a volte la punizione è segreta. Matrimonio, istituzione prestigiosa, una, se non la sola, delle cose più ragionevoli che sono state dette sul matrimonio è che qualunque cosa tu faccia, dopo esserti sposato, te ne pentirai. Ognuno di noi è un potenziale assassino – in ognuno di noi sorge di tanto in tanto il desiderio di uccidere – sebbene non la volontà di uccidere. Ma lo sia-
mo tutti, e non potete immaginare come un paio di scarpe scomode possano acuire questa sensazione al punto di farla diventare inevitabile. Ho imparato che non si può tornare indietro, che l’essenza della vita è quella di andare avanti. La vita è davvero una strada a senso unico. La migliore ricetta per il romanzo poliziesco? Il detective non deve mai sapere di più di quanto non sappia il lettore. La parola è un’invenzione dell’uomo che serve a impedirgli di pensare. Pochissimi di noi sono ciò che sembrano. Un buon consiglio viene sicuramente sempre ignorato, ma non c’è ragione per non darlo. Cosa curiosa, le abitudini. Le persone stesse non sanno mai di averle. La malvagità non è qualcosa di sovraumano, è solo qualcosa di meno umano. È un gran sollievo non essere costretti a manifestare doti che non si posseggono. Il momento migliore per pianificare un libro è mentre stai lavando i piatti. Per finire, sempre che questa possa essere considerata una fine. cosa saprei fare? Se interessa a qualcuno? Magari su questo stesso treno che sarà pure iperveloce ma sembra non muoversi ? Beh, tanto per cominciare so scrivere. Non mi piace la folla, la gente che mi preme da vicino. Non mi piacciono le voci forti, i rumori, le chiacchiere troppo prolungate e i ricevimenti. Mi piace il silenzio. Mi piace dormire, sognare, mangiare. Mi piace l’odore del caffè. Mi piacciono i mughetti, adoro i cani e amo andare a teatro. Insomma, bisogna pure che mi rassegni a essere quella che sono, dovrebbero farlo tutti. A un certo punto tirate un grosso sospiro, pensatelo come a un sospiro di sollievo, e cominciate ad essere sempre quello che siete, sarà molto riposante e avrete anche una pelle migliore”.
Virginia Woolf
Credo assolutamente e risolutamente di poter essere descritta come una cattiva scrittrice, credo che scrivere questo possa descrivere con precisione quello che sono, ma al contempo devo aggiungere a questa descrizione il fatto che sono anche una scrittrice onesta, che cerca di evitare l’estasi e la bellezza perché non sono in grado di riconoscerle, e quindi di descriverle. Mi piacciono da sempre le balene, coi loro sbuffi riescono ad uscire dall’acqua, e io cerco di fare lo stessa con la mia onestà, o con quello che ne rimane, o con quello che ne resta, io credo che l’onestà non sia permanente, che prima o poi finisca, solo che io non posso inabissarmi come la balena quando finisce il suo sbuffo, io devo rimanere lì, ed è per questo che preferisco l’onestà alla bellezza, è troppo accecante, non riuscire a scriverne.
Io non mi sento autorizzata a scrivere divinamente, cerco costantemente qualcosa che non è stato ancora detto, cerco di esprimere l’inespresso, e mentre cerco di farlo devo accantonare la bellezza e lasciare la porta aperta alla verità, che non è sempre bella. La bellezza la lascio in eredità alla prossima generazione, a quella che verrà immediatamente dopo la mia o anche oltre. Per lo stesso motivo non ho rinunciato a scrivere romanzi, non posso smettere di farlo, non posso abbandonare i miei personaggi, non posso rinunciare a farli vivere. Non posso scrivere di un albero per un intero pomeriggio, ho bisogno almeno di qualcuno che ci si appoggi e stia magari in silenzio, ma sia lì. Bisogna cercare un punto dal quale osservare la vita che si sta cercando di
raccontare, non ci si deve limitare alle proprie sensazioni, che saranno fatalmente diverse da quelle degli altri, non si può essere solo lirici e pensosamente descrittivi, senza dare vita ai personaggi, entrare nelle loro teste, che sono una emanazione della mia, dare loro un perimetro, un peso, una forza di spinta, credo di poter dire di essere completamente spacciata. E come lo sarei io, lo saremmo tutti, credo. Una generazione deve rompersi qualche osso di sua proprietà affinché la prossima possa dirsi migliore, questa è una cosa che credo fortemente, noi e nostri contemporanei non otterremo nulla, dobbiamo preparare il terreno per quelli che leggeranno le nostre parole, e le criticheranno, e ci rideranno sopra, e senza accorgersene le faranno proprie. Io ho fatto la mia personale penitenza leggendo Joyce, che mi sembra uno strano, un approccio coraggioso che finge di essere originale e poi un inedito e continuo boato che distrugge tutto, anche se la mia è stata una sola, unica, distratta lettura. Quindi continuo a dirlo, la prosa che vedete sulle pagine fatta di sole, distinte parole non è in grado di cambiare niente, se essa avrà un futuro dipenderà di chi legge, non da chi ha scritto, le parole devono involarsi dalla pagina, se ci rimangono sopra non possono fare nulla. E io, lo penso spesso ultimamente, io vorrei essere un musicista, scrivere poche righe per volta e sentire come risuonano, per poi scriverne altre tre e restare ad ascoltarle per tutto il giorno, perché da sempre mi sembra che le cose accadano a molti, lontani e diversi livelli simultanei, e io riesca a coglierne solo alcuni.
Non avevo nessuna intenzione di mangiare un croissant in piedi, a quell’ora poi. Ma i bar erano tutti chiusi, i taxi erano rari e avevo fame. Il caffè non era poi così male, e il mio riflesso nella vetrina sembrava quasi felice. Sono sempre stata molto brava con i riflessi. Soprattutto a quell’ora.
Audrey Hepburn
1. Jacques Lacan
2. Dio
3. Proclo
4. Charles Darwin e Senofonte
5. Bertolt Brecht
6. Graham Greene I
7. Benny Goodman
8. Piersandro Pallavicini
9. Thomas Mann
10. Herman Melville
11. Leonardo Fibonacci
12. Francesco Bacone
13. William Shakespeare
14. Adriano Olivetti
15. Ennio Flaiano
16. Nora Ephron
17. Molière
18. Bix Beiderbecke
19. Alfred Hitchcok
20. Graham Greene II
21. Joris-Karl Huysmans
22. Erri de Luca
23. Claudio Monteverdi
24. Sonny Rollins
25. Richard Feynman
26. Honorè de Balzac
27. Francesco Petrarca
28. Ettore Sottsass
29. Achille Succi
30. Oliver Sacks
31. Johann Sebastian Bach
32. Thelonius Monk
33. Sigmund Freud
34. Duke Ellington
35. Wolfgang Amadeus Mozart
36. Aristotele
35. Platone
36. Mario Soldati
37. Charles Mingus
38. Thelonius Monk
39. Lina Sotis
40. Cochi Ponzoni
41. Bud Powell
43. Paolo Sorrentino
44. Cannoball Adderley
45. Philippe Daverio
46. Christian Dior
47. Yiyun Li
48. Isaac Asimov
49. George Simenon
50. Fred Astaire
51. Jerome David Salinger
52. Giorgio Manganelli
53. Cary Grant
54. Giulio Mozzi
55. Gianni Rodari
56. Alessandro Bergonzoni
57. Luciano Bianciardi
58. Alvar Aalto
59. Herman Melville
60. Pelham Grenville Wodehouse
61. Luciano Canfora
62. John Keats
63. Carl Gustav Jung
64. Franz Kafka
65. Eric Rohmer
66. Stieg Larsson
67. Henning Mankell
68. Humphrey Bogart
69. Italo Calvino
70. Francesco Petrarca
71. Glenn Miller
72. Daniele Del Giudice
73. Oscar Wilde
74. Francis Scott Fitzgerald
75. Gianni Celati
76. Eduardo de Filippo
77. Sofonisba Anguissola
78. Giacomo Leopardi
79. Haruki Murakami
80. Paolo Nori
81. Nina Simone
82. Lina Wertmüller
83. Margaret Thatcher
84. Yasmine Reza
85. Franca Valeri
86. Agatha Christie
87. Virginia Woolf
88. Audrey Hepburn
Della stessa collana
100-1
Ray Banhoff
Vita da autodidatta
100-2
Donato Novellini
Hortus conclusus
100-3
Jacopo Masini Cartacce
100-4
Wilma Ducati
Anime 100-5
Igor Ebuli Poletti
Kafka non l'avrebbe mai fatto
Finito di stampare nel mese di febbraio 2025, in Italia, per conto di Agenzia NFC di Amedeo Bartolini & C. sas. www.nfcedizioni.com