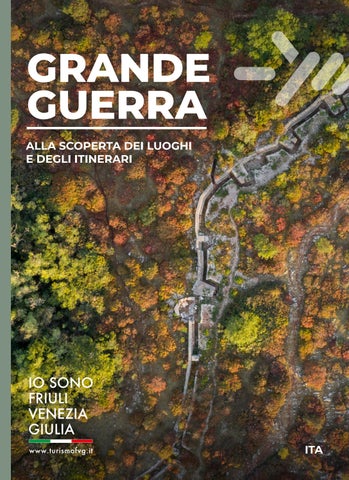GRANDE GUERRA
ALLA SCOPERTA DEI LUOGHI
E DEGLI ITINERARI
CARNIA

udine, RETROVIE FRIULANE E PORDENONESE
Alpi Giulie
CIVIDALE E Valli del Natisone


GORIZIA, Collio E CARSO ISONTINO
Fogliano Redipuglia Doberbò del Lago

Duino-Aurisina
TRIESTE E Carso TRIESTINO

LEGENDA
TRIESTE E CARSO TRIESTINO PAG. 6
GORIZIA, COLLIO e CARSO ISONTINO PAG. 20
CIVIDALE E VALLI DEL NATISONE PAG. 42
UDINE, RETROVIE FRIULANE E PORDENONESE PAG. 48
ALPI GIULIE PAG. 66
CARNIA PAG. 78
Avvertenze per gli itinerari:
Per godersi in sicurezza gli itinerari proposti si consiglia di munirsi di vestiario e attrezzatura adeguati: abbigliamento sportivo, scarpe adatte allo sterrato (o sentieri di montagna), una scorta d’acqua e una fonte di illuminazione per inoltrarsi in caverne e gallerie. Si consiglia inoltre di avere sempre con sé una mappa, cartacea o digitale, della zona che si vuole visitare e di controllare le previsioni meteo prima di ogni escursione.

Inserito nel cammino Walk of Peace
Per maggiori informazioni www.thewalkofpeace.com
Scopri tutti gli itinerari presenti nell’applicazione FVG Outdoor!
Paluzza
Malborghetto-Valbruna
Chiusaforte Resia
Caluzetto
Palmanova
Aquileia
Prosecco
Gradisca d’Isonzo
Sagrado
Monfalcone
Ragogna
SULLE ORME DELLA STORIA IN FRIULI VENEZIA GIULIA

Il Friuli Venezia Giulia sorprende per la varietà dei popoli che hanno attraversato queste terre e vi hanno impresso i segni indelebili del loro passaggio. Fin dai tempi antichi questi luoghi hanno ospitato lingue e culture diverse che hanno potuto incontrarsi e intrecciarsi, dando vita a un unicum storico.
Visitando oggi questa meravigliosa Regione si ha la possibilità di ammirare coi propri occhi le testimonianze di oltre duemila anni di storia: dai resti romani di Aquileia e Zuglio alle tracce longobarde a Cividale del Friuli, dagli imponenti castelli medievali che costellano tutto il territorio alle architetture di età veneziana che spiccano a Udine e dintorni, fino all’eredità asburgica che caratterizza le città di Gorizia e Trieste
Insieme a tutto ciò si può godere dell’impareggiabile ricchezza naturalistica che contraddistingue il Friuli Venezia Giulia: dal panorama alpino ai paesaggi marittimi, attraversando il Friuli collinare e il Carso Territori non solo ricchi di fascino artistico e naturale ma anche palcoscenico di alcune tra le più importanti vicende che hanno segnato la storia del Novecento Prima tra queste, sicuramente, la Grande Guerra Esplorando il Friuli Venezia Giulia si potrà scoprire e approfondire un capitolo importante della storia italiana ed europea, ripercorrendo i luoghi che hanno ospitato il fronte del conflitto e visitando i numerosi musei, sacrari e monumenti che custodiscono la memoria di ciò che è accaduto.

1914 – 1918: LA GRANDE GUERRA

Il territorio del Friuli Venezia Giulia, dai monti al mare, custodisce ancora oggi i segni indelebili della Grande Guerra. I “luoghi della memoria” che raccontano questo evento tragico ed epocale sono molteplici, in ragione del fatto che tra il 1915 e il 1918 il territorio regionale divenne zona di operazioni e di retrovia.
I rilievi montuosi di confine, dalla Carnia alle Alpi Giulie, dall’alto Isonzo sino al Carso furono segnati dalla guerra di trincea, dalla costruzione di molteplici linee difensive, ancora visibili sulle montagne, nei luoghi più aspramente contesi come l’altopiano carsico, oppure sotto forma di postazioni fortificate, come lungo il corso del Tagliamento. Le zone a ridosso del fronte furono modellate da intensi lavori militari: trincee, ricoveri, strade, linee ferroviarie, depositi e magazzini. Se i soldati vissero le esperienze drammatiche della guerra di alta montagna e di trincea, la popolazione delle retrovie fu intensamente mobilitata, basti considerare il caso delle donne carniche, impiegate come “portatrici” per rifornire le truppe ad alta quota; la guerra plasmò anche la vita sociale ed economica di paesi e città, profondamente trasformati dalla vasta presenza militare e dai servizi logistici; esemplare il caso di Udine che, sede del Comando Supremo di Luigi Cadorna e meta delle delegazioni alleate, divenne la “capitale della guerra”, salendo alla ribalta nazionale. La dimensione della guerra totale lasciò tracce profonde non solo nella memoria collettiva ma anche nel territorio e nel tessuto urbano, attraverso i monumenti ai caduti, i cimiteri di guerra e i grandi sacrari militari, testimoni silenziosi del lutto di massa e oggi simbolo di riconciliazione tra i popoli e monito contro gli orrori della guerra.
CRONOLOGIA
1914
28 giugno. Assassinio dell’arciduca Francesco Ferdinando d’Asburgo a Sarajevo
28 luglio. L’Austria-Ungheria dichiara guerra alla Serbia, i giovani di Trieste e delle contee di Gradisca e di Gorizia sono chiamati a combattere con l’esercito austro-ungarico
1915
23 maggio. Il Regno d’Italia dichiara guerra all’Austria-Ungheria
24 maggio. Le truppe italiane varcano il confine italo-austriaco e entrano nel Friuli orientale. Il Friuli diviene zona di operazioni e di retrovia, sottoposto all’autorità militare
23 giugno – 7 luglio. Prima Battaglia dell’Isonzo
17 luglio – 3 agosto. Seconda Battaglia dell’Isonzo
20 agosto. Udine subisce il primo bombardamento aereo
18 ottobre – 4 novembre.
Terza Battaglia dell’Isonzo
11 novembre – 5 dicembre.
Quarta Battaglia dell’Isonzo
18 novembre. Gli italiani bombardano Gorizia, all’epoca città dell’Impero asburgico
1916
11 – 15 marzo. Quinta Battaglia dell’Isonzo
Marzo. Scontri sulle Alpi Giulie e nella Zona Carnia (Pal Piccolo-Freikofel)
25 giugno. Attacco austro-ungarico con i gas sul Monte San Michele
16 – 18 luglio. Scontri tra le cime dello
Jôf di Miezegnot e del Piccolo Miezegnot, nelle Alpi Giulie
6 agosto – 17 agosto. Sesta Battaglia dell’Isonzo
9 agosto. Le truppe italiane entrano a Gorizia
14 – 17 settembre. Settima Battaglia dell’Isonzo
30 settembre – 11 ottobre.
Ottava Battaglia dell’Isonzo
1 - 4 novembre. Nona Battaglia dell’Isonzo
1917
12 maggio – 5 giugno. Decima Battaglia dell’Isonzo. Offensive dell’esercito italiano sul settore carsico e isontino
19 agosto – 19 settembre. Undicesima Battaglia dell’Isonzo. L’esercito italiano conquista l'altopiano della Bainsizza
24 ottobre. Inizio Dodicesima Battaglia dell’Isonzo. Inizia l’offensiva austro-germanica a Caporetto
9 novembre. L’avanzata dell’esercito austrogermanico si esaurisce di fronte al corso del Piave. L’intero territorio regionale è occupato dalle truppe asburgiche
Dicembre. Il Comando supremo austro-ungarico dispone che le truppe di occupazione debbano sostenersi con le sole risorse presenti nei territori occupati
1918
3 – 4 novembre. Dopo la decisiva vittoria sul Piave l’esercito italiano riprende possesso dei territori perduti dopo la ritirata di Caporetto
3 novembre. Il Cacciatorpediniere Audace giunge a Trieste sancendo il passaggio della città al Regno d’Italia
4 Novembre. Firma dell’armistizio a Villa Giusti. Si conclude il conflitto
I testi di approfondimento storico della guida sono stati curati da Matteo Ermacora all’interno del progetto PRIN 2022 PNRR “Cultural heritage of war on the borderland. Politics of memory, economic development and local communities”, diretto dal Tommaso Piffer (Università degli Studi di Udine) e Patrick Karlsen (Università degli Studi di Trieste)

TRIESTE E CARSO TRIESTINO
Molo Audace ‒ Trieste

Il Carso è un crocevia di diversità naturali, culturali e tradizioni popolari che si estende lungo tutto il confine sud-orientale del Friuli Venezia Giulia. In questo territorio è possibile immergersi nella natura, esplorando ad esempio la Grotta Gigante, visitando le risorgive del fiume Timavo, e percorrendo il Sentiero Rilke, che deve il nome al poeta che qui trovò l’ispirazione per le sue Elegie Incastonata nella natura carsica e tesa verso il mare ecco Trieste, città letteraria e capitale mitteleuropea d'eccellenza; tesoriera di un patrimonio artistico e storico ineguagliabile. Qui si può passeggiare tra le rovine di epoca romana e i sontuosi palazzi risalenti al periodo austro-ungarico, in cui la città divenne un centro di scambio commerciale e culturale grazie all’istituzione del porto franco. Il clima di pace e la convivenza culturale trovarono, però, un punto d’arresto agli inizi del Novecento. Nel 1914 la città e tutto il territorio circostante entrarono in guerra assieme al resto dell’Impero e, nell’anno successivo, divennero un obiettivo per il Regno d’Italia. La città fu difesa strenuamente dagli austro-ungarici e oggi, nel territorio che la circonda, è possibile riscoprire quel pezzo di storia visitando i numerosi resti delle fortificazioni asburgiche. Mentre in città spiccano i monumenti che celebrano il passaggio della città al Regno d'Italia.
MUSEI ED ESPOSIZIONI

CIVICO MUSEO DELLA GUERRA PER LA PACE "DIEGO DE HENRIQUEZ"
Il Museo della Guerra per la Pace nasce come musealizzazione delle straordinarie collezioni di Diego de Henriquez, studioso a cui è intitolato il museo, che comprendono circa 15 000 pezzi inventariati. Si propone come il “museo della società del Novecento in conflitto con i propri demoni e i propri orrori” evidenziando così la necessità di una pace che possa essere duratura. Lo spazio espositivo è stato ricavato negli edifici dell’ex Caserma “Duca delle Puglie” la cui ampiezza consente di esporre anche una vasta selezione di mezzi militari e pezzi di artiglieria pesante. Il piano terra dell’hangar 3 è interamente dedicato alla Grande Guerra: l’esposizione, intitolata “1914-1918 Il Funerale della Pace”, alterna i veicoli militari e i pezzi di artiglieria ad altri cimeli, tra cui divise, armi, attrezzature militari e materiale di propaganda, corredati da pannelli informativi e immagini dell’epoca. Il piano superiore è invece dedicato alla storia di Trieste durante il primo conflitto mondiale e al periodo che intercorre tra il 1918 e il ritorno della città all’Italia, nel 1954, toccando alcuni eventi della Seconda Guerra Mondiale. Qui si può scoprire anche la storia del collezionista triestino Diego de Henriquez, strettamente interconnessa a quella della sua città natale. Al termine del piano si trova un’ampia sala destinata a ospitare eventi e mostre temporanee.



3
CIVICO MUSEO DEL RISORGIMENTO E SACRARIO OBERDAN
Il Museo del Risorgimento di Trieste, allestito al primo piano della Casa del Combattente, consente di ripercorrere gli eventi che hanno interessato questo territorio a cavallo tra ‘800 e ’900. Qui sono esposti cimeli, fotografie e documenti legati all’Irredentismo dai moti del 1848 alla Grande Guerra. L’edificio stesso ha una notevole rilevanza storica in quanto comprende alcune parti dell’austriaca “Caserma grande” e la cella in cui l’irredentista Guglielmo Oberdan venne rinchiuso prima di essere giustiziato per diserzione e per aver avuto l’intenzione di attentare alla vita dell’Imperatore. Nel Sacrario a lui dedicato si trova un imponente gruppo scultoreo a opera di Attilio Selva.
2 Via XXIV Maggio, 4 presso Piazza Oberdan 34100 Trieste

MUSEO PRIVATO DELL’ASSOCIAZIONE CULTURALE ZENOBI
Il museo dell’Associazione Culturale F. Zenobi raccoglie oggetti che risalgono al periodo tra la fine dell’Ottocento e il 1918. Al suo interno si possono ammirare uniformi, fondine per armi, cartucce, Kappenabzeichen (distintivi militari austro-ungarici), decorazioni e altri cimeli. È visibile anche una raccolta di cartoline, oggetti di propaganda, documenti militari e materiali di casermaggio
Loc. Caresana ‒ Mackovlje, 12 34018 San Dorligo della Valle (TS)
MONUMENTI ED EDIFICI STORICI

FARO DELLA VITTORIA
Lungo la panoramica Strada del Friuli che dal centro città porta alla frazione di Prosecco si erge il Faro della Vittoria. Fu progettato nel primo dopoguerra dall’architetto triestino Arduino Berlam e dallo scultore Giovanni Mayer. Dopo quattro anni di lavori, dal 1923 al 1927, il faro fu inaugurato alla presenza del Re Vittorio Emanuele III, per sottolinearne il carattere di celebrazione per l’annessione della città al Regno d’Italia. Il faro, alto circa 70 metri, poggia su un basamento che faceva parte dell’ex forte austriaco Kressich, rivestito di pietra bianca di Orsera, su cui è incisa la frase attribuita a D'Annunzio “Splendi e ricorda i caduti sul mare”. Il faro stesso ha le sembianze di una colonna sulla cui sommità è posta la lanterna che illumina il Golfo e che è visibile ad una distanza di 22 miglia nautiche, pari a più di 40 km. In cima alla lanterna c’è una Nike alata, mentre a decorare la base della colonna Mayer volle una statua raffigurante un marinaio. Poco più in basso è ancora visibile l’ancora del cacciatorpediniere Audace.


CELEBRAZIONI E MONUMENTI
NEL PRIMO DOPOGUERRA
Nel primo dopoguerra tutti i paesi coinvolti nel conflitto organizzarono manifestazioni ed eressero una serie di monumenti per commemorare i propri caduti e, se vincitori, per celebrare l’esito della guerra. L’Italia non fece eccezione, e in tutti i comuni vennero eretti lapidi e monumenti dedicati ai caduti in guerra e alla vittoria. Questa pratica si diffuse anche nelle “nuove Province”, territori che avevano una valenza simbolica particolare, perché è per il loro possesso che l’Italia entrò in guerra, ed è in buona parte su di essi e nelle aree limitrofe che i soldati italiani combatterono e morirono a centinaia di migliaia. Pertanto, in queste terre la stessa presenza di monumenti dedicati ai caduti e alla vittoria vuole essere una forte riaffermazione di quest’ultima e dell’avvenuta annessione all’Italia, presentata come compimento dell’opera di unificazione nazionale risorgimentale. È per questo che nelle “terre redente” e nelle immediate vicinanze si eressero alcuni dei più grandi e maestosi monumenti d’Italia, come il Faro della Vittoria di Trieste, l’Ossario di Udine, e, in seguito, i sacrari di Redipuglia, Oslavia, Caporetto e Timau. Analogamente, il luogo scelto per l’avvio della più grande manifestazione del dopoguerra, la scelta della salma del “Milite Ignoto” e la sua partenza per il Vittoriano a Roma, fu la Basilica di Aquileia, simbolica culla ancestrale della cristianità e della latinità dell’area ormai interamente “redenta” grazie alla vittoria.

PIAZZA UNITÀ D’ITALIA E MOLO AUDACE
Uno degli scorci più belli e noti di Trieste è senza dubbio la Piazza Unità d’Italia, punto di incontro tra il mare e le strade cittadine. La piazza, aperta sul mare, è chiusa su tre lati da importanti palazzi storici come il Municipio, il palazzo della Regione (ex Lloyd Austriaco, poi Triestino) e altri ancora. Dopo il tramonto, la bellezza della piazza è esaltata dalle luci che ne delineano i contorni. Chiamata in passato semplicemente “Piazza Grande”, nel 1918 venne rinominata per celebrare l’annessione di Trieste al Regno d’Italia. Sul lato mare ci sono due pili alla base dei quali si trovano le statue dei soldati assegnati ai servizi automobilistici. I pili sono alti 25 metri e culminano in un’alabarda, simbolo della città di Trieste. Al di là della piazza, traversata la Riva Caduti per l’italianità di Trieste, si incontra la Scala Reale impreziosita dalle sculture di Fiorenzo Bacci raffiguranti a sinistra un Bersagliere con bandiera, a destra le “ragazze di Trieste” unite da un tricolore che le due stanno cucendo. Proseguendo in Riva 3 Novembre, si accede al Molo Audace, già molo San Carlo. Costruito sui resti di un antico veliero, il nome attuale ricorda il cacciatorpediniere italiano che il 3 novembre 1918, a guerra praticamente finita, attraccò al molo. Particolarmente apprezzato dai cittadini e dai visitatori che amano prendersi qui una pausa dal trambusto cittadino, il molo è anche il luogo ideale per chi voglia ammirare il mare da vicino.


IL CACCIATORPEDINIERE AUDACE E LA FINE DELLA GUERRA
Durante l’ottobre del 1918 prese avvio il processo di dissoluzione dell’AustriaUngheria e il governatore di Trieste abbandonò la città il 1° novembre 1918. Le autorità politiche e militari italiane inviarono via mare un corpo di spedizione per procedere all’occupazione della città che, assieme a Trento, era stata uno dei massimi simboli della sanguinosa guerra che si stava per concludere. La prima nave ad arrivare in città fu il cacciatorpediniere Audace, che il 3 novembre 1918 attraccò presso il molo San Carlo (poi ribattezzato Audace), dove fece sbarcare i primi bersaglieri e il generale Carlo Petitti di Roreto, nominato dall’Italia quale suo primo governatore di Trieste.


ARA DELLA TERZA ARMATA
In cima al Colle di San Giusto si trova l’Ara della Terza Armata, inaugurata nel 1929 da Emanuele Filiberto duca d’Aosta. L’opera in pietra bianca poggia su un piedistallo. Sui quattro lati sono incise le epigrafi “Le vittoriose armi qui consacrò la III Armata al comando di Emanuele Filiberto di Savoia”, “Isonzo” e “Piave” in memoria dei principali fiumi dove operò l’Armata. Sui riquadri dell’ara sono raffigurati svariati equipaggiamenti militari.
Piazza della Cattedrale 34143 Trieste

PARCO DELLA RIMEMBRANZA
Sulle pendici del Colle di San Giusto, in centro a Trieste, si trova il Parco della Rimembranza, inaugurato nel maggio del 1926 per commemorare i caduti in guerra. Esso è diviso in 26 settori in cui sono disposte le pietre carsiche su cui sono stati incisi i nomi degli irredentisti triestini caduti in guerra. Le pietre dedicate alla Prima Guerra Mondiale sono comprese tra i settori 16 e 25. Il Parco può essere raggiunto salendo da Piazza Goldoni attraverso la spettacolare Scala dei Giganti
Via Capitolina ‒ Viale della Rimembranza 34131 Trieste


MONUMENTI AI CADUTI DI TRIESTE
Al termine del Parco della Rimembranza si incontra un monumento dedicato ai caduti nella Prima Guerra Mondiale, opera di Attilio Selva. Un gruppo bronzeo alto oltre cinque metri, posto su una base in pietra bianca d’Istria, raffigura tre uomini che soccorrono un ferito, mentre un altro regge uno scudo. Sulla base è scolpita la frase “Trieste / ai caduti / nella guerra di liberazione / MCMXV - MCMXVIII” dove “guerra di liberazione” sintetizza l’idea, cara al nazionalismo dell’epoca, di una Trieste italiana liberata dall’Austria-Ungheria.
Piazza della Cattedrale, angolo Via Giuseppe Rota 34143 Trieste



STATUA DI NAZARIO SAURO
Sulle Rive della città, di fronte alla Stazione Marittima di Trieste, si trova la statua raffigurante Nazario Sauro, irredentista istriano giustiziato a Pola per alto tradimento dalle autorità austroungariche nel 1916. A Sauro è stata conferita la Medaglia d’Oro al Valore Militare alla Memoria. L’opera di bronzo, realizzata da Tristano Alberti, è stata eretta in occasione del 50° anno dalla morte di Sauro.
Piazzale Marinai d’Italia ‒ Molo dei Bersaglieri, 3 34124 Trieste

MONUMENTO AI LUPI DI TOSCANA
A San Giovanni di Duino si trova il monumento dedicato alla Brigata Toscana, che prese parte a un’azione della Decima Battaglia dell’Isonzo. La brigata è rappresentata da due lupi in bronzo posti su un masso: il primo è rivolto verso il Monte Ermada, la cui conquista era il fine della battaglia, mentre l’altro guarda verso il basso minacciando e controllando il nemico. Sul fianco del masso lo scultore Arduino Berlam intagliò i primi versi dell’Eneide in occasione del bimillenario della nascita di Virgilio, cantore delle bocche del Timavo. Accanto si trova il cippo dedicato al Maggiore Giovanni Randaccio 10
Strada Statale SS14 ‒ incrocio strada per la foce del Timavo ‒ Località San Giovanni di Duino 34011 Duino Aurisina (TS)
OSSARI, SACRARI E CIMITERI

11 CIMITERO MONUMENTALE DI SANT'ANNA
Il cimitero monumentale sul Colle Sant’Anna a Trieste custodisce, oltre alle tombe di illustri personaggi quali Umberto Saba e Italo Svevo, alcuni monumenti funerari legati al primo conflitto mondiale. Tra questi, l’Ara dei Caduti conserva le spoglie dell’irredentista Guglielmo Oberdan e di settantadue volontari caduti nella Grande Guerra. Non distante si trova la tomba della famiglia Stuparich che Giani Stuparich volle in ricordo del fratello Carlo, volontario irredento morto nel 1916.


CIMITERO MILITARE
AUSTRO-UNGARICO DI PROSECCO
Il cimitero militare di Prosecco è attualmente uno dei più importanti in Italia. Ospita le tombe di 5733 caduti di cui solamente 578 hanno conservato l’identità, le quali testimoniano le diverse provenienze dei soldati della monarchia asburgica. Il cimitero è in fondo a una dolina racchiusa da un muro di cinta; a sinistra dell’ingresso ci sono alcune lapidi originali. Il sito è raggiungibile in breve a piedi dal Monumento alla Resistenza di Prosecco.
Lungo la SP1 in direzione Campo Sacro, località Prosecco ‒ 34121 Trieste

CIMITERO MILITARE
AUSTRO-UNGARICO DI AURISINA
Il cimitero militare di Aurisina raccoglie le spoglie di 1934 caduti nelle battaglie dell’Isonzo tra Monfalcone e il Monte Ermada, e quelli deceduti nell’ospedale da campo di Aurisina-Nabrežina. Al suo interno è conservato il monumento originale del cimitero, con copie delle due urne. Il cimitero si può raggiungere a piedi partendo dalla piazza di Aurisina oppure in auto (fino a un certo punto) seguendo le indicazioni turistiche lungo la SP 5.
Dolina carsica Šišček lungo il sentiero CAI 32 ‒ 34011 Duino Aurisina (TS)

13
Via dell’Istria, 206 ‒ 34145 Trieste

LE DIFESE AUSTRO-UNGARICHE SUL CARSO
Così come già accaduto su diversi fronti aperti nella Prima Guerra Mondiale, nel volgere di poco tempo anche su quello italiano si assisté alla trasformazione del conflitto in guerra di posizione o guerra di trincea. Questa tipologia di conflitto richiedeva che entrambi gli schieramenti avversari erigessero fortificazioni, costituite da svariate linee, lungo estesissime aree del fronte. Per questo motivo il Friuli Venezia Giulia venne costellato di costruzioni militari come ridotte, casematte, postazioni per le artiglierie e l’avvistamento e, soprattutto, trincee. Il Carso è un esempio paradigmatico del fronteggiarsi dei due schieramenti perché rappresentava uno snodo cruciale per la difesa del confine dell’Impero asburgico: la sua difesa coincideva, infatti, con la difesa della città di Trieste. E difendere Trieste significava non solo impedire l’avanzamento del nemico, ma proteggere l’obiettivo stesso per cui l’Italia era scesa in guerra. Tutt’oggi lo splendido paesaggio carsico è caratterizzato dalle tracce che il conflitto ha lasciato dietro di sé: tra queste i numerosi resti delle fortificazioni austro-ungariche a partire dal campo di addestramento per soldati di Prosecco fino alla primissima linea sul Monte Ermada.
ITINERARI E PARCHI TEMATICI

PARCO DELLA TRINCEA DEL LITORALE
Difficoltà
Turistico su sentieri segnalati (CAI 12), strade forestali e sentieri non segnalati
Dislivello
Non significativo
Lunghezza
2 km
Durata
2 ore circa
Consigliato
tutto l’anno
Cartografia
cartina Tabacco 047
Punto di partenza
Parcheggio del Santuario
Mariano di Monte Grisa
La Trincea del Litorale è un’imponente struttura difensiva allestita a cura dei comandi austroungarici per difendere Trieste da un eventuale attacco via mare. Da Duino-Devin la trincea arrivava fino a Cittanova (Novigrad, Croazia). Conservata o leggibile in gran parte, alcune sezioni della trincea sono oggi visitabili al Parco 40, un museo all’aperto nei pressi del Santuario di Monte Grisa
Il sentiero che lo attraversa, immerso nella natura carsica, è di facile percorrenza e offre suggestivi scorci sul golfo. La prima sezione del parco, raggiungibile in circa 10 minuti seguendo una traccia nella vegetazione, comprende due tratti di trincea visitabili che permettono di studiare le tecniche costruttive dei muri di sostegno, realizzati in pietra a secco, nonché gli accorgimenti per facilitare la posizione di tiro dei soldati. Procedendo e continuando a seguire la traccia, aiutati anche dai pali con relativo QR code, si imbocca la strada forestale che conduce alle due tappe successive: a monte si raggiunge una trincea dotata di alcune feritoie interrotta da un varco d’accesso. Tornando sui propri passi e seguendo infine il sentiero CAI 12 si può visitare l’ultimo sito: una postazione fortificata con due caverne e un camminamento. Proseguendo per il sentiero CAI 12 si tornerà in direzione del Santuario di Monte Grisa, fino al parcheggio.

15
PARCO 97 – CAMPO DI ADDESTRAMENTO
Difficoltà
Turistico su sentieri segnalati (CAI 1 e 19), strade forestali e sentieri non segnalati
Dislivello
Non significativo
Lunghezza
2 km
Durata
2 ore circa
Consigliato
tutto l’anno
Cartografia
cartina Tabacco 047
Punto di partenza
Parcheggio all’ingresso del Bosco Fornace
DI PROSECCO
Il Parco 97 all’interno del Bosco Fornace di Prosecco è un museo all’aperto unico nel suo genere. Permette di scoprire un aspetto trascurato ma interessante del primo conflitto mondiale: l’addestramento dei soldati arrivati da altri campi di battaglia. Qui venne realizzato un poligono militare indicato in antiche mappe catastali, attorno al quale, durante la Grande Guerra, vennero realizzate strutture ricettive in caverna per i militari. Il sentiero, superata la Grotta Priamo, già ricovero di guerra con opere ben conservate sia all’interno che all’esterno, si snoda accanto ai cumuli di sassi realizzati all’epoca del poligono per fermare i proiettili destinati ai bersagli. Proseguendo nel percorso, svoltando a destra si imbocca il sentiero CAI 19 per raggiungere la trincea addestrativa, una vera e propria trincea costruita dagli stessi soldati che poi vi si esercitavano per adattarsi alle condizioni del nuovo fronte. Da notare le piste alle estremità della trincea, delimitate da sassi che simulano i camminamenti d’approccio. La trincea scavata nella roccia fronteggia una diversa posizione difensiva realizzata con muretti a secco. Infine, dopo che il sentiero avrà svoltato a destra, con una piccola deviazione dal tracciato si giungerà alla Grotta del Bersaglio Militare e ai resti di una baracca, già posto di guardia. Alla grotta si accede seguendo una scalinata scavata nella roccia che porta nella cavità, illuminata da un foro venutosi a creare con un crollo di parte della volta. Da qui si torna all’ultima deviazione descritta per poi seguire il sentiero CAI 1 fino al parcheggio da cui si è partiti.


MUSEO ALL’APERTO DEL MONTE ERMADA
Difficoltà
Turistico su sentieri
segnalati (CAI 3)
Dislivello
181m da Ceroglie alla Quota 323 163m da Medeazza alla Quota 298
Lunghezza
6 km (totale)
Durata
3 ore per percorso
Consigliato da ottobre a maggio
Cartografia
Cartina Tabacco 047
Punto di partenza
Paesi di Ceroglie e di Medeazza
A poca distanza da Trieste è possibile visitare uno dei luoghi più significativi della Grande Guerra in Friuli Venezia Giulia: il Monte Ermada, ultima linea difensiva austro-ungarica sulla via per Trieste. Un insieme di colline chiude l’accesso al Carso triestino tra il mare e il vallone di Brestovica (SLO). Il territorio è stato fortificato sin dal 1915 per venir poi rinforzato nel 1916, dopo la Sesta Battaglia dell’Isonzo. La quota principale è raggiungibile dal paese di Ceroglie con un itinerario ad anello che porta ai siti di interesse storico: la dolina del mortaio da 30,5, la grotta Dörfler o la caverna di Monte Querceto, già stazione di trasformazione della corrente elettrica. Sull’anticima del monte c’è un posto di combattimento per un comando di battaglione: qui sono riconoscibili le tracce del posizionamento di un periscopio che permetteva di controllare il terreno antistante. La cima è circondata da resti di trincee, cavernette e fortificazioni blindate e offre uno sguardo panoramico sui campi di battaglia dal mare alle Alpi Giulie. Scegliendo invece di partire dal paese di Medeazza, ultima località del Carso triestino, si raggiunge dapprima la zona del Monte Cocco con la linea degli osservatori blindati, uno dei quali conserva un’importante epigrafe, per poi spingersi fino alle caverne Karl e Zita, i cui nomi di guerra rimandano all’ultimo imperatore e all’ultima imperatrice d’Austria-Ungheria. Dalle caverne si sale facilmente la quota 298, detta impropriamente “dosso della trincea”, sito sul quale insistono i resti di una postazione antiaerea, unico esempio del genere conservato sul Carso triestino.


GORIZIA CARSO ISONTINO E COLLIO
Dolina del XV Bersaglieri

Circondata dai colli e attraversata dall’Isonzo, Gorizia è una città affascinante che raggiunse il culmine del prestigio quando divenne la principale città dell’omonima Contea Principesca dell’Impero asburgico. All’epoca si guadagnò il nome di “Nizza dell’Adriatico” o “Nizza Austriaca”, per il suo clima mite molto apprezzato dalla borghesia viennese. I meravigliosi parchi ed edifici dell’epoca tutt’oggi caratterizzano gran parte della città. In tempi più recenti, Gorizia è divenuta uno dei luoghi più significativi della storia dell’Europa e dell’Unione Europea. In seguito alla Seconda Guerra Mondiale, infatti, l'allora territorio di Gorizia venne diviso dal nuovo confine tracciato tra Italia e Jugoslavia: il cosiddetto "Muro di Gorizia", di cui oggi rimane traccia in Piazza della Transalpina - Trg Evrope. Il paesaggio che circonda la città è caratterizzato a nord dal Collio e a sud dal Carso isontino e dallo scorrere del fiume Isonzo, simbolo delle vicende che lo hanno visto protagonista durante la Grande Guerra. Nei primi giorni di conflitto, infatti, l’esercito italiano riuscì ad avanzare fino alle alture carsiche. Questo territorio divenne il fronte principale della guerra tra italiani e austro-ungarici: si combatterono ben undici battaglie prima della decisiva Dodicesima Battaglia dell’Isonzo che porterà alla ritirata di Caporetto e allo spostamento del fronte verso il Piave.
MUSEI ED ESPOSIZIONI

MUSEO DELLA GRANDE GUERRA DEL MONTE SAN MICHELE
Il Museo della Grande Guerra del Monte San Michele offre oggi un’esperienza davvero unica grazie a strumenti e contenuti multimediali interattivi in italiano e in inglese. Le tre sale, completamente riallestite nel 2018, sono l’esempio di come, oggi, la tecnologia possa contribuire alla divulgazione storica. All’interno si trovano alcuni reperti bellici e due schermi tattili con contenuti 3D e 2D in modalità interattiva che permettono di esplorare la Cannoniera di Cima 3 e la Caverna Lukachich (quest’ultima oggi non accessibile) e scoprire, attraverso un cursore temporale, cartografia, foto e informazioni storiche relative ai vari fronti della Prima Guerra Mondiale. Ma il cuore di questo allestimento si trova nella sala dedicata alla realtà virtuale (Virtual Reality - VR 360°): le postazioni VR con visori e cuffie consentono di compiere un’esperienza immersiva sul fronte isontino durante la Grande Guerra. È possibile ascoltare le testimonianze dei soldati e i racconti dei corrispondenti di guerra, vedere le trincee sotto attacco, la vita quotidiana dei soldati, la cura dei feriti in una struttura sanitaria militare, assistere al tragico attacco con i gas asfissianti del 29 giugno 1916 e sorvolare l’altopiano di Doberdò sull’aereo Spad XIII di Francesco Baracca. Al termine della visita, vale la pena dirigersi verso la terrazza panoramica. Osservando il meraviglioso paesaggio, ancora oggi si può intuire l’importanza di questa cima per il controllo del territorio.

Via Zona Sacra c/o cima del Monte San Michele ‒ 34078 Sagrado (GO)

MUSEO DELLA GRANDE GUERRA DI GORIZIA
Il Museo della Grande Guerra di Gorizia è allestito nei sotterranei di due edifici cinquecenteschi di Borgo Castello: casa Dornberg e casa Tasso. Il museo è di natura narrativa e divulgativa e mira a far conoscere, in particolare, la vita quotidiana dei soldati e dei civili durante la guerra. Il racconto si incentra sul fronte dell’Isonzo non tralasciando aspetti più generali della guerra che aiutano a comprendere la portata dell’evento. La ricca collezione museale, articolata in nove sale, comprende divise, oggetti e cimeli di soldati italiani e austro-ungarici, documenti, plastici e numerose fotografie. La sala dedicata alla città di Gorizia approfondisce l’esperienza di una città “in prima linea” e la ricostruzione a grandezza naturale di una trincea permette al visitatore di vivere l’esperienza del fronte, anche grazie alla presenza degli assordanti suoni ambientali che riproducono i rumori della guerra. L’ultima sala, allestita anche con materiali del fondo Diaz, introduce il visitatore alla comprensione degli anni successivi alla guerra. Il percorso si conclude con un focus sulla memoria del conflitto, dai piccoli cimiteri di guerra ai grandi sacrari.
Borgo Castello, 13 ‒ 34170 Gorizia


MUSEO MULTIMEDIALE DELLA GRANDE GUERRA DI REDIPUGLIA
Accanto al Sacrario Militare di Redipuglia è visitabile il Museo multimediale della Grande Guerra, allestito nella sede dell’ex stazione ferroviaria, che permette di approfondire il conflitto attraverso un’esperienza interattiva con la realtà aumentata. Il visitatore può interagire e scoprire la storia di sei personaggi: un’infermiera della Croce Rossa, un soldato italiano e uno austriaco, un ardito, un alpino e il comandante della Terza Armata Italiana Emanuele Filiberto Duca d’Aosta. Sono inoltre presenti approfondimenti sui luoghi del fronte per ogni anno in cui è stata combattuta la guerra e un ricco archivio fotografico di oltre 1200 immagini digitalizzate navigabile in autonomia dal visitatore. Oltre al Museo, in questa sede è presente anche lo IAT di Redipuglia, punto di partenza di molte visite guidate nonché luogo dove poter noleggiare diverse audioguide.
c/o Ex stazione ferroviaria di Redipuglia
Via Terza Armata, 35 ‒ 34070 Fogliano Redipuglia (GO)

La mostra permanente “Ricordi della Grande Guerra” allestita in un piccolo museo privato nel centro di San Martino del Carso costituisce un’ottima integrazione alla visita degli itinerari che si snodano tra questa località e il Monte San Michele. L’esposizione comprende diversi reperti e materiali rinvenuti proprio a San Martino, sul Monte San Michele e nei territori circostanti.

Via Zona Sacra loc. San Martino del Carso 34078 Sagrado (GO)
MONUMENTI ED EDIFICI STORICI

COLLE SANT’ELIA DI REDIPUGLIA
Il Colle di Sant’Elia, di fronte al Sacrario di Redipuglia, è un'altura che in passato ospitò il Cimitero degli Invitti della Terza Armata, il primo sacrario monumentale italiano della Prima Guerra Mondiale. Il cimitero fu inaugurato nel 1923 e raccoglieva le spoglie di trentamila soldati caduti nei territori circostanti. In seguito all’inaugurazione del Sacrario di Redipuglia nel 1938, il luogo venne riconvertito in Parco della Rimembranza
La struttura del cimitero voleva ricordare il vero campo di battaglia: era formato infatti da sette settori concentrici, sviluppati in altezza e scavati nella roccia carsica. Sulla sommità venne creato un piazzale dove culminavano i lunghi viali che attraversavano il camposanto. Dal piazzale, su cui si stagliavano una cappella votiva e un obelisco a forma di faro, era ben visibile la linea del fronte sul Carso isontino e il Monte Sei Busi. Le sepolture erano disposte a settori che rimandavano al luogo di esumazione delle salme dai numerosissimi cimiteri sparsi lungo il fronte durante il conflitto ed erano segnalate da opere realizzate con residuati bellici ritrovati sui campi di battaglia. Oggi, dopo la riconversione in Parco della Rimembranza, sono visibili le riproduzioni dei cimeli e delle epigrafi originali disposte sul grande viale a gradoni. Sulla cima, al posto della cappella e dell’obelisco, è stata posata una colonna romana proveniente da Aquileia in memoria dei caduti di tutte le guerre. 21 Via

III Armata ‒ 34070 Fogliano Redipuglia (GO)

ARA PACIS MUNDI DI MEDEA
L’Ara Pacis Mundi di Medea è un complesso monumentale realizzato nel 1951 per ricordare i caduti di tutte le guerre. L’iniziativa venne presa in risposta agli orrori della Seconda Guerra Mondiale, con l’obiettivo di condurre simbolicamente l’uomo verso la pace e la fratellanza. Per ospitare l’ambizioso progetto, che fu portato a termine in soli sei mesi, venne scelto il colle di Medea, un piccolo paese della pianura friulana che fu il punto di osservazione del Re Vittorio Emanuele III durante la Grande Guerra. Il maestoso complesso monumentale, che si estende per 1500 metri quadrati, è visibile da chilometri di distanza. Un imponente recinto in marmo travertino alto 13 metri circonda e protegge l’ara. I lati di questo recinto posti a nord e a sud sono aperti al centro e permettono l’accesso all’interno, mentre quello rivolto a est è articolato in 14 pilastri ravvicinati. L’ara vera e propria, lunga tre metri e alta cinque, è posta al centro di questo recinto. Al suo interno è custodita un’urna in legno e bronzo che contiene zolle di terra degli 800 cimiteri di guerra presenti in Italia. Quest’urna, su cui vi è incisa la scritta Odium parit mortem, vitam progignit amor (l’odio produce morte, l’amore genera vita), venne posta all’interno dell’ara dopo essere stata benedetta sull’Altare della Patria a Roma.
Via Ara Pacis ‒ 34076 Medea (GO)

CAPPELLA UNGHERESE
DI VISINTINI
La cappella ungherese a Doberdò del Lago è uno dei principali luoghi della memoria per i soldati ungheresi caduti nel Carso isontino. Nel 1918 i soldati del Regio esercito ungherese (honvédség) iniziarono a costruire la cappella per commemorare i connazionali caduti. Al termine della guerra, l’edificio non ancora terminato venne utilizzato come fienile e magazzino. Dopo un restauro a opera di operai ungheresi e cittadini del luogo, nel 2009 è stato infine consacrato e inaugurato.
Località Palchisce ‒ 34070 Doberdò del Lago (GO)

CASA CADORNA A DOBERDÒ DEL LAGO
Il rifugio Casa Cadorna si trova nei pressi del Monte Castellazzo a 106m s.l.m. all’interno della Riserva Naturale dei laghi di Doberdò e Pietrarossa Venne edificato nel 1916 lungo una strada carsica utilizzata prima dagli austroungarici e, dopo lo spostamento del fronte verso est, dagli italiani. La dedica al Generale risale a quando Cadorna visitò le truppe in questo luogo, ritenendolo ben protetto da eventuali attacchi nemici. Il rifugio è visibile lungo il sentiero CAI 77 che collega il Centro Visite della Riserva al Lago di Doberdò.
Lungo il sentiero CAI 77 (partenza da Via Vallone) 34070 Doberdò del Lago (GO)

CASA BERGAMAS A GRADISCA
La figura del Milite Ignoto è probabilmente l’emblema della commemorazione dei caduti nel primo dopoguerra. La scelta della salma da custodire al Vittoriano fu affidata a Maria Bergamas, madre di Antonio Bergamas, un giovane irredento caduto e disperso durante la Grande Guerra. A Gradisca d’Isonzo, città che ha dato i natali a Maria, è ancora presente e visibile la casa dove lei e suo figlio abitarono prima di trasferirsi a Trieste.
Via Bergamas, 37 ‒ 34072 Gradisca d’Isonzo (GO)

COLONNA DELLA REDENZIONE
DI GRADISCA
La Colonna della Redenzione, inaugurata nel 1924 al centro di Piazzale Unità a Gradisca d’Isonzo, è un monumento simbolico alto circa 10 metri e culminante con la statua del Leone di San Marco che mantiene il libro aperto, simbolo della sovranità di Venezia su Gradisca fino al 1511. I lati della base cubica sono decorati da quattro bassorilievi che raffigurano alcuni dei momenti più significativi della città di Gradisca, tra cui una Vittoria Alata con incisa la data del 4 novembre
Piazzale Unità d’Italia (di fronte al Teatro comunale) ‒ 34072 Gradisca d’Isonzo (GO)


ARA CADUTI PER L’ITALIA
E COLONNA CADUTI PER L’AUSTRIA-UNGHERIA
A Gradisca d’Isonzo sorgono due monumenti che rappresentano la complessità delle vicende della Grande Guerra in queste terre. Allo scoppio del conflitto, l’attuale provincia di Gorizia era infatti territorio asburgico, ma alcuni cittadini decisero di disertare e arruolarsi nel Regio esercito italiano. L’Ara dedicata ai Caduti gradiscani per l’Italia e la Colonna ai Caduti gradiscani per l’AustriaUngheria ricordano simbolicamente le vicende dei caduti di questo territorio.
Giardini Pubblici angolo Via Gorizia-Via Regina Elena ‒ 34072 Gradisca d’Isonzo (GO)
GALLERIE CANNONIERE DEL MONTE FORTIN
Il Monte Fortin fu un punto strategico a supporto dell’avanzata italiana e venne occupato nei primi giorni di guerra dai fanti della brigata Regina. All’interno vi furono scavate tre gallerie cannoniere, rinforzate col calcestruzzo. Esse comprendevano nove bocche da fuoco che consentivano di coprire la maggior parte del territorio circostante. Oggi, all’entrata delle gallerie, è stato posizionato un monumento alla pace intitolato “Numquam in bello” che rappresenta due soldati nell’atto di stringersi la mano, in piedi sopra ai resti di armi spezzate. L’area è proprietà privata dell’azienda vinicola Tenuta Villanova. L’accesso alle Gallerie è consentito solo previa prenotazione.
Società Agricola Tenuta Villanova Srl Via Contessa Beretta, 29 – 34072 Farra d’Isonzo (GO)

PARCO UNGARETTI DI SAGRADO
L’obiettivo del parco è accompagnare il visitatore alla scoperta della relazione tra Giuseppe Ungaretti, il paesaggio carsico e la Grande Guerra. I territori di San Martino del Carso hanno infatti visto combattere il grande poeta e hanno ispirato la sua raccolta di poesie Il porto sepolto. Il parco è suddiviso in tre aree, tra cui un labirinto di pali in legno grezzo che custodisce al suo centro una lastra di ottone con inciso il ritratto di Ungaretti in età matura, a opera di Franco Dugo.
c/o Azienda Agricola Castelvecchio
Via Castelnuovo, 2 ‒ 34078 Sagrado (GO)


GIUSEPPE UNGARETTI
E LA LETTERATURA
Numerosi studenti, intellettuali, futuristi, nazionalisti, poeti, divenuti accesi interventisti, parteciparono come volontari al conflitto mondiale. Tra di essi vi fu anche il giovane poeta Giuseppe Ungaretti, la cui opera letteraria è legata indissolubilmente all'esperienza bellica. Soldato semplice nella Brigata Brescia, Ungaretti giunse al fronte nell’autunno del 1915, partecipò alla Quinta Battaglia dell’Isonzo e alla conquista del Monte San Michele nell’agosto del 1916. Le sue poesie di guerra, contrassegnate dalle località del fronte - Cima Quattro, Valloncello di Cima Quattro, Cotici, Quota 141 - descrivono il poeta e i suoi compagni in un paesaggio devastato dalla guerra e dalla morte, tra “budella di macerie”, tra “brandelli di muro”, in trincea, nel fango, tra la pietra del San Michele, “fredda” e “dura” del Carso. Le sue parole cariche di angoscia e di speranza diventarono un manifesto di vita e di fratellanza, una rivendicazione di umanità e di armonia nell’universo turbato dalla guerra e dalla morte. Questo primo nucleo di poesie, raccolto ne Il porto sepolto pubblicato a Udine nel dicembre del 1916 grazie all’aiuto dell’amico ufficiale Ettore Serra, influenzò per lungo tempo il panorama poetico nazionale.
OSSARI, SACRARI E CIMITERI

SACRARIO MILITARE DI REDIPUGLIA
Il Sacrario Militare di Redipuglia, inaugurato il 18 settembre 1938, è il più grande sacrario italiano dedicato ai caduti della Grande Guerra: esso custodisce i resti di 100.187 soldati caduti nelle zone circostanti. La struttura rappresenta simbolicamente l’esercito schierato che scende dal cielo, guidato dal proprio comandante, per percorrere la “Via Eroica”. In cima, tre croci richiamano l’immagine del Monte Golgota e la crocifissione di Cristo. Il primo livello è costituito dalla Via Eroica: una strada lastricata in pietra delimitata da 38 targhe in bronzo su cui sono incisi i nomi delle località carsiche contese durante la Grande Guerra. Attraversata la via si giunge alle tombe dei generali Tra queste, spicca il sepolcro in marmo rosso della Val Camonica del comandante della Terza Armata Emanuele Filiberto Duca d’Aosta. Alle spalle si elevano i 22 gradoni (alti 2,5 metri e larghi 12) che custodiscono le spoglie di 39857 soldati identificati. Al centro del primo gradone si trova l’unica donna qui sepolta, l’infermiera Margherita Kaiser Parodi. Le scalinate laterali permettono di raggiungere i gradoni successivi e muoversi lungo i loculi sistemati in ordine alfabetico. In cima, due grandi tombe custodiscono i resti di oltre 60 mila soldati ignoti. Infine, sul retro dell’ultimo gradone si trovano due sale museali dove sono esposti documenti, reperti bellici e gli affreschi di Giuseppe Ciotti che decoravano la cappella del colle Sant’Elia.

Via III Armata ‒ 34070 Fogliano Redipuglia (GO)

LA NASCITA DEGLI OSSARI
E DEI SACRARI MILITARI
Alla fine del conflitto mondiale il paese si trovò ad affrontare il doloroso compito di dare una degna sepoltura e commemorare il sacrificio dei circa 600.000 soldati caduti al fronte. Se durante il periodo bellico i soldati venivano sepolti in cimiteri improvvisati, a partire dal 1920 l’Ufficio Centrale per la Cura e le Onoranze alle salme dei Caduti di Guerra ebbe il compito di localizzare i cimiteri di guerra, recuperare le salme dei dispersi ed accertarne l’identità. Furono individuati oltre 2.800 cimiteri, di cui 200 in Friuli, e migliaia di tombe. Mentre le famiglie dotate di mezzi finanziari riuscirono a riportare le salme dei propri cari nei paesi d’origine, nel periodo 1919-1922 la società civile e le autorità locali ricordarono i caduti mediante la realizzazione di statue, cippi e lapidi, le commemorazioni del Milite Ignoto del 1921 e una prima sistemazione ai sacrari militari nelle “zone inviolabili” (1922) presso i monti San Michele, Pasubio, Grappa, Cengio, Ortigara e il colle di Sant’Elia nel Carso. Tali interventi apparivano provvisori per cui nel 1927, in un clima segnato dalla celebrazione fascista della guerra vittoriosa, si costruirono nuovi grandi ossari e sacrari militari. Esemplare il caso del Sacrario di Redipuglia, inaugurato da Mussolini nel 1938: la grandiosa opera, strutturata come una scalinata sormontata da tre croci, custodiva le spoglie di 100.000 soldati noti e ignoti; la scritta “presente” sui gradoni rimarcava l’immortalità dei caduti e celebrava il regime che fondava il suo mito di fondazione nel conflitto mondiale.

SACRARIO MILITARE DI OSLAVIA
Il Sacrario Militare di Oslavia è collocato in corrispondenza della Quota 153 del Monte Calvario Venne edificato nel 1938, come il Sacrario di Redipuglia, con l’obiettivo di raccogliere le spoglie dei soldati caduti nelle battaglie combattute nella zona di Gorizia e Tolmino (oggi in Slovenia). Il Sacrario è composto da quattro torri disposte in un’area triangolare: tre sono situate ai vertici della figura e la quarta, più grande delle altre, è posta al suo centro. Lungo le pareti di ogni torre sono custoditi i loculi dei caduti identificati, per un totale di circa 20 mila nomi, di cui 138 austro-ungarici. Altre 36 mila spoglie non identificate sono invece tumulate in tre grandi ossari situati nelle torri esterne. Ogni torre è dotata di una cripta, collegate tra loro tramite tunnel sotterranei. La cripta più importante è quella della torre centrale, dove sono custodite le tombe di tredici uomini decorati con la Medaglia d’Oro al Valore Militare, fra cui il Generale Achille Papa, morto il 5 ottobre 1917, il Generale Ferruccio Trombi, colpito a morte ad Oslavia il 28 novembre 1915 e il Generale Alceo Catalocchino, ucciso nelle Valli del Natisone il 27 agosto 1917. Nella torre principale si trova anche una grande croce in marmo scuro mentre all’esterno, vicino al vertice sinistro del Sacrario, è stata collocata una campana denominata Chiara
Località Ossario, Oslavia (GO) ‒ 34170 Gorizia


CIMITERO AUSTRO-UNGARICO DI FOGLIANO
Nel cimitero austro-ungarico di Fogliano Redipuglia sono sepolte 14.550 salme di soldati caduti sul fronte isontino. Sul portale d’entrata è ben visibile la scritta Im Leben und im Tode vereint (Uniti nella vita e nella morte). 2550 soldati identificati sono ricordati da piccoli cippi in calcestruzzo. Una grande tomba custodisce le salme di 7000 soldati ignoti. Qui una targa bilingue omaggia i soldati morti per amore della patria. Infine, altri 5000 soldati ignoti sono sepolti in due tombe comuni
Via III Armata (km 11 VIII) 34070 Fogliano Redipuglia (GO)

CIMITERO AUSTRO-UNGARICO DI BRAZZANO
Il cimitero civile di Brazzano ospita un’area dedicata a centinaia di caduti austro-ungarici della Grande Guerra. Il prato è ricoperto da croci in pietra bianca e sul muro di cinta son state affisse delle lapidi. Sotto le croci di ferro, invece, riposa chi perse la vita nel campo di prigionia che venne allestito in questa località. In fondo è visibile un grande monumento piramidale risalente al 1918 su cui è incisa la frase Freund und Feind / Im Tode vereint (Amico o nemico uniti nella morte).
Via Pittoni, Loc. Brazzano ‒ 34071 Cormons (GO)

ITINERARI E PARCHI TEMATICI

Difficoltà
Turistico su sentieri segnalati (CAI 83 e 84)
Dislivello
variabile in base agli ambiti scelti, in ogni caso inferiore ai 100m
Lunghezza
variabile in base agli ambiti scelti
Durata
variabile in base agli ambiti scelti (da 1 a 4 ore)
Consigliato da ottobre a maggio
Cartografia
cartina Tabacco 047
Punto di partenza
Parcheggio di Piazzale Tommaseo (Monfalcone) o salita di Mocenigo
PARCO TEMATICO DELLA GRANDE GUERRA DI MONFALCONE
Il Parco Tematico della Grande Guerra di Monfalcone si estende per circa 4kmq sulle alture carsiche alle spalle della città; sentieri facilmente percorribili e ben segnalati ne collegano i tre ambiti. Questi possono essere visitati in un’unica giornata o in momenti diversi. Il primo ambito è dedicato alla ridotta di Quota 121, caposaldo austriaco conquistato dagli italiani durante la Sesta Battaglia dell’Isonzo. Qui si attraversa un groviglio di trincee per arrivare a una ricostruzione didattica di un osservatorio e di alcune postazioni per fucilieri. Da quota 121, la trincea della Selletta e le adiacenti postazioni di artiglieria portano verso l’ambito di Quota 85. Questa è zona monumentale caratterizzata da numerosi cippi che ricordano i reparti combattenti e alcuni decorati al valore, tra cui Enrico Toti, soldato volontario che qui cadde nel 1916 e a cui è dedicata la quota. Il terzo e ultimo ambito si trova nelle vicinanze della stazione ferroviaria e si snoda tra la Trincea intitolata al generale francese Joseph Joffre, la grotta Vergine, cavità naturale che diede riparo a centinaia di soldati, e la trincea Cuzzi. Lungo le trincee si trovano numerosi graffiti di guerra e ricoveri per le truppe


Difficoltà
Turistico su sentieri segnalati
Dislivello
Non significativo
Lunghezza
2,5km
Durata
2 ore circa
Consigliato da ottobre a maggio
Cartografia
cartina Tabacco 047
Punto di partenza
Parcheggio segnalato del museo all'aperto lungo la strada provinciale
Via del Carso (Redipuglia)
MUSEO ALL’APERTO DELLA DOLINA DEL XV BERSAGLIERI
Il Museo all’aperto del Comprensorio difensivo della Dolina del XV Bersaglieri si estende alle spalle del Sacrario di Redipuglia, nell’area del Monte Sei Busi. Il percorso si snoda principalmente lungo delle doline, conche del terreno carsico usate come postazioni dai soldati. Il nome della dolina principale è dato dalla presenza di un fregio del XV reggimento bersaglieri; questa è nota anche come dolina dei 500 a causa del gran numero di caduti qui sepolti durante il conflitto. Numerose sono le testimonianze belliche visibili: camminamenti, epigrafi, una galleria artificiale e i ruderi di un edificio utilizzato come punto di primo soccorso. Risalita la dolina, a poche centinaia di metri si può raggiungere la linea fortificata del Monte Sei Busi, parte del cosiddetto Trincerone Italiano che dal San Michele si sviluppava fino a Monfalcone. Camminando parallelamente alla linea difensiva, in cui è possibile entrare all’altezza di alcuni punti, si possono osservare le postazioni per mitragliatrici, le feritoie dei fucilieri, i cunicoli scavati per depositare le munizioni o per allestirvi ricoveri e diverse scritte lasciate dai soldati durante la loro permanenza.


MUSEO ALL’APERTO DEL MONTE SAN MICHELE
E SAN MARTINO DEL CARSO
Difficoltà
Turistico su sentieri
segnalati (CAI 73 e 76)
Dislivello
non significativo
Lunghezza
variabile in base alle zone scelte
Durata
variabile in base alle zone scelte (da 1 a 4 ore)
Consigliato
tutto l'anno
L'Area delle Battaglie da ottobre a maggio
Cartografia
cartina Tabacco 047
Punto di partenza
Parcheggio nei pressi dell’Area delle Battaglie o parcheggio del Museo del Monte San Michele
L’area che comprende il Monte San Michele e San Martino fu aspramente contesa tra il Regno d’Italia e l’Impero austro-ungarico e divenne famosa anche in virtù delle poesie che Giuseppe Ungaretti vi scrisse. Le numerose testimonianze del conflitto sono visibili lungo tre itinerari di facile percorrenza e adatti a tutti. Il primo percorre la cosiddetta Area delle Battaglie, lungo la strada che collega Sagrado a San Martino, dove si svolsero duri scontri tra il 1915 e il 1916. Oggi sono visibili i resti della Trincea delle Frasche, il Cippo della Brigata Sassari e il Cippo dedicato a Filippo Corridoni. Il secondo itinerario percorre le strade di San Martino del Carso dove si può visitare il museo privato “Ricordi della Grande Guerra” e il Cippo dedicato al 4° Honved, un reggimento di fanti ungheresi che ha combattuto a lungo in questo settore. L’ultimo itinerario si snoda sul Monte San Michele (275 metri s.l.m.).
Dal piazzale, in cui è visitabile il Museo Multimediale della Grande Guerra del San Michele, inizia il suggestivo Percorso dei Cippi che collega le 4 cime del monte e conduce alle numerose postazioni militari austro-ungariche e italiane, tra cui lo Schönburgtunnel, la Caverna del Generale Lukachich e la Galleria cannoniera della Terza Armata


NASCITA DEI SOCCORSI
D’URGENZA SUL FRONTE
Durante la Grande Guerra il numero dei feriti in combattimento è tale da imporre un ripensamento generale dei sistemi di sanità militare dei singoli eserciti che dovevano provvedere al primo soccorso, sgombero, ricovero e cura dei numerosi soldati feriti, malati e persino avvelenati dal gas. In questo contesto l’intervento tempestivo, in moltissimi casi essenziale per poter salvare la vita del soldato, si impone come una necessità: nascono quindi i soccorsi d’urgenza al fronte, il cui compito è quello di raccogliere i feriti e portarli in luoghi sicuri dove poter effettuare le prime medicazioni nel più breve tempo possibile.
Queste operazioni, necessarie dopo ma soprattutto durante i combattimenti, richiedevano un’organizzazione strutturata della sanità militare che doveva prevedere diversi posti di medicazione al fronte, talvolta anche in prima linea, e una vera e propria rete ospedaliera nelle retrovie. I pazienti venivano smistati in base alla gravità delle loro condizioni e alla loro trasportabilità. I casi più gravi venivano operati d’urgenza nei punti di medicazione o negli ospedaletti da campo o in altri ripari nelle immediate vicinanze del fronte mentre gli altri, a seconda delle possibilità, venivano curati sul posto o nelle strutture ospedaliere nelle retrovie.

PERCORSO STORICO DEL MONTE BRESTOVEC
Difficoltà
Turistico su sentieri segnalati (CAI 74)
Dislivello
Non significativo
Lunghezza
3,8 km
Durata
2 ore circa
Consigliato da ottobre a maggio
Cartografia
cartina Tabacco 047
Punto di partenza
Parcheggio del Centro Sportivo di San Michele del Carso (Savogna d’Isonzo)
Nei pressi del Monte San Michele è possibile esplorare il Percorso Storico del Monte Brestovec. La cima del monte, a 208 metri s.l.m., fu un punto di osservazione e controllo dell’esercito austroungarico e divenne una linea trincerata italiana dopo la Sesta Battaglia dell’Isonzo. L’itinerario, ben segnalato e di facile percorrenza, è pensato come un percorso ad anello storico-didattico per sollecitare una riflessione critica sulla guerra, la pace, la vita e l'esperienza dei soldati al fronte. Il percorso inizia nei pressi del Centro Sportivo di San Michele del Carso e prosegue lungo via Devetaki in direzione del Brestovec. Dopo circa mezz'ora di camminata si giungerà alla linea trincerata. Dopo di essa si troverà la Cannoniera, interamente visitabile, che ad oggi ospita installazioni con informazioni di carattere storico e racconti di vita di un soldato italiano e di uno austro-ungarico. Per tornare al punto di partenza si dovrà percorrere il sentiero CAI 74.


Difficoltà
Turistico su strade comunali
Dislivello
190 m
Lunghezza
10 km
Durata
variabile in base alle zone scelte (da 2 a 4 ore)
Consigliato
tutto l’anno
Cartografia
mappa stradale della città
Punto di partenza
Sottopasso ferroviario
Aurelio Baruzzi
ITINERARIO DEL MONTE CALVARIO E DELLA CITTÀ DI GORIZIA
L’itinerario che si snoda tra il Monte Calvario e Gorizia permette di scoprire i numerosi monumenti edificati nel primo dopoguerra per celebrare il passaggio della città al Regno d’Italia. Questo itinerario può essere percorso con mezzi propri o interamente a piedi, seguendo la tappa 8 del Walk of Peace. Si può partire dal sottopasso ferroviario intitolato ad Aurelio Baruzzi, primo soldato italiano a entrare in città l’8 agosto 1916 durante la Sesta Battaglia dell’Isonzo. Da qui, attraverso la sentieristica che si stacca dal centro di Piedimonte, si raggiunge la vetta del Calvario (240 metri s.l.m.) per osservare tre monumenti che commemorano i soldati italiani: l’Obelisco, lo spiazzo con Tre Croci e il Cippo ai Volontari Giuliani. Scendendo dall’altro versante si trova, segnalata da dei cipressi, la tomba di Scipio Slataper. Entrando in città, superato il Ponte del Torrione, si può osservare il Monumento alla Sesta Battaglia dell’Isonzo. Infine, nel centro della città si possono ammirare i monumenti presenti nel Parco della Rimembranza e nei Giardini Pubblici, dedicati a Enrico Toti e al Fante d'Italia.


PARCO DELLA PACE DEL MONTE SABOTINO
Difficoltà
Turistico su sentieri segnalati
Dislivello
Non significativo
Lunghezza
7,5 km (dal punto di partenza della strada del Sabotino
1,5 km a piedi)
Durata
2 ore circa
Consigliato
tutto l’anno
Cartografia
cartina Tabacco 054
Punto di partenza
Presso il rifugio sul Sabotin raggiungibile da Solkan (Slovenia)
Il Parco della Pace del Monte Sabotino (Sabotin Park Miru, in sloveno) è un museo all’aperto transfrontaliero tra Italia e Slovenia, a pochi chilometri a nord-est di Gorizia. L’itinerario conduce alla scoperta della seconda linea difensiva austro-ungarica conquistata dalla Seconda Armata italiana il 6 agosto 1916 durante la Sesta Battaglia dell’Isonzo. L’inizio del sentiero si trova in territorio sloveno, a est del paese di Gonjače. L’entrata è raggiungibile in macchina ed è segnalata da una piramide di pietra ben visibile, simbolo del Parco. Col proprio mezzo si prosegue lungo la strada e si raggiungeranno due ulteriori piramidi che furono erette per ricordare il punto di partenza degli attacchi italiani decisivi per la conquista del Sabotino. Oltre queste piramidi si troverà un ampio parcheggio in cui poter lasciare il proprio mezzo per proseguire a piedi. In pochi minuti si raggiunge il rifugio del monte e l'adiacente museo. Da qui partono diversi sentieri ben indicati: quello a sinistra attraversa una trincea e giunge alla caverna delle 8 cannoniere, mentre quello alle spalle del rifugio porta all’articolato sistema di gallerie su più piani, costruito dagli austro-ungarici e migliorato in seguito dagli italiani. Il terzo e ultimo sentiero, di facile percorrenza, conduce alla cima (Quota 609) in circa mezz’ora. Percorrendolo si troveranno diversi lavori di trinceramento, osservatori italiani e austro-ungarici e le postazioni d'artiglieria.


GORIZIA CITTÀ AL FRONTE
Durante il primo conflitto mondiale la cittadina di Gorizia divenne il simbolo del fronte dell’Isonzo. All’inizio del conflitto la città non venne evacuata e diventò un importante centro militare e logistico per l’esercito austro-ungarico; l’esercito italiano, nel tentativo di conquistarla, la sottopose a numerosi bombardamenti che distrussero tra il 30 e il 50% degli edifici. Nell’autunno del 1915 dei 30.000 abitanti non ne rimanevano che 5.000, costretti a rifugiarsi nelle cantine e ad affrontare gravi privazioni alimentari. La svolta avvenne nel 1916 durante la Sesta Battaglia dell’Isonzo quando le truppe italiane, dopo aver conquistato i monti Sabotino e San Michele, l’8-9 agosto entrarono a Gorizia. La vittoria, che costò la perdita di circa 100.000 soldati italiani e austro-ungarici, ebbe una vasta risonanza nazionale in quanto la città isontina era simbolo, assieme a Trieste, dell’irredentismo italiano e dell’unità nazionale. Tuttavia, con la disfatta militare di Caporetto dell’ottobre del 1917, la città, deserta e distrutta, ritornò sotto il controllo austro-ungarico. Ciò nonostante, i tentativi di ricostruzione e di ripopolamento furono ostacolati dalla mancanza di mezzi e dalla grave crisi dell’Impero. Le truppe italiane rientrarono a Gorizia il 6 novembre 1918; la città venne infine annessa formalmente al Regno d'Italia nel 1921.

CIVIDALE E VALLI DEL NATISONE
Monte Matajur

Le vicende che hanno interessato Caporetto durante la Grande Guerra sono notissime, al punto da aver dato luogo a un modo di dire comunemente usato quando ci si riferisce a una circostanza particolarmente negativa. Questa piccola località, oggi città slovena (Kobarid), ha avuto un ruolo fondamentale nella storia italiana ed europea. Fu qui, infatti, che l’esercito austroungarico, supportato da quello tedesco, colse di sorpresa le truppe italiane durante la Dodicesima Battaglia dell’Isonzo, costringendole a ritirarsi frettolosamente fino al Piave. Nella ritirata le truppe attraversarono proprio le Valli del Natisone, un insieme di vallate all’estremo oriente del Friuli Venezia Giulia dove si sviluppano le prime cime delle Prealpi Giulie
Dove le valli lasciano il posto alla pianura, ecco che si trova Cividale, Patrimonio UNESCO per i suoi tesori longobardi. Dapprima città importante per le retrovie, fu in seguito teatro dei primi tentativi di fermare l’avanzata austro-germanica.
MUSEI ED ESPOSIZIONI

MUSEO CASA RURALE DI DRENCHIA
Nella frazione di Trinco (Drenchia) è possibile visitare il piccolo museo Casa Rurale dedicato alla vita contadina nelle Valli del Natisone. Qui sono esposti oggetti e attrezzi che ripercorrono la storia del territorio dalla fine del XIX alla metà del XX secolo. Tra questi si trovano anche testimonianze relative alla Grande Guerra come cimeli e fotografie storiche. Trinco, infatti, si trova ai piedi del Monte Kolovrat, in cui passavano la seconda e terza linea difensiva italiana, oggi sede di un museo all’aperto sulla Grande Guerra.

MUSEO DELLA GRANDE GUERRA DI CIVIDALE
Il museo, allestito nella storica stazione ferroviaria di Cividale del Friuli, offre una panoramica della Grande Guerra attraverso cimeli, ricostruzioni ambientali e strumenti multimediali. Il piano interrato, sulla cui parete è posta una foto che ritrae una tregua tra l’esercito italiano e quello austro-ungarico, ospita la ricostruzione di una sezione di trincea Al pianterreno è visibile il plastico della linea ferroviaria militare che collegava Cividale a Caporetto, costruita nei primi mesi di guerra, e un’importante collezione di cimeli, armi e uniformi. Infine, al primo piano una sala dotata di visori per la realtà aumentata permette di immedesimarsi nelle vicende che hanno interessato questo territorio.
Piazza Paolo Diacono, 10 ‒ 33043 Cividale del Friuli


Frazione Trinco, 1 ‒ 33040 Drenchia (UD)
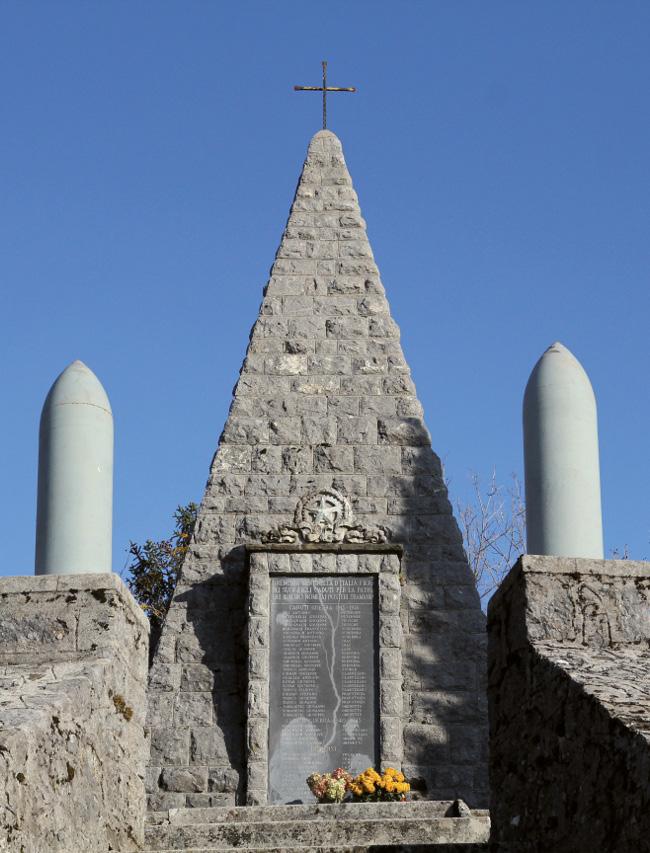
MONUMENTO AI CADUTI DI SAN VOLFANGO
Durante la Grande Guerra, l’area cimiteriale di San Volfango accolse le salme di circa 500 caduti, tra cui l’alpino Riccardo Giusto, considerato il primo caduto della Grande Guerra. Negli anni '30 del '900, il cimitero militare fu soppresso e le spoglie rimaste in loco vennero traslate al Tempio Ossario di Udine. Ad oggi rimane visibile il grande monumento ai caduti e dispersi di tutte le guerre costruito dalla popolazione locale e arricchito dalla successiva epigrafe posta in memoria dei Caduti del Comune di Drenchia. L’imponente opera, posta al termine di una scalinata, ha una forma piramidale con una base quadrata. Culmina con una grande croce di ferro posta in cima.
c/o Cimitero di San Volfango‒ 33040 Drenchia (UD)

OSSARI, SACRARI E CIMITERI

CHIESETTA DI SAN NICOLÒ A IAINICH
La Chiesetta di San Nicolò, edificio di culto medievale situato lungo la strada provinciale SP31 che da Castelmonte porta a Stregna, fu testimone dei combattimenti avvenuti il 27 ottobre 1917, durante la ritirata di Caporetto. Qui si trovano quattro lapidi poste nel 1918 che ricordano alcuni militari tedeschi, la lapide di un ufficiale italiano e l’epigrafe a ricordo dell’impegno della popolazione locale nella raccolta dei caduti.
Frazione Iainich - SP31 direzione Tribil Inferiore 33040 San Leonardo (UD)

ITINERARI E PARCHI TEMATICI

MUSEO ALL’APERTO DEL KOLOVRAT
Difficoltà
Turistico su sentieri segnalati (CAI 746)
Dislivello
300 m
Lunghezza
4,5 km
Durata
3 ore circa
Consigliato
tutto l’anno
(in inverno possibile presenza di neve)
Cartografia
cartina Tabacco 041
Punto di partenza
Parcheggio presso
Rifugio Solarie
La visita al Museo all’aperto del Kolovrat, la “terza linea di difesa italiana”, permette di scoprire le vicende della Dodicesima Battaglia dell’Isonzo e della ritirata di Caporetto. Il museo all’aperto si trova sull’omonimo altopiano al confine tra Italia e Slovenia ed è raggiungibile percorrendo la SP45 che collega Ponte San Quirino a Drenchia. Il punto di partenza è il parcheggio sul Passo Solarie, poco prima dell’ex valico tra Italia e Slovenia. Qui si trova il monumento dedicato al primo militare italiano caduto nella Grande Guerra, l’alpino Riccardo Giusto. Imboccando il sentiero CAI 746, una strada asfaltata leggermente in salita, si giunge a un piccolo spiazzo dotato di un pannello informativo dedicato alla presentazione del museo. Su sentiero si volge al Monte Podklabuc/Na Gradu (q. 1114) e al Passo Zagradan, attraversando le trincee e le postazioni in caverna ripristinate nel cuore del Museo all’aperto. Spingendosi oltre il Passo verso nord, in pochi minuti si raggiunge un punto panoramico eccezionale sopra la Valle dell’Isonzo: ecco il luogo dove, alla sera del 24 ottobre 1917, agirono le compagnie tedesche comandate dal celebre tenente Erwin Rommel. Procedendo lungo il sentiero che segue la dorsale del Monte Piatto si troveranno i resti di piazzole d’artiglieria e i ruderi di alcuni edifici. Conclusa la visita, sarà sufficiente percorrere a ritroso il sentiero CAI 746 per raggiungere lo spiazzo da cui si è partiti.


ERWIN ROMMEL
Distintosi per brillanti azioni compiute sul fronte francese e transilvano, nell’autunno del 1917 il giovane tenente tedesco Erwin Rommel (1891-1944) venne inviato con il gruppo d’élite dell’Alpenkorps bavarese nell’alto Isonzo. Il 24 ottobre del 1917, durante l’offensiva di Caporetto, sfruttando il devastante bombardamento a gas che disorientò le prime linee italiane, Rommel e i suoi uomini risalirono le pendici boscose dell’altipiano del Kolovrat e raggiunsero la sommità del monte catturando circa 500 soldati. Dopo essere riuscito a occupare i rilievi del Nagoj e del Kuk, infiltrandosi tra le linee delle brigate Arno e Salerno, il 26 ottobre 1917 Rommel conquistò il Monte Matajur (1641 m.): una posizione strategica che consentì alle truppe austro-germaniche di scendere nelle Valli del Natisone, raggiungere Cividale e dilagare nella pianura friulana. I successi militari si ripeterono anche oltre il corso del Tagliamento, nei primi giorni del novembre 1917 quando, attraversando le Prealpi pordenonesi, Rommel riuscì a catturare ottomila soldati italiani in ritirata, un’azione che gli valse la massima onorificenza militare. La sua audacia gli consentì di costruire una carriera militare che lo portò al vertice dell’Afrika Korps nel 1941, guadagnandosi il soprannome di “volpe del deserto”. Accusato di aver complottato contro Hitler, morì suicida nel 1944.

UDINE, RETROVIE FRIULANE
E PORDENONESE
Cimitero degli Eroi ‒ Aquileia

Alle spalle della linea fortificata del fronte, l’esercito italiano aveva allestito una gigantesca macchina bellica nelle retrovie, che svolse un ruolo fondamentale di supporto logistico. Le retrovie comprendevano, in particolare, la pianura e le colline friulane: in molti piccoli paesi vennero costruiti edifici per il riposo delle truppe, locali per lo svago dei soldati ma anche ospedali da campo e cimiteri di guerra
Diversi personaggi illustri attraversarono queste terre: Gabriele d’Annunzio, Giuseppe Ungaretti ed Emilio Lussu, che descrive Aiello del Friuli all’inizio del suo celebre libro “Un anno sull’altipiano”. Udine divenne la “Capitale della Grande Guerra”, sede del Comando Supremo, e Torreano di Martignacco ospitò persino la residenza del Re. Lo scenario cambiò in seguito alla ritirata di Caporetto: la resistenza di piccoli gruppi di soldati italiani non fu sufficiente ad arrestare l’avanzata degli austro-germanici che occuparono queste terre e il pordenonese per oltre un anno (ottobre 1917-novembre 1917).
MUSEI ED ESPOSIZIONI

MUSEO DELLA GRANDE GUERRA DI RAGOGNA
Costituito nel 2006 con un progetto europeo e potenziato in anni recenti, il Museo della Grande Guerra di Ragogna approfondisce le vicende della Prima Guerra Mondiale, focalizzandosi sulle battaglie della ritirata di Caporetto e sulla difesa del Tagliamento. Custodisce migliaia di reperti originali, rinvenuti sul terreno e acquisiti anche grazie alle donazioni dei discendenti dei soldati. Avvalendosi di un grande plastico in rilievo, di un aggiornato percorso illustrativo e di ricostruzioni multimediali il museo narra la storia militare del territorio e approfondisce svariate tematiche (tra cui la fortificazione permanente, la profuganza e lo spionaggio). Include anche un ricco archivio documentale, una biblioteca specializzata e una sala conferenze. Può essere preso come punto di partenza o di arrivo dei quattro itinerari del parco tematico “I luoghi della Grande Guerra nel Friuli Collinare” che si trovano nei dintorni.
Via Roma, 23 Loc. San Giacomo ‒ 33030 Ragogna (UD)

MUSEO DELLA GRANDE GUERRA E DELLA FORTEZZA DI PALMANOVA
Il Museo della Grande Guerra e della Fortezza di Palmanova permette di scoprire la storia di questa affascinante città-fortezza, gioiello di architettura militare, dalla sua fondazione (1593) ai nostri giorni. È composto da tre aree espositive: Porta Cividale, il Palazzo del Governatore delle Armi e l’area fortificazioni. Attualmente le sedi sono chiuse al pubblico.
Piazza Grande, 21 ‒ 33057 Palmanova (UD)

SALE CIMELI DEL COMANDO BRIGATA ALPINA “JULIA”
Le Sale Cimeli allestite nella caserma “di Pràmpero” a Udine ospitano un’esposizione permanente che ripercorre la storia del corpo degli Alpini, dalla sua costituzione fino ai giorni nostri. Una di queste sale è dedicata alla Grande Guerra e custodisce reperti di varia natura: armamenti e uniformi originali, la riproduzione di una trincea, una selezione di preziose fotografie storiche e la minuziosa ricostruzione di un alloggio in alta quota per ufficiali.
Caserma “di Pràmpero” Via Sant'Agostino, 8 33100 Udine
MUSEO STORICO DEL FRIULI OCCIDENTALE
Nel Museo Storico del Friuli Occidentale di San Vito al Tagliamento è esposta una collezione privata di numerosi reperti militari, cimeli del XX secolo, uniformi, documenti, filmati e fotografie storiche. L’esposizione si articola in tredici sale che ripercorrono la storia dai moti garibaldini al secondo dopoguerra, con particolare attenzione alle vicende che hanno interessato il territorio circostante e un approfondimento sulla Grande Guerra.
Piazza IV Novembre, 10 Fraz. Ligugnana ‒ 33078 San Vito al Tagliamento (PN)
MONUMENTI ED EDIFICI STORICI



MONUMENTO AI NOVE CADUTI
A CASTIONS DI STRADA
Il monumento ha un grande valore simbolico e storico in quanto onora i militari italiani caduti in quello che è passato alla storia come l’ultimo scontro del fronte italo-austriaco, avvenuto il 4 novembre 1918 (nell’imminenza dell’entrata in vigore dell’armistizio). Eretto “dai compagni d’arme del XXVIII Corpo d’Armata”, il manufatto fu inaugurato il 13 aprile 1919 con l’intervento del Duca d’Aosta Comandante la 3a Armata.
Incrocio Via Ippolito Nievo - Via Castions, Loc. Bivio Paradiso ‒ 33050 Castions di Strada (UD)
MONUMENTO ALLA POESIA
“M’ILLUMINO D’IMMENSO”
Durante la Grande Guerra, il paesino di Santa Maria la Longa si trovava in una posizione ottimale per far riposare le linee in retrovia. Vi riposò anche Giuseppe Ungaretti che proprio qui, il 26 gennaio 1917, compose le sue poesie: Dormire, Solitudine e la famosissima Mattina, capolavoro dell’ermetismo. Nel 2005 è stato inaugurato un monumento dedicato al poeta: una statua raffigurante un corpo che si innalza e si inarca. Nei pressi sono presenti anche tre pietre carsiche dove sono state incise le tre poesie
Divisione Julia ‒ 33050 Santa Maria la Longa (UD)
LAPIDE DEL PRIMO COLPO SPARATO DELLA GRANDE GUERRA A CORNO
Nella località di Visinale dello Judrio (Corno di Rosazzo) si trova il monumento, in ricordo del primo colpo sparato dal fronte italiano la notte del 23 maggio 1915, poco prima della formale apertura delle ostilità. Sulla lapide si trova una lastra bronzea, opera dello scultore Giovanni Mayer, che raffigura un militare intento a sparare, guidato dall'Italia Turrita. La targa racconta la storia del primo colpo sparato e dei finanzieri di guardia presso il confine che, grazie a esso, sventarono un attentato nemico al ponte sullo Judrio.
Incrocio SS356 - Via Primo Maggio, Loc. Visinale dello Judrio ‒ 33040 Corno di Rosazzo (UD)
P.zza
OSSARI, SACRARI E CIMITERI

CIMITERO DEGLI EROI DI AQUILEIA
Il Cimitero degli Eroi di Aquileia, allestito nel cuore della città di epoca romana a partire dal 1915, è un luogo di straordinaria importanza storica e simbolica per la memoria della Grande Guerra in Friuli Venezia Giulia. Da qui, infatti, nel 1921 iniziò il percorso celebrativo della salma del Milite Ignoto verso l’Altare della Patria. Si tratta, inoltre, dell'unico cimitero di guerra italiano ad aver mantenuto la struttura originale. Ogni tomba è caratterizzata dalla presenza di una croce in ferro su cui sono incisi il nome del caduto e la citazione oraziana Dulce et decorum est pro Patria mori (Morire per la Patria è dolce e onorevole). Sono qui custodite anche diverse opere monumentali, tra cui l’arcosolio – un sarcofago incassato in una nicchia – in cui riposano 10 militi ignoti tumulati nel 1921 e la tomba di Maria Bergamas, la madre che scelse il feretro da traslare all’altare della Patria. Sono qui sepolti anche Giovanni Randaccio, comandante dei "Lupi di Toscana", e il maggior generale Alessandro Ricordi, della Brigata Murge. Infine, due sculture realizzate da artisti soldato commemorano i caduti: Il Crocifisso e il Sacrificio del combattente di Edmondo Furlan (1921) raffigura Cristo in croce mentre conforta due fanti morenti ai suoi piedi e L’Angelo della carità di Ettore Ximenes (1917) rappresenta una figura femminile che con le ali sostiene un soldato morente.
Via Sacra (alle spalle della Basilica) ‒ 33051 Aquileia (UD)

TEMPIO OSSARIO DI UDINE
Il Tempio Sacrario di San Nicolò, noto come Tempio Ossario di Udine, si trova in pieno contesto urbano. Ideato dal parroco don Clemente Arturo Cossettini e progettato dagli architetti Alessandro Limongelli e Provino Valle, venne realizzato in più fasi fra il 1925 e il 1940. Raccoglie le spoglie di oltre 20.000 militari italiani morti nel primo conflitto mondiale, prima sepolte nei cimiteri di guerra sparsi sulle Prealpi, in parte della Carnia, nel Canal del Ferro, nella Pianura Friulana, nel Friuli Collinare e nella Destra Tagliamento. Vi riposano anche 344 caduti della Seconda Guerra Mondiale, accolti in periodi successivi. Il Tempio appare maestoso. La facciata, d’ispirazione romanica, è impreziosita da quattro severe statue che raffigurano “il Marinaio”, “l’Alpino”, “il Fante” e “l’Aviatore”, con dettagli afferenti alla Grande Guerra. Nei grandi spazi interni spiccano pregevoli elementi artistici, fra cui le 14 stazioni della “Via Crucis” di Giannino Castiglioni (che lavorò anche nei Sacrari di Redipuglia, Caporetto, Timau e Monte Grappa), poste dinnanzi alle sepolture delle cappelle laterali. Nella grandiosa cripta sotterranea si susseguono i tanti loculi dei corpi identificati, mentre due sole grandi tombe comuni custodiscono gli oltre 5600 ignoti evocati dall’epigrafe “Et nomen una cum sanguine pro Patria dedimus” (Insieme al sangue, anche il nome abbiamo dato alla Patria).
Direzione della Parrocchia S. Nicolò Tempio Ossario Piazzale XXVI Luglio ‒ 33100 Udine
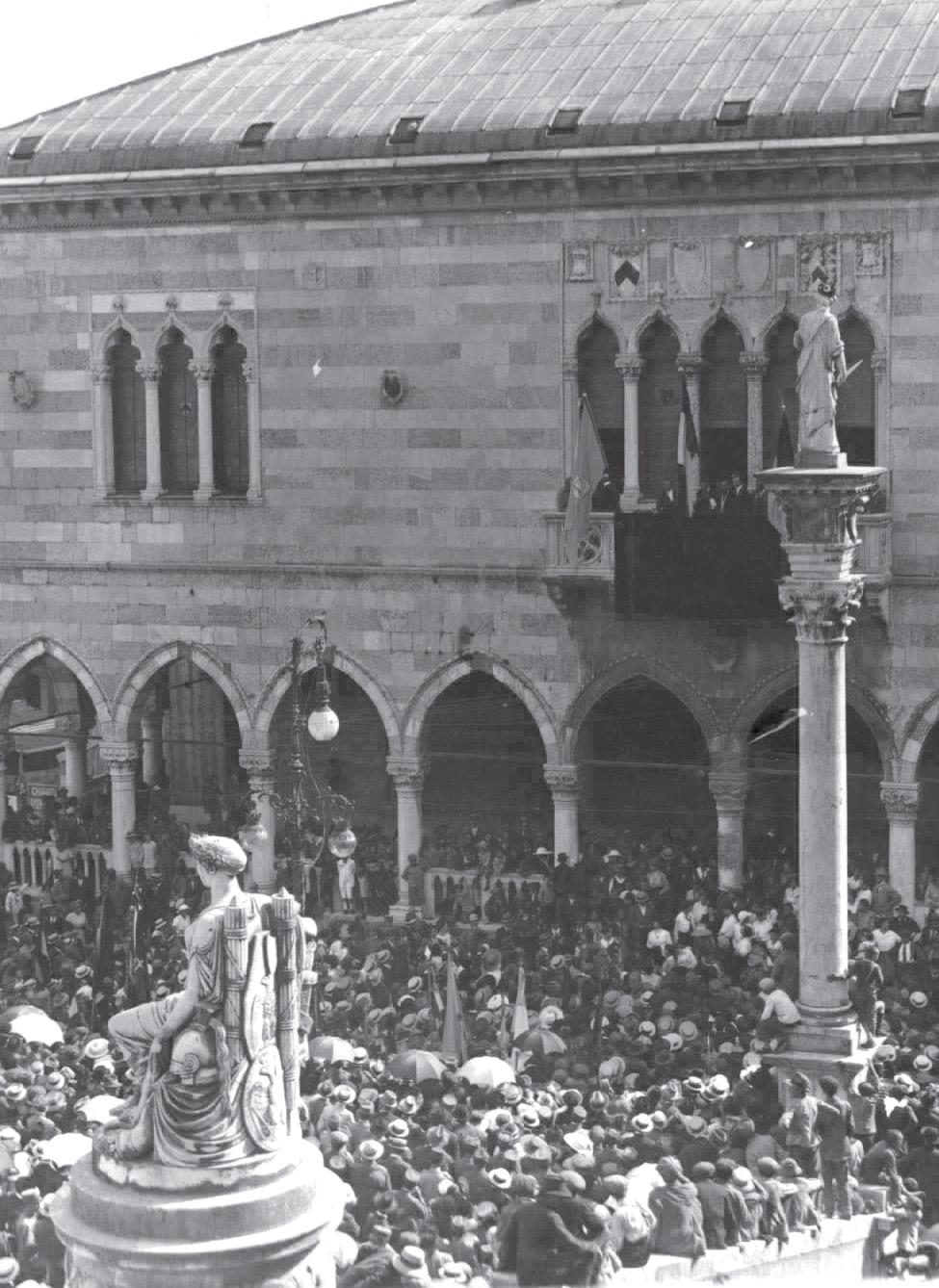
UDINE CAPITALE DELLA GUERRA
Dal maggio 1915 all’ottobre 1917 la città di Udine divenne la "capitale della guerra". Sede del Comando Supremo dell’esercito italiano del generale Luigi Cadorna, la cittadina si trasformò in uno snodo logistico e sanitario di primo piano alle spalle del fronte isontino-carnico. La città si giovò economicamente della presenza di uffici militari, corpi diplomatici, visitatori, commercianti e grossisti, raggiungendo nel 1917 una popolazione di 67 mila abitanti. Mentre per molti militari Udine, con i suoi caffè, osterie, teatri e bordelli rappresentava un’oasi di tranquillità lontana dagli orrori della guerra di trincea, per i parroci friulani divenne la “città del piacere”, simbolo del vizio e dell’immoralità. Ripetutamente bombardata dagli austro-ungarici, nell’agosto del 1917 la cittadina subì anche lo scoppio del deposito di munizioni nella frazione di San Osvaldo, che determinò diverse decine di morti e quasi 3000 sfollati. Alla fine di ottobre del 1917, con la disfatta militare di Caporetto, la città venne investita dalle truppe austro-germaniche in avanzata: circa 30 mila civili fuggirono come profughi nella penisola. Il 3 novembre 1918 le truppe italiane rientrarono a Udine, l’amministrazione comunale in esilio a Firenze tornò in città e diede avvio alla difficile fase di ricostruzione. Tra il 1919 e il 1921 Udine fu il punto di riferimento nazionale per le commemorazioni della Grande Guerra e del Milite Ignoto, divenendo nel contesto del nascente fascismo la «sentinella della Patria».


CIMITERO AUSTRO-UNGARICO
DI PALMANOVA
Il cimitero austro-ungarico di Palmanova custodisce i resti di oltre 19 mila soldati austro-ungarici I soldati identificati riposano sotto semplici lapidi in cemento in un prato attraversato da un ampio viale con cipressi, al cui centro è collocato un monumento in ricordo dei caduti. A ridosso del muro di cinta si trovano due grandi fosse comuni, in cui sono tumulati oltre 15 mila corpi non identificati. Qui è collocata una cappella, anch’essa dedicata ai caduti, che ospita un altare e una raffigurazione di Cristo morente. Alla parete è appesa una bandiera con lo stemma austro-ungarico.
OSSARIO AUSTRO-UNGARICO NEL CIMITERO CIVILE DI UDINE
Nel cimitero civile di San Vito a Udine, sul lato nord del muro di cinta, si trova un ossario in cui sono tumulati 832 caduti austro-ungarici L’ossario è costituito da un grosso cubo in pietra, su cui è stata eretta una croce in pietra bianca alta circa due metri. La targa posta sul cubo informa della presenza dei resti dei soldati austroungarici al suo interno.
Giovanni Martini, 2 ‒ 33100 Udine

CIMITERO MILITARE DI VAL DA ROS
Il cimitero militare di Val da Ros sorge fra le montagne del Pordenonese, sul teatro della Battaglia di Pradis del novembre 1917. Inaugurato solennemente nel 1920, accolse circa 280 caduti (italiani, germanici e un solo austro-ungarico) provenienti da piccoli campisanti sparsi sul territorio, allestiti dopo la battaglia dalle truppe tedesche e dai civili del luogo. Fra gli anni ’30 e gli anni ’50 del Novecento, tutte le salme vennero trasferite altrove. Il suggestivo sito conserva la cinta muraria, il portale d’ingresso assemblato con canne di fucile d’epoca, il monumento centrale, la croce in ferro battuto e molteplici lapidi.
Lungo la Strada Provinciale SP55 loc. Val di Ros 33090 Clauzetto (PN)
Via Ontagnano ‒ 33057 Palmanova (UD)
Via
FORTIFICAZIONI E BUNKER

57
FORTE DI OSOPPO
Difficoltà
Turistico
Dislivello
Assente (150 metri se si parte dal centro del paese)
Lunghezza
Variabile a seconda del percorso scelto per raggiungerlo (non più di 4 km)
Durata
3 ore circa
Consigliato
tutto l'anno
Cartografia
Cartina Tabacco 020
Punto di partenza
Parcheggio del Forte (o in centro paese)
Il Forte di Osoppo si distingue fra gli scenari principali del Risorgimento italiano, con riferimento alle vicende del 1848. In seguito al passaggio del Friuli al Regno d’Italia, venne ampliato e inserito nel sistema difensivo dell’Alto Tagliamento-Fella. Dichiarato monumento nazionale nel 1923 e smilitarizzato nel 1951, testimonia al meglio la sovrapposizione delle strutture fortificate nei secoli e, oggi, ospita eventi culturali. Una strada costruita in epoca napoleonica collega il centro di Osoppo alla cima al Forte. Dopo aver attraversato il portone d’ingresso, sulla destra è visibile un’antica piazzola d’artiglieria puntata verso il greto del Tagliamento. Giunti all’ampio piazzale in cima, alla propria destra si può osservare l’apertura di quella che era la polveriera principale di tutto il complesso. Seguendo il lato meridionale del piazzale inizia la visita alla Batteria Osoppo-sud che ospitava i quattro cannoni da 149 mm sotto cupola corazzata girevole fino al 1917. All’interno, su un lato del corridoio erano disposti i magazzini delle munizioni e i locali tecnici; dall’altro si accede alle riservette e, mediante scalinate, alle piazzole dei cannoni. Da questo punto una strada sterrata riporta verso il piazzale e conduce ai resti nella parte settentrionale del Forte, più alta rispetto all’intera struttura. Raggiunto il punto panoramico del Colle di Napoleone, si visitano le riservette incavernate dell’appostamento Osoppo Nord, i resti delle caserme e quelli di altre notevoli strutture logistiche.

58
FORTE DI MONTE ERCOLE
Difficoltà
Turistico su ex carrareccia militare
Dislivello
100 m
Lunghezza
3 km circa
Durata
2 ore circa
Consigliato
tutto l'anno
Cartografia
Cartina Tabacco 020
Punto di Partenza
Via del Lago, frazione Ospedaletto
Gemona del Friuli
Il Forte italiano di Monte Ercole è stato costruito in pochi anni, a partire dal 1904, nell’ambito della Piazzaforte “Alto Tagliamento-Fella”. Al momento della ritirata di Caporetto, l’opera venne guastata e abbandonata. Dal Lago Minisini di Ospedaletto, oggi si raggiunge in una ventina di minuti di cammino lungo la rotabile militare, immersa nella rigogliosa natura prealpina. Oltrepassato il corpo di guardia, si incrociano varie vestigia murarie e il diroccato casermone per la truppa (sulla destra), nonché le caverne deputate a magazzino polveri e munizioni (a sinistra); queste risultano collegate col livello rialzato del forte mediante un montacarichi interrato, che curiosamente sfocia nella casamatta per mitragliatrice posta a protezione del cortile più interno. Lungo la carrareccia, in pochi passi si raggiunge tale cortile e, di seguito, il monumentale ingresso al blocco corazzato. Dentro si riconoscono le riservette e i corridoi scalinati (oggi murati) che conducevano alle postazioni dei quattro cannoni da 149 mm, postati sotto cupola. Il blocco corazzato è quasi circondato da un lungo trinceramento in galleria, dotato di feritoie per fucileria e di caponiera per mitragliatrice, che senz’altro merita di essere percorso. Proseguendo in direzione di Sella Sant’Agnese, un facile itinerario escursionistico (ulteriori 300 metri di dislivello e 3 ore di cammino) conduce agli Appostamenti di Monte Cumieli.

IL SISTEMA DIFENSIVO LUNGO
IL FIUME TAGLIAMENTO
Nei decenni precedenti la Grande Guerra, l’esercito italiano costruì una vasta e complessa rete di fortificazioni lungo i fiumi Fella e Tagliamento, con l'obiettivo di creare una linea difensiva a protezione dei confini orientali del Regno d’Italia. Questo sistema difensivo, che si estendeva dai monti al mare, comprendeva una serie di forti, sbarramenti, postazioni di artiglieria e strutture per l’alloggio delle truppe. Le difese ruotavano attorno a tre principali aree: la difesa dell’Alto Tagliamento-Fella aveva il compito di sbarrare gli sbocchi delle valli a nord; nel medio Tagliamento, sulle colline moreniche, a protezione dei ponti sul Tagliamento presso Cornino e Pinzano; nel basso Tagliamento a difesa dei passaggi sul fiume a Codroipo e Latisana. Nella prima fase del conflitto molte di queste fortificazioni furono disarmate e le artiglierie trasferite sul fronte dell’Isonzo. Con l’offensiva austro-germanica di Caporetto dell'ottobre del 1917 la linea difensiva sul Tagliamento divenne cruciale. Le posizioni furono ripristinate e venne disposta la resistenza ad oltranza presso il ponte di Pinzano e il Monte di Ragogna, difesi dal Corpo d’armata speciale del generale Antonino Di Giorgio. Tra il 30 ottobre e il 3 novembre del 1917 si combatté la “battaglia del Tagliamento”: la Brigata di Fanteria Bologna, sacrificandosi sul Monte di Ragogna, riuscì a rallentare l’avanzata austro-germanica permettendo all’esercito italiano di ripiegare e di preparare una nuova linea difensiva lungo il Piave.

FORTE DI MONTE FESTA
Difficoltà
escursionistico su ex strada militare e sentiero segnalato (CAI 838)
È consigliabile avere una buona preparazione fisica
Dislivello
700 m
Lunghezza
10 km circa
Durata
6 ore circa
Consigliato
Tutto l’anno (possibile presenza di neve in inverno)
Cartografia
Cartina Tabacco 013
Punto di Partenza
Parcheggio nei pressi del bivio del Monte San Simeone e Monte Festa
Il Forte di Monte Festa, costruito fra il 1909 e il 1914, era la più potente opera della Piazzaforte “Alto Tagliamento-Fella”. Per accedervi si scavò una mulattiera militare lunga 10 km (da Bordano), trasformata in rotabile attorno al 1940. Durante la ritirata di Caporetto, fra il 30 ottobre e il 6 novembre 1917, il forte ostacolò l’avanzata austro-tedesca col fuoco d’artiglieria. La guarnigione, meno di 200 uomini comandati dal Capitano Riccardo Winderling, oppose una leggendaria resistenza e tentò la fuga una volta accerchiata. Oggi si sale al forte lungo la strada militare e il Sentiero CAI 838. Presso la sella q. 980 m si incontrano i ruderi degli alloggi per ufficiali e truppa e delle scuderie. Proseguendo, si ammirano le caverne usate per stoccare le munizioni, collegate con pozzi montacarichi alle sovrastanti batterie. Quindi, si raggiungono le quattro piazzole per cannone da 149/G della batteria esterna (sulla destra) e i locali della batteria corazzata (sulla sinistra). La copertura di quest’ultima, sede originaria dei quattro cannoni da 149/A sotto cupola e dei più leggeri pezzi contraerei, appare modificata da interventi eseguiti nel secondo dopoguerra. Ciononostante il sito, che costituisce la vetta del Monte Festa, è ben riconoscibile e dona un panorama incredibile.

BATTERIA DI SEDEGLIANO
Difficoltà Turistico
Dislivello Assente
Lunghezza Trascurabile
Durata 1 ora circa
Consigliato tutto l'anno
Punto di partenza
Via don Gino Zuliani, 33039 Sedegliano (UD)
L’opera è stata costruita fra il 1910 e il 1913, nel contesto della Piazzaforte “Basso Tagliamento”. Lunga circa 80 metri, ospitava 4 cannoni calibro 149 mm su delle piazzole rialzate a forma di mezzaluna protette da uno spalto anteriore (“piazzole in barbetta”), collegate a vani blindati deputati a riparo e riservetta solo parzialmente accessibili. Il sito è stato coinvolto da una zona militare fino agli anni ’90 del Novecento. Vi si accede, a piedi o in bici, per una stradina che si diparte da Via don Gino Zuliani (poco fuori Sedegliano).

FORTE DI COL RONCONE
Difficoltà Turistico
Dislivello Assente
Lunghezza Trascurabile
Durata 1 ora circa
Consigliato tutto l'anno
Punto di partenza
Via Roncòn, 33030 Rive D'Arcano (UD)
Il Forte di Col Roncone (o Roncòn), parte del sistema difensivo del Medio Tagliamento, è uno dei reperti meglio conservati della regione, grazie anche a un recente restauro. Il piano terra con i vani logistici, il corridoio di batteria e le riservette al primo piano, le piazzole per le artiglierie sotto cupole corazzate girevoli e la postazione per la difesa del fossato anteriore sono perfettamente visitabili, contattando per l’apertura il Comune di Rive d’Arcano.

BATTERIA DI BUJA
Difficoltà Turistico
Dislivello Assente
Lunghezza Trascurabile
Durata 1 ora circa
Consigliato tutto l'anno
Punto di partenza
Parcheggio al termine di Salita di Monte, 33030
Buja (UD)
Tra i monti Faeit e Campeon e il Tagliamento si trova il Monte di Buja (324 metri s.l.m.). Tra le alture più elevate della zona, è stato scelto come luogo dove posizionare, tra il 1909 e il 1910, due appostamenti per batteria in barbetta puntati verso Est e Sud. Con i propri mezzi si può raggiungere la cima: a destra una mulattiera conduce a tre caverne impiegate come riservetta e depositi. Attraverso la scalinata d'epoca si va verso la cima dove è ancora visibile lo spiazzo della batteria permanente e la croce dedicata ai caduti.

Difficoltà Escursionistico facile su sentiero
Dislivello 150 m
Lunghezza 3 km
Durata 3 ore circa
Consigliato tutto l'anno
Cartografia Cartina Tabacco 026
Punto di partenza Piazzale del Milite Ignoto
Via Useunt, Tarcento (UD)
FORTE DI MONTE LONZA E BATTERIA DI MONTE POCIVALO
Ultimato nel 1913-14, il Forte di Monte Lonza apparteneva alla Piazzaforte “Medio Tagliamento”. Pur dominante le provenienze dell’Alto Torre e dell’Alto Cornappo, fu disarmato prima della ritirata di Caporetto e non ebbe ruolo attivo nel corso dei combattimenti. Il forte s’impernia sul blocco corazzato di due piani, atto a dislocare quattro cannoni da 149 mm in cupola girevole. Dinnanzi si erge il Sacrario Monumento-Faro “Julia”, mentre con mezz’ora di cammino su sentiero si raggiunge il ben conservato appostamento d’artiglieria sul Monte Pocivalo

Difficoltà escursionistico facile
Dislivello 250 m
Lunghezza 9 km
Durata 3 ore e mezza
Consigliato tutto l'anno
Cartografia Cartina Tabacco 020
Punto di Partenza Parcheggio nei pressi del Roccolo del Postino (Montenars)
BATTERIE DEI MONTI CAMPEON E FAEIT
I monti di Campeon e Faeit hanno un’altezza modesta, meno di 750 metri, ma sono stati strategicamente importanti per la difesa del settore Medio Tagliamento e lo sbocco della Val Torre Partendo dal sentiero che inizia presso il cosiddetto "Roccolo del Postino" (località Flaipano) e passeggiando tra i boschi si raggiunge facilmente la cima del Campeon dove sono ancora ben visibili una riservetta munizioni del 1909 e la piazzola in barbetta per batteria da 149 mm. Attenendosi alla segnaletica, verso ovest si raggiungono i due appostamenti e le riservette del Faeit, oltre alla ben restaurata Fontana dai Soldâts.

BATTERIA DI MONTE CUMIELI
Difficoltà escursionistico facile
Dislivello 400 m
Lunghezza 7 km circa
Durata 2 ore circa
Consigliato tutto l'anno
Cartografia Cartina Tabacco 020
Punto di Partenza
Via Priorato, località Ospedaletto
Il Forte di Monte Ercole era supportato da due appostamenti d’artiglieria, dalla sezione antiaerea e dall’osservatorio del Monte Cumieli (571 m), da cui si gode un’ottima visuale sul territorio circostante, tant’è che durante la Seconda Guerra Mondiale venne utilizzato anche dall’esercito tedesco. Il Monte Cumieli è raggiungibile dal Forte di Monte Ercole, percorrendo la strada militare fino alla sella di quota 474 dove una traccia a sinistra porta in poco tempo a quota 501 e alla cima.
ITINERARI E PARCHI TEMATICI

Difficoltà Escursionistico
Dislivello
500 m
Lunghezza
10,5 km
Durata
6 ore circa
Consigliato
tutto l’anno
Cartografia
cartina Tabacco 020
Punto di partenza
Località Tabine o Piazzale
Chiesa di Muris, via Osoppo
Ragogna (UD)
ITINERARIO DEL COMPLESSO FORTIFICATO DEL MONTE DI RAGOGNA
Il Monte di Ragogna (512 m), fortificato prima e durante la Grande Guerra, nell’autunno del 1917 fu teatro di un’importante battaglia della ritirata di Caporetto. Qui, la Brigata “Bologna” si sacrificò nella difesa ad oltranza, arrestando per giorni l’avanzata austro-germanica. Un percorso ben tabellato attraversa il campo di battaglia: dalla Località Tabine si sale al Castello di Reunia e alla Batteria permanente “Ragogna Bassa”, nelle cui riservette si possono osservare delle scritte a matita lasciate dai soldati. Il sentiero, che cavalca la panoramica cresta del monte, porta quindi alla Batteria “Ragogna Alta”, al “Forte del Cavallino”, alla Chiesetta Alpina "Julia” e al Monumento ai Caduti del “Galilea”. Seguendo le trincee, si raggiungono infine i capisaldi trincerati del Cret dal Louf e della Spice, per scendere lungo la strada asfaltata al paese di Muris. Se si vuole evitare di chiudere il percorso ad anello su strada asfaltata (3,5 km), si consiglia di utilizzare due auto e lasciarne una in Loc. Tabine e l'altra a Muris.

Difficoltà Escursionistico facile
Dislivello non significativo
Lunghezza 4 km
Durata 3 ore circa
Consigliato tutto l’anno
Cartografia cartina Tabacco 020
Punto di partenza
San Giacomo incrocio tra via Torino e via Paolo
Diacono - Ragogna (UD)
ITINERARIO DEL CAMPO TRINCERATO AUSTRO-UNGARICO SULLE RIVE DEL TAGLIAMENTO (RAGOGNA)
A Ragogna sono presenti anche fortificazioni austro-ungariche risalenti al 1918, costruite durante l’occupazione del Friuli per contrastare un’eventuale avanzata italiana proveniente dal Piave. In paese a San Giacomo s’incontra una prima postazione per mitragliatrice, tra via Torino e via Paolo Diacono, e una seconda lungo via Aonedis. Dopo di che, si imbocca la carrareccia che conduce al crinale delle Rive del Tagliamento. Qui s’individuano alcune casematte blindate, di cui una ricavata su un pulpito sovrastante il letto del Tagliamento. È possibile entrare a esplorare tre di questi manufatti militari, mentre sui resti del quarto si possono osservare due epigrafi dell’epoca.

Difficoltà Escursionistico
Dislivello 250 m
Lunghezza 6 km
Durata 3 ore circa
Consigliato tutto l’anno
Cartografia cartina Tabacco 020
Punto di partenza Località Tabine, Ragogna (UD)
ITINERARIO DEL PONTE DI PINZANO E BATTERIA DEL COL COLÀT
Dalla località Tabine si seguono la mulattiera e poi la strada fino al Ponte di Pinzano, dove si può godere di una vista stupenda sul Tagliamento. Qui una lapide commemora il capitano Teodoro Moggio e i combattenti che frenarono l’avanzata imperiale nell’autunno del 1917, mentre dall’altro lato si notano l’antico casello del pedaggio e una fortificazione con copertura metallica per mitragliatrici. Prendendo un sentiero sulla destra (a tratti ripido), si toccano varie postazioni della Guerra Fredda fino a raggiungere il mai completato Ossario germanico di Col Pion. Lungo l’itinerario segnato, si procede verso il Colle del Castello di Pinzano e quindi fino al successivo Col Colàt (280 m). Qui spiccano le strutture ben conservate di un appostamento per batteria permanente (piazzole per i cannoni, polveriera interrata, riservette con montacarichi), risalenti al 1909-1910.

Difficoltà Turistico su viabilità ordinaria ed escursionistico per la salita a Monte Cuar
Dislivello 600 m
Lunghezza 40 km
Durata 7 ore circa
Consigliato tutto l’anno (in inverno possibile presenza di neve sul Monte Cuar)
Cartografia cartina Tabacco 020
Punto di partenza Ponte di Cornino, lato ovest Forgaria nel Friuli (UD) necessario disporre di un veicolo
VIE DI GUERRA TRA SAN DANIELE DEL FRIULI, FORGARIA NEL FRIULI E IL MONTE CUAR
Questo itinerario (lungo 40 km in auto) conduce alla scoperta di alcuni episodi delle battaglie della ritirata di Caporetto. La partenza è fissata presso il Ponte di Cornino, teatro dello sfondamento attuato da truppe bosniache dell’esercito austro-ungarico nella sera del 2 novembre 1917. L’Isolotto del Clapàt, fra le due campate del ponte, ospita il monumento ai difensori che “immolarono la loro giovane vita”. Si prosegue verso la Chiesetta di San Rocco, frazione di Forgaria, che accolse un comando italiano e venne colpita il 3 novembre 1917. Oltre Monte Prat, una tortuosa strada reca a Cuel di Forchia, punto di partenza per l’escursione alla vetta del Monte Cuar 1478 m (3 ore andata e ritorno). L’anello termina a San Daniele del Friuli per visitare la Sala Esposizione dei Cimeli Storici Militari e il parco del Castello, con la targa che commemora un sottotenente d’artiglieria caduto il 30 ottobre 1917.

Difficoltà Escursionistico
Dislivello 400 m
Lunghezza 9 km
Durata 4 ore
Consigliato tutto l'anno
Cartografia cartina Tabacco 028
Punto di partenza
Piazza Conte Giacomo Ceconi
Pielungo - Vito d’Asio (PN)
SENTIERO DELLA BATTAGLIA DI PRADIS
Fra Pielungo e Pradis, località oggi in provincia di Pordenone, il 5-6 novembre 1917 le truppe italiane della Zona Carnia tentarono di sfondare l’accerchiamento austro-tedesco e aprirsi un varco verso la pianura. Il sentiero, ben tabellato, ricorda questo episodio e porta alla scoperta di alcune testimonianze. Dal paese di Pielungo si sale per il costone di Sompielungo al luogo dove iniziò uno degli scontri principali. Di seguito, una carrareccia scende verso una cappella affiancata dalla lapide commemorativa di un ufficiale italiano. Poco distante, una facile deviazione raggiunge i resti del cimitero di guerra tedesco sovrastante l’abitato di Forno. Riprendendo il sentiero principale, si entra nello scenario della battaglia di Pradis: la mulattiera supera la borgata Fumatins e giunge presso il Cimitero militare di Val da Ros e l’omonima colletta. Percorrendo il sentiero a ritroso, si rientra a Pielungo. A integrazione del sentiero, si suggerisce la visita al Memoriale della Battaglia di Pradis a Clauzetto.

ALPI GIULIE
Plan dei Spadovai (Itinerario della Val Dogna – Linea dei Plans)
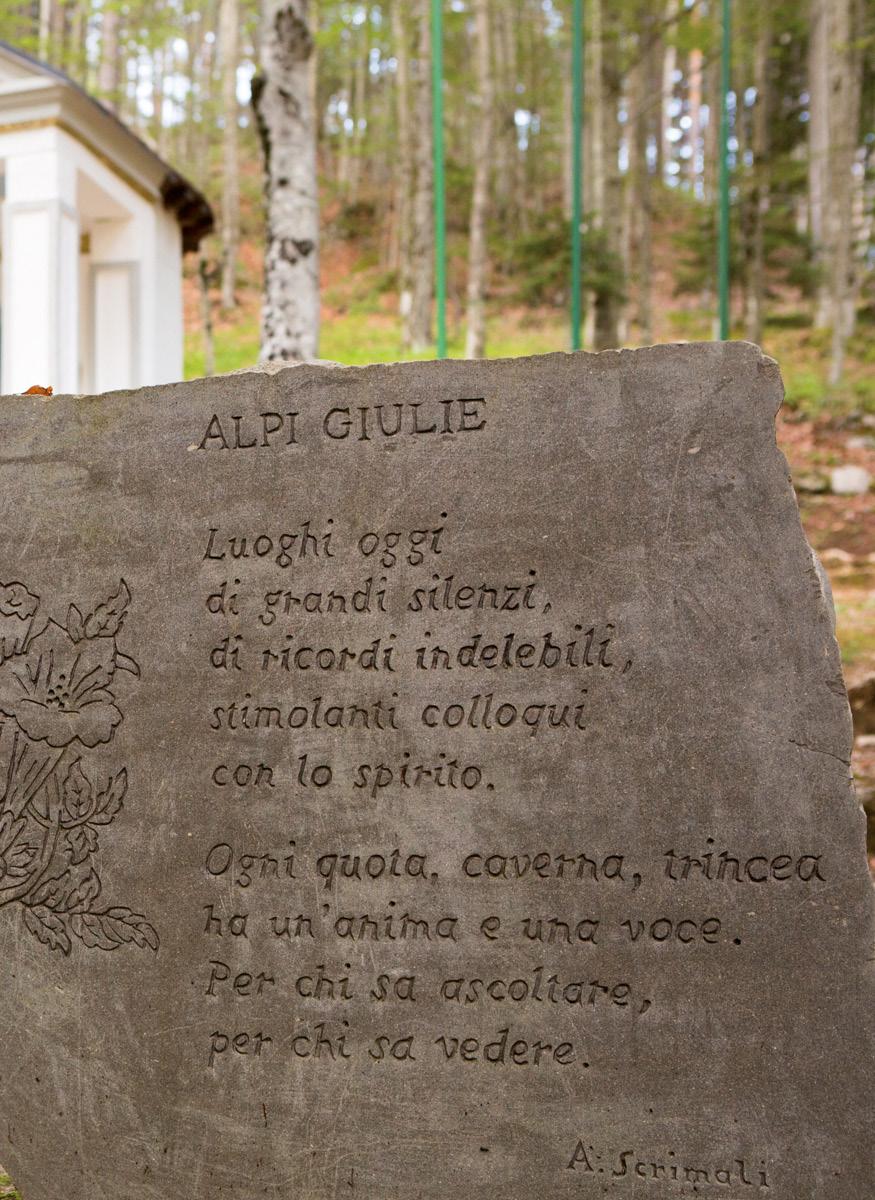
Il primo conflitto mondiale si estese anche alle cime montuose che delineavano il confine tra l’allora Regno d’Italia e l’Impero austro-ungarico. Sin dai primi giorni di guerra i ripidi dislivelli e i rigidi inverni furono lo sfondo di numerosi scontri combattuti per occupare le cime e ottenere il controllo sul territorio sottostante. Le Alpi che svettano tra la Val Dogna e la Val Canale hanno avuto, in questo senso, un ruolo cruciale. Oggi, tra sentieri alpini, prati montani e boschi è possibile riscoprire le tracce lasciate dal passaggio degli eserciti. Si possono osservare le infrastrutture – strade, sentieri, gallerie – costruite oltre un secolo fa per il trasporto di uomini, animali e materiali. Oppure percorrere i numerosi itinerari nel cuore di queste terre e immaginare quanto fosse difficile vivere e combattere in un ambiente così ostile. Non mancano nei paesi a fondovalle musei, cimiteri dove riposano
soldati austro-ungarici e italiani, forti e appostamenti militari di entrambi gli schieramenti.
MUSEI ED ESPOSIZIONI
MUSEI ED ESPOSIZIONI

MOSTRA PERMANENTE
"MEMORIE DEL CANAL DEL FERRO"
Nel centro di Chiusaforte, nei locali dell’ex caserma Zucchi è allestita una mostra permanente dedicata al territorio e alla Grande Guerra. Qui sono osservabili diversi pezzi di artiglieria, dotazioni dei soldati e una sezione dedicata all’alimentazione e alla vita sul fronte. È presente anche una gran quantità di copie di gesso di iscrizioni e fregi presenti sui manufatti rinvenuti in quest’area.
c/o Ex Caserma Zucchi, Via Ruffi 33010 Chiusaforte (UD)

MUSEO DEL TERRITORIO
Il Museo del Territorio racconta la storia della Val Dogna a partire dalla preistoria, con un’intera sezione storica dedicata alla Grande Guerra. Qui sono esposti cimeli rinvenuti nei territori circostanti, diversi pannelli informativi e foto d’epoca che permettono di approfondire le vicende che hanno caratterizzato il conflitto in questo territorio e un plastico che riproduce fedelmente la Val Dogna.
del Museo, 2 ‒ 33010 Dogna (UD)

ESPOSIZIONE PERMANENTE DELLA GRANDE
GUERRA DI PONTEBBA
La sede del Municipio di Pontebba ospita un’esposizione permanente dedicata alla Prima Guerra Mondiale allestita dall’associazione “Quello che le montagne restituiscono”. Vi sono esposti reperti rinvenuti nei territori circostanti appartenuti ai soldati che hanno vissuto e combattuto sul fronte alpino. L’allestimento approfondisce anche aspetti della vita quotidiana proponendo un vasto assortimento di oggetti d’uso comune come gavette, bottiglie di liquori, farmaci e oggetti per l’igiene personale
Piazza Garibaldi, 1 ‒ 33016 Pontebba (UD)
Vicolo

MUSEO STORICO MILITARE “ALPI GIULIE”
Cave del Predil, frazione di Tarvisio, ospita il Museo storico militare delle Alpi Giulie: un’esposizione permanente dedicata alla memoria della guerra in questo territorio, con cimeli delle campagne Napoleoniche, della Grande Guerra e della Seconda Guerra Mondiale.
OSSARI, SACRARI E CIMITERI

CIMITERO DEGLI EROI DI VALBRUNA
Fin dal 1915 l’esercito austro-ungarico allestì, tra le cime delle Alpi Giulie, piccoli cimiteri provvisori per accogliere le salme dei propri caduti. Nel 1916 i comandi militari decisero di costruire un nuovo cimitero militare lungo la seconda linea difensiva: il Cimitero degli Eroi (“Heldenfriedhof” in tedesco). Tutt’oggi visitabile, il camposanto custodisce le salme di circa 175 caduti. Tra questi ci sono i soldati, volontari carinziani, che hanno respinto l’assalto italiano al Piccolo Miezegnot e i prigionieri russi reclutati per lavorare nelle retrovie. Originariamente le sepolture erano segnalate da semplici croci in legno, sostituite negli anni '30 da lapidi in cemento. Il cimitero culmina nella bellissima cappella in legno progettata dal tenente austriaco Grosschedel e costruita, come il cimitero, dai soldati della 59^ Brigata di montagna. Ogni anno il 2 novembre si svolge una cerimonia in onore di tutti i caduti.
Via Saisera frazione Valbruna ‒ 33010 Malborghetto-Valbruna (UD)
Piazza della Chiesa, Fraz. Cave del Predil 33018 Tarvisio (UD)

LAPIDI AUSTRO-GERMANICHE
NEL CIMITERO CIVILE
DI RESIUTTA
All’esterno del cimitero civile di Resiutta, sulla destra, si trovano un’edicola funeraria e alcune lapidi germaniche e austroungariche. Le tombe germaniche sono tutte di caduti dello stesso reparto, morti durante l'avanzata successiva a Caporetto: recano infatti la data di morte negli ultimi giorni di ottobre 1917. Le lapidi, allineate a ridosso del muro di cinta, sono formate da un blocco di pietra bianca su cui è inciso il nome del caduto, il reparto e la data di morte.
Muro esterno del Cimitero civile di Resiutta lungo la SP 42 ‒ 33010 Resiutta (UD)


LAPIDI AUSTRO-UNGARICHE
NEL CIMITERO DI
PONTAFEL
L’attuale comune di Pontebba allo scoppio della Grande Guerra era attraversato dal confine tra Impero austro-ungarico e Regno d’Italia. La zona era suddivisa in Pontebba (italiana) e Pontafel (asburgica): due paesi distinti. Si possono ancora percepire alcune tracce di questa divisione nel cimitero di Sant'Antonio in cui si trovano alcune lapidi di soldati austro-ungarici traslate qui nel 1918. Si tratta di 21 targhe in cemento con iscrizioni su targhetta in metallo, collocate a terra e allineate lungo il muro est.
All’interno del Cimitero civile Via Sant’Antonio ‒ 33016 Pontebba
OSSARIO
DEL CIMITERO
DI CAVE DEL PREDIL
Il cimitero di Cave del Predil contiene un ossario con i resti di oltre 300 caduti austro-ungarici, molti dei quali appartenenti al 7° Reggimento Carinziano e circa 200 caduti provenienti dal cimitero militare di Tarvisio. Creato nel 1952, l'ossario è oggi curato dall’Associazione Croce Nera Austriaca. Esso viene aperto i giorni di Ognissanti, il 2 novembre e infine il 4 dicembre, quando viene deposta una corona d’alloro per festeggiare Santa Barbara.
Lungo la SS 54 Loc. Cave del Predil 33018 Tarvisio (UD)
FORTIFICAZIONI E BUNKER

FORT HENSEL
Difficoltà
Escursionistico su carrareccia segnalata come “Sentiero della Pace”. Possibile presenza di vegetazione lungo la via e sui resti del sito in alcuni periodi dell’anno. Per chi vuole entrare all’interno del Forte, prestare massima attenzione nelle zone dove si sono verificati alcuni crolli
Dislivello
Inferiore a 100 metri
Lunghezza
Trascurabile
Durata
2 ore circa
Consigliato
Tutto l'anno
Cartografia
Carina Tabacco 019
Punto di Partenza
Parcheggio nei pressi della Galleria “Forte”
Una delle piazzeforti più importanti del sistema difensivo austro-ungarico era il Fort Hensel, edificato nel 1882 sul promontorio dello Tschalawài, presso Malborghetto. La struttura, modernizzata nel 1905, allo scoppio della Grande Guerra ospitava 21 ufficiali e 567 militari. Fu uno dei principali obiettivi dell’artiglieria italiana: in tutta la guerra fu colpito da oltre 4.500 colpi di grosso calibro che lo resero un cumulo di macerie. Il forte era formato da due edifici distanti 50 metri: il più elevato, il Blocco A, era costituito da una caserma difensiva, due torrette blindate per obici e un bastione circolare a due piani con 4 cannoni; il secondo, il Blocco B, ospitava 8 cannoni da 12 cm, 4 in due torrette corazzate e 4 in batteria blindata. Sulla parete rocciosa del promontorio, visibile dalla statale SS13, si trova il monumento dedicato a Hensel, un leone morente trafitto da una lancia in ricordo del capitano austriaco morto qui nella difesa contro l’esercito napoleonico nel 1809.
Al Fort Hensel è dedicato un parco tematico con un percorso tabellato e curato. Si può percorrere sia partendo dal lato est seguendo la strada principale del forte, sia dal lato ovest seguendo il locale “Sentiero della Pace”.

BATTERIA DI SELLA PREDIL
Difficoltà
Turistico. Prestare attenzione in alcuni passaggi per il crollo delle murature
Dislivello
assente
Lunghezza
trascurabile
Durata
1 ora circa
Consigliato
tutto l’anno
Cartografia
Carina Tabacco 019
Punto di Partenza
Lungo la SS54 (300 metri prima del valico di confine del Passo Predil)
La batteria di Sella Predil è tutt’oggi in buono stato e parzialmente visitabile: dal cortile d’ingresso si accede alla prima parte composta da una stanza di sorveglianza, la casamatta per ufficiali, la cucina, un posto di guardia e un’infermeria. Di fronte sono visibili i resti delle casematte corazzate e due costruzioni utilizzate come magazzini per i viveri. Sulla parte superiore sono visibili le vedette, utilizzate durante la costruzione del Vallo Alpino del Littorio.

FORTE DEL LAGO PREDIL
Difficoltà
Turistico
Dislivello
assente
Lunghezza
trascurabile
Durata
1 ora circa
Consigliato
tutto l’anno
Cartografia
Carina Tabacco 019
Punto di Partenza
Parcheggi lungo strada SP76 area Lago del Predil
I resti del Forte del Lago Predil si trovano sulla sponda nord-ovest dell’omonimo lago, nel cuore delle Alpi Giulie. Venne progettato dall’Impero austro-ungarico nel 1884 a difesa del confine come parte degli Sbarramenti Carinziani. Del corpo principale situato su un promontorio dove sfocia il Rio Aibl non è rimasto nulla. Solo il fortino situato oltre la strada è tutt’oggi in buono stato di conservazione ed è visitabile anche all’interno. Consiste in un edificio in muratura che ospitava due mitragliatrici

LA GUERRA IN ALTA MONTAGNA
Durante il primo conflitto mondiale, il fronte di combattimento tra Austria e Italia si sviluppò lungo le creste delle Alpi, dove la guerra di alta montagna divenne un capitolo cruciale del conflitto. Nel settore del Fella, in particolare, lo scontro si concentrò sul controllo delle cime delle Alpi Giulie. A partire dal 1915 le forze italiane tentarono di sfondare a fondovalle, bombardando le fortificazioni di Malborghetto, Predil, Flitsch e Raibl, mentre le truppe alpine si attestarono sullo Jôf di Miezegnot e conquistarono il Due Pizzi e la forcella Chianalot. Nonostante i successivi attacchi, il fronte si stabilizzò sino alla ritirata di Caporetto. Tra le vette, il vero nemico fu la natura: con un incessante lavoro i soldati dovettero costruire caverne, ricoveri e osservatori, rifornirsi mediante le teleferiche e lottare contro le avversità atmosferiche.
ITINERARI E PARCHI TEMATICI

PARCO TEMATICO DELLA
Difficoltà
Escursionistico su sentieri segnalati per tutti i 3 anelli
Dislivello
230 m (totale)
Lunghezza
2 km circa
Durata
variabile in base alle aree scelte (da 1 a 3 ore circa)
Consigliato
da aprile a ottobre
Cartografia
cartina Tabacco 019
Punto di partenza
Parcheggio al km 3 della Strada per il Passo Pramollo
GRANDE GUERRA “BOMBASCHGRABEN” DI PONTEBBA
Nel 2015 a Pontebba è stato inaugurato il Parco tematico della Grande Guerra denominato Bombaschgraben. Visitandolo è possibile scoprire la linea degli avamposti e la prima linea difensiva allestita dall’esercito austro-ungarico per contrastare un’eventuale invasione italiana. Il parco è suddiviso in tre settori di difficoltà crescente, percorribili in un unico itinerario o separatamente, a seconda del proprio interesse e del proprio allenamento. Il primo settore, contraddistinto dal colore verde, è il più semplice: dal parcheggio designato come inizio si sale lungo il sentiero segnalato –il primo tratto è ripido ma breve – per giungere alla linea degli avamposti. Proseguendo si troverà una grande caverna usata come postazione per cannone e mitragliatrice. Da qui si può decidere se svoltare a destra e tornare al parcheggio o visitare il secondo settore (colore blu). In questo caso, imboccando la salita a sinistra, si troveranno i resti di diversi baraccamenti. Giunti al termine del sentiero si può decidere se percorrere il terzo settore (colore rosso) a quota 950. Qui si può avanzare lungo la trincea di prima linea austriaca e osservare una postazione per mitragliatrice antiaerea, l’osservatorio e la caverna artificiale per riflettore – prestando attenzione vi si può accedere tramite una scaletta. Per terminare la visita è sufficiente seguire a ritroso il percorso fatto.

PARCO TEMATICO DELLA GRANDE GUERRA
ABSCHNITT-SAISERA
Difficoltà
Turistico (anello verde)
ed escursionistico su sentieri segnalati (anelli blu e rosso)
Dislivello
292 m (totale)
Lunghezza
5,9 km (totale)
Durata
variabile in base alle aree scelte (da 1 a 3 ore circa)
Consigliato
da aprile a ottobre. L’anello verde è percorribile tutto l’anno (possibile presenza di neve durante l’inverno)
Cartografia
cartina Tabacco 019
Punto di partenza
Parcheggio P3 presso la Locanda “Jôf di Montasio”
Il Parco Tematico “Abschnitt Saisera” è un museo all’aperto dedicato alla Grande Guerra nato nel 2012 nel cuore della Val Saisera. Comprende i resti della linea difensiva “Vordere Saisera”, costruita dalle truppe austro-ungariche per contrastare un’eventuale invasione italiana Il percorso si compone di tre anelli (verde, blu e rosso), percorribili in un unico itinerario o separatamente, a seconda del proprio interesse e del proprio allenamento. I sentieri sono ben visibili e le testimonianze sono corredate da una cartellonistica con spiegazioni e immagini storiche. Il primo anello, contrassegnato dal colore verde, è il più semplice e consiste in quella che fu la tortuosa linea di fondovalle “Vordere Saisera”. Lungo il sentiero si troveranno una postazione per un riflettore, un posto di guardia, una postazione d’ascolto e una per il lancio di granate. Si giungerà infine a Villa Anna e al Sasso Bucato – un enorme masso erratico entro cui venne scavata una imponente galleria per mitragliatrici. A questo punto si può scegliere se chiudere il primo anello e tornare al punto di partenza (superando la U-Kaverne e la MG-Kaverne) oppure se proseguire lungo gli anelli blu e rosso che, con pendenze più impegnative, conducono al Fuss Nabois e alla Geschütz Kaverne, due postazioni per cannoni.
In Val Resia l’esercito italiano costruì fortificazioni, strade e mulattiere militari in previsione di un’invasione asburgica. Queste opere vennero sfruttate nell’ottobre 1917 durante la ritirata di Caporetto. Dei 12 itinerari che si snodano tra le montagne del Parco regionale delle Prealpi Giulie, pensati principalmente per escursionisti allenati, quello che comprende il campo in cui si svolsero i combattimenti dell’ottobre 1917 è semplice e adatto a tutti. Dalla sede del Parco a Prato di Resia si raggiunge l’ex cimitero di guerra. Una stradina militare conduce ai resti di appostamenti per artiglieria, della teleferica e di altri edifici militari. Svoltando verso la località San Giorgio si troveranno, infine, i resti di una postazione d’artiglieria italiana.
Difficoltà Turistico lungo strade di viabilità con basso traffico e sentieri
Dislivello 150 m
Lunghezza 11 km
Durata 4 ore circa
Consigliato tutto l’anno. In inverno possibile presenza di neve
Cartografia cartina Tabacco 027
Punto di partenza parcheggio in località Prato di Resia
85
ITINERARIO DELLA VAL DOGNA - LINEA DEI PLANS
La Val Dogna era all’epoca zona di confine tra Regno d’Italia e Impero austro-ungarico, per cui è costellata da resti di fortificazioni militari: tra questi spicca la Linea dei Plans. Partendo da Dogna e percorrendo la strada militare, dopo 12km si incrocia la linea fortificata, uno sbarramento trasversale alla valle costruito per impedire un eventuale avanzamento nemico. Riprendendo la strada principale, dopo circa 2km si giunge al Plan dei Spadovai, un pianoro in cui sono visibili i resti di postazioni di artiglieria, ruderi di un villaggio di guerra e la Cappella del Battaglione Alpini Gemona Per tornare al punto di partenza si dovrà percorrere a ritroso la strada fatta.
Difficoltà automobilistico/turistico su viabilità ordinaria e sentieri segnalati Dislivello 650 m da Dogna Lunghezza 12 km da Dogna Durata 2 ore circa Consigliato da maggio a ottobre Cartografia cartina Tabacco 019 Punto di partenza parcheggi presso Stavoli di Plans e Plan dei Spadovai
86
ITINERARIO JÔF DI MIEZEGNOT
L’itinerario che si snoda sullo Jôf di Miezegnot (2087 metri s.l.m.) permette di scoprire la vita dei soldati in montagna durante la Grande Guerra. Partendo dalla Sella di Somdogna (1389 metri s.l.m.) si imbocca il sentiero CAI 609 e, in circa un’ora, si giunge alla zona in cui venne allestito un cimitero di guerra, oggi ricordato con delle lapidi e una croce in legno. Poco distante si troveranno i ruderi del villaggio di guerra. Proseguendo lungo il CAI 609 si giungerà, su tratti rocciosi con cavi di acciaio, alla cima del monte, dove sono visibili resti di appostamenti e osservatori. Da qui si può tornare sui propri passi o si può concludere l’escursione seguendo il sentiero CAI 606 che attraversa il costone Peceit, dove sono visibili altri resti di fortificazioni italiane. In questo caso, si deve seguire la discesa e riprendere il CAI 609.
Difficoltà Escursionistico su sentieri segnalati (CAI 606 e 609)
È consigliabile avere una buona preparazione fisica
Dislivello 700 m
Lunghezza 6,2 km
Durata 4 ore e mezza
Consigliato estate
Cartografia cartina Tabacco 019
Punto di partenza Sella di Somdogna

Difficoltà Escursionistico su sentieri segnalati (CAI 610, 611, 651 e 652). È consigliabile avere una buona preparazione fisica
Dislivello 700 m
Lunghezza 7,2 km
Durata 5 ore
Consigliato estate
Cartografia cartina Tabacco 019
Punto di partenza Sella di Somdogna
ITINERARIO JÔF DI SOMDOGNA
La vetta dello Jôf di Somdogna (all'epoca denominata Kopfach) (1889m s.l.m.), punto ideale da cui controllare il confine, venne occupata dall’esercito italiano nel 1915. Partendo dalla Sella di Somdogna (1389m s.l.m.) in direzione del Rifugio Grego, sulla destra una traccia lungo un pendio erboso conduce al sentiero CAI 651 e poi al sentiero CAI 610 (a sinistra), dove sono visibili i primi resti di trincee e alloggiamenti militari. Giunti sulla forcella a quota 1762 metri, si imbocca a sinistra quella che fu una linea trincerata e si continua fino alla cima superando il Ricovero Kopfach, costruito ai tempi con funzione di osservatorio. L’escursione continua sul versante opposto: scendendo lungo il sentiero CAI 652 si osserveranno i resti di un grande alloggio militare, di una galleria blindata, di trincee fortificate e la Tomba del Mago. Si continua lungo lo stesso segnavia fino all’incrocio con il sentiero CAI 611 (a sinistra) che permette di raggiungere il Rifugio Grego e la strada che riporta alla Sella di Somdogna.

Difficoltà Escursionistico su sentieri segnalati (CAI 606, 607 e 609) È consigliabile avere una buona preparazione fisica
Dislivello 1100 m (1290 m fino alla cima dello Jôf di Miezegnot)
Lunghezza 11 km
Durata 7 ore circa
Consigliato da maggio a ottobre. In inverno possibilità di arrivare alla Cappella Zita con le ciaspe
Cartografia cartina Tabacco 019
Punto di partenza Parcheggio presso il Cimitero degli Eroi di Valbruna 88
ITINERARIO DEL PICCOLO MIEZEGNOT E JÔF DI MIEZEGNOT
L’itinerario del Piccolo Miezegnot (1972m s.l.m.) permette di vedere resti di costruzioni militari asburgiche. Dai pressi di Valbruna (800m s.l.m.) si segue il sentiero CAI 607 che porta a Cappella Zita Si prosegue fino a imboccare, a sinistra, il sentiero CAI 606 per raggiungere i resti di ricoveri e grotte Usciti dal bosco, si giungerà sul versante nord del Piccolo Miezegnot e tra ghiaie e rocce si arriverà alla sella con una spettacolare vista sui gruppi dello Jôf Fuârt e Jôf di Montasio. Seguendo a destra una traccia di sentiero si arriva ad una lastra di roccia dove una lapide ricorda i combattimenti del luglio 1916. Da qui il CAI 609 lungo la parete del monte porta alla Sella di Somdogna. In questo caso è consigliabile utilizzare due automobili da lasciare al punto di partenza e di arrivo, oppure appoggiarsi al rifugio Grego che collega la Val Saisera e la Val Dogna.

CARNIA
Museo all’aperto del Freikofel

La Carnia, situata nella zona nord-occidentale del Friuli Venezia Giulia al confine con l’Austria, fu un territorio cruciale per il fronte creatosi nella Prima Guerra Mondiale. La presenza di numerosi passaggi tre le Alpi Carniche, tra cui il valico del Passo di Monte Croce Carnico, ha costretto entrambi gli schieramenti a difendere strenuamente la zona per evitare lo sfondamento nemico. Ad oggi sono visibili i resti di questa massiccia militarizzazione del territorio nei musei all’aperto del Freikofel e del Pal Piccolo e negli itinerari che conducono alla Creta di Collinetta, al Passo Volaia e al Monte Zermula. In questi luoghi diversi itinerari, alcuni dei quali adatti solo ai più esperti, conducono alla scoperta della vita sul fronte. Ulteriori testimonianze sono visibili nei musei della Grande Guerra di Sappada, di Forni Avoltri e di Timau. A Timau è inoltre possibile visitare l’ossario e conoscere l’affascinante storia di Maria Plozner Mentil e delle altre Portatrici carniche, silenziose protagoniste della Grande Guerra.
MUSEI ED ESPOSIZIONI

MUSEO “LA ZONA CARNIA NELLA GRANDE GUERRA 1915-1918”
Il museo storico “La Zona Carnia nella Grande Guerra 1915-1918” è una delle migliori esposizioni sulla Grande Guerra in Friuli Venezia Giulia ed è un ottimo modo per integrare le visite ai musei all’aperto del Freikofel/Pal Grande e del Pal Piccolo. L’esposizione si articola in ben dieci sale disposte su due piani, arricchite da totem illustrativi che consentono di vedere filmati e interagire con percorsi multimediali. Il primo piano è dedicato alla Grande Guerra e comprende una sala interamente dedicata alle portatrici carniche e a Maria Plozner Mentil, portatrice uccisa da un cecchino austriaco. Nelle altre sale sono esposti cimeli come l’equipaggiamento completo dei soldati e una nutrita collezione di armi. Vi è inoltre una sezione dedicata all’organizzazione sanitaria militare che comprende documenti sugli interventi chirurgici, protesi per gli arti, attrezzatura per la sala operatoria, una notevole quantità di medicinali e la barella per il trasporto dei feriti. Oltre ai numerosi reperti la collezione contiene anche documenti e fotografie d’epoca, tra cui quella del padre del futuro Papa Giovanni Paolo II (Karol Wojtyla). Al piano superiore si trova una sala dedicata alla Seconda Guerra Mondiale e alla vicenda dei Cosacchi in Carnia nel periodo tra il 1944 e il 1945. Infine, è stata allestita una saletta dedicata alla cultura di Timau-Tischlbong, una delle isole alloglotte del Friuli Venezia Giulia dove tutt’ora è in uso l’antico dialetto di origine tedesca (il Tischlbongarisch).
Via Nazionale, 90 Fraz. Timau ‒ 33026 Paluzza (UD)
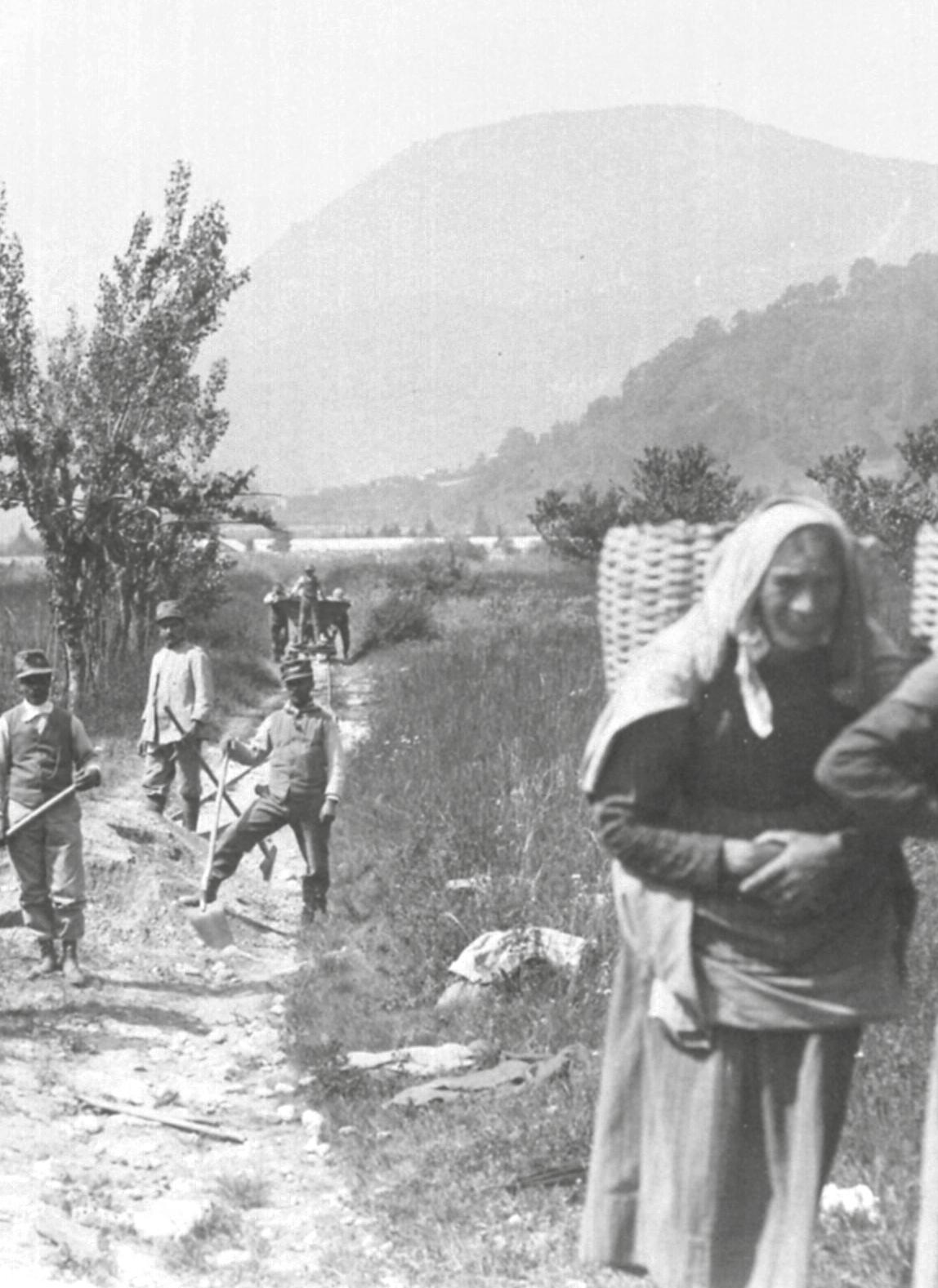
LE PORTATRICI CARNICHE
Il 15 febbraio del 1916 un cecchino austriaco colpiva a morte, presso il passo Pramosio, Maria Plozner Mentil, una delle tante portatrici carniche impiegate nel trasporto a spalla di materiali per i soldati che presidiavano le trincee ad alta quota. Con la morte di Maria nasceva il “mito” delle portatrici, simbolo della profonda mobilitazione delle popolazioni che vivevano a ridosso del fronte alpino. Tra il 1915 e il 1917 le difficoltà di rifornimento dei soldati sul fronte carnico furono superate con il reclutamento di circa 2000 portatrici che avevano il compito di portare con la gerla viveri, munizioni e materiali dai depositi militari di fondovalle sino alle linee del fronte montano. Le donne, abituate a sostituire gli uomini nei lavori agricoli e di alpeggio, per integrare i redditi familiari si adattarono alla nuova economia di guerra, affrontando grandi fatiche e contribuendo alla sussistenza dei soldati soprattutto durante i rigidi inverni. Il loro sforzo fu riconosciuto solo dopo il secondo dopoguerra: nel 1956 a Paluzza la caserma militare venne dedicata a Maria Plozner Mentil. Nel 1968 le portatrici ricevettero l’onorificenza di “Cavaliere di Vittorio Veneto” e nel 1997 la Medaglia d'Oro al Valore Militare da parte dell’allora Presidente della Repubblica Oscar Luigi Scalfaro. Si sancì così un simbolico riconoscimento della mobilitazione bellica delle donne carniche.


MOSTRA PERMANENTE "FORNI AVOLTRI
NELLA GRANDE GUERRA"
Nel piccolo Comune di Forni Avoltri, presso il “Palazzo Museale”, è allestita una mostra permanente sulla Grande Guerra nell’Alta Val Degano. Vi sono esposti cimeli e reperti bellici rinvenuti sul fronte di guerra di questo Comune, documentazioni, cartoline postali dei militari e fotografie d’epoca. Inoltre, è presente la riproduzione di una postazione in galleria con letti a castello, rinvenuta sul Monte Navagiust nel 2007.
Corso Italia, 3 ‒ 33020 Forni Avoltri (UD)
PICCOLO MUSEO DELLA GRANDE GUERRA
All'inizio del percorso che porta alle Cascatelle del Mühlbach, a Sappada, si trova il Piccolo Museo della Grande Guerra. Qui, in un edificio decorato da un murales raffigurante una scena di guerra, è esposta una variegata collezione di cimeli come divise ed equipaggiamenti dei soldati di entrambi gli schieramenti. Il museo rappresenta una viva testimonianza delle vicende che coinvolsero soldati e civili durante il primo conflitto Mondiale nella vallata di Sappada.
Borgata Mühlbach ‒ 33012 Sappada (UD)
MONUMENTI ED EDIFICI STORICI

MONUMENTO ALLE PORTATRICI CARNICHE
La guerra è un avvenimento che coinvolge e sconvolge l’intera popolazione. Molte donne ebbero una parte attiva, come le Portatrici carniche che trasportavano i rifornimenti di cibo e materiale bellico dal fondovalle ai soldati in prima linea. Nella piazza di Timau un monumento ricorda queste figure: una grande lastra in bronzo su cui un bassorilievo raffigura una portatrice morente (Maria Plozner Mentil), sorretta da due compagne mentre una quarta indica il luogo da cui è partito lo sparo.
Piazza San Pio X, Fraz. Timau ‒ 33026 Paluzza (UD)
OSSARI, SACRARI E CIMITERI

OSSARIO DI TIMAU
L’Ossario di Timau nacque per accogliere le spoglie sparse nei piccoli cimiteri di guerra della vallata di Timau e fu inaugurato poco prima dello scoppio della Seconda Guerra Mondiale, nel maggio 1939. Il progetto venne affidato a Giovanni Greppi e Giannino Castiglioni, già all’opera nella costruzione dei Sacrari di Redipuglia e Caporetto. La struttura riprende la precedente chiesa circondata su tre lati da un grande porticato in cui vi sono i resti di 1763 soldati, tra cui 298 ignoti italiani e 65 austro-ungarici. Sulla facciata principale, decorata da un mosaico raffigurante due angeli in adorazione della Croce, svetta un campanile con tre campane posizionate a piramide e tre croci che si elevano al cielo. L’interno è impreziosito da una composizione pittorica di Marino Sopracasa ispirata alla canzone Stelutis Alpinis e da un affresco alle Portatrici Carniche sotto cui riposano le spoglie di Maria Plozner Mentil. Sull’altare infine è visibile il Fante Crocifisso, opera di Giannino Castiglioni, e la Madonna delle Nevi di Pietro Fragiacomo.
Timau, Via Don Tita Bulfon ‒ 33026 Paluzza (UD)
ITINERARI E PARCHI TEMATICI

MUSEO ALL'APERTO DEL FREIKOFEL
Difficoltà
Escursionistico su sentieri
segnalati (CAI 401, 401a e 413)
Dislivello
850 m
Lunghezza
8,6 km
Durata 6 ore
Consigliato estate
Cartografia
cartina Tabacco 09
Punto di partenza
Parcheggio nei pressi di una casa cantoniera, all’imbocco del sentiero CAI 401a
Il Passo di Monte Croce Carnico (1360 metri s.l.m.), tutt’ora al confine tra Italia e Austria, è stato un luogo cruciale per la Grande Guerra in Carnia. Fin dall’entrata in guerra l’esercito italiano e quello asburgico si contesero le cime circostanti per assicurarsi il controllo del territorio. Ad oggi, nel Museo all’aperto transfrontaliero del Freikofel, realizzato dall'Associazione Amici delle Alpi Carniche, che si estende fino Passo Cavallo, sono visibili numerosi resti. Dal luogo di partenza (1064 metri s.l.m.), fissato presso la casa cantoniera dopo Timau, si imbocca il sentiero CAI 401a per raggiungere la Cappella del Battaglione Val Tagliamento (1428 metri s.l.m.) e l’ex cimitero militare. Il sentiero tracciato porta ai prati della casera Pal Piccolo dove si possono vedere i resti di un grande villaggio di guerra e un masso da cui è stato ricavato un suggestivo altare. Proseguendo ancora si imbocca, sulla sinistra, il sentiero CAI 401 fino all'incrocio con il sentiero CAI 413 che conduce in vetta (1757 metri s.l.m.). Qui sono visibili un monumento commemorativo e le strutture militari recentemente riportate alla luce. In basso si trovano i baraccamenti ricostruiti e i fregi restaurati. Si prosegue sul sentiero CAI 413 e si scende verso il Passo Cavallo e il ricovero d'Andrea, dove si possono osservare altri resti militari, e da qui si imbocca il sentiero CAI 401 per tornare alla casa cantoniera.

MUSEO ALL’APERTO DEL PAL PICCOLO
Difficoltà
Escursionistico su sentieri
segnalati (CAI 401)
È consigliabile avere una buona preparazione fisica
Dislivello
500 m
Lunghezza
5,8 km
Durata
4 ore
Consigliato
estate
Cartografia
cartina Tabacco 09
Punto di partenza
Parcheggio al Passo di Monte
Croce Carnico
Il Museo all’aperto del Pal Piccolo permette di scoprire altre testimonianze della Grande Guerra sulle Alpi Carniche. Partendo dal Passo di Monte Croce Carnico (1360 metri s.l.m.) si raggiunge a piedi l’ex confine. Dopo qualche metro in territorio austriaco si trova l’indicazione “Kleiner Pal – MG Nase” a segnalare l’inizio del sentiero che conduce alla cima della montagna. La salita, costante ma non difficile, conduce in breve alla selletta del cocuzzolo del “Naso delle mitragliatrici”: una sosta è d’obbligo per esplorare il caposaldo austriaco, tra trincee anche coperte, postazioni e baraccamenti. Il percorso prosegue attraverso il bosco e, in circa un’ora e mezza, conduce al campo base dell’associazione Dolomitenfreunde che gestisce questo museo all’aperto. Da qui si può esplorare a piacimento le complesse e articolate postazioni austriache che si estendono sulle cime circostanti (alla destra del Kleiner Pal). In breve si arriva alla vetta dove, a poca distanza l’uno dall’altro, si vedranno la cupola osservatorio, i camminamenti austro-ungarici e il cosiddetto Trincerone Italiano (1860 metri s.l.m.). Da qui, osservando coi propri occhi la prossimità delle prime linee nemiche è possibile comprendere quanto fosse difficile la vita sul fronte. Per tornare al Passo di Monte Croce Carnico, si può decidere se ripercorrere a ritroso il versante austriaco o se imboccare il sentiero CAI 401 ed esplorare il versante italiano.

Difficoltà Escursionistico su sentieri segnalati (CAI 442 e 442a) e sentiero in cresta non segnalato. Possibilità di raggiungere la cima lungo una via ferrata.
Dislivello 650 m
Lunghezza 7,4 km
Durata 5 ore
Consigliato estate
Cartografia cartina Tabacco 09
Punto di partenza
Parcheggio nei pressi della casera al Passo di Cason di Lanza
ITINERARIO DEL MONTE ZERMULA
Lo Zermula, con la sua lunga dorsale, venne fortificato dall’esercito italiano come caposaldo difensivo a protezione della retrostante valle d’Incaroio e di Paularo. La partenza è fissata alle spalle della casermetta abbandonata della Guardia di Finanza sul Passo del Cason di Lanza. Si prosegue lungo il sentiero CAI 442a e CAI 442 fino alla forca di Lanza (con resti di trincee) e poco più in là si imbocca la traccia che conduce alla cresta dello Zermula (2086 s.l.m.) fino alla cosiddetta Via delle Trincee. Dopo aver raggiunto la cima (2143 metri s.l.m.) e ammirato il panorama si dovrà tornare sui propri passi e imboccare il sentiero CAI 442 alla prima occorrenza. Lungo il percorso sarà visibile un’edicola votiva di guerra. Proseguendo si tornerà alla Forca di Lanza CAI 442a.

Difficoltà Escursionistico esperto su sentieri segnalati (CAI 146 e 147), vie attrezzate e segnavia non segnalati.
Dislivello 900 m
Lunghezza 9,5 km
Durata 7 ore
Consigliato estate
Cartografia cartina Tabacco 09
Punto di partenza
Parcheggio presso il Passo di Monte Croce Carnico
ITINERARIO DI CRETA DI COLLINETTA
L’itinerario che porta alla cima della Creta di Collinetta (o Monte Cellon) comprende una via ferrata all’interno di una galleria scavata dalle truppe austro-ungariche nel 1916 e perciò richiede una buona conoscenza della montagna e l'attrezzatura prevista. L’escursione parte dal Passo di Monte Croce Carnico (1360 metri s.l.m.) e procede oltre il confine fino all’indicazione per il percorso Geo Trail. Da qui si raggiunge la Galleria di guerra Cellon-Schulter che, salendo per 180 metri all’interno della montagna, conduce ai piedi della panoramica spalla dello Schulter (1736 metri s.l.m.), formidabile caposaldo austroungarico. Seguendo le indicazioni per il Plöckenpass, si potranno osservare alcune gallerie militari Imboccando infine il sentiero CAI 147 si risale il Pendio della Cresta Verde e in breve si raggiunge la vetta (2228 metri s.l.m.). Lungo tutto il sentiero si potranno osservare resti di fortificazioni ed edifici militari. Al ritorno si ripercorre il sentiero CAI 147 e successivamente il sentiero CAI 146 che, in 45 minuti, riconduce al Passo di Monte Croce Carnico. Chi volesse evitare la galleria ferrata, può raggiungere la cima seguendo il sentiero consigliato per la discesa.

ITINERARIO DEL PASSO VOLAIA
Difficoltà
Escursionistico su sentiero segnalato (CAI 144).
È consigliabile avere una buona preparazione fisica
Dislivello
630 m
Lunghezza
5,5 km
Durata 4 ore
Consigliato estate
Cartografia
cartina Tabacco 01
Punto di partenza
Parcheggio presso il Rifugio
Tolazzi
Il Passo Volaia è una delle mete più suggestive delle Alpi Carniche. Oltre alla presenza di un lago glaciale e allo splendido panorama, l’itinerario necessario a raggiungerlo offre anche la possibilità di scoprire significativi resti della Grande Guerra. Dal Rifugio Tolazzi (1350 metri s.l.m.) si percorre una vecchia strada militare fino a quota 1650 da dove di prosegue su mulattiera (sentiero CAI 144), raggiungendo dapprima l’ex-casermetta della Finanza e quindi il rifugio Lambertenghi Romanin nei pressi del Passo (1955 metri s.l.m.). Il sito è un museo all’aperto e presenta un articolato sistema di sbarramento italiano con un trincerone, delle postazioni, caverne e ricoveri disposti su più linee. Superato il Confine di Stato e raggiunto il lago lungo il sentiero che lo costeggia, si giunge in breve al rifugio Pichl e al soprastante cocuzzolo con il monumento dedicato ai Volontari Carinziani Terminato il percorso attorno al lago si può riprendere il sentiero CAI 144 per tornare al punto di partenza.

IL TURISMO DEL RICORDO
NEL PRIMO DOPOGUERRA
Nel dopoguerra, tra il 1919 e il 1922, emerse tra civili e reduci una necessità impellente di visitare i luoghi del conflitto, laddove avevano perso i loro cari oppure avevano combattuto. Si trattava di un turismo del ricordo, che aveva una duplice finalità: commemorare i caduti e celebrare la nazione vittoriosa. Inizialmente si sviluppò una sorta di pellegrinaggio intimo, laico e religioso al tempo stesso, alimentato dal desiderio di parenti, madri e vedove di ritrovare le tombe dei propri cari. Nondimeno, per rivivere l'esperienza centrale della propria vita, furono proprio i reduci, attraverso le neonate associazioni degli ex combattenti ad alimentare il turismo sui luoghi di guerra, come nel caso del primo pellegrinaggio degli alpini sul Monte Ortigara nel settembre del 1920. Non appena le condizioni lo consentirono, le scuole e le principali associazioni turistiche, come il Touring Club Italiano e il Club Alpino Italiano iniziarono ad organizzare escursioni sui campi di battaglia, nei sacrari militari e nelle città “redente” di Trento, Trieste, Pola e Fiume. Il fenomeno fu accompagnato dalla proliferazione delle guide turistiche dedicate a questi luoghi, divenuti simboli non solo della memoria storica, ma anche di una nuova pedagogia nazionale, che intendeva trasmettere la sacralità delle zone di combattimento e l’importanza del patrimonio storico, artistico e naturale delle terre restituite alla patria.
48 ore o 7 giorni di emozioni, cultura e....divertimento. Un’unica Card per il Friuli Venezia Giulia, a partire da 25€!
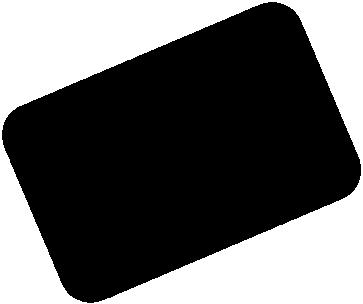
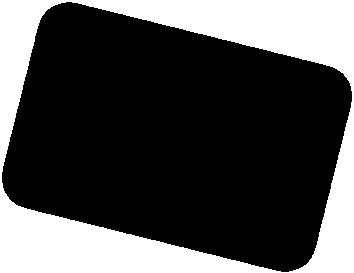
Con la FVG Card puoi vivere il Friuli Venezia Giulia da cima a fondo, grazie a una ricca offerta di esperienze gratuite e sconti esclusivi
Immergiti nella storia di questo affascinante territorio e approfitta delle visite guidate nei luoghi simbolo del conflitto e degli ingressi ai musei della Grande Guerra compresi nella Card!
Inclusi GRATUITAMENTE nella card
Musei e audioguide
• Civico Museo della Guerra per la Pace “Diego de Henriquez”
• Museo della Grande Guerra di Gorizia
• Museo della Grande Guerra del Monte San Michele
• Museo storico militare “Alpi Giulie”
• Audioguida – Grande Guerra (IAT Redipuglia)
DOVE acquistarla
• Infopoint PromoTurismoFVG
• Strutture convenzionate
• Online: www.turismofvg.it/fvg-card
Visite guidate
Tutte le visite guidate Grande Guerra organizzate in collaborazione con lo IAT di Redipuglia
La Card vale anche per 1 bambino sotto i 12 anni. Le gratuità sono utilizzabili solo una volta per struttura-servizio. Gli sconti sono riconosciuti al solo possessore della FVGcard.

Scopri tutti i vantaggi!

Elenco degli Infopoint PromoTurismoFVG
Aquileia Infopoint
Via Giulia Augusta, 11 - 33051 Aquileia (UD)
Tel. +39 0431 919491 | Cell. +39 335 7759580 info.aquileia@promoturismo.fvg.it
Arta Terme Infopoint
Via Nazionale, 1 - 33022 Arta Terme (UD)
Tel. +39 0433 929290 | Cell.+39 335 7463096 info.artaterme@promoturismo.fvg.it
Cormons Infopoint
Piazza XXIV Maggio, 15 – 34071 Cormons (GO)
Tel. +39 0481 386224 | Cell. +39 335 7697061 info.cormons@promoturismo.fvg.it
Forni di Sopra Infopoint
Via Cadore, 1 - 33024 Forni di Sopra (UD)
Tel. +39 0433 886767 | Cell. +39 335 1083703 info.fornidisopra@promoturismo.fvg.it
Gorizia Infopoint
Corso Italia, 9 - 34170 Gorizia
Tel. +39 0481 535764 | Cell. +39 335 1084763 info.gorizia@promoturismo.fvg.it
Grado Infopoint
P.zza XXVI Maggio, 16 - angolo Portanuova, 26 34073 Grado (GO)
Tel. +39 0431 877111 | Cell. +39 335 7705665 info.grado@promoturismo.fvg.it
Lignano Pineta Infopoint (stagione estiva)
Via dei Pini, 53 - 33054 Lignano Pineta (UD)
Tel. +39 0431 422169 | Cell. +39 331 1435222 info.lignanopineta@promoturismo.fvg.it
Lignano Sabbiadoro Infopoint
Lungomare Trieste, 9 - 33054 Lignano Sabbiadoro (UD) Tel. +39 0431 71821 | Cell. +39 335 7697304 info.lignano@promoturismo.fvg.it
Marano Lagunare Infopoint (stagione estiva)
Piazza Cristoforo Colombo - 33050 Marano Lagunare (UD) Cell. +39 334 6835248 info.marano@promoturismo.fvg.it
Miramare Infopoint
Porta della Bora, adiacente all’ingresso del Viale dei Lecci 34121 Trieste Cell. +39 333 6121377 info.miramare@promoturismo.fvg.it
Muggia Infopoint
Piazza Marconi, 1 a fianco dell’ufficio URP
34015 Muggia (TS)
Tel. +39 040 9571085 - Cell. +39 331 4667137 info.muggia@promoturismo.fvg.it
Monte Sei Busi (Museo all'aperto della Dolina del XV Bersaglieri)

Palmanova Infopoint
Borgo Udine, 4 - 33057 Palmanova (UD)
Tel. +39 0432 924815 | Cell. +39 335 7847446 info.palmanova@promoturismo.fvg.it
Piancavallo Infopoint
(stagione invernale ed estiva)
Via Collalto, 1 - 33081 Piancavallo - Aviano (PN)
Tel. +39 0434 655191 | Cell. +39 335 7313092 info.piancavallo@promoturismo.fvg.it
Pordenone Infopoint
Palazzo Badini
Via Mazzini, 2 - 33170 Pordenone
Tel. +39 0434 520381 | Cell. +39 335 1516948 info.pordenone@promoturismo.fvg.it
Sappada Infopoint
c/o Borgata Bach, 9 - 33012 Sappada (UD)
Tel. +39 0435 469131 | Cell. +39 335 1085932 info.sappada@promoturismo.fvg.it
Sistiana Infopoint (stagione estiva)
Sistiana 56/B - 34011 Duino - Aurisina (TS)
Tel. +39 040 299166 | Cell. +39 335 7374953 info.sistiana@promoturismo.fvg.it
Tarvisio Infopoint
Via Roma, 14 - 33018 Tarvisio (UD)
Tel. +39 0428 2135 | Cell. +39 335 7839496 info.tarvisio@promoturismo.fvg.it
Tolmezzo Infopoint
Via della Vittoria, 4 - 33028 Tolmezzo (UD)
Tel. +39 0433 44898 | Cell. +39 335 7747958 info.tolmezzo@promoturismo.fvg.it
Trieste Airport Infopoint
Via Aquileia, 46 - 34077 Ronchi Adei Legionari (GO)
Tel. +39 0481 476079 | Cell. +39 334 6430667 info.aeroportofvg@promoturismo.fvg.it
Trieste Infopoint
Via dell'Orologio, 1 (angolo Piazza Unità d'Italia)
34121 Trieste
Tel. +39 040 3478312 | Cell. +39 335 7429440 info.trieste@promoturismo.fvg.it
Udine Infopoint
Piazza I Maggio, 7 - 33100 Udine
Tel. +39 0432 295972 | Cell. +39 335 1088307 info.udine@promoturismo.fvg.it
COME ARRIVARE
IN AUTO
Autostrade:
A4 Torino/Trieste
A23 Palmanova/Udine/Tarvisio
A28 Portogruaro/Conegliano
A27/A4 Trieste/Belluno
IN AEREO
Airport of Trieste www.triesteairport.it
40 km da Trieste e Udine
80 km da Pordenone
130 km da Venezia
120 km da Lubiana
IN TRENO www.trenitalia.it www.italotreno.it
IN BICI www.alpe-adria-radweg.com www.adriabike.eu
Edizione settembre
CREDIT
FOTO
Archivio PromoTurismoFVG
Archivio fotografico del Civico Museo della Guerra per la Pace “Diego de Henriquez” Museo Grande Guerra di Ragogna
N. Brollo | Fivestudio.it
A. Cop
P. da Pozzo
F. Gallina
G. Menis
A. Michelazzi
M. Milani
M. Pascoli
Schirra-Giraldi
R. Todero
L. Vitale

INFO
PromoTurismoFVG
Strategies, Development, Operations for Tourism Trieste Airport - Via Aquileia, 46 34077 Ronchi dei Legionari (GO) info@promoturismo.fvg.it
TESTI
PromoTurismoFVG
In collaborazione con M. Ermacora
A. Ferletic
M. Pascoli
S. Stok
R. Todero
D. Tonazzi
A. Vazzaz