Transfigurative Photography rivista periodica di cultura fotografica n. 14 | Aprile 2025


Transfigurative Photography rivista periodica di cultura fotografica n. 14 | Aprile 2025

Tutte le fotografie, nel rispetto del diritto d’autore, vengono qui riprodotte per finalità di critica e discussione ai sensi degli artt. 65 comma 2, 70 comma 1 bis e 101 comma 1 Legge 633/1941.
Fotografia Transfigurativa Magazine
rivista periodica di cultura fotografica n. 14 | Aprile 2025
Comitato Redazionale
Agostino Maiello | Alessandro Mazzoli | Stefano Montinaro | Michele Palma | Andrea Virdis
Hanno collaborato a questo numero
Paola Pampalone | Carlo Riggi | Paolo Volpi
Immagine di copertina
© Franco Carlisi, dalla serie Umanità
di Agostino Maiello
La fotografia digitale non è vera fotografia, perché non si tocca. Non sappiamo chi l’abbia detto, ma di sicuro qualcuno è stato. E come quasi tutte le affermazioni un po’ tranchant, contiene un fondo di verità. È vero che il termine fotografia parla di come si forma l’immagine (la luce che interagisce con un supporto, che sia una lastra di rame o uno strato di fotodiodi), senza alcun riferimento alle modalità di fruizione della stessa, per cui imporre una consistenza fisica all’oggetto “fotografia” suona come una forzatura. È altresì vero che nulla vieta di stampare un’immagine digitale, e tornare così ad avere tra le mani l’antico e rassicurante pezzo di carta sul quale abbandonare lo sguardo. Insomma, la dimensione della fisicità sembra accompagnare in maniera implacabile ogni passo della storia della pratica fotografica: c’è per forza di cose qualcosa di fisico (esistente, reale) che si è trovato dinanzi all’obiettivo in quel momento; ed il risultato del processo è un fenomeno cui tradizionalmente assegniamo la qualifica di oggetto: ci aspettiamo, insomma, che sia un negativo, una diapositiva, una stampa. Chi ha qualche annetto sulle spalle ha dovuto o dovrà compiere - o non compiere, ma ciò non dissolve il dilemma - il salto verso la piena accettazione della smaterializzazione; chi sia nativo digitale, probabilmente, ne è esentato. Il problema, in ogni caso, si pone.
Se, dunque, esiste questa ineludibile materialità, spostando l’attenzione dall’oggetto al contenuto, insomma dalla peinture al tableau, non sorprende che una delle applicazioni più tipiche sia stata la fotografia di persone. Se n’era accorta presto Gisèle Freund, quasi un secolo fa, come scrisse Walter Benjamin a proposito del classico Fotografia e società: lo “studio di Gisèle Freund correla l’ascesa della fotografia all’ascesa della borghesia, palesando tale dipendenza tracciando la storia del ritratto”. Il resto, come suol dirsi, è storia. L’evoluzione della fotografia ha dato vita a mille rivoli, sperimentazioni, riflessioni, verifiche. Mai, in tutto questo, la persona ha assunto un ruolo di secondo piano. Volti, sguardi e corpi hanno riempito archivi analogici e digitali di milioni di fotografi dal 1839 ad oggi, e dubitiamo che ciò avrà mai fine. Poche sfide sono più affascinanti per un fotografo di quelle che lo pongono al cospetto di un’altra persona, con l’obiettivo (ci si perdoni il calembour) di trarne un ritratto. Ecco perché in questo numero ci siamo dedicati al tema del corpo, declinandolo come sempre secondo le accezioni più varie, in coerenza con l’approccio eterogeneo che permea - e non potrebbe essere altrimenti - la fotografia Transfigurativa.
di Carlo Riggi
Nel 2001, durante una delle mie scorribande tra le novità editoriali, mi imbattei in un piccolo volume, di un bianconero intenso, profondo, violento persino, fin dalla copertina.
“Altari di sassi” era il titolo, e fu l’argomento definitivo che rese necessario il mio acquisto. Da allora, Franco Carlisi è entrato di diritto nel piccolo Olimpo dei miei autori preferiti. Posto che mantiene tutt’ora, dopo tanti anni, e dopo che ho avuto il privilegio di diventargli amico.
Nella quarta di copertina, in una toccante dedica al padre, Franco scrive: “Ora che il sentimento dell’assenza esiste sono tornato a cercare i miei sassi (...) sguardi sospesi sui silenzi dell’esistenza, sogni sognati anche da altri. Fantasmi di una civiltà interiore di un’improbabile intimità condivisa (...)”.
Il libro parla di ritrovamenti; una ricerca sofferta di radici identitarie d’acchito ostiche, estranee, rese agibili grazie al potenziale oniropoietico della fotografia, fino a poterle riconoscere come familiari.
Questa foto non è contenuta nel libro, ma appartiene alla stessa ricerca. Una fotografia semplice, basica, solo una mano e un corpo, di bimbo si direbbe. L’immagine poggia formalmente sulla relazione fuoco/fuori fuoco, e si struttura graficamente su una direttrice longitudinale contrappuntata da cavità scure (l’ombelico, l’addome, la bocca), culminante nella macchia di luce sullo sfondo, uno spiritello irriverente che sembra parodiare la mimica del volto. Una linea che il gesto perpendicolare della mano interrompe di netto, affondando il dito nella carne molle. Una cesura forte, a configurare una dialettica maschile/femminile ad un tempo tenera, brutale e sensuale.
Dicevo del corpo di bambino, ma questa è una lettura soggettiva. La foto in realtà dice e non dice, e si presta a molteplici interpretazioni, frutto diretto di personalissime proiezioni e antiche reminiscenze: i nostri altari di sassi.
La mia mente, al cospetto di questa immagine, vola, planando dolcemente sul lettino da visita del mio medico di famiglia. Le sue dita sapienti spingono sul mio pancino glabro e molle, a sondare eventuali anomali ispessimenti, a provocare mirate sensazioni di dolore, e a produrre inevitabilmente le mie scomposte reazioni di solletico, che, per via dei convulsi sussulti addominali, mandano a ramengo l’ispezione diagnostica, suscitando l’ira del dottore, che puntualmente mi apostrofa con aggettivi ogni volta più fantasiosi, dopo i quali ridiamo tutti, compresi i miei genitori, adesso sollevati. Perché significa che lui ha già capito, e va tutto bene. Il resto è teatro. E affetto vero.
Ecco la self disclosure, ecco gli altari, le memorie intime che diventano nostalgia condivisa. Quello della foto, nella realtà, potrebbe essere un corpo non così giovane, magari un corpo dolente, perturbato o eccitato. La mano potrebbe non essere così amorevole e sapiente come quella dei miei ricordi.
È la peculiarità della buona fotografia, partire da un dato reale e espandere i suoi significati possibili, plasmandoli a misura del fruitore, in una relazione certo privilegiata con le intenzioni dell’autore, ma in un assetto di sostanziale autonomia.
Succede quando una fotografia è adulta, consapevole, non gelosa della propria genesi, libera di camminare da sola per diventare patrimonio di tutti coloro che la osservano.
“Pietra su pietra, segreto su segreto, sino all’apologia della fantasia”.

Ed. Abrams, 2008 | Copertina rigida, 25,4 x 32,4 cm | 303 pagine, fotografie in b/n
Nel suo valido ed utile “Guardare un quadro”, la studiosa inglese Mary Acton definisce la forma come “il termine usato dagli artisti per descrivere la sensazione di volume in un dipinto. È illusoria, nel senso che l’artista cerca di conferire un aspetto solido alla superficie piana, e per questo motivo si potrebbe dire che il termine appartiene per l’esattezza al mondo della scultura. Ma rimane il fatto che, di certo dall’epoca rinascimentale, gli artisti hanno cercato di rendere nei loro dipinti le cosiddette qualità <plastiche>.”

È probabilmente superfluo aggiungere che la fotografia non si sottrae a questo problema: specificità del mezzo a parte, la questione si pone in ogni caso, essendo una foto una rappresentazione su due dimensioni di qualcosa che è stato visto (e ritenuto degno di interesse) da un fotografo. e che noi ci troviamo ad osservare in seguito. Ciò che noi guardiamo è dunque, tra le altre cose, una versione appiattita di un frammento di realtà e, al netto delle tante possibili modalità di osservazione di un’immagine, c’è un punto fermo ineludibile: nel guardare la foto di un albero, noi osserviamo l’albero e lo identifichiamo come tale, ma nel contem-
po sappiamo che quella è una fotografia e non un vero albero; e questa consapevolezza non può essere messa da parte.
Più o meno costruita che sia, una fotografia - come un film o una rappresentazione teatrale - è implacabilmente una messa in scena di qualcosa che esiste o è esistito, in ciò distinguendosi da altre pratiche artistiche (pittura, scultura, musica) dove lo iato tra soggetto e sua rappresentazione manca del tutto (nel caso della musica) o assume tutt’altro sapore. Nessuno, guardando dei quadri, è preso dal dubbio che quei due siano davvero i coniugi Arnolfini o quella sia davvero Monna


Lisa: sappiamo che sono dipinti, e non c’è alcuna illusione di realtà in questa presentazione. Non a caso la fotografia ci ha messo un bel po’ prima di vedere riconosciute, almeno in fieri, le sue possibilità artistiche; e non a caso la sua presentazione ufficiale al mondo è avvenuta all’Accademia delle Scienze.
Tornando alla questione centrale, un’altra osservazione da fare è che nell’atto dell’osservare una foto ci viene a mancare il mondo reale che ci aspetteremmo tutt’intorno: se fossimo davvero di fronte a quell’albero avremmo non solo dinanzi a noi un vero albero, ma saremmo circondati dai suoni e dai profumi della natura. Mancanze, queste, che di certo non ci affliggono nel guardare un quadro - che sia Caravaggio, Van Gogh, Picasso o Matisse. Alle prese con la nostra foto di un albero, se fossimo in un bosco la nostra esperienza sarebbe, banalmente, vera, nel senso di sostanziarsi in un nostro atto di presenza nel mondo; laddove una fotografia al massimo può ambire ad essere verosimile. E come tale si limita a presentare al nostro sguardo la rappresentazione di qualcosa, che assomiglia in maniera inequivocabile ad un albero, ma galleggia senza scampo in quello spazio intermedio tra realtà (“quello è un albero vero, non un albero dipinto!”) e sua riproduzione. Qui ci viene in soccorso ancora la Acton; al termine del capitolo, che si compone - come gli
altri - di una serie di osservazioni sullo specifico aspetto preso in esame, sviluppate riferendosi ad opere più o meno note, c’è infatti una chiosa assai interessante: la forma “...è collegata con la volontà di comunicare l’esperienza visiva del mondo fisico e di trasmettere intuizioni su come lo comprendiamo. Poiché ha a che fare con la struttura e con il modo in cui gli oggetti sono messi insieme, la forma fornisce alle opere d’arte un senso vitale di persuasione che può accrescere l’esperienza visiva della realtà dello spettatore”.
Persuasione e beneficio dell’esperienza visiva, dunque. Un binomio che si attaglia perfettamente alla potenza ed all’efficacia di questa raccolta di immagini di Richard Avedon, una carrellata che copre molti anni, dove uno dei più grandi fotografi di tutti i tempi ha voluto selezionare fotografie che, come il titolo lascia intuire, ci mostrano una galleria di personaggi - attori, ballerini, musicisti, e così via - famosi per, appunto, le loro performance. L’esibizione (canto, scrittura, danza, recitazione e quant’altro) è ciò che ha reso immortali i vari Charlie Chaplin, Marilyn Monroe, Marlene Dietrich, Prince, Andy Warhol; loro come tanti altri (le foto sono più di 200) hanno posato per Avedon, che ha cristallizzato, con la sua tecnica sopraffina ed il suo talento immenso, una galleria di figure che hanno fatto la storia delle arti performative. Non è un dettaglio irrilevante il fatto che si tratti in massima parte di ritratti; in altre parole, quasi sempre la performance è suggerita, non mostrata. Non si tratta, insomma, di fotografie scattate durante le riprese di un film o l’esecuzione di un concerto; anche quando ci si trova davanti a scene di evidente taglio performativo, i testi a corredo ci informano che stiamo osservando scatti che ricreano appositamente, davanti all’obiettivo del fotografo, situazioni simili a quelle che si verificano sul palco durante le effettive rappresentazioni. Avedon, in altre parole, ci mostra i volti ed i corpi di coloro che danno sostanza alle performance. Una visione lucida, la sua, efficace come


poche, sempre molto precisa nel ridurre al silenzio tutto ciò che disturba la percezione dell’immagine. Fotografie purissime, dunque: i soggetti sono decontestualizzati come più non si potrebbe - non vediamo Prince su un palco, o la Hepburn che recita - eppure la fisicità dei personaggi ritratti, avvolta nella luce di Avedon, disposta con acutezza o colta con intuito, è esattamente quanto serve a far funzionare in maniera egregia ogni immagine. Le fotografie di Avedon si impongono con autorevolezza e classicità: autosufficienti per quanto sono potenti, mai eccessive, mai banali. Egli non ci fa vedere nessuno mentre si esibisce, eppure ci offre una strepitosa carrellata di esibizioni(sti). E dietro a questo poderoso corpo di lavoro, a tirare i fili c’è lui stesso, Avedon, che a sua volta si esibisce: in copertina (perché lo vediamo) ed in ogni immagine (perché sappiamo che c’era lui dietro la fotocamera). Non a caso, una sua citazione che accompagna spesso questo splendido, imponente volume, recita: “Tutti ci esibiamo. È ciò che facciamo a vicenda, sempre, deliberatamente o involontariamente. È un modo di raccontare noi stessi, nella speranza di essere riconosciuti per ciò che vorremmo essere”.

Selezione a cura di Paolo Volpi
Fotografie tratte dalla pagina Facebook Fotografia Transfigurativa - The Gallery






Ottavia Gori


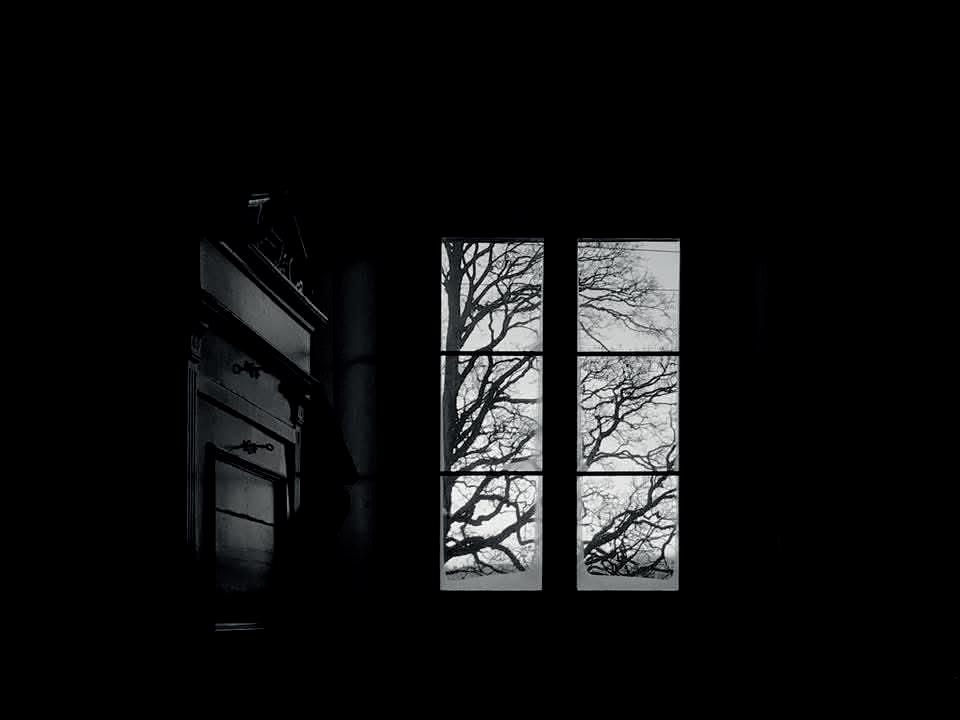











di Paola Pampalone
Riflettere sul corpo, sulle sue diverse accezioni, mi ha rimandato al pensiero animistico dei bambini.
I bambini hanno la straordinaria capacità di attribuire un’anima a un qualsivoglia oggetto, riescono a comunicare con esso e a sentirne le risposte. Hanno talmente tanto corpo da generare un proprio mondo totalmente vivo!
Paradossalmente, invece, troppi adulti mettono alla stessa stregua corpo e oggetto.
Non considerando che il corpo abbia un’anima, che non è una cosa inanimata, commettono ogni atrocità: lo maltrattano, ne abusano, lo violentano, lo mercificano, lo uccidono... Quotidianamente la cronaca lo riporta e notizie di questo genere sono diventate una costante; l’orrore ci siede accanto togliendoci la capacità di indignarci.
A questo punto, per fortuna, entra in campo l’artista che riesce a vedere l’ordinario così come lo vede un bambino e a renderlo straordinario. Ha conservato la capacità di creare, di dare un’anima alle cose generando bellezza.
Non a caso Picasso affermava che in pochi anni era riuscito a dipingere come Michelangelo ma che aveva impiegato una vita per imparare a dipingere come un bambino. Egli, aveva compreso la potenza creativa del bambino, così tanto simile a quella divina.
A quell’atto di prendere del semplice fango, plasmare un corpo e, soffiandovi, farlo vivere.
Siamo frammenti di eternità, il nostro corpo è tempo incarnato.
Noi, uomini finiti, che occupiamo un tempo e uno spazio, possiamo creare l’infinito, soffiare sulle cose dandogli vita.
Se andiamo ad indagare, scopriamo che la parola corpo, nel corso del tempo, ha subito numerose trasformazioni semantiche.
Essa viene dal latino corpus che, a sua volta, traduce il verbo greco soma. Questa parola è molto simile a sema che significa tomba. Si aveva la concezione che il corpo fosse la tomba dell’anima. Per molto tempo, infatti, la parola corpo rappresenta l’uomo privo di vita, il suo cadavere.
Tuttavia, il corpo è espressione dell’anima, e sema prende pure il significato di segno. Perciò il corpo è anche segno dell’anima.
Lungo il corso dei secoli, questa parola subì notevoli cambiamenti di significato. Ai tempi di Omero, il corpo era considerato parte del tutto, si deve a Platone la nascita del pensiero dualistico di corpo e anima, il corpo diventa una zavorra che impedisce la conoscenza. Con Cartesio, infine, il corpo diventa un organismo, un insieme di funzioni.
Questo breve excursus storico ci fa comprendere che il nostro corpo è trampolino e zavorra delle nostre potenzialità perché racchiude l’esuberanza della vita e l’orrore della morte. Sta a ciascuno di noi decidere come impiegare questo tempo incarnato che ci è stato donato. Se impiegarlo per generare vita, bellezza, relazioni in cui crescere e migliorare oppure se seminare morte e distruzione dimenticandoci di essere anche segno, non solo tomba.
Concludo questa mia riflessione intorno al corpo con dei miei versi, in cui si mostra che quando c’è armonia fra corpo e spirito, la morte scompare e il corpo diventa segno del proprio tempo.
Mi scordo di morire
Stesa sui tuoi rami
Aspetto la danza del sole
Sulla nuca, sugli occhi
Lo lascio danzare sul ventre.
Sciogliendo ogni grumo
Linfa rubina scorre
Dentro membra indifese
Catturate dal silenzioso
Arresto del tempo.
Soffio caldo che mescola
Ogni cosa.
Con una preghiera in tasca
Mi scordo di morire

di Alessandro Mazzoli
Il corpo macchina, mani che lo tengono, gambe che camminano verso il soggetto, occhi che dirigono lo sguardo nel mirino.
Se penso al corpo, e penso alla fotografia, come incipit mi viene alla mente questa sequenza, collegata con la sensazione dell’essere nel mondo, di essere un corpo e un peso. In ordine sparso: chi ha una fotocamera forse non ha perso la fisicità del gesto, un dito tocca il pulsante di scatto, un meccanismo agisce, un frammento del mondo diventa immagine, immaginazione. Il corpo come soggetto, ripreso da un oggetto grosso e pesante, una preparazione complessa, un tempo dilatato, una pratica che pochissimi erano in grado di realizzare. In meno di due secoli il tempo si è azzerato, il peso è scomparso, il rituale dissolto e anche il soggetto rischia di essere frutto di una sintesi digitale. In mezzo a questa parentesi, un po’ folli e sicuramente visionari ci siamo noi fotografi che ancora non abbiamo ceduto alle lusinghe della facilità o non del tutto, noi a cui non pesa impugnare una reflex, portarla in giro a registrare i nostri sogni possibili, anche quelli apparentemente impossibili. Chi rischia ancora affidandosi alla chimica della pellicola, chi usa vecchie ottiche facendo a meno degli automatismi, chi stampa su una carta consistente le proprie visioni, chi sfoglia un bel libro di fotografia, chi colleziona e usa decine di vecchie fotocamere. La voluttà è appannaggio del corpo, della materia, di chi non vuole perdere la fisicità come esperienza fondante della pratica artistica e anche del vivere una vita nel proprio tempo, nello spazio.
La poesia è tagliare. Noi non ce ne accorgiamo, ma tante operazioni della vita si fanno con i bisturi.
Perfino gli occhi sono un bisturi. Apri e chiudi.
Una macchina fotografica è un bisturi, uno scatto e hai tagliato un pezzo di realtà da conservare. […] Franco Arminio, La cura dello sguardo
Corpo, gesto, immagine.
Potrebbe essere un punto fermo dunque di tutta la storia della fotografia, il corpo dei fotografi, il corpo come soggetto fotografato, analizzato, raccontato e messo in scena, il mondo intero come un unico immenso corpo generatore di immagini. Cerco nella memoria cosa mi porta a dare importanza a questi valori a dispetto dell’epoca in cui ci troviamo a vivere, in cui tutto viene smaterializzato e archiviato nelle nuvole digitali, appare fugacemente sui nostri device e si perde nell’infinita sequenza delle pagine nella rete.
Un vecchio libro di tecnica della fotografia di mio padre in cui sulla copertina era stampato Nude 227N (Charis in the Doorway, Santa Monica, 1936) di Edward Weston in cui ho visto per la prima volta un corpo apparire come una scultura, la consistenza della carta fotografica baritata Ilfobrom Galerie, la meccanica e il peso della Leica M3 con cui ho imparato a fotografare, una mostra di Cartier Bresson a Roma nel 1993, le stampe giganti dei ritratti di Thomas Ruff a Francoforte.
Nostalgia? O la coscienza che senza oggetti e senza corpi fisici che li maneggiano la vita non ha presenza, non occupa uno spazio, fluisce in superficie senza mai mettere radici.
Il corpo è da sempre il soggetto portatore di memoria, come azione e come segno attraverso la sua rappresentazione nella pittura, nella scultura, fino all’ avvento della fotografia. Come un archivio in cui riporre sogni, narrazioni, impressioni, attraverso una serie di azioni, di opere che non a caso è denominato “corpus”. La nostra stessa presenza, qui e ora, fatta di peso e movimento, di spazio occupato, ci dà la misura di quanto sia vasto, potenzialmente infinito e inscindibile il rapporto delle arti con il corpo.
Una crociata contro la falsità dell’intelligenza artificiale, contro i surrogati di quello che le cose hanno ancora da raccontare. Ora, con la fotocamera tra le mani, usciamo a ritagliare frammenti di sogni.
di Stefano Montinaro
Un’intera epoca da dematerializzare, digitalizzare e condividere, esibire e ammirare, tutto attraverso dispositivi luminosi, preferibilmente da pochi pollici, per praticità.
È il paradosso del nostro tempo. Immagini sempre a portata di mano, fruibili. Ne produciamo trilioni, ce le scambiamo compulsivamente, affetti da una sorta di bulimica dipendenza. Le consumiamo, prestando sempre meno attenzione al loro corpo. Niente più ossa, pelle, sangue, fluidi, tutto bruciato e sterilizzato sull’altare del vedere senza guardare, si salva solo il simulacro, la celebrazione di un vuoto, pronto a lasciare spazio al vuoto successivo. Possibilmente in fretta.
I fotografi sono vittime e complici al tempo stesso di queste dinamiche. Non si tratta soltanto dell’infinita e a volte insulsa diatriba tra analogico e digitale, c’è in gioco parecchio altro. La vera e propria ridefinizione di un’estetica visiva, ad esempio, perpetrata tramite l’imposizione dall’esterno di canoni estetizzanti. Un filtro prefabbricato di un qualsiasi social media fa all’occhio esattamente quello che un tormentone estivo fa all’orecchio: lo aggredisce, lo abitua e lo convince. Non si ricerca, ci si lascia travolgere.
Now, let me get some action from the back section
We need body rockin’, not perfection
Let your backbone flip but don’t slip a disc
And let your spine unwind, just take a risk
Beastie Boys, Body Movin’, 1998
Viviamo un’epoca ipertecnologica, potremmo provare a indirizzarci verso una serena convivenza con essa, relegando la tecnologia alla neutralità del suo ruolo di strumento, ma non ne siamo capaci, ne abbiamo paura e, nell’elaborarla, la trasformiamo spesso in delirio di onnipotenza, allontanandoci dalle possibilità reali (corporee?) di una fotocamera, affidandoci quasi religiosamente alle sue potenzialità sempre più stravaganti, rendendola uno strumento ibrido, non più centrale, che tramite pre e postproduzione può permetterci di arrivare a qualsiasi risultato.
Siamo affetti da un desiderio di sovraesposizione, misurata in clic di approvazione da consumare velocemente, scorporati da qualsiasi tragitto di senso, da qualsiasi complessità di esplorazione. Il nostro tempo ci ha regalato un’ironica evoluzione: i quindici warholiani minuti di celebrità sono diventati quindici like. Toccano a tutti, a turno, non si negano a nessuno, ci appagano e ce li facciamo bastare, senza pensarci più.
Riportare il corpo al centro della scena che abitiamo, renderlo il vero metronomo, la vera unità di misura. Forse è proprio il corpo a poter rappresentare una forza uguale e contraria, da opporre a questo flusso.
È il nostro corpo che dovrebbe essere messo in gioco per primo, quando fotografiamo. Non soltanto nel semplice seppur fondamentale senso dello spostamento fisico, ma soprattutto nel garantire a noi stessi la sua presenza, impedire la sua sottrazione.
Dovrebbe essere messa in gioco la capacità di esserci, di stare nel qui ed ora, occupare lo spazio, lasciar andare il proprio peso, come quando si danza.
Respirare, fare rumore.
Fotografare vuol dire concatenare una sequenza di atti concreti, mai immateriali. È una continua e complessa relazione fra realtà, corpi umani e corpi macchina, in tutte le loro possibili articolazioni. Si tratterebbe solo di permettere a questa relazione di avere luogo, di avere un tempo per consumarsi.
Un proposito apparentemente facile da tenere presente, del tutto rivoluzionario da mettere in atto nel nostro tempo.
di Andrea Virdis
Il corpo non si riduce mai a semplice entità fisica: esso si fa simbolo, traccia, vibrazione dell’invisibile, soglia di transizione tra materia e spirito.
Attraverso l’obiettivo il corpo cessa di riflettere sé stesso e diviene proiezione dell’autore, specchio delle sue ossessioni, simulacro dei suoi sogni e delle sue inquietudini, memoria vivente della presenza umana nel mondo.
L’impronta autoriale del fotografo si intreccia così alla carne e la carne si dissolve nello spazio, transfigurando la luce in linguaggio.
Come in un processo alchemico, il corpo fotografato si cristallizza, non invecchia più, non muta; resta sospeso, inchiodato a quell’istante, finché il fragile supporto che lo trattiene non si arrenderà al fluire del tempo.
La fotografia ha il potere di trattenere con sé un frammento di vita e al tempo stesso di ricordarci che quell’istante è svanito per sempre dal piano materiale, per rinascere in forme nuove, dentro una dimensione più intima e profonda dell’essere.
In questo incredibile dialogo tra materia e coscienza, il corpo ci svela che non siamo solidi, ma sogni condensati, bagliori di infinito in cerca di uno sguardo che ci restituisca all’incanto dell’esistenza.
Tu non sei il corpo che vedi, ma il pensiero e la luce che lo animano. Quando avrai compreso questo, il corpo sarà per te strumento e non prigione.
Asclepio, Corpus Hermeticum
Essa è la traccia lasciata dal punto in movimento, quindi un suo prodotto. Essa è sorta dal movimento.
(Vasilij Kandinskij)