GUIDA DIDATTICA





G razie alle espansion i digitali dei libri si potrà accedere a numerosi contenuti e st rumenti aggiuntivi, da utilizzare in classe oppure a casa , in mod o semplic e e autonomo.
Attivare e scaricare il libro digitale, collegandosi alla pagina www.gruppoeli.it/libridigitali e seguendo le istruzioni.
Il codice da inserire, quando richiesto, è:
Il libro digitale, sfogliabile e interattivo, presenta: espensioni con approfondimenti ; audio per l’ascolto; video e animazioni; giochi interattivi e didattici; libro liquido: versione accessibile ad alta leggibilità che consente di modificare il tipo di carattere e la sua dimensione, l’interlinea e il colore dello sfondo della pagina e attivare il sintetizzatore vocale.
Il libro digitale è utilizzabile sia o nline sia offline ed è disponibile per PC, Mac, Tablet, LIM e Monitor interattivi.
Inquadrare i QR code presenti nelle pagine del volume, che condurranno direttamente ai contenuti a udio e video di ogni u nità.
L’insegnante può accedere, inoltre, alle risorse online contenute nella sezione # altuofianco, all’indirizzo www.gruppoeli.it/altuofianco, e utilizzarle nel modo che riterrà più opportuno.
Per ricevere assistenza, è possibile collegarsi all’indirizzo www.gruppoeli.it/assistenza/ e scegliere tra le opzioni proposte.
Seguic i anch e su
Gratis 52 numeri in versione digitale a scelta tra: Accesso gratis a:Corsi gratuiti: ELICERT-217644

oppure



«La scuola continua a essere il luogo in cui le persone possono essere riconosciute in quanto tali, possono sentirsi accolte e incoraggiate. Nonostante non si dovrà dimenticare l’importante dimensione di efficienza ed efficacia nella trasmissione delle conoscenze che permetteranno ai nostri giovani di trovare il proprio posto nella società, è fondamentale che siamo, prima di tutto, “maestri d’umanità”.
E questo può essere un contributo importantissimo offerto dall’educazione cattolica a una società che a tratti sembra avere rinunciato agli elementi che ne facevano una comunità: la solidarietà, il senso di giustizia, il rispetto per l’altro, in particolare per il più debole o più piccolo».
Papa Francesco in Disciplina e passione. Le sfide di oggi per chi deve educare
DELLA RELIGIONE CATTOLICA
L’insegnamento della Religione cattolica è una disciplina curricolare che entra a pieno titolo nel piano dell’offerta formativa della scuola e che favorisce la crescita integrale degli alunni nella loro dimensione umana e spirituale. L’IRC si qualifica come laico, aperto a tutti i valori umani, come è citato nel testo dell’ACCORDO DI REVISIONE CONCORDATARIA:
«La Repubblica italiana, riconoscendo il valore della cultura religiosa e tenendo conto che i principi del cattolicesimo fanno parte del patrimonio storico del popolo italiano, continuerà ad assicurare nel quadro delle finalità della scuola, l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche non universitarie di ogni ordine e grado». Questo insegnamento è impartito «nel rispetto della libertà di coscienza degli alunni, secondo programmi che devono essere conformi alla dottrina della Chiesa e collocarsi nel quadro delle finalità della scuola».
DPR 751/85 integr. dal DPR 202/90 all’art. 1.1
L’insegnamento della Religione cattolica si realizza inoltre in un rapporto di continuità con l’AZIONE EDUCATIVA DELLE FAMIGLIE, di cui rispetta le scelte e gli orientamenti. Esso si svolge infine secondo criteri di continuità con l’IRC della scuola dell’infanzia e della scuola secondaria di I grado, in modo da stabilire negli obiettivi, nei contenuti e nei criteri metodologici una progressione che corrisponda ai processi di MATURAZIONE DELLA PERSONALITÀ DEGLI ALUNNI .

Presentazione del progetto
Il mio libro di Religione Nuovo Detto... fatto!
Il Corso IL MIO LIBRO DI RELIGIONE - NUOVO DETTO... FATTO! recepisce le Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione (DM 254/2012) e le riferisce in modo organico al vissuto esperienziale degli alunni, al fine di stabilire un parallelo significativo tra le sfide poste dalla Rivelazione e dalla sapienza delle religioni e i “COMPITI EVOLUTIVI” DEGLI ALUNNI . Suddiviso in 4 volumi separati (testo ed eserciziario integrati), il corso presenta i contenuti scanditi/ritmati da una successione di "contenuti" (logo del libro) e pagine di "attività" (logo della matita). Tale metodologia, evidenziata dagli appositi loghi, si riconduce allo “stile” stesso di Dio che, fin dalla prima pagina della Bibbia, “dice” e quello che dice “avviene, si fa”: «Sia la luce! E la luce fu».
Gli ELEMENTI DIGITALI del testo sono evidenziati in ogni pagina, nella parte più in basso, da appositi loghi:
elementi video
elementi audio
notizie e curiosità
giochi e quiz
Il testo presenta i CONTENUTI DELLA FEDE CRISTIANA CATTOLICA in un’ottica di gradualità didattica, considerando la tenera età delle prime classi, lo sviluppo spesso precoce di molti studenti che si sentono già grandi e, infine, il contesto multietnico e multireligioso dell’epoca attuale, evidenziando il contributo che il Cristianesimo ha dato e dà al patrimonio umano, culturale e valoriale italiano ed europeo, con riferimenti anche alle varie discipline scolastiche, tra le quali in particolar l’arte, la cittadinanza, l’inglese, la storia, la matematica e le scienze.
All’alunno è proposto non solo di apprendere dei contenuti, ma di relazionarsi personalmente ai vari temi a partire dalle sue esperienze di vita quotidiana. Si dà di conseguenza spazio ai contenuti presentati dall’insegnante, al contesto, ovvero alle emozioni dell’alunno e alla metodologia, al “fare” in prima persona, a partire dai quali si innestano le finalità e i contenuti propri dell’insegnamento della Religione cattolica in quanto disciplina.
Il testo si struttura, come anticipato, in quattro volumi, in modo tale da poter graduare l’espressione lessicale ed il livello di difficoltà dei concetti proposti secondo l’età degli allievi, nel seguente modo:
VOLUME classe prima (testo/eserciziario pagg. 84)
VOLUME classi seconda e terza (testo/eserciziario pagg. 192)
VOLUME classe quarta (testo/eserciziario pagg. 120)
VOLUME classe quinta (testo/eserciziario pagg. 120)
Nei volumi sono offerti sia i contenuti del “testo”, con il logo del LIBRO, che del “quaderno operativo”, con il logo della MATITA, favorendo così l’immediata correlazione e fruizione tra i due componenti del corso, che sono presentati in modo immediato per ogni singolo argomento.
I contenuti di ciascuna classe sono articolati in 5 o 6 sezioni, ciascuna delle quali instaura un rapporto tra i contenuti IRC e le situazioni esperienziali che gli alunni si trovano a vivere nelle tappe della propria crescita. Queste le sezioni proposte che approfondiscono a “spirale” alcuni macro-nuclei tematici ricorrenti, ognuno caratterizzato dal medesimo colore ogni anno nell’impostazione grafica delle pagine:
Classe prima
Sezione 1 e 2 Primi giorni / A scuola per... settembre
Sezione 3 Una storia d’Amore ottobre - novembre
Sezione 4 È Natale! dicembre
Sezione 5
Ecco Gesù! gennaio - febbraio
Sezione 6 È Pasqua! marzo - aprile
Sezione 7 Ecco la Chiesa! maggio - giugno
Classe seconda
Sezione 1 Si ricomincia! settembre
Sezione 2 Una grande amicizia ottobre - novembre
Sezione 3 L’attesa di Gesù dicembre
Sezione 4 Gesù e i suoi amici gennaio - febbraio
Sezione 4 La luce di Pasqua marzo - aprile
Sezione 6 La Chiesa ieri e oggi maggio - giugno
Presentazione del progetto
Classe terza
Sezione 1 Si ricomincia! settembre
Sezione 2 Le grandi domande ottobre - novembre
Sezione 3 Un popolo eletto dicembre - gennaio - febbraio
Sezione 4 Una grande alleanza In una nuova terra marzo - aprile
Sezione 4 Nella pienezza dei tempi maggio - giugno
Classe quarta
Sezione 1 Per partire in quarta! settembre
Sezione 2 Viaggio nella storia ottobre
Sezione 3 Gli ebrei nella storia novembre
Sezione 4 Gesù, il Cristo dicembre - gennaio - febbraio
Sezione 4 La Pasqua cristiana marzo - aprile
Sezione 6 La Chiesa di Gesù maggio - giugno
Classe quinta
Sezione 1 Di nuovo in viaggio settembre
Sezione 2 I giganti dell’inizio ottobre
Sezione 3 La Chiesa delle origini novembre - dicembre
Sezione 4 La Chiesa nel tempo gennaio - febbraio
Sezione 4 La vita della Chiesa marzo - aprile
Sezione 6 Le grandi religioni maggio - giugno
Nelle diverse sezioni sono presenti delle pagine speciali, dedicate ai bambini con bisogni speciali (BES/DSA), alla MULTIDISCIPLINARITÀ, ai COMPITI DI REALTÀ, una MAPPA DI SINTESI che riassume e semplifica i contenuti proposti e una verifica per valutare l’apprendimento.
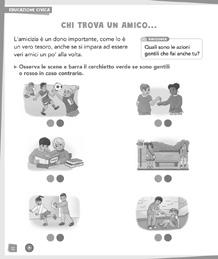



Una delle pagine “speciali” che caratterizzano il testo, è caratterizzata da un apposito logo posto nella parte alta della pagina. Presenta i temi più importanti che riguardano l’alunno in quanto “cittadino del domani”.
Caratterizzata da un apposito logo questa speciale pagina è proposta a conclusione di ogni sezione tematica affrontata. Le tematiche trattate in queste pagine si riferiscono ai contenuti della sezione in corso ma, in modo semplificato (“chiaro”) e con il testo ad alta leggibilità, particolarmente utile anche (ma non solo) per situazioni di BES/DSA.
Pagina dedicata in modo speciale espressamente all'Arte, in modo operativo e direttamente connesso alle tematiche delle sezioni in corso. Quando l'Arte... insegna!
Sintetizza e riassume i contenuti della sezione ed è caratterizzata dal colore azzurrino. Il testo delle mappe, corredato di immagini significative, è scritto per tutte e cinque le classi in stampato maiuscolo con font (carattere) certificato per la lettura facilitata.
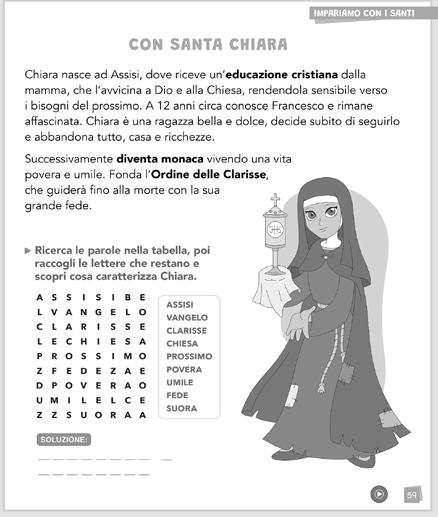
“Impariamo con i Santi” è una serie di pagine speciali dedicata a numerosi Santi e Sante (dall'antichità ai giorni d'oggi) che rappresentano una significativa testimonianza dei valori non solo del Vangelo, ma anche della solidarietà, pace, dialogo e accoglienza.
Per ognuna delle 5 classi sono proposte figure inerenti le tematiche trattate e, in questa guida didattica, sempre in relazione ai medesimi Santi e Sante ci sono letture, laboratori e numerose schede operative aggiuntive.
Diversi box presenti all’interno del testo, ciascuno dei quali ha una sua caratteristica particolare e presentano le attività proposte in modi e tipologie differenti:
BOX ATTIVITÀ: propone dei piccoli esercizi o attività relative al testo letto;
BOX RACCONTA: suggerisce all’insegnante le domande utili per il confronto e la discussione in classe;
BOX LO SAPEVI CHE?: presenta delle curiosità o aspetti particolari dei vari argomenti trattati;
BOX PAROLE NUOVE: definisce parole nuove o difficili.

A inizio di ciascuna sezione tematica di ogni classe un Qrcode permette di accedere alle risorse digitali speciali inerenti le tematiche delle sezioni stesse.
Corso di religione CattoliCa per la sCuola primaria Presentazione del progetto
consistono, in primis, nel libro digitale sfogliabile in MODALITÀ INTERATTIVA, con numerose opzioni: lettura audio vocale del testo, possibilità di impaginazione fluida lineare per BES/DSA con font e fondini ad alta leggibilità, evidenziazione/esclusione di parti sulla pagina, annidamento di appunti (testo, immagini, link…) e molto altro.
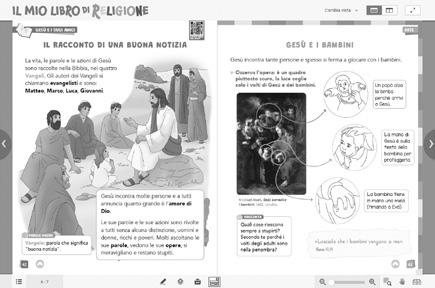
Tra gli elementi digitali presenti per ogni sezione tematica, vi sono degli APPROFONDIMENTI DI CONTENUTO considerabili come "espansioni" del testo stesso degli alunni.
Queste le espansioni proposte.
Classe prima
Wow, che emozioni!
Costruire o creare
Quando arriva Natale
Case di un tempo
La Pasqua e i suoi segni
Classe terza
La Bibbia dei poveri
Il valore ospitalità
I nomi nella Bibbia
Un passaggio portentoso
Nel campo dei pastori
Classe seconda
Il dono di Madre Terra
L’Annunciazione nell’arte
Il rito del Battesimo
Gli ultimi giorni di Gesù
Nel mondo della preghiera
Classe quarta
Nelle grotte di Altamira
Una storia avvincente
Nel mondo dei Vangeli
Paesaggi palestinesi
I successori di Pietro
Classe quinta
Chiesa, Duomo, Cattedrale, Santuario L’Islamismo
Un Dio in tre Persone L’Induismo
Tra conventi e monasteri
Il Buddismo in Italia
L’arcipelago protestante Il Buddismo
La tradizione ebraica
Le religioni tradizionali africane
Corso di religione CattoliCa per la sCuola primaria
Presentazione del progetto
Il testo, nell’ottica di un approccio protagonista e creativo dei contenuti, propone per ogni unità didattica e per ciascuna classe, un COMPITO DI REALTÀ (oltre a quelli presenti nel cartaceo) dando istruzioni online e fornendo anche elementi per la valutazione mediante le “Competenze chiave” a valenza europea.
Questi i compiti di realtà proposti.
Classe prima
La mappa dei nomi
Viaggio nel passato
Tre doni speciali
Non sono mai solo
Coi 5 sensi in chiesa
Classe terza
Al quiz della Bibbia
Abramo all’anagrafe
Interpretatori di sogni
Una rassegna poetica
Le regole dell’amicizia
Classe quinta
Itinerari del territorio
In tribunale dinanzi ai cristiani
Giornalisti di cronaca bianca
Tutti in redazione
Un documento ecumenico
Classe seconda
Esploratori naturali
Io, presepista
Donne di ieri e di oggi
Intervista agli Apostoli
La prima comunità cristiana
Classe quarta
Indagine sul senso della vita
Le feste della luce
Maschi vs femmine
Con l’emozionometro
Il valore di un pasto insieme
Corso di religione CattoliCa per la sCuola primaria
Presentazione del progetto
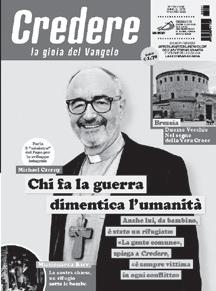
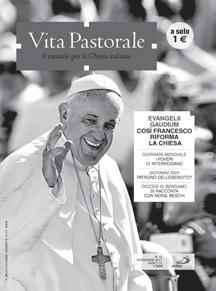

programmazione didaTTiCa annuale per unità di apprendimento
Periodo: settembre-ottobre
Traguardi per lo Sviluppo delle Compe T enze o bie TT ivi di a pprendimen T o
L’alunno
• riflette sulle emozioni e sulle esperienze dei primi giorni di scuola;
• impara il senso della condivisione e del rispetto degli oggetti;
• sviluppa il senso di convivenza e appartenenza al gruppo classe.
I valori etici e religiosi
• Scoprire la bellezza dello stare insieme e sviluppare sentimenti di rispetto e fiducia verso gli altri.
• Prendere coscienza della dimensione religiosa dell’uomo attraverso la scoperta delle emozioni.
Periodo: ottobre-novembre
Traguardi per lo Sviluppo delle Compe T enze
L’alunno
• è in grado di riflettere su Dio Creatore e Padre e di confrontarsi con l’esperienza religiosa;
L’alunno
fa propria la nuova esperienza scolastica e conosce nuovi compagni; attraverso il confronto con i pari, coglie l’unicità di ciascuno.
• Che cos’è la scuola?
• Eccomi a scuola
• Una nuova avventura
• Io come una matita
• Io sono unico
• Pronti, partenza, via!
• La mia scuola
• A scuola per imparare
• A scuola di emozioni
• Nel mio zaino
• Campioni del cuore
• riconosce che la Bibbia è il libro sacro per i cristiani. Dio e l’uomo
• Scoprire che per la religione cristiana
Dio è Creatore e Padre
La Bibbia e le altre fonti
• Ascoltare la storia biblica sulla creazione
I valori etici e religiosi
• Scoprire che il creato è un dono da rispettare.
L’alunno
inizia ad aprirsi agli altri e a riconoscere il mondo intorno a sé come un dono creato da Dio.
• La storia della creazione
• Il mondo intorno a me
• San Francesco
• Il rispetto della natura
• Dio crea, l’uomo costruisce
Programmazione didattica annuale per unità di apprendimento
Periodo: dicembre-gennaio
Traguardi per lo Sviluppo delle Compe T enze o bie TT ivi di a pprendimen T o
L’alunno
• riconosce il significato cristiano del Natale. Il linguaggio religioso
• Riconoscere i segni cristiani del Natale nell’ambiente, nelle celebrazioni e nella tradizione popolare.
• Saper collegare alcuni segni e simboli delle feste che rappresentano.
Periodo: gennaio-febbraio-marzo
L’alunno
scopre, attraverso l’osservazione del mondo che lo circonda, che il Natale è una festa fondamentale per la tradizione cristiana.
• Io sono speciale
• Si avvicina il Natale
• San Nicola
• Segni e simboli di Natale
• Una mamma speciale
• Giuseppe il falegname
• Da Nazaret a Betlemme
• La nascita di Gesù
• L’arrivo dei magi
Traguardi per lo Sviluppo delle Compe T enze o bie TT ivi di a pprendimen T o
L’alunno
• riflette sui dati fondamentali della vita di Gesù.
Dio e l’uomo
• Scoprire che Gesù è stato un bambino come tutti;
• Conoscere Gesù di Nazareth;
• Ricostruire alcuni aspetti fondamentali della vita di Gesù.
La Bibbia e le altre fonti
• Ascoltare, leggere e saper riferire circa alcuni semplici episodi chiave dei racconti evangelici.
L’alunno confronta alcuni aspetti dell’infanzia di Gesù e li confronta con la propria vita.
• Una famiglia in Palestina
• Gesù bambino a Nazaret
• Gesù bambino come me
• Io e Gesù
• Gesù incontra tutti
• Santa Gemma Galgani
• Il Vangelo di Gesù
• Un messaggio d’Amore
• Gli amici di Gesù
• I dodici apostoli
• Le parabole di Gesù
• La giornata della gentilezza
• I miracoli di Gesù
programmazione didaTTiCa annuale per unità di apprendimento
Periodo: marzo-aprile
Traguardi per lo Sviluppo delle Compe T enze o bie TT ivi di a pprendimen T o o bie TT ivi formaT ivi Con T enu T i didaTT i C i
L’alunno
• riconosce il significato cristiano della Pasqua.
Periodo: maggio-giugno
Il linguaggio religioso
• Riconoscere i segni cristiani della Pasqua nell’ambiente, nelle celebrazioni e nella tradizione popolare.
• Saper collegare alcuni segni e simboli delle feste che rappresentano.
L’alunno
Riconosce la primavera come momento di rinascita e scopre la relazione che intercorre con la morte e la risurrezione di Gesù.
• Arriva la Primavera
• Gesù a Gerusalemme
• Segni e simboli della Pasqua
• È Pasqua, Gesù risorge
• Un “passaggio” necessario
• La storia di Pasqua
Traguardi per lo Sviluppo delle Compe T enze o bie TT ivi di a pprendimen T o
L’alunno
• identifica nella Chiesa la comunità di coloro che credono in Gesù Cristo. Dio e l’uomo
• Individuare i tratti essenziali della Chiesa.
I valori etici e religiosi
• Riconoscere il valore della domenica come giorno sacro per i cristiani.
• Conoscere, per maturare forme di rispetto, i luoghi sacri delle religioni più diffuse al mondo.
L’alunno impara ad aprirsi al mondo confrontando la propria esperienza religiosa con quella dei compagni provenienti da paesi differenti; riconosce la Chiesa come propria comunità di appartenenza.
• La comunità è un dono
• Io sono un dono per la comunità
• La casa dei cristiani
• Dentro la Chiesa
• Cristiani, ebrei e musulmani
• I luoghi della preghiera
• Per un mondo di pace
• Santa Caterina da Siena
Programmazione didattica annuale per unità di apprendimento
Obiettivi minimi
• Scoprire che la natura è un dono di Dio.
• Comprendere che Dio crea dal nulla e l’uomo costruisce elaborando ciò che è stato creato.
• Sviluppare atteggiamenti di cura e rispetto per il creato.
• Riconoscere l’edificio chiesa tra le vie del paese.
• Conoscere Gesù e la sua famiglia.
• Riconoscere le principali feste cristiane.
• Prendere coscienza del nuovo gruppo nel quale si viene inseriti.
• Cogliere il valore del rispetto all’interno del gruppo classe.
Competenze finali
L’alunno…
• si rende conto che per i credenti la realtà naturale ed umana che lo circonda è un dono amorevole di Dio, in riposta al quale si esprimono sentimenti di gratitudine;
• acquisisce una prima consapevolezza della presenza, nel proprio ambiente sociale, di elementi del cristianesimo.
• sa riferire gli eventi principali della vita di Gesù e, cogliendone il significato religioso, si rende conto dell’incidenza che ha nella vita sociale.
• sa riconoscere e rispettare altre realtà religiose presenti nella società, individuandone i tratti salienti più evidenti.
Metodologia
• Lezione interattiva.
• Lavoro individuale.
• Lavoro di gruppo.
• Conversazioni guidate.
Materiali
• Libro di testo.
• Allegati al testo.
• Quaderni.
• Schede e immagini.
• Disegni.
• Materiale audiovisivo.
Spazi
• Aula.
• Aula informatica.
• Biblioteca.
• LIM
Discipline coinvolte: Italiano, Arte e immagine, Inglese, Matematica, Musica, Storia
Verifica e valutazione (degli obiettivi e delle competenze)
• Compiti di realtà su obiettivi relativi a uno o più traguardi.
• La prova sarà valutata in base ai livelli definiti dalla rubrica valutativa del curricolo verticale
• Osservazione sistematica dei progressi nel processo di apprendimento.
• Per gli alunni alloglotti, con H, con DSA, con scheda BES, si fa riferimento ai documenti appositamente predisposti.
• La valutazione terrà conto dei livelli di partenza e dei progressi compiuti, nonché dell’impegno e del grado di maturazione.
programmazione didaTTiCa annuale per unità di apprendimento
Il percorso della classe prima è scandito dalle sei unità di apprendimento che affrontano, in ordine, i seguenti argomenti:
1-2 Primi giorni / A scuola per..., l’accoglienza come valore di condivisione e unità, per vivere insieme un momento di crescita;
3 Una storia d’Amore, la creazione e il tema della vita, l’esistenza, per i cristiani e per altre esperienze religiose, di un Creatore;
4 È Natale, la festa del Natale, dai cristiani intesa come un dono di Dio, e un momento di pace e amore per tutti;
5 Ecco Gesù, la conoscenza, in modo ampio e generale, della figura di Gesù di Nazaret;
6 È Pasqua, la Pasqua cristiana, attraverso i suoi segni e i suoi significati, una festa di vita e di gioia per tutti;
7 Ecco la Chiesa, la Chiesa intesa come comunità, dove stare bene con gli altri, e quale luogo di preghiera dei cristiani.
Competenze in Chiave Europee
• Alfabetica funzionale.
• Personale, sociale e capacità di imparare a imparare.
• Multilinguistica.
• Matematica e competenza in scienze, tecnologia e ingegneria.
• Consapevolezza ed espressione culturali.
• Cittadinanza.
Metodologia, spazi e materiali
• Lezione interattiva.
• Lavoro individuale e di gruppo.
• Conversazioni guidate.
• Libro di testo e allegati.
• Quaderni.
• Schede, disegni e immagini.
• Materiale audiovisivo.
• Aula (classica, LIM, informatica).
Verifica e valutazione
• Compiti di realtà su obiettivi relativi a uno o più traguardi.
• La prova sarà valutata in base ai livelli definiti dalla rubrica valutativa del curricolo verticale.
• Osservazione sistematica dei progressi nel processo di apprendimento.
• Per gli alunni alloglotti, con H, con DSA, con scheda BES, si fa riferimento ai documenti appositamente predisposti.
• La valutazione terrà conto dei livelli di partenza e dei progressi compiuti, nonché dell’impegno e del grado di maturazione.
Saranno coinvolte le seguenti discipline: Educazione Civica, Italiano, Arte e immagine, Inglese, Matematica, Musica, Storia.
Programmazione didattica annuale per unità di apprendimento
Traguardi per lo Sviluppo delle Competenze L’alunno…
• riflette sulle emozioni e sulle esperienze dei primi giorni di scuola;
• impara il senso della condivisione e del rispetto degli oggetti;
• sviluppa il senso di convivenza e appartenenza al gruppo classe;
• è in grado di riflettere su Dio Creatore e Padre e di confrontarsi con l’esperienza religiosa;
• riconosce che la Bibbia è il libro sacro per i cristiani;
• riconosce il significato cristiano del Natale e della Pasqua;
• riflette sui dati fondamentali della vita di Gesù;
• identifica nella Chiesa la comunità di coloro che credono in Gesù Cristo.
Obiettivi di Apprendimento d io e l’uomo l a b ibbia e le alT re fon T i i l linguaggio religio S o i valori
• Scoprire che per la religione cristiana Dio è Creatore e Padre.
• Scoprire che Gesù è stato un bambino come tutti.
• Conoscere Gesù di Nazareth.
• Ricostruire alcuni aspetti fondamentali della vita di Gesù.
• Individuare i tratti essenziali della Chiesa.
• Ascoltare la storia biblica sulla creazione e di alcuni episodi chiave dei racconti evangelici.
• Riconoscere i segni cristiani del Natale e della Pasqua nell’ambiente, nelle celebrazioni e nella tradizione popolare.
• Saper collegare alcuni segni e simboli delle feste che rappresentano.
• Scoprire la bellezza dello stare insieme e sviluppare sentimenti di rispetto e fiducia verso gli altri.
• Prendere coscienza della dimensione religiosa dell’uomo attraverso la scoperta delle emozioni.
• Scoprire che il creato è un dono da rispettare.
• Riconoscere il valore della domenica come giorno sacro per i cristiani.
• Conoscere, per maturare forme di rispetto, i luoghi sacri delle religioni più diffuse al mondo.
programmazione didaTTiCa annuale per unità di apprendimento
• Che cos’è la scuola?
• Eccomi a scuola
• Una nuova avventura
• Io come una matita
• Io sono unico
• Pronti, partenza, via!
• La mia scuola
• A scuola per imparare
• A scuola di emozioni
• Nel mio zaino
• Campioni del cuore
• La storia della creazione
• Il mondo intorno a me
• San Francesco
• Il rispetto della natura
• Dio crea, l’uomo costruisce
• Io sono speciale
• Si avvicina il Natale
• San Nicola
• Segni e simboli di Natale
• Una mamma speciale
• Giuseppe il falegname
• Da Nazaret a Betlemme
• La nascita di Gesù
• L’arrivo dei magi
• Una famiglia in Palestina
• Gesù bambino a Nazaret
• Gesù bambino come me
• Io e Gesù
• Gesù incontra tutti
• Santa Gemma Galgani
• Il Vangelo di Gesù
• Un messaggio d’Amore
• Gli amici di Gesù
• I dodici apostoli
• Le parabole di Gesù
• La giornata della gentilezza
• I miracoli di Gesù
• Arriva la Primavera
• Gesù a Gerusalemme
• Segni e simboli della Pasqua
• È Pasqua, Gesù risorge
• Un “passaggio” necessario
• La storia di Pasqua
• La comunità è un dono
• Io sono un dono per la comunità
• La casa dei cristiani
• Dentro la Chiesa
• Cristiani, ebrei e musulmani
• I luoghi della preghiera
• Per un mondo di pace
• Santa Caterina da Siena
• Percepire la dimensione del sé e dell’altro.
• Scoprire il mondo come una realtà meravigliosa.
• Riconoscere come nella bellezza del creato gli uomini possono scoprire tracce di Dio.
• Comprendere che per i cristiani il mondo è un dono di Dio.
• Scoprire gli elementi della festa e comprendere il “fare festa” come momento per ricordare eventi importanti e da vivere insieme con gioia;
• Conoscere le caratteristiche principali delle feste cristiane del Natale e della Pasqua;
• Realizzare che i cristiani a Natale ricordano la nascita di Gesù, e a Pasqua celebrano la sua risurrezione.
• Scoprire l’ambiente dove Gesù è cresciuto, attraverso un confronto tra la vita quotidiana nella Palestina di quel tempo ed il vissuto di oggi.
• Percepire che il messaggio di Gesù è “universale”, cioè “buono” per tutti gli uomini.
• Scoprire che i cristiani si riuniscono ogni domenica in chiesa per celebrare la messa;
• Scoprire il valore del gesto del segno di croce dei cristiani;
• Scoprire gli elementi principali presenti all’interno dell’edificio chiesa.
L’alunno…
• sa essere consapevole delle diverse fasi della propria crescita;
• prendendo coscienza di sé nella relazione con gli altri e con l’ambiente che lo circonda, sa vivere la dimensione dell’incontro;
• sa maturare atteggiamenti di rispetto, condivisione e collaborazione;
• scoprendo la realtà naturale che lo circonda sa manifestare stupore di fronte alle bellezze del mondo;
• riconosce che il creato e la vita, per i cristiani, sono un dono di Dio;
• sa individuare nell’ambiente che lo circonda le cose create da Dio distinguendole da quelle costruite dall’uomo.
• Sa riconoscere nell’ambiente i segni e i simboli che caratterizzano le feste cristiane del Natale e della Pasqua e ne comprende il significato;
• conosce i principali episodi evangelici legati alla nascita e alla risurrezione di Gesù.
• conosce alcuni aspetti della persona e dell’ambiente di Gesù;
• descrive gli aspetti fondamentali della vita di Gesù, confrontandoli con la propria esperienza;
• attua e sperimenta atteggiamenti congrui con il messaggio d’amore insegnato da Gesù.
• percepisce la preghiera come dimensione di dialogo tra gli uomini e Dio;
• riconosce la Chiesa come luogo di preghiera per i cristiani, e ne sa individuare gli elementi fondamentali;
• sa riconoscere nella croce il simbolo principale della religione cristiana.
ALFABETICA FUNZIONALE
PERSONALE, SOCIALE E CAPACITÀ DI IMPARARE A IMPARARE
MULTILINGUISTICA
MATEMATICA E COMPETENZA IN SCIENZE, TECNOLOGIA E INGEGNERIA
CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALI
CITTADINANZA
Programmazione didattica annuale per unità di apprendimento
Competenze in Chiave Europee
• Esprimere la propria opinione e riportare un avvenimento.
• Arricchire il proprio linguaggio con lessico specifico.
• Acquisire e assimilare nuove conoscenze.
• Conoscere nuovi termini e vocaboli di lingue differenti.
• Utilizzare il pensiero matematico per risolvere semplici problemi.
• Esprimere in modo creativo le emozioni personali attraverso semplici disegni.
• Avvicinarsi a un’opera d’arte.
• Rispettare i turni di parola.
• Mettere in atto prime competenze collaborative.
raCCordo diSCiplinare Con: eduCazione CiviCa
L’educazione civica favorisce il riconoscimento di valori e comportamenti coerenti con la Costituzione attraverso il dialogo e il rispetto reciproco, volti a incoraggiare un pensiero critico personale, aperto e costruttivo, in un percorso formativo che, coinvolgendo la persona nella sua interezza e unitarietà.
Nucleo tematico: Costituzione diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà.
Traguardi per il raggiungimento delle competenze 1
• Sviluppare atteggiamenti e adottare comportamenti fondati sul rispetto di ogni persona, sulla responsabilità individuale, sulla legalità, sulla consapevolezza della appartenenza ad una comunità, sulla partecipazione e sulla solidarietà, sostenuti dalla conoscenza della Carta costituzionale, della Carta dei Diritti fondamentali dell’Unione Europea e della Dichiarazione Internazionale dei Diritti umani.
Obiettivi di Apprendimento
• Individuare i diritti e i doveri che interessano la vita quotidiana di tutti i cittadini, anche dei più piccoli. Condividere regole comunemente accettate. Sviluppare la consapevolezza dell’appartenenza ad una comunità locale, nazionale ed europea.
• Rispettare ogni persona, secondo il principio di uguaglianza e di non discriminazione di cui all’articolo 3 della Costituzione. Riconoscere, evitare e contrastare forme di violenza e bullismo presenti nella comunità scolastica.
• Curare gli ambienti, rispettare i beni pubblici e privati così come le forme di vita (piante, animali) che sono state affidate alla responsabilità delle classi.
• Aiutare, singolarmente e in gruppo, coloro che presentino qualche difficoltà per favorire la collaborazione tra pari e l’inclusione di tutti.
Programmazione didattica annuale per unità di apprendimento
Traguardi per il raggiungimento delle competenze 2
• Interagire correttamente con le istituzioni nella vita quotidiana, nella partecipazione e nell’esercizio della cittadinanza attiva, a partire dalla conoscenza dell’organizzazione e delle funzioni dello Stato, dell’Unione europea, degli organismi internazionali, delle Regioni e delle Autonomie locali. Essere consapevoli dell’appartenenza ad una comunità, locale e nazionale.
Obiettivi di Apprendimento
• Conoscere il valore e il significato dell’appartenenza alla comunità nazionale.
• Conoscere il contenuto generale delle Dichiarazioni Internazionali dei diritti della persona e dell’infanzia. Individuare alcuni dei diritti previsti nell’ambito della propria esperienza concreta.
Traguardi per il raggiungimento delle competenze 3
• Rispettare le regole e le norme che governano la democrazia, la convivenza sociale e la vita quotidiana in famiglia, a scuola, nella comunità, al fine di comunicare e rapportarsi correttamente con gli altri, esercitare consapevolmente i propri diritti e doveri per contribuire al bene comune e al rispetto dei diritti delle persone.
Obiettivi di Apprendimento
• Conoscere ed applicare le regole vigenti in classe e nei vari ambienti della scuola (mensa, palestra, laboratori, cortili) e partecipare alla loro eventuale definizione o revisione. Conoscere il principio di uguaglianza nella consapevolezza che le differenze possono rappresentare un valore quando non si trasformano in discriminazioni.
• Conoscere i principali fattori di rischio dell’ambiente scolastico, adottare comportamenti idonei a salvaguardare la salute e la sicurezza proprie e altrui e contribuire a definire comportamenti di prevenzione dei rischi.
Traguardi per il raggiungimento delle competenze 4
• Sviluppare atteggiamenti e comportamenti responsabili volti alla tutela della salute e del benessere psicofisico.
Obiettivi di Apprendimento
• Conoscere e attuare le principali regole per la cura della salute, della sicurezza e del benessere proprio e altrui, a casa, a scuola, nella comunità, dal punto di vista igienico-sanitario, alimentare, motorio, comportamentale.
Programmazione didattica annuale per unità di apprendimento
Nucleo tematico: Sviluppo economico e sostenibilità educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio
Traguardi per il raggiungimento delle competenze 5
• Comprendere l’importanza della crescita economica e del lavoro. Conoscere le cause dello sviluppo economico e sociale in Italia ed in Europa, le diverse attività economiche. Sviluppare atteggiamenti e comportamenti responsabili volti alla tutela dell’ambiente, del decoro urbano, degli ecosistemi e delle risorse naturali per una crescita economica rispettosa dell’ambiente e per la tutela della qualità della vita.
Obiettivi di Apprendimento
• Conoscere le condizioni della crescita economica. Comprenderne l’importanza per il miglioramento della qualità della vita e ai fini della lotta alla povertà. Individuare, con riferimento alla propria esperienza, ruoli, funzioni e aspetti essenziali che riguardano il lavoro delle persone con cui si entra in relazione, nella comunità scolastica e nella vita privata. Riconoscere il valore del lavoro.
• Riconoscere, a partire dagli ecosistemi del proprio territorio, le trasformazioni ambientali ed urbane dovute alle azioni dell’uomo; mettere in atto comportamenti alla propria portata che riducano l’impatto negativo delle attività quotidiane sull’ambiente e sul decoro urbano.
Traguardi per il raggiungimento delle competenze 6
• Comprendere le cause dei cambiamenti climatici, gli effetti sull’ambiente e i rischi legati all’azione dell’uomo sul territorio.
Obiettivi di Apprendimento
• Conoscere ed attuare i comportamenti adeguati a varie condizioni di rischio (sismico, vulcanico, idrogeologico, climatico, …).
• Individuare alcune trasformazioni ambientali e gli effetti del cambiamento climatico.
Traguardi per il raggiungimento delle competenze 7
• Maturare scelte e condotte di tutela dei beni materiali e immateriali.
Obiettivi di Apprendimento
• Identificare nel proprio ambiente di vita gli elementi che costituiscono il patrimonio artistico e culturale, materiale e immateriale, anche con riferimento alle tradizioni locali, ipotizzando semplici azioni per la salvaguardia e la valorizzazione.
• Riconoscere, con riferimento all’esperienza, che alcune risorse naturali (acqua, alimenti…) sono limitate e ipotizzare comportamenti di uso responsabile, mettendo in atto quelli alla propria portata.
Programmazione didattica annuale per unità di apprendimento
Traguardi per il raggiungimento delle competenze 9
• Maturare scelte e condotte di contrasto all’illegalità.
Obiettivi di Apprendimento
• Conoscere le varie forme di criminalità, partendo dal rispetto delle regole che ogni comunità si dà per garantire la convivenza. Conoscere la storia dei vari fenomeni mafiosi, nonché riflettere sulle misure di contrasto. Conoscere il valore della legalità.
Nucleo tematico: Cittadinanza digitale educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio
Traguardi per il raggiungimento delle competenze 10
• Sviluppare la capacità di accedere alle informazioni, alle fonti, ai contenuti digitali, in modo critico, responsabile e consapevole.
Obiettivi di Apprendimento
• Ricercare in rete semplici informazioni, distinguendo dati veri e falsi.
• Riconoscere semplici fonti di informazioni digitali.
Traguardi per il raggiungimento delle competenze 11
• Interagire con gli altri attraverso le tecnologie digitali consentite, individuando forme di comunicazione adeguate ai diversi contesti di relazione, adottando e rispettando le regole comportamentali proprie di ciascun contesto comunicativo.
Obiettivi di Apprendimento
• Interagire con strumenti di comunicazione digitale, quali tablet e computer.
• Conoscere e applicare semplici regole per l’utilizzo corretto di strumenti di comunicazione digitale, quali tablet e computer.
• Conoscere e applicare le principali regole di partecipazione alle classi virtuali e alle piattaforme didattiche.
Programmazione didattica annuale per unità di apprendimento
Traguardi per il raggiungimento delle competenze 12
• Gestire l'identità digitale e i dati della rete, salvaguardando la propria e altrui sicurezza negli ambienti digitali, evitando minacce per la salute e il benessere fisico e psicologico di sé e degli altri.
• Conoscere il significato di identità e di informazioni personali in semplici contesti digitali di uso quotidiano.
• Conoscere i rischi connessi con l’utilizzo degli strumenti digitali in termini di sicurezza personale.
• Riconoscere, evitare e contrastare le varie forme di bullismo e cyberbullismo.
Traguardi per lo Sviluppo delle Competenze L’alunno…
• riflette sulle emozioni e sulle esperienze dei primi giorni di scuola;
• impara il senso della condivisione e del rispetto degli oggetti;
• sviluppa il senso di convivenza e appartenenza al gruppo classe

u ni Ta di apprendimen T o p er la p rogrammazione S e TT imanale r iferimen T i al T e ST o o bie TT ivi di apprendimen T o
Primi giorni
• Prendere coscienza di sé. Scoprire la propria identità.
• La scuola, i suoi ambienti e i suoi elementi.
• Uguaglianza e diversità: il valore delle relazioni interpersonali.
Da pag. 2 a pag. 11 I valori etici e religiosi
• sa essere consapevole delle diverse fasi della propria crescita;
• fondamentali; sa riconoscere nella croce il simbolo principale della religione cristiana.
I bambini, provenienti dall’esperienza della Scuola dell’infanzia, dopo la pausa estiva, si ritrovano davanti l’INGRESSO NELLA SCUOLA PRIMARIA . Questo è un momento molto importante, perché sono chiamati ad affrontare MOLTE NOVITÀ: compagni, insegnanti, collaboratori scolastici, luoghi da conoscere. La prima parte del percorso didattico, che ha lo scopo di FAVORIRE L’INSERIMENTO E L’ACCOGLIENZA di tutti, deve essere segnato dal “gioco”. Grazie all’attività ludica, si ha la possibilità di conoscere meglio se stessi, in quanto, giocando, i bambini (ma anche gli adulti) si mostrano per quel che sono veramente, in piena spontaneità. Inoltre, attraverso il gioco, i bambini vengono aiutati a SUPERARE DIFFICOLTÀ
E TIMIDEZZE. Di fondamentale importanza sarà quindi, creare un clima sereno, distensivo e accogliente, attraverso la presentazione di vari giochi che favoriscano l’INTESA DI GRUPPO, il CONFRONTO TRA GLI ALUNNI e il RISPETTO RECIPROCO.
L’insegnante, grazie alle attività didattiche e ludiche proposte, avrà la possibilità di conoscere meglio i singoli alunni e l’intero gruppo classe, mettendo in evidenza alcuni fattori:
• il nome di ciascuno e la propria identità, che rende unico ogni bambino e bambina;
• i nuovi spazi e i materiali, il conoscere e il sapersi muovere all’intero della nuova scuola;
• il valore dell’amicizia, inteso come esperienza di condivisione e solidarietà;
• i valori dell’uguaglianza e della diversità, sottolineando come nel mondo siamo in tanti e tutti diversi e che dobbiamo imparare a vivere insieme.
Leggiamo ai bambini il racconto che segue, li aiuterà a capire l’importanza di avere un nome e di avere persone che li conoscono e li chiamano per nome. Dopo il racconto, proponiamo loro delle domande e la scheda 1 di pagina 35 con i disegni da sistemare nel corretto ordine logico-temporale.
C’era una bambina che aveva un nome come tutti i bambini del mondo. Era allegra, e andava spesso a giocare in un certo giardino. Un giorno lanciò la palla al di là di una siepe e, quando andò a cercarla, non la trovò. Cerca qua, cerca là, la palla non c’era: la bambina era stupita e anche un po’ spaventata. A un tratto sentì una vocina in alto: «È tua questa bella palla, piccina?».
La bambina guardò su, e vide un omettino magro seduto a cavallo di un ramo: aveva la palla tra le mani. «Certo che è mia. Dammela!», disse la bambina.
«E tu cosa mi dai, in cambio?».
«Niente! La palla è mia!».
«Ma adesso ce l’ho io!».
«Non ho niente da darti!» disse la bambina.
«Sì che ce l’hai: dammi il tuo nome!».
Pensando che l’ometto scherzasse, la bambina gli disse: «Va bene, te lo do: butta la palla!». Quello sorrise, lasciò cadere la palla, lei la prese e tornò a casa: si sentiva strana.
E più strana si sentì quando si accorse che la salutavano senza più dire il suo nome: poi pensandoci, si accorse che nemmeno lei lo ricordava.
«Mamma, come mi chiamo io?» chiese allora la bambina a sua madre.
«Tu? Non hai nessun nome!» rispose la mamma.
La bambina andò a guardare i suoi libri, i suoi quaderni, e vide che non c’era nessun nome.
«Tu, scendi a fare merenda!» gridò la mamma di sotto.
«La mamma mi ha sempre detto di non chiamare nessuno Tu. È proprio perché io un nome non ce l’ho...» pensò con
tristezza.
Allora, piangendo, la bambina prese la palla, andò in giardino, arrivò sotto l’albero.
L’omino era ancora lassù, con la mano chiusa, e sorrideva.
«Ridammi il mio nome! -
gridò la bambina - Ti darò la palla, se vuoi».
«Tieniti la palla, piccolina, e anche il tuo nome: e un’altra volta, non darlo a nessuno, capito?». Aprì la mano e, all’improvviso, la bambina ricordò di chiamarsi
Antonella.
Antonella si mise a saltare per la gioia. Corse a casa e la mamma chiese: «Dove sei andata, Antonella?». «Avevo perso una cosa importante, mamma»
disse la bambina. E lo disse così seria che la mamma le diede un bacio di quelli che fanno rumore.
R. Piumini - N. Costa, C’era una volta, ascolta, Edizioni EL
• Come si chiama la bambina, protagonista del racconto?
• Che cosa le succede?
• Che cosa le propone l’omino?
• Antonella, cosa comprende dopo lo scambio?
• Anche tu hai un nome: chi conosce il tuo nome?
Gigetto è un bambino di sei anni che, da pochi giorni, ha iniziato la sua nuova avventura nella Scuola Primaria del suo quartiere. È un bimbo sveglio, vivace e un po’ birichino.
Gli piace andare a scuola perché incontra tanti compagni con cui giocare: c’è Marietto che porta sempre le figurine da scambiare, c’è Luisella con le penne brillantate con cui disegnare delle bellissime macchinine sportive e c’è Bruno con cui giocare a palla fuori in cortile.
Insomma la scuola per lui è una pacchia… quando si può giocare! Il lato che non sopporta della scuola sono i compiti da fare: «Uffa, bisogna sempre faticare!» pensava ogni volta che doveva scrivere o fare dei calcoli o imparare a memoria delle poesie.
Nei momenti in cui rifiutava di far fatica, la sua grande immaginazione spaziava e lo portava a fare dei sogni ad occhi aperti: immaginava una scuola dove non c’erano maestri, ma solamente tanti bambini simpatici con cui giocare tutto il giorno.
Una bella mattina, nel mezzo di un piccolo racconto da ricopiare sul quaderno, la sua fantasia lo trasportò nella sua scuola ideale… Che bello!
Stava giocando con i suoi amici a pallone in palestra quando, all’improvviso, un corto circuito nella presa di corrente fa scoppiare un incendio! I bambini sono soli, non hanno adulti che li controllano o a cui rivolgersi, perciò si spaventano e vanno in panico. Gigetto è costretto a prendere in mano la situazione e decide di chiamare i pompieri. Sicuro di questa decisione, parte e va al vicino telefono ma scopre che per telefonare occorre saper cercare il numero sulla guida telefonica e, ahimè, lui non ha voluto imparare a leggere e a conoscere i numeri… era troppo faticoso… Cosa deve fare per salvare se stesso e i bambini?
RIFLETTIAMO
• Come viene presentato Gigetto?
• Come si chiamano i tre compagni?
• Come descrive la sua scuola ideale?
• Prova a dare un finale a questa storia.
L’insegnante leggerà la STORIA DELL’ELEFANTINO
ELMER
, quindi in classe i bambini parleranno di quando si sono sentiti diversi come il protagonista, che dovranno colorare seguendo le indicazioni numeriche date dopo il racconto.
C’era una volta un branco di elefanti. Ce n’erano di vecchi e di giovani, di alti e di bassi, di grassi e di magri, ma erano tutti dello stesso colore: color ...elefante! Tutti, tranne Elmer. Elmer era diverso, era differente da loro perché era color ...Arlecchino. Lo conoscete questo colore? No?!? E allora vi diremo che Elmer era giallo, era verde, era arancione, era rosso, era blu, era viola, era lilla, era bianco, era azzurro, era nero …insomma era di tutti i colori, ma non era di color elefante. Elmer era sempre felice e spensierato e rendeva allegri tutti gli altri elefanti. A volte lo prendevano in giro, ma dovunque c’era un sorriso, era Elmer che lo aveva acceso.
Una notte, mentre tutti gli elefanti dormivano, Elmer non riusciva a prendere sonno e mille pensieri tristi giravano nella sua testa. “Mi sono stancato di essere un elefante diverso dagli altri; che cosa se ne fanno di un elefante a toppe? Ecco perché, giustamente, ridono di me!”. Così, prima che tutti gli elefanti fossero completamente svegli, Elmer lasciò il branco in silenzio, senza farsi notare da nessuno. Mentre camminava nella giungla, incontrò alcuni animali.
«Buongiorno, Elmer!».
«Buongiorno, signor leone».
«Buongiorno, Elmer! Che faccia triste, che cosa ti succede?».
«Buongiorno, signora tigre! Te lo spiegherò un’altra volta!».
«Buongiorno, Elmer! Fermati un po’ con noi».
«Buongiorno, signora zebra! Ho da fare, ora non posso».
Cammina e cammina, finalmente trovò quello che cercava.
“Guarda, un albero con le bacche color elefante. Proprio quello che cercavo!”. Elmer si avvicinò, afferrò l’albero con la sua proboscide e lo scosse, lo scosse, lo scosse con tanta forza per far cadere le bacche a terra.
“Oh, quante! Adesso mi ci tuffo dentro e me le strofino addosso. Come sono fresche e appiccicose!”.
Elmer rotolò, rotolò e rotolò in quel succo grigio. Tutti i suoi bei colori piano piano sparirono ed Elmer diventò tutto grigio: era finalmente color elefante. Quando ebbe finito, era proprio uguale a qualsiasi altro elefante. Tornò nella foresta e incontrò di nuovo gli animali.
«Buongiorno, signor elefante!».
«Buongiorno, signor leone!».
«Buongiorno, signor elefante!».
«Buongiorno, signora tigre!».
«Buongiorno, signor elefante!».
«Buongiorno, cara zebra!».
“Non mi hanno riconosciuto. Che bello! Che bello! Che bello! Sono proprio diventato un elefante come tutti gli altri!”.
Quando arrivò al branco, trovò tutti gli altri elefanti in piedi, uno vicino all’altro, e in silenzio. S’infilò fra loro. Nessuno si era accorto che Elmer era tornato nel gruppo. Dopo un po’ a Elmer sembrò che qualcosa non andava: ma che cosa?
“La giungla è la stessa, il cielo ha lo stesso colore azzurro, la nuvola che sta per portare la pioggia è la stessa, gli elefanti sono sempre gli stessi. Eppure c’è qualcosa di diverso!”.
Elmer osservava gli elefanti; erano in piedi ed erano silenziosi. Erano così seri, così silenziosi, così fermi che gli venne voglia di ridere. Chiuse la bocca per non far uscire la risata, ma… “Non ce la faccio, non ce la faccio, non riesco più a trattenermi”.
Alzò la proboscide e la sua risata, trasformatasi in uno strano verso, gli uscì dalla bocca. Gli elefanti, sorpresi, cominciarono a saltare. Allora Elmer scoppiò in una risata a non finire.
Gli altri elefanti cominciarono a dire: «È Elmer! È tornato Elmer!». «Che gioia! Sei tornato! Ci mancavi tanto!». «Evviva Elmer, evviva Elmer, evviva Elmer!». Mentre ridevano, cominciò a cadere la pioggia dal cielo. Il giallo, il verde, l’arancione, il rosso, il blu, il viola, il lilla, il bianco, l’azzurro, il nero presero il posto del grigio sul corpo di Elmer. Parlò il più vecchio degli elefanti: I tuoi scherzi ci sono sempre piaciuti, ma questo è il più divertente che tu ci abbia fatto. Festeggeremo questo giorno ogni anno. Questo sarà il giorno di Elmer. Tutti gli elefanti si dipingeranno di cento colori e Elmer si dipingerà di “color elefante”. Questo è esattamente quello che gli elefanti fanno ogni anno: si colorano e organizzano una sfilata. E se vedete in capo alla fila un solo elefante di color elefante, non sorprendetevi. Quello è proprio Elmer.
L’insegnante legge ai bambini la FAVOLA DEL BRUTTO ANATROCCOLO, e in seguito gli alunni dovranno rispondere alle domande che riguardano il brano.
C’era una volta un brutto anatroccolo, nato in un cortile fra tanti animali: oche, galline, tacchini.
Tutti lo beccavano, perché era molto brutto. Solo la mamma anatra lo difendeva e aveva cura di lui. Disperato, un giorno fuggì e andò in giro per il mondo, ma tutti lo cacciarono. Incontrò perfino dei cacciatori che volevano ucciderlo. Arrivò l’inverno e il brutto anatroccolo aveva tanto freddo. Cercò un rifugio e riuscì a sopravvivere. A primavera era diventato grande e forte. Un giorno, in un ruscello, si incantò a guardare dei cigni bianchi: erano bellissimi. Poi nell’acqua vide la propria immagine e capì che non era più un anatroccolo brutto, ma era diventato anche lui un cigno bellissimo. Allora, finalmente felice, raggiunse gli altri cigni.
• Dove viveva il brutto anatroccolo?
• Perché gli altri animali lo beccavano?
• Chi era l’unica che se ne prendeva cura?
• Dove fuggì il brutto anatroccolo?
• Quando arrivò l’inverno cosa gli successe?
• Cosa successe a primavera?
• Cosa vide riflessa nell’acqua?
• In cosa si trasformò il brutto anatroccolo?
L’oggetto magico
I bambini si dispongono in cerchio. Al loro centro mettiamo il peluche di un animaletto simpatico o un vasetto di fiori. Mettiamoci al centro, prendiamolo in mano e presentiamolo come un oggetto magico per chi lo possiede, dicendo che dà il potere di parlare e di essere ascoltati.
L’oggetto nascosto
Iniziamo noi dicendo: «Mi chiamo maestra/o …, mi piace… e oggi sono felice». Riponiamo l’oggetto al centro e invitiamo un bambino a prenderlo e a parlare come abbiamo fatto noi. Si tratta di dire il proprio nome, ciò che piace e l’emozione che si prova. Ogni volta l’oggetto viene riposto al centro del cerchio e si continua fino a che tutti i bambini hanno potuto parlare di se stessi. Si accompagna momentaneamente un bambino fuori dall’aula. Si nasconde quindi un pupazzo in un angolo dell’aula o in un cassetto. Al suo rientro, gli si spiega che deve trovare il pupazzo e che il gruppo gli farà capire dov’è cantando. La classe esegue un canto conosciuto, alzando il volume della voce ogni volta che il bambino si avvicina al pupazzo e diminuendolo ogni volta che si allontana da esso.
Attraverso le seguenti filastrocche invitiamo i bambini a capire che a scuola non solo si viene per apprendere, ma anche per STRINGERE NUOVE E IMPORTANTI AMICIZIE. Al termine facciamo loro ripetere le strofe che più li divertono.
L’insegnante proporrà la tematica della DIVERSITÀ e dei diversi punti di vista per accettarsi, per conoscere e CONVIVERE BENE CON GLI ALTRI SENZA GIUDIZI e conflitti.
Chi trova un amico
Ho trovato un vero amico, sono proprio fortunato!
Posso dirgli ogni segreto, posso chiedere il suo aiuto.
Ho trovato un vero amico, non sarò mai più da solo, perché chi trova un amico, trova davvero un grande tesoro.
V. Baraldi - E. Storchi
Filastrocca delle differenze
Tu non sei come me: tu sei diverso
Ma non sentirti perso
Anch’io sono diverso, siamo in due
Se metto le mie mani con le tue
Certe cose so fare io, ed altre tu E messi insieme sappiamo far di più
Tu non sei come me: son fortunato
Davvero ti son grato
Perché non siamo uguali:
Vuol dire che tutt’e due siamo speciali
B. Tognolini
Questa mattina nello zainetto sai tu che cosa ci metto?
Non i quaderni e l’astuccio firmato, né per merenda, il cioccolato.
Prova a guardare con attenzione, vi troverai forse un pallone?
Quel che mi serve per questa avventura
sarà per te novità sicura: un fascio lucente di FANTASIA, un pizzico o più di ALLEGRIA, tanta AMICIZIA da regalare e tanta VOGLIA di IMPARARE!
Vorrei una scuola tutta di cioccolato, con il tetto di zucchero filato.
Vorrei una scuola fatta di fiori, con uccelli e farfalle di mille colori.
Vorrei la scuola più grande per me, ma la mia Scuola è la più bella che c’è.
Riordina le sequenze della storia, segnando nei riquadri i numeri delle vignette in successione, e poi colora.
Completa il viso connotandolo con i tratti e le caratteristiche che ti contraddistinguono.
Prova a leggere e collega le azioni ai rispettivi disegni. Colora.
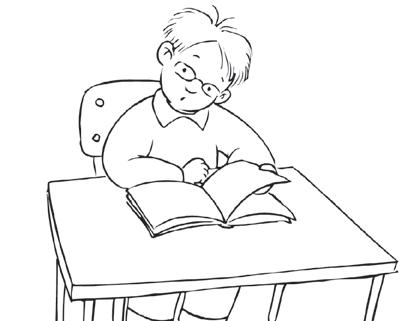

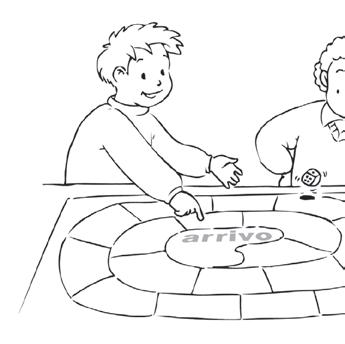





Colora solo i disegni che esprimono amicizia.

Traguardi per lo Sviluppo delle Competenze L’alunno…
• è in grado di riflettere su Dio Creatore e Padre e di confrontarsi con l’esperienza religiosa;
• riconosce che la Bibbia è il libro sacro per i cristiani.

u ni Ta di apprendimen T o p er la p rogrammazione S e TT imanale r iferimen T i al T e ST o o bie TT ivi di apprendimen T o
Una storia d’Amore
• Percepire la grandezza e la bellezza del mondo intorno a sé.
• Scoprire che per i cristiani il mondo è un’opera di Dio.
• Mettere in atto atteggiamenti di rispetto verso il creato.
Da pag. 22 a pag. 27 Dio e l’uomo
• Scoprire che per la religione cristiana Dio è Creatore e Padre.
La Bibbia e le altre fonti
• Ascoltare la storia biblica sulla Creazione.
I valori etici e religiosi
• Scoprire che il creato è un dono da rispettare.
Passiamo come seconda unità, alla SCOPERTA DELL’AMBIENTE NATURALE e delle sue meraviglie.
Ogni bambino e bambina, intorno a sé, ha un mondo tutto da scoprire, al quale si avvicina con stupore e meraviglia, prendendo gradualmente coscienza di ciò che lo circonda.
Attraverso la loro insita spontaneità, un attento spirito di osservazione e tanta curiosità, gli alunni saranno accompagnati a riflettere sull’ESISTENZA DI UN CREATO, bello e immenso, delle sue leggi e dei suoi equilibri.
Una proposta potrebbe essere quella di guidarli fuori nel giardino della scuola per lasciarli liberi di osservare e scrutare coi loro occhi tutto il creato.
Una volta rientrati in classe, saranno loro stessi a raccontare quante sono le cose
belle che ci circondano, sottolineando quelle che a loro piacciono di più e quelle meno.
A questo punto, compito dell’insegnante, sarà quello di accompagnarli nella riflessione che porterà alla conoscenza delle origini e da dove tutto il creato viene, guidandoli alla consapevolezza dell’esistenza di un Dio creatore che per amore dona tutto agli uomini, a partire dalla vita stessa.
Attraverso la lettura di questo racconto i bambini vengono stimolati a PERCEPIRE
L’ESISTENZA DI DIO che ha dato vita a tutto ciò che ci circonda, una vita di cui loro stessi sono parte integrante.
C’era una volta un uomo che voleva conoscere più cose possibili su Dio. Un mattino, dunque, partì per chiedere a tutti gli uomini e a tutte le cose di parlargli di Dio.
Disse al soldato: «Parlami di Dio!».
E il soldato lasciò cadere le armi.
Disse al povero: «Parlami di Dio!».
E il povero gli offrì il suo mantello.
Disse al ciliegio: «Parlami di Dio!».
E il ciliegio fiorì.
Disse alla casa: «Parlami di Dio!».
E la casa aprì la sua porta.
Disse all’albero: «Parlami di Dio!».
E l’albero allargò i suoi rami per proteggerlo dai raggi di sole.
Disse al bambino: «Parlami di Dio!».
E il bambino si mise a sorridere.
Disse alla neve: «Parlami di Dio!».
E la neve continuò a fioccare lieve, lieve.
Disse al pesce: «Parlami di Dio!».
E il pesce guizzò via come una freccia.
Disse all’ippopotamo: «Parlami di Dio!».
E l’ippopotamo si mise a ciondolare.
Disse al cielo: «Parlami di Dio!».
E il cielo indicò la terra e il creato.
Arrivata la sera, l’uomo se ne tornò a casa, tutto contento: non aveva mai imparato tante cose su Dio come in quel giorno!
Allora, per non dimenticare nulla, ripassò a memoria tutti gli incontri, e gli venne spontaneo ringraziare.
«Grazie, soldato: da te ho imparato che Dio è pace».
«Grazie, povero: da te ho imparato che Dio è generosità».
«Grazie, ciliegio: da te ho imparato che Dio è bellezza».
«Grazie, casa: da te ho imparato che Dio accoglie tutti».
«Grazie, albero: da te ho imparato che Dio è benigno».
«Grazie, bambino: da te ho imparato che Dio è un sorriso».
«Grazie, neve: da te ho imparato che Dio è silenzio». «Grazie, pesce: da te ho imparato che Dio è sempre giovane».
«Grazie, ippopotamo: da te ho imparato che Dio è umorista».
«Grazie, cielo: da te ho imparato che Dio è il grande Creatore di tutto!».
P. Pellegrino, Ti racconto Dio, M. Astegiano Editore
• Che cosa voleva conoscere il protagonista del racconto?
• Ricordi a chi si è rivolto per avere una risposta?
• Qual è la parola che l’uomo pronunciò al termine dei suoi incontri?
• Che cosa ha imparato?
Un giorno, in un bosco di montagna, una farfalla meravigliosa svolazzando tra un fiore e l’altro, si posò su di un fiore nato vicino ad una pietra.
La pietra vedeva passare ogni giorno quella farfalla e quel giorno, visto che le era così vicina, le disse: «Ciao, che meravigliosi colori che hai e come è bello vederti svolazzare, io invece sono qui immobile e posso vedere ben poco del mondo e poi… ho solo questo colore grigio!».
La farfalla un po’ vanitosa rispose: «Sì, ho dei bellissimi colori, tutti mi ammirano e vado dove voglio. Tu invece sei sempre lì. Ma non ti annoi?».
La pietra ci pensò un poco e rispose: «No, non mi annoio perché comunque posso vedere le cose belle del mondo che riesco a vedere di qui e ho tanti amici alberi attorno a me, però mi sento un po’ male se penso che non posso andare dove vorrei, come te».
A quel sentire, un faggio maestoso che aveva ascoltato tutto intervenne e disse: «Cara mia vecchia amica pietra, se tu non fossi qui, io come altri alberi e altra vegetazione attorno a te non potremmo vivere perché le nostre radici sono affondate nel terreno e si abbracciano con forza a te per sostenerci.
Tu che sembri una piccola pietra sei invece maestosa e imponente ed è proprio perché sei lì da secoli immobile che hai permesso a noi alberi attorno a te di crescere stabili.
È vero quindi che non hai i colori della farfalla ma la tua bellezza sta nell’essere roccia.
Tu invece cara piccola farfalla, è vero che sei splendida con i tuoi colori ed è bello vederti volare quei pochi giorni della tua vita, ma non potresti esistere se non ci fosse questa vegetazione che abbraccia le proprie radici a rocce maestose come questa che sembra una piccola pietra, ma non lo è».
Da quel giorno, la farfalla andò a trovare ogni giorno la pietra per raccontargli del creato che lei vedeva, e quando la farfalla fu sul punto di morire la pietra le disse: «Cara amica mia ti ricorderò per sempre perché, anche se pochi giorni, hai rinunciato a svolazzare un po’ del tuo tempo per raccontarmi le cose belle del mondo che io da qui non posso vedere».
RIFLETTIAMO
• Chi sono i protagonisti della storia?
• Perché non si annoia la pietra? Cosa vede ogni giorno?
• Il faggio, che interviene in un secondo momento, come descrive la pietra?
• Cosa dice invece alla farfalla?
• Cosa fa la farfalla dopo le parole del faggio?
Molto, molto tempo fa, prima dell’inizio del mondo, non c’era nulla. Il mondo era completamente deserto e buio. Vi era solo un mare grandissimo e lo Spirito di Dio si muoveva sopra le sue acque. Allora Dio disse: «Ci sia la luce!». E subito ci fu la luce. Dio chiamò la luce giorno e il buio notte. Questo fu il primo giorno.
Poi Dio disse: «Ci sia ora un grande tetto trasparente, tondo come una cupola, che vada fin lassù in alto e divida in due parti tutte queste acque!». E così avvenne. Dio chiamò questo tetto cielo e lo mise in mezzo alle acque, separando così quelle della pioggia che stanno in alto da quelle del mare che stanno in basso. Questo fu il secondo giorno.
Poi Dio disse: «Ora le acque del mare che stanno sotto il cielo si spostino per far spazio alla terra asciutta!». E così avvenne. Dio chiamò l’asciutto terra e le acque attorno ad esso mare e vide che tutto questo era proprio bello. Allora Dio disse: «Dalla terra esca ora l’erba verde, crescano piante e frutti di ogni tipo!». E così avvenne. La terra produsse piante e frutti di ogni specie. E Dio vide che tutto questo era proprio bello. Questo fu il terzo giorno.
Poi Dio disse: «Ci siano ora delle luci lassù nel cielo, per distinguere il giorno dalla notte e per segnare le feste, i giorni e gli anni». E così avvenne. Dio fece due luci, una più grande per il giorno, il Sole, e una più piccola per la notte, la Luna. Poi Dio fece tutte le stelline luccicanti del cielo che rischiarano la notte. E Dio vide che tutto questo era proprio bello. Questo fu il quarto giorno. Il quinto giorno della creazione Dio disse: «Le acque del mare si riempiano di pesci piccoli e grandi e nel cielo volino cinguettando gli uccelli!». E così fu. Dio creò tutti
gli animali del mare e del cielo e li benedisse dicendo: «Moltiplicatevi e andate in tutti i mari e i cieli del mondo». Questo fu il quinto giorno.
Poi Dio disse: «Ora ci siano anche tutti gli altri animali che vivono sulla terra, domestici e selvatici». E così avvenne. E Dio vide che tutto questo era proprio bello.
Allora, dopo aver fatto il cielo, la terra, il mare, il sole, la luna, le stelle, le piante e tutti gli animali, Dio disse: «Ora facciamo l’uomo a nostra immagine e somiglianza. Egli si prenderà cura di tutti gli animali: i pesci del mare, gli uccelli del cielo, il bestiame, gli animali selvatici e tutti i rettili che strisciano sulla terra».
Così Dio creò l’uomo a sua immagine, lo creò simile a se stesso, cioè soffiò in lui il suo respiro di vita, comunicandogli un’intelligenza e un cuore simili ai suoi. Maschio e femmina li creò.
Poi, li benedisse con queste parole: «Siate numerosi e riempite il mondo. Governatelo con saggezza e prendetevi cura di tutte le piante e gli animali».
E Dio vide che quanto aveva fatto era bellissimo. Questo fu il sesto giorno.
Nel settimo giorno Dio finì il suo lavoro e si riposò. Egli benedisse il settimo giorno e lo rese speciale perché era il giorno nel quale aveva finito la creazione del mondo.
Per introdurre il tema della creazione presentiamo ai bambini una canzone tradizionale dal titolo Alla corte di Spagna. Per far meglio memorizzare il testo, si possono accompagnare le strofe con dei gesti liberamente creati dai bambini stessi.
Alla corte di Spagna - Olé.
Alla corte di Spagna - Olé.
Il sole è così, il sole è così.
Il sole è così, il sole è così.
Alla corte di Spagna - Olé.
Alla corte di Spagna - Olé.
I monti son così.
Il sole è così.
Il sole è così.
Alla corte di Spagna - Olé.
Alla corte di Spagna - Olé.
Il mare è così, il mare è così.
I monti son così.
I monti son così.
I monti son così.
Il sole è così.
Il sole è così.
I monti son così.
Alla corte di Spagna - Olé.
Alla corte di Spagna - Olé.
Le donne son così.
Le donne son così.
Il mare è così, il mare è così.
I monti son così.
I monti son così.
Il sole è così.
Il sole è così.
Alla corte di Spagna - Olé.
Alla corte di Spagna - Olé.
Gli uomini son così.
Gli uomini son così.
Le donne son così.
Le donne son così.
Il mare è così.
Il mare è così.
I monti son così.
Il sole è così.
Il sole è così.
Alla corte di Spagna - Olé.
Alla corte di Spagna - Olé.
I tori son così.
I tori son così.
Gli uomini son così.
Gli uomini son così.
Le donne son così.
Le donne son così.
Il mare è così.
Il mare è così.
I monti son così.
I monti son così.
Il sole è così.
Il sole è così.
Alla corte di Spagna - Olé.
Alla corte di Spagna - Olé.
Per il tema della creazione, le ATTIVITÀ GRAFICO-PITTORICHE E MANIPOLATIVE sono le più immediate da proporre. Facciamo realizzare ai bambini un semplice lavoretto seguendo le istruzioni di seguito riportate.
REALIZZAZIONE
Fotocopiare la scheda a pagina 46.
• Brillantini dorati
• Cartoncino giallo e azzurro
Colorare le sagome del sole, della luna e delle stelle di un colore giallo lucente, la base rotonda di azzurro.
Ritagliare e incollare le sagome del sole, della luna e delle stelle su un cartoncino giallo. Ritagliare la base rotonda e incollala su un cartoncino azzurro.
Ritagliare nuovamente tutte le sagome.
Fare un forellino nei punti indicati e appendere il sole, la luna e le stelle al cielo azzurro con la corda o con il nastrino. 1 3 5 2 4
• Colla
• Colori
• Nastrino di raso o corda
• Forbici
Dopo la parte iniziale dedicata ai racconti, possiamo far ascoltare e ripetere una delle seguenti filastrocche.
Aria, acqua, terra, fuoco
Amica aria che volteggi leggera, che riempi tutta la nostra atmosfera, aria preziosa da respirare, aria pulita da non inquinare.
Amica acqua che nasci alla fonte che scendi veloce giù dal monte, acqua preziosa per dissetare, acqua pulita da salvaguardare.
Amica terra su cui camminiamo, su cui costruiamo e coltiviamo, terra preziosa da seminare, fertile terra da rispettare.
Amico fuoco che dai calore, che illumini tutto col tuo bagliore, fuoco prezioso per rischiarare, utile fuoco per riscaldare.
R. Sabatini
In natura sai cosa c’è?
Un mondo di cose tutte per te: alberi alti e verdeggianti, mari e fiumi serpeggianti, montagne altissime e piene di neve, cieli azzurri e vento lieve, arcobaleni di mille colori, tenera erbetta e piccoli fiori, ma la cosa più preziosa non è il profumo di una rosa, non è il sole del mattino ma è il sorriso di un bambino.
R. Sabatini
Filastrocca sul rispetto dell’ambiente
Qui si impara inver giocando, risparmiando e riciclando… per salvare questo mondo in allegro girotondo. L’acqua oggi è assai preziosa, più importante di ogni cosa, non sprecarla nella doccia e conservane ogni goccia
Pile, carta, lampadine, vetro, plastica e lattine, non buttarle tutte insieme, differenziale per bene! Mentre giochi coi colori, puoi scoprir nuovi valori: il rispetto dell’ambiente, della terra e della gente.
J. Restano
Colora le stelle, il sole e la luna, poi mediante dei fili appendili al cerchio grande come mostrato dal modellino.
Colora il pacco dono con i tuoi colori preferiti, poi incolla nel riquadro una tua fotografia.
Leggi le parole, descrivi le immagini e colora. Quale delle parole descrive un dono? Quali parole descrivono sentimenti?

10 + 6 = 16



Colora gli esseri viventi di cui Dio è Padre e Creatore. Cerchia di rosso ciò che non è vivo e non creato da Dio.

CON GLI OCCHI



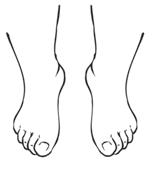
CON LE ORECCHIE




CON LA BOCCA

CON LE MANI
CON I PIEDI

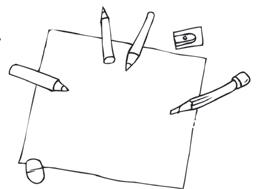
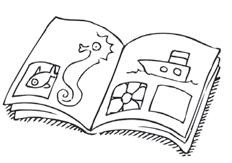

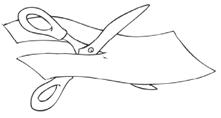
Colora gli esseri viventi di cui Dio è Padre e Creatore. Cerchia di rosso ciò che non è vivo e non creato da Dio.
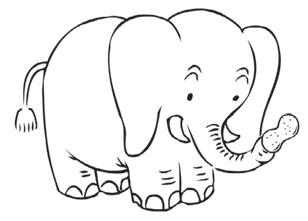


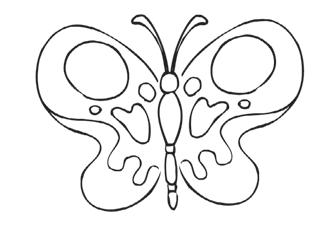
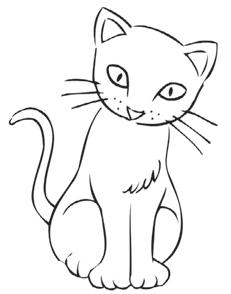
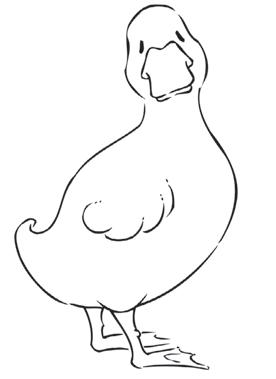



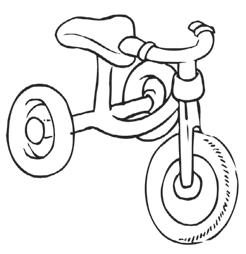
Il mondo è pieno di meraviglie: mari, monti, animali di ogni genere, piante e fiori. Tocca a noi prenderci cura di questi doni.
Colora solo ciò che è “essere vivente”, cerchia ciò che non lo è.
Colora solo chi sta rispettando la natura e cancella con una X rossa chi invece tratta male la natura. Spiega il perché della tua scelta.
Traguardi per lo Sviluppo delle Competenze L’alunno…

• riconosce il significato cristiano del Natale. u ni Ta di apprendimen T
È Natale!
rogrammazione
• Riconoscere i segni e i simboli della festa cristiana del Natale.
• Il racconto evangelico della nascita di Gesù.
Da pag. 28 a pag. 43 Il linguaggio religioso
• Riconoscere i segni cristiani del Natale nell’ambiente, nelle celebrazioni e nella tradizione popolare.
• -Saper collegare alcuni segni e simboli delle feste che rappresentano.e.
Dal miracolo e mistero affascinante della vita come dono, si passerà ad affrontare una delle feste più attese e amate da tutti i bambini del mondo: il Natale. Probabilmente è il momento più bello dell’anno, e non solo per i più piccoli, anche per i grandi, quando tutti si sentono più buoni. La riflessione partirà, anche in questa parte, dal vissuto di ogni singolo bambino, a partire dalla loro data di nascita.
Una proposta può essere quella di chiedere in quale giorno sono nati, e renderli consapevoli che ogni anno, in quella data, festeggiano il loro compleanno. Così, come ogni persona ricorda il giorno in cui è nato, i cristiani, a Natale, ricordano la nascita di Gesù, il “Dio-con-noi”, il figlio di Maria nato, più di duemila anni fa, povero in una mangiatoia a Betlemme.
Successivamente la riflessione si sposterà sulla parola simbolo, intesa come espressione e rappresentazione efficace di una realtà complessa, e l’insegnante guiderà gli alunni alla scoperta dei segni e dei simboli legati alla festa del Natale, scoprendo come, nella vita di tutti i giorni sono davvero tanti quelli presenti nella vita di ciascuno. Segni e simboli che diventano motivo per interrogarsi, per capire e per vivere meglio gesti semplici, ma importanti, quali sono un incontro, un momento in famiglia, lo scambio dei regali.
Una ragazza di nome Maria viveva in un paese chiamato Nazaret e stava per sposare un falegname di nome Giuseppe. Il Signore Dio mandò un giorno l’angelo Gabriele da Maria per portarle un annuncio importantissimo. L’angelo entrò in casa sua e le disse: «Rallegrati, Maria, piena di grazia: il Signore è con te!». Maria si meravigliò nel sentire queste parole e quasi si spaventò.
Ma l’angelo Gabriele le disse: «Non aver paura, Maria, Dio mi ha mandato per dirti che avrai un figlio che chiamerai Gesù. Egli sarà un grande re e sarà chiamato Figlio del Dio Altissimo. Il suo regno durerà per sempre!».
Allora Maria disse all’angelo: «Come può accadere questo? Come posso avere un bambino se sono ancora così giovane?».
E l’angelo rispose: «Dio può fare tutto: lo Spirito Santo scenderà su di te e la potenza di Dio ti darà questo figlio. Perciò il bambino che nascerà sarà santo e sarà chiamato Figlio di Dio. Ecco, anche Elisabetta, tua cugina, avrà un figlio anche se è già anziana: vedi che nulla è impossibile a Dio?». Allora Maria chinò il capo e disse: «Eccomi, farò tutto quello che vuole il Signore». E l’angelo si allontanò da lei.
• Perché secondo te l’angelo saluta Maria con quelle parole?
• Qual è la reazione di Maria? RIFLETTIAMO
Maria e Giuseppe vivevano felici a Nazaret, aspettando la nascita di Gesù. Un giorno dovettero partire per un paesello chiamato Betlemme, dove Giuseppe era nato, perché l’imperatore romano Cesare Augusto voleva sapere quanti erano esattamente gli abitanti del suo regno. Maria sua sposa andò con lui cavalcando un asinello.
Mentre si trovavano a Betlemme, durante una notte, arrivò per Maria il tempo di far nascere Gesù. Giuseppe chiese allora di poter entrare in una delle locande del paese, ma erano tutte piene e non ci fu posto per loro.
Maria diede quindi alla luce suo figlio Gesù dentro una povera stalla. Lo avvolse in fasce e lo mise a dormire tra la paglia in una mangiatoia.
C’erano vicino a Betlemme dei pastori che facevano la guardia di notte alle loro pecore. Un angelo luminoso si presentò a loro e disse: «Vi porto una bella notizia: oggi a Betlemme è nato il Salvatore del mondo, Gesù!».
E subito apparvero molti altri angeli che lodavano Dio cantando così: «Gloria a Dio nel più alto dei cieli e pace sulla terra agli uomini, che egli ama».
Allora i pastori raggiunsero in fretta Betlemme e là trovarono Maria, Giuseppe e il bambino, adagiato nella mangiatoia. Dopo averlo visto, dissero a tutti ciò che avevano sentito dire dagli angeli e la gente che li ascoltava si stupiva molto delle cose che essi raccontavano.
Mentre Giuseppe e Maria erano in viaggio verso Betlemme, un angelo radunò tutti gli animali per scegliere i più adatti ad aiutare la Santa Famiglia nella stalla. Per primo, naturalmente, si presentò il leone. «Solo un re è degno di servire il Re del mondo», ruggì «io mi piazzerò all’entrata e sbranerò tutti quelli che tenteranno di avvicinarsi al Bambino!». «Sei troppo violento» disse l’angelo.
Subito dopo si avvicinò la volpe. Con aria furba e innocente, insinuò: «Io sono l’animale più adatto. Per il Figlio di Dio ruberò tutte le mattine il miele migliore e il latte più profumato. Porterò a Maria e Giuseppe tutti i giorni un bel pollo!». «Sei troppo disonesta!» disse l’angelo.
Tronfio e splendente arrivò il pavone. Sciorinò la sua magnifica ruota color dell’iride: «Io trasformerò quella povera stalla in una reggia più bella del palazzo di Salomone!». «Sei troppo vanitoso!» disse l’angelo. Passarono, uno dopo l’altro, tanti animali ciascuno magnificando il suo dono. Invano.
L’angelo non riusciva a trovarne uno che andasse bene. Vide però che l’asino e il bue continuavano a lavorare, con la testa bassa, nel campo di un contadino, nei pressi della grotta.
L’angelo li chiamò: «E voi non avete niente da offrire?». «Niente, - rispose l’asino e afflosciò mestamente le lunghe orecchie - noi non abbiamo imparato niente oltre all’umiltà e alla pazienza. Tutto il resto significa solo un supplemento di bastonate!».
Ma il bue, timidamente, senza alzare gli occhi, disse: «Però potremmo di tanto in tanto cacciare le mosche con le nostre code». L’angelo finalmente sorrise: «Voi siete quelli giusti!».
Bruno Ferrero
Quando Gesù nacque a Betlemme, arrivarono nella vicina città di Gerusalemme alcuni Magi che venivano dalla lontana terra d’Oriente.
Essi domandarono: «Dov’è quel bambino di cui tutti parlano? In Oriente abbiamo visto apparire in cielo la sua stella e siamo venuti qui per onorarlo come il più grande dei re!».
Queste parole misero in agitazione Erode, che era re in quel periodo, poiché aveva paura di perdere il regno. Appena lo seppe, egli radunò tutti i suoi saggi e chiese loro: «In quale paese deve nascere questo bambino?». Essi risposero: «Secondo le antiche profezie, a Betlemme!».
Allora il re Erode chiamò i Magi venuti da lontano e li mandò a Betlemme dicendo: «Andate e cercate il bimbo. Quando l’avrete trovato, ditemelo, così anch’io andrò ad onorarlo». Ma questo non era vero: Erode aveva paura che Gesù gli rubasse il regno e voleva ucciderlo.
Ricevuto questo comando da parte del re, i Magi partirono. In viaggio, la stella che essi seguivano si muoveva davanti a loro fino a quando non arrivò sopra il posto dove si trovava il bambino. Là si fermò. Essi allora entrarono nella stalla e videro il neonato, Giuseppe e sua madre, Maria. Si inginocchiarono e adorarono il bambino. Poi aprirono i loro scrigni e gli offrirono in dono oro, incenso e mirra. Un angelo poi li avvertì in sogno di non tornare da Erode perché era cattivo e voleva uccidere Gesù. Essi, allora, ritornarono alla loro terra lontana per un’altra strada.
Anche Gesù, Giuseppe e Maria fuggirono da Betlemme e andarono a cercare rifugio in Egitto.
Scatoline variopinte
Si disegna su di un cartoncino una mini scatola da appendere come addobbo all’Albero di Natale. Dopo aver colorato ogni parete della scatola con un colore diverso si ritaglia la sagoma. Successivamente si ripiegano le pareti e le linguette che andranno poi incollate per ottenere la forma finale. Con del nastro colorato, infine, si legherà la scatola in modo da poterla appendere all’Albero di Natale.
Dopo la lettura della storia, possiamo far ascoltare e ripetere una delle seguenti filastrocche.
C’è nel cielo una grande stella, dietro di lei una pecorella. Arrivano alla capanna dove Gesù fa la nanna.
Ci sono Giuseppe e Maria che gli fanno compagnia.
C’è il timido asinello che riscalda il Bambinello.
Arrivano i pastori per offrire i loro cuori.
Quest’anno Natale
mi ha fatto un bel dono, un dono speciale.
Mi ha dato allegria, canzoni cantate in gran compagnia. Mi ha dato pensieri, parole, sorrisi di amici sinceri.
Dei vecchi regali non voglio più niente.
A ogni Natale io voglio la gente!
Roberto Piumini
Natale è la festa dei doni.
Il dono è un segno di amore fra due persone che si amano.
C’è uno che dona ed uno che riceve il dono.
Il dono è qualcosa che rende visibile l’amore invisibile che c’è in loro.
Notte di Natale, una notte speciale... gocce dorate appaion le stelle.
Nel cielo scuro son tutte belle, ma una soltanto, la stella cometa, si mette in cammino cercando un bambino Gesù.
Guarda di qua, guarda di là...
Sopra una grotta si ferma già.
Tra l’asino e il bue sorride il bambino, si chiama Gesù, il Figlio divino.
Adesso la stella riposa un pochino, mentre i pastori si fan più vicino.
Anche i re Magi ora san dove andare, sui loro cammelli stan per arrivare. È la notte di Natale, una notte davvero speciale... nel cuore d’ogni uomo scende la Pace.
Colora l’albero di Natale e il bambino che lo addobba. In quale modo anche tu addobbi la tua casa in questo periodo? Racconta.
Colora la scena dell’Annunciazione.
Accanto all’angelo scrivi AVE MARIA.
Colora i magi, poi disegna i loro doni copiandoli dai modelli in basso. Scrivi infine i nomi dei tre doni, spiegando a voce di cosa di tratta.
Riconosci e cerchia di rosso i doni che i pastori portano a Gesù. Poi colora.

Traguardi per lo Sviluppo delle Competenze L’alunno…
• riflette sui dati fondamentali della vita di Gesù.
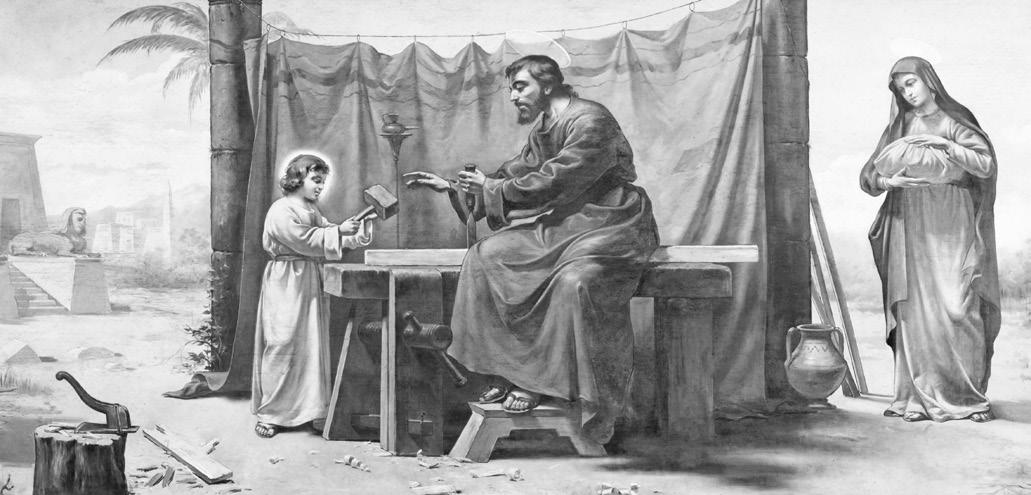
u ni Ta di apprendimen T o p er la p rogrammazione S e TT imanale r iferimen T i al T e ST o o bie TT ivi di apprendimen T o Ecco Gesù!
• Conoscere la persona, la vita e il messaggio di Gesù.
• Gesù annuncia la buona notizia con parole e azioni: parabole e miracoli.
Da pag. 44 a pag. 63 Dio e l’uomo
• Scoprire che Gesù è stato un bambino come tutti.
• Conoscere Gesù di Nazareth;
• Ricostruire alcuni aspetti fondamentali della vita di Gesù.
La Bibbia e le altre fonti
• Ascoltare, leggere e saper riferire circa alcuni semplici episodi chiave dei racconti evangelici.
Nella seconda parte dell’anno scolastico, gli alunni saranno accompagnati nella conoscenza della figura di GESÙ DI NAZARET, della sua vita e delle sue opere attraverso l’ascolto di alcuni EPISODI EVANGELICI CHIAVE . L’insegnante farà riflettere e comprendere la realtà storica di Gesù, uomo come
noi, e non frutto della fantasia, attraverso i momenti più importanti della sua vita: l’infanzia a Nazaret, la scelta dei primi amici, il Battesimo e aiuterà ciascun alunno a confrontare la vita di Gesù con la propria. Il periodo che va dal Battesimo in poi, è conosciuto come la vita pubblica di Gesù, mentre dei suoi primi trent’anni, si sanno ben poche cose, ma da questo si evince un Gesù rispettoso, educato, intelligente, ma che non ha evitato preoccupazioni ai genitori.
Una volta lasciata la casa di Nazaret, Gesù viaggiò in tutta la Palestina, dove incontrò tante persone e, in particolar modo, gli ultimi, i più bisognosi. Per tutti aveva una PAROLA DI CONFORTO O GESTI SPECIALI , e a quanti gli facevano domande, rispondeva con delle storie, utilizzando un linguaggio semplice, diretto, e che tutti potevano capire. Da qui, quindi, un ultimo passaggio, fondamentale, da parte dell’insegnante, quello di far capire che il compito di Gesù è un compito speciale: portare a tutti, con le sue parole e le sue azioni, il MESSAGGIO DI AMORE DI DIO.
«Gesù, svegliati! Il Signore ci ha donato un nuovo giorno!». Con queste parole Maria sveglia suo figlio, Gesù, che dorme sulla sua stuoia nella casetta di Nazaret. Dopo essersi alzato, Gesù insieme alla mamma recita una semplice preghiera: «Il Signore è mia luce e mia salvezza!», poi fa colazione con latte e pane, mentre i suoi genitori sono impegnati a svolgere i loro lavori. Maria prepara il pane che mangeranno durante il giorno, prende l’acqua del pozzo necessaria per la famiglia, per cucinare, per lavarsi. Giuseppe è già dietro casa che lavora con la sega, la pialla e i suoi chiodi, infatti è un falegname. Giuseppe si lava e raggiunge Maria e Gesù in casa per recitare la preghiera del mattino, stando in piedi rivolti verso Gerusalemme, come fanno tutti gli ebrei: «Ascolta Israele, il Signore è l’unico Dio. Tu amerai il Signore con tutto il cuore, con tutta l’anima, con tutte le forze…». Ora ognuno si appresta ai propri doveri: Maria torna alle faccende di casa, Giuseppe riprende il lavoro sospeso, Gesù calza i sandali, prende la tavoletta cerata per scrivere e raggiunge gli altri bambini di Nazaret nella sinagoga
che funge da scuola (solo i maschi frequentano la scuola, perché le femmine restano in casa ad aiutare le madri). Il rabbino, cioè il maestro, aspetta i bambini per insegnare loro a leggere, scrivere, contare. Suo compito è anche quello di raccontare ciò che ha compiuto Dio e le storie degli ebrei, raccolte nella Bibbia. I bambini vanno a scuola e i grandi lavorano tutti i giorni, tranne il sabato, giorno di riposo da dedicare completamente a Dio. In questo giorno anche Gesù e i suoi genitori vanno alla sinagoga per pregare e ascoltare la lettura della Bibbia e la spiegazione del rabbino. Poi Gesù può passare del tempo in casa e giocare in strada con i suoi amici, lodando il Signore per il dono della vita.
Micio Geppi era un giovane gatto un po’ sgangherato: era tutto nero con una piccola macchia bianca sotto il naso che sembrava avesse i baffetti; aveva il pelo corto e ispido, mentre la sua coda era enorme, pelosa e bella soffice; aveva un orecchio in su ed uno in giù e quando doveva iniziare a correre faceva un ridicolo balzo all’indietro e poi …via. Era molto simpatico ed affabile con tutti ed era il gatto del vicinato più ricercato per giocare perché aveva molta fantasia ed inventava giochi sempre nuovi e divertenti. Un giorno, passando davanti ad un portone, Geppi vide una bellissima gatta bianca dagli occhi verde mare molto tristi acciambellata in una cesta. Il micio rimase affascinato e, fermandosi, la invitò ad andare a giocare con lui ed i suoi amici: «Ciao! - le disse - perché non vieni a giocare con noi invece di startene lì a guardare? Vieni, vedrai che ti divertirai!».
La gattina, che si chiamava Bianca, disse: «Non posso. - rispose - Io esco sempre con la mia padroncina che mi porta in braccio a prendere un po’ d’aria oppure me ne sto qui a guardarvi giocare. Sai, io non posso camminare. Qualche tempo fa, mentre attraversavo la strada senza guardare, sono stata investita da un’auto e da allora non posso più muovere le zampette di dietro. Per questo non posso venire a giocare con voi, anche se mi piacerebbe tanto!».
Mentre parlava due grossi lacrimoni iniziarono a scenderle sul bel musetto.
Micio Geppi fu così colpito dalle parole di Bianca che immediatamente pensò di fare qualcosa per aiutarla.
Si ricordò che, nel garage della casa in cui abitava, giaceva abbandonato un carrettino di legno, di quelli usati dai cuccioli degli umani per imparare a camminare.
Chiamò a raccolta i suoi amici gatti e gattine e, dopo aver spiegato loro la situazione, tutti insieme andarono nel garage a prendere il carretto. Micio Geppi mise intorno al manico una corda, anche questa trovata nel garage e la porse a due gatti, che tenendosi allineati, tiravano un capo della corda per ciascuno, mentre tutti gli altri spingevano il carretto. Lo trasportarono dove era Bianca, la quale rimase stupita nel vedere quel trabiccolo e tanti gatti che erano venuti lì per lei. Micio Geppi le spiegò che doveva salire sul carretto e loro l’avrebbero portata a giocare sulla collina, lontano dai pericoli. Facendosi forza sulle zampette davanti ed aiutata dalle altre gattine, che le tenevano sollevate le zampette posteriori, Bianca riuscì a spostarsi e a mettersi nel carretto.
Così iniziò quello strano corteo: due gatti che tiravano il carretto come fossero una pariglia di bei cavalli, due gattine ai lati, un’altra gattina nel carretto insieme a Bianca per sostenerla in caso di difficoltà, e i quattro gatti dietro a spingere.
Arrivarono così sulla collina, trovarono un bello spiazzo sotto un grosso albero, misero il carretto in sicurezza e poi si misero a sedere in cerchio, uno accanto all’altro. Micio Geppi, che come sappiamo aveva molta fantasia, per coinvolgere Bianca pensò di fare il gioco della storia a più zampe: un gatto avrebbe iniziato il racconto di una storia che a turno tutti avrebbero dovuto continuare. Un altro giorno, invece, Geppi pensò di fare il gioco delle parole: un gatto diceva una parola e il vicino doveva inventare una frase in cui vi fosse quella parola.
Chi inventava la frase più bella vinceva.
E così via.
Ogni giorno nel primo pomeriggio si poteva vedere passare il carretto spinto dai gatti verso la collina.
E ogni giorno sulla collina sempre giochi nuovi e divertenti a cui poteva partecipare tranquillamente anche Bianca, che aveva ritrovato il sorriso.
Se invece era brutto tempo, i gatti spingevano il carretto in un posto al coperto per poter continuare a giocare tutti insieme. E se per caso vi capita di passare lì, fermatevi e guardate: vedrete un gruppo di gatti felici che hanno scoperto il gusto di una vera amicizia!
RIFLETTIAMO
• Chi sono i personaggi della storia?
• Come viene descritto Geppi?
• Perché Bianca non può più camminare?
•Cosa fece Geppi?
•Quale fu la reazione di Bianca?
Si propone di festeggiare i papà nel giorno di San Giuseppe. Attraverso il seguente racconto aiutiamo i nostri alunni a riflettere sul significato della ricorrenza e a viverne la sua autenticità.
Quando il buon Dio decise di creare il padre, cominciò con una struttura piuttosto alta e robusta. Allora un angelo che era lì vicino gli chiese: «Ma che razza di padre è questo? Se i bambini li farai alti come un soldo di cacio, perché hai fatto il padre così grande? Non potrà giocare con le biglie senza mettersi in ginocchio, rimboccare le coperte al suo bambino senza chinarsi e nemmeno baciarlo senza quasi piegarsi in due!».
Dio sorrise e rispose: «È vero, ma se lo faccio piccolo, piccolo come un bambino, i bambini non avranno nessuno su cui alzare lo sguardo».
Quando poi fece le mani del padre, Dio le modellò abbastanza grandi e muscolose. L’angelo scosse la testa e disse: «Ma... mani così grandi non possono aprire e chiudere spille da balia, abbottonare e sbottonare bottoncini e nemmeno legare treccine o togliere una scheggia da un dito».
Dio sorrise e disse: «Lo so, ma sono abbastanza grandi per contenere tutto quello che c’è nelle tasche di un bambino e abbastanza piccole per poter stringere nel palmo il suo visetto». Dio stava creando i due più grossi piedi che si fossero mai visti, quando l’angelo sbottò: «Non è giusto. Credi davvero che queste due barcacce riuscirebbero a saltar fuori dal letto la mattina presto quando il bebè piange? O a passare fra un gruppo di bambini che giocano, senza schiacciarne per lo meno due?».
Dio sorrise e rispose: «Sta’ tranquillo, andranno benissimo. Vedrai: serviranno a tenere in bilico un bambino che vuol giocare a cavalluccio o a scacciare i topi nella casa di campagna oppure a sfoggiare scarpe che non andrebbero bene a
nessun altro».
Dio lavorò tutta la notte, dando al padre poche parole ma una voce ferma e autorevole; occhi che vedevano tutto, eppure rimanevano calmi e tolleranti. Infine, dopo essere rimasto un po’ soprappensiero, aggiunse un ultimo tocco: le lacrime. Poi si volse all’angelo e domandò: «E adesso sei convinto che un padre possa amare quanto una madre?».
RIFLETTIAMO
• Perché Dio creò il padre così alto e robusto, con delle mani e dei piedi grandi?
• Perché l’angelo borbottò?
• Dopo aver lavorato tutta la notte, Dio cosa diede al padre?
• Tu sei convinto che un padre possa amare quanto una madre?
Un giorno in una città della Galilea chiamata Cana vi fu un matrimonio e alla festa furono invitati anche Gesù e sua madre Maria.
Mentre erano tutti seduti allegramente a mangiare, ecco che finì il vino. Maria se ne accorse e si girò versò Gesù sussurrando: «Non hanno più vino!», poi si alzò, andò dai servitori e disse: «Qualsiasi cosa vi dica mio figlio Gesù, voi fatela!».
Vi erano in quella casa sei grosse anfore di pietra vuote che potevano contenere cento litri d’acqua ciascuna. Gesù allora si avvicinò a queste anfore e disse: «Riempitele d’acqua».
Questi presero dell’acqua e le riempirono tutte e sei fino all’orlo. Poi Gesù aggiunse: «Bene, ora riempite delle brocche e portatele in tavola».
I servitori, meravigliati per quanto stava dicendo Gesù, fecero però come egli aveva detto e portarono le brocche in tavola. Ed ecco che da quelle invece dell’acqua uscì il vino e i servitori ne restarono davvero meravigliati.
Gli invitati alla festa, come ebbero assaggiato l’acqua diventata vino, chiamarono lo sposo e gli dissero: «Complimenti! Tutti mettono in tavola il vino buono all’inizio e, quando si è già bevuto molto, quello meno buono. Tu invece ci hai dato il vino buono dall’inizio del pranzo fino alla fine!». Dopo questo miracolo fatto da Gesù molti di quelli che erano alla festa credettero in lui.
Un giorno Gesù salì con i suoi discepoli su una barca. Dovevano passare all’altra riva del lago, ma all’improvviso si scatenò una tempesta così violenta, che la barca era quasi sommersa dalle onde. Nel frattempo Gesù si era addormentato. I suoi amici avevano molta paura, perciò lo svegliarono, dicendogli: «Salvaci Signore, o saremo perduti!». Gesù allora rispose loro: «Perché avete paura e non avete fiducia in me?». Poi si alzò in piedi sulla barca, sgridò il vento e le acque, finché non ritornò il sereno. Tutti furono pieni di stupore e si domandavano: «Chi è mai costui, che persino i venti e il mare gli obbediscono?».
Da Luca 8, 22-25
Aiutiamo i bambini a cogliere il significato del miracolo attraverso alcune domande:
RIFLETTIAMO
• Ti è mai capitato di trovarti in una situazione di pericolo?
• Come ti sei sentito?
• A chi hai chiesto aiuto?
In cortile con Gesù
Gesù, molto probabilmente, giocava all’aperto come tutti i bambini ebrei di Nazareth: correva, saltava, giocava a scalone o a “settimana”, usava dadi, biglie di terracotta o di sasso o di osso di pecora, lanciava sassi e faceva girare le trottole che erano di legno. Anche il gioco a palla era diffuso ed il pallone era costituito da un mucchio di stracci cuciti insieme.
Per presentare il tema della chiamata degli apostoli, gli amici speciali di Gesù, è opportuno riflettere insieme ai bambini sui LEGAMI D’AMICIZIA FORTI E PROFONDI che li coinvolgono totalmente. L’esecuzione della filastrocca Danza degli amici presenta il valore dell’amicizia in un’atmosfera di allegria e tenerezza.
Ondeggiando lentamente una mano solamente anche l’altra poi si aggiunge ed insieme fan clap, clap.
Con le punte aperte e chiuse i miei piedi ballano e girando su me stesso scambio il posto mio con te.
Oh sì, con te!
Ondeggiando lentamente a una mano prontamente avvicina l’altra mano ed insieme fan clap, clap.
Sulle punte saltellando i miei piedi ballano e girando su me stesso scambio il posto mio con te.
Oh sì, con te!
Ondeggiando lievemente tutti insieme allegramente con il ritmo della danza tante mani fan clap, clap. Un inchino ed un sorriso mentre tutti ballano e girando su me stesso scambio il posto mio con te.
Oh sì, con te!
Ondeggiando lentamente una mano solamente anche l’altra poi si aggiunge ed insieme fan clap, clap.
Con le punte aperte e chiuse i miei piedi ballano e girando su me stesso scambio il posto mio con te.
Oh sì, con te!
Rosanna Nassimbeni
Ho perso una pecorella
Prima di proporre un gioco semplice, ma divertente, l’insegnante avvierà questa breve riflessione. Il vero amico deve comportarsi come il pastore che va a cercare la pecorella perduta.
Ogni amico è importante e non ci si può dimenticare di nessuno. Il buon pastore promette di essere amico per sempre e se qualcuno si perde per strada, lo va a
cercare. I bambini sono disposti in cerchio. Un bambino fa il pastore e si mette in mezzo. Gli altri girano intorno al pastore eseguendo il seguente dialogo:
Pastore: «Ho perso una pecorella, dindina dindella!».
Coro: «Dove l’hai persa, dindina dindella!».
Pastore: «L’ho persa in mezzo al bosco, dindina dindella!».
Coro: «E come si chiamava, dindina dindella!».
Pastore: «Si chiamava… (nome di un/a compagno/a), dindina dindella!».
Nominata la compagna, o il compagno, il pastore lo prende per mano e lo porta in mezzo al cerchio. Il gioco si ripete più volte.
Miracolo… in gioco
Utilizziamo i colori primari delle tempere per sperimentare, con la loro mescolanza, la formazione dei colori secondari come per “magia”. C’era una volta un mago che prese il giallo del sole dorato e il blu dell’acqua di mare. Li mescolò con la sua bacchetta e ben presto comparve per magia il verde dei prati che si estendeva fino all’orizzonte.
Ora prova anche tu a mescolare i tre colori primari come ha fatto il mago e guarda cosa accade.
Costruisci il grafico dei colori mescolati su un cartellone come vedi nell’esempio qui accanto.









La casa di Gesù, vuoi conoscerla anche tu?
Vieni, vieni insieme a noi, tante cose scoprirai.
La sua casa è senza caminetto, senza sedie e divanetto; una stanza sola ha, dei tuoi mobili la metà.
Luce elettrica non c’è, né telefono, né parquet; solo fuoco e fornello per cucinare un bell’agnello.
Se di notte tu verrai gli asinelli troverai.
La sua porta bassa e stretta per te rimane sempre aperta. E se gli amici vorrai portar Non c’è bisogno di bussar.
Descrivi e colora le scene nelle quali Gesù aiuta mamma e papà. Come aiuti tu in casa? Disegna sotto quando aiuti mamma e quando aiuti papà.
Colora e descrivi le scene; sotto disegna in quale modo tu giochi con gli amici.
Costruisci la trottola ebraica: colora, piega e incolla ottenendo un dado; nei due fori infila una matita o una penna.
Costruisci la kippah, il copricapo che ogni ebreo maschio porta per entrare in sinagoga. Decoralo in maniera adatta al suo uso e indossalo come qui mostrato: taglia lungo le linee tratteggiate senza arrivare al centro; spilla, piegando leggermente per dare la forma del copricapo.
Colora e ritaglia Gesù, Maria e gli sposi e incollali nella schede seguente.
Colora e incolla qui al posto giusto quanto hai ritagliato nella schede precedente.
Al tempo di Gesù certi oggetti non esistevano. Scoprili e cerchiali con il rosso. Colora quelli giusti.
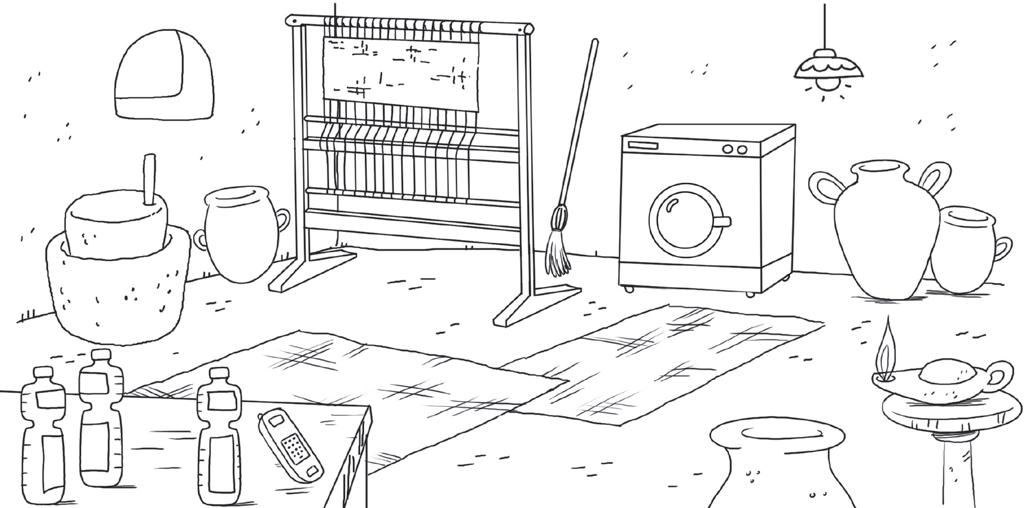
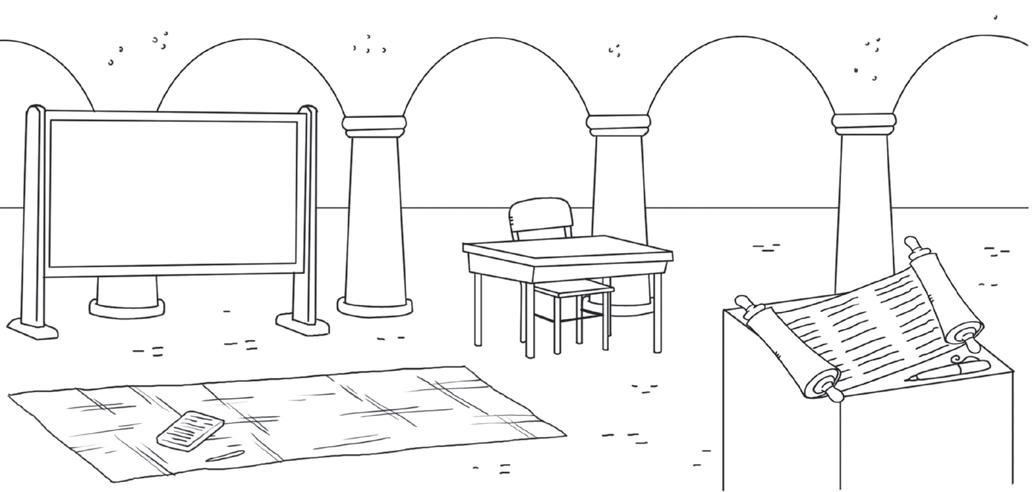
Con l’aiuto dell’insegnante descrivi l’immagine, colora e inserisci negli spazi vuoti il nome dei seguenti oggetti: MACINA, LAMPADA AD OLIO, STUOIA, GIARA, STOVIGLIE, FORNELLO.
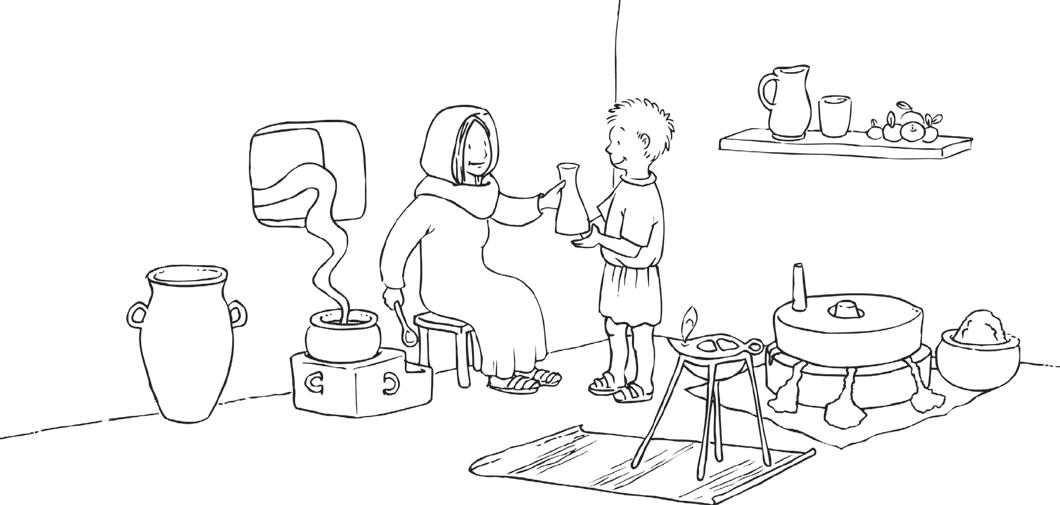

Disegna il tuo paese o la tua città. Colora il paese di Gesù e confrontalo con il tuo.
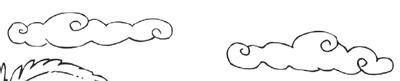

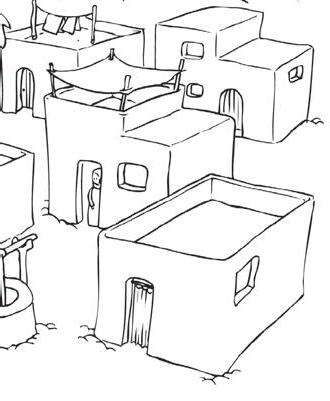
Colora e vesti i bambini con gli indumenti che trovi nella scheda successiva, poi scrivi i loro nomi (pantaloni - velo - scarpe - maglia - tunica - cappello - sandalikippah).
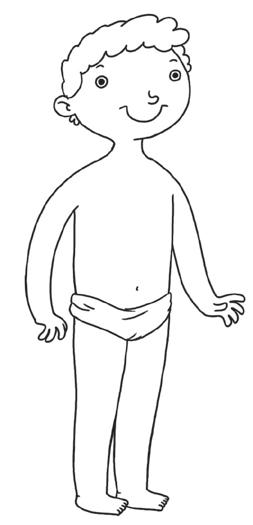
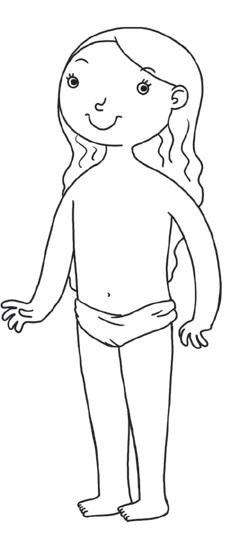
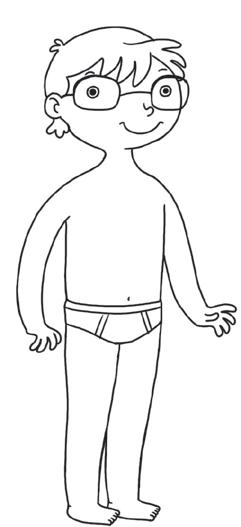

Colora gli indumenti e usali per vestire i bambini della scheda precedente.
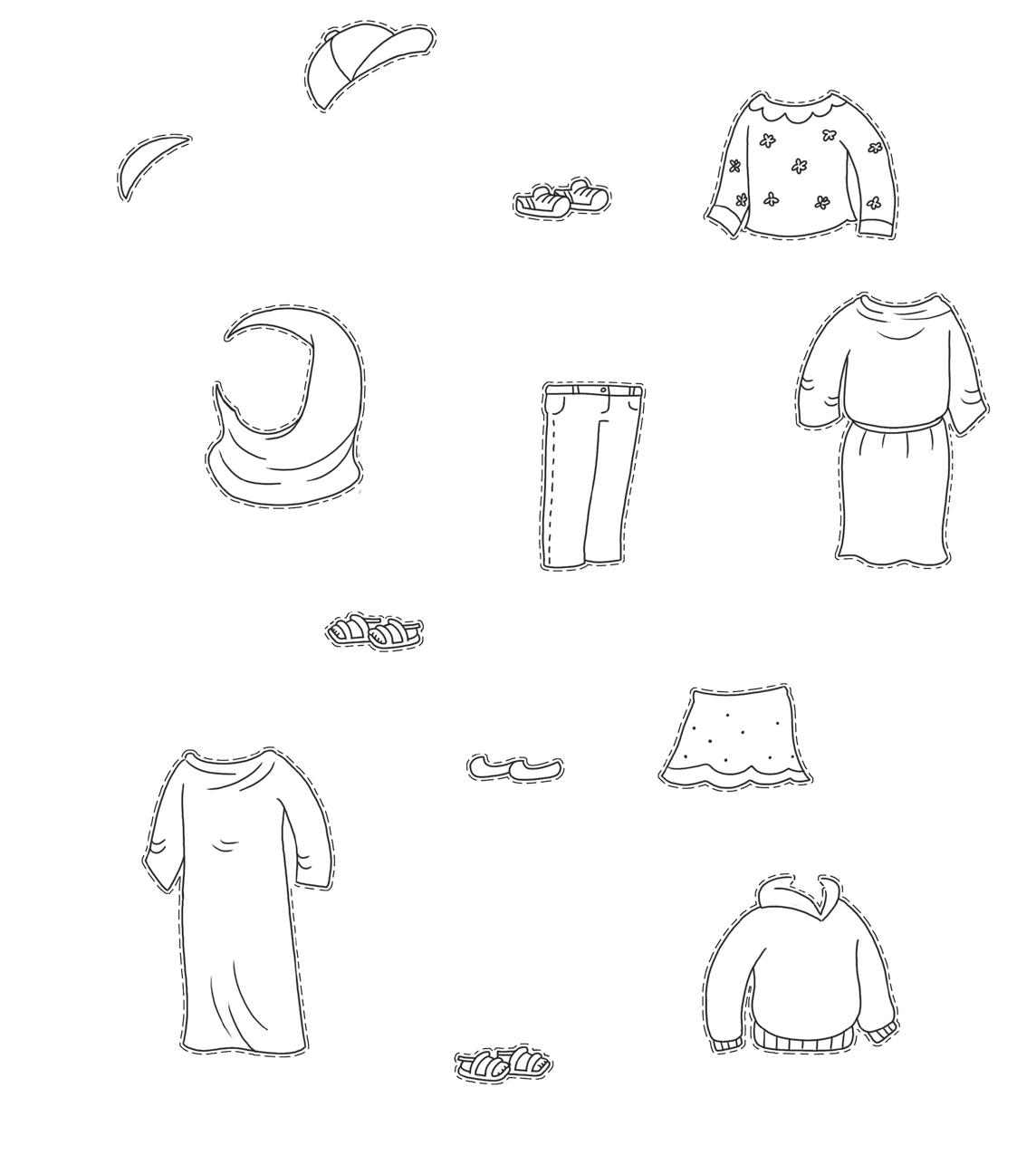
Colora e collega con una freccia le fasi della crescita di Gesù con quelle di un bambino come te.
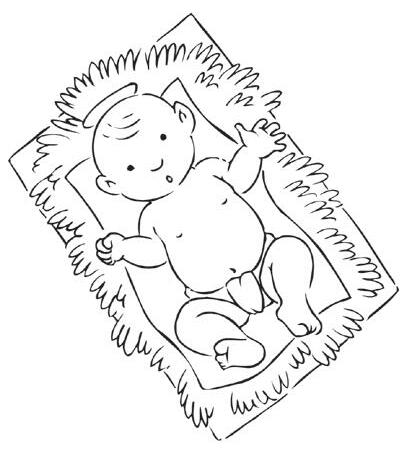

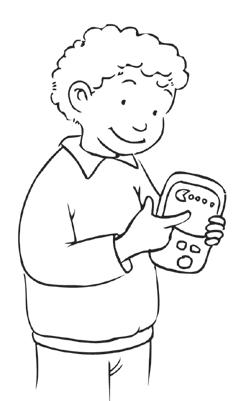


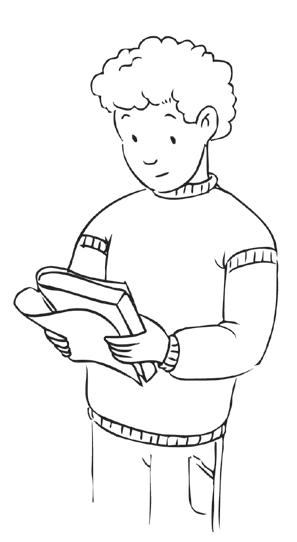
L’alunno…
Traguardi per lo Sviluppo delle Competenze
• riconosce il significato cristiano della Pasqua.

u ni Ta di apprendimen T o p er la p rogrammazione S e TT imanale r iferimen T i al T e ST o o bie TT ivi di apprendimen T o
È Pasqua!
• Riconoscere i segni della festa cristiana della Pasqua.
• La Pasqua di Gesù, il dono di nuova vita.
Da pag. 64 a pag. 71 Dio e l’uomo
• Conoscere Gesù di Nazareth, crocifisso e risorto.
Il linguaggio religioso
• Riconoscere i segni cristiani della Pasqua nell’ambiente, nelle celebrazioni e nella tradizione popolare.
• Saper collegare alcuni segni e simboli delle feste che rappresentano.
L’arrivo della primavera segna la fine della stagione invernale, e quindi del freddo, ma anche un passaggio da un periodo di tenebre che lascia, giorno dopo giorno, sempre più spazio e POSTO ALLA LUCE, con la VITTORIA DELLA VITA. I bambini saranno guidati, quindi, alla SCOPERTA DELLA FESTA DELLA PASQUA CRISTIANA , intesa come momento di passaggio: un tempo di vita nuova, in cui la natura si rinnova. Questo risveglio non si riferisce solo alla natura, ma riguarda soprattutto L’UOMO CHE VIENE LIBERATO DAL BUIO DEL PECCATO e della morte con la luce della Vita e della Risurrezione.
È il momento più importante dell’anno per i cristiani, è l’evento centrale di tutta la fede cristiana: la morte e la Risurrezione di Gesù. Partendo dalla Domenica delle Palme con l’arrivo di Gesù a Gerusalemme, l’insegnante presenterà un
Gesù buono e misericordioso, che offre il suo amore a tutti e che, solo attraverso questo dono, può manifestare quanto grande è l’AMORE DI DIO PER L’UMANITÀ intera. È importante anche far comprendere che anche Gesù ha avuto paura, essendo uomo, delle cattiverie e delle ingiustizie, ma con il suo sacrificio donerà la luce che permetterà di intraprendere la giusta strada per arrivare a Lui.
La Pasqua cristiana, intesa come vita nuova e festa della gioia, come il Natale, è fatta di segni e simboli che aiutano a capirne il significato.
Attraverso la storia del chicco di grano aiutiamo i bambini a cogliere il parallelo con la morte e risurrezione di Gesù. Anche Gesù, come il chicco di grano, è stato ucciso dai suoi nemici ed è rimasto per tre giorni nella terra dentro al sepolcro. Ma Dio, suo Padre, non lo ha lasciato prigioniero della morte. Lo ha risvegliato, dandogli una vita nuova, lo ha fatto risorgere ed ora egli vive per sempre.
Ero un piccolo chicco di grano nascosto dentro un sacco e mi stavano portando sopra un carro al mulino per essere schiacciato, frantumato e trasformato in candida farina. Non mi piaceva proprio essere schiacciato e frantumato, volevo vivere e conoscere il mondo.
Approfittai di uno scossone del carro che mi trasportava, per fare un salto e liberarmi dal sacco che si era un po’ aperto. Fu un salto molto lungo che mi portò a rotolare lungo il pendio della strada per qualche metro. Alla fine mi trovai in un campo appena aratro tra le zolle ancora fumanti.
«Sono stato fortunato!» pensai, e scivolai in mezzo alle zolle calde e umide formando come un nido. Per qualche giorno mi riposai e stetti tranquillo, poi scese la pioggia e sentii come un brivido: la terra umida aveva intaccato la mia pelle che ora cadeva come se fosse fatta di squame.
Mi accorsi che avveniva qualcosa dentro di me: sentivo un gran freddo e mi sembrava di morire, ma non potevo fare niente: ormai ero prigioniero delle zolle. Per un tempo, lunghissimo, mi sembrò di aver come dormito, poi mi svegliai: non ero più al buio. Attorno splendeva la luce e sentivo su di me il calore dei
raggi del sole. Solo allora mi accorsi di non essere più un piccolo seme: mi ero completamente trasformato, ero diventato un tenero filo d’erba verde, anzi un piccolo germoglio.
Avevo dormito sotto la neve tutto l’inverno ed ora mi risvegliavo non più seme, ma piccola pianta di frumento. Era accaduto anche a me il miracolo della vita: dal chicco che marcisce e muore nasce una nuova vita!
Ero diventato una grossa spiga piena di tanti chicchi. Non mi importava più se poi questi chicchi sarebbero stati schiacciati per diventare una bianca farina.
Ora sapevo che con la farina si fa il pane, i dolci... Si sfamano e si fanno crescere i bambini, e questo mi sembrava molto bello.
Dopo aver letto il racconto discutiamone il contenuto proponendo domande che aiutino a comprendere e interiorizzare i significati simbolici in esso nascosti:
RIFLETTIAMO
• Al chicco di grano si presentano due possibilità. Quali?
• In tutti e due i casi, che cosa gli succede?
• Come si conclude il racconto per il chicco di grano?
Una nuvola giovane (ma, è risaputo, la vita delle nuvole è breve e movimentata) faceva la sua prima cavalcata nei cieli, con un branco di nuvoloni gonfi e bizzarri. Quando passarono sul grande deserto del Sahara, le altre nuvole, più esperte, la incitarono: «Corri, corri! Se ti fermi qui sei perduta!». La nuvola però era curiosa, come tutti i giovani, e si lasciò scivolare in fondo al branco delle nuvole, così simile ad una mandria di bisonti sgroppanti. «Cosa fai? Muoviti!» le ringhiò dietro il vento. Ma la nuvoletta aveva visto le dune di sabbia dorata: uno spettacolo affascinante. E planò leggera leggera. Le dune sembravano nuvole d’oro accarezzate dal vento.
Una di esse le sorrise. «Ciao» le disse. Era una duna molto graziosa, appena formata dal vento, che le scompigliava la luccicante chioma.
«Ciao. Io mi chiamo Ola» si presentò la nuvola.
«Io Una» replicò la duna.
«Com’è la tua vita lì giù?».
«Beh... Sole e vento. Fa un po’ caldo ma ci si arrangia. E la tua?».
«Sole e vento... grandi corse nel cielo».
«La mia vita è molto breve. Quando tornerà il gran vento, forse sparirò».
«Ti dispiace?».
«Un po’. Mi sembra di non servire a niente».
«Anch’io mi trasformerò presto in pioggia e cadrò. È il mio destino».
La duna esitò un attimo e poi disse: «Lo sai che noi chiamiamo la pioggia Paradiso?».
«Non sapevo di essere così importante!» rise la nuvola.
«Ho sentito raccontare da alcune vecchie dune quanto sia bella la pioggia. Noi ci copriamo di cose meravigliose che si chiamano erba e fiori».
«Oh, è vero. Li ho visti!».
«Probabilmente io non li vedrò mai», concluse mestamente la duna.
La nuvola rifletté un attimo, poi disse: «Potrei pioverti addosso io...».
«Ma morirai...».
«Tu però, fiorirai», disse la nuvola e si lasciò cadere, diventando pioggia iridescente.
Il giorno dopo la piccola duna era fiorita.
Bruno Ferrero
Progetto “Festa di primavera”
Gli alunni, suddivisi in sottogruppi di 4-5, dovranno decidere di cosa occuparsi per la realizzazione della festa: giochi - addobbi - bibite e dolci - musiche e danze - locandina d’invito - piccolo ricordino della festa. Per aiutarli nel loro lavoro si possono predisporre delle griglie per ogni attività da svolgere sulle quali vi siano indicati i seguenti elementi.
GRUPPO 1
GIOCHI
• Nome dei partecipanti
• Quali giochi proporre
• Cosa serve
• Chi può aiutarci
GRUPPO 4
MUSICHE E DANZE
• Nome dei partecipanti
• Quali musiche proporre
• Cosa serve
• Chi può aiutarci
La gimcana
GRUPPO 2
ADDOBI
• Nome dei partecipanti
• Quali addobbi realizzare
• Cosa serve
• Chi può aiutarci
GRUPPO 5 LOCANDINA
• Nome dei partecipanti
• Quale locandina proporre
• Cosa serve
• Chi può aiutarci
GRUPPO 3
BIBITE E DOLCI
• Nome dei partecipanti
• Quali cibi sono più indicati
• Come predisporli
• Chi può aiutarci
GRUPPO 6
RICORDINO
• Nome dei partecipanti
• Quale oggetto proporre
• Cosa serve
• Chi può aiutarci
Si traccia un percorso con delle difficoltà o degli ostacoli che i bambini devono superare, evitando di andarvi addosso. Vince il bambino che compie il percorso correttamente nel minore tempo possibile.
Esempio di percorso: girare due volte intorno ad una sedia, saltare oltrepassando un sasso, passare sotto un tavolinetto, prendere un bicchiere d’acqua e portarlo correndo da un tavolo ad un altro, arrivare al traguardo saltellando su un piede.
Corsa con i sacchi
Si tracciano due linee: una di partenza e una di arrivo. I bambini si collocano sulla linea di partenza, infilandosi in un sacco. Al comando dell’insegnante “Via!” i piccoli devono saltellare e raggiungere il traguardo. Vince chi arriva per primo.
I bimbi si dispongono in cerchio e un compagno si pone al centro.
Ogni bambino rappresenta un fiore (rosa, viola, tulipano, giglio, ecc…). Il bimbo che si trova al centro del cerchio rappresenta la farfalla e lancia una palla ad un compagno, dicendo: “La farfalla vola sulla… rosa!”. Il bambino che rappresenta la rosa deve afferrare la palla che il compagno gli lancia e, a sua volta, la deve lanciare ad un altro compagno. Chi lascia cadere la palla o sbaglia a lanciarla al compagno che rappresenta il fiore da lui nominato esce dal gioco.
Due bambini fanno una rete, tenendosi per mano. Essi devono catturare i compagni, uno alla volta, quando volano liberamente nel prato.
Questi ultimi rappresentano le farfalle.
Ogni “farfalla” catturata si aggiunge alla “rete” che naturalmente diventerà sempre più lunga. Vince il gioco la “farfalla” che non viene catturata.
Costruiamo un cartellone e delle cartelle con cartoncino resistente.
Facciamo disegnare e colorare ai bambini i fiori del prato e del giardino che sbocciano in Primavera. In una scatolina mettiamo gli stessi fiori che ci sono sul cartellone in forma ridotta. Facciamo prendere a turno ai bambini un fiore. Chi riesce a coprire per primo i fiori della sua cartella con dei sassolini o legumi vince.
Dopo la lettura della storia, possiamo far ascoltare e ripetere una delle seguenti filastrocche.
Filastrocca di primavera
Filastrocca di primavera più lungo è il giorno, più dolce è la sera.
Domani forse tra l’erbetta spunterà la prima violetta.
Oh prima viola fresca e nuova beato il primo che ti trova, il tuo profumo gli dirà, la primavera è giunta, è qua.
Gli altri signori non lo sanno e ancora in inverno si crederanno: magari persone di riguardo, ma il loro calendario va in ritardo.
G. Rodari
Dall’uovo di Pasqua
Dall’uovo di Pasqua è uscito un pulcino di gesso arancione col becco turchino.
Ha detto: «Vado, mi metto in viaggio e porto a tutti un grande messaggio».
E volteggiando di qua e di là attraversando paesi e città ha scritto sui muri, nel cielo e per terra: «Viva la pace, abbasso la guerra.»
G. Rodari
C’è una chiesetta sulla collina con i fiori di pesco ed una bambina. C’è una chiesetta con le campane, suonano forte e si senton lontane, suonano a festa e brillan nel sole; è il giorno di Pasqua, è risorto il Signore.
C. Zago
Un giorno un chiccolino giocava a nascondino nessuno lo trovò e lui si addormentò.
Dormì sotto la neve un sonno lungo e greve, e quando si svegliò una spiga diventò.
Il sole la baciava, il vento la cullava, di chicchi allor s’empì pel pane di ogni dì.
Colora, decora e ritaglia i braccialetti e i segnalibri di Primavera, da donare a ricordo della festa vissuta in classe.
Colora la scena e, in base al racconto che hai ascoltato, disegna la pioggia e l’oasi verde sulla duna del deserto.
Completa e colora i disegni.
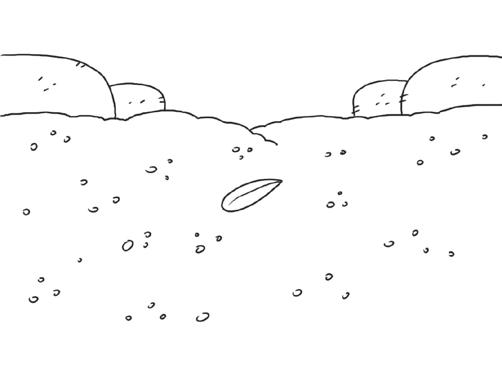
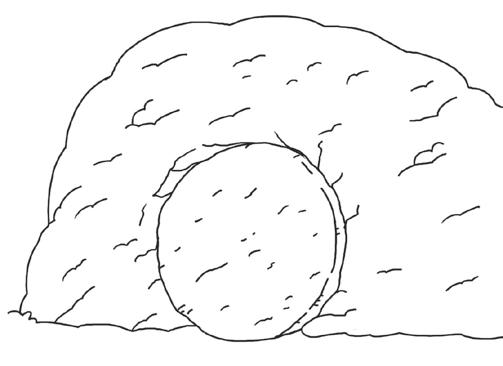


Metti una X sulla risposta giusta. Colora.
IN QUALE CITTÀ È MORTO GESÙ?
□ BETLEMME
□ GERUSALEMME
□ NAZARETH
COSA DISSE L’ANGELO ALLE DONNE?
□ NON DITE NIENTE A NESSUNO!
□ GESÙ È SCAPPATO VIA!
□ GESÙ È NON È QUI. È RISORTO!
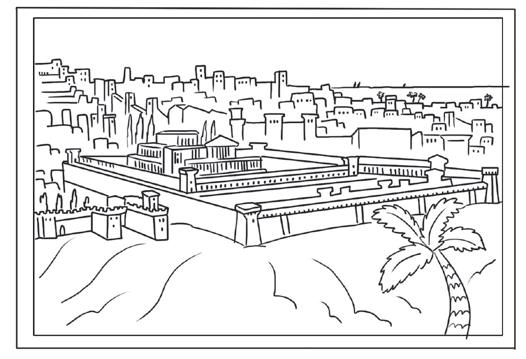
CHE COSA RICORDA LA FESTA DI PASQUA?
□ LA NASCITA DI GESÙ
□ LA RISURREZIONE DI GESÙ
□ IL RESURREZIONE BATTESIMO DI GESÙ
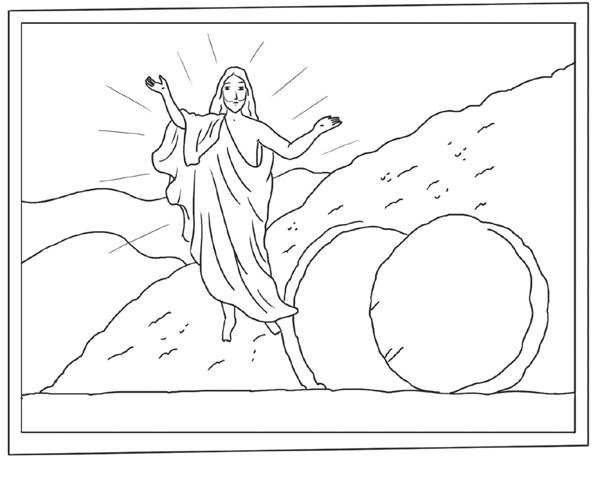

Colora e devora la campana di Pasqua come nel modello. Appendila su una finestra della scuola assieme a quelle dei tuoi compagni.
Colora il parco di giorno e di notte scegliendo i colori adatti.
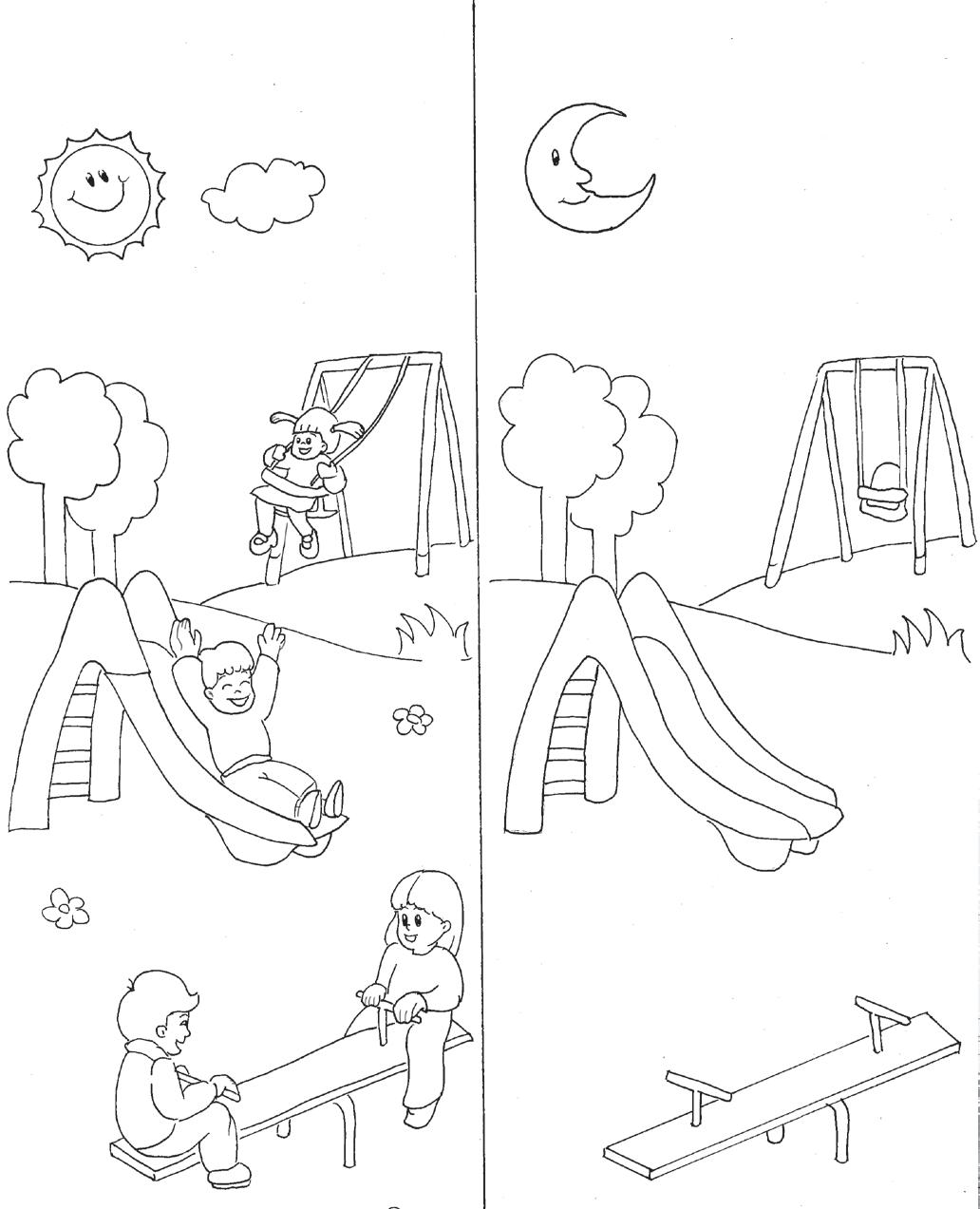
Colora le vignette e riordinale, numerandole da 1 a 4.
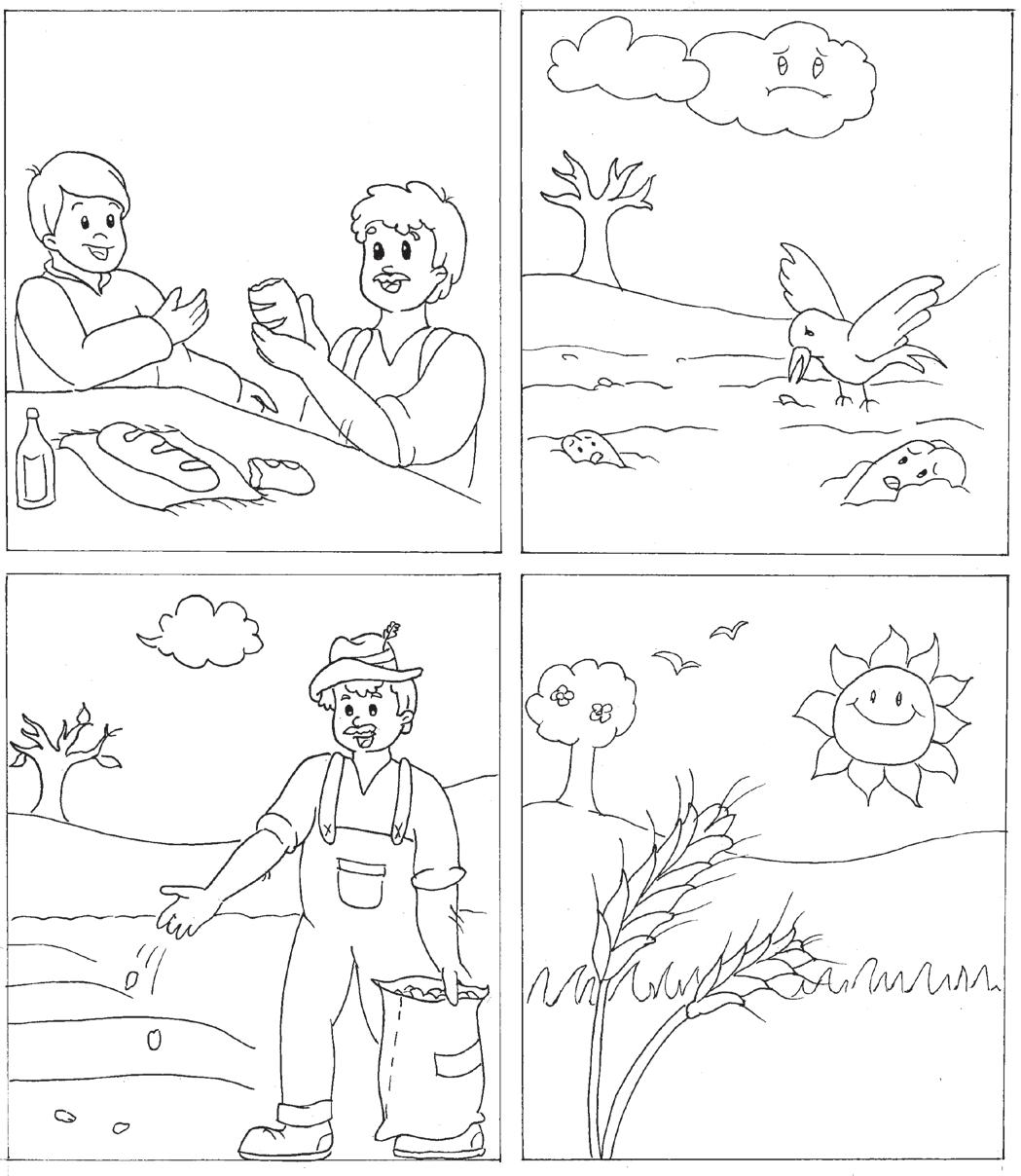
L’alunno…
Traguardi per lo Sviluppo delle Competenze

• identifica nella Chiesa la comunità di coloro che credono in Gesù Cristo. u ni Ta di apprendimen T o p er la p rogrammazione
Ecco la Chiesa! • La nascita della Chiesa.
• La Chiesa, casa di Gesù e famiglia dei credenti in Cristo risorto.
Da pag. 72 a pag. 84 Dio e l’uomo
• Individuare i tratti essenziali della Chiesa.
I valori etici e religiosi
• Riconoscere il valore della domenica come giorno sacro per i cristiani.
• Conoscere, per maturare forme di rispetto, i luoghi sacri delle religioni più diffuse al mondo.
Il nostro itinerario si avvia alla conclusione. I bambini hanno scoperto che dalle vicende pasquali è iniziata una nuova storia per l’umanità, segnata dalla nascita della Chiesa.
L’insegnante guiderà gli alunni, in questa parte finale dell’anno scolastico, a scoprire la CHIESA INTESA COME la COMUNITÀ DEI CREDENTI IN GESÙ risorto, una famiglia di famiglie, che, animata dallo Spirito Santo, annuncia ogni domenica il mistero pasquale. Verrà poi presentata anche la chiesa edificio, il luogo di culto dei cristiani, per conoscerne le parti principali e le sue funzioni. Al termine dell’anno scolastico potranno essere presentati anche i luoghi di preghiera delle altre religioni in modo da stimolare gli alunni a una visione intercul-
turale e interreligiosa della nostra realtà sociale. Spieghiamo ai bambini che vi sono persone che pregano in edifici diversi dalla chiesa perché appartengono ad ALTRE RELIGIONI.
Nel nostro contesto sociale alcune esemplificazioni dei luoghi di preghiera, diverse dalla chiesa cristiana, sono essenzialmente la MOSCHEA (Islam) e la SINAGOGA (Ebraismo). È a queste che si fa generalmente riferimento, ma se nel nostro territorio fosse presente qualche altra realtà, sarà utile tenerne debito conto.
Sia che riusciamo ad organizzare una breve visita a una chiesa del quartiere per vedere direttamente il luogo di riunione dei cristiani, sia che non prevediamo questa uscita didattica, possiamo proporre la lettura del brano che segue. Il racconto è come una visita vera e propria in cui i bambini, come i personaggi del libro di testo, si trovano a identificarsi con la protagonista.
Simona ha sei anni. Spesso, nel pomeriggio va a passeggio con nonna Ada. Simona ha sempre tante domande da fare alla nonna: le chiede notizie su tutto ciò che vede. Spesso passano sempre davanti ad un edificio diverso da tutte le altre case: è piuttosto grande, ma non è diviso in piani. Non ci sono finestre né balconi. Sulla facciata, sopra la porta c’è una grande finestra rotonda con vetri colorati. La porta è molto larga e per metà aperta, ma non ci sono né campanelli, né il nome degli inquilini. Accanto c’è come una torre che termina con una punta aguzza, dentro la torre si vedono quattro campane. Presa dalla curiosità Simona chiede alla nonna che cosa sia quell’edificio diverso dagli altri. La nonna, invece di rispondere, le dice: «Andiamo dentro, così puoi vederlo…».
Entrata dalla grande porta, Simona dapprima si ferma un po’ perplessa poiché si tratta di una grande stanza con delle file di sedie. Vorrebbe correre avanti e vedere meglio, ma la nonna la trattiene e le dice: «In chiesa non si corre, non si parla ad alta voce e... prima di tutto, si saluta!».
Simona non capisce: chi deve salutare, se non vede nessuno? Solo verso la metà della stanza si vede una giovane signora seduta in silenzio, ma lei non la cono-
sce e le hanno detto di non salutare le persone che non si conoscono. La nonna, allora, fa un gesto un po’ strano: intinge la mano in una bacinella di pietra che è vicina alla porta e solleva la mano alla fronte per fare il segno della croce e poi con il dito ancora umido di acqua traccia una piccola croce sulla fronte di Simona. La nonna, poi, tenendo sempre per mano la piccola Simona, va avanti nella grande sala e si siede su una panca davanti ad un banco di legno. Prima di sedersi, però, compie un altro gesto un po’ strano: si piega sulle ginocchia e rimane per qualche tempo in silenzio con le mani giunte. Simona è seduta accanto alla nonna e guarda intorno con curiosità. Alcune cose la incuriosiscono: in mezzo alla stanza c’è come una grande tavola di marmo coperta da una bianca tovaglia, dietro c’è come una casetta con una porticina dorata e, accanto, c’è una luce rossa che brilla. Sopra un sostegno c’è un grande libro aperto e alle pareti poi ci sono dei grandi quadri ed alcune statue. Simona tira la gonna della nonna. Vuole chiederle tante cose, ma la nonna le dice: «Aspetta che la nonna finisca di salutare Gesù e poi ti dirà tutto quello che vuoi».
Dopo qualche minuto la nonna fa un bel segno di croce e si alza dicendo: «E ora facciamo un giro per la chiesa...».
M. Filippi, Una casa per crescere e stare insieme, Elledici
• Chi sono i personaggi della storia?
• Come viene descritto l’edificio dall’esterno?
• Cosa fa la nonna quando entra in chiesa?
• Quali sono le curiosità di Simona?
• Perché seconde te nonna Ada, solo alla fine decide di accompagnare Simona a fare un giro della chiesa?
La canzone Pim Pam che tanti ricordano di aver cantato in oratorio, con gli scout, o in gita scolastica, è facile da ricordare e accompagna idealmente il cammino verso una casa speciale in cui un Signore accoglie tutti coloro che vi entrano. Spieghiamo ai bambini che questa casa è la chiesa, la casa di Dio tra gli uomini che il Signore Gesù ha scelto per mostrarci che il suo amore è sempre in mezzo a noi.
Nella casa sulla montagna un camino grande grande sta, nel camino grande grande grande un gran fuoco fuoco fuoco va.
Perciò pim pam le scarpe pim pam di notte fan sul sentiero di pietre grosse, pim pam le scarpe pim pam di notte fan sul sentiero così.
Nella casa sulla montagna un Signore grande grande sta, nella stanza verde viola e bianca tante sedie rosse e bianche ha.
Perciò pim pam le scarpe pim pam di notte fan sul sentiero di pietre grosse, pim pam le scarpe pim pam di notte fan sul sentiero così.
Nella casa sulla montagna una sedia a tutti, tutti dà; a ciascuno toglierà le scarpe tutti insieme poi si danzerà.
Perciò pim pam le scarpe pim pam di notte fan sul sentiero di pietre grosse, pim pam le scarpe pim pam di notte fan sul sentiero così.
Nella casa sulla montagna un camino grande grande sta; nel camino grande grande grande più più fuoco fuoco fuoco va.
Perciò pim pam le scarpe pim pam di notte fan sul sentiero di pietre grosse, pim pam le scarpe pim pam di notte fan sul sentiero fin qui.
Nella casa: disegnare con le mani il tetto a triangolo di una casa; sulla montagna: innalzare le braccia sopra il capo e congiungerle; un camino disegnare con i due indici un quadrato molto grande; grande, grande: allargare il quadrato un gran fuoco: incrociare le braccia e muoverle come un serpente.
Pim Pam: battere le mani a ritmo della canzone; le scarpe: battere i piedi continuare fino alla fine del ritornello.
Nella casa: disegnare con le mani il tetto a triangolo di una casa; sulla montagna: innalzare le braccia sopra il capo e congiungerle; un Signore: rivolgere il dito indice verso l’alto nella stanza: disegnare un semicerchio con il braccio; tante sedie: indicare con il dito indice le sedie della classe per due volte.
Nella casa: disegnare con le mani il tetto a triangolo di una casa; sulla montagna: innalzare le braccia sopra il capo e congiungerle; una sedia: indicare con l’indice la sedia; a tutti dà: indicare la sedia del compagno vicino toglierà le scarpe: mimare il gesto di togliersi le scarpe; da tutti insieme… fino a danzerà: mettere le mani sui fianchi e ondeggiare.
Dopo la lettura della storia, possiamo far ascoltare e ripetere una delle seguenti filastrocche.
Ecco la chiesa col suo campanile, e sul campanile splende la croce; ma dentro è deserta e non si sente voce. Suonate, campane, suonate a distesa, perché tutti vengano dentro la chiesa!
Ecco la chiesa col suo campanile, ed alta e forte la voce dei fedeli: “Gloria al Signore ch’è nei cieli!”.
M. Gross
Al centro del paese s’innalza una chiesetta: vicino il campanile, davanti una piazzetta. Lungo la settimana è quasi sempre vuota, c’è solo una vecchietta che entra per pregar. Ma quando vien domenica la vedo sempre piena di mamme e di bambini, di nonni e di papà.
La gente si saluta, poi entra con rispetto, si segna con la croce, fa la genuflessione. In mezzo c’è l’altare con le candele accese, accanto un grande libro, il libro del Vangelo.
Poi entra il sacerdote, saluta e dice a tutti: «Voi siete i benvenuti in casa del Signor».
La gente canta e prega, perdona e fa la pace, ascolta il sacerdote che parla di Gesù.
Come una grande casa così è la nostra chiesa; le porte sempre aperte per incontrar Gesù.
M. Filippi
Metti in sequenza, numerandole, le scene della parabola della pecora smarrita. Poi disegna nel riquadro le pecore tutte al sicuro nel loro recinto.
Descrivi l’immagine e colora. Scrivi al posto giusto le seguenti parole: FACCIATA - PORTALE - ROSONE - CAMPANILE - CROCE
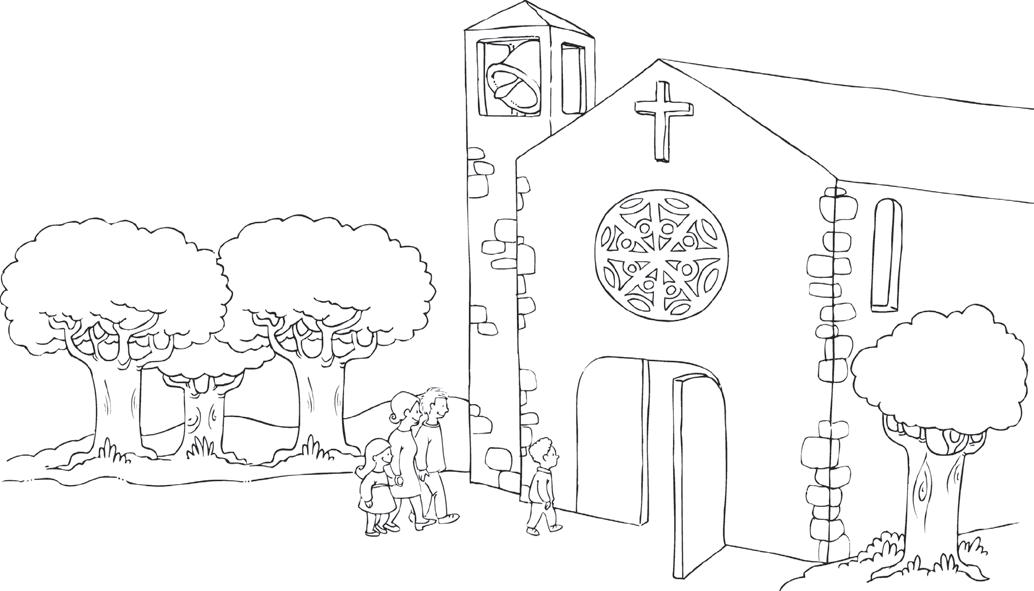
SECONDO LA TRADIZIONE, I CRISTIANI CHE ENTRANO IN CHIESA TOCCANO CON LA MANO L’ACQUA SANTA CONTENUTA NELL’ACQUASANTIERA E SI FANNO IL SEGNO DELLA CROCE. SE NELLA CHIESA È CONSERVATO IL SANTISSIMO SACRAMENTO (CIOÈ L’OSTIA CONSACRATA), IL FEDELE È INVITATO A INGINOCCHIARSI.
Colora i disegni e mettili in ordine, numerando da 1 a 4.
DURANTE LA MESSA IL SACERDOTE INVITA I FEDELI A SCAMBIARSI UN GESTO DI PACE
ATTRAVERSO UNA STRETTA DI MANO. Scrivi nel fumetto l’augurio di pace che si scambiano i due bambini.
IN TUTTI I PAESI DEL MONDO CI SONO LUOGHI IN CUI LE PERSONE PREGANO DIO CON IL CUORE RIVOLTO AL BENE.
Aiuta ogni bambino a raggiungere il proprio luogo di preghiera. Trascrivi nei puntini le lettere che incontri lungo ciascun percorso. Scoprirai i nomi di tre importanti edifici sacri.
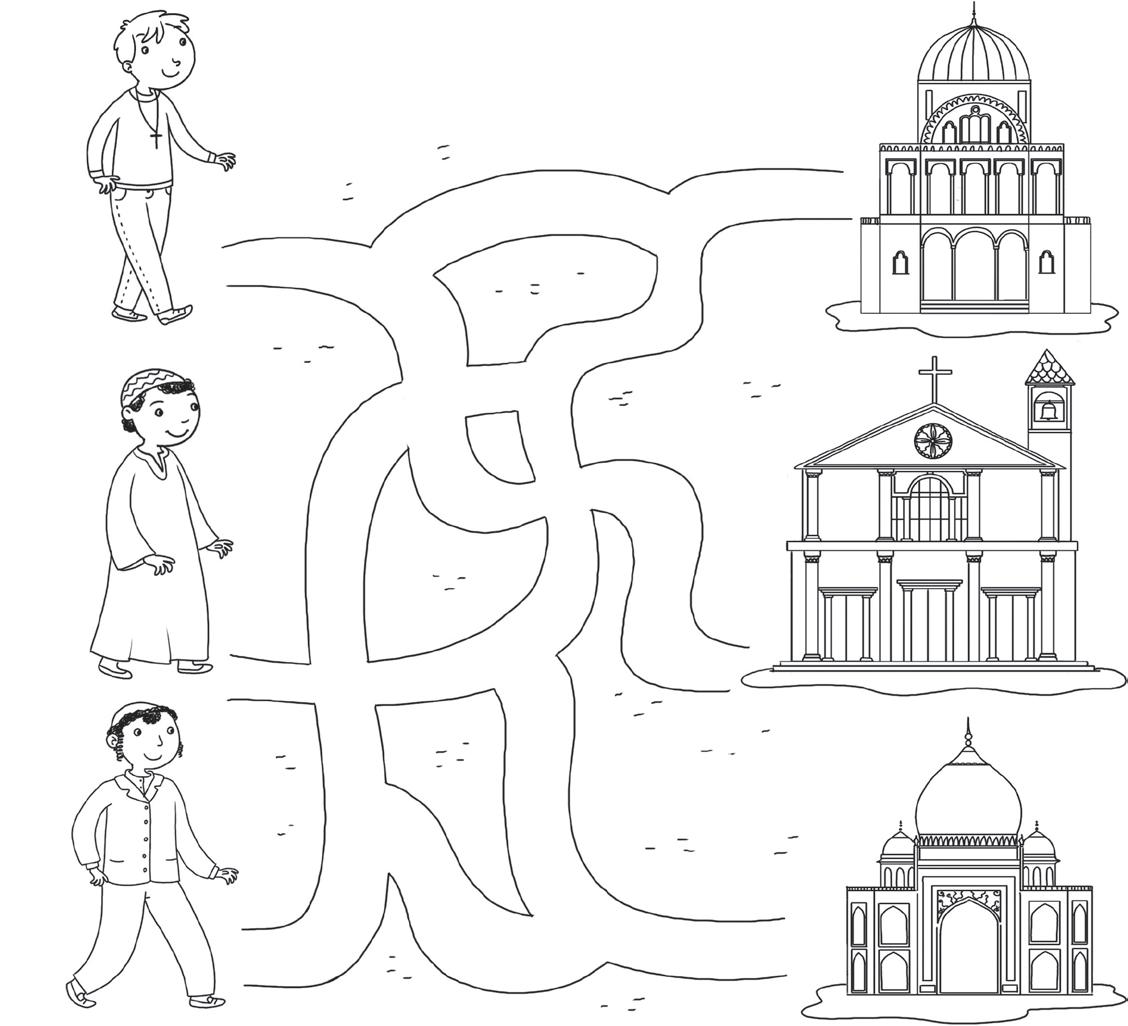
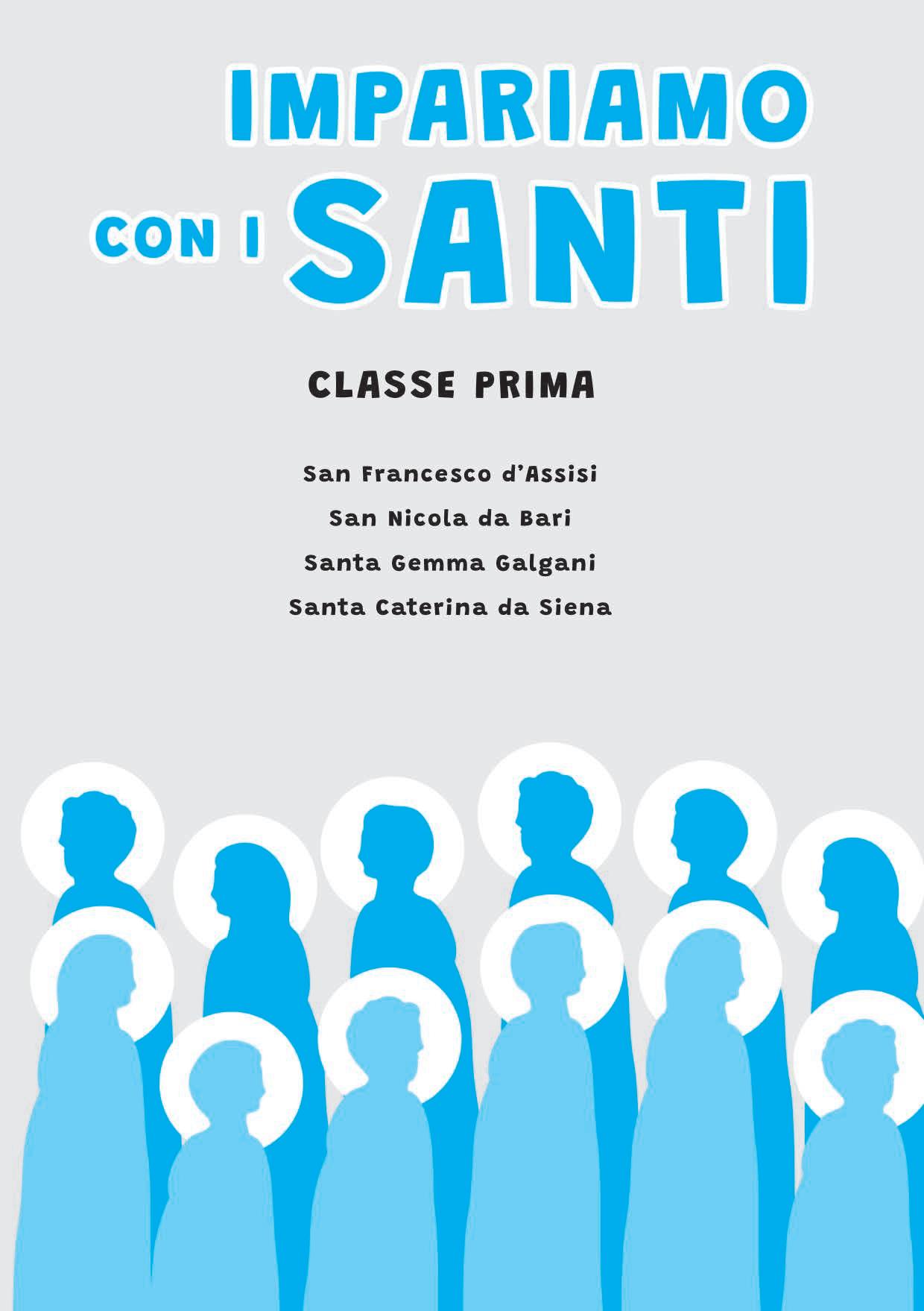
Assisi, Perugia, 1182 – 3 ottobre 1226
Francesco nacque ad Assisi nel 1182, nel pieno del fermento dell’età comunale. Figlio di un mercante, da giovane aspirava a entrare nella cerchia della piccola nobiltà cittadina. Per questo ricercò la gloria tramite le imprese militari, finché comprese di dover servire solo il Signore. Si diede quindi a una vita di penitenza e solitudine in totale povertà, dopo aver abbandonato la famiglia e i beni terreni. Nel 1209, in seguito a un’ulteriore ispirazione, iniziò a predicare il Vangelo nelle città, mentre si univano a lui i primi discepoli. Con loro si recò a Roma per avere dal papa Innocenzo III l’approvazione della sua scelta di vita. Dal 1210 al 1224 peregrinò per le strade e le piazze d’Italia: dovunque accorrevano a lui folle numerose e schiere di discepoli che egli chiamava “frati”, cioè “fratelli”. Accolse poi la giovane Chiara che diede inizio al Secondo Ordine francescano, e fondò un Terzo Ordine per quanti desideravano vivere da penitenti, con regole adatte per i laici. Morì la sera del 3 ottobre del 1226 presso la chiesa di Santa Maria degli Angeli ad Assisi. È stato canonizzato da papa Gregorio IX il 16 luglio 1228. Papa Pio XII ha proclamato lui e santa Caterina da Siena Patroni Primari d’Italia il 18 giugno 1939. I resti mortali di colui che è diventato noto come il “Poverello d’Assisi” sono venerati nella Basilica a lui dedicata ad Assisi, precisamente nella cripta della chiesa inferiore.
MERCANTE, ASSISI, CAVALIERE, ANIMALI, NATURA, GRAZIE, FRATELLI, SORELLE, PRESEPE, POVERTA
Patronato: Italia, Ecologisti, Animali, Uccelli, Commercianti, Lupetti/Coccin. AGESCI
Etimologia: Francesco = libero, dall’antico tedesco
Emblema: Lupo, Uccelli
Martirologio Romano: Memoria di san Francesco, che, dopo una spensierata gioventù, ad Assisi in Umbria si convertì ad una vita evangelica, per servire Gesù Cristo che aveva incontrato in particolare nei poveri e nei diseredati, facendosi egli stesso povero. Unì a sé in comunità i Frati Minori. A tutti, in modo itinerante, predicò l’amore di Dio, fino anche in Terra Santa, cercando nelle sue parole come nelle azioni la perfetta sequela di Cristo, e volle morire sulla nuda terra.
Della nascita di Francesco non si conosce con certezza né il giorno, né il mese e neppure l’anno. Comunemente, si accetta il 1182 come anno della sua venuta al mondo. Sia alla nascita che al fonte battesimale, il padre Pietro di Bernardone dei Moriconi, era assente, e la madre, la nobil donna Pica Bourlemont, d’origine provenzale, gli mise il nome Giovanni. Al ritorno dal viaggio di lavoro in Francia, il padre lo chiamò Francesco. Era una famiglia della borghesia nascente della città di Assisi. Riceve la prima formazione in famiglia, specialmente dalla madre Pica, molto devota e pia. Intorno ai 6 anni frequenta il primo grado di istruzione per 5 anni. Vi si insegnava a leggere e a scrivere non solo in latino (la propria lingua), ma anche in francese; a cantare inni liturgici e salmodia; e anche a misurare secondo i
non facili calcoli del tempo. E molto probabile, invece, che, per la sua elevata condizione economica e per assicurarsi una qualsiasi apertura alla vita sociale o alla carriera militare, Francesco abbia frequentato anche un corso di formazione superiore, presso qualche abbazia vicina.
La crisi
Prima del crollo definitivo di un progetto, c’è sempre un barlume di speranza, in cui l’uomo resta completamente solo con sé stesso, solo con la propria ambiguità, solo con l’essere di cui non si è potuto realizzare. Alla prima occasione, riemerge all’improvviso un guizzo dell’ideale desiderato. La campagna antimperiale, promossa dal papato nell’Italia meridionale, offrì a Francesco la possibilità di arruolarsi, per il raduno in Puglia. Così, tutto impettito nella lussuosa armatura militare a cavallo, e con profonda commozione e vivida speranza, prese commiato dai suoi cari in pena, dagli amici invidiosi e dalla ridente città natale. Il viaggio della speranza durò un sol giorno: nella tappa-sosta di Spoleto.
Episodio di Spoleto
Che cosa è accaduto? Difficile dirlo. Solo congetture. Le Fonti ricorrono al soprannaturale con l’espediente della visione in sogno. Altre ipotesi: un improvviso riacutizzarsi della malattia; qualche dispetto di commilitone; la riflessione sulle finalità dell’arruolamento per guadagno e non per ideale; un ripensamento sull’inutilità della guerra per risolvere i problemi sociali... Questi e altri pensieri avranno turbinato nell’animo di Francesco, durante la prima notte della sua avventura militare. Il ritorno inatteso e solitario fa scalpore in Assisi. Un mormorio di curiosità e di dicerie passa di porta in porta e da bocca a bocca. I genitori assaporano l’amarezza della delusione. Francesco è provato dalle contrastanti emozioni, da cui si sente circondato dentro e fuori casa. Al rientro da Spoleto, divenne più riservato solitario e taciturno, ma anche più attento alle esigenze degli altri e più prodigo verso i poveri. Cominciò a percepire una maggiore sensibilità verso la caducità della vita e delle cose. Questo “distacco” gli permetteva di essere libero-da e dare un diverso gusto alla vita, con uno spiccato bisogno interiore di stare solo con sé stesso e di abbandonare ogni altra occupazione. Onde, la ricerca di luoghi solitari e impervi. Al distacco dalle cose, Francesco aggiunse anche il “silenzio” dalle cose, aprendosi all’origine della loro esistenza, tanto da provocare in lui profonda gioia interiore, e contribuire a dimenticare anche le precedenti sofferenze. Nel cuore di Francesco era tornato la gioia: aveva trovato il segreto che lo rendeva “libero” da ogni cosa e “aperto” a ogni realtà.
Bacio al lebbroso
Ne è un esempio l’episodio del “lebbroso”. Nel contado di Assisi erano abbastanza evidenti i segni della guerra: lutti miseria malattie carestia disordine morale... La mancanza di adeguate strutture per la prima assistenza concreta costringeva alcuni ad “arrangiarsi”, girovagando per le campagne deserte, in cerca di qualcosa per sopravvivere o per tranquillizzare l’animo esacerbato dalla lotta fraterna tra ricchi e poveri. Disumana, invece, era la condizione del malato di lebbra, lasciato solo con sé stesso in balia del suo male. In un momento della sua crisi, Francesco si aggirava per le campagne in cerca di tranquillità interiore, e si incontrò con
un lebbroso. Superata l’istintiva ripulsa, lo abbracciò e gli consegnò il denaro che possedeva. Con questa nuova gioia, fece il pellegrinaggio a Roma, in S. Pietro, come “finto” povero.
Ai piedi del Cristo crocifisso, per es., la preghiera si trasformò in contemplazione, fino all’immedesimazione: Francesco si trovava come sospeso tra la profondità della sua psiche e la trascendenza di Dio: “Sommo e glorioso Dio, illumina le tenebre del cuore mio, e dammi fede retta, speranza certa e carità perfetta, saggezza e conoscimento, o Signore, affinché io faccia il tuo santo e verace comandamento” (Preghiera davanti al Crocifisso, in K. Esser, Gli Scritti di S. Francesco d’Assisi, Ed. Messaggero, Padova 1982, pp. 452-453). L’invocazione di Francesco al Crocifisso segnò il momento decisivo della sua crisi. Anche l’espressione “ripara la mia casa che è in rovina”, gettò indicibile gioia nel cuore di Francesco, che si sentì investito della missione di riparare la cappella di S. Damiano. Anche l’episodio di Foligno perfeziona la sua volontà che lottava tra due sofferenze: quella per il disagio provocato all’ambiente familiare; e l’altra per l’ostacolo non superato a riparare la casa del Crocifisso per mancanza di fondi. Intensificò, perciò, raccoglimento e preghiera. Grande giovamento ricevette dall’ascolto di alcune espressioni evangeliche, diventate di moda per la diffusione ad opera dei movimenti pauperistici. Si ricordano alcune che dividono il cuore: “Se uno non odia suo padre, sua madre, la moglie, i figli, i fratelli, le sorelle e perfino la propria vita, non può essere mio discepolo” (Lc 14, 26); “Chi non rinuncia a tutti i suoi averi, non può essere mio discepolo” (Lc 14, 33); “È più facile che un cammello entri nella cruna di un ago, che un ricco entri nel regno dei Cieli” (Mt 19, 24); “Chi avrà lasciato casa fratelli sorelle padre madre figli campi per il mio nome, riceverà cento volte tanto e avrà in eredità la vita eternal” (Mt 19, 29); “Chi compie la volontà di Dio, costui è mio fratello sorella e madre” (Mc 3, 35).
La dura decisione
Mentre Francesco era tutto intento a gustare l’immensa gioia interiore, proveniente dalla Parola del Signore, ecco che gli venne notificato, dai messi dei Consoli di Assisi, la citazione di comparizione, avanzata dallo sconsolato padre, Pietro di Bernardone. Senza punto scomporsi e valendosi di una consuetudine, diffusa tra gli eremiti e i penitenti, si autodichiarò servus Ecclesiae, sottraendosi così alla giurisdizione dell’autorità civile. Nella piazza, dove il Vescovo amministrava la giustizia, si presentò Francesco tra l’emozione di alcuni e la curiosità di molti. E compì la “dura” decisione della sua conversione.
La prima esperienza apostolica
Il campo della primitiva esperienza è Assisi. Gli ascoltatori sono i suoi concittadini. Nel vederlo e ascoltarlo, alcuni consideravano Francesco un fallito e un pazzo, altri si lasciarono commuovere dalla sua scelta. La parola di Francesco usciva dal cuore per potenza e ricchezza d’amore. All’amore non si resiste, si risponde solo con amore. E Francesco, con parola semplice e d’amore infuocata, riusciva a risvegliare negli ascoltatori più benevoli quella scintilla d’amore divino, insito in ogni cuore, che dalla curiosità porta all’ammirazione e alla sequela.
I primi compagni
Il primo gruppetto era composto da 5 amici, di cui due sacerdoti, Pietro e Silvestro; due laici, Bernardo ed Egidio; e lo stesso Francesco. Dopo l’esperienza in Assisi, per la quale era sufficiente l’autorizzazione del Vescovo per predicare il verbum exortationis, Francesco fu come spinto da un impulso interiore a travalicare i confini del contado, per espandere la fragranza della sua gioia nelle località limitrofe. Improvvisò così una piccola spedizione missionaria, inviando gli amici a due a due per le vicine città. Nel momento della verifica ad Assisi, Francesco si accorse delle reali difficoltà cui andava incontro il suo ideale e cominciò a pensare ai problemi di organizzazione. Come proposta viene fuori la necessità di dare al gruppo una organizzazione interna e garantirne la struttura giuridica. Per attuarla si decise di andare dal signor Papa, per chiedere la conferma al loro propositum vitae. Così, il gruppetto andò a Roma, ottenendo la conferma orale da parte di Innocenzo III.
La fondazione dell’Ordine
La prima Regola, presentata da Francesco nel 1221 per l’approvazione da Roma, è detta non bollata, perché non ricevette alcuna conferma da parte del Papa. In un momento molto provato della sua vita, Francesco riuscì, con la collaborazione di frati esperti e della stessa curia romana, a scrivere una nuova Regola, che Onorio III approvava con la bolla Solet annuere del 29 novembre 1223. Così, dal 1223 nasceva la Regola bollata dell’Ordine dei Frati Minori, che regola a tutt’oggi la vita dei francescani.
L’amore per la Terra Santa
Nel primo Capitolo Generale dei Frati Minori del 1217, Francesco divise il mondo da evangelizzare in “province”: tra le undici appare anche quella di Terra Santa, che comprendeva Costantinopoli e il suo impero, la Grecia e le sue isole, l’Asia Minore, Antiochia, la Siria, la Palestina, l’isola di Cipro, l’Egitto e tutto il resto del Levante. Fu affidata alle cure di Frate Elia, figura preminente nella nascente fraternità, sia per il suo talento organizzativo, sia per la sua vasta cultura. Nel 1219, lo stesso Francesco volle visitare almeno una parte della Provincia di Terra Santa. Durante la sua presenza tra i Crociati, sotto le mura di Damietta, incontrò il Sultano d’Egitto, Melek-el-Kamel, nipote di Saladino il Grande.
Il Natale di Greccio
Amore e fantasia in Francesco vanno sempre insieme, per il suo animo naturalmente poetico. Lo si evidenzia principalmente nel Natale del 1223, in cui lo spirito poetico spinge Francesco a rappresentare l’evento storico dell’Incarnazione, che gli ricordava la discesa sulla terra dello stesso Dio, rivestito di umiltà povertà e innocenza, quasi a simboleggiare i tre voti della scelta esistenziale. Rappresentazione che spiritualmente si può leggere anche come un peana di ringraziamento per il dono ricevuto dell’approvazione della Regola dalla Chiesa, pochi giorni prima (29 novembre!). Così, nel bosco di Greccio, Francesco rievoca per la prima volta la rap-
presentazione natalizia: nasce il Presepe! Della sua vita, forse, questo sembra l’“episodio più delicato e anche più ardito”, da cui prende inizio l’arte nuova della pedagogia “realistica”, sganciata dall’imperante simbolismo: la rievocazione dei fatti evangelici o la Bibbia dei poveri.
L’ “ultimo sigillo”
Il Natale non è disgiunto dalla Pasqua: ontologicamente la Pasqua precede e perfeziona il Natale. Di conseguenza, il Natale rivissuto da Francesco non poteva non proiettarsi verso la Pasqua, che, per sé, è sempre preceduta dalla sofferenza della Croce. Così, senza saperlo, Francesco si prepara a ricevere il “sigillo” pasquale sul sasso della Verna. Le sue richieste di “sentire nell’anima” la Croce, e di provare “nel cuore” la gloria della risurrezione vengono inaspettatamente assecondate dal Cristo, che, per lui, inventa il dono delle Stimmate. E così, Francesco, dal 14 settembre 1224, divenne un alter Christus. Il divin Poeta immortala l’evento con la terzina: “Nel crudo sasso intra Tevere ed Arno / da Cristo prese l’ultimo sigillo / che le sue membra due anni portarono” (Paradiso, XI, vv. 106-108). Il termine “sigillo”, raffigurante l’Agnus Dei, secondo l’uso dei lanieri, garantiva l’autenticità della merce soltanto dopo il terzo o “ultimo sigillo”. Applicato a Francesco voleva significare che, con le Stimmate o “ultimo sigillo”, la sua santità non aveva bisogno di altra autenticazione. Dopo l’episodio delle Stimmate, Francesco è certamente stanco e sofferente. Il Vicario Generale frate Elia, insieme al Vescovo Guido di Assisi cercarono di farlo riposare e curare. Venne ospitato a San Damiano da Chiara e le sue Sorelle. E qui, Francesco compose il suo capolavoro Il Cantico delle creature o, meglio, Il Cantico del Creatore.
Gli ultimi due anni di Francesco furono certamente segnati con più profondità da “sorella sofferenza” sia per le Stimmate e sia per tutte le altre malattie del corpo. Nella primavera del 1226, mentre si trovava a Siena, sentendosi mancare, dettò un “piccolo” Testamento. Dopo, mentre si trovava nel convento delle Celle a Cortona, ne fece scrivere un altro, l’ultimo, e volle che fosse legato alla Regola. Dalle sorgenti del fiume Topino, nei pressi di Nocera Umbra, dove si trovava, Francesco si fece trasportare ad Assisi, alla Porziuncola, per esalare l’ultimo respiro al tramonto del 3 ottobre 1226. Il suo corpo, dopo aver attraversato Assisi e sostato in San Damiano, venne sepolto nella chiesa di San Giorgio, da dove, nel 1230, la salma venne trasferita nell’attuale basilica, due anni dopo la sua canonizzazione da parte di Gregorio IX con la bolla Mira circa nos del 19 luglio 1228, fissando la festa liturgica al 4 ottobre.
Il secondo Ordine o Clarisse
Tutta Assisi parlava delle “bizzarìe” del giovane Francesco, che viveva in povertà con i compagni laggiù nella pianura e che spesso saliva in città a predicare il Vangelo con il permesso del vescovo, augurando a tutti “pace e bene”. Nella primavera del 1209 aveva predicato perfino nella cattedrale di San Rufino, dove nell’attigua piazza abitava la nobile famiglia degli Offreduccio, e, sicuramente, in quell’occasione, fra i fedeli che ascoltavano, c’era la giovanissima figlia Chiara. Colpita dalle sue parole, prese ad innamorarsi del suo ideale di pover-
tà evangelica e cominciò a contattarlo, accompagnata dall’amica Bona di Guelfuccio. Nella notte seguente la domenica delle Palme del 1211, abbandonò di nascosto il suo palazzo e correndo al buio attraverso i campi, giunse fino alla Porziuncola, dove chiese a Francesco di dargli Dio, quel Dio che lui aveva trovato e col quale conviveva. Francesco, davanti all’altare della Vergine, le tagliò la bionda e lunga capigliatura (ancora oggi conservata) consacrandola al Signore. Poi l’accompagnò al monastero delle benedettine a Bastia, per sottrarla all’ira dei parenti, i quali dopo un colloquio con Chiara che mostrò loro il capo senza capelli, si convinsero a lasciarla andare. Successivamente, Chiara e le compagne che l’avevano raggiunta, si spostò dopo alterne vicende, nel piccolo convento annesso alla chiesetta di San Damiano, dove, nel 1215, a 22 anni, Chiara fu nominata badessa; Francesco dettò per le “Povere donne recluse di San Damiano” una prima Regola di vita, nel 1215, sostituita da quella di Chiara, approvata il 9 agosto 1253 da Innocenzo IV. Il secondo Ordine costituisce l’incarnazione al femminile dell’ideale francescano.
Il Terz’ordine francescano, dal 1978 Ordine Secolare Francescano, è l’estensione dell’ideale francescano al mondo laicale. I primi laici francescani sono ritenuti i beati: Lucchese e Buonadonna da Poggibonsi, contemporanei del Fondatore. Proprio con riferimento alla loro conversione e all’abito penitenziale che ricevettero da Francesco, alcuni riconoscono la nascita del Terz’ordine francescano a Poggibonsi, in provincia di Siena. Nell’arco di quasi otto secoli di storia, la Regola dell’OFS ha registrato tre interventi ufficiali da parte di Roma: Nicolò IV con la bolla Supra Montem (18 agosto 1289); Leone XIII con la costituzione Misericors Dei Filius (30 maggio 1883); e Paolo VI con il breve Seraphicus Patriarcha (24 giugno 1978), che vige tutt’ora.
Il Terzo Ordine Regolare (TOR)
In parallelo all’OFS, si sviluppa anche il Terzo Ordine Regolare (TOR), una forma comunitaria di vita di perfezione con la professione dei consigli evangelici e con un apostolato aperto a tutte le necessità esistenziali dell’uomo: dal servizio pastorale a quello assistenziale educativo e scientifico. La prima approvazione ufficiale del TOR risale a Bonifacio VIII con la bolla Cupientes cultum (11 luglio 1295); Giovanni XXII, con la bolla Altissimo in divinis (18 novembre 1323) ribadisce l’approvazione ecclesiastica; Niccolò V, con la bolla Pastoralis officii (20 luglio 1447), approva la federazione delle fraternità in un Ordine centralizzato, con un unico Ministro e un Consiglio generale; Leone X con la bolla Inter caetera (20 gennaio 1521) diede al TOR la Regola propria, separandolo definitivamente dall’OFS; Pio XI, con la bolla Rerum conditio (4 novembre 1927), approva una nuova Regola; Giovanni Paolo II con il breve Franciscanum vitae propositum (8 dicembre 1982) sancisce la Regola attuale.
GLI SCRITTI
Sembra uno scherzo della storia: Francesco d’Assisi, autodefinitosi “homo sine litteris”, venga celebrato anche fra i poeti e i maestri di spirito. I suoi Scritti, oltre a essere desti-
nati all’insegnamento interno dei suoi frati, soddisfano anche il gusto estetico. L’afflato dell’arte, benché istintivo, echeggia nel linguaggio semplice scorrevole e carezzevole, almeno di alcuni dei suoi Scritti, come la Salutatio virtutum (Il saluto alle virtù), il De virtute effugante vitio (La virtù per allontanare il vizio), il Cantico delle creature, che esprimono un sicuro e indiscusso valore poetico e anche artistico. Tutti gli Scritti, eccetto il Cantico delle creature, sono vergati in un latino parlato, abbastanza idoneo a esprimere sentimenti di natura spirituale e mistica nella loro delicata gamma espressiva. Nel loro insieme, gli Scritti rivelano una forte carica emotiva, derivata più dall’esperienza spirituale che da tensione estrinseca. Per questo, lo stile denota un carattere meno razionale che emotivo, più rivolto all’aspetto immediato della verità rivelata che alla sua comprensione, più impegnato all’esaltazione di Dio presente nella natura che alla stessa realtà oggettiva. La natura assurge a “segno” e “simbolo” della realtà divina, con la conseguenza che del mondo Francesco ha più una visione religiosa che scientifica, più mistica che reale.
Il pensiero di Francesco si presenta molto variegato e di difficile sintesi organica e sistematica. Attraverso l’analisi tematica della frequenza di parole chiavi nei suoi Scritti, emerge un corpus di idee essenziali che contengono una sicura Weltanschauung (concezione del mondo e della vita) originale e geniale insieme. Questa concezione della vita e del mondo spazia dalla teologia alla filosofia, dalla valutazione positiva della natura alla necessità di un impegno sociale, dalla necessità del lavoro come mezzo normale di sussistenza alla scelta della povertà volontaria come ideale di umanesimo e al proposito della pace fondata più sul dialogo che sulla forza. Questo corpus di idee può essere raggruppato in quattro istanze: teocentriche cristologiche ecclesiali e filosofiche.
Istanze teocentriche
Le idee teologiche sono facilmente catalizzabili intorno ai misteri principali della fede cristiana: Dio, Cristo, Maria, Chiesa, Eucaristia. Il pensiero di Francesco in queste verità è espresso in uno stile piano e semplice, più intuitivo che dimostrativo, spesso anche poetico: si snoda senza seguire alcun modello precostituito, né si organizza intorno a schemi prestabiliti. Del poeta, manifesta sensibilità, intuizione e immaginazione, riuscendo a trasformare i sentimenti veri e profondi in immagini vive ed efficaci; del mistico, invece, vive l’esperienza meravigliosa della paternità di Dio in tutte le sue implicanze spirituali.
Dall’uso dei titoli divini, si ricavano utili indicazioni su Dio in rapporto all’essere (unità semplicità incorporeità perfezione eternità santità), all’intelletto (onnipotenza, onniscienza, sapienza) e alla volontà (giustizia amore e misericordia). Come linguaggio, Francesco utilizza sia quello catafatico o positivo sia quello apofatico o negativo: con il primo esprime la vasta gamma dei sentimenti verso Dio; con l’altro, i limiti nel parlare di Dio, in quanto “è misterioso” (Giud 13, 18), ossia ineffabile per eccellenza. I titoli più suffragati: Pater, Dominus Deus, Omnipotens, Altissimus.
Francesco ha di Dio una visione unitaria e originale ben marcata, che investe la sua semplici-
tà radicale, percepibile solo nella visione mistica della vita. La realtà empirica è considerata meno naturalisticamente che teologicamente, nel senso che l’incanto del mistero di Dio illumina l’essere in tutti i suoi spessori. Francesco è come “incantato” da questa luce ineffabile di Dio. Il suo linguaggio più positivo che negativo spiega anche il senso metaforico dell’uso dei nomi divini, che si riferiscono quasi sempre all’agire di Dio ad extra, e mai in quello ad intra. La visione teocentrica che emerge è rappresentabile nello schema: la fede in Dio Padre conduce alla scoperta del Figlio di Dio Incarnato, la cui sequela riconduce a Dio Padre attraverso l’opera dello Spirito Santo.
Istanze cristologiche
Dai titoli e dai relativi contesti in cui vengono utilizzati, si evince che Francesco è conquiso e affascinato dal mistero della divinità di Cristo. I titoli più utilizzati: Dominus, Filius Dei, Deus verus, Corpus et sanguinis Domini. Dalla visione d’insieme, si evince che Francesco ha una conoscenza del mistero cristologico, come rivelazione del mistero trinitario che si realizza storicamente in Cristo e continua nella Chiesa, fino al termine del tempo. La centralità del Cristo è considerata più nella luce della divinità e dell’uguaglianza con il Padre nello Spirito Santo, che in quello dell’Incarnazione. L’idea principale che si deduce è quella di una visione dell’amore divino verso l’uomo che fa aprire Francesco al sentimento di riconoscenza e ringraziamento, di adorazione e benedizione verso Colui che solo piace a Dio, perché lo ama come Dio. Interessante notare: il titolo di Sapientia, che, benché usato una sola volta, costituisce come il fondamento a tutti gli altri titoli nella costruzione della vita cristiana e religiosa. La sua mancanza, infatti, è la causa di chi non si converte, di chi non crede, di chi non segue il Cristo, di chi si allontana dalla retta via, di chi non osserva ciò che ha promesso, perché non ha conosciuto l’amore, ossia “il Figlio di Dio, che è la vera Sapienza del Padre” (Epistola ai Fedeli II, 67). L’esperienza religiosa di Francesco appare, perciò, come immersa nell’oceano dell’altissimo e ineffabile mistero di Dio, dal quale trae alimento, vita e gioia.
Istanze ecclesiali
Dagli Scritti di Francesco emerge con evidenza l’unità teologica del suo pensiero. Anche nei titoli “ecclesiali” o del “Regno di Cristo”, attraverso la trilogia dei misteri – Chiesa, Eucaristia e Vergine Maria – ne è una testimonianza eloquente. Questa trilogia è considerata da Francesco meno come verità isolate che estensione nel tempo dell’azione di Cristo. Per quanto riguarda, per esempio, il mistero della Chiesa, messa in discussione da alcuni movimenti pauperistici ed ereticali, Francesco manifesta il suo modo di sentire la Chiesa, attraverso l’uso e la frequenza di titoli - santità e romanità - che denotano profonda fede sia alla gerarchia costituita e sia alla realtà misterica insegnata. L’Eucaristia rappresenta per Francesco meno un mistero di devozione e di adorazione che la sintesi efficace del disegno di Dio sull’umanità. L’utilizzo dei titoli nell’esprimere questo mistero fondamentale rispecchia il clima di confusione che regnava all’epoca. Come per i titoli ecclesiali, così anche per quelli eucaristici, la preoccupazione di Francesco è di ordine teologico e disciplinare, perché intende salvaguar-
dare il suo movimento da ogni ingerenza estranea all’ortodossia, e proteggere i suoi frati da eventuali abusi in una materia così delicata. Da uno sguardo generale ai titoli e alla varietà degli Scritti, in cui vengono utilizzati, si evince che per Francesco l’importanza dell’Eucaristia consiste meno nell’elemento cultuale che nel mistero della presenza reale del Signore, come cuore del disegno di salvezza voluto da Dio. Da ciò, scaturisce anche la venerazione verso il “sacerdote”, visto come colui che confeziona e amministra l’Eucaristia. Dai due testi mariani, il Saluto alla Vergine e l’Antifona all’Ufficio della passione, si ricava l’impressione che le idee di Francesco derivino più da un atteggiamento di fede vissuta nella dottrina insegnata dalla Chiesa, che da uno studio sull’argomento. Nella loro composizione, Francesco evita di parlare della Vergine Maria come realtà a sé stante, ma sempre in contesto teologico, perché il suo mistero non può essere compreso se non da chi appartiene già a Cristo: è presentata sempre come “dono” di Dio all’umanità. E come tale, Francesco sente irrompente il bisogno di elevare inni di ringraziamento; ed ebbro di gioia invita la stessa Vergine a cantare, insieme alla corte celeste, l’inno di lode a Dio, Uno e Trino. Le due composizioni sono principalmente delle preghiere contemplative, in cui la fede si effonde in esclamazioni di lode, ammirazione e ringraziamento a Dio, da non lasciare spazio al pensiero umano di pensare. Dei titoli, tre sono di natura mariana (Virgo, Domina e Regina), uno ecclesiale (Virgo ecclesia facta), uno cristologico (Mater Domini), e gli altri di carattere trinitario. Tutti ruotano intorno alla “maternità divina”. Anche intorno al mistero della Madonna, Francesco è attratto dalla sublimità del mistero di Dio, Uno e Trino, e in lui contempla tutta la pienezza della divinità realizzata nel Cristo storico e nel Cristo della fede. Il contesto cristologico, pur essendo meno appariscente, è profondamente presente, tanto da costituire il centro della vita di Francesco. Interessante è l’aspetto ecclesiale dei titoli mariani, specialmente attraverso la bella espressione “Maria, quae es Virgo ecclesia facta” (Maria è la Vergine fatta Chiesa), come a dire: Maria è venerata come la prima Chiesa consacrata da Dio, e in senso storico e in senso spirituale. Oggi, potrebbe corrispondere al titolo di “Madre della Chiesa”.
Istanze filosofiche
Di fronte al mistero di Dio, Francesco tiene ben distinta la conoscenza dalla dimostrazione della sua esistenza. L’idea di Dio nasce in lui da un’esperienza originaria, che si chiarisce e definisce in atteggiamento religioso. Lo conferma il suo linguaggio, la cui caratteristica fondamentale conserva ancora una mentalità simbolico-mitica e mistico-poetica. In diversi luoghi dei suoi Scritti, si parla di una conoscenza di Dio, in cui si possono distinguere tre aspetti diversi e complementari: conoscenza di Dio in sé, conoscenza di Dio nell’uomo e conoscenza di Dio nel mondo. Brevemente.
Conoscenza di Dio in sé
Il leit-motiv della conoscenza di Dio in Francesco è la fede nella “creazione”, che, da un lato, manifesta la sua indiscussa certezza nella potenza creatrice divina, e, dall’altro, rivela il limite ontologico della natura umana. Pensiero espresso chiaramente nella Regola non bollata (Rnb): “I frati annuncino agli increduli la parola di Dio, perché credano in Dio onnipotente Padre Fi-
glio e Spirito Santo come creatore di tutte le cose” (Rnb 16, 7); “Temete e onorate, lodate e benedite, ringraziate e adorate il Signore Iddio onnipotente, nella trinità e unità, Padre Figlio e Spirito Santo, creatore di tutte le cose” (Rnb 21, 2); “Onnipotente, santissimo, altissimo e sommo Iddio, Padre santo e giusto, Signore e Re dell’universo, per te stesso ti rendiamo grazie, perché, per la tua santa volontà e mediante l’unico Figlio tuo nello Spirito Santo, hai creato tutte le cose spirituali e materiali, e noi, fatti a immagine e somiglianza tua…” (Rnb 23, 1ss).
Quale il fondamento filosofico di questa conoscenza?
La risposta di Francesco impressiona per semplicità e profondità, ma anche per difficoltà ermeneutica: “Considera, uomo, in quale condizione ti ha innalzato il Signore Iddio: ti creò formandoti a immagine del suo diletto Figlio per il corpo, e a sua immagine per l’anima” (Ammonizione, 5, 1). Come l’immagine tende per sua natura a ritornare alla propria origine, così anche l’essere umano diventa uomo, quando, trascendendo sé stesso, tende a identificarsi con la realtà di cui è immagine.
Conoscenza di Dio nell’uomo
Nell’aspetto della conoscenza di Dio nell’uomo, Francesco rivela anche la sua visione antropologica: “Tanto vale l’uomo quanto vale davanti a Dio, e non di più” (Ammonizione, 19, 3); “Lo Spirito del Signore abita nel cuore dei suoi fedeli” (Ammonizione, 1, 12); “Costruiamo sempre nei nostri cuori una stabile dimora al Signore Iddio onnipotente” (Rnb 22, 27); “Coloro che vivono nella conversione continua e si nutrono con fede dell’Eucaristia, sono benedetti e beati, perché lo Spirito del Signore riposerà su di essi e nei loro cuori costruirà la sua stabile dimora” (Epistola ai Fedeli, I, 3-6); “Lo Spirito del Signore riposerà su di essi e nei loro cuori costruirà la sua stabile dimora” (Epistola ai Fedeli, II, 48). L’idea principale emergente da questi testi è la certezza che Dio abita nel cuore dell’uomo, come dono, del quale l’uomo non può aver alcun motivo per gloriarsi, come lui stesso ricorda: “Anche se fossi così intelligente e sapiente, da possedere ogni scienza ed essere in grado d’interpretare ogni lingua e di penetrare nei misteri celesti, non potresti vantarti di queste qualità” (Ammonizione, 5, 5). Riconoscere questo rapporto creaturale significa essere di Dio, appartenere a Dio, ascoltare Dio e ricambiare tale amore.
Il riconoscimento di Dio in sé stesso orienta l’attenzione di Francesco, quasi naturalmente, verso la sapienza divina presente nella realtà dell’universo, come si evince dal Cantico delle creature, che sviluppo è in tre tempi: apertura intuitiva al trascendente teologico, intuizione del trascendente immanente nel mondo, e ritorno laudativo e contemplativo al trascendente teologico. Ogni tempo scandisce un preciso attributo divino: l’Onnipotenza di Dio che ha chiamato all’esistenza ogni creatura; la Sapienza di Dio che conserva nell’ordine le cose create; e l’Amore di benevolenza con cui Dio assiste l’essere creato. Come i tre attributi esprimono la medesima realtà, così anche i tre tempi del Cantico vanno considerati nella loro unità, come l’invocazione iniziale esprime “Altissimu onnipotente bon Signore”: con il termine “Altissimu” viene esprime l’assoluta trascendenza; con l’“onnipotente”, la potenza creatrice; e con il “bon Signore”, l’amore di benevolenza. In sintonia con la mentalità simbolica del XII secolo, Francesco afferma poeticamente che
all’uomo è impedito ontologicamente di parlare in modo positivo e affermativo di Dio: “et nullu homo ene dignu te mentovare”; e ringrazia lo stesso Dio per la consapevolezza che gli ha dato della sua immanenza anche nell’universo: “laudato sie, mi signore, cum tucte le tue creature”. Di fronte all’umana impossibilità di penetrare la trascendenza di Dio, Francesco si concentra sul vestigium Dei, espresso bellamente dal verso: “de te, altissimo, porta significatione”, che richiama la tradizione fondata su Isaia: “se non crederai, non potrai comprendere” (Is 7, 9); cui fa Alano di Lilla (1120-1203): “La lira poetica nella corteccia superficiale della lettera risuona falsamente, ma interiormente manifesta agli uditori il segreto di un significato più elevato, affinché gettata via la scorza della falsità esteriore, il lettore trovi internamente il nucleo più dolce della riposta verità” (De planctu naturae, cit. in Henri De Lubac, Esegesi medievale, ed. Paoline, Roma 1972, II, p. 1340; M.D. Chenu, La teologia nel medio evo, Jaca Book, Milano 1972, p. 175); “ogni creatura dell’universo è per noi quasi un libro, un quadro e uno specchio [di Dio]” (Rytmus, cit. in M. D. Chenu, Op. cit., pp. 184-185); e Ugo di San Vittore che considera il mondo come un “libro scritto dalla mano di Dio” (Didascalicon, cit. in M. D. Chenu, Op. cit., p. 185). Lo sviluppo dell’immagine della natura-libro porta a considerare non solo l’invisibile sapienza di Dio, anche la diversità dei lettori: chi crede e chi non crede. La chiave di lettura, perciò, è la fede che riesce a leggere il valore ontologico delle cose e a fare il salto di qualità verso la sapienza di Dio; chi non crede, l’“insipiens”, si ferma soltanto all’aspetto esteriore delle cose. La lettura della natura di Francesco è da “sapiens”, cioè non limitata all’essere che appare, ma trascende la dimensione percettiva per penetrare all’interno dell’essere fino a cogliere l’aspetto ontologico delle cose sottraendole ai limiti del linguaggio puramente esperienziale e scientifico. IL CULTO
Nella famosa opera Del primato morale e civile degli italiani (1843), V. Gioberti, per celebrare la grandezza di Francesco d’Assisi lo chiama “il più amabile, il più poetico e il più italiano de’ nostri santi”! Solo successivamente, il giornalista Enrico Filiziani, nell’articolo “Per san Francesco d’Assisi”, pubblicato sul giornale La Vera Roma, il 18 gennaio 1903, completò la frase giobertiana in: “il più santo fra gli Italiani, il più Italiano fra i santi”. Lo storico e scrittore, Enrico Pepe, definiva Francesco “Patrimonio dell’umanità”. Da Pio XII è stato riconosciuto come il “più italiano dei santi e più santo degli italiani” e il 18 giugno 1939, e lo proclamava Patrono principale d’Italia.
E Giovanni Paolo II lo eleggeva a “Patrono dell’ecologia” con la Lettera Apostolica Inter sanctos del 29 novembre 1979. Francesco è uno dei santi più conosciuto nel mondo sia occidentale che orientale, sia dai cattolici che dai non credenti; è anche il più amato dal popolo, specialmente per il suo spirito di umiltà e povertà. Nei luoghi dove trascorse la sua vita sono nati dei santuari. Assisi, dopo Roma, è il luogo più gettonato dal turismo spirituale mondiale. La festa liturgica è il 4 ottobre.
Autore: P. Giovanni Lauriola ofm
È uno dei santi più amati e conosciuti in Italia e nel mondo. Il 26 settembre 1182, ad Assisi (Perugia), da una ricca famiglia di mercanti di stoffe, nasce un bimbo che il padre Pietro Bernardone chiama Francesco in onore dei buoni affari intrapresi con la Francia.
Francesco è intelligente, studia e si diverte, partecipando a balli e banchetti. Viene educato dalla mamma Giovanna Pica (di origine francese) ad essere generoso con i poveri. Il padre sogna per il figlio una carriera militare. Quando nel 1202 scoppia la guerra tra Assisi e Perugia, Francesco vi partecipa. Ferito viene messo in prigione. Dopo la liberazione, il giovane entra in crisi e viene considerato pazzo per la sua condotta. Una notte una voce gli indica la via da percorrere: disfarsi di ogni bene e vivere in onore di “Madonna Povertà”. Il giovane dona ai poveri tutto. Perfino le stoffe e il denaro del padre che, per la rabbia, lo caccia via da casa. Il “Poverello d’Assisi”, o anche “il Giullare di Dio”, come viene chiamato, vuole essere libero dalla schiavitù di possedere cose inutili e desidera vivere come Gesù. Indossa un misero saio di ruvida stoffa che rattoppa sempre. Vive in letizia pregando e chiedendo il cibo in elemosina. Alcuni giovani decidono di unirsi a lui e trovano riparo in una piccola chiesa in rovina e con l’aiuto di benefattori cercano di sistemarla. Nel 1210 papa Innocenzo III approva la Regola di Francesco basata su povertà, umiltà e castità istituendo l’Ordine Conventuale dei Frati Minori (piccoli fratelli). Francesco ama il Creato, parla agli animali, compone il Cantico delle Creature per inneggiare al sole, alla luna e alle stelle che per lui sono fratelli e sorelle. Famosi sono gli episodi della predica agli uccellini e l’incontro con un lupo feroce che, minaccioso, si avvicina a Gubbio e, grazie alle parole di Francesco, diventa mansueto. Nel 1224, mentre prega sul Monte della Verna (Arezzo), dove oggi sorge un santuario francescano meta di pellegrinaggio e ritiri spirituali, Francesco riceve i segni della “Passione di Cristo” sulle mani, sui piedi e sul costato: le stimmate che lui sopporterà con umile silenzio per tutta la vita. Due anni dopo la sua morte, avvenuta ad Assisi il 3 ottobre 1226, viene proclamato santo. Innumerevoli sono i miracoli di guarigione avvenuti per sua intercessione, prima e dopo la sua morte. I Frati Minori si moltiplicano e viaggiano in Europa e in Oriente per diffondere tra gli uomini di buona volontà “la Buona Novella”, ovvero la buona notizia del Vangelo e del messaggio di Gesù. Nel 1211 Francesco crea pure il Terz’Ordine Francescano (detto anche Ordine Francescano Secolare OFS, da cui deriva la Gi.Fra. Gioventù Francescana), attivo e diffuso ancora oggi in tutto il mondo, dedicato ai laici che desiderano vivere ispirandosi a San Francesco. Grazie a San Francesco è nata, poi, la tradizione del presepio: nel 1223 a Greccio (Rieti), la notte di Natale, il frate allestisce una mangiatoia con la statua del Bambino Gesù con accanto animali veri, il bue e l’asinello e, assieme a un gruppo di pastori e contadini, inscena il primo presepe vivente. Famoso è il “Cammino di Francesco”, un percorso religioso-naturalistico di rara bellezza, intrapreso a piedi da tanti pellegrini dei nostri giorni, che porta ad Assisi e si snoda nella Valle Santa Reatina (Rieti) sui luoghi visitati dal “Poverello”. San Francesco d’Assisi è patrono d’Italia, ecologisti, animali, tappezzieri, tessitori, floricoltori, poeti, poveri, commercianti, Lupetti e Coccinelle dell’AGESCI (Associazione Guide e Scouts Cattolici Italiani). Per i francescani San Francesco rappresenta la “prima luce” (la seconda luce è Santa Chiara e la terza è Santa Margherita da Cortona). Jorge Mario Bergoglio, eletto papa il 13 marzo 2013, argentino di origini italiane (i suoi nonni, piemontesi di Portacomaro d’Asti, emigrarono in Sud America nel 1929), è il primo pontefice che ha assunto il nome Francesco in onore al Santo d’Assisi.
Autore: Mariella Lentini
Nascita e genitori
Francesco nacque ad Assisi, in Umbria, nei primi del 1182 (ma secondo altri la nascita potrebbe però datarsi all’estate o all’autunno 1181) da Pietro di Bernardone, agiato mercante di panni, e da Giovanna detta Pica, nobile di origine forse provenzale. In omaggio alla nascita di Gesù, madonna Pica volle partorire il bambino in una stalla improvvisata al pianterreno della casa paterna, in seguito detta “Stalletta” o “Oratorio di San Francesco piccolino”, ubicata presso la piazza principale della città umbra. La madre, in assenza del marito Pietro, impegnato in un viaggio di affari in Provenza, lo battezzò con il nome di Giovanni, in onore del Battista. Tuttavia, al suo ritorno, il padre volle aggiungergli il nome di Francesco, che prevarrà poi sul primo.
Questo aggettivo corrisponde all’attuale “francese”. La motivazione potrebbe essere sia un omaggio alla Francia, meta dei suoi frequenti viaggi, sia dovuto al fatto che la madre fosse francese.
Una giovinezza spensierata
Francesco crebbe tra gli agi della sua famiglia, che come tutti i ricchi assisiati godeva dei tanti privilegi imperiali, concessi loro dal governatore della città, il duca di Spoleto Corrado di Lützen.
Aveva appreso le nozioni essenziali di scrittura e di latino presso la scuola parrocchiale di San Giorgio e le sue cognizioni letterarie erano limitate.
Ad ogni modo, conosceva il provenzale, lingua materna, ed era abile nel mercanteggiare le stoffe dietro gli insegnamenti del padre, che vedeva in lui un valido collaboratore e l’erede dell’attività di famiglia.
Era estroso ed elegante: primeggiava fra i giovani, amava le allegre brigate e spendeva con una certa prodigalità il denaro paterno, tanto da essere acclamato “rex iuvenum” (re dei giovani), titolo che lo poneva alla direzione delle feste.
Combattente nella guerra tra Assisi e Perugia
Con la morte dell’imperatore di Germania Enrico IV (1165-1197) e l’elezione a papa del cardinal Lotario di Segni, che prese il nome di Innocenzo III (1198-1216), gli scenari politici cambiarono. Il nuovo Papa, sostenitore del potere universale della Chiesa, prese sotto la sua sovranità il ducato di Spoleto, compresa Assisi, togliendolo al duca Corrado di Lützen.
Ciò portò ad una rivolta del popolo contro i nobili della città, asserviti all’imperatore e sfruttatori dei loro concittadini: furono cacciati dalla rocca di Assisi e si rifugiarono a Perugia, poi, con l’aiuto dei perugini, mossero guerra ad Assisi (1202-1203). Francesco, infiammato di spirito d’avventura, si buttò nella lotta fra le due città così vicine e così nemiche. Dopo la disfatta subita dagli assisiati a Ponte San Giovanni, fu fatto prigioniero dai perugini a fine 1203 e restò in carcere per un anno.
Inizio della conversione
Dopo che i suoi familiari ebbero pagato un consistente riscatto, Francesco ritornò in famiglia, con la salute ormai compromessa. La madre lo curò amorevolmente durante la lunga malattia. Una volta guarito, tuttavia, il giovane non era più quello di prima: la sofferenza aveva scavato nel suo animo un’indelebile solco.
Non sentiva più nessuna attrattiva per la vita spensierata e i suoi antichi amici non potevano più stimolarlo. Pensò allora di arruolarsi nella cavalleria del conte Gualtiero di Brienne, che in Puglia combatteva per il papa. Quando però fu giunto a Spoleto, cadde in preda ad uno strano malessere. La notte ebbe un sogno in cui una voce misteriosa che lo invitava a “servire il padrone invece che il servo” e a ritornare ad Assisi. Colpito dalla rivelazione, tornò alla sua città, accolto con preoccupazione dal padre e con una certa disapprovazione di buona parte dei concittadini. Lasciò definitivamente le allegre brigate per dedicarsi ad una vita d’intensa meditazione e pietà, avvertendo nel suo cuore il desiderio di servire il Signore, ma non sapendo come. Andò anche in pellegrinaggio a San Pietro in Roma, con la speranza di trovare chiarezza.
La voce del Crocifisso
Ritornato deluso ad Assisi, continuò nelle opere di carità verso i poveri ed i lebbrosi, ma fu solo nell’autunno 1205 che Dio gli parlò. Era assorto in preghiera nella chiesetta campestre di San Damiano, mentre fissava un crocifisso bizantino. Ad un tratto, udì per tre volte questo invito: «Francesco va’ e ripara la mia chiesa, che come vedi, cade tutta in rovina». Pieno di stupore, Francesco interpretò il comando in riferimento alla cadente chiesetta di San Damiano, pertanto si mise a ripararla con il lavoro delle sue mani; utilizzò anche il denaro paterno.
La restituzione dei beni
A questo punto il padre, considerandolo ormai irrecuperabile, anzi pericoloso per sé e per gli altri, lo denunziò al tribunale del vescovo Guido II come dilapidatore dei beni di famiglia. Francesco si spogliò dei vestiti, restituendoli al padre, mentre il vescovo lo copriva con il proprio mantello, anche a significare la sua protezione.
Il giovane fu affidato ai benedettini, con la speranza che potesse trovare nel loro monastero la soddisfazione alle sue esigenze spirituali. I rapporti con i monaci furono buoni, ma riconobbe non era quella la sua strada. Ben presto riprese la sua vita di “araldo di Gesù re”: indossò i panni del penitente e prese a girare per le strade di Assisi e dei paesi vicini, pregando, servendo i più poveri, consolando i lebbrosi e ricostruendo, oltre San Damiano, le chiesette diroccate di San Pietro alla Spira e di Santa Maria degli Angeli.
L’inizio della sua missione
Nell’aprile del 1208, durante la celebrazione della Messa a Santa Maria degli Angeli, Francesco ascoltò dal celebrante la lettura del Vangelo di Matteo sulla missione degli Apostoli. In breve tempo, riconobbe che quelle parole di Gesù costituivano la risposta alle sue preghiere
e alle sue domande. L’invito del Crocifisso a San Damiano non si riferiva quindi alla ricostruzione del piccolo tempio, ma al rinnovamento della Chiesa nei suoi membri.
Depose allora i panni del penitente: indossò un abito di tela ruvida, si cinse i fianchi con una rude corda e si coprì il capo con il cappuccio in uso presso i contadini del tempo; camminava a piedi scalzi.
Iniziò così la sua nuova vita. Rendendosi interprete di sentimenti diffusi nel suo tempo, prese a predicare la pace, l’uguaglianza fra gli uomini, il distacco dalle ricchezze e la dignità della povertà, l’amore per tutte le creature di Dio e al disopra di ogni cosa e la venuta del regno di Dio.
I primi compagni
Ben presto, attirati dalla sua predicazione, si affiancarono a Francesco quelli che sarebbero diventati suoi inseparabili compagni: Bernardo di Quintavalle, un ricco mercante; Pietro Cattani, dottore in legge; Egidio, contadino. A loro si aggiunsero poco dopo anche Leone, Rufino, Elia, Ginepro e altri, fino al numero di dodici, proprio come gli Apostoli.
Il loro impegno era vivere alla lettera il Vangelo, senza preoccupazioni teologiche e senza ambizioni riformatrici o contestazioni morali e in obbedienza alle autorità religiose: indicavano così un nuovo stile a chi voleva vivere in carità e povertà all’interno della Chiesa. Il vescovo di Assisi li seguiva con interesse e permise loro di predicare.
La prima approvazione papale
Ai primi del 1209 il gruppo si riunì in una capanna nella località di Rivotorto, nella pianura sottostante la città di Assisi, presso la chiesa di Santa Maria degli Angeli, detta “Porziuncola”. Durante un intero anno Francesco trasmise ai compagni i suoi insegnamenti, alternando preghiera, assistenza ai lebbrosi e questua per sostenersi e per riparare le chiese danneggiate. Poiché ormai essi sconfinavano fuori dalla competenza della diocesi, e ciò poteva procurare problemi, il vescovo Guido consigliò Francesco e il suo gruppo di recarsi a Roma dal papa Innocenzo III. Il loro sodalizio fu approvato oralmente dal Papa, il quale rimase molto colpito da Francesco, dopo un incontro con lui e i suoi compagni.
Chiara e le Povere Dame di San Damiano
Tutta Assisi parlava delle “bizzarrie” di frate Francesco, che viveva in povertà con i compagni laggiù nella pianura e che spesso saliva in città a predicare il Vangelo. Nella primavera del 1209 aveva predicato perfino nella cattedrale di San Rufino.
Tra coloro che lo ascoltavano c’era Chiara degli Offreduccio, figlia di una nobile famiglia. Colpita dalle sue parole, prese ad innamorarsi dei suoi ideali di povertà evangelica. Nella notte seguente la Domenica delle Palme del 1211, abbandonò di nascosto la casa paterna e giunse fino alla Porziuncola: Francesco, davanti all’altare della Vergine, le tagliò la bionda e lunga capigliatura, poi l’accompagnò al monastero delle benedettine a Bastia. Solo dopo che Chiara ebbe mostrato ai parenti il segno della sua consacrazione, essi si convinsero a lasciarla stare. Successivamente Chiara e le compagne che l’avevano raggiunta si spostarono nel piccolo
convento annesso alla chiesetta di San Damiano. Nel 1215, a 22 anni, Chiara fu nominata badessa delle “Povere Dame di San Damiano” (poi dette Clarisse). Francesco dettò loro una prima Regola di vita, sostituita più tardi da quella composta dalla stessa Chiara.
I Protomartiri francescani
Francesco desiderava non solo ricondurre il mondo cristiano agli originari principi evangelici, ma anche raggiungere i non credenti, specie i saraceni. Se in quell’epoca i rapporti fra il mondo cristiano e quello islamico erano sostanzialmente di lotta, Francesco volle capovolgere questa mentalità: nei saraceni vedeva anzitutto dei fratelli a cui annunciare il Vangelo, non con le armi, ma offrendolo con amore: se fosse il caso, dovendo subire anche il martirio. Mandò per questo i suoi frati anzitutto in Spagna, dove vennero condannati a morte e poi graziati dal Sultano. Un secondo invio fu in Marocco, dove il rischio del martirio si concretizzò: i frati Berardo, Pietro, Accursio, Adiuto e Ottone, mentre predicavano, furono arrestati. Vennero imprigionati, flagellati e infine decapitati il 16 gennaio 1220. Il ritorno in Portogallo dei corpi dei protomartiri, suscitò la vocazione francescana in un canonico regolare di Sant’Agostino, Ferdinando: divenne quindi frate Antonio, detto di Padova, anche lui destinato agli onori degli altari.
I viaggi di Francesco in Oriente
Francesco non si scoraggiò: nel 1219-1220 volle tentare personalmente l’impresa missionaria diretto in Marocco, ma una tempesta spinse la nave sulla costa dalmata. Il secondo tentativo lo fece arrivare in Spagna, ma si ammalò e dovette tornare indietro. Infine, un terzo tentativo, lo fece approdare in Palestina. Si presentò al sultano egiziano Al-Malik al Kamil, che lo ricevette con onore, ascoltandolo con interesse, pur non convertendosi.
Il “capitolo delle stuoie” e la “Regola bollata”
Verso la metà del 1220, Francesco dovette ritornare in Italia per rimettere ordine fra i suoi frati, cresciuti ormai in numero considerevole. Appariva necessario risolvere alcuni problemi di organizzazione, di formazione, di studio, di adattamento alle necessità dell’apostolato in un mondo sempre in evoluzione.
Il “Poverello d’Assisi”, come divenne noto, non aveva infatti inteso fondare dei conventi, ma solo delle “fraternità”, piccoli gruppi di fratelli che vivessero in mezzo al mondo, mostrando come la felicità non risiedesse nel possedere i beni materiali, ma nel vivere in perfetta armonia secondo i comandamenti di Dio.
Nell’affollato “capitolo delle stuoie”, tenutosi ad Assisi nel 1221, Francesco autorizzò frate Antonio, venuto da Lisbona, d’insegnare la sacra teologia ai frati, specie a quelli addetti alla predicazione e alle confessioni. La nuova Regola, dettata da Francesco a frate Leone, fu accolta con soddisfazione dal cardinale protettore dell’Ordine, Ugolino de’ Conti (futuro papa Gregorio IX) e da tutti i frati. Venne approvata il 29 novembre 1223 da papa Onorio III con la bolla Solet Annuere: è infatti conosciuta come “Regola bollata”.
In essa si ribadivano la povertà, il lavoro manuale, la predicazione, la missione tra gli infedeli
e l’equilibrio tra azione e contemplazione. Si permetteva ai frati di avere delle Case di formazione per i novizi e si stemperò il concetto di divieto della proprietà privata. Di fatto, i seguaci di Francesco erano venuti a costituire un Ordine mendicante, quello dei Frati Minori.
Il presepe di Greccio
La notte del 24 dicembre 1223, Francesco si sentì invadere il cuore di tenerezza e di slancio: volle rivivere nella selva di Greccio, vicino Rieti, l’umile nascita di Gesù Bambino. Nacque così la tradizione del Presepio nel mondo cristiano, che fu ripresa dall’arte e dalla devozione popolare lungo i secoli successivi.
Le stimmate
Nell’estate del 1224 Francesco si ritirò sul monte della Verna nel Casentino, insieme ad alcuni dei suoi primi compagni, per prepararsi con un digiuno di quaranta giorni alla festa di san Michele arcangelo.
La mattina del 14 settembre, festa della Esaltazione della Santa Croce, mentre pregava su un fianco del monte, vide scendere dal cielo un serafino con sei ali di fiamma e di luce, che gli si avvicinò in volo rimanendo sospeso nell’aria. Fra le ali del serafino, Francesco vide lampeggiare la figura di un uomo con mani e piedi distesi e inchiodati ad una croce. Quando la visione scomparve, lasciò nel cuore del frate un ammirabile ardore e nella carne i segni della crocifissione: per la prima volta nella storia della santità cattolica si era verificato il prodigio delle stimmate.
Il declino fisico
Disceso dalla Verna, visibilmente dolorante e trasformato, volle ritornare ad Assisi. Era anche prostrato da varie malattie, allo stomaco, alla milza e al fegato, con frequenti emottisi. Inoltre la vista lo stava lasciando, a causa di un tracoma contratto durante il suo viaggio in Oriente. Dopo le ultime prediche all’inizio del 1225, Francesco si rifugiò a San Damiano, nel piccolo convento annesso alla chiesetta da lui restaurata tanti anni prima, dove vivevano Chiara e le sue sorelle.
In quel luogo compose il “Cantico di frate Sole” o “Cantico delle Creature”, dal quale si comprende quanto Francesco fosse penetrato nella più intima realtà della natura, contemplando in ogni creatura la presenza di Dio.
In seguito, ospite per un certo tempo nel palazzo vescovile, dettò anche il suo famoso «Testamento», l’ultimo messaggio ai suoi figli, affinché rimanessero fedeli a “madonna Povertà”. In esso affermò: «Nessuno mi insegnava quel che io dovevo fare; ma lo stesso Altissimo mi rivelò che dovevo vivere secondo il Santo Vangelo».
La morte
Per l’interessamento del cardinale Ugolino e di frate Elia, Francesco accettò di sottopor-
si alle cure dei medici della corte papale a Rieti, poi ancora a Fabriano, Siena e Cortona. Nell’estate del 1226 non solo non era migliorato, ma si fece sempre più evidente il sorgere di un’altra grave malattia: l’idropisia. Dopo un’altra sosta a Bagnara, sulle montagne vicino a Nocera Umbra, perché potesse avere un po’ di refrigerio, i frati visto l’aggravarsi delle sue condizioni, decisero di trasportarlo ad Assisi e su sua richiesta all’amata Porziuncola. Francesco morì in quel luogo la sera del 3 ottobre 1226, adagiato sulla nuda terra. Le allodole, amanti della luce e timorose del buio, nonostante che fosse già sera, vennero a roteare sul tetto dell’infermeria. Appariva quasi un ultimo saluto a colui che un giorno, fra Camara e Bevagna, aveva invitato gli uccelli a cantare lodando il Signore, e che in un’altra occasione, in un campo verso Montefalco, aveva tenuto loro una predica.
La glorificazione
La mattina del 4 ottobre, il suo corpo di Francesco fu traslato con una solenne processione dalla Porziuncola alla chiesa parrocchiale di San Giorgio ad Assisi, dove era stato battezzato e dove aveva cominciato, nel 1208, la sua predicazione. Lungo il percorso il corteo si fermò a San Damiano, dove la cassa fu aperta, affinché santa Chiara e le sue compagne potessero vedere un’ultima volta il suo viso.
Il 16 luglio 1228, papa Gregorio IX, a meno di due anni dalla morte, lo proclamò santo, fissandone la memoria liturgica al 4 ottobre. I suoi resti mortali rimasero nella chiesa di San Giorgio rimase tumulato fino al 1230, quando venne portato nella Basilica a lui dedicata, precisamente nella Basilica Inferiore, fatta costruire da frate Elia.
I «Fioretti di San Francesco»
Gli episodi della sua vita e dei suoi primi seguaci, furono raccolti e narrati nei «Fioretti di San Francesco», opera di un anonimo trecentesco, che contribuì nel tempo alla larga diffusione del suo culto, unitamente alla prima e seconda «Vita», scritte dal suo discepolo Tommaso da Celano (1190-1260), su richiesta di papa Gregorio IX. Alcuni episodi sono entrati nell’iconografia del santo e riprodotti dall’arte, come la predica agli uccelli, il roseto in cui si rotolò per sfuggire alla tentazione, il lupo che ammansì a Gubbio, l’impressione delle Stimmate.
I patronati
San Francesco è patrono dell’Umbria e di molte città, fra le quali San Francisco negli USA che da lui prese il nome. Innumerevoli sono le chiese, le parrocchie, i conventi, i luoghi pubblici che portano il suo nome. Tanti altri santi e beati, venuti dopo di lui, ebbero al battesimo o adottarono nella vita religiosa il suo nome.
Papa Pio XII, con il Breve pontificio «La sollecita cura» del 18 giugno 1939, proclamò Patroni Primari d’Italia lui e santa Caterina da Siena. Anche i Lupetti e le Coccinelle dell’AGESCI (Associazione Guide e Scouts Cattolici Italiani) lo considerano loro patrono.
I primi contrasti tra i Frati Minori
L’Ordine dei Frati Minori si propagò rapidamente: vivente ancora il fondatore, annoverava già
13 Province. Il suo massimo responsabile prese il titolo di Ministro Generale. Le Costituzioni furono redatte da fra Bonaventura da Bagnoregio, anche lui canonizzato. Mentre ancora l’organizzazione si stava consolidando, scoppiarono i primi contrasti. I membri dell’Ordine si divisero in due fazioni: la prima intendeva adottare forme meno severe di vita comunitaria e prescindere dall’obbligo assoluto della povertà, al fine di rendere meno difficile lo sviluppo dell’Ordine stesso.
La seconda, al contrario, si proponeva di uniformarsi alla lettera e allo spirito delle norme lasciate dal fondatore.
Osservanti e Conventuali e la nascita dei Cappuccini
I numerosi tentativi per placare i dissensi non ebbero effetto, anzi questi si acuirono di più quando Gregorio IX, con la bolla Quo elongati (1230), concesse ai frati di ricevere beni e di amministrarli per le loro esigenze. Nel campo opposto, le correnti degli “Spirituali” e dei “Fraticelli”, portavano avanti un programma di rinnovamento religioso misto a una rinascita politico-sociale, che sarebbe dovuto sfociare nell’avvento del regno dello Spirito; tuttavia, si attirarono scomuniche e persecuzioni dalle autorità ecclesiastiche e feudali. La divisione tra Frati Minori Osservanti e Conventuali fu sancita ufficialmente nel 1517 da papa Leone X. Nel 1525 papa Clemente VII approvò il nuovo ramo dei frati Cappuccini: guidati dal frate Matteo da Bascio della Marca d’Ancona, Osservante, erano dediti ad una più austera disciplina, alla povertà assoluta e alla vita eremitica.
La riforma dell’Ordine
Altre famiglie francescane riformate sorsero nei secoli (Alcantarini, Riformati, Amadeiti), in seno o a fianco degli Osservanti, ma tutte obbedivano al Ministro Generale dell’Osservanza. Ai membri delle varie famiglie dell’Osservanza papa Leone XIII, nel 1897, ingiunse di prendere il nome comune di Frati Minori.
L’Ordine francescano comprende quindi tre rami: il Primo Ordine, ossia i frati (sacerdoti e non), il Secondo Ordine, rappresentato dalle monache Clarisse, e il Terz’Ordine, fondato dallo stesso san Francesco nel 1221 per raccogliere i numerosi seguaci già sposati o comunque laici. Oltre alle pratiche religiose e ascetiche, i Frati Minori sono tuttora dediti alla predicazione, all’apostolato e all’opera missionaria.
Autore Antonio Borrelli
Pàtara, Asia Minore (attuale Turchia), ca. 250 - Mira, Asia Minore, ca. 326
La carità è il “miracolo” più grande che nasce dalla fede: prendersi cura degli ultimi, del prossimo in genere, oggi è il messaggio più profetico e rivoluzionario che ci lascia san Nicola. Nato tra il 250 e il 260 a Patara, nella Licia, divenne vescovo di Mira in un tempo di persecuzione e dovette affrontare anche la prigionia: si salvò grazie alla libertà di culto concessa dall’Editto di Costantino nel 313. Difensore dell’ortodossia, forse partecipò al Concilio di Nicea nel 325. La tradizione gli attribuisce un’attenzione particolare nei confronti dei bisognosi, come le due giovani ragazze che poterono sposarsi solo grazie al dono da parte del vescovo di una dote. Morto attorno all’anno 335, nel 1087 le sue reliquie arrivarono a Bari, dove è venerato come patrono e considerato un protettore anche del ponte di dialogo che unisce Occidente e Oriente.
Patronato: Bambini, Ragazzi e ragazze, Scolari, Farmacisti, Mercanti, Naviganti, Pescatori, Etimologia: Nicola = vincitore del popolo, dal greco
Emblema: Bastone pastorale, tre sacchetti di monete (tre palle d’oro)
Martirologio Romano: San Nicola, vescovo di Mira in Licia nell’odierna Turchia, celebre per la sua santità e la sua intercessione presso il trono della grazia divina.
San Nicola è uno dei santi più venerati ed amati al mondo. Egli è certamente una delle figure più grandi nel campo dell’agiografia. Tra il X e il XIII secolo non è facile trovare santi che possano reggere il confronto con lui quanto a universalità e vivacità di culto. Ogni popolo lo ha fatto proprio, vedendolo sotto una luce diversa, pur conservandogli le caratteristiche fondamentali, prima fra tutte quella di difensore dei deboli e di coloro che subiscono ingiustizie. Egli è anche il protettore delle fanciulle che si avviano al matrimonio e dei marinai, mentre l’ancor più celebre suo patrocinio sui bambini è noto soprattutto in Occidente.
San Nicola nacque intorno al 260 d.C. a Patara, importante città della Licia, la penisola dell’Asia Minore (attuale Turchia) quasi dirimpetto all’isola di Rodi. Oggi tutta la regione rientra nella vasta provincia di Antalya, la quale comprende, oltre la Licia, anche l’antica Pisidia e Panfilia. Nell’antichità i due porti principali erano proprio quelli delle città di San Nicola: Patara, dove nacque, e Myra, di cui fu vescovo. Prima dell’VIII secolo nessun testo parla del luogo di nascita di Nicola. Tutti fanno riferimento al suo episcopato nella sede di Myra, che appare così come la città di San Nicola. Il primo a parlarne è Michele Archimandrita verso il 710 d. C., indicando in Patara la città natale del futuro grande vescovo. Il modo semplice e sicuro con cui riporta la notizia induce a credere che la tradizione orale al riguardo fosse molto solida. Di Patara parla anche il patriarca Metodio nel testo dedicato a Teodoro e ne parla il Metafraste. La notizia pertanto può essere accolta con elevato grado di probabilità.
L’infanzia
Di S. Nicola di Bari, si sa ben poco della sua infanzia. Le fonti più antiche non ne fanno parola. Il primo a parlarne è nell’VIII secolo un monaco greco (Michele Archimandrita), il quale, spinto anche dall’intento edificante, scrive che Nicola sin dal grembo materno era destinato a santificarsi. Sin dall’infanzia dunque avrebbe cercato di mettere in pratica le norme che la Chiesa suggerisce a chi si avvia alla vita religiosa.
Nicola nacque nell’Asia Minore, quando questa terra, prima di essere occupata dai Turchi, era di cultura e lingua greca. La grande venerazione che nutrono i russi verso di lui ha indotto alcuni in errore, affermando che sarebbe nato in Russia. Non è mancato chi lo facesse nascere nell’Africa, a motivo del fatto che a Bari si venerano alcune immagini col volto del Santo piuttosto scuro (“S. Nicola nero”). In realtà, Nicola nacque intorno all’anno 260 dopo Cristo a Patara, importante città marittima della Licia, penisola della costa meridionale dell’Asia Minore (oggi Turchia). Nel porto di questa città aveva fatto scalo anche S. Paolo in uno dei suoi viaggi.
Il fatto che l’Asia Minore fosse di lingua e cultura greca, sia pure all’interno dell’Impero Romano, fa sì che Nicola possa essere considerato “greco”. Il suo nome, Nikòlaos, significa popolo vittorioso, e, come si vedrà, il popolo avrà uno spazio notevole nella sua vita. Da alcuni episodi (dote alle fanciulle, elezione episcopale) si potrebbe dedurre che i genitori, di cui non si conoscono i nomi, fossero benestanti, se non proprio aristocratici. In alcune Vite essi vengono chiamati Epifanio e Nonna (talvolta Teofane e Giovanna), ma questi, come vari altri episodi, si riferiscono ad un monaco Nicola vissuto (480-556) due secoli dopo nella stessa regione. Questo secondo Nicola, nato a Farroa, divenne superiore del monastero di Sion e poi vescovo di Pinara (onde è designato anche come Sionita o di Pinara). Amante del digiuno e della penitenza, quando era ancora in fasce, Nicola era già osservante delle regole relative al digiuno settimanale, che la Chiesa aveva fissato al mercoledì ed al venerdì. Il suddetto monaco greco narra che il bimbo succhiava normalmente il latte dal seno materno, ma che il mercoledì ed il venerdì, proprio per osservare il digiuno, lo faceva soltanto una volta nella giornata. Man mano che il bimbo cresceva, dava segni di attaccamento alle virtù, specialmente alla virtù della carità. Egli rifuggiva dai giochi frivoli dei bambini e dei ragazzi, per vivere più rigorosamente i consigli evangelici. Molto sensibile era anche nella virtù della castità, per cui, laddove non era necessario, evitava di trascorrere il tempo con bambine e fanciulle.
La dote alle fanciulle
Carità e castità sono le due virtù che fanno da sfondo ad uno egli episodi più celebri della sua vita. Anzi, a questo episodio si sono ispirati gli artisti, specialmente occidentali, per individuare il simbolo che caratterizza il nostro Santo. Quando si vede, infatti, una statua o un quadro raffigurante un santo vescovo dell’antichità è facile sbagliare sul chi sia quel santo (Biagio, Basilio, Gregorio, Ambrogio, Agostino, e così via). Ed effettivamente anche in libri di alta qualità artistica si riscontrano spesso di questi errori. Il devoto di S. Nicola ha però un segno infallibile per capire se si tratta di S. Nicola o di uno fra questi altri santi. Un vescovo che ha in mano o ai suoi piedi tre palle d’oro è sicuramente S. Nicola, e non può essere in alcun modo
un altro Santo. Le tre palle d’oro sono infatti una deformazione artistica dei sacchetti pieni di monete d’oro, che sono al centro di questa storia.
L’episodio si svolge a Mira, città marittima ad un centinaio di chilometri da Patara, ove probabilmente Nicola con i suoi genitori si era trasferito. Secondo alcune versioni i suoi genitori erano morti ed egli era divenuto un giovane pieno di speranze e di mezzi. Secondo altre, i genitori erano ancora vivi e vegeti e Nicola dipendeva ancora da loro. Quale che sia la verità, alle sue orecchie giunse voce che una famiglia stava attraversando un brutto momento. Un signore, caduto in grave miseria, disperando di poter offrire alle figlie un decoroso matrimonio, aveva loro insinuato l’idea di prostituirsi allo scopo di raccogliere il denaro sufficiente al matrimonio. Alla notizia di un tale proposito, Nicola decise di intervenire, e di farlo secondo il consiglio evangelico: non sappia la tua sinistra ciò che fa la tua destra. In altre parole, voleva fare un’opera di carità, senza che la gente lo notasse e lo ammirasse. La sua virtù doveva essere nota solo a Dio, e non agli uomini, in quanto se fosse emersa e avesse avuto gli onori degli uomini, avrebbe perduto il merito della sua azione. Decise perciò di agire di notte. Avvolte delle monete d’oro in un panno, uscì di casa e raggiunse la dimora delle infelici fanciulle. Avvicinatosi alla finestra, passò la mano attraverso l’inferriata e lasciò cadere il sacchetto all’interno. Il rumore prese di sorpresa il padre delle fanciulle, che raccolse il denaro e con esso organizzò il matrimonio della figlia maggiore.
Vedendo che il padre aveva utilizzato bene il denaro da lui elargito, Nicola volle ripetere il gesto. Si può ben immaginare la gioia che riempì il cuore del padre delle fanciulle. Preso dalla curiosità aveva cercato invano, uscendo dalla casa, di individuare il benefattore. Con le monete d’oro, trovate nel sacchetto che Nicola aveva gettato attraverso la finestra, poté fare realizzare il sogno della seconda figlia di contrarre un felice matrimonio.
Intuendo la possibilità di un terzo gesto di carità, nei giorni successivi il padre cercò di dormire con un occhio solo. Non voleva che colui che aveva salvato il suo onore restasse per lui un perfetto sconosciuto. Una notte, mentre ancora si sforzava di rimanere sveglio, ecco il rumore del terzo sacchetto che, cadendo a terra, faceva il classico rumore tintinnante delle monete. Nonostante che il giovane si allontanasse rapidamente, il padre si precipitò fuori riuscendo ad individuarne la sagoma. Avendolo rincorso, lo raggiunse e lo riconobbe come uno dei suoi vicini. Nicola però gli fece promettere di non rivelare la cosa a nessuno. Il padre promise, ma a giudicare dagli avvenimenti successivi, con ogni probabilità non mantenne la promessa. E la fama di Nicola come uomo di grande carità si diffuse ancor più nella città di Mira.
Nicola è eletto vescovo
Intorno all’anno 300 dopo Cristo, anche se il cristianesimo non era stato legalizzato nell’Impero e non esistevano templi cristiani, le comunità che si richiamavano all’insegnamento evangelico erano già notevolmente organizzate. I cristiani si riunivano nelle case di aristocratici che avevano abbracciato la nuova fede, e quelle case venivano chiamate domus Ecclesiae, casa della comunità. Per chiesa infatti si intendeva la comunità cristiana. E questa comunità partecipava attivamente all’elezione dei vescovi, cioè di quegli anziani addetti alla cura e all’incremento della comunità nella fede e nelle opere. Questi divenivano capi della comunità
e la rappresentavano nei concili, cioè in quelle assemblee che avevano il compito di analizzare e risolvere i problemi, e quindi di varare norme che riuscissero utili ai cristiani di una o più province. Solitamente erano eletti dei presbiteri (sacerdoti), laici che abbandonavano lo stato laicale per consacrarsi al bene della comunità. L’imposizione delle mani da parte dei vescovi dava loro la facoltà di celebrare l’eucarestia, e questo li distingueva dai laici. Non mancano però casi, e Nicola è uno di questi, in cui l’eletto non è un presbitero, ma un laico. Il che non significa che passava direttamente al grado episcopale, ma che in pochi giorni gli venivano conferiti i vari ordini sacri, fino al presbiterato che apriva appunto la via all’episcopato. In questo contesto ebbe luogo l’elezione di Nicola, che lo scrittore sacro descrive in una cornice che ha del miracoloso. Essendo morto il vescovo di Mira, i vescovi dei dintorni si erano riuniti in una domus Ecclesiae per individuare il nuovo vescovo da dare alla città. Quella stessa notte uno di loro ebbe in sogno una rivelazione: avrebbero dovuto eleggere un giovane che per primo all’alba sarebbe entrato in chiesa. Il suo nome era Nicola. Ascoltando questa visione i vescovi compresero che l’eletto era destinato a grandi cose e, durante la notte, continuarono a pregare. All’alba la porta si aprì ed entrò Nicola. Il vescovo che aveva avuto la visione gli si avvicinò e chiestogli come si chiamasse, lo spinse al centro dell’assemblea e lo presentò agli astanti. Tutti furono concordi nell’eleggerlo e nel consacrarlo seduta stante vescovo di Mira. L’episodio forse avvenne diversamente, anche perché, come si è detto, all’elezione dei vescovi partecipava sempre il popolo. Ma l’agiografo, vissuto in un’epoca in cui i vescovi avevano un potere più autonomo rispetto al laicato, narrando così l’episodio intendeva esprimere due concetti: Nicola fu fatto vescovo da laico e la sua elezione era il risultato non di accordi umani, ma soltanto della volontà di Dio.
Nel 303 d.C. l’imperatore Diocleziano mise fine alla sua politica di tolleranza verso i cristiani e scatenò una violenta persecuzione. Questa durò un decennio, anche se i momenti di crudeltà si alternarono con momenti di pausa. Nel 313 gli imperatori Costantino e Licinio a Milano si accordarono sulle sfere di competenza, prendendosi il primo l’occidente, il secondo l’oriente. Essi emanarono anche l’editto che dava libertà di culto ai cristiani. Sei anni dopo (319), in contrasto con la politica costantiniana filocristiana, Licinio riaprì la persecuzione contro i cristiani. Nelle fonti nicolaiane antiche (anteriori al IX secolo) non si trova alcun riferimento alla persecuzione. Considerando però che il vescovo di Patara Metodio affrontò coraggiosamente la morte, sembra probabile che anche il nostro Santo abbia dovuto patire il carcere ed altre sofferenze, non ultima quella di vedere il suo gregge subire tanti patimenti. Alcuni scrittori, come il Metafraste verso il 980 d.C., specificavano che Nicola aveva sofferto la persecuzione di Diocleziano, finendo in carcere. Qui, invece di abbattersi, il santo vescovo avrebbe sostenuto ed incoraggiato i fedeli a resistere nella fede e a non incensare gli dèi. Il che avrebbe spinto il preside della provincia a mandarlo in esilio. Autori successivi hanno voluto posticipare la persecuzione patita da Nicola, individuandola in quella di Licinio, piuttosto che in quella di Diocleziano. Ciò per ovviare al fatto che durante la persecuzione Nicola era già vescovo e, secondo loro, sarebbe stato consacrato vescovo fra il 308 ed il 314. Lo storico
bizantino Niceforo Callisto, per rendere più viva l’impressione di un Nicola vicino al martirio e con i segni delle torture ancora nelle carni, scriveva: Al concilio di Nicea molti splendevano di doni apostolici. Non pochi, per essersi mantenuti costanti nel confessare la fede, portavano ancora nelle carni le cicatrici e i segni, e specialmente fra i vescovi, Nicola vescovo dei Miresi, Pafnuzio e altri.
L’imperatore Costantino, con la sua politica a favore dei cristiani, il 23 giugno dell’anno 318 emanava un editto col quale concedeva a coloro che erano stati condannati dalle normali magistrature di presentare appello al vescovo. Ma, mentre la Chiesa con simili provvedimenti si rafforzava nella società pagana, ecco che un’opinione intorno alla natura di Gesù Cristo come Figlio di Dio (se uguale o inferiore a quella del Padre) suscitò una polemica tale da spaccare l’impero in due partiti contrapposti. A scatenare lo scisma fu il prete alessandrino Ario (256-336), coetaneo di S. Nicola. Per risolvere la questione e riportare la pace l’imperatore convocò la grande assemblea (concilio) a Nicea nel 325. Data l’ubicazione in Asia Minore ben pochi furono i vescovi occidentali che vi presero parte, mentre quelli orientali furono quasi tutti presenti. Qualcuno ha voluto mettere in dubbio la partecipazione di Nicola a questo primo ed importantissimo concilio ecumenico. Ma se è vero che il suo nome (come quello di S. Pafnuzio) non compare in diverse liste, è anche vero che compare in quella redatta da Teodoro il Lettore verso il 515 d.C., ritenuta autentica dal massimo studioso di liste dei padri conciliari (Edward Schwartz). Una delle preghiere più note della liturgia orientale si rivolge a Nicola con queste parole: O beato vescovo Nicola, tu che con le tue opere ti sei mostrato al tuo gregge come regola di fede (kanòna pìsteos) e modello di mitezza e temperanza, tu che con la tua umiltà hai raggiunto una gloria sublime e col tuo amore per la povertà le ricchezze celesti, intercedi presso Cristo Dio per farci ottenere la salvezza dell’anima.
Questa antica preghiera viene solitamente collegata proprio al ruolo svolto da Nicola al concilio di Nicea. Alla carenza di documentazione sulle sue azioni a Nicea suppliscono alcune leggende, la più nota delle quali (attribuita in verità anche a S. Spiridione) è quella del mattone. Dato che a provocare lo scisma era stato Ario, che non ammetteva l’uguaglianza di natura fra il Dio creatore e Gesù Cristo, il problema consisteva nel dimostrare come fosse possibile la fede in un solo Dio se anche Cristo era Dio. Considerando poi che la formula battesimale inseriva anche lo Spirito Santo, Nicola si preoccupò di dimostrare la possibilità della coesistenza di tre enti in uno solo. Preso un mattone, ricordò agli astanti la sua triplice composizione di terra, acqua e fuoco. Il che stava a significare che la divinità del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo non intaccava la verità fondamentale che Dio è uno. Mentre illustrava questa verità, ecco che una fiammella si levò dalle sue mani, alcune gocce caddero a terra e nelle sue mani restò soltanto terra secca.
Ancor più nota a livello popolare è la leggenda dello schiaffo ad Ario, legata all’usanza dei pittori di raffigurare agli angoli in alto il Cristo e la Vergine in atto di dare l’uno il vangelo l’altra la stola. Secondo questa leggenda Nicola, acceso di santo zelo, udendo le
bestemmie di Ario che si ostinava a negare la divinità di Cristo, levò la destra e gli diede uno schiaffo. Essendo stata riferita la cosa a Costantino, l’imperatore ne ordinò la carcerazione, mentre i vescovi lo privavano dei paramenti episcopali. I carcerieri dal canto loro lo insultavano e beffeggiavano in vari modi. Uno di loro giunse anche a bruciargli la barba. Durante la notte Nicola ebbe la visita di Cristo e della Madonna che gli diedero il vangelo (segno del magistero episcopale) e la stola o omophorion (segno del ministero sacramentale). Quando andò per celebrare la messa, indotto da spirito di umiltà, Nicola evitò di indossare i paramenti vescovili, ma alle prime sue parole ecco scendere dal cielo la vergine con la stola e degli angeli con la mitra. Ed appena terminata la celebrazione ecco rispuntargli folta la barba che la notte precedente i carcerieri gli avevano bruciata. Queste però sono tutte leggende posteriori, poiché, a parte la sua presenza in quel concilio (sull’autorità di Teodoro il Lettore ed alcune liste del VII-VIII secolo), non si sa nulla di ciò che fece Nicola a quel concilio. Certo è che fu dalla parte di Atanasio e dell’ortodossia, altrimenti la liturgia non l’avrebbe chiamato regola di fede.
L’eretico
Il silenzio degli antichi scrittori sul ruolo di Nicola a quel concilio si spiega forse col fatto che Nicola ebbe un atteggiamento diverso da quello del capo del partito cattolico ortodosso, Atanasio di Alessandria. Pur avendo un carattere altrettanto energico, Nicola era più sensibile alla ricomposizione dell’armonia nella Chiesa. Non si fermava come Atanasio alla difesa ad oltranza delle fede, ma tentava anche tutte le vie per riportare gli erranti (eretici) nel grembo della Chiesa. Un atteggiamento che dovette apparire ad Atanasio come troppo incline al compromesso, e di conseguenza non degno di essere ricordato fra i difensori della fede. Questa “damnatio memoriae” da parte di Atanasio (che pure menziona molti vescovi) si spiega anche col fatto che quasi certamente Nicola militava politicamente nel “partito” opposto. Mentre infatti Atanasio parla di Ablavio, prefetto di Costantino, come “amato da Dio”, l’antico biografo di Nicola lo definisce “perverso e malvagio” (come ritiene anche il grande storico Eusebio di Cesarea e tutti gli storici pagani). Né la cosa deve sorprendere più di tanto. Anche oggi infatti persone degnissime militano politicamente su versanti opposti. Che in S. Nicola si incontrassero il grande amore per la retta fede col grande amore dell’armonia nella Chiesa, è testimone S. Andrea di Creta, il quale scrive: Come raccontano, passando in rassegna i tralci della vera vite, incontrasti quel Teognide di santa memoria, allora vescovo della Chiesa dei Marcianisti. La disputa procedette in forma scritta fino a che non lo convertisti e riportasti all’ortodossia. Ma poiché fra voi due era forse intervenuta una sia pur minima asprezza, con la tua voce sublime citasti quel detto dell’Apostolo dicendo: “Vieni, riconciliamoci, o fratello, prima che il sole tramonti sulla nostra ira”. Nonostante il riferimento ai Marcianisti (talvolta è scritto Marcioniti), il vescovo Teognide è quasi certamente il vescovo di Nicea al tempo del Concilio di cui si è parlato. Simpatizzante dell’eretico Ario, Teognide si lasciò tuttavia convincere e alla fine firmò gli atti del concilio. Quasi certamente Nicola si era messo in contatto con lui già in precedenza e dovette avere un certo ruolo nel farlo decidere a firmare gli atti. In realtà Teognide successivamente non mutò
atteggiamento verso Atanasio, che continuò ad avversare decisamente. Dopo un esilio di tre anni in Gallia, al ritorno continuò a criticare il termine “consustanziale” col quale Atanasio e la Chiesa definivano il rapporto fra Padre e Figlio. Nel 336 contribuì a fare esiliare S. Atanasio. Come si può vedere, l’antichità cristiana non fa eccezione. Anche all’interno di sostenitori della retta fede si formarono “partiti” diversi. Il che comportò persino giudizi contrapposti sul piano della spiritualità. È il caso di Teognide, da S. Andrea di Creta ritenuto di “santa memoria”, da altri pur sempre un eretico. Ed è il caso di Teodoreto (storico della Chiesa), dalla chiesa greca considerato un eresiarca, dalla russa un “beato” (blažennyj). Ed è pure il caso del patriarca Anastasio (729-752), dalla chiesa latina ritenuto un iconoclasta, da quella greca “di santa memoria” perché pentito, dopo essere stato salvato proprio da S. Nicola dall’annegamento.
Costantino aveva lasciato libertà di culto ai pagani, tuttavia è chiaro che almeno a partire dal 318, coi poteri giurisdizionali ai vescovi, i cristiani ebbero uno spazio privilegiato all’interno dell’impero. Non pochi vescovi, e sembra che Nicola sia stato fra di essi, si impegnarono per quanto possibile a cancellare dalle loro città i segni della religione pagana fino ad abbattere alcuni templi. La tradizione ci fa vedere Nicola impegnato in tal senso. Andrea di Creta nel suo celebre Encomio di S. Nicola, rivolgendosi al nostro Santo esclama: Hai dissodato, infatti, i campi spirituali di tutta la provincia della Licia, estirpando le spine dell’incredulità. Con i tuoi insegnamenti hai abbattuto altari di idoli e luoghi di culto di dèmoni abominevoli e al loro posto hai eretto chiese a Cristo. Pur rimanendo molto vicino al testo di Andrea, Michele Archimandrita, “concretizzava” l’opera di Nicola facendo riferimento non alle armi della parola e dell’insegnamento, ma a vere e proprie spranghe di ferro per abbattere il tempio di Diana, che si ergeva imponente. Era questo il maggiore di tutti i templi sia per altezza che per varietà di decorazioni, oltre che per presenza di demoni.
Che Michele Archimandrita si fosse documentato su fonti miresi dirette è dimostrato proprio da queste sue parole. Se non avesse fatto ricorso a tali documenti difficilmente avrebbe potuto sapere di questo ruolo preminente del tempio di Diana. Dopo recenti scavi archeologici è risultato infatti che nel 141 questo tempio era stato restaurato ed ampliato dal mecenate licio Opramoas di Rodiapoli. Una conferma, questa, che quanto dice il monaco Michele riflette i racconti che si narravano a Mira nell’VIII secolo.
È probabile che la verità sia quella di Andrea di Creta, che ci mostra un Nicola che abbatte il paganesimo con le armi della parola. Tuttavia, a giudicare dal carattere energico del vescovo di Mira (dimostrato in altre occasioni), non è impossibile che sia avvenuto secondo il racconto dell’Archimandrita. Ciò che li accomuna, ed era una credenza molto diffusa a livello popolare, è il particolare dei demoni che abitavano in questi templi pagani, per cui quando questi venivano demoliti, i demoni venivano a trovarsi senza un tetto ed erano costretti a cercarsi altre dimore.
Il santo vescovo era impegnato però non soltanto nella diffusione della verità evangelica, ma anche nell’andare incontro alle necessità dei poveri e dei bisognosi. La parola della fede era seguita dalla messa in pratica della carità. Al tempo del suo episcopato mirese scoppiò una grave carestia, che mise in ginocchio la popolazione. Pare che Nicola prendesse varie iniziative per sovvenire ai bisogni del suo gregge, e l’eco di queste attraversò i secoli, rimanendo nella memoria dei Miresi. Una leggenda lo vede apparire in sogno a dei mercanti della Sicilia, suggerendo loro un viaggio sino alla sua città per vendere il grano, ed aggiungendo che lasciava loro una caparra. Quando i mercanti si resero conto di aver avuto la stessa visione e trovarono effettivamente la caparra, subito fecero vela per Mira e rifornirono la popolazione di grano.
Ancor più noto è l’episodio delle navi che da Alessandria d’Egitto fecero sosta nel porto di Mira. Nicola accorse e, salito su una delle navi, chiese al capitano di sbarcare una certa quantità di grano. Quello rispose che era impossibile, essendo quel grano destinato all’imperatore ed era stato misurato nel peso. Se fosse stato notato l’ammanco avrebbe potuto passare i guai suoi. Nicola gli rispose che si sarebbe addossato la responsabilità, e alla fine riuscì a convincerlo. Il frumento fu scaricato e la popolazione trovò grande sollievo, non solo perché si procurò il pane necessario, ma anche perché arò i terreni e seminò il grano che restava e poté raccoglierlo anche negli anni successivi. Quanto alle navi “alessandrine”, queste giunsero a Costantinopoli e, come il capitano aveva temuto, il tutto dovette passare per il controllo del peso. Quale non fu la sua gioia e meraviglia quando vide che il peso non era affatto diminuito, ma era risultato lo stesso della partenza delle navi da Alessandria. Questo miracolo è all’origine non solo di tanti quadri che lo raffigurano, ma anche di tante tradizioni popolari legate al pane di S. Nicola. A Bari, anche per facilitarne il trasporto nei paesi d’origine, ai pellegrini che giungono nel mese di maggio vengono date “serte” di taralli, tenuti insieme da una funicella.
Nicola salva tre innocenti
Tutti gli episodi sinora narrati hanno subìto l’incuria del tempo. Essi venivano narrati dai miresi e da nonni a nipoti giunsero fino all’VIII-IX secolo. Il lungo travaglio orale fece loro perdere i connotati della “storia” per apparire piuttosto come “tradizione” o come “leggenda”. I nomi dei protagonisti delle vicende si perdettero quasi del tutto. È vero che in tante Vite di S. Nicola si trovano i nomi dei genitori, dello zio archimandrita, del suo predecessore sulla cattedra di Mira, del nocchiero che l’avrebbe condotto in pellegrinaggio in Egitto e in Terra Santa, e così via. Ma si tratta di nomi che nulla hanno a che fare col nostro Nicola. Bisogna rassegnarsi alla realtà che, ad eccezione del concilio di Nicea e del vescovo Teognide, nessun nome compare nella vita del nostro Santo prima della storia dei tre innocenti salvati dalla decapitazione. Questa storia, insieme a quella successiva dei generali bizantini (Praxis de stratelatis), è il pezzo forte di tutta la vicenda nicolaiana. Nell’antichità, per esprimere il concetto che questa narrazione era la più importante di tutte quelle che riguardavano S. Nicola, spesso non veniva indicata come Praxis de stratelatis (racconto intorno ai generali) ma semplicemente come
Praxis tou agiou Nikolaou (storia di S. Nicola), quasi che tutti gli altri racconti non rivestissero alcuna importanza a paragone con questo.
In occasione della sosta di alcune navi militari nel porto di Mira, nel vicino mercato di Placoma scoppiarono dei tafferugli, in parte provocati proprio dalla soldataglia che sfogava così la tensione di una vita di asperità. In quei disordini le forze dell’ordine catturarono tre cittadini miresi, i quali dopo un processo sommario furono condannati a morte. Nicola si trovava in quel momento a colloquio con i generali dell’esercito Nepoziano, Urso ed Erpilio, i quali gli stavano dicendo della loro imminente missione militare contro i Taifali, una tribù gotica che stava suscitando una rivolta in Frigia. Invitati da S. Nicola, i generali riuscirono a fare riportare l’ordine. Ma ecco che alcuni cittadini accorsero dal vescovo, riferendogli che il preside Eustazio aveva condannato a morte quei tre innocenti. Seguito dai generali, Nicola prese il cammino per Mira. Giunto al luogo detto Leone, incontrò alcuni che gli dissero che i condannati erano nel luogo detto Dioscuri. Nicola procedette così fino alla chiesa dei santi martiri Crescente e Dioscoride. Qui apprese che i condannati erano già stati portati a Berra, il luogo ove solitamente venivano messi a morte i condannati. Ben sapendo che solo lui, in quanto vescovo, avrebbe potuto fermare il carnefice, accelerò il passo e vi giunse, aprendosi la strada fra la folla che faceva da spettatrice. Il carnefice era già pronto, e i condannati stavano già col collo sui ceppi, quando Nicola si avvicinò e tolse la spada al carnefice.
Avendo liberato gli innocenti dalla decapitazione, Nicola si recò al palazzo del preside Eustazio, entrandovi senza farsi annunciare. Giunto dinanzi al preside l’apostrofò accusandolo di ingiustizie, violenze e corruzione. Quando minacciò di riferire la cosa all’imperatore, Eustazio rispose che era stato indotto in errore da due notabili di Mira, Simonide ed Eudossio. Ma Nicola, senza contestare il particolare, gli rinfacciò nuovamente la corruzione e, giocando sulle parole, gli disse che non Simonide ed Eudossio, ma Crisaffio (oro) e Argiro (argento) l’avevano corrotto. Avendo così ristabilita la verità e la giustizia, Nicola non infierì ma perdonò al preside pentito.
I generali liberati dalla prigione
Edificati dal comportamento del santo vescovo, tre generali ripresero il mare e raggiunsero la Frigia, ove riuscirono a sottomettere le forze ribelli all’impero. Un po’ per il successo dell’impresa un po’ perché Nepoziano era parente dell’imperatore, il loro ritorno a Costantinopoli avvenne in un’atmosfera di vero e proprio trionfo. Tuttavia la gloria e gli onori durarono poco, perché queste sono spesso accompagnate da gelosie ed invidie. Gli agiografi parlano di malevoli suggerimenti del diavolo, certo è che ben presto si formò un partito avverso a Nepoziano e compagni. I componenti di questo partito riuscirono a coinvolgere il potente prefetto Ablavio, il quale convinse l’imperatore che i tre generali stavano complottando per rovesciarlo dal trono. Convinto o meno dell’attendibilità della notizia, Costantino preferì non correre rischi, e li fece mettere in prigione. Dopo alcuni mesi i seguaci di Nepoziano si stavano organizzando su come liberare i generali. Per cui i loro avversari, col denaro promesso a suo tempo, tornarono da Ablavio e lo convinsero a suggerire all’imperatore un prov-
vedimento più drastico. Infatti, Costantino diede ordine di sopprimerli quella notte stessa. Appresa la notizia, il carceriere Ilarione corse ad avvertire i generali, che furono presi da grande angoscia. Sentendosi prossimo alla morte, Nepoziano si sovvenne dell’intervento in extremis del vescovo Nicola a favore dei tre innocenti. Allora levò al Signore questa preghiera: Signore, Dio del tuo servo Nicola, abbi compassione di noi, grazie alla tua misericordia e all’intercessione del tuo servo Nicola. Come, per i suoi meriti, hai avuto compassione dei tre uomini condannati ingiustamente salvandoli da sicura morte, così ora ridà la vita anche a noi, mosso a misericordia dall’intercessione di questo santo vescovo. Il Signore esaudì la preghiera di Nepoziano, fatta propria dai compagni. Quella notte S. Nicola apparve in sogno all’imperatore minacciandolo: Costantino, alzati e libera i tre generali che tieni in prigione, poiché vi furono rinchiusi ingiustamente. Se non fai come ho detto, conferirò con Cristo, il re dei re, e susciterò una guerra e darò in pasto i tuoi resti a fiere ed avvoltoi. Spaventato, Costantino chiese chi fosse: Sono Nicola, vescovo peccatore, e risiedo a Mira, metropoli della Licia. Nicola apparve minaccioso anche ad Ablavio, e quando l’imperatore lo mandò a chiamare, entrambi pensarono ad un’opera di magia. Mandarono a prendere i tre generali per chiedere spiegazioni. Il colloquio aveva preso il binario della “magia”, quando Costantino chiese a Nepoziano se conoscesse un tale di nome Nicola. Nepoziano si illuminò, accorgendosi che la sua preghiera era stata esaudita. E narrò tutto all’imperatore, che seduta stante ne ordinò la liberazione. Anzi, volle che andassero a Mira a ringraziare il santo vescovo ed a portargli da parte sua preziosi doni, fra cui un Vangelo tutto decorato d’oro e candelieri ugualmente d’oro. Altri autori aggiungono che giunti a Mira si tagliarono i capelli in segno di gratitudine e di devozione verso il Santo.
La riduzione delle tasse
È difficile dire quanto ci sia di vero e quanto sia stato il parto della fantasia di un popolo consapevole di aver avuto un “progenitore” ed un difensore. Per i Miresi Nicola era colui che aveva riportato la retta fede, la giustizia ed il benessere alla loro città. Non per nulla, secondo la testimonianza sia della Vita Nicolai Sionitae sia dell’Encomio di Andrea di Creta, essi istituirono la festa delle “rosalie del nostro progenitore S. Nicola”. Fra le tante iniziative del Santo a favore della popolazione, intorno al VII secolo si narrava il suo intervento per fare ridurre le tasse per i Miresi (Praxis de tributo). È nota a diversi storici la tendenza di Costantino a gravare le popolazioni dell’impero con tasse esorbitanti. Ed anche se i cristiani cercavano delle attenuanti, i pagani come Zosimo ricordavano che Costantino era costretto a una pesante politica tributaria a causa della sua eccessiva prodigalità. L’anonimo scrittore che compose l’Epitome de Caesaribus descriveva così la sua politica tributaria: Per dieci anni eccellente, nei dodici anni successivi predone, negli ultimi dieci fu chiamato pupillo per le eccessive prodigalità. Quando anche la città di Mira si trovò a dover pagare tasse esorbitanti, i rappresentanti del popolo si rivolsero a Nicola affinché scrivesse all’imperatore. Nicola fece di più. Partì alla volta di Costantinopoli e chiese udienza. L’anonimo scrittore qui si lascia prendere la mano e, non tenendo conto che Nicola era vissuto al tempo di Costantino, immagina i vescovi della capitale che gli rendono omaggio riunendosi nel tempio della
Madre di Dio alle Blacherne, chiedendogli la benedizione. A parte l’esagerazione di una simile accoglienza, quel tempio sarebbe stato costruito un secolo dopo la morte del Santo. L’abbellimento agiografico si nota anche al momento dell’arrivo di Costantino. Prima che cominciasse il colloquio, l’imperatore gettò il suo mantello ed ecco che questo, incrociando un raggio di sole, rimase sospeso ad esso. Il prodigio rese timoroso e benevolo l’imperatore. Quando Nicola gli riferì come i Miresi fossero oppressi dalle tasse, chiedendogli di apportare una sensibile riduzione, l’imperatore chiamò il notaio ed archivista Teodosio, e secondo il desiderio di Nicola operò una netta riduzione a soli cento denari. Nicola prese la carta su cui era registrata questa concessione e legatala ad una canna, la gettò in mare. Per volere di Dio la canna giunse nel porto di Mira e pervenne nelle mani dei funzionari del fisco, i quali furono molto sorpresi ma si adeguarono. Intanto però a Costantinopoli i consiglieri di Costantino fecero notare all’imperatore che forse la concessione era stata un tantino esagerata. Per cui l’imperatore chiamò nuovamente Nicola per correggere la somma della tassa che i Miresi dovevano pagare. Il Santo gli rispose che da tre giorni la carta era pervenuta a Mira. Essendo ciò impossibile, Costantino promise che se le cose stavano veramente così avrebbe confermato la precedente concessione. I nunzi, da lui inviati per verificare quel che era accaduto, tornarono e riferirono che Nicola aveva detto la verità. Mantenendo la promessa, l’imperatore confermò la concessione.
La morte del Santo
Considerando la tradizione secondo la quale era già anziano al tempo del concilio di Nicea, con ogni probabilità il nostro Santo morì in un anno molto prossimo al 335 dopo Cristo. Come della sua nascita, anche della sua morte non si sa alcunché. Gli episodi e i particolari che si leggono in alcune Vite non riguardano il nostro Nicola, ma un santo monaco vissuto due secoli dopo nella stessa regione.
Traslazione delle reliquie
Nel 1087 una spedizione navale partita dalla città di Bari si impadronì delle spoglie di San Nicola, che nel 1089 vennero definitivamente poste nella cripta della Basilica eretta in suo onore. L’idea di trafugare le sue spoglie venne ai baresi nel contesto di un programma di rilancio dopo che la città, a causa della conquista normanna, aveva perduto il ruolo di residenza del catepano e quindi di capitale dell’Italia bizantina. In quei tempi la presenza in città delle reliquie di un santo importante era non solo una benedizione spirituale, ma anche mèta di pellegrinaggi e quindi fonte di benessere economico.
Autore: Padre Gerardo Cioffari O.P.
Proclamato patrono della Grecia, Nicola nasce nel III secolo a Patara, in Licia (Turchia), in una ricca famiglia che lo educa ad essere generoso con i bisognosi. Nicola è di buon cuore e si sente portato verso la spiritualità. Prega e frequenta la chiesa. Aiuta i poveri donando loro il cibo ed è sua abitudine gettarlo nelle misere case dalla finestra, per non farsi scoprire. Diventa vescovo della Myra (Turchia) e, rimanendo molto umile, compie tanti miracoli: libera condannati a morte
ingiustamente, moltiplica il grano per gli affamati, converte i cuori malvagi, guarisce e salva dai pericoli. La leggenda narra che il piccolo Nicola il mercoledì e il venerdì succhiasse il latte materno solo una volta al giorno e in piccole quantità, per rispettare i dettami del digiuno cristiano. Una famiglia sul lastrico sta per vendere le proprie figlie ma, grazie all’intervento generoso di San Nicola, le tre ragazze sono salve. Il vescovo, di nascosto, getta nella loro povera casa tre borse d’oro, la dote occorrente alle fanciulle per potersi sposare. E tre palle d’oro sono, infatti, uno dei simboli con i quali il santo viene spesso raffigurato. Un gruppo di marinai, poi, miracolosamente si salva da una bufera, ancora per intercessione di Nicola. Nei Paesi del Nord Europa San Nicola viene comunemente chiamato Santa Claus, nome che deriva dal tedesco Nicolaus. Per i bambini di questi Paesi è tradizione che a Natale, giorno in cui si celebra la nascita di Gesù, Santa Claus porti loro giocattoli e dolci. Ecco le origini di Babbo Natale: il vescovo con la lunga barba che, in sella a un cavallo bianco, regala cibo ai poveri, si trasforma in un simpatico “nonno”, vestito di rosso, che guida una slitta trainata da renne. Infatti San Nicola è protettore dei bambini e della loro salute, dei ragazzi e delle ragazze. È patrono anche di porti di mare, marinai, barcaioli, pescatori, panettieri, produttori e commercianti di olio, prestatori di denaro, banchi di pegno e bisognosi. Viene invocato contro i pericoli del mare, i furti e i ladri, le carestie, gli errori giudiziari e per avere un matrimonio felice. Festeggiato il 6 dicembre, giorno in cui muore intorno al 343 a Myra, nel 1087 le sue reliquie vengono portate a Bari (Puglia), di cui San Nicola diventa il patrono. In questa città, che si affaccia sul Mare Adriatico, sorge una grande basilica che custodisce i resti di San Nicola, meta di pellegrinaggio per tanti fedeli.
Autore: Mariella Lentini
SANTA GEMMA GALGANI
Capannori, Lucca, 12 marzo 1878 - Lucca, 11 aprile 1903
Nasce il 12 marzo 1878 a Borgonuovo di Camigliano (Lucca). La mamma Aurelia muore nel settembre del 1886. Nel 1895 Gemma riceve l’ispirazione a seguire impegno e decisione la via della Croce. Gemma ha alcune visioni del suo angelo custode. L’11 novembre 1897 muore anche il padre di Gemma, Enrico. Ammalata, Gemma, legge la biografia del venerabile passionista Gabriele dell’Addolorata (ora santo), che le appare e la conforta. Gemma nel frattempo matura una decisione e la sera dell’8 dicembre, festa dell’Immacolata, fa voto di verginità. Nonostante le terapie mediche, la malattia di Gemma, osteite delle vertebre lombari con ascesso agli inguini, si aggrava fino alla paralisi delle gambe, dalla quale però viene guarita miracolosamente. Le visioni di Gemma continuano e le viene data la grazia di condividere le sofferenza di Cristo. Nel maggio del 1902 Gemma si ammala nuovamente, si riprende, ma ha una ricaduta in ottobre. Muore l’11 aprile 1903. Il Martirologio Romano ricorda Santa Gemma l’11 aprile, mentre la Famiglia Passionista e la diocesi di Lucca celebrano la sua memoria liturgica il 16 maggio.
Etimologia: Gemma = dal nome generico delle pietre preziose
Emblema: Giglio
Martirologio Romano: A Lucca, santa Gemma Galgani, vergine, che, insigne nella contemplazione della Passione del Signore e nella paziente sopportazione dei dolori, a venticinque anni nel Sabato Santo concluse la sua angelica esistenza.
Gemma Galgani nasce il 12 marzo 1878 a Borgonuovo di Camigliano (Lucca), riceve il battesimo il 13 marzo. Il 26 maggio 1885, nella chiesa di San Michele in Foro, l’arcivescovo di Lucca amministra a Gemma la Cresima. La mamma Aurelia muore nel settembre del 1886. Un altro grande dolore per Gemma fu la morte del fratello Gino, seminarista, avvenuta nel 1894, ad appena 18 anni. Nel 1895 Gemma riceve l’ispirazione a seguire con impegno e decisione la via della croce, quale itinerario cristiano. Gemma ha alcune visioni del suo angelo custode che le ricorda che i gioielli di una sposa del crocifisso sono la croce e le spine. L’11 novembre 1897 muore anche il padre di Gemma, Enrico, e le misere condizioni della famiglia, la obbligano a lasciare la casa di via S. Giorgio per quella di via del Biscione, 13 (oggi via S. Gemma 23). Gemma trascorre un periodo a Camaiore, presso la zia che l’aveva voluta con sé dopo la morte del babbo, ma nell’autunno 1899 si ammala gravemente e ritorna in famiglia. I mesi invernali segnano grandi sofferenze per tutti e le ristrettezze economiche si fanno sentire penosamente sulla numerosa famiglia: oltre alle due zie Elisa ed Elena, vi sono i fratelli di Gemma, Guido, Ettore e Tonino, e le sorelle Angelina e Giulietta. Guido, il fratello maggiore, studia a Pisa e, dopo la laurea in farmacia, cerca di aiutare la famiglia lavorando presso l’ospedale di Lucca. Anche Tonino studia a Pisa con sacrificio di tutti. Nel periodo della malattia, Gemma legge la biografia del venerabile passionista Gabriele dell’Addolorata (ora santo). Gemma ha un’apparizione del venerabile che ha per lei parole di conforto.
Gemma nel frattempo matura una decisione e la sera dell’8 dicembre, festa dell’Immacolata, fa voto di verginità. Nella notte seguente il venerabile Gabriele le appare nuovamente chiamandola “sorella mia” e porgendole a baciare il segno dei passionisti che gli posa sul petto. Nel mese di gennaio nonostante le terapie mediche, la malattia di Gemma, osteite delle vertebre lombari con ascesso agli inguini, si aggrava fino alla paralisi delle gambe. Ad aggravare la situazione, il 28 gennaio si manifesta anche un’otite purulenta con partecipazione della mastoide. Proprio in quei giorni, il fratello Guido si trasferisce a Bagni di San Giuliano dove ha ottenuto una farmacia. Gemma è confortata dalle visioni del venerabile Gabriele e del suo angelo custode, ma è tentata dal demonio, che riesce a vincere con l’aiuto del venerabile Gabriele, ormai sua guida spirituale. Il 2 febbraio i medici la danno per spacciata, secondo loro non supererà la notte, ma Gemma trascorre le giornate in preghiera, tra indicibili sofferenze.
Il 3 marzo è il primo venerdì del mese e la giovane ha terminato una novena in onore della beata Margherita Maria Alacoque (ora santa) e si è accostata all’eucarestia, quando avviene la guarigione miracolosa. Il 23 dello stesso mese, tornata a casa dopo l’Eucaristia, Gemma ha una visione del venerabile Gabriele, che le indica il Calvario come meta finale. Il 30 marzo, Giovedì Santo, Gemma è in preghiera, compie l’«Ora Santa» in unione a Gesù nell’Orto degli Ulivi, e Gesù a un tratto le appare ferito e insanguinato. Nell’aprile seguente, preoccupata di non sapere amare Gesù, Gemma si trova nuovamente davanti al Crocifisso e ne ascolta parole di amore: Gesù ci ha amati fino alla morte in Croce, è la sofferenza che insegna ad amare. L’8 giugno, dopo essersi accostata all’Eucarestia, Gesù le appare annunciandole una grazia grandissima. Gemma, sente il peso dei peccati, ma ha una visione di Maria, dell’angelo custode e di Gesù. Maria nel nome di suo Figlio li rimette i peccati e la chiama alla sua missione. Dalle ferite di Gesù non esce più sangue, ma fiamme che vanno a toccare le mani, i piedi ed il cuore di Gemma. Gemma si sente come morire, sta per cadere in terra, ma Maria la sorregge e quindi la bacia in fronte. Gemma si ritrova in ginocchio a terra con un forte dolore alle mani, ai piedi e al cuore, da dove esce del sangue. Quei dolori però anziché affliggerla gli danno una pace perfetta. La mattina successiva si reca all’Eucarestia, coprendo le mani con un paio di guanti. I dolori le durano fino alle ore 15 del venerdì, festa solenne del Sacro Cuore di Gesù. Da quella sera, ogni settimana Gesù chiama Gemma ad essergli collaboratrice nell’opera della salvezza, unendola a tutte le Sue sofferenze fisiche e spirituali. questa grazia grandissima è motivo per Gemma di ineffabili gioie e di profondi dolori. In casa vi sono perplessità e incredulità per quanto avviene, Gemma è spesso rimproverata dalle zie e dai fratelli, talvolta viene derisa e canzonata dalle sorelle, ma Gemma tace e attende.
Nei mesi estivi conosce i Passionisti impegnati nella Missione popolare in Cattedrale e da uno di essi viene introdotta in casa Giannini. Gemma conosceva già la signora Cecilia, ma frequentandola nella casa di via del Seminario, inizia una vera e profonda amicizia con quella che sarà per lei come una seconda madre.
Nel gennaio del 1900, Gemma comincerà a scrivere a padre Germano, il sacerdote passionista che avrebbe riconosciuto in lei l’opera di Dio e nel settembre successivo lo incontrerà
personalmente. Sempre in settembre, Gemma lascia definitivamente la sua famiglia per andare ad abitare in casa Giannini, tornerà alla sua casa solo in rare occasioni per consolare la sorella Giulietta quando sofferente. Nel maggio del 1902 Gemma si ammala nuovamente, si riprende, ma ha una ricaduta in ottobre. Nel frattempo muoiono la sorella Giulia (19 agosto) e il fratello Tonino (21 ottobre). Il 24 gennaio 1903, per ordine dei medici, la famiglia Giannini deve trasferire Gemma in un appartamento affittato dalla zia Elisa, Gemma vive così l’esperienza dell’abbandono di Gesù in croce e del silenzio di Dio. È fortemente tentata dal demonio, ma non smarrisce mai la fede, non perde mai la pazienza ed è sempre piena di amore e di riconoscenza verso chi l’assiste nella malattia. Al mezzogiorno dell’11 aprile 1903, Sabato Santo, come si usa all’epoca, le campane annunciano la risurrezione del Signore e alle 13.45, Gemma si addormenta nel Signore, assistita amorevolmente dai Giannini. Il 14 maggio 1933 papa Pio XI annovera Gemma Galgani fra i Beati della Chiesa. Il 2 maggio 1940 papa Pio XII, riconoscendo la pratica eroica delle sue virtù cristiane, innalza Gemma Galgani alla gloria dei Santi e la addita a modello della Chiesa universale.
Il Martirologio Romano ricorda Santa Gemma l’11 aprile, mentre la Famiglia Passionista e la diocesi di Lucca celebrano la sua memoria liturgica il 16 maggio.
Autore: Maurizio Misinato
SANTA CATERINA DA SIENA
Siena, 25 marzo 1347 - Roma, 29 aprile 1380
«Niuno Stato si può conservare nella legge civile in stato di grazia senza la santa giustizia»: queste alcune delle parole che hanno reso questa santa, patrona d›Italia, celebre. Nata nel 1347 Caterina non va a scuola, non ha maestri. I suoi avviano discorsi di maritaggio quando lei è sui 12 anni. E lei dice di no, sempre. E la spunta. Del resto chiede solo una stanzetta che sarà la sua «cella» di terziaria domenicana (o Mantellata, per l›abito bianco e il mantello nero). La stanzetta si fa cenacolo di artisti e di dotti, di religiosi, di processionisti, tutti più istruiti di lei. Li chiameranno “Caterinati”. Lei impara a leggere e a scrivere, ma la maggior parte dei suoi messaggi è dettata. Con essi lei parla a papi e re, a donne di casa e a regine, e pure ai detenuti. Va ad Avignone, ambasciatrice dei fiorentini per una non riuscita missione di pace presso papa Gregorio XI. Ma dà al Pontefice la spinta per il ritorno a Roma, nel 1377. Deve poi recarsi a Roma, chiamata da papa Urbano VI dopo la ribellione di una parte dei cardinali che dà inizio allo scisma di Occidente. Ma qui si ammala e muore, a soli 33 anni. Sarà canonizzata nel 1461 dal papa senese Pio II. Nel 1939 Pio XII la dichiarerà patrona d’Italia con Francesco d’Assisi
Patronato: Italia, Europa (Giovanni Paolo II, 1/10/99)
Etimologia: Caterina = donna pura, dal greco
Emblema: Anello, Giglio
Martirologio Romano: Festa di Santa Caterina da Siena, vergine e dottore della Chiesa, che, preso l’abito delle Suore della Penitenza di San Domenico, si sforzò di conoscere Dio in se stessa e se stessa in Dio e di rendersi conforme a Cristo crocifisso; lottò con forza e senza sosta per la pace, per il ritorno del Romano Pontefice nell’Urbe e per il ripristino dell’unità della Chiesa, lasciando pure celebri scritti della sua straordinaria dottrina spirituale.
Quando si pensa a santa Caterina da Siena vengono in mente tre aspetti di questa mistica nella quale sono stati stravolti i piani naturali: la sua totale appartenenza a Cristo, la sapienza infusa, il suo coraggio. I due simboli che caratterizzano l’iconografia cateriniana sono il libro e il giglio, che rappresentano rispettivamente la dottrina e la purezza. L’insistenza dell’iconografia antica sui simboli dottrinali e soprattutto il capolavoro de Il Dialogo della Divina Provvidenza (ovvero Libro della Divina Dottrina), l’eccezionale Epistolario e la raccolta delle Preghiere sono stati decisivi per la proclamazione a Dottore della Chiesa di santa Caterina, avvenuta il 4 ottobre 1970 per volere di Paolo VI (1897-1978), sette giorni dopo quella di santa Teresa d’ Avila (1515-1582).
Caterina (dal greco: donna pura) vive in un momento storico e in una terra, la Toscana, di intraprendente ricchezza spirituale e culturale, la cui scena artistica e letteraria era stata riempita da figure come Giotto (1267-1337) e Dante (1265-1321), ma, contemporaneamente, dilaniata da tensioni e lotte fratricide di carattere politico, dove occupavano spazio preponderante le discordie fra guelfi e ghibellini.
Nasce a Siena nel rione di Fontebranda (oggi Nobile Contrada dell’Oca) il 25 marzo 1347: è la ventiquattresima figlia delle venticinque creature che Jacopo Benincasa, tintore, e Lapa di Puccio de’ Piacenti hanno messo al mondo. Giovanna è la sorella gemella, ma morirà neonata. La famiglia Benincasa, un patronimico, non ancora un cognome, appartiene alla piccola borghesia. Ha solo sei anni quando le appare Gesù vestito maestosamente, da Sommo Pontefice, con tre corone sul capo ed un manto rosso, accanto al quale stanno san Pietro, san Giovanni e san Paolo. Il Papa si trovava, a quel tempo, ad Avignone e la cristianità era minacciata dai movimenti ereticali. Già a sette anni fece voto di verginità. Preghiere, penitenze e digiuni costellano ormai le sue giornate, dove non c’è più spazio per il gioco. Della precocissima vocazione parla il suo primo biografo, il beato Raimondo da Capua (1330-1399), nella Legeda Maior, confessore di santa Caterina e che divenne superiore generale dell’ordine domenicano; in queste pagine troviamo come la mistica senese abbia intrapreso, fin da bambina, la via della perfezione cristiana: riduce cibo e sonno; abolisce la carne; si nutre di erbe crude, di qualche frutto; utilizza il cilicio... Proprio ai Domenicani la giovanissima Caterina, che aspirava a conquistare anime a Cristo, si rivolse per rispondere alla impellente chiamata. Ma prima di realizzare la sua aspirazione fu necessario combattere contro le forti reticenze dei genitori che la volevano coniugare. Aveva solo 12 anni, eppure reagì con forza: si tagliò i capelli, si coprì il capo con un velo e si serrò in casa. Risolutivo fu poi ciò che un giorno il padre vide: sorprese una colomba aleggiare sulla figlia in preghiera. Nel 1363 vestì l’abito delle «mantellate» (dal mantello nero sull’abito bianco dei Domenicani); una scelta anomala quella del terz’ordine laicale, al quale aderivano soprattutto donne mature o vedove, che continuavano a vivere nel mondo, ma con l’emissione dei voti di obbedienza, povertà e castità. Caterina si avvicinò alle letture sacre pur essendo analfabeta: ricevette dal Signore il dono di saper leggere e imparò anche a scrivere, ma usò comunque e spesso il metodo della dettatura. Al termine del Carnevale del 1367 si compiono le mistiche nozze: da Gesù riceve un anello adorno di rubini. Fra Cristo, il bene amato sopra ogni altro bene, e Caterina viene a stabilirsi un rapporto di intimità particolarissimo e di intensa comunione, tanto da arrivare ad uno scambio fisico di cuore. Cristo, ormai e in tutti i sensi, vive in lei (Gal 2,20). Ha inizio l’intensa attività caritatevole a vantaggio dei poveri, degli ammalati, dei carcerati e intanto soffre indicibilmente per il mondo, che è in balia della disgregazione e del peccato; l’Europa è pervasa dalle pestilenze, dalle carestie, dalle guerre: «la Francia preda della guerra civile; l’Italia corsa dalle compagnie di ventura e dilaniata dalle lotte intestine; il regno di Napoli travolto dall’incostanza e dalla lussuria della regina Giovanna; Gerusalemme in mano agli infedeli, e i turchi che avanzano in Anatolia mentre i cristiani si facevano guerra tra loro» (F. Cardini, I santi nella storia, San Paolo, Cinisello Balsamo -MI-, 2006, Vol. IV, p. 120). Fame, malattia, corruzione, sofferenze, sopraffazioni, ingiustizie…
Le lettere
Le lettere, che la mistica osa scrivere al Papa in nome di Dio, sono vere e proprie colate di lava, documenti di una realtà che impegna cielo e terra. Lo stile, tutto cateriniano, sgor-
ga da sé, per necessità interiore: sospinge nel divino la realtà contingente, immergendo, con una iridescente e irresistibile forza d’amore, uomini e circostanze nello spazio soprannaturale. Ecco allora che le sue epistole sono un impasto di prosa e poesia, dove gli appelli alle autorità, sia religiose che civili, sono fermi e intransigenti, ma intrisi di materno sentire: «Delicatissima donna, questo gigante della volontà; dolcissima figlia e sorella, questo rude ammonitore di Pontefici e di re; i rimproveri e le minacce che ella osa fulminare sono compenetrati di affetto inesausto» (G. Papàsogli, Caterina da Siena, Fabbri Editori RCS, Milano 2001, p. 201). Usa espressioni tonanti, invitando alla virilità delle scelte e delle azioni, ma sa essere ugualmente tenerissima, come solo uno spirito muliebre è in grado di palesare. La poesia di colei che scrive al Papa «Oimé, padre, io muoio di dolore, e non posso morire» è costituita da sublimi altezze e folgoranti illuminazioni divine, ma nel contempo, conoscendo che cosa sia il peccato e dove esso conduca, tocca abissi di indicibile nausea, perché Caterina intinge il pensiero nell’inchiostro della realtà tutta intera, quella fatta di bene e male, di angeli e demoni, di natura e sovranatura, dove il contingente si incontra e si scontra nell’Eter no.
Per la causa di Cristo
Una brulicante «famiglia spirituale», formata da sociae e socii, confessori e segretari, vive intorno a questa madre che pungola, sostiene, invita, con forza e senza posa, alla Causa di Cristo, facendo anche pressioni, come pacificatrice, su casate importanti come i Tolomei, i Malavolti, i Salimbeni, i Bernabò Visconti… Lotte con il demonio, levitazioni, estasi, bilocazioni, colloqui con Cristo, il desiderio di fusione in Lui e la prima morte di puro amore, quando l’amore ebbe la forza della morte e la sua anima fu liberata dalla carne… per un breve spazio di tempo. I temi sui quali Caterina pone attenzione sono: la pacificazione dell’Italia, la necessità della crociata, il ritorno della sede pontificia a Roma e la riforma della Chiesa. Passato il periodo della peste a Siena, nel quale non sottrae la sua attenta assistenza, il 1° aprile del 1375, nella chiesa di Santa Cristina, riceve le stimmate incruente. In quello stesso anno cerca di dissuadere i capi delle città di Pisa e Lucca dall’aderire alla Lega antipapale promossa da Firenze che si trovava in urto con i legati pontifici, che avrebbero dovuto preparare il ritorno del Papa a Roma. L’anno seguente partì per Avignone, dove giunse il 18 giugno per incontrare Gregorio XI (1330–1378), il quale, persuaso dall’intrepida Caterina, rientrò nella città di san Pietro il 17 gennaio 1377. L’anno successivo morì il Pontefice e gli successe Urbano VI (1318–1389), ma una parte del collegio cardinalizio gli preferì Roberto di Ginevra, che assunse il nome di Clemente VII (1342– 1394, antipapa), dando inizio al grande scisma d’Occidente, che durò un quarantennio, risolto al Concilio di Costanza (14141418) con le dimissioni di Gregorio XII (1326–1417), che precedentemente aveva legittimato il Concilio stesso, e l’elezione di Martino V (1368–1431), nonché con le scomuniche degli antipapi di Avignone (Benedetto XIII, 1328–1423) e di Pisa (Giovanni XXIII, 1370–1419). All’udienza generale del 24 novembre 2010 Benedetto XVI ha affermato, riferendosi proprio a santa Caterina: «Il secolo in cui visse - il quattordicesimo - fu un’epoca travagliata per la vita della Chiesa e dell’intero tessuto sociale in Italia e in Europa. Tuttavia, anche nei momenti di maggiore difficoltà, il Signore non cessa di benedire il suo Popolo, suscitando
Santi e Sante che scuotano le menti e i cuori provocando conversione e rinnovamento». Amando Gesù («O Pazzo d’amore!»), che descrive come un ponte lanciato tra Cielo e terra, Caterina amava i sacerdoti perché dispensatori, attraverso i Sacramenti e la Parola, della forza salvifica. L’anima di colei che iniziava le sue cocenti e vivificanti lettere con «Io Catarina, serva e schiava de’ servi di Gesù Cristo, scrivo a voi nel prezioso sangue suo», raggiunge la beatitudine il 29 aprile 1380, a 33 anni, gli stessi di Cristo, nel quale si era persa per ritrovare l’autentica essenza.
Autore: Cristina Siccardi
Prima donna ad essere stata proclamata dottore della Chiesa, è compatrona d’Europa, d’Italia e di Roma. Caterina nasce a Siena il 25 marzo 1347, nell’attuale contrada dell’Oca. Penultima di venticinque figli, sopravvive alla sorella gemella. A sei anni ha la prima visione di Gesù. La bambina non è interessata ai giochi della sua età, desidera, invece, dedicare la sua vita a Dio. Tuttavia i genitori (Jacopo Benincasa, agiato tintore, e la moglie, Lapa Piacenti) intendono farla sposare. Pur di non sottostare ai voleri dei genitori, la giovane e bella Caterina si taglia tutti i capelli. La ragazza è ubbidiente, aiuta la mamma ad accudire la numerosa famiglia. Tuttavia, per punizione svolge i lavori domestici più umili, ma di matrimonio non ne vuole sapere. I conflitti con i genitori continuano. Un giorno, il padre vede la figlia in una stanza della casa assorta nella preghiera e in alto, sopra al suo capo, volare una colomba, simbolo dello Spirito Santo. Questo per lui è un segno del Cielo. I genitori fanno ammettere la figlia tra le “Suore della Penitenza” – le “Mantellate” vestite di bianco con un mantello nero – nell’Ordine di San Domenico, in seguito ad un sogno di Caterina dove il santo la invita ad entrare nella propria congregazione. Continuano le visioni e le estasi. Tra preghiere, penitenze e digiuni (mangia pochissimo), la ragazza assiste poveri e infermi. Sempre sorretta dalla sua fede, Caterina cura anche gli ammalati di peste senza venirne contagiata. La giovane diventa famosa per i suoi miracoli, la capacità di convertire i peccatori e la coraggiosa lotta per la pace: parla alle persone semplici e alle autorità, consiglia, conforta, predica il Bene. Una visione spinge, poi, Caterina ad occuparsi della Chiesa. Tra i vari obiettivi raggiunti il ritorno del papa a Roma da Avignone e la riforma delle regole della Chiesa. Caterina è quasi analfabeta ma riceve da Dio il dono di saper leggere. Invia, facendole scrivere sotto dettatura, lettere ai papi e ai potenti dell’epoca. Famosi i suoi scritti Lettere e Dialogo della Divina Provvidenza. Come è capitato ad altri santi, riceve le stimmate (1375). Celebre il miracolo di guarigione del cappellano dell’ospedale di Siena: con un’esortazione ad alzarsi, il prete guarisce all’istante! Santa Caterina si spegne a Roma nel 1380. I suoi simboli sono il libro e il giglio, ovvero la sapienza e la purezza. Patrona di Siena, del Cif Centro Italiano Femminile e delle Infermiere Volontarie della Croce Rossa Italiana, è protettrice di giovani da marito, studenti, boy scouts, lavandaie, corrieri, ciclisti, sarte, infermieri, malati e degli ospedali.
Autore: Mariella Lentini
Da giovane realizzò il sogno di diventare cavaliere del re, ma non era felice. La croce di San Damiano gli parlò, chiedendogli di ricostruire la Chiesa Francesco decise di servire solo il Signore, scegliendo una vita di penitenza e povertà.
Iniziò a predicare il Vangelo e in molti, affascinati dai suoi modi, lo seguirono.
Nel testo sono evidenziate delle parole. Cercale nella tabella sotto e con le lettere che restano scopri la parola chiave di Francesco.
Soluzione:
Attività 1
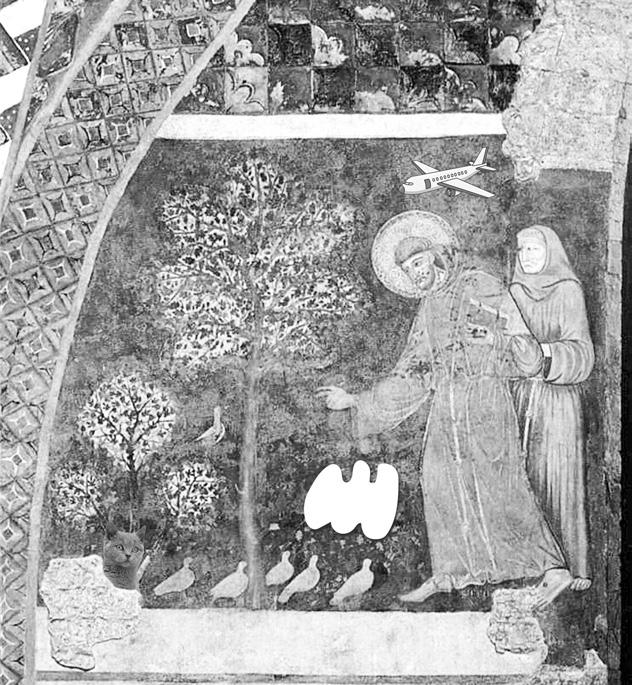
Maestro di San Francesco, San Francesco predica agli uccelli, 1253-60, Basilica di San Francesco, Assisi.
Nell’opera ci sono degli intrusi, cercali e mettici una X sopra.
Attività 2
Nell’opera manca un particolare, sul ramo più vicino a Francesco mancano 3 animali. Quali sono? Disegnali.
Attività 3
Dopo aver ascoltato la storia del santo e/o visto un video a lui dedicato, racconta quale è stato l’episodio che ti ha colpito di più, poi prova a disegnarlo tu.
Il messaggio più importante che ci ha lasciato San Nicola è prendersi cura degli ultimi
Nato nei primi secoli, da giovane divenne vescovo di Mira e contrastò con la fede le persecuzioni contro i cristiani.
Morì a Bari dove il suo corpo è ancora oggi conservato.
Nel testo sono evidenziate delle parole. Cercale nella tabella sotto e con le lettere che restano scopri la parola chiave di Nicola.
Soluzione:
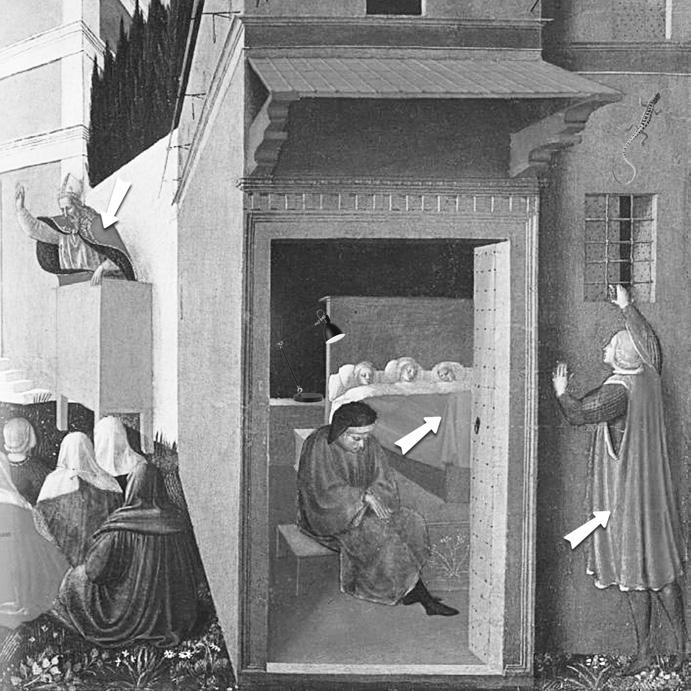
Attività 1
Nell’opera ci sono degli intrusi, cercali e mettici una X sopra.
Attività 2
Nell’opera il mantello di Nicola a sinistra, la coperta dei bambini al centro e la veste di Nicola a destra hanno lo stesso colore, quale? Scoprilo e poi colora anche tu le parti mancanti.
Attività 3
Dopo aver ascoltato la storia del santo e/o visto un video a lui dedicato, racconta quale è stato l’episodio che ti ha colpito di più, poi prova a disegnarlo tu.
Gemma da piccola rimase orfana prima della mamma Aurelia e poi del padre Enrico
Anche lei malata, si dedicò alla lettura della biografia di un santo, Gabriele dell’Addolorata, che, come un angelo custode, le appare e la conforta.
La malattia di Gemma si aggrava, ma lei guarisce miracolosamente. Riceve inoltre la grazia di condividere le sofferenze di Cristo.
Nel testo sono evidenziate delle parole. Cercale nella tabella sotto e con le lettere che restano scopri la parola chiave di Gemma. Soluzione:
Attività 1
Nell’opera ci sono degli intrusi, cercali e mettici una X sopra.
Attività 2
Nell’opera mancano dei particolari, quali sono?
Scoprilo e poi prova tu a disegnarli.
Attività 3
Dopo aver ascoltato la storia del santo e/o visto un video a lui dedicato, racconta quale è stato l’episodio che ti ha colpito di più, poi prova a disegnarlo tu.
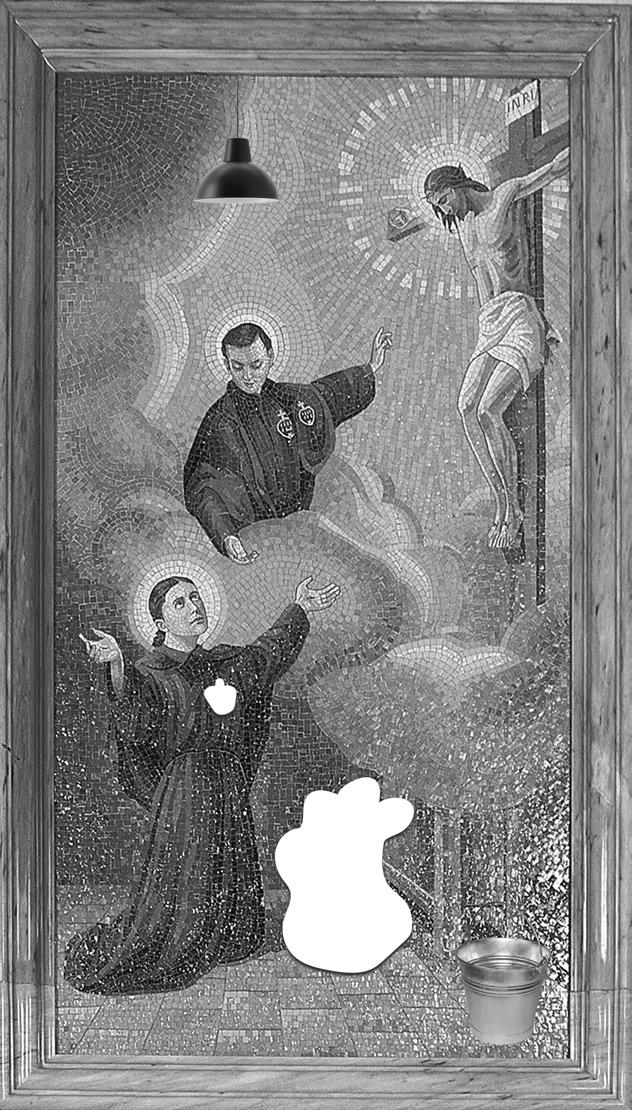
Caterina da piccola non frequentò la scuola, ma imparò a leggere e scrivere in modo autonomo, scrivendo spesso lettere a papi e re. Una volta donna rifiutò il matrimonio per lei combinato, vivendo da sola in una stanzetta, che fu ben presto ritrovo per artisti e intellettuali. Caterina fu poi chiamata a svolgere un’importante missione diplomatica in Francia a favore di papa Gregorio XI, rivestendo un ruolo significativo nella storia della Chiesa
Proclamata patrona d’Italia, Santa Caterina è conosciuta per il suo forte impegno verso la giustizia e la pace.
Nel testo sono evidenziate delle parole. Cercale nella tabella sotto e con le lettere che restano scopri la parola chiave di Caterina.
Soluzione:

Attività 1
Nell’opera ci sono degli intrusi, cercali e mettici una X sopra.
Attività 2
Nell’opera mancano dei particolari, quali sono? Scoprilo e poi prova tu a disegnarli.
Attività 3
Dopo aver ascoltato la storia del santo e/o visto un video a lui dedicato, racconta quale è stato l’episodio che ti ha colpito di più, poi prova a disegnarlo tu.

Programmazione didattica annuale per unità di apprendimento
Periodo: settembre
Traguardi per lo Sviluppo delle Compe T enze o bie TT ivi di a pprendimen T o o bie TT ivi formaT ivi Con T enu T i didaTT i C i
L’alunno
• riflette su Dio Creatore.
I valori etici e religiosi
• Scoprire la bellezza dello stare insieme e sviluppare sentimenti di rispetto e fiducia verso gli altri.
L’alunno partecipa alla discussione del gruppo classe in modo adeguato e pertinente, rispettando il proprio turno di parola.
Periodo: settembre-ottobre-novembre
Traguardi per lo Sviluppo delle Compe T enze o bie TT ivi di a pprendimen T o
L’alunno
• riflette su Dio Creatore del mondo e della vita e Padre di ogni uomo;
• comprende che il mondo è un meraviglioso dono di Dio che merita rispetto;
• sa riconoscere e mettere in pratica atteggiamenti rispettosi di sé, dell’ambiente e degli altri.
Dio e l’uomo
• Comprendere che il creato è un dono di Dio, fatto all’uomo e va custodito.
La Bibbia e le altre fonti
• Ascoltare, leggere e saper riferire circa alcune semplici storie bibliche fondamentali.
I valori etici e religiosi
• Sviluppare atteggiamenti di rispetto verso la natura.
L’alunno
attraverso i testi biblici, trasmette agli uomini messaggi di fondamentale importanza; comprende che il mondo è stato creato da Dio e coglie, attraverso l’esempio di San Francesco, che la natura è un dono prezioso da rispettare.
• Prerequisiti
• Ricordo giocando
• Una gigantesca amicizia
• Insieme è più bello
• Dio Creatore
• Dio Padre
• Ogni cosa ha un nome
• Il diritto di avere un nome
• Dio un grande amico
• Custodi del mondo
• Un’amicizia difficile
• San Francesco d’Assisi
• Il Cantico delle Creature
• La storia di Noè
• Il rispetto verso tutti
Periodo: novembre-dicembre
Traguardi per lo Sviluppo delle Compe T enze
L’alunno
• riconosce e sa spiegare il significato cristiano del Natale.
Programmazione didattica annuale per unità di apprendimento
Il linguaggio religioso
• Riconoscere i segni cristiani del Natale nell’ambiente, nelle celebrazioni e nella tradizione popolare.
• Prendere coscienza del particolare carattere dell’avvento come tempo di attesa e desideri.
• Saper collegare alcuni segni e simboli delle feste che rappresentano.
I valori etici e religiosi
• Riconoscere nella fiducia di Maria un atteggiamento di risposta positiva al progetto di Dio.
L’alunno
comprende che la gioia è l’emozione che caratterizza la festa del Natale; riconosce, attraverso la figura dei magi, che il messaggio di pace che porta da Gesù, arriva a tutti gli angoli della terra.
• Giuseppe prende con sé Maria
• Maria ed Elisabetta
• Il momento dell’attesa
• La corona dell’Avvento
• Il Natale di Gesù
• Una grande gioia
• I fatti del Natale
• Il dono dei magi
Periodo: gennaio-febbraio-marzo
Traguardi per lo Sviluppo delle Compe T enze
L’alunno
• è in grado di riflettere sulla vita e sugli insegnamenti di Gesù e di operare un collegamento con la propria esperienza personale.
La Bibbia e le altre fonti
• Ascoltare, leggere e saper riferire circa alcune semplici storie bibliche e circa gli episodi chiave dei racconti evangelici.
I valori etici e religiosi
• Riconoscere che la morale cristiana si fonda sul comandamento dell’amore di Dio e del prossimo come insegnato da Gesù.
L’alunno
comprende, attraverso i brani evangelici delle parabole, il messaggio che Gesù vuol trasmettere agli uomini; comprende che la regola d’oro è uno dei principi fondanti della religione cristiana.
• Il racconto di una buona notizia
• Gesù e i bambini
• La Palestina
• La vita a Nazaret
• Tutti a tavola
• L’infanzia di Gesù
• Gesù a scuola
• I diritti dei bambini
• Gesù al Tempio
• Il Battesimo di Gesù
• I simboli del Battesimo
• Gli amici di Gesù
• Santa Chiara d’Assisi
• Le parabole di Gesù
• I miracoli di Gesù
• La vita di Gesù
Programmazione didattica annuale per unità di apprendimento
Periodo: marzo-aprile
Traguardi per lo Sviluppo delle Compe T enze o bie TT ivi di a pprendimen T o o bie TT ivi formaT ivi Con T enu T i didaTT i C i
L’alunno
• riconosce e sa spiegare il significato cristiano della Pasqua. Dio e l’uomo
• Conoscere Gesù di Nazareth, Emmanuele e Messia, crocifisso e risorto, e come tale testimoniato dai cristiani.
Il linguaggio religioso
• Scoprire nella Pasqua il centro della fede cristiana.
• Conoscere i principali segni e i simboli pasquali e il loro significato.
L’alunno
attraverso i segni e i significati della Pasqua cristiana, comprende che Gesù ha donato la propria vita per tutti gli uomini.
• La Domenica delle Palme
• L’Ultima Cena di Gesù
• Gesù muore in croce
• La Pasqua di Gesù
• I fatti della Pasqua
Periodo: maggio-giugno
Traguardi per lo Sviluppo delle Compe T enze o bie
L’alunno
• identifica nella Chiesa la comunità di coloro che credono in Gesù Cristo e si impegnano per mettere in pratica il suo insegnamento.
Programmazione didattica annuale per unità di apprendimento
Dio e l’uomo
• Riconoscere la preghiera come dialogo tra l’uomo e Dio.
Il linguaggio religioso
• Individuare i tratti essenziali della Chiesa e della sua missione.
I valori etici e religiosi
• Riconoscere il valore della domenica come giorno sacro per i cristiani.
L’alunno
coglie che vi sono molteplici modi per comunicare con Dio e che il suo Spirito d’Amore è presente nel cuore degli uomini.
• Gesù appare ai discepoli
• Santa Maria Maddalena
• La Pentecoste
• Un fuoco che scalda i cuori
• I simboli dello Spirito Santo
• La nascita della Chiesa
• La Chiesa ieri ed oggi
• In dialogo con Dio
• La preghiera personale
• Il Padre Nostro
• Tutti insieme come fratelli e sorelle
• Preghiere dal mondo
• Luoghi e religioni
• Chiara Lubich, testimone dell’amore

Programmazione didattica annuale per unità di apprendimento
Obiettivi minimi
• Conoscere Gesù come il Salvatore venuto per ristabilire l’amicizia con Dio.
• Conosce il “Padre Nostro “come preghiera data da Gesù.
• Conoscere la Bibbia ci parla dell’amore e dell’amicizia con Dio.
• Mettere a confronto il quotidiano di ogni bambino con quello di Gesù.
• Conoscere gli amici di Gesù.
• Comprendere il significato delle feste natalizie.
• Riconoscere attraverso i simboli, la festa della Pasqua.
• Sperimentare il dono dell’accoglienza e dell’amicizia.
• Riconoscere il sentimento dell’amore e del perdono.
Competenze finali
L’alunno…
• Partendo dal proprio nome e dalla sua identità personale, apprezza l’unicità e la specialità di sé stesso e degli altri e mostra un atteggiamento di accoglienza e rispetto verso tutti.
• Comprende che le tradizioni religiose legate alle feste, rappresentano un momento di condivisione gioiosa e di affermazione dell’appartenenza ad una comunità di credenti.
• Riconosce nella preghiera il desiderio ed il bisogno dell’uomo di entrare in dialogo con il divino, dal quale per i credenti dipende la vita umana e dell’intero universo.
Metodologia
• Lezione interattiva.
• Lavoro individuale.
• Lavoro di gruppo.
• Conversazioni guidate.
Materiali
• Libro di testo.
• Allegati al testo.
• Quaderni.
• Schede e immagini.
• Disegni.
• Materiale audiovisivo.
• Aula.
• Aula informatica.
• Biblioteca.
• LIM.
Discipline coinvolte: Italiano, Arte e immagine, Inglese, Matematica, Musica, Storia
Verifica e valutazione (degli obiettivi e delle competenze)
• Compiti di realtà su obiettivi relativi a uno o più traguardi.
• La prova sarà valutata in base ai livelli definiti dalla rubrica valutativa del curricolo verticale
• Osservazione sistematica dei progressi nel processo di apprendimento.
• Per gli alunni alloglotti, con H, con DSA, con scheda BES, si fa riferimento ai documenti appositamente predisposti.
• La valutazione terrà conto dei livelli di partenza e dei progressi compiuti, nonché dell’impegno e del grado di maturazione.
per unità di apprendimento
Il percorso della classe seconda prosegue il cammino iniziato in prima, ripete e approfondisce le sei unità di apprendimento che affrontano, in ordine, i seguenti argomenti:
1. Si ricomincia, una buona accoglienza e il ripasso dei principali argomenti dell’anno precedente per vivere insieme un nuovo anno;
2. Una grande amicizia, la storia della Creazione e il tema della vita, la custodia del creato e il valore di amicizia che unisce Dio all’uomo.
3. L’attesa di Gesù, il tema della festa, quella più attesa di bambini, che per i cristiani ricorda la nascita di Gesù.
4. Gesù e i suoi amici, le parole e le azioni, parabole e miracoli con la quale Gesù mostra agli uomini e alle donne lo stile di amore con il quale Dio si relaziona con tutti gli uomini, proponendo relazioni fatte di perdono, amicizia, cura, festa;
5. La luce di Pasqua, Gesù dona tutta la sua vita per amore degli uomini, e attraverso la sua risurrezione mette in luce una vita nuova;
6. La Chiesa ieri e oggi, presentata come comunità di credenti in Gesù, una grande famiglia che attraverso atteggiamenti e comportamenti si impegna a seguire e mettere in pratica gli insegnamenti di Gesù stesso.
Competenze in Chiave Europee
• Alfabetica funzionale.
• Personale, sociale e capacità di imparare a imparare.
• Multilinguistica.
• Matematica e competenza in scienze, tecnologia e ingegneria.
• Consapevolezza ed espressione culturali.
• Cittadinanza.
Metodologia, spazi e materiali
• Lezione interattiva.
• Lavoro individuale e di gruppo.
• Conversazioni guidate.
• Libro di testo e allegati.
• Quaderni.
• Schede, disegni e immagini.
• Materiale audiovisivo.
• Aula (classica, LIM, informatica)
Verifica e valutazione
• Compiti di realtà su obiettivi relativi a uno o più traguardi.
• La prova sarà valutata in base ai livelli definiti dalla rubrica valutativa del curricolo verticale.
• Osservazione sistematica dei progressi nel processo di apprendimento.
• Per gli alunni alloglotti, con H, con DSA, con scheda BES, si fa riferimento ai documenti appositamente predisposti.
• La valutazione terrà conto dei livelli di partenza e dei progressi compiuti, nonché dell’impegno e del grado di maturazione.
Saranno coinvolte le seguenti discipline: Educazione Civica, Italiano, Arte e immagine, Inglese, Matematica, Musica, Storia.
Programmazione didattica annuale per unità di apprendimento
Traguardi per lo Sviluppo delle Competenze L’alunno…
• riflette su Dio Creatore del mondo e della vita e Padre di ogni uomo;
• comprende che il mondo è un meraviglioso dono di Dio che merita rispetto;
• sa riconoscere e mettere in pratica atteggiamenti rispettosi di sé, dell’ambiente e degli altri;
• riconosce e sa spiegare il significato cristiano del Natale e della Pasqua;
• è in grado di riflettere sulla vita e sugli insegnamenti di Gesù e di operare un collegamento con la propria esperienza personale;
• identifica nella Chiesa la comunità di coloro che credono in Gesù Cristo e si impegnano per mettere in pratica il suo insegnamento.
Obiettivi di Apprendimento d io e l’uomo l a b ibbia e le alT re fon T i i l linguaggio religio S o i valori e T i C i e religio S i
• Comprendere che il creato è un dono di Dio, fatto all’uomo e va custodito.
• Conoscere Gesù di Nazareth, Emmanuele e Messia, crocifisso e risorto, e come tale testimoniato dai cristiani.
• Riconoscere la preghiera come dialogo tra l’uomo e Dio.
• Ascoltare, leggere e saper riferire circa alcune semplici storie bibliche fondamentali e gli episodi chiave dei racconti evangelici.
• Conoscere l’ambiente di Gesù e il suo tempo.
• Riconoscere i segni cristiani del Natale nell’ambiente, nelle celebrazioni e nella tradizione popolare.
• Prendere coscienza del particolare carattere dell’avvento come tempo di attesa e desideri.
• Saper collegare alcuni segni e simboli delle feste che rappresentano.
• Scoprire nella Pasqua il centro della fede cristiana.
• Conoscere i principali segni e i simboli pasquali e il loro significato.
• Individuare i tratti essenziali della Chiesa e della sua missione.
• Scoprire la bellezza dello stare insieme e sviluppare sentimenti di rispetto e fiducia verso gli altri.
• Sviluppare atteggiamenti di rispetto verso la natura.
• Riconoscere nella fiducia di Maria un atteggiamento di risposta positiva al progetto di Dio.
• Riconoscere che la morale cristiana si fonda sul comandamento dell’amore di Dio e del prossimo come insegnato da Gesù.
• Riconoscere il valore della domenica come giorno sacro per i cristiani.
per unità di apprendimento
• Prerequisiti
• Ricordo giocando
• Una gigantesca amicizia
• Insieme è più bello
• Sono un po' cresciuto
• Il diritto ad avere un nome
• Dio Creatore
• Dio Padre
• Ogni cosa ha un nome
• Il diritto di avere un nome
• Dio un grande amico
• Custodi del mondo
• Un’amicizia difficile
• San Francesco d’Assisi
• Il Cantico delle Creature
• La storia di Noè
• Il rispetto verso tutti
• Giuseppe prende con sé Maria
• Maria ed Elisabetta
• Il momento dell’attesa
• La corona dell’Avvento
• Il Natale di Gesù
• Una grande gioia
• I fatti del Natale
• Il dono dei magi
• Il racconto di una buona notizia
• Gesù e i bambini
• La Palestina
• La vita a Nazaret
• Tutti a tavola
• L’infanzia di Gesù
• Gesù a scuola
• I diritti dei bambini
• Gesù al Tempio
• Il Battesimo di Gesù
• I simboli del Battesimo
• Gli amici di Gesù
• Santa Chiara d’Assisi
• Le parabole di Gesù
• I miracoli di Gesù
• La vita di Gesù
• La Domenica delle Palme
• L’Ultima Cena di Gesù
• Gesù muore in croce
• La Pasqua di Gesù
• I fatti della Pasqua
• Gesù appare ai discepoli
• Santa Maria Maddalena
• La Pentecoste
• Un fuoco che scalda i cuori
• I simboli dello Spirito Santo
• La nascita della Chiesa
• La Chiesa ieri ed oggi
• In dialogo con Dio
• La preghiera personale
• Il Padre Nostro
• Apprezzare il valore dello stare insieme e sviluppare atteggiamenti di collaborazione e solidarietà.
• Conoscere, attraverso i brani della Genesi, la storia della Creazione del mondo.
• Riconoscere che per i cristiani la Creazione è opera di Dio.
• Apprendere che ad ogni uomo e donna è stato affidato il compito di prendersi cura del creato in modo responsabile.
• Conoscere la figura di San Francesco d’Assisi.
• Scoprire che il Dio della Bibbia è un amico fedele sempre pronto a rinnovare la sua amicizia con gli uomini.
• Approfondire gli avvenimenti legati alla nascita di Gesù.
• Conoscere gli eventi più significativi della Pasqua di Gesù, in particolare quelli celebrati durante la Settimana Santa dai cristiani.
• Riconoscere il carattere gioioso della festa pasquale, dato dalla vittoria della vita sulla morte nell’esperienza di Gesù, risorto a “vita nuova”.
• Comprendere che, attraverso la celebrazione della risurrezione di Gesù, ogni domenica per i cristiani è Pasqua.
• Approfondire le conoscenze sull’ambiente in cui Gesù è vissuto attraverso un confronto tra la vita quotidiana nella Palestina di quel tempo ed il vissuto di oggi.
• Conoscere alcuni episodi della vita pubblica di Gesù narrati nei vangeli.
• individuare nelle parabole e nei miracoli la specificità del messaggio d’amore portato da Gesù.
• Conoscere la figura degli apostoli come personaggi legati a Gesù da un legame di amicizia.
• Scoprire come Gesù ha insegnato agli uomini come rivolgersi a Dio, chiamandolo Padre.
• Conoscere la festa di Pentecoste e scoprire le origini della Chiesa, comunità dei credenti in Gesù Cristo, morto e risorto.
• Conoscere la missione della Chiesa oggi, attraverso la sequela agli insegnamenti di Gesù.
L’alunno…
• Assume comportamenti di condivisione e di collaborazione verso gli altri.
• scoprendo la realtà naturale che lo circonda sa manifestare stupore di fronte alle bellezze del mondo.
• riconosce che il creato e la vita, per i cristiani, sono un dono di Dio.
• conosce e sa riferire le principali tappe della storia della Creazione, raccontata nel libro della Genesi.
• sa comprendere il valore dell’amicizia grazie alle figure bibliche di Adamo ed Eva e Noè.
• sa apprezzare la vita e la natura come doni gratuiti, da rispettare e custodire.
• Approfondisce gli episodi principali legati alla nascita di Gesù.
• Comprende il valore religioso della festa dell’Epifania.
• Sa identificare nella festa della Pasqua cristiana la celebrazione della risurrezione di Gesù.
• Comprende il concetto di “vita nuova” legato alla festa di Pasqua.
• Conosce gli episodi evangelici della Passione di Gesù e li sa associare alle celebrazioni cristiane della Settimana Santa.
• Individua nella domenica il giorno più importante per i cristiani.
• Sa associare alla celebrazione eucaristica il ricordo della Pasqua di Gesù.
• Sa descrivere gli aspetti fondamentali della vita familiare, sociale e religiosa dell’ambiente in cui Gesù è vissuto.
• Conosce la missione d’amore di Gesù.
• Comprende e sa riferire gli insegnamenti che Gesù ha trasmesso con le parabole e i miracoli.
• È in grado di attuare e sperimentare nel proprio vissuto comportamenti coerenti al messaggio d’amore cristiano, portato da Gesù.
ALFABETICA FUNZIONALE
PERSONALE, SOCIALE E CAPACITÀ DI IMPARARE A IMPARARE
MULTILINGUISTICA
MATEMATICA E COMPETENZA IN SCIENZE, TECNOLOGIA E INGEGNERIA
CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALI
CITTADINANZA
programmazione didaTTiCa annuale per unità di apprendimento
• Esprimere la propria opinione e riportare un avvenimento;
• ampliare il patrimonio lessicale con l’uso di termini specifici.
• Porre domande pertinenti per conoscere gli altri;
• mostrare interesse nel voler approfondire nuove conoscenze;
• applicare le conoscenze in contesti nuovi.
• Conoscere nuovi termini e vocaboli di lingue differenti.
• Utilizzare il pensiero matematico per risolvere problemi di vita quotidiana.
• Esprimere in modo creativo le emozioni personali attraverso attività pittoriche e manuali;
• provare a leggere un’opera d’arte.
• Rispettare i tempi di parola;
• prestare attenzione alle narrazioni altrui;
• mettere in atto competenze collaborative.
raCCordo diSCiplinare Con: eduCazione CiviCa
L’educazione civica favorisce il riconoscimento di valori e comportamenti coerenti con la Costituzione attraverso il dialogo e il rispetto reciproco, volti a incoraggiare un pensiero critico personale, aperto e costruttivo, in un percorso formativo che, coinvolgendo la persona nella sua interezza e unitarietà.
Nucleo tematico: Costituzione diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà.
Traguardi per il raggiungimento delle competenze 1
• Sviluppare atteggiamenti e adottare comportamenti fondati sul rispetto di ogni persona, sulla responsabilità individuale, sulla legalità, sulla consapevolezza della appartenenza ad una comunità, sulla partecipazione e sulla solidarietà, sostenuti dalla conoscenza della Carta costituzionale, della Carta dei Diritti fondamentali dell’Unione Europea e della Dichiarazione Internazionale dei Diritti umani.
Obiettivi di Apprendimento
• Individuare i diritti e i doveri che interessano la vita quotidiana di tutti i cittadini, anche dei più piccoli. Condividere regole comunemente accettate. Sviluppare la consapevolezza dell’appartenenza ad una comunità locale, nazionale ed europea.
• Rispettare ogni persona, secondo il principio di uguaglianza e di non discriminazione di cui all’articolo 3 della Costituzione. Riconoscere, evitare e contrastare forme di violenza e bullismo presenti nella comunità scolastica.
• Curare gli ambienti, rispettare i beni pubblici e privati così come le forme di vita (piante, animali) che sono state affidate alla responsabilità delle classi.
• Aiutare, singolarmente e in gruppo, coloro che presentino qualche difficoltà per favorire la collaborazione tra pari e l’inclusione di tutti.
Programmazione didattica annuale per unità di apprendimento
Traguardi per il raggiungimento delle competenze 2
• Interagire correttamente con le istituzioni nella vita quotidiana, nella partecipazione e nell’esercizio della cittadinanza attiva, a partire dalla conoscenza dell’organizzazione e delle funzioni dello Stato, dell’Unione europea, degli organismi internazionali, delle Regioni e delle Autonomie locali. Essere consapevoli dell’appartenenza ad una comunità, locale e nazionale.
Obiettivi di Apprendimento
• Conoscere il valore e il significato dell’appartenenza alla comunità nazionale.
• Conoscere il contenuto generale delle Dichiarazioni Internazionali dei diritti della persona e dell’infanzia. Individuare alcuni dei diritti previsti nell’ambito della propria esperienza concreta.
Traguardi per il raggiungimento delle competenze 3
• Rispettare le regole e le norme che governano la democrazia, la convivenza sociale e la vita quotidiana in famiglia, a scuola, nella comunità, al fine di comunicare e rapportarsi correttamente con gli altri, esercitare consapevolmente i propri diritti e doveri per contribuire al bene comune e al rispetto dei diritti delle persone.
Obiettivi di Apprendimento
• Conoscere ed applicare le regole vigenti in classe e nei vari ambienti della scuola (mensa, palestra, laboratori, cortili) e partecipare alla loro eventuale definizione o revisione. Conoscere il principio di uguaglianza nella consapevolezza che le differenze possono rappresentare un valore quando non si trasformano in discriminazioni.
• Conoscere i principali fattori di rischio dell’ambiente scolastico, adottare comportamenti idonei a salvaguardare la salute e la sicurezza proprie e altrui e contribuire a definire comportamenti di prevenzione dei rischi.
• Sviluppare atteggiamenti e comportamenti responsabili volti alla tutela della salute e del benessere psicofisico.
Obiettivi di Apprendimento
• Conoscere e attuare le principali regole per la cura della salute, della sicurezza e del benessere proprio e altrui, a casa, a scuola, nella comunità, dal punto di vista igienico-sanitario, alimentare, motorio, comportamentale.
Programmazione didattica annuale per unità di apprendimento
Nucleo tematico: Sviluppo economico e sostenibilità educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio
Traguardi per il raggiungimento delle competenze 5
• Comprendere l’importanza della crescita economica e del lavoro. Conoscere le cause dello sviluppo economico e sociale in Italia ed in Europa, le diverse attività economiche. Sviluppare atteggiamenti e comportamenti responsabili volti alla tutela dell’ambiente, del decoro urbano, degli ecosistemi e delle risorse naturali per una crescita economica rispettosa dell’ambiente e per la tutela della qualità della vita.
Obiettivi di Apprendimento
• Conoscere le condizioni della crescita economica. Comprenderne l’importanza per il miglioramento della qualità della vita e ai fini della lotta alla povertà. Individuare, con riferimento alla propria esperienza, ruoli, funzioni e aspetti essenziali che riguardano il lavoro delle persone con cui si entra in relazione, nella comunità scolastica e nella vita privata. Riconoscere il valore del lavoro.
• Riconoscere, a partire dagli ecosistemi del proprio territorio, le trasformazioni ambientali ed urbane dovute alle azioni dell’uomo; mettere in atto comportamenti alla propria portata che riducano l’impatto negativo delle attività quotidiane sull’ambiente e sul decoro urbano.
Traguardi per il raggiungimento delle competenze 6
• Comprendere le cause dei cambiamenti climatici, gli effetti sull’ambiente e i rischi legati all’azione dell’uomo sul territorio.
Obiettivi di Apprendimento
• Conoscere ed attuare i comportamenti adeguati a varie condizioni di rischio (sismico, vulcanico, idrogeologico, climatico, …).
• Individuare alcune trasformazioni ambientali e gli effetti del cambiamento climatico.
Traguardi per il raggiungimento delle competenze 7
• Maturare scelte e condotte di tutela dei beni materiali e immateriali.
Obiettivi di Apprendimento
• Identificare nel proprio ambiente di vita gli elementi che costituiscono il patrimonio artistico e culturale, materiale e immateriale, anche con riferimento alle tradizioni locali, ipotizzando semplici azioni per la salvaguardia e la valorizzazione.
• Riconoscere, con riferimento all’esperienza, che alcune risorse naturali (acqua, alimenti…) sono limitate e ipotizzare comportamenti di uso responsabile, mettendo in atto quelli alla propria portata.
Programmazione didattica annuale per unità di apprendimento
Traguardi per il raggiungimento delle competenze 9
• Maturare scelte e condotte di contrasto all’illegalità.
Obiettivi di Apprendimento
• Conoscere le varie forme di criminalità, partendo dal rispetto delle regole che ogni comunità si dà per garantire la convivenza. Conoscere la storia dei vari fenomeni mafiosi, nonché riflettere sulle misure di contrasto. Conoscere il valore della legalità.
Nucleo tematico: Cittadinanza digitale comunicazione virtuale e sviluppo del pensiero critico
Traguardi per il raggiungimento delle competenze 10
• Sviluppare la capacità di accedere alle informazioni, alle fonti, ai contenuti digitali, in modo critico, responsabile e consapevole.
Obiettivi di Apprendimento
• Ricercare in rete semplici informazioni, distinguendo dati veri e falsi.
• Riconoscere semplici fonti di informazioni digitali.
Traguardi per il raggiungimento delle competenze 11
• Interagire con gli altri attraverso le tecnologie digitali consentite, individuando forme di comunicazione adeguate ai diversi contesti di relazione, adottando e rispettando le regole comportamentali proprie di ciascun contesto comunicativo.
Obiettivi di Apprendimento
• Interagire con strumenti di comunicazione digitale, quali tablet e computer.
• Conoscere e applicare semplici regole per l’utilizzo corretto di strumenti di comunicazione digitale, quali tablet e computer.
• Conoscere e applicare le principali regole di partecipazione alle classi virtuali e alle piattaforme didattiche.
Traguardi per il raggiungimento delle competenze 12
• Gestire l'identità digitale e i dati della rete, salvaguardando la propria e altrui sicurezza negli ambienti digitali, evitando minacce per la salute e il benessere fisico e psicologico di sé e degli altri.
Obiettivi di Apprendimento
• Conoscere il significato di identità e di informazioni personali in semplici contesti digitali di uso quotidiano.
• Conoscere i rischi connessi con l’utilizzo degli strumenti digitali in termini di sicurezza personale.
• Riconoscere, evitare e contrastare le varie forme di bullismo e cyberbullismo.
Traguardi per lo Sviluppo delle Competenze L’alunno…
• riflette su Dio Creatore. u ni Ta di apprendimen T
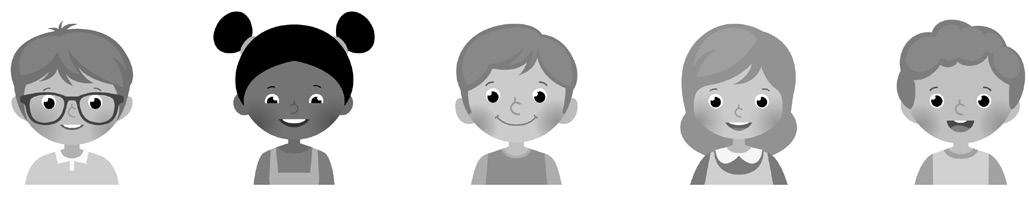
Si ricomincia
• Riepilogo delle attività svolte lo scorso anno.
• Conversazione guidata sugli argomenti del nuovo anno
Da pag. 2 a pag. 5 I valori etici e religiosi
• Scoprire la bellezza dello stare insieme e sviluppare sentimenti di rispetto e fiducia verso gli altri.
I primi giorni di scuola, dopo il RIENTRO DALLE VACANZE, sono molto importanti per aiutare i bambini a RITROVARE IL RITMO DI STUDIO e la GIUSTA ARMONIA all’interno del gruppo classe.
Oltre ai racconti delle proprie vacanze, con i quali si farà attenzione a descrivere i luoghi e le bellezze visitate, l’insegnante proporrà un riepilogo degli argomenti trattati lo scorso anno, soprattutto in forma ludica, e presenterà gli argomenti che saranno affrontati in questo nuovo percorso.
Dedichiamo le prime lezioni del nuovo anno scolastico a raccogliere notizie sulle vacanze appena trascorse. Invitiamo gli alunni a raccontare le proprie vacanze e successivamente ad ascoltare il racconto seguente.
C’era una volta una bambina che sapeva suonare molto bene il pianoforte e realizzare bellissimi vestitini per le sue bambole. Quando però la maestra le diceva di scrivere una storia, cominciavano le difficoltà. Il foglio bianco la spaventava e le storie rimanevano racchiuse nella sua testa. Il primo giorno di scuola, l’insegnante chiese agli alunni di raccontare il più bel giorno delle loro vacanze. La bambina lo ricordava bene. Era stata una giornata al mare, piena di sole con un fresco venticello. Al mattino presto era salita con il suo papà su una barca di pescatori e aveva visto tanti pesci d’argento nuotare tra le onde. La sera, al ritorno, si era seduta con i genitori sulla piazza del paese e aveva mangiato un grosso cono di gelato. Il cielo era rosso per il tramonto e i gabbiani volavano, stridendo, sulla spiaggia. Il ricordo di quella giornata era ancora vivo e nitido nella sua mente, ma non riusciva a descriverlo né con le parole, né con la penna. Allora prese le matite colorate e cominciò a disegnare. Disegnò il sole e la spiaggia, le barche e il mare e la bella serata d’estate piena di luci e colori. Quando ebbe terminato mostrò il suo disegno ai compagni e alla maestra: «Guardate – esclamò – questa è la mia giornata indimenticabile delle vacanze.».
RIFLETTIAMO
• È capitato anche a te di non riuscire a trovare le parole giuste per descrivere le cose belle che hai visto e vissuto durante le vacanze?
• Quali emozioni hai provato?
• A che cosa e a chi ti hanno fatto pensare?
Facciamo poi realizzare agli alunni una CARTOLINA DELLE VACANZE con questa consegna: invia ai tuoi amici una cartolina che descrive un momento bello delle tue vacanze.
Io sono stato qui!
Proiettiamo alla LIM la mappa dell’Italia (Google Maps o Google Earth) e chiediamo, a turno, che tutti gli alunni e le alunne vengano alla cattedra e cerchino nella mappa - se serve con il nostro aiuto - una località nella quale sono stati in vacanza questa estate. Facciamo raccontare di che posto si tratta, cosa ha di bello da vedere e fare e se si sono divertiti, se hanno fatto nuove esperienze e conoscenze. Salviamo la località tra i “preferiti” per avere alla fine una visione globale d’insieme di tutti i punti di interesse nei quali è stata la classe.
Dopo la lettura della storia, possiamo far ascoltare e ripetere una delle seguenti filastrocche.
Il giorno dell’inizio è già arrivato e indossi il grembiulino di bucato.
I bimbi hanno cestini o zainetti.
E dentro tu lo sai cosa ci metti; la gomma, le matite colorate, le forbici con le punte arrotondate.
In classe la lavagna trovi pure e i cartelloni pieni di figure.
Si ritaglia, si incolla, si colora, così si cambia gioco ad ogni ora.
E che divertimento la lettura, che gusto con i conti e la scrittura!
Quante scoperte splendide da fare, quante storie stupende da ascoltare!
E poi è bello stare in compagnia di amici vecchi e nuovi, in allegria.
Con loro parli, ridi e canti in coro.
Allora buona scuola… e buon lavoro!
Il giorno dell’inizio è già arrivato
Ho aperto il quaderno nuovo sul banco, il primo foglio è così bianco, quasi splende, tanto è pulito ed ho paura a posarvi il dito.
Intingo la penna, trattengo il fiato e, curvo sul foglio immacolato, scrivo con cura la prima parola di questo primo giorno di scuola.
Domani, forse dopo, chissà, sul foglio bianco una macchia cadrà... Ma non perderò per questo il coraggio; un colpo di gomma e avanti in viaggio!
Vivian Lamarque Gianni Rodari
Colora e completa con i dati richiesti.

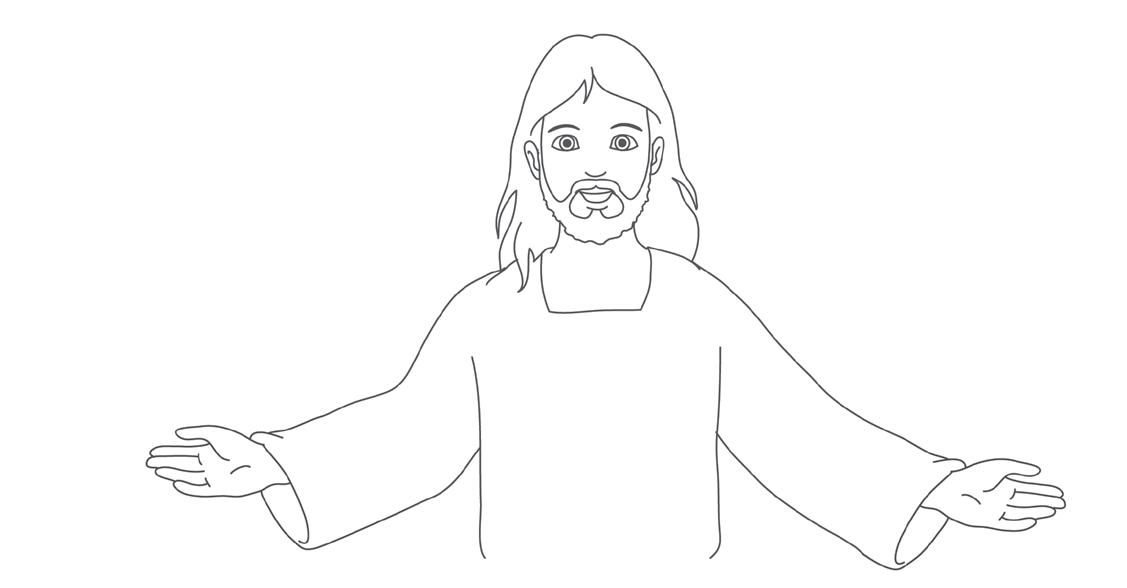
Traguardi per lo Sviluppo delle Competenze L’alunno…
• riflette su Dio Creatore del mondo e della vita e Padre di ogni uomo;
• comprende che il mondo è un meraviglioso dono di Dio che merita rispetto;
• sa riconoscere e mettere in pratica atteggiamenti rispettosi di sé, dell’ambiente e degli altri.

u ni Ta di apprendimen T o p er la p rogrammazione S e TT imanale r iferimen T i al T e ST o o bie TT ivi di apprendimen T o
Una amicizia grande
• La storia della Creazione narrata nella Bibbia.
• Il valore del rispetto e la cura del creato.
• San Francesco d’Assisi.
Da pag. 6 a pag. 27 Dio e l’uomo
• Comprendere che il creato è un dono di Dio, fatto all’uomo, e va custodito.
La Bibbia e le altre fonti
• Ascoltare, leggere e saper riferire circa alcune semplici storie bibliche fondamentali.
I valori etici e religiosi
• Sviluppare atteggiamenti di rispetto verso la natura.
In questa prima parte, l’insegnante approfondirà il tema della Creazione, rileggendo la storia biblica del libro della Genesi, ponendo l’accento sulla concezione cristiana che tutto è un dono gratuito di Dio, soffermandosi, giorno dopo giorno, nell’opera divina e suddividendo il percorso in vari momenti:
• Lo stupore e la meraviglia verso le cose create da Dio;
• Il concetto di Dio creatore;
• Il compito degli uomini di prendersi cura del creato, ruolo di responsabilità.
• La presenza nel mondo del male, gli ostacoli e le difficoltà nel mantenere fede al patto di alleanza fatto tra Dio e l’uomo, e tra gli uomini stessi.
• Il concetto di un Dio amico dell’uomo, che non lo abbandona nemmeno dopo averlo tradito.
Gli alunni saranno poi accompagnati a un’attenta riflessione sulle responsabilità che l’uomo ha nei confronti del creato, e sugli atteggiamenti che lui ha verso la natura. Prendendo spunto dai vari testi magisteriali, l’insegnante (in realtà è compito della scuola tutta) avrà la possibilità di formare nei più piccoli una rinnovata coscienza e sensibilità verso il rispetto della terra e la custodia del creato.
La civiltà attuale, distratta e frenetica non comprende più il linguaggio della natura. La creazione è un libro pieno di messaggi per chi sa vivere a sensi aperti e per i cristiani è addirittura una delle vie per giungere a Dio. Mettiamolo in evidenza attraverso un racconto contenitore che offre spunti di narrazione interna.
La classe seconda B partì per la passeggiata con il consueto travolgente entusiasmo. Evelina, la maestra, si affannava per quattro a tenere insieme la numerosa combriccola. Era una gita breve, appena fuori città, un ultimo straccetto di vacanza nell’inizio dell’anno scolastico. La meta erano i boschi tra il grande fiume e l’antico castello. Una cosa da poco, ma c’è pur sempre una bella differenza tra
correre nei boschi e stare zitti e buoni in un’aula scolastica. I bambini erano tutti felici e scatenati. Veramente, non tutti... Gianluca, il primo della classe, quello che sapeva tutto sui computer, trotterellava dietro al gruppo senza dimostrare una gioia eccessiva.
Gianluca non era un ragazzo cattivo, anzi. Era dolce e gentile, ma era abituato a viaggiare in lungo e in largo per il mondo con i suoi genitori, possedeva tutti i documentari in CD del National Geographic e i più bei videogame della Mattel. Per finire era una specie di enciclopedia ambulante. «Ma che c’è da vedere in un bosco?» si chiedeva tra sé, mentre i compagni si rincorrevano. «Perché poi? Per andare dove?». Un ciuffo di fragoline, rosse e minuscole, strappò strilli di gioia alle bambine. «Al supermercato sono grosse dieci volte di più e costano pochissimo» pensò Gianluca. Un piccolo torrente dall’acqua limpida moltiplicò l’attività e gli schiamazzi dei bambini. Gianluca si mise a far merenda. Aveva visto il Rio delle Amazzoni, lui. Aveva un grosso «Tutto qui?» stampato in faccia. Serena, la bambina più sensibile della classe, gli si avvicinò. «Non ti piace?», gli chiese con una nota di simpatia nella voce. «È tutto così bello. Le foglie, i ranocchi, i ricci con le castagne…».
Avrebbe voluto parlare a Gianluca di tante altre sensazioni, ma non trovava le parole adatte. Parlargli dell’albero grande dal tronco liscio, delle nuvole, dell’acqua, dei trilli degli usignoli, del profumo del muschio... «Io lo trovo proprio bello», pensava Serena. «Stupendissimo…». Gianluca scrollò le spalle ed estrasse dalla tasca un giochino elettronico che portava sempre con sé. La maestra aveva visto l’indifferenza di
Gianluca e aveva anche sentito le parole di Serena. Ad un certo punto batté le mani e chiamò i bambini. Accaldati e stremati dalle corse, si accoccolarono volentieri attorno alla maestra. Come tanti pulcini intorno alla chioccia. «Una storia, per piacere...» supplicò uno.
«Sì, sì…» fecero eco gli altri.
«D’accordo!» disse la maestra. «È la storia di un grande principe che viveva... vediamo un po’... in Giappone!». Senza volerlo guardò Gianluca, che ascoltava attento, perché le storie della maestra piacevano anche a lui.
RIFLETTIAMO
• Chi sono i personaggi della storia?
• Qual è la meta della gita?
• Perché Gianluca sembra annoiato?
• Cosa fa Serena?
• Qual è la reazione di Gianluca?
• Cosa fa la maestra?
L’insegnante leggerà ai bambini il brano tratto da Genesi 1-2 riguardante la creazione del mondo.
In principio Dio creò il cielo e la terra. Ora la terra era informe e deserta e le tenebre ricoprivano l’abisso e lo spirito di Dio aleggiava sulle acque. Dio disse: «Sia la luce!». E la luce fu. Dio vide che la luce era cosa buona e separò la luce dalle tenebre e chiamò la luce giorno e le tenebre notte. E fu sera e fu mattina: primo giorno.
Dio disse: «Sia il firmamento in mezzo alle acque per separare le acque dalle acque». Dio fece il firmamento e separò le acque, che sono sotto il firmamento, dalle acque, che son sopra il firmamento. E così avvenne. Dio chiamò il firmamento cielo. E fu sera e fu mattina: secondo giorno. Dio disse: «Le acque che sono sotto il cielo, si raccolgano in un solo luogo e appaia l’asciutto».
E così avvenne. Dio chiamò l’asciutto terra e la massa delle acque mare. E Dio vide che era cosa buona. E Dio disse: «La terra produca germogli, erbe che producono seme e alberi da frutto, che facciano sulla terra frutto con il seme, ciascuno secondo la sua specie». E così avvenne: la terra produsse germogli, erbe che producono seme, ciascuna secondo la propria specie e alberi che fanno ciascuno frutto con il seme, secondo la propria specie. Dio vide che era cosa buona. E fu sera e fu mattina: terzo giorno. Dio disse: «Ci siano luci nel firmamento del cielo, per distinguere il giorno dalla notte; servano da segni per le stagioni, per i giorni e per gli anni e servano da luci nel firmamento del cielo per illuminare la terra».
E così avvenne: Dio fece le due luci grandi, la luce maggiore per regolare il giorno e la luce minore per regolare la notte, e le stelle. Dio le pose nel firmamento del cielo per illuminare la terra e per regolare giorno e notte e per separare la luce dalle tenebre. E Dio vide che era cosa buona. E fu sera e fu mattina: quarto giorno. Dio disse: «Le acque brulichino di esseri viventi e uccelli volino sopra la terra, davanti al firmamento del cielo». Dio creò i grandi mostri marini e tutti gli esseri viventi che guizzano e brulicano nelle acque, secondo la loro specie, e tutti gli uccelli alati secondo la loro specie. E Dio vide che era cosa buona. Dio li benedisse: «Siate fecondi e moltiplicatevi e riempite le acque dei mari; gli uccelli si moltiplichino sulla terra». E fu sera e fu mattina: quinto giorno. Dio disse: «La terra produca esseri viventi secondo la loro specie: bestiame, rettili e bestie selvatiche secondo la loro specie».
E così avvenne: Dio fece le bestie selvatiche secondo la loro specie e il bestiame secondo la propria specie e tutti i rettili del suolo secondo la loro specie. E Dio vide che era cosa buona.
E Dio disse: «Facciamo l’uomo a nostra immagine, a nostra somiglianza, e domini sui pesci del mare e sugli uccelli del cielo, sul bestiame, su tutte le bestie selvatiche e su tutti i rettili che strisciano sulla terra».
Dio creò l’uomo a sua immagine; a immagine di Dio lo creò; maschio e femmina li creò. Dio li benedisse e disse loro: «Siate fecondi e moltiplicatevi, riempite la terra; soggiogatela e dominate sui pesci del mare e sugli uccelli del cielo e su ogni essere vivente, che striscia sulla terra». Poi Dio disse: «Ecco, io vi do ogni erba che produce seme e che è su tutta la terra e ogni albero in cui è il frutto, che produce seme: saranno il vostro cibo. A tutte le bestie selvatiche, a tutti gli uccelli del cielo e a tutti gli esseri che strisciano sulla terra e nei quali è alito di
vita, io do in cibo ogni erba verde».
E così avvenne. Dio vide quanto aveva fatto, ed ecco, era cosa molto buona. E fu sera e fu mattina: sesto giorno. Così furono portati a compimento il cielo e la terra e tutte le loro schiere. Allora Dio, nel settimo giorno portò a termine il lavoro che aveva fatto e cessò nel settimo giorno da ogni suo lavoro. Dio benedisse il settimo giorno e lo consacrò, perché in esso aveva cessato da ogni lavoro che egli creando aveva fatto. Queste le origini del cielo e della terra, quando vennero creati.
A seguire l’insegnante può leggere ai bambini la STORIA DI MAGO MERLINO per stimolare una piccola conversazione e aiutare i bambini ad affrontare il tema della disobbedienza e del peccato. Avviamo il dialogo prendendo spunto dalle piccole proibizioni che ci sono a scuola o in famiglia per FAR RIFLETTERE GLI ALUNNI
SUI PRINCIPI CHE DEVONO REGOLARE I RAPPORTI .
La mancata osservanza di questi diventa un piccolo peccato, cioè una piccola macchia che sporca il legame tra le persone e fra l’uomo e Dio.
Nella storia seguente, che parla di un vecchietto e di una vecchietta, che hanno rifiutato delle regole fissate dal Mago Merlino, gli alunni scopriranno delle analogie con Adamo ed Eva, i quali disobbedendo a Dio hanno perduto la loro libertà e il segreto della felicità. Mago Merlino però, così come fa Dio, non si vendica anzi, invita al pentimento ed è sempre disposto al perdono.
C’erano una volta un vecchio e una vecchia. Il vecchio aveva un galletto, la vecchia aveva una pollastrella. Ora, un bel giorno che razzolavano nell’aia, il galletto e la pollastrella trovarono una fava ed un fagiolo. Il vecchio prese il fagiolo e la fava e li gettò sotto la panca, vicino la tavola.
Ma ecco che il fagiolo e la fava germogliarono subito: tirarono fuori le radici, un fusticino robusto e cominciarono a crescere. In un momento arrivarono alla panca.
«Che si fa?», chiese il vecchio.
«Taglia la panca!», disse la vecchia.
E il vecchio segò la panca.
Il fagiolo e la fava continuarono a crescere. Crebbero tanto che arrivarono all’altezza del tavolo. «Che si fa?», chiese il vecchio.
«Taglia la tavola!», disse la vecchia.
E il vecchio segò la tavola.
Il fagiolo e la fava crebbero ancora. Arrivarono al soffitto.
«Che si fa?», chiese il vecchio. «Fa’ un buco nel soffitto!», disse la vecchia.
E il vecchio fece un buco nel soffitto.
Così il fagiolo e la fava continuarono a crescere. Arrivarono al tetto.
«Che si fa?», chiese il vecchio.
«Fa un buco nel tetto!», disse la vecchia. E il vecchio fece un buco nel tetto.
Ma il fagiolo e la fava non cessarono di crescere. Salivano e salivano verso il cielo.
Finché, tac!, toccarono il cielo.
«Hai visto?», disse il vecchio. «Sono arrivati fino in cielo!».
«E allora - disse la vecchia - perché non ci andiamo anche noi?».
«E come?», domandò il vecchio.
«Basta arrampicarsi su per le piante», disse la vecchia.
E il vecchio e la vecchia cominciarono ad arrampicarsi: la vecchia sulla fava, e il vecchio sul fagiolo. Salirono e salirono.
«Siamo quasi arrivati?», domandava il vecchio.
«Non ancora», rispondeva la vecchia.
«È alto!». Ma finalmente giunsero al termine della loro fatica.
Erano arrivati in cima alle piante del fagiolo e della fava. Erano entrati in cielo.
C’erano un bel giardino e una casetta. «È la casa del Mago Merlino» disse la vecchia. Timidamente, bussarono alla porta della casa.
«Entrate!», disse una voce. Il Mago Merlino era là.
«Ci permetti di dormire qui? - domandò la vecchia - Siamo così stanchi...».
«Certo, potete dormire qui - disse il Mago Merlino - ma non toccate le mie focaccine».
«Te lo promettiamo.» dissero il vecchio e la vecchia, e andarono a dormire. Ma, nel cuore della notte, la vecchia si svegliò. «Hanno veramente un buon profumo, le focaccine del Mago Merlino...» disse. «Mi piacerebbe tanto assaggiarle».
C’erano un bel giardino e una casetta. «È la casa del Mago Merlino» disse la vecchia. Timidamente, bussarono alla porta della casa.
«Entrate!», disse una voce. Il Mago Merlino era là.
«Ci permetti di dormire qui? - domandò la vecchia - Siamo così stanchi...».
«Certo, potete dormire qui - disse il Mago Merlino - ma non toccate le mie focaccine».
«Te lo promettiamo.» dissero il vecchio e la vecchia, e andarono a dormire. Ma, nel cuore della notte, la vecchia si svegliò. «Hanno veramente un buon profumo, le focaccine del Mago Merlino...» disse. «Mi piacerebbe tanto assaggiarle». «Non le dobbiamo toccare! - disse il vecchio - Il Mago Merlino potrebbe arrabbiarsi». La vecchia obbedì e si riaddormentò.
Ma poco dopo si risvegliò di nuovo e disse al vecchio: «Non ce la faccio più: devo assaggiare le focaccine. Oh, ma solo un bocconcino!». Appena ebbe allungato la mano verso le focaccine, il piatto si spezzò, le focaccine ridivennero pasta e cominciarono a colare dappertutto. Il vecchio e la vecchia cercarono di rimettere la pasta nel piatto, di rifare le focaccine, ma pur lavorando tutta la notte non riuscirono a combinare niente. Al mattino, il gallo cantò.
E di colpo il piatto ridivenne intero e le focaccine si riformarono come prima. Il Mago Merlino si avvicinò e domandò: «Avete dormito bene?».
«Certo, grazie...» risposero i due vecchi.
«Non avete per caso toccato le mie focaccine?».
«Oh no!» risposero il vecchio e la vecchia.
Allora il Mago Merlino si arrabbiò e li mandò via dal cielo.
Il giorno dopo, il vecchio e la vecchia si arrampicarono di nuovo lungo il fagiolo e la fava e tornarono nel magico giardino del Mago Merlino che stava sulle nuvole.
«Ci permetti di dormire da te?» chiese la vecchia al buon mago.
«Potete restare nel giardino» accondiscese il buon Mago. «Mangiate tutto quello che volete, ma non toccate le mie mele!».
«Te lo promettiamo!» dissero il vecchio e la vecchia.
E cominciarono a passeggiare nel bellissimo giardino. Quando cadde la notte si addormentarono sull’erba soffice. Ma ad un certo punto la vecchia si svegliò.
«Sono così belle le mele del Mago Merlino. Vorrei tanto assaggiarne una...».
«Non dobbiamo toccarle. Il Mago potrebbe arrabbiarsi» disse il vecchio. Ma, poco dopo, la vecchia colse una mela dall’albero e in quel preciso istante tutte le mele dell’albero piombarono a terra e si misero a rotolare in tutti gli angoli del giardino.
Spaventati, il vecchio e la vecchia non sapevano che fare. Il vecchio strappò qualche capello alla vecchia e cercò invano di riannodare le mele al ramo. Ma le mele pesavano troppo e ricadevano a terra. Al mattino, il gallo cantò. In quel medesimo istante tutte le mele ripresero il loro posto sull’albero.
Il Mago Merlino si avvicinò e domandò: «Non avete mica toccato le mie mele?». «Oh no!» Risposero il vecchio e la vecchia. Il Mago si arrabbiò e li cacciò dal cielo.
Il terzo giorno, per la terza volta, il vecchio e la vecchia si arrampicarono sul fagiolo e sulla fava e arrivarono in cielo, alla magica dimora di Mago Merlino. «Ci permetti di dormire da te?”, domandò la vecchia. «Andate pure nella mia rimessa - rispose il buon Mago - ma non toccate la mia carrozza».
«Te lo promettiamo!» dissero il vecchio e la vecchia. Essi si istallarono confortevolmente nella grande rimessa.
Durante la notte la vecchia si svegliò e disse al vecchio: «Mi piacerebbe tanto fare un giretto per il cielo con la carrozza del Mago Merlino!».
«Non dobbiamo toccarla, - disse il vecchio - lo sai bene».
Ma la vecchia era testarda. Salì sulla carrozza e in quel momento le ruote caddero a pezzettini. Il vecchio e la vecchia si affannarono invano a cercare di ripararle. Al mattino il gallo cantò. In quell’istante, le ruote ripresero il loro posto, integre come fossero nuove.
Per la terza volta, il buon Mago Merlino si avvicinò e domandò: «Non avete mica toccato la mia carrozza?».
«Oh no!» risposero il vecchio e la vecchia, mentendo per la terza volta.
Allora il Mago Merlino si arrabbiò e li cacciò via dal suo giardino sulle nuvole per l’ultima volta… Rapidi, rapidi, il vecchio e la vecchia scivolarono lungo il fagiolo e la fava.
Ma questa volta non erano ancora arrivati a terra che le due piante si ruppero e il vecchio e la vecchia piombarono al suolo.
Da quel momento rimasero a casa loro, con il loro galletto e la loro pollastrella.
RIFLETTIAMO
• Dove sarebbero adesso il vecchio e la vecchia se avessero ascoltato le parole del Mago Merlino?
• Perché sono stati cacciati via?
• Hai trovato nella storia delle somiglianze con il racconto del peccato originale?
• In particolar modo, dove?
«Forse seminare non è un lavoro da principi, ma è sempre meglio che combattere contro della gente inerme». Il popolo rimase stupefatto alla vista del principe che lavorava nei giardini del palazzo.
Giorno dopo giorno, egli continuò a coltivare le sue piante, senza curarsi del caldo o del gelo.
Poi, un mattino, arrivò all’improvviso la primavera. Il giardino traboccava di fiori e di profumi; le api ronzavano e gli uccellini cinguettavano, la gente per strada sorrideva al sole. Ma dov’era il principe?
Aveva lavorato tanto per creare quel giardino, perché dunque non veniva a goderselo insieme alla sua gente? Il principe si era appartato, stringendo in mano un ramoscello in fiore.
Mentre lo guardava, grosse lacrime gli rigavano il volto, perché non riusciva a capire come mai la primavera rendesse sempre tutti così felici. Tutti meno lui.
Non lo aveva mai capito, ma quest’anno era diverso: aveva lavorato sodo per creare un bel giardino e voleva proprio conoscere il segreto di quella felicità. Poi, come in un sussurro, gli sembrò di udire la voce soave della ragazzina.
Lo esortava a guardare, a guardare con il cuore i fiori e l’erba, gli uccelli e il cielo, gli insetti affaccendati e la gente ridente. E tutt’a un tratto il principe li vide come non li aveva mai visti prima. Una gioia immensa gli colmò il cuore e vide i colori brillare al sole e sentì il profumo inebriante dei fiori. Per la prima volta si sentì veramente felice e si accorse di amare il suo popolo.
Un attimo di silenzio profondo aleggiò sulla fine della storia. «Domani a scuola parleremo di questa storia - disse la maestra - Ora, raccogliete le vostre cose e torniamo in città. E buttate la cartaccia nei cestini…». Dopo un po’ tutto il gruppo era sulla via del ritorno.
«Una bella passeggiata, vero Serena?», disse la maestra, quando si trovò accanto la bambina. «Pensa a tutte quelle persone che non possono muoversi o non possono vedere. Potessimo dare loro qualche pezzo di noi!».
«Io - mormorò Serena - Vorrei lasciare i miei occhi a Gianluca».
Al termine del racconto l’insegnante chiederà agli alunni di elencare le cose meravigliose che i bambini del racconto hanno visto nel tragitto tra casa e scuola, ciò che hanno sentito, che cosa hanno toccato, cosa hanno odorato e ciò che hanno gustato.
Infine sottolineerà tutto quello che invece non hanno saputo vedere o sentire.
L’insegnante leggerà un brano tratto da “PINOCCHIO” per introdurre il concetto della DISOBBEDIENZA. Dopo aver letto il brano, gli alunni dovranno disegnare sul proprio quaderno una scena del racconto.
C’era una volta... Geppetto, un falegname che non aveva figli e così costruì un burattino e lo chiamò
Pinocchio. Quando si accorse che parlava e pensava come un bambino, lo amò come un figlio. Geppetto felice gli comprò l’abbecedario e lo mandò a scuola.
Ma Pinocchio non ne aveva alcuna voglia, vendette il libro e comprò il biglietto per lo spettacolo dei burattini.
Tutti i burattini erano contenti di conoscere Pinocchio e gli fecero una grande festa, ma il burattinaio Mangiafuoco si arrabbiò per il gran chiasso e catturò lo sfortunato.
Sentita poi la sua triste storia si impietosì, gli regalò quattro monete d’oro e lo rimandò dal padre.
L’insegnante leggerà alla classe la FAVOLA DI “CAPPUCCETTO ROSSO”, ponendo l’attenzione sul momento in cui la bambina, pur messa in guardia dalla mamma sui pericoli del bosco, trasgredisce l’ordine ed entra proprio nel luogo vietato. È opportuno sottolineare particolarmente le CONSEGUENZE DELLE AZIONI
C’era una volta una bambina che viveva con la mamma in una casetta al margine del bosco: questa bambina si chiamava Cappuccetto Rosso perché la mamma le aveva fatto una mantellina con un cappuccio rosso, che la bambina portava sempre perché le piaceva molto.
Cappuccetto Rosso aveva una nonna, molto vecchia, che abitava in una casetta al di là del bosco e che un giorno si ammalò. La mamma pensò di mandare Cappuccetto Rosso a portarle delle focaccine, un po’ di burro e della marmellata. Prima di partire, la bambina promise alla mamma di non entrare nel bosco per
nessun motivo, di non parlare con nessuno e di camminare dritta verso la casa della nonna.
Cappuccetto Rosso uscì di casa e si avviò ma, per fare prima entrò nel bosco si lasciò distrarre dai fiori, dagli animaletti e si fermò a giocare.
Il lupo, che abitava nel bosco, vide la bambina e si mise a chiacchierare con lei amabilmente. Venne così a sapere dove stava andando e le consigliò la strada più lunga, in modo da poter arrivare per primo a casa della nonna. Quando arrivò, si fece aprire la porta facendo una vocina come quella di Cappuccetto Rosso, entrò, si mangiò la nonna in un boccone e si mise a letto, sotto le coperte, ad aspettare la bambina per mangiare anche lei.
Cappuccetto Rosso arrivò, guardò quella che credeva essere la nonna e disse: «Nonnina, che occhi grandi hai!» e il lupo «È per guardarti meglio» - «E che orecchie grandi hai!» - «È per sentirti meglio» - «E che bocca grande hai!» - «È per mangiarti meglio!!!» e il lupo saltò fuori dal letto e se la mangiò.
Un cacciatore, che passava lì vicino, sentì le grida di Cappuccetto Rosso, corse dentro la casetta, vide il lupo che dormiva profondamente con la pancia gonfia e gliela tagliò con un coltello. Cappuccetto Rosso e la nonna saltarono fuori, facendo grandi feste al coraggioso cacciatore.
Gli uomini si moltiplicarono sulla terra ma il male era entrato nel mondo e tutti diventavano ogni giorno sempre più cattivi. Il Signore Dio vide che la malvagità degli uomini era grande e si addolorò in cuor suo. Così disse: «Manderò sulla terra un diluvio di pioggia che cancellerà tutte queste cattiverie e tutte queste malvagità!».
Diversamente da tutti gli altri uomini, però, un vecchio di nome Noè era buono e si comportava come piace a Dio. Egli aveva tre figli: Sem, Cam e Iafet.
Dio parlò quindi a Noè e gli disse: «Ho deciso di eliminare tutte le cattiverie che sono sulla terra! Manderò perciò un diluvio di pioggia che distruggerà tutto ciò che esiste nel mondo. Salverò però te e la tua famiglia, poiché sei un uomo buono. Costruisciti perciò un’arca, essa ti servirà per salvarti dal diluvio di pioggia che sto per mandare. Oltre ai tuoi familiari, vi farai entrare anche una coppia per ogni animale, un maschio e una femmina perché voglio salvare la vita di
tutti gli animali del mondo».
Noè fece tutto ciò che Dio gli aveva comandato. Costruì una grande arca a tre piani, lunga centocinquanta metri e, finiti i lavori, vi entrò con i figli Sem, Cam e Iafet, con sua moglie, le mogli dei suoi figli e con tutte le coppie di animali che esistono nel mondo. Dopo sette giorni che Noè fu entrato nell’arca, sulla terra cadde tantissima pioggia per quaranta giorni e quaranta notti. L’acqua sulla terra aumentava sempre più fino a che l’arca cominciò a galleggiare.
Con il passare del tempo, le acque continuarono sempre a crescere e coprirono addirittura tutte le montagne. Si salvarono solamente Noè, i suoi parenti e gli animali che erano con lui nell’arca. Poi le acque cominciarono ad abbassarsi e l’arca si posò sopra i monti di un posto chiamato Ararat. Allora Noè aprì la finestra dell’arca e fece uscire un corvo. Il corvo volò via ma poi tornò indietro perché le acque erano ancora alte e non aveva trovato un luogo asciutto dove posarsi.
Dopo qualche giorno, allora, Noè fece uscire una colomba, ma anch’essa fece come il corvo. Aspettò ancora una settimana e mandò di nuovo la colomba fuori dall’arca ed ecco, verso sera, essa tornò da lui con nel becco una tenera foglia di ulivo. Noè capì che le acque erano ormai completamente sparite dalla terra e aspettò ancora un’altra settimana. Lasciò di nuovo andare la colomba e questa non tornò più da lui poiché la terra era completamente asciutta ed essa aveva trovato un posto dove posarsi.
Allora Dio disse a Noè: «Uscite tutti dall’arca, uomini e animali, e moltiplicatevi su tutta la terra. Ecco, io mi impegno a non mandare più le acque del diluvio. Il mio arco sulle nubi, l’arcobaleno, vi ricorderà questa mia promessa».
L’oggetto magico
L’insegnante proporrà un gioco per il quale, se non si seguono le regole, gli alunni saranno eliminati (ad esempio giocando a palla avvelenata).
A conclusione del gioco discuterà con gli alunni sulle conseguenze derivanti dal non rispetto delle regole circa le relazioni tra i giocatori e il funzionamento del gioco stesso.
Dopo la lettura della storia, possiamo far ascoltare e ripetere una delle seguenti filastrocche.
Se a scuola vuoi venire e grande diventare le regole devi imparare. Non è difficile sai: se ascoltare saprai grande diventerai.
La prima regola dice che: non si litiga coi compagni che cresceranno insieme a te.
La seconda è quella che: ascoltare la maestra tu dovrai per non sbagliare mai.
Le altre verranno pian piano perché la scuola ti porterà per mano. Nel tempo capirle tu dovrai perché un domani adulto diverrai.
Se ami la natura raccogli la spazzatura. Poi aiuta a differenziare, così si può riciclare. Schiaccia la bottiglia e vedrai che meraviglia: un’altalena colorata si fa con plastica riciclata.
Metti il vasetto nel suo cassonetto: con il vetro riciclato un bottiglione verrà creato. La carta, bianca, gialla o rosa, è una cosa assai preziosa: un vecchio foglio scarabocchiato diventerà un nuovo libro illustrato!
P. Dessanti
Colora l’arca di Noè, poi ripassa e colora le gocce di pioggia, disegnandone anche altre tu.
Ascolta dall’insegnante il racconto della creazione. Colora i disegni e scrivi sotto ad ognuno il giorno corrispondente.
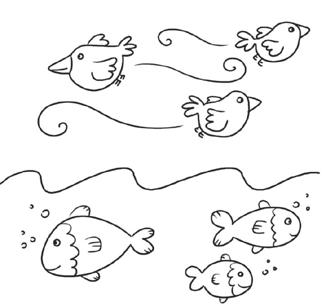
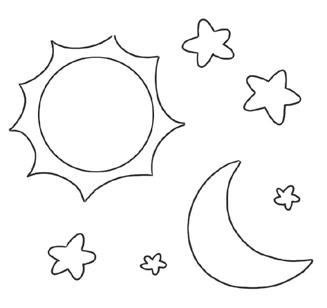

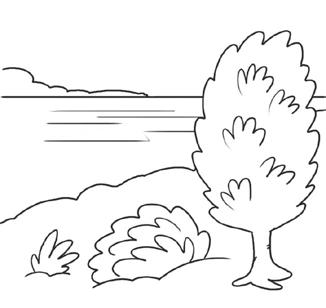



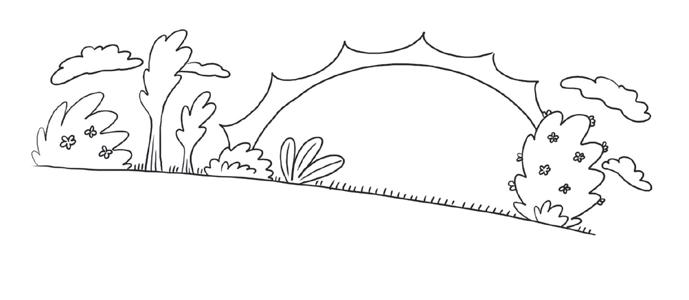
Il mondo in cui viviamo ultimamente è un po’ malandato. Stiamo rovinando il posto meraviglioso che Dio ci ha dato per vivere. Vogliamo provare a cambiarlo?
Disegna nei riquadri vuoti il mondo come Dio lo ha creato e scrivi nei puntini i rimedi per ciascuna situazione.
Abbiamo abbattuto le foreste.
Abbiamo avvelenato i fiumi e i mari.
Abbiamo riempito l’aria di fumi velenosi.
Abbiamo anche rovinato il clima.
L’insegnante proporrà alla classe di completare il disegno con un giardino attuale,

Dopo la lettura della favola disegna negli spazi i 4 momenti più significativi del racconto.
Traguardi per lo Sviluppo delle Competenze L’alunno…
• riconosce il significato cristiano del Natale.

u ni Ta di apprendimen T o p er la p rogrammazione S e TT imanale r iferimen T i al T e ST o o bie TT ivi di apprendimen T o
L’attesa di Gesù
• Il valore dell’attesa: i cristiani e l’avvento.
• La storia della nascita di Gesù:
• Maria e l’annunciazione;
• Da Nazaret a Betlemme;
• L’annuncio ai pastori;
• La visita dei magi.
Da pag. 28 a pag. 41 Il linguaggio religioso
• Riconoscere i segni cristiani del Natale nell’ambiente, nelle celebrazioni e nella tradizione popolare.
• Prendere coscienza del particolare carattere dell’avvento come tempo di attesa e desideri.
• Saper collegare alcuni segni e simboli delle feste che rappresentano.
I valori etici e religiosi
• Riconoscere nella fiducia di Maria un atteggiamento di risposta positiva al progetto di Dio.
Dopo la storia della Creazione e il peccato di Adamo ed Eva, Dio, da buon amico, non lascia soli gli uomini e, dopo aver ristabilito il suo patto di alleanza per mezzo di Noè, promette agli uomini la venuta del Messia, il figlio di Dio.
Infatti, nella seconda parte, gli alunni verranno accompagnati nella MAGICA ATMOSFERA DEL NATALE: le strade illuminate, le vetrine decorate, le varie tradizioni che rivivono nelle case dei cristiani con la preparazione del presepe e dell’albero. Questo conto alla rovescia viene presentato in maniera approfondita con il tema dell’AVVENTO, ovvero il momento dell’attesa, che i cristiani vivono e sentono in modo particolare, perché precede la NASCITA DEL MESSIA atteso, promesso da Dio e annunciato dai profeti.
In questo percorso di attesa della festa, sarà importante far riflettere gli alunni sul vero VALORE E SIGNIFICATO DEL NATALE, che, purtroppo, nella società del nostro tempo, spesso rischia di essere solo un momento dedicato al consumismo. Il Natale è un momento di festa che porta con sé un messaggio ben preciso per i cristiani: Dio si fa uomo e per mezzo di Gesù, fratello di tutti, porta nel mondo l’amore di Dio.
L’insegnante leggerà i seguenti testi, successivamente i bambini coloreranno i 4 angioletti del colore appropriato.
Gli angeli dell’Avvento sono quattro, proprio come le quattro settimane che preparano al Natale. Vengono in visita sulla Terra, indossando abiti di un colore diverso, ciascuno dei quali rappresenta una particolare qualità. L’angelo blu. Durante la prima settimana un grande angelo discende dal cielo per invitare gli uomini a prepararsi per il Natale. È vestito con un grande mantello blu, intessuto di silenzio e di pace. Il blu del suo mantello rappresenta appunto il silenzio e il raccoglimento. L’angelo rosso. Durante la seconda settimana un angelo con il mantello rosso scende dal cielo, portando con la mano sinistra un cesto vuoto. Il cesto è intessuto di raggi di sole e può contenere soltanto ciò che è leggero e delicato. L’angelo rosso passa su tutte le case e cerca, guarda nel cuore di tutti gli
uomini, per vedere se trova un po’ d’amore… Se lo trova, lo prende e lo mette nel cesto e lo porta in alto, in cielo. E lassù, le anime di tutti quelli che sono sepolti in Terra e tutti gli angeli prendono questo amore e ne fanno luce per le stelle. Il rosso del suo mantello rappresenta l’amore.
L’angelo bianco. Nella terza settimana un angelo bianco e luminoso discende sulla terra. Tiene nella mano destra un raggio di sole. Va verso gli uomini che conservano in cuore l’amore e li tocca con il suo raggio di luce. Essi si sentono felici perché nell’inverno freddo e buio, sono rischiarati ed illuminati. Il sole brilla nei loro occhi, avvolge le loro mani, i loro piedi e tutto il corpo. Anche i più poveri e gli umili sono così trasformati ed assomigliano agli angeli, perché hanno l’amore nel cuore. Soltanto coloro che hanno l’amore nel cuore possono vedere l’angelo bianco… Il bianco rappresenta il simbolo della luce e brilla nel cuore di chi crede. L’angelo viola. Nella quarta e ultima settimana di Avvento, appare in cielo un angelo con il mantello viola. L’angelo viola passa su tutta la Terra tenendo con il braccio sinistro una cetra d’oro. Manca poco all’arrivo del Signore. Il colore viola è formato dall’unione del blu e del rosso, quindi il suo mantello rappresenta l’amore vero, quello profondo, che nasce quando si sta in silenzio e si ascolta la voce del Signore dentro di noi.
Era una fredda mattina di novembre di fine Ottocento e il piccolo Gerhard continuava a torturare la mamma chiedendole quando esattamente sarebbe arrivato Natale. Era un bambino ancora troppo piccino per avere il senso della matematica e del tempo che passava e così ogni mattina la mamma si trovava a spiegargli e rispiegargli quanto tempo ancora ci voleva prima dell’arrivo del tanto atteso Babbo Natale.
Gerhard annuiva serio, e sembrava aver capito, ma il giorno dopo ricominciava con la solita domanda: «Mamma, quanti giorni mancano ancora per Natale?». Finché un giorno, esattamente il primo dicembre, la mamma ebbe una di quelle idee geniali da super mamme.
Chiamò il piccolo Gerhard e gli disse: «Ho preparato per te 24 biscotti speziati, uno per ogni giorno dell’Avvento. Potrai mangiarne uno ogni mattino e quando i biscotti saranno finiti, allora vorrà dire che è arrivato Natale». Effettivamente
si trattava di una genialata e Gerhard crebbe sereno e contento sgranocchiando i suoi biscotti dell’Avvento e aspettando Natale. Passarono tanti anni e Gerhard era ormai diventato un panciuto e rispettabile uomo d’affari con un debole per i biscotti speziati.
Un giorno passando davanti a una vetrina addobbata con le decorazioni natalizie si ricordò di quando era piccolo e aspettava con ansia Natale mangiando i biscotti preparati con amore da sua madre e pensò: “Sono sicuro di non essere stato il solo bambino a torturare la propria mamma ogni giorno per sapere quando esattamente arrivava Natale. L’idea della mia mamma piacerebbe a tantissime altre mamme … Ho deciso! Fabbricherò dei calendari dell’Avvento con 24 finestrelle per tutti i bambini!”.
E fu così, che nel dicembre del 1920 nacque il primo calendario dell’Avvento, che naturalmente piacque a mamme, papà e bambini ed ebbe subito un enorme successo, prima in Germania, poi in Svezia e poi piano, piano nel resto d’Europa. Sembra una storia inventata, eppure è avvenuto tutto proprio come ve l’ho raccontato. Anche il piccolo Gerhard è esistito veramente e il suo nome completo era Gerhard Lang.
Jan-Öjvind Swan
Si propone la storia del presepe di Greccio per presentare ai bambini il principale segno del Natale. Il seguente testo tratto da La storia del presepe di A. Tarzia, oltre ad offrire notizie riguardanti l’origine del presepe vivente, potrebbe essere utilizzato sia come approfondimento per l’insegnante, sia come lettura in classe da far fare ai bambini.
Leggiamo nelle cronache del tempo che Francesco, qualche tempo prima di intonare il suo Cantico delle creature, inventò a Greccio, vicino Rieti, il primo presepe. Un giorno un nobiluomo di nome Giovanni, incontrando Francesco, gli chiese che cosa doveva fare per seguire le vie del Signore. Francesco gli disse di prepararsi e preparare il Natale. Allora quel tale fece costruire una stalla, vi fece portare del fieno e condurre un bove e un asino. Poi arrivò dicembre. La notte di Natale del 1223 molti pastori e contadini, artigiani e povera gente si avviarono verso la grotta che Giovanni da Greccio aveva preparato per Francesco. Alcuni
avevano portato doni per farne omaggio al bambino e dividerli con i più poveri. Francesco disse di voler celebrare un rito nuovo, più intenso e partecipato e per questo aveva chiesto il permesso al Papa. Invitò un sacerdote, che su un altare improvvisato, celebrò la Messa.
Francesco, attorniato dai suoi frati, cantò il Vangelo. Mentre faceva questo, egli stava davanti alla mangiatoia ricolmo di pietà, cosparso di lacrime, ma traboccante di gioia. Dopo il canto del Vangelo disse: «Fratelli, questa è la festa delle feste. Oggi Dio si fa piccolo infante e prende il latte dalla mamma».
La commozione era tale che Francesco si sentiva egli stesso un bambino e cominciò a balbettare, come fanno appunto i bambini.
Allora si vide dentro la mangiatoia un bellissimo bambino addormentato che, il beato Francesco, stringendo con ambedue le braccia, sembrava destare dal sonno. Fra i testimoni del miracolo molti erano personaggi degni di fede e questo contribuì a divulgare la notizia in tutto il Lazio, l’Umbria e la Toscana fino a Genova e a Napoli: ovunque ci fosse un convento e ovunque si festeggiasse il Natale.
Da quel miracolo molti trassero benefici spirituali e corporali: alcuni si convertirono e diventarono più buoni, altri presero il fieno della mangiatoia di Greccio e lo usarono come medicina contro i malanni degli uomini e delle bestie, una donna travagliata da un parto difficile, trovò forza e pace, nacque felicemente un bambino e fu festa per tutta la casa. Tutto il paese sapeva di questi prodigi e teneva memoria di quella notte santa, quando un Bambino era apparso a Francesco, che aveva voluto ricostruire l’ambiente del primo Natale in un bosco dell’Appennino.
A. Tarzia

Per condurre gli alunni a cogliere il SIGNIFICATO DEL NATALE, dobbiamo partire dalle loro conoscenze pregresse. I bambini hanno già alcune idee della FESTA DI GESÙ, e noi abbiamo il compito di rilevarle per progettare il nostro intervento.
Facciamo una piccola inchiesta per conoscere che cosa essi sanno e che cosa si ricordano di Gesù e della sua nascita.
• Stiamo avvicinandoci al Natale, ma che cos’è?
• Perché facciamo festa?
• Come festeggiamo?
• Sapete dove è nato Gesù?
• Perché volle nascere in tanta povertà?
• Chi per primi si recarono alla grotta ad adorare Gesù?
• Chi diede loro il lieto annuncio?
• Chi è Gesù per i cristiani?
• Le buone azioni si debbono compiere solo a Natale?
Uniti in attesa
Costruiamo insieme il CALENDARIO DELL’AVVENTO da appendere in classe.
L’insegnante preparerà un albero di cartoncino verde abbastanza grande da appendere, dove i bambini andranno ad attaccare (a seconda del numero degli alunni della classe), il loro cerchio di cartoncino colorato con sopra il numero del giorno.
L’insegnante preparerà 25 cerchi che i bambini dovranno colorare e ritagliare ed incollare all’albero.
• cartoncino verde
• cartoncino bristol bianco
• pennarelli
• forbici
• colla
Realizziamo insieme ai bambini due lavoretti di Natale, il primo da donare ai familiari, il secondo per addobbare la propria aula.
Gesù Bambino… al freddo e al gelo!
REALIZZAZIONE
Fissare con della colla Gesù Bambino al coperchio del barattolo, lasciare asciugare per qualche ora.
3 2 4
Versare nel contenitore un bicchiere scarso di acqua e il polistirolo (o perline).
Avvitare il tappo con la statuina attaccata, capovolgere il barattolo.
Agitare il tutto: ecco Gesù Bambino al freddo e al gelo!
• Un barattolo di vetro con il tappo a vite (ad esempio di marmellata)
• Piccolo Gesù Bambino i plastica
• Colla a caldo
• Perline piccole bianche o polistirolo sbriciolato
Il presepe nell’albero
REALIZZAZIONE
Ritagliare le fotocopie (Gesù Bambino, Maria e Giuseppe, i re Magi e i pastori).
Incollare i disegni ritagliati e colorati dentro i piatti.
Attaccare i piatti sul cartoncino disponendoli a forma di albero di Natale secondo il seguente ordine: per primo Gesù Bambino, sotto Maria e Giuseppe, nella terza fila i re Magi ed infine i pastori.
Ritagliare e colorare la stella cometa e gli angeli.
Incollare la stella cometa in cima e gli angeli attorno ai piatti disposti ad albero.
OCCORRENTE
• Piatti di plastica
• Un cartoncino bristol di grande dimensione
• Fotocopia della scheda n° 11
• Colori a pastello e a spirito
• Colla
• Forbici
• Brillantini
Scatoline variopinte
Si disegna su di un cartoncino una mini scatola da appendere come addobbo all’Albero di Natale.
Dopo aver colorato ogni parete della scatola con un colore diverso si ritaglia la sagoma. Successivamente si ripiegano le pareti e le linguette che andranno poi incollate per ottenere la forma finale. Con del nastro colorato, infine, si legherà la scatola in modo da poterla appendere all’Albero di Natale.
Dopo la lettura della storia, possiamo far ascoltare e ripetere una delle seguenti filastrocche.
La notte di Natale, è nato un bel bambino, bianco, rosso e tutto ricciolino.
La neve cadeva. Cadeva giù dal cielo, Maria col suo velo copriva Gesù.
Maria lavava, Giuseppe stendeva il Bimbo piangeva dal freddo che aveva. «Sta’ zitto mio figlio che adesso ti piglio, del latte ti do; ma pane non ho!».
La neve cadeva, cadeva giù dal cielo, Maria col suo velo copriva Gesù!
Un dono speciale
Quest’anno Natale mi ha fatto un bel dono, un dono speciale. Mi ha dato allegria, canzoni cantate in gran compagnia. Mi ha dato pensieri, parole, sorrisi di amici sinceri.
Dei vecchi regali non voglio più niente.
A ogni Natale io voglio la gente.
Roberto Piumini
Son piccolino chi non lo sa?
«Son birichino» dice papà.
Signori miei ma dentro, qui, c’è un amore grande, grande così, che ama tutti e per tutti prega.
E per Natale così dico:
«Piccolo Amore, Bambino Gesù, grazie e bontà donami tu.
Porta la gioia alla mammina, sempre al mio cuore tienila vicina; e sulla strada del mio papà getta tesori in quantità.
Poi fammi crescere come vuoi tu, Piccolo Amore, Bambino Gesù».
Come ogni anno arriva Natale, e un grande abete voglio addobbare.
Basta palline e nastri lucenti, facciamo un albero di sentimenti.
Delle grandi strisce di tranquillità, che abbraccino l’intera umanità.
Sfere luminose piene di speranza che spandano in giro la tolleranza.
Infine una stella non può mancare, perché nessuno stia più male.
Giochiamo insieme con il dado dell’Avvento: colora e componi il cubo poi, lanciandolo con i compagni, spiega chi sono i personaggi che compaiono di volta in volta.
Completa la poesia colorando le immagini e trascrivendo le relative parole ad essa mancanti. Impara a memoria.
Mentre il , piano piano dietro ai tramontava, nella terra di Betlemme un evento s’annunciava...
Una passeggiava or vicina ed or lontana.
Che voleva? Dove andava, quella stella lunga e strana?
Un bell’ dall’ali grandi e aperte allor comparve
disse: «È notte di Natale. e nato!» e poi scomparve.
«Gesù è nato! Osanna! Osanna!» col suo ........................ ogni pastore corre verso la , inneggiando al Redentore.
Pieni i cuori di letizia. Alle genti più lontane, corre, vola la notizia tra un frastuono di campane !
Tutti vedon la , così fulgida e splendente!
«Essa c’indica una meta!» lieta mor mora la gente.
Nato, sì ! Ma senza nulla, senza fasce poverino.
Senza maglia, senza culla, con la per lettino!
Il Bambino è poverello. Per scaldarlo non c’è ........................!
Solo un bue, un asinello ed il della sua mamma.
Ma quel Bimbo è il Redentore e la ........................, da lassù, fa che tutti, al suo chiarore, giunger possano a ........................!
Colora e realizza i personaggi per il tuo presepe a dita.
Le parole dei profeti si avverano. Maria si prepara ad attendere la nascita di Gesù, il Salvatore del mondo.
Riproduci e ingrandisci la scena dell’Annunciazione. Colora.

Colora la cornice e leggi la preghiera.
Ave, o Maria, piena di grazia il Signore è con te tu sei benedetta tra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
Santa Maria, madre di Dio prega per noi peccatori adesso, e nell’ora della nostra morte, Amen
Colora con i pastelli, poi incolla le illustrazioni della scheda 4 per completare l’albero dell’avvento.
Un angelo mandato dal Signore avvertì i pastori della nascita di Gesù ed essi accorsero in fretta alla grotta dove trovarono un bambino che giaceva in una mangiatoia.
Disegna tra le mani dei pastori i doni che essi portarono a Gesù.
Riordina le immagini che si riferiscono alla nascita di Gesù: dall’annunciazione all’arrivo dei Magi. Poi colorale e scrivi sotto ad ognuna a quale episodio del Vangelo si riferiscono.



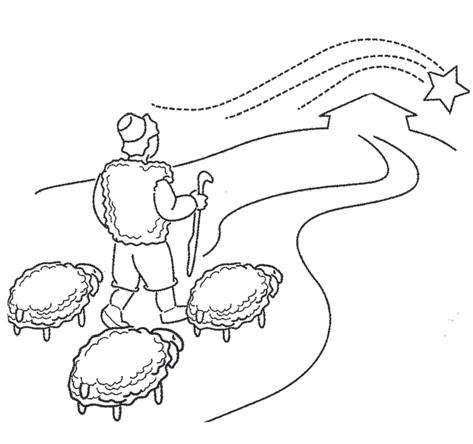
Colora i personaggi e ritagliali per costruire il tuo presepe in classe.
L’insegnante proporrà un gioco: cercare le differenze tra 2 disegni che, apparentemente identici, rappresentano una scena tipica del Natale (i disegni si differenziano di 6 particolari).
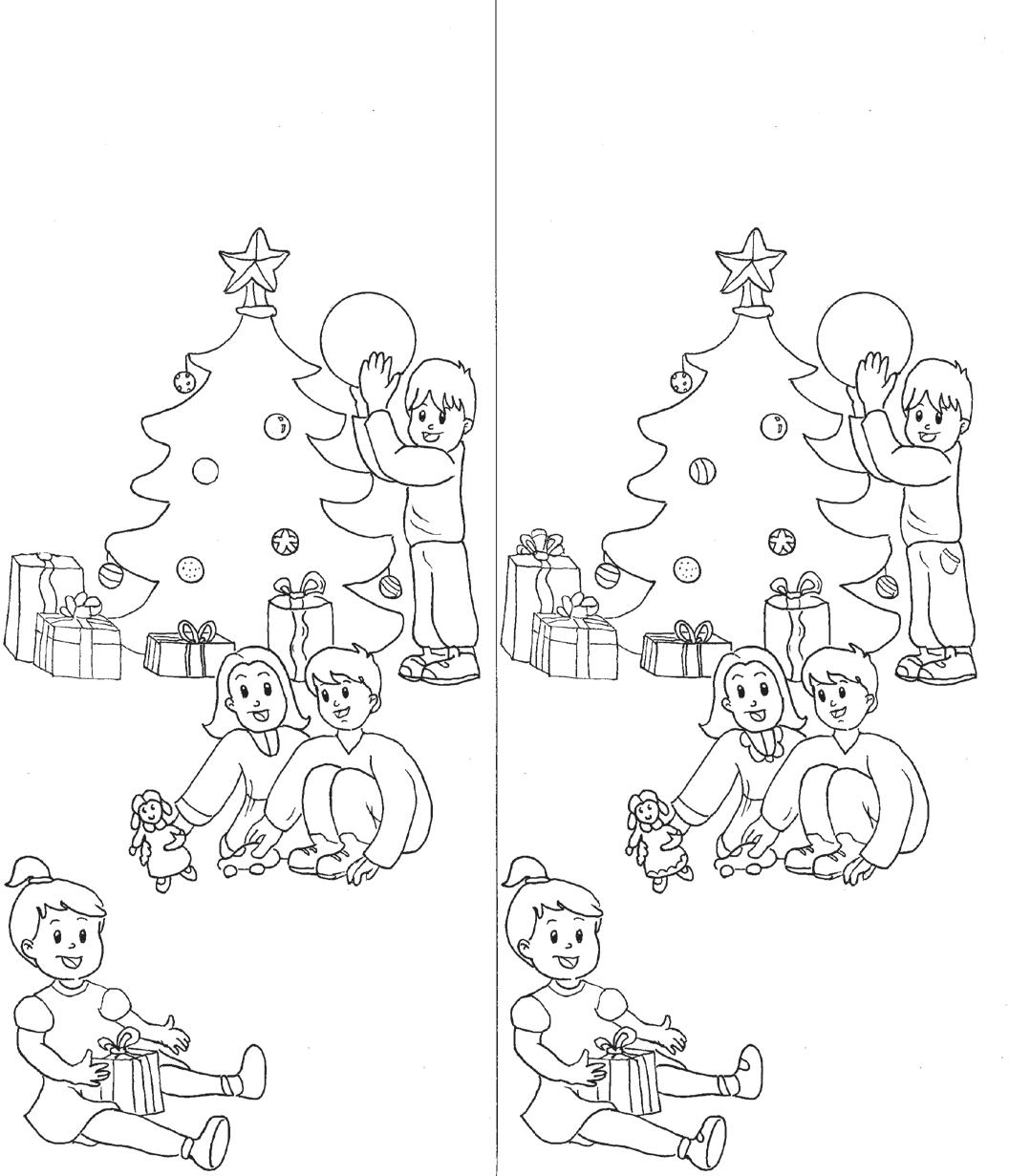
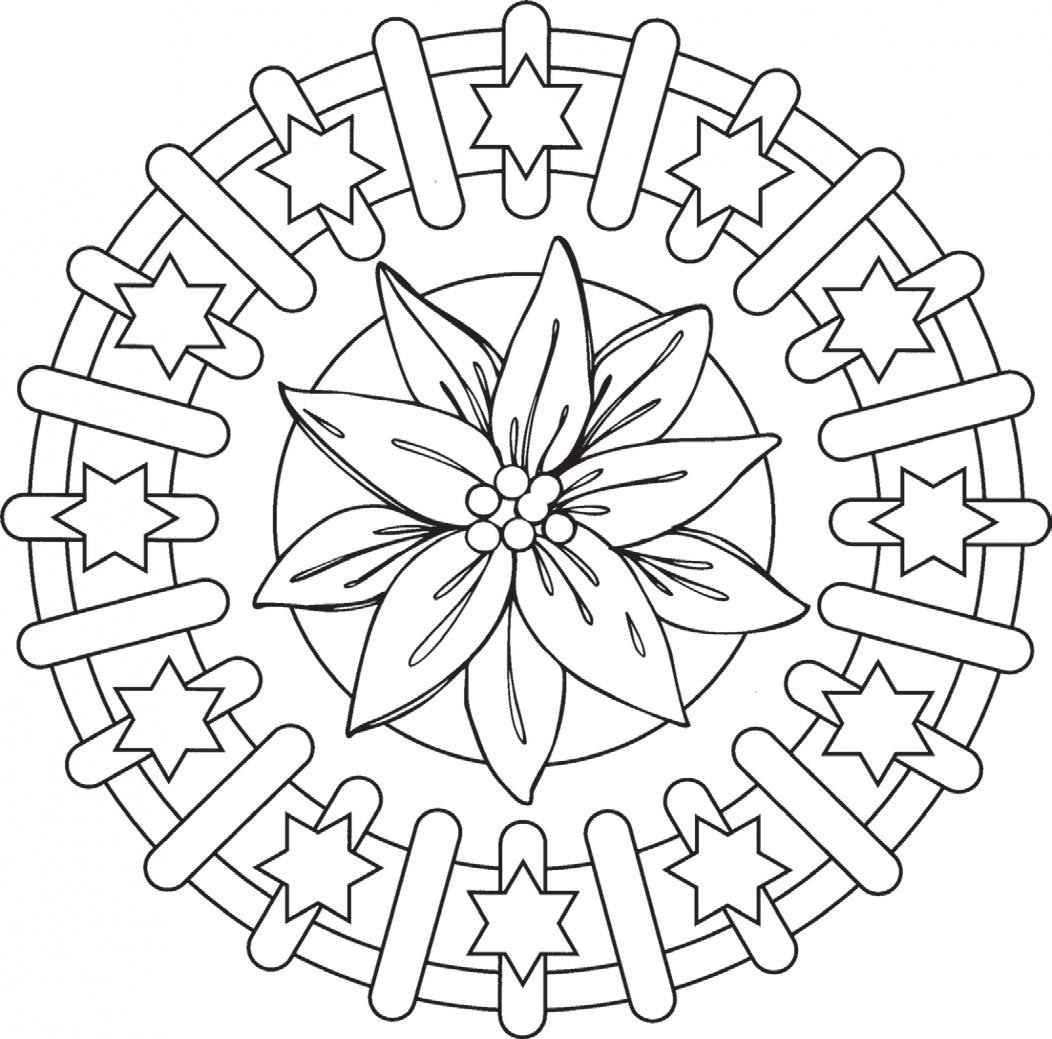
Traguardi per lo Sviluppo delle Competenze L’alunno…
• è in grado di riflettere sulla vita e sugli insegnamenti di Gesù e di operare un collegamento con la propria esperienza personale.
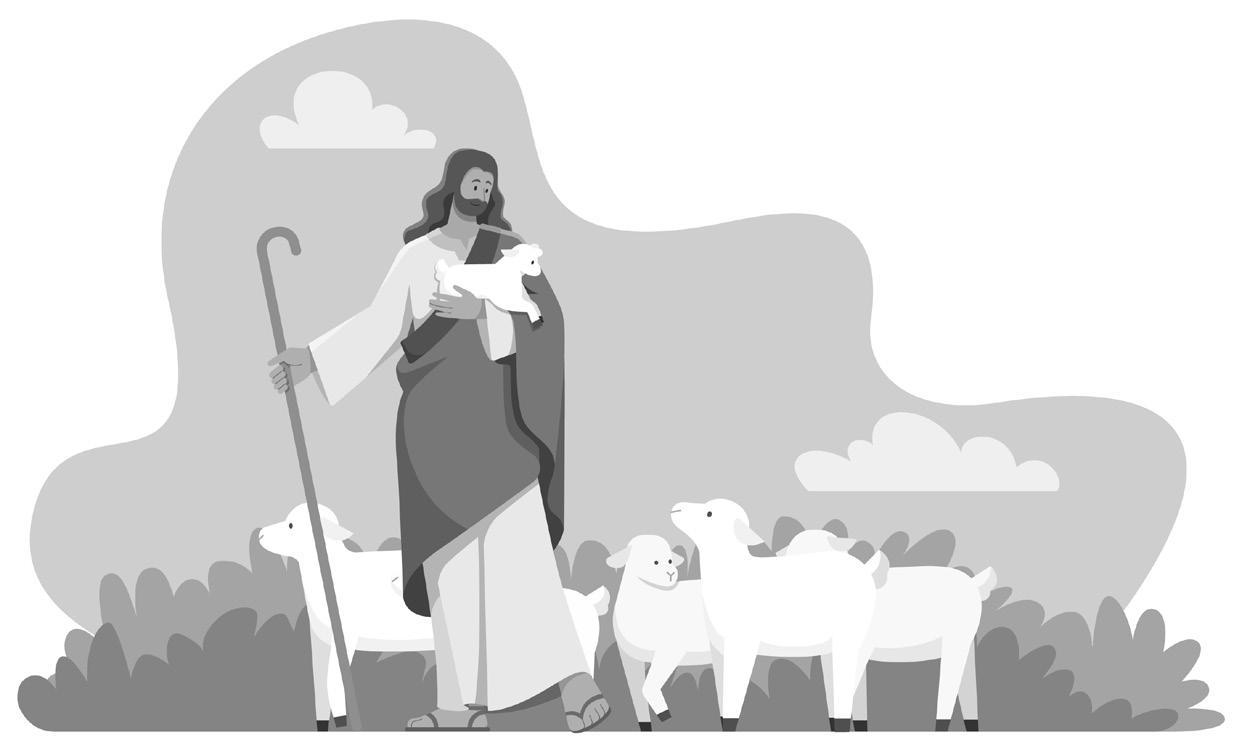
Gesù e i suoi amici
• L’infanzia di Gesù:
• a scuola in Sinagoga;
• nel Tempio tra i maestri.
• Il battesimo di Gesù e il battesimo cristiano oggi.
• Gli amici di Gesù: gli apostoli.
• Il Vangelo, la buona notizia.
• Parabole e miracoli di Gesù.
Da pag. 42 a pag. 69 La Bibbia e le altre fonti
• Ascoltare, leggere e saper riferire circa alcune semplici storie bibliche.
• Conoscere l’ambiente di Gesù e il suo tempo.
I valori etici e religiosi
• Riconoscere i fondamenti della morale cristiana.
LA PAROLA AMORE NON È FACILE DA SPIEGARE , quello che possiamo fare è aiutare gli alunni a comprenderne il vero significato attraverso il MESSAGGIO DI GESÙ, che possiamo sintetizzare con una frase: «Come il Padre ha amato me, anche io ho amato voi. Rimanete nel mio amore.»
Durante la sua vita pubblica, Gesù ha attraversato tutta la Palestina, annunciando a tutti la buona novella. Tanta gente gli andava incontro con curiosità o lo aspettava solo per vederlo.
Gesù non escludeva nessuno, aveva parole e sguardi per tutti, soprattutto per gli ultimi ed esclusi dalla società, ma non faceva differenza tra ebrei e stranieri, giusti e peccatori, ricchi e poveri, farisei e pubblicani, gente colta e poveri ignoranti, uomini e donne, vecchi e bambini (per la quale mostra una speciale predilezione come dimostra il racconto evangelico di Marco 10,13-16).
LA MISSIONE
CON
E
IL GRANDE AMORE DI DIO per gli uomini, rivelando che Dio considera gli uomini come figli e li ama tutti allo stesso modo. Gesù infatti ha insegnato a chiamare Dio con il nome di Padre (Abbà).
In un villaggio, che sorgeva ai piedi di un’alta montagna, vivevano due vicini di casa che litigavano dal mattino alla sera. Si facevano dispetti, vendette, ripicche. Erano veramente insopportabili: per colpa loro, nel villaggio non c’era mai un giorno di pace. Un anziano decise di mettere fine alla cosa. Prese in disparte uno dei due e gli disse: «Vai sulla montagna a incontrarti con Dio». L’uomo si mise in marcia e, dopo molti giorni di fatica, giunse in cima alla montagna. Dio era là che lo aspettava. Fu proprio una sorpresa: l’uomo si stropicciò gli occhi invano; non c’era alcun dubbio: Dio aveva la faccia del suo vicino antipatico e rissoso. Ciò che Dio gli disse, nessuno lo sa. Ma al ritorno nel villaggio non era più lo stesso uomo. L’altro però continuava ad inventare pretesti per litigare. Così gli anziani si dissero: «È meglio che anche lui vada a vedere Dio». Così anche il secondo uomo salì sulla montagna. E lassù scoprì che Dio aveva il volo del suo vicino! Da quel giorno tutto è cambiato e la pace regna nel villaggio.
RIFLETTIAMO
• Chi sono i protagonisti del racconto?
• Che cosa facevano dalla mattina alla sera?
• Quale consiglio diede l’anziano del paese?
• Come si manifestò Dio?
• Che cosa cambiò da quel giorno?
• Qual è l’insegnamento di questo racconto?
Il gioco dei cerchietti
Servono 2 bastoncini lunghi 40 cm circa e 1 cerchietto del diametro di 10 o 15 cm di cartone (tubi di cartone per rotolare le stoffe tagliati e ricoperti con stoffa o con pelle).
Disporre gli alunni in 2 file una di fronte all’altra. Il primo dovrà lanciare il cerchietto al compagno che ha di fronte che dovrà prenderlo con i bastoncini.
Come far volare il cerchietto? Semplice, basta insegnare la tecnica e si divertiranno un mondo! Si sospende il cerchietto alle due bacchette incrociate, lo si lancia in avanti e in alto, scostando i due legnetti rapidamente a striscio l’uno sull’altro. Oppure si sospende alla sola bacchetta destra, tenuta orizzontalmente, infilando la sinistra, pure orizzontalmente, nella parte inferiore del cerchio. In questo secondo caso, tenuta ferma la sinistra, si dà lo slancio con la destra. Il cerchietto deve essere ricevuto dal compagno in volo su una bacchetta, o meglio ancora su ambedue. Il gioco continua fin tanto che uno dei due giocatori lascia cadere a terra il cerchietto. In questo caso prende il punto il compagno che lo ha lanciato. Perde chi per prima lascia cadere a terra il cerchietto per ben 12 volte.
Tiro alla fune
Serve una corda lunga almeno 4 o 5 metri. Tracciare a terra un segno con il gesso e porvi sopra la corda perpendicolarmente, metà da un lato e metà dall’altro
lato. Formare due o quattro squadre, in base al numero degli alunni. Nominare un capitano per squadra per scegliere i componenti. Al via ogni componente della squadra cercherà di tirare la fune verso la sua parte. Vince la squadra che farà oltrepassare la linea disegnata a terra ad un giocatore avversario. Le squadre vincenti del primo turno si scontreranno per determinare la squadra vincitore finale.
La trottola è un gioco per bambini conosciuto in tutto il mondo fin dai tempi antichi. Risale a più di 6000 anni fa, alcune trottole perfettamente conservate, con le fruste utilizzate per metterle in moto, sono state ritrovate durante gli scavi di Ur in Mesopotamia.
I bambini facevano vere e proprie competizioni per vedere chi riusciva a farla girare più a lungo. Giochiamo con i nostri alunni allo stesso modo, cronometro alla mano.
Il telaio
Per far avvicinare i bambini ancora di più ai mestieri del tempo e agli oggetti che si producevano proponiamo la realizzazione di un telaio per la tessitura.
Attraverso l’intreccio di fili e il meccanismo ripetitivo con cui si ottiene la trama rendiamo l’arte della tessitura interessante da vivere come un normale gioco.
Un gioco che è però anche istruttivo perché aumenta la coordinazione visiva-manuale e il loro bagaglio di conoscenze.
1
2
Con un righello segnare sul bordo (in alto) del cartoncino o vassoio delle linee verticali distanti tra loro un centimetro (fino al fondo in basso).
Tagliare il cartoncino in corrispondenza di queste linee (sia in alto che in basso), rientrando di uno o due cm.
• Un cartoncino o piccolo vassoio di cartone
• Filati di lana o cotone colorati
• 4 bastoncini di legno (ad esempio quelli del gelato)
• Forbici
L’ordito del telaio
L’ordito del telaio sarà formato da fili tesi in verticale, sui quali verrà intrecciata la trama.
Far passare il filo attraverso la prima fessura del cartoncino (in alto a sinistra), lasciare un pezzo lungo dietro (che verrà usato alla fine per chiudere tutto).
Una volta fissato il filo nella prima fessura, proseguire verso il basso e far passare il filato nella prima fessura a sinistra.
Proseguire portando il filo nella seconda fessura in basso, poi riportarlo in alto, nella seconda fessura. Proseguire in questo modo, fino a che non sarà terminata la larghezza dell’ordito. Sul davanti del cartoncino si otterranno tanti fili tesi in verticale, nel retro invece ci saranno piccoli occhielli che seguiranno l’andamento delle fessure.
Inserire un bastoncino di legno in alto e uno in basso nel telaio, sotto all’ordito. Serviranno per lavorare meglio con il filato e lasciare il giusto margine per finire il lavoro. Prendere un lungo filo e annodarlo ad un bastoncino di legno. Il bastoncino fungerà da ago e servirà per passare con facilità attraverso l’ordito.
La trama
Iniziare a passare con il bastoncino attraverso l’ordito, una volta sopra e una volta sotto e così via. Con un bastoncino di legno raccogliere le maglie, e stringerle tutte in modo da lavorare sempre senza spazi tra un passaggio e l’altro.
Cambiare filo: la trama potrà essere fatta di tanti colori differenti! Basta unire i filati con un piccolo nodino a lato.
Chiusura del lavoro _ Una volta terminata la trama, togliere i due bastoncini alle due estremità. Iniziare poi a sfilare l’ordito dal telaio, facendo attenzione a non perdere le maglie. Tagliare gli occhielli dell’ordito e annodarli fra loro. Il lavoro è terminato.
Proponiamo alla classe dei giochi per consolidare negli alunni il racconto del MIRACOLO DI BARTIMEO
Ciechi e zoppi
Da una parte ci sono i ciechi con gli occhi bendati, di fronte a loro gli zoppi. Ad un segnale (un battito di mani, un via…), ogni cieco corre dal suo zoppo e lo
prende a cavalcioni. Lo zoppo ha il compito di guidare il cieco che deve tornare al punto di partenza.
I giocatori, a questo punto, si scambiano i ruoli e rifanno il percorso in senso contrario. Quando la distanza è parecchia, gli zoppi possono mettere un certo richiamo precedentemente concordato (verso di animali, battito di mani...) per guidare il proprio cieco a sé. Il gioco diventerà particolarmente interessante se la strada del ritorno avrà degli ostacoli da superare. Vince naturalmente la coppia che completa il percorso per prima.
• Fazzolettoni per bendare i giocatori
• Oggetti da usare come ostacoli (birilli, bottiglie di plastica, scatole…)
Attenti agli ostacoli!
Un bambino viene bendato e, partendo da un lato della stanza in cui ci si ritrova, deve raggiungere un compagno in un punto opposto.
Per raggiungerlo egli dovrà attraversare una stanza o un percorso, in cui verranno disposti degli ostacoli e, per non finirci contro, dovrà seguire le indicazioni date dal compagno da raggiungere.
Gli altri alunni hanno il ruolo di disturbatori e devono confondere il bambino bendato, cercando di non fargli capire le indicazioni provenienti del compagno da raggiungere. Il gioco può essere svolto ad alti volumi con il bambino da raggiungere che detta le mosse ed i movimenti da attuare per evitare gli ostacoli: «Avanti! Destra! Sinistra! Fermo!» e gli altri alunni che per disturbare possono urlare, cercando di coprire con le loro voci le indicazioni o nel caso non si possono alzare i toni, attuare la stessa modalità ma con indicazioni da seguire sulla base di un codice (un battito di mani, o uno schioccare di dita = destra, due schioccare di dita = sinistra...) Inventate un codice e tutti gli altri bambini del gruppo dovranno cercare di disturbare il suono allo stesso modo.
Dopo la lettura della storia, possiamo far ascoltare la seguente canzone.
Un vero amico chi è?
È quello che non lascia mai,
Un vero amico
ha qualcosa che poi
Gli manca se tu te ne vai.
Un vero amico si sa
Aiuta e non chiede perché
Ma se per caso si mette nei guai
Tu lascia tutto e corri da lui.
Per un amico metti su il sorriso
più grande che hai
Più grande che hai
Prova a fare sempre
tutto quello che puoi,
Quello che puoi
Un amico vero
non lo scorderai mai
Se pensi che sia giusto
non far caso a tutto il resto.
Un amico è il bene più prezioso che hai Il bene che hai
Ogni cosa è meno bella senza lui
Senza lui
Un amico vero non ti lascerà mai
Non fare caso al resto
Per un amico questo ed altro.
Con un amico però
A volte si litiga, sai
Ma una parola, una stretta di mano
Non può partire sempre da lui.
Per un amico
metti su il sorriso
più grande che hai
Più grande che hai
Tiri sempre il cuore in ballo, fra di voi Fra di voi
Un amico vero non lo perderai mai
Tu lascia stare il resto
Per un amico questo ed altro. È un’avventura che se vuoi,
Può non finire mai
Quando incontri
un altro bambino
Hai un amico vicino e così...
Per quell’amico
Metti su il sorriso
più grande che hai
Più grande che hai
Prova a fare sempre tutto quello che puoi, Quello che puoi
È un amico vero
e non lo scorderai mai
Se pensi che sia giusto non far caso a tutto il resto
Na na na
Un amico vero non lo perderai mai
Tu lascia stare il resto
Perché un amico è tutto questo.
Na na na na na
Perché un amico è tutto questo.
Colora e costruisci la sinagoga di Nazaret seguendo le istruzioni date.
Colora e ritaglia i 12 Apostoli, gli amici di Gesù.
Colora in giallo le monete che rappresentano i veri talenti e in grigio quelle che non lo sono. Puoi continuare l’elenco dei veri talenti, scrivendo nelle righe in basso della scheda, soprattutto individuando i tuoi.
Osserva la giornata di Gesù, poi completa la sveglia disegnando le tue azioni quotidiane. Colora.

Leggi il Vangelo di Marco 10,13-16 e collega ogni immagine con la didascalia corrispondente.
GESÙ DICE: LASCIATE CHE
I BAMBINI VENGANO A ME.
GESÙ PRENDE
I BAMBINI TRA
LE BRACCIA E LI BENEDICE.
I DISCEPOLI SGRIDANO I BAMBINI.
Traguardi per lo Sviluppo delle Competenze L’alunno…
• riconosce e sa spiegare il significato cristiano della Pasqua.

u ni Ta di apprendimen T o p er la p rogrammazione S e TT imanale r iferimen T i al T e ST o o bie TT ivi di apprendimen T o
La luce di Pasqua • L’ultima settimana di Gesù a Gerusalemme.
• Conoscere gli avvenimenti legati alla Pasqua cristiana.
Da pag. 70 a pag. 77 Dio e l’uomo
• Conoscere la figura di Gesù.
Il linguaggio religioso
• Scoprire nella Pasqua il centro della fede cristiana.
• Conoscere i principali segni e i simboli pasquali e il loro significato.
In questa parte l’insegnante presenterà agli alunni una riflessione sulla Pasqua cristiana alla luce dei brani evangelici. Gesù, sulla croce, vuole dimostrare quanto grande sia l’amore di Dio per tutti gli uomini. Amare è un sentimento tanto bello, tanto complesso, difficile da mettere in pratica, soprattutto verso i propri nemici, verso chi non ci vuole bene; Gesù ha dimostrato il suo amore lungo tutta la sua esistenza terrena, accogliendo ogni uomo. Sulla croce il suo amore è diventato dono totale di sé nel sacrificio della vita. Gesù insegna a rispondere al male con il bene, ribalta e vince le sfide: dalla tristezza alla gioia, dal buio alla luce, dalla morte alla vita. L’alunno, attraverso un percorso che parte dalla descrizione dei segni che parlano della festa della
Pasqua, viene introdotto a cogliere l’avvenimento centrale di tutta la fede cristiana: Gesù muore e risorge per la salvezza di tutti gli uomini di ogni tempo. Le vicende della morte e risurrezione e i luoghi della passione aiuteranno gli alunni a comprendere che la Pasqua di Gesù è un evento storico e reale. Le cose che Gesù fece e disse sono così importanti che da allora tutti i cristiani le ricordano durante la Settimana Santa.
L’insegnante dovrà poi sottolineare come la Pasqua di Gesù segna l’evento centrale per i cristiani, che da quel momento saranno chiamati a testimoniare proprio questo amore grande e sconfinato che Gesù ha portato, fino al suo sacrificio sulla croce.
Presentiamo ai bambini alcune leggende legate alla festa di Pasqua.
Quando Gesù pregava fra gli ulivi, questi erano alberi dritti e robusti, molto amati dai falegnami che usavano il loro legno per creare vari oggetti di uso domestico. Quando Gesù fu arrestato e poi condannato, Caifa, il Sommo Sacerdote di Gerusalemme, mandò in giro per la campagna alcuni soldati a cercare un albero per farne una croce. I soldati uscirono dalla città con le accette e si diressero verso il bosco. Il bosco allora cominciò ad agitarsi, come investito da un uragano. Gli alberi invocavano la morte, chiamavano il fulmine, chiedevano di diventare cenere. Quando i soldati giunsero al bosco si fece silenzio: non si sentivano né canti di uccelli, né fruscii di fronde. Ogni albero pregava il cielo, perché gli risparmiasse un così terribile destino. Infine un soldato disse: «Né palma, né cedro fanno al caso nostro. Ci vuole l’ulivo!» Cedri e palme trassero un grosso sospiro di sollievo. Gli ulivi, invece, si sentirono perduti. Tentarono di sradicarsi, si torsero, si ingobbirono e si spaccarono.
Alla fine rimasero fermi, impossibilitati a fuggire, ma inutili per sempre ad essere legno di croce. Invano i soldati cercarono un ulivo dritto. Da allora, l’albero dalle foglie d’argento vive felice di essere storto.
R. Pezzani
RIFLETTIAMO
• Chi era Caifa? Cosa ordina ai soldati?
• Cosa fanno nel bosco i soldati?
• Cosa dice uno dei soldati?
• Come finisce la storia?
• Prova a spiegare perché.

Gesù saliva verso il Calvario, portando sulle spalle piagate la croce pesante. Sangue e sudore scendevano a rigare il volto santo coronato di spine. Vicino a lui camminava la madre, insieme ad altre pie donne.
Gli uccellini, al passaggio della triste processione, si rifugiavano, impauriti, tra i rami degli alberi. Ad un tratto Gesù cadde a terra. Due soldatacci, armati di frusta, si precipitarono su di lui, allontanando la madre, che tentava di rialzarlo. «Su, muoviti! E tu, donna, stattene da parte».
Gesù tentò di rialzarsi, ma la croce troppo pesante glielo impedì. Era caduto ai piedi di un salice. Cercò inutilmente di aggrapparsi al tronco. Allora l’albero pietoso chinò fino a terra i suoi rami lunghi e sottili perché potesse, afferrandosi ad essi, rialzarsi con minor fatica.
Quando Gesù riprese il faticoso cammino, l’albero rimase coi rami pendenti verso terra: perciò fu chiamato Salice Piangente.
RIFLETTIAMO
• Dopo aver letto ed ascoltato la storia, prova a raccontare le tue emozioni.
Nei giorni lontani, quando il mondo era tutto nuovo, la primavera fece balzare dalle tenebre verso la luce tutte le piante della Terra, e tutte fiorirono come per incanto.
Solo una pianta non udì il richiamo della primavera, e quando finalmente riuscì a rompere la dura zolla, la primavera era già lontana… «Fa’ che anch’io fiorisca, oh Signore!» pregò la piantina. «Tu pure fiorirai» rispose il Signore. «Quando?» chiese con ansia la piccola pianta senza nome.
«Un giorno…» e l’occhio di Dio si velò di tristezza. Era ormai passato tanto tempo, la primavera anche quell’anno era venuta e al suo tocco le piante del Golgota avevano aperto i loro fiori. Tutte le piante, fuorché la piantina senza nome. Il vento portò l’eco di urla sguaiate, di gemiti, di pianti: un uomo avanzava fra la folla urlante, curvo sotto la croce, aveva il volto sfigurato dal dolore e dal sangue…
«Vorrei piangere anch’io come piangono gli uomini» pensò la piantina con un fremito…
Gesù in quel momento le passava accanto, e una lacrima mista a sangue cadde sulla piantina pietosa.
Subito sbocciò un fiore bizzarro, che portava nella corolla gli strumenti della passione: una corona, un martello, dei chiodi… era la passiflora, il fiore della passione.
RIFLETTIAMO
• Dopo aver letto ed ascoltato la storia, prova a raccontare le tue emozioni.
È meraviglioso portare in casa un SEGNO DI VITA NUOVA nel periodo di Pasqua. Come la Pasqua stessa, i germogli e i fiori primaverili ci ricordano la promessa di Dio di una vita nuova. Proponiamo allora la COSTRUZIONE DI UN ALBERO DI PASQUA.
• Ramo con foglie o fiori
• Pennarelli
• Forbici
• Lustrini
• Colla
• Perforatrice
• Nastrini colorati
Tagliare alcuni rami con le foglie o con i fiori.
Mettere i rami in un vaso abbastanza grande pieno di acqua.
Disegnare su cartoncini colorati i simboli pasquali, colorarli con pennarelli e decorarli a piacere.
Perforare all’estremità i cartoncini con i simboli e inserire i nastrini colorati per appenderli.
Dopo la lettura della storia, possiamo far ascoltare e ripetere una delle seguenti filastrocche.
Mattino di Pasqua
Din-don, din-don, din-don!
Sole sui fiori
Pasqua
Pasqua è nuova ogni anno anche i grandi lo sanno: è nuovo il riso dei bambini, è fresco il ciliegio nei giardini. E tutti sentono nel cuore la novità fatta d’amore. È la voglia di esser più veri, è la gioia di esser sinceri; è la pace che Cristo dà a chi ha buona volontà.
e rondini sul tetto
Sia benedetto il nome del Signore.
Din-don, din-don, din-don!
Festa d’amore
Gesù è risorto, ’inverno è morto.
Din-don, din-don, din-don!
G. Fanciulli
Campane di Pasqua
Campane di Pasqua festose che a gloria quest’oggi cantate, oh voci vicine e lontane che Cristo risorto annunciate, ci dite con voci serene: “Fratelli, vogliatevi bene! Tendete la mano al fratello, aprite le braccia al perdono; nel giorno del Cristo risorto ognuno risorga più buono!”. E sopra la terra fiorita, cantate, oh campane sonore, ch’è bella, ch’è buona la vita, se schiude la porta all’amore.
Leggi e racconta a voce all’insegnante cosa accadde a Gesù a Pasqua. Scrivi le parole nei rettangoli: la lettera iniziale ti aiuta. Colora.
Collega con una freccia i simboli alla parola corretta.
Tra le seguenti frasi cerchia solamente quelle giuste.
• Gesù muore a Nazaret.
• Gesù muore in croce.
• Gesù viene messo in un sepolcro.
• Gesù risorge di domenica.
Ripassa i tratteggi, colora e descrivi l’immagine. Ripeti la filastrocca.
Cantano le campane
Un dolce inno d’amore: ‘Alleluia, Alleluia, è risorto il Signore.’
L’alunno…
Traguardi per lo Sviluppo delle Competenze
• identifica nella Chiesa la comunità di coloro che credono in Gesù Cristo e si impegnano per mettere in pratica il suo insegnamento.

u ni Ta di apprendimen T o p er la p rogrammazione S e TT imanale r iferimen T i al T e ST o o bie TT ivi di apprendimen T o
La Chiesa ieri e oggi
• La nascita della Chiesa e il valore della domenica.
• Sapere che in ogni parte del mondo gli uomini si rivolgono al proprio Dio mediante la preghiera.
• La preghiera cristiana per eccellenza: il Padre Nostro.
Da pag. 78 a pag. 96 Dio e l’uomo
• Riconoscere la preghiera come dialogo tra l’uomo e Dio.
Il linguaggio religioso
• Individuare i tratti essenziali della Chiesa e della sua missione.
I valori etici e religiosi
• Riconoscere il valore della domenica.
Nell’ultima parte dell’anno viene presentata la CHIESA COME COMUNITÀ, riprendendo un po' il tema trattato già nella classe prima.
La Chiesa, animata dallo Spirito Santo, ha lo scopo di testimoniare e continuare a trasmettere il MESSAGGIO D’AMORE che Gesù ha portato e mostrato a tutti.
Già al termine della classe prima i bambini hanno conosciuto la chiesa come l’edificio in cui ci si incontra e si prega, ora si tratta di recuperare tale apprendimento per approfondire la conoscenza della Chiesa come comunità cristiana.
Agli alunni, inoltre, vengono proposti dei valori quali la CONDIVISIONE, la COMUNIONE, la FRATELLANZA, vissuti dai primi cristiani come frutti della vita nuova donata da Gesù a coloro che attraverso il Battesimo entrano a far parte del nuovo Popolo di Dio.
Per i cristiani, il ricordo della Pasqua di Gesù si compie ogni domenica nella celebrazione eucaristica (la Santa Messa), dove i cristiani riuniti in preghiera, rivivono gli ultimi momenti della vita di Gesù. Ogni cristiano, poi, nella propria vita personale, cerca un dialogo con Dio, che trova il suo fondamento nel Padre Nostro, la preghiera che Gesù stesso ha insegnato agli Apostoli.
Leggiamo agli alunni due brevi storie che li porteranno a scoprire il significato delle prime due parole che compongono il Padre Nostro. Spieghiamo che essa è la preghiera più importante dei cristiani perché è stata donata da Gesù stesso. È una preghiera bellissima in cui i cristiani sono invitati da Gesù a chiamare Dio con il nome di Padre.
In un paesino di montagna c’era un’usanza molto bella.
Ogni primavera si svolgeva una gara fra tutti gli abitanti. Chi riusciva a trovare il primo fiore sarebbe stato il re di tutte le feste dell’anno. Per questo partecipavano tutti, giovani e vecchi. Un anno, appena la neve cominciò a sciogliersi, partirono tutti alla ricerca del primo fiore. Per ore e ore, cercarono in alto e in basso. Stavano già abbandonando l’impresa, quando udirono la voce di un bambino. «È qui! L’ho trovato!». Corsero tutti da lui. Il bambino indicava con il dito il primo fiore.
Era sbocciato in mezzo alle rocce, qualche metro sotto il cigno di un terribile dirupo. La bocca spalancata del burrone faceva paura. Il bambino scoppiò in pianto. Voleva il fiore, ma aveva paura del precipizio. Tutti gli altri erano gentili, lo volevano aiutare. Cinque uomini forti portarono una corda. «Ti legheremo e ti caleremo giù» dissero. «No, no. Ho paura!» piangeva il bambino.
Si misero in quindici, i più forti del paese: «Ti terremo noi!». Niente da fare. Poi, ad un tratto, il bambino smise di piangere. Con una mano si asciugò le lacrime. Tutti fecero silenzio. «Va bene» disse il bambino. «Andrò giù, andrò giù se terrà la corda mio padre».
Bruno Ferrero
RIFLETTIAMO
• Quale usanza c’era nel paesino di montagna?
• Chi poteva partecipare alla gara?
• Che cosa accadde?
• Quando il bambino smise di piangere?
• Cosa vuol dire contare su qualcuno?
• Che cosa vuol essere Dio per gli uomini?
Si racconta che nell’antichità più antica, tutti gli uomini erano bianchi. I colori si erano divertiti a colorare ogni cosa; le montagne, le piante, gli animali, il cielo ma si erano dimenticati di colorare proprio gli esseri più importanti che esistevano sulla Terra: gli uomini. Quando se ne accorsero, decisero subito di rimediare e si riunirono per stabilire a chi sarebbe spettato farlo. I concorrenti erano tanti. «Spetta a me! - gridò il viola - sono il colore più distinto!». «Perché tu? Gli uomini saranno molto più belli verdi!» ribatté il verde. «No, sono io, il celeste, il colore più adatto!».
Alla fine di una discussione burrascosa si passò ai voti e tre ottennero lo stesso numero di preferenze: il nero, il giallo e l’arancione. I tre colori prescelti vennero ad un accordo; il nero avrebbe colorato gli uomini che vivevano in Africa, il giallo quelli che vivevano in Asia e l’arancione quelli che vivevano in America. Subito partirono per mettersi al lavoro, ma a causa dei violenti litigi era avvenuta un’altra dimenticanza: i colori si erano scordati degli uomini che vivevano in Europa. Così gli europei restarono bianchi e, figuratevi la loro rabbia, quando cominciarono a viaggiare e si accorsero che in Africa, in Asia e in America viveva
gente con la pelle nera, gialla o arancione. Forse proprio per la vergogna che i colori si fossero dimenticati di loro, presero a guardare in malo modo e addirittura disprezzare chi aveva la pelle colorata. Questo durò vari secoli. Ai giorni nostri, però le cose sono abbastanza cambiate. Molti bianchi, infatti, considerano oggi la pelle dei neri addirittura più bella della loro, tanto è vero che d’estate prendono il sole per ore e ore per diventare neri. Ma per quanto si sforzino, si vede subito che sono dei bianchi soltanto abbronzati.
RIFLETTIAMO
• Cosa ci vuol far capire secondo te questa storia?
Approfondiamo
Raccontiamo ai bambini che cosa accadde il giorno di Pentecoste. Durante questa festa ebraica si ha una delle manifestazioni più potenti dell’effusione dello Spirito.
Gli apostoli riuniti nel Cenacolo insieme a Maria hanno il privilegio di assistere e ricevere una copiosissima effusione dello Spirito, che darà loro la forza di uscire allo scoperto per proclamare le grandi opere di Dio, annunciare Cristo morto e risorto e restare fedeli a lui.
Nel giorno di Pentecoste, la potenza dello Spirito trasforma il piccolo lievito del Cenacolo in una nuova comunità destinata a durare fino alla fine dei tempi. Per manifestarsi e investire della sua forza, lo Spirito rompe anche gli argini della normale esperienza sensoriale ed esplode in una serie di manifestazioni fisiche e spirituali: vento impetuoso, misteriose lingue di fuoco, rapimenti estatici, tutte le forze divine per mettere in moto la nave della Chiesa.
Cinquanta giorni dopo la Pasqua, ricorreva la festa di Pentecoste, una delle grandi feste dell’anno, quando gli ebrei accorrevano a Gerusalemme da tutti i paesi nei quali si erano trasferiti a vivere.
La città traboccava di forestieri: erano tutti ebrei, ma sembravano stranieri perché vestivano secondo l’uso dei popoli in mezzo ai quali abitavano e di cui parlavano le varie lingue.
Nella casa dove abitavano, gli apostoli erano riuniti con Maria, la madre di Gesù, e con un gruppo di discepoli.
D’improvviso sentirono qualcosa di molto strano: la casa fu scossa come dal rumore di un forte vento e lingue come di fuoco andarono a posarsi sulla testa di ciascuno dei presenti. Mentre fino a poco tempo prima gli apostoli erano pieni di paura e se ne stavano nascosti, ora si sentivano forti, coraggiosi e con il cuore ardente di gioia.
Subito uscirono e alla folla curiosa di sapere che cosa fosse stato quel rumore si misero ad annunciare Gesù risorto invitando i presenti a divenire suoi discepoli. Gli ascoltatori, provenienti da tanti paesi diversi, anche se parlavano lingue diverse, riuscivano a capire ciò che gli apostoli stavano dicendo come se parlassero la loro lingua.
Il primo a prendere la parola fu Pietro e lo fece in modo così convincente che alla fine molti gli chiesero: «Che cosa dobbiamo fare, dunque?».
Pietro rispose: «Pentitevi dei vostri peccati, fatevi battezzare nel nome di Gesù e riceverete anche voi con il battesimo, lo Spirito Santo».
Molti gli diedero retta.
Quel giorno circa tremila persone si fecero battezzare. Entrarono così a far parte della Chiesa, la famiglia dei discepoli di Gesù.
R. Brunelli - M. Fiodorov
• Durante quale festa discende lo Spirito Santo?
• Quanti giorni sono passati dalla Pasqua?
• Chi riceve questo grande dono?
• Come si manifesta lo Spirito Santo?
• Come reagiscono gli apostoli?
• Cosa dice Pietro alla folla?
• Come reagisce la gente?
• Che cosa nasce in questo giorno?
Leggiamo il seguente racconto per aiutare i bambini a comprendere il concetto di COMUNITÀ COME UN INSIEME DI PERSONE IN CUI CIASCUNO CON LA PROPRIA IDENTITÀ È
IMPORTANTE. Nel mondo di oggi il concetto di comunità non è affatto scontato, soprattutto per i bambini cresciuti in appartamento, davanti al computer, che hanno scarse possibilità di incontro con i coetanei.
La fiaba di Pezzettino li aiuterà a riflettere sull’IMPORTANZA DELLO STARE INSIEME e di far parte di un gruppo che funziona.
C’era una volta un piccolo pezzo di un puzzle di cartone che era scivolato dietro un frigorifero e che nessuno era più riuscito a trovare. Era un pezzo di puzzle molto grazioso: aveva la forma di un omino e portava sul dorso un curioso disegno giallo, marrone, rosso e bianco. Stava da così tanto tempo dietro il frigorifero che aveva dimenticato che cos’era. Perché i pezzetti di puzzle hanno la memoria corta. Perciò aveva deciso di chiamarsi Pezzettino. Lo aveva deciso guardandosi intorno: tutti gli altri che vedeva erano chiaramente loro, degli oggetti ben definiti. Il tavolo era il tavolo, la sedia era la sedia, perfino il gatto era il gatto. Ma lui cos’era?
«Sono certamente il pezzetto di qualche cosa. Ma di che cosa?».
Così decise di partire per scoprirlo. Con le sue gambette tonde uscì in giardino e cominciò la sua ricerca.
«NON HO BISOGNO DI NESSUNO IO!»
La prima cosa in cui si imbatté fu un grosso sasso.
«Salve» disse Pezzettino al sasso.
«Salve» brontolò il sasso.
«Fa freddino, eh?» continuò Pezzettino senza scoraggiarsi.
«Io non sento niente» rispose il sasso, scostante.
«Hai voglia di fare due passi?».
«Io non mi muovo mai!».
«Vuoi dire che stai sempre lì?».
«Esatto!».
«Per caso, ti manca qualcosa?».
«No. Una pietra è una creatura perfetta. Non manca di niente».
«Neanche un pezzettino…». E il piccolo pezzo di puzzle sussurrò: «...come me?». «Vattene! Io non ho bisogno di niente e di nessuno» rispose il sasso.
Impaurito dal tono della pietra, Pezzettino fece un rapido dietro-front e ricominciò a vagare per il giardino per trovare la cosa a cui mancava un pezzetto proprio come lui. Cammina, cammina (in realtà fece pochi centimetri, ma se guardate bene, le gambe dei pezzi di puzzle sono proprio minuscole), arrivò sul bordo di una pozzanghera. Era una bella pozzanghera di acqua sporca. Dovete sapere che, nel regno delle pozzanghere, quelle di acqua sporca sono ritenute le più belle perché riescono a riflettere le stelle e le nuvole.
«Buongiorno», disse Pezzettino.
«Ehilà, sgorbietto, come va?», rispose la pozzanghera. Le pozzanghere non sono beneducate e amano molto fare scherzi e inzaccherare il prossimo. Si piazzano apposta sotto le ruote delle automobili, per schizzare sui passanti quando questi meno se l’aspettano.
«Scusami» continuò Pezzettino, «sono un pezzetto di te?». «Uhm… - borbottò la pozzanghera - Perché no? Vieni dentro che c’è posto!». «Ah, che bello! - gridò Pezzettino - Sono un pezzo di pozzanghera». E si tuffò. Appena dentro la pozzanghera, però, cominciò a rammollirsi e a soffocare. «Aiuto, affogo!», gridava disperato. Si dibatteva, cercava di stare a galla, ma l’acqua lo attirava inesorabilmente verso il basso. Il misterioso disegno che portava sul dorso cominciava a svanire. «Aiuto, salvatemi!». La pozzanghera sogghignava: «Povero illuso! Sei solo un pezzo di cartone, sgorbietto!».
Ma un merlo, che stava facendo colazione nel prato con la sua signora, si impietosì e con il lungo becco giallo pescò Pezzettino nella pozzanghera e lo stese ad asciugare sopra una margherita.
DEGLI SCOMODI COMPAGNI
I raggi del sole e una brezza dolce dolce asciugarono Pezzettino, che fu ben presto in grado di riprendere la sua ricerca. Cammina cammina, Pezzettino arrivò nei pressi di una forma tondeggiante, irta di puntine e con una piccola porticina. «Come ti chiami?» chiese Pezzettino.
«Riccio di Castagno», rispose l’altro.
«Un bel nome» disse Pezzettino. E fece la sua domanda anche al riccio di castagno. Il riccio non ci pensò molto.
«Ma certo! Sentivo tanto la tua mancanza! Sono sempre solo quaggiù e non ho
nessuno con cui giocare!».
«Che bello!» esclamò Pezzettino. «Sono un pezzetto di riccio!».
«Dai abbracciamoci e poi giochiamo insieme» gli fece eco il riccio.
Pezzettino si buttò verso il riccio, ma… «Ahia!».
Pezzettino si sentì pungere dappertutto. Ci riprovò, ma… «Ahia!».
Non c’era niente da fare. Il riccio aveva spine pungenti dappertutto.
«Adesso capisco perché non hai amici» disse mestamente Pezzettino.
«Se sto con te divento un colino. Credo proprio di non essere un pezzetto di te».
Disse addio al riccio e, per nulla scoraggiato, riprese a vagare per il giardino alla ricerca della cosa a cui mancava un pezzo uguale a lui.
Una serie di sfacciati luccichii richiamò la sua attenzione. Si diresse da quella parte e si ritrovò in mezzo a una combriccola di pezzi di vetro colorati che si divertivano a giocare con i raggi del sole. «Ehi, amici!».
«Ciao!» risposero quasi all’unisono, ma non gli fecero troppo caso.
«Non sono per caso un pezzetto della vostra banda?», chiese Pezzettino speranzoso perché quei pezzi di vetro gli sembravano divertenti e simpatici.
«Può darsi...» disse il più grosso.
«Allora posso restare?». «Resta».
Pezzettino cominciò a giocare con i suoi nuovi fratelli, ma… «Sei proprio una schiappa!» gli gridò il pezzo di vetro con cui cercava di giocare a ping-pong con i raggi di sole. La superficie di Pezzettino non rifletteva un bel niente, anche se lui ci metteva tutta la buona volontà. Inoltre il suo disegno giallo, marrone, rosso e bianco rimaneva incomprensibile e il piccolo pezzo di puzzle si sentiva un po’ a disagio. Uno dei pezzi di vetro, che stava di vedetta, ad un tratto gridò: «Arriva, ragazzi!». Una ventata di eccitazione percosse i pezzi di vetro. Smisero immediatamente di giocare e si disposero in modo da avere la parte tagliante verso l’alto. Pezzettino si accorse di non avere nessuna parte tagliente e rimase lì in mezzo, esitante, a vedere cosa succedeva.
«Un grosso premio a chi lo buca al primo colpo!» disse il pezzo di vetro più grosso. «Ci mancavi tanto».
Bucare, ma che cosa? Poi Pezzettino capì. I pezzi di vetro si trovavano in mezzo ad un sentiero, sul quale stava arrivando una bicicletta.
«Ma perché?» esclamò invano Pezzettino.
La bicicletta arrivò sui pezzi di vetro e… Pluff!
«Oh, no!», disse il bambino. Scese dalla bicicletta e contemplò con aria afflitta
il piccolo pneumatico che si era rapidamente sgonfiato. Mentre faceva questo, il suo sguardo si fissò su Pezzettino. «Guarda che non sono stato io!» gridò con tutte le sue forze Pezzettino.
Il bambino non conosceva la lingua dei pezzi di puzzle, perciò lo afferrò e corse in casa gridando: «Mamma, mamma! L’ho trovato! Ho trovato il pezzo del mio puzzle!».
Come succede ai bambini, aveva già dimenticato la bicicletta bucata per la gioia di aver ritrovato il pezzo di puzzle smarrito.
Un istante dopo, Pezzettino si trovò abbracciato a tanti pezzetti come lui e, con immensa gioia, capì che la sua ricerca era finita. Ora sapeva chi era! Ora avevano un significato anche le macchie colorate sul dorso: il giallo e il marrone erano parti del muso di una tigre, il rosso e il bianco erano denti e bocca spalancata. Tutti insieme, i piccoli pezzi formavano una magnifica tigre nella giungla. «Benvenuto! Ti aspettavamo!», gridarono in coro gli altri pezzetti del puzzle. «Ci mancavi tanto!». «Anche voi mi siete mancati tanto, fratellini miei», disse Pezzettino al colmo della felicità.
RIFLETTIAMO
• Che cosa vuole scoprire Pezzettino?
• Chi lo aiuta?
• Quali ostacoli incontra?
• Cosa scopre alla fine Pezzettino?
Dopo aver presentato la preghiera fondamentale del Cristianesimo, insieme ai bambini si ricorderanno altre preghiere cristiane. In seguito possiamo aggiungere che in ogni grande religione del mondo, i fedeli riconoscono un Essere grande e buono a cui si rivolgono per lodarlo, ringraziarlo e chiedere aiuto. A questo punto, si potranno ricercare altre preghiere, avvalendosi della collaborazione di bambini e genitori originari di altri paesi e di diversa fede.
Per aiutare i nostri alunni a rispettare la fede di persone di religione diversa e a comprendere i diversi modi di manifestarla, imparando a scoprire più le somi-
glianze e le uguaglianze che le differenze, viene proposta la realizzazione di un albero della preghiera.
L’albero della preghiera
REALIZZAZIONE
Disegnare sul cartoncino bianco la sagoma di un grande albero dalla grande chioma.
Colorarlo con le tempere utilizzando la tecnica della spugnatura.
Appenderlo.
Nei fogli bianchi ciascun bambino disegnerà dei grandi fiori. Al centro scriverà il testo di una preghiera scelta tra quelle riportate di seguito, oppure tra quelle che verranno portate in classe dopo la ricerca.
I petali saranno colorati con fantasia e ritagliati.
Ogni bambino incollerà il fiore realizzato sulla chioma dell’albero.
Preghiera indù:
OCCORRENTE
• Cartoncino bianco, spesso, di grandi dimensioni
• Colori a tempera (verde, marrone e azzurro)
• Spugnette
• Fogli bianchi
• Colori a pastello
• Forbici
• Colla
O mio Signore, aiutami a sopportare serenamente gioia e dolori. Aiutami a fare sempre la tua volontà.
Preghiera buddista:
Se ti capita di fare del bene, ripetilo.
Lascia che metta radici in te e ti riempia di gioia.
Preghiera musulmana:
Noi siamo tuoi testimoni; noi cerchiamo rifugio nello splendore della tua potenza, in modo che Tu possa mostrare nella tua grandezza e nella tua volontà ciò che tu vuoi.
Preghiera ebraica:
Il Signore è il mio pastore: non manco di nulla. Sui pascoli erbosi mi fa riposare, ad acque tranquille mi conduce. Mi rinfranca, mi guida per il giusto cammino, per amore del suo nome.
Preghiera dei Sioux:
Oh, Grande Spirito, la cui voce odo nei venti e il cui respiro dona la vita a tutto il mondo, ascoltami! Io mi avvicino a te, uno dei tuoi figli. Io sono piccolo e debole: ho bisogno della tua forza e della tua saggezza.
La girandola
Proponiamo un lavoretto: semplice e rapido (la girandola) che insegnerà che è la forza del vento (simbolo dello Spirito Santo) a far muovere la girandola e svilupperà le competenze manuali degli alunni.
REALIZZAZIONE
Disegnare un quadrato di 20 x 20 cm su un cartoncino e ritagliarlo.
Con un righello tracciare le diagonali, ma evitare che le linee arrivino al centro del foglio.
Fare un segno al centro del foglio.
Ritagliare le linee precedentemente tracciate, ricordando che non si deve arrivare fino al centro.
OCCORRENTE
• Cartoncino colorato
• Forbici
• Cannuccia
• Puntina
• Ago/spillo
• Gomma
Delle otto punte che ha il nostro cartoncino così ritagliato, prenderne quattro, alternandole alle altre (una sì e una no). Piegarle e fermarle con un ago o con uno spillo.
Far passare una puntina da disegno nei buchi che corrispondono alle quattro punte della girandola. Nella parte posteriore fermarla sulla cannuccia, che sarà il manico della nostra girandola.
Infilare un pezzetto di gomma sulla sporgenza della puntina in modo che non ci si possa pungere. La girandola è pronta.
Al termine dell’anno scolastico, come gesto di amore e di affetto verso gli altri, chiediamo ai bambini di realizzare un dono per l’amico o l’amica: il braccialetto dell’amicizia.
Il braccialetto dell’amicizia
• Filo da ricamo di tre differenti colori
• Qualche puntina da disegno
• Un supporto
Prendi tre fili da un metro.
Piegali in due e annodali per formare un piccolo ricciolo.
Fissa il ricciolo con una puntina da disegno sopra un supporto.
Metti i sei fili in piano, alternando i colori.
Prendi il primo filo sulla sinistra. Passalo sul secondo e giragli attorno. Stringi bene tirando il tuo filo verso l’alto.
Di seguito, annoda questo primo filo al terzo. Continua così fino al sesto. Il tuo primo intreccio è terminato.
Ora prendi il filo da sinistra. Annodalo sugli altri fili come hai fatto con il primo intreccio.
Dopo qualche intreccio, metti una seconda puntina sul braccialetto, così non si girerà.
Continua in questo modo finché il braccialetto non sarà abbastanza lungo.
Per terminare, dividi i fili in due gruppi da tre. Fai due piccole trecce. Termina ogni treccia con un nodo.
Per chiudere il braccialetto, passa una delle trecce nel ricciolo e annodala all’altra.
La colomba di Pentecoste
REALIZZAZIONE
Inizia con una normale piatto di carta.
Innanzitutto taglialo in tre parti in grandi strisce. I pezzi esterni diventano le ali e il centro diventa il corpo della colomba.
Taglia la coda e il corpo della colomba dalla sezione centrale dopo aver tagliato le ali libere. Il corpo della colomba è facile da disegnare perché è ha la stessa forma di pupazzo di neve.
Taglia le due parti laterali e poi assemblale come una colomba con una delle ali grandi su ogni lato. Fissa le ali sul dorso della colomba con del nastro o della colla.
Disegna delle semplici zampe, un becco e due occhi con i pennarelli.
• piatto di carta bianca
• pennarelli
• forbici, colla e scotch
• cartoncino giallo
• nastro colorato rosso
Disegna e ritaglia da un cartoncino giallo 7 sagome di “fiamma” e scrivi al loro interno i doni dello Spirito Santo con dei pennarelli. Attacca poi con lo scotch le “fiammelle” con i doni a di nastri rossi e fissa a loro volta il tutto sulle ali della colomba.
Dopo la lettura della storia, possiamo far ascoltare e ripetere una delle seguenti filastrocche.
È tanto bello quando si è amici, giocare insieme, sentirsi felici. Col mio amico è bello parlare aver mille segreti da raccontare e ridere insieme ridere assai i motivi per ridere non mancano mai. Certo, a volte può capitare di ritrovarsi a litigare e in quei momenti dirsi: Addio, tu non sei più amico mio!
Presto però lo vai ad abbracciare senza di lui non sai proprio stare. E ancor per mano contenti e felici camminano insieme i veri amici.
Gyo Fujikawa
Pelle Bianca come la cera
Pelle Nera come la sera
Pelle Arancione come il sole
Pelle Gialla come il limone tanti colori come i fiori.
Di nessuno puoi farne a meno per disegnare l’arcobaleno.
Chi un sol colore amerà un cuore grigio sempre avrà.
Gianni Rodari
Costruisci la “girandola dello Spirito Santo” seguendo le istruzioni date.
Nella Bibbia il fuoco simboleggia a volte qualcosa di positivo, altre volte qualcosa di negativo, come puoi costatare dalle due immagini riportate qui sotto a titolo esemplificativo
Scrivi sotto ciascuna di esse alcuni aggettivi o proprietà fuoco che ritieni accostabili a quanto vedi.
Osserva e descrivi la scena. Colora.
Nei vangeli la colomba simboleggia lo Spirito Santo al momento del Battesimo di Gesù:
Ed ecco, in quei giorni, Gesù venne da Nazaret di Galilea e fu battezzato nel Giordano da Giovanni. E subito, uscendo dall’acqua, vide squarciarsi i cieli e lo Spirito discendere verso di lui come una colomba. E venne una voce dal cielo: «Tu sei il Figlio mio, l’amato: in te ho posto il mio compiacimento».
Colora e commenta il disegno.
Scrivi una lettera al tuo amico del cuore. Che cosa gli scriveresti?
Prima di salutare i suoi amici e salire al cielo, Gesù raccomandò ai suoi discepoli di diffondere ovunque il suo messaggio di amore e di pace. Essi andarono dunque in tutto il mondo allora conosciuto per portare la Buona Notizia, cioè il...
Trascrivi le lettere seguendo le frecce.
Commenta la frase di Gesù e colora il planisfero.
"AMATEVI COME IO HO AMATO VOI."
Colora il disegno e completa la frase inserendo al posto giusto le seguenti parole: • SPIRITO SANTO • GESÙ CRISTO
Con la parola chiesa si fa riferimento da una parte all’edificio in muratura che ospita le assemblee dei cristiani, dall’altra alle persone, i fedeli che, uniti insieme, formano appunto la Chiesa.
Disegna altre persone che ascoltano la messa, poi colora.
Collega le parole al significato corretto. Chiesa casa dei cristiani chiesa comunità di fedeli
La comunità dei cristiani non ha barriere e accetta come fratelli tutti coloro che vogliono entrarvi. La Chiesa è aperta a tutti con un amore senza limiti.
Colora l’immagine e ripeti la filastrocca. Prova a scrivere anche tu un messaggio di pace.
Filastrocca per tutti i bambini, per gli italiani e per gli abissini, per i russi e per gli inglesi, gli americani ed i francesi, per quelli neri come il carbone, per quelli rossi come il mattone,
per quelli gialli che stanno in Cina dove è sera se qui è mattina, per i bambini di tutto il mondo che fanno un grande girotondo, con le mani nelle mani, tutti fratelli, vicini e lontani.
I cristiani cercano di mettere in pratica le parole di Gesù aiutando gli altri. Alcuni di essi, in particolare, vanno incontro ai fratelli di ogni parte del mondo, senza fare distinzione di lingua, razza e religione: sono i missionari.
Completa la frase e colora, commentando i disegni.
Secondo me la parola “solidarietà” significa:
Pregare è dialogare con Dio. In tutto il mondo ci sono popoli che pregano in modi diversi.
Osserva le immagini, collega le preghiere e gli oggetti ai rispettivi personaggi.
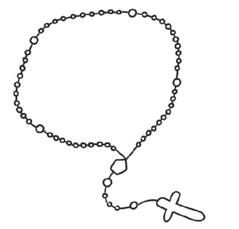

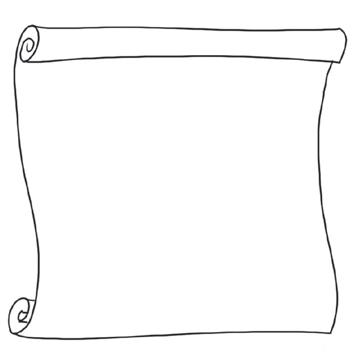
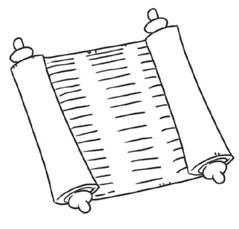
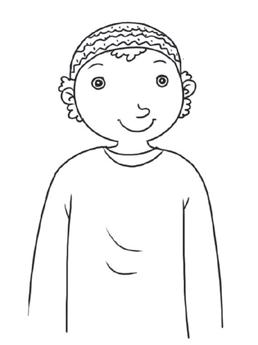
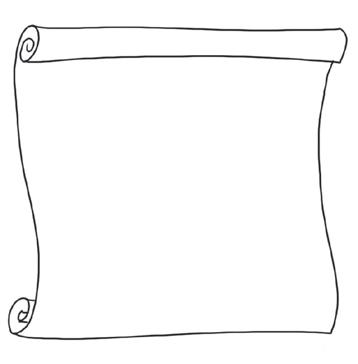
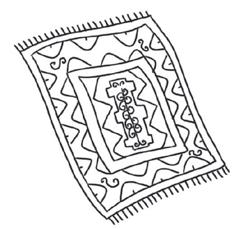

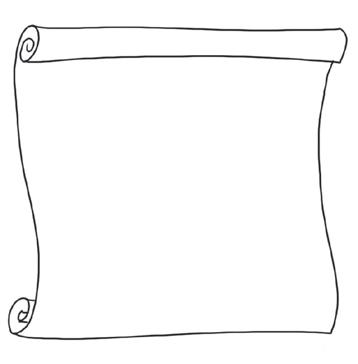

Assisi, 1193/1194 - Assisi, 11 agosto 1253
Ha appena dodici anni Chiara, nata nel 1194 dalla nobile e ricca famiglia degli Offreduccio, quando Francesco d’Assisi compie il gesto di spogliarsi di tutti i vestiti per restituirli al padre Bernardone. Conquistata dall’esempio di Francesco, la giovane Chiara sette anni dopo fugge da casa per raggiungerlo alla Porziuncola. Il santo le taglia i capelli e le fa indossare il saio francescano, per poi condurla al monastero benedettino di S. Paolo, a Bastia Umbra, dove il padre tenta invano di persuaderla a ritornare a casa. Si rifugia allora nella Chiesa di San Damiano, in cui fonda l’Ordine femminile delle «povere recluse» (chiamate in seguito Clarisse) di cui è nominata badessa e dove Francesco detta una prima Regola. Chiara scrive successivamente la Regola definitiva chiedendo ed ottenendo da Gregorio IX il «privilegio della povertà». Per aver contemplato, in una Notte di Natale, sulle pareti della sua cella il presepe e i riti delle funzioni solenni che si svolgevano a Santa Maria degli Angeli, è scelta da Pio XII quale protettrice della televisione. Erede dello spirito francescano, si preoccupa di diffonderlo, distinguendosi per il culto verso il SS. Sacramento che salva il convento dai Saraceni nel 1243.
Patronato: Televisione
Etimologia: Chiara = trasparente, illustre, dal latino
Emblema: Giglio, Ostia
Martirologio Romano: Memoria di santa Chiara, vergine, che, primo virgulto delle Povere Signore dell’Ordine dei Minori, seguì san Francesco, conducendo ad Assisi in Umbria una vita aspra, ma ricca di opere di carità e di pietà; insigne amante della povertà, da essa mai, neppure nell’estrema indigenza e infermità, permise di essere separata. Di nobile e ricca famiglia, Chiara nasce ad Assisi nel 1194. Prossima al parto sua madre Ortolana sente una voce che rassicurante le dice: «Stai tranquilla, avrai un felice parto, nascerà una figlia “chiara fonte di luce” che splenderà nel mondo». La bambina viene chiamata, infatti, Chiara. La santa è allevata dai genitori cristiani. Fanciulla dodicenne incontra San Francesco e capisce che vuole seguire i suoi insegnamenti, la sua semplicità, il suo essere povero tra la gente. Chiara cresce, da lei si espande la grazia angelica della purezza dell’anima. La sua bellezza attira i pretendenti che lei respinge. Un mercante più insistente – favorito dal padre di Chiara, Favarone – ottiene di averla in sposa. Tuttavia, decisa a seguire la sua vocazione, a diciotto anni Chiara fugge di casa, recandosi alla “Porziuncola” (una piccola chiesetta) dove trova Francesco e i suoi frati. Tagliati i lunghi capelli, Chiara indossa un ruvido saio e, pronunciati i voti di obbedienza, castità e povertà, si rifugia in un monastero. Viene poi raggiunta dalle sorelle Agnese e Beatrice (in seguito anche dalla madre rimasta vedova) e con il loro aiuto fonda l’Ordine delle Clarisse. La loro regola è durissima. Si affidano alla “Divina Provvidenza”, vivono di elemosina e dedicano la loro vita alla preghiera. Chiara continua, per molti anni, con semplicità e umile sapienza, a guidare le consorelle a lei affidate. Si prodiga anche per la sua città natale. Nel 1240 l’esercito di Federico II di Svevia (odierna Germania), deciso a conquistare Assisi, giunge sotto le sue mura. Chiara, anche se
in pessima salute, chiede di esservi accompagnata tenendo tra le mani l’ostensorio del Santissimo Sacramento, mostrandolo ai nemici che, accecati dalla sua sfolgorante luce, fuggono. Devota di San Francesco, con lui condivide l’amore per la natura e per la bellezza del Creato. Muore l’11 agosto 1253 nella sua città, ventisette anni dopo San Francesco. Invocata per guarire dalle malattie agli occhi, è protettrice di oculisti, ottici, lavandaie, stiratrici, vetrai, ricamatrici. Santa Chiara per i francescani rappresenta la “seconda luce” (la prima luce è San Francesco e la terza è Santa Margherita da Cortona). Nel 1958 viene proclamata patrona della televisione e delle telecomunicazioni per aver seguito “in diretta”, grazie a una visione, sulla parete della sua cella, una veglia di Natale che si svolgeva nella Chiesa di Santa Maria degli Angeli ad Assisi.
Autore: Mariella Lentini
La sera della domenica delle Palme (1211 o 1212) una bella ragazza diciottenne fugge dalla sua casa in Assisi e corre alla Porziuncola, dove l’attendono Francesco e il gruppo dei suoi frati minori. Le fanno indossare un saio da penitente, le tagliano i capelli e poi la ricoverano in due successivi monasteri benedettini, a Bastia e a Sant’Angelo. Infine Chiara prende dimora nel piccolo fabbricato annesso alla chiesa di San Damiano, che era stata restaurata da Francesco. Qui Chiara è stata raggiunta dalla sorella Agnese; poi dall’altra, Beatrice, e da gruppi di ragazze e donne: saranno presto una cinquantina. Così incomincia, sotto la spinta di Francesco d’Assisi, l’avventura di Chiara, figlia di nobili che si oppongono anche con la forza alla sua scelta di vita, ma invano. Anzi, dopo alcuni anni andrà con lei anche sua madre, Ortolana. Chiara però non è fuggita “per andare dalle monache”, ossia per entrare in una comunità nota e stabilita. Affascinata dalla predicazione e dall’esempio di Francesco, la ragazza vuole dare vita a una famiglia di claustrali radicalmente povere, come singole e come monastero, viventi del loro lavoro e di qualche aiuto dei frati minori, immerse nella preghiera per sé e per gli altri, al servizio di tutti, preoccupate per tutti. Chiamate popolarmente “Damianite” e da Francesco “Povere Dame”, saranno poi per sempre note come “Clarisse”. Da Francesco, lei ottiene una prima regola fondata sulla povertà. Francesco consiglia, Francesco ispira sempre, fino alla morte (1226), ma lei è per parte sua una protagonista, anche se sarà faticoso farle accettare l’incarico di abbadessa. In un certo modo essa preannuncia la forte iniziativa femminile che il suo secolo e il successivo vedranno svilupparsi nella Chiesa. Il cardinale Ugolino, vescovo di Ostia e protettore dei Minori, le dà una nuova regola che attenua la povertà, ma lei non accetta sconti: così Ugolino, diventato papa Gregorio IX (1227-41) le concede il “privilegio della povertà”, poi confermato da Innocenzo IV con una solenne bolla del 1253, presentata a Chiara pochi giorni prima della morte. Austerità sempre. Però “non abbiamo un corpo di bronzo, né la nostra è la robustezza del granito”. Così dice una delle lettere (qui in traduzione moderna) ad Agnese di Praga, figlia del re di Boemia, severa badessa di un monastero ispirato all’ideale francescano. Chiara le manda consigli affettuosi ed espliciti: “Ti supplico di moderarti con saggia discrezione nell’austerità quasi esagerata e impossibile, nella quale ho saputo che ti sei avviata”. Agnese dovrebbe vedere come Chiara sa rendere alle consorelle malate i servizi anche più
umili e sgradevoli, senza perdere il sorriso e senza farlo perdere. A soli due anni dalla morte, papa Alessandro IV la proclama santa. Chiara si distinse per il culto verso l’Eucarestia. Per due volte Assisi venne minacciata dall’esercito dell’imperatore Federico II che contava, tra i suoi soldati, anche saraceni. Chiara, in quel tempo malata, fu portata alle mura della città con in mano la pisside contenente il Santissimo Sacramento: i suoi biografi raccontano che l’esercito, a quella vista, si dette alla fuga.
Autore: Domenico Agasso
Magdala, sec. I
La Chiesa latina era solita accomunare nella liturgia le tre distinte donne di cui parla il Vangelo e che la liturgia greca commemora separatamente: Maria di Betania, sorella di Lazzaro e di Marta, la peccatrice «cui molto è stato perdonato perché molto ha amato», e Maria Maddalena o di Magdala, l’ossessa miracolata da Gesù, che ella seguì e assistette con le altre donne fino alla crocifissione ed ebbe il privilegio di vedere risorto. L’identificazione delle tre donne è stata facilitata dal nome Maria comune almeno a due e dalla sentenza di San Gregorio Magno che vide indicata in tutti i passi evangelici una sola e medesima donna. I redattori del nuovo calendario, riconfermando la memoria di una sola Maria Maddalena senz’altra indicazione, come l’aggettivo “penitente”, hanno inteso celebrare la santa donna cui Gesù apparve dopo la Risurrezione. È questa la Maddalena che la Chiesa oggi commemora e che, secondo un’antica tradizione greca, sarebbe andata a vivere a Efeso, dove sarebbe morta. In questa città avevano preso dimora anche Giovanni, l’apostolo prediletto, e Maria, Madre di Gesù. Papa Francesco ha elevato al grado di Festa la sua memoria.
Patronato: Prostitute pentite, Penitenti, Parrucchieri
Etimologia: Maria = amata da Dio, dall’egiziano; signora, dall’ebraico
Emblema: Ampolla d’unguento
Martirologio Romano: Memoria di santa Maria Maddalena, che, liberata dal Signore da sette demòni, divenne sua discepola, seguendolo fino al monte Calvario, e la mattina di Pasqua meritò di vedere per prima il Salvatore risorto dai morti e portare agli altri discepoli l’annuncio della risurrezione.
“Apostola degli apostoli”, si deve a Tommaso d’Aquino il titolo riconosciuto a Maria Maddalena, il cui nome deriva da Magdala, il villaggio di pescatori, di cui era originaria, sulla sponda occidentale del lago Tiberiade. Di lei racconta l’evangelista Luca, nel capitolo 8: Gesù andava per città e villaggi annunciando la buona notizia del regno di Dio e c’erano con lui i Dodici e alcune donne che erano state guarite da spiriti cattivi e da infermità e li servivano con i loro beni. Fra loro vi era “Maria, chiamata Maddalena, dalla quale erano usciti sette demoni”.
Gli equivoci sulla sua identità: non era una prostituta
Come insegna l’esegesi biblica, l’espressione ‘sette demoni’ poteva indicare un gravissimo
male fisico o morale, che aveva colpito la donna e da cui Gesù l’aveva liberata. Ma la tradizione, perdurante sino a oggi, ha fatto di Maria Maddalena una prostituta e questo solo perché nel precedente capitolo 7 del Vangelo di Luca, si narra la storia della conversione di un’anonima “peccatrice nota in quella città”, che aveva cosparso di olio profumato i piedi di Gesù, ospite in casa di un notabile fariseo, li aveva bagnati con le sue lacrime e li aveva asciugati coi suoi capelli”. Così, senza nessun reale collegamento testuale, Maria di Magdala è stata identificata con quella prostituta senza nome. Ma c’è un ulteriore equivoco, spiega il cardinale Ravasi, l’unzione con l’olio profumato è un gesto che è stato compiuto anche da Maria, la sorella di Marta e Lazzaro, in una diversa occasione, di cui riferisce l’evangelista Giovanni. E così, Maria di Magdala da alcune tradizioni popolari verrà identificata proprio con questa Maria di Betania, dopo essere stata confusa con la prostituta di Galilea.
Sotto la croce
Maria Maddalena compare ancora nei Vangeli nel momento più terribile e drammatico della vita di Gesù, quando lo accompagna al Calvario e insieme ad altre donne rimane ad osservarlo da lontano. Ed è presente ancora quando Giuseppe d’Arimatea depone il corpo di Gesù nel sepolcro, che viene chiuso con una pietra. Ed è lei che dopo il sabato, al mattino del primo giorno della settimana torna al sepolcro e scopre che la pietra è stata tolta e corre ad avvisare Pietro e Giovanni, i quali, a loro volta, correranno al sepolcro scoprendo l’assenza del corpo del Signore.
L’incontro con il Risorto
Mentre i due discepoli fanno ritorno a casa, Maria Maddalena rimane, in lacrime. Qui ha inizio un percorso che dall’incredulità si apre progressivamente alla fede. Chinandosi verso il sepolcro scorge due angeli e dice loro di non sapere dove sia stato posto il corpo del Signore. Poi, volgendosi indietro, vede Gesù ma non lo riconosce, pensa sia il custode del giardino e quando Lui le chiede il motivo di quelle lacrime e chi stia cercando, lei risponde: “Signore, se l’hai portato via tu, dimmi dove lo hai posto e io andrò a prenderlo”. Gesù allora la chiama per nome: “Maria!” E lei voltandosi risponde: “Rabbunì!”, che in ebraico significa: “Maestro!”.
Gesù le consegna quindi una missione: “Non mi trattenere, perché non sono ancora salito al Padre; ma va’ dai miei fratelli e di loro: Io salgo al Padre mio e Padre vostro, Dio mio e Dio vostro”. Maria di Magdala andò quindi ad annunziare ai discepoli: “Ho visto il Signore! e anche ciò che le aveva detto” (cf. Gv 20).
È lei che proclama Gesù come Colui che ha vinto la morte
Maria Maddalena è la prima fra le donne al seguito di Gesù a proclamarlo come Colui che ha vinto la morte, la prima apostola ad annunciare il gioioso messaggio centrale della Pasqua. Quando il Figlio di Dio entra nella storia, questa donna è fra coloro che maggiormente lo amarono, dimostrandolo. Quando giunse il tempo del Calvario, Maria Maddalena era insieme a Maria Santissima e a San Giovanni, sotto la Croce. Non fug-
gì per paura come fecero i discepoli, non lo rinnegò per paura come fece il primo Papa, ma rimase presente ogni ora, dal momento della sua conversione, fino al Santo Sepolcro.
Per volontà di Papa Francesco, la memoria obbligatoria di Maria Maddalena, è stata elevata al grado di Festa, il 22 luglio 2016, per significare la rilevanza di questa fedele discepola di Cristo.
Fonte: Vatican News
Il 3 giugno 2016 la Congregazione per il Culto Divino ha pubblicato un decreto con il quale, «per espresso desiderio di papa Francesco», la celebrazione di santa Maria Maddalena, che era memoria obbligatoria, viene elevata al grado di festa. Il Papa ha preso questa decisione «per significare la rilevanza di questa donna che mostrò un grande amore a Cristo e fu da Cristo tanto amata», ha spiegato il segretario del Dicastero, l’arcivescovo Arthur Roche. Ma chi era Maria Maddalena, che Tommaso d’Aquino definì «apostola degli apostoli»?
Magdala
Nei Vangeli si legge che era originaria di Magdala, villaggio di pescatori sulla sponda occidentale del lago di Tiberiade, centro commerciale ittico denominato in greco Tarichea (Pesce salato). Qui, negli anni Settanta del Novecento è stata condotta un’estesa campagna di scavi dai francescani dello Studium Biblicum Franciscanum di Gerusalemme: è venuta alla luce una vasta porzione del tessuto urbano comprendente, fra gli altri, una grande piazza a quadriportico, una villa mosaicata e un completo complesso termale. Con successivi scavi i francescani hanno riportato alla luce anche importanti resti di strutture portuali. In un’area adiacente, di proprietà dei Legionari di Cristo, una campagna di scavi avviata nel 2009 ha invece permesso di rinvenire la sinagoga cittadina, una delle più antiche scoperte in Israele: per la sua posizione, sulla strada che collega Nazaret e Cafarnao, si ritiene che probabilmente sia stata frequentata da Gesù.
Maria Maddalena fa la sua comparsa nel capitolo 8 del Vangelo di Luca: Gesù andava per città e villaggi annunciando la buona notizia del regno di Dio e c’erano con lui i Dodici e alcune donne che erano state guarite da spiriti cattivi e da infermità e li servivano con i loro beni. Fra loro vi era «Maria, chiamata Maddalena, dalla quale erano usciti sette demoni». Come ha scritto il cardinale Gianfranco Ravasi, «di per sé, l’espressione [sette demoni] poteva indicare un gravissimo (sette è il numero della pienezza) male fisico o morale che aveva colpito la donna e da cui Gesù l’aveva liberata. Ma la tradizione, perdurante sino a oggi, ha fatto di Maria una prostituta e questo solo perché nella pagina evangelica precedente – il capitolo 7 di Luca – si narra la storia della conversione di un’anonima “peccatrice nota in quella città”, che aveva cosparso di olio profumato i piedi di Gesù, ospite in casa di un notabile fariseo, li aveva bagnati con le sue lacrime e li aveva asciugati coi suoi capelli». Così, senza nessun
reale collegamento testuale, Maria di Magdala è stata identificata con quella prostituta senza nome. Ma c’è un ulteriore equivoco: infatti, prosegue Ravasi, l’unzione con l’olio profumato è un gesto che è stato compiuto anche da Maria, la sorella di Marta e Lazzaro, in una diversa occasione (Gv 12,1-8). E così, Maria di Magdala «da alcune tradizioni popolari verrà identificata proprio con questa Maria di Betania, dopo essere stata confusa con la prostituta di Galilea».
La liberazione dal male
Afflitta da un gravissimo male, di cui si ignora la natura, Maria Maddalena appartiene dunque a quel popolo di uomini, donne e bambini in molti modi feriti che Gesù sottrae alla disperazione restituendoli alla vita e ai loro affetti più cari. Gesù, nel nome di Dio, compie solo gesti di liberazione dal male e di riscatto della speranza perduta. Il desiderio umano di una vita buona e felice è giusto e appartiene all’intenzione di Dio, che è Dio della cura, mai complice del male, anche se l’uomo (fuori e dentro la religione) ha sempre la tentazione di immaginarlo come un prevaricatore dalle intenzioni indecifrabili.
Sotto la croce
Maria Maddalena compare ancora nei Vangeli nel momento più terribile e drammatico della vita di Gesù. Nel suo attaccamento fedele e tenace al Maestro Lo accompagna sino al Calvario e rimane, insieme ad altre donne, ad osservarlo da lontano. È poi presente quando Giuseppe d’Arimatea depone il corpo di Gesù nel sepolcro, che viene chiuso con una pietra. Dopo il sabato, al mattino del primo giorno della settimana – si legge al capitolo 20 del Vangelo di Giovanni – torna al sepolcro: scopre che la pietra è stata tolta e corre ad avvisare Pietro e Giovanni, i quali, a loro volta, correranno al sepolcro scoprendo l’assenza del corpo del Signore.
L’incontro con il Risorto
Mentre i due discepoli fanno ritorno a casa, lei rimane, in lacrime. E ha inizio un percorso che dall’incredulità si apre progressivamente alla fede. Chinandosi verso il sepolcro scorge due angeli e dice loro di non sapere dove sia stato posto il corpo del Signore. Poi, volgendosi indietro, vede Gesù ma non lo riconosce, pensa sia il custode del giardino e quando Lui le chiede il motivo di quelle lacrime e chi stia cercando, lei risponde: «“Signore, se l’hai portato via tu, dimmi dove lo hai posto e io andrò a prenderlo”. Gesù le disse: “Maria!”» (Gv 20,15-16). Il cardinale Carlo Maria Martini al riguardo commentava: «Avremmo potuto immaginare altri modi di presentarsi. Gesù sceglie il modo più personale e il più immediato: l’appellazione per nome. Di per sé non dice niente perché “Maria” può pronunciarlo chiunque e non spiega la risurrezione e nemmeno il fatto che è il Signore a chiamarla. Tutti però comprendiamo che quell’appellazione, in quel momento, in quella situazione, con quella voce, con quel tono, è il modo più personale di rivelazione e che non riguarda solo Gesù, ma Gesù nel suo rapporto con lei. Egli si rivela come il suo Signore, colui che lei cerca». Il dialogo al sepolcro prosegue: Maria Maddalena, «si voltò e gli disse in ebraico: “Rabbunì!”, che significa: “Maestro!”. Gesù le disse: “Non mi trattenere, perché non sono ancora salito al Padre; ma va’ dai miei fratelli e di’ loro: Io salgo al Padre mio e Padre vostro, Dio mio e Dio
vostro”. Maria di Magdala andò ad annunziare ai discepoli: “Ho visto il Signore!” e anche ciò che le aveva detto» (Gv 20, 16-18).
«La Maddalena è la prima fra le donne al seguito di Gesù a proclamarlo come Colui che ha vinto la morte, la prima apostola ad annunciare il gioioso messaggio centrale della Pasqua», osserva la teologa Cristiana Dobner, carmelitana scalza. «Ella esprime la maternità nella fede e della fede ossia quella attitudine a generare vita vera, una vita da figli di Dio, nella quale il travaglio esistenziale comune ad ogni uomo trova il suo destino nella risurrezione e nell’eternità promesse e inaugurate dal Figlio, «primogenito» di molti fratelli (Rom 8,29). Con Maria Maddalena si apre quella lunga schiera, ancor oggi poco conosciuta, di madri che, lungo i secoli, si sono consegnate alla generazione di figli di Dio e si possono affiancare ai padri della Chiesa: insieme alla Patristica esiste anche, nascosta ma presente, una Matristica. La decisione di Francesco è un dono bello, espressione di una rivoluzione antropologica che tocca la donna e investe l’intera realtà ecclesiale. L’istituzione di questa festa, infatti, non va letta come una rivincita muliebre: si cadrebbe stolidamente nella mentalità delle quote rosa. Il significato è ben altro: comprendere che uomo e donna insieme e solo insieme, in una dualità incarnata, possono diventare annunciatori luminosi del Risorto».
Nella storia dell’arte: la mirofora
Maria Maddalena, nel corso dei secoli, è stata raffigurata principalmente in quattro modi: «Anzitutto – afferma monsignor Timothy Verdon, docente di storia dell’arte alla Stanford University e direttore del Museo dell’Opera del Duomo di Firenze – è spesso ritratta come una delle mirofore, le pie donne che la mattina di Pasqua si recarono al sepolcro portando gli unguenti per il corpo del Signore. Fra loro la Maddalena è riconoscibile per il fatto che, a partire dalla fine del Medioevo, viene raffigurata con lunghi capelli sciolti, spesso biondi: questo fa capire che gli artisti, secondo una tradizione affermatasi in Occidente (e non condivisa nell’Oriente cristiano), la identificavano con la donna peccatrice che aveva asciugato i piedi di Gesù con i propri capelli. I capelli lunghi sono quindi un’allusione a questo intimo contatto e alla condizione di prostituta: le donne per bene non andavano in giro con i capelli sciolti».
La penitente
Nell’arte del tardo Medioevo Maria Maddalena compare anche come penitente perché – spiega Verdon – secondo una leggenda ella era una grande peccatrice che, dopo la conversione e l’incontro con il Risorto, era andata a vivere come romitessa nel sud della Francia, vicino a Marsiglia, dove annunciava il vangelo: «Il culto della Maddalena penitente ha affascinato molti artisti, che l’hanno considerata il corrispettivo femminile di Giovanni Battista. In genere viene raffigurata con abiti simili a quelli del Battista oppure è coperta solo dai capelli. La bellezza esteriore l’ha abbandonata, il volto è segnato dai digiuni e dalle veglie notturne in preghiera, ma è illuminata dalla bellezza interiore perché ha trovato pace e gioia nel Signore. La statua della Maddalena penitente di Donatello, scolpita per il Battistero di Firenze, è un autentico capolavoro».
L’addolorata
Sovente la Maddalena è ritratta anche ai piedi della croce: una delle opere più significative, a giudizio di Verdon, è un piccolo pannello di Masaccio (esposto a Napoli) nel quale la Maddalena è ritratta di spalle, sotto la croce, le braccia protese a Cristo, i lunghi capelli biondi che cadono quasi a ventaglio su un enorme mantello rosso: «Un’immagine di forte drammaticità. Non di rado il dolore composto della Vergine è stato contrapposto a quello della Maddalena, quasi senza controllo. Si pensi ad esempio, alla Pietà di Tiziano, nella quale la donna avanza come volesse chiamare il mondo intero a riconoscere l’ingiustizia della morte di Gesù, che giace fra le braccia di Maria; oppure si pensi al celebre gruppo scultoreo di Niccolò dell’Arca, nel quale fra le molte figure la più teatrale è proprio quella della Maddalena che si precipita con la forza di un uragano verso il Cristo morto».
Chiamata per nome
Vi sono inoltre molte raffigurazioni dell’incontro con il Risorto: «Esemplari e magnifiche sono quelle di Giotto, nella Cappella degli Scrovegni, e del Beato Angelico nel convento di san Marco», conclude Verdon. «Maria Maddalena ha vissuto un’esperienza di salvezza profonda per opera di Gesù: quando si sente chiamata per nome in lei si accende il ricordo dell’intera storia vissuta con Lui: c’è tutto questo nell’iconografia della scena che chiamiamo “Noli me tangere”».
Autore: Cristina Uguccioni
«Non toccarmi!»
“Noli me tangere”… Maddalena (Gv 20,11-18)
La chiave di lettura di questa pericope è l’amore. Maddalena è tra coloro che amano di più il Maestro: è presente al Calvario, perché non fugge per la paura come fanno gli altri apostoli; è la prima a recarsi al sepolcro all’alba, quando intorno ci sono ancora le tenebre, corre in fretta ad annunciare che il sepolcro è vuoto…
Tutto è avvolto nel dubbio, nella paura, nell’incertezza, nell’incapacità di comprendere … È sempre la donna ad esserci quando c’è il dolore, è così per sua costituzione fisica, mentale, spirituale… è capace di affrontare e sopportare il dolore, di guardarlo in viso.
La fede di Maddalena è ancora agli albori, procede a tentoni. È “il primo giorno” della settimana, quello nel quale la Chiesa si riunirà per spezzare il pane e fare memoria. La Bibbia parla di “primo giorno” nella creazione, quando Dio crea la luce. Maddalena sta cercando il suo Signore, va (perché per trovare il Signore occorre cercarlo) ma non lo trova nel sepolcro (che indica la fine di tutto!). Trova che il masso è stato tolto, il corpo non è più al suo posto, vede la pietra ribaltata, è uno sguardo con gli occhi del corpo, vede ma non comprende. Quel masso rappresenta il peso del nostro peccato, la pietra tombale significa fine, morte definitiva. Ma la pietra è stata rimossa, qualcosa è cambiato, dov’è Lui? La liturgia, in riferimento a lei, richiama le parole del Cantico dei Cantici:” Cercherò colui che amo con tutta l’anima… L’ho cercato, ma non l’ho trovato”… Il sole sta nascendo, i suoi occhi sono pieni di pianto, appannati dalle lacrime e da quella luce che la acceca.
Maddalena cerca con ostinazione, è ansiosa, inquieta, si accontenterebbe di sapere dove lo hanno portato. Guarda verso il sepolcro ormai vuoto, che ora rappresenta il passato:” Rivive nel passato la sua vita, la rilegge, fa un’anamnesi”… Scorge qualcuno, forse il custode del giardino… Quando il Signore la chiama per nome, si volge verso di Lui e tutto cambia. Lo riconosce e si sente a sua volta riconosciuta nella pienezza.
“Conoscere” nella Bibbia ha un significato di conoscenza piena, totale, anche fisica. Maddalena vorrebbe toccarlo, ascoltarlo, adorarlo, restare con Lui… Ma il maestro le dice:” Non mi trattenere”, c’è ancora qualcosa di molto importante da compiere: deve salire al Padre! Intanto però, Gesù le dimostra la sua predilezione, la premia per il suo amore ostinato, la ama così tanto da renderla apostola degli apostoli. La invia a portare l’annuncio: proprio lei, una donna! E Maddalena corre ad aprire sentieri di speranza. Ella rappresenta l’Umanità intera alla ricerca del Salvatore, c’è in lei tutta la ricerca umana di una società afflitta e smarrita. Lo vede, non lo riconosce, ma tutto cambia quando la chiama per nome. L’incontro col Signore è assolutamente intimo e personale. È così per ciascuno di noi, ma occorre cercarlo con ostinazione e Lui si farà trovare e conoscere. In lei tutti noi siamo rappresentati. Maddalena porterà l’annuncio. Pietro e Giovanni correranno insieme al sepolcro. Giovanni ( il più giovane, il prediletto, che vede con gli occhi del cuore) arriverà per primo, ma si fermerà alla soglia del Mistero, lascerà che entri Pietro (l’istituzione) a constatare con più prudenza, attenzione, riflessione. Poi entrerà Giovanni. Ora entrambi vedono con gli occhi della fede, entrambi, insieme, cercano di capire.
La Chiesa è ai primi albori, la fede non è un fatto privato (di Maddalena, di Pietro, di Giovanni…) c’è un cammino comune da condividere. Maddalena è detta nel culto orientale “la mirofora” cioè colei che portò al sepolcro la mirra per l’unzione. Umberto de Romans afferma:”
Dopo la Vergine Maria, non si trova donna alla quale sia data maggior gloria”. San Gregorio Magno la definisce: ”Testis divinae Misericordiae”. Maddalena è esempio e modello di ogni donna nella Chiesa.
Chi è Maddalena
Sarebbe bello poter chiedere a Maddalena:” Come cercavi tu il Signore?” “Come lo hai conosciuto?” “Come lo hai proclamato?”
Per secoli si è fatta una gran confusione tra Maria Maddalena, Maria di Betania, la prostituta… identificando queste ultime col personaggio di Maddalena. In realtà sono “diverse Marie”. Maddalena è stata guarita da sette demoni, non sappiamo quali fossero; forse nel numero sette si vuole indicare tutta una serie di situazioni pericolose, gravi… quello che conta è ciò che segue nella vita e nel cuore di questa donna. C’è una liberazione che innesca una serie di sentimenti: amore, affetto, riconoscenza, tenerezza, desiderio di seguire il maestro, di servirlo, di ascoltarlo, di stargli vicino. Non dobbiamo però fraintendere queste affermazioni. Maddalena non vuole legarlo a sé in modo possessivo e morboso, ella Lo ama con viscere materne, come un figlio prediletto, un maestro, un Messia da annunciare. Del resto nessuna donna dei Vangeli che incontra Gesù, è spinta da impulsi possessivi e morbosi, perché tutte lo amano con un tratto tipicamente femminile. La donna è per sua stessa natura fatta per il dono della vita, non può
ripiegarsi su sé stessa. Nel Vangelo si dice che la predicazione di Gesù attrae donne facoltose che lo seguono con i loro beni; tra queste c’è Maddalena che è stata liberata da sette demoni. Il card. Martini afferma che il gruppo delle donne che seguiva Gesù (Lc. 8) si rivelava come depositario della parte di Dio che è “traboccante” “esagerata” “capace di uscire da sé” perché proprio così è l’amore femminile: è straripante, ti inonda, ti sommerge… Il cardinale ci invita a ripercorrere i Vangeli con Maddalena, per imparare da lei la dedizione, la capacità di promuovere l’altro.
Maddalena negli apocrifi
In certi trattati gnostici è Maddalena a guidare il dialogo e a porre domande a Gesù. Sarà da Lui lodata come “Tu, beata pienezza!” Questa ammirazione del Maestro susciterà il biasimo e la gelosia di Pietro per questa donna. Col tempo la misoginia prese sempre più il sopravvento. Nel Vangelo apocrifo di Tommaso troviamo Pietro che attacca Maddalena. Gesù osserva: ”La guiderò fino a farne un maschio!” Affermazione che richiede una riflessione sulle convinzioni del tempo: allora, infatti, si pensava che le donne fossero “uomini imperfetti”, un gradino al di sotto degli uomini, occorreva dunque promuoverle al grado superiore di maschi! Gesù afferma che, tramite il Suo insegnamento, la renderà identica all’uomo. Nel Vangelo apocrifo di Filippo, scritto in lingua copta, tre persone camminavano sempre con Gesù: Maria sua madre, la sorella di sua madre e Maddalena e annota: Maria si chiamavano tanto sua madre, che la sorella di sua madre, che la compagna di Lui. Gesù amava Maddalena e la baciava spesso! Ella aveva col Signore un rapporto di intimità. Di bacio santo nelle assemblee parla anche san Paolo; il bacio è dunque un simbolo del fatto che a Maddalena è stata rivelata la Verità. Pietro la ritiene prediletta da Gesù non certo sul piano sessuale, ma su quello spirituale (e ne è geloso!).
Possiamo chiederci con Marinella Perroni: ”A cosa si deve l’amnesia che ha portato al susseguirsi di infinite leggende che, pur conservando il ricordo di Maria di Magdala lo hanno alterato e reso insignificante?” Qualche studioso afferma che fu lei e non Pietro a fondare il Cristianesimo.
Il ruolo di Maddalena fu sminuito dagli uomini del tempo che avevano posizioni autorevoli; Pietro e Paolo prevalsero! La fama di Maddalena perdurò intatta nell’ambiente gnostico.
La figura di questa donna del Vangelo è tra le figure più controverse ed enigmatiche, è portatrice delle prime scintille di emancipazione ed eguaglianza tra i sessi. Possiamo dire che Maria di Magdala “racchiude in sé la sintesi della cristologia giovannea”. Papa Giovanni Paolo II e Papa Francesco hanno riproposto nella Chiesa cattolica la figura della Maddalena che il Vangelo ci offre: discepola, testimone, partecipe e collaboratrice nell’evangelizzazione con i 12, “apostola della nuova e più grande speranza”.
Autore: Maria Adelaide Petrillo
Chiara proveniva da una famiglia nobile. A dodici anni conosce San Francesco d’Assisi, e affascinata dai suoi modi, sette anni dopo scappa da casa per unirsi a Francesco e ai suoi seguaci.
Francesco le taglia i capelli e le fa indossare il saio, portandola al monastero di S. Paolo, dove il padre tenta senza successo di riportarla a casa.
Successivamente Chiara fonda l’Ordine delle “povere recluse”, oggi “Clarisse” e scrive la Regola definitiva.
È scelta da papa Pio XII come protettrice della televisione e si distingue per il suo amore verso il SS. Sacramento.
Nel testo sono evidenziate delle parole. Cercale nella tabella sotto e con le lettere che restano scopri la parola chiave di Chiara.
Soluzione:
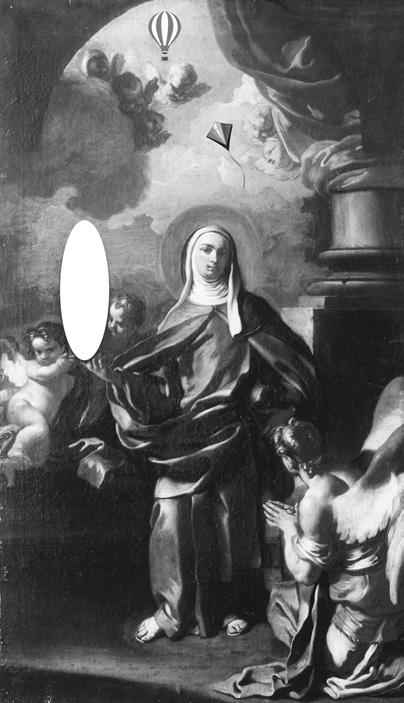
Attività 1
Nell’opera ci sono degli intrusi, cercali e mettici una X sopra.
Attività 2
Nell’opera manca uno dei particolari, quale? Cercalo e scopri il suo nome con l’aiuto dell’insegnante. Poi prova tu a disegnarlo.
Attività 3
Dopo aver ascoltato la storia del santo e/o visto un video a lui dedicato, racconta quale è stato l’episodio che ti ha colpito di più, poi prova a disegnarlo tu.
San Tommaso d’Aquino, un grande dottore della Chiesa, ha dato a Maria Maddalena il titolo di “Apostola degli apostoli”.
Il nome Maddalena deriva da Magdala, il villaggio di pescatori, di cui era originaria, sulla sponda occidentale del lago Tiberiade.
Di lei racconta Luca nel suo Vangelo, al capitolo 8 quando scrive così: “Gesù andava per città e villaggi annunciando la buona notizia del regno di Dio e c’erano con lui i Dodici e alcune donne che erano state guarite da spiriti cattivi e da infermità e li servivano con i loro beni. Fra loro vi era Maria, chiamata Maddalena, dalla quale erano usciti sette demoni”. La Chiesa oggi onora Maria Maddalena come figura importante nella fede cristiana.
Nel testo sono evidenziate delle parole. Cercale nella tabella sotto e con le lettere che restano scopri la parola chiave di Maria Maddalena.
Soluzione:
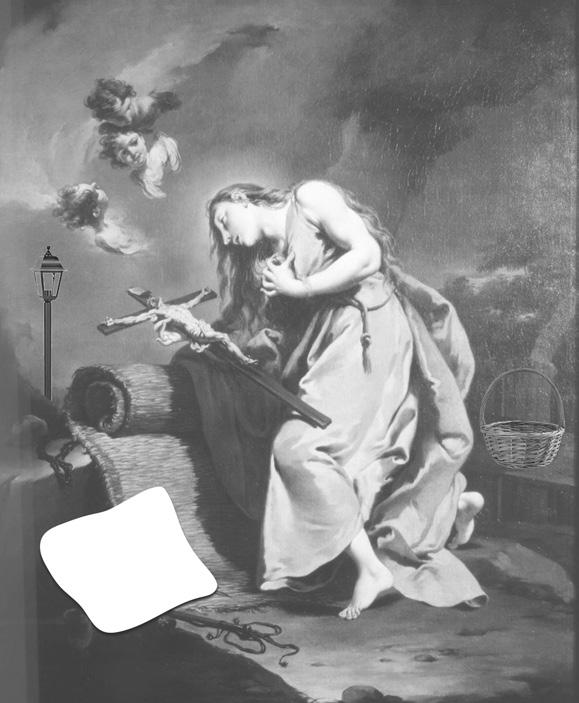
Attività 1
Nell’opera ci sono degli intrusi, cercali e mettici una X sopra.
Attività 2
Nell’opera manca uno dei particolari, quale? Cercalo e scopri il suo nome con l’aiuto dell’insegnante. Poi prova tu a disegnarlo.
Attività 3
Dopo aver ascoltato la storia del santo e/o visto un video a lui dedicato, racconta quale è stato l’episodio che ti ha colpito di più, poi prova a disegnarlo tu.

Programmazione didattica annuale per unità di apprendimento
Periodo: settembre
Traguardi per lo Sviluppo delle Compe T enze
L’alunno
• riflette su Dio Creatore.
bie TT ivi di a pprendimen T o
I valori etici e religiosi
• Scoprire la bellezza dello stare insieme e sviluppare sentimenti di rispetto e fiducia verso gli altri.
Periodo: ottobre-novembre
L’alunno partecipa alla discussione del gruppo classe in modo adeguato e pertinente, rispettando il proprio turno di parola.
Traguardi per lo Sviluppo delle Compe T enze o bie TT ivi di a pprendimen T o
L’alunno
• riflette su Dio Creatore del mondo e della vita e lo riconosce Padre di ogni uomo;
• scopre che da sempre l’uomo cerca una risposta ai perché della vita.
Dio e l’uomo
• Riflettere sulla dimensione religiosa dell’uomo.
• riflettere sulla dimensione spirituale dell’uomo a partire dai suoi bisogni..
La Bibbia e le altre fonti
• saper confrontare le ipotesi storicoscientifiche con quella biblica.
L’alunno comprende che fin dalla preistoria gli uomini hanno cercato un contatto con la divinità e riconosce in Dio il creatore dell’universo; riconosce che la religione e la scienza non sono in contrapposizione, ma rispondono a domande differenti.
• Prerequisiti
• Ricordo giocando
• Il tempo… non ha prezzo
• Vorrei avere più tempo per…
• La linea del tempo
• Il senso religioso
• Le domande dell’uomo
• Dalle origini ai miti
• La risposta della scienza: la teoria del Big Bang
• La risposta della Bibbia: la storia della Creazione
• La ricerca della verità
• Alla ricerca di Dio
Programmazione didattica annuale per unità di apprendimento
Periodo: dicembre-gennaio-febbraio
Traguardi per lo Sviluppo delle Compe T enze
L’alunno
• riconosce che la Bibbia è il libro sacro per cristiani ed ebrei e documento fondamentale della nostra cultura, sapendola distinguere da altre tipologie di testi;
• identifica le caratteristiche essenziali di un brano biblico e sa farsi accompagnare nell’analisi di alcune pagine a lui più accessibili, per collegarle alla propria esperienza.
Dio e l’uomo
• Scoprire che per la religione cristiana
Dio è Creatore e Padre e che fin dalle origini ha voluto stabilire un’alleanza con l’uomo.
La Bibbia e le altre fonti
• Ascoltare, leggere e saper riferire circa alcune semplici storie bibliche.
L’alunno
riconosce in Dio il creatore dell’universo e coglie l’importanza del testo biblico, conoscendone la suddivisione e la sua composizione; conosce la particolarità di un territorio ed entra in contatto con i popoli che lo abitavano; riconosce l’importanza del patto di alleanza tra Dio e il suo popolo.
• Dal senso religioso alla religione
• La mezzaluna fertile
• Un popolo eletto
• La Bibbia: un album di famiglia
• La Bibbia cristiana: Antico e Nuovo Testamento
• Sant’Ambrogio
• La nascita della Bibbia
• La prima Bibbia stampata: Gutenberg
• La Bibbia ebraica
• I testi sacri delle grandi religioni
• La chiamata di Abramo
• La nascita dei popoli arabi
• Dio mette alla prova Abramo
• La storia di Abramo
Programmazione didattica annuale
per unità di apprendimento
Periodo: settembre-ottobre
Traguardi per lo Sviluppo delle Compe T enze
L’alunno
• riconosce che la Bibbia è il libro sacro per cristiani ed ebrei e documento fondamentale della nostra cultura, sapendola distinguere da altre tipologie di testi;
• identifica le caratteristiche essenziali di un brano biblico e sa farsi accompagnare nell’analisi di alcune pagine a lui più accessibili, per collegarle alla propria esperienza.
Dio e l’uomo
• Scoprire che per la religione cristiana Dio è Creatore e Padre e che fin dalle origini ha voluto stabilire un’alleanza con l’uomo.
La Bibbia e le altre fonti
• Ricostruire le principali tappe della Storia della Salvezza.
• Ascoltare, leggere e saper riferire circa alcune semplici storie bibliche.
I valori etici e religiosi
• Riconoscere il valore delle regole nella vita sociale delle persone.
L’alunno
riconosce i patriarchi come figure significative e fondamentali per la storia del popolo ebraico.
• I grandi patriarchi del popolo ebraico
• Esaù e Giacobbe
• Le dodici tribù d’Israele
• Giuseppe, il re dei sogni
• La storia di Giuseppe
• Mosè, “salvato dalle acque”
• Mosè contro il faraone
• Le dieci piaghe d’Egitto
• Un “passaggio” verso la libertà
• La Pasqua ebraica
Periodo: aprile-maggio
Traguardi per lo Sviluppo delle Compe T enze
L’alunno
• riconosce che la Bibbia è il libro sacro per cristiani ed ebrei e documento fondamentale della nostra cultura, sapendola distinguere da altre tipologie di testi;
• identifica le caratteristiche essenziali di un brano biblico e sa farsi accompagnare nell’analisi di alcune pagine a lui più accessibili, per collegarle alla propria esperienza.
Programmazione didattica annuale per unità di apprendimento
Dio e l’uomo
• Scoprire che per la religione cristiana
Dio è Creatore e Padre e che fin dalle origini ha voluto stabilire un’alleanza con l’uomo.
La Bibbia e le altre fonti
• Ricostruire le principali tappe della Storia della Salvezza.
• Ascoltare, leggere e saper riferire circa alcune semplici storie bibliche.
I valori etici e religiosi
• Riconoscere il valore delle regole nella vita sociale delle persone.
L’alunno
riconosce i patriarchi come figure significative e fondamentali per la storia del popolo ebraico.
• Un patto di amicizia
• Le tavole della Legge
• Il Giubileo
• Un viaggio lungo e faticoso
• La storia di Mosè
• L’Esodo e la guida dei Giudici
• I re d’Israele:
• Saul
• Davide
• Salomone
• Il tempio di Gerusalemme
Programmazione didattica annuale per unità di apprendimento
Periodo: dicembre-giugno
Traguardi per lo Sviluppo delle Compe T enze o
L’alunno
• sa spiegare, collegandolo al contesto in cui vive, il significato cristiano della Pasqua;
• riflette sui dati fondamentali della vita di Gesù e sa collegare i contenuti principali dei suoi insegnamenti alle tradizioni dell’ambiente in cui vive.
La Bibbia e le altre fonti
• Ascoltare, leggere e saper riferire circa alcune semplici storie bibliche e circa gli episodi chiave dei racconti evangelici.
• Conoscere l’ambiente di Gesù e il suo tempo.
Il linguaggio religioso
• Riconoscere i segni cristiani del Natale e della Pasqua nell’ambiente, nelle celebrazioni e nella tradizione popolare.
• Conoscere i termini che esprimono la Pasqua e saper distinguere il diverso significato che assume per ebrei e cristiani.
• Individuare negli eventi pasquali il valore della pace e della speranza per tutti gli uomini.
L’alunno
conosce la differenza tra la Pasqua ebraica e la Pasqua cristiana, cogliendone i rispettivi significati.
• I profeti
• Dai profeti a Gesù
• Santa Madre Teresa di Calcutta
• San Giovanni Paolo II
• Il Natale
• Un grande annuncio di… Amore
• Un Amore che dona la vita
• Dalla Pasqua ebraica alla Pasqua cristiana
Programmazione didattica annuale per unità di apprendimento
Obiettivi minimi
• Scoprire che tutto ha un'origine e un’evoluzione.
• Scoprire che per i cristiani Dio ha creato il mondo per amore.
• Scoprire la Bibbia, libro sacro per i cristiani.
• Conoscere i miti biblici dell'Antico Testamento.
• Conoscere la storia dei Patriarchi.
• Conoscere il significato della Pasqua ebraica e cristiana.
• Riconoscere il valore della fede in Dio.
• Riconoscere la preghiera come dialogo tra l’uomo e Dio.
Competenze finali
L’alunno…
• riconosce che la dimensione religiosa è connaturale all’uomo perché presente fin dalle origini della vita umana, come documentato dalla ricerca storico-scientifica. Riguardo al tema dell’origine dell’universo e della vita, matura consapevolezza che vi sono orizzonti esplicativi diversi, rispetto ai quali può confrontarsi senza escluderne nessuno. Comprende, altresì, che all’origine delle religioni ebraica e cristiana vi è il vissuto concreto di un popolo che ha determinato modi di vivere e pensare di milioni di persone nel corso della storia, come nel mondo di oggi. Mostra rispetto ed apprezzamento per il vissuto di fede dei credenti di altre religioni riconoscendolo ugualmente fondato su dei testi considerati sacri.
Metodologia
• Lezione interattiva.
• Lavoro individuale.
• Lavoro di gruppo.
• Conversazioni guidate.
Materiali Spazi
• Libro di testo.
• Allegati al testo.
• Quaderni.
• Schede e immagini.
• Disegni.
• Materiale audiovisivo.
• Aula.
• Aula informatica.
• Biblioteca.
• LIM.
Discipline coinvolte: Italiano, Arte e immagine, Inglese, Matematica, Musica, Storia
Verifica e valutazione (degli obiettivi e delle competenze)
• Compiti di realtà su obiettivi relativi a uno o più traguardi.
• La prova sarà valutata in base ai livelli definiti dalla rubrica valutativa del curricolo verticale.
• Osservazione sistematica dei progressi nel processo di apprendimento.
• Per gli alunni alloglotti, con H, con DSA, con scheda BES, si fa riferimento ai documenti appositamente predisposti.
• La valutazione terrà conto dei livelli di partenza e dei progressi compiuti, nonché dell’impegno e del grado di maturazione.
Programmazione didattica annuale
per unità di apprendimento
l percorso della classe terza accompagna i bambini nella conoscenza della Bibbia, in particolare dell’Antico Testamento.
Nel corso dell’anno scolastico gli alunni saranno guidati alla scoperta di alcuni personaggi e fatti legati alla storia del popolo ebraico.
Le sei unità di apprendimento affrontano in ordine:
1. Si ricomincia, continua il percorso attraverso i valori di condivisione e unità, per vivere un nuovo momento di crescita;
2. Le grandi domande, il tema delle grandi domande che l’uomo si pone da sempre, in particolare sulle origini del mondo;
3. Un popolo eletto, una breve presentazione della Bibbia e la scelta da parte di Dio del popolo ebraico;
4. Una grande alleanza, la storia degli ebrei, da Abramo a Mosè;
5. Gesù di Nazaret, un breve ripasso, arricchito di piccoli particolari, sui principali avvenimenti della vita di Gesù.
Competenze in Chiave Europee
• Alfabetica funzionale.
• Personale, sociale e capacità di imparare a imparare.
• Multilinguistica.
• Matematica e competenza in scienze, tecnologia e ingegneria.
• Consapevolezza ed espressione culturali.
• Cittadinanza.
Metodologia, spazi e materiali
• Lezione interattiva.
• Lavoro individuale e di gruppo.
• Conversazioni guidate.
• Libro di testo e allegati.
• Quaderni.
• Schede, disegni e immagini.
• Materiale audiovisivo.
• Aula (classica, LIM, informatica).
Verifica e valutazione
• Compiti di realtà su obiettivi relativi a uno o più traguardi.
• La prova sarà valutata in base ai livelli definiti dalla rubrica valutativa del curricolo verticale.
• Osservazione sistematica dei progressi nel processo di apprendimento.
• Per gli alunni alloglotti, con H, con DSA, con scheda BES, si fa riferimento ai documenti appositamente predisposti.
• La valutazione terrà conto dei livelli di partenza e dei progressi compiuti, nonché dell’impegno e del grado di maturazione.
Saranno coinvolte le seguenti discipline:
Educazione Civica, Italiano, Arte e immagine, Inglese, Matematica, Musica, Storia, Scienze.
programmazione didaTTiCa annuale
per unità di apprendimento
Traguardi per lo Sviluppo delle Competenze
L’alunno…
• riflette su Dio Creatore del mondo e della vita e lo riconosce Padre di ogni uomo;
• scopre che da sempre l’uomo cerca una risposta ai perché della vita;
• riconosce che la Bibbia è il libro sacro per cristiani ed ebrei e documento fondamentale della nostra cultura, sapendola distinguere da altre tipologie di testi;
• identifica le caratteristiche essenziali di un brano biblico e sa farsi accompagnare nell’analisi di alcune pagine a lui più accessibili, per collegarle alla propria esperienza;
• sa spiegare, collegandolo al contesto in cui vive, il significato cristiano del Natale e della Pasqua;
• riflette sui dati fondamentali della vita di Gesù e sa collegare i contenuti principali dei suoi insegnamenti alle tradizioni dell’ambiente in cui vive;
• si confronta con l’esperienza religiosa e distingue la specificità della proposta del cristianesimo.
di Apprendimento
• Riflettere sulla dimensione religiosa dell’uomo;
• riflettere sulla dimensione spirituale dell’uomo a partire dai suoi bisogni.
• Scoprire che per la religione cristiana Dio è Creatore e Padre e che fin dalle origini ha voluto stabilire un’alleanza con l’uomo.
• saper confrontare le ipotesi storicoscientifiche con quella biblica.
• Ricostruire le principali tappe della Storia della Salvezza.
• Ascoltare, leggere e saper riferire circa alcune semplici storie bibliche e circa gli episodi chiave dei racconti evangelici.
• Conoscere l’ambiente di Gesù e il suo tempo.
• Riconoscere i segni cristiani del Natale nell’ambiente, nelle celebrazioni e nella tradizione popolare.
• Riflettere sul vero significato del Natale e sui valori legati a questa festa.
• Conoscere i termini che esprimono la Pasqua e saper distinguere il diverso significato che assume per ebrei e cristiani.
• Individuare negli eventi pasquali il valore della pace e della speranza per tutti gli uomini.
• Riconoscere il valore delle regole nella vita sociale delle persone.
Programmazione didattica annuale
per unità di apprendimento
Con T enu T i didaTT i C i
• Prerequisiti
• Ricordo giocando
• Il tempo… non ha prezzo
• Vorrei avere più tempo per…
• La linea del tempo
• Il senso religioso
• Le domande dell’uomo
• Dalle origini ai miti
• La risposta della scienza: la teoria del Big Bang
• La risposta della Bibbia: la storia della Creazione
• La ricerca della verità
• Alla ricerca di Dio
• Dal senso religioso alla religione
• La mezzaluna fertile
• Un popolo eletto
• La Bibbia: un album di famiglia
• La Bibbia cristiana: Antico e Nuovo Testamento
• Sant’Ambrogio
• La nascita della Bibbia
• La prima Bibbia stampata: Gutenberg
• La Bibbia ebraica
• I testi sacri delle grandi religioni
• La chiamata di Abramo
• La nascita dei popoli arabi
• Dio mette alla prova Abramo
• La storia di Abramo
• I grandi patriarchi del popolo ebraico
• Esaù e Giacobbe
• Le dodici tribù d’Israele
• Giuseppe, il re dei sogni
• La storia di Giuseppe
• Mosè, “salvato dalle acque”
• Mosè contro il faraone
• Le dieci piaghe d’Egitto
• Un “passaggio” verso la libertà
• La Pasqua ebraica
bie TT ivi annuali Compe T enze aTT e S e
• Scoprire che l’uomo fin dalle sue origini, si è sempre posto domande su di sé e sull’universo per dare senso alla vita.
• Scoprire che la religiosità dell’uomo nasce dal bisogno di dare delle risposte alle domande di senso, in particolare sulle origini del mondo.
• Conoscere le caratteristiche essenziali delle religioni del mondo antico e la suddivisione delle stesse in monoteiste e politeiste.
• Scoprire cosa si intende per culto e conoscere i vari modi in cui si può praticare, partendo dall’analisi dei comportamenti delle popolazioni antiche, confrontandoli con quelli di oggi.
• Conoscere la storia di alcuni miti sulle origini del mondo.
• Conoscere la figura del profeta relativa all’annuncio del Messia.
• Approfondire la conoscenza degli avvenimenti legati alla nascita di Gesù, attraverso l’analisi dei brani evangelici.
• Conoscere la Bibbia come documento letterario e religioso, e libro sacro per ebrei e cristiani.
L’alunno…
• Comprende che il sapere umano è alimentato da diverse discipline che rispondono al bisogno di conoscenza dell’uomo.
• Sa rilevare come le teorie scientifiche e la religione sono complementari tra loro in riferimento alle domande di senso dell’uomo.
• Conosce i tratti essenziali delle religioni antiche.
• Sa riconoscere tra le espressioni religiose conosciute, quelle che identificano la preghiera come bisogno dell’uomo di comunicare con Dio.
• Comprende il carattere mitologico del racconto biblico della creazione e ne percepisce il valore religioso per i credenti.
• Conosce la figura di alcuni profeti e sa riferire su quelli conosciuti attraverso il testo biblico.
• Sa ricostruire gli avvenimenti della nascita di Gesù attraverso la lettura dei testi evangelici.
• Individua nella Bibbia il libro sacro e documento essenziale per conoscere la storia di ebrei e cristiani, che racconta dell’amicizia tra Dio e gli uomini.
• Sa comprendere il valore della storia dell’amicizia fedele di Dio verso gli uomini.
Programmazione didattica annuale per unità di apprendimento
Con T enu T i didaTT i C i
• Un patto di amicizia
• Le tavole della Legge
• Il Giubileo
• Un viaggio lungo e faticoso
• La storia di Mosè
• L’Esodo e la guida dei Giudici
• I re d’Israele
• Il tempio di Gerusalemme
• I profeti
• Dai profeti a Gesù
• Santa Madre Teresa di Calcutta
• San Giovanni Paolo II
• Il Natale
• Un grande annuncio di… Amore
• Un Amore che dona la vita
• Dalla Pasqua ebraica alla Pasqua cristiana
o bie TT ivi annuali
• Accostarsi alle figure più importanti dell’Antico Testamento e del popolo ebraico.
• Scoprire che Dio nella Bibbia si presenta come un amico fedele, sempre pronto a rinnovare la sua amicizia con gli uomini.
• Conoscere i riti e i simboli della Pasqua ebraica.
• Comprendere in modo più approfondito, il significato cristiano della Pasqua.
• Conoscere la Pentecoste, festa cristiana dalla quale ha origine la Chiesa, comunità dei credenti.
• Conoscere e approfondire il valore della celebrazione eucaristica della domenica per i cristiani.
• Scoprire la missione affidata da Gesù agli apostoli.
Compe T enze aTT e S e
L’alunno…
• Sa identificare in Gesù il messia, annunciato dai profeti e mandato da Dio per salvare gli uomini.
• Sa confrontare, rilevandone le differenze, la Pasqua ebraica e la Pasqua cristiana.
• Sa individuare nella Pentecoste, la festa cristiana che celebra la nascita della Chiesa, intesa come comunità di credenti in Cristo.
• Conosce il mandato che Gesù ha dato agli apostoli di evangelizzare in tutto il mondo.
• Percepisce il valore della domenica per i cristiani, e della presenza sin dalle origini, di Gesù risorto.
Programmazione didattica annuale
per unità di apprendimento
ALFABETICA FUNZIONALE
PERSONALE, SOCIALE E CAPACITÀ DI IMPARARE A IMPARARE
MULTILINGUISTICA
MATEMATICA E COMPETENZA IN SCIENZE, TECNOLOGIA E INGEGNERIA
CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALI
CITTADINANZA
• Esprimere la propria opinione e riportare un avvenimento;
• leggere e comprendere un testo narrativo e una consegna;
• comprendere messaggi e definizioni, arricchendo il proprio linguaggio con lessico specifico.
• Raccordare nuove conoscenze in un discorso narrativo;
• assimilare le conoscenze attraverso la costruzione di mappe concettuali;
• saper confrontare idee e contenuti diversi;
• usare le proprie conoscenze per saperne acquisire nuove, in contesti diversi.
• Conoscere nuovi termini e vocaboli di lingue differenti.
• Utilizzare il pensiero matematico e applicare le conoscenze scientifiche e tecnologiche per risolvere problemi di vita quotidiana.
• Leggere un’opera d’arte.
• Partecipare attivamente al dialogo;
• ascoltare e rispettare le opinioni degli altri.
• utilizzare competenze collaborative.
raCCordo diSCiplinare Con: eduCazione CiviCa
L’educazione civica favorisce il riconoscimento di valori e comportamenti coerenti con la Costituzione attraverso il dialogo e il rispetto reciproco, volti a incoraggiare un pensiero critico personale, aperto e costruttivo, in un percorso formativo che, coinvolgendo la persona nella sua interezza e unitarietà.
Nucleo tematico: Costituzione diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà
Traguardi per il raggiungimento delle competenze 1
• Sviluppare atteggiamenti e adottare comportamenti fondati sul rispetto di ogni persona, sulla responsabilità individuale, sulla legalità, sulla consapevolezza della appartenenza ad una comunità, sulla partecipazione e sulla solidarietà, sostenuti dalla conoscenza della Carta costituzionale, della Carta dei Diritti fondamentali dell’Unione Europea e della Dichiarazione Internazionale dei Diritti umani.
Obiettivi di Apprendimento
• Individuare i diritti e i doveri che interessano la vita quotidiana di tutti i cittadini, anche dei più piccoli. Condividere regole comunemente accettate. Sviluppare la consapevolezza dell’appartenenza ad una comunità locale, nazionale ed europea.
• Rispettare ogni persona, secondo il principio di uguaglianza e di non discriminazione di cui all’articolo 3 della Costituzione. Riconoscere, evitare e contrastare forme di violenza e bullismo presenti nella comunità scolastica.
• Curare gli ambienti, rispettare i beni pubblici e privati così come le forme di vita (piante, animali) che sono state affidate alla responsabilità delle classi.
• Aiutare, singolarmente e in gruppo, coloro che presentino qualche difficoltà per favorire la collaborazione tra pari e l’inclusione di tutti.
Programmazione didattica annuale per unità di apprendimento
Traguardi per il raggiungimento delle competenze 2
• Interagire correttamente con le istituzioni nella vita quotidiana, nella partecipazione e nell’esercizio della cittadinanza attiva, a partire dalla conoscenza dell’organizzazione e delle funzioni dello Stato, dell’Unione europea, degli organismi internazionali, delle Regioni e delle Autonomie locali. Essere consapevoli dell’appartenenza ad una comunità, locale e nazionale.
Obiettivi di Apprendimento
• Conoscere il valore e il significato dell’appartenenza alla comunità nazionale.
• Conoscere il contenuto generale delle Dichiarazioni Internazionali dei diritti della persona e dell’infanzia. Individuare alcuni dei diritti previsti nell’ambito della propria esperienza concreta.
Traguardi per il raggiungimento delle competenze 3
• Rispettare le regole e le norme che governano la democrazia, la convivenza sociale e la vita quotidiana in famiglia, a scuola, nella comunità, al fine di comunicare e rapportarsi correttamente con gli altri, esercitare consapevolmente i propri diritti e doveri per contribuire al bene comune e al rispetto dei diritti delle persone.
Obiettivi di Apprendimento
• Conoscere ed applicare le regole vigenti in classe e nei vari ambienti della scuola (mensa, palestra, laboratori, cortili) e partecipare alla loro eventuale definizione o revisione. Conoscere il principio di uguaglianza nella consapevolezza che le differenze possono rappresentare un valore quando non si trasformano in discriminazioni.
• Conoscere i principali fattori di rischio dell’ambiente scolastico, adottare comportamenti idonei a salvaguardare la salute e la sicurezza proprie e altrui e contribuire a definire comportamenti di prevenzione dei rischi.
• Sviluppare atteggiamenti e comportamenti responsabili volti alla tutela della salute e del benessere psicofisico.
Obiettivi di Apprendimento
• Conoscere e attuare le principali regole per la cura della salute, della sicurezza e del benessere proprio e altrui, a casa, a scuola, nella comunità, dal punto di vista igienico-sanitario, alimentare, motorio, comportamentale.
Programmazione didattica annuale per unità di apprendimento
Nucleo tematico: Sviluppo economico e sostenibilità educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio
Traguardi per il raggiungimento delle competenze 5
• Comprendere l’importanza della crescita economica e del lavoro. Conoscere le cause dello sviluppo economico e sociale in Italia ed in Europa, le diverse attività economiche. Sviluppare atteggiamenti e comportamenti responsabili volti alla tutela dell’ambiente, del decoro urbano, degli ecosistemi e delle risorse naturali per una crescita economica rispettosa dell’ambiente e per la tutela della qualità della vita.
Obiettivi di Apprendimento
• Conoscere le condizioni della crescita economica. Comprenderne l’importanza per il miglioramento della qualità della vita e ai fini della lotta alla povertà. Individuare, con riferimento alla propria esperienza, ruoli, funzioni e aspetti essenziali che riguardano il lavoro delle persone con cui si entra in relazione, nella comunità scolastica e nella vita privata. Riconoscere il valore del lavoro.
• Riconoscere, a partire dagli ecosistemi del proprio territorio, le trasformazioni ambientali ed urbane dovute alle azioni dell’uomo; mettere in atto comportamenti alla propria portata che riducano l’impatto negativo delle attività quotidiane sull’ambiente e sul decoro urbano.
Traguardi per il raggiungimento delle competenze 6
• Comprendere le cause dei cambiamenti climatici, gli effetti sull’ambiente e i rischi legati all’azione dell’uomo sul territorio.
Obiettivi di Apprendimento
• Conoscere ed attuare i comportamenti adeguati a varie condizioni di rischio (sismico, vulcanico, idrogeologico, climatico, …).
• Individuare alcune trasformazioni ambientali e gli effetti del cambiamento climatico.
Traguardi per il raggiungimento delle competenze 7
• Maturare scelte e condotte di tutela dei beni materiali e immateriali.
Obiettivi di Apprendimento
• Identificare nel proprio ambiente di vita gli elementi che costituiscono il patrimonio artistico e culturale, materiale e immateriale, anche con riferimento alle tradizioni locali, ipotizzando semplici azioni per la salvaguardia e la valorizzazione.
• Riconoscere, con riferimento all’esperienza, che alcune risorse naturali (acqua, alimenti…) sono limitate e ipotizzare comportamenti di uso responsabile, mettendo in atto quelli alla propria portata.
Programmazione didattica annuale per unità di apprendimento
Traguardi per il raggiungimento delle competenze 9
• Maturare scelte e condotte di contrasto all’illegalità.
Obiettivi di Apprendimento
• Conoscere le varie forme di criminalità, partendo dal rispetto delle regole che ogni comunità si dà per garantire la convivenza. Conoscere la storia dei vari fenomeni mafiosi, nonché riflettere sulle misure di contrasto. Conoscere il valore della legalità.
Nucleo tematico: Cittadinanza digitale comunicazione virtuale e sviluppo del pensiero critico
Traguardi per il raggiungimento delle competenze 10
• Sviluppare la capacità di accedere alle informazioni, alle fonti, ai contenuti digitali, in modo critico, responsabile e consapevole.
Obiettivi di Apprendimento
• Ricercare in rete semplici informazioni, distinguendo dati veri e falsi.
• Riconoscere semplici fonti di informazioni digitali.
Traguardi per il raggiungimento delle competenze 11
• Interagire con gli altri attraverso le tecnologie digitali consentite, individuando forme di comunicazione adeguate ai diversi contesti di relazione, adottando e rispettando le regole comportamentali proprie di ciascun contesto comunicativo.
Obiettivi di Apprendimento
• Interagire con strumenti di comunicazione digitale, quali tablet e computer.
• Conoscere e applicare semplici regole per l’utilizzo corretto di strumenti di comunicazione digitale, quali tablet e computer.
• Conoscere e applicare le principali regole di partecipazione alle classi virtuali e alle piattaforme didattiche.
Traguardi per il raggiungimento delle competenze 12
• Gestire l'identità digitale e i dati della rete, salvaguardando la propria e altrui sicurezza negli ambienti digitali, evitando minacce per la salute e il benessere fisico e psicologico di sé e degli altri.
Obiettivi di Apprendimento
• Conoscere il significato di identità e di informazioni personali in semplici contesti digitali di uso quotidiano.
• Conoscere i rischi connessi con l’utilizzo degli strumenti digitali in termini di sicurezza personale.
• Riconoscere, evitare e contrastare le varie forme di bullismo e cyberbullismo.
L’alunno…
• riflette su Dio Creatore
u ni Ta di apprendimen T o
Si ricomincia
Traguardi per lo Sviluppo delle Competenze
p er la p rogrammazione S e TT imanale r iferimen T i al T e ST o o bie TT ivi di apprendimen T o
• Riepilogo delle attività svolte lo scorso anno.
• Conversazione guidata sugli argomenti del nuovo anno.
Da pag. 98 a pag. 99 I valori etici e religiosi
• Scoprire la bellezza dello stare insieme e sviluppare sentimenti di rispetto e fiducia verso gli altri.
Prima di affrontare il ricco programma della classe terza, coinvolgiamo gli alunni nel ricordo dei principali argomenti dello scorso anno, che hanno avuto come filo conduttore l’AMICIZIA: nella prima parte dell’anno quella tra Dio e gli uomini per mezzo della creazione, nella seconda parte quella mediante la venuta di Gesù, la sua vita e le sue opere.
È sempre importante creare un CLIMA SERENO E POSITIVO ALL’INTERNO DEL GRUPPO
CLASSE, e soprattutto a inizio anno, dopo la pausa estiva, far riacquisire il ritmo studio a ciascun alunno, e questo può essere favorito grazie a schede semplificate di ripasso e attività ludiche.

Come punto di partenza, per introdurre il tema della BIBBIA, leggiamo ai bambini questa storia in cui si può cogliere un parallelismo tra gli ELEMENTI SIMBOLO e la SACRA SCRITTURA. Ciò che rappresenta la conchiglia per il protagonista della fiaba è così prezioso quanto lo è Bibbia per il cristiano.
COME LA VOCE DELLA CONCHIGLIA AIUTA GIANNINO A SUPERARE LE DIFFICOLTÀ, COSÌ NELLA PAROLA DI DIO IL CREDENTE PUÒ TROVARE CORAGGIO, CONSOLAZIONE E AIUTO.
Il ricco e potente re delle Terre Ombrose aveva tre figli. Li aveva cresciuti nell’orgoglio ed educati alla forza e alla generosità. Ma i tre fratelli erano molto diversi uno dall’altro.
Il primogenito si chiamava Valente. Era dotato di una gagliarda forza fisica e di un carattere risoluto, ma si mostrava a volte altezzoso e arrogante.
Il secondo si chiamava Folco. Era intelligente e acuto, ma spesso avido e senza scrupoli. Il terzo era poco più che un ragazzo e si chiamava Giannino. Portava lunghi capelli biondi che gli incorniciavano un viso simpatico e lentigginoso in cui brillavano gli occhi color delle castagne mature.
Giannino era svelto e furbo, ma doveva guardarsi continuamente dagli scherzi che gli giocavano i fratelli più grandi che non lo stimavano molto. Il re delle Terre Ombrose era ormai vecchio ed era giunto il momento in cui doveva cercarsi un successore. Ma il buon re non sapeva quale dei tre figli scegliere.
Li amava tutti e tre, e per tutta la vita non aveva mai fatto preferenze. Così un giorno li convocò nella sala del trono.
«Figli miei... - disse abbracciandoli con gli occhi - Uno di voi sarà il mio successore. Ma sento di amarvi tutti allo stesso modo e non riesco a scegliere. Farò così. Salirà sul trono delle Terre Ombrose quello di voi che riuscirà a portarmi lo Smeraldo Verde, custodito nella Grotta Ferrea, nel Paese del Nord».
I tre fratelli rimasero senza fiato.
Lo Smeraldo Verde era il sogno di tutti i cavalieri e di tutti i guerrieri delle Terre Ombrose. Ma tutti coloro che erano partiti alla sua ricerca non erano mai tornati. Troppe difficoltà erano disseminate sul percorso.
«So che è un’impresa difficile, ma so che voi potete riuscirci. Vi lascerò tre doni che vi aiuteranno». Pronunciando queste parole, il re alzò un panno ricamato che copriva tre oggetti posati su un tavolo. Erano una spada dalla lama lucente, un bel mucchio di monete d’oro e una conchiglia, grossa due volte il pugno di un uomo.
«La mia forza, la mia ricchezza, le mie parole» spiegò il re. «La lama di questa spada non può essere spezzata, chi avrà queste monete d’oro sarà il più ricco della terra e in questa conchiglia ci sono tutte le mie parole, quelle che vi ho detto da quando siete nati ad oggi. Scegliete». Valente e Folco si scambiarono un’occhiatina e scelsero secondo le loro inclinazioni, senza badare a Giannino. Con mossa rapida Valente la spada fiammeggiante e Folco il sacco di monete. Giannino prese la conchiglia e se la legò al collo. Poi tutti e tre partirono. Valente sul suo focoso destriero, Folco sulla sua carrozza dorata, Giannino a piedi, ma fischiettando.
Il primo ostacolo era la Foresta Tenebrosa, dove regnava il feroce Malak, il bandito. Valente fu il primo ad arrivare. Quando le sentinelle di Malak lo videro gli sbarrarono il passo, ma il giovane principe sguainò la spada e ingaggiò un terribile combattimento. Folco arrivò poco dopo sulla sua carrozza e si fece condurre da Malak in persona. «Se mi fai passare ti offro cento monete d’oro.» disse al bandito.
«Ne voglio cento e cinquanta» rispose Malak. «Cento e trenta» ribatté Folco. «Duecento».
«Centoquaranta...».
E la cosa cominciò ad andare per le lunghe. Giannino arrivò verso sera. Valente stava ancora combattendo e Folco era più che mai avviluppato nelle sue aspre contrattazioni. Il giovane portò la conchiglia all’orecchio. Sentì, chiara e piena
di bontà, la voce di suo padre: “Ricordati, figlio mio, che si pigliano più mosche con una goccia di miele che con un barile d’aceto”.
Giannino capì. Raccolse lamponi e mirtilli e preparò una bevanda dissetante e profumata. Con un gesto semplice e cordiale la offrì a Malak.
Il bandito sanguinario non aveva mai ricevuto un regalo in tutta la sua vita (e per questo era così cattivo). Assaggiò la bevanda, si asciugò i baffi e poi disse a Giannino, con un po’ di sospetto:
«Perché lo fai?».
«Perché mi hanno detto che lei è il più coraggioso cavaliere dei dintorni!».
«Sei un ragazzo in gamba. Chiedimi quello che vuoi e te lo darò».
«Mi lasci attraversare la foresta e permetta che passino anche i miei fratelli, potente e generoso cavaliere».
Nessuno aveva mai detto generoso a Malak, che quasi si sciolse in lacrime. Così i tre fratelli passarono la Foresta Tenebrosa. Valente e Folco stremati per la gran fatica si buttarono a terra e piombarono in un sonno profondo. Giannino si portò di nuovo la conchiglia all’orecchio.
«Ricordati che le ore del mattino hanno l’oro in bocca...» disse la voce del padre. Era ancora notte e Giannino ripartì.
Il secondo ostacolo era il Lago delle Tempeste e quando Giannino arrivò era ancora ghiacciato.
Il giovane lo poté così attraversare rapidamente. I suoi due fratelli arrivarono che il sole era alto, il ghiaccio era sciolto e le onde dell’immenso lago ruggivano assassine. Valente e Folco furono costretti a iniziare un giro lunghissimo e disseminato di pericoli per evitare il lago. Così Giannino giunse per primo al terzo decisivo ostacolo: la terrificante Palude della Tristezza.
La palude della Tristezza era una sconfinata distesa di fango viscido. Solo chi aveva coraggio, tenacia e una forza di volontà impareggiabile la poteva attraversare. Giannino cominciò risolutamente. Ma le sabbie mobili e le radici delle piante morte sembravano tentacoli che lo attiravano verso il basso. Ogni passo gli costava enorme fatica. Più tardi arrivarono anche Valente e Folco. Per loro le cose si misero subito male.
Il cavallo di Valente affondò e il giovane tentò di proseguire a piedi, ma la spada e l’armatura lo impacciavano. A ogni passo affondava nella fanghiglia fino al naso. La carrozza di Folco si rovesciò, il sacco dell’oro si aprì e tutte le monete finirono nelle sabbie mobili che le inghiottirono, una dopo l’altra. Folco tentò invano di salvarne anche una sola.
Dopo un po’ Valente e Folco si ritrovarono seduti su un tronco marciscente a piangere sulla loro sfortuna. Più tristi della Palude della Tristezza.
E Giannino?
Vennero anche per lui momenti difficili.
Camminava da un giorno e la palude sembrava non finire mai.
Ma quando insidiosi mulinelli di fango gli avvinghiavano le caviglie, si portava la conchiglia all’orecchio.
«Io ho una grande fiducia in te, figliolo. Tu sei tutto quello che ho al mondo. Io sono fiero del tuo coraggio» diceva la voce del padre.
E altre volte sussurrava: «Non si va da nessuna parte senza fatica e perseveranza. Se vuoi una vita grande, devi vivere alla grande... Coraggio, figlio mio, i grandi ideali fanno grandi le forze... Scava nella tua anima, troverai energie insospettabili...».
Ogni volta che sentiva la voce del padre, Giannino ripigliava animo. Finché vinse la Palude della Tristezza e si trovò all’imboccatura della Grotta Ferrea, dove splendeva lo Smeraldo Verde. Allora, pieno di gioia, gridò: «Grazie, papà!». Bruno Ferrero
• Chi sono i protagonisti della fiaba?
• Che cosa debbono trovare?
• Che cosa può rappresentare la ricerca dello Smeraldo Verde?
• Quali doni hanno a disposizione per riuscire nell’impresa?
• Che cosa rappresentano?
• Quali ostacoli incontrano?
• Chi riesce a portare a termine la missione?
• Come ci riesce?
Nei tempi primitivi, quando gli uomini vivevano in caverne e non sapevano dare spiegazioni ai fenomeni naturali, la meraviglia lasciava il posto alla paura. Ad esempio quando un fulmine colpiva un albero, si spaventavano e dicevano: «Chi è costui che può lanciare terribili fulmini? Deve essere certamente un dio molto più potente di noi, capace di lanciare frecce di fuoco.» Essi allora lo temevano e gli offrivano sacrifici per beneficiare dei suoi favori.
Il test proposto prende in considerazione la PAURA, un’EMOZIONE NATURALE che nessuno di noi può dire di non conoscere. Per valutare meglio le reazioni dei bambini nel momento del pericolo, essi proveranno a rispondere a queste domande, ma senza tremare.
1. A scuola, vieni interrogato ma non hai studiato...
a. Parti sparato, cerchi di inventare qualcosa, senza preoccuparti troppo di quello che dici.
b. Sei congelato: non riesci neanche ad aprire bocca.
c. Preferisci ammettere che non hai studiato.
2. Prendi l’aereo per la prima volta...
a. Ti rifiuti di allacciare la cintura di sicurezza.
b. Cerchi un posto che sia il più lontano possibile dagli oblò e il più vicino alle uscite di sicurezza.
c. Dal tuo oblo ammiri i reattori dell’aereo e il paesaggio.
3. Vedi un ragno nel tuo letto...
a. Cerchi di imprigionarlo in un barattolo per sbarazzartene.
b. In piedi sul letto, urli «Aiuto!»
c. Ti addormenti pensando che le piccole bestie non mangiano le grosse.
4. Un cane ti guarda con aria minacciosa...
a. Gli urli: «A cuccia!»
b. Sfrecci via, senza guardare dove stai andando, pur di allontanarti da lui.
c. Gli passi davanti senza mostrare che hai paura di lui.
5. Stai facendo un campeggio con i tuoi amici, quando scoppia un temporale...
a. Cerchi rifugio sotto un albero, sicuro che il fulmine non ti colpirà.
b. Ti getti a capofitto nel tuo sacco a pelo.
c. Suggerisci di cercare un rifugio sotto un riparo più sicuro.
6. Stai giocando, un amico si ferisce al ginocchio...
a. Gli bendi subito il ginocchio con il tuo fazzoletto.
b. Alla vista del sangue ti senti venir meno.
c. Cerchi un pronto soccorso per medicarlo accuratamente.
7. Devi fare il bagno al mare ma c’è la bandiera rossa...
a. Il bagnino deve correrti dietro per impedirti di gettarti con gioia tra i cavalloni.
b. Corri al lettino e riprendi la lettura del tuo fumetto preferito.
c. Decidi di fare una passeggiata lungo il bagnasciuga per goderti lo spettacolo del mare infuriato.
8. Sei da solo in camera. Improvvisamente viene a mancare la luce:
a. Cerchi, da solo, di cambiare la lampadina.
b. Ti corichi sotto le coperte. Senza muoverti, aspetti che la luce ritorni da sola.
c. A tentoni, vai alla ricerca di una pila.
9. Tornato dalle vacanze entri in camera tua...
a. Sei preoccupato di sistemare per bene le cose che hai comperato.
b. Pensi che durante la tua assenza qualcuno sia entrato in camera tua.
c. Cerchi di ricordarti dove hai messo il tuo videogiochi preferito.
10. Un tuo amico abita in un grattacielo, per andare a trovarlo devi prendere l’ascensore:
a. Sei deluso. Pensavi che andasse più veloce e invece, per te, sta procedendo troppo lentamente.
b. Sei preoccupato. Potrebbe bloccarsi da un momento all’altro.
c. Stai pensando quale gioco fare con il tuo amico.
Calcola se la maggioranza delle tue risposte sono a, b o c.
Maggioranza a: Non hai proprio paura di nulla, anche a rischio di essere un rompicollo! Sta' attento! La tua temerarietà potrebbe farti fare degli errori. Rifletti di più, prima di gettarti corpo e anima nell’azione.
Maggioranza b: Sei ansioso/a e spesso hai paura. Qualche volta questo serve. La tua prudenza ti permette di prendere delle decisioni ragionevoli, di analizzare bene dove siano tutti i rischi. Ricordati però che la paura non cancella il pericolo! Bisogna imparare ad affrontarlo.
Maggioranza c: Sei un ragazzo/a riflessivo e pieno di buon senso. Le tue reazioni davanti al pericolo dimostrano che sei capace di gestire la tua paura e scegliere la soluzione migliore. Ma non prendere in giro chi ha paura, perché un giorno potresti provarla anche tu!
Dopo la lettura della storia, possiamo far ascoltare e ripetere una delle seguenti filastrocche.
Io sono il tempo vecchio e saggio lascio il segno del mio passaggio se mi perdi in un momento scappo veloce come fossi il vento. Non dubitare mai di me non puoi vedermi ma sono sempre con te ti tengo per mano e piano piano non te ne accorgi ma ti porto lontano.
Marilla Guiotto
Tutti crescono
Una volta l’uomo era un bambino, il gatto una volta era un micino. Cresce il cucciolo e diventa cane. I girini crescono e diventano rane. Un piccolo arbusto diventa una pianta, un uovo diventa un uccello che canta.
Se tutte le cose crescon da sé, perché i vestiti non crescon con me?
P. Fisher
La filastrocca scacciapensieri parla di oggi e parla di ieri, parla del tempo che va veloce, parla del fiume che va alla foce. Viene la sera e viene il giorno: il tempo vissuto non fa ritorno, la settimana è presto passata e la domenica è già arrivata.
Passano i mesi e cambia stagione cadon la foglie, occorre il maglione! Passano i mesi, il freddo è finito l’albero spoglio è già rifiorito. L’anno che passa non ha importanza, se tu lo vivi con la speranza di preparare un mondo migliore dove la gente ragiona col cuore!
Marilla Guiotto
Traguardi per lo Sviluppo delle Competenze L’alunno…
• riflette su Dio Creatore del mondo e della vita e lo riconosce Padre di ogni uomo;
• scopre che da sempre l’uomo cerca una risposta ai perché della vita.
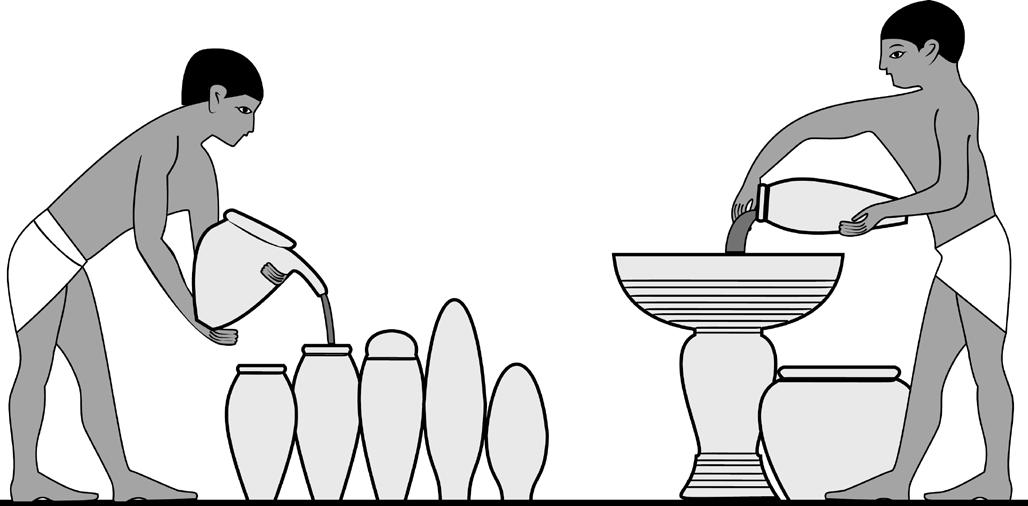
Le grandi domande
Stupore e meraviglia:
• la bellezza del creato e la nascita del sentimento religioso.
Alla scoperta delle risposte:
• I miti antichi.
• La scienza e la teoria del Big Bang.
• La Bibbia e la Storia della Creazione.
• Scienza e fede in dialogo, alla ricerca della verità.
Da pag. 100 a pag. 114 Dio e l’uomo
• Riflettere sulla dimensione religiosa dell’uomo.
• riflettere sulla dimensione spirituale dell’uomo a partire dai suoi bisogni.
La Bibbia e le altre fonti
• Saper confrontare le ipotesi storicoscientifiche con quella biblica.
Scopo di questa unità, che ha come tema le GRANDI DOMANDE ESISTENZIALI DELL’UOMO, in particolare quella sull’ORIGINE DELL’UNIVERSO, è quello di aiutare gli alunni a risvegliare in loro le domande sul senso della vita e intuire che le diverse risposte queste domande, non sono necessariamente in opposizione tra loro, ma si com-
pletano tra loro a seconda della tipologia di domanda cui rispondono. Gli alunni che quest’anno studieranno la preistoria, durante l’ora di religione scopriranno che ogni aspetto dell’esistenza di quelle popolazioni era pervaso da una forma di religiosità. I disegni, i resti ritrovati nelle grotte, le statuette di idoli, gli oggetti relativi al culto dei morti sono la testimonianza di questo sentimento religioso, da sempre esistito.
Il percorso presenta le varie risposte date nel corso dei secoli alla domanda sulle
ORIGINI DELLA VITA, a partire dalla mitologia e dai miti, racconti ricchi di fascino e di mistero, l’uomo cerca di colmare il suo bisogno che s’interroga su sé stesso. Successivamente l’attenzione si sposta alle RISPOSTE DELLA SCIENZA e sui RACCONTI
BIBLICI DELLA CREAZIONE , per giungere a una conclusione dialogante, che pone la scienza come risposta a domande sul come e sul quando, e la fede come risposta alla domanda sul perché e sul chi ha creato l’universo.
Il forte legame con le discipline storiche permette anche l’organizzazione di momenti di lezione condivisa con i colleghi di italiano e di storia.
Spieghiamo ai bambini che gli uomini da sempre si sono posti delle domande importanti sulla loro esistenza e sull’esistenza del mondo. Essi, per dare una risposta a queste domande di senso, hanno fatto ricorso ad alcuni miti.
Questi sono RACCONTI TRAMANDATI ORALMENTE che hanno come protagonisti EROI
LEGGENDARI, PRINCIPI e DIVINITÀ. Le loro vicende si svolgono in un tempo lontano, all’inizio del mondo, e sono narrate con un linguaggio semplice, fatto di frasi brevi e immagini suggestive.
Da principio non c’era terra.
C’era soltanto il mare, una massa d’acqua che di sotto si stendeva all’infinito. Di sopra c’era Olorun. Olorun (il dio del cielo) e Olokun (il dio del mare) erano della stessa età. Olorun chiamò il figlio Odudua e gli disse: «Va’, prendi del terriccio e il pollo dalle cinque dita e forma la terra sul mare».
Odudua andò, prese il terriccio, discese e lo pose sul mare, mettendoci sopra il pollo dalle cinque dita. Il pollo si mise a razzolare e distese la sabbia spingendo da parte l’acqua. Il luogo dove questo avvenne fu Ite: la città santa.
Negli illuminati spazi dell’universo, prima della creazione della terra e del cielo, viveva un essere onnipotente. Con l’andare del tempo si sentì più vicino a morire e chiamò a se la sorella Fuuna.
A sua sorella diede istruzioni precise circa la sepoltura e trasmise a lei tutti i suoi poteri miracolosi.
Egli lasciò detto, morendo, che dai suoi occhi si creassero il sole e la luna, dal suo petto il cielo, dal dorso la terra, dalle sopracciglia venisse l’arcobaleno, le altre parti del corpo si trasformassero nei vari particolari dell’universo e del mondo di sotto. Poi spirò. E Fuuna puntualmente eseguì i comandi del fratello. E così fu creato il mondo.
Tàaroa, il creatore di ogni cosa, abitava in una conchiglia, simile ad un uovo. Non esistevano né cielo, né terra, né luna, né stelle. Tàaroa, con una scossa, uscì dalla sua conchiglia: era completamente solo nell’oscurità e nel silenzio. Decise allora di ritirarsi in una nuova conchiglia e di iniziare la sua opera di creazione. Prima creò il cielo e la terra con delle conchiglie, poi scosse le sue piume rosse e gialle e queste, cadendo sulla terra, presero la forma di alberi, di foglie e di fiori.
Dopo aver letto i racconti, facciamo completare lo schema con le informazioni richieste.
Dove (luogo) ..........................................................................................................
Quando (tempo) .......................................................................................................
Chi (personaggi) ......................................................................................................
Perché (scopo) ........................................................................................................
Cosa (contenuto) ......................................................................................................
Come (linguaggio) ....................................................................................................
Un piccolo glossario potrà servire agli alunni per avvicinarli ancora di più all’affascinante e misterioso mondo della Bibbia e per fare loro acquisire termini nuovi che andranno a consolidare il linguaggio specifico religioso.
Bibbia: deriva dal greco ta biblìa che significa i libri, definizione che è stata data dagli antichi autori cristiani per indicare le Sacre Scritture. Essa comprende 73 libri: 46 dell’Antico Testamento e 27 del Nuovo. Per i credenti essa è il dialogo di Dio col suo popolo, è Parola di Dio. Testamento: dall’ebraico berith che significa patto, alleanza. Due sono le alleanze, i patti stipulati con gli uomini: l’Antica Alleanza venne stipulata con Abramo ed i suoi discendenti; la Nuova Alleanza è stipulata da Dio in Gesù morto e risorto.
Bibbia ebraica: la Bibbia ebraica, diversamente da quella cristiana, contiene solo l’Antico Testamento. Essa contiene 39 libri, scritti tutti prima di Cristo, che vengono solitamente suddivisi in tre sezioni:
• La Torah (o Legge) comprendente i primi cinque libri, Genesi, Esodo, Levitico, Numeri, Deuteronomio;
• I Profeti, comprendenti i libri di Giosuè, Giudici, 1-2 Samuele, 1-2 Re, Isaia, Geremia, Ezechiele e i 12 “profeti” minori da Osea a Malachia;
• Gli Scritti, cioè i libri dei Salmi, Proverbi, Giobbe, Cantico dei Cantici, Ruth, Lamentazioni, Qoèlet, Ester, Daniele, Esdra, Neemia, 1-2 Cronache.
Canone: dal greco kanon che significa regola, misura esatta, è l’elenco ufficiale dei testi che fanno parte della Sacra Scrittura. La facoltà di definire il Canone delle Scritture per i cattolici risiede nella Chiesa, che riconosce in quali libri ha operato l’ispirazione divina.
Apocrifi: dal greco apokruphos che vuol dire nascosto. Per apocrifi si intendono quei libri che presentano grande somiglianza con la Sacra Scrittura e che pretenderebbero di avere la medesima autorità, ma la Chiesa non ne ha riconosciuto la canonicità. Apocrifo quindi si contrappone a canonico, ed è quindi sinonimo di non canonico, fuori dal canone.
Rivelazione: dal latino re-velare, togliere il velo, rendere noto, è il farsi conoscere di Dio che si manifesta all’uomo.
Attraverso la Scrittura l’uomo può conoscere colui che l’ha creato, colui che lo ama come un Padre al punto da offrirsi per salvarlo dalla morte e donargli la vita eterna.
Esegeta: dal greco ex-ago, tirar fuori; è colui che interpreta le Sacre Scritture per comprenderne e spiegarne il significato più profondo.
Agiografi: dal greco aghios-graphoi, scrittori sacri. Dio ha ispirato degli uomini a scrivere perché parlassero di lui e trasmettessero il suo messaggio d’amore all’uomo. Questi hanno scritto in piena libertà, secondo le loro capacità, secondo la loro cultura, secondo la loro epoca, utilizzando anche modi di dire e conoscenze tipiche del periodo in cui hanno scritto. Proprio perché la Parola di Dio è stata espressa dalle persone di vari tempi, occorre interpretare correttamente la Bibbia per capire quale messaggio Dio ha voluto trasmettere attraverso gli agiografi. Per i cristiani cattolici, la corretta interpretazione della Bibbia viene data dall’insegnamento dei vescovi, ossia dal Magistero della Chiesa.
Papiri e pergamene: la Bibbia fu scritta su rotoli di papiro e pergamena. Il papiro è una pianta che cresce soprattutto in Egitto, sulla riva del Nilo, veniva tagliata in strisce, queste venivano incrociate, poste una sull’altra e poi incollate, pressate e lisciate. Si ottenevano così dei fogli di papiro sui quali si scriveva per mezzo di inchiostro o colore, usando un pennello o una specie di penna. I singoli fogli potevano essere incollati o cuciti uno dopo l’altro, ottenendo delle strisce anche di diversi metri di lunghezza. Ponendo due bastoncini all’estremità, la lunga striscia di papiro poteva essere arrotolata: è il rotolo di papiro. Il papiro fu importato dall’Egitto in Palestina e divenne materiale ordinario di scrittura anche per l’antico Israele. Solo più tardi gli ebrei conobbero dai Persiani un materiale più duraturo ma anche più costoso, la pelle di animale. La preparazione del cuoio di montone e di capra, per tale uso, fu perfezionata nella città di Pergamo da cui derivò il nome di pergamena. Anche i fogli di pergamena venivano cuciti l’uno dopo l’altro, formando un lungo rotolo.
Codice: la forma del codice, ovvero del libro formato con fogli posti l’uno sopra l’altro rilegati tra loro su un lato, entrò in uso dal I sec. d.C. in poi. Il nuovo sistema si applicava anche al papiro; i celebri papiri del N.T., hanno appunto il formato di codice.
Vangelo: proviene dal greco e vuol dire buona notizia. Nel mondo greco indicava l’annuncio di un lieto messaggio e la ricompensa per tale annuncio. In un secondo momento, con la parola Vangelo, si sono indicati quegli scritti del Nuovo Testamento che presentano in quattro forme l’unica Buona Notizia proclamata da Gesù, annunciata e trasmessa dalla predicazione cristiana. Gli autori degli scritti chiamati Vangeli hanno raccolto le parole e le opere di Gesù, componendo quattro libri: il Vangelo secondo Matteo, Marco, Luca e Giovanni.
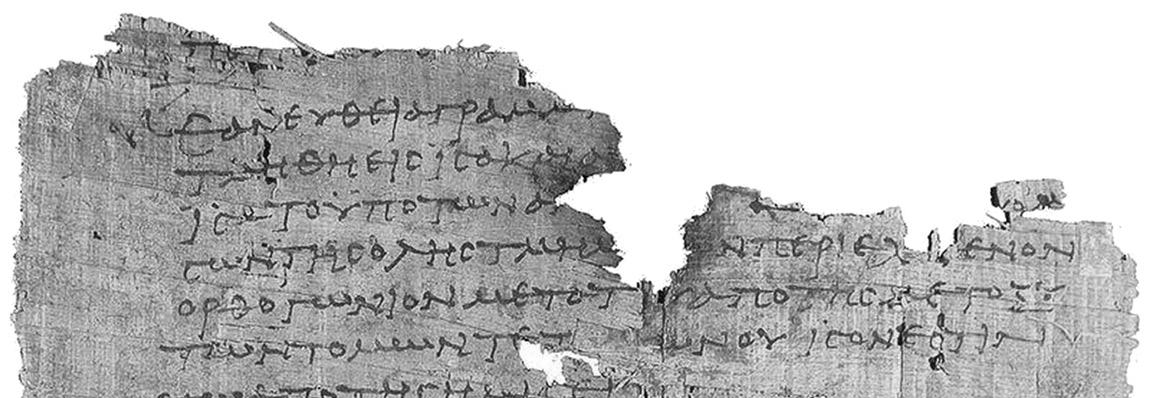
Era il 1947 quando Mohammed detto “il lupo”, un giovane beduino di 15 anni, stava cercando una capra persa nella regione desertica, ai bordi nord-occidentali del Mar Morto, in Giordania.
A un tratto scorse uno stretto pertugio sulla superficie di una rupe. Il ragazzo vi gettò dentro alcune pietre, e udì il rumore di qualcosa che s’infrangeva.
Pensando che potesse trattarsi di un tesoro nascosto, andò a chiamare un amico, Ahmed Muhammad, e insieme si calarono nel buco. Si trovarono in una caverna lunga quasi 9 m e larga 2, dove, in mezzo a frammenti di vasi, trovarono un certo numero di alti recipienti cilindrici d’argilla.
I ragazzi, molto eccitati, strapparono i tappi dei cilindri, ma, invece dell’oro o delle gemme, trovarono soltanto strani involti scuri, odoranti di muffa, racchiusi in pezze di lino. Erano 11 rotoli fatti di sottili strisce di pergamena cucite insieme e ricoperte di cuoio dall’aspetto gommoso, ormai decomposto.
I rotoli, che risultarono lunghi da uno a circa sette metri, erano coperti da un lato da colonne di antica scrittura ebraica.
I ragazzi si sentirono delusi, ma riuscirono a vendere per una piccola somma la loro scoperta a un mercante di Gerusalemme. Risultò poi che si trattava di uno dei più preziosi gruppi di manoscritti biblici, i Rotoli del Mar Morto.
Sebbene un impiegato del Dipartimento delle Antichità in Palestina li definisse molto superficialmente di nessun va1ore, cinque dei rotoli furono acquistati l’anno seguente dal Monastero Ortodosso Siriaco di S. Marco, in Gerusalemme; gli altri sei furono acquistati dall’Università Ebraica della stessa città.
Quando il dottor John Trever, vicedirettore dell’Istituto Americano per le Ricerche Orientali a Gerusalemme, esaminò i rotoli di San Marco, scoprì che uno di essi conteneva il Libro di Isaia. E il carattere arcaico delle lettere suggeriva l’ipotesi che i rotoli risalissero a prima della nascita di Cristo!
Una scoperta senza precedenti.
Siccome non esisteva un testo dell’Antico Testamento in ebraico che risalisse a più di 1.500 anni, si trattava evidentemente di una scoperta straordinaria.
Dall’esame delle foto di una parte del Libro di Isaia il dottor William Albright, storico e archeologo della John Hopkins University, stabilì la data del rotolo intorno all’anno 100 a.C. e dichiarò che si trattava di un rinvenimento assolutamente incredibile: la più grande scoperta di manoscritti antichi dei tempi moderni.
Archeologi e beduini cominciarono allora ad esplorare l’area intorno al Mar Morto, e in pochi anni scoprirono che altre 10 caverne contenevano rotoli e frammenti di pergamene. La maggior parte delle pergamene conosciute e dei frammenti fino al 1968 sono stati custoditi nel Museo Rockefeller a Gerusalemme. Oggi molte di queste pergamene e frammenti si trovano presso il Santuario del Libro, nel Museo di Israele, mentre altri sono presso l’Università di Chicago o in collezioni private.
Riportiamo il PRIMO RACCONTO DELLA CREAZIONE (Gen 1,1-2,4a) che può essere analizzato insieme ai bambini facendo notare che esso ha il RITMO DI UN CANTO, di una preghiera. L’autore, in maniera schematica, ripete per ogni opera della creazione i seguenti ritornelli:
• Comando di Dio
• Esecuzione
• Costatazione della bontà della creazione
• Fu sera e fu mattina: l’indicazione del giorno
La ripetitività, esprime proprio la LODE PER IL CREATO, tipica della preghiera. Nel racconto si assiste a tre opere di separazione:
• La luce dalle tenebre
• Le acque di sopra da quelle di sotto
• Il mare dalla terra
In seguito hanno inizio le prime forme elementari di vita, la vegetazione, con l’alternanza del giorno e della notte. Altre creazioni sopravvengono nell’ambiente già preparato: gli animali dell’aria e dell’acqua. Tra le opere della creazione emergono l’uomo e la donna, creati a immagine e somiglianza di Dio, chiamati ad esistere quando l’ambiente è ormai pronto ad accoglierli.
Il racconto si conclude con il riposo. Il settimo giorno a differenza degli altri riceve la benedizione perché è il giorno in cui si fa memoria degli eventi salvifici di Dio e lascia intravedere il risultato della presenza di Dio: un MONDO ORDINATO E IN PERFETTA ARMONIA.
Primo giorno
In principio Dio creò il cielo e la terra.
La terra era senza forma e deserta e le tenebre ricoprivano l’abisso e lo spirito di Dio aleggiava sulle acque.
Dio disse: «Sia la luce!» E la luce fu. Dio vide che la luce era buona e separò la luce dalle tenebre e chiamò luce giorno e le tenebre notte.
E fu sera e fu mattina: primo giorno.
Secondo giorno
Poi Dio disse: «Vi sia il firmamento tra le acque per separare le acque dalle acque».
Dio fece il firmamento e separò le acque inferiori da quelle superiori.
E così avvenne.
Dio chiamò il firmamento cielo.
E fu sera e fu mattina: secondo giorno.
Terzo giorno
Dio disse: «Le acque che sono sotto il cielo, si raccolgano in un solo luogo e appaia l’asciutto». E così avvenne.
Dio chiamò l’asciutto terra e la massa delle acque mare. E Dio vide che era cosa buona. Poi Dio disse: «La terra produca germogli, erbe che facciano semi e alberi da frutto.»
E così avvenne. Dio vide che era cosa buona.
E fu sera e fu mattina: terzo giorno.
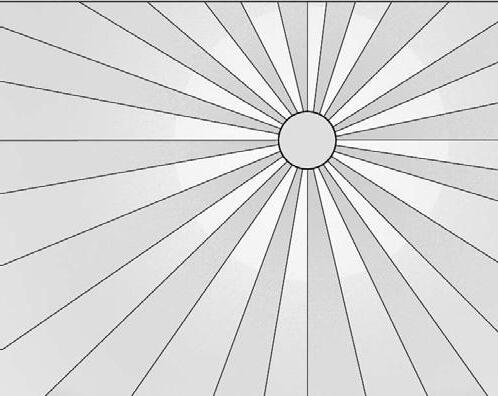
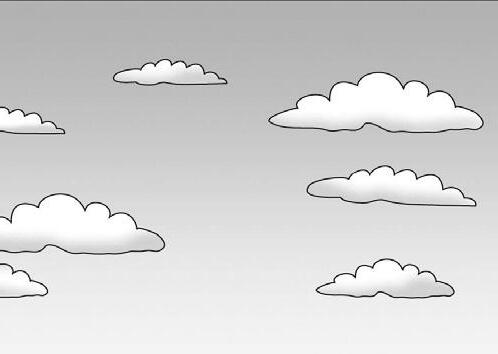
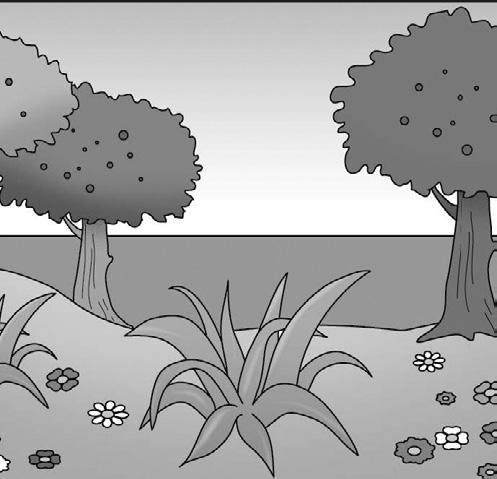
Quarto giorno
Poi Dio disse: «Vi siano delle luci nel firmamento del cielo, per distinguere il giorno dalla notte; servano da segni per le stagioni, per i giorni e per gli anni, facciano luce nel firmamento del cielo per illuminare la terra.»
E così avvenne. Dio fece le due grandi luci: la luce maggiore per illuminare il giorno e la luce minore per illuminare la notte; e fece pure le stelle.
E Dio vide che era cosa buona.
E fu sera e fu mattina: quarto giorno.
Quinto giorno
Dio disse: «Le acque producano in abbondanza esseri viventi, e volino degli uccelli nel cielo, sopra la terra.» Dio creò i grandi mostri marini e tutti gli esseri viventi che si muovono nell’acqua e tutti gli uccelli del cielo. Dio vide che era cosa buona. Dio li benedisse: «Siate fecondi e moltiplicatevi e riempite le acque dei mari; gli uccelli si moltiplichino sulla terra.»
E fu sera e fu mattina: quinto giorno.
Sesto giorno
Poi Dio disse: «La terra produca animali viventi secondo la loro specie: bestiame, rettili e animali selvatici». E così avvenne: Dio fece le bestie selvatiche secondo la loro specie e il bestiame secondo la propria specie e tutti i rettili del suolo secondo la loro specie. E Dio vide che era cosa buona.


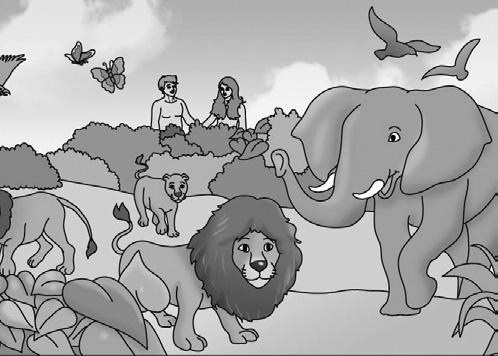
E Dio disse: «Facciamo l’uomo a nostra immagine, a nostra somiglianza, e domini sui pesci del mare e sugli uccelli del cielo, sul bestiame, su tutte le bestie selvatiche e su tutti i rettili che strisciano sulla terra.»
Dio creò l’uomo a sua immagine; a immagine di Dio lo creò; maschio e femmina li creò. Dio li benedisse e disse loro: «Siate fecondi e moltiplicatevi, riempite la terra; soggiogatela e dominate sui pesci del mare e sugli uccelli del cielo e su ogni essere vivente, che striscia sulla terra».
Poi Dio disse: «Ecco, io vi dò ogni erba che produce seme e ogni albero in cui è il frutto: saranno vostro cibo. A tutte le bestie selvatiche, a tutti gli uccelli del cielo e a tutti gli esseri che strisciano sulla terra e nei quali è alito di vita, io do in cibo ogni erba verde».
E così avvenne. Dio vide quanto aveva fatto, ed ecco, era cosa molto buona. E fu sera e fu mattina: sesto giorno.
Settimo giorno
Così furono portati a compimento il cielo e la terra e tutte le loro schiere. Allora Dio, nel settimo giorno, portò a termine il lavoro che aveva fatto e cessò nel settimo giorno da ogni suo lavoro.
Dio benedisse il settimo giorno e lo consacrò, perché in esso aveva cessato da ogni lavoro che egli creando aveva fatto. Queste le origini del cielo e della terra, quando vennero creati.

Scienza e religione sono strumenti preziosi per riflettere sulla REALTÀ DELLA VITA ma hanno fini differenti: l’una studia il come, l’altra il perché delle cose.
La ricerca delle verità le accomuna e deve spingerle al RISPETTO RECIPROCO e all’armonia, così come ricordano le parole di Enrico Medi, grande figura di scienziato e credente del nostro tempo. Egli era un uomo semplice e meditativo allo stesso tempo che aveva scelto di impegnarsi nella ricerca scientifica attraverso lo studio della fisica perché solo tramite la conoscenza della natura riteneva di poter arrivare a riconoscere in essa la traccia visibile del Creatore. Per Medi la ragione e la fede conducevano l’uomo a svelare i misteri che lo circondano, glorificando poi la grandezza di Dio. Era dunque un uomo che prima di essere uno scienziato era un credente.
Enrico Medi: nasce a Porto Recanati il 26 aprile 1911, dove il padre esercita la professione di medico chirurgo. Compie i suoi studi a Roma, laureandosi in fisica pura con Enrico Fermi. Ancora giovanissimo, a soli 26 anni, è libero docente in fisica terrestre, subito dopo vince la cattedra di fisica sperimentale all’Università di Palermo.
A 38 anni è direttore dell’Istituto Nazionale di Geofisica e titolare della cattedra di fisica terrestre presso l’Università di Roma. Nel 1958 è nominato vice presidente dell’Euratom. Attraverso la stampa, la radio e la televisione diffonde l’insegnamento scientifico. Il suo ricordo è vivissimo in quanti lo seguirono nel 1969, quando guidò i telespettatori a comprendere il significato del primo allunaggio umano della Storia. Un uomo impegnato anche politicamente e socialmente. È membro della Costituente italiana e successivamente deputato al parlamento nella prima legislatura. Nel 1971 è il primo degli eletti con 75000 voti preferenziali al Consiglio Comunale di Roma.
Profondamente credente, riesce a conciliare scienza e fede, e a coinvolgere tutta la sua persona di uomo, di sposo, di padre, di professionista in un meraviglioso esempio di coerenza totale. Muore a Roma il 26 maggio del 1974. Questo, che segue, il testo di un suo inno alla creazione.

O voi misteriose galassie, voi mandate luce ma non intendete, voi mandate bagliori di bellezza ma bellezza non possedete, voi avete immensità di grandezza ma grandezza non calcolate. Io vi vedo, vi calcolo, vi intendo, vi studio e vi scopro, vi penetro e vi raccolgo.
Da voi io prendo la luce e ne faccio sapienza, prendo lo sfavillio dei colori e ne faccio poesia; io prendo voi, o stelle, nelle mie mani e tremando nell’umiltà dell’essere mio vi alzo al di sopra di voi stesse e in preghiera vi porgo a quel Creatore che per mio mezzo voi stelle potete adorare.
Enrico Medi
Movimenti e teorie dell'origine della vita
Geocentrismo: È un modello astronomico che pone la Terra al centro dell’universo, mentre tutti gli altri corpi celesti ruoterebbero attorno ad essa. Tale sistema ebbe ampia diffusione nell’Antichità e nel Medio Evo, soprattutto per ragioni filosofiche e religiose. Esso fu soppiantato tra il XVI e il XVII secolo dal sistema eliocentrico.
Questo passaggio, noto come Rivoluzione Copernicana, segnò l’affermazione del metodo scientifico e la nascita della scienza moderna.
Eliocentrismo: È una teoria astronomica (dal greco helios, sole, e kentro, centro) che postula che il sole sia fisso al centro dell’universo e/o del sistema solare, e che i pianeti vi girino intorno. L’eliocentrismo è opposto al geocentrismo.
Nel 1543 l’astronomo Nicolò Copernico con il suo De Revolutionibus orbium coelestium (la rivoluzione dei mondi celesti) propone la corretta visione del sistema solare: è il sole e non la terra ad essere al centro del sistema.
La teoria copernicana fu in seguito rivisitata da Galileo Galilei. Egli per aver esposto come tesi scientifiche quelle che fino ad allora erano state considerate solamente ipotesi fu condannato dal Santo Uffizio al carcere a vita, pena che dovette scontare nella proprio villa ad Arcetri.
Inoltre fu condannato a recitare preghiere quotidiane per tre anni e dovette pronunciare un atto di abiura (alla fine del quale la leggenda dice che mormorò la celeberrima frase: E pur si muove). Durante il processo a Galileo, si contestò che in un famoso passo della Bibbia, Giosuè (Gs 10,12-14) aveva pronunciato le parole: «Fermati o sole!» e che quindi la Sacra Scrittura aveva confermato la teoria geocentrica.
Nel 1992 papa Giovanni Paolo II ritirò la condanna della Chiesa cattolica allo scienziato; pubblicamente riconobbe la validità e la verità scientifica delle teorie di Galileo e chiese scusa, da parte della Chiesa, per aver ingiustamente condannato non solo il fondatore della scienza moderna, ma indiscutibilmente una delle menti più brillanti e geniali dello scorso millennio.
Creazionismo: Il termine viene riferito ai movimenti che si oppongono all’evoluzionismo. Per i creazionisti, Dio, autore dell’universo, lo ha creato proprio come è raccontato nella Bibbia, in modo diretto indipendentemente dalle leggi naturali. Tale movimento nasce negli Stati Uniti nella seconda metà del 1800.
Evoluzionismo: È una dottrina che si contrappone al determinismo: afferma infatti che non esiste un piano predeterminato, né un disegno concepito da una volontà trascendente (Dio). Secondo questa teoria l’universo ha subito, nel corso del tempo delle trasformazioni dovute a un naturale processo di sviluppo che, da un primitivo stato di indifferenziazione e di omogeneità, ha portato tutti gli esseri a stati sempre più differenziati e complessi. Charles Darwin, nell’opera L’origine della specie (1859) sostiene che le trasformazioni si sono determinate dalla “selezione naturale” che favorisce la sopravvivenza e la discendenza degli individui più adatti a vincere la lotta per l’esistenza in quanto dotati di variazioni di carattere ereditari che si accentuano attraverso le generazioni e portano alla formazione di nuove specie. Dunque si ha dapprima lo sviluppo di una grande varietà di individui che poi, sono selezionati secondo il criterio per cui solo il più adatto sopravvive.
Materialismo: Questa corrente filosofica afferma che tutto ha origine dalla materia e tutto è riconducibile ad essa. Per la sua matrice atea, nega l’esistenza di un ente spirituale creatore e ordinatore dell’universo.
Clonazione: La parola clone deriva dal greco klon, e significa germoglio o ramoscello. In biologia di per sé significa la riproduzione di un’entità biologica identica geneticamente a quella originante, ossia la possibilità di duplicare il patrimonio biologico-genetico di qualsiasi essere vitale.
La prima clonazione di animali ottenuta con successo è stata quella delle rane (1951), particolare scalpore ha suscitato la nascita in laboratorio della pecore Dolly (1997) ad opera di due scienziati scozzesi. Se tale applicazione avvenisse sugli uomini si potrebbero avere persone umane senza procreazione, senza che l’uomo e la donna esercitino la loro naturale paternità e maternità, ma semplicemente clonando una cellula.
Bioetica: Si tratta di una nuova disciplina che si propone di valutare i limiti morali al di là dei quali le attuali applicazioni scientifiche possono essere considerate illecite.
La bioetica si propone di sollevare domande etiche, cioè morali, sulla vita, sul suo valore, sul miglioramento della sua qualità, sia in riferimento alla singola persona umana, sia in riferimento all’umanità.
La comunità scientifica internazionale, riconoscendo il ruolo della bioetica, ha iniziato a definire una serie di norme comportamentali per prevenire eventuali abusi.
La scoperta del FUOCO degli uomini primitivi fu una rivoluzione culturale per l’umanità. Questa scoperta permise all’uomo di illuminare durante le ore di buio, UNA GRANDE RIVOLUZIONE
cuocere la carne e difendersi dagli animali feroci che erano spaventati dalle fiamme.
Questo fenomeno può essere in alcuni casi anche dannoso e pericoloso per gli esseri viventi, e ancora oggi viene usato dall’uomo nella sua vita quotidiana.
1. La pila elettrica (1799) da Alessandro Volta.
2. Il telefono (1871) da Meucci.
3. La radio (1895) da Guglielmo Marconi.
4. La banca (1462) inventata nel nord dell’Italia. 5 - Il pianoforte (1698) da Cristofali.
6. Gli occhiali (1300).
7. La plastica (anni ’60) da Natta.
8. L’elicottero (1930) da Ascanio.
9. L’autostrada (1923).
10. Il microchip (anni ’60) dal fisico Faggin.
LA PRIMA SPEDIZIONE IN AMERICA
Il 3 agosto 1492 COLOMBO partì con tre caravelle e un equipaggio di 90 uomini. Il 12 ottobre dello stesso anno la spedizione sbarcò su di un’isola che Colombo chiamò SAN SALVADOR. In seguito raggiunsero l’attuale Cuba. Nel gennaio del 1493 Colombo iniziò il viaggio di ritorno, raggiungendo la Spagna nel marzo del 1494, solo con due caravelle (la Nina e la Pinta) perché la Santa Maria era naufragata.
La nascita di internet è il frutto dello SVILUPPO TECNOLOGICO nelle telecomunicazioni. I primi progetti sono degli anni ’50, ma trent’anni dopo le tecnologie che costituirono la base di internet cominciarono a diffondersi in tutto il mondo. La rete informatica che permette agli utenti di COMUNICARE, ha raggiunto il suo massimo sviluppo negli anni novanta con il WORLD WIDE WEB.
ALBERT BRUCE SABIN
Grande scoperta fu quella del VACCINO CONTRO LA POLIOMIELITE, da parte del medico Albert Bruce Sabin (1906-1993). La poliomielite, detta anche paralisi infantile, è una malattia altamente contagiosa, con diverse manifestazioni, anche di tipo neurologico. Si manifestava con attacchi di febbre improvvisi, seguiti dalla paralisi immediata di una parte del corpo.
Il Big Bang è la teoria per cui l’Universo si è formato dall’esplosione di corpi gassosi che hanno dato origine al Sole e i detriti sono diventati gli attuali pianeti. Questa è la più grande scoperta del XX secolo, assieme ad altre direzioni di ricerca che cercano di dimostrare, ad esempio, che esistono altri universi oltre al nostro.
Che cos’è un atomo? L’atomo è il componente fondamentale della materia che forma il nostro Universo. Rappresenta l’unità più piccola da cui dipendono tutte le caratteristiche degli elementi di cui sono fatti gli oggetti comuni che ci circondano ogni giorno.
Lavoriamo come gli scienziati. Per conoscere i fenomeni naturali e dimostrare come accadono si usa il metodo scientifico. Quali fasi deve seguire lo scienziato per osservare e capire un fenomeno?
1. Osserva e si pone delle domande.
2. Cerca di darsi una possibile spiegazione (fare un’ipotesi).
3. Compie degli esperimenti per verificare l’esattezza della sua risposta.
4. Durante gli esperimenti, lo scienziato registra i dati che rileva nell’esperienza.
5. Infine comunica a tutti la sua risposta (tesi).

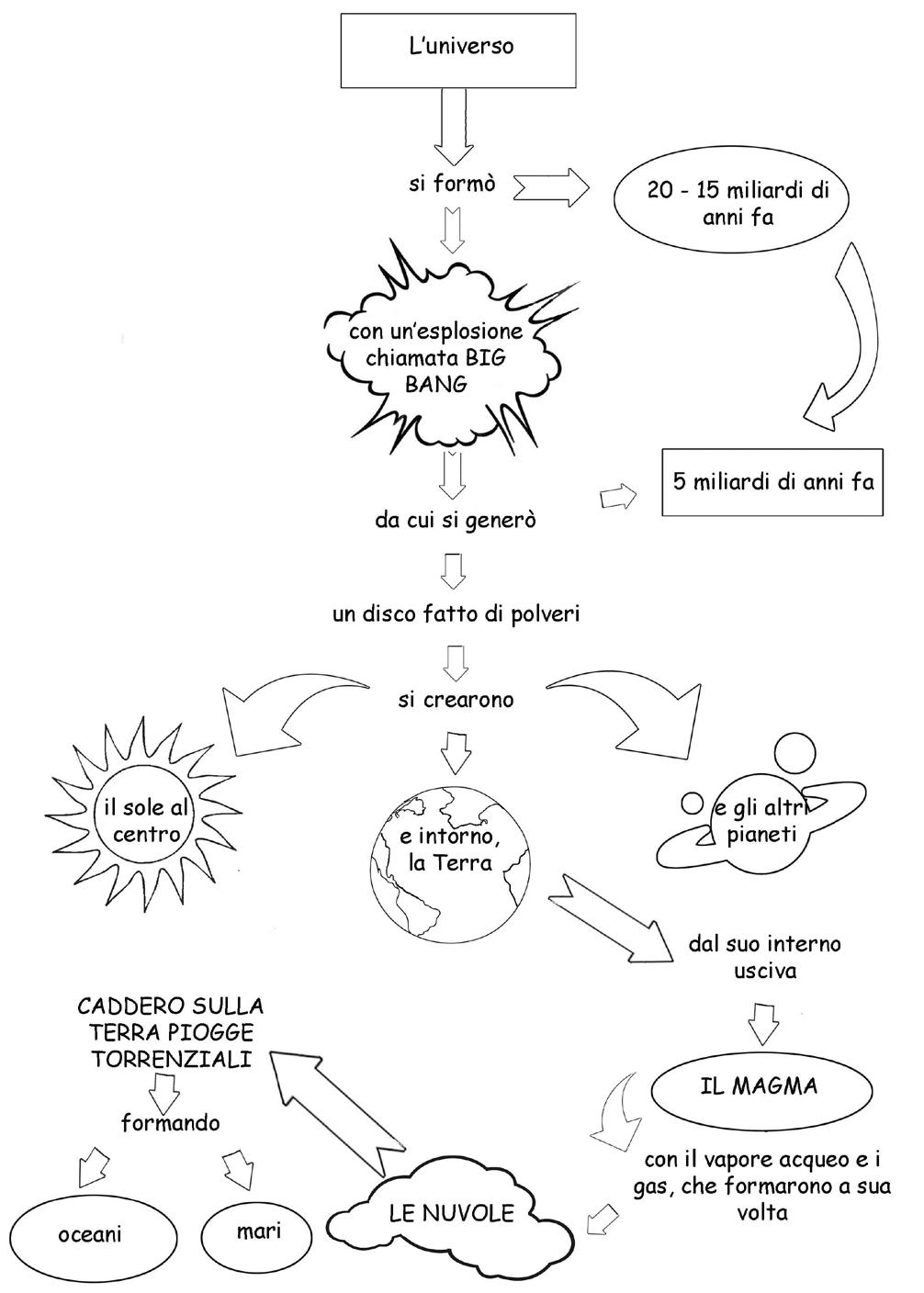
Insegniamo a distinguere fra gli esatti significati di questi termini.
• La STORIA è la NARRAZIONE, fondata su documenti, di ciò che è realmente accaduto (per esempio che siamo nati in un dato anno è certificato all’anagrafe).
• La LEGGENDA è un FATTO IN PARTE STORICO, IN PARTE ABBELLITO con circostanze di fantasia (per esempio il re Alarico seppellito nel fiume Busento).
• Il MITO è una SPIEGAZIONE FANTASTICA e non reale che i popoli primitivi cercavano di dare a fatti naturali e umani (per esempio il sole, al tramonto, si corica a dormire sotto il mare).
• La FIABA è un RACCONTO FANTASTICO, con fate, maghi, streghe e altri esseri del tutto irreali (per esempio Biancaneve e i sette nani, Shrek).
• La FAVOLA è un RACCONTO IN CUI AGISCONO QUASI SEMPRE ANIMALI , che spesso impersonano vizi e virtù, a scopo di insegnamento morale (per esempio Il lupo e l’agnello oppure i tre porcellini).
Lasciare un’impronta della mano su una parete rocciosa, scheggiare una pietra per farne uno strumento di lavoro o riprodurre con sorprendente verosimiglianza tori, orsi, cavalli, cervi e l’imponente mammut, sfruttando la curvatura naturale delle pareti e del soffitto: ecco le PRIME CREAZIONI ARTISTICHE DELL’UOMO . Le più antiche risalgono al tempo del Paleolitico superiore (35.00010.000 anni a.C.) quando l’uomo preistorico era un cacciatore-raccoglitore e doveva spostarsi continuamente alla ricerca di cibo. Per l’uomo delle caverne, queste espressioni artistiche avevano soprattutto una FUNZIONE MAGICO-PROPIZIATORIA, servivano cioè ad anticipare con l’immaginazione il momento in cui la preda sarebbe stata abbattuta. Le più remote rappresentazioni raffigurative che si conoscono sono le pitture rupestri delle grotte di Altamira in Spagna e di Lascaux in Francia. Nella preistoria per produrre i colori si usavano sostanze naturali come terre, pietre frantumate, succhi vegetali o guano (sterco di uccelli), diluiti con acqua o con grasso animale. Il colore veniva disteso con le dita o servendosi di rudimentali strumenti come piume, pezzetti
Per avvicinare ancor più i bambini al mondo della preistoria proponiamo alla classe di realizzare alcune attività che si ispirano a incisioni e dipinti dell’uomo primitivo.
Si possono usare diverse tecniche: graffito, pittura rupestre e spalmatura.
Graffito di legno, pelli di animali, oppure spruzzato con cannucce di osso.
Sul foglio stendere per bene un colore a cera chiaro, scegliere preferibilmente il giallo che è un colore vivo che si stende con facilità.
Poi sul colore giallo passare un tono più scuro. È preferibile usare il rosso come secondo colore. Stenderlo in modo compatto, prima farne una passata leggera e poi una più intensa, spandendo il colore prima in senso orizzontale e poi in quello verticale.
Passare un terzo colore più scuro nello stesso modo degli altri, si potrebbe usare un blu o un marrone scuro.
Come ultimo colore passare il nero e coprire tutto in modo compatto, distribuire sempre il colore in modo uniforme.
A questo punto prendere un oggetto appuntito ed incidere e pressare per creare il disegno (che si ha in mente di fare o quello proposto dall’insegnante attraverso le fotocopie) graffiando leggermente per ottenere le varie sfumature di colore che vanno dal blu all’arancione e al giallo.
• Fotocopie di soggetti preistorici da mostrare agli alunni per la realizzazione dell’attività
• Foglio di album liscio
• Colori a cera (giallo, rosso, blu o marrone scuro, nero)
• Oggetto ben appuntito
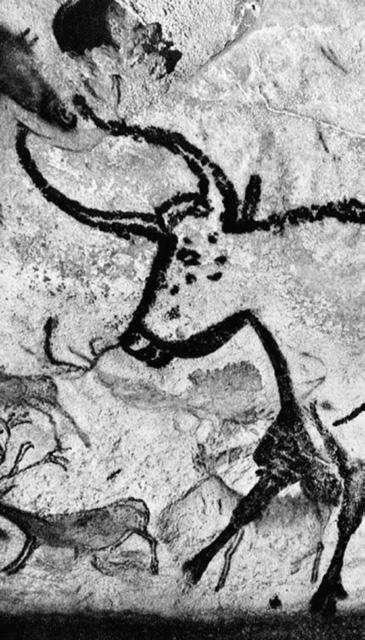
Pittura rupestre
REALIZZAZIONE
Sul foglio disegnare una figura rupestre ripassandone i contorni con un carboncino nero.
Colorare l’interno delle figure con il sale colorato, ottenuto girando il pennarello del colore scelto all’interno del bicchierino con il sale.
Passare uno strato di vinavil sopra la figura e fissarci sopra il sale.
Come ultimo colore passare il nero e coprire tutto in modo compatto, distribuire sempre il colore in modo uniforme.
Spalmatura
REALIZZAZIONE
Versare della tempera in un piattino diluendola con dell’acqua fino a renderla sufficientemente liquida.
Indossare un guanto di gomma aderente.
Imprimere il palmo della propria mano nel colore e poi lasciare la propria impronta sul cartoncino.
Ripetere l’operazione con altri colori fino a riempire completamente lo spazio.
OCCORRENTE
• Fotocopie di soggetti preistorici
• Foglio di album
• Carboncino nero
• Sale
• Bicchiere di carta
• Pennarello marrone scuro o rosso
• Pennello
• Vinavil

OCCORRENTE
• Cartoncino
• Guanto di gomma aderente
• Tempera
• Piattino di carta
• Colori a tempera
• Acqua

Costruiamo il rotolo di pergamena
REALIZZAZIONE
Modella con il das quattro palline e infilale all’estremità dei bastoncini per fare i pomelli.
Una volta asciutti vernicia i pomelli e i bastoncini di marrone.
Metti in infusione, in poca acqua fredda, le bustine di tè o del caffè solubile. Spennella più volte con la soluzione i fogli di carta fino ad ottenere l’effetto pergamena. Lasciare asciugare.
Incolla i fogli sul lato più lungo e poi cucili a punti larghi con il filo di lana grossa.
Incolla un lato del primo foglio ad uno dei bastoncini e il lato dell’ultimo foglio all’altro bastoncino.
Con il pennarello scrivi la seguente frase tratta dalla scrittura: “Tutta la scrittura è ispirata da Dio” (2Timoteo 3,16).
Incolla o trascrivi sul rotolo brani biblici particolarmente significativi.
Richiudi la pergamena arrotolandola sui bastoncini e legala con il filo di lana.
Fossili... di gesso
• Due aste di legno o due canne (di plastica o di bambù)
• Fogli di carta
• Tempera marrone
• Pennelli
• Forbici • Colla
• Filo di lana grossa
• Ago di lana
• Pennarello scuro (marrone o nero)
• Das
• Acqua
• Bustine di tè o caffè solubile
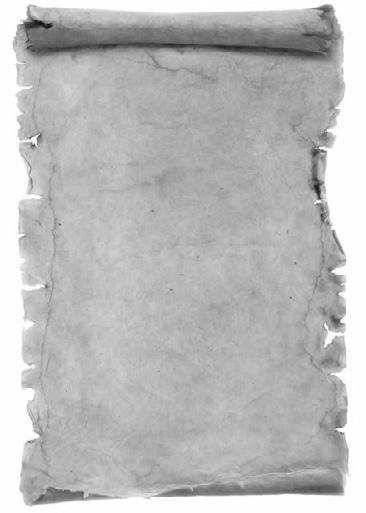
I fossili esercitano sempre nei bambini un grandissimo interesse: voci di un passato remoto raccontano la storia della terra e della vita.
Proponiamo la FABBRICAZIONE DI UN FOSSILE, un’attività di semplice esecuzione il
cui risultato gratificherà enormemente gli alunni.
Tra le forme da fossilizzare suggeriamo di utilizzare anche delle FOGLIE DI GINKGO
BILOBA, considerato un fossile vivente perché l’albero già esisteva più di duecento milioni di anni fa. Si trovano diversi esemplari nei giardini e nei parchi pubblici.
REALIZZAZIONE
Preparare su di un foglio di plastica una lastra di mastice non troppo grande (esempio cm 10x15) spessa circa un cm.
Eliminare le impronte delle dita premendo sopra un corpo scabro (sasso spezzato, calcinaccio…).
Sopra al mastice così preparato premere con cura le foglie di ginkgo in modo da avere un’impronta chiara e netta sia del bordo che delle venature.
Fissare tutt’intorno al pezzo un bordo di mastice alto un paio di centimetri.
In una mezza palla o in un recipiente di plastica molle preparare la scagliola piuttosto liquida. Versarla, evitando che si formino bolle d’aria, e riempire la forma per almeno 1 cm.
Quando, poco a poco, la scagliola comincia a indurire, togliere la striscia intorno e, anche rompendolo un po’, rendere il bordo irregolare.
Appena la lastra si è solidificata, toglierla dal mastice.
Colorarla mentre è ancora bagnata mescolando alla tempera marroncina o grigiastra anche terra o sabbia fine con un po’ di colla. Usare per le foglie una tinta leggermente più scura.
• Foglie di ginkgo biloba
• Gusci di conchiglie di diverse dimensioni (pettini, ostriche, vongole…)
• Mastice per vetri o plastilina
• Scagliola
• Colori a tempera
• Sabbia o terra fine
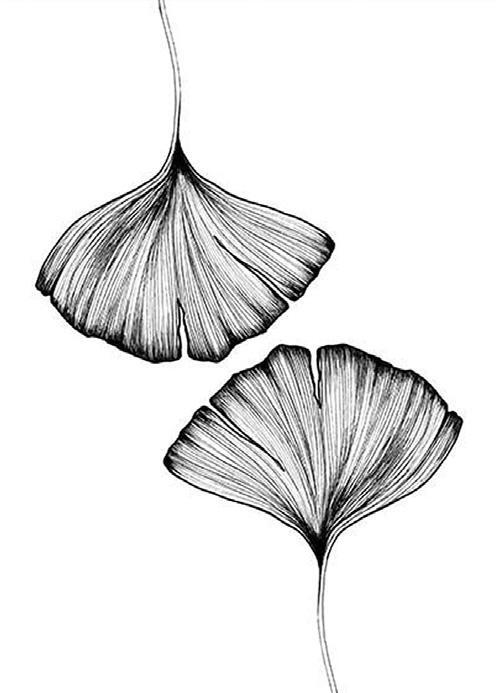
Laudato si, creatore e padre
Laudato si’, Signore mio, perché ci hai creato e redento, Tu Padre di immensa tenerezza e bontà.
Laudato si’, Signore mio, per il dono del creato che hai affidato alla nostra custodia e messo nelle nostre mani, non sempre attente ed oculate nel conservare i beni che ci hai lasciato a nostra gioia e felicità.
Laudato si’, Signore mio per ogni uomo e donna di questa martoriata terra, afflitta da tanti mali incurabili del corpo e dello spirito.
Fa’ che nessuno di questi nostri fratelli possa assaporare la freddezza del nostro cuore e l’indifferenza della nostra mente, presa da tanti personali problemi, incapace di leggere il dolore e la sofferenza sul volto di chi non conta in questo mondo.
Laudato si’, Signore mio, per tutte le croci che ci doni ogni giorno e ci inviti a portare con dignità senza scaricarle sulle spalle degli altri, ma felici di salire con te sul calvario
e donare la nostra vita, come vittime espiatrici per la conversione e la santificazione del genere umano.
Laudato si’, Signore mio per le tante umiliazioni che ci hai fatto sperimentare attraverso quanti non sanno e non vogliono amare sinceramente gli altri e si fanno giudici severi del prossimo e molto tolleranti con se stessi.
Laudato si’, Signore mio per ogni cosa e per tutto quello che guardiamo con i nostri occhi, gustiamo con il nostro palato, tocchiamo con le nostre mani, odoriamo con il nostro naso, ascoltiamo con le nostre orecchie, soprattutto se sei Tu Signore a parlare direttamente al nostro cuore, perché ci vuoi totalmente consacrati al tuo amore e alla tua lode, nella cristiana speranza di lodarti per sempre nella gioia del tuo Regno, dove ci attendi per donarci la pace e la felicità che non ha fine, insieme a Maria, la Tua e la nostra Madre, Regina del cielo e della terra. Amen.
Padre Antonio Rungi
Continuiamo il nostro percorso sulla religiosità dei popoli primitivi proponendo agli alunni una filastrocca che parla delle ESPRESSIONI ARTISTICHE RELIGIOSE delle grotte di Altamira. In questo modo li aiuteremo ad osservarle con gli occhi di chi le ha realizzate.
Sembra vivo quel bisonte ch’è graffito in prima fila e pensare che di anni ne ha più di ventimila. Chi ammira queste scene che dell’arte son gioiello presto pensa al suo autore, primo grande Raffaello. A graffiare queste pietre quanto tempo avrà impiegato? È lavoro tutto suo o qualcun lo avrà aiutato?
L’avrà fatto per diletto, per magia, per propiziare dei e dee, quando a caccia già pensava di andare? Son domande destinate a restar senza risposta; ma se ascolti, c’è una voce che ripete senza sosta: mise Dio nella sua mente questa fiamma dell’amore, perché fosse ancor più bello quel che fece il suo Creatore.
S. Ferraresso
Eccola. È qua. Tintinna come al solito dapprima lieve in sordina accorda lo strumento poi sempre più fitta distorce le immagini lava gli animi e seduce i marciapiedi arrivando a terra.
Fredda e acida si raccoglie in pozze e ci restituisce il miracolo… un sole riflesso tra le braccia stanche di un materno arcobaleno.
Sabrina Balbinetti
Secondo te quali sensazioni provavano gli uomini primitivi di fronte alle manifestazioni naturali o agli avvenimenti della vita? Scrivi sotto ogni immagine una frase riferita alle loro sensazioni e una alle tue.
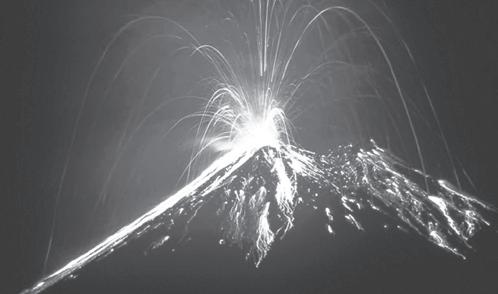





Osserva le scene e descrivi cosa avviene in modo il più possibile “scientifico”.
Osserva le scene e descrivi cosa avviene in modo il più possibile “scientifico”.
Colora i numeri e racconta cosa è avvenuto in ciascun giorno della creazione. Ritagliali e incollali sul quadernone scrivendo per ciascuno una didascalia.
Ricostruisci la sequenza esatta delle vignette numerandole, poi scrivi sotto ciascuna cosa succede.
Disegna tra Adamo ed Eva l’albero della conoscenza del bene e del male con il serpente astuto che li ingannò.
Un giorno Dio convocò i suoi angeli e disse loro: «Ho un grosso dispiacere. Ho sentito una bambina che diceva alla mamma: “Mamma, perché Dio non mi risponde quando gli parlo?”. Sono preoccupato, voglio che andiate sulla terra a vedere se anche gli uomini, come questa bambina, si stanno dimenticando di me, perché non mi sentono parlare».
Così, Dio decise di mandare quattro angeli a fare un’inchiesta sulla terra. Essi partirono per i quattro punti della terra, il Nord, il Sud, il Levante e il Ponente.
Quando tornarono Dio chiese loro che cosa avevano visto.
L’angelo venuto dal Nord gli disse: «Ho visto il fuoco del sole, la luna di ghiaccio, le foreste d’America e la sabba d’Africa, tutti i pesci, tutte le lucertole fino alle grosse fiere e alle zanzare. Ho visto tutta la creazione, e tutto sulla Terra parla di te».
L’angelo venuto dal Sud continuò: «Ho visto le città e le capanne, i bambini giocano, i vecchi mettono le rughe. Tutti sorridono, tutti accarezzano, fino alle lacrime. Ho visto tutto l ’uomo, e tutto sulla Terra parla di te».
E l’angelo del Levante: «Ho visto i templi e le moschee, le acque del Gange e i testi sacri. Tutte le preghiere, tutti i ceri, fino ai grandi re e ai più poveri. Ho visto tutta la storia, e tutto sulla Terra parla di te».
Allora Dio si voltò verso il quarto angelo che tornava da Ponente: «E tu, non hai nulla da dire?».
E l’angelo rispose: «Sono andato a vedere la bambina che avevi sentito. Giocava a nascondino e non trovava nessuno. Mi sono avvicinato come una corrente d’aria e le ho soffiato: Tu non trovi perché cerchi dove non c’è».
Disegna che cosa hanno visto gli angeli. Poi inventa e scrivi la conclusione della storia.
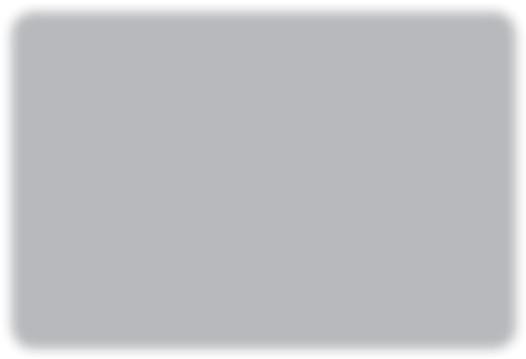



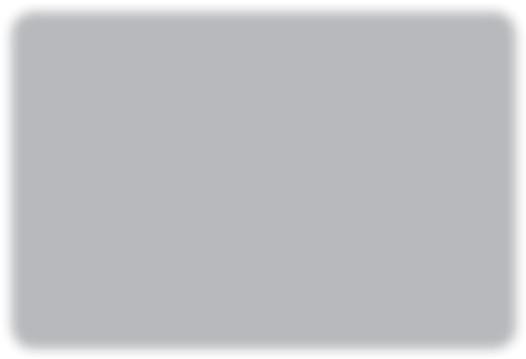
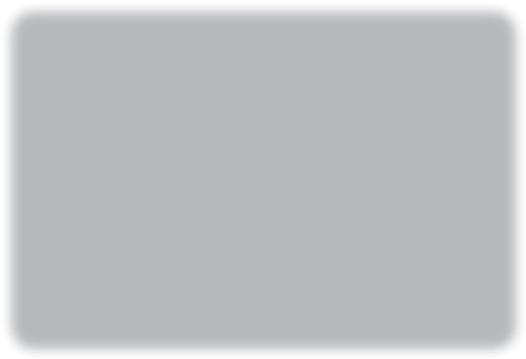
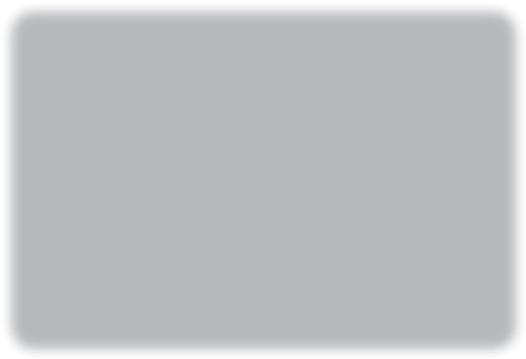

Osserva i disegni e abbinali alle giuste didascalie. Scoprirai che cosa è accaduto nella primavera del 1947 a Qumran.





Impaurito scappa e poi torna con un amico. Calatosi nella grotta scopre otto giare chiuse con coperchi.
Un giovane pastore, Mohamed “Il lupo” pascola le sue capre nelle vicinanze del Mar Morto.
Le apre e scopre che contenevano dei rotoli: si trattava di manoscritti di testi biblici.
Alla ricerca di una capra smarrita, butta delle pietre in una grotta scura.
Non sente nessun belato, ma solamente il rumore dei cocci rotti.
Credere in Dio Creatore è un articolo di fede spesso frainteso, non solo negli ultimi secoli, ma fino ai giorni nostri. In realtà, affermare l’esistenza di Dio Creatore non vuol dire fare un discorso contro la scienza e l’evoluzione, ma sostenere che il mondo e l’uomo hanno un senso e un valore. Ecco cosa dicono due famosi scienziati e due grandi uomini di fede, uno del passato e l’altro del presente.
Ripassa ciascun percorso di una tinta differente e scoprirai da quali personaggi sono stati pronunciati i discorsi.
“Una cosa è sicura. Nessuno scienziato è in grado di dire come andrà a finire il mondo. Solo Colui che ha fatto il mondo lo sa. Quando uno scienziato lavora è come se fosse in colloquio diretto con Colui che ha fatto il mondo”.
“Non siamo il prodotto casuale e senza senso dell’evoluzione. Ciascuno di noi è il frutto di un pensiero di Dio. Ciascuno di noi è voluto, ciascuno è amato, ciascuno è necessario”.
“Oggi nuove conoscenze conducono a non considerare più la teoria dell’evoluzione una mera ipotesi. Essa si è progressivamente imposta all’attenzione dei ricercatori, a seguito di una serie di scoperte fatte nelle diverse discipline del sapere”.
“Sebbene la Scrittura non può errare, potrebbe talvolta errare qualcuno dei suoi interpreti ed espositori, in vari modi. Nella Scrittura il Signore ci vuole rivelare come si vada in cielo, non come funziona il cielo”.

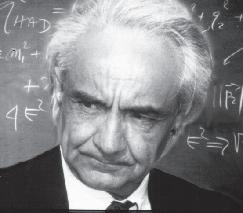
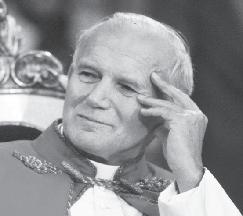
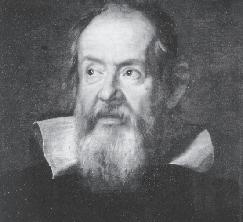
Cerca nella tabella le parole della lista. Cancellale e scrivi le lettere rimaste e scoprirai una frase. Chiedi all’insegnante di spiegarti il significato di alcuni termini che ancora non conosci.
Il problema relativo all’origine del mondo ha generato diverse ipotesie interventi della Chiesa.

L A F M A T E R I A L I S M O E C L O N A Z I O N E D E E L A
S C I E C R E A Z I O N I S M O
G I O V A N N I P A O L O I I N
Z A R I S B I O E T I C A P O N
E L I O C E N T R I S M O D O N
O E V O L U Z I O N I S M O A I
B E N E D E T T O X V I P I U G
R A N D G E O C E N T R I S M O
I I C H A R L E S D A R W I N N
N I C O L O C O P E R N I C O T
E E N R I C O M E D I R R O G A
L E T T E R E T D I S C O R S I
I V P I O D O D I C E S I M O I
D G A L I L E O G A L I L E I E
L L E N C I C L I C H E U O M O
EVOLUZIONISMO
CREAZIONISMO
ELIOCENTRISMO
MATERIALISMO
GEOCENTRISMO
CLONAZIONE
BIOETICA
CHARLES DARWIN
GALILEO GALILEI
NICOLÒ COPERNICO
ENRICO MEDI
PIO DODICESIMO
GIOVANNI PAOLO II
BENEDETTO XVI
ENCICLICHE
LETTERE
DISCORSI
È un argomento difficile! Possiamo cominciare giocando con le parole? ....................................................................................................... ................................................................................................ ..............................
NOME ...............................................................................................
CLASSE ................................... DATA ...................................
L’alunno…
Traguardi per lo Sviluppo delle Competenze
• riconosce che la Bibbia è il libro sacro per cristiani ed ebrei e documento fondamentale della nostra cultura, sapendola distinguere da altre tipologie di testi;
• identifica le caratteristiche essenziali di un brano biblico e sa farsi accompagnare nell’analisi di alcune pagine a lui più accessibili, per collegarle alla propria esperienza.
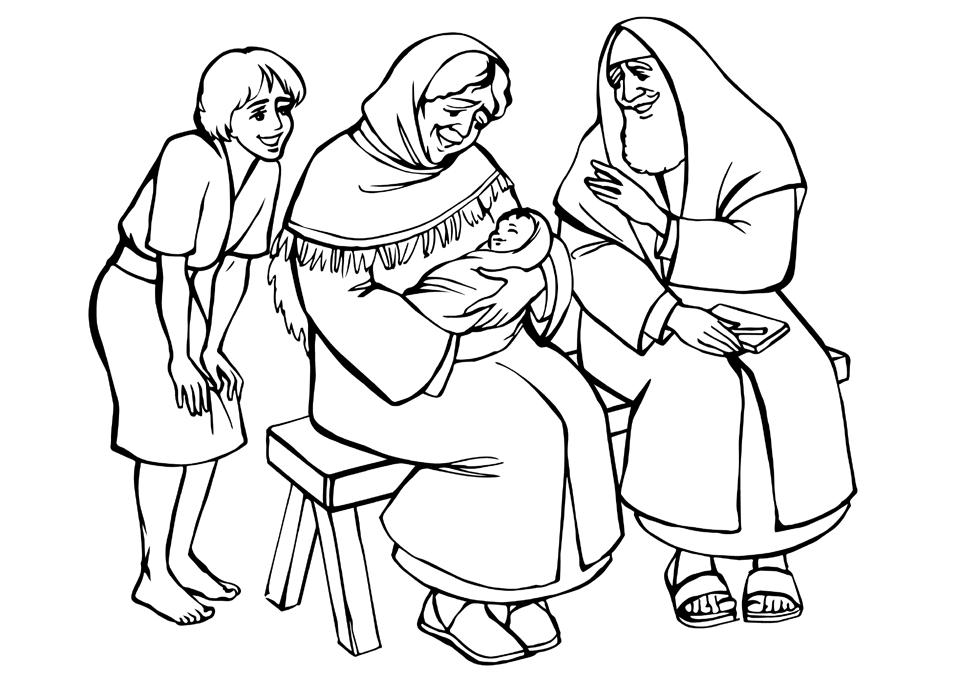
u ni Ta di apprendimen T o p er la p rogrammazione S e TT imanale r iferimen T i al T e ST o o bie TT ivi di apprendimen T o
Un popolo eletto
• Gli ebrei: il popolo eletto scelto da Dio per la sua alleanza con gli uomini.
• La Bibbia, il libro sacro per ebrei e cristiani.
• La Bibbia cristiana: Antico e Nuovo Testamento.
• Dio chiama Abramo, primo patriarca e padre della fede.
Da pag. 115 a pag. 137 Dio e l’uomo
• Scoprire che per la religione cristiana Dio è Creatore e Padre e che fin dalle origini ha voluto stabilire un’alleanza con l’uomo.
La Bibbia e le altre fonti
• Ascoltare, leggere e saper riferire circa alcune semplici storie bibliche.
In questa parte dell’anno l’attenzione sarà tutta per la conoscenza e l’approfondimento del popolo scelto da Dio per la sua alleanza: GLI EBREI. Cosa fondamentale sarà presentare la fonte principale per studiare il popolo ebraico, ovvero la BIBBIA. L’insegnante dovrà sottolineare le varie caratteristiche della Bibbia, affinché gli alunni siano in grado di comprendere la differenza tra la Bibbia ebraica e quella cristiana. Il percorso poi proseguirà con gli episodi principali della nascita del popolo ebraico, a partire dal capostipite Abramo, il prescelto da Dio, chiamato a essere il capo di una grande discendenza, il patriarca del popolo ebraico.
Abramo, pastore nomade, ascolta la voce di Dio e obbedisce alla sua volontà, incamminandosi da Ur fino alla Terra di Canaan, dove si stabilirà con tutta la sua famiglia.
Aspetto fondamentale della vicenda di Abramo è la sua grande fede in Dio, che lo vedrà protagonista di un episodio molto particolare: il sacrificio del suo unico figlio Isacco. Dio sottopone il primo patriarca del popolo ebraico a questa prova, e la sua grande fede, farà di Abramo il padre della fede per tutte e tre le grandi religioni monoteiste: ebrei, cristiani e musulmani.
Per introdurre la figura di Abramo, capostipite del popolo ebraico, leggiamo agli alunni il seguente racconto.
La tua vita è piena di avventure. Scopri sempre qualcosa di nuovo. Incontri degli ostacoli, magari anche dei pericoli. Vivi delle belle esperienze.
Puoi essere contento, perché nella vita non c’è motivo di annoiarsi. Si vive una grande avventura quando si ama un’altra persona.
Ma è possibile vivere l’avventura più grande di tutte quando si ama Dio.
La Bibbia racconta la storia di Abramo, il primo avventuriero di Dio.
La sua avventura cominciò così: Abramo viveva con la sua famiglia e tutti i suoi parenti nella regione di Ur. Erano tutti pastori nomadi. Nelle vicinanze della città di Ur, Abramo un giorno sentì una voce: era la voce di Dio, che gli diceva:
«Esci dalla tua patria e dalla casa paterna e va’ nella terra che io ti indicherò». In chi si può aver fiducia più che in Dio? Dal momento che era stato Dio a dirgli questo, Abramo si mise in cammino verso terre lontane e sconosciute senza sapere quale altra gente avrebbe incontrato.
Tutto, per lui, era nuovo. Attraversò deserti e montagne. Imparò a conoscere nuovi orizzonti. E intanto sognava di come sarebbe stata la sua vita una volta arrivato nella terra che Dio gli aveva promessa. Una terra che sarebbe stata sua. Ma Dio non aveva promesso ad Abramo soltanto una terra: gli aveva anche promesso un figlio, da sua moglie Sara. Un figlio maschio per continuare la sua discendenza. E questo era un fatto straordinario, perché Sara non aveva mai potuto avere figli. Era sterile. All’inizio tutto andò bene. Il bestiame aumentava, perché nelle terre che Abramo attraversava si trovavano degli ottimi pascoli. Anno dopo anno Abramo attraversò paesi sconosciuti, deserti e montagne. Diventò vecchio: ormai aveva quasi ottant’anni. Ma non era ancora arrivato nella terra promessa da Dio. E ancora Sara non gli aveva dato un figlio. Forse, chissà, le promesse di Dio non si sarebbero mai avverate. E Sara, anziana com’era, si sentiva ormai certa di non potere più avere figli. Ma allora chi avrebbe ereditato tutto il bestiame e il patrimonio?
È facile immaginare che ogni tanto questi pensieri tormentassero Abramo. Ma una sera che se ne stava seduto nella sua tenda a pensare, il vecchio improvvisamente, sentì nuovamente la voce di Dio: «Abramo, tutto andrà secondo la mia promessa. Avrai un figlio da tua moglie Sara. Esci dalla tua tenda e alza gli occhi verso le stelle. Contale, se puoi! Ecco: i tuoi discendenti saranno numerosi come le stelle del cielo».
Allora Abramo non ebbe più dubbi. Dio non dimentica ciò che promette. Bisogna solo avere molta pazienza. Forse, quella notte, Abramo restò sveglio a lungo, e non perché fosse preoccupato, ma per la gioia che la promessa di Dio si sarebbe avverata.
Abramo si rimise in cammino con sua moglie, la sua gente e i suoi animali. Passarono altri anni. Poi Dio tornò a dargli la sua parola. Era l’ora più calda di un giorno d’estate quando, all’improvviso, davanti alla tenda di Abramo comparvero tre uomini. Abramo li salutò con grande rispetto e poi disse loro: «Sedete qui all’ombra e riposatevi.» Fece portare da bere e da mangiare: del latte, dei pani e del vitello arrosto. Allora uno dei tre uomini disse: «Entro un anno tua moglie Sara avrà un bambino».
Sara, che stava ad origliare dietro la tenda, quando sentì parlare del bambino si mise a ridere. Non poteva crederci: una donna già anziana, che potrebbe essere nonna o bisnonna, non può più mettere al mondo dei bambini.
E Sara era molto anziana. Eppure ebbe un bambino, esattamente un anno più tardi.
Adesso babbo Abramo e mamma Sara sapevano – e dovevano ricordarsene ogni giorno – che Dio mantiene ciò che promette. Il piccolo Isacco ne era la prova.
Vocazione di Abramo: Gn 12,1-9: Dio fa ad Abramo tre promesse molto importanti, quella di fare di lui un popolo grande, di benedirlo, e di rendere famoso sempre il suo nome perché da lui nascerà un popolo.
Abramo in Egitto: Gn 12,10-20: la moglie Sarai viene fatta passare per sorella di Abramo, sposa il faraone ma poi sarà lui stesso a cacciarli via.
Abramo si separa da Lot: il nipote, affinché non ci sia contesa tra loro.
Promesse di Dio ad Abramo: Gn 13,14-18.
Dio promette un figlio ad Abramo e fa con lui un’Alleanza: Gn 15,1-8. 12-16.
Abramo ha come figlio Ismaele da una serva: quello è sì suo figlio, ma non un figlio avuto da Sara, sua moglie. Ismaele sarà benedetto da Dio e molto amato da Sara e Abramo fino a quando Isacco non nascerà.
Patto fra Dio e Abramo: Gn 17,1-8.
Promessa di un figlio (Isacco) e cambio di nome a Sara: Gn 17,15-17.19-22: Sara Principessa, madre di numerosi figli, mentre Sarai è una forma diversa dello stesso nome. Isacco sorriso, figlio del sorriso (perché veniva in un’età insperata), colui che ride.
Nascita di Isacco, il figlio promesso: Gn 21,17.
Dio prova Abramo: Gn 22,1-19.
Morte di Sara: Gn 12,1-19.
Isacco si sposa con Rebecca: Gn 24,29-67.
Morte di Abramo: Gn 25,5-11.
Ebrei significa “gente senza dimora fissa” perché erano un popolo di pastori nomadi originari della Mesopotamia; si stabilirono nella terra di Canaan, che oggi corrisponde all’incirca allo stato di Israele e ai territori palestinesi. La loro storia non è legata a un solo territorio, ma è segnata da continui spostamenti.
La terra di Canaan è una striscia pianeggiante e fertile che si estende lungo la costa del Mar Mediterraneo. È circondata da un altopiano desertico e montuoso, solcato da un fiume, il Giordano, e dal deserto del Sinai. Il clima era caldo e umido nei territori pianeggianti. Vi crescevano palme, sicomori, fichi e mandorli. I deserti, invece, erano caldi e aridi con pochi arbusti spinosi. Allevavano cavalli, buoi, cammelli e asini adatti ai lavori più faticosi, pecore e capre per la carne, il latte e la lana.
Coltivavano viti, olivi e alberi da frutto. Utilizzavano un aratro trainato da animali per seminare cereali, come frumento e orzo, e legumi, come fave e lenticchie. Scambiavano i prodotti della terra con i popoli vicini per procurarsi le merci che non possedevano. Per esempio, ottenevano dai Fenici un colorante per tessuti, la porpora, e dagli Egizi rame, ferro, oro e spezie. Tutto quanto serviva per la vita quotidiana era costruito in famiglia: abiti, vasellame, attrezzi da lavoro.
Non esistevano artigiani specializzati e gli architetti venivano dalla Fenicia.
Gli ebrei erano divisi in dodici tribù, ciascuna formata da più famiglie imparentate fra loro. Alla guida di ogni tribù vi era un patriarca, ma in caso di pericolo veniva eletto un capo unico per tutto il popolo: il giudice. Il re era circondato da funzionari e sacerdoti. Con Saul le tribù si riunirono in un unico regno. A lui succedettero il re Davide e poi il re Salomone, che fece costruire a Gerusalemme, la capitale, un famoso tempio.
Gli ebrei conoscevano la scrittura alfabetica, che avevano imparato dai Fenici. Nell’alfabeto ebraico le lettere erano soltanto consonanti. Solo pochi ebrei sapevano leggere e scrivere; i testi venivano trascritti su fogli di papiro, che si arrotolavano intorno a due bastoncini.
A differenza di altri popoli che credevano in molti dèi, gli ebrei erano monoteisti. Jaweh, il Dio unico, non ha forme umane ed è invisibile agli uomini; non può essere rappresentato e nemmeno invocato con il suo nome.
C’era un unico luogo sacro: il TEMPIO DI GERUSALEMME. Al centro c’era il santuario (la parte più sacra), che conteneva l’Arca dell’Alleanza, una cassa che custodiva i Dieci Comandamenti, ovvero le Tavole della Legge che, secondo gli Ebrei, Mosè aveva ricevuto direttamente da Jaweh.
Solo i sacerdoti e il re potevano entrare nel santuario: essi cantavano inni, detti salmi, e facevano danze di ringraziamento a Jaweh. Le vicende dei re di Israele sono narrate nella Bibbia, che è il libro sacro degli Ebrei.
Nella Bibbia sono compresi la tradizione e il pensiero religioso degli Ebrei; è una raccolta di molti libri.
I primi cinque libri, che gli Ebrei chiamano Torah, contengono le regole della religione, i precetti della vita quotidiana, le preghiere e il racconto dei fatti e dei personaggi importanti della storia di Israele.
IL POPOLO EBRAICO: LA STORIA
- Dalla Mesopotamia alla Palestina
Intono al 2000 a.C. gli ebrei vivevano nei pressi della città di Ur ed erano suddivisi in gruppi chiamati tribù. A capo di ogni tribù c’era un patriarca. Sotto la guida del patriarca Abramo, intorno al 1900 a.C., essi iniziarono un lungo viaggio verso la Palestina, nella valle del fiume Giordano. Questa era la “Terra promessa” che gli aveva indicato il loro Dio Jahvè. Qui si stabilirono diventando agricoltori sedentari e mantenendo l’organizzazione in tribù.
- Dalla Palestina all’Egitto
Nel 1700 a.C. le carestie e gli scontri con i popoli confinanti costrinsero gli Ebrei a migrare in Egitto. Qui vissero per alcuni secoli in pace, apprendendo l’uso dell’aratro e di nuove tecniche agricole, fino a quando il faraone Ramesse II li rese schiavi.
- Dall’Egitto alla Palestina
Nel 1200 a.C. circa, Mosè, uno dei patriarchi, liberò il suo popolo e lo condusse nuovamente in Palestina. Giunti in Palestina, per meglio difendersi dagli attacchi delle popolazioni confinanti, gli ebrei riunirono le loro dodici tribù sotto un
unico capo. Nacque così il Regno di Israele, con capitale Gerusalemme. Il primo re fu Saul, a cui seguirono Davide e Salomone.
- La deportazione a Babilonia
Il Regno di Israele non durò a lungo. Alla morte di Salomone, nel 933 a.C., fu diviso nel regno di Israele e nel regno di Giuda, con capitale Gerusalemme. I due regni erano circondati da popoli forti che volevano controllare la Palestina, attraversata dalle più importanti vie commerciali del tempo.
Nel 722 a.C., gli Assiri conquistarono il regno di Israele e, poco più di un secolo dopo, nel 586 a.C., i Babilonesi conquistarono quello di Giuda. Gerusalemme con il suo tempio fu rasa al suolo e gli ebrei furono deportati come schiavi a Babilonia per quasi cinquant’anni da Nabucodonosor.
- Il ritorno in Palestina
Ritornati in Palestina, gli ebrei non riuscirono più a formare uno Stato forte e vennero sottomessi da vari popoli, finché, nel 70 d.C., furono nuovamente costretti a lasciare la Palestina e a disperdersi per il mondo (diaspora).
- Nell’epoca moderna e contemporanea
A partire dalla fine dell’Ottocento, molti ebrei, dopo secoli di persecuzioni e di dispersione nei vari Paesi del mondo, sono tornati in Palestina. Qui, nel 1948, hanno fondato lo Stato di Israele. La convivenza con la popolazione palestinese e con gli stati Arabi vicini, però, è stata fin da subito molto difficile. Ancora oggi il territorio è sconvolto da violenze e da attentati terroristici.

Esci dalla tua terra e va’ dove ti mostrerò.
Esci dalla tua terra e va’ dove ti mostrerò.
Abramo non partire, non andare, non lasciare la tua terra, cosa speri di trovar?
La strada è sempre quella, ma la gente è differente, ti è nemica, dove speri di arrivar?
Quello che lasci tu lo conosci, il tuo Signore cosa ti dà?
“Un popolo, la terra e la promessa”, parola di Jahvè:
Esci dalla tua terra e va’ dove ti mostrerò.
Esci dalla tua terra e va’ dove ti mostrerò.
La rete sulla spiaggia abbandonata l’han lasciata i pescatori, son partiti con Gesù.
La folla che osannava se n’è andata, ma il silenzio una domanda sembra ai dodici portar:
Quello che lasci tu lo conosci, il tuo Signore cosa ti dà?
“Il centuplo quaggiù e l’eternità”, parola di Gesù.
Esci dalla tua terra e va’ dove ti mostrerò.
Esci dalla tua terra e va’ dove ti mostrerò.
Partire non è tutto certamente c’è chi parte e non dà niente, cerca solo libertà.
Partire con la fede nel Signore con l’amore aperto a tutti può cambiar l’umanità.
Quello che lasci tu lo conosci, quello che porti vale di più.
“Andate e predicate il mio Vangelo”, parola di Gesù.
Esci dalla tua terra e va’ dove ti mostrerò.
Esci dalla tua terra e va’ dove ti mostrerò.
Completa le seguenti frasi inserendo le parole corrette, scelte tra le seguenti: INSEGNAMENTI • PERGAMENA • TRADOTTA • TESTI • CONTENUTA • INSEGNAMENTI
RACCONTA • SCRIVONO • ANNI • NARRATA
Per controllare se hai svolto bene l’attività, inserisci in ogni pallino le lettere delle parole che hai scritto corrispondenti al numero indicato (esempio: nella frase 1: anni, la prima e la terza lettera sono A e N).
Scrivi tutto in ordine sui trattini: scoprirai in quale modo è divisa la Bibbia.
1. I libri più antichi furono scritti tremila –– –– –– –– fa.
2. La Bibbia contiene gli –– ––
3. La Sacra Scrittura –– ––
4. La Bibbia fu scritta su fogli di –– ––
5. Essa è una specie di biblioteca ––
di Dio al suo popolo.
–– in un solo libro.
6. Gli autori sono numerosissimi, –– –– –– –– –– –– –– –– a mano, spesso sono sconosciuti.
7. I –– –– –– –– –– della Bibbia richiedono spesso qualche aiuto per la comprensione.
8. Nella prima parte della Bibbia viene ––
–– la storia del popolo ebraico.
9. I Vangeli raccontano le opere e gli –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– di Gesù.
10. La Bibbia è –– –– –– –– –– –– –– –– in tutte le lingue del mondo.

Riordina i disegni numerandoli. Completa ciascuna didascalia con le parole giuste. Colora i disegni.
• L’INVENZIONE DELLA STAMPA • PAPIRO E PERGAMENA • CD ROM • TRAMANDATE ORALMENTE
Con ..
. la Bibbia si diffuse in tutto il mondo.
Le vicende dell’antico testamento furono
dagli anziani.
Oggi puoi trovare la Bibbia anche in
I racconti della Bibbia furono scritti a mano sui rotoli di ..
Con il termine incunabolo si indica un libro risalente al XV secolo, quando l’arte della stampa era agli inizi. Il nome deriva dal latino cuna, cunabulum, e anche incunabula (fasce da neonato). Il più antico incunabolo che si conosca è la Bibbia in latino, stampata da Gutenberg. Nel mondo esistono 450.000 incunabuli, di cui 100.000 in Italia. Le lettere erano scolpite nel legno. Molto elaborate erano le lettere iniziali, chiamate capilettera.
Osserva i capilettera illustrati e disegna le lettere I, P, O e F seguendo lo stesso stile.
Le citazioni di un brano biblico seguono queste regole: Si scrive il libro, secondo le abbreviazioni consuete.
• Si indica il capitolo di riferimento.
• Si inserisce una virgola e si scrive il versetto al quale si rinvia.
• Se si desidera citare due o più versetti separati , si usa il punto.
• Se si cita un brano che va da un versetto all’altro si mette il trattino
• Se la citazione comprende due capitoli, si separano con il punto e la virgola.
Leggi il brano della Bibbia ed evidenzia con colori diversi le seguenti citazioni: Gn, 2-12; Gn, 2,8-10; Gn, 2,1.14; Gn, 2,16;19
Così furono portati a compimento il cielo e la terra e tutte le loro schiere. 2Allora Dio, nel settimo giorno portò a termine il lavoro che aveva fatto e cessò nel settimo giorno da ogni suo lavoro. 3Dio benedisse il settimo giorno e lo consacrò, perché in esso aveva cessato da ogni lavoro che egli creando aveva fatto. 4Queste le origini del cielo e della terra, quando vennero creati.
La prova della libertà. Il paradiso
Quando il Signore Dio fece la terra e il cielo, 5nessun cespuglio campestre era sulla terra, nessuna erba campestre era spuntata - perché il Signore Dio non aveva fatto piovere sulla terra e nessuno lavorava il suolo 6e faceva salire dalla terra l’acqua dei canali per irrigare tutto il suolo -; 7allora il Signore Dio plasmò l’uomo con polvere del suolo e soffiò nelle sue narici un alito di vita e l’uomo divenne un essere vivente.
8Poi il Signore Dio piantò un giardino in Eden, a oriente, e vi collocò l’uomo che aveva plasmato. 9Il Signore Dio fece germogliare dal suolo ogni sorta di alberi graditi alla vista e buoni da mangiare, tra cui l’albero della vita in mezzo al giardino e l’albero della conoscenza del bene e del male. 10Un fiume usciva da Eden per irrigare il giardino, poi di lì si divideva e formava quattro corsi. 11Il primo fiume si chiama Pison: esso scorre intorno a tutto il paese di Avìla, dove c’è l’oro 12e l’oro di quella terra è fine; qui c’è anche la resina odorosa e la pietra d’ònice. 13Il secondo fiume si chiama Ghicon: esso scorre intorno a tutto il paese d’Etiopia. 14Il terzo fiume si chiama T igri: esso scorre ad oriente di Assur Il quarto fiume è l’Eufrate.
15Il Signore Dio prese l’uomo e lo pose nel giardino di Eden, perché lo coltivasse e lo custodisse.
16Il Signore Dio diede questo comando all’uomo: «Tu potrai mangiare di tutti gli alberi del giardino, 17ma dell’albero della conoscenza del bene e del male non devi mangiare, perché, quando tu ne mangiassi, certamente moriresti».
18Poi il Signore Dio disse: «Non è bene che l’uomo sia solo: gli voglio fare un aiuto che gli sia simile». 19Allora il Signore Dio plasmò dal suolo ogni sorta di bestie selvatiche e tutti gli uccelli del cielo e li condusse all’uomo, per vedere come li avrebbe chiamati: in qualunque modo l’uomo avesse chiamato ognuno degli esseri viventi, quello doveva essere il suo nome.
Completa e rispondi.
• La Bibbia racconta che Dio dopo aver creato il mondo, l’uomo e la donna, stringe un “patto” di amicizia con Adamo ed Eva e li pone nel ................................................... donando loro tutto ciò che aveva creato.
• Poi Dio dà loro un consiglio: “Non mangiate il ................................ di quell’albero altrimenti ……………………….”.
• A chi credono Adamo ed Eva?
Alla parola di Dio.
Alla parola del serpente.
• Adamo ed Eva, disubbidendo a Dio, rompono l’amicizia con Lui e la pace e la felicità.
• Dio Padre vuole bene alle sue creature e per questo promette di mandare suo figlio per ristabilire l’amicizia.
• Per i cristiani, Gesù ridona l’amicizia con Dio, la pace e la felicità a tutti gli uomini. Come ti senti quando rompi l’amicizia con un compagno? solo; felice; triste.
Disegna il Salvatore promesso da Dio.
Confronta le due scene che raffigurano il profeta Samuele chiamato da Dio e trova i 7 particolari mancanti.


Colora e descrivi la scena, raccontando come si viveva nelle tende presso il deserto.
Traccia sulla mappa il percorso che fece Abramo partendo dalla città di Ur. Colora.
Con Abramo inizia la storia del popolo ebraico. Egli è stato il primo a credere in un unico Dio e a fidarsi totalmente di Lui.
Traccia sulla cartina il percorso di Abramo partendo da Ur, passando per Carran e arrivando a Sichem nella Terra di Canaan, l’attuale Palestina.
Leggi i seguenti brani biblici e completa le frasi, inserendo la località corrispondente.
• Genesi 12,4: Abramo aveva 75 anni quando lasciò .. . .... . .... . .... .
• Genesi 12,6: Abramo attraversò il paese fino alla località di ..
• Genesi 12,4: Abramo aveva 75 anni quando lasciò
presso la quercia di More.
• Genesi 12,10: venne una carestia nel paese e Abramo scese in per soggiornarvi.
• Genesi 12,6: Abramo attraversò il paese fino alla località di , presso la quercia di More.
• Genesi 12,10: venne una carestia nel paese e Abramo scese in ..
per soggiornarvi.
Leggi e illustra una scena del racconto a tuo piacere.
Un giorno Abramo sente una voce misteriosa, profonda e dolcissima, che lo chiama: «Abramo, Abramo!», «Eccomi» risponde prontamente il vecchio patriarca. La voce riprende: «Prendi tuo figlio, il tuo unico figlio che ami e offrilo in olocausto su di un monte che io ti indicherò».
Abramo nell’udire questo comando del Signore si sente smarrito.
Non gli aveva promesso quel Dio dolce e terribile che da Isacco sarebbe sorto un popolo numeroso come le stelle? E ora quello stesso Dio, contraddicendosi, gli ordina di uccidere il figlio della promessa!
Ma Abramo, nella sua fede incrollabile, non fa obiezioni.
Obbedisce al Signore anche se il comando è contro la logica, contro la ragione, contro la voce stessa del sangue.
Abramo si alza di buon mattino, sella l’asino, raccoglie la legna e poi si avvia con il figlio Isacco verso il luogo che Dio gli ha indicato. Durante il viaggio Isacco chiede al padre: «Padre, ecco qui la legna per il fuoco, ma dov’è l’agnello per l’olocausto?» Abramo con il cuore che gli batte forte, vincendo l’emozione, dice: «Dio stesso provvederà l’agnello per l’olocausto, figlio mio».
Arrivati sul monte e preparato l’altare, Abramo senza esi- Caravaggio, Il sacrificio di Isacco, 1594-1596, tazione sta per immergere il Galleria degli Uffizi, Firenze. lungo coltello nella gola di Isacco, quando la voce misteriosa, ferma e dolcissima, gli dice :«Abramo, Abramo, non stendere la mano contro il ragazzo e non fargli alcun male. Ora so che temi Dio e non mi hai rifiutato tuo figlio, il tuo unico figlio». Allora Abramo, con il cuore sollevato da quella angoscia mortale che lo aveva accompagnato durante tutto il viaggio, alza lo sguardo: impigliato con le corna in un cespuglio, vede un ariete che si divincola, capisce che quella è la vittima che il Signore vuole in olocausto.
E la voce dice ad Abramo: «Poiché tu non mi hai rifiutato tuo figlio, io ti benedirò con ogni benedizione e renderò la tua discendenza numerosa come le stelle del cielo e come la sabbia che è sul lido del mare».
Leggi e completa il testo tratto dal libro della Genesi.
Dopo queste cose, Dio mise alla prova Abramo e gli disse: “Abramo! Abramo!” . Rispose: “Eccomi!” . Riprese: “Prendi tuo figlio, il tuo unico figlio che ami, Isacco, va’ nel territorio di Moria e offrilo in olocausto su di un .................................... che io ti indicherò”. Abramo si alzò di buon mattino, sellò l’.................................... prese con sé due servi e il figlio Isacco, spaccò la legna per l’olocausto e si mise in viaggio verso il luogo che Dio gli aveva indicato. Il terzo gior no Abramo alzò gli occhi e da lontano vide quel luogo. Allora Abramo disse ai suoi servi:” Fermatevi qui con l’...... ..............................; io e il ragazzo andremo fin lassù, ci prostreremo e poi ritorneremo da voi”. Abramo prese la legna dell’olocausto e la caricò sul figlio Isacco, prese in mano il fuoco e il coltello, poi proseguirono tutt’e due insieme. Isacco si rivolse al padre Abramo e disse: “Padre mio!”. Rispose: “ Eccomi, figlio mio”. Riprese: “Ecco qui il fuoco e la ...................................., ma dov’è l’.................................... per l’olocausto?”. Abramo rispose:” .................................... stesso provvederà l’agnello per l’olocausto, figlio mio!”. Proseguirono tutt’e due insieme; così arrivarono al luogo che Dio gli aveva indicato; qui Abramo costruì l’...................................., collocò la legna, legò il figlio Isacco e lo depose sull’altare sopra la legna. Poi Abramo stese la mano e prese il coltello per immolare suo figlio. Ma l’angelo del Signore lo chiamò dal cielo e gli disse: “Abramo! Abramo!”. Rispose: “Eccomi!”. L’.................................. disse: “Non stendere la mano contro il ragazzo e non fargli alcun male! Ora so che tu .................................... Dio e non mi hai rifiutato tuo figlio, il tuo unico figlio”.
(Gn 22,1-12)
Dopo queste cose, Dio mise alla prova Abramo e gli disse: “Abramo! Abramo!” Rispose: “Eccomi!” Riprese: “Prendi tuo figlio, il tuo unico figlio che ami, Isacco, va’ nel territorio di Moria e offrilo in olocausto su di un che io ti indicherò”. Abramo si alzò di buon mattino, sellò l’ prese con sé due servi e il figlio Isacco, spaccò la legna per l’olocausto e si mise in viaggio verso il luogo che Dio gli aveva indicato. Il terzo gior no Abramo alzò gli occhi e da lontano vide quel luogo. Allora Abramo disse ai suoi servi:” Fermatevi qui con l’ ; io e il ragazzo andremo fin lassù, ci prostreremo e poi ritorneremo da voi”. Abramo prese la legna dell’olocausto e la caricò sul figlio Isacco, prese in mano il fuoco e il coltello, poi proseguirono tutt’e due insieme. Isacco si rivolse al padre Abramo e disse: “Padre mio!”. Rispose: “ Eccomi, figlio mio”. Riprese: “Ecco qui il fuoco e la , ma dov’è l’ per l’olocausto?”. Abramo rispose:” stesso provvederà l’agnello per l’olocausto, figlio mio!”. Proseguirono tutt’e due insieme; così arrivarono al luogo che Dio gli aveva indicato; qui Abramo costruì l’ , collocò la legna, legò il figlio Isacco e lo depose sull’altare sopra la legna. Poi Abramo stese la mano e prese il coltello per immolare suo figlio. Ma l’angelo del Signore lo chiamò dal cielo e gli disse: “Abramo! Abramo!”. Rispose: “Eccomi!”. L’ disse: “Non stendere la mano contro il ragazzo e non fargli alcun male! Ora so che tu Dio e non mi hai rifiutato tuo figlio, il tuo unico figlio”
(Gn 22,1-12)
Rispondi alle seguenti domande.
Rispondi alle seguenti domande.
• Di chi si è fidato Abramo?
Rispondi alle seguenti domande.
• Di chi si è fidato Abramo?
• Come è stata premiata la sua fiducia in Dio?
• Come è stata premiata la sua fiducia in Dio?
...................................
Osserva le immagini e scrivi a parole tue il racconto del cosiddetto “sacrificio di Isacco”.
Traguardi per lo Sviluppo delle Competenze L’alunno…
• riconosce che la Bibbia è il libro sacro per cristiani ed ebrei e documento fondamentale della nostra cultura, sapendola distinguere da altre tipologie di testi;
• identifica le caratteristiche essenziali di un brano biblico e sa farsi accompagnare nell’analisi di alcune pagine a lui più accessibili, per collegarle alla propria esperienza.
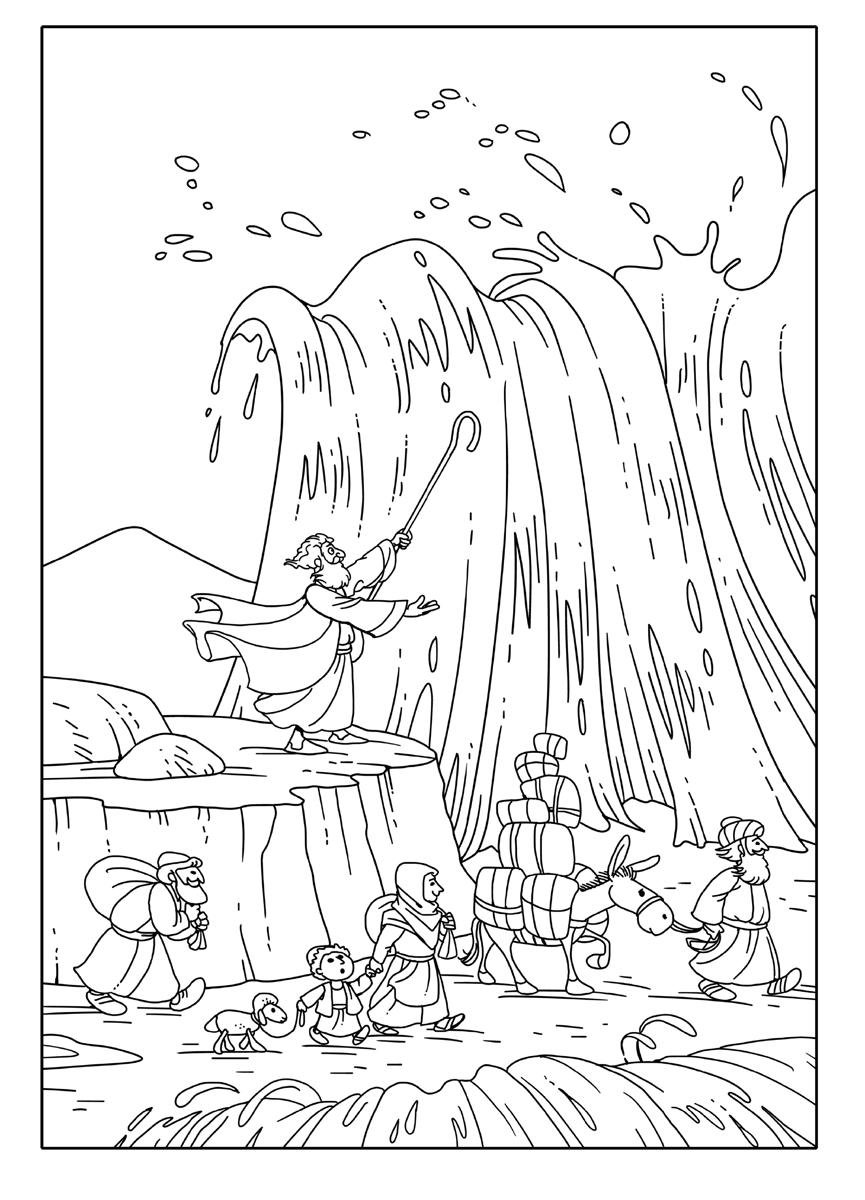
Unita di apprendimento p er la p rogrammazione settimanale r iferimenti al testo o biettivi di apprendimento
Una grande alleanza
• I grandi patriarchi del popolo ebraico: Abramo, Isacco e Giacobbe.
• La storia di Esaù e Giacobbe.
La storia di Giuseppe:
• venduto dai fratelli
• alla corte del faraone
• di nuovo insieme
La storia di Mosè:
• la chiamata di Dio
• la Pasqua ebraica
• l’Esodo
• I dieci comandamenti
• I re d’Israele: Saul, Davide e Salomone
Da pag. 138 a pag. 181 Dio e l’uomo
• Scoprire che per la religione cristiana Dio è Creatore e Padre e che fin dalle origini ha voluto stabilire un’alleanza con l’uomo.
La Bibbia e le altre fonti
• Ricostruire le principali tappe della Storia della Salvezza.
• Ascoltare, leggere e saper riferire circa alcune semplici storie bibliche.
Dio e l’uomo
• Scoprire che per la religione cristiana Dio è Creatore e Padre e che fin dalle origini ha voluto stabilire un’alleanza con l’uomo.
Dopo aver conosciuto e approfondito la storia di Abramo, scopo di questa unità è quello di AVVICINARE GLI ALUNNI ALLA NARRAZIONE BIBLICA e alla conoscenza degli avvenimenti principali che portarono allo SVILUPPO DEL POPOLO DI ISRAELE
Viene dato ampio spazio alla narrazione, fatta sia attraverso la lettura e l’ascolto del racconto dell’insegnante, sia attraverso l’approccio diretto al testo biblico originale.
Il percorso, molto ampio, prende il via dai grandi patriarchi del popolo ebraico e successori di Abramo: ISACCO, GIACOBBE e GIUSEPPE. Punto centrale dell’unità è la conoscenza delle vicende di Mosè: dal suo passato da “egiziano” fino alla chiamata di Dio.
La MISSIONE DI MOSÈ, il racconto della Pasqua ebraica, i riti e le tradizioni ebraiche che ancora oggi si ripetono e ricordano questa figura fondamentale per le vicende di tutto il popolo ebraico.
Da qui il lungo e faticoso viaggio, che dalla LIBERAZIONE DELLA SCHIAVITÙ IN EGITTO ha portato gli ebrei alla libertà e alla TERRA PROMESSA, con particolare importanza
al dono del Decalogo. In questa sezione dell’unità, lo scopo sarà quello di aiutare gli alunni a capire il VALORE DELLA LIBERTÀ e delle regole che non contengono solo obblighi, ma garantiscono diritti. Una volta entrati nella Terra Promessa per opera di Giosuè, l’ultima parte dell’unità affronta il periodo storico dei Giudici e dei Re che hanno guidato il popolo ebraico per circa cinquecento anni, con particolare riferimento alle vicende di Saul, Davide e Salomone, con la relativa costruzione del grande Tempio di Gerusalemme.
Giuseppe e i suoi sogni: Gn 34,1-11.
Giacobbe manda Giuseppe dai fratelli: Gn 37,12-24.
Venduto dai fratelli: Gn 37,25-36.
Giuseppe in Egitto in casa di Putifar: Gn 39,1-4.
La padrona lo tenta: Gn 39,7-17.
Giuseppe arrestato: Gn 39,19-23.
I sogni di Faraone: Gn 41,1-8; 14-16; 25-35.
Giuseppe diventa viceré d’Egitto: Gn 41,37-44.
I sogni si avverano: Gn 41,46-49.
I fratelli vanno in Egitto: Gn 42,1-38.
I fratelli tornano da Giuseppe con Beniamino.
Giuseppe mangia con i fratelli: Gn 43,24-33.
Giuseppe mette alla prova i fratelli.
Giuseppe si fa riconoscere dai fratelli.
In un paese di questo mondo la gente si era proprio stancata delle regole. Tutto era comandato: a che ora dovevano alzarsi, a che ora dovevano essere sul posto di lavoro. Agli scolari veniva prescritto a che ora cominciava la scuola e quando potevano tornare a casa. E poi dovevano portarsi un fazzoletto, lavarsi i denti, avere le mani pulite, attraversare la strada sulle strisce, non camminare in mezzo alla strada.
Veramente, le regole erano tante e per tutti, grandi e piccoli; perciò la gente si
mise d’accordo e decise: «D’ora in avanti non ci saranno più regole. Che bello!». Naturalmente la scuola rimase vuota, perché i ragazzi preferivano andare a giocare. La gente metteva i tavoli in mezzo alla strada perché lì c’era più sole. I giovani alzavano gli stereo al massimo volume, ventiquattro ore su ventiquattro.
Quando la gente voleva andare a dormire, gli altoparlanti continuavano a trasmettere musica a tutta forza. Era una gran confusione!
Nel pieno della notte, un uomo si mise a suonare le campane della chiesa. La gente accorse sulla piazza e quando tutti furono riuniti alcuni esclamarono: «No, così non possiamo più vivere!». «No, così non possiamo più vivere!», risposero tutti.
«Dobbiamo avere delle regole. Sì, vogliamo di nuovo avere delle regole!», ripeté in coro tutta la gente. E insieme cominciarono a fissare alcune regole:
• I bambini devono obbedire ai genitori.
• I genitori devono amare i figli.
• Nessuno deve fare del male all’altro.
• Bisogna dire la verità.
Ne stabilirono tantissime. Qualcuno ne diceva sempre una nuova, necessaria perché la vita fosse possibile. Alla fine uno suggerì: «Non potremmo riassumere tutte queste regole in alcune poche che le contengano tutte?».
Un ragazzino sveglio e vivace si fece avanti e disse che la maestra aveva insegnato dieci regole che riassumevano tutte le regole possibili. E cominciò a recitare:
1. RISPETTA GLI ALTRI.
2. RISPETTA IL BABBO E LA MAMMA.
3. RISPETTA TE STESSO.
4. RISPETTA L’AMBIENTE.
5. RISPETTA LE REGOLE DEL VIVERE INSIEME.
6. NON UCCIDERE.
7. NON RUBARE.
8. NON DIRE BUGIE.
9. NON COMMETTERE ATTI VIOLENTI CONTRO LE PERSONE E LE COSE.
10. NON ESSERE INVIDIOSI DI CIÒ CHE HANNO GLI ALTRI.
Vocazione di Mosè Es 2,10: la parola Mosè vuol dire salvato dalle acque.
Mosè fugge nel paese di Madian: Es 2,11-22.
Il roveto ardente: Es 3,1-15.
Dio rassicura Mosè: Es 4,1-17.
Mosè parte per l’Egitto.
Primi contatti con il Faraone: Es 5,1-9.
Il segno del bastone: Es 7, 6-13.
Le piaghe d’Egitto: Es 7,14 - 10,29.
Minaccia della decima piaga: Es 11,4-10.
Istituzione della Pasqua: Es 12,1-20.
Decima piaga: Es 12,29-30.
Il popolo d’Israele parte per l’Egitto: Es 12,31-36.
Il Faraone insegue gli Ebrei: Es 14,5-14.
Passaggio del Mar Rosso: Es 14,19-31.
Viaggio nel deserto e miracolo dell’acqua miracolosa: Es 17,1-7.
Arrivo al monte Sinai: Es 19,9-13.
Dio si manifesta sul Sinai: Es 19,16-25.
I dieci comandamenti: Es 20,1-17.
Organizzazione dell’arca dell’Alleanza.
Il vitello d’oro: Es 32,1-6.
Mosè spezza le tavole della legge: Es 31,15-20.
Mosè elegge Giosuè come suo successore: Dt 31,1-8.
Morte di Mosè: Dt 34,1-10.
La Pasqua è il centro sia della religiosità ebraica che di quella cristiana. Per i cristiani è il culmine del Triduo pasquale, centro e cuore di tutto l’anno liturgico. Prosegue con l’ottava di Pasqua (la settimana successiva) e con il tempo liturgico di Pasqua che dura 50 giorni, inglobando la festività dell’Ascensione, fino alla solennità della Pentecoste.
Che significa la parola “Pasqua”?
Deriva dal greco: pascha, a sua volta dall’aramaico pasah e significa propriamente “passare oltre”, quindi “passaggio”. Gli ebrei ricordavano il passaggio attraverso il Mar Rosso dalla schiavitù d’Egitto alla liberazione. Per i cristiani è la festa del passaggio dalla morte alla vita di Gesù Cristo.
Quali sono le origini di questa festa?
Presso gli ebrei la Pasqua (Pesach) era in origine legata all’attività agricola ed era la festa della raccolta dei primissimi frutti della campagna, a cominciare dal frumento.
Altre feste, solo per ricordarle, erano la Festa delle Settimane, che celebrava la raccolta del grano ai primi di giugno, e la Festa dei Tabernacoli, cioè della vendemmia, a settembre.
In seguito, la Pasqua diventa la celebrazione annuale della liberazione degli ebrei dalla schiavitù, significato che si aggiunse all’altro, come ricordo della fuga dall’Egitto e del fatto che con il sangue degli agnelli si fossero dipinti gli stipiti delle porte affinché l’angelo sterminatore, come dice la Bibbia, passando da quelle case, risparmiasse i primogeniti.
Ancora oggi, la cena pasquale presso gli ebrei si svolge secondo un preciso ordine detto Seder. Ci si nutre di cibi amari per ricordare l’amarezza della schiavitù egiziana e lo stupore della libertà ritrovata.
Per celebrare la Pasqua gli israeliti al tempo di Gesù ogni anno si recavano a Gerusalemme. Anch’egli vi si recava. La sua morte avvenne, infatti, in occasione della Pasqua ebraica. Egli per i cristiani è l’agnello pasquale che risparmia dalla morte, il pane nuovo che rende nuovi (cfr 1Cor 5,7-8).
Perché si mangia l’agnello?
La tradizione di consumare l’agnello per Pasqua deriva dalla Pesach, la Pasqua ebraica. Infatti l’agnello fa parte dell’origine di questa festività. In particolare si fa riferimento a quando Dio annunciò al popolo di Israele che lui lo avrebbe liberato dalla schiavitù in Egitto dicendo “In questa notte io passerò attraverso l’Egitto e colpirò a morte ogni primogenito egiziano, sia fra le genti che tra il bestiame”. Ordinando, così, al popolo d’Israele di marcare le loro porte con del sangue d’agnello in modo che lui fosse in grado riconoscere chi colpire col suo castigo e chi no.
Inoltre in passato esisteva un comandamento riguardo la Pasqua ebraica che diceva di fare l’offerta dell’agnello il giorno 14 del mese ebraico di Nisan e di consumare quella stessa notte il sacrificio di Pesach.
Con il Cristianesimo, il simbolo dell’agnello immolato per la salvezza di tutti diventa Cristo stesso e il suo sacrificio ha valore di redenzione.
“Sara”, il cui nome significa principessa, segue silenziosamente e docilmente Abramo nel suo pellegrinare dietro la voce del Signore verso la terra promessa. Lungo questo viaggio pieno di peripezie, di fatiche, di notti oscure, se pur trapuntate di stelle, ella gli è sempre accanto come sposa, come sorella, come madre, come donna saggia che gli attira benevolenza... Ma nasconde nel cuore una ferita che vela di tristezza la sua esistenza: è sterile. Ed ecco che un giorno, mentre ormai anziana dimora con Abramo nella tenda presso la quercia di Mamre, il Signore la visita e le dà l’annunzio della maternità umanamente impossibile. Dio si rivela così come colui che può e vuole operare meraviglie di grazia nell’estrema debolezza e impotenza umana.
Al tempo stabilito, davanti al tanto desiderato dono, Sara esclama: «Motivo di lieto riso mi ha dato Dio», e chiama il bambino “Isacco”.
“Rebecca”, sposa di Isacco, è una donna tutta disponibilità. Cercata in terra lontana, lascia la casa paterna accompagnata da una bellissima benedizione: «Tu, sorella nostra, diventa migliaia di miriadi...», scenda su di te la benedizione che Dio ha promesso.
Il volto nascosto dietro il velo, il suo mistero traspare nella bellezza di quel segno di pudore e di fedeltà, di esclusiva appartenenza. Vera madre anche nello spirito, Rebecca avverte come suo principale compito quello di proteggere, di tutelare la vita, di evitare gli scontri violenti tra i due fratelli che ha dato miracolosamente alla luce dopo lunga attesa e che fin dal suo grembo aveva percepito in rapporto conflittuale.
“Rachele”, sposa di Giacobbe, nel suo incontenibile desiderio di maternità, dà un nome altamente simbolico al figlio ottenuto per grazia: Giuseppe, ossia «Dio aggiunga». Che cosa aggiunga? Un altro figlio... E mentre è in viaggio, lungo la strada verso Efrata, Rachele muore dando alla luce Beniamino, il «figlio del dolore». Altra tomba nella Terra promessa.
Se le donne dei patriarchi sono madri che portano avanti la catena delle gene-
razioni mettendosi al servizio della vita con struggente amore, fino all’estremo sacrificio, altre donne dopo di loro, fragili ed eroiche ad un tempo, sostengono il popolo nel suo cammino irto di difficoltà.
La carestia aveva costretto i figli di Israele a ritornare popolo errante, a scendere esuli in Egitto. Nell’ardua attraversata del deserto per la riconquista della Terra promessa incontriamo, accanto al grande e umile Mosè, anche la sorella “Myriam”, significativa figura femminile che sembra impersonare gli slanci di ardore e le gravi debolezze dell’intero popolo in cammino. Ci appare allora come colei che porta su di sé le conseguenze del peccato di molti ed insieme come colei che, guarita per intercessione dello stesso Mosè, impara per viva esperienza che cosa siano l’umiltà e l’amore gratuito.
DEBORA
Nel libro dei Giudici emerge la figura di “Debora”, la profetessa, che, abitata dallo Spirito del Signore, veglia su tutto Israele.
Debora celebra la liberazione di Israele con uno stupendo cantico in cui esprime l’amore di Dio per il suo popolo e l’amore riconoscente del popolo per il suo Dio da cui si sente fortemente protetto. Poesia, teologia e storia si intrecciano, offrendo un grandioso quadro dove è messo in risalto l’intervento dell’onnipotenza divina mediante figure femminili.
Con “Giuditta” ed “Ester” ci troviamo ancora di fronte a donne che, attingendo forza da Dio, salvano il popolo di Israele in momenti in cui ai capi responsabili viene meno il coraggio.
L’esercito di Oloferne avanza minaccioso, tutta la città di Betulia è in preda al panico: l’acqua e i viveri scarseggiano. Il re Ozia e gli anziani del popolo sono sul punto di consegnarsi al nemico. Ma c’è una donna che crede fermamente nell’aiuto che viene dal Signore proprio nelle situazioni più disperate: “Giuditta”. Vedova, vive ritirata nella sua casa sotto lo sguardo di Dio; tutta raccolta in preghiera, riceve luce e forza dall’Alto. Ella si pone perciò davanti agli anziani con l’autorità che le viene dall’essere una donna che ama Dio al di sopra di tutto e che ama il popolo con viscere materne.
Questa fiducia non la rende però passiva; anzi, pur consapevole della propria debolezza, riceve il coraggio di mettere in pericolo la propria vita per affrontare apertamente il «nemico».
Giuditta perciò si prepara al passo decisivo con digiuno, penitenza, preghiera. E così preme sul cuore di Dio: «La tua forza non sta nel numero, ma nell’amore che si china pietoso al grido dei poveri, degli oppressi, dei deboli, dei derelitti, degli sfiduciati, dei disperati».
Sul popolo eletto in terra d’esilio pende un editto di sterminio. Per vie misteriose Dio prepara una giovane ebrea, “Ester”, a diventare strumento di salvezza per Israele.
Orfana e lontana dalla sua terra, ancora giovinetta viene provvidenzialmente scelta tra tante sue coetanee per sostituire la regina Vasti ripudiata dal grande re Assuero.
Ella si trova quindi a corte nel tempo in cui tutti gli Israeliti esuli vivono con «la morte davanti ai loro occhi». Il suo posto di privilegio diventa subito per lei un posto di più grande responsabilità: se è lì, non è per avere salva la propria vita, ma per salvarla ai suoi fratelli.
Fede integra e angoscia mortale si combattono nel suo cuore da cui sgorga un grido di preghiera che è insieme altissima testimonianza di amore e pressante invocazione di aiuto: «Mio Signore, nostro re, tu sei “l’unico”! Vieni in aiuto a me che sono “sola” e non ho altro soccorso se non te, perché un grande pericolo mi sovrasta».
Malgrado le grandi tentazioni cui ogni giorno la vita di corte certamente la esponeva, il cuore di questa donna è unicamente posseduto dall’amore del suo Dio e del suo popolo.
All’inizio del primo libro di Samuele troviamo “Anna”, moglie di uno “zufita” delle montagne di Efraim, un’altra donna sterile, come le spose dei patriarchi... Essa, umiliata e disprezzata per questa sua condizione, va a sfogare la sua angoscia davanti al Signore nel santuario di Silo.
Là osa pronunciare un voto: «Signore, se vorrai ricordarti di me, se darai alla tua schiava un figlio maschio, io lo offrirò al Signore per tutti i giorni della sua vita».
La sua preghiera di povera è esaudita e Anna mantiene il voto: nasce il grande profeta Samuele. Dopo lo svezzamento, offre il piccolo Samuele al Signore per tutti i giorni della sua vita. Al momento dell’offerta, dal suo cuore e dalle sue labbra sgorga un bellissimo cantico di ringraziamento, il primo Magnificat: «Il mio cuore esulta nel Signore, la mia fronte s’innalza grazie al mio Dio. L’arco dei forti s’è spezzato, ma i deboli sono rivestiti di vigore».
Su uno scenario di povertà e di debolezza si apre anche il libro di “Rut”: Noemi, emigrata in terra di Moab, rimasta vedova, senza figli e senza nipoti, decide di far ritorno alla sua terra d’origine... Benché si avvii da un paese straniero verso la terra dei suoi padri, non parte sospinta dalla speranza, bensì con l’animo abbattuto di chi si sente sconfitto dalla vita.
Ma Rut, la nuora, tenacemente fedele, la segue. Ed ecco le due donne giungere a Betlemme al tempo della mietitura dell’orzo: bellissimo segno di speranza. Rut va a spigolare dietro i mietitori, con l’umiltà di chi è consapevole non solo di essere povera, ma anche di essere straniera.
Sollecita e riservata, viene definita “donna virtuosa”, “donna forte” nel bene, forte nella mansuetudine, nella bontà, nell’amore fino al sacrificio.
Ed è per questo che trova grazia agli occhi di Booz, il padrone del campo e suo parente prossimo con il «diritto di riscatto».
Così Rut entra nel solco delle generazioni d’Israele, diventa antenata di Cristo, anzi, entra nel “Nuovo Testamento”, perché il suo nome compare nella genealogia del nato Messia (cfr. “Matteo” 1, 1-17).

La Pasqua ebraica
Questo lavoro potrà essere utilizzato sia per apparecchiare la tavola della cena pasquale ebraica, sia per organizzare una gara in cui gli alunni si sfideranno cercando di ricordare i significati dei cibi.
OCCORRENTE
Disegnare nei piatti vuoti le pietanze dell’uovo, pane azzimo, vino, charoset, erbe amare, agnello.
Ritagliare le spiegazioni che riguardano i cibi disegnati e incollarle sul retro del piatto. 1 2
• Sei piatti di plastica
• Colori
• Forbici
• Colla
Insegniamo poi agli alunni come si preparano il charoset e il pane azzimo. La prima ricetta può essere preparata in classe insieme agli alunni che porteranno gli ingredienti necessari, la seconda invece, dal momento che per la cottura si richiede l’uso del fornello, potrà essere realizzata a casa con l’aiuto dei genitori.
Charoset
COME SI PREPARA
Tritare le nocciole, le mandorle e le noci.
Sminuzzare i fichi secchi.
Spremere le arance.
Grattugiare le mele.
Versare una tazza di ogni ingrediente in una ciotola. Dolcificare con il miele.
Aggiungere il succo di arancia.
Mescolare a lungo.
Servire in piccoli bicchiere di plastica e gustare.
INGREDIENTI
• Nocciole tostate
• Noci sgusciate
• Quattro arance
• Fichi secchi
• Mandorle tostate
• Mele
• Miele

Pane azzimo
Mescolare in una ciotola gli ingredienti.
Aggiungere un po’ alla volta l’acqua.
Impastare nella ciotola o su una spianatoia infarinata per 10/15 minuti fino ad ottenere una pasta morbida ed elastica.
Coprire con un panno umido e lasciar riposare per 30 minuti.
Impastare nuovamente, formando delle polpette da schiacciare con le mani.
Ripassare con il mattarello e ridurle in sfoglie sottili.
Mettere su una teglia a calore medio e girare un paio di volte (sulla superficie appaiono delle bolle);
Togliere con un forchettone e passare leggermente sulla fiamma viva in modo che si gonfi un altro po’.

• Una tazza di farina di frumento integrale
• Due, tre pizzichi di sale grosso
• Due, tre pizzichi di cumino macinato o di coriandolo
• Una tazza d’acqua a temperatura ambiente
In ogni casella è scritta una frase che caratterizza un personaggio. Colora le varie caselle utilizzando un colore diverso per ciascuno di esso:
• GIALLO per ABRAMO
• AZZURRO per ISACCO
• ARANCIONE per GIACOBBE.
Prese due mogli ed ebbe dodici figli.
Strappò il diritto di primogenitura a suo fratello.
Fu salvato da un angelo del Signore.
Aveva quarant’anni quando sposò Rebecca.
Si mise in viaggio fino alla terra di Canaan.
Era un ricco pastore che viveva in Mesopotamia.
Era sposato con una donna di nome Sara.
Il suo nome significa padre di molti popoli.
Fu costretto a trovare rifugio da suo zio Labano.
Ebbe un altro figlio di nome Ismaele.
Il suo nome significa sorriso di Dio.
Fu padre di Esaù e Giacobbe.
Sognò una scala la cui cima raggiungeva il cielo.
Il Signore cambiò il suo nome, chiamandolo Israele.
Quando nacque, suo padre aveva cento anni.
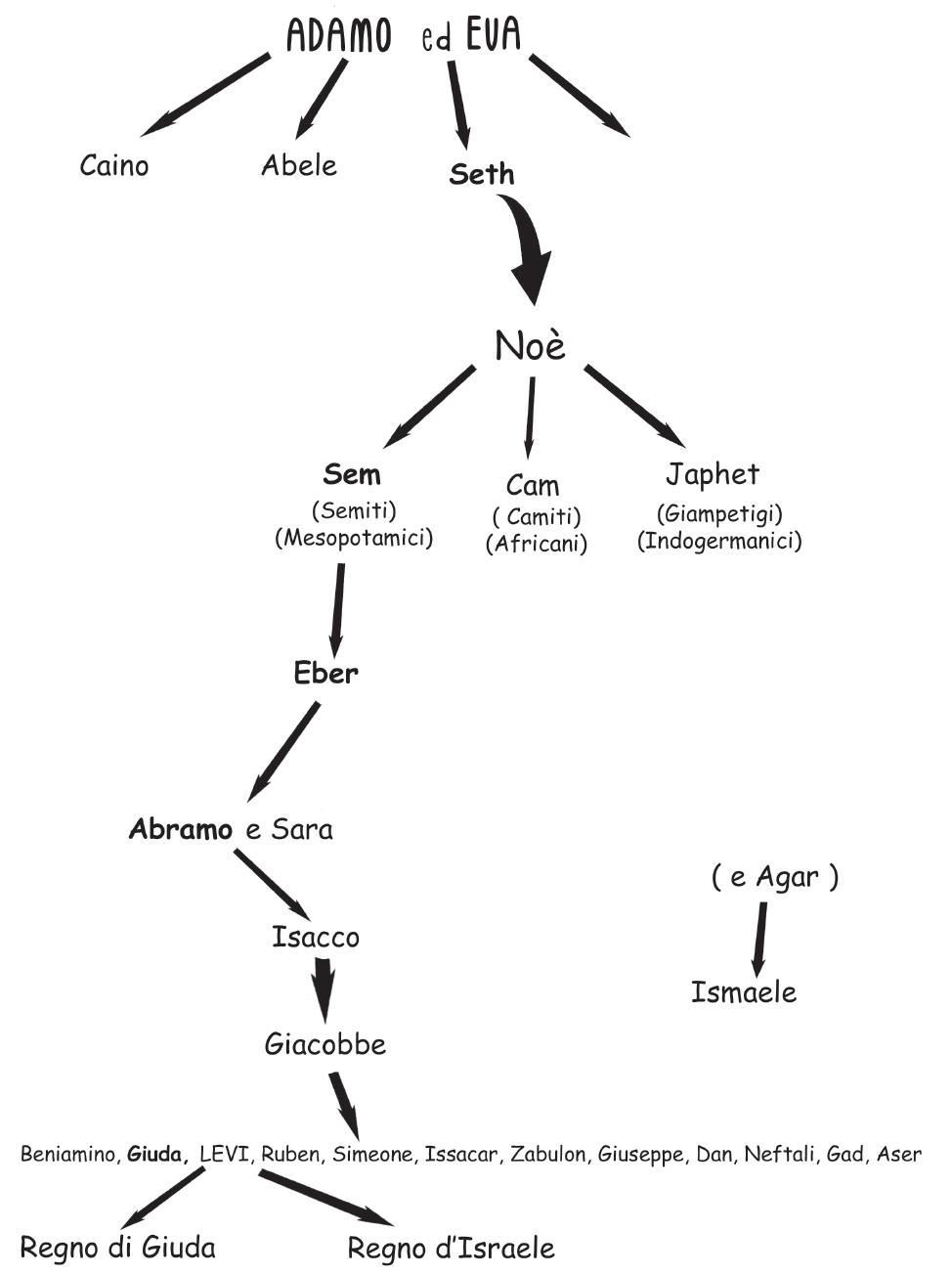
Leggi e illustra una scena del racconto a tuo piacere.
Isacco e Rebecca ebbero due figli gemelli: Esaù, che nacque per primo ed era il preferito di Isacco, mentre Giacobbe lo era della madre Rebecca. Esaù era un abile cacciatore, Giacobbe invece era un pastore. Un giorno, Esaù tornò molto stanco e affamato dalla caccia e vedendo che Giacobbe stava cucinando una minestra di lenticchie gliene chiese una scodella. Il fratello gliela diede ma gli fece giurare che gli avrebbe dato in cambio la primogenitura. In seguito, quando il vecchio padre stava per morire, Giacobbe indossò gli abiti di Esaù e coprì la sua pelle con il pelo di un capretto per assomigliare al fratello, così Isacco, pensando di parlare ad Esaù gli diede la benedizione patriarcale. A quel tempo, quella benedizione, significava il diritto ad ereditare la terra di Canaan e la promessa divina di diventare il patriarca dell’intera nazione d’Israele. Esaù voleva uccidere Giacobbe, così la madre lo mandò dallo zio Labano. In questo dipinto, l’autore pone l’attenzione sulle mani di Giacobbe ricoperte dal pelo del capretto per simulare il fratello Esaù molto peloso. Dietro la madre Rebecca, che si accerta che il marito non riconosca Giacobbe.

Scrivi i nomi delle dodici tribù di Israele, facendoti aiutare dalla mappa messa a disposizione dall’insegnante. Colora.
Commenta e colora il disegno.
Gelosi del bene che il padre dimostrava verso Giuseppe, gli altri fratelli decisero un gior no di venderlo ad alcuni mercanti che lo portarono in Egitto per divenire
Gelosi del bene che il padre dimostrava verso Giuseppe, gli altri fratelli decisero un gior no di venderlo ad alcuni mercanti che lo portarono in Egitto per divenire
schiavo del
schiavo del
Risolvi il cruciverba e, nella colonna evidenziata, scoprirai di chi divenne schiavo Giuseppe.
1. Il padre di Giuseppe.
1. Il padre di Giuseppe.
2. Giuseppe ne aveva undici.
2. Giuseppe ne aveva undici.
3. Si abbatté sulla terra di Giacobbe causando fame e povertà.
3. Si abbatté sulla terra di Giacobbe causando fame e povertà.
4. Il numero delle tribù d’Israele.
4. Il numero delle tribù d’Israele.
5. Giuseppe era bravo ad interpretarli.
5. Giuseppe era bravo ad interpretarli.
6. Il numero delle vacche magre.
6. Il numero delle vacche magre.
Leggi e illustra una scena del racconto a tuo piacere.

Giacobbe ebbe 12 figli, ma il suo prediletto era Giuseppe perché avuto da Rachele la moglie più amata. I fratelli erano invidiosi di questo sentimento e un giorno, trovandosi al pascolo, lo spogliarono e lo gettarono in un pozzo. In seguito fu venduto ad una carovana di mercanti che andava in Egitto, qui divenne amministratore dei beni di Potifar, il capo delle guardie del faraone che capì le sue doti. Purtroppo anche la moglie di Potifar lo apprezzò ma venendo respinta lo accusò di violenza e così Giuseppe fu imprigionato.
Durante la carcerazione Giuseppe interpretava i sogni così bene che divenne Visir. Alcuni anni più tardi la carestia costrinse i suoi fratelli a venire in Egitto in cerca di cibo ma Giuseppe, non riconosciuto, li fece incarcerare e tenuto in ostaggio uno di loro volle che ritornassero con Beniamino l’ultimo dei fratelli. Così al loro ritorno, Giuseppe liberò tutti i fratelli riuscendo, con un espediente, a trattenere Beniamino. A questa notizia, Giuda, uno dei fratelli si offrì di rimanere al suo posto perché se Beniamino non fosse ritornato dal padre, egli ne sarebbe morto dopo il grande dolore avuto dalla scomparsa di Giuseppe. Questo comportamento rivelò a Giuseppe il cambiamento dei fratelli, così si rivelò a loro e li fece venire a vivere in Egitto insieme al padre.
Dio disse a Mosè di salire sul monte Sinai e lì gli consegnò le Tavole della Legge, cioè i Comandamenti. Ricordi uno dei dieci Comandamenti? Scrivilo qui sotto dentro alla nuvola e commentalo a fianco.
CHE COSA DEVO FARE SIGNORE?
Cosa ricordi dei Dieci Comandamenti? Scrivili nelle Tavole della Legge.
Risolvi il cruciverba. Ricopia in fondo alla pagina le lettere delle caselle evidenziate in verticale e scoprirai il nome delle leggi date da Dio agli uomini.

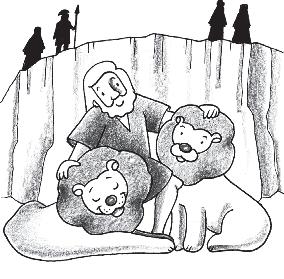
1. Il suo nome significa risata.
2. Le sue acque salvarono Mosè.
3. Gli ebrei passarono il…
4. La moglie di Abramo.
5. Fu imprigionato nella fossa dei leoni.
6. Rivelò a Mosè il suo nome.
7. Aveva 12 figli.
8. Il pane della fretta.
9. Luogo arido.
10. Li faceva Giuseppe.
11. Lo costruì Abramo per il Signore.
12. Le inflisse Dio agli egiziani.
Le leggi date da Dio agli uomini sono i
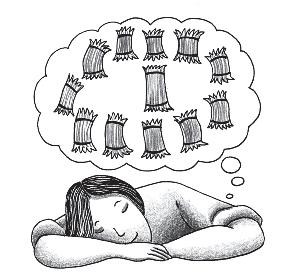
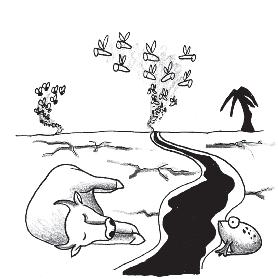
Il seguente testo biblico, tratto dal libro dell’Esodo, contiene le indicazioni date a Mosè dal Signore per celebrare la Pasqua prima dell’uscita dall’Egitto. Leggi il brano e inserisci al posto giusto le seguenti parole mancanti:
• PRIMOGENITO • SANGUE • PASQUA • AZZIMI • RITO • CASE • QUATTORDICI
• BASTONE • FESTA • AGNELLO
“Il dieci del mese di Nisan ciascuno si procuri un
per famiglia.
Sia senza difetto, maschio, nato nell’anno; potrete sceglierlo tra le pecore o tra le capre e lo serberete fino al di questo mese: allora tutta l’assemblea della comunità d’Israele lo immolerà al tramonto.
Preso un po’ del suo ..
lo porranno sui due stipiti e sull’architrave delle case in cui lo dovranno mangiare.
In quella notte ne mangeranno la carne arrostita al fuoco; la mangeranno con e con erbe amare.
Ecco in qual modo lo mangerete: con i fianchi cinti, i sandali ai piedi, il in mano; lo mangerete in fretta. È la
del Signore!
In quella notte io, il Signore; passerò per il paese d’Egitto e colpirò ogni nel paese d’Egitto, uomo o bestia; così farò giustizia di tutti gli dèi dell’Egitto. Io sono il Signore! Il sangue sulle vostre
sarà il segno che voi siete dentro: io vedrò il sangue e passerò oltre, non vi sarà per voi flagello di sterminio, quando io colpirò il paese d’Egitto. Questo giorno sarà per voi un memoriale; lo celebrerete ogni anno come una del Signore: di generazione in generazione, lo celebrerete come un
perenne”. (Esodo 12,2-14)
Durante la cena pasquale degli ebrei vengono gustati alcuni piatti tradizionali. Ognuno di questi alimenti ha un particolare significato.
Disegna in ciascun riquadro l’elemento indicato; scrivi poi sotto il suo significato biblico.
Pane azzimo
Uovo
Charoset
Anche oggi, in occasione della cena pasquale, le famiglie ebree portano in tavola i cibi e le bevande della tradizione.
Colora il disegno e scrivi su ogni pietanza il nome giusto: • ERBE AMARE • CHAROSET • AGNELLO • PANE AZZIMO • UOVO • ACETO • ACQUA SALATA
Leggi e completa il testo scrivendo al posto giusto le parole qui sotto: • SEMPRE • FIGLI • LEGGI • TERRA • ISRAELE • PICCOLO •
Nella Bibbia troviamo molti personaggi amici di Dio,
Prima della nascita di Gesù, in fra questi Davide è uno dei più eroici.
regnava Saul. Gli ebrei si erano stabiliti sulla .
di Canaan e l’avevano suddivisa discendevano da Abramo. in dodici regioni, quante erano le tribù che
Dio stesso aveva scelto per loro Saul come re, rispettato le sue e Dio chiamò il profeta Samuele e gli disse: perché li guidasse e li proteggesse. Ma Saul non aveva
– Saul per me non è più il re di Israele. Vai a Betlemme
da Iesse e cerca fra i suoi figli, perché fra di loro
ho trovato il re che voglio. Porta con te l’olio sacro.
Samuele obbedì perché per diventare re si doveva ricevere la santa unzione. Veniva versato un po’ di olio sul capo del prescelto che diventava così l’”unto del Signore”, incaricato e consacrato per una missione.
A casa di Iesse i sette sfilarono davanti a Samuele che non riconobbe in nessuno l’eletto di Dio.
– Sono qui tutti i tuoi figli? – chiese a Iesse. – Manca solo il più .
, Davide.
– Mandalo a cercare – ordinò Samuele. Davide era ancora un ragazzo, con i capelli rossi e lo sguardo fiero. Dio allora mormorò a Samuele: – Alzati e dagli l’ : è lui.
Samuele prese l’olio dal corno, consacrò Davide e da quel momento lo Spirito di Dio fu con lui per
Colora il Tempio di Gerusalemme e scrivi una didascalia accanto a ciascun personaggio cercando di individuare chi è e cosa fa o sta facendo.
Traguardi per lo Sviluppo delle Competenze L’alunno…
• sa spiegare, collegandolo al contesto in cui vive, il significato cristiano della Pasqua;
• riflette sui dati fondamentali della vita di Gesù e sa collegare i contenuti principali dei suoi insegnamenti alle tradizioni dell’ambiente in cui vive.

u ni Ta di apprendimen T o p er la p rogrammazione S e TT imanale r iferimen T i al T e ST o o bie TT ivi di apprendimen T o
Nella pienezza dei tempi
• I profeti annunciano la venuta del Messia.
• Il racconto della nascita Gesù.
• I simboli del Natale.
La vita pubblica di Gesù:
• le parole (parabole)
• i gesti (miracoli)
• Il racconto della Pasqua di Gesù.
• La Pasqua cristiana e la Pasqua ebraica.
• La Pasqua oggi.
Da pag. 182 a pag. 192 La Bibbia e le altre fonti
• Ascoltare, leggere e saper riferire circa alcune semplici storie bibliche e circa gli episodi chiave dei racconti evangelici.
• Conoscere l’ambiente di Gesù e il suo tempo.
Il linguaggio religioso
• Riconoscere i segni cristiani del Natale e della Pasqua nell’ambiente, nelle celebrazioni e nella tradizione popolare.
• Conoscere i termini che esprimono la Pasqua e saper distinguere il diverso significato che assume per ebrei e cristiani.
• Individuare negli eventi pasquali il valore della pace e della speranza per tutti gli uomini.
Questa unità ha come contenuto la vita di Gesù e le due principali feste cristiane: il Natale e la Pasqua.
IL NATALE: l’annuncio dei profeti e il messaggio dell’angelo a Maria e Giuseppe, induce l’insegnante a parlare dei messaggi e dell’ascolto di Dio, e comprendere come sia importante prestare attenzione alla voce degli altri, per prendere decisioni che possono cambiare la vita, per portare nel mondo un annuncio di pace, speranza e amore.
LA VITA DI GESÙ: gli eventi (già conosciuti dagli alunni in classe prima e seconda) narrati nei vangeli attraverso le parabole e i miracoli.
LA PASQUA DI GESÙ: la Pasqua cristiana, con gli eventi dell’ultima settimana di vita terrena di Gesù, messa in relazione con la Pasqua ebraica.
Le tappe della passione, morte e risurrezione di Gesù sono il dono più grande dell’amore di Dio verso l’umanità, la vita che trionfa, la morte sconfitta per sempre. Ma lo scopo di questa parte dell’unità è anche quello di accompagnare gli alunni in un percorso di SCOPERTA E CONSAPEVOLEZZA DI COME LA PASQUA CRISTIANA ABBIA LE SUE RADICI NELLA PASQUA EBRAICA.
Natale in letteratura
Dino Buzzati, scrittore, giornalista, drammaturgo, librettista… affronta in questo racconto il tema del Natale. Egli afferma che di Natale ce n’è troppo, troppo Natale in senso consumistico e troppo poco nel suo vero significato. NON SONO I DONI A FARE IL NATALE! Essi sono espressione di un rapporto nuovo tra gli uomini, un rapporto di fratellanza che si fonda sulla scoperta di un Padre comune.
«Ti ricordi?» chiese, nel Paradiso degli animali, l’anima del somarello all’anima del bue, «Per caso ti ricordi quella notte, tanti anni fa, quando ci siamo trovati in una specie di capanna, e là, proprio nella mangiatoia…». «Lasciami pensare… Ma sì,» confermò il bue, «nella mangiatoia c’era un bambino appena nato. Come lo potrei dimenticare? Era un bambino così bello.» «Da allora, se non sbaglio... sai tu, da allora, quanti anni sono passati?» «Figurati,
con la memoria da bue che ho!» «Quasi duemila.» «Caspita!» «E, a proposito, lo sai chi era quel bambino?» «Come faccio a saperlo? Era gente di passaggio. Certo, un fantolino meraviglioso. Chissà perché, non mi è mai uscito di mente. E sì che i genitori parevano gente molto comune. Dimmi, chi era?» L’asinello sussurrò qualche cosa in un orecchio al bue. «Ma no!» fece costui sbalordito. «Sul serio? Vorrai scherzare, spero.» «La pura verità. Lo giuro… Del resto, io l’avevo subito capito.» «Io no, confesso. Si vede che tu sei più intelligente. A me, non mi aveva neanche sfiorato il sospetto. Benché, certo, a vedersi fosse un bambino straordinario.» «Bene, da allora, gli uomini, ogni anno, fanno gran festa per l’anniversario della nascita. E per loro non ci sono giornate più belle. Tu li vedessi. È il tempo della serenità, della dolcezza, del riposo dell’animo, della pace, delle gioie familiari, del volersi bene. Perfino gli assassini diventano buoni come agnelli. Lo chiamano Natale. Anzi, amico, mi viene un’idea. Vuoi che ti conduca a vederli?» “Chi?» “Gli uomini che festeggiano il Natale.» “Dove?» “Giù, sulla terra, no?»
“Ci sei già stato?» «Ogni anno faccio una scappata. Mi hanno dato un lasciapassare speciale. Ma immagino lo possa avere anche tu.» «Su, vieni, se non vuoi perdere il meglio. Oggi è proprio la vigilia.» «E il lasciapassare per me?» «Subito fatto. Ho un cugino nell’ufficio passaporti.» Il lasciapassare fu concesso.
Partirono. Lievi, lievi, planarono dal cielo su una grandissima città della terra. Ed eccoli, il somarello e il bue, invisibili aggirarsi per le vie del centro. Così potevano vedere tutto a loro agio.
Era uno spettacolo impressionante. I mille lumi delle vetrine, i festoni, le ghirlande, gli abeti e lo sterminato ingorgo di automobili e il formicolio vertiginoso della gente che andava e veniva, entrava ed usciva, si accalcava nei negozi, si caricava di pacchi e pacchetti, tutti con un’espressione ansiosa e frenetica. A quella vista il somarello sembrava divertito. Il bue, invece, si guardava intorno con spavento.
«Senti, amico asinello, tu mi hai detto che mi portavi a vedere il Natale. Guarda che ti devi essere sbagliato. Te lo dico io: qui stanno facendo la guerra.» «Ma non vedi come sono tutti contenti?» «Contenti? A me sembrano dei pazzi. Ma non vedi che facce spiritate?» «Perché tu sei un provinciale, caro il mio bue, che non ti sei mai mosso dal paradiso. Tu non sei pratico degli uomini moderni, tutto qui. Per divertirsi, per trovare gioia, per sentirsi felici, hanno bisogno di rovinarsi i nervi»
Il bue fece una svolazzatina e si fermò a curiosare a una finestra del settimo piano. E l’asinello, gentilmente, dietro. Videro che alcune persone erano molto indaffarate a scrivere biglietti su biglietti e dovunque arrivassero, era il medesimo spettacolo. Andare e venire, comprare e impaccare, spedire e ricevere, chiamare e rispondere. E tutti guardavano continuamente l’orologio, tutti correvano, tutti ansimavano col terrore di non fare in tempo.
«Mi avevi detto...» osservò il bue, «...che era la festa della serenità, della pace, del riposo dell’animo.» «Già, una volta era così. Ma cosa vuoi, da qualche anno, all’avvicinarsi del Natale, gli uomini si comportano in questo modo.» Il bue ascoltò, stupito. Per le strade, nei negozi, negli uffici, nelle fabbriche, uomini e donne parlavano fitto, fitto scambiandosi l’un l’altro, come automi, delle monotone formule: «Buon Natale, auguri, auguri a lei, grazie altrettanto, auguri, auguri, felici feste, grazie, auguri, auguri, auguri.» Era un brusio che riempiva la città.
«Ma ci credono?» chiese il bue. «Lo dicono sul serio? Vogliono così veramente bene al prossimo?» L’asinello tacque. «Dimmi, tu che sei pratico» chiese il bue, ancor poco persuaso, «sei proprio sicuro che non siano tutti pazzi?» «No, no, è semplicemente Natale.» «Ce n’è troppo di Natale, allora. Ma ti ricordi quella notte, a Betlemme, la capanna, i pastori, quel bel Bambino? Era freddo, anche lì, eppure c’era una pace, una soddisfazione. Come era diverso!» «È vero. E quelle zampogne lontane, che si sentivano appena, appena.» «E sul tetto come un lieve svolazzamento. Chissà che uccelli erano.» «Uccelli! Testone che non sei altro! Erano angeli.» «E quei tre ricchi signori che portavano regali, li ricordi? Come erano educati, come parlavano piano, che persone distinte. Te li immagini, se capitassero in mezzo a quella baraonda?» «E la stella? Non ti ricordi che razza di stella, proprio sopra la capanna? Chissà che non ci sia ancora. Le stelle di solito hanno vita lunga.» «Ho idea di no...» disse il bue. «C’è poca aria di stelle, qui.» Alzarono i musi a guardare, e infatti non si vedeva niente. Sulla città c’era un soffitto di caligine.
RIFLETTIAMO
• Che cosa si raccontano gli animali del presepe?
• Come descrivono il primo Natale e quello dei giorni nostri?
• Sono differenti? In che cosa?
• Che cosa significano le parole del bue: “Ce n’è troppo di Natale? ”.
• Qual è il vero spirito del Natale?
Natale in arte
Nella classe terza il Natale viene presentato attraverso le opere d’arte e i segni simbolo della tradizione, per ANIMARE CULTURALMENTE L’AMBIENTE SCOLASTICO e favorire le opportune riflessioni su quegli aspetti trascendenti dell’evento che altrimenti non sarebbero colti dall’alunno di questa età.
L’ARTE, in generale, PERMETTE ALL’UOMO DI ESPRIMERE SE STESSO, i suoi sentimenti e il senso che egli attribuisce alla vita. Così molti pittori, di diversi luoghi ed epoche, hanno creato varie opere sulla nascita di Gesù, ricostruendone la storia in modo davvero particolare e coinvolgente.
Le tradizioni natalizie del passato e del presente mostrano che questa festa non si riduce a puro consumismo, ma è profondamente radicata nel vissuto di milioni di persone che vedono in essa un evento unico per tutta l’umanità.
Proposta 1
Per far comprendere straordinarie opere d’arte come la Natività di Lorenzo Lotto, l'Adorazione dei pastori di Van Honthorst e l'Adorazione dei Magi di Nicolas Poussin, leggiamo in classe i brani evangelici di Luca e Matteo da cui questi artisti hanno tratto la loro ispirazione.
In quei giorni un decreto di Cesare Augusto ordinò che si facesse il censimento di tutta la terra. Questo primo censimento fu fatto quando era governatore della Siria Quirinio. Tutti andavano a farsi registrare, ciascuno nella sua città. Anche Giuseppe, che era della casa e della famiglia di Davide, dalla città di Nazaret in Galilea salì in Giudea alla città di Davide, chiamata Betlemme, per farsi registrare insieme a Maria sua sposa, che era incinta. Mentre si trovavano in quel luogo, si compirono per lei i giorni del parto. Diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo depose in una mangiatoia, perché per loro non c’era posto nell’albergo.
ADORAZIONE DEI PASTORI (LUCA 2,8-20)
C’erano in quella regione alcuni pastori che, pernottando all’aperto vegliavano di notte facendo la guardia al loro gregge. Un angelo del Signore si presentò a loro e la gloria del Signore li avvolse di luce. Essi furono presi da grande timore,
ma l’angelo disse loro: «Non temete: ecco, vi annuncio una grande gioia, che sarà di tutto il popolo: oggi nella città di Davide, è nato per voi un Salvatore, che è Cristo Signore. Questo per voi il segno: troverete un bambino avvolto in fasce, adagiato in una mangiatoia.» E subito apparve con l’angelo una moltitudine dell’esercito celeste, che lodava Dio e diceva: «Gloria a Dio nel più alto dei cieli e pace in terra agli uomini che Egli ama.» Appena gli angeli si furono allontanati da loro verso il cielo, i pastori si dissero l’un l’altro: «Andiamo fino a Betlemme, vediamo questo avvenimento che il Signore ci ha fatto conoscere.» Andarono dunque senz’indugio, e trovarono Maria Giuseppe e il bambino, adagiato in una mangiatoia. E dopo averlo visto, riferirono ciò che del bambino era stato detto loro. Tutti quelli che udivano, si stupirono delle cose che i pastori dicevano. Maria, da parte sua, custodiva tutte queste cose meditandole nel suo cuore. I pastori poi se ne tornarono, glorificando e lodando Dio per tutto quello che avevano udito e visto, com’era stato detto loro.
ADORAZIONE DEI MAGI (MATTEO 2,1-12)
Gesù nacque a Betlemme di Giudea, al tempo del re Erode. Ecco alcuni magi giunsero da Oriente a Gerusalemme e dicevano: «Dov’è il re dei Giudei che è nato? Abbiamo visto sorgere la sua stella e siamo venuti ad adorarlo.» All’udire queste parole, il re Erode restò turbato e con lui tutta Gerusalemme. Riuniti tutti i capi dei sacerdoti e gli scribi del popolo si informava da loro sul luogo in cui doveva nascere il Messia. Gli risposero: «A Betlemme di Giudea, perché così è scritto per mezzo del profeta: E tu, Betlemme, terra di Giuda, non sei davvero l’ultima delle città principali di Giuda: da te infatti uscirà un capo che sarà il pastore del mio popolo, Israele.» Allora Erode, chiamati segretamente i magi, si fece dire da loro con esattezza il tempo in cui era apparsa la stella e li inviò a Betlemme dicendo: «Andate e informatevi accuratamente del bambino e, quando l’avrete trovato, fatemelo sapere, perché anch’io venga ad adorarlo.» Udite le parole del re, essi partirono. Ed ecco la stella, che avevano visto spuntare, li precedeva, finché giunse e si fermò sopra il luogo dove si trovava il bambino. Al vedere la stella, provarono una gioia grandissima. Entrati nella casa, videro il bambino con Maria sua madre, si prostrarono e lo adorarono. Poi aprirono i loro scrigni e gli offrirono in dono oro, incenso e mirra. Avvertiti in sogno di non tornare da re Erode, per un’altra strada fecero ritorno al loro paese.
Proposta 2
Spieghiamo in modo particolare il dipinto della Natività di Lorenzo Lotto.
Facciamo comprendere che Lotto, grande pittore del 1500, è stato capace in questo dipinto di rendere naturale e veritiera la scena della Natività e, nello stesso tempo, di caricarla di un significato simbolico teso a renderne più profondo il messaggio. Spieghiamo che nel dipinto i personaggi sono collocati in primo piano tanto da mettere l’osservatore in posizione privilegiata, proprio dentro alla stalla, e in una condizione di intimità con il mistero che si rivela.
In quest’opera, i dettagli comunicano la verità. Ad essi Lotto affida il compito di completare l’annuncio evangelico, appaiono come presenze discrete, eppure trasmettono concetti fondamentali.








Lo sposo di Maria che di solito viene rappresentato in disparte, qui è affiancato alla Madonna, prega e un sorriso muove il suo volto.
Egli è inginocchiato in segno di adorazione.









La Madonna ha gli occhi fissi su Gesù. Osserva il bambino che le sta parlando con lo sguardo, con il movimento delle labbra, con i piedini che scattano e con le mani che si muovono in uno slancio d’affetto. Lui, che è Dio, si vuole aggrappare a sua madre.
La mamma ha le braccia conserte che svelano delle dita che fremono, l’inclinazione del suo busto comunica l’attrazione verso suo Figlio. Egli è inginocchiato in segno di adorazione.







IL FIGLIO
Il bimbo è deposto in una cesta di paglia, lì per terra, a significare che è proprio venuto in questo mondo. La culla è un umile cesto perché Luca ricorda che il Figlio di Dio fu deposto in una mangiatoia. Appoggiate ad essa si trovano un sacchetto di iuta annodato e una botticella: il pane e l’acqua, quel poco che basta per sfamare chi tra poco dovrà mettersi in viaggio (fuga in Egitto).


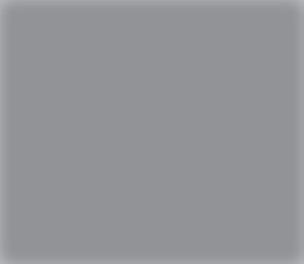


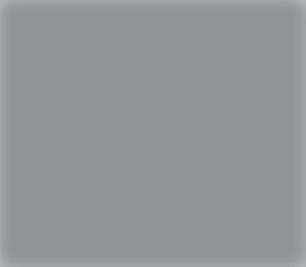

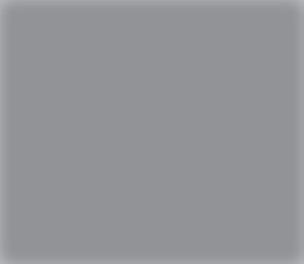



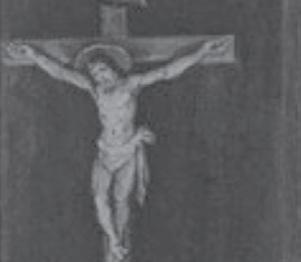
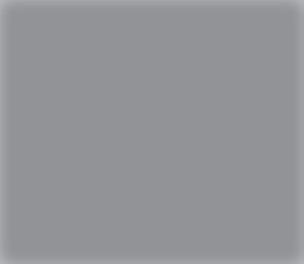
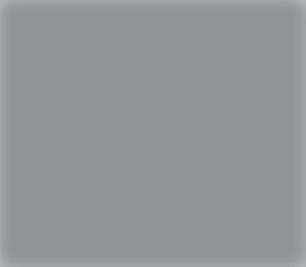


Tre angioletti cantano esultanti, tenendo tra le mani un foglio di musica con il visibile pentagramma. Un modo molto umano per far partecipare anche le potenze celesti a questo evento gioioso.
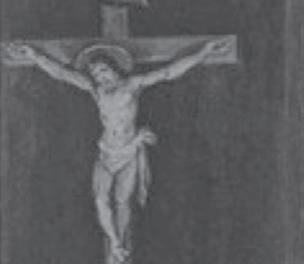

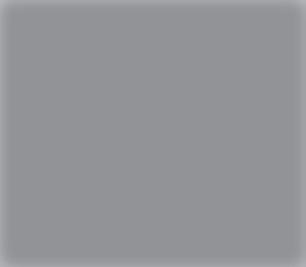
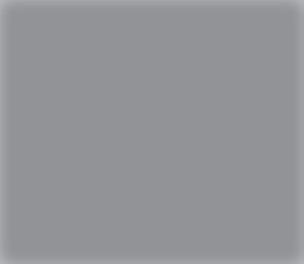

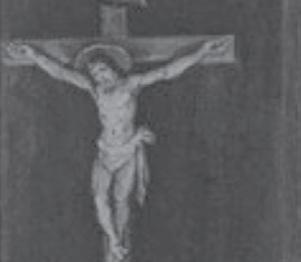



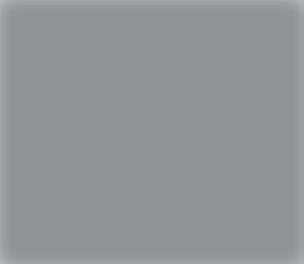
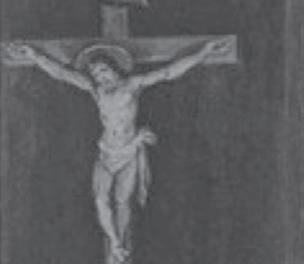
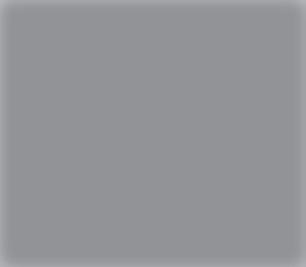

Appeso alla parete sinistra, dietro San Giuseppe, il crocifisso, predice e nello stesso tempo ricorda il destino finale del Cristo appena nato: la morte in croce per la salvezza dell’umanità.
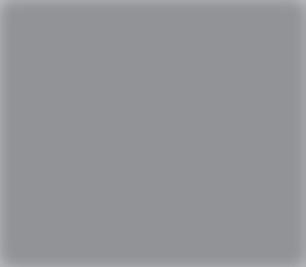



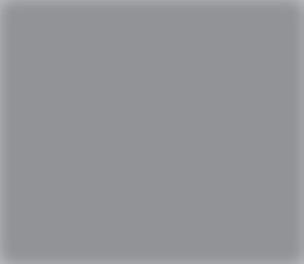

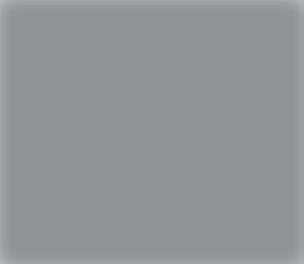



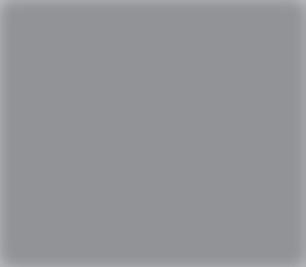


La coppia di tortore che sta appollaiata su di un bastone all’ingresso della capanna è lì perché nella simbologia cristiana medioevale rappresenta la Chiesa nei suoi rapporti con lo sposo divino, e testimonia la fedeltà perché la tortora non si riaccoppia quando rimane vedova.

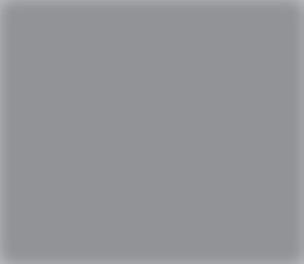



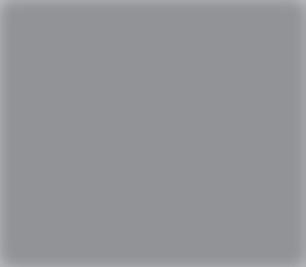



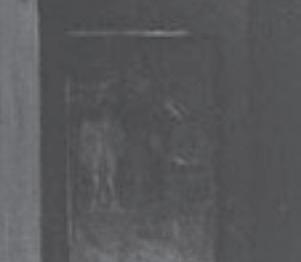
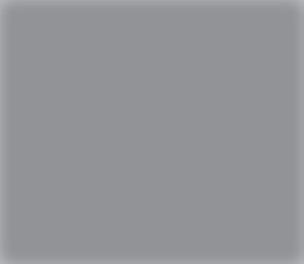
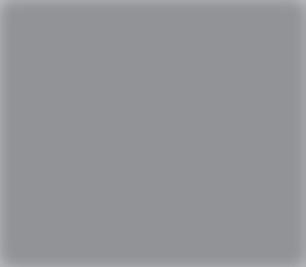

La scala appoggiata alla capanna oltre a richiamare l’ambiente contadino ricorda l’episodio biblico del sogno di Giacobbe. Inoltre essa è divenuta simbolo che annuncia l’incarnazione di Cristo, l’unione della terra con il cielo.


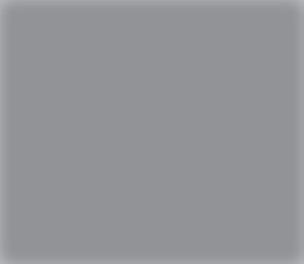
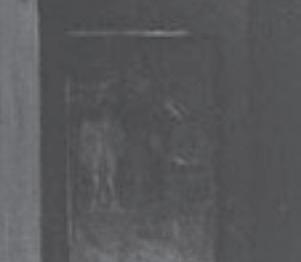
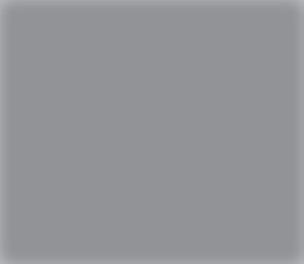
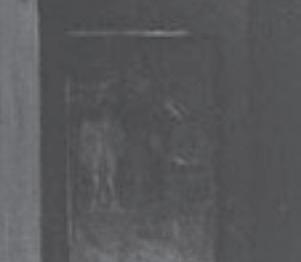
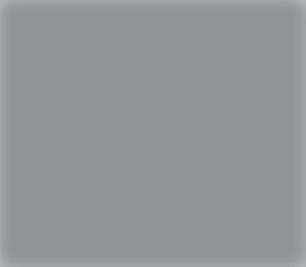



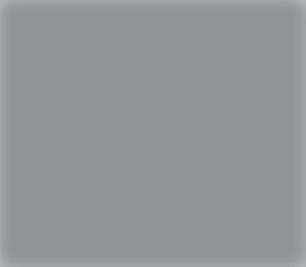

La tradizione vuole la presenza dell’asino e del bue. Lotto li colloca lontani, dentro la capanna e legati alla greppia. Qui sono pressoché inesistenti. Il pittore infatti conosce la teologia e sa che i due animali non compaiono nelle prime iconografie del Natale, sono infatti un’aggiunta successiva.
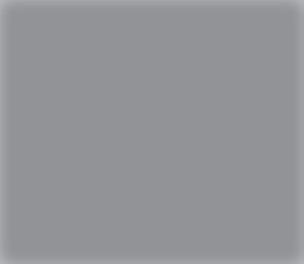






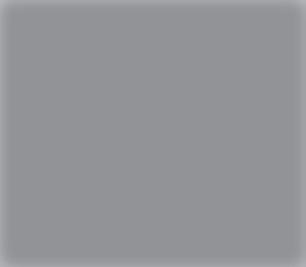

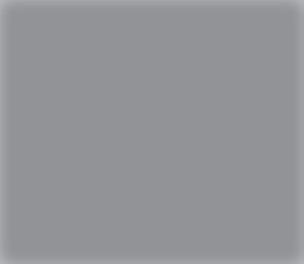

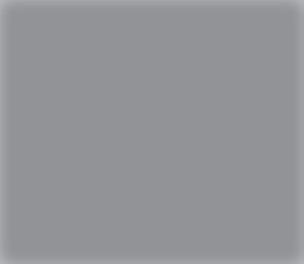

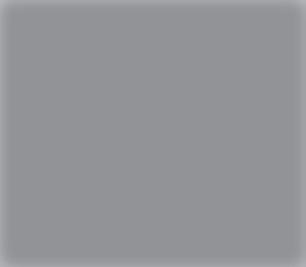

Attraverso una ricerca gli alunni potranno mettere a confronto le tradizioni natalizie del passato e di oggi.
La ricerca sulle usanze presenti nel proprio ambiente mostrerà che esse non si riducono a puro folclore, ma preparano il terreno affinché i nostri bambini sappiano cogliere il significato del Natale in modo corretto. L’approfondimento seguente vuole inserirsi proprio in questa direzione, presentando alcuni aspetti storici e simbolici delle usanze natalizie che forse non tutti conoscono.
OGNI FESTA CRISTIANA VIENE SALUTATA DAL SUONO FESTOSO DELLE CAMPANE. Chi diede infatti agli uomini l’annuncio della nascita del Redentore? Gli angeli. E non sono forse gli angeli gli inventori delle campane, attraverso il cui suono fanno sentire al mondo la loro voce? In realtà le campane vennero introdotte nelle chiese piuttosto tardi, intorno al IX secolo dopo che per millenni, piccoli bronzi, erano stati usati per consentire all’uomo, attraverso i loro rintocchi, di ENTRARE IN CONTATTO CON LE MISTERIOSE ARMONIE DEL SOPRANNATURALE .
IL VISCHIO E L’AGRIFOGLIO
Sono il SIMBOLO DELLA VITA CHE CONTINUA. La leggenda nordica che racconta l’antica origine del vischio e dell’agrifoglio come simboli di buon augurio e di pace è paradossalmente una leggenda di odio e di sangue. Si racconta infatti che Baldur, figlio di Odino, venne ucciso da un suo acerrimo nemico. Loki, con una freccia ricavata da un ramo di vischio. Odino maledisse la pianta, ma la moglie del dio vi sparse sopra tutte le sue lacrime, che miracolosamente, si trasformarono in perle. Il vischio, comunque, per volere di Odino, fu allontanato dai templi ove in epoche remotissime era entrato come una pianta sacra e venne sostituito con l’agrifoglio sul cui cespuglio Baldur era caduto trafitto dalla freccia. Per ricompensare questa pianta, ultimo giaciglio del figlio, Odino la rese sempreverde e punteggiata di bacche rosse in ricordo del sangue sparso dall’amato Baldur. Questa è LA LEGGENDA: in realtà invece, pare che le due piante entrassero a far parte dei riti dei Druidi, gli antichi sacerdoti celti, che nelle loro foglie sempreverdi vedevano un simbolo della perennità della vita e dell’approssimarsi della primavera. Anche qui, dunque, siamo di fronte a un’origine pagana di due
simboli natalizi che il cristianesimo accettò come uso popolare, cambiando le lacrime versate dalla moglie di Odino in quelle sparse dalla Vergine, e il sangue di Baldur in quello di Cristo.
Pochi sanno che la tradizione di addobbare l’abete è nata in Egitto. In quei luoghi infatti l’albero era costituito da una piccola piramide di legno, costruita a imitazione dei giganteschi monumenti come simbolo culturale e propiziatorio. Dalla terra dei faraoni, dunque, un viaggiatore portò questa idea in Europa e parte delle popolazioni germaniche, scandinave e russe lo adottarono per celebrare il solstizio d’inverno, il ritorno di quel sole e di quel calore di cui il clima d’Egitto era simbolo.
Fu Martin Lutero, dicono alcuni, ad introdurre l’abete, sostituendolo al simulacro egizio di cui ricordava la forma. Le sue fronde sempreverdi potevano essere anche in pieno inverno presagio di primavera.
Le candeline poi, furono inventate dai luterani e avevano questo significato: la loro luce rappresentava la vita e la fede. Attorno all’albero di Natale sono nate le leggende più gentili e fantasiose, tra queste ne scegliamo una...
C’era una volta nell’antica Germania un boscaiolo. Tornando a casa in una notte d’inverno, gelida, ma serena, l’uomo fu colpito dal meraviglioso spettacolo delle stelle che brillavano attraverso i rami di un abete carico di neve e di ghiaccio. Per spiegare alla moglie lo splendore che aveva visto, il boscaiolo tagliò un piccolo abete, lo portò a casa e lo adornò di candeline accese e di allegri festoni. Le candeline somigliavano alle stelle che aveva visto brillare, e i festoni alla neve e ai ghiaccioli che pendevano da rami. Altri videro l’albero e piacque tanto a tutti, specialmente ai bambini, e presto l’usanza dell’abete con le candeline si diffuse in ogni casa.
È una pianta ornamentale del Messico dove cresce spontaneamente fino a raggiungere anche un’altezza fra i due e i quattro metri.
Una leggenda narra che in un piccolo villaggio messicano viveva una bambina di nome Altea. Giunse la notte di Natale e tutti andarono in chiesa con un piccolo dono per Gesù. Solo Altea rimase a casa perché non aveva nulla da donargli,
quando all’improvviso le apparve un angelo. «Perché sei così triste?» chiese l’angelo alla bambina. «Perché non ho nulla da portare a Gesù!» rispose Altea. Allora l’angelo le disse: «Tu hai una cosa molto importante da donare a Lui: il tuo amore. Raccogli le frasche che crescono ai bordi della strada e portale in chiesa. Vedrai, il tuo dono sarà il più bello di tutti.» Altea fece come le aveva detto l’angelo, andò in chiesa e depose un mazzo di frasche davanti all’altare. Mentre la bambina pregava le frasche si trasformarono in una pianta meravigliosa con foglie verdi e rosse: era nata la Stella di Natale.
Il ceppo protegge la casa da qualunque pericolo. È una delle usanze pagane diffuse in Europa fin dai tempi più lontani per festeggiare il solstizio d’inverno: si accendevano grossi fuochi come simbolo modesto, ma significativo, del nuovo calore del sole. La tradizione pagana si mantiene viva in molte regioni italiane e in diversi paesi. In Umbria come in Emilia, Marche e Abruzzi, si fa ardere un grosso ceppo di ulivo fino ai primi di gennaio, quando le ceneri vengono sparse sui campi e nelle vigne come augurio di buon raccolto. In Puglia e in Calabria il ceppo viene coperto di edera e circondato da dodici legni più piccoli, simbolo dei dodici apostoli. In Sardegna si osa digiunare davanti al fuoco fino a mezzanotte, mentre una gentile tradizione toscana vuole che le porte delle case rimangano aperte ad ogni ospite di passaggio per tutto il tempo in cui il ciocco arde nel camino.
Gli antichi Romani, in occasioni di feste e a capodanno, erano soliti scambiarsi dei regali chiamati “strenne”. Tale consuetudine si ricollegava ad una tradizione secondo la quale, il primo giorno dell’anno, al re veniva offerto in dono un ramoscello raccolto nel bosco della dea Strenna. Questo rito augurale si diffuse tra il popolo e, ben presto, i rametti di alloro, di ulivo e di fico vennero sostituiti da regali vari. Tale tradizione, presente ancora ai giorni nostri, si riveste in occasione del Natale di nuovi significati richiamando, attraverso il gesto del dono, all’amore di Dio che ha donato suo figlio Gesù all’umanità intera e all’omaggio che i magi hanno presentato per onorarlo.
Proposta 2
Ai bambini, avidi di storie e racconti meravigliosi non presenteremo solo i miracoli che suscitano meraviglie e stupore, ma faremo vedere come esistano altre realtà degne della nostra ammirazione e della nostra riconoscenza. I gesti di amore, di generosità, di coraggio sono il prolungamento nel tempo dell’amore di Gesù: ancora oggi Gesù continua a fare miracoli attraverso la generosità e la bontà come testimoniano questi due racconti.
Questa è la storia vera di una bambina di otto anni che sapeva che l’amore può fare meraviglie.
Il suo fratellino era destinato a morire per una grave malattia.
I suoi genitori erano poveri, ma avevano fatto di tutto per salvarlo, spendendo tutti i loro risparmi.
Una sera, il papà disse alla mamma in lacrime: «Non ce la facciamo più, cara. Credo sia finita. Solo un miracolo potrebbe salvarlo.»
La piccola, con il fiato sospeso, in un angolo della stanza aveva sentito. Corse nella sua stanza, ruppe il salvadanaio e, senza far rumore, si diresse alla farmacia più vicina. Attese pazientemente il suo turno. Si avvicinò al bancone, si alzò sulla punta dei piedi e, davanti al farmacista meravigliato, posò sul banco tutte le monete. «Per cos’è? Che cosa vuoi piccola?».
«È per il mio fratellino, signor farmacista. È molto malato e io sono venuta a comprare un miracolo.»
«Che cosa dici?» borbottò il farmacista. «Si chiama Andrea, papà ha detto alla mamma che è finita, non c’è più niente da fare e che ci vorrebbe un miracolo per salvarlo. Vede, io voglio tanto bene al mio fratellino, per questo ho preso tutti i miei soldi e sono venuta a comperare un miracolo.» Il farmacista accennò un sorriso triste. «Piccola mia, noi qui non vendiamo miracoli.»
«Ma se non bastano questi soldi posso darmi da fare per trovarne ancora. Quanto costa un miracolo?» C’era nella farmacia un uomo alto ed elegante, dall’aria molto seria, che sembrava interessato alla strana conversazione. Il farmacista allargò le braccia mortificato. La bambina, con le lacrime agli occhi, cominciò a recuperare le sue monetine.
L’uomo si avvicinò a lei. «Perché piangi, piccola? Che cosa ti succede?» «Il signor
farmacista non vuole vendermi un miracolo e neanche dirmi quanto costa... È per il mio fratellino Andrea che è molto malato. Mamma dice che ci vorrebbe un’operazione, ma papà dice che costa troppo e non possiamo pagare e che ci vorrebbe un miracolo per salvarlo. Per questo ho portato tutto quello che ho.»
«Quanto hai?» «Un dollaro e undici centesimi... Ma, sapete...» aggiunse con un filo di voce, «posso trovare ancora qualcosa...» L’uomo sorrise «Guarda, non credo sia necessario. Un dollaro e undici centesimi è esattamente il prezzo di un miracolo per il tuo fratellino!» Con una mano raccolse la piccola somma e con l’altra prese dolcemente la manina della bambina. «Portami a casa tua, piccola. Voglio vedere il tuo fratellino e anche il tuo papà e la tua mamma e vedere con loro se possiamo trovare il piccolo miracolo di cui avete bisogno.» Il signore alto ed elegante e la bambina uscirono tenendosi per mano.
Quell’uomo era il professor Carlton Armstrong, uno dei più grandi neurochirurghi del mondo. Operò il piccolo Andrea, che poté tornare a casa qualche settimana dopo completamente guarito.
«Questa operazione» mormorò la mamma «è un vero miracolo. Mi chiedo quanto sia costata...». La sorellina sorrise senza dire niente.
Lei sapeva quanto era costato il miracolo: un dollaro e undici centesimi... più, naturalmente l’amore e la fede di una bambina.
Una giovane madre era in attesa del secondo figlio. Quando seppe che era una bambina, insegnò al suo bambino primogenito, che si chiamava Michele, ad appoggiare la testolina sulla sua pancia tonda, e cantare insieme a lei una «ninna nanna» alla sorellina che doveva nascere.
La canzoncina, che faceva «Stella stellina, la notte si avvicina...», piaceva tantissimo al bambino, che la cantava più volte.
Il parto però fu prematuro e complicato. La neonata fu messa in una incubatrice per cure intensive... I genitori trepidanti furono preparati al peggio: la loro bambina aveva pochissime probabilità di sopravvivere.
Il piccolo Michele li supplicava: «Voglio vederla! Devo assolutamente vederla!». Dopo una settimana, la neonata si aggravò ancor di più. La mamma allora decise di portare Michele nel reparto di terapia intensiva della maternità.
Un’infermiera cercò di impedirlo, ma la donna era decisa ed accompagnò il bambino vicino al lettino ingombro di fili e tubicini, dove la piccola lottava per la vita.
Vicino al lettino della sorellina, Michele istintivamente avvicinò il suo volto a quello della neonata e cominciò a cantare sottovoce: «Stella stellina...».
La neonata reagì immediatamente. Cominciò a respirare serenamente, senz’affanno. Con le lacrime agli occhi, la mamma disse: «Continua, Michele, continua!» Il bambino continuò.
La bambina cominciò a muovere le braccine. La mamma e il papà piangevano e ridevano nello stesso tempo, mentre l’infermiera incredula fissava la scena a bocca aperta. Qualche giorno dopo, la piccola entrò in casa in braccio alla mamma, mentre Michele manifestava rumorosamente la sua gioia!
I medici della clinica, imbarazzati, definirono l’avvenimento con parole difficili. Ma la mamma e il papà sapevano che era stato semplicemente un miracolo dell’amore di un fratellino per una sorellina tanto attesa.
Bruno Ferrero
Dopo la morte del re Salomone, la terra di Canaan fu divisa in due regni e continuamente minacciata dagli Assiri e dai Babilonesi. In questo terribile periodo vennero distrutti il Tempio, l’Arca dell’Alleanza e trasferite a forza (deportate) numerose persone.
Il popolo ebraico, nei momenti di difficoltà e di scoraggiamento si affidò alla voce dei profeti.
Il profeta è “colui che parla al popolo in nome di Dio”. Il suo compito era quello di mantenere la speranza e la fede in Dio.
Il profeta ricordava a tutti che Dio non avrebbe abbandonato il suo popolo e che aveva promesso di mandare un Salvatore a riportare pace e giustizia.
Nella Bibbia troviamo 16 profeti e le loro storie sono narrate nei libri profetici. Ciascun libro porta il nome del suo protagonista.
Il giovane Samuele continuava a servire il Signore sotto la guida di Eli. La parola del Signore era rara in quei giorni, le visioni non erano frequenti. In quel tempo Eli stava riposando in casa, perché i suoi occhi cominciavano a indebolirsi e non riusciva più a vedere.
La lampada di Dio non era ancora spenta e Samuele era coricato nel tempio del Signore, dove si trovava l’arca di Dio. Allora il Signore chiamò: «Samuele!» e quegli rispose: «Eccomi», poi corse da Eli e gli disse: «Mi hai chiamato, eccomi!». Egli rispose: «Non ti ho chiamato, torna a dormire!». Tornò e si mise a dormire. Ma il Signore chiamò di nuovo: «Samuele!» e Samuele, alzatosi, corse da Eli dicendo: «Mi hai chiamato, eccomi!». Ma quegli rispose di nuovo: «Non ti ho chiamato, figlio mio, torna a dormire!». In realtà Samuele fino allora non aveva ancora conosciuto il Signore, né gli era stata ancora rivelata la parola del Signore. Il Signore tornò a chiamare: «Samuele!» per la terza volta; questi si alzò ancora e corse da Eli dicendo: «Mi hai chiamato, eccomi!». Allora Eli comprese che il Signore chiamava il giovinetto. Eli disse a Samuele: «Vattene a dormire e, se ti si chiamerà ancora, dirai: Parla, Signore, perché il tuo servo ti ascolta». Samuele andò a coricarsi al suo posto. Venne il Signore, stette di nuovo accanto a lui e lo chiamò ancora come le altre volte: «Samuele, Samuele!». Samuele rispose subito: «Parla, perché il tuo servo ti ascolta».
Collegate alla lettura degli episodi del Vangelo l’insegnante può suggerire attività di drammatizzazione.
Gesù guarisce un paralitico
Cast:
(Mc 2,1-12)
Narratore: Narratore, Gesù, Scriba 1, Scriba 2, Scriba 3, Persona. Gesù entrò di nuovo a Cafarnao dopo alcuni giorni. Si seppe che era in casa e si radunarono tante persone, da non esserci più posto neanche davanti alla porta, ed egli annunziava loro la parola. Si recarono da lui con un paralitico portato da quattro persone. Non potendo però portarglielo, a causa della folla, scoperchiarono il tetto nel punto dov’egli si trovava e, fatta un’apertura, calarono il lettuccio su cui giaceva il paralitico. Gesù, vista la loro fede, disse al paralitico:
Gesù:
Narratore:
Scriba 1:
Scriba 2:
Scriba 3:
Narratore:
Gesù:
Narratore:
Persona:
Figliolo, ti sono rimessi i tuoi peccati.
Seduti là erano alcuni scribi che pensavano in cuor loro;
Perché costui parla così?
Bestemmia!
Chi può rimettere i peccati se non Dio solo?
Ma Gesù, avendo subito conosciuto nel suo spirito che così pensavano tra se, disse loro:
Perché pensate così nei vostri cuori? Che cosa è più facile: dire al paralitico Ti sono rimessi i peccati, o dire Alzati, prendi il tuo lettuccio e cammina?. Ora, perché sappiate che il Figlio dell’uomo ha il potere sulla terra di rimettere i peccati, ti ordino: Alzati, prendi il tuo lettuccio e va’ a casa tua.
Quegli si alzò, prese il suo lettuccio e se ne andò in presenza di tutti e tutti si meravigliarono e lodavano Dio dicendo:
Non abbiamo mai visto nulla di simile!
Cast:
Narratore:
Maria:
Narratore:
Gesù:
Narratore:
Gesù:
Narratore:
Marta:
Gesù:
Marta:
Gesù: Marta:
Narratore:
(Gv 11,1-44)
Narratore, Maria, Gesù, Marta, Persona1, Persona2.
Era malato un certo Lazzaro di Betania, il villaggio di Maria e Marta sua sorella. Maria era quella che aveva cosparso di olio profumato il Signore e gli aveva asciugato i piedi con i suoi capelli; suo fratello Lazzaro era malato. Le sorelle mandarono dunque a dirgli: Signore, ecco, il tuo amico è malato.
All’udire questo, Gesù disse:
Questa malattia non è per la morte, ma per la gloria di Dio, perché per essa il Figlio di Dio venga glorificato.
Gesù voleva molto bene a Marta, a sua sorella e a Lazzaro. Quand’ebbe dunque sentito che era malato, si trattenne due giorni nel luogo dove si trovava. Poi disse ai discepoli:
Andiamo di nuovo in Giudea! Il nostro amico Lazzaro si è addormentato; ma io vado a svegliarlo. (Pausa).
Venne dunque Gesù e trovò Lazzaro che era già da quattro giorni nel sepolcro. Marta dunque, come seppe che veniva Gesù, gli andò incontro; Maria invece stava seduta in casa. Marta disse a Gesù:
Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto! Ma anche ora so che qualunque cosa chiederai a Dio, egli te la concederà.
Tuo fratello risusciterà.
So che risusciterà nell’ultimo giorno.
Io sono la risurrezione e la vita; chi crede in me, anche se muore, vivrà; chiunque vive e crede in me, non morrà in eterno. Credi tu questo?
Sì, o Signore, io credo che tu sei il Cristo, il Figlio di Dio che deve venire nel mondo.
Dopo queste parole se ne andò a chiamare di nascosto Maria, sua sorella:
Marta:
Narratore:
Maria:
Narratore:
Scriba 3:
Maria e Marta:
Narratore:
Persona 1:
Narratore: Persona 2:
Narratore:
Gesù:
Marta:
Gesù:
Narratore:
Gesù:
Narratore:
Gesù:
Il Maestro è qui e ti chiama.
Quella, udito ciò, si alzò in fretta e andò da lui. Allora i giudei che erano in casa con lei a consolarla, quando videro Maria alzarsi in fretta e uscire, la seguirono pensando: “Va’ al sepolcro per piangere là”. (Pausa).
Maria, dunque, quando giunse dov’era Gesù, vistolo si gettò ai suoi piedi dicendo:
Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto!
Gesù allora quando la vide piangere e piangere anche i giudei che erano venuti con lei, si commosse profondamente, si turbò e disse:
Dove l’avete messo?
Signore, vieni a vedere!
(Lentamente): Gesù scoppiò in pianto. Dissero allora i giudei:
Vedi come lo amava!
Ma alcuni di loro dissero:
Costui che ha aperto gli occhi al cieco non poteva anche far si che questi non morisse?
Intanto Gesù, ancora profondamente commosso, si recò al sepolcro; era una grotta e contro vi era posta una pietra. Disse Gesù:
Togliete la pietra!
Signore, già manda cattivo odore, poiché è di quattro giorni!
Non ti ho detto che, se credi, vedrai la gloria di Dio?
Tolsero dunque la pietra, Gesù allora alzò gli occhi e disse:
Padre, ti ringrazio che mi hai ascoltato. Io sapevo che sempre mi dai ascolto, ma l’ho detto per la gente che mi sta attorno, perché credano che tu mi hai mandato. (Pausa; a gran voce) Lazzaro, vieni fuori!
Il morto uscì, con i piedi e le mani avvolti in bende, e il volto coperto da un sudario. Gesù disse loro:
Scioglietelo e lasciatelo andare.

Dopo la lettura della storia, possiamo far ascoltare e ripetere una delle seguenti filastrocche.
Il gregge stanco ansando riposava sotto le stelle nella notte fonda. Dormivano i pastori. Il tempo andava. Quand’ecco una gran luce il cielo inonda. È mezzanotte. Ed ecco un dolce canto suona per l’aria, in armonia gioconda. Si destano i pastori, al gregge accanto, e ascoltano: «Sia gloria a Dio nei cieli e pace in terra all’uomo!». O dolce incanto! È nato un bimbo tutto luce e amore.
In stalla, avvolto in pochi veli, povero è nato eppure è il re dei cieli.
E dice a tutti: «State cuore a cuore, come fratelli! Non odiate mai!
L’anima che perdona è come un fiore. Chi crede in me non perirà mai!».
Ettore Bogno
Natale. Guardo il presepe scolpito dove sono i pastori appena giunti alla povera stalla di Betlemme.
Anche i Re Magi nelle lunghe vesti salutano il potente Re del mondo. Pace nella finzione e nel silenzio delle figure in legno ed ecco i vecchi del villaggio e la stalla che risplende e l’asinello di colore azzurro.
Salvatore Quasimodo
S’io facessi il fornaio vorrei cuocere un pane così grande da sfamare tutta, tutta la gente che non ha da mangiare. Un pane più grande del sole, dorato, profumato come le viole. Un pane così verrebbero a mangiarlo dall’India e dal Chilì i poveri, i bambini, i vecchietti e gli uccellini. Sarà una data da studiare a memoria: un giorno senza fame!
Il più bel giorno di tutta la storia.
Gianni Rodari
Disegna nei riquadri gli elementi più significativi della chiamata dei profeti.
Il Signore scelse alcuni uomini, chiamati profeti, per parlare al popolo d’Israele in suo nome. La Bibbia ci racconta quando e come avvenne la loro chiamata.
Un serafino gli toccò le labbra con un carbone ardente.
Il Signore stese la mano, gli toccò la bocca e disse: “Ecco, ti metto le mie parole sulla bocca”.
Il Signore gli fece mangiare un rotolo e gli ordinò di parlare agli israeliti.
EZECHIELE
OSEA
Il Signore gli disse che avrebbe perdonato il suo popolo e lo avrebbe amato con tutto il cuore.
Dopo l’ascolto del testo evangelico dell’Annunciazione scrivi a memoria, come le ricordi, le due frasi pronunciate da Maria all’angelo.
La nascita di Gesù
Leggi con attenzione e rispondi.
La nascita di Gesù
Ecco come avvenne la nascita di Gesù: sua madre Maria, essendo sposa di Giuseppe, prima che andassero a vivere insieme, si trovò incinta per opera dello Spirito Santo. Giuseppe, suo sposo, che era giusto e le voleva bene, decise di licenziarla in segreto. Mentre però stava pensando di separarsi da lei, ecco apparve un angelo del signore e gli disse: “Giuseppe, non temere di prendere con te Maria, tua sposa, perché quel che è generato in lei viene dallo Spirito Santo. Ella partorirà un figlio e tu lo chiamerai Gesù.
Egli infatti salverà i8l tuo popolo dai suoi peccati.”
Destatosi dal sonno, Giuseppe fece come gli aveva ordinato l’angelo del Signore e prese con sé la sua sposa, che partorì un figlio, chiamato Gesù. (Matteo 1,18-24)
Ecco come avvenne la nascita di Gesù: sua madre Maria, essendo sposa di Giuseppe, prima che andassero a vivere insieme, si trovò incinta per opera dello Spirito Santo. Giuseppe, suo sposo, che era giusto e le voleva bene, decise di licenziarla in segreto. Mentre però stava pensando di separarsi da lei, ecco apparve un angelo del signore e gli disse: “Giuseppe, non temere di prendere con te Maria, tua sposa, perché quel che è generato in lei viene dallo Spirito Santo. Ella partorirà un figlio e tu lo chiamerai Gesù. Egli infatti salverà i8l tuo popolo dai suoi peccati.”
Destatosi dal sonno, Giuseppe fece come gli aveva ordinato l’angelo del Signore e prese con sé la sua sposa, che partorì un figlio, chiamato Gesù. (Matteo 1,18-24)
• Con quali parole l’angelo annuncia la nascita di Gesù a Giuseppe?
• Perché Giuseppe accetta?
• Quale sarà il compito di Gesù?
• Con quali parole l’angelo annuncia la nascita di Gesù a Giuseppe?
• Perché Giuseppe accetta?
• Quale sarà il compito di Gesù?
Disegna nei riquadri vuoti quello che è indicato dalla didascalia, e completa le frasi secondo il contenuto dei disegni.

Natale è Natale è perdonarsi.

è Natale doni offrire è Natale
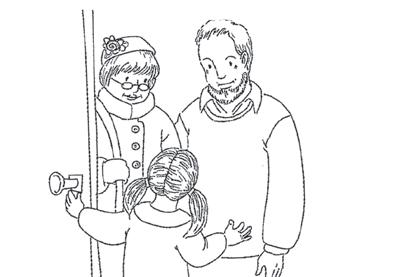
Natale è Natale è pensare a chi è solo.
Scopri i nomi dei Re Magi e le razze che rappresentano riordinando le lettere messe alla rinfusa. Colorali tenendo conto delle razze a cui appartengono e scrivi sotto ad ognuna la dicitura giusta. Completa le frasi utilizzando le seguenti parole (unguento - incenso - re - mirra - tempio - oro); conoscerai i doni che i magi portarono a Gesù e il loro significato.
L’evangelista Matteo ci presenta il racconto dei Magi (Matteo 2,1-12), uomini sapienti venuti da paesi lontani per adorare e offrire doni al Bambino Gesù.

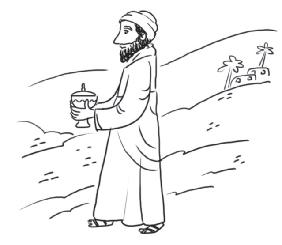
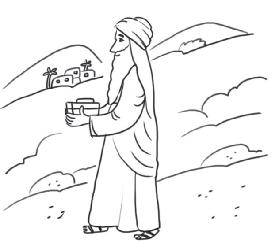
1. L’……...........................………. veniva offerto solo ai perché era molto costoso.
2. L’……...........................………. veniva bruciato al Era un dono che si offriva a Dio.
3. La veniva usato come profumo e come per conservare il corpo dei morti. Questo dono significa che Gesù era un uomo.
Risolvi il cruciverba. Nella colonna evidenziata scoprirai che i miracoli vengono chiamati anche:
D E FINIZIONI :
1 ) L e g ett ò il paralitico .
2 ) V i v iv e va Lazzar o .
3 ) L e op e rò Ges ù
4 ) I mir a co l i s o no g esti
5 ) Bart i meo era del l a città di …
6 ) Gu a rì un u om o posseduto o .. .
7) I l primo miracoli d i Gesù
8) La vide il cieco .
9) Gesù ne g u arì d i e ci .
10 ) Gesù ca l m ò la
11 ) Gesù resuscitò l a fig l i a di
12 ) Gesù mo l t i plicò …
13 ) Gu a rigi o n i prodi g i o se .
Colora e completa la coniugazione del verbo donare.
Quando a scuola studi i verbi è importante che tu sappia utilizzare il modo, il tempo e la persona in modo corretto.
Quando a scuola studi i verbi è importante che tu sappia utilizzare il modo, il tempo e la persona in modo corretto.
Pensando a quanto ti propone la disciplina della Religione cattolica, un verbo interessante da studiare è il verbo “donare”.
“Donare” è il verbo che tutti i cristiani si impegnano a coniugare al tempo passato, presente e futuro.
Pensando a quanto ti propone la disciplina della Religione cattolica, un verbo interessante da studiare è il verbo “donare”. “Donare” è il verbo che tutti i cristiani si impegnano a coniugare al tempo passato, presente e futuro.
Modo indicativo
Tempo presente
Modo indicativo
Tempo futuro semplice
Modo indicativo
Io dono
Tu doni
Tempo presente
Io dono
Egli
Tu doni
Noi
Egli
Voi donate
Noi
Essi donano
Voi donate
Essi donano
Modo indicativo
Tempo passato prossimo
Modo indicativo
Io ho donato
Tu hai
Tempo passato prossimo
Egli ha
Io ho donato
Noi abbiamo
Tu hai
Voi avete
Egli ha
Essi hanno
Noi abbiamo
Voi avete
Essi hanno
Modo indicativo
Io
Tu donerai
Tempo futuro semplice
Io
Egli donerà
Noi
Tu donerai
Egli donerà
Voi donerete
Noi
Essi doneranno
Voi donerete
Essi doneranno
Modo indicativo
Tempo passato remoto
Io donai
Modo indicativo
Tu donasti
Tempo passato remoto
Egli
Io donai
Noi
Tu donasti
Egli
Voi
Noi
Essi
Voi
Essi
Completa la frase e colora, commentando i disegni.
I cristiani cercano di mettere in pratica le parole di Gesù aiutando gli altri. Alcuni di essi, in particolare, vanno incontro ai fratelli di ogni parte del mondo, senza fare distinzione di lingua, razza e religione: sono i missionari.
Secondo me la parola “solidarietà” significa:
Gesù dà un significato completamente nuovo alla cena pasquale ebraica. Osserva le immagini qui sotto e rispondi alle domande.
• Quale alimento ebraico è rimasto anche nella celebrazione eucaristica cristiana?
• Quale alimento ebraico è rimasto anche nella celebrazione eucaristica cristiana?
• Quale alimento ebraico è rimasto anche nella celebrazione eucaristica cristiana?
il pane azzimo
il pane azzimo
le erbe amare
il pane azzimo
le erbe amare
l’agnello
• Quale alimento ebraico è rimasto anche nella celebrazione eucaristica cristiana?
le erbe amare
l’agnello
l’agnello
il pane azzimo
• Offrendo il suo Corpo e il suo Sangue, Gesù dona se stesso come nuova vittima per la cancellazione del male e del peccato. A quale dei tre elementi della pasqua ebraica fa maggiormente riferimento questa sua offerta?
le erbe amare
• Offrendo il suo Corpo e il suo Sangue, Gesù dona se stesso come nuova vittima per la cancellazione del male e del peccato. A quale dei tre elementi della pasqua ebraica fa maggiormente riferimento questa sua offerta?
l’agnello
• Offrendo il suo Corpo e il suo Sangue, Gesù dona se stesso come nuova vittima per la cancellazione del male e del peccato. A quale dei tre elementi della pasqua ebraica fa maggiormente riferimento questa sua offerta?
al pane azzimo
al pane azzimo
alle erbe amare
• Offrendo il suo Corpo e il suo Sangue, Gesù dona se stesso come nuova vittima per la cancellazione del male e del peccato. A quale dei tre elementi della pasqua ebraica fa maggiormente riferimento questa sua offerta?
al pane azzimo
alle erbe amare
all’agnello
alle erbe amare
all’agnello
al pane azzimo
all’agnello
alle erbe amare
all’agnello
Colora il calice e l’ostia.
Spiega di quali due differenti eventi fanno memoria la cena ebraica e la celebrazione dell’Eucaristia dei cristiani.
Colora e ritaglia le due parti; soprapponi poi quella con la scritta su quella con le immagini, fissandola al centro con un fermacampione. Fa’ scorrere le immagini e commentale.

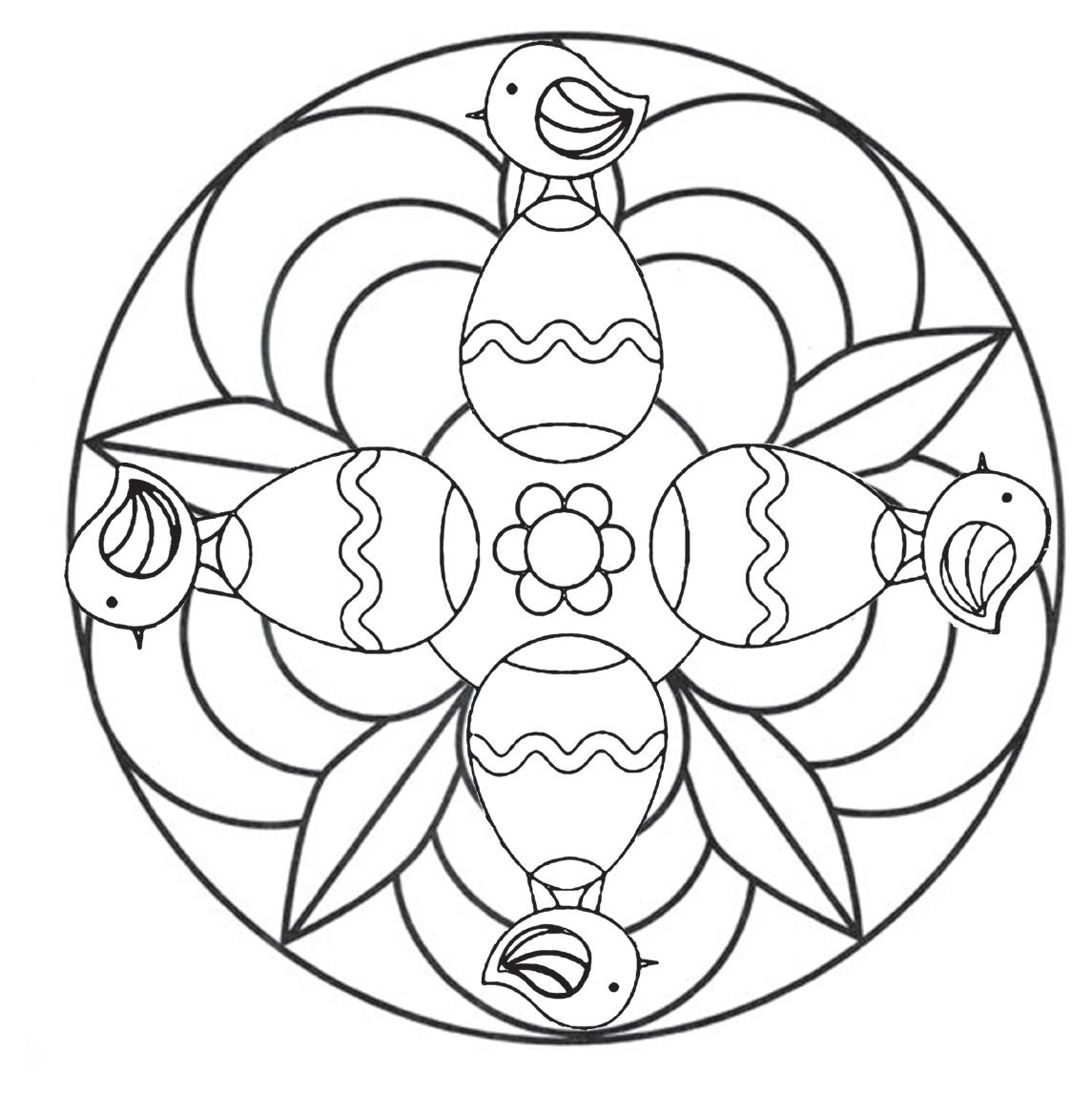
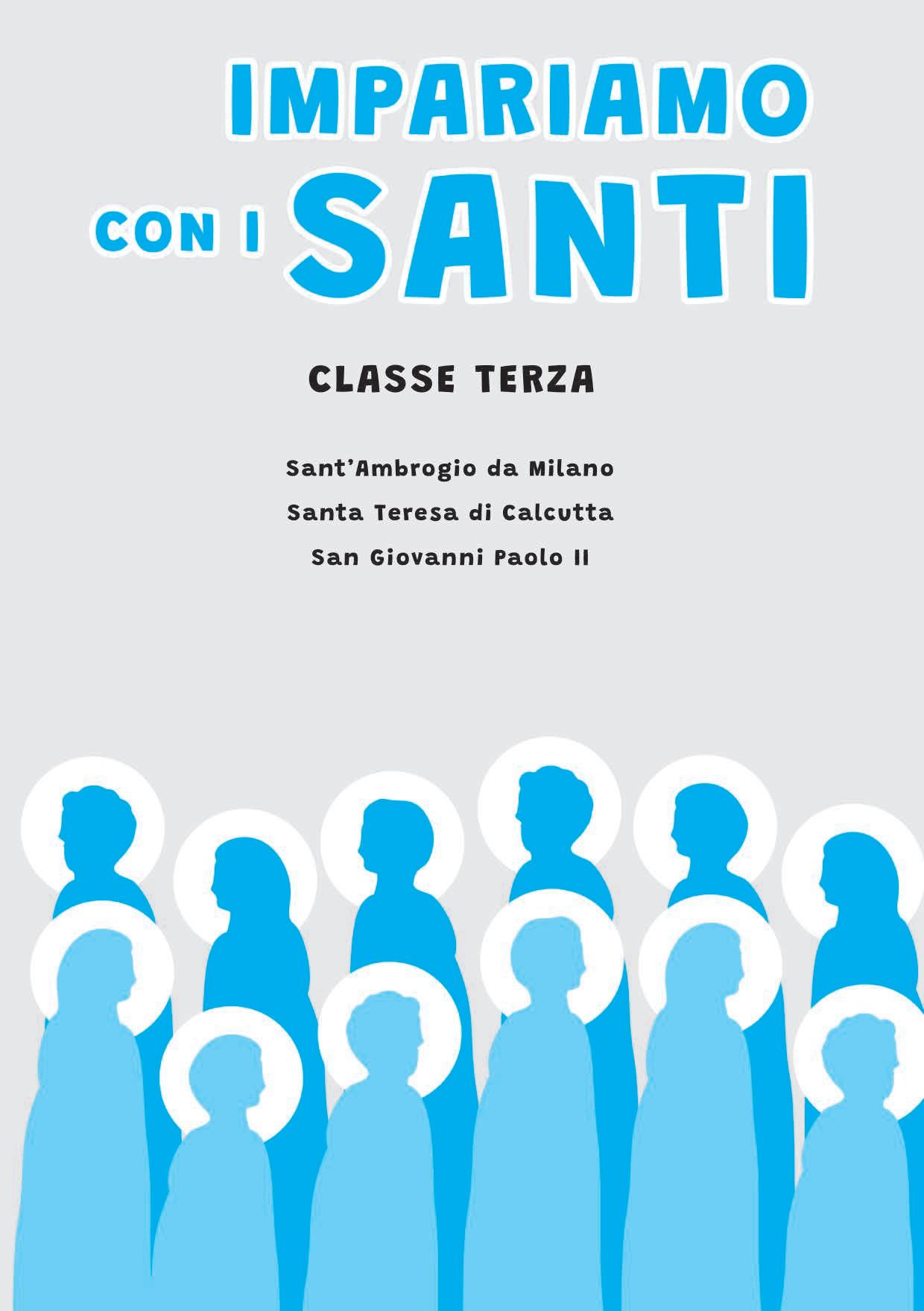
Augusta Treverorum, 339-340 – Milano, 4 aprile 397
Chi amministra la vita pubblica ha il potere di creare comunione, così come può alimentare le divisioni. Sant’Ambrogio, padre della Chiesa di Milano, scelse la via dell’unione, del superamento dei contrasti. Per questo fu scelto come vescovo dalla comunità milanese nel 374: tra le diverse fazioni in campo per la scelta del pastore, infatti, egli, che era prefetto della città ma era solo un catecumeno, fece da mediatore. Nel suo ministero si piegò sulle necessità degli ultimi e scrisse opere esegetiche, morali e spirituali. Diede forma alla Chiesa milanese e piantò il seme del suo rito liturgico particolare. Nato a Treviri nel 339-340, nel 370 era governatore della provincia Aemilia et Liguria; guidò la Chiesa di Milano fino alla morte nel 397. È dottore della Chiesa.
Patronato: Apicoltori, Vescovi, Lombardia, Milano e Vigevano
Etimologia: Ambrogio = immortale, dal greco
Emblema: Api, Bastone pastorale, Gabbiano
Martirologio Romano: Memoria di sant’Ambrogio, vescovo di Milano e dottore della Chiesa, che si addormentò nel Signore il 4 aprile, ma è venerato in particolare in questo giorno, nel quale ricevette, ancora catecumeno, l’episcopato di questa celebre sede, mentre era prefetto della città. Vero pastore e maestro dei fedeli, fu pieno di carità verso tutti, difese strenuamente la libertà della Chiesa e la retta dottrina della fede contro l’arianesimo e istruì nella devozione il popolo con commentari e inni per il canto.
Milano 374. In una delle chiese della città, gremita fino all’inverosimile, presbiteri e laici, vecchi e giovani, cattolici e ariani stavano discutendo animatamente sul nome del successore del vescovo Assenzio (ariano) morto di recente. Era un po’ di tempo ormai che le due fazioni si affrontavano animatamente anche per le strade, con qualche pericolo per l’ordine pubblico. Non si poteva far finta di niente.
E infatti Ambrogio, il governatore (della Lombardia, Liguria ed Emilia, con sede appunto a Milano) si recò in quella chiesa per calmare gli animi e per incoraggiare il popolo a fare la scelta del nuovo vescovo in un clima di dialogo, di pace e di rispetto reciproco. Il popolo accolse le sue esortazioni, anche perché era un governatore imparziale, stimato e ben voluto dalla popolazione essendosi dedicato sempre al bene di tutti. La sua missione di funzionario pubblico sembrava compiuta e con successo, quando accadde l’imprevisto che gli cambierà completamente la vita.
Qualcuno dalla folla, sembra un bambino, gridò forte: “Ambrogio vescovo” e l’intera assemblea, cattolici e ariani, vecchi e giovani, presbiteri e laici, quasi folgorati da quel grido (era un’ispirazione dall’alto?) ripeterono a loro volta “Ambrogio vescovo”. Non si diceva già allora “Vox populi, vox Dei”?.
A furor di popolo, ecco trovata la soluzione allo spinoso problema. Tutti d’accordo sul nuovo vescovo: il loro governatore, anche se era un semplice catecumeno e per giunta senza ambizioni ecclesiastiche. E l’interessato? Per la verità non era proprio entusiasta. Proprio lui ancora semplice catecumeno e per di più a completo digiuno di teologia (quindi senza un’adeguata
preparazione ad essere vescovo)? Sembrava tutto assurdo. Si appellò a Valentiniano protestando la propria inadeguatezza all’incarico “datogli” dal popolo. Non trovò una sponda favorevole nell’imperatore: anzi questi gli disse che si sentiva lui stesso lusingato per aver scelto un governatore “politico” (Ambrogio) che era stato ritenuto degno persino di svolgere l’ufficio episcopale (anche perché allora il vescovo di Milano aveva una specie di giurisdizione su quasi tutto il Nord Italia, quindi era un incarico molto prestigioso). Ed Ambrogio accettò. Fu così che nel giro di una settimana venne battezzato e poi consacrato vescovo, il 7 dicembre del 374. Cominciava così per lui una seconda vita.
Un vescovo tutto per Dio e tutto per il popolo
Ambrogio era nato a Treviri, in Germania, da una nobile famiglia romana della Gens Aurelia. Suo padre era governatore delle Gallie, quindi un importante funzionario imperiale. Quando questi improvvisamente morì, Ambrogio con la sorella Marcellina (Santa) e la madre ritornarono a Roma. Qui continuò gli studi, imparò il greco e divenne un buon poeta e un oratore. Proseguì poi gli studi per la carriera legale ottenendo molti successi in questo campo come avvocato, finché l’imperatore Valentiniano lo nominò nel 370 governatore, con residenza a Milano. Una carriera impressionante.
Ambrogio fece il governatore solo quattro anni, ma la sua opera fu molto incisiva. Era un uomo al di sopra delle parti e dei partiti, aveva costantemente l’occhio rivolto al bene di tutta la popolazione, non escludendo nessuno specialmente i poveri. Questo atteggiamento gli guadagnò non solo la stima ma addirittura l’affetto sincero di tutta la popolazione, senza distinzione. Possiamo dire che fece così bene il governatore che il Popolo di Dio (con l’imperatore e il Vescovo di Roma Papa Damaso) lo ritennero degno di fare il vescovo. E la “promozione” non era da poco.
Fatto vescovo, decise di rompere ogni legame con la vita precedente: donò infatti le sue ricchezze ai poveri, le sue terre e altre proprietà alla Chiesa, tenendo per sé solo una piccola parte per provvedere alla sorella Marcellina, che anni prima si era consacrata Vergine nella Basilica di San Pietro durante una solenne liturgia di Natale, presente il Papa Liberio. Ambrogio ebbe sempre una grande stima per la madre, per la sorella e per la decisione presa da lei. Consapevole della sua impreparazione culturale in campo teologico, si diede allo studio della Scrittura e alle opere dei Padri della Chiesa, in particolare Origene, Atanasio e Basilio. La sua vita era frugale e semplice, le sue giornate dense di incontri con la gente, di studio e di preghiera. Ambrogio studiava e poi faceva sostanza della sua preghiera ciò che aveva studiato, quindi, dopo aver pregato, scriveva e quindi predicava. Questo era il suo modo di porgere la Parola di Dio al popolo. Lo stesso Agostino d’Ippona ne rimase affascinato tanto da sceglierlo come maestro nella fede, proprio perché con il suo modo di fare e di predicare aveva contribuito alla sua conversione (insieme alla madre Monica, e naturalmente allo Spirito Santo). Ogni giorno diceva la Messa per i suoi fedeli dedicandosi poi al loro servizio per ascoltarli, per consigliarli e per difenderli contro i soprusi dei ricchi. Tutti potevano parlargli in qualsiasi momento. Ed è anche per questo che il popolo non solo lo ammirava ma lo amava sinceramente.
È rimasto famoso il suo comportamento quando alcuni soldati nordici avevano sequestrato, in una delle loro razzie, uomini donne e bambini. Ambrogio non esitò a fondere i vasi sacri della chiesa per pagare il loro riscatto. E a coloro (gli ariani) che ebbero il coraggio di criticarlo per l’operato rispose:
“Se la Chiesa ha dell’oro non è per custodirlo, ma per donarlo a chi ne ha bisogno... Meglio conservare i calici vivi delle anime che quelli di metallo”.
“Dove c’è Pietro, c’è la Chiesa”
La Chiesa del tempo di Ambrogio attraversava una grave turbolenza dottrinale: la presenza cioè dell’eresia ariana, originata e predicata da Ario. Questi negava la divinità di Cristo e la sua consustanzialità col Padre, affermando che anche lui era una semplice creatura, scelta da Dio come strumento di salvezza. Come si vede un’eresia dirompente e devastante per la cristianità, che minacciava il centro stesso del Cristianesimo: Gesù Cristo, e questi Figlio di Dio. Purtroppo ebbe molti seguaci anche nei ranghi alti delle autorità e cioè imperatori e imperatrici, governatori, ufficiali dell’esercito romano che la sostennero con il loro peso politico e militare. Ambrogio conosceva il problema già da governatore, ma dovette affrontarlo specialmente da vescovo di Milano scontrandosi addirittura con la più alta autorità: quella imperiale. Nel 386 fu approvata una legge che autorizzava le assemblee religiose degli ariani e il possesso delle chiese, ma in realtà bandiva quelle dei cristiani cattolici. Pena di morte a chi non obbediva. Ambrogio incurante della legge e delle conseguenze personali, si rifiutò di consegnare agli ariani anche una sola chiesa. Arrivarono le minacce contro di lui. Allora il popolo, temendo per il proprio vescovo, si barricò nella basilica insieme con lui. Le truppe imperiali circondarono e assediarono la chiesa, decisi a farli morire di fame. Ambrogio, per occupare il tempo, insegnò ai suoi fedeli salmi e cantici composti da lui stesso e raccontò al popolo tutto ciò che era accaduto tra lui e l’imperatore Valentiniano, riassumendo il tutto con la famosa frase: “L’imperatore è nella Chiesa, non sopra la Chiesa”. Nel frattempo Teodosio il Grande, imperatore d’Oriente, dopo aver sconfitto e giustiziato l’usurpatore Massimo che aveva invaso l’Italia, reintegrò Valentiniano (facendogli abbandonare l’arianesimo) e si fermò per un po’ di tempo a Milano.
La riconoscenza di Ambrogio all’imperatore tuttavia non gli impedì di affrontarlo in ben due occasioni, quando ritenne che il suo comportamento era riprovevole e condannabile pubblicamente. Fu specialmente dopo l’infame massacro di Tessalonica del 390, in cui morirono più di settemila persone, tra cui molte donne e bambini, in rivolta per la morte del governatore. Furono uccisi tutti senza distinzione di innocenti e colpevoli.
Ambrogio, inorridito per l’accaduto, insieme ai suoi collaboratori ritenne responsabile pubblicamente Teodosio stesso, invitandolo a pentirsi. Alla fine l’imperatore cedette e piegò la testa. Questo spiega la grande autorità morale di cui godeva il vescovo. Teodosio morì tre anni dopo e lui stesso ne fece un sincero elogio lodandone l’umiltà e il coraggio di ammettere le proprie colpe, additandone l’esempio anche agli inferiori.
Ambrogio non solo fu un baluardo a difesa della fede cattolica contro l’eresia ariana, ma si adoperò a difendere anche il Vescovo di Roma, Papa Damaso contro l’antipapa Ursino.
Egli così riconosceva la funzione ed il primato del Vescovo della Città Eterna (in quanto successore di Pietro) come centro e segno di unità per tutti i cristiani.
È a lui che si deve la famosa frase che recita: “Ubi Petrus, ibi Ecclesia” (Dove c’è Pietro, lì c’è la Chiesa), e l’altra: “In omnibus cupio sequi Ecclesiam Romanam” e cioè “In tutto voglio seguire la Chiesa Romana” quasi un’attestazione del primato della Chiesa di Roma, sul quale la discussione andrà avanti per secoli e, come si sa, non è ancora finita.
Per i suoi molteplici scritti teologici e scritturistici è uno dei quattro grandi dottori della Chiesa d’Occidente, insieme a Gerolamo, Agostino e Gregorio Magno.
Nella Lettera apostolica Operosam diem (1996) per il centenario della morte di Ambrogio, Giovanni Paolo II, di venerata memoria, ha messo in risalto due importanti aspetti del suo insegnamento: il convinto cristo-centrismo e la sua originale Mariologia. Ambrogio viene considerato l’iniziatore della Mariologia latina. Giovanni Paolo II (in Operosam diem, n. 31): “Di Maria Ambrogio è stato il teologo raffinato e il cantore inesausto. Egli ne offre un ritratto attento, affettuoso, particolareggiato, tratteggiandone le virtù morali, la vita interiore, l’assiduità al lavoro e alla preghiera.
Pur nella sobrietà dello stile, traspare la sua calda devozione alla Vergine, Madre di Cristo, immagine della Chiesa e modello di vita per i cristiani. Contemplandola nel giubilo del Magnificat, il santo vescovo di Milano esclama: “Sia in ciascuno l’anima di Maria a magnificare il Signore, sia in ciascuno lo spirito di Maria a esultare in Dio”.
Del suo cristo-centrismo così ha scritto Giovanni Paolo II: “Al centro della sua vita, sta Cristo, ricercato e amato con intenso trasporto. A Lui, tornava continuamente nel suo insegnamento. Su Cristo si modellava pure la carità che proponeva ai fedeli e che testimoniava di persona... Del mistero dell’Incarnazione e della Redenzione, Ambrogio parla con l’ardore di chi è stato letteralmente afferrato da Cristo e tutto vede nella sua luce”.
Questo suo pensiero centrale può essere sintetizzato nella famosa frase del De Virginitate: “Cristo per noi è tutto”.
Ambrogio visse e operò totalmente e incessantemente tutto per Cristo e tutto per la Sua Chiesa. Il suo amore a Cristo era inscindibile dal suo amore alla Chiesa. Operare per far crescere l’amore a Cristo significava per lui lavorare, soffrire, studiare, predicare, piangere, rischiare la vita davanti ai potenti del tempo per la Chiesa, popolo di Dio, perché Ambrogio era profondamente convinto che “Fulget Ecclesia non suo, sed Christi lumine” (La Chiesa risplende non di luce propria ma di quella di Cristo), senza dimenticare mai che “Corpus Christi Ecclesia est”, (Il Corpo di Cristo è la sua Chiesa), quindi i fedeli possono benissimo dire tutti: “Nos unum corpus Christi sumus”. E per questi fedeli, che sono la Chiesa, che è il corpo di Cristo, e per amore di Cristo presente nella Sua Chiesa, Ambrogio vescovo lavorò, studiò, rischiò la vita, pianse, pregò, predicò, viaggiò e scrisse libri fino alla fine. Questa arrivò, per la verità non inaspettata, il 4 aprile, all’alba del Sabato Santo quando correva l’anno 397.
Autore: Mario Scudu
Ambrogio nasce in una nobile famiglia di cristiani a Treviri (Germania) nel 339 circa. Il padre è un prefetto dell’Impero romano. Si narra che quando era neonato uno sciame di api si sia av-
vicinato alla sua bocca, presagio di un futuro grande oratore. Il santo, dalla corporatura esile, i capelli ricci e neri, brillante studente, diventa avvocato. Nel 370 viene nominato governatore di Liguria ed Emilia e poi dell’Italia settentrionale con sede a Milano, allora capitale dell’impero, dove si susseguono duri scontri tra cattolici, pagani e ariani. Quando il vescovo ariano della città Aussenzio muore, il popolo si riunisce per eleggere il suo successore. Sul nome del prescelto nascono dissidi tra cattolici e ariani. Ambrogio cerca di calmare gli animi in qualità di funzionario imperiale. Mentre parla alla folla un bambino grida «Ambrogio vescovo!». Così, con suo immenso stupore, il 7 dicembre del 374, Ambrogio si vede acclamare vescovo anche se non è stato ancora battezzato. Accetta il nuovo incarico sentendosi indegno, pensando di seguire la volontà di Dio. Si fa battezzare, dona le sue ricchezze ai poveri, conduce vita umile, digiuna, prega e si mette a studiare la Bibbia, scrivendo libri di grande valore. Ambrogio diventa una guida importante per i cristiani. Nonostante la sua salute sia cagionevole, è attivo nel diffondere la “Buona Novella” cioè il Vangelo. Difensore dei deboli vende anche i calici d’oro per riscattare gli schiavi. È il più bravo oratore del suo tempo ed artefice della conversione di Sant’Agostino. Il vescovo è un abile diplomatico e, appoggiato dal popolo che lo ama per la sua bontà, risolve i contrasti tra ariani, pagani e cattolici e lotta contro i potenti, come l’imperatore romano Valentiniano II e sua madre Giustina di religione ariana. Sant’Ambrogio induce, poi, gli imperatori Teodosio I, Graziano e Valentiniano II a proclamare religione di Stato il Cristianesimo (Editto di Tessalonica del 27 febbraio 380) e nel 390 ottiene il pentimento pubblico dell’imperatore Teodosio I, in seguito al feroce massacro di innocenti compiuto a Tessalonica (odierna Salonicco, Grecia). Sant’Ambrogio muore a Milano nel 397 e qui viene accolto, nella basilica a lui intitolata. Patrono di Milano e della Lombardia, proclamato dottore della Chiesa, è il primo ad introdurre i canti sacri come forma di preghiera per implorare, lodare, ringraziare. Compone inni in uno stile musicale da lui ideato chiamato “Canto ambrosiano”. Protegge gli apicoltori e i vescovi.
Autore: Mariella Lentini
Skopje, Macedonia, 26 agosto 1910 - Calcutta, India, 5 settembre 1997
Agnes Gonxhe Bojaxhiu, nata nell’attuale Macedonia da una famiglia albanese, a 18 anni concretizzò il suo desiderio di diventare suora missionaria ed entrò nella Congregazione delle Suore Missionarie di Nostra Signora di Loreto. Partita nel 1928 per l’Irlanda, un anno dopo giunse in India. Nel 1931 emise i primi voti, prendendo il nuovo nome di suor Maria Teresa del Bambin Gesù (scelto per la sua devozione alla santa di Lisieux), e per circa vent’anni insegnò storia e geografia alle allieve del collegio di Entally, nella zona orientale di Calcutta. Il 10 settembre 1946, mentre era in treno diretta a Darjeeling per gli esercizi spirituali, avvertì la “seconda chiamata”: Dio voleva che fondasse una nuova congregazione. Il 16 agosto 1948 uscì quindi dal collegio per condividere la vita dei più poveri tra i poveri. Il suo nome è diventato sinonimo di una carità sincera e disinteressata, vissuta direttamente e insegnata a tutti. Dal primo gruppo di giovani che la seguirono sorse la congregazione delle Missionarie della Carità, poi espanse in quasi tutto il mondo. Morì a Calcutta il 5 settembre 1997. È stata beatificata da san Giovanni Paolo II il 19 ottobre 2003 ed infine canonizzata da Papa Francesco domenica 4 settembre 2016.
Martirologio Romano: A Calcutta in India, beata Teresa (Agnese) Gonhxa Bojaxhiu, vergine, che, nata in Albania, estinse la sete di Cristo abbandonato sulla croce con la sua immensa carità verso i fratelli più poveri e istituì le Congregazioni delle Missionarie e dei Missionari della Carità al pieno servizio dei malati e dei diseredati.
Al piano terra della Mother House, la casa-madre nella Lower Circular Road di Calcutta, c’è la cappella semplice e disadorna dove dal 13 settembre 1997, dopo i solenni funerali di Stato, riposano le spoglie mortali di Madre Teresa. Fuori, nel fitto dedalo di viuzze, i rumori assordanti della metropoli indiana: campanelli di risciò, vociare di bimbi, lo sferragliare di tram scalcinati attraverso i gironi infernali della miseria. Dentro, invece, il tempo sembra fermarsi ogni volta, cristallizzato in una specie di bolla rarefatta: la cappella accoglie una tomba povera e spoglia, un blocco di cemento bianco su cui è stata deposta la Bibbia personale di Madre Teresa e una statua della Madonna con una corona di fiori al collo, accanto a una lapide di marmo con sopra inciso, in inglese, un versetto tratto dal Vangelo di Giovanni: “Amatevi gli uni gli altri come io ho amato voi” (15,12). Madre Teresa di Calcutta, al secolo Agnes Gonxha Bojaxhiu, era nata il 26 agosto 1910 a Skopje (ex-Jugoslavia, oggi Macedonia), da una famiglia cattolica albanese. A 18 anni decise di entrare nella Congregazione delle Suore Missionarie di Nostra Signora di Loreto. Partita nel 1928 per l’Irlanda, un anno dopo è già in India. Nel 1931 la giovane Agnes emette i primi voti prendendo il nuovo nome di suor Mary Teresa del Bambin Gesù(scelto per la sua devozione alla santa di Lisieux), e per circa vent’anni insegnerà storia e geografia alle ragazze di buona famiglia nel collegio delle suore di Loreto a Entally, zona orientale di Calcutta. Oltre il muro di cinta del convento c’era Motijhil con i suoi odori acri e soffocanti, uno degli slum più miserabili della megalopoli indiana, la discarica del mondo. Da lontano suor Teresa poteva sentirne i miasmi che arrivavano fino al suo collegio di lusso, ma non lo conosceva. Era l’altra faccia dell’India, un mondo a parte per lei, almeno fino a quella fatidica sera del 10 settembre 1946, quan-
do avvertì la “seconda chiamata” mentre era in treno diretta a Darjeeling, per gli esercizi spirituali. Durante quella notte una frase continuò a martellarle nella testa per tutto il viaggio, il grido dolente di Gesù in croce: “Ho sete!”. Un misterioso richiamo che col passare delle ore si fece sempre più chiaro e pressante: lei doveva lasciare il convento per i più poveri dei poveri. Quel genere di persone che non sono niente, che vivono ai margini di tutto, il mondo dei derelitti che ogni giorno agonizzavano sui marciapiedi di Calcutta, senza neppure la dignità di poter morire in pace. Suor Teresa lasciò il convento di Entally con cinque rupie in tasca e il sari orlato di azzurro delle indiane più povere, dopo quasi 20 anni trascorsi nella congregazione delle Suore di Loreto. Era il 16 agosto 1948. La piccola Gonxha di Skopje diventava Madre Teresa e iniziava da questo momento la sua corsa da gigante. Il 7 ottobre 1950 la nuova Congregazione ottiene il suo primo riconoscimento, l’approvazione diocesana. È una ricorrenza mariana, la festa del Rosario, e di certo non è casuale, dal momento che a Maria è dedicata la nuova famiglia religiosa. L’amore profondo di Madre Teresa per la Madonna aveva salde radici nella sua infanzia, a Skopje, quando mamma Drone, che era molto religiosa, portava sempre i suoi figli (oltre a Gonxha c’erano Lazar e Age) in chiesa e a visitare i poveri, ed ogni sera recitavano insieme il rosario. “La nostra Società – si legge nel primo capitolo delle Costituzioni – è dedicata al Cuore Immacolato di Maria, Causa della nostra Gioia e Regina del Mondo, perché è nata su sua richiesta e grazie alla sua continua intercessione si è sviluppata e continua a crescere”. La figura della Vergine ha ispirato lo Statuto delle Missionarie della Carità, al punto che ognuno dei 10 capitoli delle Costituzioni è introdotto da una citazione tratta dai passi mariani dei Vangeli. La Madonna è detta la prima Missionaria della Carità in ragione della sua visita a Elisabetta, in cui dette prova di ardente carità nel servizio gratuito all’anziana cugina bisognosa di aiuto. In aggiunta ai tre usuali voti di povertà, castità e obbedienza, ogni Missionaria della Carità ne fa un quarto di “dedito e gratuito servizio ai più poveri tra i poveri”, riconoscendo in Maria l’icona del servizio reso di tutto cuore, della più autentica carità. (…)La devozione al Cuore Immacolato di Maria è l’altro aspetto del carisma mariano e missionario dell’opera di Madre Teresa, praticato con i mezzi più tradizionali e più semplici: il S. Rosario, pregato ogni giorno e in ogni luogo, persino per la strada; il culto delle feste mariane (la professione religiosa delle sue suore cade sempre in festività della Madonna); la preghiera fiduciosa a Maria affidata anche alle “medagliette miracolose”( Madre Teresa ne regalava in gran quantità alle persone che incontrava); l’imitazione delle virtù della Madre di Dio, in special modo l’umiltà, il silenzio, la profonda carità. “I thirst” (ho sete), c’è scritto sul crocifisso della Casa Madre e in ogni cappella – in ogni parte del mondo – di ogni casa della famiglia religiosa di Madre Teresa. Questa frase, il grido dolente di Gesù sulla croce che le era rimbombato nel cuore la fatidica sera della “seconda chiamata”, costituisce la chiave della sua spiritualità. La figura minuta di Madre Teresa, il suo fragile fisico piegato dalla fatica, il suo volto solcato da innumerevoli rughe sono ormai conosciuti in tutto il mondo. Chi l’ha incontrata anche solo una volta, non ha più potuto dimenticarla: la luce del suo sorriso rifletteva la sua immensa carità. Essere guardati da lei, dai suoi occhi profondi, amorevoli, limpidi, dava la curiosa sensazione di essere guardati dagli occhi stessi di Dio.
Attiva e contemplativa al tempo stesso, nella Madre c’erano idealismo e concretezza, pragmatismo e utopia. Lei amava definirsi “la piccola matita di Dio”, un piccolo semplice strumento fra le Sue mani. Riconosceva con umiltà che quando la matita sarebbe diventata un mozzicone inutile, il Signore l’avrebbe buttata via, affidando ad altri la sua missione apostolica: “Anche chi crede in me compirà le opere che io compio, e ne farà di più grandi” (cfr. Gv 14, 12).
Madre Teresa è scomparsa a Calcutta la sera del venerdì 5 settembre 1997, alle 21.30. Aveva 87 anni. Il 26 luglio 1999 è stato aperto, con ben tre anni di anticipo sui cinque previsti dalla Chiesa, il suo processo di beatificazione; e ciò per volontà del S. Padre che, in via del tutto eccezionale, ne ha voluto accelerare la procedura: per la gente Madre Teresa è già santa. Il suo messaggio è sempre attuale: che ognuno cerchi la sua Calcutta, presente pure sulle strade del ricco Occidente, nel ritmo frenetico delle nostre città. “Puoi trovare Calcutta in tutto il mondo – lei diceva – , se hai occhi per vedere. Dovunque ci sono i non amati, i non voluti, i non curati, i respinti, i dimenticati”. I suoi figli spirituali continuano in tutto il mondo a servire “i più poveri tra i poveri” in orfanotrofi, lebbrosari, case di accoglienza per anziani, ragazze madri, moribondi. In tutto sono 5000, compresi i due rami maschili, meno noti, distribuiti in circa 600 case sparse per il mondo; senza contare le molte migliaia di volontari e laici consacrati che portano avanti le sue opere. “Quando sarò morta – diceva lei –, potrò aiutarvi di più…”.
Autore: Maria Di Lorenzo
Agnese Gonhxa Bojaxhiu nasce nel 1910 a Skopje, Albania (attuale Macedonia del Nord), in una ricca famiglia di commercianti albanesi. Trascorre un’infanzia felice ma a sette anni perde l’amato papà. La mamma parla ad Agnese di Gesù e le insegna ad aiutare il prossimo. La ragazza ha diciotto anni quando decide di diventare suora. Si fa chiamare Maria Teresa come Santa Teresa di Lisieux, alla quale Agnese è molto devota. Nel 1929 va in India a dirigere una scuola per fanciulle benestanti, ma l’India è ben altro: c’è la carestia. Uomini, donne, vecchi e bambini muoiono di fame. I neonati vengono abbandonati ancora vivi nella spazzatura. Un giorno Maria Teresa vede una moribonda pelle e ossa su di un marciapiede. La soccorre e la porta in ospedale, ma qui la rifiutano. La suora, sconvolta, capisce che il Signore la chiama ad una missione: soccorrere gli ultimi degli ultimi. Ha trentasei anni e diventa “Madre Teresa”. Sa quello che deve fare ma non come. È certa di una cosa. Gesù ha detto: «Tutto quello che avete fatto a uno solo di questi miei fratelli malati, emarginati, affamati, l’avete fatto a me». Madre Teresa, una donna piccola e minuta, sempre sorridente, si allontana dal confortevole convento per andare a vivere in strada. I bambini poveri la seguono. Lei insegna scrivendo sulla terra con un dito. Riesce, poi, a trovare un rifugio dove porta i moribondi che raccoglie per strada: li conforta e li aiuta a trascorrere dignitosamente le ultime ore di vita. Alcune ex allieve la raggiungono e le suore si moltiplicano. Madre Teresa di Calcutta (città in cui presta la sua opera) fonda la Congregazione delle Missionarie della Carità. Le suore indossano un sari bianco (il colore dei poveri) con tre strisce azzurre (il colore della Madonna). Grazie alla generosità di persone ricche, Madre Teresa costruisce la “Casa dei Bambini” e un ospedale. Attiva e operosa, la santa è sempre alla ricerca
di aiuti per i suoi assistiti e, grazie alla sua tenacia, la congregazione si diffonde in ogni continente. Premio Nobel per la Pace nel 1979, chiede che i soldi per il banchetto organizzato in suo onore siano destinati ai poveri. Si spegne a 87 anni, il 5 settembre 1997. Papa Francesco la proclama santa il 4 settembre 2016. Madre Teresa – che si definisce «una piccola matita nelle mani di Dio» – insegna a provare gioia quando si ha il necessario per vivere e a trovare una “Calcutta” in ogni luogo in cui si vive, dove poter dare il proprio aiuto.
Autore: Mariella Lentini
Wadowice, Cracovia, 18 maggio 1920 - Città del Vaticano, 2 aprile 2005 (Papa dal 22/10/1978 al 02/04/2005 ). Nato a Wadowice, in Polonia, è il primo papa slavo e il primo Papa non italiano dai tempi di Adriano VI. Nel suo discorso di apertura del pontificato ha ribadito di voler portare avanti l’eredità del Concilio Vaticano II. Il 13 maggio 1981, in Piazza San Pietro, anniversario della prima apparizione della Madonna di Fatima, fu ferito gravemente con un colpo di pistola dal turco Alì Agca. Al centro del suo annuncio il Vangelo, senza sconti. Molto importanti sono le sue encicliche, tra le quali sono da ricordare la “Redemptor hominis”, la “Dives in misericordia”, la “Laborem exercens”, la “Veritatis splendor” e l’”Evangelium vitae”. Dialogo interreligioso ed ecumenico, difesa della pace, e della dignità dell’uomo sono impegni quotidiani del suo ministero apostolico e pastorale. Dai suoi numerosi viaggi nei cinque continenti emerge la sua passione per il Vangelo e per la libertà dei popoli. Ovunque messaggi, liturgie imponenti, gesti indimenticabili: dall’incontro di Assisi con i leader religiosi di tutto il mondo alla preghiere al Muro del pianto di Gerusalemme. Così Karol Wojtyla traghetta l’umanità nel terzo millennio. Papa Benedetto XVI lo ha beatificato il il 1° maggio 2011 ed Infine Papa Francesco, alla presenza del predecessore, ha canonizzato San Giovanni Paolo II il 27 aprile 2014. Il suo corpo riposa in un altare laterale della Basilica di San Pietro in Vaticano. La sua memoria liturgica facoltativa ricorre il 22 ottobre.
Karol Józef Wojtyła, eletto Papa il 16 ottobre 1978, nacque a Wadowice, città a 50 km da Cracovia, il 18 maggio 1920. Era il secondo dei due figli di Karol Wojtyła e di Emilia Kaczorowska, che morì nel 1929. Suo fratello maggiore Edmund, medico, morì nel 1932 e suo padre, sottufficiale dell’esercito, nel 1941. A nove anni ricevette la Prima Comunione e a diciotto anni il sacramento della Cresima. Terminati gli studi nella scuola superiore Marcin Wadowita di Wadowice, nel 1938 si iscrisse all’Università Jagellónica di Cracovia. Quando le forze di occupazione naziste chiusero l’Università nel 1939, il giovane Karol lavorò (1940-1944) in una cava ed, in seguito, nella fabbrica chimica Solvay per potersi guadagnare da vivere ed evitare la deportazione in Germania. A partire dal 1942, sentendosi chiamato al sacerdozio, frequentò i corsi di formazione del seminario maggiore clandestino di Cracovia, diretto dall’Arcivescovo di Cracovia, il Cardinale Adam Stefan Sapieha. Nel contempo, fu uno dei promotori del “Teatro Rapsodico”, anch’esso clandestino. Dopo la guerra, continuò i suoi studi nel seminario maggiore di Cracovia, nuovamente aperto, e nella Facoltà di Teologia dell’Università Jagellónica, fino alla
sua ordinazione sacerdotale a Cracovia il 1 novembre 1946. Successivamente, fu inviato dal Cardinale Sapieha a Roma, dove conseguì il dottorato in teologia (1948), con una tesi sul tema della fede nelle opere di San Giovanni della Croce. In quel periodo, durante le sue vacanze, esercitò il ministero pastorale tra gli emigranti polacchi in Francia, Belgio e Olanda. Nel 1948 ritornò in Polonia e fu coadiutore dapprima nella parrocchia di Niegowić, vicino a Cracovia, e poi in quella di San Floriano, in città. Fu cappellano degli universitari fino al 1951, quando riprese i suoi studi filosofici e teologici. Nel 1953 presentò all’Università cattolica di Lublino una tesi sulla possibilità di fondare un’etica cristiana a partire dal sistema etico di Max Scheler. Più tardi, divenne professore di Teologia Morale ed Etica nel seminario maggiore di Cracovia e nella Facoltà di Teologia di Lublino. Il 4 luglio 1958, il Papa Pio XII lo nominò Vescovo titolare di Ombi e Ausiliare di Cracovia. Ricevette l’ordinazione episcopale il 28 settembre 1958 nella cattedrale del Wawel (Cracovia), dalle mani dell’Arcivescovo Eugeniusz Baziak. Il 13 gennaio 1964 fu nominato Arcivescovo di Cracovia da Paolo VI che lo creò Cardinale il 26 giugno 1967. Partecipò al Concilio Vaticano II (1962-65) con un contributo importante nell’elaborazione della costituzione Gaudium et spes. Il Cardinale Wojtyła prese parte anche alle 5 assemblee del Sinodo dei Vescovi anteriori al suo Pontificato. Viene eletto Papa il 16 ottobre 1978 e il 22 ottobre segue l’inizio solenne del Suo ministero di Pastore Universale della Chiesa. Dall’inizio del suo Pontificato, Papa Giovanni Paolo II ha compiuto 146 visite pastorali in Italia e, come Vescovo di Roma, ha visitato 317 delle attuali 332 parrocchie romane. I viaggi apostolici nel mondo - espressione della costante sollecitudine pastorale del Successore di Pietro per tutte le Chiese - sono stati 104. Tra i suoi documenti principali si annoverano 14 Encicliche, 15 Esorta-zioni apostoliche, 11 Costituzioni apostoliche e 45 Lettere apostoliche. A Papa Giovanni Paolo II si ascrivono anche 5 libri: “Varcare la soglia della speranza” (ottobre 1994); “Dono e mistero: nel cinquantesimo anniversario del mio sacerdozio” (novembre 1996); “Trittico romano”, meditazioni in forma di poesia (marzo 2003); “Alzatevi, andiamo!” (maggio 2004) e “Memoria e Identità” (febbraio 2005). Papa Giovanni Paolo II ha celebrato 147 cerimonie di beatificazione - nelle quali ha proclamato 1338 beati - e 51 canonizzazioni, per un totale di 482 santi. Ha tenuto 9 concistori, in cui ha creato 231 (+ 1 in pectore) Cardinali. Ha presieduto anche 6 riunioni plenarie del Collegio Cardinalizio. Dal 1978 ha convocato 15 assemblee del Sinodo dei Vescovi: 6 generali ordinarie (1980, 1983, 1987, 1990; 1994 e 2001), 1 assemblea generale straordinaria (1985) e 8 assemblee speciali (1980, 1991, 1994, 1995, 1997, 1998 [2] e 1999).
Nessun Papa ha incontrato tante persone come Giovanni Paolo II: alle Udienze Generali del mercoledì (oltre 1160) hanno partecipato più di 17 milioni e 600mila pellegrini, senza contare tutte le altre udienze speciali e le cerimonie religiose (più di 8 milioni di pellegrini solo nel corso del Grande Giubileo dell’anno 2000), nonché i milioni di fedeli incontrati nel corso delle visite pastorali in Italia e nel mondo; numerose anche le personalità governative ricevute in udienza: basti ricordare le 38 visite ufficiali e le altre 738 udienze o incontri con Capi di Stato, come pure le 246 udienze e incontri con Primi Ministri. Muore a Roma, nel suo alloggio nella Città del Vaticano, alle ore 21.37 di sabato 2 aprile 2005. I solenni funerali in Piazza San Pietro e la sepoltura nelle Grotte Vaticane seguono l’8 aprile.
Ambrogio, uno dei grandi dottori della Chiesa, fu prima avvocato di gran successo e poi governatore della Lombardia, in un momento fu scelto come vescovo dal popolo stesso, viste le sue capacità di saper guidare, tenere uniti e la sua infinita saggezza. Recatosi nella Chiesa di Milano per calmare gli animi e per incoraggiare il popolo a fare la scelta del nuovo vescovo in un clima di dialogo, di pace e di rispetto reciproco, si ritrovò a essere nominato vescovo per acclamazione.
Ambrogio si occupò delle necessità degli ultimi, scrisse opere e contribuì alla Chiesa milanese.
Nel testo sono evidenziate delle parole. Cercale nella tabella sotto e con le lettere che restano scopri la parola chiave di Ambrogio.
Attività 1
Nell’opera ci sono degli intrusi, cercali e mettici una X sopra.
Attività 2
Nell’opera manca uno dei particolari, quale? Cercalo e scopri il suo nome con l’aiuto dell’insegnante. Poi prova tu a disegnarlo.
Attività 3
Dopo aver ascoltato la storia del santo e/o visto un video a lui dedicato, racconta quale è stato l’episodio che ti ha colpito di più, poi prova a disegnarlo tu.
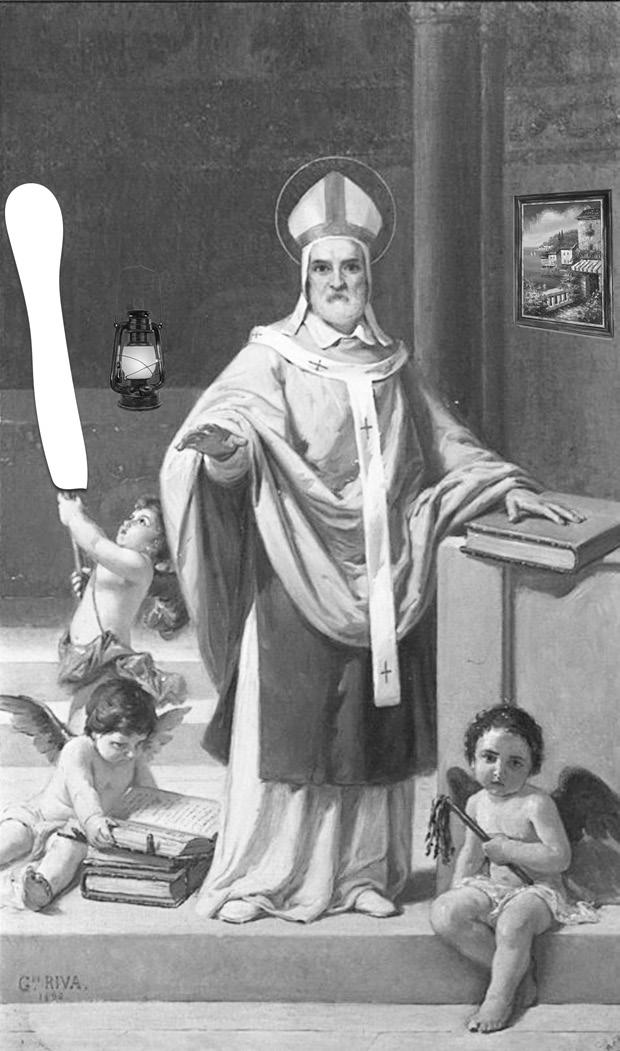
Agnes Gonxhe Bojaxhiu, nata in Macedonia da una famiglia albanese, a 18 anni divenne suora missionaria entrando nella Congregazione delle Suore Missionarie di Nostra Signora di Loreto. Partì per l’Irlanda per poi raggiungere l’India dove emise i primi voti con il nome di Madre Teresa del Bambin Gesù e insegnò per circa vent’anni a Calcutta. Fondò una nuova congregazione di suore, le Piccole Missionarie della Carità. Madre Teresa, per la Chiesa è una figura centrale nel servizio ai poveri, è un simbolo di carità globale, avendo ispirato molte persone con la sua vita e il suo lavoro.
Nel testo sono evidenziate delle parole. Cercale nella tabella sotto e con le lettere che restano scopri la parola chiave di Madre Teresa.
Soluzione:
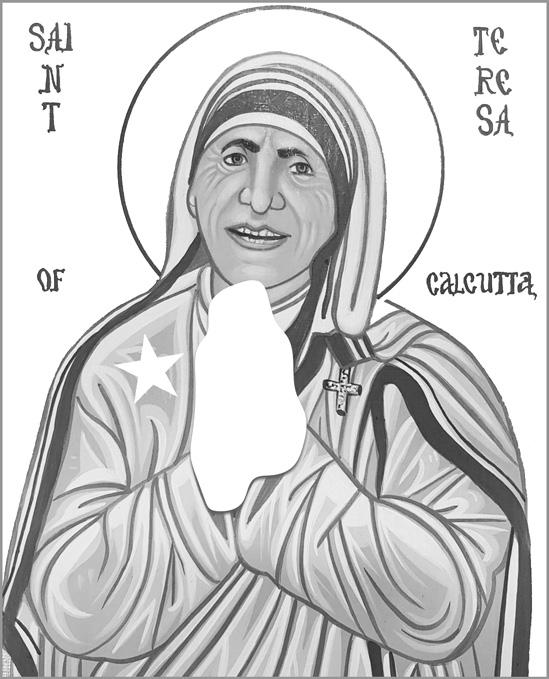
Attività 1
Nell’opera ci sono degli intrusi, cercali e mettici una X sopra.
Attività 2
Nell’opera manca il colore dello sfondo? Qual è? Scoprilo e cercane il significato con l’aiuto dell’insegnante. Poi completa colorando tu.
Attività 3
Dopo aver ascoltato la storia del santo e/o visto un video a lui dedicato, racconta quale è stato l’episodio che ti ha colpito di più, poi prova a disegnarlo tu.
Karol Wojtyła, sacerdote e vescovo polacco, è stato il primo papa non italiano della Storia della Chiesa
Da papa scelse il nome di Giovanni Paolo II e mise il Vangelo al centro del suo annuncio, facendosi testimone delle idee del Concilio Vaticano II.
Ha promosso il dialogo interreligioso, la pace e la dignità umana viaggiando in tutto il mondo e scrivendo numerose encicliche.
Nel testo sono evidenziate delle parole. Cercale nella tabella sotto e con le lettere che restano scopri la parola chiave di Giovanni Paolo II.
Soluzione:
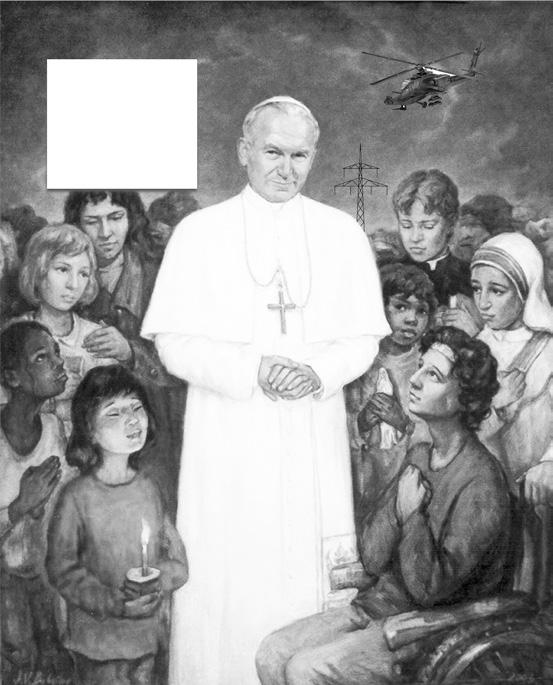
Attività 1
Nell’opera ci sono degli intrusi, cercali e mettici una X sopra.
Attività 2
Nell’opera mancano alcuni particolari, quali? Cercali con l’aiuto dell’insegnante e poi prova a disegnarli.
Attività 3
Dopo aver ascoltato la storia del santo e/o visto un video a lui dedicato, racconta quale è stato l’episodio che ti ha colpito di più, poi prova a disegnarlo tu.

Indicazioni nazionali per l’IRC ......................
La valutazione dell'IRC .................................
Le 8 competenze chiave europee ..................
La nuova Educazione Civica .........................
Atlante biblico ............................................. pag. 432 pag. 446 pag. 451 pag. 454 pag. 474
indiCazioni nazionali per l’irC
D.P.R. dell’11/02/2010
Traguardi per lo sviluppo delle competenze e Obiettivi di Apprendimento dell’insegnamento della Religione Cattolica per il primo ciclo d’istruzione.
Primo ciclo d’istruzione
L’insegnamento della religione cattolica fa sì che gli alunni riflettano e si interroghino sul SENSO DELLA LORO ESPERIENZA per elaborare ed esprimere un PROGETTO DI VITA, che si integri nel mondo reale in modo dinamico, armonico ed evolutivo. Vista la ripartizione delle discipline d’insegnamento in tre distinte aree disciplinari, l’insegnamento della religione cattolica si colloca nell’area linguisticoartistico-espressiva in cui, a partire dal confronto interculturale e interreligioso, l’alunno si interroga sulla propria identità e sugli orizzonti di senso verso cui può aprirsi, affrontando anche le essenziali DOMANDE RELIGIOSE e misurandosi con i codici simbolici in cui esse hanno trovato e trovano espressione. In tale contesto si collocano gli strumenti per cogliere, interpretare e gustare le espressioni culturali e artistiche offerte dalle diverse tradizioni religiose e l’insegnamento della religione cattolica, impartito secondo gli accordi concordatari e le successive intese.
Religione cattolica
Nel quadro delle diverse discipline appartenenti a ciascuna area, l’insegnamento della religione cattolica si presenta nel modo seguente. Il confronto esplicito con la dimensione religiosa dell’ESPERIENZA UMANA svolge un ruolo insostituibile per la piena formazione della persona. Esso permette, infatti, l’acquisizione e l’uso appropriato di strumenti culturali che, portando al massimo sviluppo il processo di simbolizzazione che la scuola stimola e promuove in tutte le discipline, consente la COMUNICAZIONE anche su realtà altrimenti indicibili e inconoscibili. Il confronto, poi, con la forma storica della religione cattolica svolge un ruolo fondamentale e costruttivo per la CONVIVENZA CIVILE, in quanto permette di cogliere importanti aspetti dell’identità culturale di appartenenza e aiuta le relazioni e i RAPPORTI TRA PERSONE DI CULTURE E RELIGIONI DIFFERENTI .
La religione cattolica è parte costitutiva del patrimonio storico, culturale ed umano della società italiana; per questo, secondo le indicazioni dell’Accordo di
indiCazioni nazionali per l’irC
D.P.R. dell’11/02/2010
revisione del Concordato, la Scuola Italiana si avvale della collaborazione della Chiesa cattolica per far conoscere i principi del cattolicesimo a tutti gli studenti che vogliano avvalersi di questa opportunità. L’insegnamento della religione cattolica (Irc), mentre offre una prima conoscenza dei dati storico-positivi della Rivelazione cristiana, favorisce e accompagna lo sviluppo intellettuale e di tutti gli altri aspetti della persona, mediante l’approfondimento critico delle questioni di fondo poste dalla vita. Per tale motivo, come espressione della laicità dello Stato, l’Irc è offerto a tutti in quanto OPPORTUNITÀ PREZIOSA PER LA CONOSCENZA DEL CRISTIANESIMO, come radice di tanta parte della cultura italiana ed europea. Stanti le disposizioni concordatarie, nel rispetto della libertà di coscienza, è data agli studenti la possibilità di avvalersi o meno dell’Irc.
La proposta educativa dell’Irc consente la riflessione sui grandi interrogativi posti dalla condizione umana (ricerca identitaria, vita di relazione, complessità del reale, bene e male, scelte di valore, origine e fine della vita, radicali domande di senso…) e sollecita il confronto con la risposta maturata nella tradizione cristiana nel rispetto del processo di crescita della persona e con modalità differenziate a seconda della specifica fascia d’età, approfondendo le implicazioni antropologiche, sociali e valoriali, e promuovendo un confronto mediante il quale la persona, nell’esercizio della propria libertà, riflette e si orienta per la scelta di un responsabile progetto di vita.
Emerge così un ulteriore contributo dell’Irc alla formazione di persone capaci di dialogo e di rispetto delle differenze, di comportamenti di reciproca comprensione, in un contesto di pluralismo culturale e religioso.
In tal senso l’Irc – al di là di una sua collocazione nell’area linguistico-artistico-espressiva si offre anche come preziosa opportunità per l’elaborazione di attività interdisciplinari, per proporre percorsi di sintesi che, da una peculiare angolatura, aiutino gli alunni a costruire mappe culturali in grado di ricomporre nella loro mente una comprensione unitaria della realtà.
I traguardi per lo sviluppo delle competenze sono formulati in modo da esprimere la tensione verso tale prospettiva e collocare le differenti conoscenze e abilità in un orizzonte di senso che ne espliciti per ciascun alunno la portata esistenziale.
IndIcazIonI nazIonalI per l’Irc
D.P.R. dell’11/02/2010
Gli obiettivi di apprendimento per ogni fascia d’età sono articolati in quattro ambiti tematici, tenendo conto della centralità della persona di Gesù Cristo:
Obiettivi di Apprendimento d io e l’uomo l a b ibbia e le alT re fon T i i l linguaggio religio S o i valori e T i C i e religio S i
• con i principali riferimenti storici e dottrinali del Cristianesimo.
• per offrire una base documentale alla conoscenza.
• nelle sue declinazioni verbali e non verbali.
Traguardi per lo Sviluppo delle Competenze
• per illustrare il legame che unisce gli elementi squisitamente religiosi con la crescita del senso morale e lo sviluppo di una convivenza civile, responsabile e solidale.
L’alunno…
• riflette su Dio Creatore e Padre, sui dati fondamentali della vita di Gesù e sa collegare i contenuti principali del suo insegnamento alle tradizioni dell’ambiente in cui vive.
• riconosce il significato cristiano del Natale e della Pasqua, traendone motivo per interrogarsi sul valore di tali festività nell’esperienza personale, familiare e sociale.
• riconosce che la Bibbia è il libro sacro per cristiani ed ebrei e documento fondamentale della nostra cultura, sapendola distinguere da altre tipologie di testi, tra cui quelli di altre religioni.
• identifica le caratteristiche essenziali di un brano biblico, sa farsi accompagnare nell’analisi delle pagine a lui più accessibili, per collegarle alla propria esperienza.
• si confronta con l’esperienza religiosa e distingue la specificità della proposta di salvezza del Cristianesimo.
• identifica nella Chiesa la comunità di coloro che credono in Gesù Cristo e si impegnano per mettere in pratica il suo insegnamento.
• coglie il significato dei Sacramenti e si interroga sul valore che essi hanno nella vita dei cristiani.
dell’11/02/2010
Obiettivi di apprendimento al termine della classe terza della scuola primaria d io e l’uomo l a b ibbia e le alT re fon T i i l linguaggio religio S o i valori e T i C i e religio S i
• Scoprire che per la religione cristiana Dio è Creatore e Padre e che fin dalle origini ha voluto stabilire un’alleanza con l’uomo.
• Conoscere Gesù di Nazareth, Emmanuele e Messia, crocifisso e risorto e come tale testimoniato dai cristiani.
• Individuare i tratti essenziali della Chiesa e della sua missione.
• Riconoscere la preghiera come dialogo tra l’uomo e Dio, evidenziando nella preghiera cristiana la specificità del «Padre Nostro».
• Conoscere la struttura e la composizione della Bibbia.
• Ascoltare, leggere e saper riferire circa alcune pagine bibliche fondamentali, tra cui i racconti della creazione, le vicende e le figure principali del popolo d’Israele, gli episodi chiave dei racconti evangelici e degli Atti degli apostoli.
• Riconoscere i segni cristiani in particolare del Natale e della Pasqua, nell’ambiente, nelle celebrazioni e nella pietà e nella tradizione popolare.
• Conoscere il significato di gesti e segni liturgici propri della religione cattolica (modi di pregare, di celebrare, ecc.).
• Riconoscere che la morale cristiana si fonda sul comandamento dell’amore di Dio e del prossimo, come insegnato da Gesù.
• Riconoscere l’impegno della comunità cristiana nel porre alla base della convivenza umana la giustizia e la carità.
nazIonalI per l’Irc
D.P.R. dell’11/02/2010
Obiettivi di apprendimento al termine della classe quinta della scuola primaria d io e l’uomo l a b ibbia e le alT re fon T i i l linguaggio religio S o i valori e T i C i e religio S i
• Descrivere i contenuti principali del credo cattolico.
• Sapere che per la religione cristiana Gesù è il Signore, che rivela all’uomo il volto del Padre e annuncia il Regno di Dio con parole e azioni.
• Cogliere il significato dei sacramenti nella tradizione della Chiesa, come segni della salvezza di Gesù e azione dello Spirito Santo.
• Riconoscere avvenimenti, persone e strutture fondamentali della Chiesa cattolica sin dalle origini e metterli a confronto con quelli delle altre confessioni cristiane evidenziando le prospettive del cammino ecumenico.
• Conoscere le origini e lo sviluppo del Cristianesimo e delle altre grandi religioni individuando gli aspetti più importanti del dialogo interreligioso.
• Leggere direttamente pagine bibliche ed evangeliche, riconoscendone il genere letterario e individuandone il messaggio principale.
• Ricostruire le tappe fondamentali della vita di Gesù, nel contesto storico, sociale, politico e religioso del tempo, a partire dai Vangeli.
• Confrontare la Bibbia con i testi sacri delle altre religioni.
• Decodificare i principali significati dell’iconografia cristiana.
• Saper attingere informazioni sulla religione cattolica anche nella vita di santi e in Maria, la madre di Gesù.
• Intendere il senso religioso del Natale e della Pasqua, a partire dalle narrazioni evangeliche e dalla vita della Chiesa.
• Riconoscere il valore del silenzio come «luogo» di incontro con se stessi, con l’altro, con Dio.
• Individuare significative espressioni d’arte cristiana (a partire da quelle presenti nel territorio), per rilevare come la fede sia stata interpretata e comunicata dagli artisti nel corso dei secoli.
• Rendersi conto che la comunità ecclesiale esprime, attraverso vocazioni e ministeri differenti, la propria fede e il proprio servizio all’uomo.
• Scoprire la risposta della Bibbia alle domande di senso dell’uomo e confrontarla con quella delle principali religioni non cristiane.
• Riconoscere nella vita e negli insegnamenti di Gesù proposte di scelte responsabili, in vista di un personale progetto di vita.
“Il curricolo di Istituto è espressione della libertà di insegnamento e dell’autonomia scolastica e, al tempo stesso, esplicita le scelte della comunità scolastica e l’identità di istituto”.
Indicazioni Nazionali per il curricolo, 2012
Il curricolo è uno strumento disciplinare e metodologico di organizzazione dell’apprendimento, frutto di un lavoro collettivo, interno alla scuola, di “traduzione” delle Indicazioni Nazionali, che pongono lo studente al centro dell’azione educativa in tutti i suoi aspetti: cognitivi, affettivi relazionali, corporei, estetici, etici, spirituali, religiosi. Il curricolo verticale viene anche chiamato “curricolo d’istituto”, perché richiama l’insieme delle attività didattiche che rientrano nell’offerta formativa di ogni singolo istituto.
Con la sempre più frequente presenza di istituti cosiddetti “comprensivi”, ovvero che comprendono sia scuola primaria che secondaria inferiore (elementari e medie), il curricolo verticale si “spalma” su entrambi i cicli di istruzione (che a volte salgono addirittura a tre, in quegli istituti che comprendono anche la scuola dell’infanzia). In questi casi è ancor più sentita l’esigenza di PREDISPORRE DEI PIANI FORMATIVI che si basino su elementi di sviluppo graduale e progressivo delle conoscenze dell’allievo, con obiettivi trasversali e interconnessi (l’uno propedeutico all’altro).
Progettare insieme un Curricolo Verticale significa progettare un percorso unitario scandito da obiettivi graduali e progressivi, che permettano di consolidare l’apprendimento e al tempo stesso di EVOLVERE VERSO NUOVE COMPETENZE.
IndIcazIonI nazIonalI per l’Irc
D.P.R. dell’11/02/2010
Campo di e S perienza
i l S e e l’alT ro
il C orpo e il movimen T o
Scuola dell’infanzia
Traguardi per lo S viluppo delle Compe T enze l ivello iniziale l ivello b a S e l ivello in T ermedio l ivello avanzaT o
L’alunno scopre nei racconti del Vangelo la persona e l’insegnamento di Gesù, da cui apprende che Dio è Padre di tutti e che la Chiesa è la casa di chi crede in Lui.
L’alunno riconosce nei segni del corpo l’esperienza religiosa propria e altrui per cominciare a manifestare anche in questo modo la propria interiorità, l’immaginazione e le emozioni.
L’alunno riconosce alcuni linguaggi simbolici e figurativi caratteristici delle tradizioni e della vita dei cristiani per poter esprimere con creatività il proprio vissuto religioso.
Se stimolato, costruisce un’idea positiva di sé come persona e come creatura di Dio.
Si intuisce come persona e creatura di Dio.
Riconosce il proprio corpo, le sue diverse parti.
Conosce gli spazi scolastici e vi si orienta.
Conosce gli organi di senso e le loro funzioni.
Conosce e distingue i concetti di suono, rumore, silenzio e fonte sonora.
Conosce forme e figure, sagome, tracce, segni e linee.
Sperimenta schemi posturali e motori e li applica ai giochi di gruppo.
Utilizza i sensi per conoscere la realtà.
Coglie sé stesso e il mondo come donato da Dio e perciò da amare e custodire.
Apprezza sé stesso e il mondo come donato da Dio e perciò da amare e custodire.
Distingue i suoni dai rumori associandoli ai vari contesti.
Rappresenta graficamente in modo spontaneo, guidato e creativo.
Controlla l’esecuzione del gesto, valuta il rischio, interagisce con gli altri nei giochi di movimento, nella danza, nella comunicazione espressiva.
Si orienta e si muove con disinvoltura, con crescente sicurezza e autonomia negli spazi che gli sono familiari, anche in rapporto con gli altri e con le regole condivise.
Conosce vari strumenti e generi musicali.
Memorizza canti e li esegue in coro.
Conosce l’uso del colore per esprimere sentimenti ed emozioni.
conosce il proprio ruolo in un’attività musicale.
Utilizza in modo appropriato e creativo il colore.
Legge semplici immagini e le descrive.
Campo di e S perienza
i di SC or S i e le parole
Traguardi per lo S viluppo delle Compe T enze l ivello iniziale l ivello b
L’alunno impara alcuni termini del linguaggio cristiano, ascoltando semplici racconti biblici, ne sa narrare i contenuti riutilizzando i linguaggi appresi, per sviluppare una comunicazione anche in ambito religioso.
Riconosce alcuni simboli relativi alle principali feste cristiane.
Riconosce i simboli relativi alle principali feste cristiane ed alcuni termini specifici del linguaggio cristiano.
D.P.R. dell’11/02/2010
Impara alcuni termini del linguaggio cristiano. Ascolta semplici racconti biblici.
Ascolta semplici racconti biblici e riesce a narrare i contenuti.
l a C ono SC enza del mondo
L’alunno osserva con meraviglia ed esplora con curiosità il mondo, riconosciuto dai cristiani e da tanti uomini religiosi come dono di Dio creatore, per sviluppare sentimenti di responsabilità nei confronti della realtà, abitandola con fiducia e speranza.
Si orienta nel tempo della vita quotidiana.
Osserva i fenomeni naturali con curiosità.
Conosce la sequenza temporale.
Osserva i fenomeni naturali con attenzione.
Coglie semplici relazioni di causa / effetto.
Denomina i giorni della settimana.
Esplora ambienti naturali e artificiali.
Pone domande, discute, confronta ipotesi e soluzioni.
Riferisce eventi del passato recente ed è consapevole della loro collocazione temporale. Risolve semplici problemi e chiarisce soluzioni attraverso domande.
IndIcazIonI nazIonalI per l’Irc
D.P.R. dell’11/02/2010
Al termine della classe terza della scuola primaria o bie TT ivi di apprendimen T o
Traguardi per lo S viluppo delle Compe T enze l ivello iniziale l ivello b a S e l ivello in T ermedio l ivello avanzaT o
d io e l’uomo
L’alunno riflette su Dio Creatore e Padre, sui dati fondamentali della vita di Gesù e sa collegare i contenuti principali dell’insegnament o alle tradizioni del suo ambiente.
Riconosce in Dio il creatore del mondo.
Conosce alcune caratteristiche di Gesù.
Conosce il linguaggio specifico relativo agli argomenti trattati.
Conosce e comprende in modo appropriato il lessico specifico relativo agli argomenti trattati.
Conosce, comprende, applica e padroneggia in modo appropriato il lessico specifico relativo agli argomenti trattati.
l a b ibbia e le alT re fon T i
Riconosce che la Bibbia è il libro sacro per cristiani ed ebrei e documento fondamentale della nostra cultura; identifica le caratteristiche essenziali di un brano biblico.
Conosce alcuni semplici passi biblici, come il racconto della Genesi e i fatti principali della vita di Gesù.
Conosce il linguaggio specifico relativo agli argomenti trattati.
Comprende e utilizza il lessico specifico relativo agli argomenti trattati.
Comprende e utilizza in modo sempre appropriato il lessico specifico relativo agli argomenti trattati.
i l linguaggio religio S o
Riconosce il significato cristiano del Natale e della Pasqua, traendone motivo per interrogarsi sul valore di tali festività nell’esperienza personale, familiare e sociale.
Conosce le principali feste cristiane e alcuni simboli ad esse collegati.
Conosce il linguaggio simbolico legato alle principali feste cristiane.
Conosce e comprende il linguaggio simbolico legato alle principali feste cristiane.
Sa argomentare circa il valore simbolico legato alle principali feste cristiane.
Al termine della classe terza della scuola primaria o bie TT ivi di apprendimen T o
D.P.R. dell’11/02/2010
Traguardi per lo S viluppo delle Compe T enze l ivello iniziale l ivello b a S e l ivello in T ermedio l ivello avanzaT o
i valori e T i C i e religio S i
LSi confronta con l’esperienza religiosa e distingue la specificità della proposta di salvezza del Cristianesimo; identifica nella Chiesa la comunità di coloro che credono in Gesù Cristo.
Riconosce nella figura di Gesù un buon esempio di vita.
Riconosce nel messaggio di Gesù una proposta di vita per “crescere bene” nel rispetto di sé, degli altri e dell’ambiente.
Riconosce i valori di cui è portatore il messaggio evangelico e sviluppa atteggiamenti di rispetto verso gli altri e l’ambiente.
Riconosce i valori incarnati da Gesù e coglie in essi una proposta di vita fondata sul rispetto degli altri e dell’ambiente.
IndIcazIonI nazIonalI per l’Irc
D.P.R. dell’11/02/2010
Al termine della scuola primaria o bie TT ivi di apprendimen T o
Traguardi per lo S viluppo delle Compe T enze l ivello iniziale l ivello b a S e l ivello in T ermedio l ivello avanzaT o
d io e l’uomo
L’alunno riflette su Dio Creatore e Padre, sui dati fondamentali della vita di Gesù e sa collegare i contenuti principali del suo insegnamento alle tradizioni dell’ambiente in cui vive.
Conosce i principali argomenti trattati ed è in grado di esporli in modo accettabile.
È in grado di rielaborare i contenuti posti in un contesto semplificato.
Conosce gli argomenti trattati ed è in grado di esporli in modo corretto.
È in grado di rielaborare i contenuti e di proporre analisi e sintesi adeguate alle richieste.
Conosce in modo completo gli argomenti trattati ed è in grado di esporli in modo organico, con buona proprietà di linguaggio.
È in grado di rielaborare i contenuti in modo appropriato.
Conosce in modo approfondito gli argomenti trattati ed è in grado di esporli in modo organico, con un’ottima proprietà di linguaggio e apporti personali.
È in grado di rielaborare i contenuti in modo autonomo.
l a b ibbia e le alT re fon T i
Riconosce che la Bibbia è il libro sacro per cristiani ed ebrei e documento fondamentale della nostra cultura, sapendola distinguere da altre tipologie di testi.
Conosce il lessico relativo agli argomenti trattati in modo accettabile.
Conosce e utilizza il lessico specifico relativo agli argomenti trattati.
Conosce, comprende e utilizza in modo organico il lessico specifico relativo agli argomenti trattati.
Conosce, comprende e utilizza in modo sempre appropriato il lessico specifico relativo agli argomenti trattati.
o bie TT ivi di apprendimen T o
i l linguaggio
religio S o
Traguardi per lo S viluppo delle Compe T enze
Riconosce il significato cristiano del Natale e della Pasqua, traendone motivo per interrogarsi sul valore di tali festività nell’esperienza personale, familiare e sociale.
i valori e T i C i e religio S i
Si confronta con l’esperienza religiosa e distingue la specificità della proposta di salvezza del Cristianesimo; identifica nella Chiesa la comunità di coloro che credono in Gesù.
D.P.R. dell’11/02/2010
l ivello iniziale l ivello b a S e l ivello in T ermedio l ivello avanzaT o
Conosce e comprende alcuni aspetti del linguaggio simbolico legato alle principali feste cristiane.
Conosce, comprende ed è in grado di verbalizzare, in modo accettabile, il significato essenziale di segni e simboli sacri.
Conosce il senso religioso delle feste di Natale e Pasqua per l’uomo di oggi.
Conosce la risposta della religione cristiana alla domanda di senso dell’uomo.
Conosce la risposta della religione cristiana alla domanda di senso dell’uomo e quella delle grandi religioni del mondo.
Conosce, comprende ed è in grado di verbalizzare, in modo corretto, il significato essenziale di segni e simboli sacri.
Conosce e comprende il senso religioso delle feste di Natale e Pasqua per l’uomo di oggi.
Conosce la risposta della religione cristiana alla domanda di senso dell’uomo e sa operare un confronto con le risposte fornite dalle grandi religioni del mondo.
Conosce, comprende ed è in grado di verbalizzare, in modo organico e critico, il significato essenziale di segni e simboli sacri.
Comprende e sa argomentare circa il valore delle feste di Natale e Pasqua per l’uomo di oggi.
Sviluppa riflessioni e sa rielaborare la risposta della religione cristiana alla domanda di senso dell’uomo.
Mette in relazione la proposta biblica con quella delle grandi religioni del mondo.
IndIcazIonI nazIonalI per l’Irc
D.P.R. dell’11/02/2010
Scuola secondaria di secondo grado o bie TT ivi di apprendimen T o Traguardi per lo S viluppo delle Compe T enze l ivello iniziale l ivello b a S e l ivello in T ermedio l ivello avanzaT o
L’alunno è aperto alla ricerca della verità e sa porsi domande di senso, cogliendo l’intreccio tra dimensione religiosa e culturale.
d io e l’uomo
l a b ibbia e le alT re fon T i
A partire dal contesto in cui vive, sa interagire con persone di religione differente, sviluppando un’identità capace di accoglienza, confronto e dialogo.
L’alunno individua, a partire dalla Bibbia, le tappe essenziali della storia della salvezza, della vita e dell’insegnamento di Gesù, del Cristianesimo delle origini.
Comprende, conosce e confronta in modo semplice.
Pone alcune domande sul senso della vita ed instaura relazioni essenziali con i compagni.
Comprende, conosce e confronta in modo adeguato.
Elabora domande di senso e instaura relazioni positive con i compagni e le figure di riferimento.
Comprende, conosce e confronta in modo completo.
Elabora domande di senso per le quali ricerca risposte proprie
Si rapporta efficacemente con pari e adulti.
Comprende, conosce e confronta in modo approfondito e personale.
Si pone domande sul senso della vita con senso critico, si rapporta con gli altri in modo autentico, dimostrando piena capacità di accoglienza.
Utilizza il testo biblico e individua gli elementi specifici dei documenti in modo semplice.
Riconosce alcuni elementi essenziali della storia della Chiesa.
Utilizza il testo biblico e individua gli elementi specifici dei documenti in modo adeguato.
Riconosce e confronta gli elementi fondamentali della storia della Chiesa.
Utilizza il testo biblico e individua gli elementi specifici dei documenti in modo completo.
Ricostruisce e confronta le tappe della storia della Chiesa.
Utilizza il testo biblico e individua gli elementi specifici dei documenti in modo approfondito e personale.
Ricostruisce, rielabora e interpreta le tappe della storia della Chiesa.
o bie TT ivi di apprendimen T o
l a b ibbia e le alT re fon T i
Traguardi per lo S viluppo delle Compe T enze l ivello iniziale l ivello b a S e l ivello in T ermedio
Ricostruisce gli elementi fondamentali della storia della Chiesa, li confronta con le vicende della storia civile passata e recente.
i l linguaggio religio S o
Lo studente riconosce i linguaggi espressivi della fede (simboli, preghiere, riti, ecc.), ne individua le tracce presenti in ambito locale, italiano, europeo e nel mondo imparando ad apprezzarli dal punto di vista artistico, culturale e spirituale.
Comprende, riconosce e utilizza il linguaggio specifico in modo molto semplice, anche a partire dal contesto in cui vive.
Conosce i principali riti, feste, simboli.
Comprende, riconosce e utilizza il linguaggio specifico in modo adeguato a partire dal contesto in cui vive.
Conosce riti, feste, simboli e ne apprezza il loro valore.
Comprende, riconosce e utilizza il linguaggio specifico in modo appropriato a partire sia dal contesto familiare che da quello sociale.
Conosce feste, riti, simboli e ne riconosce il significato.
Comprende, riconosce e utilizza il linguaggio specifico in modo approfondito e personale, sia a partire dal proprio contesto che da altri contesti.
Conosce feste, riti, simboli, ne coglie il valore spirituale e l’intreccio con gli ambiti artistici e culturali.
i valori e T i C i e religio S i
Lo studente coglie le implicazioni etiche della fede cristiana e le rende oggetto di riflessione in vista di scelte di vita responsabili.
Comprende e riconosce in modo semplice i valori proposti dal Cristianesimo.
Comprende, coglie e riconosce in modo adeguato i valori proposti dal Cristianesimo e dalle altre religioni.
Comprende, coglie e riconosce in modo appropriato i valori proposti dal Cristianesimo e dalle altre religioni.
Comprende, coglie e riconosce in modo approfondito e personale i valori proposti dal Cristianesimo e dalle altre religioni.
IndIcazIonI nazIonalI per l’Irc
D.P.R. dell’11/02/2010
o bie TT ivi di apprendimen T o Traguardi per lo S viluppo delle Compe T enze l ivello iniziale
i valori e T i C i e religio S i
Lo studente coglie le implicazioni etiche della fede cristiana e le rende oggetto di riflessione in vista di scelte di vita responsabili.
Riflette sulle proprie scelte di vita in modo essenziale, intuisce l’importanza del proprio comportament o nel rapporto con gli altri.
l ivello b a S e l ivello in T ermedio
Riflette sulle proprie scelte e sul proprio comportamento.
Riflette sulle proprie scelte di vita e sul proprio comportamento in modo consapevole.
l ivello avanzaT o
Riflette sulle proprie scelte di vita sul proprio comportamento in modo consapevole e maturo.
La valutazione dell’IRC nella scuola primaria
Il Ministero dell’Istruzione, in data 4 dicembre 2020, ha pubblicato l’ordinanza sulla valutazione periodica e finale degli apprendimenti nella SCUOLA PRIMARIA, con le rispettive linee guida e una nota contenente le indicazioni operative.
Da tale documentazione si evince che, almeno per il momento, NON È PREVISTA PER L’IRC LA FORMULAZIONE DI UN GIUDIZIO DESCRITTIVO come valutazione periodica e finale degli apprendimenti nella scuola primaria, MA È RIBADITO L’IMPIEGO DI UN GIUDIZIO SINTETICO, che resta disciplinato dall’art. 2, commi 3 e 7, del decreto legislativo n. 62 del 13 aprile 2017; dunque, “RIMANGONO INVARIATE LE MODALITÀ PER LA VALUTAZIONE DELL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA ”, che è comunque resa su una nota distinta, con un giudizio sintetico sull’interesse manifestato e i livelli di apprendimento conseguiti.
Facendo riferimento alle circolari ministeriali n. 20/1964 e n. 491/1996 e tenendo conto, nel contempo, delle mutate esigenze di carattere pedagogico-didattico, si propone di seguito uno schema dei diversi livelli di competenza e una tabella, che ha il solo scopo esemplificativo, di possibili GIUDIZI SINTETICI PER LA VALUTAZIONE PERIODICA E FINALE DELL’IRC:
Livelli di competenza
avanzaT o
in T ermedio
ba S e
iniziale
Lo studente svolge compiti e problemi complessi in situazioni anche non note, mostrando padronanza nell’uso delle conoscenze e delle abilità. Porta a termine in modo autonomo i compiti assegnati. Sa proporre e sostenere le proprie opinioni e assumere autonomamente decisioni consapevoli. È in grado di reperire e organizzare conoscenze nuove e di proporre soluzioni originali.
Lo studente svolge compiti e risolve problemi complessi in situazioni note, compie scelte consapevoli, mostrando di saper utilizzare in modo adeguato le conoscenze e le abilità acquisite. Porta a termine in modo autonomo i compiti assegnati.
Lo studente svolge compiti semplici in situazioni note, mostrando di possedere conoscenze ed abilità essenziali e di saper applicare regole e procedure fondamentali. Porta a termine in modo abbastanza autonomo i compiti assegnati.
L’alunno, se guidato, svolge compiti semplici in situazioni note. Non ha ancora la padronanza adeguata delle conoscenze e delle abilità. Porta a termine in modo non autonomo i compiti assegnati.
avanzaT o e CC ellen T e 10
avanzaT o o TT imo 9
in T ermedio di ST in T o 8
Spiccato interesse per le tutte le attività svolte. Acquisizione piena dei contenuti proposti e capacità di utilizzarli costruttivamente in contesti nuovi e complessi.
Vivace interesse per tutte le attività svolte. Acquisizione dei contenuti proposti e capacità di utilizzarli costruttivamente anche in altri contesti.
Vivace interesse per le attività svolte. Acquisizione dei contenuti proposti e capacità di utilizzarli costruttivamente.
in T ermedio buono 7 Interesse per le attività svolte. Acquisizione dei contenuti proposti.
ba S e S uffi C ien T e 6
Interesse per alcune attività svolte. Acquisizione dei contenuti di base.
iniziale non S uffi C ien T e 5 Poco interesse per le attività svolte. Informazioni di base non acquisite.
La valutazione scolastica riguarda l’apprendimento e il comportamento degli studenti e i docenti procedono alle verifiche intermedie, periodiche e finali, coerentemente con gli OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO previsti dal PTOF della scuola, in coerenza con le INDICAZIONI NAZIONALI e le LINEE GUIDA SPECIFICHE per i diversi livelli. Il decreto legislativo 62/2017 attuativo della Legge 107/2015 ha modificato il modello di valutazione della scuola del primo ciclo, senza stravolgimenti bensì nell’ottica di apportare i miglioramenti di cui, negli anni, la comunità pedagogica ha condiviso l’opportunità.
La valutazione nel primo ciclo di istruzione
La valutazione degli apprendimenti delle alunne e degli alunni frequentanti la scuola primaria è stata rivista alla luce di un impianto valutativo che supera il voto numerico e introduce il GIUDIZIO DESCRITTIVO PER CIASCUNA DELLE DISCIPLINE previste dalle Indicazioni nazionali per il curricolo, Educazione civica compresa al fine di rendere la valutazione degli alunni sempre più trasparente e coerente con il percorso di apprendimento di ciascuno. Secondo quanto previsto dalle nuove disposizioni, il giudizio descrittivo di ogni studente sarà riportato nel documento di valutazione e sarà riferito a QUATTRO DIFFERENTI LIVELLI
Avanzato:
l’alunno porta a termine compiti in situazioni note e non note, mobilitando una varietà di risorse sia fornite dal docente, sia reperite altrove, in modo autonomo e con continuità.
Intermedio:
l’alunno porta a termine compiti in situazioni note in modo autonomo e continuo; risolve compiti in situazioni non note, utilizzando le risorse fornite dal docente o reperite altrove, anche se in modo discontinuo e non del tutto autonomo.
Base:
l’alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e utilizzando le risorse fornite dal docente, sia in modo autonomo ma discontinuo, sia in modo non autonomo, ma con continuità.
Iniziale (in via di prima acquisizione): l’alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e unicamente con il supporto del docente e di risorse fornite appositamente.
I livelli di apprendimento saranno riferiti agli esiti raggiunti da ogni alunno in relazione agli obiettivi di ciascuna disciplina. Nell’elaborare il giudizio descrittivo si terrà conto del percorso fatto e della sua evoluzione. La valutazione degli alunni con disabilità certificata sarà correlata agli obiettivi individuati nel Piano Educativo Individualizzato (PEI), mentre la valutazione degli alunni con disturbi specifici dell’apprendimento terrà conto del Piano Didattico Personalizzato (PDP).
Riferimenti normativi
• Decreto n. 122 del 2009, Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione.
• Decreto legislativo n. 62/2017, recante norme in materia di valutazione e di certificazione delle competenze.
• DM n. 741/2017, dedicato a disciplinare in modo organico gli esami di Stato di scuola secondaria di I grado.
• DM n. 742/2017, con il quale sono stati adottati i modelli nazionali di certificazione nazionale delle competenze al termine della scuola primaria e del primo ciclo di istruzione. - Nota n. 1865 del 10 ottobre 2017, volta a fornire indicazioni in merito a valutazione, certificazione delle competenze ed Esame di Stato nelle scuole del primo ciclo di istruzione.
• Ordinanza n. 172 del 4 dicembre 2020 , Valutazione periodica e finale degli apprendimenti delle alunne e degli alunni delle classi della scuola primaria.
• Linee guida valutazione scuola primaria, La formulazione dei giudizi descrittivi nella valutazione periodica e finale della scuola primaria.
www.miur.gov.it/valutazione
g iudizio di profi TT o (in riferimen T o a C ono SC enze, abili Ta, C ompe T enze di SC iplinari) l ivello di profi TT o
• Conoscenze complete, organiche, particolarmente approfondite e senza errori;
• ottima capacità di comprensione e di analisi, corretta ed efficace applicazione dei concetti;
• esposizione fluida, rigorosa, ricca e ben articolata con l’uso di una terminologia corretta e varia, un linguaggio specifico appropriato, una sicurezza nell’esposizione;
• autonomia di sintesi, di organizzazione e di rielaborazione delle conoscenze acquisite;
• capacità di operare collegamenti tra discipline e di stabilire relazioni.
• Conoscenze ampie, complete e approfondite;
• apprezzabile capacità di comprensione e di analisi, corretta ed efficace applicazione dei concetti;
• esposizione chiara, precisa, ricca e ben articolata con l’uso di una terminologia corretta e varia, un linguaggio specifico appropriato, una sicurezza nell’esposizione;
• autonomia di sintesi, di organizzazione e di rielaborazione delle conoscenze acquisite; capacità di operare collegamenti tra discipline e di stabilire relazioni.
• Conoscenze sicure, complete e integrate con qualche apporto personale;
• buona capacità di comprensione e di analisi, idonea applicazione dei concetti;
• esposizione chiara e articolata con l’uso di una terminologia corretta e varia, un linguaggio specifico appropriato;
• autonomia di sintesi, di organizzazione e di rielaborazione delle conoscenze acquisite con apporti critici talvolta originali.
• Conoscenze generalmente sicure e complete;
• adeguata capacità di comprensione e di analisi, discreta applicazione dei concetti;
• esposizione chiara e sostanzialmente corretta con l’uso di una terminologia appropriata e discretamente varia ma con qualche carenza nel linguaggio specifico;
• parziale autonomia di sintesi e di rielaborazione delle conoscenze acquisite.
• Conoscenze semplici e sostanzialmente corrette dei contenuti disciplinari più significativi;
• elementare, ma pertinente, capacità di comprensione e di analisi, accettabile e generalmente corretta applicazione dei concetti;
• esposizione semplificata e sostanzialmente corretta con qualche errore a livello linguistico, lessico povero ma appropriato;
10 avanzaT o
9
8 in T ermedio
7
6 ba S e
CompeTenze CHiave europee
Le competenze Chiave europee:
Le competenze chiave europee sono le otto Raccomandazioni adottate dal Consiglio dell’Unione Europea (22 maggio 2018) che fanno emergere la crescente necessità di competenze imprenditoriali, sociali e civiche, indispensabili per garantire la capacità di adattarsi ai cambiamenti da parte di ciascun alunno/a.
Non sono ordinate in modo gerarchico, ma sono da considerarsi tutte di pari importanza:
Competenza alfabetica funzionale
Si concretizza nella piena capacità di comunicare, sia in forma orale che scritta, nella propria lingua, adattando il proprio registro ai contesti e alle situazioni. Fanno parte di questa competenza anche il pensiero critico e la capacità di valutazione della realtà.
Competenza multilinguistica
Prevede la conoscenza del vocabolario di lingue diverse dalla propria, con conseguente abilità nel comunicare sia oralmente che in forma scritta. Infine, fa parte di questa competenza anche l’abilità di inserirsi in contesti socio-culturali diversi dal proprio.
Competenza matematica e competenza di base in scienze e tecnologie
Le competenze matematiche considerate indispensabili sono quelle che permettono di risolvere i problemi legati alla quotidianità. Quelle in campo scientifica e tecnologico, invece, si risolvono nella capacità di comprendere le leggi naturali di base che regolano la vita sulla terra.
Competenza digitale
È la competenza propria di chi sa utilizzare con dimestichezza le nuove tecnologie, con finalità di istruzione, formazione e lavoro. A titolo esemplificativo, fanno parte di questa competenza: l’alfabetizzazione informatica, la sicurezza online, la creazione di contenuti digitali.
Competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare
È la capacità di organizzare le informazioni e il tempo, di gestire il proprio percorso di formazione e carriera. Vi rientra, però, anche la spinta a inserire il proprio contributo nei contesti in cui si è chiamati ad intervenire, così come l’abilità di riflettere su sé stessi e di autoregolamentarsi.
Competenza sociale e civica in materia di cittadinanza
Ognuno deve possedere le skill che gli consentono di agire da cittadino consapevole e responsabile, partecipando appieno alla vita sociale e politica del proprio paese.
Competenza imprenditoriale
La competenza imprenditoriale si traduce nella capacità creativa di chi sa analizzare la realtà e trovare soluzioni per problemi complessi, utilizzando l’immaginazione, il pensiero strategico, la riflessione critica.
Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale
In questa particolare competenza rientrano sia la conoscenza del patrimonio culturale (a diversi livelli) sia la capacità di mettere in connessione i singoli elementi che lo compongono, rintracciando le influenze reciproche.
eduCazione CiviCa
Il quadro di riferimento nazionale ed internazionale
La Legge 20 agosto 2019, n. 92 (d’ora in avanti, Legge) ha istituito l’insegnamento scolastico dell’Educazione Civica e ha previsto che con decreto del Ministro siano definite le Linee guida per tale insegnamento che individuano, “ove non già previsti, specifici traguardi per lo sviluppo delle competenze e obiettivi specifici di apprendimento, in coerenza con le Indicazioni nazionali per il curricolo delle scuole dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione, nonché con il documento Indicazioni nazionali e nuovi scenari e con le Indicazioni nazionali per i licei e le Linee guida per gli istituti tecnici e professionali vigenti” . Secondo quanto previsto dalle Linee guida adottate in via di prima applicazione con decreto ministeriale 22 giugno 2020, n. 35, le Istituzioni scolastiche sono state chiamate ad aggiornare i curricoli di istituto e l’attività di progettazione didattica nel primo e nel secondo ciclo di istruzione al fine di sviluppare “la conoscenza e la comprensione delle strutture e dei profili sociali, economici, giuridici, civici e ambientali della società”. Inoltre, in questo primo quadriennio di attuazione della Legge, le scuole del primo ciclo hanno individuato propri traguardi per lo sviluppo delle competenze e obiettivi di apprendimento, mentre quelle del secondo ciclo di istruzione hanno individuato propri risultati di apprendimento al fine di integrare il curricolo di istituto con riferimento all’Educazione Civica.
A seguito delle attività realizzate dalle scuole e tenendo conto delle novità normative intervenute, a partire dall’anno scolastico 2024/2025, i curricoli di Educazione Civica si riferiscono a traguardi e obiettivi di apprendimento definiti a livello nazionale, come individuati dalle presenti Linee guida che sostituiscono le precedenti.
Tra le tematiche recentemente richiamate dalla normativa nazionale si sottolinea una particolare attenzione alla tutela dell’ambiente, alla educazione stradale4 e alla promozione dell’educazione finanziaria. Le Linee guida si configurano come strumento di supporto e sostegno ai docenti anche di fronte ad alcune gravi emergenze educative e sociali del nostro tempo quali, ad esempio, l’aumento di atti di bullismo, di cyberbullismo e di violenza contro le donne, la dipendenza
dal digitale, il drammatico incremento dell’incidentalità stradale – che impone di avviare azioni sinergiche, sistematiche e preventive in tema di educazione e sicurezza stradale – nonché di altre tematiche, quali il contrasto all’uso delle sostanze stupefacenti, l’educazione alimentare, alla salute, al benessere della persona e allo sport.
Le Linee guida, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 1 della Legge, mirano innanzitutto a favorire e sviluppare nelle istituzioni scolastiche la conoscenza della Costituzione italiana – riconoscendola non solo come norma cardine del nostro ordinamento, ma anche come riferimento prioritario per identificare valori, diritti, doveri, compiti, comportamenti personali e istituzionali finalizzati a promuovere il pieno sviluppo della persona e la partecipazione di tutti i cittadini all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese – nonché delle istituzioni dell’Unione Europea.
La conoscenza della Costituzione – nelle sue dimensioni storiche, giuridiche, valoriali – rappresenta il fondamento del curricolo di Educazione Civica. In questo senso va sottolineato il carattere personalistico della nostra Costituzione. Ne discende la necessità di sottolineare la centralità della persona umana, soggetto fondamentale della storia, al cui servizio si pone lo Stato.
Da qui nasce l’importanza di valorizzare i talenti di ogni studente e la cultura del rispetto verso ogni essere umano. Da qui il carattere fondamentale dei valori di solidarietà, di libertà, di eguaglianza nel godimento dei diritti inviolabili e nell’adempimento dei doveri inderogabili. Da qui il concetto stesso di democrazia che la nostra Costituzione collega non casualmente alla sovranità popolare e che, per essere autentica, presuppone lo Stato di diritto. Da qui anche la funzionalità della società allo sviluppo di ogni individuo (e non viceversa) ed il primato dell’essere umano su ogni concezione ideologica.
Le nuove Linee guida, in piena coerenza con il dettato costituzionale, sottolineano non solo la centralità dei diritti, ma anche dei doveri verso la collettività, che l’articolo 2 della nostra Carta costituzionale definisce come “doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale”. L’importanza di sviluppare anche una cultura dei doveri rende necessario insegnare il rispetto verso le regole che sono poste per una società ordinata al fine di favorire la convivenza civile, per
far prevalere il diritto e non l’arbitrio. Da qui l’importanza fondamentale della responsabilità individuale che non può essere sostituita dalla responsabilità sociale. Pienamente coerente con la Costituzione è anche la necessità di valorizzare la cultura del lavoro come concetto fondamentale della nostra società da insegnare già a scuola fin dal primo ciclo di istruzione. La scuola, unitamente alla famiglia e alle altre istituzioni del territorio, ha la responsabilità di supportare gli studenti nel percorso che li porta a diventare cittadini responsabili, autonomi, consapevoli e impegnati in una società sempre più complessa e in costante mutamento. In questo contesto è fondamentale l’alleanza educativa fra famiglia e scuola. La scuola “costituzionale” che ispira l’educazione alla cittadinanza, proprio perché dà centralità alla persona dello studente, deve sempre favorire l’inclusione, a iniziare dagli studenti con disabilità, dal recupero di chi manifesta lacune negli apprendimenti, dal potenziamento delle competenze di chi non ha eguali opportunità formative e di chi non utilizza pienamente l’italiano come lingua veicolare. Insomma, la scuola costituzionale è quella che stimola e valorizza ogni talento.
In questa prospettiva, l’Educazione Civica favorisce il riconoscimento di valori e comportamenti coerenti con la Costituzione attraverso il dialogo e il rispetto reciproco, volti a incoraggiare un pensiero critico personale, aperto e costruttivo, in un percorso formativo che, coinvolgendo la persona nella sua interezza e unitarietà, inizia dall’infanzia e prosegue lungo tutto l’arco della vita.
L’Educazione Civica deve contribuire ad una formazione volta a favorire l’inclusione degli alunni stranieri nella scuola italiana. L’insegnamento dell’Educazione Civica può supportare gli insegnanti nel lavoro dell’integrazione, producendo nei suoi esiti coesione civica e senso della comunità, evitando che anche in Italia si verifichino fenomeni di ghettizzazione urbana e sociale.
Le Linee Guida per l’insegnamento dell’Educazione Civica offrono una cornice efficace entro la quale poter inquadrare temi e obiettivi di apprendimento coerenti con quel sentimento di appartenenza che deriva dall’esperienza umana e sociale del nascere, crescere e convivere in un Paese chiamato Italia. È in tale realtà geografica ed esperienziale insieme che il bambino comincia a rappresentare se stesso e se stesso in relazione al mondo. Per questa ragione il ruolo della scuola diventa fondamentale anche al fine di svelare il significato del ricchissimo patrimonio culturale e ambientale dell’Italia, dei suoi territori e delle sue comu-
nità. L’Educazione Civica può proficuamente contribuire a formare gli studenti al significato e al valore dell’appartenenza alla comunità nazionale che è comunemente definita Patria, concetto che è espressamente richiamato e valorizzato dalla Costituzione .
Rafforzare il nesso tra il senso civico e l’idea di appartenenza alla comunità nazionale potrà restituire importanza, fra l’altro, al sentimento dei doveri verso la collettività, come prescritto dall’articolo 2 della Costituzione, nonché alla coscienza di una comune identità italiana come parte, peraltro, della civiltà europea ed occidentale e della sua storia, consapevolezza che favorisce un’autentica integrazione.
Inoltre, l’insegnamento dell’Educazione Civica aiuta gli studenti a capire la storia intera del Paese, riconoscendola nella ricchezza delle diversità dei singoli territori e valorizzando le varie eccellenze produttive che costituiscono il “Made in Italy”. Dovrebbe far comprendere che la cittadinanza si costruisce attraverso l’identificazione con i valori costituzionali, l’esercizio responsabile delle virtù civiche, la valorizzazione dei territori che costituiscono la Repubblica, con le loro tipicità e tradizioni. In questo contesto l’appartenenza alla Unione Europea appare coerente con lo spirito originario del trattato fondativo volto a favorire la collaborazione tra Paesi che hanno valori ed interessi generali comuni.
Importante risulta anche educare a riconoscere la sussidiarietà orizzontale quale principio costituzionale che promuove l’iniziativa autonoma dei cittadini, sia come “singoli” che in “forma associata”. Spirito di iniziativa e di imprenditorialità sono, inoltre, competenze sempre più richieste per affrontare le sfide e le trasformazioni sociali attuali oltre che espressione di un sentimento di autodeterminazione. Parallelamente alla valorizzazione della iniziativa economica privata si evidenzia l’importanza della proprietà privata, tutelata dall’articolo 42 della Costituzione e che, come ben definisce la Carta dei diritti fondamentali della Unione Europea, è un elemento essenziale della libertà individuale e che va dunque rispettata e incoraggiata.
In tali direzioni, le Linee guida propongono un approccio sistematico e trasversale per la progettazione, valutazione e promozione dei valori e delle competenze di Educazione Civica.
Il richiamo al principio della trasversalità dell’insegnamento dell’Educazione Civica si rende necessario anche in ragione della pluralità degli obiettivi di apprendimento e delle competenze attese, non ascrivibili ad una singola disciplina e
neppure ad ambiti disciplinari delimitati.
La scelta italiana di individuare l’Educazione Civica come insegnamento trasversale e ambito di apprendimento interdisciplinare è coerente con i documenti europei e internazionali in materia di educazione alla cittadinanza. Inoltre, accanto al principio della trasversalità, è opportuno fare riferimento anche a quello dell’apprendimento esperienziale, con l’obiettivo, sotto il profilo metodologico-didattico, di valorizzare attività di carattere laboratoriale, casi di studio, seminari dialogici a partire da fatti ed eventi di attualità, così come esperienze di cittadinanza attiva vissute dagli studenti in ambito extra-scolastico e che concorrono a comporre il curricolo di Educazione Civica, grazie anche ad una loro rilettura critico-riflessiva e alla loro discussione sotto la guida del docente e nel confronto reciproco tra pari, ovvero nel confronto esperienziale fra studenti. Le Linee guida, infine, riconoscendo e valorizzando il principio dell’autonomia delle istituzioni scolastiche, mirano a favorire e incoraggiare un più agevole raccordo fra le discipline, nella consapevolezza che ogni disciplina è, di per sé, parte integrante della formazione civica e sociale di ciascuno studente.
Al fine di favorire l’unitarietà del curricolo e in considerazione della contitolarità dell’insegnamento tra tutti i docenti di classe o del consiglio di classe, le Linee guida sono impostate secondo i nuclei concettuali di cui all’articolo 3 della Legge che, per loro natura interdisciplinari, attraversano il curricolo e possono essere considerati in ogni argomento che tutti i docenti trattano quotidianamente.
La conoscenza del dettato costituzionale, della sua storia, delle scelte compiute nel dibattito in Assemblea costituente e la riflessione sul suo significato rappresentano il primo e fondamentale aspetto da trattare. Esso contiene e pervade tutte le altre tematiche, poiché le leggi ordinarie, i regolamenti, le disposizioni normative devono sempre trovare coerenza con la Costituzione, che rappresenta il fondamento della convivenza e del patto sociale nel nostro Paese. Collegati alla Costituzione sono innanzitutto i temi relativi alla conoscenza dell’ordinamento e delle funzioni dello Stato, delle Regioni, degli Enti territoriali e delle Organizzazioni internazionali e sovranazionali, prime tra tutte l’Unione Europea e le Nazioni Unite, così come la conoscenza approfondita di alcuni articoli della Costituzione, in particolare di quelli contenuti nei principi generali
quali gli artt. dall’1 al 12. Anche i concetti di legalità, di rispetto delle leggi e delle regole comuni in tutti gli ambienti di convivenza (ad esempio, il codice della strada, i regolamenti scolastici) rientrano in questo primo nucleo concettuale, come pure la conoscenza dell’Inno e della Bandiera nazionale, come forme di appartenenza ad una Nazione, la conoscenza dell’Inno e della Bandiera europei come appartenenza ad una civiltà comune con i popoli europei, la conoscenza della Bandiera della regione e dello Stemma del comune, come appartenenza ad una comunità e ad un territorio che contribuiscono a formare la Repubblica. In particolare, nello studio delle leggi (dalla Costituzione alle leggi ordinarie) occorre evidenziare che esse non sono prescrizioni etico/morali, ma strumenti giuridici; che sono fatte per le Persone e non le Persone per loro; che sono rivolte all’interesse comune di tutti i cittadini e servono allo scopo di regolare il rapporto autorità/libertà tra i cittadini e lo Stato. Educazione alla legalità, quindi, significa favorire la consapevolezza della necessità del rispetto delle norme per il benessere di tutti i cittadini. Rientra in questo nucleo anche l’educazione contro ogni forma di discriminazione e contro ogni forma di bullismo intesa come violenza contro la persona. Di grande importanza appare il contrasto ad ogni forma di criminalità e illegalità e in particolare la criminalità contro la persona, contro i beni pubblici e privati. La tematica potrà essere opportunamente affrontata analizzando la diffusione territoriale della criminalità organizzata, i fattori storici e di contesto che hanno favorito la nascita e la crescita delle mafie e i suoi effetti economici e sociali, identificando comportamenti privati che possano contribuire a contrastare ogni forma di criminalità. Analogamente, trova collocazione l’educazione stradale –intesa anche come sicurezza stradale – finalizzata all’acquisizione da parte degli studenti di comportamenti responsabili quali utenti della strada, abituando i giovani al rispetto della vita propria e altrui e delle regole del codice della strada. Infine, in questo primo ambito, rientra anche l’esplicitazione della dimensione dei diritti e dei doveri che conseguono alla partecipazione alla vita della comunità nazionale ed europea e che sono spesso intrecciati fra loro, come insegna l’esempio del lavoro, inteso non solo come diritto (articolo 4, comma 1, della Costituzione) ma anche come dovere civico (articolo 4, comma 2, della Costituzione), e in più valore sul quale si fonda la nostra Repubblica (articolo 1, comma 1, della Costituzione).
È importante educare i giovani ai concetti di sviluppo e di crescita. Per questo, la valorizzazione del lavoro, come principio cardine della nostra società, e dell’iniziativa economica privata è parte fondamentale di una educazione alla cittadinanza. La diffusione della cultura di impresa consente alle studentesse e agli studenti di potenziare attitudini e conoscenze relative al mondo del lavoro e all’autoimprenditorialità. Ovviamente, lo sviluppo economico deve essere coerente con la tutela della sicurezza, della salute, della dignità e della qualità della vita delle persone, della natura, anche con riguardo alle specie animali e alla biodiversità, e più in generale con la protezione dell’ambiente. In questa prospettiva, che trova un particolare riferimento in diversi articoli della Costituzione, possono rientrare tematiche riguardanti l’educazione alla salute, alla protezione della biodiversità e degli ecosistemi, alla bioeconomia, anche nell’interesse delle future generazioni (così come previsto dall’articolo 9 della Costituzione recentemente riformulato). In questo quadro si inserisce pure la cultura della protezione civile per accrescere la sensibilità sui temi di autoprotezione e tutela del territorio.
Analogamente trovano collocazione nel presente nucleo concettuale il rispetto per i beni pubblici, a partire dalle strutture scolastiche, la tutela del decoro urbano nonché la conoscenza e valorizzazione del ricchissimo patrimonio culturale, artistico e monumentale dell’Italia.
Sempre nell’ottica di tutelare la salute e il benessere collettivo e individuale si inseriscono nell’Educazione Civica sia l’educazione alimentare per la realizzazione del corretto rapporto tra alimentazione, attività sportiva e benessere psicofisico, sia i percorsi educativi per il contrasto alle dipendenze derivanti da droghe, fumo, alcool, doping, uso patologico del web, gaming e gioco d’azzardo. Conoscere i rischi e gli effetti dannosi del consumo di ogni tipologia di droghe, comprese le droghe sintetiche, e di altre sostanze psicoattive, nonché dei rischi derivanti dalla loro dipendenza, anche attraverso l’informazione delle evidenze scientifiche circa i loro effetti per la salute è essenziale per prevenire ogni tossicodipendenza e promuovere strategie di salute e benessere psicofisico, anche conoscendo le forme di criminalità legata al traffico di stupefacenti e le azioni di contrasto esercitate dallo Stato. Rientra in questo nucleo pure l’educazione finanziaria e assicurativa e la pianificazione previdenziale, anche con riferimento
all’utilizzo delle nuove tecnologie digitali di gestione del denaro. In tale nucleo dovrà essere evidenziata l’importanza della tutela del risparmio. L’educazione finanziaria va intesa inoltre come momento per valorizzare e tutelare il patrimonio privato.
Alla “Cittadinanza digitale”, da intendersi come la capacità di un individuo di interagire consapevolmente e responsabilmente con gli sviluppi tecnologici in campo digitale, è dedicato l’intero articolo 5 della Legge che esplicita le abilità essenziali da sviluppare nei curricoli di Istituto, con gradualità e tenendo conto dell’età degli studenti.
Lo sviluppo impetuoso delle tecnologie digitali ha portato importanti e inedite possibilità di progresso e di benessere, ma ha anche trasformato, con incredibile velocità e con effetti difficilmente prevedibili, l’organizzazione sociale del nostro tempo. La dimensione “fisica”, tangibile, della vita si è ridotta: la maggior parte delle attività si svolge nello spazio digitale, dando luogo ad una produzione massiccia di dati che circolano, in modo incessante, attraverso la rete.
I più giovani, proprio perché più vulnerabili ed esposti, sono le “vittime” elettive quando si verifica un uso lesivo della rete, perché non sempre hanno gli strumenti per capire in modo adeguato i rischi a cui si espongono. Fondamentale, pertanto, e in linea con quanto indicato dall’articolo 5, comma 2 della Legge, è l’attività di responsabilizzazione e promozione di una reale cultura della “cittadinanza digitale”, attraverso cui insegnare agli studenti a valutare con attenzione ciò che di sé consegnano agli altri in rete.
Non si tratta però solamente di una questione di conoscenza e di utilizzo degli strumenti tecnologici, ma del tipo di approccio agli stessi; per questa ragione, affrontare l’educazione alla cittadinanza digitale non può che essere un impegno che coinvolge tutti i docenti contitolari della classe e del Consiglio di classe. Utile strumento di lavoro può essere il Quadro delle Competenze Digitali per i Cittadini – DigComp2.2 – recentemente tradotto in italiano, che fornisce esempi di conoscenze, abilità e atteggiamenti nel campo del digitale, anche con riferimento all’intelligenza artificiale, che può essere d’altro canto un utilissimo strumento per favorire la personalizzazione della didattica e degli apprendimenti. Particolare attenzione potrà essere riposta nell’aiutare gli studenti a valutare
criticamente dati e notizie in rete, individuando fonti attendibili e modalità di ricerca adeguate; allo stesso modo, potranno essere previsti approfondimenti in tema di privacy e tutela dei propri dati e identità personale, oltre ad adeguati focus che mirino a prevenire e contrastare attività di cyberbullismo. Infine, la rapida evoluzione tecnologica nel campo dell’Intelligenza Artificiale, riguardante tutti gli ambiti e temi finora menzionati, suggerisce adeguati approfondimenti in merito.
Sviluppare la cittadinanza digitale a scuola, con studenti che sono già immersi nel web e che quotidianamente si imbattono nelle tematiche proposte, significa da una parte consentire l’acquisizione di informazioni e competenze utili a migliorare questo nuovo e così radicato modo di stare nel mondo, dall’altra mettere i giovani al corrente dei rischi e delle insidie che l’ambiente digitale comporta, considerando anche le conseguenze sul piano concreto. Pertanto, l’approccio e l’approfondimento di questi temi dovrà iniziare dal primo ciclo di istruzione con opportune e diversificate strategie. Insomma, l’educazione all’uso responsabile dei dispositivi elettronici va di pari passo con la consapevolezza che l’utilizzo corretto delle tecnologie è quello che potenzia l’esercizio delle competenze individuali, non quello che lo sostituisce. In conformità con gli indirizzi ministeriali, occorre evitare l’utilizzo di smartphone e tablet nella scuola dell’infanzia e dello smartphone nella scuola primaria e secondaria di I grado; nelle scuole del primo ciclo di istruzione il tablet può essere utilizzato per finalità didattiche e inclusive.
I nuclei concettuali dell’insegnamento dell’Educazione Civica sono già impliciti nelle discipline previste nei curricoli dei diversi percorsi scolastici. Per fare solo alcuni esempi, “l’educazione ambientale, sviluppo ecosostenibile e tutela del patrimonio ambientale, delle identità, delle produzioni e delle eccellenze territoriali e agroalimentari” trovano una naturale interconnessione, tra le altre, con le Scienze naturali e con la Geografia; l’educazione alla legalità e al contrasto alle mafie si nutre non solo della conoscenza del dettato e dei valori costituzionali, ma anche della consapevolezza dei diritti inalienabili dell’uomo e del cittadino, del loro progredire storico, del dibattito filosofico e letterario. Le tematiche connesse alla cittadinanza digitale afferiscono alle competenze digitali e a tutte le
discipline, in particolare l’italiano, la matematica, la tecnologia e l’informatica. Si tratta dunque di far emergere all’interno dei curricoli di istituto elementi già presenti negli attuali ordinamenti e di rendere più consapevole ed esplicita la loro interconnessione, nel rispetto e in coerenza con i processi di crescita dei bambini e dei ragazzi nei diversi gradi di scuola.
La trasversalità dell’insegnamento si esprime, quindi, nella capacità di dare senso e significato a ogni contenuto disciplinare. I saperi hanno lo scopo di fornire agli allievi strumenti per sviluppare conoscenze, abilità e competenze per essere persone e cittadini autonomi e responsabili, rispettosi di sé, degli altri e del bene comune. Il Collegio dei Docenti e le sue articolazioni, nonché i team docenti e i consigli di classe, nella predisposizione del curricolo e nella sua pianificazione organizzativa, individuano le conoscenze e le abilità necessarie a perseguire i traguardi di competenza fissati dalle Linee Guida, attingendo anche dagli obiettivi specifici in esse contenuti. Possono, in sede di pianificazione, essere individuati percorsi didattici, problemi, situazioni, esperienze anche laboratoriali idonei ad aggregare più insegnamenti/discipline e che richiedano la specifica trattazione di argomenti propri dell’Educazione Civica. È fondamentale che le tematiche trattate siano sempre coerenti e integrate nel curricolo e siano funzionali allo sviluppo delle conoscenze, abilità e competenze previste nei traguardi per lo sviluppo delle competenze dalle Indicazioni Nazionali per il primo ciclo, dalle Linee Guida degli Istituti tecnici e professionali e dalle Indicazioni per i Licei.
La trattazione interdisciplinare deve in ogni caso salvaguardare, con l’opportuna progressività connessa all’età degli allievi, la conoscenza della Costituzione, degli ordinamenti dello Stato e dell’Unione Europea, dell’organizzazione amministrativa decentrata e delle autonomie territoriali e locali.
Riveste particolare importanza nell’insegnamento dell’Educazione Civica l’approccio metodologico, al fine di consentire agli allievi di sviluppare autentiche competenze civiche, capacità di partecipazione, cittadinanza attiva, rispetto delle regole condivise e del bene comune, attenzione alla salvaguardia dell’ambiente e delle risorse, pensiero critico e capacità di preservare salute, benessere e sicurezza nel mondo fisico e in quello virtuale. Il tema della Costituzione, pri-
mario e fondante, non può esaurirsi nel proporre la lettura e la memorizzazione di una serie di articoli e neanche nella conoscenza, pure necessaria e imprescindibile, dell’ordinamento e dell’organizzazione dello Stato, degli Organismi territoriali, delle Organizzazioni sovranazionali e internazionali.
L’etica nell’uso del digitale non è legata solo alle abilità tecniche e alla conoscenza dei potenziali rischi nell’utilizzo dei dispositivi e della rete.
Lo sviluppo di autentiche e stabili abilità e competenze civiche si consegue in un ambiente di apprendimento dove prima di tutto gli adulti sono modelli coerenti di comportamento, dove l’organizzazione dei tempi, degli spazi e delle attività consente la discussione, il confronto reciproco, la collaborazione, la cooperazione e l’esperienza diretta.
Occasioni di esercizio della corretta convivenza e della democrazia devono essere presenti fin dai primi anni nella quotidianità della vita scolastica, attraverso l’abitudine al corretto uso degli spazi e delle attrezzature comuni, l’osservanza di comportamenti rispettosi della salute e della sicurezza propria e altrui, la cura di relazioni improntate al rispetto verso il prossimo, verso gli adulti, e verso i coetanei, l’assunzione di responsabilità verso i propri impegni scolastici, la cura di altri compagni, di cose e animali, la partecipazione alla definizione di regole nel gioco, nello sport, nella vita di classe e di scuola, l’assunzione di ruoli di rappresentanza. L’attitudine alla convivenza democratica si sviluppa, infatti, in ambienti che consentono l’esercizio di comportamenti autonomi e responsabili. Le conoscenze e le abilità connesse all’Educazione Civica trovano stabilità e concretezza in modalità laboratoriali, di ricerca, in gruppi di lavoro collaborativi, nell’applicazione in compiti che trovano riscontro nell’esperienza, nella vita quotidiana, nella cronaca.
Il laboratorio, la ricerca, il gruppo collaborativo, la riflessione, la discussione, il dibattito intorno a temi significativi, le testimonianze autorevoli, le visite e le uscite sul territorio, le attività di cura e di responsabilità come il service learning, i progetti orientati al servizio nella comunità, alla salvaguardia dell’ambiente e delle risorse, alla cura del patrimonio artistico, culturale, paesaggistico, gli approcci sperimentali nelle scienze sono tutte attività concrete, da inserire organicamente nel curricolo, che possono permettere agli studenti non solo di “applicare” conoscenze e abilità, ma anche di costruirne di nuove e di sviluppare competenze.
In un ambiente di apprendimento così organizzato, anche l’utilizzo responsabile e consapevole dei dispositivi digitali riveste importanza primaria per la ricerca, l’assunzione critica, la condivisione e lo scambio di informazioni attendibili da fonti autorevoli, con l’attenzione alla sicurezza dei dati, alla riservatezza e al rispetto delle persone.
L’affidamento agli studenti di occasioni di costruzione attiva e autonoma di apprendimento, in contesti di collaborazione, costituisce la modalità necessaria per il conseguimento di conoscenze e abilità stabili e consolidate e di competenze culturali, metodologiche, sociali, relazionali e di cittadinanza.
La contitolarità dell’insegnamento e il coordinamento delle attività
La Legge prevede che all’insegnamento dell’Educazione Civica siano dedicate non meno di 33 ore per ciascun anno scolastico.
Nelle scuole del primo ciclo l’insegnamento è affidato, in contitolarità, a docenti della classe/del consiglio di classe, tra i quali è individuato un coordinatore. Nelle scuole del secondo ciclo, l’insegnamento è affidato ai docenti delle discipline giuridiche ed economiche, se disponibili nell’ambito dell’organico dell’autonomia. In caso contrario, in analogia a quanto previsto per il primo ciclo, l’insegnamento è affidato in contitolarità ai docenti del consiglio di classe. In ogni caso, anche laddove la titolarità dell’insegnamento venga attribuita a un insegnante di materie giuridiche ed economiche, gli obiettivi di apprendimento vanno perseguiti attraverso la più ampia collaborazione tra tutti i docenti, valorizzando la trasversalità del curricolo. Nell’arco delle 33 ore annuali i docenti potranno proporre attività che sviluppino con sistematicità conoscenze, abilità e competenze relative all’educazione alla cittadinanza, all’educazione alla salute e al benessere psicofisico e al contrasto delle dipendenze, all’educazione ambientale, all’educazione finanziaria, all’educazione stradale, all’educazione digitale e all’educazione al rispetto e ai nuclei fondamentali che saranno oggetto di ulteriore approfondimento, di riflessione e ricerca in unità didattiche di singoli docenti e in unità di apprendimento e moduli interdisciplinari trasversali condivisi da più docenti. Si potranno così offrire agli allievi gli strumenti indispensabili per affrontare le questioni e i problemi in modo trasversale al curricolo, favorendo un dialogo interdisciplinare e realizzando la prospettiva educativa che rappresenta l’autentica sfida dell’insegnamento dell’Educazione Civica.
Inoltre, le Linee guida offrono l’opportunità di leggere e interpretare tutto il curricolo della scuola con riferimento ai principi e ai nuclei fondanti previsti per l’insegnamento dell’Educazione Civica, dal momento che ogni sapere potrà essere orientato ad azioni finalizzate all’esercizio di diritti e doveri, al bene comune, all’ulteriore sviluppo della conoscenza e alla salvaguardia dei patrimoni materiali e immateriali delle comunità. Tale prospettiva richiede la messa a punto di percorsi didattici che, per tutte le discipline, prevedano l’aspetto civico degli argomenti trattati.
La Legge dispone che l’insegnamento trasversale dell’Educazione Civica sia oggetto delle valutazioni periodiche e finali previste dal D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 62 per il primo ciclo e dal D.P.R. 22 giugno 2009, n. 122 per il secondo ciclo. I criteri di valutazione deliberati dal Collegio dei docenti per le singole discipline e già inseriti nel PTOF dovranno essere integrati in modo da ricomprendere anche la valutazione di tale insegnamento.
In sede di scrutinio il docente coordinatore dell’insegnamento, acquisendo elementi conoscitivi dai docenti del team o del Consiglio di Classe, formula la proposta di valutazione, espressa ai sensi della normativa vigente, da inserire nel documento di valutazione.
La valutazione deve essere coerente con le competenze, abilità e conoscenze indicate nel curricolo dell’Educazione Civica e affrontate durante l’attività didattica. I docenti della classe e il consiglio di classe possono avvalersi di strumenti condivisi, quali rubriche e griglie di osservazione, finalizzati ad accertare il conseguimento da parte degli alunni delle conoscenze e abilità e del progressivo sviluppo delle competenze previste nella sezione del curricolo dedicata all’Educazione Civica.
Anche per l’Educazione Civica il Collegio dei docenti delle scuole del primo ciclo, in coerenza con il disposto dell’art. 2 del D. Lgs. 62/2017, esplicita a quale livello di apprendimento corrisponde il voto in decimi attribuito agli alunni della scuola secondaria di primo grado. Per gli alunni della scuola primaria, la valutazione avverrà in base alla normativa in vigore nell’anno scolastico di riferimento.
L’Educazione Civica per il primo e per il secondo ciclo di istruzione: traguardi per lo sviluppo delle competenze e obiettivi di apprendimento
Le Linee guida individuano traguardi per lo sviluppo delle competenze e obiettivi di apprendimento dell’Educazione Civica, da perseguire progressivamente a partire dalla scuola primaria e da conseguire entro il termine del secondo ciclo di istruzione.
I traguardi per lo sviluppo delle competenze e gli obiettivi di apprendimento delineano i risultati attesi in termini di competenze rispetto alle finalità e alle previsioni della Legge e sono raggruppati tenendo a riferimento i tre nuclei concettuali: Costituzione, Sviluppo economico e sostenibilità, Cittadinanza digitale.
Per il primo ciclo di istruzione, gli obiettivi di apprendimento rappresentano la declinazione dei traguardi per lo sviluppo delle competenze e sono distinti per la scuola primaria e secondaria di primo grado.
Per il secondo ciclo, le competenze sono declinate in obiettivi di apprendimento che possono ulteriormente essere graduati dai consigli di classe per anno di corso e possono essere realizzati attraverso una didattica per moduli, unità di apprendimento, sillabi coerenti con l’età degli studenti, il curricolo specifico del corso e la sua progressione nelle diverse annualità.
Nei corsi di istruzione per gli adulti di primo e secondo livello istituiti a norma del D.P.R. 29 ottobre 2012, n. 263, i traguardi, le competenze e gli obiettivi sono perseguiti attraverso percorsi che tengono conto delle Linee Guida di cui al D.M. 12 marzo 2015 e dei patti formativi individuali sottoscritti con gli studenti. Gli obiettivi comprendono conoscenze e abilità ritenute funzionali allo sviluppo dei traguardi e delle competenze e concorrono a sviluppare gradualmente le otto competenze chiave per l’apprendimento permanente.
Primo ciclo di istruzione
Nucleo concettuale: COSTITUZIONE
Traguardo per lo sviluppo delle competenze n. 1
Sviluppare atteggiamenti e adottare comportamenti fondati sul rispetto di ogni persona, sulla responsabilità individuale, sulla legalità, sulla consapevolezza della appartenenza ad una comunità, sulla partecipazione e sulla solidarietà, sostenuti dalla conoscenza della Carta costituzionale, della Carta dei Diritti fondamentali dell’Unione Europea e della Dichiarazione Internazionale dei Diritti umani.
Obiettivi di apprendimento
• Conoscere i principi fondamentali della Costituzione e saperne individuare le implicazioni nella vita quotidiana e nelle relazioni con gli altri.
• Individuare i diritti e i doveri che interessano la vita quotidiana di tutti i cittadini, anche dei più piccoli.
• Condividere regole comunemente accettate.
• Sviluppare la consapevolezza dell’appartenenza ad una comunità locale, nazionale ed europea.
• Rispettare ogni persona, secondo il principio di uguaglianza e di non discriminazione di cui all’articolo 3 della Costituzione.
• Riconoscere, evitare e contrastare forme di violenza e bullismo presenti nella comunità scolastica.
• Curare gli ambienti, rispettare i beni pubblici e privati così come le forme di vita (piante, animali) che sono state affidate alla responsabilità delle classi.
Traguardo per lo sviluppo delle competenze n. 2
Interagire correttamente con le istituzioni nella vita quotidiana, nella partecipazione e nell’esercizio della cittadinanza attiva, a partire dalla conoscenza dell’organizzazione e delle funzioni dello Stato, dell’Unione europea, degli organismi internazionali, delle Regioni e delle Autonomie locali. Essere consapevoli dell’appartenenza ad una comunità, locale e nazionale. Obiettivi di apprendimento
• Conoscere l’ubicazione della sede comunale, gli organi e i servizi principali del Comune, le principali funzioni del Sindaco e della Giunta comunale, i principali servizi pubblici del proprio territorio e le loro funzioni essenziali.
• Conoscere gli Organi principali dello Stato (Presidente della Repubblica, Camera dei deputati e Senato della Repubblica e loro Presidenti, Governo, Magistratura) e le funzioni essenziali.
• Conoscere la storia della comunità locale, nazionale ed europea a partire dagli stemmi, dalle bandiere e dagli inni.
• Conoscere il valore e il significato dell’appartenenza alla comunità nazionale.
• Conoscere il significato di Patria.
• Conoscere l’Unione Europea e l’ONU.
• Conoscere il contenuto generale delle Dichiarazioni Internazionali dei diritti della persona e dell’infanzia.
• Individuare alcuni dei diritti previsti nell’ambito della propria esperienza concreta.
Traguardo per lo sviluppo delle competenze n. 3
Rispettare le regole e le norme che governano la democrazia, la convivenza sociale e la vita quotidiana in famiglia, a scuola, nella comunità, al fine di comunicare e rapportarsi correttamente con gli altri, esercitare consapevolmente i propri diritti e doveri per contribuire al bene comune e al rispetto dei diritti delle persone.
Obiettivi di apprendimento
• Conoscere ed applicare le regole vigenti in classe e nei vari ambienti della scuola (mensa, palestra, laboratori, cortili) e partecipare alla loro eventuale definizione o revisione.
• Conoscere il principio di uguaglianza nella consapevolezza che le differenze possono rappresentare un valore quando non si trasformano in discriminazioni.
• Conoscere i principali fattori di rischio dell’ambiente scolastico, adottare comportamenti idonei a salvaguardare la salute e la sicurezza proprie e altrui e contribuire a definire comportamenti di prevenzione dei rischi.
• Conoscere e applicare le principali norme di circolazione stradale.
Traguardo per lo sviluppo delle competenze n. 4
Sviluppare atteggiamenti e comportamenti responsabili volti alla tutela della salute e del benessere psicofisico.
Obiettivi di apprendimento
• Conoscere e attuare le principali regole per la cura della salute, della sicurezza e del benessere proprio e altrui, a casa, a scuola, nella comunità, dal punto di vista igienico-sanitario, alimentare, motorio, comportamentale.
• Conoscere i rischi e gli effetti dannosi delle droghe.
Traguardo per lo sviluppo delle competenze n. 5
Comprendere l’importanza della crescita economica e del lavoro. Conoscere le cause dello sviluppo economico e sociale in Italia ed in Europa, le diverse attività economiche. Sviluppare atteggiamenti e comportamenti responsabili volti alla tutela dell’ambiente, del decoro urbano, degli ecosistemi e delle risorse naturali per una crescita economica rispettosa dell’ambiente e per la tutela della qualità della vita.
Obiettivi di apprendimento
• Conoscere le condizioni della crescita economica. Comprenderne l’importanza per il miglioramento della qualità della vita e ai fini della lotta alla povertà.
• Individuare, con riferimento alla propria esperienza, ruoli, funzioni e aspetti essenziali che riguardano il lavoro delle persone con cui si entra in relazione, nella comunità scolastica e nella vita privata.
• Riconoscere il valore del lavoro.
• Conoscere, attraverso semplici ricerche, alcuni elementi dello sviluppo economico in Italia ed in Europa.
• Riconoscere, a partire dagli ecosistemi del proprio territorio, le trasformazioni ambientali ed urbane dovute alle azioni dell’uomo; mettere in atto comportamenti alla propria portata che riducano l’impatto negativo delle attività quotidiane sull’ambiente e sul decoro urbano.
• Individuare nel proprio territorio le strutture che tutelano i beni artistici, culturali e ambientali e proteggono gli animali, e conoscerne i principali servizi.
• Analizzare, attraverso l’esplorazione e la ricerca all’interno del proprio comune, la qualità degli spazi verdi, e dei trasporti, il ciclo dei rifiuti, la salubrità dei luoghi pubblici.
Traguardo per lo sviluppo delle competenze n 6
Comprendere le cause dei cambiamenti climatici, gli effetti sull’ambiente e i rischi legati all’azione dell’uomo sul territorio. Comprendere l’azione della Protezione civile nella prevenzione dei rischi ambientali.
Obiettivi di apprendimento
• Conoscere ed attuare i comportamenti adeguati a varie condizioni di rischio (sismico, vulcanico, idrogeologico, climatico, …) anche in collaborazione con la Protezione civile.
• Individuare alcune trasformazioni ambientali e gli effetti del cambiamento climatico.
Traguardo per lo sviluppo delle competenze n. 7
Maturare scelte e condotte di tutela dei beni materiali e immateriali.
Obiettivi di apprendimento
• Identificare nel proprio ambiente di vita gli elementi che costituiscono il patrimonio artistico e culturale, materiale e immateriale, anche con riferimento alle tradizioni locali, ipotizzando semplici azioni per la salvaguardia e la valorizzazione.
• Riconoscere, con riferimento all’esperienza, che alcune risorse naturali (acqua, alimenti…) sono limitate e ipotizzare comportamenti di uso responsabile, mettendo in atto quelli alla propria portata.
Traguardo per lo sviluppo delle competenze n. 8
Maturare scelte e condotte di tutela del risparmio e assicurativa nonché di pianificazione di percorsi previdenziali e di utilizzo responsabile delle risorse finanziarie.
Obiettivi di apprendimento
• Conoscere e spiegare il valore, la funzione e le semplici regole di uso del denaro nella vita quotidiana. Gestire e amministrare piccole disponibilità economiche, ideando semplici piani di spesa e di risparmio, individuando alcune forme di pagamento e di accantonamento.
• Individuare e applicare nell’esperienza e in contesti quotidiani, i concetti economici di spesa, guadagno, ricavo, risparmio.
• Riconoscere l’importanza e la funzione del denaro.
Traguardo per lo sviluppo delle competenze n. 9
Maturare scelte e condotte di contrasto all’illegalità.
Obiettivi di apprendimento
• Conoscere le varie forme di criminalità, partendo dal rispetto delle regole che ogni comunità si dà per garantire la convivenza. Conoscere la storia dei vari fenomeni mafiosi, nonché riflettere sulle misure di contrasto.
• Conoscere il valore della legalità.
Traguardo per lo sviluppo delle competenze n. 10
Sviluppare la capacità di accedere alle informazioni, alle fonti, ai contenuti digitali, in modo critico, responsabile e consapevole.
Obiettivi di apprendimento
• Ricercare in rete semplici informazioni, distinguendo dati veri e falsi.
• Utilizzare le tecnologie per elaborare semplici prodotti digitali.
• Riconoscere semplici fonti di informazioni digitali.
Traguardo per lo sviluppo delle competenze n. 11
Interagire con gli altri attraverso le tecnologie digitali consentite, individuando forme di comunicazione adeguate ai diversi contesti di relazione, adottando e rispettando le regole comportamentali proprie di ciascun contesto comunicativo.
Obiettivi di apprendimento
• Interagire con strumenti di comunicazione digitale, quali tablet e computer.
• Conoscere e applicare semplici regole per l’utilizzo corretto di strumenti di comunicazione digitale, quali tablet e computer.
• Conoscere e applicare le principali regole di partecipazione alle classi virtuali e alle piattaforme didattiche.
Traguardo per lo sviluppo delle competenze n. 12
Gestire l’identità digitale e i dati della rete, salvaguardando la propria e altrui sicurezza negli ambienti digitali, evitando minacce per la salute e il benessere fisico e psicologico di sé e degli altri.
Obiettivi di apprendimento
• Conoscere il significato di identità e di informazioni personali in semplici contesti digitali di uso quotidiano.
• Conoscere i rischi connessi con l’utilizzo degli strumenti digitali in termini di sicurezza personale.
• Conoscere semplici modalità per evitare rischi per la salute e minacce al benessere psico-fisico quando si utilizzano le tecnologie digitali. Riconoscere, evitare e contrastare le varie forme di bullismo e cyberbullismo.

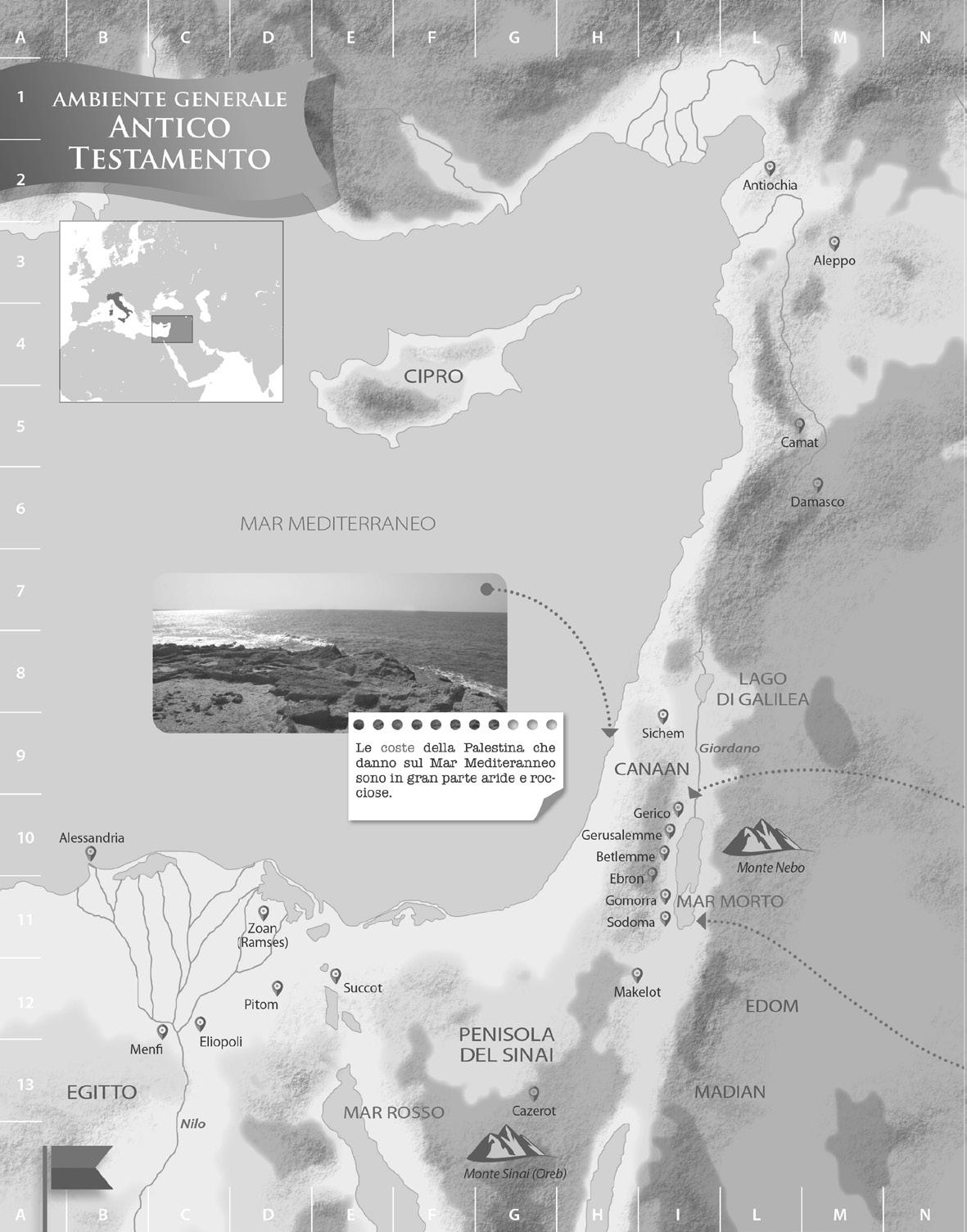
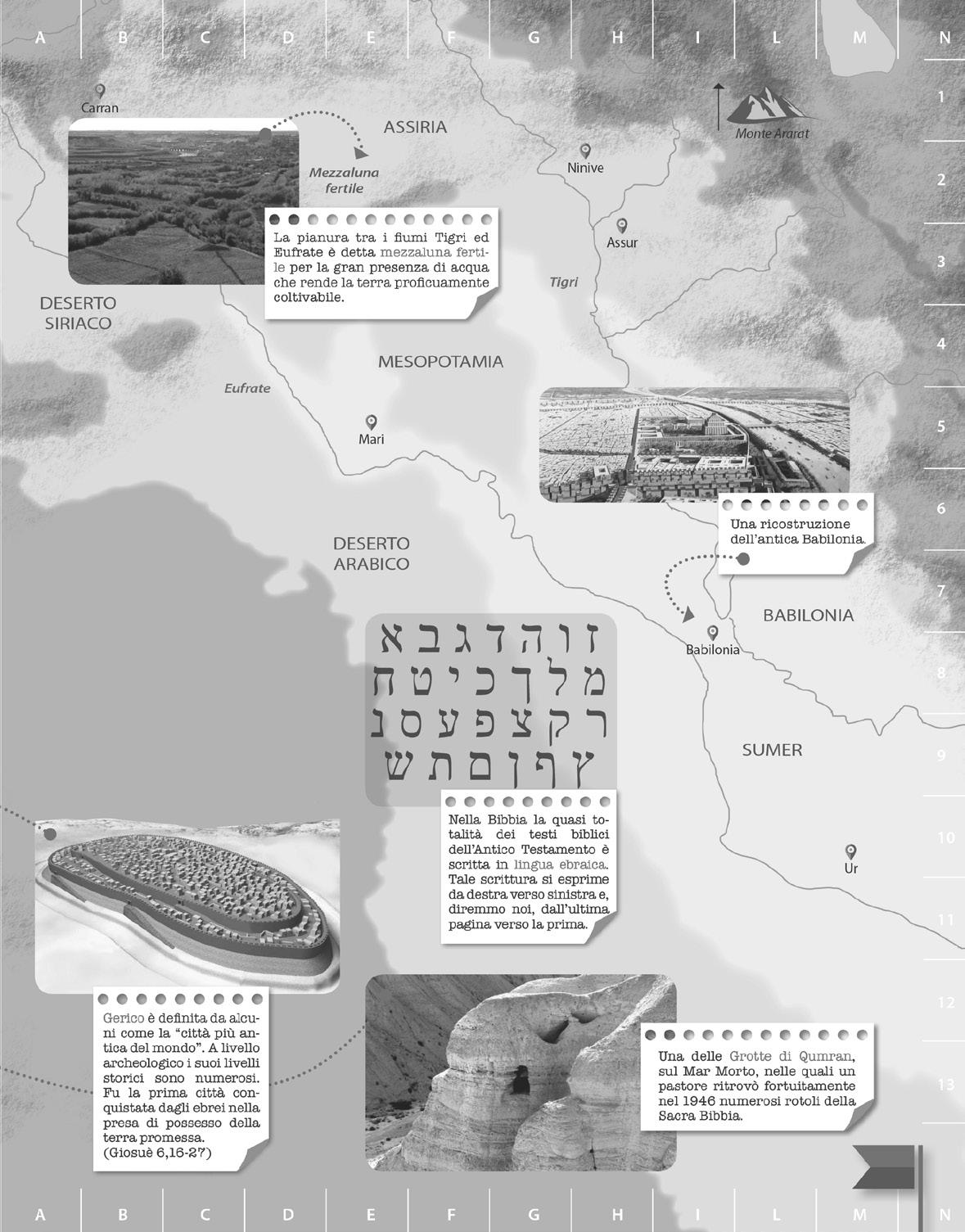
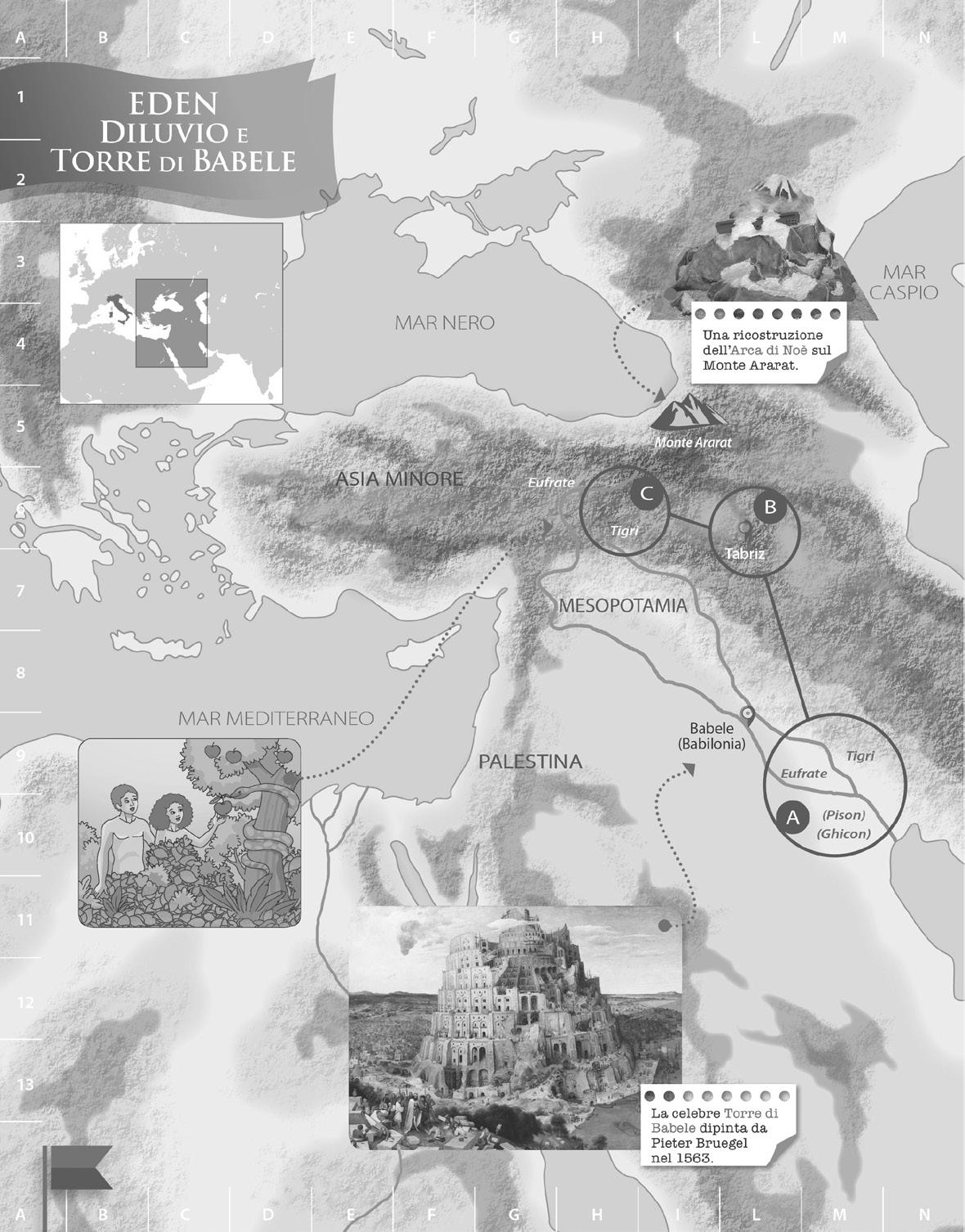
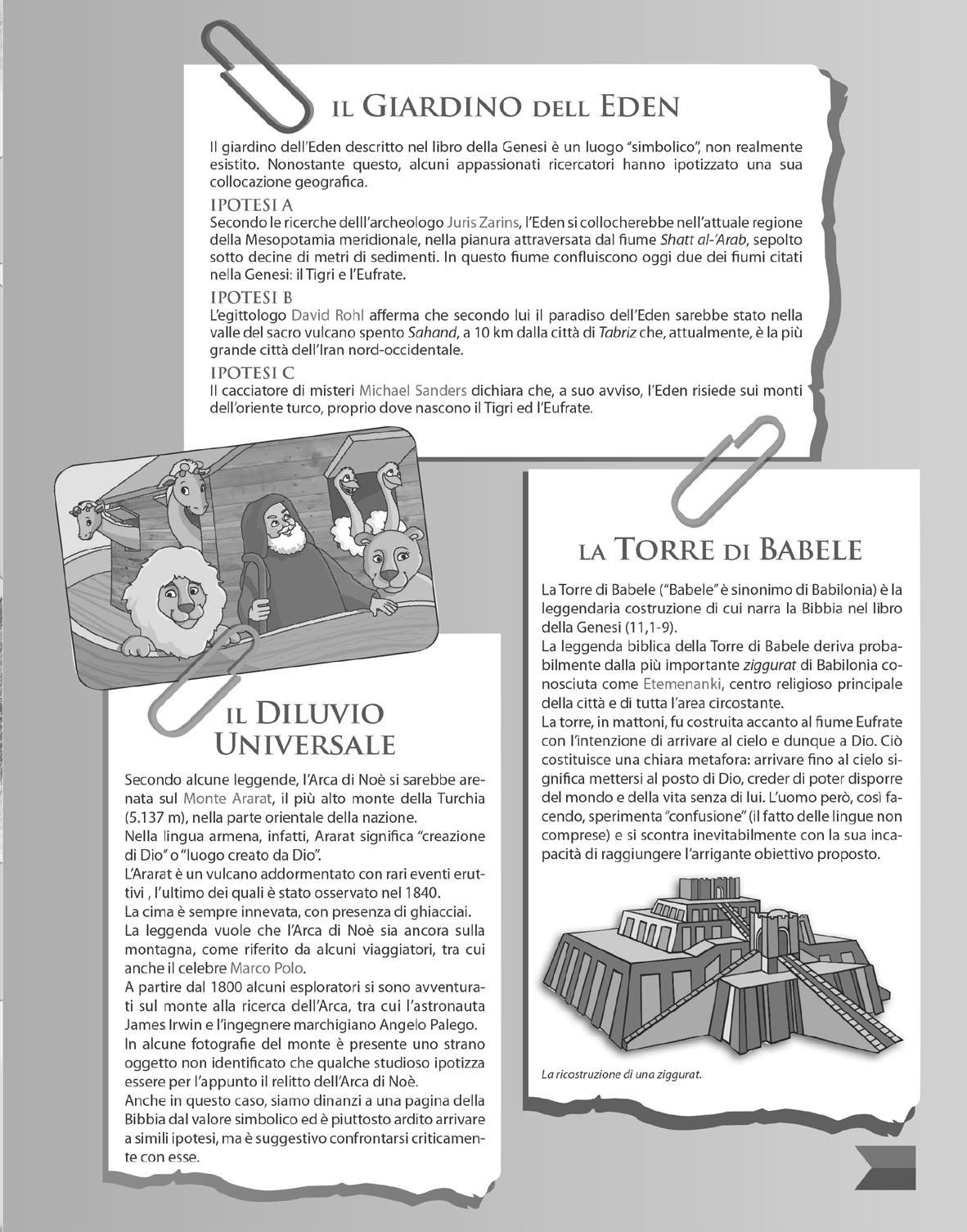
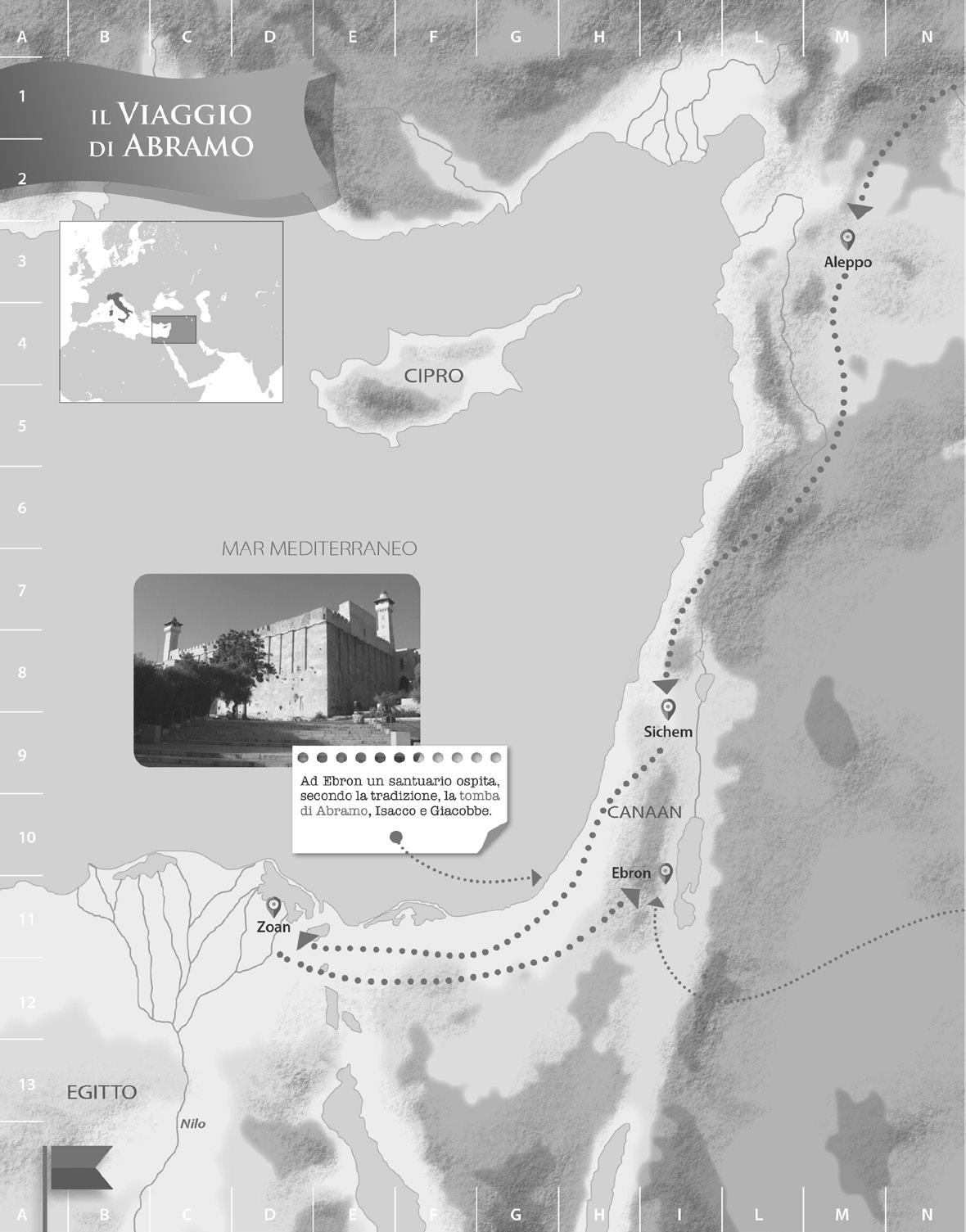
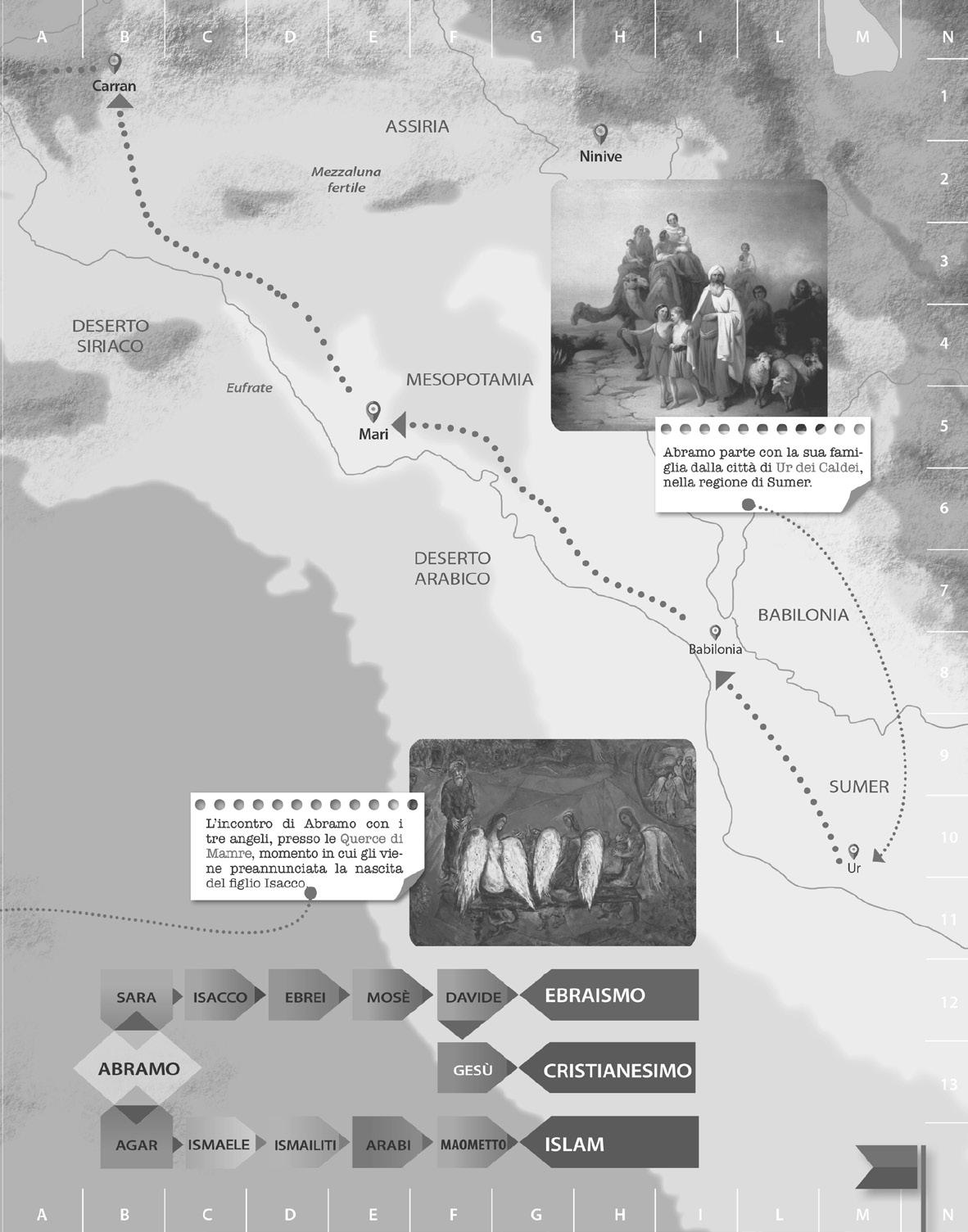
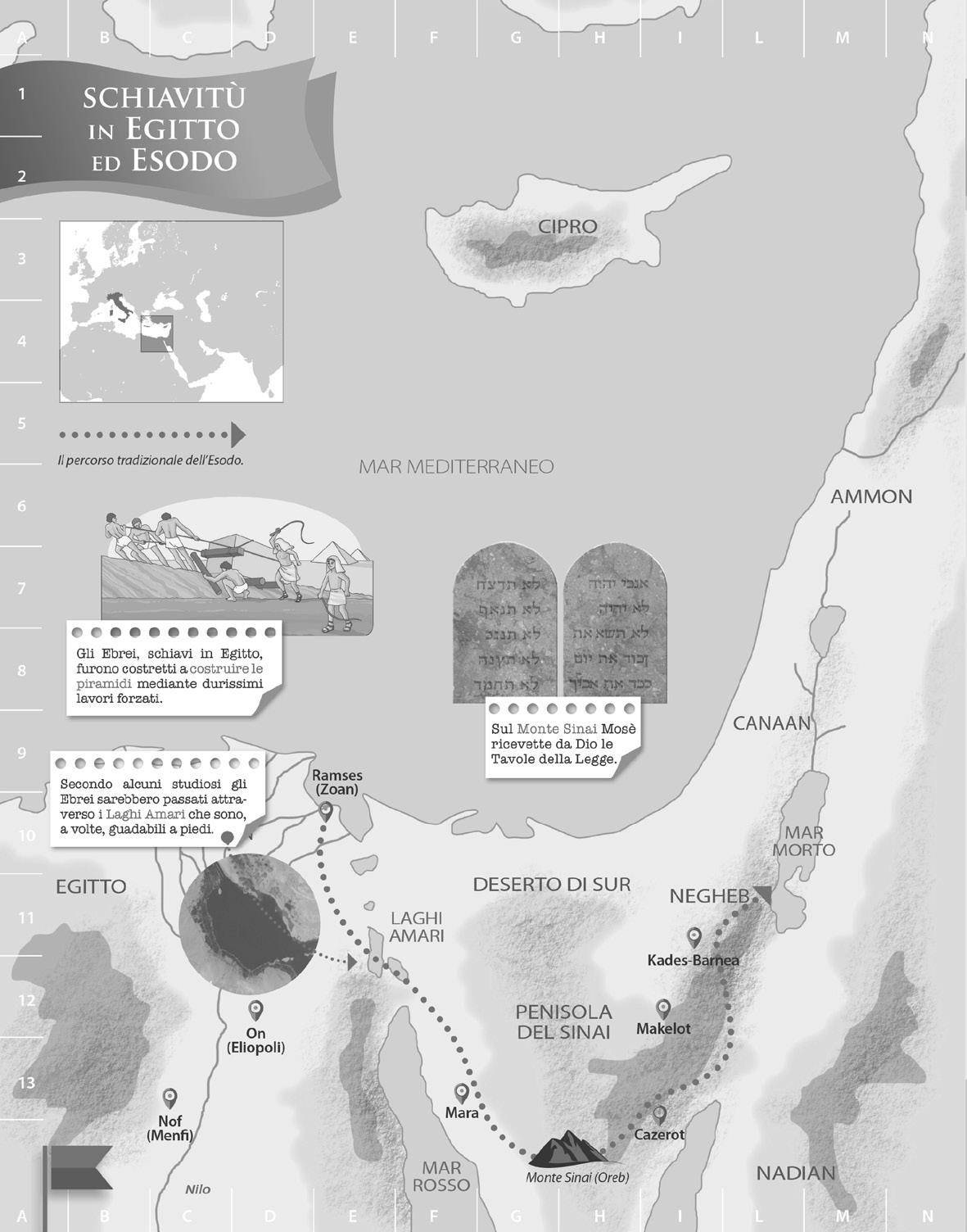

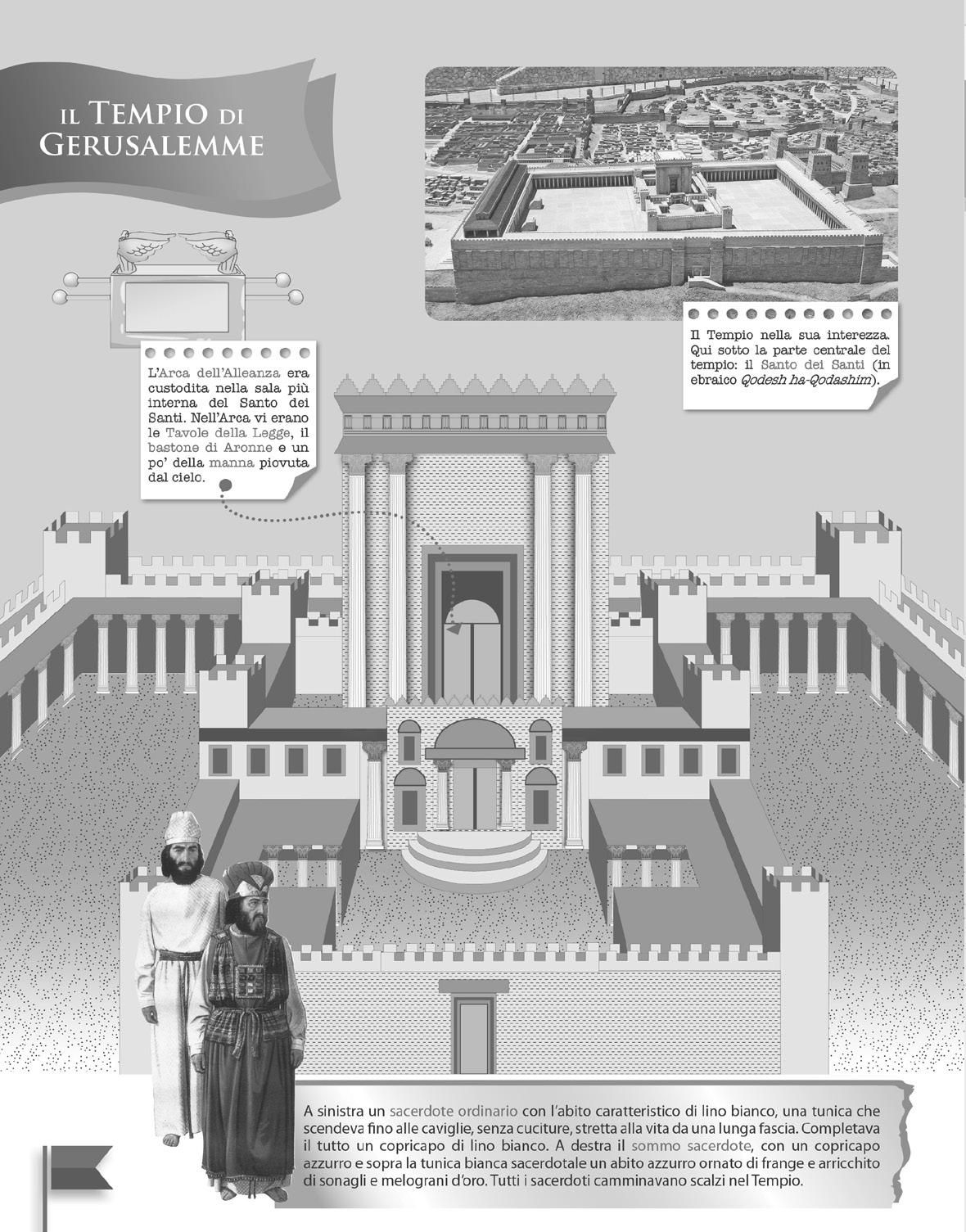
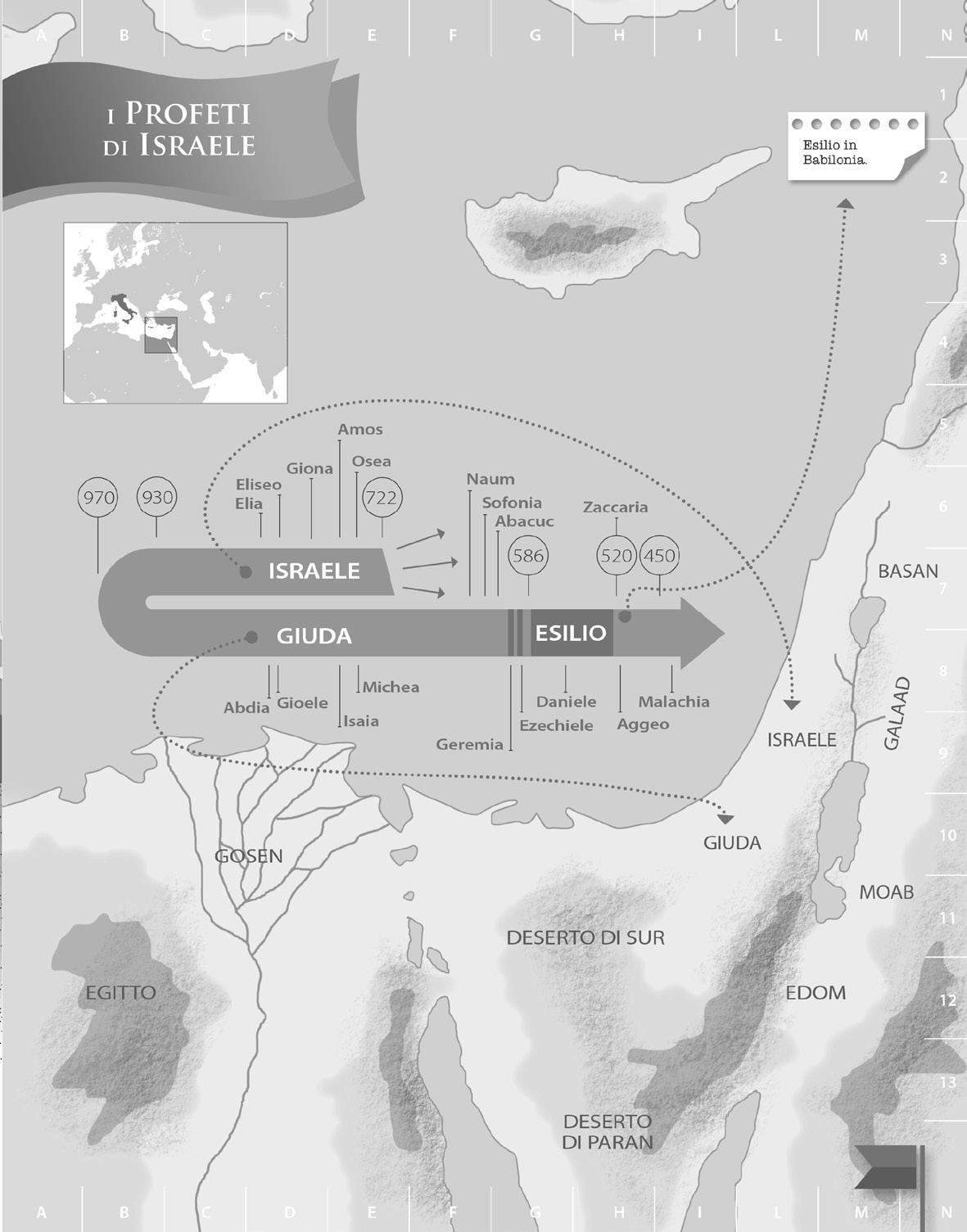

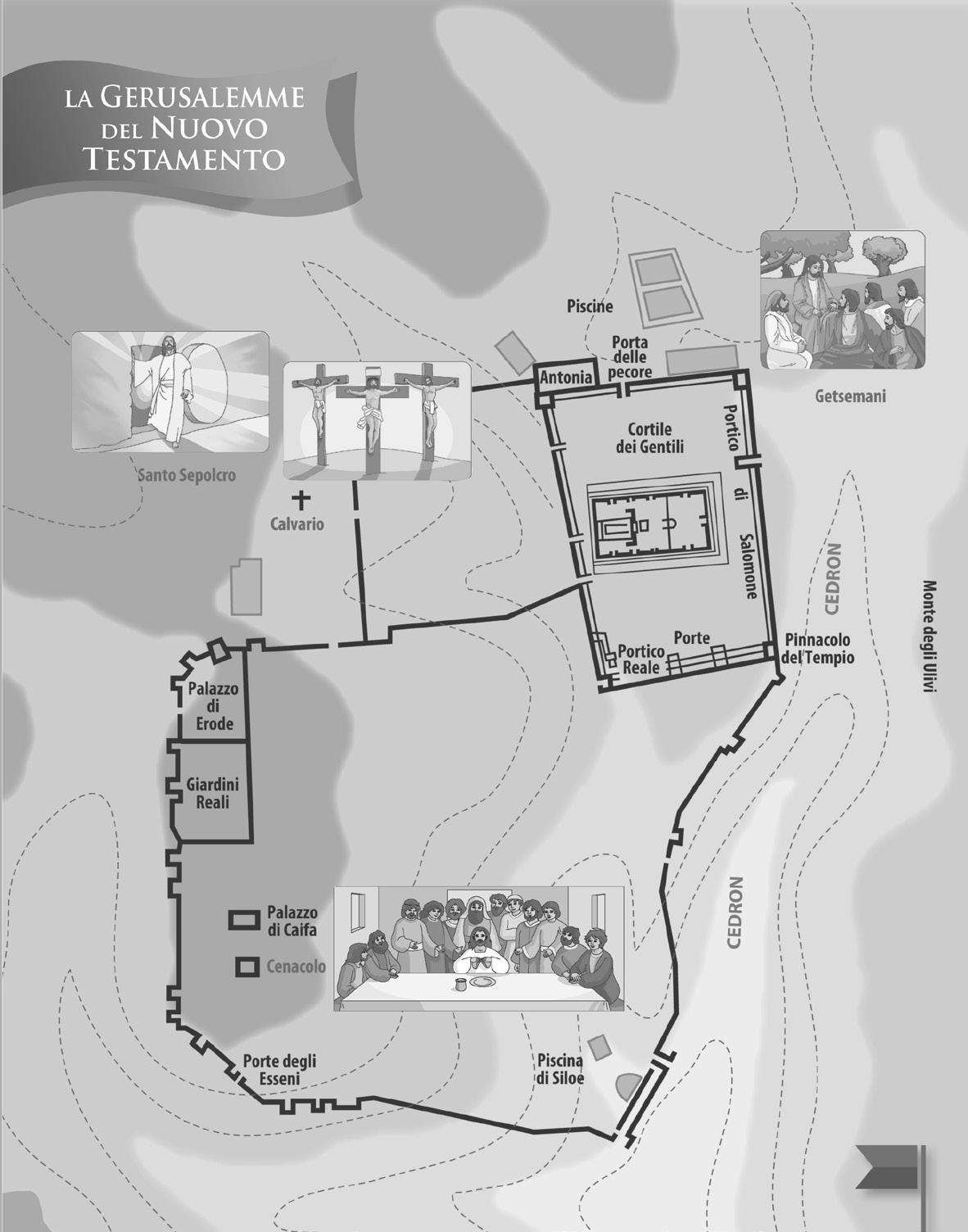
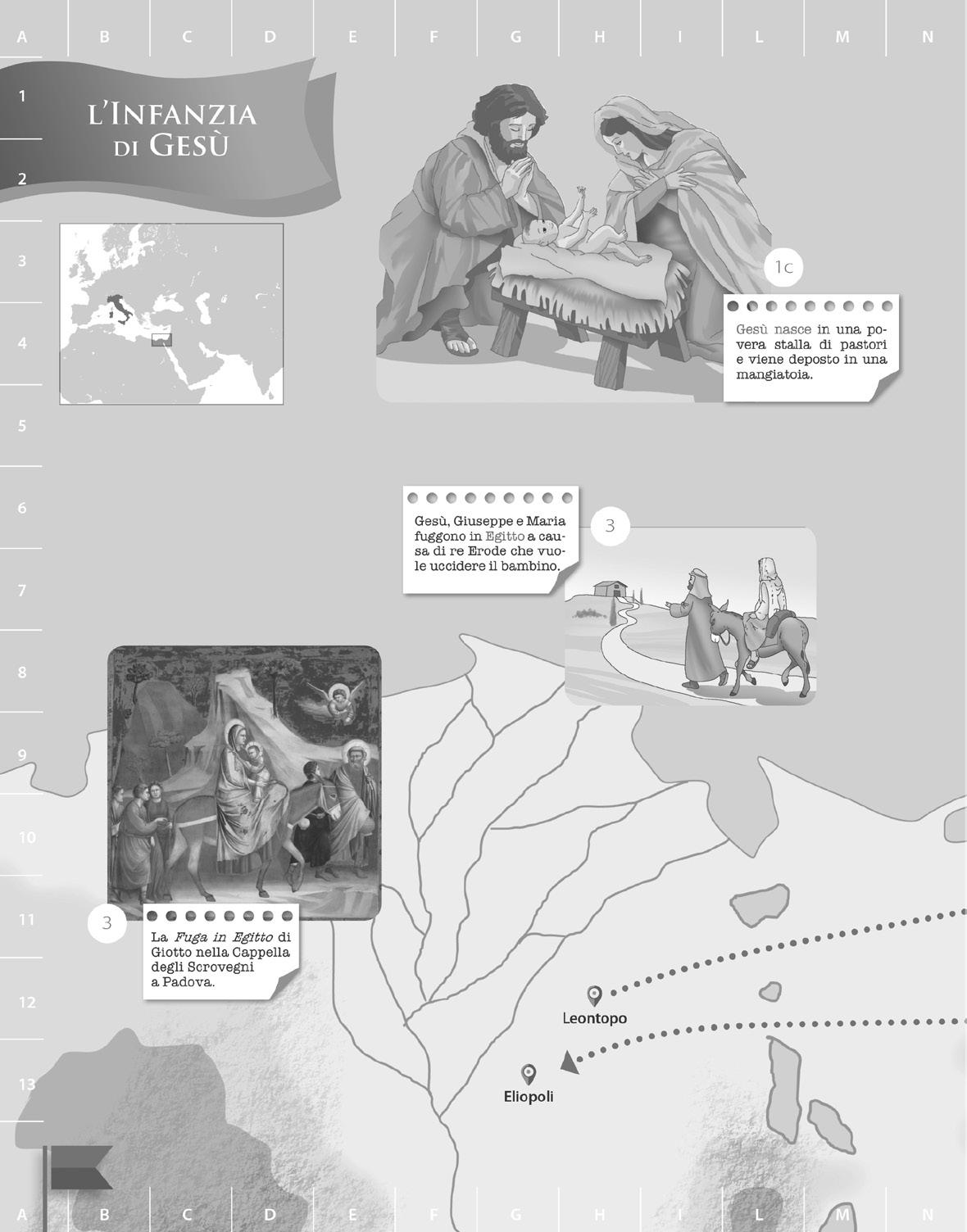
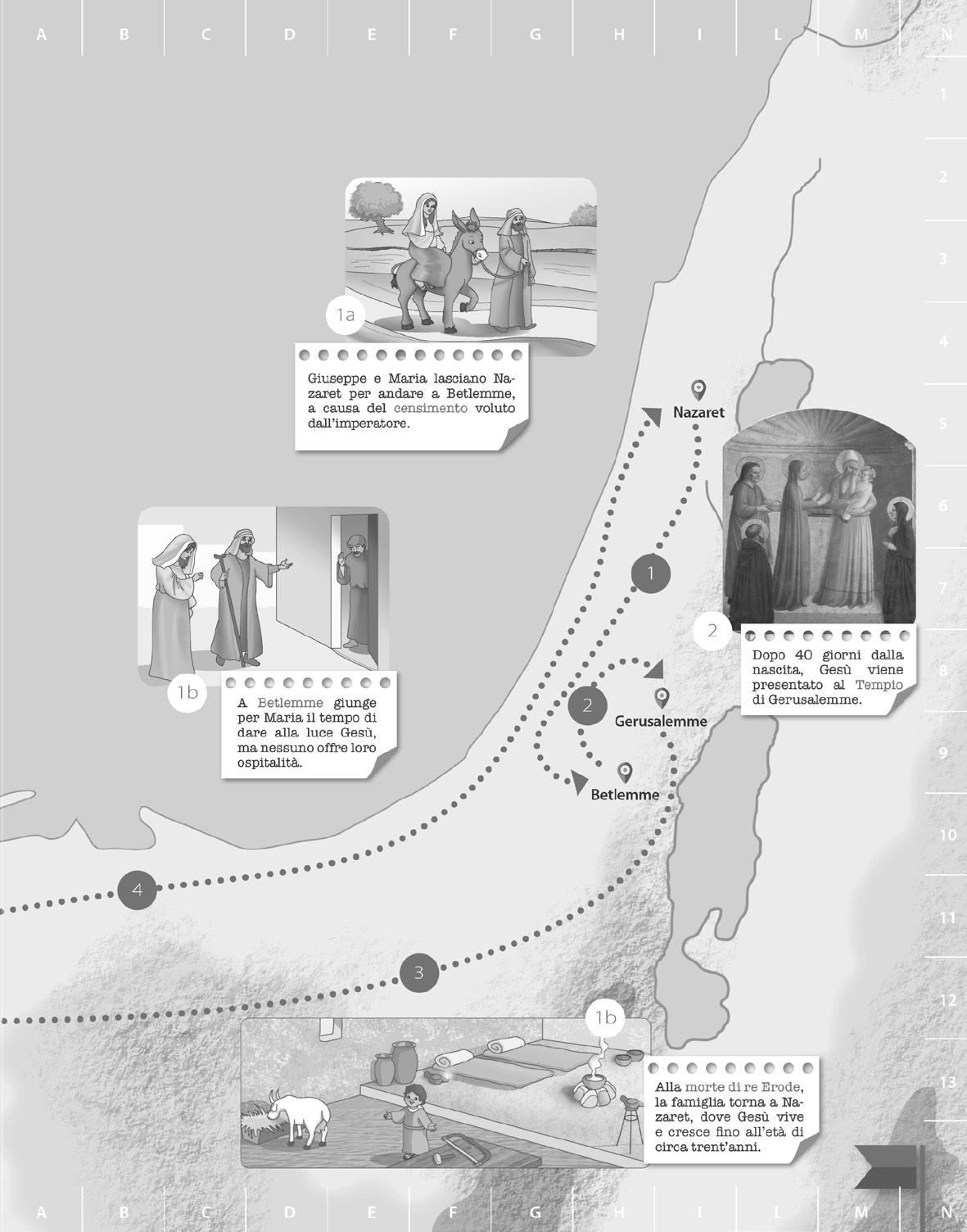
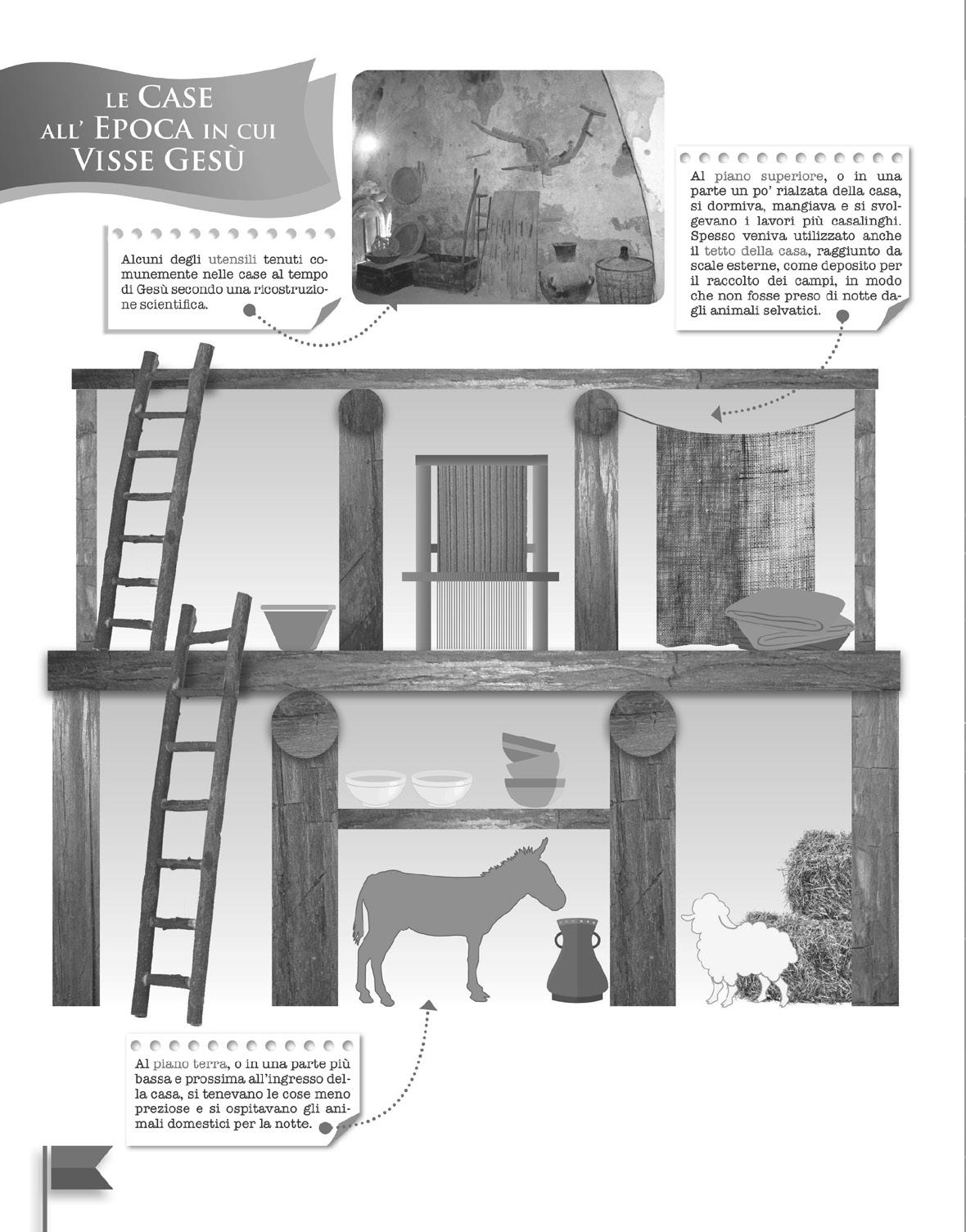
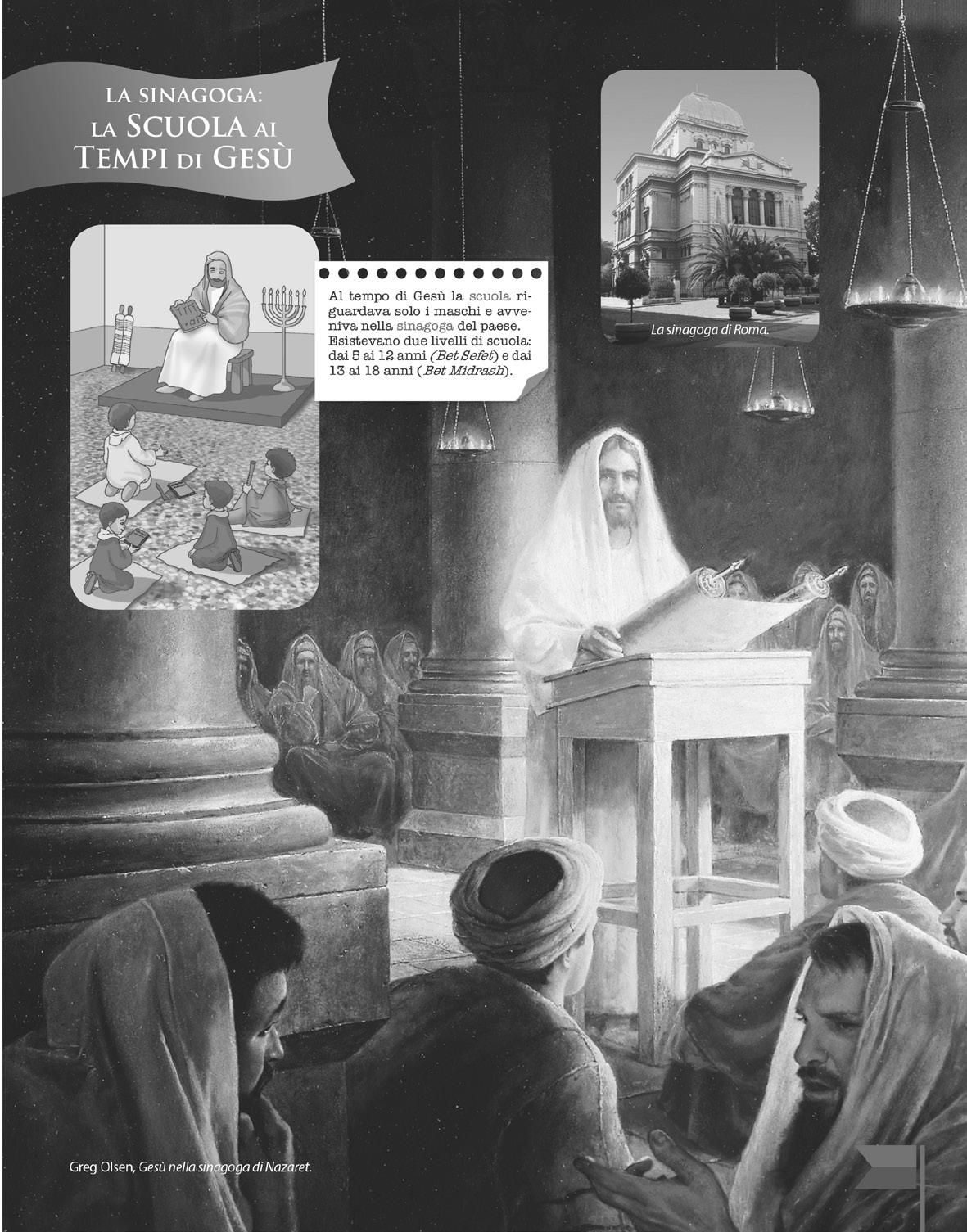
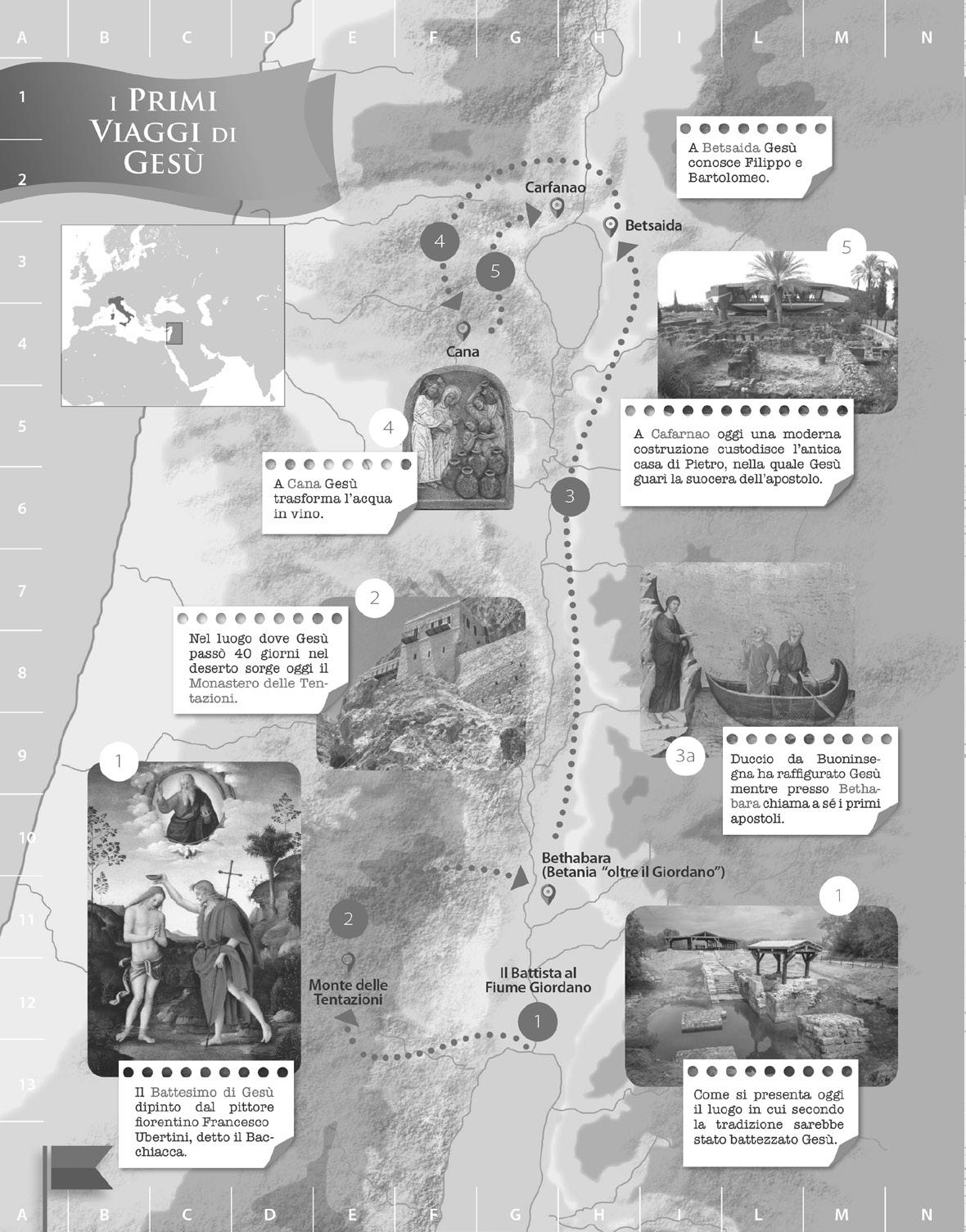
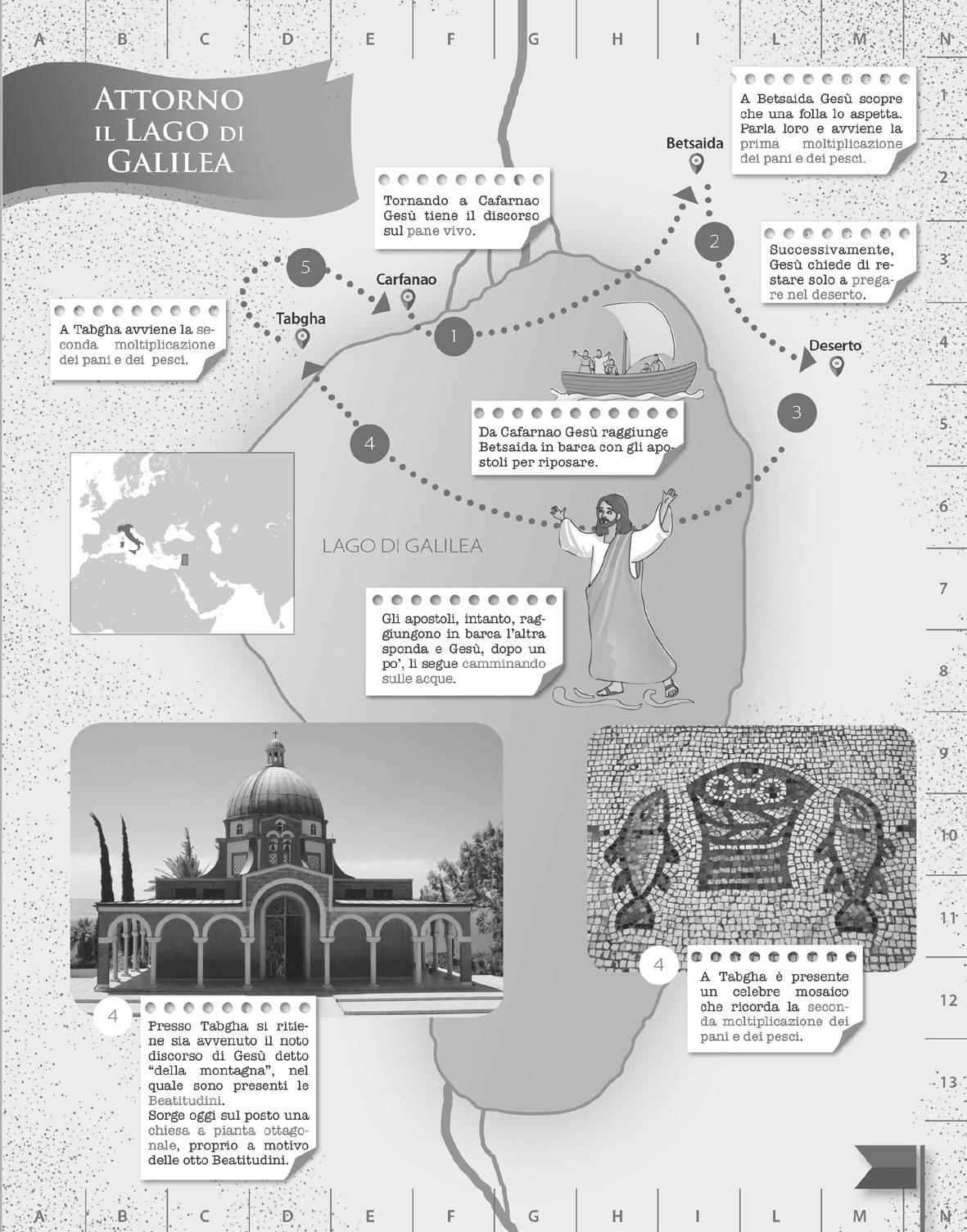

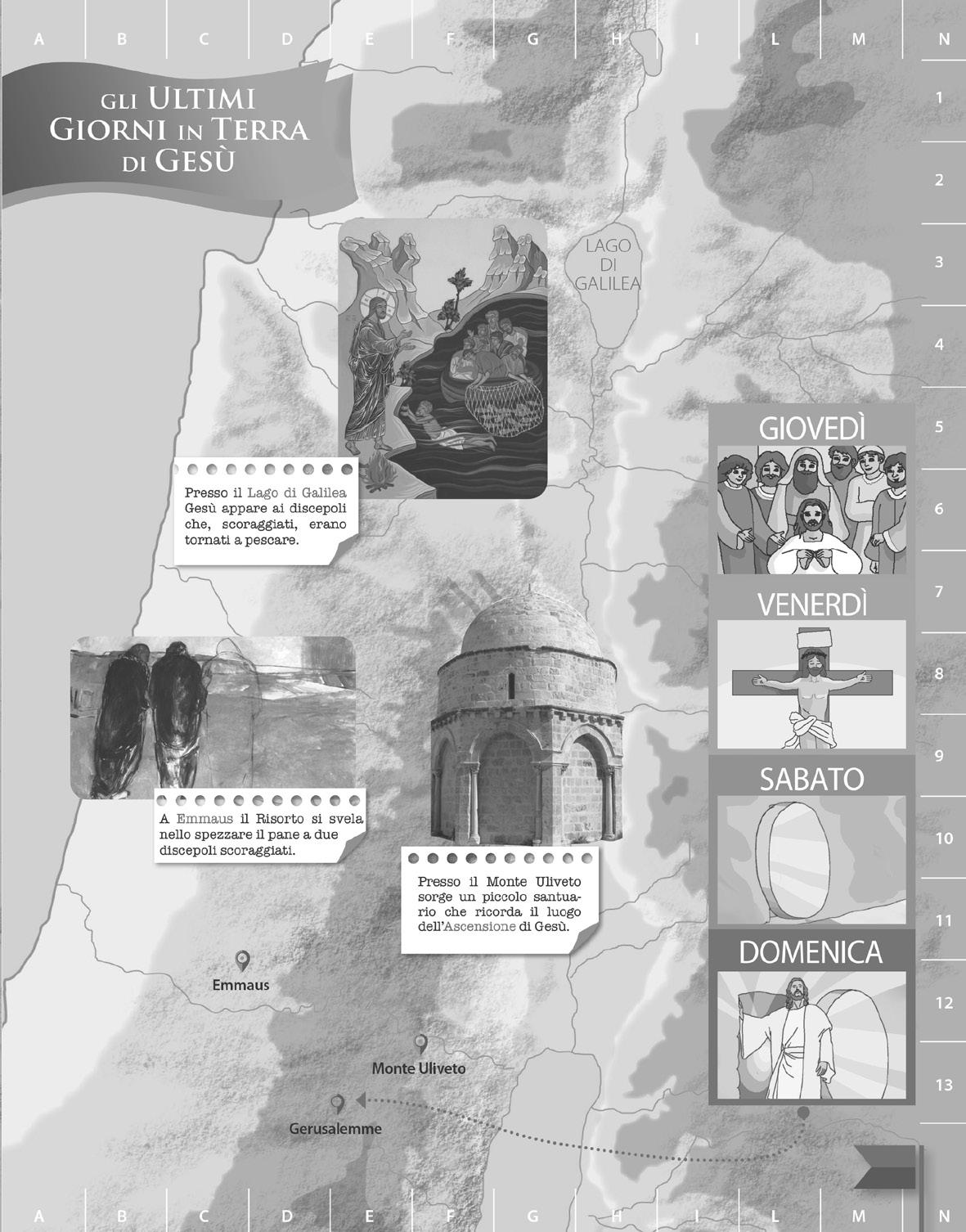
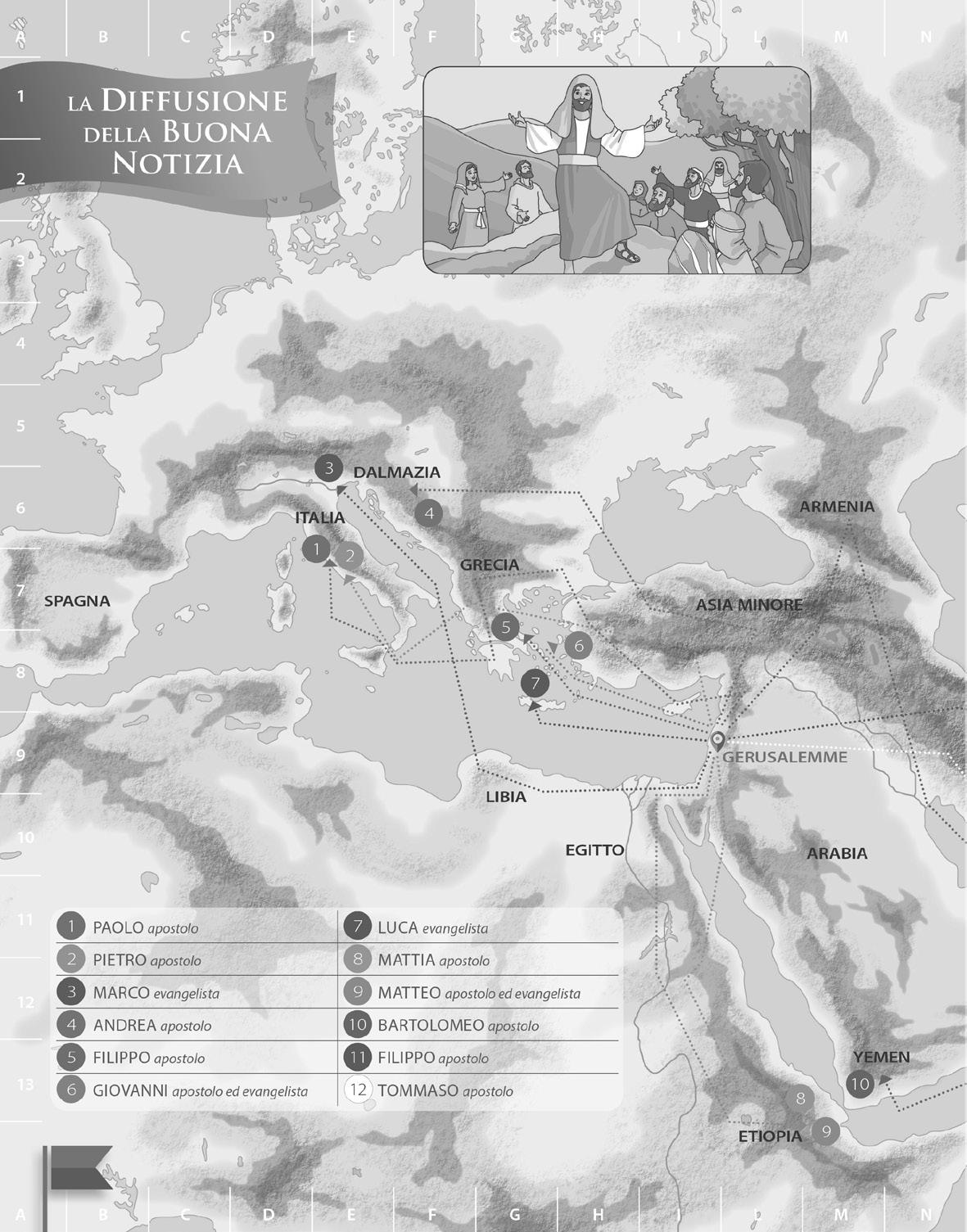
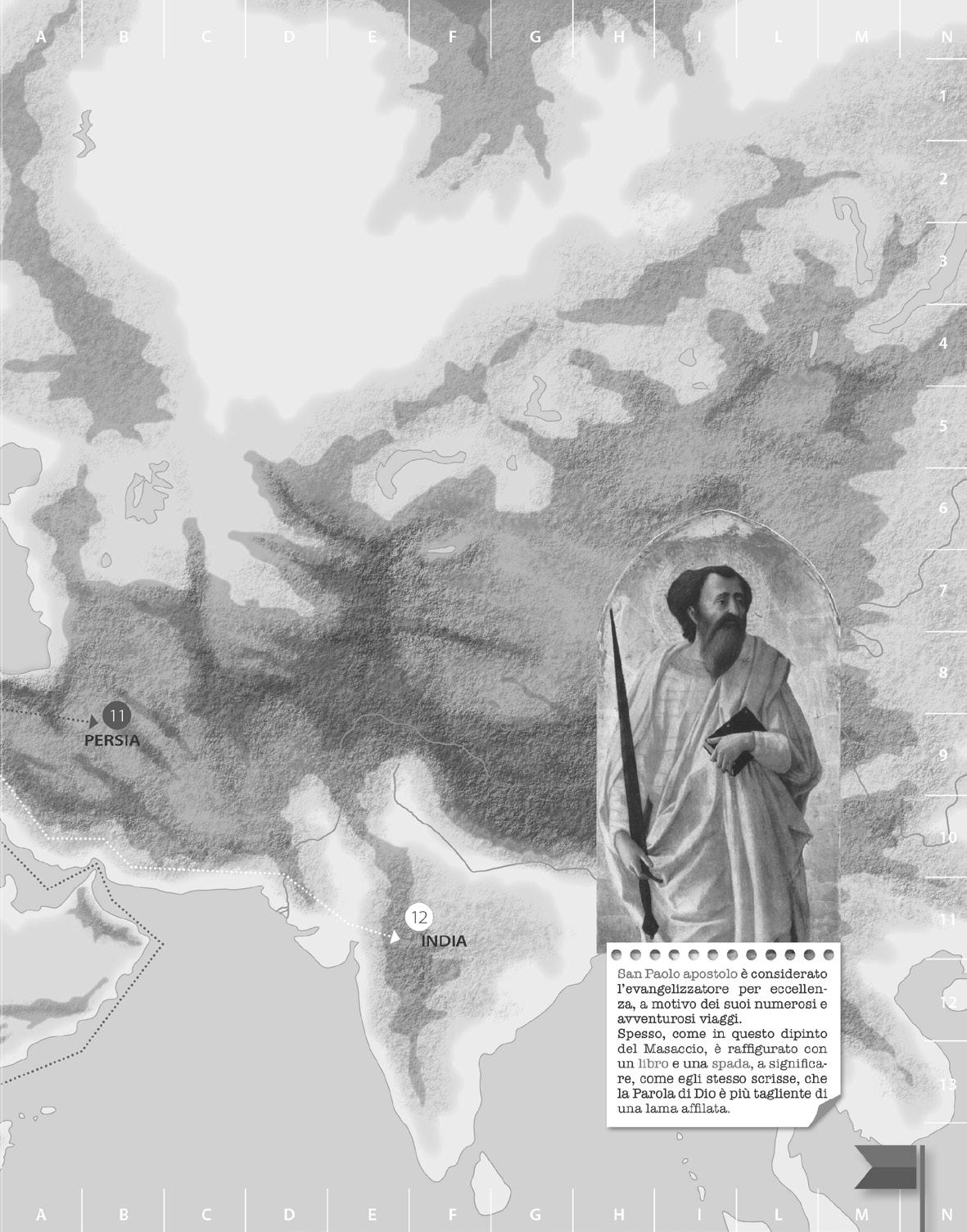
Presentazione ..............................................
Il mio libro di Religione .................................
CLASSE PRIMA
Programmazione didattica ...........................
Sezioni 1-2: Primi giorni / A scuola per...............
Sezione 3: Una storia d'Amore .......................
Sezione 4: È Natale! ......................................
Sezione 5: Ecco Gesù! ....................................
Sezione 6: È Pasqua! .....................................
Sezione 7: Ecco la Chiesa! .............................
Impariamo con i Santi .................................
CLASSE SECONDA
Programmazione didattica ...........................
Sezione 1: Si ricomincia! ...............................
Sezione 2: Una grande amicizia ...................
Sezione 3: L'attesa di Gesù ............................
Sezione 4: Gesù e i suoi amici .......................
Sezione 5: La luce di Pasqua .........................
Sezione 6: La Chiesa ieri e oggi .....................
Impariamo con i Santi ..................................
CLASSE TERZA
Programmazione didattica ...........................
Sezione 1: Si ricomincia! ...............................
Sezione 2: Le grandi domande ......................
Sezione 3: Un popolo eletto ..........................
Sezione 4: Una grande alleanza ...................
Sezione 5: In una nuova terra ......................
Sezione 6: Nella pienezza dei tempi .............
Impariamo con i Santi ..................................
APPENDICE
Indicazioni Nazionali per l'IRC .......................
La valutazione dell'IRC ..................................
Le 8 competenze chiave europee ...................
La nuova Educazione Civica ..........................
Atlante biblico .............................................
di Carmine Picariello
I S B N per l ’adozione : 97 8 - 8 8 - 4 6 8 - 4 5 2 8-3
Coordinamento e redazione: Diego Mecenero
Consulenza editoriale: Natale Benazzi
Progetto grafico e impaginazione: Elisa Panzieri
Copertina: Diletta Brutti
Illustrazioni: Stefania Bellucci, Maria Alejandra Ardila, Be Orange Ricerca iconografica: Diego Mecenero
Responsabile di produzione: Francesco Capitano
Stampa: Tecnostampa – Pigini Group Printing Division
Loreto – Trevi 25 83 095 0
Nulla osta della Conferenza Episcopale Italiana Prot n 63/2022
Roma, 25 gennaio 2022 + card. Gualtiero Bassetti
Presidente della Conferenza Episcopale Italiana
Imprimatur della Diocesi di Prato
Prot n SV-2022-0042
Prato, 2 febbraio 2022 + mons. Giovanni Nerbini
Vescovo di Prato
Parere positivo di Conformità della Conferenza Episcopale Italiana Prot. n. 4029/2024
Roma, 16 dicembre 2024
È assolutamente vietata la riproduzione totale o parziale di questo testo, così come la trasmissione sotto qualsiasi forma o con qualunque mezzo, senza l’autorizzazione delle Case Editrici Produrre un testo scolastico comporta diversi e ripetuti controlli a ogni livello, soprattutto relativamente alla correttezza dei contenuti Ciononostante, a pubblicazione avvenuta, è possibile che errori, refusi, imprecisioni permangano Ce ne scusiamo fin da ora e vi saremo grati se vorrete segnalarceli al seguente indirizzo: redazione@elionline com
© 2025 | La Spiga, Gruppo Editoriale ELI info@gruppoeli it www.gruppoeli.it
© 2025 | San Paolo Edizioni sanpaoloedizioni@stpaulus it www.edizionisanpaolo.it
EquiLibri • Progetto Parità è un percorso del Gruppo Editoriale ELi in collaborazione con l’Università di Macerata per promuovere una cultura delle pari opportunità rispettosa delle differenze di genere, della multiculturalità e dell’inclusione, in armonia con il Magistero della Chiesa cattolica per quanto riguarda i testi di Religione cattolica
Educability è un evento per docenti e dirigenti scolastici di ogni ordine e grado, erogato dal Gruppo Editoriale ELi e riconosciuto dal MIM Offre a docenti e dirigenti corsi di formazione sulle competenze non cognitive, grazie ai più importanti esperti in Italia di pedagogia, di psicologia e delle scienze comportamentali Visita il sito internet: www educability it
“il mio libro di Religione - Nuovo Detto... Fatto!” è un corso di Religione cattolica caratterizzato da forte operatività proposta in modo chiaro, semplice e lineare. A ogni pagina di contenuti corrisponde, immediatamente di seguito, l’offerta di esercizi e attività che continuano anche negli allegati ai testi degli alunni La presente Guida didattica segue passo passo il percorso e offre inoltre altri numerosi materiali aggiuntivi. cla ssi 1 2 3
Per lo studente





Codice
Per il docente