ANNO XLIX numero 1 2023
Estrildidi Fringillidi e Ibridi Il Canarino Silice, work in progress



Canarini di Colore
Commento all’articolo




“La mutazione Azul”
 Canarini di Forma e Posizione Arricciati Criticità e precisazioni sull’Arricciato Padovano
Veterinario Uova chiare
Rivista mensile di Ornitologia Scientifica - Tecnica - Pratica Organo Ufficiale della F.O.I.-Onlus
Canarini di Forma e Posizione Arricciati Criticità e precisazioni sull’Arricciato Padovano
Veterinario Uova chiare
Rivista mensile di Ornitologia Scientifica - Tecnica - Pratica Organo Ufficiale della F.O.I.-Onlus









AMMINISTRAZIONE E PUBBLICITÀ:
Segreteria F.O.I.-Onlus Via Caorsana, 94 - Località Le Mose 29122 Piacenza
Tel. 0523.593403 - Fax 0523.571613
Web: www.foi.it - E-mail: redazione@foi.it

Direttore Responsabile: Antonio Sposito
Caporedattore: Gennaro Iannuccilli


Collaboratori di Redazione: Giovanni Canali, Maurizio Manzoni, Francesco Rossini
Commissione Salute, Benessere animale e Ricerca Scientifica:


Elena Circella, Giuseppe Marruchella, Gianluca Todisco
Coadiutore Editoriale: Lorenza Cattalani
Associato all’Unione Stampa Periodica Italiana ISSN 0391-254X (International Standard Serial Number)


Autorizzazione del Tribunale di Bologna n. 4396 del 12-3-1975
Stampa: TEP s.r.l. - Strada di Cortemaggiore, 50 29122 Piacenza - Tel. 0523.504918
Inoltro postale in Italia: Effezeta srl
Via Francesco Nicoli 10/G - 29122 Piacenza
ABBONAMENTI ANNUI:
Italia € 50,00 - Estero-Europa € 70,00
Estero-ExtraEuropa € 90,00
Un numero € 5,00 - Arretrato € 6,50 C.C.P. 53684957
Le quote abbonamento vanno versate, mediante vaglia o assegno, alla Segreteria. Le opinioni espresse dagli Autori non impegnano la Rivista e la sua Direzione.
La Redazione si riserva il diritto di non pubblicare o emendare gli articoli proposti. I collaboratori assumono piena responsabilità delle affermazioni e delle immagini contenute nei loro scritti. Vietata la riproduzione, anche parziale, se non espressamente autorizzata. © F.O.I. In copertina: Ibrido maschio di Diamante fetonte x Diamante codarossa
Foto: PIERLUIGI PAGANI
ANNO XLIX NUMERO 1 2023 sommario Un Mondiale di forma e sostanza Gennaro Iannuccilli 3 Il Canarino Silice, work in progress Bruno Zamagni 5 Commento all’articolo “La mutazione Azul” Giovanni Canali 9 Criticità e precisazioni sull’Arricciato Padovano Emilio Sabatino 13 Sul Diamante fetonte Neochmia phaeton (Hombron e Jacquinot, 1841) Ivano Mortaruolo 17 Photo Show Le foto scattate dagli allevatori 21 Si fa presto a parlare di Jaspe Pasquale Leone 23 Il Diamante di Gould a groppone giallo Francesco Faggiano 27 Uova chiare Diego Cattarossi 33 L’Amaranto comune Pierluigi Mengacci 38 Spazio Club Club Diamante codalunga & Poephila Italia 44 Il Saltimpalo (Saxicola torquatus) - 1ª parte Piercarlo Rossi 47 L’altra faccia della F.O.I. Rosa Meola 51 OrniFlash News al volo dal web e non solo 52 Pagina aperta Argomenti a tema 54 Influenze reciproche tra vincoli genetici e vincoli ambientali Francesco Di Giorgio 57 Congresso Tecnico di Specializzazione Federico Vinattieri 59 Pensieri in libertà Argomenti a tema 62 Attività F.O.I. - Sintesi verbale C.D.F. del 2 e 3 settembre 2022 64 Estrildidi Fringillidi
Canarini
Canarini di Forma e Posizione Arricciati Veterinario 5 9 13 33 Italia Ornitologica è la rivista ufficiale della F.O.I. - Federazione Ornicoltori Italiani, pubblicata in 10 (dieci) numeri annuali a cadenza mensile, 2 (due) dei quali in versione bimestrale nel periodo estivo (Giugno/Luglio e Agosto/Settembre). Il numero 1 - 2023 è stato licenziato per la stampa il 7/2/2023
e Inridi
di Colore









Un Mondiale di forma e sostanza

Dedichiamo questo spazio redazionale soprattutto ad alcune immagini scattate durante le varie fasi dell’appena trascorso 70° Campionato Mondiale di Ornitologia, organizzato dalla FOI sotto l’egida della COM. Un Mondiale a tutti gli effetti di forma e di sostanza: la splendida cornice della Mostra d’Oltremare di Napoli ha reso irripetibile un evento del genere, grazie alla particolare dislocazione dei padiglioni fieristici all’interno dell’ampio parco cittadino, unico nel suo genere; la “sostanza” è stata fornita dalle migliaia di allevatori che hanno partecipato con oltre 21600 uccelli iscritti al prestigioso concorso, dai tanti espositori commerciali che hanno scelto di essere presenti con i loro stand colmi di innovativi prodotti e dalla moltitudine di visitatori accorsi in Mostra nei giorni di apertura al pubblico.


Le immagini in questi casi rendono meglio delle parole l’atmosfera percepita nei giorni di svolgimento dell’evento ornitologico più importante dell’anno. Siamo sicuri che il 70° Campionato Mondiale di Napoli resterà nella mente e nei cuori di quanti hanno avuto modo di viverlo in prima persona.





(fotografie gentilmente fornite da NICOLA D’ANGELO)

Editoriale
Editoriale













Il Canarino Silice, work in progress
 testo e foto di BRUNO ZAMAGNI
testo e foto di BRUNO ZAMAGNI
Era il 1922, cento anni fa, quando due allevatori tedeschi, Hans Duncker e Karl Reich, si accorsero che era possibile traslare nei Canarini la capacità di sviluppare colorazioni marcatamente rosso-arancio grazie alla ibridazione con il Cardinalino del Venezuela.
Aperta la strada, dopo di loro molti
altri si sono cimentati in questa pratica e molte generazioni di canarini, sempre più rossi, si sono succedute. Dal nostro punto di vista, intendo quello amatoriale, questa è stata una svolta epocale che ha scatenato notevoli entusiasmi. Parallelamente possiamo però anche aggiungere che per lungo tempo sono stati poco

Diverse tra le varianti cromatiche ad oggi fissate nel Lucherino europeo Spinus spinus, che in diversi casi sono sovrapponibili a quelle già conosciute nel Canarino

compresi i meccanismi genetico/fisiologici che erano dietro questa acquisizione. A giustificazione della diversa qualità del colore rosso nei vari ceppi si pensava infatti a differenti “percentuali di sangue” del Cardinalino presenti nei rispettivi ceppi. Conoscenze più attuali indicano invece che a differenziare il genoma dei canarini rossi non sono quei massicci “inquinamenti” genetici ipotizzati, ma sono un pugno esiguo di alleli in grado di produrre un processo ossidativo dei lipocromi più marcato rispetto al classico giallo originale.
Nel nostro ambiente si è pensato inoltre che una acquisizione di questo tipo, diciamo indotta artificialmente, dovesse rimanere un caso isolato ed eccezionale, quindi non replicabile; invece, in tempi relativamente recenti, con il diffondersi dell’allevamento di diverse specie di Spinus, ci si è accorti che questi animali utilizzati in ibridazione sembrano non avere nel loro DNA efficaci difese a protezione della purezza genetica della specie. Il risultato è che i loro derivati ibridi sono in diversi casi fecondi. Se poi consideriamo gli incroci all’interno del genere, per intenderci ibridi tra Spinus, la fecondità degli F1 è pressoché totale in entrambi i sessi. Questa conoscenza ha consentito di traslare senza la minima difficoltà da una specie all’altra le varie mutazioni che nel tempo sono apparse. Non è infatti un caso se diverse tra le varianti cromatiche ad oggi fissate nel Lucherino europeo Spinus spinus, che in diversi casi sono sovrapponibili a quelle già conosciute

NUMERO 1 - 2023 5 ESTRILDIDI FRINGILLIDI IBRIDI
R1 di Canarino Silice
nel Canarino, quali la bruno, la pastello, la topazio (proveniente originariamente dal Lucherino TN), la intenso (conosciuta come giallo), la pheo, la avorio, la diluito, le ritroviamo spalmate in buona parte dei diversi Spinus sud-americani di comune allevamento.


L’ultima mutazione del Lucherino sopra citata, la “diluito”, merita una sottolineatura in quanto è alla base di un secondo clamoroso caso di travaso genetico tra specie appartenenti a generi diversi: mi riferisco a quello che oggi conosciamo come Canarino Jaspe, che è notoriamente il frutto di un doppio salto di specie. Questo gene autosomico a dominanza parziale, apparso originariamente nel Lucherino europeo, poi fissato in uno Spinus sudamericano (probabilmente il Cardinalino, anche se la storiografia ufficiale spagnola parla dell’utilizzo del Lucherino testa nera), è stato poi inserito nel genoma del Canarino grazie ad una fortunata trafila di accoppiamenti che ha visto la nascita di maschi F1 fecondi e poi tutta una sequenza di reincroci R1, R2, R3, mirati al ripristino delle fattezze somatiche originali del Serino domestico. Il tutto agevolato dalla trasmissione a dominanza parziale sopracitata che consente di lavorare sempre con riproduttori mutati e non con portatori, o probabili tali, come invece si è obbligati a fare nei tentativi con fattori a trasmissione recessiva.


Fatta questa premessa, e citati questi precedenti, voglio ora raccontare un
lavoro che mi sta vedendo impegnato da diversi anni e che come obbiettivo contempla la creazione, tramite mirate ibridazioni, di una nuova forma mutata di Canarino: il Silice.

Il Lucherino Silice
Apparsa in un ceppo di Lucherini europei nell’allevamento del Sig. Mojmir Bradzil e da lui fissata, la mutazione silice è stata in un primo momento denominata “giallo cecoslovacco”, un nome abbastanza improponibile ed infatti Renzo Esuperanzi, in occasione di un incontro tecnico svolto in concomitanza di una passata edizione di “Fringillia”, ha proposto di sostituirlo appunto con Silice. È stata una intuizione molto felice, tanto che in breve tale denominazione è diventata di uso comune. Questo fattore, a trasmissione genetica autosomica a dominanza parziale, ha un effetto sul piumaggio decisamente vistoso, con uno spinto abbattimento delle melanine, tanto che queste restano confinate in caratteristiche orlature soprattutto nelle penne forti ed anche in tracce di nero che restano evidenti soprattutto a livello di calottina e pizzetto, distretti dove la fisiologica concentrazione della eumelanina è massima. Nel resto del piumaggio c’è una sorta di scarsa diffusione, mentre occhi, becco e zampe restano pienamente ossidati, cosa che fa ritenere che il meccanismo di azione dipenda più da una (incostante?) difficoltà nel passaggio delle melanine dal melanocita al follicolo della penna che da una deficienza nella loro produzione. Il sottopiuma è nero.
A questa descrizione c’è solo da aggiungere che, rispetto ai primi mutati giunti in Italia, con la selezione si è molto rafforzata la presenza di melanina nel piumaggio; mi riferisco ovviamente a soggetti “singolo fattore”. Gli omozigoti, cioè i “doppio fattore”, come ho potuto verificare durante queste mie sperimentazioni, appaiono con un piumaggio decisamente più schiarito. Ma di questi risvolti cromatico/fenotipici avremo occasione di riparlare in altra occasione.
6 NUMERO 1 - 2023
R1 di Canarino Silice, all. A. Panfini
Cardinalino Silice, all. A. Panfini
Il Lucherino ventre giallo Silice
Un giorno, durante uno dei nostri ricorrenti pranzi di fine anno con i miei amici Sergio Lucarini e Renzo Esuperanzi, ci venne da pensare che, come già era stato fatto a proposito della mutazione diluito/jaspe, sarebbe stata possibile la traslazione sempre nel Canarino anche del fattore silice. In quella occasione tracciando un possibile percorso, ipotizzammo che sarebbe stato meglio non tentare una ibridazione diretta tra il nostro Lucherino e la Canarina, ma preventivamente trasferire tale fattore nel Cardinalino (Spinus cucullatus) o nel Lucherino ventre giallo (Spinus xanthogaster) e poi tramite questi, visti i numerosi casi di fecondità dei relativi ibridi, introdurre con più facilità il nuovo fattore nel Canarino. Tanto mi affascinava l’idea di affrontare tale impresa che passare dalla teoria alla pratica è stato un tutt’uno. Di questa “strana” idea abbiamo già parlato sul numero 3/21 di questa rivista. In tale occasione ho tenuto a specificare che inizialmente sono stato avvantaggiato dal fatto che ho intrapreso la trafila degli accoppiamenti non partendo da zero: Alex Valentini, mio consocio alla A.A.A. di Rimini, che al tempo oltre ai Lucherini Silice aveva anche di-
versi Xanthogaster. Dopo avergli esposto le mie intenzioni, Alex ha gentilmente accettato di produrre per me nella successiva primavera direttamente i primi ibridi.


È stato così che alla fine dell’estate del 2014 due splendidi maschi F1 mutati Silice di Lucherino ventre giallo x Lucherina arrivarono nel mio allevamento. Nel frattempo mi ero procurato due femmine di xanthogaster e, dato che ho l’abitudine di produrre personalmente i soggetti per portare avanti le mie selezioni, ho rimediato anche una bella coppia da far riprodurre in purezza.
Evidentemente è vero che la fortuna aiuta gli audaci; infatti, il primo anno sono riuscito a produrre una decina di soggetti tra i quali cinque mutati, tre maschi e due femmine. Mi ricordo che questi R1 (reincroci di prima generazione) avevano una taglia notevole, superiore a quella dei loro genitori, con un cappuccio più simile a quello di un Lucherino testa nera che di un Lucherino ventre giallo.


Nella successiva stagione, oltre ai maschi R1, testai anche una femmina che accoppiata ad un maschio Xanthogaster puro si presentò totalmente feconda. Stessa cosa con tutte le altre femmine negli anni a seguire.

Nel portare avanti il mio progetto ho mantenuto negli anni la barra diritta, mettendo in essere cioè nelle varie generazioni accoppiamenti che vedevano coinvolti soggetti mutati Silice, i vari “R” sia maschi che femmine, uniti a xanthogaster esclusivamente puri non mutati.
Una generazione dietro l’altra, la taglia e i disegni si avvicinavano sempre più a quelli del Lucherino ventre giallo. Chiaramente, ho sempre lavorato salvaguardando la presenza nella discendenza della mutazione silice, cosa d’altra parte agevole vista
NUMERO 1 - 2023 7
Cardinalina Silice
F1 Cardinalino x Canarino, all. A. Panfini
Apparsa in un ceppo di Lucherini europei nell’allevamento del Sig. Mojmir Bradzil e da lui fissata, la mutazione silice è stata in un primo momento denominata “giallo cecoslovacco”
la sua peculiare trasmissione genetica. Per verificare il progresso nell’avvicinamento alle caratteristiche strutturali e di colore dello xanthogaster puro ho ovviamente sempre preso come riferimento i fratelli ancestrali che mi nascevano nelle covate miste.



Il Cardinalino Silice
Parallelamente alla trafila sopra descritta per arrivare al Lucherino ventre giallo Silice, per non farmi mancare nulla, ho iniziato un analogo percorso anche per giungere al Cardinalino Silice. Anche in questo caso a facilitare le cose, oltre alla dominanza del fattore da traslare, c’è stata anche la piena fecondità in entrambi i sessi sia degli F1 che dei vari reincroci. Oltretutto, come ho già anticipato nel sopra citato articolo, con il Cardinalino ho avuto la sorpresa di ottenere da subito soggetti con una ossidazione più accentuata. In effetti,

riflettendoci, è noto che tra gli Spinus esotici, il Ventre giallo sia tra quelli che a livello puramente ibridativo trasmettono meno nero ai loro discendenti. Cosa abbastanza strana se consideriamo che come diffusione di nero nel piumaggio è tra i più dotati. Come si può apprezzare nella foto allegata, nei maschi Cardinalini Silice, pur nella spinta rarefazione melanica, il cappuccio è abbastanza evidente. Naturalmente, quando questa variante sarà più consolidata è auspica-
bile che in un futuro standard venga indicato un cappuccio il più possibile ossidato e completo.
Il Canarino Silice
Fin qui ho riferito della parte più facile del percorso. Percorso che, non dimentichiamolo, già dagli inizi che datano oramai circa a nove anni fa, ha sempre avuto come obbiettivo finale la stabilizzazione di una nuova varietà di Canarino. A facilitare il compito la più volte citata completa fertilità degli ibridi tra Spinus, che ha infatti dato una bella mano. Relativamente semplice è stato anche ottenere i primi tre F1 maschi di Cardinalino x Canarina. Nel frattempo comunque, per non correre il rischio di veder naufragare tutto a causa della fecondità notoriamente non completa di questi soggetti, per aumentare la probabilità statistica di arrivare alla meta ho pensato utile coinvolgere nell’esperimento l’amico Alex Panfini e con lui ci siamo divisi i soggetti da testare: Cardinalini, F1 e poi gli R1. Che si sia trattato di una mossa giusta l’ho potuto verificare quando con il mio F1 la scorsa stagione ho prodotto solo reincroci femmine, soggetti notoriamente inutilizzabili in quanto quasi certamente sterili. Alex, più fortunato, ha invece ottenuto anche due maschi. Uno è rimasto da lui, mentre il secondo è ora a svernare nel mio allevamento. Un ultimo appunto riguarda le Canarine che stiamo utilizzando: per evitare interferenze potenzialmente poco decifrabili con altri fattori mutati, Alex ed io stiamo mettendo in coppia esclusivamente delle ottime nere mosaico rosso, nello specifico delle campionesse cedutemi da Aldo Donati, belle e tipiche, una garanzia per produrre Canarini mutati Silice, che quando arriveranno saranno già a livelli di eccellenza. Per ora il racconto termina qui; se tutto fila liscio, come spero, l’appuntamento è per la fine della prossima stagione cove quando mi auguro di poter mostrare le foto degli incroci di terza generazione (R2): esemplari che già avranno fattezze da Canarino, soggetti che, quantomeno, ci consentiranno di cominciare a capire quale sia il vero impatto della mutazione “silice” sul fenotipo del nostro serino.
8 NUMERO 1 - 2023
Piccoli di Cardinalino Silice
Nei maschi Cardinalini Silice, pur nella spinta rarefazione melanica, il cappuccio è abbastanza evidente
Commento all’articolo “La mutazione Azul”
di GIOVANNI CANALI, foto E. DEL POZZO
Ho visto con interesse l’articolo

“La mutazione Azul” (I.O. 12/2022) di Alberto Santafé Pastor, con introduzione di Gaetano Zambetta pure interessante.
Anni or sono ho avuto occasione di vedere i primi azul, in Italia chiamati monomelanici. All’epoca si discuteva se si trattasse di selezione o di mutazione. Io fin dall’inizio mi sono schierato per la mutazione. In effetti, avendo osservato la totale assenza di feomelanina espressa, mi è sembrato subito essere un risultato non raggiungibile con la sola selezione. Ricordo di aver osservato con particolare attenzione un soggetto nero bianco ed anche un nero giallo avorio, varietà che sottolineano la presenza di feomelanina, ma non si vedeva nulla. Successivamente è emerso che anche gli immaturi non presentano feomelanina, direi fatto determinante. Gli allevatori qualificati che ho contattato mi dicevano trattarsi di mutazione recessiva autosomica, circostanza oggi accettata quasi da tutti. Personalmente preferisco di gran lunga la definizione monomelanico invece di azul, che significa azzurro. Per me l’azzurro è altra cosa; quando tanti anni or sono criticavo i discorsi che si facevano su di un fantomatico “fattore ottico del blu”, cosa diversa dal monomelanico, citavo il pap-


pagallino ondulato azzurro cielo come vero azzurro, o il cobalto come vero blu. Certo non si può negare che i canarini nero bianco presentino riflessi metallico bluastri, ma secondo me è poca cosa per poter parlare di blu o di azzurro. Semmai è molto importante notare che questi riflessi ci sono sempre con qualche modesta variazione. La circostanza
può essere spiegata con il fatto che l’eumelanina non è tutta concentrata nel disegno (striature, vergature e marcature) ma è presente in tracce anche fuori dai centri di convergenza suddetti. C’è da presumere in granuli abbastanza fini, tali da generare l’effetto metallico bluastro, in assenza di carotenoidi espressi che altrimenti interferiscono.

NUMERO 1 - 2023 9 CANARINIDI COLORE
Nero intenso giallo, foto: E. del Pozzo
Preferisco di gran lunga la definizione monomelanico
Si deve sempre ricordare che blu, azzurro e violetto sono colori strutturali a base di eumelanina, di regola a granuli ridotti, altrimenti si ha facilmente il nero, il marrone scuro o tuttalpiù il grigio. La presenza di eumelanina fuori dal disegno che costituisce il suo centro di convergenza è stata rilevata in Italia da Diego Crovace con l’adesione di altri tecnici. Il monomelanico non aumenta in modo rilevante i suddetti effetti ottici, quindi secondo me è meglio chiamarlo appunto monomelanico e non azul; fra l’altro l’agata opale è ben più azzurro dell’azul. Osservando i mono-

melanici ho avuto l’impressione che anche l’eumelanina sia intaccata, anche se in modo modesto. Comunque mi pare che il disegno dei neri classici sia meglio espresso di quello dei monomelanici. In seguito a ragionamenti logici e soprattutto al confronto con allevatori qualificati, ritengo che il monomelanico inibisca ma non distrugga la feomelanina. Quindi non possiamo sapere quanta ne nasconda. Da qui il fatto che accoppiando un monomelanico con un classico c’è il rischio di vedere aumentare e non ridurre la feomelanina stessa. Dipende da quanta è stata inibita. Una si-

tuazione simile a quella del bianco recessivo, che non distrugge ma solo inibisce i carotenoidi, e quindi può fare sorprese di ogni genere. A suo tempo, ed anche in seguito, ho segnalato l’importanza di considerare che la mutazione monomelanico rischia di diventare prevalente nei ceppi nei quali la feomelanina è considerata difetto. A livello di agata ed isabella ho fatto un parallelo con i potatori di satiné, anche se si tratta di fenomeno diverso.
L’articolo di Alberto Santafé Pastor è valido e con un’ottima documentazione fotografica alquanto indicativa. Bene ha fatto Zambetta a sollecitarlo. Trovo un solo punto non condivisibile, anche se solo ipotetico, e cioè quello in cui ipotizza che la feomelanina potrebbe trasformarsi in feomelanina grigio ferro. Nero e grigio sono colori da eumelanina, quindi si deve pensare alle tracce di eumelanina preesistenti anche nei classici. I colori della feomelanina vanno dal giallo al marrone, passando attraverso l’arancio ed il rosso. Riflessi o comunque percezioni di colori aventi natura strutturale: blu, azzurri e violetti presuppongono base di eumelanina, come dicevo sopra. Verde e viola sono pure strutturali e richiedono oltre all’eumelanina anche pigmenti gialli o rossi, di solito lipocromici. Mi sembra quindi che se un aumento di tali effetti metallico bluastri ci fosse, potrebbe essere spiegato con una maggiore evidenza dovuta all’inibizione della feomelanina, ipotesi pure considerata, ma anche e direi forse più probabilmente con fattori di inscurimento sopraggiunti di cui parla Zambetta nell’introduzione, aspetto che considererò in seguito.


Ora ci sarebbe da chiedersi il da farsi. Da riconoscere o no i monomelanici? Confesso di aver avuto sempre dubbi, non del tutto superati neppure ora, tanto da non aver mai fatto proposte, almeno fino ad oggi.
In particolare rilevo che le differenze fra i neri monomelanici ed i neri attuali selezionati contro le feomelanine sono poca cosa, anche se i classici hanno disegno migliore. Se non avessimo abbandonato la giusta selezione per i nero-bruni, cioè con nero e bruno, le differenze sarebbero maggiori. Inutile piangere sul latte versato. Qualcuno
10 NUMERO 1 - 2023
Nero intenso rosso, foto: E. del Pozzo
però (Iannuccilli) mi ha suggerito che, nel caso dovesse essere eventualmente riconosciuto il monomelanico, si potrebbe addirittura ipotizzare di ritornare al nero-bruno per distinguere maggiormente i due tipi. Mi sembra un’idea non male, tuttavia difficilmente accettabile dai più. Problema maggiore ci può essere nei diluiti. Evidenza maggiore nei bruni.
In effetti, oggi c’è chi vorrebbe avere anche i bruni senza bruno da feomelanina, ma solo da eumelanina; idea pessima, forse il riconoscimento dei bruni monomelanici potrebbe scongiurare questo pericolo. Di conseguenza non posso non dire che gradirei un riconoscimento dei bruni monomelanici.
In questo caso ritengo che non potremmo non riconoscere anche i neri monomelanici. I neri monomelanici si differenziano poco dai neri classici selezionati contro la feomelanina, tuttavia sono riconoscibili.
Vengono in aiuto le ali, o per meglio dire le penne che non sono mai mutate sulle ali: remiganti primarie, secondarie e grandi copritrici delle primarie, spesso mutate le terziarie e quelle dell’alula, le quali conservano almeno la feomelanina propria dei novelli. Fuori dall’ala, le timoniere mutate con media frequenza.


Un problema difficile da affrontare sa-

rebbe dato dai diluiti agata ed isabella; tuttavia anche qui tracce di feomelanina, pur diluitissima, sono percepibili nelle penne suddette anche dei soggetti migliori, nei difettosi ampiamente. Si potrebbe considerare quindi un riconoscimento pure in questo caso, anche se difficile. Altrimenti si imporrebbe dare già da ora l’indicazione perentoria che nei neri, come soprattutto nei diluiti (agata ed isabella), si dia l’ottimo anche in presenza di feomelanina visibile purché minima e non solo se totalmente inibita. Direi provvedimento necessario, altrimenti i monomelanici rischiano di diventare onnipresenti. Semmai da valutare bene l’interferenza sia pure modesta che il monomelanico ha sull’eumelanina. In presenza di altre ulteriori interazioni, dubito che si possa fare un discorso ampio, magari caso per caso. In un allevamento ho visto un nero pastello ali grigie molto “slavato”, quasi irriconoscibile. Ebbene in quel ceppo c’era finito anche qualche monomelanico; suppongo che l’ali grigie suddetto fosse un’interazione con il monomelanico, con pessimo risultato. Nell’introduzione di Zambetta ci sono spunti molto interessanti che non riguardano soltanto il monomelanico bensì fattori di inscurimento che potrebbero riguardare anche altri fenomeni, direi forse anche l’all black.
In effetti è possibile la presenza di piccole mutazioni eventualmente in concorso fra di loro, e non si può neppure escludere l’acquisizione di fattori di inscurimento dagli Spinus, sempre come ipotizzato da Zambetta. Forse un po’ meno probabile l’origine Spinus, visto che il cardinalino del Venezuela non ha trasmesso nulla a livello di disegno, nonostante reiterate ibridazioni; comunque altri Spinus potrebbero averlo fatto, avendo qualcosa in più come melanine. Penso quindi che il discorso su questi fattori di inscurimento richieda approfondimenti, e non solo per il monomelanico. Certo da non confondere i vari casi possibili. Da non dimenticare comunque l’importanza del tipo base, appunto basilare in tutte le interazioni. Suggerisco attenzione nei paragoni che in seguito potrebbero essere fatti riguardo i fattori di inscurimento da mutazione, come quello del pappagallino ondulato che trasforma il verde chiaro in oliva quando è omozigote ed in verde scuro l’eterozigote (intermedio). Questo anche per altri fattori di inscurimento noti nell’organetto, poiché sembrano piuttosto diversi e di netta espressione rispetto a quelli sopra ipotizzati.
Esprimo apprezzamento per la pubblicazione in oggetto, introduzione compresa, che merita attenzione.
NUMERO 1 - 2023 11
Nero mosaico rosso maschio, foto: E. del Pozzo
Nero mosaico giallo femmina, foto: E. del Pozzo









Criticità e precisazioni sull’Arricciato Padovano
di EMILIO SABATINO (Presidente della C.T.N. C.F.P.A.), foto G. PISANI e E. SABATINO
La CTN-CFPA, unitamente ai rappresentanti del Club del Padovano ed in piena sintonia con i vertici dello stesso, dopo vari incontri avuti, ritengono opportuno puntualizzare, tra le altre cose, che l’obiettivo primario è e rimane quello di indurre gli appassionati a selezionare canarini Padovani il più possibile attinenti allo Standard espresso nei Criteri di Giudizio.
Nella valutazione generale fatta sulla moltitudine di soggetti esposti negli ultimi anni, si deduce che questo obiettivo richieda, in senso migliorativo, un continuo impegno da parte di tutti gli operatori del settore. Sia la CTN sia il Club “custodi dello standard” cercheranno, insieme, di mantenere alta la guardia ed il livello di attenzione, onde evitare deviazioni dallo standard.
Nelle diverse riunioni tenutesi, sono


state esaminate dettagliatamente le varie voci di giudizio ed al congresso Tecnico di Specializzazione tenutosi nella Città di Fiuggi a Settembre 2022 si è discusso, in modo particolare, sulle caratteristiche dei vari considerando inerenti lo standard del Padovano. In quel contesto, c’è stata la partecipazione e la collaborazione sia dei rappresentanti del Club che quella dei Giudici di Specializzazione. Grazie all’ausilio di diapositive, presentazioni in power point e soggetti dal vivo, si sono affrontate le molteplici problematiche inerenti ai difetti, ma si è anche discusso dei pregi che i nostri canarini possiedono. Una ulteriore dinamica affrontata è stata quella volta ad uniformare quanto più possibile la valutazione nel corso del giudizio da parte dei giudici, attenendosi esclusivamente alle guide espresse nello standard, affinché venga espressa un’univoca linea di giudizio nelle mostre, possibilmente senza oscillazioni di vedute e contrastanti interpretazioni tra giudici e, di conseguenza, tra giudici ed allevatori.
La posizione di entrambi (CTN e CLUB) è dettata anche e principalmente dalla constatazione che in molti, spesso anche attraverso meticciamenti o comunque errati accoppiamenti, tendono ad allontanarsi (a volte per motivi di mercato) da quelle che sono le vere e primarie caratteristiche del canarino Padovano; non va dimenticato che esso è, tra l’altro,

NUMERO 1 - 2023 13 CANARINIDI FORMAE POSIZIONE ARRICCIATI
L’obiettivo primario è e rimane quello di indurre gli appassionati a selezionare canarini Padovani il più possibile attinenti allo Standard
Padovano T. C. Lipocromico P.to, all. G. Pisani
Padovano T. C. Melanico Verde, all. E. Sabatino
una delle razze, diciamo così, “pesanti” e dobbiamo fare di tutto per mantenere intatta anche questa prerogativa, evitando comunque di selezionare soggetti troppo grandi o
troppo piccoli. L’impegno deve essere quello di rimanere coscienziosi e non dare seguito ad errori o ad orrori sconsiderati, alla vana ricerca di questo o quel connotato che magari manca nel proprio ceppo; in questo senso dobbiamo stare molto attenti a non mandare in fumo anni di sacrifici e di corretta selezione. Meglio un ceppo con qualche pecca pazientemente correggibile piuttosto che uno geneticamente inquinato, quindi compromesso irrimediabilmente. Bisogna sfatare le infauste dicerie secondo cui per avere degli esemplari migliori bisogna anche meticciarli; a tal proposito, ricordiamo ancora una volta che per elevare i caratteri distintivi di una razza necessitano anni di lavoro; per inserirvi i difetti, invece, è sufficiente solo una stagione di accoppiamenti errati. Insieme, come CTN e Club, cercheremo di far rispettare e mantenere l’equilibrio dei connotati descritti nello Standard. In particolar modo testa – collo, ove sono ancora presenti molti difetti (favoriti, “fagianine”, ciuffi anomali, calvizie nucale, assenza di collari, grondaie e baveri); da correggere il differente portamento


che spesso notiamo tra il Padovano t.c. ed il t.l. (il t.c. solitamente più eretto anche a causa del ciuffo che ricade sugli occhi); questo difetto si riscontra ancora in molti soggetti, pertanto bisogna tener presente che la posizione prevista dai Criteri di Giudizio è con angolatura di 65°, indipendentemente dalla presenza o meno del ciuffo. Importante ed essenziale da ricordare è che il portamento è una tra le caratteristiche tipiche di questa razza.

Da precisare, per non lasciare adito a dubbi sulla dicitura “piumaggio voluminoso e composto” che le tre arricciature primarie (jabot, fianchi e spalline) devono essere ben visibili e delineate. Le parti, senza ombra di


14 NUMERO 1 - 2023
Padovano T. C. Melanico Verde, all. G. Pisani
Padovano T. L. Lipocromico P.to, all. E. Sabatino Padovano T. C. Lipocromico, all. G. Pisani
Padovano T. L. Lipocromico P.to, all. G. Pisani
Bisogna sfatare le infauste dicerie secondo cui per avere degli esemplari migliori bisogna anche meticciarli
dubbio più visibili ad occhio, devono essere gli stacchi tra jabot – fianchi e spalline, e tra jabot e addome. Pessime pure quelle arricciature dell’addome scarne, carenti delle piumosità delle coulottes e spesso attaccate alla base dello jabot senza il caratteristico vuoto.


Gli allevatori del Padovano e gli estimatori di questo canarino sanno benissimo quali sono i pregi che bisogna portare avanti, ottenibili però solo fa-



cendo una rigida selezione; pertanto, ancora una volta, esortiamo e raccomandiamo di evitare qualsiasi utilizzo di soggetti di altre razze o altri metodi che ne danneggerebbero drasticamente il patrimonio genetico. La CTN, di comune accordo con il Club, organizzerà nel prossimo anno mostre, incontri con allevatori, giudici ed appassionati di questo splendido canarino, per la divulgazione, lo studio e la discussione sulle sue principali caratteristiche. Infine, chi volesse approfondire può consultare i nuovi criteri di giudizio della F.O.I., dove troverà una descrizione dello standard molto dettagliata. Lo scopo della CTN e del Club del Padovano è quello di cercare di eliminare quanto più possibile le criticità, percorrendo tutti insieme la strada della giusta selezione, l’allevamento, la collaborazione e la valorizzazione di questa eccellente razza italiana.

NUMERO 1 - 2023 15
Padovano T. L. Lipocromico, all. G. Pisani
Bisogna tener presente che la posizione prevista dai Criteri di Giudizio è con angolatura di 65°









Sul Diamante fetonte Neochmia phaeton (Hombron e Jacquinot, 1841)
Cenni di tassonomia
La specie in esame fu segnalata per la prima volta nel 1841 (Annales des Sciences serie II, vol. XVI, pagg. 314-315) con il nome scientifico di Fringilla phaeton e quello volgare di Bengalin phaethon. Nella descrizione vengono indicati i caratteri fenotipici di un esemplare maschio proveniente dalla Baia di Bay (Territorio del Nord, Australia).Gli autori, Jaques Bernard Hombron (17981852) e Charles Hector Jacquinot (1796-1879), rispettivamente medico e capitano di vascello, scoprirono questa specie (e molte altre) in occasione di un avventuroso viaggio nel Polo Sud e nell’Oceania, realizzato con le corvette Astrolabe e Zélée (quest’ultima comandata da Jacquinot).

Nel 1845 i suddetti esploratori e naturalisti proposero, sul volume Voyage au Pole Sud e dans l’Océanie, un’ornitografia (la tavola n. 22) che raffigura anche il Diamante fetonte,
indicato col nome Neochmie phaethon. La scelta di tale francesismo ha naturalmente destato qualche perplessità, in quanto non rispettosa

della sintassi latina che avrebbe imposto la lettera finale “a” (Neochmia). Ma le trasformazioni nomenclaturali degli autori non finirono qui. Nel


NUMERO 1 - 2023 17 ESTRILDIDI FRINGILLIDI IBRIDI
La
di IVANO MORTARUOLO, foto I. MORTARUOLO e P. PAGANI
specie in esame fu segnalata per la prima volta nel 1841
Maschio di Diamante fetonte della sottospecie nominale (Neochmiaphaetonphaeton), foto e allevamento: Ivano Mortaruolo
1853, infatti, venne proposta la denominazione di Erythrura phaeton, argomentando sul fatto che le peculiarità fenotipiche del volatile (grossezza del becco e brevità dei tarsi) imponessero un distacco tassonomico dalle specie simili e che, dunque, il genere Neochmia non dovesse essere adottato: favorendo, così, la scelta del taxon Erythrura


Va inoltre evidenziato che, ancor prima di tale data (1853), ornitologi come G.R.Gray (The Genera of Birds, 1849) e L. Bonaparte (Conspectus Generum Avium, 1850) indicavano l’attuale nome generico di Neochmia. Un’altra tappa importante nella storia tassonomica del Diamante fetonte fu raggiunta nel 1879, allorquando Luigi Maria D’Albertis (1844-1901) e Tom-

Nel 1879 Luigi Maria
Naturale di Genova”



maso Salvadori (1835-1923) descrissero un taxon con il nome di Neochmia evangelinae sugli “Annali del Museo Civico di Storia Naturale di Genova” (vol. XIV, pagg. 88-89). Vennero rappresentati due soggetti catturati il 30 ottobre 1877 nei pressi del fiume Fly (uno dei più importanti corsi d’acqua della Papua Nuova Guinea) in occasione della terza e ultima spedizione effettuata dal D’Albertis nella parte meridionale di tale regione. Nella descrizione gli autori non nascondono le loro perplessità sull’attribuzione tassonomica dei volatili e così scrivono: “Siamo incerti se questi due esemplari siano da riferire veramente alla N. phaeton o ad una nuova specie”. Ma dopo aver valutato i dati biometrici, forniti dal Conte Tu-

18 NUMERO 1 - 2023
Femmina di Diamante fetonte della sottospecie nominale (Neochmiaphaetonphaeton), foto e allevamento: Ivano Mortaruolo
Maschio di Diamante fetonte della sottospecie evangelinae, foto e allevamento: Ivano Mortaruolo
D’Albertis e Tommaso Salvadori descrissero un taxon con il nome di Neochmia evangelinae sugli “Annali del Museo Civico di Storia
rati, di un esemplare catturato nella penisola di Capo York, i due si avventurarono a proporre il nome di Neochmia evangelinae,in parte rassicurati dal fatto che i due specimina in loro possesso avessero dimensioni più ridotte e sostanzialmente poiché la regione ventrale era caratterizzata da cromie chiare.La loro intuizione si rivelerà arguta e fortunata, poiché attualmente gli studiosi sono concordi nel ritenere che i volatili descritti costituiscano una delle due sottospecie riconosciute (Neochmia phaeton evangelinae).

Tuttavia, fino a un recente passato, al D. fetonte venivano attribuite tre sottospecie. Detto altrimenti, era preso in considerazione anche il taxonalbiventer, descritto dall’austra-

liano Gregory M. Mathews nel 1914 (South Australian Ornithology, vol. I, pag. 13), ma la comunità scientifica considerò tale sottospecie come un sinonimo di evangelinae. Purtroppo, questo pregevole personaggio, che pur non essendo uno zoologo di professione maturò una cultura non comune che gli consentì di realizzare diverse monografie e di far parte di vari organismi scientifici, ricoprendone pure importanti incarichi, conobbe altre “bocciature ornitologiche”. Infatti, propose anche le razze geografiche iredalei e fitzroyi (entrambe segnalate nel 1912 e, naturalmente, relative alla specie Neochmia phaeton), che però non furono riconosciute. Molto verosimilmente l’errore scaturì, in particolar modo per la sottospecie evan-





NUMERO 1 - 2023 19
Ibrido maschio di D. fetonte x Diamante codarossa Bathilda ruficauda, foto e allevamento: PierluigiPagani
Femmina di Diamante fetonte della sottospecie evangelinae, foto e allevamento: Ivano Mortaruolo
La loro intuizione si rivelerà arguta e fortunata, poiché attualmente gli studiosi ritengono che i volatili descritti costituiscano una delle due sottospecie riconosciute
gelinae, dal fatto che esista una variabilità individuale nelle cromie, seppur lieve, la quale potrebbe essere accentuata sia dall’età dei volatili sia dall’abrasione del piumaggio. Negli anni Sessanta del secolo scorso altri due tentativi di revisione tassonomica del D. fetonte non furono accolti dalla comunità scientifica, pur offrendo interessanti informazioni e spunti di riflessione. In estrema sintesi, un autore, I. G. Mitchell (1962), propose d’includere il D. fetonte nel genere Lagonosticta poiché la somiglianza cromatica ed etologica con alcuni esponenti di questo taxon è notevole (The taxonomic position of the Crimson Finch, Emu 62: 115-125). L’altro ornitologo è C. J. O. Harrison (1963) che, prendendo in esame le cromie della livrea di entrambi sessi, la dimensione e la forma allungata del corpo, considerò la specie in esame molto affine al Granatino purpureo
Granatina granatina (Taxonomy of the Crimson Finch and Red-Browed Finch, Emu 63: 48-56).
Per diverso tempo gli studiosi sono stati pressoché concordi nel ritenere che al genere Neochmia (questa parola deriva dal greco Neokmia e significa “innovazione, cambiamento”) dovessero essere ascritti anche il Diamante codarossa, il D. modesto e l’Astro di Sidney. Il primo passo verso questo raggruppamento tassonomico si ebbe negli anni 1962 e 1965, allorquando il tedesco K. Immelmann ritenne che a tale taxon, oltre al D. fetonte, dovesse appartenere anche il D. codarossa poiché vari aspetti comportamentali e fenotipici sono simili, soprattutto se si prendono in esame le femmine e i giovani. Orientamento condiviso nel 1968 anche da E. Mayr (The sequence of genera in the Estrididae, Breviora 287: 114). Ma si dovette attendere l’anno 1987 per raccogliere le quattro specie



in questo genere, allorquando L. Christidis, in base ai suoi studi cromosomiali ed elettroforetici, giunse a siffatta conclusione (Phylogeny and Systematics of EstrildineFinches and their relationships to Other Seed-eating Passerines, Emu 87: 119-123).

Tale “condivisione tassonomica” è attualmente contestata da un recente studio realizzato da U. Olsson e P. Alström (A comprehensive phylogeny and taxonomic evaluation of the waxbills -Aves: Estrildidae), reso disponibile onlineil 3 febbraio 2020 dalla Elsevier Inc. I due ricercatori, infatti, dopo accurati e numerosi esami genetici, sono giunti alla conclusione che il D. codarossa vada collocato nel genere Bathilda e il D. modesto nel genere Aidemosyne, mentre hanno inserito nel taxonNeochmia solo l’Astro di Sidney e il D. fetonte. Questa proposta è stata accolta pressoché unanimemente dalla collettività scientifica.


20 NUMERO 1 - 2023
•Invitiamo tutti gli allevatori a inviare foto di soggetti provenienti dai propri allevamenti, con descrizione della specie, razza e mutazione, all’indirizzo: redazione@foi.it

•All’autore della foto mensilmente prescelta da un comitato interno, verrà offerto in omaggio un libro edito dalla FOI in base alla preferenza e alla disponibilità.
(*)Tutte le foto inviate, anche quelle non pubblicate, rimarranno a disposizione della FOI a titolo gratuito e potranno essere utilizzate, senza alcun limite o vincolo temporale, per pubblicazioni, iniziative e scopi promozionali della Federazione


Questo mese, il protagonista di Photo Show è: ROBERTO ZUFFOLI R.N.A FE78 con la fotografia che ritrae il soggetto: Agapornis taranta maschio verde oliva Complimenti dalla Redazione!













Si fa presto a parlare di Jaspe
testo e foto di Pasquale Leone
Adifferenza delle altre mutazioni che sono apparse spontaneamente, la Jaspe è una mutazione che è stata volutamente traslata nella canaricoltura di colore; difatti in origine la mutazione è apparsa nel lucherino europeo (Spinus spinus) dove ha avuto notevole successo.



Nell’intento, dunque, di traslare la mutazione nel canarino, è stata eseguita una serie di ibridazioni simili ma non uguali sia in Italia che in Spagna. In Italia sono state fatte utilizzando nell’ibridazione il cardinalino del Venezuela (Spinus cucullatus), mentre in Spagna sono state fatte utilizzando il lucherino testa nera (Spinus magel-

lanicus). I primi soggetti nati in Italia furono chiamati Ametista, in Spagna Jaspe. Inizialmente le diverse denominazioni avevano creato qualche perplessità, prontamente chiarita visto che Ametista e Jaspe sono le due
facce della stessa medaglia, trattandosi della stessa mutazione.
In virtù di quanto detto, non dobbiamo sorprenderci, quindi, se ci troviamo di fronte ad un comportamento genetico che non si era mai
visto prima nella canaricoltura di colore, un comportamento ereditario definito “autosomico semidominante ad espressività variabile” sul quale sarebbe opportuno fare dei chiarimenti.
NUMERO 1 - 2023 23 CANARINIDI COLORE
Foto 1 - Particolare delle remiganti canarino Jaspe s.f.
I primi soggetti nati in Italia furono chiamati Ametista, in Spagna Jaspe.
Inizialmente le diverse denominazioni avevano creato qualche perplessità
Per cercare di rendere più semplice l’argomento che mi appresto ad affrontare, provo a spiegare, in maniera estremamente sommaria, il significato dei termini gene, cromosoma ed allele.


Il gene è un segmento di DNA che contiene le informazioni ereditarie, il cromosoma è la struttura che contiene i geni di un soggetto. In ogni coppia cromosomica sono presenti due geni, uno trasmesso dal padre e l’altro trasmesso dalla madre. In ogni individuo, i cromosomi sono presenti a coppia e ogni individuo presenta due coppie dello stesso gene. Ogni coppia è un allele.

Tornando alla mutazione Jaspe, essa si può esprimere in due modi: può interessare solo un allele o può interessare tutti e due gli alleli.
Se interessa un solo allele, avviene una mutazione parziale (di fatto sarebbe una mutazione a metà) che riduce sì le melanine, le diluisce rispetto al tipo base, ma tecnicamente ci troviamo di fronte ad un soggetto non ancora completamente mutato in Jaspe. Questo è il Jaspe a singolo fattore, o a singola diluizione, il quale, pur avendo delle caratteristiche fenotipiche ben definite, è genetica-
mente un soggetto eterozigote. Per intenderci, se ci trovassimo di fronte ad un’altra mutazione della canaricoltura di colore, questo soggetto sarebbe quello che in gergo viene chiamato “portatore”.
Se invece la mutazione interessa ambedue gli alleli, allora la mutazione è completa. Ci troveremmo in questo caso di fronte ad un soggetto Jaspe omozigote, ed è questa la vera mutazione Jaspe.
Questo concetto è stato sempre ben chiaro, fin da prima che la mutazione stessa fosse riconosciuta… la confusione si è creata successivamente.
Quando la CTN dei canarini di colore

ha pubblicato lo standard del canarino Jaspe (vedi Italia Ornitologica 10, 2015), al punto “Generalità della mutazione Jaspe semplice diluizione nel canarino” ha fatto l’errore di elencare le caratteristiche del singolo fattore riferendosi al doppio fattore. La dizione “autosomico semidominante” è corretta solo allorquando ci riferiamo al canarino Jaspe omozigote. Nel caso della semidominanza, si ottiene un fenotipo intermedio diverso da quello di entrambi i genitori; difatti, unendo uno Jaspe doppio fattore ad un tipo base, si ottiene tutta la prole Jaspe singolo fattore. Un concetto semplice, a sentire i genetisti, poco chiaro invece a sentire i canaricoltori. Appare comunque chiaro a tutti come e quanto siano differenti i comportamenti ereditari del singolo fattore paragonati a quelli del doppio fattore. Che sia stata fatta confusione potrebbe essere comprensibile, specialmente se consideriamo la singolarità delle circostanze. Per la prima volta siamo di fronte ad una mutazione della quale sono stati riconosciuti (quali soggetti a concorso) per primi i portatori e successivamente i soggetti mutati. Ovviamente, tale osser-

24 NUMERO 1 - 2023
Foto 2 - Particolare del timoniere canarino Jaspe, s.f.
Foto 3 - Penne nero bianco, aspe nero bianco s.f., Jaspe nero bianco d.f.
La mutazione Jaspe si può esprimere in due modi: può interessare solo un allele opuò interessare tutti e due gli alleli
vazione ha una valenza prettamente genetica: è innegabile che lo Jaspe singolo fattore abbia delle caratteristiche fenotipiche ben precise che gli permettono di godere di un apposito standard ben definito. Le barrature sulle remiganti (foto 1) e quelle sulle penne caudali (foto 2) sono delle caratteristiche distintive; tuttavia, anche le altre penne e l’espressione melanica che la mutazione esprime hanno precise singolarità (foto 3). Resta da capire, tuttavia, come mai altri aspetti fenotipici caratteristici non vengano presi in considerazione. Ci sarebbe da riflettere come mai non siano stati condotti finora approfondimenti su come la mutazione agisca e, auspico, anche con quale potere di incisività agisca sulla diluizione melanica del piumaggio. A parte Giovanni Canali, sicuramente una delle voci più autorevoli della canaricoltura di colore, non mi pare che nessun altro si sia espresso in tale direzione. Altro punto di riflessione andrebbe fatto considerando la mutazione nell’aspetto complessivo del piumaggio. Prendiamo ad esempio il nero Jaspe. Nei criteri di giudizio si parla di “massima espressione melanica nel rachide”: peccato che non vi sia menzione di come la mutazione agisca anche sulla parte esterna del vessillo. La cosiddetta “fotografia al negativo”, creata giusto da queste interazioni, è una peculiarità della stessa del canarino Jaspe. Dal punto di vista fenotipico è evidente, ci sarebbe da chiedersi come mai venga presa in considerazione soltanto dagli allevatori della razza.

Di sicuro la pandemia degli ultimi anni ha limitato notevolmente il nostro movimento ma già dalla stagione mostre 2020 (stagione che poi, di fatto, non si è svolta proprio a causa del Covid-19), i Jaspe a doppio fattore sono stati inseriti nelle categorie a concorso delle mostre ornitologiche e purtroppo nulla è stato scritto a riguardo. Eppure la mutazione è veramente interessante, bella anche sotto l’aspetto fenotipico ma stenta a prendere piede e trovare una giusta collocazione nella canaricoltura di colore.
Il club italiano del canarino Jaspe, del quale mi onoro di far parte, in questi anni divulgazione ne ha fatta. Abbiamo organizzato convegni tecnicodivulgativi in tutta Italia, corsi di aggiornamento, seminari ma tutto quanto fatto finora pare non sia bastato.

Al momento, su iniziativa del presidente del club Marco Potitò, stiamo raccogliendo delle penne di tutti gli otto tipi dello Jaspe (singolo e doppio fattore) e le stiamo sottoponendo a degli ingrandimenti al microscopio.

Abbiamo un duplice intento. In primo luogo, vorremmo portare avanti uno
studio, basato su questa metodologia, che osservi come la mutazione distribuisca le melanine sul rachide e sul vessillo. In secondo luogo, vorremmo realizzare un database digitale per monitorare l’evoluzione selettiva della mutazione nell’arco dei vari anni.

A scanso di equivoci, sottolineo che non è mia intenzione sollevare delle critiche sterili. Credo appaia evidente, in questo preciso momento storico, la necessità di effettuare ulteriori approfondimenti tecnici e probabilmente anche valutativi su tutti i quattro tipi Jaspe, sia nel singolo che nel doppio fattore. Nutro la speranza che quanto scritto funga da stimolo affinché si divulghi di più a riguardo del canarino Jaspe, in particolare su quello a doppio fattore, se si vuole far sì che questa mutazione venga portata avanti da parte degli allevatori in maniera seria.
Parafrasando Diego Crovace, che in uno suo articolo (La mutazione jaspe nel canarino, Italia Ornitologica 2, 2011) scrisse “… Di questa mutazione si parla molto, si è scritto poco e si sa quasi nulla …” beh, non è che le cose nell’arco di dodici anni siano poi cambiate più di tanto.
NUMERO 1 - 2023 25
G. Canali durante un convegno sul canarino Jaspe a Lamezia Terme, maggio 2017
Stiamo raccogliendo delle penne di tutti gli otto tipi dello Jaspe (singolo e doppio fattore) e le stiamo sottoponendo a degli ingrandimenti al microscopio
Originari appunti di riepilogo sullo Jaspe
di GIOVANNI CANALI
La mutazione jaspe dominante parziale autosomica ed a penetranza completa, si caratterizza per una notevole espressività variabile

In effetti ci sono molti soggetti singolo fattore, che presentano penne anomale, quasi da classico, per la minore riduzione delle melanine. Vi sono variazioni anche nei doppi fattori.
In alcuni soggetti sono molto piccole, in altri notevoli ed acquistano l’aspetto di “toppe”. Molto evidenti nei singoli fattori, più subdole per la scarsa evidenza nei doppi fattori.
Nei doppi fattori, si nota molto spesso una singola penna tettrice (la cosiddetta piuma) anomala con un solo vessillo scuro, cioè la metà per il lungo.
Esistono però anche situazioni inverse cioè con zone che potremmo chiamare ipertipiche nei singoli fattori.
Si ha l’impressione netta che siano parti acianiche (lipocromiche)
Riguardano sia le penne forti che le unghie, proprio come le zone acianiche nei melaninici normali.
Osservando la molto diffusa presenza di queste zone apparentemente acianiche che appaiono negli jaspe singolo fattore, ma non nei melanici classici loro fratelli, all’inizio si pensa ad un caso. Poi visto che la cosa si ripete in modo costante, appare evidente che caso non può essere. Nelle penne si può notare qualcosa alla base, mentre nelle unghie no. Anche in fringillidi ovel’acianismo non c’è (ad esempio il Lucherino ove è comparsa la mutazione), queste zone appaiono ugualmente , segno evidente che di acianismo non si tratta.
Sembrerebbe logico quindi non squalificare, ma solo penalizzare, anche se c’è il rischio di far passare tracce acianiche vere, quindi è discutibile.
Il discorso penalizzazione o squalifica si potrebbe fare anche per le parti atipiche scure. Si potrebbe optare per la squalifica, come per la penalizzazione, come per situazioni intermedie a seconda della gravità del difetto. Sono aspetti molto discutibili.
Le penne che paiono acianiche possono avere un minimo di riconoscibilità, specie se viste alla mano nella zona iniziale, le unghie pare di no. Nella discussione sarebbe bene tener presente che l’espressività variabile non è selezionabile o, se lo è, in misura minima.
C’è anche da considerare l’aspetto che la grande severità indurrebbe a tolettature pesanti. Da non dimenticare che lo jaspe sembra avere una sorta di antagonismo con l’agata, infatti la riduzione è maggiore nei neri singolo fattore, nei quali si forma la bifora, rispetto agli agata singolo fattore che sono più scuri e senza bifora. La stria sembra allargata ma omogenea.
I bruni seguono il nero e gli isabella l’agata. È bene usare il termine bifora poiché a quella assomigliano: rachide scura e lati della scaglia scuri (lati scaglia non bordo penna) convergenti in punta. Altre descrizioni sono meno precise; ad esempio i “binari” non convergono. Bisogna assolutamente recepire che la barratura alare non deriva dagli Spinus! È diversa: la prima remigante (contando all’europea) è barrata, la prima degli Spinus no, se non in misura minima nel vessillo interno. In alcune specie non sono barrate le prime tre.
La barratura dello jaspe è più ampia, rispetto agli Spinus, ma limitata a poche penne; raramente supera la settima remigante primaria, mentre negli Spinus va oltre secondarie comprese.
In jaspe anomali ci può essere una seconda barratura sulle copritrici che non esiste negli Spinus.
I fratelli normali ne sono immuni totalmente e gli Spinus non nascono certo jaspe, ma la barratura è nei normali.
Ho usato il termine fattore e non diluizione poiché il discorso è genetico e di diluizione non si tratta.
Negli omozigoti detti doppio fattore suggerisco a livello descrizione il termine “cristallino”, per indicare l’effetto che inducono le melanine fortemente ridotte.
Non vado oltre, si tratta solo di appunti, tesi ad evitare errori di base.
26 NUMERO 1 - 2023
Il Diamante di Gould a groppone giallo


Genetica, sviluppi e selezione
di FRANCESCO FAGGIANO, foto F. FAGGIANOE M. DE FREITAS
Introduzione
Quattro o cinque anni fa, in un mondo molto diverso da quello di oggi, ho avuto la fortuna di incontrare un grande ornicoltore innamorato del Diamante di Gould. Il Signor Manny
De Freitas, uomo di grande esperienza orniculturale, esperienza ben diversa dalla nostra perché realizzata in un paese molto lontano dall’ Europa: il Sudafrica. Come già scritto in un precedente articolo sempre su I.O., il signor Manny da qualche anno si è trasferito a Lanciano, nel cuore dell’Italia, scelta fatta anche dopo aver conosciuto il gruppo ornitologico di Erythruria, che organizza ogni anno una delle più belle manifestazioni europee sul Diamante di Gould. Nel suo trasferimento, quest’uomo silenzioso ed attento, tra mille difficoltà è riuscito a portare con sé i suoi amati Diamanti di Gould, ma in particolare ha portato in Italia un’interessante mutazione definibile “Groppone Giallo”.

Perché groppone e non codione… il nome giusto alla mutazione
In ornicoltura, cercando di dare un senso logico e un riferimento tecnico alle cose che ci riguardano, in primo luogo si cerca di denominare ogni mutazione con una definizione che indichi il principale effetto mutante sul fenotipo, il colore richiesto dalla logica selettiva e possibilmente la trasmissione ereditaria. Nel caso specifico evidenzieremo come l’effetto più
Questa variante genetica presenta una trasmissione ereditaria dominante
significativo della mutazione sia la perdita del calzone, ovvero dell’area compresa tra il dorso e il codione, che scende sui fianchi sotto le ali. In zoologia (vocabolario Treccani) questa porzione, ovvero la parte estrema

NUMERO 1 - 2023 27 ESTRILDIDI FRINGILLIDI IBRIDI
Diamante di Gould groppone giallo
dorsale posteriore del tronco degli uccelli, che confina col sopraccoda, è chiamata groppone. Partendo da questo termine, per dare una nomenclatura tecnicamente efficace e corretta, sarebbe opportuno usare il termine “Groppone Giallo” per denominare il fenotipo, usando le due maiuscole per evidenziare la trasmissione dominante della mutazione. Va detto che anche il codione diventa lipocromico, ma rispetto alla perdita del calzone è sicuramente un fenomeno meno rilevante e già presente in altri fenotipi.

La genetica del nuovo fenotipo Questa variante genetica del Diamante di Gould presenta una trasmissione ereditaria dominante, per cui la sua stabilizzazione non ha comportato particolare difficoltà, considerando che l’effetto metabolico pare non essere fisiologicamente debilitante. Va evidenziato che lo stesso ornicoltore titolare della mutazione ci descrive come indistinguibili i soggetti omozigoti da quelli eterozigoti. Il signor Manny ci racconta che nei primi anni d’allevamento ha approntato solo coppie tra mutato x classico presunti portatori, ottenendo statistica-



mente il 50% di figli classici e il 50% di figli mutati, pensando che la mutazione fosse recessiva, ma i risultati di queste coppie, troppo statici per una mutazione recessiva, non convincevano statisticamente. Per questo ad un certo punto ha accoppiato esemplari mutati con soggetti estranei alla stirpe, evidenziando la dominanza netta del carattere perché accoppiando un mutato con un classico non imparentato col suo ceppo ha ottenuto già in prima generazione figli mutati. Così facendo ha irrobustito il ceppo e determinato esattamente la peculiarità della trasmissione genetica. Con questo nuovo accoppiamento non poteva però sapere se eventuali soggetti omozigoti palesassero un fenotipo differente.
Considerando la peculiarità del carattere, ha pensato che probabilmente un eventuale doppio fattore potesse avere un fenotipo più caratterizzato e spinto del singolo fattore; ha quindi accoppiato un presunto mutato eterozigote con un altro presunto mutato eterozigote da cui ha ottenuto il 75% dei soggetti a “Groppone Giallo” ed il 25% dei soggetti a fenotipo Classico. Le leggi della genetica ci insegnano che già in questo primo accoppiamento il 25% dei mutati, sempre statisticamente, è omozigote, ma tutti i soggetti a “Groppone Giallo” erano fenotipicamente sovrapponibili, nessuno evidenziava l’immaginata amplificazione dell’effetto mutante. Questo ha richiesto all’allevatore un’ulteriore indagine a conferma che il fenotipo degli eterozigoti e quello degli omozigoti fosse sovrapponibile. La possibilità che di circa 15 soggetti nati dall’accoppiamento tra mutanti eterozigoti non fosse nato nemmeno un doppio fattore era veramente bassa. Due le possibilità più realistiche: o il doppio fattore era fenotipicamente uguale agli eterozigoti, oppure esisteva una letalità dell’embrione omozigote (cosa ancora tecnicamente non provata), cosa però non soste-

28 NUMERO 1 - 2023
Diamante di Gould blu a groppone giallo femmina
Diamante di Gould blu a groppone giallo maschio
Ad un certo punto ha accoppiato esemplari mutati con soggetti estranei alla stirpe, evidenziando la dominanza del carattere
nuta dalla buona schiusa media registrata nella stagione riproduttiva. A questo punto il signor Manny, da vero ornicoltore consapevole e capace, per verificare che la deduzione sull’unicità del fenotipo di questo mutante fosse vera, ha accoppiato tutti i figli mutati nati da genitori eterozigoti con esemplari a fenotipo classico. In questo modo ha evidenziato che in effetti 5 esemplari accoppiati con esemplari a fenotipo classico hanno prodotto il 100% della figliolanza mutata, stabilendo che in effetti il genitore a “Groppone Giallo” fosse un omozigote, ma indistinguibile da un singolo fattore. Da attento e meticoloso selezionatore, Il signor Manny oggi riporta che i soggetti doppio fattore presentano da pulli aree acianiche più estese, cosa che non è però rilevabile nei soggetti adulti.
L’azione sul fenotipo Nel descrivere l’effetto sul fenotipo di questa caratteristica mutazione, dobbiamo riferirci al fatto che la livrea del Diamante di Gould non si compone semplicemente attraverso il deposito stratificato e uniforme delle melanine e dei lipocromi. Nel Diamante di Gould, come in molte altre specie, la disposizione di questi pigmenti è fortemente organizzata da più geni regolatori e non solo da quelli produttori del pigmento. Sono questi geni regolatori che permettono ad esempio di modulare la qualità del lipocromo, rosso o arancio, nella maschera o addirittura la sua sostituzione con l’eumelanina nella varietà testanera. È questa complessa relazione tra molti geni con funzioni ed attività differenti che determina l’effetto fenotipico finale di ogni mutazione. Ogni fenotipo classico dipende da una sequenza di geni (ognuno dei quali implementa su uno o più passaggi della determinazione del fenotipo) che interviene nella fase di accrescimento del piumaggio secondo una cronologia e una modalità modulata e gestita da tutta una serie di interazione. Questo pool genico è organizzato per esprimersi durante la crescita delle piume in una sequenza temporale, ma non lineare,



perché i vari geni possono avere azione sequenziale, congiunta o intermittente, regolata da altri geni modulatori e/o regolatori, che permettono di realizzare differenze di colore, intensità, sfumature, disegni ecc. anche in base all’area anatomica in cui si esprimono. Se una mutazione interessa un gene all’inizio di questa cronologia, che possiamo definire come una “rete tridimensionale” di eventi, è chiaro che tutto il processo si modifica o addirittura si interrompe. Ad esempio le varie forme di albinismo intervengono all’inizio del processo di melanogenesi inibendo la tirosinasi… così tutto il processo legato alla melanizzazione è inficiato in rapporto al deficit iniziale. Analizzando il nuovo fenotipo del Diamante di Gould, notiamo che sul tipo classico il target principale su cui incide la nuova mutazione si riduce essen-
zialmente, come abbiamo evidenziato, in primis al groppone, parte distale del dorso che si attacca al sovracoda anch’esso demelanizzato. Determinando la perdita del calzone all’altezza della groppa e del codione, andando a realizzare così un’ampia zona acianica, leggermente interessata soprattutto nella parte superiore da soffuso lipocromo giallo, da cui il nome della mutazione. Altre caratteristiche vanno a completare questo particolare fenotipo: una depigmentazione periferica dall’apice verso il rachide delle timoniere, una modifica del collarino che appare più ampio e sfumato, ma soprattutto di un colore più tendente al violetto e non al turchese, ed infine la comparsa di una tenue banda alare all’apice delle copritrici primarie e secondarie di colore bianco giallastro. Su questo particolare carattere faremo di seguito una riflessione accurata che potrebbe portare anche a dovuti spunti sulla selezione dei tipi classici. Queste peculiari caratteristiche presenti sul fenotipo dei Diamanti di Gould a “Groppone Giallo” ci indicano un’azione che riduce localmente la pigmentazione melanica delle piume durante la prima fase di crescita delle stesse considerando che ad esempio le timoniere presentano l’apice apigmentato, così come le piume del co-
NUMERO 1 - 2023 29
La livrea del Diamante di Gould non si compone semplicemente attraverso il deposito stratificato e uniforme delle melanine e dei lipocromi
Confronto tra il groppone di un soggetto mutato a sinistra e classico a destra
dione che presentano melanina localizzata solo nella parte mediale e bassa. Questa precisa localizzazione della melanina ci indica un avvio ritardato della melanizzazione almeno nel terzo inferiore del corpo, ma con un proseguimento presumibilmente adeguato nel resto del corpo. Questo ci evidenzia che così come per il petto esistono uno o più geni che regolano la pigmentazione di queste specifiche aree.
Un parallelismo tra mutazioni: groppone giallo versus pettonero Il mondo dei fenotipi mutatici riserva spesso novità impensabili, tranne che nel Diamante mandarino; fino a pochi anni fa, non conoscevamo ancora mutanti genici capaci di modificare il disegno di una specie o per lo meno non ne avevamo consapevolezza. Eppure, sarebbe bastato guardare un po’ meglio il mondo circostante per capire immediatamente che in tutti gli animali parti diverse del corpo possono essere diversamente interessate da una mutazione e presentare colori e/o disegni diversi dalle altre. È questo il caso ad esempio della mutazione “opalino”, oggi ampiamente diffusa negli psittacidi, dove la muta-
zione di un singolo gene sessolegato produce una modificazione sostanziale del disegno e del colore della specie. Forse meno evidente ma comunque indicativo a tal proposito poteva essere addirittura lo stesso policromismo della maschera nel Diamante di Gould, dove due distinti geni determinano modificazioni precise del colore di quell’area. Ancor più significativo per la mutazione in questione è il caso della tortora diamantina (Geopelia cuneata) che nel suo panorama selettivo ci propone una mutazione a dominanza incompleta, che produce un fenotipo assimilabile detto a “Groppone Bianco”. La mutazione in eterozigosi determina la depigmentazione del groppone e dell’apice delle timoniere, fenotipo


sovrapponibile a quello del Gould a “Groppone Giallo”, mentre in omozigosi tutta la porzione posteriore comprese le timoniere diventa acianica e questo sostiene l’ipotesi di una eventuale letalità degli omozigoti nel Gould.
Questo breve excursus ci mette nuovamente in evidenza come lo stesso gene sia spesso presente in molte specie e come sempre un singolo gene può determinare effetti macroscopici localizzati in porzioni somatiche isolate. Questo perché ogni gene può subire mutazioni che, pur sviluppando fenotipi simili o addirittura sovrapponibili, non sempre corrispondono, perché date da cambiamenti tecnicamente diversi, ovvero lo stesso gene può presentare mutazioni distinte. Tali comparazioni sono importanti perché ci permettono di interpretare meglio ogni nuovo fenotipo e di orientarci adeguatamente ed in modo uniforme nella selezione. Proprio osservando e comparando questi interessanti soggetti esposti anche a “Gould mania” di Cesena in occasione di “Piume”, eccellente Expo ornitologica, abbiamo ipotizzato che la mutazione in questione potrebbe essere geneticamente riconducibile

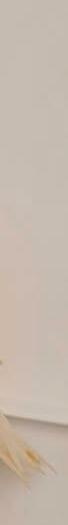

30 NUMERO 1 - 2023
Diamante di Gould pastello SF pettobianco a groppone giallo
Diamante di Gould petto bianco groppone giallo
La mutazione in eterozigosi determina la depigmentazione del groppone e dell’apice delle timoniere
al gene che determina il pettonero nel Diamante mandarino; ovviamente questa è un’ipotesi basata su alcuni indizi, primo tra tutti la perdita del calzone, elemento non da poco. Altro indizio interessante è la tendente localizzazione della melanina sull’asse centrale della piuma con la comparsa di orlature/perlatura sulle penne forti e sulle copritrici alari. Chiaramente poi il mutante si esprime in modo differente in quanto la sopraindicata “rete tridimensionale” di geni regolatori della disposizione dei pigmenti tra Diamante di Gould e Diamante mandarino è ben diversa, ma gli indizi di un gene condiviso ci sono. Certo, questo poco ci aiuta nello stabilire l’espressione più corretta per questo mutante e l’ipotesi rimane più come informazione a sé che altro.

Prospettive della selezione
Anche se siamo ancora agli esordi della selezione di questa inedita mutazione del Diamante di Gould, possiamo certamente indicarne come punti salienti per il miglioramento fenotipico l’enfatizzazione dei tre elementi caratterizzanti la stessa: groppone, banda alare e collarino. A nostro parere dovremmo cercare con la selezione di ampliare il groppone depigmentato, intensificando la pigmentazione lipocromica, rinforzare e rendere regolare e ben evidente la banda alare e stabilizzare l’espressione cromatica violacea del collarino e dell’area retrostante che tende al dorato. La trasmissione dominante della mutazione agevolerà sicuramente la selezione, perché ci permette di giocare a carte scoperte sia con gli eterozigoti che con gli omozigoti, così come ha fatto finora il si-



gnor Manny, che ad oggi ha già sovrapposto questo fenotipo praticamente a tutti quelli già fissati compreso il bruno. Interessante è notare la stabilità espressiva della mutazione, che ovviamente diventa quasi insignificante sui fenotipi più schiariti come il lutino e ancor più sul pastello, dove poco si evidenzia per ovvi motivi. Molto interessante è la combinazione con il pettobianco, dove la sovrapposizione dei fenotipi enfatizza il contrasto tra dorso e testa pigmentati e lo schiarimento del groppone che, senza soluzione di continuità, si lega al ventre limpido che sale fino al candido petto. In questa combina-
zione migliora anche la banda alare che appare appena più accentuata, probabilmente per un sinergismo tra il ritardato inizio della melanizzazione, l’azzeramento della feomelanina e l’ingerenza del pettobianco sul deposito eumelanico. La combinazione a nostro parere più suggestiva è quella col blu pettobianco, tanto più nel testanera, dove il contrasto tra bianco delle parti inferiori e celeste del dorso contrasta in modo suggestivo, il tutto enfatizzato dallo stacco del nero della testa rotto dal becco color bianco perla. Dall’approfondimento e lo studio di questo nuovo fenotipo possiamo però co-
NUMERO 1 - 2023 31
Nidiata di gould blu a groppone giallo
Ogni gene può subire mutazioni che, pur sviluppando fenotipi simili o addirittura sovrapponibili, non sempre corrispondono
gliere l’occasione per sviluppare e rivedere forse alcuni presupposti granitici inerenti la selezione classica del Diamante di Gould, che forse oggi, anche grazie a questa nuova mutazione, possiamo considerare diversamente. In particolare la mutazione a “Groppone Giallo” mette in evidenza come il presupposto dell’uniformità del colore delle ali sia da rivalutare attentamente, alla luce della “comparsa” della banda alare in questi soggetti. È questo un ornamento caratterizzante e piacevole della mutazione?
Probabilmente sì, che si basa essenzialmente su una predisposizione atavica della specie, fortemente contrastata dalla selezione domestica, però ancor oggi presente sia nei soggetti selvatici che in quelli domestici. In effetti, nei primi soggetti a “Groppone Giallo”, derivanti da un ceppo sudafricano non assoggettato alla selezione europea, che di contro richiede una colorazione verde uniforme del dorso e delle ali, penalizzando l’orlatura bluastra delle copritrici, la banda alare gialla era molto più uniforme ed espressiva. Nei soggetti esposti alle specialistiche del 2022 questo carattere è molto meno evidente pro-

babilmente perché l’ornicoltore, nell’intento di migliorare il suo ceppo, negli ultimi tre anni ha più volte usato ottimi soggetti italiani, assoggettati da più generazioni ad una selezione che spinge sull’azzeramento del carattere, premiando i soggetti con ali verdi uniformi. È pur vero che nonostante i 50 anni di selezione domestica questo carattere è ancora fortemente presente nei nostri aviari, dove almeno il 30 % dei soggetti lo mostra.
Questo dovrebbe forse indurci a rivedere anche l’orientamento selettivo delle forme classiche del Gould, in virtù dell’attuale possibilità di osservare anche soggetti selvatici in ambiente naturale, dove è palese la presenza ubiquitaria della suddetta
banda alare bluastra. Se noi come zootecnici dobbiamo stabilire le caratteristiche del fenotipo domestico di una specie sulle basi generali dell’ingentilimento fenotipico, ovvero migliorando parametri come intensità, uniformità, precisione del colore e del disegno, è altrettanto vero che dobbiamo preservare l’identità della specie, in particolare mantenendo e migliorando quelle “caratteristiche ornamentali” anche minori come la soffusione blu dell’apice delle copritrici alari. Perché se è assolutamente corretto selezionare un dorso uniforme intenso e brillante, potrebbe essere anche corretto considerare la banda alare bluastra un disegno ornamentale e quindi selezionabile verso parametri di precisione e non cercare di eliminarla.


Conclusioni
L’ornicoltura amatoriale diventa una disciplina sempre più complessa e competente, eppure a fronte di questa sua evoluzione tecnica è vessata da pressioni estranee a questo mondo, perché si crede ancora che i cattivi della favola siano gli allevatori. Per questo, la conoscenza e la divulgazione di ciò che facciamo e proteggiamo attraverso la selezione domestica devono essere l’arma e lo scudo a difesa del nostro fragile mondo, dove dietro i tavoli del mercato della domenica mattina si cela un impegno impagabile di risorse e amore, che non può più rimanere conoscenza solo degli addetti ai lavori. Dobbiamo abbandonare le opinioni ed alzare la nostra competenza media per avere strumenti oggettivi che evidenzino in primis la distanza tra i nostri uccelli domestici e le stirpi selvatiche e poi l’importanza che queste razze domestiche hanno nella difesa della biodiversità di un pianeta che vive ufficialmente la sesta grande estinzione di massa. Per questo, ogni ceppo, ogni selezione e ancor più ogni nuovo mutante che compare in una specie allevata assume oggi un valore universale e non solo estetico... in un mondo dove non c’è più la possibilità che nuove creature viventi prendano forma spontaneamente a causa della devastazione degli habitat.

32 NUMERO 1 - 2023
Coppia di Diamante di Gould blu pettobianco a groppone giallo
La mutazione a “Groppone Giallo” mette in evidenza come il presupposto dell’uniformità del colore delle ali sia da rivalutare attentamente
Uova chiare
testo e foto di dr. Diego Cattarossi (*)
Per uova “chiare” si intendono uova nelle quali non si osserva lo sviluppo dell’embrione durante il periodo di incubazione, naturale o artificiale.
Rappresenta un grosso problema nell’allevamento amatoriale di molte specie di uccelli; molti allevatori lamentano un aumento di incidenza del problema, soprattutto in alcune annate.

Il termine uova chiare deriva dalla pratica della speratura delle uova, manovra con la quale l’uovo viene osservato tenendolo tra le dita in ambiente poco luminoso, con una fonte di luce molto intensa posizionata dal lato opposto rispetto a quello dell’osservatore. Se la luce passa senza trovare impedimenti, l’uovo risulta “chiaro”, ovvero senza embrione all’interno. Se invece all’interno dell’uovo si sta sviluppando un pulcino, la luce troverà questo ostacolo e quindi l’uovo sarà scuro al suo interno. In molte specie con uova di piccole dimensioni e guscio sottile, tramite la speratura è spesso possibile osservare, nelle uova fertili, il movimento del pulcino ed apprezzarne il battito cardiaco.



Sotto questa nomenclatura pratica, possiamo includere fattispecie diverse. Infatti, possiamo trovarci nella condizione nella quale l’uovo non sia stato fecondato, oppure che l’uovo pur fecondato non abbia potuto dare alla luce un embrione e quindi un pulcino. In questo secondo caso la mortalità embrionale dovrebbe essere precocissima (primi giorni), non per-
mettendo neppure lo sviluppo dei primi capillari ematici. Tra le diverse cause di mancata fertilizzazione dell’uovo possiamo citare tra le più probabili:
NUMERO 1 - 2023 33 VETERINARIO
Uovo chiaro alla speratura
Il termine uova chiare deriva dalla pratica della speratura delle uova, manovra con la quale l’uovo viene osservato tenendolo tra le dita in ambiente poco luminoso
(*)Medico Veterinario aviare presso Clinica Veterinaria Casale sul Sile
-Mancata formazione della coppia. La femmina è pronta a deporre l’uovo ma per mancato affiatamento non è avvenuta la copula tra maschio e femmina
-Scorretta identificazione del genere di appartenenza (due femmine)
-Incapacità meccanica durante l’accoppiamento da parte del maschio a trasferire lo sperma nell’apparato genitale femminile (es.

piumaggio eccessivamente lungo in alcune razze, obesità con deposito di grasso in addome, alterazione della colonna vertebrale, posatoi inadeguati, ecc.)

-Coppie disturbate o inidonea gestione, soprattutto in specie nervose o di recente domesticazione

-Convivenza della coppia con altri animali della stessa specie o di specie diverse, accoppiamenti tra specie diverse per la formazione di ibridi
-Mancata vitalità degli spermatozoi dopo l’accoppiamento (maschio molto anziano, infezione dei testicoli o atrofia dei testicoli, intossicazione a carico di metalli pesanti o micotossine, ecc.)
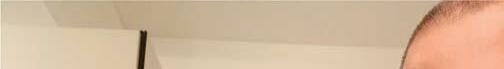

-Eccessivo stress (competizioni, trasferimenti, manipolazioni eccessive, ecc.)
-Malattie sistemiche che riguardino i riproduttori.


34 NUMERO 1 - 2023
Diego Cattarossi, in clinica con gyrfalcon
Diego Cattarossi, internazionale SOR di Modena
La soluzione spesso adottata dagli allevatori nel caso di uova chiare, in assenza di accertamenti veterinari, è l’integrazione della dieta con vitamina E, oppure con complessi vitaminici contenenti vitamina E, selenio ed oligoelementi
Tra le cause di mortalità precoce dell’embrione:

-Accoppiamenti con geni letali o sub-letali in alcune razze molto selezionate
-Alterazioni cromosomiche che inducano malformazioni incompatibili con la vita
-Infezioni batteriche/virali/parassitarie delle vie genitali, soprattutto femminili
-Patologia dell’ovaio e della salpinge infiammatorie, degenerative, tossiche, ecc.

-Malattie sistemiche dei riproduttori, malattie a trasmissione verticale
-Infezioni dell’uovo dopo la deposizione attraverso il guscio
-Carenze nutrizionali, disordini vitaminico-minerali, carenza di calcio e squilibrio calcio-fosforo, eccesso di integratori errati.



La soluzione spesso adottata dagli allevatori nel caso di uova chiare, in assenza di accertamenti veterinari, è l’integrazione della dieta con vitamina E, oppure con complessi vitaminici contenenti vitamina E, selenio ed oligoelementi. Per quanto questi elementi siano responsabili dell’integrità delle membrane e degli epiteli, la semplice integrazione senza aver individuato il reale problema non è mai risolutiva. L’integrazione di una singola vitamina, in assenza di una reale ed acclarata carenza, potrebbe addirittura causare un disordine alimentare per la competizione che avviene a livello intestinale nell’assorbimento di altri nutrienti.
La soluzione al problema delle uova chiare, quindi, non può prescindere dallo studio ed individuazione della precisa causa che ne determina la presenza. Solo in questo modo sarà possibile risolvere il problema eliminando la causa invece che procedere per tentativi, con il rischio di perdere l’intera annata riproduttiva.

NUMERO 1 - 2023 35


















L’Amaranto comune
Da erbaccia infestante a pseudocereale superfood


 di PIERLUIGI MENGACCI, foto WIKIPEDIA, WWW AFRICANBIRDCLUB ORG, WIKIMEDIA
di PIERLUIGI MENGACCI, foto WIKIPEDIA, WWW AFRICANBIRDCLUB ORG, WIKIMEDIA
Premessa
Che cos’è un’erbaccia? Quante volte me lo sono chiesto! Quante volte la parola erbaccia ci rincorre durante la giornata! Quando camminiamo nei marciapiedi, oppure nei sentieri di campagna o di montagna, nei prati o parchi di città. Quante volte diciamo “È un’erbaccia!” calpestandola sotto i nostri piedi.
Ma un’erbaccia cos’è?A questa domanda, che più volte mi son posto, ho trovato queste risposte: Secondo il dizionario è una “pianta erbacea che la terra produce spontaneamente, senza coltura”, oppure “una pianta selvatica (non coltivata deliberatamente) che cresce dove non la si vuole” o ancora “erba inutile, dannosa al seminato, infestante”.
Secondo Wikipedia “per pianta infestante (oppure malerba o popolarmente erbaccia) si intende una pianta che, non rivestendo alcuna funzione ritenuta utile per la produzione agricola, va a danneggiare le piante esistenti entrando in competizione con esse o parassitandole”.
SecondoDuog Larson, giornalista, “un’erbaccia è una pianta che ha imparato tutte le abilità di sopravvivenza ad eccezione di come crescere in fila”. Potrei citare altre definizioni ma, secondo me, la più attinente e perspicace è quella del filosofo R. W. Emerson: “Che cos’è un’erbaccia? Una pianta di cui non sono state ancora scoperte le virtù”. Quest’ultima frase mi è tornata in mente un giorno mentre ero intento a potare e pulire dalle “erbacce” la siepe di alloro e mi è capitata tra le mani una pianticella mai vista nel giardino; prima di sradicarla, mi sono chiesto: “È un’erbaccia, o… una pianta di cui non conosco le virtù?!”. Guardandola meglio, le foglie leggermente seghettate e nervate attaccate al fusto da un lungo picciolo, il formarsi di una specie di pannocchia sull’apice mi hanno ricordato una pianticella che mi fece notare l’amico agronomo Massimo, anni or sono, durante la visita ad un fabbricato colonico da ristrutturare. Durante le nostre uscite in campagna, per lavoro o meno, Massimo mi presentava sempre qualche pianticella “strana”, elencandone pregi,
difetti e virtù e se fosse più o meno commestibile. Quel giorno mi fece notare una pianticella nata al piede di una parete in pietre e mattoni del fabbricato in questione, dicendomi:
“Gigi conosci questa pianticella?”.
La guardai: era una pianticella che più volte avevo incontrato nelle mie escursioni campagnole, alla quale non avevo mai prestato alcuna considerazione, anzi, da sempre la consideravo un’erbaccia infestante.
“È un’erbaccia infestante” gli rispondo “che ogni tanto si incontra passeggiando lungo i sentieri di campagna o in qualche campo abbandonato”.
“Si, hai ragione, è considerata una pianta infestante e purtroppo viene eradicata anche con i diserbanti. Ne conosci il nome? Sai che…”. Lo interrompo.
38 NUMERO 1 - 2023 ALIMENTAZIONE
ORG, P. MENGACCI,
Dal libretto dei miei appunti orto-ornitofili e non solo
Amaranthus retroflexus, fonte: wikimedia.org
Pianta di Amaranto comune (Amaranthus retroflexus), foto: P.Mengacci
“Non mi dire adesso che anche questa è commestibile ed ha super poteri !?”. “Hai detto bene: è commestibile! È considerata uno pseudo-cereale che ha molte proprietà nutritive: le sue foglie si possono usare al posto degli spinaci. Si chiamaAmaranto Comunee i suoi semi sono ricchi di proteine, vitamine, minerali, ecc. E poi tu, che sei un ornitofilo e amante delle erbe selvatiche, dovresti sapere che passeri,cardellini, verdoni e altri silvani si nutrono dei semi di questa pianta. Inoltre, quello che le nostre mani oggi strappano e buttano via come erbaccia infestante potrebbe diventare un alimento vitale per il futuro”.
Le parole di Massimo hanno “toccato”
il mio amor proprio e, tornato a casa, non vedevo l’ora di conoscere questa erbaccia infestante pseudo-cereale.
Alcuni dati botanico-storici

La pianta erbacea dell’Amaranto appartiene alla famiglia delle Amarantaceae ed è una grande famiglia che comprende oltre 500 specie di cui l’Amaranto Comune (Amaranthus retroflexus) è il parente selvatico di quelle coltivate per la produzione di semi commestibili (oltre 60 specie). Le piante più rinomate e coltivate,non solo per la produzione di semi ma anche per arredare giardini e parchi, sono Amaranthus caudatus, Amaranthus cruentus e Amaranthus hypochondriacus. Sonopiante dicotiledoni, vale a dire caratterizzate da un embrione dotato di due cotiledoni (foglia embrionale), a differenza dei cereali,
piante monocotiledoni, con foglia singola.
Etimologicamente il nome deriva dal greco amarantos = che non appassisce (le infiorescenze rimangono intatte anche dopo l’essiccamento); inoltre, molte specie hanno fiori rossi, per cui la parola ha finito per identificare una varietà cromatica tra il rosso scarlatto e il cremisi. Retroflexus = piegato all’indietro, attitudine tipica della pannocchia centrale dell’amaranto ad essere piegata all’indietro.
A proposito del color amaranto, esiste anche un uccello esotico chiamato Amaranto del Senegal o Amaranto rosso (Lagonosticta senegala (Linnaeus, 1766) ed è un uccello passeriforme della famiglia degli Estrildidi. La pianta è di origine sudamericana e fu introdotta per errore in Europa nei primi viaggi dalle Americhe. Le popolazioni delle civiltà Azteca e Maya consideravano queste piante “l’oro degli Dei” e i semi erano noti per le alte qualità nutrizionali ed energetiche ed erano ritenuti i semi più importanti tra tutti quelli alimentari. Altrettanto, se non maggiormente importante, era l’uso che ne veniva fatto nei riti religiosi. Si dice che gli Aztechi impastassero l’amaranto con farina di mais per forgiare delle figure antropomorfe che richiamavano i loro idoli venerati, figure che venivano poi consumate al termine dei riti propiziatori. L’amaranto è una pianta erbacea annuale. Ha un apparato radicale fittonante che raggiunge un’ottima profondità nel terreno. Ha un fusto


eretto, legnoso nella parte inferiore di colorazione verde chiaro, più rossastro alla base e può raggiungere un’altezza media di 100 cm, ma in condizioni ideali può arrivare fino a 2 metri. La pianta crescendo assume una forma cespugliosa che le viene data dalle varie ramificazioni che si dipartono dal fusto a partire dalla rosetta basale. Le foglie, di color verde, con margine leggermente ondulato e chiare nervature, sono attaccate al fusto da un lungo picciolo.
I fiori o infiorescenze sono a forma di spiga sulle ramificazioni laterali ed hanno la forma di una grossa pannocchia terminale lunga anche 15 cm sita all’apice del fusto. È una pianta monoica, ovvero i fiori femminili e maschili si trovano sulla stessa pianta. Ogni pannocchia produce molti semi di colore marrone o rossastro, la cui caratteristica peculiare è quella di rimanere vitali nel terreno per molti anni. La pianta dell’amaranto comune, oltre che nei campi coltivati, la troviamo nei prati, nei bordi dei sentieri, nelle aie di fabbricati colonici abbandonati, negli orti ecc. e trattandosi di una pianta piuttosto resistente a parassiti, malattie e temperature elevate non ha bisogno di particolari cure.
La pianta è commestibile per intero. Foglie, semi e radici sono da sempre impiegati nell’alimentazione. Le foglie hanno un sapore delicato simile a quello degli spinaci; le radici sono ricche di amido con un sapore che ricorda il latte; i semi hanno un retrogusto di nocciola.
NUMERO 1 - 2023 39
Amaranto fiammante (Hypargos niveoguttatus), fonte: www.africanbirdclub.org
Amaranto (Lagonostictasenegale), fonte: wikipedia.org
Valori nutrizionali calcolati per 100gr. di semi crudi di Amaranto.

Fonte: database USDA - Dipartimento dell’Agricoltura degli Stati Uniti

40 NUMERO 1 - 2023
Principali Calorie kcal 371 Calorie kj 1554 Grassi g 7.02 Carboidrati g 65.25 Proteine g 13.56 Fibre g 6.7 Zuccheri g 1.69 Acqua g 11.29 Amido g 57.27 Ceneri g 2.88 Minerali Calcio mg 159 Sodio mg 4 Fosforo mg 557 Potassio mg 508 Ferro mg 7.61 Magnesio mg 248 Zinco mg 2.87 Rame mg 0.525 Manganese mg 3.333 Selenio mcg 18.7 Vitamine Retinolo (Vit. A) mcg 0 Vitamina A, IU IU 2 Betaina mg 67.6 Vitamina A, RAE mcg_RAE 0 Tiamina (Vit. B1) mg 0.116 Riboflavina (Vit. B2) mg 0.2 Niacina (Vit. B3) mg 0.923 Acido Pantotenico (Vit. B5) mg 1.457 Piridossina (Vit. B6) mg 0.591 Acido folico (Vit. B9 o M o Folacina) mcg 0 Folato alimentare mcg 82 Folato, DFE mcg_DFE 82 Folati, totali mcg 82 Cobalamina (Vit. B12) mcg 0 Vitamina B-12, aggiunta mcg 0 Acido ascorbico (Vit. C) mg 4.2 Vitamina D (D2+D3) mcg 0 Colecalcifenolo (Vit. D) IU 0 Alpha-tocoferolo (Vit. E) mg 1.19 Fillochinone (Vit. K) mcg 0 Colina totale (Vit. J) mg 69.8 Carotene, beta mcg 1 Carotene, alfa mcg 0 Criptoxantina, beta mcg 0 Licopene mcg 0 Luteina + zeaxantina mcg 28 Tocoferolo beta mg 0.96 Tocoferolo gamma mg 0.19 Tocoferolo delta mg 0.69 Zuccheri Destrosio g 0.27 Fruttosio g 0.01 Galattosio g 0 Lattosio g 0 Maltosio g 0.01 Saccarosio g 1.4 Lipidi Acidi grassi, monoinsaturi g 1.685 Acidi grassi, polinsaturi g 2.778 Acidi grassi, saturi g 1.459 Colesterolo mg 0 Fitosteroli mg 24 Grassi saturi 8:0 g 0 10:0 g 0 12:0 g 0 14:0 g 0.011 15:0 g 0 16:0 g 1.154 17:0 g 0 18:0 g 0.223 20:0 g 0.052 22:0 g 0.018 Grassi monoinsaturi 14:1 g 0 15:1 g 0 16:1 indifferenziato g 0 17:1 g 0 18:1 indifferenziato g 1.671 20:1 g 0.014 Grassi polinsaturi 18:2 indifferenziato g 2.736 18:3 indifferenziato g 0.042 18:3 n-3 c,c,c g 0.042 18:3 n-6 c,c,c g 0 20:2 n-6 c,c g 0 20:3 indifferenziato g 0 20:4 indifferenziato g 0 Aminoacidi Acido aspartico g 1.261 Acido glutammico g 2.259 Alanina g 0.799 Arginina g 1.06 Cistina g 0.191 Fenilalanina g 0.542 Glicina g 1.636 Isoleucina g 0.582 Istidina g 0.389 Leucina g 0.879 Lisina g 0.747 Metionina g 0.226 Prolina g 0.698 Serina g 1.148 Tirosina g 0.329 Treonina g 0.558 Triptofano g 0.181 Valina g 0.679 Altro Alcol etilico g 0
Proprietà e benefici I valori nutrizionali precedentemente elencati ci fanno comprendere come l’amaranto, pur non appartenendo alla famiglia delle graminacee o delle leguminose, abbia caratteristiche nutrizionali similari che lo pongono a metà strada tra un legume ed un cereale. Infatti, rispetto ai cereali che vengono abitualmente consumati nel nostro paese (grano, mais, riso, orzo, ecc.) ed alcune leguminose (piselli, fagioli, soia) i suoi valori nutrizionali sono alquanto superiori.
Le proprietà nutrizionali principali che hanno permesso all’amaranto di entrare nella categoria dei superfood sono riassumibili nei seguenti punti:
-Ottimo contenuto proteico e migliore qualità proteica. Va precisato che pur essendo ottime, non sono proteine nobili come quelle animali.
-Ottima ricchezza in vitamine e sali minerali.
-Assenza di glutine; ideale nella preparazione di alimenti per celiaci, pappe per neonati, bambini e minestroni di verdure per convalescenti e anziani.
-Abbondanza dell'aminoacido lisina, superiore rispetto a diversi alimenti vegetali (cereali, fagioli, piselli, soia) e animali (carne, latte, uova), limitante nella scagliola.
-Elevato contenuto di microelementi quali calcio, ferro e fosforo ecc. che contribuiscono ad elevare la qualità nutrizionale dell'amaranto.
-Ottima presenza di fibre che apportano un effetto benefico sulla digestione. I benefici che l’amaranto può apportare all’organismo, noti fin dall’antichità, dopo un periodo di “oscuramento”, sono ritornati in auge nel 1975, grazie alla pubblicazione di un libro di botanica a cura della American Academy of Sciences in cui venivano descritte le caratteristiche nutritive di diverse piante dimenticate tra cui, appunto, anche l’amaranto. Nell’ultimo ventennio poi, vari studi scientifici e diverse pubblicazioni scientifiche in campo mondiale hanno dimostrato che l’Amaranto come alimento o con i suoi derivati (farina, olio, latte, ecc.) è assai utile per il nostro organismo come prevenzione ed anche di supporto in situazioni delicate derivanti da diverse patologie.
Riassumo brevemente alcuni benefici utili al nostro organismo ma che possono es-
sere utili anche all’alimentazione dei nostri volatili:
- Alta digeribilità: la completa assenza di glutine e l’abbondanza di fibre ne fanno un alimento altamente digeribile, adatto non solo per i celiaci, ma anche per chi ha problemi intestinali, nello svezzamento dei bambini, nelle convalescenze e nella preparazione di pappe per anziani.

- Assorbimento del calcio: il buon contenuto di lisina, un amminoacido essenziale, scarsamente presente nei cereali (limitante nella scagliola), nelle verdure e nelle carni animali aiuta l’organismo a fissare il calcio nelle ossa e produrre energia. È una sostanza fondamentale per la salute della pelle, dei tessuti e per le difese immunitarie.
-Contrasta il diabete: possedendo un basso indice glicemico rispetto ai cereali dove il contenuto di fibre contribuisce a diminuire l’assorbimento degli zuccheri, è un alimento che diabetici possono consumare senza avere fastidiosi picchi insulinici. Inoltre, anche la ricchezza di proteine contribuisce a regolare i livelli glicemici.
- Abbassamento del colesterolo: dovuto principalmente al contenuto di fitosteroli, che hanno proprietà utili per contrastare la formazione di colesterolo LDL e trigliceridi.
- Perdita di peso: viene consigliato per chi vuol perdere peso. È dimostrato da diversi studi che una alimentazione ricca di fibre vegetali aumenti il senso di sazietà ed aiuti a prevenire il rischio di obesità.
-Previene l’anemia: grazie al contenuto di una buona quantità di ferro, soprattutto nelle foglie, e di vitamina C può essere di aiuto a prevenire stati anemici derivanti dalla carenza di questo minerale.
- Antiossidante: il contenuto di acidi fenolici, composti vegetali con attività antiossidante, di vitamine del gruppo B, C ed E e la buona presenza di minerali quali potassio, fosforo, magnesio, ferro ecc. rendono questa pianta un supporto utile per l’organismo a contrastare gli effetti nocivi dei radicali liberi che possono causare gravi malattie croniche. È stato dimostrato che l’effetto antiossidante è maggiore nel seme crudo che in quello cotto. Inoltre, gli estratti ottenuti dall’amaranto in fase vegetativa sono una preziosa fonte di antiossidanti e sono adatti alla formazione di nutraceutici oppure usati come alimenti funzionali.


NUMERO 1 - 2023 41
Amaranthushypochondriacus, fonte: wikipedia.org
Amaranthus caudatus, fonte: wikipedia.org
- Alimentazione vegana: l’amaranto, grazie al buon contenuto di proteine e sostanze ritenute le più nutrienti tra quelle di origine vegetale e considerate simili a quelle di origine animale, viene consigliato come un valido alimento per la dieta di tutte quelle persone che hanno deciso, per vari motivi, di non mangiare più alimenti di origine animale.


-Superfood: l’insieme di tutte le proprietà nutritive sopra accennate, scientificamente documentate e utili per la salute, hanno fatto sì che l’amaranto, per il rilevante profilo nutrizionale, sia annoverato nella categoria degli alimenti dichiarati “superalimenti”.
Amaranto: usi vari

Come detto in precedenza, l’intera pianta è commestibile e trova usi versatili nel campo gastronomico. Le foglie tenere basali, molto apprezzate per la ricchezza di ferro, sono utilizzabili in misticanze di insalata, mentre le più vecchie sono migliori se cotte come gli spinaci. I giovani fusti, tagliati a pezzi, spellati e lessati, si possono utilizzare come gli asparagi. I semi si possono consumare per la preparazione di ricette salate. Prima della cottura è opportuno lavarli sotto l’acqua corrente e vanno bolliti in due parti di acqua con un cuc-
chiaio di sale. Una volta cotto, questo pseudocereale assume una consistenza gelatinosa e dal sapore dolciastro; è consigliabile farlo riposare per 10 minuti e poi unirlo a del riso, orzo o verdure, per ottenere un gusto complessivo più gradevole. Oltre che nella classica versione a chicchi, l’amaranto può essere trasformato in farinae usato per fare pane, pizze e gnocchi. Inoltre, la sua versatilità è anche nella possibilità di impiegarlo in nutrienti zuppe, minestre, sformati; è pure utilizzato come base per polpette e burger vegetali. Un’altra versione molto gradevole prevede di utilizzarlo per fare i popcorn: riscaldati in una padella con un filo di olio, scoppiano, proprio come il mais. Infine, è molto famosa la torta di amaranto, pere e cioccolato. Un accenno particolare merita l’olio di amaranto, molto utilizzato anche in cosmesi, in quanto è ricco di squalene, un acido grasso vegetale dalle proprietà eudermiche e ricostituenti e con una buona concentrazione di vitamina E. Le sue proprietà sono ideali non solo per chi è abituato a prendere la tintarella al mare in quanto assorbe i raggi UV: si assorbe velocemente, è ideale per pelli secche e irritate, favorisce la rigenerazione della pelle ed è leggermente antinfiammatorio. Viene anche consigliato nei casi di psoriasi; infine, avendo pro-

prietà antiossidanti contrasta l’azione dannosa dei radicali liberi.
Va fatto presente che generalmente il consumo alimentare di amaranto non desta alcun disturbo e non ha effetti collaterali ma, essendovi contenute discrete quantità di acido ossalico, è sconsigliato a chi è affetto da patologie renali in quanto può nuocere all’assimilazione da parte dell’organismo di alcuni minerali, tra cui il calcio, e pertanto è consigliabile una alimentazione molto varia. Nel campo specifico dell’alimentazione avicola è stato rilevato che una dieta a base di amaranto in un allevamento di polli abbia mostrato effetti benefici; nei nostri volatili familiari l’amaranto è tenuto in considerazione soprattutto negli allevamenti di pappagalli e silvani. Pannocchie di amaranto sono commercializzate come quelle di panico e sono dichiarate ideali per favorire il foraging in quanto aiuta gli uccelli a tenersi impegnati e al tempo stesso a mantenere una buona forma fisica. Un amico allevatore di cardellini, verdoni, cardinalini e loro ibridi, che abita in campagna, avendo la possibilità di reperire l’amaranto comune, sono anni chelo fornisce ai suoi uccelli sia nella fase di fioritura della pianta sia quando questa ha le pannocchie piene di semi, con piena soddisfazione e senza aver riscontrato effetti collaterali.

42 NUMERO 1 - 2023
Infiorescenza di Amaranto comune, foto: P.Mengacci
Elenco proprietà dell’Amaranto, fonte: viversano.net
Su suggerimento dell’amico ibridatore e col pensiero che questa pianta ricca di proteine, minerali, fibre, vitamine non dovesse mancare nell’alimentazione dei miei canarini di colore, ho lasciato crescere le pianticelle trovate tra la siepe di alloro e quando ho ritenuto le pannocchie mature le ho introdotte nella voliera. Per i canarini è stata una sorpresa…. Ma, dopo un po’, erano lì a litigarsi il posto sopra di esse. Da quel giorno, per tutto il periodo autunno-inverno anche l’amaranto comune è entrato a far parte delle mie piante selvatiche.


Chiudo, ritornando alla premessa, con questa profonda osservazione sulle erbacce della giornalista Francesca Della Giovampaola, permacultrice (permacultura= cooperare con la natura per un ambiente sostenibile, equilibrato ed estetico e non lavorare contro di essa), che dovrebbe farci riflettere:“Le erbacce non esistono. Esiste solo un immenso e indeterminato numero di specie vegetali, che popolano il pianeta e contribuiscono in maniera fondamentale a
renderlo la meraviglia che ammiriamo. Sono arrivate prima di noi sulla Terra e hanno preparato le condizioni per la nostra evoluzione. Ci nutrono, ci forniscono fibre, medicinali, combustibile, riparo e ossigeno. Plasmano il nostro ambiente e, grazie alla loro capacità di trasformare l’energia del sole in carboidrati, sono alla base della catena alimentare che nutre tutti gli esseri viventi. Crescendo nei nostri orti e giardini, sui muri, ai margini dell’asfalto, nei campi coltivati, sotto gli alberi e tra i filari, tra le mattonelle o sui marciapiedi, non fanno altro che seguire il loro istinto. Esattamente come noi, vogliono vivere, riprodursi e conquistare nuovi territori”.

Ad maiora, semper
Alcune fonti:
- F. Della Giovampaola, giornalista professionista-permacultrice-Bosco di Ogigia

-https://www.viversano.net/alimentazione/mangiaresano/amaranto-proprieta

-https://www.coltivazionebiologica.it/pianta-di-amaranto/ - wikipedia.org.

NUMERO 1 - 2023 43
Amaranthus cruentus, fonte: wikipedia.org
S pazio Club
Club Diamante Codalunga & Poephila: fare per


Il 25 settembre 2022 si è conclusa la mostra specialistica Erythruria tenutasi a Lanciano che anche quest’anno ci ha visti protagonisti, insieme al Parrot Finches European Club.

L’appuntamento, magistralmente organizzato dall’associazione A.O.C.A. presieduta da Donato Sabatini e dal direttore mostra Luciano Di Biase, presidente del Parrot Finches, è stato punto d’incontro per tutti gli allevatori italiani dei generi Erythrura e Poephila. Complice la sua location, ha unito l’intero stivale da nord a sud con convogli arrivati da tutta la penisola a dimostrazione che l’unione fa la forza. Fin da subito il livello selettivo dei soggetti esposti si è dimostrato altissimo, a testimonianza delle abilità selettive degli allevatori italiani, dell’impegno e delle costanti attività dedicate ai soci dal club e non solo. Così anche per noi, come alla fine di ogni evento, è giunto il momento dei bilanci. Erythruria vede presente il nostro club con 15 espositori e 109 ingabbi divisi in 78 soggetti di diamante codalunga e 31 di diamante mascherato. Erano presenti codalunga in tutte le mutazioni oggi standardizzate e numerose delle combinazioni possibili. Vincitore indiscusso per la categoria ancestrali singoli e stamm è Gianluca Moroni che con i suoi soggetti ottiene 93 punti per il singolo, con il quale conquista il titolo di primo di genere e 370 punti per lo stamm. Stesso esito è stato ottenuto da Da-



niele Zanichelli nella categoria “Grigi” raggiungendo 93 punti per il singolo e 368 punti per lo stamm.

Destino diverso invece per i topazio, i cui titoli vengono aggiudicati per i singoli a Gildo Tomasini con 92 punti e a Daniele Zanichelli per gli stamm, il quale totalizza punti 366. Il primo posto per le categorie “bruno” e “ino” va a Gildo Tommasini e Manuel Conocchia che rispettivamente si piazzano con 90 e 92 punti. Il dato più sorprendente che va oltre ogni aspettativa è quello dell’altissimo numero di ingabbi di diamante mascherato, mai visti così tanti in una mostra italiana fino ad oggi; un vero e proprio record, nel quale Igor Baggi raggiunge i 93 punti per il singolo e 366 per lo stamm. Questi risultati evidenziano l’importanza di un coordinamento tecnico e della divulgazione delle specie.
Il Club del Codalunga e Poephila, presieduto dal giovane Luca Maglia, negli ultimi anni è particolarmente cresciuto in termini umani e di attività tanto che ad oggi conta 27 soci impegnati nella valorizzazione e selezione di questi piccoli estrildidi domestici. Gli sforzi degli ultimi anni si sono concentrati, con la fattiva collaborazione della CTN e dell’intero consiglio federale, sull’ammodernamento dello standard del diamante codalunga ottenendo il ricono-
Club
di Specializzazione
44 NUMERO 1 - 2023
tracciare una strada della selezione
S pazio Club
scimento di esotico domestico al pari di specie più diffuse e allevate. Questo costante impegno ha fatto sì che il club sia diventato nell’intero panorama mondiale un punto di riferimento per la crescita tecnica e qualitativa della specie. In questi anni il club ha presenziato congressi sullo standard e sulle mutazioni anche all’estero, come in Francia e in Belgio. Eventi che hanno visto la partecipazione di giudici specializzati di tutto il mondo e che, con un pizzico del nostro orgoglio, hanno importato e condiviso lo standard italiano.


Da gennaio 2021 il direttivo, con l’approvazione dei soci e delibera della FOI, ha ampliato i suoi sforzi in termini di studio e selezione a tutto il genere Poephila, integrando così anche il diamante bavetta e il diamante mascherato. Da quel momento si è lavorato assiduamente di concerto al miglioramento dello standard del diamante bavetta e la stesura di quello del diamante mascherato, fino ad oggi assente. Elaborati dal nostro team di esperti, approvati dalla CTN e ratificati dalla FOI, i due standard sono entrati in vigore a marzo di quest’anno e sono già utilizzati con successo in questa stagione mostre.
Nel maggio del 2021 l’attività si è concentrata sulla divulgazione, con la realizzazione di un webinar sul diamante codalunga tenuto da Gianluca

Moroni in collaborazione con il Raggruppamento Ornitologico Toscano, nel quale sono stati trattati parecchi argomenti che hanno toccato fra l’altro la selezione, le mutazioni e le loro combinazioni e in fine il giudizio internazionale. È stato certamente un momento di formazione e crescita per gli allevatori che vi hanno partecipato ma, non da meno, è stato un momento d’incontro e aggregazione, anche se a distanza, visto il periodo buio che si stava attraversando. Esattamente ad un anno di distanza, la prima pubblicazione vede la nascita del “Manuale del Diamante Codalunga” che è stato distribuito gratuitamente a tutti i soci. Un volume che, oltre a trattare nozioni di natura tecnica e all’inserimento del nuovo standard, è stato arricchito di bellissime foto. Per questo lavoro di pregio vogliamo ringraziare Antonio Venturoli, Marco Foglia e Saverio Parisella per l’impegno e il tempo dedicatoci.
Progetti per il futuro?
Sicuramente la stesura di un altro manuale che vedrà protagonisti il diamante bavetta, il diamante mascherato e i loro ibridi.

Le idee e la voglia di fare non mancano per un 2023 pieno di progetti, eventi e novità.
LIA PORCINO Club Diamante Codalunga & Poephila Italia

Club di specializzazione
NUMERO 1 - 2023 45









Il Saltimpalo (Saxicola torquatus)

 di PIERCARLO ROSSI, foto THOMAS WENDT
di PIERCARLO ROSSI, foto THOMAS WENDT
Gli uccelli insettivori, a differenza dei granivori, hanno affinato movenze e comportamenti adattandoli al particolare tipo di nutrimento: la ricerca di prede vive ed in continuo movimento. Questo ha pilotato l’evoluzione verso una conoscenza sempre più evoluta della realtà che li circonda. L’insettivoro deve essere vigile, attento, perennemente in movimento; deve contrastare l’eventuale azione di fuga e di difesa dell’insetto che per spirito di conservazione deve poter sfuggire alle insidie della cattura. Ciò ha favorito uno spiccato indivi-


Prima parte
dualismo, un territorio da conquistare e difendere, uno spirito battagliero, un instancabile moto. Di contro, molti di loro hanno linee armoniche e piacevoli, un canto eccellente, colori splendidi e cangianti, altre volte modesti e mimetici. Quanto appena descritto è certamente riscontrabile nella specie di cui vorrei parlarvi oggi, il Saltimpalo.
Conosciuto con il nome latino di Saxicola torquatus è un piccolo uccello dell’ordine dei Passeriformi appartenente alla famiglia dei Muscicapidi, lungo circa 12 cm, con un peso di 13 grammi e un’apertura alare di 22 cm. Il suo curioso nome deriva dalla sua abitudine di caccia; infatti, questi uccelli sostano su posatoi elevati sempre attenti all’ambiente circostante con tipici e continui movimenti della coda e delle ali, subito pronti a lanciarsi all’inseguimento degli insetti di cui si cibano, per poi tornare sullo stesso posatoio, spesso un palo, appunto, sempre accompagnato dall’in-

NUMERO 1 - 2023 47 ESTRILDIDI FRINGILLIDI IBRIDI
Maschio di saltimpalo, foto e all.: Thomas Wendt
Femmina di saltimpalo, foto e all.: Thomas Wendt
confondibile e più accentuato movimento sincrono d’ali e coda.

La sua diffusione
Le svariate sottospecie di Saxicola torquata sono diffuse praticamente in ogni parte del vecchio continente, dove le condizioni ambientali lo consentano; esse si distribuiscono lungo una ampia fascia che comprende tutta l’Europa dal Mediterraneo alla



Scozia settentrionale, alla Danimarca, alla Polonia meridionale, l’Ucraina, la Russia centromeridionale, fino alla Siberia meridionale ed al Giappone. A sud l’area di distribuzione raggiunge la Persia, il Tibet e la Birmania. In Africa nidifica a nord del Sahara e nella parte occidentale fino al Madagascar ed al Sud-Africa. Nella parte settentrionale del suo areale il Saltimpalo è migratore, giungendo tra febbraio e marzo e ripartendo per l’Africa fra settembre ed ottobre. Dove il gelo non è eccessivo come in Italia non migra, ma abbandona il territorio di nidificazione e diviene erratico.
La distribuzione invernale di questi uccelli è strettamente legata al gelo: inverni particolarmente freddi e soprattutto nevosi ne fanno strage.
Descrizione
Fra agosto e settembre il Saltimpalo muta completamente il suo piumaggio assumendo una livrea alquanto diversa per i due sessi. Il maschio adulto presenta le parti superiori nero lucide con margini rossicci che nascondono in parte la tinta di fondo; il groppone è invece biancastro, formando la caratteristica macchia chiara alla base della coda. Questa, piuttosto corta, è di colore nero uniforme. L’ala, lunga dai 65 ai 68 mm è anch’essa nera ad eccezione di una barra bianca formata dalle copritrici. Testa e gola sono pure nere ed il becco, sempre nero, è lungo circa
13,5-15 mm. Le parti inferiori sono di un color castano, più acceso sul petto, che sbiadisce fino al biancastro sotto il ventre; pure bianche sono due vistose macchie ai lati del collo. Non ha muta estiva, ma col tempo le penne perdono per abrasione gli apici fulvi cosicché la livrea si presenta a tinte più marcate. La lunghezza dell’intero animale è di 12,5-13 cm e quella del tarso 21-23 mm.
La femmina è molto meno vistosa, avendo il dorso e la gola brune con striature nerastre; anche la testa ha lo stesso colore, ma con una sfumatura spesso più scura. Le copritrici superiori della coda sono fulve, la coda e le ali sono anch’esse brune screziate di scuro e manca o è poco marcata la barra bianca sull’ala come pure le macchie ai lati del collo, mentre viceversa presenta una macchia chiara sotto il mento; la gola, invece, è nerastra.
Le parti inferiori sono di un color castano meno acceso di quello del maschio.
48 NUMERO 1 - 2023
Novello di saltimpalo, foto e all.: Thomas Wendt
Novelli a nido, foto e all.: Thomas Wendt Voliere d'allevamento, foto: Thomas Wendt
Fra agosto e settembre il Saltimpalo muta completamente il suo piumaggio assumendo una livrea alquanto diversa per i due sessi
Il giovane ha la schiena, la testa, le ali e la coda bruno nerastre con screziature chiare. Lo spazio chiaro sull’ala manca in molti esemplari ed è appena accennato negli altri. La gola è bianco sporco e le parti inferiori fulvo chiare, con screziature più scure sul petto e sui fianchi; il sopraccoda è rossiccio. Rispetto allo Stiaccino, altro rappresentante del genere Saxicola, il Saltimpalo è più corpulento ed ha una postura più eretta; tra le due specie la colorazione del maschio è inconfondibile mentre la femmina ed il giovane somigliano a degli stiaccini molto scuri; si possono distinguere però con certezza per la mancanza di sopracciglio e di bianco ai lati della coda. Gli individui stanziali in Sardegna hanno tinte più vivaci di quelli continentali.
Dove poterlo osservare in natura
Frequenta territori aperti e soleggiati, possibilmente incolti, brughiere, cave di sabbia, margini di zone paludose e campagna coltivata a cereali; nelle savane dove sverna ed in generale in ogni landa scoperta e cosparsa radamente di alberi e cespugli normalmente lo si vede appollaiato sulla cima di un arbusto, di un palo o su di un filo

che attende una preda, stando impettito e vibrando continuamente le ali e la coda. Molto diffidente per natura, difficilmente si lascia avvicinare, ma malgrado ciò si abitua a vivere anche lungo strade trafficate e ferrovie. È un uccello che si adatta molto al territorio e infatti nidifica spesso dal livello del mare fino a circa 1.500 m di altitudine.
Il suo richiamo è molto particolare in quanto è formato da ripetizioni molto
veloci di note doppie, ritmicamente alte e basse e dura un po’ più a lungo se emesso in volo.
Viene utilizzato sia per delimitare il territorio che durante i voli nuziali.
Alimentazione
Il Saltimpalo si nutre principalmente di insetti, ragni, vermi e altri animali che trova nel terreno; usa la tecnica di caccia da appostamento: attende la sua preda e una volta avvistata parte in picchiata e la cattura, usando il metodo “atterra e abbatti la preda”. Discende per catturare la preda a terra e ritorna sullo stesso trespolo da cui era partito.


Cattura ogni sorta di insetti sia in volo che a terra: piccoli coleotteri, ditteri, cavallette, larve, farfalle ed anche formiche. Mangia anche piccoli lombrichi, lumachine, ragni e miriapodi; in inverno, periodo di carestia, raccoglie anche dei piccoli semi, ma il suo becco è poco adatto a frantumarli.


Stagione riproduttiva
I maschi stabiliscono dei territori di superficie estremamente variabile dalle 30 are fin oltre i due ettari, secondo i casi, che occupano un anno dopo l’altro.
NUMERO 1 - 2023 49
Varie tipologie di nidi in voliera
Varie tipologie di cibo fornito giornalmente
La colorazione del maschio è inconfondibile mentre la femmina ed il giovane somigliano a degli stiaccini molto scuri
Si nutre principalmente di insetti, ragni, vermi e altri animali che trova nel terreno
Il corteggiamento inizia verso i primi di marzo ed è composto da un volo nuziale molto particolare, nel quale il maschio si libra nell’aria in maniera verticale battendo le ali molto velocemente fino a 10-20 metri da terra, salendo e scendendo poi sul posto come se fosse appeso ad un filo; durante questo volo il canto è molto più sostenuto del solito.
In ricordo di Giovanni Paone

I NOSTRI LUTTI

Dopo il corteggiamento la femmina sceglie un posto, in genere ai piedi di un arbusto, molto ben nascosto e coperto dalla vegetazione, dove costruirà da sola il nido con erbe, molto muschio, crini e piume. La prima deposizione avviene alla fine di marzo o ai primi di aprile e l’incubazione inizia con la deposizione del penultimo uovo.

Le uova, generalmente 5 o 6, si presentano ellittiche-ovali, di colore verde-azzurro pallido finemente punteggiate di bruno chiaro.
Hanno dimensioni di mm18.2 x mm14.2.
La femmina cova da sola per un paio di settimane circa ed i piccoli restano nel nido per una quindicina di giorni, dopodiché ne escono, ma non sapendo ancora volare saltellano nei dintorni ricevendo il cibo dal padre per 20 giorni circa. Dopo circa una settimana dall’abbandono del primo nido la femmina ne costruisce un secondo vicino all’altro e depone una seconda covata.

Quando la stagione lo consente, o se uno dei due nidi è stato predato, viene deposta una terza covata fra la fine di giugno ed i primi di luglio. La produzione di uova è dunque abbondante, ma non più della metà di queste danno dei giovani che arrivano all’indipendenza, essendo la mortalità molto elevata a causa dei topi, dei piccoli carnivori e degli incendi.
Il12 Dicembre 2022, ha concluso la sua esistenza terrena Giovanni Paone, socio cofondatore dell’Associazione Ornitologica AR.CA.FRA.
Giovanni, faceva parte di quella categoria di esperti allevatori capace di consolidare e ampliare il sistema associativo del nostro hobby, riuscendo a diffondere la nostra passione tra gli allevatori.
Capace di influenzare altri a farlo, con il suo modo sapiente e accattivante fatto di racconti e aneddoti acquisiti in oltre quarant’anni di allevamento di canarini.
A noi mancherà l’amico, il punto di riferimento della nostra Associazione, all’ornitologia un instancabile allevatore.
Il direttivo e soci dell’Associazione Ornitologica AR.CA.FRA.

50 NUMERO 1 - 2023
Il maschio di saltimpalo in vigile attesa, la femmina in cova.
La prima deposizione avviene alla fine di marzo o ai primi di aprile e l’incubazione inizia con la deposizione del penultimo uovo
L’altra faccia della F.O.I.
testo e foto di Rosa Meola
In data 02/10/2022 abbiamo indetto la riunione per la Convocazione dell’Assemblea Generale dei Soci dell’Associazione Ornitologica Sanseverese che prevedeva all’ordine del giorno sia l’approvazione del bilancio consuntivo che l’approvazione del bilancio preventivo e come terzo punto le varie mostre a cui partecipare. Per quanto riguarda i primi due punti si è parlato pochissimo, ma sulle Mostre a cui partecipare si è acceso un confronto in cui mi sembrava di stare a un dibattito televisivo; la discussione è stata animata da argomenti che, però, riguardavano sempre il piacere di partecipare a più Mostre, incontrare più amici e, perché no, anche di esprimere un sano agonismo di competizione. Ci siamo divertiti e tutto questo non poteva certamente finire lì. Purtroppo, per via del Covid, ci siamo visti pochissimo ed ora che abbiamo avuto occasione di stare insieme a parlare della nostra passione,

che è quella di allevare, confrontarci e prenderci anche in giro, abbiamo deciso di prolungare quella magnifica giornata. La nostra Associazione ha deciso di invitare tutti i soci a pranzo in un agriturismo che ha fatto da cornice ad una giornata a dir poco indimenticabile. Voglio ringraziare tutti i soci che con la loro presenza hanno contribuito a realizzarla. Ci siamo seduti a tavola alle ore 13,00 ed abbiamo finito alle 18,00, neanche fosse stato un matrimonio, ma senza annoiarci, anzi. Ecco perché dico: “l’altra faccia della F.O.I.”. Credo si parli troppo spesso di Statuti, di Standard, di regole, di numeri di ingabbio. Abbiamo smesso di fare mostre divulgative per avvicinare i ragazzi a questo magnifico mondo, screditiamo ragazzi che ci chiedono consigli per le loro due coppiette di canarini perché siamo così superbi che non vogliamo perdere tempo con loro, siamo così presi da noi stessi da dimenticarci che anche noi




abbiamo iniziato con due coppiette. Cerchiamo tutti insieme di tornare a sognare e sentirci una famiglia; il nostro hobby non è solo un’istituzione, quindi cerchiamo di fare al meglio quello che ci siamo prefissati di fare. “Allevare e Proteggere”: se non sbaglio questo è ancora il nostro motto. Un tale diceva: “Se non sei un albero cerca di essere una siepe, non un cespuglio” oppure “Se non sei un’autostrada cerca di essere un sentiero e non uno sterrato”. Dovremmo stare più vicini ed accompagnare per mano coloro che si avvicinano a questa passione. Si dà la colpa ai social e ai ragazzi che sono distratti da altro. No, amici miei, la colpa è solo nostra. La cosa che mi rincuora è che la F.O.I. è una grande Famiglia e c’è molta gente che dà l’anima per tutti noi. Vi voglio ringraziare di vero cuore, anche questa giornata trascorsa prima con una riunione e dopo a pranzo c’è stata perché c’è la F.O.I. Grazie F.O.I.!

NUMERO 1 - 2023 51
CRONACA
e non solo
O rniFlash
Quanti uccelli ci sono nel mondo?
Secondo
il comitato ornitologico internazionale nel mondo esistono oltre 10.000 specie di uccelli (e potrebbero essere addirittura di più, se non il doppio) classificate in 44 ordini, 253 famiglie e oltre 2000 generi. Rappresentano quindi un tesoro di biodiversità, in particolar modo in ambienti come la foresta amazzonica che da sola conta oltre 1300 specie diverse, quasi il 15% di quelle conosciute. Per avere una stima approssimativa sul numero di uccelli presenti sulla terra, i ricercatori australiani si sono avvalsi dell’utilizzo di una piattaforma online: si chiama eBird ed è gestita dal Cornell Lab of Ornitology, curata da scienziati e cittadini. Oltre 600.000 persone hanno registrato su questa piattaforma avvistamenti di uccelli da tutto il mondo, riportando i dati relativi alla specie dell’uccello avvistato e al luogo dell’avvistamento. Tra le diverse specie, alcune sono particolarmente abbondanti come per esempio il passero domestico, la rondine e il gabbiano becco ad anelli. Altre invece sono più rare ed estremamente vulnerabili, lottano per la sopravvivenza e sono seriamente a rischio di estinzione. Si tratta di un prospetto alquanto drammatico se pensiamo anche all’importanza degli uccelli nel nostro fragile ecosistema. Per esempio si occupano dell’impollinazione delle piante e del trasporto di semi più grandi, nonché tengono sotto controllo i parassiti agricoli. Una delle principali minacce per le popolazioni di uccelli è il fenomeno dell’agricoltura, intensiva e non. Altra minaccia è rappresentata dal disboscamento: ogni anno infatti vengono abbattuti oltre 7 milioni di ettari di foresta a danno di molte specie come l’aquila. Infine il fenomeno della crisi climatica che causa violente tempeste, incendi e lunghi periodi di siccità mette a rischio la sopravvivenza di tutti gli esseri viventi, compresi gli uccelli. È necessario quindi intraprendere una rapida azione di conservazione e salvaguardia degli uccelli o non ci sarà futuro per molti di questi animali.

Fonte: https://www.greenme.it/ambiente/natura/quanti-uccelli-ci-sono-nel-mondo-sono-6-volte-piu-di-noi/


Gli scriccioli in città cantano più forte
Conun peso di meno di 5 grammi, lo scricciolo (Troglodytes troglodytes) è uno degli uccelli più piccoli d’Europa, spesso si nasconde tra arbusti, rovi e vegetazione lungo le rive di canali, fiumi e ruscelli. L’espansione dell’antropizzazione, tuttavia, ha portato molte specie degli ecosistemi agricoli a colonizzare anche alcune aree urbane e sub-urbane. Lo scricciolo non sfugge a questa regola e sono in aumento le osservazioni di questa specie in diverse aree metropolitane o comunque in alcune città. L’Università di Salamanca ha pubblicato sulla rivista Acta Ornithologica uno studio molto interessante, coordinato dall’ornitologo Víctor Colino-Rabanal, nel quale si dimostra che gli scriccioli “cittadini” sviluppano canti più complessi e articolati con frequenze più alte e note più lunghe rispetto ai loro omologhi rurali. Gli uccelli periurbani, nelle periferie, occupano una posizione intermedia, sebbene più vicina a quelli urbani nella lunghezza delle note.
I risultati di questa interessante ricerca mostrano che l’inquinamento acustico produce importanti effetti di stress e di mutamento degli equilibri naturali, ricordando che il canto per molte specie di uccelli è lo strumento più importante per difendere il proprio territorio piuttosto che per conquistare e difendere la propria partner. Anche negli scriccioli, con vocalizzazione ad alta frequenza, l’interferenza con il rumore antropico urbano delinea alcuni cambiamenti nelle loro vocalizzazioni e questi studi consentono di comprendere che l’impatto dell’uomo è molto più profondo di quanto non pensiamo. I sensi sviluppati degli animali possono essere fortemente danneggiati dall’inquinamento luminoso e da quello acustico. Nei progetti di conservazione futuri bisognerà tener presente anche questi aspetti. Fonte: http://www.parks.it/news/dettaglio.php?id=72823
News al volo
web
dal
52 NUMERO 1 - 2023
O rniFlash
Avvistata la Cicogna nera in Sila
Il22 gennaio 2023 è stata vista dopo molto tempo volteggiare sopra i cieli di Cosenza e della Sila. Un avvistamento eccezionale, considerando che si sta parlando di una delle specie più elusive e rare dell’avifauna europea. È la Cicogna nera (Ciconia nigra) che proprio in questo mese ha iniziato a svernare in Italia, compiendo la sua migrazione annuale verso il Mediterraneo. L’animale è un adulto ed è stato visto sorvolare i boschi innevati del Parco Nazionale della Sila, vicino alla quota di 1300 metri. È apparsa perfettamente in salute, per quanto facesse freddo per il gelo indotto dall’inverno. La Cicogna nera è un trampoliere molto simile alla Cicogna bianca (Ciconia ciconia). A differenza dell’altra specie, più famosa e diffusa, presenta un piumaggio nero lucente sul dorso, il collo e la testa, mentre presenta un piumaggio bianco classico sul petto e il ventre. Altra caratteristica che la differenzia dagli altri trampolieri è che si tratta di una specie solitaria o che si muove in piccoli gruppi. Non forma infatti grandi stormi durante le migrazioni, come quelli che sono possibili notare con la Cicogna bianca. Inoltre non gradisce per nulla le zone antropizzate. Non potremo perciò mai trovare questa specie sotto alcuni ponti fluviali, come può succedere per le altre specie, nelle grandi metropoli come Roma, Palermo o Salerno (tutte città che presentano corsi fluviali al loro interno). Le coppie riproduttive di questa specie fortunatamente sono invece in costante aumento, rifugiandosi durante l’inverno soprattutto in alcune regioni meridionali. Per quanto risulti ancora difficile intravederli ed essere capaci di seguirli a lungo, la loro popolazione quindi sta aumentando. Se siamo inoltre stati capaci di conoscere bene l’esemplare che in questi giorni è stato avvistato in Calabria, è solo grazie al contributo eccezionale dell’ornitologo Gianluca Congi, che da anni segue queste specie fra le montagne della Sila e tra le altre cose è anche il vicepresidente della Società ornitologica italiana (Soi).


Fonte: https://www.kodami.it/avvistata-la-cicogna-nera-in-sila-e-uno-degli-uccelli-piu-rari-deuropa/
Caccia ai ladri di pappagalli del New Jersey
Ècaccia aperta, nel New Jersey, all’imprendibile banda di ladri di...pappagalli. I due uomini sono ricercati dalle varie forze di polizia per una serie infinita di furti ai danni di negozi e rivendite di animali, volatili in particolare. L’ultimo colpo della gang, il furto di un piccolo pappagallo in un negozio di Delran, borgata di 17 mila anime nella contea di Burlington, potrebbe però risultare fatale per la carriera della coppia di malintenzionati. Su Facebook, infatti, è stato postato il video del furto, con i volti dei ladri abbastanza riconoscibili. Le ricerche sono state intensificate negli ultimi giorni e la polizia locale sostiene che i due hanno rubato l’uccello, per valore di mercato superiore ai 1000 dollari, in pieno pomeriggio. “Era sabato - conferma Chris Luberski, titolare del negozio - intorno alle 17.30, di solito, passiamo in rassegna i nostri uccelli per somministrare loro la razione quotidiana di mangime. È stato a quel punto che ci siamo resi conto che mancava uno dei nostri piccoli conuri ananas, tra l’altro già venduto e in attesa di essere ritirato dal suo futuro proprietario”. La preoccupazione dei titolari del negozio è evidente. “L’uccellino ha pochi mesi di vita - confermano - veniva ancora nutrito manualmente con una formula speciale di mangime, tre volte al giorno. È come fosse un bambino molto vulnerabile, se non viene nutrito correttamente rischia la vita”. Il videofilmato del circuito interno di sorveglianza, subito consegnato alla polizia, mostra un negozio affollato e, sullo sfondo, due uomini vicino alla finestra della nursery dove sono tenuti diversi piccoli di pappagalli. Si vede che uno dei due ne acchiappa subito uno e poi gira l’angolo. “L’uccellino è stato portato dietro una colonna del negozio, nascosto - precisa Lubeski - ed è lì che il ladro se l’è infilato in tasca”. Animalisti e amanti degli animali sono increduli per la vicenda. “È molto triste - dicono - era l’animale domestico che una famiglia attendeva di adottare con amore ed entusiasmo”, ha detto Jill Hebner, il manager che gestisce la catena di negozi. “A causa di questo incidente faremo installare serrature su tutte le gabbie.”
Fonte: https://www.lastampa.it/la-zampa/2023/01/29/news/ pappagallo_rubato_in_negozio_caccia_ladri-385333294/

e non solo
News al volo
web
dal
NUMERO 1 - 2023 53
P agina aperta
L’affermazione che il bianco è l’unione di tutti i colori ha origini antiche. Le sue variazioni di luce sono moltissime e possono variare tanto. Il bianco è formato dalla somma di tutti i colori dello spettro elettromagnetico. È un fattore ad alta luminosità ma senza tinta e infatti viene anche detto acromatico. Il suo opposto è invece il nero, che è dato dall’assenza di tutti i colori.
La svolta fu data da Isaac Newton, fisico e matematico inglese, considerato uno dei più grandi scienziati di tutti i tempi; egli fece un’osservazione basata sul fatto che la luce del sole, ma anche di qualunque altra sorgente luminosa, sia composta di radiazioni diverse, ognuna con differente intensità.
Newton dimostrò così che la luce che ci appare bianca non è in sé monocromatica, ma è la somma di una serie di frequenze di onde luminose, ciascuna delle quali con una differente lunghezza d’onda. A Newton si deve anche il primo modello di rappresentazione del colore, un cerchio che ha al suo centro il bianco e lungo la circonferenza, ordinatamente disposti, i colori scomposti.
Ogni canarino possiede un patrimonio di geni ereditato dai genitori capace di condizionarne sia l’aspetto esteriore che altre caratteristiche individuali. Colore della pelle, degli occhi, posizione, tipo e colore del piumaggio, ecc... Il patrimonio genetico dei nostri protetti, a proposito di mutazioni spontanee, è riuscito a perpetuarsi negli anni solo grazie alla tutela da parte degli allevatori. Se pensiamo ai canarini bianchi o chiari in generale, sarebbero difficilmente capaci di rimanere in vita fino all’età riproduttiva in quanto non riuscirebbero a sfuggire ai predatori esistenti nell’habitat naturale.
Non si pensi che basta guardare un cromosoma al microscopio per veder scritto, a fianco di ogni gene, la sigla che lo caratterizza! La conoscenza e la classificazione dei geni deriva dall’osservazione degli scienziati e degli allevatori, cui sono seguite deduzioni e interpretazioni talora vere, talora non vere. Talora le osservazioni dei piccoli

allevatoripotrebbero trasformarsi in una goccia che fa traboccare il vaso, potrebbero significare la soluzione di un problema annoso.
Veniamo ora al punto saliente di questo scritto.
Apigmentato: tempo fa, nei canarini di forma e posizione lisci, si usava il termine “apigmentato” per descrivere il canarino a fondo bianco con alcune parti (o anche tutte) del piumaggio ricoperto da melanine. Nel caso dei pezzati, il bianco (fattore epistatico) riesce a nascondere solo la cromaticità gialla e non anche quella scura (anche se in parte).
Acianismo: vocabolo non trovatosul vocabolario Treccani e sull’enciclopedia medica. Se si prova a digitare la parola “acianismo” sul web, vengono fuori collegamenti relativi solo ed esclusivamente al modo ornitologico, come se questo sostantivo fosse stato coniato e usato solo nel campo dell’avicoltura. Come riferito da Giovanni Canali nel suo testo del 1992 “I colori nel canarino” (pag.64), tale termine, pur essendo inesatto, è in voga; riferendoci all’etimologia di questa parola, essa richiama una provenienza greca (kyanotikos) con l’alfa privativo, ed ecco il termine “acianico”.Ora, con l’aiuto di alcuni amici greci, ho cercato di chiarirmi se i dubbi che mi sono sorti siano fondati o meno. Possiamo affermare che il termine kyanotikos (bluastro) è usato nella lingua greca per indicare, appunto, un colore bluastro e questa parola viene usata solo ed esclusivamente in campo medico (corpo dal colore cianotico, privo di ossigeno, non ossigenato bene). Sicuramente tale termine non sarebbe improprio e potrebbe essere accettato se esistesse la melanina blu, ma questa mutazione nei canarini ancora non esiste. Anche il Prof. Zingoni nel suo capolavoro “Canaricoltura”, a pag. 426, evidenziava l’inesattezza del termine. Circa la mutazione bianco recessivo, però, invece di “acianico” sarebbe più appropriato definirlo “cianico” a causa della pelle proprio kyanotikos (“pelle blu”). Ma sicuramente calzerebbe stretto per i gialli e ancor di più per i rossi privi di melanina.
Argomenti a tema
Se
a: redazione@foi.it
desideri proporre un argomento scrivi
54 NUMERO 1 - 2023
Acianismo, Xanticismo, Melachorismo: termini a proprio uso e consumo
P agina aperta
XANTICISMO: Concordando con l’esimio Canali, il termine “xanticismo” sembrerebbe più appropriato del precedente perché tale termine deriva dal nome del dio atzeco Xantico, dio della luce bianca. Quindi potrebbe adattarsi benissimo per descrivere i bianchi puri, cioè i recessivi, ma anche i bianchi dominanti.
MELACHORICI: Se proprio volessimo disturbare la lingua dei padri della filosofia, potremmo definire i canarini che oggi sono accomunati sotto il termine di lipocromici con il termine in neretto che precede. Infatti, nella lingua greca per dire “privi di melanine” usano “choris melanini”, quindi tutti i canarini chiari potrebbero essere indicati come affetti da “chorismo”,cioè quella mutazione che consente di coprire i colori scuri dati dalle melanine. Infatti, non esistono ceppi puri di canarini senza macchie melaniche, di tanto in tanto qualche macchia viene fuori.
LIPOCROMI o CAROTENOIDI. Parole di origine
scientifica in quanto sono sostanze liposolubili (cioè solubili nei grassi), uguali a quelle che troviamo anche nelle piume degli uccelli (Veeerkamp, pag. 49).


Pigmenti a catena carboniosa, liposolubili, quali la xantofilla e la luteina, detti anche carotenoidi. La lipocromia è la pigmentazione giallastra causata da abbondante e ripetuto consumo di sostanze ricche di carotenoidi. Ora, in considerazione di quanto sopra riportato, potremmo definire i canarini colorati e senza melanine lipocromici o carotinoici (brutta parola), mentre i bianchi non possiamo definirli né con il primo né con il secondo termine. I bianchi devono essere esclusi dal gruppo dei lipocromici in quanto non hanno alcuna caratteristica dei lipocromici propriamente detti. Io definirei il Bianco dominante “Canarino Xantico” ed il Bianco recessivo “Canarino Cianico a piumaggio acromatico”.


Argomenti
a tema
NUMERO 1 - 2023 55
SERGIO PALMA









Influenze reciproche tra vincoli genetici e vincoli ambientali
di FRANCESCO DI GIORGIO, foto G. MARSON
Waterslager.
È certo che per ottenere nei Malinois degli ottimi cantori non basta avere dei buoni maschi derivanti da un ceppo di alto valore genealogico; quindi delle buone femmine da razza valgono quanto dei buoni maschi cantori.

La scelta delle femmine nei Malinois è più complessa che in altre razze, in quanto la femmina non canta e quindi non mostra le buone doti genetiche di canto le quali restano un incognita; mentre nelle altre razze (vedi colore, posizione ecc.) le qualità richieste sono visibili sia nei maschi che nelle femmine.
L’edificio del canto Malinois si costruisce pietra su pietra; con scienza, fatica e sacrificio. Ottenere le melodie caratteristiche d’acqua e quelle usignolate fuse insieme, è compito arduo. Vi concorre il binomio combinato dell’ereditarietà e dell’ambiente.
L’ereditarietà è la facoltà con la quale i discendenti di piante o animali rassomigliano ai loro ascendenti nelle qualità e nelle caratteristiche in forma palese o lo sono in forma latente. Attenta ed oculata deve essere, nel

nostro animaletto, la selezione dell’apporto respiratorio, facendo in modo che questo abbia fibre muscolari più adatte all’emissione del canto speciale richiesto. Perché ciò si verifichi occorre conoscere il potenziale canoro dei maschi destinati alla riproduzione, cioè il numero e la qualità dei tours (frasi) in possesso.

Un modo per conoscere questo potenziale è dato dalla scheda di giudizio oppure da un’attenta valutazione del canto effettuata da un allevatore anziano esperto conoscitore del canto
Perciò l’allevatore del Malinois per la scelta di una buona femmina deve far ricorso al registro di allevamento, nel quale si vanno ad esaminare i parenti in linea diretta e cioè il padre, la madre, il nonno i fratelli e le sorelle in fatto di buona resa canora e buona trasmissione dai genitori ai figli del canto desiderato.
Comunque nei primi mesi dell’anno cominceranno a nascere i primi pulli con grande gioia di noi allevatori. Vedendoli crescere fantastichiamo: “questo sarà un campione! No, forse lo sarà quest’altro! Ma guarda che collo taurino ha questo esemplare: certamente si imporrà con tutta la potenza delle sue corde vocali!”.
Trascorrono i giorni ed iniziano a mangiare da soli.
NUMERO 1 - 2023 57 CANARINIDA CANTO
Da qui entrano in gioco, ad una ad una, tutte le pratiche occorrenti affinché i soggetti assolvano nel migliore dei modi alla funzione per cui vengono chiamati e cioè dare vita al canto artistico e da competizione. Due procedure diversamente segnate.
L’educazione canora degli Harzer è, forse, solo un “educere” (etimologicamente: “trarre fuori”). Ci sono di mezzo patrimonio genetico fortemente stabile e poca inventiva dei soggetti; paragono il canarino Harzer all’abete, che cresce sempre diritto (anche quando imperversano le bufere e il vento).
Quella dei Malinois - Waterslager è, sì, un partorire delle disposizioni naturali ma affiancato – lo si sa da sempre – da canto, estro e creatività. È noto l’aneddoto. Uno psicologo domanda a un professore:” che cosa occorre conoscere per insegnare il
latino a Giovannino?” “Il latino”, risponde subito il professore. “No”, replica lo psicologo, “bisogna conoscere Giovannino”.
Assimilo il toponimo di Malines a qualsiasi albero che abbia bisogno di appoggio e di cure particolari per crescere bene.
Ciò per dire che se è indispensabile l’apporto dell’alato adulto, da concepire come “ratio et via” di formazione


canora, altrettanto ineludibile è che tale guida assecondi la più perfetta aderenza alle esigenze della natura degli educandi.


Ma i cantori giovani di maggior talento, nel nostro ambito, sono proprio quelli che si permettono bellamente delle licenze, tradotte in vere e proprie raffinatezze e squisitezze espressive. Senza sacrificio – abbiamo detto – non si alleva.
Dietro il tunnel di amalgama graduale dell’universo canoro c’è un’alba piena di promesse.
Il canto pieno dipende anche dalla capacità dell’uccello a sentire sé stesso cantare (feed-back uditivo).

Poi arriva il tempo dei concorsi e delle performance (verifica, in sede professionistica, dei livelli qualitativi raggiunti).
Comunque, anche se non sortiranno effetti di gloria, l’appagamento sarà grande!
58 NUMERO 1 - 2023
È certo che per ottenere nei Malinois degli ottimi cantori non basta avere dei buoni maschi derivanti da un ceppo di alto valore genealogico
Congresso Tecnico di Specializzazione
Città di Fiuggi, 10 e 11 settembre 2022 - C.T.N. C.F.P.A.… ad maiora!

 testo e foto di Federico Vinattieri
testo e foto di Federico Vinattieri
Passione… noi ornitologi conosciamo bene questo termine. La parola “passione” troppo spesso viene utilizzata a sproposito o in situazioni sbagliate, talvolta anche quando questa non è veramente presente. Noi, che abbiamo seguito l’ultimo Congresso Tecnico di Specializzazione per i Giudici F.O.I., tenutosi a Fiuggi il 10 e 11 settembre, abbiamo ben compreso che questo termine può assumere un significato molto più intenso di quanto si possa immaginare.
Nell’ambito del Congresso, voluto ed organizzato dalla nostra Federazione (F.O.I.), si sono tenute le varie conferenze tecniche di Specializzazione, compresa quella della nostra F.P.A. La nostra Commissione Tecnica ha voluto fortemente riunire i giudici, pro-
prio allo scopo di mostrare una nuova concezione ed un nuovo metodo di lavoro che non prevede solo sterili nozioni messe a disposizione di ogni esperto giudice, ma incrementa ed incentiva la collaborazione, la condivisione, la gestione all’unisono proprio di quella passione tanto blasonata, che però, con questa nuova gestione, diventa di colpo assai tangibile. Emilio Sabatino ha sottolineato che è innegabile che la nostra specializzazione sia prossima ad un ricambio generazionale e, conseguentemente, sia necessario dare preparazione, competenza e specializzazione alle nuove leve per assicurarsi stima e fiducia da parte degli allevatori.

L’impressione spontanea, di primo acchito, non era quella di assistere ad un
semplice congresso, bensì quella di far parte di una comunità di appassionati che compartecipano e trasferiscono la propria esperienza ad altri colleghi. L’esperienza, insieme alla competenza, è l’ingrediente più importante per far sì che un giudice svolga al meglio il proprio servizio.
Questa è la vera filosofia della nuova C.T.N. che tutela le razze di Canarini Arricciati: promuovere la collaborazione, stimolare il dibattito, custodire lo Standard.
- “Più che colleghi, ci siamo sentiti parte di una vera famiglia...” - questo è stato dichiarato dalla maggior parte dei colleghi che hanno preso parte a questo Meeting Tecnico.
Possiamo senza dubbio dire che questo congresso sia stata la prima “uscita uf-
NUMERO 1 - 2023 59 CRONACA
ficiale” della nostra neo-eletta Commissione Tecnica Nazionale ed è innegabile che sia stato un vero successo. La prima pietra, che getta le fondamenta di una nuova forma di amministrazione, gestione, visione futuristica. - “In questi due giorni siamo stati una vera famiglia, abbiamo discusso, ci siamo confrontati, ci siamo lamentati, ci siamo divertiti, proprio come si fa tra parenti che si ritrovano” - questo ha asserito Emilio Sabatino, Presidente C.T.N.
Abbiamo recuperato dei concetti che stavano per esser perduti e che fortunatamente sono stati riportati in auge: il confronto ed il dialogo.
Il confronto ed il dialogo tra colleghi giudici sono la chiave per ottenere una omogeneità di giudizio, una giustapposizione ideale compiuta a scopo di valutazione, un raffronto tra esperti che comporta un inevitabile rafforzamento delle proprie capacità di determinare il valore di un esemplare esposto. Questo confronto era stato sì ricercato negli anni, ma mai come questa volta è stato portato a compimento.
Il Congresso Tecnico di Specializzazione C.T.N. F.P.A. è iniziato con il saluto del Presidente Emilio Sabatino, che ha dato il benvenuto ai Colleghi giudici ed espresso un grazie per la partecipazione che dimostrava in maniera chiara e consapevole l‘impegno, l’interesse e la responsabilità che ci si pone nello svolgere il delicato ed importante compito di Giudici della Federazione Ornicoltori Italiani.


Ringraziando il Presidente della FOI Antonio Sposito, il Responsabile CC.TT.NN. Vice Presidente FOI e Presidente OMJ Diego Crovace, il Presidente dell’Ordine dei Giudici Andrea Benagiano e il Presidente di Collegio Angelo Ceccarelli, che hanno realizzato lo svolgimento di questo Aggiornamento Tecnico, ha sottolineato l’importanza di questi due giorni di Meeting, illustrando la successione degli step delle razza da relazionare, ringraziando per il lavoro svolto dai relatori; un ringraziamento particolare all’allevatore

Pietro Peluso, creatore della razza italiana Benacus, intervenuto al congresso. Il sabato pomeriggio ha avuto inizio con un interessante resoconto da parte del relatore Giulio Pisani sulle peculiarità dell’Arricciato Padovano, che sappiamo essere una delle razze più discusse e anche più difficili da valutare.
Anche questa prima lezione, di per sé, non è stata la solita lettura standard che apporterebbe pochissime informazioni; è stato invece un approfondito confronto, un’analisi sinottica sui criteri di giudizio e sui difetti comunemente riscontrabili. Un confronto collettivo tra esperti, visionando dal vivo, soggetto dopo soggetto, esemplari portati lì appositamente, pur tenendo conto della loro fase di muta ma focalizzando le nostre attenzioni sui difetti relativi alle arricciature, al piumaggio, al ciuffo, alla taglia, al famigerato collarino, che è stato ben spiegato da Pisani, da Sabatino e da altri colleghi che hanno voluto condividere la propria esperienza sul campo.
Abbiamo parlato e discusso guardando i canarini, osservando e analizzandone la morfologia, la biometrica ed i connotati peculiari della razza. Nozioni che non si imparano sui libri, ma solo dalla conoscenza acquisita mediante il contatto e il dialogo dinanzi alla gabbia. La prima giornata si è conclusa con una splendida cena, durante la quale abbiamo riso e scherzato tutti insieme,

60 NUMERO 1 - 2023
Pisani evidenzia le peculiarità del Padovano
Sabatino e Pisani durante la conferenza
Rosa e Vicchitto spiegano l'Arricciato del Sud
in cui ci siamo “spogliati” delle vesti di giudici e siamo ritornati ad essere degli allevatori e, soprattutto, dei semplici amici ornitofili.
Al mattino seguente ci siamo ritrovati nella medesima sede, a relazionare sui canarini Arricciato del Sud e Benacus. I relatori, Rosario Vicchitto e Antonio Rosa, hanno spiegato le caratteristiche dell’Arricciato del Sud, facendo riferimento al nostro standard nei “criteri di giudizio” e commentando ogni voce, indicandone eventuali pregi e difetti direttamente sui soggetti portati in visione e allo stesso tempo facendo scorrere alcune immagini chiarificatrici con il proiettore. Un processo di acquisizione di nozioni utilissime, che agevoleranno indubbiamente il nostro lavoro e la nostra abilità di individuare sia soggetti meritevoli sia soggetti scarsi sul piano morfologico, durante tutte le nostre valutazioni future.
Abbiamo appreso quel che dobbiamo tener presente in fase di giudizio per riconoscere esemplari che possiedono i requisiti necessari per un’attribuzione di merito, ma anche ciò che dobbiamo ben guardarci dal premiare, ossia esemplari con determinati difetti oggettivamente distinguibili.
Mai dimenticare che il giudice è colui che deve fornire le direttive per le future selezioni; pertanto, è stato più volte ribadito che siamo noi giudici a dover segnalare e penalizzare eventuali preoccupanti deviazioni di tipo che sovente si evidenziano in mostra. Il congresso è proseguito con l’intervento del relatore Luigi Mollo, che insieme al graditissimo ospite, l’allevatore Pietro Peluso creatore della nuova razza italiana Benacus, ha illustrato questo arricciato di posizione, commentandone ogni prerogativa, ogni tratto caratteristico, rendendoci partecipi, in una parola, dell’identità della razza.
Anche in questo caso, la spiegazione è avvenuta con esemplari alla mano, portati sul posto dall’allevamento del Sig. Peluso. V’erano soggetti di ottima qualità, ma anche esemplari poco rappresentativi, questi ultimi portati appositamente per far comprendere quali siano i soggetti da non premiare. Per tutti i giudici presenti, adesso il Bena-
cus ha assunto una definizione ben precisa. Per far comprendere ancor di più le svariate differenze tra le razze, sono stati portati anche un esemplare di Gibber Italicus ed un Giboso, che messi a confronto con il Benacus hanno manifestato ai nostri occhi tutte le divergenze di tipo, che non lasciano dubbi sulla specificità della postura, delle arricciature, della taglia di ognuna di queste tre razze, inconfondibili.
Il congresso è terminato con un ringraziamento da parte dei membri della C.T.N. Emilio Sabatino e Giulio Pisani, i quali hanno dichiarato che questo è stato il primo passo per una nuova fase della nostra specializzazione, esortando anche nuovi colleghi a farsi avanti per assumere il ruolo di relatori in futuri convegni pertinenti a specifiche razze, essenziali per incrementare le nostre abilità di osservazione e valutazione tecnica.
Non possiamo che ringraziare tutti i relatori di questo incontro, ma anche e soprattutto il nostro Rappresentante di collegio Dr. Angelo Ceccarelli per aver, con grande impegno, provveduto all’organizzazione di questo importante e proficuo evento. Desideriamo ringraziare anche il Presidente dell’Ordine dei Giudici e tutta la nostra Federazione per averci dato la possibilità di seguire questo congresso.



Come affermò il Dr. Alan Kay, Il miglior modo per predire il futuro è inventarlo! Beh, che dire… a quanto pare questa nuova C.T.N. ha ben afferrato tale pensiero e farà di tutto per metterlo in atto, organizzando nuovi incontri, lavorando a fianco dei giudici per garantire valutazioni sempre più efficienti e potenziare la nostra cultura, le nostre capacità, sempre incentivando il confronto tra noi colleghi e amici giudici. Ad maiora, semper!

NUMERO 1 - 2023 61
Il Presidente C.T.N. Emilio Sabatino
Osservazioni dei Benacus con Pietro Peluso
nostri ricordi
P ensieri in libertà

I nostri ricordi






Ina giornata dal sapore particolare, una fuga dall’attuale realtà o un ritorno alla normalità dopo questi anni di pandemia?






Mi trovo a casa di Gianni Davito il 14 giugno per portargli a vedere come procede la crescita della mia cucciola Schnauzer media pepe

I
62 NUMERO 1 - 2023
P ensieri in libertà
e sale; mi propone di accompagnarlo a Pordenone per una riunione ornitologica con allevatori del Friuli Venezia Giulia, partenza venerdì 1° luglio rientro nella mattinata del giorno successivo.




Gli rispondo che gli farò sapere; d’impeto ho già deciso di andare per passare una giornata a parlare del nostro hobby, per ricordare, per pianificare il futuro, ma la ragione e gli impegni che possono verificarsi mi consigliamo prudenza. Mentre torno a casa il filo dei pensieri e dei ricordi prende il sopravvento: ci conosciamo dai primi anni 80, entrambi impegnati nell’Associazione Ornitologica Torinese. A quel tempo collaboravamo, oltre che per i compiti sociali normali, anche alla stesura di un Notiziario e allora, appena arrivato a casa, riprendo in mano con nostalgia alcuni numeri di cui voglio condividere con voi alcune pagine.




Poi la vita di ciascuno prende strade diverse per motivi di lavoro e altro, comunque rinnovare le amicizie anche solo incontrandosi ad una Mostra o ad un giudizio, o per caso in

un’altra occasione, è fonte di crescita e di appagamento interiore.

Per queste ragioni ho poi deciso di accompagnarlo per incontrare gli Amici: Michele, Claudio, Ezio, Tiziano e tanti altri; ben 45 hanno risposto all’appello per partecipare all’incontro in una ampia sala. Non entro nel merito dell’incontro, ma resto soddisfatto di queste ore trascorse al di fuori della routine giornaliera. Nella strada del ritorno abbiamo ricordato tante immagini del passato della Torino ornitologica che non c’è più: il Mercato domenicale di Porta Palazzo, le vecchie sedi sociali di via Fiocchetto e di via Bazzi, le mostre ai padiglioni espositivi del Valentino, tanti volti, tanti nomi, che continueranno a vivere scolpiti nelle nostre menti. Abbiamo anche parlato del futuro della mostra specialistica che il Club degli Psittacidi vuole organizzare con obiettivi ambiziosi; sicuramente con la super volontà di Walter sarà difficile non riuscirci. Poi l’arrivo, un caldo saluto e un arrivederci alla prossima avventura.
Paolo Corbelletto
I nostri ricordi
NUMERO 1 - 2023 63
Attività F.O.I.
Sintesi verbale del Consiglio Direttivo Federale del 2 e 3 Settembre 2022
(La versione integrale è pubblicata sul sito www.foi.it/verbali )
-Verbale ODG del 8/7/2022: determinazioni;
Il CDF ritiene di non assoggettare a ratifica, così come richiesto, i programmi redatti dalle CTN in funzione del meeting di aggiornamento dei giudici di Fiuggi in quanto il contenuto dei medesimi ha rilevanza squisitamente tecnica.
Il CDF, preso atto degli accertamenti eseguiti dall’ODG circa il reale interesse dell’allievo giudice Gaetano Romano alla continuazione del corso, in quanto più volte convocato non risponde alle mail ed alle telefonate, ne ratifica la decadenza.
Il CDF, ritenendo valide le motivazioni addotte, ratifica le dimissioni del giudice della sezione altri psittaciformi Leonardo Lopez, disponendone la cancellazione dai ruoli.
-Disamina, risposta ed eventuale ratifica da parte del CDF in ordine alle deliberazioni contenute nei verbali degli altri Organi Federali con riferimento ai tempi di ricevimento degli stessi;
Il CDF comunica che la disamina, la risposta e l’eventuale ratifica delle deliberazioni contenute nei verbali degli altri organi federali avverrà unicamente se questi ultimi perverranno presso la segreteria federale almeno 30 giorni prima della data fissata per la prossima riunione del CDF. Quanto innanzi perché, per il compiuto approfondimento e per la necessaria istruttoria di tali argomentazioni ogni consigliere delegato dovrà disporre di un sufficiente lasso temporale, in esso compresa anche la relazione al plenum del CDF. In tale novero non saranno considerate le urgenze, qualora ritenute tali.
-Programmi Organi Federali;
Tutti gli Organi della Federazione dovranno far pervenire le attività programmatiche che intendono realizzare, sviluppate in ogni loro esplicazione (argomentativo, istituzionale, tecnico, previsione di impegno economico), entro e non oltre il 31 ottobre (termine perentorio). Quanto innanzi perché il CDF dovrà avere disponibilità di un congruo lasso di tempo per valutare la valenza e, soprattutto, per verificare la disponibilità della posta economica da inserire nel bilancio di previsione. Conseguentemente proposte programmatiche pervenute dopo tale data verranno considerate per l’anno successivo, se possibile.
L’organizzazione di meeting, aggiornamenti tecnici giudici e quanto altro gli organi intendono sviluppare dovranno essere predisposti e pianificati negli anni intermedi alle eventuali elezioni degli Organi istituzionali interessati.
-Calendario-Programma delle attività Organi Federali; Il CDF istituisce il Calendario-Programma delle attività che gli Organi della Federazione intendono sviluppare/Organizzare durante l’anno. Ogni Organo, prima di fissare a calendario un’attività programmata
che intende realizzare, dovrà obbligatoriamente e preventivamente verificare se in quella stessa data sono calendarizzate altre attività relativamente alle quali si possa realizzare interferenza. Il calendario-programma prevederà la seguente gradualità di inserimento delle attività da parte degli Organi:
-CDF
-Ordine dei Giudici/RR.RR
-CCTTNN
Al Presidente Federale ed al CDF spetterà il compito di eliminare possibili sovrapposizioni e di valutare la compatibilità di eventuali più attività fissate nella medesima data.
-Costituzione, riordino ed organizzazione della biblioteca in sede federale;

Con riferimento alla biblioteca FOI il CDF delibera l’istituzione di apposito progetto che, nella sua concreta esplicazione, viene affidato alla cura del Consigliere Francesco Badalamenti. Il progetto dovrà prevedere, oltre alle tradizionali forme di conservazione bibliografica, catalogazione, archiviazione, rilegatura e consultazione, anche tutte le forme di digitalizzazione dei testi bibliografici, dei documenti storici, della rivista Italia Ornitologica, dei manifesti, dei calendari e delle descrizioni museali.
- Il CDF, a seguito delle richieste pervenute dall’Associazione Fiorentina Ornitologica (mail del 30 agosto 2022), delle richieste avanzate dalla AAA di Rimini (mail del 26 agosto 2022) e dalla A.O. Ragusana (mail del 31 agosto 2022), pur ritenendo le stesse meritevoli di positiva valutazione, dispone la remissione degli atti ai competenti raggruppamenti regionali Toscana, Emilia Romagna e Sicilia per l’emissione dei prescritti pareri.
-Il CDF, dopo aver udito il vice presidente federale Diego Crovace in ordine alla validazione dei criteri di giudizio del canarino malinois da parte della CTN neo eletta e del presidente di Collegio in occasione della riunione dell’ODG dell’8 luglio 2022, ne dispone la pubblicazione sul sito federale e la comunicazione mediante i canali ufficiali.
-Il CDF, ai sensi dell’art. 17 del Regolamento Organico FOI, delibera l’apertura di procedimento disciplinare nei confronti del tesserato Domenico Pullì (RNA n. CC84) a motivo delle gravissime offese rivolte ai componenti del Consiglio Direttivo Federale e delle affermazioni false e diffamatorie verso i medesimi, rinvenibili in un video filmato postato da prima sul social network facebook e successivamente sul proprio canale YouTube in data 30 agosto 2022. Tale condotta sembrerebbe legittimare altresì la configurazione di diverse ipotesi di reato relativamente alle quali i componenti del CDF riservano ogni più opportuna valutazione.
64 NUMERO 1 - 2023

























 Canarini di Forma e Posizione Arricciati Criticità e precisazioni sull’Arricciato Padovano
Veterinario Uova chiare
Rivista mensile di Ornitologia Scientifica - Tecnica - Pratica Organo Ufficiale della F.O.I.-Onlus
Canarini di Forma e Posizione Arricciati Criticità e precisazioni sull’Arricciato Padovano
Veterinario Uova chiare
Rivista mensile di Ornitologia Scientifica - Tecnica - Pratica Organo Ufficiale della F.O.I.-Onlus















































 testo e foto di BRUNO ZAMAGNI
testo e foto di BRUNO ZAMAGNI












































































































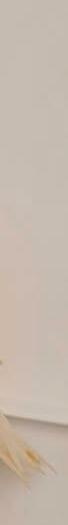












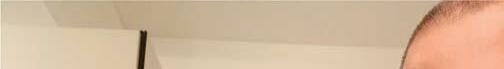





























































 di PIERCARLO ROSSI, foto THOMAS WENDT
di PIERCARLO ROSSI, foto THOMAS WENDT























































































