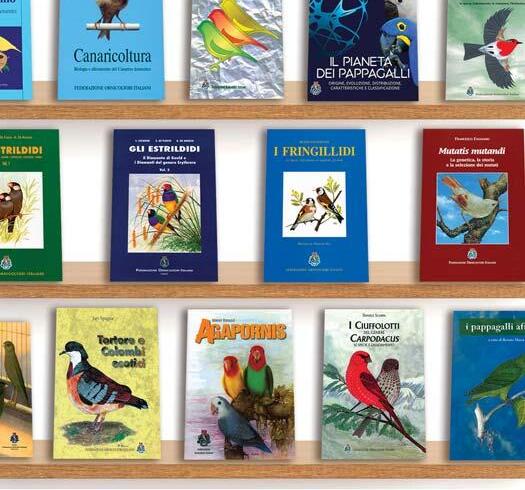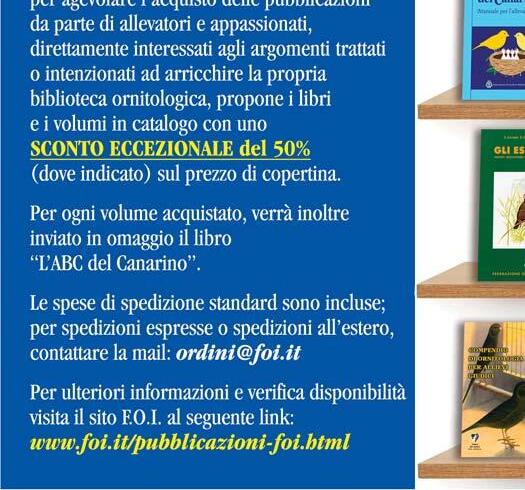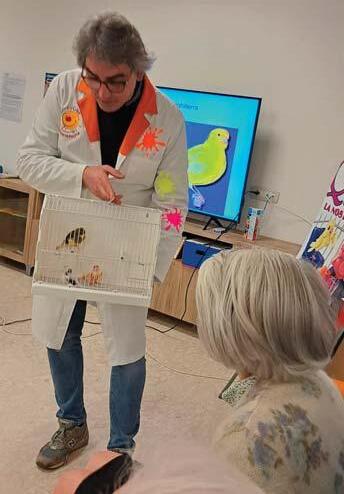Categorie nel canarino: un nuovo approccio








2023
ANNO XLIX numero 4
Canarini di Colore
Estrildidi Fringillidi e Ibridi La mia esprienza con il Lucherino di Haiti
Ondulati ed altri Psittaciformi Il maschera gialla australiano (Golden Face)
Canarini di Forma e Posizione Lisci Lo stato dell’arte del canarino Salentino
Rivista mensile di Ornitologia Scientifica - Tecnica - Pratica Organo Ufficiale della F.O.I.-Onlus






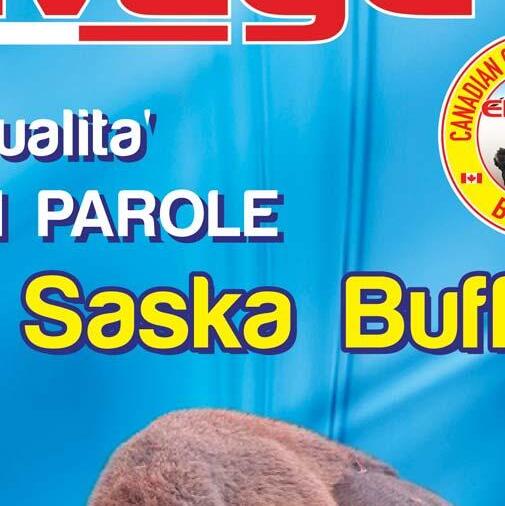

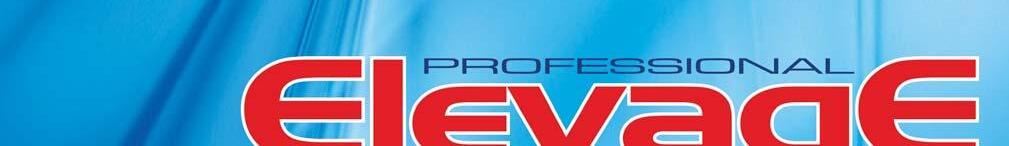
F.O.I. Canarini di Colore Estrildidi Fringillidi e Ibridi Ondulati ed altri Psittaciformi Canarini di Forma e Posizione Lisci
ANNO OrniFlash News al volo dal web e non solo 40 Canarini Border: un modello futuristico Angelo Lagi 43 Spazio Club Lizard Canary Club Italiano 44 Cose risapute? Sergio Palma 45 Assistenza alle coppie nidificanti Rafael Zamora Padrón 48 Con la F.O.I. ci divertiamo Rosa Meola 50 Birdgardening Dino Tessariol 51 Quando si riesce a vedere oltre… Lia Porcino 54 Il Satiné ossidato (alias Bruno Satiné) Peppino Vitti 57 Aggiornamenti su attività divulgative e non solo Giuseppe Albergo 61 Attività F.O.I. - Sintesi verbali C.D.F 3/4 febbraio e 24/25 febbraio 2023 63



AMMINISTRAZIONE E PUBBLICITÀ: Segreteria F.O.I.-Onlus Via Caorsana, 94 - Località Le Mose
29122 Piacenza Tel. 0523.593403 - Fax 0523.571613
Web: www.foi.it - E-mail: redazione@foi.it

Direttore Responsabile: Antonio Sposito
Caporedattore: Gennaro Iannuccilli
Collaboratori di Redazione: Giovanni Canali, Maurizio Manzoni, Francesco Rossini
Commissione Salute, Benessere animale e Ricerca Scientifica:

Elena Circella, Giuseppe Marruchella, Gianluca Todisco
Coadiutore Editoriale: Lorenza Cattalani
Associato all’Unione Stampa Periodica Italiana ISSN 0391-254X (International Standard Serial Number)


Autorizzazione del Tribunale di Bologna n. 4396 del 12-3-1975
Stampa: TEP s.r.l. - Strada di Cortemaggiore, 50 29122 Piacenza - Tel. 0523.504918
Inoltro postale in Italia: Effezeta srl
Via Francesco Nicoli 10/G - 29122 Piacenza
ABBONAMENTI ANNUI:
Italia € 50,00 - Estero-Europa € 70,00
Estero-ExtraEuropa € 90,00
Un numero € 5,00 - Arretrato € 6,50
C.C.P. 53684957
Le quote abbonamento vanno versate, mediante vaglia o assegno, alla Segreteria. Le opinioni espresse dagli Autori non impegnano la Rivista e la sua Direzione.
La Redazione si riserva il diritto di non pubblicare o emendare gli articoli proposti. I collaboratori assumono piena responsabilità delle affermazioni e delle immagini contenute nei loro scritti. Vietata la riproduzione, anche parziale, se non espressamente autorizzata. © F.O.I.
In copertina:
Agata Topazio mosaico giallo maschio (Serinus canaria)
5 11 15 18 Italia Ornitologica è la rivista ufficiale della F.O.I. - Federazione Ornicoltori Italiani, pubblicata in 10 (dieci) numeri annuali a cadenza mensile, 2 (due) dei quali in versione bimestrale nel periodo estivo (Giugno/Luglio e Agosto/Settembre). Il numero 4 - 2023 è stato licenziato per la stampa il 5/5/2023
XLIX NUMERO 4 2023 sommario Assemblea delle Associazioni
Foto: ANTONIO JAVIER SANZ 2023 Gennaro Iannuccilli 3 Categorie nel canarino: un nuovo approccio Mimmo Alfonzetti 5 La mia esperienza con il Lucherino di Haiti Stefano Picco 11 Il maschera gialla australiano (Golden Face) Giovanni Fogliati 15 Lo stato dell’arte del canarino Salentino Vulzio Lazzarini 18 Confronto e dialogo sul Fiorino Raffaele Roberto e Federico Vinattieri 21 Il canto che conta Umberto Marini e Gregorio Piccoli 24 Luoghi comuni sui semi germinati Pasquale Leone 27 Sul colore ed altro Giovanni Canali 29 Photo Show Le foto scattate dagli allevatori 34 Sul Diamante papuano Erythrura papuana (Hartert, 1900) Ivano Mortaruolo 35
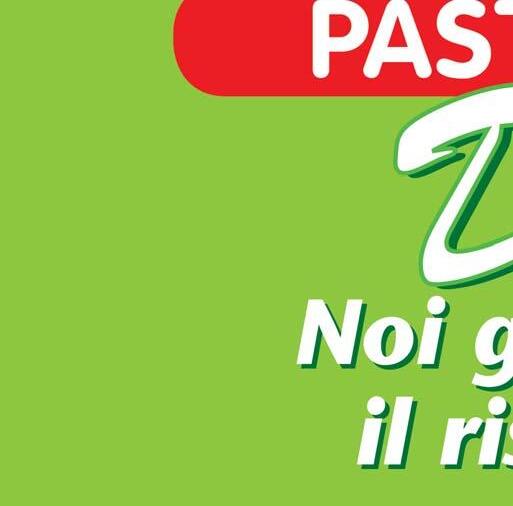








Assemblea delle Associazioni F.O.I. 2023

 di G ENNARO IANNUCCILLI
di G ENNARO IANNUCCILLI
Lo scorso 16 Aprile si è svolta l’annuale assemblea delle Associazioni, momento focale della vita federale targata FOI. Dopo le ultime edizioni che hanno attraversato il tormentato periodo pandemico, tenutesi nella amena località di Chianciano Terme, quest’anno siamo tornati nella città di Piacenza, “casa” della nostra Federazione, dove l’assemblea ha avuto luogo presso la Sala Gatti dell’ente fieristico.


Nonostante non fossero previsti all’ordine del giorno appuntamenti elettivi o punti dedicati a tematiche di particolare urgenza, la partecipazione delle Associazioni – rappresentate dai rispettivi presidenti o delegati per un totale di 123 presenze – è stata molto attenta e sentita. Ciò è stato dimostrato anche dai momenti di discussione inerenti argomenti di interesse comune, a testimoniare la volontà di condividere un percorso di gestione e crescita dell’or-

NUMERO 4 - 2023 3 Editoriale
Editoriale
nitologia amatoriale e sportiva, compatibilmente con i tempi critici che stiamo vivendo.

Il bilancio Consuntivo e Preventivo, nonché il bilancio Sociale previsto per gli Enti del Terzo Settore del quale la FOI fa parte, sono stati approvati all’unanimità con l’auspicio di poter far fronte alle prossime sfide che vedono la Federazione impegnata in prima linea per garantire e tutelare le attività di tutti gli allevatori iscritti presso le associazioni affiliate.

L’assemblea è stata arricchita anche dalla illustrazione della ricerca finanziata dalla FOI e condotta dal dott. Gianluca



Todisco e dal dott. Giuseppe Marruchella sul microbiota intestinale del canarino, e si è conclusa con un video introduttivo al prossimo Campionato Italiano di Ornitologia 2023 che svolgerà a Lanciano (CH). Come sempre, in queste occasioni lasciamo spazio più alle immagini che ai testi, poiché attraverso di esse è possibile scorgere e trasmettere il senso di partecipazione alla base del movimento FOI che consente, al di là di tutti gli impegni istituzionali in programma, di incontrarsi e vivere momenti di convivialità altresì necessari per continuare a nutrire la nostra passione.


4 NUMERO 4 - 2023
Categorie nel canarino: un nuovo approccio
 di MIMMO ALFONZETTI, foto e E. DEL POZZO
di MIMMO ALFONZETTI, foto e E. DEL POZZO
Prefazione


L’ornitologia da diletto, in particolare la canaricoltura, ha negli ultimi decenni compiuto notevoli progressi sia nel campo dell’alimentazione ma soprattutto nel campo della biologia. Quante uova ho lessato, tanti anni fa, per preparare il pastoncino alle coppie in cova, le schiacciavo con la forchetta, aggiungevo la giusta dose di savoiardi ed un giro di olio e le somministravo ai pulli.
Nel campo delle scienze sono aumentate
le indagini sul piumaggio
Ora sono scomparsi anche i semi per il becchime, si usa una razione costante composta da cereali, proteine vegetali,
oli e grassi, zuccheri, sostanze minerali, probiotici, vitamine, aminoacidi, antiossidanti, aromi (e chi ne ha più ne metta) tritati più o meno finemente, concentrati, miscelati in modo tale da non poter consentire al canarino di poter scegliere cosa mangiare tra i componenti della razione.
Nel campo delle scienze, dove le ricerche erano prevalentemente indirizzate verso gli animali da reddito, sono invece


NUMERO 4 - 2023 5 CANARINIDI COLORE
Agata intenso giallo, foto: E. del Pozzo
Agata intenso rosso, foto: E. del Pozzo
decisamente aumentate le indagini scientifiche sui piumaggi degli uccelli, sulla origine della cromia delle piume. Stabilire i legami tra fenotipo e genotipo è di grande importanza per risolvere questioni chiave sull’evoluzione, il mantenimento e la funzione adattativa della variazione fenotipica. Dati i recenti progressi negli strumenti molecolari che consentono di scoprire polimorfismi genetici e misurare i livelli di espressione genica e proteica, è stato necessario rivedere la letteratura sulla genetica della colorazione degli uccelli. Ciò che sorprende sono le numerose pubblicazioni sulle cromie dei canarini, sui geni che giustificano le nuove e vecchie mutazioni. L’approccio negli anni passati è stato soprattutto “sperimentale” e basato sulla semplice osservazione della morfologia e della dicromia esterna del piumaggio dei canarini. Attraverso gli accoppiamenti e i risultati ottenuti nella prole si tentava di capire le varie possibili combinazioni geniche. Una giusta dose di “intuizione” era necessaria per collegare le modifiche morfologiche alla base genomica che giustificasse l’esistenza di queste, nulla o quasi nulla di scientificamente probante. Gli esperti, più che essere tali, erano più vicini agli indovini e non sto a raccontare le soluzioni suggerite per combattere certe malattie, vere pozioni di stregoneria. Ricordo, parlo di cinquanta anni fa, di quando in un nido, forse di agata, mi nascevano dei canarini con evidenti occhi rossi, mai visti fino allora. Chiesi aiuto al mio mentore, un anziano allevatore calabrese. Mi disse –Mimmo passa un dito davanti agli occhi, se non reagisce è certamente cieco, toglilo, darai maggiore probabilità di vita agli altri pulli! –Ahimè quanti rubino ho fatto passare a nuova vita!


Oggi l’allevamento del canarino
può essere coadiuvato da metodologie scientifiche che si basano sull’analisi genetica attraverso sofisticate tecnologie che analizzano

i geni e le loro espressioni che si manifestano nelle variazioni morfologiche (colore del piumaggio, dimensioni, malattie, ecc). Si indaga su ciò che succede all’interno dell’infinitamente piccolo per poi giustificare quello che si manifesta all’esterno. Le righe successive hanno la pretesa di proporre una giustificazione della base genetica delle mutazioni che sostengono la classificazione delle categorie dei canarini tramite un approccio diverso. È una mia personale intuizione e come tale può essere fallace anche perché non esiste alcun riscontro scientificamente probante, non hanno alcun supporto sperimentale, sono da considerarsi come
semplici appunti ornitologici. È un modesto tentativo di colmare dei buchi di conoscenza della canaricoltura non con semplici supposizioni ma con un minimo di certezza scientifica.
Il considerando “Categoria”
Trascrivo testualmente ciò che è riportato nei “Criteri di giudizio dei canarini di colore” che compendiono il giudizio analitico dei canarini nelle manifestazioni ornitologiche da competizione:
-Tipo - Rappresenta il disegno tipico del canarino che viene costituito dalle striature, vergature, marcature e mustacchi, tutte riferite alle melanine
-Categoria – Rappresenta la distribuzione dei pigmenti (varietà) sul piumaggio del canarino
-Varietà – Rappresenta il colore di fondo del canarino espresso quasi esclusivamente dai Carotenoidi
La categoria, in maniera meno sintetica, è la disposizione dei pigmenti carotenoidi sul piumaggio trascurando la conformazione dalle sue strutture morfologiche. Di conseguenza, l’espressione cromatica riconosciuta dalla canaricoltura da competizione si espone in tre modalità: brinato, intenso, mosaico. Molto semplicemente, il brinato ha l’apice delle piume decolorate, l’intenso ha le piume colorate fino all’apice, il mosaico ha il pigmento lipocromico limitato in alcune precise regioni. Ho preferito elencare le categorie nell’ordine prima indicato perché la categoria brinato è strettamente legata alla origine del canarino domestico, al wild type (Serinus canaria).
La naturale evoluzione cronologica operata dall’uomo ha indotto delle mutazioni selezionando proprio questa caratteristica. Separando i soggetti che mostravano un tipo di piumaggio più o meno ricco di quello medio della specie selvaggia, è riuscito a creare due distinti modelli: uno costituito da piume tectrici massimamente svi-
6 NUMERO 4 - 2023
Isabella brinato giallo, foto: E. del Pozzo
Isabella brinato rosso, foto: E. del Pozzo
luppate nella superfice del vessillo, nelle barbole e nell’iporachide, e spesso visivamente più povero di pigmenti, ed un altro che risulta esattamente l’opposto. L’intenso, infatti, ha una piuma la cui struttura è caratterizzata da una cheratinizzazione più densa, da barbe corte, da barbole esili e limitate al tratto prossimale della barba e da scarsa iporachide; da cui la massima concentrazione del colore lipocromico di queste strutture.
È opportuno ricordare che il concetto di categoria non è contemplato in zoologia ma è frutto della canaricoltura da competizione. I “Criteri di giudizio dei canarini di colore” editi in Italia, credo tra i primi al mondo, sono stati assemblati intorno agli anni ‘60. Era il tempo in cui non era ancora concepita la distinzione fra tipo, categoria e varietà, i canarini di colore erano anche chiamati “Harzer colorati”, i canarini brinati rossi venivano chiamati salmonati, muffati, esisteva una unica voce “Colore” il cui considerando statuiva 50 punti. Bisogna aspettare il 1967 con la pubblicazione dei primi “Criteri di giudizio dei canarini sassoni” stampato a Messina, per annoverare la presenza delle categorie.

La genetica dei carotenoidi
I numerosi progressi tecnologici (come il sequenziamento ad alto rendimento) hanno portato recentemente a sostanziali progressi nello scoprire le basi genetiche della colorazione dei carotenoidi negli uccelli (Funk e Taylor, 2019). In particolare, diverse classi di geni coinvolti nell’assorbimento dei carotenoidi, nella chetolazione e nella degradazione sono emersi come attori chiave nella colorazione da carotenoidi: questi sono rispettivamente i recettori trasportatori (SCARB1), le chetolasi (CYP2J19) e le beta-carotene ossigenasi (BCO2). Il recettore SCARB1, recettore proteico che riconosce le lipoproteine che trasportano i carotenoidi, è importante per la colorazione dei salmonidi, bachi da seta e capesante. Solo di recente ne è stato confermato il ruolo nella colorazione degli uccelli. Un esempio importante è una sua mutazione che fa sì che il colore delle piume cambi dal giallo selvatico al bianco nei canarini comuni (Toomey et al. 2017), cioè i bianchi recessivi.
Le chetolasi CYP2J19 sono enzimi che convertono i carotenoidi in chetocarotenoidi attraverso una reazione di ossidazione che aggiunge un gruppo chetonico (o carbonile). Le chetolasi sono responsabili della trasformazione dei carotenoidi gialli rivenienti dalla dieta in chetocarotenoidi rossi negli uccelli con piume rosse. In particolare, il citocromo P450 CYP2J19 è stato collegato alla variazione della colorazione rossa nelle piume dei canarini domestici “a fattore rosso” e ai becchi e alle zampe dei mutanti del fringuello zebra e di alcuni scriccioli dal dorso rosso. Il gene BCO2 è, invece, importante nella degradazione dei carotenoidi dei vertebrati,
ne regola la giusta concentrazione per garantire il benessere degli organismi ed è certamente rilevante, a mio avviso, nella genesi delle categorie del canarino domestico. Le mutazioni di BCO2, accertate scientificamente, possono favorire la dissoluzione ma anche l’arricchimento dei carotenoidi

Le influenze del gene BCO2 nei vertebrati
Le beta-carotene ossigenasi (BCO2) sono coinvolte nella degradazione dei carotenoidi. La codifica e la regolazione delle proteine che le costituiscono, hanno la funzione di scindere (scissione ossidativa) i carotenoidi colorati in apocarotenoidi incolori, giustificando così le espressioni carotenoidi nelle pecore, mucche e uccelli (approfondito in Toews et al. 2017). Le carcasse di pecore con grasso giallo sono state osservate sporadicamente nei macelli norvegesi. Questo fenomeno è causato dall’accumulo di carotenoidi nel tessuto adiposo che porta al grasso giallo. È nelle pecore un tratto recessivo ereditario che è attribuito a una mutazione di BCO2.
Una mutazione nella β-caroteneossigenasi 2 bovina influenza il colore del latte modificando il contenuto di β-carotene del latte che così appare più o meno giallognolo.
Negli uccelli, BCO2 è stato inizialmente collegato alla colorazione dei carotenoidi nei polli domestici, dove la modifica dell’azione regolatrice influenza l’estensione della pigmentazione dei carotenoidi gialli nella pelle (Eriksson et al. 2008), giustificando i polli a carne giallastra.
Un polimorfismo nel colore del becco dei nidiacei si trova nella maggior parte delle specie di fringuelli di Darwin. I becchi sono rosa o gialli. Il becco giallo è recessivo e controllato da una mutazione che colpisce l’espressione di BCO2. Recentemente (Gazda et al. 2020) è stato dimostrato che il dicromatismo a base di carotenoidi nei canarini “mosaico” è spiegato dalla degradazione differenziale dei carotenoidi nel tegumento, piuttosto che dalla variazione nelle funzioni fisiologiche come l’assorbimento o il trasporto del pigmento. La sovraregolazione di BCO2 nelle femmine di canarino mosaico giustifica il dicromatismo sessuale. Mi-
NUMERO 4 - 2023 7
Fig 1 - Pubblicato a Messina nel 1967. Non esistevano ancora le Commissioni Tecniche nazionali e la pubblicazione era sotto l’egida del “gruppo di specializzazione razza sassone”
I numerosi progressi tecnologici hanno portato recentemente a sostanziali progressi nello scoprire le basi genetiche della colorazione dei carotenoidi negli uccelli
surando l’espressione di BCO2 nello sviluppo dei follicoli delle piume, hanno dimostrato che la sovraregolazione di BCO2 nelle piume femminili provoca la degradazione dei carotenoidi e quindi la nascita di piume bianche. L’espressione di BCO2 sembra anche essere regolata dagli estrogeni. Il ruolo dell’espressione di BCO2 nel dicromatismo carotenoide sembra estendersi ad almeno un’altra specie, i fringuelli (Serinus serinus). Tutto quanto sopra è stato possibile grazie a metodologie scientifiche e sofisticate tecnologie come l’ibridazione in situ e l’analisi del trascrittoma (totalità degli RNA trascritti a partire dal genoma).
L’attualità di queste ricerche sui canarini, l’attendibilità degli istituti universitari che le hanno programmate, la serietà delle riviste scientifiche che hanno curato la pubblicazione rendono, a mio avviso, questi risultati dei capisaldi della canaricoltura moderna. Eventuali contestazioni sui risultati di tali ricerche, cose certamente lecite, dovrebbero essere possibili soltanto disponendo di argomenti scientifici di pari portata, supportate da opportune indagini eseguite
con sofisticate metodologie laboratoriali della bioingegneria. La scienza può essere contrapposta solo da altra scienza.

Unità dermiche: Elaborazione dei carotenoidi
Le ricerche prima descritte, in particolare
A genetic mechanism for sexual dichromatism in birds (Malgorzata e altri)sbaraglia da ogni dubbio le supposizioni, le illazioni sulla natura del mosaico: è senza ombra di dubbio il risultato di una mutazione. Nessun legame quindi con l’ibridazione col cardinalino del Venezuela, né con altri fringillidi. Il cardinalino ha fornito soltanto la base genomica dei caroteni rossi e niente altro, nulla del suo dimorfismo sembra essere stato trasmesso.



Per comprendere l’evoluzione nel tempo delle espressioni cromatiche delle categorie del canarino domestico occorre riferirsi al “wild type”, al tipo ancestrale. Il piumaggio del Serinus canaria presenta dicromatismo sessuale abbastanza evidente. Nei maschi, infatti, la livrea si presenta dominata dai toni del giallo-verde,
più brillante su testa, petto e parte superiore del ventre, mentre nuca, dorso e ali tendono al bruno, più scuro e quasi nerastro proprio sulle ali e sulla coda: il sottocoda è invece bianco. La livrea della femmina è simile a quella del maschio, ma il lipocromo giallo è quasi assente, risultando in toni giallo-verdi molto più sbiaditi in speciale modo sulla testa. I carotenoidi nel canarino selvatico non pigmentano l’apice della penna e la evidente rarefazione delle melanine fa sembrare l’apice decolorata, come piccola scaglia bianca. La decolorazione è forse dovuta ad una minore velocità e quindi ad un ritardo nella pigmentazione della cheratina da parte dei follicoli dermici. Le colorazioni del piumaggio si formano attraverso la deposizione differenziale di pigmenti neri (melanine) e gialli (carotenoidi) lungo le piume in crescita nel dorso. Le unità dermiche (accorpamento di mesoderma, melanociti, germe, dentriti…), di cui i follicoli sono parte integrante, fanno parte del pattern di piumaggio influenzato da informazioni posizionali che determinano la specificità regionale del corpo. Sono codificati singolarmente per pigmentare in maniera diversa in relazione alla zona del derma interessata, o meglio: il modello di pigmento della piuma varia a seconda delle caratteristiche della regione in cui le piume possono crescere (striatura, testa, gola, pterili...). Ne consegue che le lunette apicali hanno dimensioni variabili (non è un caso che nelle zone di elezione dei lipocromi quasi non si apprezzano).
I follicoli elaborano, oltre agli enzimi presenti nel sangue, anche le lipoproteine, più o meno modificate dal fegato, che trasportano i carotenoidi. Nel flusso sanguigno ci sono certamente gli enzimi delle beta-caroteneossigenasi (BCO2) la cui normale concentrazione garantisce la corretta degradazione dei carotenoidi e la regolare pigmentazione del piumaggio.
Una probabile base genomica delle categorie
Il canarino domestico della categoria brinato è sommamente probabile che possieda il medesimo assetto enzimatico della specie selvaggia, che garantisce sia l’espressione di similari livelli di
8 NUMERO 4 - 2023
Bruno mosaico giallo femmina, foto: E. del Pozzo
carotenoidi e sia la medesima struttura del piumaggio con le caratteristiche lunette. È comunque innegabile che la selezione messa in atto dagli allevatori (ambiente esterno) può alterare la morfologia delle piume, la consistenza e i modelli di pigmento.
L’enzima β-caroteneossigenasi 2 ossida i carotenoidi anche nei canarini domestici. Dopo l’assorbimento, il trasporto e la conversione metabolica, i carotenoidi assegnati alla colorazione del corpo vengono depositati nelle cellule del tegumento. I geni coinvolti in questo ultimo processo sono ancora in gran parte sconosciuti ma certamente BCO2 svolge una funzione rilevante.

L’espressione maggiore o minore dei lipocromi e la differenza di ampiezza del vessillo, più in generale l’espressione cromatica e la morfologia del piumaggio dei canarini, sono condizionati da evidente poligenia ma certamente BCO2 è il più importante gene mediatore nella evoluzione della colorazione del piumaggio degli uccelli, regolando la deposizione dei carotenoidi (Vage & Boman, 2010).
Le sue mutazioni possono favorire la dissoluzione ma anche l’arricchimento dei carotenoidi. In alcune specie di fringuelli, BCO2 genera un evidente dicromatismo sessuale; nelle piume di molti fringuelli femmine ne è stata rilevata una maggiore concentrazione e una minore in molte piume maschili. Ne consegue che la livrea dei maschi appare più colorata, differenziando nel colore i due sessi. È evidente che anche nei nostri canarini questo enzima svolge la funzione di regolarizzazione dei lipocromi. L’azione è comunque modesta perché comunemente i canarini non sono sessualmente dicromatici; sia i maschi che le femmine hanno poca espressione di BCO2 nelle loro piume, perché non sono in grado di abbattere in maniera significativa i pigmenti che si manifestano nel piumaggio ordinario.


La categoria intenso è certamente correlata ad una mutazione. Pregevoli sono diversi articoli di G. Canali che descrivono minuziosamente la mutazione sia in termini di espressione dei carotenoidi sia in termini di morfologia del piumaggio. Tra i geni multipli che contribuiscono al manifestarsi del genotipo in-
tenso, a mio avviso, è una mutazione del gene BCO2 l’artefice principale, il gene maggiore. La mutazione allelica è recessiva e necessita della doppia dose per manifestarsi sul fenotipo. La minore regolazione della concentrazione delle βcaroteneossigenasi induce, nell’intenso, un arricchimento dei carotenoidi rendendo il colore più concentrato, più saturo. A mio avviso c’è un aumento dei pigmenti nelle piume, viene attivata una maggiore velocità di pigmentazione della cheratina per gestire un flusso aumentato di carotenoidi.
Resta da giustificare la natura delle modifiche morfologiche sulla ampiezza dei vessilli che la mutazione intenso comporta. Ci può essere una sola spiegazione: il pleiotropismo di sviluppo. Fenomeno genetico che consiste nella possibilità di un singolo gene mutante di produrre diverse manifestazioni fenotipiche, a prima vista anche non correlate fra di loro. Tale capacità, in realtà, è soltanto apparente perché l’effetto primario del gene rimane unico, ma determina una serie di conseguenze.

I follicoli, o meglio le papille, si trovano a gestire una quantità rilevante di carotenoidi superiore a quelle di normale gestione; devono mettere in atto precisi meccanismi differenziali nello spazio e nel tempo (suggeriti dal corredo genetico) inducendo quelle modifiche morfologiche che consentano un maggiore

NUMERO 4 - 2023 9
Nero mosaico rosso, foto: E. del Pozzo
Fig. 2- Il gene G1 codifica contemporaneamente il fenotipo F1 e F2 (pleiotropia). Il fenotipo F1 è correlato ai geni G1 e G2 (poligenia)
deposito. Un chiaro esempio di effetti pleiotropici si annoverava nella mutazione Opale (sul tipo Nero) che alterava la struttura cheratinica della piuma. Il pleiotropismo influisce sia sul colore ma anche sulla struttura delle piume e forse anche sulla taglia dei soggetti. Nella categoria mosaico, come dimostrato da numerose pubblicazioni scientifiche,la sovraregolazione di BCO2 provoca la degradazione dei carotenoidi, un abbattimento di questi decisamente maggiore nelle femmine e minore nei maschi. Anche qui il pleiotropismo si presenta: le piume sono più vaporose, il vessillo modifica in ampiezza il suo sviluppo, maggiore sviluppo delle barbole, l’angolo di innesto delle barbe diventa meno acuto.
Nella categoria brinato la concentrazione delle βcaroteneossigenasi rientra nel range corrente di normalità e consente l’abbattimento correttamente funzionale dei carotenoidi garantendo il normale sviluppo dei vessilli delle piume. Rientrando il genotipo brinato nella eredità quantitativa (poligenia), sarà certamente soggetto all’influenza dell’ambiente esterno. L’eredità poligenica è il risultato sommativo dell’espressione di due o più geni che determinano un unico carattere fenotipico.
La figura successiva (3) semplifica gli effetti pleiotropici delle mutazioni di
BCO2 (è un gene poliallelico) sul piumaggio dei canarini.
Il canarino mosaico è dimorfico o dicromatico?
È una domanda che spesso mi sono posto nelle mie elucubrazioni mentali: è corretto dire che i canarini mosaici sono dimorfici o sono forse dicromatici? Il dubbio riviene non tanto dalla esegesi del termine ma per rispondere alla esigenza di chiamare ogni cosa col giusto nome. Personalmente propendo per l’aggettivo dicromatico. Dimorfismo, dal greco δίμορϕος«che ha duplice forma», è in biologia l’esistenza di due forme morfologicamente diverse nell’ambito della medesima specie animale o vegetale. A me non sembra che la forma dei canarini mosaici femmine siano molto diverse da quella dei maschi, esistono dei caratteri secondari che li contraddistinguono, ma sostanzialmente i due aspetti morfologici sono quasi coincidenti. Dicromatismo dal greco χρῶμα -ατος «due-colore»è in zoologia la differenziazione nel colore dei due sessi in alcuni animali (Wikipedia). Mi sembra che questa definizione sia più aderente al fenotipo dei sessi dei canarini mosaici. D’altra parte le ricerche pubblicate in inglese parlano di sexual dichromatism ei termini tecnici della letteratura inglesesono inequivocabili, netti, unici e precisi. Quindi i canarini mosaici dovrebbero essere sessualmente dicromatici.
Note
La pleiotropia (dal greco pleion, πλείων, “molteplice”, e tropein, τροπή, “cambiamento”) è un fenomeno genetico per il quale un unico gene determina effetti fenotipici multipli, a prima vista anche non correlati fra di loro. Tale capacità, in realtà, è soltanto apparente perché l’effetto primario del gene rimane unico, ma determina una serie di conseguenze. La
pleiotropia di sviluppo avviene quando le mutazioni hanno effetti multipli sul fenotipo risultante. L’eredità poligenica è il risultato sommativo dell’espressione di due o più geni che determinano un unico carattere fenotipico. Molti caratteri umani, come il colore della pelle, l’altezza, l’iride degli occhi, variano all’interno della popolazione senza presentare chiare suddivisioni proprio a causa dell’elevata quantità di geni coinvolti la cui minima variazione comporta un lieve cambiamento fenotipico.
Fonti
1. Canaricoltura, Umberto Zingoni - FOI
2. Avian Coloration Genetics: Recent Advances and Emerging Questions - Rosalyn Price-Waldman, Mary Caswell Stoddard
3. Transgenia nei canarini di colore, Mimmo Alfonzetti, IO 2/2023 - FOI
4. A nonsense mutation in the beta-carotene oxygenase 2 (BCO2) gene is tightly associated with accumulation of carotenoids in adipose tissue in sheep (Ovis aries) - Dag I. Våge & Inger A. Boman
5. Mutation in Bovine β-Carotene Oxygenase 2 Affects Milk Color – S. D. Berry, S. R. Davis, E. M. Beattie, N. L. Thomas, A. K. Burrett, H. E. Ward, A. M. Stanfield, M. Biswas, A. E. Ankersmit-Udy, P. E. Oxley
6. A multispecies BCO2 beak color polymorphism in the Darwin’s finch radiation, C. Grace Sprehn, Arhat Abzhanov, Huijuan Bi, Mariya P. Dobreva, Owen G. Osborne, Carl-Johan Rubin, Peter R. Grant, B. Rosemary Grant, Leif Andersson .
7. A genetic mechanism for sexual dichromatism in birds. Małgorzata A. Gazda, Pedro M. Araujo, Matthew B. Toomey e altri

8. Origini e genetica del canarino mosaico - S.Lucarini - IO 4/2021 - FOI
9. Pigment patterns in neural crest chimeras constructed from quail and guinea fowl embryos -Richardson, M. K., Hornbruch, A. and Wolpert, L. (1991).
CAROTENOIDI PIUMA
Categoria concentrazione BCO2 Saturazione lunghezza angolo innesto sottopiuma brinato normale normale normale 45° normale intenso diminuita aumentata diminuita Meno di 45°diminuito mosaico aumentata diminuita aumentata Quasi 90 ° aumentato
Fig 3 - Nella teoria dei colori e in discipline correlate come la fotografia, la saturazione o purezza è l'intensità di una specifica tonalità. Una tinta molto satura ha un colore vivo e pieno (forte); al diminuire della saturazione, il colore diventa più tenue. Gli angoli di innesto delle barbe indicati sono correlati alle probabili curve di variabilità (campana di Gauss) e quindi non scevre da tolleranze
10 NUMERO 4 - 2023
Un chiaro esempio di effetti pleiotropici si annoverava nella mutazione Opale (sul tipo Nero)
Le ricerche in inglese parlano di sexual dichromatism ei termini tecnici della letteratura inglesesono inequivocabili
La mia esperienza con il Lucherino di Haiti
testo e foto di STEFANO PICCO
Lo Spinus dominicensis o lucherino di Haiti, come dice il nome, vive nella Repubblica Dominicana e ad Haiti, paesi a clima tipicamente tropicale.
Abita sia boschi di montagna che pianura, si nutre sia di semi immaturi che di semi secchi ed occasionalmente di qualche bacca.
Ha una lunghezza di 12 cm; il maschio ha calotta, gola, guancia e zona oculare di colore nero.
Il dorso è verde oliva intenso, mentre il petto, il ventre, il sottocoda ed il codione sono giallo oro.

Remiganti e timoniere sono nere con barrature alari di colore giallo. Il becco è giallo senza tracce melaniche, molto conico, mentre le zampe e le unghie sono nere.
La femmina ha il dorso grigio-verde, con la base delle timoniere e barra alare di un giallo meno intenso che nel maschio. Ne vidi per la prima volta una coppia alla fiera di Reggio Emilia e devo dire che in quella occasione non mi colpì particolarmente.
Circa tre anni dopo, mi recai a fare visita all’amico Arrigo Ottoborgo e nel suo allevamento ebbi l’occasione di rivedere l’Haiti.
Infatti, tra gli altri Spinus che lui allevava, c’erano appunto anche due coppie di Spinus dominicensis che mi colpirono per la loro pulizia nei colori (evidentemente quelli che avevo visto a Reggio non erano al massimo della loro condizione). Come spesso succede a tutti noi, non riuscii a fare a meno di chiedergli se a fine stagione sarebbe stato in grado di cedermi un paio di coppie. Coppia di Lucherino di Haiti

Essendo Arrigo un ottimista, mi rispose che si poteva fare, quindi aspettai la fine della stagione. Purtroppo inutilmente, in quanto le coppie non avevano voluto saperne di riprodursi (forse non ave-

NUMERO 4 - 2023 11 ESTRILDIDI FRINGILLIDI IBRIDI
Maschio Lucherino di Haiti
Ne vidi per la prima volta una coppia alla fiera di Reggio Emilia
vano avuto un periodo sufficiente di ambientamento).
Nella primavera successiva, mi recai nuovamente da Arrigo per rinnovargli la mia richiesta e già a quel tempo le due femmine avevano deposto le prime uova, che però risultarono non fertili. Arrigo, pur essendo un omone, era cagionevole di salute, e nel giugno dello stesso anno fu ricoverato all’ospedale. La notizia della sua morte improvvisa e quanto mai inaspettata ci colpì moltissimo. Al di là del grande dolore che tutti noi amici, in particolare del nostro Club, provammo, rimaneva aperto il problema di chi avrebbe continuato a gestire l’allevamento degli uccelli. Gli eredi, non avendo intenzione di far fronte a questo ulteriore “problema”,
ci chiesero se fosse possibile che qualcuno si occupasse di cedere i soggetti. Si trattava di uccelli che si trovavano in pieno, o quasi, periodo riproduttivo, per cui in un momento assai delicato. In poco più di due settimane, il nostro Club risolse il tutto e trovò la sistemazione presso i soci.
Naturalmente, io acquistai tre maschi e una femmina di Haiti anche se in pieno periodo riproduttivo, senza peraltro nutrire nessuna velleità di ottenere ulteriori nidiate nella stessa stagione. Li alloggiai in una voliera da cm 75x150x190 con la modestia di gestire in modo corretto il loro periodo della muta. Dopo pochi giorni mi accorsi che un maschio, quello più in forma, cercava di scacciare gli altri maschi: frequentava insistente-

mente la femmina seguendola in tutti i suoi spostamenti, fintanto che notai entrambi con degli sfilacci di sisal, juta e cotone nel becco.

Sistemati due nidi con cestino di cocco sul frontale della voliera, allontanai i due maschi non in estro; il giorno dopo la femmina scelse quasi subito uno dei due nidi e lo imbottì utilizzando juta e cotone. Da lì a poco depose il primo uovo, seguito da altri due che alla speratura risultarono tutti fecondi. Non vi dico la mia emozione! Ma tutto non può andare bene, tant’è che dopo sette giorni di cova indisturbata la femmina interruppe la cova. Considerato che la coppia era da sola perché avevo per tempo tolto i due maschi, la cosa mi sorprese. Una lucherina europea ritardataria, però, mi risolse il problema e portò a termine la cova nei tempi normali. Nacquero due pulli su tre, ma per me la cosa rappresentava una strana gioia unita da un sano orgoglio nei confronti dell’amico Arrigo, al quale piacevano questi uccelletti così diversi dai classici Spinus.


Mi consultai con degli amici allevatori tedeschi con i quali mi sento spesso, per saperne di più in relazione all’alimentazione durante lo svezzamento di questi particolari e rari abitanti delle isole delle Antille. Miscela per lucherini e pastoncino con uovo sodo, piselli, insetti e perle. Ma non è finita qui, perché nel frattempo la Haiti aveva già deposto altre tre uova nel nido opposto al primo. Questa volta la coppia svezzò l’unico nato senza problemi. In seguito, la fem-

12 NUMERO 4 - 2023
Giovani Lucherini di Haiti pronti ad uscire dal nido
Uova di Lucherino di Haiti Piccoli di Lucherino di Haiti di 3 giorni
mina depose altre uova ma in maniera non consecutiva, quindi non le recuperai. Arrivati oramai alla prima settimana di ottobre, misi assieme giovani e riproduttori in modo da andare incontro al delicato periodo della muta. Per un occhio allenato, dagli Spinus europei i giovani maschi si distinguono subito per l’intensità del piumaggio e dallo spuntare in anticipo delle piccole piume ai margini del cappuccio.





A muta ultimata, i giovani risultarono due maschi ed una femmina, che furono per me una sfida vinta per l’amico Arrigo che, con tanto orgoglio, mi presentava i suoi esemplari ogni volta che lo andavo a trovare. Qual è la morale di tutto questo? La cosa più importante, ovvero aver dedicato ad Arrigo la ‘nostra’ (mia e sua) vittoria. Fatte tutte le considerazioni, però, ribadisco la mia fede nel nostro lucherino, nei colori classici e nelle sue mutazioni che, in dieci anni, hanno sbaragliato la concorrenza degli altri miei amici alati, regalandomi soddisfazioni e notorietà in un campo fino ad allora quasi sconosciuto. Inoltre, voglio ringraziare gli amici Graziano Fabris e Paolo Gregorutti, per me molto più che amici, dei guru, delle fonti inesauribili di insegnamenti sia a livello umano che ornitologico. Persone che porterò sempre nel cuore.

NUMERO 4 - 2023 13
Sisal - juta - cotone





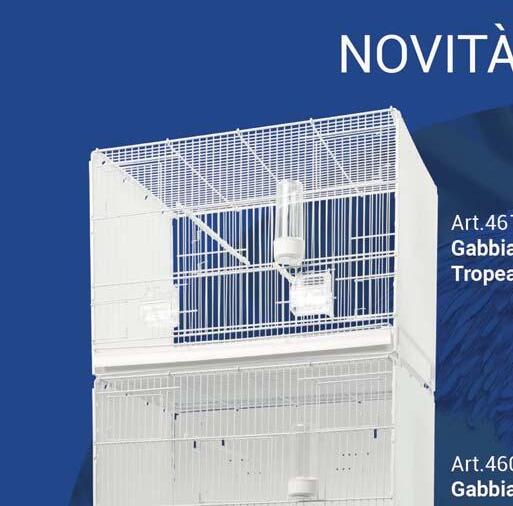



Il maschera gialla australiano (Golden Face)

Attualmente sono ufficialmente riconosciute dal WBO (World Budgerigar Organisation), tre varietà della mutazione Faccia Gialla: il Tipo I, noto anche come Blu 2 (quando in doppio fattore, omozigote, è fenotipicamente identico al Blu), il Tipo II, entrambi conosciuti come inglesi e l’Australiano spesso chiamato Faccia Oro (Goldenface). In Italia, nonostante il buon numero di soggetti presenti, complice probabilmente la confusione o la cattiva informazione, le prime due sono accomunate e per questo quasi sempre meticciate fra loro dando vita a soggetti con caratteri fenotipici intermedi e non rispondenti ai canoni standard. Discorso diverso il caso del Maschera Gialla Australiano che, meno popolare, è raramente presente negli aviari nostrani; probabilmente a causa della livrea meno appariscente nella forma a singolo fattore (eterozigote), spesso confusa con un normale Verde, non ha riscontrato il favore degli allevatori italiani, per cui la sua apparizione nelle nostre esposizioni è piuttosto recente.


Descrizione
Tutti i Faccia Gialla possono essere a singolo (eterozigote) o a
Tutti i Faccia Gialla possono essere a singolo (eterozigote) o a doppio (omozigote) fattore
doppio (omozigote) fattore, nel successivo paragrafo sull’ereditarietà ne vedremo meglio il significato genetico; in ogni caso il doppio fattore presenta meno giallo sia nel corpo che nelle ali rispetto al singolo fattore. Nel Maschera Gialla Australiano (M.G.A.), il singolo fattore somiglia molto ad un Verde, con il giallo della maschera di un bel colore caldo e brillante e nessun segno di bianco tra ondulazioni e barrature, mentre il colore del corpo, uniforme e pulito, si presenta come un piacevole verde acquamarina. Il doppio fattore presenta una faccia giallo dorato carico mentre il resto del corpo dovrebbe idealmente avvicinarsi al colore di un soggetto della serie Blu. Purtroppo, spesso lo sconfinamento del giallo dalla maschera con conseguenti sfumature verdemare è un difetto comune, peraltro assai difficile da eliminare. Tutti i Faccia Gialla possono essere considerati come uccelli verdi con il pigmento giallo parzialmente rimosso. Se in un soggetto Verde si rimuove tutta la Psittacofulvina, quel soggetto apparirà Blu, rimuovendo il pigmento giallo parzialmente si otterranno svariate tonalità turchesi. Al momento attuale non è ancora chiaro come sia possi-
NUMERO 4 - 2023 15 ONDULATIEDALTRI PSITTACIFORMI FORMA & POSIZIONE PARTIAMO DALLE BASI
testo, foto e disegni di GIOVANNI FOGLIATI
A sinistra M.G.A. singolo fattore e, a destra, M.G.A. doppio fattore
bile e da cosa dipenda l’esistenza di diverse forme di Psittacofulvina (più o meno carica). Indipendentemente dalla conoscenza delle diverse caratteristiche chimico-fisiche di Psittacofulvina gialla, l’analogia più semplice è di pensare ad un Faccia Gialla come ad un Verde con il giallo parzialmente rimosso in maniera non uniforme; con la massima espressione su Testa e Maschera. Nel MGA, questo tratto è più vistoso se paragonato alle altre due forme di MG. In questa varietà, il giallo non si mescola al blu, ma lo copre come una sorta di velo più o meno esteso.

Gli attuali standard non riconoscono (e di fatto scoraggiano) la naturale disuniformità delle tinte richiedendo di fatto colorazioni omogenee e nette. Purtroppo, la selezione incontra molte difficoltà con il MG Australiano in virtù del giallo più carico e brillante. Molti MGA a singolo fattore presentano una Psittacofulvina così calda che il colore del corpo arriva ad avvicinarsi a quello del Verde. Questa caratteristica ha portato spesso ad errate identificazioni. Un suggerimento utile potrebbe essere di controllare le piume sotto le ali che nel Verde sono verdi, mentre

nel MG Australiano sono blu. Caratteristica interessante del MGA è che gran parte del pigmento giallo del corpo non appare completamente fino a dopo la prima muta, ciò significa che il colore del corpo nei novelli sarà molto più blu.

L’ereditarietà
In passato si classificavano le tre varietà di Faccia Gialla come completamente separate e non correlate fra loro, quindi, si tendeva a riconoscerle geneticamente come dominanti sul Blu e “mascherate” dal Verde. Oggi sappiamo con certezza che tutte le varietà di Faccia Gialla sono alleliche tra loro e con il Blu. Si è stabilito definitivamente, peraltro, che in tutte le altre specie di pappagalli in cui sono presenti mutazioni del tipo “yellow face” equivalenti o quasi a quelle dell’ondulato, di chiamarle “parblue” (un’abbreviazione di “partial blue”), termine usato anche in italiano senza la e finale: “parblu”.
Pertanto, riepilogando, tutte le varietà di Faccia Gialla, incluso il corrispondente allele non mutato di tipo selvatico Verde e quello mutato che genera il Blu, non sono indipendenti tra loro ma alleli multipli alternativi dello stesso locus.
Sulla base delle conoscenze attuali possiamo affermare con certezza che tutte le varietà di Faccia Gialla ed il Blu sono mutazioni autosomiche recessive alleliche tra loro. Molti autori ritengono che sia probabilmente presente un ordine di dominanza come segue: Il Verde è dominante sul Faccia Gialla Australiano, che a sua volta è parzialmente dominante rispetto al Faccia Gialla Tipo II, che a sua volta è parzialmente dominante sul Faccia Gialla Tipo I, che a sua volta è parzialmente dominante sul Blu. Con la regola che più pigmento giallo presenta la mutazione, più questa è dominante. Molto più attendibile, geneticamente, è che, trattandosi di mutazioni alleliche, i soggetti eterozigoti generano un fenotipo intermedio tra le forme di Faccia Gialla coinvolte, mentre è certo che l’allele selvatico è dominante su tutti gli altri e che quelli dei Faccia Gialla sono dominanti su quello del Blu.

16 NUMERO 4 - 2023
Maschio Cannella Faccia Gialla Australiano Grigio omozigote
TABELLA 1
2 alleli di tipo selvaticoVerde (omozigote)
2 alleli Blu Blu (omozigote)
1 allele selvatico + 1 allele
M.G.A. Verde / M.G.A. (eterozigote)
2 alleli M.G.A. M.G.A. (omozigote)
1 allele M.G.A. + 1 allele BluM.G.A. / Blu (eterozigote)

1 allele M.G.A. + 1 allele
M.G. Tipo I
1 allele M.G.A. + 1 allele
M.G. Tipo II

M.G.A. / M.G. Tipo I (eterozigote) soggetto intermedio
M.G.A. / M.G. Tipo II (eterozigote) soggetto intermedio
Ogni uccello ha due di questi alleli contemporaneamente, che potranno essere uguali, in tal caso si parla di soggetto omozigote, o diversi, ovvero soggetto eterozigote.
Nella TABELLA 1 soprariportata sono riassunte le casistiche possibili per il Maschera Gialla Australiano (Faccia Oro).
Risulta interessante sapere anche che il locus bl, della serie allelica di cui parliamo, e il locus S, responsabile del fattore scuro, sono concatenati tra loro (ovvero geni tra loci vicini sullo stesso cromosoma), situazione geneticamente nota con il termine inglese LINKAGE.
Esperienze personali
Non credo di essere stato il primo ad allevare il Maschera Gialla Australiano in Italia, sicuramente però sono stato il primo ad esporli ufficialmente. Acquistai un M.G.A. presso il signor Clemens Keller (Germania) oltre vent’anni fa. Il soggetto era un maschio a singolo fattore (eterozigote) dalla splendida livrea uniforme, anche se di costituzione mediocre. Alcuni anni dopo (e tante prove), mi sentii pronto per portarne uno in esposizione e scelsi l’Internazionale di Reggio Emilia. L’uccello si piazzò primo nella categoria Maschera Gialla. Tre anni dopo un secondo soggetto ricalcò le orme del primo. Purtroppo, nel giro di poche generazioni persi la mutazione; un po’ per la difficoltà nel trovare giusti partner, un
po’ per le esigue nascite di M.G.A., un po’ per inesperienza e un po’ per cause non dipendenti dalla mia volontà.
Allevando e selezionando questa mutazione notai una particolarità che li differenziava dagli altri Faccia Gialla: il colore giallo debordante sul corpo non dava segno di miscelarsi alla tinta sottostante della livrea e formare così il verde, piuttosto l’impressione era di vedere il giallo “velare” il corpo blu o grigio come se una pellicola gialla si interponesse tra gli occhi e il soggetto, modificandone sostanzialmente la resa cromatica.


NUMERO 4 - 2023 17
Maschio Comune Faccia Gialla Australiano Grigio eterozigote
Lo stato dell’arte del canarino Salentino

Osservazioni personali dal giudizio alla Specialistica di Novoli (LE)
Nell’allevamento amatoriale degli uccelli da compagnia, il lavoro di selezione ha, come è noto, il fondamentale scopo di selezione al fine di conoscere e comprendere al meglio le risposte genetiche alla base degli accoppiamenti, nella prospettiva di garantire il raggiungimento dello standard richiesto. Ma lo scopo più importante è certamente quello che permette di ricondurre tutti gli obbiettivi di selezione prefigurabili all’acquisizione del “metodo selettivo” (inteso come la continuazione e approfondimento e/o modifica dello sforzo iniziale che ha portato al riconoscimento internazionale della razza), permettendo agli allevatori di acquisire familiarità sia con le necessarie metodologie di allevamento (alimentazione/colorazione) sia con le tecniche di allevamento.
In ogni esperimento di accoppiamento si devono avere chiari gli obbiettivi che si vogliono raggiungere: il miglioramento di una specifica caratteristica, la correzione di un particolare difetto, il mantenimento dello standard richiesto. Solamente dai risultati ottenuti si potranno trarre le conclusioni di un miglioramento o un peggioramento dello status quo ante. Frequentemente può accadere che i risultati che si ottengono non si accordino con quanto ci si aspettava, anche in contrasto con le convenzioni genetiche conosciute.
Ciò deve preoccupare quando queste sperimentazioni vengono condotte nell’assoluta assenza di corrispondenza tra allevatori e trovano rilievo negativo all’atto del confronto/giudizio ma, ancor peggio, l’interscambio di questi soggetti (fenotipicamente validi ma con impurezze genotipiche) vanifica il lavoro fin qui fatto di selezione in purezza.
Il ruolo del Giudice in queste osservazioni è essenziale ed obbligato nell’inquadrare lo stato dell’arte della razza, assumendo su di sé la responsabilità di suggerire attraverso il giudizio le correzioni necessarie.
Se è vero che il passaggio dall’astratto al concreto (giudizio) segna una crescita nella vita dell’allevatore, allora è anche vero che solo l’interpretazione e la consapevolezza del valore del soggetto esposto possano, a ragione, dirsi formative.
Dopo questa premessa doverosa e rispettosa del lavoro di selezione portato avanti per lustri sia dagli ideatori storici che da appassionati, che negli anni si sono interessati all’allevamento portando a compimento il riconoscimento della razza “Salentino”, voglio esporre le mie osservazioni in merito al giudizio espresso in occasione della prima specialistica di razza che mi ha visto, onorato, presiedere.
In un’ottica esplicativa posso confermare senza ombra di dubbio che i 76 Salentini giudicati con metodologia

18 NUMERO 4 - 2023 CANARINIDI FORMAE POSIZIONE LISCI
testo e foto di VULZIO LAZZARINI (GIUDICE O.M.J., SEZ. E)
Salentino testa ciuffata unicolore lipocromico intenso
In ogni esperimento di accoppiamento si devono avere chiari gli obbiettivi che si vogliono raggiungere
analitica su scala ufficiale COM/FOI avevano in generale un buon livello di standard espositivo, in particolare nelle voci:

- Posizione: buona parte dei soggetti presentava una corretta posizione del corpo con schiena perpendicolare al posatoio, ma pochi mostravano una corretta posizione di testa/collo (che deve essere a 90°) rispetto al corpo, di media lunghezza, a terminare nella testa, che deve essere di forma ovale (anche questo particolare era presente in buona parte dei soggetti).

- Forma del corpo: elemento fondamentale insieme alla taglia per distinguere il Salentino dal Bossù. La mia impressione è che vi siano ancora troppi triangoli nel corpo, marcatamente visibili in molti soggetti.
- Taglia: nessun soggetto è stato penalizzato pesantemente sulla voce taglia (> 14cm); molti eccedevano dai 12,5cm considerati ideali e non ricordo di aver visto soggetti sotto tale misura. Su questa voce vorrei farvi partecipi del mio pensiero che non è solamente esportabile ai Salentini ma riferibile ad ogni razza. Nel dizionario Treccani la voce “taglia” è contemplata nella sua interezza di significato, anche se quello che interessa a noi è la definizione: “una proporzione del corpo”. Quindi, la taglia deve considerarsi una proporzione tra due valori; nel nostro caso, una lunghezza certa (12,5cm) e quale altro indice? Per non cadere nelle sorti occorse ad altre razze, dove non si è mai voluta fare una seria analisi del significato di “taglia”, convinti che sostituire questa parola con “lunghezza” potesse risolvere il problema, invito il sodalizio del Club a produrre una soluzione dando interpretazione al valore mancante o decidendo la sostituzione di “taglia” con “lunghezza”.
- Ciuffo/Testa: anche questa voce, per quanto stabilito dallo standard, ha trovato conforto nella maggioranza dei soggetti esposti. Ho notato pochi ciuffi scomposti, la quasi totalità screziati con melanina, anche se il problema della screziatura debordante (nella parte superiore della nuca, oltre la zona del ciuffo) era presente. Ho dovuto penalizzare un soggetto con “non giudicabile” rilevando una non continuità tra la screziatura del ciuffo e una pez-
zatura della nuca. Il mio consiglio in merito: nel caso di evidente screziatura debordante, esporre il soggetto nella categoria dei pezzati, altrimenti chiedere consiglio. - Piumaggio e colore: la colorazione (obbligatoria) in generale era ben fatta. Ho notato la differenza di esperienza nell’uso del colorante ma in generale confermo che il colore non è tra le voci critiche, mentre la voce “piumaggio”, come per quasi tutte le altre razze, è condizionata da molti fattori: location, alimentazione, gestione dell’allevamento, pulizia, tipologia della gabbia, promiscuità tra soggetti. Quindi, è difficile avere un buon piumaggio in mancanza di questi presupposti. Il difetto di piumaggio rilevato in molti soggetti era attribuibile ad una esposizione esagerata dei femori, che impedivano una chiusura armonica del piumaggio del basso petto e dell’addome (caratteristica del Gibber Italicus). Devo dire, però, che sia il 94 ciuffato che il 94 testa liscia si presentavano con un magnifico piumaggio e un ottimo colore. - Zampe: ho avuto modo di esprimere in sede di giudizio la mia contrarietà circa la scelta di inserire caratteristiche tipiche del Gibber Italicus, che nulla hanno a che vedere con lo standard del Salentino e che impediscono il manifestarsi di una leggera elegante flessione.
In conclusione, la strada per la fissazione di una razza è sempre ostica ed incerta ma, con le dovute attenzioni e una stretta collaborazione tra gli allevatori/estimatori della razza, una maggior presenza nelle manifestazioni ornitologiche e una adeguata formazione del corpo giudicante, questo magnifico canarino troverà la sua giusta soddisfazione nei CFPLisci.

NUMERO 4 - 2023 19
Salentino 1° classificato testa ciuffata intenso
I 76 Salentini giudicati con metodologia analitica su scala ufficiale C.O.M./F.O.I. avevano in generale un buon livello di standard espositivo









Confronto e dialogo sul Fiorino
Incontro dedicato alle sue problematiche
testo di RAFFAELE ROBERTO e FEDERICO VINATTIERI
Confronto e dialogo… due parole che sembrano ovvie o banali, ma che all’atto pratico si rivelano due concetti che nella nostra eccentrica collettività vengono esperiti sempre più raramente.
Il confronto, ossia quel prezioso rapportarsi tra più teste, che rafforza la competenza, intensifica la piena capacità di orientarsi in una valutazione e al contempo amplifica la sicurezza nello svolgere un giudizio.
Il dialogo, ossia un costruttivo scambio di opinioni per favorire la comprensione di determinati connotati.
Questi due apparentemente semplici, convenzionali termini, al giorno d’oggi non sono poi così scontati.
Il giorno 5 Marzo 2023, nella Città di Poggiomarino (Napoli), grazie alla disponibilità del Club del Fiorino, nelle persone del Presidente Vincenzo Castiello e del Consigliere Bartolomeo Cozzolino e grazie all’organizzazione della C.T.N.- C.F.P.A, nelle persone del Presidente Emilio Sabatino e del collega Giulio Pisani nonché del relatore Giudice C.O.M. O.M.J. Gaetano Buonocore, si è svolto un breve confronto tecnico per sottolineare e meglio de-



finire alcune voci dello standard del nostro Fiorino.
Nel dettaglio, si sono affrontate le seguenti argomentazioni:
1.La taglia del Fiorino;
2.I criteri adottati nel formulare il giudizio (taglia, forma, lunghezza, ecc.);

3.Il giudizio alla presenza di alcuni soggetti, con relativo commento e spiegazioni.
L’incontro di aggiornamento tecnico ha preso spunto, senza nessuna forma polemica, da quanto successo all’ultimo Campionato Mondiale di ornito-
NUMERO 4 - 2023 21 CRONACA
Locandina ufficiale dell'evento
Alcuni rappresentanti della C.T.N. e del Club
logia, tenutosi a Napoli presso la Mostra D’Oltremare, dove sono stati premiati alcuni soggetti decisamente oltre i 13 cm di lunghezza, giudicati da un giudice straniero, il quale evidentemente non ha tenuto conto dei prin-



cipali descrittori dello standard di questa razza.
L’incontro tecnico si è aperto con il saluto ed i ringraziamenti a tutti coloro che erano intervenuti da parte dei Membri della C.T.N. E. Sabatino e G. Pisani; a seguire, c’è stata la distribuzione dei fascicoli illustrativi sul canarino Fiorino e le spiegazioni delle varie voci inerenti allo standard.
Dopo una breve introduzione sullo svolgimento dell’incontro, in riferimento al lavoro dei giudici, il Presidente della C.T.N. ha sottolineato quanto segue: “In riferimento ai fatti successi al recente Mondiale, un giudice deve continuamente aggiornarsi e rimanere al passo con i tempi. Innanzitutto, deve conoscere tutte le regole emanate dalla CTN, i vari criteri di giudizio, in modo da applicarli al meglio in fase di valutazione, limitando così note di disparità in fase di operato”.

Infatti, quello che si auspica è un livellamento verso l’alto del bagaglio di conoscenza e d’esperienza di tutti i componenti del corpo giudicante e questo può essere attuato grazie ad
una collaborazione tra colleghi, onde eliminare vicendevolmente eventuali carenze.
In quest’ottica si spera, in futuro, alle mostre internazionali e Mondiali, di poter effettuare “giudizi a due”, dove i giudici lavoreranno in coppia, se è possibile, o comunque andrebbe trovato il modo di affiancare chi conosce meglio la razza con chi ne è meno esperto, in un crescendo di abilità e competenza.

Successivamente la parola è passata al relatore, il giudice internazionale Gaetano Buonocore, il quale ha evidenziato, in maniera puntuale e precisa, dopo una attenta e pregevole analisi delle voci inerenti i nostri “criteri di giudizio”, che oramai ci sono Fiorini di altissima qualità, grazie all’ottimo lavoro di selezione che dura da decenni svolto dagli allevatori della razza e dall’attento lavoro di controllo della C.T.N.
Inoltre, anche lui ha suggerito, per quanto attiene l’individuazione dell’esperto giudicante nelle manifestazioni internazionali e ai campionati mondiali, che sarebbe opportuno affiancare ai giudici stranieri i nostri giudici italiani, soprattutto quando si trattano le nostre razze italiane, come appunto il Fiorino.
Questa osservazione è risultata condivisa anche dai componenti della C.T.N. e da tutti i presenti.
Il Presidente Sabatino ha poi espresso il proprio punto di vista sullo standard del canarino Fiorino, puntualizzando che un aspetto molto importante da valutare è la taglia, chiarendo che essa non si riferisce solo alla lunghezza del canarino ma alla sommatoria di forma, massa e lunghezza che, valutate all’unisono, formano l’armonia generale dell’animale, e che è quindi opportuno penalizzare i soggetti oltre tale misura, come da standard.
A tal proposito, è sempre bene ribadire ciò che ci ha insegnato il Professor Zingoni, il quale scrisse: “La taglia, a differenza di quanto si continua erroneamente a credere, non è la lunghezza… [omissis]… la taglia rappresenta la mole del soggetto nel giusto e armonico rapporto di tutte le sue parti, in modo da esaltare la sua bellezza; ha
22 NUMERO 4 - 2023
Alcuni soci del Club durante il dibattito
Alcuni soggetti portati come esempio
come indice di misura la lunghezza… [omissis]… un caso particolare: Border e Fife hanno forma pressoché identica, ma la taglia è assai differente, semplicemente perché è differente la lunghezza: ma il più delle volte non è così”. (U. Zingoni, “Canaricoltura” II° ediz. 1997, F.O.I., pp. 464-465).

C’è stato anche l’interessante intervento del giudice Luigi Mollo, il quale ha ribadito l’importanza di valutare i soggetti tenendo conto di tutte le voci dello standard, dove sicuramente la taglia ha un ruolo determinante, ma tenendo anche presente l’assoluta e fondamentale attinenza delle arricciature al modello ideale, che in alcune razze sono purtroppo passate in secondo piano ma che nella nostra specializzazione devono sempre godere di un’attenzione particolare da parte di colui che attribuisce il giudizio. La valutazione della forma deve andare pertanto di pari passo con la valutazione della taglia… e viceversa. Il segretario della C.T.N. G. Pisani ha poi fatto notare l’importanza del fattore collaborazione tra allevatori e giudici, sottolineando ancora una volta l’intento di questa C.T.N.: dialogo e confronto come presupposto di crescita.
L’incontro di aggiornamento basato sul dibattito è durato circa un’ora e mezza, con notevole partecipazione dei presenti, circa una quarantina di persone equamente divise tra allevatori ed esperti giudici; molti hanno assistito all’evento attraverso video-con-

ferenza, dove il collega giudice Angelo Cremone è stato un ottimo direttore tecnico; si è potuto così assistere ad una costruttiva e pertinente discussione che sicuramente ha arricchito sia i presenti sia gli spettatori in streaming, fornendo informazioni molto tecniche.
Quello che ci sentiamo di evidenziare e sottolineare è che questa Commissione Tecnica mette in essere un confronto costruttivo e basato sul dialogo, come peraltro già evidenziato al convegno tecnico di Fiuggi dello scorso anno, dove finalmente si respira un’aria di familiarità, di disponi-

bilità e di confronto, dominata dal rispetto tra i rappresentanti delle due figure chiave dell’ornitofilia, ossia giudici ed allevatori, e soprattutto sussiste un’opportunità reale di crescita come promotori di una selezione (allevatori) e come arbitri della selezione stessa (giudici).
Noi speriamo che la ferrea volontà con cui opera questa Commissione Tecnica prosegua su questa strada di confronto non solo con i Club di specializzazione ma anche con tutti i colleghi, in modo tale da ridurre al minimo le futili polemiche che immancabilmente ad ogni mostra si presentano.


NUMERO 4 - 2023 23
Da sinistra: Cozzolino, Sabatino, Buonocore e Pisani
Prima pagina della broschure fornita dalla C.T.N.
Attestato ufficiale del convegno
Il canto che conta
testo e foto di UMBERTO MARINI eGREGORIO PICCOLI
Come tutti gli esseri viventi che per comunicare emettono dei suoni, anche i nostri canarini da canto Malinois Waterslager si esprimono pronunciando una serie di note che, messe insieme, formano una melodia (tour).
La particolarità di questi speciali uccellini, che con soli circa 20-30 grammi di peso affascina e stupisce, è la capacità e la possibilità che hanno di riprodurre suoni alti, medi e bassi, con le preziose ed apprezzatissime note d’acqua che ne determinano il nome: Waterslager (suono d’acqua). Con l’armonia dei suoni tra i più belli presenti in natura, sin dalla creazione della razza, molti anni di selezione da parte di allevatori appassionati hanno portato questi piccoli cantori ad avvicinarsi sempre più al suono reale al quale si paragonano le note.


Ora, per dare una spiegazione più dettagliata, parleremo di come si possono confrontare le note che i nostri cantori riescono ad emettere, le quali trovano nella nostra quotidianità alcuni suoni che le rappresentano alla perfezione.
Prendiamo come esempio primario le note d’acqua, che sono le più famose, le più difficoltose, le più instabili, ma anche le più amate e ricercate. Sicuramente sarà capitato un po’ a
tutti di ascoltare casualmente il suono, il rumore, il fruscio che l’acqua genera nelle sue innumerevoli forme.
Immaginiamo la goccia che cade in un recipiente, la quale, a seconda della dimensione o del livello di riempimento dello stesso, crea un suono più o meno limpido, più o meno risonante o intrinseco di eco o con pastose vibrazioni; ebbene, quel suono profondo, inconfondibile, che non lascia il benché minimo dubbio in chi lo ascolta è un suono d’acqua scandito! Scandito dalla pausa che si crea tra un colpo e l’altro, accompagnato dalla delicatezza, nonché dalla morbida ma decisa risonanza che ne chiude il colpo.


Stiamo parlando proprio della klok! (suono d’acqua scandito).
Sappiamo tutti cos’è questa nota, ma sappiamo veramente capire quando

24 NUMERO 4 - 2023 CANARINIDA CANTO
La particolarità di questi speciali uccellini è la capacità e la possibilità che hanno di riprodurre suoni alti, medi e bassi
ci troviamo di fronte a una vera klok o siamo solo in presenza della sua struttura?
Ecco che nella quotidianità delle nostre azioni possiamo trovare il confronto, il paragone, la matrice della nota che il cantore dovrebbe emettere, ma dobbiamo comunque tenere conto del fatto che il nostro animaletto non sarà mai in grado di emettere perfettamente tale suono; però, per lo stesso motivo non possiamo transigere.

Nella nostra mente deve essere ben chiara il tipo di selezione che dobbiamo operare e quando abbiamo un minimo dubbio ricordiamoci che il suono reale esiste, quindi dobbiamo solo confrontarlo senza prenderci in giro.
La klokkende equivale a un suono d’acqua e non al cagnolino che abbaia. Ecco il motivo del nome che portano le tre note principali; quindi, se vogliamo essere precisi, esse sono classificate come note composte, aventi il suono d’acqua come complemento, e non primario.
Tuttavia, possiamo affermare che quando un cantore emette una buona o un’ottima klok, oltre alla profondità anche la liquidità dev’essere ben presente, e quando il complemento supera la struttura, la qualità è molto alta, perché paragonabile e molto simile al suono reale. Ora, dobbiamo considerare che ogni nota presente nel repertorio, trova in natura o in alcuni strumenti musicali la possibilità di realizzare un confronto per attribuirle il giusto valore.
Ricordiamoci, quindi, che il valore è direttamente proporzionale a quanto il cantore è in grado di emulare il suono reale.
Stessa attenzione si deve porre alle altre due note d’acqua ed anche se potrebbero sembrare meno complesse troviamo nella bollende una maggiore difficoltà di comparazione. Sono pochi i suoni e poche le azioni che ordinariamente la rappresentano, se non l’acqua in ebollizione, o le bolle d’aria dalla frequenza ravvicinata che fuoriescono dall’acqua.
Comunque sia, la boll è un borbottio, un movimento cadenzato dai toni pu-
liti e ben definiti, anche di veloce emissione, esente da qualsiasi collegamento infra-nota.

Inutile dire che, come accade nella klok, anche in questo caso la componente complementare non può e non deve mancare.
Nella boll la liquidità, il movimento e il suono d’acqua, talvolta sono un tutt’uno con la struttura, ma come per la klok, regina delle note, anche nella bollende, la morbidezza, l’acquosità e la purezza sono caratteristiche indispensabili che le conferiscono il fa-
Il canto dell’allevatore
Sono grandi e son piccini, non son solo canarini…
Gialli o con una macchietta, grazia e garbo ci si aspetta…
Ti fan tanta compagnia, e ti avvolge la magia…
Nell’ascolto tutti attenti, se veloci oppure lenti…
Ogni uomo n’è stregato, e rimane senza fiato…
Quanta gioia ed allegria, quando senti l’armonia…
Tanta acqua ci sarà, nei Waterslager Malinois!!! di UMBERTO
MARINI e GREGORIO PICCOLI
scino che merita, con l’importanza di essere la principessa delle note.
Tra regine e principesse, tutti si aspettavano a questo punto l’entrata del principe… invece no! Parliamo del “ranocchio”.
La rollende, fanalino di coda e di facile rappresentazione, la troviamo in molte azioni quotidiane, ad esempio quando apriamo un rubinetto ed un filo d’acqua incontra altra acqua, cascando in essa, oppure nel mormorio di un rigagnolo... chissà quante volte abbiamo sentito involontariamente questi suoni!
Quando la roll è di alta qualità, è come lo sciabordio dell’acqua ed è simile al suono che produce l’acqua incontrando delle rocce o dei sassi; prende il nome di clapotis.
Quest’ultima variante è poco frequente.
Nella roll, come per le altre note d’acqua, le caratteristiche fondamentali sono il tono profondo e la morbidezza di emissione, accompagnate dal suono dell’acqua come complemento.
Ricordiamoci che la rollende è una nota rullata continua e la morbidezza significa che non deve avere un tono forzato, ma calmo e dolce, essendo la peculiarità che la distingue dalla belroll.
Giunti a questo punto, abbiamo tutti la possibilità di confrontare e di capire quanto siamo vicini o quanto distanti dalla realtà.
Capita spesso di avere una visione errata, ma non perdiamoci d’animo, c’è sempre tempo e modo per migliorare!
Sin dalla creazione della razza, gli allevatori, amanti del canto, alla ricerca di qualcosa di particolare che potesse soddisfare le loro fantasie, hanno voluto che il canarino da canto Malinois Waterslager fosse dotato di capacità superiori a qualsiasi altro canarino, selezionando e costruendo uno standard, conferendo al cantore l’arte di poter esprimere tante diverse note. Quindi non sono solo le tre principali note d’acqua a catturare l’attenzione di chi ascolta i Malinois Waterslager, ma anche tutte le altre, che incantano nel passaggio di melodie dai ritmi e toni diversi. Non dimentichiamole!
NUMERO 4 - 2023 25





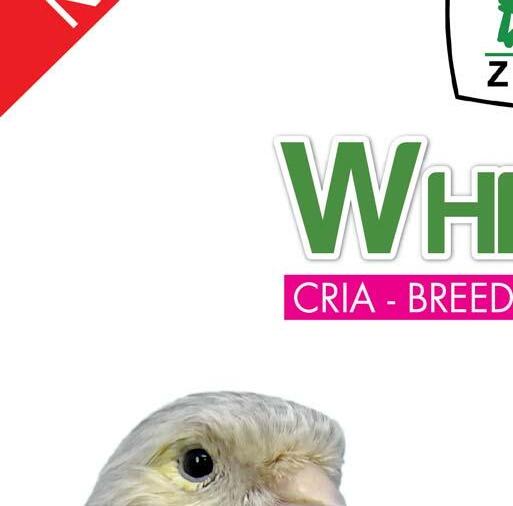



Luoghi comuni sui semi germinati
testo e foto di PASQUALE LEONE
L’utilizzo dei semi germinati è una delle pratiche più diffuse nell’allevamento degli uccelli d’affezione. Circa la reale utilità per la somministrazione di questi semi, i pareri sono spesso discordanti se non addirittura opposti. Penso quindi possa essere d’aiuto sfatare una serie di luoghi comuni al fine di poter avere una più obiettiva opinione sull’utilizzo o meno degli stessi.
Semi germinati o germogliati Molti ritengono che i termini germinati o germogliati siano sinonimi, ma in realtà non è così. La differenza è molto sottile e consiste nel fatto che la germinazione è il processo mediante il quale un organismo cresce
da un seme, mentre il germogliare è il processo attraverso il quale i semi sono indotti a produrre i germogli. Tuttavia, se guardiamo il tutto in chiave prettamente nutrizionale, esiste un’ulteriore differenza che è legata al fatto che, nei due differenti stadi, vi è una diversa quantità di valori nutrizionali. Per fare un esempio
pratico, per semi germinati si intendono quelli che, appena spuntano le radichette, vengono somministrati agli uccelli, mentre i semi germogliati sono quelli che, cresciuti intorno ai 3 cm, si usano per preparare le insalate della cucina macrobiotica (vedi semi di soia o alfa-alfa).


I semi germinati sono un ottimo surrogato dei semi lattiginosi Credo che questa affermazione, specialmente dal punto di vista nutrizionale, sia fuorviante. Parlare di surrogati alimentari negli uccelli di affezione e riferendosi, come termine di paragone, all’alimentazione degli uccelli silvani, non ha molto senso, visto che le necessità nutrizionali sono

NUMERO 4 - 2023 27 ALIMENTAZIONE
Semi germinati al giusto stadio per essere somministrati
Semi in uno stadio avanzato di germinazione
Circa la reale utilità per la somministrazione di questi semi, i pareri sono spesso discordanti se non addirittura opposti
diverse. Anche in questo caso, si tratta di due diverse fasi dello sviluppo che porta dal seme alla pianta, con valori nutrizionali molto differenti.
I semi germinati provocano le cosiddette “dorature” del piumaggio
Dipende da tanti fattori. Innanzitutto bisogna vedere quali siano i semi che vengono utilizzati per la germinazione e, cosa importante, con quanta costanza vengono somministrati ai canarini. Alcuni semi, se germinati, non interferiscono affatto con la colorazione in quanto la presenza di sostante che interferiscono con la colorazione è minima. Le sostanze principalmente responsabili delle alterazioni della colorazione sono i carotenoidi. Vi sono alcuni semi comunemente utilizzati in canaricoltura dove i carotenoidi aumentano di 7-8 volte; pertanto utilizzare giornalmente tali semi, per chi alleva i cosiddetti canarini ad “ala bianca”, significa avere sicuramente un inquinamento delle penne forti (remiganti e timoniere). Cosa diversa è l’uso occasionale, che ha di fatto una minima incidenza ma che ha poco senso considerando che, come dicevo prima, si possono selezionare i semi da germinare che non interagiscono con la colorazione.
I semi germinati causano
micosi e/o malattie
Sicuramente le condizioni ambientali che favoriscono la germinazione sono le stesse che favoriscono le micosi nonché diverse malattie, ma ciò non significa che i semi ne siano la causa. Se viene prestata particolare attenzione all’igiene degli strumenti utilizzati per la germinazione, i rischi che avvengano dei problemi sono molto bassi. Se poi, addirittura, per far germinare i semi si utilizza un germinatore per uso alimentare, i rischi sono da ritenersi completamente trascurabili. Di fatto, tali germinatori sono
studiati affinché si mantenga il giusto grado di umidità all’interno dei contenitori dove alloggiano i semi e che non si creino dei ristagni d’acqua, avendo questi degli appositi canali di scolo per l’acqua in eccesso. Pertanto, qualora si verificassero degli inconvenienti, quest’ultimi sarebbero da attribuire a degli errori derivanti dalle comuni pratiche d’igiene.


Per finire, vorrei chiarire il punto che crea più discordia tra gli ornicoltori, ovvero i valori nutrizionali dei semi germinati. Si commette spesso l’er-
rore, per valutare la qualità di un alimento, di controllare la quantità di proteine in esso contenute tralasciando gli altri elementi. In nutrizione, la qualità delle proteine viene stabilita non per la quantità, ma in base al loro valore biologico, un parametro che prende in considerazione gli amminoacidi presenti e le loro assimilabilità.
Durante il processo di germinazione, le proteine migliorano di qualità (incremento del valore biologico) in virtù del fatto che alcuni minerali come il calcio o il magnesio si legano alle proteine rendendole maggiormente biodisponibili. Aumentano le vitamine, gli enzimi e gli amminoacidi essenziali; il valore nutrizionale, per alcuni semi come il girasole o il grano, cresce fino a 30 volte in più.
I semi germinati sono altresì una fonte di antiossidanti; se prendiamo ad esempio il germe di grano, questi è uno degli alimenti più ricchi di vitamina E (potente antiossidante, non soltanto utile per la preparazione alle cove); non a caso questa vitamina venne scoperta agli inizi del ‘900 proprio in questo alimento.
Molteplici studi hanno dimostrato che le caratteristiche compositive ed i principi attivi presenti sono apportatori di notevoli benefici che vanno da un miglioramento generale delle prestazioni fisiche alla diminuzione di cellule cancerogene, sembrerebbe per alcuni tipi di cancro; appare quindi chiaro che i semi germinati sono un ottimo alleato per la salute dei nostri uccelli.
In un mio precedente articolo (Alimentazione e nutrizione, I.O. Novembre 2020) mettevo in guardia gli allevatori a prendere le dovute precauzioni al fine di non avere dei soggetti super alimentati ma sottonutriti; orbene, qualora tutti gi allevatori utilizzassero, anche saltuariamente, i semi germinati nella dieta dei loro soggetti, questo problema non avrebbe ragione di esistere.

28 NUMERO 4 - 2023
Particolare del canale di scolo del germinatore che evita il ristagno dell'acqua, potenziale causa della creazione di muffe
Alcuni dei più comuni tipi di germinatori per uso umano
Sul colore ed altro
di GIOVANNI CANALI, foto E. DEL POZZO, F.O.I.e P. ROCHER
Sto ricevendo domande sul colore delle ali e penalizzazioni. Pare che le diverse pubblicazioni non siano bastate, del resto ci sono vari punti id vista. Parlando di ali, in questi casi, si fa riferimento alle penne forti (remiganti e grandi copritrici delle primarie) non al loro complesso. Cioè ci si riferisce solo alle penne non cambiate in prima muta, concetto esteso anche alle timoniere che non fanno parte dell’ala. Prescindo dai criteri di giudizio che devono essere seguiti anche se non condivisi e faccio valutazioni tecnico scientifiche logiche.

Bisogna ricordare che in prima muta il canarino (come anche altre specie) non cambia tutte le penne. Non sono mai mutate: le remiganti primarie, le secondarie e le grandi copritrici delle primarie, salvo incidenti. Sono cambiate con diversa frequenza: le timoniere, media frequenza, e le remiganti terziarie, molto spesso. Delicato è l’aspetto dell’alula che sembra avere frequente cambio della prima penna ma non delle altre. Comunque l’alula di solito non è considerata, visto che le tracce di lipocromo sono molto ridotte, limitate al bordo, e spesso sfuggono. Non è neppure considerata la prima remigante primaria che è appena abbozzata (ridottis-

sima), è spesso ignorata e nemmeno contata, la quale è sempre mutata a differenza delle altre; spesso il colore traspare sotto le penne dell’alula, nei lipocromici (vedere: “Curiose osservazioni sulla piccola remigante dell’ala” I. O. n°6/7 del 2017 di Luciano Baruffaldi).

Le ali del canarino selvatico hanno, nelle penne forti, marcature di eumelanina nera ampie, bordo di feomelanina bruna più ridotto e lipocromi, vale a dire carotenoidi, gialli pure periferici.
Nei canarini acianici, vale a dire lipocromici, le melanine sono inibite, mentre i lipocromi rimangono, da cui il nome. È importante notare che nei canarini acianici o lipocromici che dir si voglia, le penne tettrici (erroneamente dette piume nel nostro ambiente) non presentano lipocromi nella parte vaporosa (il cosiddetto sotto piuma nel nostro gergo) mentre sono interamente interessate dai lipocromi (categoria a parte, vale a dire la brinatura) nella parte superiore (pars pennacea), invece nelle

NUMERO 4 - 2023 29 CANARINIDI COLORE
Intenso giallo ali bianche, foto: E. del Pozzo
Bisogna ricordare che in prima muta il canarino (come anche altre specie) non cambia tutte le penne
penne forti rimane solo il bordo lipocromico. Questo significa che nelle penne tettrici, in origine, sotto le melanine ci sono i carotenoidi, mentre nelle penne maggiori no. Il risultato è che quando le melanine sono inibite le penne maggiori sono bianche, tranne il bordo lipocromico, mentre le altre sono colorate ampiamente dai carotenoidi. È molto importante capire la localizzazione naturale dei carotenoidi. In altre specie ci possono essere situazioni diverse; infatti nel lucherino testa nera, quando le melanine sono molto ridotte, sulla testa traspare il giallo, denotando la presenza di carotenoidi coperti, mentre nel cardinalino del Venezuela, in analoga situazione, la maschera da nera diventa biancastra, denotando l’assenza di carotenoidi coperti (in un certo senso, diventa quasi l’opposto della maschera del mosaico maschio, aspetto da meditare…). Mi sembra lecito ipotizzare che i carotenoidi coperti dalle melanine (non a caso detti “colore di fondo”), non siano molto utili, tuttavia comportino un modestissimo o nullo prezzo da pagare, pertanto possono permanere su moltissime penne, anche se coperti. Del

resto i carotenoidi di regola non scarseggiano nell’alimentazione naturale. Quando si fa la colorazione da nido (sistema assai deprecabile) è facile colorare il bordo di remiganti e timoniere, luogo deputato naturale dei carotenoidi, invece molto difficile pigmentare anche il resto della penna. Non a caso bisogna caricare moltissimo (non so con quali danni alla salute) con i coloranti, prima ancora della deposizione. Si nota anche che la cantaxantina sintetica agisce molto di più della luteina sintetica, pertanto l’esito è maggiore e meno difficile nei rossi rispetto ai gialli. Nei gialli, le penne forti dell’ala non sono quasi mai ben pigmentate di colore artificiale.



Ora ci si può chiedere: quando non si colora da nido, il giallo su remiganti e timoniere può essere considerato difetto di varietà? Per come la vedo io, si nei fattori rossi ove il giallo sulle ali dimostra scarsa quantità di rosso e permanenza eccessiva di giallo, non certo nei gialli! Il giallo nei gialli è fatto naturale, anzi gialli sbiaditi sono difettosi, appunto, per carenza di giallo. Da qui la necessità di evitare l’espressione “ali bianche” e preferire “ali naturali”. Ho dovuto sentire molti errori gravi su questo punto. Intanto paralleli perfetti fra gialli e rossi, a livello di ali, non sono ammissibili, come indicato prima. Bisogna anche recepire il fatto che riduzioni localizzate non sono possibili. Da qui l’utilità dei paragoni; infatti in certe razze inglesi l’abuso di accoppiamenti in purezza fra brinati, sbiadisce il giallo, anche di molto, ma in tutto il corpo. Qui desidero fare un inciso sul giallo soffuso nelle ali dei mosaico gialli che si vuole considerare difetto. Ebbene non può esserlo. La categoria mo-

30 NUMERO 4 - 2023
Intenso rosso ali bianche, foto: E. del Pozzo
Intenso rosso, foto: E. del Pozzo
Nelle penne tettrici, in origine, sotto le melanine ci sono i carotenoidi, mentre nelle penne maggiori no
saico non agisce sulle penne forti e neppure il brinato. Quanto all’intenso non agisce molto, anzi pochissimo, solo la soffusione tende ad essere leggermente più carica, causa l’accorciamento delle barbe. Non può neppure essere difetto di varietà nei gialli, poiché è semmai un pregio, visto che c’è una maggiore espressione del giallo. Espressione che si ripercuote utilmente sulle zone di elezione. Comunque è una questione di varietà non certo di categoria. Il giallo sulle ali è difetto nei rossi, mosaico compresi, ed ovviamente anche qui di varietà, per il minore rosso ed i residui di giallo.

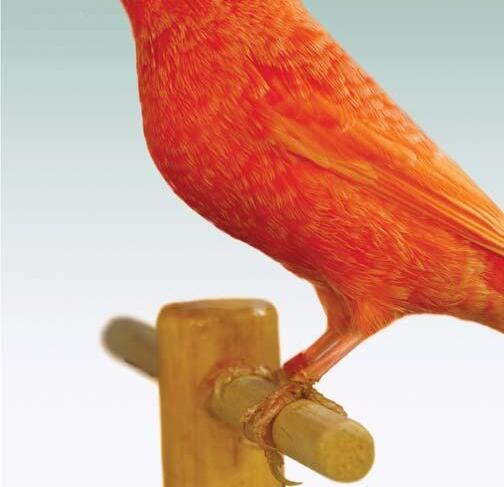
Si consideri anche che, accoppiando mosaico x mosaico, come brinato x brinato, il lipocromo si indebolisce e si indebolisce anche sulle ali.


Alcuni pensano che le ali deboli di giallo siano migliori per avere più effetto limone. Ora sappiamo che la tonalità limone si apprezza meglio con lipocromi deboli, non a caso ho più volte ribadito che a parità di valore, la migliore tonalità limone la troviamo nelle femmine brinate e la minore nei maschi intensi. Senza considerare l’avorio giallo, ove la circostanza è evidentissima, poiché per avere il crema (l’equivalente del dorato) occorrono carenze molto rilevanti di strutture della penna, mentre nei gialli il dorato appare anche con carenze modeste di strutture. Sappiamo che la femmina ha meno lipocromo e nell’intenso il lipocromo si concentra, pertanto si ha l’esito di cui sopra. Tuttavia pensare di sbiadire il giallo per avere più toni verdognoli limone è sbagliato; la varietà giallo deve esprimersi al massimo come pigmento oltre che come effetto strutturale limone, e pazienza se nei maschi intensi non si potrà avere l’effetto limone pari alle femmine sorelle brinate.


Comunque sia chiaro che il bianco nelle ali dei gialli non è raggiungibile a pieno, neanche con lipocromi deboli. A questo proposito ricordo qualche episodio divertente. Un allevatore vantava di avere ali bianchissime nei suoi gialli, ebbene gli dissi di guardare meglio, ma non bastò, allora gli

NUMERO 4 - 2023 31
Brinato rosso, foto: E. del Pozzo
Intenso giallo
chiesi di prendere in mano un soggetto e misi il dito sulla soffusione alare gialla. Chiedendogli: “e allora?” la risposta fu: “sì ma non si vede…”. È sempre necessario avere valutazioni obiettive, il pregiudizio può fare brutti scherzi. Un aspetto ingannevole è che la soffusione delle remiganti secondarie si vede con evidenza, mentre quella delle primarie può sfuggire, confondendosi con il giallo delle penne tettrici quando le ali sono chiuse. Anche difetti di piumaggio che talora avvolge l’ala possono mascherare tale soffusione. In passato si sono segnalati gialli con ali molto bianche, ma poi non ho più avuto notizie. A suo tempo li ho visti, comunque non era un effetto totale, inoltre di dubbia trasmissibilità. Forse un difetto di espressione del lipocromo, che se non ricordo male, si manifestava anche in altri siti anatomici e non è certo il caso di cercare di selezionare anomalie.
C’è poi l’aspetto, nei rossi non colorati da nido, quando presentano delle penne mutate e quindi colorate con la colorazione classica dopo lo svezzamento.


A questo proposito ho sempre presente un soggetto veramente ottimo, brinato rosso del mio allevamento. Ebbene aveva mutato alcune timoniere, nonostante ciò riuscì ad avere i 90 punti e ad arrivare terzo in un campionato regionale. Certo avrebbe avuto diverse prospettive non mutando tali penne.
Anche prima di allora mi ero posto il problema ed ancora me lo pongo. È corretto considerare le penne mutate un difetto? E se sì, di che cosa? Si possono avere diverse opinioni.


Alcuni potrebbero dire di “varietà”, visto che comunque riguarda il colore lipocromico, ma altri potrebbero obiettare che l’espressione della varietà, diciamo il rosso, può essere espressa al meglio anche con penne mutate.

Alcuni potrebbero preferire considerarlo un difetto di “piumaggio”, visto che sono state cambiate penne non previste come cambiate, ma altri ancora, potrebbero obiettare che si potrebbe considerare difetto di piumag-

32 NUMERO 4 - 2023
Intenso giallo, foto: P. Rocher
Brinato giallo, foto: E. del Pozzo
gio solo se le penne cambiate fossero quelle che non sono mai cambiate, se non per fatti traumatici, ma non nel caso di penne che potrebbero essere mutate spontaneamente. Inoltre il piumaggio potrebbe essere complessivamente ottimo.
Alcuni potrebbero optare per un difetto di “condizioni e benessere”, magari solo se ad essere mutate fossero le penne mai mutate spontaneamente, ma non quelle che possono essere mutate in modo naturale. Facendo riferimento a possibili trascuratezze dell’allevatore o meno. Vero, direi per tutti, che non si può sapere se timoniere mutate lo siano per effetto traumatico, come l’aggressione di un altro soggetto, o per fatto spontaneo. Viene in mente la massima giuridica “in dubio pro reo” vale a dire che nei casi dubbi non si può punire. Questo aspetto dovrebbe avere qualche tipo di considerazione. Del tutto inopportuno, secondo me, penalizzare le remiganti terziarie, poiché cambiate spessissimo, e spesso ben poco visibili, in quanto in gran parte coperte dalle scapolari.


Recentemente mi sono recato presso l’allevamento di un amico, ottimamente gestito, ed in un gabbione niente affatto affollato, alcuni soggetti erano senza coda. Il responsabile del misfatto non era ancora stato individuato. Certo in allevamenti mal condotti ed affollati succede spesso, ma talora anche in allevamenti del tutto ben gestiti. Penso quindi che la severità sia molto discutibile. Ora qualcuno penso che si chiederà qual è la mia opinione personale, ebbene io penso che quando sono mutate, diciamo sono rosse, penne talora mutate spontaneamente, non si dovrebbe penalizzare affatto, “in dubio pro reo”; se invece fossero mutate penne che non sono mai mutate: remiganti primarie e secondarie nonché grandi copritrici delle primarie, salvo traumi, ritengo che si dovrebbe penalizzare, secondo me preferibilmente nella voce “condizioni e benessere”, visto che si prospetta almeno un incidente, se non un errore di gestione. Questo poiché mi
dispiacerebbe veder penalizzati la varietà o il piumaggio, che potrebbero essersi mantenuti ottimi (più difficile per il piumaggio). Comunque non auspico severità, per non incoraggiare troppo certe “tolettature” e dover rinunciare ad esporre soggetti molto pregiati.
Trattasi solo di mia opinione sommessamente espressa. Non certo sommessa la mia ostilità verso la colorazione da nido, per la quale auspico qualche intervento medico teso a dimostrare eventuali effetti negativi sulla salute. Tale sistema è anche nocivo per l’estetica rendendo mono-


tono il colore, mentre bellissimo è il contrasto con le ali naturali. Inoltre, le ali colorate non consentono una buona valutazione della genetica, specialmente nei rossi. Anzi, direi che nei rossi quasi si incoraggia la selezione di ali gialle per avere colore più uniforme, visto che nei migliori ad ali bianche si crea una leggera differenza di tonalità, dato che arriva solo cantaxantina sintetica.
Nei gialli il danno estetico è forse leggermente minore, ma si ostacola la tonalità limone caricando i carotenoidi.
Mi auguro che in OMJ si ottengano altri risultati utili, dopo l’ammissione delle ali bianche nei lipocromici, togliendo la penalizzazione minima nei melanici nei quali, fra l’altro, in certi tipi il danno estetico è rilevante. Come precedenti pubblicazioni, mi limito a citare il mio testo “I colori nel Canarino” e fra i tanti articoli l’ultimo “Ali bianche, l’origine del concetto e le conseguenze I. O. n°2 del 2023”. Disponibile ad ulteriori discussioni concludo.
NUMERO 4 - 2023 33
Brinato rosso avorio ali bianche, foto: E. del Pozzo
Un aspetto ingannevole è che la soffusione delle remiganti secondarie si vede con evidenza, mentre quella delle primarie può sfuggire
•Invitiamo tutti gli allevatori a inviare foto di soggetti provenienti dai propri allevamenti, con descrizione della specie, razza e mutazione, all’indirizzo: redazione@foi.it



•All’autore della foto mensilmente prescelta da un comitato interno, verrà offerto in omaggio un libro edito dalla FOI in base alla preferenza e alla disponibilità.
(*)Tutte le foto inviate, anche quelle non pubblicate, rimarranno a disposizione della FOI a titolo gratuito e potranno essere utilizzate, senza alcun limite o vincolo temporale, per pubblicazioni, iniziative e scopi promozionali della Federazione

Questo mese, il protagonista di Photo Show è:

LUCA ADDUCI R.N.A. 94XU con la fotografia che ritrae il soggetto:

“Novello di Crociere fasciato”
(Loxia leucoptera)
Complimenti dalla Redazione!

Sul Diamante papuano Erythrura papuana (Hartert, 1900)
Note tassonomiche e sistematiche
chetto di Musschenbroeki Neopsittacus musschenbroekii).
Diamante papuano Erythrurapapuana , fonte: https://gelatikblog. wordpress.com/2014/01/17/papuan-parrotfinch/


Il Diamante papuano Erythrura papuana è una specie monotipica, endemicadell’isola della Nuova Guinea. Vive nelle foreste (primarie e secondarie) e nelle aree erbose ai bordi di queste, ad altitudini comprese fra i 1200 e i 2600 metri, ma è stato osservato anche a circa 500 metri. Da alcuni autori viene considerato una specie di orientamento trofico tendenzialmente “specialistico”, in quanto consuma preferibilmente le infiorescenze dei fichi, ma la sua dieta è composta anche da semi di varie erbe prative, insetti, frutti di una pianta del genere Castanopsis e forse anche da nettare (è stato osservato sovente presso alberi in fiore insieme al Lori-
Il D. papuano ha un aspetto molto simile, sia per cromia sia per morfologia, a quello di una sottospecie del Diamante di Kittlitz Erytrura trichroa sigillifera, con la quale condivide l’habitat. Quest’ultimo volatile, che occupa anche areali di più ampia altitudine (dai 750 ai 3000 metri), orienta la propria strategia alimentare prevalentemente sui semi di bambù, ma si ciba anche di semi di graminacee, di bacche e d’insetti. Queste due specie non di rado vengono avvistate nella stessa località, e in tali occasioni la precisa identificazione diventa molto difficile, se non ardua. Infatti, come già accennato, i colori della livrea e la loro disposizione possono ri-
tenersi pressoché sovrapponibili, mentre la struttura corporea, compresa quella del becco, è maggiore nel D. papuano. A titolo di esempio, riporto alcuni dati biometrici della specie in esame (tra parentesi i valori del D. di

NUMERO 4 - 2023 35 ESTRILDIDI FRINGILLIDI IBRIDI
di IVANO MORTARUOLO, foto WORDPRESS.COM, L. DE CICCO, BIODIVERSITY HERITAGE LIBRARY, WIKIPEDIA, WWW.NHM.AC.UK, OLSSONE ALSTRÖN
Comparazione fra il Diamante papuano (A) e il Diamante di Kittlitz (B). Risulta evidente la superiorità corporea (becco compreso) della prima specie, fonte: LucasH.DeCicco , 2020
Il Diamante papuano ha un aspetto molto simile, sia per cromia sia per morfologia, a quello di una sottospecie del Diamante di Kittlitz Erytrura trichroa sigillifera
Kittlitz): peso g 19-21 (12-16), lunghezza totale cm 13,5 (12), lunghezza delle ali cm 65-70 (59-65), lunghezza del becco mm 10,0-10,9 (8,6-9,6) e larghezza della mandibola cm 8,6-9,8 (7,17,8).
Tali somiglianze, che in tempi recenti sono state oggetto di indagini scientifiche, hanno creato qualche disorientamento anche fra gli ornitologi di fine
Ottocento e dei primi anni del secolo successivo. Dovendo tracciare un profilo degli avvenimenti che hanno caratterizzato la storia tassonomica del papuano, mi accingo a presentare tre illustri studiosi, due dei quali blasonati. Il primo è il Conte Adelardo Tommaso Salvadori Paoletti (1835-1923), un ornitologo di statura internazionale che purtroppo non trovò adeguata collocazione nella struttura dove prevalentemente conduceva i suoi studi. Dopo aver conseguito la laurea in medicina e chirurgia, venne infatti assunto come assistente presso il Museo di Zoologia dell’Università di Torino, ma non gli fu mai conferita la funzione di direttore: ottenne, dopo diversi anni di duro lavoro, soltanto l’incarico di vice direttore. Fu autore di centinaia di pubblicazioni scientifiche e di diversi libri che
gli valsero il rispetto e la stima del mondo ornitologico. Non a caso tra il 1890 e il 1894 venne chiamano dal prestigioso British Museum of Natural History di Londra per la stesura di tre cataloghi attinenti agli uccelli ivi conservati.
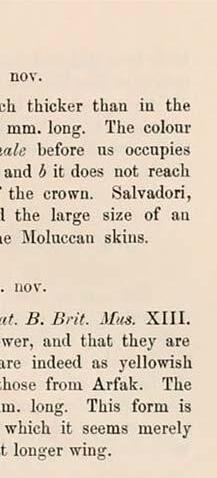
A pagina 442 della sua famosa opera Ornitologia della Papuasia e delle Molucche (volume III,1881) prende in esame la specie Erythrura trichroa, rappresentata da un eterogeneo gruppo diotto specimina provenientida tre distinte località. Il primo esemplare, contrassegnato dalla lettera a, fu catturato nel giugno 1877 presso i Monti Arfak (situati nell’attuale provincia indonesiana della Papua Occidentale). Il secondo, con la lettera b, fu catturato il 29 novembre del 1874 a Ternate, un’isola dell’arcipelago delle Molucche (il suo attuale nome scientifico è Erythrura trichroa modesta), e reca la seguente annotazione dell’autore: “Differisce dal primo pel becco meno grosso e meno robusto, per le dimensioni alquanto minori, per la tinta verde un poco meno intensa, e per aver sui lati del collo una lievissima tinta giallobruna, ma tanto leggera che è appena discernibile”.


Dunque, il Salvadori evidenzia per la prima volta che nella Nuova Guinea vi è un’Erythrura trichroa didimensioni maggiori e con qualche espressione cromatica leggermente differente rispetto ai conspecifici.
Dopo aver accennato a questo primo passo del percorso tassonomico del D. Papuano, mi accingo a presentare il secondo personaggio: Lord Lionel Walter Rothschild (1868-1937), figlio del barone Nathan Mayer Rothschild (18401915). Apparteneva dunque a una nobile e ricchissima famiglia di banchieri di origine ebraica, il che agevolò molto la sua formazione di studioso di zoologia. Sin da giovanissimo manifestò uno spiccato interesse per il mondo animale e già da allora espresse il desiderio di allestire un proprio museo. Evento questo che si realizzò nel 1889, quando suo padre, in occasione del ventunesimo compleanno di Walter (1), fece costruire la struttura nei pressi del parco di Tring (una cittadina a circa km 50 da Londra). Da rilevare che già a quella data il no-

36 NUMERO 4 - 2023
Descrizione dell’Erythruratrichroapapuana(Diamante papuano) e dell’Erythruratrichroawoodfordi(Diamante di Kittlitz) effettuata da Hernst Hartert nel 1900 (Novitates Zoologicae, Volume VII), fonte: BiodiversityHeritageLibrary
Indice del fascicolo in cui Hernst Hartert descrisse per la prima volta il Diamante papuano, attribuendogli il nome scientifico di Erytrhuratrichroapapuana , fonte: BiodiversityHeritageLibrary
Dunque, il Salvadori evidenzia per la prima volta che nella Nuova
Guinea vi è un’Erythrura trichroa didimensioni maggiori
stro aveva raccolto una quantità impressionante di reperti zoologici, che aumentarono enormemente nel corso degli anni, sino a diventare la più vasta collezione naturalistica mai realizzata da una singola persona (notevole era anche il numero dei libri di ornitologia posseduti). La sua passione lo spinse anche ad acquisire un gran numero di animali, soprattutto peculiari e rari come, ad esempio, i Casuari (ne tenne, nel corso degli anni, 64) e le Tartarughe giganti (il numero era davvero eccezionale: 144)(2).
Nonostante fosse un omone alto m. 1,91, la sua salute era un po’ cagionevole e, pertanto, non gli permetteva di avventurarsi in lontane spedizioni scientifiche. In compenso sovvenzionò varie missioni zoologiche e mantenne contatti con i maggiori esploratori e studiosi di allora. Scrisse vari libri e numerosi articoli, descrisse per la prima volta diverse specie animali e vari zoologi attribuirono il suo nome ad alcuni taxa scoperti (propongo soltanto due esempi: Storno di Bali Leucopsar rothschildi Stresemann,1912;Canarino d’Arabia Serinus rothschildi OgilvieGrant, 1902 – attualmente denominato Crithagra rothschildi).
Il suo museo, il Tring Museum (3), aprì al pubblico nel 1892 sotto la direzione dell’ornitologo tedesco Ernst Hartert (1859-1933), che conservò l’incarico fino al 1929. Come ogni altra struttura museale che si rispetti, periodicamente veniva dato alle stampe un resoconto delle ricerche e degli studi effettuati, dal titolo Novitates Zoologicae, la cui gestione era affidata a Hartert, all’entomologo tedesco Ernest Karl Jordan (1861-1959) e naturalmente a Rothschild. Ed è proprio su questa pubblicazione che, nel volume VII del 1900, Hartert firma l’articolo The Birds of Runk in the Central Carolines e a pagina 7 segnala il D. papuano, attribuendogli il nome scientifico di Erythrura trichroa papuana:considerandolo quindi una sottospecie del D. di Kittlitz. Nella stringata nota viene riferito che il tipo esaminato (un maschio) è stato prelevato da Arfak e che l’ala misurava mm 67 (in un successivo scritto verrà indicato che il soggetto fu acquisito dalla Collezione Rothschild nel febbraio
Lord Lionel Walter Rothschild (1868-1937)

Sono anche incline a credere che tale duplice attribuzione di merito sia un’occasionale e mera espressione di riconoscenza e forse anche di deferenza verso il proprio “datore di lavoro”. Questa mia ipotesi sembrerebbe suffragata anche dal fatto che nel 1930, sul volume XXXVI sempre di Novitates Zoologicae, Hartert pubblica la List of the birds collected by Ernest Mayr” e a pagina 43 propone l’attuale nomenclatura di Erythrura papuana, macita sé stesso e la descrizione effettuata nel 1900.

del 1894). Si accenna inoltre alla suddetta segnalazione del Salvadori (l881). Trascorrono diciannove anni (1919), e nel volume XXVI della stessa rivista viene pubblicata la nota dal titolo Types of Birds in the Tring Museum, scritta sempre da Hartert, in cui a pagina 142 viene indicato che gli autori della segnalazione dell’Erythrura trichroa papuana sono Rothschild e Hartert. Invito, a questo punto, il lettore a soffermarsi su questa duplice e postuma attribuzione di paternità tassonomica. Evidenzio ciò perché attualmente qualche autore o organismo ornitologico si ostina a proporre il seguente nome scientifico: Erythrura papuana Rothschild e Hartert. A mio giudizio si sta incorrendo in un’inesattezza che non rende giustizia all’effettivo autore della descrizione: vale a dire Hartert.
Ernst Hartert (1859-1933). Fu un reputato ornitologo specializzatosi in oologia e per molti anni curò la gestione del TringMuseum,fonte: https://www.nhm.ac.uk/discover/walterrothschild-a-curious-life.html

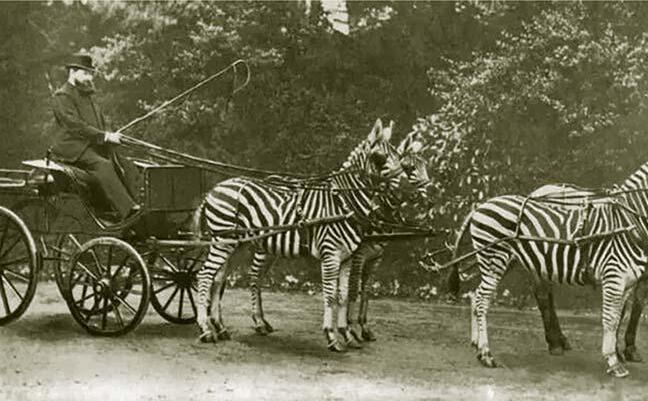
NUMERO 4 - 2023 37
L’estroso Lord Walter Rothschild (1868-1937) propose anche un’insolita quadriglia di Zebre, fonte: WikipediaCommons
scrisse vari libri e numerosi articoli, descrisse per la prima volta diverse specie animali e vari zoologi attribuirono il suo nome ad alcuni taxa scoperti
Rappresentazione grafica della relazione genetica esistente fra il D. papuano, il D. di Kittlitz e il D. Coloria, fonte: DeCiccoetalii , 2020
A corredo delle mie affermazioni propongo pure la foto dell’indice del suddetto volume VII (fascicolo n.1 del marzo 1900), in cui Hartert segnala per la prima volta la specie in esame. Pertanto, a mio giudizio, la corretta indicazione del taxon è Erythrura papuana (Hartert, 1900).
Riportando il discorso ai nostri giorni, è opinione diffusa che le informazioni raccolte sulla biologia del D. papuano siano scarse, frammentarie e, non raramente, contraddittorie. Fra i diversi interrogativi che gli studiosi si sono posti, un ruolo di rilievo ha assunto la convivenza in alcuni habitat col D. di Kittlitz e le affinità morfologiche delle due specie. Per cercare di comprendere la natura di tali relazioni, segnalo due recenti studi i quali, pur non offrendo risposte precise e definitive, propongono ipotesi di un certo interesse.
Il primo lavoro porta la firma di due biologi, Urban Olsson e Per Alströn (2020), che, in un’approfondita ricerca
tassonomica e filogenetica sugli esponenti della famiglia Estrididae (A comprehensive phylogeny and taxonomic evaluation of the waxbills -Aves: Estrildidae), hanno apportatoimportanti contributi. Tra l’altro evidenziano che la papuana e la trichroa hanno le stesse caratteristiche genetiche (in gergo scientifico si direbbe che hanno “aploidi” identici). Da questa constatazione i ricercatori formulano le seguenti ipotesi: 1) che l’attuale orientamento tassonomico è sbagliato in quanto le due specie non sono separate; 2) che tale realtà è stata causata da un fenomeno di introgressione; 3) che, in sede di esami di laboratorio, può essersi verificato un banale scambio di materiale biologico, originando così un esito inesatto.

Prima di passare alla seconda ricerca, credo che sia utile, soprattutto per i giovani lettori, chiarire il concetto di cui al punto 2 (introgressione). In estrema sintesi, ciò avviene quando fra
due distinte specie si creino varie ibridazioni (F1, R1 eccetera), con conseguente scambio di materiale genetico. Tale fenomeno generalmente si verifica allorquando le barriere interspecifiche sono annullate o si allentano (si pensi, per esempio, a due distinti taxa separati territorialmente da una foresta che venga poi distrutta da un incendio). L’ibridazione introgressiva (così viene anche definito il fenomeno) è abbastanza rara negli uccelli, tuttavia in Italia ne abbiamo un chiaro esempio. Mi riferisco alla popolazione ibrida, nota come Passera d’Italia Passer italiae (4), sorta dalla convivenza della Passera domestica Passer domesticus conla Passera sarda Passer hispaniolensis. Il secondo studio è stato pubblicato nello stesso anno del primo (2020), ma affronta direttamente il tema, come è annunciato nel titolo: New Guinea Erythrura parrotfinches: one species or two?
Gli autori, L.H. DeCicco, B.W. Benz, D.A. DeRaad, P.M. Hime e R.G. Mayle, per fugare dubbi e perplessità espressi in letteratura (Diamond,1972), hanno svolto accurate rilevazioni dei dati morfometrici dai quali è emersa incontrovertibilmente la superiorità corporea della specie in esame. Ma le loro indagini sono andate ben oltre, effettuando ricerche per valutare le affinità genetiche esistenti fra le due specie. Va evidenziato che, per quanto attiene al D. di Kittlitz, sono stati utilizzati materiali biologici sia di esemplari della Papua Nuova Guinea sia delle Isole Salomone (secondo l’attuale orientamento tassonomico, i volatili provenienti da queste ultime isole sono ascritti alla sottospecie Erythrura trichroa woodfordi) (5). Inoltre, la ricerca è stata estesa a due esemplari di Diamante coloria Erythrura coloria, specie ritenuta molto affine alle altre due. Dagli esami realizzati, utilizzando DNA mitocondriale, è così emerso che la papuana e la trichroa sono geneticamente uguali.
Rappresentazione filogenetica dalla quale emerge che il D. papuano e il D. di Kittlitz sono pressoché coevi e che, fra le Erythrure, costituiscono i taxa più recenti, fonte: OlssoneAlströn , 2020
Gli autori concludono che altre ricerche si renderanno necessarie, segnatamente del DNA nucleare, per avere un quadro completo della storia evolutiva dei due taxa; limitandosi, per ora, a proporre le appresso indicate ipotesi. 1) Le due specie hanno vissuto in territori se-
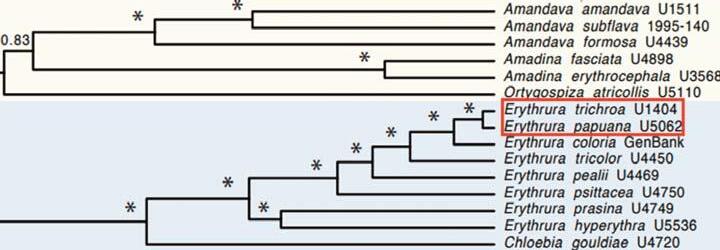

38 NUMERO 4 - 2023
parati (il fenomeno è noto con il nome allopatria) senza che vi siano stati evidenti cambiamenti genetici, oppure si è verificata una condizione di simpatria secondaria (tra breve tenterò di offrirne un cenno di spiegazione); 2) le due specie, pur condividendo lo stesso territorio (in questo caso il fenomeno viene chiamato simpatria), stanno effettuando un proprio, autonomo processo di speciazione; 3) le due specie costituiscono un’unica popolazione che si caratterizza per il suo polimorfismo e per la possibilità di accoppiamenti casuali fra i componenti (questa caratteristica comportamentale è chiamata panmissia).
La simpatria secondaria si verifica qualora fra due popolazioni, le quali vivono isolate ma per un tempo che non ha consentito fondamentalimutamenti fenotipici e genotipici, venga rimosso l’ostacolo che ne impediva il contatto (un esempio potrebbe essere quello,

dianzi proposto, della foresta distrutta che precedentemente separava le due specie). Risulta evidente che, a seconda delle modificazioni (anche di natura etologica) verificatesi nei due gruppi, vi sarà una maggiore o minore possibilità di ibridazione introgressiva.
Il Diamante papuano si rivela, dunque, una specie interessante anche dal punto di vista sistematico. Non sorprenderebbe se futuri studi lo ascrivessero, dopo circa un secolo di “prestigio tassonomico”, all’originario livello di sottospecie. Anche se ciò accadesse, la sua bellezza e il suo fascino rimarrebbero comunque immutati.
Ricerca effettuata per conto della Parrot Finches European Club


nato di scienze naturali ma soprattutto un competente e apprezzato entomologo (fece anche degli approfondimenti sui parassiti degli uccelli). Charles trasmise la sua passione per gli insetti a sua figlia Miriam (1908-2005), la quale si distinse per i suoi sudi e per le sue iniziative sociali e filantropiche.
(2)Informazioni tratte dall’articolo Walter Rothschild, a curious life di Kerry Lotzof(Natural History Museum di London).
(3)Da tempo il Tring Museum costituisce un distaccamento del Natural History Museum di Londra.
(4)La Passera d’Italia presenta caratteristiche morfologiche intermedie a entrambi i parentali (Passera domestica e Passera sarda). Da anni i tassonomisti la ritengono una specie a sé stante. In passato alcuni autori la consideravano una sottospecie della P. domestica, mentre altri la ritenevano una sottospecie della P. sarda.



NOTE
(1)Walter Rothschild aveva un fratello, Nathaniel Charles (1877-1923), anch’egli un appassio-
(5)Sempre a pagina n.7 del volume VII di Novitates Zoologicae, 1900 (detto altrimenti, nella stessa pagina in cui fu descritto il Diamante papuano), Hernst Hartert segnalava una nuova sottospecie di Diamante di Kittlitz con il nome Erythrura trichroa woodfordi, in onore del naturalista inglese Charles Morris Woodford (1852-1927).
NUMERO 4 - 2023 39
e non solo
O rniFlash
I pappagalli imparano a fare videochiamate

Unnuovo studio condotto da ricercatori della Northeastern University –Boston, in collaborazione con scienziati del Massachusetts Institute of Technology (MIT) e dell’università di Glasgow, ha cercato di capire cosa succede quando a un gruppo di pappagalli domestici viene insegnato a chiamarsi l’un l’altro. Rébecca Kleinberger e Jennifer Cunha della Northeastern e Ilyena Hirskyj-Douglas dell’università di Glasgow, hanno mostrato a un gruppo di pappagalli di diverse specie e ai loro assistenti volontari come usare tablet e smartphone per videochiamarsi su Facebook e Messenger. Poi, per tre mesi, hanno osservato come gli uccelli usassero quella nuova abilità. Secondo la Kleinberger, «I pappagalli più popolari erano anche quelli che lanciavano più richiami, suggerendo una dinamica reciproca simile alla socializzazione umana. E mentre, in gran parte, gli uccelli sembravano apprezzare l’attività stessa, i partecipanti umani hanno svolto un ruolo importante. Alcuni pappagalli apprezzavano l’attenzione extra che stavano ricevendo dai loro umani, mentre altri formavano attaccamenti per gli umani dall’altra parte dello schermo». Il team di ricerca, che aveva già utilizzato l’interazione con il computer per arricchire e comprendere la vita di specie animali che vanno dai cani alle orche, si è concentrato sui pappagalli per alcuni motivi: «La loro intelligenza è straordinaria; alcune specie, come i cacatua e i cenerini africani, hanno dimostrato capacità cognitive pari a quelle di un bambino in età scolare. La loro vista consente loro di dare un senso ai movimenti su uno schermo». L’esperimento consisteva in una schermata iniziale del tablet con le immagini di possibili amici da chiamare, con coppie e terzetti di pappagalli raggruppati principalmente per taglia e fuso orario. Durante sessioni coordinate di tre ore, usando i loro becchi per toccare lo schermo, ogni pappagallo poteva avviare fino a due chiamate della durata non superiore a 5 minuti ciascuna. La Hirskyj-Douglas conclude: «Tutto questo ci parla davvero di quanto questi uccelli siano complessi dal punto di vista cognitivo e quanta capacità abbiano di esprimersi».

Fonte: https://greenreport.it/news/aree-protette-e-biodiversita/i-pappagalliimparano-a-fare-videochiamate-per-chattare-con-altri-pappagalli-video/
Scoperte due specie di uccelli velenosi

InPapua Nuova Guinea, gli scienziati hanno scoperto due specie di uccelli velenosi. L’esistenza di volatili che contengono delle tossine nel proprio organismo era nota da tempo. Nel caso delle due specie oceaniche, si tratta della brachiotossina, così chiamata perché scoperta inizialmente in alcune specie di rane in America. Basta un semplice tocco di questi animali per provocare la morte di un essere umano. Non a caso una di queste è stata chiamata “rana freccia”, in quanto le tribù indigene utilizzano il veleno per impregnare le punte delle loro frecce. Fortunatamente, gli uccelli di cui parliamo hanno un livello di tossicità molto inferiore rispetto ai piccoli anfibi. A scoprirli è stato un team di ricerca internazionale con a capo un gruppo di scienziati del Museo di Storia Naturale della Danimarca e dell’Università di Copenhagen, in collaborazione con il gruppo del Leibniz Institute for Natural Product Research and Infection Biology di Jena, in Germania. La cosa ancora più sorprendente è che si tratta, come anticipato, di due specie molto comuni in Papua Nuova Guinea (Pachycephala schlegelii e Aleadryas rufinucha). La caratteristica peculiare dei due uccellini, è che la tossicità non viene prodotta dall’organismo, ma viene sviluppata attraverso l’alimentazione, consumando grandi quantità di insetti portatori di brachiotossina, ma la ricerca è ancora in corso e non se ne ha la certezza. Dunque, nel corso del tempo, i volatili hanno sviluppato non solo un modo per digerire e annullare la tossina, ma anche per accumularla nel proprio corpo, rendendolo velenoso. Le loro bellissime e colorate piume quindi, innescano una forte lacrimazione e una sensazione di fastidio al setto nasale. I dettagli della ricerca sono stati pubblicati sulla rivista scientifica “Molecular Ecology”.
Fonte: https://www.ilfattoquotidiano.it/2023/04/05/pericolo-in-aria-scopertedue-specie-di-uccelli-velenosi-che-attaccano-con-una-potente-neurotossina-ecco-dove-vivono/7120996/
News al volo dal
web
40 NUMERO 4 - 2023
O rniFlash
I corvi non dimenticano i volti umani Icorvi
sono uccelli intelligenti e affascinanti che appartengono alla famiglia dei corvidi, insieme ai corvi imperiali, alle gazze e ai gracchi. Sono presenti in tutto il mondo, tranne che in Sud America, e si trovano in una grande varietà di habitat, dal deserto alle foreste tropicali. Questi uccelli hanno una reputazione leggendaria di astuzia e intelligenza. Sono in grado di risolvere problemi complessi, utilizzare attrezzi e perfino comprendere l’uso dello specchio. Una recente ricerca ha dimostrato che la loro memoria è molto più sviluppata di quanto si pensasse ed infatti si crede che questi uccelli siano in grado di ricordare i volti umani. Gli esperimenti effettuati da alcuni ricercatori di Seattle dimostrano che i corvi hanno un’etica molto simile a quella degli esseri umani e questo ha aperto nuove strade di studio sulla loro capacità di interagire e comunicare con gli altri membri della loro specie. Ma perché i corvi ricordano i volti umani e serbano rancore? Probabilmente, questa caratteristica ha radici evolutive: i corvi sono animali sociali che vivono in gruppi gerarchici e l’abilità di ricordare chi ha fatto loro del male può essere un’arma importante nella lotta per il potere all’interno del gruppo. Inoltre, questo comportamento potrebbe anche proteggerli da potenziali predatori, permettendo loro di riconoscere e attaccare un nemico che li ha già attaccati in passato, raccontando ai loro “amici” chi ha fatto loro del male. Nello specifico, i corvi americani utilizzati nell’esperimento hanno dimostrato di ricordare i volti di persone incontrate persino anni prima, attaccandoli e informando anche altri corvi di attaccare la persona. La scoperta che i corvi serbano rancore come gli esseri umani ha importanti implicazioni per la nostra comprensione dell’intelligenza animale e della natura delle emozioni.

Fonte: https://www.orizzontenergia.it/2023/04/25/corvi-non-dimenticano-volti-umani-recente-studio/
Uccelli… Ingannati dalla plastica
Glioceani sono la confluenza terminale di una moltitudine di corsi fluviali che trasportano plastica di ogni formato, tipologia e dimensione e, se consideriamo anche l’immissione di plastica direttamente nei mari, è facile intuire quanto questo fenomeno possa risultare impattante per la fauna oceanica. Oltre ai pesci anche gli uccelli ingeriscono grandi quantità di plastica e molti studi convergono nel sottolineare la pericolosità di questo elemento fluttuante. In uno studio più recente, pubblicato nel 2022 sulla rivista Frontiers in Marine Science – Section Marine Pollution, è stata esaminata l’ingestione di plastica in uccelli marini altamente migratori come le berte dell’Atlantico (Ardenna gravis). Sono state studiate ben 217 berte trovate e recuperate in diverse località durante il loro ciclo migratorio annuale attraverso il nord-ovest e il sud dell’Atlantico per valutare l’accumulo di plastica ingerita, nonché le tendenze nelle stagioni e rispetto ai luoghi. Un totale di 2328 frammenti di plastica è stato documentato nella porzione ventricolare del tratto gastrointestinale, con una media di ben 9 frammenti di plastica per uccello. Nessun frammento della stessa dimensione o aspetto è stato trovato nella preda elettiva, il pesce Sand Lance (Ammodytes spp.) che sostiene a livello trofico la popolazione di berte dell’Atlantico nella baia del Massachusetts, suggerendo che gli uccelli ingeriscono direttamente la maggior parte della plastica piuttosto che tramite l’ingestione dei pesci.
Si ritiene che gli uccelli marini dell’ordine Procellariiformes (ad esempio albatri, berte, procellarie e uccelli delle tempeste) siano i più vulnerabili all’ingestione di plastica in relazione alle loro abitudini pelagiche ad ampio raggio e a un uso sostanziale di segnali olfattivi e visivi durante il foraggiamento. Tuttavia, la frequenza dell’ingestione di plastica varia ampiamente tra i membri di queste specie. La situazione per gli uccelli di mare è davvero preoccupante, speriamo che le nuove politiche di riduzione del consumo di plastica usa e getta possano mettere un freno a tutto questo.

Fonte: https://rivistanatura.com/ingannati-dalla-plastica/
dal web e non solo

News al volo
NUMERO 4 - 2023 41









Canarini Border: un modello futuristico
testo e foto di ANGELO LAGI
Premessa
Nel 2016, il modello 3D in porcellana (Italia Ornitologica n.10/2016 pp. 4748) segnò per me la realizzazione concreta di un ideale di Canarino Border proiettato nel futuro, con forme più armoniose ed eleganti.
Evoluzione che mi portò successivamente (era il 2020) ad elaborare un disegno ancora più “futuristico”, da tenere in considerazione come ispirazione selettiva in allevamento, una sorta di icona alla quale far riferimento.
Mi riferisco ad un percorso di crescita tecnico-culturale nella specializzazione, possibile solo attraverso il “Border Canary Club Italiano” di cui mi onoro di far parte.

Doveroso sottolineare, a scanso di equivoci, che resta una mia personale interpretazione del modello, senza voler assolutamente mettere in discussione quello riconosciuto ufficialmente come
riferimento nelle mostre ornitologiche nazionali, internazionali e specialistiche.
La mattonella in ceramica
Nel 2021 pensai che quel disegno, adottato da subito sul logo del mio allevamento, meritasse una maggiore rilevanza, se non dal punto di vista tecnico magari dal punto di vista artistico, guardando al futuro della Razza con un occhio più “raffinato”.
Nacque così l’idea di imprimere l’immagine su un supporto nobile quale la mattonella o piastrella in ceramica.
La lavorazione sembrerebbe di facile attuazione, ma non lo è.
Per realizzare queste opere d’arte artigianali e personalizzate si parte da un’immagine ad alta risoluzione (almeno 300 DPI); nel caso specifico, parliamo di un disegno creato interamente al PC (non una foto) con l’ausilio di un software di grafica. Il file viene poi esportato in formato .jpg ad una risoluzione di 1.000 DPI, dimensionato secondo il formato della mattonella che si sceglie (es. cm 15x15).
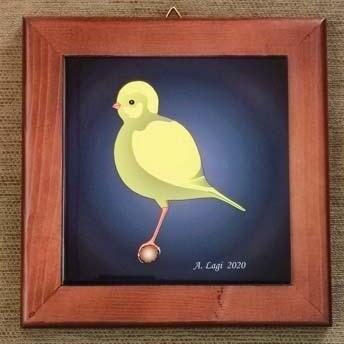
Nella fase successiva è fondamentale, per ottenere un risultato eccellente, individuare un fornitore serio e professionale al quale inviare il file dell’immagine (tramite e-mail), file che a fine lavorazione verrà cancellato dagli archivi del fornitore onde evitare che possa essere replicato all’insaputa del committente.

L’utilizzo di mattonelle di prima scelta, attrezzature in grado di riprodurre fedelmente l’immagine (vasta gamma di colori e sfumature), cottura in forno con tempi e temperature prestabilite, im-
ballaggio curato e spedizione veloce: sono queste le caratteristiche sinonimo di serietà professionale.
Questa mattonella, arrivata a destinazione, viene arricchita ulteriormente con una cornice in legno trattato color noce e con un gancio per appenderla a parete, operazione che curo personalmente.
Conclusioni
Agli occhi di un profano il prodotto potrebbe sembrare un oggetto bello ma inutile, mentre per me e, spero, per tante altre persone, rappresenta l’espressione artistica di una grande passione per una magnifica Razza che allevo ormai da ben 18 anni.
Mi auguro, quindi, che possa trovare nel tempo l’apprezzamento che merita e, in un futuro non troppo lontano, che possa essere un riferimento sempre più reale nella selezione specialistica.
NUMERO 4 - 2023 43 CRONACA
Logo Allevamento
Mattonella con cornice
S pazio Club
Comunicato del Lizard Canary Club Italiano



Aseguito di regolari votazioni il Lizard Canary Club Italiano ha rinnovato il proprio Consiglio Direttivo, che per il triennio 2023-2026 risulta così composto:
Presidente:Antonio Di Tillio
Vice Presidente:Giammarco Orazi
Segretari:Guglielmo Carillo e Paolo Vicidomini
Consiglieri:Giorgio Massarutto, Pietro Botrugno e Savino Berardi
Riteniamo doveroso ringraziare per il lavoro fin qui svolto i Consiglieri uscenti Furio Coppelli, Piero Fanfani e Nicola Giordano, questi ultimi soci fondatori del Club e pietre miliari dell’allevamento del canarino Lizard in Italia, i quali, anche in veste di semplici soci, continueranno ad offrire il loro prezioso contributo all’attività associativa in termini di esperienza, competenza e professionalità.
Il L.C.C.I. si ripropone di essere uno stimolo ed un motivo di aggiornamento e approfondimento tecnico per gli amanti del Lizard, offrendo risposte a quesiti e chiarimenti a dubbi in merito all’allevamento ed alla selezione della razza.
Il nostro Club annovera tra i propri iscritti i migliori allevatori del mondo, ma ogni socio è ugualmente importante nel fornire il proprio apporto alla tutela ed al miglioramento di un gioiello vivente così antico ed unico come il canarino Lizard.
Vogliamo che i nostri soci traggano giovamento da una sana e leale competizione sportiva, in cui prevalga sempre l’aspetto ludico-ricreativo. La gratificazione espositiva rappresenta certamente l’acme di una pratica come l’allevamento amatoriale che, comunque, sappiamo essere quotidiana. L’ornicoltura è inoltre conoscenza, in senso lato, perché oltre all’apprendimento di nozioni tecnico-scientifiche favorisce anche spostamenti in località diverse e rapporti interpersonali tra individui animati dalla stessa passione ma di varia provenienza, estrazione socio-culturale, occupazione e personalità che, proprio per questo, si arricchiscono umanamente e reciprocamente.
Anche per quest’anno la sede designata per la mostra specialistica è stata individuata nella bella città di Cesena che, avendo ereditato la tradizione
di Bologna, offre garanzie relativamente a capacità organizzative e funzionalità dei locali, oltre ad essere facilmente raggiungibile grazie ad una posizione geografica particolarmente idonea.
Si invitano infine tutti gli amanti della razza Lizard a collaborare con il Club di specializzazione rinnovando o richiedendo per la prima volta l’iscrizione, per la tutela della razza e per poter restare sempre aggiornati o anche solo per scambiare pareri e opinioni con gli altri allevatori entrando nella chat dedicata; per partecipare alle prestigiose mostre specialistiche organizzate annualmente (previste distinte categorie per novizi e campioni); per ricevere il notiziario e il distintivo; per partecipare alle assemblee e pubblicizzare i propri esemplari.
A tal fine si riportano qui di seguito alcuni recapiti:
Presidenza:e-mail: presidenza@lizardcanaryclubitaliano.it
Cell.: 3388803439
Segreteria:e-mail: segreteria@lizardcanaryclubitaliano.it

Cell.: 3474651796 - 3270236871
Sito web:https://www.lizardcanaryclubitaliano.it Facebook:lizardcanaryclubitaliano
Per il L.C.C.I. il Presidente ANTONIO DI TILLIO
Club di specializzazione
44 NUMERO 4 - 2023
Cose risapute?
di SERGIO PALMA, foto F.O.I. e WWW PETS-LIFE NET

In tutti i campi, i soggetti di allevamento altamente selezionati sono tali perché posseggono particolari salienti che caratterizzano una determinata razza o ceppo; questi sono il risultato di ripetuti e continui accoppiamenti tra soggetti scelti. Anno dopo anno, i riproduttori che possiedano quelle volute particolari qualità vengono fatti riprodurre per raggiungere una utopica perfezione. Questo vale per le caratteristiche peculiari dei nostri canarini come forma, posizione e certi tipi di disegni come ad esempio quello del canarino Lizard, o una particolare tonalità di colore come il giallo o come il cinnamon. Tali particolarità, sicuramente, possono verificarsi per caso in alcuni singoli uccelli, ma se questo carattere si verifica
nella progenie, allora lo possiamo definire particolare segno distintivo di un ceppo o di una famiglia e significa che la selezione dura da molte generazioni. Alcuni pensano che questo non possa avvenire negli uccelli selvatici, ma in realtà, a volte, specialmente nella segregazione naturale dovuta a cause ambientali, questo accade. Darwin ha insegnato come la “selezione naturale” indotta dall’ambiente, dal cibo, dalla lotta per la nuda esistenza e la compe-

tizione tra i numeri in eccesso sia la più feroce; non è modificata dalla pietà o capriccio e la Natura non varia i propri metodi se non in maniera lenta, lunga e impercettibile. Essa non sceglie come fa l’uomo, un anno questo e un altro quello, ma la sua condizione è la stessa per generazioni e spesso per secoli; da qui la meravigliosa uniformità e la permanenza dei suoi caratteri come nel piumaggio del Cardellino o del Ciuffolotto quando non è inquinato da alcuna spinta che arriva dall’esterno. È in questo senso che possiamo definire vera la proverbiale frase “simile produce simile”. Hanno tutti lo stesso schema per quanto riguarda il colore e i punti salienti del fenotipo, sebbene alcuni esemplari possano essere meglio sviluppati di altri. È ambizione di ogni allevatore produrre esemplari il più possibile vicini all’optimum ed è ragionevole aspettarsi il maggior numero di giovani idonei da quegli esemplari che mo-
strano al meglio le caratteristiche desiderate. Nel ricercare la grandezza, per esempio, dovremmo naturalmente aspettarci di ottenerla da soggetti che possiedono un’ottima taglia piuttosto che da uno che era stato allevato da genitori di buone dimensioni ma non aveva sviluppato quella qualità. Lo stesso vale per il colore, la forma, la posizione, il piumaggio o qualsiasi altra qualità si desideri selezionare.
È fin troppo facile, anche quando si è in cima alla scala, fare un passo falso e scivolare fino in fondo; quasi impossibile iniziare dal basso e raggiungere la cima se i pioli sono marci; quindi bisognerebbe esortare gli appassionati ad avere sempre quanto di meglio i mezzi permettano. Quando si posseggono soggetti molto vicini allo standard, bisogna tenerli da conto alimentandoli in maniera esemplare e cercare di usarli negli anni in quanto molti soggetti possono essere utili solo per tre o quattro anni,

NUMERO 4 - 2023 45 CRONACA
I riproduttori che possiedano quelle volute particolari qualità vengono fatti riprodurre per raggiungere una utopica perfezione
alcuni anche di più. Pertanto, un uccello eccellente deve essere scartato a fini riproduttivi solo quando non riesce a svolgere le funzioni necessarie. Assicurarsi buoni riproduttori per i quali non importa l’età ma solo se sono in salute. Si ascoltano varie teorie sull’argomento dell’età, ma sicuramente nessuna di esse è valida per tutti, perché ogni allevamento è un micromondo a sé stante ed ognuno di noi ha un suo pensiero. Anche il periodo dell’anno in cui gli uccelli vanno accoppiati ha molte variabili a seconda delle condizioni di luce, temperatura, alimentazione. Non c’è niente



nell’intero ciclo dell’allevamento dei canarini che richieda una mente così fredda come capacità di resistere alle tentazioni ed al “prurito” che tutti abbiamo all’inizio della primavera, o anche prima, per iniziare con le cove. Anche questo oggi è personalizzabile con l’introduzione di apparecchi alba-tramonto, riscaldatori d’ambiente, umidificatori e deumidificatori; è solo l’esperienza che rende saggio l’allevatore in questo senso. La Natura, se solo si volesse studiarla, ha regolato bene ogni cosa per la protezione di tutti ed anche dei giovani uccelli; è l’allevatore
che spesso suole cercare di forzarla con risultati disastrosi. Anche supponendo che si riesca a far deporre le canarine e le uova si dimostrino fertili e si schiudano, ci sono probabilità di non allevare i piccoli proprio a causa della giovane età della femmina che, pur deponendo, non è in grado di accudire la figliolanza. Va ricordato che i giovani robusti sono generosamente ricoperti da una sottile piuma setosa simile a una peluria, che è sufficiente per i primi giorni, mentre la madre li tiene strettamente coperti e lascia il nido solo a intervalli di pochi secondi, per prendere qualche beccata di pastone con cui sfamare i pulli; successivamente la femmina si allontana dal nido più frequentemente e rimane lontana per periodi più lunghi e, quindi, i pericoli aumentano se la temperatura non è adeguata e fa freddo, poiché i giovani senza piume si raffreddano, l’infiammazione si instaura e compromette rapidamente la covata. Naturalmente, solo se proprio necessario, si potrebbe usare il calore artificiale. Altro risultato dell’accoppiamento anticipato sono le decine di uova non fertili che si possono avere. I sintomi di questo desiderio di accoppiare gli uccelli troppo presto sono più o meno gli stessi; generalmente si manifestano in una giornata di sole, magari dopo una breve passeggiata in campagna dove forse ci siamo imbattuti in qualche sprazzo di primavera testimoniato da qualche germoglio


46 NUMERO 4 - 2023
fonte: www.pets-life.net
o mandorlo in fiore o anche giovani foglie di tarassaco: questo a noi sembra infondere nuova vita, facendoci pensare che la nostra sensazione possa influenzare anche il nostro allevamento. Invece, a quel punto, di irrequieto c’è solo l’allevatore e non i suoi uccelli. Il proditorio ritorno del tempo inclemente produce una reazione in noi stessi ma soprattutto negli uccelli, facendoci ritenere di essere contenti di aver resistito alla tentazione di accoppiare i nostri beniamini. “Più si va di fretta, più si arriva tardi”, questo detto dovrebbe essere scritto su ogni porta degli allevamenti. Ora si sa che per il freddo si possono perdere molte femmine a causa della ritenzione dell’uovo; la loro perdita per infiammazione dell’ovidotto è la punizione per aver posto gli uccelli in cova prima che i giorni freddi, bui e tristi dell’inverno siano passati. La politica di aspettare che la primavera sia abbastanza avanzata è, quindi, ovvia. Una regola sicura, basata sul buon senso e sulla lunga esperienza, è quella di attendere la metà di marzo, anche se il tempo è buono nelle zone più meridionali, e fino all’inizio di aprile nell’area centro-settentrionale. Quando l’inverno sta per finire, conviene tenere d’occhio i soggetti destinati alla riproduzione e dividere i maschi dalle femmine, cercando di tenerli tranquilli senza esporli ad elementi che potrebbero farli andare in estro troppo presto. Dovrebbero essere nutriti con una dieta semplice, come scagliola con un po’ di semi condizionatori due o tre volte alla settimana. Quando i maschi gradualmente saranno “pronti”, dovranno essere spostati nelle gabbie da cova se si usano coppie fisse; se invece si usano i maschi “al salto”, bisogna spostarli in gabbie più piccole ma che diano comunque la possibilità di svolazzare. Attenzione ai maschi molesti: normalmente, se lo sono con i propri compagni di svernamento, lo saranno anche con le femmine. Molti appassionati in questo momento commettono un grave errore, dando da mangiare alle loro femmine troppo liberamente il pastoncino all’uovo, trascurando i maschi che molti di noi ritengono di non aver bisogno di particolari cure, con la conseguenza che all’accoppiamento si avranno uova non

fertili. La regola vorrebbe che le femmine devono arrivare in condizione amorosa prima dei maschi. I maschi, comunque, non vanno ingozzati con il pastoncino per non farli ingrassare. Una


regola sicura da seguire è di concedere loro un cucchiaino di pastoncino due volte a settimana e alle femmine la stessa quantità tre volte a settimana. Il maschio sarà quindi pronto contemporaneamente alle femmine per accoppiarsi. Si può aggiungere del niger alla dieta di semi delle femmine, in giorni diversi da quelli in cui si somministra il pastoncino. Quando gli uccelli sono pronti per essere accoppiati, si posiziona il nido tra i due posatoi, con il fondo a livello con loro, o quasi, lasciando che la parte superiore del nido sia a circa 3 cm dai posatoi; questo offrirà agli uccelli uno spazio ottimo e, stando in piedi, potranno tranquillamente alimentare i nidiacei. Tutte queste disposizioni di nido e posatoi, tuttavia, sono interamente questioni di gusto, poiché in realtà non significa molto se i canarini svolgono il loro esercizio perenne con dei salti. C’è, tuttavia, un vantaggio nel mantenere la parte superiore del nido appena sopra il trespolo, poiché obbliga la femmina a lasciare il nido, con meno probabilità di trascinare fuori con sé i piccoli. Quando la parte superiore del nido è appena sopra i posatoi, la femmina di solito si alza e si avvicina al bordo del nido e poi salta sul posatoio. Dopo la costruzione del nido e i canonici tredici giorni di incubazione, se le uova sono state fecondate, ci sarà la schiusa e i pulli verranno alla luce. Da lì comincia un altro ménage.

NUMERO 4 - 2023 47
Quando l’inverno sta per finire, conviene tenere d’occhio i soggetti destinati alla riproduzione
Assistenza alle coppie nidificanti
testo di RAFAEL ZAMORA PADRÓN (*), foto MOISÉS PÉREZ (LPF)
Il nuovo anno, nel centro di allevamento del Loro Parque Fundación, è iniziato con l’incipiente riproduzione di alcune specie che di solito iniziano ad accoppiarsi qualche mese dopo. Questo indicatore risponde ad un inverno particolarmente mite in termini di temperature che, in questa ultima stagione, non sono state molto basse. Le nuove coppie e quelle che si stavano preparando dalla fine della scorsa estate, hanno dato una risposta immediata agli stimoli offerti.




Frequentemente l’inizio dell’anno nei centri riproduttivi del mondo, in particolar modo all’inizio della stagione riproduttiva, si caratterizza per alcuni risultati di uova sterili. Cosa che può essere considerata normale se gli esemplari di ciascuna coppia non sono stati in grado di stimolarsi a vicenda in modo corretto e sincronizzato. Le Ara, ad esempio, sono già con i loro primi pulcini e ciò fa presagire buoni risultati per quelle coppie che avranno il tempo di portare comodamente a termine le loro seconde covate.
I pappagalli Eclectus hanno pulcini impiumati che mostrano il loro vigore sin dal momento della schiusa. Questo è un altro dettaglio che indica che i genitori hanno avuto una buona alimentazione e che le loro condizioni sono ottimali in questo periodo dell’anno. Nel caso delle specie australiane, molte sono alla loro seconda covata poiché ini-


ziano nel nostro inverno; questo è il momento in cui si dovrebbe prestare at-

48 NUMERO 4 - 2023 ONDULATIEDALTRI PSITTACIFORMI
(*)Direttore Scientifico Fondazione Loro Parque
Pulcino di pappagallo Ecletto con nuove piume lucenti che indicano che i genitori hanno seguito una buona dieta
Gli esemplari riproduttori devono ricevere stimoli nutrizionali durante la fase riproduttiva per ottenere energia. In foto: Eunymphichuscornutus
tenzione alle giovani coppie che non hanno iniziato così presto e, quindi, si
accoppiano all’inizio della primavera. È importante distinguere tra il mangime di supporto per i riproduttori, costituito




da mangime extra proteico, facile da consumare, e cibo “verde” (verdure ed erbe stagionali) che aggiunge umidità alla mi-

scela poi rigurgitata dai genitori. Quando si tengono coppie in fasi diverse, è un errore comune dare loro lo stesso cibo con la stessa frequenza. Questo dovrebbe essere evitato perché se viene dato troppo cibo a coloro che non hanno iniziato la riproduzione, possiamo andare incontro a problemi di infertilità e aggressività. Nel caso di coppie che non hanno ancora effettuato la prima deposizione dell’anno, dovrebbero essere somministrate a giorni alterni quantità moderate di cibo “verde” e pochissimo pastone per l’allevamento, in modo che si abituino a questo tipo di cibo. Per le coppie già con pulcini, le quantità dovrebbero essere costanti giornalmente, soprattutto nelle prime ore del mattino e in funzione della taglia dei pulcini e del loro numero. Rinnovare queste poppate supplementari a mezzogiorno è importante e, spesso, nel tardo pomeriggio stimolerà anche i giovani genitori a dare un ultimo pasto alla prole.


NUMERO 4 - 2023 49
Pulcini di Pappagallo ali bronzate (Pionuschalcopterus)
Con la F.O.I. ci divertiamo
testo e foto di ROSA MEOLA
Ero impegnata con la pulizia delle gabbie e i vari accessori per ospitare al meglio i miei beniamini per la nuova fase riproduttiva; osservavo i riproduttori da utilizzare per la selezione delle nuove coppie e ad un certo punto gli occhi si sono fermati ad osservare la Nostra Bandiera: quella della F.O.I. Guardandola, mi sono ricordata di tutto quello che abbiamo fatto quest’anno.
Con l’apertura della stagione espositiva abbiamo girato l’Italia partendo dal Sud, passando per il Centro e giungendo fino al Nord incontrando molti amici e, con la scusa delle vittorie, si andava a festeggiare in ristoranti e pizzerie (con il rammarico della mia dietista che non riesce a farmi perdere peso).



Con la mia Associazione, abbiamo fatto didattica ornitologica con dei bambini favolosi e grazie alla Nostra mitica Federazione, che ci ha fornito molto materiale didattico, abbiamo fatto felici molti bimbi, anche se noi eravamo più felici di loro nello starli a guardare. Abbiamo partecipato alle riunioni del

nostro amato Raggruppamento, ci siamo incontrati nei vari allevamenti per discutere quali mangimi utilizzare, che tipo di pastone usare e alla fine sono volati i giorni e i mesi. Mi chiedo, se non ci fosse stata la F.O.I., tutto il popolo appassionato di questo hobby cosa avrebbe fatto. Certe volte mi trovo con delle amiche, che non condividono il nostro Hobby, le quali, chiac-
chierando, mi dicono che si annoiano, che fanno sempre le stesse cose, che un viaggio è uguale ad un altro. Noi con la F.O.I. non ci annoiamo; magari ci “arrabbiamo” per qualche sciocchezza e poco dopo siamo felici per un altro motivo ma restiamo sempre attivi, sempre felici. Ecco perché dico che con la F.O.I. ci divertiamo.
Grazie, F.O.I.

50 NUMERO 4 - 2023 CRONACA
Birdgardening
Ovvero il giardino per gli uccelli
di DINO TESSARIOL, immagini dal volume “Birdgarden” di A. ZAFFIGNANI MEZZATESTa, Ed. GiorgioMondadori, 1992 e WWW.LIPU.IT

Credo che il sogno di ogni ornitologo appassionato sia quello di poter osservare quanti più uccelli possibile, meglio ancora se intorno alla propria abitazione, ma questa esigenza di ritorno alla natura è ora sentita anche da molte persone comuni e questo pensiero “ecologico” si sta diffondendo con grande rapidità in un’epoca ormai segnata da una perdita globale di biodiversità e di impegno, anche politico, sulla riconversione e sul recupero dell’ambiente Terra.
Da oltre quarant’anni ho la fortuna di abitare in una zona di grande valore naturalistico ed ambientale che mi ha permesso di affinare tecniche e conoscenze per avere sempre tante specie di uccelli intorno a casa per le mie ricerche scientifiche; mi sto anche cimentando nella stesura sintetica di progetti per valorizzare e/o riconvertire alla natura aree
deturpate e dismesse. Anche nella mia passata vita professionale da geometra ho progettato numerosi impianti di fitodepurazione delle fognature civili che danno la possibilità di piantumare essenze ad alto consumo d’acqua organica e che possono diventare dei piccoli biotopi ad indirizzo naturale.

Il Nord Europa, da sempre all’avanguardia nel rispetto e nella tutela degli uccelli, già da anni pratica il “birdgardening”, che altro non significa che “il giardino per gli uccelli”.
Nulla di impossibile e di complicato, basta conoscere le abitudini e le preferenze sia alimentari che ambientali degli uccelli che frequentano la zona intorno alla nostra casa.
L’estensione dell’area ha un’importanza relativa, anche se una maggior superficie dà la possibilità di piantumare un maggior numero di alberi e cespugli e quindi offrire maggiore rifugio ed alimentazione per gli uccelli; anche se il nostro giardino si trova in un ambiente urbano, il risultato potrà essere comunque buono perché, specialmente negli ultimi anni, molti uccelli si sono ambientati in città e nei parchi cittadini, in quanto maggiormente al riparo dai predatori.
A volte è possibile partire da zero, se il nostro giardino è ancora da realizzare; altre volte, avendo un giardino già realizzato, serve convertirlo ed adattarlo a

NUMERO 4 - 2023 51 CRONACA
Esempio di giardino per gli uccelli, fonte: Birdgarden, ed. GiorgioMondadori, 1992
Ospiti autunnali, fonte: Birdgarden, ed. GiorgioMondadori, 1992
La disposizione di siepi e piante può essere casuale e quindi l’effetto sarà maggiormente selvatico
richiamare la presenza dei nostri amati volatili.
La prima azione da mettere in atto, che spesso è più importante della presenza di cibo, è quella di fare in modo che ci sia la presenza di acqua, sufficientemente pulita, durante tutto l’anno. Non intendo “pulita” nel senso di potabile, ma che non sia marcescente o maleodorante a seguito di stagnazione, caduta delle foglie o presenza di animali non graditi. Ideale sarebbe ricavare un piccolo ruscelletto con l’acqua in movimento almeno per qualche ora al giorno, sufficiente per ossigenarla e quindi depurarla, ma anche un piccolo laghetto con acqua ferma può bastare, a patto che si immetta qualche pesciolino che si nutre delle uova di zanzara e qualche pianta per depurare l’acqua stessa, quali per esempio il papiro, le ninfee, il giacinto d’acqua e la lattuga acquatica. Come materiali si possono usare le apposite forme in plastica poco profonde per il laghetto e dei coppi degradanti in leggera pendenza per il piccolo ruscello; se vogliamo creare l’acqua in movimento basterà stendere un tubo in plastica per acquedotto sotto i coppi del ruscelletto e a valle creare una piccola pozza dove far pescare una pompa che, quando accesa da un orologio temporizzatore, faccia tornare l’acqua al laghetto superiore. È più complicata la spiegazione che la realizzazione. Risolto l’argomento dell’acqua, possiamo iniziare a scegliere le piante da
mettere a dimora, ricordando che devono essere adatte a procurare un rifugio sicuro e una adeguata alimentazione per gli uccelli. Per quanto riguarda la creazione di un rifugio, che molto spesso è usato anche come dormitorio, sono molto adatte delle siepi miste o delle piante singole di bosso, le edere di tutte le specie, il carpino che mantiene le foglie secche anche d’inverno ed il bambù, con l’avvertenza di metterlo a dimora su vasi o recinti metallici interrati per evitare che si moltiplichi, essendo una pianta pioniera che in poco tempo si propaga a dismisura. Anche l’alloro ed il lauro a foglia piccola, con le loro foglie sempreverdi, offrono un ottimo rifugio per gli uccelli. Passando a piante e cespugli adatti ad alimentare gli uccelli, non c’è che l’imbarazzo della scelta; io ne elenco alcune che possono essere individuate in base ai gusti ed agli uccelli che si vogliono attirare.
L’edera, il sambuco, l’alloro, il ligustro, la fitolacca, la rosa canina, il biancospino, il crataegus, il sorbo degli uccellatori, il bagolaro, l’agrifoglio, il mirtillo oltre a piante annuali come il girasole, bello anche da fiore, la scagliola, il ravizzone, il sorgo. I primi sono degli ottimi produttori di bacche necessarie agli uccelli soprattutto nel periodo invernale quando gli insetti scarseggiano; le erbacee elencate per seconde offrono sementi e cereali graditi ai granivori. Da ricordare che gli uccelli sono degli ottimi



disseminatori e quindi bisogna regolare il disseminarsi spontaneo, soprattutto delle piante da bacca, altrimenti nel giro di qualche anno ci troveremo con un bosco impenetrabile a danno delle radure a prato, molto importanti per l’alimentazione sul terreno e per ammirare gli uccelli in volo.
La disposizione di siepi e piante può essere casuale e quindi l’effetto sarà maggiormente selvatico o rispettoso di una disposizione secondo i propri gusti e geometrie; l’importante è che le piante da bacche non siano raggruppate tutte insieme, perché allora non vedremo mai gli uccelli volare in quanto troppo fermi, e che siano presenti, appunto, delle belle radure per il volo libero. Naturalmente in un giardino di questo tipo sarà assolutamente bandita la chimica, sia nella concimazione, per la quale bisognerà adoperare sostanza organica naturale come letame, stallatico o terriccio, sia per i trattamenti che dovranno seguire i dettami dell’agricoltura biologica, con l’impiego di bentoniti e rame per le malattie fungine e oli essenziali o infusi vari per il controllo degli insetti dannosi, col grande vantaggio che questi ultimi saranno regolati dagli uccelli insettivori.
Di grande importanza per richiamare gli uccelli sono i nidi artificiali da appendere sui muri della casa o ricavati su piccole strutture a secco, magari per il contenimento di pendenze o terrapieni, fissati agli alberi a diverse altezze e con
52 NUMERO 4 - 2023
Lo stagno, fonte: Birdgarden, ed. GiorgioMondadori, 1992
Ospiti primaverili, fonte: Birdgarden, ed. GiorgioMondadori, 1992
un’uniforme distribuzione; per fare alcuni esempi, è utile appendere anche un paio di ricoveri diurni per le nottole ed i pipistrelli, che sono feroci sterminatori di zanzare, un nido per la civetta sul tetto od al riparo di un camino della casa allo scopo di dare riparo ad un animale utile per contenere i piccoli micromammiferi come topolini e toporagni che spesso d’inverno si intrufolano furbescamente nelle case; poi ancora nidi per cinciallegre e cinciarelle, codirossi e pigliamosche, la cui utilità la esprime il nome stesso; nidi per rondini, rondoni e balestrucci che puliranno l’aria dai moscerini e qualcosa per lo scricciolo che farà piazza pulita dei ragni. Altri tipi di nidi saranno scelti a seconda del contesto ambientale esterno e delle specie già presenti, indirizzando la scelta alle specie che maggiormente ci posso attrarre. Per esempio, se avessimo la fortuna di abitare vicino ad un corso d’acqua potremmo richiamare luì grossi e piccoli; avendo dei salici o dei saliconi potremmo sperare nella meravigliosa nidificazione del pendolino e veder spuntare qualche cannaiola o il canapino. La vicinanza di discariche o aziende agricole ad indirizzo cerealicolo porta la presenza di ratti e sarà utilissimo richiamare il barbagianni, che si alimenta quasi esclusivamente di questi pericolosi mammiferi; se non ci si impressiona nel vedere qualche rapace posato nei dintorni, è semplice issare una bella canna di bambù alta 6/7 metri con un posatoio orizzontale in sommità, indicato per la sosta, appunto, dei rapaci che perlustrano le vicinanze per cacciare le loro prede. Se poi non è troppo complicato, è bene metterci sopra qualche scarto di carne, in modo che la sosta di uno sparviero o di una poiana sia quasi certa. Il massimo sarebbe predisporre in un luogo adatto un bel cesto per richiamare le cicogne che, grazie a progetti di recupero, stanno ricolonizzando molte aree dell’Italia.
Se si ha il dono della manualità, i diversi nidi si possono costruire da sé, altrimenti sul mercato, anche via web, si possono acquistare a prezzi modici. Per tutta la stagione fredda è consigliata l’installazione di qualche mangiatoia anche di forma semplice, basta che sia coperta e regolarmente foraggiata
in quanto molti uccelli rimangono in zona anche con condizioni climatiche avverse, sapendo di trovare del cibo, e possono trovarsi in notevole difficoltà se improvvisamente non sono più in grado di alimentarsi. Come becchime si possono fornire semi di girasole, strisce di lardo, arachidi infilzate ed appese agli alberi, palle di grasso e semi, briciole e resti di panettoni natalizi, oppure conservare bacche e frutta autunnale di cui quasi tutti sono ghiotti, in particolare cachi e mele di scarto che, se non abitiamo proprio in centro città, richiameranno prima o poi tordi e cesene. Verso la seconda metà di marzo si deve eliminare gradualmente la pastura per dare modo ai volatili di reperire in libertà l’alimentazione adatta per l’allevamento dei nidiacei.
Con nidi e mangiatoie in una zona residenziale o agricola con una buona biodiversità vegetale si può tranquillamente attirare qualche decina di specie di uccelli, molti dei quali utili a creare
un ambiente sano, vivibile ed esteticamente bello e ricco.
Come vi sarete resi conto, la realizzazione di un giardino per gli uccelli non presenta grandi difficoltà e ci ripagherà con la bellezza e la gioia di avere sempre molti volatili intorno alla nostra casa. Alcuni bei libri che trattano ed illustrano questo argomento: “Il giardino con le ali” di Cesare della Pietà edito da L’erba, “Il Giardino degli uccelli” di Antonio Romagnoli edito da Il filo di Arianna e “Il giardinaggio per gli animali” di Barbara Rijpkema edito da Ricca.
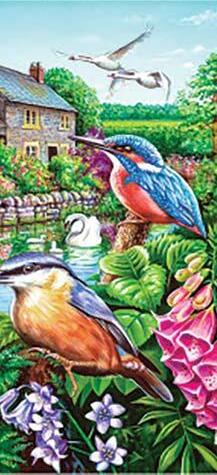

Chi fosse interessato a maggiori notizie, consigli o studi fatti dal sottoscritto sull’utilizzo degli uccelli per la protezione delle colture agricole o anche semplicemente per qualche piccola conferenza, può tranquillamente contattarmi alla mail dino@tessariol.it a al cell/W-app 347 4317892: sarò ben felice di discorrere su questo argomento. Sto predisponendo un sito web amatoriale per la specifica progettazione di giardini e spazi naturali adatti agli uccelli.
Concludo con un riferimento all’Enciclica “Laudato sii” di Papa Francesco che esorta ad impiegare quanto ci è stato offerto da Dio per rendere utilità all’uomo assecondando la natura, che è grande maestra di vita non solo per i cristiani ma per tutti quelli che sperano in un mondo migliore.

NUMERO 4 - 2023 53
Esempio di laghetto artificiale, fonte: www.lipu.it/articoli-natura
Naturalmente in un giardino di questo tipo sarà assolutamente bandita la chimica
Quando si riesce a vedere oltre…
 testo e foto di LIA PORCINO (Presidente del Club del Diamante codalunga & Poephila)
testo e foto di LIA PORCINO (Presidente del Club del Diamante codalunga & Poephila)

Apochi giorni dalla mia elezione a Presidente del Club Codalunga & Poephila, ricevo sulla mia chat privata da parte di Daniele Zanichelli, segretario e socio, un testo che leggo con molta curiosità e attenzione, soprattutto conoscendo le capacità tecniche e letterarie dell’autore in questione.
Devo ammettere che non rimango molto stupita dalla sensibilità di quel-

l’omone che spesso può sembrare, per chi lo valuta con superficialità, anche un po’ burbero e scontroso.
Lì per lì mi sono soffermata sull’aspetto quasi romanzato del testo ma poi sono riuscita a spogliare lo scritto da tutti gli ornamenti che mi avevano colpito all’inizio e che, da bravo scrittore quale è, l’autore aveva inserito (a mio parere) di proposito. È stato allora che sono riuscita a leggere con occhi


54 NUMERO 4 - 2023 CRONACA
ci dimentichiamo che dovremmo innanzitutto amare i nostri piccoli pennuti come parte della famiglia
Spesso
Diamanti di Gould
Pullo di Diamante codalunga
diversi e soprattutto sono riuscita a vedere oltre… così mi sono chiesta: e se avessimo perso la vera essenza del nostro hobby?




Probabilmente siamo troppo concentrati sul nostro ego che ci spinge a voler raggiungere traguardi e successi, a vincere coccarde e trofei e ad ottenere titoli, perdendo così di vista la vera sostanza dell’allevare. Siamo sempre alla ricerca della miscela con le giuste percentuali di semi, del miglior multivitaminico e, un po’ come il piccolo chimico, alla rincorsa delle formulazioni più adatte per “produrre” campioni, tanto che spesso ci dimentichiamo che dovremmo innanzitutto amare i nostri piccoli pennuti come parte della famiglia. Dovremmo considerare che come ogni figlio umano ha il suo carattere e le sue capacità, ma lo amiamo lo stesso nonostante sia timido o non abbia preso il massimo dei voti in un compito di matematica, così le nostre creature piumate andrebbero amate se non ottengono un 95 o un podio. Dovremmo imparare a relazionarci con


loro secondo il loro carattere… perché, ebbene sì, anche loro ne hanno uno! Penso che tutti noi dovremmo imparare a GUARDARE OLTRE, così mi sono detta: “questo testo non può rimanere chiuso in un cassetto!”.

NUMERO 4 - 2023 55
Pulli di Agapornisroseicollis
Ondulato di colore
Novello di Ondulato di colore
Penso che tutti noi dovremmo imparare a GUARDARE OLTRE
Sperando che serva ad altri come spunto di riflessione e che ognuno possa trarre le sue riflessioni personali, come io ho tratto le mie, vi auguro una buona lettura…
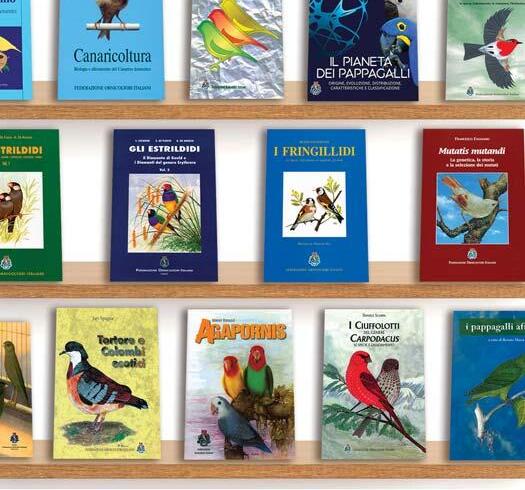
Poche volte ho sentito o letto argomentazioni inerenti al rapporto affettivo che si ha con i propri uccelli; in tanti anni di allevamento ho riscontrato che, oltre ai pappagalli, tutte le specie a loro modo instaurano un rapporto che definirei emotivo con il proprio allevatore. Da allevatore di esotici, nel tempo ho instaurato un legame con tutte le specie che ho allevato e, cosa buffa, per ognuna ho definito il suo carattere. Carattere non inteso per movimenti o abitudini bensì per relazione con l’allevatore.

A tutti è capitato che un uccellino ci indichi che gli manca l’acqua o il mangime: già questo ci dimostra che loro vedono in noi un “essere” dedito alla loro vita e alle loro necessità, non sapendo che anche loro sono lì per le nostre necessità, la mia per esempio è quella di entrare in un’altra realtà.
L’hobby ornitologico è uno dei più nobili che esista poiché richiede attenzione, dedizione e sacrificio da parte dell’allevatore; diciamoci la verità, solo chi ha un pizzico di pazzia può farlo. Si usa dire che i cani assumono il

carattere dei padroni ma, nel nostro caso, siamo noi a dover capire il carattere dei nostri amati pennuti, diversi come sono diverse le dita di una mano.
Alcune specie in particolare manifestano un carattere unico, per esempio:
il Diamante mascherato - timido e dolce
il Diamante di Gould - curioso è diffidente
il Diamante di Kittlitz - pazzo scatenato come lo sono anche gli altri appartenenti al genere Erythrura
il Diamante mandarino - allegro e casinista
il Diamante codalunga - prepotente e burlone (ha una particolare abilità a prendere in giro i pappagalli fino a farli ammutolire, il che - se vogliamo - è un bene)
il Padda - fiero e temerario
il Passero del Giappone - amorevole ma diffidente
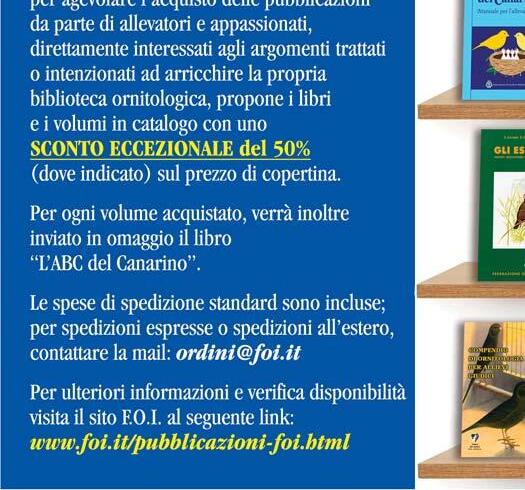
Potrei andare avanti per tanti altri ma credo di aver reso l’idea.
Chissà, magari un giorno oltre ad argomentare delle mutazioni, alimentazioni e fotoperiodi, si inizierà anche a guardare l’allevamento sotto il profilo emotivo e familiare
Grazie per l’attenzione
Con affetto e stima

56 NUMERO 4 - 2023
ANTONIO VENTUROLI
Il Satiné ossidato (alias Bruno Satiné)
Le sue origini e la sua riscoperta
di PEPPINO VITTI, foto E. DELPOZZO e C. ROUSSEL
Se vogliamo parlare delle origini vere e proprie del Satiné ossidato (alias Bruno Satiné), dobbiamo affermare che tale fenotipo ha avuto origine negli anni settanta, allorquando è apparsa la mutazione Satiné. Dico questo perché effettivamente è così! Il Satiné di tipo Bruno non è una nuova mutazione, bensì è una riscoperta, una nuova interpretazione della stessa, e ritengo, senza falsa modestia, di essere stato l’iniziale interprete di tale concetto. Dunque dobbiamo parlare di origini ma anche di riscoperta.
Parlando di origine, dobbiamo fare una disamina della mutazione. Come abbiamo precedentemente accennato, è apparsa negli anni settanta, forse in Argentina, chiamata inizialmente “ino legato al sesso”; alcuni dicono in Olanda, altri ancora asseriscono sia apparsa in un allevamento italiano, ma, non compresa, sia stata in seguito selezionata in Francia da un noto allevatore italo/francese, il sig. Ascheri. È da questo signore che mi sono procurato una femmina per iniziare ad allevare canarini Satiné: una sola femmina, visti i costi poco abbordabili.

Per parlare di riscoperta, bisogna necessariamente accennare anche al comportamento genetico della mutazione Satiné. Senza alcun dubbio possiamo affermare che trattasi di una mutazione sessolegata ed esercita la sua azione inibendo l’eumelanina nera, riducendo qualitativamente l’eu-


melanina bruna, riducendo fortemente la feomelanina. Alcuni ritengono che anche la feomelanina venga inibita ma ho forti dubbi in merito; attualmente troviamo Isabella Satiné con presenza di feo. Si ritiene che sia anche una mutazione allelica alla mutazione Agata. Il sottoscritto, in riferi-

NUMERO 4 - 2023 57 CANARINIDI COLORE
Bruno Satiné mosaico rosso maschio, foto: E. del Pozzo (all. Benagiano)
Tale fenotipo ha avuto origine negli anni settanta, allorquando è apparsa la mutazione Satiné
mento all’allelia, non la pensa allo stesso modo. Comunque, non essendoci in merito riscontri scientifici, ognuno è libero di pensarla come meglio crede.



Stabilito il comportamento genetico, ora occorre fare una precisazione sul livello selettivo del periodo in cui è apparsa tale mutazione: il Nero veniva chiamato Nero-Bruno, presentava strie di eumelanina nera, lunghe e larghe (ben lontane, però, da quelle attuali) nonché una forte presenza di feomelanina; l’Agata presentava delle strie nere ridotte quantitativamente, contornate da una leggera presenza di feomelanina; il Bruno si presentava, nel complesso, con una tonalità bruno-carico e strie eumelaliniche marroni lunghe e larghe (lontano anni luce dalla selezione attuale); l’Isabella si presentava, nel complesso, con un fondo di feomelanina brunastra abbastanza ridotta rispetto a quella del “tipo Bruno” e con strie anch’esse ridotte sia qualitativamente sia quantitativamente. A detta dei colleghi giudici di allora, si conside-
rava Bruno un soggetto più ossidato rispetto a quello Isabella. Da quanto detto sul comportamento ereditario della mutazione Satiné e dal livello selettivo del canarino di colore di quel periodo, posso solo intuire il motivo per cui la selezione del Satiné si è sviluppata verso l’Isabella accantonando il tipo Bruno. Ritengo che in quel periodo



la mutazione Satiné, abbinata ai due tipi, il Bruno e l’Isabella, generasse fenotipi pressoché identici e, quindi, è stato preferito l’indirizzo selettivo verso l’Isabella, mutazione allora più ricercata, poiché in possesso di un fenotipo più chiaro, più luminoso. Oltre a questa mia considerazione ipotetica, dobbiamo anche pensare che in quel periodo si venne a consolidare il concetto (ancora attualmente in essere) che fosse una mutazione allelica alla mutazione Agata e che pertanto i possibili fenotipi riscontrabili fossero solo due:
-Melaninico ad oo.rr. (di tipo Agata)attualmente non più a concorso; -Satiné (di tipo Isabella).
Pertanto, persistendo la teoria dell’allelia, il Bruno Satiné non esisterebbe, né potrebbe esistere! Io, invece, che non ritengo la mutazione Satiné allelica all’Agata, dico che il Bruno Satiné esiste ed attualmente viene ammirato in tutta la sua bellezza. L’inizio del percorso di riconoscimento in atto, anche da parte della C.O.M., ne è la conferma.
Premetto che all’epoca anch’io, allevatore alle prime armi, fidandomi degli esperti, consideravo la mutazione Satiné allelica a quella Agata. Da allevatore principiante, in quel periodo, allevavo solo bianchi, albini e appunto canarini Satiné. Dopo alcuni anni di selezione del Satiné, un bel dì mi propongo di traslare tale mutazione sul Verzellino.
Dall’accoppiamento maschio Verzellino per femmina Satiné, ottengo diversi
58 NUMERO 4 - 2023
Bruno Satiné mosaico rosso femmina, foto: E. del Pozzo (all. Benagiano)
Bruno Satiné mosaico rosso femmina (all. Benagiano) Nero Satiné (all. P. Vitti)
“F1” maschi, naturalmente tutti portatori di Satiné, che riaccoppio con altrettante femmine Satiné, con l’intento di ottenere qualche “R1” maschio Satiné, da riaccoppiare con femmine Verzellino.



Ritenendo la mutazione allelica all’Agata, come è noto, da tali “F1” possono nascere solo Neri, Bruni, Satiné e Melaninici oo.rr. …mai, ripeto mai, soggetti Isabella. Invece, con stupore,



mi sono ritrovato con un paio di femmine Isabella. È da qui che in me si è innescato il concetto della non allelia della mutazione Satiné, e che pertanto fosse possibile inserire tale mutazione

NUMERO 4 - 2023 59
Bruno mosaico rosso femmina (all. Caiazzo)Bruno eumo, foto: E. DEL POZZO (all. Pignatelli)
in tutti e quattro i tipi base, così come tutte le altre mutazioni legate al sesso: il Pastello e l’Avorio. Tutto questo, da componente facente parte dell’allora C.T.N., l’ho fatto presente in un congresso, il primo in assoluto, dei giudici del colore nel lontano anno 2001, ma, come da previsione, sono stato deriso e sbeffeggiato. Con la teoria della non allelia andavo a mettere in discussione, a ribaltare completamente le opinioni dei grandi dell’ornitologia contemporanea. Come poteva un vaso di vetro, il sottoscritto, competere con i tanti vasi di acciaio dell’ornitologia nazionale e internazionale? Sì, sono stato umiliato con aggettivi poco piacevoli! Ho sofferto per questo, tant’è che non mi sono più candidato a componente la C.T.N. del colore. Ma forse questa umiliazione è stata la molla che mi ha dato lo stimolo per selezionare il tanto discusso Bruno Satiné. Dovevo dimostrarlo con i fatti! Un detto dice: “il tempo è galantuomo”, e infatti lo è stato. Il Bruno Satiné oggi è una gran bella realtà che difficilmente potrà essere di nuovo messa in discussione. Per quanto riguarda la differenza tra Isabella Satinè e Bruno Satiné, possiamo approfondire meglio e mettere a fuoco qualche altra caratteristica. In primis, bisogna obbiettivamente riconoscere che è difficile confondere il fenotipo del Bruno Satiné da quello dell’Isabella Satiné. La differenza dei due fenotipi è talmente netta che neanche un ipovedente potrebbe non riconoscerla. I due tipi, inoltre, si differenziano anche per il loro corredo genetico. Dico questo perché io riaffermo, con convinzione, che la mutazione Satiné non è una mutazione allelica, bensì una mutazione che occupa un “locus” differente da quello della riduzione Agata, cosa che, com’è noto, molti altri non ritengono accettabile. Io non intendo convincere alcuno, ma pretendo rispetto per la mia opinione. Il fenotipo del Bruno Satiné è dovuto all’interazione di due “locus” genici: quello del Bruno e quello del Satiné. Il fenotipo dell’Isabella Satiné, invece, è dovuto all’interazione di tre “locus” genici: Bruno-Agata-Satiné. Perché tre nell’Isabella Satiné? Come è ben noto,

l’Isabella non è una mutazione a sé stante, il suo fenotipo è dovuto all’interazione della mutazione Bruno con quella dell’Agata. Pertanto, due “locus” dell’Isabella, più quello del Satiné, fanno tre. A titolo informativo vi dico che un Nero/Isabella Satiné, statisticamente, per crossing-over, è in grado di generare femmine con otto fenotipi differenti: Nero, Bruno, Agata, Isabella, Nero Satiné, Bruno Satiné, Agata Satiné (Melaninico oo.rr.), Isabella Satiné.

Attualmente sto cercando di selezionare il Nero Satiné; ho un paio di soggetti Nero/Satiné e un unico maschio Nero Satiné. Voglio sperare che quest’anno mi vada meglio degli anni scorsi. Il Nero Satiné è un canarino meno appariscente rispetto al tipo Bruno, si presenta con un leggero disegno velato lungo e largo, oo.rr. Tale selezione a me serve solo per una riconferma della non allelia della mutazione. La selezione del tipo Nero Satiné deve essere indirizzata ad ottenere un disegno leggero ma visibilmente il più apprezzabile possibile. Per quanto riguarda la selezione del Satiné ossidato a oggi, è la C.T.N. “Colore” che dà le direttive e tutti hanno l’obbligo di rispettarle, anche se non si condividono. Come dovrebbe essere il Bruno Satiné? I soggetti devono presentare un disegno lungo, largo e simmetrico, quantitativamente identico a quello del Bruno classico, ma ridotto qualitativamente, beige molto scuro, non marrone, e deve interessare il dorso, i fianchi e la testa. Si deve estendere su un fondo in cui persiste la presenza di una leggera patina di feomelanina.
L’effetto del contrasto tra disegno e fondo, tipico della mutazione Satiné, permane evidente anche nel tipo Bruno, poiché il disegno più scuro (rispetto al tipo Isabella) sopperisce alla leggera presenza della feomelanina di fondo. Occhi rosso/bruno abbastanza netti. Perché ritengo che il disegno deve essere beige scuro e non marrone, su un fondo in cui deve persistere una leggera patina di feomelanina? Secondo me per differenziare nettamente tale selezione da quella del Bruno Eumo, il quale si presenta con disegno marrone, leggermente ristretto rispetto al tipo base e con un fondo in cui il lipocromo è molto brillante grazie all’azione più spinta sulla riduzione della feomelanina.
In Italia siamo stati i primi a selezionare il tipo Bruno Satiné; ora anche all’estero, in Francia e Spagna, lo stanno allevando con ottimi risultati. Dalla Francia, l’amico Claude Roussel, con cui sono in contatto, mi ha mandato delle foto di soggetti molto interessanti.

60 NUMERO 4 - 2023
Bruno Satiné bianco (all. C. Roussel)
Bruno Satiné intenso rosso, (all. C. Roussel)
Aggiornamenti su attività divulgative e non solo
testo e foto di GIUSEPPE ALBERGO
Cari Amici, siamo sempre più felici di raccontarvi come le nostre attività vanno avanti sostenute dal vostro appoggio e consenso. Questa volta vi parliamo di tre incontri, di seguito documentati:
- L’Associazione Piccoli Appassionati di Canarini è stata ospite del Villaggio Berukhà di Bari che assiste minori e adulti diversamente abili. Anche qui abbiamo portato momenti di svago e spensieratezza iniziando il nostro laboratorio con le immagini dei canarini dalle loro origini alle loro mutazioni, fino ad arrivare ai nostri esemplari odierni. C’è stato un scambio emotivo molto forte perché la meraviglia e la curiosità manifestata dai ragazzi ci ha regalato veramente tanta soddisfazione.


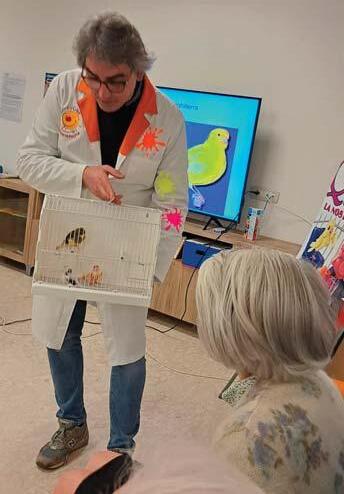

Il nostro laboratorio didattico, avvalendosi di immagini proiettate su un maxi schermo, permette ai presenti di conoscere realtà magari a loro sconosciute e si completa con la conoscenza sensoriale perché diamo loro la possibilità di toccare e scoprire da vicino come è fatto un canarino. Basta guardare le foto scattate in quei momenti per capire quanto questo scambio emozionale abbia gratificato sia noi che loro. L’obiettivo di contagiare, divulgare, trasmettere la nostra passione anche questa volta è stato raggiunto!
- La nostra “missione” divulgativa ci ha poi portato alla Fondazione Giovanni Paolo II di Bari San Paolo. Anche qui abbiamo presentato ai bambini della struttura la provenienza del ca-

NUMERO 4 - 2023 61 CRONACA
narino, le sue abitudini e quanto la sua presenza e compagnia rappresenti un valore aggiunto dal punto di vista educativo, espressivo ed emozionale. I bambini erano incuriositi e pronti a conoscere tutto quello che riguarda la vita di un canarino. Alle loro domande e richieste è seguito un momento di conoscenza sensoriale dell’animale; infatti, molti non avevano mai avuto la possibilità di guardare da vicino le loro movenze. Siamo riusciti a sollecitare la loro curiosità, invogliandoli a tenere in casa un animaletto, tant’è che qualche giorno dopo la piccola Giada accompagnata dalla sua mamma è venuta a trovarci in allevamento per scegliere un canarino giallo che le abbiamo volentieri donato. - I nonni patrimonio di saggezza, ricchezza d’animo e turbinio di emozioni! Un’esperienza singolare, perché siamo stati ospiti del Centro Riabilitativo per Anziani Elisir di Bari. Un incontro spe-



ciale perché ha risvegliato i ricordi giovanili di molti nonnini che hanno cresciuto canarini o comunque avuto in casa un uccellino. Mi guardavano commossi ed è qui che ho ricevuto il più bel complimento da quando ho iniziato con la nostra associazione l’esperienza della Didattica Pet. Una nonnina, ex insegnante mi ha detto: “Giuseppe, tutto l’amore che provi per questi esserini lo trasmetti perfettamente a chi ti guarda e ti ascolta, ti brillano gli occhi perché ami quello che fai.” Ditemi voi se posso non essere felice!
Non smetterò mai di ringraziare la FOI e tutti voi che sostenete le nostre iniziative. Ci piacerebbe soltanto che più persone possibili ci aiutassero in questo intento; invitiamo pertanto Voi lettori a contattarci.
Giuseppe Albergo
contatti: cell 3403039199


email: associazione.apac@gmail.com

62 NUMERO 4 - 2023
Attività F.O.I.
Sintesi verbale del Consiglio Direttivo Federale del 3 e 4 febbraio 2023
(La versione integrale è pubblicata sul sito www.foi.it/verbali)

Il CDF esamina le risultanze finali del bilancio consuntivo, analizzando le singole voci e procedendo alla comparazione delle stesse rispetto alle previsioni di bilancio.
Il CDF delibera quanto segue:
-le gabbie e le attrezzature ornitologiche vengono ammortizzate con aliquota del 10%, valutando le condizioni del parco gabbie;
-viene ammortizzato al 50% il costo pluriennale per programma mostre;
-viene interamente utilizzato il fondo accantonamento assemblea giudici a parziale copertura del costo sostenuto nell’anno;
-viene parzialmente utilizzato il fondo accantonamento Campionato Internaz. Clubs di specializzazione per euro 14.865,18, a copertura costi sostenuti per l’iniziativa;
-vengono svalutati ulteriormente del 50% i tablet assegnati in comodato ai giudici.
Il CDF delibera altresì la destinazione del 5 per mille a copertura costi museali.
Il CDF approva la stesura definitiva del bilancio consuntivo 2022 che presenta un avanzo di gestione pari ad euro 38.342,43.
Il CDF delibera l’approvazione del Bilancio Sociale 2022 che consta delle seguenti sezioni: metodologia, informazioni generali sull’ente, struttura governo e amministrazione, persone che operano per l’ente, obiettivi e attività, situazione economico-finanziaria, altre informazioni, monitoraggio svolto dall’organo di controllo.
Il CDF delibera l’approvazione del bilancio preventivo 2023 di cui al documento del quale si dispone allegazione al presente verbale, sì che dello stesso costituisca parte integrante e sostanziale.
-Sede Campionato Italiano 2023: determinazioni;
Il CDF da atto del pervenimento della candidatura per l’organizzazione del Campionato Italiano 2023 del comitato costituito dalle associazioni di Pescara, Chieti, Sulmona, Teramo, L’Aquila e Lanciano. La proposta prevede due possibili località alternative individuata in Pescara Fiere e Lanciano Fiera. Il CDF in tempi brevi provvederà ad effettuare un sopralluogo al fine di verificare l’idoneità dei locali. Non essendo allo stato pervenute altre proposte il CDF riterrà con titolo preferenziale quella di cui si è innanzi riferito.
Il CDF delibera la concessione dei contributi in favore degli Organi di seguito partitamente indicati:
CTN-CFPA euro 1.500,00
CTN-CANARINI DI COLORE euro 2.000,00
CTN-CFPL euro 1.500,00
CTN-EFI euro 1.000,00
CTN-O&aP euro 2.500,00
Non si dispone la concessione di contributo alla CTN Canto in quanto non ancora pervenuto dalla stessa alcun rendiconto.
-Attivazione Piattaforma Intranet FOI per inserimento Mostre 2023; Per l’inserimento delle mostre nella piattaforma intranet e per le successive attività di verifica e di approvazione, il CDF conferma la seguente calenda-
rizzazione, come già utilizzata per la stagione Mostre dello scorso anno 2022:
-Fino al 31 marzo 2023 quale termine ultimo di inserimento per le associazioni e per i Club;
-Fino al 15 aprile 2023 per i Presidenti di Raggruppamento (verifica di rispondenza delle mostre alla nomenclatura regolamentare ed al rispetto delle relative prescrizioni, approvazione).
Le richieste di organizzazione di mostre saranno ammissibili e procedibili solo se accompagnate dal versamento di una quota pari al 30% (trenta) del costo Giudici, come previsto dall’ art. 7 del Regolamento Generale Mostre.
Il CDF, preso atto della decisione assunta dall’assemblea straordinaria dei soci dell’Ass. Ornitologica Centese (cod. 135) tenutasi in data 15/12/2022, ne dispone la disaffiliazione.
Il CDF, preso atto che le associazioni Carbonia (cod. 096), ASAO (cod 448), Cellarium (cod. 487), appartenenti al Raggruppamento Sardegna, e l’associazione ANXUR (cod. 509) appartenente al Raggruppamento Lazio, non hanno fatto pervenire alcun tesseramento di soci al 31 dicembre 2022, ne dispone la disaffiliazione.
Il CDF, in relazione alla richiesta di revoca del riconoscimento avanzato da consiglio direttivo del club del canarino Phaeo e Topazio, prima di procedere in tal senso, ritiene di effettuare ulteriori approfondimenti.
Il CDF, con riferimento alla richiesta pervenuta dalle associazioni Recanatase Val Musone, Centro Marche e Sambenedettese in ordine alla istituzione del Raggruppamento Marche, ritiene di doverla denegare per le seguenti motivazioni:
-la costituzione di un nuovo raggruppamento è deliberata dal CDF; -non si appalesa intendimento di questo CDF deliberare nei sensi di cui innanzi anche in considerazione che la richiesta proviene da una minoranza di associazioni (tre su sette presenti nel territorio della Regione Marche);
-la richiesta è pervenuta durante la decorrenza del termine per la presentazione delle candidature.
Il CDF, in accoglimento di specifica richiesta concede l’utilizzo all’Associazione Ornicoltori Salernitani del furgone per il trasporto degli animali vivi, al fine di consentire il convogliamento verso la mostra internazionale in programma per il mese di ottobre 2023.
Il CDF delibera l’erogazione del contributo annuale di affiliazione all’associazione EmaF (Esotici ma Familiari) della quale la FOI è socio fondatore.
Il CDF, dopo aver esaminato le conclusioni cui perviene l’Ordine dei Giudici nella relazione allegata al proprio verbale del 5 dicembre 2022 (delibera n. 27/2022), delibera quanto segue:
-Apertura di procedimento disciplinare nei confronti del sig. Roberto Rossi (RNA 8679) ai sensi degli artt. 16 e 17 del Regolamento Organico nella graduazione che si terrà configurabile nel caso all’esame;
-Lettera di biasimo da inoltrare ai signori Vitale Raffaele e Varriale Fabrizio.
NUMERO 4 - 2023 63
Attività F.O.I.
Il CDF ratifica la delibera n. 24 del 23 settembre 2022 contenuta nel verbale dell’ODG in pari data in particolare approvando lo standard del canarino Timbrado e disponendo la pubblicazione dello stesso sul sito istituzionale della FOI.
Il CDF ratifica la delibera n. 25 del 23 settembre 2022 contenuta nel verbale dell’ODG in pari data in relazione alle dimissioni del giudice Ivan Fontana.
Il CDF, relativamente alle proposte di ratifica delle decisioni della CTN-CFPL di cui alla delibera n. 26 del verbale dell’ODG del 23 settembre 2022 così provvede:
-Ratifica le delibere n. 3/2022 CTN (Bossù belga) e n. 11/2022 (Gloster Fancy);

-Pur ritenendo apprezzabili i profili tecnici esaminati nelle scale valori afferenti le razze Border, (delibera n. 1/2022 CTN), Crest (delibera n. 2/2022 CTN), Norwich (delibera 4/2022 CTN), Scotch Fancy (delibera n. 5/2002 CTN) e Yorkshire (delibera n. 6/2022 CTN), il CDF al fine di scongiurare ipotesi di sviamento degli allevatori che si ritroverebbero al cospetto di schede di giudizio differenti a seconda delle tipologie di mostre, indica la preventiva devoluzione delle predette proposte al vaglio dell’OMJ affinché possano essere valutate da prima in quella sede.
Il CDF ratifica la delibera n. 29/2022 del 5 dicembre 2022 contenuta nel verbale dell’ODG in pari data in relazione alle dimissioni del giudice Francesco Fontana.
Il CDF, pur considerando la volontà di semplificazione delle procedure di acquisizione delle prove documentali circa l’effettività della pratica di allevamento nella sezione di appartenenza del giudice ritiene ancora in questa fase di confermare l’obbligo di cui all’art. 31 lettera B del Regolamento ODG, sospendendo ogni determinazione in ordine alla ratifica della delibera n. 30 di cui al verbale ODG 5 dicembre 2022. Con riferimento invece alla formazione della Commissione di cui è cenno nella medesima delibera, peraltro già disciplinata dal Regolamento ODG, il CDF si esprime favorevolmente alla stessa.
Il CDF, dopo aver visionato il preventivo di spesa ricevuto dalla ditta Officine Grafiche Soc. Coop. di Palermo, delibera l’accettazione dello stesso per la stampa di n. 1.000 volumi di un nuovo lavoro di Giovanni Matranga con titolo “AVIFAUNA D’ITALIA VOL. 2. Il prezzo di vendita al pubblico viene determinato in euro 35,00. Il CDF ringrazia l’Autore per il senso di appartenenza costantemente dimostrato.
Sintesi verbale del Consiglio Direttivo Federale del 24 e 25 febbraio 2023
(La versione integrale è pubblicata sul sito www.foi.it/verbali )
Il CDF dà atto della tenuta della riunione con l’ODG e con le Commissioni Tecniche Nazionali sull’argomento di cui in intestazione. La stessa si è sviluppata in un clima di cordialità e di collaborazione e gli esiti conclusivi hanno rimarcato la volontà di ognuno dei rappresentanti dei predetti Organi di riaffermare il rispetto dei ruoli, aumentando ancora di più l’interazione e l’intercomunicazione. L’incontro è stato poi una favorevole occasione per soffermarsi sulle prospettive programmatiche della Federazione a breve termine e per precisare i compiti di ognuno in chiave di raggiungimento degli obiettivi più urgenti.
Il CDF ha ricevuto le dimissioni del Consigliere Davide Soncini a mezzo mail del 26/01/2023. Le stesse sono state fondate su motivazioni di carattere personale e di impegno lavorativo. Il CDF, anche in considerazione dei rapporti interpersonali, ha invitato il Consigliere Soncini a riconsiderare la sua decisione che però dopo una ulteriore riflessione è stata confermata.
Il CDF ringrazia il Consigliere Soncini per l’impegno profuso e per il lavoro svolto a vantaggio del movimento federale e gli augura ogni bene personale e professionale.
Il CDF istituisce un gruppo di Lavoro per il miglioramento e l’ottimizzazione della funzionalità del Programma Ornimostre.
I componenti del Gruppo verranno convocati in presenza presso la Sede Federale il giorno 18 marzo 2023 alle ore 10,00, laddove incontreranno il responsabile della Dinamoweb per dare corso all’inizio delle attività. Seguiranno riunioni in videoconferenza a cadenza di 10 giorni ed i lavori dovranno essere completati entro la fine del mese di maggio.
ll CDF delibera la concessione ai Raggruppamenti Regionali ed Interregionali i seguenti contributi ordinari per l’anno 2023: -Piemonte Valle d’Aosta, euro 1.000,00;
-Liguria, euro 2.500,00 (di cui 1.276 per rimborso spese anticipate dal Presidente);
-Veneto Trentino Alto Adige, euro 2.500,00;
-Emilia Romagna, euro 2.000,00 (di cui 1.300,00 a titolo di spese di viaggio di convogliatori);
-Marche Umbria, euro 1.000,00;
-Abruzzo Molise, euro 1.500,00;
-Lazio, euro 3.000,00 (per rimborsi non ancora effettuati);
-Campania, euro 1.500,00;
-Puglia Basilicata, euro 1.500,00;
-Calabria, euro 1.500,00;
-Sicilia, euro 2.000,00;
-Toscana, euro 1.500,00;
I contributi come sopra determinati potranno essere parzialmente utilizzati per attività di convogliamenti.
Il CDF delibera la concessione al Presidente dell’Ordine dei Giudici il seguente contributo ordinario per l’anno 2023: euro 3.000,00.
Il CDF delibera di accettare il preventivo di spesa della ditta Bertani & C. srl di Cavriago (RE) per la stampa di n. 10.000 quaderni didattico divulgativo. Il CDF, in accoglimento della richiesta pervenuta dall’associazione ARO, su parere favorevole del Raggruppamento Regionale Lazio, concede un contributo di euro 350,00 per il convegno ornitologico da tenersi a Colleferro il 26 marzo 2023.
Il CDF delibera l’accettazione del preventivo della Cremona Ufficio pervenuta in data 23/02/2023 per l’acquisto di una stampante Badge e di un videoproiettore con relativi accessori.
Il CDF delibera l’accettazione del preventivo pari ad euro 1.000,00 (oltre IVA) pervenuto dalla ditta Goodnight Agency di Marigliano per sviluppi grafici e stampati vari.
64 NUMERO 4 - 2023
































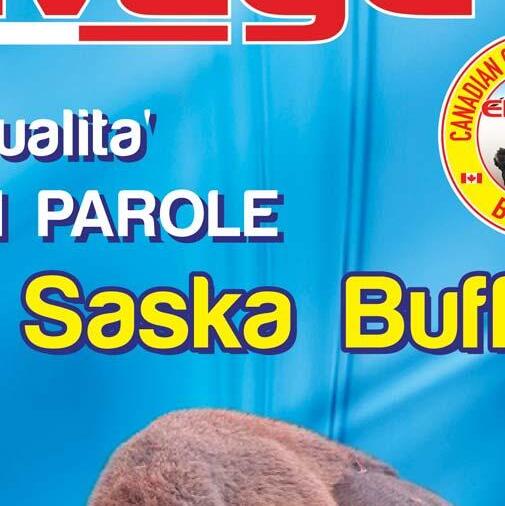

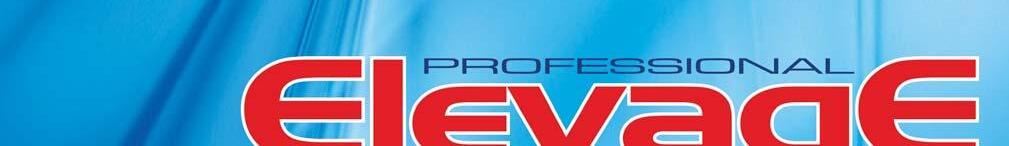






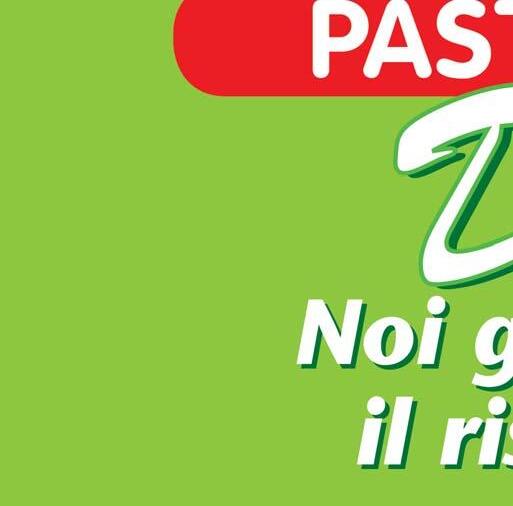

















































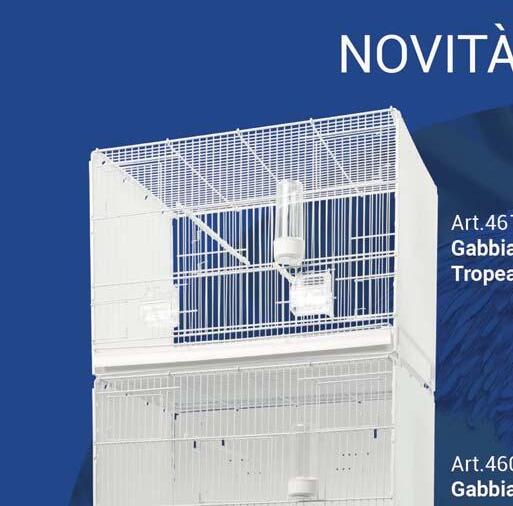












































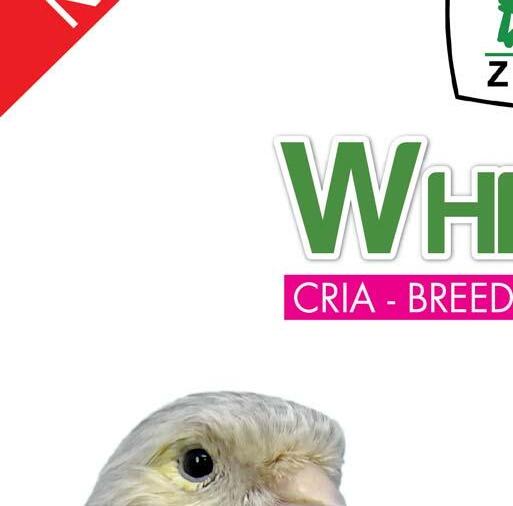















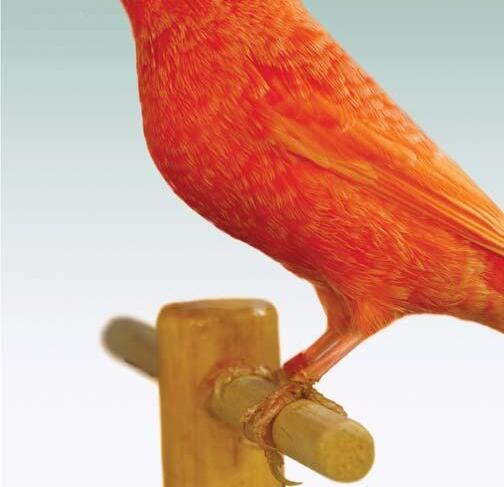




















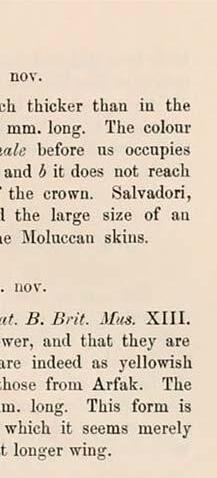




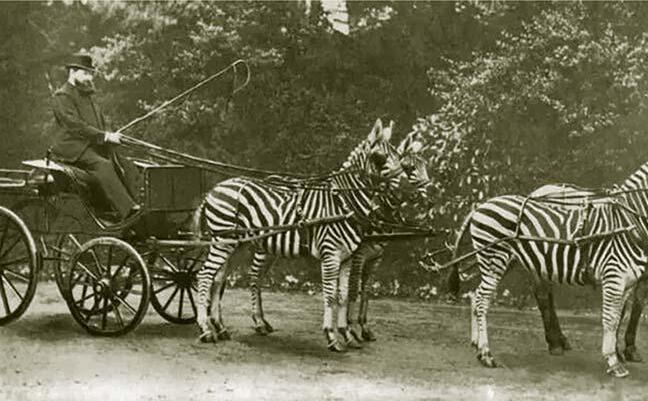
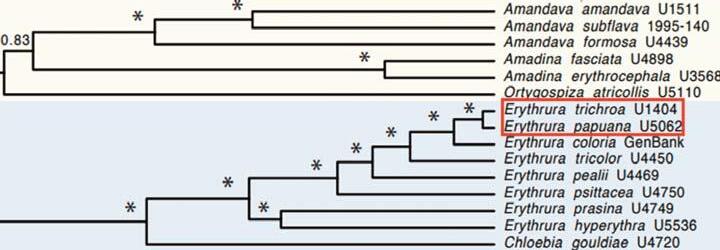




















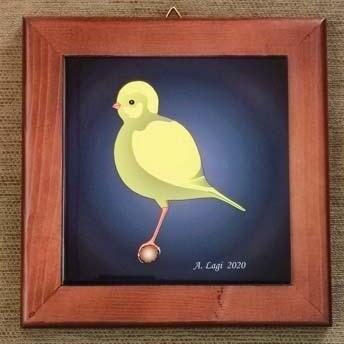






























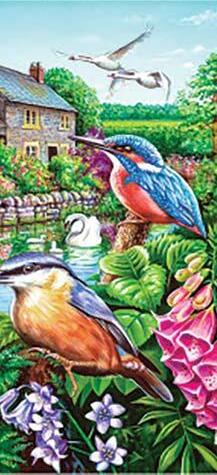

 testo e foto di LIA PORCINO (Presidente del Club del Diamante codalunga & Poephila)
testo e foto di LIA PORCINO (Presidente del Club del Diamante codalunga & Poephila)