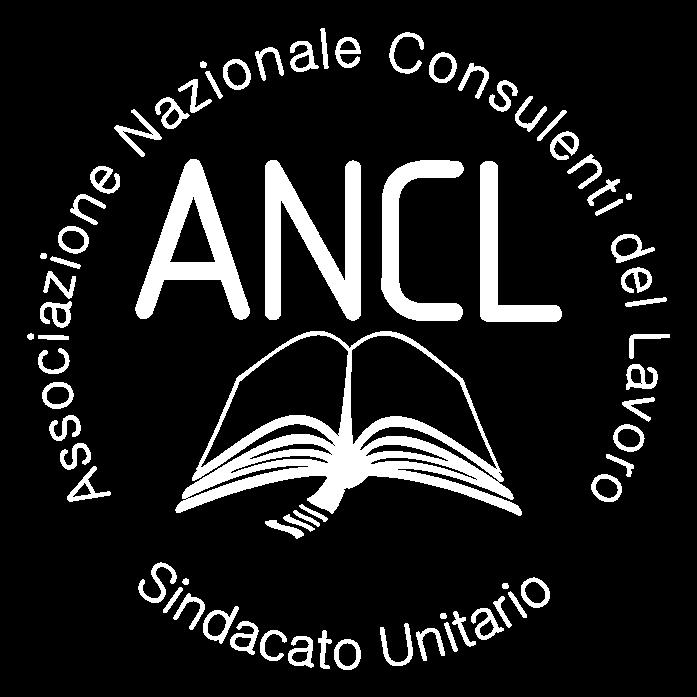LA COMPLESSITÀ NORMATIVA:

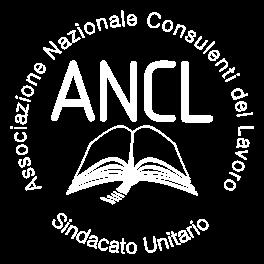





SOMMARIO
Numero chiuso in data 3 Aprile 2025
EDITORIALE
LA COMPLESSITÀ NORMATIVA:
UNA REALE SFIDA PER IL NUOVO MERCATO DEL LAVORO
a cura di Dario Montanaro - p.4
AREA DIRITTO DEL LAVORO
AGEVOLAZIONI PER L’ANNO 2025: QUALI NOVITÀ E QUALI CONFERME?
a cura di Alice Chinnici- p.8
DISCIPLINA DEL CONTRATTO A TERMINE: QUAL È IL REGIME ATTUALE?
a cura di Mattia Agosta, Simone Baghin, Bianca Barbus e Francesca Maleci- p.15
LA DURATA DEL PERIODO DI PROVA NEI CONTRATTI A TERMINE:
LA NOVITÀ DEL COLLEGATO LAVORO 2025
a cura di Giovanni Cruciani ed Eleonora Maria Fongaro - p.24
LA NUOVA PACE CONTRIBUTIVA:VANTAGGI TANGIBILI
E NUOVE PROSPETTIVE DI CONSULENZA ENTRO IL 2025
a cura di Maria Luisa Giovannone - p.29
ESONERO UNDER 36: COMMENTO ALLA SENTENZA
DEL TRIBUNALE DI AREZZO DEL 26 GIUGNO 2024, N. 425
a cura di Stefania Vettorello - p.35
AREA FISCALE
LA RIFORMA FISCALE DEI REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE
a cura di Stefano Camassa e Maria Elisena Gatto - p.39
I FRONTALIERI NELLA LEGGE DI BILANCIO 2025
a cura di Alessandra Lazzati - p.45
SOMMARIO
Numero chiuso in data 3 Aprile 2025
AREA SICUREZZA
QUALI NOVITÀ IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO
CON L’ENTRATA IN VIGORE DEL COLLEGATO LAVORO?
a cura di Gian Luca Di Rocco, Barbara Garbelli ed Eleonora Zambon - p.50
IL RUOLO ATTIVO DEL LAVORATORE PER LA PREVENZIONE
DEGLI INFORTUNI: LEGITTIMO IL LICENZIAMENTO A SEGUITO
DI RIFIUTO DI SOTTOPORSI A VISITA MEDICA
a cura di Alberto Balestrini - p.59
AREA SINDACALE
LAVORO STAGIONALE E CONTRATTAZIONE COLLETTIVA
a cura di Emanuela De Palma e Francesco Geria - p.64
LA DISCIPLINA DELLE “DIMISSIONI PER FATTI CONCLUDENTI”: QUALE SPAZIO ALLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA?
a cura di Michele Siliato, Francesca Stufetti ed Eleonora Zambon - p.82
GIURISPRUDENZA
CORTE DI CASSAZIONE, SENTENZA 20 MARZO 2025, N. 7480 - p.92
QUESITI
INDENNITÀ DI TRASFERTA E TRACCIABILITÀ DAL 2025 - p.103
AGEVOLAZIONE ESONERO GIOVANI - p.105
BACHECA - P. 108
DIRIGENTI E SEDI - P. 109

EDITORIALE
DARIO MONTANARO
PRESIDENTE
L’evoluzione tecnologica degli ultimi anni ha avuto un impatto irreversibile sul mondo del lavoro e termini quali lavoro agile, luogo di lavoro liquido, iperconnessione sono ormai entrati nel lessico quotidiano, segno questo di quanto il cambiamento sia generalizzato e riconosciuto.
Non possiamo in questa occasione non rilevare il livello di maturità e di qualità che il sistema imprenditoriale ha saputo esprimere a tale riguardo: nonostante il tessuto economico italiano sia costituito nella stragrande maggioranza da piccole e medie imprese - soggetti che già hanno risentito in forte misura delle difficoltà economiche e produttive, soprattutto dopo la crisi pandemica - possiamo ragionevolmente affermare che queste si siano già adeguate con grande elasticità al nuovo assetto. Le stesse che storicamente hanno sempre risentito della complessità del quadro normativo e burocratico proprio in ragione della loro piccola dimensione hanno saputo aggiornarsi rapidamente e radicalmente per restare “al passo coi tempi” quanto a modalità organizzative, competenze e più in generale cultura d’impresa.
È innegabile che l’impatto delle nuove forme della prestazione lavorativa sia stato nei primi tempi dirompente anche per noi Consulenti del Lavoro: da un lato è stato necessario concentrarsi quotidianamente sulla concretezza delle procedure e degli adempimenti, dall’altro si è avvertito uno smarrimento nel transitare dalla originaria rigidità del quadro giuridico e normativo di riferimento alla sempre maggiore flessibilità attribuita anche ai contratti collettivi, circa la determinazione degli elementi che tradizionalmente risultano essere alla base di un rapporto di lavoro, luogo e orario della prestazione. Nel quadro generale del sistema-lavoro, in cui l’equilibrio fra prestazione lavorativa e vita privata assume pari rilevanza rispetto alle altre forme di remunerazione, l’attenzione si sposta dal tema della selezione a quello della retention del personale, con un ribaltamento di prospettiva in cui è il lavoratore a scegliere l’azienda che più incontra le sue aspettative e ad intavolare con essa un percorso individuale modellato sulle proprie esigenze e stile di vita: smartworking e polverizzazione organizzativa non sono più da considerarsi quali concessioni del datore di lavoro bensì elementi di incontro fra le parti. Attrarre e mantenere in azienda i talenti è ormai obiettivo primario per le imprese, tanto più che il numero di giovani da formare, quale che sia l’attività lavorativa da avviare, è sempre più esiguo. Si tratta di una necessità già sperimentata negli anni dalle grandi aziende,
soprattutto da quelle di avanzato livello tecnologico, per le quali la competitività in un mercato ad alta velocità è già da tempo un forte impulso allo sviluppo di strategie di retention. La sfida che si pone oggi alle imprese medio-piccole è di poter garantire ai propri dipendenti all’interno della struttura organizzativa un adeguato livello di benessere - che comprenda profili di crescita e coinvolgimento sul piano professionalema anche benefici e misure di sostegno al lavoratore e alla sua famiglia, nonostante risorse limitate e il confronto con le politiche di gestione del personale e di welfare che le aziende medio-grandi sono già storicamente in grado di attuare. Strumenti come la bilateralità si stanno rivelando fondamentali, in quanto validi per offrire soluzioni di retention e attrattività per i lavoratori.
Ed è in questa fase storica che l’apporto consulenziale può assumere un ruolo preminente, a partire dalla funzione tradizionale di interpretazione e applicazione di un quadro normativo incerto o quanto meno ancora incompleto; inoltre, in virtù del rapporto continuo e puntuale con le aziende, il Consulente è in grado di rilevare immediatamente le principali esigenze e criticità emergenti nel mercato del lavoro attuale e di proporre soluzioni non solo di carattere pratico-


operativo ma anche nell’area organizzativa e nella gestione delle risorse umane, per quanto concerne ad esempio il welfare aziendale, la formazione continua e i vari servizi offerti nell’ambito della bilateralità.
La complessa gestione del capitale umano al quale si fa riferimento ricomprende quell’attività di consulenza resa all’imprenditore che si sostanzia nel promuovere un comportamento, suggerire una politica contrattuale o stabilire delle priorità nella relazione da instaurare col lavoratore; queste attribuzioni sono di esclusiva competenza del Consulente del Lavoro. La sensibilità nel prevedere ed affrontare il cambiamento nel prossimo futuro richiederà un ruolo sempre più strategico all’interno dell’impresa, da parte della quale aumentano le aspettative nell’ambito dei nuovi scenari contrattuali e organizzativi, laddove gli aspetti essenziali del rapporto di lavoro a partire appunto da luogo e orario di lavoro, sono rivoluzionati. Questa rilevante funzione ci imporrà un aggiornamento continuo per ampliare la “libreria delle competenze” e al contempo una grande adattabilità alle esigenze peculiari di ciascuna realtà aziendale.
Alla luce di queste riflessioni, come ho avuto occasione
di ricordare anche nel Seminario di studi dell’ASRI a Tor Vergata “Il luogo di lavoro a geometria variabile: tra spazi fisici e virtuali” dello scorso 26 marzo 2025, non dobbiamo allora guardare al modello di polverizzazione della prestazione di lavoro come a un fenomeno negativo, bensì semplicemente come ad un’evoluzione che richiede un adeguamento normativo. La messa a disposizione di strumenti tecnologici che consentono la possibilità di eseguire la prestazione lavorativa al di fuori della sede aziendale, impatta su un ordinamento emanato per modelli ormai superati nella prassi, come dimostra emblematicamente l’immutato articolo 4 dello Statuto dei Lavoratori che vieta “l’uso di impianti audiovisivi e di altre apparecchiature per finalità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori”; quello che il sistema oggi richiede non è una replica dell’esistente, bensì degli strumenti adeguati alla varietà, specificità e rapidità di cambiamento delle tipologie della prestazione lavorativa. Questa complessità normativa rappresenta la vera sfida da affrontare, con efficacia, da parte del Legislatore: per farlo, è necessario aderire al cambiamento di paradigma, senza riproporre quanto già in essere.
Come Consulenti del Lavoro dobbiamo monitorare l’evoluzione in atto con attenzione e competenza, per saper interpretare il nuovo e sostenere a 360° una dialettica imprese-lavoratori che abbia ricadute positive sul piano gestionale, economico e in ultima analisi sociale.


AREA DIRITTO DEL LAVORO

ALICE CHINNICI
CONSULENTE DEL LAVORO IN GIANO DELL’UMBRIA, MEMBRO DEL CENTRO STUDI NAZIONALE ANCL

AGEVOLAZIONI PER L’ANNO 2025: QUALI NOVITÀ E QUALI CONFERME?
INDICE
1. Premessa 4. Donne
3. Giovani under 35
5. Incentivi all’autoimpiego nei settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica
6. Nuova Decontribuzione Sud
7. Conclusioni 2. ZES
1. PREMESSA
Per i datori di lavoro che vogliono incrementare la forza lavoro in azienda o stabilizzare personale già precedentemente assunto con contratto a tempo determinato, le assunzioni agevolate rappresentano uno dei principali strumenti di contenimento del costo del lavoro purché però utilizzate nel rispetto dei requisiti normativamente previsti. Le norme che introducono gli esoneri o le riduzioni contributive prevedono, infatti, il rispetto di determinati requisiti pena la revoca dei benefici accompagnata dalla restituzione degli importi e, sovente, dal pagamento degli interessi.
Poiché accanto alle agevolazioni introdotte in modo strutturale nel nostro ordinamento vi sono anche svariate misure la cui fruizione è limitata alle sole assunzioni effettuate in un determinato arco temporale, risulta opportuno effettuare un riepilogo delle nuove agevolazioni applicabili per l’anno 2025, soffermandosi sulle misure “transitorie” introdotte dal Decreto Coesione e dalla Legge di Bilancio 2025.
2. ZES
Per sostenere lo sviluppo occupazionale della Zona Economica Speciale per il Mezzogiorno - ZES unica, l’art. 24 del Decreto-legge n. 60/2024 (Decreto Coesione) introduce per i datori di lavoro privati che dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025 assumono personale non dirigenziale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato - per un periodo massimo di ventiquattro mesi – un esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’Inail, nel limite massimo di importo pari a 650 euro su base mensile per ciascun lavoratore.
La misura è riconosciuta esclusivamente ai datori di lavoro privati che occupano fino a 10 dipendenti nel mese di assunzione e che assumono presso una sede o unità produttiva ubicata in una delle regioni della ZES unica per il Mezzogiorno – ossia nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna - lavoratori nelle medesime regioni.
Per quanto concerne i lavoratori l’agevolazione spetta nel caso di assunzione di soggetti che alla data
dell’assunzione abbiano compiuto trentacinque anni di età e siano disoccupati da almeno ventiquattro mesi. Inoltre, l’agevolazione spetta anche per quei lavoratori che alla data dell’assunzione incentivata sono stati occupati a tempo indeterminato alle dipendenze di un diverso datore di lavoro che ha beneficiato parzialmente dell’esonero. Restano invece esclusi dalla misura i rapporti di lavoro domestico e i rapporti di apprendistato.
Quanto agli ulteriori requisiti è richiesto il rispetto dei principi generali di fruizione degli incentivi sanciti dall’articolo 31 del D.Lgs. n. 150/2015 e, anche se non espressamente menzionato dalla disposizione, va da sé che anche per la nuova agevolazione – come per le assunzioni agevolate in generale – il beneficio è subordinato alla regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale, ai sensi della normativa in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC); all’assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e al rispetto degli altri obblighi di legge; al rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Inoltre, l’esonero contributivo spetta ai datori di lavoro che, nei sei mesi precedenti l’assunzione, non hanno proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi, ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, nella medesima unità produttiva.
Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto con l’esonero o di un lavoratore impiegato con la stessa qualifica nella medesima unità produttiva del primo, se effettuato nei sei mesi successivi all’assunzione incentivata, comporta la revoca dell’esonero e il recupero del beneficio già fruito.
Quanto al regime di cumulabilità della misura la stessa non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente ed è invece compatibile, senza alcuna riduzione, con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni ex art. 4 D.Lgs. n. 216/2023.
Infine, per quanto riguarda l’autorizzazione da parte della Commissione europea giova precisare che sebbene l’art. 22 del Decreto disponga che l’efficacia della misura è subordinata, ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del TFUE, all’autorizzazione della Commissione europea, il Decreto interministeriale del 7 gennaio 2025 - recante i criteri e modalità attuative – invece afferma, coerentemente con quanto stabilito dal regolamento UE 651/2014, che l’incentivo si applica nel rispetto di tale regolamento e, pertanto, nessuna autorizzazione è stata ritenuta necessaria. Ciò in quanto lo stesso regolamento Ue 651/2014 prevede, al punto 99 dell’articolo 2, che gli aiuti a favore dei lavoratori privi di impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, essendo considerati lavoratori molto svantaggiati, non debbano soggiacere a notifica preventiva, secondo quanto indicato al considerando numero 7 del medesimo regolamento.
Benché il Decreto interministeriale sia stato già emanato ancora oggi manca la Circolare Inps e pertanto la misura risulta non ancora applicabile.
3. GIOVANI UNDER 35
Il Decreto Coesione introduce – o meglio reintroduce con qualche differenza rispetto al passato –
un’agevolazione contributiva per i datori di lavoro che assumono giovani lavoratori.
In particolare, l’art. 22 del Decreto riconosce - al fine di incrementare l’occupazione giovanile stabile - ai datori di lavoro privati che dal 1° settembre 2024 e fino al 31 dicembre 2025 assumono personale non dirigenziale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o effettuano la trasformazione del contratto di lavoro subordinato da tempo determinato a tempo indeterminato, per un periodo massimo di ventiquattro mesi, l’esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’Inail, nel limite massimo di importo pari a 500 euro su base mensile per ciascun lavoratore.
L’esonero spetta inoltre in misura maggiorata – nel limite massimo di importo pari a 650 euro su base mensile per ciascun lavoratore – per le assunzioni relative a sedi o unità produttive ubicate nelle regioni della ZES unica per il Mezzogiorno.
Quanto ai lavoratori portatori dell’incentivo l’esonero spetta con riferimento ai soggetti che alla data dell’assunzione incentivata non hanno compiuto il trentacinquesimo anno di età e non sono stati mai occupati a tempo indeterminato. Per poter accedere al beneficio l’assunzione deve riguardare il personale non dirigenziale ed essere effettuata con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato (verosimilmente – data la mancata esclusione da parte del legislatore - anche con contratto di lavoro part time); l’esonero spetta inoltre anche nel caso di trasformazione del contratto di lavoro subordinato da tempo determinato a tempo indeterminato e nei casi di precedente assunzione con contratto di lavoro di apprendistato non proseguito come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
Il Decreto riconosce la portabilità dell’agevolazione disponendo che l’esonero spetta anche ai soggetti che alla data dell’assunzione incentivata sono stati occupati a tempo indeterminato alle dipendenze di un diverso datore di lavoro che ha già beneficiato parzialmente dell’esonero. Resta da capire se la portabilità sarà riconosciuta anche in caso di prima assunzione effettuata entro il compimento del trentacinquesimo anno di età e successiva assunzione effettuata oltre il compimento del trentacinquesimo anno di età (come

già previsto per l’under 36 biennio 2021-2022 Circ. Inps n. 56/2021).
Rimangono fuori dal perimetro di operatività dell’esonero le assunzioni con contratto di apprendistato e i rapporti di lavoro domestico.
Con riferimento all’arco temporale entro cui deve essere effettuata l’assunzione per poter fruire dell’esonero si ricorda che, mentre l’art. 22 del Decreto dispone espressamente che l’esonero spetta per le assunzioni effettuate dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025, il Decreto interministeriale firmato in data 27 febbraio 2025 - pubblicato nel sito istituzionale del governo e poi depubblicato - aveva disposto che l’esonero sarebbe stato riconosciuto solo per le assunzioni effettuate dal 31 gennaio (data in cui è arrivata l’autorizzazione da parte delle Commissione europea) e comunque successivamente alla presentazione della relativa domanda all’Inps di accesso all’agevolazione.
Attualmente l’orientamento prevalente del Ministero è che l’autorizzazione della Commissione europea sia necessaria solo per la versione dell’esonero giovani maggiorata a 650 euro. Di conseguenza, quest’ultimo decorrerà dalla data dell’autorizzazione (31 gennaio
2025), mentre per la misura da 500 euro si sta ancora discutendo con la Commissione per farlo decorrere dal 1° settembre 2024.
Anche per l’agevolazione in commento la norma dispone che, fermi restando i principi generali di fruizione degli incentivi ex art. 31 D.Lgs. n. 150/2015, l’esonero contributivo spetta ai datori di lavoro che, nei sei mesi precedenti l’assunzione, non hanno proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi, ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, nella medesima unità produttiva. Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto con l’esonero in commento o di un lavoratore impiegato con la stessa qualifica nella medesima unità produttiva del primo, se effettuato nei sei mesi successivi all’assunzione incentivata, comporta la revoca dell’esonero e il recupero del beneficio già fruito.
Infine, per quanto concerne il regime della cumulabilità l’esonero non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, mentre è integralmente compatibile con la maggiorazione, stabilita al fine della deduzione dalle imposte sui redditi per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, del costo del personale dipendente di nuova assunzione a tempo indeterminato – maggiorazione prevista dall’articolo 4 del D.Lgs. 30 dicembre 2023, n. 216.
In attesa della conclusione delle interlocuzioni con le istituzioni europee la misura non è ancora operativa.
In alternativa appare dunque utile ricordare che per le assunzioni di giovani under 30 è possibile fruire dell’agevolazione prevista dalla legge n. 205/2017 avente appunto carattere strutturale.
4. DONNE
Accanto alle agevolazioni per le assunzioni di donne svantaggiate introdotte strutturalmente dalla legge n. 92/2012, il Decreto Coesione prevede per i datori di lavoro privati che dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025 assumono lavoratrici - in possesso di determinati requisiti - per un periodo massimo di ventiquattro mesi, l’esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’Inail,
nel limite massimo di importo pari a 650 euro su base mensile per ciascuna lavoratrice.
Il beneficio si applica nel rispetto del regolamento (UE) n. 651/2014, in relazione alle assunzioni a tempo indeterminato di donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, residenti nelle regioni della ZES unica per il Mezzogiorno, ammissibili ai finanziamenti nell’ambito dei fondi strutturali dell’Unione europea, o operanti nelle professioni e nei settori di cui all’articolo 2, punto 4), lettera f), del predetto regolamento, annualmente individuati con Decreto del Ministro del lavoro e delle Politiche Sociali, nonché in relazione alle assunzioni a tempo indeterminato di donne di qualsiasi età prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi, ovunque residenti. Anche in questo caso restano fuori dal perimetro di operatività della misura i rapporti di lavoro domestico e i rapporti di apprendistato.
Le assunzioni devono comportare un incremento occupazionale netto calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei dodici mesi precedenti. Per i dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale, il calcolo è ponderato in base al rapporto tra il numero delle ore pattuite e il numero delle ore che costituiscono l’orario normale di lavoro dei lavoratori a tempo pieno. L’incremento della base occupazionale è considerato al netto delle diminuzioni del numero degli occupati verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.
Quanto al regime di cumulabilità della misura la stessa non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente ed è invece compatibile, senza alcuna riduzione, con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni ex art. 4 D.Lgs. n. 216/2023.
Per quanto concerne l’autorizzazione da parte della Commissione europea benché l’art. 23 non l’abbia espressamente prevista, la stessa è stata rilasciata in data 31 gennaio 2025 solo per le assunzioni di lavoratrici prive di impiego retribuito da almeno sei mesi effettuate nella ZES. Verosimilmente - sulla scorta di quanto accaduto per l’agevolazione dei
giovani under 35 - anche per l’agevolazione delle donne si avrà un periodo di fruizione differenziato (31 gennaio 2025- 31 dicembre 2025 per le donne prive di impiego retribuito da almeno sei mesi assunte nei territori della ZES e 1° settembre 2024- 31 dicembre 2025 per le altre fattispecie previste dall’art. 23).
5. INCENTIVI ALL’AUTOIMPIEGO
NEI SETTORI STRATEGICI PER LO
SVILUPPO DI NUOVE TECNOLOGIE E LA TRANSIZIONE DIGITALE ED ECOLOGICA
Ai sensi dell’art. 21 del Decreto Coesione le persone disoccupate che non hanno compiuto i trentacinque anni di età e che avviano sul territorio nazionale, a decorrere dal 1° luglio 2024 e fino al 31 dicembre 2025, un’attività imprenditoriale avente le caratteristiche definite con apposito Decreto ed operante nell’ambito dei settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica possono chiedere, per la durata massima di tre anni e comunque non oltre il 31 dicembre 2028, per i dipendenti assunti a tempo indeterminato dal 1° luglio 2024 al 31 dicembre 2025 e che alla data della assunzione non hanno compiuto il trentacinquesimo anno di età, l’esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’Inail, nel limite massimo di importo pari a 800 euro su base mensile per ciascun lavoratore.
Con riferimento alla platea dei datori di lavoro, per fruire della misura in commento il soggetto che avvia la nuova attività nei settori individuati della norma deve essere disoccupato e non deve aver raggiunto il trentacinquesimo anno di età.
Quanto invece ai lavoratori incentivabili si tratta di soggetti assunti con contratto a tempo indeterminato anch’essi under 35 al momento dell’assunzione.
L’esonero non si applica ai rapporti di lavoro domestico e ai rapporti di apprendistato, non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente ed è invece compatibile, senza alcuna riduzione, con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni ex art. 4 D.Lgs. n. 216/2023.
Le imprese avviate dai medesimi soggetti possono richiedere all’Istituto nazionale della previdenza sociale un contributo per l’attività pari a 500 euro mensili per la durata massima di tre anni e comunque non oltre il 31 dicembre 2028.
Quanto all’autorizzazione da parte della Commissione europea, benché l’art. 21 del Decreto preveda espressamente che l’efficacia della misura sia subordinata, ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del TFUE, all’autorizzazione della Commissione europea, dalla lettura dell’autorizzazione per agevolazioni giovani e donne (SA.114799) si evince la non necessità dell’autorizzazione per il bonus autoimpiego in settori strategici.
Anche questa agevolazione al momento non può essere applicata poiché si è ancora in attesa del Decreto attuativo e della circolare Inps recanti le istruzioni operative.
6. NUOVA DECONTRIBUZIONE SUD
L’art. 1, commi 406-420, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (Legge di Bilancio 2025), al fine di mantenere i livelli di crescita occupazionale nel Mezzogiorno e contribuire alla riduzione dei divari territoriali, ha introdotto una nuova misura agevolativa ricalcando – seppur con notevoli differenze – la disciplina della Decontribuzione Sud che, nella versione precedente, ha cessato di produrre i suoi effetti il 31 dicembre 2024.
Nello specifico, a differenza della misura in vigore negli anni passati, la nuova previsione introduce alcune regole differenti a seconda che l’impresa fruitrice rientri nella nozione di microimpresa, piccola e media impresa oppure no.
In particolare, rientrano nella nozione di microimpresa e di piccola e media impresa i datori di lavoro privati che hanno alle proprie dipendenze non più di 250 dipendenti, ai sensi dell’allegato I al regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014.
Partendo dalla disciplina in comune alle PMI e alle altre imprese l’esonero è riconosciuto alle imprese che occupano lavoratori a tempo indeterminato nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna ed è articolato nel seguente modo:
• per l’anno 2025, in misura pari al 25% dei complessivi contributi previdenziali per un importo massimo di 145 euro su base mensile per dodici mensilità, per ciascun lavoratore a tempo indeterminato assunto alla data del 31 dicembre 2024;
• per l’anno 2026, in misura pari al 20% dei complessivi contributi previdenziali per un importo massimo di 125 euro su base mensile per dodici mensilità, per ciascun lavoratore a tempo indeterminato assunto alla data del 31 dicembre 2025;
• per l’anno 2027, in misura pari al 20% dei complessivi contributi previdenziali per un importo massimo di 125 euro su base mensile per dodici mensilità, per ciascun lavoratore a tempo indeterminato assunto alla data del 31 dicembre 2026;
• per l’anno 2028, in misura pari al 20% dei complessivi contributi previdenziali per un importo massimo di 100 euro su base mensile per dodici mensilità, per ciascun lavoratore a tempo indeterminato assunto alla data del 31 dicembre 2027;
• per l’anno 2029, in misura pari al 15% dei complessivi contributi previdenziali per un importo massimo di 75 euro su base mensile per dodici mensilità, per ciascun lavoratore a tempo indeterminato assunto alla data del 31 dicembre 2028.

A prescindere dalla dimensione aziendale l’esonero non si applica: ai rapporti di apprendistato; agli enti pubblici economici; agli istituti autonomi case popolari trasformati in enti pubblici economici ai sensi della legislazione regionale; agli enti trasformati in società di capitali, ancorché a capitale interamente pubblico, per effetto di procedimenti di privatizzazione; alle ex istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza trasformate in associazioni o fondazioni di diritto privato, in quanto prive dei requisiti per la trasformazione in aziende di servizi alla persona, e iscritte nel registro delle persone giuridiche; alle aziende speciali costituite anche in consorzio ai sensi degli articoli 31 e 114 del TU delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al Decreto legislativo n. 267/2000; ai consorzi di bonifica; ai consorzi industriali; agli enti morali; agli enti ecclesiastici.
Sempre a prescindere dalle dimensioni aziendali per fruire del beneficio è richiesto il rispetto dei principi generali ex art. 31 del D.Lgs. n. 150/2015, il rispetto delle condizioni stabilite dall’articolo 1, co. 1175, della legge n. 296/2006. Inoltre, le agevolazioni non spettano ai datori di lavoro che non siano in regola con gli obblighi di assunzione previsti dall’articolo 3 della legge n. 68/1999.
Quanto alla cumulabilità con altri incentivi, per entrambe le tipologie di aziende (PMI e altre imprese) la legge fissa un divieto di cumulo con le sole agevolazioni introdotte dal Decreto Coesione.
Nella circolare Inps n. 32/2025 relativa alla Decontribuzione PMI al paragrafo 6 si specifica che – coerentemente con il dato normativo – il divieto di cumulo sussiste con le agevolazioni del Decreto Coesione mentre “in ragione dell’entità dello sgravio, lo stesso risulta cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta, salvo non vi sia un espresso divieto di cumulo previsto da altra disposizione” . Ebbene, qualche rigo più sotto nel fornire gli esempi di cumulo –probabilmente a causa di un refuso – tra le agevolazioni con cui è possibile cumulare la decontribuzione sud viene erroneamente indicata anche l’agevolazione under 30 per la quale la legge n. 205/2017 all’art.1, co.114, prevede invece espressamente un divieto di cumulo con altre agevolazioni.
Passando alle differenze tra Decontribuzione Sud Pmi e Decontribuzione Sud altre imprese, mentre solo per le prime è richiesto il rispetto dei limiti del regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo agli aiuti de minimis, per le seconde (non micro, piccole e medie) è invece richiesta la realizzazione dell’incremento occupazionale, al 31 dicembre di ogni anno, rispetto all’anno precedente, dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato. Inoltre, sempre solo per le aziende che non rientrano tra le micro, piccole e medie imprese l’agevolazione è subordinata, ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del TFUE, all’autorizzazione della Commissione europea ed è sospesa fino alla data di adozione della decisione.
Al momento è infatti operativa solo la Decontribuzione Sud PMI.
7. CONCLUSIONI
A bene vedere dopo circa undici mesi dalla pubblicazione del Decreto Coesione e tre mesi dalla pubblicazione della Legge di Bilancio 2025 la sola misura operativa è la Decontribuzione Sud per le PMI, pertanto, i datori di lavoro che hanno effettuato assunzioni di lavoratori contando sulla riduzione del costo del lavoro si trovano, ancora oggi, a pagare la contribuzione piena nella speranza di recuperare il prima possibile gli arretrati.

MATTIA AGOSTA
CONSULENTE DEL LAVORO IN GENOVA, MEMBRO DEL CENTRO STUDI NAZIONALE ANCL


SIMONE BAGHIN
CONSULENTE DEL LAVORO IN VICENZA, MEMBRO DEL CENTRO STUDI NAZIONALE ANCL


BIANCA BARBUS
CONSULENTE DEL LAVORO IN UDINE, MEMBRO DEL CENTRO STUDI NAZIONALE ANCL


FRANCESCA MALECI
CONSULENTE DEL LAVORO IN FIRENZE

DISCIPLINA DEL CONTRATTO A TERMINE: QUAL È IL REGIME ATTUALE?
INDICE
1. Contratto a termine e durata
2. Novità introdotte nel 2025
3. Conclusioni
1. CONTRATTO A TERMINE E DURATA
Il contratto a tempo determinato ha subito nel corso dell’ultimo periodo modifiche sostanziali al fine di renderlo uno strumento di flessibilità per le aziende in grado di rispondere ai variati contesti economici e sociali. A decorrere dal 2023, con l’entrata in vigore del Decreto Lavoro (dl 48/2023 conv. l. 85/2023), si è voluto “bypassare” alcuni limiti stringenti e delle rigidità con riferimento alle c.d. causali o condizioni, riconoscendo un ruolo chiave alla contrattazione collettiva nel poter costruire una sorta di causalità “sartoriale” specifica per settore economico.
Ruolo chiave riconosciuto alla contrattazione collettiva che riguarda anche la durata massima del termine apponibile al rapporto di lavoro che non è stata modificata nel corso dell’ultimo intervento legislativo.
L’art. 19 del d.lgs. 81/2015 stabilisce un principio generale ovvero che al contratto di lavoro subordinato non può essere apposto un termine di durata superiore a 12 mesi.
Si deroga a tale limite, che non richiede alcuna causale/motivazione, consentendo il proseguimento del rapporto, fermo restando un limite massimo cui si vedrà in seguito, solo ed esclusivamente al verificarsi di una delle seguenti condizioni/causali:
a) nei casi previsti dai contratti collettivi di cui all’articolo 51;
b) in assenza delle previsioni di cui alla lettera a), nei contratti collettivi applicati in azienda, e comunque entro il 31 dicembre 2025, per esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva individuate dalle parti;
b bis) in sostituzione di altri lavoratori.
Nello stabilire un primo periodo di “acausalità” di 12 mesi tra le parti nel contratto a termine, la norma prevede che fatte salve diverse disposizioni dei contratti collettivi e al di fuori delle attività stagionali (che non computano), la durata dei rapporti di lavoro a tempo determinato intercorsi tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, per effetto di una successione di contratti, conclusi per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale e indipendentemente dai periodi di interruzione tra un contratto e l’altro, non può superare i 24 mesi.
Il riferimento del legislatore è di un contatore unico collegato allo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale, con la conseguenza che nella durata massima del rapporto sarà necessario tener conto sia dei periodi a termine diretti che delle somministrazioni a tempo determinato.
Si ricorda che l’eventuale superamento del limite massimo di 24 mesi previsto per legge ovvero del diverso limite previsto dal CCNL comporta l’applicazione, a titolo sanzionatorio, della trasformazione del contratto a termine in contratto a tempo indeterminato dalla data di tale superamento.
Per quanto riguarda il ruolo riconosciuto alla contrattazione collettiva nel prevedere un diverso termine rispetto ai 24 mesi di legge, il Ministero del Lavoro con la Circ. 17/2018 ha chiarito (con riferimento alle modifiche ante decreto Lavoro 2023 e precedentemente introdotte dal dl 87/2018) che i contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale (secondo la definizione degli stessi contenuta all’articolo 51 del d.lgs. n. 81/2015) potranno continuare a prevedere una durata diversa, anche superiore, rispetto al nuovo limite massimo dei 24 mesi

Pare utile ricordare che il limite dei 24 mesi ovvero il diverso limite previsto dal CCNL è da intendersi quale limite perentorio anche qualora il termine fosse motivato da eventuale ragione sostitutiva. È il caso, per esempio, del contratto a termine sottoscritto in sostituzione di maternità: qualora gli eventi tutelati INPS (congedo di maternità e parentale) e le altre eventuali assenze collegate all’evento maternità (fruizione delle ferie maturate post maternità) dovessero andare oltre i 24 mesi sarà necessario al raggiungimento di tale termine cessare il rapporto a termine indipendentemente dall’effettivo rientro della lavoratrice assente. Qualora il rapporto dovesse proseguire, lo stesso di intenderà a tempo indeterminato sin dallo sforamento dei 24 mesi.
Il 3° comma dell’art. 19 del d.lgs. 81/2015 prevede infine il c.d. contratto a termine assistito. In particolare viene prevista la possibilità di stipulare un ulteriore contratto a tempo determinato fra gli stessi soggetti, della durata massima di 12 mesi, la sede competente per territorio dell’ITL.
Si ricorda che il contratto a termine assistito deve essere sempre con condizione/causale e il massimale dei 12 mesi ulteriori va applicato anche laddove i contratti collettivi abbiano previsto un periodo diverso (minore o maggiore).
Sintetizzando:
a) è possibile la stipula di “solo” un contratto a termine assistito;
b) nel format del contratto, da sottoscrivere con il lavoratore, va precisata la disposizione di riferimento ovvero stipulato ai sensi dell’articolo 19, comma 3, del decreto legislativo n. 81/2015;
c la sottoscrizione del contratto assistito, per essere valida, deve avvenire dinanzi ad un funzionario dell’Ispettorato territoriale del Lavoro;
d) il contratto, essendo a tutti gli effetti un rinnovo di precedenti contratti a termine, deve contenere anche la causale di riferimento tra quelle previste dal legislatore;
e) qualora stipulato per una durata inferiore a 12 mesi, non potrà essere prorogato né rinnovato, ne potrà
essere prevista la c.d. “prosecuzione di fatto”;
f) va corrisposta la contribuzione aggiuntiva dello 0,50% (escluse le motivazioni sostitutive), oltre che la contribuzione maggiorata dell’1,40%.
g) dal contratto assistito sono escluse quelle attività previste dall’articolo 29 (es. dirigenti) del decreto legislativo n. 81/2015.
1.1. Causali per il contratto a termine oltre 12 mesi
La conversione in Legge del Decreto Milleproroghe 2025 ha stabilito che i contratti collettivi nazionali, territoriali e aziendali possano definire i “casi” in cui è possibile stipulare contratti a termine superiori a 12 mesi, con l’intento di semplificare il quadro normativo e adattarlo meglio alle esigenze aziendali.
In particolare, i contratti aziendali redatti sulla base delle esigenze concrete del datore di lavoro, seppur meno formalizzati rispetto a quelli nazionali, possono anch’essi individuare causali specifiche per contratti a termine, rafforzando la flessibilità e riducendo il rischio di contestazioni.
L’introduzione di causali collettive ha risposto all’esigenza di rendere il sistema più agile, permettendo la stipulazione di contratti a termine per eventi come saldi, fiere o picchi produttivi temporanei. Tali causali sono definite nei contratti collettivi, ad esempio nel CCNL Terziario Confcommercio sono state individuate, a titolo esemplificativo, le seguenti:
• saldi: lavoratori assunti nei periodi interessati dai saldi relativi alle vendite di fine stagione, sia invernali che estive, come da specifica regolamentazione regionale;
• fiere: lavoratori assunti nei periodi interessati dallo svolgimento di fiere individuate dal calendario fieristico nazionale e internazionale compresi tra sette giorni precedenti e sette giorni successivi la fiera;
• festività natalizie: lavoratori assunti durante le festività natalizie, nel periodo compreso tra il 15 novembre e il 15 gennaio;
• festività pasquali: lavoratori assunti durante le festività pasquali, nel periodo compreso tra quindici giorni precedenti e quindici giorni successivi al giorno di Pasqua;
• riduzione impatto ambientale: lavoratori assunti con

specifiche professionalità e impiegati direttamente nei processi organizzativi e\o produttivi che abbiano l’obiettivo di ridurre rimpatto ambientale dei processi medesimi;
• terziario avanzato: lavoratori assunti per specifiche mansioni di progettazione, di realizzazione e di assistenza e vendita di prodotti innovativi, anche digitali, nell’ambito del terziario avanzato;
• digitalizzazione: lavoratori assunti con specifiche professionalità per lo sviluppo di metodologie e di nuove competenze in ambito digitale;
• nuove aperture: lavoratori assunti per aperture di nuova unità produttiva/operativa e ristrutturazioni nel periodo massimo di 24 mesi a far data dal giorno della nuova apertura di unità produttiva/operativa o nel periodo massimo di 24 mesi nella fase di ristrutturazione di unità produttive/operative, intesa come espansione della superficie di vendita o apertura di nuovi reparti, in tal caso, come previsto dall’art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2015, saranno esclusi dai limiti percentuali solamente i rapporti di lavoro instaurati nei primi 12 mesi dalla nuova apertura;
• incremento temporaneo: lavoratori assunti per progetti o incarichi temporanei di durata superiore ai 12 mesi o prorogati oltre i 12 mesi continuativi, per una durata massima di 24 mesi.
Per quanto riguarda il caso in cui non siano state previste delle causali dalla contrattazione collettiva applicata in azienda, rimane la possibilità di individuare una causale “individuale”: la normativa prevede una soluzione temporanea per cui, fino al 31 dicembre 2025, le parti del contratto possono indicare nel contratto individuale stesso le ragioni giustificative (tecniche, organizzative o produttive) che rendono legittima la durata del termine. Questo strumento è pensato come una misura provvisoria, mentre si definiscono le modalità per la contrattazione collettiva.
1.2. Deroghe alla disciplina sui tempi determinati ex d.lgs. 81/2015
L’articolo 29 del D.Lgs. 81/2015 stabilisce una serie di esclusioni dall’ambito di applicazione delle disposizioni sui contratti a tempo determinato, indicando i casi in cui si applicano normative specifiche:
1. Esclusioni generali:
• Lavoratori agricoli: i contratti a tempo determinato tra datori di lavoro agricoli e operai, disciplinati da specifiche normative (D.Lgs. 375/1993), non rientrano nelle disposizioni del Decreto.
• Personale volontario dei Vigili del Fuoco: i richiami in servizio del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco non sono inclusi.
2. Esclusioni specifiche:
• Dirigenti: i contratti a tempo determinato con i dirigenti, che non possono durare più di cinque anni, sono esclusi.
• Contratti brevi nel turismo e pubblici esercizi: i contratti di durata non superiore a tre giorni, nel settore turistico e dei pubblici esercizi, sono esclusi, se definiti dai contratti collettivi. Lo stesso vale per i contratti di lavoro portuale temporaneo.
• Supplenze scolastiche e personale sanitario: i contratti a tempo determinato per supplenze nel settore scolastico (docenti e ATA) e per il personale sanitario, anche dirigente, del Servizio Sanitario Nazionale, sono esclusi.
• Contratti universitari: i contratti a tempo determinato stipulati ai sensi della Legge 240/2010 per il personale universitario sono esclusi.
3. Personale artistico e tecnico nelle fondazioni musicali:
• Le disposizioni relative ai contratti a tempo determinato non si applicano al personale artistico e tecnico delle fondazioni di produzione musicale (D.Lgs. 367/1996).
Ricordiamo infine che per il settore sportivo è prevista una speciale disciplina in deroga rispetto a quanto previsto per i tempi determinati dal D.Lgs. 81/2015. Nello specifico, i contratti a tempo determinato nel settore sportivo possono avere una durata massima di 5 anni ed è ammessa la successione di più contratti fra gli stessi soggetti.
1.3. Modalità di computo rispetto ai tempi indeterminati in azienda
Come accennato in precedenza la disciplina del tempo determinato ha subito un notevole snellimento con l’introduzione delle novità dettate dal Decreto Lavoro, ma permane chiara la volontà del nostro legislatore di indirizzare le aziende verso la stabilizzazione dei rapporti lavorativi, orientandole verso il tanto agognato contratto a tempo indeterminato.
Per questo motivo le modifiche via via apportate al Capo III del D. Lgs. 81/2015 hanno posto in essere dei forti e limitanti paletti, non solo dal punto di vista temporale come visto in precedenza, ma anche sul piano quantitativo. Infatti, i datori di lavoro possono assumere con contratto a tempo determinato in misura non superiore al 20% dei prestatori assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato. Ai fini del calcolo è necessario considerare i lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell’anno in cui si effettua l’assunzione a termine. Tuttavia, nel caso in cui l’azienda si trovasse nel primo anno di attività, il limite percentuale dovrà essere verificato in riferimento ai lavoratori a tempo indeterminato in forza al momento dell’assunzione del lavoratore a termine. Per completezza, occorre precisare che le aziende da 1 a 5 dipendenti possono sempre stipulare un contratto di lavoro a termine pur essendoci, solo matematicamente parlando, il superamento del citato limite del 20%.
Come d’altronde in tutti gli elementi che contraddistinguono la normativa sul tempo
determinato, anche in questo caso, il legislatore lascia ampio spazio di manovra alla contrattazione collettiva nazionale, territoriale ed aziendale, permettendo di concordare tra le parti sociali la possibilità di fissare un limite percentuale diverso da quello previsto dall’art. 23 D.Lgs. 81/2015, sempre che i firmatari degli accordi siano i sindacati maggiormente rappresentativi sul piano nazionale (art. 51 D.Lgs. 81/2015).
Prima di proseguire è opportuno focalizzare alcuni punti utili alla definizione della base di computo per non rischiare di superare la soglia del 20%, verificando quali siano le tipologie contrattuali da includere all’interno della rosa dei lavoratori a tempo indeterminato. I lavoratori in regime di part-time, rimanendo nell’ambito del D.Lgs. 61/2000, dovranno essere considerati in proporzione all’effettivo orario di lavoro, così come anche accade con riguardo ai lavoratori intermittenti (senza indennità di disponibilità). Diversamente gli apprendisti dovranno essere esclusi.
Tuttavia, è da considerare che non tutti i lavoratori a tempo determinato vanno ad erodere il limite in argomento, infatti ne devono essere esclusi i rapporti a termine conclusi:
• nella fase di avvio di nuove attività, per i periodi definiti dai contratti collettivi, anche in misura non uniforme con riferimento ad aree geografiche e comparti merceologici;
• per lo svolgimento di attività stagionali;
• per specifici spettacoli o specifici programmi radiofonici o televisivi o per la produzione di specifiche opere audiovisive;
• per sostituzione di lavoratori assenti;
• con lavoratori di età superiore a 50 anni.
Ma come ci dobbiamo comportare se la compagine sociale è composta, oltre che da assunti “diretti”, anche da lavoratori in somministrazione? In tal caso la somma tra i lavoratori a tempo determinato ed i lavoratori assunti in somministrazione a termine non dovrà eccedere il limite del 30% dei lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l’utilizzatore (sempre con riferimento alla fotografia della situazione al 1° gennaio). Anche in questo caso non incideranno sul limite quantitativo appena menzionato i lavoratori in somministrazione a tempo indeterminato di specifiche categorie di lavoratori, definite in maniera tassativa.
Tra queste rientrano i disoccupati che beneficiano, da almeno sei mesi, di trattamenti di disoccupazione non agricola o di ammortizzatori sociali, nonché i lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati, identificati dal Decreto Ministeriale del 17 ottobre 2017.
Dal punto di vista dell’apparato sanzionatorio, nel caso in cui l’assunzione a tempo determinato avvenga in violazione del limite percentuale del 20%, così come sopra definito, resta esclusa la trasformazione dei rapporti a termine in rapporti a tempo pieno ed indeterminato (come avviene per le violazioni degli altri limiti imposti dalla norma), ma, per ciascun lavoratore, verrà applicata una sanzione amministrativa pari al:
a) 20% della retribuzione, per ciascun mese o frazione di mese superiore a 15 giorni di durata del rapporto di lavoro, se il numero dei lavoratori assunti in violazione del limite percentuale non è superiore a 1;
b) 50% cento della retribuzione, per ciascun mese o frazione di mese superiore a 15 giorni di durata del rapporto di lavoro, se il numero dei lavoratori assunti in violazione del limite percentuale è superiore a 1.
La normativa sanzionatoria oggetto di analisi presenta caratteristiche piuttosto atipiche nell’ambito del diritto del lavoro, dove solitamente le sanzioni amministrative pecuniarie sono predeterminate, almeno nei loro limiti minimi e massimi. Diversamente, nel caso in esame, l’entità della sanzione è variabile e dipende sia dalle retribuzioni percepite dal lavoratore a termine in eccesso, sia dal periodo di tempo trascorso tra la sua assunzione e l’accertamento del superamento del limite numerico previsto.
1.4. Proroghe e rinnovi nei contratti a termine: quadro normativo, limiti e implicazioni operative
Il contratto di lavoro a tempo determinato rappresenta uno strumento contrattuale di ampia diffusione nel mercato del lavoro italiano, utilizzato dalle imprese per far fronte a esigenze produttive temporanee. Tuttavia, la sua regolamentazione è soggetta a stringenti limiti normativi volti a prevenirne un uso distorto e a tutelare il principio della stabilità occupazionale.
La disciplina delle proroghe e dei rinnovi, così come i limiti alla durata complessiva del contratto, sono elementi chiave che devono essere attentamente monitorati per garantire la conformità alla normativa
vigente ed evitare il rischio di conversione automatica del rapporto a tempo indeterminato.
Il presente contributo esamina, il quadro normativo vigente, con particolare riferimento al D.Lgs. 81/2015, così come modificato dal Decreto Dignità (D.L. 87/2018, convertito con modificazioni nella L. 96/2018) e dalle più recenti disposizioni in materia.
La gestione dei contratti a tempo determinato è un aspetto cruciale per le imprese e i Consulenti del Lavoro, poiché richiede una precisa conoscenza delle normative vigenti per evitare errori che possono comportare gravi conseguenze. Di seguito esamineremo le regole relative alle proroghe e ai rinnovi dei contratti a termine, nonché le conseguenze per il datore di lavoro in caso di violazione delle norme.

1.5. Proroga e Rinnovo: Distinzione Concettuale e Normativa
La distinzione tra proroga e rinnovo di un contratto a tempo determinato è di fondamentale importanza, in quanto le due fattispecie rispondono a discipline differenti e sono soggette a limiti distinti.
• Proroga: si configura quando il contratto di lavoro, ancora in essere, viene prolungato nella sua durata senza interruzioni. Non determina la cessazione del rapporto e prevede la continuità dello stesso.
• Rinnovo: si verifica quando, successivamente alla scadenza del contratto, ne viene stipulato uno nuovo tra lo stesso lavoratore e lo stesso datore di lavoro. Il rinnovo presuppone quindi un’interruzione tra il primo e il secondo contratto
La corretta qualificazione dell’istituto è essenziale per l’applicazione della normativa sui limiti quantitativi e sulle eventuali causali obbligatorie richieste per il prolungamento del rapporto oltre determinate soglie temporali.
Proroghe:
Un contratto a termine può essere prorogato fino a 4 volte nell’arco dei 24 mesi consentiti. Ogni proroga deve essere formalizzata prima della scadenza del contratto iniziale. Questo significa che il datore di lavoro deve comunicare per iscritto al lavoratore la proroga del contratto prima che scada il termine precedente.
Per contratti superiori a 12 mesi, è obbligatoria la presenza di una causale valida – ad avviso di chi scrive, a maggior tutela dell’azienda, è opportuno anche qualora i 12 mesi siano superati, per effetto di una o più proroghe, che la causale possa essere sostenuta fin dall’inizio del contratto a tempo determinato - ciò implica che ogni proroga deve essere motivata da una delle causali ammesse dalla legge o dai CCNL
Rinnovi:
Anche i rinnovi sono limitati a un massimo di 4 volte nell’arco dei 24 mesi totali.
Ogni rinnovo richiede l’interruzione del rapporto per almeno:
• 10 giorni se il contratto precedente aveva una durata fino a 6 mesi;
• 20 giorni se il contratto precedente superava i 6 mesi.
Questo intervallo (detto comunemente Stop & Go) è necessario per evitare che il rinnovo sia considerato una proroga, che altrimenti potrebbe superare il limite consentito.
Ogni rinnovo deve essere accompagnato dall’indicazione di una nuova causale, indipendentemente dalla durata del contratto precedente. Ciò significa che il datore di lavoro deve motivare ogni rinnovo con una delle causali ammesse, anche se il contratto precedente aveva una durata inferiore a 12 mesi.
Conseguenze per il datore di lavoro ed il lavoratore in caso di violazione delle norme sulle proroghe e sui rinnovi:
La normativa sui contratti a tempo determinato prevede una serie di sanzioni e conseguenze legali per il mancato rispetto dei limiti previsti in materia di proroghe, rinnovi e durata massima del rapporto. L’obiettivo del legislatore è evitare il ricorso abusivo al contratto a termine e garantire la stabilità occupazionale, imponendo la conversione automatica a tempo indeterminato in determinate circostanze.
Di seguito analizziamo le singole violazioni e le relative conseguenze in termini di trasformazione del contratto, contenzioso giudiziario e sanzioni amministrative
1)Superamento del numero di proroghe consentito: L’art. 21, comma 1, del D.Lgs. 81/2015 stabilisce che il contratto a tempo determinato può essere prorogato al massimo quattro volte.
Se il rapporto viene ulteriormente prorogato per una quinta volta, si verifica una violazione del limite normativo.

• Effetto giuridico:
a) Il rapporto di lavoro si trasforma automaticamente a tempo indeterminato a partire dalla data di decorrenza della quinta proroga.
b) Il datore di lavoro non ha alcuna possibilità di regolarizzare la situazione ex post, né con il consenso del lavoratore né con modifiche contrattuali retroattive.
• Profili di contenzioso:
a) Il lavoratore può impugnare il contratto e ottenere una pronuncia giudiziale che confermi la conversione.
b) Il datore di lavoro può opporsi solo dimostrando che non si tratta di una vera e propria proroga, ma di un contratto diverso con elementi sostanziali nuovi (ipotesi residuale e difficile da provare).
2) Mancato rispetto dei giorni di sospensione tra i due rapporti di lavoro in caso di rinnovo del contratto a termine: L’art. 21, comma 2, del D.Lgs. 81/2015 stabilisce che tra un contratto a termine e il successivo debba intercorrere un periodo minimo di interruzione obbligatoria (Stop & Go). Se il datore di lavoro riassume il lavoratore senza rispettare il periodo di Stop & Go, si applicano automaticamente le seguenti conseguenze:
• Effetto giuridico:
a) Il secondo contratto si considera a tempo indeterminato sin dalla data di assunzione.
b) Non è possibile “regolarizzare” la violazione, neanche con accordo individuale con il lavoratore.
• Eccezioni e deroghe:
Il CCNL applicato potrebbe prevedere esenzioni dallo Stop & Go, in particolare per settori ad alta stagionalità. Per le attività stagionali, come definite dai contratti collettivi e dal D.M. 23 ottobre 2004, lo Stop & Go non si applica.
• Profili di contenzioso:
a) Il lavoratore può impugnare il secondo contratto per ottenere il riconoscimento del rapporto a tempo indeterminato.
b)L’INL potrebbe intervenire d’ufficio con un accertamento e ordinare la trasformazione del contratto.
Mentre il lavoratore beneficerebbe della trasformazione del contratto in un rapporto a tempo indeterminato, con maggiore stabilità nel rapporto di lavoro e tutela in caso di licenziamento; acquisendo così i diritti e le tutele previste per i contratti a tempo indeterminato, inclusi il diritto a un giusto procedimento e a eventuali indennità di mancato preavviso.
2.
2.1. Proroga delle causali flessibili
Il Decreto Milleproroghe 2025 estende fino al 31 dicembre 2025 la possibilità di stipulare contratti a tempo determinato superiori a 12 mesi, ma non oltre i 24 mesi, anche in assenza di specifiche disposizioni nei contratti collettivi nazionali di lavoro (CCNL). Questo significa che i datori di lavoro possono utilizzare causali generiche legate a esigenze tecniche, organizzative o produttive per giustificare la durata del contratto oltre i 12 mesi. Rimangono tuttavia rigidi i limiti relativi alla durata massima (24 mesi) e al numero massi di proroghe e rinnovi (4 ciascuno).
2.2. Flessibilità nella stipula dei contratti
La normativa consente ai datori di lavoro e ai lavoratori di concordare individualmente le ragioni che giustificano l’apposizione di un termine superiore ai 12 mesi. Questo accordo può avvenire anche in assenza di previsioni specifiche nei CCNL, aumentando la flessibilità nella gestione dei contratti a termine.
2.3. Limiti quantitativi e durata massima
La durata massima complessiva dei contratti a tempo determinato rimane fissata a 24 mesi, inclusi eventuali rinnovi e proroghe. Oltre questo limite, il contratto si trasforma automaticamente in un contratto a tempo indeterminato.
2.4. Esclusioni e limitazioni
Le novità introdotte non si applicano in situazioni particolari, come i contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni o dalle società che promuovono la ricerca e l’innovazione. Inoltre, i contratti a termine devono rispettare i limiti quantitativi previsti dalla legge, che prevedono che il numero complessivo di lavoratori a termine non superi il 30% dei dipendenti a tempo indeterminato in azienda.
2.5 Implicazioni per le imprese
Le novità introdotte offrono maggiore flessibilità alle imprese, consentendo loro di gestire meglio i contratti a termine in base alle esigenze aziendali. Tuttavia, è importante che i datori di lavoro rispettino i limiti e le causali previste dalla legge per evitare sanzioni o la trasformazione automatica dei contratti in rapporti a tempo indeterminato.
3. CONCLUSIONI
La gestione dei contratti a termine richiede una precisa conoscenza delle normative vigenti per evitare errori che possono comportare gravi conseguenze. È fondamentale per i Consulenti del Lavoro monitorare attentamente l’applicazione delle causali e rispettare i vincoli normativi per evitare contenziosi o la conversione automatica dei contratti in rapporti a tempo indeterminato. La trasformazione del contratto in un rapporto a tempo indeterminato rappresenta una delle principali conseguenze per il datore di lavoro che supera il limite di proroghe consentito.

GIOVANNI CRUCIANI
CONSULENTE DEL LAVORO IN PERUGIA, PRESIDENTE REGIONALE ANCL UMBRIA, MEMBRO DEL CENTRO STUDI NAZIONALE ANCL


ELEONORA MARIA FONGARO
CONSULENTE DEL LAVORO IN VICENZA, MEMBRO DEL CENTRO STUDI NAZIONALE ANCL

LA DURATA DEL PERIODO DI PROVA NEI
CONTRATTI A TERMINE: LA NOVITÀ DEL COLLEGATO LAVORO 2025
INDICE
1. Premessa
2. Definiamo il patto di prova
3. Il periodo di prova nel contratto a termine: il meccanismo di riproporzionamento del Collegato Lavoro
4. Questioni controverse
1. PREMESSA
Il Collegato Lavoro, legge n. 203/2024, è entrato in vigore con decorrenza dal 12 gennaio 2025, intervenendo su varie materie riguardanti i contratti di lavoro, la gestione dei rapporti di lavoro, nonché la loro conclusione.
Tra le novità apportate analizziamo, con il presente testo, le modifiche introdotte in merito al periodo di prova nei contratti a tempo determinato.
2. DEFINIAMO IL PATTO DI PROVA
Il patto di prova è un patto accessorio al contratto di lavoro subordinato e viene disciplinato all’art.2096 del c.c. il quale recita: “Salvo diversa disposizione, l’assunzione del prestatore di lavoro per un periodo di prova deve risultare da atto scritto. L’imprenditore e il prestatore di lavoro sono rispettivamente tenuti a consentire e a fare l’esperimento che forma oggetto del patto di prova. Durante il periodo di prova ciascuna delle parti può recedere dal contratto, senza obbligo di preavviso o d’indennità. Se però la prova è stabilita per un tempo minimo necessario, la facoltà di recesso non può esercitarsi prima della scadenza del termine. Compiuto il periodo di prova, l’assunzione diviene definitiva e il servizio prestato si computa nell’anzianità del prestatore di lavoro”.
In ogni tipologia di contratto di lavoro le parti possono dunque prevedere l’effettuazione di un periodo di prova con lo scopo di permettere ad entrambi di valutare la convenienza del rapporto di lavoro. Da un lato l’imprenditore misurerà le capacità e le attitudini professionali del prestatore di lavoro, dall’altro il lavoratore valuterà la propria adattabilità al tipo di attività lavorativa e all’ambiente di lavoro in cui sarà destinato ad operare.
Per il patto di prova è prevista la forma scritta ad substantiam e ciò implica che, in caso di mancata apposizione con atto scritto, lo stesso debba essere considerato nullo. In assenza di patto di prova validamente sottoscritto, l’eventuale risoluzione anticipata del rapporto di lavoro dovrà essere ricondotta ad un ordinario licenziamento per giusta causa o giustificato motivo.
Ai fini della validità del patto di prova è importante che siano indicate precisamente le mansioni affidate al
lavoratore in quanto la giurisprudenza ha precisato in più occasioni che il requisito della forma può considerarsi rispettato solo se il patto di prova contiene anche la specifica (non generica) indicazione delle mansioni da svolgere (si v. Corte di Cassazione, n. 21698/2006) o, in caso di rinvio al contratto collettivo, laddove in esso la mansione sia delineata specificatamente (sul punto Corte di Cassazione, n. 5881/2003).
Nel corso della prova il contratto di lavoro è definitivamente costituito e i diritti e gli obblighi delle parti sono pienamente operanti, salvo però la particolarità consistente nel fatto che in questo periodo le parti possono recedere liberamente dal contratto senza obbligo di preavviso. A tal proposito, è bene evidenziare che è opportuno per il datore di lavoro che intende risolvere unilateralmente il contratto di lavoro durante la prova, far trascorrere un periodo che consenta di accertare le capacità lavorative del lavoratore per evitare possibili impugnazioni del licenziamento. (In ogni caso graverebbe sul dipendente dimostrare l’illegittimità del recesso in quanto basato esclusivamente su elementi estranei alla funzione del patto di prova, o per motivo illecito o in caso di prova non consentita in concreto per periodo inadeguato a permettere un’idonea valutazione delle capacità).

3. IL PERIODO DI PROVA NEL CONTRATTO
A TERMINE: IL MECCANISMO DI RIPROPORZIONAMENTO DEL COLLEGATO LAVORO
La legge (art. 10, L. n. 604/1966) fissa la durata massima del periodo di prova in:
• 6 mesi per tutti i lavoratori
• 3 mesi per gli impiegati non aventi funzioni direttive
I contratti collettivi, specifici per settore, fissano poi la durata del periodo di prova, sempre entro i limiti di legge, distinguendo in alcuni casi tra operai e impiegati, prevedendo taluni casi di riduzione, determinando il criterio di calcolo dei giorni (se di calendario o di effettivo lavoro).
Vi è sempre stata una certa incertezza in merito al calcolo del periodo di prova per i contratti di lavoro a tempo determinato e in particolare sul metodo di riproporzionamento.
L’art.13 della L. n. 203/2024 ha apportato una modifica all’art.7, comma 2, del D.L.gs n.104/2022 (Decreto Trasparenza) il quale prevedeva che nel rapporto di lavoro a tempo determinato il periodo di prova dovesse essere stabilito in misura proporzionale alla durata del contratto e alle mansioni da svolgere in relazione alla natura dell’impiego, senza però approfondire relativamente alle modalità di calcolo della proporzione da effettuare.
L’art 13, dunque, richiamando quanto previsto dal sopracitato art. 7 del Decreto Trasparenza, stabilisce che, fatte salve le disposizioni più favorevoli della
contrattazione collettiva, il periodo di prova nei contratti a termine è stabilito in un giorno di effettiva prestazione per ogni 15 giorni di calendario a partire dalla data di inizio del rapporto di lavoro.
Viene previsto anche un limite minimo e un limite massimo in base alla durata del contratto di lavoro:
• nei rapporti fino a 6 mesi: da un minimo 2 a un massimo 15 giorni di prova,
• nei rapporti di durata maggiore a 6 mesi e inferiore di 12 mesi: il periodo di prova non può essere superiore a 30 giorni,
• nei rapporti di durata superiore a 12 mesi: fatte salve le più favorevoli previsioni della contrattazione collettiva, il periodo di prova sarà calcolato moltiplicando un giorno di effettiva prestazione per ogni quindici giorni di calendario, anche oltre la durata massima di 30 giorni, stabilita per contratti a termine di durata inferiore a dodici mesi.
Esempio:
• contratto TD inizio 1/01/2025 fine 28/02/2025 = 59 giorni. Durata patto di prova 3 giorni di prestazione effettiva;
• contratto TD inizio 01/01/2025 fine 30/06/2025 = 181 giorni. Durata patto di prova 12 giorni di prestazione effettiva;
• contratto TD inizio 01/01/2025 fine 31/12/2025 = 365 giorni. Durata patto di prova 24 giorni di prestazione effettiva.
DURATA DEL CONTRATTO A TERMINE
Previsione generale
DURATA DELLA PROVA
1 giorno di effettiva prestazione ogni 15 giorni di calendario
In ogni caso
Contratti a termine non superiori a 6 mesi
Contratti a termine superiori a 6 mesi ma inferiori a 12 mesi
Almeno 2 giorni e massimo 15 giorni
Almeno 2 giorni e massimo 30 giorni
Con la richiamata circolare n. 6 del Ministero del lavoro viene operato un tentativo di definizione di ciò che debba intendersi per “più favorevole” intervento della contrattazione collettiva.
Nella circolare n.6 del 27/03/25 il Ministero afferma “Per quanto riguarda i criteri in base ai quali valutare quali disposizioni contrattuali siano più favorevoli rispetto alla previsione normativa, occorre considerare che generalmente – in applicazione del principio del favor praestatoris, per il quale in ambito lavoristico è da preferire l’interpretazione che accorda una maggiore tutela al lavoratore – viene considerata più favorevole per il lavoratore una minore estensione del periodo di prova, a causa della precarietà che lo stesso comporta per il lavoratore”.
Interpretazione non del tutto condivisibile poiché non è sempre un periodo di prova inferiore nell’interesse del lavoratore, specie valutando profili che richiedono una certa qualificazione, non è detto che un tempo inferiore sia favorevole alle aspirazioni del lavoratore che in questo caso potrebbe avere tutto l’interesse di un tempo più lungo per dimostrare le sue qualità.
Dunque la questione rimane aperta dal momento che qualche elemento in più verrà fornito all’interprete solo con le prime sentenze dato che, in ultima analisi, sarà il Giudice a decidere le questioni controverse.
4. QUESTIONI CONTROVERSE
Spesso anche le norme che cercano di risolvere vuoti e ambiguità lasciano aperte strade interpretative non sempre di facile soluzione.
In attesa che giurisprudenza e dottrina si interroghino su queste possibilità interpretative cogliamo l’occasione per portare alla luce alcune questioni controverse.
Dalla lettura della norma emergono alcune perplessità in merito al criterio di proporzionalità, in ragione del parametro adottato (1 giorno di prova ogni 15 giorni di calendario) che porterebbe ad assimilare la durata della prova di lavoratori con contratti di pari durata ma con orario diverso (è il caso, ad esempio, di due lavoratori, entrambi con un contratto a termine di 180 giorni, uno con orario full-time e l’altro con un part-time di poche ore a settimana, che in assenza di specifiche disposizioni del contratto collettivo, si vedrebbero applicare lo stesso limite calcolato in 12 giorni di prova).
Altra osservazione potrebbe riguardare il calcolo del periodo di prova in caso di contratti a tempo parziale di tipo verticale: in questo caso il calcolo effettuato sui giorni di calendario poco si confà con i giorni di effettiva prestazione.
Inoltre è lecito chiedersi: se in un rapporto a termine di sei mesi la durata del periodo di prova è di massimo 12 giorni, perché il legislatore pone il limite a 15 giorni? Si tratta di un limite che teoricamente non è raggiungibile e nemmeno superabile. La stessa cosa vale per la durata massima del periodo di prova nei contratti inferiori ai 12 mesi. Perché indicare un valore di 30 giorni, quando non si potranno mai superare i 24 giorni di prova?
L’art. 13 del Collegato Lavoro integra l’art. 7 del Decreto Trasparenza, così precisa la Nota INL del 30 dicembre 2024. Viene introdotta quindi una durata predeterminata ex lege dei limiti minimi e massimi del periodo di prova nei rapporti di lavoro a tempo determinato, dal momento che il Decreto Trasparenza aveva introdotto il principio ma senza declinare le regole applicative.
Fatta salva una “previsione più favorevole nei CCNL”, lascia aperti una serie di dubbi che difficilmente possono trovare una soluzione certa. I termini della contrattazione collettiva potrebbero essere più ampi o più contenuti. In entrambi i casi l’ampiezza del margine o l’esiguità possono essere a vantaggio del lavoratore e viceversa.
Che vuole dire, che con l’intervento normativo la contrattazione collettiva ha meno autonomia? I margini in cui opera verranno ridotti? Per l’ampliamento del margine le parti sociali non hanno più autorità? Alcuni contratti collettivi non saranno più applicabili? Per le mansioni più complesse, cosa accadrà?
La Circolare n. 6, di nuovo azzarda una interpretazione quando afferma che nel caso di contratti di lavoro a termine di durata superiore a dodici mesi, fatte salve le più favorevoli previsioni della contrattazione collettiva, il periodo di prova sarà calcolato moltiplicando un giorno di effettiva prestazione per ogni quindici giorni di calendario, anche oltre la durata massima di 30 giorni, stabilita per contratti a termine di durata inferiore a dodici mesi.
La norma prevede che il calcolo numerico previsto per legge sia subordinato a eventuali disposizioni

“più favorevoli” della contrattazione collettiva, ma il concetto rischia di poter essere interpretabile in varie maniere.
Infatti ad una prima lettura, la contrattazione collettiva non sembra autorizzata a superare i limiti massimi della durata del periodo di prova, in quanto l’eventuale ampliamento difficilmente potrà essere considerato come “più favorevole” per il lavoratore.
Sull’argomento è intervenuta la Circolare del Ministero del Lavoro n.6 del 27/03/2025 la quale specifica che i limiti massimi non possono essere derogati neppure dalla contrattazione collettiva, come definita dall’articolo 51 del decreto legislativo n. 81/2015, atteso che l’autonomia contrattuale non può – per principio generale – introdurre una disciplina peggiorativa rispetto a quella legale.
Per quanto riguarda i criteri in base ai quali valutare quali disposizioni contrattuali siano più favorevoli rispetto alla previsione normativa, occorre considerare che generalmente – in applicazione del principio del favor praestatoris, per il quale in ambito lavoristico è da preferire l’interpretazione che accorda una maggiore tutela al lavoratore – viene considerata più favorevole per il lavoratore una minore estensione del periodo di prova, a causa della precarietà che lo stesso comporta per il lavoratore.
Se dunque possiamo constatare che l’art. 13 del Collegato Lavoro chiarisce sicuramente un po’ meglio il concetto di proporzionalità del periodo di prova nei contratti a termine previsto dalla direttiva europea in materia e dal Decreto Trasparenza, in qualche modo riempendo un precedente “vuoto normativo” che poteva essere portatore di controversie legali, dobbiamo però porre massima attenzione, sia da un punto di vista applicativo che gestionale, rispetto a come la nuova disposizione incide sulle clausole previste dai vigenti Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro e alla predisposizione dei nuovi contratti individuali di lavoro.

MARIA LUISA GIOVANNONE
CONSULENTE DEL LAVORO IN PRATO

LA NUOVA PACE CONTRIBUTIVA: VANTAGGI TANGIBILI E NUOVE PROSPETTIVE DI CONSULENZA ENTRO IL 2025
INDICE
1. Introduzione al sistema pensionistico italiano
2. Definizione di pace contributiva
3. Requisiti, soggetti ammessi e calcolo onere
4. Motivi e vantaggi della pace contributiva
5. Opportunità per i Consulenti del Lavoro
La Legge 30 dicembre 2023, n. 213, precisamente ai commi 126-130 dell’articolo 1, c.d. Legge di bilancio 2024, in vigore dal 1° gennaio 2024, ha reintrodotto per il biennio 2024-2025 l’istituto della pace contributiva, recepito dall’INPS con la circolare INPS 29 maggio 2024, n. 69. Tale misura offre ai lavoratori la possibilità di aggiungere fino a cinque anni alla propria carriera contributiva tramite il riscatto di periodi non coperti da contribuzione, rivolto ai “contributivi puri”, ovvero coloro che non hanno contributi precedenti al 1° gennaio 1996. Ma iniziamo col fare una introduzione sul sistema pensionistico italiano per meglio capire come lo strumento può essere utile ai contribuenti che versano alla gestione INPS e ai Consulenti del Lavoro, nella propria attività professionale.
1. INTRODUZIONE AL SISTEMA PENSIONISTICO ITALIANO
Il sistema pensionistico italiano si configura come un modello a ripartizione intergenerazionale, fondato sul principio costituzionale dell’art. 38 che garantisce la tutela previdenziale attraverso assicurazioni sociali obbligatorie gestite da enti pubblici. Strutturato su tre pilastri, prevede un PRIMO pilastro PUBBLICO: sistema obbligatorio finanziato da contributi versati dai lavoratori attivi, gestito da enti come l’INPS con la gestione AGO (compreso forme esclusive e sostitutive), per la generalità dei lavoratori, insieme alle 18 casse professionali per i lavoratori autonomi che svolgono attività professionale per i propri contributi. Un SECONDO pilastro COMPLEMENTARE COLLETTIVO: è facoltativo e si attiva tramite l’adesione a un fondo pensione negoziale o aperto, spesso legato al contratto collettivo di lavoro o a iniziativa individuale, in cui si versa il TFR ed eventualmente contribuzione aggiuntiva. Infine, il TERZO pilastro è INTEGRATIVO INDIVIDUALE: è facoltativo e consiste in strumenti scelti in autonomia dal lavoratore per integrare ulteriormente la pensione, come Fondi pensione aperti o PIP (Piani Individuali Pensionistici) e gli investimenti a lungo termine finalizzati alla pensione (es. assicurazioni sulla vita, piani di accumulo, ecc.).
La normativa ha introdotto degli obblighi sulle caratteristiche chiave sui requisiti e sugli accessi alla pensione che INPS ha recepito ed a cui faremo riferimento nell’articolo, mentre le casse professionali
hanno creato delle regole personalizzate sulla scorta delle caratteristiche che i propri iscritti possono avere e la sostenibilità della propria cassa (ad esempio la pensione di vecchiaia in INPS si matura al compimento dei 67 anni, mentre per le casse professionali è spesso al compimento dei 70 anni). Le caratteristiche chiave del sistema italiano si sono modificate nel tempo creando una normativa stratificata, quelle attuali si possono riassumere in:
• Finanziamento a ripartizione: i contributi dei lavoratori attivi sostengono direttamente le pensioni correnti, senza accumulo di riserve, se non nel patrimonio dell’ente per garantire una sostenibilità nell’erogazione delle pensioni.
• Calcolo: attualmente è in vigore il “metodo contributivo” introdotto con la riforma Dini (1995) e modificato dalla Fornero (2011). Con questo metodo si calcolano le pensioni in base ai contributi versati durante la carriera e l’assegno pensionistico è calcolato sul montante pensionistico accumulato rispetto agli anni di pensione da erogare (distanza tra età di entrata in pensione e aspettativa di vita attualmente 85,2 anni per le donne e 81,1 anni per gli uomini – dati Istat 2023). Solo in modo residuale alcuni possono avere il calcolo

retributivo puro (pensione calcolata sulla media delle retribuzioni degli ultimi 10 anni, per chi aveva 18 anni di versamenti al 31/12/95) o misto (in parte retributivo e in parte contributivo per coloro che hanno iniziato a versare prima del 1/1/95).
• Requisiti di accesso: una pensione di vecchiaia legata all’età anagrafica, ed una pensione anticipata legata alla quantità dei contributi versati oltre ad altre possibilità esposte nello schema di seguito. Si veda Tabella Riassuntiva “Accesso alla pensione in Italia”.
• La possibilità di sommare i versamenti in gestioni separate (sia questi nei vari fondi INPS o in casse professionisti) con regole diverse, con o senza onere, per il raggiungimento del requisito necessario all’accesso alla pensione.
Questo quadro, pur essendo stato oggetto di numerose riforme (Amato, Dini, Fornero), presenta criticità legate alla sostenibilità demografica e alla discontinuità contributiva, particolarmente rilevante per i lavoratori con carriere irregolari. Alcuni fondi che prima erano autonomi (esempio il lavoro pubblico una volta INPDAP) sono stati riassorbiti in INPS che ora gestisce al suo interno una gestione dedicata con regole diverse: si usa generalizzare riferendosi alla gestione AGO (FLPD - COMMERCIANTI ARTIGIANI e AGRICOLI - SEPARATA) ma le gestioni in INPS sono diverse tra fondi speciali ed ex gestioni riassorbite. Proprio per affrontare quest’ultimo aspetto, la pace contributiva 2024-2025 rappresenta uno strumento strategico per colmare i “buchi” previdenziali, tema che verrà approfondito nei prossimi paragrafi.
2. DEFINIZIONE DI PACE CONTRIBUTIVA
La pace contributiva è stata istituita la prima volta in Italia con il Decreto-legge 28 gennaio 2019 n. 4, convertito con modificazioni dalla Legge 28 marzo 2019, n. 26. La misura è nata come uno strumento sperimentale per il triennio 2019-2021 con un onere che era detraibile al 50% dalle imposte in dieci anni e rateizzabile in massimo 60 rate mensili. La misura è stata riproposta e aggiornata dalla Legge di Bilancio 2024 (Legge 30 dicembre 2023, n. 213) per il biennio 2024-2025, con nuove condizioni più vantaggiose (es. deducibilità piena, rate fino a 120 mesi). La pace contributiva 2024-2025 è
esclusivamente gestita dall’INPS e non coinvolge le 18 casse professionali (es. ENPACL, Cassa Forense, ENPAM, INARCASSA ecc...). I professionisti iscritti a casse autonome possono ricongiungere i contributi presso l’INPS (alcune particolarità sono previste per la Gestione Separata INPS) o mantenere la posizione nella cassa di appartenenza, ma senza accesso alla pace contributiva. La domanda di ricongiunzione va presentata direttamente alla cassa professionale o all’INPS, a seconda della destinazione scelta. Le casse non hanno recepito la delega per la pace contributiva, mantenendo regimi previdenziali autonomi Eventuali riscatti di periodi scoperti sono regolati da normative interne.
La pace contributiva 2024-2025 influenza la posizione assicurativa in modo strutturale, modificando sia i requisiti di accesso alla pensione sia il calcolo dell’assegno in quanto può incidere con l’AUMENTO dell’anzianità contributiva. I periodi riscattati (fino a 5 anni) vengono accreditati come contributi effettivi, contribuendo al raggiungimento dei requisiti minimi per la pensione di vecchiaia o anticipata. Inoltre, può incidere INCREMENTANDO il montante contributivo. I periodi riscattati aumentano il valore dell’assegno pensionistico nel sistema contributivo, poiché il montante si calcola moltiplicando i contributi versati per i coefficienti di rendimento.
Importante sottolineare il divieto di anzianità contributiva precedente al 1996: se si acquisisce contribuzione anteriore al 1996 (es. servizio militare), il riscatto viene annullato con restituzione degli importi. Inoltre, non è possibile chiedere l’applicazione della pace contributiva se le lacune sono derivanti da omissioni contributive (es. lavori non dichiarati).
3. REQUISITI E SOGGETTI AMMESSI
ALLA
PACE CONTRIBUTIVA 2024-2025 E CALCOLO DELL’ONERE
La pace contributiva rappresenta uno strumento temporaneo, perché la domanda deve essere presentata entro il 31 dicembre 2025, per colmare i buchi contributivi nel sistema pensionistico italiano. I periodi ammessi al riscatto sono massimo 5 anni (anche non continuativi) e devono collocarsi in epoca successiva al 31 dicembre 1995 e precedente al 1° gennaio 2024, data di entrata in vigore della legge 213/2023 (legge di bilancio). Secondo i testi normativi e le circolari INPS,

non tutti i vuoti contributivi possono essere accreditati ma i periodi riscattabili devono essere collocati tra il primo e l’ultimo contributo accreditato presso le forme assicurative INPS, con divieto di riscatto per contributi acquisiti presso casse previdenziali autonome. Non sono riscattabili periodi con obbligo contributivo (es. lavori non dichiarati o contributi omessi dal datore).
I requisiti soggettivi invece prevedono che non deve essere già attiva una pensione al momento della domanda e i lavoratori devono essere iscritti a forme pensionistiche obbligatorie a partire dal 1° gennaio 1996 (sistema contributivo puro). Vi è un divieto espresso di anzianità pre-1996: chi acquisisce contributi anteriori al 1996 (ad esempio per il riscatto del militare o della laurea) perde il diritto al riscatto, con restituzione degli importi versati.
La domanda può essere presentata:
• dal lavoratore stesso, tramite il portale INPS (area “Riscatti”) o anche avvalendosi dei patronati o tramite il numero verde INPS 803.164 da rete fissa;
• dai superstiti o parenti entro il secondo grado (es. coniuge, figli, genitori) del lavoratore che hanno
interesse a incrementare il conto pensionistico del lavoratore;
• dal datore di lavoro, utilizzando il modulo AP135 per destinare premi di produzione (massimo € 3.000) e/o welfare aziendale (che deve essere strutturato, non discriminatorio).
Tuttavia, utile ricordare che la facoltà di riscatto non può essere esercitata per recuperare periodi di svolgimento di attività lavorativa soggetti ad obbligo di versamento contributivo: tale preclusione opera necessariamente anche nei casi in cui l’obbligo contributivo sia già prescritto. In tali casi si possono recuperare i periodi di lavoro attivando altri istituti già previsti dalla vigente normativa nelle singole gestioni previdenziali, come la regolarizzazione contributiva o, nei casi in cui sia intervenuta la prescrizione dei contributi, utilizzando la costituzione di rendita vitalizia ai sensi dell’articolo 13, legge 1338/1962.
Il costo del riscatto da pace contributiva viene determinato applicando l’aliquota contributiva vigente nella gestione previdenziale scelta, calcolata sull’imponibile previdenziale degli ultimi 12 mesi precedenti la domanda, per gli anni richiesti nella domanda. Ad esempio, per il lavoratore dipendente l’aliquota IVS attuale è del 33% e sarà applicata all’imponibile previdenziale comunicato con gli Uniemens dei 12 mesi precedenti alla domanda e rapportata al periodo richiesto. Nel caso in cui la richiesta sia riferita, ad esempio, al periodo con contribuzione “commercianti”, l’aliquota IVS è del 24% dell’annualità precedente.
L’onere risultante per il riscatto può essere pagato in unica soluzione o rateizzato fino ad un massimo di 120 rate, con importo minimo di €30. Si deve segnalare che la rateizzazione è vietata se il riscatto serve per ottenere immediatamente la pensione. L’onere viene calcolato con l’aliquota contributiva vigente al momento della domanda.
4. MOTIVI E VANTAGGI PER CONSIGLIARE LA PACE CONTRIBUTIVA
La scelta di aderire alla pace contributiva ha vantaggi sia fiscali nell’anno in cui sono sostenuti, sia contributivi sull’estratto conto. Il vantaggio, infatti, per i periodi riscattati ha riflessi sia ai fini
dell’acquisizione del diritto alla pensione, sia per il calcolo dell’assegno pensionistico.
La pace contributiva permette di coprire fino a 5 anni di buchi contributivi (1996-2023), accelerando il raggiungimento dei requisiti per la pensione anticipata o di vecchiaia. Utile per chi ha carriere discontinue (es. interruzioni tra un impiego e l’altro) specialmente per coloro che, ancora a inizio delle carriere, hanno redditi non elevati e riescono a sostenere un onere per dare copertura ai periodi con investimenti non elevati. Ad esempio: un lavoratore con imponibile previdenziale dei 12 mesi precedenti alla domanda di € 20.000 riscatta nella gestione FLPD ogni anno con un contributo di €6.600 che rateizzato in 120 rate equivale ad un impegno finanziario di 55€ a rata per anno richiesto. La domanda non implica che si debbano chiedere tutti i periodi riscattabili, ma il numero di settimane (la pensione si calcola in settimane) che si possono sostenere. Inoltre, l’adesione alla pace contributiva attuale non esclude l’adesione ad una futura domanda, in caso di altra apertura, come è successo per l’attuale che è stata rivolta a coloro che già avevano aderito alla pace contributiva L. 04/2019 (per i periodi tra il 01/01/1995 e 19/01/2019).
L’onere è deducibile integralmente dal reddito complessivo IRPEF, senza limiti massimi (diversamente dal tetto di € 5.000 per i contributi volontari) e nell’anno in cui sono sostenuti. Per cui si può scegliere di destinare una parte di risorse finanziarie nell’anno dalle imposte ai contributi.
Inoltre, si deve considerare che il pagamento può essere rateizzato in 120 rate mensili (minimo € 30 a rata), senza interessi. Per cui si configura un finanziamento ai fini previdenziali, utile per chi non dispone immediatamente della somma, ma vuole sfruttare la misura prima della scadenza del 31 dicembre 2025.
Inoltre, la pace contributiva consente di maturare i requisiti per pensioni anticipate (es. Quota 103, APE Sociale) o integrare l’anzianità per accedere a forme di previdenza complementare.
5. OPPORTUNITÀ PER I CONSULENTI
DEL LAVORO
I Consulenti del Lavoro, che nascono come la figura professionale che può assistere le aziende e i lavoratori
sulla contribuzione, possono offrire una consulenza personalizzata: valutazione della convenienza economica in base all’imponibile degli ultimi 12 mesi e alle prospettive pensionistiche. Il Consulente del Lavoro verifica la storia lavorativa e contributiva del cliente, identificando eventuali buchi contributivi (es. periodi non coperti da contributi), errori di accreditamento (es. contributi non registrati o duplicati) e opportunità di riscatto (es. pace contributiva, riscatto di laurea).
Il consulente, direttamente o indirettamente (con l’ausilio di colleghi preparati), può stimolare i clienti a richiedere consulenze sul confronto di scenari pensionistici. La valutazione di varie opzioni previdenziali può iniziare già dal valutare con quale configurazione l’imprenditore sta alimentando la propria posizione previdenziale e quella dei propri dipendenti, aiutandolo a capire quanto il valore della corretta elaborazione dei cedolini è indispensabile per la costruzione di un futuro. Inoltre, in base alla normativa vigente, il professionista può valutare con il cliente se la pace contributiva riesce a far accedere lo stesso ad una pensione anticipata (tipo Quota 103, APE Sociale) o se ci può essere convenienza ad utilizzare altri strumenti quali i riscatti (laurea dei periodi non lavorativi) e le ricongiunzioni (trasferimento contributi tra casse o Paesi UE). Il professionista può, sulle singole situazioni personalizzate dei clienti, creare delle simulazioni di montante contributivo per calcolare l’importo della pensione e valutare se necessario apportare cambiamenti.
Inoltre, con la pianificazione previdenziale il Consulente massimizza l’efficacia economica delle scelte considerando la deduzione integrale degli oneri per riscatti o contributi volontari (senza tetto dei € 5.000), la rateizzazione agevolata (fino a 120 rate per la pace contributiva) e l’integrazione con fondi pensione complementari per aumentare l’assegno.
Il Consulente del Lavoro può gestire le pratiche amministrative per la presentazione e l’invio domande all’INPS o alle casse professionali (es. ENPAM, INARCASSA), compresi la risoluzione di controversie (es. errori di calcolo dell’INPS) e il monitoraggio delle evoluzioni normative (es. modifiche alle aliquote o requisiti) nonché la pianificazione a lungo termine. Infatti, il consulente elabora strategie personalizzate per anticipare il pensionamento tramite riscatti o ricongiunzioni, mantenere la coerenza contributiva in caso di
cambi di lavoro o trasformazioni aziendali (es. passaggio da autonomo a dipendente) cercando di ottimizzare l’importo della pensione attraverso contributi volontari o integrazioni previdenziali.
Ovviamente, sono indispensabili le competenze e la conoscenza approfondita delle riforme pensionistiche (Dini, Fornero, Legge di Bilancio 2025) e delle normative delle casse professionali, oltre alla predisposizione alla capacità di analisi per valutare scenari complessi (es. cumulo contributivo UE).
ACCESSO ALLA PENSIONE IN ITALIA - TABELLA RIASSUNTIVA (2025)
TIPOLOGIA DI
Vecchiaia
Anticipata ordinaria
Lavoratori precoci
Quota 103
Opzione Donna
Invalidità
Superstiti (Reversibilità)
Assegno sociale
Pensione di vecchiaia contributiva
Pensione ordinaria al raggiungimento dell’età pensionabile
Pensione anticipata basata solo sui contributi
Anticipata per chi ha lavorato prima dei 19 anni
Anticipo temporaneo con requisiti combinati
Anticipata per donne con ricalcolo contributivo
Per chi non può più lavorare per gravi motivi di salute
Ai familiari in caso di decesso del lavoratore o pensionato
Sostegno economico per chi non ha diritto alla pensione contributiva
Per ‘contributivi puri’ (senza contributi prima del 1996)
67 anni di età, almeno 20 anni di contributi
Adeguamento automatico all’aspettativa di vita
42 anni e 10 mesi di contributi (uomini), 41 anni e 10 mesi di contributi (donne) Nessun requisito anagrafico
41 anni di contributi, categoria tutelata, 12 mesi prima dei 19 anni
62 anni di età, 41 anni di contributi
35 anni di contributi, 58-60 anni di età (variabili)
Invalidità accertata, 5 anni di contributi di cui 3 negli ultimi 5
Requisiti del defunto per diritto alla pensione
67 anni, residenza in Italia, reddito basso
71 anni di età, almeno 5 anni di contributi effettivi
Richiede almeno 12 mesi di contributi prima del 19° anno
In vigore per il 2024, possibile proroga nel 2025, importo limitato fino ai 67 anni
Riduzione dell’assegno per il calcolo interamente contributivo
Prestazione assistita da visita medica e requisiti sanitari
Quote diverse a seconda del familiare (coniuge, figli, genitori, ecc.)
Non è una vera pensione ma una prestazione assistenziale
Solo per chi ha iniziato a lavorare dopo il 1995

STEFANIA VETTORELLO
CONSULENTE DEL LAVORO IN TORINO, MEMBRO DEL CENTRO STUDI NAZIONALE ANCL

ESONERO UNDER 36: COMMENTO ALLA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI AREZZO DEL 26 GIUGNO 2024, N. 425
INDICE
1. Il quadro normativo di riferimento
2. La sentenza del Tribunale di Arezzo
1. IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO
L’applicazione delle agevolazioni contributive soggiace al via libera della Commissione europea, che assume parere favorevole ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul Funzionamento dell’Unione europea. Tale posizione è spesso comunque accompagnata da imprecisioni, le quali spesso possono determinare contenziosi che portano a interpretazioni giurisprudenziali rilevanti.
È il caso dell’ “esonero under-36” e dell’esclusione dall’applicazione nel settore finanziario.
Ripercorrendo la storia dell’incentivo, ricordiamo che l’esonero contributivo per le nuove assunzioni di giovani under 36 è stato introdotto dalla Legge 27 dicembre 2017, n. 205, articolo 1, commi 100-105 e 107, con l’obiettivo di promuovere l’occupazione giovanile stabile. Successivamente, la Legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Legge di Bilancio 2021), all’articolo 1, commi 10-15, ha ampliato questa misura prevedendo un esonero contributivo del 100% per le nuove assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni di contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato, effettuate nel biennio 2021-2022, per giovani che non abbiano compiuto il 36° anno di età alla data dell’assunzione. Questa agevolazione è stata ulteriormente estesa dalla Legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Legge di Bilancio 2023), articolo 1, comma 297, alle assunzioni effettuate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, con un innalzamento del limite massimo dell’incentivo a 8.000 euro annui.
Nella previsione normativa, risultava chiara la non applicabilità dell’agevolazione nei confronti della Pubblica Amministrazione, poiché circoscritta e individuabile assumendo a riferimento la nozione e l’elencazione recate dall’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; al contrario, peccava di troppa genericità l’esclusione dal beneficio nei riguardi delle imprese del settore “finanziario”
in quanto non rientranti nell’ambito di applicazione della comunicazione C(2020) 1863 final del 19 marzo 2020 e successive modificazioni1, facendo riferimento alle imprese che svolgono le attività indicate nella classificazione NACE al settore “K” - Financial and insurance activities2
2. LA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI AREZZO
Nel merito di questa complessa casistica interviene la pronuncia del Tribunale di Arezzo del 26 giugno 2024, n. 425.
Nel caso di specie l’INPS nel 2024 aveva emesso avviso di addebito verso l’azienda XXXX S.R.L. per l’omesso pagamento di contributi e sanzioni nel periodo dal 01/10/2021 al 31.08.2023 per € 9.639,59 per indebita fruizione dell’esonero contributivo per le nuove assunzioni a tempo indeterminato nel periodo intercorrente tra il mese di ottobre 2021 e il mese di Agosto 2023.
A fronte delle somme richieste, l’azienda agisce nei confronti dell’INPS opponendosi all’avviso di addebito e assumendone l’infondatezza e l’illegittimità, con ricorso depositato in data 20.4.2024 a seguito del quale, ritualmente, la parte resistente INPS chiedendo la reiezione della pretesa ex adverso formulata, in quanto asseritamente infondata in fatto e in diritto, proprio in funzione di quanto sopra espresso e sulla base dell’effettiva attività svolta che non rientrerebbe nel settore finanziario, ma bensì in quello assicurativo e in quello afferente ai servizi agli automobilisti quale delegazione ACI.
L’INPS infatti assume che la parte ricorrente sarebbe risultata non possedere i requisiti previsti per il riconoscimento dell’esonero avuto riguardo a quanto espressamente previsto dalla normativa menzionata (comma 14) e riportata al punto 2 della circolare n. 56/2021: “…l’incentivo non può essere
1S’intende come “successiva modificazione” l’introduzione del punto 20-bis del paragrafo 2, introdotto dalla Comunicazione C (2020) 3156 dell’8 maggio 2020, che recita: “Gli aiuti agli enti creditizi e finanziari non devono essere valutati a norma della presente comunicazione, fatta eccezione per: i) i vantaggi indiretti accordati agli enti creditizi o finanziari che convogliano gli aiuti sotto forma di prestiti o garanzie in applicazione delle sezioni da 3.1 a 3.3, conformemente alle garanzie di cui alla sezione 3.4, e ii) gli aiuti di cui alla sezione 3.10 a condizione che il regime non sia destinato esclusivamente ai dipendenti del settore finanziario“.
2La classificazione NACE al settore “K” - Financial and insurance activities corrisponde alla classificazione statistica delle attività economiche nella Comunità europea, con le relative divisioni (codice a 2 cifre), gruppi (codice a 3 cifre) e classi (codice a 4 cifre), che corrisponde a quella dell’ATECO 2007. Tutti i codici ATECO (a 6 cifre), rientranti nelle divisioni 64, 65 e 66, fanno parte della divisione “K” della classificazione ATECO 2007.
riconosciuto nei riguardi delle imprese del settore finanziario, in quanto non rientranti nell’ambito dell’applicazione della comunicazione C (2020) 1863 final del 19 marzo, fatta salva diversa determinazione che dovesse essere assunta dalla Commissione europea nell’ambito della procedura di autorizzazione della misura” ed al punto 7 della circolare n. 57/2023: “…..si conferma che l’esonero in trattazione non può trovare applicazione in relazione ai settori del lavoro domestico e del settore finanziario”. Nella prospettiva dell’INPS le imprese escluse dall’esonero sono quelle che svolgono le attività indicate nella classificazione NACE al settore “K” – Financial and insurance activities e pertanto, a giudizio dell’Istituto, il codice Ateco posseduto da parte ricorrente escluderebbe in radice la pretesa illegittimità del recupero.
Da quanto sopra, si può notare una presa di posizione da parte dell’ente fondata sulle affermazioni contenute nelle circolari da esso stesso emesse e con un forzato riferimento al “comma 14” – dell’articolo 1 della Legge 30 dicembre 2020, n. 178 che in maniera esplicita rimanda ai contenuti della comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final.
È infatti per primo il giudice a rilevare un mancato adempimento probatorio da parte del ricorrente INPS, poiché “Anzitutto appare incontestata fra le parti sia la regolarità contributiva della ricorrente sia la circostanza per la quale la ricorrente risultava in possesso, al momento dell’assunzione agevolata, dei requisiti per fruire degli sgravi connessi all’assunzione di under 36 di cui all’art. 1 co. 10,12 e 14 della L.178/2020” e che “Le difese dell’INPS si soffermano esclusivamente sulla asserita appartenenza della ricorrente al novero delle società del settore finanziario, escluso dal settore degli aiuti di stato, sulla base della mera circostanza formale per la quale il “Codice Ateco” con il quale la ricorrente è classificata nel RR.II. sarebbe dirimente ai fini dell’esclusione della GBG S.r.l. dalle agevolazioni contributive in relazione alle assunzioni di lavoratori under 36.”
La carenza di onere probatorio si rileva altresì attraverso l’esame della visura camerale prodotta in giudizio da INPS (!), da cui si evince che l’attività prevalente è quella di “Agenzia di assicurazione”, che non può certo essere considerata equivalente all’attività bancaria e finanziaria.
Occorre in ultimo rilevare, al fine di avere un quadro completo dello scenario, che i Codici Ateco da attribuire alle imprese sono definiti da appositi decreti ministeriali che, in quanto atti amministrativi dovevano essere prodotti in giudizio da parte resistente a sostegno della propria tesi difensiva, in quanto non rientrano nell’alveo del noto principio iura novit curia3 .
Da quanto sopra, era inevitabile la soccombenza da parte dell’INPS in un giudizio su una tematica senz’altro complessa e articolata poiché richiama il diritto e la prassi comunitaria; tuttavia, appare evidente che la fretta di fare cassa con il recupero di agevolazioni contributive è risultata essere cattiva consigliera dell’ente e consente, ai fini giurisprudenziali, di porre un’importante ancorché primo tassello chiarificatore rispetto all’applicazione di una normativa che dal 2017 ad oggi è stata riproposta a più riprese e a cui è seguito un copioso numero di circolari applicative.

3Le SS.UU. della S.C. hanno da tempo stabilito che “La natura di atti meramente amministrativi dei decreti ministeriali … rende ad essi inapplicabile il principio “iura novit curia” di cui all’art. 113 cod. proc. civ., da coordinarsi, sul piano ermeneutico, con il disposto dell’art. 1 delle disp. prel. c.c. che non comprende, appunto, i detti decreti tra le fonti del diritto.” (Cfr. Cass., Sez. Un., 29/04/2009, n. 9441).

AREA FISCALE

STEFANO CAMASSA
CONSULENTE DEL LAVORO IN MONZA E BRIANZA, TESORIERE NAZIONALE ANCL, MEMBRO DEL CENTRO STUDI NAZIONALE ANCL


MARIA ELISENA GATTO
CONSULENTE DEL LAVORO IN REGGIO CALABRIA, CONSIGLIERA NAZIONALE ANCL, MEMBRO DEL CENTRO STUDI NAZIONALE ANCL

LA RIFORMA FISCALE DEI REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE
INDICE
1. Introduzione
2. L’indennità esente
3. L’ulteriore detrazione
1. INTRODUZIONE
La Legge di Bilancio per il 2025 (LEGGE 30 dicembre 2024, n. 207) ai commi da 2 a 11 ha introdotto diverse novità ai fini della determinazione dei redditi di lavoro dipendente, con esclusione delle pensioni, in modo strutturale, intervenendo sul TUIR, oltre ad aver confermato alcune misure varate, sperimentalmente, per il 2024, dall’art. 1 del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216.
Le misure confermate sono:
1. La riduzione a 3 scaglioni della curva dell’IRPEF.
2. L’innalzamento della detrazione per redditi di lavoro dipendente ed assimilati per redditi non superiori ad euro 15.000 da 1.880 a 1.955 euro.
Sono invece di nuova introduzione:
3. La previsione di un’indennità esente per i redditi fino a 20.000 euro (comma 4).
4. La previsione di un’ulteriore detrazione per i redditi superiori a 20.000 euro, ma non a 40.000 euro (comma 6).
Le misure di cui ai punti 3 e 4, sono andate a sostituire l’esonero parziale contributivo di quanto a carico del lavoratore, previsto nella percentuale del 7% per un imponibile previdenziale non superiore ad euro 1.923 mensili, con esclusione delle mensilità aggiuntive, ridotto al 6% per importi mensili imponibili superiori ad euro 1.923 ma non a 2.692 euro.
Infine viene limitata all’età massima di anni 30 (comma 11) la detrazione per figli a carico di età superiore a 21 anni, mentre resta senza il predetto limite superiore per i figli disabili.
2. L’INDENNITÀ ESENTE
L’indennità esente è espressa in misura percentuale rispetto al reddito percepito secondo lo schema seguente:
INDENNITÀ ESENTE
CALCOLO DELL’IRPEF
Ai soli fini dell’individuazione dello scaglione, per gli assunti ed i cessati in corso d’anno, il reddito è rapportato ad anno.
Nelle intenzioni del legislatore l’introduzione dell’indennità esente avrebbe dovuto sostituire in modo sostanzialmente neutrale l’esonero parziale della contribuzione in capo al lavoratore. A parere di chi scrive, inoltre, la misura di sostegno fiscale, ancorata ad un reddito annuale, in luogo di quella contributiva, parametrata ad un imponibile previdenziale mensile, ha il vantaggio di evitare fluttuazioni mensili, anche dipendenti da retribuzioni straordinarie o premiali che magari potevano far perdere, in termini di netto in busta, più di quanto facevano guadagnare. Per non dire di effetti distorsivi che si potevano generare nel caso in cui lo stock di ferie arretrate avrebbe comportato l’innalzamento dell’imponibile previdenziale, per la necessità dell’assoggettamento contributivo anticipato dello stock rispetto al momento della fruizione delle ferie. Per non dire, altresì, delle possibili distorsioni che si potevano generare, nell’ambito delle insinuazioni al passivo dei datori di lavoro sottoposti a liquidazione giudiziale, rispetto all’individuazione del grado di privilegio cui legare tali importi, destinati con molta probabilità a non vedere mai il riparto.
Tuttavia, non si può tacere che nella elaborazione della curva dell’indennità esente, vi sia un difetto, una specie di colpo di coda postumo dell’esonero contributivo.
Ricordiamo, infatti, che i beneficiari dell’indennità esente, così come i beneficiari dell’esonero previdenziale contributivo, qualora capienti, avrebbero potuto avere diritto al trattamento integrativo di cui all’articolo 1, comma 1, del Decreto Legge 5 febbraio 2020, n. 3, convertito con modificazioni nella Legge 2 aprile 2020, n. 21. Ora, proprio l’effetto, in realtà regressivo, dell’esonero contributivo, aumentava la base imponibile IRPEF. Ma l’effetto regressivo era compensato, per una sia pur ristretta fascia di reddito, dal beneficio di rendere i lavoratori capienti di imposta, ai fini dell’applicazione del trattamento integrativo.
Con l’eliminazione dell’effetto regressivo, alcuni lavoratori diventano incapienti, perdendo il diritto al trattamento integrativo, con una minima compensazione dovuta all’esenzione delle addizionali regionale e comunale IRPEF.
Vediamo il raffronto tra nuovo e previgente regime.
Si può quindi concludere che l’avvento dell’indennità esente sia sostanzialmente ininfluente rispetto al reddito disponibile di coloro che abbiano una RAL inferiore ad euro 8.400. Si assiste ad una forte penalizzazione delle RAL fra 8.400 e 9.000 euro, mentre vi è un piccolo incremento per retribuzioni lorde superiori.
3. L’ULTERIORE DETRAZIONE
Come detto, la Legge 207 del 2024 è stata introdotta per ridurre il peso dell’IRPEF sulle buste paga dal 2025, abbandonando la misura prevista dalla Legge 213/2023 e allargando i beneficiari del vantaggio. Fino al 2024 si prevedeva una riduzione dei contributi previdenziali e assistenziali pari a 6 o 7 punti percentuali, in base a un imponibile contributivo mensile rispettivamente non superiore a 2.692 euro o 1.923 euro. Dal 2025, il cuneo fiscale è quindi passato da una misura contributiva/ previdenziale a una misura fiscale.
A chi spetta l’ulteriore detrazione:
• Per redditi annuali da lavoro dipendente superiori a 20.000 euro e fino a 40.000 euro, è riconosciuta una “ulteriore” detrazione IRPEF, aggiuntiva rispetto alle detrazioni già conosciute.
• Sono esclusi dal beneficio: titolari di reddito da pensione e assimilati, quali collaboratori coordinati e continuativi, personale parasubordinato, lavoratori autonomi dello spettacolo, autonomi sportivi e tirocinanti.
Dettaglio dei benefici:
Il reddito complessivo si calcola considerando anche la quota esente per i lavoratori rientrati in Italia, escludendo però il reddito della prima casa e delle sue pertinenze. L’importo della detrazione è così suddiviso:
Oltre € 40.000
Per l’applicazione mensile, l’importo è diviso per 365 giorni e moltiplicato per i giorni di spettanza nel mese.
Differenze principali tra cuneo fiscale e ulteriore detrazione:
• Il cuneo fiscale (per redditi fino a 20.000 euro) è una somma aggiuntiva al reddito che non concorre alla
€ 1.000 x (€ 40.000 - reddito totale) / € 8.000
€ 0
formazione del reddito complessivo, riconosciuta in misura decrescente al crescere del reddito.
• L’ulteriore detrazione (per redditi da 20.000 a 40.000 euro) agisce invece direttamente sul calcolo delle ritenute fiscali, riducendo l’IRPEF lorda.
ESEMPIO BUSTA PAGA
I sostituti di imposta devono riconoscere in via automatica l’ulteriore detrazione all’atto della erogazione delle retribuzioni e verificare in sede di conguaglio la spettanza della stessa.
Nuovo cuneo e conguaglio fiscale:
A valere sia per l’indennità esente sia per l’ulteriore detrazione:
• In sede di conguaglio annuale se l’importo da restituire supera i 60 euro, viene rateizzato in 10 rate, a partire dal mese del conguaglio.
• Se l’importo da restituire è inferiore a 60 euro o se il conguaglio avviene durante l’anno, l’importo viene trattenuto in un’unica soluzione.


ALESSANDRA LAZZATI
CONSULENTE DEL LAVORO IN COMO, MEMBRO DEL CENTRO STUDI NAZIONALE ANCL

I FRONTALIERI NELLA LEGGE DI BILANCIO 2025
INDICE
1. Premessa
2. Inquadramento storico legislativo
3. Il nuovo accordo tra Italia e Svizzera per i lavoratori frontalieri
4. Gli interventi della Legge di Bilancio 2025 sui frontalieri svizzeri
5. Gli interventi della Legge di Bilancio 2025 sui frontalieri in generale
Anche nella Legge di Bilancio 2025 si parla di lavoratori frontalieri, in particolare di quelli italo-svizzeri, ma non solo. Per i primi, si conferma la disciplina sullo smart working di cui ai recenti accordi tra gli Stati e si ravvisano benefici per i ‘nuovi comuni di confine’.
Dell’attenzione del legislatore giova però anche la generalità dei lavoratori transnazionali, laddove si esplicita un’interpretazione autentica dell’articolo 51 comma 8-bis del TUIR, chiarendo la portata del regime di applicazione delle retribuzioni convenzionali, in un mercato del lavoro in cui la crescente mobilità dei lavoratori, soprattutto in zone di frontiera ma non solo, ha comportato la necessità di una cura e un’attenzione particolare da parte dei legislatori dei vari Stati.
1. PREMESSA
Dopo oltre trent’anni di stabilità giuridica, i lavoratori frontalieri italiani che prestano attività in Svizzera stanno destando ultimamente il vivo interesse e l’attenzione del legislatore, perfino nelle manovre di bilancio. Il riferimento specifico è da individuarsi nei rapporti con lo Stato elvetico, ma il processo di modifica dei vecchi accordi bilaterali a volte straborda e si sussume alla fattispecie generale. Dall’anno 2020 ci sono stati notevoli cambiamenti, il più impattante è dato dalla sottoscrizione del nuovo Accordo per il lavoro dei frontalieri che va a sostituire l’Accordo del 1974, citato dalla Convenzione contro le doppie imposizioni stipulata tra l’Italia e la Svizzera nel 1976.
2. INQUADRAMENTO STORICO LEGISLATIVO
Ma andiamo con ordine. Il cosiddetto ‘vecchio Accordo per i lavoratori frontalieri’ firmato a Roma il 3 ottobre del 1974 da Italia e Svizzera e ratificato con Legge del 26 luglio del 1975 n. 386, aveva ad oggetto la regolamentazione dell’imposizione fiscale dei lavoratori frontalieri italiani che prestavano attività oltre confine e la correlata compensazione finanziaria a favore dei Comuni.
Il principio cardine era quello dell’imposizione esclusiva e alla fonte nello Stato di svolgimento dell’attività, con la previsione di un meccanismo di riversamento delle imposte all’altro Stato (ossia ai Comuni italiani, considerandone l’unilateralità).
La definizione di frontaliere non è mai stata esplicata a livello legislativo ed è stata desunta dalla prassi, identificandolo in quel lavoratore residente in un Comune italiano il cui territorio fosse compreso in tutto o in parte nella fascia di 20 km dal confine con uno dei Cantoni del Ticino, del Grigioni e del Vallese, ove si recava, pressoché quotidianamente, a svolgere l’attività lavorativa (Risoluzione Ade n. 38 del 28/03/2017).
In forza di accordi di politica internazionale tra i due Stati sottoscritti nel 2015 (Roadmap on the way forward in fiscal and financial issues between Italy and Switzerland), Italia e Svizzera si impegnavano ad intraprendere una serie di iniziative bilaterali con svariati obiettivi tra cui lo scambio automatico di informazioni sui conti correnti finanziari (attuato nel 2017), l’inclusione della Svizzera nella white list italiana (attuato nel 2016), la modifica della normativa su interessi e dividendi (ancora in fase di lavorazione) e la modifica della normativa sui lavoratori frontalieri, attuata, come detto nel 2020.
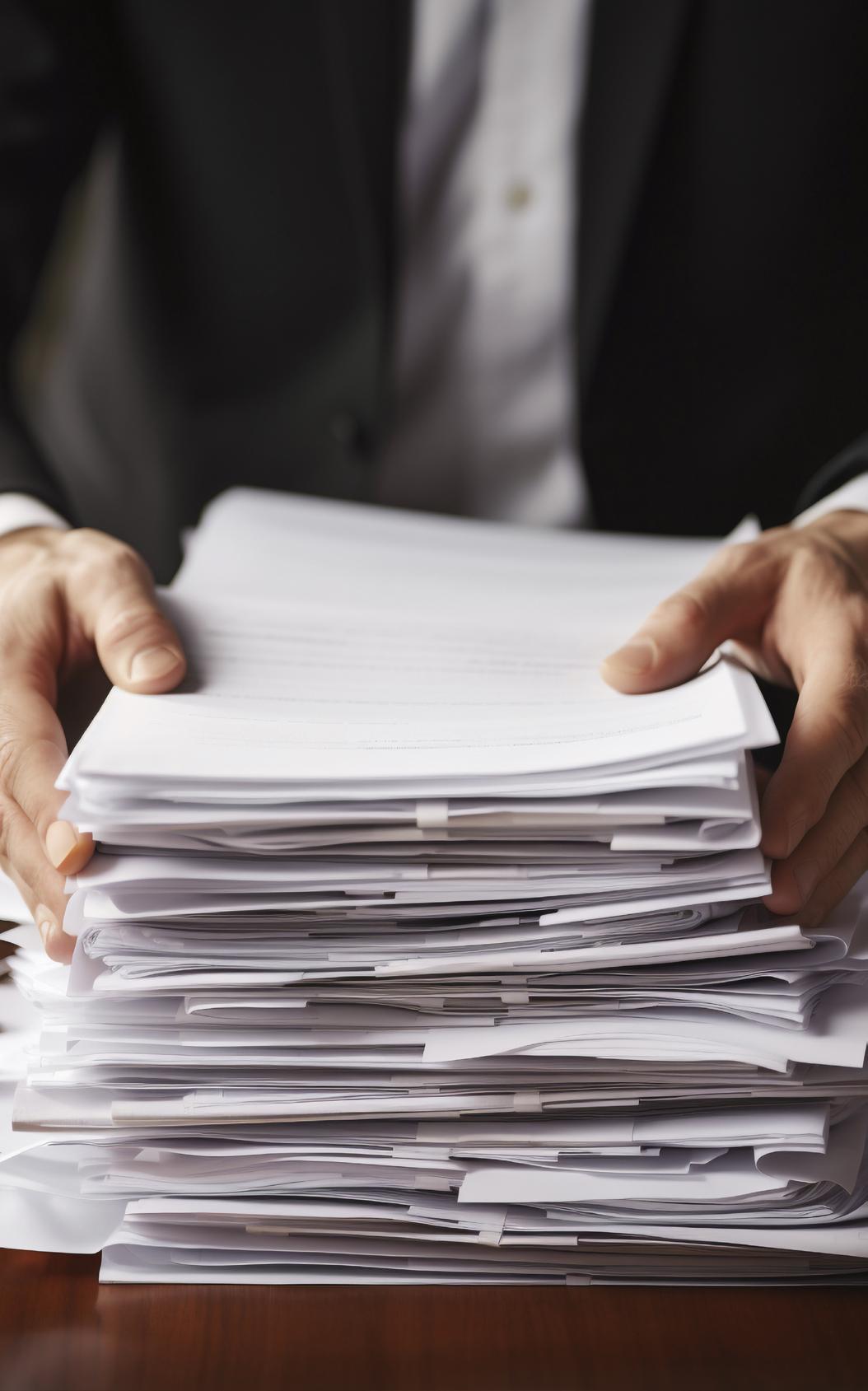
3. IL NUOVO ACCORDO TRA ITALIA
E SVIZZERA PER I LAVORATORI
FRONTALIERI
Il nuovo Accordo per i lavoratori frontalieri è stato sottoscritto a Roma il 23 dicembre del 2020 e ha richiesto un iter di ratifica con procedura solenne (ex art. 80 Cost.), concluso tre anni più tardi, con la Legge n. 83 del 13 giugno 2023, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 30 giugno del 2023 e in vigore dal 17 luglio 2023.
Varie sono le novità: anzitutto all’articolo 1 è introdotto per la prima volta il principio di reciprocità, in base al quale il nuovo Accordo si applica alle persone fisiche residenti in uno Stato contraente che lavorano quali frontalieri nell’area di frontiera dell’altro Stato contraente, senza specificare che si tratti di uno Stato rispetto all’altro. Nell’accordo del 1974 invece, nelle premesse, si leggeva che l’esigenza di regolamentazione nasceva dalla constatazione ‘che un numero elevato di frontalieri residenti in Italia esercita un’attività dipendente in Svizzera, (..)’ e dalla considerazione dell’‘importante contributo che i frontalieri italiani forniscono a diversi livelli, all’economia dei Cantoni in quali essi lavorano (…)’.
Viene ora più precisamente delineata l’area di frontiera e si trova maggior cura nelle definizioni: il frontaliere è un lavoratore residente di uno Stato contraente in un Comune il cui territorio si trova totalmente o parzialmente nella zona di 20 km dal confine con l’altro Stato e che svolge attività di lavoro dipendente nell’area di frontiera per un datore di lavoro residente nell’altro Stato, ritornando in linea di principio quotidianamente al proprio domicilio, nello Stato di residenza. Con successivo Accordo sottoscritto tra le due Nazioni il 22 dicembre del 2023, sono stati poi predisposti specifici elenchi contenenti l’individuazione dei comuni di frontiera sia per la Confederazione Svizzera che per la Repubblica Italiana.
Da qui una serie di criticità:
• la prima: l’elenco stilato per individuare i comuni italiani di cui all’allegato B dell’accordo, reca 72 comuni in più rispetto a quelli originariamente presi in considerazione in base alle liste predisposte unilateralmente dai cantoni svizzeri al fine del riversamento delle imposte nei comuni italiani e mai espressamente disconosciute dal nostro Paese. La disparità di trattamento che si sarebbe venuta a creare tra i vecchi frontalieri destinatari fino alla
pensione della normativa previgente di maggior favore ed i residenti nei ‘nuovi’ Comuni che invece avrebbero scontato la nuova tassazione, è stata ovviata dal legislatore con l’articolo 6 del cosiddetto ‘Decreto Omnibus’, DL n. 113 del 9 agosto 2024, convertito in Legge n. 143 del 7 ottobre 2024, che ha introdotto una disciplina proprio per i lavoratori frontalieri residenti nei 72 ‘nuovi’ comuni. In particolare, è riservata loro la possibilità di optare per un’imposta sostitutiva del 25% delle imposte pagate in Svizzera, senza possibilità di scomputo delle imposte pagate all’estero;
• la seconda: i lavoratori delle Provincie di Sondrio e Brescia che avevano rilevanza inizialmente solo per prestazioni rese nel Cantone dei Grigioni, vengono ora a pieno diritto inclusi nella categoria dei lavoratori frontalieri anche se svolgono attività lavorativa nei Cantoni del Vallese e del Ticino. Anche per loro il DL Omnibus prevede la possibilità di optare in Italia per l’applicazione dell’imposta sostitutiva del 25% dell’imposta versata in Svizzera.
La novità più impattante per i nuovi frontalieri sta indubbiamente proprio nell’introduzione del principio di tassazione concorrente, con previsione di prelevamento di una ritenuta alla fonte da parte dello Stato ove è svolta l’attività in misura non superiore all’80% delle imposte dovute in base alle disposizioni locali e anche di tassazione nello Stato di residenza, eliminando la doppia imposizione. L’Italia ha optato per il meccanismo del credito di imposta, la Svizzera per la previsione di una quota di esenzione pari a 4/5 del reddito, rilevante comunque ai fini della determinazione dell’imposta elvetica.
Il nostro legislatore, in sede di ratifica dell’Accordo, quindi nell’ambito della Legge 83/2023, ha disposto l’aumento della franchigia di cui all’articolo 1 comma 175 dalla Legge 147/2013 per i lavoratori frontalieri da Euro 7.500 ad Euro 10.000; innovazione questa a beneficio di tutti i lavoratori frontalieri, non sono quelli svizzeri.
Il nuovo accordo è in vigore dal 17 luglio del 2023 ed è applicabile agli assunti da tale data (seppur con inizio di efficacia dal 2024) ed è previsto un regime transitorio per coloro i quali hanno assunto la qualifica di frontaliere in un periodo compreso tra il 31 dicembre 2018 e il 17 luglio 2023.

Nonostante il momento storico durante il quale il “nuovo Accordo” è stato sottoscritto fosse quello caratterizzato dalla pandemia, manca la previsione di una puntuale disciplina dello smart working. Vi è un solo cenno nel Protocollo aggiuntivo, al punto 3, nel quale è previsto un generico impegno reciproco degli Stati di consultazione periodica per monitorare il fenomeno ed eventualmente intervenire. Per amor del vero, il 18 giugno precedente era stato sottoscritto un accordo sul tema, in via meramente transitoria, col quale era previsto che i giorni di lavoro prestato da un frontaliere presso lo Stato di residenza, per conto di un datore di lavoro dell’altro Stato, fossero considerati giorni di lavoro prestato nell’altro Stato. Il periodo di efficacia dell’accordo era previsto dal 24 febbraio 2020 al 31 gennaio 2023. La Legge di ratifica, n. 83/2023, ha prorogato quanto disposto in regime emergenziale, prevedendo però l’ammissibilità di telelavoro per non più del 40% del tempo totale, estesa dapprima fino al 30 giugno 2023, poi fino al 31 dicembre 2023. È solo con il Protocollo del 6 giugno 2024 che si arriva alla predisposizione di una normativa con l’auspicio che venga recepita a regime, con la quale viene ammesso il telelavoro dal proprio domicilio di residenza fino al massimo del 25% dell’orario di lavoro nel corso di un anno, senza che ciò provochi il venir meno dello status di frontaliere.
4. GLI INTERVENTI DELLA LEGGE DI BILANCIO 2025 SUI FRONTALIERI SVIZZERI Il primo intervento della Legge di Bilancio 2025, Legge del 30 dicembre 2024 n. 207, sulla tematica dei frontalieri che quotidianamente si recano nello Stato elvetico, si occupa proprio di risolvere il buco normativo sul telelavoro ed è ravvisabile al comma 97 dell’articolo 1. Riprendendo il contenuto del Protocollo
del 6 giugno 2024, viene espressamente previsto che i lavoratori frontalieri, anche definiti tali in vigenza del vecchio Accordo, possano svolgere fino al 25% del loro tempo di lavoro presso il proprio domicilio nello Stato di residenza, senza inficiare la qualifica di frontaliere. La norma è retroattiva dal 1° gennaio 2024 e sino alla data di ratifica delle opportune modifiche all’Accordo del 23 dicembre 2020.
Il secondo intervento della Legge di Bilancio 2025 riguarda sempre l’ambito specifico dei frontalieri di cui all’accordo tra Italia e Svizzera, ed è ravvisabile al comma 99 del citato articolo 1. È previsto che per i comuni italiani di frontiera, dettagliati dal DL Omnibus n. 113/2024, che non erano stati precedentemente inclusi negli elenchi predisposti dalla Svizzera per il riversamento delle imposte, la quota del contributo effettivamente spettante sarà determinata sulla base dei criteri individuati da apposito decreto attuativo, previsto dalla Legge 83/2023 e nessuna contribuzione sarà invece dovuta per le annualità antecedenti a quella di istituzione dell’apposito fondo presso il MEF.
5. GLI INTERVENTI DELLA LEGGE DI BILANCIO 2025 SUI FRONTALIERI IN GENERALE
Il comma 98 articolo 1 della Legge di Bilancio 2025 detta una norma di interpretazione autentica relativa all’articolo 51 comma 8-bis del TUIR. Detta regola in deroga, infatti, aveva suscitato dubbi laddove dispone che il reddito di lavoro dipendente prestato all’estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto da dipendenti che nell’arco dei 12 mesi soggiornano nello Stato estero per un periodo superiore a 183 giorni, debba essere determinato sulla base delle retribuzioni convenzionali definite annualmente con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Ci si domandava, infatti, quale fosse l’esatto perimetro della locuzione “in via continuativa”, in particolare se i frontalieri che soggiornavano settimanalmente nell’altro Stato per prestare in via esclusiva la loro attività lavorativa ma con rientro settimanale e quindi interrompendo un’ipotetica continuità, avessero diritto o meno all’applicazione del regime favorevole delle retribuzioni convenzionali. La Legge di Bilancio 2025 interviene chiarendo che tale fattispecie rientra di diritto nell’ambito del comma 8-bis dell’articolo 51 del TUIR e quindi dell’applicazione del regime delle retribuzioni convenzionali.

AREA SICUREZZA

GIAN LUCA DI ROCCO
CONSULENTE DEL LAVORO IN BORDIGHERA, MEMBRO DEL CENTRO STUDI NAZIONALE ANCL


BARBARA GARBELLI
CONSULENTE DEL LAVORO IN PAVIA, PRESIDENTE UNIONE PROVINCIALE ANCL DI PAVIA, MEMBRO DEL CENTRO STUDI NAZIONALE ANCL


ELEONORA ZAMBON
CONSULENTE DEL LAVORO IN FIRENZE, MEMBRO DEL CENTRO STUDI NAZIONALE ANCL

QUALI NOVITÀ IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO
CON L’ENTRATA IN VIGORE DEL COLLEGATO LAVORO?
INDICE
1. Premessa
2. L’evoluzione della disciplina in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
3. Le novità introdotte dal Collegato Lavoro
4. Il medico competente e la sorveglianza sanitaria nella normativa italiana: evoluzione e aggiornamenti alla luce del Collegato Lavoro 2025
5. Il Collegato Lavoro 2025: tracciabilità e verifica degli obblighi formativi
6. Le novità introdotte dalla Legge n. 203/2024
1. PREMESSA
Negli ultimi anni, il tema della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro è tornato al centro dell’attenzione del Governo, spinto dal crescente numero di infortuni. Questa emergenza ha reso evidente la necessità di potenziare le misure di prevenzione e protezione, semplificando una normativa spesso complessa e frammentata. Gli incidenti sul lavoro, spesso tragici, hanno messo in luce criticità nelle pratiche di sicurezza e sollevato interrogativi sulle responsabilità di aziende e Istituzioni.
Per affrontare questa sfida, il Governo ha rafforzato il sistema di vigilanza e ha introdotto misure preventive mirate, promuovendo una cultura della sicurezza condivisa da tutti gli attori coinvolti: imprese, lavoratori e autorità. In un contesto produttivo sempre più articolato, diventa essenziale un’azione coordinata per migliorare le condizioni lavorative, applicare con maggiore rigore le normative e intensificare i controlli, con particolare attenzione ai cantieri, dove le irregolarità risultano più diffuse.
Dal 2021 ad oggi, il Governo ha adottato una serie di norme finalizzate a modificare e rafforzare il Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro, con l’obiettivo di garantire la massima tutela attraverso un sistema di prevenzione strutturato e partecipativo. Queste riforme evidenziano un impegno crescente nella riduzione degli infortuni e nel miglioramento delle condizioni lavorative, creando un quadro normativo più efficace e coordinato.
Oltre a rispondere alle nuove esigenze del mondo del lavoro, tali interventi ribadiscono l’importanza di una cultura della sicurezza che coinvolga attivamente datori di lavoro, lavoratori e istituzioni. La tutela della salute nei luoghi di lavoro rappresenta oggi una priorità fondamentale, non solo per il benessere dei lavoratori, ma anche per uno sviluppo sostenibile delle imprese e per la salvaguardia dei diritti fondamentali.
2. L’EVOLUZIONE DELLA DISCIPLINA IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA NEI
LUOGHI DI LAVORO
Con l’avvento della seconda Rivoluzione Industriale e con la conseguente crescita del settore, il legislatore ha posto, sin dalla fine dell’Ottocento, l’attenzione
sul tema della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, emanando, nel 1898, il regolamento generale per la prevenzione degli infortuni nelle imprese e nelle industrie (L. n. 80/1898).
Durante il ventennio fascista la prevenzione nei luoghi di lavoro è stata oggetto di un incremento legislativo in materia, ma è solo con l’avvento della Repubblica e la promulgazione della Costituzione che in Italia si assiste allo sviluppo di un corpus normativo di prevenzione e protezione, mettendo in primo piano il diritto dei lavoratori alla tutela della integrità fisica e psichica. Infatti, con l’emanazione dello Statuto dei Lavoratori, L. n. 300/1970, il legislatore ha riconosciuto il diritto alla rappresentanza e al controllo sull’applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, oltre al diritto di attivazione della ricerca, dell’elaborazione e dell’attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la salute dei lavoratori e la loro integrità fisica.
Tra gli interventi normativi più importanti in materia possiamo richiamare il D.Lgs. n. 626/1994, emanato in attuazione della direttiva CEE n. 89/391 e successive, che a reso più incisiva la previsione di cui all’art. 2087 c.c., introducendo, all’interno del nostro ordinamento, alcuni principi cardine, come, ad esempio:

• La prevenzione mediante l’eliminazione dei rischi alla fonte;
• La ripartizione delle responsabilità e dei compiti in capo a più soggetti;
• L’obbligo di istituzione di un servizio di prevenzione e protezione aziendale che mira alla costituzione di una infrastruttura interna all’azienda con specifici compiti di implementazione e verifica dell’osservanza delle norme di prevenzione e di protezione;
• La consultazione e la partecipazione dei lavoratori alle decisioni sulla sicurezza e della loro informazione, compito attribuito, oggi, al Rappresentate dei Lavoratori per la Sicurezza.
A seguito del riordino e dell’armonizzazione della normativa in materia di prevenzione, i principi sopra citati sono stati raccolti nel Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro (T.U.), adottato con il D.Lgs. n. 81/2008. Dal 2021, il Governo ha introdotto una serie di modifiche e integrazioni al T.U., con l’obiettivo di rafforzarne l’efficacia e garantire la massima tutela dei lavoratori attraverso un sistema di prevenzione strutturato e partecipativo1
3. LE NOVITÀ INTRODOTTE DAL COLLEGATO LAVORO
Il più recente intervento in materia è rappresentato dalla legge n. 203 del 13 dicembre 2024, il c.d. Collegato Lavoro, con il quale, attraverso l’articolo 1, comma 1, vengono introdotte importanti novità in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, di cui al d.lgs. n. 81/2008. In particolare l’ambito di intervento della riforma si è focalizzato: sulla composizione della Commissione per gli interpelli, sulle comunicazioni annue del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali alle Camere, sull’educazione continua in medicina per i medici competenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro; sulla sorveglianza sanitaria dei lavoratori, sullo svolgimento dei lavori in locali chiusi sotterranei o semi-sotterranei, sugli obblighi inerenti alla fornitura e all’esposizione delle tessere personali di riconoscimento.
3.1. Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro
La Commissione per gli interpelli, introdotta con il Decreto Direttoriale del 28 settembre 2011, è istituita presso il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali ed è disciplinata dall’art. 12 del d.lgs. n. 81/2008. Essa ha il compito di rispondere ai quesiti di ordine generale sull’applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
In base alla formulazione attuale, la Commissione per gli interpelli è composta da otto membri:
• due rappresentanti del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di cui almeno uno con profilo professionale giuridico;
• due rappresentanti del Ministero della salute, di cui almeno uno con profilo professionale giuridico;
• da quattro rappresentanti delle regioni e delle province autonome, di cui almeno due con profilo professionale giuridico.
Rispetto a quanto previsto nel testo previgente, l’art. 1, c. 1 Collegato Lavoro richiede che almeno quattro rappresentanti abbiano un profilo professionale giuridico. Questo requisito è previsto con riferimento ad almeno un Rappresentante del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, almeno un rappresentante del Ministero della Salute, almeno due rappresentanti delle regioni e province autonome di Trento e Bolzano.
A seguito della modifica che verrà apportata, salvo ulteriori variazioni, resta fermo il principio di invarianza degli oneri di finanza pubblica e la struttura della Commissione. Inoltre, qualora la materia oggetto di interpello riguardi anche competenze di altre amministrazioni pubbliche, la Commissione è integrata con rappresentanti delle stesse.
3.2. Comunicazioni annue del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali alle Camere
Per contrastare le irregolarità nel mondo del lavoro e per tutelare maggiormente la salute e la sicurezza dei lavoratori, il Governo, attraverso il comma 1, lett. b)
1 Esame per Consulente del Lavoro. Manuale di base. Programma completo per la prova scritta e orale, Edizioni Simone Giuridico, Napoli 2022, p. 79; V. Silvestri, Sicurezza nei luoghi di lavoro, in Consulenza del Lavoro. Manuale pratico, TeleConsul, Roma 2022, pp. 355-358.
dell’articolo 1 l. n. 203/2024 ha introdotto l’articolo 14-bis all’interno del d.lgs. n. 81/2008, con il quale viene inserito l’obbligo, per il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di trasmettere alle Camere una relazione annuale.
Tale comunicazione, da presentare entro il 30 aprile di ogni anno con riferimento all’anno precedente, ha l’obiettivo di informare le Camere sullo stato della sicurezza nei luoghi di lavoro, sulle misure necessarie per migliorare le condizioni di salute e di sicurezza dei lavoratori e sulle iniziative normative e programmatiche che il Governo intende adottare nel corso dell’anno.
4. IL MEDICO COMPETENTE E LA SORVEGLIANZA SANITARIA NELLA
NORMATIVA ITALIANA: EVOLUZIONE E AGGIORNAMENTI ALLA LUCE DEL COLLEGATO LAVORO 2025
La figura del medico competente riveste un ruolo sempre più strategico nel garantire la tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Con l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 81/2008, il cosiddetto Testo Unico sulla Sicurezza, il legislatore ha fornito una cornice normativa articolata, definendo con precisione le responsabilità, i compiti e i requisiti del medico competente. Tra questi, uno dei pilastri fondamentali è rappresentato dall’obbligo di educazione continua in medicina, finalizzato a garantire l’adeguatezza professionale nel tempo. Questo quadro normativo che ha conosciuto negli anni una progressiva evoluzione, è stato ulteriormente rafforzato con l’approvazione del Collegato Lavoro 2025 (Legge n. 203/2024), che ha introdotto nuove disposizioni sia sulla formazione dei medici competenti sia sulla gestione della sorveglianza sanitaria dei lavoratori.
4.1. Il medico competente ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008
Il D.Lgs. 81/08 definisce il medico competente come il professionista in possesso di requisiti specifici (specializzazione in medicina del lavoro o discipline equipollenti, o esperienza professionale specifica), incaricato di effettuare la sorveglianza sanitaria sui lavoratori, in relazione ai rischi professionali presenti nell’ambiente di lavoro.
Secondo quanto previsto dall’articolo 38, il medico
competente, oltre a possedere titoli specifici, ha l’obbligo di mantenere nel tempo la propria qualificazione professionale. Questo si traduce nell’obbligo di partecipazione al programma nazionale di Educazione Continua in Medicina (ECM), con l’acquisizione di almeno 150 crediti formativi per ogni triennio, di cui almeno il 70% in discipline affini alla medicina del lavoro.
Questa disposizione risponde all’esigenza, sempre più evidente, di avere professionisti in grado di fronteggiare i continui mutamenti del contesto produttivo e normativo, aggiornati sulle innovazioni in materia di rischi professionali, diagnostica, prevenzione e promozione della salute nei luoghi di lavoro.
L’attività del medico competente non è mai statica: egli è chiamato a confrontarsi con nuovi rischi emergenti (dallo stress lavoro-correlato alle problematiche muscolo-scheletriche, dai rischi chimici ai fattori psicosociali), adattando i protocolli sanitari alle peculiarità di ciascuna realtà aziendale.
Tra le sue principali funzioni rientrano:
• Effettuare le visite mediche previste (preventive, periodiche, su richiesta del lavoratore, alla cessazione del rapporto, ecc.);
• Istituire e aggiornare la cartella sanitaria e di rischio;
• Collaborare con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione aziendale alla valutazione dei rischi;
• Partecipare alla programmazione della sorveglianza sanitaria e alla predisposizione delle misure per la tutela della salute;
• Rilasciare pareri sull’idoneità dei lavoratori alla specifica mansione;
• Informare e formare i lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria.
5. IL COLLEGATO LAVORO 2025: TRACCIABILITÀ E VERIFICA DEGLI
OBBLIGHI FORMATIVI
Con la pubblicazione del Collegato Lavoro 2025, è stata rafforzata la tracciabilità dell’adempimento formativo.
In particolare, il Ministero della Salute è ora incaricato di effettuare controlli periodici, tramite l’anagrafe

nazionale ECM, per verificare il rispetto degli obblighi formativi da parte dei medici competenti.
La novità sostanziale è che il sistema consente una verifica oggettiva e automatizzata della regolarità formativa. Non basta più una semplice autodichiarazione: il professionista che non risulta in regola viene sospeso d’ufficio dall’elenco nazionale, perdendo il diritto di esercitare la propria attività come medico competente fino alla regolarizzazione.
Questa scelta politica si inserisce in una più ampia logica di responsabilizzazione dei professionisti sanitari, fondata sulla trasparenza e sulla valorizzazione delle competenze effettivamente possedute.
Sorveglianza sanitaria: evoluzione e innovazioni normative
La sorveglianza sanitaria, come definita dall’art. 41 del D.Lgs. 81/08, rappresenta un insieme articolato di attività cliniche e diagnostiche che il medico competente mette in atto per valutare l’idoneità dei lavoratori rispetto ai rischi professionali. Con l’introduzione
del Collegato Lavoro 2025, questa funzione è stata oggetto di importanti aggiornamenti procedurali.
Ecco le principali novità:
• Visita medica preventiva pre-assuntiva: la riforma riconosce questa visita come pienamente valida ai fini della valutazione dell’idoneità al lavoro, con l’obbligo che essa venga effettuata dal medico competente aziendale. Viene meno, dunque, la possibilità per il datore di lavoro di rivolgersi a strutture pubbliche come i Dipartimenti di Prevenzione delle ASL.
• Utilizzo di accertamenti clinici pregressi: il medico competente, in fase di valutazione sanitaria, deve tenere conto degli esami già eseguiti dal lavoratore, riportati nella cartella sanitaria e di rischio. Questo evita duplicazioni diagnostiche e ottimizza l’efficacia degli accertamenti.
• Visita medica al rientro da assenza prolungata: la nuova normativa stabilisce che tale visita sia obbligatoria solo in caso di assenze superiori a 60 giorni continuativi e solo se ritenuta necessaria dal medico competente, restituendo al professionista la responsabilità di una valutazione clinica personalizzata.
• Ricorsi contro i giudizi del medico competente: i ricorsi contro i giudizi del medico competente, anche per le visite preventive, devono essere presentati all’azienda sanitaria locale (ASL) di riferimento. Prima, il ricorso poteva essere gestito dall’organo di vigilanza sul lavoro territorialmente competente, ma ora viene semplificata la procedura per evitare dubbi interpretativi.
• Accertamenti su tossicodipendenza e alcol: con la pubblicazione della Legge n. 203/2024 è stato posticipato il termine per la revisione delle procedure in materia; si è pertanto in attesa di accordo in Conferenza Stato-Regioni previa consultazione delle parti sociali, con l’obiettivo di aggiornare protocolli e criteri clinici in linea con le più recenti evidenze scientifiche.
Queste modifiche evidenziano una volontà chiara del legislatore: potenziare l’efficienza del sistema di prevenzione, valorizzando la figura del medico competente come regista della tutela sanitaria aziendale.
Un ruolo sempre più centrale
Il contesto normativo attuale richiede al medico competente di apporre l’accento su una visione moderna e più ampia del proprio ruolo. Non è più sufficiente limitarsi agli adempimenti tecnici: è necessario agire come consulente strategico per la promozione della salute, come interlocutore proattivo nella gestione del rischio, e come garante di un sistema sanitario aziendale efficace e trasparente.
La verifica ministeriale dell’ECM non deve essere vissuta come un controllo punitivo, ma come una garanzia di qualità del servizio offerto alle aziende e ai lavoratori.
Il Collegato Lavoro 2025 offre, in questo senso, l’opportunità di consolidare un modello virtuoso di sorveglianza sanitaria, fondato sulla competenza, sull’aggiornamento continuo e sulla responsabilità professionale.
Investire nella formazione e nel rafforzamento delle procedure significa investire nella salute dei lavoratori e, quindi, nel futuro delle imprese.
5.1. Le modifiche alle modalità di riconoscimento dei lavoratori nei cantieri temporanei e mobili
A partire dal 1° ottobre 2006, i datori di lavoro del settore edile sono obbligati a fornire ai propri dipendenti una tessera di riconoscimento, contenente una fotografia e le informazioni personali del lavoratore, insieme ai dati del datore di lavoro. I lavoratori, da parte loro, devono esporre la tessera durante l’attività lavorativa.
L’obbligo si estende anche ai lavoratori autonomi che operano direttamente nei cantieri, i quali devono provvedere autonomamente alla richiesta del tesserino.
Il Decreto Legislativo 81/2008 ha ribadito questa normativa, estendendone però l’applicazione ad altri settori, non limitandosi esclusivamente all’edilizia, ma estendendola alle attività svolte in regime di appalto o subappalto.
In particolare:
• L’articolo 18 stabilisce che i datori di lavoro e i dirigenti, nell’ambito di attività di appalto o subappalto, devono fornire ai lavoratori una tessera di riconoscimento, completa di fotografia, con le
generalità del lavoratore e i dati del datore di lavoro;
• L’articolo 26, comma 8, obbliga i datori di lavoro a fornire il tesserino di riconoscimento ai propri dipendenti;
• L’articolo 20, comma 3, stabilisce che i lavoratori impiegati in attività di appalto o subappalto devono esporre il tesserino.
Con la nota n. 656 del 23 gennaio 2025, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha chiarito l’obbligo per i datori di lavoro di fornire ai dipendenti un tesserino di riconoscimento e per i lavoratori di esporlo durante l’attività lavorativa.
Queste precisazioni sono diventate necessarie a seguito delle modifiche introdotte dalla Legge n. 203/2024 (Collegato Lavoro), che ha modificato l’articolo 304, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 81/2008, e abrogato i commi 3, 4 e 5 dell’articolo 36-bis del D.L. n. 223/2006 (convertito con modificazioni dalla Legge n. 248/2006).
Cos’è e a cosa serve il tesserino di riconoscimento nei cantieri
Il tesserino di riconoscimento in cantiere è un documento che certifica l’identità dei lavoratori e degli altri soggetti autorizzati ad accedere al cantiere, in conformità alle normative sulla sicurezza sul lavoro, assicurando che ogni persona presente nel cantiere possieda una qualifica specifica e operi in linea con le normative vigenti.
Cosa deve contenere il tesserino aziendale?
Un tesserino di riconoscimento deve generalmente includere:
• Nome e cognome del lavoratore;
• Mansione o ruolo ricoperto;
• Eventuale certificazione o qualifica (ad esempio, qualifica di sicurezza sul lavoro);
• Foto del lavoratore;
• Numero identificativo (ID);
• Data di scadenza, se applicabile.
Differenti tipologie di tesserino di riconoscimento
Il tesserino identificativo, pur mantenendo lo scopo comune di identificare agevolmente i lavoratori autorizzati ad accedere al cantiere temporaneo o mobile, deve contenere informazioni differenti a seconda della tipologia di contratto che lega il lavoratore a quel cantiere.
Nello specifico:
1. Tesserino di riconoscimento per lavoratore dipendente:
• Cognome e nome
• Fototessera
• Data di nascita
• Impresa (datore di lavoro)
• Partita IVA
• Data di assunzione
2. Tesserino di riconoscimento per lavoratore dipendente di impresa in subappalto:
• Cognome e nome
• Fototessera
• Data di nascita
• Impresa (datore di lavoro)
• Partita IVA
• Data di assunzione
• Subappalto autorizzato in data
3. Tesserino di riconoscimento per lavoratore autonomo:
• Ragione sociale
• Fototessera
• Cognome e nome
• Data di nascita
• P.IVA/C.F.
• Committente
Verbale di consegna del tesserino di riconoscimento
Si propone di seguito un esempio di verbale per la consegna del tesserino identificativo:
Il sottoscritto/a ______________________________________, nato a __________________________ il ________________, dichiara di aver ricevuto il tesserino di riconoscimento, come previsto dall’articolo 26, comma 8 del D.Lgs. 81/08, corredato di fototessera e contenente le sue generalità.
Il tesserino dovrà essere esposto durante le attività in regime di appalto e subappalto. In caso di deterioramento o perdita del tesserino, il lavoratore è tenuto a segnalare immediatamente la situazione al datore di lavoro.
Luogo e data
Il datore di lavoro (per avvenuta consegna)
Il lavoratore (per ricevuta) ______________________
Obbligo di tesserino di riconoscimento
Il tesserino di riconoscimento è obbligatorio per tutti i lavoratori del settore edile, che devono riceverlo dal datore di lavoro. Esso deve contenere una fotografia e le generalità del lavoratore, insieme ai dati del datore di lavoro. Inoltre, anche i lavoratori autonomi e i membri delle imprese familiari che operano in attività di appalto o subappalto devono possedere un tesserino di riconoscimento.
Regime sanzionatorio
Il datore di lavoro che non fornisce il tesserino di riconoscimento ai propri dipendenti, come previsto dalla normativa, è soggetto a sanzioni amministrative, che variano da 100 a 500 euro, come stabilito dall’articolo 55, comma 5, lettera i, del D.Lgs. 81/2008.
Utilizzo in deroga di ambienti chiusi sotterranei o semi-sotterranei
Il Collegato Lavoro (Legge n. 203/2024), all’articolo 1, comma 1, lettera e), ha attribuito all’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) la competenza di vigilare sull’uso di locali sotterranei o semi-sotterranei per attività lavorative, stabilendo che i datori di lavoro devono informare l’Ispettorato tramite PEC prima di utilizzare tali ambienti. L’obbligo di comunicazione è stato introdotto come misura per garantire la sicurezza dei lavoratori che operano in spazi che non rispettano i normali standard di ventilazione, illuminazione e microclima.
Con questo provvedimento, sono stati modificati i commi 2 e 3 dell’articolo 65 del D.Lgs. n. 81/2008, che in precedenza permettevano l’utilizzo di locali privi di adeguate condizioni di salubrità, a condizione che fossero sotterranei o chiusi. La modifica stabilisce che ora, per tale utilizzo in deroga, la decisione spetta all’Ispettorato Nazionale del Lavoro, che deve essere preventivamente informato, ma non rilascia una vera e propria autorizzazione.
La competenza dell’Ispettorato si estende a locali che, pur non soddisfacendo i requisiti standard, possono essere utilizzati per esigenze lavorative particolari. Tuttavia, l’utilizzo di questi ambienti è vietato per attività che generano emissioni di agenti nocivi.
6. LE NOVITÀ INTRODOTTE DALLA
LEGGE N. 203/2024
In passato, la verifica delle condizioni dei locali era compito delle Aziende Sanitarie Locali (ASL), ma con la nuova normativa, questa responsabilità è passata all’Ispettorato Nazionale del Lavoro. Il datore di lavoro, pertanto, deve inviare una comunicazione tramite PEC, allegando la documentazione necessaria a supporto, prima di utilizzare tali spazi per attività lavorative.
Anche se non si tratta di una vera e propria autorizzazione, la comunicazione è obbligatoria e deve contenere informazioni dettagliate sul tipo di attività svolta, specificando che non sono previsti agenti nocivi. La nuova disciplina, inoltre, si applica a tutti i locali sotterranei o semi-sotterranei che vengono utilizzati per “particolari esigenze tecniche”, come previsto dalla normativa.
Quando non è possibile inviare la comunicazione
Non è possibile presentare la comunicazione nel caso in cui le attività lavorative comportino l’emissione di agenti nocivi, come ad esempio lavori di stampa, falegnameria, ricarica di batterie o attività simili, che non sono consentite in locali privi di adeguati sistemi di ventilazione e aerazione.
Modalità e tempi per inviare la comunicazione
La comunicazione deve essere inviata 30 giorni prima dell’effettivo utilizzo, modifica o voltura dei locali, utilizzando il modulo predisposto dall’Ispettorato e disponibile sul sito ufficiale. È possibile inviarla esclusivamente tramite PEC, al competente Ufficio territoriale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro.
La documentazione da allegare alla comunicazione include:
• Una relazione dettagliata che descriva l’attività lavorativa che si svolgerà nei locali, con l’indicazione delle lavorazioni previste per ciascun ambiente.
• Un’asseverazione di un tecnico abilitato che certifichi la conformità dei locali alle normative urbanistiche, edilizie e igienico-sanitarie vigenti, così come la loro agibilità e il rispetto delle norme relative all’illuminazione, all’aerazione e al microclima.
• L’asseverazione deve inoltre attestare che i locali siano conformi alle normative in materia di sicurezza e salute sul lavoro, e che siano presenti sistemi di ventilazione adeguati per garantire la salubrità dell’aria, e che il microclima rispetti i requisiti per il tipo di attività svolta.
Attività vietate e controllo delle emissioni
Il Collegato Lavoro ha stabilito un elenco non esaustivo delle attività che non sono consentite nei locali sotterranei o semi-sotterranei, in quanto potrebbero generare agenti nocivi. Tra queste, vi sono attività come lo sviluppo e la stampa fotografica, la tipografia, la falegnameria, e la ricarica di batterie. Inoltre, è prevista una specifica attenzione all’eventuale presenza di gas radon, il cui monitoraggio dovrà avvenire entro 24 mesi dall’inizio dell’attività.
Situazione pre-esistente
Per le aziende che già utilizzavano locali sotterranei o semi-sotterranei prima dell’entrata in vigore della legge, non è necessaria una nuova comunicazione, a meno che non siano presenti emissioni nocive. In tali casi, sarà l’Ispettorato a valutare se le condizioni di sicurezza siano state rispettate e se l’utilizzo del locale sia conforme alle normative.
Conseguenze in caso di mancato rispetto delle normative
Se le condizioni richieste per l’utilizzo di locali sotterranei o semi-sotterranei non sono soddisfatte, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro può negare l’utilizzo dei locali e inviare una PEC motivata con la comunicazione del diniego. Le aziende che non rispettano queste normative sono soggette a sanzioni per non aver seguito la procedura corretta di comunicazione e per l’utilizzo non autorizzato dei locali.


ALBERTO BALESTRINI
CONSULENTE DEL LAVORO IN COMO, MEMBRO DEL CENTRO STUDI NAZIONALE ANCL

IL RUOLO ATTIVO DEL LAVORATORE PER LA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI: LEGITTIMO
IL LICENZIAMENTO A SEGUITO DI RIFIUTO DI SOTTOPORSI A VISITA MEDICA
INDICE
1. L’evoluzione degli eventi infortunistici in Italia (La situazione aggiornata a Giugno 2024)
2. L’obbligo di sicurezza sul lavoro e il ruolo attivo assunto dal lavoratore
3. La vicenda processuale
4. Conclusioni
1. L’EVOLUZIONE DEGLI EVENTI
INFORTUNISTICI IN ITALIA (LA SITUAZIONE AGGIORNATA A GIUGNO 2024)
Al di là di quanto riscontrabile attraverso i consueti canali di informazione, mass media e social network in primis, al fine di valutare in modo serio il reale andamento delle condotte infortunistiche all’interno del nostro territorio non si può che utilizzare la sezione “Open data” consultabile all’interno del portale INAIL, attraverso la quale lo stesso Istituto rende periodicamente disponibili i dati analitici delle denunce di infortunio e di malattia professionale presentate mediante i ben noti servizi telematici.
Analizzando, dunque, i dati pervenuti al 30 Giugno 2024 e con l’avvertenza di porre in essere le dovute cautele necessarie in virtù delle inevitabili tempistiche di trattazione delle pratiche, amministrative e sanitarie, legate ad eventi così particolari, si riscontra, nel primo semestre del 2024 e a seguito di confronto rispetto all’analogo periodo del 2023, un lieve aumento delle denunce di infortunio in complesso e una crescita delle malattie professionali, curiosamente con un aumento più rilevante (+5,4%) con riferimento agli eventi avvenuti nel tragitto casa-lavoro.
Nello specifico le denunce di infortunio presentate all’INAIL nei primi sei mesi del 2024 risultano in aumento dello 0,9% rispetto al primo semestre del 2023; nel dettaglio, le denunce di infortunio con esito mortale sono state 469 con un incremento del +4,2% rispetto all’anno precedente.
In un quadro ancora incontrovertibilmente negativo e pur considerando un aumento delle denunce di infortunio inviate come indicato in premessa, l’unica notizia positiva fa riferimento all’andamento tradotto in termini di incidenza infortunistica, cioè rapportando i valori assoluti al numero di occupati ISTAT rilevato a Giugno 2024; ebbene tale andamento, fortunatamente, mostra una tendenza al ribasso. Si passa, infatti, da 1.394 denunce di infortunio ogni centomila occupati ISTAT del 2019 a 1.250 del 2024 (-10,3%). Rispetto poi al 2023 il calo è dello 0,5% (da 1.256 a 1.250).
Andando ad approfondire l’andamento infortunistico, si nota come il numero delle denunce di infortunio sul lavoro ha segnato un -0,7% nella gestione industria e servizi, un -0,2% in agricoltura e un +7,3% nel c.d. “Conto Stato”.
Tra i settori di attività con i maggiori incrementi percentuali si evidenziano la sanità e l’assistenza sociale (+22,1%), il noleggio e i servizi di supporto alle imprese (+16,8%), le costruzioni (+14,7%), le attività dei servizi di alloggio e di ristorazione (+14,6%), il trasporto e magazzinaggio (+8,1%) e il commercio (+8,0%).
L’analisi territoriale evidenzia un aumento delle denunce di infortunio nelle Isole (+2,7%), seguite dal Centro (+1,5%), Nord-Ovest (+0,9%) e Nord-Est (+0,6%) con, diversamente, un calo al Sud (-0,4%). Tra le regioni con i maggiori incrementi percentuali si segnalano la provincia autonoma di Trento (+17,8%), il Molise (+4,7%), la Sicilia (+3,9%) e la Calabria (+3,6%), mentre per i decrementi vi sono quelli relativi all’Abruzzo (-4,8%), alla Campania (-3,4%), alla Basilicata e alla Liguria (-2,0% ciascuna).
Con riferimento all’analisi dei dati in relazione al genere, si evidenzia che l’aumento che emerge dal confronto dei primi semestri del 2023 e 2024 è legato sia alla componente maschile (+0,6%) che a quella femminile (+1,5%). L’incremento ha interessato i lavoratori italiani (+0,3%) ed extracomunitari (+5,0%), mentre il dato dei comunitari risulta al momento in calo (-3,2%).

L’analisi per classi di età mostra aumenti considerevoli tra gli under 15 (+20,6%), soprattutto per l’incremento degli infortuni tra gli studenti (sul tema, è bene considerare l’inevitabile effetto dell’estensione assicurativa INAIL disposta dal D.L. n. 48/2023), nella fascia 25-29 anni (+3,0%) e in quella 60-74 anni (+5,8%). Si registra, diversamente, un calo tra i 1524enni (-2,2%) e tra i 30-59enni (-2,8%).
Infine, anche con riferimento alle malattie professionali comunicate all’Istituto la tendenza appare chiaramente al rialzo, con un aumento del 19,6% rispetto al primo semestre 2023, dato sicuramente elevato ma senz’altro ben più contenuto rispetto alla pesante tendenza riscontrata negli ultimi anni (+46,4% rispetto al 2022, +57,7% rispetto al 2021, +123,8% rispetto al 2020).
Pertanto, sulla base di uno scenario caratterizzato da numeri ancora troppo elevati e certamente molto preoccupanti, appare ancora una priorità chiedersi come poter aumentare realmente la tutela dei lavoratori sui luoghi di lavoro; sul punto, ritornare a ragionare sull’obbligo di sicurezza sul lavoro e sui ruoli di entrambe le parti, datore di lavoro e lavoratore, non risulta forse così scontato.
2. L’OBBLIGO DI SICUREZZA SUL LAVORO
E IL RUOLO ATTIVO ASSUNTO DAL LAVORATORE
Com’è noto, tra gli obblighi derivanti dalla stipula di un rapporto di lavoro di natura subordinata di cui all’art. 2094 del Codice Civile vi è senz’altro l’obbligo di sicurezza, naturalmente gravante, quanto meno in primis, in capo al datore di lavoro. Nello specifico i doveri ai quali tale soggetto risulta chiamato, minuziosamente riportati dal Testo Unico in materia di sicurezza sul lavoro (D.Lgs. n. 81/2015) appaiono senz’altro numerosi, spaziando dalla nomina del medico competente, alla valutazione dei rischi sul lavoro, dalla fornitura dei dispositivi di protezione individuale (DPI) alla concreta vigilanza circa il rispetto di tali norme da parte dei lavoratori.
È bene precisare, fin da subito, come gli stessi lavoratori però, pur essendo indubbiamente considerati come soggetti beneficiari di dette misure di tutela a beneficio della loro salute, vantano però un vero e proprio ruolo attivo in tale ambito in quanto proprio l’art. 20 del sopracitato Testo Unico statuisce chiaramente come
“Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.”
La norma, in aggiunta, continua elencando precisamente alcune condotte alle quali tutti i lavoratori risultano tenuti tra le quali è possibile notare, oltre ad alcune formulazioni senz’altro più generiche (contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all’adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro) anche obblighi maggiormente definiti e precisi (sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico competente) che ci verranno in soccorso proprio in occasione della peculiare vicenda in questione nonché oggetto del presente approfondimento.
3. LA VICENDA PROCESSUALE
La vicenda risulta originata dal licenziamento comunicato ad una lavoratrice rea confessa di essersi rifiutata (nello specifico, per ben due volte a seguito della medesima richiesta datoriale, a distanza di poco meno di una settimana) di sottoporsi a visita medica regolarmente prevista nell’ambito della sorveglianza sanitaria a seguito di variazione della mansione a lei assegnata.
È bene precisare come, argomento successivamente analizzato anche dagli stessi giudici, la lavoratrice, a sostegno del proprio rifiuto, apparentemente inspiegabile, adduceva non una questione “di principio” slegata da qualsivoglia precise motivazioni, ma specificamente conseguente al timore di risultare, in caso di esito negativo della visita, potenzialmente demansionata o, ancor peggio, destinataria di una procedura espulsiva per inidoneità fisica da parte del datore di lavoro.
A seguito del recesso datoriale in virtù di tale rifiuto a sottoporsi a detta visita, la lavoratrice, al fine di tutelare la propria posizione, ha deciso di presentare ricorso presso il Tribunale di Bologna, organo che ha inizialmente accolto le ragioni della stessa per poi vedere però ribaltato il proprio giudizio in sede di successivo appello presso la rispettiva Corte.
Le motivazioni che hanno in seguito portato ad una
sentenza di senso opposto risultano essere state, successivamente, condivise anche dalla Corte Suprema di Cassazione, sezione Lavoro, ovvero l’organo che, aderendo all’orientamento assunto dalla Corte di Appello di Bologna (sentenza n. 701/2019 depositata il 24 Settembre 2019), ha ritenuto pienamente legittimo il licenziamento adottato dal datore di lavoro attraverso la sentenza del 6 Settembre 2022 n. 26199.
La Corte di Cassazione, infatti, avallando il comportamento datoriale ha ritenuto illegittimo il rifiuto della lavoratrice sostenendo, nei fatti, che il semplice timore, solamente ipotizzato dalla lavoratrice, per ipotetiche ed eventuali conseguenze relative ad un’eventuale inidoneità alla mansione, non poteva certamente andare a invalidare un vero e proprio obbligo da parte del datore di lavoro, ovvero quello di sottoporre i propri lavoratori alla sorveglianza sanitaria prevista; viene ribadito, in aggiunta, che tale prassi risultava per il datore di lavoro una vera e propria condotta del tutto obbligatoria e non, diversamente, una mera facoltà per lo stesso. Obbligo effettivo, quindi, per il datore di lavoro, in quanto l’esigenza di procedere con una visita medica si verificava sia in occasione del cambio mansione che in virtù del generico obbligo di sottoporre a visita medica a cadenza annuale.
Appare superfluo, precisare che, come rammentato giustamente dalla Suprema Corte, ove tale imposizione non risultasse correttamente adempiuta da parte del datore di lavoro, avrebbe senz’altro esposto tale soggetto a possibili sanzioni per l’omissione della condotta, colposa o dolosa, oltre che reso eventualmente lo stesso destinatario di pesanti responsabilità derivanti da un potenziale evento dannoso.
In aggiunta, è stato poi precisato dalla stessa Corte che la lavoratrice, caratterizzata dal timore sopra indicato, anche in tale situazione di indubbia difficoltà non sarebbe ugualmente rimasta senza possibilità di protezione e tutela; anche a seguito dello svolgimento della visita medica rimaneva, sempre, fatta salva la possibilità per la stessa, in caso di esito sfavorevole, di impugnare l’esito qualora non venisse da lei condiviso.
Alla luce delle suddette riflessioni, dunque, a detta della Corte di Cassazione chiamata a pronunciarsi definitivamente sulla vicenda, l’atto espulsivo adottato nei confronti della lavoratrice risultava del tutto legittimo e pienamente proporzionato al fatto commesso in quanto basato su un comportamento
che andava a costituire una grave insubordinazione da parte di ogni lavoratore subordinato, ovvero quella di non sottoporsi alle visite mediche come, diversamente, ordinariamente previsto dal già citato art. 20 del D.Lgs. n. 81/2015.
4. CONCLUSIONI
Tale vicenda processuale e le relative determinazioni assunte in fase di giudizio non possono far altro che ribadire, in un linguaggio decisamente pratico, come gli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di sicurezza risultano effettivamente ricadenti in capo al datore di lavoro ma, parimenti, viene richiesto a tutti gli effetti un ruolo attivo anche al lavoratore il quale, concretamente, dovrà attivarsi per consentire di creare un ambiente di luogo sicuro e confortevole per sé e per gli altri.
Ove ciò, per qualsiasi motivazione, non accada ben dovrà (e, si badi, non meramente “potrà”) il datore di lavoro attivarsi con tutti gli strumenti a lui concessi al fine di incentivare, e nei fatti obbligare, il lavoratore ad adempiere. Tali strumenti, costituiti senz’altro in primis dal ben noto iter di contestazione disciplinare di cui all’art. 7 della Legge n. 300/1970, ma anche, in extrema ratio, dal concreto allontanamento del lavoratore autore della condotta omissiva mediante licenziamento per giusta causa, proprio come avvenuto, in modo pienamente legittimato, nel caso in esame.

AREA SINDACALE

EMANUELA DE PALMA
CONSULENTE DEL LAVORO IN CAGLIARI, MEMBRO DEL CENTRO STUDI NAZIONALE ANCL


FRANCESCO GERIA
CONSULENTE DEL LAVORO IN VICENZA, MEMBRO DEL CENTRO STUDI NAZIONALE ANCL

LAVORO STAGIONALE E CONTRATTAZIONE COLLETTIVA
INDICE
1. Premessa
2. Normativa generale sul lavoro stagionale
3. Contratto di lavoro stagionale
4. Tutele previdenziali e assistenziali
5. Aspetti Fiscali
6. Tabella di riepilogo
7. Il lavoro stagionale e il ruolo fondamentale della contrattazione collettiva
1. PREMESSA
Il lavoro stagionale si caratterizza quale forma di impiego temporaneo contraddistinto dalla necessità di personale in specifici periodi dell’anno, tipicamente legati a cicli naturali o a particolari condizioni economiche, come il turismo estivo o la raccolta agricola.
La normativa italiana definisce il lavoro stagionale come un contratto a termine che risponde alle esigenze di determinati settori economici che richiedono un incremento di forza lavoro in periodi predefiniti.
Inoltre, il c.d. Collegato Lavoro (L. n. 203/2024) ha fornito la corretta interpretazione della definizione di lavoro stagionale, in particolare di quello disciplinato attraverso la contrattazione collettiva.
Il lavoro stagionale svolge un ruolo cruciale nell’economia italiana, soprattutto in settori come il turismo, l’agricoltura e il commercio. Consente alle aziende di adattarsi alle variazioni della domanda senza dover sostenere i costi fissi di personale permanente. Inoltre, offre opportunità di impiego a molte persone, inclusi giovani e studenti, durante i periodi di alta stagione.
Con il presente contributo si vuole fornire una panoramica della normativa vigente (definizione, caratteristiche dei contratti, diritti e i doveri dei lavoratori, tutele previdenziali e assistenziali) e della sua regolamentazione attraverso la contrattazione collettiva, tenuto conto delle novità introdotte.
2. NORMATIVA GENERALE SUL LAVORO STAGIONALE
Legislazione di riferimento
La normativa italiana sul lavoro stagionale è principalmente regolata dal Jobs Act (D. Lgs. n. 81/2015) e dal Decreto Dignità (D.L. n. 87/2018), con successivi aggiornamenti apportati dal Decreto Lavoro (D.L. n. 48/2023) e dal Collegato Lavoro (L. n. 203/2024). Il Jobs Act, infatti, ha introdotto una disciplina organica per il lavoro a tempo determinato, prevedendo specifiche deroghe per il lavoro stagionale.
Fonti normative:
• D.Lgs. del 15 giugno 2015, n. 81 e succ. mod. (artt. 19, 21, 23 e 24)
• D.L. del 12 luglio 2018, n. 81 convertito in Legge 9 agosto 2018, n. 96
• D.P.R. del 7 ottobre 1963, n. 1525
• Ministero Lavoro Interpello del 12 febbraio 2016, n. 7
• Ministero del Lavoro Interpello del 20 maggio 2016, n. 15
• Legge 17 dicembre 2024, n. 203
• Circolare Ministero del lavoro 27 marzo 2025, n. 6

Differenze tra lavoro stagionale e altre forme di lavoro a termine
I contratti di lavoro stagionale si differenziano dai contratti a termine ordinari principalmente per le deroghe previste in termini di durata, causali e limiti di contingentamento. Le principali differenze possono essere così riassunte: CARATTERISTICA
Durata Massima
Clausole di Rinnovo/Proroga
Contingentamento
Contributi Addizionali
24 mesi
Obbligatorie oltre i 12 mesi
20% del personale permanente e in base alle previsioni deli CCNL
Applicabili
Durata del contratto
Nessun limite
Non obbligatorie
Nessun limite
Esenzioni per le attività disciplinate dal DPR n. 1525/1963
La durata dei contratti stagionali può variare in base alle esigenze specifiche del settore e dell’azienda. A differenza dei contratti a termine ordinari, non sono soggetti al limite massimo di 24 mesi imposto dal Decreto Dignità, così come modificato dal D.L. n. 48/2023.
D.Lgs. n. 81/2015 - Art. 19 - Apposizione del termine e durata massima
..omissis….
2. Fatte salve le diverse disposizioni dei contratti collettivi, e con l’eccezione delle attività stagionali di cui all’articolo 21, comma 2, la durata dei rapporti di lavoro a tempo determinato intercorsi tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, per effetto di una successione di contratti, conclusi per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale e indipendentemente dai periodi di interruzione tra un contratto e l’altro, non può superare i ventiquattro mesi. Ai fini del computo di tale periodo si tiene altresì conto dei periodi di missione aventi ad oggetto mansioni di pari livello e categoria legale, svolti tra i medesimi soggetti, nell’ambito di somministrazioni di lavoro a tempo determinato. Qualora il limite dei ventiquattro mesi sia superato, per effetto di un unico contratto o di una successione di contratti, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di tale superamento.
Ambiti di applicazione del lavoro stagionale
Il lavoro stagionale si applica principalmente nei seguenti settori:
• Turismo: alberghi, ristoranti, strutture ricettive, stabilimenti termali e balneari;
• Agricoltura: per tutte le attività a carattere stagionale (es. raccolta, potatura, vendemmia, fienagione etc);
• Commercio: vendite durante i saldi, festività;
• Eventi e manifestazioni: fiere, festival, eventi sportivi, parchi di divertimento etc.
3. CONTRATTO DI LAVORO STAGIONALE
Definizione e caratteristiche del contratto stagionale
Il contratto di lavoro stagionale è un contratto a tempo determinato utilizzato per soddisfare esigenze di manodopera legate a specifici periodi dell’anno. Questi contratti beneficiano di deroghe rispetto ai contratti a termine ordinari, consentendo maggiore flessibilità alle aziende.
Come è facile comprendere il termine “stagione” (e la sua derivazione – stagionalità) può essere declinato in una molteplicità di significati.
Come anticipato è possibile rifarsi al concetto astronomico di stagione quando collegato ai classici quattro periodi dell’anno (equinozi e solstizi) per mezzo dei quali ripartire le durate in periodi costanti (circa 3 mesi).
Ma rimanendo legati agli eventi metereologici è possibile individuare le stagioni c.d. “climatiche” (calda, fredda, umida, piovosa, secca, bella, buona, brutta, cattiva, etc.), che non necessariamente dovranno coincidere con le fasi astronomiche.
La stagionalità, inoltre, non interessa solo i fenomeni naturali essendo riconducibile anche alla tipologia di attività svolta (es. periodo della vendemmia, stagione della semina etc.).
Tralasciando il settore agricolo, altri comparti possono essere interessati da periodi di stagionalità, come le attività commerciali nei periodi di saldi e in occasione di particolari periodi dell’anno (periodo natalizio, estivo, etc.).
Possono, inoltre, definirsi “stagione” anche particolari periodi dell’anno in cui si svolgono determinate attività o eventi: la stagione teatrale, della prosa, della lirica, cinematografica, calcistica, ciclistica, etc.
Infine, anche i momenti di “alta o bassa stagione” sono termini con cui sono stati storicamente individuati alcuni specifici periodi dell’anno in cui l’attività turistico alberghiera risultava particolarmente intensa (ad esempio, il mese di agosto in una località balneare) o ridotta (ad esempio, il mese di agosto in una città d’affari o il mese di gennaio al mare).
In merito alla corretta definizione di “stagionalità”, la L. n. 203/2024 (c.d. Collegato Lavoro) ha chiarito come “rientrano nelle attività stagionali, oltre a quelle indicate dal decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, le attività organizzate per fare fronte a intensificazioni dell’attività lavorativa in determinati periodi dell’anno, nonché a esigenze tecnico-produttive o collegate ai cicli stagionali dei settori produttivi o dei mercati serviti dall’impresa, secondo quanto previsto dai contratti collettivi di lavoro, ivi compresi quelli già sottoscritti alla data di entrata in vigore della presente legge, stipulati dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative nella categoria, ai sensi dell’articolo 51 del decreto legislativo n. 81 del 2015”.
L’intervento normativo in esame, essendo di interpretazione autentica, ha natura retroattiva e si applica, come specificato dall’art. 11, anche in relazione ai contratti collettivi sottoscritti prima dell’entrata in vigore della legge.
In tema di stagionalità è intervenuto anche il Ministero del Lavoro con Interpello del 20 maggio 2016, n. 15, rispondendo ad un quesito dell’Assaereo (Associazione Nazionale Vettori e Operatori del trasporto aereo), in merito alla corretta interpretazione delle disposizioni di cui agli artt. 19 e ss. D.Lgs. n. 81/2015 concernenti la disciplina del lavoro a tempo determinato.
In particolare, l’istanza si focalizzava su quanto disposto dall’articolo 21, comma 2 nella parte in cui la norma sancisce la non applicazione del regime degli intervalli tra un contratto a tempo determinato e la stipulazione del successivo (Stop and Go), nelle ipotesi in cui si tratti “di lavoratori impiegati nelle attività stagionali individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, nonché nelle ipotesi individuate dai contratti collettivi”.
Il Ministero del Lavoro in tal senso chiariva che il regime degli intervalli non trova applicazione “nei confronti dei lavoratori impiegati nelle attività stagionali individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, nonché nelle ipotesi individuate dai contratti collettivi, salva l’applicazione delle disposizioni del D.P.R. n. 1525/1963 nelle more dell’adozione del decreto ministeriale.
La suddetta disposizione viene, inoltre, richiamata all’art. 19, comma 2, e 23, comma 2, al fine di individuare le ipotesi per le quali non operano rispettivamente il limite massimo dei 36 mesi (vecchia normativa – ndr) nonché i limiti quantitativi di ricorso al contratto a termine”.
D.P.R. del 7 ottobre 1963, n. 1525 - Attività a carattere stagionale
• sgusciatura delle mandorle;
• scuotitura, raccolta e sgranatura delle pigne;
• raccolta e conservazione dei prodotti sottobosco (funghi, tartufi, fragole, lamponi, mirtilli ecc;);
• raccolta e spremitura delle olive;
• produzione del vino comune (raccolta, trasporto, pigiatura dell’uva, torchiatura delle vinacce, cottura del mosto, travasamento del vino);
• monda e trapianto, taglio e raccolta del riso;
• motoaratura, mietitura, trebbiatura meccanica dei cereali e pressatura dei foraggi;
• lavorazione del falasco;
• lavorazione del sommacco;
• maciullazione e stigliatura della canapa;
• allevamento bachi, cernita, ammasso e stufatura dei bozzoli;
• ammasso, sgranatura, legatura, macerazione e stesa, all’aperto, del lino;
• taglio delle erbe palustri, diserbo dei canali, riordinamento scoline delle opere consortili di bonifica;
• raccolta, infilzatura ed essiccamento della foglia del tabacco allo stato verde;
• cernita e condizionamento in colli della foglia di tabacco allo stato secco;
• taglio dei boschi, per il personale addetto
D’altra angolatura l’attuale quadro normativo permette di demandare alla contrattazione collettiva la possibilità di prevedere altre ipotesi, ulteriori rispetto a quelle già indicate come stagionali dal D.P.R. n. 1525/1963 per le quali non operano alcune delle previsioni di cui al D.Lgs. n. 81/2015.
all’abbattimento delle piante per legname da opera, alle operazioni per la preparazione della legna da ardere, alle operazioni di carbonizzazione nonché alle relative operazioni di trasporto;
• diradamento, raccolta e trasporto delle barbabietole da zucchero;
• scorzatura del sughero;
• salatura e marinatura del pesce;
• pesca e lavorazione del tonno;
• lavorazione delle sardine sott’olio (per le aziende che esercitano solo tale attività);
• lavorazione delle carni suine;
• produzione di formaggi in caseifici che lavorano esclusivamente latte ovino;
• lavorazione industriale di frutta, ortaggi e legumi per la fabbricazione di prodotti conservati e di bevande (limitatamente al personale assunto nel periodo di lavorazione del prodotto fresco), nonché fabbricazione dei relativi contenitori;
• produzione di liquirizia;
• estrazione dell’olio dalle sanse e sua raffinazione;
• estrazione dell’olio dal vinacciolo e sua raffinazione;
• estrazione dell’alcool dalle vinacce e dalle mele;
• fabbricazione del ghiaccio (durante il periodo estivo);
• estrazione di essenze da erbe e frutti allo stato fresco;
• spiumatura della tiffa;
• sgranellatura del cotone;
• lavatura della paglia per cappelli;
• trattura della seta;
• estrazione del tannino;
• fabbricazione e confezionamento di specialità dolciarie nei periodi precedenti le festività del Natale e della Pasqua;
• cave di alta montagna;
• montaggio, messa a punto e collaudo di esercizio di impianti per zuccherifici, per fabbriche di conserve alimentari e per attività limitate a campagne stagionali;
• fabbricazione dei laterizi con lavorazione a mano o mista a mano e a macchina nelle quali si faccia uso di essiccatoi all’aperto;
• cernita e insaccamento delle castagne;
• sgusciatura ed insaccamento delle nocciole;
• raccolta, cernita, spedizione di prodotti ortofrutticoli freschi e fabbricazione dei relativi imballaggi;
• raccolta, cernita, confezione e spedizione di uve da tavola e da esportazione;
• lavaggio e imballaggio della lana;
Sempre con riferimento alle novità introdotte dalla L. n. 203/2024, il Ministero del Lavoro è intervenuto a chiarire la portata dell’interpretazione autentica fornita come in seguito approfondito.
3.1. Altri aspetti del contratto di lavoro stagionale
Clausole specifiche
a) Periodo di prova
Il contratto stagionale può prevedere un periodo di prova, durante il quale entrambe le parti possono recedere dal contratto senza preavviso. La durata del periodo di prova è generalmente stabilita dai contratti collettivi nazionali di lavoro (CCNL). Essendo il contratto di lavoro stagionale un contratto a tempo determinato, in assenza di chiarimenti ufficiali, si ritengono applicabili allo stesso le disposizioni di cui all’art. 7, c. 2 del D.Lgs n. 104/2022 come recentemente novellato dal Collegato Lavoro L. n.
• fiere ed esposizioni;
• lavori preparatori della campagna salifera (sfangamento canali, ripristino arginature, mungitura e cilindratura caselle salanti, sistemazione aie di stagionatura), salinazione (movimento di acque, raccolta del sale);
• spalatura della neve;
• attività svolte in colonie montane, marine e curative e attività esercitate dalle aziende turistiche che abbiano, nell’anno solare, un periodo di inattività non inferiore a settanta giorni continuativi o a centoventi giorni non continuativi;
• preparazione e produzione di spettacoli per il personale addetto a singoli spettacoli o serie di spettacoli consecutivi di durata prestabilita;
• attività del personale addetto alle arene cinematografiche estive;
• attività del personale assunto direttamente per corsi di insegnamento professionale di breve durata e soltanto per lo svolgimento di detti corsi;
• conduzione delle caldaie per il riscaldamento dei fabbricati.
203/2024, in rispetto delle quali: “Nel rapporto di lavoro a tempo determinato, il periodo di prova è stabilito in misura proporzionale alla durata del contratto e alle mansioni da svolgere in relazione alla natura dell’impiego.
Fatte salve le disposizioni più favorevoli della contrattazione collettiva, la durata del periodo di prova è stabilita in un giorno di effettiva prestazione per ogni quindici giorni di calendario a partire dalla data di inizio del rapporto di lavoro. In ogni caso la durata del periodo di prova non può essere inferiore a due giorni né superiore a quindici giorni, per i rapporti di lavoro aventi durata non superiore a sei mesi, e a trenta giorni, per quelli aventi durata superiore a sei mesi e inferiore a dodici mesi.
In caso di rinnovo di un contratto di lavoro per lo svolgimento delle stesse mansioni, il rapporto di lavoro non può essere soggetto ad un nuovo periodo di prova.”
b) Orario di lavoro e straordinari
L’orario di lavoro nei contratti stagionali deve rispettare le norme generali sul lavoro, ma può
prevedere flessibilità in base alle esigenze stagionali. Gli straordinari devono essere compensati come previsto dalla normativa vigente e dalla contrattazione collettiva applicata, con una maggiorazione sulla retribuzione ordinaria.
c) Retribuzione e indennità
La retribuzione nei contratti stagionali deve rispettare i minimi salariali stabiliti dai CCNL. Possono essere previste indennità specifiche per compensare la stagionalità del lavoro, come indennità di disponibilità per il lavoro intermittente.
d) Rinnovo e proroga del contratto
I contratti stagionali possono essere rinnovati e prorogati senza le limitazioni imposte ai contratti a termine ordinari, purché rispettino le specifiche clausole del settore di riferimento. Non è necessaria una causale specifica per il rinnovo dei contratti stagionali.
e) Diritto di precedenza
Come evidenziato dal comma 3 dell’articolo 24 del D.Lgs. n. 81/2015, anche i lavoratori stagionali sono destinatari del diritto di precedenza nei casi di nuove assunzioni. Ma con delle differenze rispetto ai normali contratti a termine: infatti, il lavoratore assunto in attività stagionali gode di un diritto di precedenza nelle nuove assunzioni sempre a carattere stagionale.
Tale diritto deve però essere esercitato entro tre mesi dalla cessazione del contratto di lavoro: trascorso un anno senza che il lavoratore manifesti la sua volontà, il diritto di precedenza si estinguerà definitivamente.
In merito anche il Ministero del Lavoro ha assunto la propria posizione con l’Interpello del 12 febbraio 2016, n. 7.
Con tale provvedimento il Ministero del Lavoro, all’indomani delle novità introdotte dall’articolo 24 del D.Lgs. n. 81/2015 (a quel tempo di recente emanazione), puntualizzava come i lavoratori assunti a termine per svolgere attività di carattere stagionale avessero un diritto di precedenza rispetto alle nuove assunzioni a tempo determinato (ma solo su queste) che il datore di lavoro dovesse effettuare per le stesse attività stagionali.
Infine, vi è da ricordare che, al fine di permettere ai lavoratori – anche stagionali – di poter manifestare il proprio diritto di precedenza, il datore di lavoro ha l’obbligo di richiamare espressamente tale diritto di precedenza del lavoratore nell’atto scritto con cui viene fissato il termine del contratto. La Circolare n. 18/2014 (sia pure resa sul previgente analogo quadro regolatorio determinato dal D.L. n. 34/2014, convertito dalla Legge n. 78/2014) ha specificato l’obbligo di indicazione dei diritti di precedenza nell’atto scritto che contiene il termine di durata del contratto a tempo determinato.
Va da sé che la mancata informativa al lavoratore “non incide sulla possibilità che il lavoratore possa comunque esercitarli” (cfr. Circolare Ministero Lavoro n. 18/2014), anche se tale omissione non “appare specificatamente sanzionata” (sebbene gli ispettori del lavoro possano impartire una disposizione ad ottemperare a norma dell’articolo 14 del D.Lgs. n. 124/2004).
Vi è infine da tenere in considerazione che la violazione del diritto di precedenza – nei confronti di tutte le tipologie di contratti a termine - non ha riflessi sul rapporto di lavoro a suo tempo instaurato, ma permette al lavoratore leso di richiedere un risarcimento del danno (Cfr.

Sentenza Tribunale di Milano 28 aprile 1990; Cass. n. 12505/2003), anche se nel passato vi sono state pronunce volte a riconoscere il diritto del lavoratore pretermesso alla costituzione del rapporto di lavoro in forma specifica (Pret. Milano 29 giugno 1988; Cass. n. 8568/2004).
f) Sicurezza sul lavoro e igiene nei luoghi di lavoro
I lavoratori stagionali hanno diritto ad un ambiente di lavoro sicuro, con adeguate misure di prevenzione e protezione. Il datore di lavoro deve garantire la formazione necessaria in materia di sicurezza e salute sul lavoro.
Le normative sulla salute e igiene nei luoghi di lavoro di cui al D.Lgs. n. 81/2008 si applicano anche ai lavoratori stagionali, garantendo loro adeguate condizioni lavorative. I lavoratori devono essere informati sui rischi specifici del loro lavoro e sulle misure di prevenzione adottate.
g) Formazione
I datori di lavoro devono fornire la formazione necessaria per garantire la sicurezza e l’efficienza del lavoratore stagionale. Questo include la formazione su attrezzature specifiche e procedure di sicurezza.
h) Rispetto delle mansioni assegnate
I lavoratori stagionali devono svolgere le mansioni previste dal contratto in maniera diligente e professionale. È loro dovere rispettare le direttive e le istruzioni impartite dai superiori.
i) Rispetto degli orari di lavoro
È dovere del lavoratore stagionale rispettare gli orari di lavoro stabiliti dal contratto, inclusi eventuali turni e straordinari. Devono inoltre rispettare le pause e i periodi di riposo previsti dalla legge.
4. TUTELE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI
Contributi previdenziali
I lavoratori stagionali sono soggetti agli stessi contributi previdenziali dei lavoratori a tempo indeterminato, garantendo loro accesso alle prestazioni pensionistiche e assistenziali. I contributi sono calcolati in base alla retribuzione percepita e alle ore lavorate.
La contribuzione addizionale
Tra le molteplici novità del Decreto Dignità quella della contribuzione aggiuntiva sembra essere una delle note più dolenti nei confronti dei contratti a termine stagionali.
L’articolo 3, comma 2, del D.L. n. 87/2018, modificando quanto già stabilito all’articolo 2, comma 28 della Legge n. 92/2012 (contribuzione 1,40%) prevede che per ogni rinnovo l’aliquota contributiva (cioè, la percentuale a titolo di contribuzione aggiuntiva NASpI dell’1,40% applicata alla retribuzione) aumenti dello 0,50%.
La normativa NASpI ad oggi vigente esonera dalla contribuzione dell’1,40% i lavoratori assunti a termine per lo svolgimento delle attività stagionali di cui al D.P.R. n. 1525/1963, nonché – per i periodi contributivi maturati dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015 –per lo svolgimento delle attività stagionali definite tali dagli avvisi comuni e dai contratti collettivi nazionali stipulati entro il 31 dicembre 2011, dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative.
Per contro, invece, tale contribuzione è dovuta in capo ai rapporti a termine per attività stagionali previste dalla contrattazione collettiva non annoverate tra quelle sopra indicate e che, ordinariamente, si reiterano annualmente senza alcun rispetto della durata massima del contratto a tempo determinato.
Di conseguenza, per effetto del nuovo dettato normativo ci si troverà dinnanzi ad una duplice regolamentazione: nessuna applicazione dell’aliquota contributiva dello 0,50% per i contratti stagionali di cui al D.P.R. 1525/1963 ma obbligatorietà per quelli di cui alla contrattazione collettiva.
In merito sarebbero auspicabili ulteriori interventi a chiarimento poiché nemmeno la Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 31 ottobre 2018, n. 17 ha fornito precise indicazioni.
A seguito delle novità introdotte dal Collegato lavoro (L. n. 203/2024) l’INPS è intervenuta con due distinti messaggi a breve distanza tra i due.
Con il Messaggio del 23 gennaio 2025, n. 269, l’Istituto chiariva come “Per i lavoratori a tempo determinato assunti nell’ambito di attività “per fare fronte a intensificazioni dell’attività lavorativa in determinati

periodi dell’anno, nonché a esigenze tecnico-produttive o collegate ai cicli stagionali dei settori produttivi o dei mercati serviti dall’impresa, secondo quanto previsto dai contratti collettivi di lavoro”, ancorché definite “stagionali” dall’articolo 11 della legge n. 203/2024, non rientrando queste nell’elencazione recata dal D.P.R. n. 1525/1963, è dovuto il contributo addizionale NASpI e l’aumento del medesimo contributo nei casi di rinnovo dei contratti di lavoro a tempo determinato dei predetti lavoratori.
Ai fini della compilazione del flusso di denuncia mensile UniEmens, i datori di lavoro che assumono lavoratori per lo svolgimento delle citate attività, non ricomprese nell’elencazione di cui al D.P.R. n. 1525/1963 ma definite “stagionali” dall’articolo 11 della legge n. 203/2024, devono utilizzare le modalità in uso e validare l’elemento qualifica 3 con il valore “S” avente il significato di “Stagionale (restanti tipologie)”
Successivamente con il Messaggio del 7 febbraio 2025, n. 483, l’INPS precisava che, “in forza della previsione contenuta nel comma 28 dell’articolo 2 della legge n. 92/2012, come modificato dall’articolo 1, comma 13, lettera a), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, l’esonero dal versamento del contributo addizionale NASpI e dall’incremento previsto in occasione di ciascun rinnovo - oltre a trovare applicazione con riferimento ai lavoratori assunti a termine per lo svolgimento delle attività stagionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525 - continua ad applicarsi anche ai contratti di lavoro a tempo determinato, stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2020, per lo svolgimento delle attività stagionali “definite dagli avvisi comuni e dai contratti collettivi nazionali stipulati entro il 31 dicembre 2011 dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative” (cfr., sul punto, la circolare n. 91 del 4 agosto 2020).
Pertanto, tali lavoratori devono continuare a essere esposti nel flusso Uniemens con la qualifica 3 uguale a “G”, avente il significato di “Stagionale assunto dal 01.01.2013 al 31.12.2015 ed a decorrere dall’1.1.2020 per attività definite da avvisi comuni e da CCNNLL stipulati entro il 31.12.2011”.
Assicurazioni obbligatorie
È obbligatorio per i datori di lavoro fornire copertura assicurativa ai lavoratori stagionali contro infortuni sul lavoro e malattie professionali. Questo presuppone l’iscrizione all’INAIL (Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro).
Indennità di disoccupazione
I lavoratori stagionali hanno diritto all’indennità di disoccupazione (NASpI) se soddisfano i requisiti contributivi previsti dalla legge. La NASpI è una prestazione economica erogata dall’INPS (Istituto Nazionale della Previdenza Sociale) a seguito della cessazione involontaria del rapporto di lavoro.
Malattia e infortunio
Durante i periodi di malattia o infortunio, i lavoratori stagionali hanno diritto a prestazioni economiche previste dalla normativa vigente. L’indennità di malattia è corrisposta dall’INPS, mentre l’indennità per infortunio è erogata dall’INAIL.
5. ASPETTI FISCALI
Imposizione del reddito da lavoro stagionale
Il reddito derivante da lavoro stagionale è soggetto a tassazione secondo le aliquote IRPEF previste per i redditi da lavoro dipendente. Le trattenute fiscali sono operate direttamente dal datore di lavoro in qualità di sostituto d’imposta.
Inoltre, i lavoratori stagionali possono beneficiare di deduzioni e agevolazioni fiscali previste per i redditi da lavoro dipendente, come le detrazioni per carichi di famiglia. Queste deduzioni riducono l’imponibile fiscale, diminuendo l’importo delle imposte dovute.
6. TABELLA DI RIEPILOGO
CARATTERISTICA
Normativa e prassi di riferimento
Ambiti principali di applicazione
Definizione
DESCRIZIONE
• D.Lgs. del 15 giugno 2015, n. 81 e succ. mod. (artt. 19, 21, 23 e 24)
• D.L. del 12 luglio 2018, n. 81 convertito in Legge 9 agosto 2018, n. 96
• D.P.R. del 7 ottobre 1963, n. 1525
• Ministero Lavoro Interpello del 12 febbraio 2016, n. 7
• Ministero del Lavoro Interpello del 20 maggio 2016, n. 15
• Legge 17 dicembre 2024, n. 203
• Circolare Ministero del Lavoro 27 marzo 2025, n. 6
• D.P.R. n. 1525/1963
• Settori e ambiti previsti dalla Contrattazione collettiva
Contratto a tempo determinato utilizzato per soddisfare esigenze di manodopera legate a specifici periodi dell’anno
Durata Massima Nessun limite
Clausole di Rinnovo/Proroga Non obbligatorie
Contingentamento Nessun limite
Contributi Addizionali
Orario di lavoro, straordinario, periodo di prova, retribuzione
Diritti dei lavoratori
Doveri dei lavoratori
Tutele previdenziali
Imposizione fiscale
Esenzioni per le attività disciplinate dal D.P.R. n. 1525/1963; dovuti per la stagionalità prevista dalla contrattazione collettiva.
Come da previsioni del CCNL, CCPL o Contratto collettivo aziendale applicato
• Precedenza: applicabile
• Sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro: applicabile
• Formazione: applicabile
Come da Contratto collettivo o in ossequio agli art. 2014, 2015 e 2016 del c.c.
• Indennità di disoccupazione: prevista
• Malattia e infortunio: previsti
Come la generalità dei redditi da lavoro dipendente
7.
IL LAVORO STAGIONALE E IL
RUOLO FONDAMENTALE DELLA
CONTRATTAZIONE COLLETTIVA
Come abbiamo già evidenziato nei paragrafi precedenti, il Jobs Act ha introdotto una disciplina organica del lavoro a tempo determinato, prevedendo specifiche deroghe per il lavoro stagionale. In particolare, il comma 2 dell’art. 21 stabilisce che, con riferimento alle disposizioni sul contratto a termine, “di cui al presente comma non trovano applicazione nei confronti dei lavoratori impiegati nelle attività stagionali individuate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali nonché nelle ipotesi individuate dai contratti collettivi”.
Il testo del citato comma 2 è parso sin da subito di difficile interpretazione, non essendo sufficientemente chiaro il margine d’azione della contrattazione rispetto all’individuazione di ulteriori fattispecie di attività stagionali, oltre a quelle già individuate dalla normativa vigente.
In tal senso è intervenuto il legislatore che attraverso l’art.11 della legge 203 del 13 dicembre 2024, ha fornito una interpretazione autentica del D.Lgs. 81/2015 e che, in quanto tale, ha valenza retroattiva ovvero, come già specificato in precedenza.
Nello specifico tale norma ha chiarito che i contratti collettivi possono prevedere delle tipologie di lavoro stagionale ulteriori rispetto a quelle contenute nel D.P.R. n. 125/1963. Al fine di una corretta applicazione, è fondamentale definire con chiarezza il concetto di contratto collettivo
Il D.Lgs. 81/2015, c.d. Jobs Act, venne promulgato con l’intento di rendere il più possibile omogenea e contenuta in un testo unico, tutta la normativa inerente alla disciplina dei contratti di lavoro; si trattò, a suo tempo, di un atto normativo piuttosto innovativo poiché diede ampio spazio al ruolo della contrattazione collettiva.
Ma a quale livello di contrattazione voleva riferirsi il legislatore? Il Jobs Act si compone di 57 articoli, eppure solo all’art. 2, che disciplina le collaborazioni coordinate e continuative, e al capo V in tema di apprendistato, il legislatore fa esplicito rinvio agli “accordi collettivi nazionali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”. In tutti gli altri casi nel testo si trova un
rinvio generico all’autonomia negoziale dei “contratti collettivi”, nell’accezione prevista dall’art. 51 del T.U. Tale finalità della norma è stata finalmente chiarita dall’interpretazione autentica operata dall’ art. 11 della Legge 203/2024, dell’ articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in materia di attività stagionali.
Art. 51 Norme di rinvio ai contratti collettivi
1. Salvo diversa previsione, ai fini del presente decreto, per contratti collettivi si intendono i contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e i contratti collettivi aziendali stipulati dalle loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria.
Art.21 comma 2 D.Lgs. 81/2015
2. (omissis) Le disposizioni di cui al presente comma non trovano applicazione nei confronti dei lavoratori impiegati nelle attività stagionali individuate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali nonché nelle ipotesi individuate dai contratti collettivi. Fino all’adozione del decreto di cui al secondo periodo continuano a trovare applicazione le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525.
Come è evidente, la recente interpretazione autentica dell’art. 51 del D.Lgs. 81/2015 conferma le intenzioni del legislatore di allora di delegare alla contrattazione ampio spazio di manovra nello stabilire l’individuazione di ulteriori attività stagionali a livello nazionale, territoriale o aziendale tenendo conto, quindi, non solo del mercato del lavoro di riferimento in cui le aziende operano ma anche delle stesse peculiarità aziendali.
Tuttavia, al fine di evitare un abuso distorsivo dell’autonomia negoziale, la contrattazione decentrata è tenuta a procedere all’individuazione delle ulteriori fattispecie in conformità con quanto stabilito dalla Direttiva 1999/70/CE in materia di lavoro a tempo determinato, non potendosi limitare ad una mera elencazione ma individuando in maniera puntuale le ragioni obiettive che ne giustifichino la stagionalità e il soddisfacimento dei requisiti legali.
Successivamente all’entrata in vigore del Jobs Act, diversi contratti collettivi si sono adeguati alla nuova normativa, ampliando le tipologie di attività stagionali. Di seguito analizziamo quattro diversi CCNL che hanno individuato delle fattispecie ulteriori di attività stagionali, partendo dai contratti che disciplinano il rapporto di lavoro nel settore turistico.
7.1. Il lavoro stagionale nel settore turistico
Il settore del turismo è certamente uno dei settori maggiormente interessati dalla stagionalità, che normalmente è strettamente legata all’area territoriale.
Si pensi per esempio a tutte quelle aziende che operano nel settore turistico in luoghi dove non vi è chiusura periodica e quindi non si possono definire propriamente “stagionali” ma di fatto si lavora tutto
l’anno perché si differenzia l’attività o perché il flusso di clientela, sebbene in misura inferiore, è costante.
I due principali contratti collettivi del settore turistico, sottoscritti rispettivamente da Confesercenti e da Confcommercio, negli anni immediatamente successivi all’entrata in vigore del Jobs Act, in maniera pressoché identica, hanno ampliato le tipologie di lavoro stagionale basandosi sull’esigenza per le aziende del settore di uniformarsi alle intensificazioni di attività in alcuni periodi dell’anno ma anche in occasioni particolari come fiere, promozioni ecc.
Dal confronto tra i due testi contrattuali, appare evidente come gli stessi siano quasi identici, confermando l’obiettivo del legislatore di adattare i criteri dell’accezione di stagionalità al settore specifico di riferimento.
CCNL Turismo – Confesercenti Filcams CGIL, Fisascat CISL e UILTuCS – Art. 83 Intensificazioni dell’attività lavorativa in determinati periodi dell’anno
1) Le parti convengono, nell’ambito della propria autonomia contrattuale, che rientrano nei casi di legittima apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato le intensificazioni dell’attività lavorativa in determinati periodi dell’anno, quali:
• periodi connessi a festività, religiose e civili, nazionali ed estere;
• periodi connessi allo svolgimento di manifestazioni;
• periodi interessati da iniziative promozionali e/o commerciali;
• periodi di intensificazione stagionale e/o ciclica dell’attività in seno ad aziende ad apertura annuale. (omissis)
• una delle principali caratteristiche dei settori è la diretta correlazione tra l’andamento dell’occupazione e l’intensificazione dell’attività legata al flusso della clientela. Tali intensificazioni sono riconducibili alla stagionalità, da intendersi come tale non solo per le aziende che nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia, osservano nel corso dell’anno uno o più periodi di chiusura al pubblico, ma anche per le aziende ad apertura annuale;
• in tal senso, si condivide l’esigenza di valorizzare e preservare la permanenza nei settori delle professionalità esistenti e quelle in via di costituzione.
Tutto ciò premesso le Parti concordano che quanto definito dall’art. 83 del CCNL del 4/3/2010 e la successiva Ipotesi di Accordo del 18/7/2018 soddisfa i requisiti legali richiesti dal D.Lgs. 15/6/2015 n. 81 ai fini dell’applicazione delle specifiche normative
Fermo restando quanto previsto dal presente accordo, sono fatte salve le ulteriori disposizioni del CCNL e successive Ipotesi di Accordo in tema di stagionalità.
CCNL Turismo FIPE, Confcommercio, FILCAMS-CGIL, la FISASCAT-CISL,la UILTUCS-UI – Art. 90
Intensificazioni dell’attività lavorativa in determinati periodi dell’anno
Le parti convengono, nell’ambito della propria autonomia contrattuale, che rientrano nei casi di legittima apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato le intensificazioni dell’attività lavorativa in determinati periodi dell’anno, quali:
• periodi connessi a festività, religiose e civili, nazionali ed estere;
• periodi connessi allo svolgimento di manifestazioni;
• periodi interessati da iniziative promozionali e/o commerciali;
• periodi di intensificazione stagionale e/o ciclica dell’attività in seno ad aziende ad apertura annuale.
(omissis)
• una delle principali caratteristiche del settore è la diretta correlazione tra l’andamento dell’occupazione e l’intensificazione dell’attività legata al flusso della clientela. Tali intensificazioni sono riconducibili alla stagionalità da intendersi come tale non solo per le aziende che nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia, osservano nel corso dell’anno uno o più periodi di chiusura al pubblico, ma anche per le aziende ad apertura annuale;
• in tal senso, si condivida l’esigenza di valorizzare e preservare la permanenza nel settore delle professionalità esistenti e quelle in via di costituzione;
• sulla materia sono intervenuta modifiche legislative.
Tutto ciò premesso:
le Parti, firmatarie il suddetto CCNL concordano che quanto definito dall’art. 90 dal CCNL per i dipendenti dei settori Pubblici Esercizi, Ristorazione Collettiva e Commerciale e Turismo 8/2/2018 soddisfa i requisiti legali richiesti dal D.Lgs. 15/6/2015 n. 81 al fine dell’applicazione delle specifiche normative.
Fermo restando quanto previsto dal presente accordo, sono fatte salve le ulteriori disposizioni del CCNL in tema di stagionalità.
7.2. La disciplina del lavoro stagionale nel settore terziario
Per il settore commercio-terziario si è ritenuto di prendere come riferimento il CCNL Confcommercio. Come è noto, tale contratto nazionale abbraccia al suo interno settori tra loro molto diversi, si pensi a mero titolo esemplificativo, al terziario avanzato, ai CAF ecc.
Le parti sociali hanno disciplinato il lavoro stagionale definendolo proprio in base al sottosettore di riferimento con particolare riguardo anche alla
collocazione territoriale delle imprese che applicano il CCNL. Come possiamo vedere dagli articoli estratti dal citato contratto, il criterio assunto dalle parti sociali per individuare ulteriori tipologie di lavoro stagionale si fonda sia su criteri relativi all’attività svolta, sia con riferimento al territorio in cui sono ubicate le imprese.
CCNL COMMERCIO CONFCOMMERCIO CONFEDERAZIONE GENERALE ITALIANA
DEL COMMERCIO, DEL
TURISMO, DEI SERVIZI, DELLE PROFESSIONI E DELLE
P.M.I. e la FILCAMS-CGIL, la FISASCAT-CISL e la UILTUCS-UI –
Stagionalità per le imprese ubicate in località a vocazione turistica
Art. 75 Ipotesi di stagionalità in località turistiche
Le Parti, preso atto che in determinate località a prevalente vocazione turistica le aziende che applicano il presente CCNL, pur non esercitando attività a carattere stagionale secondo quanto previsto dall’elenco allegato al DPR 7/10/1963. n. 1525 e successive modificazioni, necessitano di gestire picchi di lavoro intensificati in determinati periodi dell’anno, concordano che i contratti a tempo determinato conclusi per gestire detti picchi di lavoro siano riconducibili a ragioni di stagionalità, pertanto esclusi da limitazioni quantitative ai sensi dell’art. 23, co. 2, lett. c) del D.Lgs. n. 81/2015.
Le Parti concordano che l’individuazione delle località a prevalente vocazione turistica con le connesse attività e relativi periodi ove si collocano le suddette assunzioni a tempo determinato, siano definite dalle organizzazioni territoriali aderenti alle parti stipulanti il presente CCNL, con apposito accordo
Le Parti, infine, a seguito delle modifiche intervenute al quadro normativo di riferimento hanno sottoscritto un verbale di intesa in data 17/4/2019 a cui fanno espressamente rinvio. Verbale di accordo 2016/07/2020 “Ricorso delle assunzioni a tempo determinato. Per far fronte alle specifiche necessità dei CAF e della loro attività è necessario il ricorso alle assunzioni a tempo determinato per lo svolgimento di attività stagionali così come previsto dal succitato D. Lgs. n. 81/2015 per gli effetti di cui agli artt. 19, comma 2; 21, comma 01; 21, comma 2; 23, comma 2, lett. c), ed in deroga a quanto previsto dal CCNL del terziario, distribuzione e servizi in quanto non corrispondenti alla tipicità del servizio svolto.
ALLEGATO 14 - Verbale di intesa del 17/4/2019 in materia di stagionalità settore turistico
Attività stagionali dei CAF
Verbale di accordo 2016/07/2020 “Ricorso delle assunzioni a tempo determinato.
Per far fronte alle specifiche necessità dei CAF e della loro attività è necessario il ricorso alle assunzioni a tempo determinato per lo svolgimento di attività stagionali così come previsto dal succitato D. Lgs. n. 81/2015 per gli effetti di cui agli artt. 19, comma 2; 21, comma 01; 21, comma 2; 23, comma 2, lett. c), ed in deroga a quanto previsto dal CCNL del terziario, distribuzione e servizi in quanto non corrispondenti alla tipicità del servizio svolto.
ALLEGATO 15 - Accordo nazionale sulla definizione di attività stagionale per i centri di assistenza fiscale del 20/2/2019
Verbale di accordo 9/6/2022 – CAF - CONFCOMMERCIO IMPRESE PER L’ITALIA e FILCAMSCGIL, FISASCAT-CISL e UILTUCS-UIL,
Considerato che:
a) le campagne fiscali/previdenziali dettate da inderogabili disposizioni di legge, legate alla compilazione dei modelli e dichiarativi fiscali, rientrino a pieno titolo tra le attività a carattere stagionale
b) le Parti firmatarie hanno già regolamentato le fattispecie sopra richiamate in ragione della stagionalità delle stesse, con la sottoscrizione di un accordo in data 20 febbraio 2019 successivamente prorogato.
c) l’art. 16-bis, co. 5 del DL 124/2019 ha operato il riordino dei termini per l’assistenza fiscale prestata dai sostituti d’imposta e dai CAF, estendendo dal 23 luglio al 30 settembre il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi per i suddetti soggetti. Tutto ciò considerato, le Parti concordano:
1) che, le attività di assistenza fiscale svolte dai CAF nel periodo intercorrente dal 1° gennaio al 30 settembre di ogni anno rientrino a pieno titolo nella definizione di attività stagionale;
2) per far fronte alle specifiche necessità nell’ambito delle attività connesse alla campagna fiscale, che i CAF possano ricorrere ad assunzioni a tempo determinato per lo svolgimento di attività stagionali, così come previsto dal DLgs n. 81/2015 per gli effetti di cui agli artt. 19, co. 2; 21, co. 1; 21, co. 2; 23, co. 2, lett. c), ed in deroga a quanto previsto dal CCNL Terziario, Distribuzione e Servizi, in quanto non corrispondenti alla tipicità del servizio svolto;
3) per le motivazioni suesposte, che sono da intendersi sospese le limitazioni quantitative di cui ai co. 1 e 2 dell’art. 31 del DLgs n. 81/2015 - come modificato dalla L n. 96/2018 - per le assunzioni dei lavoratori somministrati con contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato;
4) che i lavoratori assunti a tempo determinato stagionale per lo svolgimento degli adempimenti sopra citati, godranno ai sensi dell’art. 24 co. 3, del DLgs n. 81/2015 del diritto di precedenza rispetto alle assunzioni per le campagne successive, purché ne segnalino la volontà per iscritto entro tre mesi dalla conclusione del rapporto di lavoro.
Quanto sopra concordato troverà applicazione sino al 30 settembre di ogni anno e per ciò che non è stato espressamente previsto troveranno comunque applicazione le disposizioni di legge e di contratto.
7.3. Il lavoro stagionale nel settore logisticatrasporti
La disciplina in deroga del lavoro stagionale nel settore della logistica, si fonda su criteri relativi ai settori specifici, all’andamento delle richieste del mercato rispetto alla distribuzione di determinati prodotti
e infine sulla tipologia di impresa con particolare riferimento a quelle del comparto artigiano che possono trarre vantaggi economici dal la valorizzazione della stagionalità in determinati periodi dell’anno. Si riporta di seguito un estratto del CCNL della logistica e dei trasporti.
CCNL LOGISTICA, TRASPORTO MERCI E SPEDIZIONE
AITI, l’ASSOESPRESSI, l’ASSOLOGISTICA, FEDESPEDI, FEDIT, FISI, TRASPORTOUNITO FIAP, assistite dalla CONFETRA, l’ANITA, la FAI, l’ASSOTIR, la FEDERTRASLOCHI, la FEDERLOGISTICA, la FIAP, l’UNITAI, assistite dalla CONFTRASPORTO, la CNA-FITA, la CONFARTIGIANATO TRASPORTI, la CASARTIGIANI, la CLAAI, la CONFCOOPERATIVELAVORO E SERVIZI, la LEGACOOP PRODUZIONE E SERVIZI, l’AGCI SERVIZI, l’AITE e la FILT-CGIL, la FIT-CISL, la UILTRASPORTI
Art. 55 comma 22 DISPOSIZIONI GENERALI
Le parti convengono che hanno carattere stagionale le seguenti attività di autotrasporto:
a) attività legate al settore agricolo;
b) attività legate a incrementi di volumi concentrati in particolari periodi dell’anno (caldo freddo);
c) trasporto combustibili vari comprese nei periodi invernali (novembre - aprile);
d) attività legate al turismo;
e) attività legate alla distribuzione farmaceutica di vaccini;
23. Le Parti stabiliscono che nell’arco dello stesso ciclo stagionale la durata complessiva massima sarà di sci mesi per ogni singolo contratto, ivi comprese eventuali proroghe.
24. Nell’ambito degli accordi di cui all’art. 38 del presente CCNL, potranno essere stipulate intese finalizzate all’individuazione di ulteriori ipotesi di stagionalità.
25. Ai contratti di cui sopra si applicheranno le disposizioni previste dalla vigente normativa.
26.Il lavoratore assunto con contratto a termine per lo svolgimento di attività stagionali, ha diritto di precedenza, rispetto a nuove assunzioni a termine da parte dello stesso datore di lavoro per le medesime attività stagionali.
Per accedere a tale diritto di precedenza, il lavoratore dovrà manifestare per iscritto la propria volontà entro tre mesi dalla data di cessazione del rapporto stesso e si estingue entro un anno dalia data di cessazione del rapporto di lavoro.
27. Il periodo di prova per il personale stagionale assunto in forza del presente articolo è ridotto in misura del 50% rispetto al periodo di prova stabilito dal presente CCNL per la generalità dei lavoratori.
Ai sensi dell’art. 23 c. 1 D.Lgs. 81/2015 i contratti di lavoro a termine per attività stagionali non computano per l’applicazione dei limiti quantitativi stabiliti dal presente CCNL con riferimento contratti a termine acausali.
Articolo 7 SEZIONE QUARTA - ARTIGIANA – STAGIONALITÀ
In considerazione delle particolarità del settore artigiano nell’autotrasporto, le Parti si danno reciprocamente atto che le attività stagionali costituiscono una risorsa per l’occupazione e uno strumento per quelle aziende la cui attività è fortemente condizionata dalla domanda del consumatore e dalle disponibilità delle materie prime in alcuni periodi dell’anno.
Pertanto, concordano che il ricorso al lavoro stagionale è possibile oltre che per le attività previste dal D.P.R. 1525/1963, e successive modifiche ed integrazioni, anche per quei contratti di lavoro riconducibili alla attività stagionale in senso ampio, ossia quella concentrata in periodi dell’anno e finalizzata a rispondere all’intensificazione della domanda per esigenze cicliche o variazioni climatiche o connesse a eventi civili, religiosi, tradizionali e promozionali.
A titolo esemplificativo ancorché non esaustivo:
1. Trasporto stagionali legati al settore agricolo;
2. Trasporto di prodotti legati a consumi concentrati in particolari periodi dell’anno (caldi o freddi), anche con riferimento ai flussi turistici;
3. Trasporto combustibili vari nel periodo invernale (novembre-aprile).
Ulteriori specifiche esigenze, potranno essere individuate dalle parti a livello regionale, anche in considerazione delle punte di più intensa attività legate alle produzioni locali.
Le Parti stabiliscono che nell’arco dello stesso ciclo stagionale la durata complessiva massima sarà di sei mesi per ogni singolo contratto, ivi comprese eventuali proroghe.
Ai sensi della legislazione vigente, nei casi di riassunzione di un lavoratore per ragioni di carattere stagionale non trovano applicazione le norme che dispongono per il datore di lavoro l’obbligo di rispettate il periodo di intervallo tra un contratto a termine ed un altro.
Il lavoratore assunto con contratto a termine per lo svolgimento di attività stagionali ha diritto di precedenza, rispetto a nuove assunzioni a termine da patte dello stesso datore di lavoro per le medesime attività stagionali.
Per accedere a tale diritto di precedenza, il lavoratore dovrà manifestare per iscritto la propria volontà entro tre mesi dalla data di cessazione del rapporto stesso e si estingue entro un anno dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.
Il periodo di prova per il personale stagionale assunto in forza del presente articolo è ridotto in misura del 50% rispetto al periodo di prova stabilito dal presente CCNL per la generalità dei lavoratori.
Ai sensi dell’art. 23 comma 1 D.Lgs. 81/2015 i contratti di lavoro a termine per attività stagionali non si computano per l’applicazione dei limiti quantitativi stabiliti dal presente CCNL con riferimento ai contratti a termine acausali.

La Legge n. 203/2024 Collegato Lavoro, all’art. 11 fornisce una interpretazione autentica del comma 2 art. 21 del D.Lgs 81/2015, che stabilisce la possibilità per la contrattazione collettiva nell’accezione prevista dall’art. 51 del Jobs Act, di derogare all’elenco delle attività stagionali di cui al D.P.R. del 7 ottobre 1963, n. 1525, prevedendo ulteriori ipotesi di stagionalità.
Le parti sociali stipulanti devono tuttavia operare nei limiti previsti dalla normativa comunitaria e nazionale che disciplina il contratto di lavoro a termine di cui il lavoro stagionale è una species.
Al di fuori della disciplina giuridica e delle deroghe contrattuali dalla stessa previste, non è consentito stipulare contratti individuali di lavoro stagionale.
La disciplina del rapporto di lavoro stagionale prevede delle particolarità ampiamente descritte nella prima parte del presente elaborato e di cui si richiama all’attenzione del lettore la fattispecie della contribuzione addizionale con riferimento a tutti quei contratti di lavoro instaurati in virtù di deroghe contrattuali e non ai sensi del D.P.R. 1525/1963.

MICHELE SILIATO
CONSULENTE DEL LAVORO IN MESSINA, MEMBRO DEL CENTRO STUDI NAZIONALE ANCL


FRANCESCA STUFETTI


ELEONORA ZAMBON
CONSULENTE DEL LAVORO IN FIRENZE, MEMBRO DEL CENTRO STUDI NAZIONALE ANCL

LA DISCIPLINA DELLE “DIMISSIONI PER FATTI CONCLUDENTI”: QUALE SPAZIO ALLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA?
AVVOCATO E CONSULENTE DEL LAVORO IN SIENA, MEMBRO DEL CENTRO STUDI NAZIONALE ANCL INDICE
1. Premessa
2. Dalle dimissioni in bianco alle dimissioni per fatti concludenti
3. Nuove forme di risoluzione del rapporto di lavoro: le dimissioni per fatti concludenti
4. Criticità interpretative e deleghe alla contrattazione collettiva per la risoluzione di fatto
1. PREMESSA
Le dimissioni rappresentano un aspetto fondamentale della disciplina del rapporto di lavoro, garantendo al lavoratore la possibilità di recedere unilateralmente dal contratto. Si tratta di una decisione che può essere dettata da molteplici fattori, tra cui nuove opportunità professionali, motivazioni personali o insoddisfazione lavorativa. Tuttavia, nel corso del tempo, sono emerse diverse problematiche legate da un lato alle modalità di presentazione delle dimissioni, con particolare riferimento alle pratiche abusive, e dall’altro all’applicazione della nuova forma di cessazione del rapporto di lavoro introdotta dal legislatore con il Collegato Lavoro.
In questo approfondimento verrà analizzato il tema delle dimissioni, soffermandoci su alcune fattispecie particolari: le dimissioni “in bianco”, una pratica illecita e oggetto di abuso, in passato, a danno dei lavoratori; le dimissioni per fatti concludenti, ovvero un tema complesso nel diritto del lavoro in quanto coinvolgono sia la volontà del lavoratore di interrompere il rapporto di lavoro sia l’interpretazione del comportamento da parte del datore di lavoro; e le criticità delle dimissioni per fatti concludenti e il ruolo della contrattazione collettiva, con particolare attenzione ai rischi e alle contestazioni che possono sorgere sia per il lavoratore che per il datore di lavoro.
Il tema delle dimissioni è di grande rilevanza non solo per il singolo lavoratore, ma anche per il sistema giuslavoristico nel suo complesso, poiché incide sulle dinamiche occupazionali e sulla tutela dei diritti fondamentali dei dipendenti.
L’obiettivo è fornire un quadro chiaro e approfondito di queste tematiche, evidenziando le implicazioni giuridiche e le tutele previste dall’ordinamento per garantire un corretto esercizio del diritto di recesso dal rapporto di lavoro da parte del lavoratore.
2. DALLE DIMISSIONI IN BIANCO ALLE DIMISSIONI PER FATTI CONCLUDENTI
Le dimissioni del lavoratore dal rapporto di lavoro sono disciplinate dall’art. 2118, c. 1, c.c., secondo il quale ciascuna delle parti ha il diritto di “recedere dal contratto di lavoro a tempo indeterminato, dando preavviso nel termine e nei modi stabiliti, dagli usi o secondo equità 1”.
Il legislatore, dunque, riconosce alle parti la facoltà di interrompere unilateralmente il rapporto di lavoro a tempo indeterminato (recesso ad nutum), con l’unico obbligo di rispettare il periodo di preavviso, la cui durata è disciplinata dai Contratti Collettivi.
Pertanto, le dimissioni rappresentano un atto unilaterale recettizio, attraverso il quale il lavoratore esercita il proprio diritto di recesso dal contratto che lo lega al datore di lavoro. Quest’ultimo, in quanto destinatario della comunicazione, ne subisce gli effetti con la conseguente cessazione del rapporto di lavoro.
Le dimissioni hanno efficacia indipendentemente dall’accettazione del datore di lavoro, e in base all’art. 1334 c.c.2 producono i loro effetti dal momento della loro convalida, secondo le procedure stabilite dalla normativa vigente. La scelta di dimettersi è libera e insindacabile, trattandosi di una prerogativa del lavoratore, salvo il caso in cui egli si sia impegnato a garantire una durata minima del rapporto di lavoro.
Se il dipendente non rispetta il periodo di preavviso stabilito dalla contrattazione collettiva, il datore di lavoro, ai sensi del comma 2 dell’art. 2118 c.c., ha diritto a un’indennità sostitutiva del preavviso, il cui importo equivale alla retribuzione spettante per il periodo non lavorato, a meno che il datore rinunci a tale preavviso3.
Tuttavia, il successivo art. 2119 c.c. introduce un’eccezione alla regola generale appena vista, prevedendo la possibilità di recedere immediatamente dal rapporto di lavoro senza obbligo di preavviso in caso di gravi inadempimenti del datore di lavoro. In tale ipotesi, nota come dimissioni per giusta causa, la condotta del datore deve essere tale da rendere impossibile la prosecuzione, nemmeno provvisoria, del rapporto di lavoro4
1 Art. 2118, c. 1 c.c. in https://www.brocardi.it/codice-civile/libro-quinto/titolo-ii/capo-i/sezione-iii/art2118.html
2 Art. 1334 c.c. Gli atti unilaterali producono effetto dal momento in cui pervengono a conoscenza della persona alla quale sono destinati
3F. Meroni – A. Motta, Il lavoro. Manuale per consulenti e operatori del diritto (a cura di) R.P. Platti, Giuffrè Francis Lefebvre, Milano, 2019, p. 859; R. Del Punta, Diritto del lavoro nona edizione, Giuffè Editore, Milano, 2017, pp. 640-641.
4 Ibidem
Nonostante il principio di libertà decisionale del lavoratore, il legislatore è stato chiamato più volte ad intervenire sul tema in esame al fine di garantire che le dimissioni siano espressione di una volontà genuina e consapevole. Questa necessità è sorta per debellare una pratica molto diffusa in passato che minavano il principio suddetto: le cosiddette dimissioni “in bianco”.
Attraverso le dimissioni “in bianco” il datore di lavoro faceva firmare al lavoratore una lettera di dimissioni priva di una data, in bianco appunto, al momento dell’assunzione o nel corso del rapporto di lavoro, consentendo al datore di lavoro di compilarla ed utilizzarla a proprio vantaggio, in qualsiasi momento, per interrompere il rapporto di lavoro con il dipendente senza preavviso o giusta causa.
Questa pratica, oltre a sfruttare la posizione debole e di vulnerabilità del lavoratore, aveva anche lo scopo di eludere le tutele previste dalla legge, in particolare per:
• evitare le garanzie relative alla maternità e paternità, obbligando le lavoratrici in gravidanza a lasciare il posto di lavoro senza la possibilità di impugnazione;
• esimersi dal pagamento dell’indennità di licenziamento, come la NASpI (indennità di disoccupazione) o altre spettanze economiche;
• licenziare il dipendente senza seguire le procedure previste dalla normativa vigenze, evitando le conseguenze di un licenziamento illegittimo.
Dato che le dimissioni “in bianco” rappresentano una grave violazione dei diritti dei lavoratori e un attacco ai principi di equità e giustizia nel mercato del lavoro, il legislatore italiano è intervenuto più volte in materia per contrastare il fenomeno illecito.
Per garantire una maggiore genuinità della decisione del lavoratore, il Governo italiano ha previsto una nuova modalità di rassegnazione delle dimissioni attraverso l’emanazione del d.lgs. n. 151/2015 (il c.d. Jobs Act). Infatti, l’art. 26 d.lgs. n. 151/2015 prevede che le dimissioni siano presentate esclusivamente in modalità telematica su appositi moduli resi dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, accedendo al portale del Ministero del Lavoro con le credenziali dello SPID personale. Il modulo compilato viene poi inviato al datore di lavoro e alla Direzione Territoriale del Lavoro competente.
Gli unici soggetti ai quali non si applicano le regole suddette sono:
• i lavoratori e le lavoratrici che rassegnano le dimissioni nelle sedi c.d. protette (Direzione territoriale del lavoro, sindacato o Commissione di certificazione);
• le lavoratrici in gravidanza, nonché le lavoratrici e i lavoratori durante i primi tre anni di vita del bambino o nei primi tre anni di accoglienza del minore adottato o in affidamento. In questi casi, le dimissioni devono essere convalidate dal servizio ispettivo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali competente per territorio, come previsto dall’art. 55 del Testo Unico sulla maternità;
• i lavoratori domestici.
Per semplificare alcune procedure nella gestione dei rapporti di lavoro, recentemente, il legislatore è intervenuto nuovamente sul tema, introducendo, con la l. n. 203/2024, il c.d. Collegato Lavoro, una nuova forma di cessazione del rapporto di lavoro: le dimissioni per fatti concludenti. Questa procedura consente al datore di licenziare il lavoratore, considerandolo dimissionario, che si assenti senza un giustificato

motivo per un determinato periodo di tempo e senza adeguata motivazione, evitando così il pagamento del ticket di licenziamento.
Le dimissioni per fatti concludenti vengono talvolta paragonate alle dimissioni in bianco poiché in entrambe le situazioni l’interruzione del rapporto di lavoro avviene senza una chiara manifestazione di volontà da parte del lavoratore. Tuttavia, esistono differenze fondamentali:
• le dimissioni in bianco rappresentano una pratica illecita da parte del datore di lavoro che induce il lavoratore a firmare preventivamente una lettera di dimissioni senza data, sfruttandola in futuro a propria discrezione per interrompere il rapporto di lavoro senza rispettare le tutele previste;
• le dimissioni per fatti concludenti, invece, derivano da un comportamento inequivocabile del lavoratore, che con la sua condotta dimostra di voler interrompere il rapporto lavorativo, pur senza presentare formalmente una lettera di dimissioni. Un esempio tipico è l’assenza ingiustificata e prolungata che può essere interpretata dal datore di lavoro come un abbandono volontario dell’impiego.
Il confronto tra le due tipologie di dimissioni nasce dal fatto che in entrambi i casi non vi è una formale manifestazione di volontà da parte del lavoratore. Tuttavia, la differenza sostanziale risiede nella volontarietà dell’atto: le dimissioni per fatti concludenti possono derivare da una scelta implicita del lavoratore, mentre le dimissioni in bianco rappresentano una chiara violazione dei suoi diritti.
Le dimissioni sono un diritto fondamentale del lavoratore, ma il loro esercizio deve avvenire in modo consapevole e volontario. Se da un lato la legislazione ha eliminato il fenomeno delle dimissioni in bianco attraverso strumenti come le dimissioni telematiche, dall’altro l’introduzione delle dimissioni per fatti concludenti ha aperto un nuovo dibattito sulla tutela dei lavoratori e sull’equilibrio tra le esigenze del datore di lavoro e i diritti del dipendente. La sfida futura sarà garantire che nessun meccanismo di cessazione del rapporto lavorativo possa essere utilizzato in modo improprio, assicurando un sistema equo e trasparente per entrambe le parti.
3. NUOVE FORME DI RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO: LE DIMISSIONI PER FATTI CONCLUDENTI
Tra le numerose novità del Collegato Lavoro, la Legge 13 dicembre 2024, n. 203, entrata in vigore dal 12 gennaio 2025, ha modificato l’art. 26 del D. Lgs. 14 settembre 2015, n. 151, che disciplina le modalità per attuare le dimissioni volontarie e la risoluzione consensuale del lavoratore.
In particolare l’istituto delle dimissioni per fatti concludenti viene previsto dal nuovo comma 7-bis dell’art.26 del D.Lgs. n. 151/2015, che tratta delle dimissioni telematiche, segnatamente con la nuova disposizione:
• in caso di assenza ingiustificata del lavoratore protratta oltre il termine previsto dal contratto collettivo nazionale applicato al rapporto oppure, in difetto di previsione contrattuale, superiore a 15 giorni, il datore comunica la circostanza alla sede territoriale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, che può verificarne la veridicità;
• in questo caso, il rapporto si intende risolto per volontà del lavoratore e non si applica l’articolo 26;
• quanto sopra non trova applicazione nel caso in cui il lavoratore dimostri l’impossibilità, per causa di forza maggiore o per fatto imputabile al datore, di comunicare i motivi che giustificano la sua assenza.
3.1. La procedura da seguire
Come già precisato, il datore di lavoro che intenda avvalersi della procedura delle dimissioni per fatti concludenti, in caso di assenza ingiustificata del lavoratore protratta oltre il termine previsto dal CCNL applicato o, in mancanza di previsione contrattuale, per un periodo superiore a quindici giorni, provvede a comunicare lo scioglimento del rapporto di lavoro su propria iniziativa alla sede territoriale INL, che potrà verificare la veridicità della comunicazione.
La comunicazione ha l’effetto di portare alla risoluzione del rapporto di lavoro conferendo all’assenza ingiustificata il valore di comportamento concludente, indice della volontà del lavoratore di dimettersi.

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro con la Nota n. 579/2025 interveniva con istruzioni operative e procedurali a favore dei datori di lavoro che intendono utilizzare la procedura, fornendo anche un format di comunicazione da utilizzare.
In particolare l’INL ha precisato che:
• il datore che vuole avvalersi delle dimissioni “per fatti concludenti” del dipendente dovrà, dapprima, individuare la sede dell’ITL competente in base al luogo di svolgimento del rapporto di lavoro, e quindi inviare, preferibilmente a mezzo PEC, una comunicazione all’indirizzo istituzionale della sede territorialmente competente;
• la comunicazione deve essere compilata, secondo quanto previsto dal modello allegato alla Nota INL 579/2025, riportando tutte le informazioni concernenti il lavoratore, riferibili non solo ai dati anagrafici ma soprattutto ai recapiti, anche telefonici e di posta elettronica, di cui il datore è a conoscenza;
• in base alla comunicazione pervenuta e ad eventuali altre informazioni già in suo possesso, la sede dell’Ispettorato Territoriale potrà verificare la “veridicità della comunicazione”;
• la procedura di indagine dell’Ispettorato deve concludersi entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione inviata dal datore;
• una volta decorso il periodo previsto dal CCNL o almeno i 15 giorni di legge, e inviata la PEC all’ITL, il datore provvede a comunicare la cessazione del rapporto (tramite UNILAV) e questo anche se ancora l’Istituto non si fosse attivato oppure anche qualora lo stesso non avesse terminato i propri accertamenti;
• in tal caso, quindi, come da norma, il rapporto si intende risolto per volontà del lavoratore, ossia per dimissioni, senza altre formalità.
L’INPS ha inoltre precisato con il messaggio n. 639 del 19.2.2025 che, in questa circostanza, le dimissioni per fatti concludenti introdotte dal Collegato Lavoro sono assimilabili alle dimissioni volontarie e, pertanto, il lavoratore assente non può accedere alla prestazione di disoccupazione NASpI.
La circostanza dell’assenza del diritto alla NASpI consente al datore di lavoro di non essere tenuto al versamento del contributo dovuto per l’interruzione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato, ovvero del ticket licenziamento.
Preme evidenziare anche che, dal 12 gennaio 2025, tali cessazioni devono essere esposte nel flusso Uniemens con il nuovo codice -Tipo Cessazione- “1Y”, avente il significato di: -Risoluzione rapporto di lavoro articolo 26 D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151, comma 7 bis-.
Occorre inoltre precisare che qualora il lavoratore invece provi l’impossibilità, per forza maggiore o fatto imputabile al datore di lavoro, di comunicare i motivi che giustificano la condotta posta in essere il rapporto di lavoro non si risolve.
Preme infine rilevare che qualora all’esito dell’accertamento venisse riscontrata la non veridicità della comunicazione datoriale, o il lavoratore fornisse prova dell’impossibilità di comunicare i motivi per causa di forza maggiore o per fatto imputabile al datore di lavoro, l’Ispettorato procede a comunicare la ricostituzione del rapporto ad entrambe le parti.
Inoltre se venissero riscontrate gravi inadempienze poste in essere dal datore di lavoro, tali da costituire gli estremi di giusta causa (come a mero
titolo esemplificativo il mancato pagamento delle retribuzioni), l’Ispettorato potrà procedere a riqualificare le dimissioni come inoltrate per giusta causa.
4. CRITICITÀ INTERPRETATIVE E DELEGHE ALLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA PER LA RISOLUZIONE DI FATTO
Non v’è dubbio che le novità normative introdotte ed analizzate nei precedenti paragrafi abbiano il nobile scopo di arginare il noto fenomeno delle c.d. assenze strategiche, volte ad ottenere un recesso datoriale ed il consequenziale accesso al sussidio di disoccupazione, nonché di riequilibrare – almeno apparentemente – le contrapposte situazioni giuridiche dei contraenti.
Prima di addentrarsi nell’ennesimo tentativo interpretativo, è bene evidenziare che, per la fattispecie in argomento, oltre ad esservi una scontata assenza di precedenti giurisprudenziali, gli enti vigilanti hanno ritenuto opportuno escludere, per probabile prudenza ermeneutica, qualsiasi speculazione esegetica sul merito della norma, limitandosi – come raramente accade – ad un intervento di prassi amministrativa assolutamente minimale e stringatamente sotteso all’affidamento conferito dal legislatore. In tale ambito, nell’incertezza del diritto, solo un futuro e consolidato orientamento giurisprudenziale potrebbe dirimere le criticità applicative che di seguito verranno poste e, per quanto possibile, esaminate. Tutto ciò al netto della recentissima quanto controversa circolare ministeriale 27 marzo 2025, n. 6.
L’art. 19, legge 13 dicembre 2024, n. 203 (c.d. Collegato Lavoro), aggiunge il nuovo comma 7-bis, all’art. 26, decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151, rubricato Dimissioni volontarie e risoluzione consensuale, secondo cui “In caso di assenza ingiustificata del lavoratore protratta oltre il termine previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro applicato al rapporto di lavoro o, in mancanza di previsione contrattuale, superiore a quindici giorni, il datore di lavoro ne dà comunicazione alla sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro, che può verificare la veridicità della comunicazione medesima. Il rapporto di lavoro si intende risolto per volontà del lavoratore e non si applica la disciplina prevista dal presente articolo. Le disposizioni del secondo periodo non si applicano se il lavoratore dimostra l’impossibilità, per causa di forza maggiore o per fatto imputabile al datore
di lavoro, di comunicare i motivi che giustificano la sua assenza”. Sinteticamente, viene dunque introdotta nel nostro ordinamento una nuova fattispecie di recesso dal rapporto di lavoro dipendente, volgarmente denominabile dimissioni per fatti concludenti, la cui attuazione è facoltativamente esperibile dal datore di lavoro nei casi in cui il lavoratore sia risultato assente dal luogo di lavoro senza giustificato motivo per un periodo eventualmente previsto dal contratto collettivo nazionale applicato al rapporto di lavoro o, in mancanza, superiore a quindici giorni, e previa informazione o comunicazione da rendersi alla sede territorialmente competente dell’INL. La lettura della neo-introdotta ed auspicata fattispecie va però, nostro malgrado, ragionata all’interno dell’articolato impianto giuslavoristico del Bel Paese, nel quale l’ipotesi delle dimissioni per fatti concludenti si incardina tra le generali regole – attualmente vigenti – secondo cui la risoluzione per volontà del lavoratore deve, a pena di inefficacia e senza possibilità di adottare mezzi equipollenti, avvenire attraverso i canali telematici noti; di talché essa costituisce una “eccezione” – di fatto –rispetto a tutte le altre forme di recesso, se non altro per l’assenza di qualsivoglia atto recettizio tra le parti.
Procedendo con l’analisi letterale, si rileva in primis che la fattispecie in argomento è configurabile in caso di “assenza ingiustificata” del lavoratore. In assenza di più precise indicazioni legislative (poteva essere sufficiente aggiungere, al termine superiore a quindici giorni, la locuzione “di calendario” ovvero “lavorabili”), vi è da chiedersi quando effettivamente si realizzi la fattispecie dell’assenza ingiustificata, con il chiaro scopo di poterne con certezza conteggiare le giornate utili prescritte ex lege per considerare concluso il rapporto di lavoro. Al riguardo, sebbene la nota INL 22 gennaio 2025, n. 579, preveda timidamente che “laddove il datore di lavoro intenda effettuare la comunicazione, dovrà (…) verificare che (…) siano trascorsi almeno quindici giorni dall’inizio del periodo di assenza”, facendo propendere per un conteggio civilistico del periodo d’assenza (sposato da parte della dottrina), l’assunto appare porsi in aperto contrasto con il dato letterale della disposizione normativa. Posizione, peraltro, ripresa apertamente nella circolare 27 marzo 2025, n. 6, secondo cui “in mancanza di ulteriori specificazioni da parte della norma, possono intendersi come giorni di calendario, ove non diversamente disposto dal CCNL applicato al rapporto di lavoro”. Voglia, infatti, condividersi l’assunto secondo cui l’assenza ingiustificata può concretamente verificarsi solo
nelle giornate in cui, pur sussistendo un’obbligazione contrattuale, non si sia realizzata la prestazione lavorativa e che detta inadempienza venga – in qualche modo – rilevata come tale da colui che si attende di ricevere la prestazione d’opera contrattualizzata. In extremis, un focus su cui ragionare è se l’assenza possa considerarsi ingiustificata solo allorquando il datore di lavoro la consideri tale e quindi l’abbia conseguentemente rilevata sotto il profilo disciplinare. Voglia, insomma, escludersi che possano essere tecnicamente conteggiate le giornate “non lavorabili”, nelle quali, di fatto, non essendoci l’aspettativa/ l’obbligo di ricevere la prestazione, non può realizzarsi l’illecito (potenzialmente disciplinarmente rilevante) dell’assenza ingiustificata. Detta interpretazione, certamente prudenziale e maggiormente aderente al tenore letterale della disposizione, però paga lo scotto di apparire estremamente dilatoria rispetto ai principi di celerità e certezza tipici del rapporto di lavoro dipendente. Supponendo, ad absurdum, una prestazione d’opera da realizzarsi in una sola giornata nel corso della settimana (ma ben potrebbero esistere fattispecie ancor più incisive), la fattispecie delle dimissioni per fatti concludenti potrebbe realizzarsi solo successivamente alla quindicesima settimana d’assenza. Di converso, a sostegno della tesi sopraesposta (confermata dalla prassi amministrativa), lasciando inalterato il rapporto di lavoro con prestazione di una sola giornata nel corso della settimana, potrebbe considerarsi legittimo un recesso per fatti concludenti dopo “sole” due giornate di assenza ingiustificata? Ciò tenendo, comunque a mente che, per la stragrande maggioranza dei contratti collettivi, non è previsto, per le ipotesi di assenza ingiustificata di “sole” due giornate, nemmeno il recesso datoriale disciplinare?
Proseguendo nella lettura, l’assenza ingiustificata deve essere letteralmente protratta oltre il termine previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro applicato al rapporto di lavoro (…). L’utilizzo dell’aggettivo protratta vuol chiaramente significare che trattasi di un’assenza prolungata nel tempo, continuata per il periodo previsto dalla norma, potenzialmente applicabile solo in “rari” casi concreti. Più che altro perché un termine così ampio, oltre a correre il rischio di potersi incartare rispetto ad eventuali stringenti termini previsti dalla contrattazione collettiva per l’esecuzione di procedimenti disciplinari paralleli (di cui si dirà in seguito), non giova ad equilibrare i pesi della bilancia, potendo i furbetti della NASpI scovare a bizzeffe
ulteriori espedienti (rispetto alla “banale” assenza ingiustificata) per raggiungere il traguardo della NASpI. Quanto alla delega al contratto collettivo nazionale di lavoro applicato al rapporto di lavoro, forse, parrebbero sussistere meno perplessità. Non vi sono riferimenti a gradi e stellette di rappresentatività, sia “semplice” che “comparata” (nemmeno con rinvii a norme differenti – fra tutti, l’art. 51, decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81), sicché la delega legislativa opera indiscriminatamente su tutta la negoziazione collettiva con un’unica eccezione: essa deve essere svolta a livello nazionale, senza possibilità di regolare la materia in via decentrata, sia territoriale che aziendale. Rimanendo in tema di contrattazione, come possiamo individuare se il CCNL applicato al rapporto di lavoro abbia o meno disciplinato tale forma di recesso? E, soprattutto, possiamo assimilare l’eventuale tipizzazione dell’assenza ingiustificata già generalmente in uso nel procedimento disciplinare per la nuova fattispecie del recesso per fatti concludenti? Anche in questo caso la dottrina sembrerebbe essere non univoca, sebbene chi scrive ritiene – con forte convincimento – che si tratti di due procedure e presupposti a sé stanti. Invero, la fattispecie dell’assenza ingiustificata generalmente tipizzata dalla contrattazione collettiva, nelle sezioni o articoli che regolano l’esperimento della
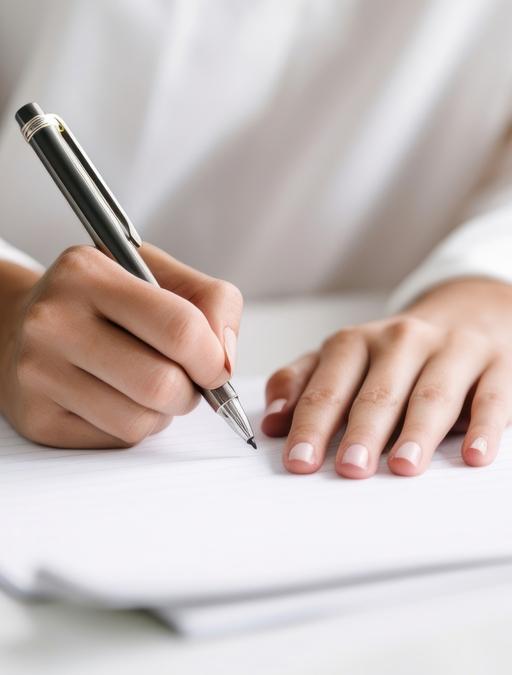
procedura disciplinare e/o le sanzioni disciplinari, porta con sé la prerogativa di una procedura legale/ contrattuale finalizzata a garantire l’esercizio del diritto di difesa del lavoratore dipendente. Questione non di poco conto se si prenda atto che l’invalidità del recesso per fatti concludenti è eccepibile solo nel caso in cui il lavoratore dimostra l’impossibilità, per causa di forza maggiore o per fatto imputabile al datore di lavoro, di comunicare i motivi che giustificano la sua assenza. Motivi che, si badi bene, non riguardano l’assenza, quanto piuttosto l’impossibilità di comunicare gli stessi al datore di lavoro. Vieppiù, anche nel caso in cui accordi di derivazione collettiva abbiano, in tempi antecedenti all’entrata in vigore del Collegato Lavoro, disciplinato forme e modalità di dimissioni per fatti concludenti, si ritiene che la disposizione contrattuale, per essere adoperata in funzione delle nuove disposizioni di cui al comma 7-bis, debba essere concretamente ed opportunamente rivisitata dalle parti sociali. Sul punto, si rileva, infatti, che la giurisprudenza ha univocamente evidenziato che all’autonomia collettiva (ma anche a quella individuale, rispetto al divieto di apposizione di clausole di risoluzione espressa) non è consentito regolare la disciplina della risoluzione del rapporto di lavoro prevedendo cause ulteriori a quelle disciplinate dalla legge. Fattispecie, quella in analisi, che può essere tendenzialmente oggetto di contrattazione raggiunta solo post 12 gennaio 2025, ovverosia nel momento in cui le parti sociali abbiano effettivamente preso atto della delega conferita dal legislatore e, dunque, nella piena coscienza degli effetti che l’eventuale regolamentazione dell’istituto può avere nei rapporti individuali di lavoro. A mero titolo esemplificativo, si ritiene che la disposizione del CCNL Metalmeccanica Artigianato, secondo cui “Il lavoratore che entro tre giorni dal termine del periodo della malattia non si presenti al lavoro, sarà considerato dimissionario”, già presente sin dal primo accordo del 26 luglio 1968, seppur confermata ad ogni rinnovo, non possa essere presa in considerazione per il realizzarsi del nuovo recesso per fatti concludenti. Al riguardo, l’indirizzo ministeriale (circolare 27 marzo 2025, n. 6) più recente (e controverso) ha peraltro confermato che l’eventuale deroga della contrattazione collettiva potrà essere posta solo in melius, per il lavoratore, rispetto al termine legale di che trattasi, sicché anche nel caso in cui le parti sociali riducano i termini dell’assenza ingiustificata utile alla risoluzione per fatti concludenti dovrà comunque farsi riferimento al periodo previsto dalla norma. Non può non evidenziarsi che il sopradetto assunto appare porsi in netto contrasto
con il tenore letterale della disposizione che, invece, individua proprio la contrattazione collettiva nazionale (delegittimando eventuali accordi di secondo livello) quale primario soggetto deputato all’individuazione del periodo utile alla maturazione del recesso di fatto del lavoratore, subordinando, in mancanza di tale previsione, l’applicazione del termine legale (superiore a quindici giorni).
Rimanendo ancorati al primo periodo del comma 7-bis, vi è poi un’ultima questione meritevole d’essere affrontata: nel periodo intercorrente tra il realizzarsi della fattispecie in argomento, è possibile, comunque, avviare un procedimento disciplinare?
Dal tenore letterale della norma, non vi sono preclusioni all’avvio di un contestuale procedimento disciplinare né espresse incompatibilità con l’art. 7, legge 20 maggio 1970, n. 300, sicché è presuntivamente possibile affermare che le strade del licenziamento disciplinare e delle dimissioni per fatti concludenti siano ipoteticamente parallele (ipotesi confermata dalla circolare ministeriale 27 marzo 2025, n. 6). Soluzione astrattamente pacifica ma che, contrariamente a quanto affermato dagli assunti della geometria euclidea, corre il rischio che le due procedure possano incontrarsi (o scontrarsi), conducendo a pericoli nascosti, incerti e imprevedibili. Parte della dottrina sostiene che la circostanza dell’assenza possa essere etichettata come ingiustificata solo quando la stessa sia rilevata sotto il profilo squisitamente disciplinare dalla parte destinataria dell’obbligo contrattuale, con un sostanziale e propedeutico “obbligo” (in extremis) di avviare il procedimento ex art. 7, legge 20 maggio 1970, n. 300, al fine di poter consacrare detta assenza come ingiustificata. A ragione, non si voglia sostenere che un’eventuale inerzia del datore di lavoro nell’avvio del procedimento possa, per facta concludentia, rappresentare una acquiescenza all’assenza del lavoratore dipendente, con conseguente implicita dichiarazione di ammissione dell’insussistenza, in concreto, di alcuna lesione dell’interesse datoriale. Laddove si intenda seguire tale interpretazione, il datore di lavoro sarebbe chiamato presumibilmente a gestire in contemporanea ambedue i procedimenti, entrambi con i propri termini e scadenze. Giunti al “momento della decisione”, per ovvi motivi meramente economici, il datore di lavoro potrebbe allora attivare le comunicazioni di rito presso la sede dell’Ispettorato territorialmente competente, procedendo alla risoluzione per fatti concludenti. E il procedimento disciplinare? Sebbene non vi sia un

obbligo di concludere e materialmente eseguire il provvedimento sanzionatorio, pro bono pacis dell’azione avviata, c’è chi asserisce con fermezza, sebbene non sia privo di fondamento, che sia comunque possibile, post risoluzione per fatti concludenti, notificare il licenziamento disciplinare per l’assenza rilevata (previa valutazione degli elementi di fatto e/o di diritto eventualmente evidenziati nel corso della difesa da parte del lavoratore), subordinando gli effetti della comunicazione del recesso datoriale solo in caso di caducazione delle dimissioni di fatto e conseguente ripristino del rapporto di lavoro. Nozione questa, sebbene ardua, che trova conferma giurisprudenziale
nelle analoghe ed assimilabili ipotesi di c.d. doppio licenziamento. Altra parte della dottrina, invece, ritiene di dover prendere il cammino dell’una o dell’altra strada, anche in applicazione del principio generale di certezza del diritto che contraddistingue in nostro ordinamento e secondo cui ogni persona deve essere posta in condizione di valutare e prevedere, sulla base delle norme, le conseguenze giuridiche della propria condotta. Secondo tale tesi, il procedimento disciplinare potrebbe, invero, essere avviato all’eventuale rientro (anche avvenuto nella quindicesima giornata d’assenza) del lavoratore, ovverosia quando, pur rilevandosi l’assenza ingiustificata, non si sia raggiunto il termine o il periodo fissato dal contratto collettivo applicato o dalla legge previsto per la realizzazione della fattispecie incriminatrice. Sul punto – continua tale orientamento – non vi sarebbero contestazioni di sorta, nemmeno rispetto ai principi di tempestività dell’azione disciplinare, atteso che vi è una norma (il comma 7-bis) che, in qualche modo, giustifica l’attesa posta eventualmente in essere dal datore di lavoro. Tesi che sembrerebbe essere condivisa dalla prassi ministeriale (circolare 27 marzo 2025, n. 6), che si è spinta ad affermare che il procedimento ex art. 7, legge 20 maggio 1970, n. 300, è del tutto alternativo a quello previsto dall’art. 19 in commento, ritenendo, nel silenzio della norma, che i due istituti in argomento debbano essere considerati come un corpus unico

GIURISPRUDENZA
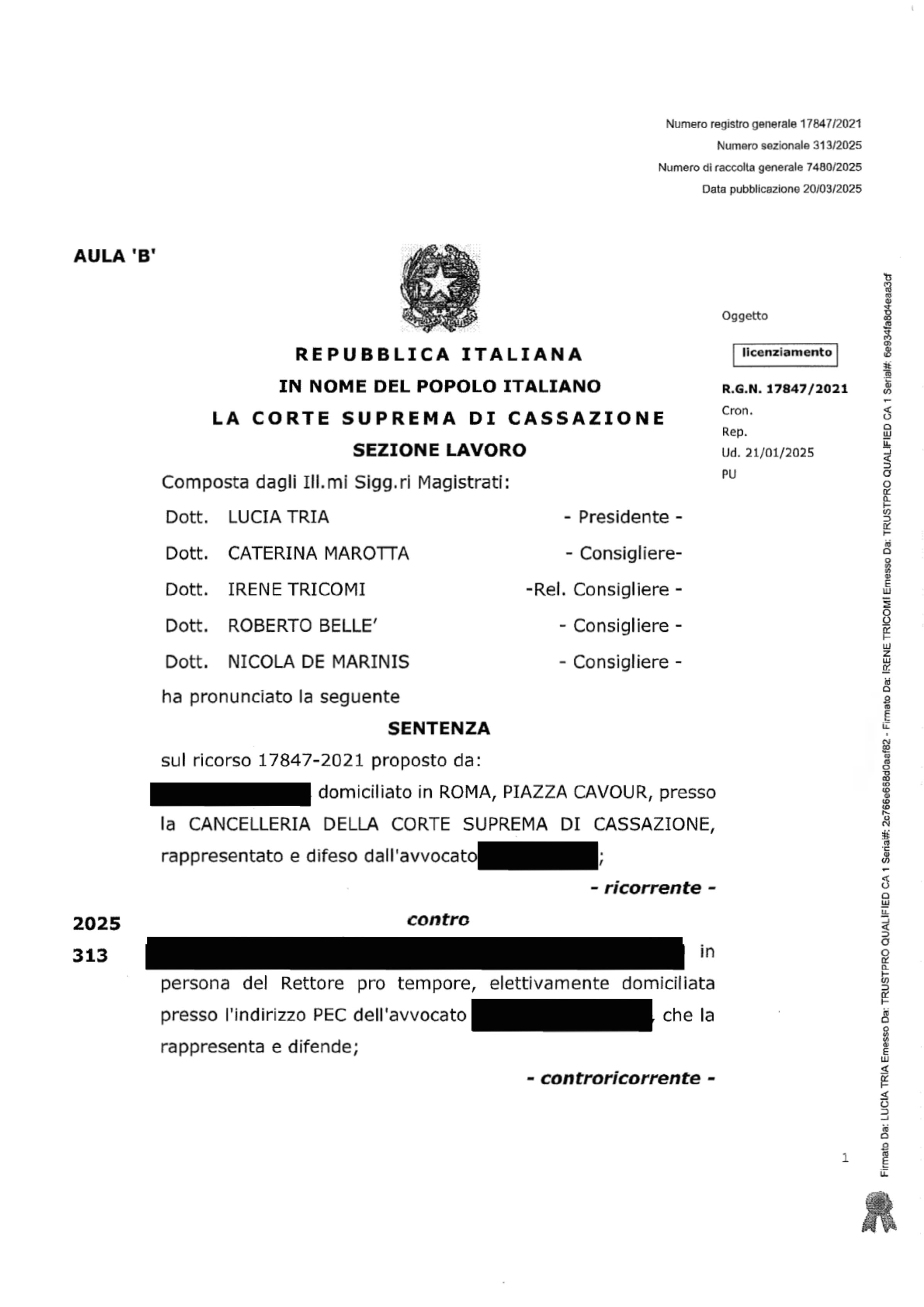
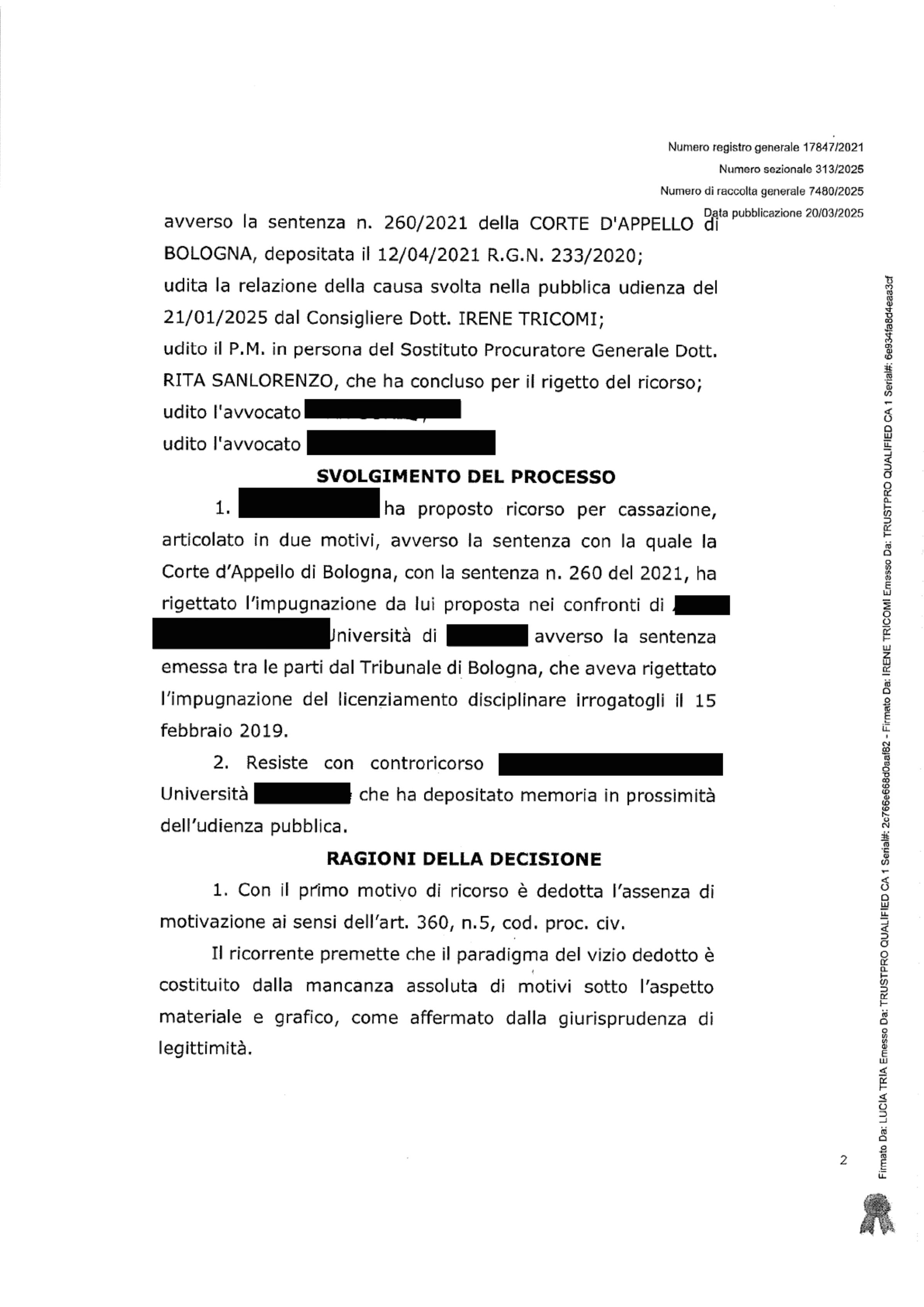
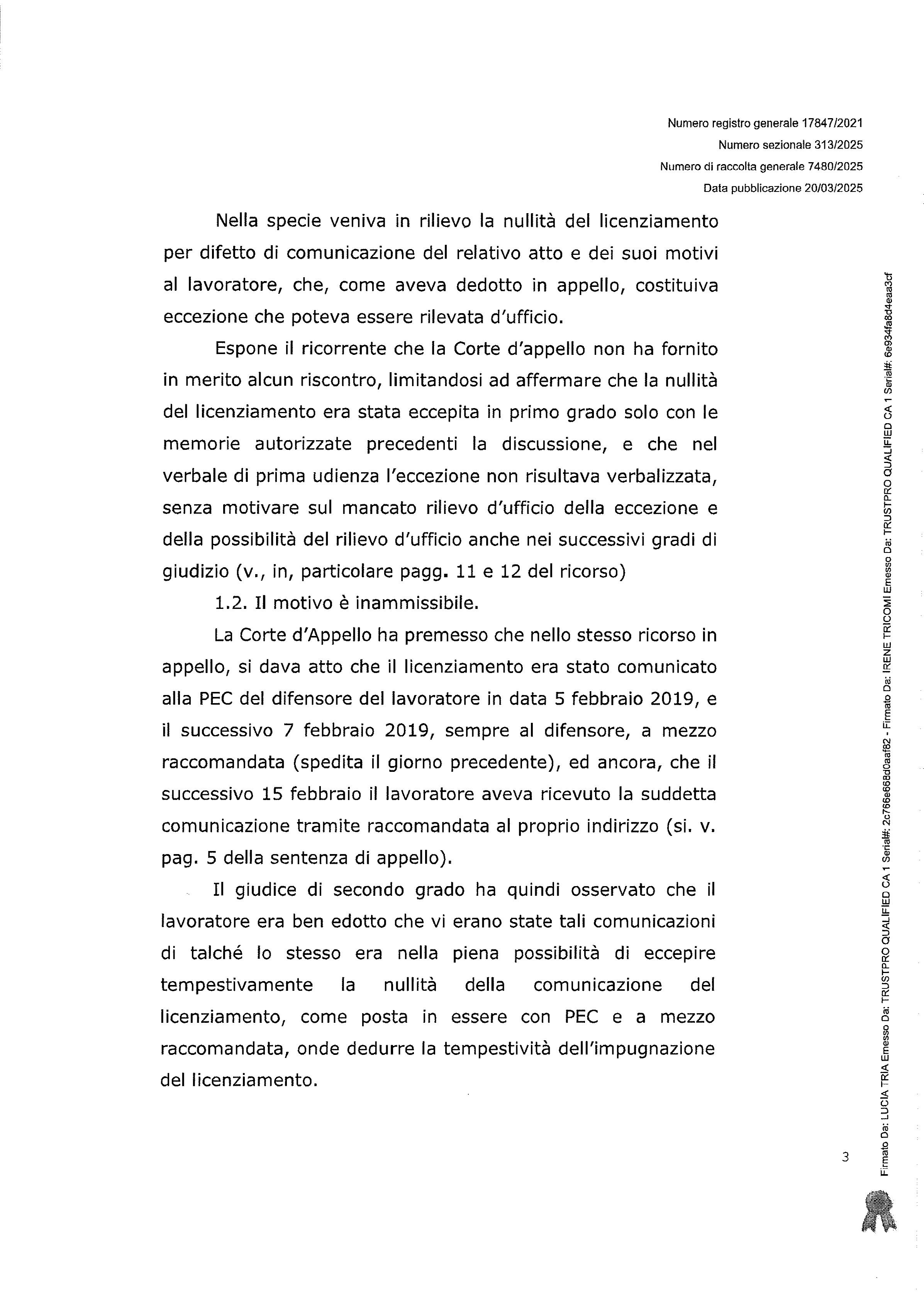

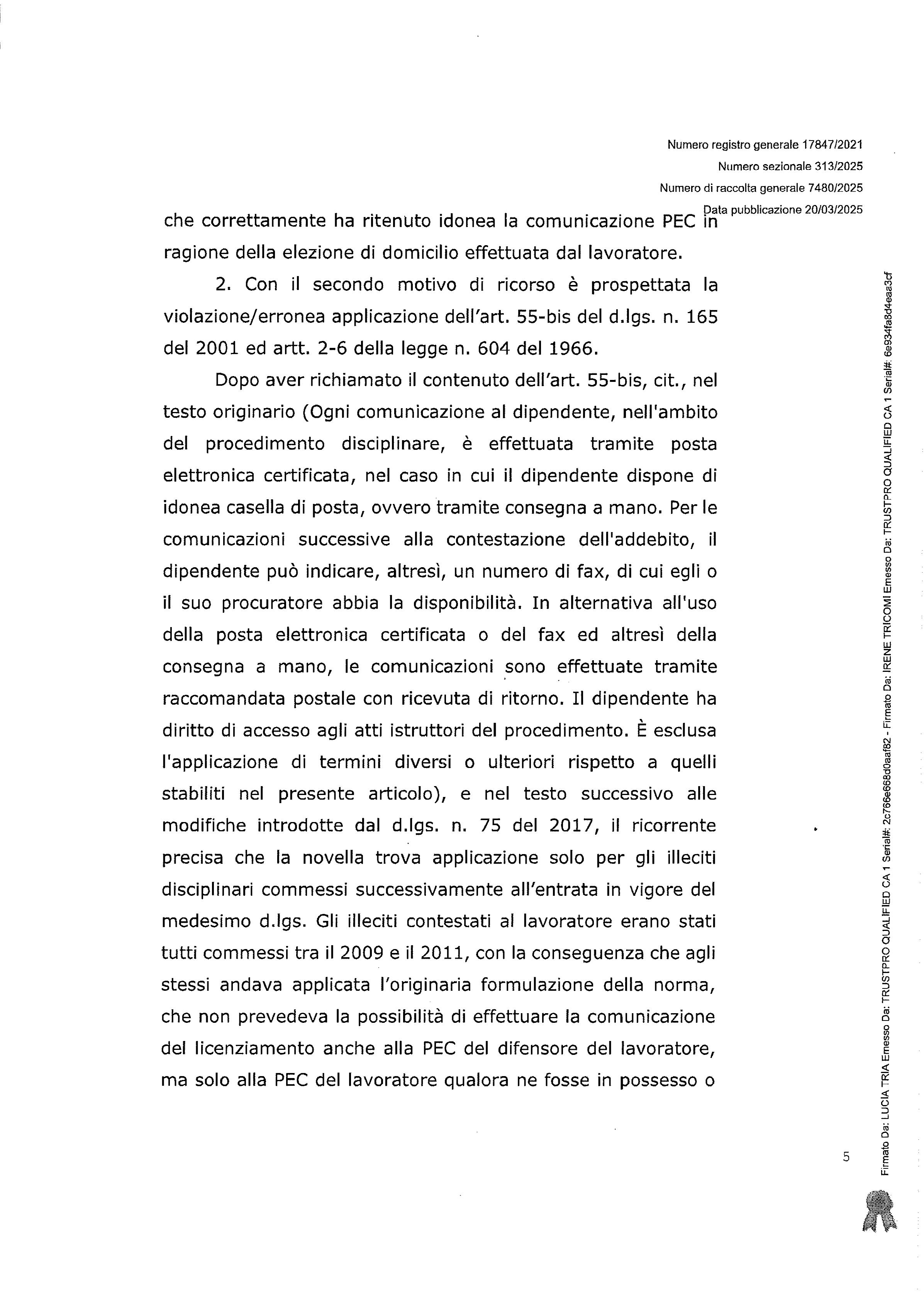
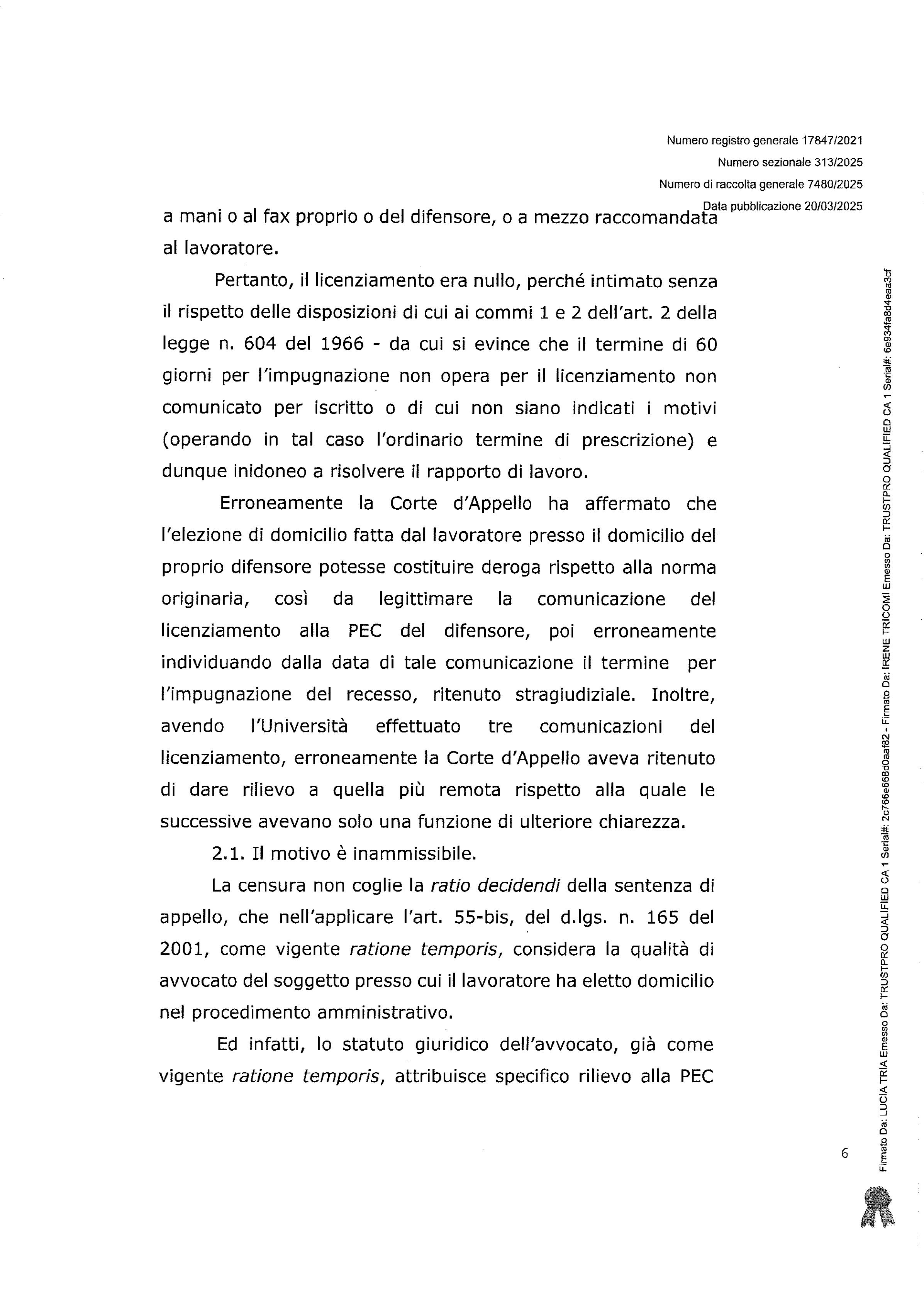
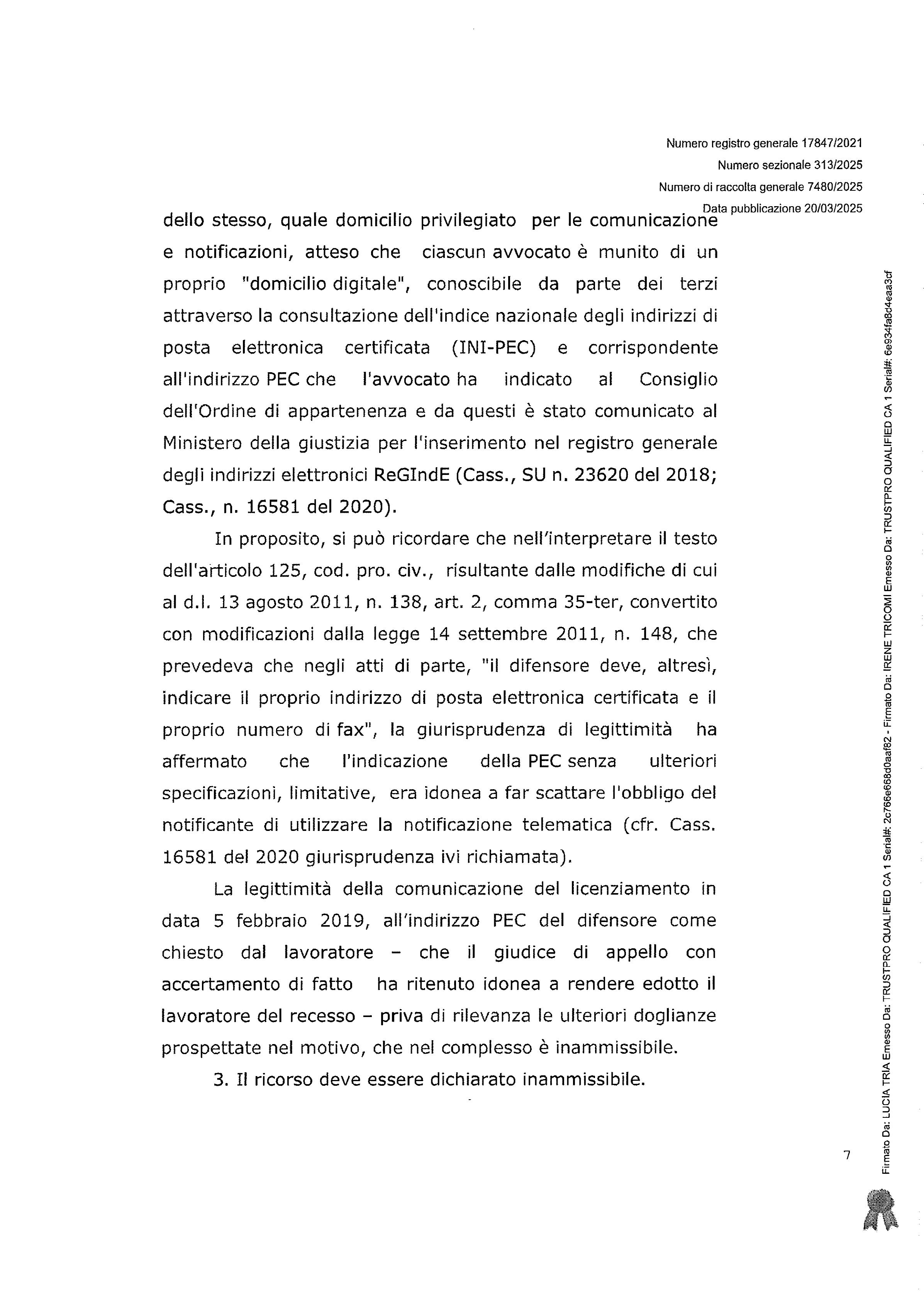
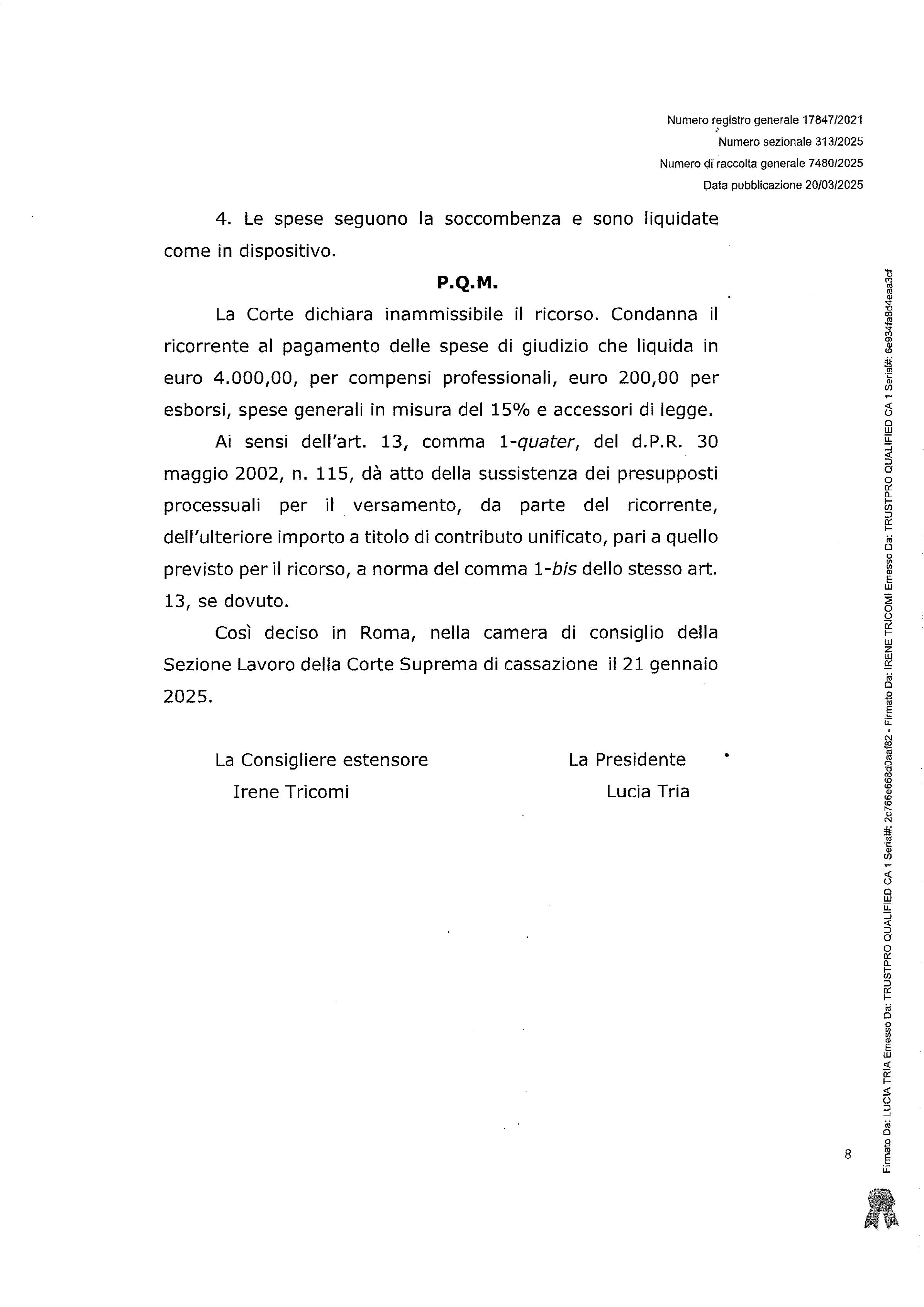
SENTENZE - STRALCI
CORTE DI CASSAZIONE
ORDINANZA 12 FEBBRAIO 2025, N. 3627
La Cassazione afferma che l’invio di una email al proprio superiore gerarchico per accusarlo di mobbing, con in copia tutti i colleghi, non legittima il licenziamento se il dissenso è comunicato, nei limiti della continenza formale e sostanziale, senza offese od aggressioni gratuite. Il caso di specie è la vicenda del cardiochirurgo, occupato presso una struttura ospedaliera, che è stato licenziato a seguito di una email rivolta al suo superiore gerarchico e per conoscenza a tutti i medici dell’istituto, con la quale denunciava l’esclusione dalla sala operatoria e altre forme di discriminazione. Dopo che la Corte d’Appello ha ritenuto la sanzione espulsiva sproporzionata, la Suprema Corte nella sentenza del 12 febbraio 2025 nel punto 21 afferma che:
“Posto che, come detto, la critica è per definizione espressione di dissenso, disapprovazione, di giudizi negativi sull’altrui operato, la offensività di una singola parola o di una specifica frase, estrapolata peraltro da un intero contesto, in tanto può oltrepassare la barriera della continenza formale in quanto sia veicolata con epiteti volgari, disonorevoli o infamanti oppure qualora non abbia alcun nesso con la disapprovazione espressa e motivata e si risolva pertanto in una aggressione gratuita e fine a sé stessa dell’altrui reputazione”.
CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONE LAVORO
ORDINANZA 10 FEBBRAIO 2025, N. 3400
Con l’ordinanza del 10 febbraio 2025 n.3400, la Corte di Cassazione ha affermato che in caso di accertato demansionamento, la determinazione del danno subito dal lavoratore deve includere il mancato aggiornamento professionale, soprattutto se questi opera in un settore ad alta innovazione tecnologica.
“In tema di dequalificazione professionale, è risarcibile il danno non patrimoniale ogni qual volta si verifichi una grave violazione dei diritti del lavoratore, che costituiscono oggetto di tutela costituzionale, da accertarsi in base alla persistenza del comportamento lesivo, alla durata e alla reiterazione delle situazioni di disagio professionale e personale, all’inerzia del datore di lavoro rispetto alle istanze del prestatore di lavoro, anche a prescindere da uno specifico intento di declassarlo o svilirne i compiti. La relativa prova spetta al lavoratore, il quale tuttavia non deve necessariamente fornirla per testimoni, potendo anche allegare elementi indiziari gravi, precisi e concordanti, quali, ad esempio, la qualità e la quantità dell’attività lavorativa svolta, la natura e il tipo della professionalità coinvolta, la durata del demansionamento o la diversa e nuova collocazione lavorativa assunta dopo la prospettata dequalificazione (Cass. n. 24585/2019; Cass. n. 21/2019).”
SENTENZE - STRALCI
CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONE LAVORO ORDINANZA 6 MARZO 2025, N. 5948
La Cassazione con ordinanza del 6 marzo 2025 n. 5948 interviene in un caso di licenziamento per abuso dei permessi ex art. 33, comma 3, della L. 104/1992.
La Corte d’Appello rigetta l’impugnazione del licenziamento, in quanto nei giorni di permesso in questione il parente disabile era ricoverato in una struttura sanitaria ed il ricorrente era stato in visita al medesimo solo brevemente.
La Cassazione si pronuncia confermando come legittimo il licenziamento del dipendente che fruisce dei permessi ex lege 104 per i giorni in cui il parente disabile è ricoverato in ospedale oppure in altre strutture sanitarie con assistenza continuativa. In particolare nei punti 4 e 5 dell’ordinanza la Corte afferma:
4. “Nel caso di specie il ricorrente ha argomentato sulla erroneità della interpretazione dell’art. 33 della legge n. 104 del 1992, alla quale - secondo il lavoratore - è stata data una lettura del tutto restrittiva, secondo un orientamento ormai superato da più avveduta giurisprudenza di legittimità (che in sintesi, ritiene idonea un’assistenza al familiare disabile anche svolta in orari diversi da quelli dell’orario di lavoro), ma nulla ha dedotto sull’altra ragione del rigetto, affrontata per prima dalla Corte territoriale, ossia il ricovero del familiare disabile presso una struttura (residenza per persone anziane autosufficienti e non autosufficienti) del tutto assimilabile ad una struttura ospedaliera trattandosi di struttura che assicura assistenza sanitaria continuativa (come da accertamento di fatto, insindacabile in questa sede di legittimità, nonché in ossequio ad orientamento già espresso da questa Corte, cfr. Cass. n. 21416 del 2019); tale circostanza, come richiede l’incipit del comma 3 dell’art. 33 della legge n. 104 del 1999, esclude la sussistenza del diritto ai permessi giornalieri retribuiti.
5. L’omessa impugnazione di tutte le rationes decidendi rende inammissibili, per esistenza del giudicato sulla ratio decidendi non censurata, le censure relative alle singole ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ultime, quand’anche fondate, non potrebbero comunque condurre, stante l’intervenuta definitività delle altre non impugnate, all’annullamento della decisione stessa.”
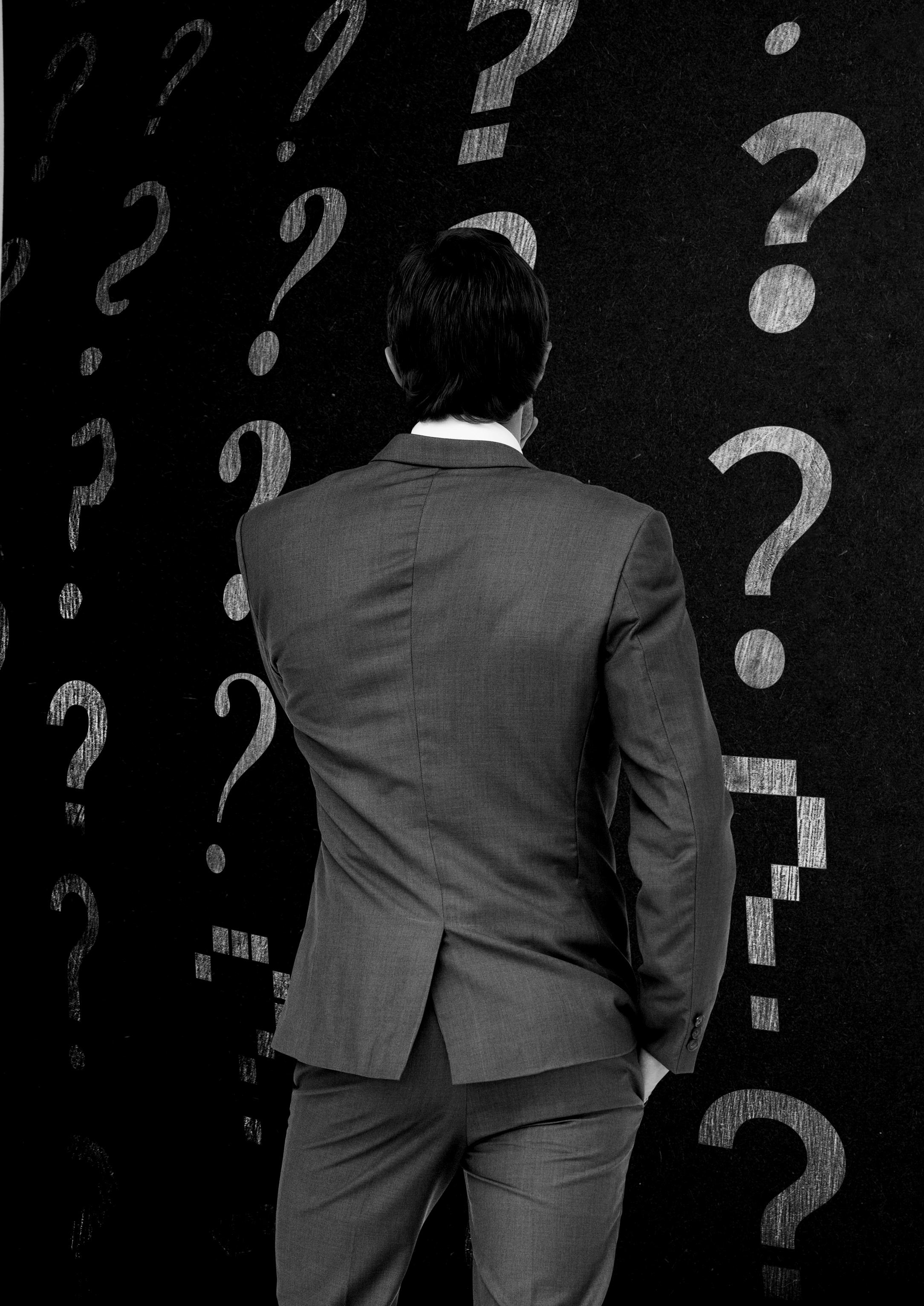
AREA QUESITI
INDENNITÀ DI TRASFERTA E TRACCIABILITÀ DAL 2025
Convenuto che dal 2025 per le trasferte effettuate fuori dal Comune della sede di lavoro, il regime fiscale distingue due modalità principali per il rimborso delle spese:
Indennità forfettarie:
• Sono imponibili solo per la parte eccedente i limiti fissati dalla normativa.
• Consentono un rimborso semplificato senza necessità di documentazione analitica delle spese.
Rimborsi analitici:
• Le spese di viaggio e trasporto (incluse indennità chilometriche) sono esenti da imposizione fiscale e contributiva, purché adeguatamente documentate.
• I costi per vitto e alloggio seguono limiti di esenzione giornaliera (180 euro per trasferte in Italia, 258 euro per trasferte all’estero), oltre i quali diventano imponibili.
È obbligatorio che il rimborso avvenga tramite strumenti di pagamento tracciabili a partire dal 2025.
Qualora in LUL si ricorra alla voce “trasferta indennità forfettaria” (quindi senza particolare necessità di documentazione analitica delle spese) l’esenzione sarà sempre per Italia 46,48 euro al giorno o si ridurrà a 15,49 euro al giorno in quanto assente di documentazione analitica?
QUANTO AL QUESITO
In merito al quesito sottoposto all’attenzione dello Scrivente è possibile rispondere come segue.
Nel caso in cui si opti per l’erogazione di una indennità di trasferta forfettaria, troverà applicazione quanto previsto dall’art. 51 co. 5 del TUIR che non è stato oggetto di modifica.
Pertanto sarà possibile erogare:
a) indennità forfettaria esente nel limite di 46,48 euro per la trasferta Italia e 77,47 euro per la trasferta estero, oltre che spese di viaggio e trasporto;
b) indennità forfettaria esente nel limite di 30,99 euro per la trasferta Italia e 51,65 euro per la trasferta estero nel caso di fornitura o rimborso di vitto o alloggio, oltre che spese di viaggio e trasporto;
c) indennità forfettaria esente nel limite di 15,49 euro per la trasferta Italia e 25,82 euro per la trasferta estero nel caso di fornitura o rimborso di vitto e alloggio.
Nelle ipotesi b) e c) l’eventuale rimborso di vitto o alloggio ovvero vitto e alloggio per essere esente in capo al lavoratore dovrà essere effettuato mediante strumenti di pagamento tracciabili; in assenza, le eventuali somme rimborsate saranno considerate imponibili ai fini fiscali e previdenziali.
Centro Studi Associazione Nazionale Consulenti del Lavoro
N.B. il parere sopra riportato è fornito nell’esclusivo interesse dell’associato e, pertanto, non è opponibile ai terzi.
La risposta fornita, in ogni caso, non rappresenta una consulenza professionale. L’associato può scegliere di seguire i consigli contenuti nel parere nella piena autonomia professionale.
QUESITO N. 2 AGEVOLAZIONE ESONERO GIOVANI
Un rapporto di lavoro Part Time agevolato ai sensi dell’art 1 c. da 10 a 15 L. 178/2020 (esonero giovani) è stato trasformato nel mese di dicembre 2024 in Full Time.
Si chiede, cortesemente, se la soglia massima di esonero della contribuzione debba essere rapportata al Full Time, oppure resta sempre calcolata alla percentuale del Part Time che il lavoratore aveva al momento dell’acquisizione dell’agevolazione (nello specifico trasformazione di un rapporto da tempo determinato a tempo indeterminato dal 30/06/2022 fine agevolazione 29/06/2026).
QUANTO AL QUESITO
In merito al quesito sottoposto all’attenzione dello Scrivente è possibile rispondere come segue.
Come noto, la legge 30 dicembre 2020, n. 178 (c.d. “Legge di Bilancio per l’anno 2021”) al fine di promuovere l’occupazione giovanile stabile, ha previsto all’articolo 1, commi da 10 a 15, un esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui, per un periodo di 36 mesi (48 mesi in caso di assunzioni in una sede o unità produttiva ubicata nelle Regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna).
Nota: si evidenzia che tale esonero, pur nelle sue specificità, trae la sua disciplina dall’esonero strutturale giovanile di cui all’articolo 1, commi da 100 a 108, 113 e 114, della legge n. 205/2017 (Legge di Bilancio 2018).
L’esonero di cui alla Legge di Bilancio 2021 è riconosciuto in favore dei datori di lavoro che, nel biennio 2021/2022, assumano a tempo indeterminato o trasformino contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato giovani che, “alla data dell’evento incentivato”, non abbiano compiuto il trentaseiesimo anno di età e che non abbiano mai avuto, nel corso dell’intera vita lavorativa, un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con il medesimo o altro datore di lavoro.
In data 16 settembre 2021, la Commissione europea ha autorizzato la concedibilità dell’esonero in oggetto per le assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato effettuate entro il 31 dicembre 2021 e l’INPS, con circolare n. 56/2021, ha illustrato le condizioni e gli adempimenti previdenziali connessi al godimento dell’esonero in trattazione.
Con successivo messaggio n. 3389/2021 l’Istituto ha fornito le istruzioni per la sua fruizione nonché le modalità compilazione delle dichiarazioni contributive da parte dei datori di lavoro.
Con messaggio n. 403 del 26 gennaio 2022 l’Istituto ha comunicato che la Commissione europea, in data 11 gennaio 2022, ha prorogato l’applicabilità delle agevolazioni in oggetto al 30 giugno 2022, termine finale di operatività del Temporary Framework.
Di conseguenza, i benefici in oggetto potranno trovare applicazione anche in riferimento agli eventi incentivati (assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato di rapporti a termine di giovani under 36 o di donne svantaggiate) che si verificheranno “nel periodo ricompreso tra il 1° gennaio 2022 e il 30 giugno 2022”.
QUANTO AL QUESITO
L’esonero in oggetto è riconosciuto a tutti i datori di lavoro privati per le nuove assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato, effettuate nel biennio 2021-2022, di soggetti che, alla data dell’evento incentivato, non abbiano compiuto il trentaseiesimo anno di età e non siano stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro nel corso dell’intera vita lavorativa (Il limite di età di trentasei anni compiuti si intende rispettato qualora il lavoratore, alla data dell’assunzione o trasformazione, abbia un’età inferiore o uguale a trentacinque anni e 364 giorni).
L’incentivo è pari, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, all’esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui.
La soglia massima di esonero della contribuzione datoriale riferita al periodo di paga mensile è, pertanto, pari a 500 euro (€ 6.000/12) e, per rapporti di lavoro instaurati e risolti nel corso del mese, detta soglia va riproporzionata assumendo a riferimento la misura di 16,12 euro (€ 500/31) per ogni giorno di fruizione dell’esonero contributivo.
Nelle ipotesi di rapporti di lavoro a tempo parziale, il massimale dell’agevolazione deve essere proporzionalmente ridotto.
Alla luce di quanto sopra descritto, a parere di chi scrive, si ritiene che il limite massimo dell’esonero dovrebbe essere rapportato alla percentuale del rapporto part time originale.
Centro Studi Associazione Nazionale Consulenti del Lavoro
N.B. il parere sopra riportato è fornito nell’esclusivo interesse dell’associato e, pertanto, non è opponibile ai terzi.
La risposta fornita, in ogni caso, non rappresenta una consulenza professionale. L’associato può scegliere di seguire i consigli contenuti nel parere nella piena autonomia professionale.
BACHECA

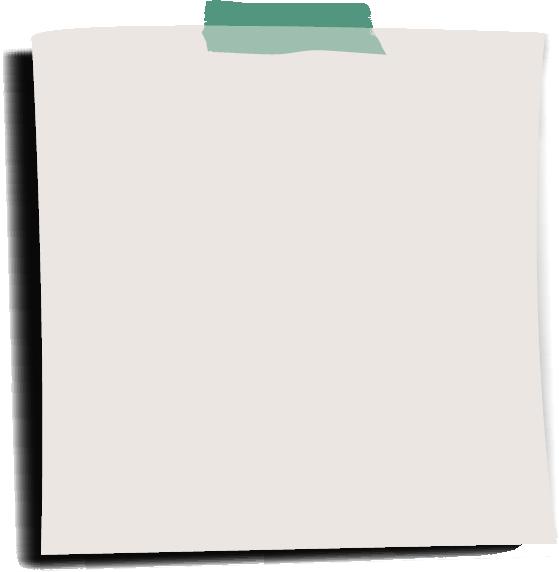
DISPONIBILI LE PRIME PUNTATE DEL PODCAST ANCL
Attrattività e retention delle imprese con Dario Montanaro
Donne e lavoro con Francesca Bravi
Autotrasporto e disciplina del rapporto di lavoro con Giovanni Cruciani
Salute e sicurezza sul lavoro nell’era della digitalizzazione con Barbara Garbelli

1° ANNIVERSARIO DALLA COSTITUZIONE DELLA SCUOLA DI RELAZIONI INDUSTRIALI DELL’ANCL, ASRI
“Il luogo di lavoro a geometria variabile: tra spazi fisici e virtuali” Seminario di studi ASRI all’Università Tor Vergata - ASRI
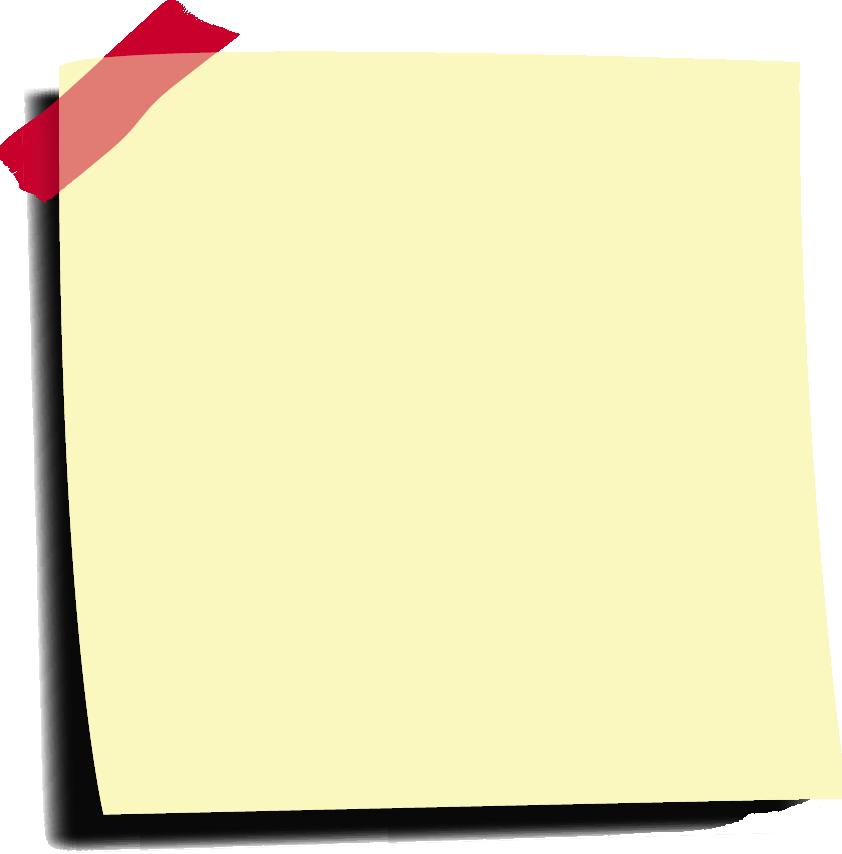
I RECENTI
“TEMI DEL MESE”ANCL
Gennaio 2025
Il contratto d’appalto
Febbraio 2025
Il lavoro nello spettacolo
Marzo 2025
Il lavoro nell’impresa familiare
Aprile 2025
Il lavoro stagionale
DIRIGENTI E SEDI
CONSIGLIO NAZIONALE
Consiglieri di estrazione congressuale
Alagna Barbara, Balloch Luca, Barella Omar, Battistella Elisabetta, Bernardo Mario, Bertagnin Alessio, Besio Giovanni, Biscarini Paolo, Bonati Luca, Borghi Annalisa, Bortot Lara, Bravi Francesca, Buda Cristian, Burali Bianca Maria, Camassa Stefano, Campo Pietro, Cannati Maria, Cappa Giuseppe, Casieri Graziana, Chini Luca, Cillino Andrea, Ciriello Filomena, Colaianni Annalisa, Colaone Daniele, Colucci Gennaro, Comi
Raffaele, Costanzo Massimiliano, Crimi Stella, Cugini Cristina, De Santis Rita Amelia, Della Rosa Laura, Donati Francesca, Flagella Marco, Frati Furio Faimo, Fratini Matteo, Furlan Debora, Gatto Maria Elisena, Izzo
Alfonso, Laiolo Massimo, Lamberti Zanardi Alessandra, Maffiotti Manuela, Maltese Leonardo, Manca Fabrizio, Manzati Silvia, Marchioni Paola, Marziali Elisabetta, Nalini
Augusto, Pascazio Leonardo, Pellicci Stefano, Peterlini Antonella, Raffin Anna, Ricciardi Gaetano, Sandiano Secondo, Sante Pierpaolo, Solomita Fabrizio, Spalletti Antonella, Stella Antonio, Tessenda Maurizio, Trettaccone
Nora, Tura Francesco, Vannicola Enrico, Venanzi Sergio, Zambon Enio.
EX PRESIDENTI
ED EX SEGRETARI GENERALI Consiglieri nazionali di diritto
De Lorenzis Roberto, Innocenti Giuseppe, Longobardi Francesco, Perini Gabriella.
PRESIDENTI CONSIGLI REGIONALI ANCL
Scarpone Lucia (Abruzzo), Scarfone Beniamino (Calabria), Damiani Stefania (Campania), Piscaglia Luca (Emilia Romagna), Gerin Elena (Friuli Venezia Giulia), Alonzi Rocco (Lazio), Schenone Luigi (Liguria), Fortuna Andrea (Lombardia), Romanelli Giuseppina (Marche), Bongiovanni Gian Luca (Piemonte), Solomita Fabrizio (Puglia), Giorgi Annalisa (Sardegna), Patinella Gaspare (Sicilia), Azzini Alberto (Toscana), Cruciani Giovanni (Umbria), Degan Marco (Veneto), Fratini Matteo (Aosta), Colaone Manuel (Bolzano), Paoli Fabiano (Trento).
EDITORE
ASSOCIAZIONE NAZIONALE
CONSULENTI DEL LAVORO
Via Cristoforo Colombo, 456 sc. B 10° piano - 00145 Roma
PRESIDENTE NAZIONALE E
COORDINATORE DEL CENTRO STUDI NAZIONALE
Dario Montanaro
RESPONSABILE OPERATIVO DEL CENTRO STUDI NAZIONALE
Cecilia Catalano
Registrato presso il Tribunale Civile di Roma – sezione Stampa al n. 371/2009
VISITA IL SITO E RIMANI SEMPRE AGGIORNATO su attività, approfondimenti, seminari e tanto altro

Il prossimo numero della rivista lo trovi su ancl.it/consulentemilleottantuno