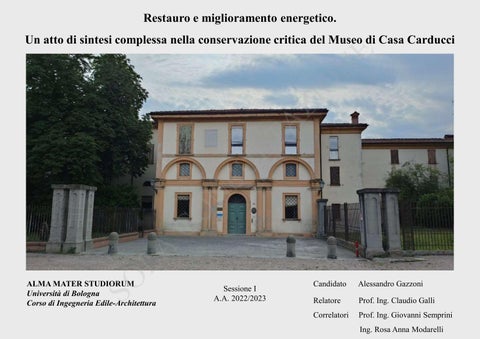Restauro e miglioramento energetico.
Un atto di sintesi complessa nella conservazione critica del Museo di Casa Carducci

ALMAMATER STUDIORUM
Università di Bologna
Corso di Ingegneria Edile-Architettura
Sessione I
A.A. 2022/2023
Relatore Prof. Ing. Claudio Galli
Correlatori Prof. Ing. Giovanni Semprini
Ing. Rosa Anna Modarelli
Candidato Alessandro GazzoniOBBIETTIVO DELLA TESI
«Il restauro si nutre del dubbio e della conseguente ricerca, richiedendo apertura mentale ed equilibrio, rigore concettuale e insieme spirito pratico. Quindi ciò che si può insegnare è, al massimo, una metodologia d'approccio a problemi che si pongono, ogni volta, in modo diverso»
Restauro e miglioramento energetico.
Un atto di sintesi complessa nella conservazione critica del Museo di Casa Carducci
quale strategia si può adottare per ottenere un equilibrio tra la conservazione del valore storico e il miglioramento energetico?
atto di sintesi complessa =
SOLACONSULTAZIONE
equilibrio tra conservazione del valore storico e implementazione con soluzioni più performanti
criterio metodologico in grado di assistere all’intervento di miglioramento energetico co m e?
Giovanni CarbonaraIL
CRITERIO METODOLOGICO
rapporto con l’esistente: coerenze e divergenze
analisi delle trasformazioni dell’opera nel corso del tempo
analisi delle trasformazioni degli impianti nel corso del tempo
ricerche storico-archivistiche e cambiamento delle esigenze passate
stato attuale (rilievi) e stato di conservazione (indagini tematiche)
analisi generale dell’impianto esistente
definizione delle esigenze odierne
evoluzione storica del bene stato di fatto del bene
1. INIZIO DEL PROCESSO DI PIANIFICAZIONE
individuazionedegli elementi soggetti a vincolo compatibilità, reversibilità e minimo intervento integrazione con il bene
implementazione all’inclusione di conoscenza del monumento
implementazione tecnologica come opportunità anche per beni storici
analisi specifica dell’impianto esistente e visita in centrale termica
individuazionedelle utenze e degli usi in ogni ambiente del complesso
abaco delle unità stratigrafiche murarie
abaco dei serramenti e dei terminali
SOLACONSULTAZIONE
definizione criterio d’intervento
3. PRECISAZIONE DEGLI
OBBIETTIVI
stratificazione secolare è indice di adattamento nel patrimonio storico
definizione benefici d’intervento
4. DECISIONE SULLA
rappresentazione dei risultati mediante programma di calcolo calcolo dell’indice di prestazione energetica
incidenza percentuale dei componenti per delineare le criticità
azioni preliminari alla diagnosi interpretazioni dei risultati
2. RILIEVO E VALUTAZIONE DELL’EDIFICIO
matrice di reversibilità misure differenziate in funzione dell’uso della zona
collocazione spaziale dei nuovi componenti/elementi da installare vantaggi/svantaggi possibili soluzioni per un restauro energetico valutazioni delle possibilità
5. VALUTAZIONE E SCELTA
DELLE MISURE
confronto indici di prestazione energetica iniziale e finale
analisi e comparazioni dei risultati e incidenza dei componenti
valutazione dell’intervento
6. DECISIONE
IL
CRITERIO METODOLOGICO
rapporto con l’esistente: coerenze e divergenze
analisi delle trasformazioni dell’opera nel corso del tempo
analisi delle trasformazioni degli impianti nel corso del tempo
ricerche storico-archivistiche e cambiamento delle esigenze passate
stato attuale (rilievi) e stato di conservazione (indagini tematiche)
analisi generale dell’impianto esistente
definizione delle esigenze odierne
evoluzione storica del bene stato di fatto del bene
1. INIZIO DEL PROCESSO DI PIANIFICAZIONE
individuazionedegli elementi soggetti a vincolo compatibilità, reversibilità e minimo intervento integrazione con il bene
implementazione all’inclusione di conoscenza del monumento
implementazione tecnologica come opportunità anche per beni storici
analisi specifica dell’impianto esistente e visita in centrale termica
individuazionedelle utenze e degli usi in ogni ambiente del complesso
abaco delle unità stratigrafiche murarie
abaco dei serramenti e dei terminali
SOLACONSULTAZIONE
definizione criterio d’intervento
3. PRECISAZIONE DEGLI
OBBIETTIVI
stratificazione secolare è indice di adattamento nel patrimonio storico
definizione benefici d’intervento
4. DECISIONE SULLA NECESSITÀ
DEL MIGLIORAMENTO
rappresentazione dei risultati mediante programma di calcolo calcolo dell’indice di prestazione energetica
incidenza percentuale dei componenti per delineare le criticità
azioni preliminari alla diagnosi interpretazioni dei risultati
2. RILIEVO E VALUTAZIONE DELL’EDIFICIO
matrice di reversibilità misure differenziate in funzione dell’uso della zona
collocazione spaziale dei nuovi componenti/elementi da installare vantaggi/svantaggi possibili soluzioni per un restauro energetico valutazioni delle possibilità
5. VALUTAZIONE E SCELTA
DELLE MISURE
confronto indici di prestazione energetica iniziale e finale
analisi e comparazioni dei risultati e incidenza dei componenti
valutazione dell’intervento
6. DECISIONE
IL
CRITERIO METODOLOGICO
rapporto con l’esistente: coerenze e divergenze
analisi delle trasformazioni dell’opera nel corso del tempo stato attuale (rilievi) e stato di conservazione (indagini tematiche)
analisi delle trasformazioni degli impianti nel corso del tempo
ricerche storico-archivistiche e cambiamento delle esigenze passate
analisi generale dell’impianto esistente
definizione delle esigenze odierne
evoluzione storica del bene stato di fatto del bene
1. INIZIO DEL PROCESSO DI PIANIFICAZIONE
individuazionedegli elementi soggetti a vincolo compatibilità, reversibilità e minimo intervento integrazione con il bene
implementazione all’inclusione di conoscenza del monumento
implementazione tecnologica come opportunità anche per beni storici
analisi specifica dell’impianto esistente e visita in centrale termica
individuazionedelle utenze e degli usi in ogni ambiente del complesso
abaco delle unità stratigrafiche murarie
abaco dei serramenti e dei terminali
SOLACONSULTAZIONE
definizione criterio d’intervento
3. PRECISAZIONE DEGLI
OBBIETTIVI
stratificazione secolare è indice di adattamento nel patrimonio storico
definizione benefici d’intervento
4. DECISIONE SULLA NECESSITÀ
DEL MIGLIORAMENTO
rappresentazione dei risultati mediante programma di calcolo calcolo dell’indice di prestazione energetica
incidenza percentuale dei componenti per delineare le criticità
azioni preliminari alla diagnosi interpretazioni dei risultati
2. RILIEVO E VALUTAZIONE DELL’EDIFICIO
matrice di reversibilità misure differenziate in funzione dell’uso della zona
collocazione spaziale dei nuovi componenti/elementi da installare vantaggi/svantaggi possibili soluzioni per un restauro energetico valutazioni delle possibilità
5. VALUTAZIONE E SCELTA
DELLE MISURE
confronto indici di prestazione energetica iniziale e finale
analisi e comparazioni dei risultati e incidenza dei componenti
valutazione dell’intervento
6. DECISIONE
IL
CRITERIO METODOLOGICO
rapporto con l’esistente: coerenze e divergenze
analisi delle trasformazioni dell’opera nel corso del tempo stato attuale (rilievi) e stato di conservazione (indagini tematiche)
analisi delle trasformazioni degli impianti nel corso del tempo
ricerche storico-archivistiche e cambiamento delle esigenze passate
analisi generale dell’impianto esistente
definizione delle esigenze odierne
evoluzione storica del bene stato di fatto del bene
1. INIZIO DEL PROCESSO DI PIANIFICAZIONE
individuazionedegli elementi soggetti a vincolo compatibilità, reversibilità e minimo intervento integrazione con il bene
implementazione all’inclusione di conoscenza del monumento
implementazione tecnologica come opportunità anche per beni storici
analisi specifica dell’impianto esistente e visita in centrale termica
individuazionedelle utenze e degli usi in ogni ambiente del complesso
abaco delle unità stratigrafiche murarie
abaco dei serramenti e dei terminali
SOLACONSULTAZIONE
definizione criterio d’intervento
3. PRECISAZIONE DEGLI
OBBIETTIVI
stratificazione secolare è indice di adattamento nel patrimonio storico
definizione benefici d’intervento
4. DECISIONE SULLA NECESSITÀ
rappresentazione dei risultati mediante programma di calcolo calcolo dell’indice di prestazione energetica
incidenza percentuale dei componenti per delineare le criticità
azioni preliminari alla diagnosi interpretazioni dei risultati
2.
RILIEVO E VALUTAZIONE DELL’EDIFICIO
matrice di reversibilità misure differenziate in funzione dell’uso della zona
collocazione spaziale dei nuovi componenti/elementi da installare vantaggi/svantaggi possibili soluzioni per un restauro energetico valutazioni delle possibilità
5. VALUTAZIONE E SCELTA
DELLE MISURE
confronto indici di prestazione energetica iniziale e finale
analisi e comparazioni dei risultati e incidenza dei componenti
valutazione dell’intervento
6. DECISIONE
SOLACONSULTAZIONE
RICERCA STORICA E RILIEVI
SOLACONSULTAZIONE
la Chiesa di Santa Maria della Pietà detta del Piombo
il Museo del Risorgimento e Casa Carducci
le trasformazioni e il rapporto con l’esistente
i rilievi e le indagini tematiche
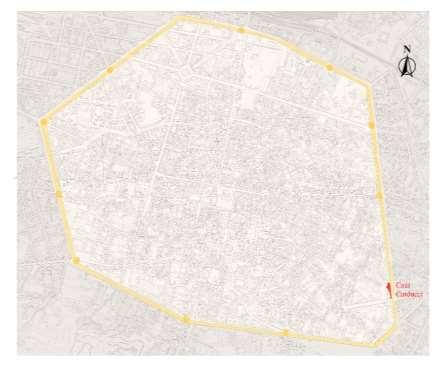

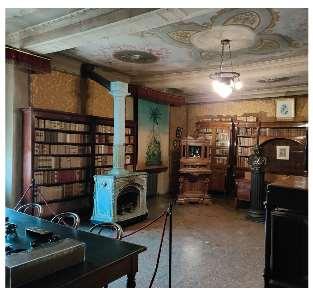
SOLACONSULTAZIONE

SOLACONSULTAZIONE
Il Museo di Casa Carducci era, originariamente, una delle dodici chiese costruite sulle mura: Santa Maria della Pietà Le dodici sono correlate da un unico progetto anche se la loro datazione di estende in quattro secoli
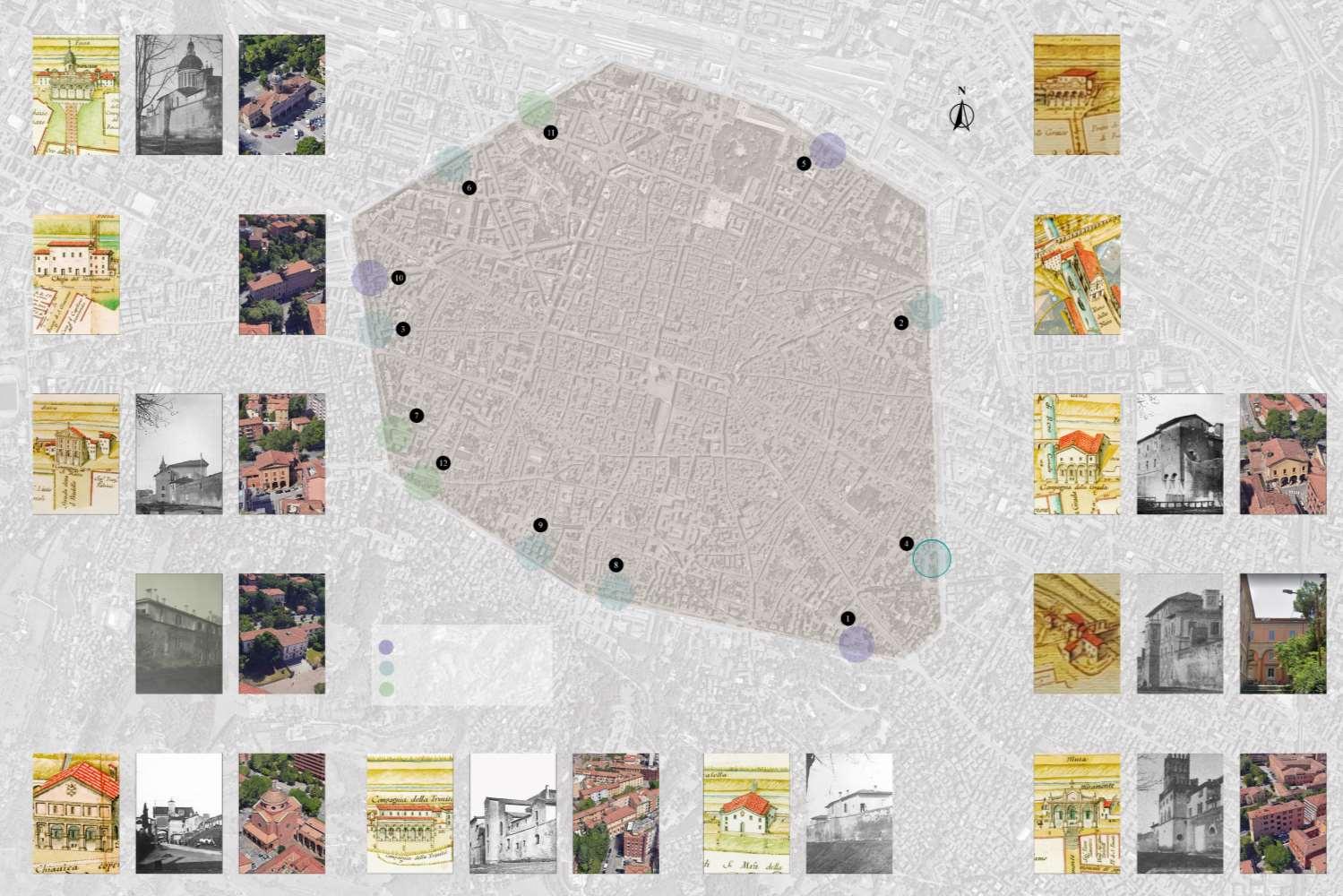
LEGENDA
SANTUARIO
DIFFERENTE DESTINAZIONE D USO
DEMOLITA
PIANTA PIANO TERRA
SOLACONSULTAZIONE
PIANTA PIANO SECONDO
camera di Elvira sala da pranzo
camera di Giosuè
corridoio stanza da lavoro
Museo del Risorgimento aula espositiva
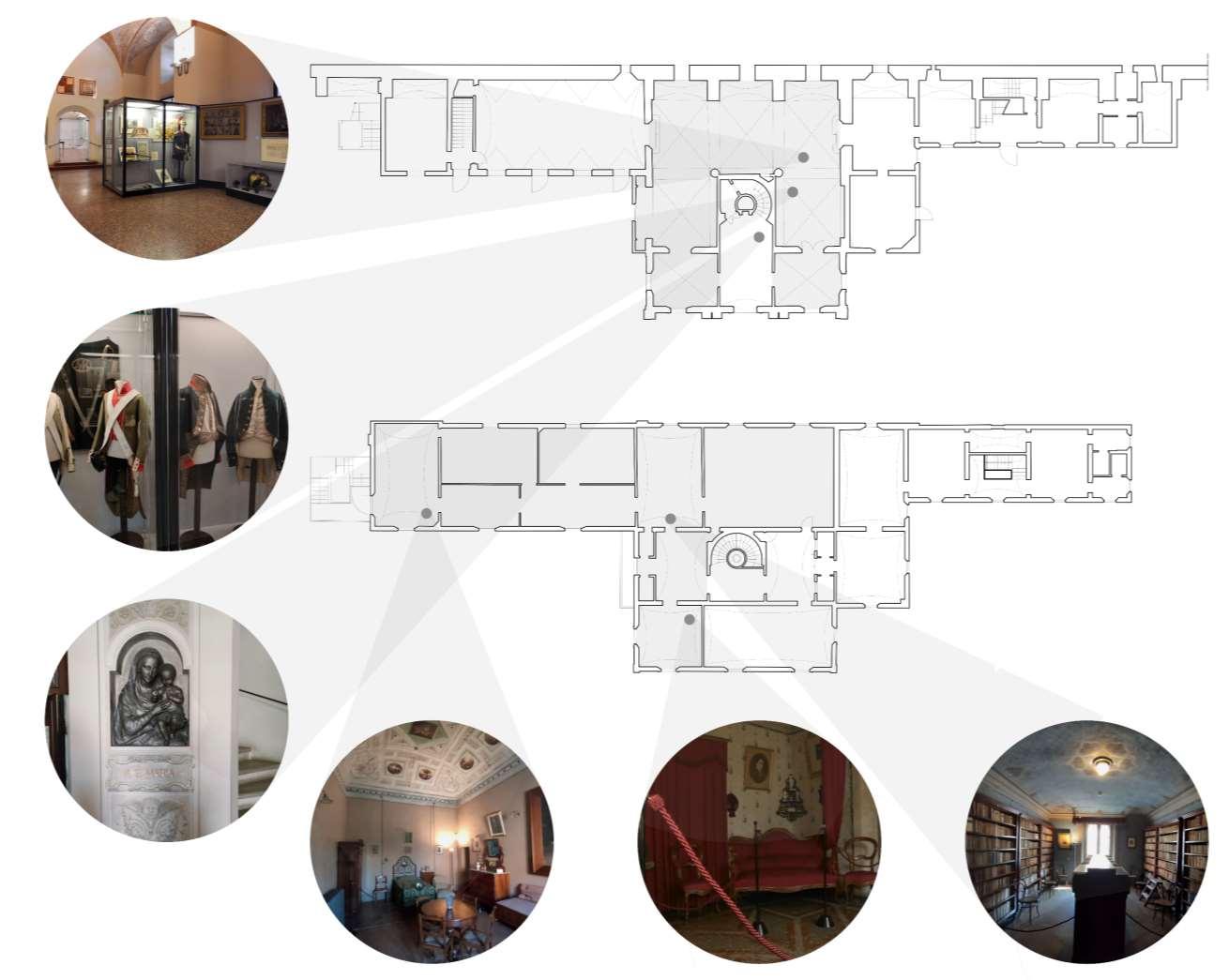
atrio ingresso
spazi al servizio dei visitatori del
Civico
biblioteca
ingresso studio di Giosuè
salotto buono
1 1502: prima costruzione e inizio del culto 2 1550 c.a.: costruzione oratorio e campanile 3 1598: costruzione del portico
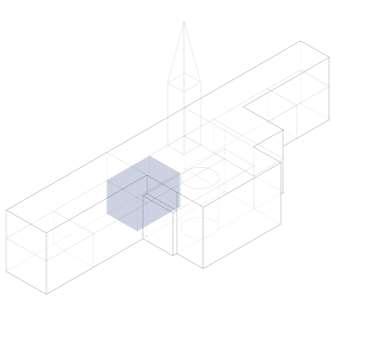
1611: avanzamento del portico
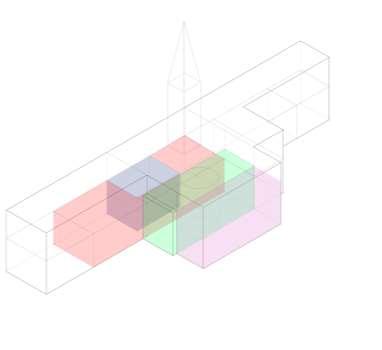

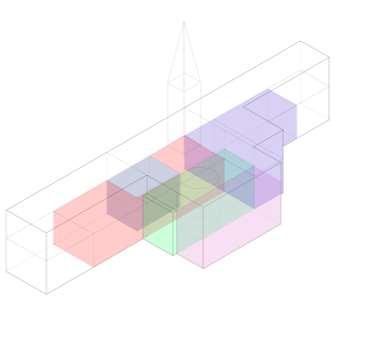
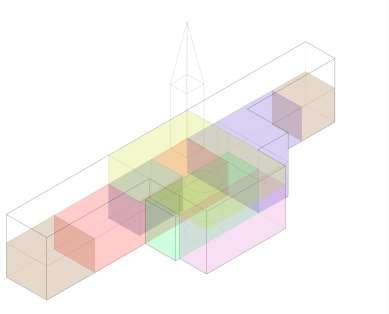
SOLACONSULTAZIONE
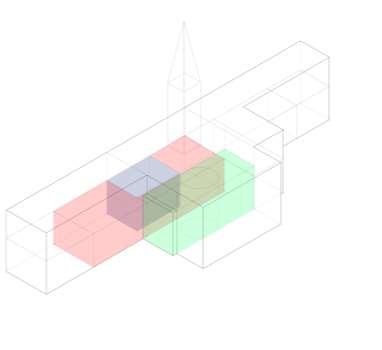
5 1612: costruzione della sagrestia 6 1712-1798:ampliamenti dopo l’incendio 7 1814: elevazione della parte centrale
8 1822: elevazione delle ali laterali 9 1871: costruzione della scala a chiocciola
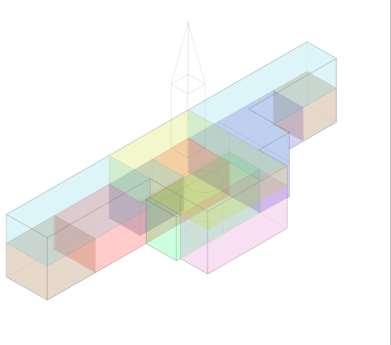
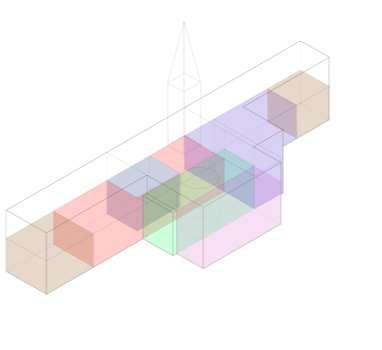
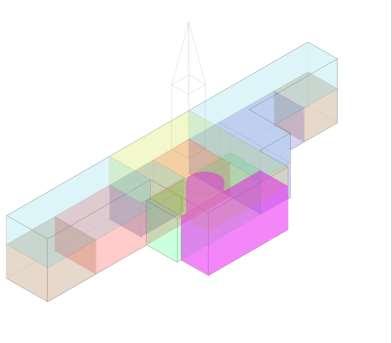
PIANTA PIANO INTERRATO
SOLACONSULTAZIONE
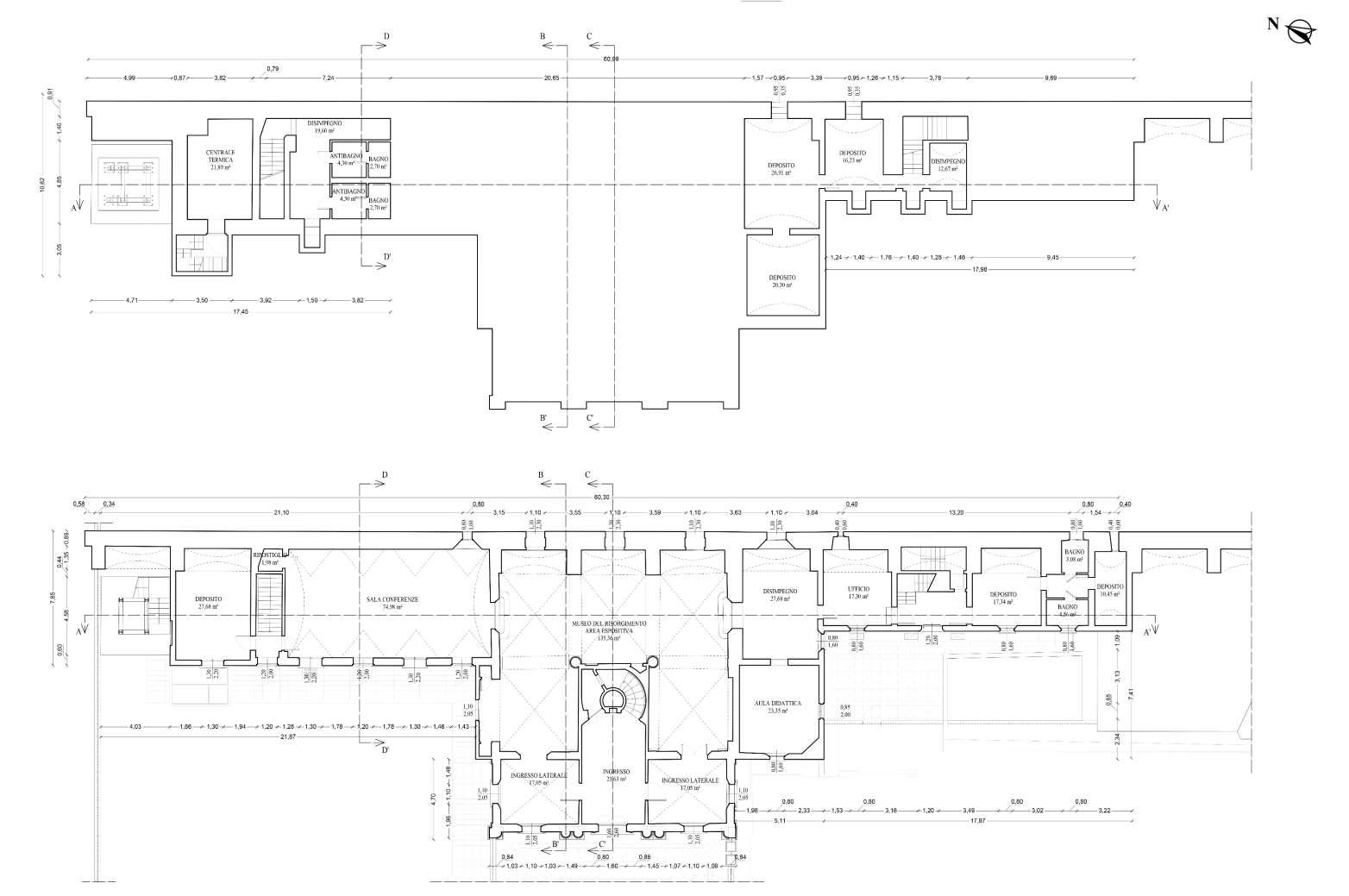
PIANTA PIANO PRIMO
SOLACONSULTAZIONE
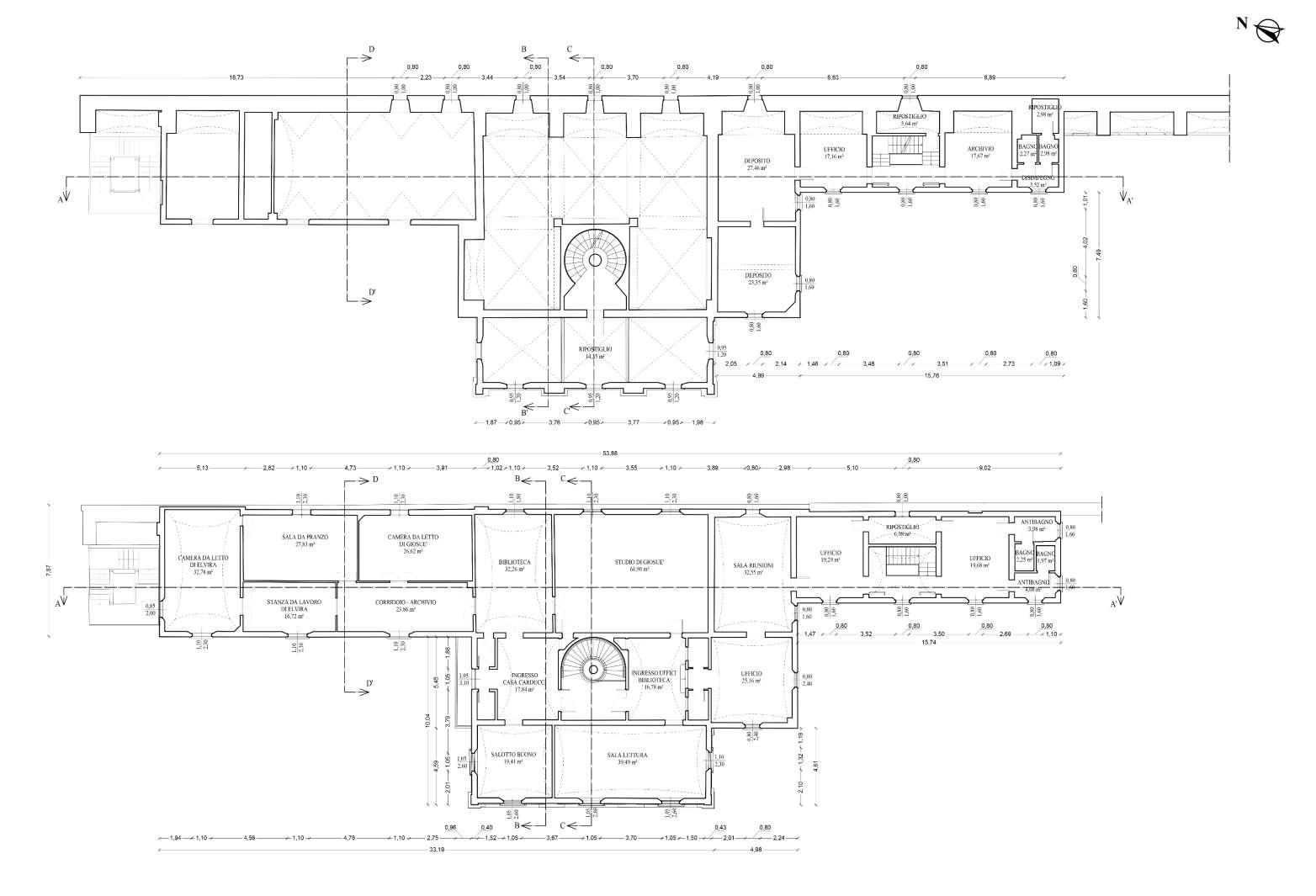
PROSPETTO OVEST
PROSPETTO EST
SOLACONSULTAZIONE
copertura in legno con coppi in cotto
finitura esterna intonacata bianca
finitura apertura intonacata gialla
lastra memoriale in marmo
muratura in mattoni con tecnica a sacco

capitelli e basamenti colonne in arenaria

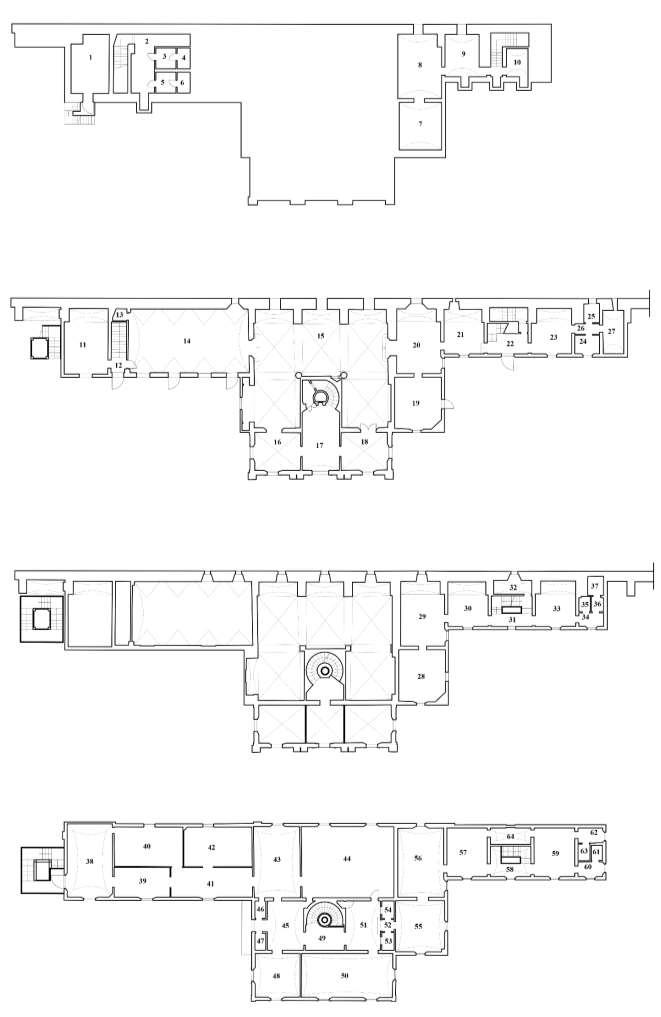
SOLACONSULTAZIONE
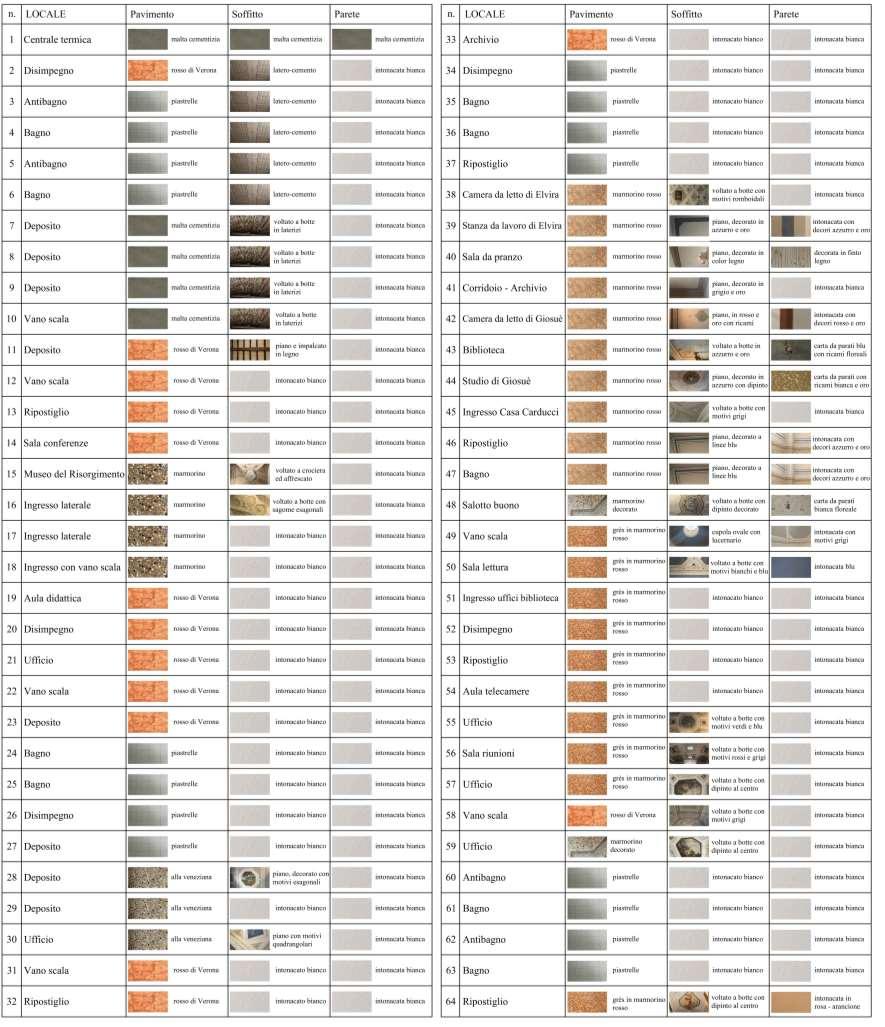
sala da pranzo
camera da letto di Giosuè camera da letto di Elvira
stanza da lavoro di Elvira
corridoio - archivio
biblioteca
ingresso
salotto buono
studio di Giosuè
SOLACONSULTAZIONE
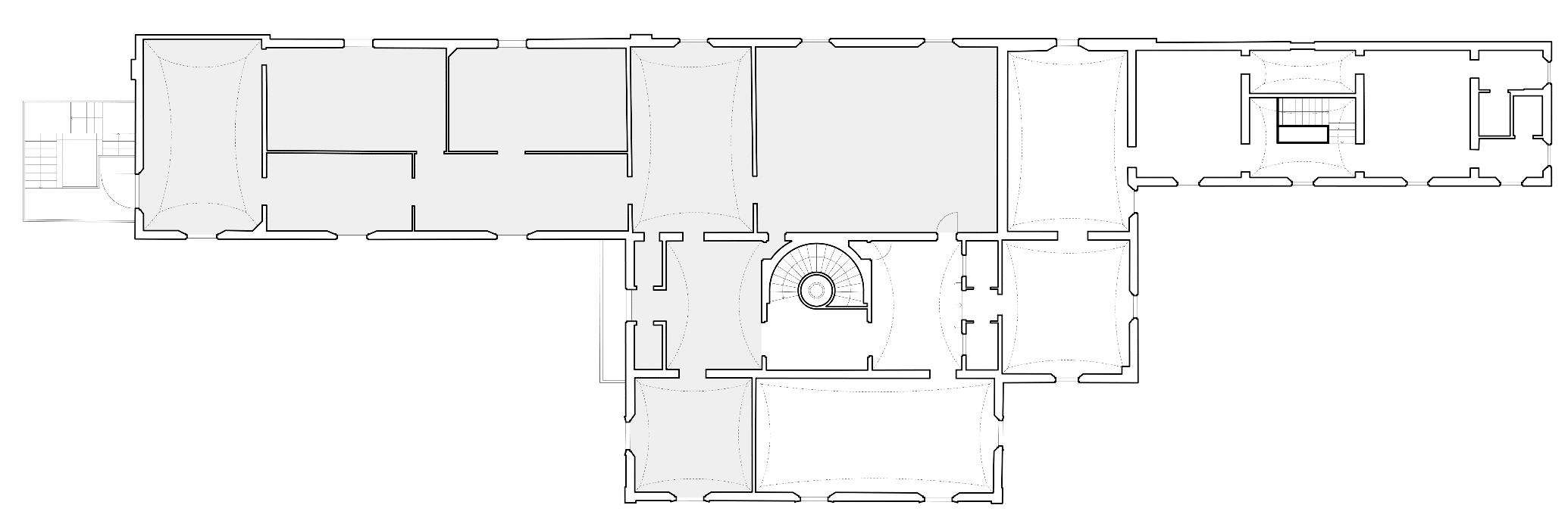
PAVIMENTO SOFFITTO PARETE LOCALE
camera da letto di Elvira
stanza da lavoro di Elvira
sala da pranzo
corridoio - archivio
camera da letto di Giosuè
biblioteca
studio di Giosuè
ingresso
salotto buono

marmorino rosso
marmorino rosso
marmorino rosso
marmorino rosso
marmorino rosso
marmorino rosso
marmorino rosso
marmorino rosso
marmorino decorato
voltato a botte con motivi romboidali intonacata di bianco
piano, decorato in azzurro e oro
piano, decorato in color legno
intonacata bianca con decori azzurro e oro
carta da parati in finto legno
piano, decorato in grigio e oro intonacata di bianco
piano, decorato in rosso e oro con ricami
voltato a botte in azzurro e oro
piano, decorato in azzurro con dipinto
intonacata bianca con decori rosso e oro
carta da parati blu con ricami floreali
carta da parati con ricami bianca e oro
voltato a botte con motivi in rilievo grigi intonacata di bianco
voltato a botte con dipinto decorato
carta da parati bianca floreale
RICERCA STORICA E RILIEVI
AZIONI PRELIMINARI ALLA DIAGNOSI
DIAGNOSI ENERGETICA
SOLACONSULTAZIONE
INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO
abaco delle unità stratigrafiche murarie
abaco degli infissi
indagini in centrale termica sul generatore di calore
Sono state analizzate tutte le unità stratigrafiche presenti, differenziate in base allo spessore. Tutte le strutture sono in laterizio pieno, ad eccezione di M1, essendo eseguita con la tecnica a sacco dato che è inglobata dalla cinta muraria.
PIANTA PIANO TERRA
I paramenti sono stati poi suddivisi se: - divisori (M2, M5, M6, M7) - confinanti con l’esterno (M1, M3, M4)
LEGENDA:
M1: sp. 92 cm
M2: sp. 85 cm
M3: sp. 46 cm
M4: sp. 33 cm
M5: sp. 30 cm
M6: sp. 20 cm
M7: sp. 10 cm
SOLACONSULTAZIONE

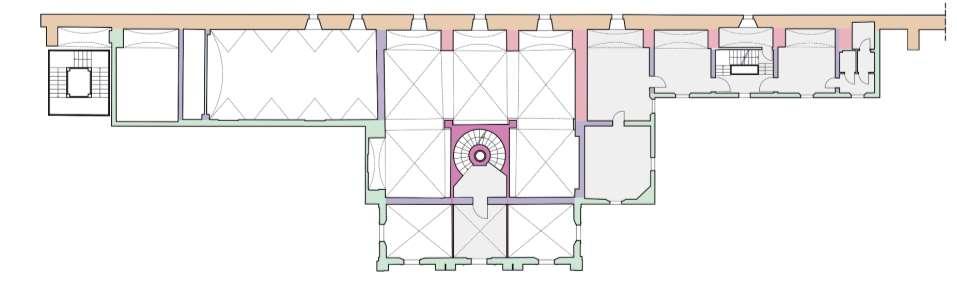


PIANTA PIANO INTERRATO
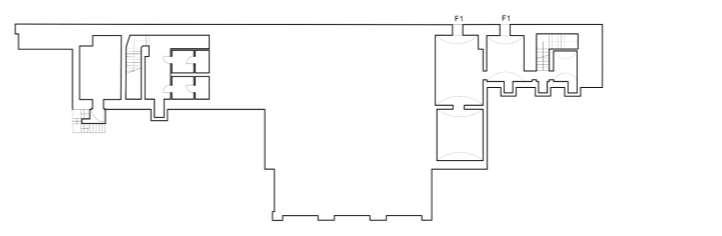
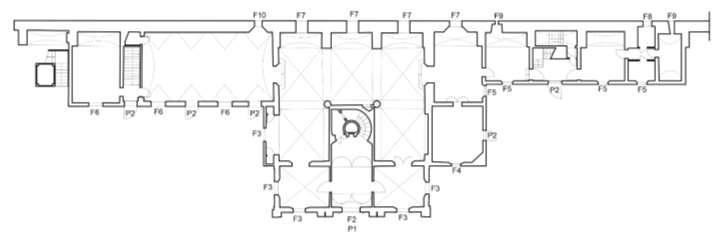
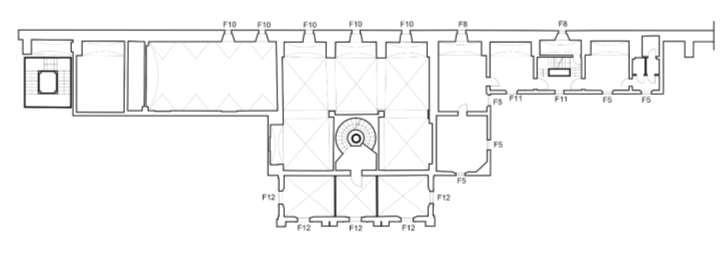
SOLACONSULTAZIONE
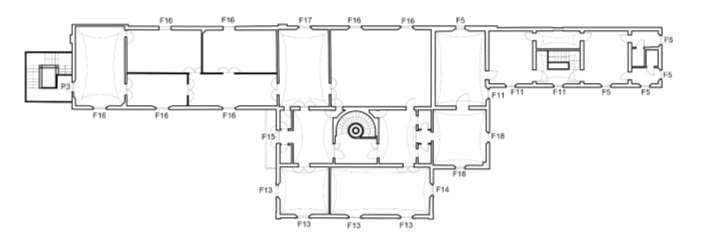
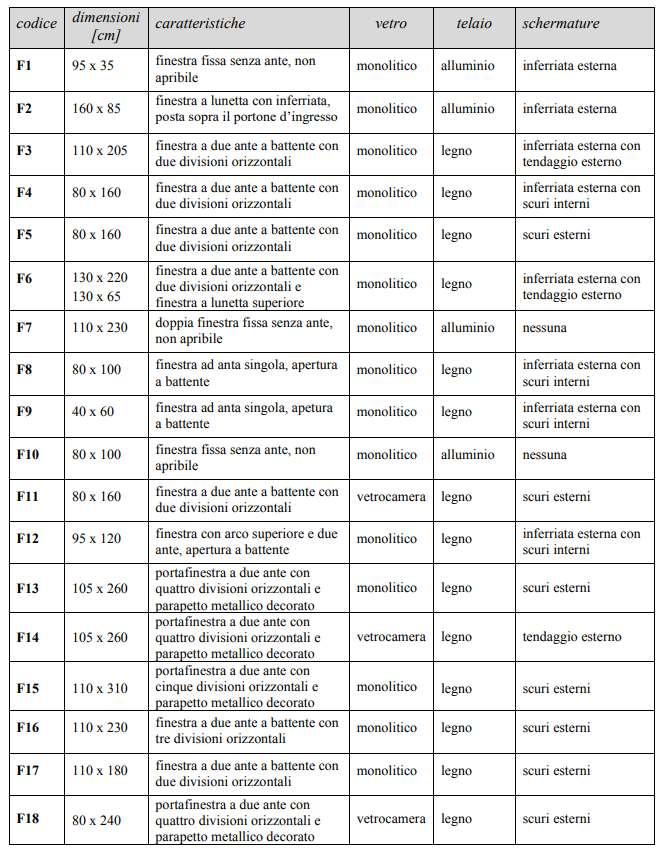
PIANTA PIANO INTERRATO
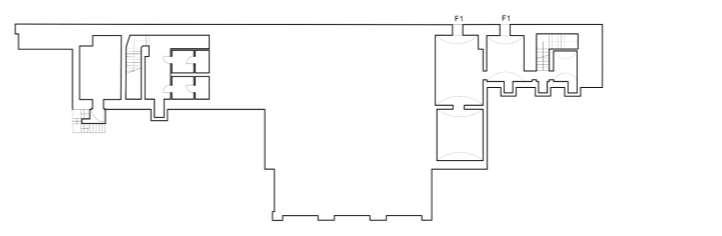
PIANTA PIANO TERRA
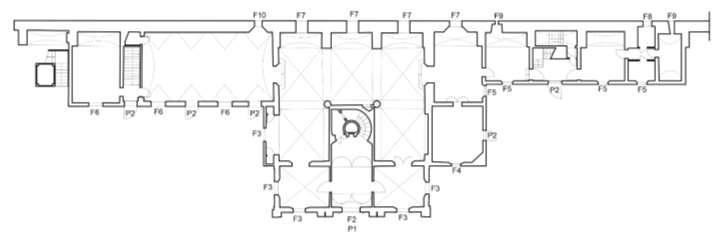
PIANTA PIANO PRIMO
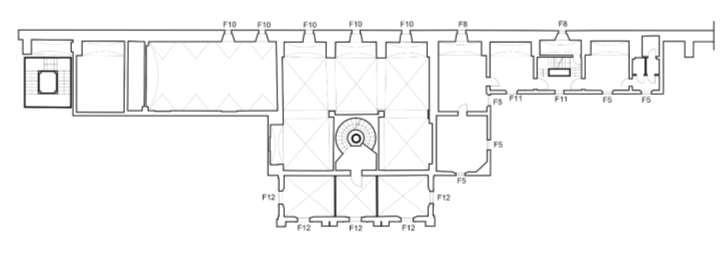
PIANTA PIANO SECONDO
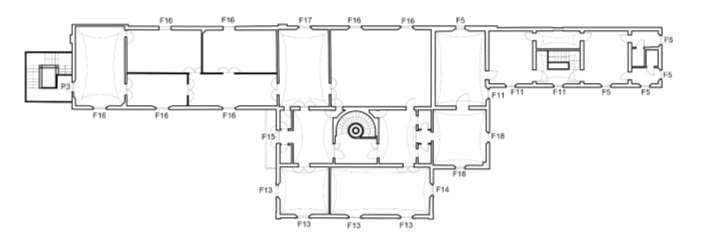
Analogamente, dopo l’analisi
degli infissi, sono state calcolate le trasmittanze UW
ABACO DEGLI INFISSI
SOLACONSULTAZIONE
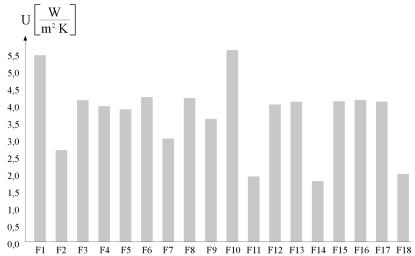

RICERCA STORICA E RILIEVI
SOLACONSULTAZIONE
inserimento delle componenti dell’involucro nel programma di calcolo
calcolo delle potenze e delle perdite energetiche
incidenza dei componenti
analisi dei risultati uscenti dal calcolo
strategia di progetto in funzione dei risultati
PIANTA PIANO INTERRATO
LOCALI CLIMATIZZATI
LOCALI NON CLIMATIZZATI
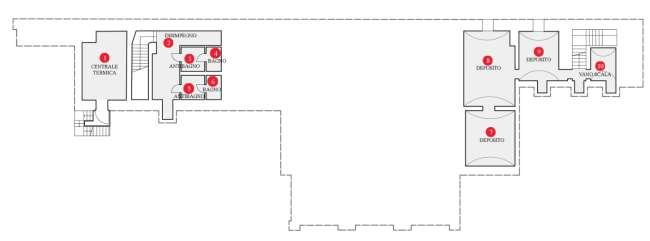
PIANTA PIANO TERRA
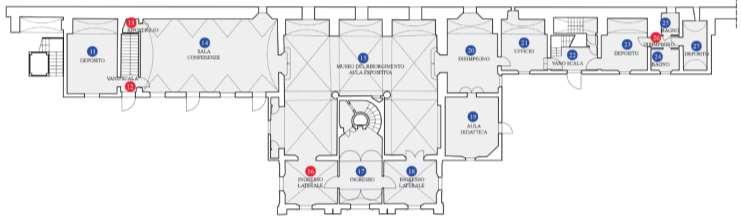
PIANTA PIANO PRIMO
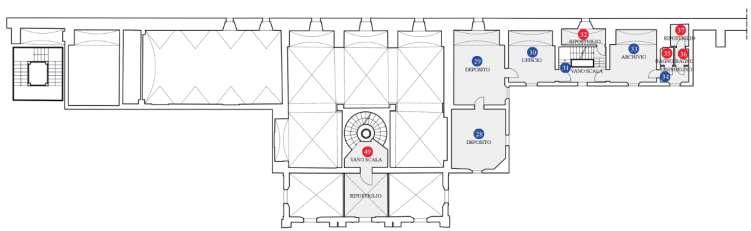
SOLACONSULTAZIONE
PIANTA PIANO SECONDO
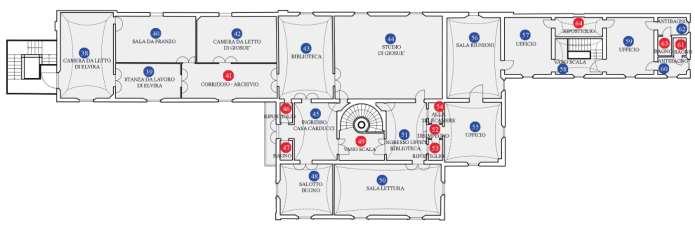
carico termico invernale
Pd = Pt + Pv + Pr = (Ht + Hve + Hr) ·ΔT [W]
Ht, Hve, Hr = coefficienti di dispersione termica [W/K]
Pd: potenza termica totale di progetto (ΦHL);
Pt: potenza termica per trasmissione (ΦTR);
Pv: potenza termica per ventilazione (ΦVE);
Pr: potenza termica di ripresa (ΦRH).
dispersioni per trasmissione: Pt
Pt = Ht · (Ti - Te
dispersioni per ventilazione: Pv
Pv = Hv · (Ti - Te) = 0,34 · n · V · (Ti - Te) [W]
dispersioni per intermittenza del locale: Pr
Pr = fr ·Ap [W]
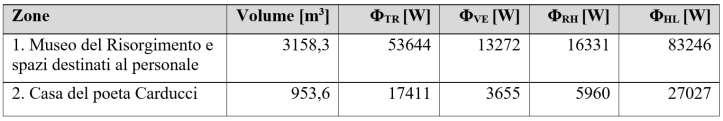
dispersioni per trasmissione (ΦTR), ventilazione (ΦVE), intermittenza (ΦRH) e totali (ΦHL) di ogni zona: Museo del Risorgimento e spazi destinati al personale (1) e Casa del poeta Carducci (2)
STRUTTURE VERTICALI
unitàstratigrafica M1
unitàstratigrafica M3
unitàstratigraficaM4
STRUTTURE ORIZZONTALI pavimentopiano interrato
pavimentopiano terra copertura
INFISSI finestre
porte esterne
PONTI
TERMICI
SOLACONSULTAZIONE
tabella dei risultati delle perdite energetica per trasmissione ed extraflusso di Casa Carducci, con l’identificazione della classe energetica
W: parete - telaio
GF: parete - solaio controterra e
IF: parete - solaio interpiano
R: parete - copertura
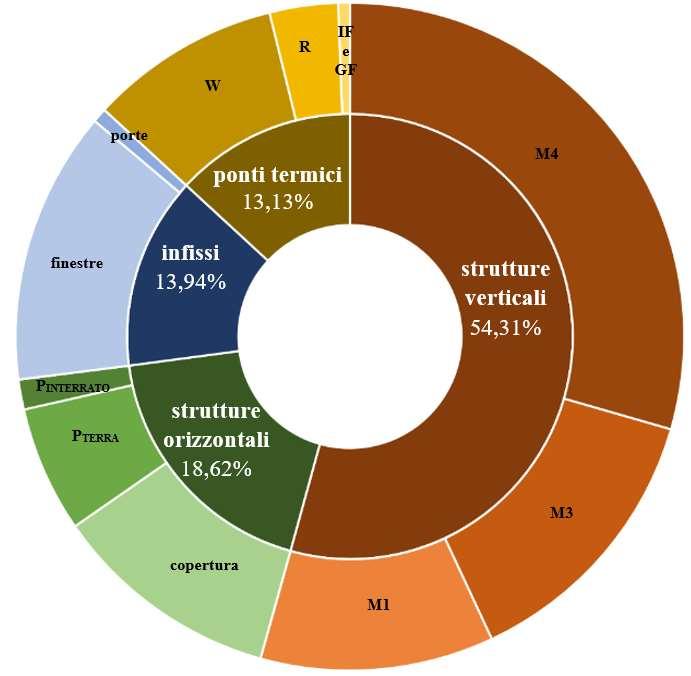
QH, tr + QH, r

tabella dei risultati delle perdite energetica per trasmissione ed extraflusso di ogni componente con la relativa incidenza sul valore totale
QH, tr: scambio di energia termica per trasmissione
perdite di calore attraverso le superfici dell’edificio che avvengono per conduzione termica, a causa della differenza di temperatura esterno-interno
QH, r: scambio di energia termica per extraflusso
perdite di calore associate alle infiltrazioni d’aria non controllate, causando un flusso indesiderato di aria che porta a dispersioni di calore
Il diagramma a torta radiale sull'incidenza dei componenti delle perdite energetiche rivela informazioni cruciali per identificare le aree critiche in cui intervenire. L'analisi evidenzia che più della metà delle perdite energetiche sono attribuibili alle pareti, ma anche gli infissi e la copertura svolgono un ruolo significativo nell'inefficienza di Casa Carducci.
RICERCA STORICA E RILIEVI
AZIONI PRELIMINARI ALLA DIAGNOSI
DIAGNOSI ENERGETICA
SOLACONSULTAZIONE
il quadro delle possibilità: la matrice di reversibilità
isolamento della copertura
isolamento interno nella zona riservata agli addetti ai lavori
il rinnovamento infissi: sostituzione completa e del solo vetro
ventilazione meccanica controllata decentralizzata
VALUTAZIONE DELL’INTERVENTO
PIANTA PIANO INTERRATO
SOLACONSULTAZIONE
interventi proposti:
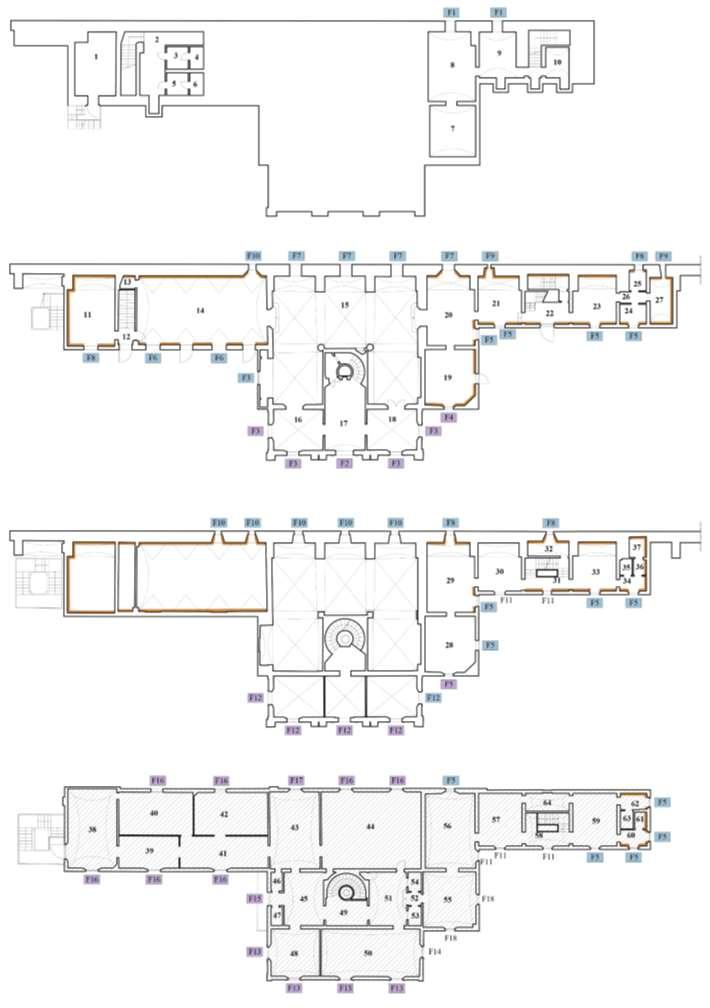
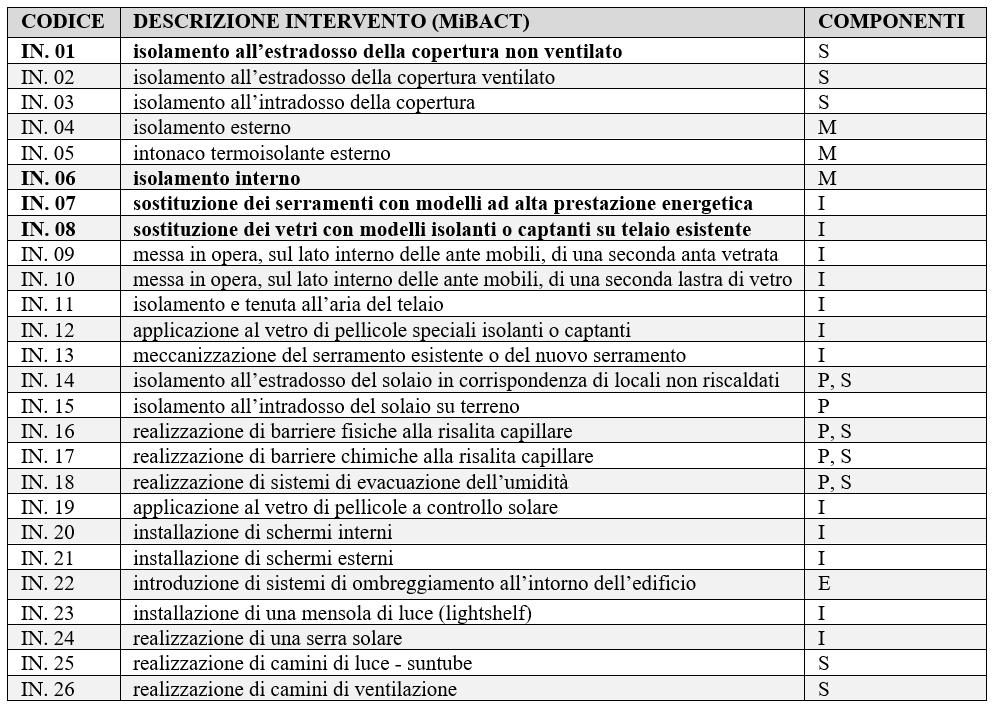




PIANTA PIANO INTERRATO

INTERVENTI PROPOSTI:
PIANTA PIANO TERRA
PIANTA PIANO PRIMO
SOLACONSULTAZIONE
PIANTA PIANO SECONDO
IN.01: isolamento all’estradosso della copertura non ventilato
l’intervento pone la propria praticità, mediante la conservazione dei coppi esistenti, nell’applicazione di un nuovo isolante ed una nuova guaina
IN.06: isolamento interno
è possibile, non in tutti i locali, migliorare le caratteristiche legate alla trasmittanza con un isolamento interno mediante pannelli sottovuoto a spessore ridotto
IN.07: sostituzione completa dei serramenti
applicato negli infissi degradati, in quelli che non si affacciano sul prospetto principale e agli infissi in alluminio che non rispecchiano la storia dell’edificio
IN.08: sostituzione del solo vetro su telaio esistente
applicato negli infissi non deteriorati e gli infissi che si affacciano sul prospetto principale

Legenda degli interventi:
applicabile
applicabile parzialmente o con cognizione non applicabile
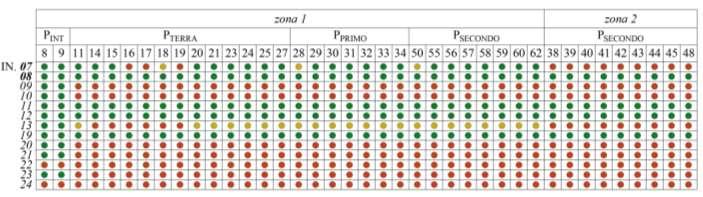
IN.01: ISOLAMENTO DELLA COPERTURA
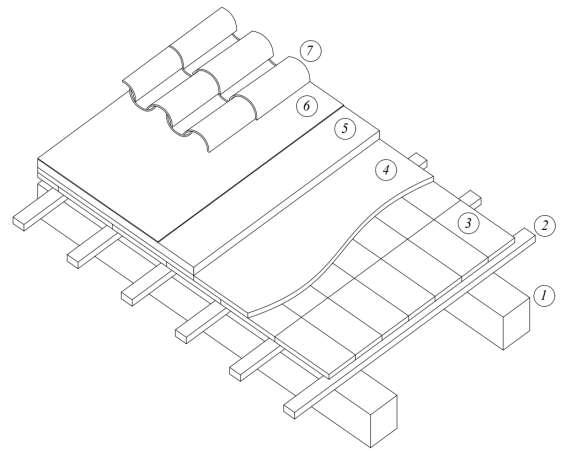 LEGENDA COPERTURA ESISTENTE:
LEGENDA COPERTURA ESISTENTE:
1. orditura principale, travi 20x20 cm
2. orditura secondaria, travetti 4x8 cm
3. tavelle in cotto,sp. 3 cm
4. caldana, sp. 3 cm
5. isolante in lana di roccia, sp. 5 cm
6. guaina impermeabilizzante, sp. 0,2 cm
7. coppi in cotto,sp. 1 cm.
Nel 1988 i lavori di restauro hanno mostrato problemi legati all’infiltrazione della copertura. Per questo l’intervento proposto ha un duplice obbiettivo: sia di miglioramento energetico, ma altresì mira a ridurre problemi legati all’infiltrazione delle acque, che hanno portato un degrado delle volte e soffitti decorati sottostanti
Per questo è stato deciso di inserire, al di sopra della guaina esistente, un altro strato di isolante per un miglioramento della trasmittanza e una nuova guaina prima del posizionamento degli stessi coppi esistenti, in modo da non alterare l’estetica, anche dall’alto, di Casa Carducci. La verifica di Glaser è soddisfatta se la linea della tendenza del materiale di passare dalla fase condensata a evaporare non interseca quella del cambiamento di fase da liquido a vapore.
SOLACONSULTAZIONE

INTERVENTO:
1. orditura principale, travi 20x20 cm
2. orditura secondaria, travetti 4x8 cm
3. tavelle in cotto,sp. 3 cm
4. caldana, sp. 3 cm
5. isolante in lana di roccia, sp. 5 cm
6. guaina impermeabilizzante, sp. 0,2 cm
7. isolante in lana di roccia, sp. 11 cm
8. guaina impermeabilizzante, sp. 0,2 cm
9. coppi in cotto,sp. 1 cm.

verifica di condensa superficiale della stratigrafia proposta
andamento della pressione di vapore relativa andamento della pressione di saturazione
guaina impermeabilizzante
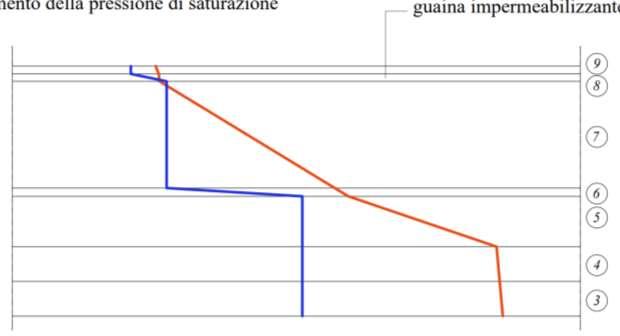
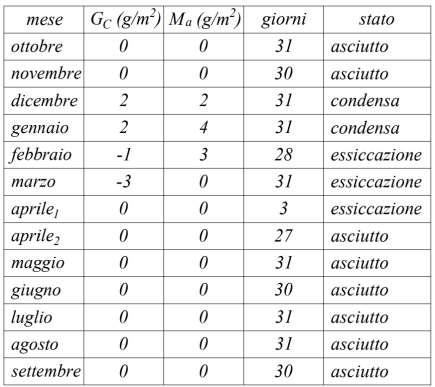
tabella mensile sulla verifica di condensa eseguita da Edilclima, secondo la UNI EN 13788
Gc: flusso di vapore condensato
Ma: quantità di condensa accumulata
IN.06: PANNELLI ISOLANTI SOTTOVUOTO
LEGENDA DEGLI ELEMENTI:
1. cavalieri, sp. 12 mm
2. montanti, sp. 15 mm
3. pannello isolante sottovuoto,sp. 15 mm
4. lastra in cartongesso, sp. 12 mm
5. rete autoadesiva, sp. 1,5 mm
6. finitura bianca, sp. 1,5 mm
spessore totale: 30 mm

SOLACONSULTAZIONE
con IN.06: isolamento interno stato attuale unità stratigrafica muraria
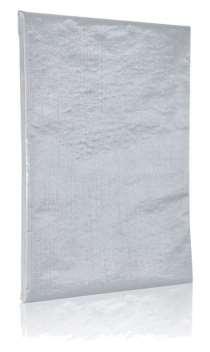
pannello isolante sottovuoto composto da un nucleo in fibra di vetro e alluminio con una conducibilità λ = 0,002 W/(m·K)
L’isolante interno è applicato nelle pareti intonacate, che si trovano principalmente nella zona 1 del complesso di Casa Carducci
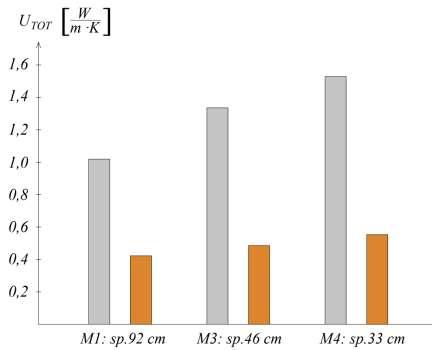
FASI DELL’INTERVENTO:


e soffitto

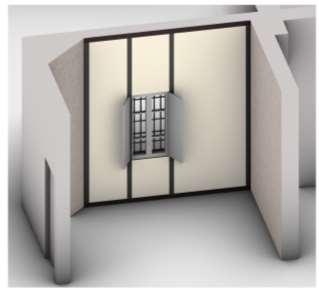
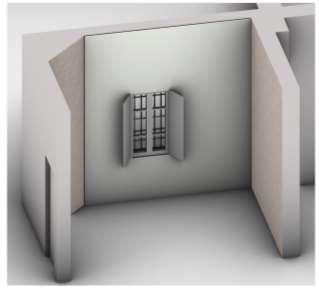

esempio di applicazione: infisso F5




SOLACONSULTAZIONE
Tutti gli infissi presentano un sistema di apertura e chiusura mediante un cardine con biforcazione che collega direttamente il telaio mobile alla spalla muraria, senza un telaio fisso. Nonostante il cardine conferisca maggiore robustezza, non è indicato per sostenere pesi eccessivamente elevati, come nel caso di un vetrocamera di dimensioni 4/16/4 mm, con gas argon. Inoltre, l’intervento è applicato alle finestre che non si affacciano sul prospetto principale, che presentano degrado o materiali non coerenti con lo stile dell'edificio


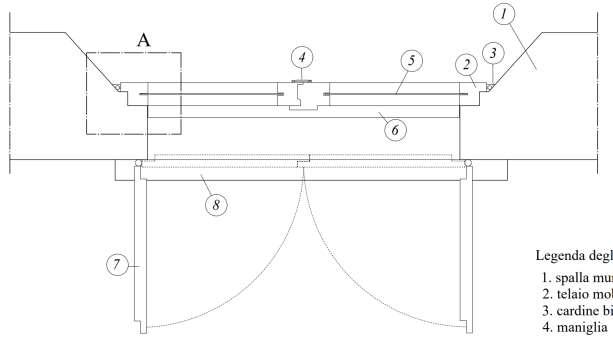
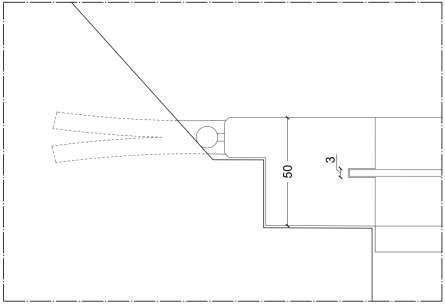
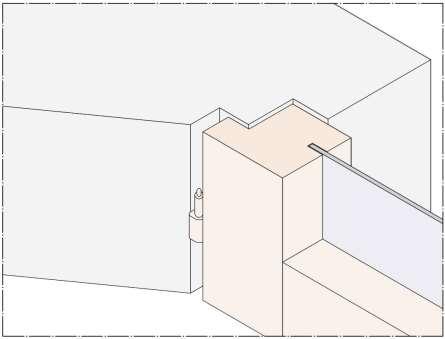
LEGENDADEGLI ELEMENTI
1. spalla muraria
2. telaio mobile
3. cardine biforcato a muro
4. maniglia
5. vetro singolo monolitico 3 mm
6. gocciolatoio
7. scuro esterno
8. bancale
9. nuovo telaio fisso
10. cerniera
11. nuovo telaio mobile
12. vetrocamera 4/16/4
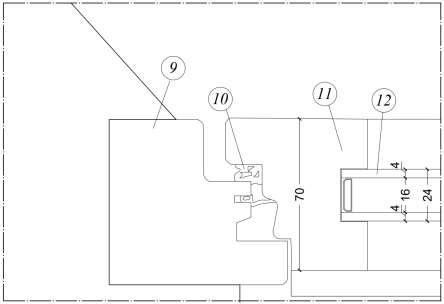
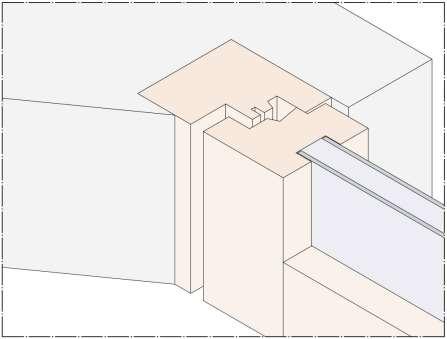
IN.08: SOSTITUZIONE DEL SOLO VETRO SU TELAIO ESISTENTE
esempio di applicazione: infisso F4


È mantenuto intatto il telaio originale, preservando così l'aspetto storico-estetico dell'elemento e rispettandone appieno il principio di compatibilità. Si propone un vetrocamera 3/9/3 mm per evitare soluzioni che potrebbero compromettere la stabilità e la resistenza del telaio, dato che un vetro più spesso comporterebbe un aumento significativo del peso e potrebbe influire negativamente sulla struttura.
SOLACONSULTAZIONE

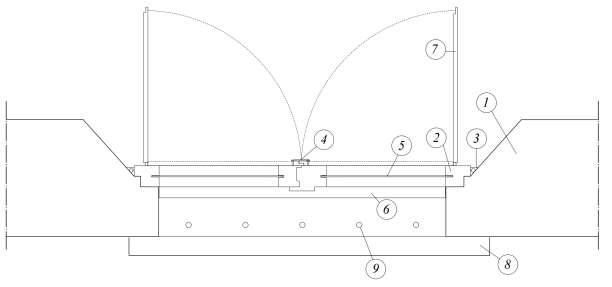
conservazione dell'integrità strutturale e dell'estetica originale
affrontare le sfide del cambiamento di peso durante la sostituzione del vetro
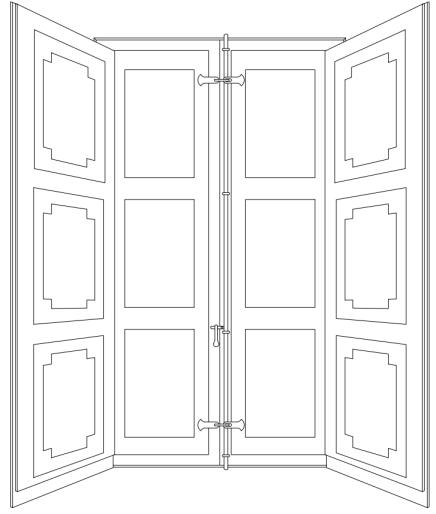
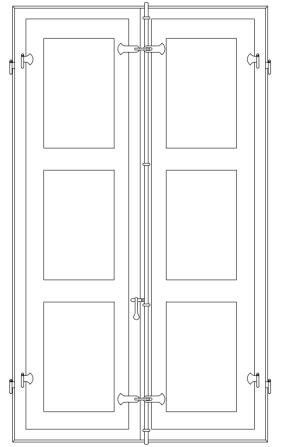
LEGENDADEGLI ELEMENTI
1. spalla muraria
2. telaio mobile
3. cardine biforcato a muro
4. maniglia
5. vetro singolo monolitico 3 mm
6. gocciolatoio
7. scuro esterno
8. bancale
9. Inferriata esterna
I) angolari di rinforzo a L in ferro
zincato
II) cavo metallico esterno
III) rinforzi obliqui collaboranti negli angoli delle ante

IN.08: SOSTITUZIONE DEL SOLO VETRO SU TELAIO ESISTENTE
esempio di applicazione: infisso F4


fotografia esterna fotografia interna con scuretto aperto
È mantenuto intatto il telaio originale, preservando così l'aspetto storico-estetico dell'elemento e rispettandone appieno il principio di compatibilità. Si propone un vetrocamera 3/9/3 mm per evitare soluzioni che potrebbero compromettere la stabilità e la resistenza del telaio, dato che un vetro più spesso comporterebbe un aumento significativo del peso e potrebbe influire negativamente sulla struttura.
proposta I: angolare di rinforzo a Lin ferro zincato
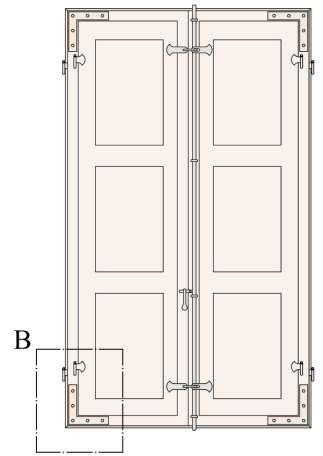
SOLACONSULTAZIONE
sezione dell’infisso F4
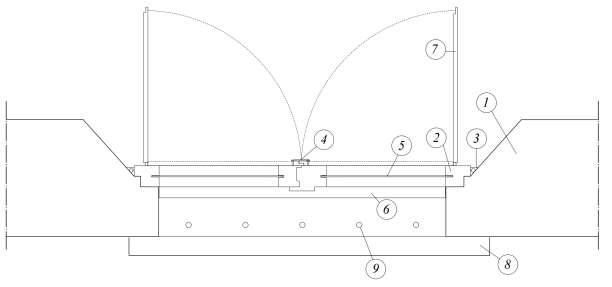
conservazione dell'integrità strutturale e dell'estetica originale
affrontare le sfide del cambiamento di peso durante la sostituzione del vetro
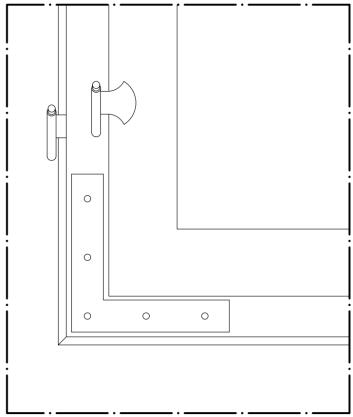

LEGENDADEGLI ELEMENTI
1. spalla muraria
2. telaio mobile
3. cardine biforcato a muro
4. maniglia
5. vetro singolo monolitico 3 mm
6. gocciolatoio
7. scuro esterno
8. bancale
9. Inferriata esterna
I) angolari di rinforzo a L in ferro zincato
II) cavo metallico esterno
III) rinforzi obliqui collaboranti negli angoli delle ante
forma a L per una maggiore resistenza alla deformazione rombica
utilizzo dell'acciaio zincato a caldo per elevata durabilità e resistenza alla corrosione
verniciatura a fuoco per riprodurre il colore del telaio esistente ed essere minor visibile
elemento leggermente invasivo in termini di impatto estetico sull'infisso
adatto agli infissi con scuretto interno, poiché l'elemento rimane nascosto quando aperto
IN.08: SOSTITUZIONE DEL SOLO VETRO SU TELAIO ESISTENTE
esempio di applicazione: infisso F4


fotografia esterna fotografia interna con scuretto aperto
È mantenuto intatto il telaio originale, preservando così l'aspetto storico-estetico dell'elemento e rispettandone appieno il principio di compatibilità. Si propone un vetrocamera 3/9/3 mm per evitare soluzioni che potrebbero compromettere la stabilità e la resistenza del telaio, dato che un vetro più spesso comporterebbe un aumento significativo del peso e potrebbe influire negativamente sulla struttura.
proposta II: cavo metallico esterno
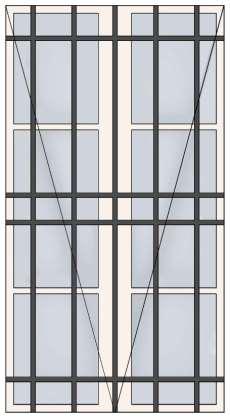
SOLACONSULTAZIONE
sezione dell’infisso F4
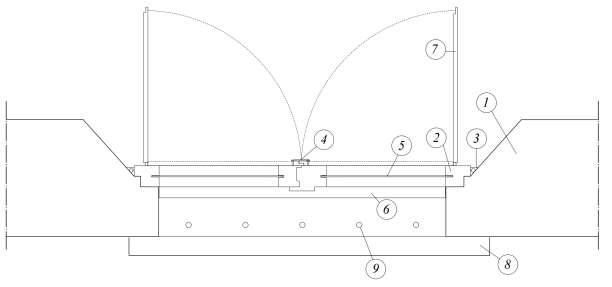
conservazione dell'integrità strutturale e dell'estetica originale
affrontare le sfide del cambiamento di peso durante la sostituzione del vetro

LEGENDADEGLI ELEMENTI
1. spalla muraria
2. telaio mobile
3. cardine biforcato a muro
4. maniglia
5. vetro singolo monolitico 3 mm
6. gocciolatoio
7. scuro esterno
8. bancale
9. Inferriata esterna
I) angolari di rinforzo a L in ferro zincato
II) cavo metallico esterno
III) rinforzi obliqui collaboranti negli angoli delle ante
distribuisce le forze lungo l'intera struttura del telaio, riducendo la concentrazione su punti critici
collegamento ipotizzato con morsetti a fascetta
minor invasività del cavo per infissi con scuri interni e/o inferriata esterna come F4
l’intervento è completamente reversibile
preferenza per soluzioni conservatrici che preservino integrità e autenticità
compromette il principio di compatibilità in edifici storici come Casa Carducci, data la visibilità del cavo
IN.08: SOSTITUZIONE DEL SOLO VETRO SU TELAIO ESISTENTE
esempio di applicazione: infisso F4


fotografia esterna fotografia interna con scuretto aperto
È mantenuto intatto il telaio originale, preservando così l'aspetto storico-estetico dell'elemento e rispettandone appieno il principio di compatibilità. Si propone un vetrocamera 3/9/3 mm per evitare soluzioni che potrebbero compromettere la stabilità e la resistenza del telaio, dato che un vetro più spesso comporterebbe un aumento significativo del peso e potrebbe influire negativamente sulla struttura.
proposta III: rinforzi collaboranti obliqui negli angoli delle ante
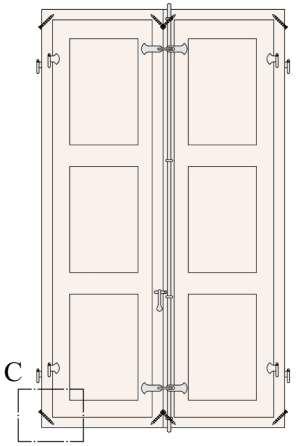
SOLACONSULTAZIONE
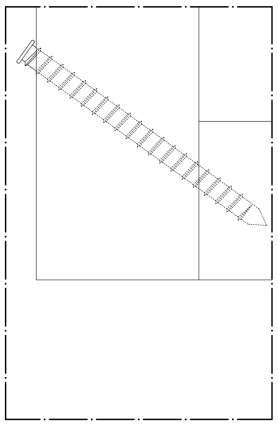
sezione dell’infisso F4
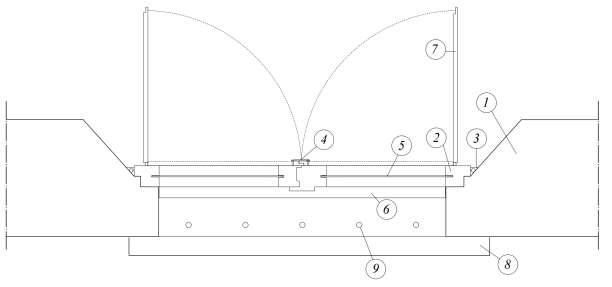
conservazione dell'integrità strutturale e dell'estetica originale
affrontare le sfide del cambiamento di peso durante la sostituzione del vetro
LEGENDADEGLI ELEMENTI
1. spalla muraria
2. telaio mobile
3. cardine biforcato a muro
4. maniglia
5. vetro singolo monolitico 3 mm
6. gocciolatoio
7. scuro esterno
8. bancale
9. Inferriata esterna
I) angolari di rinforzo a L in ferro zincato
II) cavo metallico esterno
III) rinforzi obliqui collaboranti negli angoli delle ante
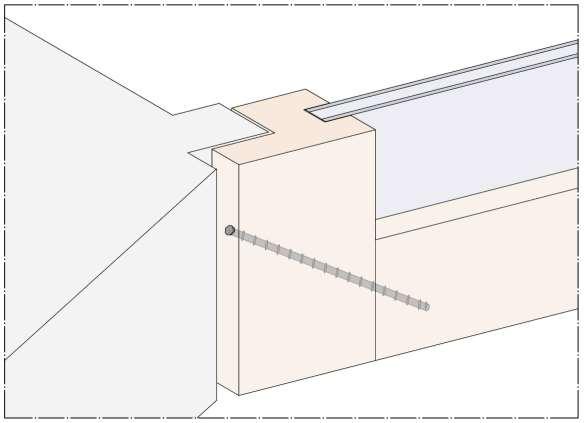
le quattro viti posizionate agli angoli delle ante del telaio consentono una distribuzione uniforme delle forze, prevenendo la deformazione rombica
la disposizione diagonale delle viti aumenta la resistenza alle forze di torsione sul telaio durante l'apertura e la chiusura dell'infisso
non altera significativamente il design originale dell'infisso storico, preservando l'estetica e l'integrità
soluzione meno invasiva e visibile tra le opzioni proposte
zona ventilata - Museo del Risorgimento e spazi destinati al personale
zona ventilata - casa del poeta Carducci zona di transizione
PIANTA PIANO INTERRATO
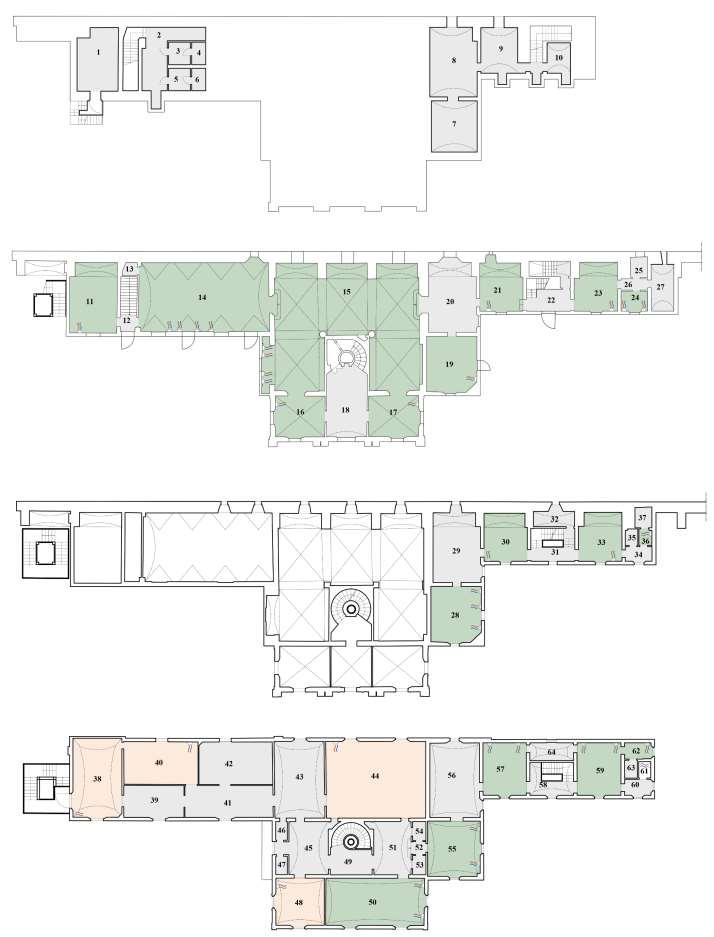
L’obbiettivo è garantire condizioni ottimali di temperatura e umidità, contribuendo a creare un ambiente piacevole e confortevole sia per i visitatori del museo che, soprattutto, per il lavoro quotidiano degli addetti ai lavori.
PIANTA PIANO TERRA
PIANTA PIANO PRIMO
SOLACONSULTAZIONE
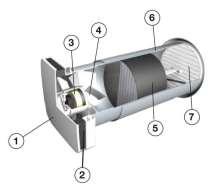
1. cover ambiente interno (180x180 mm)
2. filtro dell'aria
3. motore
4. ventilatore
5. recuperatore di calore
6. tubo telescopico
7. griglia esterna (Φ190 mm)
PIANTA PIANO SECONDO
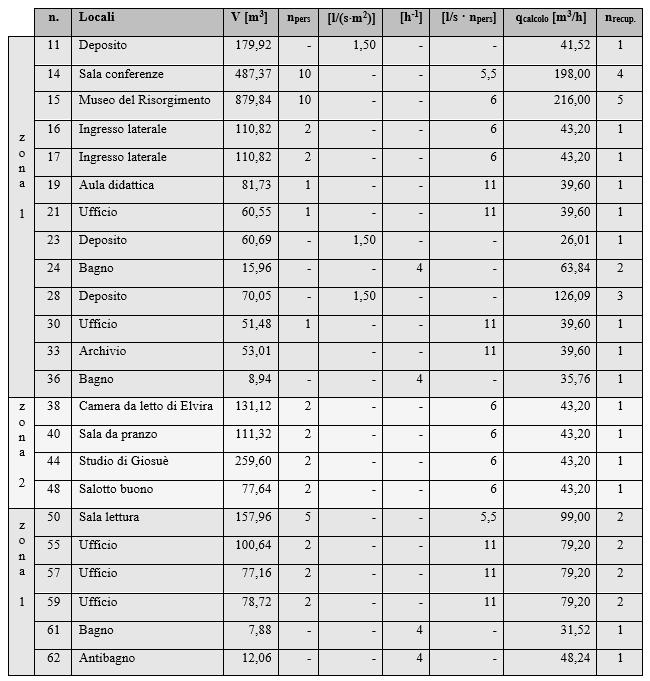
sala conferenze - zona 1
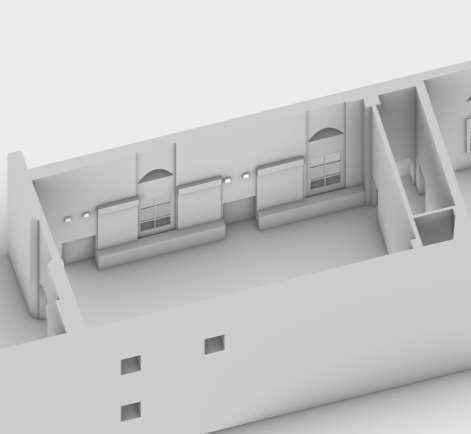

vista tridimensionale della sala conferenze, al pian terreno del complesso
sala da pranzo - zona 2
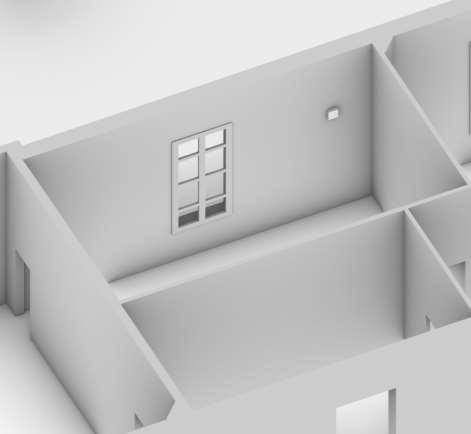

traccia in cartongesso

recuperatore di calore
recuperatore di calore
SOLACONSULTAZIONE

traccia in rame

traccia in rame
recuperatore di calore
RICERCA STORICA E RILIEVI
AZIONI PRELIMINARI ALLA DIAGNOSI
DIAGNOSI ENERGETICA
SOLACONSULTAZIONE
INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO
analisi risultati prima e dopo l’intervento analisi sulle differenze tra le due zone considerate il cambiamento dell’incidenza dei componenti
L'intervento ha generato maggiori benefici nella zona 1, che include il Museo del Risorgimento e gli spazi del personale, grazie alla maggiore flessibilità di intervento come l'applicazione di isolamento interno.
La casa del poeta Carducci, situata al secondo livello, presenta vincoli più rigidi per pareti e infissi. Tuttavia, è interessante notare che nella casa del poeta si è registrato un indice di miglioramento più significativo grazie all'intervento sul solaio di copertura. Questo ha portato a una considerevole riduzione delle perdite energetiche, essendo posizionata all'ultimo piano.
SOLACONSULTAZIONE
Il miglioramento energetico ha determinato una variazione di tre classi, ma l'obbiettivo principale è sempre stato trovare un equilibrio tra la conservazione del valore storico e il miglioramento delle prestazioni energetiche. Considerando l'importanza dei principi del restauro e per garantire l'integrità di Casa Carducci, ulteriori interventi non avrebbero apportato un beneficio significativo in termini di conservazione monumentale.
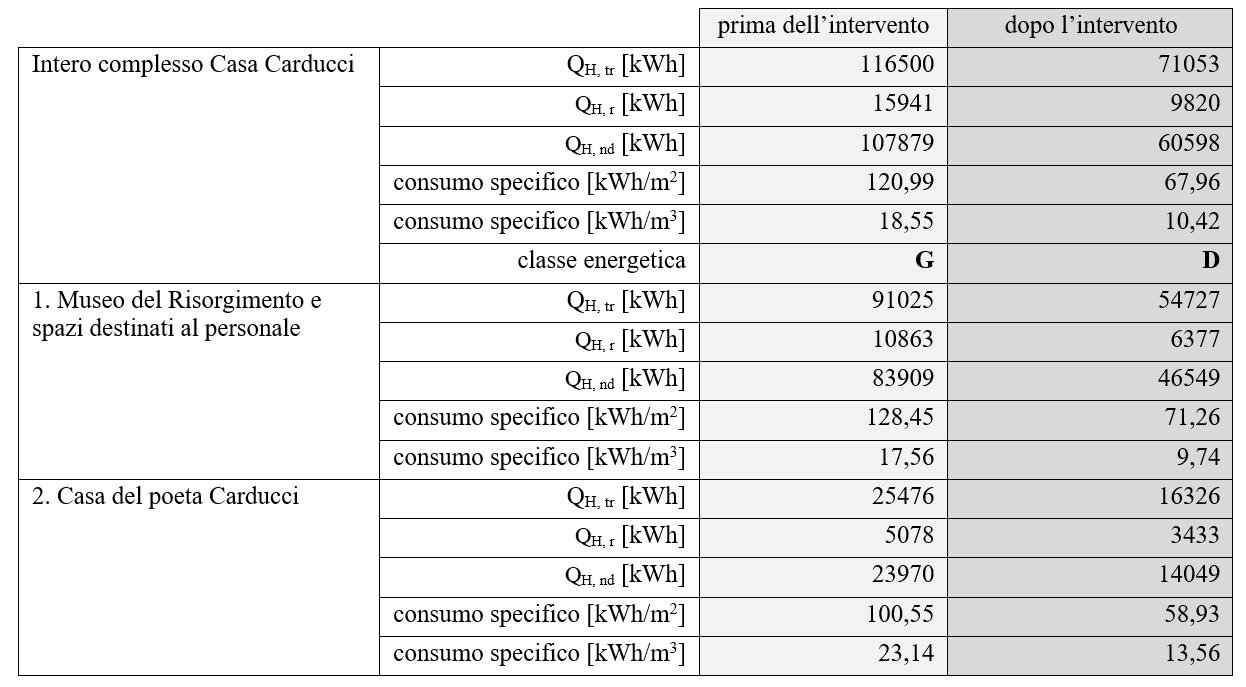
e

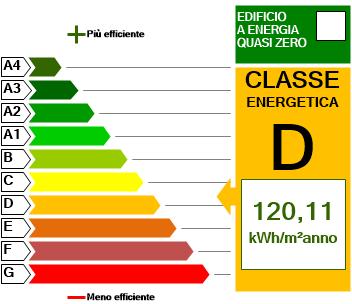
Nel capitolo di diagnosi energetica è stata studiata l’incidenza di ogni componente (strutture verticali, orizzontali, infissi e ponti termici) ed è risultato interessante capire, dopo l’intervento, quali sono i componenti che causano un peggior indice di prestazione energetica dopo le proposte trattate.
SOLACONSULTAZIONE
Dai risultati emerge che, non potendo eseguire degli interventi invasivi come il cappotto esterno, la maggior parte delle perdite appartenga ancora alle strutture verticali con un indice addirittura superiore rispetto al precedente, ma comunque con un valore di kWh inferiore per l’inserimento, ove possibile, dei pannelli sottovuoto come isolamento interno. Inoltre, si osserva anche come l'intervento sull'isolamento della copertura e degli infissi abbia apportato benefici significativi in termini di riduzione delle perdite energetiche.
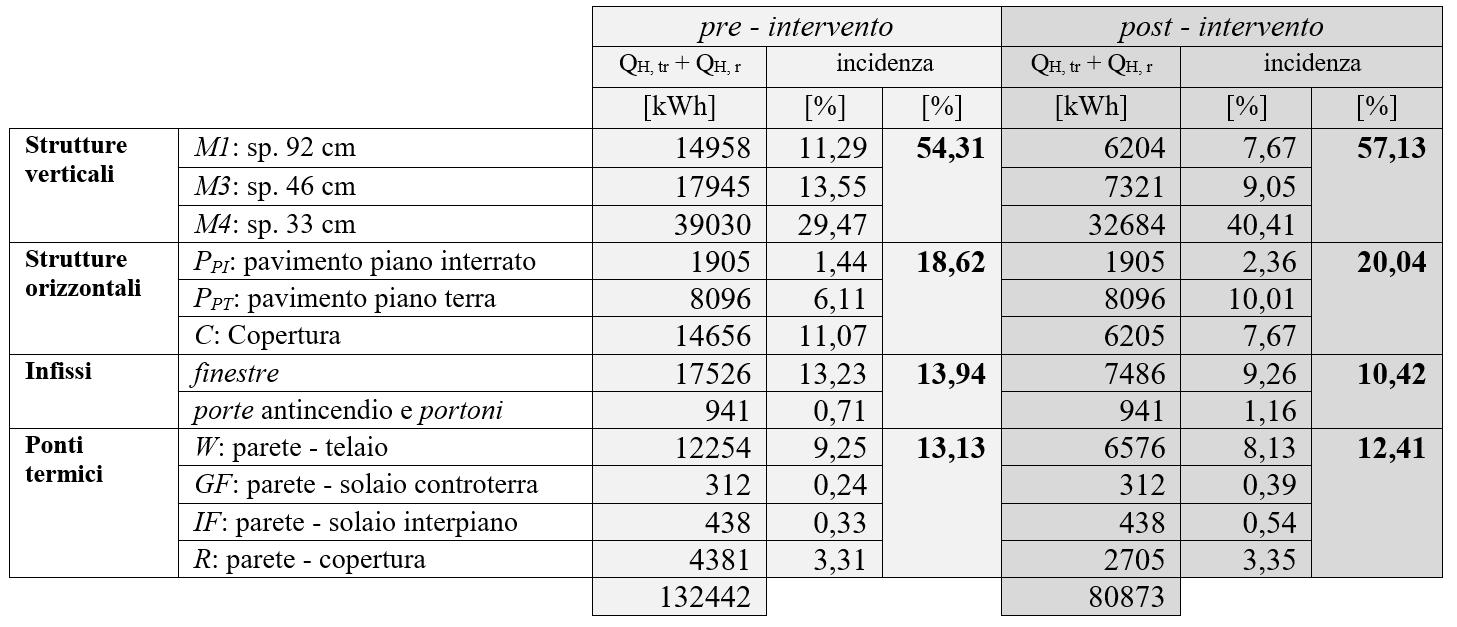
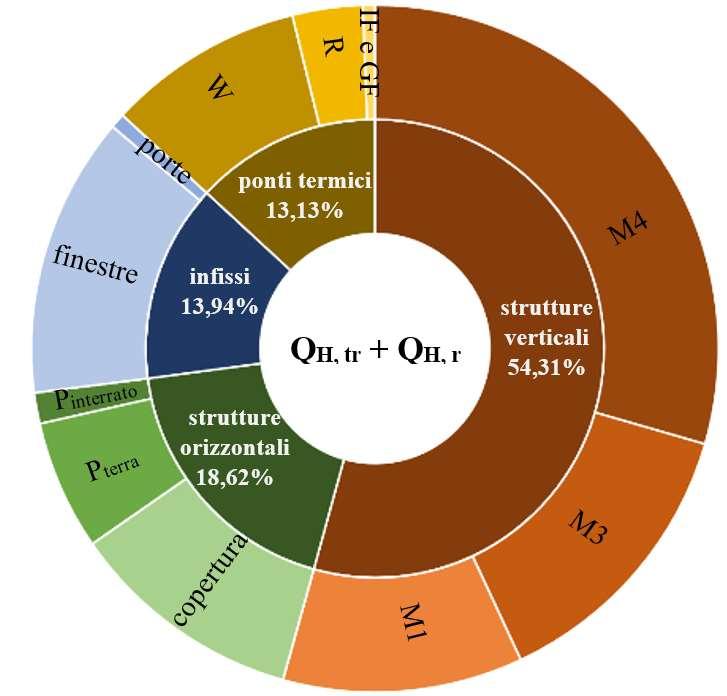
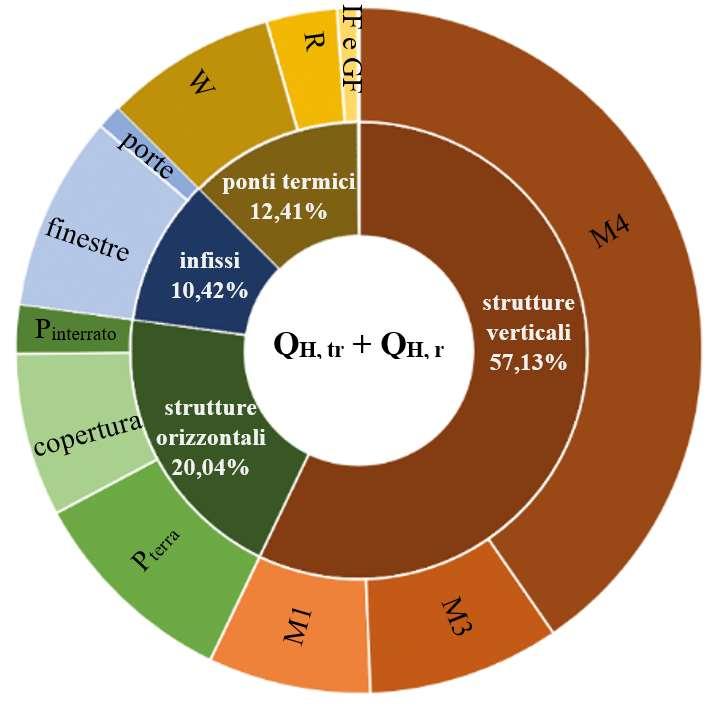
Nel capitolo di diagnosi energetica è stata studiata l’incidenza di ogni componente (strutture verticali, orizzontali, infissi e ponti termici) ed è risultato interessante capire, dopo l’intervento, quali sono i componenti che causano un peggior indice di prestazione energetica dopo le proposte trattate.
SOLACONSULTAZIONE
Dai risultati emerge che, non potendo eseguire degli interventi invasivi come il cappotto esterno, la maggior parte delle perdite appartenga ancora alle strutture verticali con un indice addirittura superiore rispetto al precedente, ma comunque con un valore di kWh inferiore per l’inserimento, ove possibile, dei pannelli sottovuoto come isolamento interno. Inoltre, si osserva anche come l'intervento sull'isolamento della copertura e degli infissi abbia apportato benefici significativi in termini di riduzione delle perdite energetiche.
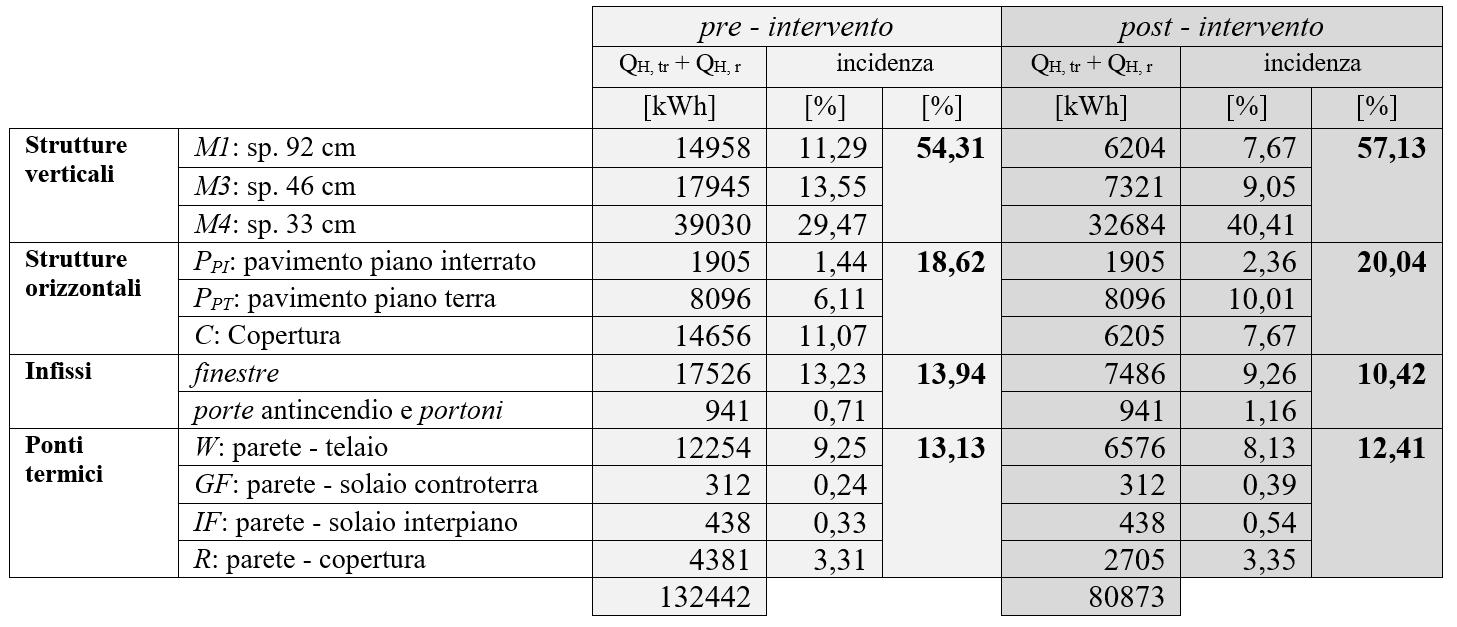
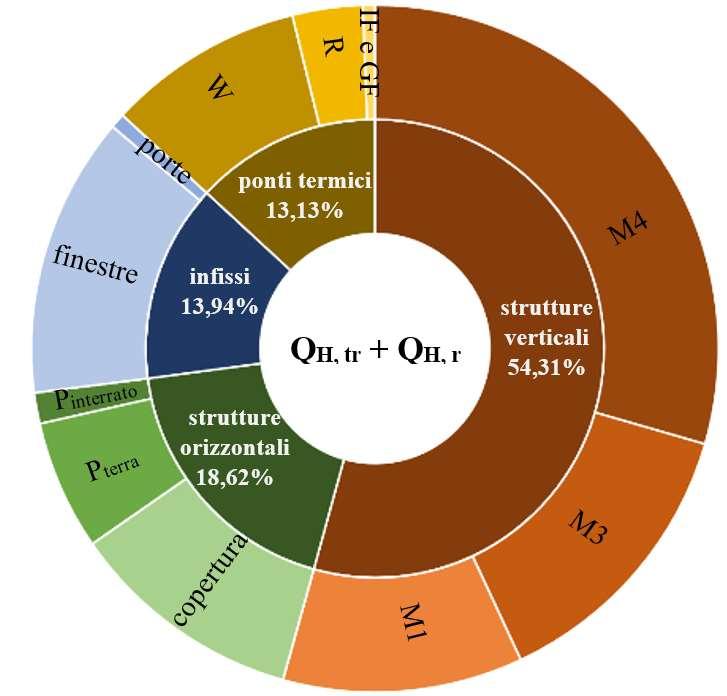
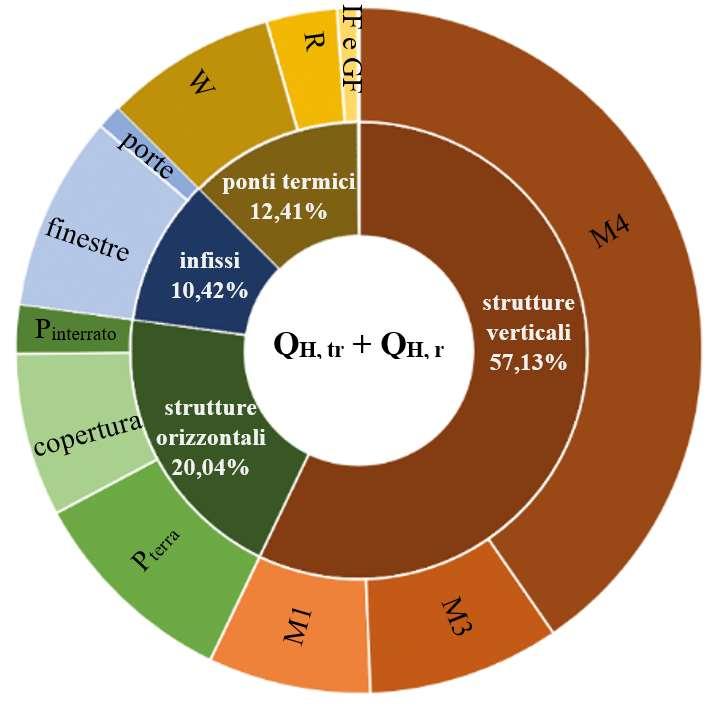
CONCLUSIONI
atto di sintesi complessa = equilibrio tra conservazione del valore storico e implementazione con soluzioni più performanti
criterio metodologico in grado di assistere all’intervento di miglioramento energetico co m e?
«il restauro, da intendere, in prima definizione, come intervento diretto sull’ opera e anche come sua eventuale modifica, condotta sempre sotto un rigoroso controllo tecnico-scientifico e storico-critico; conservazione, come opera di prevenzione e salvaguardia, da attuare proprio per evitare che si debba poi intervenire con il restauro, il quale costituisce pur sempre un evento traumatico per il manufatto»
La matrice di reversibilità si è rivelata un aiuto nell’integrazione del tema energetico nel restauro di Casa Carducci
È stato possibile delineare i limiti e le potenzialità del miglioramento energetico negli edifici storici
SOLACONSULTAZIONE
Il criterio metodologico ha instaurato un rapporto con l’opera analizzante, ponendo maggiori domande sui temi proposti, attraverso una consapevolezza critica sulla necessità del miglioramento
Casa Carducci persiste come testimonianza intatta del nostro prezioso patrimonio storico-culturale ed è quindi essenziale ricercare soluzioni che si riflettano nella possibilità di raccontare la sua storia ispirando le generazioni future
Giovanni Carbonara