La rivista di divulgazione scientifica più diffusa in Italia



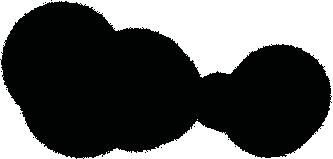

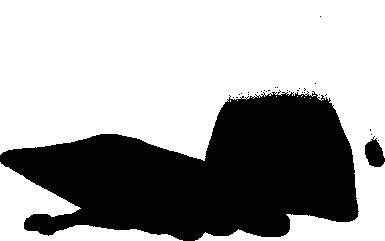






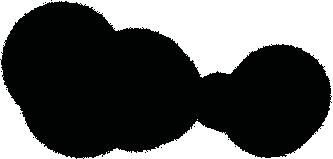

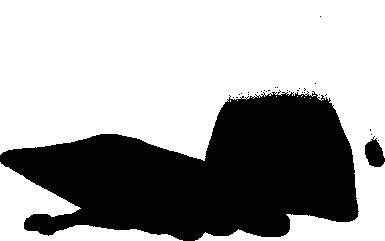


Carla Lucia Esposito
I
Collaborazioni 08/ FUMO E CANCRO
Convenzione Quadro OMS per la lotta al tabagismo
Delibere AIRC
Terapie cellulari
La parola a...
Telomeri
Lasciti testamentari
Cambiamento
Alimentazione
Sostenitori 5 per mille
Bilancio d’esercizio 2024
FONDAMENTALE
Anno LIII - Numero 3 giugno 2025 - AIRC Editore
DIREZIONE E REDAZIONE
Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro ETS
Viale Isonzo, 25 - 20135 Milano tel. 02 7797.1 - airc.it - redazione@airc.it Codice fiscale 80051890152
Autorizzazione del Tribunale di Milano n° 128 del 22 marzo 1973. Stampa Rotolito S.p.A.



DIRETTORE RESPONSABILE
Daniele Finocchiaro
COORDINAMENTO EDITORIALE
Anna Franzetti, Simone Del Vecchio REDAZIONE
Simone Del Vecchio, Jolanda Serena Pisano PROGETTO GRAFICO E IMPAGINAZIONE kilowatt.bo.it
TESTI
Anna Lisa Bonfranceschi, Denise Cerrone, Cristina Da Rold, Riccardo Di Deo, Fabio Di Todaro, Camilla Fiz, Antonino Michienzi, Roberta Villa, Antonella Viola FOTOGRAFIE E INFOGRAFICHE
Claudio Bonoldi 2024, Simone Comi 2025, Dario Garofalo 2025, Getty Images, Marco Onofri 2025, Carlo Ramerino 2021 e 2025, Pierluigi Siena 2024
RACCOLTA FONDI

Fondamentale è stampato su carta certificata e proveniente da foreste gestite in maniera corretta e responsabile secondo rigorosi
• con conto corrente postale n. 307272;
• con carta di credito, telefonando al numero verde 800 350 350, in funzione tutti i giorni 24 ore su 24 o collegandosi al sito airc.it;
• con un piccolo lascito nel suo testamento; per informazioni, airc.it/lasciti oppure tel. 02 77 971; • in banca:
BPER Banca S.p.A.
IBAN: IT36 S05387 01665 0000 4243 3665; Banco BPM
IBAN: IT18 N050 3401 633 00000000 5226;
Intesa Sanpaolo
IBAN IT14 H030 6909 4001 00000103 528;
Banca Monte dei Paschi di Siena
IBAN IT87 E 01030 01656 00000 1030151; Unicredit PB S.p.A.
IBAN IT96 P020 0809 4230 0000 4349176;
• con un ordine di addebito automatico in banca o su carta di credito (informazioni al numero verde 800 350 350)
SEI UN’AZIENDA?
Scopri come possiamo collaborare. Scrivi a partnership@airc.it
ATTENTI ALLE TRUFFE
AIRC non effettua la raccolta fondi “porta a porta”, con incaricati che vanno di casa in casa. Nel caso dovesse succedere, stanno tentando di truffarvi. Denunciate subito la truffa chiamando il numero unico per le emergenze 112.

Andrea Sironi Presidente AIRC
In questo numero dell’anno, dopo l’approvazione del bilancio da parte dei nostri organi sociali, siamo soliti fare il punto della situazione, ancorandoci ai risultati economici che abbiamo conseguito. Oggi la nostra Fondazione è più forte di quanto non lo sia mai stata. La raccolta fondi è cresciuta di 9 milioni di euro rispetto al 2023 ed è arrivata a un totale di 182 milioni. A fronte di questa crescita, i costi complessivi della Fondazione sono cresciuti di soli 500.000 euro. Un risultato importante che ci consente di migliorare ulteriormente la nostra efficienza e di programmare un incremento delle erogazioni per il futuro. Nel 2024, per ogni euro che abbiamo ricevuto, gli oneri per la raccolta fondi sono stati pari a 15 centesimi. Complessivamente, l’incidenza dei costi arriva al 18% della raccolta, posizionando AIRC fra le fondazioni più efficienti in Italia e in Europa.
La raccolta relativa al 2024 è cresciuta in tutte le sue principali forme, dalle iniziative di piazza (azalee, arance e cioccolatini) agli eventi promossi dai comitati regionali, fino alle donazioni da parte di donatori regolari e non, piccoli e grandi. Non si è invece registrato l’incremento dei fondi provenienti dal 5 per mille che ci saremmo attesi in seguito all’aumento delle firme dei contribuenti italiani a favore di AIRC, a causa di un tetto posto dal governo al totale dei fondi disponibili per questa forma di sostegno al terzo settore. Ci auguriamo che in futuro il governo possa rivedere questa scelta, consentendo a tutti i contribuenti di vedere rispettata la propria volontà. Nel 2024 è cresciuta in modo particolare la raccolta da lasciti testamentari, con un aumento di 3,7 milioni di euro. Un segno che anche questo strumento sta diventando sempre più popolare presso i nostri donatori per continuare a sostenere la ricerca sul cancro. In questo numero di Fondamentale raccontiamo la storia di uno di loro, Alessandro, che ha scelto di fare testamento a favore della ricerca sul cancro di AIRC. Anche sul fronte patrimoniale, AIRC ha ulteriormente rafforzato la propria posizione, con un incremento del patrimonio libero, il quale consente a tutti noi di guardare con serenità alle sfide future della nostra Fondazione.
Alla luce di questi risultati così positivi desidero esprimere un ringraziamento sincero, personale e a nome di tutta AIRC, a tutti i nostri donatori e ai nostri volontari, che con il loro lavoro e le loro energie rendono possibili questi traguardi e il conseguente finanziamento della ricerca oncologica in Italia.
In conclusione, vorrei esprimere un ringraziamento particolare a tre donne speciali che hanno deciso, per motivi diversi, di lasciare AIRC dopo tanti anni di preziosa collaborazione in ruoli importanti della governance della nostra Fondazione: Maria Francesca De Cecco, presidente del Comitato Abruzzo, Esmeralda Rettagliata, presidente del Comitato Lombardia e vice presidente nazionale, e Rosella Serra, presidente del Comitato Calabria.

Vita da ricercatrice
Carla Lucia Esposito
In questo articolo:
— RICERCA IN SUD ITALIA
— RNA
— RETI DI RICERCATORI

Carla Lucia Esposito guida un gruppo di ricerca al CNR – IEOMI di Napoli. Ha vinto un finanziamento Southern Italy Scholars e punta a sfruttare mini-molecole di RNA per riprogrammare le cellule tumorali a cura di Antonino Michienzi
"Se oggi mi guardo indietro, mi accorgo che la ricerca è quello che ho sempre voluto fare. Fin da giovanissima mi sono appassionata al mondo della scienza e volevo fare un lavoro stimolante, in continua evoluzione. Essere una ricercatrice vuol dire proprio questo: continuare a cercare, mettersi in discussione e volere sempre andare avanti ponendosi nuove domande.” Carla Lucia Esposito non ha dubbi su come sia iniziato il suo percorso lavorativo, che l’ha portata, oggi, a guidare un gruppo di ricerca all’Istituto degli endotipi in oncologia, metabolismo e immunologia G. Salvatore (IEOMI) del CNR, a Napoli. Laurea in biotecnologie, un dottorato di ricerca, il lavo-
Questo articolo è disponibile in versione podcast. Scopri dove ascoltarlo inquadrando il QR Code.

ro al CNR e poi, due anni fa, l’inizio come ricercatrice indipendente anche grazie a un grant Southern Italy Scholars (SIS) di AIRC, un bando destinato a ricercatori che intendano stabilire il proprio laboratorio e portare avanti il proprio progetto di ricerca in un ente nell’Italia meridionale e insulare.
“Ora che sono passata dall’altra parte capisco di più i miei capi. Un po’ come quando un figlio diventa genitore, mi rendo conto delle difficoltà di gestione, del maggiore impegno. Soprattutto delle responsabilità che comporta guidare un gruppo di ricerca; responsabilità nei confronti di ricercatori più giovani che hanno bisogno di risposte, ma anche di qualcuno che creda in loro” dice. “Mi manca un po’ il lavoro al bancone, che ormai ho dovuto ridurre, ma alla fine è una grande soddisfazione: poter realizzare le proprie idee è ciò che ogni ricercatore desidera.”
L’idea a cui Carla sta lavorando da anni è quella di mettere a punto nuove terapie antitumorali basate su piccole molecole costituite con le stesse lettere che danno vita al codice genetico. Vengono chiamate aptameri: sono semplici da produrre e possono potenzialmente agire ai livelli più profondi della catena di meccanismi che danno luogo al cancro.

“Sono piccole sequenze oligonucleotidiche – nel mio caso specifico, di RNA – che hanno la peculiarità di legare il loro bersaglio ripiegandosi in strutture tridimensionali. Pensiamo di usare queste molecole per inibire la metilazione del DNA, un fenomeno che regola l’espressione dei geni e che è deregolato nei tumori” spiega la ricercatrice.
Carla lavora da anni sulla possibilità di mettere a punto terapie antitumorali basate su piccole molecole chiamate aptameri
Carla e il suo gruppo puntano a sfruttare queste piccole molecole per modulare l’espressione dei geni alterati nel cancro e risintonizzarla. Un po’ come si fa quando si accordano gli strumenti per restituire loro il suono corretto.
Gli aptameri hanno diversi vantaggi. “Innanzitutto, sono di piccole dimensioni. Inoltre, sono fortemente versatili e hanno una maggiore capacità – rispetto a molecole più grandi – di penetrare all’interno dei tessuti”
spiega la ricercatrice. “In più, sono abbastanza semplici ed economici da produrre in laboratorio.”
C’è di più: possono essere abbinati ad altri approcci per migliorarne l’efficacia. “Noi stiamo lavorando allo sviluppo di un sistema basato sulle nanotecnologie per ‘direzionare’ la terapia, indirizzandola specificamente verso il tumore” spiega. “In particolare, stiamo sviluppando un sistema capace di ‘inglobare’ gli aptameri e di rilasciarli direttamente nelle cellule tumorali.”
Il progetto è ancora alle fasi iniziali, ma già si intuiscono le potenzialità. “Abbiamo identificato delle molecole che sembrano molto promettenti: riducono la capacità di crescita delle cellule tumorali cambiando il loro profilo di metilazione. Per ora si tratta di test su campioni di cellule; se i primi risultati saranno confermati si dovrà passare a esperimenti nei modelli animali. Solo a quel punto si potrà pensare a una sperimentazione sull’uomo, ma la strada è ancora lunga” aggiunge Carla.
Il finanziamento AIRC SIS ha proprio l’obiettivo di farle compiere questo pezzo di strada. “Copre le spese per i materiali e lo stipendio di una persona che lavori sul progetto” spiega Carla.
Ma non solo: nel budget sono comprese anche risorse per la formazione e per favorire la creazione di rapporti con altri scienziati, attraverso la partecipazione a meeting e a eventi di divulgazione.
Inutile negarlo: “Il Sud sconta ancora un notevole ritardo rispetto al Nord. Non difetta di grandi scienziati o idee, tuttavia esiste una carenza oggettiva di infrastrutture e tecnologie innovative. Questo contesto rende più difficile per i ricercatori meridionali competere con lo scenario globale” dice Carla. “Per questo mi sembra importante che questo bando – più di tutti gli altri finanziamenti AIRC – punti molto sulla formazione e, soprattutto, sul fare rete con altri centri di ricerca.”
Ci sono stati già due incontri tra tutti i ricercatori che ricevono questo finanziamento. “Sono stati molto interessanti e siamo ormai in contatto gli uni con gli altri. È stato molto bel-
"Mi sembra importante che questo bando punti molto sulla formazione e, soprattutto, sul fare rete con altri centri di ricerca"
lo confrontarsi. Oltre a condividere i problemi e le difficoltà, queste relazioni permettono di aprire nuove prospettive di ricerca e sperimentare nuove modalità di interazione. È un aspetto che mi piace molto del programma” continua la ricercatrice. Nonostante le maggiori difficoltà che incontra chi decide di fare ricerca al Sud, Carla ha deciso di rimanere a Napoli. E oggi – ironia della sorte – i laboratori in cui lavora si trovano proprio all’interno della facoltà di biotecnologie all’Università Federico II in cui ha cominciato il suo percorso.
“Ho fatto esperienze all’estero che sono state molto stimolanti, ma sono convinta della mia scelta di rimanere a lavorare qua” dice. “Amo il Sud e credo che sia un ambiente speciale: la forte socialità che si respira a Napoli, e che per qualcuno è un limite, per me rappresenta una grande forza. Dopotutto la scienza è interazione, partecipazione, condivisione. E poi, se ce ne andiamo tutti, non potrà mai succedere niente di buono.”
Certo, ammette, non è semplice.
“La ricerca non è un lavoro canonico. Ha bisogno di grossa dedizione e non lascia molto spazio al resto. Ciononostante, sono riuscita a coniugare lavoro e vita personale.”
Carla ha due bambini, uno di tre anni e mezzo e uno di un anno e mezzo.
“I miei figli mi hanno regalato le gioie più belle anche dal punto di vista professionale. Ho ricevuto il finanziamento di Fondazione AIRC quando il più piccolo era nato da pochissimo. Mi ha portato bene o, forse, semplicemente, pur tra mille difficoltà, i figli e la gravidanza danno a una donna uno sprint speciale” conclude.
Ridurre le disparità regionali promuovendo la creazione di nuove unità di ricerca, o consolidando quelle esistenti, nell'Italia meridionale o insulare, sostenendo progetti promettenti portati avanti da giovani scienziati di talento. È questo l’obiettivo del Southern Italy Scholars (SIS) di AIRC. Il bando, della durata di 5 anni, è destinato a ricercatori con un dottorato o una specializzazione conseguito da 15 anni o meno che svolgano la loro attività in centri di ricerca situati in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna o Sicilia. Tra i punti di forza del finanziamento, la sua intenzione di promuovere collaborazioni tra i ricercatori che hanno ricevuto il finanziamento e altri gruppi situati nel resto d'Italia e all'estero, in modo che conoscenze, competenze e best practice possano essere condivise e diffuse. Nel lungo periodo, il grant punta a creare ricercatori completamente indipendenti che lavorino al Sud, ma facciano parte di una rete collaborativa che coinvolga organizzazioni di ricerca di alto livello e che possa competere per programmi di finanziamento, italiani e internazionali, destinati a ricercatori affermati.
Percentuale di persone con più di 15 anni che fumano nel mondo
nazioni hanno effettivamente fatto dei grossi passi avanti, e continuano a farne, altre rimangono ancora indietro, e faticano a raggiungere gli obiettivi della convenzione e ridurre i consumi di prodotti del tabacco tradizionale. L’Italia, per esempio, secondo la Tobacco Control Scale, è tra queste.
UNA NUOVA EPIDEMIA
Accanto alle criticità locali, poi, negli ultimi anni l’arrivo di nuovi prodotti del tabacco e a base di nicotina ha completamente cambiato le carte in tavola. Le abitudini sono cambiate, e accanto alle sigarette tradizionali sempre più trovano posto sigarette elettroniche e prodotti da tabacco riscaldato. Tutto questo, scrivono gli esperti di salute pubblica su The Lancet , ha contribuito a creare una nuova, preoccupante forma di epidemia.
Le sigarette elettroniche rappresentano un rischio per la salute, tanto quella delle persone che dell’ambiente, anche se la scienza, molto attiva nel campo, non è ancora riuscita a quantificare bene i danni. È ormai riconosciuto che il consumo delle e-cig, specialmente nei più giovani, può favorire la dipendenza da nicotina e rendere più facile il consumo delle sigarette tradizionali, riassume l’OMS. Un recente studio
finanziato da AIRC e condotto in Italia, per esempio, ha confermato che e-cig e prodotti da tabacco riscaldato rendono sia più difficile smettere con le sigarette tradizionali, sia più facile iniziare per chi non le fumava. Tanto che, analizzando il trend della prevalenza di fumo in Italia, si osserva uno stallo proprio a partire dalla diffusione dei nuovi prodotti, una decina di anni fa. Segno inequivocabile, per i ricercatori dell’Istituto Mario Negri coordinati da Silvano Gallus e autori dell’analisi, del fatto che e-cig e prodotti da tabacco riscaldato aiutino a mantenere viva l’epidemia da tabacco.
Le sostanze rilasciate con lo svapo, inoltre, sono state associate al
stato rilevato un aumentato rischio di malattia in chi svapa, ma le sostanze contenute e rilasciate con le e-cig sono in grado di modificare il comportamento delle cellule, con meccanismi che possono favorire l’insorgenza e la progressione di tumori.
Questo da solo sarebbe motivo sufficiente per lanciare l’allarme, ma i danni di questi prodotti non riguardano solo le patologie oncologiche: il consumo di sigarette elettroniche minaccia la salute cardiovascolare, quella respiratoria e può produrre irritazioni della pelle e degli occhi. Motivi per cui la lotta al tabacco e alla nicotina non dovrebbe dimenticare i nuovi prodotti.
IL
AL TABAGISMO
“La convenzione quadro si trova a un punto di svolta inevitabile” scrivono Anna B. Gilmore e colleghi. “Se si vuole proteggere una generazione di giovani e si vuol tornare a fare progressi nel campo della lotta al fumo, i Paesi che hanno sottoscritto la convenzione quadro devono essere più ambiziosi." Il monito è non solo a rimettersi in carreggiata ma a impegnarsi di più, cominciando a richiamare all'ordine l’industria del tabacco ricordandole le sue responsabilità.
Nel documento diffuso su The Lancet , sono elencate una serie di possibili misure a sostegno della mission della convenzione quadro e della lotta al tabacco. Da un lato, l’indicazione è, come già ricordato, di con-
Le sigarette elettroniche rappresentano un rischio per la salute, tanto quella delle persone che dell'ambiente, anche se ancora non siamo riusciti a quantificare i danni
rischio di cancro. Secondo una recente revisione degli studi in materia, pubblicata sulla rivista Tobacco Induced Diseases , al momento non è
centrare l’attenzione non solo sui più tradizionali prodotti da tabacco, ma anche su quelli da poco arrivati sul mercato, per cercare di ridurne il
"L'industria
tabacco
posizionarsi come parte della
al problema fumo, mentre ostacola gli sforzi per il controllo del consumo di tabacco"
più possibile l’utilizzo. Ma il punto su cui più spingono gli esperti è la necessità di far pagare alle aziende produttrici i danni arrecati alla salute e all’ambiente da quanto mettono sul mercato. E ancora: dovrebbero essere attuate misure più forti per scoraggiare l’ingerenza e i conflitti di interesse delle industrie nelle politiche di contrasto al fumo e ai prodotti da tabacco in senso lato, e dovrebbe essere garantito un fondo comune per consentire agli Stati
LE NUOVE NORMATIVE CONTRO FUMO
PASSIVO E SIGARETTE ELETTRONICHE
Più divieti, meno pubblicità, meno visibilità, lotta alle e-cig usa e getta. Da più parti, nel corso dell’ultimo anno, diversi Stati e istituzioni hanno adottato o hanno annunciato politiche più stringenti contro fumo passivo e sigarette elettroniche. La Commissione europea, per esempio, ha invitato di recente i Paesi membri a estendere i divieti di fumo all’aperto, come pertinenze di centri sportivi, stazioni e parchi. Una proibizione che, secondo la Commissione, sarebbe meglio estendere sia ai prodotti più tradizionali sia alle sigarette
di difendersi dalle eventuali cause legali intentate dalle aziende del settore, si legge su The Lancet . Da ultimo, gli esperti raccomandano di aumentare i finanziamenti ai programmi di ricerca indipendenti che possano costituire una solida base scientifica per l’implementazione di politiche antifumo e antisvapo. Un punto quanto mai fondamentale, visto che le aziende, proseguono gli esperti, hanno provato a presentare i nuovi prodotti senza combustione
elettroniche e ai prodotti da tabacco riscaldato. Alcuni Stati, non solo europei, hanno già iniziato a fare qualche passo in questa direzione. Australia, Nuova Zelanda, Belgio, Gran Bretagna, Italia: ciascuno a modo suo, ma con un sentimento comune, hanno accelerato la lotta al tabacco e alla nicotina emanando nuove norme contro fumo passivo e sigarette elettroniche, a tutela della salute – soprattutto dei più giovani – e dell’ambiente. In Australia le e-cig si possono acquistare solo in farmacia e con possibilità di ricarica limitata ogni mese. La Nuova Zelanda, invece, ha inasprito le misure sulle e-cig vietando qualsiasi iniziativa di promozione commerciale o sconto, e l’uso di immagini e nomi accattivanti – anche per quel che riguarda i gusti dei liquidi – o che richiamino ai cartoni o ai giochi sulle
e le sigarette elettroniche come fondamentali nelle strategie di riduzione del danno.
“L'industria del tabacco ora cerca di posizionarsi come parte della soluzione al problema fumo, mentre ostacola attivamente gli sforzi per il controllo del consumo di tabacco che potrebbero salvare milioni di vite in più rispetto a quanto avviene ora” ha commentato in proposito Adriana Blanco Marquizo, Head of the Secretariat of the WHO FCTC. “La FCTC dell'OMS fornisce agli Stati sottoscrittori una serie di misure complete per proteggere le popolazioni dalle tattiche in continua evoluzione dell'industria, progettate per trarre profitto a costo della vita delle persone e della salute del nostro pianeta."
confezioni. Inasprite anche le misure sulla stessa visibilità che i rivenditori possono dare alle e-cig e vietata la vendita di prodotti usa e getta senza meccanismi di sicurezza per bambini e non ricaricabili in alcun modo. Anche il Belgio ha posto dei paletti alla vendita dei prodotti usa e getta, ed è previsto che, a partire da metà di quest’anno, il Regno Unito ne segua l’esempio. Oltremanica sono inoltre in discussione una serie di misure aggiuntive, all’interno del Tobacco e Vapes Bill, per arginare la visibilità e la promozione delle e-cig, limitare la disponibilità di gusti e vietare il fumo nei parchi giochi e nelle vicinanze di scuole e ospedali. In merito ai divieti di fumo, in Italia, a Milano, dall’inizio del 2025 è vietato fumare in tutti i luoghi e all’aperto se sono presenti delle persone a meno di dieci metri di distanza.
mato peer review). Quest’anno la direzione scientifica di AIRC ha ricevuto più di mille domande di finanziamento in risposta a diversi bandi, disegnati per finanziare ricerca di varia natura, e ricercatori a diversi stadi di carriera.
Prima di entrare nel dettaglio, però, quali sono i tipi di ricerca che AIRC finanzia? Parliamo di ricerca di base, traslazionale e clinica. La prima si occupa di studiare i meccanismi alla base della trasformazione delle cellule e dei tessuti da normali a tumorali, di studiare cioè i meccanismi alla base dell’insorgenza dei tumori, del loro comportamento e suscettibilità ai farmaci. La seconda, ossia la ricerca traslazionale, si occupa invece di disegnare nuove strategie di prevenzione o cura e di validarle su modelli animali. La ricerca clinica è infine dedicata all’analisi dei pazienti e sui pazienti.
Con le delibere del 2024, AIRC finanzia progetti che rientrano in tutte e tre le tipologie di ricerca. I nostri ricercatori e le nostre ricercatrici studieranno le cause di insorgenza e le basi della prevenzione dei tumori, le basi biologiche del loro sviluppo, strategie innovative per una diagnosi precoce e per prognosi sempre più precise fino a possibili nuove terapie. Alcuni dei progetti non sono specifici per singole forme di tumorali (14% dei fondi a disposizione dedicati), mentre altri sono focalizzati su una determinata patologia d’organo. Tra questi i progetti che si occupano dei tumori della mammella (12%), del colon e del retto (12%), del sangue (11%), del polmone (8%), del pancreas (7,5%) e del cervello (6%), percentuali che rispecchiano le necessità cliniche, dimostrate da tassi di incidenza e mortalità ancora alti per molte di queste tipologie di tumore.
E quali sono le domande scientifiche poste dai ricercatori? Solo a titolo esemplificativo, alcuni studi prospettano di capire i meccanismi attraverso i quali il DNA muta e può diventare bersaglio di terapie, o come il metabolismo è regolato dai nostri comportamenti e incide sullo sviluppo del tumore, o come variazioni nel microbioma intestinale influiscano

sulla progressione del tumore o la risposta alle terapie. Al fine di garantire gruppi di ricerca equilibrati, e la compresenza di giovani menti e ricercatori con esperienza, AIRC ha identificato diverse misure per finanziare la ricerca sul cancro, commisurate alle capacità e le complessità progettuali dei ricercatori. Dalle borse di studio per progetti a breve termine per i giovani laureati, ai finanziamenti necessari per far partire nuove progettualità e nuovi gruppi di ricerca (My First AIRC Grant, Start-Up Grant), fino a quelli che sostengono ricercatori e medici più esperti (Next Gen Clinician Scientist, Investigator Grant, Southern Italian Scholars). Le proposte arrivano da quasi tutta Italia, e i finanziamenti sono diretti a 96 istituzioni di ricerca, per la maggior parte pubbliche. I risultati si vedranno nei prossimi anni, ma guardando indietro sappiamo che la ricerca AIRC genera conoscenza, nuove terapie, nuove linee guida per la prevenzione, la diagnosi e la cura, e nuovi approcci pronti a essere valutati in studi clinici innovativi. La fiducia dei donatori ha permesso nuovamente di poter finanziare le migliori progettualità in un circolo virtuoso: dal cittadino, per il cittadino attraverso la ricerca. Il 2025 è iniziato e i ricercatori sono all’opera.
Per selezionare i progetti di ricerca più meritevoli di finanziamento, AIRC si affida al processo di peer review, utilizzato in tutto il mondo. La valutazione dei progetti viene svolta in modo anonimo da esperti di livello internazionale, operanti in istituti di ricerca esteri, o facenti parte del Comitato tecnico scientifico di AIRC. A loro viene chiesto di valutare la qualità scientifica della nuova progettualità, la coerenza del tema e l’impatto sulla ricerca, sulla cura o sulla prevenzione del cancro, oltre alla sua competitività a livello internazionale. La selezione valuta inoltre la fattibilità del progetto in relazione alla competenza e produttività scientifica dei proponenti e il supporto dichiarato dall’istituto ospitante. Il processo termina con la preparazione di una graduatoria meritocratica, che determina il finanziamento delle progettualità migliori.
Guida alle terapie
Terapie cellulari

In questo articolo:
— TIL
— ANTIGENI TUMORALI
— CAR-CIK E CAR-NK
Oggi le terapie cellulari sono uno dei campi di ricerca oncologica più attivi, con sperimentazioni in corso sia per rendere più efficienti le CAR-T, sia per mettere a punto trattamenti che usino nuovi prodotti come CAR-CIK, CAR-NK e TIL
Itrattamenti cellulari appartengono al campo delle terapie avanzate, e in parte sono ancora approcci “di frontiera”, ma l'idea di usare cellule per trattare i tumori è tutt’altro che nuova. “Il loro primo utilizzo risale alla fine degli anni Cinquanta, quando si cominciò a ricorrere a trapianti di midollo osseo da donatori compatibili per curare le leucemie” racconta Chiara Bonini, ordinaria di ematologia presso l’Università Vita-Salute San Raffaele e group leader dell’Unità di ematologia sperimentale all’IRCCS Ospedale San Raffaele di Milano. “Osservando questi pazienti si capì infatti che i casi di remissione completa o di definitiva guarigione dalla malattia non dipendevano solo dall’aggressiva chemioterapia che precedeva il trapianto, ma anche dai linfociti T presenti nel midollo del donatore, che attaccavano eventuali cellule tumorali sopravvissute.”

Antonella Viola è scienziata e divulgatrice. È professoressa ordinaria di patologia generale presso l’Università degli studi di Padova e studia il funzionamento del sistema immunitario. È stata direttrice scientifica dell’Istituto di ricerca pediatrica di Padova, membro del Comitato tecnicoscientifico di AIRC e revisore per la Commissione europea e per molte agenzie nazionali e internazionali. In aggiunta, Viola si occupa attivamente di divulgazione scientifica nell’ambito della salute. È autrice di numerosi libri di successo, editorialista, ospite e autrice di trasmissioni televisive e radiofoniche e manifestazioni culturali.

a cura di Antonella Viola
Negli ultimi anni, le coperture vaccinali in età pediatrica e adolescenziale hanno subito un calo preoccupante, con ripercussioni sulla protezione collettiva contro malattie prevenibili. I dati aggiornati al 2023 mostrano una lieve flessione per la maggior parte delle vaccinazioni raccomandate nei primi anni di vita. Sebbene la copertura per la polio – utilizzata come indicatore per l’esavalente – rimanga alta (94,76% nella coorte 2021), resta ancora sotto il 95% raccomandato dall’OMS. Ancora più allarmante è la situazione del morbillo: mentre la copertura della prima dose si attesta al 94,64%, quella della seconda dose a 5-6 anni è scesa sotto l’85%, ben lontana dall’obiettivo del 95% necessario per garantire l’immunità di gregge. Il quadro si complica ulteriormente con le forti differenze regionali, che
/ La parola a… La parola a...
evidenziano una distribuzione disomogenea della protezione vaccinale sul territorio italiano. Il quadro è particolarmente negativo nel caso della vaccinazione contro il Papillomavirus umano (HPV), che rappresenta uno strumento fondamentale nella prevenzione del tumore della cervice uterina e di altre neoplasie associate all’infezione virale.
VACCINARSI?
Il Papillomavirus umano (HPV) è un virus molto comune, trasmesso principalmente per via sessuale. Esistono oltre 200 varianti di HPV, alcune delle quali possono causare lesioni benigne, come le verruche, mentre altre sono responsabili di tumori, tra cui il carcinoma della cervice uterina, il tumore dell’ano, della vulva, del pene e alcuni tumori orofaringei.
L’infezione da HPV è estremamente diffusa: si stima che la maggior parte delle persone sessualmente attive la contragga almeno una volta nella vita. Nella maggior parte dei casi l’infezione è asintomatica e transitoria, ma in alcune persone può persistere per anni, aumentando il rischio di trasformazione cellulare e, quindi, di sviluppo tumorale. Il vaccino contro l’HPV è un’opportunità straordinaria per prevenire queste patologie. Funziona stimolando il sistema immunitario a riconoscere e neutralizzare il virus prima che possa infettare le cellule. Se somministrato prima dell’inizio dell’attività sessuale – motivo per cui è raccomandato attorno ai 12 anni – offre una protezione altamente efficace, con una riduzione significativa del rischio di sviluppare tumori HPV-correlati in età adulta. Dopo i 12 anni, la vaccinazione è comunque raccomandata per ridurre il rischio di infezione.
DI COPERTURA VACCINALE
L’obiettivo dell’OMS è l’eliminazione del carcinoma della cervice uterina attraverso un’ampia copertura vaccinale, in modo da bloccare la circolazione del virus. Tuttavia, i dati italiani mostrano una situazione lontana da questa prospettiva. La copertura vaccinale completa per HPV tra le ragazze nate nel 2010 si attesta intorno al 40%, ben distante dal target del 95% auspicato per garantire una protezione efficace della popolazione. Ancora più critica è la situazione tra i ragazzi, con percentuali inferiori e un divario significativo rispetto alle coetanee. Questo dato evidenzia non solo un problema di adesione alla vaccinazione, ma anche una persistente percezione errata del virus come un rischio esclusivamente femminile, nonostante sia responsabile anche di tumori orofaringei, anali e del pene nei maschi. Il calo delle vaccinazioni pediatriche è un fenomeno complesso e multifattoriale, che riguarda molti
Solo il 40% delle ragazze nate nel 2010 è vaccinato contro
l'HPV, ben distante dall'obiettivo del 95%
Paesi, non solo l'Italia. Non è riconducibile a una singola causa, quanto piuttosto all'interazione di diversi fattori. Tra questi c’è senza dubbio la scarsa percezione del rischio delle malattie prevenibili: le vaccinazioni pediatriche hanno avuto così tanto successo che le malattie contro cui proteggono sono diventate invisibili. Molti genitori non hanno mai visto un caso di morbillo grave, di difterite o di poliomielite. Questo porta a una percezione distorta: il vaccino viene percepito come un intervento potenzialmente rischioso, mentre la malattia, ormai rara, sembra un pericolo astratto. Il risultato è un paradosso: proprio il successo delle vaccinazioni ha reso più difficile convincere le persone della loro necessità.
Per invertire il calo delle vaccinazioni pediatriche, è fondamentale migliorare la comunicazione scientifica con informazioni chiare e accessibili, semplificare l’accesso ai vaccini riducendo le barriere logistiche e burocratiche, riportare la prevenzione al centro del dibattito pubblico e contrastare attivamente la disinformazione, investendo nell’alfabetizzazione scientifica fin dalla scuola. Il calo delle vaccinazioni pediatriche è un campanello d’allarme che non possiamo ignorare. Ogni punto percentuale perso nelle coperture si traduce in nuove vulnerabilità per la salute pubblica. Non possiamo permetterci di abbassare la guardia.


vengano aggiustate, ma il DNA dei telomeri non riesce a essere riparato” spiega d’Adda di Fagagna. “Il segnale rimane attivo in modo permanente e la cellula può bloccarsi in uno stato di senescenza.” Si tratta di una condizione del tutto nuova per le cellule, che smettono di replicarsi e iniziano a rilasciare una serie di proteine chiamate SASP. “Paradossalmente, la senescenza interrompe la proliferazione delle stesse cellule, ma stimola la crescita di quelle circostanti” commenta il ricercatore. La conseguenza è che si crea un ambiente favorevole alla formazione dei tumori. Invecchiando, le cellule senescenti si accumulano e aumentano le probabilità che insorga la malattia, ma queste condizioni non sono ancora sufficienti perché si sviluppi. Nella maggior parte dei casi, infatti, i tumori sono causati dalla combinazione di diversi elementi predisponenti. Nel caso di un paziente anziano con molte cellule senescenti e telomeri corti, la patologia può essere innescata dall’inserimento di una mutazione genetica, per esempio del gene TP53, che favorisce la crescita delle cellule. “I telomeri
"I telomeri possono divenire un motore di instabilità nel genoma. Possono fondersi con altri cromosomi e promuovere la formazione di alterazioni nel DNA"
possono così diventare un ulteriore motore di instabilità nel genoma. Si possono fondere con altri cromosomi e promuovere la formazione di alterazioni nel DNA” continua d’Adda di Fagagna. “In questo modo, viene favorita la selezione dei cloni più capaci di proliferare e resistenti alle terapie.” Per continuare a crescere, le cellule tumorali possono anche modificare la regolazione dei telomeri a proprio vantaggio, utilizzando due strategie. Quasi la totalità dei casi attiva la telomerasi, un enzima che allunga le estremità dei telomeri e aumenta il numero di replicazioni a cui possono andare incontro. Una minoranza –che riguarda circa un caso ogni 10 –sfrutta un metodo basato sulla ricombinazione del DNA, detto Alternative Lengthening of Telomeres (ALT). Se per la prima tipologia di tumori è stata approvata nel 2024 una terapia mirata dalla Food and Drug Administration (FDA), l’ente statunitense per la regolazione dei farmaci, per le neoplasie ALT non sono ancora disponibili trattamenti specifici. Il gruppo di ricerca di d’Adda di Fagagna lavora proprio per individuare nuove applicazioni terapeutiche per questa categoria che, seppur sia una minoranza nel complesso delle patologie oncologiche, costituisce gran parte dei glioblastomi e osteosarcomi.
“Qualche anno fa, siamo riusciti a individuare una vulnerabilità per i tumori ALT” afferma il ricercatore riferendosi ai risultati di uno studio pubblicati sulla rivista Nature Communications nel 2023. Il gruppo di ricerca ha scoperto che, per allungare i telomeri e continuare a proliferare, queste neoplasie hanno bisogno di
particolari RNA chiamati dilncRNA (da damage-induced long-non coding RNAs). “Abbiamo provato a inibire queste molecole in alcune linee di cellule tumorali ALT e abbiamo visto che morivano, perché non riuscivano più a mantenere i telomeri” spiega d’Adda di Fagagna. Negli ultimi due anni, il gruppo ha lavorato per sviluppare una terapia combinata: “Attraverso numerosi esami di screening, siamo riusciti a identificare una classe di farmaci antitumorali adatta. Adesso stiamo studiando una nuova combinazione terapeutica tra questi medicinali e gli inibitori degli RNA telomerici che abbiamo testato nello studio precedente”.
IFOM, l’Istituto di oncologia molecolare di AIRC, è un centro di ricerca di eccellenza internazionale dedicato allo studio della formazione e dello sviluppo dei tumori a livello molecolare, nell’ottica di un rapido trasferimento dei risultati scientifici dal laboratorio alla cura del paziente. Fondato nel 1998 a Milano da Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro, che da allora ne sostiene lo sviluppo, IFOM oggi può contare su 269 ricercatori di 25 diverse nazionalità, e si pone l’obiettivo di conoscere sempre meglio il cancro per poterlo rendere sempre più curabile.

Il cambiamento climatico sembra
avere un impatto anche sul cancro, per via degli inquinanti atmosferici e dei danni degli eventi climatici estremi
problemi respiratori. Il cambiamento climatico sembra avere un impatto anche sul cancro, sia direttamente, per esempio perché favorisce la diffusione di sostanze cancerogene nell'aria, sia indirettamente, perché gli eventi climatici estremi possono ridurre la possibilità di accesso agli esami e alle cure.
L’inquinamento dell’aria è legato a doppio filo con la crisi climatica. Da un lato, ne è una causa, perché favorisce l’aumento delle temperature medie: alcuni gas inquinanti che si accumulano nell’atmosfera intrap-
polano il calore sulla superficie terrestre, come avviene nelle serre (da cui le espressioni “gas serra” ed “effetto serra”). Dall’altro, il cambiamento climatico alimenta l’inquinamento atmosferico, per esempio perché favorisce gli uragani, che possono distruggere impianti industriali e quindi liberare nell’ambiente composti come le diossine, e gli incendi, che liberano benzene, idrocarburi policiclici aromatici e altri inquinanti. È quanto si è visto a inizio 2025 con gli incendi che hanno devastato la zona di Los Angeles, in California. Anche se gli incendi boschivi sono fenomeni normali in aree ricche di alberi e arbu-
sti soggette a lunghi periodi di caldo, diversi studi mostrano che il cambiamento climatico e la siccità che porta con sé in alcune zone del mondo rendono eventi di questo tipo di circa 3 volte più frequenti in Canada e quasi 30 volte più frequenti in Amazzonia. E si stima che, se le emissioni di gas serra dovessero aumentare ancora, entro la fine del secolo gli incendi boschivi potrebbero diventare oltre 10 volte più frequenti di oggi. Gli inquinanti atmosferici possono compromettere la qualità dell’aria per mesi o persino anni, comportando danni a lungo termine all’ambiente – e anche alla salute. Come riporta l’Organizzazione mondiale della sanità, circa il 99% della popolazione mondiale vive in aree con livelli di inquinanti dell’aria non sicuri. Un effetto importante riguarda l’incremento del rischio di tumore al polmone, anche se l’abitudine al fumo resta la causa dell’85-90% dei casi di carcinoma polmonare, oltre ad aumentare il rischio di almeno altri 11 tipi di neoplasie. Uno studio pubblicato
su The Lancet Respiratory Medicine, che ha considerato i dati sui tumori polmonari in 185 Paesi, ha mostrato che i casi di cancro del polmone non associati al fumo sono in ascesa, principalmente tra le donne e in popolazioni asiatiche. Gli autori hanno sottolineato che tra le cause potrebbe esserci proprio l’aumento di sostanze inquinanti in atmosfera.
UN VASTO IMPATTO
Il riscaldamento globale imputabile alle attività umane intensifica l’esposizione a fattori di rischio oncologici in molti altri modi. Per esempio, favorendo le inondazioni, dal momento che si stima abbia aumentato di quasi il 20% l’intensità e la frequenza delle precipitazioni. I danni delle alluvioni includono la distruzione di industrie, raffinerie di petrolio e altri siti dove sono presenti anche sostanze cancerogene, che l’acqua può portare nelle aree abitate. È proprio quanto è accaduto, per esempio, con la tempesta seguita all’uragano Florence, che ha colpito il North Carolina, negli Stati Uniti, nel settembre del 2018.
La crisi climatica può aumentare il rischio di cancro anche a causa del suo impatto sulle diete. Infatti, secondo alcune stime pubblicate nel 2016 sulla rivista The Lancet, entro il 2050 i cambiamenti climatici potrebbero ridurre la disponibilità di alimenti del 3,2%, e in particolare del 4% quella di frutta e verdura. Ciò comporterebbe oltre 500.000 decessi, dovuti principalmente al fatto che sarebbe favorita un’alimentazione poco salutare, con un incremento dei casi di malattie cardiovascolari e di cancro. Inoltre, il cambiamento climatico può favorire la proliferazione di microrganismi associati all’insorgenza di alcuni tipi di tumore. Per esempio, ad alte tem-
perature le coltivazioni di mais e di altre colture alimentari sono più di frequente contaminate da muffe che liberano aflatossine, sostanze che aumentano il rischio di sviluppare il cancro del fegato.
Le variazioni climatiche contribuiscono infine anche all’assottigliamento dello strato di ozono in atmosfera e alla riduzione della copertura nuvolosa, aumentando così l’esposizione ai raggi ultravioletti, noti per essere un fattore di rischio per il melanoma e altri tumori della pelle.
Per prevenire, diagnosticare e trattare i tumori occorrono risorse adeguate, come l’elettricità e le giuste terapie. Per questo i pazienti oncologici sono tra le popolazioni più vulnerabili ai danni degli eventi climatici estremi. Per esempio, nel 2018 in Porto Rico l’uragano Maria colpì diverse infrastrutture, rendendo inutilizzabili alcuni macchinari per la radioterapia e compromettendo uno stabilimento che produceva molte delle sacche utilizzate negli Stati Uniti per la somministrazione di medicinali. Di conseguenza, non solo molti pazienti oncologici portoricani non si poterono curare adeguatamente, ma anche molti pazienti statunitensi, perché diversi centri USA non riuscirono a rifornirsi di antibiotici e altri farmaci necessari per le terapie. Allo stesso modo, gli eventi meteorologici estremi possono ritardare le diagnosi di tumore, per esempio causando problemi nei laboratori di analisi. Fenomeni del genere possono ridurre la sopravvivenza dei pazienti, come ha mostrato uno studio pubblicato nel 2019 sulla rivista JAMA. I ricer-
Consumare più legumi e verdure
e meno carne può contribuire a contrastare il cambiamento climatico e ridurre il rischio di tumore
catori hanno confrontato i dati di pazienti con cancro del polmone non a piccole cellule (NSCLC), trattati con radiazioni. Per 1.934 di loro la terapia era stata interrotta a causa di un ciclone. Rispetto ad altri 129.080 pazienti che avevano completato la stessa cura senza interferenze di catastrofi naturali, i primi avevano ricevuto un trattamento prolungato; ciononostante, la loro sopravvivenza era più breve in media di 2 mesi rispetto agli altri pazienti. Lo svantaggio aumentava se il disastro ambientale era durato più a lungo.
Nell’ultimo secolo le morti dovute a disastri ambientali sono diminuite di quasi 10 volte, passando da circa 500.000 ogni anno tra il 1920 e il 1930 a circa 38.000 nel 2020. Questo anche grazie a interventi nazionali e internazionali come il monitoraggio dei fenomeni ambientali e il coinvolgimento delle popolazioni affinché segnalino eventuali servizi di assistenza, sociali o sanitari da soddisfare per limitare i danni delle catastrofi naturali. Cosa possiamo fare per prevenire il problema della crisi climatica? Oltre 100 Paesi oggi sono impegnati per ridurre l’impatto ambientale e il riscaldamento globale che ne consegue, ma secondo le previsioni di questo passo l’Europa raggiungerà la neutralità climatica solo nel 2100. I governi, quindi, dovranno agire subito e in modo più incisivo per minimizzare il problema. Anche a livello individuale possiamo fare qualcosa. Peraltro, molte azioni sostenibili coincidono anche con abitudini salutari, che aiutano a prevenire il cancro: per esempio, preferire i mezzi pubblici, la bici o gli spostamenti a piedi alle automobili riduce le emissioni di gas serra e contribuisce a contrastare la sedentarietà, che è un fattore di rischio per alcuni tipi di cancro. Anche portare in tavola più legumi e verdure e meno carne può aiutarci sia a tenere sotto controllo le emissioni di gas serra, contenendo i cambiamenti climatici, sia a ridurre il rischio di tumore, perché i vegetali, nostri preziosi alleati nella prevenzione oncologica, sono gli alimenti meno impattanti dal punto di vista ambientale.
In questo articolo:
— MELANOMA
— TUMORE DEL COLON-RETTO
— TUMORE DEL FEGATO

a cura di Camilla Fiz e Denise Cerrone

Alcune persone con melanoma reagiscono meglio all’immunoterapia con inibitori dei checkpoint immunitari anche perché nel loro microbiota sono presenti alcuni peptidi, detti FLach. Lo dicono i risultati di uno studio pubblicati sulla rivista Cell Host & Microbe, che contribuiscono anche a chiarire perché l'immunoterapie che usa gli inibitori dei checkpoint immunitari è una cura valida per molti, ma non tutti, i pazienti con melanoma che non possono ricorrere alla rimozione chirurgica del tumore. “Abbiamo bisogno di capire quali casi hanno maggiori o minori probabilità di rispondere all’immunoterapia” afferma Luigi Nezi, che ha coordinato il gruppo di ricerca presso l’Istituto europeo di oncologia (IEO) a Milano, grazie al sostegno di AIRC. Queste informazioni potrebbero permettere di evitare di trattare pazienti che potrebbero non rispondere
e invece essere soggetti a effetti collaterali anche importanti.
Il gruppo di ricerca coordinato da Luigi Nezi ha ipotizzato un ruolo per il microbiota intestinale, l’insieme di microrganismi che vivono nel nostro intestino. Oltre a regolare il metabolismo e numerose funzioni biologiche, è sempre più riconosciuta la sua capacità di influenzare l’attività del sistema immunitario e la risposta all’immunoterapia. Nel 2017, mentre stava svolgendo un post-dottorato all’MD Anderson Cancer Center, negli Stati Uniti, Nezi ha partecipato a un importante studio sullo stesso tema. “Abbiamo osservato che il microbiota intestinale dei pazienti con melanoma conteneva alcuni elementi che favorivano la risposta del tumore all’immunoterapia” afferma il ricercatore. Negli anni successivi questi risultati sono stati confermati grazie ad altri studi clinici, senza che però si riuscisse a compren-

Un team di ricercatori dell’Università di Stanford ha sviluppato e descritto su Nature un modello di intelligenza artificiale in grado di prevedere l’evoluzione di alcune forme di cancro e la risposta dei pazienti all'immunoterapia nei tumori polmonari e gastroesofagei. Sebbene il modello non sia ancora pronto per l'uso clinico, rappresenta una grande promessa per il futuro della medicina di precisione. Il modello si chiama Multimodal Transformer with Unified maSKed modeling (MUSK) ed è stato addestrato su oltre 50 milioni di immagini istopatologiche e un miliardo di token testuali provenienti da referti clinici. La sua funzione principale è quella di prevedere la prognosi oncologica integrando dati visivi e linguistici, un approccio che rispecchia quello utilizzato dai medici oncologi, i quali attingono a più fonti per prendere decisioni terapeutiche informate.
MUSK si differenzia così da altri modelli di intelligenza artificiale in oncologia, che tradizionalmente trattano i dati da diverse fonti in modo separato.

LA
Un gruppo di ricercatori del King's College di Londra e dell'Università di Washington ha recentemente identificato e descritto sulla rivista Proceedings of the National Academy of Sciences una proteina batterica precedentemente sconosciuta, che potrebbe aprire nuove strade nella somministrazione mirata di farmaci antitumorali. La proteina, chiamata BeeR, appartiene a una famiglia di batteri che si trovano nel terreno e nel microbioma intestinale umano e possiede una struttura unica che presenta una cavità centrale. Questo la differenzia dalle proteine a struttura filamentosa come l'actina, che normalmente si trovano nelle cellule umane. Grazie alla capacità della sua struttura di assemblarsi e scomporsi facilmente in presenza di ATP, BeeR offrirebbe un mezzo controllabile per il rilascio mirato dei farmaci direttamente nelle aree tumorali. Il team di ricercatori, attraverso lo spin-off Prosemble, sta ora testando l'efficacia di questo approccio in modelli preclinici di cancro al seno. In futuro, BeeR potrebbe consentire di migliorare significativamente l'efficacia e la precisione dei trattamenti, riducendo gli effetti collaterali legati alla somministrazione sistemica dei farmaci.
BeeR potrebbe consentire di migliorare l'efficacia e la precisione delle terapie
Consigli per i pazienti
Alimentazione durante le cure

In questo articolo:
— MALNUTRIZIONE PER DIFETTO
— EFFETTI COLLATERALI DELLE TERAPIE
— INTEGRAZIONE DELLA DIETA
Nel corso delle cure, è bene che le indicazioni sull’alimentazione siano personalizzate per assecondare esigenze e gusti di ogni paziente. Senza trascurare (quando necessario) il ricorso ai supporti nutrizionali
cura
Mangiare in maniera varia ed equilibrata è importante non soltanto per ridurre le probabilità di ammalarsi di cancro. La dieta ha un valore significativo anche se si è già intrapreso un percorso di cure oncologiche. Oltre che possibile spia di una malattia non ancora diagnosticata, la perdita di peso è infatti frequente anche nel corso delle diverse fasi terapeutiche che un paziente è chiamato ad affrontare. Sono ormai decine gli studi che lo confermano: se particolarmente accentuata, la malnutrizione e il conseguente calo ponderale possono limitare la risposta alle terapie e condizionare la prognosi. Ma – sempre grazie alla ricerca scientifica – oggi sappiamo come intervenire per limitare questo problema.

“Mai come in questa situazione, per nutrirsi è richiesto un impegno ulteriore ai pazienti oncologici” afferma Riccardo Caccialanza, direttore della Struttura complessa di dietetica e nutrizione clinica dell’IRCCS Policlinico San Matteo di Pavia. “Ciò significa, per i caregiver, dover programmare la spesa e i pasti in modo diverso dal solito. E avere pazienza, perché, pur conoscendo i gusti di una persona, si possono ricevere dei rifiuti che inizialmente appaiono inattesi.” La priorità è evitare la malnutrizione per difetto, quindi uno stato di magrezza eccessiva, che può comparire soprattutto nel corso del trattamento o nel periodo immediatamente successivo. In particolare, chemioterapia e radioterapia sono tra i protocolli di cura che più di frequente determinano una perdita di appetito.
Dal punto di vista pratico, ci sono alcuni accorgimenti che si possono adottare per agevolare un malato di cancro a seguire una dieta bilanciata. Ai pazienti oncologici si con-
Ai pazienti oncologici si consiglia di mangiare poco ma spesso, tenendo sempre a portata di mano qualcosa da sgranocchiare
DIFFICILE ALIMENTARSI
Sapere come muoversi in queste situazioni è il primo passo per garantire – a se stessi o a una persona malata vicina – una dieta adeguata. Durante il percorso di cura per una malattia oncologica, anche un gesto naturale ed essenziale come alimentarsi può costituire un problema. Quando si presenta un tumore – per effetto diretto della malattia o come conseguenza degli effetti collaterali delle terapie – il metabolismo può cambiare. Inappetenza e dimagrimento sono sintomi spesso descritti dai pazienti oncologici.
siglia di mangiare poco ma spesso, tenendo sempre a portata di mano qualcosa da sgranocchiare. E di farlo lentamente, masticando bene e riposando dopo ogni pasto. Se l’appetito è buono, non dovrebbe essere difficile assumere adeguate quantità di cibo. Al contrario, se è scarso, si può optare per alimenti più ricchi in calorie e proteine, così da garantire un apporto congruo di nutrienti attraverso un numero inferiore di pasti. Ragion per cui, in questi casi, si possono sostituire piccoli pasti con bevande nutrienti o saporite. Consigli che nei mesi scorsi il World Cancer Research Fund ha riepiloga-
to in una guida destinata ai pazienti oncologici. Tra gli alimenti da prediligere, gli esperti raccomandano il consumo di cereali integrali, legumi ben cotti (anche in crema), pesce (meglio se azzurro), verdure di stagione, frullati e spremute (in assenza di altre controindicazioni). Da limitare invece il ricorso a carni rosse e lavorate (salumi, insaccati) e formaggi molto grassi, mentre è bene prestare attenzione all’eccessivo consumo di alimenti ricchi di amido (in particolari quelli a base di frumento, patate, mais) composti da zuccheri semplici. Meglio evitare infine alimenti fritti o caratterizzati da un forte odore, cereali cotti al forno e bevande dolci.
“Ci sono poi altre indicazioni” aggiunge l’esperto “che vengono fornite sulla base dei bisogni del singolo paziente, per fronteggiare la comparsa di effetti collaterali quali la nausea e il vomito: suddividere i pasti in 5-6 spuntini, offrire del cibo a temperatura ambiente o comunque mai bollente, bere soprattutto lontano dai pasti e non trascurare l’apporto di micronutrienti attraverso il consumo di frutta e verdura.” Il consiglio, in ogni caso, è quello di personalizzare l’approccio. “Tenere conto delle preferenze di chi sta affrontando un percorso di cure oncologiche è un aspetto non meno importante” chiarisce Caccialanza. “Nell’ambito di ciò che può essere offerto loro, basarsi sulle preferenze personali in una fase in cui si possono registrare nausea, alterazioni del gusto e dell’olfatto può fare la differenza nell’accettazione o meno di un piatto.”
Fatte queste considerazioni, una dieta di tipo mediterraneo risulta comunque sempre la più indicata, anche per il suo effetto antinfiammatorio. Da evitare invece qualsiasi estremismo, dal ricorso al veganesimo all’assunzione di integratori senza indicazioni di uno specialista.
Testimonianze
Sostenitori 5 per mille
Scegli AIRC per il tuo 5 per mille inserendo nello spazio per la ricerca scientifica il codice fiscale 80051890152, e scopri i risultati che abbiamo raggiunto grazie al tuo sostegno su programmi5permille.airc.it


a cura della redazione
Quasi 6 contribuenti su 10, circa 25 milioni di persone, non esprimono una volontà sull’organizzazione cui destinare il proprio 5 per mille. Nel periodo dell’anno in cui gli italiani compilano la dichiarazione dei redditi, soprattutto a loro è rivolto il pensiero di Deborah (50 anni) e Claudio (36), che da anni destinano le rispettive quote delle loro imposte ad AIRC (oltre a impegnarsi come volontari nelle iniziative di piazza). “È l’unione a fare la forza.”
LA RICERCA PER LA
PREVENZIONE E LA CURA DEI TUMORI
Deborah e Claudio hanno già alle spalle l’esperienza di una malattia oncologica. Nel primo caso, un tumore del rene diagnosticato nel 2023. Nel secondo, una neoplasia del testicolo (2017). “Non crediamo quasi mai di poter entrare personalmente in questo tunnel, ma quando accade ci accorgiamo di tutti i benefici della ricerca” racconta Deborah, maestra della scuola dell’infanzia. “C’è un altro aspetto che dovrebbe convincere chi è ancora scettico. Fondazione AIRC non lavora soltanto per chi è già alle prese con tumore, ma, attraverso l’impegno nella divulgazione, mette a disposizione di tutti le raccomandazioni per condurre una vita sana e ridurre il rischio di ammalarsi di cancro.” Un pensiero corroborato
da quello di Claudio. “Oggi è difficile trovare una famiglia che non sia stata toccata dal cancro” afferma. “Inoltre, la ricerca non significa solo cure più efficaci, ma partecipa al benessere della società, in tutte le sue forme. E la prevenzione, che Fondazione AIRC promuove e sostiene quotidianamente attraverso vari canali, è in molti casi la chiave più efficace per non ammalarsi.”
5 PER MILLE: UNA FIRMA PER SOSTENERE LE CAUSE CHE AMIAMO
La scelta di destinare il proprio 5 per mille a una causa che ci sta a cuore, come la ricerca sul cancro di AIRC, non comporta nessuna maggiorazione d'imposta. In fase di compilazione della dichiarazione dei redditi, se si decide di non spuntare l’apposito riquadro, la quota rimane nelle casse dello Stato. "Agli scettici, dico: dedicate dieci minuti a informarvi su come AIRC investe i fondi ricevuti” si raccomanda Deborah. “A chi mi dice che sempre più persone si ammalano di cancro, ricordo che l’aumento dei casi è frutto anche della ricerca” chiosa Claudio. “Infatti, questo aumento dipende anche da una capacità diagnostica più accurata e precoce, che consente di aumentare la probabilità di guarigione. Per alcuni tumori c’è ancora tanto lavoro da fare. Ma quale altra ragione, in fondo, dovrebbe convincere ognuno di noi a fare la propria parte?”
Collaborazioni
a cura della redazione
Nel mese di maggio, in occasione della Festa della mamma, si è svolta la 41a edizione dell’Azalea della Ricerca di Fondazione AIRC, con l'obiettivo di raccogliere fondi per la ricerca sui tumori che colpiscono le donne e sensibilizzare il pubblico sull'importanza della prevenzione. Grazie anche ai progetti finanziati da AIRC nei suoi 60 anni di storia, in Italia, due donne su tre sono vive cinque anni dopo la diagnosi di cancro. Tuttavia, è ancora prioritario sostenere medici e ricercatori per rendere curabili tutti i tumori femminili, cercando cure più efficaci e meno invasive, e restituendo alle pazienti i loro sogni e progetti di vita. Quest'anno, i volontari AIRC sono tornati in oltre 3.900 piazze italiane per raccogliere fondi attraverso la distribuzione delle iconiche piantine di azalea, simbolo della salute femminile. Oltre ai volontari, un ringraziamento speciale va alle aziende partner che hanno contribuito al successo dell'iniziativa e che supportano la ricerca sui tumori femminili, aiutando AIRC a diffondere i messaggi

di prevenzione. Banco BPM, partner istituzionale, ha rinnovato il suo impegno per favorire la divulgazione scientifica e coinvolgere il pubblico nel sostegno alla ricerca, con iniziative che riflettono una visione più ampia di responsabilità sociale d'impresa. Le reti Imprese Retail e Corporate di Banco BPM si sono attivate per mobilitare ulteriormente le aziende clienti a supporto della ricerca. Molte aziende hanno scelto di sostenere gli studi sui tumori femminili insieme ad AIRC, con contributi concreti destinati a progetti e borse di studio. Dolomia, brand di Unifarco, ha donato 25.000 euro per finanziare la borsa di studio della ricercatrice Laura Formenti sul tumore ovarico, contribuendo al progresso delle terapie. Gillette Venus, con la campagna Cura il visibile. Proteggiti dall’invisibile, sta co-finanziando il progetto di Alessandra Soriani sul tumore della cervice uterina. Maire ha destinato 25.000 euro alla borsa di studio assegnata ad Angelo Velle, impegnato in un progetto di ricerca sul tumore ovarico. Melinda ha finanziato una borsa
di studio con una donazione minima di 25.000 euro e, nei mesi di aprile e maggio, devolverà 0,10 euro ad AIRC per ogni vassoio di mele Renetta venduto in Esselunga, Tigros e Iperal. Anche quest'anno Mitsubishi Electric ha rinnovato il suo impegno come partner dell’iniziativa Azalea della Ricerca, finanziando con 25.000 euro una nuova borsa di studio sui tumori che colpiscono le donne. Infine, Stroili ha contribuito con 25.000 euro, permettendo di bandire una nuova borsa di studio sui tumori femminili, destinata a un giovane ricercatore o una giovane ricercatrice che inizierà il suo lavoro nel 2026. A queste aziende si aggiungono numerose realtà imprenditoriali italiane che hanno scelto le piantine di azalea AIRC per omaggiare dipendenti e clienti, organizzare un punto di distribuzione in azienda o coprire i costi delle azalee distribuite dai volontari nelle piazze, aumentando l’impatto per la ricerca. Una grande rete di imprese, che si è attivata in diversi modi per rispondere a un importante obiettivo comune: affrontare il cancro, insieme.