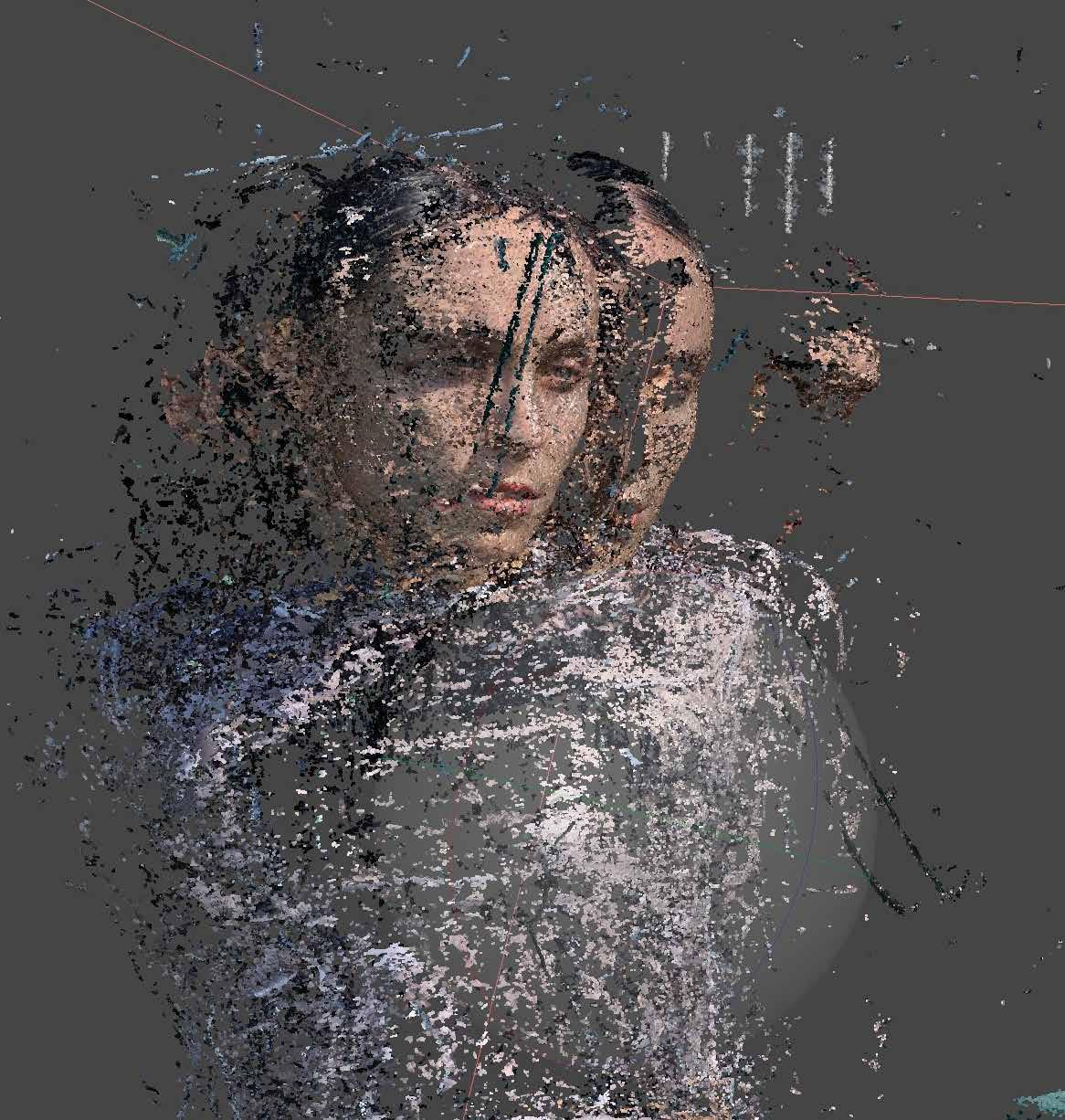


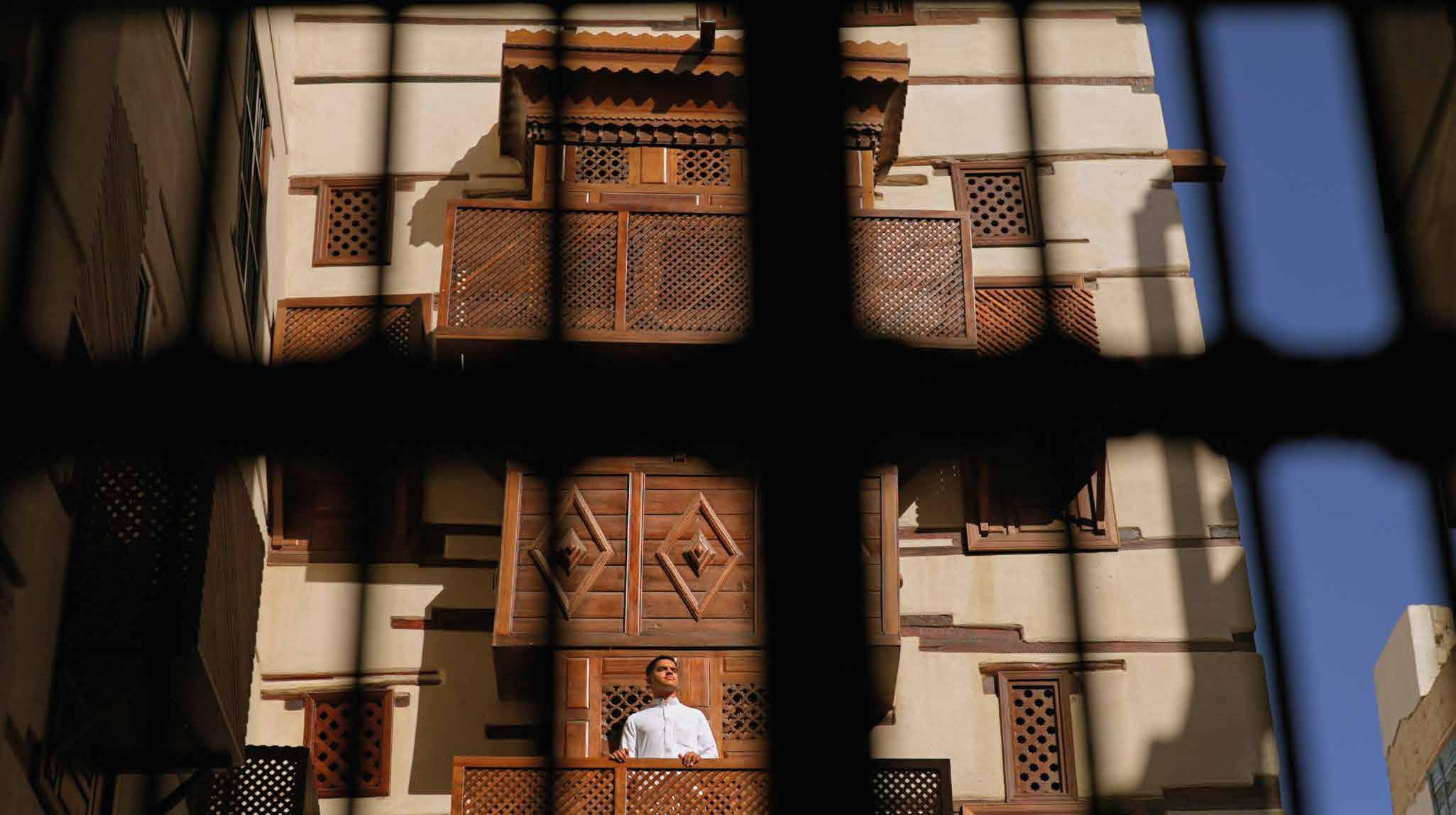
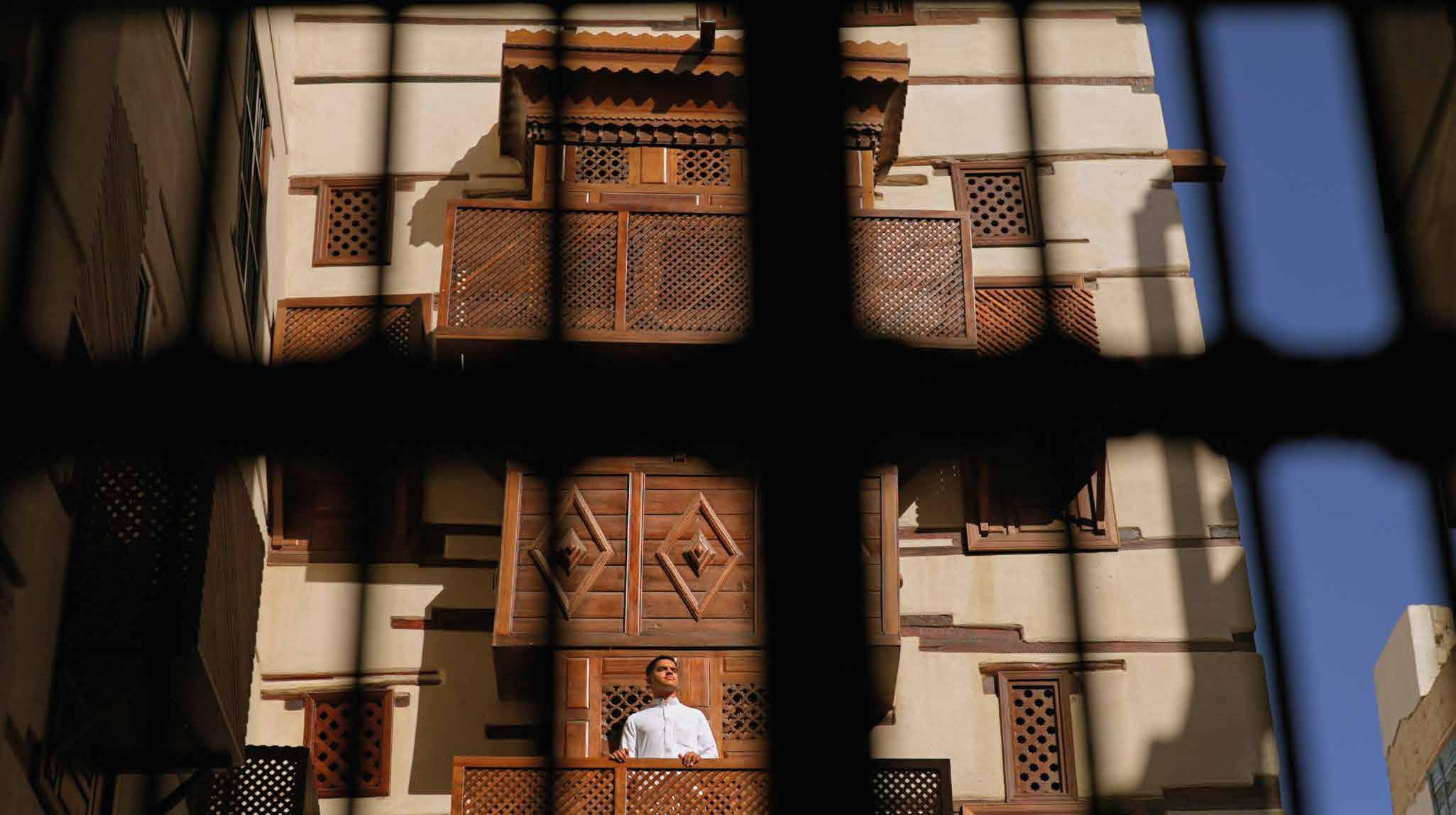






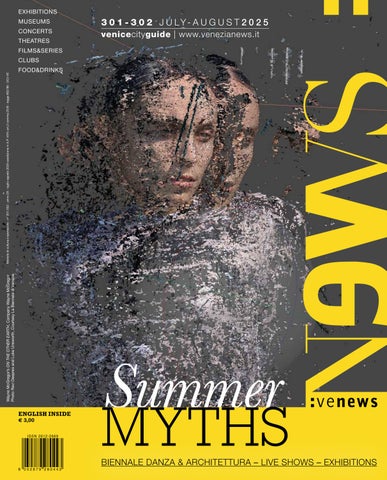
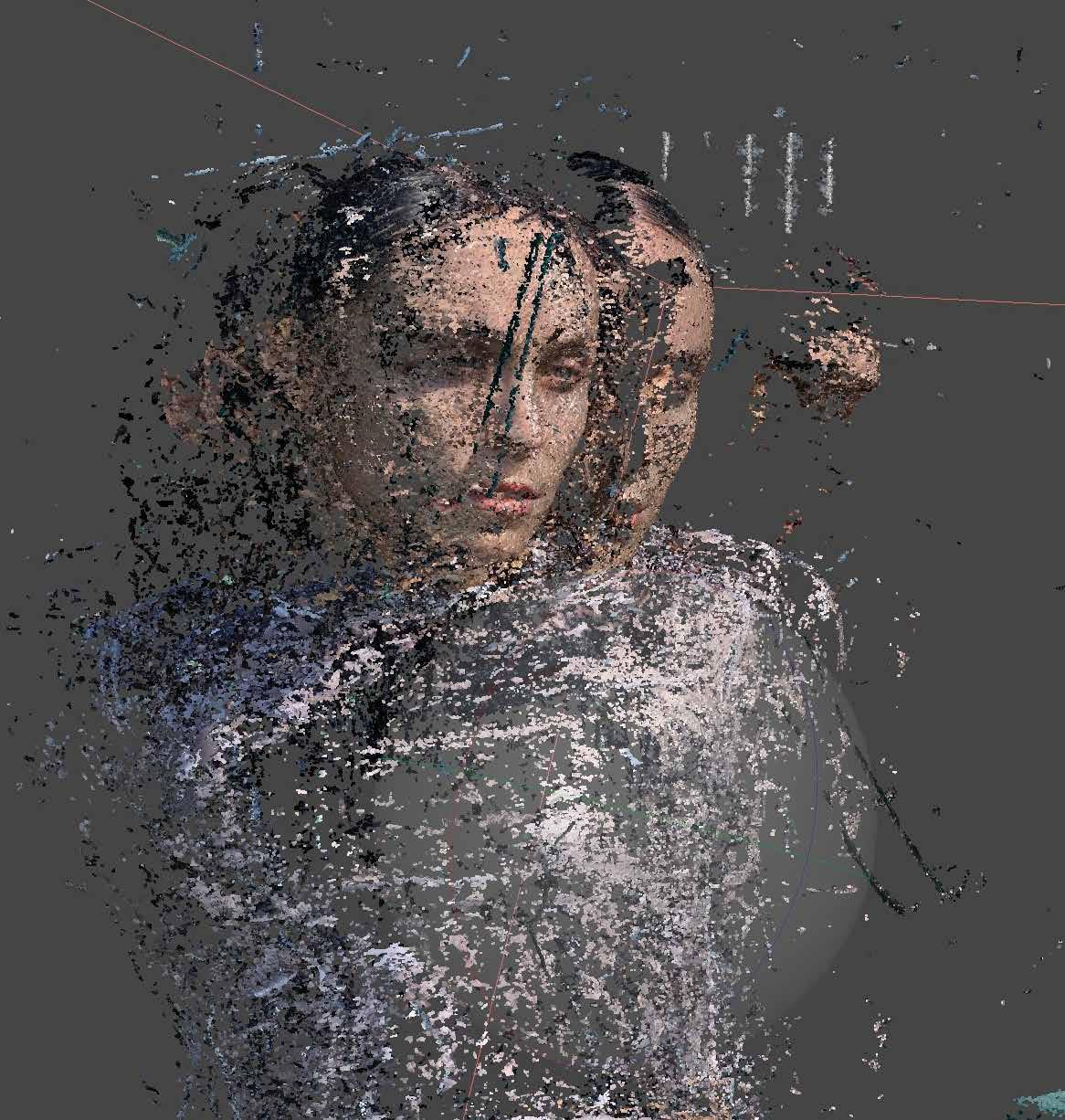


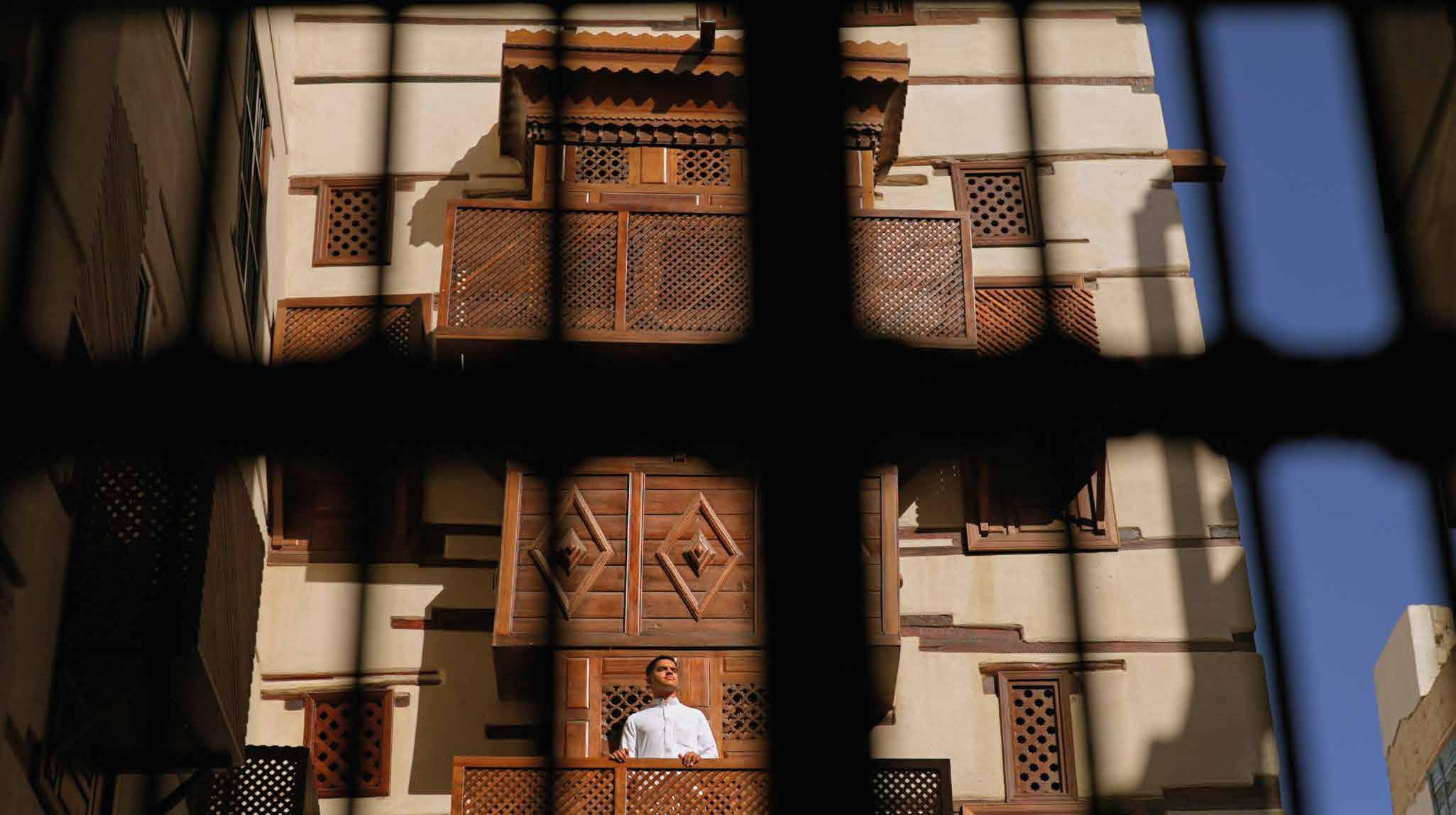
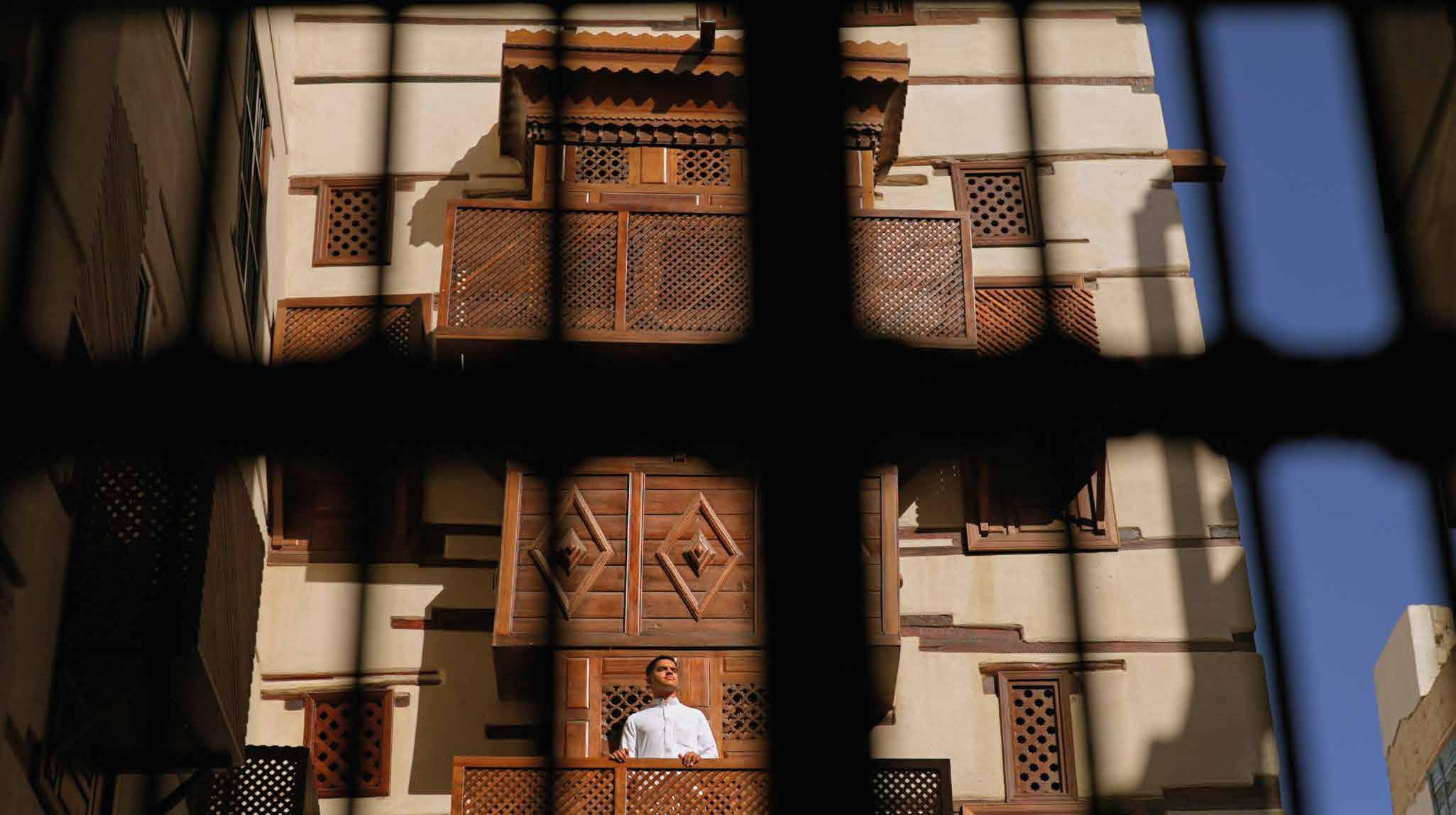






di Massimo Bran
Il dato curioso, e verrebbe da dire penoso nei suoi esiti odierni, di questo nostro convulso tempo, il suo tratto insieme più assurdo e temibile, sta tutto in un impasto di sapori apparentemente inconciliabili che vanno a definire un pastiche di fatto indigeribile, contorcendo anime e stomaci di chi non sa arrendersi alla destrutturazione caotica di qualsivoglia pietanza commestibile. Tutto si mescola, si affastella, si confonde in un piano orizzontale in cui risulta sempre più vano qualsiasi sforzo di riportare un po’ di ordine, di sano raziocinio, al fine di ricomporre una direzione dotata di senso logico in cui gli elementi, gli ingredienti della vita trovino ciascuno a proprio modo e per la rispettiva funzione una determinata collocazione, un proprio utilizzo razionale. Una destrutturazione che si registra nella vita di tutti i giorni e a tutte le scale, da quella di condominio a quella della White House, sempre più dorata e cafonal, a dire il vero, che white. Chi ha una certa età, diciamo almeno dai 40 in su, ma forse anche dai 50 in poi, è stato abituato a crescere, a formarsi in percorsi in qualche modo mandati a memoria, con delle gerarchie nella trasmissione dei saperi, fossero essi di studio o dei mestieri, fondate sull’esperienza, sulla costruzione di una conoscenza progressiva che nel suo consolidarsi richiedeva pazienza, tempi lunghi, respiro ampio. Gerarchie che certo potevano apparire ai più giovani asfissianti e che a un certo punto sono state radicalmente messe in discussione se non proprio demolite, vedi in quei fin troppo mitizzati anni ‘60 che ad ogni modo hanno prodotto un’autentica rivoluzione nel costume e nell’architettura dei ruoli sociali più che sul terreno politico, il cui portato odora di vecchio da tempo immemore. Eppure, dopo ogni sommovimento anche tellurico come quello del ‘68, queste stesse gerarchie, naturalmente con delle grammatiche radicalmente rinnovate, tornavano poi a ricomporsi, perché dopo la sbornia del 6 politico non si riusciva a trovare via di uscita alternativa alla vecchia, per quanto rinnovata nelle sue fondamenta relazionali, progressiva trasmissione del sapere in cui l’esperienza, la formazione non conoscevano scorciatoie temporali. Una società uscita rinnovata in molte sue sembianze, assorbiti gli scossoni sovversivi prodotti dalle sue componenti più fresche e vitali, non poteva però rinunciare alla sua costitutiva vocazione progettuale della vita fondata su un’idea di prospettiva, di orizzonte largo, da disegnare pianificando, mi si passi il termine ammuffito e lessicalmente quasi inservibile, le varie tappe necessarie a costruire un edificio esistenziale, professionale, imprenditoriale. E politico. Sì, perché proprio alle entità politiche preposte alla mediazione sociale, con un ruolo di cerniera fondamentale nel legare e armonizzare in una sintesi civile tutte le più disparate istanze provenienti dai diversi strati sociali e dalle diverse fasce generazionali, ossia ai
grandi partiti di massa così come a quelli più piccoli ma vitalmente attivi nel proscenio pubblico, che poi andavano a costruire la classe dirigente, il corpo istituzionale di un Paese, era assegnato il compito di disegnare un percorso di crescita fondato su una visione ampia che guardava al domani e ancor di più al dopodomani, processo indispensabile per dare un senso minimamente compiuto a qualsivoglia atto presente consumato in società. Al netto di tutte le inevitabili contraddizioni, le inadeguatezze, le trame anche oscure che connotavano queste non certe intonse entità organizzative delle compagini sociali, si aveva fino all’altro ieri sempre la sensazione di far parte di un percorso in qualche modo pensato, disegnato, insomma, progettato. Il che infondeva una certa sicurezza nei più, perché era un po’ come farsi condurre in una destinazione lontana da un pilota esperto, professionale, che era lì a svolgere la propria funzione dopo essersi formato a dovere per anni e anni. Un processo che per tempo immemore, ovviamente con modalità radicalmente mutate nel corso dei secoli dalle trasformazioni tecnologiche e sociali nel frattempo prodottesi, è rimasto sostanzialmente nei suoi tratti costitutivi pressoché inalterato, con i padri e le madri a trasmettere ai figli la grammatica della vita in tempi lunghi. Improvvisamente, o quasi, questo processo che sembrava dover essere eterno si è interrotto, sordamente. Game over. Ai tempi necessariamente lunghi del formarsi, del farsi persona, è subentrato un’orizzontalità incapace di leggere oltre al momento consumato qui ed ora. La sconvolgente ed eccitante rivoluzione tecnologica digitale, che come tutti gli epocali sommovimenti radicali della società producono eccessi contrastanti nel bene e nel male, ci ha scaraventato in un’altra dimensione linguistica proprio, in cui per la prima volta nella storia chi nasce apprende le nuove grammatiche della comunicazione sociale in maniera altra e radicalmente più accelerata rispetto alle modalità attraverso le quali vi accedono, se vi accedono, le proprie madri e i propri padri. L’esito non può che essere una frattura nella trasmissione tradizionale del sapere, anche quello più basico e quotidiano. Perché è proprio l’alfabeto delle relazioni a subire un processo di ricodificazione il cui esito, mentre tale processo è nel suo pieno atto, non può che essere il caos, una certa destabilizzazione dei ruoli, delle funzioni, della consapevolezza di quello che dovrebbe essere il senso del proprio agire fino ad ora mandato, per l’appunto, a memoria. In questa marmellata pirotecnica, dove tutto e il suo contrario ha licenza di esistere a stese di post, clic, link (“le parole sono importanti…” diceva qualcuno fino a poco più di ieri) e quant’altro, a saltare per prime sono state proprio le grandi entità di mediazione sociale che avevano esattamente il compito di equilibrare i contrasti esistenti nel mondo del lavoro, delle

professioni, tra le generazioni. Saltate le quali, come in tutte le rivoluzioni vere, si è liberato lo spazio per la semplificazione, l’epurazione di ciò a cui veniva attribuita la responsabilità di tenere costretto un mondo con le sue regole, le sue tavole eterne codificate in ruoli e funzioni immutabili. E quindi via con l’uno vale uno, con la nuova divinità dei social che tutto dice e niente dice e il mondo consuma in un nanosecondo, passando poi a un altro e un altro ancora di mondo, senza più capire in che cazzo di mondo ci si ritrova a vivere. Qui non si tratta di fare i soloni nostalgici, i patetici cantori della vita che fu. Per carità! Facendo magari come i vegan chic, quelli per cui «che bene che si stava una volta che ci si cibava dei prodotti del proprio campetto tutti buoni e naturali», dimenticando che per avere un figlio dovevi farne quattro grazie all’arretratezza scientifica e tecnologica del tempo, a loro dire grande nemica della vita sana (sic). Figuriamoci. Evviva la tecnologia, la ricerca, la genialità scientifica, eccome!
Il problema è un altro, ed è per l’appunto la mediazione. Come trasmettere responsabilmente il sapere in un quadro di innovazione così radicalmente accelerato.
Un quesito per ora senza risposte, perché qualsiasi proposta a riguardo suona alle nostre orecchie oggi come pura utopia, perché di fatto inservibile. Si chiederebbe però almeno in chi ricopre ruoli apicali di attivare di tanto in tanto i neuroni della memoria, ricordandosi di come le funzioni di governo di una società, di paesi grandi e piccoli, venivano assecondate da persone guidate da un senso di
responsabilità che era il requisito primo richiesto a chi questi ruoli era chiamato a rivestire. Che lo si assecondasse in senso autentico o retorico, sinceramente o ipocritamente, poco importava in un’ottica di comunicazione relazionale con le varie componenti sociali, perché comunque il messaggio che passava rimaneva quello. Ora a leggere queste parole, come altre ben migliori di queste ma dello stesso tenore, sai gli sbadigli nelle coorti trumpiane, salviniane, orbaniane, putiniane e chi più ne ha più ne metta. L’establishment social non sa che farsene di programmare, pianificare; conta il narcisismo tronfio del clic, fosse per sganciare bombe o sparare cazzate a go go non fa differenza. Conta l’onnipotente clic, punto. Quindi che dire al cospetto di questo desolante vuoto colmo di parole monche, emoticon, fotine a riempire l’attimo che è già fuggito mentre si consuma, altro che fuggente? Niente di prevedibilmente sensato, se non un auspicio: che digerita questa rivoluzione, con annessi e connessi effetti collaterali che saranno e sono già materia incandescente di studio e di lavoro per schiere di psichiatri in ogni dove, ne arrivi un’altra assai più noiosa. Sì, una rivoluzione tediosa, capace di usare la mirabolante tecnologia con tanto di intelligenze artificiali al servizio di volti a loro volta tediosi capaci di progettare tediosamente dei piani non dico quinquennali, guai mai…!, ma almeno stagionali, in grado di riportarci a vedere il mondo in divenire come minimo oltre il prossimo clic. Vuoi mai che per una volta l’ennesimo ribaltone risulti addirittura incruento?
Ccoverstory (p. 12 ) Intervista Wayne McGregor – 19. Biennale Danza. Creatori di Miti/Myth Makers | On The Other Earth | Leone d’Oro alla Carriera Twyla Tharp | Intervista Carolina Bianchi – Leone d’Argento | Chunky Move | Intervista Virginie Brunelle | TAO Dance Theatre | Aakash Odedra Company | Bullyache | Nuovo Balletto di Toscana | Intervista Kor’sia | Intervista Yoann Bourgeois | Tânia Carvalho | Marcos Morau –La Veronal | William Forsythe & RubberLegz | Biennale College tradition (p. 54 ) Festa del Redentore | Storia, tavola, tradizione | architettura (p. 60 ) Architherapy | | Catalogo Biennale Architettura | Regno del Bahrain | Intervista Marina Otero Verzier e Giovanna Zabotti – Santa Sede | Intelligens: The Architecture Lobby (TAL). Organizing in the Lobby | National Participations: Svizzera, Polonia, Ungheria, Irlanda | Collateral Events: Jean Nouvel, The Next Earth Computation, Crisis, Cosmology | Not Only Biennale: Casa Sanlorenzo | Time Space Existence | keep cool! Workshop for Cool Cities | Intervista Filippo Bricolo – Alps. Architecture. South Tyrol. | Migrating Modernism | Ljubodrag Andric | L’impronta leggera | Jung Youngsun & Collaborators | No Doubt About It | Carlo Scarpa e l’Officina Zanon | The Place of Wonders | The Lens of the Time storie (p. 98 ) Carlo Ghega e il Semmering arte (p. 106 ) Robert Mapplethorpe | 61. Biennale Arte – In Minor Keys | Tatiana Trouvé | John Baldessari | Corpi moderni | Giulio Aristide Sartorio | Thomas Schütte | Ocean Space | Diagrams. A project by AMO/OMA | Intervista Zhang Zhaoying – Lifelong Beauty | Tolia Astakhishvili | Maria Helena Vieira da Silva | Luc Tuymans | Banksy. Migrant Child | Museo Fortuny 50 | Arte Salvata | Perpetuo | Telemachus | L’oro dipinto | L’Ospite a Palazzo | Fratelli Toso | Vlastimil Beránek | 1932-1942 Il vetro di Murano e la Biennale di Venezia | Spazio Luciano Vistosi | Galleries musica (p. 136 ) Patti Smith | Jean-Michel Jarre | Ludovico Einaudi | Giovanni Allevi | Venezia Jazz Festival | Women For Freedom in Jazz | Base Festival | Cesare Cremonini | Marco Mengoni | Operaestate Festival | CCCP – Fedeli alla linea | The Who | Sexto ‘Nplugged | Festival del Vittoriale | Sea Music Festival | Burning Spear | Villa Manin Estate | Marostica Summer Festival | AMA Music Festival | No Borders Music Festival | Sublime@DesBains | | Il Muretto | King’s Club classical (p. 156 ) Cavalleria Rusticana | Casanova Opera Pop | Preview Stagione Lirica e Sinfonica Teatro La Fenice | Arena di Verona Opera Festival | Operaestate theatro (p. 162 ) Intervista Daniele Finzi Pasca – Titizé - A Venetian Dream | 13. Venice Open Stage | Preview: Teatro Goldoni, Teatro Verdi, Teatro Mario del Monaco, Teatro Toniolo | Intervista Michele Mele –Operaestate Festival | L’Estate Teatrale Veronese | cinema (p. 172 ) Kim Novak Leone d’Oro 82. Mostra del Cinema | Le città di pianura | San Polo Cinemoving | Venezia e la musica per film –La morte ha fatto l’uovo | Cinemoving | Operaestate Cinefestival | Supervisioni | Cinefacts: Col senno di poi… etcc... (p. 186 ) Intervista Roberto Ferrucci | Intervista Ryoko Sekiguchi | Intervista Roberto Nardi | Parole: Fair Play citydiary (p. 197 ) Agende | Mostre a Venezia

San Marco basin illuminated by fireworks on the most iconic summer night –highlight of Venice’s most beloved celebration.
A miracle that returns faithfully each year, set against a backdrop of timeless, unmatched beauty. t radition p. 54

From Jarre’s electronic sounds to Patti Smith’s poetic rock, from the historic opera of La Fenice to the pop musical Casanova, and finally to Ludovico Einaudi’s refined contemporary new age. Five live performances transform Piazza San Marco into a crossroads of time, sound, and imagery beneath the stars. musica p. 136


A couple of artists, lovers, and friends – refined and tireless explorers of artistic languages who have shaped twentiethcentury cultural history. Patti Smith’s concert on July 7 in Piazza San Marco and Robert Mapplethorpe’s exhibition at Le Stanze della Fotografia: simply unmissable! arte p. 106
After a long and successful tour, the show written and directed by Daniele Finzi Pasca returns to where it all began. The Teatro Stabile del Veneto revives at the Goldoni Theatre a unique blend of entertainment, “commedia dell’arte”, acrobatics, clowning, and music, enveloped in the delicate, suspended atmosphere of a dream. t heatro p. 162
Reappointed as director for the fifth year, Sir Wayne McGregor opens his Festival, Myth Makers, featuring major names from the global stage – such as Golden Lion recipient Twyla Tharp – alongside emerging performative expressions from the contemporary scene. cover story p. 12

A professional, an innovator, a social and political agent – the architect is called to face the challenges of a rapidly shifting world. Carlo Ratti’s multifaceted Biennale urges reflection, placing the architect at the core of a radical change. a rchitettura p. 60

ETRead THE BAG
Biennale Architecture Guide


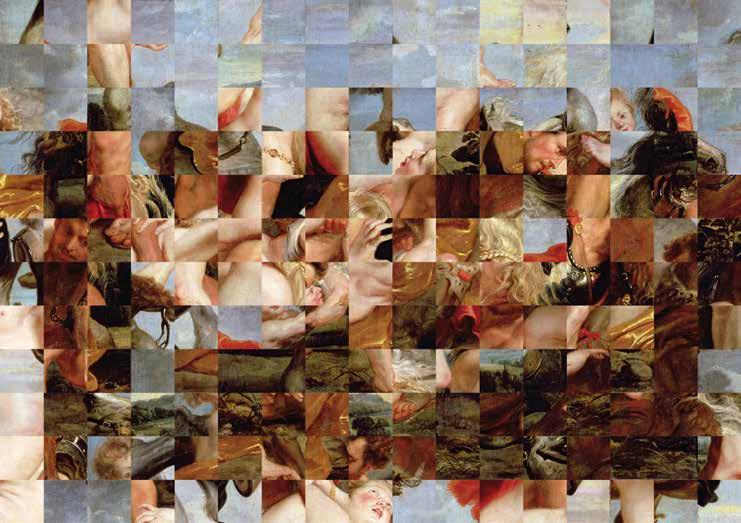
Il mio pubblico ideale è quello con una mente aperta, capace di lasciarsi attraversare, di ricevere e far emergere il significato My ideal audience is open-minded and can let art flow through, receive meaning and let it grow
Wayne McGregor Direttore 19. Biennale Danza
a cura di Chiara Sciascia
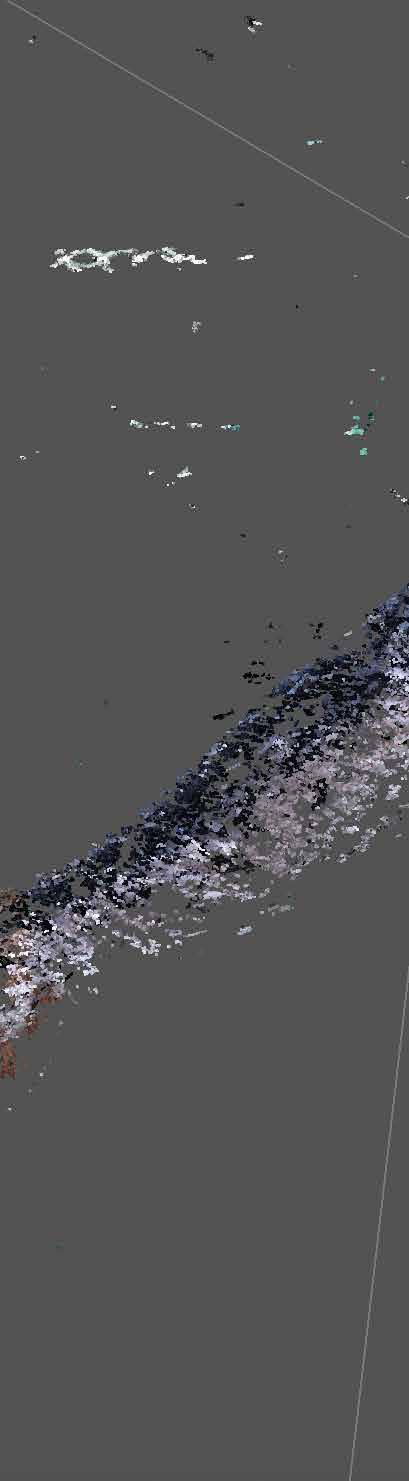

WAYNE MCGREGOR
di Loris Casadei
Per la verità, anche secondo Cartesio, nell’uomo corpo e anima interagiscono armonicamente, rompendo con la dottrina classica platonica del corpo come carcere. Le neuroscienze hanno poi confermato il ruolo fondamentale del corpo e dei suoi organi nella conoscenza del mondo, nelle emozioni, nell’affettività, nella stessa formazione dell’identità personale. È in questa direzione – o meglio, direi esplorazione – che si muove la ricerca di Sir Wayne McGregor, ossessionato dalla tecnologia del corpo e da come questo possa comunicare idee al pubblico. Nominato direttore della sezione Danza della Biennale nel 2021 e riconfermato dal neo presidente Pietrangelo Buttafuoco anche per il biennio 2025/26, McGregor è un coreografo acclamato non solo nel mondo della danza, ma anche nelle arti visive, nel cinema, nel teatro, nell’opera e nei grandi concerti. Quest’anno ha dedicato il Festival ai Creatori di Miti / Myth Makers
«In una società contemporanea, con rapidi progressi tecnologici e sfide globali come il cambiamento climatico e la diseguaglianza sociale, c’è un urgente bisogno di miti che siano in risonanza con l’attuale esperienza umana».
Il suo ruolo di direttore lo prende estremamente sul serio: non si limita a raccogliere ciò che è già pronto sulla scena internazionale, ma invita i coreografi ad accettare una sfida, quella di porsi come artisti, creatori di miti del loro tempo. Continuatori, scrive, «degli straordinari atti creativi del passato: piramidi nubiane, antiche pitture rupestri dell’Azerbaigian, mosaici dell’Iran, i testi classici, la musica, la scultura e la poesia, così come gli straordinari rituali performativi, le danze e le canzoni che continuano a perseguitarci, ispirarci, a evocare, stimolarci, sfidarci e scuoterci».
Non era forse questo l’obiettivo delle antiche tragedie greche?
Anche quest’anno incontriamo con grande piacere sir McGregor per approfondire il suo pensiero e la visione che guida il 19. Festival.
Cosa pensa degli attuali sistemi di finanziamento della danza in Europa e del loro impatto sulle carriere dei coreografi emergenti?
Credo sia fondamentale che le grandi istituzioni liriche, operistiche e coreutiche ricordino che sono stati proprio gli “eroi” della coreografia – quelli che oggi fanno incassare cifre importanti – a permettere a questi luoghi di esistere. Tutti noi, all’inizio della nostra carriera, eravamo artisti indipendenti, senza risorse; solo chi ha ricevuto investimenti ha potuto sviluppare il proprio lavoro e collaborare con i grandi teatri. Penso al mio percorso: quando ho iniziato, non avevo alcuna esperienza nel balletto, ma ho avuto la fortuna di incontrare alcuni straordinari direttori e curatori di danza contemporanea che mi hanno sostenuto, commissionandomi lavori e offrendomi la possibilità di sperimentare. Quello slancio iniziale mi ha poi consentito di arrivare nei grandi teatri. Le istituzioni devono tenere presente come funziona la crescita di un talento, il ricambio generazionale. Occorre agire concreta-
19. Festival Internazionale di Danza Creatori di Miti / Myth Makers 17 luglio-2 agosto www.labiennale.org
Descartes once said that body and soul interact harmoniously, breaking away from Platonic ideals of the body as a prison. Neuroscience then confirmed the body’s primary role in the way we know the world, our emotions, our feelings, and the way we build our identity.
In this direction, or shall I say in this exploration, Wayne McGregor researches body technology and how the body can communicate ideas to any audience. Nominated director of the Venice Dance Biennale in 2021 and recently reconfirmed for 2025/26 by the new Biennale president Pietrangelo Buttafuoco, McGregor is a well-respected choreographer not only in the world of dance, but also in visual art, cinema, theatre, opera, and large concerts. This year, he dedicated the Dance Biennale to Myth Makers. “In modern society, with rapid technological progress and global challenges such as climate change and social inequality, we urgently need mythologies that resonate with the actual human experience”.
Wayne McGregor takes his role as Dance Biennale director seriously: he’s not happy with merely collecting what exists in the international scene, he invites choreographers to take a challenge, to be artists, to create modern myths. Those artists will take it upon themselves to continue “extraordinary creative acts from the past: Nubian pyramids, ancient cave paintings in Azerbaijan, Iranian mosaics, classical texts, music, sculpture, poetry, performative rituals, dance, songs that keep on harassing, inspiring, stimulating, challenging, and shaking us”.
Weren’t Greek tragedies all about this, too?
We are so pleased to meet Wayne McGregor again and to further discuss his vision.
What do you think of the current funding systems for dance in Europe, and how they impact the careers of emerging choreographers?
One of the things I would say is that it’s really important for large-scale lyric, opera, and dance houses to remember is that it’s all thanks to their hero choreographers who make them lots of money now to be able to fund those huge shows that you’re talking about. We’re all kind of independent makers with no money early on who got investment early and were able to develop their work to be able to work in opera houses. So, I think about my own career, and I remember that when I started, I had no experience in ballet, but I had a group of really amazing presenters, contemporary dance presenters who supported me and commissioned, gave me money to work on ideas and experiment. Over time, that commitment allowed me then to work in the big opera houses. I think it’s important for those big institutions to remember what the talent pipeline is. So even if it becomes legislation that that happens, they need to do something about that recursive system. So, I’d say that they have to be mindful of that. But the call to action plays down to this: where is the noise about all of this reduction in funding? about these changes in the funding system? About arts being suppressed, certainly in the UK? You know, 80% of the GCSE dance that used to be on offer has been removed

WAYNE MCGREGOR
mente per garantire un sistema che funzioni in modo ricorsivo. Serve consapevolezza. Ma serve anche rumore: dove sono le voci che denunciano il taglio dei fondi? Dove sono le proteste? L’arte è sotto pressione, nel Regno Unito come altrove. L’80% dei corsi di danza previsti nel sistema scolastico è stato cancellato. Nessuno studia più danza, ma dove sono le reazioni? C’è poco rumore e invece dobbiamo farne di più, che si sia scrittori, danzatori o coreografi. Tutti dobbiamo farci sentire, lottare per un cambiamento positivo. Non possiamo rassegnarci. È sempre più scoraggiante la situazione ma proprio per questo non possiamo arrenderci, dobbiamo continuare a combattere. Vogliamo sentire cosa ne pensano di questo contesto complessivo infragilito La Scala o la Royal Opera House, perché non basta che loro stiano bene. È fondamentale pensare all’intero ecosistema e una delle opportunità positive che la Biennale ci offre è proprio la possibilità di fare questo, con uno sguardo olistico e risorse adeguate. Qual è l’alternativa? Andare avanti. Ma farlo con energia, con passione, coinvolgendo chi può davvero fare la differenza. Prendiamo l’esempio degli Stati Uniti, dove Trump è diventato presidente del Kennedy Center e ha iniziato a controllare i programmi: gli artisti hanno reagito, hanno smesso di lavorare lì. Questa è la nostra forza, il nostro “soft power”: dobbiamo continuare ad usarlo! Anche nel Regno Unito vedo profilarsi politiche simili a quelle americane, il che è davvero preoccupante. Il nuovo piano di finanziamento quinquennale dell’Arts Council, previsto per l’estate, è stato rimandato di un anno e mezzo, tutto congelato. Questo significa che un giovane coreografo che non ha ricevuto una borsa di studio sei anni fa, ora potrebbe doverne attendere oltre sette prima di poter accedere a nuovi fondi. È un’intera vita artistica, sette anni! Questo tipo di politica che tenta di minimizzare tutti i rischi non porta nulla al mondo dell’arte. Chi ha voce deve usarla. Con più forza.
Nelle sue coreografie quanto attinge dalla danza classica, dalla danza moderna o persino da elementi pop come Grease?
In realtà nel mio lavoro non separo mai nettamente i generi, le diverse forme espressive del fare danza. Adoro Grease, La febbre del sabato sera e la disco music. Quando ero giovane ho preso lezioni di ballo latino-americano e disco per circa nove anni. È così che ho iniziato. Quando creo qualcosa di ritmico per una compagnia contemporanea o classica, posso lavorare su una rumba oppure su un riff disco, capisce? Non si può separare l’intelligenza fisica che ci compone, nello stesso modo in cui non si può isolare ogni singola esperienza fisica passata. Siamo tutto questo insieme. Ed è proprio questa la bellezza della propria firma fisica: nel mio caso, essendo un coreografo molto esperto, posso anche suonare lo strumento del corpo. Posso iniziare con un danzatore classico, usando il suo vocabolario, finché non sento che ha raggiunto una certa sicurezza, per poi iniziare a portarlo fuori dai suoi confini netti e prestabiliti. Probabilmente non partirei subito da un approccio contemporaneo. Cercherei un modo per arrivarci gradualmente. Con altri, invece, inizierei direttamente con materiale più bizzarro. Con altri ancora cercherei una via più morbida. Questa è la grande tecnica: puoi insaporire il tuo piatto come vuoi, trovare un modo per renderlo autenticamente tuo.
Spesso lavora ad occhi chiusi, perché?
Già. Perché? Domanda interessante. Penso che gran parte del nostro sistema sensoriale sia basato sulla visione. Riceviamo molte informazioni tramite la vista, è il nostro canale primario di accesso al mondo. È supportato da altri sensi naturalmente, ma rimane pur sempre quello principale. Quando passo da uno spazio reale a uno immaginato mi piace chiudere gli occhi per immaginarlo dal di dentro, per visualizzare un’immagine diversa da quella che ho davanti. Ad esempio posso guardare quella finestra e immaginare un prato verde, e se chiudo gli occhi, il prato verde lo vedo davvero. La finestra passa in secondo piano. È un modo per controllare le immagini in tempo reale. E poi, privandoci della vista, si attiva un altro senso. Un processo prezioso, questo, in particolare durante le prove: se non so come proseguire, posso dare priorità a un altro senso e d’un tratto si apre un nuovo flusso creativo. Questa è una delle meraviglie della danza: possiamo giocare con i sensi. A volte guardo le prove tecniche con un solo senso attivo, come se disattivassi l’udito e mi concentrassi solo sul visivo. Li alterno, li esploro.
Lei sostiene che la danza racconta storie. Ha mai provato a testare il suo pubblico e a indagare come interpreta le sue storie?
Spesso, quando pensiamo a delle storie, pensiamo alle nostre esperienze come a qualcosa di immediatamente e interamente comprensibile, quando in realtà la nostra coscienza lavora su una linea piatta e le emozioni emergono nel corso della giornata. Avere chiaro ciò è assai importante quando si parla di narrazione. Ci aspettiamo che la danza racconti una storia lineare, che accade in tempo reale, e che sia assolutamente, esplicitamente comprensibile, passo dopo passo. Ma non è così che viviamo le nostre vite interiori. Abbiamo già molte voci dentro di noi. La vera domanda è: cosa vuoi che il tuo pubblico riceva o comprenda di una narrazione? Secondo me la danza deve provocare sensazioni, dalle quali nasce il significato. Non il contrario. Senti qualcosa di stimolante, la tua chimica cambia, e questo evoca un’emozione già vissuta. Detto questo, una cosa che mi interessa molto per il futuro è lavorare con l’informatica quantistica per analizzare come il pubblico percepisce un’opera, usando poi i dati ricavati per costruire la composizione. Qual è il rapporto tra la percezione del pubblico e la storia che stai raccontando? Come si può ridurre quel divario? È un tema di grande interesse per me in questo momento. Mi affido anche molto alla capacità del pubblico di dare un senso personale a ciò che vede. Alcuni non lo faranno mai, perché vogliono una storia chiara e raccontata; lo capisco, è il loro modo di vedere, lo rispetto. Ma il mio pubblico ideale è quello con una mente aperta, capace di lasciarsi attraversare, di ricevere e far emergere il significato. Questa per me è la cosa più meravigliosa che la danza può offrire.
Ha diretto già quattro edizioni di grande successo di pubblico e critica. L’imminente suo quinto capitolo alla guida della Biennale Danza promette di essere ancora migliore. Cosa vedremo di nuovo?
Una cosa importante da ricordare è che il Festival dura solo tre settimane. Non programmo spettacoli per dodici mesi. Ciò
from schools, so nobody is doing this, but where is the noise? There’s not much noise and I think what we have to try and do all of us – whichever area of this amazing art form we’re working in, whether you’re a writer or you’re a choreographer or a dancer – is to make as much noise as possible to advocate for better change to keep going, we have to keep fighting. We can’t just accept it. It’s very challenging and it’s often very depressing, but we still have to keep fighting.
We want to hear La Scala on this subject, we want to hear the Opera House on this subject. It’s not enough that they’re OK, it’s really important that they think about the whole ecology and I think that’s one of the things that is really good here is that we’re allowed to think about the whole ecology in a holistic way and actually resource it.
What’s the option? The only option is forward. That’s the only option, but forward with energy and with passion to get the stakeholders to make a difference. Say that it’s not going to work. You know, you look at Trump now being the chairman of the Kennedy Center in America and controlling what work is at the Kennedy Centre: artists have congregated and are now stopping showing their work there. We do have soft power, and we need to keep using it. That’s in the UK, too. I see what’s happening in the States and some of those policies creeping into the UK. I see similarities and it’s really, really worrying. The Arts Council in the UK were supposed to be doing the new spending round, namely, who would get money over the next five years. It was supposed to happen in the summer. They’ve postponed it for a year and a half and frozen everybody. What that means is that any young choreographer who didn’t get a grant six years ago is now in a situation where they can’t even get a proper grant for seven years. That’s a whole artistic life, seven years. It’s a long time. This kind of risk-averse policy is not going to serve the arts well. I think those who have a place to have a voice need to voice it more strongly.
In your choreographies, to what extent do you draw inspiration from classical dance, modern dance, or even pop elements like Grease?
That’s interesting because I don’t ever separate them out. I know, you know, I loved Grease and Saturday Night Fever and disco. When I was young, I had ballroom Latin American and disco lessons for like nine years. That’s how I started. When I do a rhythmic thing in any contemporary company or a classical company, it might be based on a rumba, or it might be based on a kind of a disco riff, you know? I think you can’t separate the physical intelligence that makes up you in the same way that you can’t take your physical experience that you’ve had and separate it out into individual things. It just is you. And that’s the beautiful thing about having your own physical signature, obviously because I’m a very experienced choreographer I can also play the instrument of the body, right? So, I can start with a classical dancer in a classical vocabulary until I really feel that they feel secure and then move them out of it. I wouldn’t probably start with a contemporary first. I’d find a way to get there. Others, I would start immediately with some weird material.
Others I’d find a softer way in. That’s what great technique is. You can spice your cooking in any way that you want. You find a way of making that thing essentially yours.
Quite often you close your eyes.
Well, that’s actually a really interesting question because I think a lot of our sensing system is visual. We take a lot of visual information and process it and we receive the world most often through vision. It’s supported by other senses, but vision is a primary one. When I move between a real-life space and an imaginative space, I quite like to close my eyes to have an interior imaginative space, an image that might be different from this one. I can look at that window, but I can imagine a green field. When I imagine the green field and I close my eyes, I really see the green field. The window goes into relief. It’s a way of controlling images in real time. The other thing I’d say is when you close your eyes you activate another one of your senses, right? By depriving one you give attention to another, and that’s actually a really interesting gift in the rehearsal. When I’m stuck on what to do next, if you prioritise a different sense, suddenly you enter a new state of flow. That’s, again, one of the wonderful things about dance. You can move through playing with your senses. Sometimes I watch technical rehearsals like this: I turned off the sonic input and really concentrated only on the visual sense. I play the senses that way.
You once said you use dance to tell stories. I wonder if you ever tested your public about how they interpret your stories.
There are some great things in there that really interest me. The first thing is that often when we think about stories, we think about our real-life experience as if we’re in a state of understanding all the time, when actually, our consciousness works on a flatline and emotions emerge in the day so, the space between what we know and understand is far less than the things that we just don’t understand. That is important when thinking about storytelling because you know, we’re often expected in dance to tell a linear story that unfolds in real time and is absolutely, explicitly understood at every step of the way. But that’s not how we live our lives in our own head! We’ve got multiple voices, anyway. The question is: what do you want your audience to receive or understand about a narrative or a story? And I think for me, the way dance works is it provokes you to feel sensation and the sensation generates meaning. It’s not the other way around. You feel something tingling, your chemistry changes, and it gives you the feeling of an emotion that you’ve experienced before, right? Given that, I think one thing I’m interested in doing in the next few years is working with quantum computing to sense what is happening in the audience when they sense work and to see if you can use that data to construct the composition of the work. What is the relationship between the audience sensing and the story that you’re telling? And how can you narrow that gap? That’s a big interest of mine at the moment. Otherwise, I just trust that the audience will do the work that allows meaning to unfold for themselves. Some
WAYNE MCGREGOR
che è disponibile in quel periodo non restituisce, quindi, l’intero mondo della danza, è una selezione dettata da limiti curatoriali. Ma in questi anni, grazie alla mia presenza costante, molti artisti hanno iniziato a condividere con me i loro progetti in anticipo, a dirmi cosa sta arrivando, cosa hanno in cantiere. Sono qui da quattro anni e frequento artisti che hanno progetti in lavorazione da cinque anni, quindi adesso ho a disposizione cose che non ho mai potuto usare altre volte. Posso finalmente avere una visione a lungo termine e questo aiuta moltissimo. La mia passione è trovare artisti che abbiano veramente qualcosa di straordinario da dire: per il modo in cui lo fanno, per il significato che le loro opere trasmettono, o ancora per il processo lavorativo che le informano. Quindi in un certo senso è mio compito essere “nuovo”. Tocca a me riflettere la novità che accade nel mondo della danza. Ed è un grande piacere e privilegio poterlo fare.
Se fosse un animale, quale sarebbe?
La mia risposta vi stupirà. In parte sono come un giaguaro: veloce, un po’ impaziente, capace di percorrere grandi distanze. Ma in parte sono anche un bradipo, perché apprezzo profondamente la “visione lenta”. Penso che la danza tragga beneficio dall’osservazione lenta. Vedere più volte, vedere lentamente. Non guardare uno spettacolo, scriverne e poi dimenticarlo. Penso che tutta la nostra esperienza guadagni molto dalla lentezza dello sguardo. Quindi sì, sarei una combinazione di questi due mammiferi.
audiences will never do that because they want to be told a story. I understand that I can’t change that. That’s their bias. I understand that and I respect it, but the best audiences for me are those that go in there so open that they are able to receive and allow meaning to emerge. For me, that is the most wonderful thing about dance. And if I were to pick my ideal audience, that’s what I would want.
You always planned beautiful Biennales, and the coming Biennale promises to be even better. What new things will we see? What’s important to remember is that the festival happens only for three weeks a year. I don’t programme a whole year’s worth of shows. The things that are available for a festival that are happening in three weeks are not the whole of the dance world, right? They are very specific things, so already that’s a curatorial restriction. But because I’ve been here, and because people started to understand the kinds of things that I’m trying to do, a lot of artists share work with me directly. They tell me: this is coming up, this is coming down the line, which means I have a much longer runway. I’ve been here for four years and can see and work with the artists that plan projects that are five years out, things that I wasn’t able to bring in the past but now I can to bring together, and so that longitudinal vision is really, really helpful in terms of what’s new. My passion has always been to find the artists that really have something extraordinary to say right now, either in the way they make it or the meaning of the work that they make, or the processes that they choose, and so in a way, it’s not incumbent for me to be new. It’s for me to reflect the newness of what happens in the world of dance and it’s a great, great pleasure to do that.
If you were an animal, what would you be? I’ve got a probably surprising answer. Part of me is like a jaguar: fast, kind of impatient, kind of travelling great distances. Part of me is that, but part of me is a sloth, because I really value slow watching, I really do. I think that dance benefits from slow watching, repeat viewing and slow watching, not just watching something, writing about it and then it’s over, you don’t see it anymore. I think all our experience benefits from slow watching. I would be a combination of those two.


Presentata in prima assoluta alla Biennale Danza 2025, On The Other Earth è la nuova installazione coreografica post-cinematografica di Wayne McGregor, ispirata a Deepstaria, recente lavoro teatrale dal vivo dedicato a una medusa abissale capace di assumere forme imprevedibili. Un organismo misterioso, sospeso tra trasparenza e trasformazione, che diventa metafora di un corpo in costante ridefinizione. L’installazione, co-prodotta da Studio Wayne McGregor, Hong Kong Ballet e Hong Kong Baptist University, si sviluppa all’interno di nVis, spazio immersivo ideato da Jeffrey Shaw: una struttura cilindrica di otto metri per quattro con schermo LED stereoscopico a 360°, primo nel suo genere, in grado di restituire immagini 3D panoramiche a 26 milioni di pixel. In questo ambiente visionario, McGregor fonde danza dal vivo, AI, sensori multimodali, imaging digitale e suono spazializzato, dando vita a un’esperienza performativa in tempo reale, fluida e interattiva. Lo spettatore non è più solo osservatore, ma presenza attiva, immersa in una dimensione percettiva amplificata. In gruppi di venti, i visitatori entrano in un mondo “altro” che sfida i confini del corpo e della scena, interrogando il significato stesso di presenza, movimento e visione. C.S.
ENG Premiering at the 2025 Biennale Danza, On The Other Earth is Wayne McGregor’s new post-cinematic choreographic installation, inspired by Deepstaria, a recent live stage work dedicated to a deep-sea jellyfish known for its unpredictable, shape-shifting forms. This mysterious organism, suspended between transparency and transformation, becomes a metaphor for a body in constant redefinition. Co-produced by Studio Wayne McGregor, Hong Kong Ballet, and Hong Kong Baptist University, the show has been installed at nVis, an immersive space designed by Jeffrey Shaw. It features a ground-breaking cylindrical structure of roughly 13 by 26 feet equipped with a 360-degree stereoscopic LED screen delivering panoramic 3D images at 26 million pixels. In this visionary environment, McGregor blends live dance, AI, multimodal sensors, digital imaging, and spatialized sound to create a real-time, fluid, and interactive performance experience. Audience is no longer a passive observer but an active presence, immersed in an amplified perceptual dimension. In groups of twenty, visitors enter an other world that challenges the boundaries of body and stage, questioning the very meaning of presence, movement, and vision.
On The Other Earth
19 luglio-2 agosto
Sala d’Armi, Arsenale
TWYLA THARP
LEONE D’ORO

“Fenomeno” l’ha definita Wayne McGregor. «Una delle più importanti coreografe esistenti. I suoi contributi rivoluzionari all’ecologia della danza mondiale non hanno eguali, grazie a un lavoro che combina rigore e gioco, disciplina classica e tecnica del balletto con danza moderna e movimenti naturali, per coreografie radicalmente innovative destinate sia al teatro che al cinema». Leone d’Oro alla carriera della Biennale Danza 2025, Twyla Tharp celebra quest’anno i sessant’anni della sua compagnia, la cui costellazione di lavori ha attraversato la scena americana e internazionale imprimendo un proprio segno inconfondibile.
Formatasi tra l’American Ballet Theater e gli studi di Graham, Cunningham e Taylor, Tharp fonda la Twyla Tharp Dance nel 1965. Da allora ha agito come un autentico catalizzatore di energie e linguaggi, scardinando i confini tra i generi: danza classica e moderna, jazz e tip tap, musical e rock, tutto può diventare materiale per una partitura coreografica, purché sia contenuto vivo, pertinente, urgente. A renderla unica è la sua capacità di combinare precisione e libertà, matematica del gesto e ironia, strutture complesse e movimento quotidiano in un’equazione sempre nuova.
Il suo stile ha attraversato palcoscenici e media: dal Joffrey al Royal Ballet, dal New York City Ballet all’Opéra di Parigi, fino al cinema di Milos Forman ( Hair ), alla televisione, alla moda e ai videoclip. Ha collaborato con Baryshnikov e coreografato su musiche di Billy Joel, Frank Sinatra, David Byrne, Philip Glass. La sua opera si
muove tra l’altissima cultura e il pop più trasversale, facendo della coreografia un laboratorio culturale che parla a pubblici diversi, senza mai abbassare l’ambizione artistica. In questo senso, il suo lavoro ha aperto la strada a una nuova idea di coreografo-autore, capace di agire su più fronti e con strumenti molteplici.
La Biennale celebra questa traiettoria con un programma in prima europea che aprirà il Festival il 17 luglio al Teatro Malibran. Diamond Jubilee Tour accosta due lavori emblematici: Diabelli, storica coreografia del 1998 sulle 33 variazioni per pianoforte composte da Beethoven, e Slacktide, nuova creazione costruita sulla partitura Aguas da Amazonia di Philip Glass. La musica è materia viva nella danza di Tharp. Diabelli si muove in dialogo con la geometria della scrittura beethoveniana, mentre Slacktide immerge i corpi in un paesaggio sonoro ispirato ai fiumi amazzonici, eseguito dal vivo dall’ensemble Third Coast Percussion. L’elemento acquatico, con il suo flusso continuo e la sua instabilità, diventa qui una metafora del tempo e del movimento, del rischio e della metamorfosi. L’accostamento tra i due lavori, solo in apparenza distanti, suggerisce un’inaspettata continuità: «Come la stessa Tharp – ha osservato il Minnesota Star Tribune – anche Beethoven e Glass decostruiscono le forme e le riassemblano, mostrando la loro maestria nel processo».
Oggi come ieri la danza per Tharp è una forma di pensiero, un campo di possibilità dove corpo e musica si incontrano per inventare ogni volta un’altra logica del mondo. C.S.

Wayne McGregor has called her a phenomenon and “One of the most important choreographers alive. Her revolutionary contributions to the global dance ecology are unmatched, thanks to a body of work that blends rigor and play, classical discipline and ballet technique with modern dance and natural movement, creating radically innovative choreographies for both stage and screen.”
Twyla Tharp, recipient of the Golden Lion for Lifetime Achievement at the 2025 Biennale Danza, celebrates her company’s 60th anniversary.
Trained at the American Ballet Theater and influenced by Graham, Cunningham, and Taylor, Tharp founded Twyla Tharp Dance in 1965. Since then, she acted as a true catalyst of energy and language, breaking down boundaries between genres: classical and modern dance, jazz and tap, musicals and rock. All can be material for choreography, as long as the content is alive, relevant, and urgent. What makes her unique is her ability to combine precision and freedom, mathematical gesture and irony, complex structures and everyday movement into a constantly evolving equation.
Her style graced stages and media worldwide: from the Joffrey
Twyla Tharp
Diabelli / Slacktide
17, 18 luglio Teatro Malibran
Ballet to the Royal Ballet, from New York City Ballet to the Paris Opera, and into the world of film with Milos Forman (Hair ), television, fashion, and music videos. She has collaborated with Mikhail Baryshnikov and choreographed to music by Billy Joel, Frank Sinatra, David Byrne, and Philip Glass. Her work moves fluidly between high culture and broad popular appeal, turning choreography into a cultural laboratory that speaks to diverse audiences without ever compromising artistic ambition. The Biennale honours this extraordinary journey with a European premiere that opens the Festival on July 17 at Malibran Theatre. The Diamond Jubilee Tour presents two emblematic works: Diabelli, a historic 1998 choreography set to Beethoven’s 33 piano variations, and Slacktide, a new creation set to Philip Glass’s Aguas da Amazonia. In Tharp’s dance, music is living matter. Diabelli engages with the geometry of Beethoven’s writing, while Slacktide immerses bodies in a soundscape inspired by the Amazon rivers, performed live by Third Coast Percussion. The aquatic element – with its continuous flow and instability –becomes a metaphor for time and movement, risk and transformation. The pairing of these two works, seemingly distant, reveals an unexpected continuity: “Like Tharp herself,” noted the Minnesota Star Tribune, “Beethoven and Glass deconstruct forms and reassemble them, showcasing their mastery in the process.”
CAROLINA BIANCHI
Intervista Carolina Bianchi Leone d’Argento di Loris Casadei
Regista, scrittrice e performer, Leone d’Argento della Biennale Danza 2025, Carolina Bianchi presenta a Venezia The Brotherhood, secondo atto della trilogia Cadela Força ( Il potere della puttana, in portoghese), un progetto teatrale che affronta da prospettive diverse la violenza patriarcale e il trauma sessuale, intrecciando autobiografia, mito e politica. Ogni capitolo è autonomo ma interconnesso, pensato come un’immersione radicale nelle contraddizioni del desiderio, della memoria e del corpo femminile. Il primo episodio, A Noiva e o Boa Noite Cinderela, ha debuttato ad Avignone nel 2023 ed è stato premiato in Francia come miglior debutto internazionale della stagione da Le Prix du Syndicat de la Critique. The Brotherhood, in scena alla Biennale, è il secondo capitolo: un lavoro collettivo che ruota attorno alla mascolinità, all’immaginario virile e allo sguardo maschile. Nove performer si muovono in uno spazio scenico carico di riferimenti mitologici e tensioni emotive, tra affermazione e vulnerabilità.
Fondatrice del collettivo Cara de Cavalo a San Paolo, oggi vive ad Amsterdam, si muove da anni tra i più importanti palcoscenici europei ed è molto attiva sul piano sociale, anche in Italia. A Bologna, per il Festival Fuori!, ha recentemente proposto Percurso, un’azione pubblica ispirata alle teorie urbanistiche femministe di Leslie Kern, critica verso un’architettura urbana “costruita sull’esclusione patriarcale”.
La sua pratica artistica – fisica, psichica, politica – si inscrive nella tradizione della performance femminile più estrema, da Gina Pane a Marina Abramovic´, da Ana Mendieta a Tania Bruguera, pur aprendosi a nuove forme e interrogativi. Come ha sottolineato Wayne McGregor nell’assegnarle il Leone d’Argento, Bianchi impiega il proprio corpo come elemento centrale, mettendo in discussione convenzioni e linguaggi scenici con una forza espressiva che non fa sconti. Personalmente i suoi lavori mi ricordano il teatro di Antonin Artaud in quanto luogo ove è possibile usare una fittizia crudeltà rivelatrice.
De Sade e prima ancora Voltaire, e forse lo stesso Thomas Hobbes, avevano teorizzato e scritto sull’uomo qualificandolo certamente come animale sociale, ma capace in condizioni non rare a farsi ag-

gressivo nei confronti degli altri così come di sé stesso. Mi trovavo a Vienna nel 1968 quando artisti oggi dimenticati quali Kren, Brus e Schwarzkogler misero in piedi un happening all’Università, poi noto come Arte e Rivoluzione, aprendo la strada all’uso del corpo come ultimo strumento di disvelamento. Quando penso a Carolina, mi torna in mente anche Valie Export, con le sue azioni di protesta e provocazione che utilizzavano il corpo per sfidare ipocrisie e finzioni.
Mi piace immaginare che tra le righe delle sue creazioni risuoni un’accusa ai fondamenti stessi del patriarcato – perfino all’intoccabile poeta tragico Euripide, quando fa dire a Peleo che Menelao non dovrebbe stupirsi se Paride ha rapito Elena, «abituata da spartana a girare non troppo vestita».
Molti ritengono che la violenza sia insita nel DNA dell’animale-uomo, eredità “biologica” delle scimmie da cui discendiamo. Altri, come Johan Galtung, sostengono

invece che la consapevolezza della violenza possa aprire la strada a un cambiamento. Lei cosa pensa a riguardo? E quale ruolo possono avere le sue performance in questo processo di consapevolezza?
In questa trilogia mi interessa riflettere sulla violenza attraverso la storia dell’arte e attraverso un linguaggio; un linguaggio scenico, che attinge al teatro, alla performance art e alla poesia. Avverto una necessità assoluta: che tutte le domande che mi pongo sulla violenza sessuale, sul trauma, sulla violenza che portiamo dentro di noi o che ci viene inflitta, emergano sempre tramite un linguaggio elaborato artisticamente.
I miei spettacoli non denunciano nulla, non cercano di “fare la cosa giusta”, non tentano nemmeno di dire ciò che la gente si aspetta di sentire. Il mio personale modo di fare teatro è dedicato all’immaginazione, alla poetica, agli enigmi, alla complessità. Per me il teatro è una camminata nell’ombra. È entrare nella selva oscura, come direbbe Dante.
È
Filmmaker, author, and performer, 2025 Venice Dance Biennale Silver Lion awardee Carolina Bianchi presents The Brotherhood, the second chapter of trilogy Cadela Força, a theatre project on patriarchal violence and sexual trauma, a blend of memoir, mythology, and politics. Every chapter stands on its own, though also connects into a radical immersion into the contradictions of desire, memory, and the female body.
The first segment, A Noiva e o Boa Noite Cinderela, premiered in Avignon, France, in 2023, and was met with critical praise.
The Brotherhood, which we will see at the Biennale, is the second chapter, a collective piece around masculinity, virile imagery, and the male gaze. Nine performers will populate a scene full of mythological references and emotional tension, between affirmation and vulnerability. The third chapter will premiere next year.
Carolina Bianchi lives in Amsterdam, though is active all-around Europe and is also socially engaged. In Bologna, for festival Fuori!, she produced Percurso, a public action performance inspired by Leslie Kern’s feminist urban planning theories, a kind of urban architecture built on patriarchal exclusion. Bianchi’s art – physically, psychically, politically – follows the tradition of extreme female artmaking, that of Gina Pane and Marina Abramovic´, Ana Mendieta, Tania Bruguera. The artist uses her body as a central element, unhinging conventions and languages and using an expressive strength that is second to none.
Many seem to think that violence is inherent to the DNA of man – the animal, a biological legacy of the great apes we descend from. Others, like Johan Galtung, maintain that awareness of our own violence can open the door to change. What do you think? And what role can your art play in this awareness process?
In this trilogy, I reflect on violence trough art history, and a language, a kind of stage language that is connected to theatre, performance art and poetry.
I need all my questions around sexual violence, trauma, the violence we carry inside ourselves, the violence we are inflicted, and everything else to come through a language that is developed artistically. My shows do not denounce anything,

L’artista Giuseppina Pasqualino di Marineo, meglio conosciuta come Pippa Bacca, è morta nel suo abito da sposa durante una performance-viaggio per la pace, ma il suo lavoro è meno ricordato rispetto a quello di altre figure
come Gina Pane o Yoko Ono con Cut Piece. In alcuni casi sembra esserci una componente voyeuristica nel modo in cui il pubblico guarda all’uso del corpo per denunciare la violenza. Che opinione ha in merito?
Non sono sicura che tutte le artiste che usano il proprio corpo come mezzo artistico e che trattano il tema della violenza nelle loro opere intendano in realtà denunciare la violenza attraverso i loro corpi. Alcune sì, ma questo dipende anche da come interpretiamo i loro lavori.
Pippa Bacca, ad esempio, non stava lavorando sulla violenza, ma sul concetto di ospitalità. Dovremmo studiare le opere di queste artiste e provare a spingerci un po’ oltre, cercare di entrare anche nella loro visione, nei loro mondi metaforici.
Per quanto riguarda il pubblico, la violenza tocca sempre, ma in modi molto diversi. Non credo ci sia sempre voyeurismo: a volte sì, ma esistono anche altre possibilità, come la condivisione, la paura, l’odio, il desiderio, la curiosità, il nulla... Tante cose possono esistere tra un’opera e chi la guarda.
Com’è Carolina Bianchi nei momenti che precedono l’ingresso in scena? E subito dopo lo spettacolo?
È attenta alla durata degli applausi, desiderosa di sapere come è andata, oppure preferisce allontanarsi e restare in silenzio?
Carolina Bianchi si prepara con la sua squadra, scherza, ride ed è estremamente concentrata.
Dopo lo spettacolo? Se ne va via senza farsi notare, perché è molto timida!
In una sua recente intervista ha dichiarato che Emily Dickinson è la sua poetessa preferita. Da una sua poesia: «C’è un altro cielo / sempre sereno e bello / e c’è un’altra luce del sole». Dove si trova per lei questo “altro cielo”?
È qualcosa che si può raggiungere attraverso i rapporti umani?
No. Solo con la poesia e l’immaginazione.
The Brotherhood è il secondo atto della trilogia Cadela
Força. A che punto è arrivata questa sua ricerca e come si inserisce il nuovo lavoro nel percorso della trilogia? Sta già lavorando al terzo capitolo o ha in mente anche altre direzioni artistiche da esplorare?
Il secondo spettacolo è sul teatro come soggetto e linguaggio utile per porre domande e affrontare problemi su violenza e storia dell’arte e, soprattutto, su una fratellanza – The Brotherhood –che ci coinvolge tutt , in modo diretto o indiretto.
Penso che questo capitolo scavi ancora più a fondo nelle questioni che riguardano le forme di conoscenza, l’intellettualità e le dinamiche della violenza e dell’amore.
E sì, sto già lavorando all’ultimo capitolo, previsto per l’anno prossimo.
nor try to do the ‘right thing’, or even say what people expect to hear. The theatre I make is committed to imagination, to poetics, to enigmas, to complexity. Theatre is a walk in a shadow for me. It means to enter Dante’s dark forest
Artist Pippa Bacca died in her wedding gown during a peace-inspired travel art performance. Still, her work is less known compared to other artists’ such as Gina Pane or Yoko Ono with Cut Piece. In some cases, we notice a voyeuristic component in the way the public sees the body used to denounce violence. What is your opinion on the matter?
I am not sure that all the works of female artists that use their own body as a medium, that work with violence inside of their works – I am not sure that they are all denouncing violence trough their bodies. Some of them do, but this has to do with how we read their works. Pippa Bacca, for example, didn’t work with violence, but with the concept of hospitality. We should study the works of these artists and try to see a bit beyond, to engage with their metaphors, too. About public: violence always touches people, in many different ways, and I don’t think it is all about voyeurism, maybe sometimes, but other things exist with audiences, such as companion, fear, hate, desire, curiosity, nothing… many possibilities.
What does Carolina Bianchi look like in the moments right before entering stage? Is she focused, do we find her exercising, or does she laugh and joke with her company? What about right after the show? Does she notice how long her audience cheers her, is she interested in how the show goes, or would she rather just walk away unnoticed? Carolina Bianchi warms up with her team. She jokes, she laughs, and she is extremely focused. When the show’s over, she walks away unnoticed. She is shy that way.
In a recent interview, you said Emily Dickinson is your favourite poet. From Dickinson: “There is another sky / Ever serene and fair / And there is another sunshine”. Where do you think we can find this ‘other sunshine’? Is it something we can reach via human relationships? No, only with poetry and imagination.
The Brotherhood is the second instalment of the trilogy Candela Força. What stage did your research reach, and where do we place your new show in the trilogy’s path? Are you working on the third instalment, or are you thinking about something else at the moment?
The second show focuses on Theatre as a subject and a language to raise questions, issues of violence and art history, and a fraternity – the Brotherhood that involves all of us, whether indirectly or very directly. I think this chapter goes even deeper on the subject of forms of knowledge, intellectuality, and the dynamics of violence and love.
And yes, I am already working on the last chapter, due next year.

Tra le realtà più radicali della scena australiana, Chunky Move si distingue da oltre vent’anni per una danza che travalica i generi, mescola corpi, materiali e strumenti digitali e costruisce ambienti performativi a forte impatto visivo e sensoriale. Fondata a Melbourne nel 1995 e oggi diretta da Antony Hamilton e Kristy Ayre, la compagnia indaga il corpo come materia instabile, capace di assorbire immagini, tecnologie e conflitti contemporanei. Le sue creazioni, formalmente audaci e visivamente sorprendenti, si sviluppano spesso come composizioni sceniche in cui la danza entra in contatto con elementi elettronici, sonori e multimediali, dando forma a paesaggi immaginari densi di significati contemporanei. È il caso di U>N>I>T>E>D, ambizioso spettacolo in prima europea, che prosegue l’indagine di Hamilton su un possibile “futuro speculativo”. Sei danzatori si trasformano in creature post-umane, esseri mitologici e meccanici, avvolti in esoscheletri animatronici che ne amplificano forza e movimento fino a renderli entità ibride, tra umano e macchina. In una scena tagliata da luci stroboscopiche, costumi da motocross riciclati e nudità frammentarie espongono un corpo insieme vulnerabile e potenziato, mentre un flusso techno, pulsante travolge lo spettatore.
Nel paesaggio sonoro firmato dal duo indonesiano Gabber Modus Operandi, tra trance giavanese, distorsioni elettroniche e gamelan i cyborg/centauri non danzano: combattono, invocano, resistono. Come nei paesaggi urbani e dilatati di Blade Runner, lo spettacolo ci proietta in un futuro sporco, sensuale e rituale, dove spiritualità e intelligenza artificiale coesistono, e la macchina non è più mero strumento, ma oggetto di culto, divinità del nostro tempo. Coreografo pluripremiato e figura chiave della danza australiana, Hamilton lavora da anni su un’idea di corpo primitivo esposto alla cultura digitale. I suoi lavori, da Black Project 1 a Token Armies, costruiscono visioni dense e disturbanti, in cui la coreografia diventa la chiave per interrogare la nostra identità più profonda. Con U>N>I>T>E>D porta in scena un’esperienza immersiva, ipnotica e visionaria, che ridefinisce i confini dell’umano, del presente e del futuro.
Chiara Sciascia
ENG Chunky Move, one of Australia’s most radical dance companies, blends bodies, digital media, and immersive environments to build performative environments featuring radical visual and sensorial impact. Founded in 1995 and now led by Antony Hamilton and Kristy Ayre, the company seeks to explore the body as unstable matter. In Venice, they will present U>N>I>T>E>D, a European premiere envisioning a speculative future. Six dancers turn into post-human hybrids in animatronic exoskeletons, moving through strobe-lit scenes with techno beats by Gabber Modus Operandi. The performance evokes a raw, ritual-

istic world where cyborgs battle and pray, and machines become divine. With recycled motocross gear and exposed architecture, the show merges vulnerability and power. Hamilton, known for probing the digital body with such works as Black Project 1 and Token Armies, crafts a hypnotic, immersive experience that redefines humanity and futurism using choreography.
Chunky Move
U>N>I>T>E>D 17, 18 luglio Teatro alle Tese, Arsenale
VIRGINIE BRUNELLE
Intervista Virginie Brunelle di Loris Casadei
Montreal, tra le capitali mondiali della danza, città di artisti, anche grazie alla lungimiranza del governo cittadino, che ha continuato a investire in tutti i settori dell’arte. Non possiamo dimenticare l’amata Marie Chouinard, per quattro anni direttrice della sezione Danza della Biennale, o Louise Lecavalier ( So Blue, 2017), o ancora la più giovane Daina Ashbee, vista anch’essa nell’edizione 2017 con Unrelated, opera incentrata sul tema dei tabù e della sessualità femminile. Scuole e coreografi che sanno coniugare il contemporaneo con il classico, pur affrontando temi attualissimi e spesso di rottura.
È in questo contesto che si forma Virginie Brunelle, laureatasi all’Université du Québec à Montréal nel 2008. Un anno dopo fonda la Compagnie Virginie Brunelle con l’intento programmatico di porre la musica al centro del processo creativo. Il suo stile personale e visionario le apre rapidamente le porte dei grandi teatri europei, tra cui il Theaterhaus di Stoccarda dove nel 2018 presenta Les corps avalés, un connubio teso tra musica classica e corpi calpestati dalla brutalità del mondo contemporaneo.
Dopo il debutto in anteprima mondiale al Lugano Dance Project Festival nel 2022, Fables arriva a Venezia rispondendo all’appello Creatori di miti lanciato da Wayne McGregor: dodici performer e un pianista raccontano, in tre tableaux, storie di donne archetipiche della libertà. Una riflessione sul sociale, non disgiunta da un sano senso dell’humour.
L’ambientazione simbolica è il mitico Monte Verità, montagna emblematica di una controcultura idealistica d’inizio Novecento, che richiama alla memoria Rudolf Laban, Isadora Duncan, Ida Hofmann, Mary Wigman, Charlotte Bara e molti altri ancora. «Un universo di grande potenza evocativa, vicino al teatro-danza, che riecheggia un bisogno disperato di utopia, di speranza, di umanità».
Dal XV secolo la libera espressione del corpo è stata spesso limitata da rigide regole di movimento, almeno fino all’avvento della modern dance. Oggi, nel mondo della danza contemporanea, esistono ancora limiti imposti dal mercato o da altri fattori? Assolutamente. Anche se la danza contemporanea è nata in reazione a certe forme di codificazione, non sfugge ad altri tipi di pressioni. Il mercato culturale, i programmatori, i formati imposti dalle istituzioni o le aspettative del pubblico possono diventare vincoli impliciti. C’è una tensione costante tra il desiderio di libertà artistica e le esigenze di visibilità, leggibilità o sostenibilità economica. Credo tuttavia sia possibile rimanere fedeli al proprio approccio, cercando un equilibrio tra sincerità, creatività e adattabilità, liberandosi dallo sguardo critico degli altri.
Fables, creazione del 2022, viene ora presentata alla Biennale 2025 il cui tema è Creatori di miti/Myth Makers. In che modo questo pezzo risponde a quel tema e cosa l’ha spinta a sceglierlo rispetto a suoi lavori più recenti quali Sans quoi nous créverons o Les corps avalés, attualmente in tournée in Germania?
Fables esplora la costruzione di narrazioni simboliche all’interno delle comunità umane. Ogni quadro agisce come un mito in sé, come allegoria contemporanea delle tensioni, delle lotte e degli impulsi che ci attraversano. Lo spettacolo non racconta una storia nel senso tradizionale, ma crea archetipi, frammenti di leggende incarnate. Si inserisce quindi naturalmente nel tema Myth Makers


Montreal – a city of dancers and artists, in no short measure thanks to cultural policy, given how local government always invested in all forms of art. We will mention our beloved Marie Chouinard, who directed the Venice Dance Biennale for four years, Louise Lecavalier (So Blue, 2017), and Daina Ashbee, whose Unrelated, a story on the taboos of female sexuality, was presented at the Biennale at the Biennale in 2017. Montreal’s schools and choreographers know how to wed the classic and the modern while authoring pieces on very current, often very divisive, themes. Virginie Brunelle grew within this context. She graduated from Quebec University in 2008 and a year later, she formed her eponymous company to put music at the centre of the creative process. Her personal, visionary style opened the doors of the greatest European theatres for her, including the Theaterhaus in Stuttgart (Les corps avalés, 2018).
The piece Brunelle will show in Venice, Fables, premiered at the 2022 Lugano Dance Project Festival in Switzerland. It answers 2025 Venice Dance Biennale director Wayne McGregor’s theme Mythmakers with twelve performers and a pianist telling stories about women who are archetypes of freedom. A reflection on society with a sprinkle of humour. Its symbolic setting is Mont Vérité (lit. ‘truth hill’), the emblematic hilltop of early twentieth-century idealistic counter-culture that reminds one of Rudolf Laban, Isadora Duncan, Ida Hofmann, Mary Wigman, Charlotte Bara, and others.
Rigid rules for dance no more.
While modern dance was, in fact, born to counter certain codes, that doesn’t mean it is immune from other forms of pressures. Cultural markets, productions, formats imposed by institutions, and audiences’ expectations are real constraints. There’s a constant tension between a desire for artistic freedom and a need for visibility, readability, and fiscal sustainability. I still believe it is possible to keep true to one’s ideas and find a balance between sincerity, creativity, and adaptability.
Fables as an entry in the Biennale programme. Fables explores the building of symbolical narrations within human communities. Every tableau is a myth in itself, a modern allegory of tension, struggle, and impulses that we harbour within. The show is not a story in a traditional sense, but a construction of archetypes, pieces of embodied legends. It falls naturally in the theme of Myth Makers. The final choice was McGregor’s, though, and I understand his choice: Fables is my piece that is closest to a modern mythology. Sans quoi
Detto questo, Fables non è stata una mia proposta, ma una scelta di Wayne McGregor. E ne comprendo la ragione: è probabilmente il mio pezzo più vicino all’idea di mitologia contemporanea. A differenza di Sans quoi nous crèverons, più radicato in una critica socio-politica attuale, o di Les corps avalés, con una struttura più pittorica e introspettiva, Fables propone immagini che riecheggiano quasi le fiabe, con personaggi senza tempo, al contempo familiari e simbolici, che incarnano forze, desideri o conflitti universali.
Ha spesso sottolineato come la musica e il simbolismo siano centrali nelle sue creazioni, mentre Les corps avalés richiama fortemente i colori e la potenza pittorica di Caravaggio. In che momento della creazione di uno spettacolo decide aspetti visivi fondamentali come costumi e luci?
Gli elementi visivi emergono gradualmente, in dialogo con il materiale coreografico e la musica. Non parto mai con un’immagine fissa in mente, ma lascio che siano le mie intuizioni a guidarmi per i costumi e le luci. Durante le prove i colori si impongono, le texture appaiono e un universo visivo inizia a prendere forma. Con la costumista costruiamo questo mondo a strati successivi, basandoci su ciò che la danza rivela e su cosa il costume può offrire. Per quanto riguarda la luce, invece, è solo verso la fine, durante la residenza tecnica, che l’universo visivo si costruisce a partire dalle idee che ho raccolto per tutto il tempo e dalle intuizioni del lighting designer.
In Fables però il processo è stato un po’ diverso: ho voluto che il costume fosse parte dell’ideazione fin dall’inizio, cosa non sempre avvenuta nelle mie creazioni precedenti. Volevo che il costume raccontasse quanto il gesto o la musica, che riuscisse a dispiegarsi come un elemento scenografico a sé stante. L’abito diventa così contenitore di storie, di simboli, quasi un prolungamento del corpo nello spazio. Partecipa pienamente all’elaborazione del significato e alla tessitura poetica dell’opera.
Temi come unione, rottura, fascino erotico, fatica e adulterio ricorrono spesso nelle sue opere. Al contempo, in varie dichiarazioni, parla di inserire riferimenti autobiografici, desiderare momenti ludici e umorismo. Come riesce a conciliare questi aspetti apparentemente contrastanti con il suo appello all’utopia, alla speranza e all’umanità?
Credo profondamente che l’essere umano sia intrinsecamente contraddittorio, ed è proprio questo che di esso mi affascina. Le mie opere non cercano di risolvere le tensioni, ma di metterle a nudo. Umorismo, tenerezza e assurdità convivono con dolore, disillusione o desiderio. Come nella vita, la curva drammatica non è mai lineare: ogni momento di leggerezza fa da contrappunto a una scena più cupa e viceversa. Questo dialogo tra gli estremi dà rilievo a ogni emozione, permettendo loro di risuonare più in profondità. Far coesistere l’ultra-drammatico e il bizzarro significa parlare del mondo in cui viviamo.
L’umanità, per me, passa attraverso la verità e quindi l’imperfezione. Per questo mi interessa tanto la fatica fisica: a un certo punto il performer non può che impegnarsi pienamente nel compito. Il superamento di questa soglia svela l’uomo dietro il tecnico. Il corpo, nella fatica, mostra una sincerità cruda, una vulnerabilità preziosa.
L’utopia, tema centrale in Fables, emerge in quelle grandi scene di gruppo in cui tutti cercano di unirsi per un obiettivo comune mante -

nendo la propria individualità. È questa tensione tra il desiderio di fusione e l’affermazione della differenza che cerco di esplorare. Un modo per immaginare, forse, un altro modo di stare insieme.
L’arte offre uno spazio di riflessione, uno specchio. Esponendo le nostre lotte intime e collettive attraverso il movimento invitiamo il pubblico a guardare con occhi nuovi le proprie sfide, le relazioni e il posto che occupa nella società. L’arte non trasforma sempre il mondo concretamente, ma lo rende visibile in modo diverso. E a volte questo è sufficiente per seminare il dubbio, accendere una domanda o far nascere la speranza.
In un mondo così frammentato, in cui l’uomo sembra essere in guerra continua contro i suoi simili, il richiamo a Monte Verità in Fables le sembra ancora attuale?
Preferirebbe ispirarsi all’Inno al Sole di Laban o alla sua Danza al tramonto?
Per essere del tutto onesta, non ho visto Sang an die Sonne né Sonnenuntergang nelle loro versioni originali. Detto questo, da quello che conosco di queste opere le percepisco come ricerche simboliche di armonia, sia in uno slancio vitale verso la luce, sia in uno spazio più ambiguo tra fine e nuovi inizi. Monte Verità rimane per me un potente simbolo di resistenza dolce: un luogo in cui poter trovare nuovi modi di vivere fuori

dagli schemi dominanti di industrializzazione e gerarchia sociale. In Fables mi sono ispirata a due temi chiave di questo spirito: la ricerca della parità di genere e il desiderio collettivo di utopia. Lo spettacolo si apre con un prologo che ritrae una società fredda, sconnessa, quasi meccanica, in netto contrasto con un epilogo in cui emerge gradualmente un calore umano, una coesione ritrovata. Tra questi due poli si dipanano favole femministe che presentano figure femminili più grandi della vita, ispirate alle nostre nonne e ad archetipi universali. Sono donne che si emancipano attraverso la loro tenacia, il loro umorismo, la loro forza. Portano in sé un soffio di trasformazione, celebrando l’umanità nella sua forma più resiliente e profondamente vitale.
I suoi cortometraggi Réminiscences (2021) e Show me the exit (2025) hanno purtroppo poche possibilità di essere visti dal pubblico. Ci sarà occasione di ammirarli alla
Biennale Danza o magari altrove?
Ne sarei molto lieta. Questi cortometraggi sono per me preziosi spazi di creazione che permettono di esplorare un’altra temporalità, un altro rapporto con la danza. Siamo sempre aperti a opportunità per proiezioni in festival o sale. Al momento è disponibile solo Réminescences, ma se la Biennale volesse includerlo in una sezione parallela o in una programmazione speciale sarebbe per me un grande onore.
nous crèverons is more of a socio-political critique, while Les corps avalés has a more pictorial, introspective structure. Fables echoes fairy tales, with timeless characters that are at once familiar and symbolical. They incarnate universal forces, desires, and conflicts.
Colour and pictorial power in Les corps avalés.
Visual elements emerge gradually as they converse with choreography and music. I never start out with a given image in mind, I rather let my intuition guide me in my choices of costumes and lighting. While rehearsing, colours impose their presence, textures appear, and a visual universe comes into place. My costume designer and I build this world in layers, based on what dance reveals and what costumes can offer. In Fables the process has been a little different: I wanted costumes to be part of the creation from the very beginning, unlike anything I did before. Costumes were supposed to tell my stories as much as gestures and music do, and to become a scenic element in its own right. Costumes contain stories, symbols, and act as extensions of the body. They fully participate in the elaboration of meaning and poetry.
Contradictions in the art you make.
Human beings are essentially contradictory, which I find absolutely fascinating. I don’t make art to solve contradictions, but to show them in full light. Humour, tenderness, and absurdity coexist with pain, disillusionment, and desire. Much like in life, the tension of drama is never linear. Every moment of lightness counterpoints a darker scene, and vice versa. This dialogue of opposites highlights every feeling and allows them to resonate more deeply. To make the ultra-dramatic and the bizarre coexist means to speak of the world we live in.
Mont Vérité is, to me, a powerful symbol of sweet resistance, a place where we can find new lifestyles, different than the ones we know are dominated by industrialization and social hierarchy. For Fables, I took inspiration from two key elements: the quest for gender equality and a collective desire for utopia. The show opens with a prologue of a cold, disconnected, almost mechanical society, in contrast with an epilogue of slowly emerging human warmth and newly found unity. Between these two poles are feminist fairy tales inspired by our ancestresses and by universal archetypes. These women found their emancipation in their perseverance, their humour, their strength. They carry a breath of transformation and celebrate humanity in its most resilient, most deeply vital form.
Your short movies Réminescences and Show me the exit. I would love it if they could make it into the Biennale programme. These short movies are precious creative spaces that allow us to explore a different timeline, a different relationship with dance. We are always open to distribution opportunities, whether in festivals or in theatres. Currently, only Réminescences is available. If the Biennale included it into a parallel section or some special programme, I would be honoured.

L’atteso ritorno della “danza del corpo” di TAO Dance Theater
Dopo il Leone d’Argento ricevuto nel 2023, TAO Dance Theater torna alla Biennale Danza con la prima europea di 16 e 17, nuovi capitoli della lunga Numerical Series, co-commissione della Biennale. Fondata a Pechino nel 2008 da Tao Ye, Duan Ni e Wang Hao, la compagnia si è affermata a livello internazionale per il rigore formale e l’astrazione radicale con cui affronta il corpo e il movimento, secondo un principio di “danza pura” che rifiuta narrazione e rappresentazione.
Al centro della ricerca è il corpo, indagato attraverso il Circular Movement System, tecnica basata su movimenti continui, curvi, senza inizio né fine, come pennellate nello spazio. Niente specchi in sala prove, nessun riferimento esterno: la coscienza del corpo si costruisce dall’interno, attraverso esercizi che trasformano la ripetizione in atto conoscitivo. La danza, in questo orizzonte, non è espressione ma presenza, non rappresentazione ma attenzione, che sollecita una percezione viscerale e quasi cinestesica.
La Numerical Series – priva di titoli – è concepita come un’opera unica in tappe, ognuna delle quali esplora un’ipotesi sul movimento. 16 si concentra sui moti della testa, normalmente marginali, qui portati al centro dell’azione. 17 indaga la relazione tra suono e corpo, attraverso quella che i coreografi definiscono “immaginazione cinestesica del suono”: una tensione costante tra forma sonora e fisica.
Ogni numero nasce da un’idea minima, sviluppata fino alle estreme conseguenze. L’estetica è asciutta, essenziale, reiterativa. Il ritmo nasce dalla persistenza. Nulla distrae dalla materia viva del corpo: né scenografie né costumi, solo luce, suono e precisione assoluta. In un’epoca di iperstimolazione e sovra-narrazione, TAO Dance Theater sceglie la via contraria: la rarefazione. Ogni gesto è una domanda. Ogni sequenza un esercizio spirituale. La danza – ci raccontava Tao Ye due anni fa – «attiva i sette sensi e restituisce il corpo alla sua condizione originaria, quella di un microcosmo vivo e pulsante». È un’arte che non pretende di spiegare, ma di far sentire. E forse proprio per questo, di far capire. Chiara Sciascia
ENG After receiving the Silver Lion in 2023, TAO Dance Theater returns to the Biennale Danza with the European premiere of 16 and 17, new chapters in their long-running Numerical Series, co-commissioned by the Biennale. Founded in Beijing in 2008 by Tao Ye, Duan Ni, and Wang Hao, the company is internationally acclaimed for its formal rigor and radical abstraction, embracing a principle of pure dance that rejects narrative and representation. At the core is the body, explored through the Circular Movement System, namely a technique of continuous, curved motion without beginning or end, like brushstrokes in space. No mirrors, no external references: body awareness is built from within, through repetition as a form of knowledge. Dance becomes presence, not expression; attention, not representation. Each number in the Numerical Series explores a movement hypothesis. 16 focuses on head motion; 17 on the kinaesthetic imagination of sound. The aesthetic is minimal, repetitive, and precise, stripped of sets and costumes, leaving only light, sound, and the living body.



Il segreto dell’usignolo Rani Khanam e Aakash Odedra, echi di cultura sufi
Rani Khanam è un’importante ballerina e coreografa indiana, riconosciuta a livello nazionale e specializzata nello stile classico indiano Kathak. È discepola di Pandit Birju Maharaj, il più grande maestro di quest’arte. La danza Kathak, storicamente nata come arte narrativa sacra nei templi indiani attorno al IV secolo a.C., si è espansa nel tempo alle corti musulmane. E attraverso questo intreccio si è arricchita di nuovi elementi come la sensualità, l’eleganza, il virtuosismo tecnico. Recuperata nel ‘900 come danza classica nazionale è oggi compresa tra le otto principali danze classiche dell’India.
Rani Khanam è una delle poche interpreti nota per la sua capacità di coniugare la danza tradizionale con contenuti spirituali ispirati a testi sufi (corrente mistica dell’Islam), culture islamiche e interreligiose. Nello spettacolo Songs of the Bulbul, in programma il 26 e 27 luglio, Rani Khanam con una cifra personalissima dirige il danzatore Aakash Odedra, étoile del panorama della danza contemporanea. Di origine sud asiatica, nato e cresciuto a Birmingham (Regno Unito), Odedra è un danzatore rinomato per l’espressività fisica e la precisione tecnica, con la particolarità di essere guidato nella danza da una forte componente autobiografica, che esplora vulnerabilità personali come la dislessia. Protagonista centrale dello spettacolo è il “bulbul”, un usignolo di un mito della cultura sufi, che simboleggia la bellezza del mondo e delle divinità. Catturato e fatto prigioniero in gabbia, l’uccello tenterà di fuggire trovando salvezza solo nella morte, drammatico espediente che lo unirà indissolubilmente al divino. La storia tormentosa e metafora umana viene restituita in un viaggio emotivo raccontato attraverso la danza, avvolta e sostenuta
dalla musica sacra devozionale di Rushil Ranjan. A parlare è il corpo umano, che attraverso contorsioni, movimenti rapidi dei piedi, sguardi, posture simboliche e giri vorticosi (quasi stordenti), infonde allo spettatore lo spirito trascendentale.
Songs of the Bulbul, che ha debuttato al Lyceum Theatre di Edimburgo nell’agosto del 2024, intraprendendo poi un tour nel Regno Unito, ha riscosso molte stelle e lodi. Il Guardian lo definisce: “Un assolo di danza sontuosamente graffiante... traboccante di emozioni”, mentre il The Scotsman lo descrive come “Un’opera di bellezza e tristezza squisita”.
Da spettatori scopriremo alla fine dello spettacolo – indagando nel profondo del nostro intimo –, quale residuo avrà lasciato la delicata immersione in questa cultura. Sara Abra Carrol Smersu ENG Renowned Indian dancer and choreographer Rani Khanam is a leading figure in the classical Kathak tradition and a disciple of the legendary Pandit Birju Maharaj. Kathak, rooted in sacred temple storytelling since the fourth century BC, later evolved through its encounter with Islamic court culture, gaining sensuality, elegance, and technical brilliance. In Songs of the Bulbul (July 26–27), Khanam will direct acclaimed dancer Aakash Odedra, known for his expressive, autobiographical style. The performance centres on the bulbul, a nightingale from Sufi mythology symbolizing divine beauty. Trapped and caged, the bird finds transcendence only through death – a metaphor for spiritual liberation. The story unfolds through Kathak’s intricate footwork, symbolic gestures, and dizzying spins, set to Rushil Ranjan’s devotional music. The piece premiered in Edinburgh in 2024 to critical acclaim for its emotional depth and visual richness. As the final notes fade, the audience is left to reflect on the intimate resonance of this poetic, cross-cultural journey.

Cosa può accadere quando le icone della cultura pop si confrontano con le macerie della crisi finanziaria del 2008? Se lo chiedono i Bullyache, duo formato da Courtney Deyn e Jacob Samuel, vincitore del bando internazionale per nuove coreografie della Biennale Danza 2025. A Good Man is Hard to Find, in prima mondiale al Teatro alle Tese, prende spunto da quella crisi e dalla “Cremation of Care”, rituale segreto celebrato ogni anno al Bohemian Grove dalle élite globali per liberarsi simbolicamente dal senso di colpa prima di esercitare il potere. Lo spettacolo mette in scena il mito della mascolinità dominante, con le sue derive tra arroganza, bullismo e autodistruzione. Cinque danzatori incarnano la psiche frammentata di questi uomini, intrappolati tra divinità e adolescenza: i loro gesti, i rapporti di forza, la loro autorità si costruiscono in forme sempre più ritualizzate.
Con radici nella ballroom culture e una formazione alla Rambert School, Deyn è anche musicista e filmmaker; Samuel ha un background in antropologia visiva. Insieme fondano a Londra, nel 2020, Bullyache: progetto interdisciplinare che esplora il sovraccarico emotivo e visivo della vita contemporanea attraverso la lente dell’identità queer e della cultura operaia, in un linguaggio sensoriale, ibrido e sfaccettato. Un’esplosione estetica che mette in crisi le gerarchie e lascia spazio all’empatia, anche nel mezzo del disastro. C.S.
ENG What may happen when pop icons confront the remnants of the 2008 financial crisis? That’s what Bullyache wonder. Bullyache, a duo formed by Courtney Deyn and Jacob Samuel, will present A Good Man is Hard to Find in world premiere at the 2025 Venice Dance Biennale, a show on the myth of dominating masculinity and its degenerations: arrogance, bullying, self-destruction. Five dancers play the fragmented psyches of these men, trapped between divineness and adolescence.

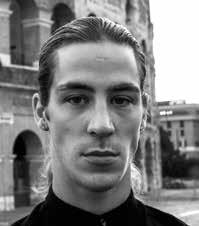
Sisifo re di Corinto, conosciuto per le sue astuzie attraverso le quali ingannava gli dèi, venne condannato da Zeus a spingere un’enorme masso fino alla cima di una montagna, ma ogni volta che egli faticosamente arrivava vicino alla vetta, la pietra gli sfuggiva rotolando a valle, costringendolo così a ricominciare tutto da capo. Più che una punizione, questa fu una vera tortura che lo obbligò a vivere imprigionato in un circolo vizioso di inutile fatica. Questo mito è la sintesi metaforica della vita, è la moderna istantanea della persona umana che agisce in un ciclo costante e ripetitivo di laboriose azioni prive di senso. La performance, che la compagnia Nuovo Balletto di Toscana presenta in anteprima mondiale alla 19. Biennale Danza, è stata ispirata dal saggio pubblicato nel 1942 da Albert Camus. Qui lo scrittore (premio Nobel 1957), nel suo sguardo profondo alla vita, è scientifico e contemporaneamente caustico – «Vivere è dare vita all’assurdo» –, ma in quest’ottica paradossale con freddezza e acume, riesce a sfoderare anche una risolutiva chance, offrendoci di prendere in considerazione il suicidio come un’opportunità, una potenziale libera scelta che permette all’uomo di astenersi alla partecipazione aquesto gioco senza premi. Di converso, decidere di esistere, vale a subirne le conseguenze. È guardare in continuazione la pietra rotolare giù, ma è anche cercare di immaginare Sisifo felice, e infatti lui lo è, perché costringendosi a quel moto perpetuo, ottiene l’immortalità deificandosi. Ma Albert Camus, da umano, è impossibilitato ad essere immortale e con abilità filosofica, ci sorprende e ripiega. Egli riesce a blandire la vita trovando in essa tre ragioni per rimanerci dentro: rivolta, libertà personale e passione.
La danza è un potente linguaggio, una delle più antiche forme di espressione; salvifico mezzo attraverso il quale si sono spesso mascherate le esternazioni di sentimenti proibiti. La performance Sisifo felice dei coreografi del Nuovo Balletto di Toscana, firmata dal neodirettore Philippe Kratz e dal coreografo spagnolo Pablo Girolami, attraverso un dittico (due pezzi distinti ma perfettamente collegati tra loro) ci permette di vivere fisicamente le elucubrazioni esistenziali che affliggono la nostra esistenza, quelle meditazioni che affiorano impetuose nei momenti in cui non siamo distratti dalla fatica. Attraverso il flusso del movimento dei corpi, veicoli materiali di emozione e psiche, riusciremo a indagare il senso dell’esistenza. Da spettatori ci inoltreremo, vagheggiando sonnambuli, nelle volute disegnate nell’aria dalle animazioni dei danzatori, e in quella rarefazione di spirito, sapremmo forse leggere la felicità che Camus immaginava per Sisifo e per sé stesso. S.A.C.S. ENG Zeus sentenced Corinthian king Sisyphus, known for his cunning ability to trick the gods, to push a boulder up to a hilltop, only to see the boulder roll down every time, forcing him to start over again. Torture, more than punishment, trapped in a vicious cycle of useless labour. Life – metaphorically. The Nuovo Balletto di Toscana dance company present, in world premiere, a happy Sisyphus (Sisifo felice) at the 2025 Venice Dance Biennale, inspired by a 1942 essay by Albert Camus. “The realization that life is absurd cannot be an end, but only a beginning”.
ANTONIO DE ROSA / MATTIA RUSSO KOR’SIA
Intervista Kor’sia Antonio de Rosa / Mattia Russo di Chiara Sciascia
Un’identità artistica che si è imposta in pochi anni tra le più riconoscibili e audaci della scena europea: Kor’sia è il collettivo italo-spagnolo fondato nel 2015 da Antonio de Rosa e Mattia Russo, insieme a Giuseppe Dagostino e in collaborazione con Agnès López-Río. Il nome richiama da un lato la kóre¯ , figura archetipica dell’arte greca antica, e dall’altro l’idea di una “scia” o “scena” in movimento: un’immagine di corpo e memoria che si imprime nel tempo e nello spazio.
A Madrid, città in cui oggi ha sede la compagnia, hanno iniziato un percorso di creazione coreografica che amalgama movimento, drammaturgia e arti visive in opere capaci di interrogare con forza l’esperienza contemporanea.
Con Simulacro, presentato per la prima volta in Italia, Kor’sia affronta la tensione sempre più ambigua tra realtà e artificio, tra fisicità e immagine nel tempo dell’iperconnessione. Una riflessione coreografica sulla crisi della percezione e sull’identità del corpo che continua il lavoro di ridefinizione del linguaggio della danza condotto dal collettivo negli ultimi anni. Li abbiamo incontrati per approfondire la genesi dello spettacolo e la loro visione della scena contemporanea.
Kor’sia nasce a Madrid dall’incontro tra percorsi artistici e culturali diversi. Come descrivereste oggi l’identità del collettivo e la vostra modalità di lavoro? Essere un collettivo è un atto politico, oltre che artistico?
L’identità di Kor’sia è, prima di tutto, fluida e in costante evoluzione. Nasce dall’incontro di esperienze differenti – coreutiche, visive, teoriche, performative – che trovano forza proprio nella loro diversità. Non cerchiamo un’uniformità estetica, ma un pensiero comune che si nutre del confronto quotidiano, del dubbio e della coesistenza di sguardi molteplici. Kor’sia è nato a Madrid perché è il luogo dove ci siamo ritrovati a lavorare insieme, dopo anni di percorsi diversi, come danzatori. Oggi è divenuto un organismo vivo, in continua trasformazione, che utilizza la danza come strumento per interrogare il presente e stimolare lo sguardo critico del pubblico. La nostra modalità di lavoro è orizzontale, anche se ci sono ruoli definiti. Ogni creazione nasce da un processo collettivo che coinvolge corpi, immagini, parole, musica, riferimenti

culturali e archivi. Ci piace circondarci di collaboratori, artiste e artisti provenienti da ambiti diversi – performer, compositori, drammaturghi, visual artist – con cui costruire opere che siano paesaggi sensoriali, esperienze immersive. Essere un collettivo è per noi una scelta tanto artistica quanto politica. In un tempo segnato dall’individualismo e dalla competitività, decidere di creare insieme, condividere responsabilità e visioni, è una forma di resistenza. È una presa di posizione contro le strutture gerarchiche tradizionali e un’affermazione del tipo di mondo che vogliamo abitare: un mondo basato sull’ascolto, la fiducia e la responsabilità condivisa. Anche se io e Antonio siamo alla guida del progetto, il nostro obiettivo è generare un ambiente in cui ogni contributo possa nutrire e rafforzare la creazione. Far pensare, far riflettere attraverso la metafora, aprire spazi di senso: questo è il nostro modo di fare arte. Essere un collettivo, per noi, significa questo: un’alleanza creativa, fondata su un dialogo costante e una visione comune.
Vi siete formati entrambi alla Scala, con una solida base classica. Cosa vi ha portato verso un linguaggio così ibrido e contemporaneo? E che traccia ha lasciato l’Italia nel vostro percorso?
La formazione classica all’Accademia Teatro alla Scala di Milano è stata fondamentale: ci ha dato una grammatica, una disciplina e soprattutto un profondo rispetto per il corpo e per il lavoro quotidiano. Ma col tempo abbiamo sentito la necessità di oltrepassare quei codici, cercando un linguaggio che rispecchiasse davvero il nostro presente e la complessità

che ci abita. Oggi il nostro è un linguaggio ibrido, in continua trasformazione, costruito a partire da tutto ciò che siamo stati e che siamo: esperienze, incontri, dubbi, memorie. È come se portassimo con noi uno zaino pieno di vissuti personali e collettivi che si trasforma ogni volta in materia coreografica. Non rifiutiamo la tradizione: la attraversiamo, la interroghiamo, a volte la sovvertiamo, nel tentativo di farla dialogare con le urgenze del nostro tempo. L’Italia ci ha lasciato un forte senso del rigore, della bellezza, dell’armonia. Ma ci ha anche dato, forse proprio per contrasto, l’impulso a cercare nuovi modelli, meno conservatori, più liberi. È stata una base solida, ma anche una spinta verso l’altrove. Rimane comunque un punto di riferimento costante: siamo nati in Italia, circondati dalla sua bellezza, e ne siamo ancora profondamente innamorati. Ci manca di vivere lì, ci torniamo spesso per lavoro e vacanza, tutti i nostri lavori sono co-prodotti da istituzioni italiane e in prima nazionale, e chissà… forse un giorno tornare a casa potrebbe essere davvero bello.
In Simulacro, in un tempo dominato dall’illusione e dalla virtualità, parlate del desiderio di un ritorno alla terra. Che ruolo hanno oggi, per voi, l’empatia, la materia e la presenza fisica nella costruzione di una coreografia? Oggi essere presenti fisicamente assume un valore quasi rivoluzionario. In un’epoca dominata dalla smaterializzazione e dalla virtualità, il corpo reale – con le sue imperfezioni, il sudore, la fatica – rappresenta l’ultimo spazio in cui sperimentare un’autenticità insostituibile. L’empatia nasce nei gesti più minuti: nello sguardo che incrocia un altro sguardo, nella mano che sfiora
An artistic identity that has quickly become one of the most recognizable and bold in the European scene: Kor’sia is the Italo-Spanish collective founded in 2015 by Antonio de Rosa and Mattia Russo, along with Giuseppe Dagostino and in collaboration with Agnès López-Río. The name evokes both the kóre¯ , an archetypal figure of ancient Greek art, and the idea of a “trail” or “scene” in motion – an image of body and memory imprinted in time and space.
In Madrid, where the company is currently based, Kor’sia began a journey of choreographic creation that blends movement, dramaturgy, and visual arts in works that powerfully question contemporary experience. With Simulacro, presented for the first time in Italy, Kor’sia addresses the increasingly ambiguous tension between reality and artifice, between physicality and image in the age of hyperconnectivity. It is a choreographic reflection on the crisis of perception and the identity of the body, continuing the collective’s recent efforts to redefine the language of dance. We met with them to explore the genesis of the performance and their vision of the contemporary scene.
The identity, politics, and art of a collective.
The identity of Kor’sia is, above all, fluid and constantly evolving. It arises from the meeting of diverse experiences – choreographic, visual, theoretical, and performative – that find strength in their differences. We do not seek aesthetic uniformity but a common thought nourished by daily dialogue, doubt, and the coexistence of multiple perspectives. Kor’sia was born in Madrid because it is where we came together to work after years of different paths as dancers. Today, it has become a living organism, continuously transforming, using dance as a tool to question the present and stimulate the audience’s critical gaze. Being a collective is both an artistic and political choice for us. In a time marked by individualism and competitiveness, choosing to create together, sharing responsibilities and visions, is a form of resistance. It is a stance against traditional hierarchical structures and an affirmation of the kind of world we want to inhabit: one based on listening, trust, and shared responsibility.
classical
Our classical training at the Scala Theatre academy in Milan has been fundamental: it provided us with a grammar, discipline, and above all, a deep respect for the body and daily work. However, over time, we felt the need to go beyond those codes, seeking a language that truly reflects our present and the complexity within us. Today, our language is hybrid, continuously evolving, built from everything we have been and are: experiences, encounters, doubts, and memories. It’s as if we carry a backpack full of personal and collective experiences that transforms into choreographic material each time.
We do not reject tradition – we engage with it, question it, and sometimes subvert it, attempting to make it converse with the urgencies of our time. Italy has instilled in us a strong sense of rigor, beauty, and harmony. Yet, perhaps in contrast, it has

ANTONIO DE ROSA / MATTIA RUSSO KOR’SIA
appena un’altra pelle. Non è solo un’emozione, ma una connessione profonda, silenziosa, che travalica le parole. La materia, con il suo peso tangibile, ci radica, restituendoci la dimensione concreta dell’esistenza. Il corpo, prima immagine e poi carne viva, cerca la propria verità proprio nella fragilità che lo rende umano. Per noi questo ritorno alla terra significa in fondo un ritorno al corpo: la nostra radice più naturale, da riscoprire e riconnettere in un mondo sempre più contaminato dal digitale. In Simulacro la coreografia attraversa questi mondi irreali e si apre a domande sospese, interrogativi che permettono ai danzatori di rivelarsi nella loro autenticità più profonda. Così la danza si evolve in una trasformazione imperfetta, reale, viva, forse più umana.
Il corpo in scena diventa un’interfaccia tra mondi diversi, in una narrazione immersiva che dialoga con linguaggi e tecnologie. Qual è stata la sfida principale nel dare forma a questo paesaggio scenico?
La sfida principale è stata mantenere il corpo al centro, nonostante l’ampio utilizzo delle tecnologie. Viviamo in un’epoca iperconnessa ma spesso disincarnata: la tecnologia pervade ogni spazio, rischiando però di far scomparire il corpo, la sua fisicità e la sua presenza tangibile.
In Simulacro abbiamo cercato un equilibrio delicato: il video è un elemento potente che, se usato senza attenzione, può oscurare i corpi.
Per questo abbiamo lavorato affinché il corpo resti vivo, reale e presente, anche all’interno di paesaggi virtuali o concettuali. L’uso della tecnologia non deve mai sostituire l’emozione, ma piuttosto amplificarla e accompagnarla, creando un dialogo armonico.
La costruzione dello spettacolo nasce da un confronto costante tra elementi visivi, sonori e fisici che insieme compongono un vero e proprio ecosistema. La vera difficoltà sta nel fare in modo che tutti questi linguaggi convivano senza che nessuno prenda il sopravvento sugli altri, mantenendo così un equilibrio dinamico e vivo.
Il vostro lavoro sembra sempre interrogare il presente, anche nella sua dimensione politica: l’identità, la collettività, l’inclusione. Quale ruolo credete possa avere oggi l’arte – e in particolare la danza – in un’epoca segnata da preoccupanti slittamenti verso l’indifferenza, i conflitti, l’intolleranza?
Per noi l’arte non ha il compito di offrire risposte, ma di generare domande, di aprire spazi di riflessione e immaginazione. La danza, in particolare, ha qualcosa di profondamente potente: parla attraverso il corpo, e proprio per questo riesce a oltrepassare le barriere linguistiche, culturali, sociali. È un linguaggio primordiale, universale, che tocca senza bisogno di spiegare.
Viviamo in un tempo segnato da mutamenti continui, in cui le identità si moltiplicano, si trasformano, talvolta si frammentano. In questo contesto instabile, la danza può diventare uno spazio di riconoscimento e di possibilità, un luogo dove immaginare nuove forme di coesistenza, nuovi modi di abitare il mondo, di stare insieme, di sentire con l’altro.
Per questo crediamo che la danza sia, nel profondo, un atto politico. Non tanto per ciò che afferma, ma per ciò che fa sentire. In un’epoca che tende a renderci distratti, insensibili, anestetizzati, l’esperienza viva, vulnerabile, tangibile del corpo sulla scena ci riporta all’essenziale. E forse oggi il gesto più radicale e necessario è proprio questo: ritrovarsi insieme in un teatro a condividere un’esperienza che accade nel presente, tra corpi che si espongono, si ascoltano e respirano insieme.
also given us the impulse to seek new, less conservative, and freer models. It has been a solid foundation but also a push towards the elsewhere.
Empathy, materiality, and physical presence in choreography.
Today, being physically present takes on an almost revolutionary value. In an era dominated by dematerialization and virtuality, the real body – with its imperfections, sweat, and effort – represents the last space to experience an irreplaceable authenticity. Empathy arises in the smallest gestures: in the glance that meets another gaze, in the hand that lightly brushes another’s skin. It is not just an emotion but a deep, silent connection that transcends words. Matter, with its tangible weight, grounds us, restoring the concrete dimension of existence. The body, first an image and then living flesh, seeks its truth in the fragility that makes it human. For us, this return to the earth ultimately signifies a return to the body: our most natural root, to be rediscovered and reconnected in an increasingly digital world.
The challenge of shaping the scene.
The main challenge has been to keep the body at the centre, despite the extensive use of technology. We live in a hyperconnected yet often disembodied era: technology permeates every space, risking the disappearance of the body, its physicality, and its tangible presence. In Simulacro, we sought a delicate balance: video is a powerful element that, if used carelessly, can overshadow the bodies. Therefore, we worked to ensure that the body remains alive, real, and present, even within virtual or conceptual landscapes. The use of technology should never replace emotion but rather amplify and accompany it, creating a harmonious dialogue.
The role of art, and dance in particular, in a time of indifference, conflict, and intolerance.
For us, art does not aim to provide answers but to generate questions, to open spaces for reflection and imagination. Dance, in particular, possesses something profoundly powerful: it speaks through the body, and for this reason, it transcends linguistic, cultural, and social barriers. It is a primordial, universal language that touches without the need for explanation.
We believe that dance is, at its core, a political act. Not so much for what it asserts, but for what it makes us feel. In an era that tends to make us distracted, insensitive, and anesthetized, the live, vulnerable, tangible experience of the body on stage brings us back to the essential. Perhaps today, the most radical and necessary gesture is precisely this: coming together in a theatre to share an experience that occurs in the present, among bodies that expose themselves, listen, and breathe together.
YOANN BOURGEOIS
Intervista Yoann Bourgeois
di Mariachiara Marzari
Impegnato in un’arte viva, radicalmente multidisciplinare e innovativa, primo artista circense a dirigere un’istituzione nazionale dedicata all’arte coreografica – il CCN2 di Grenoble dal 2016 al 2022 –, Yoann Bourgeois immagina le sue creazioni attraverso dispositivi fisici che amplificano fenomeni, permettendogli di investire spazi straordinariamente vari e di proporre infinite variazioni. Questa costellazione è una ricerca della vita, un processo permanente di creazione che lui chiama: “Il punto di sospensione irraggiungibile”. È incredibile come le sue parole, che procedono secondo ritmi sintattici personalissimi e incisivi, offrono già sulla carta la sensazione di perdita di equilibrio, di soglia, di infinito, di vita. Ti catturano. Non poteva quindi che essere attesissima la sua produzione fortemente voluta da Wayne McGregor per il Festival di Danza 2025.
Teatro, musica, circo, installazione e molto altro... come definirebbe la sua arte?
E quale la sua personale definizione di danza?
Faccio fatica a definire la mia arte, perché nasce proprio negli interstizi, quelle zone di attrito in cui le discipline smettono di avere confini impermeabili. Non cerco di produrre un oggetto identificabile o classificabile, ma di provocare un’esperienza, un’esperienza fisica, sensibile e vertiginosa. La vertigine, in fondo, è al centro del mio approccio, non come semplice sensazione di squilibrio, ma come uno stato particolare di presenza. Uno stato in cui i punti di riferimento abituali vacillano, intensificando il nostro stesso grado di presenza. In un momento storico in cui le nostre certezze stanno crollando, credo che questo stato di sospensione possa aiutarci a immaginare altre possibilità.
Il Festival Internazionale di Danza di Sir Wayne McGregor si intitola quest'anno Myth Maker. Quali sono stati i suoi miti?
Sono sempre stato affascinato dalle figure mitiche che non si lasciano rinchiudere in un solo racconto, quelle che incarnano un movimento incessante piuttosto che un compimento cristallizzato: Sisifo, condannato a ricominciare all’infinito; Icaro, sospinto dall’impulso del desiderio prima della caduta; Orfeo, tra il mondo dei vivi e quello dei morti. Sono figure di passaggio, sempre in divenire. Ma c’è un personaggio mitico, poco conosciuto, che trovo particolarmente ispirante: Bute.
Mentre la spedizione degli Argonauti faceva ritorno, a differenza dei navigatori spaventati dal canto delle sirene, che si riempivano le orecchie di cera per non lasciarsi sviare e morire, o di Ulisse, che si fa legare all’albero maestro per resistervi, Bute invece cede. Si getta in mare. Non per debolezza, ma per una vertigine d’abbandono. Questo gesto mi

commuove profondamente: non cerca né di conquistare né di sopravvivere. Risponde a una chiamata. Attraversa il limite. Bute, per me, incarna quel momento così raro in cui si accetta di perdere l’equilibrio per lasciarsi raggiungere, non tanto da uno scopo, ma da una musica interiore, più antica della volontà stessa.
La sua ricerca, come ha appena spiegato, mira a raggiungere il “punto di sospensione” o meglio è sempre in bilico, un attimo prima della caduta. Perché è affascinato dal concetto di caduta? Che significato assume la gravità nelle sue opere?
La caduta è uno dei pochi movimenti universali. Non richiede alcun apprendimento, è presente fin dalla nascita, irrevocabile, inevitabile.
Quello che mi affascina non è tanto la caduta in sé, quanto l’istante che la precede. Quell’istante infinitesimale in cui tutto cambia, in cui il corpo non tocca più terra, in cui il futuro è sospeso. Quel punto, io lo considero come una porta tra i mondi.
La gravità, da parte sua, non è un nemico. È il mio partner. Dà la misura, detta le regole del gioco. Il mio lavoro consiste nel dialogare con essa, nel cercare come ritardare l’inevitabile, o al contrario, nell’accettarlo pienamente.

Yoann Bourgeois committed to a living, radically multi-disciplinary, innovative form of art. He is the first circus artist and performer to direct a national choreography institute – the CCN2 in Grenoble, France, from 2016 to 2022 – and imagines his art by working on physical devices that amplify different phenomena, allowing him to invest in diverse spaces and offer infinite variations. Bourgeois researches life in a process of constant creations that he calls ‘the unattainable point of suspension’. His words follow very personal, distinctive syntactical rhythms. How on mere paper they can bring about that feeling of dizziness, threshold, infinity, life… is nothing short of incredible. You’ll feel captured. We are looking forward to seeing his much-anticipated new production for the 2025 Venice Dance Biennale.
Theatre, music, circus, installation art, and more – how to define your art? What about your personal definition of dance?
I struggle to name my art, for it is born precisely in the interstices – those zones of friction where disciplines cease to have watertight borders. I do not seek to produce an identifiable or
classifiable object, but to provoke an experience: a physical, sensitive, and dizzying experience. Vertigo, at the heart of it, is at the core of my approach. Not as a simple sensation of imbalance, but as a certain state of presence. A state where the usual landmarks waver, which intensifies our degree of presence. In a historical moment where our certainties are collapsing, I believe that this state of suspension can help us envisage other possibilities.
Sir Wayne McGregor titled his International Dance Festival Myth Maker this year. What were your idols?
I have always been fascinated by mythical figures who do not allow themselves to be confined to a single narrative, those who embody an incessant movement rather than a fixed accomplishment: Sisyphus, condemned to start over endlessly; Icarus, carried by the momentum of desire before the fall; Orpheus, between the world of the living and that of the dead. These are figures of passage, always in the making. But there is a mythical character, little known but which I find particularly inspiring: Butes. Unlike the terrified navigators frightened by the sirens’ song who filled their ears with wax so as not to be led astray and die, or Ulysses, who had himself tied to the mast to resist them, Butes yields to them. He throws himself into the sea. Not out of weakness, but out of a vertigo of abandonment.
Ogni caduta contiene una lezione di vita. E ogni sospensione, una possibilità di reinvenzione.
Pittura, architettura, scultura sono riferimenti presenti sempre nel suo lavoro. Quali sono le influenze artistiche e intellettuali che hanno plasmato l’estetica delle sue coreografie?
Sono profondamente nutrito dalle arti dello spazio: la pittura, l’architettura, l’incisione, la scultura. In Goya o Bacon, è l’intensità cruda della presenza che mi ispira. In Escher, il disorientamento dei punti di riferimento: quella vertigine dello spazio mentale che si ricollega alla mia ricerca fisica.
Sul piano intellettuale, mi riferisco a pensatori del movimento come Bergson o Deleuze, che mi hanno insegnato a pensare l’arte come flusso, come divenire, piuttosto che come forma fissa. La mia estetica nasce da queste tensioni: tra solidità e fragilità, tra costruzione architettonica e movimento instabile. È un’arte della soglia, sempre in disequilibrio, sempre in mutazione.
Quale evidenza assume lo spazio e in particolare il suo spazio connotato da presenze definite, come per esempio la scala?
Lavoro a partire dai dispositivi perché, come suggerisce Giorgio Agamben, sono essi a plasmare i nostri gesti, i nostri desideri, le nostre soggettività.
Il dispositivo, per me, non è un semplice strumento scenico, ma una matrice: un campo di vincoli e possibilità che produce senso, molto più di quanto ne illustri. Crea condizioni di apparizione.
Ciò che mi interessa non è tanto ciò che l’individuo fa nello spazio, ma ciò che lo spazio fa all’individuo, come lo trasforma, lo influenza, lo attraversa.
In questa prospettiva, il performer non è un “attore” in senso classico, padrone della propria intenzione, ma un soggetto attraversato, una presenza porosa, messa alla prova da un’architettura, da una gravità, da un ritmo.
Questo ribaltamento mi aiuta a eludere le forme classiche di antropocentrismo, in cui tutto parte dall’umano per imporsi al mondo. Qui è il mondo – le sue leggi fisiche, le sue materie, i suoi vuoti – ad agire. E l’essere umano impara a comporre con esso, in un rapporto di attenzione, di fragilità, talvolta di resistenza. Il mio lavoro, in questo senso, non è tanto una scrittura di gesti quanto una scenografia di forze eloquenti.
Siamo rimasti colpiti dal suo ritratto sulla scala bianca, un’ immagine potente e poetica. Ci ha conquistato subito il contrasto tra la tensione del movimento, la caduta, la pace del trovarsi sospesi tra le nuvole. Cosa ha il privilegio di vedere, là dalla cima di quella scala, forse irraggiungibile per la maggior parte di noi “comuni” mortali?
Dall’alto della scala non c’è alcuna vista spettacolare. Nessuna rivelazione grandiosa. Niente da conquistare, niente da dominare. Solo un leggero spostamento dello sguardo. Uno scarto quasi impercettibile che basta a riattivare una visione antica: quella in cui le cose galleggiavano, in cui il mondo non era ancora irrigidito, assegnato, bloccato.
Ciò che cerco non è una vetta. È uno stato. Quello della sospensione.
Un istante sospeso non è un tempo vuoto, è un tempo pieno, ma sottratto all’urgenza. Un tempo che si apre dentro il tempo.
Questa è l’eternità, per me: non un al-di-là, ma un “qui” radicale, senza proiezioni.
Una presenza che non è né nel prima né nel dopo, ma nella vibrazione stessa di ciò che sfugge. Un puro battito. Questa via di mezzo – né ascesa, né caduta – è fragile, incerta, quasi inaccessibile, eppure ci riguarda tutti.
È in questo spazio che qualcosa può ridisegnarsi. Perché la sospensione, lungi dall’essere una fuga mistica, è anche un modo per aggirare i rapporti di forza. Per rallentare, interrompere, riconfigurare ciò che sembrava inevitabile. È un atto di resistenza contro l’accelerazione, contro l’efficienza, contro la verticalità trionfante.
La scala, come molti dei miei dispositivi, non è una via verso un compimento. È una metafora della ricerca: un’ascesa che non mira a raggiungere, ma a esperire. A percepire meglio ciò che, nell’istante, trema, scompare o si rivela.
È lì che si annida, forse, una forma di libertà: in questa attenzione a ciò che vacilla.
Che ruolo ha la scelta musicale nelle sue creazioni? Il brano musicale detta una storia o diventa paesaggio?
La musica, nel mio lavoro, non è né un supporto narrativo né un semplice sfondo sonoro.
Costituisce una struttura di forze, una materia che organizza lo spazio, modifica la gravità dei corpi, influenza il ritmo dei gesti. Come la drammaturgia che pratico, procede per intensità, per dinamiche, molto più che per racconto. Può emergere fin dall’inizio del processo come impulso fondante, oppure arrivare più tardi, come una necessità organica. Ma agisce sempre. Scolpisce l’invisibile.
Attribuisco grande importanza ai silenzi, alle pause, alle musiche capaci di aprire dei vuoti.
Amo collaborare con musicisti che concepiscono il suono come uno spazio di ascolto condiviso, non per accompagnare il movimento, ma per coesistere con esso in un equilibrio non gerarchico.
Venezia è per antonomasia una città sospesa tra il cielo e l'acqua ed è piena di scale (ponti), deduciamo che possa essere la sua città ideale! Quale il suo legame con la città?
Venezia è, ai miei occhi, una città che sfida le consuete leggi della realtà. Sembra galleggiare tra due mondi, come un sogno che ha preso forma. Ciò che mi colpisce è il suo rapporto con il tempo: un tempo rallentato, poroso, quasi sospeso.
Mi sento vicino a questa città perché costringe a rinunciare alla linea retta. Invita all’erranza, all’inatteso. A ogni angolo, una soglia. A ogni soglia, una storia possibile.
This gesture deeply moves me: he seeks neither to conquer nor to survive. He responds to a call. He crosses the limit. Butes, for me, embodies that rare moment when one accepts to lose one’s footing to let oneself be reached - not by a goal to be achieved, but by an inner music, more ancient than will itself.
Your research aims at a ‘point of suspension’, or rather, it always balances on the step right before the fall. Why does the concept of ‘fall’ fascinate you so? What meaning does gravity have in your art?
The fall is one of the few universal movements. It requires no learning, it is there from birth - irrevocable, inevitable. What fascinates me is not so much the fall itself as the instant just before. That infinitesimal moment when everything tips over, when the body no longer touches the ground, when the future is suspended. That point, I consider it a door between worlds. Gravity, for its part, is not an enemy. It is my partner. It gives the measure, it dictates the rules of the game. My work consists in dialoguing with it, in seeking how to delay the inevitable, or on the contrary, how to fully accept it. Each fall contains a life lesson. And each suspension, a possibility of reinvention.
Painting, architecture, sculpture are always present as reference points in your art. What artistic and intellectual influences shape the aesthetics of your choreographies?
I am deeply nourished by the arts of space: painting, architecture, engraving, sculpture. In Goya or Bacon, it is the raw intensity of presence that inspires me. In Escher, the disturbance of landmarks - that vertigo of mental space that joins my physical research. On an intellectual level, I refer to thinkers of movement like Bergson or Deleuze, who have taught me to think of art as flux, as becoming, rather than as a fixed form. My aesthetics are born of these tensions: between solidity and fragility, between architectural construction and unstable movement. It is an art of the threshold, always off-balance, always in mutation.
What role for space, and in particular, the space around defined presences, such as the steps?
It is props and items that shape our gestures, our desires, our subjectivities. These devices, for me, are not a mere scenic tool, but a matrix: a field of constraints and possibilities that produces meaning, far more than it illustrates. It manufactures conditions of appearance. What interests me is not so much what the individual does in the space, but what the space does to the individual. How it transforms, influences, and traverses him. From this perspective, the performer is not a “classical” actor, master of his intention – he is a traversed subject, a porous presence, tested by an architecture, by a gravity, by a rhythm. This reversal helps me to thwart classical forms of anthropocentrism, where everything starts from the human to impose itself on the world. Here, it is the world – its physical laws, its materials, its voids – that acts. And the human being learns to compose with it, in a relationship of attention, fragility, sometimes resistance. My work, in this sense, is less a writing of gestures than a scenography of eloquent forces.
We picked your very beautiful image of the staircase as the cover picture for our magazine. We loved it for the contrast between the tension of the motion, the fall, the peace of finding ourselves up in the clouds. What can you see from atop the staircase, a point that most of us mere mortals cannot reach?
From the top of the stairs, there’s no breath-taking view. No grand revelation. Nothing to conquer, nothing to dominate. Just a slight shift in the gaze. A nearly imperceptible shift that’s enough to reactivate an old vision – one where things floated, where the world wasn’t yet fixed, assigned, or locked in place. What I’m looking for isn’t a summit. It’s a state. The state of suspension.
A suspended moment isn’t empty time. It’s full time but subtracted from urgency. Time that opens within time. That’s what eternity means to me: not a beyond, but a here – a radical here, without projection. A presence that’s neither in the before nor the after, but in the vibration of what escapes. A pure beat. This in-between – neither ascent nor descent – is fragile, uncertain, almost inaccessible, and yet it concerns us all. It’s in that space that something can be rewritten. Because suspension, far from being a mystical escape, is also a way to subvert the power dynamics. To slow down, interrupt, and reconfigure what seemed inevitable. It’s an act of resistance to acceleration, efficiency, and triumphant verticality.
The staircase, like many of my devices, isn’t a path to accomplishment. It’s a metaphor for the quest – an ascent that doesn’t aim to reach, but to feel. To feel more what, in the instant, trembles, fades, or reveals itself. That’s where perhaps a form of freedom lies: in the attention given to what wavers.
What role for music in your art? Does a piece of music dictate the story, or is it part of the background?
Music in my work is not a narrative support or a simple sonic backdrop. It’s a structure of forces – a material that organizes space, modifies the gravity of bodies, and affects the rhythm of gestures. Like the dramaturgy I practice, it proceeds by intensities, by dynamics, rather than by narrative. It can emerge from the beginning of the process as a foundational impulse or come later as an organic necessity. But always, it acts. It sculpts the invisible. I give great importance to silences, to breaths, to music that can open voids. I enjoy collaborating with musicians who think of sound as a shared space of listening – not to accompany movement, but to coexist with it in a non-hierarchical balance.
Venice is known as a city suspended between water and sky, and one where steps (on bridges) are all over. You’ll find that ideal! Tell us about your relationship with Venice. To me, Venice is a city that defies the usual laws of reality. It seems to float between two worlds, like a dream that has taken shape. What touches me is this relationship to time: a sloweddown, porous, almost suspended time. I feel close to this city because it forces us to give up straight lines. It invites us to wander, to the unexpected. At every street corner, a threshold. At every threshold, a possible story.

Energia grezza. Bellezza e caos esplodono imprevedibili nella vita come nel ventre di un vulcano. Ventre do Vulcão, appunto, è il titolo dell’ultimo assolo di Tânia Carvahlo, artista e coreografa portoghese, chiamata da Wayne McGregor a presentare il suo lavoro in prima mondiale all’interno del cartellone della 19. Biennale Danza. Carvahlo spinta da un profondo fascino per le forze che modellano i nostri mondi interiori e le nostre esperienze, accede ai campi più alti della creatività celebrando la bellezza, la gioia e l’amore. La sua coreografia fonde la precisione classica ereditata dalla sua formazione artistica con il movimento espressivo e caotico, rispecchiando l’imprevedibilità della vita. Una miscela che cattura la complessità della bellezza e dell’oscurità dell’esperienza umana. L’assolo «nasce – scrive Tânia Carvalho – dalla curiosità di capire come noi, in quanto artisti, possiamo fungere da contenitori per l’energia grezza. Piuttosto che modellare consapevolmente emozioni specifiche, mi concentro sul lasciare che sia l’energia del momento a guidare il movimento. La sfida è quella di non definire il lavoro, ma di rimanere aperti all’imprevedibile, permettendo all’energia di fluire. Questa fusione di struttura e spontaneità cattura la complessità della nostra bellezza e delle nostre ombre ed è un invito per il pubblico a connettersi con le nostre emozioni e istinti più profondi».
Diletta Rostellato
ENG Beauty and chaos erupt unpredictably in life, like in the belly of a volcano. Ventre do Vulcão (lit. ‘the volcano’s belly) is the title of the latest solo by Portuguese artist and choreographer Tânia Carvalho. Driven by a deep fascination with the forces shaping our inner worlds, Carvalho reaches the heights of creativity, celebrating beauty, joy, and love. Her choreography blends classical precision with expressive, chaotic movement, mirroring life’s unpredictability. “This solo – says Carvalho – was born from the curiosity of how we, as artists, can act as vessels for raw energy. Rather than shaping specific emotions, I focus on letting the energy of the moment guide the movement. The challenge is to stay open to the unpredictable”. This fusion of structure and spontaneity invites the audience to connect with their deepest emotions and instincts.
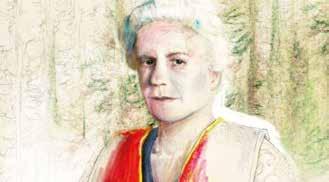
La mort i la primavera di Marcos Morau, la cui prima assoluta va in scena il primo e il 2 agosto al Teatro Malibran, trae ispirazione dal romanzo più moderno e complesso dell’autrice Mercè Rodoreda, scrittrice spagnola di lingua catalana, figura di spicco del XX secolo, attivamente impegnata contro il franchismo e per l’indipendenza della Catalogna. Una penna cruda, spesso contaminata dal continuo confronto con la vita e il suo senso ultimo. Scrive: «La morte fuggì dal cuore e quando non ebbi più la morte dentro morii». La forte personalità e lo spirito idealista della scrittrice si riverberano con costanza nei suoi romanzi, e in particolar modo in questo, che già dal titolo esprime con potenza la complessità dell’esistenza umana, confusa e febbricitante dentro i temi di libertà e responsabilità, dentro i conflitti, nelle discordanze di pensiero, nella guerra. La mort i la primavera (La morte e la primavera) sono una coppia di parole in catalano di fortissimo contrasto: da una parte la morte come fine e oscurità, dall’altra la primavera, come fioritura, rinascita, amore.
L’artista Marcos Morau, classe 1982, dopo gli studi in coreografia presso l’Institut del Teatre de Barcelona, il Conservatorio Superior de Danza de Valencia e il Movement Research a New York, fonda nel 2005 la sua compagnia La Veronal. Attraverso la danza Morau codifica la storia di Rodoreda in un’esperienza visiva e, mescolando immagini, corpi e movenze, plasma la crudezza fino a convertirla in rito. Morau costruisce così un ponte tra letteratura e danza contemporanea, traducendo il legame in avventura immersiva che intreccia estetica, riflessione politica e spirituale.
Ma davvero il senso dello spettacolo è una finzione che racconta un mondo distopico con le atmosfere di una fiaba oscura? Oppure, pensandoci, siamo consapevoli che questa non è fabula ma lo specchio che ci riflette in un mondo già distopico? Godiamo dello spettacolo e proviamo a sfatare la morte con il mezzo che abbiamo più a portata di mano… l’amore.
Sara Abra Carrol Smersu
ENG La mort i la primavera by Marcos Morau, premiering August 1 and 2 at Teatro Malibran, is inspired by Mercè Rodoreda’s most modern, complex novel. A key Catalan writer and anti-Franco activist, Rodoreda explored life’s raw truths. Her words “Death fled from my heart, and when I no longer had death inside, I died” echo in this work. Morau (b. 1982) studied choreography at the Theatre Institute of Barcelona, the Valencia Professional Dance Conservatory, and at the Movement Research in New York before founding La Veronal dance company. Morau transformed Rodoreda’s story into a visual ritual through dance, blending literature, politics, and spirituality. Is this a dark fable or a mirror of our already dystopian world? Let’s face death with the only tool we truly have: love.

Quali narrazioni possono fornire i miti dei nostri giorni? Quale il compito degli artisti contemporanei? Tra gli interrogativi che Wayne McGregor pone attraverso il tema Creatori di Miti / Myth Makers ideato per 19. Biennale Danza sembrano emergere chiare anche queste domande. Se i miti hanno svolto un ruolo cruciale nel corso della storia, fornendo – come scrive McGregor nel suo intervento di presentazione del cartellone – «un quadro di riferimento per comprendere l’esistenza, la moralità e il cosmo, allora in tempi di disordini o di transizione, quando le convinzioni e le strutture tradizionali iniziano a crollare, l’umanità è chiamata a creare nuove narrazioni per far fronte all’incertezza e ispirare speranza». Dare una risposta a queste esigenze è, dunque, obbligo morale degli artisti, che da sempre dei miti sono i creatori. Con le loro nuove narrazioni, che anche nella danza e nel movimento trovano uno strumento di espressione, possono favorire un senso di connessione, appartenenza e scopo, guidando gli individui e le comunità in tempi difficili.
In un palinsesto pensato per raccogliere e suggerire nuovi sguardi, strumenti e direzioni per potersi orientare, sir McGregor non poteva non scegliere William Forsythe, maestro della danza contemporanea tra i massimi coreografi del nostro tempo, come uno dei fari da seguire. Al Teatro alle Tese debutta, in prima italiana e co-commissionato dalla Biennale Danza, Friends of Forsythe, progetto nato dalla collaborazione tra Forsythe stesso e il coreografo e danzatore Rauf Yasit (in arte RubberLegz). Fedele alla sua messa in discussione delle convenzioni del balletto tradizionale, il coreografo statunitense già direttore del balletto di Francoforte porta sul palcoscenico sei danzatori che esplorano le radici della danza folk, del balletto e dell’hip hop, dando vita a un dialogo affascinante che integra armonicamente stili diversi in un vibrante e multiforme arazzo. Il risultato è una celebrazione del carattere universale del movimento, capace di abbattere ogni tipo di barriera, sociale, culturale, politica. Friends of Forsythe esalta la diversità delle culture della danza e il suo profondo linguaggio. È un esempio straordinario di come quest’arte possa mettere in contatto persone di diversa provenienza e stile, e mostra il potere e la bellezza che risiedono nel movimento e nella mescolanza delle diverse tradizioni della danza. Il potere trasformativo della danza e del movimento diventa così strumento di unione tra le persone. Diletta Rostellato
What narratives can today’s myths offer? What is the role of contemporary artists? These is what 2025 Venice Dance Biennale director Wayne McGregor investigates with programme Myth Makers. If myths have historically provided a framework for understanding existence, morality, and the cosmos, then in times of upheaval or transition, when traditional beliefs and structures falter, humanity must craft new narratives to face uncertainty and inspire hope. Artists, as the eternal creators of myths, have a moral duty to respond. Using new narratives, they can foster connection, belonging, and purpose. In a programme designed to offer new perspectives and tools, McGregor chose William Forsythe, a master of contemporary dance, as a guiding light. Friends of Forsythe, co-commissioned by Biennale Danza, will premiere at Teatro alle Tese. Created with choreographer Rauf Yasit (aka RubberLegz), it features six dancers blending folk, ballet, and hip hop in a vibrant tapestry. The piece celebrates the universal power of movement to transcend social, cultural, and political barriers, uniting people through the transformative force of dance.
William Forsythe & RubberLegz
Friends of Forsythe
1, 2 agosto Teatro alle Tese, Arsenale

Sedici giovani danzatori, tre mesi di residenza, due creazioni. Biennale College Danzatori 2025 si misura con due grandi Maestri e due progetti che affrontano in modo radicale il tema della coesistenza. Nel celebre In C, la coreografa tedesca Sasha Waltz lavora con gli Allievi sulla partitura musicale minimalista di Terry Riley del 1964, trasformandola in un organismo coreografico flessibile. Cinquantatré sequenze, eseguite secondo logiche non lineari, danno vita a una danza che muta forma ad ogni replica. L’architettura non è mai imposta: ciascun interprete contribuisce attivamente a determinare direzione e ritmo. Il gruppo, come in una società ideale, vive di relazioni dinamiche, di ruoli mobili, di ascolto.
In risposta all’opera itinerante su larga scala The Herds – parata itinerante di grandi mandrie artificiali in marcia attraverso il Pianeta contro il disastro climatico – che lo scorso giugno ha fatto tappa a Venezia, la star dell’hip-hop Anthony Matsena ha messo a punto per il College un progetto che assume un tono rituale. The Remaining Silence mette in scena un mondo ormai senza animali, attraversato da corpi umani che ne portano l’eco. I danzatori si muovono in uno spazio che evoca un “museo dell’estinzione”, scavando dentro la memoria fisica, tra postura, mancanza e urgenza. Due modi opposti di abitare la scena, entrambi costruiti sull’ascolto reciproco e sulla responsabilità del gesto. C.S. ENG Sixteen young dancers, three months of residency, two creations. Biennale College Dancers 2025 engages with two great masters of dance and two projects exploring the theme of coexistence. The famous In C by German choreographer Sasha Waltz transforms Terry Riley’s 1964 minimalist score into a flexible choreographic organism for the 2025 class. Each dancer shapes the rhythm and direction, creating a dynamic, ever-changing performance. In The Remaining Silence, Anthony Matsena imagines a post-animal world, where dancers create a ‘museum of extinction’ and echo vanished species in a ritual of memory and urgency. Two opposite ways of living the stage, though both built on mutual listening and a sense of responsibility.

Due coreografi, tre mesi di lavoro, un laboratorio a porte socchiuse. Biennale College Coreografi 2025 non è soltanto un percorso produttivo, ma formativo: un tempo di studio e sperimentazione guidato dallo stesso Wayne McGregor, pensato per sostenere artisti all’inizio della loro traiettoria. Lavorare con i danzatori del College, confrontarsi con l’esperienza, accettare l’errore, sospendere il giudizio: la creazione coreografica qui si misura prima di tutto con un’interrogazione del proprio sguardo. In Coexistence, Wang Le ripercorre i giorni incerti della propria transizione da danzatore a coreografo. I movimenti gli apparivano in sogno, come frammenti da raccogliere e tradurre in azione. La coreografia nasce da lì: da una fiducia nel lavoro sotterraneo dell’inconscio, da un’attenzione al dettaglio impercettibile. Il corpo, prima ancora di comporre, ricorda.
Con Ai’m, Tamara Fernando e Matthew Totaro proseguono su questa linea, ma rifiutando ogni logica narrativa o spiegazione immediata. La danza, per loro, non è da decifrare ma da attraversare. I gesti non chiedono interpretazione, ma un tempo di esposizione, di ricezione lenta. L’inconscio – dicono – è il vero motore del processo creativo: non si mostra subito, ma lascia tracce che maturano nel tempo. In entrambi i lavori la composizione nasce in assenza di un significato predeterminato. Il coreografo non detta, ma facilita. Le immagini non illustrano, ma si depositano. Ed è in questo scarto – tra ciò che si mostra e ciò che ancora sfugge – che il College si conferma un contesto vivo, dove la creazione non cerca risposte, ma zone di tensione da abitare. C.S.
ENG Two choreographers, three months of work, a workshop behind closed doors (or half-closed?) The 2025 Venice Dance Biennale College – Choreographers Section is not just a production path, but a formative one, a time for study and experimentation guided by Biennale Dance director Wayne McGregor that supports emerging artists. In Coexistence, Wang Le revisits his transition from dancer to choreographer, drawing on dreams and unconscious detail. In Ai’m, Tamara Fernando and Matthew Totaro reject narrative to embrace slowness and intuition. In both works, meaning emerges through process, not prescription. Creation as a space of tension, not resolution.

17/07
h. 18 | Arsenale, Teatro alle Tese CHUNKY MOVE
U>N>I>T>E>D (55’) ** A seguire, talk con l’artista
h. 21 | Teatro Malibran
TWYLA THARP DANCE (Leone d’Oro alla carriera) DIABELLI (58’)
+ SLACKTIDE (30’) **
A seguire, talk con l’artista
18/07
su invito | Arsenale, Sala d’Armi E WAYNE MCGREGOR ON THE OTHER EARTH *** installazione commissione La Biennale di Venezia, Tai Kwun Gallery (Hong Kong), Somerset House, (London)
h. 18 | Arsenale, Teatro alle Tese CHUNKY MOVE
U>N>I>T>E>D (55’) **
h. 20 | Teatro Piccolo Arsenale CAROLINA BIANCHI (Leone d’Argento)
CADELA FORÇA TRILOGY Chapter II: THE BROTHERHOOD (220’) * A seguire, talk con l’artista
h. 21 | Teatro Malibran
TWYLA THARP DANCE
(Leone d’Oro alla carriera)
DIABELLI (58’)
+ SLACKTIDE (30’) **
19/07
h. 12-14-16-18 | Arsenale, Sala d’Armi E WAYNE MCGREGOR ON THE OTHER EARTH *** installazione commissione La Biennale di Venezia, Tai Kwun Gallery (Hong Kong), Somerset House, (London)
h. 12.00 | Ca’ Giustinian, Sala delle Colonne Cerimonia di consegna Leone d’Oro alla carriera
TWYLA THARP Leone d’Argento
CAROLINA BIANCHI
20/07
h. 12-14-16-18 | Arsenale, Sala d’Armi E WAYNE MCGREGOR ON THE OTHER EARTH *** installazione commissione La Biennale di Venezia, Tai Kwun Gallery (Hong Kong), Somerset House, (London)
h. 17 | Teatro Piccolo Arsenale CAROLINA BIANCHI (Leone d’Argento) CADELA FORÇA TRILOGY Chapter II: THE BROTHERHOOD (220’) *
h. 21 | Arsenale, Teatro alle Tese BIENNALE COLLEGE DANZATORI
coreografia SASHA WALTZ IN C (60’) *** produzione La Biennale di Venezia A seguire, talk con gli artisti
21/07
h. 12-14-16-18 | Arsenale, Sala d’Armi E WAYNE MCGREGOR ON THE OTHER EARTH *** installazione commissione La Biennale di Venezia, Tai Kwun Gallery (Hong Kong), Somerset House, (London)
22/07
h. 12-14-16-18 | Arsenale, Sala d’Armi E WAYNE MCGREGOR ON THE OTHER EARTH *** installazione commissione La Biennale di Venezia, Tai Kwun Gallery (Hong Kong), Somerset House, (London)
h. 18 | Arsenale, Tese dei Soppalchi BIENNALE COLLEGE DANZATORI
coreografia ANTHONY MATSENA produzione La Biennale di Venezia
h. 21 | Arsenale, Teatro alle Tese BIENNALE COLLEGE DANZATORI
coreografia SASHA WALTZ IN C (60’) *** produzione La Biennale di Venezia
23/07
h. 12-14-16-18 | Arsenale, Sala d’Armi E WAYNE MCGREGOR ON THE OTHER EARTH *** installazione
commissione La Biennale di Venezia, Tai Kwun Gallery (Hong Kong), Somerset House, (London)
h. 18 | Arsenale, Tese dei Soppalchi BIENNALE COLLEGE DANZATORI
coreografia ANTHONY MATSENA produzione La Biennale di Venezia
h. 20 | Teatro Piccolo Arsenale VIRGINIE BRUNELLE FABLES (65’) *
A seguire, talk con l’artista
24/07
h. 12-14-16-18 | Arsenale, Sala d’Armi E WAYNE MCGREGOR ON THE OTHER EARTH *** installazione
commissione La Biennale di Venezia, Tai Kwun Gallery (Hong Kong), Somerset House, (London)
h. 19 | Teatro Piccolo Arsenale VIRGINIE BRUNELLE FABLES (65’) *
h. 21 | Arsenale, Teatro alle Tese vincitori del bando internazionale per una nuova coreografia BULLYACHE
A GOOD MAN IS HARD TO FIND (60’) *** co-produzione La Biennale di Venezia, Nancy May Roberts at Metal & Water
A seguire, talk con gli artisti
25/07
h. 12-14-16-18 | Arsenale, Sala d’Armi E WAYNE MCGREGOR ON THE OTHER EARTH *** installazione
commissione La Biennale di Venezia, Tai Kwun Gallery (Hong Kong), Somerset House, (London)
h. 18 | Arsenale, Teatro alle Tese vincitori del bando internazionale per una nuova coreografia BULLYACHE
A GOOD MAN IS HARD TO FIND (60’) ***
co-produzione La Biennale di Venezia, Nancy May Roberts at Metal & Water
h. 21 | Teatro Malibran TAO DANCE THEATER 16 + 17 (75’) **
co-produzione La Biennale di Venezia, Tao Dance Theater
A seguire, talk con l’artista
26/07
h. 12-14-16-18 | Arsenale, Sala d’Armi E WAYNE MCGREGOR ON THE OTHER EARTH *** installazione
commissione La Biennale di Venezia, Tai Kwun Gallery (Hong Kong), Somerset House, (London)
h. 19 | Arsenale, Teatro alle Tese AAKASH ODEDRA COMPANY SONGS OF THE BULBUL (55’) * A seguire, talk con l’artista
h. 21 | Teatro Malibran TAO DANCE THEATER 16 + 17 (75’) **
co-produzione La Biennale di Venezia, Tao Dance Theater
27/07
h. 12-14-16-18 | Arsenale, Sala d’Armi E WAYNE MCGREGOR ON THE OTHER EARTH *** installazione
commissione La Biennale di Venezia, Tai Kwun Gallery (Hong Kong), Somerset House, (London)
h. 20 | Arsenale, Teatro alle Tese AAKASH ODEDRA COMPANY SONGS OF THE BULBUL (55’) *
29/07
h. 12-14-16-18 | Arsenale, Sala d’Armi E WAYNE MCGREGOR ON THE OTHER EARTH *** installazione
commissione La Biennale di Venezia, Tai Kwun Gallery (Hong Kong), Somerset House, (London)
h. 19 | Teatro Piccolo Arsenale KOR’SIA SIMULACRO (60’) *
produzione Gabriel Blanco, Paola Villegas, Andrea Mendez (Spectare) co-produzione La Biennale di Venezia, Centro de Cultura Contemporánea Conde Duque, Centro Nazionale di Produzione della Danza ResExtensa | Porta d’Oriente, Montpellier Danse - Agora Montpellier, Theater Freiburg
A seguire, talk con l’artista
h. 21 | Arsenale, Tese dei Soppalchi TÂNIA CARVALHO VENTRE DO VULCÃO (50’) *** co-produzione La Biennale di Venezia
A seguire, talk con l’artista






30/07
h. 12-14-16-18 | Arsenale, Sala d’Armi E WAYNE MCGREGOR ON THE OTHER EARTH *** installazione
commissione La Biennale di Venezia, Tai Kwun Gallery (Hong Kong), Somerset House, (London)
h. 18 | Forte Marghera, Padiglione 30 BIENNALE COLLEGE
COREOGRAFI
WANG LE
COEXISTENCE (30’) *** TAMARA FERNANDO E MATTHEW TOTARO
AI’M (30’) ***
h. 19 | Arsenale, Tese dei Soppalchi TÂNIA CARVALHO VENTRE DO VULCÃO (50’) *** co-produzione La Biennale di Venezia
h. 21 | Sala Marghera – zona industriale YOANN BOURGEOIS ART COMPANY
YOANN BOURGEOIS & PATRICK WATSON (60’) * A seguire, talk con l’artista
h. 21 | Teatro Piccolo Arsenale KOR’SIA
SIMULACRO (60’) * produzione Gabriel Blanco, Paola Villegas, Andrea Mendez (Spectare) co-produzione La Biennale di Venezia, Centro de Cultura Contemporánea Conde Duque, Centro Nazionale di Produzione della Danza ResExtensa | Porta d’Oriente, Montpellier Danse - Agora Montpellier, Theater Freiburg
31/07
h. 12-14-16-18 | Arsenale, Sala d’Armi E WAYNE MCGREGOR ON THE OTHER EARTH *** installazione
commissione La Biennale di Venezia, Tai Kwun Gallery (Hong Kong), Somerset House, (London)
h. 18 | Forte Marghera, Padiglione 30 BIENNALE COLLEGE COREOGRAFI
WANG LE COEXISTENCE (30’) *** TAMARA FERNANDO E MATTHEW TOTARO AI’M (30’) ***
h. 20 | Arsenale, Teatro alle Tese vincitori del bando nazionale per una nuova coreografia NUOVO BALLETTO DI TOSCANA
SISIFO FELICE ***
co-produzione La Biennale di Venezia, Nuovo Balletto di Toscana, Fabbrica Europa, House of IVONA
A seguire, talk con gli artisti
h. 21 | Sala Marghera – zona industriale YOANN BOURGEOIS ART COMPANY
YOANN BOURGEOIS & PATRICK WATSON (60’) *
1/08
h. 12-14-16-18 | Arsenale, Sala d’Armi E WAYNE MCGREGOR ON THE OTHER EARTH *** installazione commissione La Biennale di Venezia, Tai Kwun Gallery (Hong Kong), Somerset House, (London)
h. 18 | Arsenale, Teatro alle Tese WILLIAM FORSYTHE/ RAUF “RUBBERLEGZ” YASIT FRIENDS OF FORSYTHE (60’) * co-produzione La Biennale di Venezia
A seguire, talk con l’artista
h. 21 | Teatro Malibran MARCOS MORAU –LA VERONAL
LA MORT I LA PRIMAVERA (75’) ***
co-produzione La Biennale di Venezia, Teatre Nacional de Catalunya A seguire, talk con l’artista
h. 21 | Arsenale, Teatro alle Tese vincitori del bando nazionale per una nuova coreografia NUOVO BALLETTO DI TOSCANA
SISIFO FELICE ***
co-produzione La Biennale di Venezia, Nuovo Balletto di Toscana, Fabbrica Europa, House of IVONA 2/08
h. 12-14-16 -18 | Arsenale, Sala d’Armi E WAYNE MCGREGOR ON THE OTHER EARTH *** installazione commissione La Biennale di Venezia, Tai Kwun Gallery (Hong Kong), Somerset House, (London)
h. 19 | Arsenale, Teatro alle Tese WILLIAM FORSYTHE/ RAUF “RUBBERLEGZ” YASIT FRIENDS OF FORSYTHE (60’) * co-produzione La Biennale di Venezia
h. 21 | Teatro Malibran MARCOS MORAU –LA VERONAL
LA MORT I LA PRIMAVERA (75’) ***
co-produzione La Biennale di Venezia, Teatre Nacional de Catalunya
*** Prima assoluta
** Prima europea
* Prima italiana
Il programma può subire variazioni


Immersed in a living canvas of extraordinary architectural wonders the Gritti Terrace continues to be the social hub of Venice. Drop by for an informal lunch, an afternoon snack, or a glass of perfectly chilled bubbles. From 12:30pm until 5:30pm FOR RESERVATIONS, PLEASE CALL +39 041 794611 OR VISIT CLUBDELDOGE.COM
La notte più lunga e attesa dell’anno, il Redentore è il vero Capodanno di Venezia in cui la festa si annida anche tra gli interstizi delle antiche pietre serenissime. La notte dei foghi è una di quelle notti in cui la città se possibile assume un aspetto ancor più da favola, sembra incredibile che tutto questo splendore sia a portata di sguardo e l’emozione di seguire i riti del Redentore – attraversare il canale della Giudecca sul ponte votivo, la visita alla Basilica palladiana, la pesca di beneficenza, il cibo tradizionale da consumare in lunghe tavolate in attesa dei fuochi lungo le rive o sulle barche addobbate, lo scoccare della mezzanotte e l’inizio dello spettacolo indescrivibile, il bagno al Lido all’alba della domenica e infine le regate nel canale della Giudecca – non trasmette mai un senso di déjà vu Fabio Marzari


FESTA DEL REDENTORE

Nella seconda metà del Cinquecento, in soli due anni, la peste nera si portò via più di un terzo della popolazione. Il Senato veneziano diede così ordine di costruire la Chiesa del Redentore come ex voto per liberare la città da questo flagello. Nel luglio del 1577 la peste fu debellata e vennero proclamati tre giorni di grande festa, che da allora ha il suo fulcro alla Giudecca, le cui rive, occupate da decine di tavole imbandite, risplendono di lampioncini gialli.
ENG In the late 1500s, the black plague wiped out more than a third of the population of Venice in two years. The Venetian Senate ordered the construction of the Redentore Church as a vow to set the city free from the disease. In July 1577, the plague was over. Since that day, the Redentore feast is centred in the Giudecca Island.
Commissionata ad Andrea Palladio dal Senato veneziano, la Chiesa del Redentore rappresenta uno dei massimi capolavori architettonici del Rinascimento e fu terminata dopo la morte del celebre architetto (1580) da Antonio da Ponte, che ne rispettò fedelmente il progetto. La facciata, che a distanza emana il fascino di un bassorilievo, ha il tipico impianto palladiano con i timpani spezzati dalle semicolonne e l’elemento orizzontale che la contiene e la geometrizza. L’interno, intonacato di bianco, ha la grandiosa semplicità del tempio classico. La chiesa e la sagrestia sono ricche di opere d’arte di grande importanza fra cui spiccano i lavori di Tintoretto, Francesco Bassano, Paolo Piazza, Palma il Giovane e Alvise Vivarini. ENG Commissioned to Andrea Palladio by the Government of Venice, the Redentore Church is a masterpiece of Renaissance architecture and was completed after the death of Palladio himself (1580) by Antonio da Ponte, who kept true to the original design. The façade is as fascinating as a bas-relief and shows the typical Palladian style of split tympanum, half-columns, and a horizontal elements encircling the two. The whitewashed interior is as majestic as a classical temple. The church and the sacristy are decorated with beautiful masterpieces by Tintoretto, Francesco Bass- ano, Paolo Piazza, Palma il Giovane, and Alvise Vivarini.
Costruito temporaneamente solo per la Festa, quest’opera ingegneristica lunga 330 metri, in legno e acciaio, è composta da 16 moduli galleggianti ancorati da pali e sorretti da 34 barche. Collega la Fondamenta delle Zattere alla Giudecca a ricordo di quello costruito, in soli quattro giorni, su ottanta galee e ricoperto da un ricco drappo, che collegava San Marco all’opposta riva della Giudecca nel primo solenne corteo del 1577.
ENG The votive bridge is a 330 meters long work of engineering in wood and steel, composed of 16 floating modules anchored by poles and sustained by 34 boats. It links Fondamenta delle Zattere with Giudecca, in memory of the one built in only 4 days on eighty galleys and covered by rich drapery for the solemn procession of 1577.
La domenica, il canale della Giudecca viene restituito per poche ore a sua maestà il Remo. La prima sfida è quella dei giovanissimi su pupparini a due remi, tipica imbarcazione dal profilo sottile e slanciato, si prosegue con la gara tra uomini sempre su pupparini a due remi, per poi completare con la sfida su gondole a due remi, una vera prova di forza fisica e intelligenza per governare al meglio l’imbarcazione, prendendo la giusta corrente lungo il percorso che dal Redentore segue il canale della Giudecca, il canale di Fusina e ritorno con arrivo nei pressi della Chiesa del Redentore.
ENG The first challenge is for youths on two-oared pupparini, typical boats with a slender profile. Then there will be a men’s competition, once again for two-oared pupparini, followed by the two-oared gondola challenge, a true test of physical strength and intelligence: it is necessary to control the boat with great care, finding just the right current along the route from the Redentore church along the Giudecca Canal, the Fusina Canal and back to the Redentore Church.
I bigoi in salsa, l’anara in tecia, il saor, la pasta e fasioi, il rabosetto e l’anguria sono il menù della tradizione, non serve essere filologici nel rispetto di esso, già le tavole imbandite in riva alla Giudecca e alle Zattere, le barche in festa, le terrazze e le altane dei fortunati piene di gente, sono uno spettacolo nello spettacolo, un ricordo, vivo, di una festa ancora radicata.
La ricetta (vedi pagina seguente) pare risalga ai primi anni del 1300 e che sia nata dalla necessità dei marinai di conservare più a lungo il pesce. Il mix di cipolle e aceto permetteva al pesce di durare molto a lungo.
ENG The word saor is none other than the Venetian rendering of savour, or seasoning, while the sarde are the humble sardines, which are fried and then set in layers with blanched onion, raisins, and pine nuts. The saor turns into a preserve after a few days of resting in the fridge. We know of recipes as old as the year 1300, minus the fridge. Apparently, the preserve allowed the fish to last longer, a feature treasured by Venetian seamen.
La ricetta ha radici molto antiche, alcuni la fanno risalire addirittura all’epoca di Marco Polo e rappresenta un piatto povero, ma molto ricco di sapore, un classico della cucina veneziana e veneta. Un tipo di pasta fatta in casa, la tradizione vorrebbe i bigoi di Bassano – in extremis si possono usare anche gli spaghetti –, condita con una salsa di acciughe e cipolla. Da servire rigorosamente senza parmigiano e, se avanzano, sono ancor più buoni freddi il giorno dopo. ENG A very ancient recipe, back from the times of Marco Polo, they say. It is a poor dish, though rich in taste, and a classic of Venetian cuisine. The bigoi are a kind of thick spaghetti – and spaghetti will do, if bigoi should play hard to get – seasoned with a sauce (salsa) of onion and anchovy. No grated cheese on top! It just doesn’t pair well. Any leftover (who am I kidding) will taste even better, cold, the day after.
Si possono utilizzare varie tipologie di pasta, anche se tradizione vorrebbe la “tiracca trevigiana”, i ditalini o il riso; i fagioli possono essere interi, macinati o mezzi e mezzi, dipende se si preferisce un piatto più o meno asciutto. Ottimi se serviti tiepidi, ma anche freddi sempre con un giro d’olio versato a filo. La tradizione prescrive una regola fondamentale: la provenienza dei fagioli, rigorosamente di Lamon, nel feltrino, a 600 metri di quota.
ENG Pasta, you know what that is. Any kind will do (yes, I said that). Fasioi are beans: you boil them first, then you make up your mind, do you like them whole, mashed, or half and half? Let them rest for a bit, lukewarm is best for this dish, and it will go down better with a dash of olive oil stirred in. Tradition says that the best beans come from Lamon, in the Alps, just under 2000 feet above sea level.
L’ànara col pien è una ricetta veneta dei tempi lontani, una pietanza delle grandi occasioni, quando la carne arrivava a imbandire anche le tavole più umili prendendo il posto del pesce che in laguna era più comune e alla portata di tutti. L’uso di cucinare l’anatra col pien, cioè con un saporito ripieno a base di fegatini, soppressa – un particolare insaccato veneto – e talvolta anche pinoli e amaretti, è tipico della notte del Redentore, quando le trattorie ancora fedeli alla tradizione la servono in tavola insieme ad altre pietanze rituali come i sfogi in saor, i bigoli in salsa o i bovoleti e, a seguire, l’immancabile anguria! ENG The Venetian dialect name of this recipe translates to stuffed duck and is quite an old one, back to the times when the occasion was so important that meat made it even to the humblest of homes and replaced the common Venetian meal – fish. The tradition of stuffing duck with a tasty filling of fowl liver, cured ground pork, and, according to taste, pine nuts and almonds, is typical of the Redentore feast.
Le lumachine degli orti sono un tipico piatto da osteria, immancabile nelle allegre tavolate del Redentore. Si mangiano con le mani senza tanti fronzoli, togliendo dal guscio con uno stuzzicadenti il minuscolo gustoso animaletto. Facili da preparare: si stufa la cipolla con olio e molto aglio e si versano i bovoleti assieme ad abbondante prezzemolo, pepe e sale. Vanno consumati freddi accompagnati da una fetta di polenta bianca (da Venezia in cucina di Carla Coco, Editori Laterza). ENG Escargots are associated, and rightly so, with gourmet French cuisine, but I will have you know that in Venice and the Venetia, they are common in every tavern and a staple of the Redentore Feast.The Feast is the most loved by Venetians and partying begins in the kitchen. Stew onion and garlic with olive oil, then add the escargots and season with parsley – lots of it – pepper, and salt. Once cold, use a toothpick to drive the meat out of the shell.
a cura di Fabio Marzari

In bilico
tra la dimensione ancestrale della
cucina
lagunare e
quella
più
misteriosa – a tratti esoterica – dell’atelier d’artista, il ricettario “atipico” di Zaira Zarotti ci porta alle radici della cultura veneziana, rivelando le segrete alchimie di due mondi diversi ma profondamente legati da ciò che sta alla base di ogni civiltà: il cibo e i suoi ingredienti
*Saor
Il “saor”, che in veneziano significa “sapore”, è una preparazione molto antica, che risale al 1300 e che prevede l’idea di trattare il pesce – ma anche le verdure – con l’aceto. La sua origine è strettamente collegata alla necessità di conservare il pesce durante i lunghi viaggi per mare, infatti questa preparazione affonda le sue radici proprio nelle abitudini degli uomini di mare che dovevano nutrirsi e conservare il proprio pescato il più a lungo possibile, durante i grandi viaggi. Oltre all’aceto, altro ingrediente essenziale di questa ricetta è la cipolla, facilmente reperibile dagli orti delle isole lagunari o di Chioggia, che nel passato rappresentava un buon rimedio contro lo scorbuto, una malattia tipica dei marinai, privati di vegetali freschi durante le interminabili traversate oceaniche.
L’aggiunta di uvetta e pinoli, ingredienti più pregiati, sembrano essere invece più moderna – nobile ed elitaria – frutto degli intensi contatti di Venezia con l’Oriente.
Il tipo di pesce che più si adopera per il saor sono le sardine, ma esistono diverse versioni anche con altri pesci di laguna e non, come piccole sogliole, passere e anche mazzancolle, curate della loro corazza e filo nero presente sul dorso.
Un’altra piccola variante di questa ricetta, prevede inoltre l’aggiunta di un cucchiaino di zucchero nelle cipolle, per aumentare l’effetto agro-dolce.
Il saor si conserva a lungo, fino ad un mese anche fuori dal frigo, ma è consigliabile consumarlo prima e riporlo comunque in un luogo fresco. Questo piatto non manca mai tra le pietanze tipiche da portarsi in barca, la notte della festa del Redentore.

Ricetta tratta da:
VENEZIA TRA
CUCINA E ATELIER
Ricette tramandate per artisti e cuochi appassionati di Zaira Zarotti (The Freaky Table) Elzeviro, 2024
Ingredienti:
1 kg di sardine
1,5 kg di cipolle bianche
½ bicchiere (150 ml circa) di aceto di vino bianco
Farina 00, quanto basta per infarinare il pesce
Olio di semi di girasole, quanto basta per friggere + 50 ml
40 g pinoli
70 g uvetta
2 foglie di alloro
Sale e pepe nero
Squamare ed eviscerare le sardine sotto l’acqua corrente, tenendo la lisca, la coda e la testa. Risciacquarle accuratamente e metterle a scolare in un ampio scolapasta.
Adagiare le sardine su alcuni fogli di carta paglia, tamponando leggermente anche con della normale carta da cucina, per asciugarle. In un’ampia padella dai bordi un po’ alti, porre l’olio a scaldare e portarlo ad una temperatura di circa 175-180 gradi. Se non avete un termometro da cucina sarà sufficiente immergere la punta di uno stuzzicadenti nell’olio; quando si formeranno tante bollicine vuol dire che è pronto per friggere.
Infarinare le sardine e passarle al setaccio per rimuovere la farina in eccesso. Gettarle ordinatamente nell’olio caldo e friggerle da entrambi i lati per un paio di minuti, girandole con una forchetta. Non appena le sardine appaiono dorate estrarle dall’olio e riporle su un vassoio ricoperto di carta paglia, che assorbirà l’olio in eccesso. Salare e tenere da parte, in un luogo protetto, in modo che si mantengano tiepide.
Filtrare l’olio della frittura attraverso un colino per rimuovere le impurità, quindi riversarne circa 50 ml all’interno della padella appena utilizzata. Se preferite, si può usare dell’olio nuovo.
Pelare le cipolle, lavarle, ed affettarle sottilmente, poi riporle nella padella con l’olio sul fuoco basso.
Le cipolle dovranno appassire gentilmente senza mai scurire, quindi cuocerle con pazienza fino a che appariranno morbide e traslucide, mescolando di tanto in tanto con un mestolo. A fine cottura versare l’aceto e lasciar sobbollire per circa un minuto per far evaporare leggermente il liquido, riducendolo così di circa metà del suo volume. Rimuovere dal fuoco e aggiungere l’uva passa, i pinoli e un paio di foglie di alloro.
In una grande terrina di vetro o di coccio disporre ordinatamente un primo strato di sardine e coprirle con qualche cucchiaiata di salsa di cipolle, tirandola bene con il dorso del cucchiaio in modo da ricoprire il pesce. Proseguire così, alternando strati di sardine e salsa di cipolle fino a terminare gli ingredienti. Terminare l’ultimo strato con una generosa dose di salsa di cipolle, riversando anche tutto il liquido acidulato rimasto sul fondo della padella.
Coprire la terrina con un piatto rovesciato, lasciare raffreddare e riposare per almeno 24 ore prima della consumazione.
di J.J.C.
Non era cominciata così.
Non era certo partito da casa con l’idea di farsi una terapia. Anzi: pensava di andare a Venezia per ritrovare conferme, consumando quel suo rito personale che ripete a ogni Biennale e che lo fa tornare a casa più architetto di prima. In effetti la Biennale serve anche a questo – un bagno di idealismo, per ravvivare sogni e desideri che questa professione così burocratica e sottopagata non gli regala più da tempo. E invece eccolo lì: sei ore dopo l’ingresso alle Corderie, seduto su una oblunga installazione di marmo che ha la forma di una panca in bilico, del tutto fuori scala (la didascalia informa che è anche uno strumento musicale funzionante), con la testa fra le mani, in piena crisi d’identità.
Il punto è che quest’anno la Biennale sembra fatta apposta per provocare questo: metterti uno specchio davanti e aspettare beffardamente le tue risposte – o le tue crisi. Lo dice tra sé mentre nota le isolette galleggianti per far riprodurre dei grilli riflesse nell’acqua della laguna, convinto che davanti a quello specchio non ci sia tanto l’Architettura, quanto l’architetto. Quello della prima sala (di specchio, s’intende) gli dava ancora una certa sicurezza, persino un conforto: il mondo va a pezzi, ma eccomi qui. Sono io quello che può fare qualcosa, l’Architettura è ancora una speranza! Era entrato sentendosi integro; un architetto con tutte le sue convinzioni, i ruoli interiorizzati, il bagaglio di riferimenti e di piccole sicurezze. Ma ben presto il percorso si era rivelato tutt’altro che innocente, nonostante fosse stato annunciato come un compiaciuto catalogo di fiduciose risposte, esito di una mastodontica call internazionale. Una grande chiamata alle armi fatta proprio dall’architetto/curatore, il demiurgo che chiama a raccolta i saperi per plasmare il mondo, il direttore d’orchestra che coordina matematici, musicisti, cuochi, scienziati, ingegneri, astronauti, biologi e fisici per rispondere alle sfide del presente. Descrizioni che gli erano sembrate abbastanza convincenti da decidersi a venire a Venezia e avventurarsi nella mostra per il solito rito dell’identità. E invece il labirinto che segue è parso ben presto una lunga, implacabile seduta. Una terapia per l’architetto. Del resto è chiaro: intelligens è un participio presente, un’identità in divenire, ancora tutta da compiere. Così come l’impianto dell’allestimento: non ordina ma disperde, non guida ma frammenta, confonde e smarrisce. Un altro modo per dire che l’architetto, oggi, non sa più bene chi egli sia.
La coscienza ecologica del cataclisma climatico e delle sue soluzioni, che già era fragile, si complica. Tra mani-
festi di circolarità, piante sui tetti di Parigi, pietre fumanti che producono muschi e nodi tecnologici innestati sui rami di alberi sopravvissuti agli tsunami…, l’architetto è ancora colui che costruisce, o dovrà smettere di farlo per evitare di contraddirsi? È ancora un progettista, o piuttosto un moralista dell’imperativo etico?
Un certo spazio di libertà di creazione gli era sembrato tuttavia ancora abbastanza praticabile, tra acque, legni e pietre, ma la successiva performatività delle robotizzazioni lo aveva rapidamente distratto: AI che conversano, testi generati da macchine, prototipi che sembrano pensati più da algoritmi che da autori. Ma allora l’architetto cosa è, un umano che progetta o un curatore di sistemi automatici? Il mito della superiorità umana sul digitale vacilla. E anche dove era sembrato riemergere – nella sezione Collective – in realtà il vecchio sogno dell’architetto-genio, solitario e riconoscibile, evaporava nel turbinio di voci e di progetti condivisi, nel noi indistinto e nelle responsabilità liquide. Il processo sopra la firma, che nel turbolento sguardo dall’esterno del Pianeta della sezione Out riportava l’architetto al ruolo di coordinatore di tecnologie: per far crescere piante su Marte o per imparare dagli astronauti come rifugiarsi dentro una tuta spaziale a forma di casa.
Quando finalmente si era trovato davanti ai progetti per Venezia, quelli della sezione Living Lab, la crisi era ormai aperta, acclarata. Progetti che vorrebbero interagire con la città e che si scontrano con i limiti della messa in scena: ottimi esperimenti, affascinanti ricerche che hanno impiegato anche dieci anni a vedere la loro luce, e che però non cambiano il reale, perché il loro compito è quello di suggerire ipotesi.
Così, invece di ritrovare le conferme del mestiere, tra monitor, progetti a tutte le scale, robot e biciclette d’acqua, l’architetto si ritrova a mettere in discussione sé stesso. Il rito dell’idealismo si spezza in troppe domande. C’è ancora spazio per essere autore? A che prezzo l’architetto può ancora pretendere di essere intellettuale? Tecnico? Burocrate della sostenibilità? Lavoratore in cerca di diritti? Influencer del pensiero urbano? Quello che è certo è che sarà necessario ora più che mai, e come minimo, ridiscutere l’identità della professione.
Come in ogni buona terapia, prima viene la frattura, poi, forse, la ricomposizione. Per ora, dell’architetto resta il corpo fisico, che con le gambe a penzoloni su quella panca in marmo esce più leggero di certezze, ma al contempo assai più gravato di dubbi.
Non è detto che sia un male.




It hadn’t started like this. He didn’t leave home looking for therapy. He just wanted to return from Venice feeling more like an architect, as he did after every Biennale. A dose of idealism to revive desires that his now bureaucratic and underpaid profession no longer provided. And yet, here he was, six hours after entering the Corderie, sitting on a marble bench installation, in the midst of an identity crisis. This year’s Biennale seems made precisely for this: holding up a mirror and waiting for your response—not about Architecture, but about the architect. The mirror in the first room had given him confidence: “It’s me, I can do something, Architecture is still a hope!” But the journey quickly proved anything but reassuring. Announced as a collective and optimistic exhibition, the result of an international call, it turned out to be a long psychoanalytic session. A therapy for the architect. After all, intelligens is a present participle – an identity still becoming. The exhibition layout says the same: it doesn’t organize, it disperses; it doesn’t guide, it confuses. The architect today no longer knows exactly who they are. The already fragile ecological awareness grows more complicated: green rooftops, smoking stones, branches grafted with tech – should the architect
keep building or stop altogether? Are they a designer or an ethical moralist? At first, he had glimpsed a margin of creative freedom –through wood, water, and stone. But then came the robotics: AI in conversation, algorithm-generated prototypes. So, what is the architect now? An author or a curator of automated systems? Even the old dream of the architect-genius fades in the Collective section, drowned in shared voices and liquid responsibilities. The author dissolves into processes and collaborations, becoming a coordinator of technologies – whether to grow plants on Mars or design an inhabitable astronaut suit. By the time he reached the Living Lab section and the projects for Venice, the crisis had fully taken hold. Even the most impressive research remained hypothetical, unable to change reality. Instead of reassurance, the architect was left questioning himself. The ritual of idealism shattered into too many questions: Is there still space to be an author? An intellectual? A technician? A bureaucrat? An urban influencer? As with any good therapy, fracture comes first – then, perhaps, a reassembling. For now, all that remains is the architect’s body, legs dangling from a marble bench, lighter in certainties but far heavier with doubt. And maybe, that’s not such a bad thing.
Oltre alle Corderie, e in assenza del Padiglione Centrale, la 19. Mostra Internazionale di Architettura si sviluppa quest’anno in modo sostanziale anche sulla carta. Il Catalogo della Biennale, oltre a rappresentare il consueto e nobilissimo esercizio di archivio, è parte integrante della Mostra: ignorarlo sarebbe un errore, perché è ricco di riflessioni e approfondimenti che orientano, arricchiscono e spiegano la visita. Trascurarlo, quindi, equivarrebbe a perdere la possibilità di utilizzare una bussola fondamentale per comprendere il futuro dell’architettura e per interrogarsi sull’identità stessa dell’architetto. Se nell’allestimento frattale e a tratti dispersivo dell’Arsenale il visitatore si può smarrire, nel Catalogo troverà invece percorsi chiari, analisi puntuali, chiavi di lettura solide. Non è un semplice supporto, ma un elemento centrale della proposta curatoriale. Non lo diciamo per retorica. È lo stesso curatore ad averne sottolineato il ruolo in ogni conferenza stampa, riservando ampio spazio alla presentazione dei due maggiori contributi culturali che il volume raccoglie accanto all’archivio dei progetti: i saggi e le “conversazioni impossibili”. Il Catalogo si presenta, come di consueto, in due volumi, con il secondo tradizionalmente riservato ai padiglioni nazionali. È però il primo volume a riflettere con maggiore evidenza lo sforzo curatoriale. Seguendo le sei sezioni principali della Mostra – Intro, Natural, Artificial, Collective, Out e Living Lab – il Catalogo documenta tutti i progetti esposti (compreso uno che, in realtà, non è mai arrivato a Venezia, il magnifico Transspecies Kitchen di Andrés Jaque, che pare non arriverà affatto), e chiarisce il senso dell’allestimento, definito “frattale”. Frattale, in questo caso, significa sostanzialmente gerarchico. I progetti sono distribuiti secondo una struttura a livelli – primo, secondo, terzo – organizzati sulla carta con pesi e proporzioni di impronta squisitamente strutturalista. Carlo Ratti ha affermato che per «assorbire ogni tema, ogni citazione, ogni connessione» siano necessari almeno cinque giorni. Oppure il Catalogo. Uno strumento prezioso, che offre la possibilità concreta di studiare e approfondire le complesse galassie della sua proposta curatoriale. Intercalati ai progetti, come dicevamo trovano spazio i fondamentali saggi e le “conversazioni impossibili”, ovvero dialoghi ipotetici tra figure storiche e contemporanee dell’architettura. Lo strumento del dialogo non è nuovo; lo impiegava già la filosofia greca per introdurre il sapere. In una Biennale che ammicca alla linguistica, con un titolo che si insiste a descrivere come “il participio presente del verbo latino intelligo”, la scelta non può che essere intenzionale. Qui, però, i dialoghi non nascono dallo sforzo speculativo, ma sono generati con l’Intelligenza Artificiale. L’obiettivo è chiaro: collocare la Mostra entro un quadro culturale specifico, facendo leva sulle ‘spalle dei giganti’ per riformulare il presente e individuare quelli che potrebbero diventare i nuovi maestri. Così, ad esempio, Christopher Alexander (1936-2022) – architetto e urbanista che concepiva la città come un organismo frattale composto da pattern riproducibili – ‘dialoga’ con Carlo Ratti sul tema della partecipazione, uno dei nuclei centrali del pensiero e dei volumi del curatore. Mentre Ebenezer Howard (1850-1928), pioniere della città-giardino, attribuisce a Stefano Boeri una forza simbolica che lo consacra come possibile nuovo maestro dell’armonizzazione tra crescita urbana ed esigenze del mondo vegetale. Un programma decisamente ambizioso, insomma. Dal Catalogo emergono almeno due lezioni fondamentali. La prima è
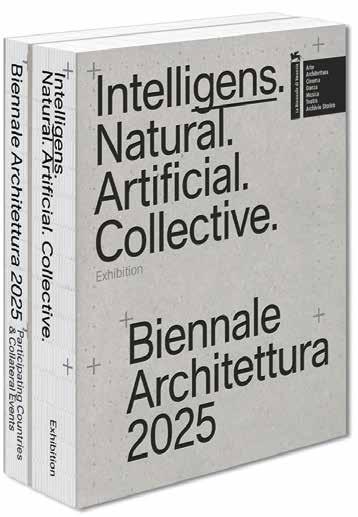
che questa Biennale non è una mostra, ma una ricerca. Lo chiarisce con efficacia il saggio di Albena Yaneva – tra i curatori del progetto Constructing La Biennale – riportando le parole del Curatore durante il processo di lavoro: «Stiamo complicando la vita ai partecipanti. Sarebbe più facile scegliere cose già esistenti e limitarsi a portarle a Venezia». E invece no. La Biennale presenta quest’anno pochissimi edifici costruiti e una moltitudine di esperimenti, prototipi, tentativi di risposta a una domanda di fondo: quale ruolo può ancora avere l’architettura in un mondo segnato da crisi ambientali, energetiche e sociali? La seconda lezione riguarda l’autorialità. Si abdica consapevolmente all’idea di un curatore dominante che definisce tutto per muoversi invece verso una pluralità delle voci, verso la moltiplicazione dei punti di vista e l’ibridazione dei saperi. Una dispersione che può talvolta generare una certa confusione, ma che apre a una ridefinizione dell’identità stessa dell’architetto, riscritta attraverso una molteplicità di significati e di ruoli possibili. Tra i dialoghi, quello dedicato a Venezia è il più malinconico. John Ruskin conversa con l’ingegnere Andrea Rinaldo, interrogandosi sul destino di una città che, tra cinquant’anni, nemmeno il Mose potrà più salvare. Tra speranze tecnologiche e romanticismi per le rovine, il confronto assume i toni di un’accorata esortazione. Venezia è “poesia in movimento”, ma una urbs senza civitas – una città di muri senza la sua comunità – è destinata ad affondare. Michele Cerruti But
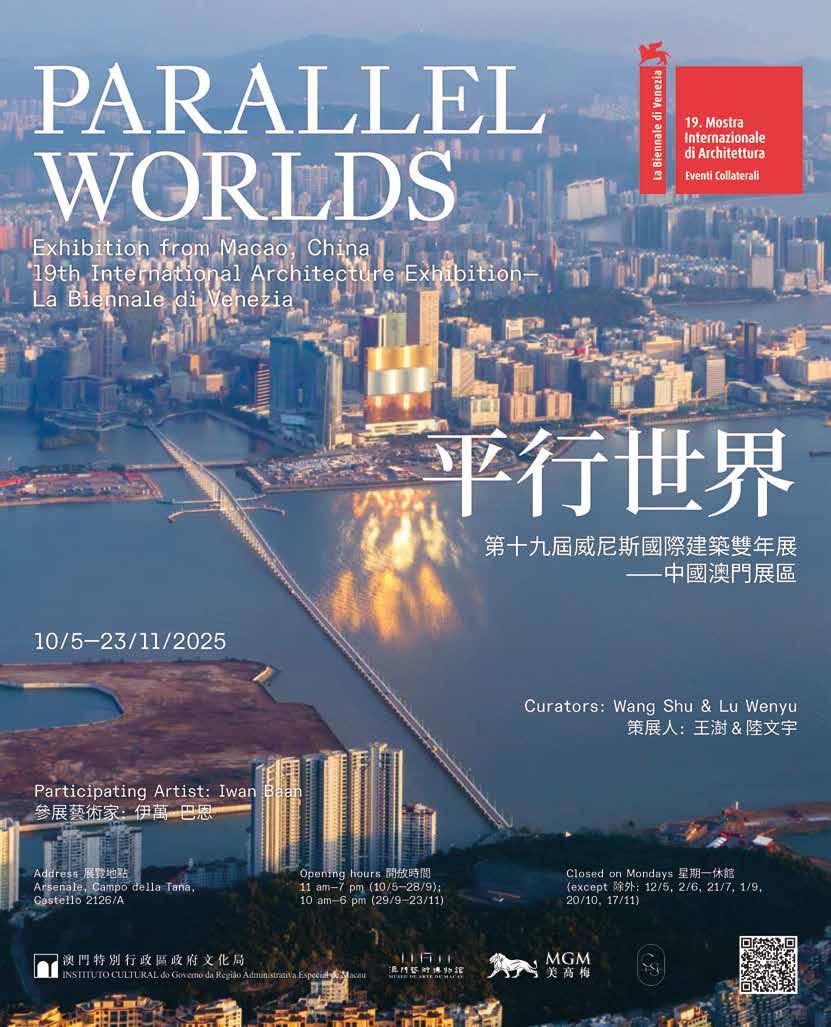

In persiano “badghir” significa “torre del vento”. È un’antica tecnica edilizia che, nei Paesi in cui il caldo torrido non è questione recente, sfrutta le differenze di pressione e permette un raffreddamento passivo degli ambienti. Il Padiglione del Regno del Bahrain, vincitore del Leone d’Oro per la miglior partecipazione nazionale, unisce questo patrimonio architettonico all’ingegneria moderna per creare un sistema di raffreddamento di spazi pubblici. Heatwave ( Canicola ) – questo il nome dell’esposizione curata da Andrea Faraguna alle Artiglierie dell’Arsenale – vuole dare una risposta sia speculativa sia concreta alle domande che la crisi ambientale pone ai progettisti. Un asse centrale collega un pozzo geotermico a una tettoia e, grazie al principio del camino solare (interpretazione moderna della torre del vento), permette lo scambio di calore dal sottosuolo alla superficie. «In Bahrain, a 20 metri di profondità, la temperatura si aggira intorno ai 27 gradi –spiega Faraguna –, questo ci permette di creare, sotto la tettoia, un ambiente stabile attorno ai 30 gradi». L’impiego di strategie geotermiche per il raffrescamento dell’aria si rivela particolarmente efficace nei climi aridi, più delle tecniche basate sull’acqua. Lo dimostrano anche le mappe termiche esposte, come quella del villaggio costiero di Askar, che restituiscono il reale impatto di questa soluzione. Ma non è solo una questione di ingegneria e tradizione. Heatwave vuole riflettere sul ruolo che gli spazi pubblici hanno nel mitigare gli effetti della crisi climatica. Il tema, infatti, è anche socio-culturale: il modulo è potenzialmente riproducibile e adattabile ai più diversi contesti, ma un’attenzione particolare è stata rivolta ai cantieri che possono essere così ombreggiati e rinfrescati. Occuparsi del clima di questi spazi diventa così anche una forma di equità. Al centro del progetto c’è il lavoro dell’ingegnere geotermico Alexander Puzrin dell’Eth di Zurigo, dell’ingegnere strutturista Mario Monotti dell’Accademia di Architettura di Mendrisio e di Wafa Al-Ghatam, ricercatrice che si è occupata degli studi sul Bahrain. Insieme a loro, molti altri collaboratori. La ricerca condotta esplora strategie locali ma rilevanti per le sfide globali, riflettendo, al tempo stesso, lo spirito più ampio della Biennale curata da Carlo Ratti: un invito a riscoprire le meccaniche naturali attraverso una tecnologia che si fonda su un sapere condiviso. Giovanni Santarelli
In Persian, “badghir” means “wind tower.” It is an ancient architectural technique used in hot regions that harnesses pressure differences to cool spaces passively. The Pavilion of the Kingdom of Bahrain, winner of the Golden Lion for best national participation, combines this heritage with modern engineering to create a cooling system for public spaces. Heatwave, curated by Andrea Faraguna, offers both speculative and practical answers to the environmental crisis. A central axis connects a geothermal well to a canopy, employing the solar chimney principle – a modern reinterpretation of the traditional wind tower – to circulate air from underground to the surface, creating a stable environment of around 30°C beneath the canopy. Geothermal cooling proves especially effective in arid climates, as shown by thermal maps of places like Askar village. Heatwave also addresses the socio-cultural role of public spaces in climate mitigation, emphasizing equity by improving shading and cooling at construction sites. It also embodies the very spirit of this year’s Biennale by rediscovering natural mechanics through shared knowledge and technology.
REGNO DEL BAHRAIN Heatwave Artiglierie, Arsenale IG @bah.pavilion
Intervista Marina Otero Verzier e Giovanna Zabotti
di Mariachiara Marzari
Il Complesso di Santa Maria Ausiliatrice, risalente al 1171, già ospizio di pellegrini quindi ospedale più antico della città, è ora sede del Padiglione della Santa Sede, che occuperà i 500 mq dello spazio per quattro anni fino a riportare completamente a nuova vita architettonica, culturale e sociale l’intero edificio. Sotto lo sguardo attento del Cardinale José Tolentino de Mendonça, a capo del Dicastero per la Cultura e l’Educazione della Santa Sede, il progetto, intitolato Opera Aperta, richiamo all’omonimo libro di Umberto Eco, è curato da Marina Otero Verzier, architetta, curatrice e ricercatrice, e Giovanna Zabotti, direttrice artistica di Fondaco Italia e già curatrice del Padiglione Venezia, le quali hanno collaborato con due tra i più importanti studi internazionali di architettura specializzati in costruzione responsabile e cura collettiva: Tatiana Bilbao ESTUDIO (Tatiana Bilbao, Alba Cortés, Isaac Solis Rosas, Helene Schauer), con sede a Città del Messico, e MAIO Architects (Anna Puigjaner, Guillermo Lopez, Maria Charneco, Alfredo Lérida), di stanza a Barcellona. Opera aperta ridarà vita a una chiesa sconsacrata con un processo di restauro che avverrà su diversi livelli e coinvolgerà un’ampia gamma di competenze e mestieri. Uno spazio in continuo divenire, di scambio, negoziazione e riparazione, che invita il visitatore e la comunità a partecipare alla costruzione di una sua rinnovata identità. La giuria della 19. Biennale Architettura, presieduta da Hans Ulrich Obrist, ha per questa serie di ragioni assegnato alla Santa Sede una Menzione Speciale come Partecipazione Nazionale. Entriamo nel vivo del Padiglione guidati dalle curatrici Marina Otero Verzier e Giovanna Zabotti.
L’attesa per la Partecipazione del Vaticano alla Biennale è sempre altissima. Come è nato il progetto Opera Aperta? E come incide la Menzione Speciale sul vostro percorso?
Marina Otero Verzier_Sin dall’inizio abbiamo immaginato il Padiglione non come un’esposizione, ma come una pratica vivente: un processo di riparazione collettiva che si estende oltre gli edifici per prendersi cura delle istituzioni, delle comunità, degli ecosistemi e dei fragili legami tra di essi. Il riconoscimento della Biennale attraverso la Menzione Speciale riafferma l’urgenza di questo approccio: convalida l’idea di riparazione non come gesto nostalgico, ma come un atto radicale e orientato al futuro. Quest’anno diversi padiglioni nazionali si sono concentrati sulle nozioni di cura, gestione e manutenzione, sottolineando un diffuso desiderio condiviso di ridefinire la pratica architettonica. Siamo orgogliosi di far parte di questa conversazione più ampia. Attraverso Opera Aperta speriamo di contribuire a questo cambiamento, che infonde sia alla disciplina che al mondo in generale un rinnovato senso di responsabilità in questi tempi incerti.
Giovanna Zabotti Opera Aperta nasce dalla consapevolezza che la presenza della Santa Sede alla Biennale non può mai caratterizzarsi in una sua valenza esclusivamente espositivo. Soprattutto nelle sue ultime

edizioni, condotte dal Cardinale José Tolentino de Mendonça, si è profondamente incarnata nei luoghi, nella città e nel tempo e parallelamente si è fatta manifesto di messaggi universali. Dopo San Giorgio e le Vatican Chapel nel 2018 e l’intervento Amicizia Sociale: incontrarsi nel giardino sempre a San Giorgio nel 2023, solo per citare le presenze in Biennale Architettura, il Padiglione 2025 si confronta con un intero complesso monumentale da riattivare, quello di Santa Maria Ausiliatrice a Castello.
La Menzione Speciale della Biennale ci onora, ma soprattutto conferma che l’approccio che abbiamo scelto – inclusivo, processuale, aperto – è non solo necessario, ma anche riconosciuto come significativo nel più ampio contesto del dibattito architettonico e culturale internazionale.
Il titolo richiama palesemente Opera aperta di Umberto Eco. Quali le ragioni di questa scelta e quale legame vivo mantiene il Padiglione con questo libro?
M.O.V. _Il concetto di “opera aperta” di Eco, benché concepito decenni fa, rimane straordinariamente attuale. Ci permette di entrare in contatto con persone attive in diverse discipline e trasmette immediatamente l’etica del Padiglione. Allo stesso tempo ci siamo permessi di appropriarci e di reinterpretare questa nozione per il nostro contesto specifico.
Il Padiglione è di per sé un’opera aperta, che si dispiega nel tempo; resiste alla chiusura e invita alla partecipazione. I suoi significati cambiano ed evolvono, modellati dalle persone che lo abitano e se ne prendono cura, ma anche dal sale della laguna che incide sulle pareti, dagli insetti che vivono nelle fessure e dagli uccelli che nidificano sul tetto. Il riferimento a Eco non è semplicemente simbolico, ma è fondamentale per il modo in cui immaginiamo l’architettura: aperta, porosa, relazionale.


The Santa Maria Ausiliatrice Complex, a former hospice and hospital dating back to 1171, will become home to the Holy See Pavilion for the next four years. For the 2025 Architecture Biennale, the Pavilion presents Opera Aperta – a project curated by Marina Otero Verzier and Giovanna Zabotti, in collaboration with leading architecture firms Tatiana Bilbao ESTUDIO and MAIO Architects. The project transforms the deconsecrated church into a dynamic, evolving space dedicated to care, dialogue, and collective transformation. Under the patronage of Cardinal José Tolentino de Mendonça, Prefect of the Dicastery for Culture and Education, the project reflects a vision of architecture as a tool for social and cultural regeneration. For its originality and depth, Opera Aperta received a Special Mention from the international jury of the Biennale, chaired by Hans Ulrich Obrist. We spoke with the curators to explore the ideas and values behind the Pavilion.
The Vatican’s participation in the Biennale is always highly anticipated. How did the project Opera Aperta come about? And how does the Special Mention impact your trajectory?
Marina Otero Verzier_Indeed, from the outset we envisioned this Pavilion not as a display, but as a living practice, a process of collective repair that extends beyond buildings to care for institutions, communities, ecosystems, and the fragile ties between them. The recognition from the Biennale through the Special Mention reaffirms the urgency of this approach: it validates repair not as a nostalgic gesture, but as a radical, future-oriented act. This year, several national pavilions centered on notions of care, stewardship, and maintenance, signaling a shared desire to
redefine architectural practice. We are proud to be part of this larger conversation. Through Opera Aperta, we hope to contribute to this shift, one that infuses both the discipline and the world at large with a renewed sense of responsibility and purpose in these uncertain times.
Giovanna Zabotti Opera Aperta was born from the awareness that the Holy See’s presence at the Biennale is never merely an exhibition. Especially in recent editions led by Cardinal José Tolentino de Mendonça, it has been deeply rooted in place, in the city, and in time, while also serving as a platform for universal messages. Following the Vatican Chapels in 2018 and Social Friendship: Meeting in the Garden in 2023, the 2025 Pavilion engages with the monumental complex of Santa Maria Ausiliatrice in Castello, aiming to reactivate it.
The Special Mention from the Biennale is an honour, but more importantly, it affirms that the approach we’ve chosen – inclusive, process-based, and open – is not only necessary but also recognized as meaningful in the international architectural and cultural discourse.
The title references Umberto Eco’s book Opera aperta. What inspired this choice, and how does the Pavilion maintain a living connection to the book?
M.O.V._Eco’s concept of the “open work,” though conceived decades ago, remains strikingly relevant today. It allows us to connect with people across disciplines and immediately conveys the ethos behind the Pavilion. At the same time, we’ve
G.Z._Il libro di Eco, pubblicato nel 1962, ci ha offerto una cornice teorica perfetta: la visione dell’opera come sistema aperto, incompiuto, vivo, che si compie attraverso l’interpretazione attiva del fruitore. Questo è esattamente ciò che vogliamo che accada nel nostro Padiglione. Il visitatore non è uno spettatore passivo, ma un co-autore. Opera Aperta è un invito a pensare l’architettura – e più in generale lo spazio collettivo – come un processo generativo, che non si esaurisce in una forma ma che si apre al tempo, alla comunità, alla trasformazione.
Santa Maria Ausiliatrice a Castello è stata scelta come laboratorio condiviso. Quali azioni saranno portate avanti e come viene concretamente coinvolto il visitatore?
M.O.V._Le molte vite passate del Complesso di Santa Maria Ausiliatrice – come ospizio, ospedale, scuola, dormitorio – hanno informato profondamente il nostro approccio. Invece di nascondere le sue crepe, le disegniamo, le curiamo, le accudiamo. Questi gesti di attenzione diventano atti di riconoscimento, onorando le storie stratificate incorporate nell’edificio e le vite – passate, presenti e future – che lo hanno plasmato.
I visitatori sono invitati a partecipare a questo processo in quotidiano divenire contribuendo a definire nuovi strati e connessioni, confrontandosi con il lavoro degli artigiani locali, condividendo i pasti alla tavola comune ospitata dalla cooperativa NonSoloVerde, ascoltando le prove degli studenti del Conservatorio di Venezia la cui musica si riverbera nello spazio. Attraverso questi incontri l’architettura diventa un sito di esperienza vissuta, un luogo in cui si intrecciano cura, cultura e vita quotidiana.
G.Z._Abbiamo scelto Santa Maria Ausiliatrice per il suo potenziale latente e per la sua posizione nel cuore di un quartiere vivo. Il lavoro che stiamo portando avanti non è solo un restauro architettonico, ma più estesamente un processo di cura collettiva. Il visitatore è invitato a entrare in un cantiere aperto, a osservare, a lasciare un segno, a confrontarsi con mestieri, materiali, narrazioni. Ci sono laboratori, archivi viventi, spazi di ascolto e collaborazione e spazi per la musica attrezzati. È un invito alla partecipazione, alla responsabilità condivisa nel costruire senso.
La direzione artistica è affidata a Tatiana Bilbao ESTUDIO e MAIO Architects. Quali le ragioni di questa scelta? A che punto è il progetto di restauro?
M.O.V._Tatiana Bilbao ESTUDIO e MAIO Architects sono noti per la loro capacità di intrecciare valori sociali alla forma architettonica. Il loro lavoro non si limita ad affrontare meramente l’ambiente costruito, attento com’è alle dimensioni politiche, emotive ed ecologiche che circondano l’ambiente in oggetto stesso. Il restauro è concepito sia come una pratica quotidiana che come un impegno a lungo termine: a volte veloce, a volte deliberatamente lento, sempre reattivo. Non si tratta solo di riparare un edificio, ma di ascoltarlo, riconoscendo le molte vite che ha ospitato e i materiali che custodiscono quei ricordi. Ecco perché è importante riunire diverse forme di lavoro, di conoscenza e di esperienze incarnate: sono tutte di per sé rilevanti.
La riparazione, in questo caso, non è una semplice fase lavorativa, ma rappresenta più profondamente un’assunzione di responsabilità continua.
G.Z._Tatiana Bilbao e MAIO condividono un approccio profondamente etico e relazionale all’architettura. Entrambi gli studi lavorano con un’idea di progetto che parte dall’ascolto, dall’inclusione, dalla stratificazione culturale. Il progetto di restauro è già in atto: alcune aree del complesso sono state riattivate per l’apertura della Biennale, altre seguiranno nei prossimi mesi, aderendo a una logica di intervento progressivo e sostenibile. È un processo che si costruisce nel tempo, con la comunità e con una pluralità di saperi.
La Santa Sede gestirà lo spazio per quattro anni. Quali programmi culturali state costruendo?
M.O.V. _Ci auguriamo che questa non sia un’installazione temporanea, bensì l’inizio di un lungo processo. In collaborazione con il Dicastero per la Cultura e l’Educazione vaticano e con un’ampia gamma di attori locali stiamo dando forma a un programma che valorizza le conoscenze trasmesse di generazione in generazione, le culture condivise oltre i confini e l’apprendimento come atto collettivo. La nostra programmazione ruota attorno ai rituali di mantenimento, pratiche di intrattenimento che includono la socialità, la cucina, la musica e l’artigianato intese come forme vitali dello stare insieme. Ci auguriamo che, al termine della Biennale, queste relazioni si consolidino e che il sito rimanga un luogo di incontro – radicato a Venezia, aperto al mondo – dove la cultura non venga esclusivamente consumata, ma co-creata.
G.Z._Spero che questo spazio diventi un polo creativo e culturale per Venezia e per chi la abita. Stiamo costruendo un programma che unisce arte, formazione, ricerca, artigianato, spiritualità. L’idea è che il complesso possa accogliere residenze d’artista, workshop, incontri, pratiche condivise. Sarà uno spazio aperto e inclusivo, dove si coltiva il dialogo tra culture, generazioni e discipline. Un’officina di pensiero e di azione per la città.
Come Opera Aperta entra nel dibattito promosso da Carlo Ratti sulla nuova definizione di architetto e architettura?
M.O.V. _Accogliamo con favore questo dibattito. In un’epoca segnata dal collasso ecologico, istituzionale, sociale, crediamo che l’architettura debba essere soprattutto un atto di gestione. Pertanto il Padiglione propone un diverso tipo di agenzia architettonica: quella che non domina lo spazio, ma che lo tiene aperto per gli altri.
G.Z. Opera Aperta propone un’idea di architettura come processo partecipativo e come responsabilità condivisa. Non più l’architetto demiurgo, ma il facilitatore di possibilità. In questo senso il progetto entra pienamente nel dibattito proposto da Carlo Ratti: riformulare il ruolo dell’architetto in quanto attivatore di relazioni, ascoltatore, costruttore di significati collettivi. L’architettura, in Opera Aperta, non è mai soltanto costruzione: è sempre anche gesto, parola, cura, riparazione. Un’opera di intelligenza comunitaria.
allowed ourselves to reinterpret and appropriate this notion for our specific context.
The Pavilion is itself an opera aperta – a work that unfolds over time, resists closure, and invites participation. Its meanings shift and evolve, shaped by the people who inhabit and care for it. But also, by the salt of the lagoon that affects the walls, the insects that live in its cracks, and the birds that nest on the roof. The reference to Eco is not merely symbolic; it is foundational to how we imagine architecture: open-ended, porous, and relational.
G.Z._ Umberto Eco’s 1962 book provided the perfect theoretical framework: the idea of a work of art as an open, unfinished, living system, completed through the active interpretation of the viewer. This is exactly what we hope to achieve with our Pavilion. The visitor is not a passive spectator but a co-author. Opera Aperta invites us to think of architecture, and collective spaces more broadly, as a generative process, not limited to form but open to time, community, and transformation.
Santa Maria Ausiliatrice in Castello was chosen as a shared laboratory. What actions will be carried out, and how is the visitor involved?
M.O.V._The many past lives of the Complesso di Santa Maria Ausiliatrice – as hospice, hospital, school, dormitory – have deeply informed our approach. Rather than concealing its cracks, we draw them, tend to them, care for them. These gestures of attention become acts of recognition, honoring the layered histories embedded in the building and the lives – past, present, and future – that have shaped it.
Visitors are invited into this ongoing process: to contribute to new layers and connections, to engage with the work of local artisans, to share meals at the communal table hosted by the cooperative NonSoloVerde, to hear rehearsals by students from the Venice Conservatory reverberating through the space. Through these encounters, architecture becomes a site of lived experience, a place where care, culture, and daily life intertwine.
G.Z._We chose the Church of Santa Maria Ausiliatrice for its latent potential and its location in the heart of a vibrant neighbourhood. Our work is not just architectural restoration, but a process of collective care. Visitors are invited into an open construction site: to observe, to leave a mark, to engage with crafts, materials, and stories. There are workshops, living archives, listening and collaboration spaces, and areas equipped for music. It’s an invitation to participate and to share responsibility in creating meaning.
The artistic direction is entrusted to Tatiana Bilbao ESTUDIO and MAIO Architects. What led to this choice? How is the restoration project progressing?
M.O.V._Tatiana Bilbao ESTUDIO and MAIO Architects are known for their ability to weave social values into architectural form. Their work doesn’t just address the built environment: it engages with the political, emotional, and ecological dimensions that surround it. The restoration is conceived as both a daily practice and a long-
term commitment – sometimes fast, sometimes deliberately slow, and always responsive. It’s not just about fixing a building, but about listening to it, acknowledging the many lives it has hosted and the materials that hold those memories. That’s why it is important to bring together diverse forms of labor, knowledge, and embodied experiences: these are all relevant. Repair, here, is not a phase but an ongoing responsibility.
G.Z._Tatiana Bilbao and MAIO share a deeply ethical and relational approach to architecture. Both studios begin their projects with listening, inclusion, and cultural layering. The restoration is already underway: some areas of the complex were reactivated for the Biennale’s opening, and others will follow in the coming months, following a progressive and sustainable logic. It’s a process built over time, with the community and a plurality of knowledge.
The Holy See will manage the space for four years. What cultural programs are you developing?
M.O.V._This is, we hope, not a temporary installation. It’s the beginning of a long process. In collaboration with the Vatican Dicastery for Culture and Education and a wide range of local actors, we’re shaping a program that values knowledge passed through generations, cultures shared across borders, and learning as a collective act. Our programming revolves around rituals of maintenance: entertainment practices that include socializing, cooking, music, and craft. These are understood as vital forms of being together. We hope that after the Biennale closes, these relations will last and the site will remain a place of encounter – rooted in Venice, open to the world – where culture is not consumed, but co-created.
G.Z._We hope this space becomes a creative and cultural hub for Venice and its residents. We are building a program that brings together art, education, research, craftsmanship, and spirituality. The idea is for the complex to host artist residencies, workshops, gatherings, and shared practices. It will be an open and inclusive space, cultivating dialogue between cultures, generations, and disciplines. A workshop of thought and action for the city.
How does Opera Aperta engage with the debate initiated by Carlo Ratti on redefining the architect and architecture?
M.O.V._We welcome this debate. In an era marked by collapse –ecological, institutional, social – we believe architecture should be, above all, an act of stewardship. Therefore, the Pavilion proposes a different kind of architectural agency: one that doesn’t dominate space, but holds it open for others.
G.Z. Opera Aperta proposes an idea of architecture as a participatory process and shared responsibility. No longer the architect as demiurge, but as a facilitator of possibilities. In this sense, the project fully aligns with the debate proposed by Carlo Ratti: to redefine the architect’s role as a connector, a listener, a builder of collective meaning. In Opera Aperta, architecture is never just construction, it is also gesture, word, care, and repair. A work of communal intelligence.
Se c’è un progetto di questa Biennale che obbliga davvero a interrogarsi su chi sia – o dovrebbe essere – l’architetto, è certamente l’installazione del collettivo internazionale The Architecture Lobby (TAL). Non tanto per il suo impatto formale – lo spazio che occupa nelle Corderie dell’Arsenale è essenziale, spoglio, senza concessioni alla spettacolarità, incastonato nel sistema modulare dei progetti laterali disegnato dallo studio berlinese sub – quanto per la radicalità della sua proposta: riportare la figura dell’architetto alla dimensione collettiva, politica e sociale del lavoro. The Architecture Lobby nasce nel 2013 a New York da un gruppo di architetti stanchi di accettare, o perpetuare, condizioni professionali segnate da precariato cronico, sfruttamento e da una cultura di studio ancora fortemente legata al mito dell’individuo geniale. In oltre dieci anni la rete si è ampliata e articolata, arrivando a includere professionisti e attivisti di diversi paesi e generazioni. Oggi il collettivo dialoga con gruppi come Architectural Workers United o Architects! Climate Action Network e con diverse figure indipendenti. A tenerli insieme è l’idea che il lavoro in architettura debba essere ripensato alle radici: nell’organizzazione collettiva, nei diritti, nelle condizioni materiali, nelle ricadute sociali e ambientali. Il gruppo opera nel mondo attraverso un Manifesto e una serie di Gruppi di Lavoro basati sulla partecipazione attiva dei membri. Il cuore dell’installazione è decisamente anti-retorico: ventisei interviste video per oltre sedici ore di testimonianze, raccolte fra professionisti e attivisti che lavorano oggi nel mondo dell’architettura (tutte disponibili sul canale YouTube del collettivo). Non si tratta di un discorso teorico, ma di racconti concreti: esperienze di lavoro precario e non retribuito, abusi di potere negli studi, discriminazioni di genere e razziali, episodi di burnout, ma anche pratiche di resistenza, esperimenti di sindacalizzazione, riflessioni sui legami tra giustizia climatica e giustizia del lavoro. Il quadro che ne emerge è potente e spiazzante. Non solo perché demolisce l’immagine idealizzata dell’architetto-star che ancora domina l’immaginario professionale e mediatico, ma anche perché rimette in gioco la questione centrale del “fare architettura” come pratica collettiva e profondamente politica. L’installazione è quasi una provocazione: collocata proprio all’angolo dello Speakers Corner – l’invenzione di Carlo Ratti di una agorà dove invitare esponenti del mondo dell’architettura per discutere dei temi più diversi del contemporaneo – fa capolino il pannello di Organizing in the Lobby, con un sarcastico “GRAZIE PER IL LAVORO NON RETRIBUITO / THANK YOU FOR YOUR UNPAID LABOUR ” che incombe alle spalle di chi è invitato a parlare, trasformando ogni relatore in un inconsapevole testimonial della necessaria campagna politica per i diritti della professione. Dietro il pannello l’installazione ricostruisce un comune luogo di lavoro dell’architettura, con la prosaicità delle call online e una scrivania piena di trascrizioni degli incontri, tra piantine finte e un tazebao su cui i visitatori sono invitati a descrivere il proprio lavoro non retribuito nel sistema dell’architettura. La figura dell’architetto si spoglia così
delle narrazioni eroiche per tornare ad essere quella di un lavoratore, evidenziata dai quattro principi che maggiormente emergono proprio dal confronto delle interviste: l’urgenza di organizzarsi in collettivi, la valorizzazione della forza lavoro creativa e collaborativa in alternativa al mito del genio, l’impegno politico comune al posto delle soluzioni tecniche individuali per risolvere il problema della crisi climatica, la necessità di resistere ai modelli di profitto che governano l’abitare contemporaneo. Di fatto, come ha sottolineato qualcuno, si tratta di una “storia orale” dei nuovi movimenti sindacali e delle prese di coscienza che stanno attraversando il mondo dell’architettura, in una fase storica in cui la crisi del lavoro si intreccia sempre più con quella climatica e sociale. In questo senso Organizing in the Lobby è anche un invito. Un invito rivolto a chiunque si stia oggi chiedendo che tipo di architetto vogliamo e dovremmo essere e quali siano le condizioni in cui si possa realmente continuare a fare Architettura. Michele Cerruti But




If there is one project at this Biennale that truly compels us to question who the architect is, or should be, it is certainly the installation by the international collective The Architecture Lobby (TAL). Not so much for its formal impact but for the radical nature of its scope: to return the figure of the architect to the collective, political, and social dimension of labour. The Architecture Lobby was founded in 2013 in New York by a group of architects tired of professional conditions marked by chronic precarity, exploitation, and a studio culture still deeply tied to the myth of the genius individual. Over years, the network has expanded and evolved, now including professionals and activists from various countries and generations. Today, the collective engages with groups like Architectural Workers United and Architects! Climate Action Network, as well as various independent figures. What unites them is the belief that architectural labour must be rethought at its roots: in collective organization, rights, material conditions, and social and environmental impacts.
Twenty-six video interviews totalling over sixteen hours of testimony from professionals and activists working in architecture today (all available on the collective’s YouTube channel). The resulting picture is powerful and unsettling. Not only does it dismantle the idealized image of the starchitect that still dominates professional and media narratives, but it also reintroduces the central issue of “doing architecture” as a collective and deeply political practice.
The installation is almost a provocation: placed right at the corner of the Speakers Corner – Carlo Ratti’s invention of an agora for discussing contemporary architectural themes – a panel from Organizing in the Lobby peeks out with a sarcastic “THANK YOU FOR YOUR UNPAID LABOUR,” looming behind invited speakers, turning each into an unwitting spokesperson for the necessary political campaign for professional rights.
Behind the panel, the installation reconstructs a typical architectural workplace, complete with the mundanity of online calls and a desk cluttered with meeting transcripts, fake plants, and a tazebao where visitors are invited to describe their own unpaid labour in the architectural system. The figure of the architect is stripped of heroic narratives and returned to that of a worker. This is effectively an “oral history” of new union movements and growing awareness within architecture, at a time when the labor crisis increasingly intersects with the climate and social crises. In this sense, Organizing in the Lobby is also an invitation – an invitation to anyone wondering today what kind of architect we want and need to be, and under what conditions architecture can truly continue to be practiced.

Relazione e finzione. Performance e contestazione. L’intervento di Annexe – le quattro architette Elena Chiavi, Kathrin Füglister, Amy Perkins e Axelle Stiefel, con l’artista Myriam Uzor – affronta la storica assenza di donne tra i progettisti dei padiglioni nazionali della Biennale e pone una domanda provocatoria: se fosse stata Lisbeth Sachs, e non Bruno Giacometti, a disegnare quello svizzero? Tutti i ventinove padiglioni ai Giardini, infatti, sono stati progettati da uomini. E se le donne architette, in passato, avessero avuto lo stesso riconoscimento che è spettato ai loro colleghi? La risposta arriva dalla favola, dalla finzione per l’appunto, e apre a nuove possibilità spaziali e speculative. Lisbeth Sachs (1914–2002), contemporanea di Giacometti, è stata una delle prime architette elvetiche a essere registrata come tale. Annexe ha materialmente sovrapposto il suo Padiglione delle Belle Arti – costruito nel 1958 per l’Esposizione Svizzera per il Lavoro Femminile di Zurigo (SAFFA) e demolito a fine mostra – a quello coevo di Giacometti ai Giardini della Biennale. Due strutture che «non potrebbero essere più diverse nel loro linguaggio formale». La fluidità sinuosa delle pareti radiali in calcestruzzo (qui ricostruite in legno), i tetti a membrana traslucidi, le aperture verso l’esterno dell’opera di Sachs si intersecano con la rigidità dei volumi di Giacometti. Se l’ultima edizione della Biennale si era concentrata sull’architettura dell’edificio stesso dei Giardini, quella del 2025 si muove in una direzione diversa. L’esposizione, le riflessioni che porta con sé e l’esperienza spaziale che ne scaturisce sono possibili non grazie a un autore o un architetto-demiurgo, ma grazie a un dialogo. A un incontro, al tempo stesso strutturale e simbolico, che prende forma nelle relazioni attivate dall’intervento: tra Giacometti e Sachs, tra le curatrici e il patrimonio del passato, tra i visitatori e l’esperienza multisensoriale che li attraversa. L’esperienza di chi si ritrova tra i muri di Giacometti e, al tempo stesso, sotto i tendaggi di Sachs è quella di una “memoria spaziale immersiva”: un attraversamento in cui il progetto originario dell’architetta si intreccia con un’installazione sonora site-specific. Conversazioni, suoni, frammenti delle fasi costruttive del cantiere sono stati registrati e qui restituiti: le voci del passato e del presente si incontrano, evocando temi etici ed estetici. L’architettura si fa corpo vivo e risonante, oltre la mera dimensione spaziale. Giovanni Santarelli
Annexe – the collective of four architects (Elena Chiavi, Kathrin Füglister, Amy Perkins, and Axelle Stiefel) with artist Myriam Uzor – confronts the historic absence of women among the designers of the national pavilions at the Venice Biennale with a provocative question: “What if Lisbeth Sachs, not Bruno Giacometti, had designed the Swiss Pavilion?” All 29 pavilions in the Giardini were in fact designed by men. The response comes through fiction, opening speculative spatial possibilities. Sachs (19142002), one of the first registered Swiss women architects, designed the Fine Arts Pavilion for the 1958 Swiss Exhibition for Women’s Work (SAFFA). Annexe overlays this vanished building onto Giacometti’s coeval structure, contrasting Sachs’ fluid, translucent, open forms with Giacometti’s design. This 2025 intervention invites a multisensory dialogue – between architects, past and present, and visitors – shaping an immersive spatial memory where architecture becomes a resonant, living body.
SVIZZERA
Endgültige Form wird von der Architektin am Bau bestimmt Giardini www.prohelvetia.ch | IG @prohelvetia_venice

L’architettura ha a che fare con la paura. Nel tempo i timori dell’uomo sono cambiati, ma non la sua ricerca di rifugio e di difesa nello spazio naturale e costruito. Il conforto che l’architettura può fornire, però, non è solo fisico. Con Lari e Penati: sul costruire un senso di sicurezza in architettura il Padiglione polacco racconta e rende visibili quelle pratiche e quei rituali che in Polonia infondono senso di sicurezza. La curatrice Aleksandra Ke˛dziorek, in collaborazione con l’architetto Maciej Siuda e gli artisti Krzysztof Maniak e Katarzyna Przezwan´ska, interpreta così la chiamata a esplorare strategie fondate sul contesto locale. In questo senso, però, l’architettura non è fatta dall’architetto, ma da chi, vivendola, trova in essa sostegno. Nessuna paternità progettuale, in linea con la proposta di autorialità collettiva che Carlo Ratti offre ai visitatori. Un ritorno a un’architettura di stratificazioni, forze multiple, tempi lenti. E allora il ruolo centrale è di chi gli spazi li vive con le loro valenze simboliche. Di chi attinge a un’antica saggezza contadina e gode dei suoi poteri magici di conforto. E, godendone, li tramanda. L’esposizione raccoglie tracce di saperi e gesti antichi che ancora oggi resistono: piccole pratiche simboliche che riflettono un legame profondo con l’ambiente e con l’invisibile. Ghirlande appese nei cantieri come talismani contro la sfortuna, una candela accesa sul davanzale contro il maltempo, soglie di pietra che marcano il passaggio tra fuori e dentro come varchi rituali. Tra i reperti anche una vera asta da rabdomante per individuare falde acquifere, che suggerisce un’attenzione alle energie del luogo e alle dinamiche sottili della natura. Le pratiche e i rituali legati all’architettura polacca, però, sono anche un archetipo primordiale. Lari e Penati si muove tra l’antropologia e l’arte e i due livelli su cui gioca sono quello della sicurezza e quello del senso di sicurezza. Ecco allora che un estintore è accolto da una nicchia decorata a mosaico, in una sovrapposizione tra elemento funzionale e immaginario estetico. Certificati dei vigili del fuoco, spioncini e serrature sono incorniciati come opere d’arte, o inseriti in scenografie che ne esaltano il valore simbolico. Tutto a conferma che le divinità tutelari della casa nell’antica Roma, i Lari e i Penati appunto, svolgono la loro funzione di protezione domestica anche oggi. Sotto altre forme. Giovanni Santarelli
Architecture deals with fear. While human fears have changed over time, the need for shelter and protection – both physical and emotional – remains. The Polish Pavilion, with Lares and Penates: On Building a Sense of Security in Architecture, explores practices and rituals in Poland that foster a sense of safety. Curator Aleksandra Ke˛dziorek, with architect Maciej Siuda and artists Krzysztof Maniak and Katarzyna Przezwan´ska, responds to the Biennale’s call for locally rooted strategies. Here, architecture isn’t authored by architects but shaped by those who live it. It’s a collective, layered process rooted in slow time and symbolic meaning. The exhibition highlights folk wisdom and everyday magic: garlands hung at construction sites as talismans, candles lit against storms, stones marking thresholds as ritual passages. A real divining rod hints at attention to unseen energies. Lares and Penates moves between anthropology and art, between safety and the feeling of safety. A fire extinguisher is enshrined in a mosaic niche; peepholes and locks are framed like art. Protective deities still dwell in our homes – just in new forms.
POLONIA
Lares and Penates. On Building a Sense of Security in Architecture Giardini www.labiennale.art.pl

«No is more», dicono dall’Ungheria. Lo studio di architettura evocato all’interno del Padiglione è vuoto, abbandonato. Manichini bianchi e rossi sono seduti ai tavoli, alle scrivanie, di fronte agli schermi. Ma gli architetti se ne sono andati. In rivolta contro un sistema che ha fatto della progettazione un meccanismo asservito al mercato immobiliare, all’industria edilizia e alla prosperità economica. La mostra, coordinata dal Ludwig Museum di Budapest e curata da Màrton Pintér, con la collaborazione di Júlia Böröndy, András Graf e Ingrid Manhertz, è intitolata There Is Nothing to See Here. Export Your Knowledge! (Non c’è niente da vedere. Esporta il tuo sapere!). L’esortazione è rivolta ad architetti laureati affinché applichino le loro conoscenze al di fuori dell’industria edilizia. Ed è un modo per dire – a chi inizia, a chi lascia o a chi ha già una carriera – che un’alternativa è possibile. In un periodo in cui il ruolo del progettista viene problematizzato, in una Biennale in cui la figura dell’architetto-autore viene contestata in virtù di un coinvolgimento collettivo e non gerarchico dei diversi attori del progetto, il Padiglione ungherese propone una critica auto-riflessiva raccontando tredici storie di successo in settori alternativi. L’esposizione è il risultato di una ricerca decennale del curatore documentata nella sua tesi di dottorato The Professional, the Specialist, and the Technician. «L’architetto non è più in grado di svolgere il proprio ruolo sociale e culturale» scrive Pintér, che denuncia una «erosione dei principi guida» del fare architettura. Intraprendere un percorso alternativo, però, non è una fuga. Anzi, è un ritrovare l’architettura in quanto processo creativo portatore di cultura e una dimostrazione del fatto che «un architetto può fare molto di più che costruire una casa (dopotutto non vi è nulla di più sostenibile che il non costruire)». Tra gli esempi di “conoscenza architettonica esportata con successo” ci sono inventori, scienziati, politici, operatori culturali e dei media e professori universitari. Ci sono i musicisti Dániel Gryllus e Vilmos Gryllus, la scenografa Judit Varga e le ricerche di Ádám Somlai-Fischer, creatore di start up che uniscono spazio, tecnologia e interattività. Ma per capire quale possa essere il destino dell’architetto in questo periodo di transizione i curatori hanno ascoltato anche giovani studenti ungheresi. Le loro risposte – riportate su pannelli corredati da grafici e dati – mostrano una spiccata sensibilità ai problemi di una nuova generazione. E la convinzione che fare architettura sia molto di più che costruire meri edifici. Giovanni Santarelli
“No is more,” says Hungary. The architectural studio inside the Hungarian Pavilion is empty. White and red mannequins sit at desks and tables, but the architects have left in protest. Against a system that reduces design to a tool for real estate, construction, and economic growth. Curated by Márton Pintér with the Ludwig Museum of Budapest and collaborators Júlia Böröndy, András Graf, and Ingrid Manhertz, the exhibition There Is Nothing to See Here. Export Your Knowledge! urges architects to apply their skills beyond the building industry. Challenging the myth of the architect as sole author, the Pavilion tells thirteen success stories of professionals who shifted into fields like science, politics, media, and education. Pintér’s research, based on his PhD thesis, denounces the erosion of architecture’s social role. But leaving construction isn’t giving up – it’s reclaiming architecture as cultural practice. “There’s nothing more sustainable than not building.” The voices of Hungarian students reinforce this idea: architecture is much more than making buildings.
UNGHERIA
There Is Nothing to See Here Giardini www.ludwigmuseum.hu www.noismore.com | IG @noismore_

Nel 2016 l’Irlanda ha istituito la sua prima Assemblea di Cittadini. Si tratta di un gruppo di 99 residenti, estratti a sorte, che si riunisce per discutere e formulare proposte al Governo. Questa forma di democrazia partecipativa è stata spesso contrapposta alle piazze virtuali dei social network. Le piattaforme di proprietà privata, oggi, sono spesso l’unico spazio di discorso pubblico dove realtà come quella irlandese cercano di far riscoprire il valore dell’incontro fisico, della riflessione, del dibattito e del consenso. Nel Padiglione irlandese Cotter & Naessens Architects propongono di estendere i principi di queste assemblee anche a scala ridotta e locale, chiedendosi quale possa essere la forza dell’intervento architettonico nel favorire lo scambio e la partecipazione democratica. Può il progetto influenzare le pratiche politiche di una comunità? Può l’architettura svolgere un ruolo decisivo nel creare dialogo? In inglese “assembly” indica sia il raduno sia la costruzione. Il Padiglione ospita il prototipo concettuale di una struttura che facilita la comunicazione tra estranei, mette in discussione le gerarchie spaziali tradizionali e propone un modello e uno spazio di interazione per processi lenti e pensieri ponderati, in opposizione al rapido flusso di algoritmi che caratterizza la contemporaneità. La struttura circolare e modulare, è pensata per essere inserita in spazi pubblici e per trasformarli in luoghi di partecipazione. Sfruttando materiali rinnovabili e antichi, competenze artigianali e saperi collaborativi, Assembly è stato realizzato a mano con legno selezionato e stagionato dall’artigiano Alan Meredith. Un esoscheletro a traliccio sostiene un cono in faggio irlandese, mentre a terra un tappeto tessuto a mano di Ceadogán Rugs accoglie chi entra. La struttura, poi, funziona come uno strumento sonoro che armonizza voci dissonanti. All’interno casse acustiche diffondono un intreccio di musica, poesia, interviste con i progettisti e i partecipanti dell’Assemblea. Frutto di una collaborazione estesa, che coinvolge anche l’artista sonoro David Stalling, l’architetta e poetessa Michelle Delea e il curatore Luke Naessens, Assembly è un’esperienza multisensoriale in cui l’atto del ritrovarsi è al tempo stesso vissuto e rappresentato. I visitatori vengono immersi in un ambiente in cui elementi architettonici, acustica e parola parlata si intrecciano per restituire al dialogo pubblico il suo peso specifico nella società contemporanea. Giovanni Santarelli
In 2016, Ireland established its first Citizens’ Assembly, a randomly selected group of 99 residents tasked with discussing key issues and advising the government. Often seen as a counterpoint to the fastpaced, polarized discourse of social media, these gatherings value physical presence, dialogue, and consensus. In the Irish Pavilion, Cotter & Naessens Architects explore how such participatory models might be scaled locally through architecture. Can design foster political dialogue? Can space shape democratic practice? Their conceptual prototype assembly, a circular, modular timber structure, creates room for slow thought and exchange. Built by craftsman Alan Meredith using seasoned Irish beech and traditional techniques, it includes a handmade rug by Ceadogán Rugs and functions as a sound instrument. Inside, speakers play music, poetry, and voices from assembly participants. Blending architecture, sound, and storytelling, Assembly is a multisensory space for gathering – both physically and symbolically –reclaiming the social role of dialogue.
IRLANDA
Assembly Artiglierie, Arsenale www.irelandatvenice2025.ie | IG @irelandatvenice

C’erano tempi in cui il titolo di “Archi Star” era il più ambito, poi in un’ottica social e diffusamente collettiva e politically correct tale definizione non è stata più di moda. Tuttavia oggi, riprendendo la sua originaria accezione, ritengo si debba ripristinarne l’uso originale o cambiarlo in “Archi Star Master”. In una Biennale in cui l’architetto ripensa in maniera allargata la sua professione, quasi allontanandosi dal progetto puro, respirare l’odore della china per tracciare linee e ideare volumi è come una madeleine proustiana. E non poteva che essere francese, stiamo parlando dell’Evento Collaterale, ospitato sull’Isola di San Giorgio Maggiore, The Fondation Cartier pour l’art contemporain by Jean Nouvel. Proprio l’architetto o meglio il Maestro, che nel 1980 aveva scritto Il futuro dell’architettura non è più architettonico, presenta il suo nuovo incredibile edificio-simbolo come lente per esplorare il futuro dell’architettura. La sua visione dell’architettura come pratica critica è capace di interrogare la realtà e immaginare nuovi mondi. Torna indietro per andare avanti. A trent’anni di distanza dalla storica sede in Boulevard Raspail a Parigi – l’emblematico cubo di vetro progettato da Jean Nouvel nel 1994, che allora rivoluzionava la museografia con la sua apparente immaterialità – una nuova sede della Fondation Cartier prende vita in Place du Palais-Royal, a due passi dal Louvre. Non fatevi ingannare dall’impianto tradizionale della mostra –planimetrie, un enorme modello in scala che può essere attraversato, fotografie a grandezza naturale e proiezioni che esaltano gli elementi distintivi, ambiziosi e rivoluzionari del progetto –, gli effetti speciali li produce il progetto stesso. Ciò che emerge infatti è l’approccio ‘contestuale’ dell’architetto, che consiste nel creare spazi che non sono semplicemente edifici, ma ambienti culturali e intellettuali, un’architettura che trascende i propri confini e quelli delle arti che ospiterà. La resa in pianta, come si suol dire, viene ottenuta attraverso cinque piattaforme regolabili in altezza che consentiranno di creare liberamente combinazioni di volumi, vuoti e spazi, trasformando questo palazzo storico in un dispositivo flessibile in grado di abbracciare un ampio spettro di proposte creative.
La mostra si concentra sui principi progettuali che hanno guidato l’ideazione della nuova sede: dinamicità, modularità e mobilità degli ambienti espositivi, appositamente concepiti per assecondare la vocazione multidisciplinare dell’offerta artistica della Fondazione Cartier. M.M.
There was a time when everybody wanted to be a starchitect. Over time, the term fell out of fashion. Today, however, revisiting its original meaning, it seems fitting to restore it, or maybe allow it to evolve into something more meaningful. At a Venice Architecture Biennale where architects rethink their profession, moving beyond pure design, the scent of ink and the act of drawing lines and imagining volumes evoke a Proustian madeleine. Fittingly, this comes from France, specifically, the Fondation Cartier pour l’art contemporain by Jean Nouvel. The architect who in 1980 stated how “the future of architecture is no longer architectural” now presents a new symbolic building as a lens to explore architecture’s future. Thirty years after his iconic glass cube on Boulevard Raspail in Paris, a new Fondation Cartier site emerges near the Louvre. Don’t be misled by the traditional exhibition setup: plans, a walkable scale model, lifesize photos, and projections. The real spectacle is the project itself. Nouvel’s contextual approach creates cultural and intellectual environments, transcending architecture’s boundaries. The design features five adjustable platforms, enabling dynamic spatial configurations. Dynamism, modularity, and mobility.
The Fondation Cartier pour l’art contemporain by Jean Nouvel Fino 14 settembre Isola di San Giorgio Maggiore www.fondationcartier.com

A Palazzo Diedo prende forma The Next Earth: Computation, Crisis, Cosmology, mostra promossa da Berggruen Arts & Culture come Evento Collaterale della 19. Biennale Architettura. Un titolo che è insieme programma e mappa mentale, indizio di un percorso che non si accontenta di esplorare lo spazio costruito, ma si spinge a interrogare le strutture profonde del pensiero contemporaneo. L’esposizione si sviluppa su due piani del palazzo settecentesco, già riaperto al pubblico nel 2023 con la mostra Janus, e oggi animato da un doppio asse curatoriale. Da un lato, Antikythera, think tank filosofico e tecnologico fondato da Benjamin H. Bratton e collegato al Berggruen Institute di Los Angeles; dall’altro, il Dipartimento di Architettura del MIT, uno dei laboratori più avanzati al mondo per lo studio dell’ambiente costruito. Curata dallo stesso Bratton con Nicholas de Monchaux e Ana Miljacki, la mostra si presenta come una doppia costellazione: riflessione teorica e sperimentazione concreta, cosmologia computazionale e progetto ecologico. Al piano terra prende vita la sezione Antikythera con The Noocene: Computation and Cosmology from Antikythera to AI, un video che raccoglie cortometraggi, animazioni e teorie sulla computazione planetaria. “Noocene” è un neologismo coniato da Bratton, in dialogo con le idee di Gregory Bateson e Teilhard de Chardin: designa una nuova era in cui l’intelligenza – umana, artificiale, bioinformatica – trasforma la Terra in un sistema cognitivo complesso. Qui la computazione non è più un mero strumento di calcolo, ma una domanda sul nostro modo di abitare e pensare il mondo. Più che fornire risposte, il progetto apre interrogativi che intrecciano la filosofia, l’ecologia, l’astrofisica.
Al piano superiore si accede tramite la spettacolare scala-opera di Carsten Höller, intervento site-specific che fonde esperienza fisica e spaesamento concettuale. Nel grande salone, Climate Work: Un/
Worlding the Planet raccoglie quaranta progetti in corso del MIT, con un focus sull’emergenza climatica. Se il settore edilizio produce oltre il 40% delle emissioni globali di CO 2, che ruolo può assumere l’architettura in una trasformazione sistemica? Le risposte non sono utopiche ma progettuali: si passa dal recupero delle tecniche vernacolari all’uso di materiali sostenibili, da sistemi di raffreddamento passivo a nuove forme di coabitazione tra umano e ambiente. The Next Earth non è una mostra di architettura nel senso classico, né un manifesto sulla tecnologia. È una meditazione visiva e teorica su come la Terra possa essere pensata non solo come oggetto d’intervento tecnico, ma come orizzonte di conoscenza. Un invito a considerare la crisi attuale non soltanto come catastrofe, ma come occasione di una profonda riflessione: siamo ancora capaci di immaginare, di progettare, di co-evolvere con il Pianeta? Irene Machetti ENG At Palazzo Diedo, The Next Earth: Computation, Crisis, Cosmology unfolds as a Collateral Event of the 2025 Venice Architecture Biennale. More than an architectural show, the exhibition is a conceptual journey into the structures of contemporary thought. Curated by Benjamin H. Bratton, Nicholas de Monchaux, and Ana Miljacki, it bridges philosophy and design through two curatorial lines: the Antikythera think tank and MIT’s Department of Architecture. On the ground floor, The Noocene explores planetary computation through video works and speculative theory, proposing a new era where intelligence – human, artificial, and biological – reshapes Earth as a cognitive system. Upstairs, Climate Work presents 40 MIT projects addressing the climate crisis, from vernacular techniques to sustainable materials and passive cooling systems. A site-specific staircase by Carsten Höller connects the levels, blending physical and conceptual disorientation. The Next Earth is not a traditional architecture show, but a visual and theoretical meditation on Earth as a horizon of knowledge. It invites us to see crisis not only as catastrophe, but as a chance to rethink how we live, imagine, and co-evolve with the planet.
NOT ONLY BIENNALE
Sanlorenzo ha trovato la sua Casa
In occasione della prima edizione della Venice Climate Week e nel contesto della Biennale di Architettura di Venezia, il 3 giugno Sanlorenzo ha inaugurato Casa Sanlorenzo.
Casa: un termine che può sembrare strano a Venezia, dove la qualità dell’abitare è tradizionalmente associata all’idea del Palazzo. Storicamente, la gloria della Serenissima si immortala attraverso la sequenza dei Palazzi che definiscono la quinta unica e inconfondibile del Canal Grande. O nell’interno, in campi e calli, dove si scoprono palazzi raffinatissimi come scrigni preziosi. Invece Sanlorenzo a Venezia ha trovato Casa. La scoperta di una realtà rara e peculiare, una dimora signorile e di qualità architettonica altissima che parla però un linguaggio diverso, unico, singolare: riporta la dimensione della dimora, dell’abitare di famiglia, della quiete di un giardino introverso e di grandissimo respiro. Con uno “scorrere” orizzontale Casa Sanlorenzo si contrappone in modo raffinato ed equilibrato alle grandi facciate dei palazzi, delle chiese con cui si confronta da vicino. E con questa declinazione segna la sua unicità, sottolineata da gesti e segni garbati ma inconfondibili, come i pregevoli parapetti in marmo, come i bellissimi portoni a bugne in legno. E con un privato e personale percorso di avvicinamento, un altro episodio di unicità: si attraversa l’acqua e si giunge sulla porta di casa; un ponte, che si mette in fila con altri sullo stesso Rio, ma che come su un fossato difensivo rafforza ancor più l’idea di accedere ad uno spazio intimo, riservato, tranquillo, silenzioso. Il Canal Grande si vede, ma non si domina; la Basilica della Salute con la sua esuberante imponenza entra nella casa, che se ne appropria in mille visioni ma non si contrappone, la guarda dal basso quasi in una sorta di riverenza esaltandone così la magnificenza dei volumi; il rumore si attenua, si spegne, lascia spazio al suono delle campane.
Così nasce l’edificio, come casa privata, tra gli anni Quaranta e gli anni Cinquanta, con una storia probabilmente anche complessa in anni di carenza di materia prima per la costruzione, di autarchia, di guerre, che in qualche modo chi ha seguito il restauro ha potuto intravvedere al di sotto dell’elegantissima e raffinata cifra decorativa degli interni. Così Sanlorenzo riconosce l’idea di una Casa a Venezia: una casa per «celebrare e sostenere il connubio tra arte, design e cultura, dove l’innovazione e la creatività possano fiorire senza limiti» ha dichiarato Massimo Perotti, Executive Chairman di Sanlorenzo. «Casa Sanlorenzo diventa il luogo in cui si entra per fermarsi, riflettere e condividere. Uno spazio di ricerca, dove l’arte non decora, ma interroga. Dove il design non impressiona, ma accompagna. Dove la bellezza non è mai fine a sé stessa, ma portatrice di un’etica. In un mondo sempre più virtuale, abbiamo voluto investire sulla presenza, sull’incontro, sull’esperienza. Perché crediamo che l’autenticità abbia bisogno di materia, di tempo, di sguardi. E Venezia rappresenta il luogo perfetto per questo progetto». Così, affidando l’interpretazione di questo obiettivo e calandolo sul raro contesto, Sanlorenzo ha affidato all’architetto Piero Lissoni il compito di tradurre con i segni e il linguaggio di una nuova architettura il senso profondo dei contenuti e del contenitore di questo progetto innovativo. Ne
Casa Sanlorenzo
Dorsoduro 170 www.sanlorenzoyacht.com


nasce un progetto di altissima qualità, che coniuga un perfetto equilibrio tra conservazione dell’esistente e dei tratti caratteristici e inserimento del nuovo, esaltando il rapporto visivo tra gli interni e gli spazi esterni: le monumentali viste prospettiche verso la Chiesa della Salute, gli scorci poetici sulla Basilica di San Gregorio, l’apertura verso il bellissimo giardino privato, che ora si può gustosamente intravvedere dal cancello disegnato per l’ingresso sulla Calle dell’Abbazia.
E il nuovo ponte, che con una poetica progettuale di leggerezza e rigore enfatizza il gesto di avvicinarsi alla Casa, di entrare in uno spazio unico percorrendo un cammino orizzontale, quasi come un racconto che prendendo per mano il visitatore lo conduce attraverso le sale espositive, gli spazi comuni, il giardino, fino ad uscire in un altro punto, come in una sorta di viaggio attraverso una Venezia intima, unica, da scoprire e riscoprire a ogni passo e a ogni sguardo. ON.

For the first edition of Venice Climate Week, Sanlorenzo, the art charity arm of one of the world’s largest luxury yacht builders, opened an office in Venice. A home, more than an office, in a city where dwelling quality is more easily associated with its beautiful palazzos. Casa Sanlorenzo is a distinguished, finely crafted piece of architecture that speaks a unique language, different from similar buildings around it: it is the language of family, of a quiet private yard. The home develops horizontally, a balanced, refined counterpoint to the vertical extension of other palaces and churches. This highlights its uniqueness, as do its beautiful marble railings and rusticated wood portals. You can see the Grand Canal from here, though the point of view is not a dominating one. Rather, it is the imposing Salute Basilica that you see from the ground up, in reverence. The house was designed between the 1940s and 50s. At the time, war and shortages influenced heavily its coming into being, as did elsewhere in the country. Its peculiar history commanded careful restoration to preserve its elegance and its refined décor. Sanlorenzo wanted a home in Venice to “celebrate and support the union of art, design, and culture, a place where innovation and creativity can blossom […] Casa Sanlorenzo is a place you visit to rest, reflect, and share. It is a space for research, a place where
art is not mere décor, but something that inspires us to question what we see. Beauty, here, is never an end to itself, but a bearer of ethics. In a world that grows more virtual every day, we wanted to invest in real presence, real meetings, experiences, because we believe that authenticity needs material, time, presence. Venice is the perfect place to carry out our project”.
Sanlorenzo hired architect Piero Lissoni to translate the deeper sense of the contents and container of this innovative project into the signs and language of new architecture. What came of it is a project of the highest quality and a perfect balance of preservation of what exists and embedding the new, highlighting the visual relationship between inside and outside spaces: the monumental views on the Salute Church, dreamlike perspectives on the San Gregorio Basilica, and the private garden, which one can barely see through the new gate.
A new bridge of exquisite lightness and rigour highlights our approaching the home, our entering an extraordinary space via a horizontal pathway that is, metaphorically, a story. We feel taken by the hand and walked through the several halls, the common areas, the garden, until we find ourselves in a different place. A journey through a Venice that is intimate and unique.

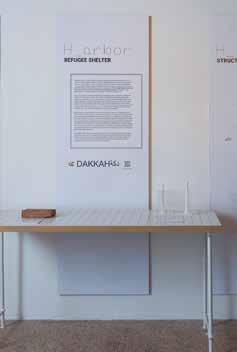

All’interno della pluralità di voci presentate dall’European Cultural Centre con Time Space Existence – incentrata quest’anno sui temi Riparare, Rigenerare e Riutilizzare – emergono progetti che rispondono con lucidità alle istanze del presente. In particolare, tre interventi esposti a Palazzo Mora affrontano con forza le sfide poste da sfollamento, disuguaglianza e migrazione indotta dai conflitti: tre proposte sperimentali che sfidano i confini convenzionali e dimostrano il potenziale trasformativo del design spaziale in risposta alle crisi umanitarie.
Con Roots of Hope, Layers of Resilience, Islam El Mashtooly and Karim Moussa / Pragma ci parlano di Gaza come di un palinsesto vivente, una tela su cui, nel tempo, si sono scritti, cancellati e riscritti strati di narrazioni umane ed ecologiche. Pragma colloca Gaza in una visione di speranza, in un paesaggio rigenerativo che riconnette le persone alla terra e ripara l’ecologia attraverso mappature, biorisanamento e design sostenibile, immaginando un futuro in cui architettura, agricoltura e memoria si intrecciano in un nuovo equilibrio. Lo studio statunitense Hyperlocal Workshop e l’egiziano Handover Projects propongono H_arbor, un sistema modulare per la ricostruzione in contesti di emergenza. Al centro, una struttura portante a forma di H, realizzata con materiali locali come terra o macerie, funge da base per unità abitative e spazi collettivi. I moduli possono essere montati singolarmente o in sequenza per dare vita a scuole, cucine, ambulatori. Pensato per essere montato rapidamente e replicato su larga scala, il progetto valorizza le risorse locali e il coinvolgimento diretto delle comunità.
Infine, The Portable Play è l’ultima iniziativa della Global Design Initiative for Refugee Children (GDIRC), gruppo di professionisti di Boston attivo dal 2016 nella progettazione di spazi gioco per bambini in situazioni di crisi. A Venezia GDIRC presenta due prototipi: The Cube Climber (Palazzo Mora) è una struttura modulare realizzata con materiali semplici e pannelli colorati traforati che creano giochi di luce e spazi per l’esplorazione; The Climbing Hive (Giardini della Marinaressa) è ispirato alle forme esagonali della natura, combinando aree dinamiche e zone protette per un’esperienza di gioco libera e adattabile. Ogni modulo diventa uno spazio di socialità e riparo, pensato per ambienti in costante trasformazione. Marisa Santin
ENG Within the diverse voices of the European Cultural Centre’s Time Space Existence, three projects at Palazzo Mora stand out for addressing urgent humanitarian crises linked to displacement, inequality, and migration. Roots of Hope by Islam El Mashtooly and Karim Moussa / Pragma reimagines Gaza as a living palimpsest, using mapping, bioremediation, and sustainable design to restore ecological and social resilience. H_arbor, by Hyperlocal Workshop and Handover Projects, is a modular shelter system made from local materials like earth and rubble. Its H-shaped units can be combined to create adaptable community spaces, enabling displaced populations to rebuild sustainably. Global Design Initiative for Refugee Children (GDIRC) presents The Portable Play : two versatile play structures designed for displaced children. The Cube Climber uses simple materials and assembly to foster creativity, while The Climbing Hive (at Marinaressa Gardens) provides climbing zones and quiet spaces, supporting social bonds and resilience. Together, these projects highlight spatial design’s potential to respond creatively and compassionately to crises.

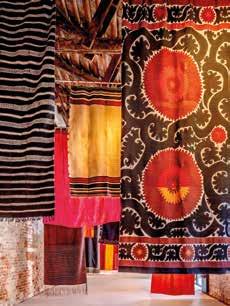
Il riscaldamento locale delle città a causa del cambiamento climatico e dell’intensificazione dell’urbanizzazione è ampiamente discusso. È chiaro ormai che in assoluto il fenomeno non è più arrestabile, è necessario un cambiamento di paradigma. Come convivere con il cambiamento climatico? In occasione della 19. Biennale Architettura, keep cool! Workshop for Cool Cities è una riflessione visiva sul problema del surriscaldamento delle città, richiamando in particolare l’attenzione sulle tradizioni costruttive locali e sulle conoscenze ecologiche ereditate. Con un format espositivo che trova perfetta definizione negli spazi del Salone Verde, e attraverso una collaborazione interdisciplinare tra tre istituzioni accademiche tedesche e l’artista Antje Schiffers, la mostra-laboratorio propone strategie non convenzionali per adattarsi al cambiamento climatico offrendo prospettive di architettura, design, ingegneria e arte. L’insieme delle voci accademiche e artistiche trasformano il Salone Verde in un “laboratorio per le città fredde”, uno spazio di ascolto per ampliare o mettere in discussione i modi di vivere e di costruire in un mondo in rapido riscaldamento. La prospettiva è dunque quella di creare spazi abitativi confortevoli utilizzando tecnologie ad alta intensità energetica. Le culture che hanno accettato le alte temperature per secoli hanno sviluppato tecnologie che rispondono in modo intelligente a queste condizioni. Le loro tecniche di costruzione, i materiali e le forme contraddicono i nostri standard convenzionali ed è proprio grazie a questo contrasto che offrono nuove prospettive di bellezza universale. Gli stili costruttivi locali sono capolavori di adattamento alle condizioni, in quanto utilizzano le risorse naturali e mantengono un equilibrio tra uomo e natura. Tecnologia, arte e natura si intrecciano, invitando a scoprire connessioni sorprendenti.
La mostra presenta due diverse risposte: la prima, Flight into Shadow, sviluppata da professori e studenti dell’Institute of Building Construction, Building Technology and Design, IBK University of Stuttgart, HFT Stuttgart Interior Architecture, Deggendorf Institute of Technology, è una risposta organica al surriscaldamento delle città. La ricerca identifica il micelio, un architetto del rinnovamento, antico, in costante evoluzione e adattamento, che non vediamo, di cui non sentiamo l’odore, non lo percepiamo, eppure è lì, non solo come materiale da costruzione naturale, ma come mediatore tra la natura e l’ambiente costruito. I materiali a base di micelio hanno intrinsecamente una bassa conducibilità termica e capacità di accumulo del calore. Se ap-
plicati alle aree urbane, possono ridurre la quantità di calore assorbita durante il giorno e diminuire la successiva ridiffusione di calore durante la notte. A differenza del legno, il micelio cresce in pochi giorni. La sua pelle bianca e fungina riflette naturalmente la luce solare, creando alti valori di albedo. La struttura viene realizzata solidificando i tessuti con una sottile pellicola di pasta di micelio e lasciandola crescere in un ambiente di laboratorio dedicato. Tecnologia, design e natura si intrecciano, invitandoci a scoprire connessioni sorprendenti. Il micelio incarna una forma di intelligenza che stiamo solo iniziando a comprendere: una rete vivente che impara, si adatta e si connette, proprio come esemplificato negli spazi del Salone Verde. Per la seconda risposta, Heat is a Psychological Problem proposta da Antje Schiffers, vengono utilizzati i media artistici come strumenti flessibili per l’interazione e la narrazione. Come ambasciatrice e corrispondente, come artista di compagnia, come pittrice itinerante e botanica di spedizione, Schiffers si immerge in mondi diversi e sperimenta ruoli e metodi. Il suo lavoro è collaborativo e offre spazio alla polifonia, alla complessità e alla cooperazione. Schiffers ha preso in prestito tappeti intrecciati e coperte pesanti, provenienti dal Mali e dall’Anatolia, dal Marocco e dall’Uzbekistan, che portano diverse tradizioni visive, tecniche e conoscenze di regioni in cui la convivenza con il calore fa parte della vita quotidiana, e li ha appesi alle travi del tetto del Salone Verde: il loro ondeggiare lento agita pigramente l’aria, favorendone il circolo e la mitigazione del calore. «Con il caldo non si corre, con il caldo si respira» (Antje Schiffers). M.M. ENG Urban warming caused by climate change and intensified urbanization is widely discussed. The phenomenon is now irreversible, meaning what’s needed is a paradigm shift. How can we live with climate change? At the 2025 Venice Architecture Biennale, keep cool! Workshop for Cool Cities offers a visual reflection on urban overheating, focusing on local building traditions and inherited ecological knowledge. Through an interdisciplinary collaboration between three German academic institutions and artist Antje Schiffers, the exhibition proposes unconventional strategies for adaptation, blending architecture, design, engineering, and art. The Salone Verde becomes a “laboratory for cool cities”, exploring how we might live and build in a warming world. The exhibition shows two approaches: Flight into Shadow, exploring mycelium as a natural, reflective, and insulating material; and Heat is a Psychological Problem, where Schiffers uses heavy woven textiles from hot regions to cool the space and invite reflection: “In the heat, you don’t run: you breathe”.
FILIPPO BRICOLO ALPS. ARCHITECTURE. SOUTH TYROL.
Intervista Filippo Bricolo architetto e curatore Alps. Architecture. South Tyrol di Mariachiara Marzari
Intelligens. Natural. Artificial. Collective, tema della 19. Biennale Architettura, è il filo conduttore della mostra Alps. Architecture. South Tyrol., in corso a Palazzo Cavanis fino al 23 novembre, che documenta l’orizzonte architettonico che si è sviluppato in Alto Adige tra il 2018 e il 2024. La selezione dei progetti è stata curata da una giuria internazionale composta dal curatore Filippo Bricolo (Italia), architetto (Bricolo Falsarella Architetti) e docente al Politecnico di Milano, affiancato da Annette Spiro (Svizzera), architetta (Spiro + Gantenbein Architekten ETH/SIA AG) e professoressa ordinaria di architettura e costruzione al Politecnico federale di Zurigo (ETH), e da Elisa Valero Ramos (Spagna), architetta e professoressa di architettura presso la Escuela Técnica Superior de Arquitectura dell’Università di Granada. Tra le 240 proposte pervenute, sono stati selezionati 28 progetti principali e 28 menzioni speciali al fine di restituire una visione attenta di un territorio contraddistinto da un’architettura che risponde alle esigenze del vivere contemporaneo, cercando allo stesso tempo di radicarsi intimamente nella particolarità del suo contesto attraverso un approccio umanizzante intriso di un forte senso di profonda appartenenza. Alps. Architecture. South Tyrol. affronta così la questione centrale formulata da Filippo Bricolo, ovvero se esista un’architettura altoatesina e quali siano le sue caratteristiche distintive, secondo un inventario che ricalca i temi guida della Biennale. I progetti si distinguono per una pianificazione sostenibile, per il recupero attento dei centri urbani e per un utilizzo delle risorse, del paesaggio e dei materiali il più possibile accorto – aspetti che caratterizzano il cambiamento culturale in corso nel settore architettonico della Regione. La mostra è accompagnata da un catalogo completo e da un programma di talk, workshop ed eventi serali, tra cui incontri con le architette e gli architetti degli studi coinvolti, approfondimenti che trasformano Palazzo Cavanis in un prezioso presidio di indagine sul fare architettura oggi. Abbiamo incontrato il curatore Filippo Bricolo.
La mostra è legata al repertorio dell’edificato nella Provincia autonoma di Bolzano - Alto Adige che ogni sei anni viene commissionato a un curatore diverso. Com’è nato questo progetto? E quali esiti produce nel tempo, di sei anni in sei anni? L’architettura è un grande autoritratto che una società fa di sé. Un autoritratto perfetto, fedelissimo. Quando vogliamo conoscere una nazione, una cultura, infatti, visitiamo le città, osserviamo l’architettura. Una comunità che sa guardare attraverso lo specchio dell’architettura è




Intelligens. Natural. Artificial. Collective, the theme of the 2025 Venice Architecture Biennale, guides the exhibition Alps. Architecture. South Tyrol., at Palazzo Cavanis through November 23. The show explores architectural developments in South Tyrol, a region in Northern Italy formerly part of Austria and still home to a German-speaking majority, from 2018 to 2024, presenting a curated selection of 28 main projects and 28 special mentions from 240 submissions. The selection was made by an international jury: curator and architect Filippo Bricolo (Italy), Annette Spiro (Switzerland), and Elisa Valero Ramos (Spain).
The exhibition highlights architecture that responds to contemporary living while remaining deeply rooted in the local context. It emphasizes sustainable planning, thoughtful urban renewal, and careful use of resources, landscape, and materials, which are the hallmarks of a cultural shift in the region’s architectural approach. At the heart of the exhibition is a question posed by Bricolo: Does a distinct South Tyrolean architecture exist, and what defines it? The projects reflect the Biennale’s themes, offering a portrait of a region where architecture is both innovative and grounded in place. Accompanying the exhibition is a comprehensive catalogue and a program of talks, workshops, and evening events. These include meetings with the featured architects and in-depth discussions, transforming Palazzo Cavanis into a vibrant hub for exploring the practice of architecture today.
How did it all start, and what are we looking forward to?
Architecture is a society’s self-portrait: accurate and revealing. To understand a culture, we look at its cities and buildings. South Tyrol has embraced this reflective process through the Recent Architecture in South Tyrol project, launched with the new millennium. The first edition covered 2000–2006; the current one spans 20182024. Unlike typical architecture awards, this initiative offers a critical, cyclical analysis of the region’s architectural evolution, producing exhibitions and catalogues as lasting records. Each edition is curated by someone from a different region or country, ensuring diverse perspectives. South Tyrol also benefits from other tools of architectural reflection, such as the magazine Turris Babel. Together, these efforts make it a leading hub for architectural discourse in Italy.
The themes explored in South Tyrolean architecture reflect broader contemporary concerns, without any single issue taking precedence. What the region offers is an alternative to models often shaped by major cities. In South Tyrol, architecture reveals a deep, dynamic relationship with its context – understood broadly as landscape, heritage, and culture – whether in urban settings or natural environments.
It’s time for Italy to refocus on its provinces, where a more human-centered and sustainable architectural approach is emerging. Here, sustainability isn’t just about performance, but about rebuilding meaningful connections between people and place. This makes the Alps exhibition’s presence in Venice especially important, offering a vital perspective amid global architectural discourse. Too often, attention is given to strategies and processes rather than the actual outcomes of architectural work. South Tyrol, with-
FILIPPO BRICOLO ALPS. ARCHITECTURE. SOUTH TYROL.

una società che sa guardare dentro sé stessa per crescere, per migliorarsi. È il percorso unico che ha intrapreso questo territorio con il progetto editoriale-espositivo Architetture recenti in Alto Adige, che si svolge ogni sei anni. E lo ha fatto simbolicamente a partire dallo scoccare del nuovo millennio. La prima edizione ha raccolto infatti le opere realizzate dal 2000 al 2006, mentre ora abbiamo analizzato il periodo dal 2018 al 2024. Non c’è in Italia, e forse nel mondo intero, un’area territoriale che abbia mostrato la stessa capacità di autoanalisi. Perché in fondo questo è il valore dell’iniziativa, ovvero di non essere un premio di architettura come ce ne sono molti, ma una vera e propria lettura critica volta ad analizzare ritmicamente l’evoluzione della propria architettura e a produrre cataloghi e mostre che sono gli esisti di questa indagine profonda. Osservando i diversi cataloghi si può notare l’evoluzione e la crescita del fenomeno Alto Adige. La stessa scelta di affidare di volta in volta l’indagine a un curatore diverso e proveniente da una diversa area, regione o nazione denota la volontà di ottenere diversi sguardi, molteplici letture a riguardo. Ricordiamo anche che l’Alto Adige dispone di molti altri strumenti di analisi della propria architettura, tra cui il lavoro straordinario della rivista Turris Babel. Insieme queste attività rendono la provincia più a nord d’Italia un presidio importantissimo per l’architettura.
Quali i temi più sensibili che l’architettura della regione Alto Adige ha sviluppato come prioritari? E come partecipa al dibattito internazionale sull’architettura contemporanea? I temi dell’architettura dell’Alto Adige sono quelli tipici della nostra contemporaneità; non mi pare vi siano dei temi particolarmente prioritari rispetto ad altri. Il nostro contributo al grande dibattito sull’architettura contemporanea è dato da una sorta di offerta di un’alternativa ai modelli che spesso vengono lanciati dalle grandi città. In Alto Adige sembra di poter leggere la presenza di un rapporto dialettico e intenso con il contesto, inteso in un’accezione assai vasta, ovvero come paesaggio, preesistenze, ma anche come cultura. Questo sia nelle opere costruite dentro le città storiche, che nella natura. Credo che sia arrivato il momento in Italia di tornare a guardare alla provincia, perché è indubbio che in queste aree si sta sviluppando una ricerca di un’architettura umanizzante e sostenibile. E qui non

intendo sostenibilità in termini prestazionali, bensì come un fare architettura capace di ricostruire un rapporto intenso tra esseri umani e i luoghi che abitano. Guardare dentro la provincia, nel cuore di queste ricerche laterali che si sviluppano nella nostra nazione, è un gesto urgente e necessario. Per questo è molto importante aver portato la mostra Alps a Venezia nel momento in cui questa città diventa un punto di osservazione privilegiato sulle diverse ricerche in corso nel mondo dell’architettura. È importante che, tra tutti questi sguardi, ci sia anche questo. Perché a volte si tende più a vedere la strategia o il processo che ne stanno alla base piuttosto che il risultato concreto ottenuto dalle progettazioni architettoniche. Si parla di rigenerazione e di altri temi significativi da un punto di vista della sostenibilità, si utilizzano i termini più attuali, ma ciò che conta davvero è comprendere cosa producano effettivamente queste strategie: quali costruzioni generano, quali ricadute hanno sui territori e sulle persone. L’Alto Adige, senza grandi proclami né teorie alla moda, mi sembra da tempo in grado di realizzare opere di grande valore capaci di fare propri i temi contemporanei trasformandoli in architetture in cui si può vivere bene. E questo, a mio avviso, non è affatto un dato marginale.
Quest’anno è stato lei a condurre, insieme a una giuria internazionale, il lavoro di selezione di questo repertorio, riproducendolo in mostra attraverso otto diverse sezioni. Come avete costruito questa scelta? E come si sviluppa oggi nel percorso espositivo?
Nei cataloghi e nelle mostre delle edizioni precedenti le architetture erano suddivise per vallate o aree geografiche. Una formula felice e profondamente adatta al periodo in cui quelle selezioni furono svolte. La giuria di quest’anno, composta da me, Elisa Valero e Annette Spiro, ha iniziato a mettere in discussione questo criterio attraverso la scrupolosa osservazione dei progetti pervenuti e visitando direttamente le architetture in loco. Dal 2000 ad oggi è trascorso quasi un quarto di secolo e la comunicazione dell’architettura ha conosciuto una grande trasformazione: le influenze si sono moltiplicate e gli architetti sono entrati in contatto con sperimentazioni provenienti da contesti diversi. In Alto Adige, inoltre, operano anche studi e progettisti non originari del territorio, che hanno realizzato – e stanno

realizzando – opere significative. Tutto ciò ha reso meno rilevante una lettura basata esclusivamente su criteri geografici. Abbiamo quindi deciso di strutturare la selezione secondo elenchi tematici che, è bene sottolinearlo, non costituiscono categorie rigide a sé, né una proposta di classificazione. Si tratta piuttosto di una strategia per riunire “famiglie” di progetti, per creare connessioni, sollecitare riflessioni e dialoghi aperti. La nostra mostra, come il catalogo, non intende fornire risposte o certezze; vuole al contrario invitare a vivere le domande che questo territorio ci pone attraverso la sua architettura. Le categorie affrontano diversi temi: Riuso riflessivo, ovvero il recupero come atto critico che attiva un rispecchiamento di strati profondi; Evocazioni urbane, il costruire in città edifici moderni ma radicati nella memoria; Architettura naturans, ossia il dialogo tra costruito e paesaggio; Topografia partecipata, dove il luogo diventa coautore del progetto; Vernacoli plausibili, che esplora il dialogo vivo e umanizzante con la tradizione; Scavo generativo, un ritorno alla terra, a un’architettura “terrestre”; Interni poetici, dedicato alla necessaria riscoperta dell’intimità; Arte e architettura, che riapre un confronto tra due mondi tra loro prossimi ma non sempre felicemente connessi.
Alla fine di questa ricognizione sembra emergere la definizione di un linguaggio architettonico proprio, o forse addirittura una vera e propria scuola. Lei che idea si è fatto? Non credo si possa parlare di un linguaggio. Il tema del linguaggio, in architettura, è una questione sfuggente e complessa. E non ritengo sia importante trovare una risposta definitiva. È forse più interessante leggere e valutare l’architettura di questo territorio come una domanda aperta. È questo l’aspetto che ci ha interessato: una curatela che non afferma “guardate, è così!” o, che so, “l’Alto Adige è questo”. Il saggio parte da una domanda e vuol essere esso stesso un quesito aperto da condividere con visitatori e lettori. In un’epoca in cui le grandi narrazioni stanno lasciando spazio a verità semplificate, brevi, talvolta false o distorte, dobbiamo imparare a vivere fuori da questo sistema fatto solo di affermazioni. Dovremmo promuovere iniziative che restituiscano valore al dubbio – nella sua delicatezza, nella sua umanità profonda. Dovremmo immaginare mostre che invitino a vivere uno spazio abitato da una gentile incertezza.

out grand statements or trends, has long produced architecture that quietly embodies contemporary values – creating spaces where people can truly live well. That, ultimately, is what matters most.
In previous editions, architectural works were organized by valleys or geographic areas – a fitting approach for its time. This year, however, the jury (myself, Elisa Valero, and Annette Spiro) questioned that method after closely reviewing the submissions and visiting the sites. Nearly 25 years have passed since the project began, and architectural communication has evolved. Influences are more diverse, and many architects working in South Tyrol today come from outside the region, making a purely geographic reading less relevant.
We chose instead to group projects thematically – not as rigid categories, but as a way to create connections and spark dialogue. The exhibition and catalogue don’t offer definitive answers but invite visitors to engage with the questions raised by the region’s architecture.
Themes include: Reflective Reuse (restoration as critical reflection), Urban Evocations (modern buildings rooted in memory), Architecture Naturans (dialogue with landscape), Participatory Topography (site as co-author), Plausible Vernaculars (living tradition), Generative Excavation (earthbound design), Poetic Interiors (intimacy rediscovered), and Art and Architecture (reconnecting two creative worlds).
I don’t believe we can speak a single architectural language. The idea of “language” in architecture is elusive and complex and perhaps not something that needs a definitive answer. It’s more meaningful to view the architecture of this region as an open question. That’s what interested us: a curatorial approach that doesn’t declare “this is what South Tyrol is” but instead invites reflection. In a time when grand narratives are giving way to simplified, often distorted truths, we must learn to live outside a system built solely on assertions. We should foster initiatives that restore value to doubt, in its subtlety, in its deep humanity. Exhibitions should invite us to inhabit spaces shaped by gentle uncertainty.

Mostra inaugurale del nuovo SMAC – San Marco Art Centre, alle Procuratie Vecchie in Piazza San Marco, Migrating Modernism. The Architecture of Harry Seidler, che termina il 14 luglio, merita assolutamente una visita. Non solo per il nuovo contesto espositivo, negli spazi antichi ristrutturati da David Chipperfield, ma soprattutto per la straordinaria storia personale e l’opera del principale architetto moderno Harry Seidler (1923, Vienna – 2006, Sydney). Fuggito dalla Vienna nazista all’età di 15 anni, si rifugiò in Inghilterra. Dopo essere stato internato come straniero nemico, fu deportato in altri campi in Canada. Una volta rilasciato, nel 1941, si laureò in architettura prima di trasferirsi negli Stati Uniti. Alla Harvard Graduate School of Design e al Black Mountain College, dove decise di studiare, si trovò davanti a una notevole schiera di maestri, tra cui Walter Gropius, Josef Albers e Marcel Breuer. Nel periodo trascorso in Brasile collaborò con Oscar Niemeyer, prima di recarsi in Australia. Arrivato a Sydney nel 1948 per progettare una casa per i suoi genitori, la Rose Seidler House, aprì il suo studio privato nel 1949. Diventerà una delle voci più influenti del Movimento Moderno in Australia, dando forma a un’eredità che comprende case unifamiliari, torri commerciali e residenziali e progetti abitativi su larga scala, realizzati in città diverse come Sydney, Acapulco, Parigi, Hong Kong e la natia Vienna. La vita e l’opera di Seidler tracciano l’arco del Modernismo come un viaggio personale e una narrazione globale, invitando a riflettere sull’architettura come mezzo attraverso il quale le idee migrano tra continenti e tempo.
Curata da Ann Stephen del Chau Chak Wing Museum e da Paolo Stracchi della School of Architecture Design and Planning dell’Università di Sydney, con la consulenza curatoriale di Nikolaus Hirsch, la mostra prende in esame in modo approfondito sia i singoli progetti che le collaborazioni di Seidler con architetti e artisti, tra cui Josef Albers, Alexander Calder, Helen Frankenthaler, Frank Stella, Lin Utzon
e Sol LeWitt, e con l’ingegnere strutturale italiano Pier Luigi Nervi. La sua competenza tecnica, soprattutto nel campo del cemento armato, era rara nella sua generazione e lo distingueva dai suoi colleghi. Questo ha anche fornito le basi per le forme fluide prodotte con Pier Luigi Nervi che hanno caratterizzato il suo lavoro a partire dai primi anni Sessanta. La combinazione di competenza ingegneristica ed estro scultoreo fece di lui uno dei pochi designer della sua epoca in grado di realizzare il sogno modernista di integrare arte e tecnologia. Lettere, disegni, fotografie, manufatti e modelli, oltre a documenti personali e opere d’arte di coloro, che hanno influenzato Seidler o con cui ha collaborato, compongono il percorso espositivo.
Tra i progetti più importanti figurano l’Ambasciata Australiana a Parigi (1973-77), un progetto gestito in collaborazione con Marcel Breuer, l’Hong Kong Club (1980-84) e il Wohnpark Neue Donau (1993-99) e l’Hochhaus Neue Donau (2002), che hanno rappresentato un ritorno alla natia Vienna. M.M.
ENG The first exhibition at the new SMAC – San Marco Art Centre, in the Procuratie Vecchie in Piazza San Marco, is Migrating Modernism. The Architecture of Harry Seidler, running until July 14. The new exhibition venue is worth a visit on its own, being newly restored by David Chipperfield, though we found the exhibition on the extraordinary life and work of Harry Seidler (1923, Vienna –2006, Sydney), a leading figure of Modernist architecture, extremely compelling. Fleeing Nazi Vienna aged fifteen, he sought refuge in England where he was taken into custody as foreign enemy, then deported to Canada. Once released, he studied architecture in the U.S. under Gropius, Albers, and Breuer. After working with Niemeyer in Brazil, he moved to Sydney in 1948, founding his studio in 1949. His legacy spans continents, from Sydney to Paris, Hong Kong, and Vienna. The exhibition, curated by Ann Stephen and Paolo Stracchi, explores his projects and collaborations with artists like Albers, Calder, and Nervi. Seidler’s technical skill and sculptural vision made him a rare figure in his ability to blend art and technology.
NOT ONLY BIENNALE
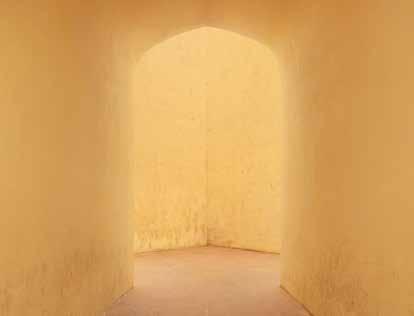
Dettagli architettonici svelati attraverso giochi di luce e ombra che creano visioni altre: sono le fotografie di grande formato che compongono la mostra Ljubodrag Andric. Spazi, soglie, luci, curata da Francesco Tedeschi e organizzata dalla galleria BUILDING di Milano, al terzo piano di Palazzo Cini fino all’8 settembre. Di origine serba e ora residente in Canada, Ljubodrag Andric si trasferisce in giovane età a Roma dopo aver concluso gli studi universitari, quando inizia a coltivare con maggiore impegno la sua passione per la fotografia. Dopo i primi lavori, si afferma come un fotografo di architetture rivelate tramite dettagli, restituendo un’immagine che non si ferma alla semplice mimesi della realtà, ma che, grazie a tagli originali, assume una connotazione quasi astratta. Le 17 fotografie in mostra, testimoni silenti dei viaggi in India e in Italia, sono esemplari di questo suo stile enigmatico. Tra un’opera e l’altra si coglie infatti la volontà del fotografo di trovare corrispondenze tra le strutture degli edifici indiani e quelli veneziani, catturati tramite scatti che mettono al centro la ricerca di riflessi, colori, luci e ombre. Le immagini assumono diverse connotazioni: oltre al taglio architettonico, il carattere quasi pittorico della resa dei colori e la ricerca di forme scultoree. Tutti questi aspetti, che definiscono il suo sguardo personalissimo, sovrastano la linea dei soggetti stessi offrendo la possibilità di trovare punti in comune tra edifici culturalmente lontani, accomunati dalle stesse geometrie e atmosfere. Marina Borroni
ENG Architectural details revealed through games of light and shadow that create alternate visions, as pictured in large-format photographs featured in Ljubodrag Andric. Spaces, Thresholds, Lights, curated by Francesco Tedeschi at the third floor of Palazzo Cini. Originally from Serbia and now based in Canada, Andric moved to Rome after university, where he trained as a photographer. His work focuses on architecture through detail, offering images that go beyond mere representation to achieve an almost abstract quality. The 17 photographs on display, taken in India and Italy, reflect his enigmatic style. Andric seeks visual parallels between Indian and Venetian buildings, emphasizing reflections, colour, and shadows.
Ljubodrag Andric. Spazi, soglie, luci Fino 8 settembre Palazzo Cini, Campo San Vio, Dorsoduro 864 www.palazzocini.it

Un’interessante mostra, ospitata nel contesto iconico dell’Area Scarpa della Fondazione Querini Stampalia, racconta il progetto del Diriyah Art Futures, il primo hub del contemporaneo per l’arte digitale e i new media dell’Arabia Saudita progettato dallo studio internazionale di architettura Schiattarella Associati, specializzato in spazi pubblici per la cultura. Voluto dal Ministero per la Cultura saudita, inaugurato lo scorso novembre a Riad, questo centro per la ricerca, l’esposizione, la residenza di artisti internazionali, è parte di un ecosistema creativo in continua espansione nel quale arte e architettura contemporanee sono diventate strategiche sotto la spinta delle trasformazioni previste da Vision 2030.
La mostra, curata da Marta Francocci, si avvale di plastici, schizzi, video, disegni, fotografie, oggetti, materiali tradizionali di progettazione che offrono in maniera esaustiva la possibilità di approfondire il progetto e la sua visione architettonica. L’edificio costruito a nord della Capitale saudita, nella regione desertica del Mena, appare subito come un continuum con l’ambiente circostante. «Il deserto insegna a rinunciare a ogni aggettivo. Allora l’architettura diventa quasi naturale, percorribile da tutti, da chi conosce la città e da chi non la conosce» affermano i progettisti. I volumi dell’edificio sono d’oro, un’allusione all’architettura realizzata in pietra di Riad e alla terra, entrambe sensibili alla luce accecante e asciutta che proietta ombre potenti come volumi.
Il deserto diventa metafora di un’architettura capace di rinunciare, come il tradizionale modo di costruire saudita, a ciò che non è in grado di dialogare con
L’impronta leggera. Diriyah Art Futures / Schiattarella Associati Fino 24 agosto Area Scarpa, Fondazione Querini Stampalia www.schiattarella.com | www.dgda.gov.sa
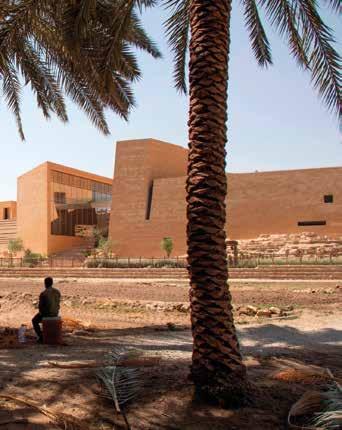
l’identità del luogo, con la sua storia stratificata.
La sabbia solidificata del deserto, il fango, il vento, l’ombra, tutto nel Diriyah Art Futures diventa materia contemporanea, fondendo la dimensione umana e quella digitale, il rigore della geometria con l’imprevedibilità della natura..
Per gli architetti Schiattarella, il dialogo è un tema cruciale. Se al centro dell’Area Scarpa è l’edificio a imporsi come protagonista, sulle pareti e nella saletta adiacente prevale la nebulosa delle idee che lo hanno generato: una lunga conversazione che sembra proseguire da sé, tra materia e luce, vuoti e pieni, memoria e futuro, ambienti costruiti e natura.
ENG An engaging exhibition presents the Diriyah Art Futures project, the first contemporary hub for digital art and new media in Saudi Arabia. Designed by international architecture firm Schiattarella Associati, the centre was commissioned by the Saudi Ministry of Culture and opened in Riyadh in November. It serves as a space for research, exhibitions, and artist residencies, part of a growing creative ecosystem driven by Vision 2030. Curated by Marta Francocci, the exhibition features models, sketches, videos, drawings, and materials that explore the project’s architectural vision. Built in the desert north of Riyadh, the structure blends with its surroundings. “The desert teaches us to strip away excess”, say the architects. The golden shapes echo Riyadh’s stone architecture and the land’s sensitivity to light and shadow. The building reflects a dialogue with place, history, and nature, where sand, mud, wind, and shadow become contemporary materials. The exhibition reveals a continuous conversation between form and idea, memory and future, matter and light.

I giardini orientali sono modelli a cui tutti si ispirano, frutto di tradizione, filosofia, lavoro e passione, in cui antico e contemporaneo si incontrano. La loro bellezza è frutto di un equilibro e di grande rispetto dove la natura dialoga con l’uomo fondendo estetica ed ecologia. Una mostra – da visitare, affrettatevi chiude il 13 luglio! – allo SMAC, Procuratie Vecchie in Piazza San Marco, For All That Breathes on Earth: Jung Youngsun and Collaborators, ci conduce attraverso il lavoro della principale architetta paesaggista coreana, ripercorrendo lo sviluppo della sua pratica dall’attivismo di base ad ambiziosi progetti statali come quelli per le Olimpiadi di Seoul e per l’Aeroporto Internazionale di Incheon. Una profonda connessione tra natura, architettura e resilienza umana è alla base dell’azione di Jung Youngsun, prima donna coreana a ottenere il titolo di ingegnere del territorio. Il suo lavoro, costruito sull’etica ecologica, sulla continuità culturale e sulla progettazione per le generazioni future, ha favorito una nuova sensibilità per la riabilitazione e la creazione di spazi verdi, sia in ambito urbano che in vari ambiti pubblici e privati, concentrandosi sulla progettazione non solo per la natura ma anche per le comunità.
«L’architettura del paesaggio – afferma Jung Youngsun – può essere una poesia scritta sulla terra e può risuonare profondamente». Jung, sostenitrice della resilienza ecologica e della biodiversità, ha integrato nei suoi progetti specie ed ecologie autoctone molto prima che queste pratiche diventassero standard. I suoi lavori danno priorità alla vitalità a lungo termine dei paesaggi attraverso strategie radicate nella sensibilità del luogo, nella conservazione degli habitat e nella relazione simbiotica tra sistemi naturali e vita urbana.
ENG Oriental gardens are models that inspire all. They are born of tradition, philosophy, labor, and passion. Their beauty lies in balance and deep respect, where nature and humanity engage in dialogue, blending aesthetics and ecology. An exhibition at SMAC, in Piazza San Marco, For All That Breathes on Earth: Jung Youngsun and Collaborators, guides us through the work of Korea’s leading landscape architect. It traces her journey from grassroots activism to major state projects like the Seoul Olympics and Incheon International Airport. Jung Youngsun, the first Korean woman to earn the title of land engineer, grounds her work in ecological ethics, cultural continuity, and future-focused design. Her projects promote green space rehabilitation in both urban and private contexts, designing not only for nature but for communities. “Landscape architecture” says Jung, “can be poetry written on the earth and resonate deeply”. A pioneer of ecological resilience and biodiversity, she integrated native species and ecosystems into her work long before it became standard, prioritizing long-term vitality through place-based strategies and symbiotic urban-natural systems.
“No Stone Unturned. Conceptual Photography”
Martí Guixé
“Q spot. Seat, read, think, repeat”
“Lions on the Field ”
Fondazione
5 may — 23 november 2025






L’architettura è dialogo, non silenzio No Doubt About It, piattaforma di discussione del contemporaneo
Una piattaforma-mostra per idee architettoniche intenzionalmente diverse, persino contraddittorie, cariche di innovazione e preoccupazioni ecologiche, individualismo e collaborazione, arte e pragmatismo e fondamentalmente libere da qualsiasi ideologia. Condividere, discutere e giustapporre idee distinte è l’obiettivo finale di No Doubt About It, a cura di Vladimir Belogolovsky. Nel Magazzino Gallery di Palazzo Contarini Polignac trovano espressione le strategie progettuali di sei progetti internazionali: teatri, due musei e un isolato residenziale.
Zaiga Gaile, studio Zaigas Gailes Birojs a Riga, specializzata nel restauro del patrimonio architettonico, offre la sua visione unica per lo storico Teatro Wagner, situato nel cuore della Capitale lettone. Dopo aver condotto una ricerca approfondita per far rivivere e recuperare il teatro storico, ha progettato accostamenti inediti di elementi autentici e contemporanei.
L’architetto berlinese Sergei Tchoban, Tchoban Voss Architekten, espone i suoi disegni a mano libera realizzati durante sessioni performative con professori e studenti della Waldorf School di Magdeburgo, in Germania, per il progetto di una nuova Festival Hall del campus. Il progetto comprende un auditorium con 543 posti a sedere e diverse sale multifunzionali. Il materiale da costruzione visibile sia sulle facciate interne che esterne è il legno. La geometria e la scelta dei materiali nell’auditorium garantiscono un’acustica ottimale. La coppia di architetti Zhang Yingfan e Bu Xiaojun dell’Atelier Alter Architects di Pechino racconta il progetto del Dali Transformer Park. «Stiamo trasformando una città in un teatro e un teatro in una città». L’elemento chiave del progetto è una fabbrica di trasformatori
abbandonata riconvertita in un teatro, fucina artistica multisensoriale e nuovo centro multimediale. Un collage di architettura vernacolare restaurata, ex strutture industriali riutilizzate e l’inserimento strategico di opere d’arte e curiosi manufatti industriali.
Robert Konieczny, fondatore di KWK PROMES a Katowice, in Polonia, ripensa in chiave paesaggistica il progetto completato quasi un decennio fa, del Przełomy Dialogue Centre a Stettino, un museo sotterraneo trasformato in un generoso spazio pubblico. La struttura, per metà edificio e per metà piazza, è costruita principalmente con un unico materiale, il cemento.
Nikoloz Lekveishvili di TIMM Architecture, con sede a Tbilisi, Georgia, integra il suo studio di un tradizionale balcone delle chiacchiere nel complesso residenziale di Metra Hills. L’architetto ha suggerito che un balcone, soglia spaziale tra interno ed esterno, solitudine e comunità, vita domestica e mondo urbano, potrebbe essere un palcoscenico teatrale. A Tbilisi, i balconi non sono semplici appendici degli edifici, ma estensioni essenziali di uno stile di vita locale. Fungono da stanze elevate, palcoscenici urbani e tradizionali, balconi del gossip dove l’architettura incontra il rituale, incorniciando azioni quotidiane come cenare, riposare, osservare, trascorrere il tempo, trasformandole in esperienze urbane condivise. Un motivo continuo e abitabile di balconi profondi avvolge l’intera struttura residenziale, sostituendo l’idea di una facciata fissa con un involucro vivo e dinamico.
Ashot e Armine Snkhchyan, co-fondatori dello studio snkh. di Yerevan, Armenia, sono impegnati nella trasformazione del Yerevan Modern Art Museum, edificio modernista sovietico degli anni ‘80. L’idea progettuale è preservarne il patrimonio, reinterpretandolo come un dinamico hub di arte contemporanea, inserito in un progetto che valorizza gli spazi pubblici circostanti, inclusi quelli sotterranei.
MAESTRI

di Mario Dal Co
Carlo Scarpa e l’Officina Zanon. I materiali del progetto, a cura di Maria Bonaiti e Marko Pogacnik, è il titolo del nuovo approfondimento dei Quaderni Iuav. Ricerche (Venezia, 2025) dedicato alla mostra in corso fino al 25 luglio alla Fondazione Masieri. La mostra espone lavori, progetti, documenti che testimoniano la collaborazione tra l’Architetto e l’Officina Zanon, uno tra «i principali artigiani con i quali Carlo Scarpa ha collaborato, tra i quali Angelo e Saverio Anfodillo (falegnameria), Eugenio De Luigi (decorazioni e dipinture), Luciano Zennaro (marmista), Luigi Pasinetti (tappezziere), ciascuno fonte preziosa di lezioni specifiche e di inediti dialoghi» (Maria Bonaiti). La mostra rappresenta il dialogo tra progettista ed esecutore, ma anche quello tra committente e artigiano: dialoghi ricchi di insegnamenti reciproci.
La fucina, non quella di Vulcano “ardua che fuma”, sprizza ancora scintille nello stridere dei metalli. Paolo e Francesco, i due fratelli Zanon, i titolari, tengono alta la bandiera del saper fare artigiano, di cui Venezia è stata ed è ancora patria e porto. Patria, ça va sans dire, porto perché negli anni recenti la città ospita artigiani provenienti dal mondo. Sono ancora una esigua minoranza, ma speriamo crescano di numero e qualità. Una politica lungimirante, sfuggendo ai campanilismi e curando gli interessi di lungo periodo delle tradizioni veneziane, incentiverebbe la loro presenza e la loro piena cittadinanza. Alla collaborazione con Carlo Scarpa sono dovute molte opere esposte nella mostra Carlo Scarpa e l’Officina Zanon. I materiali del progetto alla Palazzina Masieri o facilmente identificabili nei dettagli e nella realizzazione di luoghi divenuti iconici dell’architettura moderna e contemporanea: il Negozio Olivetti in Piazza San Marco, il Padiglione Centrale ai Giardini della Biennale, la Fondazione Querini Stampalia, il Museo Correr, la Gipsoteca di Possagno, Palazzo Abatellis e, sempre a Palermo, il contrastato e tormentato progetto di Palazzo Steri, sede dell’Università. Il Quaderno Iuav fornisce una ricostruzione puntuale e approfondita di queste vicende che marcano le indelebili, accurate e spesso minute collaborazioni tra Scarpa e l’Officina Zanon. Imperdibile e imprevedibile, quindi sempre sorprendente, il rapporto di scambio tra committente e artigiano è un processo di apprendimento reciproco, di cui la mostra della Fondazione Masieri è testimonianza viva. Si spiega chiaramente la differenza tra artigianato e industria, meglio di molte distinzioni scolastiche o amministrative: non è questione di tecnologia e neppure di complicazione nell’esecuzione del prodotto. La questione sta nella scala della produzione e nella natura del rischio. La produzione industriale raccoglie anonima-
mente le informazioni dal mercato finché giunge alla produzione di serie a cui l’utente deve adattarsi, potendo scegliere tra quale serie trova il prodotto più confacente al suo modello mentale. La differenza è insita poi nel rischio. Il processo di produzione in serie abbatte i rischi con la prototipazione e con le analisi di marketing dei prodotti concorrenti: alla fine il cliente compra un prodotto che non dovrebbe presentare rischi.
Nel rapporto con l’artigiano, invece, non ci sono prototipi e analisi di marketing in grado di ridurre i rischi: l’abilità dell’artigiano è l’unica assicurazione possibile. Sta al committente saperne trarre vantaggio riducendo i suoi rischi. L’artigiano raccoglie le informazioni direttamente dal committente; non solo, le fornisce egli stesso al committente sulla base del suo saper fare. Il committente, consapevole di parlare con un artigiano e non con un qualunque venditore, sa che deve ascoltarlo. Perché la qualità del prodotto finale, con i suoi limiti e le sue potenzialità, sono note solo a lui. Ma, al contempo, solo il cliente conosce dove e come il prodotto deve inserirsi in un dato contesto. È uno scambio di informazioni reciproco. Stranamente, sia detto tra parentesi dato che la rete è fatta di reciproca interazione, l’artigianato non ha ancora sviluppato strumenti e app in grado di valorizzare queste proprietà del suo modo di fare. Prova ne è l’esercizio assai complesso e curato, con interazione continua tra artigiani specialisti di manutenzione e di materiali, svolto di recente per il restauro del Negozio Olivetti di Piazza San Marco dal Fondo Ambiente Italiano, con il sostegno di Generali Real Estate, in collaborazione stretta con l’Officina Zanon. Interventi incredibili: solo per citarne uno, la porta di marmo del Negozio che ruota su cardini e supporti speciali e pesa 250 chili, così come, non da meno, quella della Fondazione Masieri.
La storia dell’Officina Zanon si intreccia strettamente con i progetti di Carlo Scarpa e di altri architetti che hanno sentito e seguito la sua strada. Ma non solo gli architetti, anche gli artigiani hanno approfitta-

to della “scuola” che Scarpa aveva avviato per chiunque lavorasse dentro ai suoi progetti. In quella scuola la tassa di iscrizione erano la cura e la dedizione, tratti essenziali per raggiungere un livello di eccellenza che ha consentito, per decenni, di esportare al seguito del Maestro il lavoro di decine di artigiani veneziani. Il loro saper fare è uscito da Venezia, muovendosi anche fuori dall’Italia. Quella scuola, come tutte le grandi scuole, vive nel rapporto del maestro con gli allievi: un dare e un ricevere. Lo ricorda Francesco Zanon nelle pagine del Quaderno Iuav: «Le nuove macchine gli facevano venire delle idee, delle curiosità. A Scarpa piaceva dialogare, parlare e anche noi lo ascoltavamo volentieri, qualsiasi cosa dicesse era una cosa interessante. Una volta è venuto in officina e avevamo un seghetto speciale che tagliava putrelle fino a 200 mm e tagliava anche a 45°, importante perché altrimenti bisognava tagliare con la fiamma ossidrica. L’anno dopo ha ricevuto l’incarico alla Biennale per il Padiglione Centrale e ha progettato un soppalco fatto tutto con queste putrelle realizzate con questa macchina». Altri interventi di manutenzione filologica sono stati fatti al Padiglione del Venezuela e alla Fondazione Querini Stampalia. Per dimostrare la vitalità dell’Officina, Francesco Zanon mi ha mostrato l’ultima sua opera; e qui Scarpa non c’entra più, almeno non direttamente. Nell’Officina hanno recuperato una serie di scarti di lavorazione in acciaio inox, pezzi fulgidi che ricordano i quadrilobi o quadrifogli delle finestre gotiche veneziane. Montati insieme in una sorta di croce mobile hanno dato luogo ad una scultura suggestiva. Suggerisco di chiamarla Croce dei Miracoli e magari di collocarla in quel gioiello dell’architettura rinascimentale veneziana che è Santa Maria dei Miracoli. Mi hanno spiegato che quella lavorazione dell’acciaio inox di grosso spessore è realizzata con macchine che tagliano il duro materiale con la sola pressione dell’acqua, con il livello di precisione e raffinatezza voluto. «Hai dovuto farle tagliare in terraferma?» ho chiesto attendendo una conferma scontata. «No – mi ha risposto Francesco Zanon – quelle macchine sono qui in una ditta specializzata a Cannaregio». Miracoli veneziani, ancora una volta. Gino ha lavorato in officina fino a 81 anni. I figli Paolo (classe 1938) e Francesco (classe 1942) tirano avanti. Non mancano i clienti, mancano i successori: «Una volta chiusa l’Officina non verrà più riaperta».

La Fondazione Alma Dal Co ETS, opera a livello internazionale per promuove giovani scienziati in ambiti interdisciplinari tra la biologia, la fisica, la computazione e sostiene giovani musicisti. Quest’anno, dal 29 settembre al 4 ottobre, promuove a Venezia:
ALMA DAL CO SCHOOL ON COLLECTIVE BEHAVIOUR
La Scuola ha un ampio spettro disciplinare che va dalla fisica alla biologia, all’analisi quantitativa e coinvolge 18 speakers con 36 giovani scienziati partecipanti, che danno vita a una settimana di lavoro con seminari, presentazioni e poster. La Scuola riflette lo spirito scientifico e la vitalità di Alma Dal Co, il suo impegno collaborativo nella scienza, il suo amore per Venezia, la sua formazione internazionale tra Padova, Torino, Zurigo, Harvard e Losanna.
La Scuola è diretta dai proff. Silvia De Monte, Flavio Seno e Simon van Vliet, con il sostegno scientifico delle Università di Padova e del Dipartimento di Astronomia e Fisica Galileo Galilei, dell’Università di Losanna e del Département de biologie computationnelle, dell’Istituto Veneto di Scienze Lettere ed Arti, che ospita da Scuola nello splendido Palazzo Franchetti in Campo S. Stefano e con il supporto dell’International Center for Theoretical Physics La Scuola è l’occasione per scoprire una Venezia viva, innovativa, aperta, grazie a occasioni di incontro con la città: la presentazione di European Cultural Center a Palazzo Bembo e la visita dei Giardini del Redentore restaurati e gestiti dalla Venice Gardens Foundation, fondata e presieduta da Adele Re Rebaudengo. Infine, la Scuola si apre al pubblico con due incontri sulla città e sul rapporto tra scienza e musica.
INCONTRI APERTI AL PUBBLICO
LETTURA SU VENEZIA
Venerdì 3 ottobre, h. 18
Palazzo Franchetti, Istituto Veneto di Scienze Lettere ed Arti, S. Marco 2847, Venezia, del prof. Francesco Musco, presidente del CORILA
SCIENZA E MUSICA
Sabato 4 ottobre, h. 17
Conservatorio Benedetto Marcello, Sala Concerti, San Marco, 2810, Venezia,
• Conversazione con il filosofo Massimo Cacciari, il musicologo Sandro Cappelletto, la neuroscienziata Daniela Perani, con un saluto del Cardinale Matteo Zuppi.
• Incontro-concerto con i dottorandi del Conservatorio di Venezia.
Alma Dal Co School on Collective Behaviour e gli incontri aperti al pubblico hanno ricevuto il contributo di: Allianz Bank Financial Advisors, Conservatorio Benedetto Marcello, Consorzio per il coordinamento delle ricerche inerenti al sistema lagunare di Venezia, European Cultural Centre, Fondazione Cariparo, Venice Gardens Foundation.
*Un ringraziamento a Luca Pilot del Laboratorio sperimentale per la didattica di Iuav per le immagini. almadalcofondazione.org




Hotel Londra Palace sorprende con The Place of Wonders
L’hotellerie a Venezia era un’arte, l’accoglienza dei viaggiatori dopo lunghi tragitti in mare era come un riparo avvolgente e seducente, un luogo che diventava un’isola. Nella Venezia del 2025 moltissimo è cambiato e l’offerta alberghiera è vastissima, tuttavia nella miriade di strutture piccole, medie e grandi, le eccellenze sono ascrivibili a poche decine di queste stesse strutture. Non stiamo parlando solo di stelle naturalmente, ma di “filosofia dell’accoglienza”, ossia ciò che rende unico un albergo e il soggiorno in esso, la sua storia, la sua identità, come nel tempo abbia saputo trasformarsi in chiave contemporanea, fondendo lusso, cultura e creatività sempre vivendo un fortissimo legame con la città e le sue radici più autentiche. Tra questo ristretto gruppo di autentiche eccellenze va annoverato senza se e senza ma l’Hotel Londra Palace, noto per la cura con cui connota stanze, lobby, ristorante, dove ogni dettaglio racchiude un’esperienza all’insegna della bellezza. Massima l’attenzione rivolta all’ospite che si traduce in un’offerta di servizi, attraverso un personale attentamente formato, elegantemente impeccabile e al contempo informale. In perfetto equilibrio tra modernità e tradizione, l’Hotel Londra Palace, assieme a The Place a Firenze e Borgo dei Conti Resort a Montepetriolo (Perugia), è di proprietà della famiglia Babini, attiva da svariati decenni nell’hotellerie di alto profilo. Le tre strutture, tutte di grande fascino e dalla spiccata personalità nonché perfettamente integrate sul territorio, sono protagoniste di The Place of Wonders, fondazione della famiglia Babini diretta da Michela Canzi Blanc impegnata a proteggere, preservare e promuovere la tradizione secolare dell’artigianato italiano. L’idea è di pensare all’ospitalità come a un legame, una passione, un’esperienza, una relazione con il luogo, la cultura, la storia, la tradizione e il carattere di una città, di un territorio. Questo sguardo ravvicinato si traduce materialmente non solo in esperienza esclusiva per il viaggiatore ospite, ma soprattutto in attenzione verso le specialità artigianali minori che in tempi di globalizzazione stanno soffrendo e in gran parte rischiano di sparire. The Place of Wonders trova le sue radici e la sua forza nella città stessa, in questo caso Venezia, dove recentemente sono stati presentati i risultati dell’iniziativa Mano a Mano, progetto creato in partnership con Venezia da Vivere, riscoprendo legami e valorizzando idee che possano raccontare al meglio l’identità di un luogo unico quale è la Serenissima. L’Hotel Londra riscrive così la narrazione di una città, oggi al centro delle cronache – rosa o nere che siano – quasi esclusivamente per l’overtourism che la sta soffocando al cospetto del quale si dimostra incapace di ricompattarsi guardando sistemicamente al futuro, presentando le piccole eccellenze artigianali rimaste in città e creando un network che punta a valorizzare il patrimonio culturale, incentivando materialmente il ricambio generazionale. Avvicinare i ragazzi a questi piccoli e affascinanti mondi rappresenta una preziosa occasione per offrire loro la possibilità di cimentarsi direttamente in questi antichissimi mestieri, sostenendo in tal modo la formazione di una nuova generazione di artisti della tradizione. Questo è l’obiettivo fondamentale
www.theplaceofwonders.org | www.londrapalace.com/it

del progetto: creare, promuovere, formare nuove figure professionali del miglior artigianato attraverso borse di studio della durata di un anno, a totale copertura dei costi dei nuovi corsi della durata totale di 120/220 ore con lezioni teoriche e pratiche in bottega. I Wonder, così giustamente definiti i maestri artigiani che continuano a salvaguardare e promuovere l’alto artigianato veneziano, protagonisti di Mano a Mano sono: Alessia Fuga, artista di perle di vetro, designer e insegnante di tecniche di lavorazione a lume, e Marisa Convento, artista nota per le sue creazioni con perle di Murano nonché una delle ultime impiraresse; Lunardelli Venezia, dal 1967 punto di riferimento in Laguna per la lavorazione del legno; Arzanart, laboratorio artistico che crea carta marmorizzata artigianale utilizzando la tradizionale tecnica veneziana risalente al XVII secolo; Saverio Pastor, uno degli ultimi maestri remèri, dedito alla creazione artigianale delle forcole e dei remi veneziani; Giuliana Longo, erede della Famiglia Longo che dal 1901 confeziona i tradizionali cappelli da gondoliere e creazioni su misura; Martina Vidal, che reinterpreta in chiave moderna la tradizione del merletto di Burano; Fonderia Valese, ultima rimasta nella Venezia insulare, che continua la tradizione della lavorazione dell’ottone e del bronzo; l’antica Tessitura Luigi Bevilacqua, che utilizzando antichi telai del XVIII secolo realizza velluti, lampassi, damaschi e rasi di raro splendore; Ramosalso, che rinnova e trasforma vecchi capi di abbigliamento provenienti da circuiti sociali o direttamente dall’armadio; Meracu, pelletteria artigianale di alta qualità. Una composita teoria di mestieri tenacemente resilienti a testimonianza dell’incredibile varietà e ricchezza delle produzioni artigiane ancora attive sul territorio lagunare. Questi straordinari artigiani più di tutti sentono la necessità di far rivivere la loro passione che negli anni è diventata vera e proprio arte fatta a mano.
I primi risultati degli studenti selezionati sono già tangibili grazie a una serie di oggetti realizzati durante il loro stage presso gli artigiani coinvolti e ora in mostra negli spazi della lobby dell’Hotel Londra. M.M.
«Con The Lens of Time si è voluto attraversare il Tempo, raccontare come l’occhiale sia stato, nei secoli, non solo oggetto funzionale ma anche simbolo, status, accessorio di moda, dispositivo medico, oggetto d’arte, testimone di evoluzioni tecnologiche, riflesso di bisogni sociali, culturali, estetici. E soprattutto, è stato ed è, identità. Quella dei territori, delle aziende, delle persone che lo creano e di quelle che lo indossano» (Lorraine Berton, Presidente di Anfao). È una clessidra verticale a forma di occhiali, l’originale logo che accompagna The Lens of Time, in corso fino al 30 luglio a Palazzo Flangini, nuova sede della Fondazione di Venezia, partnership insieme a Fondazione M9 – Museo del ‘900 di questa piccola, grande mostra-gioiello, ideata, realizzata e promossa grazie al sostegno di Anfao, Associazione Nazionale Fabbricanti Articoli Ottici e della Fondazione Museo dell’Occhiale di Pieve di Cadore. L’esposizione è incentrata sulla storia delle lenti, dalle sue origini nel XIII secolo fino alla contemporaneità, passando con disinvoltura, curiosità e competenza dalla storia alla moda, ricordando la nascita della prima fabbrica dell’occhialeria fondata nel 1878 a Calalzo di Cadore, fino alla rivoluzione industriale successiva, celebrando il made in Italy che si è fatto conoscere a livello internazionale. Centocinquanta pezzi iconici provengono da prestigiose raccolte private, oltre a quelle del Museo dell’Occhiale, la Collezione Famiglia Vascellari di Venezia e la Collezione Arte del Vedere del designer Lucio Stramare.
Dalle “lenti da lettura o d’ingrandimento” o lapides ad legendum medievali, in cristallo o vetro, derivano i “roidi da ogli” veneziani, citati alla voce “Cristalleri” dei Capitolari delle Arti veneziane (1284), due lenti convesse per correggere la presbiopia su montatura di cuoio, legno ed osso, tenute insieme da un perno o snodo, come nell’affresco che raffigura il cardinale Ugo di Provenza opera di Tommaso Da Modena (1352) e nell’“Occhiale a rivetto” ricostruito e portato da Sean Connery nel film Il nome della rosa Si passa poi alle lenti “ad arco”, rinascimentali, composte da ferro, rame, ottone, argento o avorio, arricchite da decorazioni e trafori, o agli “occhiali da berretta”, con un’asticella che si aggancia al copricapo.
Nel Settecento compaiono a Venezia lenti colorate di verde, per la presenza di ossido di ferro, per difendersi dal sole e dai riflessi sull’acqua, come quelle degli occhiali appartenuti alla famiglia del doge Alvise IV Mocenigo. Il modello detto “Goldoni” ha astine ad asola e protezioni laterali di seta. Nascono anche le bifocali, per vederci da lontano e vicino, e i “Fassamano”, che si svilupperanno ulteriormente nell’Ottocento e in tutta Europa, accessori per la nobiltà e borghesia, sia femminili che maschili, a manico lungo, a forma di forbice o a ciondolo, in metallo, tartaruga o argento, decorati con intarsi e pietre preziose. Le donne portano anche ventagli con integrati occhiali e binocoli da teatro, ciondoli in ottone e cristallo a forma di boccette di profumo, trasformabili in cannocchiali. La prima fabbrica italiana di occhiali in Cadore è visitata nel 1881



dalla Regina Margherita di Savoia: tre sono i fondatori, Angelo e Leone Frescura, Giovanni Lozza. Già nel 1885 si producevano 500 occhiali al giorno. Negli anni Venti e Trenta aprono fabbriche di occhiali quali Lozza e Safilo, che lavorano materie plastiche e la celluloide, l’alpacca, la galalite e la bachelite, per creare montature con colori e forme diverse, specie rotondeggianti. La ditta Ratti di Torino nel 1917 sperimenta le lenti affumicate per gli occhiali da aviatore, poi lenti da sole Persol nel 1938. ll cinema hollywoodiano dalla fine degli anni Quaranta influenza la produzione, con tendenze estrose, si pensi al modello “Cat eye” o a farfalla con ali aperte creato dall’artista Edward Melcarth, come gli occhiali portati da Peggy Guggenheim. Le montature sono d’alluminio, imitano la madreperla, presentano strass, dorature. Gli anni Sessanta o della “Dolce vita” vedono occhiali arrotondati o a cuore, ampliati maggiormente nelle loro dimensioni, bianchi o neri oppure optical nelle montature, talora con sfumature cangianti. Dagli anni Settanta in poi vige sempre più la sperimentazione (si scopre l’optyl, polimero sintetico ad alta resistenza) e si susseguono montature a mascherina, forme squadrate o arrotondate, “oversized”, colorazioni forti, impreziosite talora da


decorazioni e inserti vari. Oggi l’ultima tendenza è data dagli smart glasses, in cui il design va a braccetto con la tecnologia e quindi con la realtà aumentata, essendo dotati di micro display, sensori, fotocamere e connessioni wireless. I campi a cui si rivolgono sono molteplici: dal lifestyle al fitness, alla navigazione assistita e telemedicina. Occhiali progettati per l’inclusione, grazie all’intelligenza artificiale, che coniugano estetica e comfort, per ipovedenti o ipoacusici. Il visitatore di Lens of the Time, a cura di Daniela Zambelli ed Alessandra Cusinato, è guidato da una sintesi di oggetti, immagini e testi, ed ha la possibilità di vivere anche due esperienze virtuali, accostandosi al un totem interattivo “Timeless Frames”, ove può indossare virtualmente gli occhiali che hanno fatto la storia e condividerli tramite selfie, poi può visitare con l’ausilio di visori o QR code, per chi ancora non lo conosce, il Museo dell’Occhiale di Pieve di Cadore, che val bene una visita anche dal vivo.
L’artista Maurizio Paccagnella dà inoltre il suo contributo con Trasparenze, opera scultorea in acetato usato nelle montature odierne per gli occhiali, che si ispira nelle forme alle montagne del Cadore dove è nata l’Occhialeria italiana, omaggiando al contempo nel colore il ve-

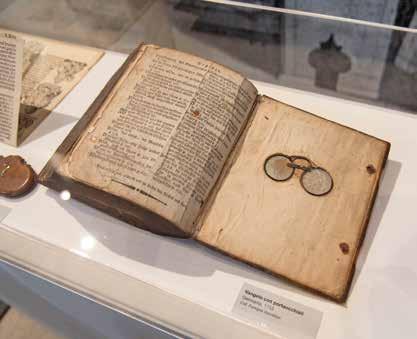
tro veneziano muranese impiegato nelle origini. La sua installazione Sguardo nel tempo, invece, “cristallizza gli sguardi e gli occhiali nel tempo” vertendo sugli occhiali donati da Stramare e racchiusi in una superficie fluida come la Laguna, che assurge a metaforica “porta” trasparente, con un effetto di sospensione nel vuoto di sguardi di vite di chi quegli occhiali, galleggianti in una dimensione spazio temporale invisibile ai più, li ha portati e vissuti sulla propria pelle. Originalità e creatività sono il motore e il collante di una mostra che celebra il passato e l’oggi attraverso la vista, organo sensoriale primario che è parte di noi come “stato” interiore ed esteriore. Chi disegna e produce un occhiale, compiendo anche un’operazione di tipo artistico, interpreta uno stile, aggiungendo al contempo qualcosa di sé. E chi sceglie un occhiale preciso, piuttosto che un altro, mostra inevitabilmente un lato del proprio sé, con cui è “in sintonia”, e che magari, non avrebbe il coraggio di mostrare o al contrario non vede l’ora di mostrare. L’occhiale è doppio, è destra e sinistra, vela e rivela. E se abbiamo inforcato con l’immaginazione gli occhiali di The Lens of the Time, ora ce li togliamo, uscendo, grati di averli indossati almeno per lo spazio della visita in mostra. Luisa Turchi
Carlo Ghega (1802–1860), veneziano di nascita e albanese di origine, ingegnere, architetto, inventore, amante delle arti, fu chiamato a Vienna per realizzare il progetto di collegamento ferroviario tra la capitale dell’Impero asburgico e il porto di Trieste. Riuscì in questa impresa titanica, ritenuta con i mezzi tecnologici del tempo quasi impossibile: viadotti, gallerie, ponti in un insieme di straordinario rispetto della natura compongono la prima ferrovia europea di alta montagna, il Semmering, oggi patrimonio UNESCO.
Tanto onorato in Austria, quanto dimenticato in Italia, Ghega è ora protagonista della mostra Carlo Ghega e il Semmering: una ferrovia per cambiare la storia, aperta il 25 giugno nel Palazzo dei Congressi di Tirana in Albania, curata da Lucia Nadin e Gjon Radovani. I materiali utilizzati nella mostra fanno riferimento al Fondo Carlo Ghega posseduto dal Museo Correr di Venezia su lascito testamentario dello stesso Ghega. È da questo Fondo che parte la nostra riscoperta di un genio. Buon viaggio (in treno, naturalmente)!
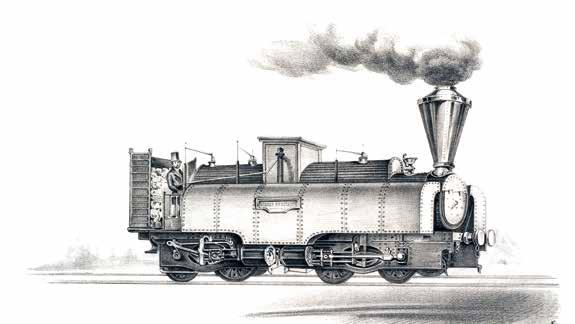

di Camillo Tonini *
* Il lascito di Carlo Ghega al Museo Correr: sorte di una collezione particolare – dal catalogo, anche disponibile online, della mostra Carlo Ghega e il Semmering. Una ferrovia per cambiare la storia, a cura di L. Nadin e Gjon Radovani, Tirana, Giugno 2025.
Il 14 marzo 1860 moriva a Vienna all’età di cinquantotto anni Carlo Ghega, o come amava essere chiamato Karl Ritter von Ghega, per il titolo di Cavaliere della Corona di Ferro, ricevuto dall’Imperatore nel 1851 all’apice dei suoi successi professionali. Una morte, causata da una “infezione polmonare” contratta per i lunghi periodi passati a seguire i lavori ferroviari da lui progettati, che lo colse ancora giovane nell’aspetto, quando oramai la sua brillante carriera sembrava essere irrimediabilmente compromessa. In quei giorni la notizia della sua morte non ebbe alcun eco a Venezia. Né alcun annuncio venne pubblicato dalla Gazzetta Uffiziale, il quotidiano controllato dalla censura asburgica, che nel pesante clima politico a ridosso dell’armistizio di Villafranca non voleva dare alcun pretesto a rivendicazioni indipendentistiche, né suscitare pericolosi sentimenti nazionalisti.
La notizia, però, non sfuggiva a Emanuele Antonio Cicogna, attento osservatore del suo tempo e della realtà veneziana, che alla data del 5 aprile nei suoi Diari, registrava la morte a Vienna di Ghega con un sunto delle sue volontà testamentarie a favore della città natale.
Ghega, pur nato a Venezia nel 1802 da famiglia di antica origine albanese, era a tutti gli effetti cittadino dell’Impero asburgico, che aveva servito con zelo e merito tanto da avere raccolto in vita molti riconoscimenti ufficiali al suo talento tecnico. Gli ultimi anni della sua vita furono, però, contrastati da invidie e maldicenze sul suo conto, anche perché l’orientamento finanziario dell’Impero era mutato, preferendo affidare a società private i lavori di ampliamento delle reti ferroviarie che a partire dalla capitale si irraggiavano verso i lontani territori dell’Impero e così, di fatto, relegando Ghega a un ruolo tecnico-amministrativo subalterno e di secondo piano.
La disaffezione verso la Corte asburgica e l’entourage viennese provocata da queste scelte, probabilmente indusse Ghega a redigere il proprio testamento a Vienna il 21 gennaio 1858 con l’intenzione determinata di destinare il proprio patrimonio esclusivamente alla sua città natale, ai familiari ancora li viventi, ai poveri che l’abitavano, al sostegno in favore di due “povere ragazze oneste che si maritano” e di un “giovane povero studente”, scelti tra quelli di San Pietro di Castello, sua parrocchia d’origine. Una parte della somma veniva anche devoluta ai restauri della Basilica di San Marco. Gli oggetti di casa di valore artistico e storico, le sue opere manoscritte e i libri della sua biblioteca, invece, erano destinati ai due istituti veneziani di cultura che fornivano le migliori garanzie perché questi materiali fossero al meglio conservati e valorizzati. Nulla del suo patrimonio artistico e culturale doveva dunque rimanere a Vienna, ma trasportato a Venezia a beneficio delle due realtà culturali prescelte: «Ben lontano da voler dare un pregio ai miei libri e manuscritti e stampe, ecc. desidero però che passino ad uno o più stabilimenti pubblici onde non siano distratti o venduti. A tal uopo lascio i miei libri e manuscritti tutti italiani e francesi e tedeschi in proprietà
della biblioteca di San Marco, come lascio le mie stampe d’incisione e litografie, i miei quadri col mio grande ritratto ad olio, li miei album, le mie medaglie compresavi una d’oro ed alcune d’argento, le mie monete antiche, i pietrificati e le mie decorazioni cavalleresche al museo Veneto denominato Museo Correr.»
Scelta che oggi non sarebbe del tutto condivisibile – libri e manoscritti alla Biblioteca Marciana, opere d’arte, manufatti storici, materiali iconografici, monete e medaglie al Museo Civico – perché così facendo si sarebbe rotta l’unità scientifica, culturale e documentale del suo fondo, ma comunque scelta lungimirante perché affidava a prestigiosi istituti culturali pubblici testimonianze importanti del suo tempo e consegnava loro la sua personale memoria.
La parte toccata al Museo Civico era composta di oggetti molto numerosi e vari tra loro, cosicché difficilmente avrebbero trovato collocazione nei locali dove allora risiedeva l’originaria sede di Casa Correr, in contrada San Zan Degolà. Venne comunque redatto un primo sommario inventario dal direttore del Museo, Vincenzo Lazari che per sua formazione, sensibilità e cultura museale, esperto numismatico, era indotto a privilegiare i materiali storici e artistici e trascurare quella parte del lascito di album e stampe sciolte, frutto della passione collezionistica del donatore che aveva raccolto brani illustrativi di ritratti di personaggi famosi e vedute e prospettive architettoniche di città.
Il nucleo, che per la sua specificità e unicità risultava essere il più singolare e interessante dell’intero fondo, era quello che documentava lo sviluppo delle comunicazioni ferroviarie nei territori dell’Impero asburgico e la descrizione grafica, oltre che tecnica, delle innovazioni nel tracciamento dei percorsi ferroviari e delle moderne macchine a vapore, che l’ingegnere aveva conosciuto nel suoi numerosi viaggi in Europa e in America.
Siamo a metà Ottocento, nel periodo di passaggio tra gli esiti dell’illustrazione litografica e l’avvento della fotografia. Ghega aveva sempre mostrato l’interesse per l’arte già coltivata con gli studi giovanili all’Accademia di Belle Arti di Venezia, dove tra il 1817 e il 1819 aveva frequentato i corsi di Ornato di Giuseppe Borsato e quelli di Architettura di Giannantonio Selva, e per la frequentazione di molti artisti a lui contemporanei legati alla tradizione dell’Accademia viennese e alla moda Biedermeier, allora in voga nella capitale dell’Impero.
A questi artisti – pittori, disegnatori, litografi – alcuni imprenditori dei titanici lavori ferroviari si erano rivolti per illustrare gli inusuali soggetti delle opere ingegneristiche nate dal genio di Ghega, testimonianze visive raccolte in album che esaltavano il valore progettuale di viadotti, tunnel, stazioni e percorsi ferroviari, sempre inseriti in ambientazioni ricche di particolari umani e paesaggistici. Egli stesso si era cimentato nelle elaborazioni grafiche di ambienti montani con la presenza delle nuove opere in costruzione, come risulta da una raccolta autografa di disegni in parte a grafite in parte colorate, pubblicata solo in occasione di questo studio, relativa alla costruzione del tracciato della ferrovia montana del Semmering. Questi disegni e i tanti album di litografie della sua collezione ci restituiscono i sistemi di ponteggi usati all’epoca per la costruzione di ponti, viadotti, terrapieni, contrafforti; descrivono le attrezzature per il recupero e il trasporto dei materiali, le tecniche per il traforo delle gallerie. I suoi disegnatori, i suoi incisori e litografi, oltre

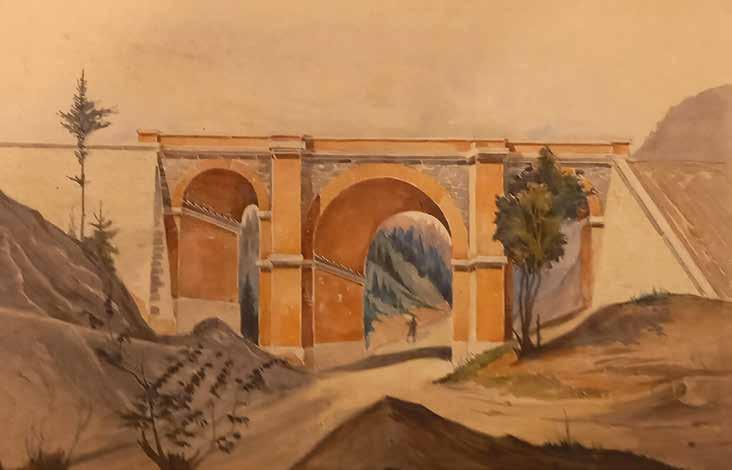

che a illustrare quei capi d’opera, erano anche chiamati a usare quella stessa attenzione che Ghega usava nel tracciare le sue linee ferroviarie nel rispetto dell’ambiente, con l’usare il linguaggio dell’arte per descrivere la vita dei cantieri, il lavoro degli operai, il contributo delle donne e dei bambini alla realizzazione di quelle grandi opere, a rappresentare le povere abitazioni raggruppate in piccoli villaggi provvisori cresciuti accanto ai quei luoghi di pesante e faticosa attività. Un inedito repertorio di memorie figurative che sembra anticipare la vicina stagione artistica del Realismo sociale. Ne sono esempi vivissimi, tra gli altri, l’album Malerischer Atlas des Eisenbahn über den Semmering (1854) di Ludwig Czerny, un sorprendente cosmorama in diciannove fogli uniti tra loro, che esaltava l’armonioso inserimento del tracciato ferroviario nel paesaggio montano, così come tanti altri album che vennero commissionati e finanziati in occasione dell’inaugurazione delle diverse tratte ferroviarie dagli imprenditori e costruttori che le avevano realizzate e che venivano offerte in dono alle maggiori autorità degli apparati politici, burocratici e tecnici dell’Impero. Non mancava nella sua collezione anche un album di fotografie come il Die grösseren bauwerke der Eisenbahn – Strecke, Trauerberg bis Loitsch, dono dell’imprenditore ingegnere Arcari, con immagini di undici viadotti della Ferrovia Meridionale, dove appare predominante nel nuovo linguaggio fotografico la messa a fuoco dei
manufatti su uno sfondo paesaggistico poco rilevante. Quando anche la figura umana è inserita, per ovvi limiti dell’allora mezzo tecnico, l’obiettivo inquadra persone in atteggiamenti poco naturali mentre in posa attendono i tempi lunghi dello scatto.
Quando l’intero lascito arrivò al Museo Civico veneziano, allora ancora nella casa di Teodoro Correr, pochi mesi dopo la morte di Ghega, fu inevitabile che la collezione venisse smembrata, perché troppo varia, non di particolare valore artistico, non patriottica, come richiedeva il clima politico per il culto del Risorgimento dopo l’annessione di Venezia all’Italia nel 1866. Benché nato a Venezia, e a questa avesse donato il suo intero patrimonio, non sembrava, inoltre, opportuno celebrare un personaggio che non rappresentava nessuna famiglia della vecchia e nuova nobiltà veneziana, che aveva profuso tanto zelo e ingegno al servizio di un Impero del quale la sua città d’origine per tanto tempo era stata suddita. Su Ghega e sul suo lascito da allora cadde l’oblio, nonostante una successiva donazione avrebbe potuto rinverdire la sua fama e gloria. Nel 1869, infatti, su iniziativa del Congresso delle Ferrovie Tedesche a Vienna e per merito dell’Associazione degli Ingegneri e Architetti di Vienna fu deciso di dedicargli un monumento posto all’apice del Semmering ideato in stile rinascimentale dell’eclettico
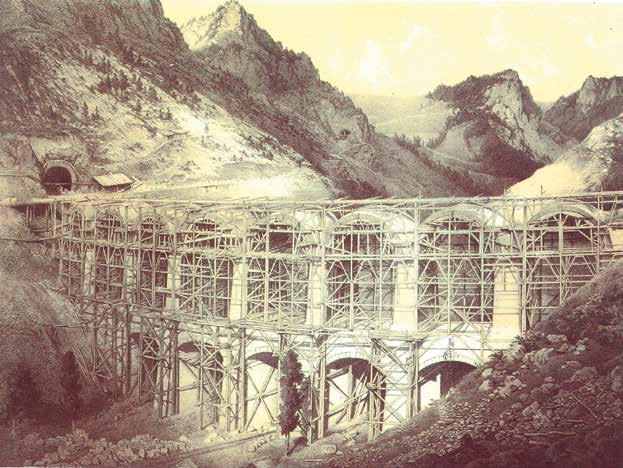
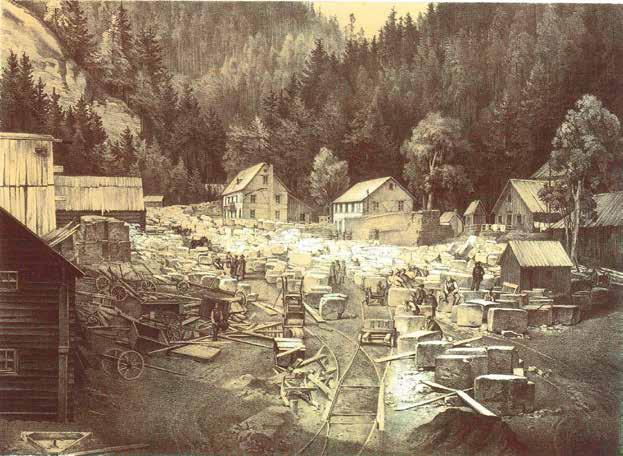

J. Bosch, Albun fotografico del Semmering (1854) © Fondazione Musei Civici di Venezia
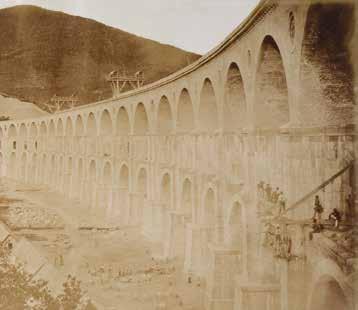
architetto Heinrich von Ferstel (Vienna, 1828 – Grinzing, 1870) e decorato nella parte centrale da un’edicola con al centro il tondo bronzeo del profilo di Carlo Ghega coronato di alloro, opera dello scultore Franz Pönninger.
La raccolta Ghega non trovò successivamente nemmeno nell’ampliato allestimento della nuova sede del Museo Civico al Fondaco dei Turchi una sua identità specifica, non le venne dedicata una sezione distinta e così le opere vennero smembrate, mescolate e ricomposte scegliendo il meglio dalle singole collezioni su tematiche specifiche o seguendo il mero e più semplice criterio ordinativo ed espositivo per “materie” – dipinti, disegni, bronzi, ceramiche, vetri, ecc. – che rifletteva inevitabilmente il principio di inventariazione degli oggetti

raggruppati per classi di appartenenza. E così pure alle Procuratie Nuove e nell’Ala Napoleonica, dove il Museo Correr trovò sede dal 1922, gli oggetti della collezione Ghega se vennero esposti, furono dispersi senza alcuna identificazione nell’affollato allestimento museale al primo piano.
Solo nel 1952, con tardivo riconoscimento, la Municipalità veneziana ricordava il lascito di Carlo Ghega in occasione dei 150 anni della sua nascita, mentre è nel 1954, a cent’anni dell’inaugurazione del tracciato del Semmering, che il 22 ottobre nella Sala dello Scrutinio di Palazzo Ducale venne tenuta una solenne commemorazione dell’ingegnere veneziano, presenti le maggiori autorità politiche, cittadine e del comparto dei trasporti internazionali tra l’Italia e l’Austria. Il programma
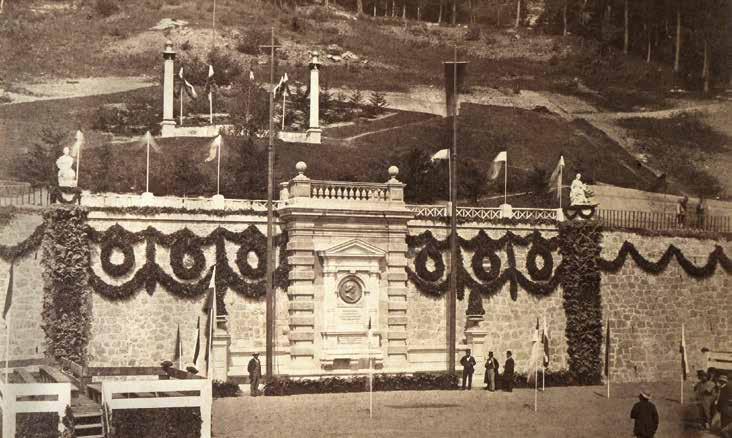
Inaugurazione del Monumento a Carlo Ghega al Semmering (1869) © Fondazione
di celebrazioni, che ebbe eco nella stampa locale, proseguiva con l’inaugurazione di una mostra allestita nella Sala delle Colonne a Ca’ Giustinian dedicata alle sue opere ingegneristiche, dove venne esposto parte del ricco materiale bibliografico, di stampe e foto relative alle realizzazioni delle strade ferrate progettate da Ghega. La mattina dopo, il 23 ottobre, in Fondamenta di San Gioacchino, al numero civico 452 del Sestiere di Castello, dove Ghega era nato nel 1802, venne scoperta una lapide che ricordava il suo nome e che inneggiava alla sua coraggiosa e innovativa impresa ferroviaria del Semmering. Il programma delle celebrazioni si completava il 12 novembre quando una delegazione italo-austriaca rendeva omaggio alla tomba monumentale dell’Ingegnere veneziano nel Zentralfriedhof di Vienna.
A partire dall’ultimo decennio del secolo passato è iniziata, e tuttora continua, una vasta campagna di catalogazione inventariale informatica dei beni della Fondazione Musei Civici di Venezia, disponibile in rete, che ha riguardato anche il Fondo Ghega. Ne è conseguito che alcuni dei materiali, finalmente segnalati alla comunità scientifica e di studiosi, sono stati presentati nella mostra Dalle Alpi all’Adriatico in ferrovia con la Meridionale (1857) e con la Transalpina (1906), che si è tenuta a Gorizia tra il 2007 e il 2008 con al centro la figura di Carlo Ghega. Il bel ritratto a olio di Ghega è stato esposto nella sezione dedicata all’ingegnere veneziano nella mostra Venezia che spera. L’unione all’Italia (1859-1866), allestita nel 2011 al Museo Correr, con il corredo di numerose stampe litografiche dagli album documentari delle costruzioni ferroviarie del quale Ghega era stato progettista. Nell’occasione è stata prodotta una prima versione catalografica, strumento essenziale per la conoscenza delle sue opere, che ora è stata revisionata e pubblicata nel catalogo della mostra che si è inaugurata a Tirana nel giugno 2025, Carlo Ghega e il Semmering: una ferrovia per cambiare la storia, che sarà ripresa anche in altre sedi europee dove rimane ancora viva la memoria dell’ingegnere veneziano.

Lapide sulla facciata della casa natale di Carlo Ghega, Fondamenta di San Gioacchino a Castello (1954) © Fondazione Musei Civici di Venezia
P. Del Negro, Ghega, Carlo, ad vocem in DBI, vol. 53, 2000
Dalle Alpi all’Adriatico in ferrovia con la Meridionale e con la Trasalpina, mostra e catalogo a cura di M. Bressan, Mariano del Friuli, 2007.
Venezia che spera. L’unione all’Italia (1859-1866), mostra e catalogo a cura di C. Crisafulli, F. Lugato. C. Tonini, Museo Correr, Venezia 2011 (pp. 73-75).
Carlo Ghega e il Semmering. Una ferrovia per cambiare la storia, mostra e catalogo a cura di L. Nadin e Gjon Radovani con la collaborazione scientifica di C. Tonini, Tirana, Giugno 2025.
Un maestro dell’obiettivo e la sacerdotessa del rock. Una coppia di artisti, amanti, amici, raffinati e instancabili esploratori del contemporaneo che hanno segnato la storia culturale del Novecento. Patti Smith e Robert Mapplethorpe sono due giovani ventenni quando si incontrano nel 1967 a New York, affamati di vita, esperienze, relazioni. Si riconoscono in un baleno come spiriti affini. Dopo una brevissima frequentazione decidono di andare a vivere insieme, prima vicino al Pratt Institute, poi al Chelsea Hotel di Manhattan, casa di metà pantheon del miglior rock in poesia di sempre, dando inizio a una relazione profonda e reciprocamente formativa. Frequentano i luoghi della controcultura, i ritrovi artistici più in voga del panorama newyorkese.
Vivono la Factory di Warhol, stringono rapporti con Gerard Malanga, Viva, Jackie Curtis, Danny Fields, Bob Dylan, Janis Joplin e Arthur C. Clarke. C’è fermento artistico e politico ovunque, la città nasconde locali che sono luoghi di esplorazione sessuale e sociale; ci sono profonde disuguaglianze nelle strade polverose di quella New York tra fine anni ‘60 e ‘70, città ribelle e trasgressiva, in piena trance creativa prima della tragica stagione dell’AIDS. È in questo clima ribollente, nel cuore di questa autentica rivoluzione culturale che Mapplethorpe sperimenta la sua libera espressione creativa, riscrivendo con il suo occhio geniale i codici della fotografia di ritratto e di nudo, mentre Patti, nel 1975, pubblica il suo primo album, Horses, immediatamente acclamato come uno degli album più influenti nella storia del rock, opera innovativa nella quale convivono suggestioni del primo punk e fraseggi di poeti, dalla beat generation a Rimbaud e Baudelaire. La copertina dell’album, scattata da Mapplethorpe, è senza discussioni una delle più iconiche di sempre. Patti dedicherà a lui e al loro sodalizio Just Kids, volume uscito nel 2010 che restituisce nei più intriganti dettagli la loro amicizia e relazione, dove la rockeuse newyorchese definisce il fotografo semplicemente come “l’artista della mia vita”.
Quando si dice, ebbene sì, un incontro seminale tra due
menti e corpi in febbrile movimento nell’epicentro assoluto dei linguaggi contemporanei. Quella NYC livida e fertile, tesissima e libera, dove davvero a ogni incrocio di Manhattan, in particolare tra il Village e Soho, il crossover più radicale e fervido nei suoni e nelle immagini, nelle arti performative e nelle mode urbane, dettava anarchicamente legge, ebbene, quella grande mela velenosa e irresistibile fa una certa impressione oggi trovarcela restituita qui, nel cuore della Serenissima, tra Piazza San Marco e l’Isola di San Giorgio. Smith in piazza per la sua unica data italiana del suo tour estivo, Mapplethorpe in isola per la sua straordinaria retrospettiva ospitata a Le Stanze della Fotografia. Mostra in cui la prima occupa una intera sezione con i ritratti di lei giovanissima scattati dal secondo a New York. Robert ritrae Patti in molti scatti androgini e sensuali, immagini iconiche e al contempo quotidiane, segnando in modo esplicito l’impatto che il suo poliedrico talento avrebbe avuto a livello estetico, di immagine, anche sulla musica, non solo sulla fotografia, divenendo uno dei maestri indiscussi della rivisitazione classica del corpo in chiave contemporanea. Il ritratto in bianco e nero di Patti Smith con il colletto rialzato, con lei che guarda direttamente nell’obiettivo, è diventato simbolo non solo della sua personalità carismatica e del suo stile unico, ma più estesamente l’immagine stringente di un’intera scena. Mapplethorpe, con il suo occhio attento ai dettagli e alla forma, ha saputo catturare la forza, la vulnerabilità e l’intensità di Patti, sia come artista che come persona. Le foto sono state scattate in vari momenti della loro vita, offrendo uno sguardo intimo sulla loro relazione e sull’evoluzione del loro lavoro.
Insomma, quando dire un’abbinata imperdibile è per una volta tutto fuorché retorica. Qui, a casa nostra. Cosa di meglio?
Robert Mapplethorpe. Le forme del classico Fino 6 gennaio 2026
Le Stanze della Fotografia, Isola di San Giorgio Maggiore www.lestanzedellafotografia.it

Amaster of the lens and the priestess of rock.
A pair of artists, friends, lovers, and refined explorers of modernity who shaped the cultural history of the 20th century. Patti Smith and Robert Mapplethorpe were two twenty-somethings when they met in 1967 in New York, hungry for life, experience, and connection. They instantly recognized each other as kindred spirits. After a brief romance, they decided to live together, first near Pratt Institute, then at the Chelsea Hotel, home to half the pantheon of poetic rock legends, beginning a deep, mutually formative relationship. They immersed themselves in the counterculture, frequenting the most vibrant artistic circles of New York. They lived the Warhol Factory scene, forming ties with Gerard Malanga, Viva, Jackie Curtis, Danny Fields, Bob Dylan, Janis Joplin, and Arthur C. Clarke. Artistic and political energy pulsed through the city, with underground venues serving as spaces of sexual and social exploration. Amid the gritty streets of late ’60s and ’70s New York – rebellious, transgressive, and creatively electrified before the tragic AIDS era
– Mapplethorpe found his voice, redefining portrait and nude photography with his visionary eye. In 1975, Patti released Horses, her debut album, hailed as one of most influential rock records, blending early punk with poetic echoes of the Beat Generation, Rimbaud, and Baudelaire. Its cover, shot by Mapplethorpe, remains one of the most iconic ever.
Patti would later dedicate Just Kids (2010) to their bond, a memoir rich in detail where she calls Mapplethorpe “the artist of my life”. A seminal meeting that now finds itself echoed here, in the heart of Venice, between Piazza San Marco and the Island of San Giorgio.
Smith performs her only Italian tour date in the Piazza, while Mapplethorpe is honoured with a major retrospective at Le Stanze della Fotografia. One section is entirely devoted to portraits of a young Patti, captured by Robert in androgynous, sensual, iconic yet intimate images. His black-and-white portrait of Patti with an upturned collar, staring directly into the lens, became a symbol of her charisma and style.


La Biennale Arte 2026 si intitolerà In Minor Keys, secondo il progetto curatoriale lasciato da Koyo Kouoh. Nata a Douala nel 1967, attiva tra Camerun e Svizzera, fondatrice del centro culturale RAW Material Company a Dakar (2008) e direttrice dello Zeitz MOCAA di Città del Capo dal 2019, Kouoh è stata la prima donna africana a essere chiamata alla direzione della Biennale Arte di Venezia. La sua improvvisa scomparsa, lo scorso 10 maggio, ha scosso profondamente il mondo dell’arte, che oggi si stringe attorno alla sua visione curatoriale. La Biennale ha infatti deciso di onorarne la memoria portando avanti la mostra esattamente come da lei concepita, con il pieno consenso della famiglia e del team che la stava affiancando: Gabe Beckhurst Feijoo, Marie Helene Pereira, Rasha Salti, Siddhartha Mitter e Rory Tsapayi. Kouoh aveva iniziato a lavorare al progetto nell’autunno del 2024, definendone nel dettaglio struttura, identità grafica, testi e spazi espositivi, e stabilendo collaborazioni fondamentali con artisti, studiosi e curatori. Il risultato è una partitura curatoriale che, come scrive lei stessa nel testo redatto per la Biennale e letto pubblicamente dai suoi collaboratori, «invita ad ascoltare i segnali persistenti della terra e della vita», sintonizzandosi sulle tonalità minori – quelle frequenze emotive, sensoriali e affettive che sfuggono alla frenesia dominante. In Minor Keys non è una litania di commenti, né un’esposizione estranea alle crisi contemporanee, ma una riconnessione radicale con l’habitat naturale dell’arte che privilegia l’incontro, la poesia e la riparazione. Kouoh parla di “ascoltare i minori”, ovvero le voci soffocate dalle
In Minor Keys di Koyo Kouoh
61. Esposizione Internazionale d’Arte della Biennale di Venezia
9 maggio-22 novembre 2026 Giardini, Arsenale, Venezia
narrative dominanti. Un messaggio potente, che guarda a pensatori come James Baldwin, Édouard Glissant, Patrick Chamoiseau, Toni Morrison e che riflette sulla stanchezza del mondo, sull’esigenza di ritrovare forme di resilienza e guarigione. La mostra si propone dunque come una lente obliqua per esplorare la condizione umana attraverso suoni, gesti e pratiche che si muovono a bassa voce: il blues, le danze nei cortili, i giardini creoli, gli spazi dell’arte intesi come oasi. Non una mostra “minore”, ma un’ode alla complessità, alla stratificazione culturale, alle forme dell’improvvisazione e dell’ascolto. Kouoh non propone una mostra che commenti il mondo, ma che ne attraversi i margini privilegiando il sensibile rispetto al concettuale, l’incontro rispetto alla narrazione, la poesia rispetto alla didattica. In questo orizzonte, gli artisti invitati – le cui pratiche saranno annunciate nei prossimi mesi – sono intesi come custodi di conoscenze radicali, capaci di generare bellezza e consapevolezza anche nel pieno della crisi. In Minor Keys si configura come un percorso multisensoriale, tra spazi meditativi e rituali in cui le opere saranno dislocate non solo ai Giardini e all’Arsenale, ma anche in luoghi diffusi della città. L’allestimento – fedele alla visione di Kouoh – porrà al centro relazioni, frammenti di vita e gesti minimi, attraverso i quali il visitatore sarà invitato a rallentare, ascoltare, meravigliarsi, restare. In un’epoca in cui la retorica della produttività e del progresso soffoca le forme più fragili e vitali dell’esistenza, In Minor Keys diventa un invito a praticare una resistenza sensibile all’accelerazione sistemica e al riemergere di ideologie espansionistiche. Un richiamo alla possibilità di abitare ancora spazi e linguaggi in cui si coltivano solidarietà, lentezza e meraviglia. Perché, come scriveva Toni Morrison, «bisogna avere l’amore e bisogna avere la magia – anche questa è vita». Marisa Santin

La Collection Pinault a Venezia ospita la prima grande mostra antologica in Italia dedicata a Tatiana Trouvé, curata da Caroline Bourgeois e James Lingwood, in stretta collaborazione con l’artista. La strana vita delle cose, titolo che suggerisce subito il concetto al centro dell’esposizione, è un’indagine poetica e materica su come gli oggetti, i luoghi e i ricordi possano assumere vita propria, caricandosi di storie, affetti e stratificazioni temporali. La mostra si snoda lungo i tre piani di Palazzo Grassi, trasformandolo in un organismo vivente dove scultura, disegno e installazione diventano strumenti di una narrazione frammentata e profonda, sospesa tra autobiografia e visione cosmica.
Al centro del lavoro di Trouvé c’è il rapporto tra il visibile e l’invisibile: i segni lasciati dal tempo e dalla memoria nei luoghi, la presenzaassenza delle persone, l’eco di un passato personale che si intreccia con quello collettivo. L’artista costruisce ambienti in cui si percepiscono lo scorrere del tempo e la fragilità delle cose, lavorando spesso per stratificazioni, accumuli e trasformazioni.
All’ingresso di Palazzo Grassi, l’installazione site-specific Hors-sol (2025) accoglie con un gesto di rottura: parte del pavimento in marmo è ricoperto da asfalto scuro, da cui emergono elementi stradali in bronzo, argento e oro. Ne nasce una mappa che connette città, corpi celesti e memorie sotterranee. Il visitatore, costretto a camminarci, entra fin dall’inizio in una dimensione spaesante: la mostra è un attraversamento, non pura contemplazione.
Tra le opere più emblematiche, la serie The Guardians, sculture
che raffigurano sedie abbandonate, modellate in bronzo o ottone, coperte da oggetti quotidiani come libri, scarpe o borse. Queste presenze silenziose, quasi reliquie di passaggi umani, sono ispirate all’esperienza personale dell’artista, che per anni ha lavorato come guardiana nei musei del Sud Italia. Seduta ore in attesa, Trouvé osservava gli spazi e immaginava storie invisibili. I suoi Guardians sono testimoni immobili, figure marginali e potenti allo stesso tempo: metafore di una sorveglianza interiore, di un ascolto silenzioso del mondo. L’uso del metallo conferisce a questi oggetti una solidità che contrasta con la loro funzione effimera, come se ogni sedia portasse con sé il peso di chi l’ha occupata e il vuoto di chi se n’è andato. Altro punto focale della mostra è Navigation Gate (2024), composta da rami di bronzo piegati che rielaborano antiche mappe di navigazione polinesiane. L’opera traccia rotte impossibili, onde e costellazioni che sembrano fluttuare nello spazio. Questa mappa simboleggia il tentativo di rappresentare l’intangibile, i viaggi interiori, le derive del pensiero e della memoria. L’opera dialoga con il contesto veneziano, città-isola sospesa tra acqua e cielo, ma anche con il senso più profondo della mostra: esplorare ciò che non si vede, ciò che rimane quando le cose smettono di funzionare come dovrebbero. La strana vita delle cose non si limita a mostrare opere, costruisce ambienti e paesaggi della mente. Tra riflessi, frammenti e segni, il visitatore è chiamato a un’esperienza sensoriale e intellettuale. In un’epoca di accelerazioni e smaterializzazioni, Trouvé ci invita a fermarci, ad ascoltare ciò che gli oggetti hanno da dire, a misurare il peso delle assenze. Palazzo Grassi diventa così una sorta di “mondo interiore in forma di museo”, dove ogni opera è archivio e traccia. Delphine

Figura imprescindibile dell’arte concettuale americana e spirito lucido e irriverente del secondo Novecento, John Baldessari continua a stupire e a stupirci. Nato nel 1931 a National City, in California, Baldessari ha scardinato i confini tra fotografia, pittura, scrittura e performance, costruendo un linguaggio ibrido dove ogni immagine diventa paradosso, e ogni opera una domanda sospesa.
Alla Fondazione Querini Stampalia la sua No Stone Unturned – Conceptual Photography (Nessuna pietra lasciata intatta) è già una dichiarazione di metodo: nulla sfugge all’indagine, tutto può essere rovesciato, persino il senso stesso dell’arte. Baldessari non cerca risposte, ma nuovi modi di formulare le domande. L’autorialità è una di queste. Nella celebre serie Commissioned Paintings del 1969, si fa fotografare mentre indica un oggetto a caso; poi affida l’immagine a un pittore, gli commissiona una copia e gliela fa firmare. Il risultato è un corto circuito perfettamente calcolato: chi è, davvero, l’autore dell’opera? L’artista o l’esecutore? L’idea o la mano che la dipinge? Il dipinto diviene performance e l’ironia è definire cosa sia davvero l’arte.
In mostra vengono esposte anche le Kissing Series, fotografie in cui oggetti apparentemente incongrui si “baciano” in accostamenti poetici e spiazzanti, e le Blasted Allegories, immagini televisive abbinate a parole arbitrarie, che destrutturano il rapporto tra segno e significato. Baldessari gioca con le convenzioni visive, le manomette con l’arma dell’ironia, e costruisce un mondo in cui l’immagine non documenta, ma provoca. È un filosofo dell’apparenza, un sofista del visibile che trasforma ogni opera in un rompicapo concettuale.
La fotografia è parte integrante della sua opera, è strumento e decostruzione dell’immagine, è una sfida alla percezione dell’immagine. «Non riuscivo a capire perché fotografia e arte dovessero avere storie separate», affermava con disarmante semplicità. E così ha deciso di sovvertire la distinzione, rendendo la fotografia uno strumento plastico, una materia da manipolare, scomporre, contaminare. Le sue opere sembrano nascere da un gesto semplice – un taglio, un collage, una parola – ma esplodono in riflessioni sul linguaggio, sulla percezione, sull’atto stesso del guardare. Visitabile fino all’autunno, la mostra offre un raro affaccio sul laboratorio di uno dei più acuti pensatori per immagini della contemporaneità. Un artista che ha insegnato, tra le altre cose, che ogni opera è anche un gioco, un enigma, un invito a dubitare. E che il senso, se esiste, non va mai cercato sotto la pietra: va sollevato, spostato, messo in discussione. Irene Machetti
A key figure in American conceptual art, John Baldessari (1931–2020) challenged the boundaries between photography, painting, writing, and performance. At Fondazione Querini Stampalia, exhibition No Stone Unturned – Conceptual Photography reflects his radical approach: nothing escapes scrutiny, and even the meaning of art is up for debate. In works like Commissioned Paintings (1969), Baldessari questions authorship by outsourcing painting based on random photos he staged. His Kissing Series and Blasted Allegories further disrupt visual conventions, pairing incongruous objects or images with arbitrary words to challenge meaning. For Baldessari, photography is not documentation but provocation – a tool to deconstruct perception. His art, often arising from simple gestures, brings about complex reflections on language and vision. The exhibition, open until November 23, offers a view into the mind of a visual philosopher who taught us that every piece of art is a puzzle and that meaning is always up for questioning.
John Baldessari. No Stone Unturned. Conceptual Photography Fino 23 novembre Fondazione Querini Stampalia www.querinistampalia.org
In un’estate che si preannuncia torrida, il corpo e la sua nudità occupano l’attenzione collettiva. Ed emerge il dilemma che un bellissimo dipinto ci pone in maniera diretta: ideale o reale? Verità o vanità? In un contemporaneo effimero e al contempo crudamente reale, la tavoletta in questione del 1490 di Giovanni Bellini, Allegoria della Verità o Vanitas, conservata alle Gallerie dell'Accademia di Venezia, tra le opere protagoniste della mostra Corpi moderni, in corso fino al 27 luglio, è un memento che invita a non lasciarsi ingannare dalla vanità delle cose terrene. Rappresenta un nudo femminile con lunghi capelli sciolti, in piedi su un alto piedistallo in marmo, che regge e indica uno specchio convesso sulla cui superficie è riflesso un volto maschile. Nessuno è perfetto, in termini anatomici, verrebbe da dire, tranne naturalmente quello splendido Uomo Vitruviano di Leonardo che indaga le proporzioni perfette, anch’esso eccezionalmente esposto nella mostra. Un uomo nudo, in due pose sovrapposte, inserito in un quadrato e un cerchio concentrici che ne esaltano le perfette proporzioni. Uno studio ideale, tuttavia realizzato da Leonardo sulla base di numerose misurazioni empiriche condotte sul corpo di giovani uomini in carne ed ossa. Dietro il corpo ideale, geometricamente perfetto, c’è il corpo empirico, misurato e indagato nella sua concretezza e variabilità naturale: materia viva appunto. «Il corpo umano è il più scontato, comune, forse il più banale dei soggetti – nell’arte italiana del Rinascimento, è quello di gran lunga più frequentato dagli artisti» afferma Francesca Borgo, curatrice della mostra Corpi moderni assieme a Guido Beltramini e Giulio Manieri Elia. «Bisogna catturarne la bellezza» scrive Durer, presente in mostra con alcune opere sublimi, prestiti eccezionali, «La bellezza del corpo va cercata nelle persone, tra la folla, nella moltitudine».
La bellezza del corpo, quindi, come raggiungerla? In mostra un manuale del 1561, I secreti de la signora Isabella Cortese..., un ricettario di bellezza del Rinascimento, che istruisce alle tecniche di cura e abbellimento del corpo attraverso la medicina, l’alchimia e la cosmesi. L’autrice, Isabella Cortese, rimane una figura enigmatica per cui non esistono evidenze biografiche, il nome “Cortese” anagramma di “segreto” riecheggia l’idea di un sapere di carattere scientifico, esoterico e oscuro, depositario di una tradizione antica resa finalmente accessibile.
Sempre in mostra, tra opere sublimi di Leonardo, Michelangelo, Dürer, Giorgione, Tiziano e molti altri, vestiti, accessori di cosmesi e cura del corpo testimoniano la necessità dell’uomo e della donna rinascimentali di aderire a standard e modelli sociali che si riflettessero nella loro raffigurazione. Tra i vari og-
Corpi moderni. La costruzione del corpo nella Venezia del Rinascimento. Leonardo, Michelangelo, Dürer, Giorgione
Fino 27 luglio Gallerie dell'Accademia www.gallerieaccademia.it

getti legati alla bellezza spicca un rarissimo scrigno del XVI secolo, una sorta di contemporanea e preziosa make-up box, col suo contenuto di specchi, profumi e oggetti della cura di sé, proveniente da una collezione privata. Pronti per la prova costume? Corpi moderni, che esplora un modo di pensare incredibilmente vicino al nostro tempo, indagando scienze, arti e i miti di oggi come di allora, potrebbe offrirvi la risposta su bellezza, invecchiamento, confini dell’umano, identità. M.M.
ENG In a summer where the body and nudity take centre stage, Corpi moderni at the Gallerie dell’Accademia in Venice explores the tension between the ideal and the real, between truth and vanity. At its heart is Giovanni Bellini’s Allegory of Truth or Vanitas (1490), a striking nude holding a convex mirror reflecting a male face – an invitation to question appearances. Nearby, Leonardo’s Vitruvian Man embodies perfect proportions, yet is based on real, measured bodies, reflecting the contrast between ideal geometry and living matter. Curated by Francesca Borgo, Guido Beltramini, and Giulio Manieri Elia, the exhibition features masterpieces by Leonardo, Michelangelo, Dürer, Giorgione, and Titian, alongside Renaissance-era make-up handbooks like Isabella Cortese’s 1561 Secreti, blending science, alchemy, and cosmetics. A rare 16th-century beauty case, filled with mirrors and perfumes, reflects the era’s aesthetic ideals. Using art, science, and myth, Corpi moderni explores enduring questions of beauty, aging, identity, and the human form – then and now.

L’irrompere della modernità Sartorio a Ca’ Pesaro, l’umanità in scena tra tenebre e luce
Un viaggio immersivo nell’immaginario simbolista di uno dei più raffinati interpreti del modernismo pittorico italiano: Giulio Aristide Sartorio. Il poema della vita umana a Ca’ Pesaro, fino al 28 settembre. Curata da Elisabetta Barisoni e Matteo Piccolo, la mostra riporta al pubblico, in tutto il suo vigore originario, un monumentale ciclo pittorico che per troppo tempo era rimasto nell’ombra, ora finalmente riallestito dopo un accurato restauro sostenuto da Chanel e Art Bonus.
Siamo nel 1906 quando Antonio Fradeletto, figura centrale della Biennale nascente, commissiona a Sartorio un’opera destinata a decorare il salone principale dell’Esposizione Internazionale d’Arte dell’anno successivo. Il progetto è ambizioso: raffigurare, attraverso la lente della mitologia, un Poema della vita umana che racconti l’intera parabola dell’esistenza. Sartorio risponde con una sequenza grandiosa: quattordici tele per un totale di 240 metri quadrati, realizzate in appena nove mesi con una tecnica rapida e innovativa a base di cera, acquaragia e olio di papavero. L’effetto è di una densità scenica vertiginosa. Il ciclo si articola in quattro grandi scene – La Luce, Le Tenebre, L’Amore, La Morte – inframmezzate da dieci teleri verticali in cui si alternano allegorie della Grazia, dell’Arte e della Forza virile. È una visione drammatica e dinamica della condizione umana, tesa tra nascita e dissoluzione. Al centro, il dualismo morale tra Eros e Himeros, amore buono e amore distruttivo, incarna una tensione tipicamente decadente. Non c’è quiete nella pittura di Sartorio: le figure ruotano, si accavallano, si moltiplicano in una spirale di corpi e simboli che richiama l’arte nordica e preannuncia il vortice astratto del moderno. I teleri delle Tenebre e della Morte spiccano per potenza visionaria, quasi che l’immagine si liberasse dalla narrazione per farsi pura forza espressiva. Dopo l’esposizione del 1907, il ciclo decorativo fu trasferito a Ca’ Pesaro grazie a un dono regale di Vittorio Emanuele III. Ora, per la
prima volta dopo oltre un secolo, è nuovamente visibile nella sua integrità, valorizzato da un allestimento che restituisce il carattere immersivo e scenografico dell’opera.
La mostra prosegue con un’ampia selezione di paesaggi e bozzetti che documentano l’altro volto di Sartorio, più intimo e meno esaltato, in netto contrasto con le atmosfere mitiche del Poema. Interessante anche il dialogo con autori del Simbolismo nordico e tedesco, tra cui spiccano interpreti di una spiritualità più esoterica e introversa. Un controcanto prezioso che arricchisce il contesto europeo dell’opera di Sartorio.
Il percorso si chiude con un coup de théâtre museale: l’apparizione della Giuditta II di Gustav Klimt, icona della Secessione viennese, che segna l’irrompere della modernità in Laguna. In questo dialogo finale tra Venezia, Vienna e Roma, tra decadenza e visione, la mostra suggella il suo intento: restituire al Simbolismo italiano la forza di un’epopea figurativa che merita di essere riletta, oltre ogni nostalgia. Irene Machetti
ENG
The Poem of Human Life at Ca’ Pesaro (open until September 28th) offers an immersive journey into the Symbolist vision of Giulio Aristide Sartorio, a master of Italian modernist painting. Curated by Elisabetta Barisoni and Matteo Piccolo, the exhibition restores and re-displays a 1907 monumental cycle of fourteen paintings – over 2500 square feet – originally created for the Venice Biennale. The art narrates human existence through mythological allegory and is divided into four scenes: Light, Darkness, Love, and Death, interspersed with vertical panels representing Grace, Art, and Strength. Sartorio’s dynamic, swirling figures evoke Nordic art and foreshadow modern abstraction. The show also includes landscapes and sketches revealing a more intimate side of the artist, alongside works by Northern Symbolists. It concludes with Klimt’s Judith II, an icon of Viennese Secession that links Venice, Vienna, and Rome in a powerful finale reclaiming Italian Symbolism as a vital, visionary movement.
Thomas Schütte, volumi in contrastato, vitale divenire
Genealogies. Al plurale, sì. Titolo migliore non poteva davvero esserci per restituire in maniera stringente e insieme aperta, libera, la cifra estetica della produzione artistica di Thomas Schütte, uno dei protagonisti indiscussi del contemporaneo a cui è dedicata questa potente, è proprio il caso di dirlo, a tratti vertiginosa, personale allestita dalla Fondazione Pinault a Punta della Dogana in questo 2025. Un’immersione dialettica tra generi, materie, linguaggi, poetiche che ci trascina in un vero magma incandescente, alle volte silente, altre assordante, in cui il fare arte è, come raramente accade così corporeamente, il mezzo per scavare nelle pieghe più intime e pulsanti della vita. Una successione di forme, di volumi, di dimensioni enormi così come minute, realizzati con materie difformi, che davvero ci restituiscono nel loro insieme in una resa a dir poco emozionante il corpus multiforme di questo straordinario artista tedesco. Sculture, spesso bicefale o a più teste, in vibrante tensione con lo spazio che le accoglie e con chi le osserva, accompagnate da una estesa teoria di disegni che rappresentano la parte in qualche modo segreta del suo lavoro. Disegni che raramente ha infatti esposto nella sua lunga carriera artistica, alcuni dei quali qui in mostra per la prima volta. Opere la gran parte in acquerello che il più delle volte dialogano e arricchiscono di valore e senso le piccole e grandi sculture che davvero sembrano essere state concepite ad hoc per i meravigliosi spazi reinventati sedici anni fa da Tadao Ando. Difficile esaurire le suggestioni che suscita e insieme i percorsi tangibili che dipana questa meravigliosa mostra negli spazi ristretti di un articolo. È perciò inevitabile circoscrivere, selezionare i tratti forse più salienti che qui emergono dal variegato baule espressivo di Schütte. Tra tutti ne sceglierei due: il tema dei generi; la fluidità del suo linguaggio espressivo, ben restituito dallo stato liquido degli elementi solidi delle sue composizioni plastiche. Niente di più opportuno a riguardo fare nostre le parole di Camille Morineau e Jean-Marie Gallais, curatrice e curatore dell’esposizione: «Vorremmo insistere qui su un aspetto sorprendentemente poco commentato del suo lavoro, ovvero il gioco sugli stereotipi di genere. Schütte si dichiara fortunato di non dover risolvere la questione del genere di alcune delle sue sculture, come nel caso dei Geister, quegli «spiriti» senza volto ma la cui gestualità in forma di pantomima anima lo spazio; o anche di alcuni animali ibridi che ritroviamo nei suoi acquerelli. In altre parole, è inevitabile constatare che il suo universo è polarizzato tra due generi, che tratta in modo diverso. Il maschile, la smorfia, l’arroganza del potere, l’opposizione netta ma assurda tra «bene e male». Il femminile, l’interiorità, l’umiltà degli occhi chiusi, la calma, a volte il pianto e l’emozione, il corpo in piedi ancorato alla terra, un’altra for-
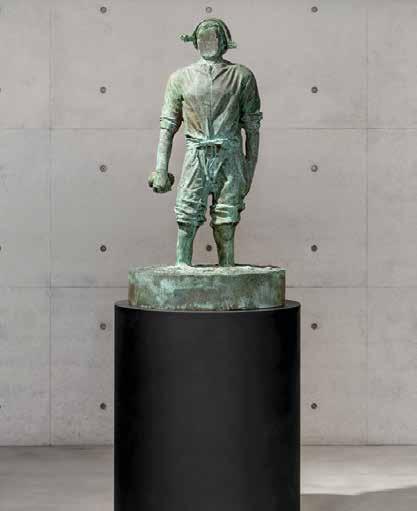
ma di autorità, dolce. La recentissima e monumentale Mutter Erde (Madre Terra, 2024) corrisponde peraltro al suo antecedente Vater Staat (Padre Stato, 2010), nel quale pensavamo di vedere riassunto il lavoro di Schütte. Così si costruisce in definitiva l’opera di colui che non ama interpretarne le evidenze: la natura e il calmo potere al femminile completano e sottolineano la netta differenza con lo Stato maschile, che paradossalmente si impone, con gli occhi spalancati, nelle sembianze di ingrandimento di una marionetta impacciata». Una visione, un approccio dicotomico mai troppo assertivo, sempre vissuto e restituito con una dialettica materica e insieme poetica di rara presa emotiva. E però il dato del contrasto, della frizione tra effettivi o apparenti opposti sembra davvero connotare costitutivamente il suo pensiero e, di conseguenza, le sue creazioni: «Oltre a costituire la rappresentazione di un archetipo, l’acqua evoca lo scorrere del tempo, considerato dallo stesso Schütte uno dei materiali della scultura, come accade in alcune installazioni di Robert Gober. È espressione di una fluidità – termine che, tuttavia, Schütte rifugge, preferendo opporgli la solidità dei materiali che durano nel tempo. È questo uno dei paradossi dello scultore tedesco, che perfino nei materiali più resistenti come l’acciaio o il bronzo, utilizzati a partire dagli inizi degli anni Novanta, riesce a trasmettere un senso di fluidità. Il rapporto che la sua pratica intrattiene con gli elementi non è estraneo a questo fatto: acqua, terra, fuoco e aria circolano permanentemente nei medium che impiega, essendo in gran parte sottoposti a cambiamenti di stato.»
Basterebbero (eccome!) queste due “sole” direzioni semantiche, insomma, per essere obbligati senza se e senza ma a visitare questa imperdibile mostra. Immaginatevi poi di trovarne almeno una decina di altre di queste direzioni… Beh, vedrete che la realtà surclasserà ogni preventiva forma di immaginazione. Provare per credere. Massimo Bran


Genealogies. Yes, in plural form. There could not be a more fitting title to capture the aesthetic essence of Thomas Schütte’s art. One of the undisputed protagonists of contemporary art, Schütte is the focus of this powerful, at times dizzying, solo exhibition presented by the Pinault Foundation at Punta della Dogana, an immersion across genres, materials, languages, and poetics, pulling us into a molten, incandescent core – sometimes silent, sometimes deafening – where artmaking becomes, in a rare and deeply physical way, a means of probing the most intimate and vital folds of life.
A succession of forms and volumes, both monumental and minute, crafted from diverse materials, collectively delivers an emotionally charged portrait of this extraordinary German artist’s diverse body of work. His sculptures are accompanied by an extensive series of drawings, a more private aspect of his practice, many of which are shown here for the first time. Mostly watercolours, these works enrich and deepen the meaning of the sculptures, which seem almost tailor-made for the stunning spaces reimagined by Tadao Ando sixteen years ago.
It’s difficult to exhaust the layers of meaning and the tangible paths this remarkable exhibition unfolds within the confines of a single article. One must inevitably narrow the focus and highlight a few of the most striking elements that emerge from Schütte’s expressive treasure chest. Two stand out: the theme of gender and the fluidity of his expressive language, conveyed through the liquid state of the solid elements in his sculptural compositions.
On this, the words of curators Camille Morineau and Jean-Marie Gallais are especially apt:
“We’d like to emphasize a surprisingly underdiscussed aspect of his work: the play on gender stereotypes. Schütte considers himself lucky not to have to resolve the gender of some of his sculptures, such as the Geister – faceless ‘spirits’ whose pantomime-like gestures animate the space – or the hybrid animals in his watercolours. His universe is polarized between two genders, which he treats differently: the masculine – grimaces, the arrogance of power, the stark yet absurd opposition of ‘good and evil’ and the feminine – interiority, the humility of closed eyes, calm, sometimes tears and emotion, the grounded body, another form of gentle authority. His recent monumental Mutter Erde (Mother Earth, 2024) complements Vater Staat (Father State, 2010), once thought to encapsulate his oeuvre. Nature and the calm power of the feminine complete and contrast with the masculine State, which paradoxically asserts itself with wide eyes in the form of an oversized, awkward puppet.”
This dichotomous vision – never overly assertive – is always expressed through a material and poetic dialectic of rare emotional impact. Yet contrast, the friction between real or apparent opposites, seems to fundamentally define his thinking and, by extension, his creations. These two semantic directions alone would be more than enough to justify a visit to this unmissable exhibition. Now imagine discovering ten more such threads… Reality will surpass even your most vivid expectations.
Commissionata da TBA21–Academy per gli spazi monumentali di Ocean Space nella ex Chiesa di San Lorenzo, otras montañas, las que andan sueltas bajo el agua invita il pubblico a interrogarsi sui concetti di percezione, potere e trasformazione. «L’Oceano è uno spazio comune per i processi emancipativi contemporanei della specie umana – processi che inevitabilmente si estendono alle forme di vita non umane. […] Se le strutture materiali e simboliche che abbiamo ereditato sono ancorate alle nozioni di binarietà e stabilità, la prospettiva oceanica offre una cornice alternativa per la formazione della vita attraverso il moto perpetuo» spiega la curatrice Yina Jiménez Suriel. La mostra presenta le commissioni inedite di Nadia Huggins (Trinidad e Tobago, 1984) e Tessa Mars (Haiti, 1985), narrazioni intrecciate – installazioni video e sonore site-specific, sculture e dipinti di grandi dimensioni – che offrono una via per attuare le trasformazioni più urgenti nei nostri modi di pensare, muoverci e sostenere la vita.

ALA EST
NADIA HUGGINS
A shipwreck is not a wreck (2025)
Nella sua installazione video – lo scheletro di un relitto, dove corpi, rocce e coralli sommersi evocano esperienze temporali profonde –Huggins esplora il potenziale dell’improvvisazione~freestyle come strumento per interagire con la percezione umana.
Quest’opera esperienziale invita a reimmaginare i confini artificiali costruiti attorno al tempo, alla percezione e al movimento. Sopra il livello del mare, il corpo umano è quasi sempre verticale – in piedi, seduto, in movimento – ma sott’acqua il galleggiamento modifica l’orientamento, creando la possibilità di nuovi modi di essere. Il suo lavoro fonde pratiche documentarie e concettuali, che esplorano l’ecologia, l’appartenenza, l’identità e la memoria.
ENG In her video installation (an underwater wreck’s skeleton where bodies, rocks, and corals evoke profound experiences of time) Huggins explores the potential of freestyle improvisation as a tool to engage human perception. This experiential work invites us to reimagine the artificial boundaries built around time, perception, and motion. Above sea level, the human body is almost always vertical: standing, sitting, walking. But underwater, buoyancy alters orientation, opening up new ways of being. Her practice merges documentary and conceptual approaches to explore ecology, belonging, identity, and memory.
Ocean Space
Chiesa di San Lorenzo, Castello 5069 www.ocean-space.org | www.tba21.org/academy

a call to the ocean
L’installazione pittorica immersiva di Mars presenta personaggi «risvegliati» che navigano uno spazio ibrido – le montagne nelle montagne – dove incarnano la fluidità dell’improvvisazione~freestyle. L’artista indaga la capacità degli organismi viventi di resistere ai continui cambiamenti della realtà. Lavorando principalmente con la pittura e il papier mâché, Mars mostra figure che sembrano immerse in un sonno profondo, in preda a mutamenti formali e strutturali che riconciliano le loro realtà corporee con il più ampio processo di moto perpetuo dell’Oceano. Attraverso la stratificazione, la texture e il suono, l’artista immagina l’improvvisazione come un processo ciclico che resiste alla cooptazione sfidando le strutture rigide del potere. ENG Mars’s immersive painted installation presents awakened figures navigating a hybrid space, mountains within mountains, where they embody the fluidity of freestyle improvisation. The artist investigates the ability of living organisms to endure changes. Working primarily with paint and paper-mâché, Mars depicts figures in deep slumber, undergoing formal and structural transformations that reconcile their bodily realities with the ocean’s broader perpetual motion. Through layering, texture, and sound, Mars imagines improvisation as a cyclical process that resists co-optation by challenging rigid power structures.
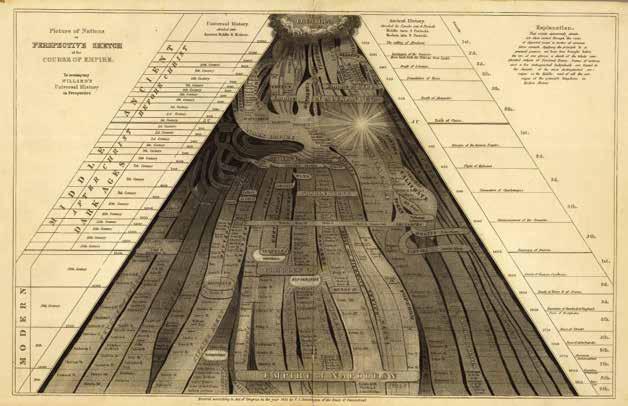
Fondazione Prada mette in scena a Ca’ Corner della Regina, sua sede veneziana, Diagrams, la nuova, straordinaria mostra organizzata dallo Studio AMO/OMA di Rem Koolhaas. E come sempre ci sorprende e ci costringe a riflettere. Non una semplice esposizione di grafici o modelli infatti, come il titolo potrebbe suggerire, ma un tentativo radicale di mostrare e dimostrare come i diagrammi non siano solo strumenti visuali, bensì dispositivi cognitivi, strumenti di potere, architetture della comprensione e talvolta della manipolazione. Oltre trecento oggetti distribuiti tra piano terra e primo piano raccontano, attraverso nove nuclei tematici, il ruolo che i diagrammi hanno avuto (e hanno) nel costruire la realtà: Ambiente costruito, Salute, Disuguaglianza, Migrazione, Ambiente naturale, Risorse, Guerra, Verità e Valore. Ogni sezione è ospitata in una teca parallela alle altre, in un percorso visivo e mentale che attraversa secoli e discipline, dallo studio anatomico alla strategia militare, dal flusso dei migranti alle economie dell’estrazione.
«Il diagramma è una forma durevole di comunicazione», afferma Koolhaas. «Spiega e persuade, a prescindere dal medium: dalla moda alla religione, tutto può essere trasformato in diagramma». E la mostra sembra dare corpo a questa intuizione, mostrando come il mondo intero possa essere disegnato, sezionato, ridotto a forma, senza perdere densità, ma guadagnando spesso in chiarezza. Ci si muove tra rappresentazioni geografiche e mappe energetiche, manoscritti medievali sull’arte della guerra e grafici di epidemiologia, passando per visualizzazioni incredibili del corpo umano e flussi demografici che raccontano migrazioni, esodi, espulsioni. Una delle sezioni più intense è proprio quella sulla migrazione, che espone non solo i movimenti, ma le ragioni sistemiche che li generano: guerra, economia, disuguaglianze, ecologia. Tutto è connesso, e lo si vede con precisione spietata.
Spicca, per valore storico e politico, la parte dedicata al lavoro del sociologo afroamericano W.E.B. Du Bois, che all’Esposizione Universale di Parigi del 1900 presentò una serie di infografiche sulla condizione dei Black Americans. I suoi grafici, potenti e sobri, trasformano numeri e dati in coscienza visiva, tracciando con eleganza le strutture dell’ingiustizia.
La sezione finale, dedicata alla guerra, ci ricorda con crudezza come anche la violenza possa essere ridotta a diagramma. Dalle strategie napoleoniche ai bombardamenti del Novecento, le mappe belliche ci mettono di fronte all’apparente neutralità della rappresentazione. Ma sotto la superficie, e Diagrams lo dimostra con lucidità, ogni scelta grafica è già un atto ideologico.
Più che una mostra, Diagrams è un trattato visivo. Non celebra la neutralità dei dati, ma ne espone la retorica, le derive e le possibilità. Un invito urgente a imparare a leggere, disinnescando i linguaggi invisibili che modellano la nostra comprensione del mondo.
Irene Machetti
ENG At Ca’ Corner della Regina in Venice, Fondazione Prada presents Diagrams, a groundbreaking exhibition curated by Rem Koolhaas’s AMO/OMA studio. Far from a simple display of charts, the show explores diagrams as cognitive tools, mechanisms of power, and frameworks for understanding – and sometimes manipulating – reality. Over 300 objects, arranged across nine thematic sections (from Health and Inequality to War and Value), illustrate how diagrams shape our perception of the world. Highlights include W.E.B. Du Bois’s pioneering infographics on Black American life and visualizations of migration driven by systemic forces. The exhibition culminates in a stark look at war, revealing how even violence can be diagrammed. Koolhaas asserts that diagrams transcend media, turning everything from fashion to religion into visual logic. Diagrams is not just an exhibition, it’s a visual manifesto urging us to decode the hidden languages that shape our world.
Intervista Zhang Zhaoying
di Mariachiara Marzari
Considerato una delle figure di spicco tra gli artisti della generazione post-1985, capace di reinterpretare con perizia espressiva unica l’evoluzione della pittura cinese dagli anni ‘90 a oggi, Zhang Zhaoying (Guangzhou, Cina, 1988) presenta a Venezia, al secondo piano del magnifico Museo di Palazzo Grimani, Lifelong Beauty, mostra personale curata da Lü Peng, Li Guohua e Carlotta Scarpa. Sebbene influenzato dal Rinascimento, dal modernismo europeo e dalle avanguardie, Zhang Zhaoying ha evitato di aderire rigidamente a schemi pittorici predefiniti creando una sintesi straordinaria tra la tecnica libera e la pittura controllata, esplorando le trasformazioni culturali del suo Paese e le nuove dinamiche sociali della globalizzazione per interrogarsi infine sulla bellezza e la verità universale. Lungo un percorso espositivo composto da 26 opere, l’artista decostruisce e ricostruisce iconografie tradizionali, intrecciando passato e presente, tradizione e innovazione, sviluppando una narrazione visiva che invita lo spettatore a un dialogo tra culture diverse. Una mentalità e linguaggio ibrido, che emerge potente dalle stesse parole dell’artista. Fino al 3 agosto, da non perdere.
Il primo impatto con le sue opere colpisce per la personalissima e straordinaria sintesi tra tecnica libera e pittura controllata. Come nasce la sua arte e come il tempo l’ha definita?
Il mio percorso artistico è iniziato con la pura curiosità e l’esplorazione del linguaggio visivo. Quando ho incontrato per la prima volta la pittura, sono stato profondamente attratto dalle tecniche realistiche della tradizione pittorica occidentale. Dal modellare luci e ombre su calchi di gesso allo studio dell’anatomia umana, la capacità di replicare con precisione la realtà attraverso il pennello è diventata la chiave che mi ha aperto le porte dell’arte. In seguito, movimenti come l’Espressionismo e il Surrealismo hanno completamente sconvolto la mia precedente concezione della pittura: linee, colori e forme potevano liberarsi dalla realtà e diventare espressioni indipendenti del subconscio e delle emozioni.
Il Tempo è il vero alchimista nel plasmare lo stile. Nei miei primi lavori, oscillavo tra realismo e astrazione, cercando di trovare un equilibrio: mantenere il controllo necessario per una rappresentazione accurata, consentendo al contempo la libertà di espressione emotiva. Man mano che la mia esperienza è cresciuta, ho iniziato a confrontarmi con temi più ampi – la cultura, la storia e la trasformazione sociale – che mi hanno portato a integrare le riflessioni sociologiche nella mia pratica artistica. Il mio stile attuale è il risultato di anni passati a decostruire e riorganizzare diversi linguaggi artistici. Ogni pennellata espressiva è sostenuta da una logica attentamente strutturata: ogni linea, ogni macchia di colore, è una risposta visiva alla complessità del mondo di oggi.
Zhang Zhaoying. Lifelong Beauty Fino 3 agosto Museo di Palazzo Grimani, Castello 4858 www.zhaoyingzhang.wordpress.com




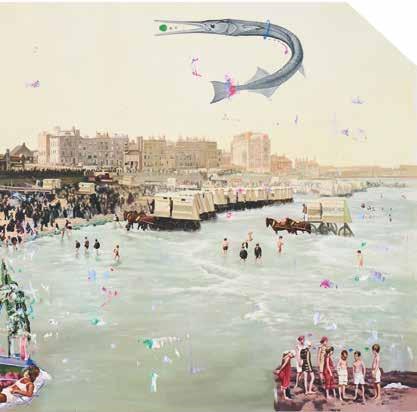
Considered one of the leading figures among artists of the post1985 generation, with a unique ability to reinterpret the evolution of Chinese painting from the 1990s to the present day, Zhang Zhaoying (Guangzhou, China, 1988) presents Lifelong Beauty in Venice, on the second floor of the magnificent Palazzo Grimani Museum. The solo exhibition is curated by Lü Peng, Li Guohua and Carlotta Scarpa. Although influenced by the Renaissance, European modernism, and the avant-gardes, Zhang Zhaoying staunchly refused to adhere to a given style or genre, rather choosing to create an extraordinary synthesis between free technique and controlled painting. Zhang explores the cultural transformations and new social dynamics of globalization to ultimately question universal beauty and truth. Along an exhibition path comprising 26 pieces, the artist deconstructs and reconstructs traditional iconographies, weaving together past and present, tradition and innovation, developing a visual narrative that invites the viewer to a dialogue between different cultures. A hybrid mindset and language, which emerges powerfully from the artist’s own words. Until 3 August, not to be missed.
The first impact with your works is striking for the highly personal and extraordinary synthesis of free technique and controlled painting. How did your art come about and how has time defined it?
My artistic journey began with a pure curiosity and exploration of visual language. When I first encountered painting, I was deeply drawn to the realistic techniques of the Western painting tradition. From shaping light and shadow on plaster casts to studying human anatomy, I found that precisely replicating reality through a brush opened the door to art for me. Later, movements such as Expressionism and Surrealism completely shattered my previous understanding of painting – lines, colors, and forms could break free from reality and become independent carriers of the subconscious and emotion.
Time is the true alchemist in shaping style. In my early work, I oscillated between realism and abstraction, trying to find a balance: maintaining the control necessary for accurate depictions while allowing the freedom of emotional expression. As my experience grew, I began to engage with broader themes – culture, history, and social transformation – which led me to integrate sociological reflections into my artistic practice. My current style is the result of years spent deconstructing and reorganizing different artistic languages. Every expressive brushstroke is underpinned by a carefully structured logic – each line, each patch of color, is a visual response to the complexity of the world today.
From the particular to the universal and vice versa. The subjects of his paintings explore the cultural transformations and new social dynamics of globalization. The works are deconstructed and reconstructed, interweaving past and present, layered and, despite their pop appearance, profound meanings. What is the underlying message of his iconic images? In the wave of globalization, each of us becomes a vessel of fragmented culture. The figures in my work are both an excavation of collective memory and a deconstruction of individual identity. For instance, I might collage traditional opera masks with
ZHANG ZHAOYING
LIFELONG BEAUTY
Dal particolare all’universale e viceversa. I soggetti dei suoi dipinti esplorano le trasformazioni culturali e le nuove dinamiche sociali della globalizzazione. Le opere vengono decostruite e ricostruite, intrecciando passato e presente, significati stratificati e, nonostante l’apparenza pop, profondi. Quale il messaggio sotteso alle sue immagini iconiche?
Sull’onda della globalizzazione, ognuno di noi diventa un contenitore di cultura frammentata. Le figure del mio lavoro sono sia uno scavo della memoria collettiva sia una decostruzione dell’identità individuale. Per esempio, potrei mettere in collage maschere d’opera tradizionali con elementi tecnologici moderni, o collocare manufatti storici in una metropoli illuminata al neon. Questi accostamenti apparentemente assurdi pongono una domanda più profonda: mentre i confini culturali si confondono, come possiamo mantenere la nostra unicità in questo scontro di molteplicità?
Il linguaggio visivo della cultura pop è lo “strumento di dialogo” che ho scelto. Cattura rapidamente l’attenzione dello spettatore, ma ciò che intendo veramente trasmettere è una cautela e una riflessione sull’omogeneizzazione culturale. I simboli stratificati del mio lavoro rendono omaggio al passato e offrono anche una visione del futuro: solo rispettando la complessità culturale e la differenza individuale possiamo trovare un’ancora spirituale nel torrente della globalizzazione.
Quale il ruolo assunto dal colore nella resa della narrazione visiva?
Il colore è il mio “traduttore emozionale”. Non solo crea l’atmosfera, ma trascende anche il linguaggio, colpendo direttamente il subconscio dell’osservatore. Nel mio lavoro, i colori brillanti e altamente saturi spesso contrastano nettamente con i toni scuri. Questo scontro rispecchia le contraddizioni e le tensioni della società contemporanea: la prosperità di superficie contro l’inquietudine interiore, il peso della tradizione contro la leggerezza della modernità, tutto si materializza attraverso il confronto e la fusione dei colori. Ad esempio, potrei delineare i simboli culturali tradizionali con toni fluorescenti, facendo rinascere le immagini antiche in una modernità stridente. Oppure avvolgo soggetti vivaci in sfondi grigi per suggerire che alcune cose care vengono inghiottite dalla nebbia del tempo. Non ci sono regole fisse per l’uso del colore: è sempre al servizio della narrazione. Spero che l’impatto visivo induca gli spettatori a sentire e riflettere sugli strati emotivi e intellettuali più profondi che si trovano sotto la superficie.
«Esponente della Nuova Generazione, ha saputo reinterpretare, con una perizia espressiva unica, l’evoluzione della pittura cinese dagli anni ‘90 a oggi, attraversando un periodo di grandi cambiamenti sociali, economici e culturali». Quale Paese emerge dalle sue opere? E a quale Cina si ispira?
Per me la Cina è come un vasto poema narrativo senza fine. Presenta capitoli pesanti, fondati su millenni di civiltà, ma anche passaggi sperimentali innescati dall’era delle riforme e dell’apertura. Il mio lavoro cerca di catturare questa “simbiosi contraddittoria”. Per esempio, troverete un drago meccanico dall’estetica steampunk intrecciato con gli Apsaras volanti di Dunhuang o codici QR in dialogo con le scritture in osso degli oracoli. Queste immagini sono allo stesso tempo metafore della rapida modernizzazione della Cina e tributi alla vitalità della cultura tradizionale.

La mia ispirazione scaturisce dalle scene quotidiane della vita ordinaria, dalle silenziose reliquie di bronzo nei musei e dall’estrosa creatività dei giovani nell’era digitale. Sono affascinato da quei momenti “indefiniti” all’interno della società cinese, dove tradizione e modernità si intersecano, ci sono sempre individui che creano nuovi paesaggi culturali a modo loro. La mia arte mette insieme questi frammenti in una favola visiva per i nostri tempi.
Essere a Venezia, e in particolare a Palazzo Grimani, straordinario esempio di architettura rinascimentale tosco-romana. Qual è il ruolo dell’arte occidentale nel suo percorso creativo?
Venezia è per me il luogo perfetto per un dialogo tra arte Orientale e Occidentale. Quando gli affreschi della cupola di Palazzo Grimani incontrano i simboli orientali del mio lavoro, si ha la sensazione di un collasso del tempo e dello spazio, un momento in cui risuona la saggezza di civiltà diverse.
L’arte occidentale mi ha influenzato non solo attraverso la tecnica, ma anche in termini di mentalità. La celebrazione rinascimentale dell’umanità, la tensione drammatica dell’arte barocca, la dissezione onirica del Surrealismo: tutto mi ha insegnato ad affrontare la creazione con una prospettiva più aperta.
Ma questa influenza si intreccia sempre con le mie radici culturali. Non ho mai cercato di imitare l’arte occidentale. La vedo invece come uno specchio che riflette il DNA estetico unico della cultura cinese. Per esempio, potrei usare le tecniche prospettiche della pittura a olio classica per costruire fantastici spazi di giardini cinesi, o applicare la logica del collage della Pop Art per riassemblare storie mitologiche cinesi. L’arte occidentale è sia uno strumento che un catalizzatore, che mi aiuta a scoprire continuamente nuove possibilità all’interno della tradizione attraverso l’attrito delle culture.

modern technological elements, or place historical artifacts in a neon-lit metropolis. These seemingly absurd juxtapositions ask a deeper question: as cultural boundaries blur, how can we maintain our uniqueness amid this clash of multiplicities?
Pop culture’s visual language is the “tool of dialogue” I choose. It grabs the viewer’s attention quickly, but what I truly aim to convey is a caution and reflection on cultural homogenization. The layered symbols in my work pay tribute to the past while also offering a vision of the future – only by respecting cultural complexity and individual difference can we find a spiritual anchor within the torrent of globalization.
What role does colour play in the rendering of visual narrative?
Color is my “emotional translator.” It not only sets the mood but also transcends language, striking directly at the viewer’s subconscious. In my work, bright, highly saturated colors often contrast sharply with dark tones. This clash mirrors the contradictions and tensions of contemporary society: surface prosperity vs. inner anxiety, the weight of tradition vs. the lightness of modernity – all materialize through the confrontation and fusion of color.
For example, I might outline traditional cultural symbols in fluorescent tones, allowing ancient imagery to be reborn in a jarring modernity. Or I’ll envelop vibrant subjects in gray-toned backgrounds to suggest that certain cherished things are being engulfed by the fog of time. There are no fixed rules for using color; it always serves the narrative. I hope the visual impact provokes viewers to feel and reflect on the deeper emotional and intellectual layers beneath the surface.
Tutto ciò che vediamo nasconde qualcos’altro; vogliamo sempre vedere ciò che è nascosto da ciò che vediamo
René Magritte
“As an exponent of the New Generation, he has been able to reinterpret the evolution of Chinese painting from the 1990s to the present day with a unique expressive skill, going through a period of great social, economic and cultural changes”. Which Country emerges from his works? And which China is he inspired by?
To me, China is like a vast, never-ending narrative poem. It has weighty chapters grounded in millennia of civilization, as well as experimental passages sparked by the reform and opening-up era. My work attempts to capture this “contradictory symbiosis.” For instance, you’ll find a steampunk mechanical dragon entwined with Dunhuang’s flying apsaras, or QR codes in dialogue with oracle bone script. These images are both metaphors for China’s rapid modernization and tributes to the vitality of traditional culture. My inspiration flows from the everyday scenes of ordinary life, the silent bronze relics in museums, and the whimsical creativity of young people in the digital age. I’m fascinated by those “undefined” moments within Chinese society – where tradition and modernity intersect, there are always individuals creating new cultural landscapes in their own ways. My art pieces these fragments together into a visual fable for our times.
Being in Venice, and in particular in Palazzo Grimani, an extraordinary example of Tuscan-Roman Renaissance architecture. What is the role of western art in your creative journey?
Venice, to me, is the perfect venue for a dialogue between Eastern and Western art. When the dome frescoes of Palazzo Grimani encounter the Eastern symbols in my work, it feels like a collapse of time and space, a moment where the wisdom of different civilizations resonates.
Western art has influenced me not just through technique, but in terms of mindset. The Renaissance’s celebration of humanity, the dramatic tension of Baroque art, the dreamlike dissection of Surrealism – all taught me to approach creation with a more open perspective.
But this influence is always interwoven with my own cultural roots. I never sought to imitate Western art. Instead, I see it as a mirror that reflects the unique aesthetic DNA of Chinese culture. For example, I might use the perspective techniques of classical oil painting to construct fantastical Chinese garden spaces, or apply Pop Art’s collage logic to reassemble Chinese mythological stories. Western art is both a tool and a catalyst, helping me continually discover new possibilities within tradition through the friction of cultures.

La nuova sede veneziana di Nicoletta Fiorucci Foundation è stata inaugurata il 7 maggio (e rimarrà aperta fino al 23 novembre) con la mostra To Love and Devour, installazione site-specific di Tolia Astakhishvili, curata da Hans Ulrich Obrist. L’artista georgiana ha abitato lo spazio a Dorsoduro 2829 nei primi mesi del 2025, trasformando radicalmente l’edificio quattrocentesco – un tempo studio del pittore Ettore Tito – con un intervento totale. La mostra ruota attorno alla metafora della “bocca che ama e divora”: un gesto intimo che scompone e ricompone la struttura architettonica. Muri smontati e ricostruiti, specchi, impianti e tubature svelati, spazi ridefiniti, un bagno ampliato e integrato nel percorso espositivo: la casa si trasforma in organismo vivente, diaframma pulsante tra interno ed esterno. Fotografie, disegni, scritte a mano, video e frammenti narrativi popolano stanze percorse da luce e ombra. «Tutti sanno che vivere significa accumulare cose», recita Astakhishvili nella performance inaugurale, evocando un universo di presenze invisibili e ricordi depositati. Il progetto coinvolge otto artisti invitati: Ketuta Alexi-Meskhishvili, Zurab Astakhishvili, Thea Djordjadze, Heike Gallmeier, Rafik Greiss, James Richards, Maka Sanadze e Dylan Peirce. Quest’ultimo è l’autore di Taste (snoring and the sound of pigeons): un pannello in cartongesso dove restano intrappolate posate d’argento, oggetti sospesi tra passato e possibilità.
L’intervento architettonico recupera elementi ottocenteschi e lascia emergere le tracce degli anni ‘70, come le tubature esposte del vecchio bagno: “interiora” che rendono l’edificio un corpo sezionato, fragile e rivelato.
To Love and Devour è un’esperienza sensoriale e concettuale, dove spazio e opera si confondono in un lento atto digestivo. Una casa che ama, inghiotte e restituisce. Delphine Trouillard
ENG The Nicoletta Fiorucci Foundation’s new space in Venice opened with To Love and Devour, a site-specific installation by Georgian artist Tolia Astakhishvili, curated by Hans Ulrich Obrist. The show transformed a fifteenth-century building into a living organism to explore themes of memory, transformation, and perception. Featuring works by eight artists, the exhibition blends architecture, performance, and visual art into a visceral, poetic experience. A sensorial, conceptual experience where art and space blend in a slow metabolizing process.

Una retrospettiva, una soglia. La mostra dedicata a Maria Helena Vieira da Silva ci chiede di attraversare un confine tra dentro e fuori, tra ordine e smarrimento. Circa settanta opere provenienti da prestigiose gallerie e realtà museali internazionali compongono un percorso attraverso le visioni di un’artista che ha fatto della pittura un labirinto percorribile, una geografia emotiva in cui orientarsi senza mai fissare una destinazione. La linea espositiva ripercorre la traiettoria creativa dell’artista dagli esordi degli anni ‘30 fino alla piena maturità degli anni ‘80, concentrandosi sul vivace panorama internazionale di Parigi, città dove Vieira da Silva si trasferisce giovanissima per completare la sua formazione. Nata a Lisbona nel 1908, è proprio nella capitale francese che l’artista affina la sua ricerca, sperimentando l’accostamento di frammenti di colore e dando forma a strutture che rimandano al gioco ipnotico degli azulejos portoghesi, tra geometria e poesia. Seguiranno gli anni dell’esilio a Rio de Janeiro durante la Seconda Guerra mondiale: quella di Vieira da Silva è una biografia di spostamenti e stratificazioni, che nei suoi quadri si traducono in tessiture di linee, fughe prospettiche, città che si deformano, piazze senza centro, mappe prive di punti cardinali. Ogni tela è una stanza che si apre su un’altra, ogni griglia un’illusione che innesca uno spaesamento: le sue architetture non sono mai statiche, ma corpi in movimento in cui tutto diventa anatomia viva dello spazio. In mostra anche l’ombra leggera del marito, il pittore Árpád Szenès, compagno di vita, di esilio e di visione. Ma è sempre lei, Maria Helena, a tenere il centro con la forza di chi vive l’arte come esercizio spirituale e tensione politi-
Maria Helena Vieira da Silva. Anatomia di uno spazio Fino 15 settembre Collezione Peggy Guggenheim www.guggenheim-venice.it

ca, una forza che non mancherà di affascinare Peggy Guggenheim. Nel 1943 la mecenate la include nella mostra Exhibition by 31 Women, tenutasi nella galleria newyorkese Art of This Century. Ma già prima, nel 1937, Hilla Rebay – prima direttrice del Museum of Non-Objective Painting, futuro Solomon R. Guggenheim Museum di New York – aveva acquistato uno dei suoi quadri più emblematici, Composition (1936), tutt’oggi nella collezione del museo americano. E oggi, a Venezia, tra le sale della Collezione Peggy Guggenheim, il visitatore è invitato a entrare nel ritmo segreto della sua pittura e a perdersi in quel silenzio fatto di colore e spazio. Perché è nella voce bassa delle sue opere che Vieira da Silva continua a raccontare. Marisa Santin
ENG A retrospective, a threshold: the exhibition dedicated to Maria Helena Vieira da Silva invites us to cross the boundary between order and disorientation, between architecture and intuition. Over seventy works, from major international institutions, trace the journey of an artist who transformed painting into an emotional geography, a maze with no fixed destination. Curated by Flavia Frigeri, the esposition follows her trajectory from the 1930s to the 1980s, focusing on Paris, where Vieira da Silva trained as a young woman. Born in Lisbon in 1908, she developed a personal style composed of textures, perspective shifts, and visual patterns that recall Portuguese azulejos. During her wartime exile in Rio de Janeiro, her painting became even more intense, a cartography of the soul. Today in Venice, at the Peggy Guggenheim Collection, visitors are invited into the quiet rhythm of her painting. Through the subtle interplay of color and space, Vieira da Silva’s narrative continues to unfold.

«Quando portano via i teleri, rimaniamo con due profonde lacune sull’altare?». Si deve essere chiesto qualcuno all’indomani della rimozione per restauro delle due grandi opere presbiteriali di Jacopo Tintoretto (Venezia, 1518-1594), l’Ultima Cena e Il Popolo d’Israele nel deserto, nel coro della Basilica di San Giorgio Maggiore. Ma la Comunità Benedettina non ha esitato un momento: «Lo occupiamo temporaneamente commissionando due nuove opere». E così è stato, oggi il coro è completato da due grandi dipinti dell’artista belga Luc Tuymans (1958) che, attraverso toni cromatici inconsueti, prospettive disorientanti e atmosfere surreali, offrono una narrazione senza storia, che nasconde il senso del divino nella quotidiana e ordinaria esperienza del fedele in viaggio tra cultura e spiritualità.
ENG Two altarpieces by Jacopo Tintoretto (1518–1594) have been temporarily removed from San Giorgio Maggiore Basilica to be restored. The Benedictine who ran the church didn’t want to leave two big hollow spaces by the altar, though, so they commissioned two new pieces of art. Belgian painter Luc Tuymans’ art hides the sense of the divine into the ordinary life of a travelling believer.
Luc Tuymans Fino 24 novembre Abbazia di San Giorgio Maggiore, Isola di San Giorgio Maggiore www.abbaziasangiorgio.it

Cosa ne penserà Banksy? Il suo Migrant Child lasciato sul muro di un palazzetto su Rio Novo (all’altezza di San Pantalon) è stato rimosso per restauro. Banca Ifis, che ha acquisito la proprietà per farne la sede della sua nuova Fondazione dedicata all’arte, ha deciso di inserire l’opera all’interno di un progetto più ampio di restauro che prevede il recupero dell’intero palazzetto. L’opera era certamente danneggiata dal tempo e dagli agenti atmosferici, tuttavia forse la sua caducità e l’inevitabile sbiadire erano effetti cercati dall’artista stesso per ricordare come la nostra memoria sia ormai di una durata temporale limitatissima. Parallelamente per Banksy il luogo dell’installazione del murale ha un senso profondo e fondamentale, quindi una rimozione permanente toglierebbe moltissimo all’impatto emotivo dell’opera. Segue dibattito. ENG What would Banksy think? His Migrant Child has been removed to be restored. The painting had already been damaged, though maybe the way it was supposed to decay so rapidly was what the artist had in mind all along… but anyway, the foundation that owns it and the building will take care of that. We can’t wait to hear the debate.
Banksy. Migrant Child Palazzetto San Pantalon www.bancaifis.it
Luce soffusa e velluto
Museo Fortuny, mezzo secolo di creatività, innovazione e storia
È un omaggio all’eclettismo che spazia oltre i confini delle arti quello che si respira al Museo Fortuny; varcarne la soglia è come aprire uno scrigno ricco di gioielli preziosi per immergersi in un’atmosfera di luci soffuse e velluti cangianti, che riportano al lontano Oriente e alla Belle Epoque, al Rinascimento fino al Settecento: casa-fabbrica nata tra le mura di Palazzo Pesaro Orfei, dove storia e modernità si incontrano intrecciando ricerca e slancio visionario, citazioni antiche e brevetti avveniristici di un Leonardo del Novecento. Prima nel sottotetto, poi, dopo l’acquisto dei piani sottostanti, per cinquant’anni fu abitato e vissuto in una straordinaria simbiosi sentimentale e artistica da Mariano Fortuny y Madrazo e da Henriette Negrin. Di Granada lui, di Fontainebleau lei, si sono conosciuti a Parigi nel 1902 e sposati nel 1924; grazie alla loro complicità e al loro intuito trasformarono il palazzo veneziano dalle inconfondibili polifore gotiche in un luogo vitale, moderna fucina di idee e di creatività, dove furono concepite e realizzate pagine memorabili di una vicenda imprenditoriale da cui nacque per la prima volta il marchio “made in Italy”. Lasciato nel 1956 in eredità al Comune di Venezia da Henriette, rimasta vedova nel 1949, con l’impegno che restasse centro propulsivo, laboratorio di cultura ed arti – come non ricordare qualche lustro prima la donazione di un’altra donna “illuminata” Felicita Bevilacqua La Masa che destinò il suo Palazzo Pesaro sul Canal Grande ai giovani artisti – ospitò l’Università Internazionale delle Arti fondata da Bepi Mazzariol e il Centro di documentazione fotografica. Dal 1975 aprì al pubblico, entrando dagli anni ‘90 come fiore all’occhiello nel circuito dei Musei Civici, che oggi, sotto la direzione di Elisabetta Barisoni, lo festeggiano celebrandone il mezzo secolo di storia attraverso convegni, concerti e documentari. Figlio d’arte, il padre, Mariano Fortuny da cui prese il nome, morì giovane, lasciandogli la passione per la pittura e per il collezionismo. Dopo un’infanzia parigina con la madre e il nonno, direttore del Museo del Prado, giunto diciottenne in Laguna si tuffò nello studio dei maestri del passato, approfondendone le tecniche pittoriche e copiando Tiziano, Tintoretto, Veronese e Tiepolo, ma coltivando contemporaneamente gli altri suoi interessi per il teatro, la musica e la fotografia. Curioso sperimentatore, interpretò perfettamente l’idea wagneriana di Gesamtkunstwerk, secondo cui le arti, in una compenetrazione totale, confluiscono e si completano nella bellezza; inventò un nuovo dispositivo scenografico, quella “Cupola” che consentiva una illuminazione indiretta a teatro, portandola in scena alla Scala nel 1922 con la rappresentazione del Parsifal. A documentarne i passaggi in esposizione il prezioso album Theatre lumiere che raccoglie appunti schede e disegni che illustrano le sue avanguardistiche innovazioni nell’ambito scenografico e illuminotecnico. Memoria visiva dei suoi brevetti nel campo dei tessuti le innovative stampe su stoffa di velluto di seta con disegni che sembravano usciti dai teleri del Carpaccio e dalle lontane tradizioni copte o moresche; tutto questo reso possibile risalendo alle fonti attraverso foto, do-
Museo Fortuny 50
Campo San Beneto, San Marco 3958 fortuny.visitmuve.it
Nella soffitta di Palazzo Orfei, in cui lavoravo, una lama di sole tagliava nettamente il pavimento. Nel disporre la carta, questa mi cadde proprio nella zona illuminata dal sole. Ristetti sorpreso.
La luce che rimbalzò intorno dal foglio illuminato, nella soffitta bassa e cupa, era la luce che cercavo: non luce diretta, ma riflessa
Mariano Fortuny
cumenti o tessuti originali. Mariano si cimentò anche con la creazione di pigmenti i cui segreti gli vennero invidiati da Sargent, Klimt, Bonnard. Realizzò i costumi per l’Otello rappresentato nel cortile di Palazzo Ducale nel 1933. Presenziò alle Biennali dal 1922 al 1942, esponendovi o in qualità di commissario per il Padiglione spagnolo. Quel Palazzo affacciato su Campo San Beneto fu trasformato dalla coppia in un laboratorio con oltre cento lavoranti al terzo piano e punto d’incontro al piano nobile dell’intellighenzia veneziana e internazionale, dimora accogliente per poter dipingere a cavalletto, consentendo a Mariano di esprimersi in quella che considerava la sua vera passione.
Scivolando oggi tra le sue stanze, al piano nobile, inevitabile l’omaggio ad Henriette, di cui ricorrono tra l’altro i 60 anni dalla morte, artefice e musa ispiratrice della gestione dell’atelier tessile, dal cui intuito nacquero il Delphos in seta plissettata, semplice ed essenziale come il chitone dell’Auriga di Delfi, o il Peplos, abiti iconici che Isadora Duncan, Sarah Bernhardt, Eleonora Duse, la Marchesa Casati, fino a Geraldine Chaplin e Barbra Streisand, fecero a gara per indossare e che ancora oggi sembrano sfilare in una passerella senza tempo che ne suggerisce i fruscii. Dopo l’itinerario tra i tesori della biblioteca privata, una sorta di Wunderkammer di oggetti preziosi: incisioni di Rembrandt, Tiepolo e Goya, volumi rari di Vitruvio, Scamozzi e Serlio. Impossibilepoi non essere avvolti dal “Giardino d’inverno” iniziato nel 1915 e terminato negli anni ‘40, un ciclo parietale di 140 metri quadrati a trompe-l’oeil in un tripudio di colori a tempera su carta incollata su teli di canapa fissati alle pareti, che coprono tre lati della stanza; un giardino incantato e luminoso popolato di figure allegoriche, satiri e animali esotici, tra festoni di fiori e frutta all’interno di logge corinzie veronesiane. Mentre il modellino del “Teatro delle Feste”, nato dalla collaborazione con l’amico Gabriele D’Annunzio, testimonia il loro sodalizio documentato dal carteggio e dal reciproco scambio di lettere.
Mariano come uno straordinario Aladino, che riesce a far uscire dalla sua lampada ad ogni evento, nuovi, inattesi tesori, in un dialogo tra il suo e il nostro tempo. Michela Luce

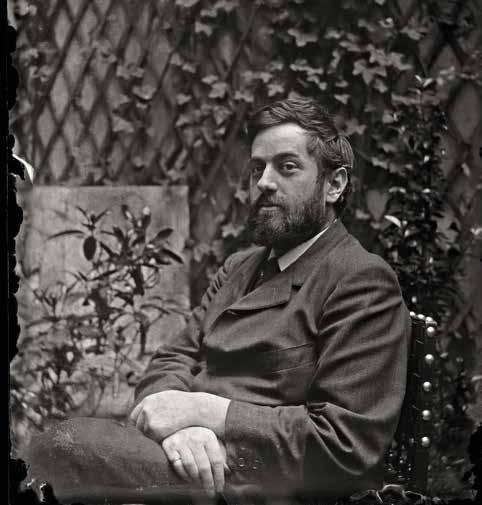
An homage to eclecticism: the exhibition at Museo Fortuny is a treasure trove of precious, soft velour that will take you to the Orient, to the Belle Epoque, and further into the eighteenth century. A combination house and factory built at Palazzo Pesaro Orfei where history and modernity meet and blend. For over fifty years, Mariano Fortuny y Madrazo and Henriette Negrin lived here. The two met in Paris in 1902 before moving to Venice and turning this palazzo into a vital place of ideas and creativity. Henriette bequeathed the mansion to the City of Venice in 1956 under the condition that the workshop would be kept intact. In 1975, it opened to the public in museum form.
Mariano Fortuny first came to Venice in his late teens to learn painting. He copied Titian, Tintoretto, Veronese, and Tiepolo, though he was also interested in theatre, music, and photography. An experimenter, he embraced the Wagnerian ideal of Gesamtkunstwerk, or total work of art, and invented a dome-based lighting system for theatres, which was first used publicly in Milan in 1922 for a Parsifal show.
The visual memory of his patented fabrics and innovative fabric printing technology are held in photographs, documents, and the original fabrics themselves. Mariano also concocted pigment mixes, which Sargent, Klimt, Bonnard envied. He also made costumes for an Othello produced in Venice in 1933 and participated in the 1922 and 1942 Biennales. At its peak, Palazzo Fortuny housed over 100 workers. In its main halls, we will see his homage to his wife Henriette, his long-time muse and collaborator. Her intuition brought us the Delphos in pleated silk and the iconic Peplos worn by Isadora Duncan, Sarah Bernhardt, Eleonora Duse, marchioness Casati, Geraldine Chaplin, and Barbra Streisand.
The visit goes on through the library room, itself a Wunderkammer of precious items: engravings by Rembrandt, Tiepolo, and Goya, rare Vitruvius, Scamozzi, and Serlio volumes. You will be fascinated by the ‘winter garden’ started in 1915 and finished in the 1940s: a cycle of trompe-l’oeil mural painting on wallpaper that cover three sides of a room for a total of 1500 square feet. An enchanting, luminous garden populated by allegorical characters, satyrs, and exotic animals. Fortuny created the ‘party theatre’ model with contemporary Italian author Gabriele D’Annunzio, a testament to their friendship together with their correspondence.
Like the mythical Aladdin, Mariano Fortuny took out of his magical lamp the finest treasures of beautiful art.

Il porto di Le Havre fu uno degli obiettivi fondamentali per il successo dello sbarco in Normandia. Nel settembre del 1944 gli Alleati attaccarono pesantemente la cittadina affacciata sul canale della Manica con bombardamenti aerei, navali e da terra per liberarla dall’occupazione tedesca al fine di garantire, attraverso il porto, l’accesso dei rifornimenti per le armate sbarcate. Fu l’Astonia, l’operazione militare che rase al suolo il centro storico della città causando decine di migliaia di vittime, tra morti e sfollati. Eppure, in un disastro di tali proporzioni, l’arte fece il suo miracolo. La maggior parte dei capolavori custoditi al MuMa – Museo d’Arte Moderna André Malraux di Le Havre sopravvissero ai bombardamenti e, assieme al Museo che li custodisce, divennero successivamente il perno simbolico della rinascita e della ricostruzione della città, guidata dall’architetto Auguste Perret. Oggi, nell’ottantesimo anniversario della Seconda Guerra mondiale, è proprio l’immagine dell’arte che resiste alla forza distruttrice della guerra e diventa memoria condivisa che l’M9 – Museo del ‘900 celebra con la mostra temporanea Arte salvata. Capolavori oltre la guerra dal MuMa di Le Havre, visitabile fino al 31 agosto. L’esposizione rappresenta un nuovo capitolo delle collaborazioni internazionali di M9, mettendo in mostra 51 opere provenienti dal prestigioso Museo di Le Havre, che ospita una delle più importanti collezioni di dipinti impressionisti di Francia. Curata dalla direttrice Géraldine Lefebvre e da Marianne Mathieu, una delle maggiori esperte mondiali di Impressionismo e Postimpressionismo, Arte salvata esprime l’intento di raccontare una storia di rinascita. Non solo quella di Le Havre, ma anche quella di Mestre e Porto Marghera, che subirono danni ingenti durante il conflitto bellico. Le opere esposte celebrano la passione di una comunità che ha contribuito alla visione di artisti locali e internazionali, come Eugène Boudin e del suo allievo Claude Monet, Pierre-Auguste Renoir, Alfred Sisley, Maxime Maufra e Henry Moret, ma anche Paul Gauguin, Jean-Francis Auburtin, Ker Xavier Roussel, Maurice Denis, Marie Droppe fino alla genesi del Fauvismo, con Raoul Dufy e Othon Friesz. Nelle sale di M9 il racconto di Arte salvata si intreccia con quello dell’esposizione permanente, che illustra il capitolo della Guerra Totale e del dopoguerra italiano, integrando, inoltre, una dimensione locale: per tutta la durata della mostra sarà presente una sezione fotografica dedicata all’esperienza della Guerra a Mestre. Diletta Rostellato
The port of Le Havre was a key objective for the success of the Normandy landings.
In September 1944, the Allies launched heavy air, naval, and ground attacks on the city facing the English Channel to liberate it from German occupation and secure supply access through its port. Operation Astonia devastated the old town, causing tens of thousands of casualties and displacements. Yet, amid such destruction, art made a miracle. Most masterpieces at the MuMa – André Malraux Museum of Modern Art – survived and became symbols of the city’s rebirth, led by architect Auguste Perret. On the 80th anniversary of WWII, The M9 Museum in Mestre honours this resilience with exhibition Saved Art. Masterpieces Beyond War from MuMa Le Havre, open until August 31. Featuring 51 pieces, the exhibition celebrates the spirit of Le Havre, Mestre, and Porto Marghera, and artists like Monet, Renoir, Gauguin, and Dufy.
The show intertwines with M9’s permanent exhibit on wartime and post-war Italy, including a photo section on Mestre’s wartime experience.
Arte Salvata. Capolavori oltre la guerra dal MuMa di Le Havre Fino 31 agosto M9 – Museo del ‘900-Mestre www.m9museum.it

Entrando nella Chiesa rinascimentale, dalle forme classicheggianti e a unica navata, di Santa Maria della Visitazione alle Zattere si viene immediatamente investiti dalla potente dolcezza dell’installazione site-specific della scultrice ceca Veronika Psotkova (1981). L’opera, dal titolo emblematico, Perpetuo, vuole essere una riflessione sulle modalità di fruizione dei social network nel nostro quotidiano: la grande scultura in filo metallico si presenta infatti come un ponte tra reale e virtuale, due mondi i cui limiti sono sempre più sfumati tra loro. La scelta dell’artista di instaurare un forte dialogo con lo spazio antico connotato di sacralità, offre ulteriori sfumature: da un lato, afferma come i social media siano diventati una nuova rete a cui ci affidiamo così come prima ci si rivolgeva alla religione, dall’altro esprime la volontà di non trascurare i luoghi simbolo della tradizione. Veronika Psotková ha intessuto il filo metallico per creare una moltitudine di corpi che si susseguono fino a formare un grande arco. La rappresentazione del corpo segue i modelli scultorei rinascimentali e barocchi, che la chiesa ispira, ma l’uso di questo particolare medium – la rete – ostacola un realismo dettagliato e conferisce alle figure un’aura astratta ed evanescente. L’accostamento confuso delle figure, all’interno di un continuum spazio-temporale plastico e narrativo, diventa metafora della proliferazione incessante di immagini nei post iconografici e della nostra abitudine a una fruizione continua, imposta dai social network: un flusso visivo ininterrotto che ci impedisce spesso di soffermarci, con sguardo critico, su ciascuna unità iconografica. La mostra, aperta fino al 23 novembre, è promossa e realizzata grazie a Valea Art. Marina Borroni
ENG Upon entering the Renaissance church of Santa Maria della Visitazione, with its classical forms and single nave, we are immediately struck by the powerful delicacy of Czech sculptor Veronika Psotková’s site-specific installation, Perpetuo The large wire sculpture reflects on how we engage with social media, acting as a bridge between the real and virtual. Psotková weaves metal wire into a congregation of bodies forming a great arch, evoking Renaissance and Baroque forms. The physical features of the art medium, metal wire, cannot accommodate any detailed realism, which gives the characters an abstract, evanescent aura. These translucent figures mirror the endless flow of images on social media, where constant visual input hinders critical reflection. The exhibition, open until November 23, is presented by Valea Art.
Perpetuo Fino 23 novembre Chiesa Santa Maria della Visitazione, Zattere www.perpetuo-venice.art

L’Estate è la stagione della Grecia, del suo mare, ma anche della sua storia, leggenda e mito. Prima di partire per le vacanze o nel rimanere in città, godetevi un tuffo ideale nell’Egeo immergendovi nella mostra Telemachus, secondo capitolo espositivo tratto dall’Odissea di Omero, promossa dalla Fondation Valmont nella sua sede di Venezia a Palazzo Bonvicini. Tutto è nato però in Grecia, a Villa Valentine, una delle quattro Résidences Valmont, sull’isola di Hydra, dove da un incontro tra due coppie di artisti, Pavel Roucka e Jakub Flejšar e Didier e Maxence Guillon, e i curatori, Francesca Giubilei, Luca Berta e Valentina Secco, si è concretizzata l’idea di una mostra che mettesse al centro il complicato rapporto tra padre e figlio, idealmente Ulisse e Telemaco.
Entrando a Palazzo Bonvicini, nelle prime due sale Jakub Flejšar e Pavel Roucka posizionano le loro opere in connessione le une con le altre, a simboleggiare come l’identità artistica del più giovane ha ormai trovato la sua direzione solo dopo aver conosciuto l’arte del patrigno. Questa tensione è ben espressa dalla scultura di Flejšar collocata tra le due sale ma messa di spalle rispetto ai dipinti di Roucka, che rappresentano diverse scene del viaggio di Telemaco alla ricerca del padre.
Nelle successive due sale, l’installazione di Maxence Guillon illustra come il suo percorso artistico sia stato indirizzato dal padre Didier, rappresentando un cammino verso un’arena sorvegliata da un’austera figura statuaria. Didier guarda al sogno come ad uno strumento per comprendere il passato e agire con riguardo verso il futuro: la scritta sogno in dieci lingue diverse campeggia sopra totem monolitici che ospitano alcuni disegni del trisnonno Alphonse Lami. La mostra è un viaggio nel nostro contemporaneo. Marina Borroni ENG Summer is the season of Greece: its sea, its history, legends, and myths. Whether you’re heading on vacation or staying in town, take a symbolic dive into the Aegean Sea with the exhibition Telemachus, the second chapter inspired by Homer’s Odyssey presented by Fondation Valmont at Palazzo Bonvicini in Venice. The show explores the complex father-son bond (Ulysses and Telemachus) through works by artists Pavel Roucka, Jakub Flejšar, Didier, and Maxence Guillon. One of the highlights of the exhibition is Flejšar’s sculpture spanning two halls, breaking away from Roucka’s paintings depicting Telemachus’ travels in search of his father.
The Quest for Self Fino 22 novembre Fondation Valmont, Palazzo Bonvicini www.fondationvalmont.com

L’arte è, e lo è sempre stata, un mezzo tra i più straordinari per costruire ponti e connessioni, e la mostra L’oro dipinto. El Greco e la pittura tra Creta e Venezia in corso a Palazzo Ducale, ne è un chiaro e raffinato esempio. Sulla rotta mediterranea che legava Venezia a Creta per più di quattro secoli (1204-1669), si viene a costituire una ricchissima scuola pittorica a metà tra Oriente bizantino e Occidente latino. La Scuola veneto-cretese diventerà il segno tangibile e visivo dell’eredità di una secolare tradizione bizantina che si sposta, dopo la caduta di Costantinopoli (1453), nell’isola di Candia, così veniva denominata all’epoca Creta nell’esteso panorama dello Stato da Mar della Repubblica di Venezia, diventando una sorprendente fucina artistica. In quel momento critico per i greci ortodossi, violentemente repressi dagli ottomani, il sicuro ambiente cretese favorisce sotto l’ala della Serenissima la convivenza con i non ortodossi. Sull’esempio veneziano nascono numerosissime botteghe e corporazioni artistiche: oltre un centinaio, tra “Maestri iconografi” e anonimi “Madoneri”, attivi nella produzione su larga scala di immagini sacre, le icone. Oggetti devozionali, ma anche opere d’arte da collezionare, le icone cretesi verranno esportate e mostreranno in contemporanea, spesso per opera dello stesso pittore, una varietà di suggestioni, un adattamento di linguaggio e di stile, da quelle più legate alla tradizione bizantina a quelle dove si sente l’influenza di un più libero stile naturalistico occidentale gradito ai committenti cattolico-romani.
Oltre ad essere ben impaginata, in ordine cronologico con ricchezza di apparati esplicativi, la mostra presenta una selezione di più di 100 icone che provengono da importanti Musei e Collezioni internazionali, in particolare si segnalano le numerose opere del Museo Bizantino e Cristiano di Atene.
Il viaggio parte dalla metà XV secolo con alcune opere dei primi importanti maestri della Scuola cretese come Angelo Akotantos e Andrea Ritzos, rappresentati in mostra da numerose varianti della Theotokos-Madre di Dio, e da icone in cui si coglie già lo sguardo verso l’Occidente gotico. Alla fine del Quattrocento, i riferimenti gotici lasciano gradualmente spazio ai nuovi modelli del Rinascimento veneto. I pittori cretesi cominciano a essere documentati a Venezia, con soggiorni prolungati o trasferimenti stabili. Tra questi, Ioannis Permeniatis, che realizza pale d’altare “alla veneziana”, influenzato dalla pittura dei Vivarini e di Giovanni Bellini. Si potrebbe rimanere ore ad ammirare l’icona In Te gioisce di Georgios Klontzas, rampollo di una famiglia benestante con bottega nella Piazza San Marco di Candia, rinomato miniaturista della seconda metà del Cinquecento. L’immagine è una sintesi di fonti che vanno dal popolare inno del monaco Giovanni Damasceno In te gioisce all’inno Acatisto dedicato alla Madre di Dio, che celebra il mistero dell’incarnazione, dal Dodekaorton, le dodici festività dell’anno liturgico ortodosso, al Libro della Genesi fino a scene tratte dal ciclo zodiacale. Con una Gerusalemme celeste che galleggia sulle acque dei fiumi del Paradiso, che evoca a una veduta di Venezia e della sua laguna, ci si trova in uno stato di dolce smarrimento.

A metà percorso si giunge alle due personalità più rappresentative di questa narrazione: Michael Damaskinos (1530 ca-1593) e Domenikos Theotokópoulos (1541-1614), entrambi cretesi e presenti a Venezia nella seconda metà del Cinquecento e, dunque, influenzati dai grandi maestri del Manierismo veneziano. Damaskinos lavorerà alcuni anni per la Chiesa greco ortodossa di San Giorgio, nella quale si può ancora ammirare le sue opere nell’iconostasi e nelle conche absidali, mentre Theotokópoulos sarà di passaggio per ben due volte prima del trasferimento definitivo in Spagna, nel 1577, per diventare quel genio visionario che tutti conosciamo come El Greco. La selezione di opere di questi due pittori, i cui destini per certi versi si incrociano, è assolutamente adatta a mostrarci come solamente il grande El Greco, e nessun altro tra questi artisti, riesca a far propria la lezione veneziana. La piccola e straordinaria tavoletta del Prado con la Fuga in Egitto, non a caso in passato attribuita a Jacopo Bassano, diventa il manifesto di questa svolta. Di vibrante espressività pittorica, grazie a una pennellata vorticosa accesa da bagliori di luce e a contrasti cromatici che risentono dello studio di Tintoretto, questa piccola opera possiede tutta la forza della grande pittura veneta cinquecentesca.
Dopo una pausa storica che narra le vicende della guerra e perdita di Creta nel 1669 con il lunghissimo assedio di Francesco Morosini che tenta disperatamente la riconquista, la mostra prosegue con i pittori della diaspora, costretti a lasciare Creta, caduta in mano turca, e trasferirsi nelle veneziane isole ionie. Alcuni si stabilirono a Venezia come Theodoro Poulakis, mentre altri raggiunsero Corfù, Zante e Cefalonia proseguendo nel Seicento e Settecento quella contaminazione tra resistente tradizione bizantina e nuovi influssi occidentali.
Una mostra che approfondisce un fenomeno culturale rilevantissimo e ancora poco indagato, un mondo di immagini da scoprire dove l’oro non solo risplende ma ci avvolge di un profondo senso di spiritualità. Franca Lugato
Antoon Van Dyck (Anversa, 1599 – Londra, 1641) era giunto in Italia per completare il tradizionale viaggio di formazione, pratica che tutti gli artisti sentivano obbligata per raggiungere la maturità stilistica, tra il 1621 e il 1627, toccando le principali città italiane: Genova, Roma, Venezia, Firenze, Palermo, per poi tornare a Genova. La sua arte, già segnata da una grande intensità coloristica di matrice veneta, era pervasa da una forte irruenza compositiva, derivata dall’influenza di Rubens, presso cui aveva trascorso un periodo giovanile. È in questo contesto che Van Dyck realizza il Cristo crocifisso, nel 1627, una tela di 124 per 93 cm. Il pittore fiammingo mette in scena il corpo di Cristo inchiodato sulla croce, che si staglia contro un cielo cupo addensato di nubi livide, spezzate da guizzi di luce abbacinante, appena addolciti da venature rosate. Un voluminoso, quasi ingombrante, drappo bianco copre la vita, accartocciandosi sinuosamente al vento ed esaltando la figura ancora viva del Cristo dal volto rigato di sangue, che volge lo sguardo, intenso e dolente, verso il cielo. Il paesaggio roccioso e spoglio che circonda la croce perdendosi nell’oscurità del fondo esprime la dimensione drammatica entro cui si rifrange la dolente emotività del Cristo. Dall’oscurità si staglia con forza l’invenzione del bianco panneggio, punto emozionale del dipinto e cifra stilistica di un grande regista della luce.
Come spiega Luca Massimo Barbero, direttore dell’Istituto di Storia dell’Arte della Fondazione Giorgio Cini dove il dipinto è in mostra nell’ambito della rassegna L’Ospite a Palazzo – in prestito dal Palazzo Reale dei Musei Nazionali di Genova –, si tratta di «un capolavoro di straordinaria intensità lirica, giocato su accostamenti cromatici di grande suggestione. È una vivida testimonianza dell’arte del maestro fiammingo, memore della lezione rubensiana, cui si affianca l’uso sapiente e raffinato del colore e del contrasto luministico».
Non sono state trovate sinora notizie sulla committenza e sulla storia del dipinto antecedenti al 1821, quando il prezioso dipinto fu acquistato da Carlo Felice di Savoia, insieme alla raccolta di opere di Andrea Carlo Gabaldoni. È registrato per la prima volta nell’inventario di Palazzo Reale a Genova nel 1836, con una attribuzione a Van Dyck che non solo non è mai stata messa in dubbio, ma è considerata da buona parte della critica come l’unico Crocifisso autografo del

maestro anversano sopravvissuto tra quelli eseguiti nei suoi anni italiani. Nella Galleria di Palazzo Cini, raffinata casa-museo sorta nel 1984, il magnifico dipinto di Antoon Van Dyck si pone in dialogo con la raccolta d’arte antica di Vittorio Cini (1885 – 1977), a cominciare dalle suggestive Croci dei maestri primitivi della sezione dei fondi oro. M.M.
ENG Anthony Van Dyck (Antwerp, 1599 – London, 1641) travelled through Italy between 1621 and 1627 as part of his artistic training, including visits to Genoa, Rome, Venice, Florence, and Palermo. Deeply influenced by Rubens and the Venetian colour tradition, Van Dyck developed a dynamic and expressive style. In 1627, he painted a Crucified Christ, a 48 by 36-inch canvas depicting Christ on the cross against a stormy sky, pierced by flashes of blinding light. An oversized white cloth wraps around his waist, adding to the dramatic tension and emotional intensity of the scene. The barren, rocky landscape deepens the sense of sorrow. Giorgio Cini Foundation director Luca Massimo Barbero noted how the painting is a lyrical masterpiece, rich in contrast, and a testament to Van Dyck’s refined use of light and colour, an echo of Rubens’ influence. The painting’s history before 1821 is unknown; it was acquired that year by Carlo Felice of Savoy and first recorded in Genoa’s Royal Palace inventory in 1836. It is widely considered Van Dyck’s only surviving Crucifixion from his Italian period. L’Ospite a Palazzo.
crocifisso di Antoon Van Dyck
8 settembre Palazzo Cini, Campo San Vio


La vetreria Fratelli Toso, fondata nel 1854 dall’iniziativa di sei fratelli Toso, è stata una delle vetrerie più rinomate nel panorama artistico della Murano dell’Ottocento e del Novecento. Nel corso degli anni, generazione dopo generazione, i Toso con le loro diversificate vocazioni e competenze – maestri, tecnici, disegnatori, dirigenti –hanno contribuito al successo di una realtà produttiva che ha saputo costantemente aggiornarsi e rinnovarsi anche grazie a collaborazioni con artisti e designer esterni, pur mantenendo sempre un carattere familiare. A 170 anni dalla sua fondazione, i Fratelli Toso celebrano la loro Storia di fabbriche. Storia di famiglie al Museo del Vetro di Murano, dal 12 luglio al 24 novembre. Le curatrici, Chiara Squarcina e Caterina Toso, hanno costruito una retrospettiva puntuale sulla migliore produzione artistica del Novecento, raccontata attraverso il lavoro dei direttori artistici e dei disegnatori e con particolare attenzione a una delle punte di diamante della sua produzione: la murrina. Le opere in vetro e il materiale d’archivio integralmente conservato dalla famiglia raccontano l’evoluzione delle sue murrine nel tempo, le partnership con artisti di rilievo, il contributo di disegnatori e maestri vetrai che hanno plasmato il percorso artistico e produttivo della vetreria. Di decennio in decennio la produzione si rinnova raggiungendo punte di assoluta eccellenza stilistica e tecnica per stare al passo con il mercato contemporaneo, confermando che la Fratelli Toso è una delle grandi protagoniste della storia del vetro muranese. Schizzi originali, bozzetti, fotografie e documenti rappresentano un materiale fondamentale per riscoprire questa storia.
ENG Glassmakers Fratelli Toso was founded by the six Toso brothers in 1854 and grew into one of the most renowned art glass factories in Venice. Over time, the business was renovated thanks to the contributions of talented engineers, designers, and managers. 170 years since its establishment, Fratelli Toso celebrate the best art production of the twentieth century with particular attention to the crown jewel of their production: the murrina pieces. The exhibition includes original sketches, photographs, and documents of this long, beautiful history.
Storie di fabbriche. Storie di famiglie. Fratelli Toso 12 luglio-24 novembre Museo del Vetro Spazio Ex Conterie, Murano museovetro.visitmuve.it

Sculture monumentali in vetro dell’artista ceco Vlastimil Beránek campeggiano negli spazi di Palazzo Barovier & Toso a Murano, che con Stillness in Motion / Immobilità in Movimento prosegue la missione di Barovier&Toso ARTE di presentare l’arte contemporanea in vetro in tutte le sue variazioni, questa volta discostandosi dalle tecniche veneziane tradizionali. Collocandosi infatti all’intersezione tra la tradizione vetraria ceca e l’innovazione contemporanea, Beránek rende onore all’eredità dell’artigianato del cristallo boemo espandendo i limiti tecnici del vetro come mezzo artistico. Mentre l’arte vetraria ceca è stata storicamente celebrata per le sue tecniche di taglio, di precisione, incisione e soffiatura, il lavoro di Beránek rappresenta l’evoluzione verso approcci più scultorei e concettuali, iniziati nella seconda metà del XX secolo. Le sue forme astratte di grandi dimensioni, spesso ispirate a elementi naturali come l’acqua e il fuoco, hanno spinto il medium vetro in nuovi territori che trascendono la categorizzazione convenzionale tra arte e artigianato. Artista vetraio di terza generazione, Beránek realizza le sue sculture monumentali con la tecnica del casting, ovvero il riscaldamento del vetro fino allo stato fuso e la sua colatura in stampi dove lentamente si raffredda e solidifica, permettendo di creare forme solide tridimensionali impossibili da ottenere attraverso tecniche tradizionali di soffiatura. Innovazioni tecniche nei materiali per gli stampi e nuovi processi e metodi di lavorazione a freddo hanno ampliato le possibilità artistiche, permettendo la creazione di forme scultoree più grandi e complesse che mostrano le proprietà ottiche uniche del vetro e la sua interazione con la luce, che crea sorprendenti gradienti cromatici. Il vetro è qui immaginato come una forma dinamica di espressione. M.M. ENG Monumental glass sculptures by Czech artist Vlastimil Beránek are on display at Palazzo Barovier & Toso in Murano. Stillness in Motion continues the Barovier&Toso ARTE mission to showcase contemporary glass art beyond traditional Venetian techniques. Blending Czech glassmaking heritage with innovation, Beránek pushes the limits of glass through casting, creating large abstract forms inspired by nature that would otherwise be impossible to create using other techniques, like glassblowing. His works explore light, colour, and the expressive potential of glass as a dynamic medium.

Il ruolo della Biennale di Venezia che negli anni ha consolidato il primato artistico e culturale a livello internazionale e la fondamentale importanza del vetro artistico di Murano, non nascono oggi ma affondano le radici nel passato. Appare infatti evidente nell’affascinante mostra in corso a Le Stanze del Vetro, 1932-1942 Il vetro di Murano e la Biennale di Venezia, a cura di Marino Barovier, come alcuni passaggi storici ed estetici siano stati determinanti per sancire l’autorevolezza artistica del vetro di Murano. La volontà da parte dell’Ente Biennale – con il suo Presidente Giuseppe Volpi di Misurata – di promuovere iniziative oltre l’ambito delle arti figurative portò nel 1932 alla costruzione di un padiglione destinato alle arti decorative, il Padiglione Venezia realizzato dall’architetto Brenno Del Giudice. Nel Padiglione, costituito da un’ampia “galleria” curva affiancata alle estremità da due salette destinate ai merletti, il vetro era di fatto il protagonista assoluto. Dal 1932, le fornaci muranesi ebbero l’opportunità così di presentarsi ogni volta con la migliore produzione, sapendo cogliere gli stimoli che la Biennale offriva loro. Tra le fornaci, in particolare, si distinse la Venini che si avvalse della collaborazione di Carlo Scarpa, mentre la Barovier Seguso Ferro, poi Seguso Vetri d’Arte, vide la presenza di Flavio Poli; il pittore Dino Martens, invece, collaborò prima con la Salviati & C. e la Successori Andrea Rioda e poi con la Aureliano Toso. La Salviati & C. si avvalse del pittore Mario De Luigi che firmò i suoi lavori con lo pseudonimo di Guido Bin. A Ercole Barovier si devono le numerose serie proposte dalla storica vetreria Barovier, divenuta dal 1936 Ferro Toso-Barovier e dal 1939 Barovier Toso & C. M.M.
ENG The Venice Biennale’s global cultural role and the importance of Murano glass have deep historical roots. This is apparent in the exhibition 1932–1942 Murano Glass and the Venice Biennale at Le Stanze del Vetro, curated by Marino Barovier. In 1932, under President Giuseppe Volpi, the Biennale created the Venice Pavilion for Decorative Arts, where Murano glass took centre stage. Furnaces like Venini, Barovier, and Salviati stood out, collaborating with artists such as Scarpa, Poli, Martens, and De Luigi, shaping the legacy of Murano glass art.

Il vetro è stato per Luciano Vistosi (1931– 2010), apprendista e poi artista all’interno della vetreria fondata dal padre, l’esercizio quotidiano, la dimostrazione che con la materia viva si può fare altro seguendo obiettivi e modalità diverse. La freschezza inventiva che si ritrova nelle lampade, nelle coppe e in generale negli oggetti d’uso creati con successo fino agli anni ‘70, sottendono quello che è il vero esito del suo talento: la scultura. Infatti, forzando i limiti della materia e delle lavorazioni tradizionali, Luciano Vistosi ha creato opere soffiate alte più di due metri, sculture da blocchi di vetro industriale scolpiti come se fosse marmo, la “scultura-architettura” come le città di cristallo e i ponti dell’Accademia e dell’Arsenale, ed infine la sua Croce creata come testimonianza di un secolo difficile come il 1900 per la Basilica di San Marco a Venezia.
Espressione di un percorso artistico unico nella storia del vetro, dopo alcuni lavori di restauro, ha riaperto lo Spazio Luciano Vistosi, il suo studio, un luogo carico di vita vissuta e di suggestione, a ridosso della Basilica di San Donato. Voluto dall’artista stesso e ricavato nel 1985 dai locali della Vetreria Vistosi, lo Spazio permette di scoprire le varie tecniche di lavorazione e di ricerca che Vistosi ha utilizzato per le sue creazioni, siano esse soffiate o scolpite. Un centinaio di opere, che animano le sale della fornace, dei locali di raffreddamento e della moleria, rivelano una ricerca di perfezione nella forma in cui le linee si richiudono su sé stesse in un infinito continuo e la luce e la trasparenza in esse catturata trasmettono una rifrangenza a volte mistica, irraggiungibile se non con la materia vetro. M.M. ENG For Luciano Vistosi (1931–2010), glassmaking was a daily practice and a way to explore new forms beyond tradition. From lamps and bowls to monumental sculptures, he pushed the limits of glass, creating art over two meters tall and sculpting industrial blocks as if it was marble. His studio, now reopened near the Basilica of San Donato in Murano, showcases over a hundred pieces, blown and carved, showing the artist’s interest for form, light, and a mystical transparency that is unique to glass.

Architetture Terrone
Fino Until 10 settembre September
Romina De Novellis (Napoli, 1982) è artista visiva, performer, ricercatrice e antropologa con radici mediterranee, ma attiva da molti anni a Parigi. In chiave retrospettiva, l’esposizione mette in luce alcune delle performance più significative che l’artista ha realizzato negli ultimi quindici anni, valorizzate qui attraverso strutture installative di diversa natura. Questi dispositivi labili e temporanei si fanno strumento visivo per ripensare lo spazio e le costrizioni e limitazioni che lo definiscono. Prive della presenza del corpo che le ha abitate, le installazioni sono messe in relazione con video e fotografie, tracce essenziali dell’attività performativa di De Novellis.
ENG Romina De Novellis (Naples, 1982) is a visual artist, performer, researcher, and anthropologist with Mediterranean roots but has been active in Paris for many years. In retrospective key, her exhibition highlights some of the most significant performances the artist created over the past fifteen years, enhanced by a peculiar installation. These temporary devices serve as visual tools to rethink space and the constraints and limitations that define it. Devoid of the bodily presence that once inhabited them, the installations relate to videos and photographs, themselves essential traces of De Novellis’ performative art.
Calle dei Guardiani, Dorsoduro 2403/H www.albertapane.com

Temple of Love. Cœur
FOSBURY ARCHITECTURE
Design x ABC
Fino Until 12 ottobre October
Due nuovi progetti di arte e architettura contemporanea. Il primo è la personale dell’artista francese Gaëlle Choisne, che conclude la residenza alla Scuola Piccola Zattere con un nuovo capitolo della sua serie espositiva ispirata a Frammenti di un discorso amoroso di Roland Barthes. Tramite un approccio che combina molteplici media, tecniche e materiali, Choisne costruisce una narrazione progressiva in continua evoluzione. Il secondo è l’intervento di Fosbury Architecture per il design del nuovo ristorante ABC Zattere. Concepito in dialogo con l’identità e il programma della Scuola, il progetto crea una continuità tra interno ed esterno, tradizione e modernità.
ENG Two new projects in contemporary art and architecture. The first is a solo exhibition by French artist Gaëlle Choisne, which concludes her residency at Scuola Piccola Zattere with a new chapter in her exhibition series inspired by Roland Barthes’s A Lover’s Discourse: Fragments Through an approach that combines multiple media, techniques, and materials, Choisne constructs a progressively evolving narrative. The second project is an intervention by Fosbury Architecture for the design of the new ABC Zattere restaurant. Designed in dialogue with the identity and programme of the school, the project creates continuity between the indoor and outdoor, blending tradition with modernity. Dorsoduro 1401 www.scuolapiccolazattere.com
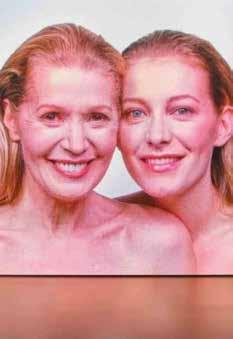
Fino Until 23 novembre November «L’immagine del paradiso, esemplificata dall’estetica pubblicitaria, può diventare un’immagine dell’inferno – afferma Clément Cogitore – La mia storia sta nel mezzo, nel passaggio dall’uno all’altro». L’artista francese porta a Venezia The Evil Eye, video installazione realizzata nel 2018. Un grande schermo a LED cattura l’attenzione in uno spazio paradossalmente intimo, una voce narrante femminile accompagna lo spettatore in un viaggio attraverso scene anonime e stereotipate tratte da banche globali che forniscono immagini per spot pubblicitari e campagne politiche. L’artista, prendendo in prestito immagini promozionali e trasformandole in cronaca, crea una messa in scena ambivalente e straniante.
ENG “The image of paradise, exemplified by advertising aesthetics, can become an image of hell,” says Clément Cogitore. “My story lies in between, in the passage from one to the other.” The French artist brings The Evil Eye to Venice, a video installation created in 2018. A large LED screen draws attention in a paradoxically intimate space, while a female narrator guides viewers through a journey across anonymous, stereotyped scenes sourced from global archives of images used in commercials and political campaigns. By borrowing and reframing these promotional visuals as documentary fragments, Cogitore stages an unsettling and ambivalent mise-en-scène.
Espace Louis Vuitton Venezia San Marco 1353

DAVIDE RIVALTA
Leoni in campo
Fino Until 23 novembre November Davide Rivalta torna su uno degli animali più cari del suo bestiario per rivelare, ancora una volta, il leone e la leonessa nella loro doppia essenza: maestosi e silenziosi, emblemi di libertà, potenza e controllo. Con Leoni in campo, l’artista intreccia mito e realtà, inserendo queste creature imponenti in uno spazio urbano messo in sospensione. La loro immobilità non è passività, ma una forma di resistenza. Con il suo linguaggio scultoreo, Davide Rivalta ci invita a confrontarci non solo con la loro dimensione mitologica e simbolica, ma anche con quella naturale, facendo dei leoni i testimoni, ma anche i protagonisti di un dialogo che coinvolge il cuore della città e la sua storia.
ENG Davide Rivalta’s large-scale sculptures have been installed in the public areas facing Palazzo Querini Stampalia: monumental bronze lions that inhabit urban spaces, engaging in dialogue with the city. The artist returns to one of the most iconic animals in his bestiary to reveal, once again, its composite essence: majestic and silent, and a symbol of freedom, power, and control. Its standing still does not mean passivity but a form of resistance. With Lions on the Field, Rivalta blends together myth and reality, exploring the relationship between urban space and the wild, not yet completely tamed and anthropized, and the complex relationship between different living beings.
Campo Santa Maria Formosa, Castello 5252 www.querinistampalia.org


Giuseppe Adamo, Maurizio Donzelli, Serena Fineschi, Silvia Giordani, Aldo Grazzi, Olga Lepri, Giulio Malinverni, Laura Omacini, Paolo Pretolani
The dream of infinity
Fino Until 26 luglio July
In un dialogo tra filosofia e poesia, l’esposizione si interroga sul concetto di apparizione. Le opere esposte non si rivelano immediatamente, richiedono tempo, immaginazione e riflessione. I nove artisti coinvolti offrono una densa pluralità di linguaggi e tecniche pittoriche ed espressive. Le loro opere, esplorando i confini tra presenza e assenza, realtà e sogno, luce e ombra, indicano un percorso che parte dall’immagine negata e si muove verso la sua ricostruzione soggettiva, un cammino in cui ogni spettatore diviene l’artefice della propria personale e intima apparizione.
ENG In a dialogue between philosophy and poetry, the exhibition explores the concept of apparition. The exhibited works do not reveal themselves immediately; they require time, imagination, and reflection. The nine artists involved offer a dense plurality of languages and expressive and pictorial techniques. Their art explores the boundaries between presence and absence, reality and dream, light and shadow, and indicate a path that starts with a denied image and moves towards its subjective reconstruction, a journey where every spectator becomes the creator of their own personal and intimate apparition. Rio Terà dei Catecumeni, Dorsoduro 141 www.marignanaarte.it
Fino Until 27 settembre September Eleonora Rinaldi (Udine, 1994, vive e lavora a Parigi) esplora il confine tra il visibile e l’invisibile, tra la realtà e il sogno, tra la percezione e la memoria visiva. Órama – titolo della mostra che deriva dal greco antico e significa “visione” o “sogno” – si fonda sulla riflessione della natura come spazio primordiale della visione e della rivelazione. I dipinti di Rinaldi presentano paesaggi sospesi tra il reale e l’onirico, in cui la vegetazione non è semplice sfondo, ma si fa protagonista attiva, avvolgendo le figure umane e dissolvendone i contorni in un intreccio cromatico ipnotico. La sua pittura richiama il simbolismo ottocentesco e il surrealismo, evocando atmosfere che dialogano con la tradizione, ma che si proiettano in una dimensione profondamente contemporanea.
ENG Eleonora Rinaldi explores the boundary between the visible and the invisible, between perception and visual memory. Órama – meaning “vision” or “dream” – is rooted in a reflection on nature as a primordial space of revelation. Rinaldi’s paintings depict landscapes where vegetation is not merely a backdrop but takes on an active role, enveloping human figures and dissolving their outlines in a hypnotic chromatic weave. Her painting recalls 19th-century Symbolism and Surrealism, evoking atmospheres that converse with tradition while projecting themselves into a contemporary dimension.
Galleria Internazionale d’Arte Moderna Project room capesaro.visitmuve.it

La sua voce è quella di chi non accetta compromessi: canta la resistenza, la libertà, la spiritualità, ma anche il dolore e la perdita
di Alberto Marzari
Patti Smith è un’icona culturale. Non è affatto retorico ribadirlo, è un fatto. Un’artista che ha saputo unire poesia, rock e impegno civile in una carriera unica e coerente. Nata a Chicago nel 1946, cresciuta nel New Jersey in una famiglia modesta, si trasferisce a New York alla fine degli anni Sessanta, dove inizia a farsi conoscere nei circoli artistici della città. Fin dai primi passi la sua arte sfida le convenzioni: non è soltanto una cantante, ma una performer, una poetessa, una scrittrice. Il suo linguaggio è colto e viscerale, ispirato da Rimbaud, William Blake e dalla cultura underground newyorkese.
Nel 1975 pubblica il suo primo album, Horses, prodotto da John Cale dei Velvet Underground. La copertina diventa subito un manifesto: rottura con le immagini femminili tradizionali, dichiarazione di indipendenza e androgina ribellione. La title track, Gloria, inizia con un verso diventato celebre: “Jesus died for somebody’s sins, but not mine”. È l’inizio di una nuova era del rock, in cui la parola scritta si fonde con la potenza del punk nascente.
Negli anni successivi Patti Smith continua a incidere dischi, a scrivere poesie e a prendere posizioni nette su temi politici e sociali. La sua voce è quella di chi non accetta compromessi: canta la resistenza, la libertà, la spiritualità, ma anche il dolore e la perdita.
Dopo le morti premature di Mapplethorpe, suo compagno e amico fraterno per sempre, di cui tra l’altro è in corso una personale alle Stanze della Fotografia nell’Isola di San Giorgio, e del marito Fred “Sonic” Smith, leader della seminale band protopunk della scena di Detroit MC5, la sua carriera subisce una lunga pausa, ma a fine anni Novanta ritorna con nuova energia sulle scene internazionali guadagnandosi anche un suo nuovo pubblico. Il suo memoir Just Kids (2010), dedicato alla sua amicizia e alla relazione con Mapplethorpe, vince il National Book Award e diventa un bestseller internazionale. Il libro racconta la New York degli anni Settanta, il Chelsea Hotel, le gallerie d’arte, il CBGB, gli incontri con Warhol, Dylan, Burroughs. È un omaggio a un’epoca, ma anche una riflessione profonda sul significato dell’arte, dell’amore e della perdita.
Smith ha un legame speciale con l’Italia, dove gode di un seguito affezionato e trasversale. Ha spesso dichiarato il suo amore per il nostro Paese, per la cultura e la bellezza dei luoghi. È stata ospite di festival letterari e musicali, ha suonato nei teatri e nelle piazze, da Roma a Firenze, da Milano a Napoli.
È particolarmente legata alla figura di Pier Paolo Pasolini, che ha omaggiato più volte nei suoi concerti. In Italia ha anche ricevuto numerosi riconoscimenti, tra cui la laurea honoris causa in Lettere moderne all’Università di Parma. Nelle sue visite, non manca mai di parlare di poesia, politica, arte e spiritualità, con quell’intensità che la rende unica.
Patti Smith è oggi considerata una figura di riferimento per diverse generazioni di artisti. La sua influenza si estende ben oltre la musica: è una testimone del nostro tempo, una voce che continua a risuonare con forza, capace di parlare con autenticità tanto ai giovani quanto a chi ha vissuto il suo stesso cammino. Con il suo stile asciutto, profondo, visionario, ha ridefinito il ruolo della donna nel rock e ha dimostrato che l’arte può essere allo stesso tempo fragile e rivoluzionaria.
Patti Smith is a cultural icon. This is not a rhetorical statement: it’s a fact. An artist who has uniquely and consistently blended poetry, rock, and civic engagement throughout her career.
Born in Chicago in 1946 and raised in a modest family in New Jersey, she moved to New York in the late 1960s, where she began to make a name for herself in the city’s artistic circles. From the very beginning, her art defied convention: she was not just a singer, but a performer and author. Her language is both intellectual and visceral, inspired by Rimbaud, William Blake, and New York’s underground culture.
In 1975, she released her debut album Horses, produced by John Cale of Velvet Underground. Its cover is now iconic: a break from traditional female imagery, a declaration of independence, and an androgynous rebellion. The title track, Gloria, opens thus: “Jesus died for somebody’s sins, but not mine”. In the years that followed, Patti Smith continued to record albums, write poetry, and take strong stances on political and social issues. Her voice is one of uncompromising resistance, freedom, spirituality, and also of pain and loss. After the premature deaths of her lifelong friend and companion Robert Mapplethorpe and her husband Fred “Sonic” Smith, leader of the seminal Detroit proto-punk band MC5, her career paused for several years. By the late 1990s, she returned to the international stage with renewed energy, gaining a new generation of fans.
Her memoir Just Kids (2010), dedicated to her relationship with Mapplethorpe, won the National Book Award and became an international bestseller. It recounts 1970s New York – the Chelsea Hotel, art galleries, CBGB, encounters with Warhol, Dylan, Burroughs. It’s both a tribute to an era and a profound meditation on art, love, and loss.
Smith has a special bond with Italy, where she enjoys a devoted and diverse following. She has often expressed her love for the country, its culture, and its beauty. She’s been a guest at literary and music festivals, performing in theatres and piazzas from Rome to Florence, Milan to Naples. During her visits, she always speaks of poetry, politics, art, and spirituality with the intensity that defines her. Today, Patti Smith is a reference point for generations of artists. Her influence extends far beyond music: she is a witness of our time, a voice that continues to resonate with authenticity, speaking to both the young and those who’ve walked her same path. With her raw, profound, and visionary style, she has redefined the role of women in rock and shown that art can be both fragile and revolutionary.

“Pioniere”. Questo è il titolo che spesso si attribuisce a un musicista iconico, un precursore, anticipatore di stili e tendenze, personaggio capace di oltrepassare i confini musicali e abbattere le barriere culturali, artistiche e politiche tra le nazioni. Perché anche l’arte e la cultura, e quindi la musica, possono avere una funzione politica e sociale molto importante. Questo è Jean-Michel Jarre, un avanguardista dell’epoca del pop, un artista multisensoriale. Jarre ritorna in Italia in grande stile ospite del Venezia Jazz Festival, annunciando una stagione concepita come un’opera totale nel senso più ampio del termine: un viaggio attraverso suono, immagine e intelligenza artificiale senza preclusioni di sorta.
Il suo percorso artistico si conferma a 360° affiancando al concerto del 3 luglio in Piazza San Marco l’iconica partecipazione alla 19. Biennale Architettura, dove è stato invitato da Carlo Ratti tra i partecipanti della mostra Intelligens con l’installazione Oxyville, visione utopica e interattiva di una città di un futuro non troppo prossimo. Una sequenza integrata di installazioni, mostre e concerti per un’esperienza immersiva di sicura presa ed altrettanta suggestione. L’esibizione live a Venezia, organizzata da Veneto Jazz, rappresenta per Jarre un punto culminante del proprio percorso in cui confluiscono profonde ispirazioni legate all’arte, all’architettura e alla storia italiana, l’instancabile desiderio di innovazione attraverso la tecnologia e una capacità senza pari di creare esperienze musicali uniche in luoghi iconici. Un modo per celebrare la tradizione guardando al futuro, in linea con la sua visione di artista e di ambasciatore culturale. ENG Pioneers. This is what we often call iconic musicians, trailblazers who anticipate styles and trends, crossing musical boundaries and breaking cultural, artistic, and political barriers between nations. Art and culture, including music, can play a vital political and social role. Jean-Michel Jarre is a perfect example: a pop-era avant-gardist and multisensory artist. He will visit Italy in grand style as a guest of the Venice Jazz Festival, unveiling a season conceived as a total artwork—an immersive journey through sound, visuals, and artificial intelligence. His artistic path expands with a July 3 concert in Piazza San Marco and participation in the 2025 Architecture Biennale, invited by Carlo Ratti to the Intelligens exhibition with Oxyville, an interactive utopian city of the near future. Jarre’s performance in Venice will be a highlight in the artist’s journey, blending Italian art, architecture, history, and his relentless drive for innovation through technology.
Jean-Michel Jarre
3 luglio Piazza San Marco www.venetojazz.com
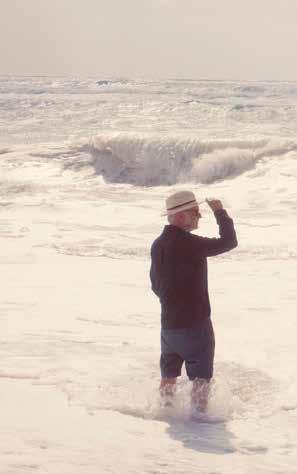
The Summer Portraits, diciassettesimo album di Ludovico Einaudi, segna il ritorno del compositore a timbri e sonorità orchestrali, in una fioritura di ricordi personali suscitati dal sole d’estate, dai ricordi delle vacanze in famiglia. «Ognuno di noi – racconta – ha un album di ricordi estivi. Il mio album è il ritratto musicale di quel tempo, per noi tutti infinito e meraviglioso».
Einaudi arriva sul palco di Piazza San Marco il 13 luglio per un concerto organizzato da Ponderosa Music & Arts e Zen Production in collaborazione con il Comune di Venezia, il Teatro La Fenice e Vela: assieme a lui Federico Mecozzi (violino), Redi Hasa (violoncello), Francesco Arcuri (percussioni), Alberto Fabris (basso), Gianluca Mancini (tastiere), Rocco Nigro (fisarmonica) e l’Ensemble d’archi Rimini Classica.
Il compositore e pianista torinese fa parte a pieno titolo di quella categoria di artisti capaci di affrontare la Piazza senza gambe tremanti o mani incerte, portatore di una musica che anzi in questo luogo iconico sarà senza ombra di dubbio troverà nuova luce, rendendo unico ogni momento del concerto.
Dopo una tournée iniziata lo scorso autunno che ha riscosso grande successo nei più prestigiosi teatri d’Europa e Asia e un ciclo
Ludovico Einaudi
13 luglio Piazza San Marco www.comune.venezia.it

di concerti sold-out nelle principali arene italiane ed europee tra cui Milano, Abu Dhabi e Rotterdam, di recente Ludovico Einaudi ha presentato un lavoro speciale e profondamente personale: Einaudi vs Einaudi. Echoes from The Summer Portraits. Il progetto nato da una collaborazione inedita con il figlio Leo, musicista, produttore e arrangiatore, è frutto di un’intesa creativa maturata negli anni e dell’incontro tra due visioni artistiche affini ma distinte, fatto di elementi elettronici e strutture ritmiche strettamente legate tra loro. ENG The Summer Portraits, Ludovico Einaudi’s seventeenth album, marks his return to orchestral tones and textures, inspired by the warmth of summer and memories of family holidays. “Each of us,” he says, “has a summer memory album. Mine is a musical portrait of that time”. Einaudi will perform in Piazza San Marco on July 13 in a concert produced by Ponderosa Music & Arts and Zen Production in collaboration with the City of Venice, Teatro La Fenice, and Vela. He willl be joined by Federico Mecozzi (violin), Redi Hasa (cello), Francesco Arcuri (drums), Alberto Fabris (bass), Gianluca Mancini (keyboards), Rocco Nigro (accordion), and the Rimini Classica string ensemble. Composer and pianist Ludovico Einaudi belongs to that rare group of artists who can command such an iconic stage with confidence. Following a successful tour across Europe and Asia, he recently unveiled Einaudi vs Einaudi. Echoes from The Summer Portraits, a deeply personal collaboration with his son Leo, blending electronic elements and rhythmic structures in a unique artistic dialogue.

Accompagnato dall’Orchestra Sinfonica Italiana, Giovanni Allevi presenta l’8 luglio alla Fenice il Concerto MM22 per Violoncello e Orchestra, opera scritta durante la degenza ospedaliera del 2022 e che trae spunto da una melodia scaturita dalla trasformazione in note della parola “mieloma”, secondo un metodo matematico già usato da Bach, per poi dipanarsi in un viaggio interiore struggente, rarefatto, luminoso e commovente.
Un tour estivo partito alla fine di giugno da Caracalla, due ore di concerto tra musica, riflessioni, pensieri e parole, chiuso con i bis Nostalgia e A perfect day che fin dal primo appuntamento, andato immediatamente sold-out, ha messo in connessione l’artista e un pubblico che non vedeva l’ora di ritrovare la sua musica sul palcoscenico, con la data del Venezia Jazz Festival in Laguna tra le più attese dell’estate.
Ma non saranno solo le note del compositore classico a lasciare senza parole il pubblico: per la prima volta nella sua carriera, Allevi si servirà nei propri concerti dell’uso innovativo di una tecnologia video e luci, che trasformerà il palcoscenico in uno scenario onirico e surreale. Proiezioni immersive, giochi di luci sincronizzate e ambientazioni multimediali daranno vita a un’atmosfera magica e irripetibile, facendo vivere al pubblico un’esperienza in cui musica e arti visive si fonderanno in un’unica, potente emozione.
Un ritorno a Venezia per Allevi, dopo il concerto in piano solo tenuto al Goldoni nell’ottobre dello scorso anno in cui il pubblico ha goduto di un repertorio comprendente i suoi brani più celebri da Come sei veramente a Il bacio e Ode alla gioia, accanto alle sue ultime composizioni discografiche.
ENG Accompanied by the Italian Symphony Orchestra, Giovanni Allevi presents his Concerto MM22 for Cello and Orchestra at the Fenice Theatre on July 8. Composed during his 2022 hospital stay, the piece is based on a melody derived from the word myeloma using a mathematical method once employed by Bach. It unfolds into a poignant, luminous inner journey.
Part of a summer tour launched in June, the concert blends music, reflections, and words, closing with encores Nostalgia and A Perfect Day. The Venice Jazz Festival date is among the most anticipated. For the first time, Allevi incorporates innovative video and lighting technology, transforming the stage into a dreamlike, immersive space where music and visual art merge. The event marks his return to Venice after last year’s solo piano concert at Teatro Goldoni, where he played both his most famous pieces and some of his more recent work.
Giovanni Allevi
8 luglio Teatro La Fenice
www.venetojazz.com
VENEZIA JAZZ FESTIVAL
Questa edizione rappresenta un perfetto equilibrio tra profondità artistica e apertura al pubblico. Siamo felici di accogliere grandi nomi della scena internazionale come Jarre, Bollani e Gurtu, Allevi e i Take 6, ma anche di dare spazio ad artisti originali e giovani talenti



2 luglio h. 19, Sale Apollinee-Teatro La Fenice
Serata dedicata ai giovani talenti del jazz italiano, vincitori del Premio Tomorrow’s Jazz, firmato da Veneto Jazz. Lorenzo Simoni, sassofonista e compositore da sempre diviso fra recital cameristici e musica improvvisata, dopo aver suonato per diversi anni con i singoli componenti del gruppo decide di unire le qualità ed esperienze di ognuno di loro per creare un quartetto. La band Elimi nasce nel 2019 da un gruppo di amici e colleghi musicisti, tutti studenti del Conservatorio di Trapani. Il sound e l’impronta musicale richiamano uno stile nu-jazz, mentre il nome prende spunto dall’antico popolo degli Elimi, abitanti appartenenti alla zona Occidentale della Sicilia. ENG A night dedicated to the youngest talents of Italian jazz. Lorenzo Simoni alternates sax and composition and is the man that brought the quartet together after years of work with each component. Band Elimi came to be in 2019 thanks to a group of friends and fellow musicians, all students at the Trapani Conservatory in Sicily. Their sound echoes nu jazz, while their name comes from the ancient Elimi tribe of western Sicily.
4 luglio h. 19, Sale Apollinee-Teatro La Fenice
Ancora serata firmata Premio Tomorrow’s Jazz. Heartbeat è il nuovo progetto del batterista Alessandro Rossi spirato dal libro di Bruno Munari Fantasia. Invenzione, creatività e immaginazione nelle comunicazioni visive. La batteria al centro, come voce e filo conduttore di un flusso artistico dove i musicisti (heart) interagiscono con il mondo che ci circonda (beat). Il Vitantonio Gasparro Trio nasce nell’autunno del 2022 da un’idea del vibrafonista jazz e compositore di cui porta il nome. Il trio pone l’attenzione sulle composizioni del band leader e sulla reinterpretazione di standard della tradizione afroamericana.
ENG Heartbeat is a new project by drummer Alessandro Rossi, inspired by architect and designer Bruno Munari’s essay Fantasy. The drums, front and centre, are the voice and the guide of an art flow where performers (the heart) interact with the world around them (beat). Vitantonio Gasparro Trio has been around since 2022. They play variations on the titular character’s composition and African-American jazz standards.
Una serata speciale all’insegna della musica dal vivo, dell’eleganza e dell’ospitalità firmata Starhotels. Il salotto musicale nel cuore della città accoglie il duo Bow & Bellows, formato da Mattia Martorano al violino ed Enzo Moretto alla fisarmonica. Il loro è un incontro raffinato e suggestivo che unisce le tradizioni di due strumenti profondamente evocativi in un intreccio sonoro che oscilla tra popular, jazz e cafè concert. Con un repertorio che spazia tra brani internazionali e composizioni originali, Bow & Bellows accompagna il pubblico in un percorso emotivo e sensoriale tra culture, melodie e suggestioni che attraversano mezzo mondo.
ENG A special night of live music, elegance, and hospitality authored by Starhotels. Duo Bow & Bellows will perform in a delicate, suggestive programme that blends the traditions of two evocative instruments into a sound wavering between pop, jazz, and café-concert. Their repertoire ranges from international hits to original compositions.




17 luglio h. 21, Piazza Mercato-Marghera TAKE 6
Formatisi negli Stati Uniti nel 1980, i Take 6 sono stati elogiati da Quincy Jones e sono oggi considerati il gruppo a cappella più importante al mondo. Sei voci eccezionali si fondono in armonie cristalline, tra ritmi sincopati, arrangiamenti audaci e groove travolgenti, dando vita a un sound unico che unisce gospel, jazz, R&B e pop. Acclamati da leggende come Ray Charles, Stevie Wonder, Brian Wilson, Ella Fitzgerald e Whitney Houston, i Take 6 vantano una carriera costellata di riconoscimenti: 10 Grammy Awards, 3 dischi d’oro, 1 disco di platino, 10 Gospel Music Awards e ben 21 nomination ai Grammy.
ENG The Take 6 got together in 1980, have been appreciated by Quincy Jones, and are now considered one of the best a cappella groups in the world. Six extraordinary voices blend in crystal-clear harmony, and their syncopated rhythms, daring arrangements, and enthusiastic grooves give life to a unique sound. The Take 6 earned ten Grammy Awards, three Gold Records, one Platinum Record, ten Gospel Music Awards, and a further twenty-one Grammy nominations.
18 luglio h. 18, Auditorium Lo Squero, Isola di San Giorgio Maggiore ROGER CORRÊA QUARTETO
Fisarmonicista e compositore nato a Guaíba (Brasile) nel 1998, Corrêa ha iniziato a suonare la fisarmonica diatonica a 6 anni, perfezionandosi nel progetto Fábrica de Gaiteiros di Renato Borghetti. L’incontro con il linguaggio del Choro lo ha avvicinato alla musica di artisti come Pixinguinha e Jobim. Trasferitosi a Florianópolis a 19 anni, ha esplorato nuovi generi come samba e jazz, sviluppando un forte senso dell’improvvisazione. Seguendo la ricerca di nuovi suoni e fusioni tra la musica sudamericana e l’improvvisazione jazz, il quartetto attraversa le influenze e le immagini sonore di Roger fino al momento attuale del suo percorso, attraverso le sue composizioni e reinterpretazioni di opere che ammira.
ENG Roger Corrêa is an accordionist and composer born in Brazil in 1998 who studied at Renato Borghetti’s Fábrica de Gaiteiros. His passion for Choro drew him closer to artists such as Pixinguinha and Jobim to later explore other genres, like samba and jazz, all the while developing a strong sense for improvisation. The quartet will revisit Roger’s influences and sound images and reinterpret his favourite pieces.
25 luglio h. 21.30, Parco Oriana Fallaci-Fiesso d’Artico GIOVANNI FALZONE
Il progetto Freak Machine elabora una serie di brani composti da Giovanni Falzone in forma non convenzionale. L’obbiettivo principale di questo progetto è quello di ripercorrere, secondo la visione personale del leader, momenti esecutivi con strutture ben definite per tutti gli strumenti e momenti di puro interplay, basandosi su vari tipi di approccio all’improvvisazione e sull’utilizzo dell’elettronica. Fanno parte di questo progetto musicisti capaci e attenti con i quali Falzone ha instaurato un rapporto di complicità ed intesa musicale, grazie soprattutto alla loro sensibilità e capacità di recepire ogni piccolo segnale.
ENG Freak Machine elaborates a choice of pieces composed by Giovanni Falzone in unconventional form. Their main goal is to retrace well-defined execution for all instruments and moments of pure interplay based on improvisation and the use of electronics.
2 agosto h. 21, Combo
Nella sede veneziana di Combo, inaugurata a maggio 2019 e più volte partner di Veneto Jazz a cui offre ospitalità culturale e programmatica, gran finale con il trio di Adam Holzman, tastierista newyorkese e storico collaboratore di Miles Davis. Con lui Stefano Olivato (basso e armonica) e Davide Ragazzoni (batteria), in un concerto potente e sofisticato, a chiusura del Moog Summer Workshop, prodotto da Nu Fest, lo storico festival di musica elettronica e contemporanea nato nel 2007 dall’inesauribile passione e capacità di intuizione sperimentale di Marcello Mormile.
ENG Gran finale with the Adam Holzman Trio. Holzman is a New York keyboardist and a veteran Miles Davis collaborator. Together with Stefano Olivato (bass and harmonica) and Davide Ragazzoni (drums), he will run a powerful, sophisticated concert to close the Nu Fest-produced Moog Summer Workshop.
www.venetojazz.com

La nona edizione di Women For Freedom in Jazz conserva l’obiettivo di dare voce alle donne del mondo in situazioni di fragilità, difficoltà, discriminazione, attraverso il sostegno ai progetti dell’organizzazione umanitaria Women For Freedom e prevede un ciclo di tre concerti sulla terrazza Top of The Carlton Sky Lounge dell’Hotel Carlton On The Grand Canal di Venezia il 7, 14 e 21 luglio. Il festival quest’anno incontra la collaborazione dell’Associazione Bacàn, fresca realtà veneta di talenti della musica jazz e contemporanea, e vede protagoniste giovani artiste che si stanno rivelando tra le più originali e raffinate del territorio.
Il progetto “VOCI DI DONNA”, del gruppo Dòni - interamente composto da musiciste - nasce con l’intento di condividere tematiche che toccano il femminile, attraverso brani scritti da grandi artiste del passato ma anche da nuove cantautrici contemporanee, italiane e straniere. La loro performance apre il festival con un’esperienza unica, costruita interamente sul dialogo tra voci, pianoforte, percussioni. Ogni elemento sonoro diventa parte di un filo narrativo sostenuto da arrangiamenti originali e racconti inediti.
Una settimana dopo, spazio a Valentina Fin e Marco Centasso e al loro progetto CU, un nome che richiama il simbolo chimico del rame, eredità del loro primo gruppo, Rame appunto, con cui i due musicisti hanno registrato i loro primi dischi e scritto le prime composizioni originali. Insieme da oltre dieci anni, i due hanno costruito un’intesa musicale consolidata, nata tra le aule del Conservatorio Pedrollo di Vicenza.
Il 21 luglio ecco Sarra Douik, con la musicista tunisina a proporre in solo composizioni inedite e arrangiamenti di brani della tradizione musicale del suo Paese. L’intreccio tra la voce sognante e il dialogo costante con l’oud, strumento a corda della famiglia dei liuti, danno vita ad una vera e propria conversazione musicale che attraversa il Mediterraneo. Sempre attiva in iniziative collaterali alla carriera musicale, dal 2020 Sarra Douik fa parte di Medinea (MEDiterranean INcubator of Emerging Artists), progetto sostenuto dall’Unione Europea con cui ha tenuto vari concerti ad Hammamet (Tunisia), Aix en Provence (Francia), Bruxelles (Belgio) e Ljubljana (Slovenia).
Women For Freedom in Jazz 7, 14, 21 luglio Hotel Carlton On The Grand Canal Fb: Women for Freedom in Jazz

Di questi tempi, pensare ad una ex base missilistica trasformata in luogo di aggregazione e condivisione, con un festival musicale a dare concretezza a questi precetti, fa bene non solo alle orecchie ma anche al cuore, all’anima.
Torna anche nel 2025 Base Festival, il festival che da due anni anima l’ex base missilistica di Peseggia, frazione di Scorzè, con concerti live e dj set, per un programma dedicato alla musica e alla cultura musicale. Quattro le serate previste per quest’anno, dal 28 al 31 agosto, per quello che ormai è un appuntamento fisso, nonché atteso, nel calendario dell’estate veneziana. La formula è collaudata: due palchi, che vedranno succedersi artisti e artiste di diversi generi, un’area food truck, un angolo dedicato alla creatività con realtà locali. Il tutto nella cornice dell’ex base missilistica di Peseggia, dove ampi spazi verdi e murales colorati raccontano oggi una storia di trasformazione, in un contesto nato per motivi diametralmente opposti e oggi più che mai al centro della cronaca. La lineup completa non è ancora stata rivelata, ma il nome già annunciato lascia intendere come l’intenzione degli organizzatori, l’Associazione Culturale Musica Base, sia quella di alzare ulteriormente il livello rispetto alle due precedenti edizioni. È proprio la serata inaugurale a vedere sul palco il progetto più indecifrabile nel panorama della musica indipendente italiano: Pop X, guidato dal trentino Davide Panizza. Non è facile descrivere Pop X a chi non conosce il progetto, per il semplice fatto che “niente è come Pop X”: cantautorato elettronico, spesso demenziale e psichedelico, a tratti romantico, talvolta pop, ma sempre fedele alla sua anima decisamente punk. Quella di Scorzè è una delle tappe della tournée estiva che celebra i vent’anni del progetto musicale. I concerti di Pop X sono un’esperienza unica che negli anni è rimasta intatta e radicata, fatta di ritmi incalzanti e atteggiamenti folli e nonsense, ma aperta a convivere con nuove scoperte e nuovi pubblici come quello del Base Festival. «Nelle scorse settimane – spiega Andrea Scattolin, Presidente dell’Associazione Musica Base – Pop X è stato al MI AMI Festival di Milano e al Poplar UTOPIA nella splendida cornice del MART di Rovereto: riuscire ad inserirci fra questi palcoscenici è davvero un onore per noi, riconoscimento del lavoro che stiamo facendo».
A spectacular journey throughout the summer, including night events, national premieres and original creations. A dense program of dance, theater, music, contemporary circus that will inhabit theaters, art venues, landscapes of Bassano del Grappa and the Venetian Foothills, from July to September 2025.
Among the guest artists: Silvia Gribaudi 10/07, Lella Costa 11/07, Paolo Fresu+Uri Caine 12/07, Giuliana Musso 13/07, Orchestra Di Padova e del Veneto 14/07, Babilonia Teatri 17/07, Tom Cassani 18/07, Marco D’Agostin 19/07, Christos Papadopoulos 24/07, Elio Germano+Teho Teardo 25/07, Adriano Bolognino 31/07, Populous 02/08, Ascanio Celestini 05/08, Stefano Bollani 06/08, Andrea Pennacchi+Nicola Bressi 07/08, Marcos Morau/La Veronal 08/08, Marco Paolini 15/09



fu ragazzo pop
L’età adulta di un riuscito narratore
C’è una generazione, o più di una, che è cresciuta con la sua voce. Dapprima allegra, spensierata, quasi ingenua. Poi via via più intensa, introspettiva, matura. Cesare Cremonini è oggi uno degli artisti italiani più completi, capaci di coniugare successo popolare e qualità musicale, leggerezza radiofonica e profondità autoriale. Bolognese, classe 1980, irrompe sulla scena musicale a soli 19 anni come frontman dei Lunapop, una delle meteore più luminose del pop italiano. Il loro album …Squérez? è un fenomeno generazionale: “50 Special”, “Qualcosa di grande”, “Un giorno migliore” diventano inni di un’Italia giovane e ottimista, con uno stile scanzonato e orecchiabile che conquista classifiche e cuori. Ma proprio quando avrebbe potuto restare intrappolato nel ruolo di eterno ragazzo prodigio, Cremonini sceglie la strada più difficile: quella dell’evoluzione.
Nel 2002 pubblica Bagus, il suo primo album da solista. È l’inizio di un percorso personale, artistico e stilistico che si distaccherà sempre di più dal pop adolescenziale degli esordi per abbracciare una scrittura più adulta e ricercata. Album dopo album affina un linguaggio musicale che mescola Beatles, Battisti, Bowie, senza mai risultare derivativo. Al contrario, Cremonini costruisce un suono e una poetica riconoscibili, capaci di parlare con sincerità e leggerezza di amore, tempo, amicizia, solitudine. Uno dei suoi punti di forza è proprio la scrittura: è un autore che cura le parole con sensibilità quasi letteraria. Ma Cremonini è anche un grande performer. I suoi concerti, sempre più ambiziosi, hanno raggiunto vette spettacolari. Sul palco alterna momenti di
pura energia a intermezzi più intimi, in cui il pubblico diventa parte integrante di un racconto collettivo.
Centrale nella sua poetica è Bologna, città che abita da sempre il suo immaginario. Non solo come luogo fisico, ma come spazio mentale ed emotivo. In molte sue canzoni Bologna compare come scenario, ma anche come simbolo di un tempo che passa, di una giovinezza che muta, di un’umanità che cerca risposte.
Negli anni Cremonini è riuscito in un’impresa tutt’altro che scontata: farsi amare da un pubblico trasversale mantenendo intatta la propria integrità e sempre viva la sua curiosità. Non ha mai inseguito mode, rinnovandosi sì ma senza mai perdere i suoi tratti identitari di sempre. Anche nei momenti in cui la scena musicale italiana sembrava orientata altrove lui ha proseguito per la sua strada, con coerenza quasi ostinata. E il tempo gli ha dato ragione.
Il suo ultimo progetto, Cremonini 2C2C The Best Of, è molto più di una raccolta: è una dichiarazione poetica, un racconto in musica che ripercorre vent’anni di carriera e guarda al futuro.
Cremonini rappresenta una rara forma di continuità all’interno di un panorama musicale frammentato e voracemente rapido. Un artista che è cresciuto con il suo pubblico e che ha saputo crescere anche per il suo pubblico, offrendo canzoni che parlano all’anima senza mai perdere contatto con la realtà.
Oggi, guardando con occhio più attento alla sua carriera, viene naturale pensare che non sia semplicemente un cantautore pop. È un narratore del quotidiano, un interprete sincero delle emozioni contemporanee, capace di trovare poesia nei dettagli della vita. E, forse, è proprio questo il segreto del suo successo duraturo: saper raccontare ciò che proviamo, anche quando non abbiamo le parole giuste per farlo. Alberto Marzari

Le due vite di un re matto Nel vortice multisensoriale di Marco Mengoni
Marco Mengoni è uno degli artisti più significativi e influenti della musica pop italiana contemporanea. Nato a Ronciglione il 25 dicembre 1988, ha saputo conquistare pubblico e critica grazie alla sua voce potente, al suo carisma sul palco e a un’evoluzione artistica costante. Il grande pubblico inizia a conoscerlo nel 2009, quando vince la terza edizione di X Factor. Nel 2010 esce il suo primo album Re matto, che scala subito le classifiche italiane. Mengoni è un artista camaleontico, capace di fondere pop, soul, rock ed elettronica mantenendo sempre una propria identità riconoscibile. La sua voce gli consente di affrontare repertori diversificati con consumata naturalezza.
Uno dei momenti chiave della sua carriera è sicuramente la vittoria al Festival di Sanremo 2013 con L’essenziale, brano diventato un classico della musica italiana. Questo successo lo porta anche a rappresentare l’Italia all’Eurovision Song Contest nello stesso anno, consolidando la sua popolarità internazionale.
Mengoni non è solo un cantante, ma un vero e proprio autore e sperimentatore. Con il progetto Parole in circolo e il successivo Le cose che non ho si conferma artista maturo, capace di raccontare la complessità dei sentimenti e del nostro tempo attraverso testi intensi e arrangiamenti ricercati.
Negli anni successivi prosegue il suo percorso artistico con una nuova consapevolezza, approfondendo tematiche legate all’identità, alla libertà personale e al rapporto con la società. Nel 2021 lancia il progetto Materia, articolato in tre album: Terra, Pelle e Prisma Questo trittico rappresenta un viaggio musicale e personale in cui Mengoni esplora le sue radici, la sua apertura al mondo e la complessità del suo essere.
Nel 2023 torna trionfalmente sul palco dell’Ariston, vincendo nuovamente il Festival di Sanremo con Due vite, un brano introspettivo che parla di amore, distanza e riconciliazione. Questa seconda vittoria lo consacra definitivamente come uno dei grandi cantautori italiani contemporanei. La sua performance all’Eurovision, di nuovo in rappresentanza dell’Italia, è accolta con entusiasmo dal pubblico europeo, rafforzando la sua dimensione internazionale. Oltre al talento musicale, Marco Mengoni è noto per il suo impegno sociale. Ha sempre promosso messaggi di inclusività, rispetto e libertà d’espressione, diventando una voce importante anche fuori dal palco. Ha parlato apertamente del valore della diversità, sostenendo la comunità LGBTQ+ e invitando il pubblico a superare i pregiudizi. Il suo stile raffinato e la cura estetica nei videoclip e nei concerti rivelano anche una forte sensibilità artistica e visiva. I suoi tour sono veri e propri spettacoli multisensoriali, dove la musica si fonde con scenografie suggestive e una narrazione emozionale che coinvolge totalmente il pubblico. Alberto Marzari
jazz contemporaneo italiano ed internazionale, mentre la musica


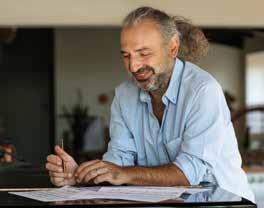
12 luglio h. 21.20, Teatro al Castello “Tito Gobbi” PAOLO
Dal fortunatissimo incontro tra due grandi personalità del jazz contemporaneo, Paolo Fresu e Uri Caine, è nato il progetto discografico Improvvisi, fulcro di questo strepitoso live. Si tratta di una delle liaison più interessanti allestite nel mondo del jazz degli ultimi anni: il timbro malinconico e onirico della tromba lirica e sognante di Fresu si sposa magnificamente con il pianismo di Uri Caine, fatto di mille citazioni, dal blues, al jazz più mainstream all’avanguardia, fino alla musica classica. Insieme danno vita a un universo di pura poesia, tra citazioni, virtuose fusioni, intensità straordinaria, in un incontro che si nutre con delicatezza della tradizione e del vissuto, offrendo immagini inedite e indelebili. Improvvisi non è solo il titolo del concerto, ma rappresenta l’essenza stessa della loro esibizione, grazie alla capacità dei due artisti di creare un dialogo musicale irripetibile e magnetico.
25 luglio h. 21.20 Teatro al Castello “Tito Gobbi”
Elio Germano e Teho Teardo portano in scena Il sogno di una cosa di Pier Paolo Pasolini, intrecciando parole e musica. Concepito e scritto tra il 1948 e il 1949, viene pubblicato solamente nel 1962 e rappresenta paradossalmente il romanzo d’esordio e di epilogo della stagione narrativa di Pasolini. Racconta la storia di tre giovani friulani alla soglia dei vent’anni che affrontano il mondo e vivono la loro breve giovinezza: la povertà delle origini, le lotte contadine, l’emigrazione, ma anche l’amicizia, l’amore, la solidarietà, fino alle illusioni perdute. Al centro della storia stanno persone che, stremate dalla povertà, sono partite dall’Italia del secondo dopoguerra verso la Jugoslavia, con la speranza di vivere dignitosamente. La voce narrante di Elio Germano e la sua corporeità, diventano strumenti risonanti parole e significati amplificati dalla tessitura sonora di Teho Teardo. I due artisti insieme creano, con sensibilità e intensità, un’esperienza al tempo stesso visiva, sonora ed emozionale.
6 agosto h. 21, Villa Dolfin-Boldù (Rosà)
Talento ineguagliabile del pianoforte, Stefano Bollani è compositore e interprete dalla tecnica inappuntabile, dalla sensibilità finissima e dalla verve incontenibile. Per lui la musica è un gioco divertente da reinventare di volta in volta, giocando in modo sempre diverso, improvvisando sul momento con diverse band e con grandi artisti come Richard Galliano, Bill Frisell, Paul Motian, Chick Corea, Hamilton de Holanda, Caetano Veloso, Hector Zazou, Chucho Valdés e il suo mentore, Enrico Rava. Ma l’essenza del suo umorismo, del suo spirito gioioso e della sua versatilità nel fare musica si esprime al meglio quando si esibisce da solo. Non è un caso se i suoi concerti più popolari sono quelli in Piano solo, dove è completamente libero: le sue qualità di intrattenitore hanno un ruolo centrale e il suo pubblico è maggiormente coinvolto. Bollani accoglie l’umore del pubblico, adora intrattenere e sorprendere gli spettatori, come anche sé stesso.
www.operaestate.it



Allora, la notizia è questa: i CCCP – Fedeli alla linea, la band di rock più importante in Italia attiva dal 1982 fino al 1990, e riunitasi l’anno scorso a regalare ai fans un bouquet di fiori fatto di una mostra sulla loro carriera ospitata a Reggio Emilia, un disco immortalante il loro primo concerto a Reggio Emilia nel giugno del 1983 e un tour estivo che, sia pure di breve durata, data l’età dei componenti, aveva riempito le cosiddette locations, hanno deciso di prolungare l’agonia della fine regalandoci un supplemento di tour anche per l’estate del 2025. Il tour prenderà il via il 30 giugno non più, come originariamente annunciato, al Circo Massimo di Roma, visto che la data è stata spostata alla cavea dell’Auditorium di Renzo Piano. Proseguirà poi a luglio con altre sei date, una di queste il 18 del mese verrà ospitata in Villa Contarini a Piazzola sul Brenta. Chiusura il 30 luglio, al Teatro Antico di Taormina. I comunicati degli uffici stampa assicurano che si tratta sul serio del loro ultimo tour, che rappresenterà così un vero e proprio evento storico per la musica alternativa italiana. La mia prima reazione quando ho letto la notizia è una parafrasi di quella definizione dell’opera lirica fatta da George Bernard Shaw (ci pare di ricordare): “l’opera lirica è quella cosa in cui il tenore, quando viene pugnalato a morte, si mette a cantare”. Per la band di Giovanni Lindo Ferretti ci sarebbe venuto in mente questo: i CCCP sono quel gruppo che, quando non ha più niente da dire, si mette a fare un tour. Ma in realtà la reazione di un vecchio aficionado dei CCCP quale sono stato, insieme a milioni di altri della mia generazione di baby boomers e di quella successiva della Generation X (se andiamo a tirare fuori anche i CSI, che smisero agli inizi del Duemila), non può e non deve essere questa. Né può essere l’affermazione ispirata
alla scuola del liberalismo economico di stile reaganiano: non fanno niente di illegale, coprono una domanda di mercato e di bellezza anche, se il tour finirà a Taormina. Sgomberiamo pure il campo dalle critiche da odiatori seriali sul fatto di guadagnare gli ultimi soldini da mettere in banca, perché sono accuse insultanti per chi come loro ha svelato, come angeli benjaminiani, ai propri infiniti adoratori di quante macerie fosse costellato quello che chiamavamo Progresso. E se è vero che nel marzo di quest’anno, all’ennesima reunion nel teatro reggiano, avevano assicurato che quella sarebbe stata davvero la fine vera, perché ‘tutto finiva là dove tutto era cominciato’, non vorremo mica tacciarli per questo, solo per questo ora di incoerenza, vero? «Mi contraddico? Contengo moltitudini» diceva Whitman. E davvero i CCCP hanno contenuto moltitudini: di musica magnifica, ovvio, di improvvisi svelamenti, di insegnamenti, soprattutto.
No, la risposta è un’altra, e va trovata secondo me in una specifica e meravigliosa branca del porno femdom, che si chiama edging (stare sul bordo), in cui lo schiavo viene costretto dalla padrona a godere in attesa della fine che però non arriva mai, perché la padrona interrompe la titillazione non appena vede che lo schiavo sta per esplodere. Giochi di potere, controllo del piacere, nobile arte in cui il sottomesso sperimenta l’arte del concedersi ad un’altra persona che ne decide le sorti.
Ecco, Lindo Ferretti, è lui la nostra mistress adorata, che allontana da noi schiavi la fine banalissima della conclusione del piacere e la protrae perché ci vuole regalare un’altra forma di piacere. Più sottile, più raffinata, in cui il dominio sia davvero totale perché sta nel rinvio del piacere. E allora, Lindo, per favore: inventatevi un tour anche l’anno prossimo, l’altro anno ancora, e quello dopo ancora, così, fino alla fine vera, fino alla notte dei tempi, fino alla dissoluzione del Tempo che così ferocemente hai cantato… F.D.S.

Non è certo la prima volta che gli Who annunciano il loro tour d’addio, ma questa sembra proprio essere quella definitiva. Roger Daltrey, da poco Sir per il suo impegno con il Teenage Cancer Trust, e Pete Townshend hanno entrambi svoltato gli 80, e se per Roger ci sono problemi di vista e udito, Pete è alle prese con la depressione ricorrente e comunque le fatiche di un tour non le ha mai amate molto. Si rischia quindi di vedere due dinosauri acciaccati sul palco? Niente di più sbagliato: magari Pete le chitarre non le sfascia e non zompa di qua e di là e magari Roger fa roteare il microfono un po’ più lentamente, ma gli Who nel 2025 sono ancora una macchina da guerra live. Basta guardare i video del concerto tenuto in marzo alla Royal Albert Hall di Londra: fenomenali! Per presenza, carisma, credibilità, mestiere, tecnica fanno ancora mangiare la polvere a qualsiasi next big thing Il tour prende il nome da The song is over, pezzo del 1971 da Who’s Next e partirà proprio con i due appuntamenti italiani: all’Anfiteatro Camerini di Piazzola sul Brenta il 20 luglio e al Parco della Musica di Milano due giorni dopo, per poi proseguire con date esclusivamente nel Nord America.
Archiviata la querelle Zack Starkey (licenziato, anzi no…anzi sì!), la line up vedrà alla batteria Scott Devours, fedelissimo di Townshend, ed al basso Jon Button. Sezione ritmica tutta U.S.A., dunque, per la band forse più british in assoluto. Difficile fare meglio di Starkey e Pino Palladino però, vedremo.
Non hanno prodotto molto gli Who, 12 album in 60 anni di carriera, ma hanno attraversato i decenni indenni da tentazioni modaiole o
commerciali. Da idoli mod (da questo non si affrancheranno mai: once a mod, always a mod ) alle opere rock, al cinema ( Quadrophenia è da poco diventato anche un balletto), fino a diventare icona, con il bullseye della R.A.F. a farsi marchio quanto la linguaccia e la mela. Hanno perso prima Keith Moon e poi John Entwistle, ma hanno saputo resistere alle incertezze, proseguendo inscalfibili fino ad oggi con saggezza, prendendosi i tempi giusti e lo spazio per i progetti personali, senza cedere un grammo di credibilità e di affetto da parte dei fan anche grazie proprio alla loro formidabile potenza sul palcoscenico. La voce di Roger è quella della working class inglese: forte, orgogliosa, testarda, inconfondibile. Lo stile di Pete, non il più bravo, non il più veloce, ma immediatamente riconoscibile nei suoi riff taglienti, a volte rabbiosi, a volte incredibilmente immaginifici, ha ispirato generazioni di chitarristi. Un rapporto che è sempre stato piuttosto burrascoso tra i due, con Roger, lavoratore maniacale e vero cardine del gruppo, che mal sopportava gli eccessi del chitarrista (figurarsi quelli di Keith Moon) e Pete, geniale creativo, che invece ne soffriva la personalità forte e decisa, al limite della soggezione. Solo in anni recenti il legame fra loro si è fatto quasi fraterno. Ci resterà comunque Sir Roger, che di smettere del tutto proprio non ha intenzione, del resto lo ha sempre detto: Pete ha i diritti, io devo cantare per guadagnare (ed è ben nota la sua particolare “parsimonia”). Non sarà un evento celebrativo, non sarà una tribute band di loro stessi, non sarà revival: gli Who faranno quello che fanno da sempre, vale a dire un grande concerto rock. Quanto dichiarato in My Generation nel 1965, “spero di morire prima di diventare vecchio”, vale ancora: questi due, vecchi, non intendono proprio diventarlo mai. Sergio Collavini

«Il nostro obiettivo è sempre stato quello di fare cultura musicale, perché ognuno di voi indagasse nell’ascolto e avesse una fame profonda della genesi sonora».
Ecco la dichiarazione d’intenti che campeggia in bella mostra nel sito web di Sexto ‘Nplugged, festival musicale arrivato alla ventesima edizione in forma smagliante e senza mai essere venuti meno all’incipit di cui sopra.
A ben vedere, ogni concerto della storica manifestazione musicale potrebbe essere a buon titolo definito “indagine dell’ascolto”, proprio per l’ostinata volontà di coprire sentieri altri rispetto a quelli della produzione commerciale squisitamente pop, non andando in cerca di consensi facili seguendo i nomi del momento ma segnando piuttosto una strada precisa, studiata, figlia della più vorace curiosità musicale. L’edizione di quest’anno, la ventesima appunto, non tradisce di sicuro le attese. Il post-punk dei bielorussi Molcˇat Doma (Egor Škutko, Roman Komogorcev e Pavel Kozlov) allaccia in maniera esemplare suoni del passato con echi contemporanei, come il pubblico del 3 luglio avrà modo di verificare di persona. Per una volta, c’è da ringraziare i social, lo schizofrenico TikTok nello specifico: al potentissimo e abusato mezzo di diffusione si deve infatti la circolazione virale del loro pezzo Sudno, compreso nell’album E taži, comparso in centinaia di migliaia di video e che avrete di sicuro sentito anche voi che leggete. I Black Country, New Road hanno metabolizzato l’abbandono da parte del cantante e chitarrista Isaac Wood spostando i propri equilibri musicali verso sonorità più barocche e folk, ma conservando intatta tutta l’energia sprigionata dai loro live. In Piazza Castello il 4 luglio portano Forever Howlong, album pubblicato ad aprile, assieme a pezzi provenienti dal precedente lavoro del 2022, Ants From Up There, elogiato dalla critica e adorato dal pubblico. Il 5 e 6 luglio l’energia del live è convogliata verso lidi autoriflessivi, intimi, non per questo meno potenti e travolgenti. Prima con Anna von Hausswolff e il suo rock gotico, impareggiabile nell’ipnotizzare gli spettatori e incarnazione vivente di quell’indagine musicale di cui sopra, uno stile che con Ceremony del 2012 si è imposto in tutta la sua carica emotiva spiazzante, che induce gli ascoltatori ad accettare il mistero e l’ambiguità. Poi con i Baustelle, capaci di stare sempre lì, sul crinale che si affaccia sul pop d’autore unito all’elettronica più raffinata, guardando tutto dall’alto, dove gli stupidi confini tracciati con il righello semplicemente non esistono. Davide Carbone
Sexto ‘Nplugged
3-6 luglio Piazza Castello-Sesto al Reghena sextonplugged.it

Da quattordici anni, ormai, l’inizio dell’estate coincide con il coronamento delle fatiche invernali: si alza il sipario sulla nuova edizione di Tener-a-mente e l’emozione si rinnova sempre identica. Gli spazi rimangono quelli a cui siamo abituati, ma che stupiscono ogni volta, sterminati come l’orizzonte su cui l’occhio si poggia dai gradoni in marmo rosso voluti da D’Annunzio, uno che all’estetica badava eccome.
L’Anfiteatro del Vittoriale ospita un’edizione 2025 che porta in Italia gli artisti migliori, poche discussioni a riguardo, senza fossilizzarsi su un unico genere musicale ma anzi cercando di scandagliare il più possibile gli anfratti sonici di un panorama tutto da scoprire.
Giugno è passato con gli Hermanos Gutierrez e The The, questi ultimi assenti dalle scene dal 2018 e capitanati da Matt Johnson, ad accompagnare la pubblicazione di Ensoulment, il primo disco di inediti a quasi 25 anni di distanza da NakedSelf. Luglio è da stropicciarsi gli occhi, con 12 concerti in 20 giorni che vedono alternarsi in scena nomi di primo, primissimo piano, in alcuni casi assenti dalla nostra Penisola da diversi anni e determinati nello scegliere Gardone Riviera come luogo di ritorno in grande stile.
Marcus King è alla sua prima volta al Vittoriale, il 5 luglio, per lui garantisce tra gli altri Rick Rubin, leggendario produttore che ha lavorato negli anni con purosangue del calibro di Adele e Johnny Cash.
Dal 13 al 17 del mese, un poker capace di mettere al tappeto ogni altra rassegna non solo in Italia: Bill Callahan, Brandi Carlile, Anastacia e Kamasi Washington spaziano tra indie, folk-rock, pop e jazz d’avanguardia per accompagnare poi l’uditorio a due appuntamenti andati sold-out in scioltezza, vale a dire il concerto di Morrissey il 23 luglio e quello di Mika il giorno successivo. Tra le voci più influenti del panorama contemporaneo, Morrissey ha segnato la storia della musica prima con The Smiths e poi con una carriera solista che conta tredici album in studio e una serie di successi internazionali. Considerato uno dei più grandi parolieri della sua generazione, a Gardone arriva con un concerto che ha fatto storia ancora prima di andare in scena.
Edizione 2025 archiviata? Nemmeno per sogno, dal 25 al 29 luglio ecco una doppia data di Antonello Venditti (26 e 29) e i concerti di Capossela (25) e Kenny Wayne Shepherd (27), il primo con un progetto dedicato alla forza ammaliatrice delle sirene, il secondo all’unica possibilità per questa estate di vederlo dal vivo in Italia. Daniele Pennacchi
Tener-a-mente. Festival del Vittoriale Fino 29 luglio Anfiteatro del Vittoriale-Gardone Riviera www.anfiteatrodelvittoriale.it

Quando Winston Rodney (Saint Ann, Jamaica, 1945), in arte Burning Spear, sale sul palco, non si tratta di un semplice concerto: è un rituale. Le prime note di Slavery Days scuotono l’anima: «Do you remember the days of slavery?» non è una semplice domanda, ma un richiamo alla memoria collettiva. In un tempo come il presente, violentato e oscurato da guerre lontane e vicine – Palestina, Iran, Israele – e da un’Europa sempre più chiusa e repressiva, quella domanda torna a pesare, più urgente che mai. Stiamo davvero vivendo giorni da Slavery Days : un presente di conflitti, paure, oppressioni. E in questo scenario inquietante, la voce di Burning Spear si fa ancora più necessaria, potente.
Il tour mondiale 2025 lo porta anche all’Isola dell’Unione, nell’ambito del Sea Music Festival di Chioggia, il 12 agosto. Sono passati trent’anni dall’ultima sua apparizione in zona: un ritorno storico, atteso e inatteso al tempo stesso. Lo farà senza effetti speciali, né ammiccamenti, lo conosciamo: sul palco lui solo, affiancato dalla sua immancabile band, e una scansione spirituale che permane nell’aria e nel cuore molto dopo l’ultimo accordo.
Brani come Marcus Garvey, Jah Is Real e No Destroyer sono inni alla ribellione interiore, alla consapevolezza del sé, costruiti su ritmi profondi e fiati elegiaci – colonne sonore di una comunità africana disperata ma ostinatamente orgogliosa. Vincitore di due Grammy® per Calling Rastafari (2000) e Jah Is Real (2009), e nominato per No Destroyer (2023), Spear ha mantenuto intatta la propria integrità artistica e spirituale.
Elemento fondamentale delle sue performance è la potente sezione fiati, il cosiddetto “burning brass”, composta da musicisti di alto livello che lo accompagnano da anni e contribuiscono a rendere ogni live un’esperienza intensa e coinvolgente. Per la data di Chioggia, l’organizzazione – firmata anche da Steve Giant di Rastasnob Italian Reggae Magazine – sta definendo la lineup completa della band, ma è certo che la sezione fiati sarà protagonista, amplificando la forza rituale del concerto.
La sua voce è rimasta la stessa: profonda, circolare, ipnotica. Sentirlo dal vivo oggi significa attraversare la storia del reggae nella sua forma più potente, senza mediazioni, e farlo in un tempo che sembrava ormai chiuso. È una possibilità rara, che pochi artisti ancora viventi possono offrire con questa intensità. Il concerto si inserisce all’interno del Sea Music Festival, in programma dall’8 al 18 agosto sull’Isola dell’Unione. Undici serate con artisti italiani e internazionali, tra cui Edoardo Bennato (16 agosto) e Steve Aoki (18 agosto). Ma con il leggendario Burning è come se, per una notte, si aprisse un varco nel tempo. Un’oasi nel deserto. E da quell’oasi risuonasse il battito profondo, vitale, della libertà. Chiara Sciascia
Sea Music Festival | Burning Spear 12 agosto Isola dell’Unione, Chioggia www.seamusicfestival.it

In principio, fu Alanis. Il 22 giugno scorso è infatti toccato alla formidabile rocker canadese aprire l’edizione 2025 dei concerti estivi sul prato di Villa Manin a Codroipo, spazio che ha consegnato agli annali memorabili live tra cui Foo Fighters e Radiohead. Diecimila persone hanno riaccolto Alanis Morissette in Italia in un’ora e mezza di musica che ha restituito al pubblico un’artista che conserva intatta tutta la potenza irriverente che negli anni ‘90 le fece intraprendere una carriera inimitabile, fatta tra le altre cose di 60 milioni di dischi venduti e sette Grammy. Con un ospite d’esordio di questo calibro, mantenere lo standard di qualità all’altezza per il resto della rassegna è una sfida quasi proibitiva. Sfida che tuttavia gli organizzatori di Villa Manin Estate possono dire a buon titolo di aver vinto, in questa estate 2025 ad alto tasso musicale.
Una programmazione che sembra cronologicamente divisa per settori, come diverse correnti che ci si trova ad attraversare immergendosi in esibizioni live abbracciate dalle barchesse porticate della splendida Villa che fu dimora dell’ultimo doge di Venezia, Ludovico Manin. Dal 2 al 5 luglio largo a Irama, Ghali e Anna ed al loro pubblico anagraficamente ben connotato ma non troppo, per poi proseguire con una tappa del tour europeo della signora del rock italiana Gianna Nannini (6) e il concerto di Sting il 9, grande appuntamento di GO!2025&Friends, cartellone di eventi che affianca la rassegna ideata e promossa dalla Regione Friuli Venezia Giulia in occasione di Nova Gorica-Gorizia Capitale europea della Cultura. In questo programma votato all’eccellenza ecco un’incursione nella musica classica, il 20 luglio, con una leggenda del podio come Riccardo Muti alla guida dei 130 elementi dell’Orchestra giovanile Luigi Cherubini, fondata nel 2004 su sua iniziativa e composta da straordinari strumentisti di età compresa tra i 18 e i 30 anni.
Il 21 luglio, Giorgia porta a Codroipo l’unico concerto nel nordest del tour Come saprei Live 2025: una voce che tutto il mondo conosce e ci invidia, potente e racchiusa nell’eleganza di un’artista che all’ultimo Sanremo si è confermata semplicemente di un’altra categoria, fuori gara. D.C.
www.villamanin.it

Poche rassegne hanno vissuto negli ultimi anni una crescita programmatica esponenziale come quella registrata dal Marostica Summer Festival. Anzi, nel tracciare una mappa sonica degli eventi musicali live del Nordest e non solo non ho potuto fare a meno di notare come la lista di illustri desaparecidos si allunghi ogni anno, vittime di tagli al bilancio magari dolorosi ma irrinunciabili, a prescindere dai colori delle amministrazioni di turno. Pochi gruppi, poi, hanno significato per la storia della musica quello che hanno significato negli ultimi quarant’anni i Dream Theater, band simbolo del progressive metal internazionale che a Marostica apre il cartellone il 30 giugno. James LaBrie è ancora al microfono e conduce i fedeli John Petrucci, Jordan Rudess, John Myung e il grande figliol prodigo Mike Portnoy alla ricerca dei confini del metal, per superarli di slancio. Sembra poi che la Piazza degli Scacchi abbia quest’anno un conto aperto con la leggenda; se seguite la musica jazz o la disco music esistono ottime possibilità che abbiate di sicuro ascoltato e ballato su note concepite da questo signore: il 9 luglio arriva a Marostica Nile Rodgers & The Chic, icona che ha segnato intere generazioni con successi indimenticabili e una produzione musicale capace di attraversare epoche e stili. Grazie a successi senza tempo come Le Freak, Good Times e le indimenticabili collaborazioni con artisti del calibro di David Bowie ( Let’s Dance ), Madonna ( Like A Virgin ), Diana Ross ( I’m Coming Out) e Daft Punk ( Get Lucky), Rodgers è riuscito a vendere oltre 500 milioni di album in tutto il mondo. Inserito nella Rock & Roll Hall of Fame e nella Songwriters Hall of Fame, è anche un simbolo di impegno sociale e culturale, insignito di prestigiosi riconoscimenti come il Grammy Lifetime Achievement Award e il più recente World Economic Forum’s Crystal Award per il suo straordinario contributo alla costruzione di un mondo più inclusivo e pacifico attraverso la musica. Dai classici che hanno segnato l’epoca della disco music ai suoni moderni e innovativi delle sue collaborazioni più recenti con Beyoncé e Daft Punk, ogni performance di Nile Rodgers & CHIC è un evento travolgente, una festa collettiva che unisce il pubblico in un indimenticabile viaggio musicale. Due giorni più tardi, la Piazza accoglie un’altra band che ha fatto la storia del rock intriso di influenze, ovvero Skin e i suoi Skunk Anansie, caso più unico che raro di compagine che dopo una pausa di riflessione durata dal 2001 al 2009 ha saputo mettere da parte isterismi e protagonismi facendo vincere la voglia di fare grande musica insieme. I fan, sentitamente ringraziano. Davide Carbone

Rock, rap, pop, indie, trap, post-punk, ska, alternative. Per quale motivo precludersi qualcosa? Chi non si è mai fatto stupire dalla musica almeno una volta nella vita, solo per aver messo un orecchio fuori dalla propria comfort zone, magari scoprendo un genere di cui non ha più potuto fare a meno? Personalmente di casi ne conosco molti, uno dei tanti riguarda anche il sottoscritto, in più di un’occasione oltretutto.
In un’epoca in cui fa tendenza mescolare i generi, l’AMA Music Festival, tra luglio e agosto al Parco di Villa Negri a Romano d’Ezzelino, può affermare a pieno titolo di essere stato un precursore, fin dai primi anni di esperienza, quando la rassegna si svolgeva ad Asolo e raccoglieva il meglio della scena indipendente italiana (Calcutta e Cosmo nel 2016, Brunori Sas e Gazzelle nel 2017, giusto per fare qualche nome).
In questo 2025 che segna il decimo compleanno di AMA, ci troviamo di fronte ad un programma che di festival ne potrebbe allestire comodamente tre o quattro, non solo per quantità dell’offerta, quanto per qualità. Quest’anno sembra essere abitudine diffusa dell’estate in musica quella di partire forte, per mettere subito le cose in chiaro e non custodire gelosamente i pezzi da novanta, da

offrire al pubblico a rilascio prolungato: il 15 luglio per la preview ecco allora il duo americano dei Black Keys formato da Dan Auerbach e Patrick Carney, in una serata che assieme a loro vede protagonisti pure i Jet, band australiana cresciuta a pane e rock classico anni ‘60 e ‘70.
Il giorno dopo, ecco i Queens of the Stone Age, alfieri dello stoner rock in attività da trent’anni: andate ad un loro concerto e scoprirete subito il perché di tanta longevità. Dopo un’anteprima del genere, tornare a metà agosto per la succosa seconda parte di festival sarà la cosa più naturale da fare, magari già dal 19 quando sul palco arrivano i Vampire Weekend, usciti ad aprile 2024 con il loro quinto album in studio, Only God Was Above Us.
Per non smentire quanto scritto nelle prime righe, ecco servita una piccola (ma nemmeno tanto) incursione in territori ‘altri’ rispetto all’indie rock con la tripletta Anna-Capo Plaza-Marte ed i loro rap variegati urban il 21 agosto, in un programma che appena cinque giorni dopo porta a Romano quella che molti considerano la massima espressione italiana di genere: Gionata Boschetti, in arte Sfera Ebbasta.
Il 23 agosto la ribalta se la prendono i Prodigy, che portano avanti nel ricordo del compianto Keith Flint la rivoluzione elettronica iniziata alla fine degli anni ‘90, quando il loro The Fat of the Land cambiò per sempre i connotati della musica beat.
E proprio quando le vostre orecchie si sono abituate a queste sonorità lisergiche, ecco che AMA mescola di nuovo le carte affidando la data di chiusura il 28 agosto al rock alternativo di Franz Ferdinand e Stereophonics. Davide Carbone

Il No Borders Music Festival, al di là di ogni retorica, è più di un Festival. È un progetto di vita che coinvolge di riflesso anche la musica, se così vogliamo definirlo.
Un evento che mette in correlazione i grandi live con gli aspetti culturali e naturalistici di alcune delle location di più grande prestigio del nostro territorio: il comprensorio dei Laghi di Fusine, l’Altopiano del Montasio, la Conca Prevala del Canin e la Val Bartolo.
Gli organizzatori hanno optato per concerti diurni, allestendo isole ecologiche per la gestione della raccolta differenziata, prevedendo un accesso alle location esclusivamente a piedi o in bicicletta, prediligendo una comunicazione digitale e gadget ecosostenibili e promuovendo un programma di attività collaterali atto a valorizzare l’offerta naturalistica e culturale locale, oltre a sensibilizzare il pubblico rispetto al tema della sostenibilità.
Aggiungete a tutto questo, un calendario musicale di primissimo ordine: quello del 19 luglio è un attesissimo ritorno per la trentesima edizione di No Borders Music Festival, con Ben Harper & The Innocent Criminals, tra i principali cantautori della sua generazione, oltre che uno dei più versatili e coraggiosi, che lavora senza problemi attraversando diversi generi, dal pop, reggae e soul, al blues, rock, funk e folk.
Il giorno dopo tocca a Mika, seguito da Jovanotti il 26 luglio, artista che non poteva mancare visto l’impegno e l’adesione programmatica a tutti gli stimoli ambientalisti di cui la rassegna si fa promotrice. La particolarità di questa data? Alla chiusura del tour dei PalaJova, sarà il primo concerto riservato esclusivamente a 5000 ciclisti. Per questa occasione, il pubblico potrà raggiungere la location solo in bicicletta, scegliendo tra itinerari semplici, intermedi o articolati, proposti dagli organizzatori.
Visto da poco al Parco Bissuola di Mestre, Lucio Corsi il 27 luglio è protagonista di un concerto già andato sold-out mentre vi scriviamo, mentre con Goran Bregovic si scavalla ad agosto in compagnia di un artista da quasi sessant’anni sulla breccia.
Il 3 agosto chiude l’edizione 2025 il concerto dei Kings of Convenience, duo indie pop formatosi a Bergen, in Norvegia, quando Erlend Øye e Eirik Glambek Bøe, entrambi classe 1975, si incontrano durante le scuole superiori. Pur non vivendo più nello stesso paese (Erlend Øye si è trasferito in pianta stabile in Sicilia), i due rimangono in piena attività incontrandosi di volta in volta per esibirsi davanti ai loro fan in giro per il mondo. D.P.

A luglio e agosto l’estate del King’s Club di Jesolo entra sempre più nel vivo, con una programmazione che ospita il meglio del djing mondiale. A luglio gli ospiti speciali del King’s sono Francis Mercier, un nome sempre più presente nei contesti che contano, in festival come il Coachella e nei migliori club di Ibiza ed Amsterdam, da tempo un riferimento per gli appassionati della musica Afro House, anche e soprattutto con le produzioni della sua etichetta discografica Deep Root Records (sabato 5); Maceo Plex, da anni protagonista nei più importanti club e festival internazionali (sabato 12); Sam Paganini, il dj e producer veneto autore di diverse produzioni techno in grado di scalare le classifiche di tutto il mondo (sabato 19); sabato 26 in console ecco le roi Bob Sinclar, l’artista francese che da sempre fa la differenza. Amatissimo in Italia, Sinclar vanta una carriera quasi trentennale costellata da hit mondiali e innumerevoli dischi di platino e oro: brani come World, Hold On, Love Generation e Til the Sun Rise Up sono autentici inni dancefloor senza tempo e senza età, per non parlare delle sue collaborazioni con Raffaella Carrà, Matia Bazar, Robbie Williams e Annalisa. Il suo nuovo singolo si intitola Cruel Summer (Again) ed è uscito lo scorso aprile. Ad agosto, sabato 2 e domenica 3 l’agenda del King’s segna un doppio appuntamento alla spiaggia del Faro con altrettanto one-day festival: sabato 2 Solid Grooves con Michael Bibi e Marco Carola e domenica 3 con Aperyshow On The Beach, edizione estiva del festival benefico svoltosi ad Arsego nell’area Campo Fiera tra aprile e maggio, capace di radunare su un’area di oltre tre ettari oltre 170mila persone e più di 300 artisti di ogni genere musicale, portando avanti messaggi di solidarietà che da sempre veicola e sostiene. Sabato 9 agosto si torna al King’s con Franky Rizardo e Sante Sansone: il dj e producer olandese Rizardo da anni è al centro della scena elettronica mondiale, reduce da un 2023 nel quale ha decisamente superato i propri standard, già parecchio elevati. Sabato 16 ospiti speciali i Mathame, autori di importanti collaborazioni discografiche con John Summit, Calvin Harris e Ellie Goulding; sabato 23 in console Twenty Six, Koko e Joey Daniel.
King’s Club
5, 12, 19, 26 luglio; 2, 3, 16 agosto www.kingsclubjesolo.it

Ci sono dei luoghi, nello specifico dei club, che potrebbero rimanere sempre uguali a sé stessi senza perdere un’unghia del proprio appeal, perché dotati di un proprio tratto identitario inconfondibile, in cui finisce per riconoscersi l’intera comunità intergenerazionale che li attraversa nel tempo.
Eppure il vecchio motto “chi si ferma è perduto” oggi è più che mai attuale anche per i luoghi più iconici dell’entertainment, che stando fermi muoverebbero comunque migliaia di adepti della notte, ma vuoi mettere aggiungere anno dopo anno una dolce ciliegia in più? Diciamo che in questo tempo liquido e orizzontale, in cui tutto si consuma in un amen, il motto di cui sopra è divenuto mantra obbligato per tutti i settori, figuriamoci per quello dei corpi in movimento in pista!
Se c’è un club tra tutti in Italia, non solo in Veneto, che risponde all’assunto iniziale, dato i 60 e passa anni di costante successo nell’universo dance, questo è certamente il Muretto. Club che però da sempre si caratterizza, si riconosce più di qualunque altro nel motto di cui sopra, facendo del movimento perpetuo in divenire il carburante che innerva e innova senza soluzione di continuità la sua inscalfibile identità strorica. Quest’anno come e più di sempre il top dei performer della consolle internazionali
Il Muretto 5, 12, 19, 23, 26, 30 luglio; 2, 9, 6, 13, 20, 23, 30 agosto www.ilmuretto.org

saranno qui di casa. Impossibile elencarli tutti nello spazio ristretto di un articolo (nel sito del club trovate tutto); basta qualche nome su tutti tra quelli già esibitisi in primavera e quelli che incendieranno l’estate jesolana: da Mochakk a David Morales, da Nico Morales a Joseph Capriati, da Chris Stussy a Ilario Alicante… Ma una decina d’altri dello stesso livello sono attesi in Via Bafile in questo 2025 on the beach. Ma, ripeto, al di là dei nomi sempre al top, sono le novità quelle che consolidano la reputazione del club, facendo che questi stessi maghi della consolle lo riconoscano di anno in anno come un must della scena elettronica internazionale. Tra queste almeno due vanno fermate qui. In primis i cinque mercoledì con il party Hardstyler, nel corso dei quali si esibiranno alcuni tra i massimi esponenti della scena hard techno, da Oguz e Valentinø, per una doppia dose di bassi e bpm, a Fantasm, da Barbara Lago a Holy Priest. Non meno importante, anzi, la valorizzazione della Terrazza, che durante l’estate ospiterà eventi open-air con guest come Archie Hamilton e Manda Moor, offrendo un’esperienza immersiva dal respiro internazionale.
Dulcis in fundo l’attesissima collaborazione con Solid Grooves, che il 2 agosto invaderà la spettacolare Spiaggia del Faro di Jesolo con un cast di livello assoluto: Michael Bibi, Marco Carola, Miguelle & Tons, Paramida e Reelow. Il tutto in collaborazione con Suonica e King’s. E se il tutto vi pare poco… Moxy B

Leggere, interpretare la cifra identitaria del Lido oggi è atto insieme semplice e dannatamente complesso. Semplice perché non ci vuole chissà quale sforzo nel riconoscere nel suo incidere flemmatico e impermeabile ai fattori esterni, umani e non, i segni evidenti di una condizione di mera sopravvivenza, comoda e spensierata quanto si vuole, ma sempre sopravvivenza. Naturalmente mai satura dal contemplare i fasti che furono, ci mancherebbe… Complesso perché, a voler davvero scommettere sull’eterno, inespresso potenziale futuro di questa curiosa, irreplicabile striscia di terra circondata dalle acque, non si saprebbe davvero da dove cominciare tanti sono i vuoti endemici che ne caratterizzano l’eterno, malinconico presente. Non sapendo quale sia il colore migliore su cui puntare la giocata, ci si perde così nell’indecisione, facendosi ricchi dell’immarcescibile potenziale che ci circonda, maledicendo, talvolta però incensandole, le irriducibili contraddizioni che caratterizzano i fondamentali di questo bellissimo, decadente luogo.
Il Des Bains da questo punto di vista rappresenta perfettamente questa condizione sospesa, incerta, senza quasi presente, con troppo passato e con più che improbabile futuro. Un luogo così culturalmente iconico, inutile ripetere i mille e più perché, lasciato marcire nella sua triste, vuota decadenza dice se non tutto, molto del Lido. Abbandono, e lì ci siamo, e potenziale rinascita, e qui auguri! Anche se è fresca notizia che un qualche emiro qualche petrodollaro pare sia interessato a scommettercelo davvero nella sua rinascita.
Per l’ennesima volta staremo a vedere… Eppure, ed ecco l’eterna contraddizione, in quel “quasi presente”, il quasi è più di un qualcosa di meramente virtuale. Infatti da un paio d’anni, attorno al suo stabilimento balneare almeno quello mai sospeso, si è sviluppato tutta una serie di attività di entertainment e di accoglienza, in primis con la ristorazione, che hanno incominciato almeno su questo terreno ad esprimere questo dannato potenziale, in attesa che il miracolo della riapertura dell’hotel un giorno si riveli per davvero. Sotto la direzione artistica di Tommy Vee per il secondo anno consecutivo l’area giardino della struttura si conferma come unica location di fascia alta dell’isola sul fronte dell’entertainment, in linea con quello che succede nei vari club on air delle storiche località balneari. Un’area giardino, totalmente ridisegnata, con più isole verdi, aree relax e salotti più confortevoli, che dall’aperitivo in poi diventerà il centro della nightlife di livello dell’isola. Quindi quotidiano aperitivo con musica direttamente sul prato, con a seguire, a seconda dei giorni, vari appuntamenti live. A partire dal Rendez-Vous, aperitivo del giovedì: dalle 19 musica live in accompagnamento alla Speciale Sangria DB, a seguire musica da club dopo cena con alla consolle lo stesso Tommy Vee e i dj resident Leo, Walterino e Keller (Aka the Dukes). Gli ospiti, invece, verranno svelati di volta per volta, e saranno comunque dj house e della miglior scena elettronica italiana ed europea. Che l’estate sia con voi anime della notte, al Lido, sì! Per il resto, verrà il giorno… Moxy B
Sublime@DesBains Grand Hotel Des Bains-Lido di Venezia www.desbains1900.com
L’arcaico conflitto siciliano tra amore
gelosia, religione e ‘onore’ virile, controllo sociale e violenza
Nicolò Ghigi
Dal 15 al 30 luglio 1928, sullo sfondo delle Procuratie napoleoniche, una maestosa scenografia, racchiusa tra due enormi fasci littori, accoglieva una storica rappresentazione della Cavalleria Rusticana nel “salotto buono” della città lagunare. Una folla di oltre 35.000 persone assistette alla rappresentazione, tra cui figurava il compositore Mascagni stesso, e l’evento entrò negli annali della lirica veneziana. Sulla scorta di questo e di altri illustri precedenti, è diventata da alcuni anni consuetudine della fondazione del Teatro La Fenice l’organizzazione di un evento estivo in Piazza San Marco; per felice scelta, il 12 luglio di quest’anno si assisterà al ritorno del capolavoro del verismo italiano nella cornice della Piazza, proposto però stavolta in forma di concerto.
Melodramma in atto unico su libretto di Giovanni Targioni-Tozzetti e Guido Menasci, ispirato all’omonima novella verghiana, la Cavalleria Rusticana di Mascagni portò per la prima volta sul palcoscenico l’estetica verista. La crudezza e il realismo della rappresentazione, che traducono in lirica il ciclo di amore, gelosia e violenza che si sviluppa attorno al sistema valoriale della profonda campagna siciliana di fine Ottocento, meritarono all’opera un’immediata fortuna sin dalla sua prima rappresentazione al Costanzi di Roma il 17 maggio 1890, fortuna che perdura immutata sino a oggi.
L’esecuzione concertistica marciana vede un sontuoso cast internazionale, con la soprano ucraina Oksana Dyka nei panni di Santuzza e Valeria Girardello in quelli di Lola, i due amori del giovane e passionale Turiddu, al quale la voce sarà prestata dal possente tenore georgiano Mikheil Sheshaberidze; il ruolo del vendicativo carrettiere Alfio sarà invece dell’esperto baritono
Franco Vassallo. A guidare il coro sarà come sempre il maestro Alfonso Caiani, mentre la direzione sarà affidata a Rico Saccani, al suo esordio alla testa dell’Orchestra del Teatro La Fenice, che va ad aggiungersi alla lunga lista di prestigiose orchestre sinfoniche nel mondo ch’egli ha diretto nel corso della sua carriera.
Cavalleria Rusticana in forma di concerto 12 luglio Piazza San Marco www.teatrolafenice.it
Amajestic scenography, bordered by fasces on both sides, once welcomed a Venetian representation of the Cavalleria Rusticana. It was the year 1928. 35,000 people came to see the show, including its very composer Pietro Mascagni, and the event would make it into the history of opera production in Venice. Since a few years, the Fenice Theatre made it a tradition to produce a summer opera event in Piazza San Marco. A single-act drama on a libretto by Giovanni Targioni-Tozzetti and Guido Menasci inspired by Giovanni Verga’s story of the same name, the Cavalleria Rusticana (lit. ‘rustic chivalry’) was the opera that first brought to the stage the then-modern verist aesthetics. The raw, realist mise-en-scène earned the opera immediate success since it premiered in Rome in 1890—a success that never faded. The upcoming Venetian show boasts an international cast of undisputed excellence: Ukrainian soprano Oksana Dyka will play Santuzza and Valeria Girardello will play Lola, the two love interests of young, passional Turiddu, who will be played by powerful Georgian tenor Mikheil Sheshaberidze. Playing his vengeful antagonist, Alfio, will be expert baritone Franco Vassallo. Choirmaster Alfonso Caiani will assist conductor Rico Saccani. Saccani worked with renowned symphony orchestra all over the world and is now at his first collaboration with the Fenice Theatre resident orchestra.

Il kolossal di teatro musicale ideato, composto e prodotto da Red Canzian Casanova Opera Pop alza ulteriormente l’asticella e per il suo ritorno in Italia dopo un tour che lo ha portato in tutto il mondo arriva il 5 luglio in Piazza San Marco, ovvero nel luogo simbolo del racconto stesso. Reduce dall’anteprima internazionale nei teatri di Shanghai e Xiamen, primo musical italiano ad essere rappresentato in italiano in Cina, con 13 repliche e 30.000 spettatori dal 20 dicembre al 3 gennaio scorso, Casanova Opera Pop si era già rivelato il più grande successo nel nostro Paese nella stagione 2022-2023, con oltre 100.000 spettatori in 88 repliche nei principali teatri italiani, in un crescendo che lo aveva portato a una lunghissima serie di sold out Per il musical ambientato nella Venezia del ‘700 e dedicato a uno dei personaggi italiani più noti al mondo, l’approdo in Piazza San Marco per questa unica rappresentazione della stagione significa sperimentare insieme al pubblico una sorta di evento “metareale”, entrare in un tempo sospeso e magico nel quale parte di ciò che accade in scena è anche ciò che avvolge la scatola teatrale, chi la abita e chi la guarda da fuori e dall’interno allo stesso tempo. Un’esperienza immersiva in senso tangibile, qualcosa di unico e irripetibile, sia per i performer in scena sia per il pubblico, che Red Canzian ha sognato di realizzare fin dal primo istante.
Prodotto da Retropalco in collaborazione con Blu Notte (Red Canzian e Beatrix Niederwieser), lo spettacolo porta in scena una Venezia settecentesca straordinariamente evocativa, tra fasti, intrighi e passioni. Con 23 straordinari performer – tra cantanti, attori e ballerini acrobati – e oltre 30 cambi scena, il pubblico viene trasportato nelle calli, nei palazzi nobiliari, nella prigione dei Piombi e nei suggestivi paesaggi del Nord Italia. Le scenografie, curate da Red Canzian, utilizzano immagini iperrealistiche di una Venezia deserta durante la pandemia del 2020, trasformate digitalmente per restituire un’esperienza visiva unica.
La storia, tratta dal best seller di Matteo Strukul Giacomo Casanova – La sonata dei cuori infranti, segue il seduttore, interpretato dal talentuoso Gian Marco Schiaretti, al rientro dall’esilio per difendere Venezia da oscure trame di potere. Accanto a lui, Silvia Scartozzoni nei panni della coraggiosa Francesca Erizzo. La regia originale è di Emanuele Gamba, con Chiara Canzian come Assistant Director e con la regia associata di Carolien Canters, la direzione creativa è di Anthony van Laast per Nick Grace Management, guru delle produzioni di maggior successo come Mamma Mia! e Cats




S’inaugurerà il 20 novembre, sulle note mozartiane de La Clemenza di Tito, la Stagione Lirica e Sinfonica 2025-26 del Teatro La Fenice, la prima della direzione artistica di Nicola Colabianchi, nominato il 6 marzo scorso nuovo Sovrintendente della Fondazione lirica veneziana. Le sue prime dichiarazioni programmatiche hanno lasciato intendere che la linea del predecessore Ortombina non verrà stravolta, compresa l’attenzione per il repertorio barocco (per il quale egli ha sottolineato le potenzialità del Teatro Malibran), ma il nuovo direttore ha chiaramente auspicato un’inedita attenzione al repertorio moderno e contemporaneo, per venire incontro a un più ampio pubblico ed evitare una “progressiva celebralizzazione”. Gli esiti di questo auspicio si vedranno nel corso degli anni, al netto della fisiologica incertezza che accompagna ogni inizio di nuovo mandato dirigenziale. Ma già nel nuovo cartellone, presentato ufficialmente da pochi giorni, non mancano i primi esperimenti: la Stagione verrà chiusa da un inedito dittico novecentesco, composto dal The Telephone di Menotti (1947) e dal Trouble in Tahiti del giovane Bernstein (1952), entrambi alla prima rappresentazione veneziana, ma verrà soprattutto segnata da una partitura contemporanea, Venere e Adone di Salvatore Sciarrino.
Per il resto, nel cartellone s’incontrano grandi classici del repertorio feniceo ( L’Elisir d’amore con la regia di Morassi, I pagliacci del Leoncavallo, la Traviata nell’allestimento di Carsen…), mentre tra gli appuntamenti più interessanti si segnalano l’Enrico di Borgogna di Donizetti, il nuovo allestimento di Micheletti del Simon Boccanegra verdiano, e soprattutto l’Ottone in villa di Vivaldi, che testimonia la volontà di proseguire nella riscoperta del Vivaldi operistico, iniziata alla Fenice ormai sei anni fa.
Accanto alla lirica, che sarà rappresentata per gran parte al Malibran in ragione dei lavori di restauro che interesseranno il palco di campo San Fantin, saranno proposti anche quest’anno quattro spettacoli di danza, dal classico Schiaccianoci a esibizioni dall’estetica fortemente contemporanea.
Nicolò Ghigi
Stagione Lirica e Sinfonica 2025-2026
Teatro La Fenice e Teatro Malibran www.teatrolafenice.it
a cura di Nicolò Ghigi

Il Simon Boccanegra fu composto da Verdi nel 1857 su insistenza dell’allora direttore della Fenice, il muranese Francesco Maria Piave, che firmò pure il libretto. Ispirato all’omonimo dramma di Antonio Gutierrez, questo si caratterizza per una notevole complessità, che, nonostante alcuni previi aggiustamenti di Giuseppe Montanelli, fu tra le cause dell’insuccesso della prima del 12 marzo: un critico contemporaneo affermò di averlo dovuto leggere sei volte per venirne a capo. Per la versione riveduta della partitura, che debuttò alla Scala oltre vent’anni dopo, il libretto fu specialmente rimaneggiato da Arrigo Boito.
ENG Giuseppe Verdi composed Simon Boccanegra in 1857 at the behest of then-director of the Fenice Theatre, Francesco Maria Piave, who also wrote its libretto. The story is convoluted, and despite further corrections, the opera premiered to an unwelcoming audience. One critic noted how he had to read it six times to make some sense of it. Author Arrigo Boito revised the libretto twenty years later, and the new version premiered at the Scala Theatre in Milan.
Simon Boccanegra
Dal 26 gennaio al 14 febbraio 2026

Su partitura e libretto del palermitano Salvatore Sciarrino, Venere e Adone debutta ad Amburgo appena due anni fa, il 28 maggio 2023. Sarà rappresentata per la prima volta in Italia proprio alla Fenice, nell’allestimento originale. Si tratta di una sintesi musicale e poetica ardita, ben radicata comunque nella tradizione letteraria e musicale barocca, con il libretto ispirato all’Adone del Marino e un evidente debito nei confronti dell’omonima opera di John Blow (1649-1708).
ENG Venere e Adone premiered in Hamburg, Germany, a mere two years ago. Its first show in Italy will take place at Fenice Theatre in Venice in its original staging. The opera is a daring musical and poetical synthesis that is nonetheless rooted in baroque tradition, with clear inspiration from Giovan Battista Marino’s 1623 epic and from John Blow’s own opera.
Venere e Adone
Dal 26 giugno al 1° luglio 2026

Si è aperta lo scorso 15 giugno la 102a stagione dell’Arena di Verona, con un Nabucco pregevolmente interpretato, audace e futuristico nella regia, fino a far perdere completamente le coordinate storiche che sono non soltanto l’occasione ma la stessa ragione tragica del libretto di Solera, e nondimeno accolto dalla critica in modo generalmente positivo. Nei prossimi mesi, il palco areniano accoglierà la colorata Siviglia di Franco Zeffirelli, per la rappresentazione della Carmen, diventata ormai un classico del festival veronese, proposta per la prima volta nel 1995 ed entrata nella leggenda; sull’opéra-comique di Bizet, infatti, il regista continuò a lavorare fino al 2009, apportando migliorie e infine progettando nuovi arricchimenti scenografici, che egli non poté mai vedere messi in scena, ma che da alcuni anni sono stati ripresi e realizzati come omaggio al maestro. La canonicità della rappresentazione, che in tutto s’ispira a quella sua storica prima, dai costumi alle coreografie, nulla toglie alla sua maestosità, tale da meritarsi la definizione di “Carmen definitiva” da parte della critica. Sarà proposta in otto diverse date, con una schiera di stelle internazionali ad alternarsi nei panni dei protagonisti. Altro classico dell’estate veronese è il Rigoletto, ormai da più di vent’anni affidato alle cure di Ivo Guerra: un allestimento tradizionale, fedele alle precise indicazioni del libretto e della partitura, ispirato dichiaratamente alla prima rappresentazione areniana dell’opera verdiana del 1928, e caratterizzato da quella grandiosità della messa in scena, caratteristica dei primi festival lirici italiani, ma che continua tutt’oggi a destare apprezzamento anche maggiore di molte reinterpretazioni moderne. Nei panni del protagonista il baritono mongolo Amartuvshin Enkhbat, che ha debuttato in questo ruolo proprio all’Arena nel 2017 dopo una lunga esperienza in patria, e si è distinto negli ultimi anni tra i migliori interpreti del buffone, per la potenza e l’espressività della voce, arricchite da ottima dizione, nonché per le doti di recitazione pienamente attinenti a un ruolo al contempo tragico e grottesco. Tra gli eventi non lirici in cartellone, oltre ai Carmina Burana e alle serate dedicate a Roberto Bolle e Jonas Kaufmann, per il balletto si segnala il ritorno di Zorba il Greco, rielaborazione a opera dello stesso Theodorakis della colonna del celeberrimo film del 1964, che debuttò proprio all’Arena nel 1988, con l’orchestra diretta dal compositore in persona. Il bianco abbagliante dei villaggi dell’Egeo che fanno da sfondo alle vibranti e coinvolgenti note del balletto sarà quest’anno eccezionalmente accolto non dall’Arena ma dalla quinta sull’Adige del Teatro Romano di Verona. Nicolò Ghigi
The 102nd season of the Arena di Verona opened on June 15 with Nabucco, boldly directed in a futuristic style that strips away its historical context, central to the original libretto by Temistocle Solera, yet was generally well received by critics. This summer, the Arena will host Franco Zeffirelli’s vibrant Carmen, a festival classic since 1995, now considered the ‘definitive’ Carmen. Also returning is the Rigoletto in Ivo Guerra’s traditional staging inspired by the 1928 Arena premiere, featuring Mongolian baritone Amartuvshin Enkhbat. Among non-opera events are Carmina Burana, evenings with Roberto Bolle and Jonas Kaufmann, and the ballet Zorba the Greek, based on Theodorakis’ iconic 1964 film score. This year, Zorba will be performed not in the Arena but at the ancient, over 2000-year-old Roman Theatre.
di Verona, Teatro Romano www.arena.it
La sezione di Operaestate curata dal violista Giovanni Andrea Zanon porta in dote linguaggi e stili differenti con il tradizionale programma dedicato ai Giovani Talenti al Museo Civico: i protagonisti di domani incontrano il pubblico in concerti concepiti ad hoc per un contesto intimo, affiancati in calendario da grandi interpreti con cui condividono un inizio di carriera scandito da riconoscimenti nei più importanti festival internazionali.





14 luglio h. 21.30, Lungo Brenta ORCHESTRA
Una grande festa per l’apertura del festival, questa volta lungo il Brenta, il concerto-evento Le quattro stagioni/I quattro elementi in musica e fuochi d’artificio, con l’Orchestra di Padova e del Veneto. In programma Le quattro stagioni di Vivaldi con l’Orchestra posizionata sul Ponte Vecchio, il simbolo della città, e la musica diffusa lungo le rive del fiume, accompagnata da spettacolari giochi pirotecnici lanciati da dieci piattaforme posizionate al centro del Brenta, ad illuminare la bellezza ritrovata dal Ponte dopo il recente restauro.
21 luglio h. 21.20, Chiostro del Museo Civico-Bassano del Grappa ELLI
Inaugurano il programma dedicato ai giovani talenti della classica la violinista Elli Choi, laureanda alla Columbia University e alla Juilliard School, e il pianista Riccardo Gagliardi, entrambi già accreditati in importanti concorsi. In programma le Sonate di Mozart, la n. 21, K304 dalla spiccata purezza melodica e di Brahms la n. 3 op. 108 dal carattere virtuosistico. Insieme alla Fantasia di Igor Frolov su temi da Porgy and Bess di Gershwin e la Sonata per violino n. 6, op. 27 di Eugène Ysaye, scritta nello stile di un’habanera spagnola, con straordinari passaggi virtuosistici.
28 luglio h. 21.20, Chiostro del Museo Civico-Bassano del Grappa GIULIA
Un trio formato da giovanissime artiste emergenti: la violinista Giulia Cellacchi e la violoncellista Maria Salvatori, entrambe del 2004, insieme alla pianista di origine armena Maya Oganyan, appena diciottenne, tutte accomunate dall’aver già ottenuto prestigiosi riconoscimenti. Propongono il Trio Elegiaco n. 1 di Rachmaninov, dal potente virtuosismo della parte pianistica, il Trio n. 1 op. 8 di Shostakovich, appassionato e romantico, e il Trio n. 1 op. 49 di Mendelssohn, pieno di quel fantastico tipico del romanticismo, e dove le tre voci soliste si fondono mirabilmente.
30 luglio h. 21.20, Chiostro del Museo Civico-Bassano del Grappa
BORIS GARLITSKY
Boris Garlitsky, violinista, camerista e didatta, dopo aver vinto nel 1982 il Concorso Paganini inizia una fortunata carriera da solista e in prestigiose orchestre come la London Philharmonic Orchestra. Sarà a Bassano anche come didatta nel progetto del Campus delle Arti, che propone in città una vasta offerta formativa con corsi di alto perfezionamento per principianti di tutte le età. Elena Garlitsky ha studiato alla Moscow Central School of Music, si è esibita in tutta Europa e negli Stati Uniti come solista in numerosi festival internazionali. Insieme propongono un programma tutto dedicato a trascrizioni e arrangiamenti realizzati dagli stessi autori.
11 Agosto h. 21.20, Chiostro del Museo Civico-Bassano del Grappa
Per la prima volta in Italia, un talentuoso pianista che si sta affermando tra i migliori interpreti della scena musicale internazionale. È il giovane canadese Tony Siqi Yun, definito dal Pianist Magazine come “un vero poeta della tastiera”. A Bassano propone la trascrizione di Busoni della Ciaccona dalla Partita n. 2 di Bach, la misteriosa ultima opera di Schumann: Variazioni degli spiriti, di Beethoven la Sonata n. 23 “Appassionata”, dalla potente carica emotiva e drammatica, e la Dante Sonata di Listz, uno dei brani più difficili del repertorio pianistico.
www.operaestate.it

di Mariachiara Marzari
Ci siamo, dopo una lunga tournée di successo, torna dove ha avuto tutto inizio Titizé. A Venetian Dream. Il Teatro Stabile del Veneto –Teatro Nazionale riporta in scena al Goldoni la formula di spettacolo d’intrattenimento, commedia dell’arte, acrobazia, clownerie, musica, dove domina l’atmosfera sospesa e delicata del sogno. Immaginata per un pubblico locale e internazionale, ma soprattutto intergenerazionale, che nelle notti estive veneziane ha voglia di immergersi in un viaggio onirico. Dopo un anno di spettacoli ora tutti gli ingredienti sono perfettamente amalgamati e i protagonisti – un cast di dieci talentuosi interpreti – hanno fatto dell’improvvisazione un’arte, andando ad arricchire di sera in sera la complessa articolazione dei diversi quadri che compongono lo spettacolo, tra innovazione e tradizione. La narrazione, apparentemente frammentata ma profondamente allusiva, si sviluppa in un gioco caleidoscopico che intreccia diversi piani di significato, rievocando un iperbolico grammelot. Un ritorno che è foriero anche di nuovi progetti. Abbiamo incontrato, prima della seconda attesissima stagione – a partire dal 9 luglio – Daniele Finzi Pasca, autore e regista di Titizé
Dopo una tournée che vi ha visto protagonisti di sold-out a Parigi, La Rochelle, Bergamo, Milano e a Napoli, tornate finalmente a Venezia. Prima di entrare in scena al Teatro Goldoni per una programmazione estiva che si preannuncia “spettacolare”, una riflessione sulla strada percorsa. Cosa ha significato per lei e per la sua compagnia quest’anno di Titizé?
È stato un anno carico di emozioni, di incontri con una critica entusiasta e oltre 60mila spettatori, un pubblico caloroso di città che seguono da tempo il nostro lavoro. Tanta emozione e la certezza che dopo questa prima tournée internazionale, a partire dalla prossima stagione, ritorneremo presto a New York, Montréal, Londra, in America Latina e molto probabilmente in Oriente.
Come si costruisce uno spettacolo di successo?
Non esiste una formula precisa, io cerco di restare fedele ad uno stile e a una continua ricerca della bellezza, sospesa tra un linguaggio onirico e l’uso misurato e “nascosto” di nuove tecnologie. Cerco di sorprendere e stupire il pubblico, mi circondo dei creatori di sempre, con i quali ogni volta ci spingiamo a esplorare nuove strade. E poi scelgo interpreti e un’equipe tecnica ricchi di talento e di una dose di umanità che li rende leggeri e straordinariamente precisi sulla scena. Il nostro è un teatro empatico: dialoghiamo con ogni singolo spettatore. Noi clown danziamo con il pubblico e per mano lo trasportiamo in mondi rarefatti, di cartapesta, dove però il sudore, il rischio, la sfida costante con le leggi della gravità sono invece tremendamente reali.
Quali novità presenterà l’edizione 2025 di Titizé qui a Venezia? Porteremo in scena uno spettacolo ancora più “giusto”, affinato nei dettagli e nel ritmo. Ci sarà un fantasma che vola sospeso per i capelli, un ritmo più incalzante per sorprendere e coinvolgere lo spettatore fin dal primo istante.
Nella Stagione 2025/26 tornate sul palcoscenico del TSV, in particolare al Teatro Verdi di Padova per Fuoriserie, con una nuovissima produzione dal titolo Prima Facie. Ci può anticipare qualcosa di questo progetto?
Da anni alterniamo creazioni oniriche, legate a un teatro fisico e visionario, a progetti in cui la parola e la narrazione affrontano temi necessari. Prima Facie di Suzie Miller è un monologo meraviglioso, una scrittura musicale, lucida e complessa. Per Melissa Vettore sarà un’autentica avventura interpretare un’avvocata che dopo aver difeso durante la sua carriera uomini accusati di stupro, si trova a vivere sulla propria pelle questa esperienza. Lo spettacolo, in questo momento, è in scena in oltre quaranta paesi diversi e ci ha onorato che Suzie Miller abbia scelto la nostra compagnia per allestire la versione italiana di questo testo così potente.
After a long, successful tour, Titizé. A Venetian Dream returns to where it all began. The Teatro Stabile del Veneto – Teatro Nazionale company brings back to the Goldoni Theatre stage its unique blend of entertainment: commedia dell’arte, acrobatics, clowning, and music, all wrapped in a delicate, dreamlike atmosphere. Designed for a local and international, intergenerational audience, it invites viewers into a journey into poetry and Venetian summer nights. After a year of performances, all ingredients are now perfectly blended. The cast have turned improvisation into an art, enriching the show night after night with new layers, balancing innovation and tradition. The narrative, seemingly fragmented yet deeply suggestive, unfolds in a kaleidoscopic play of meanings, evoking a hyperbolic grammelot. This return also marks the beginning of new projects. Ahead of the highly anticipated second season – starting July 9 – we spoke with Daniele Finzi Pasca, author and director of Titizé.
The meaning of Titizé for you and your company
It’s been a year full of emotions, with enthusiastic critics and over 60,000 spectators – a warm audience that have followed our work for years. We’re thrilled, and after this first international tour, we’re set to return soon to New York, Montréal, London, Latin America, and likely the East.
The perfect formula for a successful show
There’s no fixed formula. I try to stay true to a style and a constant search for beauty, suspended between dreamlike language and the subtle use of new technologies. I aim to surprise and move the audience, working with my longtime collaborators as we explore new paths. I choose performers and a technical team rich in talent and humanity – light yet precise on stage. Our theatre is empathetic: we connect with each member of the audience. As clowns, we dance with them, guiding them by the hand into ethereal worlds of papier-mâché, where sweat, risk, and the defiance of gravity are very real.
What’s new in 2025
We’ll present an even more refined show, polished in detail and rhythm. There will be a ghost flying suspended by her hair, and a faster pace to captivate the audience from the very first moments.
Prima Facie, your upcoming production
For years, we’ve alternated dreamlike, physical, visionary creations with projects that use narrative to address essential themes. Prima Facie by Suzie Miller is a brilliant monologue – musical, sharp, and complex. For Melissa Vettore, playing a lawyer who, after defending men accused of rape, experiences it herself, will be a true interpretive journey. The play is currently staged in over forty countries, and we’re honoured that Suzie Miller chose our company to produce the Italian version of this powerful work.
Titizé. A Venetian Dream 9 luglio-21 settembre Teatro Goldoni www.teatrostabileveneto.it

«Uscire dall’università è stato il nostro primo atto d’amore per Venezia». Questa la dichiarazione d’intenti con cui Venice Open Stage ribadisce la propria vocazione a un teatro vivo, formativo, condiviso. Nato nel 2013 da un’iniziativa dell’Università Iuav di Venezia, VOS si è trasformato negli anni in un festival internazionale ideato e curato dai membri dell’associazione culturale Cantieri Teatrali Veneziani, attivi in ambito organizzativo, produttivo e artistico. L’obiettivo: portare, in uno spazio scenico costruito all’aperto nel cuore della città, spettacoli di alta qualità accessibili al pubblico. Spazio di confronto tra accademie teatrali, compagnie emergenti e giovani professionisti delle arti performative, Venice Open Stage è dedicato a chi abita i processi creativi prima ancora che i risultati. La 13. edizione torna anche quest’anno in arena Gigi Dall’Aglio, in Campazzo San Sebastiano, dal 30 giugno al 12 luglio, con tredici giornate di spettacoli, incontri e musica a ingresso gratuito. Il titolo scelto per questa rassegna, BUH! – The time is out of joint, evoca un grido, uno strappo, una crepa nella linearità del tempo. Il riferimento ad Amleto si fa corpo politico e poetico, per una generazione chiamata a raccogliere i frammenti e tentare ancora un discorso sul presente.
Il festival si apre lunedì 30 giugno con il dj set by Opificio e i live di Piccola Orchestra MDM e Saving Serafino, mentre da martedì 1 luglio si entra nel vivo della programmazione. Ad aprire la sezione Accademie, da Verscio in Svizzera, l’Accademia Dimitri con Shooting Snow White, riflessione fisica e radicale sui cliché di genere, in replica anche il 2 luglio. Giovedì 3 si passa alla sezione Rassegna con il Collettivo EFFE e il suo Il mio corpo è come un monte, mentre il giorno successivo si inaugura la sezione Fermenti con Verderame della compagnia Le Tutto Sotto Controllo, racconto stratificato di maternità, eredità e identità femminile. Sabato 5 luglio
13. Venice Open Stage
30 giugno-12 luglio Arena Gigi dall’Aglio, Campazzo San Sebastiano veniceopenstage.org
tocca a UMAN di Navëe, concerto-spettacolo tra voce, loop station e disperazione lucida, mentre domenica 6 chiude la selezione a bando Il dilemma dei cento girasoli fotovoltaici del collettivo Matrice Teatro, che intreccia disastro ambientale e relazioni interrotte. Si torna alle accademie l’8 e il 9 luglio con l’Aristotle University of Thessaloniki e una rilettura scenica di Ulysses di Joyce (episodio Circe ), per poi proseguire il 10 e l’11 con la National Academy of Dramatic Art di Varsavia, in scena con Variations on the theme of loss, riflessione sul rapporto tra umano e natura.
A chiudere il festival, sabato 12 luglio, Sdisoré del Gruppo UROR, riscrittura furiosa e viscerale dell’Orestea attraverso la lingua incandescente di Testori. Il mito si rovescia, si fa carne e ironia, desiderio e dissacrazione, in un intreccio di corpi e parole che incendia il finale. Una chiusura potente, che raccoglie e rilancia il BUH! del titolo: il tempo è davvero fuori asse, ma resta ancora una scena da attraversare. Chiara Sciascia ENG “Getting out of the university circuit was our first act of love for Venice”. With this statement, Venice Open Stage commits to living, formative, and shared theatre. Founded in 2013 by the local IUAV Architecture College of Venice, VOS has grown into an international festival curated by cultural association Cantieri Teatrali Veneziani. Its goal: to bring high-quality performances to an open-air stage in the heart of the city, accessible to all. A space for exchange between theatre academies, emerging companies, and young performing artists, VOS focuses on creative processes over results. The 13th edition returns to Campazzo San Sebastiano, in the west end of the city, from June 30 to July 12, with thirteen days of free shows, talks, and music. This year’s theme, BUH! – The time is out of joint, evokes a cry, a rupture in time. Referencing Hamlet, it becomes a poetic and political body for a generation piecing together the present. The festival will close with Sdisoré, a visceral rewriting of Oresteia.
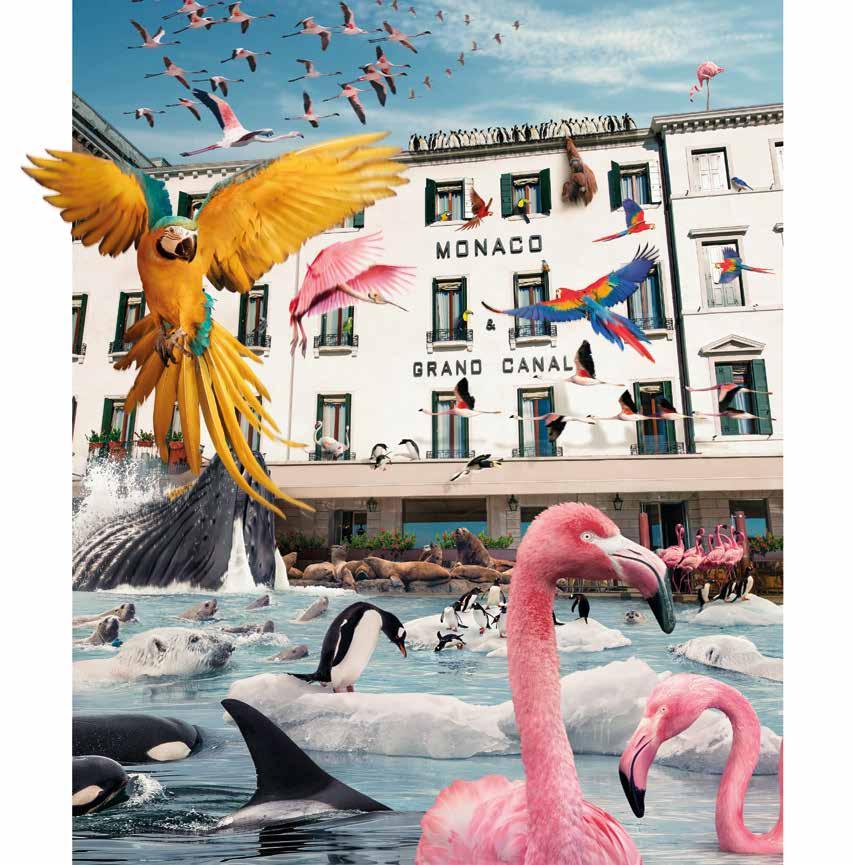

PREVIEW
Filippo Dini
Irresistibile tentazione
Si torna a teatro con un cartellone TSV 25/26 ricchissimo di storie
La nuova campagna per la Stagione 25/26 del Teatro Stabile del Veneto – Teatro Nazionale, curata dall’artista catalano Javier Jaén, colpisce dritta nel segno: «Fatti tentare dal Teatro» sembra suggerire un serpentone colorato che si arrotola formando una mela, quella mela!, per poi invitare, sempre allusivamente, a varcare la soglia, a lasciarsi coinvolgere perché «Ogni storia ha il suo inizio». È chiaro il riferimento all’immaginario biblico secondo il quale la mela e il serpente, l’atto di disobbedienza, la cacciata dal paradiso segnano la nascita della coscienza e la caduta dall’innocenza, ma sono anche l’inizio del dramma: il momento in cui la storia umana diventa un palcoscenico di conflitti, scelte e conseguenze. L’immagine del nuovo progetto artistico triennale coglie proprio nel segno, perchè la tentazione quest’anno è davvero grande, così come le storie rappresentate. La Stagione TSV 25/26, presentata con giustificato entusiasmo dal Presidente Giampiero Beltotto e dal Direttore artistico Filippo Dini, ha tutti gli ingredienti necessari per poter sedurre il pubblico e la critica – grandi nomi, nuove drammaturgie, testi classici e contemporanei, vecchie e nuove generazioni a confronto, storie note e racconti inediti –, una ricetta pensata per creare un cartellone di livello non più solo meritatamente Nazionale, ma certamente internazionale. I numeri parlano chiaro: 80 spettacoli, 37 in abbonamento (12 a Venezia, 12 a Treviso e 13 a Padova) e 13 produzioni firmate TSV.
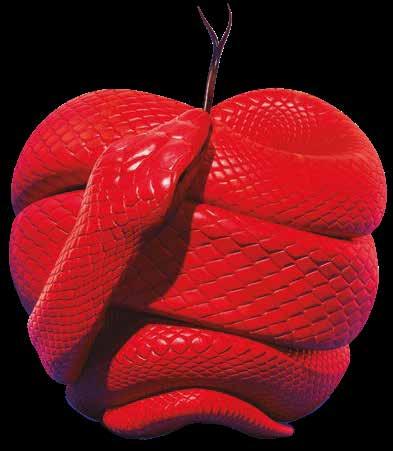
Ma scorriamo il cartellone davvero ricchissimo per individuare tra le moltissime sfumature offerte alcuni debutti significativi. Il direttore artistico Filippo Dini sceglie Cechov per la sua nuova regia: Il gabbiano debutta in prima nazionale e inaugura la Stagione del Verdi a Padova con Giuliana De Sio. Un allestimento importante, che mette in pratica la sfida del confronto generazionale, chiamando il trentatreenne Leonardo Manzan a dirigere la sezione dell’opera dedicata allo spettacolo di Kostja. Teatro nel teatro, stili divergenti, per generare un cortocircuito inedito. A Venezia è Marco Paolini, con il suo ultimo lavoro scritto a quattro mani con Giulio Boccaletti, Bestiario idrico ad aprire la Stagione al Teatro Goldoni. Per celebrare le Olimpiadi Milano-Cortina 2026, a febbraio debutta a Treviso un Carlo Goldoni internazionale con Mirandolina (con sottotitoli in inglese), originale riscrittura della Locandiera affidata alla drammaturga irlandese Marina Carr, co-prodotta dal TSV con l’Abbey Theatre – Teatro Nazionale d’Irlanda.
I tre teatri, Venezia, Padova e Treviso, sono in salute anzi stanno proprio bene come testimoniano la crescita percentuale significativa su tutte le voci, dal pubblico alle produzioni, all’Accademia, motivo per cui il nuovo Triennio si preannuncia promettente e con una volontà politica oltre che culturale di incidere sempre più sul territorio per mettere al centro delle diverse aree metropolitane proprio il teatro e la sua attività.
Stagione TSV 2025/2026
Teatro Stabile del Veneto – Teatro Nazionale
Teatro Goldoni, Teatro Verdi, Teatro del Monaco www.teatrostabileveneto.it
Portare nel presente i grandi autori del passato e rendere classici i testi contemporanei è il compito degli ospiti in cartellone: Ambra Angiolini, Luca Barbareschi, Franco Branciaroli, Luca Bizzarri, Simone Cristicchi, Familie Flöz, Anna Ferzetti, Salvo Ficarra, Paolo Fresu, Gabriele Lavia, Luca Marinelli, Stefano Massini, Paola Minaccioni, Francesco Montanari, Silvio Orlando, Umberto Orsini, Andrea Pennacchi e Amanda Sandrelli. Novità assoluta, al Teatro Maddalene di Padova, per la prima volta una Stagione dedicata con le migliori compagnie indipendenti della scena contemporanea e il Festival internazionale UAD-Universal Art Design per raccontare le diversità con artisti da Italia, Serbia e Polonia. Dopo il successo registrato lo scorso anno in tutte e tre le città, torna Fuoriserie, che a Venezia diventa occasione per “pensare a teatro” con protagonisti Buttafuoco, Cacciari, Curi, Porcelli Safonov e il giovanissimo Edoardo Prati. Tra gli spettacoli di produzione del TSV si confermano le matinée per le scuole superiori: apre la programmazione Vestire gli ignudi di Pirandello per la regia di Alessandro Businaro, giovane artista under 35. M.M.

Decani del teatro italiano, grandi nomi dello spettacolo, protagonisti della scena emergente si cimentano con prosa, danza contemporanea, musical, circo-teatro: 18 titoli che promettono divertimento, emozioni, riflessioni – intrattenimento, nella sua forma più alta. È questo il ritratto della Stagione 2025-26 del Teatro Toniolo firmata ancora una volta da Arteven, Circuito Multidisciplinare Regionale, in collaborazione con il Settore Cultura del Comune di Venezia. L’apertura è sotto il segno del musical, un genere che negli ultimi anni in Italia sta ampliando i suoi spazi, forte di un crescente consenso di pubblico: ad andare in scena è un classico di Broadway tratto da un altrettanto classico hollywoodiano, Sette spose per sette fratelli, una rilettura fresca e contemporanea con un cast di 22 interpreti, la regia di Luciano Cannito e la direzione musicale di Peppe Vessicchio (21-26 ott). Segue la compagnia ungherese di danza Eva Duta con Frida, un omaggio alla celebre pittrice messicana in cui arti visive, musica e danza si fondono (7-9 nov). Spazio quindi al teatro di narrazione di Andrea Pennacchi e al suo nuovo spettacolo Alieni in Laguna, dedicato al cambiamento climatico, in cui l’attore, con la sua cifra distintiva che mescola splendidamente registro comico e registro drammatico, accompagna il pubblico in un viaggio dove la nostalgia del passato diventa la chiave di lettura per ridefinire il rapporto tra uomo e ambiente (11-13 nov). A seguire, La vedova scaltra, testo goldoniano che segna il passaggio dalla commedia dell’arte alla commedia di carattere interpretata dall’attrice Caterina Murino, una riflessione molto attuale sul tema dell’emancipazione femminile (18-23 nov). A fine novembre, Ferdinando Bruni e Francesco Frongia del Teatro dell’Elfo portano Amadeus di Peter Shaffer, glamour allo stato puro con i sontuosi costumi di scena realizzati da Antonio Marras (26-27 nov). Il 6 e 7 dicembre, Giorgio Marchesi è protagonista de Il fu Mattia Pascal di Pirandello, in una rilettura moderna e contemporanea che strizza l’occhio alle nuove generazioni, mentre
www.comune.venezia.it
dal 12 al 14 dicembre va in scena Il birraio di Preston, travolgente racconto tragicomico di Andrea Camilleri diretto da Giuseppe Dipasquale. Il nuovo anno si apre con il nome di un grande protagonista del teatro contemporaneo, Massimo Popolizio, regista e interprete di Ritorno a casa di Harold Pinter (7-9 gen), testo intriso di humor nero e cinismo. L’esilarante e tenero duo formato da Umberto Orsini e Franco Branciaroli farà rivivere la magia de I ragazzi irresistibili di Neil Simon, tra risate e malinconia (23-25 gen). Il 27 e 28 gennaio 2026 arriva il nuovo spettacolo di Emma Dante, L’angelo del focolare, che esplora con stile diretto e potente la terribile ritualità del femminicidio e la condizione della donna in famiglia. Dal 6 all’8 febbraio Maria Paiato, sensibile e raffinata interprete, veste i panni dell’omonimo re shakespeariano in Riccardo III, mentre dal 17 al 22 febbraio Stefano Accorsi porta in scena la sua personale rilettura dell’Odissea, un viaggio intimo avvincente nel cuore della classicità. È poi il momento di Paradisum, lo spettacolo di Recirquel, prima compagnia di circo danza contemporanea (24-26 feb). Silvio Orlando, gradito ritorno, va in scena con un classico di Luigi Pirandello Il berretto a sonagli (3-6 mar), mentre Domenico Pinelli, Mario Autore e Anna Ferraioli Ravel sono i protagonisti di Ditegli sempre di sì di Eduardo De Filippo, meccanismo comico per riflettere sul tema della pazzia (11-12 mar). Comicità assicurata anche per Fantozzi. Una tragedia, interpretato da Gianni Fantoni, in cui il personaggio reso immortale da Paolo Villaggio diventa moderna maschera della commedia dell’arte nella regia visionaria di Davide Livermore (21-22 mar), mentre Paola Minaccioni è la protagonista di Le stravaganti dis-avventure di Kim Sparrow, un testo di Julia May Jonas, esilarante e toccante immersione nel mondo femminile contemporaneo (26-29 mar).
Gran finale con il ritorno dei Momix, la celebre compagnia di Moses Pendleton che torna al Toniolo con Botanica - Season 2, uno spettacolo immersivo in cui effetti tecnologici e immagini tridimensionali restituiscono il tema dell’importanza del rapporto tra uomo e natura (14-19 apr). Livia Sartori di Borgoricco
Intervista Michele Mele
Programmazione e progetti Danza Operaestate Festival di Massimo Bran
Operaestate è da tempo ormai immemore il festival sistemico per eccellenza e per definizione della nostra regione e non solo. Un progetto che nasce in un territorio con tanti medi e piccoli centri, tutti connessi dalle arti sceniche al cui centro sta Bassano del Grappa. Un festival di territorio che nasce per il pubblico di questo stesso territorio, anche proprio in un’ottica generalista. In un orizzonte così delineato non è impresa esattamente facile quella di scommettere sui linguaggi contemporanei e della sperimentazione, da Biennale per intenderci, dato che a differenza delle varie Biennali musica, danza e teatro, che nascono per definizione come epicentri della ricerca, inevitabilmente quindi di nicchia, Operaestate parte da una sorgente opposta, quella più aperta a un’audience meno, per così dire, radicale nei gusti e nelle aspettative. Eppure, in particolare con la sezione B.Motion, negli anni ha saputo eccome dare del tu alla ricerca e alla sperimentazione, ospitando in scena giovani e meno giovani protagonisti dell’avanguardia teatrale, musicale, della danza. Un atto di coraggio lucido e (con)vincente, che oggi raccoglie i suoi migliori frutti ponendosi come autentico epicentro del contemporaneo in scena. Per indagare questo percorso abbiamo dialogato con Michele Mele, colui il quale negli ultimi anni ha spinto ancora di più sull’acceleratore in questa direzione. Abbiamo fermato questa conversazione libera e informale in alcuni punti chiave che qui di seguito condensiamo.
Ricambio generazionale
Dopo due anni di lavoro, parlo per me naturalmente, sto progressivamente percependo sempre più nitidamente quanto il pubblico sia di edizione in edizione più consapevole dell’importanza che stiamo ponendo su uno degli obiettivi più rilevanti che ci siamo dati, vale a dire un ricambio generazionale profondo nella proposta artistica. Fino a due o tre anni fa molti degli artisti oggi nella sezione “main” erano presentati nella sezione B.Motion. È come se Operaestate fosse un organismo con più teste, ma in realtà si tratta di un unico grande palinsesto. Quello che abbiamo fatto è stato riconoscere a tutta una serie di artisti già sostenuti in passato nel contesto di B.Motion una visibilità maggiore. Abbiamo programmato i loro spettacoli sui grandi palchi, come il Castello “Tito Gobbi” o il Remondini. In pratica ciò che dieci anni fa era considerata “offerta per i giovani” è divenuta oggi un’offerta per il pubblico generalista. Penso a Christos Papadopoulos, Silvia Gribaudi, Marcos Morau… Abbiamo offerto a questi artisti più promozione, più pubblico, spazi più ampi. È stato un vero ricambio.
45. Operaestate Festival
27 giugno-15 settembre
Bassano del Grappa e città-palcoscenico della Pedemontana Veneta
www.operaestate.it

Nel segno della multidisciplinarietà
La multidisciplinarietà rappresenta sicuramente un percorso fertile che stiamo percorrendo con grande convinzione, facilitati anche, come dicevo, dalla gamma ampia e composita di spazi che fortunatamente abbiamo a disposizione. Abbiamo iniziato a ridefinire l’identità di B.Motion sganciandoci dall’idea di una netta separazione settoriale, B.Motion Danza, B.Motion Musica, B.Motion Teatro, andando a costruire programmi quotidiani multidisciplinari. Questo è anche in parte frutto di una mia per così dire vocazione, sensibilità personale: a me piacciono gli spettacoli che sono, già di per sé, ibridi. Vedere musica dal vivo a teatro, o in uno spettacolo di danza, o vedere un video in un progetto teatrale, o ancora vedere l’arte contemporanea ispirare una coreografia, per me rappresenta un valore aggiunto. Questo approccio mi coinvolge in primis come spettatore proprio. Spostando poi determinati artisti nella sezione principale, si è liberata la possibilità di invitare nuovi nomi. Abbiamo avuto così modo di rivolgere la nostra attenzione ai progetti di artisti più giovani, in particolare di artiste donne: tra queste Francesca Santamaria, Marina Donatone, Leda Kreider, Chiara Cecconello. Chi legge il programma con attenzione noterà che c’è una forte presenza femminile nella nuova creazione. Parallelamente si è aperto un importante spazio anche per artisti che giovani non sono più, ma che hanno formato con il loro lavoro una generazione. Penso a Pietro Babina (Teatrino Clandestino), che per la mia generazione è stato un autentico maestro. Oggi, per personali scelte artistiche, ha deciso di porsi un po’ ai margini della scena, ma è più che mai importante anche proprio per questo riproporre ora il suo lavoro. Oppure penso ancora a Daniele Albanese, Anna Basti, Wooshing Machine, artisti quasi tutti tra i 50 e 60 anni che si trovano a combattere ad armi impari con i giovani sul terreno dei bandi e dei sostegni pubblici. Il sistema quasi sempre aiuta autori sotto i 35 anni. Dopo, in questa specifica direzione, diventa difficile far corrispondere la biografia anagrafica con quella artistica.
La costruzione di un nuovo pubblico
Costruire un nuovo pubblico, ringiovanendolo, rappresenta una sfida tutt’altro che facile. Anche perché oggi abbiamo un problema concreto: ci sono più persone anziane che giovani. La sfida non è solo culturale, quindi, ma anche antropologica, sociologica, demografica. In considerazione di ciò è fondamentale oggi più che mai nel nostro

contesto fare ancora più attenzione alle scelte, alle linee curatoriali, che devono per forza di cose suscitare stimoli nuovi. Il pubblico dei giovani è sempre più difficile da intercettare e va perciò incentivato, studiando modalità di coinvolgimento più stimolanti. I ragazzi oggi, per esempio, non amano molto gli spettacoli frontali, ossia il format palco-spettatore nella sua configurazione classica. Fortunatamente noi abbiamo svariati spazi alternativi – chiese, luoghi riconvertiti, ecc. – che ci permettono di lavorare anche in questa direzione, assecondando le plurime esigenze di artisti e spettatori. Ad ogni modo i giovani oggi non vogliono, a mio avviso, più riconoscersi in una comunità specifica: non si sentono “pubblico della danza” o “pubblico del teatro”. Perché questo tipo di etichette tendono a definire un’identità specifica e circoscritta che non corrisponde alla realtà, limitandola. Quindi è interessante, e ritengo che sia nostro compito, trovare uno spazio, delle dimensioni, in cui ognuno possa essere solo pubblico senza ulteriori definizioni qualificative.
Main festival e B.Motion: il confine eroso
B.Motion è nato circa quindici anni fa per dare spazio al contemporaneo. Allora aveva molto senso, perché Operaestate era legato principalmente all’opera lirica, quindi caratterizzato sorgivamente da un’impronta più tradizionale. B.Motion è stata una riuscita, intelligente opportunità per aprirsi a un pubblico nuovo, internazionale, fatto di operatori del settore, artisti, professionisti. Bassano è diventata un punto di riferimento sovranazionale in questo senso. Quando sono arrivato qui un paio di anni fa mi ha davvero stupito l’attenzione internazionale attorno a B.Motion. Oggi, per essere del tutto sincero, trovo in assoluto che non abbia più molto senso mantenere questa divisione settoriale, ma lo ha per il pubblico più tradizionale, per il Comune, per le comunità. Bassano è una città piccola ma fatta di tante realtà che si riconoscono in alcune parti del festival. Quindi la struttura a blocchi di Operaestate risponde a questa sua funzione di rappresentanza delle diverse identità territoriali che lo attraversano. Ma idealmente io vedrei bene un’inseminazione della visione di B.Motion in tutto il palinsesto. Il Ministero e gli enti pubblici, però, come prima cosa ci chiedono numeri. Se ho un teatro da 600 posti devo riempirlo. E diventa difficile, allora, programmare un artista emergente lì, anche se magari ce ne sarebbe bisogno, per lui e per il nuovo pubblico, come l’aria. Questo riduce
lo spazio per rischiare, per scommettere su progetti radicalmente nuovi. È come applicare una logica privata a un contesto pubblico. Non è una questione di destra o sinistra, ma proprio di non approfondita coscienza della grammatica contemporanea delle politiche culturali e dell’economia della cultura. La prima volta che ho seguito un corso di organizzazione teatrale mi hanno dato da leggere un libro che spiegava il cosiddetto “morbo di Baumol e Bowen”, ossia che nel settore culturale non puoi coprire con il biglietto i costi reali di produzione. Perché un artista non ti può far pagare tutto lo studio, la ricerca, i collaboratori che stanno dietro a un determinato lavoro! Quindi il sostegno pubblico è necessario per valorizzare al meglio chi opera nel contemporaneo con ricerche e lavori innovativi. Ma questo concetto, questa idea basica delle politiche culturali sembrano da noi essersi volatilizzati.
L’artista che non c’è
Tra i molti che vorrei avere qui con noi ne scelgo uno in particolare, un coreografo che ammiro molto: Damien Jalet. Lavora con Madonna, ha curato le coreografie del film di Amalric. È straordinario. Ci conosciamo di persona, gli piacerebbe venire a Bassano. Ma le dimensioni tecniche ed economiche dei suoi lavori non ci permettono di coinvolgerlo. Portare, che so, compagnie di ballo con spettacoli con 50 persone in tour non è affare semplice per un festival come il nostro.
I numeri
Quest’anno abbiamo circa 110 eventi. Parliamo di 500 artisti che passeranno per Bassano tra luglio e agosto. Anche solo per una notte, ma porteranno il loro lavoro. E per me questa è la soddisfazione più grande: poter sostenere tanti artisti con un budget ben gestito e mantenere relazioni continuative nel tempo.
La formazione
Gli ultimi giorni del festival, a fine agosto, organizziamo con l’Università Ca’ Foscari e con il progetto AIKU delle giornate professionali per programmatori europei. Quest’anno ci sarà un focus sul Belgio e sulla Spagna e lanceremo “B.Network”, un format di lavoro collettivo ispirato all’Open Space Technology. Saranno giorni di confronto sui modelli di cooperazione internazionale. Una sorta di incubatore.

Mutabile come l’acqua L’Estate Teatrale Veronese rilegge l’animo umano attraverso Shakespeare
Acqua, terra e aria. È ispirato agli elementi di cui è composto il pianeta-mondo shakespeariano il nuovo progetto triennale dell’Estate Teatrale Veronese, delineato dal Direttore artistico uscente Carlo Mangolini. E trova in particolare nell’elemento liquido – sinonimo di mutamento e adattabilità alle differenti forme – il riferimento per l’edizione 2025, che si declina nei cartelloni di musica, teatro e danza. Il teatro, e naturalmente il teatro del Bardo, sarà la proposta protagonista del mese di luglio con quattro importanti debutti al Teatro Romano inseriti nel cartellone del Festival Shakespeariano, la rassegna che da 77 anni rinnova il legame di Verona con l’autore che l’ha resa famosa nel mondo. «La scelta convintamente obbligata di confermare la centralità di Shakespeare è stata dunque la base di partenza per costruire le fondamenta del prossimo triennio – dichiara Mangolini – Ma ho sentito forte anche l’esigenza di trovare un nuovo paradigma, per rileggere l’universo artistico del più grande autore di sempre rintracciando nei suoi testi il legame con gli stati della materia – liquido, solido e gassoso –, puntando i riflettori sulle componenti del nostro Pianeta e sulle questioni legate al cambiamento climatico».
Ad aprire la programmazione (3-4 luglio) sarà “un classico nel classico”, Rosencrantz e Guildenstern sono morti, l’esilarante tragicommedia scritta da Tom Stoppard a partire da due figure minori dell’Amleto. Personaggi che incarnano perfettamente l’idea di un mondo liquido, a partire dalla totale insensatezza del loro agire e dal palleggiare dei loro dialoghi, resi ancora più esilaranti dal talento caleidoscopico di Francesco Pannofino, affiancato da Francesco Acquaroli e Paolo Sassanelli, e dalla regia di Alberto Rizzi. Si prosegue poi con
77. Estate Teatrale Veronese – Water Fino 22 settembre Teatro Romano e Bastione delle Maddalene-Verona www.spettacoloverona.it
Otello (10-11 luglio) nella traduzione di Dacia Maraini con protagonisti il giovane Giacomo Giorgio, già interprete di serie cult come Mare fuori, e Giorgio Pasotti, qui anche in veste di regista. La versione del più celebre dramma della gelosia esplora le passioni umane attraverso la lente della violenza di genere. Arriva poi al Teatro Romano (17-18 luglio) uno dei più celebri drammi storici sul desiderio di potere e sul tradimento: Riccardo III per la regia di Andrea Chiodi, che affida il ruolo del protagonista a una donna, Maria Paiato. Un ribaltamento di prospettiva attraverso la fluidità di genere.
Ultimo appuntamento del Festival è La Tempesta (24-25 luglio) la cui regia è affidata a una delle più prestigiose firme internazionali, Alfredo Arias, che torna a dirigere dopo 40 anni questo testo ricco di simbolismi, in cui l’acqua diventa davvero l’elemento della metamorfosi, del movimento incessante e della perdita di riferimenti certi. Nel mese di luglio la vocazione shakespeariana esce dal Teatro Romano e contamina, grazie al progetto ETV in Town, anche il Parco della Provianda al Bastione della Maddalene con proposte tra teatro e danza: Luca Scarlini dà vita a una Soirée dedicata a Renato Simoni, critico e intellettuale cui si deve nel 1948 la nascita dell’Estate Teatrale Veronese; la coreografa Marcella Galbusera con Arte3 porta in scena il suo progetto di comunità Shakespeare in dream; mentre i danzatori di Ersiliadanza di Laura Corradi presentano Shakespeare in Blood Agosto, invece, si concentra su danza e teatro musicale: al Teatro Romano va in scena Pimpa. Il musical a pois presentato nel cinquantesimo anniversario della famosa cagnolina ideata da Francesco Tullio Altan e dal mago dei cartoon cinematografici Enzo d’Alò. Quindi sarà la compagnia di danza maschile più irriverente e dissacrante al mondo Les Ballets Trockadero de Monte Carlo a travolgere il pubblico tra tecnica impeccabile e incontenibile comicità.
Diletta Rostellato

A Hollywood tutti pensano di volere te, ma in realtà vogliono l’idea che loro si sono fatti di te
Kim Novak

di Andrea Zennaro
Capitata quasi per caso a recitare nello Studio System, Marilyn Pauline (Kim) Novak viene assoldata dal tycoon Harry Cohn, presidente della Columbia Pictures, intenzionato a renderla, commercialmente, una spina nel fianco di Rita Hayworth. La Novak inizia ad interpretare ruoli dal forte impatto emotivo in opere drammatiche, come ad esempio quello di Molly nel cupo capolavoro di Otto Preminger con Frank Sinatra L’uomo dal braccio d’oro (1955) o quello della moglie dello sfortunato pianista Eddy Duchin nel melodramma musicale e biopic Incantesimo (1956). Nel 1957 impersona Jeanne Eagels nel biopic sull’attrice del periodo del muto Un solo grande amore e, sempre al fianco di Sinatra, recita nel film musicale Pal Joey Continuamente tormentata dal produttore despota Cohn, che la maltrattava e minacciava, sottoponendola a ricatti ed intimidazioni di vario genere, l’attrice, con il suo forte temperamento, si oppone spesso ai dettami produttivi, seguendo il suo istinto e la sua onestà intellettuale. Non rinuncia ad accompagnarsi, in un periodo di segregazione razziale, all’attore, cantante e ballerino Sammy Davis Jr., creando indignazione e scandalo negli ambienti hollywoodiani. È con Vertigo ( La donna che visse due volte ) del 1958 che l’attrice sale all’Olimpo delle star: Hitchcock aveva l’abilità di trasformare le sue attrici in divinità intorno alle quali le trame dei suoi film si dipanavano. Nella mostra Hitchcock and Art: Fatal Coincidence tenutasi nel 2000 al Montreal Museum of Fine Arts si perlustravano tutte le connessioni, le attrazioni visive e le citazioni che il regista inglese aveva, intenzionalmente e non, inserito nella sua filmografia: in Vertigo veniva evidenziato il dettaglio del vortice dei capelli raccolti dell’attrice che interpreta Judy, mentre contempla al museo il ritratto di Carlotta Valdes. La spirale, rimando alle vertigini del protagonista ed alla trama del film, è l’elemento cardine di quest’opera, che si ritrova anche, animata in modo magistrale, nei titoli di testa del geniale Saul Bass, ispirato a sua volta, dalle astrazioni di Marcel Duchamp, Man Ray e August Sander. Kim Novak affabula e quasi ipnotizza lo spettatore, con la sua dirompente bellezza di femme fatale in bilico tra eros e thanatos: nonostante il patetico spoiler nel titolo italiano del film (qui occorrerebbe aprire un discorso a parte sulla cialtroneria dei titolisti italiani dell’epoca) l’enigma persiste e l’intero film ruota attorno alla sua figura misteriosa (Judy/Madeleine), che circuisce l’innamorato John Ferguson (Scottie), interpretato da un perfetto James Stewart. Lo stesso David Lynch venne fortemente influenzato da questa opera cinematografica intrisa di erotismo, noir e necrofilia; ritroviamo alcuni elementi nei suoi Strade perdute, con lo sdoppiamento di Patricia Arquette (Renée/Alice), e Mulholland Drive, con Naomi Watts (Betty/Diane) e Laura Harring (Rita/Camilla). Sempre nel 1958 Kim Novak e James Stewart, a causa di scambi tra case di produzione, si ritrovano co-protagonisti nella commedia raffinata Una strega in paradiso diretta da Richard Quine, all’epoca compagno dell’attrice: tra magie, incantesimi, le fusa del gatto Cagliostro ed uno straordinario Jack Lemmon ci si diverte molto.
La scoppiettante commedia degli equivoci Baciami, stupido (1964), tratta dalla pièce di Anna Bonacci, L’ora della fantasia (1944) e già portata sullo schermo da Mario Camerini con il film Moglie per una notte (1952), è una straordinaria prova attoriale per la Novak, magistralmente diretta da Billy Wilder: sotto la superficiale patina di commedia hollywoodiana il regista nasconde una tagliente critica al mondo senza scrupoli dello showbiz, con il quale l’attrice aveva già fatto i conti. Arrivata alla vetta della celebrità, il suo forte carattere, che andava contro gli stereotipi dell’epoca, le fa comprendere che lo splendore del divismo è una cosa effimera e che l’abisso può essere dietro l’angolo. Già verso la fine degli anni Sessanta l’attrice comincia un lento, ma irreversibile, ritiro dalle scene preferendo dedicarsi alla famiglia e alla sua grande passione per la pittura. Il Leone d’Oro alla carriera alla prossima Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica è il giusto coronamento di un percorso artistico che ha lasciato un solco indelebile nella storia della Settima Arte.
Almost by chance, Marilyn Pauline (Kim) Novak found herself acting within the Studio System and was signed by tycoon Harry Cohn, president of Columbia Pictures, whose goal was to make her rival Rita Hayworth. Novak began taking on emotionally intense roles in dramatic films, such as Molly in Otto Preminger’s dark masterpiece The Man with the Golden Arm (1955) opposite Frank Sinatra, and as the wife of ill-fated pianist Eddy Duchin in the musical biopic The Eddy Duchin Story (1956). In 1957, she portrayed Jeanne Eagels in the silent-era actress’s biopic Jeanne Eagels, and again with Sinatra, starred in the musical Pal Joey Constantly tormented by despotic producer Cohn –who mistreated, threatened, and blackmailed her – Novak, with her strong temperament, often resisted studio pressure, guided by instinct and intellectual honesty. During a time of racial segregation, she defiantly dated actor, singer, and dancer Sammy Davis Jr., sparking scandal and outrage in Hollywood circles. Her ascent to stardom peaked with Vertigo (1958). Hitchcock made a diva out of her. The 2000 exhibition Hitchcock and Art: Fatal Coincidence at the Montreal Museum of Fine Arts explored the visual references and artistic influences in his work. In Vertigo, the spiral in Judy’s coiffure, as she gazes at Carlotta Valdes’s portrait, symbolizes the protagonist’s dizziness and the film’s central motif. This spiral also appears in Saul Bass’s iconic opening credits, inspired by abstract art by Duchamp, Man Ray, and Sander. Novak mesmerizes the viewer with her striking beauty, embodying a femme fatale suspended between eros and thanatos. David Lynch would later draw heavily from Vertigo in films like Lost Highway and Mulholland Drive, echoing its themes of dual identity and obsession.
Also in 1958, Novak and Stewart reunited in the sophisticated comedy Bell, Book and Candle, directed by Richard Quine, her partner at the time. Amid spells, feline antics from Pyewacket the cat, and a delightful Jack Lemmon, the film offered light-hearted fun.
In Kiss Me, Stupid (1964), Novak delivered a brilliant performance under Billy Wilder’s direction. Beneath its comedic surface, the film critiques the ruthless world of showbiz, a world Novak knew all too well.
At the height of fame, Novak’s strong character clashed with the era’s stereotypes. She realized that stardom was fleeting and that the abyss was always near. By the late 1960s, she began a gradual but definitive retreat from acting, devoting herself to family and her passion for painting.
The Golden Lion for Lifetime Achievement at the upcoming Venice International Film Festival is a fitting tribute to an artistic journey that left an indelible mark on the history of cinema.
82. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia 27 agosto-6 settembre-Lido di Venezia www.labiennale.org
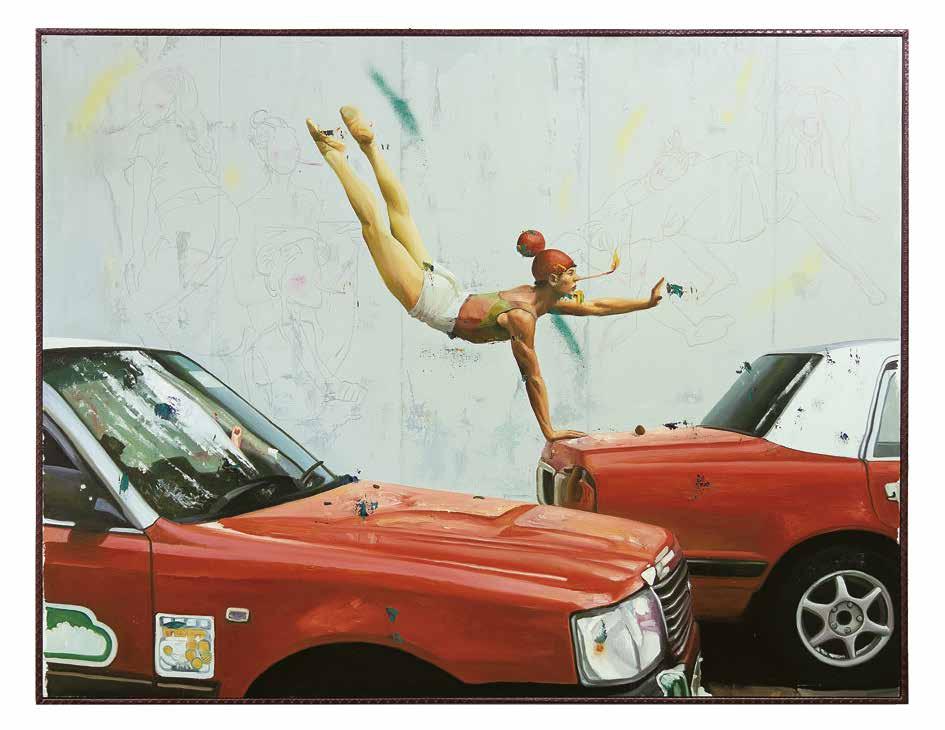

Lo so, ci si abitua. Ci siamo abituati tutti, ormai. I nostri sguardi affondano da sempre nella vastità piatta e insignificante di una pianura coltivata, sfruttata, ritmata da filari di viti, solchi di campi, geometrie posticce di capannoni, brutte chiese di cemento armato o mattoni che ricordano piste di aeroporti o muri di cinta di città inesistenti, strade eterne che conducono ovunque, rotonde cangianti e allucinatorie. Percorrendo queste terre, di rado si incontrano la bellezza fine a se stessa della natura, un manufatto pregno di storia, un ordito di strade ed edifici che portino con orgoglio i segni della storia o di una qualsiasi identità. Non c’è da stupirsi se, arrivando a Venezia, si avverta uno shock di significazione, come se questa città avesse colpevolmente risucchiato e rappreso tutto ciò che intorno ad essa è sempre mancato. Vivere qui, svuota. Nel bene e nel male, o nella loro complementarietà. Lo dice bene Carlo Scarpa con l’architettura del Memoriale Brion, che ad Altivole sorge come una cattedrale nel deserto e in quel deserto, con i suoi giochi di pieni e di vuoti, di terra e d’acqua di verticalità e orizzontalità, sintetizza la bellezza spiritualmente struggente del Veneto di provincia, terra di promesse disattese, di incompiutezze, di gelose sorprese arroccate come fortezze. Crescere qui, nel vuoto, svuota. Queste terre piatte di promesse deluse ed esistenze incompiute sono la materia intorno alla quale Francesco Sossai, già regista di Altri cannibali, ha immaginato il suo Le città di pianura, visto a Cannes ( Un certain regard ) quest’anno, tra la sorpresa - favore -
Le città di pianura di Francesco Sossai www.comune.venezia.it
vole - dei molti e la conferma dei pochi (ancora) affezionati. Se hai raggiunto i cinquanta nella provincia veneta, come i protagonisti del film Carlobianchi (Sergio Romano) e Doriano (Pierpaolo Capovilla), avrai affondato milioni di volte lo sguardo nella sua piatta campagna industrializzata, magari per spostarti da una cittadina brutta a un’altra più brutta, entrambe sorte su strade ora squassate dal rombo di tir, con i crescenti problemi di una viabilità irrisolta e irrisolvibile, ti sarai sorpreso fino allo sgomento di fronte all’assurdità di Venezia, perdendoti di notte tra le sue viscere venose chiedendoti come cazzo sia possibile che tanta bellezza sia sorta nel più illogico degli ambienti, tanta storia passata di lì, come attratta da un sifone buio dove il tempo si rimescola di continuo, e quasi sicuramente avrai ignorato l’esistenza del Memoriale di Scarpa in un cimitero della provincia trevigiana. Avrai riconosciuto il tuo grido nel fragore dirompente del rock che ha corroso dall’interno queste terre nei Novanta e di cui Capovilla (indovinato coprotagonista) è stato l’alfiere. La tua vita allora somiglierebbe alla mia, a quella dei protagonisti de Le città di pianura, perdenti per forza più che per scelta, cresciuti nel solco delle promesse di cartongesso del Nordest e poi estromessi con la crisi del 2008 e rigettati su quelle strade che sembravano non portare a nulla e a nulla, qui, infatti, hanno condotto. Non poteva che essere un film di valle, di sognatori ambulanti, irridenti e beffardi, di maschi maturi, antieroi a confronto con giovani ancora promettenti, questo racconto del bellunese Sossai. Che forse nel nulla, nel vuoto, nel gesto iterato, nell’intenzione senza sbocco, recuperano una dimensione necessariamente e spiritualmente umana. Nel passo. Nel sorso. Nella parola detta occhi negli occhi. Riccardo Triolo

La storia di Campo San Polo è la storia di Venezia stessa. Secondo per dimensioni solo a Piazza San Marco, stando ad un’antica leggenda era in origine la grande arena di una città romana che, successivamente, fu pian piano demolita per ricavare materiale utile per le varie costruzioni. Col passare del tempo questo enorme spazio venne utilizzato per i pascoli e per le coltivazioni, fino a quando fu completamente pavimentato e utilizzato come piazza per il mercato. Non serve scavare nella leggenda per capire quanto centrale possa essere uno spazio del genere in una città che dello spazio, a volte angusto, fa uno dei propri tratti distintivi al mondo. E non è affatto un caso che questo Campo abbia legato al proprio destino recente un’arena di cinema all’aperto che ha fatto la storia della città, prima facendosi appendice della Mostra del Cinema e adesso con Cinemoving, la rassegna firmata Circuito Cinema Venezia che porta proiezioni all’aperto in diversi luoghi dell’isola e della terraferma, con la sezione Uno sguardo all’Europa a farsi nucleo centrale della programmazione estiva.
Da venerdì 1 a venerdì 15 agosto, quattordici le serate in Campo dedicate al cinema europeo in cui verranno proposti lungometraggi, cortometraggi, documentari e film di finzione provenienti da diverse
Cinemoving – Uno sguardo all’Europa 1-15 agosto Campo San Polo www.culturavenezia.it
nazioni europee a cui saranno dedicati approfondimenti e presentazioni, in stretta collaborazione con diverse istituzioni internazionali, come ad esempio il Premio LUX che rende omaggio al cinema europeo ed è inteso a sensibilizzare sulle questioni sociali, politiche e culturali in Europa.
Quattro serate dal 2 al 14 agosto dedicate ad altrettanti film vincitori o candidati al Premio LUX 2025 per una collaborazione tra Europe
Direct Venezia Veneto del Comune di Venezia, Ufficio di collegamento a Milano del Parlamento europeo e Premio LUX del pubblico, con in programma pellicole come Flow, Julie Keeps Quiet, Intercepted dedicato alla guerra in Ucraina e Animal
Non mancano poi i focus sulle cineamtografie di diversi Paesi, quest’anno occhi su Francia e Ungheria, con quest’ultimo contesto che vede il 4 agosto sul megaschermo Semmelweis di Lajos Koltai, direttore della fotografia qui di nuovo regista dopo l’esperienza del 2007 con Evening e in passato candidato all’Oscar come collaboratore di Tornatore: siamo a Vienna, nel 1847. In una clinica ostetrica si diffonde una misteriosa epidemia. Il giovane medico Ignác Semmelweis cerca di contrastare la febbre puerperale sfidando le teorie consolidate della medicina del tempo. Biopic in costume ambientato nel XIX secolo, il film racconta la vita del pioniere delle pratiche antisettiche negli ospedali, passato alla storia come il “salvatore delle madri”.

















VENEZIA E LA MUSICA PER FILM
Ed eccoci al terzo appuntamento del nostro ciclo di articoli dedicati a film le cui colonne sonore sono state composte da musicisti veneziani. Dopo Arcana di Giulio Questi, musicato da Romolo Grano, e Acciaio di Walter Ruttmann, musicato da Gian Francesco Malipiero, è ora il turno di un altro film diretto dal genio di Giulio Questi, La morte ha fatto l’uovo. Le musiche del film sono state composte da un altro genio: Bruno Maderna.
Trama
Negli anni ruggenti del miracolo italiano gli allevamenti di polli sono il centro di innovazioni tecnologiche e ricerche di laboratorio che creano cambiamenti epocali. Anna è la proprietaria di uno di questi grandi allevamenti, il marito Marco lo dirige: insieme a loro vive la nipote di lei, Gabri, con cui Marco ha una love story. Complotta di uccidere la moglie per poi goderne l’eredità insieme alla nipote, che invece ha altri piani. Riuscirà il tran tran borghese del terzetto, oscillante fra relazioni ufficiali, tradimenti, perversioni più virtuali che reali, a sopportare le pressioni della logica capitalistica che esige discontinuità?
Giulio Questi, meteora irrequieta e luminosa del cinema italiano
Quando a Roma, nei giri del cinema, si diceva: «Aspetta che Giulio Questi faccia il suo primo film, poi vedrai!»… E lo fece infine, il buon Questi, il suo primo film, un western all’italiana girato alla periferia di Madrid dal titolo Se sei vivo spara con protagonista Thomas Milian, opera in cui il regista riverserà i ricordi di quando per due inverni fece il partigiano nelle alte vallate bergamasche. Ma il film fu colpito da feroce censura e passò sotto silenzio. Ne fece un altro di lì a poco, La morte ha fatto l’uovo, “figlio dell’anarchia lisergica sessantottina”, come scrive Davinotti, con un casting internazionale. Il film con i suoi incassi gli garantì un po’ di soldi, ma non gli assicurò nessun salto quantico nell’empireo del cinema italiano. Diresse a seguire, qualche anno dopo, il suo terzo ed ultimo film, Arcana, sulla persistenza della magia religiosa contadina nelle grigie periferie di Milano, dove il boom economico era già un ricordo. E se in Magnolia del 1999 Paul Thomas Anderson conclude il film con una pioggia di rane, Questi il suo lo finisce con le rane che escono dalla bocca di Lucia Bosè. Terzo film, terzo insuccesso. In cinque anni si era giocato tutto l’hype che aveva conquistato negli ambienti romani con la sua precedente attività di documentarista e di geniale factotum di produttori spregiudicati e alla ricerca di guadagni facili. Da allora la sua carriera si sarebbe svolta tutta dentro la televisione, tra Caroselli, sceneggiati e film per la tv.
Giulio Questi fu davvero la meteora irrequieta e luminosa del cinema italiano. Che vita questo regista bergamasco del 1924, morto a 90 anni, partigiano a 19, giovane scrittore coltivato da Vittorini che con un suo romanzo voleva aprire la collana I gettoni da lui diretta per Einaudi, trasferitosi a Roma nel 1950 per curiosità e subito finito nella villa di Visconti sulla Salaria, con Luchino che gli promette di chiamarlo come suo assistente per La carrozza d’oro (che poi non farà), amico di tutti i grandi nomi del cinema italiano, ma anche di Garcia Marquez (per anni Questi abitò in un’isola fuori Cartagena, in Colombia). Genio mal compreso, affabulatore nato, raffinato flaneur, intellettuale dotato di una strepitosa intelligenza empatica, uomo di cinema disposto a qualsiasi avventura pur di stare in quell’ambiente, letterato mancato che sul finire della vita scriverà una manciata di racconti sulla sua esperienza di partigiano degni di stare alla pari con i racconti di Fenoglio. Tutto questo è stato Giulio Questi. E, forse, molto di più.
Un pollo su un pullman
In viaggio per Baden Avvolto in un loden Si sente nell’Eden; sua moglie col rimmel gli fuma le Camel.
Questa poesia di Toti Scialoja, coeva del film di Questi, potrebbe davvero essere messa ad epigrafe de La morte ha fatto l’uovo Il film, infatti, ha come sua principale location un allevamento di polli. È proprio negli anni ‘60 che il pollo entra diffusamente nella cucina degli italiani, ed in particolare il pollo arrosto conquista un posto di prestigio nei pranzi della domenica. Del resto già nel 1961 le gemelle Kessler avevano raggiunto il successo italiano cantando Pollo e champagne. Ma c’è di più: nella poesia di Scialoja il pollo è sottoposto ad un processo di metamorfosi, per cui diventa cittadino, consumatore, umanoide. Essere diventato uno degli ingredienti basici della cucina italiana di quegli anni gli dà diritto a parvenze ed abitudini umane. La stessa cosa avviene nel film. «La verità è che la gente non lo conosce, il pollo! Dobbiamo abbattere questo muro d’ignoranza e obbligare tutti a conoscerlo. Qui si tratta di elevare la pubblicità a livello politico»: questo è l’input strategico del presidente dell’Associazione Allevatori di polli. E per realizzare questa missione, più di antropologia culturale che di obiettivo industriale, il pubblicitario incaricato della campagna si inventa appunto un pollo in grado di interpretare tutti i diversi ruoli sociali dell’essere umano: il pollo ingegnere, il pollo burocrate, il pollo soldato, il pollo playboy. Insomma, il pollo lascia le campagne e va alla conquista delle città. Giulio Questi è un maestro nella rappresentazione degli incubi che
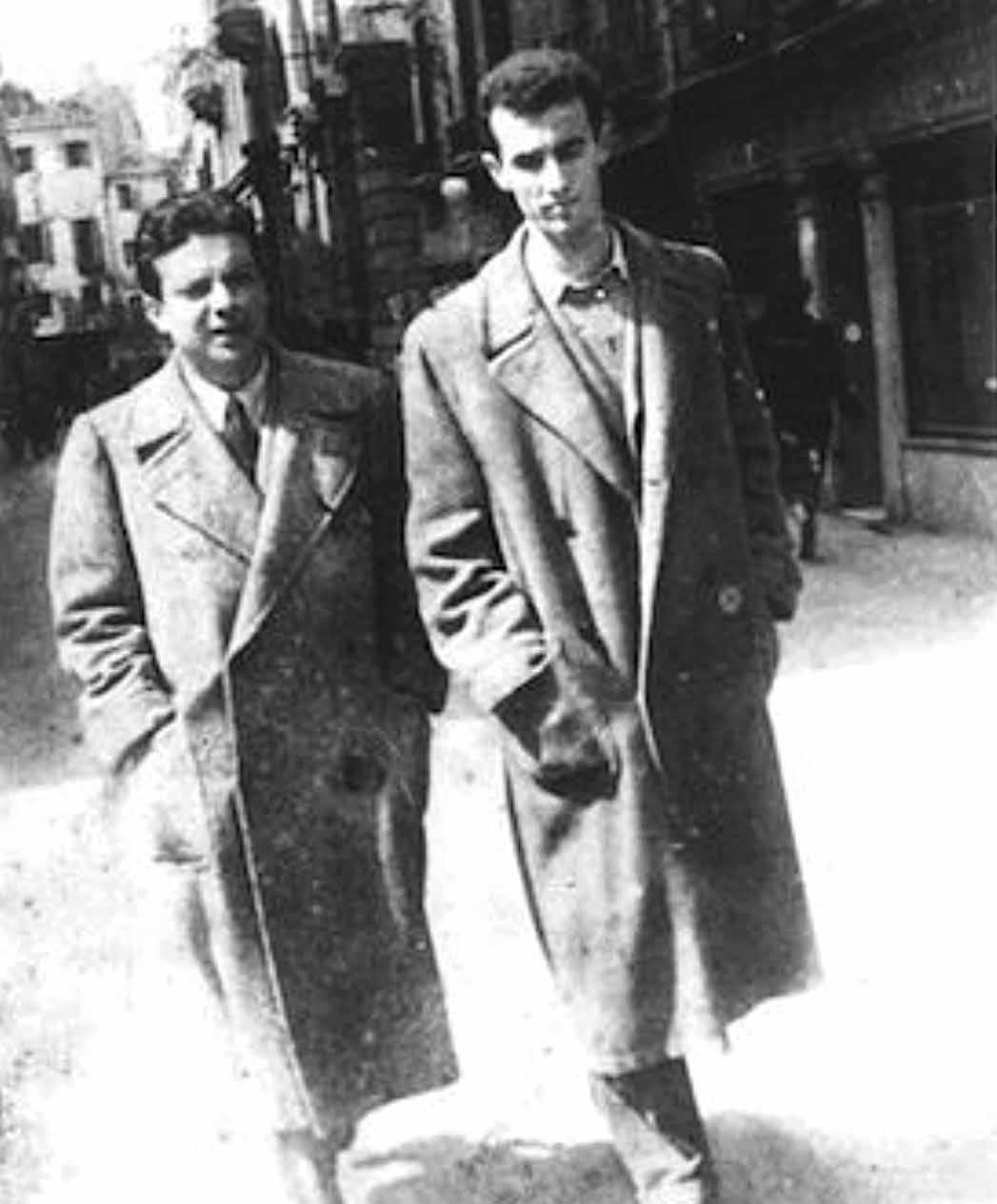
Anno: 1968
Regia: Giulio Questi
Sceneggiatura: Giulio Questi
e Franco “Kim” Arcalli
Montaggio: Franco “Kim” Arcalli
Musiche: Bruno Maderna
Interpreti: Gina Lollobrigida , Jean-Louis Trintignant , Ewa Aulin
attraversano la società, seminando nei suoi film tracce continue di mostri simbolici e perversioni che da individuali diventano collettive. In Questi la perversione è un virus che aspetta nell’ombra di diventare legge sociale. È la civiltà della campagna che sfida la civiltà della città e la sua falsa rispettabilità.
Nelle storie del cinema italiano, come quella di Gian Piero Brunetta, che a sua volta cita Miccichè, Giulio Questi appare affogato all’interno di una lunga lista di registi esordienti nella seconda metà degli anni Sessanta e destinati ad un eterno, dignitoso anonimato (per fare qualche nome, Lionello Massobrio, Giorgio Trentin, Anna Gobbi, Alfredo Angeli). La difficoltà a riconoscere il suo talento smisurato arricchito da un coraggio sfrontato, beh, forse non è tutta ascrivibile alla lettura dello storico di cinema: i film di Questi, ai tempi della loro uscita, erano dispositivi complessi la cui interpretazione analitica non era per niente facile. In superficie apparivano immersi dentro le convenzioni e i canoni più stretti del ‘genere italiano’ (spaghetti western, thriller, noir); ma da lì, da questa infinita forza auto-generativa propria del ‘genere’, partivano per addentrarsi in una interpretazione della società di cui non si sa se ammirare di più la sfrenata anarchia oppure la raffinatezza, quasi ai limiti dello sfinimento. Dice Questi: «La morte ha fatto l’uovo è pieno di cartelloni pubblicitari e non c’è niente di più pop dei cartelloni pubblicitari: ma per pop intendo anche l’immissione senza paura né vergogna nei miei film di tutti quei clichè popolari che fanno parte della stessa natura del cinema commerciale, di genere». Giulio Questi è partito dal genere e sul genere ha costruito un cinema laterale, anarchico, sovversivo.
Giulio Questi e la musica
Uno degli aspetti più intriganti, a tratti irresistibili, del Questi regista è rappresentato dalle scelte musicali: tutte le colonne sonore dei suoi film sono state composte da musicisti provenienti dall’area della musica colta. Per il suo primo film, Se sei vivo spara, Questi sceglie come autore delle musiche Ivan Vandor, compositore di origini ungheresi trasferitosi a Roma a 6 anni nel 1938, dove si diplomerà nella classe di Goffredo Petrassi. Per il secondo film, La morte ha fatto l’uovo, il regista si rivolge invece a Bruno Maderna, il più grande compositore italiano del Secondo dopoguerra (insieme a Luciano Berio) e direttore d’orchestra veneziano, cresciuto alla scuola di Malipiero. Ecco le ragioni di questa scelta dalle parole stesse del regista: «Come mai per La morte ha fatto l’uovo non ho chiamato Ivan Vandor? Perché, per una serie di circostanze, mi sono trovato davanti Bruno Maderna ed è stata troppo grande la tentazione di avvalermi delle sue qualità di sperimentatore da sposare con le sperimentazioni del mio film. Maderna era veneziano, come Kim Arcalli (grande amico di Giulio Questi, sceneggiatore e montatore dei suoi film, ndr) e Luigi Nono, tutti e tre amici da tempo. È grazie a Kim che li ho conosciuti. Gli ho dato il copione da leggere e mi ha detto subito di sì. Appena arrivato alla Fono Roma, dove registravamo, non si è accontentato dell’orchestra che ha trovato, ma si è fatto portare delle lamiere per produrre di sua mano strani rumori metallici, che abbiamo usato per buona parte del film… Più inventava più ero felice, perché andava incontro alle invenzioni del film. Non ha preso i tempi. Ha fatto in libertà una musica di interpretazione del film, una musica aperta, tagliabile, montabile, a disposizione».
Bruno Maderna e la colonna sonora Impossibile per ragioni di spazio tracciare qui un ritratto anche solo superficiale di Bruno Maderna, di quello che la sua figura di compositore, direttore d’orchestra, didatta, organizzatore ha rappresentato per la musica del Secondo Novecento. Bambino prodigio, personalità di enorme spessore umano (basti vedere su You Tube le registrazioni delle sue prove d’orchestra) e al contempo genio dell’organizzazione e del ‘fare preciso’ (difficile altrimenti creare dal nulla, come lui fece negli anni ’50 insieme a Luciano Berio, lo Studio di Fonologia RAI a Milano, che presto diventerà un centro di riferimento a livello internazionale per la musica elettronica). Come ebbe a dire proprio Berio: «… quella di Maderna è la prima musica seriale che sorrida un po’…». E questa fu sempre la costante del musicista veneziano, creare una musica dove le ragioni del canto dessero del tu al rigore ed alla espressività, lontano da ogni deragliamento dei sensi o degli affetti. Uomo curioso, che non si poneva limite alcuno, Maderna fin da giovane frequentò la dolce e remunerativa pratica della composizione di musiche per film e per la televisione. Film oggi irreperibili, a parte la colonna sonora proprio de La morte ha fatto l’uovo. Una colonna sonora di altissimo livello, in cui Maderna esplicita tutto il suo genio compositivo sospeso tra canto di fascinoso melodismo e atonalismo, libero però da ogni eccesso di furore e di parossismo. Maderna scrisse e realizzò il materiale musicale sottoponendolo poi a numerosi passaggi elettronici che ne modificano timbri, altezze, atmosfere. Dalla descrizione di Questi sopra riportata appare un Maderna principe dell’improvvisazione, che si diverte ad introdurre cambiamenti continui rispetto all’idea originale del brano. In realtà, ad un ascolto attento, tutto il materiale che costituisce la colonna sonora del film appare ricchissimo di incastri, di rimandi, di citazioni che si rincorrono da un brano all’altro, quasi come se Maderna, prima del momento dionisiaco dell’improvvisazione, si fosse preoccupato di realizzare un archivio di suoni e melodie rispondenti ad un principio efficacissimo di organizzazione interna. L’unico approccio possibile, del resto, per un film tremendamente nervoso ed irrequieto come quello di Questi, che diverrà celebre come uno dei massimi esempi di montaggio frenetico e quasi subliminale del cinema italiano. Musica libera, insomma, non scritta per il film, ma sottoposta a ferree regole interne per quanto riguarda la costruzione di blocchi e frammenti sonori dal molteplice utilizzo nell’economia del film. Sembra quasi che il previdentissimo Maderna abbia realizzato due diverse ‘catene del valore’: una legata ad un forte tonalismo, in cui si susseguono brani orecchiabili (si ascolti Musical line, un blues irresistibile suonato dal violino con una chitarra che si intromette di continuo nella linea melodica) costruiti secondo la logica dei blocchi integrabili; un’altra caratterizzata da una ‘musica destrutturata’, fatta di vampate improvvise, di clangori strumentali, di marcette svampite che fanno da sottofondo all’agire insensato dei protagonisti, vere e proprie maschere di una rispettabilità borghese solo esteriore, capaci solo di sotterfugi ed agìti dalle circostanze. Anche qui, in questo lavoro minore dimenticato da tutte o quasi le pubblicazioni su Maderna, il nostro dimostra un talento musicale ed una sapienza dell’agire pratico che colpiscono. Ed è proprio Maderna, il più fraterno, il più generoso della nidiata dei giovani ‘fratelli di Darmstadt’ (Stockhausen, Boulez, Nono…), il musicista che più di tutti risulterà capace di comunicare il nuovo attraverso una musica che respira il senso della storia e del passato. Nel suo piccolo, anche la colonna sonora de La morte ha fatto l’uovo è lì a dimostrarlo.


















In una splendida atmosfera balneare, per sette giovedì in riva al mare nella spiaggia libera di VeneziaSpiagge verranno proiettati film che osservano l’orizzonte del delicato rapporto padri e figli, alla ricerca di equilibri tra scoperta, sentimenti, conflitti e la necessità di crescere. Stesi sul proprio telo mare (non ci saranno sedie), si spazia dall’animazione Pixar di un classico come Alla ricerca di Nemo alla storia del cinema raccontata dal capolavoro di De Sica Ladri di biciclette, senza tralasciare i contributi d’autore firmati da Gabriele Muccino e il suo La ricerca della felicità con un Will Smith in stato di grazia o Gran Torino, di e con l’infallibile Clint Eastwood.
Uno sguardo all’orizzonte 10 luglio-21 agosto Spiaggia libera-Lido di Venezia www.culturavenezia.it

Novità di quest’anno, ecco sei serate al Parco Albanes con film per tutti i gusti, per sorridere e riflettere, coinvolgendo piccoli e grandi spettatori. Come Il maestro che promise il mare, biografia di Antoni Benaiges, un maestro elementare catalano che nel 1935 viene assegnato ad una scuola di un piccolo paesino nella provincia di Burgos. Il giovane insegnante rivoluziona i canoni scolastici dell’epoca, con la guerra civile spagnola a fare da sfondo minaccioso. Il 30 luglio spazio poi a Evil Does Not Exist di Ryûsuke Hamaguchi, in Concorso due anni fa alla Mostra del Cinema di Venezia dove si è aggiudicato il Gran Premio della giuria internazionale.
Cinemoving al Parco Albanese 25-30 luglio Bissuola-Mestre www.culturavenezia.it
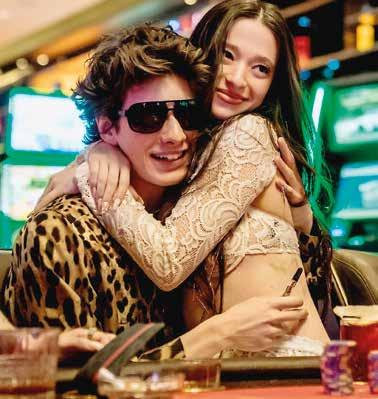
Se si tratta di una pellicola capace in qualche modo di lasciare il segno, potete stare certi che la troverete.
La prima impressione leggendo il programma delle proiezioni che Operaestate organizza all’aperto negli spazi di Villa Ca’ Erizzo Luca e dei Giardini Parolini di Bassano è che davvero nessuno, ma proprio nessuno manchi all’appello.
Del resto, parliamo di un programma che dall’1 luglio al 31 agosto si prende praticamente solo un paio di giorni di pausa, timbrando il cartellino anche a Ferragosto e proponendo ogni sera un film diverso ad un pubblico che sempre di più risponde, a dispetto del caldo o da presunte fughe dalla città.
Si comincia appunto il 1° luglio a Villa Ca’ Erizzo Luca, a due passi dal fiume Brenta con un film particolarmente significativo come Giovanni Segantini-Magia della luce di Christian Labhart: significativo perché proprio a Bassano dal 25 ottobre e fino al 22 febbraio 2026 è in programma al Museo Civico l’esposizione che celebra Giovanni Segantini, la grande mostra che celebra la vita e l’opera di uno dei massimi esponenti del Divisionismo italiano e tra i più sensibili osservatori del mondo naturale.
L’11 luglio è il turno di Vermiglio di Maura Delpero: Gran Premio della Giuria a Venezia nel 2024 e 7 David di Donatello tra cui miglior film e miglior regia (prima regista donna a riceverlo), è il film rivelazione dell’ultima annata cinematografica. Intenso, vivo, struggente, vi si è ravvisata la lezione di Ermanno Olmi per lo straordinario rigore formale nel descrivere la vita contadina piena di grazia e asperità. È ambientato nel 1944, nella frazione di Vermiglio, sui monti del Trentino.
Qui la famiglia Graziadei vive la quotidianità nel freddo e nella difficoltà degli ultimi mesi di guerra. Il capofamiglia è maestro elementare, la madre ha appena partorito il nono figlio. I letti della casa sono condivisi da ragazzi, ragazze e tanti bambini. L’arrivo di un soldato disertore cambierà gli equilibri della famiglia.

Il 19 luglio ecco Diamanti di Ferzan Ozpetek, altro caso cinematografico dell’anno assieme all’immancabile
Parthenope di Sorrentino, in programma una settimana dopo.
Dal 2 al 4 agosto spazio a pellicole tematicamente assai distanti tra loro come Emilia Pérez di Jacques Audiard, Maria di Pablo Larraín e La trama fenicia di Wes Anderson: tre pezzi da novanta che confermano come la programmazione abbia pescato il meglio del meglio della stagione cinematografica appena trascorsa.
Berlinguer – La grande ambizione (9 agosto), Anora di Sean Baker vincitore di 5 Oscar (10) e A complete Unknown (13) ci portano ad uno degli appuntamenti più attesi, quello con The Substance, in programma il 17: miglior sceneggiatura a Cannes, miglior attrice ai Golden Globes per la performance di Demi Moore e complimenti unanimi a quelle di Margaret Qualley e Dennis Quaid, incetta di nomination agli Oscar. Questo mix di commedia nera e body horror sfrutta sapientemente il genere per affrontare temi di estrema attualità. Elisabeth, attrice hollywoodiana sulla via dell’oblio, viene licenziata dal programma di fitness che conduceva, ormai troppo vecchia per gli standard dello star system. La delusione la spinge a provare un innovativo siero che ringiovanisce. Una volta somministrata, Elisabeth si rende conto che “la sostanza” agisce in modo inaspettato… Davide Carbone


Anni fa ai margini del Festival di Cannes si tenne un interessante convegno su sale cinematografiche alternative. La domanda lungimirante era se trovando spazi alternativi per una proiezione si poteva attrarre più pubblico, in particolare i giovani.
Se guardo i programmi di questa estate trovo sicuramente una risposta. Rassegne sono ospitate in luoghi d’arte, musei, gallerie. A Brescia, al Parco delle Sculture, il Museo di Santa Giulia ospita una imponente rassegna di 87 film con visite guidate, incontri e, immancabile, un’area food and drink. Anche Palazzo Pitti a Firenze apre per la prima volta al cinema. A Roma il Parco Acquedotti con l’occasione di scoprire i casali e le sue tombe, a Villa Borghese con la Casa del Cinema, poi ancora a Tor Bella Monaca o all’Idroscalo di Ostia. Forse sulla scia di Sauna di Mathias Broe o lo stupendo Smoke sauna-I segreti della sorellanza di Anna Hints anche le saune si stanno attrezzando, per ora con il teatro, ma anche con proiezioni (Aquardens Terme Verona). Per questo sorrido e non mi rattrista quando leggo che al posto di un vecchio cinema viene realizzato un’orribile costruzione di 48 appartamenti e che viene chiamato Residence della Settima Arte. Seguo invece con interesse le possibili evoluzioni della tecnologia IMAX, con le loro pretese di immergere lo spettatore nello schermo potenziando suoni, colori.
Da semplice attrazione del parco giochi Oltremare di Riccione, oggi a Las Vegas si sperimenta The Sphere, enorme palla all’interno della quale uno schermo curvo a 270 gradi si offre ai 20000 spettatori che può contenere. Quasi inaugurato dagli U2 ora ospita The Sphere experience. Postcard from Earth in cui il famoso regista Darren Aronofsky immagina una missione nello spazio in dove l’umanità possa iniziare una nuova e più saggia vita. Ma grazie all’IA si pensa di far rivivere anche un classico come Il Mago di Oz del 1939. Sarà compito della IA ricostruire dettagli mancanti per riempire lo schermo, ingrandire i personaggi secondari o ampliare lo sfondo. Lo andrò a vedere, Dorothy mi ha sempre incantato. Il cinema sta abolendo i suoi tradizionali confini, non è più la minaccia al teatro menzionata da Peter Brook: botteghini, foyer, strapuntini, luci della ribalta, cambi di scena, intervalli, musica e magari per quelli della mia età le ragazze che vendevano bibite e lupini negli intervalli. Il cinema non sa neppure cosa essere, nella progressiva erosione dei confini dei diversi settori dell’audiovisivo. D’altronde dall’invenzione del primo cinema, la Camera Oscura, sono passati più di mille anni. L’arabo Alhazen, autore dell’Opticae Thesaurus Alhazeni Arabis, nacque infatti nel 965. Loris Casadei

CINEFACTS
a cura di Marisa Santin
Nel grande archivio del cinema distopico ci sono film che hanno finito per assomigliare in modo inquietante al nostro presente. Senza insistere sui noti 1984, Fahrenheit 451, Metropolis, The Truman Show, qui una selezione di opere che forse non abbiamo preso abbastanza sul serio al momento dell’uscita e che il tempo ha reso più rilevanti che mai, tra crisi climatica, rischio di epidemie globali, collasso sociale e democrazie sotto assedio.





di Alex Garland (2024)
Una guerra civile nel cuore degli Stati Uniti, raccontata attraverso gli occhi di un gruppo di giornalisti che attraversano un Paese disgregato, sospeso tra propaganda, violenza e disinformazione. Un anno fa, quando è uscito, poteva sembrare una distopia futuribile; ora è il nostro presente portato all’estremo. Una visione necessaria in tempi di polarizzazione e verità frammentate. (Prime Video)
di David Mackenzie (2011)
Un’epidemia misteriosa priva le persone dei sensi. Prima l’olfatto, poi via via tutti gli altri fino all’ultimo: l’unico che può mettere in dubbio il fatto stesso di esistere. Pur immaginando un virus mai esistito, il film ha anticipato i risvolti psicologici che avremmo di lì a poco sperimentato con il Covid: lo smarrimento, l’adattamento forzato, il bisogno di vicinanza anche (e soprattutto) quando il mondo si chiude. (Prime Video, Chili)
(Children of Men)
di Alfonso Cuarón (2006)
Un mondo in cui gli esseri umani non riescono più a riprodursi e le frontiere si chiudono con violenza. Il film parla di speranza, ma anche di una società militarizzata e di un’Europa ossessionata dalla sicurezza, che respinge i migranti e tratta i rifugiati come rifiuti umani. Estremamente potente alla luce dell’attualità. (Netflix)
di Roland Emmerich (2004)
Quali sono le reali probabilità di un collasso climatico improvviso?
Considerato all’uscita un disaster movie esagerato, il film di Emmerich è citato oggi in studi sul climate change come un esempio (iperbolico ma non inverosimile) di eventi climatici estremi causati dal riscaldamento globale. (Disney+, Prime Video)
Gattaca
di Andrew Niccol (1997)
Eugenetica, bioetica, discriminazione genetica. Quando uscì, era un elegante film distopico, ma sembrava lontano dalla realtà. Con il progresso della scienza la sua riflessione sul determinismo biologico e sull’accesso diseguale alle tecnologie genetiche è diventata più attuale che mai. (Netflix, Prime Video, YouTube)
Malgrado i numerosissimi turisti che la invadono quotidianamente, ignari
della vita cittadina che prosegue ostinatamente, Venezia è viva! Liana Levi
Liana Levi ama Venezia e persegue il “semplice” obiettivo di dare un contributo alla vivacità della città. Lo fa pubblicando per la sua casa editrice Venezia è viva, volume redatto in tre lingue: francese, inglese e italiano. Liana vuole che la cittadinanza si allarghi, si estenda oltre i limiti imposti dalla burocrazia e dalla politica per risvegliarsi in tutti coloro che vivono la città. Curatrice di questa pubblicazione, di questa guida è Donatella Calabi, responsabile del capitolo su Rialto, ponte ed epitome delle sue ricerche di architettura e urbanistica. Le altre autrici di questo libro necessario sono: Stefania Bertelli (Giudecca), Ludovica Galeazzo (Isole), Martina Massaro (Santa Marta), Elena Svalduz (Castello). La libreria La Toletta, pilastro della formazione veneziana, punto di incontro tra giovani, meno giovani e turisti culturali, riducendo i costi di distribuzione crea spazio per contribuire alle associazioni cittadine che vivificano la città: Progetto Rialto, Poveglia per tutti, ATA-Alta Tensione Abitativa. Sono associazioni che incidono sulle politiche urbanistiche della città, riportando l’interesse pubblico – il bene comune – al centro dell’attenzione e dell’azione civile.
«Malgrado i numerosissimi turisti che la invadono quotidianamente, ignari della vita cittadina che prosegue ostinatamente, Venezia è viva. La città è percorsa da visitatori che sempre più tendono a farne una delle tante Disneyland del mondo... Nelle aree illustrate in questo libro la città non è, come spesso dà per scontato chi vi giunge per pochi giorni o poche ore, un moribondo residuo di un mitico passato, ma un insediamento urbano che prosegue i propri spostamenti, le soste, i contatti e gli scambi in una condizione fuori norma, all’interno di una struttura unica fatta d’acqua e di percorsi pedonali». Non ci potrebbe essere inizio più chiaro: l’obiettivo è di scoprire la vita della città, rivelarla anche ai “selfisti”, che usano i monumenti come sfondo della propria immagine
Venezia è viva | Venice is alive | Venise est vivante
ed. Liana Levi, Parigi, 2025 a cura di Donatella Calabi
con contributi di Stefania Bertelli, Donatella Calabi, Ludovica Galeazzo, Martina Massaro, Elena Svalduz www.lianalevi.fr
accecati dal narcisismo digitale. Venezia è viva propone diversi percorsi. Alla Giudecca, oltre alla Fondazione-Archivio Luigi Nono, che attira musicologi e studiosi da tutto il mondo, vi è anche l’incubatore di San Cosma, che ospita attività di start up, professionisti, coworking. Uno degli interventi più originali e recenti è il recupero dell’Orto Giardino del Redentore, realizzato da Venice Gardens Foundation creata da Adele Re Rebaudengo. Le Antiche Officine dei Frati aperte verso la Laguna Sud ospitano ora mostre e un Caffè dedicato all’accoglienza dei visitatori, qui immersi in questo meraviglioso giardino-orto restaurato e manutenuto con determinazione. Questo intervento segna, dopo l’esperimento straordinario dei Giardini Reali a San Marco, un cammino che la città non riesce ancora sistemicamente ad imboccare in quanto modo di fare, modo di difendere e valorizzare lo spazio pubblico, anche se il pubblico comincia ad apprezzare la cura del verde. Quello pubblico, esiguo e così prezioso nella città di pietre, è vittima di incuria da parte del Comune e spesso del pubblico stesso. Quello privato è in genere circondato da alte mura, che un nuovo regolamento comunale potrebbe contribuire ad abbattere o a ridurre, con beneficio della salute delle piante e con un effetto straordinario sulla circolazione dell’aria e della vista per chi percorre le calli e le fondamenta della città. Vedremo.
Quando il Covid ci aveva isolato nei nostri appartamenti restituendoci una città senza turisti e anche senza di noi, ci rendemmo conto dell’importanza della natura nella composizione del quadro della sua bellezza. Senza la presenza umana, rifulgeva. I canali, privi di moto ondoso, trasparenti pullulavano di pesci a vista. La Laguna si stendeva tra un’isola e l’altra senza soluzioni di continuità, senza rumori, boati, scie: l’aria priva di molte emissioni era un’aria nuova e per molti di noi prima di allora sconosciuta. Passeggiate “giustificate”, in quella drammatica primavera del 2020, portavano ai Giardini Reali, da poco restaurati e aperti, approdo ad una bellezza soverchiante e al tempo stesso commovente. Ma non è solo la bellezza il “bene pubblico” offerto da Venice Gardens Foundation. L’altro valore altamente educativo è quello

della cura, della manutenzione, valori e attività che danno vita a una città che si rinnova sempre traendo linfa dal suo passato. Una città dove il prodotto e il sapere artigiano non sono nè lusso nè nostalgia, ma espressioni della sua unicità, del suo non essere standardizzata, non essere ripetibile, del vivere la propria individualità irriducibile e avvolgente.
Venezia è un percorso singolare al punto che ogni masegno è georeferenziato, per dirla in termini digitalmente contemporanei, ossia la sua posizione è unica. In quella calle, o fondamenta, o campo, in quella fila, con quel numero d’ordine: gli operai che rifanno le pavimentazioni innanzitutto devono scrivere le coordinate sul masegno prima di rimuoverlo e accatastarlo con cura. Il pavimento della città è esemplare per capire che Venezia non può essere rifatta, ma deve essere manutenuta ( manu tenere ovvero tener per mano).
Nel capitolo sul sestiere di Castello di questo volume corale, incontriamo l’Arsenale «la prima fabbrica urbana della storia... collocata infatti al margine orientale della città, dove si producevano e armavano le navi della Serenissima. L’immenso spazio acqueo (48 ettari, circa un sesto dell’abitato) è intervallato da edifici i cui nomi evocano antiche attività».
Il libro mette giustamente in evidenza l’importanza di questo comparto-quartiere industriale, anche sotto il profilo eminentemente storico e architettonico. A ragione, poiché se da un lato dobbiamo riconoscere il ruolo decisivo della Biennale nella valorizzazione di un’area così imponente per dimensione e qualità urbanistica, da un altro tuttavia non possiamo non rilevare che in particolare la Biennale di Architettura non ha mai valorizzato in misura adeguata la sede delle sue esposizioni. I visitatori, che vengono da tutto il mondo sono avvolti da immagini, opere e progetti dei padiglioni nazionali e della mostra principale. Manca una seria guida, affidata a cartelli, qrcode e altre diavolerie digitali che consenta di percepire l’importanza della Fabbrica e il senso profondo del percorso. Anche perché il dialettico
contrasto vitale tra architettura stratificata di una antica fabbrica e nuove proposte risulterebbe assai istruttivo. I visitatori oggi, tanto per fare un esempio curioso e sorprendente su tutti, non possono immaginare che la parola “manager”, considerata tipicamente anglosassone, deriva da “maneggio”, che definiva il mestiere del direttore dell’Arsenale, responsabile dell’amministrazione dell’enorme fabbrica delle navi.

Tra le altre varie, intriganti suggestioni di questa guida trilingue c’è il gobbo parlante di Rialto, la statua dove avvenivano le esecuzioni capitali e anche uno dei luoghi dove la satira politica, come il Pasquino di Roma, poteva trovare spazio e riconoscimento. E poi ancora Santa Marta, le Terese, luoghi recuperati a nuove funzionalità universitarie mantenendo i loro valori architettonici e culturali originari, o il Molino Stucky, altro segno dell’industrializzazione di fine Ottocento, con le sue linee del Neogotico nordeuropeo, che architetti sensibili hanno difeso nel restauro commissionato da Acqua Marcia.
In conclusione, questo lavoro a più mani curato da Donatella Calabi per le edizioni di Liana Levi ci restituisce l’immagine e la sostanza di una città molto meno rassegnata di quello che si è portati oggi a pensare. Lo fa solcando tracce urbane, architettoniche, associative che semplicemente parlano con la loro persistenza, con il loro ciclico reinventarsi alimentandosi delle proprie radici, con il loro operare nel cuore vivo della società, di una città che vuole semplicemente continuare a vivere. A suo modo. Unico.
IL MONDO CHE HA FATTO
Intervista Roberto Ferrucci
di Elisabetta Gardin
Un maestro, un esempio, ma soprattutto un amico, questo è stato ed è Daniele Del Giudice per Roberto Ferrucci, che ci racconta i trent’anni della loro amicizia nel suo bellissimo libro Il mondo che ha fatto, pubblicato da La nave di Teseo. I due scrittori si conoscono nel 1985 alla Libreria Don Chisciotte di Mestre. Ci sono undici anni di differenza tra loro, Ferrucci sta studiando all’università, Del Giudice è già un autore affermato che sta per pubblicare Atlante occidentale, il suo secondo romanzo. Da allora le loro vite si intrecciano. Ferrucci farà la tesi su Del Giudice e lui gli affiderà parte del suo archivio, mettendolo in un grande sacco dell’immondizia. Lo porterà in volo su Trieste per ‘incontrare’ un certo Ettore (Ettore Schmitz, Italo Svevo), ci sarà un viaggio insieme in Jugoslavia, vivranno la comune amicizia con Antonio Tabucchi, l’incontro con Wim Wenders, regista mito di quel periodo, a cui Del Giudice aveva scritto l’introduzione del libro fotografico Una volta Molti i racconti che testimoniano la loro confidenza e complicità, gli aperitivi al bar di Campo San Polo, vicino a casa di Del Giudice, le chiacchierate, la pasticceria Targa, usata come ufficio postale dove lasciare pacchetti e corrispondenza, le pizze alle Zattere, Del Giudice che recupera il portafoglio di Ferrucci mentre galleggia sul Canale della Giudecca, le esperienze lavorative di entrambi, come Fondamenta. Venezia città di lettori, festival che Del Giudice dirige per quattro edizioni, o il lavoro di autore a TeleCapodistria di Ferrucci. Del Giudice aveva un’aria molto seria, metteva un po’ di soggezione. Ci colpisce, invece, che Ferrucci ce lo descriva sempre pronto allo scherzo. Anche Roberto stesso ne è vittima più volte, in uno c’è persino la complicità di Tabucchi. Del Giudice è un uomo coltissimo, sempre curioso degli altri, amante della meccanica e soprattutto del volo; è un pilota esperto e a questa sua grande passione dedicherà il romanzo Staccando l’ombra da terra Poi l’inizio di una malattia crudele, le prime difficoltà, i primi vuoti che lo fanno ordinare, si tratti di un tè o di una pizza, “Anch’io”, perché la memoria si inceppa e lui, che era stato precisissimo e meticoloso nei suoi romanzi, non riesce più a trovare un nome alle cose. Con grande delicatezza e commozione Ferrucci ci racconta il senso di smarrimento degli amici più vicini, mentre il buio avvolge lo scrittore che progressivamente perde la memoria, diviene sempre più assente, non riesce più neppure a riconoscere gli amici, i suoi cari. Un uomo che al linguaggio aveva dedicato la vita, il suo lavoro così importante, si ritrova incapace di esprimersi.
Del Giudice, a soli 62 anni, viene ricoverato alle Zitelle, struttura per persone affette da Alzheimer, dove rimarrà fino alla morte avvenuta nel 2021. Ferrucci racconta le visite dolorose, frustranti alle Zitelle, condivise, per cercare forse di alleggerire il disagio, con l’amico di sempre Tiziano Scarpa, altro grande scrittore veneziano.
Là Ferrucci porta a Del Giudice In questa luce, il suo libro di saggi appena pubblicato, ma l’autore non se ne rende conto, è ormai
Roberto Ferrucci
Il mondo che ha fatto
La nave di Teseo, 2025

assente, vive in una realtà tutta sua, si arriva così fino all’episodio più doloroso, che lasceremo scoprire al lettore.
I toni sono sempre misurati in questo libro, i racconti toccanti e pieni di vero affetto, rispetto. Traspare con autentica pienezza quanto Ferrucci sia legato a Del Giudice, suo punto di riferimento assoluto fin da quando aveva letto Lo stadio di Wimbledon, per lui una sorta di romanzo di iniziazione da cui rimane folgorato e che nelle sue pagine ritorna spesso.
Roberto Ferrucci è nato a Venezia (Marghera) nel 1960. Ha esordito nel 1993 con il romanzo Terra rossa, a cui sono seguiti Cosa cambia, Storie che accadono dedicato ad Antonio Tabucchi e che forma un dittico con Il mondo che ha fatto. Collabora con alcuni quotidiani. È traduttore italiano di Jean-Philippe Toussaint. Dal 2002 insegna Scrittura creativa alla facoltà di Lettere dell’Università di Padova. Per Helvetia Editrice dirige la collana Taccuini d’autore.
Chi è stato e quale ruolo occupa oggi nel panorama letterario italiano Daniele Del Giudice?
Semplice: uno dei più grandi scrittori italiani di sempre. Ci è voluto questo libro, che mi è costato più di dodici anni di lavoro, per trovare il coraggio di affermarlo, ma, soprattutto, per avere la certezza di non esagerare. Attraversare di nuovo e ripetutamente i suoi libri, i suoi articoli, le interviste, aver ripercorso la nostra amicizia, aver fatto – come ha scritto Claudio Magris nel testo con cui ha candidato il libro al Premio Strega – un lavoro da officina del romanzo, necessario per assemblare tutte le varie dimensioni della sua scrittura, farle fluire in una narrazione che contenesse anche le tappe della nostra amicizia, tutto questo mi ha dato conferma della sua grandezza.
Quale è stato suo più grande insegnamento?
Difficile isolarne uno in trent’anni di frequentazione e di letture e riletture di tutto ciò che ha pubblicato (e anche qualcosa di non

pubblicato, finito quella sera di fine anni Ottanta nel grande sacco delle immondizie...). Tra tutti forse sceglierei la sua personale visione della scrittura. Una scrittura che non deve mai essere finalizzata alla presenza costante dei propri libri sugli scaffali e nelle vetrine delle librerie. No. Questo non ha mai interessato Del Giudice, che è sempre stato in disparte, evitava il più possibile di mettersi in mostra, di essere al centro dell’attenzione, perciò poca, pochissima televisione. Niente mondanità, niente salotti. Scrittura e basta. Una scrittura elaborata, attenta, precisa, lenta, con la quale scrivere solo ed esclusivamente i libri che lui sentiva necessari, quelle storie che girano dentro di te per anni e che quando arriva il momento sono loro stesse a chiederti di essere narrate. Ecco, questo mi ha trasmesso, anche se io oggi sto attraversando l’Italia per portare in giro questo libro e i suoi. Si legge sempre meno nel nostro Paese. I libri ormai bisogna quasi presentarli porta a porta, casa per casa.
Tra tutti i suoi romanzi qual è il suo preferito?
Ho avuto la fortuna, ma solo per motivi anagrafici, di leggere Lo stadio di Wimbledon appena uscì, nel 1983. Quello è il mio libro di Daniele Del Giudice. Però, a chi dovesse avvicinarsi oggi alla sua scrittura, suggerirei di partire da Nel museo di Reims, oggi inserito nel libro I racconti pubblicato da Einaudi.
Del Giudice amava Venezia, l’aveva scelta, ma era una città ben diversa da quella che viviamo quotidianamente nel nostro presente. Pensa che si sarebbe trovato bene anche oggi in una città così stravolta da folle di turisti e degrado?
Credo che, come facciamo noi che qui ancora tenacemente viviamo, avrebbe cercato di resistere. Avrebbe trovato il modo di darsi da fare per cercare di fermare una deriva, quella della città giocattolo, che sembra sempre più ineluttabile. Del resto lo ha sempre fatto, come quando si candidò per la lista Il Ponte a inizio anni Novanta, o quando creò la manifestazione culturale Fondamenta, regalando alla città un evento internazionale di qualità con dei contenuti altissimi. Lui non ha mai scritto direttamente di Venezia nei suoi libri. Ma i tempi e le luci della città sono dentro la sua scrittura, la quale, senza il suo vissuto veneziano, non sarebbe stata quella che conosciamo.
Semplicemente uno dei più grandi scrittori italiani di sempre.
Ci è voluto questo libro, che mi è costato più di dodici anni di lavoro, per trovare il coraggio di affermarlo
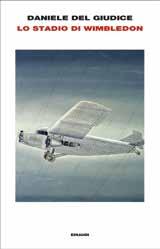


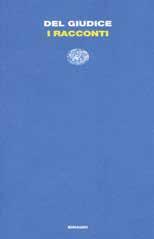
RYOKO SEKIGUCHI
Intervista Ryoˉko Sekiguchi
di Mariachiara Marzari
Poetessa, scrittrice e traduttrice giapponese trapiantata a Parigi, Ryo¯ko Sekiguchi intreccia nei suoi libri letteratura, memoria e cucina in un equilibrio raffinato tra parola ed emozione. In Italia è nota per Nagori. La nostalgia della stagione che ci ha appena lasciato (Einaudi, 2022), premiato in Francia con il Prix Mange, Livre. Nel 2018 ha pubblicato con Casadeilibri Il club dei buongustai e altri racconti culinari giapponesi, un’antologia che attraversa secoli di scrittura gastronomica ora in ristampa. Recentemente è stata in residenza a Venezia con Wetlands, casa editrice che promuove la relazione tra scrittura e luogo. Le abbiamo rivolto alcune domande partendo dal filo sottile che unisce scrittura e nutrimento.
È nata prima la passione per la cucina o quella per la letteratura? Come ha trovato il suo equilibrio tra questi due mondi? Penso che la passione per “ciò che ci nutre” in generale sia nata prima di tutto e poi si sia ramificata nella letteratura, nella cucina o nella musica. Scrivere di cucina è per me un atto politico. La cucina è considerata un genere poco importante, volgare, mentre è invece parte integrante della nostra vita ed è come una grande ciotola collegata a tutti i temi essenziali della letteratura: l’amore, la famiglia, la felicità, ma anche la malattia, la separazione, la solitudine, la morte, le lotte di classe, la questione dell’immigrazione. E poi mi piace cucinare per sentirmi connessa alla terra, alle cose concrete ed effimere, alla vita degli altri, ma anche per riflettere sul nostro destino crudele: dobbiamo nutrirci, quindi togliere la vita ad altri per poter continuare a vivere. Un giorno mi piacerebbe molto affrontare un tema molto pesante ma essenziale: la fame (e la carestia).
Nel prologo del suo libro Nagori, afferma, anzi, rivendica il ruolo e la forza della singola parola capace di suscitare ricordi, pensieri, mondi. La parola va quasi assaporata? Come ricerca le parole “originarie”? Cosa significa per lei emozionare attraverso la parola? Penso che questa “fede” o questa “fiducia” assoluta nel potere delle parole derivi dalla mia prima vocazione, la poesia. In una poesia le parole possono fare tutto: far emergere il mondo, i ricordi, modificare le nostre percezioni, la temporalità, farci sentire la musica, ritrovare l’anima che abbiamo perso. Non cerco parole “originarie”; tutte le parole, purché siano davvero parole, devono avere questo potere magico ed è anche questo che rende incredibile la lingua. Ogni giorno non smettiamo mai di lasciarci sorprendere dalle parole che pronunciamo.
Elemento fondamentale della cucina è la stagionalità, che traslata nella vita si traduce nel tempo che scorre implacabile. Quale la sua personale definizione di tempo?
La stagionalità non è sinonimo di tempo che scorre inesorabile, perché la stagione costituisce il tempo ciclico. È il tempo lineare della
nostra vita che è a senso unico. È per questo che il ritmo delle stagioni può talvolta essere la nostra salvezza, senza la quale ci troveremmo di fronte a questo tempo unico e crudele che va verso l’abisso. Parlare di stagionalità significa parlare della vita. Come scrittrice faccio solo una cosa: cerco un modo magico, anche solo in un libro, per far durare la vita e riportare in vita anche i morti, i nostri cari, le persone che abbiamo tanto amato. Un po’ come la piccola fiammiferaia di Andersen. Quella piccola venditrice di fiammiferi sarà sempre la mia eroina. Con il suo fiammifero fa emergere i momenti essenziali della vita, l’amore, la speranza. Alla fine non la salverà, morirà il giorno dopo, ma quel momento essenziale sarà esistito. Ed è forse questo che la letteratura con i suoi libri dovrebbe fare, essere quei fiammiferi.
Il Giappone, la sua terra di origine, è il protagonista indiscusso dei suoi lavori. A quale Giappone s’ispira? Quanto il suo Paese, la sua cultura influenza la sua scrittura?
Per molto tempo mi sono imposta di non scrivere alcunché sul Giappone. Tutti vedono che sono giapponese, non volevo essere un’intellettuale al servizio del Paese, una sorta di “signora giapponese”. Scrivo professionalmente dal 1988, ma fino al 2010 nei miei libri non compariva nemmeno una volta la parola “Giappone”. Proprio per questo, in particolare nel mio Paese, sono stata a lungo considerata una scrittrice profondamente influenzata dalla cultura occidentale. È stata la tripla catastrofe del 2011 (terremoto, tsunami e incidente nucleare di Fukushima) a cambiare la mia vita di scrittrice. Mi sono resa conto che stavamo perdendo il Paese. Si può contare il numero dei morti, il numero delle case spazzate via dallo tsunami, ma non si possono ‘contare’ il profumo delle magnolie che fioriscono, i piatti serviti in una famiglia, la musica suonata in un villaggio, eppure sono proprio questi piccoli, preziosi elementi che costituiscono la nostra vita. Per non parlare della cucina. E con Fukushima abbiamo perso la regione famosa per il sakè, la selvaggina e la frutta. È da quel momento che ho iniziato a scrivere di cucina, ma prima di tutto dei sapori che abbiamo perso a causa di quella catastrofe. Mi considero un’archivista dell’effimero.
Lei è stata recentemente ospite di una residenza per Wetlands a Venezia. Quali sono le sensazioni che questa città le ha trasmesso? E come questa esperienza entra nel suo percorso di scrittrice?
Ah, questo non lo dirò ancora, bisognerà aspettare l’uscita del mio prossimo libro per saperlo... Scherzi a parte, mi piace sempre questo momento in cui scrivo di una città partendo dalle mie osservazioni, dai miei incontri e dalle mie ricerche, senza che chi mi conosce possa ancora immaginare cosa sta accadendo tra le mie pagine. Mi identifico profondamente come “scrittrice di città”. Sono nata a Tokyo, vivo a Parigi. In questo spazio in cui gli esseri umani, l’am-

biente e la storia lasciata da coloro che vi hanno vissuto negoziano incessantemente, si crea un dinamismo incredibilmente stimolante da osservare e da vivere. Sarei incapace di scrivere un libro, o anche solo un breve testo, sulla campagna o su un luogo in cui l’impronta umana è minore, mentre ci sono romanzieri che eccellono nell’arte di scrivere sui luoghi disabitati.
Ho già scritto di Tokyo e ho pubblicato un altro libro su Beirut. Quest’ultimo mi ha permesso di fare tantissimi incontri e, come in un effetto domino, da questi incontri sono nate altre creazioni. Sono sicura, o almeno lo spero, che avverrà lo stesso per il libro su Venezia. Al di là di ciò che questa esperienza mi ha dato nel mio percorso di scrittrice, quando scrivo di una città cerco di darle un senso. Non scrivo “di” una città, scrivo in qualche modo “per” quella città. Mi auguro sinceramente che il mio libro abbia un senso per Venezia, che amo.


Intervista Roberto Nardi
di Mariachiara Marzari
Conscia del privilegio di poter – da giornalista – vedere aprirsi le porte di mostre, collezioni, palazzi in anteprima, mi piace osservare le reazioni dei diversi, ma siamo sempre più o meno gli stessi, invitati. Una sceneggiatura che si ripete di conferenza stampa in conferenza stampa e che nel tempo mi ha portato a indagare le diverse personalità e i diversi approcci ai linguaggi dell’arte, poi restituiti attraverso importanti articoli. Tra di essi, da molto tempo, ho avuto il piacere di conoscere prima il sorriso sornione, poi l’arguzia di poche parole e infine la delicata ironia e il garbo di Roberto Nardi. Come giornalista non è necessario sottolineare la professionalità e lo stile, tuttavia come scrittore è certo una scoperta. Sarà perché ci accomuna una passione sfrenata per la storia dell’arte, ma il suo primo libro, Perché io? Il mistero del furto della Madonna con bambino di Bellini a Venezia, è stato una piacevole rivelazione. È uscito ora da poco il suo secondo lavoro, I fiori di Matilde Klee (Mazzanti Libri, 2025), in cui Nardi intraprende la strada del romanziere puro. Niente più cronaca, solo esperienza e vissuto che si trasformano in parole, storie, vite, come ci racconta in questa intervista. Con grande piacere e curiosità, quindi, mi trovo davanti alla nuova copertina, che non poteva che essere d’autore – l’artista Jingge Dong –, e alle nuove pagine da leggere tutte d’un fiato. Buona lettura, e per Roberto... non c’è due senza tre!
Cronaca e fiction. Come si è evoluto il suo stile nel passaggio da un genere all’altro, come ha trovato un suo equilibrio in questa variazione di rotta?
C’è un nesso profondo tra Perché Io? e I fiori di Matilde Klee, entrambi editi da Mazzanti Libri, ed è legato a una dimensione personale centrata su un termine preciso: urgenza. Avevo sentito l’urgenza di scrivere due anni fa su un fatto di cronaca, il furto di un dipinto di Giovanni Bellini dalla chiesa della Madonna dell’Orto, opera mai più ritrovata, constatando il silenzio che era calato su questa ‘ferita’ per la città e più in generale per tutti coloro i quali amano l’arte. Questa “chiamata”, data la natura del fatto di cui ricorreva il trentennale, non poteva che essere assecondata da una scrittura dallo stile eminentemente “giornalistico”.
Pur di altra derivazione, sempre un’urgenza, relativa stavolta a ciò che stiamo vivendo, alle derive sociali e politiche, alle paure, alle chiusure, ai venti di guerra, alle stragi di innocenti, al riecheggiare di voci e suoni che pensavamo silenziati dalla storia, è alla base anche di questo mio secondo libro. Stavolta, però, ho deciso di scrivere una storia di fantasia che ha profonde radici nel presente, in quello che considero un amaro presente e un ancor più triste futuro, seppure ritenga ci sia un margine, una flebile luce che illumini ancora la speranza. Il passaggio dal genere della cronaca e della storia dell’arte, sotto il vincolo necessario del radicamento a fatti e persone reali, alla narrazione di una vicenda inventata, popolata da personaggi inesistenti è
Roberto Nardi
I fiori di Matilde Klee
Mazzanti Libri, 2025

stato naturale, quasi inaspettato. Non so se sono riuscito a trovare un equilibrio tra questi due modi di disporsi alla scrittura, ma so che l’uno e l’altro hanno rappresentato le naturali risposte alle due urgenze di cui parlavo prima.
Un titolo, I fiori di Matilde Klee, che è subito “erroneamente evocativo”, ma che certamente delinea un fil rouge che lega il primo al secondo dei suoi libri. Qual è il reale, effettivo ruolo che riveste l’arte nei suoi lavori? Quali le vere ragioni di questo titolo?
“L’erroneamente evocativo” nella domanda immagino riguardi il nome della protagonista, che ai più può richiamare la famiglia di Paul Klee, il pittore svizzero-tedesco icona dell’arte del Novecento. Chiariamo subito, allora, che non è un libro che parla dell’artista, tanto meno una biografia della sorella maggiore, Matilde. Il tempo della storia è oggi, è il nostro presente, non gli inizi del secolo scorso. Nel libro spiego fin da subito che è solo un caso, che non c’è alcuna relazione di parentela tra Matilde, nata nei primi anni della Seconda Guerra mondiale, e Paul Klee. Tuttavia non ho saputo non cedere al fascino, al richiamo incantatore non cercato, di un’assonanza che nella sua stessa essenza parla d’arte, crea un’aspettativa attorno alla bellezza dell’arte, rendendo naturale quasi il fatto che Matilde possieda una importante collezione di dipinti e disegni, che abbia acquistato opere realizzate nella prima metà di quel secolo travagliato segnato da grandi crisi, guerre, totalitarismi. Nel racconto le storie personali dei personaggi, la vicenda stessa narrata che li tiene uniti, si intrecciano con l’arte, con la storia, con una certa idea della funzione dell’arte nella storia. Sono grato a Jingge Dong, artista cinese che da anni vive a Venezia, per il dipinto in copertina, segno del secolare ponte tra culture diverse. I fiori di Matilde Klee, insomma, è un titolo frutto di una riflessione che ha portato a una serie di scelte e ripensamenti, il cui semplice obiettivo è stato quello di evocare, senza svelare nulla, niente di più e niente di meno che il contenuto del romanzo. Se nel titolo del libro per il furto del Bellini tutto era evidente, dichiarato, qui ho voluto

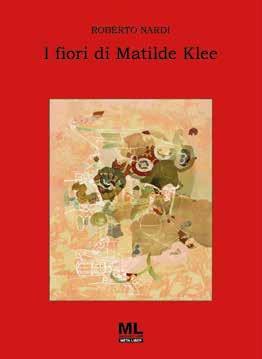
mantenere una sospensione attraverso un’immagine “erroneamente evocativa”, apparentemente chiara, quasi romantica.
Chi è Matilde Klee?
Matilde è una donna anziana, vedova, che vive una solitudine cercata e circondata da opere d’arte, dagli amati fiori e da piante, in un piano di palazzo in una città di campi e rii. Madre di un figlio che da anni vive all’estero e nonna di nipoti lontane. Una donna apparentemente algida, distante, che governa i rapporti con gli altri attraverso i discorsi sui fiori, che ogni pomeriggio va a comprare vicino a casa, e sulle notizie sentite soprattutto alla radio.
Una donna che è stata felice e che si è volutamente chiusa al mondo dopo la morte del marito, percorsa tuttavia da una energia, da una volontà che non si è mai spenta e che improvvisa, quasi inaspettata, ma in una certa misura intimamente cercata, riemerge, bussa alla porta del suo essere, quando anche la storia, quella con la S maiuscola, torna a riaffacciarsi con altre vesti sul suo quotidiano.
Il romanzo ha una trama accattivante, con un intreccio di personaggi che ruotano attraverso un disegno di un maestro del Novecento e al suo furto. Anche in questo caso, come nella sua precedente opera, il furto è l’elemento scatenante delle indagini e dell’intrecciarsi delle storie. In realtà Matilde non è la sola protagonista del romanzo. Ciò che le accade, le ragioni dello sviluppo della vicenda, sono intrecciate, a volte in modo evidente e in altre occasioni intimamente collegate, alle vite e ai pensieri di Pietro Goti, un fisico nucleare residente al terzo piano del palazzo, giovane dal carattere aperto che ama l’arte la cui gentilezza nei modi e nelle parole colpiscono Matilde positivamente, di Lucrezia, una ricercatrice francese fidanzata di Pietro, di Aldo, un corniciaio laureato in storia dell’arte, e di Gastone Rospi, un ex truffatore e ladro in lotta con sé stesso e con un passato che lo tormenta. Poi c’è un disegno di un maestro del Novecento che compare a un certo punto e pare assumere un ruolo centrale nello sviluppo della vicenda narrata, negli interessi, nelle stesse relazioni tra i vari personaggi.
Un punto di svolta nella narrazione, quasi sorgivo direi, coincide con un furto a casa di Matilde che chiama in causa direttamente il disegno. È un momento centrale perché dà origine a dei punti interrogativi, a degli sviluppi non prevedibili, all’irruzione nella storia narrata di altre vicende personali e collettive. È un elemento scatenante di un nuovo inaspettato, fautore di novità inattese.
Rispetto al libro sulla sottrazione del quadro alla Madonna dell’Orto, dove il tema del furto è centrale, nella vicenda narrata ne I fiori di Matilde Klee lo stesso tema è sì una componente importante dell’intreccio romanzesco, ma al tempo stesso rappresenta un semplice strumento, una sorta di chiave per aprire altri orizzonti.
Come nascono i suoi personaggi? Pur essendo certo fortemente e personalmente caratterizzati, ci paiono volti, profili che abitualmente incontriamo tra le calli di Venezia… Ogni personaggio è figlio di uno e mille genitori, di uno e mille ricordi, di uno e mille momenti di una vita vissuta, narrata, inventata, immaginata. È come se, mentre scrivevo, ognuna delle persone in scena indossasse una giacca, una gonna, dei pantaloni, mostrasse un sorriso, uno sguardo triste, avesse un proprio tono di voce, un taglio dei capelli che non potevano che essere quelli. Sono rimasto io stesso meravigliato da come naturalmente hanno preso forma. Non hanno un volto, un’altezza, un riferimento preciso, ma hanno una storia che è figlia di tante storie diverse. Persone che ho incontrato, che incontro, che incontrerò nelle tante Venezie della mia vita.
La città non compare in primo piano, ma viene rappresentata attraverso l’atmosfera umida e piovosa che per lunghe stagioni la caratterizza. Quale ruolo ha questa persistenza nella storia?
Accennavo prima a un silenzio attorno alla sorte di un quadro. Attorno alle sorti della città dove sono nato, che amo e che non riesco a non guardare nel suo continuo evolversi con un misto di intima delusione, di tragedia e al contempo di speranza, sento da tempo invece levarsi tante voci, sento suoni impercettibili e urla roboanti. Sento un clima di disagio, di desideri di guardare al nuovo che cercano punti d’appoggio che scivolano via. Sento di vivere immerso in un’atmosfera umida e piovosa, sì.
Ricordo che la storia narrata prende avvio con la frase «la pioggia fu annunciata dal latrare dei cani». È la messa in scena di una presenza, di una irrequietezza interiore, di un presagio di una fine che accompagna il lettore per gran parte del libro. Ma come dicevo prima, sento sempre la presenza di una speranza, di un possibile ribaltamento del dolore in gioia, di una trasformazione della prigione dell’egoismo in gioia dell’apertura verso l’altro. Chi avrà voglia di leggere il libro avrà delle sorprese a riguardo, credo.
A quale genere letterario si ispira e quali sono i suoi autori cult? Ho scelto di dividere i tempi della storia in quattro parti come se fossero quattro momenti di un racconto corale, che si nutriva del cambio delle stagioni, che aveva bisogno di questo cambio. Non vorrei entrare in categorie definite, come romanzo breve o racconto lungo; preferisco pensare al libro come a un’opera di fantasia, strutturata su un piano piuttosto classico, che si nutre del vivere, del sentire quotidiano, che trae linfa dalle emozioni personali e dalle storie che compongono il nostro presente. Riguardo agli autori che amo, la lista è lunga. Un’amica ricorda che Matilde spesso rilegge libri che ha già letto più volte, perché ogni volta trova una ragione nuova per farlo. Io sono Matilde. Ne cito solo alcuni non per definire una classifica, ma semplicemente per cercare di uscire dalle insidie della domanda: Borges, Sciascia, Del Giudice, Tabucchi e Simenon.
Non ho mai inteso scrivere nulla di Sport. Desideravo continuare ad assecondare il mio proposito di non fare il “commentatore sportivo” (perché so che non sarei in grado!). Confesso tuttavia che la competizione, in genere, malgrado tutto, mi interessa e forse qualche volta anche mi attrae. Mi rendo conto che il confronto tra due persone o due compagini, rispettando correttamente norme prestabilite che fissano i limiti e le regole della prova, ha il suo fascino. È interessante anche attendere chi, tra i contendenti, al termine del confronto, dimostra di essere il migliore. Il risultato in genere (ma non sempre, intendiamoci!) è conseguenza di una seria, saggia preparazione fisica, di uno studio tattico preventivo, di un allenamento puntiglioso che consente di prevedere con immediatezza le varie situazioni, utilizzando intelligenza, intuito, osservazione e valutazione delle capacità proprie e altrui, limiti e debolezze dell’avversario, al punto da riuscire a far diventare rapida e quasi istintiva, ogni mossa, anche se, come si sa, non tutto è prevedibile. Non in tutti gli sport le reazioni possono assomigliare. Le condizioni del gioco, infatti, sono differenti. La Boxe e il Rugby sono maggiormente basati sulla forza fisica, materiale, sulla potenza. Anche il Football richiede intesa, velocità, resistenza, intuito, tattica, reazione immediata. L’ambiente in cui si svolge quest’ultimo sport, lo Stadio, che “contiene” migliaia di sostenitori di una o dell’altra squadra, ha la sua notevole importanza (il famoso sostegno del tifo). Negli ultimi anni s’è arricchito anche di moderni sistemi pubblicitari mobili che, addirittura, durante gli incontri continuano a disturbare (ma si sa, la pubblicità…). Non solo, durante il gioco ormai è invalso l’uso di esibire, da parte del pubblico, cartelloni,
bandiere, scritte sui lenzuoli, ma anche proferire grida a sostegno o contro gli “avversari”, formare cori, spesso brevi, dal sapore di slogan (anche di contenuto politico). Si sono venute a creare addirittura zone “extraterritoriali” (le famose curve) dove prepotenze e ideologie, ancorché spesso vietate dalle leggi, trovano spazio e hanno libero sfogo. Avevano cominciato con l’essere ignorate, poi sono state tollerate, quindi (non ufficialmente) ammesse e poi, temo, oggi spesso addirittura sostenute. Non di rado, trasportati dagli entusiasmi sportivi, si possono sentire volare offese, insolenze, oltraggi, villanie, improperi, epiteti razzisti della peggior specie, in un declino straordinario di educazione che nulla ha a che fare con la gara sportiva.
Da tutto ciò, fortunatamente, si distinguono ancora alcune discipline ed uno sport in particolare, il tennis, che, per convenzione, mantiene le caratteristiche di un confronto anche serrato, per lo più corretto e talvolta anche nobile. Domenica 8 giugno scorso ho avuto piacere di assistere davanti alla televisione all’incontro tra due “fuoriclasse” di questo sport e ne ho riportato una grande soddisfazione, una lezione umana che difficilmente potrò dimenticare. Cinque ore e ventinove minuti: tanto è durata la competizione, di altissimo livello, tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz! Due giovani che si sono sfidati. Un italiano e uno spagnolo. I due campioni su terra rossa si sono battuti a Parigi offrendo al pubblico un incontro spettacolare, dall’inizio alla fine, senza mai una caduta di stile, una disattenzione.
Con i mezzi moderni di trasmissione di immagini e suoni, agli spettatori lontani, come me, è stata persino offerta la possibilità di udire i gemiti dello sforzo fatto da ciascuno dei contendenti al momento di battere il servizio. La pallina giungeva nel campo “avversario” talvolta superando anche la velocità di 200 km orari. Velocità, potenza, improvvisazioni,
PAROLE a cura di Renato
fantasia, sorprese anche nella risposta e nel successivo gioco. Battute straordinarie, risposte adeguate, angolazioni inverosimili, smorzate sbalorditive, accelerazioni strabilianti, allunghi al limite delle righe bianche che di ogni gioco costituivano l’assoluto limite invalicabile: uno spettacolo sensazionale.
Ogni tanto tra un gioco e l’altro, nei brevissimi intervalli, si poteva notare, da parte del pubblico, lo sventolare di piccole bandiere spagnole o italiane per sostenere silenziosamente, educatamente, il proprio beniamino. Le emozioni, anche tra il pubblico, si sono manifestate in maniera assolutamente contenuta, educata. Più di una volta, nell’incertezza del punto, entrambi i contendenti, con una correttezza sportiva veramente ammirevole (alla quale assistiamo di rado e che non dimenticheremo facilmente), una generosità umana che lo sport dovrebbe ricordare, hanno fatto un passo indietro, cedendo all’avversario il vantaggio o riconoscendogli apprezzamento per il colpo vincente (se solo pensiamo, nel gioco del pallone, a quante volte dobbiamo assistere a “commedie” di giocatori che si scalmanano nel pretendere dall’arbitro soddisfazione per finti danni subiti!...) Lentamente sullo stadio nel pomeriggio il sole, nel trascorrere del tempo, ha spostato progressivamente le ombre, fino ad offrirci, quasi inaspettata, la luce smorzata della sera parigina. La regia televisiva, con tanta sensibilità, alternava la visione dell’incontro ai momenti di intervallo, con l’inquadratura della Signora Siglinde, la Mamma di Jannik Sinner, sempre composta ancorché emozionata e trepidante, che di lui riconosceva ogni crampo, ogni possibile ripresa dopo attimi di stanchezza, che sapeva leggere sul viso del Figlio, apparentemente impassibile, la sofferenza, la soddisfazione, la costante determinazione, ma che ad ogni
colpo potente e corretto gioiva nella galoppata travolgente dell’incontro. Proprio quella Signora che ha saputo insegnare a Jannik come ci si deve comportare tra persone educate.
E non dimentichiamo neppure quando in un precedente incontro dell’anno scorso, interrotto per la pioggia, proprio lui, il campione, seguendo evidentemente quanto imparato a casa, ha sorretto l’ombrello ad una ragazza che era addetta ai servizi sul campo perché non si bagnasse, in attesa della possibilità della ripresa dell’incontro stesso. Non solo, ma in un’altra occasione, al termine di un match, il “suo” Campione, al momento dei ringraziamenti, non si è dimenticato di nominare neppure i raccattapalle!
Quanti Presidenti di intere Nazioni, anziché utilizzare percorsi dorati prima di raggiungere e sedersi al posto loro riservato per ostentare la loro potenza di fronte alle corti che li circondano, avrebbero da imparare dai due contendenti del Roland Garros 2025, entrambi trepidanti, ma educati, rispettosi del galateo, capaci e veramente forti. In 5 ore e 29’ silenziosamente e generosamente ci hanno offerto uno dei momenti più alti del tennis e dello sport tutto e ci hanno anche regalato una vera e preziosa lezione di capacità, educazione, correttezza, classe. Ci hanno saputo indicare, senza ostentazione, cos’è veramente il FAIR PLAY! Ed ora consentitemi una riflessione “assurda”: salvo l’umana, comprensibile delusione di Sinner, noi abbiamo avuto la sensazione che il Torneo parigino 2025 abbia avuto certamente un vincitore, Carlos Alcaraz, ma… nessun perdente! Due veri Maestri.
P.S. E poiché anche noi abbiamo le nostre piccole debolezze, facciamo un po’ di tifo: non ci siamo dimenticati del 16 agosto. Auguri, Jannik, per il tuo 24° compleanno!

SCALA DEL BOVOLO
San Marco 4303
COMPLESSO DELL’OSPEDALETTO
Barbaria de le Tole, Castello 6691
CHIESA DELLE PENITENTI
Fondamenta Cannaregio 890
ORATORIO DEI CROCIFERI
Campo dei Gesuiti, Cannaregio 4904

01
martedìTuesday
Marghera Estate
GIOVANE ORCHESTRA METROPOLITANA
Colonne sonore
Piazza Mercato-Marghera h. 21
Mirano Summer Festival FRANCO126
Pop Impianti sportivi-Mirano h. 21
Sherwood Festival
MARLENE KUNTZ
SPLEEN ORCHESTRA
Indie Park Nord Stadio Euganeo-Padova h. 19
Marostica Summer Festival
ALFA
Pop
Piazza degli Scacchi-Marostica h. 21
02
mercoledìWednesday
Venezia Jazz Festival
LORENZO SIMONI 4TET ELIMI
Jazz
Teatro La Fenice h. 19
03
giovedìThursday
Venezia Jazz Festival
JEAN-MICHEL JARRE
Musica elettronica
Piazza San Marco h. 21
Marghera Estate
JOVABAND
Jovanotti tribute
Piazza Mercato-Marghera h. 21
Sherwood Festival
LA RAPPRESENTANTE DI LISTA
Indie Park Nord Stadio Euganeo-Padova h. 19
Sexto ‘Nplugged
MOLCHAT DOMA
Post punk
Piazza Castello-Sesto al Reghena h. 21.15
Marostica Summer Festival
ALESSANDRA AMOROSO
Pop Piazza degli Scacchi-Marostica h. 21
04
venerdì Friday
Venezia Jazz Festival
HEARTBEAT
VITANTONIO GASPARRO
TRIO
Jazz
Teatro La Fenice h. 19
Marghera Estate
JOY SINGERS
Funky
Piazza Mercato-Marghera h. 21
Sherwood Festival
JUNIOR KELLY
SUD SOUND SYSTEM
Reggae
Park Nord Stadio Euganeo-Padova h. 19
ROBERTO VECCHIONI
Musica d’autore
Anfiteatro Camerini-Piazzola sul Brenta h. 21
Sexto ‘Nplugged
BLACK CONTRY, NEW ROAD
Post rock
Piazza Castello-Sesto al Reghena h. 21.15
Villa Manin Estate
GHALI
Rap
Villa Manin-Codroipo h. 21
05
sabato Saturday
PAWSA
GERMANO VENTURA
Dj-set
Il Muretto-Jesolo h. 22
FRANCIS MERCIER
Dj-set
King’s Club-Jesolo h. 22
Sherwood Festival
GHALI
WESTCROSS
Pop
Park Nord Stadio Euganeo-Padova h. 19
MAX RICHTER
Musica d’autore
Teatro Romano-Verona h. 21.15
Sexto ‘Nplugged
ANNA VON HAUSSWOLFF
Dark ambient
Piazza Castello-Sesto al Reghena h. 21.15
Festival del Vittoriale
MARCUS KING
Rock
Anfiteatro del Vittoriale-Gardone
Riviera h. 21.15
ELIO E LE STORIE TESE
Pop
Parco Ragazzi del ‘99-Bassano del Grappa h. 16
06
domenica Sunday
Sexto ‘Nplugged
BAUSTELLE
Indie rock
Piazza Castello-Sesto al Reghena h. 21.15
Villa Manin Estate
GIANNA NANNINI
Rock
Villa Manin-Codroipo h. 21
STING
Rock
Parco Ragazzi del ‘99-Bassano del Grappa h. 21
07
lunedì Monday
Festival della Bellezza
PATTI SMITH
Rock
Piazza San Marco h. 21
Women for Freedom in Jazz
DONÌ-VOCI DI DONNA
Jazz
Hotel Carlton on the Grand Canal h. 21
MUMFORD & SONS
Folk
Arena di Verona h. 21
08
martedìTuesday
Venezia Jazz Festival
GIOVANNI ALLEVI
Musica contemporanea
Tatro La Fenice h. 20
Marghera Estate
ANIME IN PLEXIGLASS
Ligabue tribute
Piazza Mercato-Marghera h. 21
ANTONELLO VENDITTI
Musica d’autore
Parco Ragazzi del ‘99-Bassano del Grappa h. 21
CESARE CREMONINI
Pop
Stadio Euganeo-Padova h. 21
09
mercoledìWednesday
MICHELE BONIVENTO 4TET
Jazz
“InOut“
M9-Museo del ‘900-Mestre h. 19
Mirano Summer Festival
NEK
Pop
Impianti sportivi-Mirano h. 21
Sherwood Festival
AFTERHOURS
Indie rock
Park Nord Stadio Euganeo-Padova h. 19
Marostica Summer Festival
NILE RODGERS & CHIC
Pop
Piazza degli Scacchi-Marostica h. 21
Festival del Vittoriale
FINNEAS
Indie pop
Anfiteatro del Vittoriale-Gardone Riviera h. 21.15
10
giovedìThursday
Venezia Jazz Festival
BOW & BELLOWS
Jazz
Splendid Venice Hotel h. 20
Mirano Summer Festival
NOMADI
Rock d’autore
Impianti sportivi-Mirano h. 21
Marghera Estate LE ORME
Progressive rock
Piazza Mercato-Marghera h. 21
Marostica Summer Festival
UMBERTO TOZZI
Pop
Piazza degli Scacchi-Marostica h. 21
11
venerdì Friday
Mirano Summer Festival
ALEX BRITTI
Blues
Impianti sportivi-Mirano h. 21
Sherwood Festival
L’ENTOURLOOP
FLEXIONAL
Musica elettronica Park Nord Stadio Euganeo-Padova h. 19
GUÈ PEQUENO
Rap
Anfiteatro Camerini-Piazzola sul Brenta h. 21
Marostica Summer Festival
SKUNK ANANSIE
Crossover
Piazza degli Scacchi-Marostica h. 21
12
sabato Saturday
JOSEPH CAPRIATI
TRAUMER
GERMANO VENTURA
Dj-set
Il Muretto-Jesolo h. 22
MACEO PLEX
Dj-set
King’s Club-Jesolo h. 22
Sherwood Festival
BANDABARDÒ
DIPOLMATICO NINCO NANCO
Folk Park Nord Stadio Euganeo-Padova h. 19
Operaestate
PAOLO FRESU
URI CAINE
Jazz
Teatro Al Castello Tito GobbiBassano del Grappa h. 21.20
Marostica Summer Festival
GIANNA NANNINI
Rock
Piazza degli Scacchi-Marostica h. 21
13
domenica Sunday
LUDOVICO EINAUDI
Musica d’autore
Piazza San Marco h. 21
IRON MAIDEN
Heavy metal
Stadio Euganeo-Padova h. 21
JACK SAVORETTI
Rock
Teatro Romano-Verona h. 21.15
Villa Manin Estate
UMBERTO TOZZI
Pop Villa Manin-Codroipo h. 21
Marostica Summer Festival
NAYT
Rap
Piazza degli Scacchi-Marostica h. 21
Festival del Vittoriale
BILL CALLAHAN
Indie
Anfiteatro del Vittoriale-Gardone
Riviera h. 21.15
14
lunedì Monday
Women for Freedom in Jazz
VALENTINA FINI
MARCO CENTASSO
Jazz
Hotel Carlton on the Grand Canal h. 21
Mirano Summer Festival
NOEMI
Pop
Impianti sportivi-Mirano h. 21
Festival del Vittoriale
BRANDI CARLILE
Country folk
Anfiteatro del Vittoriale-Gardone
Riviera h. 21.15
15
martedìTuesday
Marghera Estate ESTRA
Rock
Piazza Mercato-Marghera h. 21
Mirano Summer Festival FIORELLA MANNOIA
Musica d’autore
Impianti sportivi-Mirano h. 21
Marostica Summer Festival BLUE
Pop
Piazza degli Scacchi-Marostica h. 21
SIMPLE MINDS
New wave
Arena di Verona h. 21
AMA Music Festival
THE BLACK KEYS JET
LEMON TWIGS
Rock
Parco di Villa Negri-Romano d’Ezzelino h. 21
Festival del Vittoriale ANASTACIA
Pop
Anfiteatro del Vittoriale-Gardone
Riviera h. 21.15
16
mercoledìWednesday
Marghera Estate
RINO GAETANO BAND
Rino Gaetano tribute
Piazza Mercato-Marghera h. 21
Mirano Summer Festival
CRISTINA D’AVENA
Anni ‘80 tribute
Impianti sportivi-Mirano h. 21
AMA Music Festival QUEENS OF THE STONE AGE
THE KILLS THE AMAZONS
Rock
Parco di Villa Negri-Romano d’Ezzelino h. 21
17
giovedìThursday
Venezia Jazz Festival TAKE 6
Soul
Piazza Mercato-Marghera h. 20
Mirano Summer Festival
UMBERTO TOZZI
Pop Impianti sportivi-Mirano h. 21
MARCO MENGONI
Pop
Stadio Euganeo-Padova h. 21
AMA Music Festival
GYPSY KINGS
Flamenco
Parco di Villa Negri-Romano d’Ezzelino h. 21
Festival del Vittoriale
KAMASI WASHINGTON
Jazz
Anfiteatro del Vittoriale-Gardone Riviera h. 21.15
18
venerdì Friday
Venezia Jazz Festival
ROGER CORREA 4TET
Jazz
Auditorium Lo Squero h. 18
Marghera Estate
TONY ESPOSITO
World music
Piazza Mercato-Marghera h. 21
CCCP-FEDELI ALLA LINEA
Indie rock
Anfiteatro Camerini-Piazzola sul Brenta h. 21
19
sabato Saturday
ILARIO ALICANTE
HONEYLUV
AELITA & JANE
Dj-set
Il Muretto-Jesolo h. 22
SAM PAGANINI
Dj-set
King’s Club-Jesolo h. 22
No Borders Music Festival
BEN HARPER & THE INNOCENT CRIMINALS
Blues rock
Laghi di Fusine-Tarvisio h. 14
20
domenica Sunday
THE WHO Rock
Anfiteatro Camerini-Piazzola sul Brenta h. 21
CALIBRO 35
Indie
Teatro Romano-Verona h. 21.15
Villa Manin Estate
RICCARDO MUTI
Musica classica
Villa Manin-Codroipo h. 21
No Borders Music Festival
MIKA
Pop Laghi di Fusine-Tarvisio h. 14
21
lunedì Monday
Women for Freedom in Jazz
SARRA DOUIK SOLO PERFORMANCE
Jazz
Hotel Carlton on the Grand Canal h. 21
Villa Manin Estate
GIORGIA
Pop
Villa Manin-Codroipo h. 21
22
martedìTuesday
BEN HARPER & THE INNOCENT CRIMINALS
Blues rock
Anfiteatro Camerini-Piazzola sul Brenta h. 21
23
mercoledìWednesday BALKALÀ
Jazz
“InOut“ M9-Museo del ‘900-Mestre h. 19
VALENTINO
Dj-set
Il Muretto-Jesolo h. 22
STEWART COPELAND
Musica d’autore
Castello Scaligero-Villafranca h. 22
Festival del Vittoriale
MORRISSEY
Indie rock
Anfiteatro del Vittoriale-Gardone
Riviera h. 21.15
24
giovedìThursday
Festival del Vittoriale
MIKA
Pop
Anfiteatro del Vittoriale-Gardone
Riviera h. 21.15
25
venerdì Friday
Venezia Jazz Festival
GIOVANNI FALZONE FREAK MACHINE
Jazz Parco Oriana Fallaci-Fiesso h. 21.30
FABRI FIBRA
Rap Castello Scaligero-Villafranca h. 22
Festival del Vittoriale
VINICIO CAPOSSELA
Musica d’autore
Anfiteatro del Vittoriale-Gardone
Riviera h. 21.15
26 sabato Saturday
BLACK CHILD ANNICKA
IDRISS D MARCO ZABEO
Dj-set
Il Muretto-Jesolo h. 22
BOB SINCLAR
Dj-set
King’s Club-Jesolo h. 22
Festival del Vittoriale
ANTONELLO VENDITTI
Musica d’autore
Anfiteatro del Vittoriale-Gardone
Riviera h. 21.15
No Borders Music Festival
JOVANOTTI
Pop
Laghi di Fusine-Tarvisio h. 14
27 domenica Sunday
Festival del Vittoriale
KENNY WAYNE SHPEHERD
Blues rock
Anfiteatro del Vittoriale-Gardone
Riviera h. 21.15
No Borders Music Festival
LUCIO CORSI
Pop
Laghi di Fusine-Tarvisio h. 14
29
martedìTuesday
Festival del Vittoriale
ANTONELLO VENDITTI
Musica d’autore
Anfiteatro del Vittoriale-Gardone
Riviera h. 21.15
30
mercoledìWednesday
FANTASM
Dj-set
Il Muretto-Jesolo h. 22
02
sabato Saturday
Venezia Jazz Festival
ADAM HOLZMAN TRIO
Jazz
Combo h. 21
SOLID GROOVES
Dj-set
Spiaggia del Faro-Jesolo h. 22
THE MARTINEZ BROTHERS
OLDERIC
GERMANO VENTURA
Dj-set
Il Muretto-Jesolo h. 22
No Borders Music Festival
GORAN BREGOVIC
Pop
Rifugio Gilberti-Sella Nevea h. 12
03
domenica Sunday
Venezia Jazz Festival
ADAM HOLZMAN TRIO
Jazz Combo h. 21
No Borders Music Festival
KINGS OF CONVENIENCE
Pop
Altopiano del Montasio-Sella Nevea h. 14
06
mercoledìWednesday
BARBARA LAGO
Dj-set
Il Muretto-Jesolo h. 22
09
sabato Saturday
ANOTR
FABIO MONESI
GERMANO VENTURA
Dj-set
Il Muretto-Jesolo h. 22
12
mercoledìWednesday
Sea Music Festival
BURNING SPEAR
Reggae
Isola dell’Unione-Chioggia h. 22
Operaestate
STEFANO BOLLANI
Jazz
Villa Dolfin Boldù-Rosà h. 21.20
13
mercoledìWednesday
LUCA AGNELLI
Dj-set
Il Muretto-Jesolo h. 22
16
sabato Saturday
Sea Music Festival
EDOARDO BENNATO
Rock
Isola dell’Unione-Chioggia h. 22
18
lunedì Monday
Sea Music Festival
STEVE AOKI
Dance
Isola dell’Unione-Chioggia h. 22
19
martedìTuesday
AMA Music Festival
VAMPIRE WEEKEND THE MURDER CAPITAL
DIIV
Indie
Parco di Villa Negri-Romano d’Ezzelino h. 21
20
mercoledìWednesday
HOLY PRIEST
Dj-set
Il Muretto-Jesolo h. 22
21
giovedìThursday
AMA Music Festival
ELECTRIC CALLBOY I PREVAIL
PALEFACE SWISS
RUIDOS DEL NORTE
Hard rock
Parco di Villa Negri-Romano d’Ezzelino h. 21
22 venerdì Friday
AMA Music Festival ANNA CAPO PLAZA MARTE
Trap
Parco di Villa Negri-Romano d’Ezzelino h. 21
23
sabato Saturday
AMA Music Festival THE PRODIGY Musica elettronica
Parco di Villa Negri-Romano d’Ezzelino h. 21
24 domenica Sunday
Operaestate
CHIARA CECCONELLO
Musica elettronica
Chiesetta dell’Angelo-Bassano del Grappa h. 22
26 martedìTuesday
AMA Music Festival SFERA EBBASTA
Trap
Parco di Villa Negri-Romano d’Ezzelino h. 21
27
mercoledìWednesday
Operaestate BACÀN
Jazz
Palazzo Bonaguro-Bassano h. 19.30
28 giovedìThursday
AMA Music Festival FRANZ FERDINAND STEREOPHONICS
Rock
Parco di Villa Negri-Romano d’Ezzelino h. 21
29 venerdì Friday
Operaestate KNN
Jazz
Chiesa di San Giovanni-Bassano h. 21.30
INDIRIZZI
ALTOPIANO DEL MONTASIO
Tarvisio nobordersmusicfestival.com
ANFITEATRO CAMERINI
Piazzale Camerini-Piazzola www.zedlive.com
ANFITEATRO DEL VITTORIALE
Via Vittoriale 12-Gardone www.anfiteatrodelvittoriale.it
ARENA DI VERONA
Piazza Bra 1-Verona www.eventiverona.it
AUDITORIUM LO SQUERO
Isola di San Giorgio Maggiore www.venetojazz.com
CASTELLO SCALIGERO
Piazza Castello-Villafranca www.eventiverona.it
CHIESA DI SAN GIOVANNI
Piazza Libertà 27-Bassano www.operaestate.it
CHIESETTA DELL’ANGELO
Via Roma 38-Bassano www.operaestate.it
COMBO
Campo dei Gesuiti 4878 www.venetojazz.com
HOTEL CARLTON ON THE GRAND CANAL
Santa Croce 578
Fb: Women for Freedom in Jazz
IL MURETTO
Via Roma Destra 120-Jesolo www.ilmuretto.org
IMPIANTI SPORTIVI
Via Cavin di Sala-Mirano miranosummerfestival.it
ISOLA DELL’UNIONE
Chioggia www.seamusicfestival.it
LAGHI DI FUSINE
Tarvisio nobordersmusicfestival.com
M9 - MUSEO DEL ‘900
Via G. Pascoli 11-Mestre www.m9museum.it
PALAZZO BONAGURO
Via Angarano 77-Bassano www.operaestate.it
PARCO DI VILLA NEGRI
Romano d’Ezzelino www.amamusicfestival.com
PARCO ORIANA FALLACI
Via Zuina 65-Fiesso www.venetojazz.com
PARCO RAGAZZI DEL ‘99 Bassano del Grappa duepuntieventi.com
PARK NORD STADIO EUGANEO
Viale Nereo Rocco-Padova www.sherwoodfestival.it
PIAZZA CASTELLO
Sesto al Reghena sextonplugged.it
PIAZZA DEGLI SCACCHI Marostica marosticasummerfestival.it
PIAZZA MERCATO
Marghera www.venetojazz.com www.comune.venezia.it
PIAZZA SAN MARCO
Venezia www.comune.venezia.it
RIFUGIO GILBERTI
Sella Nevea nobordersmusicfestival.com
SPIAGGIA DEL FARO
Jesolo Lido www.kingsclubjesolo.it www.ilmuretto.org
SPLENDID VENICE HOTEL
S. Marco Mercerie, 760 www.venetojazz.com
STADIO EUGANEO
Viale Nereo Rocco-Padova www.zedlive.com
TEATRO AL CASTELLO
TITO GOBBI
Piazza Castello Ezzelini-Bassano del Grappa www.operaestate.it
TEATRO LA FENICE
Campo San Fantin 1965 www.venetojazz.com
TEATRO ROMANO
Rigaste Redentore 2-Verona www.eventiverona.it
VILLA DOLFIN BOLDÙ
Via Giardini 4-Rosà www.operaestate.it
VILLA MANIN
Stradone Manin 10-Codroipo www.villamanin.it
01
martedìTuesday
DIALOGUES DES CARMÉLITES
Direttore Frédéric Chaslin
Regia Emma Dante
Musiche di Francis Poulenc
“Stagione Lirica e Balletto 20242025”
Ingresso/Ticket € 209/99
Teatro La Fenice h. 19
04
venerdì Friday
PAOLA TALAMINI organo
Musiche di Vivaldi “Vivaldi Festival”
Ingresso libero/Free entry
Basilica Santa Maria della Salute h. 15.30
CARMEN
Direttore Francesco Ivan Ciampa
Regia Franco Zeffirelli
Musiche di Georges Bizet
“102. Arena Opera Festival”
Ingresso/Ticket € 300/35
Arena di Verona h. 21.15
05 sabato Saturday
STANISLAV
KOCHANOVSKY direttore
Orchestra del Teatro La Fenice
Musiche di Prokofiev, Cajkovskij
“Stagione Sinfonica 2024-2025”
Ingresso/Ticket € 130/15
Teatro La Fenice h. 20
CASANOVA OPERA POP
Musiche di Red Canzian
Ingresso/Ticket € 95/55
Piazza San Marco h. 21
LA TRAVIATA
Direttore Speranza Scappucci
Regia Hugo de Ana
Musiche di Giuseppe Verdi
“102. Arena Opera Festival”
Ingresso/Ticket € 300/35 Arena di Verona h. 21.15
06 domenica Sunday
ENSEMBLE VOCALE ELASTICO
PAOLA TALAMINI organo
FABRIZIO FUCILE direttore
Musiche di Vivaldi
“Vivaldi Festival”
Ingresso libero/Free entry
Basilica Santa Maria della Salute h. 15.30
STANISLAV KOCHANOVSKY
direttore
Orchestra del Teatro La Fenice
Musiche di Prokofiev, Cajkovskij
“Stagione Sinfonica 2024-2025”
Ingresso/Ticket € 130/15
Teatro La Fenice h. 17
AIDA
Direttore Francesco Ommassini
Regia Stefano Poda
Musiche di Giuseppe Verdi
“102. Arena Opera Festival”
Ingresso/Ticket € 300/35
Arena di Verona h. 21.15
07
lunedì Monday
PAULUS QUARTET
PAOLA TALAMINI organo
Musiche di Vivaldi
“Vivaldi Festival”
Ingresso libero/Free entry
Basilica Santa Maria della Salute h. 15.30
10
giovedìThursday
NABUCCO
Direttore Pinchas Steinberg
Regia Stefano Poda
Musiche di Giuseppe Verdi
“102. Arena Opera Festival”
Ingresso/Ticket € 265/38
Arena di Verona h. 21.15
11
venerdì Friday
LA TRAVIATA
Direttore Speranza Scappucci
Regia Hugo de Ana
Musiche di Giuseppe Verdi
“102. Arena Opera Festival”
Ingresso/Ticket € 300/35
Arena di Verona h. 21.15
12
sabato Saturday
SIMON ZHU violino
Musiche di Bach, Paganini
“Asolo Musica 2025”
Ingresso/Ticket € 33/11
Auditorium Lo Squero h. 16.30
CAVALLERIA RUSTICANA
Opera in forma di concerto
Direttore Rico Saccani
Orchestra e Coro del Teatro La Fenice
Musiche di Pietro Mascagni
“Stagione Lirica e Balletto 20242025”
Ingresso/Ticket € 300/30
Piazza San Marco h. 21
CARMEN
Direttore Francesco Ivan Ciampa
Regia Franco Zeffirelli
Musiche di Georges Bizet
“102. Arena Opera Festival”
Ingresso/Ticket € 300/35
Arena di Verona h. 21.15
13
domenica Sunday
TRIO HENKEL
Musiche di Vivaldi
“Vivaldi Festival”
Ingresso libero/Free entry
Basilica Santa Maria della Salute h.
15.30
AIDA
Direttore Daniel Oren
Regia Stefano Poda
Musiche di Giuseppe Verdi
“102. Arena Opera Festival”
Ingresso/Ticket € 300/35
Arena di Verona h. 21.15
14
lunedì Monday
I MAESTRI DI SAN MARCO
Musiche di Vivaldi
“Vivaldi Festival”
Ingresso libero/Free entry
Basilica Santa Maria della Salute h. 15.30
ORCHESTRA DI PADOVA E DEL VENETO
Direttore Filippo Maria Bressan
Musiche di Antonio Vivaldi
“Operaestate Festival Veneto”
Ingresso/Ticket € 10
Lungobrenta-Bassano del Grappa h. 21.30
16
AIDA
mercoledìWednesday
Direttore Daniel Oren
Regia Stefano Poda
Musiche di Giuseppe Verdi
“102. Arena Opera Festival”
Ingresso/Ticket € 300/35
Arena di Verona h. 21.15
17
giovedìThursday NABUCCO
Direttore Pinchas Steinberg
Regia Stefano Poda
Musiche di Giuseppe Verdi
“102. Arena Opera Festival”
Ingresso/Ticket € 265/38
Arena di Verona h. 21.15
18 venerdì Friday
BORIS AKISHIN oboe
AIDA VITTURI flauto
Musiche di Vivaldi
“Vivaldi Festival”
Ingresso libero/Free entry
Basilica Santa Maria della Salute h. 15.30
CARMEN
Direttore Francesco Ivan Ciampa
Regia Franco Zeffirelli
Musiche di Georges Bizet
“102. Arena Opera Festival”
Ingresso/Ticket € 300/35
Arena di Verona h. 21.15
19 sabato Saturday
LA TRAVIATA
Direttore Speranza Scappucci
Regia Hugo de Ana Musiche di Giuseppe Verdi “102. Arena Opera Festival”
Ingresso/Ticket € 300/35
Arena di Verona h. 21.15
20 domenica Sunday
MARTINA MOLIN violino Musiche di Vivaldi “Vivaldi Festival”
Ingresso libero/Free entry
Basilica Santa Maria della Salute h. 15.30
AIDA
Direttore Daniel Oren
Regia Stefano Poda
Musiche di Giuseppe Verdi
“102. Arena Opera Festival”
Ingresso/Ticket € 300/35
Arena di Verona h. 21.15
21 lunedì Monday
ELLI CHOI violino RICCARDO GAGLIARDI pianoforte
Musiche di Mozart, Brahms, Ysaye, Gershwin
“Operaestate Festival Veneto”
Ingresso/Ticket € 10
Chiostro Museo Civico-Bassano del Grappa h. 21.30
22 martedìTuesday
ROBERTO BOLLE AND FRIENDS
Musiche del repertorio classico
“102. Arena Opera Festival”
Ingresso/Ticket € 265/30
Arena di Verona h. 21.30
23
mercoledìWednesday
ROBERTO BOLLE AND FRIENDS
Musiche del repertorio classico
“102. Arena Opera Festival” Ingresso/Ticket € 265/30
Arena di Verona h. 21.30
24
giovedìThursday NABUCCO
Direttore Pinchas Steinberg
Regia Stefano Poda
Musiche di Giuseppe Verdi
“102. Arena Opera Festival”
Ingresso/Ticket € 265/38
Arena di Verona h. 21.15
25
venerdì Friday LA TRAVIATA
Direttore Francesco Ommassini
Regia Hugo de Ana
Musiche di Giuseppe Verdi
“102. Arena Opera Festival”
Ingresso/Ticket € 300/35
Arena di Verona h. 21.15
26
sabato Saturday
CARMEN
Direttore Francesco Ivan Ciampa
Regia Franco Zeffirelli
Musiche di Georges Bizet
“102. Arena Opera Festival”
Ingresso/Ticket € 300/35
Arena di Verona h. 21.15
27
domenica Sunday
LES ENSEMBLE VITTORIA
Musiche di Vivaldi
“Vivaldi Festival”
Ingresso libero/Free entry
Basilica Santa Maria della Salute h. 15.30
AIDA
Direttore Daniel Oren
Regia Stefano Poda
Musiche di Giuseppe Verdi
“102. Arena Opera Festival”
Ingresso/Ticket € 300/35
Arena di Verona h. 21.15
28
lunedì Monday
PAOLA TALAMINI organo
AURORA TAFFON violino
Musiche di Vivaldi
“Vivaldi Festival”
Ingresso libero/Free entry
Basilica Santa Maria della Salute h. 15.30
GIULIA CELLACCHI violino
MARIA SALVATORI violoncello
MAYA OGANYAN pianoforte
Musiche di Rachmaninov, Shostakovich, Mendelssohn
“Operaestate Festival Veneto”
Ingresso/Ticket € 10
Chiostro Museo Civico-Bassano del Grappa h. 21.30
30
mercoledìWednesday
BORIS GARLITSKY violino
ELENA GARLITSKY pianoforte
Musiche di Brahms Schubert, Cajkovskij
“Operaestate Festival Veneto”
Ingresso/Ticket € 10
Chiostro Museo Civico-Bassano del Grappa h. 21.30
31
giovedìThursday
NABUCCO
Direttore Pinchas Steinberg
Regia Stefano Poda
Musiche di Giuseppe Verdi
“102. Arena Opera Festival”
Ingresso/Ticket € 265/38
Arena di Verona h. 21.15
01
AIDA
venerdì Friday
Direttore Daniel Oren
Regia Stefano Poda
Musiche di Giuseppe Verdi
“102. Arena Opera Festival”
Ingresso/Ticket € 300/35
Arena di Verona h. 21
02
sabato Saturday
LA TRAVIATA
Direttore Francesco Ommassini
Regia Hugo de Ana
Musiche di Giuseppe Verdi
“102. Arena Opera Festival”
Ingresso/Ticket € 300/35
Arena di Verona h. 21.15
03
domenica Sunday
JONAS KAUFMANN tenore
Musiche del repertorio lirico
“102. Arena Opera Festival”
Ingresso/Ticket € 210/35
Arena di Verona h. 21.15
08 venerdì Friday
RIGOLETTO
Direttore Michele Spotti
Regia Ivo Guerra Musiche di Giuseppe Verdi “102. Arena Opera Festival” Ingresso/Ticket € 300/35
Arena di Verona h. 21
09
sabato Saturday
NABUCCO
Direttore Pinchas Steinberg
Regia Stefano Poda
Musiche di Giuseppe Verdi
“102. Arena Opera Festival”
Ingresso/Ticket € 265/38
Arena di Verona h. 21
10 domenica Sunday
AIDA
Direttore Daniel Oren
Regia Stefano Poda
Musiche di Giuseppe Verdi “102. Arena Opera Festival” Ingresso/Ticket € 300/35
Arena di Verona h. 21
11
lunedì Monday
TONY SIQI YUN pianoforte
Musiche di Bach, Schumann, Beethoven “Operaestate Festival Veneto” Ingresso/Ticket € 10 Chiostro Museo Civico-Bassano del Grappa h. 21.30
14
giovedìThursday
CARMEN
Direttore Francesco Ivan Ciampa
Regia Franco Zeffirelli
Musiche di Georges Bizet
“102. Arena Opera Festival”
Ingresso/Ticket € 300/35
Arena di Verona h. 21
15 venerdì Friday
CARMINA BURANA
Cantata scenica
Direttore Andrea Battistoni
Musiche di Carl Orff
“102. Arena Opera Festival” Ingresso/Ticket € 265/30
Arena di Verona h. 21.30
16 sabato Saturday
NABUCCO
Direttore Pinchas Steinberg
Regia Stefano Poda
Musiche di Giuseppe Verdi
“102. Arena Opera Festival”
Ingresso/Ticket € 265/38
Arena di Verona h. 21
17
AIDA
domenica Sunday
Direttore Daniel Oren
Regia Stefano Poda
Musiche di Giuseppe Verdi
“102. Arena Opera Festival”
Ingresso/Ticket € 300/35
Arena di Verona h. 21
21 giovedìThursday
NABUCCO
Direttore Pinchas Steinberg
Regia Stefano Poda
Musiche di Giuseppe Verdi
“102. Arena Opera Festival”
Ingresso/Ticket € 265/38
Arena di Verona h. 21
22 venerdì Friday
RIGOLETTO
Direttore Michele Spotti
Regia Ivo Guerra
Musiche di Giuseppe Verdi
“102. Arena Opera Festival”
Ingresso/Ticket € 300/35
Arena di Verona h. 21
23 sabato Saturday
CARMEN
Direttore Francesco Ivan Ciampa
Regia Franco Zeffirelli
Musiche di Georges Bizet “102. Arena Opera Festival” Ingresso/Ticket € 300/35
Arena di Verona h. 21
24 domenica Sunday
AIDA
Direttore Daniel Oren
Regia Stefano Poda
Musiche di Giuseppe Verdi
“102. Arena Opera Festival”
Ingresso/Ticket € 300/35
Arena di Verona h. 21
27
mercoledìWednesday
VIVA VIVALDI. THE FOUR SEASONS IMMERSIVE CONCERT
GIOVANNI ANDREA ZANON
violino
Orchestra Fondazione Arena di Verona
Musiche di Antonio Vivaldi
“102. Arena Opera Festival”
Ingresso/Ticket € 265/35 Arena di Verona h. 21.30
28 giovedìThursday
AIDA
Direttore Daniel Oren
Regia Stefano Poda
Musiche di Giuseppe Verdi
“102. Arena Opera Festival”
Ingresso/Ticket € 300/35 Arena di Verona h. 21
29 venerdì Friday
TOSCA
Opera in tre atti
Direttore Daniele Rustioni
Regia Joan Anton Rechi
Musiche di Giacomo Puccini
31 domenica Sunday
TOSCA
Direttore Daniele Rustioni
Regia Joan Anton Rechi
Musiche di Giacomo Puccini
Orchestra e Coro del Teatro La Fenice
Piccoli Cantori Veneziani
“Stagione Lirica e Balletto 20242025”
Ingresso/Ticket € 230/20
Teatro La Fenice h. 17
01
martedìTuesday
SHOOTING SNOW WHITE
Accademia di teatro “Dimitri” di Verscio (Svizzera)
“BUH! – Venice Open Stage 2025”
Ingresso libero/Free entry
Arena Gigi dall’Aglio
Campazzo San Sebastiano h. 21.45
02 mercoledìWednesday
SHOOTING SNOW WHITE
(vedi martedì 1 luglio)
05 sabato Saturday
UMAN
Camilla Violante Scheller aka Navëe
“BUH! – Venice Open Stage 2025” Ingresso libero/Free entry Arena Gigi dall’Aglio Campazzo San Sebastiano h. 21.45
06 domenica Sunday
IL DILEMMA DEI CENTO GIRASOLI FOTOVOLTAICI
Matrice Teatro
“BUH! – Venice Open Stage 2025”
Ingresso libero/Free entry
Orchestra e Coro del Teatro La Fenice
Piccoli Cantori Veneziani
“Stagione Lirica e Balletto 20242025”
Ingresso/Ticket € 230/20
Teatro La Fenice h. 19
CARMEN
Direttore Francesco Ivan Ciampa
Regia Franco Zeffirelli
Musiche di Georges Bizet
“102. Arena Opera Festival”
Ingresso/Ticket € 300/35 Arena di Verona h. 21
30 sabato Saturday
RIGOLETTO
Direttore Michele Spotti
Regia Ivo Guerra
Musiche di Giuseppe Verdi
“102. Arena Opera Festival”
Ingresso/Ticket € 300/35
Arena di Verona h. 21
ARENA DI VERONA Piazza Brà 1-Verona www.arena.it
AUDITORIUM LO
SQUERO
Isola di San Giorgio www.asolomusica.com
BASILICA SANTA MARIA DELLA SALUTE Dorsoduro 1 www.vivaldifestival.org
PIAZZA SAN MARCO Venezia www.teatrolafenice.it
TEATRO LA FENICE
Campo San Fantin 1965 www.teatrolafenice.it
LUNGOBRENTA
Bassano del Grappa www.operaestate.it
MUSEO CIVICO
Piazza Garibaldi 34-Bassano del Grappa www.operaestate.it
Arena Gigi dall’Aglio
Campazzo San Sebastiano h. 21.45
03 giovedìThursday
STRADA MAESTRA
di e con Laura Nardinocchi e Niccolò Matcovich
“Verde Groggia 2025”
Ingresso libero/Free entry
Campo del Ghetto h. 21.30
IL MIO CORPO È COME
UN MONTE
Collettivo EFFE
“BUH! – Venice Open Stage 2025”
Ingresso libero/Free entry
Arena Gigi dall’Aglio
Campazzo San Sebastiano h. 21.45
ROSENCRANTZ E GUILDENSTERN SONO MORTI
di Tom Stoppard e con Francesco Pannofino, Francesco Acquaroli, Paolo Sassanelli, Andrea Pannofino e Chiara Mascalzoni
Regia Alberto Rizzi
“Estate Teatrale Veronese 2025”
Ingresso/Ticket € 33/20
Teatro Romano-Verona h. 21.15
04
venerdì Friday
VERDERAME
Le Tutto Sotto Controllo
“BUH! – Venice Open Stage 2025”
Ingresso libero/Free entry
Arena Gigi dall’Aglio Campazzo San Sebastiano h. 21.45
ROSENCRANTZ E GUILDENSTERN SONO MORTI
(vedi giovedì 3 luglio)
Teatro Romano-Verona h. 21.15
Arena Gigi dall’Aglio
Campazzo San Sebastiano h. 21.45
07 lunedì Monday
JAMES JOYCE, ULYSSES, EPISODE CIRCE
Aristotle University of Thessaloniki, Faculty of Fine Arts - School of Drama (Grecia)
“BUH! – Venice Open Stage 2025” Ingresso libero/Free entry Arena Gigi dall’Aglio Campazzo San Sebastiano h. 21.45
SOPRAVVIVERE
AGLI ANNI ‘20
Regia Alberto Barutti
Drammaturgia Irene Silvestri
Compagnia Barbamoccolo
“E=TiC Estate = Teatro in Città” Ingresso libero/Free entry
Largo Divisione Julia-Mestre h. 19
08 martedìTuesday
JAMES JOYCE, ULYSSES, EPISODE CIRCE (vedi lunedì 7 luglio) Arena Gigi dall’Aglio
Campazzo San Sebastiano h. 21.45
09
mercoledìWednesday
TITIZÉ. A VENETIAN DREAM
Regia di Daniele Finzi Pasca
Compagnia Finzi Pasca
Fino al 21 settembre lo spettacolo va in scena al Teatro Goldoni ogni giorno da mercoledì a domenica
Vedi p. 165
Ingresso/Ticket € 60/22
Teatro Goldoni h. 19
SPRITZ
Corto erotico politico comico
alcolico
Baladam B-Side
“Verde Groggia 2025”
Ingresso libero/Free entry
Parco di Villa Groggia h. 21.30
RIMAYE
AZIONIfuoriPOSTO
“BUH! – Venice Open Stage 2025”
Ingresso libero/Free entry Arena Gigi dall’Aglio
Campazzo San Sebastiano h. 21.45
10
giovedìThursday
VARIATIONS ON THE THEME OF LOSS / VARIAZIONI SUL TEMA DELLA PERDITA
The Aleksander Zelwerowicz National Academy of Dramatic Art di Varsavia (Polonia)
“BUH! – Venice Open Stage 2025” Ingresso libero/Free entry Arena Gigi dall’Aglio
Campazzo San Sebastiano h. 21.45
SUSPENDED CHORUS
Concept, regia, coreografia, danza
Silvia Gribaudi
“Operaestate 2025”
Ingresso/Ticket € 20/18
Teatro Remondini
Bassano del Grappa h. 21.20
OTELLO
di William Shakespeare
Drammaturgia Dacia Maraini
Regia Giorgio Pasotti
Con Giacomo Giorgio, Giorgio Pasotti, Claudia Tosoni, Davide Paganini, Gerardo Maffei, Salvatore Rancatore, Andrea Papale
“Estate Teatrale Veronese 2025”
Ingresso/Ticket € 33/20
Teatro Romano-Verona h. 21.15
11
venerdì Friday
SDISORÉ
Gruppo UROR
“BUH! – Venice Open Stage 2025” Ingresso libero/Free entry Arena Gigi dall’Aglio
Campazzo San Sebastiano h. 21.45
OTELLO
(vedi giovedì 10 luglio)
Teatro Romano-Verona h. 21.15
13
domenica Sunday
LA NOTTE DEI BAMBINI
Drammaturgia Gaia Nanni, Giuliana Musso
Con con Gaia Nanni
Regia Giuliana Musso
“Operaestate 2025”
Ingresso/Ticket € 18/20
Teatro al Castello “Tito Gobbi”
Bassano del Grappa h. 21.20
14
lunedì Monday
IL PRIMO MIRACOLO DI GESÙ BAMBINO
da Mistero Buffo di Dario Fo e Franca Rame con Matthias Martelli
Produzione Melo Tondo APS
“E=TiC Estate = Teatro in Città”
Ingresso libero/Free entry
Piazzetta Malipiero-Mestre h. 19
15
martedìTuesday
SOIREE RENATO SIMONI
di e con Luca Scarlini
“Estate Teatrale Veronese 2025”
Ingresso/Ticket € 33/20
Bastione delle Maddalene-Verona h. 21.15
16
mercoledìWednesday
CONCERTO FETIDO SU
4 ZAMPE
Scarti. Centro di produzione
teatrale d’innovazione - Fratelli
Sinigaglia
“Verde Groggia 2025”
Ingresso libero/Free entry
Parco di Villa Groggia h. 21.30
SOIREE RENATO SIMONI
(vedi martedì 15 luglio)
Bastione delle Maddalene-Verona h. 21.15
17
giovedìThursday
19. BIENNALE DANZA
Il 19. Festival Internazionale di Danza Contemporanea si svolge dal 17 luglio al 2 agosto 2025, diretto da Wayne McGregor. In programma numerosi appuntamenti quotidiani con solisti e compagnie internazionali e l’attività di Biennale College Danza che diventa parte integrante del programma del Festival. Vedi Coverstory pp. 12-51
ABRACADABRA
di Babilonia Teatri con Enrico Castellani, Valeria Raimondi, Francesco Scimemi, Emanuela Villagrossi “Operaestate 2025” Ingresso/Ticket € 12/15
Teatro al Castello “Tito Gobbi” Bassano del Grappa h. 21.20
RICCARDO III
di William Shakespeare Riduzione e adattamento
Angela Dematté
Regia Andrea Chiodi
con Maria Paiato, Riccardo Bocci “Estate Teatrale Veronese 2025” Ingresso/Ticket € 33/20
Teatro Romano-Verona h. 21.15
18
venerdì Friday
ITERATIONS
di e con Tom Cassani “Operaestate 2025”
Ingresso/Ticket € 10
CSC San Bonaventura Bassano del Grappa h. 21.20
RICCARDO III
(vedi giovedì 17 luglio)
Teatro Romano-Verona h. 21.15
19
sabato Saturday
SHAKESPEARE IN DREAM
Ideazione e coreografia Marcella Galbusera, produzione Arte3 “Estate Teatrale Veronese 2025”
Ingresso/Ticket € 8/10
Bastione delle Maddalene-Verona h. 21.15
ASTEROIDE
di e con Marco D’Agostin
Suono Luca Scapellato
“Operaestate 2025”
Ingresso/Ticket € 15/12
Teatro Remondini
Bassano del Grappa h. 21.20
20
domenica Sunday
SHAKESPEARE IN DREAM
(vedi sabato 19 luglio)
Bastione delle Maddalene-Verona h. 21.15
21
lunedì Monday
TROPPE ARIE
Regia di Rita Pelusio
Compagnia Trioche
“E=TiC Estate = Teatro in Città”
Ingresso libero/Free entry
Piazzetta Malipiero-Mestre h. 19
SHAKESPEARE IN DREAM
(vedi sabato 19 luglio)
Bastione delle Maddalene-Verona h. 21.15
22 martedìTuesday
SHAKESPEARE IN DREAM (vedi sabato 19 luglio) Bastione delle Maddalene-Verona h. 21.15
23 mercoledìWednesday
POST
Qualcuno ha voglia di riscrivere il presente?
Diego dalla Via “Verde Groggia 2025” Ingresso libero/Free entry Parco di Villa Groggia h. 21.30
24 giovedìThursday
LANDLESS
Ideazione e coreografia Christos Papadopoulos, Georgios Kotsifakis Danzatore Georgios Kotsifakis “Operaestate 2025” Ingresso/Ticket € 20/18
Teatro Remondini
Bassano del Grappa h. 21.20
LA TEMPESTA di William Shakespeare Regia Alfredo Arias Con Graziano Piazza, Guia Jelo “Estate Teatrale Veronese 2025” Ingresso/Ticket € 33/20 Teatro Romano-Verona h. 21.15
25
venerdì Friday
LA TEMPESTA (vedi giovedì 24 luglio) Teatro Romano-Verona h. 21.15
SHAKESPEARE IN BLOOD
Coreografia e regia di Laura Corradi
Ersiliadanza
“Estate Teatrale Veronese 2025” Ingresso/Ticket € 8/10
Bastione delle Maddalene-Verona h. 21.15
26 sabato Saturday
R.OSA
10 esercizi per nuovi virtuosismi Concept, coreografia e regia Silvia Gribaudi
Performer Claudia Marsicano “Operaestate 2025” Teatro delle Mura-Castelfranco h. 21.20
SHAKESPEARE IN BLOOD (vedi venerdì 25 luglio) Bastione delle Maddalene-Verona h. 21.15
27
domenica Sunday
SHAKESPEARE IN BLOOD
(vedi venerdì 25 luglio)
Bastione delle Maddalene-Verona h. 21.15
31
giovedìThursday
SAMIA
Concetto e coreografia Adriano Bolognino
Danzatori Rosaria Di Maro, Gaia Mentoglio, Noemi Caricchia, Roberta Fanzini, Serena Pomer, Ines Giorgiutti
“Operaestate 2025”
Ingresso/Ticket € 15/12
Teatro al Castello “Tito Gobbi” Bassano del Grappa h. 21.20
01
venerdì Friday
PIMPA. IL MUSICAL A POIS
Drammaturgia Francesco Tullio
Altan, Enzo d’Alò
Regia Enzo d’Alò
“Estate Teatrale Veronese 2025”
Ingresso/Ticket € 25/23
Teatro Romano-Verona h. 21.15
02
sabato Saturday
PIMPA. IL MUSICAL A POIS
(vedi venerdì 1 agosto)
Teatro Romano-Verona h. 21.15
05
martedìTuesday
RUMBA
L’asino e il bue del presepe di San Francesco nel parcheggio del supermercato di e con Ascanio Celestini musica e voce Gianluca Casadei voce Agata Celestini immagini dipinte Franco Biagioni
“Operaestate 2025”
Ingresso/Ticket € 18/20
Teatro al Castello “Tito Gobbi” Bassano del Grappa h. 21
08
venerdì Friday
SONOMA
Ideazione e direzione artistica
Marcos Morau La Veronal “Operaestate 2025”
Ingresso/Ticket € 25/20
Teatro al Castello “Tito Gobbi” Bassano del Grappa h. 21
12
martedìTuesday
LES BALLETS
TROCKADERO DE MONTE
CARLO
Direttore artistico Tory Dobrin
“Estate Teatrale Veronese 2025”
Ingresso/Ticket € 26/40
Teatro Romano-Verona h. 21.15
22
venerdì Friday
LE CLASSIQUE C’EST CHIC
di e con Anna Basti
“Operaestate 2025 – B.Motion”
Ingresso libero/Free entry
Ponte Vecchio-Bassano del Grappa h. 17
GIGANTE
Coreografia e danza Annika
Pannitto
“Operaestate 2025 – B.Motion”
Ingresso/Ticket € 8
Chiesa di San Giovanni Bassano del Grappa h. 18
A VERY EYE
Concept e coreografia Angela
Rabaglio, Micaël Florentz
Tumbleweed
“Operaestate 2025 – B.Motion”
Ingresso/Ticket € 8
CSC San Bonaventura
Bassano del Grappa h. 20
MA L’AMOR MIO NON
MUORE/ÉPILOGUE
Ideazione Alessandro Bernardeschi
Wooshing Machine
“Operaestate 2025 – B.Motion”
Ingresso/Ticket € 8
Teatro Remondini
Bassano del Grappa h. 21.30
23
sabato Saturday
LE CLASSIQUE C’EST CHIC
(vedi venerdì 22 agosto)
Ponte Vecchio-Bassano del Grappa h. 16.30
SOLE E BALENO
Una favola anarchica
Testo Pietro Babina
Musica Alberto Fiori
“Operaestate 2025 – B.Motion”
Ingresso/Ticket € 8
CSC San Bonaventura
Bassano del Grappa h. 18
APPUNTI PER IL SOLE
Coreografia Daniele Albanese
Con Fabio Pronestì, Diego Spiga
“Operaestate 2025 – B.Motion”
Ingresso/Ticket € 8
Chiesa di San Giovanni Bassano del Grappa h. 22
24
domenica Sunday
ATTO BIANCO
Progetto, coreografia, danza Roberta Racis
Con Fabio Pronestì, Diego Spiga
“Operaestate 2025 – B.Motion”
Ingresso/Ticket € 8
Chiesa di San Giovanni Bassano del Grappa h. 18
PAS DE CHEVAL
Coreografia Andrea Costanzo
Martini
Interpreti Francesca Foscarini, Andrea Costanzo Martini
“Operaestate 2025 – B.Motion”
Ingresso/Ticket € 8
Teatro Remondini
Bassano del Grappa h. 19
AFÀNISI
Con Alessandro Paschitto, Raimonda Maraviglia, Francesco Roccasecca
Testo e regia Alessandro Paschitto
Campania Teatro Festival, Ctrl+Alt+Canc
“Operaestate 2025 – B.Motion”
Ingresso/Ticket € 8
CSC San Bonaventura
Bassano del Grappa h. 20.30
25
lunedì Monday
VÉNUS ANATOMIQUE
Concept, direzione artistica, creazione e coreografia Sarah Baltzinger
“Operaestate 2025 – B.Motion”
Ingresso/Ticket € 8
Teatro Remondini
Bassano del Grappa h. 21.30
26 martedìTuesday
PLEIN AIR
Coreografia Marina Donatone
“Operaestate 2025 – B.Motion”
Ingresso/Ticket € 8
CSC San Bonaventura
Bassano del Grappa h. 20
MEGASTRUCTURE
JEUX DE SOCIÉTÉ
Concezione generale Ezio Schiavulli
“Operaestate 2025 – B.Motion”
Ingresso/Ticket € 8
Teatro Remondini
Bassano del Grappa h. 20.30
27 mercoledìWednesday
SALOMÈ da Oscar Wilde
Ideazione e regia Maria Alterno, Richard Pareschi
Composizione coreografica e interpretazione Gloria Dorliguzzo Madalena Reversa
“Operaestate 2025 – B.Motion”
Ingresso/Ticket € 8
CSC San Bonaventura
Bassano del Grappa h. 21.30
28 giovedìThursday
TO BE SCHIEVE OR A ROMANTIC ATTEMPT
Coreografia e interprete Fanny Brouyaux
Ingresso/Ticket € 8
Bassano del Grappa h. 20 :t
Concept, coreografia e interpreti
Sarah Baltzinger, Isaiah Wilson
“Operaestate 2025 – B.Motion”
Ingresso/Ticket € 8
Teatro Remondini
Bassano del Grappa h. 21.30
“Operaestate 2025 – B.Motion”
Chiesa di San Giovanni Bassano del Grappa h. 18.30
CRAVE
dall’opera di Sarah Kane diretto e interpretato Leda Kreider
“Operaestate 2025 – B.Motion” Ingresso/Ticket € 8
CSC San Bonaventura
Bassano del Grappa h. 20
GUSH IS GREAT Concept, coreografia e performance Julie Botet, Simon Le Borgne, Max Gomard, Philomène Jander, Zoé Lakhnati, Ulysse Zangs
“Operaestate 2025 – B.Motion” Ingresso/Ticket € 8
Teatro Remondini
Bassano del Grappa h. 21.30
29 venerdì Friday
GOOD JOB, GOOD BOY II Concept e interpretazione Eloy Cruz del Prado
“Operaestate 2025 – B.Motion” Ingresso/Ticket € 8
CSC San Bonaventura
Bassano del Grappa h. 18.30
GOOD VIBES ONLY (THE GREAT EFFORT)
Concept e performance Francesca Santamaria
“Operaestate 2025 – B.Motion” Ingresso/Ticket € 8
Teatro Remondini
30
sabato Saturday
GLI ANNI VUOTI
Scene da Caduto di Emilio Vacca
Adattamento del testo Emilio Vacca
Con Valerio Pietrovita, Emilio Vacca
“Operaestate 2025 – B.Motion”
Ingresso/Ticket € 8
Palazzo Sturm-Bassano del Grappa h. 17
NO PARES, SIGUE SIGUE di Sergi Casero Nieto
Guida drammaturgica Markos
Goikolea, Mònica Molins
Occhio esterno Mònica Molins
Movimento Alicia Pirez
“Operaestate 2025 – B.Motion”
Ingresso/Ticket € 8
CSC San Bonaventura
Bassano del Grappa h. 20
MANIFESTUS
Ideazione, coreografia, regia
Jacopo Jenna
“Operaestate 2025 – B.Motion” Ingresso/Ticket € 8
Chiesa di San Giovanni
Bassano del Grappa h. 21.30
31
domenica Sunday
È SOLO UN LUNGO TRAMONTO
Testo, regia e performer Jacopo Giacomoni
“Operaestate 2025 – B.Motion” Ingresso/Ticket € 8
Palazzo Sturm-Bassano del Grappa h. 17
THE BLUE HOUR
concept, direzione artistica
Benjamin Kahn
Performance Théo Aucremanne
“Operaestate 2025 – B.Motion” Ingresso/Ticket € 8
Teatro Remondini
Bassano del Grappa h. 18.30
FLAMINGO
Invenzione e regia Matteo Maffesanti
Con Jessica Pasetto, Mirko Tomezzoli, Teresa Noronha Feio
Elevator Bunker
“Operaestate 2025 – B.Motion”
Ingresso/Ticket € 8
CSC San Bonaventura
Bassano del Grappa h. 20
DJ SHOW TWENTYSOMETHING
EDITION
Creazione Sotterraneo
Ideazione e regia Sara Bonaventura, Claudio Cirri, Daniele Villa
“Operaestate 2025 – B.Motion”
Ingresso/Ticket € 8
CSC San Bonaventura
Bassano del Grappa h. 22.30
INDIRIZZI
ARENA GIGI DALL’AGLIO
Campazzo San Sebastiano Dorsoduro www.veniceopenstage.org
BASTIONE DELLE MADDALENE
Vicolo Madonnina 12-Verona www.spettacoloverona.it
CSC SAN BONAVENTURA
Via dell’Ospedale 2-6
Bassano del Grappa www.operaestate.it
CHIESA DI SAN GIOVANNI
Piazza Libertà 27
Bassano del Grappa www.operaestate.it
PALAZZO STURM
Via Schiavonetti 40
Bassano del Grappa www.operaestate.it
PARCO DI VILLA GROGGIA
Sant’Alvise, Cannaregio www.comune.venezia.it
TEATRO AL CASTELLO
TITO GOBBI
Piazza Castello Ezzelini
Bassano del Grappa www.operaestate.it
TEATRO GOLDONI
San Marco 4650/B www.teatrostabileveneto.it
TEATRO REMONDINI
Via Santissima Trinità 8/C
Bassano del Grappa www.operaestate.it
TEATRO ROMANO
Regaste Redentore 2 www.spettacoloverona.it
04
venerdì Friday
ANIMALI FANTASTICI E DOVE TROVARLI
Regia di David Yates (2016)
“Cinemoving”
Serra dei Giardini h. 21.15
10
giovedìThursday
GRAN TORINO
Regia di Clint Eastwood (2008)
“Cinemoving”
Spiaggia Libera-Lido di Venezia h. 21.15
11
venerdì Friday
LA PROMESSA-IL PREZZO DEL POTERE
Regia di Thomas Kruithof (2021)
“Cinemoving” Serra dei Giardini h. 21.15
17
giovedìThursday
INSIEME PER FORZA
Regia di Frank Coraci (2014)
“Cinemoving” Spiaggia Libera-Lido di Venezia h. 21.15
18
venerdì Friday
RIBELLE. THE BRAVE
Regia di Mark Andrews, Brenda Chapman, Steve Purcell (2012)
“Cinemoving” Serra dei Giardini h. 21.15
24
giovedìThursday
ABOUT A BOY-UN
RAGAZZO
Regia di Paul Weitz, Chris Weitz (2002)
“Cinemoving”
Spiaggia Libera-Lido di Venezia h. 21.15
25
venerdì Friday
LOVE LIFE
Regia di Kôji Fukada (2022)
“Cinemoving” Serra dei Giardini h. 21.15
BARBIE
Regia di Greta Gerwig (2023) “Cinemoving” Parco Albanese-Mestre h. 21.15
26 sabato Saturday
PRENDI IL VOLO
Regia di Benjamin Renner (2023) “Cinemoving” Parco Albanese-Mestre h. 21.15
27
domenica Sunday
FATHER STU
Regia di Rosalind Ross (2022) “Attrici da Oscar” Piazzale Zendrini-Pellestrina h. 21.15
IL MAESTRO
CHE PROMISE IL MARE
Regia di Patricia Font (2024)
“Cinemoving” Parco Albanese-Mestre h. 21.15
28
lunedì Monday
LE STREGHE
Regia di Robert Zemeckis (2022)
“Cinemoving” Parco Albanese-Mestre h. 21.15
29 martedìTuesday
CATTIVERIE A DOMICILIO
Regia di Thea Sharrock (2023) “Cinemoving” Parco Albanese-Mestre h. 21.15
30
mercoledìWednesday
EVIL DOES NOT EXIST
Regia di Ryûsuke Hamaguchi (2023)
“Cinemoving” Parco Albanese-Mestre h. 21.15
31
giovedìThursday
ALLA RICERCA DI NEMO
Regia di Lee Unkrich, Andrew Stanton (2003)
“Cinemoving” Spiaggia Libera-Lido di Venezia h. 21.15
01
venerdì Friday
AU REVOIR, MELOGRANO
Regia di Giacomo Pedrotti (Italia, 20’)
EVELIN E LA CITTÀ DELLE
VALIGIE
Regia di Aurora Ovan (Italia, 09’ 59”)
HIDE AND SEEK
Regia di Rositsa Trayanova (Bulgaria, 14’ 30”)
NEI MIEI PANNI
Regia di Mirko Artuso (Italia, 12’ 30”)
SBENTIARE
Regia di Tiziana Troja (Italia, 5’ 50”)
UNDER THE ROCK
Regia di Nikolas Koskinas(Grecia, 19’ 20”)
WITH LOVE, YOUR BODY
Regia di Pernille Lund (Danimarca, 1’)
“Uno sguardo all’Europa” Campo San Polo h. 21
02
sabato Saturday
FLOW
Regia di Gints Zilbalodis (2024)
“Uno sguardo all’Europa” Campo San Polo h. 21
03
domenica Sunday
CAT CALL
Regia di Rozália Szeleczki (2023)
“Cinema ungherese” Campo San Polo h. 21
04
lunedì Monday
SEMMELWEIS
Regia di Lajos Koltai (2023)
“Cinema ungherese” Campo San Polo h. 21
05 martedìTuesday
IL RE DEI LADRI
Regia di Richard Claus (2006)
“Cinemoving” Campo San Polo h. 21
06
07
giovedìThursday
DIANA – LA STORIA
SEGRETA DI LADY D.
Regia di Oliver Hirschbiegel (2013)
“Viaggio cinematografico attraverso Italia e Croazia” Campo San Polo h. 21
LADRI DI BICICLETTE
Regia di Vittorio De Sica (1948)
“Cinemoving”
Spiaggia Libera-Lido di Venezia h. 21.15
09
sabato Saturday
MAMMA MIA! CI RISIAMO
Regia di Ol Parker (2018)
“Viaggio cinematografico
attraverso Italia e Croazia” Campo San Polo h. 21
10
domenica Sunday
INTERCEPTED
Regia di Oksana Karpovych (2024)
“Uno sguardo all’Europa” Campo San Polo h. 21
11
lunedì Monday
IL FARAONE, IL SELVAGGIO E LA PRINCIPESSA
“Cinemoving” Campo San Polo h. 21
12
“Uno sguardo all’Europa” Campo San Polo h. 21 : c
mercoledìWednesday
JULIE KEEPS QUIET
Regia di Leonardo Van Dijl (2024)
“Uno sguardo all’Europa” Campo San Polo h. 21
Regia di Michel Ocelot (2022)
martedìTuesday
LA PAGE BLANCHE
Regia di Murielle Magellan (2022)
“Cinemoving” Campo San Polo h. 21
13
mercoledìWednesday
FRAGILE
Regia di Emma Benestan (2021)
“Cinemoving” Campo San Polo h. 21
14
giovedìThursday
ANIMAL
Regia di Sofia Exarchou (2023)
FATHER AND SON
Regia di Hirokazu Kore-Eda (2013) “Cinemoving” Spiaggia Libera-Lido di Venezia h. 21.15
15
venerdì Friday
VENICE FILM WEEK
Selezione di cinema italiano contemporaneo “Cinemoving“ Campo San Polo h. 21
21
giovedìThursday
LA RICERCA DELLA FELICITÀ
Regia di Gabriele Muccino (2006) “Cinemoving” Spiaggia Libera-Lido di Venezia h. 21.15
INDIRIZZI
CAMPO SAN POLO
Venezia www.culturavenezia.it
PARCO ALBANESE
Via Sergio Gori 11-Mestre www.culturavenezia.it
PIAZZALE ZENDRINI
Pellestrina www.culturavenezia.it
SERRA DEI GIARDINI
Via Garibaldi 1254 www.culturavenezia.it
SPIAGGIA LIBERA
Lungomare D’Annunzio 2-Lido di Venezia www.culturavenezia.it

NATIONAL PARTICIPATIONS / COLLATERAL EVENTS
National Participations
AUSTRALIA
AUSTRIA
BELGIO
BRASILE
CANADA
Repubblica di COREA
DANIMARCA
EGITTO
FINLANDIA
(Padiglione Alvar Aalto)
FRANCIA
GERMANIA
GIAPPONE
GRAN BRETAGNA
GRECIA
PAESI BASSI
PAESI NORDICI
(Finlandia, Norvegia, Svezia)
POLONIA
QATAR/1
ROMANIA/1
SERBIA
SPAGNA
STATI UNITI D’AMERICA
SVIZZERA
UNGHERIA
URUGUAY
PADIGLIONE VENEZIA
National Participations
ALBANIA Artiglierie
ARABIA SAUDITA Sale d'Armi
ARGENTINA Sale d'Armi
Regno del BAHRAIN Artiglierie
CILE Artiglierie
CINA Repubblica Popolare Cinese Magazzino delle Vergini
CROAZIA Artiglierie
EMIRATI ARABI UNITI Sale d'Armi
FILIPPINE Artiglierie
GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO Sale d'Armi
IRLANDA Artiglierie
Repubblica del KOSOVO Artiglierie
LETTONIA Artiglierie
LIBANO Sale d’Armi
Repubblica di MACEDONIA DEL NORD Sale d’Armi
Regno del MAROCCO Artiglierie
MESSICO Sale d'Armi
Sultanato dell’OMAN Artiglierie
PERÙ Sale d'Armi
SINGAPORE Sale d'Armi
Repubblica di SLOVENIA Artiglierie
TURCHIA Sale d'Armi
UCRAINA Sale d'Armi
Repubblica dell’UZBEKISTAN
Tese Cinquecentesche
PADIGLIONE ITALIA
Tese delle Vergini
National Participations
Repubblica di ARMENIA
Tesa 41, Fondamenta Case Nuove, Castello 2738/C
Repubblica dell’AZERBAIGIAN
Campo della Tana, Castello 2127/A (opposite the Arsenale entrance)
BULGARIA
Sala Tiziano, Centro Culturale Don Orione Artigianelli Dorsoduro 909/A
Repubblica di CIPRO
Associazione Culturale Spiazzi, Castello 3865
ESTONIA
Riva dei Sette Martiri, Castello 1611
GRENADA
La Toletta Spazioeventi, Fondamenta Borgo Dorsoduro 1134
ISLANDA
Ramo de la Tana, Castello 2125 (opposite the Arsenale entrance)
KUWAIT
Tesa 42, Fondamenta Case Nuove, Castello 2738/C
LITUANIA
Chiesa di Santa Maria dei Derelitti
Complesso dell’Ospedaletto
Barbaria de le Tole, Castello 6691
MONTENEGRO
ArteNova, Campo San Lorenzo, Castello 5063
PAKISTAN
Spazio 996/A, Fondamenta Sant’Anna Castello 996/A
PORTOGALLO
Fondaco Marcello, Calle del Traghetto
San Marco 3415
QATAR/2
ACP - Palazzo Franchetti, San Marco 2847
ROMANIA/2
New Gallery of Istituto Romeno di Cultura
e Ricerca Umanistica
Palazzo Correr, Campo Santa Fosca
Cannaregio 2214
SANTA SEDE
Complesso di Santa Maria Ausiliatrice
Fondamenta San Gioachin, Castello 450
THAILANDIA
Castello Gallery, Castello 1636/A
Repubblica del TOGO
Squero Castello, Salizada Streta, Castello 368
Collateral Events
DOCKS CANTIERI CUCCHINI
Catalonia in Venice_Water Parliaments. Projective Ecosocial Architectures
San Pietro di Castello 40/A
PALAZZO ZORZI
Deep Surfaces. Architecture to enhance the visitor experience of UNESCO sites
UNESCO Regional Bureau for Science and Culture in Europe, Castello 4930
PALAZZO MORA
EUmies Awards. Young Talent 2025 Intelligens . Talent
Palazzo Mora, Strada Nova, Cannaregio 3659
PALAZZO DELLE PRIGIONI
NON-Belief.
Taiwan Intelligens of Precarity
Castello 4209 (next to Palazzo Ducale)
CAMPO DELLA TANA/1
Parallel Worlds.
Exhibition from Macao, China
Castello 2126/A (opposite the Arsenale entrance)
CAMPO DELLA TANA/2
Projecting Future Heritage. A Hong Kong Archive
Castello 2126 (opposite the Arsenale entrance)
ABBAZIA DI SAN GREGORIO
Rooted Transience
AlMusalla Prize 2025
Dorsoduro 172 (next to Chiesa della Salute)
ISOLA DI SAN GIORGIO MAGGIORE
The Fondation Cartier pour l’art contemporain by Jean Nouvel
Fino Until 14 settembre September
Fondazione Giorgio Cini
Isola di San Giorgio Maggiore
PALAZZO DIEDO
The Next Earth
Computation, Crisis, Cosmology
Berggruen Arts & Culture, Cannaregio 2386
LA FUCINA DEL FUTURO
The SKYWALK by Platform Earth
Fino Until 11 settembre September
Calle San Lorenzo, Castello 5063/B
GIARDINI DELLA MARINARESSA
unEarthed / Second Nature / PolliNATION
Fino Until 28 settembre September
Riva dei Sette Martiri, Castello

10 & ZERO UNO
JOHN ROBINSON. The Shed
Fino Until 19 luglio July Via Garibaldi, Castello 1830
CA’ PESARO/1
GIULIO ARISTIDE SARTORIO
Il poema della vita umana
Fino Until 28 settembre September Galleria Internazionale d’Arte Moderna Santa Croce 2076
CA’ PESARO/2 ANTONELLO VIOLA
L’oro della laguna
Fino Until 28 settembre September
Galleria Internazionale d’Arte Moderna (Sale Dom Pérignon), Santa Croce 2076
CASA DEI TRE OCI
BERGGRUEN ARTS & CULTURE MATTHIAS SCHALLER
Controfacciata
Fino Until 23 novembre November Berggruen Institute Europe, Fondamenta Zitelle Giudecca 43
CHIESA DI SANTA MARIA DELLA VISITAZIONE VERONIKA PSOTKOVÁ. Perpetuo
Fino Until 23 novembre November Fondamenta Zattere ai Gesuati, Dorsoduro
COLLEZIONE PEGGY GUGGENHEIM
MARIA HELENA VIEIRA DA SILVA
Anatomia di uno spazio
Fino Until 15 settembre September
Palazzo Venier dei Leoni, Dorsoduro 701
EMERGENCY VENEZIA HUMANITY LOVERS
Fino Until 31 ottobre October
Chiusa luglio e agosto/ Closed in July and August Giudecca 212
EUROPEAN CULTURAL CENTRE (ECC)/1 PALAZZO MORA | PALAZZO BEMBO GIARDINI DELLA MARINARESSA
TIME SPACE EXISTENCE
Fino Until 23 novembre November
Palazzo Mora, Strada Nova, Cannaregio 3659
Palazzo Bembo, Riva del Carbon, San Marco 4793 Giardini della Marinaressa
Riva dei Sette Martiri, Castello
EUROPEAN CULTURAL CENTRE (ECC)/2 PALAZZO MORA
TIME SPACE EXISTENCE
Portal by A INTERIORS
Fino Until 23 novembre November
ECC-Palazzo Mora, Strada Nova, Cannaregio 3659
EUROPEAN CULTURAL CENTRE (ECC)/3 PALAZZO BEMBO
TIME SPACE EXISTENCE
Henriquez Partners Architects
Fino Until 23 novembre November
ECC-Palazzo Bembo, Riva del Carbon San Marco 4793
FÀBRICA 33
UNIVERSE PAVILION
Sheltering in Space. A Guide
Fino Until 31 luglio July
Calle Larga dei Boteri, Cannaregio 5063
FONDATION VALMONT
TELEMACHUS. The Quest for Self
Fino Until 22 novembre November
Palazzo Bonvicini, The Intimate Museum
Santa Croce 2161/A
FONDATION WILMOTTE
PRIX W 2025
The Abbey of Montmajour. Winning Projects
Fino Until 23 novembre November
Fondamenta de l’Abazia, Cannaregio 3560
FONDAZIONE BEVILACQUA LA MASA PALAZZETTO TITO
PATRICIA LEITE. Cold Water
Fino Until 27 luglio July
Dorsoduro 2826
FONDAZIONE DELL’ALBERO D’ORO
DI STORIE E DI ARTE. Tre secoli di vita a Palazzo Vendramin Grimani
Fino Until 23 novembre November
Palazzo Vendramin Grimani, San Polo 2033
FONDAZIONE PRADA
DIAGRAMS A project by AMO/OMA
Fino Until 24 novembre November
Ca’ Corner della Regina, Santa Croce 2215
FONDAZIONE QUERINI STAMPALIA/1
JOHN BALDESSARI
No Stone Unturned. Conceptual Photography
FinoU ntil 23 novembre November
Campo Santa Maria Formosa, Castello 5252
FONDAZIONE QUERINI STAMPALIA/2
DAVIDE RIVALTA
Leoni in campo | Lions on the Field
Fino Until 23 novembre November
Campo Santa Maria Formosa, Castello 5252
FONDAZIONE QUERINI STAMPALIA/3 MARTÍ GUIXÉ
Q Spot. Seat, read, think, repeat
Fino Until 23 novembre November
Campo Santa Maria Formosa, Castello 5252
FONDAZIONE SANLORENZO SANLORENZO ARTS VENICE
(Apertura ufficiale fine maggio
Official opening end of May )
Dorsoduro 170
FORTE MARGHERA
ARTEFICI DEL NOSTRO TEMPO 2025
Fino Until 31 dicembre December
Padiglione 29, Via Forte Marghera 30, Mestre
GALLERIA ALBERTA PANE
ROMINA DE NOVELLIS
Architetture Terrone
Fino Until 10 settembre September
Calle dei Guardiani, Dorsoduro 2403/H
GALLERIE DELL’ACCADEMIA
CORPI MODERNI. La costruzione del corpo nella Venezia del Rinascimento. Leonardo, Michelangelo, Dürer, Giorgione
Fino Until 27 luglio July
Campo della Carità, Dorsoduro 1050
IKONA GALLERY
WILLIAM KLEIN
Fino Until 30 novembre November
Campo del Ghetto Nuovo, Cannaregio 2909
ISOLA DI SAN GIORGIO MAGGIORE/1
BASILICA DI SAN GIORGIO MAGGIORE
LUC TUYMANS. Due nuove tele del grande artista belga per l’altare di San Giorgio Maggiore
Fino Until 24 novembre November
Abbazia di San Giorgio Maggiore - Benedicti Claustra Onlus, Isola di San Giorgio Maggiore
ISOLA DI SAN GIORGIO MAGGIORE/2 LE STANZE DEL VETRO
1932-1942 Il vetro di Murano e la Biennale di Venezia
Fino Until 23 settembre September
Fondazione Giorgio Cini, Isola di San Giorgio Maggiore
ISOLA DI SAN GIORGIO MAGGIORE/3
LE STANZE DELLA FOTOGRAFIA
ROBERT MAPPLETHORPE
Le forme del classico
Fino Until 6 gennaio January, 2026
Isola di San Giorgio Maggiore
ISOLA DI SAN GIORGIO MAGGIORE/4
LE STANZE DELLA FOTOGRAFIA
MAURIZIO GALIMBERTI
tra Polaroid/Ready Made e le Lezioni Americane di Italo Calvino
Fino Until 10 agosto August
Isola di San Giorgio Maggiore
ISOLA DI SAN GIORGIO MAGGIORE/5
VATICAN CHAPELS. Andrew Berman, Francesco Cellini, Javier Corvalan, Eva Prats and Ricardo Flores, Norman Foster, Terunobu Fujimori, Sean Godsell, Carla Juaçaba, Smiljan Radic, Eduardo Souto de Moura, Francesco
Magnani and Traudy Pelzel
Fondazione Giorgio Cini
Parco dell’Isola di San Giorgio Maggiore
ISOLA DI SAN SERVOLO
SEA BEYOND. Ocean Literacy Centre
Isola di San Servolo
M9 – MUSEO DEL ‘900/1
ARTE SALVATA. Capolavori oltre la guerra dal MuMa di Le Havre
Fino Until 31 agosto August
Via Giovanni Pascoli 11, Mestre
MAGAZZINO GALLERY
NO DOUBT ABOUT IT
Projects from Armenia, China, Georgia, Germany, Latvia, and Poland
Fino Until 23 novembre November
Palazzo Contarini Polignac, Dorsoduro 874
MARIGNANA ARTE APPARITIONS
The dream of infinity
Fino Until 26 luglio July
Rio Terà dei Catecumeni, Dorsoduro 141
MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE anonymous art project LINES BY KENGO KITO
Fino Until 28 settembre September Cortile dell’Agrippa and Sala V Piazzetta San Marco 17
MUSEO CORRER
IL CORRER DI CARLO SCARPA 1953-1960
Fino Until 19 ottobre October Quadreria, San Marco 52
MUSEO DEL VETRO
Storie di fabbriche. Storie di famiglie
FRATELLI TOSO
12 luglio July-24 novembre November
Fondamenta Giustinian 8, Murano
MUSEO DI PALAZZO GRIMANI ZHANG ZHAOYING
Lifelong Beauty
Fino Until 3 agosto August
Ramo Grimani, Castello 4858
MUSEO DI PALAZZO MOCENIGO/1 IL SEDUTTORE
Il rinnovamento dell’immagine maschile al tempo di Casanova
Fino Until 27 luglio July Santa Croce 1992
MUSEO DI PALAZZO MOCENIGO/2 CASANOVA 1725-2025. L’eredità di un mito tra storia e cinema 29 agosto August-2 novembre November Santa Croce 1992
MUSEO DI STORIA NATURALE
GIANCARLO LIGABUE/1 UN OSTRIARIUM ROMANO
NELLA LAGUNA DI VENEZIA
Fino Until 2 novembre November Santa Croce 1730
MUSEO DI STORIA NATURALE
GIANCARLO LIGABUE/2
ALICE CHANNER. Megaflora
Fino Until 28 settembre September Santa Croce 1730
MUSEO FORTUNY
ALBERTO RODRÍGUEZ SERRANO
Ars Gratia Artis Venezia
Fino Until 5 ottobre October San Marco 3958
NCONTEMPORARY VENICE
WALTER NIEDERMAYR
Marghera 1997
Fino Until 19 luglio July
Fondamenta San Giacomo, Giudecca 199
NEGOZIO OLIVETTI FORMAFANTASMA. Ore streams: The Shape of Things to Come
Fino Until 28 settembre September
Piazza San Marco 101
NICOLETTA FIORUCCI FOUNDATION
TOLIA ASTAKHISHVILI
Fino Until 23 novembre November Dorsoduro 2828
OCEAN SPACE
NADIA HUGGINS | TESSA MARS otras montañas, las que andan sueltas bajo el agua [altre montagne, dissolte sotto l’acqua]
Fino Until 2 novembre November
Chiesa di San Lorenzo, Castello 5069
PALAZZO BAROVIER&TOSO
Barovier&Toso ARTE VLASTIMIL BERÁNEK
Stillness in Motion | Quiete in Movimento
Sala dell'Acqua, Fondamenta Manin 1/D, Murano
PALAZZO BOLLANI
anonymous art project
MIKA NINAGAWA with EiM. Interstice
Fino Until 21 luglio July Castello 3647
PALAZZO CAVANIS
ALPS. ARCHITECTURE. SOUTH TYROL
Fino Until 23 novembre November Fondamenta Zattere, Dorsoduro 920
PALAZZO CINI
LJUBODRAG ANDRIC Spazi, soglie, luci
Fino Until 8 settembre September
Campo San Vio, Dorsoduro 864
PALAZZO DIEDO
BERGGRUEN ARTS & CULTURE
New site-specific installations UNTITLED (FLOOR) by Piero Golia
SENZA TITOLO by Marcantonio
Brandolini d’Adda
Fino Until 23 novembre November
Cannaregio 2386
PALAZZO DUCALE
L’ORO DIPINTO. El Greco e la pittura tra Creta e Venezia
Fino Until 29 settembre September San Marco 1
PALAZZO FERRO FINI
GIANMARIA POTENZA
Elaborating New Codes
Fino Until 17 ottobre October
Consiglio Regionale del Veneto, San Marco 2322
PALAZZO FRANCHETTI/1
MATTIA MORENI. Gli oggetti le cose pensano in silenzio
Fino Until 27 luglio July
ACP - Palazzo Franchetti, San Marco 2847
PALAZZO FRANCHETTI/2
GRAHAM SUTHERLAND. Bittersweet
Fino Until 27 luglio July
ACP - Palazzo Franchetti, San Marco 2847
PALAZZO GRASSI
TATIANA TROUVÉ
La strana vita delle cose
Fino Until 4 gennaio January, 2026
Campo San Samuele, San Marco 3231
PROCURATIE VECCHIE/1
The Human Safety Net A WORLD OF POTENTIAL
Procuratie Vecchie, Piazza San Marco 105
PROCURATIE VECCHIE/2
The Human Safety Net
DREAMS IN TRANSIT
Fino Until 15 marzo March, 2026
Procuratie Vecchie, Piazza San Marco 105
PUNTA DELLA DOGANA
THOMAS SCHÜTTE. Genealogies
Fino Until 23 novembre November Dorsoduro 2
SCUOLA PICCOLA ZATTERE
FOSBURY ARCHITECTURE
Design x ABC Zattere
GAËLLE CHOISNE. Temple of Love.
Cœur
Fino Until 12 ottobre October Dorsoduro 1401
SMAC/1
SAN MARCO ART CENTRE
FOR ALL THAT BREATHES ON EARTH Jung Youngsun and Collaborators
Fino Until 13 luglio July
Procuratie Vecchie, Piazza San Marco 105
SMAC/2
SAN MARCO ART CENTRE
MIGRATING MODERNISM
The architecture of Harry Seidler
Fino Until 13 luglio July
Procuratie Vecchie, Piazza San Marco 105
THE VENICE VENICE HOTEL
M’ART&CRAFT DESIGN STUDIO
Venice M’Art Gallery, Cannaregio 5631

Mensile di cultura, spettacolo e tempo libero
Numero 301-302 - Anno XXIX Venezia, 1 luglio 2025
Con il Patrocinio del Comune di Venezia
Autorizzazione del Tribunale di Venezia n. 1245 del 4/12/1996
Direzione editoriale Massimo Bran
Direzione organizzativa Paola Marchetti
Relazioni esterne e coordinamento editoriale Mariachiara Marzari
Redazione
Chiara Sciascia, Davide Carbone
Speciali Fabio Marzari
Coordinamento editoriale
TheBAG, Daily Mostra del Cinema, Redazione Web, Newsletter Marisa Santin
Grafica Luca Zanatta
Hanno collaborato a questo numero
Katia Amoroso, Maria Laura Bidorini, Marina Borroni, Loris Casadei, Michele Cerruti But, Sergio Collavini, Mario Dal Co, Maurizio De Luca, Verdiana Di Maria, Fabio Di Spirito, Elisabetta Gardin, Nicolò Ghigi, Renato Jona, Michela Luce, Franca Lugato, Irene Machetti, Alberto Marzari, Diletta Rostellato, Giovanni Santarelli, Livia Sartori di Borgoricco, Sara Abra Carrol Smersu, Adele Spinelli, Camillo Tonini, Delphine Trouillard, Riccardo Triolo, Luisa Turchi, Giovanni Vio, Andrea Zennaro
Si ringraziano
Wayne McGregor, Carolina Bianchi, Virginie Brunelle, Yoann Bourgeois, Antonio de Rosa e Mattia Russo, Zaira Zarotti, Marina Otero Verzier e Giovanna Zabotti, Filippo Bricolo, Zhang Zhaoying, Daniele Finzi Pasca, Michele Mele, Ryoko Sekiguchi, wetlands books, Roberto Ferrucci, Roberto Nardi, Giuseppe Mormile, Cristiana Costanzo, Claudia Gioia, Flavia Fossa Margutti, Emanuela Caldirola e Marta Zannoner, La Biennale di Venezia
Traduzioni
Andrea Falco, Patrizia Bran, Richard McKenna
lo trovi qui:
Bookshop Gallerie dell’Accademia; Qshop (c/o Querini Stampalia, Santa Maria Formosa); Alef (c/o Museo Ebraico, zona Ghetto); Mare di Carta (Fondamenta dei Tolentini); Studium (zona S. Marco); Toletta, Toletta Cube e Toletta Studio (zona Campo San Barnaba) e in tutte le edicole della città.
Direttore responsabile Massimo Bran
Guide spirituali
“Il più grande”, Muhammad Alì Il nostro “Ministro della Fantasia”, Fabio Marzari
Recapito redazionale
Cannaregio 563/E - 30121Venezia tel. +39 041.2377739 redazione@venezianews.it www.venezianews.it venezianews.magazine venezia_news venews_magazine Redazione Venezianews
Stampa Cross Value Srl Via Nobel, 4 - 31020 Villorba (TV) - Tel. 0422.601400
La redazione non è responsabile di eventuali variazioni delle programmazioni annunciate

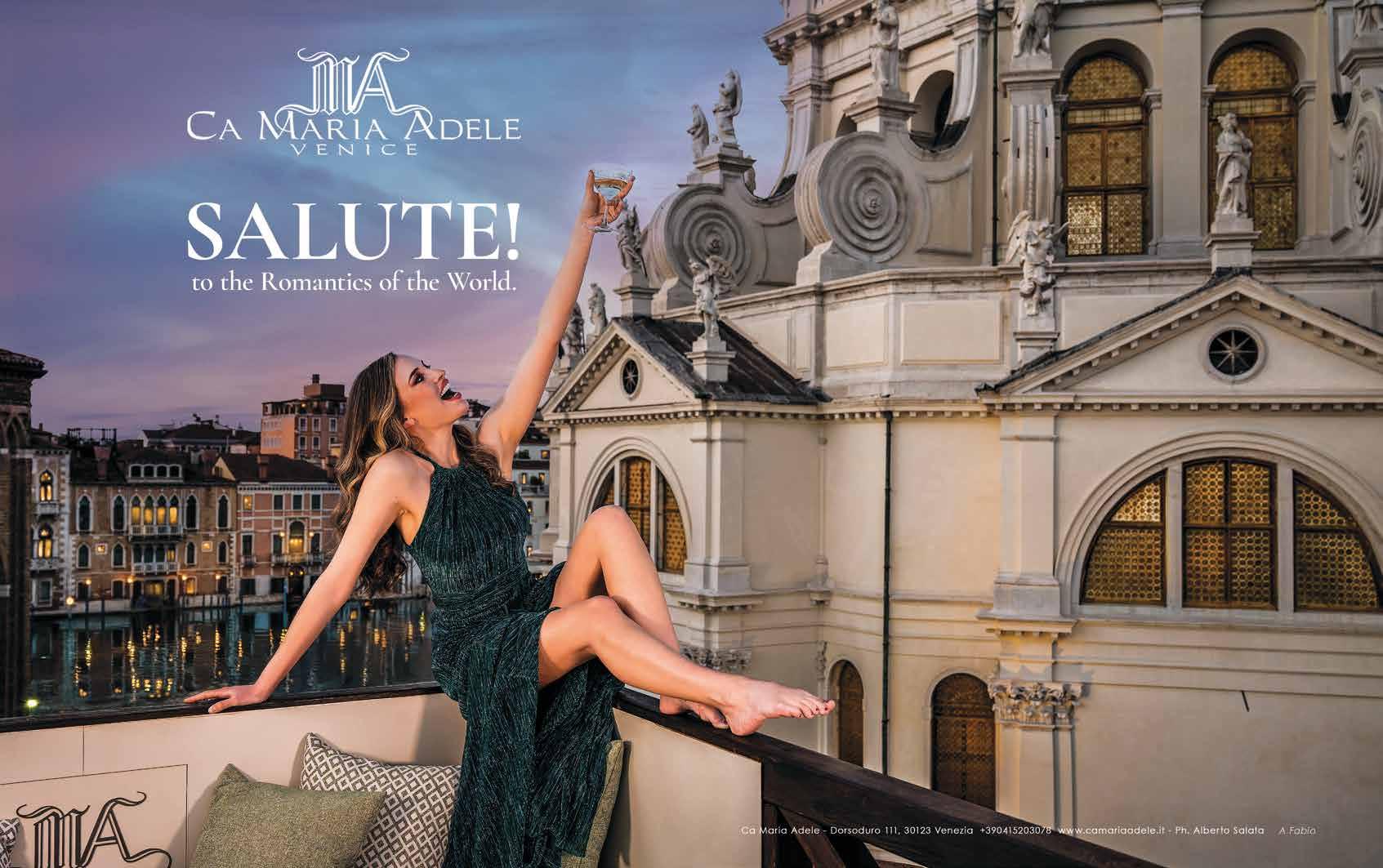
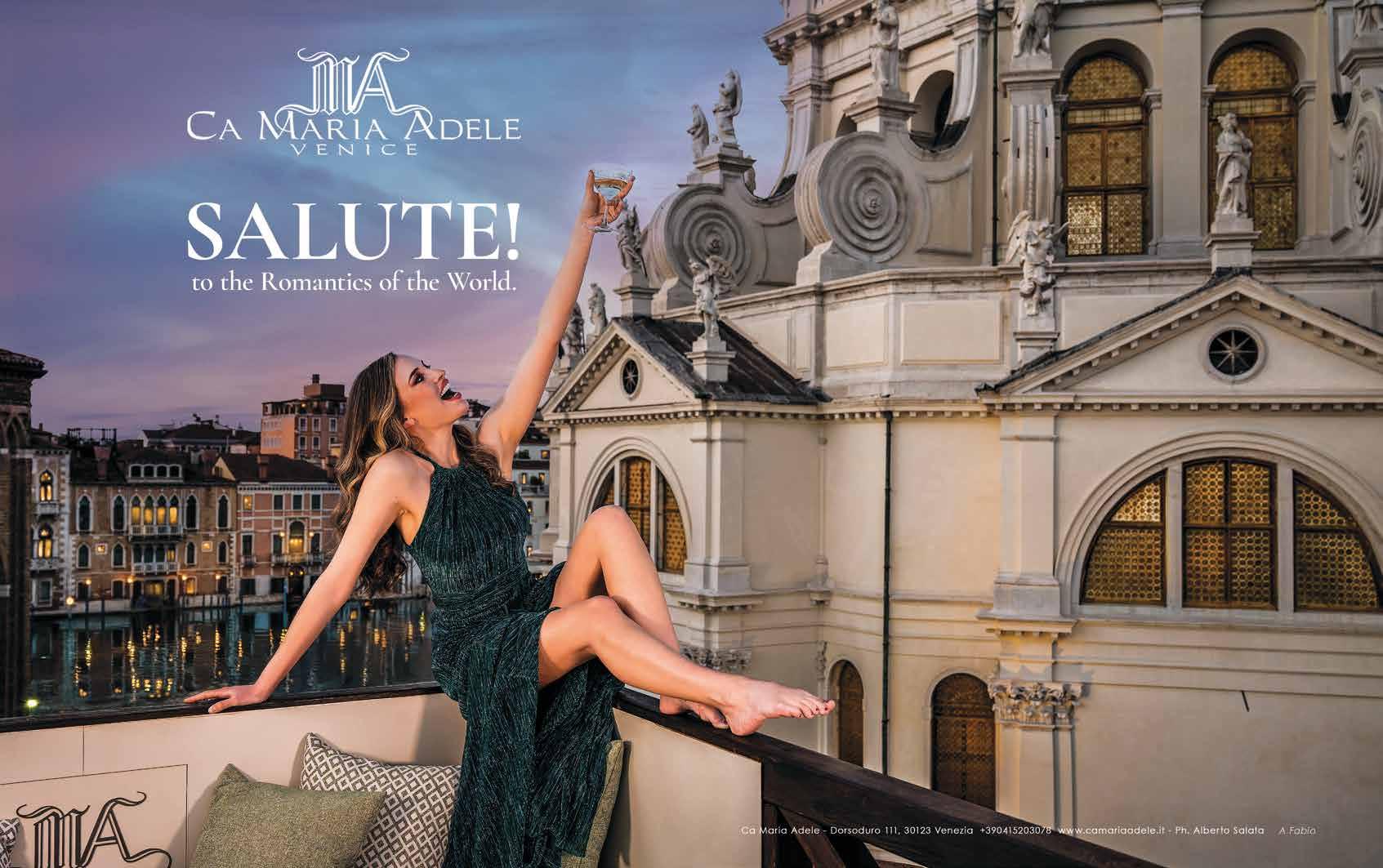
ORARIO/OPENING HOURS 10.05–28.09: 11–19H SOLO/ONLY ARSENALE VEN.SAB./FRI.SAT.: 11–20H 29.09–23.11: 10–18H
CHIUSO IL LUNEDÌ CLOSED ON MONDAYS
INFO +39 041 5218 828 PROMOZIONE@LABIENNALE.ORG
COMPRA QUI IL TUO BIGLIETTO
BUY YOUR TICKET
Biennale Architettura 2025
Architettura
LABIENNALE.ORG
#BIENNALEARCHITETTURA2025
FACEBOOK: LA BIENNALE DI VENEZIA
INSTAGRAM: LABIENNALE
X: LA_BIENNALE
YOUTUBE: BIENNALECHANNEL