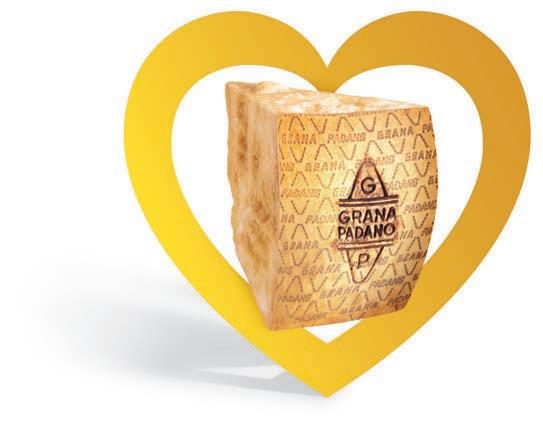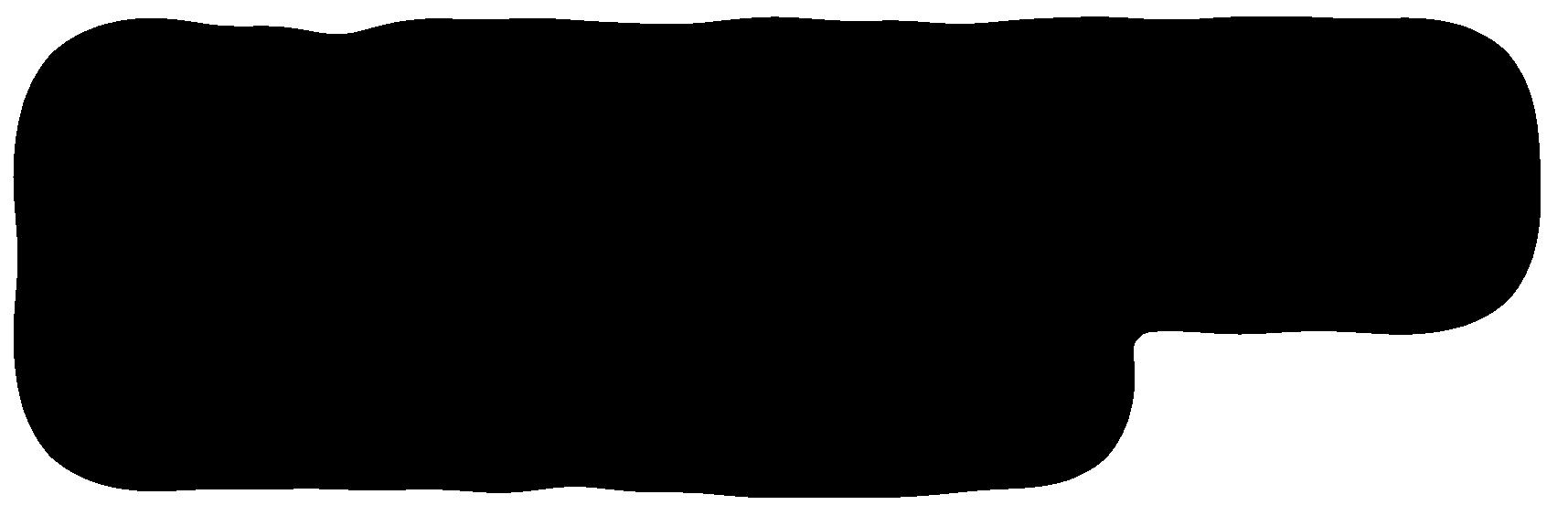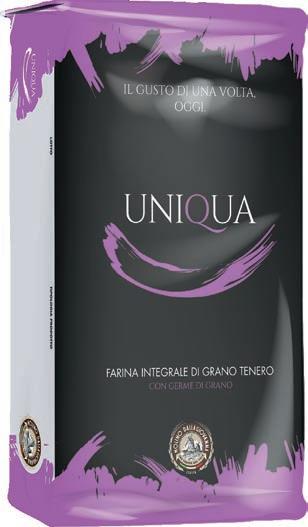


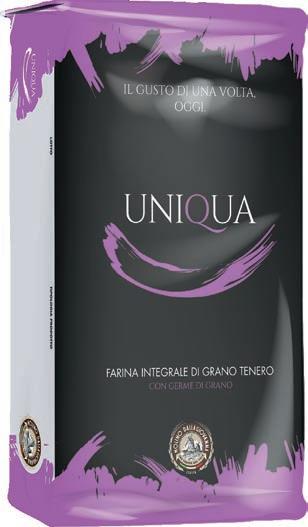
Mario Benhur Tondini
presidente Edizioni Catering srl
Imprenditore nel settore della distribuzione alimentare, gestisce con il fratello Oscar l’azienda di famiglia a Cavriana (MN), dove ha svolto anche l’incarico di sindaco.

Le competenze maturate sul piano professionale e su quello amministrativo lo hanno portato alla convinzione che il principio della condivisione sia la miglior modalità di crescita. Molte sue iniziative, anche all’interno del gruppo Cateringross (che detiene la titolarità della casa editrice), di cui è consigliere d’amministrazione, vanno in questa direzione. A questo affianca una forte sensibilità per ogni azione che dia valore al suo territorio.
benhurtondini@salaecucina.it
Marina Caccialanza
Redazione
Milanese, un passato come traduttrice, da diversi anni giornalista e redattrice per riviste del settore alimentare rivolte al mondo dell’artigianato e all’industria, in particolare nel campo della ristorazione, del dettaglio specializzato e della ricerca. Contribuisce alla realizzazione di importanti libri di comunicazione gastronomica in Italia e all’estero diretti ai professionisti e ai consumatori. Collabora con le redazioni di sala&cucina, Ecod e Trenta Editore.

Luigi Franchi
Direttore responsabile
Prima fotografo di cibo e territori, poi comunicatore, autore di numerosi libri di enogastronomia e di turismo enogastronomico. e infine giornalista di enogastronomia. Tra le sue principali pubblicazioni, scritte e/o coordinate: La prima edizione della Guida al turismo del vino in Italia, per conto del Movimento Turismo del Vino, (1997), I parchi e il turismo enogastronomico (2004), Il marketing delle Strade del Vino edizioni Agra – Rai Eri (2005), Atlante Alimentare Piacentino, con Valentina Bernardelli (2007), “cuo chi, due anime in cucina”, con Alessandra Locatelli, GL.Editore (2009), Dalle Terre Traverse al Po, GL.Editore (2010), ideatore e coautore dei Maestri del lievito madre, Edizioni Catering (2014), coautore della guida online dedicata alla ristorazione Meglio Prenotare, Edizioni Catering, Le interviste (2018) editore Mediavalue. Co-direttore di Food & Book, festival nazionale di editoria enogastronomica luigifranchi@salaecucina.it

marina.caccialanza@salaecucina.it
Redazione
Ricorda con esattezza il profumo del primo pane preparato all’età di sette anni.
Forse il suo primo traguardo e, soprattutto, l’inizio di una grande passione: per le cose semplici, per la genuinità, per gli alimenti che crescono e prendono forma. Dopo la Laurea in Scienze Gastronomiche, la specializzazione in comunicazione enogastronomica, e un periodo di alternanza nelle cucine, ha chiara la missione: scrivere per comunicare. Come? Utilizzando gli strumenti di oggi e la curiosità di sempre. Gionalista pubblicista, collabora anche con la guida di Identità Golose.

Simona Vitali
Redazione
Laureata in filosofia, ha lavorato nella comunicazione e organizzazione di grandi eventi a Parma.
Ha ricevuto una prima inconsapevole educazione al gusto per il cibo grazie all’ indimenticato oste dell’Osteria della Stazione di Felino (PR), il nonno materno Massimino. Con gli studi umanistici è poi arrivata una seconda, consapevole, educazione al gusto per l’utilizzo delle parole secondo il loro significato. Poi sono seguiti un corso di Alta Formazione alla scuola Holden e un master in Filosofia del cibo e del vino. Della ristorazione l’affascina il pensiero e la componente umana. Della formazione di settore segue movimenti ed evoluzioni.

giuliazampieri@salaecucina.it
Gabriele Adani
Grafico
Modenese, appassionato di arte figurativa, fotografia e linguaggi di comunicazione visiva.
s.vitali@salaecucina.it

Nel 1992 inizia il suo percorso professionale presso una casa editrice. Lavora poi in uno studio grafico e fonda una piccola agenzia di comunicazione in cui ricopre il ruolo di direttore creativo per 18 anni.
Viaggiatore, utilizza i frequenti viaggi a Londra e nel Sud Est asiatico per arricchire il suo bagaglio culturale e placare la sua innata curiosità per le altre culture.
Dal 2019 lavora in proprio, occupandosi di fotografia, grafica e consulenze nel campo della comunicazione.
grafica@salaecucina.it





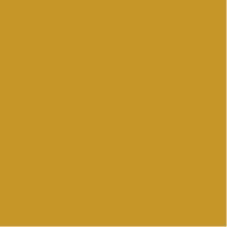

7 LA LETTERA APERTA
Aspettando il numero 100 | Luigi Franchi
9 L'EDITORIALE
Il valore del cibo e delle sue imprese | Benhur Tondini
10 IL CONFRONTO
Massimiliano Polacco | Luigi Franchi
16 LA RIFLESSIONE
Il motivo per cui si fa ristorazione | Giulia Zampieri
20 GLI AMBASCIATORI DEL GUSTO
Il pesce di lago | Luigi Franchi
25 IL CONVEGNO
La celiachia, questa (s)conosciuta | Simona Vitali
28 LA PIZZERIA
La chiameremo Grigoris | Marina Caccialanza
32 LA FORMAZIONE
La buona pratica dell’Accademia Symposium | Simona Vitali
36 DOGUSTO
Le acciughe DoGusto | Guido Parri
39 I CUOCHI
I molteplici vantaggi di riconoscere
la Cucina Italiana Patrimonio Unesco | Rocco Cristiano Pozzulo
41 LA NEUROVENDITA
Il nome del piatto influenza la scelta | Lorenzo Dornetti
46 LE CONTAMINAZIONI
Jambalaya, il mondo intero in una pentola | Federico Panetta
50 LA STORIA
Giuseppe Maffioli e La cucina trevigiana | Alessia Cipolla
54 IL VINO
Stefano Amerighi | Giulia Zampieri
58 GLI EVENTI
Hospitality - Il Salone dell’Accoglienza: appuntamento a febbraio 2026 con la 50a edizione | Guido Parri
62 L'OLIO AL CENTRO
C’è qualcosa che non va, la burocrazia uccide gli extra vergini | Luigi Caricato
64 LA DIGITAL TRANSFORMATION
Robot in sala: tra innovazione e identità, la nuova frontiera del servizio nella ristorazione | Claudia Ferrero
66 L'ANALISI
Turismo DOP: l’Italia che si racconta attraverso i suoi sapori | Ilenia Martinotti
70 LA PRODUZIONE
Salumificio F.lli Coati: qualità al servizio della ristorazione | Marina Caccialanza
72 LA PRODUZIONE
Bonduelle: soluzioni vegetali per il fuori casa | Marina Caccialanza
76 GLI EVENTI
I giornalisti di sala&cucina insigniti del Collegio Cocorum | Guido Parri
77 I LIBRI
Franco Pepe Pizza Chef | Luigi Franchi
78 LA PRODUZIONE
Lombata di Angus Unika: la perfezione del dry aged secondo Centro Carni Company | Guido Parri
79 L'ANALISI SENSORIALE
Umami e Kokumi: apologia di una proteina | Stefania Pompele

N° 99 novembre 2025
EDITORE
Edizioni Catering srl Via del Lavoro, 85 40033 Casalecchio di Reno (BO) Tel. 051 751087 – Fax 051 751011 info@salaecucina.it - www.salaecucina.it
PRESIDENTE
Benhur Mario Tondini benhurtondini@salaecucina.it
DIRETTORE RESPONSABILE
Luigi Franchi luigifranchi@salaecucina.it
COLLABORATORI ESTERNI
Luigi Caricato, Alessia Cipolla, Lorenzo Dornetti, Rocco Pozzulo, Claudia Ferrero, Federico Panetta, Guido Parri, Stefania Pompele.
FOTOGRAFIE
Stefano Caffari, Lido Vannucchi,@aromi group Archivio sala&cucina, adobestock.com, * L’editore è a disposizione per eventuali crediti fotografici di cui si ignora la fonte
RIVISTA PARTNER di AMODO
PUBBLICITÀ
Tel. 331 6872138 marketing@salaecucina.it www.salaecucina.it
PROGETTO GRAFICO
Gabriele Adani - www.gabrieleadani.it
STAMPA
EDIPRIMA s.r.l. – www.ediprimacataloghi.com
TIRATURA E DISTRIBUZIONE – 28.900 copie Ristoranti, trattorie e pizzerie 20.700 – Bar, pub e birrerie 4.000 – Hotel 3.100 – Grossisti e distributori f&b 1.100
Costo copia mensile: 4,00 euro abbonamento annuo 40,00 euro Per abbonarsi: info@salaecucina.it

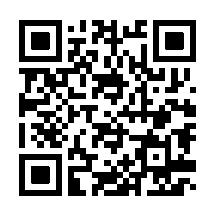

Clicca e leggi l’articolo sul web
Eh si, a dicembre 2025 uscirà il numero 100 di sala&cucina, dieci anni sono passati in fretta. Ricordo la copertina del primo numero, con l’intervista a Gianfranco Vissani, il timore di non farcela a portare avanti un progetto editoriale che partiva da zero e doveva affermarsi in un mondo, quello della ristorazione, che già allora cominciava ad avere le dimensioni dello spettacolo, con figure che avevano sempre meno a che fare con pentole e fornelli e sempre di più con le televisioni e i social.
Nel secondo numero ricordo che dissi di no a un famoso chef che voleva andare in copertina, un no forse incosciente o forse indicativo di quello che sarebbe diventata sala&cucina: uno spazio libero dove non si sarebbero stati condizionamenti di alcun tipo. La soddisfazione più grande è esserci riusciti per dieci
Ma non voglio che questo numero, il 99°, scompaia dai riflettori solo perché siamo tutti, in redazione, con la testa sull’uscita di dicembre.
Anche perché la ristorazione in senso lato non ha certo bisogno di autoreferenzialità, ce n’è già anche troppa in giro.
Parliamo piuttosto di una cosa più importante che mi ha evidenziato una bravissima cuoca e titolare del proprio ristorante chiamandomi per spiegare un particolare di cui non si parla mai abbastanza: come si presentano i ragazzi e le ragazze ai colloqui di lavoro Mi raccontava di quanto tempo perdono loro e anche gli imprenditori che cercano personale per una oggettiva incapacità di comunicare tra loro.
Quella telefonata faceva il paio con ciò che mi racconta
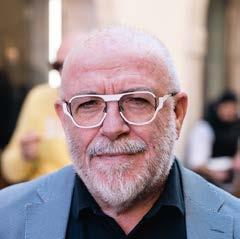
Luigi Franchi direttore responsabile
una collega di redazione impegnata, come docente, in corsi di formazione post-diploma e che ha deciso, nelle sue ore di insegnamento, di fornire ai suoi studenti le basi per un corretto curriculum ma soprattutto come presentarsi, sia nel linguaggio sia nella postura. Probabilmente, mi diceva la cuoca imprenditrice, se questi ragazzi avessero uno strumento snello che dia a loro informazioni di come presentarsi a un colloquio di lavoro nel settore della ristorazione troverebbero più attenzione da parte degli imprenditori e, soprattutto, capirebbero il bello e non solo la fatica di questo lavoro. Impresa impossibile? Niente affatto, abbiamo in casa chi può scrivere un piccolo vademecum e, pertanto, vogliamo fare la nostra parte per festeggiare i nostri primi dieci anni di vita regalando questo strumento a chiunque vorrà utilizzarlo. Nel 2026 sarà a disposizione di tutti quei giovani che vogliono lavorare seriamente nella ristorazione. Ne abbiamo un bisogno enorme!!
Trovare ragazzi e ragazze sorridenti e motivati che accolgono gli ospiti in un ristorante o in una pizzeria è una gioia per gli occhi, predispone bene ad affrontare una serata di piacere e di benessere, evita il rischio maggiore che si sta profilando all’orizzonte: quello dei robot che ti portano al tavolo il piatto!!
È un dovere per qualsiasi giornalista, blogger, comunicatore saper raccontare il mondo della ristorazione con la voglia di stimolare le persone anche a lavorarci. I primi dieci anni li abbiamo quasi raggiunti, ci auguriamo di averne ancora molti davanti per fare bene il nostro lavoro!


Clicca e leggi l’articolo sul web
707 miliardi di euro, è quanto vale la filiera allargata – dal campo agli scaffali e alla ristorazione – del cibo in Italia. A questa si aggiunge un altro numero non di poco conto: il settore impiega, nel suo complesso, circa quattro milioni di addetti.
Con queste importanti premesse vogliamo dire la nostra anche sul valore immateriale del cibo in Italia. Un valore immateriale che si traduce in una parte di quei 707 miliardi se si pensa che per il 52% del campione di un sondaggio condotto da Yougov la vera ospitalità non si misura in stelle o dotazioni ma con il benvenuto enogastronomico.
È questo il valore più importante che gioca il cibo in Italia: mettere in connessione le persone, facendo vivere esperienze condivise di felicità, di benessere. Tutto questo viene reso possibile grazie a un’imprenditoria nel mondo del vino prima e poi nell’artigianalità delle produzioni alimentari che, aprendo le porte delle loro aziende, per raccontare le loro storie d’impresa e la ricerca della qualità come prioritario impegno aziendale ai turisti italiani e internazionali, stanno portando il valore delle nostre produzioni ad essere riconosciuto in ogni parte del mondo.
Non voglio dimenticare anche il lavoro dei cuochi e del personale di sala della ristorazione italiana, che sanno infondere quella sensazione di benessere e di piacere che rende la nostra cucina tra le più apprezzate e ricercate nelle diverse nazioni del mondo. Non è un caso che il personale italiano della ristorazione sia così richiesto fuori dai confini.
Persone che fanno un lavoro duro, impegnativo, per far star bene altre persone. Non è un’immagine straordinaria questa? È generosità, condivisione, passione

quella che ti porta a intraprendere queste carriere nella ristorazione. E noi dobbiamo fare in modo che questa cosa si sappia, sempre, in ogni occasione. L’iscrizione (speriamo) della cucina italiana a Patrimonio immateriale dell’umanità UNESCO che si profila nell’incontro della commissione di valutazione il 10 dicembre a Nuova Delhi diventerebbe il giusto riconoscimento del valore che essa assume per l’Italia tutta. Quel momento sarebbe il primo che ufficializza una parte importante della storia del nostro Paese. Infatti è attraverso la cucina, raccontata dall’Artusi, che si è iniziato a parlare più in italiano che in dialetto. È con il cibo che i nostri immigrati si sono relazionati con i popoli degli altri paesi. E, infine, è con i cuochi che ne raccontiamo la bontà e il valore in ogni parte del mondo.
A questo proposito, approfitto di queste righe per ringraziare la FIc – Federazione Italiana Cuochi per aver riconosciuto, insignendo il direttore Luigi Franchi e la giornalista Simona Vitali con il Collare Amici dei Cuochi, il valore di sala&cucina, la sua vicinanza al mondo dei cuochi, il suo impegno nel dare voce alle loro esigenze e ai loro bisogni. Continueremo per questa strada con ancor più determinazione dopo questo riconoscimento.
Autore: Luigi Franchi
Clicca e leggi l’articolo sul web



Massimiliano Polacco è il direttore generale di Confcommercio Marche Centrali e vice-presidente della Camera di Commercio delle Marche, con delega al turismo ma è molto altro ancora, basta leggere online il suo curriculum vitae per capire perché abbiamo voluto intervistarlo. Un aspetto sui tanti del suo lavoro è dato dal fatto che è stato l’estensore dei protocolli che il governo ha adottato per uscire dal Covid; è a lui, incaricato dalla Regione Marche, capofila alla conferenza delle Regioni su questo argomento, che va il merito di aver indicato il distanziamento di un metro tra le persone rispetto alla proposta iniziale di quattro metri.
“Quella scelta ha consentito la ripartenza economica delle imprese del commercio, della ristorazione che non ci sarebbe mai stata con il distanziamento di quattro metri” afferma il professor Polacco nel corso di questa conversazione che parte su un tema: quello della sicurezza e della riqualificazione urbana dove il commercio, in senso lato, gioca un ruolo fondamentale.
Le agglomerazioni urbane hanno superato, è un dato di qualche anno fa, le aree rurali in termini di presenza dell’uomo. Questo fenomeno sta cambiando, in molti casi, in peggio, la visione della città. Infatti, per la crisi economica e i costi elevati di qualsiasi centro città, molte persone si trovano costrette a vivere nelle periferie; a questo aggiungiamo che, in molti casi, alcune aree dei centri storici si sono degradate perché non vengono fatti interventi di ristrutturazione dei palazzi, preferendo incassare affitti dagli immigrati che si devono accontentare di vivere in case ormai vecchi. Il tema della riqualificazione urbana, con periferie dotate di servizi e centri storici che tornino ad essere luoghi che raccontano la vita delle città, diventa quindi molto importante. Un’associazione di categoria, la più importante in Italia, che raggruppa quelli che sono gli elementi che tengono viva una città, e il Covid lo ha dimostrato - bar, ristoranti, negozi - che tipo di proposta e che tipo di impegno può dare per riqualificare le città?
“La nostra confederazione ha, da tempo, messo al primo posto proprio il progetto delle città e dei centri storici proprio perché ne rappresentano la memoria storica. Le nostre città partono dal medioevo dove si sommavano in esse la parte religiosa, la parte amministrativa e la parte economica che era rappresentata dai mercati e dalle botteghe aperte nel centro urbano. Questa memoria storica del mercato non la possiamo perdere perché poi diventa anche un fatto di vivibilità delle nostre città. Un centro storico è la rappresentazione di come si vive in una città. Ecco perché in tutta Italia stiamo riportando al centro dell’interesse proprio questo argomento della rivitalizzazione dei centri storici e in ogni territorio stiamo gestendo, come confederazione, progetti di grande respiro. Noi, nelle Marche, stiamo portando avanti un progetto regionale di centro commerciale naturale. Lo stiamo portando avanti nelle maggiori città della regione e in tutti i borghi storici per cercare di riqualificare l’offerta rivolta sia agli abitanti sia ai turisti. Infatti, se pensiamo ai borghi, ai centri storici dei borghi, come punto di attrazione del turismo dell’entroterra, la riqualificazione diventa chiaramente un forte elemento di attrazione che consentirebbe di far prosperare, anche economicamente, i nostri borghi. Ad Ancona stiamo facendo un progetto ancora più importante, perché ci stiamo confrontando con degli investitori, su un piano di riqualificazione del centro urbano e anche di riposizionamento delle attività econo-

miche, facendole diventare fortemente attrattive. Questo significa mettere a valor comune le parti che riguardano l’urbanistica, l’architettura e il commercio, favorendo l’apertura di negozi attrattivi, non solo per gli anconetani ma anche per i visitatori, i turisti, con proposte e prodotti che riflettono l’identità del territorio marchigiano. È un progetto a cui stiamo lavorando in maniera molto energica, mettendo insieme imprenditori che hanno voglia di investire”.
La tua, però, è una visione che va anche oltre le Marche. Ce l’hai ben chiara nel tuo pensiero e nelle tue azioni. Pane Nostrum, salone nazionale del lievitato, che organizzate a Senigallia ogni anno, ne è una dimostrazione. E come si esplicita il tuo ruolo nel concreto qui in regione ma anche all’interno dell’associazione?
“Bella domanda questa. A me piace sempre dire e dimostrare che noi siamo un’associazione che lavora insieme, che fa progettualità condivisa. Siamo un sistema, più che confederazione ci chiamiamo sistema proprio perché riusciamo a mettere insieme queste attività. Ma per fare questo non è sufficiente la visione di un singolo; è necessario raccogliere attorno a sé persone capaci, illuminate, che hanno voglia di confrontarsi e non di restare chiuse a difesa del proprio orticello. Per fare un esempio noi siamo una delle poche confederazioni che, all’interno di FIPE, ha scelto di avere come presidente uno chef pluristellato come Moreno Cedroni, proprio perché vogliamo avvalerci dell’eccellenza e della professionalità dei nostri imprenditori. Vogliamo poi parlare di Pane Nostrum? Quello è un progetto che chiaramente va oltre il territorio regionale, è diventato ormai un evento nazionale e ci stiamo confrontando anche con la Camera di Commercio per poterlo estendere anche all’altra sponda dell’Adriatico. Siamo riusciti a creare un momento molto formativo, e di informazione verso le persone che partecipano a quelle
giornate, legato a tutto il mondo dei lievitati, dal pane alla pasticceria e alla ristorazione. Un percorso che abbiamo approcciato forse all’inverso di quella che è una tendenza abituale che porta a ragionare in termini di chilometro zero; noi parliamo di un prodotto, il pane, che vede il fornaio ricercare i semi più adatti al suo tipo di lavorazione, a cui fa seguito la farina e il molino che la produce e questo non può assolutamente significare chilometro zero, bensì ricerca della qualità ovunque si trovi. C’è un progetto di filiera dietro a una pagnotta ed è questo, con Pane Nostrum, quello che vogliamo spiegare”.
Hai toccato un tema, quello della formazione, di cui si parla molto, quasi come per la parola sostenibilità, ma si fa ancora troppo poco; voi, invece, avete dato vita a un progetto che parte dai bisogni dell’impresa. Ce lo spieghi?
“Si tratta di un’idea innovativa che abbiamo condiviso con il presidente della Regione: quella di dar vita a un’Academy regionale, con la possibilità di fare corsi in ogni parte della Regione, nei settori del turismo e del commercio, partendo, come hai detto bene tu, dai bisogni delle imprese. Il nostro obiettivo è quello di dare un valore al lavoro, per esempio, quello fatto nella ristorazione e cercare di attrarre i giovani in questo mondo affascinante e interessante ma che non viene divulgato in maniera adeguata. La Regione ci ha dato fiducia e forse anche questa è un’innovazione tutta italiana che possiamo esportare. Noi creiamo questi corsi in base alle richieste del mercato e della domanda/offerta di lavoro che ci viene proposta. All’interno delle Academy ci sono le imprese che chiederanno e porteranno avanti, in alcuni casi direttamente, i corsi creando, fin da subito, un rapporto diretto tra l’impresa e il futuro collaboratore che verrà formato da queste academy. Molti corsi sono già operativi e riguardano le attività di sala, cucina e bar, poi ci sono quelli per
la panificazione e il marketing strategico per il settore turistico. Sono gratuiti e si avvalgono del partenariato delle aziende ma anche dell’Università Politecnica delle Marche, dell’ITS Academy-Turismo, Cultura e Nuove Tecnologie, di tutti gli Istituti alberghieri della regione”.
Parliamo delle Marche. Come ben sai sostengo, da sempre, la teoria che qui si creerà il futuro del turismo. Avete potenzialità enormi e potete sviluppare il turismo in ogni sua forma: eno-gastronomico, esperienziale, dell’arte, del teatro, della musica. Cosa è necessario fare per fare emergere tutto questo, anche in termini infrastrutturali o di promozione?
“Quando sono ritornato nelle Marche mi sono trovato, come dicevi prima, una grande potenzialità che però non veniva comunicata. C’era una ritrosia, anche da parte istituzionale, di non comunicare in maniera forte queste risorse sia nel campo del turismo sia nel campo della produzione; quando venivano espresse era per capacità del singolo imprenditore. A quei tempi c’era una pubblicità che diceva: le Marche, questa bella sconosciuta. Ma se continui a promuoverla come bella sconosciuta, rimarrà sempre una bella sconosciuta. C’è voluta la costruzione di una nuova cultura di comunicazione e questa nuova cultura della comunicazione credo che sia stata voluta soprattutto per il turismo che è diventato il driver che ha trascinato la conoscenza del nostro territorio. Perciò si usa molto il turismo come driver di questa regione anche dal punto di vista produttivo, artigianale e commerciale. È un percorso di comunicazione che stiamo portando avanti in maniera forte e credo che uno dei risultati più significativi siano le nuove rotte di voli che abbiamo messo in campo sia su Milano e sia su Roma, con due voli giornalieri per fare un collegamento con il nostro territorio, perché uno dei problemi maggiori del nostro territorio erano i collegamenti, cioè la difficoltà di raggiungere le Marche. E questo dà la possibilità non solo di collegare Ancona con due importanti hub, ma offre anche la possibilità di imbarcarsi da qualsiasi destinazione e, una volta sbarcati a Roma o Milano per il cambio tratta verso le Marche, non si devono portare i bagagli perché arrivano direttamente all’aeroporto di Ancona. Servizio che è essenziale per favorire il turismo straniero verso la nostra regione. Questo da un punto di vista infrastrutturale. Da un punto di vista della qualità delle strutture, degli alberghi, abbiamo fatto un grande lavoro proprio richiesto dagli Stati Generali del turismo della nostra organizzazione al governatore e abbiamo fatto un bando, proprio a gennaio nel 2025, di adeguamento delle nostre strutture ricettive ai nuovi standard di qualità strutturali, ma non soltanto, ma anche tecnologici. Questo ha portato a investimenti solo sulla qualità. Inoltre abbiamo chiesto e ottenuto dalla Regione di avere la categoria tre stelle di eccellenza che veniva beneficiato da questo bando. Ci sono state 190 domande; un terzo di tutte le strutture
ricettive ha fatto domanda per mettere in qualità le strutture alberghiere. Vogliamo creare un format turistico, un flusso turistico legato al benessere inteso in senso lato e alla bellezza, del paesaggio, del mare, dei borghi. La provincia di Ancona pochissimi anni fa non aveva nessun cinque stelle, ora ne ha due e un terzo in costruzione. Qualcosa vorrà pur dire!
In un’intervista che ho letto mi hanno colpito le tre parole d’ordine per il turismo d’eccellenza e anche per la ristorazione che hai elencato: ospitalità serietà e onestà, me le spiegni?
Per quanto riguarda l’ospitalità rientriamo nel ragionamento sulla formazione. Noi eravamo una regione chiusa e stiamo facendo formazione in maniera importante per cercare di diventare la regione con la massima aspirazione di ospitalità. Vorremmo che chi viene nelle Marche si sentisse ospite di casa. Serietà è invece legata alla serietà o onestà della comunicazione. Quando noi comunichiamo che da noi ci si può aspettare un certo tipo di servizio, noi dobbiamo con serietà mantenere quelle promesse, perché l’ospite possa diventare un portatore di comunicazione positiva. Onestà dei prezzi. Quest’estate ci sono stati dei rialzi esagerati in tutta Italia, mentre la nostra regione ha mantenuto i prezzi entro il 5%. Questo anche nella ristorazione”.
Parlando di ristorazione come si deve rapportare il singolo operatore della ristorazione rispetto a un’organizzazione o a un sindacato come il vostro di FIPE? E come il sindacato riesce ad aggregare?
“Gli operatori fanno due tipi di richiesta al nostro sindacato. La prima riguarda un’attenzione sulla preparazione dei nostri imprenditori della ristorazione. Su questo siamo stati i principali sostenitori di una legge regionale sulla promozione e valorizzazione delle ricette e dei menu della cucina marchigiana. La seconda richiesta è quella di essere supportati per i vari adempimenti a cui la categoria è sottoposta: HACCP, sicurezza sui luoghi di lavoro, normative fiscali ecc… Chiaramente noi siamo i firmatari dei contratti collettivi della ristorazione e dell’accoglienza e il rispetto delle richieste contrattuali diventa una delle cose più importanti. Questo sta portando a un ampliamento di orizzonti che sono legati ai welfare di settore, creati insieme agli enti bilaterali. Per essere chiari, per tutti quelli che adottano il contratto FIPE l’ente bilaterale offre una serie di provvigioni sia per l’acquisto dei computer, sia ai lavoratori su tutti quei welfare, dagli asili nido all’università, all’acquisto dei libri, all’assistenza. Infine, tra noi e il nazionale FIPE c’è stato uno scambio di nuove idee per la valorizzazione della ristorazione. Siamo stati i primi a organizzare un forum della ristorazione che poi ha spinto FIPE a lanciare la Giornata nazionale della Ristorazione”.
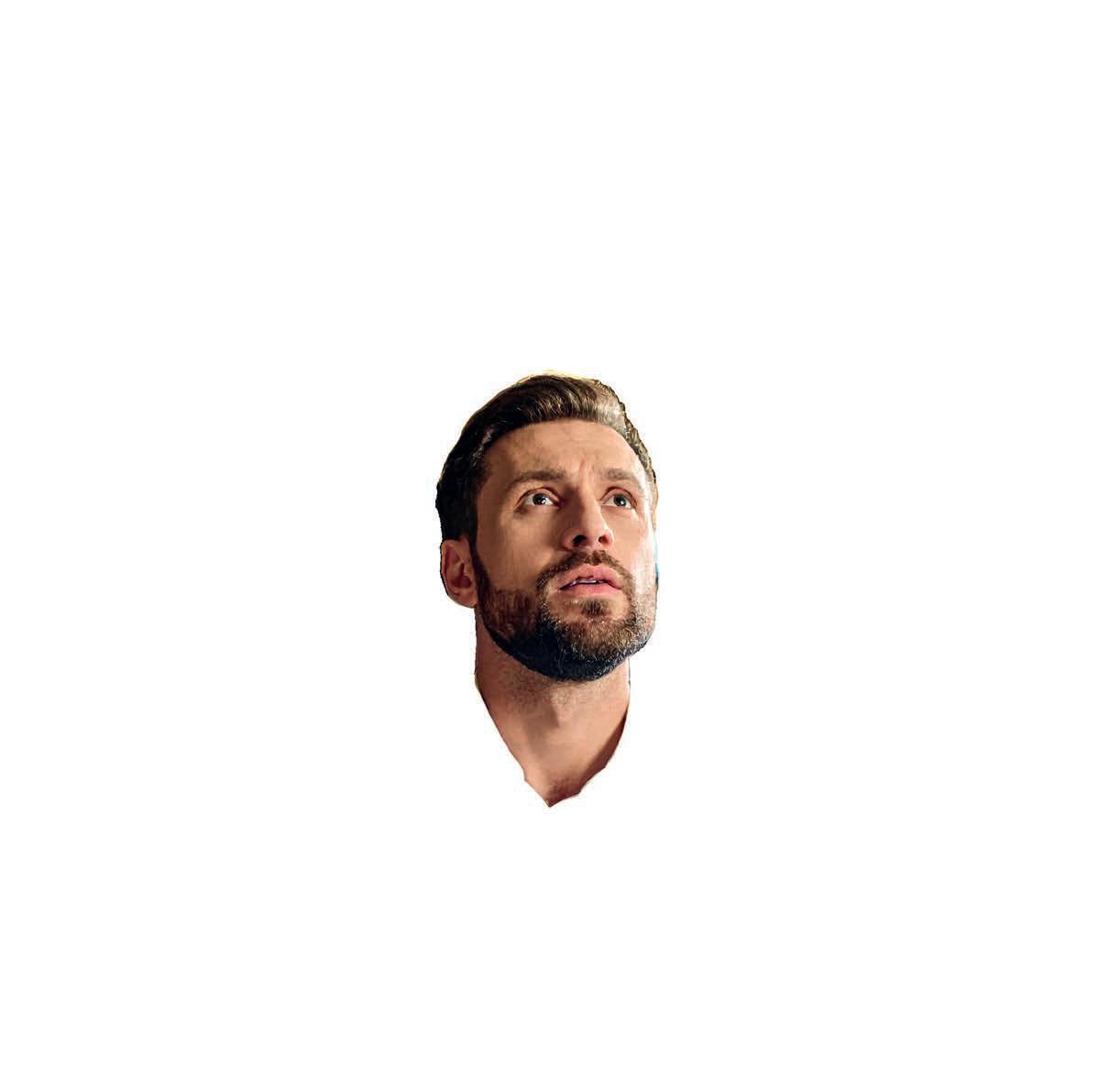
I tuoi clienti non cercano miracoli, vogliono semplicemente un piatto buono e fatto con i prodotti giusti! Scegliere i prodotti della linea Columbro è il modo migliore per garantire agli ospiti del tuo locale una qualità sicura e sempre costante che si adatta a ogni tipo di menù. Falla semplice, scegli Columbro.

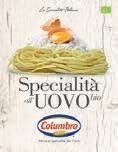




Un lavoro che va oltre la gloria, il guadagno, il sostentamento
Nel 2011 il mondo della ristorazione aveva un profilo totalmente diverso. La tecnologia e digitalizzazione erano ancora molto lontane dai ristoranti e dalle nostre vite. Parole come sostenibilità e etica non erano comuni, e se le si incontrava nel menu, o nella conversazione con un ristoratore, ci si faceva caso. Chi scrive si affacciava per la prima volta a una cucina professionale, da dentro, in un ristorante che faceva della materia prima italiana di elevatissima qualità il cardine. Non c’erano umeboshi, kimchi e kombucha sulle nostre tavole, e anche se abbiamo accolto incuriositi questi prodotti è giusto che ci ricordiamo che si tratta di comparse recenti. Nel settembre di quell’anno MasterChef Italia andò in onda per la prima volta. Per quanto alcuni possano dissentire, mi vien da dire che, un prima e un dopo, rispetto a quell’evento, possiamo tracciarlo: il cibo che diventa spettacolo ha cambiato il modo di vedere il cibo. Il cambiamento è avvenuto sia qualitativamente che quantitativamente, perché ancora oggi la maggior parte delle persone che non hanno a che fare con questo settore sono incuriosite dalla sua spettacolarizzazione, e quindi non vediamo ancora l’estinzione di programmi televisivi in cui il cibo e la sua preparazione sono protagonisti. Da allora abbiamo trattenuto progressi importanti, sono nati progetti straordinari, anche articolati, perché si è andati oltre il perimetro del locale. Qualcuno aveva già seminato e coltivato valori e azioni virtuose molto tempo addietro. Mi riferisco, su tutti, a SlowFood. Ad ogni modo, da quel momento, si è messo l’accento su un settore che prima c’era, viveva, ma non era granché attraente. A meno che non fosse un fatto di famiglia o non vi fosse una passione trainante (penso ai Cantarelli, e ad altri lumi che ancora oggi conducono un’attività di ristorazione) era difficile che la ristorazione fosse attrattiva per puro sentire.
Il cuoco - non dobbiamo ripeterlo se siete lettori di questa
rivista - godeva, o meglio subiva, un’immagine molto lontana da quella odierna. Era tutto fuorché un bel mestiere. Avere un ristorante era questione di sostentamento, e per molti rappresentava una fonte di grande guadagno, per questo lo si sceglieva.
Anche l’evasione fiscale, che si è (in parte) contratta nell’ultimo periodo con l’introduzione di nuovi metodi di pagamento, in quegli anni era consuetudine. E le gravi ripercussioni di quella prassi, anche sull’aspetto della credibilità del ristoratore, le paghiamo ancora oggi. Perché abbiamo voluto fare quest’excursus storico?
Perché ci rendiamo conto che fare ristorazione è sempre stato complicato, prima che la mediaticizzazione del cibo prendesse il là, ma lo è diventato in misura talvolta davvero insopportabile oggi. Far quadrare i conti, avere personale a sufficienza, rispondere alle provocazioni online di clienti saccenti (anche se non ci sono solo quelli, per fortuna), doversi scontrare con chi non comprende e non valorizza la professionalità, il tempo, la ricerca: tutto questo è complesso e spesso insostenibile, a fronte dei tanti sforzi quotidiani e dell’assorbimento totale che questa professione spesso richiede. D’altronde quando metti un argomento al centro della stanza, sul piedistallo, è fisiologico che attorno si sviluppino attenzioni e dinamiche nuove e non sempre felici.
Allora cosa spinge i ristoratori a fare i ristoratori? Cosa spinge il cuoco a fare il cuoco? Il cameriere a scegliere di stare in sala? Perché se fate questo nella vita dovreste starci, ancora?
Genya Malafronte è un giovane ragazzo abruzzese che ha ereditato dalla famiglia la passione per la ristorazione. Il padre è insegnante di sala all’istituto alberghiero; lo zio, Luigi Malafronte, anche lui insegnante in terra campana e presidente associazione SEML (Stabiesi Equani


e Monti Lattari) ha accolto Genya dopo gli studi di cucina per le prime esperienze. A dire il vero scopriamo che Genya aveva preso questa professione seriamente sin da giovanissimo, cominciando a lavorare in un locale vicino a casa durante il periodo scolastico.
Il percorso è diventato, poi, decisamente denso: per cinque anni ha respirato la cucina di Heinz Back a La Pergola dell’Hotel Rome Cavalieri a Roma, passaggio che potrebbe bastare per raccontare la tenacia e la determinazione che caratterizza questo ragazzo.
L’Abruzzo, però, premeva dentro: Genya ha quindi deciso di tornare nella sua regione dapprima per lavorare in un’altra attività e poi, o meglio da poco, a partire dallo scorso febbraio, per dedicarsi a un progetto tutto suo.
“Preferisco dire che è un progetto nostro perché è un ristorante di famiglia. Siamo a Morro D’Oro, in provincia di Teramo, a un passo dal mare e poco distante dal Gran Sasso. Dentro ci lavorano mio padre Nicola, che si occupa naturalmente della sala, mia madre Nataliya, e da poco anche mia sorella Annalarissa. È una casa di campagna che abbiamo ripensato come Boutique Hotel con ristorante all’interno con l’idea di valorizzare, attraverso una cucina semplice e contemporanea, il nostro territorio”.
Quando Genya mi dice il nome del ristorante rimango per un attimo in silenzio: si chiama Legàmi. Era una parola che, appena il giorno prima, un altro giovane ristoratore mi aveva messo in evidenza più volte nel
corso della nostra conversazione. Vi dirò tra qualche riga di chi si tratta.
Genya sottolinea che si tratta di un luogo che vive di “e per” le relazioni ed è stato proprio spontaneo scegliere di chiamarlo così.
“I legami sono i nostri legami, cioè quelli di famiglia, ma ci riferiamo anche a tutte le relazioni che si instaurano quando si fa ristorazione. Cioè con i fornitori, con gli altri ristoratori, e con tutti quelli che sono già venuti a trovarci. Non abbiamo condotto campagne promozionali, non abbiamo nemmeno un sito. I clienti sono arrivati con il passaparola” ci dice Genya con la pacatezza e la gentilezza che, sin dall’inizio della nostra conversazione, lo accompagnano.
A detta dei clienti, come recepiamo da un’approfondita lettura delle recensioni lasciate online, da Legàmi si ha davvero la sensazione di essere benvoluti. C’è il piacere di accogliere, di adattare, di personalizzare l’esperienza; di rendere quel tempo fuori casa una parentesi migliore, ma anche naturale, di relazione e scambio, sia per chi è ospite che per chi ospita.
Genya ci racconta di quanto per la sua famiglia questo sia il valore centrale, il moto che orienta il loro lavoro, perché senza relazioni, e senza la cura necessaria per coltivarle, questa professione sarebbe decisamente vuota. Sarebbe mera esecuzione.
Abbiamo abbandonato il concetto di cibo come nutrimento anni addietro ma forse non è ancora assodata l’idea che fare ristorazione non sia solo un lavoro. Prendersi gli oneri e gli oneri di questa attività significa prendersene cura ogni giorno, ogni ora, delle persone, avendo ben in mente che le fondamenta di un ristorante sono costituite soprattutto dalle relazioni. Non sono solo la cultura, la scelta di un prodotto di qualità, la cottura millimetrica di un alimento: è la capacità di comunicare e relazionarsi, di stabilire delle connessioni. Di accogliere, in altre parole, l’altro. E di dargli le ragioni per entrare.
Mi hanno colpita le parole di Genya, e l’impronta che con la sua famiglia ha dato al locale, e mi hanno altrettanto segnata i racconti di Nicola Masa e Fabio Ferro, dell’Antica Osteria Morelli di Pergine (TN). Chi ha assistito alla presentazione delle Guida Osterie D’Italia di quest’anno li avrà notati: sono i vincitori di Ostinati, il riconoscimento assegnato al locale per essere stato salvato e rilanciato da una piccola comunità che ha lavorato insieme per garantirne il passaggio generazionale, preservando la sua storia ed eccellenza. Siamo partiti dalle origini ma abbiamo lasciato soprattutto spazio al valore che questa storia trasmette.
“Quest’osteria è nata a fianco a quello che prima fu un mulino, fondato nel 1751, e poi fu salumificio, della famiglia Morelli. Dalla fine degli anni ’80 si sono sus-

seguite diverse gestioni fino all’arrivo, nel 2008, di Fiorenzo Varesco. Fiorenzo ha portato la sua esperienza in questo locale e lo ha reso, applicando la sua idea di ristorazione, un luogo-meta per chi ama stare bene a tavola. Qui non si viene per caso, bisogna deciderlo, non è una località di transito. Fiorenzo ha messo al centro le relazioni, il rapporto con i fornitori soprattutto, e per garantire una ristorazione di qualità questo è fondamentale!”.
Sono tante le persone che sono transitate per questa insegna o hanno contributo a tenerla viva. In primis, però, c’è il lavoro di Fiorenzo.
“Questo luogo è diventato talmente speciale che, alla notizia della sua chiusura, alcuni imprenditori locali si sono mobilitati per consentirgli di rimanere in vita.
Per questo, quando Fiorenzo ha deciso di chiudere, Fabio, che sta in cucina, ed io, che sto in sala, siamo stati contattati per dare continuità all’osteria” ci racconta Nicola.
La mobilitazione della comunità, per consentire a un bene prezioso - e, ricordiamoci, stiamo parlando di un’osteria - di rimanere in vita è un fatto straordinario. Come straordinario è stato l’impegno riposto da Fiorenzo nel corso degli anni.
“Abbiamo apportato solo alcune lievi modifiche estetiche all’interno del locale. Abbiamo deciso di mantenere alcuni piatti storici dell’insegna e, soprattutto, di non perdere la centralità che il valore umano ha per l’Antica Osteria Morelli. Fiorenzo si è impegnato a trasferirci i rapporti con i fornitori, e con la

comunità, perché questo luogo senza legami e senza di loro non sarebbe l’Antica Osteria Morelli”.
I nomi di chi produce sono in prima pagina, a confermare un attestato di fiducia reciproca. La stessa fiducia che, senza interessi, stanno riponendo in Nicola e Fabio coloro che gravitano attorno all’osteria. Qualche settimana fa una ristoratrice mi esponeva, con rammarico e, non esagero, molto dolore, il timore di chiudere la sua attività per l’impossibilità di tenerla in piedi. Per noi che, oltre a svolgere il lavoro di divulgazione di informazioni e storie vogliamo anche porgervi l’orecchio, è difficile dare consigli risanatori o risolutori. Tuttavia, ripensando a quella conversazione, siamo arrivati qui: a raccontarvi che il motivo per cui fate questo lavoro dovrebbe essere proprio questo, l’interazione e il legame con le persone. E, probabilmente, se state cercando una soluzione ai tanti problemi a cui siete sottoposti è da lì che dovete ripartire.
Autore: Luigi Franchi
Clicca e leggi l’articolo sul web

L'uovo di carciofo del Ristorante La Trota dal 1963
In pochi lo sanno ma in Italia ci sono circa 1500 laghi e il turismo lacustre vale circa il 7% dei flussi turistici del nostro Paese. A scegliere il lago per una vacanza sono, in prevalenza, gli stranieri: il lago di Garda, come si sa, è il mare del sud per i tedeschi, giusto per fare un esempio. Complice di tutto questo interesse è lo stato delle acque dei laghi italiani che non è per niente negativo, dopo che fino agli anni ’70 del secolo scorso, soprattutto nel nord industrializzato, i laghi erano una sorta di discarica dei rifiuti organici e non solo dei territori confinanti. Una rigorosa politica di cambiamento ha portato oggi a contare su ben 81 località lacustri ad avere la Vela, simbolo assegnato dal Touring Club Italiano e da Legambiente, e 22 Bandiere Blu lacustri. Con queste premesse siamo andati a indagare il ruolo della gastronomia lacustre, di quanta importanza ha il pesce di lago nella cucina italiana e nel richiamo turistico e lo abbiamo fatto grazie all’Associazione Italiana Ambasciatori del Gusto che ha avviato un percorso di approfondimento dedicato al tema della gastronomia lacustre, per valorizzare il ruolo del pesce di lago nella cucina italiana e nel racconto dei territori. L’iniziativa si inserisce nel più ampio progetto di valorizzazione della biodiversità e delle filiere italiane che l’Associazione porta avanti attraverso la rete dei propri soci, ambasciatori di un’Italia autentica, sostenibile e contemporanea.
Il pesce di lago
Anguilla, trota, carpa, salmerino, lavarello, luccio, coregone, cavedano, sarda, bosa, pesce gatto, persico, siluro sono solo alcuni delle tipologie ittiche che si trovano nei laghi italiani. Ma ce ne sono tante altre, oltre a queste più famose, che vivono nei fondali senza venire pescate. Anche nei laghi avviene quello che accade nei mari italiani: solo una decina di specie finiscono nelle pescherie, nei banchi del
supermercato o nei menu dei ristoranti, complice una strategia commerciale che non vuole complicarsi troppo la vita. La differenza tra laghi e mari è che, per fortuna, nei laghi c’è abbondanza di pesce, anche di quello più pescato; forse è perché negli ultimi vent’anni la pesca di lago è calata del 70% in generale.
Questa elevata massa di pesce offre la possibilità agli chef di esprimere al meglio la loro creatività e il loro rapporto con il lago, come testimoniano, in questo articolo, Marco Sacco, Leandro Luppi e Sandro Serva, i tre chef più noti in Italia e all’estero per la loro cucina lacustre, tutti Ambasciatori del Gusto.
Marco Sacco, patron del Piccolo Lago a Mergozzo
A pochi chilometri di distanza da Stresa, famosissima località che si affaccia sul Lago Maggiore, ci si imbatte sul Lago di Mergozzo, all’imbocco della Val d’Ossola. Un lago piccolo, di cui si leggono tutte le sponde spaziando con lo sguardo; qui, da anni, è vietato l’uso di barche a motore e questo ne ha preservato le acque che risultano essere limpidissime.
“Sono fortunato a vivere in questo paradiso che osservo ogni giorno dalle vetrate e dal giardino del mio ristorante Piccolo Lago ma tutti i bacini lacustri oggi sono in queste buone condizioni, compreso il Lago Maggiore che si trova a pochissimi chilometri di distanza. – ci racconta lo chef - Dal punto di vista ambientale, dopo gli anni ‘70 dove i laghi erano diventati discariche, oggi sono eccessivamente puliti e depurati che i pesci quasi ne soffrono. Sembra assurda come considerazione ma è un dato reale al punto che, qui vicino, nella Svizzera del Canton Ticino, stanno studiando l’ipotesi di scaricare una parte di rifiuto organico nei laghi per alimentare i pesci”.
Come scegli i pesci da cucinare?
“Dipende tutto dalla stagionalità e dai fermo pesca. In generale preferisco pesci della famiglia dei Salmonidi:

trote, salmerini, lavarelli. Hanno strutture consistenti, prediligono le cotture brevi e sono ottime materie prime su cui dare spazio a competenza e creatività”.
Quali tecniche di cottura preferisci utilizzare?
“Anche in questo caso dipende dalla tipologia di pesce. Per i capitoni e le anguille, ad esempio, prediligo la cottura sulle braci per togliere grassezza e rendere la pelle croccante e più edibile, poi un passaggio in sottovuoto con olio extravergine d’oliva e qualche spezia per dare ancor più morbidezza. Per i pesci invasivi, invece, come il siluro, anche per le sue dimensioni, utilizzo le tecniche di cottura del maiale, cotto nello strutto, ammorbidito e tagliato a carpaccio”.
Dove compri il pesce di lago?
“Prevalentemente nelle pescherie di ricerca che si trovano sul territorio. Di ricerca perché non hanno sempre e solo pesci conosciuti, quando è stagione puoi trovare anche specie meno note, puoi sbizzarirti in cucina. Le pescherie del territorio sono gestite in prevalenza dagli stessi pescatori e questo è un ulteriore indice di qualità. Il pesce di lago sta diventando un must per la cucina al punto che anche i distributori horeca lo stanno mettendo tra le loro referenze”.
È più complicato cucinare il pesce d’acqua dolce o quello di mare?
“Sicuramente quello di acqua dolce ma non parlerei di complicazione, bensì di maggior impegno da parte nostra. La differenza tra le due tipologie di pesce è data dal fatto che il pesce di acqua dolce è privo di iodio ed è, solitamente, più grasso, quindi dalle tecniche di cottura ai tagli necessita di più attenzione, di qualche spezia o di qualche lavorazione particolare, tipo in carpione. Il pesce di mare, invece, è già saporito di suo”.
Tu sei l’ideatore di Gente di Lago, una manifestazione che porta a Mergozzo molti tuoi colleghi, giornalisti, uomini e donne di cultura e di scienza: in cosa consiste questa manifestazione?

“Quando ho pensato a Gente di Lago ero mosso dalla convinzione che dovevo rendere indietro al mio territorio tutto quello che mi era stato donato. Per farlo era necessario parlare non solo di gastronomia ma di storia, di scienza, di ricerca. Per questo, fin dall’inizio, ho coinvolto CNR, istituzioni, pescatori e ristoratori. In dieci anni abbiamo analizzato tutto ciò che ruota attorno al pesce d’acqua dolce, con la sua storia, il cambio delle epoche e del pescato stesso. Andiamo due giorni anche sull’isola dei pescatori dove ho rilevato, nel 2022, lo storico albergo ristorante Il Verbano, con gli chef ospiti, i ragazzi dell’alberghiero, i pescatori per raccontare la contemporaneità del pesce d’acqua dolce, per mettere a fuoco tecniche di allevamento sostenibile di questi pesci gestite dagli stessi pescatori”.
A Marco Sacco va un grande merito, quello di tenere sempre la barra dritta in ogni sua azione, dalla conduzione del Piccolo Lago, un gioiello di ristorante, alle buone pratiche relazionali che lo hanno portato a dare una svolta al suo territorio.
Leandro Luppi, patron di Vecchia Malcesine a Malcesine
Dal Piemonte alle sponde venete del Lago di Garda. Siamo a Malcesine, nella parte alta del Lago di Garda, quella dove il lago è più profondo, all’incirca 350 metri rispetto ai 70 della parte bassa e più larga di Sirmione e Peschiera. Questo dato è molto importante per chi, come Leandro Luppi, lo chef patron del ristorante Vecchia Malcesine, una stella Michelin, posto nel cuore del centro storico di questo affascinante borgo, ritiene che i pesci della parte alta siano qualitativamente diversi.
“La profondità e la bassa temperatura delle acque che determina assenza di limo e formazioni rocciose rende le carni del pesce molto più solide. Sembrano sfumature quelle che sto raccontando ma chi, come il sottoscritto, lavora a stretto contatto con migliaia di pesci ogni anno conferma che ci sia una qualità diversa”.
Raimbow under the lake , lavarello
Comincia così la conversazione con Leandro Luppi, chef dal carattere forte e dalla simpatia contagiosa.
Quando sei arrivato a Malcesine, ormai ventott’otto anni fa, cosa hai fatto per connotare il tuo ristorante?
“Ho girato tutti i ristoranti della zona per capire qual era la proposta gastronomica: quello era il tempo di coregoni alla brace e di pesce persico impanato. Ho cercato di capire cosa non fare! Credo di essere stato tra i primi a riproporre tinca e carpa che non si utilizzavano quasi più. Il piatto si chiamava Tonno di lago perché tinca e carpa andavano in olio cottura, che faceva perdere il gusto di fango, e la percezione visiva sembrava proprio quella del tonno. Poi abbiamo reintrodotto il pesce gatto che era entrato dal Mincio e, quest’anno, anche questo rientrato purtroppo dal Mincio, faremo una proposta anche con il pesce siluro. Poi ci sono coregone e lavarello, che sono fondamentalmente la stessa cosa, che fa parte della famiglia dei Salmonidi ed è l’unico che non ha denti e, di conseguenza, si nutre succhiando l’acqua con insetti e piccole larve dando origine a carni bianche, molto pulite e buone. Le sarde che sono presenti tra giugno e luglio. Il luccio che viene pescato con la dirlindana e non sempre è disponibile. La pesca del lago non è come quella del mare che se non pescano, per esempio, branzini nell’Adriatico riescono ad averli dal Tirreno. Qui mi chiamano i pescatori al mattino e ci dicono “ho pescato questo”, noi compriamo, puliamo e abbattiamo per avere sempre una scorta pronta”.
C’è crisi tra i pescatori sul lago di Garda?
“No, però i vecchi pescatori stanno mollando e subentrano persone dall’India, dallo Sri Lanka che acquisiscono il patentino e sono disposti a fare qualche sacrificio, uscire di notte, mettere giù le reti. Fanno un lavoro più che onesto e con loro l’accordo è che mi chiamano, mi dicono cosa hanno pescato e si acquista per il bisogno del ristorante”.
Dove compri il pesce oltre che dai pescatori?



“Quando ci sono i limiti della pesca sul lago compro, per esempio riguardo alle trote, da un allevatore che è tra i migliori che operano in Italia. E, a proposito di comprare, è importante ribadire il concetto che il pesce noi ristoratori lo paghiamo a peso intero, quando viene pulito ne resta mezzo chilo e di questo il cliente deve essere consapevole”.
Quanto pesce c’è nel lago e per quanti anni si potrò andare avanti?
“È una domanda a cui non so rispondere ma se dobbiamo affrontare la questione ti racconto l’ultima che sta accadendo: le tre regioni dei laghi del nord Italia hanno fatto propria una direttiva europea che impedisce di immettere nei laghi gli avanotti di lavarello perché non è una specie autoctona ma alloctona. A cosa porterà questa misura non è dato sapere, lo scopriremo tra qualche anno. Ci sono pesci che stanno calando come il carpione ma il lago di Garda è ancora molto pescoso”.
Tra pesce di mare e pesce di lago quali sono le differenze sostanziali in termini di utilizzo e cotture?
“La differenza sostanziale è che tra i pesci di mare ci sono decine di gusti e sapidità diverse. E l’altra è il piatto che vuoi fare; il pesce d’acqua dolce necessita di una costruzione del piatto. Da noi il più famoso è la Carbonara di lago che ho in carta da 25 anni e non riesco a toglierlo. Un piatto che, invece, a me piace molto per la sua stranezza è la trota marinata con zuppa di cioccolato bianco, cren e caviale di trota”.
Tu hai ideato l’evento Fish&Chef. Quest’anno non l’avete organizzata, come mai?
“Ci siamo presi una pausa perché è necessario rinnovare e stiamo pensando a quale idea è quella più innovativa per rilanciare. Di certo c’è un dato importante: in undici anni sono venuti 100 chef da ogni parte d’Italia e, ora, in
quei locali c’è sempre una o due portate di pesce di lago”.
Sandro Serva, patron insieme a suo fratello Maurizio, del Ristorante La Trota dal 1963 a Rivodutri (RI)
“Il nostro locale si trova a tre metri da un corso d’acqua purissima e il verde della Sorgente di Santa Susanna, ideale per il pesce d’acqua dolce. Siamo stati in qualche modo condannati a utilizzare trote, tinche, persici, coregoni. Nostra madre Rolanda cucinava nel caldaio sul camino la pasta tirata dalle braccia robuste, nostro padre Emilio cuoceva alla brace le trote e le carni locali. Erano gli anni ’60 del secolo scorso e noi, intanto, diventavamo grandi tra i tavoli di questa semplice trattoria che dava un minimo di valore a questo territorio”.
Comincia così la breve ma intensa conversazione con Sandro Serva che ci porta a scoprire quella parte d’Italia, connotata dal lungo Appennino, con il suo racconto di come hanno portato avanti un cambiamento epocale nella trattoria dei genitori.
“il primo periodo di questo cambio di rotta fu agli inizi del 2000, un periodo di conflitti con i nostri genitori perché il salto era grande. Io e Maurizio andammo un po’ in giro per locali stellati per capire come erano strutturati.
Fu l’incontro con Antonio e Nadia Santini che ci convinse che la strada intrapresa era giusta. Parlando con loro, ascoltando la storia del nonno pescatore ci sembrava di sentire la nostra. Ci dettero una grande carica”.
Come siete riusciti ad affermare un ristorante di pesce d’acqua dolce nell’ambito dell’alta cucina italiana e internazionale?
“Grazie alla determinazione con la quale abbiamo affrontato il cambio di rotta. Il pubblico locale non era contento di questo cambiamento; restava fermo il nome del locale,


lo avevano coniato i nostri genitori insieme ai pescatori che dicevano “andiamo a mangiare alla Trota”, ma tutto il resto veniva trasformato. Una sala che conteneva duecento persone ne avrebbe ospitate una trentina. I piatti erano più elaborati. Ma il pubblico esterno stentava ad arrivare. Poi iniziò un incredibile passaparola positivo che ci ha portato fino a qui, ad essere l’unico ristorante europeo di pesce d’acqua dolce ad avere due stelle Michelin”. Dove comprate il pesce d’acqua dolce e quali pesci utilizzate?
“Il nostro pesce arriva in prevalenza dal lago di Campotosto, ai confini tra Lazio e Abruzzo. Un lago di montagna, a mille metri d’altezza, dove i ragazzi che hanno fondato una cooperativa di pescatori ci procura il meglio: anguilla, persico, luccio, coregone. Proprio stamattina, ci hanno avvisato che hanno pescato un persico reale di nove chili. L’altro lago a cui attingiamo è il lago del Salto (anche detto lago di Borgo San Pietro), il più grande lago artificiale del Lazio, situato in provincia di Rieti. Noi utilizziamo tutto quello che ci viene proposto anche perché, mentre in pescheria puoi trovare abbondanza di pesce di mare, pesce d’acqua dolce è difficile trovarlo”.
Come lo preparate e presentate?
“Abbiamo sia la carta sia un menu degustazione che lascia molto spazio ai pesci d’acqua dolce perché le acque lacustri, fluviali e sorgive caratterizzano da secoli questo territorio. Spesso hanno osteggiato le attività e la vita delle popolazioni locali ma, per molto tempo, il pescato è stato anche la fonte di sostentamento primaria. Ci sembra doveroso continuare a proporre questa materia prima nel rispetto dei luoghi, della tradizione e della sostenibilità ambientale”.
È più difficile cucinare pesce d’acqua dolce o pesce di mare?
“La differenza sostanziale è che il pesce di mare meno lo tocchi meglio è. Il pesce di acqua dolce deve avere un abbinamento molto attento, in particolare le verdure tipo il sedano d’acqua o il crescione di sorgente”.
Quali sono i piatti a cui volete più bene?
“Sono i piatti più storici che periodicamente vengono rimessi in carta. Uno di questi è la Zuppa di tinca con i capelli d’angelo, dove la pasta sottilissima viene tagliata a mano con il coltello e il brodo di tinca passa con le spezie nella caffettiera napoletana e va a cuocere a tavola sia il carpaccio di tinca sia i capelli d’angelo. Un altro piatto è la Trota con il foie-gras e L’uovo di carciofo, un piatto che ha fatto il giro del mondo”.
Come siete riusciti a spostare persone da ogni parte del mondo?
“Per la curiosità. Tutti dicono che se ne parla così bene che vogliamo provare. E tutti vanno via con un’esperienza che definiscono incredibile. In questo momento stiamo vivendo una nuova vita, grazie ai nostri ragazzi, mio figlio Michele e mio nipote Amedeo, che avendo studiato e viaggiato, sanno gestire benissimo la relazione con l’ospite e stanno facendo ricerca sul territorio, sia per la sala sia per la cucina. Tra qualche settimana entrerà in squadra anche mia figlia Antonella che si è laureata da poco in ingegneria alimentare a Milano. C’è un terzo figlio, il primo, Matteo, che ha scelto liberamente ed è riuscito ad affermarsi nel mondo della moda”.
Il nostro viaggio nel mondo dell’acqua dolce termina qui, con molte informazioni che diventeranno utili a chi vuole intraprendere questo percorso. Questo è anche il compito di un’associazione come gli Ambasciatori del Gusto.
Autrice: Simona Vitali
Cosa succede quando un’associazione, nello specifico AIC Marche - Associazione Italiana Celiachia Marche - costituita da chi la patologia la vive personalmente e i rischi li corre sulla propria pelle - si incontra con un gigante come la FIPE (Federazione Italiana Pubblici Esercizi), peraltro già attenta e ricettiva rispetto alla causa in questione?
Succede che le parole acquisiscono un peso specifico e non si limitano ad essere una promessa ma un impegno condiviso
Proviamo a immaginare una bella famiglia allargata che si riunisce, in un giorno di festa, attorno al tavolo di un ristorante per festeggiare. In tutti i partecipanti la stessa voglia di essere lì, qualcuno con qualche preoccupazione in più perché sta per affidare, letteralmente, il proprio stato di salute nelle mani del cuoco. Non ha allergie ma una patologia ben precisa, la celiachia, che sa essere così subdola da lavorare dentro senza manifestare sintomi, basta una minima contaminazione. Un impegno grande per chi cucina che va a rincarare la dose rispetto alla responsabilità che già ha nei confronti di tutti gli ospiti indistintamente.

Messaggio inequivocabile che per forza di cose va a far crescere l’attenzione circa questa malattia, peraltro già attenzionata da tempo, che può colpire senza limiti di età e che, come abbiamo già evidenziato, non manifesta necessariamente sintomi e può essere curata (o danneggiata) esclusivamente con l’alimentazione, cioè è letteralmente nelle mani di chi questa alimentazione la somministra.
Attualmente sono circa 250.000 i casi conclamati, 600.000 da appurare. Senza contare i circa 200.000 stranieri che ogni anno entrano in Italia. Numeri non trascurabili.
Il motivo specifico per cui , in occasione dell’appuntamento annuale di Pane Nostrum, il Salone dei lievitati, Confcommercio Marche Centrali ha deciso di organizzare il convegno Ristorazione e celiachia, tra fake news e opportunità di business è il recente risultato mandato a segno proprio ad opera di AIC Marche e altri soggetti firmatari, con l’approvazione da parte del consiglio regionale marchigiano, con voto unanime dell’aula, della proposta di legge 269/2024, “Interventi dei soggetti affetti da malattia celiaca”, che prevede una sorta di rincaro rispetto ai provvedimenti presi fino a questo momento.
Ma entriamo nel vivo dei contributi che si sono avvicendati, a partire dal saluto di Giacomo Bramucci, presidente Confcommercio Marche Centrali, in qualità di organizzatore dell’evento insieme ad altri enti del territorio: “Oggi parliamo di qualcosa che potrebbe essere considerato un problema, in realtà è un’ennesima dimostrazione di come l’attenzione profonda alle esigenze del cliente porti a un senso di condivisione molto più ampio, perché comunque stare insieme al ristorante vuol dire anche condividere e persone che

magari si trovano nell’impossibilità di vivere con altri lo stesso luogo di aggregazione si potrebbero sentire emarginate”.
Incisiva Francesca Giansante, presidente AIC Marche: “Purtroppo nel 2025 ci sono ancora troppe informazioni scorrette, troppa superficialità e sapete perché? Perché noi celiaci, non essendo allergici, spesso non abbiamo sintomi importanti. Io stessa, che sono celiaca, non ho sintomi importanti. Al netto del fatto che non ci sono sintomi, come vi dicevo prima, il nostro corpo subisce un danno anche a fronte di una contaminazione minima. Questo sapete cosa comporta? Porto la mia casistica come esempio: se penso a ogni volta che vengo invitata a una cena, a un pranzo, a un matrimonio, a un battesimo, a una cresima…io ultimamente sto veramente glissando rispetto a tutti gli inviti che ricevo, perché la mia frustrazione nasce nel momento in cui mi devo rapportare con il ristoratore. La prima cosa che mi dice è: che grado di celiachia hai? Ecco, di fronte a questo non c’è risposta, non esistono gradi di celiachia. Noi stiamo tutti male, anche se magari non sveniamo o non abbiamo un sintomo importante. Un’altra cosa assurda che mi sento dire è: Ma qui da me non è mai stato male nessuno! Vedete, non è così semplice, ma non è neanche così difficile. Tutto passa per le giuste conoscenze, le corrette informazioni, piani HACCP adeguati che, credetemi, oggi quasi nessuno ha. A livello nazionale stiamo lavorando tantissimo. Abbiamo portato a casa delle leggi importanti, una delle quali con la Regione Marche. Tutti i ristoratori, gelatieri, baristi che desiderano somministrare un alimento senza glutine, un pasto senza glutine, dovranno essere iscritti ad un registro regionale, fare dei corsi, essere monitorati, avere piano HCCP, adeguati. E que-

sto, credetemi, per noi è una vittoria enorme, perché oggi tutti dicono di sapere fare, ma di fatto non sanno fare. Possiamo veramente costruire un mondo migliore, più inclusivo, in cui non si debba sempre giustificare il proprio bisogno, bisogno dettato da un’esigenza di salute e non una scelta?”.
Incalza Laura Diodovich, biologa, responsabile progetto AFC (Alimentazione Fuori Casa) per AIC Marche: “AIC è una Federazione, che si compone di 21 associazioni regionali, nata alla fine degli anni ‘70 grazie ai genitori dei primi bambini diagnosticati, che fa tante iniziative a livello nazionale che poi si declinano anche a livello regionale con diversi progetti. I dati ci dicono che oggi i diagnosticati sono circa 250 mila e quindi noi dobbiamo pensare a 250 mila famiglie, non soltanto diagnosticati, ma famiglie che devono interfacciarsi con una dieta senza glutine che, come diceva Francesca, la nostra presidente, devono cercare dei posti, dei ristoranti che cucinano senza glutine. 250 mila diagnosticati, ma a fronte di 600 mila celiaci attesi e anche di più in realtà, perché si stima che una persona su 100 sia celiaca, ma dai nuovi studi sembra che in realtà stiamo arrivando quasi a uno e cinque, due su 100! Per non parlare poi dei turisti, perché noi abbiamo circa 200 mila turisti che arrivano in Italia e che sono celiaci”.
È necessario premettere che la celiachia prima era una malattia pediatrica, quindi era una malattia che si scopriva da bambini. Oggi in realtà non è così. Possiamo scoprire la celiachia a 30, 50, 70 anni. Quindi non possiamo dire più che è una malattia pediatrica. Come si manifesta? Nei bambini ci sono tanti disturbi intestinali e comunque c’è un arresto della crescita, l’addome globoso, le afte ricorrenti alla bocca e qualcuno ha l’alopecia, mentre negli adulti i sintomi sono più extra intestinali, quindi stanchezza cronica, anche depressione, ci possono essere anche problemi intestinali ma possono anche non esserci sintomi, come già evidenziato.
La terapia per la celiachia è la dieta senza glutine, rigorosa e permanente. Quindi il ristoratore può essere il nostro medico. Anche perché una dieta fatta male o una diagnosi tardiva comporta danni fino a un linfoma intestinale.
Ma focalizziamoci sul glutine. Cos’è? È una sostanza lipoproteica che noi troviamo in tantissimi cereali comuni nella nostra dieta che possiamo trovare come ingrediente o per contaminazione nei prodotti. Però esistono anche prodotti che sono senza glutine. Abbiamo degli alimenti permessi, degli alimenti a rischio e degli alimenti vietati. Gli alimenti vietati sono, grano, orzo, segale, avena in chicchi, farro, Kamut, spelta, triticale… contengono tutti glutine. Poi abbia-
mo una serie di alimenti permessi, quindi riso, mais, grano saraceno, miglio, amaranto, quinoa, sorgo, frutta, verdura, carne, pesce, uova e legumi. Altri alimenti che seppur trasformati vanno bene, come ad esempio l’olio, la passata di pomodoro, i formaggi tradizionali, le bevande gassate. E poi c’è la grande categoria degli alimenti a rischio che sono quelli più pericolosi, quelli che possono contenere glutine per ingredientistica o per contaminazione nel processo produttivo. E allora come facciamo con questi? Dobbiamo ricercare la scritta, il claim senza glutine. Non basta vedere che tra gli ingredienti non ci sia l’allergene glutine, dobbiamo ricercare la scritta “senza glutine” normata dal regolamento europeo 828 del 2014, che obbliga l’azienda a scrivere senza glutine, per garantire che nel prodotto il glutine sia sotto le venti parti per milione considerando anche la contaminazione.
Per noi di AIC ogni momento è un pretesto per fare formazione, informazione e sensibilizzazione.
“Oggi siamo stati invitati perché c’è comunque un accordo nazionale: un protocollo d’intesa è stato siglato a livello nazionale tra AIC e FIPE. Entrambi abbiamo capito che bisogna collaborare. Dobbiamo collaborare perché noi abbiamo la conoscenza e l’entusiasmo. FIPE ha il collegamento con i ristoratori, persone che magari vogliono mettersi in gioco” conclude.
Passiamo la parola a Daniele Ferretti che rappresenta il Centro Studi di FIPE. FIPE è il più grande sindacato italiano di pubblici esercizi con oltre 328.000 imprese associate tra ristorazione, turismo e intrattenimento, che svolge un ruolo di trait d’union tra i diversi attori del mercato e della società.
“La ristorazione è un compagno quotidiano della vita delle persone. Ce lo dicono i 96 miliardi di euro di consumi e rispetto ai consumi alimentari la ristorazione cresce molto di più dei consumi alimentari domestici. Quindi non si può chiudere gli occhi di fronte a un tema importante come questo. La ristorazione che fa dell’ospitalità e dell’accoglienza uno dei suoi pilastri non può non dimenticare questo aspetto importante. C’è da dire che oggi noi registriamo una crescita di consapevolezza e di attenzione rispetto a questi temi da parte della ristorazione. Questo protocollo che abbiamo siglato l’anno scorso a livello nazionale va nella direzione di potenziare gli strumenti che noi mettiamo a disposizione delle imprese, grazie appunto ad AIC e alle sue tante iniziative. Dal lato delle imprese poi c’è sicuramente anche un tema economico che non si può sottovalutare perché questo è un target di mercato potenziale, perché noi parliamo appunto di 600.000 persone, ipotizziamo, che vanno al ristorante, che fanno colazione al bar, che probabilmente non vanno da sole. C’è anche un discorso im-
prenditoriale di business che non può essere dimenticato. A questo proposito bisogna dire che quello della celiachia è uno di quei temi su cui girano anche tante fake news. Fra queste c’è l’idea che attrezzarsi per una ristorazione inclusiva e accessibile alle persone celiache sia un costo. C’è sicuramente magari un investimento di competenze, di formazione, ma questo non significa stravolgere un locale. Anche in questo senso il nostro obiettivo è quello di rafforzare, creare più consapevolezza, dare nuovi strumenti e nozioni alle nostre imprese associate”.
Ora la parola a Moreno Cedroni, chef patron de La Madonnina del Pescatore ma non solo e presidente regionale della FIPE:
“Io voglio tranquillizzare tutti, perché facendo la tara di alcuni nostri colleghi insensibili e ignoranti, perché ignorano, dal 2014 c’è la Legge sugli allergeni che mette il glutine al primo posto e prevede che in ogni pubblico esercizio ci sia un OSA, l’operatore del servizio alimentare, cioè è il responsabile di quel luogo, quindi il responsabile di quel ristorante, il responsabile di quel baretto sul mare, il responsabile di quell’agriturismo non so dove. Allora, se l’OSA commette qualche infrazione è punito penalmente. Questa stessa legge prevede anche che ogni operatore, ogni licenza, ognuno di noi ristoratori, pizzerie debbano dichiarare gli allergeni, la lista degli allergeni. Non è così leggera la cosa ed è molto molto sentita, quindi se poi capita quel chiamiamolo “collega” che ignora evidentemente in quel posto non ci torniamo più ma, se già all’atto della prenotazione se ci fa problemi in quel posto non ci andiamo proprio. Il sistema di prenotazioni nei miei locali è basato proprio sul dichiarare che intolleranze si hanno, su cosa non si possa mangiare, a qualsiasi livello. Devo dire comunque che ,nel corso degli anni, gli ingredienti che si acquistano sono migliorati tantissimo. La mia volontà di approfondire questa cosa, oltre che per serietà professionale, c’è anche perché è un problema di cui ho sentito il bisogno di lavorarci naturalmente. Il primo pane l’ho fatto vent’anni fa. Preparare, ad esempio, salse che non abbiano questo ingrediente e dare lo stesso sapore mi sembra una grandissima sfida. In una piramide c’è la punta e poi ci sono le parti più basse. Quindi spetta a FIPE sensibilizzare, tutta la scala. Già l’accordo fatto con FIPE a caduta andrà sui singoli esercenti, quindi è tantissimo, è qualcosa di epocale.Naturalmente se c’è qualche deriva l’andremo a togliere e o lo sensibilizzeremo, però se uno non vuole essere sensibilizzato e vuole rimanere tutta la vita ignorante nel senso che ignora, noi che dobbiamo fare? Noi ci proviamo. Ho visto il vostro vademecum: contiene i passaggi che noi seguiamo quando le ricette no glutine. È quello lì,
passo dopo passo, perché poi l’HACCP consiste proprio nello scrivere, passo dopo passo, quello che fai”. E, sul finale, lo scambio fra Laura Diokovich e Moreno Cedroni.
Laura Diocovich: “Noi abbiamo un programma, il programma Alimentazione Fuori Casa, che prevede corso di formazione teorico e pratico, una consulenza successiva, quindi siamo noi come associazione che veniamo nel vostro ristorante per darvi una mano, come degli angeli custodi. Non siamo dei NAS, non siamo dei consulenti HACCP e veniamo lì per vedere se la vostra cucina, se come vi siete sistemati per il senza glutine va bene, può essere migliorato, diamo dei consigli. Segue poi la firma di un protocollo d’intesa, dove il ristoratore si impegna a garantire che farà dei piatti senza glutine e che riceverà dei controlli. E anche qui i controlli non sono dei NAS, noi veniamo lì e controlliamo le materie prime. Perché? Perché il problema del senza glutine non è tanto cambiare il mix di farina, non è questo, ma è sapere che ci sono degli ingredienti a rischio. Da parte nostra c’è poi la comunicazione a tutti i soci che quel ristorante fa senza glutine con AFC. Il gluten-free dipende come viene fatto”.
Moreno Cedroni ribatte: “La questione della celiachia è già normata. Quindi voi potete dare indicazioni supplementari, e va benissimo, però è regolamentata la cosa”.
Stiamo parlando di una questione di vitale importanza. Non si può scherzare.

Autrice: Marina Caccialanza
Un’intuizione, la voglia di fare qualcosa di nuovo, la capacità di scavare in profondità per comprendere le ragioni delle proprie scelte e costruire un percorso di crescita professionale e personale
Foto: @aromi group

Questa è Grigoris Pizzeria. Ah già, poi c’è anche una pizza eccellente! Perché frutto di lavoro ponderato e meticoloso, di strategia e coraggio, ricerca e impegno.
Cominciamo dal nome. Da qui si intuisce il carattere vulcanico ed estroverso di Lello Ravagnan: “Amo la Grecia che ho cominciato a frequentare nell’82. Nell’87 volevo rilevare una pizzeria sull’isola di Patmos; il proprietario, tale Grigoris, sindaco dell’isola, voleva vendere ma al momento di concludere l’affare saltò fuori che non aveva informato della vendita sua moglie, la quale si oppose, e saltò tutto. Quando abbiamo aperto la nostra pizzeria a Mestre, per il nome da darle pensai ‘chiamiamola Grigoris, potrebbe essere di buon auspicio’, e così fu”.
Una storia di vita
La storia di Ruggero Lello Ravagnan comincia in una birreria tra gli anni ottanta e novanta. Poi la pizzeria: “Per caso, perché c’era l’occasione. Sono quelle scelte che si fanno d’istinto quando si è giovani, senza pensarci troppo. Il locale lavorava bene, un luogo come tanti con una pizza convenzionale e stanClicca e leggi l’articolo sul web

dardizzata, una clientela costante: un successo basato più sulla simpatia che sulla qualità del prodotto. Intorno al 2007-2008 in Italia cominciava quella trasformazione del mondo pizza che poi negli anni successivi ha rivoluzionato il settore. Per farla breve, insieme a mia moglie Pina, decidiamo di guardare oltre e cominciamo ad approfondire la conoscenza dei fornitori, dei produttori, a scegliere le farine in base alla qualità, non solo per comodità. E scopriamo un mondo! E, prima di tutto, cominciamo a lavorare con la pasta madre. Una rivoluzione”. Comincia qui la vera trasformazione di Grigoris Pizzeria, un’evoluzione che arriva ai giorni nostri densa di attività di ricerca, di voglia di scoprire nuovi modi di fare la pizza scegliendo materie prime e ingredienti di alta qualità, di nicchia, tali da arricchire impasti e lavorazioni e definire uno stile, elevare un prodotto apparentemente semplice come la pizza a specialità.
“Ogni settimana – racconta Lello Ravagnan – mia moglie ed io portavamo un piccolo cambiamento al locale, andavamo alla scoperta di nuovi produttori, aggiungevamo un piccolo investimento, per far crescere l’attività e al tempo stesso coltivare la nostra crescita personale. Oggi posso affermare che siamo stati bravi, bravi e intelligenti: nella vita ci sono dei cicli, a volte finiscono, ma è importante sapersi guardare dentro e ritrovarsi, ricominciare ogni volta e rigenerarsi. Siamo sempre alla ricerca di ispirazione, anche oggi”.
Ed è così che Lello e Pina, senza l’aiuto di esperti, iniziano a studiare, ad approfondire la loro cultura gastronomica: qual è il miglior pomodoro, da dove viene il fior di latte… Girano l’Italia, poco alla volta, e incontrano produttori, artigiani: “Da lì si è aperto un mondo – afferma Lello - abbiamo cominciato a conoscere persone, a conoscere e riconoscere la qualità del prodotto, ma soprattutto a
vivere i rapporti umani”. Incontrano realtà come Slow Food, imparano ad apprezzare prodotti di nicchia come la salsiccia rossa di Calstelpoto (salume tipico del Sannio, rosso intenso grazie al peperoncino n.d.r.), le alici pescate nel golfo di Catania, dotate di maglia sottilissima e per questo dolcissime. “Il rapporto umano è enorme –dichiara Ravagnan – e succede che ci si ritrova coinvolti grazie al passaparola. Una sera entra in pizzeria una persona e ci invita a Identità Golose. Non sapevamo neppure cosa fosse, era il 2011, e da lì abbiamo cominciato a farci conoscere fuori dai confini della nostra Mestre”.
Una storia di crescita ed evoluzione, dunque. Lello Ravagnan incontra lievitisti di valore, pasticceri e panificatori, perché conoscere i segreti degli impasti è fondamentale; gira l’Italia e quando torna a Mestre porta ai suoi collaboratori un bagaglio di conoscenza che trasmette e perfeziona. Arrivano i primi riconoscimenti dal Gambero Rosso.
“Ho sempre trasmesso ai miei collaboratori tutte queste esperienze, queste idee, anche gli errori a volte - racconta Lello - ho avuto sempre uno staff bellissimo, che ci ha aiutato e ci aiuta ancora a progredire; lavorare con la pasta madre ha dato una svolta alla qualità della nostra pizza, ha aggiunto rispetto al prodotto, ha aumentato il senso del nostro lavoro”. Da questa considerazione nasce la Bakery, costola della pizzeria, un bel laboratorio esterno dove si studiano gli impasti e si realizzano nuove proposte. Poco dopo l’apertura però arriva il Covid - una bastonata! – la definisce Lello.
Ma siccome la vita va a cicli, i Ravagnan lo hanno ben capito, ecco che diventa lo stimolo per una nuova crescita.
Chi si ferma è perduto!
“A Pina e a me è sempre piaciuto viaggiare, vedere cose nuove e imparare dalle esperienze – racconta Lello – infatti almeno due o tre volte l’anno giravamo l’Europa e
visitavamo locali, tra questi le bakery hanno sempre trasmesso un grande fascino per noi. Londra, Copenaghen, Stoccolma, Gothenburg, Berlino: sappiamo che pane fanno, ammiriamo l’estetica dei loro negozi”.
In quel periodo fanno la conoscenza di Christian Puglisi, mamma danese e papà siciliano, chef esponente della corrente nordica al Noma e in diversi locali, e della sua bakery, Mirabelle, a Copenaghen. Racconta Lello: “Riusciamo a raggiungere il posto con molte difficoltà, dato il periodo infausto – racconta Lello – ci sediamo al bancone e ci servono una fetta di pane e burro montato: guardo Pina e le dico ‘ma questo pane è pazzesco’…”. Tornato a Mestre raduna i suoi ragazzi e spiega quello che vuole fare: un pane strepitoso anche se ci vorrà del tempo per ottenerlo. E comincia a studiare, dai migliori. Come Carol Choi, newyorkese che col marito Francesco Scarrone ha aperto Rantan, una farm house nelle campagne della Valchiusella. Intanto Pina impara l’arte della pasticceria da Corrado Assenza, da Lucca Cantarin.
“Ci siamo inventati una bakery come nei paesi nordici e avviato il laboratorio di panificazione, perché fosse una cosa nostra, dove poter lavorare e coltivare la passione per la lievitazione. È stata una cosa magica, perché ha portato enormi energie in un momento di chiusura, di panico totale, quando non si sapeva più cosa fare, e nel momento in cui tutti chiudevano noi abbiamo aperto e investito: quando abbiamo visto la coda di gente che aspettava, fuori della porta, per comprare il pane, abbiamo capito di aver avuto un’intuizione geniale”.
Chi semina, raccoglie
Finito il periodo di crisi Lello Ravagnan rinnova tutto, a partire dallo staff: ragazzi giovani e entusiasti, perché la mentalità è cambiata: “Oggi bisogna capire la personalità dei giovani e individuare quelli che rispondono alla tua filosofia e al tuo personaggio, coinvolgerli, offrire loro un’esperienza costruttiva – spiega Ravagnan – ci vuo-
le molta apertura mentale per andare avanti ma è una grande soddisfazione quando ci accorgiamo che abbiamo contribuito alla loro crescita e non importa se poi vanno altrove, noi sappiamo di aver dato loro qualcosa di importante”.
La pizza di Grigoris è il risultato di una ricerca meticolosa ed estenuante, per raggiungere il massimo. “La parte organolettica – spiega Lello – è fondamentale per un’ottima digestione, ma anche un palato differente. Gli ingredienti del topping valorizzano l’impasto. C’è voluto tanto tempo per trovare il giusto equilibrio, la tecnologia ci ha aiutati, l’approccio metodico al lavoro anche: è un lavoro di gruppo”.
È soprattutto un lavoro di testa e di cuore, di ragionamento e passione. Per imparare a creare il proprio prodotto, dall’identità unica.
Via Asseggiano, 147 30174 Chirignago-Zelarino (VE) Tel. 041 915501


Autrice: Simona Vitali

e leggi l’articolo sul web
Sostengo da sempre il valore di certi Centri di formazione professionale (CFP), proprio per le buone idee e l’intraprendenza che li caratterizzano. Fatta questa premessa c’è da dire che il loro essere non vincolati da legacci e legacciuoli statali o ministeriali, che dir si voglia, rappresenta un bel vantaggio rispetto alla gestione di una scuola alberghiera, dove lo spazio di autonomia è limitato e per mandare a segno buone pensate c’è spesso da fare salti mortali. In questi anni ho visto dirigenti di istituti alberghieri illuminati e capaci di correre su un crinale, ossia sul filo estremo delle loro possibilità, e prendersi responsabilità grandi per poter imprimere un segno nei propri istituti. Per questo ho maturato il pensiero che bisognerebbe conferire loro piena autonomia, che possano gestirli come vere e proprie imprese. Detto questo, il mio sguardo rimane ampio su qualunque soggetto si occupi di formazione in materia di accoglienza e cucina, e lo faccia bene, data la grave carenza di personale che attanaglia la ristorazione, a tal punto che sta reclutando anche figure indistinte.
La singolare storia di Accademia Symposium
È di un centro di formazione professionale(CFP), denominato Accademia Symposium, che sorge in un antico convento francescano su di una collinetta nel cuore della Franciacorta, in quel di Rodengo Saiano (BS), che voglio raccontare. Nato dall’incontro di Luca Nobili, già direttore di una scuola professionale di Bergamo, che aveva nel cuore di organizzare corsi di specializzazione in materia agroalimentare in Franciacorta, con Padre Luigi Cavagna per 10 anni assistente ecclesiastico generale per tutte le sedi dell’Università Cattolica del Sacro Cuore. Questi ha accolto di buon grado l’idea e ha pensato come sede di quell’eventuale scuola a quel convento di Saiano che, dopo aver
vissuto tante vite (l’ultima delle quali ospitando per 50 anni la comunità di recupero di Padre Eligio Gelmini), i Frati Minori che ne erano proprietari stavano per vendere. Strappando l’accordo di prendere in gestione la struttura per un triennio, tempo di capire se quel progetto sarebbe riuscito a spiccare il suo volo, i due iniziano a dare forma alla scuola, Accademia Symposium appunto.
È il 2018 quando la Regione li invita a trovare una Fondazione accreditata a cui appoggiarsi, per poter partire con l’IeFP (Istruzione e formazione professionale) secondo il sistema di istruzione regionale.
La scelta cade sulla Fondazione Maddalena di Canossa di Bergamo, che accetta di buon grado, dal momento che gestisce già un CFP a Caravaggio.
A settembre 2018 parte una classe di 16 alunni con due indirizzi: Enogastronomia e Ospitalità alberghiera e Servizi per l’agricoltura e lo sviluppo rurale. Da tre anni a questa parte le richieste sono aumentate, le classi sono diventate due e più corpose.
Ben presto è emersa l’ambizione di dare una concreta e incentivante opportunità a tutti i ragazzi, che comunque si possono fermare alla Qualifica regionale del terzo anno o al Diploma del quarto anno, di accedere alla maturità. “Essendo che il nostro percorso finisce col diploma regionale – ci spiega il direttore, Andrea Nobili - abbiamo chiesto all’istituto di istruzione superiore V. Dandolo di Corsano (BS), che è sia alberghiero che agrario, se, preparati i nostri studenti qui, nella nostra scuola, con i nostri professori ma con l’apporto anche di alcuni dei loro, potessero fargli fare l’esame di maturità presso la loro sede. Questo avrebbe significato poter accedere anche all’ITS, perché prima della riforma del 4+2 occorreva il diploma.
È nata così la collaborazione fra le nostre due scuole. A quel punto quando si è affacciata la possibilità di aderire in modo sperimentale al 4+2, percorso biennale di alta formazione post diploma, è stato più facile dire: ‘facciamolo insieme’.
“C’era desiderio da parte di entrambe le realtà – ci tiene a sottolineare Padre Luigi - di far crescere qualcosa. È stato bello trovarsi subito in sintonia. È chiaro che loro sono un istituto professionale e noi un sistema di formazione professionale, ossia siamo due diversi ordini ma noi siamo fortemente per l’unire e non per il dividere: nella scuola capita che si collabori formalmente ma quando si tratta di fare qualcosa si scappa.
Le cose nascono perché ci sono stati incontri, collaborazione. Di fatto questo ha comportato una triangolazione fra tre realtà: Fondazione Maddalena di Canossa , Istituto di istruzione superiore V.Dandolo (statale) e Fondazione ITS Symposium, che ha sede a Saiano, il cui direttore generale è Luca Notari. Soci fondatori di quest'ultimo sono: Università Cattolica del Sacro Cuore, Comune di Rodengo Saiano, Istituto Agrario Statale V. Dandolo, Azienda Agricola Symposium, Fondazione Maddalena di Canossa. Abbiamo così iniziato questa sperimentazione del 4+2 parallelamente, noi e l’istituto Dandolo, ognuno presso la propria sede. Siamo al secondo anno, quindi siamo al 50% della totalità del percorso. Tutti confluiranno nell’ITS da noi”.
L’offerta formativa
L’Accademia Symposium, che si fonda su un progetto educativo valoriale e si avvale di docenti con esperienza e professionisti, contempla: - due indirizzi di IeFP (Istruzione e formazione pro-




fessionale), sistema di formazione regionale - cinque ITS di Alta specializzazione: Marketing e turismo del vino; Filiere Gastronomiche e processi alimentari; Enologia e viticoltura sostenibili; Sistemi zootecnici e trasformazione agroalimentare; Agricoltura 4.0 e sostenibilità dei sistemi colturali. Attualmente sono 400 gli studenti che popolano l’accademia (circa 200 per IeFP e altrettanti per l’ITS).
L’intero complesso si sviluppa su 10.000 mq e ciascuno spazio, piacevolmente rinnovato ma non stravolto, è ricavato in maniera armonica come se fosse nato per quella funzione e invece, come vedremo meglio, è passata tanta storia dentro questo convento di origini antiche (la chiesa di Santa Maria degli Angeli e il vicino chiostro risalgono al XVI secolo). Oltre ad aule distinte per i due indirizzi, un moderno lab cucina, cucina didattica e bar didattico, zona eventi, palestra ed un paio di saloni conta pure un lab di caseificazione, un lab
di panificazione, un’azienda agricola e, sopraelevata la cascina Frate e sole. Per ultimo citiamo il volutamente dislocato Laboratorio di microvinificazione e cantina sperimentale di Erbusco (BS), vanto dell’Accademia e del Consorzio per la tutela del Franciacorta.
Unire e non dividere
C’è un filo conduttore nelle azioni di rettore e direttore di quest’Accademia ed è la volontà di condividere perché sanno bene che a collaborare si va molto più lontano e si è in pace.
Bello e reciprocamente proficuo il rapporto che hanno costruito con l’IIS Dandolo con cui hanno potuto improntare il 4+2 e di non meno spessore la relazione che stanno costruendo con l’Università Cattolica del Sacro Cuore, per cui – a ben pensare - l’ITS diventa una sorta di competitor. E invece l’ex preside di Agraria di Cremona, Lorenzo Morelli, è stato nominato presidente di Fondazione ITS Symposium e docenti delle due sedi di Piacenza e Cremona vi insegnano. È



inoltre in corso un dialogo per il riconoscimento dei crediti formativi, perché chi intendesse fare l’Università post ITS non parta da zero. Il laboratorio di microvinificazione è stato realizzato con lo stesso criterio. “Ci siamo detti - ci racconta il direttore - facciamolo insieme al Consorzio per la tutela del Franciacorta, insieme alle cantine, per cui un giorno lo usiamo noi e altri tre lo usano loro. Il laboratorio di microvinificazione era un’esigenza del territorio. Le cantine piccole/medio piccole per poter analizzare il loro vino dovevano andare a San Michele all’Adige, partendo dalla Franciacorta, camion refrigerati ecc… Raccolto il loro interesse ci siamo poi chiesti: ‘Lo facciamo a scuola? No, lo facciamo fuori così è più comodo per loro e anche ai nostri ragazzi fa bene uscire. Abbiamo preso un capannone in affitto a Erbusco, dove con il camion si arriva comodi. L’ITS ha bisogno sempre di mettere le mani in pasta dentro l’azienda. Ricavare, dentro il laboratorio di microvinificazione, un’aula da cui vedere tutto il processo produttivo senza il bisogno di proiettare una slide è tanto. Con questa iniziativa più obiettivi sono andati a segno: un laboratorio per noi, un laboratorio per le cantine medio piccole e un rinsaldato rapporto con gli enti del territorio e aziende, che poi sono quelle che assumono i nostri ragazzi”.
Figura di grande rilevanza fra quelle che si sono avvicendate in questo convento è Lodovico Pavoni. Corre l’anno 1841 quando questi acquista il convento. Padre Luigi ci racconta di come questa figura abbia inventato l’oratorio ben prima di Don Bosco. È sua l’idea di radunare in un luogo fanciulli che non hanno la possibilità di andare a scuola. Lui è ritenuto il
pioniere della formazione professionale moderna (“ti affianco un artigiano perché tu impari il lavoro e entri nella società”). Ha fondato i Pavoniani (chiamati anche Artigianelli a Milano, Monza, Trento e Pavia), congregazione religiosa di sacerdoti e laici, che tiene vivi i grandi ideali e la “passione educativa” di colui che è divenuto San Ludovico Pavoni.
“Per uno scherzo provvidenziale - riflette il rettorestiamo portando avanti qualcosa che era nella mente di San Lodovico”.
Scherzo provvidenziale o no qui c’è una realtà che fa presagire di continuare a camminare a passo spedito. Teniamola d’occhio. Ci sorprenderà ancora.

Autore: Guido Parri
www.dogusto.it
I Filetti di Acciughe del Cantabrico DoGusto sono un prodotto di grande pregio, adatto per la ristorazione che desidera affidarsi a prodotti di elevata qualità. I filetti vengono ricavati da acciughe pescate e lavorate a mano nella regione del Mar Cantabrico secondo metodi tradizionali.
La pesca delle acciughe in quest’area, in Cantabria, sulle coste spagnole, si è affermata a cominciare dalla fine dell’800 con l’approdo dei pescatori siciliani che hanno trasferito le proprie conoscenze ai locali contribuendo alla nascita di uno dei prodotti gastronomici più apprezzati al mondo.
Dopo la pesca le acciughe vengono maturate sotto sale; grazie al lungo periodo di riposo a contatto con il sale acquisiscono un sapore unico, raggiungendo un equilibrio perfetto tra sapidità e dolcezza.
Al loro bilanciamento contribuisce anche la successiva conservazione in olio d’oliva, che inizia dopo un’accurata rimozione del sale.
Si tratta di filetti acciughe piuttosto grandi che possono essere serviti tali e quali, oppure utilizzati per guarnire pizze, insalate gourmet e molto altro, conferendo una nota salina unica nel suo genere.
Ma nelle proposte del brand DoGusto ci sono anche i Filetti di Acciughe di Sicilia che vengono lavorati a poche ore dalla cattura e provengono da una pesca tradizionale con la lampara e la rete cianciolo.
Le acciughe vengono pescate durante la notte: nel buio sono attirate dalla luce della lampara e quindi accerchiate con il cianciolo e pescate.
Dopo le accurate fasi di pulizia vengono riposte in alcuni contenitori con sale marino di Trapani o Marsala, dove riposano dai tre ai sei mesi.
Successivamente le acciughe salate e mature vengono
Clicca e leggi l’articolo sul web

avviate alla fase di filettatura e di invasettamento (operazioni eseguite a mano), oliatura e chiusura.
Da questo processo ne deriva un prodotto di altissima qualità da proporre ai propri clienti come antipasto, su crostini al burro o al naturale.
Indicate anche per nobilitare qualsiasi ricetta con sentori di mare equilibrati e autentici.
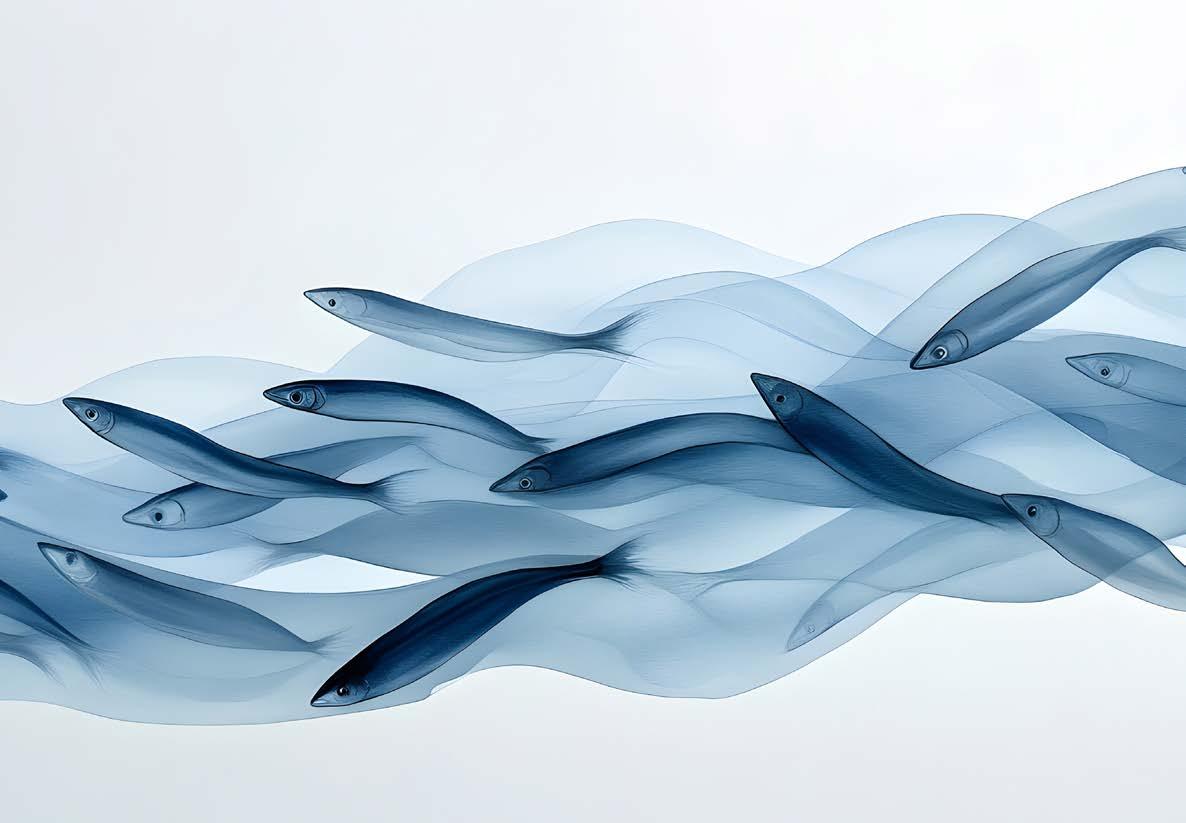






Rocco Cristiano Pozzulo Presidente nazionale FIC
La candidatura della cucina italiana a Patrimonio Immateriale dell’Umanità UNESCO è ormai in dirittura d’arrivo. Il prossimo 10 dicembre, a Nuova Delhi, si voterà in merito a questo importantissimo riconoscimento, che racchiuderebbe in sé molteplici significati, non solo di carattere gastronomico. Sin dal suo annuncio, infatti, avvenuto il 23 marzo 2023, tale candidatura è stata in grado di coinvolgere e trasportare, emotivamente e concretamente, settori fondamentali della vita anche sociale del nostro Paese. A sentirsi chiamate in causa sono state la nostra cultura, la nostra economia, la nostra identità umana e territoriale, abbracciando tutti i livelli delle nostre espressioni culinarie: dalle cucine tradizionali e popolari, regionali e provinciali, alle maggiori evoluzioni gourmet e “stellate”, fino a tematiche più contemporanee, come la biodiversità e la sostenibilità, senza tralasciare infine aspetti sociologici e antropologici, come la convivialità a tavola. Tanti spiriti e innumerevoli volti, insomma, di quella che a livello mondiale è percepita come un’unica grande e secolare tradizione: la cucina italiana!
Numerosi e prestigiosi sono stati giustamente i soggetti scesi in campo per sostenere tale candidatura, a cominciare dalle Istituzioni nazionali, come il MASAF, e naturalmente anche il mondo dei cuochi ha supportato subito la causa. La cucina italiana, infatti, crediamo non possa essere intesa come qualcosa di astratto, ma di vivo e di complesso e prende vita ogni giorno grazie al faticoso, diversificato e affascinante mondo dei cuochi, degli chef, dei ristoratori, oltre a quello delle singole cucine familiari delle nostre case e delle nostre comunità, che mantengono vive tali tradizioni e ne veicolano il messaggio nel tempo e nella storia. Nulla sarebbe la cucina, insomma, se non ci fos-
sero, oltre alle materie prime, i suoi interpreti e i suoi ambasciatori, i suoi narratori e i suoi consumatori. Chi attraverso enti e associazioni, come Federcuochi, ma anche attraverso aziende e imprese, filiere e cooperative agricole, lavora quotidianamente in tale ambito, sa perfettamente quale sia il vero valore della cucina italiana e sa già (non certo per orgoglio o per arroganza) che tale riconoscimento mondiale sarebbe la cosa più naturale. Ad esempio, il successo è decretato annualmente dai milioni di turisti che giungono nel nostro Paese, che lo visitano anche per i nostri piatti e le nostre ricette, di cui serbano un bel ricordo, assieme ai ricordi dei beni culturali, dell’arte, della natura, dei paesaggi… Turisti che scoprono il rito della tavola, la gioia di sedersi ad assaporare piatti fatti di storie e di territori, oltre che di ingredienti, che hanno la capacità di scandire un nuovo ritmo alla propria vita. Il riconoscimento UNESCO, allora, sarebbe un ulteriore tassello prestigiosissimo alla storia già nota della nostra cucina. E aiuterebbe non poco, infine, negli aspetti pratici ed economici: rilanciando il peso dei nostri prodotti sui mercati, spingendo ad una maggiore tutela degli stessi contro la contraffazione, rafforzando ulteriormente il lavoro fondamentale delle certificazioni e delle filiere di qualità. Tutti aspetti che convergono in quel grandioso gioco di squadra condotto fino ad oggi per sostenere la candidatura a un riconoscimento che, ripetiamo, sarebbe più che meritato!





Nella ristorazione di oggi, caratterizzato da incertezza economica, nuove sensibilità valoriali e un consumatore sempre più attento all’esperienza, il momento del pasto fuori casa assume un significato diverso. È uno spazio mentale di decompressione. I clienti cercano un contesto che li affranchi dallo stress e desiderano vivere un’esperienza significativa. La competizione non si gioca più solo sul prodotto ma sulla percezione del valore, le neuroscienze applicate al food service assumono un ruolo centrale. Ogni elemento, dal comfort acustico alla luce, dal servizio alla mise en place, contribuisce a modulare l’esperienza, ma uno degli strumenti più potenti e ancora poco utilizzati è il nome del piatto. I nomi non sono etichette funzionali, sono stimoli che attivano specifiche risposte cerebrali. Quando un cliente apre il menù, vive un momento di sovraccarico informativo. Deve filtrare opzioni, comprendere la proposta, orientarsi verso una decisione in pochi secondi. In questa fase entra in gioco il Sistema Reticolare Attivatore, una rete di neuroni che seleziona ciò che cattura l’attenzione e prepara il cervello a decidere. La Neurovendita, disciplina che interpreta il comportamento del cliente attraverso la neurofisiologia, dimostra che alcune categorie di parole generano una maggiore attivazione neurale perché stimolano immagini, sensazioni e stati emotivi. Parole legate al movimento, alla sensorialità, ai suoni e all’emotività rendono il contenuto più vivace sul piano percettivo, rafforzano la memorizzazione e aumentano la probabilità che il cliente scelga quel piatto.
Questi principi diventano evidenti quando si osservano le differenze nella formulazione di uno stesso piatto. Il passaggio da “Filetto di salmone” a “Salmone affumicato al profumo di cinque legni” trasforma una proposta generica in un racconto sensoriale. Non cambia solo la percezione del gusto, ma la percezione del valore. Allo stesso modo, un “Risotto ai funghi” diventa più attraen-

Lorenzo Dornetti ceo Neurovendita
te come “Risotto cremoso ai porcini”. Un semplice “Pollo alla griglia” acquista identità se presentato come “Pollo grigliato con pelle croccante ed erbe fresche”. Un dessert come “Cheesecake ai frutti rossi” suona diversa nella mente se diventa “Cheesecake soffice ai frutti rossi”.
Lo stesso effetto è evidente sui vini. Un rosso “strutturato” comunica informazioni tecniche, lo stesso vino descritto come “robusto, caldo e aromatico, con un finale che sale”, genera una rappresentazione emotiva. Un bianco “dry” è neutro, se descritto come “fresco, spumeggiante e dalle note fruttate”, acquisisce intensità percettiva. In una carta dei vini, questa differenza incide sulle vendite delle etichette meno conosciute.
La scelta del nome non esaurisce il suo impatto nel menù, la sala è un amplificatore decisivo. Quando chi è in sala utilizza consapevolmente le stesse categorie linguistiche del menù, favorisce un rafforzamento dell’immagine del piatto. Una frase come “le porto il nostro brasato, morbido, caldo, con un profumo che si apre mentre arriva al tavolo” è un’anticipazione sensoriale. Questo tipo di comunicazione allinea linguaggio, aspettativa e percezione, generando una coerenza emotiva che aumenta la soddisfazione del cliente. Per un ristoratore, comprendere questi meccanismi significa acquisire un vantaggio competitivo concreto. Il nome dei piatti aumenta le vendite dei prodotti più marginali, valorizza gli ingredienti meno conosciuti, facilita la rotazione e sostiene la percezione generale di qualità del locale. Il ristorante che costruisce un’esperienza coerente tra ciò che serve e ciò che racconta è quello che rimane nella memoria del cliente, e nella ristorazione contemporanea la memoria del cliente è la base di ogni ritorno, di ogni recensione spontanea e di ogni passaparola autentico.

























Le caratteristiche che rendono le nostre Barbecue le migliori, sono l’equilibrio di ingredienti di primissima qualità ed il gusto ricco ed appagante che sprigionano durante la cottura.
Produciamo sette ricette differenti di Barbecue, più o meno affumicate, di varia aromaticità, più o meno melassate e tutte assolutamente adatte ai professionisti.
Ognuna regala emozioni e può essere associata a tipologia di cottura, carni o ricette differenti.
Top Single Service S.r.l. - Via Casa Bianca, 4 - 26037 San Giovanni in Croce (CR) - ITALY www.topsingleservice.it 7 ricette differenti
Autore: Federico Panetta

Clicca e leggi l’articolo sul web
Nessun piatto racconta la Louisiana come il jambalaya. Nato dall’incontro tra cucine, lingue e popoli, questo riso speziato è più di una ricetta: è una dichiarazione d’identità. A New Orleans, dove l’Africa si è intrecciata con la cultura europea e caraibica, il jambalaya è diventato il simbolo di questo melting pot che proprio nell’incrocio ha trovato la sua essenza.
Le origini di questo piatto risalgono al XVIII secolo, quando gli spagnoli introdussero nel Golfo del Messico una delle espressioni più iconiche della loro cucina, la paella. Poco dopo i francesi, presenti come coloni in Louisiana dalla fine del secolo precedente (il nome Louisiana deriva infatti da Louisiane in onore di Luigi XIV) la rielaborarono con gli ingredienti che quella terra aveva a disposizione. Fu così che al posto dello zafferano arrivarono il pomodoro e le spezie locali, il riso si unì a salsiccia affumicata, pollo e crostacei: ingredienti poveri ma capaci di reggere lunghe cotture in grandi quantità. Il risultato fu un piatto nuovo, nato in un territorio già meticcio, in grado di adattarsi a chiunque lo preparasse.
Il jambalaya è, fin dalle origini, un piatto collettivo: si prepara in un’unica pentola, gli ingredienti si
mescolano senza gerarchie e si serve a tutti, nelle case come nelle feste di villaggio. È la rappresentazione gastronomica di un’idea di comunità. Nella Louisiana del Settecento, segnata da colonizzazioni e schiavitù, la cucina era uno dei pochi spazi di dialogo reale. Mettere insieme riso, carne e verdure significava dare forma concreta a un’identità creola, né europea né africana, che si definiva giorno dopo giorno nella vita quotidiana.
Il jambalaya però non si è cristallizzato, ma anzi ha iniziato un lungo viaggio seguendo le trasformazioni della società della Louisiana, fino ai giorni nostri. Quando i coloni francesi lasciarono New Orleans per le vicine campagne del bayou, attratti dai terreni più ampi e dalle possibilità di coltivazione e allevamento, portarono con sé la ricetta che, adattandosi agli ingredienti locali e alla vita rurale, perse il pomodoro e si scurì: nacque così la Cajun jambalaya, più rustica, più terrosa, figlia delle cucine delle campagne.
In città, invece, la Creole jambalaya mantenne un profilo più elegante, con il pomodoro e la ‘trinity’ di cipolla, sedano e peperone, con una base di spezie più aromatica. Due dialetti della stessa lingua, due modi di affermare un’appartenenza.
In Louisiana, cucinare è sempre stato un gesto politico. La cucina creola nasce dall’incontro, seppur forzato (è bene ricordarlo, per non cadere nell’errore di romanticizzare la storia coloniale europea) tra culture diverse e dal bisogno di far convivere mondi che la
storia ha posto uno accanto all’altro. Col tempo di è trasformata in una cucina di sopravvivenza e di orgoglio, che trasforma ingredienti semplici in un linguaggio comune. Nel jambalaya ogni elemento trova il suo spazio: il riso europeo, la salsiccia francese, il peperone americano, le spezie africane. Potrebbe quasi essere definito un piatto inclusivo, che racconta meglio di qualunque discorso cosa significhi vivere in un luogo dove tutto è contaminazione.
Ancora oggi, cucinarlo insieme significa riaffermare quell’identità collettiva. Durante i festival o le grandi riunioni di famiglia, si prepara in pentoloni che possono sfamare decine di persone, spesso all’aperto, mentre qualcuno suona e altri rimestano il contenuto delle casseruole. Ogni mano che entra nella pentola aggiunge una storia. Il jambalaya è un rito di appartenenza, un modo per ricordare che la Louisiana non è mai stata una sola cultura, ma l’intreccio di molte. Questa vitalità si riflette anche nella cultura pop, che ha trasformato il jambalaya in un simbolo riconosciuto ben oltre i confini del Sud. Nel 1952 Hank Williams scrisse Jambalaya (On the Bayou), una canzone che raccontava in poche strofe la gioia semplice della vita sulle rive del Mississippi: balli, pesce fritto e pentole che ribollono. La melodia, diventata una delle più celebri del country americano, ha attraversato decenni e generi, reinterpretata da Jerry Lee Lewis, Dolly Parton e persino dai Carpenters, che ne fecero una hit pop internazionale. Ogni versione, pur diversa, con-


serva lo stesso spirito comunitario del piatto: una festa collettiva che unisce chi canta e chi ascolta.
Anche il cinema e la televisione hanno contribuito a fissarne l’immaginario. In The Princess and the Frog, film Disney del 2009 ambientato a New Orleans, il jambalaya diventa il simbolo visivo della cultura creola: un piatto condiviso, caldo, preparato tra musica e chiacchiere, segno tangibile di una città che sopravvive attraverso la mescolanza. Nella serie Treme di David Simon, ambientata dopo l’uragano Katrina, la sua presenza ricorrente lega la cucina alla ricostruzione identitaria di New Orleans: un atto di resilienza, un modo per ricucire le ferite di una comunità.
A Gonzales, cittadina della Louisiana che si definisce capitale mondiale del jambalaya, il piatto è celebrato ogni anno con un festival che attira cuochi e visitatori
da tutto il Sud. Tra musica zydeco e profumi di pepe, si gareggia a colpi di mestoli per ottenere il titolo di miglior jambalaya: non tanto una sfida gastronomica, quanto un gesto di appartenenza collettiva. Il segreto del fascino di questo piatto è la capacità di essere sempre attuale. Pur cambiando ingredienti, proporzioni e cotture, resta intatto il principio originario: in una sola pentola può coesistere tutto. È una lezione di cucina, ma anche di tolleranza. In fondo, il jambalaya è il ritratto di una cultura che non teme la contaminazione. Ogni cucchiaiata racconta il viaggio di chi è arrivato a New Orleans e ha saputo mescolare ciò che aveva fino a creare qualcosa di unico. Un piatto nato dall’incontro e diventato identità: il sapore della Louisiana in una pentola che non smette mai di bollire.
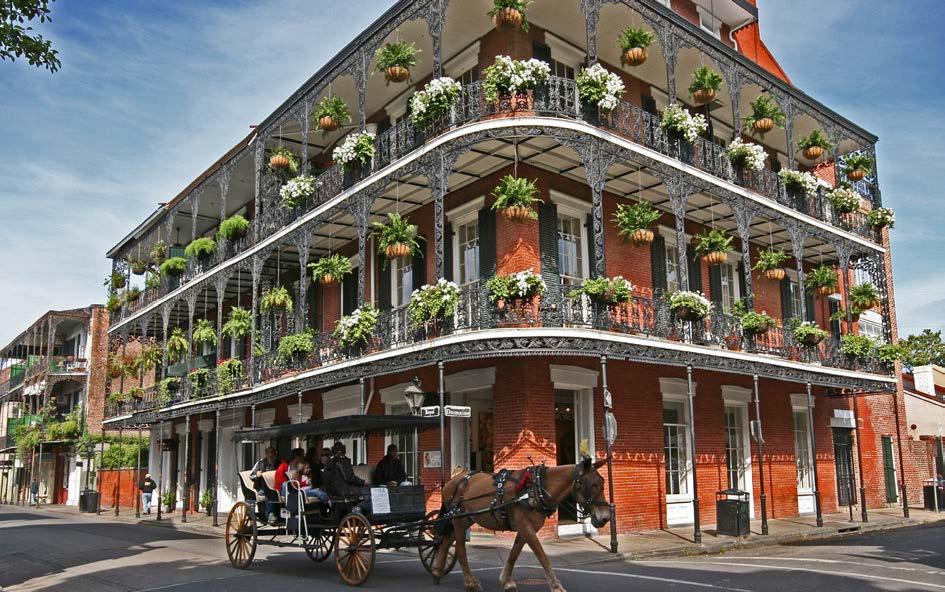


Autrice: Alessia Cipolla
Un personaggio tanto grandioso quanto dimenticato, dove il termine “eclettico” ha le sue sembianze: Maffioli fu un maestro elementare attento agli emarginati, giornalista, autore televisivo e radiofonico, drammaturgo, regista teatrale, attore e, soprattutto, un gastronomo e uno storico della cucina colto e attento alle fonti. Non sempre in questo ordine. Ma fu anche un grande cuoco e il consulente gastronomico per il capolavoro La grande abbuffata di Marco Ferreri.
Capita, talvolta, che gli uomini più illuminati vengano dimenticati. Era avanti decenni Giuseppe “Bepo” Maffioli (Padova 1925 - Treviso 1985): prima di Slowfood e di altre forme di salvaguardia del patrimonio gastronomico, puntò a tutelare le tradizioni alimentari del tessuto sociale veneto, facendo scoprire i prodotti locali in un legame reciproco tra storia, territorio, cultura e cucina, contro l’industrializzazione e l’appiattimento gustativo e culturale “moderni”.
Viaggiò molto a ciaccia di nuovi gusti e sapori, da gran curioso, dando pari dignità alla cucina delle cuoche di casa, di osteria e di grandi ristoranti in un atteggiamento aperto e cosmopolita. Era un colto gourmet dal phisique du role, ma anche un grande cuoco e generoso anfitrione che metteva a tavola, nella sua casa di Dosson di Casier (TV), democraticamente e senza differenze, tutti coloro che varcavano la soglia della sua cucina.
Poliedrico, irrequieto e dal carattere non certo accomodante, si dedicò anche alla sperimentazione,
Giuseppe Maffioli


in “guerra” contro il sistema. Era omosessuale, cosa non semplice nell’Italia e nella Treviso del periodo. Chissà per quale di questi motivi lo si è dimenticato: la verità è che non ci sono scuse.
Vi è l’Archivio Maffioli a Caerano di San Marco (TV) e gli sono stati dedicati l’Istituto Alberghiero I.P.S.S.E.O.A. di Castelfranco Veneto (TV) e il teatro a Caerano di San Marco. Oggi, finalmente, un Premio di teatro porta il suo nome e in occasione del centenario della nascita di Maffioli (1925-2025), sono nate una serie di iniziative organizzate per celebrarlo con il titolo Maffiolicento. Forse qualcosa si muove.
Dalle aule scolastiche al cinema
Si trasferì a Treviso nel 1931 con la madre, dopo la separazione dei genitori. Divenne maestro elementare, professione che svolse per tutta la vita. Due le sue grandi passioni: il teatro e la gastronomia, quest’ultima un’eredità avuta dalla gustosa cucina di casa. A 17 anni esordì come autore teatrale ne l’opera I santi cantano. Seguirono altri successi come autore di radiodrammi per la radio e regista teatrale, firmando circa 80 regie dirigendo nomi illustri del teatro come Lino Toffolo, Tino Carraro, Cesco Baseggio e Toni Barpi.
Ma il suo talento non si limitò al teatro, diventando un attore caratterista per il cinema e la televisione, partecipando a oltre trenta film. Collaborò con registi importanti, ad esempio, nelle vesti di Nicola Parigi, il rancoroso mutilato di guerra ne Il commissario Pepe (1969) di Ettore Scola e ne Il bestione (1974) di Sergio Corbucci, interpretando il camionista veneto Supershell.
Fu un immenso chef e consulente gastronomico de La grande abbuffata (1973) di Marco Ferreri, cucinando i piatti iconici dal rognone alla bourguignonne, le crêpes al Grand Marnier, il purè di patate “medicamentoso” a basso contenuto di burro, il paté di carne composto da pollo al curry, anatra al Porto, oca allo Champagne fino alla bavarese alle fragole a forma di seno femminile con
tanto di capezzolo, consumati dai quattro protagonisti Ugo Tognazzi, Marcello Mastroianni, Philippe Noiret e Michel Piccoli, fino a morirne.
Maffioli fu delegato dell’Accademia Italiana della Cucina a partire dal 1960 e collaborò con la rivista La cucina italiana fino al 1984. Nel 1974 fondò, insieme all’ex suo alunno elementare, divenuto amico, Annibale Toffolo, la rivista enogastronomica Vin Veneto, divenuta poi Taste Vin
Scrisse alcuni dei testi fondamentali della storia della cucina come Il romanzo della grande cucina (1965) e la Storia piacevole della gastronomia (1976) ma anche particolari come La cucina per amore (1970) libro di ricette afrodisiache e I cinque libri di cucina (1976) opera per bambini con ricette in filastrocche, da pedagogo sui generis.
Fu l’autore dei libri alla base della cucina veneta che raccontano con passione e intelligenza la vita, i sapori e le storie della sua terra, tra i quali Il ghiottone veneto (1968) e il trittico La cucina padovana (1981), La cucina veneziana (1982) e La cucina trevigiana (1983): quest’ultimo celebra la Marca trevigiana, un territorio noto come Marca gioiosa et amorosa, che era gastronomicamente, allora, tra i primi posti in Italia. È un ricettario storico-gastronomico che racconta di tipicità e di territorio unendo cucina d’élite e popolare, come testimonianza della storia e delle ricette della cucina della terraferma veneta.
La sopa coada, ad esempio, è un piatto-simbolo del trevigiano: Maffioli ne ipotizza una parentela con la zuppa gallurese sarda. Si tratta di un ghiotto pasticcio di piccioni (o colombini novelli, in alternativa pollo o cappone), servito come piatto unico in occasioni particolari, fatto di strati di pane raffermo tagliato a fette spesse circa un centimetro, polpa di piccione disossata e cotta lentamente in burro, sale e sedano, abbondante formaggio grattugiato e brodo ristretto, filtrato e aggiunto regolarmente
durante la cottura lenta. Il termine coada (covata) si riferisce alla lunghissima cottura fino a 5 ore nei vecchi forni economici, aggiungendo mestolini di brodo ogni venti minuti per assicurare che rimanga morbida. Alla fine, il pasticcio viene servito asciutto, accompagnato da una tazza di brodo ristretto a parte.
Il “tiramesù”
Nel 1981, sul primo numero di Vin Veneto, codificò per la prima volta l’identità storica del tiramisù, riportando la ricetta ufficiale del ristorante Le Beccherie di Treviso, attribuita a Loly Linguanotta e Alba Campeol presente anche nel libro La cucina trevigiana e nominata “Il tiramesù legittimo delle Beccherie” del 1962.
La ricetta originale è condivisa: per alcuni è nata prima in Friuli, per altri a Treviso, ma non è rilevante. La pruderie gastronomica della sua origine, poco probabile, nelle case chiuse, anche. Sta di fatto che, proprio alle Beccherie, alla ricetta di questo tipico e corroborante dolce di casa venne aggiunto il mascarpone che lo rese più stabile e duraturo, adatto quindi alla ristorazione.
Da Treviso si diffuse, poi, velocemente nel resto del Veneto, in Italia e in tutto il mondo, non solo per la bontà e la semplicità di esecuzione, ma perché la godereccia Treviso, proprio in quel periodo, era un interessante centro intellettuale e gastronomico, frequentato da alcuni tra i più grandi personaggi del momento.
La “Marca gioiosa et amorosa”
Erano i tempi della sopressa, dei risotti con l’anguilla del Sile, delle tagliatelle con i fegatini, della zuppa di trippe, della sopa coada, della poénta e osèi, dei bolliti misti con il cren, della faraona in salsa pevarada e dell’oca rosta al sedano, della selvaggina e dei fasioi sofegài. Tra i dolci, vi era la zonclada, un ripieno di formaggio fresco speziato, mele, uvetta e canditi, racchiuso in pasta frolla. Ma Treviso era anche lo scenario di cene memorabili alla presenza, oltre a Maffioli, solo per citarne alcuni, dello storico Giuseppe Mazzotti, del conte Nuvoletti, grande gastronomo e a lungo presidente dell’Accademia italiana della cucina come il giornalista milanese Orio Vergani, del soprano Toti Dal Monte, del grande poeta Andrea Zanzotto e degli scrittori Giovanni Comisso e Goffredo Parise, il geniale e irriverente giornalista Sergio Saviane, magari riuniti “Da Lino” a Pieve di Soligo, “Da Gigetto” a Miane, o a “El Toulà” di Alfredo Beltrame. C’erano anche “Carletto” una delle migliori paste e fasioj delle Tre Venezie, “Alle Beccherie”, “Gambrinus”, “L’Oca Bianca”, “Al Cacciatore” di Roncade e Giancarlo Pasin de “ Alla Pasina” dove Maffioli era di casa. Molti cuochi, spesso amici, si ricordano le visite di Maffioli in cucina, appena arrivato, ad assaggiare direttamente dalla pentola. A Treviso venne, poi, organizzato il primo festival di cucina in Italia, il Festival della Cucina Trevigiana nel
1959. De Poli (allora assessore alla cultura di Treviso) parlò dell’idea a Giuseppe Maffioli e, insieme, coinvolsero Giuseppe Mazzotti allora Direttore dell’Ente Provinciale del Turismo. L’obiettivo era contrastare l’invasione di creme e besciamelle e valorizzare il gusto semplice ma gustoso della cucina contadina.
Il successo fu straordinario. Nonostante le difficoltà, l’evento si affermò subito a livello nazionale, interessando le più prestigiose testate giornalistiche come il Corriere, il Giorno, la Stampa e il Messaggero, portando la gastronomia trevigiana all’attenzione nazionale.
Un mondo scomparso?
L’eredità di quello straordinario periodo non è stata colta. Si è forse persa, schiacciata dal globalismo, come dappertutto. Ma cosa resta del Maffioli e dei suoi insegnamenti?
Questo: un gruppo di amici attorno a un’antica tavola in legno, imbandita di cose buone, cucinate con cura e amore secondo le sue indicazioni, in una casa affacciata sul fiume Sile, piena di fascino e di libri, dove Bepi, un altro Bepi, dal cuore e dalla cucina generosi, ci legge qualche pagina de La cucina trevigiana e noi in silenzio, ascoltando di aneddoti, luoghi, personaggi e osterie ma soprattutto di cucine, oggi, purtroppo, solo un vago ricordo. Ma finché ci saranno tavole così, i Maffioli di tutto il mondo vinceranno sempre.
Perché la cucina non va solo studiata e salvaguardata, ma vissuta, con gli altri. A tavola.
Testi suggeriti:
-Maffioli G., La cucina trevigiana, 1983, Muzio editore
-Barbanti G. e Cuk A., Giuseppe Maffioli. Uomo di spettacolo, 2025, Ronzani editore
-Vianello C., Giuseppe Maffioli. Opere, ricette e viaggi di un gastronomo eclettico, 2025, Ronzani editore
Per maggiori informazioni su Maffiolicento www.maffiolicento.it/
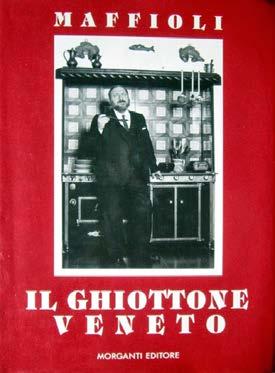
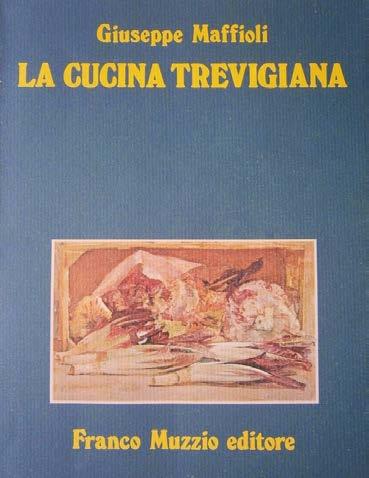


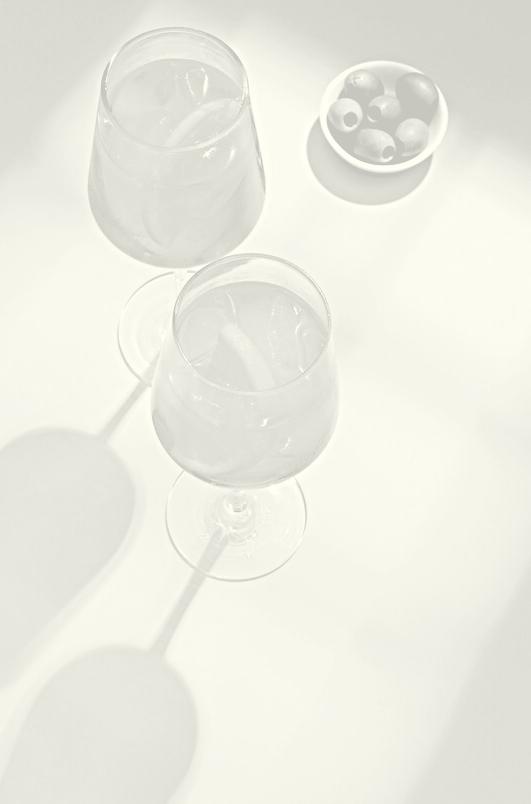

Autrice: Giulia Zampieri

e leggi l’articolo sul web
www.stefanoamerighi.it
Qualcuno, a un tavolo di degustazione, il mese scorso, mi diceva che se c’è dell’umanità dietro a un vino quell’umanità, nel vino, si sente. Non c’è nulla di scientifico in questa considerazione; nulla di misurabile, niente da annotare in una scheda tecnica.
È un pensiero che potrebbe far inasprire la lettura di questo articolo a chi del vino non ama l’approccio poetico, romantico, ma si concentra preferibilmente su aspetti tecnici.
Ma vale la pena che vi fermiate, perché se c’è un’urgenza - anche nel settore enologico - è quella di non andare avanti per inerzia e di farsi arricchire da ogni pensiero, soprattutto quando diverge dal nostro.
Dopo aver parlato con Stefano Amerighi ci è sembrato chiaro che l’umanità, in un vino, è qualcosa che va oltre l’interpretazione immateriale: è un fattore tangibile, che produce effetti pratici, che diventa conseguenza e opportunità.
L’azione che nasce come reazione
Ci arriviamo piano, a capire questo concetto dell’umanità dentro a un vino, così come ci suggerisce il produttore, Stefano Amerighi. Partiamo raccontando della Cortona aretina e di quando Stefano si è avvicinato al vino, da giovanissimo, come bevitore. Figlio di una famiglia di agricoltori-allevatori avvezzi alle pratiche convenzionali, da attento osservatore ha sviluppato un pensiero critico rispetto a ciò che accadeva un po’ dappertutto in quegli anni, che proviamo a riassumere così: impoverimento del suolo.
“Lo sfruttamento del suolo era una prassi già in corso d’opera a quel tempo. Non trovavo però una risposta soddisfacente nel biologico per come era all’epoca. All’inizio il biologico era più un’espressione ideologica che la garanzia di una produzione di qualità. Il mio orientamento alle pratiche biodinamiche è nato dopo un corso sulla biodinamica. Fui folgorato dal pensiero antroposofico di Steiner e dall’idea che si potesse approcciare alla terra con una visione olistica e non più affidandosi solo a quei parametri che rimbalzavano tra le mura di casa nostra. La terra da quel momento per me non era più solo secca, bagnata, ricca, acida… era qualcosa di molto più complesso!”.
Stefano ci racconta del primo periodo, dello studio, dell’inevitabile scontro generazionale in famiglia. E soprattutto di una presa di consapevolezza. “La mia era un’azione, anzi una reazione, a ciò che non ritenevo giusto. Quella nuova visione approfondita ha condizionato il mio modo di concepire la vigna e poi il vino. Ho lavorato sulla Syrah, che ho scoperto nel Rodano, perché qui in Val di Chiana sta bene, può esprimersi. Ma ho voluto farlo in modo diverso, quindi con fermentazioni spontanee, senza additivi e filtrazioni. Oltre a questo c’è un altro impegno che per me era essenziale: quello della responsabilità sociale, che per noi vale quanto la qualità del vino messo in bottiglia. Questa responsabilità deriva dall’idea che lavorare la terra sia qualcosa che va oltre, raggiunge la sfera della comunità”.
La responsabilità sociale
Abbiamo chiesto a Stefano perché in tanti ambiti si sia arrivati a parlare di sostenibilità sociale e invece, nel mondo del vino, settore che in parte si è fatto portatore di rispettabilissimi valori negli ultimi anni (l’artigianalità, l’associazionismo…) questo argomento riman-

ga ancora defilato. “È una bella domanda e ci penserò. Posso dirti che noi andiamo oltre l’essere produttori, ne facciamo una questione di valore per la collettività. Intendo dire che chi lavora nella mia azienda ha un contratto regolare, non è una presenza stagionale. Abbiamo impostato il rapporto professionale sul rapporto umano, cioè su una dimensione conviviale, autentica, dove c’è qualità nello stare. Vale anche per il rapporto con gli altri interlocutori, ossia i fornitori, i clienti e visitatori, perché questo impiego è una relazione continua e ciascuna merita attenzione.
Oltre a questo, la responsabilità sociale si concretizza anche con l’impegno di rispettare i suoli, le piante e in generale la complessità che abita la natura. Lo facciamo per credo e come gesto per la comunità. Chi produce vino è anche custode, non solo produttore.
Non voglio parlare di etica… ma le aziende, con le loro scelte, hanno un peso reale” ci dice Stefano Amerighi. Una bottiglia per entrare in una carta dei vini dovrebbe essere anzitutto buona, su questo non si discute. Ma la sensazione è che oggi ci sia un eccessivo accento sugli aspetti qualitativi, come parametro di scelta; o meglio, di performance e immagine del vino, in quella che sembra una continua corsa dell’etichetta. Non sono ancora abbastanza le insegne che si interrogano sulla dimensione umana e relazionale che sta dietro alla sagoma di una bottiglia. No, non basta dire: Conosco il produttore, come lavora. È poco interventista. Ha i vigneti orientati a sud. Senti che naso. Quando si millanta di fare ricerca il lavoro dovrebbe raggiungere anche questi temi, sempre più rilevanti se vogliamo immaginare un futuro “più felice”, come ci suggerisce Stefano. Bisognerebbe provare a cambiare il metodo di selezione premiando chi lavora anche per gli altri, oltre che per se stesso.



Non è già tutto scritto
Si può ancora innovare nel mondo del vino?
È la stessa domanda, declinata in ambito culinario, che ultimamente facciamo anche a tanti ristoratori. Scopriamo che molti avvertono il bisogno di tornare indietro, forse perché il serbatoio della creatività e dell’innovazione ha raggiunto alcune derive. Non significa regredire ma piuttosto tornare a una dimensione più umana, accessibile e comprensibile, oltre che economicamente sostenibile. Ed è per questo che a fianco a tante insegne fine dining sono nate trattorie omonime. Questa domanda sull’innovazione l’abbiamo posta anche a Stefano.
“Il nostro è un mondo che ha tantissime capacità ancora inespresse. Siamo passati dal vino-alimento al vino come prodotto edonistico, per poi arrivare al vino ripensato come prodotto naturale, cioè a minore impatto ambientale, ma anche al vino come prodotto che veicola l’espressività del suolo. Oggi è importante interrogarsi su un’altra evoluzione che sta attraversando il vino: l’aggregazione e lo scambio. Stanno cambiando i rapporti nella produzione e nella distribuzione. Bisognerà acquisire velocemente un modo di lavorare che mette in primo piano il futuro. E la monocoltura, intesa anche nel settore vitivinicolo, non è compatibile con il futuro” ci dice Stefano. Abbiamo parlato anche di nuove strategie di distribuzione adottate dai produttori e di piccoli gruppi che lavorano per progetto, come Halarà, un collettivo di vignaioli che insieme alleva e vinifica. Ne fanno parte Francesco De Franco (A Vita, Cirò-Crotone), Corrado Dottori (La Distesa, Cupramontana-Ancona), Giovanni Scarfone (Bonavita, Faro-Messina), Stefano Ame-

righi (Stefano Amerighi, Cortona-Arezzo). Le uve si raccolgono vicino a Contrada Bausa, nel marsalese, come ci raccontava qualche mese fa Nino Barraco in un’intervista.
Stefano è un produttore da andare a trovare. Anche lui, ci racconta, è figlio del viaggio; di quel viaggio che diventa sorgente di idee, relazioni, messe in discussione. “La mia generazione aveva conquistato una grande libertà, quella di poter viaggiare. Per me il Rodano è ancora oggi una seconda casa. In realtà, devo dire, ho iniziato a viaggiare anche stando fermo, da quando le persone hanno cominciato a farci visita. Mi soffermerei sul cambiamento radicale che sta avendo nelle zone rurali, a cui stiamo dando un’importanza nuova… ed è giusto che sia così: la natura è l’ambiente più idoneo all’essere umano. È anche per questo che la campagna è diventata un luogo di viaggio e di scambio, abbandonando la sua veste conservatrice e retrograda. Per me Poggiobello di Farneta è una doppia opportunità: vivo dove ho radici ma godo anche dell’apertura che mi portano le persone”.







Clicca e leggi l’articolo sul web
Autore: Guido Parri
Un lungo percorso fatto di impegno, innovazione e visione: Hospitality – Il Salone dell’Accoglienza, la più completa fiera italiana dedicata all’HoReCa, si prepara a celebrare la 50ª edizione, in programma a Riva del Garda dal 2 al 5 febbraio 2026
Organizzata da Riva del Garda Fierecongressi, la manifestazione si conferma place to be strategico per la filiera dell’ospitalità e della ristorazione, in un momento di grande dinamismo per il settore. Secondo il Rapporto TEHA Group 2025, nel 2024 il comparto ha generato 107,1 miliardi di euro di fatturato, 53,8 miliardi di valore aggiunto e occupa oltre 1,5 milioni di addetti.
“Per Hospitality non significa solo celebrare un traguardo storico, ma riconoscere il percorso di evoluzione costante che ha trasformato questo evento in un punto di riferimento per contenuti, qualità e partecipazione di imprese e operatori internazionali di alto livello. Guardiamo con entusiasmo alla cinquantesima edizione che metterà al centro i temi che stanno ridisegnando il mondo dell’accoglienza, con focus su innovazione, accessibilità e inclusione”, dichiara Alessandra Albarelli, Direttrice Generale di Riva del Garda Fierecongressi
La fiera offre una panoramica completa di soluzioni, tecnologie e tendenze di tutti i segmenti dell’HoReCa in un format ormai consolidato: oltre 45mila mq di spazio espositivo suddivisi in quattro aree tematiche – Beverage, Contract & Wellness, Food & Equipment e Renovation & Tech – e tre aree speciali RPM – Riva Pianeta Mixology, Spazio Vignaiolo e Solobirra, riservate alla mixology, al vino e alla birra artigianale.



Nel dettaglio, le aree Food & Equipment e Beverage ospiteranno aziende, produttori, distributori e fornitori: dalle eccellenze della filiera agroalimentare a nuove proposte gastronomiche, da attrezzature e servizi per le cucine professionali ad elettrodomestici per grandi impianti. “Il mondo del food & beverage è in continua evoluzione e ogni anno in fiera vengono presentate novità e trend capaci di trasformare il modo di fare accoglienza a 360 gradi, interpretando i bisogni e anticipando le esigenze di strutture ricettive, locali, ristoranti e camping – spiega Giovanna Voltolini, Exhibition manager di Hospitality. – È un settore in cui la qualità fa davvero la differenza, frutto di competenze, ricerca costante e lavoro di sperimentazione su materie prime, tecnologie e materiali sempre nuovi”. Anche per questo, al percorso espositivo si affianca la formazione di Hospitality Academy e gli incontri di aggiornamento professionale con il contributo di esperti e associazioni di categoria che si alterneranno sul main stage e sui palchi delle 7 arene tematiche. Tanti gli appuntamenti con alcuni tra i più importanti protagonisti del food and beverage impegnati in show cooking e degustazioni oltre alle masterclass delle aziende. Confermata la collaborazione con FIC-Federazione Italiana Cuochi e Unione Regionale Cuochi Trentino-Alto Adige, con un fitto programma che prevede anche una serie di attività con il coinvolgimento di istituti e scuole alberghieri. Trasversali a tutta la fiera, i temi di inclusione e accessibilità toccano l’area food con concorsi e iniziative promossi da associazioni attive nella valorizzazione delle diversità e delle abilità di ognuno. Attenzione alle particolari esigenze alimentari anche con le attività di AIC – Associazione Italiana Celiachia del Trentino-Alto Adige. Inoltre, sia online che attraverso la app Hospitality Digital Space, sarà possibile selezionare determinate categorie – tra cui Kosher, Halal, Lactose Free, Bio - per identificare gli espositori che offrono prodotti o soluzioni utili a venire incontro a tutte le necessità della propria clientela.
L’impegno di Hospitality per un’ospitalità accessibile e inclusiva ha il suo cuore nel progetto DI OGNUNO, realizzato in collaborazione con Village for All – V4A e Lombardini22, che per l’edizione 2026 accende i riflettori sul turismo open air – campeggi, villaggi turistici, glamping, chalet e suite immerse nella natura – per raccontare come ogni esigenza di accessibilità, sia essa permanente, temporanea o situazionale, possa trasformarsi in libertà grazie a un progetto attento e inclusivo. Con l’installazione “Orizzonti Possibili” il visitatore è invitato a intraprendere un itinerario immersivo che interpreta il viaggio outdoor come metafora della vita e del turismo, dove l’inclusione non è un punto di arrivo, ma un orizzonte sempre aperto e in continua evoluzione e trasformazione. L’obiettivo è quello di offrire spunti concreti per rendere accessibili le strutture, anche con piccoli accorgimenti.
Hospitality 2026 mantiene al centro The People Industry, il concept che ha caratterizzato le ultime edizioni e che pone l’accento non solo sugli operatori del settore HoReCa ma anche su chi lavora perché tutto sia possibile. Per la 50a edizione il claim “Celebrating with you” vuole essere un omaggio a tutti i protagonisti della community, davanti e dietro le quinte, che sono l’essenza della fiera: un luogo in cui relazioni, persone e storie si intrecciano ed evolvono, generando connessioni professionali e personali. “Con questa comunicazione abbiamo voluto valorizzare il lato autentico e umano della macchina organizzativa, fatto di passione, professionalità e dedizione, in cui ciascuno da 50 edizioni contribuisce a far crescere insieme la manifestazione e il settore”, aggiunge Alessandra Albarelli, Direttrice Generale di Riva del Garda Fierecongressi.
Il programma completo è in continuo aggiornamento e consultabile su www.hospitalityriva.it e sulla app Hospitality Digital Space, attraverso la quale è possibile organizzare la propria visita in fiera, pianificando appuntamenti con le aziende espositrici, consultare la mappa interattiva e il catalogo espositori e prodotti.
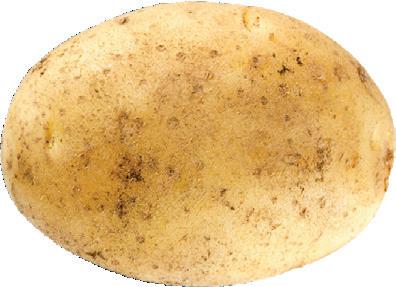
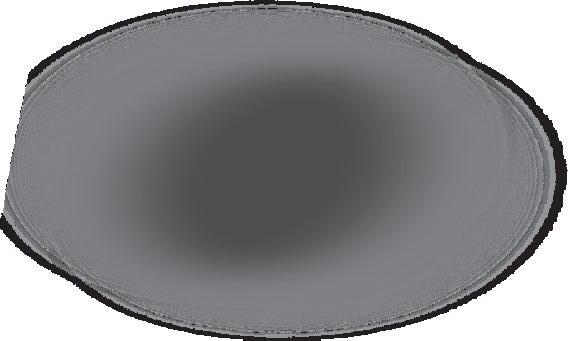

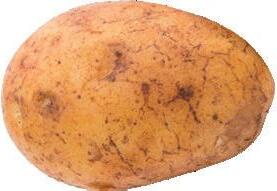
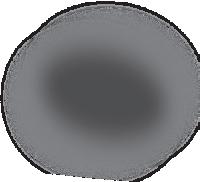
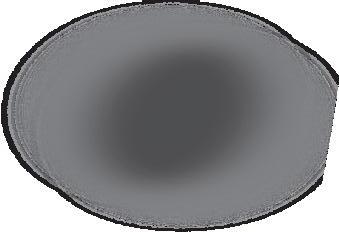
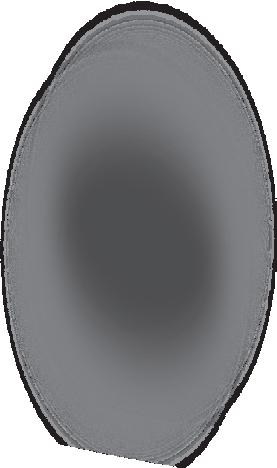
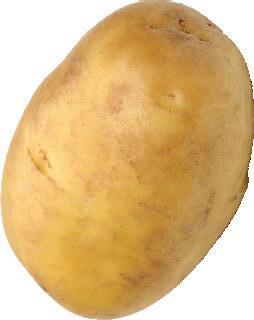
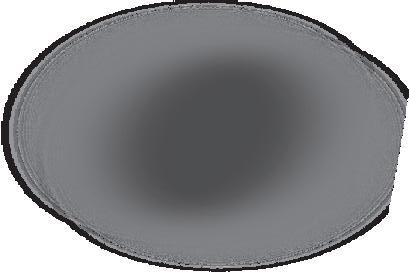

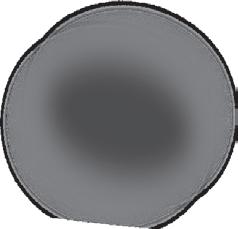
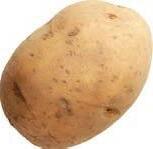
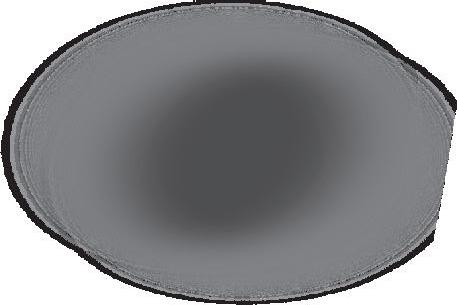

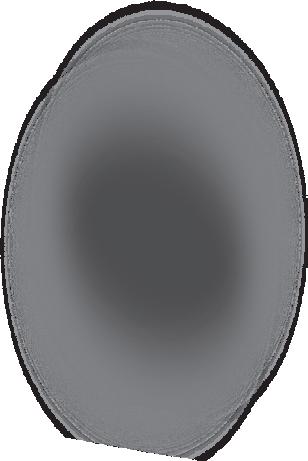
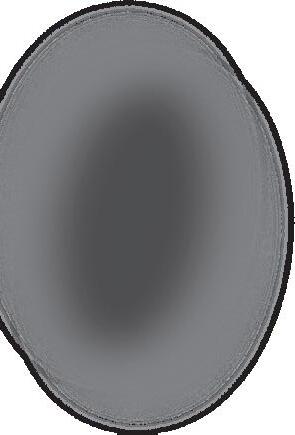
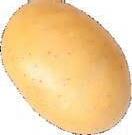
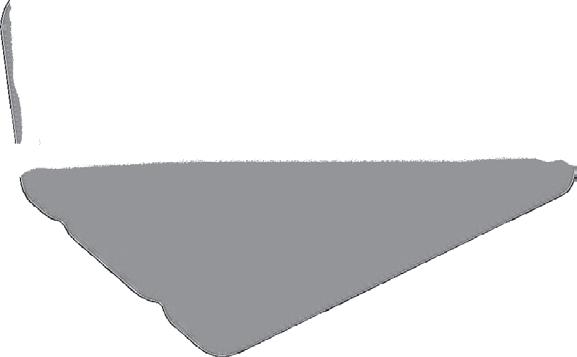

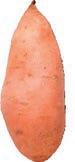
Versatili e nutrienti, si prestano a creazioni che uniscono armonia cromatica, benessere e gusto, valorizzando ogni piatto con una nota calda e contemporanea. Provale al forno, in zuppe e vellutate, in purea. Ottime anche come Dessert!
Una selezione di patate professionali ognuna col proprio utilizzo culinario, per soddisfare ogni esigenza ed arricchire i vostri menù con materie prime dal sapore autentico capaci di esaltare l’essenza delle vostre creazioni. Testate ogni giorno dai nostri chef, garantiscono Gusto costante, piatti sempre perfetti e facili da realizzare. L’intera gamma è stata eletta Prodotto dell’Anno 2025!





















fritte, gnocchi, crocchette, puré, croccanti al forno




16 - 20 Gennaio

Ogni gesto in cucina è precisione, creatività, impegno. Lo sappiamo, perché siamo al fianco, da oltre due secoli, di chi ogni giorno trasforma ingredienti in esperienze.
Da oggi nasce una gamma studiata appositamente per le necessità e le richieste dei professionisti, apponendo la firma Zucchi come sigillo dei nostri valori e della nostra qualità.







L’OLIO AL CENTRO

Luigi Caricato oleologo
Può sembrare paradossale, ma è così. È la burocrazia a spegnere l’identità e le potenzialità espressive di un prodotto di grande valore nutrizionale qual è l’olio extra vergine di oliva. E visto che i burocrati non consentono di poter raccontare liberamente natura e proprietà degli oli, al momento è solo il mondo della ristorazione a poterlo farlo senza impedimenti, sia a parole, in sala, sia con i fatti, in cucina. Un ristoratore lungimirante può prendere l’occasione al balzo per mettere in evidenza il proprio ruolo strategico e farne motivo di orgoglio trasmettendo ai propri clienti il valore degli oli quale peculiarità esclusiva del proprio locale. Ora, lo so, vi chiederete come mai l’olio extra vergine di oliva sia diventato bersaglio prediletto dalla burocrazia. Con la scusa di proteggere e tutelare il prodotto da possibili frodi e truffe (persiste ancora questo tic, di vedere truffe ovunque, anche dove non esistono), chi ha elaborato le leggi per regolamentare il prodotto ha creato regole tanto assurde quanto grottesche, al punto da impedire di fatto una regolare comunicazione del prodotto. Di fatto è vietato riportare in etichetta il profilo sensoriale dell’olio. Chi lo fa, subisce pesanti sanzioni. Si consente tale opzione solo facendo ricorso a un panel di degustatori ufficialmente riconosciuto. Questi tuttavia possono avvalersi di solo tre parole - fruttato, amaro e piccante - indicandone l’intensità, che è, come dire, non comunicare, lasciando chi legge interdetto o indifferente. Che vuol dire evidenziare la sola presenza dell’amaro e del piccante in un olio? Spesso in un consumatore generico sortisce l’effetto contrario: un netto rifiuto. E poi, lo spazio. Il fatto è che di spazi in etichetta non ve ne sono, troppe (e inutili) le diciture obbligatorie da riportare. Come la seguente: “Olio di categoria su-
periore ottenuto direttamente dalle olive e unicamente mediante procedimenti meccanici”. A parte l’eccesso di avverbi, l’insensatezza di questa pletorica dichiarazione rasenta il grottesco e sottintende che il consumatore sia cretino e ignorante. Ma poi, cosa si intende per “categoria superiore”? Con tale definizione qualsiasi extra vergine lo è. Una bottiglia da 4 euro, se non addirittura una a un prezzo inferiore, equivarrebbe in tal modo a una bottiglia di extra vergine da 30 o 50 euro. Sul mercato vi sono in realtà tanti alimenti sulle cui confezioni si legge ormai di tutto, dalla esaltazione delle note sensoriali ai benefici salutistici. Verso l’olio extra vergine di oliva, universalmente riconosciuto quale functional food e nutraceutico, c’è la massima censura, e scattano a non finire le sanzioni da parte degli organismi di controllo. In realtà sia l’Efsa per l’Ue, sia l’Fda per gli Usa hanno introdotto claim salutistici per evidenziarne i benefici apporti alla salute, claim che tuttavia non compaiono se non in rarissimi casi in etichetta, per timori di subire sanzioni. In ogni caso, l’abuso da parte dei burocrati è talmente evidente che supera ogni accettabile limite. Le associazioni di categoria latitano, non svolgono azioni sindacali. A un produttore che pur certifica il proprio olio con la Dop gli è stato impedito di riportare in etichetta i “cru”, attraverso i quali valorizzare in modo più circoscritto l’origine, come fanno da secoli i francesi con i loro vini. Sembra una guerra persa in partenza, e forse lo è, ma non lo è del tutto se si fa fronte comune. La ristorazione può fare la sua parte, raccontando nei dettagli gli oli, dicendo ciò che le etichette non possono dire per via delle assurde e incomprensibili censure. Salviamo l’olio dalla burocrazia. L’olio merita rispetto.





L’esclusività e la garanzia di un salmone a umicato di qualità superiore
Mai congelato, lavorato da fresco, a umicato su legno di faggio.
Senza coloranti e additivi e a basso contenuto di sale.
Novità
Ottobre 2025
Importante riduzione della carne scura, ideale per la ristorazione e l’hotellerie.
Negli ultimi anni, la tecnologia ha iniziato a farsi strada anche tra i tavoli dei ristoranti: il nuovo protagonista infatti è il robot cameriere, capace di trasportare piatti, portare bevande e sbarazzare. Una visione che fino a poco tempo fa sembrava fantascienza oggi è realtà, soprattutto in Asia e negli Stati Uniti, ma sta iniziando a diffondersi anche in Europa e in Italia. La loro adozione non riguarda più solo i locali più moderni. Catene di ristorazione veloce, sushi bar e persino ristoranti tradizionali iniziano a sperimentarli come supporto allo staff umano, soprattutto nei momenti di maggiore affluenza o in aree dove la carenza di personale qualificato è ormai cronica. Negli ultimi anni, infatti, trovare personale di sala è diventato sempre più difficile: turni lunghi, orari serali e condizioni di lavoro impegnative rendono il mestiere meno attrattivo per le nuove generazioni. Molti ristoratori si trovano a gestire organici ridotti o in continuo ricambio. In questo contesto, l’introduzione di robot camerieri non è solo una scelta di modernità, ma una possibile risposta a un’esigenza concreta. Queste macchine non nascono per sostituire l’essere umano, ma per affiancarlo, alleggerendo il carico di lavoro e permettendo al personale di concentrarsi su ciò che fa davvero la differenza: la relazione con il cliente, l’accoglienza, la cura dei dettagli. Anche gli alberghi rappresentano un campo di applicazione particolarmente interessante: durante il servizio delle prime colazioni, soprattutto nelle fasce orarie di punta, quando decine di ospiti si alternano rapidamente ai tavoli e richiedono bevande o piatti contemporaneamente, i robot possono rivelarsi un supporto prezioso. Possono trasportare vassoi, ritirare stoviglie o servire bevande, liberando il personale per dedicarsi all’assistenza diretta e alla gestione del buffet, dove la presenza umana resta insostituibile.
Nei ristoranti fine dining invece, la situazione è diversa.

Qui l’esperienza ruota attorno alla relazione personale e alla narrazione del piatto: il servizio è parte integrante del valore gastronomico e della ritualità del pasto. Inoltre, il fine dining è uno dei pochi segmenti che ancora non soffre in modo acuto la carenza di personale, potendo contare su professionisti motivati e attratti dal prestigio del settore. È probabile, quindi, che proprio in quest’area l’automazione resti marginale ancora per qualche tempo. Negli altri contesti, però, i vantaggi sono tangibili. I robot possono lavorare per ore senza interruzioni, ridurre la fatica dello staff, migliorare la gestione dei turni e contribuire alla sicurezza alimentare, poiché limitano il contatto diretto con i piatti. Inoltre, aiutano a ottimizzare il flusso del servizio e a diminuire gli sprechi di tempo e risorse. Tutto questo si traduce in maggiore efficienza e sostenibilità operativa per il locale.
Naturalmente, la loro introduzione deve essere calibrata con attenzione. Ogni ristorante deve chiedersi che tipo di esperienza vuole offrire: se il valore principale è la velocità e l’efficienza, l’automazione può diventare un segno distintivo; se invece si punta su calore, accoglienza e interazione, il robot dovrà avere un ruolo complementare e discreto. Non si tratta di scegliere tra uomo e macchina, ma di trovare la giusta integrazione tra le due dimensioni.
Il robot cameriere non rappresenta la fine del servizio tradizionale, ma un suo possibile nuovo capitolo. Nei prossimi anni la ristorazione vedrà sempre più spesso una collaborazione tra persone e tecnologie: i robot si occuperanno delle mansioni ripetitive e logistiche, mentre gli esseri umani continueranno a offrire ciò che nessuna macchina può replicare — empatia, racconto e presenza autentica. In un momento storico in cui trovare e trattenere personale qualificato è una delle maggiori sfide del settore, questa alleanza potrebbe rendere il lavoro più sostenibile e, paradossalmente, anche più umano.


Autrice: Ilenia Martinotti

Clicca e leggi l’articolo sul web
Prosciutto
Il 2024 ha segnato un passaggio decisivo per le Indicazioni Geografiche europee. Con il nuovo Regolamento (UE) 2024/1143, il turismo entra ufficialmente tra le funzioni che i Consorzi di tutela possono promuovere e organizzare. Una svolta che riconosce la capacità delle produzioni DOP e IGP di generare valore culturale, economico e sociale anche attraverso l’accoglienza e la narrazione dei territori. C’è un’Italia che non si scopre con le guide turistiche ma con il palato. È l’Italia dei prodotti DOP e IGP, dei luoghi dove la qualità è una tradizione tramandata più che un’etichetta. È qui che nasce il Turismo DOP, una forma di viaggio che non si limita ad assaggiare, ma vuole capire, vivere e condividere il valore profondo del legame tra prodotto e territorio.
Negli ultimi anni, il turismo enogastronomico ha cambiato pelle. Il visitatore non cerca più soltanto un ristorante tipico o una degustazione, ma un’esperienza che racconti identità, saper fare e sostenibilità. Il Turismo DOP risponde a questa evoluzione intrecciando cibo, cultura e paesaggio: un modello che trasforma le produzioni a denominazione d’origine in motore di sviluppo per interi territori. Autenticità, educazione e sostenibilità
Secondo il portale turismodop.it, i tre pilastri di questo fenomeno emergente sono autenticità, educazione e sostenibilità. Autenticità, perché la filiera certificata garantisce che ciò che si vive è vero, locale, legittimo. Educazione, perché dietro ogni formaggio, olio o salume DOP c’è una storia di persone, tecniche e regole che meritano di essere conosciute. Sostenibilità, perché valorizzare la produzione locale significa custodire i paesaggi rurali, promuovere l’economia circolare e mantenere vive le comunità.
Il Turismo DOP non è un turismo di massa, ma un turismo consapevole. Chi lo sceglie vuole entrare in contatto con chi produce, capire come nasce un’eccellenza, scoprire i segreti che si celano dietro un marchio di tutela. È un modo di viaggiare che parla di cultura, etica e responsabilità.
La visione di Mauro Rosati
“L’evoluzione che immagino – spiega Mauro Rosati, direttore di Fondazione Qualivita – è pienamente coerente con le produzioni DOP IGP e con la qualità insita nelle Indicazioni Geografiche. Il turismo deve rimanere un’attività accessoria rispetto a quella agricola e produttiva, integrandosi con essa senza snaturarla. Dobbiamo evitare la deriva “parco Disneyland” e, al contrario, arricchire i contesti produttivi
con spazi di interpretazione, fruizione e accoglienza che consentano di spiegare bene il prodotto e far conoscere la filiera. Solo così i visitatori diventano cittadini più consapevoli. In questo senso, il Turismo DOP è soprattutto un’evoluzione culturale dell’impresa e del pubblico”. In Italia, questo equilibrio si traduce in esperienze che restano legate all’essenza produttiva: visite ai caseifici, passeggiate tra i vigneti, laboratori sensoriali nei frantoi o percorsi nei borghi rurali dove la qualità si tramanda da generazioni. Non un turismo da cartolina, ma un invito a comprendere la cultura materiale che sta dietro ogni prodotto tutelato.
I dati dell’Osservatorio Turismo DOP raccontano un’Italia diffusa: le regioni più attive sono Veneto, Toscana, Emilia-Romagna e Lombardia, con decine di percorsi, eventi e infrastrutture permanenti legate ai prodotti a denominazione d’origine. Nel 2024 sono stati censiti 235 eventi e 188 strutture turistiche stabili – segno che il fenomeno è ormai strutturale.
Dalle Strade del Vino alle Fattorie Didattiche, dai caseifici ai frantoi aperti, fino ai borghi dove un prodotto DOP diventa ambasciatore del territorio: il Turismo DOP è un mosaico di esperienze che parte dal gusto per arrivare alla cultura. Chi visita un caseificio in Pianura Padana, un prosciuttificio in collina o un uliveto affacciato sul lago non è solo un turista, ma un testimone: porta con sé una storia, un profumo, un ricordo.
“Per i Consorzi – sottolinea Rosati – si apre una grande opportunità: governare in modo ordinato e qualificato una dimensione innovativa dell’Indicazione Geografica, collegandola alla sostenibilità e alla promozione. Servono un piano strategico annuale dedicato al turismo, come già avviene per la comunicazione, e regolamenti interni che fissino standard minimi di sicurezza e qualità per l’accoglienza. Il Regolamento (UE) 2024/1143 attribuisce ai Consorzi anche la funzione di organizzare i servizi turistici: non è un’opzione, ma una responsabilità. Inoltre, i Consorzi devono vigilare sull’uso improprio del nome della IG da parte di operatori non appartenenti alla filiera, per prevenire rischi reputazionali”.
Comunicare il valore dell’esperienza
La comunicazione è oggi una leva decisiva. Le esperienze DOP non si limitano più alla visita in azienda: vivono sui social, nei video, nei podcast, nelle piattaforme digitali che consentono di raccontare i territori con linguaggi contemporanei.
“Il Turismo DOP – aggiunge Rosati – racconta un’Italia che coniuga autenticità, conoscenza e responsabilità. Per questo la comunicazione deve valorizzare tre dimensioni: l’autenticità dell’esperienza da garantire, la vocazione educativa (e non meramente commerciale) e l’adozione di criteri di sostenibilità chiari e verificabili. Occorre inoltre allineare le imprese a una comunicazione coerente con il disciplinare di produzione, con il legame geografico al territorio e con i valori della comunità che rende possibile quell’esperienza. Senza una visione condivisa e una narrazione coerente, il turismo enogastronomico rischia di ridursi a un’operazione commerciale, tradendo la vera natura del Turismo DOP”.
Il Turismo DOP è ancora giovane, ma ha già un’identità precisa e un potenziale enorme. Rappresenta la sintesi più alta del “made in Italy autentico”: non un marchio, ma un modo di vivere e raccontare il Paese.
In un’epoca in cui la qualità si confonde con la quantità e la velocità spesso sostituisce la conoscenza, il Turismo DOP ci riporta all’essenza: prendersi il tempo per capire, assaggiare, ascoltare. Perché il vero viaggio – come il vero sapore – nasce solo quando c’è un legame profondo con chi lo custodisce.









Autrice: Marina Caccialanza

Il segreto per produrre salumi di qualità risiede nel saper dare il giusto valore al tempo: passione ed esperienza, insieme, fanno il resto
La produzione del Salumificio F.lli Coati è il risultato di un’esperienza che negli anni è diventata arte. Nato sulle colline della Valpolicella all’inizio del secolo scorso si è sviluppato grazie all’impegno della famiglia Coati che, di generazione in generazione, ha saputo conservare e tramandare un sapere antico oggi perfezionato con tecniche moderne, rispettose dei valori di sostenibilità e qualità della materia prima.
Per la clientela professionale Coati ha studiato una linea dedicata che riassume tutti i requisiti necessari a un utilizzo efficiente, ad alto valore di servizio, e di qualità superiore.
Linea Professional, affettati per gli operatori della tavola
Ci spiega le caratteristiche di questa Linea Professional dedicata al mondo ho.re.ca. Simone Checchi, Direttore Vendite canale Food Service del salumificio F.lli Coati: “La linea Professional è una linea consolidata e che si è evuluta nel tempo aggiungendo referenze e rispondendo in questo modo alle esigenze del mercato. Recentemente abbiamo inserito in gamma due prodotti e due formati, studiati per il mondo ho.re.ca.: la salsiccia piccante e Pancetta Bacon a fette. Sono le referenze più richieste; la salsiccia piccante nel mondo della pizzeria dove viene utilizzata come topping e il bacon nel canale hotellerie, per bar, ristoranti e, soprattutto, per il segmento in rapida espansione del fast food, che ha registrato una crescita significativa negli ultimi anni. Ogni salume di questa linea viene proposto affettato in formato vaschet-
ta, risultato di attenta riflessione e indagine, come conferma Checchi: “La scelta è stata fatta per rispondere alle crescenti esigenze quali: praticità di utilizzo, food cost certo e controllato. Favorisce la riduzione del tempo impiegato in una preparazione, una gestione più snella dei processi, aiuta a ridurre l’errore durante la lavorazione e annulla ogni spreco”.
Le confezioni vengono realizzate in diversi formati e peso; si parte dalle vaschette da 250 grammi fino a formati da 3 kg, molto adatti all’uso professionale e con le stesse caratteristiche dei formati retail.
Per tracciare un’immagine completa di questa linea innovativa del Salumificio F.lli Coati, due parole sulla tecnologia adottata per la produzione, di cui ci parla Andrea Zoli, National Area Manager: “La tecnologia adottata per proporre agli operatori del servizio ho.re.ca. i nostri prodotti professionali in formato vaschetta nasce dalla volontà di offrire un servizio idoneo a gestire al meglio il food cost e l’operato dei collaboratori. La linea di produzione è stata allestita nello stabilimento di Castelnuovo del Garda dove risiede un centro dotato di 5 linee di affettamento con camere bianche in classe 100, quindi perfettamente controllate. Questo ci permette di offrire un servizio in più particolarmente utile a chi ha poco spazio e tempi di operatività molto rapidi, pensiamo a una pizzeria che ha bisogno di alternare in affettatrice prodotti diversi in tempi stretti e non ha il tempo di sanificarla ogni volta. I clienti possono godere del vantaggio di impiegare salumi
già affettati in vaschette di grandi grammature, formato che permette una gestione efficiente delle scorte, riduce i tempi di preparazione e migliora la velocità di servizio, aspetto fondamentale per i fast food ad alto flusso di clienti. Inoltre, il bacon già affettato garantisce qualità uniforme e costante, assicurando piatti veloci ma di alta qualità, perfetti per rispondere alle aspettative dei consumatori più esigenti. Il nostro prodotto affettato non è differente da quello intero da affettare al momento, la sua qualità è intatta, i requisiti di sicurezza igienica adeguati, e siamo determinati a scardinare il pregiudizio comune – superato all’estero ma persistente in Italia –che l’affettato sia qualitativamente inferiore al prodotto da banco”.
Altra novità top di gamma di Coati è l’Arrosto di Tacchino
Alta Qualità Lenta Cottura.
La nuova referenza che utilizza soli petti interi selezionati, si caratterizza per una carne magra, cotta lentamente al vapore, e per una doratura esterna che racchiude la morbidezza e il sapore dell’arrosto. È frutto di una scrupolosa lavorazione artigianale che conferisce al prodotto un aspetto e un sapore inconfondibili, oltre a presentare ottime caratteristiche nutrizionali. Un prodotto unico che unisce gusto, qualità e versatilità.
Elia Mezza, Responsabile Ricerca e Sviluppo, tra gli ideatori di questa referenza, spiega: “L’idea del nostro nuovo prodotto, il tacchino arrosto, nasce dal desiderio di ricreare quello che è il classico arrosto di tacchino come l’abbiamo sempre fatto a casa, portarlo sul banco taglio e quindi offrire una specialità il più vicino possibile a quella che è la produzione domestica. Siamo partiti da questo concetto e per la ricettazione abbiamo utilizzato pezzi interi di origine nazionale; il prodotto viene massaggiato molto delicatamente, chiuso in una rete e poi cotto a bassa temperatura per una quindicina di ore circa con la logica della lenta cottura che caratterizza il catalogo Coati. In seguito subisce una gradevole arrostitura con un piz-

zico di rosmarino. Quello che abbiamo cercato di ricreare è la tecnica utilizzata a casa, nel modo il più semplice possibile, e l’abbiamo adeguata all’operosità della nostra azienda: se mi chiedete se è un prodotto naturale, quindi, rispondo assolutamente sì. È un prodotto da banco sotto tutti gli aspetti che viene venduto intero oppure o a metà. È ideale per l’ho.re.ca”.
L’Arrosto di Tacchino lenta cottura si presta perfettamente a essere utilizzato come elemento di una ricetta più complessa, non solo a essere servito al piatto al naturale. Per questo costituisce un valido supporto al lavoro dei cuochi. “Abbiamo fatto delle prove – afferma Mezza – col contributo di alcuni cuochi per individuare metodi di impiego diversi dalla solita presentazione in tagliere, metodo certo intuitivo ma non necessariamente l’unico. Per esempio in una fetta un po’ più spessa appena saltata in padella rovente, oppure come ingrediente di panini gourmet, cubettato in insalate, e si è rivelato strategico nel menù di un bistrot o di un bar”.
Il prodotto è molto pratico anche per lo stoccaggio in cucina perché il taglio intero, del peso di circa 4 kg, può essere conservato nell’involucro originario per 120 giorni, e una volta aperto conservato in frigo e consumato nell’arco di 4 giorni, un range di tempo che per un’attività di ristorazione rientra perfettamente nel sistema di lavorazione. “Inoltre – precisa Elia Mezza – la ricettazione è stata studiata con l’impiego di sale a ridotto contenuto di sodio in un’ottica di attenzione alla salubrità, aspetto che è molto sentito in azienda”.


Clicca e leggi l’articolo sul web

Ispirare la transizione verso un'alimentazione ricca di vegetali, per il benessere
delle
persone e del pianeta favorendo il lavoro di ristoranti e bar: questa la mission di Bonduelle Food Service
Se pensiamo all’importanza che hanno i vegetali in una cucina professionale, viene spontaneo pensare a Bonduelle che, oggi, è un punto di riferimento con la sua gamma di prodotti studiati apposta per il foodservice, e non solo. Bonduelle Food Service Italia, infatti, è la divisione di Bonduelle Italia dedicata al settore del fuoricasa e fa parte del Gruppo Bonduelle, azienda fondata nel 1853 in Francia, come realtà familiare e diventata in sette generazioni leader mondiale nella produzione di vegetali, con oltre 69.000 ettari di terreno coltivato e prodotti distribuiti in 100 Paesi. In Italia dal 1972, Bonduelle è presente con una filiale e due stabilimenti a San Paolo d’Argon (Bergamo) e a Battipaglia (Salerno), che impiegano circa 400 persone.
Oltre 500 varietà di vegetali coltivati nelle aree geografiche più idonee, raccolte fresche al momento di maturazione per essere lavorate entro le 24 ore e i prodotti conservati utilizzando le migliori tecnologie per preservare al meglio colore, consistenza e nutrienti.
L’azienda persegue il suo obiettivo proponendo a chef e operatori della ristorazione i prodotti vegetali non più solo come contorno, ma come protagonisti al centro del piatto di ricette complete e gustose.
Al servizio della ristorazione
“Tra i nostri obiettivi c’è lo sviluppo continuo del brand, attraverso una strategia che crea valore lungo
tutta la filiera”. Dichiara Matteo Cavallari, Food Service Channel Marketing Manager Bonduelle Food Service. “Puntiamo ad ampliare l’offerta di prodotti ad alto valore aggiunto, pensati per i diversi canali della ristorazione, rafforzando le relazioni con i clienti e costruendo partnership rilevanti. Al centro del nostro percorso c’è l’innovazione: di prodotto e di strumenti a supporto degli operatori del fuori casa, per offrire soluzioni all’avanguardia che rispondano alla crescente domanda di alimentazione vegetale, con i vegetali al centro del piatto”.
“I pilastri su cui poggia la strategia aziendale sono 3: competenza nei vegetali ed eccellenza nella tecnologia alimentare coniugate all’esperienza culinaria. Il primo riguarda la creazione di valore aggiunto per la categoria, trasmettendo conoscenze nel campo dell’agronomia e della nutrizione, rendendo disponibili prodotti coltivati nelle zone geografiche più idonee, raccolti, preparati e conservati con le migliori tecnologie per mantenere inalterata nel tempo la qualità. Il secondo riguarda l’adozione di processi di lavorazione dei vegetali esclusivi e brevettati, per portare reale valore agli operatori”. Conclude Matteo Cavallari.
Del terzo pilastro ci parla Fabrizio Milione, Chef Executive Bonduelle Food Service, e riguarda la comprensione delle esigenze degli operatori della ristorazione. “Attraverso l’osservazione e la collabora-

zione con professionisti provenienti da ristoranti, bar, pizzerie, abbiamo la possibilità di valutare, direttamente con i clienti utilizzatori, offerte di prodotti, innovazioni e servizi che siano una soluzione su misura per i bisogni degli operatori professionali.
Questa conoscenza del mondo culinario trova una sintesi nel progetto Greenology®, l’arte della cucina a base vegetale (https://www.bonduelle-foodservice. it/greenology-scopri). Si tratta di un sistema integrato di prodotti, servizi e strumenti di Bonduelle Food Service dedicato a chef e operatori della ristorazione per scoprire tutte le potenzialità della cucina a base

vegetale e contribuire a definire una proposta alimentare in linea con i mutamenti dei comportamenti della clientela”.
L’offerta di Bonduelle Food Service è suddivisa in due macro categorie, Surgelati e Conserve.
Tra i Surgelati spicca la linea MINUTE®, una gamma completa di verdure, cereali e legumi, ottenuti con la tecnologia brevettata Minute®, un processo esclusivo che unisce la cottura a vapore alla surgelazione rapida individuale (IQF). Le verdure, raccol -

te al giusto grado di maturazione, vengono lavorate entro 24 ore e cotte a vapore ad alta pressione, velocemente raffreddate e infine surgelate una ad una mantenendo ogni ingrediente separato, per un dosaggio pratico e una rigenerazione veloce e uniforme. Un trattamento che assicura affidabilità, massima resa ad ogni utilizzo, senza perdita d’acqua durante la preparazione, preservando al massimo le proprietà organolettiche, nutrizionali ed estetiche.
La linea MINUTE® permette di presentare all’interno dei propri menu una ricca proposta vegetale, pronta in pochi minuti o da utilizzare nella ricettazione direttamente da surgelata, senza dover ricorrere a lavorazioni o attrezzature specifiche, per una cucina più veloce, efficiente e sostenibile.
Oltre a un’ampia gamma di verdure, composta da oltre 20 referenze, fanno parte della linea MINUTE® anche i Cereali e Legumi surgelati Minute® in 5 referenze -Bulgur, Orzo, Quinoa, Lenticchie e Ceci - e i Contorni misti già pronti Minute®
La linea Conserve è composta da un’ampia gamma di verdure e legumi, pensati come arricchitori per insalate o come ingredienti per preparazioni. Grazie a un esclusivo procedimento di cottura al vapore, preservano al meglio le caratteristiche organolettiche e la consistenza propria delle verdure. La conservazione sottovuoto con una ridotta quantità di liquido di governo rende il prodotto subito pronto all’uso senza bisogno di essere sgocciolato.
Bonduelle Food Service ha presentato nel corso del 2025 tre importanti novità:
• Gusti dal mondo, la gamma in cinque referenze pensata per portare in tavola l’emozione di un viaggio

gastronomico tra culture e tradizioni lontane: Contorno Marrakech, Contorno India, Contorno TexMex, Wok China, Wok Indonesia.
• Legumi e Cereali nel nuovo formato Doypack® da 800 grammi, una vera rivoluzione in termini di servizio, disponibili in cinque referenze: Ceci, Fagioli rossi, Grano Saraceno tostato, Mix di Bulgur e Quinoa, Mix di Grano e Quinoa Rossa. Senza bisogno di essere sgocciolati, sono pronti per l’uso.
• Le Arrostite, la linea di patate e verdure selezionate, già lavate, tagliate e arrostite al forno in tre referenze: Patate arrosto, Patate dolci arrosto, Cavolfiori arrosto.
Le Arrostite sono la novità più recente, lanciata a ottobre 2025. Pronte in 10 minuti, sono pensate per portare nei diversi canali della ristorazione la massima praticità senza rinunciare al gusto. Sono ideali per diverse occasioni d’uso, da servire come contorno, aperitivo o da impiegare come ingrediente per ricette creative. Le Arrostite non necessitano di ulteriore lavorazione o di attrezzature e competenze specifiche, hanno un’altissima resa, oltre a garantire un risultato costante, un costo porzione sempre sotto controllo e nessuno spreco. Disponibili in tre referenze – patate arrosto, patate dolci arrosto, cavolfiori arrosto – presentano vantaggi significativi per il ristorante – l’ottimizzazione dei processi in cucina; l’altissima resa, senza nessuno spreco e un costo porzione sempre sotto controllo; il taglio irregolare che fornisce al piatto un aspetto autentico e genuino – e per il bar, ovvero la preparazione del piatto anche in assenza di competenze specifiche; la possibilita di utilizzare anche fornetto elettrico o friggitrice ad aria e la facilità di porzionare il prodotto, utilizzando solo il necessario.


Good Day e Polot 1882 trasformano ogni momento della giornata in un’esperienza di gusto e benessere.
Le farciture in barattolo arricchiscono croissant, pancake e dolci con sapori autentici, mentre le acque aromatizzate offrono freschezza e armonia in ogni sorso. Due linee selezionate da General Fruit per soddisfare ogni esigenza di qualità e piacere, dalla colazione al break.
IDEALI PER UNA PREPARAZIONE FREDDA O CALDA

FARCITURE 1,5 kg (Albicocca - Cioccolato bianco - Crema pasticcera - Fragola - Frutti di bosco - Nocciolata - Pistacchio)
ACQUE AROMATIZZATE 1 L (Bergamotto, Agrumi e Curcuma - Fior di sambuco, Zenzero e Menta Limonata di Sicilia - Limonata di Sicilia e Zenzero - Melagrana e Aloe vera - Tè, Mela e Cannella)
Autore: Guido Parri
Clicca e leggi l’articolo sul web
Questa prestigiosa onorificenza al merito professionale viene rilasciata dalla Federazione Italiana Cuochi agli chef che hanno operato o operano da oltre venticinque (25) anni nell’arte culinaria, onorando sempre e ovunque la tradizione e il prestigio della cucina italiana. L’evento, che si svolge a Roma ogni due anni, vede la partecipazione di oltre 600 cuochi provenienti da ogni regione italiana e da diverse parti del mondo dove la FIC – Federazione Italiana Cuochi ha le sedi. Quest’anno l’evento si è tenuto il 3 novembre al Teatro Ghione di Roma, con la brillante conduzione del giornalista Federico Ruffo (Mi Manda Rai3), alla presenza del ministro delle politiche agricole e della sovranità alimentare Francesco Lollobrigida, e oltre ai cuochi sono stati premiati una decina di giornalisti che, sulle proprie testate, nel corso degli anni, hanno dimostrato vicinanza, sostegno e sensibilità nei confronti dei cuochi italiani e della FIC. Su dieci giornalisti ben due sono di sala&cucina: Luigi Franchi e Simona Vitali, rispettivamente direttore responsabile e redattrice della rivista sala&cucina, magazine di accoglienza e ristorazione. Il presidente nazionale della FIC, Rocco Pozzulo, si è dichiarato onorato, a nome della Federazione, “di iscrivere all’Albo d’Onore e di conferire il riconoscimento del Collare Amici dei Cuochi a Luigi Franchi e Simona Vitali, nel segno di profonda gratitudine per l’impegno, la disponibilità e l’amicizia che hanno sempre manifestato verso la nostra categoria”, con la seguente motivazione: a Luigi Franchi per aver ideato e diretto da dieci anni una rivista che si è sempre distinta nel panorama editoriale italiano di settore per originalità e coerenza di contenuti; a Simona Vitali per l’impegno e la passione con cui porta avanti, sulle pagine di sala&cucina, i temi della formazione dei giovani che scelgono questa professione e gli studi ad essa connessi. Un argomento di cui non si parla quasi mai e che riveste un’importanza fondamentale per il futuro della professione”.


Autore: Luigi Franchi
Clicca e leggi l’articolo sul web
Leggendo lo splendido volume che l’editore L’ippocampo ha dedicato a Franco Pepe attraverso la scrittura sua e di Elisia Menduni, oltre alle testimonianze di Faith Willinger, Nancy Silverton e Daniel Young, mi è tornata in mente la mia prima volta a Caiazzo, nel febbraio 2017, e il mio primo incontro con il pizzaiolo più famoso del mondo. In quel pomeriggio Franco Pepe non mi parlò di sé, ci teneva invece moltissimo a farmi conoscere prima il paesaggio per dimostrare che Caiazzo non aveva nulla da spartire con la vicina Terra dei Fuochi. Mi portò su una collina che dominava tutte quelle sottostanti per dimostrarmi la bellezza dei campi, mantenuta tale dai suoi contadini. Poi mi raccontò di loro appena prima che, quella sera, ci raggiungessero in pizzeria: Domenico Barbiero de La Sbecciatrice, Antonietta Melillo, produttrice della cipolla di Alife, e Mimmo La Vecchia del caseificio Il Casolare erano lì, in rappresentanza della ben più estesa comunità di contadini che Franco Pepe aveva messo in campo. La stima nacque spontanea e perdura tuttora, come quella con il fotografo napoletano, Luciano Furia, che mi accompagnava.
Di sé mi raccontò facendo prima parlare le sue pizze e poi la sua voce, calma, lenta, pacifica. Parole che ho ritrovato, nella loro sostanza, in questo volume che racconta tutta la verità, anche quando è scomoda. Non voglio svelarvi nulla anche se, appassionati di buon cibo e professionisti della ristorazione che mi state leggendo, della storia di Franco Pepe conoscete già le parti essenziali, ma è così intensa e scritta così bene che voglio che vi sorprenda come ha fatto con me.
E poi le foto, oltre ai testi, che Elisia Menduni ci regala in questo libro sono assolutamente emozionanti. È un bel regalo di Natale questo libro, per voi e per le persone a cui volete più bene, fidatevi.
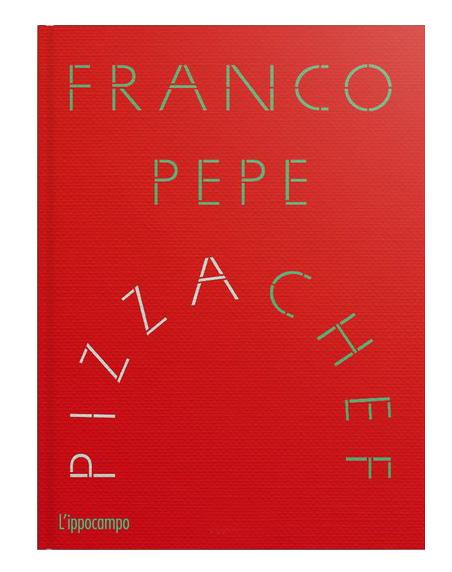
Franco Pepe Pizza Chef
Franco Pepe, Elisia Menduni Editore L’ippocampo Pagg. 240
Euro 29,90 www.ippocampoedizioni.it www.olschki.it

Con oltre 40 anni di esperienza alle spalle, Centro Carni Company di Tombolo (PD) è oggi una delle realtà di riferimento in Italia nella lavorazione e trasformazione della carne bovina, riconosciuta per la costante capacità di innovarsi e distinguersi nel settore.
Dal 2009, grazie al brand Unika, dedicato al Food Service e ai professionisti della carne, l’azienda propone un’ampia selezione di tagli anatomici sottovuoto provenienti da diverse tipologie di bovino — dai pregiati Aberdeen Angus Sired e Scottona fino ai raffinati prodotti dry aged, autentica espressione di gusto e tradizione.
Tra le eccellenze firmate Unika a spiccare di più? La Lombata di scottona di Aberdeen Angus Sired, una vera e propria esperienza sensoriale.
Lombata di angus
Frutto di un’attenta selezione e di un accurato processo di frollatura a secco (dry aging), la carne della
Lombata di Angus Unika viene frollata per circa 14 giorni in celle a temperatura e umidità controllate, dove sviluppa una straordinaria morbidezza e un sapore intenso e persistente.
Questo procedimento, riservato solo alle lombate che rispondono a rigorosi parametri di conformazione e livello di grasso, si fonda — come sottolinea l’azienda — su due elementi chiave: il tempo e l’ambiente giusto, veri segreti di una frollatura d’eccellenza.
Per completare l’esperienza, la Lombata di Angus Unika viene proposta in un’elegante confezione in cartone color legno che ne valorizza l’immagine premium.
La Lombata di Angus Unika rappresenta l’essenza della filosofia di Centro Carni Company: il tempo, la cura e la competenza trasformano ogni taglio in un capolavoro di gusto, dove qualità e tradizione si incontrano per dare vita a un’esperienza unica.
L'ANALISI SENSORIALE
Autrice: Stefania Pompele
Analista sensoriale
O della semantica che descrive il sapore di una lasagna alla bolognese

Savarin - foto di Stefano Caffarri
È forse il termine che più ha caratterizzato l’ultimo decennio gastronomico, ormai persino nell’hamburgeria di quartiere si parla di umami mentre si prepara uno smashburger. Se è vero che anche le parole per raccontare il cibo fanno tendenza, il termine è sicuramente in cima alla lista. Ma non è certo una moda priva di costrutto, tutt’altro. Ciò che definiamo umami rappresenta una delle frontiere più interessanti della scienza gastronomica contemporanea, perché fornisce elementi sui quali costruire la palatabilità di cibi complessi. E se intuitivamente li abbiamo sempre utilizzati, oggi abbiamo anche le conoscenze per comprenderli meglio e quindi governarli.
Uno scienziato, una zuppa e la ricerca del quinto sapore
Il dashi è alla base di molte zuppe giapponesi, un brodo con alga konbu e fiocchi di katsoubushi, pesce essiccato, fermentato ed affumicato. Nel 1908 Kikunae Ikeda, professore di chimica presso l’università Imperiale di Tokyo, teorizzò che il sapore intenso di queste preparazioni dipendesse da sostanze non ascrivibili ai sapori primari già noti, ma derivasse da altri composti. Isolò un sale dell’acido glutammico (MSG) da un concentrato di alghe konbu, individuando in questo composto una qualità gustativa specifica che chiamò umami. Altre classi di composti furono

isolate successivamente, l’inosinato (IMP) abbondante proprio nel katsuobushi, e il guanilato (GMP) presente in alcune varietà di funghi.
La teoria che questi composti generassero uno stimolo con una qualità gustativa propria e che insomma si potesse parlare effettivamente di sapore fu avvallata solo nel 2000, quando furono scoperti recettori specifici sulla membrana gustativa (T1R1/T1R3). Umami, saporito o sapido, sono i termini utilizzati per descrivere la risposta sensoriale a questi composti, amminoacidi, i loro sali, e nucleotidi che si formano a partire dalla degradazione delle proteine. Un sapore che ci parla insomma della capacità del nostro sistema gustativo di assolvere alla sua funzione primaria, individuando macro nutrienti in ciò che mangiamo. La particolarità di questi composti è legata alla loro azione sinergica, capace di intensificare esponenzialmente il sapore quando presenti in modo combinato, producendo un effetto sensoriale che va ben oltre la semplice somma: 1+1=3.
Lunghe cotture, fermentazioni, essicazioni e stagionature sono alla base dei processi che degradano le proteine liberando questi composti. Li troviamo in abbondanza in un brodo, nel Parmigiano Reggiano che ci grattugiamo sopra, o nel concentrato di pomodoro con cui aggiustiamo il ragù per una lasagna. Qualunque fonte proteica, anche di derivazione vegetale, può liberare composti umami. Ma l’umami bomb si attiva appunto solo in azione combinata. Un processo complesso, che vede coinvolta un’altra classe di molecole.
Kokumi: il sapore ricco di composti privi di sapore
I primi studi pionieristici sulla definizione scientifica del kokumi risalgono agli anni Novanta, quando Ueda e colleghi isolarono alcuni composti da estratti di aglio e cipolla, definendo queste sostanze attive come composti ad affetto kokumi. Sapore ricco, cosi potremmo tradurre il termine kokumi utilizzato per descrivere sensazioni complesse come ricchezza, pienezza e persistenza, associate alla presenza di oligopeptidi bioattivi, piccole catene di amminoacidi che si formano sempre a partire dalla degradazione delle proteine. Composti che, a differenza degli amminoacidi menzionati qui sopra, non attivano recettori gustativi, assaggiati in purezza sono privi di sapore, ma interagiscono con i recettori sensibili al calcio extracellulare (CaSR). Questa classe di recettori è accoppiata a specifiche proteine responsabili del mantenimento dell’omeostasi del calcio nel sangue. Si tratta di composti che in presenza di sostanze umami svolgono appunto un’azione sinergica, intensificando la percezione di sapori umami ma non solo, anche la sfera tattile e di struttura è influenzata da queste molecole, restituendo un’esperienza sensoriale riconducibile a una maggiore pienezza e persistenza. Kokumi non è un sapore ma un amplificatore, alza il volume e la complessità sensoriale in presenza di altri composti, in particolare glutammato.
Molti prodotti fermentati contengono peptidi, si trovano ad esempio nel miso, nel pane e nella salsa di soia. Sostanze ad effetto kokumi sono presenti anche
in estratti di lievito, in alcune spezie, nell’aglio e cipolla, ma anche in bevande fermentate come birra, sidro e vino. Il sinergismo tra umami e kokumi non è un semplice fenomeno additivo, ma un’interazione molecolare che si verifica prevalentemente su matrici complesse e restituisce una dimensione sensoriale altrettanto complessa. E se il meccanismo recettoriale che governa l’interazione con queste classi di composti è in parte ancora sconosciuto e talvolta è complicato riconoscere e descrivere compiutamente il percepito che ne deriva, nella pratica la cucina ha istintivamente sempre utilizzato ingredienti e processi in cui umami e kokumi hanno costruito il pilastro sensoriale, non solo per caratterizzare un piatto ma anche per concentrare e far esplodere ciò che definiamo sapore, nell’accezione più ampia del termine.
L’erba del vicino non è per forza la più sapida
E se pensate che solo in alcune cucine si trovino gli esempi più rappresentativi sono pronta a smentirvi. Certo le influenze nipponiche hanno avuto l’innegabile merito di fornirci spazi nuovi per ripensare il consueto, arricchendo la dispensa sensoriale con tecniche e ingredienti, ma non serve necessariamente guardare altrove. La tanto vituperata tradizione dello Stivale è un sussidiario validissimo sul tema. Ce lo ricorda la Bomba di Riso piacentina ad esempio, diventata uno dei best seller dell’Ostreria Fratelli Pavesi a Poden-
Umaminara - Confine
zano, una sorta di timballo di riso cotto nel brodo e mantecato, con un cuore di ragù di piccione (o altro animale da piuma) e porcini secchi, ricoperto di pangrattato e gratinato al forno. Un piatto golosissimo, con un umami stratificato e inteso, quello della cipolla, del Parmigiano, della maillard da rosolatura e del fungo. Gioca un campionato simile anche il Savarin di Riso, piatto iconico della bassa parmense che Jacopo Malpeli, talentuoso chef dell’Osteria Del Viandante di Rubiera, interpreta fedelmente secondo la ricetta di Mirella Cantarelli, che diede vita al piatto. Lingua salmistrata a fasciare una ciambella di risotto alla parmigiana con al centro polpettine di manzo e maiale fritte, servite con un sugo a base di pomodoro e funghi. Una liturgia nota e una dimensione gustativa ricca e intensa, dominata da una sapidità complessa, quella delle carni e del formaggio ma anche dell’essenziale apporto dei vegetali. Ma non serve nemmeno cercare nella ricchezza dei nostri ragù e primi piatti, ci basta ricordare il sapore di una marinara. Si chiama Umaminara, ed è ormai un signature tra le proposte di Confine a Milano: San Marzano DOP affumicato, crema d’aglio rosso di Nubia, pasta e colatura di alici, gel di basilico, crema di datterini, polvere di capperi, olive, aglio nero, origano, basilico greco e olio EVO. Una versione rivisitata ma nemmeno troppo per una delle pizze che più rappresentato la tradizione Campana in un morso direi quasi didattico. Ricco, pieno, saporito e intenso, o se preferite, umami e kokumi.