La Festa nazionale del Cuoco I giovani al ristorante Il vegetale

Umberto Giraudo
La sala è una grande scuola di vita



La Festa nazionale del Cuoco I giovani al ristorante Il vegetale

La sala è una grande scuola di vita


Mario Benhur Tondini
presidente Edizioni Catering srl
Imprenditore nel settore della distribuzione alimentare, gestisce con il fratello Oscar l’azienda di famiglia a Cavriana (MN), dove ha svolto anche l’incarico di sindaco.

Le competenze maturate sul piano professionale e su quello amministrativo lo hanno portato alla convinzione che il principio della condivisione sia la miglior modalità di crescita. Molte sue iniziative, anche all’interno del gruppo Cateringross (che detiene la titolarità della casa editrice), di cui è consigliere d’amministrazione, vanno in questa direzione. A questo affianca una forte sensibilità per ogni azione che dia valore al suo territorio.
benhurtondini@salaecucina.it
Marina Caccialanza
Redazione
Milanese, un passato come traduttrice, da diversi anni giornalista e redattrice per riviste del settore alimentare rivolte al mondo dell’artigianato e all’industria, in particolare nel campo della ristorazione, del dettaglio specializzato e della ricerca. Contribuisce alla realizzazione di importanti libri di comunicazione gastronomica in Italia e all’estero diretti ai professionisti e ai consumatori. Collabora con le redazioni di sala&cucina, Ecod e Trenta Editore.

Luigi Franchi
Direttore responsabile
Prima fotografo di cibo e territori, poi comunicatore, autore di numerosi libri di enogastronomia e di turismo enogastronomico. e infine giornalista di enogastronomia. Tra le sue principali pubblicazioni, scritte e/o coordinate: La prima edizione della Guida al turismo del vino in Italia, per conto del Movimento Turismo del Vino, (1997), I parchi e il turismo enogastronomico (2004), Il marketing delle Strade del Vino edizioni Agra – Rai Eri (2005), Atlante Alimentare Piacentino, con Valentina Bernardelli (2007), “cuo chi, due anime in cucina”, con Alessandra Locatelli, GL.Editore (2009), Dalle Terre Traverse al Po, GL.Editore (2010), ideatore e coautore dei Maestri del lievito madre, Edizioni Catering (2014), coautore della guida online dedicata alla ristorazione Meglio Prenotare, Edizioni Catering, Le interviste (2018) editore Mediavalue. Co-direttore di Food & Book, festival nazionale di editoria enogastronomica luigifranchi@salaecucina.it

marina.caccialanza@salaecucina.it
Redazione
Ricorda con esattezza il profumo del primo pane preparato all’età di sette anni.
Forse il suo primo traguardo e, soprattutto, l’inizio di una grande passione: per le cose semplici, per la genuinità, per gli alimenti che crescono e prendono forma. Dopo la Laurea in Scienze Gastronomiche, la specializzazione in comunicazione enogastronomica, e un periodo di alternanza nelle cucine, ha chiara la missione: scrivere per comunicare. Come? Utilizzando gli strumenti di oggi e la curiosità di sempre. Gionalista pubblicista, collabora anche con la guida di Identità Golose.

Simona Vitali
Redazione
Laureata in filosofia, ha lavorato nella comunicazione e organizzazione di grandi eventi a Parma.
Ha ricevuto una prima inconsapevole educazione al gusto per il cibo grazie all’ indimenticato oste dell’Osteria della Stazione di Felino (PR), il nonno materno Massimino. Con gli studi umanistici è poi arrivata una seconda, consapevole, educazione al gusto per l’utilizzo delle parole secondo il loro significato. Poi sono seguiti un corso di Alta Formazione alla scuola Holden e un master in Filosofia del cibo e del vino. Della ristorazione l’affascina il pensiero e la componente umana. Della formazione di settore segue movimenti ed evoluzioni.

giuliazampieri@salaecucina.it
Gabriele Adani
Grafico
Modenese, appassionato di arte figurativa, fotografia e linguaggi di comunicazione visiva.
s.vitali@salaecucina.it

Nel 1992 inizia il suo percorso professionale presso una casa editrice. Lavora poi in uno studio grafico e fonda una piccola agenzia di comunicazione in cui ricopre il ruolo di direttore creativo per 18 anni.
Viaggiatore, utilizza i frequenti viaggi a Londra e nel Sud Est asiatico per arricchire il suo bagaglio culturale e placare la sua innata curiosità per le altre culture.
Dal 2019 lavora in proprio, occupandosi di fotografia, grafica e consulenze nel campo della comunicazione.
grafica@salaecucina.it







7 LA LETTERA APERTA
La festa nazionale del cuoco | Luigi Franchi
9 L'EDITORIALE
Le sagre d’autunno | Benhur Tondini
10 IL CONFRONTO
Umberto Giraudo | Luigi Franchi
16 LA RIFLESSIONE
I giovani al ristorante | Giulia Zampieri
20 GLI AMBASCIATORI DEL GUSTO
Il vegetale | Luigi Franchi
25 IL RISTORANTE
Ustaria dal m’rca | Simona Vitali
28 LA DISTRIBUZIONE
Baldi festeggia i 60 anni di attività | Guido Parri
34 LE CONTAMINAZIONI
Döner e identità: come un panino ha unito due culture in Germania | Federico Panetta
36 DOGUSTO
I formaggi Dogusto | Guido Parri
39 I CUOCHI
La valorizzazione della cucina italiana passa anche dalla garanzia dei prodotti | Rocco Cristiano Pozzulo
41 LA NEUROVENDITA
Silenzio o suono? La scienza smentisce Piovani | Lorenzo Dornetti
46 IL RISTORANTE
Il Cometto a Brescia | Giulia Zampieri
50 LA STORIA
Paul Bocuse e La cucina del mercato | Alessia Cipolla
54 IL VINO
San Dionigi in Valpolicella | Giulia Zampieri
58 IL RISTORANTE
Casa Mia Bistrot | Marina Caccialanza
60 LA PIZZERIA
Gourmet con fantasia | Marina Caccialanza
62 L'OLIO AL CENTRO
Una “mappa sensoriale” per prendere confidenza con gli oli | Luigi Caricato
64 LA DIGITAL TRANSFORMATION
Dal taccuino alla realtà aumentata: come la tecnologia 3D sta rivoluzionando l’inventario nella ristorazione | Claudia Ferrero
66 L'ANALISI
I prodotti DOP come valore per la ristorazione: dal menu al racconto in sala | Ilenia Martinotti
68 LA PRODUZIONE
Segreti da Chef, la nuova gamma di Olitalia | Marina Caccialanza
70 LA PRODUZIONE
Punto di forza è la qualità | Marina Caccialanza
72 LA PRODUZIONE
Buona e sana: in horeca cresce il consumo della passata di pomodoro | La redazione
74 LA PRODUZIONE
Autentico e artigianale | Marina Caccialanza
76 L'ANALISI SENSORIALE
Sfidante, profondo, elegante: il sapore amaro | Stefania Pompele
79 LA PRODUZIONE
French Rack di Vitello e Cuberoll di Scottona l’eccellenza firmata Centro Carni Company | Guido Parri
82 I LIBRI
Il viaggio degli agrumi in Italia - Ricordo… i cibi della mia cucina che sapevano di terra e di gallina | Luigi Franchi


N° 98 ottobre 2025
EDITORE
Edizioni Catering srl Via Margotti, 8 40033 Casalecchio di Reno (BO) Tel. 051 751087 – Fax 051 751011 info@salaecucina.it - www.salaecucina.it
PRESIDENTE
Benhur Mario Tondini benhurtondini@salaecucina.it
DIRETTORE RESPONSABILE
Luigi Franchi luigifranchi@salaecucina.it
COLLABORATORI ESTERNI
Luigi Caricato, Alessia Cipolla, Lorenzo Dornetti, Rocco Pozzulo, Claudia Ferrero, Ilenia Martinotti, Federico Panetta, Guido Parri, Stefania Pompele.
FOTOGRAFIE
Archivio sala&cucina, Matteo Vizzaccaro, Desirè Tauro
* L’editore è a disposizione per eventuali crediti fotografici di cui si ignora la fonte
RIVISTA PARTNER di AMODO
PUBBLICITÀ Tel. 331 6872138 marketing@salaecucina.it www.salaecucina.it
PROGETTO GRAFICO
Gabriele Adani - www.gabrieleadani.it
STAMPA
EDIPRIMA s.r.l. – www.ediprimacataloghi.com
TIRATURA E DISTRIBUZIONE – 28.900 copie
Ristoranti, trattorie e pizzerie 20.700 – Bar, pub e birrerie 4.000 – Hotel 3.100 – Grossisti e distributori f&b 1.100
Costo copia mensile: 4,00 euro abbonamento annuo 40,00 euro Per abbonarsi: info@salaecucina.it




Clicca e leggi l’articolo sul web
È necessaria una manifestazione come quella che, ogni anno, organizza la FIC: la Festa Nazionale del cuoco. Ci vuole perché valorizza un mestiere che, pur essendo uno dei più complicati e difficili che esistano, è anche uno dei più belli se riconosciuto e valorizzato. È il mestiere che contribuisce alla felicità delle persone; basti pensare a tutte quelle tavole che connotano il nostro Paese, a tutti quei riti che si sviluppano attorno ad esse, dagli amori che vi nascono agli affari che vi si concludono, dalle occasioni di relax alla summa del piacere di milioni di turisti che vengono in Italia anche per questo. E dietro a tutto ciò ci sono donne e uomini che, nel chiuso delle loro cucine, lavorano fino a tarda sera per tutti noi.
Non ci si pensa mai abbastanza a questo aspetto, anzi… lo si considera, molte volte, un atto dovuto. Non è così, non può e non deve essere così. La professione del cuoco non è un programma televisivo, non è uno o mille show-cooking; fare il cuoco è responsabilità di prendersi cura delle persone, è fare in modo che il servizio di sala possa raccontare correttamente come è il piatto che lui ha ideato, è creare le condizioni affinché ogni materia prima sia utilizzata in maniera corretta, senza inutili sprechi.
E anche chi, oggi, è diventato famoso e magari in cucina si limita a controllare che tutto funzioni alla perfezione c’è riuscito perché ha provato lui stesso, per anni, a svolgere quel lavoro partendo dalle basi.
Questo è un mestiere che toglie il fiato, che lascia pochissimo tempo libero da dedicare a sé e ai propri affetti, che ti tiene incollato ai fornelli perché è da lì che viene il piacere di fare bene le cose.
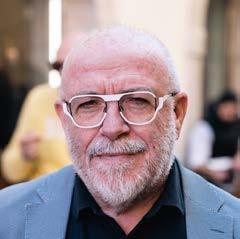
Luigi Franchi direttore responsabile
Allora ben venga la Festa del cuoco, ben venga un’associazione che li rappresenta, che ne tutela i bisogni, che ne valorizza le funzioni. In questa festa è sempre bello vedere come le città che la ospitano, diverse ogni anno e poche settimane fa è toccato a Genova, applaude queste persone, le loro divise bianche, i loro alti cappelli, patrimonio secolare di una funzione che è passata dal servire i nobili al far felici milioni di persone in ogni parte del mondo.
Mi sono chiesto spesso cosa porta una persona a scegliere una professione così totalizzante e ho capito che non esiste una risposta univoca: chi lo fa per tradizione familiare, chi per passione della cucina, chi perché non aveva voglia di studiare e si è accorto che lo studio è essenziale in questo mestiere, quasi mai lo si è scelto per i soldi.
Ma non importa il perché! Importa che esistano i cuochi, che la ristorazione diventi, poco alla volta, un mestiere pieno di dignità, che fare il cuoco venga riconosciuto come un valore sociale e, per questo, avere un’associazione in grado di tutelarne la storia, il lavoro, i bisogni è fondamentale.
Noi, persone che hanno il compito di comunicare questa professione, non dobbiamo mai dimenticare che esistono cuoche e cuochi che non sono sotto i riflettori, e sono la stragrande maggioranza. Diamo loro la soddisfazione di veder riconosciuto il loro ruolo, il loro lavoro, la loro passione!
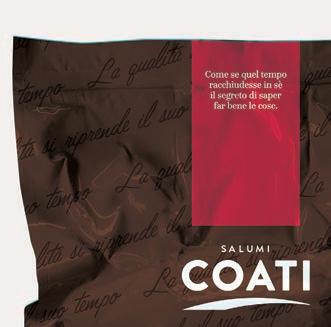






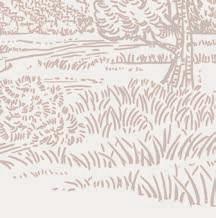




Assapora la nuova referenza della linea “Lenta”. Frutto di una scrupolosa lavorazione artigianale e prodotto a partire da soli petti interi meticolosamente selezionati.
Si caratterizza per una carne magra, cotta lentamente a vapore e una croccante doratura esterna che racchiude tutto il succo e il sapore dell’arrosto.
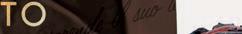

















Non è solo l’estate che vede le sagre protagoniste. In autunno, soprattutto nei borghi che costellano l’Appennino, c’è un fiorire di manifestazioni dove il cibo è protagonista e sono solitamente sagre che hanno una storia autentica, frutto delle abitudini alimentari di un tempo che connotavano quei paesi: la polenta, le castagne, la zucca, il riso, giusto per citare alcuni dei prodotti e delle ricette più diffuse. Hanno ancora un senso? A questa domanda la risposta è si, visto il favore del pubblico che le anima. Sono forse la “storia” del moderno street food, luoghi dove il mangiare per strada, nelle piazze, era il modo più facile di socializzare e ancora oggi, con quei lunghi tavoli dove ci si siede per consumare un cartoccio di castagne o un piatto di polenta, sono un invito a parlare al vicino, a commentare il gusto del piatto e il ricordo che genera quel tipo di alimentazione per i più avanti con gli anni. Ma anche, per i giovani, lo stare insieme a basso costo, e non è poco di questi tempi.
Gestire una sagra non è impegno di poco conto, considerando che si basa quasi esclusivamente su quel volontariato che distingue l’Italia in ogni comune; migliaia di persone che si danno da fare per far star bene altre migliaia e migliaia di persone. Un tessuto sociale che, quando funziona bene, coinvolge anche altri aspetti commerciali, dalle gastronomie ai piccoli produttori locali che entrano in contatto, durante i giorni di sagra, con un ampio pubblico, fino alle trattorie e ai ristoranti che propongono un menu più ricco di quello degli stand, intercettando persone che in quel paese non sarebbero forse mai andate.
Una funzione anche in chiave turistica, quella delle sagre, che non è ancora ben valorizzata, se, infatti, avessero, da parte delle istituzioni preposte, una comunicazione che superi l’ambito provinciale, divente-

Benhur Tondini presidente sala&cucina
benhurtondini@salaecucina.it
rebbero attrattive al punto che i turisti, italiani e stranieri, si fermerebbero anche a dormire in loco un paio di giorni, contribuendo all’economia locale.
Le sagre italiane, infatti, non sono solo una festa o un’occasione per mangiare, ma un elemento fondamentale per la conservazione dell’identità culturale e sociale del paese. Aspetti, questi, che sono fondamentali nell’offerta turistica del nostro Paese. È per questo che non deve esistere una ‘guerra’ tra sagre e ristorazione: il detto che, se funziona bene una cosa ce n’è per tutti, non è mai stato più vero in questi casi. Vengo da un’esperienza che mi ha fatto riflettere su questo: sono stato di recente qualche giorno in una cittadina emiliana per la gran fiera del santo patrono, molto sentita in quel territorio. Dodici giorni di festeggiamenti con il centro cittadino letteralmente invaso dallo street food, dalle bancarelle che offrivano cibo. Si poteva mangiare da qualsiasi parte delle vie e delle piazze eppure non c’era un ristorante che non fosse pieno a pranzo e a cena. Questo voleva dire che tutto il tessuto sociale si riconosceva in quella sagra, che ogni persona, abitante o turista, voleva cogliere più di un aspetto di quell’evento e di quel luogo, diventando un punto di forza nella vita delle comunità, promuovendo l’economia locale e attirando turisti alla ricerca di esperienze autentiche.
Clicca e leggi l’articolo sul web


Avere la possibilità di trascorrere del tempo con Umberto Giraudo aiuta a capire velocemente che esistono diversi modi di riscattare un mestiere, quello del cameriere, che non è quello del servitore. Lo scopriamo, insieme a tante altre cose importanti, in questa intervista che ci ha rilasciato.
Partiamo dalla tua storia professionale… “La mia carriera è iniziata molto presto, sulle navi da crociera. È stato un inizio intenso, che mi ha insegnato a gestire grandi numeri senza mai perdere di vista la qualità e l’attenzione al dettaglio. Dopo il servizio militare vado in Francia, a Carcassonne, all’Hotel de la Cité; mi sembrava di essere nel più bell’hotel del mondo ma il direttore del ristorante dell’albergo mi disse: devi andare a lavorare a Montecarlo, da Alain Ducasse. “Va bene, se lei vuole”, io stavo tanto bene lì ma obbedii e fu la mia fortuna. Era il 1992, avevo vent’anni ed ero l’unico italiano a lavorare in sala. I primi tempi furono durissimi, non avevo ancora la cultura che ho adesso; una volta mi dissero di andare a prendere il sale grigio ma pensavo mi prendessero in giro, non ne conoscevo l’esistenza. Poi, aprendo la dispensa mi sono trovato davanti a tutti i sali del mondo e lì ho capito che dovevo studiare molto di più di quello che avevo imparato fino a quel momento. Lessi tutti i libri che c’erano al ristorante, ne comprai altri e imparai molte delle regole di un buon servizio di sala. Rimasi cinque anni a Montecarlo e poi Alain Ducasse, da cui ho appreso lo stile della grande cucina francese, mi volle a Parigi. In quella struttura mi trovo ad avere a che fare con due direttori di sala, due maître e, di conseguenza, ero quinto o sesto nella gerarchia ma Ducasse mi diede il primo grande insegnamento, rispondendo a una mia domanda disse: “Non mi interessa cosa hai scritto sulla targhetta, mi interessi tu come persona qui, in questo locale”. Successivamente è arrivata la proposta che ha segnato la mia vita professionale: l’esperienza al Rome Cavalieri, al fianco di Heinz Beck a La Pergola, l’unico tre stelle Michelin di Roma. In oltre dieci anni lì ho maturato una profonda consapevolezza del ruolo della sala e del servizio come veri e propri interpreti dell’esperienza gastronomica. Nel 2012 ho avuto il riconoscimento dell’ Académie Internationale de la Gastronomie come Grand Prix de l’art de la salle e, tuttora, sono l’unico italiano ad averlo ricevuto. Questa, ripensando al motivo principale per il quale ho voluto fare questa professione, è una particolare condizione di valore morale; infatti devi sapere che all’età di dieci anni ero affascinato dall’Hotel Excelsior di Via Veneto a Roma, dove passavo davanti con mia mamma mentre andavamo al teatro Sistina per vedere qualche spettacolo e mia mamma mi diceva che lì non si poteva entrare. Decisi di studiare all’alberghiero nella speranza di varcare quella soglia. Nel 2022 mi chiama Alain Ducasse che mi informa che aprirà a Roma e che devo andare con lui. Mi aveva già chiamato altre volte ma io avevo sempre rifiutato, stavo bene dov’ero, in una struttura come il Rome Cavalieri Hilton, ero tornato nella mia città, lavoravo nell’hotel più sicuro al mondo dove avevo a che fare quotidianamente con ambasciatori, presidenti di stato, risolvevo ogni loro più piccolo problema. Gli dissi di si in un periodo particolare della mia vita e iniziai con lui a Napoli prima di arrivare al ROMEO Collection a Roma. Ero il suo restaurant manager, mi occupavo di tutto, dall’ac-

quisto della posateria alla carta dei vini. Conobbi in quel momento l’avvocato Romeo che mi volle passare di grado, elevandomi a rappresentare la ROMEO Collection come Brand Ambassador, un ruolo che mi consente di raccontare e trasmettere la nostra filosofia: un lusso che non si limita all’estetica, ma che abbraccia cultura, arte, design e benessere. I nostri hotel sono gallerie viventi, spazi che celebrano il dialogo tra passato e futuro, tradizione e innovazione. Il mio compito è interpretare e condividere questa visione con ospiti e partner, facendo percepire la ROMEO Collection come un’esperienza che va oltre il soggiorno, capace di trasformarsi in emozioni autentiche”.
Come formano il carattere e incidono sulla vita di una persona tanti anni trascorsi in sala?
“La sala è una grande scuola di vita. Ti mette costantemente di fronte all’imprevisto, ti obbliga ad ascoltare, a osservare, a capire le persone prima ancora che parlino. Ti insegna la pazienza, la precisione, ma anche l’umiltà: perché il servizio, per quanto perfetto, non è
mai protagonista, è sempre al servizio dell’altro. Dopo tanti anni in sala, il carattere ne esce temprato: impari ad avere autocontrollo, a gestire lo stress e a lavorare in armonia con gli altri. Ho imparato tanto se non tutto dai miei ospiti: vedere come si muovevano, i loro atteggiamenti, le loro richieste. Tutto questo mi ha sempre fatto molto riflettere e assimilare. Quando lavoravo a Montecarlo nel 1992, era vietato andare al lavoro in scarpe da ginnastica e in jeans. Andare al lavoro, non entrare nell’hotel. Quando vivi queste regole anche la tua vita quotidiana cambia”.
Qual è stato il momento in cui hai avvertito la felicità di una o più persone dettata dal servizio che era loro offerto in quel preciso istante. Come ricordi quel momento?
“È difficile scegliere un solo momento, perché la sala ti regala tante piccole soddisfazioni quotidiane. Forse il ricordo più bello è stato a Montecarlo, al Louis XV, quando vedevo gli ospiti che tornavano e mi cercavano con lo sguardo. Voleva dire che avevo trasmesso qual-
| ottobre 2025
che cosa. E un’altra volta quando una delle donne più ricche del mondo, una cliente australiana del Rome Cavalieri, disse che di me ci si poteva fidare. Non c’è mancia importante, fosse anche di diecimila euro, che batte questa soddisfazione”.
Oggi si fa un gran parlare, ormai da anni, sul termine cameriere che è obsoleto e non attira i giovani a intraprendere questa professione: qual è il tuo parere?
“Credo che il problema non sia solo il termine, ma la percezione che se ne ha. “Cameriere” viene spesso ridotto a un ruolo di mera esecuzione, quando invece è un’arte complessa, fatta di cultura, tecnica e sensibilità. Dobbiamo cambiare la narrazione: non si tratta di portare piatti, ma di creare esperienze. È questo che può restituire una dignità e un fascino al mestiere. Il cameriere è, allo stesso tempo, più competenze in una. Quando facevo i colloqui una delle domande era: mi sai dire tre tipologie di fragola? Questo per dire che un cameriere deve conoscere: le materie prime, innanzitutto, ma anche altre cose che impari solo con l’esperienza. Ad esempio che un cliente cinese, durante le presentazioni, attira la mano che stringe verso di sé, in un gesto che lascia un po’ stupiti, ma se lo sai e lasci che ti tenga la mano a lungo acquisisci immediatamente la sua simpatia; oppure che al cliente russo, all’inizio, non devi mai sorridere perché inter-

pretano il sorriso come una presa in giro. Poi diventano cordialissimi ma non subito. Chi lavora in sala deve conoscere la cultura degli ospiti. Quali sono le traduzioni arabe, musulmane, messicane, americane, cinesi, indiane, tedesche del rito del cibo? Mangiano nello stesso modo? No! Facciamogli però apprezzare la nostra cucina secondo i loro tempi, in modo tale che loro inconsciamente si aprano a gradirla. Occorre andare avanti in questo Paese perché altrimenti rischiamo di perdere delle opportunità incredibili. L’Italia è bella, l’ospitalità italiana è famosa, però il mondo cambia molto velocemente ed è necessario avere uno sguardo attento e sempre aperto”.
Più in generale cosa reputi necessario per attrarre giovani verso la professione? E cosa si deve cambiare per migliorare la situazione?
“Bisogna raccontare questa professione per quello che è davvero: un percorso di crescita, di viaggi, di incontri, di possibilità straordinarie. Molti giovani non sanno che grazie a questo mestiere si può arrivare a lavorare nei luoghi più belli del mondo, al fianco di grandi professionisti. Allo stesso tempo, occorre creare condizioni di lavoro più sostenibili, che valorizzino il talento e che diano prospettive chiare di carriera. Poter comunicare questa passione, quanto potrebbe essere bello e quanto potrebbe essere interessante fare questo mestiere, è una cosa straordinaria”.

Parliamo di formazione: la didattica degli istituti alberghieri necessita di cambiamenti? Come dovrebbe essere un giusto modello formativo, cosa si dovrebbe insegnare oggi?
“Credo che ci sia bisogno di un approccio più pratico e moderno. La tecnica resta fondamentale, ma oggi non basta più: bisogna insegnare anche soft skills, come la gestione del cliente, la psicologia dell’accoglienza, le lingue, la cultura del vino e della gastronomia internazionale. La formazione deve avvicinarsi alla realtà, creando collegamenti diretti tra scuole e grandi ristoranti”.
Qual è il giusto punto di equilibrio tra un servizio altamente professionale e uno più informale, secondo te?
“Il segreto è la naturalezza. Il servizio deve essere impeccabile, ma mai rigido. L’ospite deve sentire professionalità, ma senza barriere: ci deve essere calore, empatia, capacità di adattarsi alla persona che si ha davanti. L’eleganza del servizio non è mai ostentazione, è discrezione e misura. Però bisogna cercare sempre di adattarsi e farglielo capire. Se pensi che lo stesso metodo sia uguale per tutti non va bene, perché il cliente vuole un servizio personalizzato e vuole essere riconosciuto”.
Al The ROMEO Collection stai vivendo la sua attuale esperienza? In cosa si esplica?
“La mia attuale esperienza nella ROMEO Collection si esprime nel ruolo di Brand Ambassador. Questo significa essere il portavoce di una filosofia che supera il concetto tradizionale di hotel per trasformarsi in un viaggio nella cultura, nell’arte e nell’ospitalità italiana. Il mio compito è trasmettere i pilastri della Collection – il lusso e l’eccellenza, l’arte e il design, la cucina gourmet con la firma di Alain Ducasse, il benessere e l’italianità – affinché chi entra in contatto con noi percepisca non solo la qualità dei servizi, ma l’anima dei nostri spazi”.
Alain Ducasse è lo chef con il maggior numero di stelle Michelin al mondo ma, soprattutto, è un imprenditore in grado di governare strutture che vanno da un capo all’altro del mondo. Tu lo conoscibene e, ora, stai lavorando proprio nel suo locale di Roma; ci puoi definire i tratti essenziali del modo di lavorare di Monsieur Ducasse?
“Ducasse è un visionario, ma anche un uomo di grande pragmatismo. Ha una capacità straordinaria di unire creatività e organizzazione, e di trasformare la cucina in un linguaggio universale. È esigente, ma sempre orientato al futuro: sa che l’eccellenza non è mai un punto di arrivo, ma un cammino continuo. Lavorare in un suo ristorante significa condividere questa filosofia
e applicarla ogni giorno. Il suo successo deriva anche dal saper ascoltare e non avere paura di delegare il suo lavoro agli altri, perché non è egoista e non è un eccentrico. Lui ha avuto la capacità di saper delegare la sua cucina, le sue ricette, di fare queste cose, di tramandarle agli altri. E questo lo ha portato al successo”.
Ultima domanda: la ristorazione che anni ha davanti? La gerarchia ideata, molto tempo fa con la brigata, da Escoffier, che ne ha dettato le regole ha ancora motivo di esistere?
“Credo che la ristorazione viva una fase di grande trasformazione, ma i principi di Escoffier restano attuali: la brigata è un modello che dà ordine, disciplina e chiarezza dei ruoli. Quello che cambia è il modo in cui viene interpretata: oggi occorre più flessibilità, più attenzione al benessere delle persone, più collaborazione. La gerarchia deve esserci, ma deve trasformarsi da rigida catena di comando a squadra armoniosa, dove ognuno sente di contribuire al successo collettivo. Le persone, del resto, vogliono vivere un’esperienza nel ristorante, quindi il locale statico diventerà noioso. Non ci si va, non ci si andrà più. Si preferirà un ristorante dove ci sarà anche un buon servizio, dove ci saranno delle cose in sala, dove ci sarà una decorazione particolare, dove il cliente vivrà l’esperienza non soltanto del piatto ma anche del servizio”.



Autrice: Giulia Zampieri
Clicca e leggi l’articolo sul web
Come si comportano, cosa chiedono e perché non si devono ignorare

Soft Saving è un termine che indica la propensione della Gen Z (i ragazzi nati tra il 1997 e il 2012) a investire sulla qualità della vita attuale anziché accumulare risparmi per il futuro. Non arriva alle nostre orecchie come una novità: è una tendenza evidente, diffusa, senza distinzione geografica o di astrazione sociale, spesso oggetto anche di scontro con le generazioni più adulte. I giovani amano investire sul benessere attuale, sulla vita fuori casa, sui viaggi, sui concerti e utilizzano gli ambienti esterni per la socialità, cosa che implica quasi sempre un investimento - anche se piccolo - di denaro. Non abbiamo idea di quali effetti potrà avere nella stabilità finanziaria in futuro, in particolare qui, in Italia, dove la propensione al risparmio è stata finora un forte elemento caratterizzante (e anche salvifico, negli ultimi tempi); ma è questo il primo fattore che vi mettiamo sul piatto, in un’analisi che riguarda il rapporto dei giovani con la ristorazione attuale: se spendono, perché non lo fanno da voi?
No, non inveite. Vogliamo solo stimolarvi ad una riflessione su quali potrebbero essere le ragioni dell’eventuale assenza di Gen Z nel vostro locale, a maggior ragione se proponete una cucina tradizionale (apparentemente snobbata dai giovani), se non servite aperitivi e non vi trovate in centro a Milano.
La difficoltà a raggiungere questa clientela ci viene espressa da molti ristoratori. Altri, questa fascia di pubblico non la prendono nemmeno in considerazione.
Le variabili sono tantissime, e magari aggiustamenti o nuove formule non sono sempre possibili, ma ci sono
format di ristorazione “semplice e comprensibile” che funzionano anche con la Gen Z… e non si tratta di fast food.
Nel centro storico di Putignano, affacciata alla meravigliosa Piazzetta di Santa Maria, su ciottoli levigati, tra abitazioni con intonaci bianchi, c’è Santa Maria Fornello Pronto, un piccolo locale che richiama il fornello pronto pugliese, ovvero un luogo in cui si cuociono alla brace pietanze tipiche, soprattutto a base di carne e quinto quarto.
Ci ha stupito vedere come, in una sera d’estate, la piazzetta fosse gremita di persone sedute al tavolo, con un’abbondanza di giovani, ma non solo, che ordinavano una carrellata di piattini - con bombette, torcicolli, gnumirelli, animelle, diaframmi, ma anche vegetali - accompagnando con bottiglie di vino, sia locali che francesi. L’insegna, gestita da tre fratelli, Lello, Niky e Marco, con una storia familiare legata alla macelleria, è stata aperta nel 2019. Abbiamo chiesto a Lello di raccontarci come vedono i ‘giovani’ di oggi e quali sono le accortezze per attirarli.
“In termini di comunicazione i social aiutano a raggiungere il pubblico giovane, ma devono essere fatti bene e veicolare un’identità del locale, dando motivo a chi ‘osserva’ di venire a provare, di voler trascorrere una serata leggera ma anche all’insegna di qualcosa di buono e comprensibile. Non devono in sostanza essere la copia di qualcos’altro. La situazione a Santa Maria è agile, cioè non è un locale solo per giovani o solo per adulti, è un’atmosfera che va bene per entrambi e ci impegniamo affinché risulti aperta. Allo stesso tempo vogliamo che rimanga un’esperienza anche particolare, dove si apprende qualcosa di nuovo”.


Ripensando alla serata, non si avvertiva lontananza tra le varie tipologie di pubblico perché il registro di servizio e linguaggio va bene con tutti, ma allo stesso tempo è personalizzato.
Ci spiega Lello: “Ci sono ragazzi interessati che vogliono capire quale tradizione c’è dietro, assaggiare cose nuove, più particolari, a volte ci chiedono addirittura di procurare qualcosa di speciale, e lo stesso fanno con il vino.
Poi ci sono altri meno curiosi, vengono prevalentemente per stare in compagnia; cerchiamo di leggere subito quali sono le loro propensioni e ci comportiamo di conseguenza, perché la personalizzazione del servizio è sicuramente un aspetto cruciale oggi. Così come lo è fornire, per esempio, la possibilità di prenotare su whatsapp, un canale che i giovani ritengono molto più immediato”.
In generale, l’esperienza di Santa Maria Fornello Pronto ci racconta che non sono vincenti solo i format ‘esclusivi’, cioè rivolti a una generazione precisa, ma che è possibile trovare la quadra in un sistema a pubblico misto, che mette al centro la qualità, la tradizione, servendosi di strumenti contemporanei per intercettare i potenziali giovani clienti.
Non bisogna snaturarsi, ma piuttosto interrogarsi su quali sono le ragioni per cui la Gen Z non si è ancora affacciata in modo convinto. Un ulteriore spunto - che è anche una conferma - proviene da questo dato, tratto del Rapporto Annuale FIPE, riferito allo scorso anno.
“La Gen Z esce a cena in media 3–4 volte al mese, con il 15% che supera le 5 uscite mensili, manifestando una forte predilezione per l’esperienza sociale del fuori-casa. Al contrario, le generazioni più mature riservano le uscite a
occasioni speciali, privilegiando la cena in casa per ragioni di efficienza e tradizione. Questo divario evidenzia come i giovani siano più propensi a ricercare esperienze dinamiche e socializzanti, mentre gli adulti e i Boomer (la generazione nata tra il 1946 e il 1964) adottano comportamenti più focalizzati sull’aspetto funzionale…”.
Contesto dinamico e socializzante… non può essere un’osteria?
L’alta ristorazione può piacere alla Gen Z
E come si approcciano i giovani, dai ventott’anni in giù, all’alta ristorazione?
Per il fine dining le logiche sono sensibilmente diverse: è sempre più una scelta legata a un’occasione speciale più che a una questione di socialità e convivio. Solo in alcuni casi, poi, è dettata da una passione per la gastronomia.
Ne abbiamo parlato con Marco Galtarossa, chef al Villa Elena di Bergamo, ristorante due stelle Michelin del gruppo Enrico Bartolini.
“Notiamo che i giovani che arrivano a Villa Elena sono molto preparati. Sanno già cosa offre il ristorante e nel 90% dei casi scelgono un menu degustazione perché vengono per viversi un’esperienza completa. Riscontriamo una maggior curiosità sui prodotti e sulle tecniche impiegate rispetto alla clientela più adulta. In generale, li troviamo meno critici e più aperti a qualsiasi tipo di proposta, poi dipende da caso a caso, naturalmente. Sul fronte beverage, non possiamo che confermare che bevono meno vino, quindi le alternative analcoliche ci devono essere e devono suscitare curiosità”.
Non abbiamo ancora introdotto, sinora, il tema ‘utilizzo del telefono’, visto che nell’immaginario comune il giovane seduto a tavola è costantemente distratto dal dispositivo, soprattutto a causa dei social network.
“A dire il vero sì, notiamo che ci sia la presenza del telefono ma non invade il momento a tavola né è fonte di distrazione. Rimangono concentrati su ciò che stanno assaggiando e sull’esperienza in sé, probabilmente proprio perché si tratta di un momento speciale” ci conferma Marco Galtarossa.
Parlando di disponibilità economiche, i giovani dimostrano una capacità di spesa - e non è una sorpresa - inferiore rispetto al pubblico più adulto.
“È fondamentale che ci siano delle formule pensate per loro, con prezzi agevolati, per esempio dei percorsi dedicati agli under 30. Se i giovani non compaiono in certi ristoranti non è per mancanza di interesse verso questo tipo di ristorazione ma spesso per l’impossibilità di far fronte ai prezzi. Dobbiamo interrogarci tutti: se i giovani, anche i giovani adulti di oggi, non provano questo tipo di ristorazione… la sceglieranno in futuro?”.
Stando su questo segmento di ristorazione, abbiamo parlato anche con Giovanni Alajmo, direttore del ristorante Quadri a Venezia, del gruppo Alajmo.
Giovanni ci conferma le due tendenze che abbiamo già incontrato qualche riga sopra: “I giovani al Quadri tendenzialmente scelgono il percorso degustazione, per garantirsi un’esperienza più completa. Riguardo al bere, notiamo un investimento inferiore. Sembra che ci sia una differenziazione della spesa: se investono per un’esperienza gastronomica è difficile che dedichino una somma cospicua anche per il vino. Penso che bisognerebbe fare molta sensibilizzazione per avvicinare i due temi valorizzando la loro complementarietà”.
Riguardo alla provenienza del cliente, spiega: “In un ristorante come il nostro incide anche la clientela di seconda generazione, cioè i figli dei clienti per così dire storici che tornano perché in passato sono stati bene e hanno un ricordo che li lega al ristorante. Poi ci sono i giovani che si affacciano per la prima volta; presumo che molti arrivino per curiosità e tramite i social network. E ancora, tra i giovani clienti c’è chi lavora nel settore o intende affacciarsi e viene per capire, conoscere, ispirarsi. Su questo gioca un ruolo importante anche il Quadrino, il bistrot sottostante il ristorante, che si avvicina a un certo tipo di ristorazione, mantenendo un profilo più informale”. Il bistrot, così come il genere di osteria che vi abbiamo raccontato nelle prime battute, si può collocare come un format vincente con questa fascia d’età perché in grado di rispondere su tutti i fronti: al bisogno di socialità, alla ricerca di qualità ed esperienza, il tutto a una cifra accessibile e contemplabile anche oltre il ‘limite’ dell’occasione speciale.
Giovanni Alajmo ci avanza un’ultima considerazione: “I giovani quasi sempre vengono per portarsi a casa qualcosa dall’esperienza. Si aspettano di avere informazioni, di trattenere. Ascoltano chi è dall’altra parte e spesso è così che infrangono falsi miti. È nostra responsabilità garantire che vi sia una narrazione equilibrata, mai eccessiva, e soprattutto che stiano bene. Ci sono giovani che mettono da parte denaro per potersi permettere certe insegne un po’ come, e mi piace ricordarlo, facevano trent’anni fa mio padre Raffaele e mio zio Massimiliano, per andare a provare i grandi ristoranti, come quello di Paul Bocuse. Ci andavano per capire la cucina, il servizio, l’atmosfera… e il contributo di quelle esperienze nella loro vita professionale è stato cruciale. Insomma, abbiamo una responsabilità e dobbiamo ricordarcelo”.
Ci rendiamo conto che le argomentazioni siano tante, varie, e che rispondere ai dubbi specifici di chi ha un’attività di ristorazione sia complicato, anche per via della molteplicità di variabili. Il suggerimento, alla luce di quanto raccontato, è di considerare quella dei giovani una strada ancora aperta: sono lì, aspettano di essere intercettati, accompagnati e tanti dimostrano di avere le idee chiare quando sposano una causa. Non è vero che non capiscono, che non vogliono riferimenti, che non hanno visione, che non sanno distinguere ciò che è buono da cosa non lo è. Quello, o meglio questi, sono i pensieri comodi e stagnanti che bloccano gli scambi intergenerazionali, le economie, l’evoluzione.
Giovanni Alajmo

Clicca e leggi l’articolo sul web

Le azioni dell’Associazione Italiana Ambasciatori del Gusto per valorizzare l’importanza della cucina vegetale.


Parlare di vegetale, di cucina vegetariana o vegana, di come vengono usati i vegetali nel piatto, se come decorazione o come ingrediente principale, è un autentico viaggio tra tante scuole di pensiero ma un elemento è comune: il vegetale fa bene alla salute, fa star bene le persone a tavola, è ricerca allo stato puro da parte degli chef.
Attorno a questi concetti l’Associazione Italiana Ambasciatori del Gusto sta facendo un grande lavoro di formazione tra i suoi associati, anche grazie al coinvolgimento attivo delle aziende partner.
Le azioni formative che mette in campo l’Associazione Italiana Ambasciatori del Gusto
Ed è con due di queste aziende che abbiamo iniziato a capire come funziona il valore di un rapporto diretto con l’associazione e le attività di formazione e informazione, tra visite guidate e master-class, che periodicamente vengono organizzate per favorire dialogo, conoscenza e rapporto diretto.
Koppert Cress
“Tra qualche settimana ospiteremo in Olanda, presso la sede di Koppert Cress, un gruppo di professionisti aderenti agli Ambasciatori del Gusto, per far conoscere da vicino l’azienda, le tecniche di coltivazione in serra, in modo esclusivamente naturale, dei fiori, delle erbe, dei germogli. – racconta Katia Piazzi, responsabile Italia dell’azienda olandese – Il nostro resident chef, Eric Miete, terrà poi alcune lezioni per far conoscere il modo migliore per utilizzare le nostre referenze”. Koppert Cress è un’azienda nata nel 2002 quando Rob Baan ha rilevato la prima delle serre che sarebbero servite per coltivare micro-vegetali per la ristorazione. Una visione che, a quel tempo, rappresentava una novità assoluta. Il vegetale come prodotto principale del menu, coltivato in serra in dimensioni micro in modo naturale, sano e sostenibile e in un’ottica alimentare nutraceutica. Venne definita da Rob Baan architettura aromatica la sua produzione perché univa al sapore e alla bontà anche la bellezza che, da quel momento, divenne una componente fondamentale in un piatto.
“Rob creò una rete di hunters in tutto il mondo in grado di selezionare e inviare le più svariate botaniche da cui ricavò i semi, ora di proprietà di Koppert Cress, per mettere a dimora nelle serre di Monster, nell’Olanda meridionale, storicamente vocata all’orticotura e alle serre. – spiega Katia Piazzi – Inoltre sono state inventate anche nuove varietà: la vaniglia, unica in Europa, e l’Oyster Leaves ha un sapore d’ostrica leggermente salato e per questo è nota anche come ostrica vegetariana”.
“Continuando a parlare di formazione, l’Associazione Italiana Ambasciatori del Gusto, in collaborazione con Koppert Cress, promuove alcune masterclass dedicate al mondo vegetale. In programma

ne abbiamo una con Alessandro Gilmozzi, profondo conoscitore del vegetale, a cui abbiamo invitato una ventina di chef per spiegare come utilizzare i nostri prodotti non solo come guarnizione ma come ingrediente del piatto.”
L’Associazione a giugno del 2025 ha promosso e organizzato una visita guidata all’interno dell’azienda. Un’immersione completa nella natura, tra boschi e piante, un dialogo diretto con i produttori dalla terra agli essiccatoi per poi degustare a tutto tondo i prodotti, utilizzati trasversalmente per realizzare cocktail e piatti d’autore.
Nel 2010 Danilo Nadalini, con sua moglie Gertrude Pum, nel seguire i lavori di risanamento del primo rudere acquistato a Gresta, in Val di Cembra, commenta con l’amico architetto Stefano Casagrande la qualità dei terreni che li circondano. L’abbandono ha portato allo smarrimento di passate coltivazioni (cereali, noci e castagni, meli, pruni e ciliegi), di pratiche legate alla pastorizia ed al crollo di muri a secco che un tempo rappresentavano lo scheletro di questo paesaggio. Profonde ferite naturali, provocate in particolare dagli eventi meteorologici dell’autunno del 1882 e dall’alluvione del novembre del 1966, hanno segnato il suolo con smottamenti, frane e crolli. È da quella vista che decidono di fare qualcosa per quel territorio; non vigneti, già abbondanti in Val di Cembra ma selezione di erbe spontanee da coltivare, ortaggi, alberi da frutto, pecore, asini, apicoltura, cereali, castagni, fiori, piante officinali.
Nasce così Ordine Contadino che, successivamente si specializza nella coltivazione di tutte quelle erbe
spontanee che costituiscono quello che loro hanno definito “cibo primitivo”.
“Conoscevo il direttore del ristorante di Punta San Vigilio, sul Lago di Garda, che mi fece conoscere Riccardo Uleri, ceo di Longimo & Cardenal, l’azienda che seleziona i prodotti per l’alta ristorazione. – racconta Stefano Casagrande – Lo invitammo a Gresta a conoscere la nostra piccola realtà. Con lui decidemmo di specializzarci nell’essicazione di fiori ed erbe che mancavano nel suo catalogo. I nostri fiori e le nostre erbe, più di 40 referenze, vengono raccolti a mano e, nel giro di pochi minuti portati sui telai nei locali dove l’essicazione avviene con metodi naturali per non disperdere odore e gusto”.
In questo modo si ottengono anche elevate concentrazioni di oli essenziali e durata nel tempo del colore, tutti elementi essenziali per l’utilizzo in cucina. “Con Ambasciatori del Gusto stiamo sviluppando, inoltre, una serie di masterclass, dal titolo Essere Natura, sul cibo primitivo per sostenere il lavoro di ricerca degli chef che vogliono proporre cucina vegetariana” spiega Stefano Casagrande.
Il mercato dei prodotti a base vegetale, nel 2028, varrà 61,3 miliardi di dollari a livello mondiale. In Italia la spesa corrente per questi prodotti, nel 2024, è stata di 680,9 milioni di euro, con una crescita del 9% sull’anno precedente e i vegetariani/vegani rappresentano il 9,5% della popolazione. Numeri importanti che vedono la ristorazione guardare con attenzione al ridisegno dei menu, valorizzando ortaggi, radici e fermentati e trasformando la cucina vegetale in atto creativo.
Questo processo ha subito un’accelerazione nel periodo pandemico quando non si sapeva bene quale futuro avremmo avuto davanti. L’impossibilità di muoversi ha portato molti ristoranti ha crearsi il proprio orto; il lungo tempo a disposizione ha favorito un lavoro importante di ricerca di nuove ricette dove il vegetale giocava un ruolo dominante.
Molti pensano che non sia corretto far pagare un piatto vegetale al pari di un piatto di carne o di pesce ma non si tiene mai conto a sufficienza di quanto lavoro di ricerca implica un piatto vegetariano al posto di uno di carne.
Di questo e di tanto altro ci parlano i quattro chef, associati agli Ambasciatori del Gusto, che abbiamo interpellato.
La Locanda Radici non fa solo cucina vegetariana ma tutto il lavoro di Angelo D’Amico è orientato all’eco-sostenibilità e alla territorialità. In carta i piatti vengono evidenziati on la percentuale di sostenibilità raggiunta per farli. La scelta di ogni ingrediente per la preparazione dei suoi piatti tiene infatti conto dell’impatto ambientale, del risparmio energetico e dell’aspetto economico.
A lui chiediamo cosa significa cucinare con i vegetali e la risposta è questa: “Nella nostra locanda siamo ormai al 20% di ospiti che scelgono il vegetale. Per questo abbiamo deciso di fare un nostro orto e seguirne la stagionalità: in questo periodo coltiviamo zucche e verze, adattandoci alla natura. Il vegetale è vita, natura, benessere. Le stesse cose che vogliamo far vivere ai nostri ospiti. È più complicato lavorare in questo modo, c’è una continua ricerca per far sì che il piatto sappia di buono e gustoso
ma dopo che si è provata la cucina vegetale ti cattura per sempre”.
Luca Miuccio, executive chef di Bátu e del Grand Hotel San Pietro 5*L a Taormina
Questo chef sta virando sempre di più verso una proposta green e, per fare questo, ha addirittura dato al locale una parola antica, che viene dal greco ed evoca il fiore dell’ulivo, ma soprattutto ha cambiato le carte in tavola nei suoi menu: “Il contorno è la proteina, mantenendo il focus sul vegetale. – ci racconta - Peperone ammuttunatu (fermentato e cotto al forno con capperi, pane raffermo e basilico), il Risotto al pomodoro, il plin, la segale e l’orto, base crema di topinambur, poi polvere di ortaggi e plin di farina di segale ripieni di cipolla fermentata; questi sono solo alcuni dei piatti che ho in carta. Vengo da una famiglia che, di professione, distribuisce prodotti ortofrutticoli e, di conseguenza, posso dire di esserci cresciuto in mezzo al vegetale, ma quello che più conta è aver capito come questo tipo di cucina incontra l’interesse di un pubblico, soprattutto più giovane, molto attento al benessere del proprio corpo. Con gli Ambasciatori del Gusto dobbiamo lavorare tutti insieme, e in parte lo stiamo già facendo, per far capire come la cucina green rappresenti un futuro di cambiamento, dobbiamo andare a portare le nostre esperienze nelle scuole alberghiere, coinvolgere i ragazzi nei nostri progetti”.
Michele Talarico, chef del ristorante
Tea del Kosmo a Livigno (SO)
Siamo in un ristorante a 1816 metri di altezza s.l.m., a Livigno, considerata ancora zona franca dallo stato italiano. Fare cucina vegetale qui è ancor più complicato, Angelo D'Amico Luca Miuccio



considerando che la neve copre tutto il territorio per numerosi mesi all’anno ma Michele Talarico, per di più pugliese di origine, non si perde certo d’animo, dal momento che ha ideato Cook the mountain all’insegna del rispetto della natura, dell’approvvigionamento in loco, della sostenibilità e dello scarto zero. “Ho scelto questa filosofia di cucina perché per me sono essenziali il rispetto della natura, delle materie prime e di tutti quelle sfaccettature che ne rendono possibile l’utilizzo” spiega Michele Talarico, cresciuto alla scuola di Norbert Niederkofler.
Nel suo menu degustazione vegetariano la scelta è quella dello spreco zero, infatti i piatti sono composti da un solo vegetale per volta, preparato in ogni forma possibile utilizzandolo in tutte le sue parti, come nel caso della Carota, doppiamente cotta (prima al vapore e poi sulla brace) che esprime tutto il potenziale dei sapori della terra, con il ciuffo della carota, utilizzato anch’esso.
“L’ospite viene da noi appositamente, per quello che noi facciamo. Sono tutti molto interessati, li portiamo in laboratorio a vedere i procedimenti del nostro foraging raccolto d’estate e preservato per l’inverno” racconta Michele che aggiunge a proposito degli Ambasciatori del Gusto:
“Si lavora bene con gli Ambasciatori, c’è molto dialogo e dobbiamo continuare con questo interscambio di idee, progetti e pensieri. Sul vegetale ci sono in programma

diverse iniziative che contribuiranno a dare maggior valore alla ricerca che comporta questo tipo di cucina”.
Stua Noa a Livigno (SO)
“La mia filosofia culinaria è guidata dalla passione per l’eccellenza e l’innovazione. Alla Stua Noa Fine Dining, come negli altri sei ristoranti del gruppo Lungolivigno, cerco di portare avanti questa visione, offrendo piatti raffinati, autentici e ricercati che riflettono le mie radici e la mia creatività”, con queste parole inizia la breve conversazione con Andrea Fugnanesi, raggiunto sulla scala dell’aereo che lo stava portando in brasile per lavoro, ma è bastata per capire anche la sua idea rispetto al vegetale.
“La nostra proposta per il vegetale è decisamente estrema, siamo stati i primi a fare un ristorante vegetariano a Livigno, utilizzando, per l’estate, la tecnica del foraging mentre per l’inverno abbiamo un rapporto solido con le aziende partner di Ambasciatori del Gusto, operanti nel settore. Non è facile fare una cucina vegetariana, implica moltissima ricerca ed è importante che un’associazione come la nostra riesca a far arrivare al potenziale cliente che quella vegetale è una cena completa, sana, piena di buoni colori, attraverso eventi, racconti come questo articolo, e molta formazione”.


È il 2001 quando Gabriele Boffetti cultore del buono e grande appassionato di cucina, fino a quel momento dedito ai numeri, matura di assecondare questa vocazione rilevando quel piccolo locale intimo e raccolto, una sorta di tavernetta a cui si accede scendendo di tre scalini da un viale alberato, che fino a quel momento aveva ospitato un bar, in quel di Borgo Val di Taro, vivace comune dell’Alta Val Taro (PR).
“Mi è sempre piaciuto questo spazio - ci racconta Gabriele - dove ho potuto ricavare una piccola ma ben attrezzata cucina e una sala proporzionata, che ho allestito con massicci tavoli in legno, sedie impagliate e un bancone da mescita. All’inizio facevo anche servizio bar, al mattino dalle 10 alle 12 e nel tardo pomeriggio dalle 17 alle 19.30, per poi attaccare con la cucina, volutamente piccola cucina, con la proposta di qualche antipasto, quattro
primi e quattro secondi - in linea con le stagioni -, di tradizione emiliana ma con qualche incursione nei territori confinanti. La regola era quella di fare la spesa la mattina e, in giornata, terminare quel che si era preparato. Prodotti sempre freschi, quindi”.
“Sin dall’inizio c’è stata – prosegue Ivan Borella, che tiene saldamente le redini della sala – l’intenzione di riproporre l’osteria di un tempo con la sua cucina casereccia e un menu che cambiasse giornalmente”. Proprio lui, che oggi rappresenta “l’acquisto” che a Gabriele mancava per potersi dedicare in tutta serenità alla cucina, per molti anni è stato estimatore di quest’osteria in qualità di cliente. “Quando lavoravo altrove nella ristorazione e avevo il mio giorno libero – osserva Ivan - venivo a cena in questo luogo che per me era del cuore”. È comprensibile quindi come ciò che convince noi per primi determini un

altro tipo approccio al lavoro, più di cuore.
Se c’è un comandamento a cui oggi, in una fase matura della sua attività, Gabriele si attiene quello è la ricerca maniacale di materie prime e prodotti di provata qualità, che la sua cucina, schietta e sincera, mette in risalto senza il bisogno di troppe elaborazioni.
Del Fungo di Borgotaro IGP, del tartufo e di altre prelibatezze
Il territorio di Borgo Val di Taro ha in seno una grande ricchezza quale il Fungo di Borgotaro IGP, porcino considerato superiore per qualità organolettiche, olfattive e aromatiche rispetto a quelli di altre zone d’Italia e dell’estero e unico micete in Europa ad avere ottenuto l’indicazione geografica protetta (IGP).
Un intero sistema si è strutturato intorno a questa peculiarità. Ogni anno in stagione (che va da fine agosto fino a inizio ottobre ma può estendersi fino a fine ottobre) si tiene la Fiera del Fungo di Borgotaro - giusto quest’anno giunta alla sua cinquantesima edizione - che non è più soltanto una mostra mercato ma un concatenarsi di eventi per ben due fine settimana. È poi possibile visitare il piccolo ma assai didattico e ricco di curiosità Museo del Fungo Porcino di Borgotaro, parte del circuito dei Musei del cibo dislocati nella provincia di Parma. In quest’occasione tutti i locali si ingegnano a declinare il porcino in diverse ricette.
Diventa una gioia per gli occhi imbattersi nella consegna di qualche cassetta di funghi immaginando che di lì a poco troveranno la loro giusta collocazione.
Ogni stagione è a sé stante. Quest’anno, per esempio, è stata un’ottima annata ma ciò non significa che la gettata sia stata continua. E il bello è quando, come ci ha raccontato Gabriele, c’è una tavolata di persone che hanno prenotato per un pranzo esclusivamente a base di funghi a fine settimana e non c’è certezza che arrivino.
In questo l’oste è talebano: se i porcini non sono locali non cerca alternative. Capita così che una prenotazione importante resti in stand by fino all’ultimo.



Ma quando i porcini ci sono viene esposta all’esterno del locale una lavagna a quattro piedi: “Sono arrivati i funghi porcini della Val Taro” e quell’attesa viene ripagata dal poterli degustare in tanti modi: in insalata (carpaccio), a fette carnose impanate e fritte magistralmente avendo cura di cambiare l’olio, come unici protagonisti di una bomba di riso, con i tagliolini caserecci ma anche con i tortelli di patate, accompagnati alla carne (tartare di manzo o di cavallo, entrecôte di scottona, filetto di maialino…) sia crudi che trifolati…
Anche il tartufo non scherza da queste parti, sia nero pregiato (invernale) che scorzone (estivo). Hanno pure iniziato a raccogliere il bianco. Se c’è un piatto per cui in molti vanno matti quello è l’uovo fritto con il burro e una grattata di tartufo, per dire di quanto la gente vada matta per le cose più semplici.
E da novembre arriva il carrello dei bolliti (testina, lingua, guanciale, cotechino, cappello del prete, cappone) serviti con salsa verde e maionese rigorosamente della casa e mostarda.
Pure le lumache sono un’altra chicca che in tanti gradiscono: alla bourguignonne, negli spaghetti o nel ripieno di ravioli.
Quando corre stima
Chiediamo a Gabriele quali piatti lo rappresentino maggiormente: “I tortelli d’erbetta per la loro delicatezza, i ravioli di baccalà per il rimando al pesce che un tempo

qui si mangiava il venerdì e il budino di ricotta e amaretti, una sorta di ciambella umida a base dei sopraccitati ingredienti, specialità di Borgo Val di Taro, che noi serviamo in un paio di fette con una salsa di fragole e peperoncino”.
Corre una buona intesa fra sala e cucina all’ Ustaria dal m’rca: “Ivan vede quello che faccio - osserva Gabrieleha passione per il cibo e quindi proprietà della materia”. “Dal canto mio - interviene Ivan - mi propongo di essere neutro nel servizio, perché il cibo fa già la sua parte da solo”. Ma, nel caso, sa, è preparato. L’essere nato in una famiglia di albergatori lo ha forgiato molto presto. Gabriele e Ivan si stimano e si alimentano a vicenda di voglia di fare. C’è anche da dire che quella sala intima, raccolta, crea spesso un’atmosfera familiare, in particolare quando gravitano certi personaggi. E come dice Ivan: “In quei frangenti tu lavori ma te la godi”.
Si sta bene all’Usteria dal m’rca. Si trova semplicemente serietà nel trattare il cibo, senza fronzoli, cosa che fa abbassare quelle barriere spesso tenute su anche al ristorante. Ci si fida.
Ustaria dal m’rca

Autore: Guido Parri

Clicca e leggi l’articolo sul web

Fondata a Jesi nel 1965, quando Umberto Baldi avviò la sua prima macelleria a cui si aggiungeranno presto altri tre punti vendita, Baldi oggi è diventata un preciso e affidabilissimo punto di riferimento per il settore Horeca in Italia. Suddivisa in numerosi reparti – carne, ittico, food service, bottega, academy – l’azienda marchigiana opera in tutto il centro Italia con un concetto che dice tutto in poche parole: ispirazione e soluzioni su ogni tavola. L’azienda ha celebrato l’anniversario, invitando al Seebay Hotel di Portonovo (AN) tutti i soggetti che hanno a che fare con l’azienda, dagli chef alle istituzioni, dai partner alle associazioni di categoria, ai dipendenti. È stata l’occasione per presentare un’inedita fotografia del consumo di food fuori casa. Dalla survey condotta su un campione di aziende clienti e partner di Baldi sono emersi alcuni trend indicativi del settore: rincari a doppia cifra, una scarsità selettiva su alcune origini e tagli e una domanda sempre più “valoriale” (tracciabilità, sostenibilità) sono alcuni dei problemi alla base delle sfide da vincere nei prossimi anni. Dal food service al food strategy, questo il titolo del convegno nel corso del quale sono intervenuti, oltre al top management dell’azienda - Angela ed Emiliano Baldi, rispettivamente presidente e amministratore delegato, e Luca Scorcella, direttore commerciale -, anche alcuni protagonisti del panorama italiano del food, della cultura e del management: Cristina Bowerman, chef stellata e imprenditrice, Angelo Bondi, food scout e trend analyst, e Oscar Di Montigny, autore e speaker internazionale.
Tornando alla survey, ecco di seguito alcune evidenze espresse dal panel dei clienti professionali di Baldi:
• Forniture alimentari: +17% l’aumento medio degli acquisti negli ultimi 12 mesi, il 51,5% degli operatori indica rincari tra +20% e +30%
• Carne bovina di qualità: +19,9% l’aumento medio, il 62% segnala incrementi +20% / +30%
• Il 65% degli intervistati non registra difficoltà di approvvigionamento su tagli/provenienze particolari, a differenza di un 21% che evidenzia criticità, individuando Argentina, Nuova Zelanda, USA e tagli Angus/Ribs tra le aree più critiche
• Il 41,9% delle aziende intervistate ritiene che sostenibilità e tracciabilità abbiano un peso molto importante nell’orientare le scelte di acquisto dei consumatori
• La survey indica un costo della qualità in crescita, una scarsità selettiva su alcune origini e una domanda che premia tracciabilità e sostenibilità.
L’intervista a Emiliano Baldi
Come sta cambiando il comparto dei consumi fuori casa, dal punto di vista della distribuzione?
“Il nostro settore sta cambiando sotto spinte che non nascono dal food ma dall’economia reale: l’intelligenza artificiale agentica, le nuove infrastrutture digitali, la transizione energetica e la de-globalizzazione ridisegnano filiere, costi e competitività. Lo dicono chiaramente i principali osservatori internazionali e lo vediamo tutti i giorni nei fatti: catene di fornitura che si avvicinano, maggiore instabilità, inflazione più marcata sulle carni bovine. In questo scenario non basta più servire prodotti: bisogna aiutare i clienti a fare scelte rapide, informate e sostenibili”.
La vostra azienda è in crescita costante da diversi anni: qual è, se possiamo definirlo così, il segreto per essere competitivi e vincere?
“Negli ultimi cinque anni, in effetti, abbiamo consolidato una traiettoria di crescita significativa: i ricavi sono passati da € 26 milioni nel 2019 a circa € 42 milioni nel 2024, pari a +61%, e nel 2025 l’azienda punta

a mantenere volumi e mix in un contesto reso complesso dall’inflazione di filiera e dalla volatilità delle materie prime, concentrando gli sforzi su efficienza operativa, miglioramento delle rese e valorizzazione qualitativa dell’offerta. Questa evoluzione economica riflette un cambio di paradigma: Baldi non è più soltanto un fornitore, ma un partner strategico che passa da un modello lineare a un ecosistema circolare in cui dati, competenze e formazione vengono messi a fattor comune per generare risultati misurabili”.
In cosa consiste questo cambiamento che lei chiama ecosistema circolare?
“Baldi, con oggi, passa dal food service alla food strategy: il nostro ecosistema si svilupperà attraverso una nuova app che non è un e-commerce ma l’interfaccia digitale del nostro know-how. È, metaforicamente, un consulente in tasca, che legge menù e dotazioni di cucina per proporre alternative di origine e taglio, ottimizzare food cost e resa, e sostenere il pricing con tracciabilità, benessere animale e una narrazione di filiera credibile. È lo stesso approccio che portiamo nel nostro lavoro quotidiano — dalla selezione internazionale alla valorizzazione di filiere locali — per connettere persone, competenze e futuro e creare valore condiviso lungo tutta la catena”.
Parlando di valori condivisi va detto che voi fate parte di un gruppo di distribuzione – Cateringross – che raggruppa 41 aziende attive nel canale horeca: quali sono i benefici che ne derivano?
“La circolazione delle conoscenze e delle idee. Far parte di un gruppo serve a misurarci, a condividere progetti di crescita, ad essere competitivi non solo sul fronte degli acquisti ma del servizio offerto. Questo porta a molti vantaggi in un mondo, questo della distribuzione alimentare, che si sta sempre più aggregando, diventando grande”.


Prestigiosa e ricca “collezione” di funghi di prima scelta lavorati con cura e attenzione, tagliati e trifolati delicatamente secondo tradizionale ricetta. Indicati come accompagnamento per primi o secondi piatti, contorni e per la farcitura di pizze.
DEMETRA FOOD COLLECTION i prodotti che fanno tendenza.
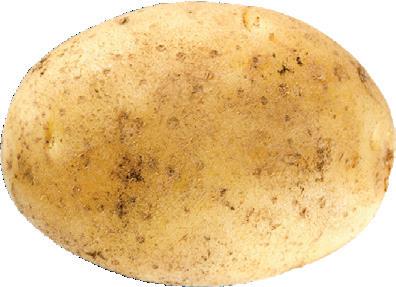
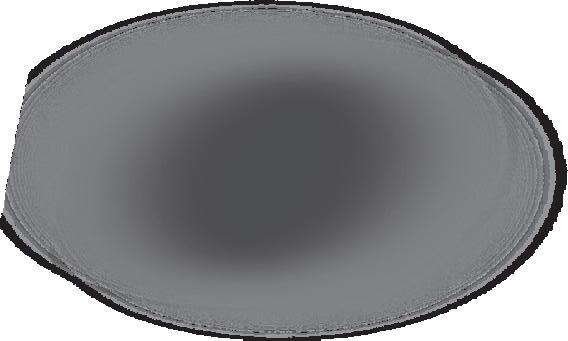

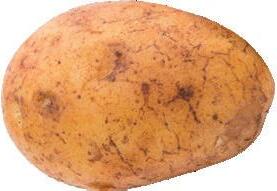
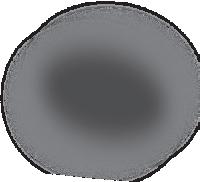
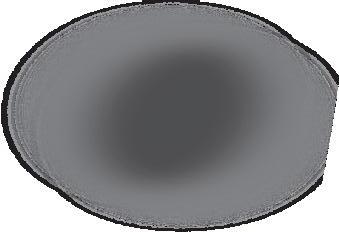
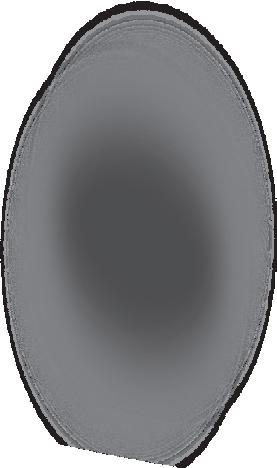
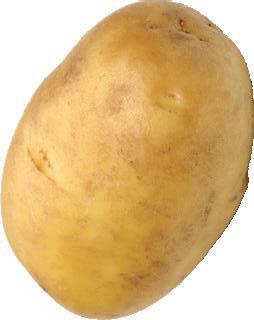
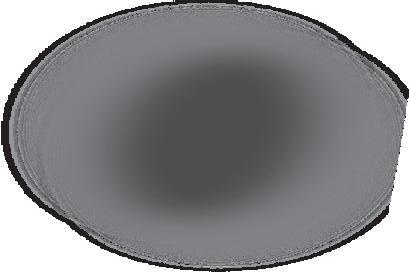
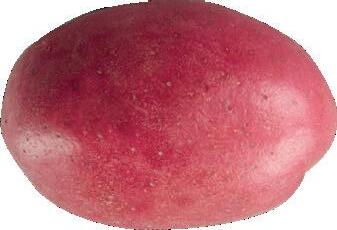
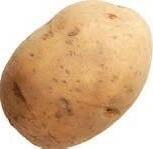
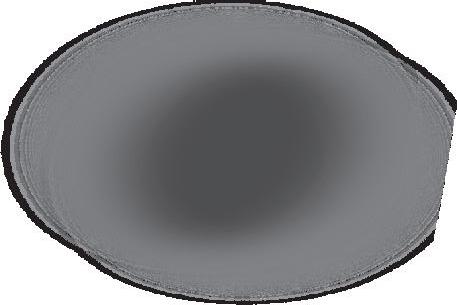
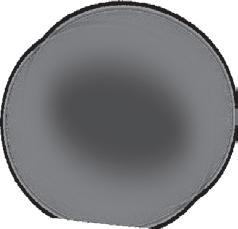


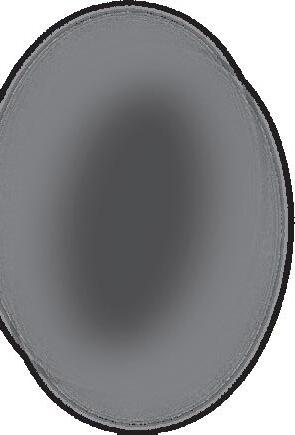
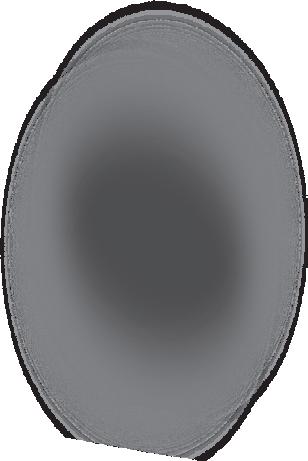
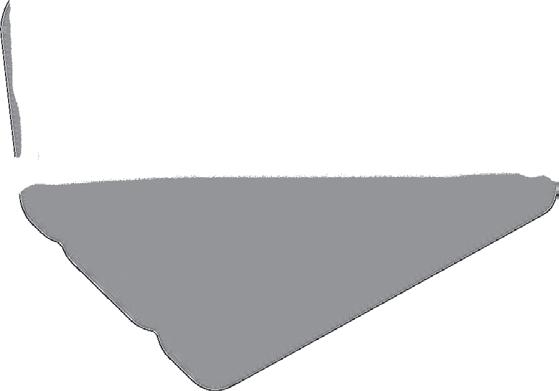


Polpa asciutta e farinosa, un sapore morbido, delicato e avvolgente che esalta ogni ricetta dalla più tradizionale alla piu' raffinata. Perfette per gnocchi soffici e purè cremosi.
Una selezione di patate professionali ognuna col proprio utilizzo culinario, per soddisfare ogni esigenza ed arricchire i vostri menù con materie prime dal sapore autentico capaci di esaltare l’essenza delle vostre creazioni. Testate ogni giorno dai nostri chef, garantiscono Gusto costante, piatti sempre perfetti e facili da realizzare. L’intera gamma è stata eletta Prodotto dell’Anno 2025!












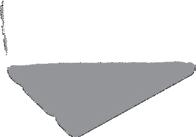






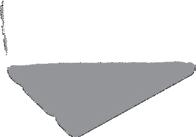

fritte, gnocchi, crocchette, puré, croccanti al forno



Autore: Federico Panetta

Clicca e leggi l’articolo sul web
Per decenni, lo street food simbolo della Germania fu il currywurst: una salsiccia tagliata a rondelle e ricoperta di ketchup speziato al curry, arrivata a Berlino grazie ai soldati britannici nel dopoguerra.
A inventarlo fu Herta Heuwer, una donna di Königsberg che, nel 1949, viveva nella Berlino distrutta e affamata della ricostruzione. Secondo la leggenda, un giorno riuscì a procurarsi ketchup, salsa Worcestershire e polvere di curry da alcuni militari inglesi di stanza in città, mescolò il tutto e lo versò su una bratwurst arrostita. Era il 4 settembre 1949, all’angolo tra Kantstraße e Kaiser-Friedrich-Straße, nel quartiere di Charlottenburg, Berlino Ovest. Quel piccolo esperimento di gusto, nato tra le macerie, intrattenne una relazione con i berlinesi che durò per decenni.
Il chiosco di Herta divenne rapidamente un punto di riferimento per operai, studenti e passanti in cerca di un pasto caldo, veloce, economico e saporito. La donna battezzò la sua invenzione Spezial Curry Bratwurst e, due anni dopo, registrò la salsa con il nome Chillup. Il segreto della ricetta morì con lei alla fine degli anni Novanta, ma la fama del piatto continuò a crescere, fino a diventare parte del patrimonio gastronomico tedesco.
Eppure, con il passare dei decenni, lo scettro dello street food più amato è passato di mano. Se il currywurst raccontava la Germania della ricostruzione, quella alla ricerca di sapore e modernità dopo la mestizia della guerra, oggi il piatto che meglio rappresenta la Germania contemporanea, con tutti i suoi contrasti, è senza dubbio il döner kebab Negli anni Sessanta, la Germania Ovest era in pieno boom economico. Le fabbriche lavoravano a ritmo serrato, e la manodopera locale non riusciva a soddisfare la mole di lavoro. Così nel 1961, dopo le ondate precedenti di lavoratori italiani, spagnoli e greci, la Repubblica Federale firmò un accordo con la Turchia per accogliere i Gastarbeiter, i “lavoratori ospiti”. In pochi anni ne arrivarono centinaia di migliaia: giovani uomini, spesso provenienti dalle campagne anatoliche, attratti dalla promessa di un salario stabile e dalla possibilità di mandare denaro alle famiglie rimaste in patria. L’idea era quella di farli rimanere per un periodo limitato di qualche anno, ma col tempo molti di loro decisero di fermarsi e mettere radici nel centro dell’Europa. Quando una parte di loro rimase senza lavo-
ro a causa dello scadere dei contratti, invece di tornare in patria si reinventò nella ristorazione, da sempre uno dei settori più accessibili per persone non ancora integrate. Col tempo le loro famiglie li raggiunsero, nacquero nuove generazioni, e con loro arrivarono anche i sapori di casa.
Il kebab prima del döner Kebab, in Turchia, è una parola generica che indica la carne arrostita. Esistono decine di varianti regionali: şiş kebab, infilzato su spiedi; Adana kebab, speziato e piccante; İskender kebab, servito su pane con salsa di pomodoro e yogurt. Il döner kebab, invece, letteralmente “kebab che gira”, è una creazione relativamente recente. La sua origine risale all’Ottocento, quando il cuoco ottomano Iskender Efendi di Bursa ebbe l’idea di infilare la carne in verticale invece che in orizzontale, lasciandola cuocere lentamente davanti al fuoco e tagliandola a fettine sottili. Da lì, il döner si diffuse in tutta la Turchia e, con l’emigrazione, nel mondo. Ma la sua trasformazione più famosa avvenne più di recente, a circa 2000 km lontano da Istanbul.
La leggenda vuole che tutto sia cominciato con Kadir Nurman, un immigrato turco arrivato a Berlino negli anni Sessanta, all’età di 33 anni. Nel 1972, davanti alla stazione ferroviaria di Zoologischer Garten, aprì un piccolo chiosco dove vendeva carne di agnello arrostita, servita non su un piatto, come si usava in Turchia, ma in mezzo a del pane, condendo il tutto con insalata e salsa allo yogurt. L’idea era semplice: un pasto caldo, economico e facile da mangiare in piedi, pensato per i lavoratori e i pendolari berlinesi. Quella trovata, pensata per adattarsi alla frenesia della vita urbana, fu rivoluzionaria. Il döner im Brot (döner nel pane) piacque subito, e nel giro di pochi anni nacquero centinaia di chioschi in tutta la Germania. A differenza della versione turca, servita al piatto, quella tedesca si arricchì di ingredienti nuovi: lattuga, pomodori, cipolla, salse bianche e rosse. Un piatto ibrido, frutto della contaminazione culturale: turco nella sostanza ma tedesco nel formato. Oggi, il döner kebab è uno dei cibi più amati in Germania:
si stima che ne vengano consumati più di due milioni al giorno. Esistono catene specializzate e innumerevoli versioni in grado di adattarsi alle esigenze di ognuno, tanto che oggi viene considerato da tutti un piatto nazionale, emblema della Berlino multiculturale e aperta. Ma dietro il successo commerciale, il döner racconta anche la trasformazione della società tedesca. Negli anni Settanta, i turchi erano visti come una forza lavoro temporanea; oggi, i loro figli e nipoti sono parte integrante del tessuto urbano, e molti dei chioschi di döner sono diventati piccole imprese familiari tramandate di generazione in generazione. Il panino, nato dall’incontro tra nostalgia e adattamento, è diventato il simbolo di un’identità condivisa: quella di una Germania che non è più solo tedesca, ma europea e, in fin dei conti, globale. Naturalmente, questo processo non fu privo di tensioni. Negli anni ’90, l’aumento della presenza turca in Germania suscitò diffidenze e ostilità, e la società faticava a considerare queste comunità parte integrante della propria nazione. A stemperare queste tensioni contribuì però una serie televisiva innovativa: Kebab for Breakfast (conosciuta in tedesco come Türkisch für Anfänger), che raccontava con ironia e autenticità la vita di una famiglia mista, andando oltre la caricatura. All’interno della serie, anche un semplice kebab diventava un ponte tra culture, capace di far incontrare gusti, abitudini e storie diverse intorno allo stesso tavolo, e forse nella vita reale qualcuno iniziò ad imitare quei gesti, assaporando così un po’ di quotidiana convivenza e curiosità reciproca.


Autore: Guido Parri
DoGusto, il brand con cui i soci del gruppo Cateringross propongono ai propri clienti esclusività dei prodotti, si arricchisce di tre formaggi selezionati in piccole realtà artigianali, dove il lavoro del casaro è determinante per l’ottenimento di un’elevata qualità: Ubriaco al Raboso, Formaggio sotto Fieno ed Erborinato ai frutti di bosco e passito sono i nomi di questi formaggi, adatti a diverse preparazioni sia in pizzeria sia al ristorante, oltre a fare bella mostra di sé sul carrello dei formaggi. Il produttore di queste forme cura ogni dettaglio con cura maniacale, monitorando le condizioni ambientali più adatte durante la stagionatura e dedicando ad ogni tipologia un preciso trattamento manuale. Dall’inversione periodica delle forme per garantire una maturazione omogenea, alla spazzolatura, dall’oliatura ai delicati lavaggi della crosta con acqua e sale. Ogni passaggio, dall’affumicatura all’inoculazione delle muffe per l’erborinatura, è pensato per esaltare la qualità unica di questi formaggi.
Formaggio sotto Fieno è un formaggio a latte vaccino dal sapore deciso e vivace, ricoperto di fieno delle Alpi bellunesi appena raccolto. I profumi dei prati erbosi vengono riproposti proprio dal fieno che, stagionando assieme alla forma di formaggio crea un connubio perfetto che rappresenta l’essenza della montagna e dalla natura in alta quota. Perfetto per ogni stagione ma si esalta in estate.
Ubriaco al Raboso è un altro formaggio a latte vaccino di pasta friabile ben saporito con alcune note piccantine. Ubriacato in vinaccia e vino Raboso viene anche cappato con la vinaccia. Molto profumato e dal gusto deciso e persistente. Ottimo per apertura o chiusura del pasto ma interessante per abbinamenti con carni ed ortaggi.
Clicca e leggi l’articolo sul web



Erborinato ai frutti di bosco e passito è, invece, un’erborinato affinato internamente con Passito Rosso e, in cappatura, con frutti di bosco disidratati. Pasta compatta, ottimo equilibrio tra dolce e salato. Perfetto a tutto pasto.
Questi formaggi sono in produzione esclusiva per i clienti dei distributori associati a Cateringross.






La valorizzazione della cucina italiana passa anche e soprattutto attraverso le certificazioni di garanzia delle materie prime, attraverso la loro tracciabilità e trasparenza, attraverso la loro chiara identità, sia territoriale che culturale. Pensiamo subito al ruolo fondamentale che svolgono in tal senso, ad esempio, i Consorzi di Tutela, le DOP (Denominazione di Origine Protetta), le IGP (Indicazioni di Origine Protetta), le STG (Specialità Tradizionale Garantita): non semplici sigle, ma realtà concrete e strategiche di intere filiere produttive, testimonianze di garanzia e di alta qualità nelle nostre cucine e sulle nostre tavole. Oggi il cuoco professionista è chiamato a interpretare e a portare avanti un altro ruolo molto delicato: quello di stratega della sostenibilità, accanto a quelli ormai noti di “ambasciatore” del territorio o di “anticipatore” della salute a tavola. Ecco, immaginare i menu dei nostri ristoranti costruiti sempre più su misura con le risorse di una determinata provincia o di una regione, con chiari riferimenti alle produzioni di eccellenza, alle DOP, alle IGP, e dunque con una tracciabilità evidente e garantita, non può che accrescere la fiducia dei consumatori nel nostro comparto, oltre che tutelarli nel consumo degli alimenti. È un aspetto che la stessa clientela dovrebbe pretendere a gran voce, come sinonimo di garanzia, quando ordina un piatto e quando chiede quale sia la storia da cui quella ricetta è nata e che sta per assaggiare.
Dietro ogni sigla, infatti, e dietro ogni materia prima tutelata, come ad esempio le DOP o le IGP, non ci sono soltanto ingredienti: c’è l’intera cultura di un popolo e di un territorio; ci sono le tradizioni e i gesti antichi con cui le tavole prendevano forma e sostanza; ci sono i racconti di come quel determinato ingrediente è nato e di come è stato tramandato fino a noi, anche grazie ai

Rocco Cristiano Pozzulo Presidente nazionale FIC
gesti sapienti compiuti in cucina, attraverso le diverse tecniche di cottura e attraverso il grande rispetto che il cuoco nutre per i prodotti genuini.
Anche per questo, sempre più la Federazione Italiana Cuochi sta puntando sulla valorizzazione di determinate filiere, sulla diffusione e conoscenza dei messaggi portati avanti da Denominazioni e Indicazioni Geografiche, con i loro marchi e Consorzi di Tutela. Lo stiamo facendo ovunque: nelle nostre competizioni, come i Campionati della Cucina Italiana, appuntamento annuale dove durante le gare si assiste al trionfo stesso delle materie prime di eccellenza e alla sapienza e conoscenza con cui i nostri Chef, giovani o veterani, trattano e cucinano il prodotto. Lo facciamo nei nostri corsi di aggiornamento con i docenti dell’Alta Formazione e con gli Chef della Nazionale Italiana Cuochi, interpreti prestigiosi di ingredienti e di prodotti unici. E lo facciamo, naturalmente, con le nostre aziende partner, preziose realtà non solo economiche e commerciali, ma altrettanto preziosi baluardi della tradizione unita alla modernità della produzione. Pensiamo, infine, richiamandoci proprio ai partner di Federcuochi, a realtà come Cateringross, impegnata ogni giorno nella valorizzazione dei marchi e dei Consorzi di Tutela. Un impegno che ha visto, ad esempio, la nascita dei prodotti della linea DoGusto, dove, per i clienti di un ristorante intenti a sfogliare il menu di un locale, le parole qualità certa non sono solo uno slogan, ma una realtà concreta di come si possa e si debba tradurre tutto questo nella ristorazione di ogni giorno.

Ogni gesto in cucina è precisione, creatività, impegno. Lo sappiamo, perché siamo al fianco, da oltre due secoli, di chi ogni giorno trasforma ingredienti in esperienze. Da oggi nasce una gamma studiata appositamente per le necessità e le richieste dei professionisti, apponendo la firma Zucchi come sigillo dei nostri valori e della nostra qualità.





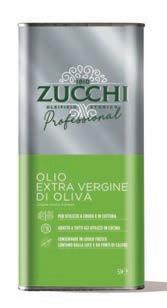


Nicola Piovani, premio Oscar e tra i più autorevoli compositori italiani, ha acceso un acceso dibattito dopo aver pubblicato su La Repubblica un intervento contro la musica di sottofondo nei ristoranti. Secondo Piovani, la musica utilizzata come semplice sottofondo finisce per essere svuotata di senso, ridotta a un rumore che degrada il valore stesso dell’arte musicale. “Una canzone di Cohen vale una di Povia, se usata come sottofondo”, ha scritto, proponendo di introdurre un bollino “music free” per segnalare i locali che scelgono il silenzio come segno di rispetto verso la musica e come spazio per chi desidera parlare, ascoltare o semplicemente gustare il momento. La provocazione ha diviso il settore. Ma cosa dicono le neuroscienze? Le ricerche hanno dimostrato che il suono influenza in modo diretto e misurabile i comportamenti, la percezione del tempo e persino la qualità dell’esperienza. Nel campo della Neurovendita, il rapporto tra musica e comportamento del cliente è ormai un dato certo: la musica non è mai neutra. Uno studio ha evidenziato che brani con un ritmo inferiore ai 100 battiti per minuto favoriscono una permanenza più lunga e un consumo più rilassato, aumentando la spesa al tavolo. Al contrario, ritmi più sostenuti spingono a mangiare più velocemente, riducendo i tempi di occupazione. La scelta della musica influisce sul flusso del servizio tanto quanto la disposizione dei tavoli o la sequenza delle portate. Uno degli esperimenti più citati risale agli anni ’90, in un’enoteca con cucina, i ricercatori alternarono giornate di musica francese e tedesca. I risultati furono sorprendenti. Durante le giornate con musica francese, aumentavano le vendite di Champagne e vini d’oltralpe, mentre nei giorni con musica tedesca cresceva la richiesta di Riesling. Solo lo 0,3% dei clienti dichiarava di essere stato influenzato dalla musica in sottofondo. Il suono agiva a livello inconscio, orientando le scelte senza che il consumatore se ne rendesse conto.

C’è un dato interessante della ricerca neuroscientifica che smentisce la posizione di Piovani. Quale? Il cervello umano “odia” il silenzio assoluto. Dal punto di vista neurobiologico, l’assenza di suoni è interpretata come un segnale di pericolo. Ciò significa che l’assenza completa di stimoli sonori può generare disagio, inibendo in parte proprio la comunicazione e la conversazione tra le persone.
Il problema, allora, non è la musica in sé, ma come e quanto viene usata. Due errori sono particolarmente comuni nella ristorazione: la radio accesa e le hit da classifica. La radio introduce una programmazione incontrollata, interrotta da pubblicità e notizie che rompono il ritmo del servizio. La playlist con le hit sposta il focus dall’esperienza gastronomica al ricordo personale del brano. Il risultato è un cortocircuito sensoriale. La musica non accompagna più il piatto, ma lo copre.
La chiave musicale nei ristoranti è nella coerenza e nella consapevolezza. La musica, come l’arredamento o la mise en place, è parte dell’identità del locale. Il consiglio pratico per i ristoratori è semplice: definire la “sound identity” del locale. Studiate playlist coerenti, regolate il volume in base all’ora, evitate le interferenze della radio e le hit ripetute. Il cliente non deve accorgersi della musica, ma sentirla come parte naturale dell’ambiente. Piovani ha ragione a difendere il valore dell’ascolto consapevole, ma nel mondo della ristorazione l’obiettivo non è “ascoltare” la musica, bensì viverla come parte dell’esperienza. Il direttore d’orchestra Enrico Melozzi ha proposto di formare una nuova figura professionale, il “sommelier del suono”, in grado di selezionare generi e volumi in base al tipo di ambiente, alla fascia oraria e al target di clientela. In un ristorante, come in un’orchestra, la musica migliore è quella che non si impone, ma accompagna: discreta, calibrata, invisibile e perfettamente intonata con l’anima del luogo.























Good Day e Polot 1882 trasformano ogni momento della giornata in un’esperienza di gusto e benessere.
Le farciture in barattolo arricchiscono croissant, pancake e dolci con sapori autentici, mentre le acque aromatizzate offrono freschezza e armonia in ogni sorso. Due linee selezionate da General Fruit per soddisfare ogni esigenza di qualità e piacere, dalla colazione al break.
IDEALI PER UNA PREPARAZIONE FREDDA O CALDA

FARCITURE 1,5 kg (Albicocca - Cioccolato bianco - Crema pasticcera - Fragola - Frutti di bosco - Nocciolata - Pistacchio)
ACQUE AROMATIZZATE 1 L (Bergamotto, Agrumi e Curcuma - Fior di sambuco, Zenzero e Menta Limonata di Sicilia - Limonata di Sicilia e Zenzero - Melagrana e Aloe vera - Tè, Mela e Cannella)

•CIDNI A ZIONEGEOGRAFICAPRO T ATTE
Da selezionati bovini grass fed: allevati all’aperto per almeno 220 giorni l’anno, alimentati per il 90% con erba
Autrice: Giulia Zampieri

Come definiresti la tua professione oggi?
È una domanda che ci stiamo ponendo, e vi poniamo, per capire qual è la percezione più diffusa. Stiamo assistendo a grandi cambiamenti che interessano il settore dell’ospitalità e della ristorazione - ma anche quello della comunicazione specializzata e generalista, della produzione alimentare, della divulgazione scientifica, della legislazione, e potremmo continuare.
Sono cambiamenti che gonfiano le agende, perforano talvolta la sfera personale, non consentono distrazioni o leggerezze, rendono la lista delle voci di un bilancio sempre più lunga. Pensiamo alle nostre giornate lavorative: le defezioni sono poco tollerate, non parliamo dell’incoerenza; ogni giorno si deve performare, pena il giudizio, la recensione, il richiamo da parte di un cliente, di un ospite. È tutto amplificato.
Ma tornando alla domanda: Riccardo Scalvinoni, la mente e il traino della cucina del ristorante Il Colmetto, a Brescia, risponde senza tentennare “Il nostro lavoro oggi è molto complesso. Lo è in generale fare qualsiasi mestiere”.
Come non essere d’accordo? Aggiungiamo: è talmente complesso che bisognerebbe rimettere ordine, ristabilire le priorità e i confini. Riconsegnare il giusto valore al cibo - come sosteniamo da tempo - e alle relazioni, mantenendosi più lucidi ed evitando di lasciarsi sopraffare dalle tendenze.
Basta salse disposte tutte allo stesso modo, basta scelte comunicative replicate qua e là.
Dobbiamo tornare a parlare, magari poco, ma con schiettezza e senza retoriche, di temi veri, applicati e applicabili.
Se parliamo di sostenibilità non facciamolo a vanvera. Diciamo le cose come stanno: essere sostenibili sul piano economico e ambientale è difficile. È complesso, appunto. Non basta scriverlo, non basta nemmeno impegnarsi in uno o due compitini.
“Il nostro obiettivo a Il Colmetto è dare spazio l’autoproduzione e, dove non è possibile, selezionare le materie

prime da realtà che hanno un senso. Produciamo circa l’80% di ciò che serviamo al ristorante - mi dice Riccardo mentre mi fa strada tra distese di brassicacee e aiuole di erbe aromatiche - Ma abbiamo bene a mente che la sostenibilità un conto è cercarla, un conto è ottenerla.
Costa fatica, tempo, bisogna disporre di una certa struttura. E sicuramente il pensiero sostenibile sposta il fine su un altro piano: quello che si fa lo si fa per fare bene le cose, non per altro!”.
Poco dopo mi allunga un pomodoro verde pescato da uno dei vasi in fermentazione, raccontando il rapporto con il prodotto e la stagionalità.
“Non c’è molto da discutere. Non mi interessa svolgere questo mestiere in modi diversi, ovvero senza seguire la stagionalità, senza utilizzare le materie prime per intero, senza allungare la vita dei prodotti che possono essere conservati”.
Riccardo non lo dice in modo esplicito ma lo trasmette: per gestire la complessità, oggi, c’è bisogno di pensieri semplici ma fermi. Di motivazioni reali, perché altrimenti ci si perde, e quasi sempre ci si contraddice. A quel punto non rimangono che “siti vetrina” e manifesti vuoti, altro che ristoranti sostenibili.
Finiamo a parlare di ristorazione contemporanea, di conquiste e derive.
“Sembra un aspetto secondario ma avere il ristorante pieno è la cosa che conta. Ricordiamocelo: i cuochi cucinano per le persone… non per sé stessi! Invece a volte pare che lo scopo sia raggiungere dei traguardi più che

far star bene le persone. Dovremmo tornare tutti a servire sostanza, non provocazioni” ci dice Riccardo. Non vi raccontiamo per filo e per segno la sua storia; ci limitiamo a darvi che proviene da una famiglia di fornai, ha lavorato con Piergiorgio Parini al Povero Diavolo, da Futura Osteria a Monteriggioni, ed è arrivato a Il Colmetto nel 2020. Insomma qualche passaggio, professionale e anche geografico, c’è stato, ma ora ha spostato questo progetto da cinque anni.
“L’irrequietezza abita chi lavora nella ristorazione e oggi sembra ancora più evidente. Si staziona per pochi mesi, al massimo un anno, nella maggior parte dei ristoranti. Poi c’è il bisogno di cambiare. Sicuramente c’è un fattore-curiosità che incide ma c’è anche un mondo in movimento, in cui ci si lega poco al presente e tanto alle proiezioni di dove potremmo essere. Credo che cambiare per il gusto di cambiare non abbia più molto senso, anche stando fermi si può crescere”.
Come spesso accade tra una considerazione e l’altra saltano fuori nomi di ristoratori, di realtà simili o diametralmente opposte. Gli chiediamo qual è il rapporto con i suoi colleghi.
“Non c’è più la concorrenza come la si intendeva in passato. Era una condizione animata anche dall’odio e da tante invidie. Si allungava l’occhio per vedere se gli altri erano pieni. Oggi, per quella che è la mia esperienza, si collabora molto; si cerca di alzare costantemente la qualità. Alcuni hanno capito che farsi prendere dall’invidia e non metterla sul piano della condivisone genera una

perdita. Nella collaborazione tra persone che fanno lo stesso lavoro c’è una possibilità di guadagno per tutti”.
La condivisone è un tema centrale anche nelle scelte di servizio del Il Colmetto: quando si opta per i percorsi di degustazione - che cambiano settimanalmente - i piatti arrivano al tavolo tutti assieme, al centro.
“Dicevo dello scambio… vogliamo che ci sia lo scambio anche nei nostri tavoli, che si passino i piatti tra una mano e l’altra, genera una tensione positiva”.
Si crea una bella situazione nel perimetro di ciascun tavolo, come bella è la situazione che si crea in sala, dove ci sono tutte le condizioni per godersi un momento riservato ma anche per interagire con i vicini, allungare una bottiglia, trascorrere del tempo senza che l’atto di consumo sia un rituale liturgico ma piuttosto un momento di pura convivialità.
Il Colmetto, in breve
Abbiamo dato spazio alla conversazione con Riccardo Scalvinoni ma Il Colmetto è una realtà articolata che merita di essere visitata, prima o dopo aver riposto le posate sul tavolo. Il ristorante si trova all’interno di un ecosistema più ampio in cui protagonista è la società agricola

guidata da Roberta e Romina Agosti sviluppata su trenta ettari in Franciacorta, nel comune di Rodengo Saiano, al confine con Castegnato (BS).
Ospita un allevamento di capre Saanen e di asini romagnoli, un piccolo caseificio per la produzione di formaggi di capra con rivendita interna, serre e orti per l’autoproduzione di verdure e ortaggi e, appunto, il ristorante. Stiamo parlando - come rimarcavamo qualche riga sopra - di una filiera cortissima, controllata e a ciclo chiuso, ma che sa guardare anche fuori per migliorarsi. Sul ristorante, di cui abbiamo parlato con Riccardo, aggiungiamo: oltre alla cucina, golosa e riconoscibile, divertente, ma anche connotata dal rispetto per qualsiasi materia prima, vale la pena allungare la mano sulla carta vini. E pure sulla Torta di rose, quando c’è. Il Colmetto Via Finilnuovo, 9/11 25050 Rodengo Saiano (BS) Tel. 030 6811292



Industria Molitoria Perteghella SAS www.perteghella.it - info@perteghella.it
Autrice: Alessia Cipolla
Clicca e leggi l’articolo sul web
Architetto della Nouvelle Cuisine e custode dell’eccellenza gastronomica francese del XX secolo, lo chef Paul Bocuse ha segnato un’epoca, e non solo

Siamo tutti figli della Nouvelle Cuisine, nel bene e nel male, volenti o nolenti. Abbiamo ereditato così tanto da, spesso, dimenticarlo.
La Nouvelle Cuisine non è emersa dal nulla, ma è stata il prodotto di un’epoca di profondi cambiamenti sociali, economici e culturali in Francia e nel mondo occidentale. Nonostante l’arrivo della società dei consumi, nel secondo dopoguerra la fame era rimasta, con la preferenza per piatti abbondanti e una cucina ricca e sontuosa, perlomeno fino alla ‘lipofobia’ che impose, piano piano, diete leggere e sane. Il ‘68, poi, spazzò via le convenzioni, le gerarchie e il potere autorevole, anche in cucina: iniziò così a creparsi l’egemonia della ‘pesante’ e ‘dogmatica’ cucina classica e internazionale di Escoffier e del suo testo le Guide Culinaire a favore di un movimento regionalista guidato dal celebre gastronomo Maurice Edmond Sailland (1872 -1956), con lo pseudonimo Curnonsky, che criticava la cucina internazionale per la sua ridondanza e artificiosità, promuovendo il “gusto autentico” dei prodotti. Era già successo: Nicolas de Bonnefons, maestro di sala alla corte del re di Francia Luigi XIV, nel testo Délices de la Campagne (1684) propose di portare in cucina la semplicità dei sapori e la naturalità del gusto contro le regole della cultura rinascimentale che imponeva di modificare e migliorare il sapore, la consistenza, la forma e il colore delle preparazioni attraverso ‘artefizi’ gustativi. Un precedente di “nouvelle cuisine”.
Lo chef artista
Nel secondo dopoguerra chef come Fernand Point, Alexandre Dumaine e André Guillot iniziarono a sperimentare cotture più semplici e leggere, sebbene in modo isolato e non ancora sistematizza-
| ottobre 2025

to, decidendo di alleggerire l’haute cuisine e la cucina borghese del tempo.
Arrivò poi una nuova generazione, innovativa e pronta alla rottura con il passato, composta da chef come Paul Bocuse, i fratelli Troisgros (Jean e Pierre, poi Michel), Michel Guérard, Alain Chapel, Roger Vergé, Louis Outhier, Jean Delaveyne e altri che, inizialmente, si sostennero a vicenda, condividendo idee e tecniche, lavorando per affermare il cuoco come artista e imprenditore.
Il servizio al piatto, per come lo conosciamo oggi, riconosciuto come ‘inventato’ dai fratelli Troisgros (come anche il menu degustazione), trasformò l’impiattamento in una forma d’arte: ogni piatto divenne una tela sulla quale esprimere la propria creatività. Questo spostò l’attenzione dalla sala alla cucina, dal maître d’hôtel allo chef come autore e creativo.
Grazie a due critici gastronomici francesi il movimento di ‘nuovi’ chef ebbe il suo battesimo.
Henri Gault e Christian Millau
Nel novembre 1973, sulla copertina del loro Nouveau Guide Gault-Millau, apparve la frase “Vive la Nouvelle Cuisine Française!”. Questa operazione giornalistica non inventò una nuova cucina, ma codificò un fenomeno in crescita, legittimando un nuovo corso della gastronomia fatta di semplicità, raffinatezza, leggerezza e audacia.
Furono loro a scrivere il celebre decalogo della Nouvelle Cuisine, in pieno contrasto con la cucina classica: tra i punti più importanti ci fu l’alleggerimento dei piatti con cotture brevi, l’uso limitato di grassi preferendo sapori e prodotti freschi e di qualità. Le salse dovevano essere leggere e naturali. Si prediligeva la semplicità nella preparazione e nella presentazione, aprendosi a influenze giapponesi e cinesi. Grande era l’attenzione alla salute e alla dietetica: lo chef Michel Guérard, con la sua Grande Cuisine Minceur ( grande cucina dimagrante), ne fu un pioniere. La presentazione artistica, L’assiette comme une toile ( il piatto come una tela), era un elemento centrale dell’atto culinario. Il decimo comandamento di Gault e Millau “Essere inventivi: tutto è permesso!” liberò i cuochi dai dogmi

del passato, incoraggiando la sperimentazione e la composizione contemporanea dei piatti.
La cucina francese venne esportata in tutto il mondo: gli chef aprivano ristoranti all’estero e cuochi stranieri andavano a formarsi in Francia. Paul Bocuse, in particolare, divenne una vera e propria star internazionale. Nacquero ‘nuove cucine’ in Germania con lo chef Eckart Witzigman, nel Regno Unito con i fratelli Roux e Raymond Blanc, in Italia con il maestro Gualtiero Marchesi, in Scandinavia e in paesi come Brasile, Perù e Stati Uniti.
All’apice del successo iniziò la crisi: la ‘starizzazione’ degli chef, il manierismo e la teatralità eccessivi, il plagio dei piatti, la complessità fine a sé stessa, l’eccessiva sperimentazione e la critica di porzioni ridotte e prezzi elevati portarono alla fine (apparente) di un movimento che ha, però, lasciato segni profondi in tutte le generazioni successive. Come dice lo chef Joël Robuchon: “La Nouvelle Cuisine non ha più bisogno di un nome: è quella che, più o meno, facciamo tutti i giorni.”
Bocuse si dissociò dalle derive della Nouvelle Cuisine già alla fine degli anni ’70.
Nato nel1926 a Collonges-au-Mont-d’Or vicino Lione, dove i suoi antenati erano cuochi e ristoratori sin dal XVII secolo, Paul Bocuse fu leggendario sin da subito: nel 1944 si arruolò come volontario nell’esercito di liberazione del Generale De Gaulle, subendo una ferita in Alsazia e venendo curato dagli americani, che gli tatuarono un gallo “gaulois” sulla spalla sinistra. Quel periodo definì la sua profonda identità francese che si rifletté nella sua cucina.
Dopo la guerra, Bocuse si perfezionò come cuoco sotto la guida di maestri illustri. Lavorò dalla grande cuoca Eugénie Brazier, figura iconica delle mères lyonnaises, raggiungendo il ristorante sulla cima del Col de la Luère in bicicletta, salendo per ventisei chilometri, e Gaston Richard al Lucas Carton. Tuttavia, l’incontro più importante fu con Fernand Point al ristorante La Pyramide di Vienne, dove lavorò otto anni a partire dal 1948. Point aveva già costruito la sua fama sul-

la cucina del territorio, utilizzando i prodotti locali.
Secondo Bocuse, fu Point a “eliminare, prima della guerra, tutte quelle salse, quei piatti complicati, troppo ricchi, quelle guarnizioni che dettavano legge nella cucina del XIX secolo”. Point, infatti, aveva una cucina semplice e generosa, sebbene non ancora leggera come quella che sarebbe venuta con la generazione degli allievi. Insegnò a Bocuse l’importanza della cucina del mercato e di eliminare i prodotti avanzati del giorno per “ripartire da zero ogni mattina” con prodotti freschi.
L’Auberge du Pont de Collonges fu il ristorante di famiglia che Bocuse fece conoscere a tutto il mondo: nel 1965 il ristorante ottenne le 3 stelle Michelin che conservò per oltre cinquant’anni
Nel 1987 Paul Bocuse and Albert Romain idearono la prima edizione del Bocuse d’Or un campionato mondiale di alta cucina per chef, organizzato a Lione ogni due anni: ad oggi tra le più prestigiose gare al mondo di cucina.
Paul Bocuse è morto a 91 anni, il 20 gennaio 2018 nella stessa stanza in cui era nato.
“La cucina del mercato”: un manifesto di freschezza
Nel 1976, Paul Bocuse pubblicò il libro La Cuisine du Marché (La cucina del mercato), un best seller che uscì tre anni dopo il celebre articolo di Gault et Millau sulla Nouvelle Cuisine.
Il libro includeva non solo le sue ricette, ma anche quelle di molti dei suoi colleghi e amici della Nouvelle Cuisine, come Roger Vergé (il suo paté di anguille caldo), Charles Barrier (casseruola di gamberi alla marinara), i fratelli Troisgros (scaloppa di salmone all’acetosella), Michel Guérard (spigola alle alghe), Louis

Outhier (cappone ripieno), Pierre Laporte (capesante con piccole verdure), Raymond Thuilier (triglia al pesto), Alain Chapel (gâteau di fegatini di pollo), René Lasserre (saltimbocca d’agnello con piccole verdure), Gaston Lenôtre (ragù di animelle con gamberi) e Paul Haeberlin (lepre alla royale).
Con questo testo Bocuse non volle solo trasmettere delle ricette ma creare un vero e proprio manifesto basato sulla qualità, la freschezza e il rispetto dei prodotti di stagione e su una nuova attenzione alla salute opponendosi all’alimentazione industriale. Disse: “La ‘Nouvelle Cuisine’, in fondo, è la vera cucina. Ma come definirla più precisamente? Prima di tutto con l’attenzione data alla qualità dei prodotti. In questo campo, non bisogna imbrogliare ma cercare sempre il meglio come carne, verdure, ecc.”
La Cuisine du Marché fu anche un’operazione diplomatica da parte di Bocuse che si propose come un ponte tra il passato e il futuro della cucina.
Il libro non fu esente da polemiche. Il critico gastronomico de Le Monde Robert Courtine accusò Bocuse di aver copiato molte ricette dal defunto Alfred Guérot (direttore della “Société des cuisiniers de Paris” e autore di “La cuisine et la pâtisserie françaises”, 1953). Ma la grandezza di Bocuse non potrà mai essere messa in discussione. Inchiniamoci.

Autrice: Giulia Zampieri
www.vinimontetino.com

Clicca e leggi l’articolo sul web
Costruire il nuovo, o ripristinare, senza stravolgere il culto
Da più di due anni raccogliamo storie di viticoltori che ci hanno speranza. Non ne facciamo una questione economica, o di posizionamento del vino italiano su scala globale, bensì una questione umana e valoriale. Abbiamo parlato di resistenze, di generazioni che imparano a convivere sotto la stessa azienda, di attività che mettono prima il rispetto per il territorio e per la sua salvaguardia, e poi tutto il resto. Di progetti che sono riusciti a nobilitare vitigni impoveriti e banalizzati per decenni. Qualche settimana prima dell’inizio della vendemmia abbiamo incontrato, in una torrida giornata estiva, Elettra Gugole. Con il fratello Umberto dal 2022 si prende cura di un nuovo capitolo di San Dionigi, l’azienda di famiglia, sita in Valpolicella, appena qualche minuto fuori da Verona città. E abbiamo aggiunto un ulteriore tassello a questo mosaico che pare tutt’altro che compiuto.
Un passaggio sentito
San Dionigi è stata fondata nel ’68 dal nonno materno di Elettra e Umberto. Aveva scelto di non vinificare; il suo era un interesse prettamente agricolo, pertanto tutte le uve venivano conferite. Alla fine degli anni ’90 Maria Vittoria Valle e Mario Gugole, i genitori di Elettra e Umberto, entrano nell’attività con un


orientamento preciso: riformulare l’etica di lavorazione in campo approcciando al biologico.
“Ma non per moda, era un modo di vedere e fare che ci apparteneva già nella vita domestica” ricorda Elettra. Incrociamo Mario poco dopo, mentre costeggia la cantina di rientro da qualche attività in campo, ma non prende mai la scena, rimane sempre defilato.
“Da quando ha iniziato a lavorarci lui - continua Elettra - si sono susseguite stagioni di risanamento dei terreni, cioè la chimica è volata al vento e sono entrate gradualmente nuove pratiche. Si è iniziato a lavorare con rese più basse in favore di un’uva più sana, e lo stesso è valso per l’olivicoltura”.
La sperimentazione è l’altro grande tema in casa Gugole, come ci spiegano sin dalle prime battute.
“Stiamo provando tecniche di agricoltura rigenerativa e sintropica nel bosco di proprietà, sfruttando le pendenze e impiegando nel compostaggio gli scarti naturali. Inoltre stiamo cercando di capire come attuare l’agro-forestazione, cioè vogliamo realizzare un ambiente misto con viti maritate e varietà di frutti antichi”.
È curioso che in San Dionigi non ci sia stato, fino al 2022, orientamento alla produzione di bottiglie. Come sottolineava Elettra, la leva era il principio e non l’idea di apporre un bollino su un’etichetta… e lo dimostra il fatto che di etichette non ce n’erano!
“Umberto sta studiando enologia e agronomia. Io arrivavo da un periodo all’estero e da un grande interesse per la ristorazione e per i viaggi. Abbiamo deciso di entrare poco più che ventenni e dare continuità a questo progetto di famiglia aggiungendo l’ultimo anello mancate, quello della trasformazione delle uve. Papà e mamma fino ad
allora non avevano voluto battere questa strada. Siamo partiti con mezzo ettaro il primo anno e andiamo via via aumentando i volumi. Ci auspichiamo un giorno di ridurre a zero il conferimento. Ci vuole tempo, come ci è voluto tempo per risanare i terreni dopo la conversione”.
Le varietà allevate sono principalmente quelle tipiche del territorio: Corvina, Corvinone, Rondinella, Molinara, Oseleta, Spigamonti, Croatina e… Sangiovese (quest’ultima varietà non è autoctona, come ben sapete, ma hanno voluto valorizzarla come se fosse tale in un vino, Parcella 341, davvero originale).
La buona regola per i Gugole rimane la lentezza: si fa una cosa per volta. Dapprima Elettra e Umberto si sono concentrati sulla Corvina, e nel 2023 sono uscite δίχα (Corvina in rosato) e Καρδία (Corvina in purezza).
Per il primo Amarone bisognerà attendere ancora un po’, ma dietro a questo nome estremamente rappresentativo della Valpolicella Elettra e Umberto hanno un’idea già definita, contornata, su come produrre e con quali consapevolezze, tenendo conto dell’immagine attuale che questo vino ha nel mondo.
Parlare di Amarone non dev’essere scomodo
Abbiamo chiesto loro quanto sia complicato oggi parlare di Amarone alla ristorazione e che prospettive vedono per il loro territorio.
“L’Amarone è un vino con una sua intrinseca unicità: l’appassimento. Come tanti altri grandi vini - Baroli, Brunelli, Aglianici, Barbareschi, Chianti…- la sua grandissima forza è la longevità ma con questa peculiarità: le uve riposano, almeno 90 giorni, e durante questo periodo cambiano e perdono anche circa la metà del loro peso. Negli ultimi anni, purtroppo, si è iniziato a pensare che

questa tecnica debba portare a un risultato più estratto, più pesante, meno dinamico e meno interpretativo di un’annata. L’Amarone è sicuramente un vino di estrazione ma è un vino che racconta - anche emozionalmenteun’annata tramite l’appassimento. L’appassimento non livella un risultato, come tante volte abbiamo sentito erroneamente dire, ma seleziona il risultato. È un vino fortemente fatto in vigna, dove l’uva diventa regina. Non ci sono scorciatoie, solo una materia prima meravigliosa - sempre che l’annata lo consenta”.
E qual è, nella pratica, la strada adottata da Elettra e Umberto? Incalziamo noi, visto che alcuni esempi di Amaroni ‘livellati’, invece, ci verrebbero in mente.
“Effettuiamo appassimenti aperti, non sterilmente chiusi e condizionati o termoregolati, che consentono all’uvaun po’ come in pianta - di dipendere dalla temperatura e dall’umidità di fuori, dal caldo o dal freddo, perché vorremmo consentire a questo vino di riflettere fortemente le annate. In quanto al mercato, pensiamo che l’Amarone sia un vino intoccabile - e forse anche prezioso - perché non soggetto a mode o umori. L’Amarone è una scelta e la scelta è farlo se l’annata consente, in modo ancora più sentito se si decide di produrlo secondo una tradizione più artigianale in fermentazione spontanea. È difficile pensare che in un mondo sempre più incline ai vini scarichi, di beva rapida, di sensazioni immediate, l’Amarone sia un vino da ricercare. E invece probabilmente lo è, per tornare indietro e ricordarsi di non correre troppo, per tenerci stretti l’idea che le cose grandi richiedono tempo e che a fare un grande vino è sempre e solo una grande uva. Ce lo immaginiamo non come un vino da meditazione ma un vino che fa riflettere. Non come un vino pesante ma un vino da pesare”.
Il vino in una società che corre
Elettra è una grande frequentatrice di ristoranti. Le abbiamo chiesto come vede collocato in questo momento il vino nelle tavole italiane.
“Mi sento di parlare più da consumatrice che da produttrice di vino perché neofita nella seconda. La velocità della società odierna ha avuto pro e contro, sicuramente, ma
nel vino ho notato quasi solo i contro. Una lettura che mi ha ispirata molto su questo tema è la Società liquida di Baumann. C’è una corsa a tutto: le etichette di tendenza, le aspettative sociali, la costante ricerca di qualcosa che è sulla bocca di tutti. Bello tutto. Ma chi ci sta dietro, chi sta dietro ai vini, chi quei vini li ha fatti, come potrebbe sentirsi?
I prezzi fuori regola, la ricerca spasmodica… e gli artigiani dietro a quelle etichette? Quei vini hanno un valore per l’uomo o per la donna che li hanno prodotti e rischiano di prenderne un altro a causa di un mercato dopato e di una richiesta smisurata. E quindi? La cultura del vino qui si ferma perché si ferma il dialogo attorno ai tavoli e perché l’aspettativa dietro a un’etichetta è talmente alta e il prezzo è incredibilmente fuori misura che il vino diventa ciò che non doveva essere”.
C’è una considerazione che abbiamo ritrovato in altri colleghi viticoltori ma che Elettra e Umberto spiegano con una riflessione molto chiara: “Se l’agricoltura, quella vera, deve essere consapevole e fortemente indirizzata verso un progresso volto al beneficio della terra allora anche il consumo deve forzarsi ad essere identico: sensato, consapevole e rispettoso di chi il prodotto sceglie di farlo. Agri-cultura e cultura del bere sono due espressioni che dovrebbero spartire lo stesso obiettivo”. Anche questa piccola realtà della Valpolicella, se pur giovane sotto il profilo vinicolo, e con una limitata disponibilità di bottiglie, ci racconta che un certo equilibrio si può perseguire. Non solo: che questo equilibrio si colloca perfettamente nel modo migliore di consumare oggi. Si può costruire il nuovo senza stravolgere il culto che si cela dietro a un nome, un vino, un prodotto. Ma bisogna fermarsi e ripristinare l’ascolto di cosa sia più sensato, corretto e compatibile con il futuro.





L’esclusività e la garanzia di un salmone a umicato di qualità superiore
Mai congelato, lavorato da fresco, a umicato su legno di faggio.
Senza coloranti e additivi e a basso contenuto di sale.
Novità
Ottobre 2025
Importante riduzione della carne scura, ideale per la ristorazione e l’hotellerie.
Autrice: Marina Caccialanza
Clicca e leggi l’articolo sul web
Accogliente, come a casa, ma curato nei minimi particolari per offrire qualità e professionalità ai massimi livelli

La storia di Casa Mia Bistrot e della famiglia Carlucci parte da lontano, in Romagna. Numerose esperienze nel mondo della ristorazione e poi, nel 1999, il trasferimento a Ostuni dove Fedele Carlucci apre col fratello una prima attività per poi trasferirsi a Carovigno, nel cuore del Salento.
Nasce Casa Mia Bistrot, pizzeria e ristorante dove il buon cibo rappresenta il rispetto per la tradizione, descrive la professionalità dei suoi artefici e incarna la sensibilità di una brigata prevalentemente al femminile: da mamma Maria che fa la pasta fresca a mano alla giovane chef Lory Ignone coi suoi piatti curati e gustosi.
Racconta Fedele Carlucci: “Abbiamo aperto questa nuova sede tre anni fa e puntiamo su una cucina ricercata, frutto di ricerca e perfezionismo quasi maniacale: ci piace prendere in considerazione ogni sfumatura e ogni dettaglio per proporre piatti realizzati con materie prime essenzialmente del territorio, elaborate con cura, per dare origine a ricette ispirate alla tradizione ma

proiettate alla contemporaneità e interpretare i tempi valorizzando tecniche e sapori”.
Uno staff di 12 persone con Fedele alla direzione e la chef Lory a capo della brigata, dunque, un gruppo coeso e un’offerta studiata per una clientela esigente.
Carovigno è cittadina antica, affacciata sul mare in un territorio immerso tra gli oliveti, noto per le sue bellezze naturali e per le risorse. Casa Mia Bistrot gode di una clientela vasta che richiede un alto livello di professionalità, spiega Carlucci: “La nostra clientela è molto varia, per la metà composta da gente del luogo ma per il resto da stranieri che in questa zona, il Salento, possiedono ville e risiedono o sostano per buona parte dell’anno. Il turismo abbraccia tutti i mesi e la clientela è di alto livello e richiede attenzione, ma offre anche buone soddisfazioni”.
Una cucina che riprende le tradizioni, dunque, e si ispira ai migliori prodotti locali perché valorizzarli significa elevare il territorio, tramandarne le eccellenze. Un menù dove la carne prevale, come il filetto di maialino avvolto in foglie di vite o la fiorentina alla griglia ma non mancano proposte a base di pesce, siamo a due passi dal mare, e i primi piatti sono vere delizie: “Quest’anno, per esempio, abbiamo fatto un maccheroncino con ricotta e datterino, fico e capocollo – spiega Fedele – proprio per valorizzare i prodotti iconici delle nostre terre; ma anche le linguine agli scampi in doppia consistenza, cotti e in tartare; strepitosa l’interpretazione di riso, patate e cozze, un classico pugliese che non potrebbe mancare. La nostra chef Lory Ignone svolge un lavoro di preparazione iniziale molto accurato e competente che sfocia in rivisitazioni eccellenti che mirano a valorizzare la tradizione e il territorio in veste moderna, dimostrando grandi capacità”.
La carta delle pizze infine rappresenta perfettamente il


Via Paolo Borsellino, 10 72012 Carovigno (BR) Tel. 0831 182 2594 www.casamiabistrot.com
gusto della qualità, con proposte classiche e creative realizzate con le migliori farine, lievito madre, e guarnite con ingredienti della tradizione locale.
Casa Mia Bistrot esprime la passione di chi ama la cucina e sa come accogliere e accontentare l’ospite, perché la preparazione del buon cibo è un atto d’amore.
Autrice: Marina Caccialanza
Foto: Desiré Tauro
Clicca
e leggi l’articolo sul web
Per molti le sue pizze sono come quadri, per lui pezzi unici da mangiare: Ivan Signoretti entra in cucina per nutrire il cuore e l’anima, poi certamente il corpo
“Sono cresciuto a Rimini – esordisce Ivan Signoretti – e i miei avevano un albergo. La scuola alberghiera fu una scelta naturale. Erano gli anni 80/90 e muovevo i primi passi in cucina. Così, dopo varie esperienze sulla costa romagnola, tra ristoranti e alberghi, mi sono avvicinato alla figura del pizzaiolo, perché era molto richiesta”. Ed è così che emerge un vero talento per i lievitati; una passione coltivata tra i più grandi maestri e perfezionata da corsi di specializzazione e frequentazione con personaggi di rilievo del mondo della panificazione/pizzeria come Giuliano Pediconi, Ezio Marinato, Renato Bosco; uno stage con Beniamino Bilali col quale approfondisce le tecniche e lavora a Sp.accio, la pizzeria di San Patrignano. “Venivano in tanti da Sp.accio – racconta Ivan – Bottura, Camerucci, Cedroni…ci regalavano un po’ delle loro ricette, e noi prendevamo appunti, e spunti. Era il momento del fermento per la pizza gourmet, gli anni duemila, quando la pizza cominciava ad assumere una sua identità nuova. Mi sono trovato al posto giusto nel momento giusto”.
In quegli anni, consulente per il forno, a San Patrignano, è Giuliano Pediconi, uno dei maggiori esponenti della lievitazione moderna, spiega Signoretti: “Ci diede le prime dritte sulla lievitazione naturale. Allora si conosceva poco questo metodo, specialmente per la pizza. Lui conosceva tutte le sfaccettature possibili, ci forniva i rinfreschi, ci spiegava come risolvere i problemi, perché il lievito madre non è proprio facile da gestire. Tanti provavano a metterlo nella pizza ma poi non sapevano lavorarlo nel modo giusto. Giuliano conosce la chimica, in pratica e in teoria, ed è stato, lui e gli altri, una buona scuola”. Inizia una fase durante la quale le esperienze, anche in giro per il mondo, si susseguono e Ivan Signoretti si trova in luoghi iconici della ristorazione, conosce sfaccettature del mestiere e approfondisce la sua tecnica. È il momento di avere un posto tutto suo e mettere in pratica ciò che ha imparato.
Insieme a Thomas Agostini apre Il Cortile in Centro a Rimini, la sua città. “Ci conosciamo da bambini, avevamo questa voglia di avere una pizzeria a Rimini, perché mancava in città, per offrire un luogo dove si sente il cuore e quella secondo me è la differenza che ancora ci distingue. E così siamo stati i primi” afferma con una certa soddisfazione. Il Cortile in Centro è una pizzeria con una personalità unica, impossibile da standardizzare, tanto che Ivan e Thomas ci provano partecipando all’apertura di Oppalà a Santarcangelo ma è diverso, spiega Ivan: “I clienti cercano anche il per-



sonaggio, hanno piacere di vedere il protagonista dietro il bancone, i collaboratori sono bravi ma non è lo stesso. E così, ogni locale ha la sua identità. Mi chiamano e mi chiedono ‘ma ci sei? Allora vengo’. Sembrerà strano ma anche la presenza contribuisce a soddisfare il cliente”. La convivialità ha la sua importanza, è un ingrediente fondamentale, e il rapporto diretto col cliente contribuisce a rendere una pizza eccellente perfetta. Così come protagonista delle pizze del Cortile è il lievito madre che Ivan Signoretti coltiva da trent’anni: “Io lo faccio vedere, al cliente, glielo presento, e gli dico che ha trent’anni, perché era dal 1990 a San Patrignano, e dal 2000 è con me; sono quasi venticinque anni che andiamo insieme in giro per il mondo e lo porto a tavola, lo presento e faccio vedere chi è, racconto che è nato con delle mele, ne mettiamo la quantità giusta nell’impasto e abbiamo ventiquattro ore di lievitazione in una cella, lievitazione naturale a quindici gradi; che dietro c’è tanto lavoro, tanto studio, maniacale a volte, perché basta una stagione variabile e cambia, un abbassamento di temperatura dell’acqua anche di poco, o un farina un po’ più calda e muta la sua struttura perché il lievito è molto sensibile, è un po’ come noi: se siamo bene, le pizze sono buone, se lo trattiamo male o siamo un po’ nervosi, non funziona…è una sorta di simbiosi che si crea negli anni”. E trovare il giusto equilibrio, col lievito madre, non è uno scherzo, spiega Ivan: “Facciamo anche una ricerca approfondita sulle farine, le cerchiamo italiane perché ormai anche le farine italiane hanno la giusta forza e sono perfettamente adatte al tipo di lavorazione che facciamo; un tempo si usava la 00 a bassa forza mentre ora abbiamo a disposizione farine molto performanti con le quali possiamo gestire anche 2 o 3 rinfreschi al giorno, alle 4 e alle 8 di sera, qualche volta anche la mattina dopo che ha riposato per 14 ore nella sua cella; il lievito è vivo. I grandi maestri utilizzano questa formula per i panettoni, io ci faccio la pizza con le mie dosi e la mia ricetta”.
Una ricetta che dà origine a una pizza dalle caratteristiche organolettiche interessanti: una lieve punta di acidità che si può percepire al palato; poco sale, il 2% rispetto al 3% normalmente utilizzato, ovvero 20 grammi per ogni chilo; e una profumazione, un aroma ineguagliabile, quasi come il vino, con un bouquet di profumi intenso e quando la si taglia un’alveolatura regolare perché la lievitazione non è controllata ma selvaggia: solo acqua, farina e lievito, naturale. “Al massimo – spiega Ivan – si può aggiungere un po’ di malto, giusto per dare un po’ di doratura. Poi ci piace giocare con le farine, le multi-cereali per esempio, con la curcuma; abbiamo da poco inserito l’impasto senza glutine e un impasto low carb, a basso contenuto di carboidrati, fatto con farina di tapioca e amido resistente, con 0,5 grammi di carboidrati su 100 grammi di pasta: possiamo addirittura chiamarla pizza chetogenica. Si cerca di seguire le tendenze alimentari perché Rimini è una città cosmopolita con una clientela vasta e molto eterogenea”.
Grande ricerca dunque, prodotti di qualità, un gioco di sapori che rispetta le stagioni, qualche influenza orientale, verdure fresche. “Mi piace ispirarmi agli chef – afferma Signoretti – consultare i libri, trovare sempre qualcosa di nuovo e intrigante da portare nella pizza, senza dimenticare la pizza classica che è sempre apprezzata, o un buon calzone. E poi la pizza dolce, che ho creato per mio figlio Santiago. È composta di otto pezzi ed è un fantastico dessert, un vero sfizio”. Tanta ricerca e fantasia, dunque, perché come dice Ivan: “Con la fantasia ci vado a nozze, senza non si va da nessuna parte!”.

Luigi Caricato oleologo
C’è un modo efficace e diretto per prendere la giusta confidenza con gli oli extra vergini di oliva e scegliere sempre i migliori in funzione sia della qualità, sia di un loro funzionale impiego. Basta poco, in fondo: è sufficiente realizzare delle proprie, personali, “mappe sensoriali”. Niente di così difficile, perché occorre semplicemente agire attraverso i propri sensi: annusare e gustare. Si presuppone infatti che uno chef, un addetto alla sala e un ristoratore, proprio perché hanno a che fare quotidianamente con gli alimenti, posseggano tutti i requisiti per farlo. Le scelte di acquisto non possono mai fondarsi unicamente sulla sola categoria merceologica (“mi basta che sia extra vergine”) e di conseguenza sul prezzo più basso con cui risparmiare. L’approccio deve essere differente. Si deve partire sempre dalla valutazione della materia prima. Una scelta sbagliata, senza prestare la giusta attenzione, nuoce sempre. Che senso ha illudersi di risparmiare sull’olio per poi compromettere l’esito finale di una preparazione? Occorre mutare i criteri di scelta e acquisto. Intanto sarebbe bene concepire quanto meno due distinte opzioni: oli per la sala e per la cucina, in primo luogo; e poi, sia per la sala, sia per la cucina, sarebbe altrettanto utile pianificare diversi acquisti, in funzione degli impieghi. Il risparmio è un valore importante per tenere i conti in ordine, e allora occorre farlo bene, in maniera virtuosa. Se si desidera valorizzare una materia prima di grande valore nutrizionale qual è l’oliva, allora per le fritture possono benissimo essere utilizzati, al posto degli extra vergini, i più economici oli di oliva o perfino gli oli di sansa di oliva (sono più salutari di molti altri oli vegetali). Per le cotture ci sono oli extra vergini più economici,
ma è bene sceglierli non solo per il prezzo più basso, ma anche (e soprattutto) in funzione del loro profilo sensoriale. Che senso avrebbe d’altra parte risparmiare optando per degli oli senza averli mai provati, sia attraverso l’assaggio in purezza, sia nella verifica diretta in cottura. Risparmiare è una buona cosa, ma non a scapito della qualità. Per non cadere in simili errori è sufficiente prendere la giusta confidenza con la materia prima olio: annusare, gustare. Quanti lo fanno? Quanti hanno mai frequentato un corso di assaggio dell’olio? Bisogna partire dalla formazione. Ecco allora il criterio della “mappa sensoriale”. In diverse mie pubblicazioni riporto sempre una fotografia/radiografia dei tantissimi oli in commercio (e per tantissimi non intendo riferirmi alle diverse marche, ma alle diverse origini e ai tanti oli mono-olivigno o blend di extra vergini). Ciascun olio esprime una propria identità sensoriale ed è pertanto inquadrabile in diverse opzioni di utilizzo. Ecco perché si consiglia sempre di acquistare differenti oli, proprio per utilizzarli volta per volta per ogni uso e contesto differente. Considerando inoltre che l’olio extra vergine di oliva più che un condimento è soprattutto un alimento (e per giunta universalmente elevato a pieno titolo al ruolo di nutraceutico), commettere errori in tal senso, scivolando su scelte inadeguate di prodotti, per un ristorante non è certo una soluzione di cui andare fieri. Il criterio di agire attraverso la costruzione di una propria “mappa sensoriale” non è altro che un invito a prestare la massima attenzione a tutte le produzioni olearie in commercio e scegliere con raziocinio e saggezza.

I grissini monoporzione Valledoro : un elegante biglietto da visita per la tua tavola .
Chi lavora nella ristorazione lo sa bene: uno dei compiti più noiosi, ma al tempo stesso è cru ciale per il buon funzionamento di un locale. Che si tratti di un ristorante, di un bar indipendente o di un hotel, sapere con precisione cosa c’è in magazzino e cosa manca può fare la differenza tra un servizio impec cabile e una giornata costellata di imprevisti.
Tradizionalmente, il controllo delle scorte richiede fogli di calcolo, cartelle stampate e un lungo lavoro manuale che impegna svariate ore del personale, rubando tempo ad altri impegni molto più importanti. Oggi, però
questo processo grazie alla combinazione di visione artificiale, intelligenza spaziale 3D e realtà aumenta ta. Non si tratta di un’utopia futuristica: con un semplice tablet, i dipendenti possono scansionare gli scaffali, rico noscere automaticamente i prodotti e ricevere in tempo reale un report aggiornato delle disponibilità.
Il cuore del sistema è la visione artificiale, ovvero la capa cità del software di “vedere” ed interpretare le immagini catturate dalla fotocamera del tablet. A questa si unisce l’intelligenza spaziale 3D, che permette di comprendere non solo quali articoli siano presenti, ma anche dove si trovino nello spazio. Infine, la realtà aumentata entra in gioco per fornire al dipendente un’interfaccia chiara e intuitiva: gli articoli vengono evidenziati direttamente sullo schermo, con indicazioni visive che mostrano quali prodotti sono in abbondanza, quali in esaurimento e qua li del tutto mancanti.
Immaginiamo un esempio concreto: un dipendente en tra in dispensa con il tablet, punta la fotocamera verso lo scaffale dei latti vegetali e in pochi secondi il sistema segnala che il latte d’avena è rimasto in sole due confe zioni. Sullo schermo compare un riquadro rosso attorno al prodotto, accompagnato da un avviso che suggerisce di inserirlo nella lista del prossimo ordine. Tutto senza dover prendere in mano penna, fogli o contare manual
Clicca e leggi l’articolo sul web


Una gamma di gusti vegetali per pizze, bruschette e ricette della cucina italiana: FUNGHI, ZUCCA, CARCIOFI, ASPARAGI, PEPERONI e molto altro ancora!
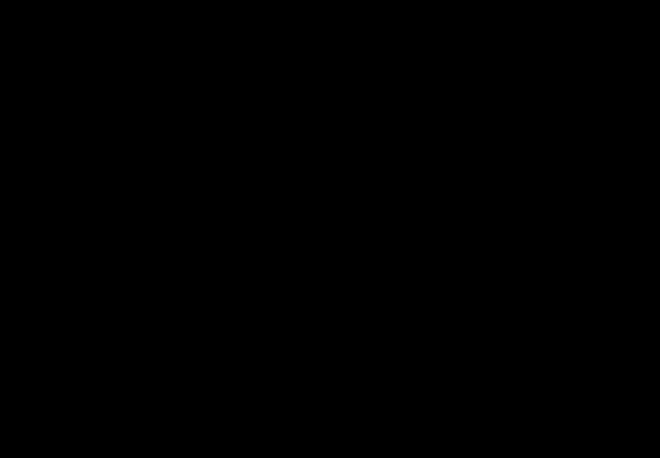
100% Plant Based
senza conservanti
senza lattosio
senza glutine


Autrice: Ilenia Martinotti

Clicca e leggi l’articolo sul web
I prodotti DOP come valore per la ristorazione: dal menu al racconto in sala Immagina di aprire un menu al ristorante. Non è solo una lista di piatti, ma una mappa di territori e storie. Quelle tre lettere – DOP – che compaiono accanto a un ingrediente non sono un dettaglio burocratico: sono una promessa di autenticità, una garanzia di qualità certificata, un invito a scoprire l’anima di un piatto. Per la ristorazione, imparare a valorizzare i prodotti a Denominazione di Origine Protetta significa offrire all’ospite un’esperienza più ricca e memorabile.
Il caso FIPE–AFIDOP: un esempio virtuoso
Nel 2024 FIPE-Confcommercio e AFIDOP, l’associazione che riunisce i Consorzi dei formaggi italiani
DOP e IGP, hanno presentato delle Linee Guida per aiutare i ristoratori a usare e comunicare correttamente questi prodotti nei menu. Lo studio preliminare, condotto su oltre 21.000 ristoranti italiani, ha evidenziato un dato sorprendente: i formaggi DOP compaiono in un menu su quattro, ma solo il 10% dei locali li valorizza davvero, riportando in maniera corretta il nome completo, la dicitura DOP e le informazioni più significative.
Da qui sono nati suggerimenti pratici: non abbreviare i nomi, non usare diciture di fantasia, indicare la stagionatura e rispettare la denominazione ufficiale. Una sorta di “grammatica del menu” che, se applicata, restituisce dignità al prodotto e chiarezza al cliente.
Dai
Quello che vale per i formaggi si può estendere a tutto il mondo delle denominazioni: prosciutti, oli, aceti, vini, ortaggi e frutta. Ogni DOP è un ambasciatore del territorio da cui proviene, porta con sé un disciplinare rigoroso e racconta un pezzo di cultura gastronomica. Inserirla in un piatto significa dare profondità al menu e differenziare la proposta del ristorante rispetto all’anonimato degli ingredienti generici.
Come inserirli nel menu
Un errore frequente è indicare genericamente un ingrediente: “formaggio grattugiato”, “prosciutto crudo”, “olio extravergine”. Molto più efficace – e corretto – è scrivere: “Risotto mantecato con Grana Padano DOP Riserva oltre 20 mesi”, oppure “Tagliolini al Prosciutto di San Daniele DOP”. Poche parole ben scelte
trasformano la descrizione di un piatto in una dichiarazione di identità.
Alcuni ristoratori dedicano sezioni specifiche: il carrello dei formaggi DOP, una selezione di salumi certificati, un angolo dedicato agli oli. Non si tratta di ridondanza, ma di valorizzazione: un modo per rendere il menu una vetrina delle eccellenze.
Il racconto in sala
Il menu incuriosisce, ma è il personale di sala a rendere viva la storia. Bastano due frasi per fare la differenza: “Questo Parmigiano Reggiano DOP ha una stagionatura di 30 mesi, che gli conferisce un gusto più complesso”; “Quest’olio Garda DOP viene prodotto in un frantoio storico della zona, con cultivar autoctone”. Non serve trasformare la cena in una lezione di geografia: l’importante è trasmettere autenticità, legame con il territorio e rispetto per il prodotto.
Formare chi lavora in sala significa trasformare il servizio in narrazione: il cameriere diventa ambasciatore, il piatto diventa esperienza.
Perché conviene al ristoratore
Valorizzare i prodotti DOP non è solo un atto di rispetto verso la tradizione italiana, ma una scelta strategica. Valore percepito più alto: un piatto con ingredienti certificati giustifica il prezzo, perché racconta un contenuto. Posizionamento: un ristorante che evidenzia i DOP comunica serietà, qualità e autenticità.
Fidelizzazione: l’ospite ricorda non solo il gusto, ma la storia che ha accompagnato il piatto.
Tutela del Made in Italy: citare correttamente le denominazioni significa combattere le imitazioni e difendere le eccellenze italiane. Riconoscimento della filiera: scegliere e nominare un prodotto DOP dà valore alla passione e alla competenza di chi lo produce, dall’allevatore al casaro, fino a chi custodisce la stagionatura. È un modo per portare in sala il lavoro, spesso invisibile, di un intero territorio. Un menu non è un elenco, ma un racconto. Ogni DOP è una voce che parla di territorio, cultura e tradizione. Il ristoratore che sa valorizzarla non solo arricchisce i suoi piatti, ma offre al cliente un viaggio nella storia e nell’identità del Made in Italy. Perché ogni prodotto DOP non è un ingrediente qualsiasi: è un’esperienza pronta a farsi ricordare.

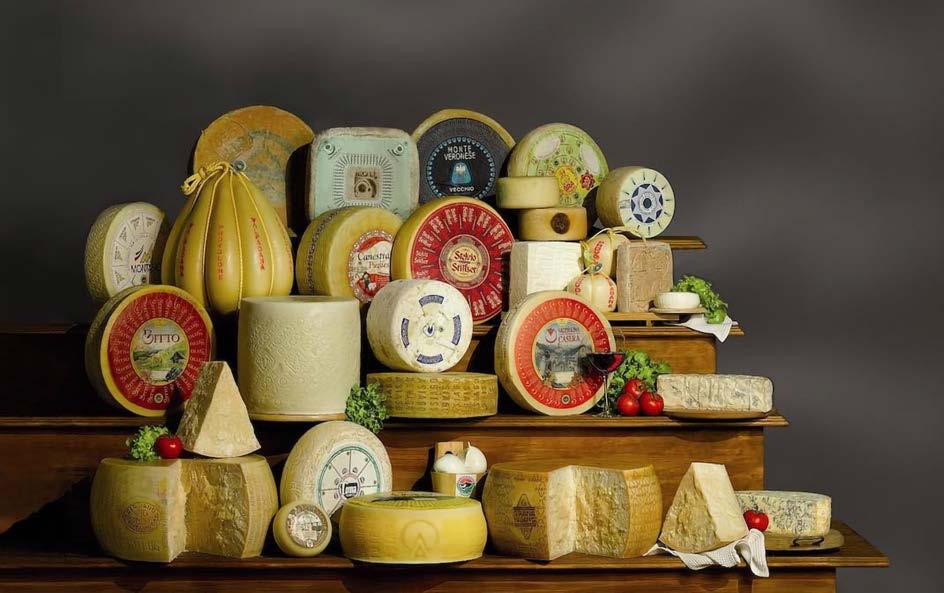
Autrice: Marina Caccialanza
Clicca e leggi l’articolo sul web

Una gamma innovativa, pensata per il canale professionale, per ispirare la creatività degli chef e dare vita a ricettazioni esclusive
Olitalia rinnova il proprio impegno al fianco degli chef, proponendo soluzioni concrete e creative che interpretano al meglio le nuove esigenze del settore. L’azienda, realtà italiana specializzata in oli e aceti, in collaborazione con APCI, Associazione Professionale Cuochi Italiani, ha infatti studiato e messo a punto una nuova linea di prodotti pensata dagli chef per gli chef: Segreti da Chef è una gamma a base di pregiati aceti monovitigni e mela arricchiti con erbe e spezie selezionate 100% naturali.
Olitalia, è noto del resto, è altamente specializzata nel food service, settore nel quale è leader in Italia: l’azienda fu fondata proprio per soddisfare le esigenze specifiche dei ristoratori ed è cresciuta nel tempo ponendo sempre grande attenzione a questo mondo. La proficua relazione con il mondo della ristorazione continua anche grazie alle collaborazioni attive con i migliori professionisti e associazioni di settore italiane ed internazionali.
Basi aromatiche naturali
Segreti da Chef è una linea di basi aromatiche na-
turali realizzate con pregiati aceti, aromi e spezie, per un prodotto che permette di ispirare e velocizzare i tempi di preparazione offrendo un sapore intenso e costante nel tempo.
La gamma comprende quattro originali varianti, ciascuna con una precisa identità aromatica:
1. L’Agrumato: a base di aceto di vino Chardonnay, è impreziosito dall’aroma di pepe rosa e limone. Ideale per dare freschezza e carattere sia a piatti dolci che salati, è perfetto per il pesce.
2. Il Delicato: realizzato con aceto di mela, si distingue per le sue note morbide e avvolgenti di miele, zenzero e bergamotto, perfetto per abbinamenti più raffinati è particolarmente indicato con le verdure.
3. Il Deciso: unisce aceto di vino e birra con un vivace aroma di lime, pensato per ricette strutturate e dal gusto deciso, accompagna alla perfezione le carni bianche.
4. Il Mediterraneo: racchiude in sé tutta l’essenza del territorio grazie all’aceto di vino Chianti arricchito da erbe mediterranee, per evocare sapori autentici e intramontabili ed è ottimo con le carni rosse.
I plus di un prodotto innovativo
Segreti da Chef aiuta lo chef nelle sue preparazioni e stimola la sua fantasia offrendo vantaggi unici e un supporto sempre a disposizione. Tra i numerosi plus della linea possiamo ricordare:
• sapore costante nel tempo: grazie alla formulazione stabile, gli aromi presenti nei Segreti da Chef restano invariati nel tempo garantendo gusto e qualità ad ogni utilizzo aromi sempre disponibili: a differenza degli ingredienti freschi, soggetti alla stagionalità, i Segreti da Chef offrono gusti pronti all’uso tutto l’anno, senza compromess riducono tempi in cucina: grazie agli aromi già integrati, semplificano le preparazioni, evitando passaggi extra come infusioni o taglio degli ingredienti, e rendendo più veloce ogni ricetta evita scarti alimentari: viene utilizzata solo la quantità di aroma necessaria, senza scarti di ingredienti freschi, come accade invece nelle preparazioni realizzate dallo chef in cucina facile utilizzo e deposito: è disponibile in formato in PET da 1 litro e casse da 12 bottiglie, pratiche da maneggiare e conservare
All’interno della linea Olitalia Professional, Segreti da Chef valorizza ogni preparazione e diventa vera e propria alleata nella costruzione dell’identità culinaria di ogni ristorante.
Il progetto Segreti da Chef nasce infatti dall’incontro tra competenza tecnica e passione per la cucina, e per questo si traduce in una proposta sviluppata dagli chef per gli chef, frutto dell’esperienza concreta nei ritmi, nei gesti e nelle esigenze delle cucine professionali.
Pensati per essere pronti all’uso, questi prodotti si prestano perfettamente a una molteplicità di impieghi: si possono utilizzare a crudo o in cottura, per marinare, rosolare, sfumare, insaporire e, soprattutto, sperimentare! Sono strumenti versatili, capaci di accompagnare ogni tecnica e ispirazione, riducendo i tempi operativi senza compromettere il risultato finale.
Dietro ogni grande piatto c’è un’idea, un’intuizione, un ingrediente che fa la differenza. ‘Segreti da Chef’ nasce per questo: per accompagnarti ogni giorno in cucina, con la stessa passione di chi crea con amore.”




LA PRODUZIONE
Clicca e leggi l’articolo sul web
Nasce nel 1832 e oggi, dopo oltre 190 anni, Molino Dallagiovanna è guidato dalla quinta e sesta generazione, unendo tradizione, innovazione e passione
Fondata a Gragnano Trebbiense in provincia di Piacenza, l’azienda nasce con la raccolta e commercializzazione dei cereali. Solo nel 1870 viene acquistato il primo molino a pietra, che segna l’inizio di una lunga tradizione molitoria. La svolta avviene nel 1949, con Guido, Renzo e Vittorio Dallagiovanna, che costruiscono il primo molino a cilindri: nasce così Molino Dallagiovanna G.R.V.
L’accurata selezione dei grani, il lavaggio – unico grande molino italiano a effettuare ancora questo passaggio fondamentale per una pulizia ottimale e una bagnatura omogenea del grano –, la macinazione lenta e la continua ricerca sono alla base e costituiscono il punto di forza dell’azienda: la qualità.
Con un fatturato di 47 milioni di euro, una produzione di 3.000 quintali di grano lavorato ogni giorno, 54 dipendenti e una presenza in 67 Paesi, Molino Dallagiovanna è oggi un punto di riferimento del settore, ambasciatore dell’eccellenza alimentare italiana nel mondo.
• Oltre 190 anni di storia
• 5° e 6° generazione
• Oltre 450 tipologie di farine
• 3 mila quintali di grano lavorato al giorno
• 80 mila quintali di farina stoccata
• 47 milioni di fatturato
• 54 dipendenti
• Presente in 67 Paesi nel mondo
• Export 28%
• Un’offerta completa, per ogni utilizzo
L’offerta comprende oltre 450 farine, da quelle tradizionali per pane, pizza, pasta e dolci alle linee senza glutine e lattosio. Tra queste:
Uniqua, la linea di farine multiuso, che nel 2025 celebra
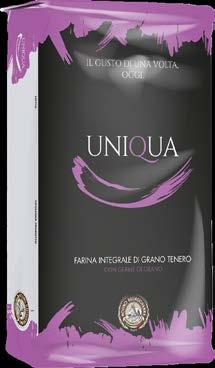
10 anni con la Purple Edition, laNapoletana, la linea per il mondo pizza, leDolcissime, gamma interamente dedicata alla pasticceria, dove Molino Dallagiovanna è leader, che porta la firma di grandi Maestri come Achille Zoia e Iginio Massari, Oltregrano, le miscele sviluppate per garantire facilità d’utilizzo, unicità e ottime performance in cottura, Senza Glutine, la linea di preparati senza glutine e senza lattosio per rispondere alle intolleranze alimentari emergenti e a completare la proposta per un impasto perfetto anche PH4, i lieviti naturali, attivi e inattivi.
La linea Uniqua è composta di 8 farine multiuso pensate per rispondere al desiderio di gusto e benessere del consumatore, da utilizzare singolarmente o da miscelare fra loro creando nuove ricette e nuovi colori del gusto. Uniqua rispecchia i sapori a tutto tondo di una volta, quando una era la farina e tanti i modi per utilizzarla. Come allora, mantiene inalterati tutti i componenti del chicco di grano, i macronutrienti e il germe.
Il nome nasce dalla fusione delle parole “Unica” e “Acqua”: Unica perché ogni farina della linea è multiuso e permette quindi di realizzare tutte le preparazioni dal pane alla pasta, dalla pizza alla pasticceria; Acqua per l’importanza che ricopre nel processo produttivo in Molino Dallagiovanna. Comune denominatore e punto di forza di tutte le farine dell’azienda molitoria piacentina è infatti il lavaggio a immersione del grano, che permette di ottenere un grano pulito, libero da tutte le impurità che lo ricoprono come terra, sassi, polvere e pronto per assorbire la giusta quantità d’acqua, che lo rende più morbido e pronto per la molitura.
Nel 2025 Molino Dallagiovanna celebra i 10 anni della linea Uniqua con la Purple Edition, la nuova farina integrale di grano tenero con germe di grano, ottenuta dalla

macinazione di grani naturalmente pigmentati e lavati. Ricca di fibre e antiossidanti, è di media forza, ideale per pani rustici, focacce, pizze a media lievitazione, frolle, cakes e croissant dal gusto connotato e deciso e dal colore purpureo e violaceo. Disponibile in sacchi da 10 kg, pratici e facili da gestire e stoccare.
Oltre alla Purple Edition, la linea include le farine di Tipo 1 Blu, Gialla, Bianca di forza decrescente, la Rossa 100% integrale, la Verde Tritordeum, cereale innovativo, incrocio naturale tra orzo selvatico e grano duro e le due referenze Magenta e Arancio di Tipo 2.
Molino Dallagiovanna è un marchio dal respiro internazionale, ma con radici profonde nel territorio che lo ha visto nascere e crescere.
A settembre, presso la sede di Molino Dallagiovanna a Gragnano Trebbiense, si svolge ogni anno “La Festa dei Granai”, un appuntamento che celebra l’anima più autentica dell’azienda piacentina: il suo legame indissolubile con il territorio, la Wheat Valley, cuore pulsante della produzione di grano tenero in Italia. Non è un caso che la festa si svolga proprio a settembre, mese simbolo del ciclo molitorio: il grano, raccolto d’estate, dopo il tradizionale riposo di quaranta giorni è pronto per essere macinato. Un rito antico che scandisce da secoli la vita agricola di Gragnano Trebbiense, testimoniato dalla presenza della spiga nello stemma comunale.
La Festa dei Granai non è solo un omaggio alla cultura del grano, ma anche un momento di valorizzazione delle eccellenze del territorio piacentino e dei suoi protagonisti: gli agricoltori. A loro è dedicato il Premio “Chicco d’Oro”, che riconosce l’impegno e la qualità nella produzione delle diverse varietà di frumento – biscottiero, panificabile, di forza e taylor – ribadendo quanto il futuro dell’azienda, pur proiettato verso i mercati di tutto il mondo, resti saldamente ancorato alla sua terra.
Premi e riconoscimenti a la Festa dei Granai 2026
La seconda edizione della Pastry Bit Competition, tenutasi il 13 settembre presso la sede di Molino Dallagiovanna a Gragnano Trebbiense, in occasione della tradizionale Festa dei Granai, ha coronato Dallagiovanna Pastry Ambassador 2026–2027:
• il giovane pasticcere Antonio Costagliola di Bacoli (Napoli).
Antonio Costagliola ha trionfato nella sfida sul panettone con impasto al cioccolato, da realizzare con lievito madre vivo e senza creme siringate. Ha infatti convinto la giuria con un panettone che ha saputo combinare gusto, equilibrio e grande padronanza tecnica.
Nel corso dell’annuale Festa dei Granai, inoltre, è stato anche conferito il premio Chicco d’Oro a:
• Fabio Azzali per il grano biscottiero
• l’Azienda Agricola Casa di Ferro per il grano panificabile
• Giorgio Ferrari per il grano di forza
• Roberto Scrocchi per la categoria grano Taylor.
• È stato inoltre assegnato a Giorgio Derme il premio speciale “Miglior Panettone al Cioccolato”, conferito dalla Callebaut Chocolate Academy.

Autrice: Marina Caccialanza
Clicca e leggi l’articolo sul web
Nel canale horeca cresce la passata di pomodoro, ingrediente indispensabile in dispensa, per una cucina che non teme il recupero della tradizione mediterranea, non solo italiana
Bandito per decenni dalle cucine stellate, assieme alla pasta secca, il pomodoro torna a farsi apprezzare da una ristorazione più libera dalla scuola francese, che riscopre finalmente il valore della freschezza e dell’acidità, giocando con le consistenze e le diverse cultivar del pomodoro. Nel canale horeca come in gdo, cresce la passata di pomodoro, ingrediente indispensabile in dispensa, per una cucina che non teme il recupero della tradizione mediterranea, non solo italiana.
Nonostante la stagnazione economica, infatti, crescono i consumi delle famiglie in servizi ristorativi che spostano l’asse creativo e imprenditoriale dal fine dining al foodish, una cucina della gioia più rilassata e divertente, etnica o local, con proposte che conquistano il pubblico e rilanciano il ruolo centrale del pomodoro in conserva, in particolare della passata.
Buona ma anche sana, la passata torna in auge anche grazie al successo della tendenza clean eating che mette al centro l’apporto nutrizionale del pomodoro, ricco di vitamine e antiossidanti, tra cui il licopene, che proprio dopo la cottura diventa più biodisponibile (cioè assimilabile) e con un effetto probiotico maggiore, fondamentale per mantenere in equilibrio l’organismo.
Infine, in un mercato di prodotti legati ai ‘bei vecchi tempi’, la passata ci riporta alla memoria le estati al Sud, il rito delle ‘bottiglie di pomodoro’ fatte in casa in Campania, in Sicilia, in Puglia, ma anche in Abruzzo: un’occasione di incontro e condivisione, in cui intere famiglie

preparavano scorte da consumare tutto l’anno, spesso raccogliendo i pomodori nel proprio orto, per poi passare alla lavorazione manuale, alla passatura e all’imbottigliamento in contenitori di vetro sterilizzati, poi bolliti per creare il sottovuoto.
Oggi, i ritmi di vita sono decisamente diversi, il tempo a disposizione, reale o percepito, è sempre più scarso e la disponibilità di celebrare riti è assai limitata. Ecco, dunque, che la ricerca di una buona passata di pomodoro, fresca e genuina, vellutata e corposa, diventa una necessità, tanto per i professionisti della ristorazione quanto per le famiglie.
Ma come riconoscere una buona passata di pomodoro? Preliminarmente, dall’esame visivo: una passata di qualità si caratterizza per il colore rosso vivo e la consistenza equilibrata. Un rosso brillante e uniforme, non troppo chiaro né troppo scuro, indice della perfetta maturazione dei pomodori e di una giusta cottura, che evita concentrazioni eccessive e preserva le caratteristiche organolettiche delle materie prime. La consistenza della passata dovrà essere omogenea, senza separazioni tra siero acquoso e polpa, che denunciano una centrifugazione non corretta.
Inoltre, una buona passata implica l’impiego di pomodori dall’origine tracciata e certificata. E qui l’esempio dell’azienda La Fiammante di Buccino (SA) è ormai un caso di scuola per l’intero settore: cliccando il QrCode in etichetta, è possibile risalire a tutte le informazioni sull’ori-

gine delle materie prime e sulla lavorazione in conserva di ogni singola bottiglia prodotta. Una trasparenza che è frutto di relazioni di filiera corta, cioè di accordi diretti con gli agricoltori, di rigidi disciplinari di coltivazione, di un monitoraggio costante fin dalla semina, e di calendari rigorosi di trapianto e raccolta, per assicurare una rapida lavorazione del pomodoro fresco.
La Fiammante è il marchio di punta di un’azienda familiare di lunghissima tradizione - ICAB (Industria Conserve Alimentari Buccino) - che negli anni ha saputo crescere in innovazione, riducendo significativamente l’impatto ambientale e migliorando il benessere dei lavoratori, senza mai abbandonare l’approccio artigianale nei passaggi chiave della produzione.
ICAB La Fiammante vuol dire 100% pomodoro italiano da filiera corta completamente tracciata in blockchain, una filiera costruita dal giovane CEO dell’azienda, Francesco Franzese, sul valore delle relazioni e sulla centralità del fattore umano: una vera e propria rivoluzione per il settore, con l’obiettivo di valorizzare i prodotti assieme alle persone, alle comunità, ai territori, a partire dal giusto prezzo delle materie prime e dalla lotta al caporalato, oggi fianco a fianco con l’Associazione NoCap di Yvan Sagnet.
Una qualità autentica, dunque, una qualità che si sente. Una volta aperta, infatti, la passata deve sprigionare al naso un profumo fresco e naturale, che corrisponde alla data di lavorazione indicata dal codice del lotto stampato sul tappo o sul vetro: una sequenza di lettere e numeri che indica l’anno e il giorno di produzione (ad esempio, R per il 2025, G per il 2024). E anche su questo argomento, La Fiammante rappresenta un esempio virtuoso, perché la passata è prodotta e imbottigliata secondo stagionalità, a poche ore dal conferimento in azienda delle materie prime. Viceversa, altre aziende fanno ricorso alla rilavorazione del concentrato di pomodoro, anche dopo molti
mesi dalla raccolta: un procedimento assolutamente legale, che però può compromettere genuinità e freschezza della passata di pomodoro.
Ultima nata nello stabilimento La Fiammante di Buccino, alle porte del Cilento, è la Passata ‘Dolcissima’, una passata di alta qualità nella nuova bottiglia ‘gioiello’ disegnata in esclusiva per dare la giusta luce all’alta qualità del pomodoro, per migliorare la resistenza della confezione senza incidere sui costi della logistica e per facilitarne la presa a scaffale da parte dei consumatori. Una passata vellutata, dal gusto dolce e fresco, ottenuta dalla lavorazione di solo pomodoro italiano da filiera corta, coltivato in pieno campo nel rispetto della stagionalità.

Francesco Franzese
Autrice: Marina Caccialanza
Clicca e leggi l’articolo sul web
L’artigianalità di una pasta di grande qualità, una linea studiata per comunicare la tradizione di un prodotto autentico e sostenibile nelle parole del suo artefice Andrea
Columbro


“Mi chiamo Andrea Columbro, titolare del Pastificio Artigianale Columbro, creato con l’obiettivo di offrire ai nostri clienti un prodotto autentico e artigianale che rappresenti nel mondo il meglio della cultura gastronomica italiana. Mi definisco un “artigiano del gusto “, e attraverso l’utilizzo di tecniche di produzione semplici ed antiche, ambisco a riportare sulle nostre tavole i sapori di un tempo. Seguo personalmente ogni passo del processo produttivo, dalla selezione dei grani ai singoli cicli di essiccazione, fino al confezionamento, l’artigianalita è il principio che mi guida! Amo la trasparenza, perchè credo che la fiducia si costruisca attraverso la chiarezza e l’onestà, anche per questo adotto pratiche che minimizzano l’impatto ambientale, utilizzo energia rinnovabile e collaboro con fornitori che condividono i miei stessi valori, praticando una coltivazione responsabile, per un futuro più verde e sano. Come parte del mio impegno verso una produzione sostenibile e una dieta sana, concedo molto spazio al biologico certificato, e assieme ai miei collaboratori lavoro ogni giorno con grande passione per dar vita ad una pasta che soddisfi le aspettative di chi è alla ricerca di un prodotto sano, gustoso e tradizionale, di grande qualità, e il piùpossibile ecologico. Grazie ai nostri prodotti entrerete a far parte del nostro mondo, fatto di cuore e maestria, provateli ... non resterete delusi!”
È così che si presenta Andrea Columbro, titolare del pastificio omonimo di Fano, nelle Marche.
Tradizione marchigiano-emiliana
La loro produzione si ispira alla tradizione marchigiano-emiliana, rinomata in tutto il mondo per la sua ec-

cellenza nella pastificazione all’uovo. Grazie all’accurata scelta delle materie prime e all’attenzione meticolosa durante ogni fase della lavorazione, riusciamo a creare una pasta che conserva il sapore autentico di una volta. L’uovo, ingrediente chiave della nostra produzione, è selezionato con cura e rappresenta l’anima della nostra pasta, dando vita a un prodotto dal gusto ricco e dalla consistenza unica.
Materie prime e qualità
“Per noi la qualità non è uno slogan, ma una realtà tangibile che parte dalla selezione delle migliori materie prime. – continua Andrea - Usiamo esclusivamente uova biologiche italiane, certificate e provenienti da allevamenti selezionati, per garantire una tracciabilità completa del prodotto. I grani che utilizziamo sono al 100% marchigiani, scelti per la loro tipicità (Senatore Cappelli, farro monococco, farro dicocco, grano duro ecc…), per la loro eccellente qualitàe per la loro capacità di esaltare il sapore della nostra pasta”.
Lavorazione artigianale: laminazione a trafila ruvida
Il processo produttivo di questo pastificio si distingue per l’utilizzo di metodi tradizionali come la laminazione della pasta all’uovo e per la trafilatura ruvida. La laminazione, operata con grande maestria, permette di ottenere sfoglie di pasta sottili, elastiche e perfettamente uniformi, rispettando i tempi e i ritmi che solo la lavorazione manuale sa garantire.
La trafila ruvida, invece, conferisce sia ai loro formati di 100% semola di grano duro che alla loro pasta, la sua caratteristica superficie porosa, ideale per trattenere i con-

dimenti e rendere ogni piatto un’esperienza sensoriale completa.
Questo processo richiede una cura particolare, che solo una lunga tradizione artigianale può offrire e consente, allo stesso tempo, di mantenere un elevato standard qualitativo.
Uno dei segreti della loro pasta è la lenta essiccazione, un procedimento che preserva il sapore e le proprietà organolettiche delle materie prime, garantendo al contempo una consistenza perfetta. L’essiccazione avviene a basse temperature rispettando i lunghi tempi imposti dalla lavorazione artigianale, in modo naturale, mantenendo inalterate le qualità nutritive e sensoriali dei grani utilizzati.
Certificazione bio, sostenibilità e filiera “Il nostro impegno verso l’ambiente e la salute dei consumatori si manifesta anche nella nostra certificazione biologica. – afferma Andrea Columbro - Ogni fase della produzione avviene nel rispetto dei più alti standard di qualità e sostenibilità, a partire dall’utilizzo di materie prime biologiche. La nostra attenzione alla sostenibilità non si limita alla produzione biologica, ma si estende anche alla scelta di materie prime provenienti principalmente da produttori locali. Collaboriamo con una fitta rete di fornitori marchigiani, promuovendo così l’economia del territorio e riducendo al minimo l’impatto ambientale legato ai trasporti. Questo approccio ci permette di avere un controllo diretto su tutta la filiera,
garantendo ai nostri clienti un prodotto di altissima qualità e di origine certificata. Il nostro amore per l’alta qualità si esprime al meglio nella produzione che dedichiamo alle linee per la ristorazione. È proprio per questo che, con grande soddisfazione, siamo stati scelti dal brand DoGusto per la produzione di tutta la sua linea di pasta secca, selezionando per loro le nostre eccellenze dedicate al mondo dei professionisti della cucina”.
Trofie, riccioli marchigiani, gigli, rigatoni, pappardelle... dai formati più classici a quelli più curiosi la gamma di Columbro è molto ampia, più di ottanta formati diversi per far il meglio dell’eccellenza pastaia italiana. “Ciò che ci rende speciali è l’amore per il nostro lavoro e per il territorio da cui proveniamo, un legame che si riflette in ogni singolo pacco di pasta che produciamo, con la certezza di offrire al consumatore un prodotto di altissima qualità, sano e genuino” conclude Andrea.


Autrice: Stefania Pompele
Analista sensoriale L'ANALISI SENSORIALE
Clicca e leggi l’articolo sul web
Una
monografia
sulla nostra relazione, sensoriale e culturale, con il sapore amaro
Il sapore amaro occupa una posizione liminale nella storia dell’alimentazione umana. Biologicamente associato al sospetto, ha assunto nel tempo un ruolo culturale di rilievo, ricordandoci come il gusto non sia soltanto una percezione sensoriale ma una costruzione culturale che riflette sistemi simbolici, strutture sociali e pratiche rituali. Né immediatamente gratificante come il dolce, né vitalmente necessario come il salato, ma sulla soglia tra nutrizione e pericolo, piacere e rifiuto, medicamento e alienazione. Dei sei sapori fondamentali (abbiamo recettori gustativi anche per i grassi) l’amaro è forse quello che più ha generato diffidenza e fascinazione: è il sapore delle tossine ma anche delle piante medicinali e delle bevande rituali. Se è vero che l’avversione innata all’amaro ha avuto una funzione protettiva contro l’ingestione di sostanze tossiche presenti nel regno vegetale, è altrettanto vero che i processi di selezione e addomesticamento di piante amare commestibili — dalla cicoria ai carciofi, dal radicchio alle brassicacee — hanno trasformando un segnale di allarme in risorsa alimentare.
Ciacco panettone Amaro


Risorsa che nacque nelle cucine contadine, fu nobilitata in quelle aristocratiche, ed è parte del giacimento gastronomico che caratterizza la cucina del Bel Paese. Ciò che Massimo Montanari definisce “retrogusto contadino”, evidenziando come la costante presenza di vegetali sia il “primo segreto” della ricchezza e varietà che contraddistingue la cucina italiana. L’amaro è diventato così un sapore di distinzione sociale: bevande come caffè, tè, birra e cacao hanno conosciuto fortune alterne, passando da medicine a prodotti di lusso, e infine a beni di consumo di massa. Da minaccia a cura, da rito a piacere estetico, l’amaro ha assunto un ruolo di identità culturale: sgraziato, potente e divisivo ma altrettanto fine, elegante e profondo in relazione alla dimensione sensoriale in cui lo si fa esprimere.
I composti responsabili di ciò che definiamo amaro sono numerosi e appartengono a famiglie chimiche differenti: alcaloidi, come la caffeina, teina o chinina, rappresentano alcuni degli esempi più noti. Un’altra grande categoria è quella dei polifenoli, particolare rilevanza hanno anche i glucosidi amari, tipici della cicoria e di altre erbe spontanee, ma anche peptidi derivanti da idrolisi proteica, presenti ad esempio in alcuni formaggi stagionati. La cucina dello Stivale ha saputo valorizzare l’amaro trasformandolo in un tratto identitario di molte tradizioni regionali: la cicoria
catalogna trova impiego in piatti come la puntarella romana, dove l’amaro viene mitigato dalla salinità e sapidità della salsa di alici. Nel Meridione le erbe selvatiche amarognole caratterizzano le minestre bilanciando la grassezza di legumi e maiale. Misticanze, radicchi in insalata, cicorie ripassate, hanno sempre avuto un ruolo da protagonista nelle cucine domestiche.
La percezione del sapore amaro è un tratto fenotipico che mostra una notevole variabilità nelle popolazioni umane. La risposta sensoriale agli amari è mediata di specifici recettori (TAS2R) espressi da 25 geni, ma le conoscenze circa la relazione tra fattori genetici e sensibilità gustativa è perlopiù limitata a due di questi. Insomma, sebbene la nostra relazione con l’amaro sia tra i temi più sviscerati in letteratura scientifica, mancano ancora tasselli per completare il puzzle. Sappiamo però -l’ho ribadito nel corso di questa rubrica- che la genetica ha un impatto significativo sulla percezione, perché si riflette sulla fisiologia degli apparati. Avere un numero più o meno elevato di recettori del gusto ci rende più o meno sensibili ai sapori, non solo all’amaro. Di certo con alcuni amari la relazione diventa per alcuni soggetti particolarmente sfidante, proprio per questioni genetiche. Era il 1994 quando Linda Bartoshuk, allora in forze alla Yale University, pubblicò uno
studio fondamentale sull’influenza della genetica sul senso del gusto. Il lavoro della ricercatrice si basava sulla valutazione della capacità dei soggetti coinvolti nello studio di percepire l’amaro di due composti: la feniltiocarbammide (PTC, un composto organico prodotto da molte piante che funge da repellente per gli erbivori) e il 6-n-propiltiouracile (detto PROP, simile ma meno tossico), già da tempo utilizzati in questo tipo di ricerche. Il lavoro della Bartoshuk evidenziò una diversa sensibilità a questi composti- da nulla ad estremamente forte- proprio per ragioni genetiche. Questa condizione è dovuta ad una variazione del gene TAS2R38, che secondo quanto evidenziato in Italian Taste, il progetto di ricerca orchestrato dalla Società Italiana di Scienze Sensoriali per indagare tendenze e abitudini alimentari dello Stivale, riguarderebbe più le femmine dei maschi. Nel campione preso in esame per lo studio infatti, il 34,6% delle femmine è risultato supertaster (ipersensibile all’amaro del PROP), mentre solo il 21,1% dei maschi ha questo tipo di ipersensibilità. La risposta sensoriale che sperimentano i cosiddetti supertaster non va ricercata solo nell’intensità dello stimolo, semmai nella natura dell’amaro. Un po’ come se quel composto scatenasse nell’assaggiato-

re una risposta atavica avversa da incasellare alla voce veleno. Non ci si può educare granché in questo caso, proprio perché alla base ci sono codici genetici. Ma quei codici sono circoscritti, in altre parole espongono alcuni di noi ad esperienze sfidanti con alcuni amari ma non ci impediscono di apprezzarne altri. Del resto le amarezze sono parte di un retaggio culturale che ha radici profonde.
Contemporaneo e trasversale:
le strade dell’amaro
Come quelle della tradizione liquoristica legata agli amari, categoria che racconta meglio di qualunque altra una tradizione italiana, e che oggi sta vivendo un momento di rinascita grazie al lavoro di nuovi interpreti e ad un approccio più contemporaneo. E di amaro si parla anche quando si pensa al movimento delle birre artigianali; se il luppolo è stato l’ingrediente della rivoluzione, il primo decennio è stato dominato non solo da inedite aromaticità ma anche da amari impattanti. E non mancano certo esempi contemporanei se ci si sposta dal calice al piatto. Gianluca Gorini è tra gli interpreti che più hanno elevato il pensiero sull’amaro, strutturando spesso i piatti su questa dimensione sensoriale. Fulgido esempio lo spaghetto tonico, pre-dessert di rara profondità, in cui l’amaro sferzante ed erbaceo della genziana si intreccia alle note agrumate del bergamotto candito.
Lettura colta sull’amaro anche nelle proposte di Davide di Fabio, tra le voci più interessanti del fine dining d’autore, alla guida della cucina di Dalla Gioconda. I cappelletti di olive amare, burro all’arancia e ricci di mare, signature ispirato ad un classico autunnale dell’entroterra marchigiano, sono una rilettura colta e contemporanea del territorio.
E se dare all’amaro un ruolo da protagonista in un piatto può risultare divisivo, affrontare il tema con ciò che per definizione nasce dolce suona come una contraddizione in termini, eppure Stefano Guizzetti, gelatiere e lievitista tra i più talentuosi dello Stivale, ha saputo relazionarsi con amari diversi e stratificati, aprendo scenari inediti nel gelato e non solo. Come nel suo Amaro, un grande lievitato che cesella le estrazioni di rabarbaro, genziana e china in un morso amaro, lungo ed elegante, veicolato dal burro e arricchito dagli agrumi, canditi e in pasta. Sono solo alcuni esempi che tratteggiano le diverse dimensioni di un sapore sfidante, parte del giacimento culturale del nostro passato, mai come oggi presente nel pensiero gastronomico contemporaneo.
Referenze
Exploring influences on food choice in a large population sample: the Italian Taste Project https://www. researchgate.net/publication/314095784
Centro Carni Company Spa è tra le principali realtà italiane nella lavorazione della carne bovina e si distingue per la sua leadership nel disosso, con una capacità produttiva che raggiunge le 80 tonnellate al giorno. Un traguardo reso possibile da una lunga tradizione avviata nel 1890 e che ancora oggi guida l’azienda verso un obiettivo chiaro e costante: offrire ai propri consumatori prodotti di eccellenza assoluta.
Unika: una selezione di tagli anatomici d’eccellenza
Per rispondere alle richieste di un mercato sempre più attento ed esigente, nel 2009 nasce Unika, il brand dedicato al Food Service. La linea propone una selezione accurata di tagli anatomici confezionati sottovuoto, provenienti da diverse tipologie di carne: dall’Aberdeen Angus Cross alla Scottona, dal Vitello al Bovino Adulto, fino ai pregiati tagli dry aged (frollati a secco).
Ciò che rende queste carni uniche sono la continuità nella qualità, l’elevato livello di marezzatura, la conformità agli standard e una selezione scrupolosa dei pezzi migliori.
French Rack di Vitello e Cuberoll di Scottona
Tra le proposte più apprezzate firmate Unika spiccano il French Rack di Vitello e il Cuberoll di Scottona:
Il French Rack è un taglio di vitello che comprende la lombata con le costole, pulite e scoperte, per una presentazione scenografica e di grande impatto visivo. Questo taglio preserva il sapore delicato e la tenerezza della parte più pregiata della lombata, consentendo una cottura uniforme e gustosa.
Il Cuberoll di Scottona è un taglio pregiato ricavato

dalla lombata del bovino. Proviene dalla parte più tenera e saporita della schiena, compresa tra la quarta e la tredicesima costola. La marezzatura – il grasso intramuscolare – si scioglie durante la cottura, conferendo alla carne un sapore ricco e intenso. La Scottona, una giovane femmina di bovino che non ha mai figliato, garantisce una carne particolarmente tenera, succulenta e dal gusto unico, perfetta per chi cerca qualità superiore.
L’impegno costante di Centro Carni Company
Centro Carni Company si impegna a far conoscere a clienti B2B e consumatori finali l’intero percorso che porta la carne dalla stalla alla tavola. Dalla selezione accurata degli animali, valorizzando alcune delle razze bovine più pregiate, fino alla scelta di strutture all’avanguardia per la lavorazione, ogni fase è pensata per garantire la massima qualità.
L’attenzione è totale e riguarda ogni dettaglio: dall’igiene degli ambienti al monitoraggio dello stato di salute degli animali, fino a un’alimentazione controllata e studiata per assicurare carni eccellenti. Per Centro Carni Company, ogni passaggio della filiera è fondamentale per offrire un prodotto finale che soddisfi appieno le aspettative dei consumatori più esigenti.
































Autore: Luigi Franchi
Clicca e leggi l’articolo sul web
La storia degli agrumi in Italia vede la sua prima apparizione in un libro scritto in un forbito latino dal gesuita Giovanni Battista Ferrari e pubblicato in folio a Roma nel 1646: 480 pagine e 120 tavole costituiscono Hesperides, sive De malorum aureorum cultura et usu.
In quel libro c’è già, ben evidente, il fatto che, in Italia, data la felice situazione climatica, gli agrumi non sono solo coltivati in protetti vasi e giardini ma in piena terra definendo, in tal modo, anche il paesaggio. In questo bellissimo volume, edito da Leo S.Olschki, Paola Fanucci e Alberto Tintori, ripercorrono, a distanza di secoli dalle Hesperides, una storia degli agrumi indicandone la ricchezza in termini di biodiversità, di luoghi, di nomi, sapori e profumi. Ben 48 specie censite, di cui si racconta la storia, le origini, i sapori. Un viaggio tra gli agrumeti d’Italia per capire quanto è radicata la presenza degli agrumi. Nella seconda parte del ricchissimo volume vengono, invece, riassunte molte indicazioni pratiche sulla coltivazione degli agrumi, corredate da illustrazioni molto dettagliate ed esplicative. Un libro che profuma ad ogni pagina, rimandando a ricordi di luoghi e di sensazioni.

Ricordo… i cibi della mia cucina che sapevano di terra e di gallina
Carla Fiorentini pubblicazione indipendente per acquistarlo: Amazon
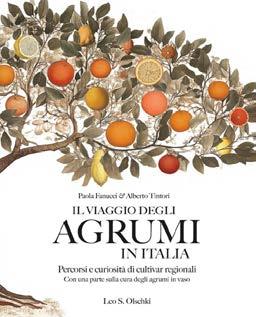
Paola Fanucci e Alberto Tintori
Leo S. Olschki
Pagg. 330
euro 29,00 www.olschki.it
Ricordo… i cibi della mia cucina che sapevano di terra e di gallina
Un libro che è un racconto dell’anima, scritto con il cuore e non con il computer. È questa la particolarità che ci ha spinto a scriverne la recensione. Carla Fiorentini, l’autrice, non è una scrittrice professionista, non è una cuoca professionista, ma questo libro di ricette scritte con una singolare forma poetica è il suo modo di dire: esisto! È il suo amorevole omaggio alla figlia Giulia con parole normali che vogliono lasciare il senso profondo delle loro vite. Scrive Carla:
SENTI GIULIA…
In questi profumi di oggi c’è tutto il passato della nostra famiglia che non morirà mai fin quando qualcuno seminerà le sue usanze, i suoi sapori, i suoi insegnamenti. Forse quel seme attecchirà in una terra sconosciuta che così saprà di Noi, di me, di te… Io sarò il seme e tu il vento che lo porterà con sé… e un altro albero crescerà e un altro vento spargerà i suoi semi. Allora, vento, ascolta, che ti racconto una storia.
Da quel momento, divisa per stagioni, c’è la storia culinaria della loro famiglia che è la storia di migliaia e migliaia di famiglie italiane che si sono accontentate di cose semplici e di grandi valori.
Ricette che raccontano storie di vita, episodi di felicità: la minestra seguitata, il cavolo strascicato, la farinata bruscolosa, le peschine di tutte le stagioni sono solo alcune delle decine che trovate nel libro.

I tuoi clienti non cercano miracoli, vogliono semplicemente un piatto buono e fatto con i prodotti giusti! Scegliere i prodotti della linea Columbro è il modo migliore per garantire agli ospiti del tuo locale una qualità sicura e sempre costante che si adatta a ogni tipo di menù. Falla semplice, scegli Columbro.

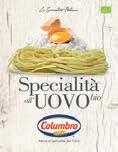



www.fassacoop.it | ordini.ingross@fassacoop.it