




Mario Benhur Tondini
presidente Edizioni Catering srl
Imprenditore nel settore della distribuzione alimentare, gestisce con il fratello Oscar l’azienda di famiglia a Cavriana (MN), dove ha svolto anche l’incarico di sindaco.

Le competenze maturate sul piano professionale e su quello amministrativo lo hanno portato alla convinzione che il principio della condivisione sia la miglior modalità di crescita. Molte sue iniziative, anche all’interno del gruppo Cateringross (che detiene la titolarità della casa editrice), di cui è consigliere d’amministrazione, vanno in questa direzione. A questo affianca una forte sensibilità per ogni azione che dia valore al suo territorio.
benhurtondini@salaecucina.it
Marina Caccialanza
Redazione
Milanese, un passato come traduttrice, da diversi anni giornalista e redattrice per riviste del settore alimentare rivolte al mondo dell’artigianato e all’industria, in particolare nel campo della ristorazione, del dettaglio specializzato e della ricerca. Contribuisce alla realizzazione di importanti libri di comunicazione gastronomica in Italia e all’estero diretti ai professionisti e ai consumatori. Collabora con le redazioni di sala&cucina, Ecod e Trenta Editore.

Luigi Franchi
Direttore responsabile
Prima fotografo di cibo e territori, poi comunicatore, autore di numerosi libri di enogastronomia e di turismo enogastronomico. e infine giornalista di enogastronomia. Tra le sue principali pubblicazioni, scritte e/o coordinate: La prima edizione della Guida al turismo del vino in Italia, per conto del Movimento Turismo del Vino, (1997), I parchi e il turismo enogastronomico (2004), Il marketing delle Strade del Vino edizioni Agra – Rai Eri (2005), Atlante Alimentare Piacentino, con Valentina Bernardelli (2007), “cuo chi, due anime in cucina”, con Alessandra Locatelli, GL.Editore (2009), Dalle Terre Traverse al Po, GL.Editore (2010), ideatore e coautore dei Maestri del lievito madre, Edizioni Catering (2014), coautore della guida online dedicata alla ristorazione Meglio Prenotare, Edizioni Catering, Le interviste (2018) editore Mediavalue. Co-direttore di Food & Book, festival nazionale di editoria enogastronomica luigifranchi@salaecucina.it

marina.caccialanza@salaecucina.it
Redazione
Ricorda con esattezza il profumo del primo pane preparato all’età di sette anni.
Forse il suo primo traguardo e, soprattutto, l’inizio di una grande passione: per le cose semplici, per la genuinità, per gli alimenti che crescono e prendono forma. Dopo la Laurea in Scienze Gastronomiche, la specializzazione in comunicazione enogastronomica, e un periodo di alternanza nelle cucine, ha chiara la missione: scrivere per comunicare. Come? Utilizzando gli strumenti di oggi e la curiosità di sempre. Gionalista pubblicista, collabora anche con la guida di Identità Golose.

Simona Vitali
Redazione
Laureata in filosofia, ha lavorato nella comunicazione e organizzazione di grandi eventi a Parma.
Ha ricevuto una prima inconsapevole educazione al gusto per il cibo grazie all’ indimenticato oste dell’Osteria della Stazione di Felino (PR), il nonno materno Massimino. Con gli studi umanistici è poi arrivata una seconda, consapevole, educazione al gusto per l’utilizzo delle parole secondo il loro significato. Poi sono seguiti un corso di Alta Formazione alla scuola Holden e un master in Filosofia del cibo e del vino. Della ristorazione l’affascina il pensiero e la componente umana. Della formazione di settore segue movimenti ed evoluzioni.

giuliazampieri@salaecucina.it
Gabriele Adani
Grafico
Modenese, appassionato di arte figurativa, fotografia e linguaggi di comunicazione visiva.
s.vitali@salaecucina.it

Nel 1992 inizia il suo percorso professionale presso una casa editrice. Lavora poi in uno studio grafico e fonda una piccola agenzia di comunicazione in cui ricopre il ruolo di direttore creativo per 18 anni.
Viaggiatore, utilizza i frequenti viaggi a Londra e nel Sud Est asiatico per arricchire il suo bagaglio culturale e placare la sua innata curiosità per le altre culture.
Dal 2019 lavora in proprio, occupandosi di fotografia, grafica e consulenze nel campo della comunicazione.
grafica@salaecucina.it







7 LA LETTERA APERTA
Smettiamola di essere così stupidi | Luigi Franchi
9 L'EDITORIALE
La cucina italiana nel mondo vale 251 miliardi | Benhur Tondini
10 IL CONFRONTO
La famiglia Barbieri | Luigi Franchi
14 LA RIFLESSIONE
Il pesce al ristorante | Giulia Zampieri
19 LA FORMAZIONE
Istituti alberghieri: lavori in corso | Simona Vitali
22 GLI AMBASCIATORI DEL GUSTO
La pasta, vista dagli chef e dai produttori | Luigi Franchi
28 IL RISTORANTE
DamatOsteria | Luigi Franchi
34 LA DISTRIBUZIONE
Una giornata con gli agenti di vendita | Guido Parri
39 I CUOCHI
Crescita e orgoglio di appartenenza anche con i premi e riconoscimenti | Rocco Cristiano Pozzulo
41 LA NEUROVENDITA
Oltre i confini, la retail hospitality | Lorenzo Dornetti
46 LE CONTAMINAZIONI
IlStoria del kare raisu: come il curry è diventato popolare in Giappone | Federico Panetta
50 LA STORIA
Matilde Serao e Il ventre di Napoli | Alessia Cipolla
54 LA DISTRIBUZIONE
Selezioni di gusto | Guido Parri
57 IL VINO
Il caos nel vino | Giulia Zampieri
60 LA PIZZERIA
La saggezza dell’esperienza | Marina Caccialanza
62 L'OLIO AL CENTRO
Anche gli oli creano valore | Luigi Caricato
64 LA DIGITAL TRANSFORMATION
Digitalizzare turni e orari per migliorare la gestione | Claudia Ferrero
66 LA PRODUZIONE
Sapori d’Irlanda, talenti italiani | Marina Caccialanza
68 LA PRODUZIONE
L’eccellenza ittica che ha riscritto le regole del fresco | Marina Caccialanza
70 LA PRODUZIONE
Grana Padano DOP, stagionature di piacere | Marina Caccialanza
72 LA PRODUZIONE
Authentic food passion | Marina Caccialanza
74 LA PRODUZIONE
General Fruit: eccellenza italiana tra radici familiari e visione internazionale | Marina Caccialanza
76 L'ANALISI SENSORIALE
Il sapore acido: retrospettiva di un ventennio gastronomico | Stefania Pompele
78 GLI EVENTI
Borgofood, l'alfabeto del gusto | Guido Parri
80 LA PRODUZIONE
Centro Carni Company: una filiera integrata per affrontare le sfide del presente e costruire il futuro | Guido Parri

N° 97 agosto/settembre 2025
EDITORE
Edizioni Catering srl
Via del Lavoro, 85 40033 Casalecchio di Reno (BO) Tel. 051 751087 – Fax 051 751011 info@salaecucina.it - www.salaecucina.it
PRESIDENTE
Benhur Mario Tondini benhurtondini@salaecucina.it
DIRETTORE RESPONSABILE
Luigi Franchi luigifranchi@salaecucina.it
COLLABORATORI ESTERNI
Luigi Caricato, Alessia Cipolla, Lorenzo Dornetti, Rocco Pozzulo, Claudia Ferrero, Federico Panetta, Guido Parri, Giovanni Rossi.
FOTOGRAFIE
Archivio sala&cucina, Stefano Saccani, Mary Iannicello, Lido Vannucchi.
* L’editore è a disposizione per eventuali crediti fotografici di cui si ignora la fonte
RIVISTA PARTNER di AMODO
PUBBLICITÀ
Tel. 331 6872138 marketing@salaecucina.it www.salaecucina.it
PROGETTO GRAFICO
Gabriele Adani - www.gabrieleadani.it
STAMPA
EDIPRIMA s.r.l. – www.ediprimacataloghi.com
TIRATURA E DISTRIBUZIONE – 28.900 copie Ristoranti, trattorie e pizzerie 20.700 – Bar, pub e birrerie 4.000 – Hotel 3.100 – Grossisti e distributori f&b 1.100
Costo copia mensile: 4,00 euro abbonamento annuo 40,00 euro Per abbonarsi: info@salaecucina.it




Il 29 settembre è la Giornata internazionale della consapevolezza delle perdite e degli sprechi alimentari istituita dalle Nazioni Unite per sensibilizzare sull’importanza di ridurre lo spreco di cibo lungo la catena di produzione e consumo.
È uno degli obiettivi di sostenibilità previsti dalla famosa Agenda 2030 che, mentre si avvicina la data, si allontana sempre di più dai risultati attesi.
Pensiamoci, si parla sempre meno di sostenibilità, dopo aver fatto il pieno di parole ma poco di azioni e intanto il mondo sta scendendo una china pericolosissima.
Prendiamo proprio il tema dello spreco alimentare analizzando il rapporto Waste Watcher 2025. L’Agenda 2030 chiede a tutto il mondo di “dimezzare lo spreco alimentare globale pro capite a livello di vendita al dettaglio e di consumo e ridurre le perdite alimentari lungo le catene di produzione e di approvvigionamento”, entro il 2030.
La FAO, invece, ci conferma che, ogni anno, si sprecano nel mondo oltre 1,5 miliardi di tonnellate di cibo –un terzo del cibo prodotto nel mondo – per un valore economico che viene stimato in 1.200 miliardi di dollari. Di chi è la colpa? Potrebbe importare poco accusare e invece è giusto individuare le cause: in primis le famiglie che rappresentano il 60% dello spreco alimentare globale. Nella civilissima Europa ogni anno si gettano via 59 milioni di tonnellate di cibo, per un valore di 132 miliardi di euro. Ogni cittadino europeo spreca, in media, circa 70 chili di cibo in ambito domestico e 12 chili nei ristoranti.
Alimenti che sono stati acquistati e poi gettati nell’immondizia, con i costi aggiuntivi dello smaltimento. Biso-
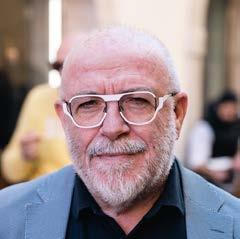
Luigi Franchi direttore responsabile
gna veramente essere stupidi, tutti noi, nessuno escluso!
E perché questo avviene? Perché non vogliamo più nemmeno fare la fatica di scrivere una normale lista della spesa!
E questo avviene mentre nel mondo una persona su 11 soffre la fame e circa il 28,9% della popolazione mondiale, ovvero 2,33 miliardi di persone, patisce l’insicurezza alimentare moderata o grave. Ma questo avveniva nel 2023. Da allora la situazione è peggiorata di molto, basta pensare al dramma di Gaza e all’assurda guerra in Ucraina.
Che fare? Vanno bene le Giornate internazionali, almeno per qualche giorno ci si preoccupa ma andrebbero ancor meglio dei corsi obbligatori di educazione civica per le famiglie, per i professionisti del cibo, per i buyers delle catene distributive, per chiunque voglia uscire da questa condizione di stupidità latente che avvolge l’intera società.
Non sei ore al giorno a imbottirsi di reel, video assurdi, social ricolmi di fake-news, ma almeno mezz’ora al giorno per cominciare a saper fare di conto; vedreste quanti soldi risparmiati, quanto tempo risparmiato anche nell’andare a fare la spesa inebetiti, quanti soldi e quanto tempo nuovo da dedicare a cose più interessanti.
Usciamo dai condizionamenti e dalla stupidità, siamo ancora in tempo!







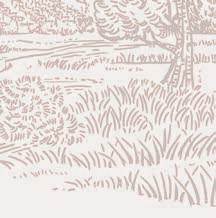




Assapora la nuova referenza della linea “Lenta”. Frutto di una scrupolosa lavorazione artigianale e prodotto a partire da soli petti interi meticolosamente selezionati.
Si caratterizza per una carne magra, cotta lentamente a vapore e una croccante doratura esterna che racchiude tutto il succo e il sapore dell’arrosto.
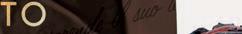














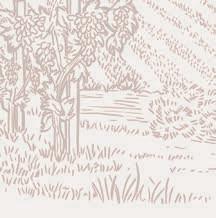

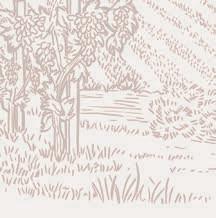
Clicca e leggi l’articolo sul web
È di poche settimane fa il Deloitte Foodservice Market Monitor 2025, un rapporto annuale che evidenzia i dati dei consumi fuori casa a livello internazionale. Se il Rapporto Ristorazione di FIPE, pubblicato in primavera, fissava in 93 miliardi il valore della ristorazione in Italia, il Deloitte innalza questo dato a 251 miliardi di valore raggiunti nel 2024 dalla cucina italiana nel mondo, pari al 19% della valutazione complessiva dei consumi che si attestano a 2.916 miliardi di euro nel 2024.
Sono dati che fanno ben sperare nella crescita, anche qualitativa, della ristorazione in un periodo, quello estivo appena trascorso, dove il dato che emerge è quello di una crisi economica che colpisce prevalentemente ceto medio e lavoratori dipendenti con scarsa disponibilità ai consumi extra, come può essere una cena al ristorante.
Sono state innumerevoli le prese di posizione di molte associazioni di ristoratori che hanno dipinto uno scenario non particolarmente brillante.
Ma restiamo sul valore internazionale della cucina italiana; siamo quarti nel mondo per i full service restaurant (ristoranti con servizio al tavolo); Stati Uniti e Cina sono le due nazioni che più apprezzano la nostra cucina e che, insieme, ne rappresentano il 61% a valore; siamo secondi, dopo la cucina locale, in moltissimi paesi del mondo, togliendo questo scettro alla cucina francese.
Una vitalità che sta coinvolgendo anche gli investitori, soprattutto nel campo della moda, che mai come quest’anno, hanno scelto di scommettere sulla ristorazione, in particolare quella alta ma senza disdegnare un modello di ristorazione tipicamente italiano, molto apprezzato dai turisti internazionali che è quello del-

Benhur Tondini presidente sala&cucina
benhurtondini@salaecucina.it
le trattorie; locali belli, con personale qualificato, con menu comprensibili, che attirano per la loro semplicità.
Il Deloitte ha anche indagato le tendenze per i prossimi anni, dove emerge con forza la maggiore attenzione alla sostenibilità: il 65% dei consumatori è disposto a pagare qualcosa di più per prodotti che soddisfino questo parametro, mentre il 76% ha ridotto il consumo di carne per motivi ambientali.
In crescita la richiesta di ristoranti esperenziali, con maggiore ricerca rivolta ai luoghi di ritrovo e il ristorante viene percepito come tale, soprattutto dai più giovani, con la generazione Z che visita ristoranti e takeout in media 3-4 volte al mese, tra l’altro spendendoci nel 2025 anche lo 0,7% in più rispetto all’anno precedente.
Un contesto dove diventa sempre più importante cambiare le regole del gioco, investendo sulle giovani generazioni, facendo crescere la consapevolezza che i mestieri della ristorazione, pur complicati e faticosi, portano con sé anche molte soddisfazioni e varietà di professioni.
Per ottenere tutto ciò è indispensabile puntare sulla formazione, a tutti i livelli, dagli studenti degli alberghieri, alle figure che sono già impegnate nel settore. Una formazione dinamica, che sappia raccontare la modernità di questa professione.
Uso la parola modernità perché è così che deve essere vista e vissuta la ristorazione; non è un caso che il consumo fuori casa sia ormai una condizione del vivere quotidiano, e non solo nei momenti di festa come capitava fino a qualche anno fa, ma questo cambiamento deve essere percepito compiutamente; cosa che non è ancora del tutto accaduta.
Autore: Luigi Franchi
Clicca e leggi l’articolo sul web
essere testimoni di un territorio




Il 30 agosto 1960 il papà di Vincenzo (Enzo) Barbieri, piccolo impresario edile di Altomonte (CS), prese per mano Enzo, lo portò sulla collina di fronte al paese e gli disse: “Affacciati qui, gioia di papà. Ti faccio vedere dove nascerà l’albergo più bello di tutta la Calabria”. Comincia così la bella conversazione con Enzo Barbieri. Allora aveva sette anni e, quello stesso giorno, nasceva la sua sorellina Mariangela, oggi scrittrice e insegnante al liceo Classico di Ferrara. Quel ricordo è scaturito dalla mia curiosità di capire come poteva esistere un albergo negli anni ’60 ad Altomonte, un borgo medievale che oggi è nel club dei Borghi più belli d’Italia, è Città Slow, è Città del Pane ed è frequentatissimo da un turismo colto. Ma nei primi anni ’60 era uno dei mille paesi del sud isolati, chiusi nelle loro tradizioni, non collegati con alcuna via di grande percorrenza. Eppure Italo Barbieri, quinta elementare ma una grande passione per la storia e per le lingue, conosceva latino, tedesco, inglese e, soprattutto, aveva le chiavi della chiesa di Santa Maria della Consolazione, una chiesa del 1300, che la sua impresa doveva restaurare.
Ogni volta che arrivava uno studioso la Soprintendenza chiedeva a Italo di accompagnarlo a vedere le opere ivi custodite.
“Fu da quegli episodi che gli venne in mente l’idea dell’hotel. Se vengono così tante persone per vederla ancora in fase di restauro, chissà quando verrà aperta al pubblico” pensò.
Enzo, però, non aveva la minima intenzione, né di portare avanti l’impresa edile né di fare l’albergatore. Appena raggiunta l’età per le superiori andò a Ferrara a studiare, ospite della nonna Maria, con l’intenzione di non tornare ad Altomonte. A Ferrara conobbe Patrizia, che diventò sua moglie; aveva gli amici; voleva trovare lì un lavoro, una volta terminata l’università. Intanto l’albergo era stato messo in piedi e prosperava, grazie alla determinazione di Italo che, purtroppo, morì giovanissimo, a 46 anni, d’infarto.
“A Ferrara, mentre studiavo, lavoravo anche nel ristorante di mia nonna: Eden, si chiamava. Era un’autentica scuola di vita e fu lì che mi raggiunse la brutta notizia. Era il 27 novembre 1974. Partii e restai qualche settimana perché il lavoro nell’hotel stava esplodendo, grazie alla costruzione di un ospedale a Lungro, a pochi chilometri, dove non c’era neppure un albergo per ospitare le numerose maestranze. Mia moglie Patrizia, quando ci sposammo, giovanissimi, mi aveva fatto giurare che non saremmo mai venuti ad abitare ad Altomonte. Le telefonai, chiedendole di raggiungermi per qualche tempo. Non siamo più tornati a Ferrara e lei ha pianto per tre anni ma è stata con me. È stata ed è ancora la mia fortuna avere avuto lei come moglie!” Patrizia aveva imparato a cucinare all’Eden, per stare vicino a Enzo e anche questa è stata una fortuna che, unita alla loro cordialità e gentilezza ha fatto dell’Hotel Barbieri di Altomonte un preciso punto di riferimento per chiunque voglia scoprire questa straordinaria regione.
L’hotel Barbieri oggi è davvero diventato uno degli alberghi più famosi della Calabria, realizzando il sogno di tuo padre ma, con la tua gestione altre cose si sono affiancate al Barbieri. Ad esempio l’antico Palazzo dei Giacobini ora è di vostra proprietà. Un raffinato edificio di fine ‘800, carico di fascino e cultura, che fu originariamente abitato dagli agenti feudali dei Sanseverino. Per cosa lo utilizzate?
“Palazzo Giacobini era nato ai primi dell’Ottocento come fabbrica di liquori dei fratelli Ciro e Luigi Giacobini che provenivano da Napoli.
Producevano liquori per il mondo intero e nel museo che esiste ad Altomonte sono esposte migliaia di etichette coloratissime e le centinaia di premi che vinsero, furono fornitori ufficiali della Martini a cui vendevano uve particolari per il loro vermouth. Dopo di loro un certo Moliterno acquistò l’azienda, affiancando una fabbrica di bevande e bibite. Nel Palazzo aveva aperto un circolo dopolavoristico dove si andava a giocare a carte e ho un ricordo molto bello di me bambino che va con lui. Negli anni ’50 il palazzo fu ceduto a un commerciante di stoffe che aveva la particolarità di far entrare un cliente per volta, fino agli anni ’80 quando comprammo il palazzo per farci eventi. Con questa struttura, per vent’anni, siamo stati i leader assoluti degli eventi in Calabria. Quando aprii, per la prima volta, ospitai una mostra di Luigi Rincicotti, artista famoso vincitore della Triennale di Milano e della Biennale di Venezia. Stavano talmente bene quei quadri che decisi di non sostituirli con null’altro, pagando, a quel tempo, con decine di assegni. Adesso lo utilizziamo ancora per bei ricevimenti quando il Barbieri è tutto occupato ma l’idea è creare la prima scuola di cucina di alta qualità della Calabria”.
E la Cantina Barbieri dov’è e cosa fa?
“La Cantina Barbieri è nata per valorizzare uno degli angoli più belli di Altomonte. Conteneva le migliori etichette nazionali e locali. Per un paio d’anni ha funzionato molto bene anche perché la utilizzavo anche come piccola trattoria tradizionale. Ora la usiamo per cene particolari come quella di poche settimane fa degli inglesi. Inglesi che vengono ogni anno ad Altomonte per conoscere l’arte bizantina e la cultura arbëreshë, una cultura antica originaria dei primi albanesi arrivati qui nel XV secolo per sfuggire alle invasioni ottomane. Sono vent’anni che lavoro con loro e l’agenzia di viaggio mi ha detto che la sosta italiana più bella è quella dai Barbieri. Mio figlio li porta in giro per Altomonte con il calessino, tra i vicoli e le piazzette”.
Ultima cosa tra le tue invenzioni. La DOB, Denominazione d’origine Barbieri. Questa quando l’hai pensata?
“Alcuni miei amici, vedendo il mio tunnel dove si cruscano i peperoni, li hanno denominati DOB, perché, mi dissero, li fai solo tu così buoni e particolari. Vorrei far comparire la DOB sulle etichette della portulaca, dei carciofini selvatici, della confettura di percocche e di tutti i prodotti che produciamo solo noi. Anche perché ci vuole tanta tempra e passione per fare queste cose che valorizzarle al massimo è solo soddisfazione”.
E qui veniamo alla Bottega Barbieri, all’interno dell’hotel…
“La Bottega è nata per rispondere alle richieste degli ospiti. A tavola, quando facciamo assaggiare il nostro olio, ne vorrebbero sempre comprare qualche bottiglia. Il problema è che noi lo avevamo solo in confezioni da cinque litri, così come per le conserve. Un giorno mi decisi e feci imbottigliare una parte di olio e inscatolare una parte di conserve in confezioni più piccole e cominciai a venderle agli ospiti prima della partenza. Poi dissi a mia moglie, ma perché non sistemiamo quella stanza che oggi funge da magazzino. Detto, fatto. Oggi la Bottega Barbieri ha in vendita i 160 prodotti che faccio, prevalentemente, con il nostro orto, sono piccoli diamanti gastronomici e nessun ospite lascia l’hotel senza prima fare un giro in Bottega. Inoltre ho cominciato a commercializzarli in alcune boutique gastronomiche in giro per l’Italia”.
Parlando di prodotti la Calabria ne ha di straordinari che, finora, sono rimasti un po’ troppo dentro ai confini: tu, da molto tempo, hai fatto esattamente il contrario e ci sei riuscito. Come è oggi la situazione?
“Sta migliorando notevolmente perché, per fortuna, ci sono vari Barbieri, oggi, in giro per la Calabria. Sicuramente il prodotto che identifica maggiormente la Cala-


bria è la ‘nduja. È la prima cosa che mi chiedono quando partecipo agli eventi in giro per il mondo. Un’altra cosa che mi chiedono è la Rosa Marina, la neonata di pesce azzurro. A ruota segue la cipolla di Tropea, la patata Silana che noi valorizziamo tantissimo. Poi la nicchia dei nostri prodotti come la Portulaca; i carciofini selvatici, faticosissimi ma di grande soddisfazione; i fichi dottati caramellati per cui le persone impazziscono; per finire le conserve in olio extravergine, dove il prodotto, che siano zucchine o melanzane o qualsiasi altra cosa sono raccolte da me e trasformate da me. Non è roba in salamoia. Noi dobbiamo puntare sul piccolo laboratorio artigianale su cui dobbiamo insistere. Questa è la strada da percorrere per far emergere il nostro territorio. L’olio extravergine della Calabria è un prodotto coscienzioso; i vini della Calabria, anche se in grande ritardo, adesso si stanno affermando a livello internazionale. Se poi c’è una cosa che mi fa arrabbiare è che ci siamo vergognati per troppo tempo delle nostre produzioni: il peperone crusco come i lampascioni ci sono, da sempre, anche qui, eppure nessuno lo sa e si sono affermati in Basilicata e in Puglia. Sul peperone crusco abbiamo posto rimedio dando vita alla confraternita dei Zafarani Cruschi del Pollino (lo zafarano è il termine calabrese per indicare il peperone); una confraternita condotta da mio figlio Michele che vanta 600 confratelli. Sai quale è il frutto ufficiale nei ristoranti calabresi? L’ananas, nella terra dei buonissimi fichi d’India; lo dico con grande dispiacere. Io ho fatto, anni fa, una proposta all’ente pubblico: compriamo una fabbrica dismessa a Milano, ristrutturiamo e la rendiamo il luogo dove si trovano e si comprano tutti i prodotti made in Calabria originali. Non se ne è fatto nulla però continuo ad essere ottimista!”
La famiglia Barbieri è stata tra le prime a parlare di stagionalità ed eco-sostenibilità, immaginando e realizzando sin dai primi anni ‘70 un modello diverso di
ristorazione e di accoglienza, puntando sul marketing territoriale, perché non diventa azione collettiva?
“Per i motivi che ho detto poc’anzi anche se qualcosa sta cambiando dai tempi in cui Veronelli scriveva che “da Barbieri si mangia da Dio, peccato che abbia solo una carta dei vini calabresi”. Questo succedeva cinquant’anni fa e io, a quel tempo, ero il primo crociato contro il Mateus portoghese che impazzava in Italia. Piano piano li ho sconfitti tutti e la mia carta dei vini calabresi è ora motivo di grande orgoglio e di qualità del nostro ristorante. Uno degli esempi di maggior successo è il nostro olio che viene venduto all’estero a 60 euro a bottiglia. Il marketing va insegnato, non si improvvisa, però alcune cose le ho dentro grazie agli insegnamenti di mia nonna Maria che, a Ferrara utilizzava tutte le strategie di marketing dell’accoglienza in maniera spontanea e naturale”.
Quanto conta la gestione familiare nell’attività ristorativa oggi?
“È fondamentale! Di mia moglie ti ho detto, senza di lei, del suo supporto, della sua bravura come cuoca, madre, moglie, non sarei quello che sono e il nostro lavoro non avrebbe portato ad essere riconosciuto in termini di valore. Poi ho tre figli straordinari che, però, ho dovuto crescere come mia nonna ha fatto con me: facendogli assaporare la vita dell’hotel e del ristorante giocando. Diversamente non sarebbero così. Michele in sala è semplicemente straordinario, la sua capacità di racconto dei piatti, dei prodotti, di Altomonte è una garanzia per il nostro ristorante. Alessandra è l’interprete perfetta di una delle principali doti di un albergatore: non farsi distrarre da nessuno e avere sempre un sorriso per tutti senza fare preferenze di alcun tipo. Laura, la più piccola (per modo di dire piccola ndr), è il mio alter ego in cucina. Lei riesce a gestire catering di mille persone come le cene più intime al ristorante senza mai sbagliare un colpo. Avere una compagnia come questa ti permette, partendo da Altomonte di arrivare alle stelle”.
Autrice: Giulia Zampieri
Clicca e leggi l’articolo sul web
Prima di pensare all’abbinamento bisogna ragionare sulla scelta del fornitore, sulla competenza del personale e sulla consapevolezza dell’ospite

Quando si parla di pietanze di pesce nell’immaginario di molte persone persiste ancora l’associazione con locali che costeggiano il mare, ove si ha una parvenza che la freschezza e la qualità siano garantite.
Non è sempre così, anzi. Chi opera nel settore, da ristoratore o da fornitore, sa bene che le discriminanti per un prodotto ittico di qualità non sono la prossimità al mare, o insomma la “pertinenza” territoriale, bensì le scelte qualitative e commerciali di una cucina, e naturalmente la capacità di selezione e le accortezze di lavorazione della materia prima. Il punto è che non sempre la comunicazione, anche da parte dei ristoranti stessi, è stata in grado di far trasparire questo concetto.
Bisognerebbe raccontare in modo sempre più accurato a chi è seduto al tavolo cosa significa qualità, quali sono i vantaggi di una logistica sempre più rapida e performante, quanta rapidità e precisione ci sia oggi nelle consegne del prodotto fresco o surgelato.
Apriamo questo approfondimento dedicato al prodotto ittico portandovi subito alcune rifles-

sioni da La Ciau del Tornavento, leggendario ristorante di Treiso (CN) che, sin dall’apertura, avvenuta quasi trent’anni fa, ha abituato i suoi clienti a proposte di pesce di altissima qualità. Con un particolare: siamo a pochi chilometri da Alba e molto lontani, quasi novanta chilometri, dalle prime coste liguri.
Negli ultimi anni la tecnologia applicata ai trasporti e ai sistemi di conservazione ha raggiunto livelli altissimi. Per i prodotti ittici, soggetti a facile deperibilità, gli effetti positivi sono evidenti, e la qualità è costantemente in ascesa. Marco Lombardo, che conduce con Maurilio Garola la cucina de La Ciau del Tornavento, rimette in fila questi passaggi, portando l’esperienza diretta.
“In questi ultimi anni sono stati fatti grandi passi avanti in termini di gestione della catena del freddo e di stoccaggio. Penso subito ai prodotti congelati a bordo, che talvolta risultano più buoni e sicuri dello stesso pesce fresco. Il primo aspetto che ne ha beneficiato è la sicurezza, che è sicuramente l’elemento più importante quando si parla di una categoria di alimenti così delicati. Ne ha giovato anche la qualità organolettica del prodotto, quindi una maggiore affidabilità per noi che poi il prodotto lo maneggiamo e lo serviamo a tavola. Siamo convinti che la scelta dei fornitori sia essenziale e primaria e deve essere un rapporto basato sulla fiducia assoluta”.
A La Ciau del Tornavento lavorano solo con pesci interi, dalle grandi taglie a quelle più piccole, passando per cefalopodi e molluschi. La lavorazione è un tema delicatissimo; c’è bisogno di competenza. Marco ci confessa
che disporre di personale qualificato non è semplice, ma chi proviene dal Giappone, dal Perù, dalle Filippine, dimostra una grande sensibilità.
“Il nostro obiettivo è esaltare la materia prima, ed è un attimo rovinarla. In Italia abbiamo una predilezione per la semplicità, non intendiamo coprire i prodotti con eccessivi condimenti o stressarli con forti cotture, per questo nel nostro menu si rintracciano proposte dalle cotture ‘gentili’ e il crudo. Seguiamo questa linea, una linea sale e olio, per così dire, che un po’ ricorda la modalità di trattamento della Fassona Piemontese. Ci mettiamo quello che basta per valorizzare la texture e il sapore”. Parliamo anche di consumi; rintracciare dei dati è complesso, ma il percepito dei singoli ristoranti sicuramente aiuta a definire il quadro. Molte volte non c’è la possibilità di reperire un prodotto eccellente, o non c’è la competenza nello sceglierlo e lavorarlo tra le mura di casa, ci raccontano dalla cucina de La Ciau. Trovare queste competenze in un ristorante incentiva il cliente a scegliere proprio quel prodotto.
“Il consumo di pesce nel nostro ristorante è aumentato in questi anni - precisa ancora Marco - soprattutto da parte del cliente straniero. Anche gli ospiti italiani, spesso avvezzi a consumare in casa piatti della tradizione, quando vengono al ristorante amano sperimentare proposte di pesce, consapevoli di trovare una selezione e un certo tipo di lavorazione. Poi c’è un grande lavoro di sensibilizzazione da perseguire, a cominciare dalla falsa credenza che in tutti i ristoranti di mare si mangi dell’ottimo pesce. Anzi, talvolta si tratta di attività stagionali che non riescono a garantire costanza o ad avere personale ade-

guatamente preparato. Specifico che, ovviamente, non stiamo parlando in termini assoluti ma di alcune situazioni che generano poi confusione nel cliente”.
Come sopra scritto, vi sono attività di ristorazione in località balneari che non riescono ad offrire una proposta di pesce soddisfacente, costante, come ci si aspetterebbe da un ristorante sul mare… ma non sono la regola. In Italia si contano molti locali virtuosi, a pochi metri dal bagnasciuga, che sanno stare al passo con i cambiamenti del mercato pur mantenendosi radicati ad alcuni principi, quali la tipicità e la territorialità.
Uno di questi è il Ristorante Pagaia di Senigallia; indirizzo - ci tengono a sottolinearlo - di matrice familiare, in cui da 37 anni si serve un menu di pesce attingendo prevalentemente dalla tradizione (ma non solo). Ci racconta Daniela Renzi, titolare con la sorella Roberta e il fratello Emanuele dell’attività: “La nostra è una lunga storia di famiglia, il pesce è il cuore del nostro ristorante. L’esperienza mi porta a dire che per lavorarlo c’è bisogno, prima di tutto, di materia prima eccellente, quindi di ricerca, solo così si può tenere alto il livello della proposta. Un’altra voce è la conservazione: nel prodotto ittico, probabilmente più che in altre materie prime, il modo in cui si conserva diventa cruciale. La chiave per riuscire in queste buone pratiche sta nell’individuare dei fornitori che lavorano con etica. Noi abbiamo modo di controllare la merce quando arriva e da sempre ci preoccupiamo di testarla anche per valutarne la continuità, ma il fornitore è l’intermediario che veicola informazioni primarie importanti, quali origine, modalità di gestione del prodotto. Insomma è colui che si fa portavoce della catena del freddo e delle peculiarità del
prodotto. Bisogna fidarsi, bisogna potersi fidare!”. Daniela, come altri colleghi, nota importanti cambiamenti nelle preferenze del pubblico, ed evidenzia la necessità di acquistare referenze innovative, che si prestano ad applicazioni originali, ma che siano anche gestibili agilmente in cucina.
“Sono convinta ci sia bisogno di aziende che mettono in campo prodotti specifici, sicuri, ma anche originali, su cui si può lavorare con creatività. Noi siamo legati a una cucina di tradizione ma vogliamo affiancare anche delle alternative. Il pubblico è affezionato ai sapori riconoscibili ma è anche curioso di provare nuovi abbinamenti, nuove formule. Inoltre la manodopera in cucina risulta sempre meno specializzata: c’è l’esigenza di referenze che semplifichino e agevolino il personale”.
Santo Gusto
Sul fattore personale fa leva anche Santo Nicolosi, titolare di una duplice insegna nel bresciano
“Quello che sta facendo e farà davvero la differenza sarà la competenza, la capacità di selezionare e gestire le materie prime. Lavorare con gli alimenti significa avere una responsabilità, e con il pesce la responsabilità è ancora più marcata. Si tratta di materie prime facilmente deperibili, delicate; ogni pesce ha le sue temperature ed è fondamentale che il personale sia informato su tutte le procedure e le rispetti. Noi in questi dieci anni di attività siamo aumentati in modo esponenziale numericamente” - Oggi per Santo Gusto lavorano quaranta persone e ciascuno è preparato nel suo ambito - “La formazione di ogni componente della squadra è un tassello importante e deve essere promossa dal datore di lavoro stesso”. Una buona formazione, ad ogni modo, non può marciare senza elementi di supporto adeguati. E anche qui le
scelte di investimento del ristoratore fanno la differenza. “Trattiamo tantissime tipologie di prodotto e in grandi quantità, quotidianamente. Dai pesci di grande taglia ai molluschi (per esempio abbiamo una lunga lista di ostriche, selezionate dai migliori produttori) e poi ancora crostacei di prima scelta. Il nostro menu ospita tantissime voci e gestirle correttamente non sarebbe possibile se non ci fossero le strumentazioni e gli spazi adeguati. Mi riferisco ad abbattitori, frigoriferi con diverse temperature, spazi dedicati alla lavorazione del crudo. Si parla molto della qualità della materia prima, della freschezza, dei fornitori, ed è corretto, anche noi abbiamo stabilito dei rapporti di stretta fiducia con gli attori del mercato per garantirci il meglio, ma per lavorare il pesce come si dovrebbe c’è bisogno di fornire al personale un contesto lavorativo adeguato, con tutto l’occorrente. Inoltre, siamo ben strutturati, c’è una precisa suddivisione dei compiti. Abbiamo anche un ufficio acquisti interno che si assicura della qualità dei prodotti ad ogni arrivo”.
Santo aggiunge che la trasparenza, come il controllo accurato della merce in arrivo, è una pratica ‘invisibile’, lunga e dispendiosa ma necessaria, che viene premiata dalla qualità e, dunque, dalla soddisfazione dell’ospite.
Abbiamo parlato finora prevalentemente di dinamiche legate al rapporto ristoratore-fornitore e delle complessità di gestione, dentro al ristorante, delle materie prime ittiche.
Abbiamo solo fatto cenno ad altri temi rilevanti che riguardano l’ospite: per esempio qual è il grado di competenza e come stanno cambiando le preferenze?
Martina Lombardo di Scale del Gusto a Ragusa ci consegna una fotografia precisa: “Notiamo in generale un cliente molto più preparato; è attento alla freschezza,
spesso dimostra di saper valutare l’ingrediente o, se non altro, pone delle domande sulla provenienza e vuole sapere quando si tratta di prodotto fresco”
Le domande vengono poste sia dai clienti abituali sia da chi viene da fuori, compreso il pubblico straniero; c’è molta curiosità e recepiamo molta più conoscenza della materia rispetto al passato”.
Mentre in sala c’è Martina, in cucina c’è Maurizio Musumeci, che ci racconta quali sono le ‘rilevazioni’ gastronomiche che gravitano attorno ai prodotti ittici.
“Noi non abbiamo un menu lungo, lavoriamo con ingredienti prettamente stagionali e i clienti apprezzano questa scelta. Tra le nostre proposte di mare spaziamo in base alla stagionalità; possono esserci i gamberi, i ricci di mare, e senz’altro i pesci di grande taglia, come la ricciola e il tonno. Abbiamo deciso di proporre anche i crudi ma con l’accortezza di servire versioni creative, insomma non solo la classica tartare. Le persone cercano anche di portare a casa una nuova esperienza gustativa”.
In questo periodo, per esempio, leggiamo dal menu de Le Scale del Gusto di un crudo di ricciola abbinato ai cladodi di fico d’india, al guazzetto di pomodoro pendolino e all’olio d’oliva aromatizzato al basilico e gelsomino.
Proporre questi piatti lavorando sull’abbinamento significa anche connotarsi, dare un tono alla proposta, imprimere il ricordo di un accostamento nuovo (a patto che il prodotto di partenza sia di alta qualità, ma questo lo abbiamo già sottolineato in ogni contributo di quest’articolo!).
E infatti, ci racconta Martina, i loro clienti apprezzano l’elemento in più.
In altre parole, vengono premiate l’identità e la personalizzazione applicate al buono. Le chiavi per chi oggi e in futuro vuole fare ristorazione.




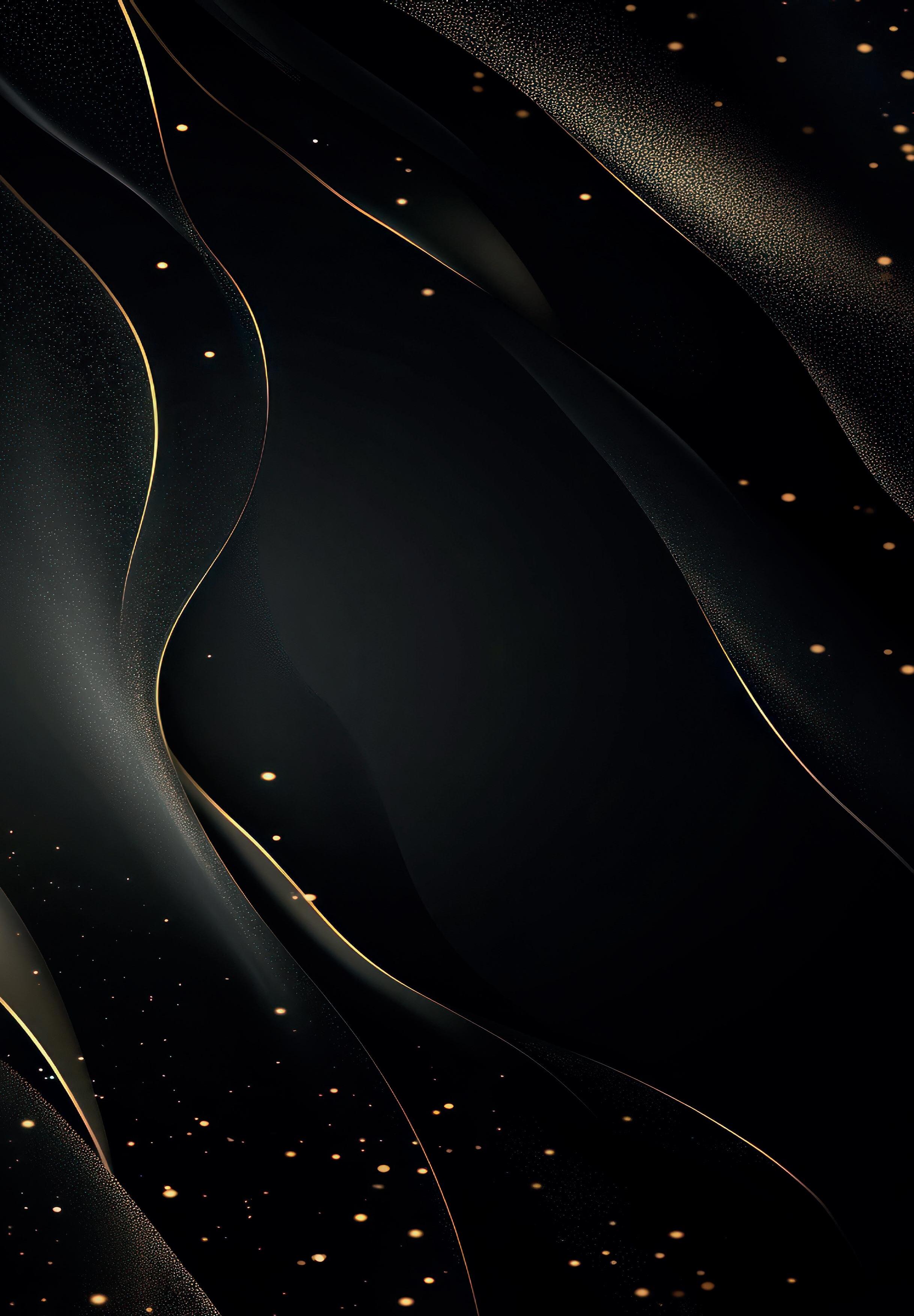
www.graziadeisurgelati.com
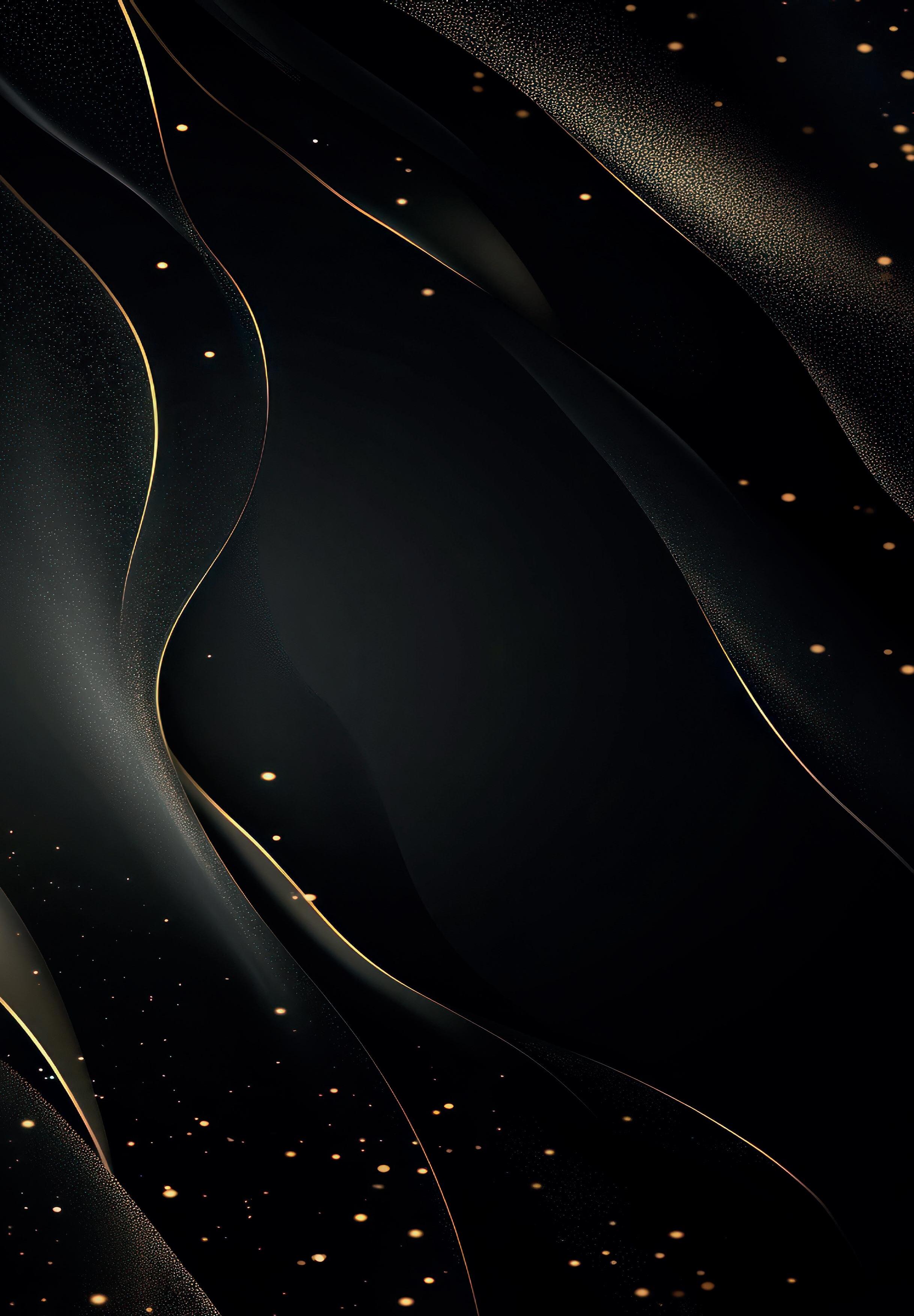
Autrice: Simona Vitali
Clicca e leggi l’articolo sul web

Ogni stravolgimento comporta operazioni imponenti ma soprattutto tempi di assorbimento e rielaborazione che non hanno certamente effetti immediati come si vorrebbe.
Ha voluto tracciare una strada completamente nuova il ministro Giuseppe Valditara, immettendo nel circuito degli istituti tecnici e professionali un percorso formativo - denominato 4+2 perché quadriennale e integrabile (non obbligatoriamente) con due anni di specializzazione post diploma (ITS)che si affianca a pieno titolo al percorso quinquennale in auge. Di fatto dopo i 4 anni è possibile anche non proseguire con il biennio o accedere direttamente all’Università.
Assicura il ministro che adottando la nuova filiera formativa il numero di professori in organico rimarrà invariato, che le scuole potranno coinvolgere esperti esterni con specializzazioni particolari e potranno altresì decidere di aumentare le ore di scuola-lavoro (PCTO) e di apprendistato formativo.
Insomma ci sarà un marcato collegamento con il mondo del lavoro.
Di contro, aggiungiamo noi, ci sono sfide non piccole da mandare a segno come il riuscire a mettere a punto un nuovo programma didattico efficace e concentrato su 4 anni anziché 5, per non parlare
del velocizzare la nascita di ITS in tutto lo Stivale, per consentire quei due anni di specializzazione che contribuirebbero a fare la differenza (per chi opta per questa scelta, non obbligatoria).
Partito sottotraccia lo scorso anno, in questo anno scolastico il nuovo percorso formativo si appresta a prendere un po’ più piede.
Mentre scriviamo la scuola è in dirittura di partenza per cui non abbiamo ancora dati alla mano circa l’effettiva adesione delle scuole a questo modello, che per ora rimane parallelo rispetto all’esistente. Il Ministero ha stimato di riuscire a coinvolgere fino al 30% degli istituti. Seppur il “4+2” sia diventato ordinamentale, quest’anno scolastico ne vedrà il rodaggio, come accade con tutto ciò che è completamente nuovo. Staremo quindi a vedere, step by step.
La domanda però diventa se questo nuovo modello formativo, che a detta del ministro toglierà all’alberghiero l’etichetta di serie B ma che altresì richiederà il suo tempo per affermarsi (auspicando che accada perché non ci si può permettere di perdere giri), se questo modello formativo, appunto, sia sufficiente nel medio breve a riaccendere nei ragazzi la fiammella verso il mondo della ristorazione e dell’accoglienza, che sappiamo bene esse-

re in stato di grave sofferenza, in termini di vocazioni. Sono ancora troppi gli ostacoli che i ragazzi devono superare per poter scegliere in serenità quali studi intraprendere in vista della loro futura professione.
Lo abbiamo detto più volte e ora lo ribadiamo: ci sono le velleità dei genitori che spesso sembrano ragionare a senso unico, l’ignoranza (nel senso di non conoscenza) degli insegnanti delle cosiddette scuole medie (scuole secondarie di primo grado)…a quel punto non resta molta libertà di valutare ma spesso, troppo spesso, solo condizionamento.
Hanno bisogno di toccare con mano la passione, la motivazione, la storia dei professionisti veri: in questo vanno contagiati. Devono sentire un contraltare, un’altra campana, rispetto a chi li porterebbe altrove. Che poi sappiamo per certo che c’è, appunto a causa dei suddetti impedimenti, chi reprime le proprie aspirazioni.
A 15 anni non sempre hai la forza di ribellarti a chi ha la presunzione di scegliere per te. Anche se a dire il vero incontriamo cuochi che ci raccontano anche questo, a riprova della loro inarrestabile motivazione.
E chi quella forza non ce l’ha? Lasciamo che soccomba sotto il suo sogno? E chi vorrebbe ma non è sicuro? Speriamo che abbia la fortuna di incontrare le persone giuste
Ma chi sono le persone giuste? Sono coloro che quel


settore lo vivono e lo esperiscono ogni giorno. Sono i lettori di riviste come questa, gli stessi che stanno vivendo con preoccupazione il momento storico in atto.
L’ascolto
È qui che ciascuno di noi, in qualunque situazione si imbatta a tu per tu con questi ragazzi, può intervenire, semplicemente interessandosi a loro, chiedendo di loro, dei loro sogni per via di quel bisogno di ascolto che hanno. Recentemente ho preso parte a una commissione d’esame di un corso di specializzazione post diploma in materia di enogastronomia, ed è curioso come anche in questi casi i partecipanti vi approccino perché confusi, con il gran bisogno di fare chiarezza, di trovare il loro filo, spesso pure cambiare direzione, sebbene siano più grandicelli degli adolescenti in fase di scelta della scuola. Situazioni delicate anche queste, quindi.
Ecco, in quest’occasione sono rimasta colpita da come un giovane collega, Sebastiano Ricci, ricercatore in tecnologie alimentari specializzato in analisi sensoriale presso l’Università di Parma, ha approcciato ogni singolo esaminando sapendo toccare le giuste corde per farlo aprire, entrando in sintonia con lui.
“È importante – sostiene Sebastiano che è stato a suo tempo educatore e poi allenatore sportivo di diverse categorie giovanili - riuscire a porsi sullo stesso livello della persona che si ha di fronte, che non è lì solo per essere giudicata da te ma capita. Bisogna che ritariamo il senso del giudizio che ci impedisce di interfacciarci in maniera costruttiva con gli altri, ponendoci senza altezzosità e cercando di capire in che modo il ragazzo può essere stimolato. Una parola detta in modo opportuno al momento giusto può fare molto di più di chissà quali azioni”.
Della stessa idea è Antonio Cammarota, fondatore della fattoria/comunità Macinarsi, che delle relazio-
ni umane è diventato profondo conoscitore attraverso esperienze forti:
“ Le parole sono preziose perché ci costruiscono anche. - ha raccontato in occasione di un forum in cui si è parlato di giovani e di pace - Le parole giuste poi, quelle dedicate, soppesate, diventano maestre. Ricordo ancora che nel mio percorso di vita ho avuto non un maestro ma molti maestri che in quel momento mi hanno dedicato quella parola giusta che ha accompagnato per anni la mia vita. Le parole costruiscono anche considerazione. I ragazzi devono essere considerati. La psicologia sia classica che moderna è basata sulla considerazione. Se non si offre considerazione a un essere umano questo si spegne o entra nel caos, perché non ha tempo per germogliare felice”.
E ora moltiplichiamo questo gesto per tutti coloro che operano nel settore della ristorazione e dell’accoglienza e pensiamoli a transitare nei luoghi più svariati, da una sala d’attesa al treno alla palestra o anche soltanto nel loro luogo di lavoro ed entrare in contatto con i ragazzi. Ovunque si trovino tutti quanti loro (noi compresi) possono lasciare un segno, incidere a qualche titolo nella loro vita, attingendo dalla propria esperienza. Semplicemente parlando con loro.
A ben pensare non siamo così bravi a contagiare con la nostra motivazione l’altrui motivazione. Semplicemente perché non ci applichiamo.
È qui che possiamo recuperare tempo e risorse preziose, non lagnandoci che la ristorazione piange, che non c’è personale, che sono altri che devono provvedere.
Chi salva un’anima salva sé stesso, diceva Enzo Biagi. Per non parlare poi del problema – lato ristoratori/albergatori - di riuscire a conservarli una volta conquistati, questi ragazzi.
Al concorso Emergente Pastry, la giovane Matilde Morandi che affianca lo chef Gaetano Trovato presso il ristorante Arnolfo a Colle d’Elsa (SI), ha raccontato che lo chef al mattino le chiede: “Hai sognato stanotte?”.
Autore: Luigi Franchi GLI AMBASCIATORI

Clicca e leggi l’articolo sul web
Un lungo viaggio nel prodotto simbolo della cucina italiana
“L’Associazione Italiana Ambasciatori del Gusto riunisce i grandi protagonisti della ristorazione italiana: chef, pizzaioli, sommelier, maestri gelatieri, produttori e professionisti che, con la loro competenza e passione, rendono unica la cucina Made in Italy nel mondo. La sua missione nasce dalla consapevolezza che raccontare, qualificare e valorizzare l’enogastronomia italiana significa contribuire, in sinergia con le Istituzioni, allo sviluppo e al progresso del Paese. Dal 2016, l’Associazione si impegna a costruire progetti concreti per far conoscere la nostra cultura gastronomica, consolidando un modello che è espressione di identità, qualità e tradizione.”
La FIPE, in una recente ricerca, ha stimato che un buon piatto di pasta arriva a sancire il successo di un locale per il 67% dei ristoratori. Il motivo? È il piatto che gli ospiti ricordano più a lungo! E cambiare tipologia di pasta per risparmiare dieci centesimi a confezione è una scelta suicida da parte dei ristoratori che, in alcuni casi, invece lo fanno!
Alberto Gipponi, chef patron del Ristorante Dina, Ambasciatore del gusto
E se è vero che l’ospite premia il ristorante lo fa anche perché è una materia prima che permette agli chef di dare sfogo alla loro creatività e all’innovazione, come ha fatto Alberto Gipponi, chef-patron del ristorante Dina di Gussago, in provincia di Brescia: “Quattro anni fa misi in carta un menu-degustazione composto solamente dalla pasta, proprio io che da bambino non apprezzavo né la pasta né i dolci che, invece, sono diventati uno dei miei obiettivi quando ho aperto Dina. Il menu si chiamava Inpasta e faceva leva sulla gestualità dell’impastare, parlava di morsi e strutture della pasta. Un mondo meraviglioso quello della pasta, creatività, innovazione e tradizione che si fondono insieme per dare il massimo dei piaceri. Le persone hanno reagito con grande curiosità alla proposta, molto complessa perché an-

dava dall’antipasto al dolce, ma una complessità che mi ha dato grandi soddisfazioni. Oggi non so se rifarei quel menu, sono cambiato diventando più equilibrato nelle scelte e quello era un menu troppo didascalico rispetto a quello che farei oggi”.
Ma la passione per la pasta non lo ha abbandonato infatti sta collaborando con l’università per individuare dei percorsi innovativi che possono essere davvero tanti: dalle strutture ai tempi di cottura che non alterino il reticolo proteico della pasta.
“Sono collaborazioni che faccio sia con l’università che con le aziende affinché si trovi un’innovazione che riesca a diventare popolare, di tutti. Infatti, soprattutto l’industria, grazie alla collaborazione con gli chef, può dar vita anche al senso sociale del suo lavoro e dei suoi prodotti”
Un’ultima domanda: hai un formato che preferisci tra gli oltre 300 che rappresentano la pasta italiana?
“No, non ho un formato preferito. Scelgo la pasta in base agli obiettivi che voglio raggiungere. La mia idea pensa sempre all’interno dell’ingrediente e quella meravigliosa scoperta che è la pasta penso che debba diventare vettore non solo di sughi ma anche di grano”.
Alex Gaspari, chef patron dell’Osteria dei Coghi a Costermano (VR), Ambasciatore del gusto
Alex Gaspari fa il cuoco da ormai 23 anni, ma l’Osteria dei Coghi, dopo diverse esperienze, l’ha aperta nel 2015, dieci anni fa. Dieci anni di sperimentazione incentrata prevalentemente sulla pasta, come ci racconta lui stesso.
“Affrontare il tema della pasta, per me, significa fare un discorso molto articolato perché dobbiamo dividere in due l’argomento: la pasta prodotta da me e la pasta dei piccoli pastifici artigianali e le utilizzo entrambe. Per me la pasta ha un ruolo fondamentale, è il simbolo della cucina italiana e deve sempre essere protagonista, con molto carattere e identità. Quella prodotta da me, in trafile di bronzo, è fatta con grani antichi per dare uno

spessore e un’importanza alla pasta stessa. E, in alcuni casi, si tratta di paste lavorate anche con alghe di acqua dolce o caffè dei carciofi per far assaporare anche la pasta stessa, oltre al condimento. Un esperimento che mi sta dando grandi soddisfazioni per la versatilità di questi piatti. Ho realizzato anche una ricetta interamente mia di sfoglia: una pasta croccante da scottare a vapore e a bassa temperatura in forno, con i vari condimenti che chiamo la sfoglia croccante. Negli ultimi dieci anni ho fatto molta ricerca, senza vincoli di nessun tipo, realizzando all’incirca 60/70 ricette di pasta. Per la pasta secca che utilizzo ho fatto la scelta dei piccoli pastifici artigianali. Faccio una degustazione alla cieca per scegliere quella che mi piace e convince di più. Con quella preparo ricette come quella che ho in carta adesso: i maccheroni con germogli di abete rosso, funghi prugnoli e cimbro. Credo molto nella pasta in menu, è l’italianità per eccellenza, e sono convinto che un ristorante che rinuncia alla pasta fa fatica a restare nella memoria”.
Fabrizio Facchini, chef patron di Stellina Hospitality in USA, Ambasciatore del gusto
Fabrizio Facchini, oltre ad essere il fondatore del gruppo FFS Hospitality che, quattro anni fa, ha dato vita a Stellina Hospitality negli Stati Uniti che è un insieme di strutture di ristorazione; inoltre è caterer e chef di riferimento per le istituzioni italiane negli Stati Uniti.
A lui chiediamo se, per la pasta, negli Stati Uniti, rispetto anche ad altre ricette italiane, qual è il livello di conoscenza e competenza che oggi si ha tra i consumatori e gli chef?
“Oggi i consumatori sono molto più attenti: se prima non capivano la differenza, ora vogliono la ricetta originale. Penso all’esempio della carbonara, forse il piatto italiano più discusso e conosciuto nel mondo: in passato negli Stati Uniti veniva spesso preparata con panna, pancetta o addirittura piselli, mentre oggi sempre più clienti la richiedono nella sua versione autentica. Questo cambiamento è stato favorito anche dall’apertura del mercato

agli ingredienti italiani, che da 15-20 anni arrivano con più facilità, e dall’arrivo di una nuova generazione di chef e imprenditori italiani in America, soprattutto a New York e in altre grandi città, che propongono menu fedeli alla tradizione. Questo è un passaggio fondamentale per far conoscere la vera cucina italiana al consumatore. Faccio un esempio, i miei clienti spesso mi dicono: “questo piatto mi ricorda quello che ho mangiato a Roma o a Napoli, ed è identico”. Ed è proprio questo che cercano: rivivere un pezzo d’Italia pur trovandosi a New York. Le ricette innovative, infatti, hanno sempre un loro spazio e vengono apprezzate, ma la mia esperienza negli Stati Uniti mi dice che l’autenticità resta al centro dell’interesse dei clienti. Oggi anche molti chef americani e italo-americani stanno cercando di riprodurre i piatti autentici della nostra tradizione. È un segnale positivo: significa che c’è interesse e rispetto verso la cucina italiana. Io stesso non disprezzo la cucina italo-americana, quando è fatta bene: è parte della nostra storia di immigrati. Ma la tendenza attuale è chiara: si punta sempre più sulla vera cucina italiana”.
L’innovazione tecnica e creativa della pasta
Gragnano è una delle città dove la pasta è nata e cresciuta. Dove se ne celebra la tradizione e la cultura centenaria ma anche, e soprattutto, l’innovazione tecnica e la creatività dei formati.
Sono finiti i tempi dove, a Gragnano, le vie e le piazze erano invase dai tralicci su cui appoggiavano spaghetti lunghissimi ad asciugare al sole. Quel periodo, attorno all’800, scomparve con l’invenzione del metodo ‘Ci-

rillo’, ideato da un ingegnere di Torre Annunziata che, guardando appunto quei lunghi spaghetti, progettò delle celle all’interno delle quali mise dei bracieri (oggi sostituiti da grandi caloriferi) che riscaldavano l’aria e potenti ventole ne distribuivano l’emissione del calore.
Oggi questo metodo permette di essiccare la pasta lentamente, in tre o quattro giorni, ed è fondamentale per ottenere la consistenza così amata dagli estimatori della pasta artigianale.
Il Pastificio dei Campi, in qualità di partner Ambasciatori del gusto
Pastificio dei Campi spa è un’azienda nata proprio nella città della pasta, a Gragnano, ed è tra quelle che hanno saputo trasformare la sapienza dei vecchi pastai in tecnica, innovazione, creatività, senza togliere nulla alla tradizione e alla qualità. Abbiamo incontrato Margherita Foglia, brand manager dell’azienda e, con lei, abbiamo fatto un lungo excursus tra storia e innovazione, con un particolare riferimento al grano duro.
“Pastificio dei Campi è un’azienda che produce pasta a Gragnano, dal 2010; fondata da Giuseppe Di Martino, quarta generazione di pastai gragnanesi, Pastificio dei Campi ha avviato il processo di ricerca fin dal 2004, quando Giuseppe conobbe Nicola De Vita, il nostro attuale mugnaio. Insieme avviarono la ricerca rispetto al nostro prodotto e a tutte le caratteristiche che lo rendono tale. Cercare di migliorare un prodotto già di per sé eccezionale – ricordiamo che la pasta a Gragnano è certificata già dal 1500 – era un’impresa non facile. Quello che lui notò all’epoca è che c’era pochissima attenzione verso una delle materie prime per produrre la
pasta: cioè il grano. E anche nel 2014 quando la pasta di Gragnano ottenne l’IGP le venne assegnata senza una legislazione sulla provenienza del grano. Giuseppe, invece, insieme a Nicola, decisero di puntare su una pasta ottenuta solo con grano italiano, di provenienza certa. A quel tempo era una scelta decisamente inconsueta e poi quello era il periodo d’oro dei grani americani che si pensava fossero più alto-proteici e quindi più resistenti. Oggi questi concetti sono stati completamente capovolti, il merito è anche di Giuseppe e di Nicola, perché molte altre aziende ora stanno portando avanti la filiera italiana. Tengo a specificare che non è detto che i grani italiani siano i migliori ma di certo vantano un’eccellente biodiversità, essendo coltivai da millenni. Il grano duro, infatti, è una varietà cerealicola tipica del bacino mediterraneo, coltivato nel sud Italia e nel nord Africa. Si tratta di una pianta autoctona che ha bisogno di terreni fortemente drenanti, pochissima acqua e zero umidità. Caratteristiche tipiche del sud Italia e non certo del nord America dove, nel corso degli ultimi settant’anni, si sono sviluppati solo quattro o cinque genotipi rispetto ai 250 del nostro Paese. Consumare poche varietà crea anche dei problemi alla salute, come sta succedendo con le intolleranze al glutine, perché queste varietà devono essere supportate da interventi chimici per raggiungere lo stato di essicazione in campo. Riprendere a coltivare grano italiano non era facile perché si dovevano trovare contadini disposti a coltivare grano duro, per di più alto-proteico per tenere testa alla concorrenza americana, e l’unico modo per farlo era tornare a una tecnica di coltivazione che prevede il maggese prima e il sovescio poi per mantenere un equilibrio del suolo. Per convincere

i contadini a tornare a questa produzione estensiva si è fatto un importante investimento economico, si sono fatti dei contratti di filiera, si è dovuto contrattare un prezzo del grano che implicasse anche i due anni di pausa dovuti al maggese e al sovescio. Questa lunga premessa è alla base della creazione di un’azienda che doveva lottare contro i colossi che consideravano pasta e grano come una commodity. Si è vinta una battaglia grazie anche al miglioramento degli standard qualitativi richiesto dagli chef e anche dalle persone. Nel 2010, quando siamo arrivati sul mercato, il nostro era un prodotto molto costoso e, quindi, ci siamo da subito, rivolti agli chef. L’alta ristorazione è stato il primo cliente ad approcciare alle nostre paste. Poi è stata la volta delle botteghe gastronomiche e, infine, l’online. Questo ha significato poter parlare con il consumatore che, attraverso un qrcode in evidenza sulla confezione, arriva a conoscere, tramite la block-chain, tutto il percorso di quel pacco di pasta”.
Margherita Foglia prosegue affrontando il tema dell’IGP. “All’interno della pasta di Gragnano Igp c’è un mondo, di artigiani e di industria, quindi c’è la necessità di produrre e far sapere come, da parte di ogni singola azienda, anche perché Gragnano non significa grano bensì acqua e aria che permetteva l’essicazione all’aperto. Noi abbiamo voluto, oltre all’aria che oggi è riprodotta, identica, con tecnologie industriali lavorare sulla maglia glutinica della nostra pasta, mantenendo l’elasticità e senza rompersi. La sottigliezza è un’altra nostra caratteristica a differenza di molte altre aziende che producono a doppio strato. Più una pasta è sottile più vuol dire che il grano è di grande qualità e più lunga e lenta è stata l’essicazione. Una pasta non deve mai superare i 12 minuti di cottura. In catalogo abbiamo 61 formati di pasta ma spaghetti e linguine restano i più venduti. Siamo orgogliosi della nostra pasta mista che chiamiamo ‘mischiato potente’ o ‘mischiato delicato’, con sette tipologie di pasta. Con gli chef, i nostri primi e, ancor oggi, più importanti clienti, abbiamo un rapporto diretto tramite una nostra rete vendita diretta che ci consente di rafforzare sempre il confronto. Ultima informazione: abbiamo anche una pasta creata da un designer, Mauro Olivieri. La giornalista Faith Willinger, parlando con Giuseppe, lamentava il fatto della dimensione del pacchero, della difficoltà a metterlo in bocca. Da quella conversazione è partita la ricerca di un formato a metà tra il pacchero e la calamarata ed è nato il Campotto, che ha vinto nel 2014 il Compasso d’oro, il più autorevole premio, a livello internazionale, per il design”.
Da Gragnano al nord, esattamente in Val di Fiemme (TN), dove, dal 1908, quattro generazioni della famiglia Felicetti portano avanti una produzione pastaria altamente specializzata, mentre la quinta generazione ha da poco
fatto il suo ingresso in azienda.
Valentino Felicetti ebbe l’intuizione che l’acqua di sorgente e l’aria d’alta quota potessero conferire alla pasta di grano duro un sapore riconoscibile. Un esperimento imprenditoriale da cui è nata una dinastia di pastai tra le Dolomiti e un percorso produttivo di ricerca fortemente distintivo. Ancora oggi Felicetti è l’unico pastificio in Europa situato sopra i 1000 metri di altitudine.
Di strada ne hanno fatta tanta ma sempre con un obiettivo: quello di restare sul territorio per dare valore anche alle persone.
Le loro produzioni sono realizzate interamente con semole di provenienza italiana e, soprattutto, biologiche.
Un metodo di lavoro, condiviso con una filiera che pratica l’uso responsabile di terreni e risorse, nel rispetto dell’ambiente.
L’azienda produce complessivamente oltre 100 formati di pasta, raggiungendo complessivamente le 35 mila tonnellate all’anno (di cui 20 mila realizzate nel sito di Predazzo e 15 mila in quello di Molina).
La vostra pasta Monograno quando è nata, con quali obiettivi, come risponde la ristorazione a questa tipologia di pasta?
“Il progetto Monograno nasce all’inizio degli anni Duemila con un obiettivo preciso: sviluppare una pasta in grado di valorizzare le qualità organolettiche di singole varietà di grano, coltivate in territori selezionati. Un’ispirazione presa in prestito dal mondo del vino, applicata però a un prodotto base della dieta mediterranea. Con la linea Monograno, Felicetti ha svolto un ruolo di apripista per l’attribuzione di una identità geografica al grano, in un contesto storico nel quale la pasta veniva percepita prevalentemente come un alimento quotidiano, domestico, realizzato con miscele di semole italiane ed estere. Il pubblico di riferimento per la pasta monovarietale è stato sin da subito quello dell’alta ristorazione. Una scommessa che si è rivelata vincente: oggi Monograno è presente nei ristoranti di ricerca di tutto il mondo e ha dato un importante contributo nel riportare la pasta secca nei menu di alta cucina, complice il confronto continuo con tutti gli attori della filiera – dagli agricoltori, ai mugnai agli chef – che ha consentito di creare un prodotto capace di rispondere alle esigenze della ristorazione gourmet”.
La vostra storia è intimamente legata al territorio: questo
valore è riconosciuto dagli chef?
“In oltre cento anni di storia, il Pastificio si è evoluto conservando un fortissimo legame con le origini. A non essere cambiato, in tutto questo tempo, è prima di tutto il rapporto con il territorio della Val di Fiemme, che ancora oggi – come aveva intuito Valentino – rappresenta il nostro tratto distintivo. Gli chef che utilizzano le nostre paste hanno una grande consapevolezza di questo valore e riconoscono nei nostri prodotti una sintesi virtuosa tra eccellenza e sostenibilità, sposandone l’approccio etico e il legame con il territorio”.
Eliminiamo una volta per tutte che la pasta è stata scoperta da Marco Polo così non ci affidiamo alle leggende. Scrivono Silvano Serventi e François Sabban nel loro saggio intitolato La pasta: “Molti episodi del cammino della pasta, un viaggio che in realtà racconta i primi passi della storia dell’umanità e della tecnica, ci sono ancora oscuri… si ritrovano tracce storiche di questo cibo universale dalla Germania all’Iran, dalla Grecia alla Russia, dalla Turchia alla Polonia, senza contare i paesi dell’Asia Centrale e Meridionale, né dimenticare il Mediterraneo Centrale e il Medio Oriente da cui provengono probabilmente le prime ricette di pasta secca”.
Alimento autoctono dunque, come ci ricorda in questo articolo Margherita Foglia. Ma in Italia quando si inizia a parlare di pasta? Sicuramente ai tempi dell’Antica Roma, con le lagane, una sfoglia che ricorda l’attuale lasagna. Poi in Sicilia, intorno all’anno Millecento, il geografo arabo Muhammad al-Idrīsī (1099 ca.-1164 ca.) parlò di Trabia, una località posta, scrive lo storico dell’alimentazione Giovanni Ballarini nelle sue Interviste impossibili, “tra le pendici del pizzo Cameccia e il mare, è ricca di acque che servono ai molti mulini costruiti secondo le più recenti conoscenze tecniche degli studiosi arabi e che macinano i grani coltivati sulla vicina, ampia area della Sicilia occidentale, e infine ha una favorevole esposizione ai venti e un facile porto”.
Trabia pare che derivasse da triyah che significa vermicelli.
Insomma molti lati ancora oscuri ma certo è il fatto che, oggi, l’Italia è l’unica nazione al mondo ad essere indissolubilmente legata alla pasta. Questo è un valore. Non gettiamolo al vento!


Prestigiosa e ricca “collezione” di funghi di prima scelta lavorati con cura e attenzione, tagliati e trifolati delicatamente secondo tradizionale ricetta. Indicati come accompagnamento per primi o secondi piatti, contorni e per la farcitura di pizze.
DEMETRA FOOD COLLECTION i prodotti che fanno tendenza.
Autore: Luigi Franchi

Clicca e leggi l’articolo sul web
Ma quanti Gianni D’Amato ho conosciuto in tutti questi anni?
È questa la domanda che mi sono posto non appena ho parcheggiato l’auto davanti al castello di Arceto, al limitare delle prime colline reggiane ma ancora in pianura, esattamente a metà strada tra Reggio Emilia e Modena.
È qui che Gianni, con la sua famiglia, Fulvia la moglie, Federico il figlio, ha messo nuove radici, tornando nella sua terra d’elezione. Infatti D’AmatOsteria si trova nella stessa provincia reggiana dove i D’Amato avevano dato vita a uno dei più belli e buoni ristoranti italiani – Il Rigoletto – che hanno dovuto lasciare a causa del terremoto del 2012.
La serenità degli ambienti si sposa con la bontà della cucina
Dopo Il Rigoletto, per la famiglia D’Amato è stata una ricerca mai interrotta di un luogo che rispecchiasse la loro volontà di trovare una serenità perduta. Non era facile reagire dopo una perdita come quella che avevano ingiustamente subito ma la loro forza di volontà li ha spinti a cercare, a sperimentare nuovi luoghi, nuove ricette dovute alla visione di Federico che ha affiancato Gianni in cucina con grandi litigate e grandi soddisfazioni per entrambi. Prima al Caffè Arti & Mestieri in centro a Reggio Emilia, poi al mare a Tellaro, in Liguria, a prendere in gestione la storica Locanda miranda cambiandone nome e qualità dei piatti e del servizio. Ma, crediamo conoscendoli un po’, che la ricerca non fosse terminata ancora. Fino ad ora, in una piccola raffinata osteria all’interno di un castello che ne ha viste tante nella sua storia che risale alla seconda metà del X secolo. Chissà se i vescovi proprietari immaginassero avanti di un millennio.
Di certo, ora, il castello fa da splendida cornice a un altrettanto splendida osteria, con uno spazio all’aperto circondato da piante selezionate direttamente dai D’Amato, con il criterio della bellezza e dei profumi che si sommano a quelli di una cucina dove si sente pienamente quella che, in gergo, si chiama ‘la mano’.
Gianni D'Amato - Foto Lido Vannucchi

La cucina di D’AmatOsteria
Solida, sicura, comprensibile e, soprattutto, buonissima. Non c’è stato un piatto fuori riga la sera in cui siamo andati da loro.
E siamo convinti che quello che abbiamo provato noi venga replicato, senza sbavature, a ogni pranzo e a ogni cena.
Non appena è arrivato il menu la prima sorpresa: un menu degustazione a 60 euro!! In un periodo in cui pizza e birra non costano ormai meno di 25 euro.
C’è tutto in quel menu degustazione per soddisfare ogni genere di palato; c’è soprattutto la storia di Gianni D’Amato, infatti il menu si intitola: I classici di famiglia “oggi”. Nella carta, breve come deve essere un menu contemporaneo, ci sono, invece, le storie di padre e figlio, che si sovrappongono in una simbiosi perfetta. Cito alcuni nomi di piatti, giusto per far capire che non si scherza per niente: Brandade di baccalà, pizzaiola di pesche Percocche e cialda di ceci; Spaghetti all’arrabbiata di totani, cozze, finocchietto e zafferano; Ricciola tonnata, fagiolini, cannellini, soia e Aceto Balsamico Tradizionale di Reggio Emilia.
Quando uscirà questo articolo sarà già il tempo del menu autunnale ma non cambierà la bontà. Quando c’è esperienza da vendere, unita alla freschezza di una mente giovane come quella di Federico, il risultato è sicuro
E in sala?
In sala c’è il sorriso e l’eleganza di Fulvia come da tempo non vedevamo. Abbiamo davvero raccolto serenità in questo luogo.
All’interno c’è spazio per una trentina di coperti, in un’ambiente che culmina con lo scalone da cui salivano anticamente i cavalli e le carrozze. Un pezzo di passato che si coniuga al presente grazie all’eleganza: degli arredi, delle sedute, dei piatti e dei bicchieri. Non è Il Rigolet-

Via G. Pagliani 2 Arceto (RE) Tel. 328 8909980
to, questo è ovvio, ma quando si nasce professionalmente in un luogo magico come quello non lo si dimentica più. Ritorna nei gesti di Fulvia, nel suo modo di raccontare, nel porgere il piatto, nell’essere sempre presente con la massima discrezione.
Ci sei riuscito Gianni, con l’aiuto della tua bella famiglia! Non è stato un percorso facile, anche le amicizie a volte si sono dimostrate meno solide del previsto ma questa è la vita. Quella che ti insegna che da solo puoi sempre farcela, basta aver coraggio, determinazione e un saper fare che significa a volte pensare diversamente, che è la cifra migliore in questo mestiere difficile del cuoco e del ristoratore!




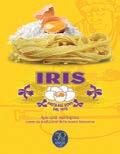




Clicca e leggi l’articolo sul web
Autore: Guido Parri

Un argomento di cui non si parla mai: la professione dell’agente di vendita. Siamo stati con loro per un giorno
Sosteniamo da sempre che fare ristorazione è uno dei mestieri più complicati che esistono e riflettendo su questo ci siamo chiesti: e come sono le professioni al servizio della ristorazione?
Non si parla quasi mai del lavoro che, ogni giorno, svolge un’agente di vendita di un distributore di prodotti alimentari per la ristorazione. Perché, se è vero, che i ristoranti fine dining molto spesso si riforniscono direttamente dai produttori, dagli agricoltori e dai pescatori, c’è tutto il mondo della ristorazione intermedia che rappresenta, da sempre, la strutturazione dell’accoglienza enogastronomica italiana che, invece, compra la prevalenza dei prodotti dai quasi 4.000 distributori che, ogni giorno, tramite gli agenti di vendita, varcano la soglia di ristoranti, trattorie, pizzerie e gastronomie per rifornirli.
Un giorno accanto agli agenti di vendita
Per spiegare nel migliore dei modi il ruolo di un’agente l’unica cosa da fare era affiancarlo e così siamo stati un giorno intero con gli agenti della F.lli Tondini, un’azienda di distribuzione che opera tra il Lago di Garda e le province di Mantova e Verona.
L’appuntamento con Matteo Fantuzzi è alle nove al casello di Mantova Nord.
“Non sono solo. – mi dice appena arrivo – Con me c’è Andrea Rognara, lavora con noi da pochi mesi ed è sotto la mia ‘giurisdizione’, essendo io il suo capo-area”.
Va benissimo, due voci sono meglio di una e Andrea ha solo ventun anni. Voleva, a tutti i co-

sti, questo lavoro, dopo aver conseguito il diploma di ragioniere, uno studio che oggi viene nobilitato con il termine ‘amministrazione, finanza e marketing’.
La prima domanda, appena partiti, la faccio a lui: cosa ti piace di questo mestiere, al punto di volerlo a tutti i costi?
“Perché ho sempre visto mio padre fare questo lavoro. Lui è rappresentante di vini e, da ragazzino, vedevo in lui una libertà di movimento, di capacità decisionale, di problem solving che mi affascinava. Dopo aver lavorato, dopo il diploma, qualche mese in ufficio, non ce la facevo proprio. Sapendo che i fratelli Tondini cercavano agenti per espandere il loro mercato, mi sono proposto ed eccomi qui”.
Nel frattempo ci avviciniamo al primo degli appuntamenti della giornata. Andrea ha in mano i clienti di Mantova città e dell’immediata periferia. Le domande, intanto, cominciano a turbinare ma avrò tempo. Ora dobbiamo entrare dal primo cliente.
“Come ti presentiamo?” mi chiedono Matteo e Andrea. “Come volete, potete anche non presentarmi. Sono qui per ascoltare” rispondo.
Il primo cliente ha un problema, il prosciutto crudo che gli è stato consegnato non lo soddisfa. Entra in
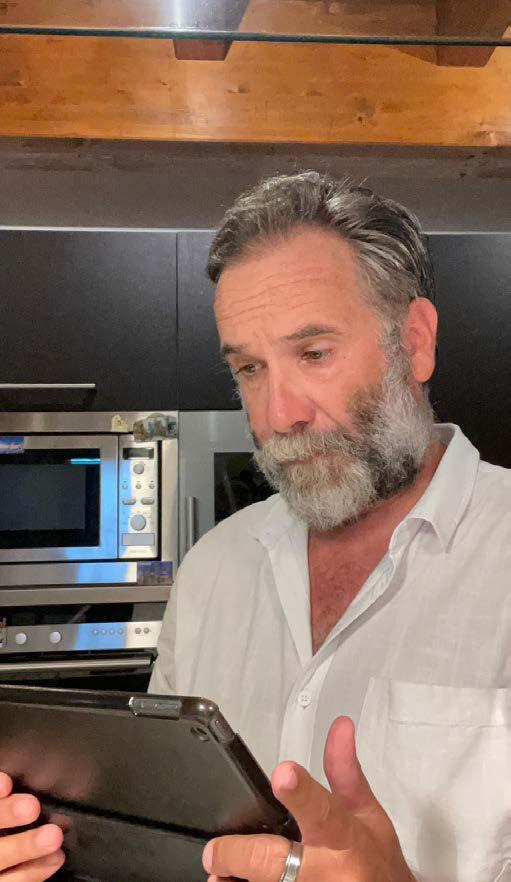
gioco l’esperienza di Matteo Fantuzzi che questo mestiere lo fa da vent’anni.
“Lo scontiamo sul nuovo ordine, può essere che una partita a volte non sia all’altezza, sono prodotti vivi.
E, se posso consigliare, provi quest’altro, è di qualità superiore e costa pochi centesimi in più”.
Accordo fatto.
“Ma quanto tempo vi mette a disposizione un cliente?” chiedo.
“Questo è uno dei problemi di questo lavoro. In media, al massimo, dieci/quindici minuti. E in quel lasso di tempo devi raccogliere quello di cui ha bisogno perché ha finito le scorte, incuriosirlo su novi prodotti particolarmente adatti alla sua cucina e, spesso, occuparci anche della riscossione delle fatture precedenti. Oltre a risolvere i problemi come quello di prima”, mi racconta Matteo.
Le arrabbiature sono all’ordine del giorno?
“Spesso ma si impara a non farci caso. Soprattutto facendo domande si capisce l’origine del problema. Te ne racconto una dei miei inizi: – continua Matteo – un cliente si lamentava che del prosciutto che gli fornivamo si strappava la fetta. Cambialo una, due, tre volte e il problema rimaneva, anche con prosciutti diversi.
Il mio capo-area di allora mi suggerì la tecnica delle domande e ne feci una al cliente: ma l’affettatrice funziona bene? Il problema stava lì”.
Quali fasce orarie avete a disposizione?
“Nel ristorante quelli bravi li trovi alle 9/9,30. Altrimenti alle 10,30/11 e poi ti devi fermare fino al pomeriggio quando li vai a visitare dalle 16,30 alle 18. Capisci che il tempo a disposizione è troppo limitato per un’azienda come la nostra che ha un catalogo di 5/6000 referenze. Nelle pizzerie, tranne quelle da asporto che iniziano presto, hai gli stessi tempi. Diventa quindi indispensabile, per ognuno di noi, pianificare con estrema cura il lavoro. Nel tempo che è escluso dalle visite, analizziamo ogni cliente, valutiamo il suo modo di rapportarsi a noi, studiamo strategie per rendere ottimale il tempo che gli dedichiamo, oppure facciamo dei giri per la città e i paesi per vedere nuove aperture, cambi di gestione, studiare i menu, analizzare i nuovi prodotti che l’azienda vuole spingere” mi dice Andrea.
Il secondo cliente, un bar storico di Mantova, in pieno centro, fa l’ordine e ascolta Andrea per le nuove proposte che sono in promozione questa settimana. Nel salutarci dice a Matteo, a voce alta, “tenetevelo stretto questo ragazzo. È bravo, gentile, non insiste e ci sa fare”.
Prima abbiamo parlato di arrabbiature ma ci sono anche le gratificazioni vedo…
“Si, questa è una. – afferma Matteo – Quando trovi persone così ti resta dentro la voglia di continuare. Una volta, ero con Oscar Tondini da un cliente che gli dice: “Se Matteo non dovesse più lavorare con voi io cambio fornitore”. È stata una bella soddisfazione. Ma quello che più conta è l’azienda in cui lavori, specialmente quando sei in un'impresa come questa dei Tondini. Sono bravissime persone, sia Benhur che suo fratello Oscar e anche le figlie di Benhur, che rappresentano la generazione futura, Carlotta e Cecilia, sono della stessa pasta. Datori di lavoro che hanno una autentica capacità di ascolto, sempre disponibili a questo, a cercare soluzioni ai problemi”.
Come siete strutturati? Prima, Matteo, mi parlavi di capo-area…
“Ci siamo dati questo tipo di organizzazione perché siamo in crescita. Oggi la Tondini può contare su 19 agenti. Immagina se ogni agente portasse direttamente i problemi in azienda, gli uffici andrebbero in tilt. Per questo abbiamo suddiviso gli agenti tra cinque capi-area. Ognuno di noi ha anche un margine di autonomia sulla scontistica, sui tempi di consegna e gli agenti pongono a noi tutte le problematiche. Poi abbiamo un sistema di raccolta ordini con l’Ipad che


smette di funzionare quando il cliente supera la terza fattura senza aver pagato nei termini di scadenza. In quel modo l’agente non può fare l’ordine. Fino a qualche anno fa le aziende di distribuzione erano in serie difficoltà perché si trovavano a fare da banca ai clienti. Ora non è più così, per fortuna”.
In attesa di entrare da un cliente
“Poi ci sono questi problemi, arrivi e c’è già un altro fornitore e, per correttezza aspetti. Non tutti fanno come noi, una volta stavo raccogliendo un ordine e avevo alle spalle uno della concorrenza” mi racconta Andrea.
L’attesa si prolunga in strada per venti minuti. Ne approfitto per continuare con le domande. Non riuscite a prendere un appuntamento preciso? Gli ordini notturni, tramite il digitale, sostituiranno il vostro lavoro? Come approcciate a un nuovo cliente?
“Andiamo con ordine. Gli appuntamenti: ci proviamo sempre, perché crediamo che un appuntamento in cui nessuno, né noi né il cliente, è distratto da fattori esterni, cambierebbe la qualità del nostro e del suo lavoro. Quando ci riusciamo il risultato è immediato. Dobbiamo insistere su questa strada. Gli ordini notturni: vanno bene, ormai il catalogo delle nostre referenze è in mano a ogni cliente e questo metodo sta prendendo piede. Ci consentirebbe di diventare veri consulenti quando andiamo a fare le visite. Però con il cliente devi mantenere il rapporto umano, quello che ti consente di monitorare le scelte. I nuovi clienti? La
strategia migliore è andare per conoscere. Mi spiego meglio: preferisco andare, chiedere se c’è il responsabile acquisti perché altrimenti il rischio è che tu parli per venti minuti e poi scopri che stavi parlando con la persona sbagliata. E poi chiedere sempre un primo appuntamento. Mai andare da un nuovo cliente con l’obiettivo di fare un ordine immediato”.
Il cliente perfetto
La mattina volge al termine, usciamo dalla città e ci avviamo verso la periferia. Arriviamo in un ristorante – la Risosteria Sant’Andrea - che non fa il servizio del mezzogiorno. La cuoca, anche socia del locale, ci accoglie e ci fa accomodare fuori, in veranda. Vedo le facce di Andrea e Matteo che sprizzano entusiasmo alla riflessione di Veronica (questo il nome della cuoca): “Sto pensando al cambio di menu per l’autunno, cosa mi proponete?”
La conversazione va avanti per mezz’ora buona. Matteo dà il meglio di sé, spiegando le fluttuazioni del mercato della carne, proponendo i tagli adatti al carrello dei bolliti oppure di piatti già pronti, cotti a bassa temperatura sottovuoto che il cuoco deve solo finire con un briciolo di creatività e che risolvono il problema del personale. Andrea lo osserva raccogliendo come una spugna. La cuoca si fida e non fa problemi di prezzo, vuole qualità per i suoi clienti e trova nel servizio dei F.lli Tondini tutte le risposte.
“Vedi – mi dice Matteo – una volta al giorno ci capita di far valere la nostra competenza, il nostro sapere e questo aiuta moltissimo i nostri clienti”.
Da Mantova a Sirmione
È solo mezz’ora di strada ma all’arrivo trovo una dimensione completamente diversa rispetto a Mantova. Qui, del resto, c’è un turismo pazzesco che arriva dal nord-Europa e che viene qui per apprezzare l’ospitalità e il buon mangiare italiano, oltre alla bellezza dei luoghi.
Ho appuntamento con Giordano Comparini, agente di vendita di F.lli Tondini, che svolge la sua missione tra Sirmione e Desenzano.
“Io adoro questo lavoro perché si basa sulla fiducia. Un valore inestimabile la fiducia e, oltre a quella dei miei clienti, io l’ho trovata con l’azienda per cui lavoro. Sono persone oneste e corrette come poche” inizia così la conversazione con Giordano Comparini mentre mi accompagna da un suo cliente, l’Hotel Miramar di Sirmione E lì riesco a toccare con mano che mi sta dicendo la verità. La signora Elisa, proprietaria della bella struttura, ci accoglie con una stretta di mano che trasmette trasparenza.
“Sono riuscito a creare i miei rapporti facendo capire la nostra grande disponibilità a risolvere i loro bisogni. Quando ho iniziato, circa 14 anni fa, erano pochissimi i clienti di questa parte del lago, una decina in tutto, oggi superiamo i settanta clienti, tutte realtà solide, professionali, rappresentative di queste due località lacustri. E qui è tutto molto difficile, sul lago ci sono oltre 200 aziende di distribuzione che i spartiscono la fetta dell’ho.re.ca. Quindi la scelta di vivere a Sirmione, di aver sposato una sirmionese mi ha aiutato molto nell’affermare l’azienda per cui lavoro. Sirmione è piccola, mia moglie è responsabile di un negozio di moda e conosce tutti, mi è stata di grande aiuto all’inizio”.
Come funziona a Sirmione la professione di agente? “Ho improntato il lavoro con la possibilità di ricevere gli ordini fino alla mezzanotte per le consegne il giorno successivo. L’azienda ha accettato questa impostazione e i risultati si vedono. I clienti ordinano tramite l’app e io vado a trovarli ogni giorno per presentare le novità e capire l’evoluzione del mercato”.
La qualità come la racconti e come viene percepita?
Faccio questa domanda mentre stiamo andando a trovare lo chef Antonio Zepino del ristorante La Gola, nell’Olivi Hotel. Lo chef, sentendo la mia domanda, si assenta e torna con il suo menu, bellissimo nella parte grafica e molto interessante nella proposta: “Questo è ciò che facciamo con la qualità dei prodotti che Giordano ci propone”.
Poi è la volta di Marco Merlo, patron dell’Hotel Ideal e presidente degli albergatori di Sirmione, che ci accoglie con grande disponibilità raccontandoci del suo impegno a garantire unità di visione per fare dell’ospitalità sirmionese un valore d’eccellenza.
Con Giordano che non raccoglie ordini oggi che è con me, ma crea relazioni che diventeranno forti anche per il suo lavoro.
“Vedi – mi dice – questa professione ha un obiettivo molto preciso e definito: vendere al meglio delle possibilità. Ma vendere significa anche fare un giro pomeridiano come quello che stiamo facendo insieme perché da te posso trarre qualche ulteriore insegnamento, vista la tua esperienza, e dai miei clienti andare per fare una cosa diversa significa rafforzare le relazioni. Anche questa è formazione non credi? La formazione è il futuro per questa nostra professione, sempre più gli chef, i pizzaioli, i ristoratori si rivolgeranno a noi per trovare soluzioni adeguate. E noi sapremo dargliele se, oltre a vendere, dedichiamo tempo a conoscere”.
La conferma di queste parole la troviamo nel corso dell’ultimo incontro, all’Hotel Catullo, con una bellissima terrazza vista lago, nel momento in cui il titolare, Fabio Barelli, lamenta la scarsa qualità del turismo mordi e fuggi che investe Sirmione: “Noi abbiamo bisogno di creare le condizioni, anche sul piano gastronomico, per garantire qualità ai nostri clienti. E dico questo perché, se c’è una cosa che il cliente non dimentica di un luogo, è un buon pasto”.
La giornata è finita e, con questa esperienza, voglio condividere una parte del mondo della ristorazione che è preziosa ma ancora troppo nascosta.

Clicca e leggi l’articolo sul web
Se provassimo a descrivere l’affascinante, variegato e festoso mondo delle premiazioni e dei riconoscimenti in ambito FIC e della cucina professionale, sarebbe bene sottolineare subito che non si tratta soltanto di possedere un bel medagliere o di arricchire la propria bacheca, per puro narcisismo! Salendo su un podio o intervenendo da un palco, non si compie semplicemente un gesto estetico o un’azione dimostrativa della propria bravura. C’è qualcosa di più intimo e di profondo, che ci fa ripercorrere spesso mentalmente e sentimentalmente tutta una vita lavorativa, mettendo a confronto il momento presente che stiamo vivendo (hic et nunc, qui e ora!) col nostro passato, la nostra formazione, il nostro bagaglio culturale e, soprattutto, col nostro futuro, con ciò che ancora dobbiamo compiere e che vogliamo costruire e realizzare. Come ben si comprende, non è facile sintetizzare in poche righe ciò che un cuoco professionista, uno chef, un cuoco docente o formatore, ma anche un dirigente, prova quando riceve un premio, una coppa, una medaglia... Non è, infatti, il “semplice”, seppure importante gesto che si compie e che si riceve, a riempire quel determinato momento. Dietro i nostri riconoscimenti c’è molto di più. Pensiamo, ad esempio, alla prestigiosa premiazione dei Collari Cocorum, di imminente organizzazione anche quest’anno, e che vedranno ancora una volta nello storico contesto degli ambienti parlamentari a Roma centinaia di berrette bianche, centinaia di professionisti della cucina convergere nella Capitale da tutte le regioni d’Italia e dall’estero, per ricevere il premio dedicato a quanti hanno raggiunto l’importante traguardo dei 25 anni di carriera. Qui l’orgoglio c’è tutto, certo, ma non solo quello personale: c’è l’orgoglio di appartenenza, a FIC e alla professione, quella

splendida sensazione di far parte di ciò che da anni chiamiamo la nostra “Grande Famiglia” dei cuochi, che celebra sempre con la massima attenzione i momenti di festa e quelli istituzionali, cercando di non trascurare nessuno dei suoi 15 mila associati. Una festa che travalica i confini nazionali non solo geograficamente, ma anche moralmente e deontologicamente, facendo giungere il nostro “codice comportamentale” nei 5 continenti, fatto di serietà, professionalità, rispetto del prossimo e del cibo, del pianeta terra e del nostro lavoro, come di quello altrui. Uno spirito che non è difficile riscontrare anche durante altri momenti FIC davvero importanti. Pensiamo, per citare un altro esempio prestigioso, alle entusiasmanti giornate dei Campionati della Cucina Italiana, che ogni febbraio vedono il palco della Fiera di Rimini riempirsi di professionisti e dei loro messaggi, soprattutto per i più giovani. “Scommettete su voi stessi, ragazzi, confrontatevi con i colleghi e crescete anche attraverso le competizioni”, ripetiamo sempre. Ecco, ci piace pensare che si possa crescere anche attraverso un semplice premio o riconoscimento, che i nostri sforzi possano essere tangibili, veri e concreti anche attraverso la consegna di un Collare Cocorum o di una medaglia, perché ammirandoli appesi magari nelle nostre cucine o nei nostri uffici dopo anni, ci possiamo sempre ricordare di quell’abbraccio o di quella stretta di mano tra amici e colleghi in una delle nostre tante cerimonie festose. E pensare che siamo cresciuti anche grazie a questo.
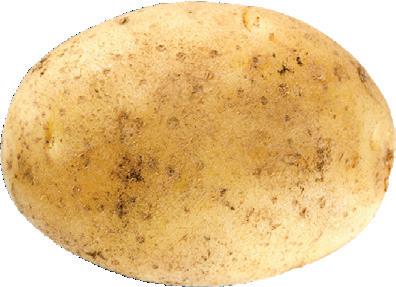
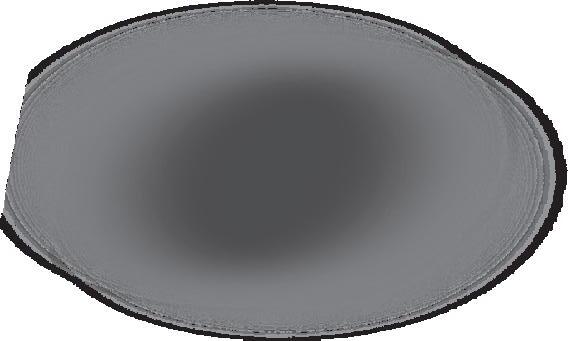

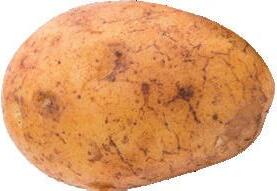
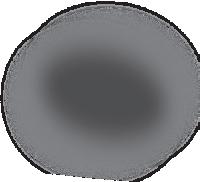
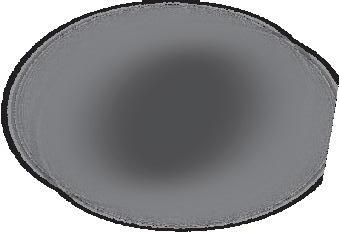
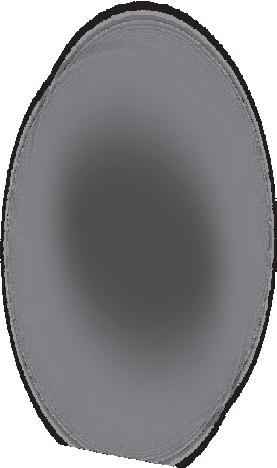
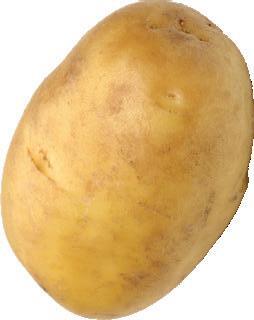
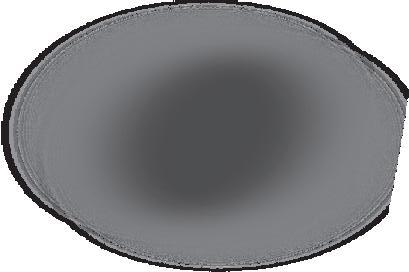

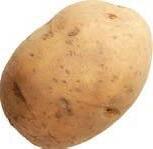

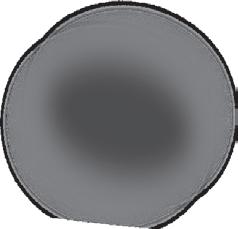







Gusto intenso e polpa consistente, le patate rosse regalano ad ogni piatto un tocco irresistibile da veri intenditori.
Ideali per gnocchi e arrosto dal sapore pieno e deciso.
Una selezione di patate professionali ognuna col proprio utilizzo culinario, per soddisfare ogni esigenza ed arricchire i vostri menù con materie prime dal sapore autentico capaci di esaltare l’essenza delle vostre creazioni. Testate ogni giorno dai nostri chef, garantiscono Gusto costante, piatti sempre perfetti e facili da realizzare. L’intera gamma è stata eletta Prodotto dell’Anno 2025!









Imbattibili e facili da realizzare





Al vapore, arrosto e in insalata







fritte, gnocchi, crocchette, puré, croccanti al forno




I confini tra settori si sono dissolti. La moda si insedia in spiagge ed hotel. Il retail, da semplice vendita di vestiti ed accessori, diventa esperienza, anche culinaria. È un cambio di paradigma. Il cliente non vuole più solo comprare un prodotto o sedersi per un piatto, vuole sentirsi immerso in un mondo, percepire coerenza, entrare in una storia. Il fashion system è stato il primo a muoversi con decisione. Armani ha capito che un marchio non si esprime solo su una passerella. Le sue boutique hanno inglobato ristoranti e caffè, trasformando lo shopping in un gesto che continua a tavola, davanti ad un piatto o un cocktail. È un universo coerente, dove ogni elemento parla la stessa lingua. Louis Vuitton ha seguito la stessa strada con Le Café V a Parigi, il lusso non si ferma al guardaroba, conquista la cucina. Dior ha spinto oltre con Avenue Montaigne, trasformando un indirizzo iconico in un ecosistema: boutique, ristorante, pâtisserie e una suite per soggiornare dentro il brand. Entrare da Dior non significa comprare un abito, ma vivere un mondo, che include ristorazione ed hotellerie.
L’estate 2025 ha segnato il picco assoluto di ibridazione tra brand, ospitalità e ristorazione, tanto da coniare il termine “retail hospitality”, per definire il fenomeno.
Che cosa hanno in comune questi esempi? Il valore per il cliente si costruisce attraverso l’esperienza complessiva. Il prodotto è un pezzo del puzzle. È l’insieme dei dettagli, la coerenza del racconto, la capacità di sorprendere che creano fedeltà.
Per un ristoratore è il punto chiave. La cucina resta il cuore, ma non è più sufficiente. La partita si gioca fuori dal piatto. Il cliente non si accontenta di una buona carbonara servita in fretta e in un ambiente anonimo. Vuole atmosfera, ritualità, segni distintivi che lo facciano sentire parte di un mondo. Come tradurre tutto questo nella quotidianità di un locale?
Il primo passo è allenare lo sguardo. Visitare regolar-

mente altri luoghi, non solo ristoranti ma anche bar, hotel, negozi, coworking, spa, musei. Entrare come cliente, osservare come si viene accolti, quali gesti scandiscono l’esperienza, quali dettagli colpiscono. È un esercizio che trasforma il mondo esterno in un laboratorio di apprendimento.
Il secondo passo è la traduzione. Se in un hotel colpisce l’uso della luce per creare intimità, chiedersi come ripensare l’illuminazione della propria sala. Se in un concept store sorprende il profumo che accompagna l’ingresso, valutare come introdurre una nota olfattiva nel proprio locale. Se un coworking crea senso di community attraverso piccoli eventi, pensare a un calendario di serate tematiche che facciano tornare i clienti.
Il terzo passo è il dettaglio. Non servono rivoluzioni costose. Bastano accorgimenti mirati. Uniformi coordinate che trasmettano identità. Una playlist pensata che accompagni il servizio. Un gesto di accoglienza che diventa segno riconoscibile. Sono piccole cose che il cliente nota, ricorda e racconta.
La lezione che arriva dal retail e dalla moda è semplice. L’ibridazione funziona perché accende i sensi, crea coerenza e sorprende. Il mondo della ristorazione deve guardare fuori da sé, lasciarsi ispirare ed avere il coraggio di provare. Il futuro appartiene a chi trasformerà un ristorante in un universo coerente, riconoscibile e capace di raccontare una storia. Faccio sempre due domande ai ristoratori che assisto professionalmente con Neurovendita. Quando è l’ultima volta che hai deciso di andare fuori dal locale, in altri mondi, per prendere idee e spunti? Quanto spesso ti prendi dei momenti di formazione, provando esperienze in altri settori? La capacità di guardare oltre i confini è la vera imprenditorialità.























Good Day e Polot 1882 trasformano ogni momento della giornata in un’esperienza di gusto e benessere.
Le farciture in barattolo arricchiscono croissant, pancake e dolci con sapori autentici, mentre le acque aromatizzate offrono freschezza e armonia in ogni sorso. Due linee selezionate da General Fruit per soddisfare ogni esigenza di qualità e piacere, dalla colazione al break.
IDEALI PER UNA PREPARAZIONE FREDDA O CALDA

FARCITURE 1,5 kg (Albicocca - Cioccolato bianco - Crema pasticcera - Fragola - Frutti di bosco - Nocciolata - Pistacchio)
ACQUE AROMATIZZATE 1 L (Bergamotto, Agrumi e Curcuma - Fior di sambuco, Zenzero e Menta Limonata di Sicilia - Limonata di Sicilia e Zenzero - Melagrana e Aloe vera - Tè, Mela e Cannella)

Ogni gesto in cucina è precisione, creatività, impegno. Lo sappiamo, perché siamo al fianco, da oltre due secoli, di chi ogni giorno trasforma ingredienti in esperienze. Da oggi nasce una gamma studiata appositamente per le necessità e le richieste dei professionisti, apponendo la firma Zucchi come sigillo dei nostri valori e della nostra qualità.





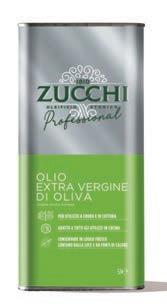


Autore: Federico Panetta

Clicca e leggi l’articolo sul web
Quando noi occidentali pensiamo alla cucina giapponese, i primi piatti che ci vengono in mente sono sushi, ramen e magari della tempura di verdure. Eppure, tra i cibi più amati e consumati del paese ce ne sono alcuni che non ci aspetteremmo di trovare nella cultura del sol levante, ma la cui diffusione ci riguarda più di quello che potremmo pensare: è il caso del kare raisu, diventato quasi un simbolo della quotidianità nipponica, servito nelle mense scolastiche, cucinato in famiglia e perfino celebrato con una giornata nazionale il 22 di gennaio. La sua particolarità? La si può evincere anche solo dalla traduzione del nome: riso al curry. Il termine curry è un adattamento europeo frutto della storpiatura di una parola in lingua tamil, kari, che indica una salsa o uno stufato speziato. Furono i portoghesi, giunti a Goa nel XVI secolo, a trasformare la parola in caril, da cui gli inglesi crearono infine la parola curry, diffondendola in Occidente come nome generico per i piatti speziati. Questa miscela, ispirata ai masala indiani, divenne popolare in Gran Bretagna già dall’Ottocento, al punto che i primi ristoranti di curry aprirono a Londra nel 1810. La prima ricetta inglese pubblicata su un libro di cucina apparve in The Art of Cookery di Hanna Glasse, pubblicato nel 1747. Il gusto britannico trasformò però il piatto, creandone una versione più dolce e densa, adattata
alle abitudini locali e destinata a viaggiare molto lontano. Furono gli inglesi a introdurre la spezia in Giappone. Durante l’era Meiji (1868-1912), che prende il nome dall’imperatore omonimo, il paese visse un periodo di grandi aperture verso l’Occidente. Per oltre due secoli la nazione era rimasta isolata: l’ingresso di stranieri o l’uscita di giapponesi era punibile con la morte, e questo impediva qualsiasi influenza culturale esterna. Con l’avvento della nuova era queste restrizioni furono allentate e il paese si aprì agli stranieri, dando il via a numerose riforme come l’adozione del calendario gregoriano, che spostò il Capodanno in linea con quello occidentale, fuori sincrono rispetto al resto dell’Asia.
Questi cambiamenti andarono di pari passo con una maggiore militarizzazione e con la necessità di nutrire soldati e marinai in modo sano e in grandi quantità. Fu in questo contesto che il curry fece il suo ingresso nel paese. All’epoca il Giappone era alle prese con il beriberi, una malattia dovuta alla carenza di vitamina B1 (tiamina), che arrivò a colpire persino la famiglia reale. La causa era da imputare al riso bianco, base della dieta, completamente privo di tiamina. Sebbene la reale causa del beriberi rimase misteriosa per decenni, già allora si intuì che la soluzione poteva essere trovata nella dieta. Analiz-

zando l’alimentazione degli eserciti stranieri, i giapponesi notarono che la marina inglese utilizzava da tempo il curry, e che i soldati non si ammalavano. Si decise quindi di introdurre questa nuova spezia anche nella dieta della marina militare giapponese. La soluzione al problema stava nella carne e nella farina impiegate nel curry, entrambe oggi note per il loro contenuto di tiamina.
La prima ricetta di curry giapponese fu pubblicata nel 1872, mentre i ristoranti iniziarono a proporlo qualche anno più tardi. Nel 1908, il libro di cucina ufficiale della marina militare pubblicò una ricetta a base di carne. Per qualche tempo il curry rimase prerogativa dei militari; solo dopo la Seconda Guerra Mondiale i soldati che tornarono a casa contribuirono a diffonderlo tra la popolazione civile.
La sua diffusione accelerò nel dopoguerra grazie all’invenzione del curry roux, dei blocchi compatti di farina e spezie pronti da sciogliere in acqua o dashi. Questo formato rese la preparazione ancora più semplice e trasformò il kare raisu nel piatto casalingo per eccellenza. Negli anni Cinquanta e Sessanta, il curry entrò stabilmente non solo nelle cucine di casa, ma anche in scuole e uffici, fino a diventare un vero comfort food made in Japan. Le caratteristiche del curry giapponese, che lo distin-


guono dagli altri, sono il fatto di essere poco speziato e piccante, ma grazie ad aggiunte di ingredienti come la salsa di soia, il gusto che spicca più di tutti è senza dubbio l’umami. La ricetta tipica prevede manzo, pollo o maiale cotti con cipolle, carote piselli e patate, insaporiti dai cubetti di roux. Spesso vengono aggiunte anche mele grattugiate o salse per arricchirne il sapore. Il risultato è un curry denso e marrone, dal sapore corposo ma equilibrato, che i giapponesi amano consumare nelle giornate più fredde. Nelle versioni più ricche, il piatto può essere completato con il tonkatsu, una cotoletta di maiale fritta, oppure con i fukujinzuke, sottaceti dolce-salati che bilanciano la ricchezza della salsa.
Col tempo, ogni regione ha creato la propria versione. A Hokkaido si usa la carne di cervo, a Hiroshima le ostriche, a Okinawa il melone amaro, nella prefettura di Shimane ne esiste addirittura una versione a base di pere nashi. In alcune prefetture è dolcificato con mele, in altre reso più corposo con latte o burro. Le varianti non si contano, ma la struttura resta invariata: una salsa densa, marrone
e leggermente dolce, servita solitamente con del riso, ma anche con udon o come ripieno del kare-pan, una soffice pagnotta fritta al curry. È proprio questa adattabilità, unita ad un sapore rassicurante, ad averne decretato il successo.
Oggi il kare raisu è talmente diffuso da essere considerato uno dei simboli della cucina giapponese contemporanea. Ogni anno milioni di confezioni di curry roux vengono vendute nei supermercati, e in media ogni cittadino giapponese consuma curry quasi una volta a settimana. In un sondaggio che ha coinvolto più di 60.000 persone, il curry si è attestato come il secondo piatto più amato dai giapponesi, battendo il ramen e arrivando secondo solo al sushi. Non manca poi la dimensione popolare e comunitaria: il curry è protagonista di festival, eventi di beneficenza, ma anche di celebri anime come Naruto e One Piece, che lo hanno consacrato come icona culturale.
Il suo successo non si ferma ai confini del Giappone. Con l’espansione della cucina nipponica nel mondo, anche il curry ha iniziato a viaggiare. Curiosamente, in Giappone i piatti a base di curry sono ancora considerati yōshoku, cioè di influenza occidentale, anche se per noi appaiono esotici. Il curry giapponese racconta così una storia di incontri culturali: un piatto indiano reinterpretato dagli inglesi e adattato alle cucine navali, che ha finito per diventare un simbolo del comfort food giapponese



Autrice: Alessia Cipolla
Clicca e leggi l’articolo sul web
Una delle più importanti scrittrici e giornaliste italiane, pioniera della scrittura progressista tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento, Matilde Serao (1856-1927) ha saputo tratteggiare mirabilmente la vitalità gastronomica, e non solo, di una città come Napoli.
Nata a Patrasso in Grecia, da padre italiano e madre greca, si trasferì a Napoli con la famiglia nel 1860. Dopo aver studiato lettere, iniziò la sua carriera come giornalista, lavorando per diversi quotidiani.
Fondò nel 1885 il Corriere di Roma con il marito Edoardo Scarfoglio, nel 1892 il quotidiano Il Mattino e Il Giorno nel 1903, in seguito alla dolorosa rottura con il marito e a un nuovo amore con il giornalista Giuseppe Natale. Alla base vi fu sempre un vivace interesse per i temi sociali e politici raccontati con uno stile realistico e incisivo.
Matilde Serao fu molte cose: una donna moderna e libera, empatica soprattutto verso i più deboli, curiosa di tutto, capace di scrivere circa 70 opere letterarie e inventare innumerevoli rubriche e riviste su svariati temi, animatrice culturale di circoli e salotti. Fu anche una talentuosa procacciatrice di sponsor pubblicitari e una brillante public relationer dalle numerose collaborazione con riviste internazionali. Scrisse di donne, per le donne e da donna ma non fu, né volle essere, femminista. Non sempre benvoluta, come capita spesso alle donne forti, fu una presenza certamente “ingombrante”, ma leggendaria.

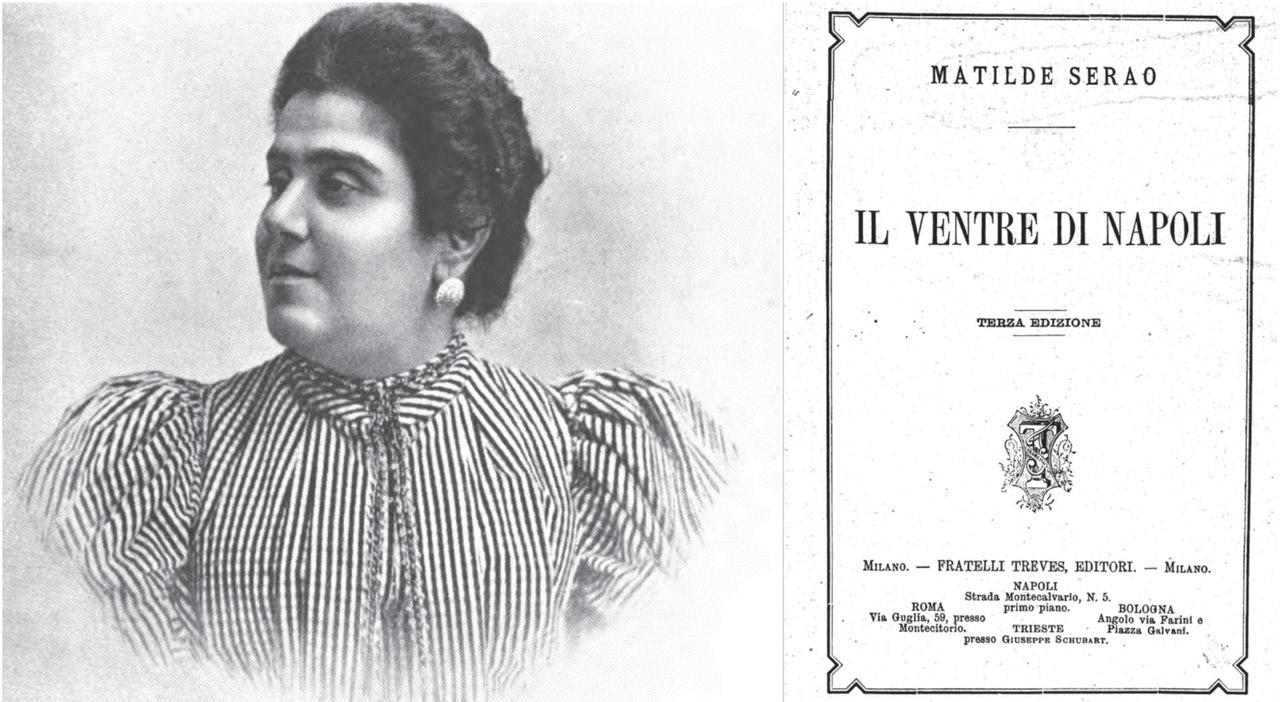
Il cibo nell’opera della scrittrice napoletana
La sfera gastronomico-alimentare svolge un importante ruolo sociale e antropologico nell’opera della giornalista. I pasti e banchetti nei suoi testi raccontano, nella maniera più realistica possibile, le disparità sociali, ma anche la teatralità tutta partenopea fatta di tempi, spazi e azioni condivise dalla società a cavallo dei due secoli. Senza, però, il luccichio della Belle Époque.
Nato dallo sdegno dell’invito a “sventrare Napoli” a seguito dell’epidemia di colera del 1884, Il ventre di Napoli (1884) è un suo testo di riferimento a metà strada tra documento storiografico, reportage e racconto sensoriale. Qui, la Napoli più umana e popolare, quella dei suoi vicoli bui e angusti, brulicanti di miseria e di grande umanità, svela i suoi segreti mentre gli abitanti più fragili, abituati a “vivere alla giornata”, trovano la forza di andare avanti, affidandosi al lotto, al fato o ai santi, a seconda delle necessità.
Gli echi del precedente Ventre di Parigi di Zola sono arrivati fino a Napoli. Matilde Serao li ha resi più crudi, fatalisti, ma anche pienamente indulgenti, sospesi tra caos e bellezza, senza dimenticare di segnalarne le contraddizioni.
Il passaggio dei suoi abitanti più umili, da affamati, a malfamati e a delinquenti è, talvolta, necessario perché: “al mattino, quando si alzano, non sanno se mangeranno e quando e cosa mangeranno.” La miseria che l’intellettuale napoletana riporta, però, non è grigia ma, anzi, vivace, uno straordinario motore di creatività e di immaginazione che rende gli abitanti partenopei i nuovi eroi moderni.
“Quello che mangiano” a Napoli
Nel capitolo “Quello che mangiano” de Il ventre di Napoli, la descrizione dei piatti, pur nella loro semplicità, è una testimonianza di una cultura identitaria che vive attraverso i suoi sapori e le sue tradizioni con radici profondissime.
La pizza emerge come un cibo universale: “In Napoli la pizza è la regina dei cibi, il trionfo della semplicità, dell’arte povera, eppure, come una regina, regna nelle tavole di tutti: del ricco e del povero.” E ancora: “Siamo tutti uomini della pizza. Lì dove nessun altro cibo riesce ad arrivare, la pizza arriva sempre, e tutti possono mangiarla, anche i più poveri. È il cibo del popolo, della città che non si piega, ma mangia con dignità.” È poi un cibo conviviale: “Una pizza condivisa è più che un piatto: è un atto di solidarietà. Il povero e il ricco, insieme, mangiano la stessa pizza, senza distinzioni, senza differenze.” E ancora “La pizza è l’unico cibo che ancora può essere mangiato con facilità, senza far pesare troppo il prezzo della miseria, un piatto che si compra a buon mercato, ma che dà una soddisfazione completa.”
Matilde Serao svela poi la stretta correlazione tra costo del cibo e condizione sociale: “La pizza rientra nella larga categoria dei commestibili che costano un soldo, e di cui è formata la colazione o il pranzo, di moltissima parte del popolo napoletano. Il pizzaiuolo crea delle schiacciate “rotonde, di una pasta densa, che si brucia, ma non si cuoce, cariche di pomidoro quasi crudo, di aglio, di pepe, di origano: queste pizze in tanti settori da un soldo, sono affidate a un garzone, che le va a vendere in qualche angolo di strada, sovra un banchetto ambulante e lì resta quasi tutto il giorno,
con questi settori di pizza che si gelano al freddo, che si ingialliscono al sole, mangiati dalle mosche.” E poi, di notte: “Le povere donne sedute sullo scalino del basso, ne comprano e cenano, cioè pranzano, con questo soldo di pizza.”
La disponibilità di cibo a quel prezzo è sorprendentemente varia, seppur modesta: “Dal friggitore si ha un cartoccetto di pesciolini che si chiamano fragaglia e che sono il fondo del paniere dei pescivendoli: dallo stesso friggitore si hanno per un soldo, quattro o cinque panzarotti, vale a dire delle frittelline in cui vi è un pezzetto di carciofo, quando niuno vuol più saperne di carciofi, o un torsolino di cavolo, o un frammentino di alici.” Oppure: “Per un soldo, una vecchia dà nove castagne allesse, denudate della prima buccia e nuotanti in un succo rossastro: in questo brodo il popolo napoletano vi bagna il pane e mangia le castagne, come seconda pietanza; per un soldo, un’altra vecchia, che si trascina dietro un calderottino in un carroccio, dà due spighe di granturco bollite.” Ed ecco un’altra
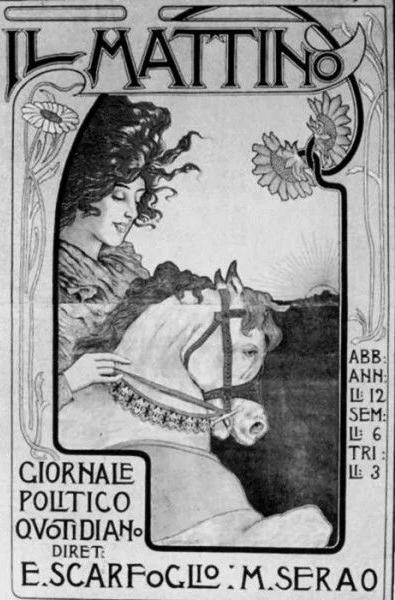
alternativa gastronomica: “ Dall’oste, per un soldo, si può comperare una porzione di scapece; la scapece è fatta di zucchetti o melanzane fritte nell’olio e poi condite con aceto, pepe, origano, formaggio, pomidoro, ed è esposta in istrada, in un grande vaso profondo, in cui sta intasata, come una conserva e da cui si taglia con un cucchiaio. Il popolo napoletano porta il suo tozzo di pane, lo divide per metà, e l’oste vi versa sopra la scapece.” Una particolare leccornia è poi la “spiritosa”: “fatta di fette di pastinache ( n.d.r. antica sorta di radici simili alle carote) gialle, cotte nell’acqua e poi messe in una salsa forte di aceto, pepe, origano e peperoni. L’oste sta sulla porta e grida: addorosa, addorosa, ‘a spiritosa! Come è naturale, tutta questa roba è condita in modo piccantissimo, tanto da soddisfare il più atonizzato palato meridionale.”
Con due o più soldi, le opzioni migliorano, e i maccheroni diventavano un desiderio quasi universale: “Appena ha due soldi, il popolo napoletano compra un piatto di maccheroni cotti e conditi; tutte le strade dei quartieri popolari, hanno una di queste osterie che installano all’aria aperta le loro caldaie, dove i maccheroni bollono sempre, i tegami dove bolle il sugo di pomidoro, le montagne di cacio grattato, un cacio piccante che viene da Cotrone”. Tutto molto pittoresco. Con lo stesso importo si può acquistare: “un pezzo di polipo bollito nell’acqua di mare, condito con peperone fortissimo: questo commercio lo fanno le donne, nella strada, con un focolaretto e una piccola pignatta”.
Ma appena ha tre soldi al giorno per pranzare: “il buon popolo napoletano, che è corroso dalla nostalgia familiare, non va più dall’oste per comperare i commestibili cotti, pranza a casa sua, per terra, sulla soglia del basso, o sopra una sedia sfiancata”.
Con quattro soldi si compone: “una grande insalata di pomidori crudi verdastri e di cipolle; o un’insalata di patate cotte e di barbabietole, o un’insalata di broccoli di rape; o un’insalata di citrioli freschi”. Ossia le verdure erano più costose e ambite di una semplice pizza. Per i più ricchi, con otto soldi al giorno, la dieta può includere minestre e maccheroni di qualità diversa: “La gente agiata, quella che può disporre di otto soldi al giorno, mangia dei grandi piatti di minestra verde, indivia, foglie di cavolo, cicoria, o tutte queste erbe insieme, la cosiddetta minestra maritata; o una minestra, quando ne è tempo, di zucca gialla con molto pepe; o una minestra di fagiolini verdi, conditi col pomidoro; o una minestra di patate cotte nel pomidoro. Ma per lo più compra un rotolo di maccheroni, una pasta nerastra, e di tutte le misure e di tutte le grossezze, che è il raccogliticcio, il fondiccio confuso di tutti i cartoni di pasta, e che si chiama efficacemente monnezzaglia: e la condisce con pomidoro e formaggio.”
E l’affresco partenopeo è servito.

Sfrigolo è il nuovo smash burger by Baldi: un concentrato di tecnica e piacere che propone ad ogni morso il crunch perfetto , una caramellizzazione che seduce ogni palato e tenuta impeccabile in cottura .
NON SI SFALDA COTTURA RAPIDA, ZERO STRESS
NON SI BRUCIA ZERO GLUTINE, TUTTO GUSTO
Autore: Guido Parri

Clicca e leggi l’articolo sul web
Selezioni di gusto è un distributore che ha fatto della qualità un segno tangibile
Con sala&cucina abbiamo sempre cercato di andare al cuore dei problemi e delle opportunità che determina il mondo dell'ho.re.ca.; per fare questo abbiamo indagato sui vari aspetti della ristorazione, dalla carenza del personale alla formazione dello stesso, dal portare esempi positivi per metterli a disposizione dei nostri lettori al non demonizzare l’industria agroalimentare.
Crediamo che un lavoro come il nostro debba aiutare a riflettere e non a rincorrere l’ennesimo banale scoop di questo settore che, non dimentichiamolo, non è fatto da macchiette social bensì da imprenditori che, se lavorano bene, fanno star bene milioni di persone.
Partendo da questo contesto abbiamo pensato bene di indagare, da questo numero, anche il mondo della distribuzione alimentare rivolto all’ho.re.ca., raccontando ogni mese un’azienda tra le oltre 4.000 che rappresentano il comparto.
Siamo in Trentino, esattamente a Pinzolo, nelle valli del Brenta e Adamello. Un’area turistica famosa per le sue bellezze paesaggistiche, per le piste da sci e per ospitare una delle mete più ambite delle Dolomiti: Madonna di Campiglio.
È in questo territorio che opera l’azienda Selezioni di gusto. Si tratta di una branchia della Famiglia Cooperativa di Pinzolo, cooperativa di consumo che nel 2025 festeggia i suoi primi 130 anni di vita. Selezioni di Gusto nasce con il nome di Ingros-Rendena negli anni ’80 del secolo scorso per estendere i servi-
zi commerciali della Famiglia Cooperativa al mondo dei consumi fuoricasa (hotel, ristoranti, pizzerie ecc…) che, in quegli anni cominciava ad avere visibilità e successo. Nel 2023 la scelta di cambiare nome ce la spiega Angelo Ferrazza, direttore commerciale di Selezioni di gusto. “Il cambio del nome avviene in contemporanea con il cambio di sede: triplicare gli spazi significava, oltre ad avere una logistica molto più efficiente, aumentare anche il numero di referenze per raggiungere quell’assortimento completo che serve a un pubblico esercizio, sia esso hotel, ristorante, bar o pizzeria. Da noi adesso si può trovare tutto il necessario per le attività di ristorazione ed è la nostra forza vendita a presentare questo assortimento, con i relativi prezzi e consigli per poi organizzare le consegne nel migliore dei modi. È stato importante il cambio del nome perché Ingros-Rendena dava la sensazione di essere semplici grossisti che coprivano un territorio limitato alla val Rendena, come era stato fino a quel momento. L’esigenza di estendere il nostro raggio d’azione implicava cambiare anche il nome”.
La nuova sede si sviluppa in 3.000 metri quadrati di magazzino, suddivisi in 1200 per i prodotti grocery, 740 per il surgelato, 150 in celle per l’ortofrutta, 160 per i prodotti freschi, 50 per le carni.
Adesso fin dove operate? E con quanti agenti di vendita?
“Ora arriviamo in Val di Sole, Val di Non, tutto il giro del Brenta, la Paganella, Andalo, Molveno e vogliamo arrivare, nei prossimi mesi, a Bagolino (BS), lago d’Idro, lago di Ledro. Per questo stiamo implementando il numero di agenti, otto in questo momento, e di clienti, settecento sono quelli attivi a settembre 2025”.
Quest’anno il mercato della ristorazione è stato connotato, in generale, tra alti e bassi; da voi qual è la situazione?
“Quest’anno noi abbiamo visto un aumento del fatturato, segno che le scelte di un assortimento più completo e del cambio di nome sono state centrate. La montagna quest’anno è stata scelta da più persone, gli alberghi nostri clienti hanno adottato servizi più funzionali, connotato menu di maggior qualità, e questo è stato apprezzato dagli ospiti”.
Come organizzate il vostro servizio di raccolta ordini e consegne?
“In alta stagione non abbiamo la possibilità di presentare nuove proposte, il nostro cliente non ha il tempo per questo, quindi a inizio stagione, estate e inverno, organizziamo un Porte Aperte dove invitiamo i clienti a venire a scoprire le novità. Il prossimo sarà l’1 e il 2 ottobre presso la nostra sede. Gli agenti visitano le strutture, raccolgono gli ordini che vanno in consegna il giorno dopo, o al massimo entro le 48 ore. Se, però, ci sono bisogni urgenti consegniamo anche in giornata con il personale degli uffici. Il cliente non viene mai trascurato”.
In termini di referenze vanno di più quelle qualitativamente migliori? Il prezzo è un elemento che incide nella trattativa?
“Devo dire che la formazione che facciamo agli agenti e gli obiettivi che poniamo hanno portato a un cambiamento molto positivo. Vediamo che presentare la qualità e il servizio è un aspetto che ci conferisce forza e identità. Se il cliente, grazie alla professionalità dei nostri agenti, arriva a capire che un saldo di pochi centesimi in più su un prodotto non gli cambia la vita se non in meglio, si determina una fiducia che diventa il collante principale. L’esempio più evidente è quello che riguarda le carni, quest’anno oggetto di oscillazioni di mercato ai limiti della decenza. Se questo viene spiegato correttamente viene compreso dal ristoratore. Oppure il prosciutto cotto che oscilla dai tre ai venti euro al chilo. Noi abbiamo spiegato che sotto a una certa qualità non siamo disposti a scendere ed è una scelta accettata”. Il fatto che siate affiliati a un consorzio nazionale –Cateringross – vi porta dei benefici?
“Moltissimi! Riusciamo ad essere informati su come si sviluppa il mercato nel suo complesso, abbiamo contratti a livello nazionale che garantiscono prezzi e consegne che altrimenti non potremmo avere. Soprattutto possiamo contare su una serie di prodotti a marchio in grado di coprire l’intera selezione di prodotti che non ha nessun concorrente e, con il fatto che i cuochi si spostano, soprattutto quelli stagionali degli hotel potergli far trovare un marchio che loro già utilizzavano, magari a mille chilometri di distanza, fa la differenza”.


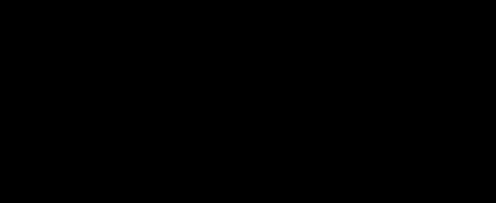



Autrice: Giulia Zampieri
Clicca e leggi l’articolo sul web

Di questi tempi, tra dati, frasi fatte e allarmismi è difficile capirne qualcosa. Ne abbiamo parlato con il sommelier Matteo Circella
Stavamo spulciando dentro a una lunga lista di dati e statistiche, interpellando osservatori e distributori, per portarvi anzitutto un quadro quanto più possibile dettagliato dei consumi di vino in Italia nell’ultimo anno, quando abbiamo deciso di fermarci.
Volevamo mettere la questione su un piano oggettivo perché, diciamocelo, ogni volta che negli ultimi tempi si introduce l’argomento vino e consumi con chi lavora nel settore - che sia operatore, oste, sommelier, venditore, distributore - diventa estremamente complesso capirci qualcosa.
Perché è così complicato?
Partiamo da qui: dalla consapevolezza che il mondo del vino oggi è complesso, stratificato, con voci autorevoli che spiccano, voci improvvisate che tentano di farsi largo, nuovi metodi di comunicazione, investimenti inspiegabili, teorie dei consumi, “imitazioni” dealcolate, gruppi di acquisto, etichette che provocano la nausea da quanto si vedono in giro. Ma è soprattutto un mercato che dipende dal luogo e dalle persone.
Questo ce lo ha rimarcato Matteo Circella, sommelier de La Brinca, con cui abbiamo conversato sull’argomento, per raccogliere un parere di chi si trova nell’anello di mezzo, tra produttore e ospite di un ristorante.
Il vino
Dovremmo partire raccontandovi La Brinca, storica insegna ligure arroccata sulle alture che si affacciano al Golfo del Tigullio, precisamente a Ne, il nome più corto che si potesse dare a una località. Ma no, arriveremo dritti al punto, o ai punti, lasciando stare premi e convenevoli, come fa Matteo Circella. Da anni è entrato con il fratello Simone dentro all’attività affiancando la madre
Pierangela e il padre Sergio e si è dato con convinzione, e qualche idea controcorrente (rispetto a quelle che vigevano fino ad allora), al mondo del vino.
Tra i punti, il primo che affrontiamo, riguarda l’abitudi-
ne, e la non abitudine, al vino.
“Parto dal fatto che ogni considerazione oggi per me è relativa. Se dovessi guardare al nostro ristorante, o alle vendite dell’e-commerce, ti direi che non c’è questa grande crisi, come sottolineano in tanti. Ma sono certo valga anche per altre situazioni di ristorazione e altre realtà di vendita. È un settore talmente diversificato che dipende da dove lo si guarda, quali sono i luoghi e i soggetti coinvolti. La cosa che mi pare più evidente, e che possa essere correlata a risvolti economici, è che sia cambiato il concetto di vino quotidiano. Quanti consumano ogni giorno un calice di vino e quanti, invece, preferiscono non bere nulla oppure consumare una birra o un cocktail? È la disaffezione al vino come bevanda l’aspetto che incide di più oggi ed è su quello che si deve lavorare. Con la pandemia si pensava a un mercato in divenire ma sono stati fatti degli errori piuttosto rilevanti dagli attori coinvolti”.
Alcuni errori li abbiamo già individuati e raccontati in passato; Matteo li mette in fila.
“Le persone, quando si sono allontanate dal vino, lo hanno fatto per varie ragioni. Una è l’inadeguatezza che si respira in certe insegne. È corretto pagare un calice di vino il giusto, ma dentro al prezzo ci deve essere anche la competenza di chi si occupa del servizio. In tanti locali si è pensato prima a riempire gli scaffali con vini in tendenza, senza tenere conto della capacità e della preparazione di chi andava a versare, a raccontare il prodotto al tavolo”.
Mentre Matteo lo sottolinea, inutile dire che gli esempi dall’archivio dei ricordi spuntano fuori come funghi.


“C’è stata un’esagerata semplificazione sia nel mondo della produzione del vino, sia in quello dell’ospitalità in cui ci vorrebbero più osti desiderosi di muoversi, di andare nelle aziende, di capire, di acquisire. Invece sembra che conti di più l’etichetta che il percorso fatto per produrla. Come si fa a integrare l’ospite in un locale, a farlo sentire coinvolto se manca tutta quella componente narrativa e se non è stata investita a monte della fatica nella ricerca?”
Il capitolo giovani
‘I giovani non bevono più’. ‘I giovani qui bevono benissimo e investono su ciò che bevono’.
Chiediamo a Matteo cosa ne pensa di queste due affermazioni, esternate da alcuni ristoratori.
“Credo valga il discorso di prima: bisogna contestualizzare perché dipende da cosa offri, in quale luogo, in che modo, con che comunicazione. Inoltre pochi si soffermano su come eravamo noi, da giovanissimi. Eravamo grandi consumatori di vino? È una bevanda a cui si approccia in età più adulta. Pertanto non sono preoccupato a riguardo. Noto invece come ci siano molti ragazzi appassionati che si stanno abituando a bere bene. Se parliamo di consumi in termini assoluti potrebbe essere solo un bene che cali la quantità ma si alzino il numero di persone consapevoli, disposte a bere meglio”.
Quando sentiamo parlare di vino dealcolato sorridiamo sempre. Altrettanto fa Matteo Circella.
“Questi prodotti non minano il mondo del vino. Io sono un grande appassionato di bevande fermentate e quelle convivono con il nostro settore, possono stare al ristorante, ci stanno bene insieme. Mentre, per quanto concerne il prodotto dealcolato, non desta interesse al bevitore appassionato. Le sfide del settore a mio avviso riguardano l’arrivare sempre di più alle persone rendendo il vino
accessibile, promuovendo spazi aggregativi e remando nella direzione che molti hanno già intrapreso, in cui sono la curiosità e la conoscenza a guidare la scelta, non la routine. Penso a mio padre che mi guardava contrariato quando ho iniziato a introdurre certe etichette in cantina e ora ha cambiato molto visione. Il pubblico molto più adulto non cambia abitudini facilmente ma può ancora ordinare molte bottiglie… scegliendo di bere qualcos’altro!”.
Matteo, piuttosto, è sul chi va là per un’altra questione. “Sembra che si stia compiendo un ciclo. Abbiamo per buona parte abbandonato un modo di approcciare al vino, intendo quello estremamente accademico, giudicante, che ti guardava dall’alto al basso, per intenderci quello della sommelierie vecchia scuola, per contrastarlo con l’esatto opposto. È così che si è radicato un certo tipo di produrre e proporre il vino, in cui ad emergere sono gli artigiani e il territorio. Ma… ma si è costituita una comunità di bevitori di etichette che ha portato in auge alcuni produttori e alcune zone, determinando un aumento smisurato dei prezzi per alcune bottiglie. Cosa ci rimane, alla fine? È così che si dà stabilità al settore, e soprattutto che si fa cultura? Oltre al fatto che, in questo calderone, si è messo dentro di tutto”
L’ultimo appunto riguarda le quantità. Sentiamo dire “c’è troppo vino”.
“Sì e no. Se pensiamo che molti viticoltori hanno scelto di abbandonare realtà consorziate per mettersi in proprio e marciare con le proprie gambe, per esempio, allora è normale che pare ci sia “tanto” vino rispetto al passato. Il vino non è tanto, è cambiata questa dinamica ed è mutata la capacità di assorbimento del mercato. Quello di cui sono certo è che il mercato del vino non morirà dall’oggi al domani. Si ridimensionerà. Sicuramente la sfida più grande spetta ai produttori nuovi e ai locali appena aperti, ma se lavori con professionalità e ricerca vieni premiato”.
Autrice: Marina Caccialanza
Clicca e leggi l’articolo sul web
e ricerca, dalle origini al futuro della
pizza, con lo sguardo al domani e i piedi ben piantati a terra: è la visione di Giovanni Santarpia, mente
aperta dove equilibrio e concretezza incontrano creatività e innovazione
“Avevo 14 anni, nell’88, e cominciavo a muovere i primi passi nel mondo della pizzeria a Castellammare di Stabia – esordisce così Giovanni Santarpia – Ero solo un ragazzino e il lavoro mi serviva per aiutare la famiglia. Non era nemmeno una pizzeria classica ma al taglio, una friggitoria alla napoletana dove si facevano i crocché, calzoni e arancini. Il locale era di proprietà di un maître d’hotel che aveva voluto cambiare vita. Un giorno entrò un vecchietto del luogo, noi lo chiamavamo zii spedito (camminava con le stampelle), e gli chiese perché non metteva un forno a legna. Il proprietario rispose che non sapeva fare la pizza e allora si offrì di insegnargli. Tutto cominciò da lì. Quasi per caso. Ma dopo un po’ cominciai ad appassionarmi e la pizza è diventata la mia vita”.
Giovanni Santarpia, oggi, dopo diverse esperienze, accoglie alle porte di Firenze, in quello che è diventato il suo regno, il locale che porta il suo nome e dove porta avanti il suo progetto di vita, di lavoro, di ricerca e innovazione. La pizza napoletana è il mezzo per esternare la sua visione di un futuro nel quale è importante dare il giusto valore al prodotto, onorare la materia prima, rispettare il cliente e il lavoro del pizzaiolo, con umiltà perché, afferma: “Umiltà vuol dire senso di responsabilità, vuol dire rispetto e questo può esistere solo se diamo valore all’esperienza, che è la vera saggezza”. Comincia in quegli anni, a Castellammare, e poi in giro per l’Italia, il lungo percorso di apprendimento e consapevolezza che forgiano il suo carattere e gli consentono, lui figlio del popolo e scarso a scuola perché dislessico, di costruire una carriera oggi riconosciuta a livello internazionale. Acume e intelligenza sostituiscono il retaggio e la formazione scolastica, buonsenso e volontà sono la sua forza. Nel ’95 è a Sassomarconi (BO), nel ’96 è in Toscana, a Vicchio del Mugello; poi a Capri per la stagione, dove si guadagna sì, ma si lavora dalle nove del mattino all’una di notte: “Facevo al massimo mezz’ora di pausa, un tuffo in mare tra due barche e tornavo al lavoro. Mi divertivo in fondo, ma quanta fatica! Non c’erano alternative, ero uno scugnizzo, e per togliermi dalla strada mio padre mi diceva ‘devi lavorare’ e così fu”. Una buona scuola, una scuola di vita. “Essere dislessico – racconta Giovanni – fu quasi una fortuna perché mi costrinse a sviluppare il mio saper fare in una forma diversa da quella convenzionale, a mettere in pratica le mie idee in modo del tutto personale: me ne inventavo di tutti i colori, e portavo a casa i soldi, cercando di fare il meglio con gli strumenti a mia disposizione”. La voglia di fare e l’impegno nel riuscire sono armi potenti, e Giovanni Santarpia le mette in pratica con tenacia, dimostrando che l’intelligenza e la volontà vincono, gli permettono di crescere e progredire. Nel ‘98 Giovanni ha 24 anni, deve capire se questo è il suo mestiere o deve cambiare vita: “Ho provato a fare l’agente pubblicitario, tutto bene, però non sei pagato come un pizzaiolo stagionale nelle località turistiche, dove c’è richiesta, e allora pensi che da questo mestiere di pizzaiolo puoi ricavare qualcosa di buono”. Tenta altri lavori e poi torna sempre lì, perché capisce che osservando, studiando le azioni dei colleghi, rubando con gli occhi i segreti di chi è più esperto può imparare e mettere a frutto, può approfondire e migliorare. “E’ così che si impara il mestiere – dichiara convinto Giovanni – e io ho rubato parecchio ed è stata una grande fortuna, una grande scuola. Oggi cerco di ridare agli altri quello che ho

imparato e se posso aiuto”. È l’espressione di una mente brillante, vuol dire saper cogliere l’attimo, fare proprio il segreto altrui modificandolo, personalizzandolo. “Devo capire come funziona – afferma Santarpia – provo, assaggio, capisco e così riesco a farlo mio, in modo diverso, magari migliorandolo”.
La svolta a Firenze, sono ormai gli anni 2000, e iniziano i riconoscimenti – Gambero Rosso, 50 Top Pizza, tra gli altri – e diventa uno dei pionieri della nuova generazione di pizzaioli, giovani, intraprendenti, preparati e determinati a portare la pizza sul podio delle specialità.
Stile napoletano ma lievitazione lunga e precisa, cura massima nella scelta delle materie prime, equilibrio perfetto. Equilibrio sembra essere la parola magica per Giovanni Santarpia, equilibrio tra gli ingredienti, equilibrio tra il personale, nello stile di vita e di lavoro; quell’equilibrio che porta alla felicità e alla realizzazione.
“La mia pizzeria è piccolina – afferma – ci sono 55 posti a sedere e con me lavorano 15 ragazzi a rotazione; la pizza che faccio è la classica napoletana che però ho ricreato secondo il mio stile, con una lievitazione di 24-36 ore, con una identità particolare perché frutto di studio e perfezionamento. Oggi mi dedico anche alle consulenze e sono spesso lontano ma i miei ragazzi seguono la linea che ho tracciato, hanno sposato lo stile di lavoro che voglio per quanto riguarda il prodotto, il servizio, come approcciarsi ai tavoli, alla gente: ci deve essere sorriso, cordialità, divertimento, passione e ovviamente bisogna stare bene tutti quanti insieme”.
La pizza più richiesta? Certamente zucca, guanciale e provola affumicata, ormai un’icona. Ma c’è anche la piccantuzza, la pomodorina gialla, l’affumicata con burrata e ‘nduja, salsiccia e friarielli, crema di zucchine, la parmigiana rivisitata con melanzane grigliate e pesto di

basilico. Alla domanda se è importante trovare sempre nuove idee risponde: “La gente cerca sempre cose nuove ma devi creare equilibrio tra gli ingredienti, e se poi riesci a fare qualcosa di originale è meglio”. Equilibrio, ecco che torna, e detto da un personaggio come lui, vulcanico, entusiasta, sempre attivo…beh vuol dire che è proprio importante trovarlo, l’equilibrio. Forse è lì il segreto, per la riuscita di un piatto.
Spiega Santarpia: “Quando fai una pizza devi fare in modo che arrivi in tavola croccante e morbida al tempo spesso, al punto giusto. Il tempo che passa da quando esce dal forno al momento in cui arriva al cliente è fondamentale: una napoletana – ma anche una pizza contemporanea - farcita e decorata all’uscita subisce uno shock termico che influisce notevolmente sulla percezione del gusto, perché si crea condensa e diventa gommosa. La devi servire immediatamente. Le pizze gourmet oggi tanto in auge sono delicate per questo motivo, meglio un condimento fatto bene e che si mantiene caldo, e…fare in fretta”.
Un prodotto di qualità, dunque, ben progettato nei dettagli - perché l’equilibrio è fondamentale! – e a fare la differenza il servizio. Una tavola ben allestita, con accessori perfetti, è un biglietto da visita ineccepibile e – Giovanni Santarpia dal sorriso disarmante ne è convinto – cortesia sempre, dialogo col cliente, umiltà e senso di responsabilità, rispetto. L’esperienza insegna, e esperienza vuol dire saggezza.

Dare valore, suscitare interesse, coinvolgere i propri ospiti. È questo il compito del ristoratore perfetto. In alcuni casi queste intenzioni sono l’obiettivo principale, e i risultati si vedono, sono oggettivi; in altri casi, il valore non si crea per vari motivi: per disattenzione, per poca voglia di investire e, a volte, anche per una professionalità non esercitata al meglio delle sue dinamiche. Chi mi conosce sa bene quanto impegno io metta nella costruzione del valore, perché sono convinto che tutto debba fondarsi su questo principio. Prima ancora del valore economico, che si traduce in guadagno, quindi in un corrispettivo in denaro, c’è il valore in sé, che è da considerare e che va concepito come qualcosa di molto importante. Spesso, tuttavia, si punta al ricavo senza mai aver mai puntato a creare quel valore immateriale che invece sostanzia e corrobora il valore economico. Nel caso specifico di una materia prima alimentare come l’olio extra vergine di oliva, ma lo stesso vale per ogni altro grasso alimentare, in tanti ritengono che sia qualcosa di per sé marginale sul quale non ha alcun senso puntare, sbagliando. Vedere l’olio come una generica voce di costo è l’approccio più sbagliato che si possa compiere. Infatti, se si guarda con occhio attento alle vendite degli oli, e in generale di tutti i condimenti (sì, perché questi sono uno dei maggiori punti di debolezza in ambito ristorativo), si nota che le scelte tendono al risparmio tout court, non a scelte pienamente consapevoli e funzionali a creare valore. L’olio, visto come una voce di costo, diventa elemento secondario e sacrificabile. E sta qui l’errore, l’atteggiamento sbagliato. Gli oli, così pure gli aceti, con tutta la serie di condimenti, anche esotici, sono il particolare che può fare la differenza. Un ristoratore non può ignorare le opportunità che possono derivare dal prestare atten-
zione alle materie prime che seleziona per il proprio locale, e nemmeno può trascurare le esigenze, talvolta non esplicitate ma latenti, dei propri avventori. Qualcuno potrà obiettare che l’olio è sempre uguale a sé stesso da almeno due millenni a questa parte, ma non è così. Ciò che è presente sul mercato richiede oggi una attenta selezione e prima ancora tanta attività di studio e ricerca, anche in termini di applicazione nelle varie preparazioni che lo chef dovrà realizzare. Oggi i condimenti tutti sono ben più complessi. Per questo, impegnarsi a creare valore a partire dagli oli è uno degli obiettivi che ci si deve prefiggere, non fosse altro per il fatto che una virtuosa gestione porta vantaggi non solo di immagine ma anche di natura economica. Oggi il compito di giungere a un cambiamento radicale e a un miglioramento sostanziale nella gestione degli oli in un ristorante è un atto necessario e doveroso. Ho curato per le edizioni Olio Officina un volume, L’olio al ristorante. Idee, linee guida, esempi e consigli d’uso per valorizzare oli e condimenti nelle sale e nelle cucine professionali, che apre la strada a un nuovo modo di concepire le materie prime alimentari, a torto ritenute secondarie e marginali. Siamo chiamati a una svolta. Presto ci saranno anche corsi specifici: la formazione viene prima di tutto, perché non ci si può improvvisare. Per avere performance produttive appaganti, occorre studiare, studiare sempre: sperimentare, stupirsi e suscitare curiosità.
























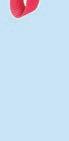





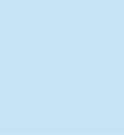
































































































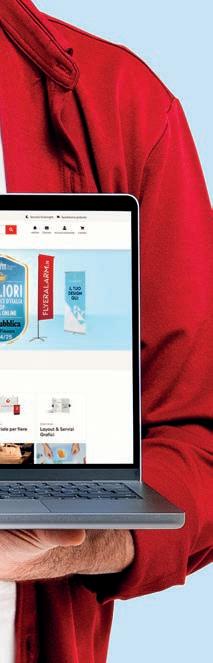





Clicca e leggi l’articolo sul web
Se lavori in una piccola impresa, dove le risorse sono limitate e ogni membro del team conta, sai che gestire correttamente i turni di lavoro non è solo una questione operativa: è una necessità strategica
Un errore nella pianificazione può avere conseguenze importanti, come un servizio zoppicante, malumore nello staff e recensioni negative.
Per questo motivo, sempre più organizzazioni stanno optando per strumenti digitali che semplificano e automatizzano questo compito.
Scopriamo quindi quali sono le principali caratteristiche di un software per la gestione dei turni di lavoro e capiamo quale soluzione può adattarsi meglio alla tua realtà.
Un software per la gestione dei turni di lavoro è innanzitutto uno strumento digitale che ti consente di pianificare e coordinare in modo più efficace gli orari di lavoro dei tuoi collaboratori.
Esistono diverse soluzioni, da programmi dedicati esclusivamente alla pianificazione dei turni di lavoro fino a piattaforme di gestione aziendale più complete, accessibili anche da smartphone e tablet.
Questi strumenti permettono di creare/gestire i turni direttamente online, che ti evitano errori dovuti ai copia e incolla manuali su fogli Excel ma soprattutto aumentano la soddisfazione dei dipendenti.
Puoi infatti adeguare rapidamente la pianificazione alle tue reali necessità, aggiornare i turni in tempo reale e inviare notifiche istantanee ai lavoratori coinvolti.
Inoltre, i software più avanzati si occupano del calcolo automatico di ore lavorate, ferie maturate e permessi. Pianificare i turni in questo modo significa anche garantire una maggiore trasparenza e accessibilità delle informazioni a tutto il personale. Il tuo staff può consultare autonomamente i suoi orari e ricevere avvisi tempestivi in caso di modifiche.
Grazie al tracciamento automatico di riposi, ferie e straordinari, si riducono incomprensioni e si tutela in modo più efficace il rispetto dei diritti dei lavoratori.
Questa trasparenza contribuisce a rafforzare il clima di fiducia all’interno del tuo locale e diventa un ele-

mento molto efficace quando devi cercare personale in quanto potrai dimostrare (con i fatti) che sei diverso dagli altri perché hai un approccio moderno e corretto. Oltretutto un software per la turnazione permette di rispettare facilmente i vincoli previsti dai CCNL legati agli orari di lavoro proteggendoti da potenziali sanzioni o controversie.
Il software da scegliere dovrà offrirti le funzionalità per garantirti un’organizzazione efficiente e flessibile del personale.
Tra le caratteristiche più rilevanti possiamo citare:
• Pianificazione e modifica dei turni: il sistema deve consentire la creazione rapida e intuitiva dei turni, con la possibilità di assegnare date, orari, sedi operative, ruoli specifici e annotazioni personalizzate.
• Visualizzazione dinamica del calendario: un calendario digitale chiaro e navigabile è cruciale per tenere sotto controllo la programmazione.
• Gestione degli scambi di turno: uno strumento efficace dovrebbe prevedere la possibilità, per i dipendenti, di proporre cambi turno all’interno della piattaforma, con un sistema di notifiche e approvazioni automatiche da parte dei supervisori.
• Gestione di ferie e assenze: il software deve includere un modulo dedicato alla richiesta di ferie, permessi o assenze, completo di un flusso approvativo personalizzabile, in grado di semplificare e velocizzare il processo.
Oltre a queste funzionalità di base, dovrebbe includere anche notifiche intelligenti per comunicare in modo tempestivo eventuali aggiornamenti o cambiamenti nei turni.
Inoltre, deve essere previsto il monitoraggio delle presenze tramite sistemi integrati di timbratura digitale. Adottare un nuovo software per la gestione dei turni di lavoro può incontrare alcune resistenze interne per questo è importante accompagnare il cambiamento coinvolgendo il team prima durante l’implementazione.
Una volta che tutti avranno colto i veri vantaggi di questo nuovo strumento, saranno molto propensi non solo ad utilizzarlo ma a non poterne più fare a meno dopo.

La Salsa Cheddar Topfood è pronta all’uso, densa, profumata e cremosa. Oltre al sapore intenso ed incomparabile, si contraddistingue per la qualità eccelsa degli ingredienti utilizzati e per l’alta resa in lavorazione. Regina degli hamburgers e dello streetfood, la nostra Cheddar Sauce è unica ed inarrivabile.
FORMATI DISPONIBILI: tank 2,3 kg, squeezer 870 ml, squeezer 290 ml, dip cup 25g
Autrice: Marina Caccialanza
Clicca e leggi l’articolo sul web
I sapori autentici dei prodotti
irlandesi si fondono con la cultura enogastronomica del Belpaese al Ristorante

Quintessenza di Trani, dove lo Chef CIBC Di Gennaro e il fratello Sommelier Saverio creano perfetti equilibri tra tradizione, ricerca e alta cucina
Nella cucina creativa di Chef Stefano Di Gennaro prende vita una narrazione gastronomica che celebra l’eccellenza delle materie prime dell’Isola di Smeraldo, in particolare della carne di manzo irlandese allevata al pascolo, esaltata dal talento dello Chef italiano e dall’expertise enologica del fratello Sommelier Saverio.
In Irlanda, dove le farm a conduzione familiare sono il cuore pulsante del settore agroalimentare, l’allevamento è una vera e propria questione di famiglia: un sapere antico e un patrimonio inestimabile da custodire e valorizzare di generazione in generazione.
La stessa dimensione che unisce tradizione e famiglia trova spazio anche nel Ristorante Quintessenza di Trani, dove Chef Stefano Di Gennaro ha dato vita a un ristorante i cui punti di forza sono la scelta di materie prime di alta qualità e la collaborazione con i suoi fratelli e con il padre agricoltore. Al Quintessenza la cucina è raffinata protagonista di una proposta sorprendente e al tempo stesso familiare e d’eccellenza, capace di creare connessioni autentiche con il territorio di origine, i produttori locali e ingredienti pregiati dal mondo come quelli dell’Isola di Smeraldo.
Ogni dettaglio è curato con attenzione, grazie a una squadra che vive e lavora insieme. Infatti, tutta la famiglia Di
Gennaro contribuisce all’identità e all’anima di questa attività. Al centro ci sono sempre le persone, la qualità delle materie prime selezionate e l’accoglienza degli ospiti. Un modo di vivere la cucina “senza ostentazione, avendo però chiare sin da subito le intenzioni e il significato di ristorare, rinvigorire, dare conforto, prendersi cura e fare stare bene l’ospite”.
Materie prime di qualità
Chef Di Gennaro è parte del Chefs’ Irish Beef Club (CIBC), iniziativa gestita da Bord Bia – ente governativo irlandese per la promozione del food & beverage – che dal 2004 riunisce chef riconosciuti a livello internazionale che condividono una passione comune: la carne di manzo irlandese, ora anche IGP (Indicazione Geografica Protetta), status che premia l’esperienza delle aziende agricole locali e il contributo dei rigogliosi pascoli irlandesi nella produzione di una carne di qualità. I membri del Club, tra cui Chef Di Gennaro, hanno deciso di farsi ambasciatori di questa carne che apprezzano per le sue caratteristiche intrinseche, come il gusto intenso e distintivo, il grasso dorato e la polpa color rosso borgogna, una marezzatura ottimale e una tenerezza unica, e scelgono di utilizzarla nei loro ristoranti proprio per la sua qualità. “In Irlanda ho avuto modo di visitare, scoprire e conoscere da vicino gli allevatori e le ampie distese verdi dove i
bovini pascolano in libertà, nutrendosi quasi esclusivamente di erba, un grande beneficio per gli animali. Nella mia cucina cerco sempre prodotti di qualità che guardino anche alla sostenibilità, come nel caso della carne di manzo irlandese”, racconta Chef Stefano Di Gennaro. “Nella carne irlandese ritrovo proprio una materia prima tracciata, eccellente, con una distribuzione dei grassi più uniforme, che la rende più tenera, gustosa e succulenta, un ottimo prodotto con cui posso sperimentare nella mia cucina”.
Un dialogo enograstronomico tra carne di manzo irlandese ed eccellenze italiane
Saverio Di Gennaro, fratello di Chef Di Gennaro è sommelier di Quintessenza e si occupa della selezione enologica del ristorante, curando con attenzione ogni abbinamento per valorizzare al meglio le creazioni dello chef e le materie prime utilizzate.
“Un vino non deve sovrastare, ma accompagnare e lasciare spazio alla qualità del prodotto. La carne di manzo irlandese si abbina bene con vini rossi strutturati, ma equilibrati.”, spiega Saverio Di Gennaro. “Il sapore intenso di questa carne viene valorizzato da vini come il Nero di Troia, dove i tannini sono presenti ma mai troppo aggressivi, e si legano alle sue proteine. Questo vino ha una buona acidità e una tendenza a essere più elegante che muscoloso, mentre le note di frutti neri e spezie esaltano al meglio il gusto della carne di manzo irlandese.”
Tra gli abbinamenti consigliati:
• Filetti e tagli nobili di carne di manzo irlandese si sposano bene con vini di eleganza e finezza, con tannino presente ma non invadente, come Nebbiolo, Barolo Giovane, Barbaresco, Chiavennasca dalla Valtellina La struttura del vino crea armonia con la
carne, la marezzatura è da incastro per la succulenza, abbinata all’astringenza del tannino del vitigno.
• Il brasato di manzo irlandese è ottimo accompagnato da un vino come il Nobile di Montepulciano che è armonioso, avvolgente, dal frutto maturo, le spezie dolci e i tannini levigati. Si tratta di una carne con un sapore persistente e una rosolatura che predilige l’abbinamento con un vino dall’aroma intenso.
• Per cotture alla brace si consiglia l’Aglianico del Vulture per la sua struttura bilanciata, l’acidità naturale e le sensazioni di grafite e di prugna. Il fuoco richiama la percezione schietta e sincera che si cerca anche nel vino, con un abbinamento degno di nota.
• Con carpacci o tagli magri di carne di manzo irlandese è ideale un vino elegante, vulcanico, fresco e con trama tannica sottile, come l’Etna Rosso da Nerello Mascalese. La sua acidità bilancia la consistenza al palato della carne, esaltandone il sapore immediato.
• Per l’hamburger di manzo irlandese è adatto, invece, il Lagrein con la sua struttura morbida, il colore intenso e una nota dolce. L’hamburger è una proposta da mangiare con spensieratezza e il Lagrein ha la medesima struttura: immediato in bocca, un vino relativamente corto, che resta un piccolo passo indietro rispetto all’hamburger, con una giusta temperatura di servizio è capace di accompagnare la carne nel migliore dei modi.
La carne di manzo irlandese allevata al pascolo trova una voce del tutto inedita nelle mani di Chef Stefano Di Gennaro e della sua famiglia, che al Ristorante Quintessenza trasformano ogni piatto e abbinamento in un racconto di sapori, territorio e visione. Un vero e proprio dialogo tra culture che unisce l’Irlanda all’Italia, attraverso l’eccellenza delle materie prime e il talento di chi sa interpretarle con autenticità e creatività.

LA PRODUZIONE
Autrice: Marina Caccialanza
Clicca e leggi l’articolo sul web
Competenza, passione e visione sono i valori su cui La Nef ha costruito il proprio percorso: un’evoluzione che ha trasformato l’importazione e la distribuzione di specialità ittiche in un vero viaggio nel sapore
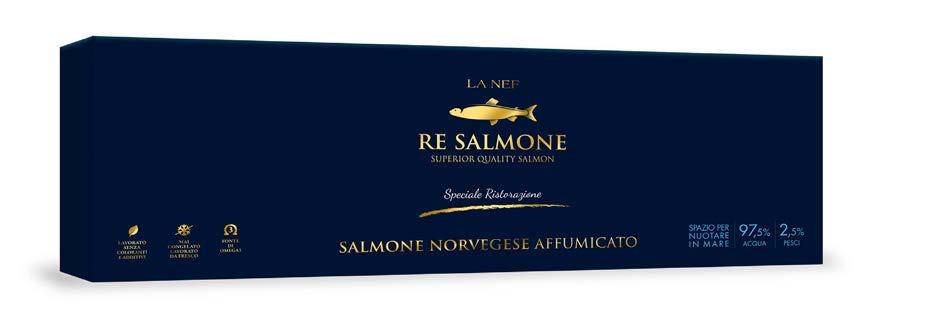
Saper scegliere è un’arte. Quando si parla di pesce, diventa anche competenza, passione e visione. È su questi valori che La Nef, storica azienda marchigiana con oltre trent’anni di esperienza, ha costruito il proprio percorso: un’evoluzione che ha trasformato l’importazione e la distribuzione di specialità ittiche in un vero viaggio nel sapore.
Il suo payoff non è solo un richiamo al gusto, ma una promessa mantenuta ogni giorno: portare in tavola solo il meglio.
Fondata ad Ancona da Giordano Palazzo – oggi affiancato dal figlio Nico – La Nef è diventata un punto di riferimento per la ristorazione professionale e per il retail di alta gamma. Il segreto del suo successo è dato da una selezione rigorosa delle materie prime e una gestione etica della filiera, pensata per chi vive ogni giorno il mondo del food con passione e responsabilità.
“Il vero valore nel food – afferma il vicepresidente Nico Palazzo - non risiede solo nel gusto, ma nella capacità di offrire un sistema efficiente, trasparente e reattivo, in grado di affrontare le sfide di un mercato dinamico
e sempre più esigente. La Nef lo dimostra ogni giorno grazie a un servizio affidabile e a una qualità costante, e si conferma un partner solido e strategico per tutti i professionisti che puntano all’eccellenza – in cucina come nella gestione del servizio”.
Il cuore dell’offerta:
il salmone affumicato e le baffe
Il simbolo dell’identità La Nef è il salmone affumicato, emblema di una filiera rigorosa e sostenibile. L’azienda seleziona esclusivamente salmoni provenienti da allevamenti a bassa densità, dove nuotano in acque composte fino al 98,5% da mare aperto. Una scelta consapevole, che tutela il benessere animale e riduce l’impatto ambientale. Il salmone viene lavorato fresco, mai congelato, senza coloranti o additivi. La lenta affumicatura con legno di faggio naturale e la salatura calibrata restituiscono un prodotto dalla texture compatta, dal colore brillante e dal gusto mai invadente. Una qualità che si esprime al meglio nel formato baffa, ideale per la ristorazione: pratico e pronto all’uso.
La linea più venduta è Re Salmone, affiancata dalle baffe Bottega del Mare, destinate al canale Horeca, e dalla linea premium Coda Nera. Ogni referenza interpreta la stessa filosofia: qualità, trasparenza e sapore distintivo. In particolare, le baffe preaffettate Re Salmone – Speciale Ristorazione offrono il perfetto equilibrio tra resa in cucina e gusto. Mentre le baffe Coda Nera rappresentano l’eccellenza: selezionate con criteri ancora più rigorosi, incarnano la massima espressione del salmone affumicato firmato La Nef.
Mai congelato: una scelta pioneristica e coerente
Ciò che definisce l’identità di La Nef è una decisione radicale, presa molti anni fa e diventata oggi un vero marchio di fabbrica: mai congelare. Come spiega Nico Palazzo: “E’ un principio adottato con coerenza, che ha anticipato i tempi e abbracciato una logica di filiera corta e distribuzione rapida. Una filosofia che si traduce in un modello produttivo unico in Italia: il salmone non viene mai congelato ma lavorato da fresco, senza l’aggiunta di coloranti o additivi”. Il prodotto, infatti, viene affumicato lentamente con legno di faggio naturale, salato delicatamente e asciugato a bassa temperatura. Il risultato è una texture morbida e un sapore inconfondibile.
Questa filosofia si traduce in un vantaggio concreto per il settore Horeca: le proprietà organolettiche restano intatte e la qualità costante favorisce la fidelizzazione del cliente.
Accanto al salmone, un’altra eccellenza firmata La Nef è la linea Regina Isabella. Una selezione esclusiva delle migliori acciughe fresche, pescate nei mesi primaverili. Questa stagione offre la migliore qualità, le acciughe hanno nuotato a lungo in acqua fredda e risultano particolarmente grandi e carnose.
Dopo la pesca, ogni acciuga viene lavorata a mano secondo antiche tecniche artigianali e lasciata maturare per dieci mesi sotto sale. I filetti vengono infine conservati in olio d’oliva di pregio, che ne esalta ogni sfumatura. Un prodotto studiato per essere pratico e versatile: perfetto per arricchire antipasti, piatti gourmet o finger food, sia in ristoranti di alto profilo che in bistrot di nuova generazione.
Le nuove referenze: eccellenza, innovazione, sostenibilità
La capacità di innovare restando fedeli ai propri principi è uno dei tratti distintivi di La Nef. Tra le novità più apprezzate spicca Estremo, un salmone superfrozen proveniente dalle Isole Faroe, un arcipelago remoto e inconta-
minato dell’Atlantico del Nord. Cresciuto in acque fredde e incontaminate, viene lavorato entro tre ore dalla pesca, quando è ancora in stato pre-rigor mortis. Questo garantisce una texture straordinaria, ideale per crudi, tartare e sashimi di alto livello. Estremo non contiene antibiotici, ormoni o OGM.
Accanto a Estremo, troviamo la Baffa di Salmone Selvaggio Sockeye Re Salmone, pescato nelle nell’isola di Kodiak, in Alaska. Il Sockeye è una delle specie più pregiate del Pacifico, pescato solo in periodi limitati dell’anno, si distingue per il colore rosso intenso, la carne soda e magra. Una baffa proposta in versione preaffettata, con una leggera affumicatura.
Infine, spiccano tra le nuove proposte le Acciughe Marinate Regina Isabella. Pescate tra febbraio e marzo nel Mar Cantabrico, quando le alici sono nel loro periodo migliore - carne soda, povera di grassi, e ricca di sapore - vengono lavorate artigianalmente in Cantabria e marinate in olio d’oliva e limone. Un prodotto dal profilo aromatico fresco e bilanciato, perfetto per aperitivi e preparazioni rapide.
La Nef System: non solo prodotto ma anche servizio
Qualità non significa solo avere un grande prodotto, significa anche garantire che arrivi in condizioni perfette. “Abbiamo sviluppato, proprio a questo scopo, un sistema integrato che unisce logistica e servizio, fondato sul rigoroso rispetto della catena del freddo - spiega il vicedirettore Palazzo - un elemento cruciale per preservare la freschezza e le proprietà organolettiche degli alimenti. La nostra sede operativa, in Ancona, è il cuore pulsante di questo sistema: ogni giorno i prodotti arrivano freschi dalla produzione e vengono distribuiti ai clienti nelle stesse 24 ore. Un’organizzazione che consente di mantenere freschezza impeccabile, ridurre al minimo le rotture di stock e assicurare tempi di consegna rapidi e puntuali: un valore aggiunto concreto per chi opera nel mondo della ristorazione”.

Autore: Luigi Franchi
Clicca e leggi l’articolo sul web
I monaci lo chiamarono caseus vetus, formaggio vecchio. Il popolo gli diede un altro nome, derivato dalla particolarità della pasta, compatta ma granulosa: formaggio di grana o più semplicemente grana
La storia
Nasce alle porte di Milano, nell’Abbazia di Chiaravalle, intorno al 1135.
I monaci ideano qui, in apposite caldaie, il processo di caseificazione di un formaggio duro e destinato a migliorare con il tempo attraverso la stagionatura.
1954: nasce il Consorzio per la tutela del Formaggio Grana Padano, che riunisce tutti i produttori e stagionatori dell’omonimo formaggio e viene definito lo standard di produzione del formaggio Grana Padano.
1955: viene riconosciuta la denominazione di origine GRANA PADANO e affidato al Consorzio l’incarico di vigilanza sulla produzione e sul commercio e nel 1966 ottiene il riconoscimento della Denominazione di Origine Protetta.
Del Consorzio per la Tutela del Formaggio Grana Padano (CTFGP) fanno parte 122 aziende produttrici con 135 caseifici produttori e 142 stagionatori.
La zona di produzione del formaggio Grana Padano si estende lungo tutta la pianura Padana e comprende 34 province dal Piemonte al Veneto, dalla provincia di Trento a quella di Piacenza; la produzione effettiva è oggi concentrata in 13 province.
Le fasi della lavorazione
• Prodotto esclusivamente con latte crudo da vacche

alimentate secondo regole precise munte due volte al giorno o da vacche munte con accesso libero a un sistema automatico di mungitura, proveniente dalla zona di produzione.
• Latte parzialmente decremato per affioramento naturale.
• Lavorato esclusivamente in caldaie in rame o con rivestimento interno in rame a forma di campana rovesciata, da ognuna delle quali si ricavano due forme.
• In ogni caldaia vanno inseriti quasi 1.000 litri di latte.
• Al latte in caldaia viene aggiunto il siero innesto naturale, riscaldato a una temperatura di 31-33C° e addizionato di caglio di vitello per la coagulazione.
• La forma racchiusa in una “fascera” di plastica viene immersa in una soluzione di acqua e sale per un periodo che varia dai 14 ai 30 giorni.
• La stagionatura, da 9 a oltre 24 mesi, avviene su assi di legno in apposite scaffalature, con moderni sistemi di controllo della temperatura, dell’umidità e dell’aerazione.
• In questa fase il formaggio subisce una serie di mutamenti biochimici-fisici, e microbiologici che si riflettono sulle sue caratteristiche organolettiche.
• Al nono mese le forme di Grana Padano sono esami-
nate con i tradizionali strumenti di controllo e ricevono il marchio a fuoco.
• Il marchio garantisce la qualità “sana, leale e mercantile” del Grana Padano DOP.
Il lisozima - enzima dotato di proprietà antibatteriche e impiegato nella produzione di vari formaggi stagionati per controllare le fermentazioni indesiderate - presente nel Grana Padano DOP è estratto dall’albume dell’uovo con metodi fisici, il quantitativo utilizzato nella caseificazione (secondo quanto previsto dal Disciplinare di produzione) è al massino di 2,5 g per 100 litri di latte, quindi in una porzione di 50 g di formaggio si trovano pochi milligrammi di lisozima.
• Grana Padano DOP 9 – 12 mesi, oltre 12 mesi e oltre 14 mesi:
Formaggio da pasto per eccellenza dal gusto dolce, delicato, che ricorda il latte e con una pasta compatta di color paglierino chiaro che non presenta ancora la tipica struttura “a grana”. Ideale per accompagnare un aperitivo, a scaglie in una insalata fresca o per completare un carpaccio. Si presta per la realizzazione di salse e creme e si abbina perfettamente a vini bianchi giovani, freschi e fruttati.
• Grana Padano DOP oltre 16 mesi e oltre 18 mesi: Dal color paglierino leggermente più intenso, il Grana Padano stagionato oltre 16 mesi e oltre 18 mesi presenta già la tipica struttura granulosa della pasta, l’inizio della formazione dei “cristalli” di tirosina e la frattura a scaglia. Ha un gusto saporito e pronunciato, ma mai piccante. Prodotto versatile, adatto alla grattugia ma anche a un consumo da pasto. Ottimo per preparazioni calde quali flan, soufflè e tortini di verdure; per la mantecatura di paste, risotti e minestre, si abbina molto bene con vini rossi dalla moderata intensità e corposità, ancora giovani e freschi.
• Grana Padano “Riserva” oltre 20 mesi e oltre 24 mesi:
Stagionato per oltre 20 mesi o 24 mesi, il Grana Padano Riserva presenta una pasta a “grana” particolarmente evidente e un colore omogeneo bianco
o paglierino. Grazie alla lunga stagionatura, ha un sapore sempre più ricco, senza tuttavia risultare mai aggressivo. Ottimo sia grattugiato che come formaggio da pasto, è perfetto anche servito con noci, frutta e confetture. Si può abbinare a vini rossi morbidi, ma tannici, con un buon contenuto di alcool. Perfetto l’abbinamento anche con vini dolci da dessert e interessante quello con le riserve di vini prodotti con metodo classico.
Sostenibilità e valori nutrizionali
• Basso impatto ambientale e benessere degli animali sono alla base della produzione.
• Il Consorzio di Tutela promuove un sistema obbligatorio per misurare il benessere animale in modo oggettivo e definito e in favore della sicurezza e qualità dell’allevamento (Classyfarm)
• In fase di approvazione da parte del MASAF e della UE l’iter per modificare il disciplinare di produzione e introdurre il requisito relativo alla tutela del benessere animale e la sostenibilità della filiera.
• Il Consorzio Tutela Grana Padano DOP, insieme al Comité Interprofessionnel de Gestion du Comté in Francia, ha dato vita al progetto LIFE TTGG –The Tough Get Going che ha l’obiettivo di orientare lo sviluppo del settore lattiero-caseario verso modelli di produzione e consumo a basso impatto ambientale.
Tre i macro-ambiti che caratterizzano la filiera lattiero-casearia:
• performance ambientali nelle aziende agricole
• efficienza energetica nel caseificio
• conservazione del prodotto e riduzione dello spreco alimentare attraverso l’ecodesign del packaging.
Valore nutrizionale
Alimento funzionale, prodotto con latte crudo, naturalmente ricco di molecole con proprieta benefiche e protettive fondamentali per l’organismo umano.
Apporta una grande quantita di nutrienti essenziali per la salute, altamente biodisponibili.
Nelle giuste quantita e all’interno di un’equilibrata e varia alimentazione, puo essere consumato da tutti e a tutte le eta.

Autrice: Marina Caccialanza
Clicca e leggi l’articolo sul web
La PASSIONE è il valore driver che guida ogni processo aziendale e che ha consentito di affermare, presso i Distributori Horeca e i punti di consumo, il marchio DEMETRA
innovazione
In meno di 40 anni di attività Demetra ha raggiunto una posizione di riferimento nel panorama italiano ed europeo nella produzione e selezione di specialità alimentari dedicate ai professionisti della ristorazione. Nell’intervista a Romolo Verg, Sales & Marketing Manager e Partner dell’azienda valtellinese, ripercorriamo le tappe di questo veloce percorso di crescita e le sfide presenti e future.
Cosa caratterizza oggi DEMETRA, dopo quasi quarant’anni di attività?
Senza dubbio la ricerca dell’eccellenza e il miglioramento continuo di tutti i processi aziendali. La crescita registrata negli ultimi 5 anni, nonostante la pandemia che ha colpito il nostro settore di riferimento l’Horeca, è stata possibile grazie a una visione che da molti anni mette al centro non solo l’azienda ma l’insieme dei nostri stakeholder: dai fornitori ai clienti, dagli addetti interni alla rete commerciale abbiamo cercato di valorizzare le persone ed i territori che collaborano con Demetra. La risposta a quanto nostro approccio è stata positiva e ha creato un grande entusiasmo in tutti i comparti tanto che la parola “Passion” è diventato il valore driver ed è stata inserita nel claim aziendale per i prossimi anni.

Quali sono i vostri NUMERI attuali?
Rispetto al 2019, per noi l’anno record di riferimento, l’azienda è cresciuta di oltre il 55% a livello di fatturato ma anche del 50% in termini di addetti occupati, siamo a quota 125, arrivando a processare annualmente più 10.000 tonnellate di materie prime declinate in circa 500 referenze, di cui oltre il 70% derivanti dalla produzione interna; produzione che è e sarà sempre il nostro punto di forza anche per il futuro grazie agli importanti investimenti tecnologici come il DIVA SYSTEM.
A livello distributivo siamo presenti in Italia e in più di 30 paesi all’estero con una rete di oltre 500 distributori Horeca e in alcune migliaia di grandi punti di consumo e catene gestite direttamente dai promoter commerciali presenti sul territorio.
Perché un Distributore specializzato nell’HORECA dovrebbe scegliere di collaborare con DEMETRA?
Direi per 3 motivi che caratterizzano fortemente la nostra azienda:
1. La produzione certificata (FSSC 22000 e ISO 9001) e innovativa sia per gli impianti produttivi quali il DIVA che per packaging come la linea CREM-A-POCHE (www.cremapoche.it).

2. Il supporto tecnico, commerciale e marketing fornito da 10 Area Manager sul territorio, 15 Specialist di prodotto e dai Tecnici della Demetra Food Academy. Team che ogni anno forma ed incentiva diverse centinaia di agenti dei distributori oltre a presenziare nelle più importanti manifestazioni fieristiche nazionali e internazionali.
3. La riconoscibilità del Brand Demetra rispetto ad altri marchi che agevola i commerciali interni e di tutti i distributori nella vendita e promozione dei prodotti e che vanta partnership esclusive con le principali associazioni dell’HORECA, quali la FIC, l’APCI, la Scuola Italiana Pizzaioli e l’Accademia Pizzaioli per citare le più rilevanti.

Autrice: Marina Caccialanza

Nel cuore della Valcalepio, a Credaro (BG), sorge una realtà che da cinque generazioni porta avanti una filosofia fatta di passione, qualità e innovazione: General Fruit. Nata ufficialmente nel 1988, l’azienda rappresenta oggi un punto di riferimento nel settore food & beverage, con una gamma che spazia dagli sciroppi ai topping, dal succo di limone ai succhi concentrati per breakfast.
L’origine di General Fruit affonda le radici nella storica ditta Lochis Liquori e Sciroppi, fondata nel 1882 da Giuseppe Lochis, soprannominato “Polot”, che iniziò con la produzione artigianale di vini, mosti e distillati. Da quel piccolo laboratorio, la famiglia Lochis ha dato vita a un’evoluzione imprenditoriale che oggi guarda ai mercati internazionali, mantenendo però intatti i valori originari: qualità, affidabilità e identità. Oggi l’azienda è ancora interamente a conduzione familiare, guidata dalla quarta e dalla quinta generazione della famiglia Lochis, con un fatturato in costante crescita e una presenza consolidata in oltre 50 Paesi
Innovazione e filiera controllata
Il cuore della produzione resta a Credaro, dove General Fruit ha sede e gestisce internamente l’intera filiera: dalla selezione delle materie prime al confezionamento. La qualità è garantita da certificazioni internazionali e da un reparto R&D in costante attività.
L’azienda è in grado di anticipare i trend di mercato of-
frendo referenze naturali e soluzioni custom per l’Ho.
Re.Ca., la GDO e l’industria alimentare.
Negli ultimi anni, General Fruit ha intrapreso importanti investimenti infrastrutturali, tra cui un nuovo polo logistico e una nuova palazzina di uffici che insieme contano 12000 metri quadrati.
Polot 1882: la miscelazione incontra la storia
Tra le business unit più rappresentative del nuovo corso aziendale, spicca il brand Polot 1882, che prende il nome dal fondatore Giuseppe Lochis. Questa linea premium nasce per il canale bar e mixology professionale ed è frutto di una sintesi perfetta tra heritage familiare e innovazione di prodotto
Polot 1882 propone oltre 100 referenze tra sciroppi classici e innovativi, topping, puree di frutta, varianti sugar-free e preparati per cocktail, tutti sviluppati per rispondere alle esigenze dei professionisti del settore.
Non a caso, Polot 1882 è oggi Official Syrups Partner di “The World’s 50 Best Bars”, un riconoscimento prestigioso che conferma l’autorevolezza del brand a livello internazionale.
Un’altra novità sono le farciture a marchio Good Day, in barattoli da 1,5 kg con apposito erogatore. Pistacchio, cioccolato bianco, l’intramontabile nocciolata e tanti gusti frutta compongono la gamma, pensata sia per arricchire i classici cornetti all’italiana che per guarnire qualsiasi tipo di dolce come crepes, waffles o pancakes.

General Fruit continua a crescere senza dimenticare da dove viene. Le sue radici profonde oggi si traducono in una struttura moderna, proiettata sui mercati globali, ma fedele ai valori che l’hanno resa una realtà d’eccellenza nel panorama alimentare italiano: è infatti sponsor ufficiale dell’Atalanta Bergamasca Calcio,
squadra di serie A, oltre a sostenere numerose realtà locali, come il volley Credaro, squadra di pallavolo femminile di serie C.
In ogni bottiglia, sciroppo, topping o preparato firmato General Fruit c’è un pezzo di questa storia. Una storia che guarda avanti, con l’energia di chi ha già dimostrato di saper evolvere restando sempre sé stesso.

Autrice: Stefania Pompele
Analista sensoriale L'ANALISI
l’acidità, come si
Il gusto non è immutabile, è vero semmai il contrario. Abitudini alimentari e tendenze sensoriali sono plasmate dal contesto culturale in cui si vive, e se si osserva la questione in un orizzonte temporale più ampio, dal contesto storico e antropologico che ha segnato quel periodo. Il ventennio appena trascorso è stato caratterizzato da una vivacissima scena gastronomica, capace di capovolgere alcuni paradigmi e approcci, anche e soprattutto da un punto di vista sensoriale. Uno dei più significativi ci ha visti familiarizzare con le intensità sferzanti e sfaccettate del sapore acido, tra gli indiscussi protagonisti del presente gastronomico.
Cenni di meccanismo percettivo
Acido o aspro è il termine utilizzato per definire la risposta sensoriale legata alla capacità di alcune sostanze di liberare protoni (ioni H) in soluzione acquosa, attivando i recettori del gusto. Fresco, sferzante, tagliente, è parte di quella semantica che ci viene in aiuto per descrivere le diverse sfaccettature delle acidità. Sostantivo plurale, perché numerose sono le sostanze presenti in alimenti e bevande che attivano questa risposta sensoriale, alcune simili per intensità percepita e natura dello stimolo -prendete l’acidità sferzante di due acidi organici come il malico e il tartarico ad esempio- altre più identitarie, come quella più tenue e rotonda dell’acido lattico, o l’acidità anche volatile tipica dell’acido acetico. La sensazione associata a questo tipo di composti viene talvolta descritta come una leggera scossetta elettrica che attraversa la lingua, più comunemente ci si concentra sull’aumento immediato di salivazione non indotta dalla masticazione. Varieranno le intensità, le eventuali interazioni con altri sistemi sensoriali e le persistenze.

La percezione dell’acidità riveste un ruolo fondamentale, perché fornisce informazioni sulla degradazione di alcuni alimenti (è il caso delle acidità da fermentazione), sulla maturità di un frutto ad esempio, o indicando la presenza di composti antimicrobici. La relazione potenzialmente sfidante con questo sapore è da ricercarsi nella funzione biologica associata in parte a meccanismi di allerta. Non si tratta solo di intensità percepita, ma soprattutto di natura del composto. Le acidità da fermentazioni e il profilo sensoriale che le caratterizza (anche la componente aromatica ha un ruolo chiave in questo caso) rappresentano senza dubbio uno spartiacque per chi assaggia. Eppure, proprio le fermentazioni e le acidità ad esse associate hanno accompagnato l’alimentazione umana dalla notte dei tempi.
L’acido e il suo ruolo da protagonista contemporaneo
Insomma quel codice sensoriale è parte di ciò che siamo, forse proprio per questa ragione ha trovato spazio nel pensiero gastronomico che ha rivalutato e modificato la funzione dell’acido. La cucina ha attraversato una trasformazione epocale nell’uso dell’acidità, elevandola da semplice nota di contrasto a vero e proprio pilastro portante delle preparazioni.
I primi approcci in tal senso sulla scena italiana del fine dining risalgono al primo decennio degli anni Duemila. Nelle cucine di Fabio Barbaglini e Antonino Cannavacciuolo si proponeva foie gras abbandonando le tradizionali mele cotte, ciliegie e fondi arricchiti con vini dolci, dando all’acidità un ruolo diverso, più nitido. Il fegato grasso veniva ora abbinato a pesce crudo e frutta tropicale. L’acidità non era più solo un contrappunto sensoriale per gestire il grasso, ma assumeva un ruolo strutturale nel piatto, trasformando la percezione di mancanza di fondi o concentrazione in un’inedita eleganza. Non dimentichiamoci poi di un emergente Enrico Bartolini, che nella sua prima esperienza solista proponeva un dessert audacemente intitolato “acidità”: sei passaggi a tema che chiudeva servendo un calice di Kriek, birra a fermentazione spontanea con aggiunta di ciliegie. Una sorsata sferzante, con l’acetica a dominare la scena sensoriale. A non voler essere ingenerosi, molto prima di loro, e precisamente nel 1981, uno sconosciuto di nome Gualtiero Marchesi realizzava quello che sarebbe diventato non solo uno dei piatti più rappresentativi del suo enorme testamento culturale, ma probabilmente il primissimo esempio di pensiero gastronomico “non allineato” rispetto all’ordine precostituito sul ruolo dell’acidità nei piatti. Il suo “riso, oro e zafferano” era caratterizzato infatti dall’utilizzo del burro acido. Non stiamo di certo parlando delle acidità sferzanti e stratificate con cui ci confrontiamo oggi, ma fu a mio
avviso un guizzo, se non il primo (mi perdonerà chi ha più memoria storica della sottoscritta), certamente il più noto. Nobilitare la funzione dell’acido affidandogli un ruolo da attore e non solo comparsa.
L’avvento della New Nordic Kitchen con René Redzepi a capofila ha fornito poi un potente slancio a questa tendenza, trovando evidentemente un terreno già fertile. La riscoperta e l’integrazione delle fermentazioni ha ampliato l’equipaggiamento dei cuochi, permettendo di creare composizioni dove l’acidità intrinseca di un ingrediente può intrecciarsi in armonizzazioni complesse con marinature, liquidi di fermentazioni, brodi acidi, e persino con l’utilizzo di lieviti e koji.
Lo sa bene Michele Valotti, tra i cuochi più illuminati del nostro tempo, che nella sua Madia in quel di Brione propone due percorsi degustazione in cui fermentazioni e acidità vivaci e cangianti hanno spesso un ruolo da protagoniste. Sono lì a raccontarci tecniche ancestrali, a parlarci della necessità di conservare e prolungare la vita di un alimento, o di valorizzare uno “scarto”, restituendoci profili sensoriali spesso inediti, dove anche la componente acida sa aggiungere elementi di golosità al piatto. La polvere di feccia di Aleatico (ripetete con me, polvere di feccia) nello spaghettone con midollo di broccolo è il cesello sensoriale acido.
Acidità evolute anche nel pensiero di Marco Ambrosino, finissima mente gastronomica che dopo la lunga esperienza milanese al 28 Posti, guida oggi le cucine di Sustànza e Scottojonno, ristorante e bistrò inseriti all’interno del progetto di riqualificazione urbana in Galleria Principe di Napoli. Il suo ripensare il Mediterraneo partendo da radici antropologiche sa esprimersi con una cucina colta e profonda, spesso caratterizzata da temi sensoriali in cui le acidità si palesano su più livelli. Come nella sua insalata primaverile, che apre il menù degustazione con una sferzata acida stratificata: quella aggiunta attraverso conserve e sottaceti, quella indotta con fermentazioni e quella naturale insita degli ingredienti stessi.
Ma non solo nei piatti. Enfatizzare secchezze, accentuare freschezze e fuggire dalle rotondità paciose anni ’80 è un tema ricorrente anche nei calici. Birre e bevande a fermentazione spontanea o mista sono un fulgido esempio: Lambic e derivati, kombucha o fermentati di frutta hanno sempre lo stesso minimo comun denominatore. Talvolta l’acidità è un tratto identitario e caratterizzante anche dei processi di estrazione del caffè che abbiamo scoperto grazie al movimento degli specialty coffee. In questa trasversalità di prodotti, tecniche, approcci e derive sensoriali il segno tangibile di quanto e come questo ventennio gastronomico abbia riscoperto ed esplorato questa qualità gustativa con una diversa consapevolezza.
Autore: Guido Parri
Fidenza, nel cuore del territorio del Parmigiano Reggiano DOP, è terra del gusto, con una ristorazione di grande qualità – fino a metà del secolo scorso aveva più di cento osterie – e una produzione agricola che si basa prevalentemente su biologico e naturale.
Per questo, da una decina d’anni, in occasione della Gran Fiera di San Donnino (patrono della città), ai primi di ottobre si tiene Borgofood, un evento di valorizzazione del patrimonio agro-alimentare locale e regionale. Perché questo nome? Per il fatto che Fidenza, prima del fascismo, si chiamava Borgo San Donnino e quella parola, borgo, è talmente rimasta nel cuore che gli abitanti preferiscono il termine borghigiani per essere definiti.
“A Borgofood, quest’anno, abbiamo unito l’alfabeto del gusto per rafforzare il concetto culturale e sociale che riveste il cibo nelle comunità. – dichiara Maria Pia Bariggi, assessore alla cultura del Comune di Fidenza – Il programma della manifestazione, oltre alla parte ludica e mangereccia, vedrà la presenza di due grandi nomi della ristorazione italiana – Antonio Santini e Davide Oldani – che saranno sul palco di Borgofood, intervistati da Luigi Franchi, direttore di
sala&cucina, nei giorni di domenica 5 ottobre il primo e sabato 11 ottobre il secondo, entrambi alle 17,30”. Il programma prevede inoltre un convegno sul ruolo sociale del cibo mercoledì 8 ottobre, alle ore 10, con gli interventi di: Silvio Barbero, vice-presidente dell’Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo; Massimo Spigaroli, chef dell’Antica Corte Pallavicina; Nicola Bertinelli, presidente del Consorzio Parmigiano Reggiano. Lunedì 6 ottobre, alle ore 20, i Cuochi di Borgo, la rete dei ristoratori fidentini, organizza una cena a scopo benefico, in Piazza Garibaldi.
Nei due weekend ci saranno, inoltre, le presentazioni di alcuni presidi Slow Food, una tappa delle selezioni per il Campionato Mondiale di Pesto Genovese al mortaio, la presentazione del progetto sociale di Case Sottane, un untico borgo rurale dell’Appenino parmense riportato in vita.
“Saranno occasioni di gusto e di riflessione su temi, come quello del cibo buono, pulito e giusto, che coinvolgono in prima persona tutti i cittadini. – continua Maria Pia Bariggi – Crediamo sia importante affrontarli con lo spirito giusto, critico ma anche ludico, per imparare a non sprecare, a dare al cibo il valore che merita in fatto di benessere, a pensare all’impegno dei tanti ristoratori che hanno a cuore la felicità dei loro ospiti”.






L’esclusività e la garanzia di un salmone a umicato di qualità superiore
Mai congelato, lavorato da fresco, a umicato su legno di faggio.
Senza coloranti e additivi e a basso contenuto di sale.
Novità
Ottobre 2025
Importante riduzione della carne scura, ideale per la ristorazione e l’hotellerie.
Autore: Guido Parri
In un momento storico complesso come quello attuale, il settore agroalimentare – e in particolare la filiera delle carni bovine – si trova a fronteggiare sfide sempre più articolate. L’instabilità geopolitica, l’aumento dei costi energetici e dei mangimi e le conseguenti pressioni inflazionistiche stanno incidendo profondamente sulla sostenibilità economica degli allevamenti, mettono a dura prova l’intero comparto.
Di fronte a questo scenario, è essenziale saper reagire, puntando su ciò che davvero fa la differenza: la qualità della materia prima, la trasparenza della filiera e il legame con il territorio. È esattamente questa la direzione intrapresa da Centro Carni Company, azienda con sede a Tombolo (PD) e oltre quarant’anni di esperienza nel settore delle carni bovine
. Un modello di filiera responsabile
Centro Carni Company ha costruito nel tempo una filiera certificata e controllata, basata su rapporti consolidati con circa 17 aziende partner, situate principalmente in Veneto, dalle quali transitano oltre 4.000 capi l’anno. Un modello virtuoso che unisce competenze, etica e attenzione alla qualità, con l’obiettivo di offrire al consumatore un prodotto sicuro, sostenibile e tracciabile in ogni fase.
Gli animali, provenienti esclusivamente da allevamenti italiani ed europei selezionati, vengono allevati per almeno quattro mesi in strutture specializzate, nel pieno rispetto dei più elevati standard di benessere animale. Qui
si preserva e si rinnova il sapere della grande tradizione zootecnica italiana, attraverso tecniche raffinate e processi rigorosi che garantiscono un controllo costante su salute, alimentazione e condizioni di vita degli animali.
Trasparenza, formazione e visione:
la forza di un sistema integrato
La Filiera CCC non è solo una catena produttiva, ma un vero e proprio progetto di valorizzazione del territorio, che guarda al futuro puntando su trasparenza, qualità e responsabilità. Un programma rivolto sia al mondo B2B sia ai consumatori finali, pensato per raccontare in modo chiaro l’intero percorso della carne: dalla selezione dell’animale fino alla tavola.
A supporto di questa visione, Centro Carni Company sostiene MEatSCHOOL, una scuola di formazione dedicata al mondo delle carni bovine, con l’obiettivo di trasmettere competenze specializzate e promuovere una nuova cultura della filiera.
In un contesto economico in cui è sempre più difficile mantenere la redditività, quindi, la risposta non può che essere il valore
Centro Carni Company ne è convinta: è nei momenti più difficili che si costruisce il futuro. E continuare a investire in una filiera responsabile, sostenibile e integrata significa non solo affrontare le difficoltà del presente, ma anche creare le basi per un domani più solido, giusto e consapevole.


Ci sono ortaggi che nascono con una vocazione precisa: essere protagonisti del piatto con equilibrio naturale tra carattere e delicatezza. Il Friggitello è uno di questi: verde, croccante, dalla buccia sottile e la polpa soda, il sapore delicato e persistente. È ricco di contenuti nutritivi (vitamine A, C, antiossidanti, fibre) e parte integrante della tradizione culinaria mediterranea. La sua struttura regge bene ogni tipo di cottura e il gusto morbido, mai invadente, fa sì che si presti a interpretazioni classiche o gourmet rendendolo protagonista di piatti di mare e di terra sorprendenti. Noi di Spirito Contadino lo coltiviamo come si faceva un tempo, in pieno campo, raccogliendolo a mano nel momento esatto in cui la polpa è ancora tenera, dolce e croccante. Così il nostro Friggitello “Sapore Antico” conserva intatti i profumi, i colori e la consistenza che raccontano la nostra Puglia.





Il friggitello è un peperone antico arrivato in Europa dopo la scoperta delle Americhe e nel Mediterraneo ha trovato una seconda patria: complice il clima mite e la vocazione agricola si è presto adattato ai campi del Sud Italia. Chiamato anche semplicemente friariello, ha sempre avuto un ruolo imprescindibile nella tradizione: era il segno discreto dell’estate che entrava. Noi di Spirito Contadino ne abbiamo recuperato la varietà più autentica: t utto nasce, cresce e viene lavorato a Borgo Tressanti. È questo legame con il territorio che dà forma al nostro concetto di “conterraneità”: un’identità agricola e culturale che ha una visione concreta. Portare in cucina il Friggitello Sapore Antico significa scegliere un ingrediente che racconta un luogo, un clima, una comunità. Un prodotto autentico, sostenibile e professionale, pensato per gli chef che cercano non solo qualità, ma anche un racconto vero da servire a tavola.

In un tempo in cui la qualità è sinonimo di benessere, Spirito Contadino è la risposta a chi cerca verdure e ortaggi con identità, coltivati con rispetto e pronti all’uso. Offriamo ai professionisti della ristorazione una risorsa naturale per la cucina d’autore, in grado di raccontare la semplicità più raffinata. Ingredienti che non hanno bisogno di eccessi per distinguersi, perché portano con sé tutto ciò che serve: sapore, storia, sicurezza.

Fai esplodere il successo della tua attività!
Con le nostre verdure al naturale e in crosta di farina di grano puoi creare piatti sempre nuovi e accattivanti che ti permetteranno di aumentare il successo del tuo locale. Entra in Conterraneum, la nostra filiera etica che dà valore ad ognuno e aumenta il valore del tuo business. Richiedi il catalogo Spirito Contadino al tuo distributore e scopri le ispirazioni che abbiamo pensato per te.



