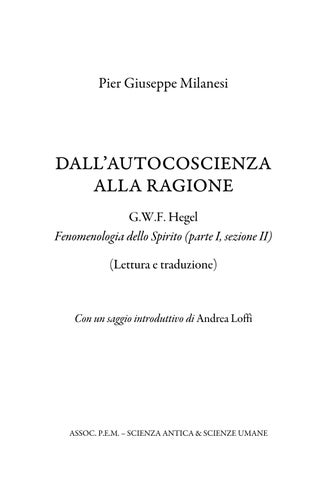ALLA RAGIONE
G.W.F. Hegel
Fenomenologia dello Spirito (parte I, sezione II)
(Lettura e traduzione)
Con un saggio introduttivo di Andrea Loffi
ASSOC. P.E.M. – SCIENZA ANTICA & SCIENZE UMANE
INTRODUZIONE
Hegel e l’ombra del corvo
Metafore per la filosofia
Uno dei tratti peculiari dello stile di Hegel è la mescolanza d’una sfinente tortuosità e succintezza concettuale con scoppi d’umorismo grossier, se non volgare, del quale di seguito riporto un esempio: «Vecchia, le vostre uova sono marce» – dice l’acquirente alla bottegaia. «Cosa?» – ribatte questa – «Le mie uova marce? Marcia sarà lei! Lei viene a dirmi questo delle mie uova? Lei? I pidocchi non hanno divorato suo padre in mezzo alla strada? E sua madre non è forse scappata con i Francesi? E sua nonna non è morta all’ospizio? […] – per lo meno si rattoppi i buchi nelle calze!»1 .
A chiarire la sua faticosissima prosa concorrono pure, oltre all’umorismo, le felici metafore che schiudono l’arida difficoltà d’un paragrafo nella luce immediata d’una rappresentazione: il colpo di pistola nella notte, il banco del macellaio, la notte in cui tutte le vacche sono nere, gli stivali delle sette leghe... Tra queste metafore ce ne sono due, una notissima e l’altra forse meno, che Hegel adopera per rappresentare la filosofia: sono la civetta, ovvero la nottola, e la talpa.
La metafora della civetta si trova in conclusione di quel testo straordinario del 1820 che è la prefazione ai Lineamenti di filosofia del diritto: «la filosofia giunge sempre troppo tardi. In quanto pensiero del mondo essa appare soltanto dopo che la realtà ha compiuto il suo processo di formazione e s’è bell’e assestata […]. Quando la filosofia dipinge il suo grigio su grigio, allora una figura della vita è invecchiata, e con grigio su grigio essa non si
1 G.W.F. Hegel, Chi pensa astrattamente? c/ di F. Valagussa, Edizioni ETS, Pisa 2014, pp. 23, 25.
10 / Dall’Autocoscienza alla Ragione
lascia ringiovanire, ma soltanto conoscere; la nottola di Minerva inizia il suo volo soltanto sul far del tramonto»2 . L’immagine è evocativa; è evidente, almeno fino a un certo punto, la temperie romantica che l’ha generata, col suo parlar di notte, di rovine, e con la sua sobria malinconia. Il senso della metafora è che la filosofia si pone eminentemente nei momenti di frattura tra un’epoca e un’altra, e coi suoi grandi occhi coglie i profili delle figure sommersi dalla tenebra, ne riassume i lineamenti essenziali, li sistematizza, li mette in relazione. La filosofia è la comprensione essenziale d’un mondo che è alla fine.
Va comunque precisato ancora un poco il senso della metafora della civetta, che presenta un curioso rovesciamento dialettico. La filosofia sarebbe per Hegel – così vuole una certa vulgata interpretativa – un disinteressato guardare al mondo, un guardare staccato da un mondo già bell’e fatto – insomma, la filosofia sarebbe per sua natura conservatrice. Sarà Marx, allora, tra l’altro con l’undicesima tesi su Feuerbach, a sostenere che i filosofi hanno fino ad allora soltanto interpretato il mondo, ora tocca di cambiarlo. In realtà, come fa notare Remo Bodei, la civetta compariva sul fregio di una certa rivista “Minerva” che Hegel conosceva fin dai suoi anni giovanili. Quella civetta sovrastava un cartiglio recante il motto leibniziano Die gegenwärtige Zeit ist schwanger mit der Zukunft, il presente è gravido del futuro3 . C’è allora nella metafora la compresenza dell’ovvio elemento guardingo, notturno, rivolto all’indietro, con il meno ovvio – ma per i contemporanei di Hegel il riferimento alla rivista poteva apparire abbastanza immediato –elemento rivolto in avanti, al futuro, al mattino che spunta dopo la notte. E qui entra in gioco la seconda metafora, quella della talpa.
Oltre alla nottola di Minerva, che arriva in ritardo e a cose fatte, delle quali si limita a prendere atto, c’è anche la talpa che arriva in anticipo, seguendo il suo istinto e procedendo cieca nel sottosuolo. Lo spirito, scrive Hegel nelle Lezioni sulla storia della filosofia, «procede incessantemente innanzi, perché soltanto lo spirito è progredire. Spesso sembra che si dimentichi e si smarrisca; ma, opposto interiormente a se stesso, continua a lavorare interiormente, come dice Amleto dello spirito di suo padre: “Hai lavorato bene, brava talpa! ” –, finché, rinfrancato, scuote ora la crosta terrestre, che lo separava dal suo sole, dal suo concetto»4 . Questa metafora significa l’attività spontanea dello spirito, l’operare non ancora riflesso, non ancora
2 G.W.F. Hegel, Lineamenti di filosofia del diritto, c/ di G. Marini, Laterza, Roma-Bari 2012, p. 17.
3 R. Bodei, La civetta e la talpa. Sistema ed epoca in Hegel, Il Mulino, Bologna 2014, pp 22-23.
4 G.W.F. Hegel, Lezioni sulla storia della filosofia, tr. it. E. Codignola e G. Sanna, La Nuova Italia, Firenze 1964, vol. III (2), p. 411.
Introduzione / 11
autocosciente del mondo umano, che però è diretto dall’astuzia dalla ragione, da un istinto che lo guida un po’ alla maniera del demone socratico. L’attività della talpa prepara inconsciamente il nuovo mondo, la nuova epoca, la nuova filosofia, che verrà poi colta dai grandi occhi della nottola.
È curioso come, in entrambe le metafore, la filosofia abbia a che fare con l’assenza di luce: nel buio della notte come nella cecità di gallerie sotterranee. Hegel rovescia così la classica metafora visivo-solare che è abbastanza canonica tanto nella storia della filosofia – la caverna di Platone ne è forse l’esempio più noto – quanto nella storia del pensiero in generale – si pensi all’uso della luce che Dante fa nella Commedia, dove guardar nel sole indica la comprensione della trascendenza.
Viceversa, nelle metafore della civetta e della talpa è l’assenza di luce esteriore il milieu del movimento della ragione – fuori è buio, e dunque è il sole interiore che consente alla filosofia di vedere. Ne parla Remo Bodei, scrivendo: «Con la scomparsa del sole reale, nella notte esteriore, si innalza per contrasto un sole interiore […]. Sole esteriore e sole interiore percorrono dunque traiettorie opposte. Quanto più il primo si abbassa sull’orizzonte, tanto più il secondo sale»5 . La notte dello spirito è filosofia, mentre durante il giorno dello spirito, quando il sole esteriore è alto – quando un mondo è nel suo rigoglio, riconciliato con sé – lo spirito sonnecchia appagato e abboddolito come il contadinod’estate in un passosuperbo delle Opere egiorni di Esiodo: «Quando il cardo fiorisce e la cicala canora dall’albero diffonde il suo canto acuto […] e arido è il corpo per il calore bruciante; allora è il momento di avere una pietra ombrosa e vino di Biblo»6 . Secondo un’altra delle famose metafore hegeliane, i periodi di felicità – quando il sole è alto –sarebbero pagine bianche nel libro della storia.
Continuando dunque su questosegno – sul segno delle metafore animali e tenebrose – vorrei provare ad adoperarne un’altra, che trovo s’addica abbastanza alla filosofia per come l’intendeva Hegel: ed è la metafora del corvo. Ma non d’un corvo qualsiasi, bensì del corvo più famoso della storia della letteratura, più famoso del corvo che viene ultimo nel racconto di Italo Calvino: il Corvo di Edgar Allan Poe – The Raven7 .
5 R. Bodei, La civetta e la talpa. Sistema ed epoca in Hegel, cit., p. 24.
6 Esiodo, Opere e giorni. Lo scudo di Eracle, c/ di S. Romani, Mondadori, Milano 2023, v. 582-596.
7 In un certo senso, si può dire che l’intenzione di questo saggio è un’intenzione chimica: si vuol vedere, cioè, quale reazione si genera mescolando due elementi eterogenei come la filosofia di Hegel e una poesia di Poe. L’intenzione non è dunque, almeno in senso stretto, storico-filosofica: non interessa un’interpretazione corretta di Hegel (qualunque cosa quel corretta significhi) – interessa però certamente un’interpretazione fedele a Hegel (neppure la
G.W.F. Hegel
FENOMENOLOGIA DELLO SPIRITO (PARTE I, SEZIONE II)
Testo originale integrato, traduzione e commento di Pier Giuseppe Milanesi
Autocoscienza. Presentazione.
Quando la coscienza diventa autocoscienza – avendo quindi il proprio stesso Sé come oggetto primario e immediatamente dato – essa accede ad una sfera appartenente alla pura dimensione spirituale entro la quale ora va a ricercare certezze e verità.
Vengono ora superati gli stadi descritti nella sezione precedente – lo stadio della “pura esperienza” del mondo – in cui avevamo una coscienza naturale che si relazionava esclusivamente ad un oggetto esterno diverso da sé, considerato fonte di verità, cercando di afferrarlo, di conoscerlo nel suo essere in sé. La domanda verteva sul “che cos’è?” l’oggetto. In questa sua ricerca l’oggetto diventava sempre più evanescente, sempre più inafferrabile fino a svanire in un universo metafisico. La coscienza, come “sapere-su” si attendeva una verità dall’oggetto. L’oggetto della conoscenza tuttavia svaniva sia nel tentativo di afferrarlo come oggetto della conoscenza sensibile, sia come oggetto sovrasensibile inseguito dall’intelletto che interpretava l’in-sé delle cose come animato da oscuri giochi di forze che, agendo attraverso “leggi” sarebbero in grado di generare gli oggetti della nostra esperienza.
Infine la coscienza scopre che il vero oggetto che si celava nella metafisica della forza era lei stessa e che l’intera realtà era (kantianamente) solo il risultato della proiezione della propria struttura cognitiva sul mondo. Nel cercare tra le cose infine ho trovato me stesso!
L’essenza delle cose non è qualcosa di metafisico da contemplare passivamente, ma è il prodotto dell’attività della nostra conoscenza: il rapporto con il mondo, e perciò con l’oggetto, è un rapporto che io stesso costruisco con la mia attività. Il mondo è lì… per me. Sono io a stabilire in che misura le cose hanno valore e significato in base ai miei progetti di vita, cioè in un contesto primario di autodeterminazione. In tal senso la ricerca di Sé “autentico”, libero da ogni condizionamento e perciò in grado di autodeterminare sé stesso diventa condizione indispensabile per avere accesso alla “verità”, poiché ogni ricerca di una “verità” passa attraverso il “filtro” di una autocoscienza che in realtà sta ricercando solo sé stessa. Non avrò alcuna certezza, se non sarò preventivamente certo di me stesso. Definire lo statuto dell’autocoscienza diventa quindi condizione preventiva per ogni accesso ad ogni successiva conoscenza.
L’oggetto dell’autocoscienza, cioè il suo modo particolare di gestire il rapporto con il mondo, si distingue dunque dal tipo di relazione così come si poneva la semplice e passiva “coscienza” (un mondo di pura esperienza) – trattato nella prima sezione della Fenomenologia – per questa sua caratteristica e cioè perché incluso in un progetto di realizzazione di sé o in un progetto di vita. Viene superato il semplice rapporto contemplativo con il mondo a vantaggio di un rapporto costruttivo che coincide con un progetto di costruzione del proprio Sé. Ed è facilmente intuibile che, in questo progetto di ricerca di sé,
42 / Dall’Autocoscienza alla Ragione
l’oggetto che l’autocoscienza per prima cosa andrà a ricercare in grado di concorrere alla costruzione del proprio Sé sarà un’altra autocoscienza.
L’autocoscienza nasce da uno “sguardo vuoto” su un mondo in cui ha visto svanire in un aldilà metafisico tutti gli oggetti che cercava di afferrare nella loro essenza e in cui riponeva la ricerca della verità e la fonte delle proprie certezze. Il suo Io, questo risultato residuale, la solitudine dell’essere-per- sé, è ora una unità vaga e astratta in cui trova spazio il desiderio di essere riempita di contenuti, di avere una identità da costruire, supportata in questo processo da un’altra autocoscienza che si trova nella stessa situazione.
Il desiderio.
Dal momento che l’oggetto mondano – oggetto preventivamente sottoposto all’indagine da parte della conoscenza sensibile, della percezione e poi dell’intelletto – che in precedenza veniva visto dalla coscienza naturale come un luogo in cui ricercare “verità”, ora entra a far parte di un progetto di vita, l’oggetto mondano si trasforma in un oggetto del desiderio e come tale degno di essere solo consumato e goduto. Non è più un rapporto semplicemente contemplativo o teoretico, ma tendente ad appropriarsi dell’oggetto trasformandolo in una propria sostanza, così come avviene per ogni organismo. La modalità con cui l’autocoscienza si relaziona all’oggetto è il desiderio. Il desiderio è però anche la forma iniziale in cui si presenta in prima istanza il conflitto interno all’autocoscienza tra dipendenza e libertà. Tutto il percorso evolutivo dell’autocoscienza è pervaso da questa interna tormentosa conflittualità tra dipendenza e indipendenza, e segnato dalla mala sorte per cui non si dà mai l’una senza l’altra. Già a partire dal desiderio. L’oggetto del desiderio è rappresentato da una cosa semplicemente indipendente ascrivibile all’ordine delle cose appartenenti alla natura, destinate ad essere consumata e goduta, inglobata nel Sé. L’autocoscienza è quindi inizialmente una unità organica, immersa nella vita e quindi oppressa da un giogo di oneri e bisogni che, pur assolti con indifferente routine (così come avviene nel mondo animale), gravano invece sul senso di libertà dello spirito nascente chiamato ad emergere con prepotenza dal sonno della natura. In questo senso si pone anche il fondamentale conflitto tra l’autocoscienza e la vita: la vita, di cui l’autocoscienza come identità organica non può comunque fare a meno, si tramuta in realtà in un peso, in una condizione di dipendenza, nella misura in cui comprime l’autocoscienza entro i limiti e le costrizioni imposti dalla natura, al punto da spingere l’individuo a liberarsi anche della vita qualora tali costrizioni siano diventate opprimenti, tali da inibire l’esercizio della sua libertà.
L’autocoscienza, come iniziale identità biologica, si rapporta quindi negativamente nei confronti del mondo della vita, che tende dunque a far proprio, a
consumare ricavando godimento, ad annullare nella sua essenza, affermando in tal modo il suo primato, il suo essere-per-sé. Tutto ciò che esiste, esiste in sua funzione. Attraverso la soddisfazione del desiderio (l’appagamento) l’autocoscienza, in quanto identità biologica, conquista una prima forma di libertà e indipendenza: una “verità” di sé stessa, ossia un senso di pienezza del Sé, di soddisfazione di sé; tuttavia destinato presto ad andare perduto, di fronte al desiderio e al bisogno che sempre si rinnova. In questo primitivo scenario, la sfera del desiderio rappresenta dunque un punto critico e conflittuale; perché il desiderio, mentre consente all’autocoscienza di far proprio l’oggetto traendone massimo godimento e pienezzadi sé, dall’altro vincola l’autocoscienza all’eterno bisogno e dipendenza da un oggetto che non è lei stessa. L’indipendenza si trasforma in dipendenza.
Essa si trova nella contraddizione di annientare l’oggetto del suo stesso desiderio per conseguire la certezza di sé stessa. Però l’annientamento dell’oggetto comporta ciclicamente la perdita di quella certezza: allora il desiderio, la mancanza di sé, nuovamente si riproduce e lo stesso oggetto sempre ricompare nella sua indelebile esistenza, come alcunché di estraneo sempre da sopprimere, da “negare”. Dagli oggetti naturali l’autocoscienza non ricava dunque la sua libertà, ma piuttosto la conferma della sua servitù dal bisogno.
Questa conflittualità spingerà l’autocoscienza a compiere un ulteriore passaggio “dalla natura allo spirito”, ossia a costruirsi una diversa forma di identità e di percezione di sé, non più come semplice identità biologica, bensì come identità spirituale o “sociale”. È in questo contesto che entra in gioco un’altra autocoscienza, quale nuovo oggetto, che concorre alla costruzione di quella nuova identità.
Come si è detto, l’autocoscienza, nel suo astratto concetto, nasce come una unità esclusiva, autoreferenziale – o “negativa” secondo il linguaggio del testo. È una unità che conosce e si orienta nel mondo nella misura in cui conosce sé stessa: ciò che crede o desidera essere o vuole essere e quali obiettivi intende perseguire. Tuttavia nessuno è in grado di stabilire a priori chi egli sia veramente, ed in ogni caso chiunque, nel realizzare sé stesso, non è spinto a perseguire obiettivi che non siano obiettivi anche condivisi. Nel rapporto immediato con sé stesso ciascuno si percepisce solo come un vuoto Io ed è spinto a ricercare sé stesso in un altro, come alcunché di concreto e reale, o fonte di “verità” su sé stessi. L’autocoscienza nasce quindi già come alienata, o come un “vedere-séstessa-in-altro”, o “fuori di sé” – come luogo in cui si deposita la sua essenza oggettiva o la sua verità su sé stessa.
Il desiderio spinge quindi la coscienza a ritrovare sé stessa non più in un oggetto semplicemente da consumare, ripristinando una identità solo biologica, ma si traduce in una spinta a ottenere unacertezza di sé in quanto autocoscienza in senso proprio attraverso un'altra autocoscienza, vale a dire attraverso un altro particolare “oggetto” che abbia gli strumenti sufficienti per avvalorare le sue scelte, i suoi orientamenti, i suoi progetti di vita ecc. Nessun altro oggetto
44 / Dall’Autocoscienza alla Ragione
inanimato o animato può essere in grado di far questo, se non un’altra autocoscienza, con la quale avviare un processo di reciproco riconoscimento che comunque si rivelerà anch’esso assai complicato.
Lo
spirito. Il Noi.
Se è nella natura dello spirito conoscere sé stesso – il suo modo di “diventare” reale – in questa specularità dell’autocoscienza, in questo ritrovare sé stessi in un altro, è già presente il concetto e la vita dello spirito, come realtà universale – la presenza del Noi – che nel progresso evolutivo della coscienza, si fa strada, emergendo dalla oscurità della natura. Lo spirito quindi traluce e incomincia “a camminare alla luce del giorno” diventando presente a sé stesso nella modalità del ricercarsi delle due autocoscienze nella prospettiva di un loro reciproco riconoscimento superando la distanza tra l’Io e l’Altro. Superando questa divisione sul piano individuale, lo spirito, quale soggetto del movimento storico universale, va compiendo un passo decisivo verso la sua traduzione in una realtà concreta e sostanziale che prende forma nella complessità di un sistema sociale e di una cultura. Essendo la singola autocoscienza (accentrata sull’Io, in quanto atomo spirituale) un elemento costitutivo che concorre a comporre la superiore unità dello spirito (cioè il Noi in cui una molteplicità di individui si riconoscono) essa è sempre in un rapporto di attrazione e dipendenza da parte di un’altra autocoscienza: è un ricercarsi costante dell’uno nell’altro. Tanto è attratta verso sé stessa, quanto è respinta fuori di sé nella braccia dell’altro. L’attrazione è anche repulsione. Nessuna autocoscienza può mai trovare una piena ragion d’essere solo in sé stessa.
L’autocoscienza è autocoscienza per un’autocoscienza. Solo per tale tramite essa è in effetti autocoscienza, perché solo in tal modo si produce per lei l’unità con sé stessa nel suo essere-altro. L’Io, l’oggetto del suo concetto, in realtà non è un oggetto; mentre d’altro canto l’oggetto del [suo] desiderio non è nient’altro che qualcosa di indipendente essendo la sostanza universale inestinguibile, l’essenza fluida uguale a sé stessa. Quando invece l’oggetto è un’autocoscienza, questa è tanto Io che oggetto. Con ciò, per noi, è già presente il concetto dello spirito. Ciò che la coscienza andrà in seguito a fare è l’esperienza di ciò che lo spirito è –quale sostanza assoluta che, nella piena libertà e indipendenza del suo opposto, cioè di una diversa autocoscienza che è per sé – ne è la loro
unità. L’Io diventa Noi e il Noi l’Io. La coscienza ha solo nell’autocoscienza, in quanto è il concetto dello spirito, il suo punto di svolta a partire dal quale, uscita dalla scintillante immanente appariscenza del mondo sensibile e dalla vacua trascendente notte del mondo sovrasensibile, prende a camminare nella luce spirituale del presente.
[Es ist ein Selbstbewusstsein für ein Selbstbewusstsein. Erst hiedurch ist es in der Tat; denn erst hierin wird für es die Einheit sei-ner selbst in seinem Anderssein; Ich, das der Gegenstand seines Begriffs ist, ist in der Tat nicht Gegenstand; der Gegenstand der Begierde aber ist nur selbstständig, denn er ist die allgemeine un-vertilgbare Substanz, das fluessige sichselbstgleiche Wesen. Indem ein Selbstbewusstsein der Gegenstand ist, ist er ebensowohl ich wie Gegenstand. Hiemit ist schon der Begriff des Geistes für uns vor-handen. Was für das Bewusstsein weiter wird, ist die Erfahrung, was der Geist ist, diese absolute Substanz, welche in der vollkom-menen Freiheit und Selbstständigkeit ihres Gegensatzes, nämlich verschiedener für sich seiender Selbstbewusstsein, die Einheit der-selben ist; Ich, das Wir, und Wir, das Ich ist. Das Bewusstsein hat erst in dem Selbstbewusstsein, als dem Begriffe des Geistes, seinen Wendungspunkt, auf dem es aus dem farbigten Scheine des sinnli-chen Diesseits, und aus der leeren Nacht des übersinnlichen Jen-seits in den geistigen Tag der Gegenwart einschreitet.]
L’intreccio girevole. Essere-per-sé, ma solo nell’essere-peraltro (e viceversa).
L’autocoscienza che in quanto puro Io è inizialmente solo una vuota, astratta, immediata unità con sé stessa, giunge pertanto ad acquisire spessore e determinatezza e a riconoscersi effettivamente per ciò che è, non attingendo alle sue risorse naturali o alla soddisfazione immediata dei propri bisogni biologici, bensì solo se il suo “sistema di valori”, il suo “credere di essere” ecc. viene riconosciuto da un’altra. In altri termini: la propria identità è una identità sociale o una costruzione sociale. Ma come avviene una siffatta “costruzione”?
Non si traduce certamente in semplice ossequiare, ma in un intreccio complicato di rapporti speculari che la dialettica cerca di schematizzare in una formula logica, in cui ogni opposto deve il suo essere-sé-stesso al proprio opposto.