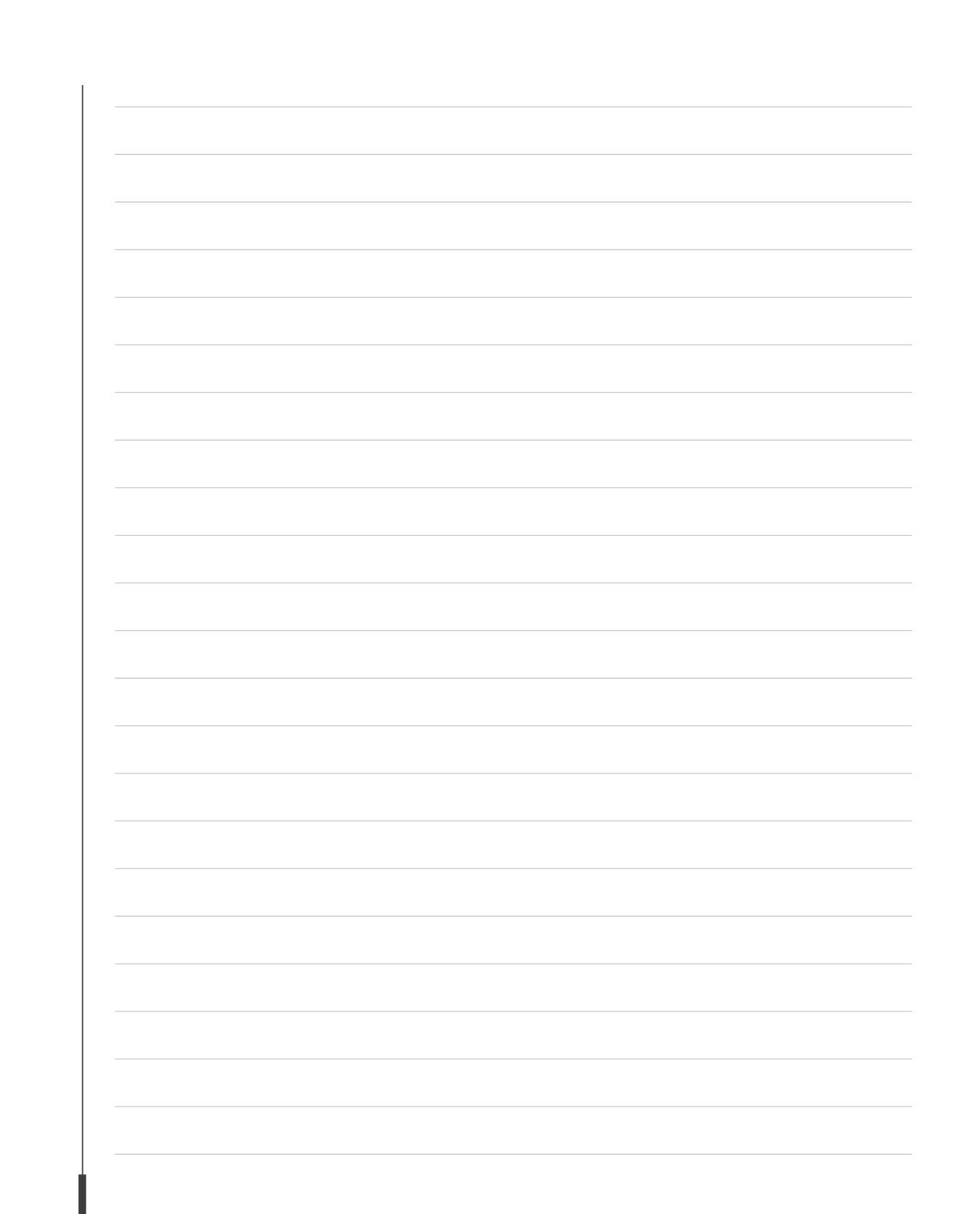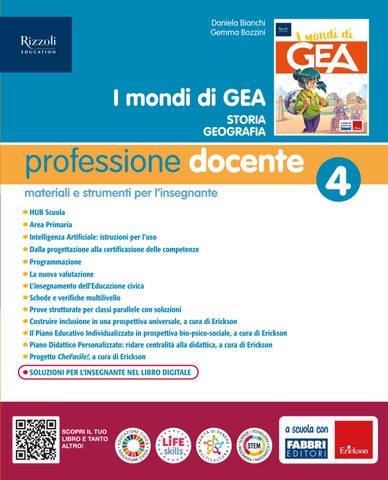professione docente materiali
e strumenti per l’insegnante
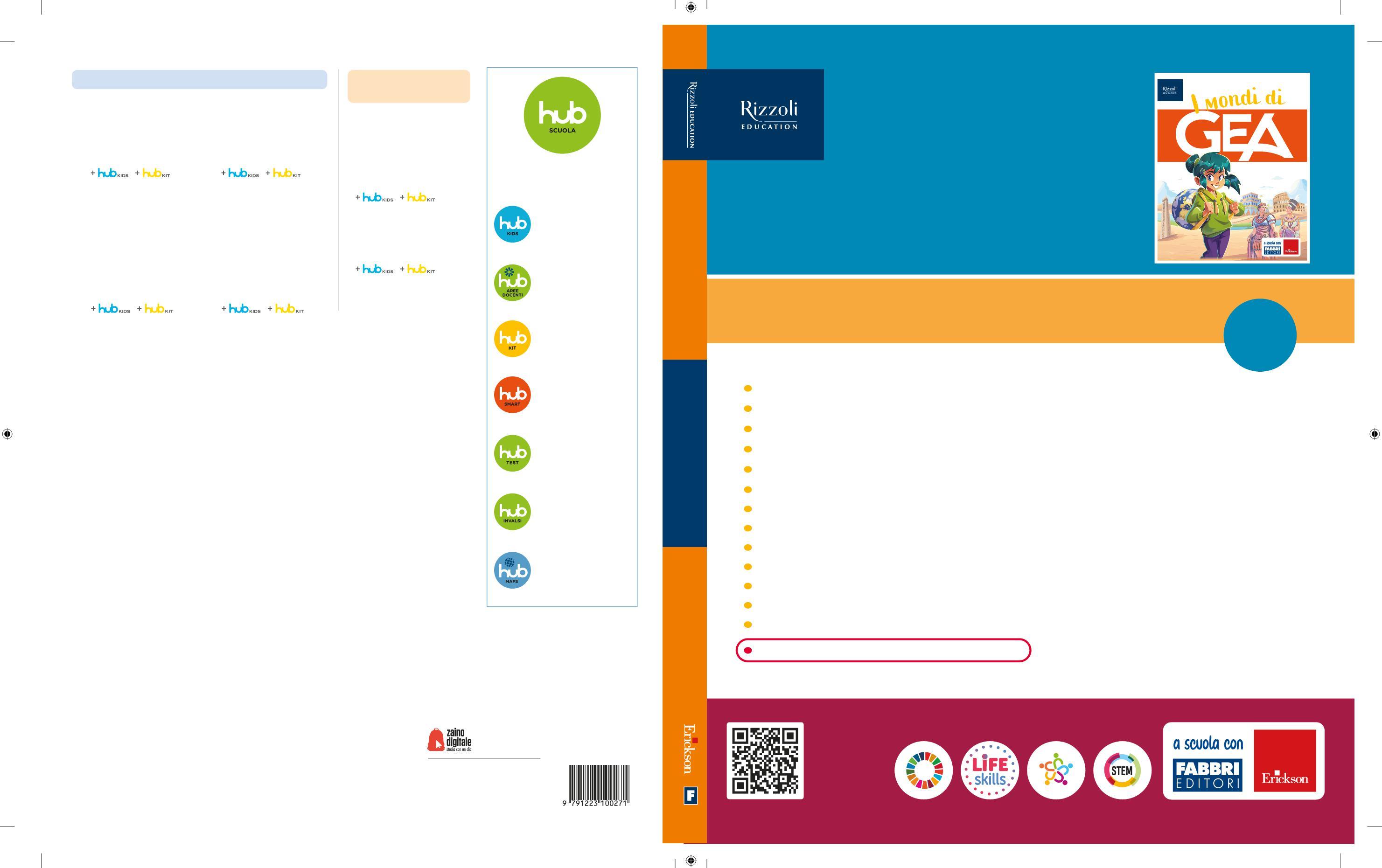
4
HUB Scuola
Area Primaria
Intelligenza Artificiale: istruzioni per l’uso
Dalla progettazione alla certificazione delle competenze
Programmazione
La nuova valutazione
L’insegnamento dell’Educazione civica
Schede e verifiche multilivello
Prove strutturate per classi parallele con soluzioni
Costruire inclusione in una prospettiva universale, a cura di Erickson
Il Piano Educativo Individualizzato in prospettiva bio-psico-sociale, a cura di Erickson
Piano Didattico Personalizzato: ridare centralità alla didattica, a cura di Erickson
Progetto CheFacile!, a cura di Erickson
SOLUZIONI PER L‘INSEGNANTE NEL LIBRO DIGITALE
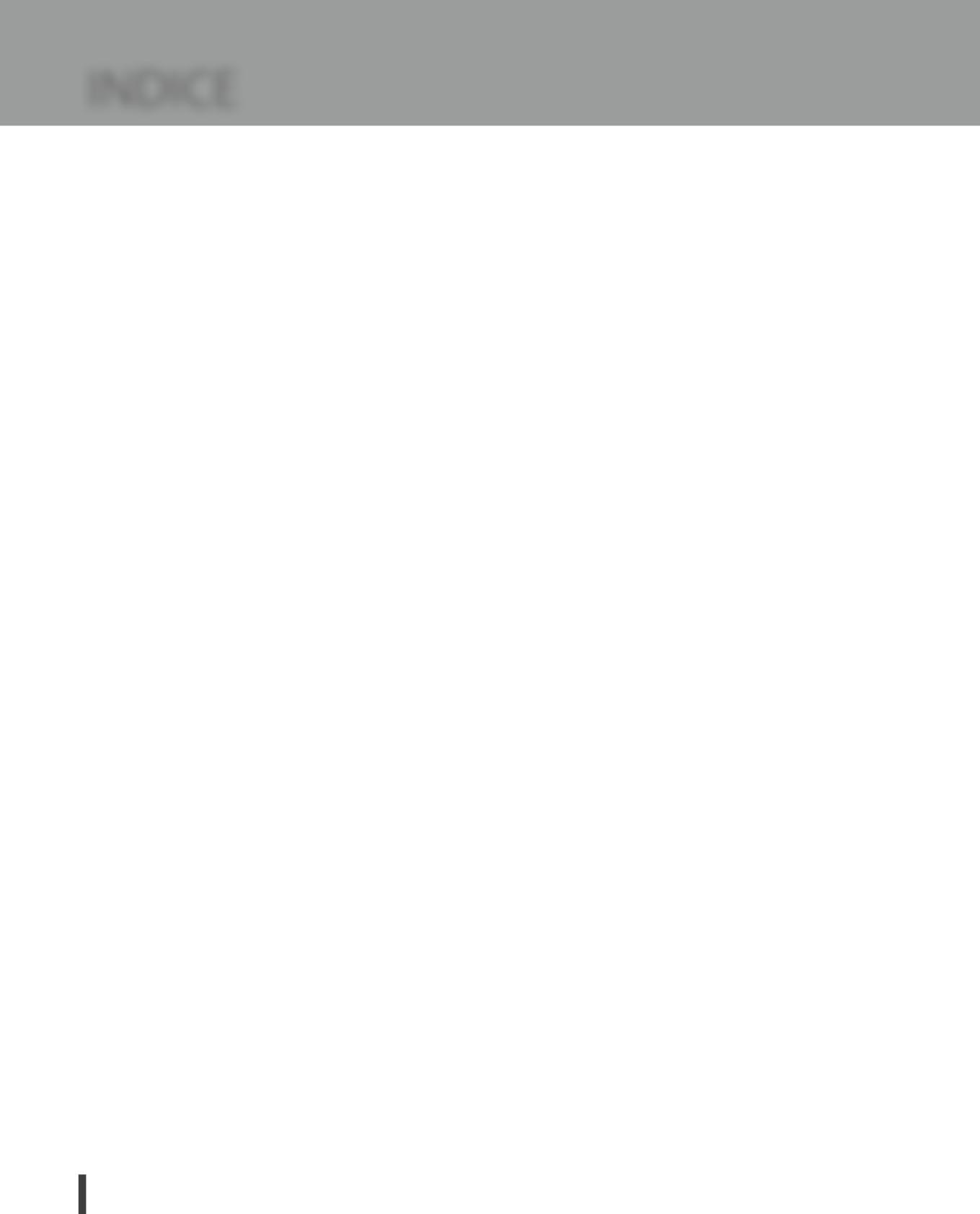
La civiltà
Una
La civiltà cinese
Un’invenzione dei cinesi: la carta
Le civiltà dei fiumi a confronto
La civiltà cretese
La leggenda del Minotauro
La civiltà fenicia
Gli
Regole
Popoli
Geografia
Le
Le
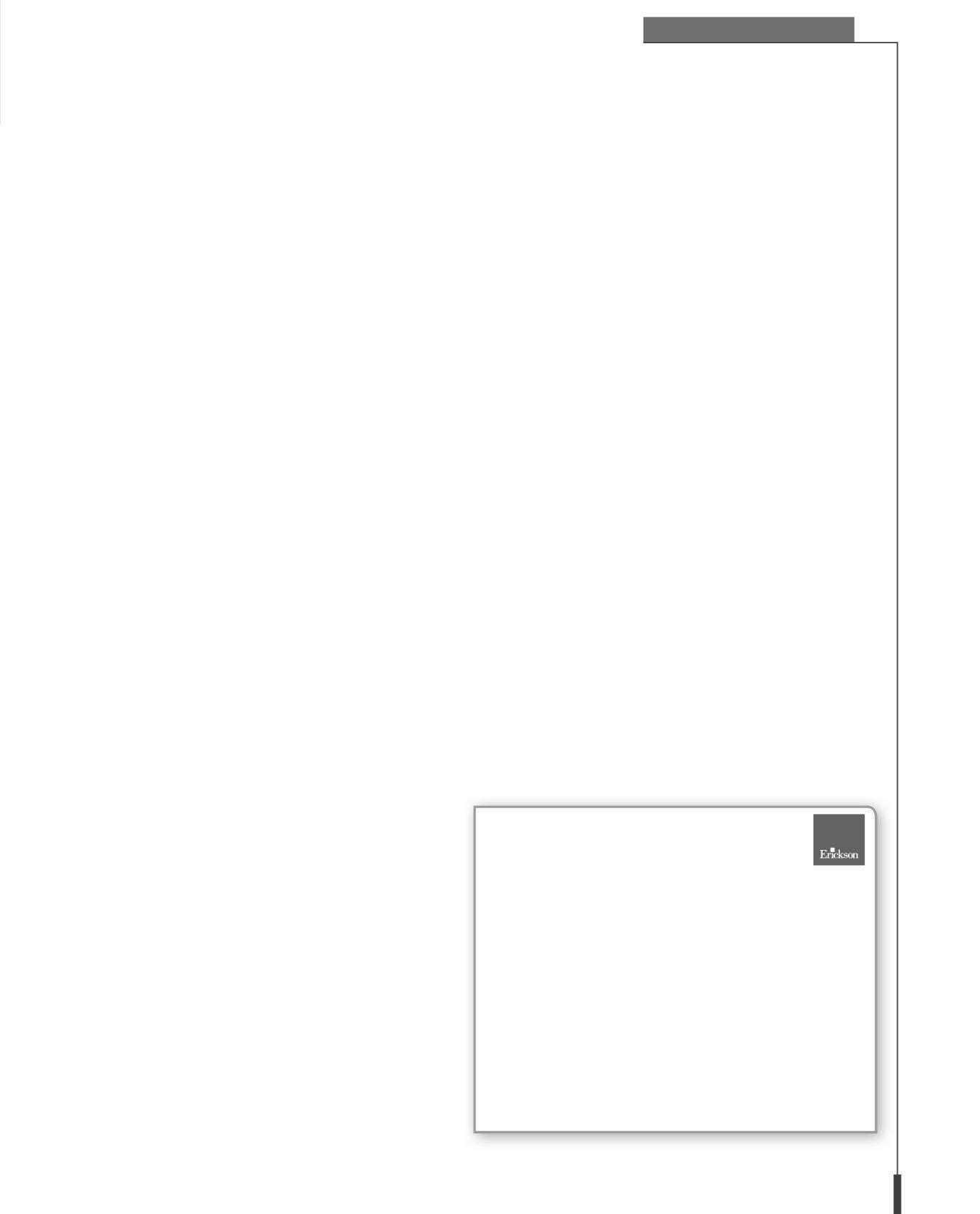
Le
Le
Il
Parchi
Le isole Tremiti
L’Italia, gli Italiani, le italiane e il lavoro 167
Il lavoro nel tempo 169
PROVE STRUTTURATE PER CLASSI PARALLELE DI STORIA E GEOGRAFIA 171
Prova d’ingresso di Storia 173
Prova intermedia di Storia 175
Prova finale di Storia 177
Prova d’ingresso di Geografia 179
Prova intermedia di Geografia 181
Prova finale di Geografia 183
Prova d’ingresso di Storia con soluzioni 185
Prova intermedia di Storia con soluzioni 187
Prova finale di Storia con soluzioni 189
Prova d’ingresso di Geografia con soluzioni
Prova intermedia di Geografia con soluzioni
Prova finale di Geografia con soluzioni
CONTRIBUTI E PERCORSI A CURA
DI RICERCA E SVILUPPO ERICKSON
Costruire inclusione in una prospettiva universale 198
Il piano educativo individualizzato in prospettiva bio-psico-sociale 203
Piano didattico personalizzato: ridare centralità alla didattica 209
I materiali per la didattica inclusiva
ne I mondi di Gea Storia e Geografia 211
Progetto CHEFACILE!
Vivere
Accendi la conoscenza con HUB Scuola
Nuova, intuitiva, dinamica.
HUB Scuola è la piattaforma che accompagna docenti, studentesse e studenti nel loro percorso educativo. Sempre più ricca di risorse, lezioni e strumenti per una didattica digitale efficace e coinvolgente, è l’alleata ideale per le sfide di ogni giorno.
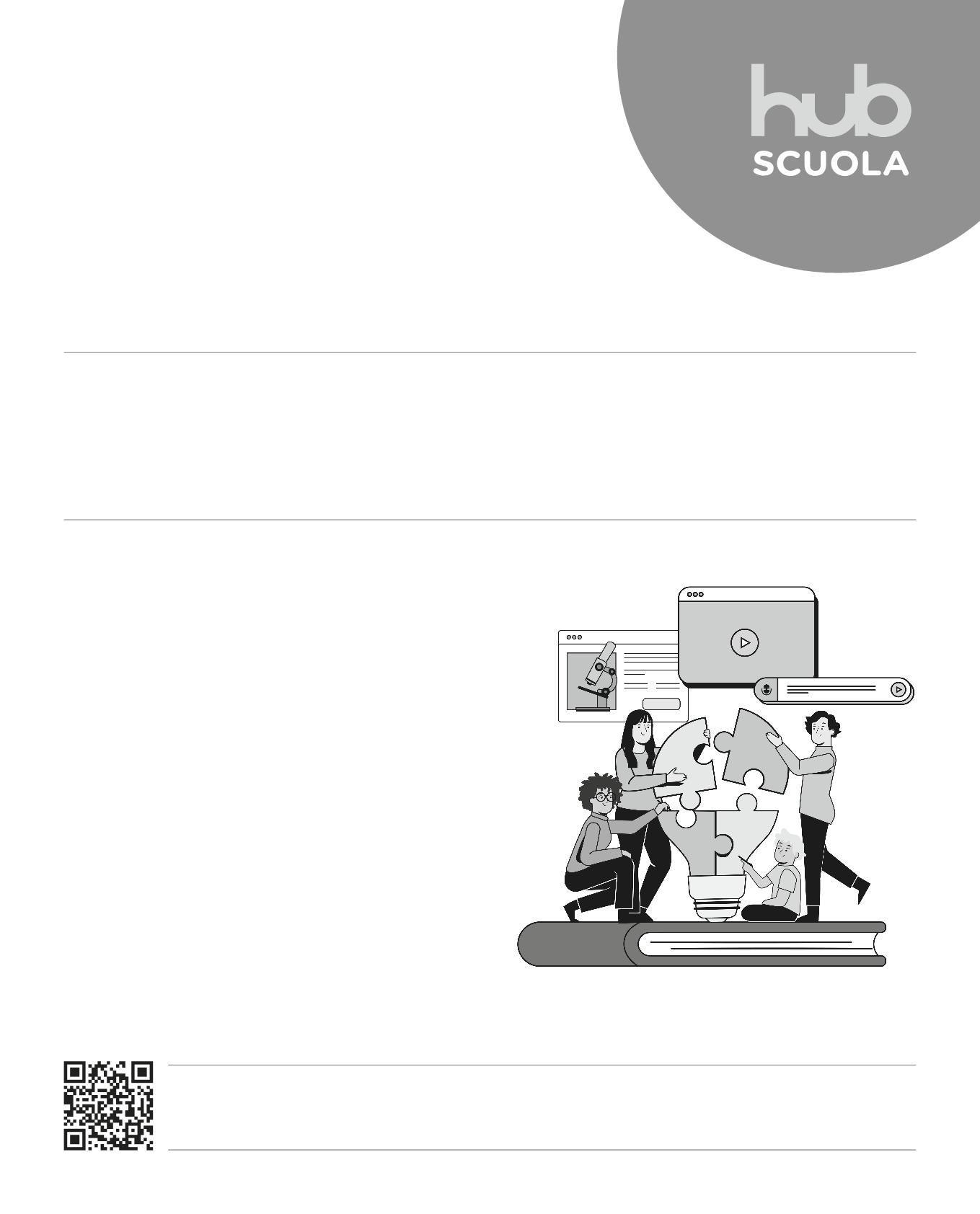
Tutta l’autorevolezza di Mondadori Education, Rizzoli Education e Deascuola in un solo ambiente digitale: HUB Scuola rappresenta la sinergia di tre grandi editori attenti alle esigenze di una scuola in continua evoluzione.
Esplora il Sito libro, il luogo dove i tuoi libri prendono vita Qui puoi immergerti nella versione digitale dei volumi e scoprire tutti i materiali, le app e gli strumenti correlati.
Se sei docente, nelle Aree Docenti trovi l’ambiente perfetto per personalizzare le lezioni grazie a proposte, approfondimenti e strumenti specifici per ogni tua materia.
Anche la sezione Test e Verifiche è una miniera di risorse: gli studenti vi trovano materiali per esercitarsi, mentre i docenti possono attingere a vasti database e creare test per ogni materia e grado scolastico.
HUB Scuola ti offre i contenuti digitali dei tre editori, integrati in un’unica piattaforma e accessibili con un’unica email e password Entra in HUB Scuola!
Scopri di più su HUB Scuola inquadrando il QR code.
www.hubscuola.it
Scopri un mondo di risorse su misura per te

Aree Docenti
Percorsi didattici e materiali pronti all’uso per ogni materia che insegni.
Sito libro
La versione digitale del tuo libro cartaceo, con tutti i contenuti extra.
Test e Verifiche
Un ampio database di quesiti ed esercizi per creare verifiche e allenarsi.
PRESENTAZIONE DEL CORSO
Il corso
I mondi di Gea è il nuovo Sussidiario delle discipline Fabbri-Erickson, realizzato seguendo le più recenti linee guida e indicazioni ministeriali.
Il corso è nato dalla collaborazione tra Rizzoli Education ed Erickson per facilitare l’accesso all’apprendimento da parte di tutti gli alunni e tutte le alunne, anche quelli con BES, creando un punto di contatto tra la didattica di classe e la personalizzazione/ individualizzazione dell’apprendimento.
Il Sussidiario propone un percorso strutturato e completo per sviluppare le competenze e fornire un valido metodo di studio, oltre che strumenti e strategie per l’apprendimento integrati e diversificati.
Il Sussidiario I mondi di Gea è suddiviso in quattro volumi base. Più pagine, attività e approfondimenti in… uno zaino più leggero! Per ogni disciplina, infatti, la parte di Sussidiario è unita a quella del relativo eserciziario. In questo modo, ogni alunno e alunna ha a disposizione volumi completi, integrati, ma compatti. Può studiare e fare le prime attività operative, esercitarsi in maniera più approfondita… tutto senza mai cambiare strumento, con anche l’ausilio dei puntuali rimandi interni ai volumi.
Composizione del corso
Per alunne e alunni
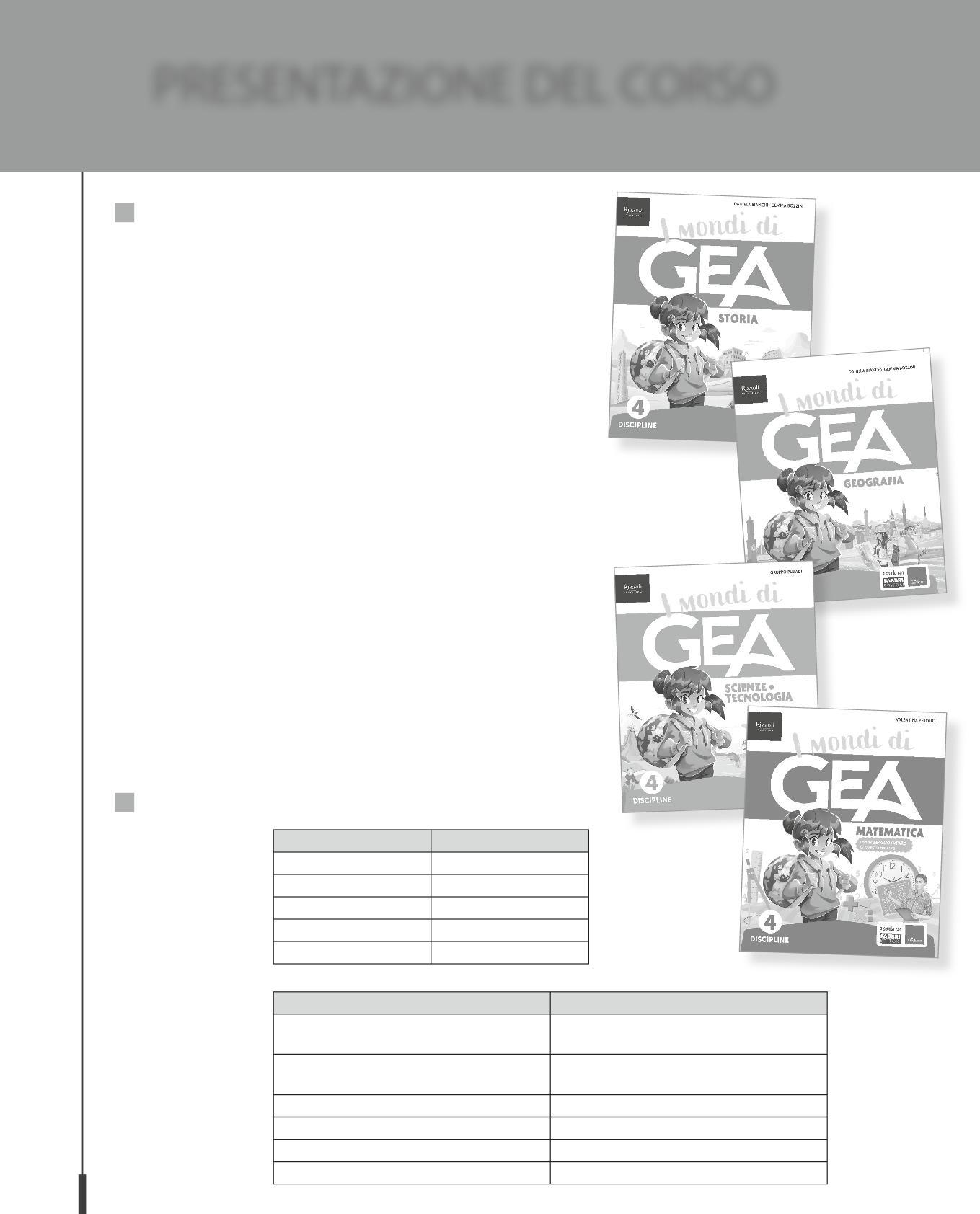
Per l’insegnante e la classe
CLASSE 4
Matematica 4
CLASSE 5
Matematica 5
Scienze e Tecnologia 4Scienze e Tecnologia 5
Storia 4
Storia 5
Geografia 4 Geografia 5
HUB Kit + HUB Kids HUB Kit + HUB Kids
CLASSE 4
Guida professione docente - Matematica e Scienze e Tecnologia 4
Guida professione docenteStoria e Geografia 4
Che facile! Saperi di base 4
Che facile! Matematica 4
CLASSE 5
Guida professione docente - Matematica e Scienze e Tecnologia 5
Guida professione docenteStoria e Geografia 5
Che facile! Saperi di base 5
Che facile! Matematica 5
LE CARATTERISTICHE DEL VOLUME DI STORIA
STORYTELLING
Tutte le unità sono introdotte da una doppia pagina di storytelling di Giorgia Cappelletti, a cura di Erickson. La narrazione favorisce l’apprendimento disciplinare. Le storie permettono di attivare quello che bambine e bambini sanno già a un livello non strutturato, coinvolgono, motivano, interessano, stimolano le emozioni. Sono un modo in più per differenziare la didattica e raggiungere il maggior numero di bambini e bambine.

APERTURE DI UNITÀ
Ogni civiltà è presentata con una doppia pagina di apertura che permette di inquadrare le civiltà e osservarne i principi indicatori in maniera semplice e piacevole con grandi foto, carte geostoriche e linee del tempo.
QUADRI DI CIVILTÀ
Ogni civiltà è presentata con i quadri di civiltà, cioè la ricostruzione del modo di vivere delle varie popolazioni attraverso gli aspetti più importanti, i cosiddetti indicatori di civiltà: chi, dove, quando, società, attività, religione, conoscenze e invenzioni.
METODO DI STUDIO E LIFE SKILLS
Tre percorsi operativi integrati tra loro
(Imparo con metodo, Imparo con competenza, Impariamo insieme) pensati, insieme a Erickson, per far acquisire un primo metodo di studio.
Imparo con metodo è fatto di operative rubricate (parole speciali, analizzo, ricostruisco, espongo) che propongono un vero e proprio metodo per la comprensione del testo espositivo.
Imparo con competenza presenta attività su competenze disciplinari specifiche: fa lavorare, per esempio, su carte, illustrazioni, testi disciplinari, fonti.
Impariamo insieme presenta attività cooperative strutturate e guidate.
LIFE SKILLS sono attività da svolgere da soli, in coppia o in piccolo gruppo che stimolano lo sviluppo delle competenze per la vita come il pensiero critico e creativo.
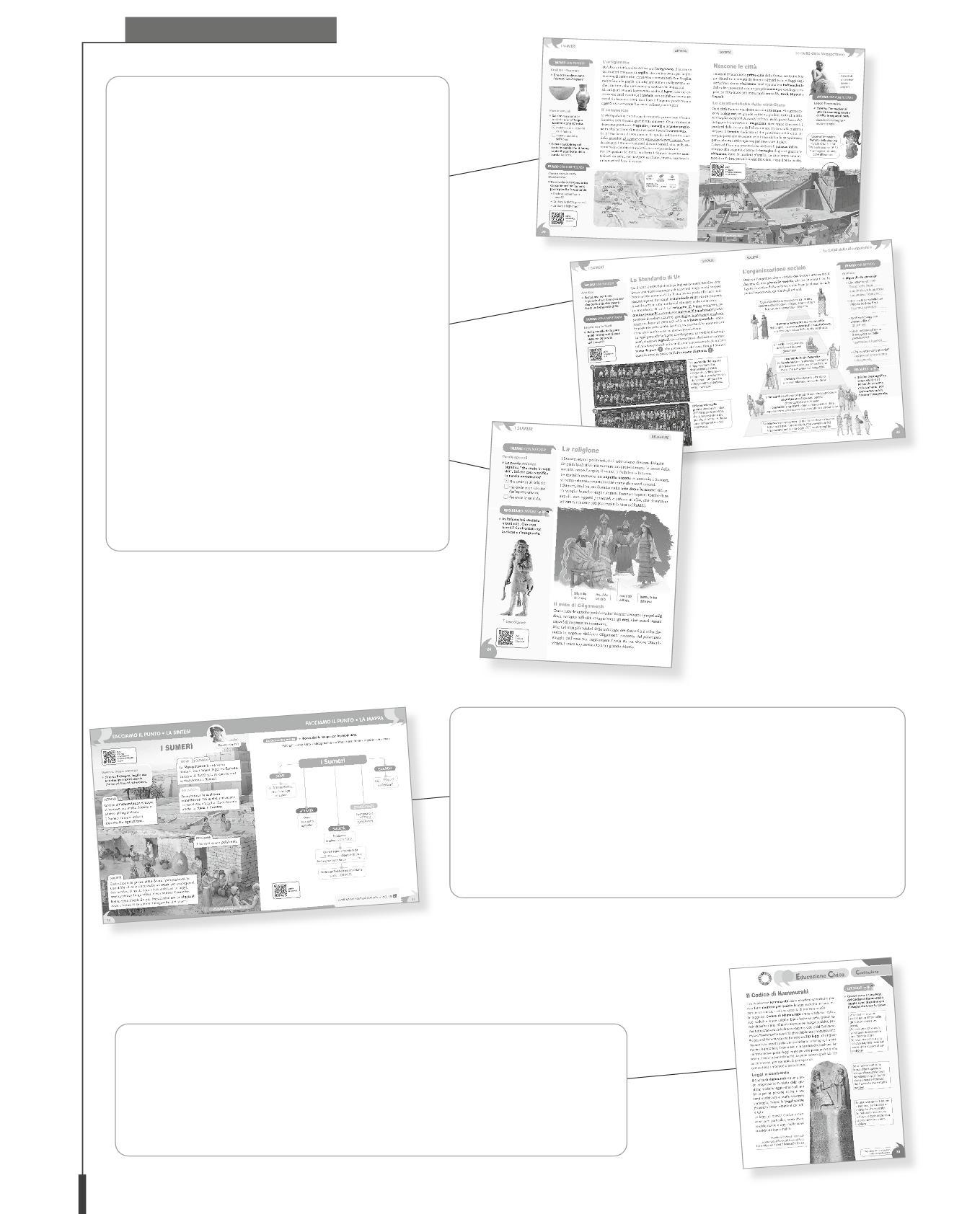
SINTESI E MAPPE DI FINE UNITÀ
Al termine di ogni unità si trova un apparato didattico di sintesi e verifica. Con questi strumenti ogni bambino e bambina, indipendentemente dal livello e da eventuali difficoltà, può iniziare a fissare gli apprendimenti seguendo e rispettando le proprie caratteristiche. Si inizia con una sintesi visiva o testuale accompagnata da immagini e si prosegue con una mappa da completare.
LA NUOVA EDUCAZIONE CIVICA
I mondi di Gea segue le più recenti linee guida per l’insegnamento dell’Educazione civica alla scuola primaria e introduce un breve ma esaustivo percorso dedicato all’Educazione finanziaria adattando gli argomenti all’età di alunni e alunne.
STEM Education
Le discipline STEM sono importantissime per la crescita e per il futuro di tutti noi e del nostro pianeta. Ne I mondi di Gea troviamo laboratori STEM e/o STEAM in tutte le materie.
COMPITI AUTENTICI
Nel volume sono presenti Compiti autentici per mettere alla prova le proprie conoscenze e competenze in ambito storico.
MI ESERCITO IN…
Ne I mondi di Gea l’eserciziario, integrato nel volume, è uno strumento ricco di schede e materiali adatti a tutte le esigenze della classe.
LE MIE MAPPE • RIPASSA CON GEA
Le prime pagine dell’eserciziario sono dedicate a mappe mentali utili per il ripasso e per fissare gli argomenti, dove sono riassunte le principali informazioni sulle civiltà. La sezione è a cura di Erickson.
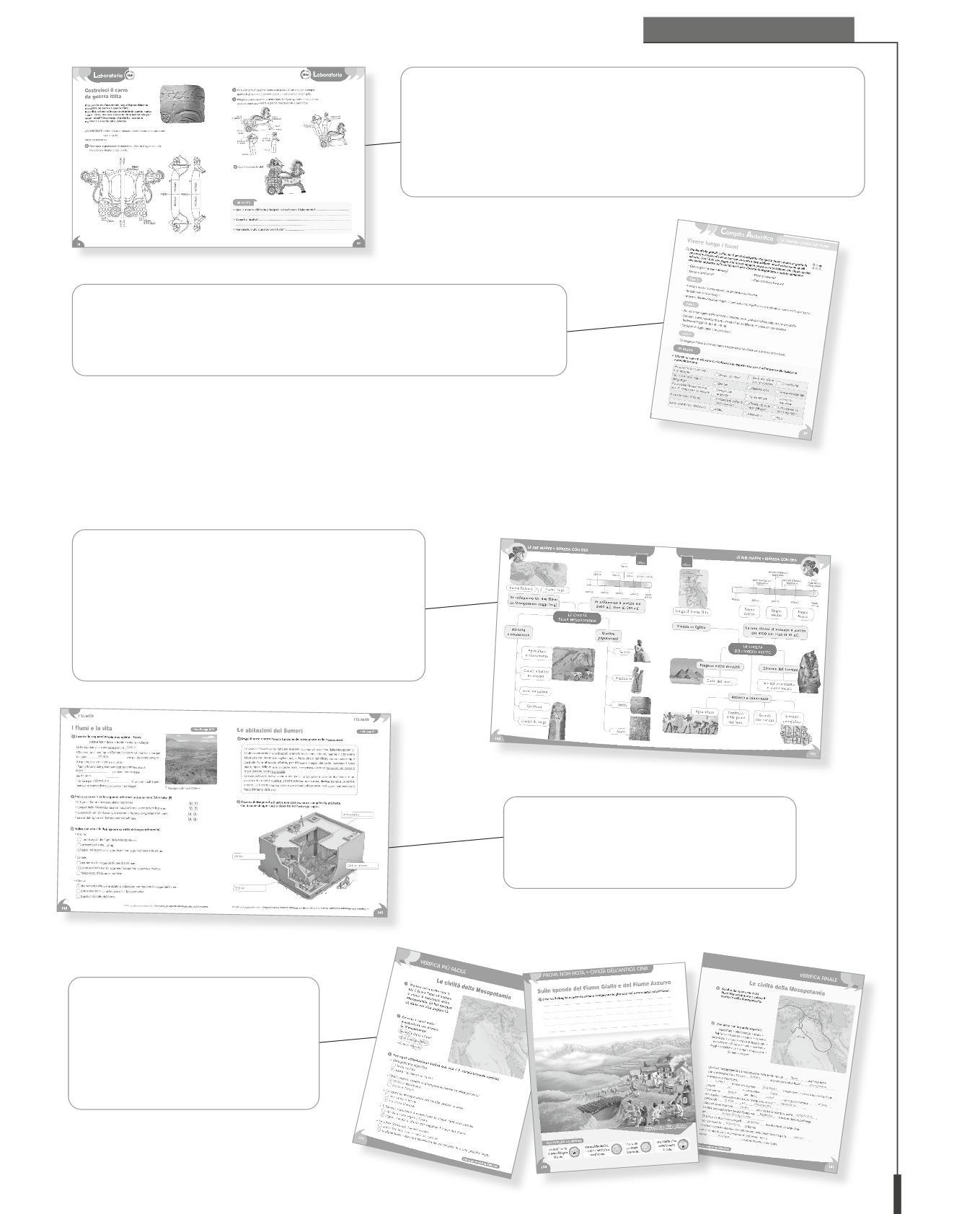
VERIFICHE MULTILIVELLO
Per ogni argomento affrontato sono presenti verifiche a livelli: PIÙ FACILE, FINALE e PROVA NON NOTA.
SCHEDE ESERCIZI
Approfondimenti ed esercizi dedicati alle civiltà.
STORYTELLING
Tutte le unità sono introdotte da una doppia pagina di storytelling di Giorgia Cappelletti, a cura di Erickson.
La narrazione favorisce l’apprendimento disciplinare. Le storie proposte permettono di attivare quello che bambine e bambini sanno già a un livello non strutturato, coinvolgono, motivano, interessano, stimolano le emozioni. Sono un modo in più per differenziare la didattica e raggiungere il maggior numero di bambini e bambine.
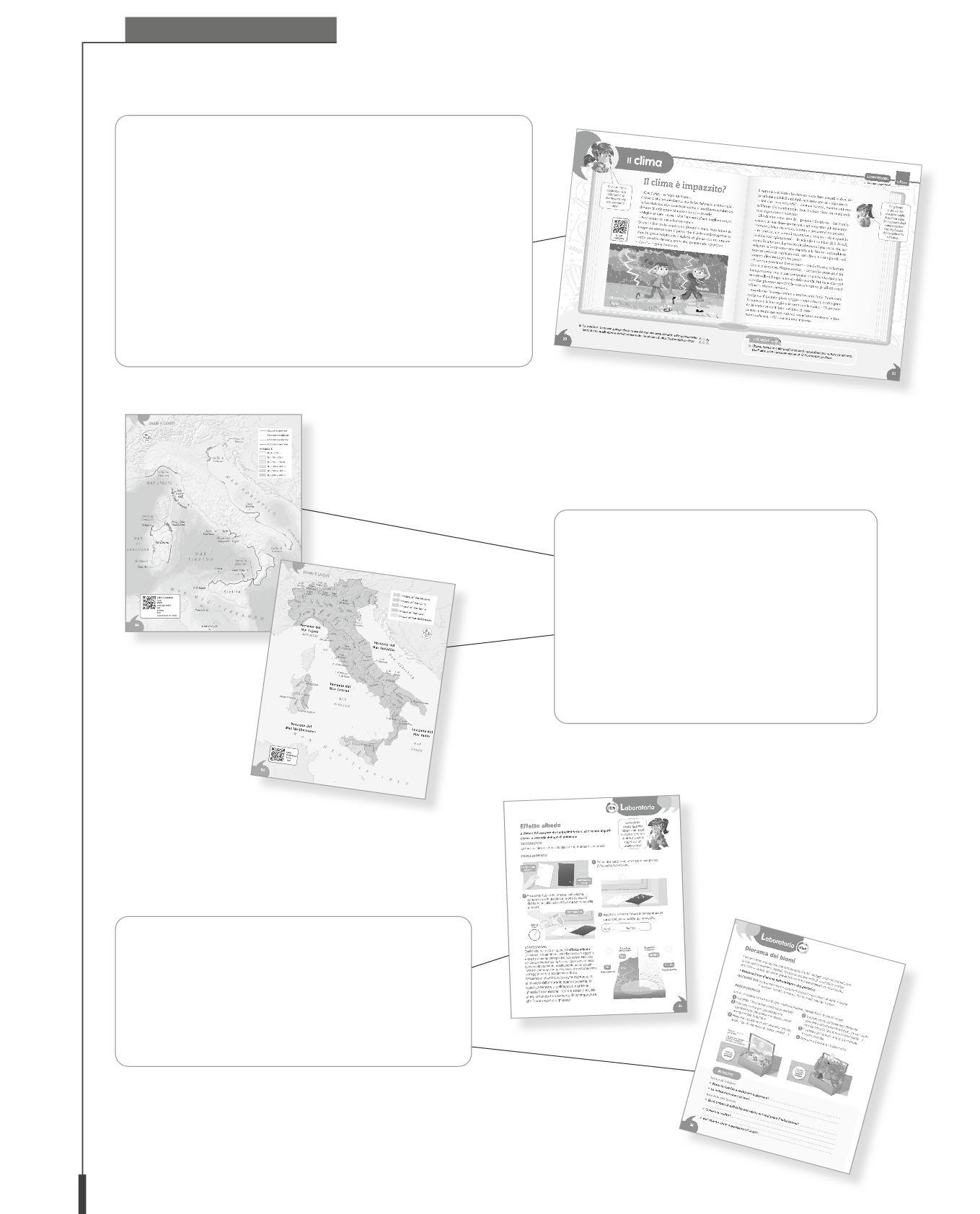
STEM Education
Le discipline STEM sono importantissime per la crescita e per il nostro futuro e quello nostro pianeta. Ne I mondi di Gea troviamo laboratori STEM e/o STEAM in tutte le materie.
LE CARTE GEOGRAFICHE
Le carte geografiche, spesso in atlanti separati, sono state inserite nel volume, così da permettere ad alunne e alunni di studiare un argomento e contemporaneamente vedere la carta corrispondente. In questo modo il libro diventa anche un atlante.
METODO DI STUDIO E LIFE SKILLS
In Geografia sono presenti tre percorsi operativi integrati tra loro (Imparo con metodo, Imparo con competenza, Impariamo insieme) pensati, insieme a Erickson, per far acquisire un primo metodo di studio.
Imparo con metodo è fatto di operative rubricate (parole speciali, analizzo, ricostruisco, espongo) che propongono un vero e proprio metodo per la comprensione del testo espositivo.
Imparo con competenza presenta attività su competenze disciplinari specifiche: fa lavorare, per esempio, su carte, illustrazioni, testi disciplinari, fonti.
Impariamo insieme presenta attività cooperative strutturate e guidate.
LIFE SKILLS sono attività da svolgere da soli, in coppia o in piccolo gruppo che stimolano lo sviluppo delle competenze per la vita come il pensiero critico e creativo.
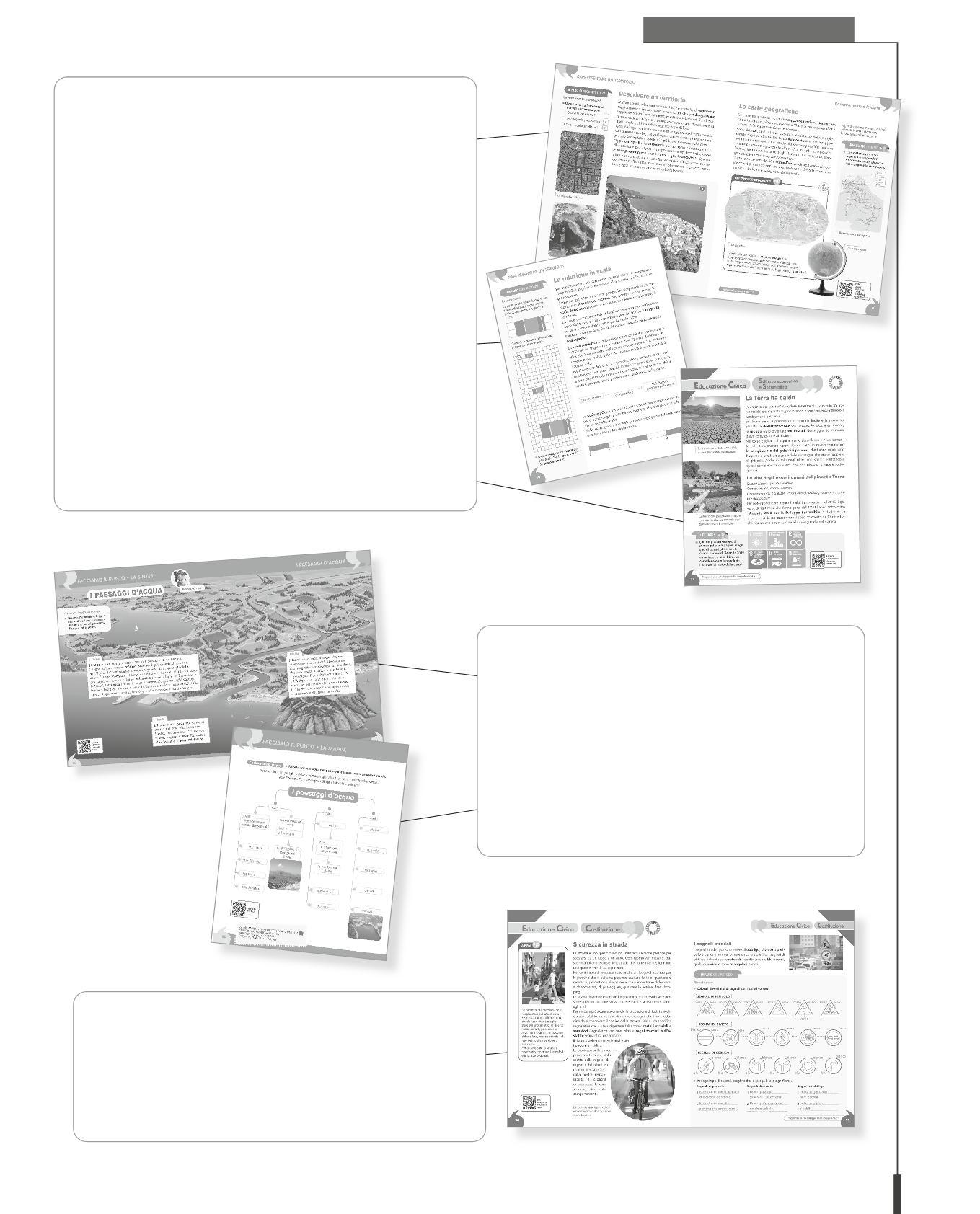
LA NUOVA EDUCAZIONE CIVICA
I mondi di Gea seguono le nuove linee guida per l’insegnamento dell’Educazione civica. Troviamo pagine dedicate ad approfondire argomenti di Geografia dal punto di vista della sostenibilità ambientale.
SINTESI E MAPPE DI FINE UNITÀ
Al termine di ogni unità si trova un apparato didattico di sintesi e verifica. Con questi strumenti ogni bambino e bambina, indipendentemente dal livello e da eventuali difficoltà, può iniziare a fissare gli apprendimenti seguendo e rispettando le proprie caratteristiche. Si inizia con una sintesi testuale accompagnata da immagini e si prosegue con una mappa da completare.
COMPITI AUTENTICI
Nel volume sono presenti Compiti autentici per mettere alla prova le proprie conoscenze e competenze in ambito geografico.
MI ESERCITO IN…
Ne I mondi di Gea l’eserciziario, integrato nel volume, è uno strumento ricco di schede e materiali adatti a tutte le esigenze della classe.
LE MIE MAPPE • RIPASSA CON GEA
Le prime pagine dell’eserciziario sono dedicate alle mappe dei principali argomenti di Geografia da utilizzare per il ripasso e per fissare gli argomenti. La sezione è a cura di Erickson.
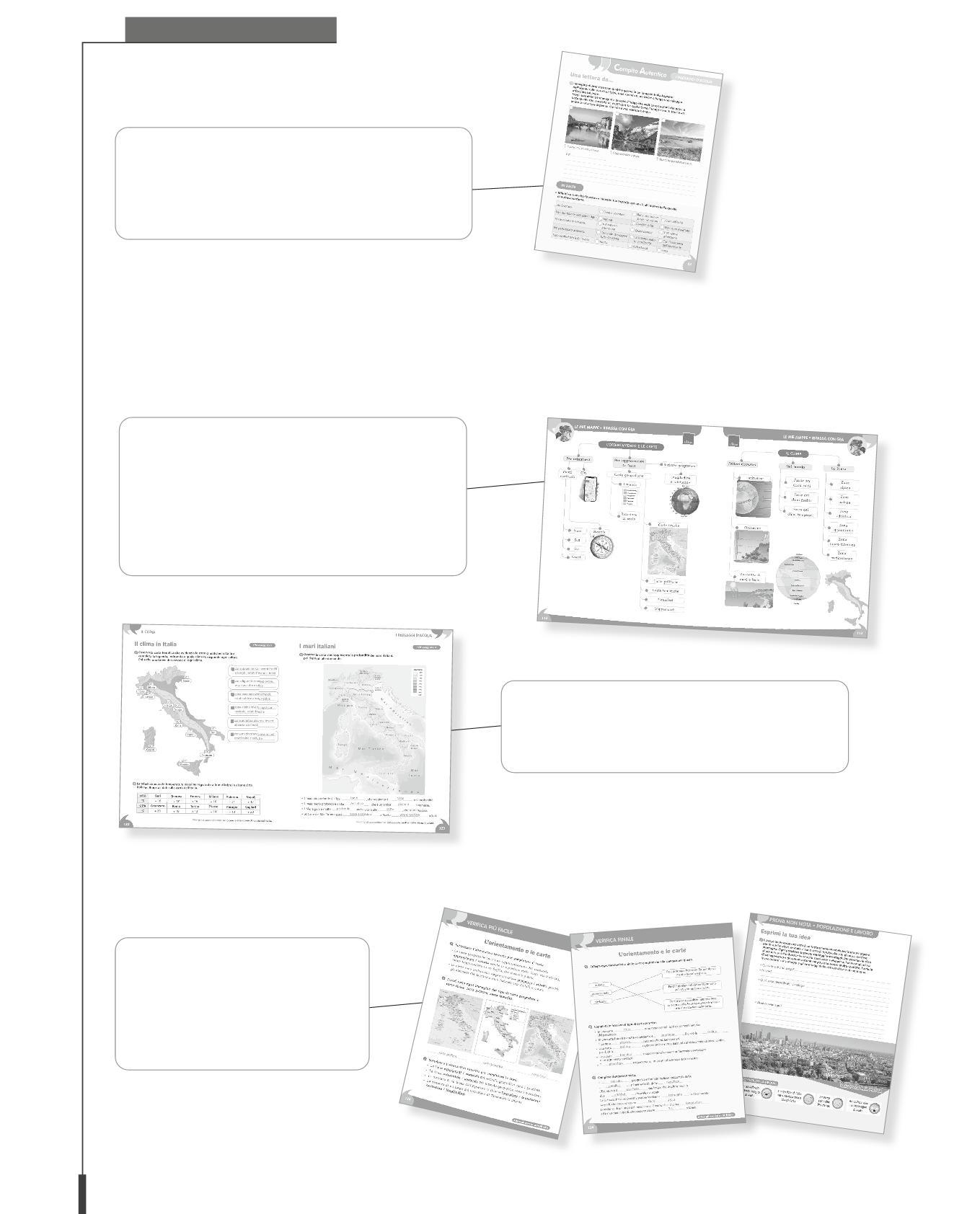
VERIFICHE MULTILIVELLO
Per ogni argomento affrontato sono presenti verifiche a livelli: PIÙ FACILE, FINALE e PROVA NON NOTA.
SCHEDE ESERCIZI
Approfondimenti ed esercizi dedicati ai vari argomenti trattati in Geografia.
I TEMI-CHIAVE DE I MONDI DI GEA
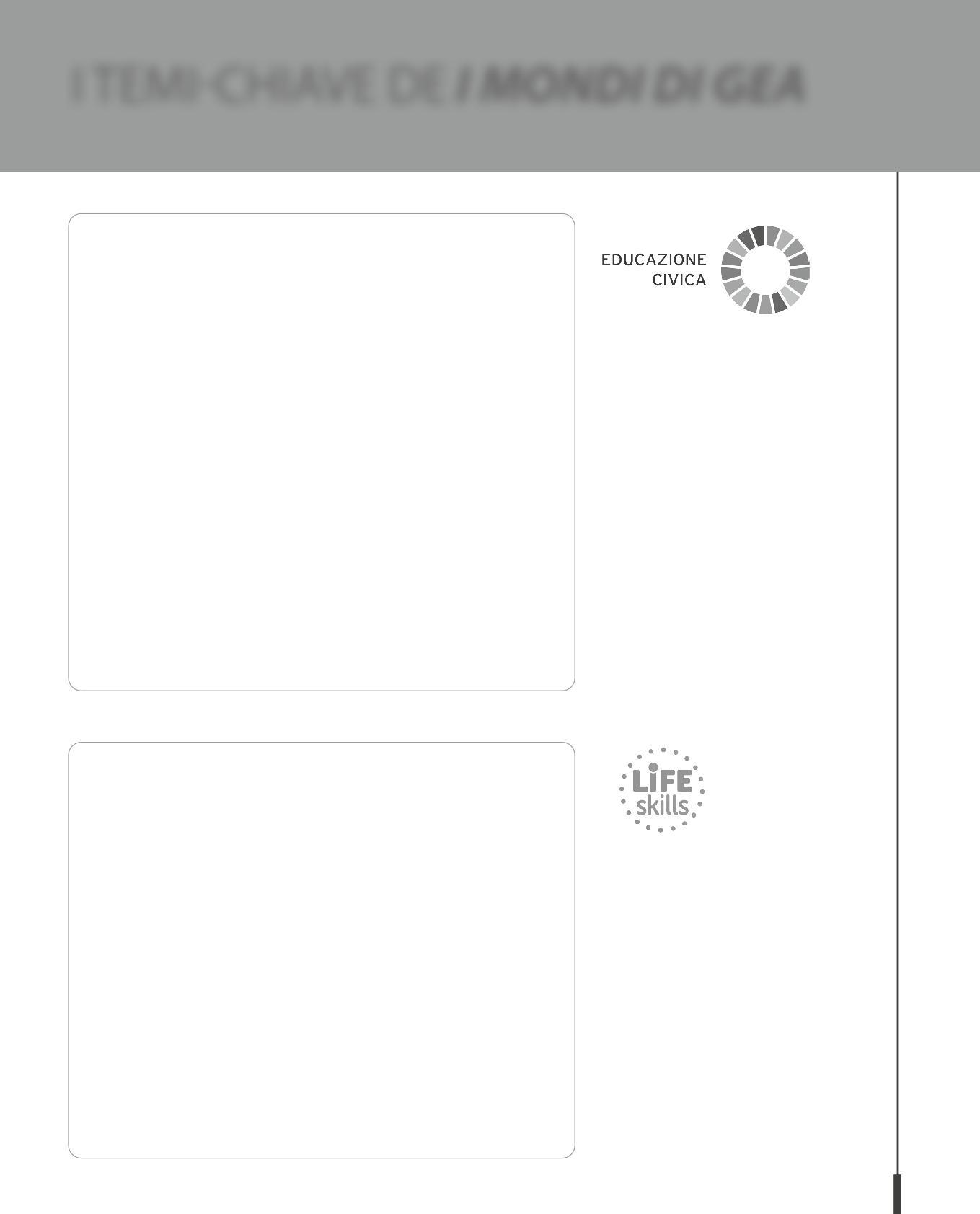
NUOVA EDUCAZIONE CIVICA
Nel settembre 2024 il MIM ha pubblicato le nuove linee guida in materia di Educazione Civica, che sono valide a partire dall’anno scolastico 2024/2025. A partire da questo anno scolastico i curricoli di Educazione civica si riferiscono ai traguardi di apprendimento definiti a livello nazionale e indicati appunto dalle nuove linee guida. L’Educazione Civica viene individuata come disciplina trasversale, come ambito di apprendimento interdisciplinare. Al centro delle nuove linee guida ci sono i tre nuclei concettuali: Costituzione, Sviluppo economico e sostenibilità, Cittadinanza digitale. Tra tutte le tematiche viene sottolineata una particolare attenzione alla conoscenza della Costituzione, alla tutela dell’ambiente, all’educazione stradale, all’educazione finanziaria (per approfondire vedi pagg. 44-49).
In tutti i corsi Fabbri–Erickson è forte questa prospettiva interdisciplinare e trasversale dell’educazione civica. Trasversalmente sono presenti pagine dedicate, laboratori e percorsi specifici (narrativi e laboratoriali) che riguardano le tematiche più importanti (tra cui il rispetto di sé e degli altri, l’educazione finanziaria, la cittadinanza digitale).
COMPETENZE NON COGNITIVE, LIFE SKILLS
Nel novembre 2024 è stata approvata la Legge che introduce “lo sviluppo di competenze non cognitive e trasversali” nei percorsi scolastici e di formazione professionale. La sottolineatura dell’importanza delle competenze non cognitive, o Life Skills o Soft Skills, viene da lontano; già nel 1993 infatti l’OMS aveva individuato alcune life skills fondamentali per il benessere e la realizzazione delle persone. Fanno parte delle life skills competenze emotive (consapevolezza di sé e delle proprie emozioni e loro gestione), competenze relazionali (comunicazione efficace, costruzione di relazioni sane ed efficaci) e poi capacità di problem solving, pensiero critico, pensiero creativo. Sono competenze fondamentali per stare bene, costruire il proprio futuro, raggiungere l’autonomia, costruire relazioni in tutti gli ambiti dell’esistenza.
In tutti i corsi Fabbri–Erickson ci sono percorsi pensati per sviluppare le competenze non cognitive, con, per esempio, rubriche didattiche, laboratori, albi illustrati.
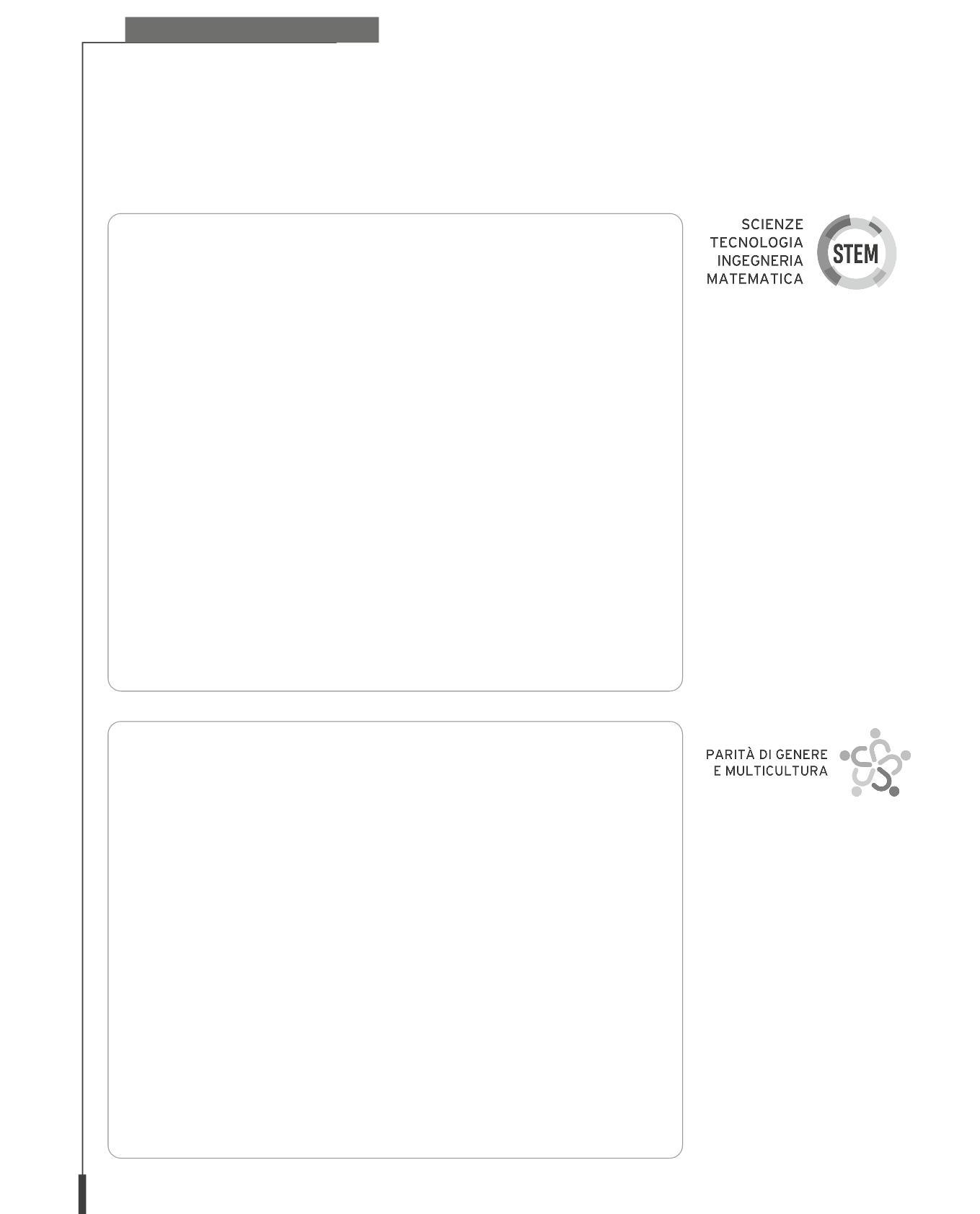
STEM E STEAM
STEM è un acronimo inglese riferito a diverse discipline: Science, Technology, Engineering and Mathematics, e viene usato per indicare l’insieme delle materie scientifiche-tecnologiche-ingegneristiche.
STEAM aggiunge all’acronimo la A di Arts e fa riferimento all’interdisciplinarità e alla dimensione creativa.
Già nel 2022 il MIM ha pubblicato delle linee guida sulla didattica STEM che accolgono la necessità di potenziare il processo di insegnamento–apprendimento delle discipline scientifiche e tecnologiche anche attraverso metodologie didattiche innovative e con la valorizzazione di trasversalità e interdisciplinarietà.
Potenziare le STEM è uno degli obiettivi più importanti per raggiungere il traguardo di un’istruzione di qualità che formi davvero i giovani del futuro. Uno degli obiettivi deve essere anche quello di eliminare le disparità di genere che permangono nell’ambito STEM.
I corsi Fabbri–Erickson dedicano grande attenzione all’insegnamento-apprendimento delle discipline STEM e STEAM con percorsi, laboratori, volumi dedicati, che tengono sempre in considerazione l’eliminazione delle disparità di genere.
PARITÀ DI GENERE E MULTICULTURA
Nell’ambito della parità di genere e multicultura Fabbri–Erickson porta avanti ormai da diversi anni Obiettivo Parità, un progetto nato per contrastare gli stereotipi di genere nei libri di testo che nel 2025 si è arricchito di una parte dedicata alla multiculturalità.
L’idea di base è che l’unico modo per costruire un futuro senza differenze di genere e per contrastare davvero fenomeni come la violenza di genere o qualsiasi tipo di discriminazione, sia partire dall’eliminare gli stereotipi dai libri di testo e da una corretta rappresentazione della realtà.
Obiettivo parità prevede che tutti i libri di letture vengano rivisti e supervisionati in modo che ci sia equilibrio nella scelta delle letture tra numero di autrici e autori e numero di protagonisti e protagoniste. Nella scelta delle letture ci sia una rappresentazione equilibrata della realtà. Non ci sia presenza di stereotipi, né femminili né maschili. Venga utilizzato, non solo nelle letture, ma in tutti i libri, il linguaggio di genere. Allo stesso modo, tutti i libri di letture vengono supervisionati in modo da avere una rappresentazione reale delle culture diverse in cui siamo immersi quotidianamente e che arricchiscono la nostra.
Apparato digitale per Storia e Geografia
Ne I mondi di Gea sono presenti video disciplinari (tutorial, esperimenti, approfondimenti) per stimolare la curiosità e facilitare la comprensione delle materie.
Inoltre:
• App ludico-didattiche che combinano gioco e apprendimento, aiutando i bambini a consolidare le competenze attraverso attività divertenti e coinvolgenti.
• Escape room: percorsi interattivi dove gli studenti risolvono enigmi e sfide per consolidare le conoscenze in modo coinvolgente e divertente.
• Immagini interattive per favorire l’apprendimento attraverso l’interazione e stimolare l’osservazione attiva.
• Presentazioni modificabili pronte all’uso e personalizzabili per facilitare la spiegazione o il ripasso degli argomenti.
• GeoGebra, lo strumento interattivo per esplorare concetti matematici e geometrici, che aiutano gli studenti a visualizzare e comprendere meglio teoremi e problemi.
• Esercizi interattivi e autocorrettivi integrati nel testo, da svolgere direttamente sul libro digitale per la verifica delle competenze.
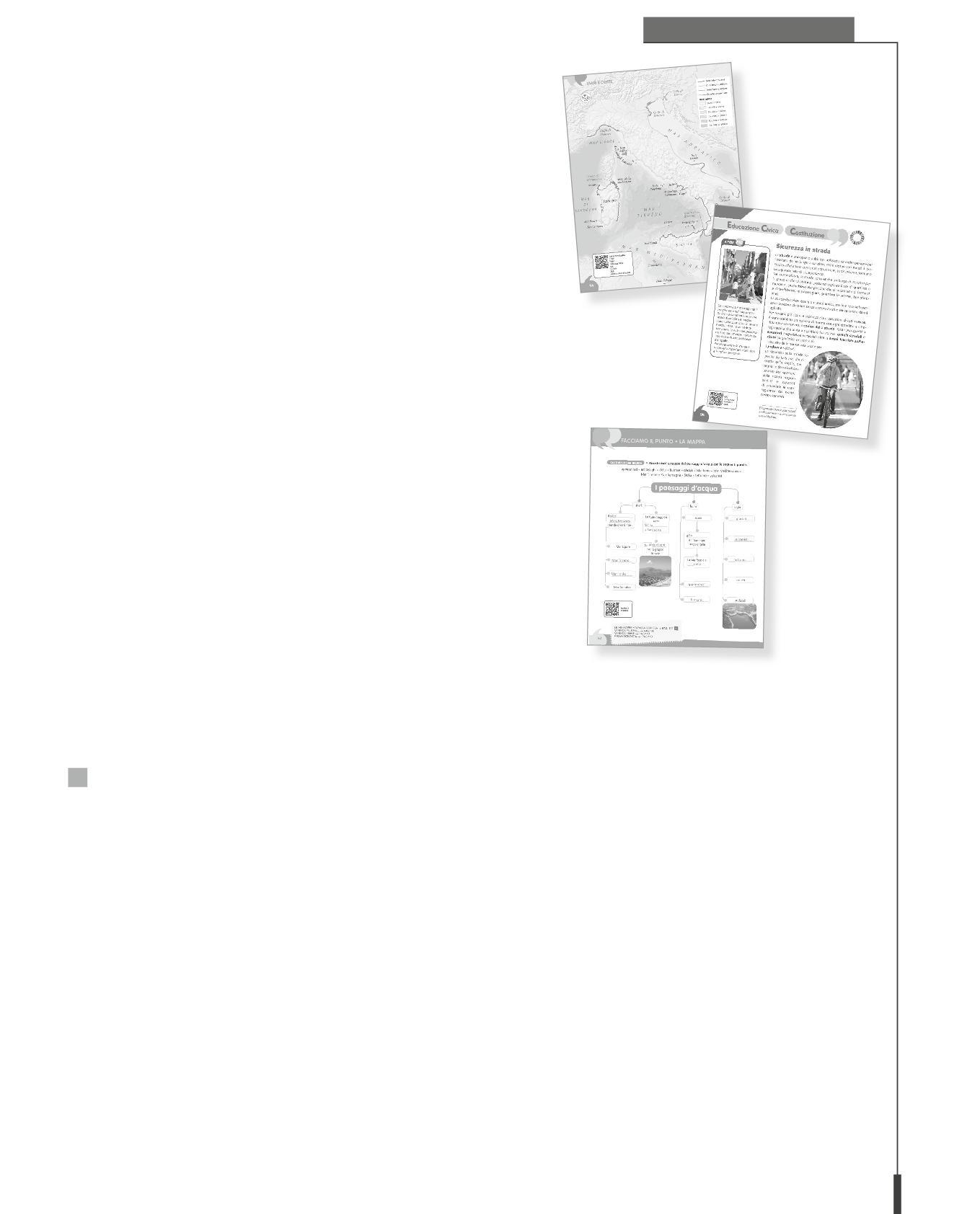
Materiali per il docente
Professione docente
Le quattro guide per l’insegnante, due per l’ambito antropologico e due per quello scientifico, sono uno strumento di lavoro ricco e indispensabile, che integra i volumi per l’alunno/a.
Contengono:
• Dalla progettazione alla certificazione delle competenze, a cura di Dino Cristanini;
• Programmazione di ogni materia;
• La valutazione degli apprendimenti alla scuola primaria;
• L’insegnamento dell’Educazione civica secondo la nuova normativa;
• Il Piano Educativo Individualizzato in prospettiva bio-psico-sociale, a cura di Erickson;
• Progetto CheFacile!, testi facilitati e semplificati, a cura di Erickson;
• Calcolo facile, a cura di Erickson;
• La Mateludica di Valentina Perolio;
• Se sbaglio imparo di M. Federica De Gasperis;
• Verifiche multilivello (di base, di recupero, di potenziamento);
• Prove strutturate per classi parallele con soluzioni in pagina;
• Metodo ELS, un metodo per imparare le Scienze, di Gruppo Pleiadi;
• Prova verso l’Invalsi con griglia soluzioni.
Area primaria
Lo spazio dedicato ai docenti con migliaia di risorse digitali utili all’insegnamento delle materie di primo e secondo ciclo e di religione. In questo spazio potrete trovare: escape room, app ludico didattiche, video, presentazioni modificabili, immagini interattive, itinerari con Google Earth, la cartografia digitale di HUB Maps, materiali per la verifica e molto altro ancora!
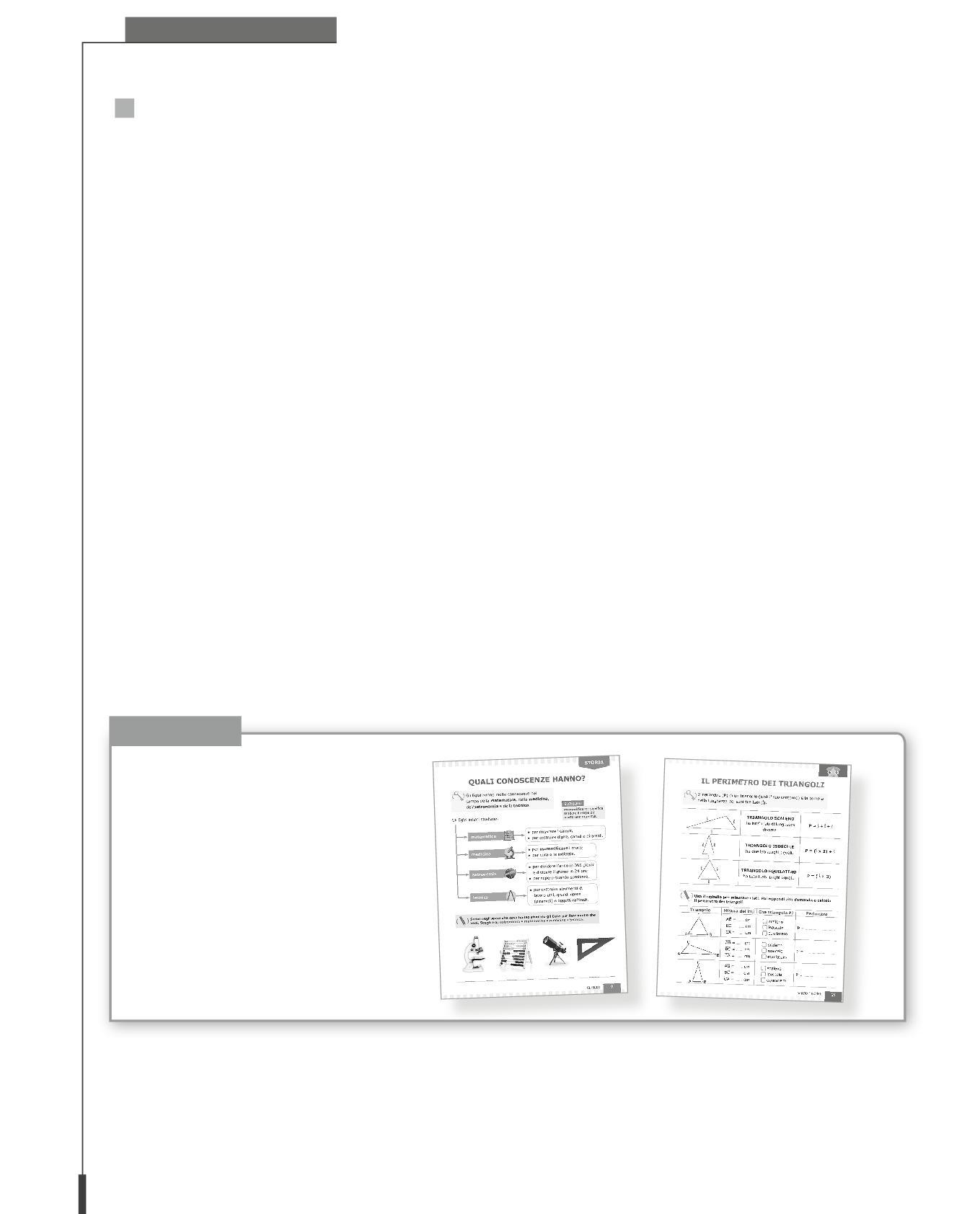
HUB Kids docente
HUB Kids per il docente, il libro digitale interattivo e multimediale, utilizzabile su computer, tablet e LIM, è arricchito da materiali aggiuntivi disponibili soltanto per l’insegnante. Inoltre il libro digitale consente di vedere le soluzioni direttamente in pagina.
HUB Kids è uno strumento indispensabile per la didattica inclusiva: permette la lettura automatica del testo, la scelta del fondino di lettura e di diversi caratteri tra cui biancoenero® (il carattere ad alta leggibilità utile per chi ha problemi di dislessia).
HUB Kit docente
Come nella versione per l’alunno, anche HUB Kit docente comprende contenuti digitali che arricchiscono ed espandono il corso.
A disposizione del docente la Guida stampabile in formato Pdf, la Programmazione e le Verifiche in Word.
HUB Test
La piattaforma di HUB Scuola per creare verifiche e mettersi alla prova, con numerosi quesiti disciplinari.
HUB INVALSI
La piattaforma di HUB Scuola per allenarsi alla Prova Nazionale INVALSI.
CHE FACILE!
Per le classi quarta e quinta, inoltre, sono disponibili su richiesta dell’insegnante i volumi CheFacile! Storia Geografia Scienze, che contengono una selezione degli argomenti principali delle tre discipline, e i volumi CheFacile! Matematica, con strumenti di facilitazione per l’apprendimento nell’area logico-matematica.
I quattro volumi sono a cura di Erickson.
La Guida di Storia e Geografia
Progettazione e certificazione delle competenze
Nella sezione Progettazione e certificazione delle competenze, a cura di Dino Cristanini, vengono fornite informazioni su come procedere nella progettazione al fine di raggiungere la certificazione delle competenze degli alunni: dai traguardi per lo sviluppo delle competenze agli obiettivi di apprendimento.
Nelle prime pagine della Guida si trovano il Quadro delle correlazioni tra i traguardi per lo sviluppo delle competenze e le competenze da certificare con il modello nazionale e le programmazioni annuali di Storia e Geografia.
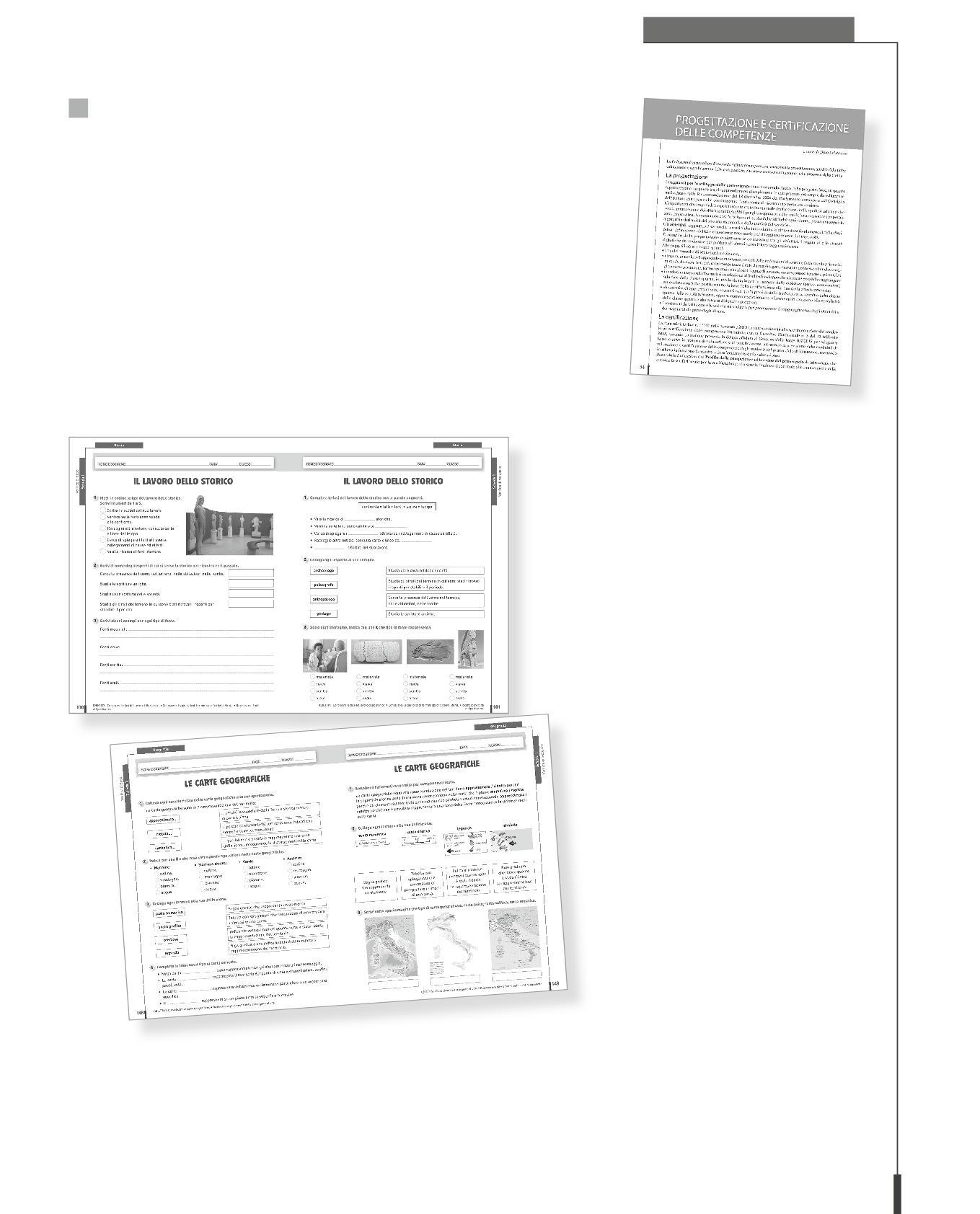
Le schede multilivello
Per ogni disciplina sono presenti delle schede multilivello sui principali argomenti.
Per ogni tematica viene presentata una scheda:
• di base; • di recupero; • di potenziamento. Le schede di base e di recupero differiscono tra loro per la modalità di proposta degli esercizi. Nelle schede di recupero, infatti, gli alunni sono maggiormente guidati nella risoluzione delle attività.
Presentazione del corso
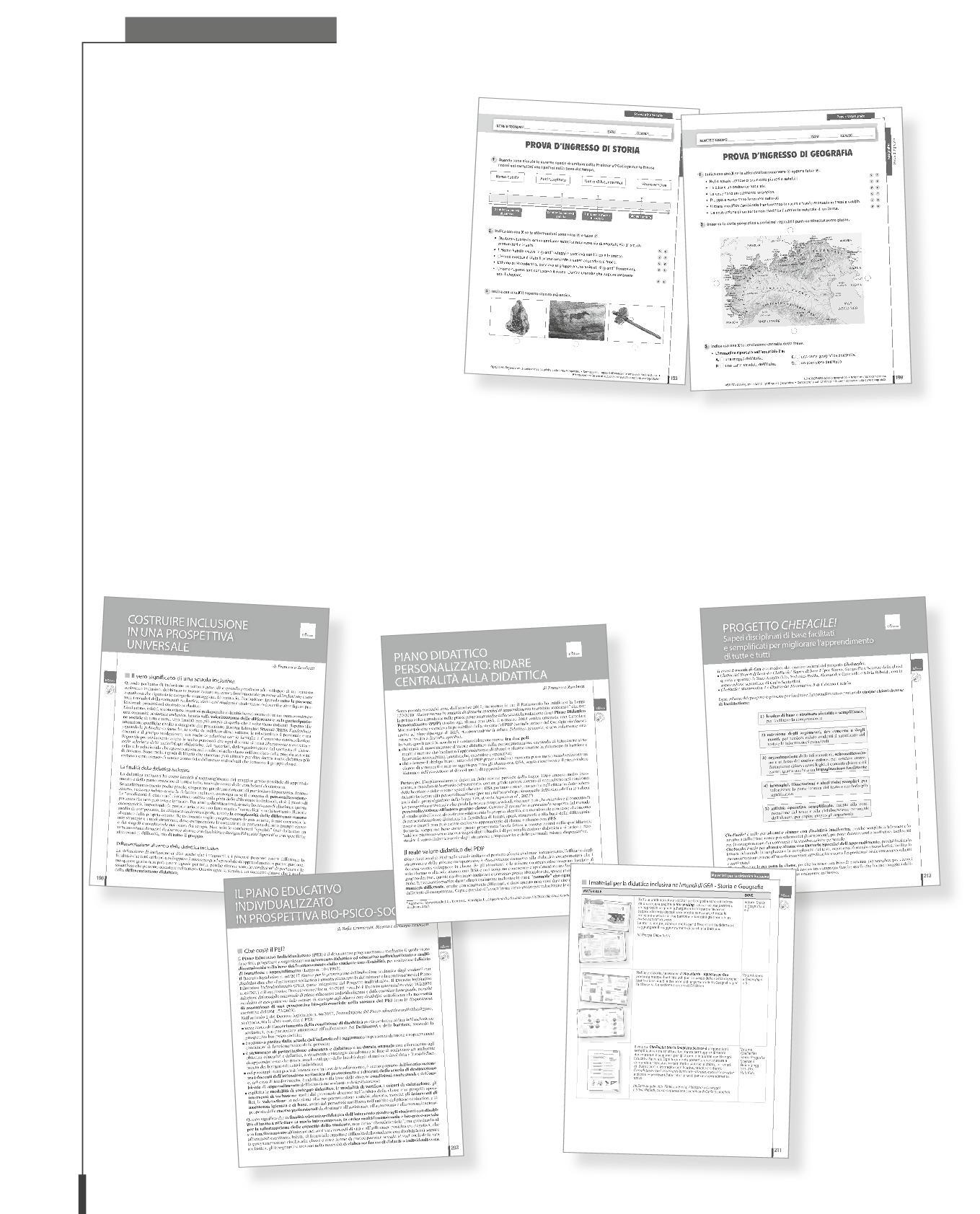
Le prove strutturate per classi parallele
Le prove strutturate per classi parallele possono essere somministrate agli alunni e favoriscono il confronto e la condivisione dei criteri di valutazione, delle strategie metodologiche e delle pratiche didattiche tra gli insegnanti.
Vengono fornite anche le prove con le soluzioni in pagina.
I materiali per la didattica inclusiva: strategie e dettagli operativi, a cura di Erickson
In questa Guida per l’insegnante sono presenti alcuni contenuti a cura di Erickson:
• introduzione “Costruire inclusione in una prospettiva universale”;
• il Piano Educativo Individualizzato in prospettiva bio-psico-sociale;
• il Piano Didattico Personalizzato: ridare centralità alla didattica;
• descrizione dei contenuti Erickson nei volumi per l’alunno, in HUB Kids e in HUB Kit, con indicazioni per il corretto utilizzo e per lo sviluppo di materiali analoghi personalizzati/individualizzati.
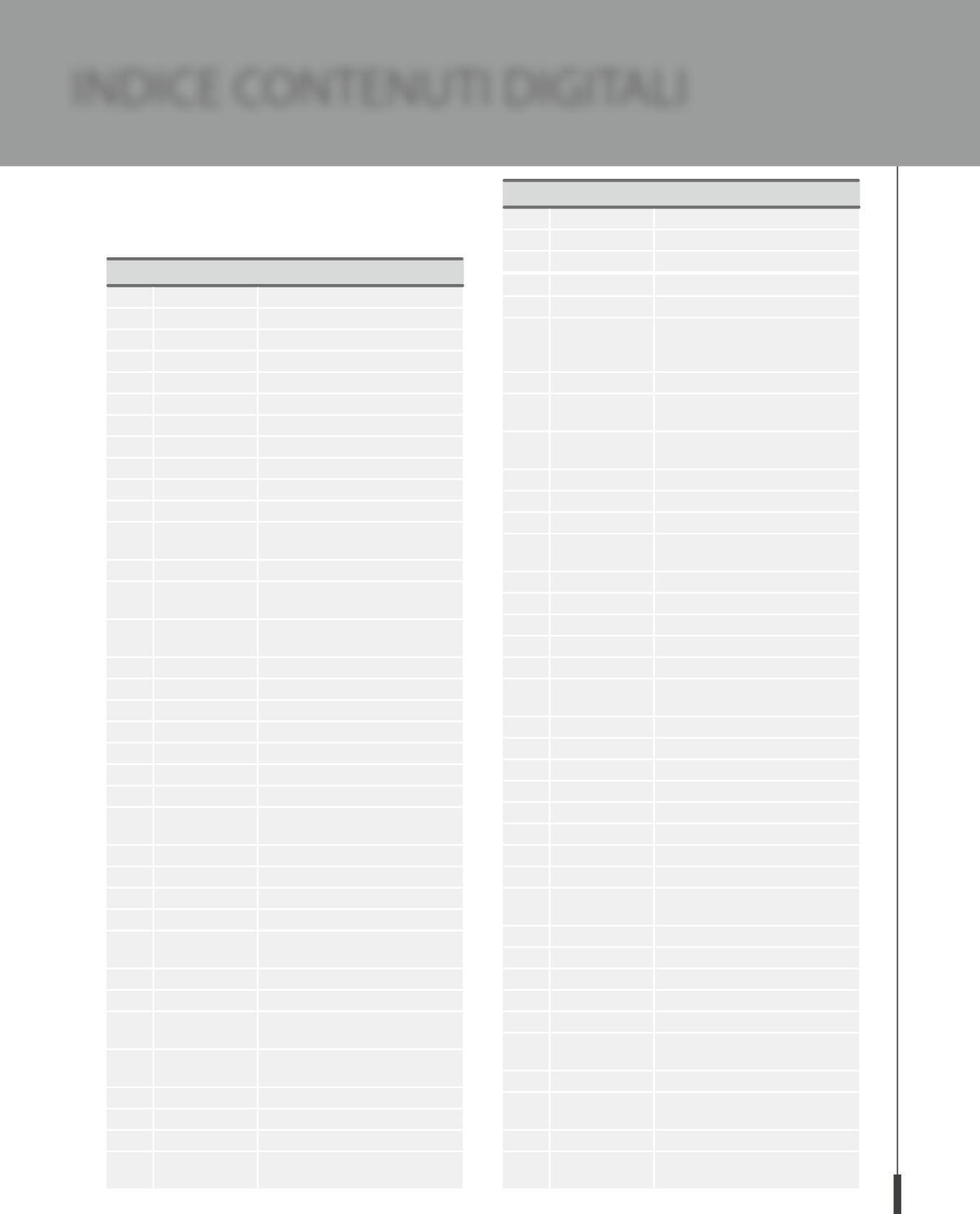
INDICE CONTENUTI DIGITALI
STORIA 4
Lettura espressiva delle pagine di Storytelling, lettura di tutti i testi, audio delle attività. Inoltre...
PAG.TIPOLOGIA TITOLO CONTENUTO
5Video Scopriamo la Storia
7Laboratorio I grandi siti preistorici
Video Ieri e oggi - Catal Huyuk
Infografica La Storia
8Video I siti archeologici
10HUB Maps La mezzaluna fertile Infografica La mezzaluna fertile
13Video Le civiltà dei fiumi
Video La storia degli esseri umani
HUB Maps Le civiltà dei fiumi
15Video La Mesopotamia
Documento Carta geostoricaLa Mesopotamia
Laboratorio Le civiltà della Mesopotamia
18Documento Carta d’identità della civiltà sumerica
Documento Carta geostorica - Il territorio dei Sumeri
HUB Maps I Sumeri
Infografica I Sumeri
20Documento Carta geostorica - I commerci
21Video La ziggurat
Infografica La città sumera
22Video Lo Stendardo di Ur
24Documento Il mito di Gilgamesh
25Documento Il mito dell’invenzione della scrittura
28Video La ruota
30Video Ieri e oggi - La Mesopotamia
Infografica I Sumeri
31PresentazioneMAPPA DI VERIFICA
32Documento Carta d’identità della civiltà babilonese
Documento Carta geostorica - I Babilonesi
HUB Maps I Babilonesi
33Documento Notizie dagli scavi archeologici: Babilonia
PresentazioneCose dell’altro mondo - La torre di Babele
37Documento Carta d’identità della civiltà ittita
HUB Maps Gli Ittiti
Documento Carta geostorica - Gli Ittiti
41Documento Carta d’identità della civiltà assira
PAG.TIPOLOGIA TITOLO CONTENUTO
Documento Carta geostorica - Gli Assiri
HUB Maps Gli Assiri
45PresentazioneMAPPA DI VERIFICA
47HUB Maps L’antico Egitto
Documento Carta geostorica - Gli Egizi
Video Scopriamo la civiltà egizia Gli Egizi
Laboratorio La civiltà egizia
51Documento Carta geostorica - I regni dell’antico Egitto
Documento Carta d’identità della civiltà egizia
52Video Il papiro
56Bacheca Le donne
58Documento La regina Nefertiti
63PresentazioneCose dell’altro mondo - I geroglifici e la scrittura corsiva
Infografica La Stele di Rosetta
Documento La stele di Rosetta
Documento The British Museum
Documento Traduzione - Il British Museum
65Documento Il mito di Iside e Osiride
Documento Attività modificabile - La mummificazione
PresentazioneLe fasi della mummificazione
PresentazioneI sarcofagi
66PresentazioneLe divinità egizie
67Video La sfinge e le piramidi di Giza
69PresentazioneLo spaccato di una piramide
Video La costruzione delle piramidi
Laboratorio Le piramidi
73Video La tomba di Tutankhamon
Documento Notizie dagli scavi archeologici: la tomba di Tutankhamon
75Infografica Gli Egizi
77PresentazioneMAPPA DI VERIFICA
Laboratorio Gli Egizi
79HUB Maps Le civiltà dell’India e della Cina
Video Le civiltà d’Oriente
83Documento Carta d’identità della civiltà dell’Indo
Video La civiltà indiana
Documento Carta geostorica - La civiltà dell’Indo
HUB Maps La valle dell’Indo
Documento Notizie dagli scavi archeologici: Mohenjo-Daro
Indice contenuti digitali
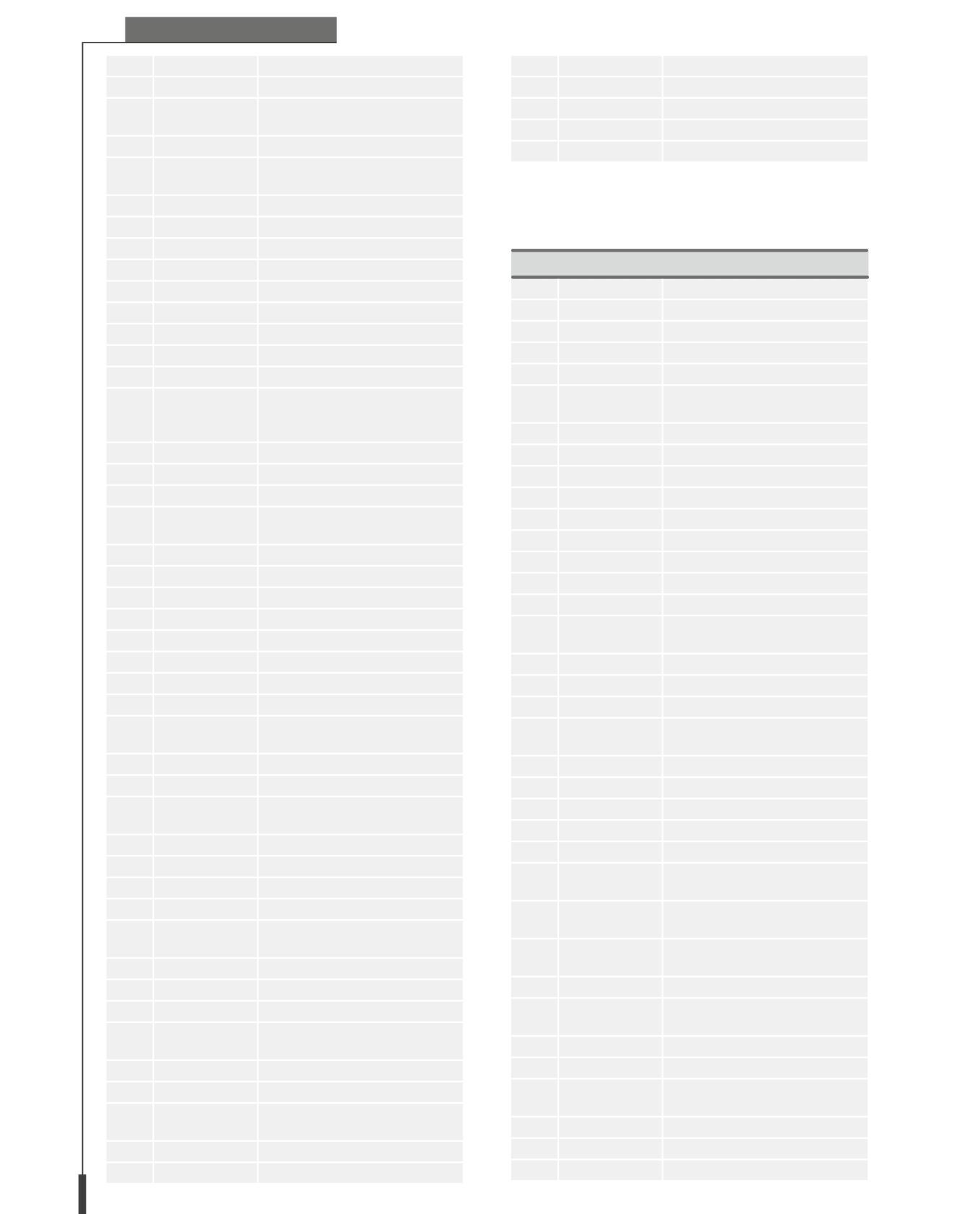
86Infografica La civiltà dell’Indo
87PresentazioneMAPPA DI VERIFICA
88Documento Carta d’identità delle civiltà del Fiume Giallo
Video La civiltà cinese
Documento Carta geostorica - La civiltà dell’Antica Cina
HUB Maps L’impero cinese
90Bacheca Il riso
HUB Maps La via della seta
94Infografica La Grande Muraglia
Laboratorio La Grande Muraglia
PresentazioneL’esercito di terracotta
95Infografica La civiltà dell’antica Cina
96PresentazioneMAPPA DI VERIFICA
99Infografica Il Mediterraneo
Video Le civiltà del mare Ieri e oggi - Il Mediterraneo
HUB Maps Le civiltà del Mediterraneo
98Video I Fenici
100HUB Maps I Fenici
104Documento Carta d’identità della civiltà fenicia
Documento Carta geostorica - La Fenicia
107Bacheca Il mare e le vie di comunicazione
HUB Maps Le colonie fenicie
HUB Maps Le rotte commerciali dei Fenici
109PresentazioneLe navi mercantili fenicie
113Video Il cyberbullismo
114Infografica La civiltà dei Fenici
115PresentazioneMAPPA DI VERIFICA
117Documento Carta geostorica - La civiltà cretese
HUB Maps I Cretesi
Video I Cretesi
120Documento Carta d’identità della civiltà minoica
121Video Il mito
Documento Il mito del labirinto
Video Il palazzo di Cnosso
122HUB Maps Le rotte commerciali cretesi
PresentazioneCose dell’altro mondo - Creta: la civiltà dei tori e del commercio
123Video La taurocatapsia
124Infografica I Cretesi
125PresentazioneMAPPA DI VERIFICA
126Documento Carta geostorica - La civiltà degli Ebrei
127HUB Maps Gli spostamenti degli Ebrei
Video Gli Ebrei
130Documento Carta d’identità della civiltà ebraica
Video Ambiente e migrazioni
132Laboratorio Gerusalemme
135PresentazioneLa Shoah
Video Anna Frank
136Infografica Gli Ebrei
137PresentazioneMAPPA DI VERIFICA
App Carte gioco - Le civiltà antiche
GEOGRAFIA 4
Lettura espressiva delle pagine di Storytelling, lettura di tutti i testi, audio delle attività. Inoltre...
PAG.TIPOLOGIA TITOLO CONTENUTO
Documento Cartina - Italia fisica
HUB Maps L’Italia fisica
Documento Cartina - Italia politica
HUB Maps L’Italia politica
3Video Scopriamo la Geografia
Documento Creare un grafico con un foglio di calcolo
Infografica La Geografia
9Video Le carte geografiche
HUB Maps Planisfero fisico
HUB Maps Planisfero politico
12PresentazioneI diversi tipi di carte geografiche
Documento Carta - Italia fisica
Documento Carta - Italia politica
Bacheca Le carte geografiche
13Documento base dymaxion
15PresentazioneCose dell’altro mondo - I fusi orari e la misurazione del tempo
17Documento MAPPA DI VERIFICA
22Video Il clima
Laboratorio Il clima
23Video I problemi ambientali delle città: l’inquinamento
24HUB Maps Le fasce climatiche
HUB Maps Gli ambienti nel mondo
Infografica I climi
Video Le fasce climatiche
Video I climi e gli ambienti
27Laboratorio Il parco nazionale di Sagarmatha in Nepal
Laboratorio Il delta del fiume Okavango in Botswana
29Video Vicino e lontano: la macchia mediterranea
HUB Maps Il clima e gli ambienti in Europa
Laboratorio Le colonne di basalto Giant’s Causeway in Irlanda
Laboratorio Le Alpi francesi
30Infografica I climi freddi
Laboratorio L’aurora boreale alle isole Lofoten
32HUB Maps I climi in italia
PresentazioneLe regioni climatiche italiane
Infografica I climi in Italia
Indice
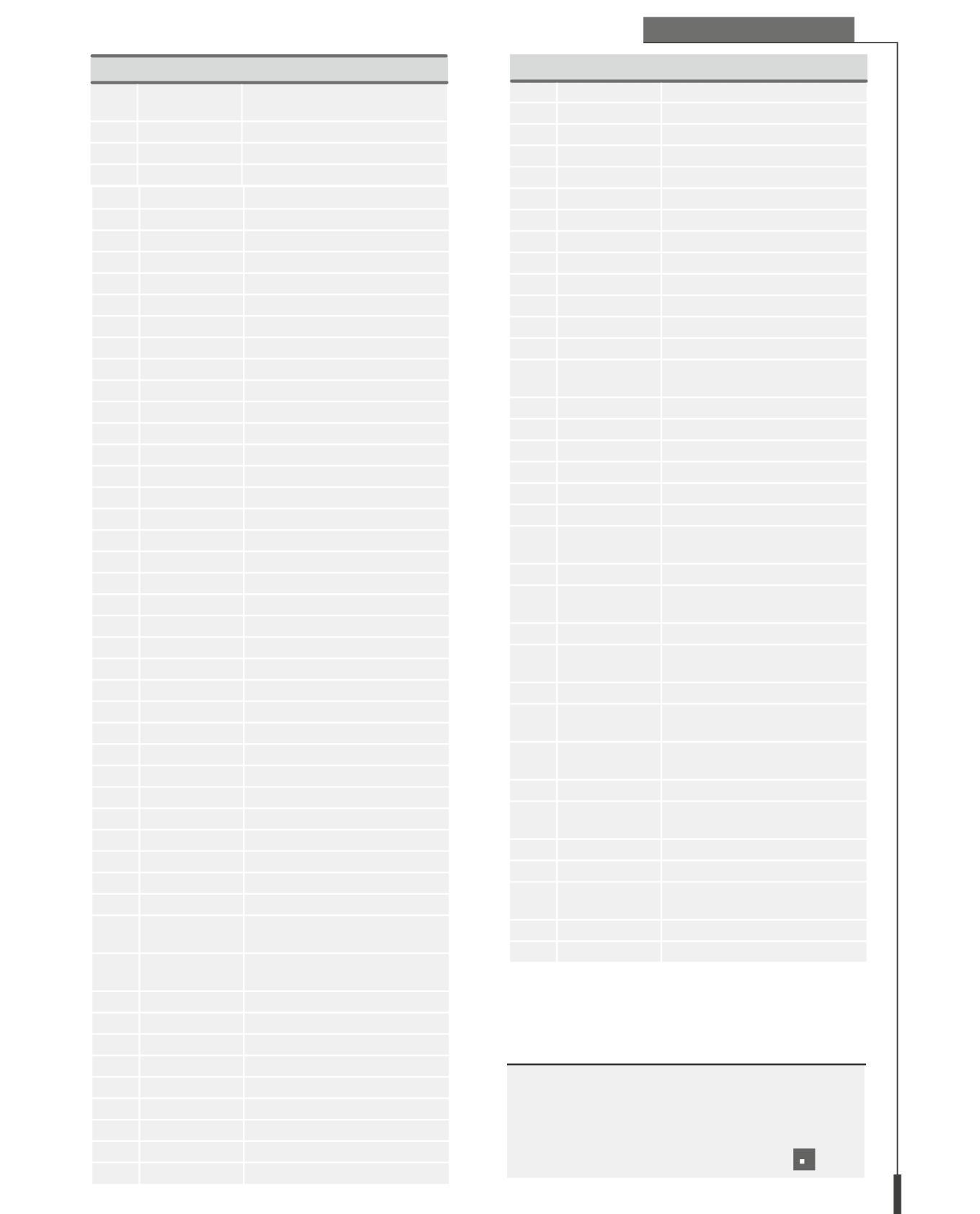
PAG.TIPOLOGIA TITOLO CONTENUTO
34Bacheca Il cambiamento climatico e l’effetto serra
38Documento MAPPA DI VERIFICA
41Video Scopriamo i paesaggi
Laboratorio Gli ambienti
44HUB Maps I mari
Laboratorio Le coste
Documento Oceani e mari nel mondo
Video Paesaggi marini
47Video I paesaggi di mare in Italia
48Infografica I mari e le coste
49Bacheca Il mare e le vie di comunicazione
Documento Cibo dal mare
50Video Flora e fauna del mare
Infografica Flora e fauna
52HUB Maps I fiumi; i laghi
53Infografica I fiumi
Video I paesaggi di fiume in Italia
Documento Fiumi nel mondo
Bacheca La vita sui fiumi
54Video I paesaggi di lago in Italia
Video Paesaggi di lago
57HUB Maps I parchi nazionali
Video Alcuni parchi nazionali
60Infografica I paesaggi d’acqua
62PresentazioneMAPPA DI VERIFICA
66Video Paesaggi montani
Video Le Alpi e gli Appennini
HUB Maps Le Alpi; Gli Appennini
67Infografica La montagna
Documento Come si sono formate le grotte
68Video Le Alpi
Documento Le Dolomiti
Laboratorio Le Alpi
70Video Gli Appennini
Documento I mestieri della montagna
72Video I vulcani
Laboratorio Il vulcano
Documento I vulcani nel mondo
73Video I terremoti e il rischio sismico in Italia
HUB Maps Le zone sismiche e i vulcani in Italia
HUB Maps Le placche tettoniche
76HUB Maps Le colline
Video I paesaggi di collina in Italia
Documento Colline nel mondo
77Infografica La collina
Video Paesaggi di collina
80Video Paesaggi di pianura
HUB Maps Le pianure
Documento Pianure nel mondo
PAG.TIPOLOGIA TITOLO CONTENUTO
81Video I paesaggi di pianura in Italia
Infografica La pianura
83Documento Il bacino del Po
Documento Le aree risorgive
84Infografica I paesaggi di terra
86PresentazioneMAPPA DI VERIFICA
89Video La popolazione in Italia
HUB Maps La densità della popolazione
Infografica La geografia umana
92Laboratorio La popolazione
93Video Il paesaggio urbano
94Video Le migrazioni di oggi
Video Identità e diversità
Video Vicino e lontano: la globalizzazione
96Bacheca Le città
97Bacheca La piazza
98Documento Le regole per muoversi in strada
100PresentazioneI settori dell’economia
Video Vicino e lontano: il lavoro
Video l’Economia e popolazione
101Documento Carta d’identità del settore primario
HUB Maps Il settore primario
103Documento Carta d’identità del settore secondario
HUB Maps Il settore secondario
105Documento Carta d’identità del settore terziario
HUB Maps Il settore terziario
Bacheca La scuola è un diritto e un dovere
Bacheca La scuola nello spazio e nel tempo
Bacheca Sport e passioni
106Documento Carta geografica - I trasporti in Italia
HUB Maps Trasporti
Bacheca Trasporti
107Documento Carta geografica - Il turismo in Italia
HUB Maps Turismo
109PresentazioneMAPPA DI VERIFICA
Materiali per l’insegnante
• Soluzioni per l’insegnate nel libro digitale.
• Schede aggiuntive e compiti di realtà.
• Guida per l’insegnante in formato digitale.
• Programmazioni annuali in word.
• Volume CheFacile! con i saperi di base di Storia e Geografia disponibile in Hub Kids
Intelligenza artificiale: istruzioni per l’uso!
L’Intelligenza artificiale (per comodità AI) è una rivoluzione tecnologica ma anche culturale e sociale. L’assegnazione dei Premi Nobel del 2024 sancisce in una duplice maniera questo dato di fatto.
Con il Nobel per la Fisica a John Hopfield e Geoffrey Hinton si celebra il grande sforzo che ha portato allo sviluppo delle reti neurali e dunque reso possibile l’apprendimento automatico (o machine learning), cioè la possibilità per una macchina, grazie a degli algoritmi, di migliorare e affinare le proprie capacità di elaborazione man mano che acquisisce nuovi dati, arrivando a svolgere anche compiti non assegnati all’inizio.

Da qui puoi accedere al
Con il Nobel per la Chimica a David Baker e Demis Hassabis and John Jumper si testimonia la potenzialità dell’AI di migliorare concretamente le nostre vite: la ricerca sulle proteine e la loro complessa struttura, la progettazione in laboratorio di nuove proteine e la successiva realizzazione sono di fatto il primo passo verso la comprensione e la cura (tramite nuovi farmaci e nuove terapie) di molte malattie.
L’emozione di fronte a tali importanti conseguimenti non deve lasciare spazio a un ingenuo ottimismo: accanto alle “magnifiche sorti e progressive” di questa tecnologia, esistono criticità o comunque situazioni che è bene indagare con attenzione e senza pregiudizi. A maggior ragione questo deve accadere nella Scuola, dove gli e le studenti stanno costruendo quella “cassetta degli attrezzi” che consentirà loro di essere cittadini consapevoli e professionisti capaci e, in definitiva, di vivere una vita serena.
Queste poche pagine servono dunque a questo: individuare alcune prime linee guida per impiegare con profitto l’AI a scuola, offrire dei consigli sempre pratici e costruire strategie risolutive che sappiano accogliere, senza timori, le sfide presenti e future cui l’AI ci chiama.
Un framework per l’AI a Scuola
Una strategia usata da molti esperti di fronte a problemi complessi e all’apparenza inattaccabili è quella del drill down: in parole più semplici e senza inutili tecnicismi, significa scomporre il problema in sotto-problemi più piccoli che quindi possono essere compresi e risolti con più facilità.
La stessa intuizione hanno avuto M. Ranieri, S. Cuomo e G. Biagini nello stendere il loro saggio Scuola e intelligenza artificiale: in questo valido contributo, gli autori costruiscono un framework che serve alla Scuola per scomporre il problema AI. Qui sotto ne riproponiamo una versione semplificata e, a nostro giudizio, più funzionale:
0. AI literacy (o alfabetizzazione)
1. dimensione conoscitiva
2. dimensione operativa
3. dimensione critica
0. AI literacy
“Cercando le parole, si trovano i pensieri”: così ammoniva con sagacia il filosofo francese Joseph Joubert. E quindi il punto di partenza di qualsiasi indagine non può che essere il lessico.
Ecco quindi un primo vocabolario di base:
intelligenza artificiale generativa
Si tratta di un tipo di intelligenza artificiale che è in grado di creare nuovi contenuti, come immagini, testi e suoni, che possono essere indistinguibili da quelli creati da esseri umani.
Esempio:
un software che produce nuove composizioni musicali dopo aver appreso lo stile di vari compositori classici, generando pezzi originali che rispecchiano il gusto e la complessità delle opere apprese.
intelligenza artificiale generale (agi)
Una forma di intelligenza artificiale che può comprendere, imparare ed eseguire compiti intellettuali su un livello paragonabile all’intelligenza umana. L’AGI sarebbe in grado di applicare la conoscenza e le abilità di problem solving in una vasta gamma di contesti diversi, mostrando adattabilità e comprensione del mondo su scala umana. Si ritiene che la realizzazione di un’AGI sia ancora molto lontana.
Esempio:
un sistema AGI potrebbe essere utilizzato per condurre ricerche mediche autonome, formulando ipotesi, conducendo esperimenti virtuali, analizzando dati di studi clinici, e sviluppando nuovi farmaci, adeguandosi alle scoperte emergenti e regolamenti in tempo reale, senza bisogno di direttive specifiche da parte di ricercatori umani.
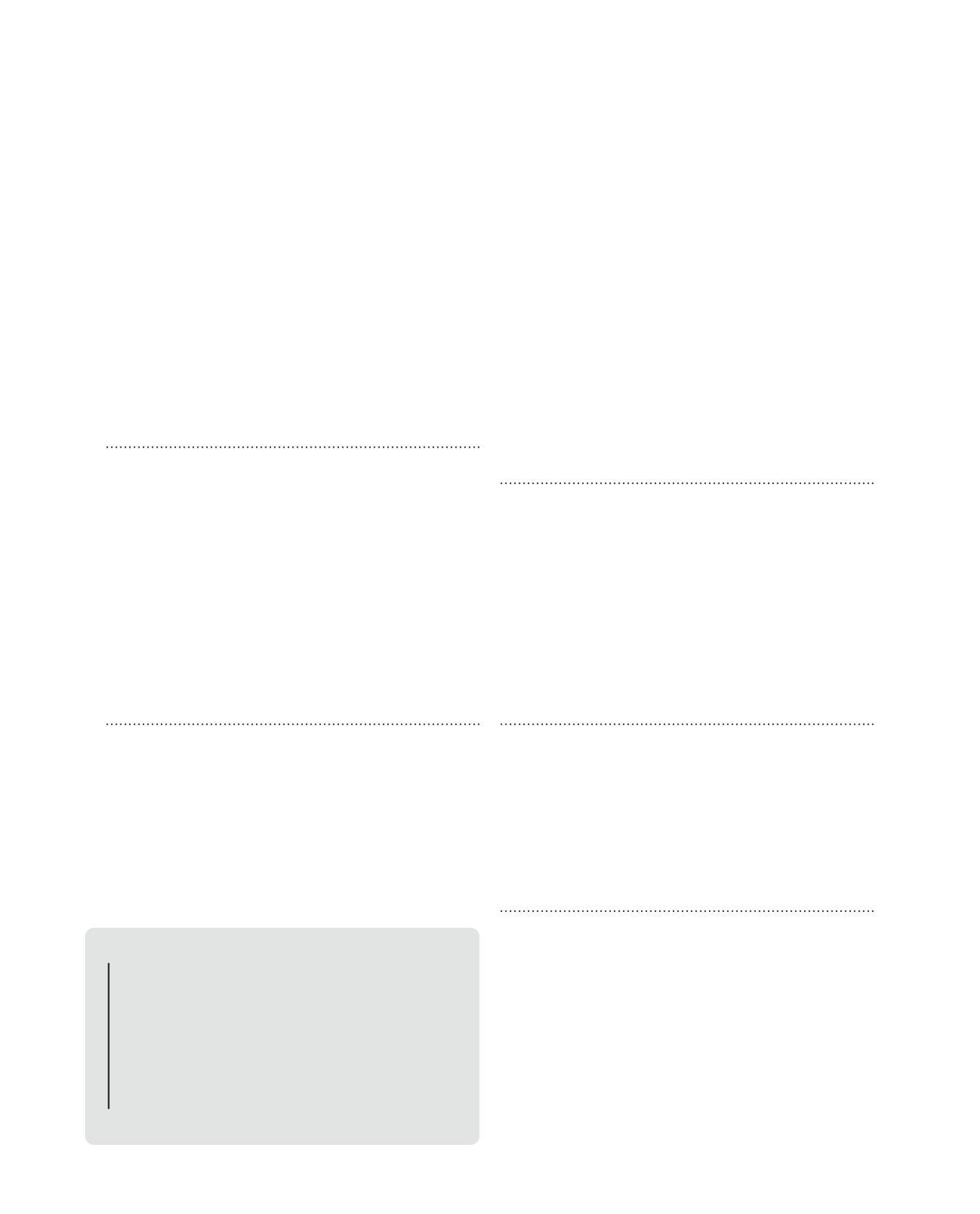
Prompt: la richiesta o l’indicazione fornita a un sistema di intelligenza artificiale per guidarlo a generare un risultato.
Devoto-Oli
large language models (llms)
I modelli di linguaggio di grandi dimensioni sono sistemi di intelligenza artificiale addestrati su vasti corpus di testo che possono comprendere e generare lingua naturale in modo coerente e contestualizzato. Questi modelli sono alla base di molte applicazioni moderne, dalla traduzione automatica ai sistemi di assistenza virtuale.
Esempio:
un assistente digitale che può svolgere compiti complessi come scrivere e-mail, comporre poesie o codificare programmi, basandosi sulla sua comprensione del linguaggio acquisita tramite l’analisi di una grande quantità di testi.
chatbot
Programmi informatici avanzati capaci di condurre una conversazione con gli utenti umani, tipicamente via testo. Questi sistemi sono spesso alimentati da algoritmi di machine learning e intelligenza artificiale per migliorare la capacità di risposta e apprendere dalle interazioni precedenti.
Esempio:
un servizio di assistenza clienti online che utilizza una chatbot per rispondere alle domande frequenti dei clienti, alleggerendo il carico di lavoro del personale di supporto.
allucinazione
Un’allucinazione in un chatbot avviene quando esso fornisce una risposta non accurata o inventata, senza alcuna base nei dati reali o nelle informazioni di cui dispone.
Esempio:
un utente chiede a un chatbot “Qual è la capitale della Svizzera?” e la risposta ottenuta è “La capitale della Svizzera è Zurigo.”
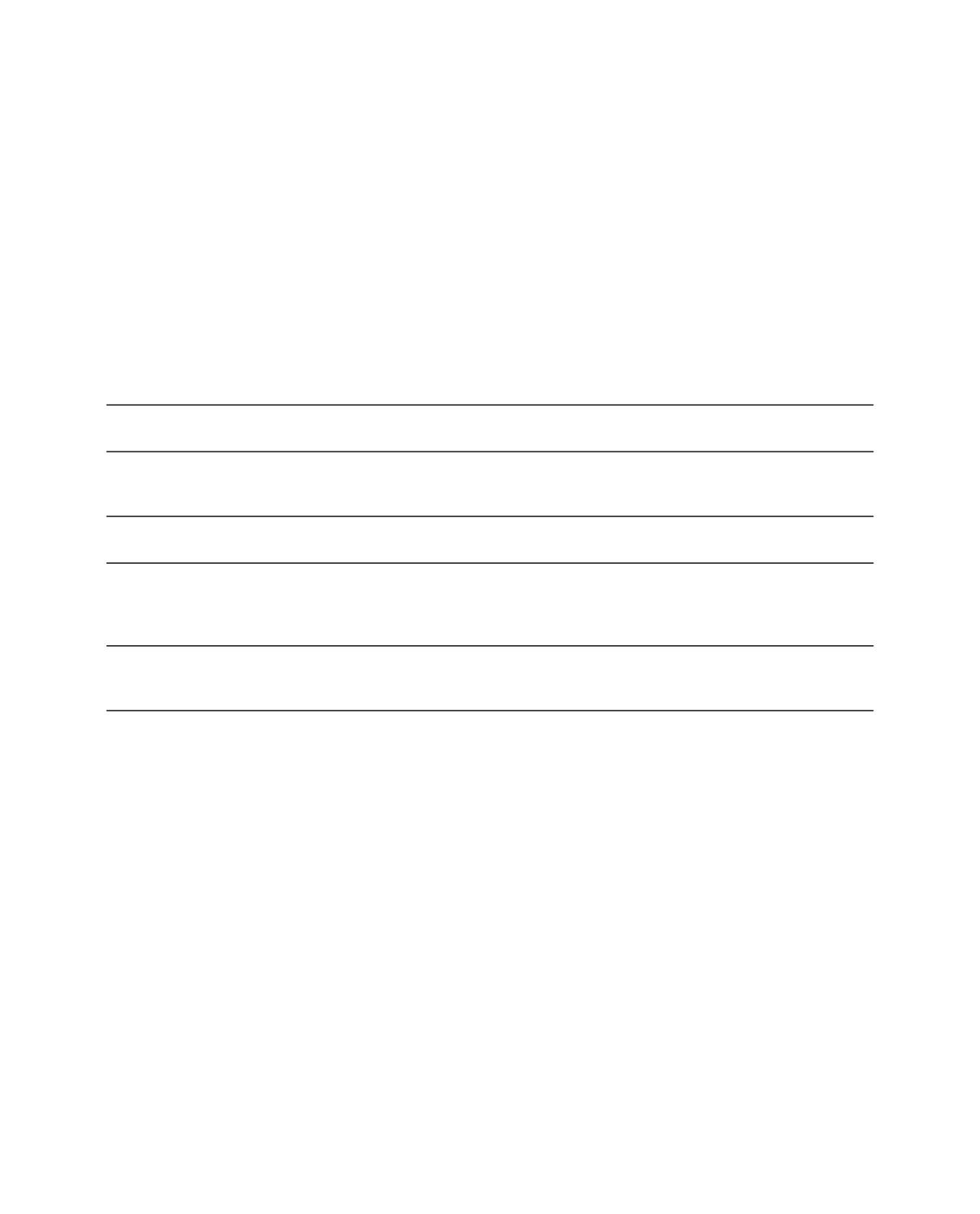
1. Dimensione conoscitiva
In questa prima fase, l’AI è l’oggetto della lezione. Questo passaggio assolve, per lo meno, a un duplice compito: ➀ dare contesto e rendere conto della complessità, anche storica e sociale, di quello che in maniera riduttiva definiamo “software”; ➁ in virtù di questo contesto, rendere più consapevoli gli studenti delle potenzialità e dei limiti dello strumento che useranno in una fase successiva.
I punti di vista possono essere molteplici e ciascuno sceglierà in base alla propria sensibilità e alle proprie competenze:
a → storico: i concetti di analogico e digitale, la costruzione e trasmissione del sapere dalle enciclopedie al web semantico, la storia delle macchine “intelligenti” (una buona sintesi si legge in G. Roncaglia, L’architetto e l’oracolo);
b → storico-sociale: il rapporto uomo-macchina (si veda per esempio: A. Longo, G. Scorza, Intelligenza artificiale. L’impatto sulle nostre vite, diritti e libertà) e il ruolo della macchina nel lavoro (ottimi spunti, anche se solo in inglese, in M. Pasquinelli, The Eye of the Master: A Social History of Artificial Intelligence);
c → filosofico: i concetti di autorialità (il punto di partenza fondamentale resta l’articolo di M. Foucault, Che cos’è un autore) e di creatività (stimolante la lettura di F. D’Isa, La rivoluzione algoritmica. Arte e intelligenza artificiale);
d → giuridico: una lettura attenta del Bejing Consensus (un documento Unesco il cui tentativo è stabilire come l’intelligenza artificiale possa essere utilizzata in modo sicuro, equo ed efficace per promuovere l’educazione a livello globale) e EU AI Act (una proposta di regolamento dell’Unione europea che mira a regolamentare lo sviluppo, l’uso e la diffusione delle tecnologie di intelligenza artificiale);
e → informatico: il funzionamento dell’apprendimento automatico (o machine learning) e la sua explainability (XAI) (si può fare riferimento a N. Cristianini, La scorciatoia. Come le macchine sono diventate intelligenti senza pensare in modo umano).
Al di là delle specifiche pratiche disciplinari, ci sono due istanze di cui ogni docente dovrebbe farsi carico:
etica per l’ai fissa i principi che possono guidare l’uso degli algoritmi nella società e nelle organizzazioni: beneficenza, non maleficenza, autonomia, giustizia, esplicabilità.
etica dell’ai
definisce i problemi etici che gli algoritmi nel loro funzionamento comportano, ovvero l’equità (fairness) e l’iniquità (unfairness): un sistema di AI è considerato equo quando le sue previsioni e decisioni non sono influenzate da pregiudizi o discriminazioni verso gruppi o individui, e quando queste sono chiare, trasparenti e ugualmente applicabili a tutti.
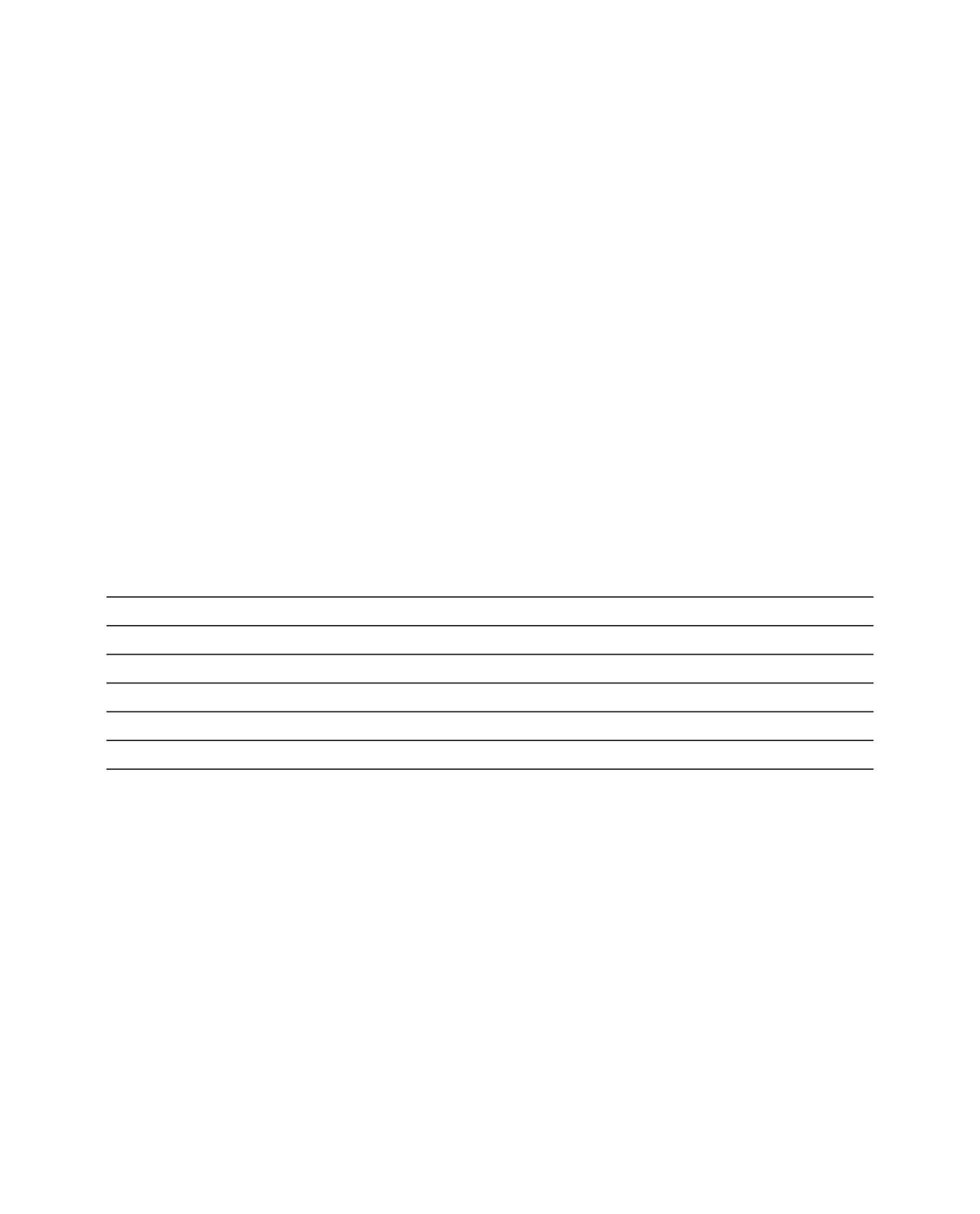
2. Dimensione operativa
In questa seconda fase, l’AI è lo strumento della lezione: grazie a un semplice chatbot gratuito, oggi è infatti possibile generare una molteplicità di artefatti (testo, immagini, video, audio). Più che resistere a questa possibilità e dunque organizzare la propria didattica come “uno strumento di una vera e propria controcultura” (secondo l’espressione del filosofo tedesco Gernot Böhme), la Scuola otterrà maggiori e più utili risultati se insegnerà agli e alle studenti a usare con saggezza questo strumento, affidandogli i compiti per cui è progettato eppure restando sempre in controllo del processo e del prodotto. Non sarà infatti un caso che, una delle più importanti aziende informatiche del pianeta, abbia scelto per i propri servizi AI la metafora del co-pilota. Non si tratta solo di una banalità pedagogica. Si ricordi infatti ciò che sancisce quella che gli esperti hanno chiamato la legge di Kasparov (in onore del grande scacchista russo e delle sue leggendarie sfide contro il supercomputer IBM Deep Blue): una combinazione efficace di intelligenza umana e intelligenza artificiale lavora meglio di ciascuna delle due intelligenze (umana o artificiale) presa singolarmente.
Lo strumento AI più diffuso e che ciascuno di noi usa quotidianamente è un chatbot, cioè un software AI che risponde a domande e interagisce con gli utenti, adattandosi al contesto delle conversazioni.
la prima cautela ricordare che un chatbot è un motore di ragionamento (reasoning engine) e non un semplice archivio di dati (fact database): per esempio, eccelle nel brainstorming creativo, ma non sempre è attendibile nelle ricerche di dati.
la seconda cautela sapere che la qualità dell’artefatto dipenderà dalla nostra capacità di porre in modo efficiente le giuste domande (ricordate la legge di Kasparov?). Ecco quindi alcune buone pratiche per dialogare (il cosiddetto prompting) con profitto con un chatbot:
➊ esprimersi in modo grammaticalmente corretto;
➋ essere chiari e specifici;
➌ fornire contesto e vincoli;
➍ utilizzare suggerimenti ed esempi;
➎ fare una richiesta alla volta;
➏ rivedere e affinare la propria richiesta.
In termini concreti, potete chiedere al chatbot di generare un testo su qualsiasi argomento e ci sono buone probabilità che il testo che riceverete come risposta non sarà soddisfacente. Sarà importante quindi, per esempio, dare indicazioni su: la forma (un punto elenco, dialogo; perché no, una breve poesia); la lunghezza; la difficoltà oppure la competenza del destinatario (una cosa è chiedere un testo destinato agli studenti e un’altra è chiedere un testo destinato ai colleghi); il tono (formale o informale) e lo stile; la lingua (i chatbot sembrano cavarsela particolarmente bene nelle attività di traduzione, per esempio). Insomma, come scrive P.C. Rivoltella: “l’IA si può rivelare una validissima alleata nel lavoro di produzione creativa e di presa di decisione; imparare a servirsene, in una logica di co-creazione, fa parte di sicuro della nuova literacy che occorre sviluppare”.
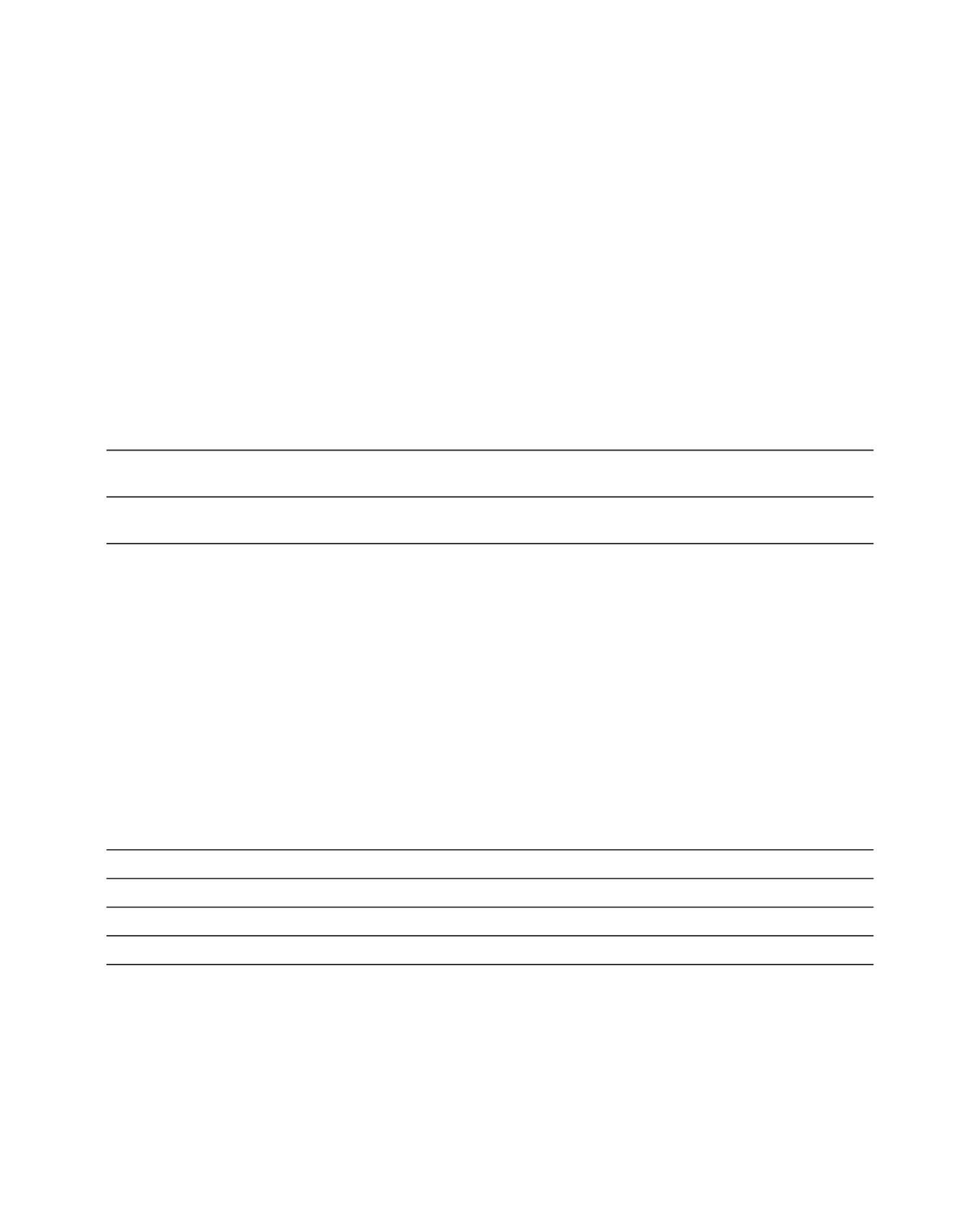
Da quanto detto fin qui, emerge che l’AI potrà essere un valido aiuto anche per il docente, nelle molteplici attività che svolge prima della lezione, durante la lezione, dopo la lezione: (a) progettare e pianificare; (b) spiegare e presentare; (c) personalizzare e supportare; (d) erogare e gestire.
Proviamo a elencare qualche esempio: generare indicazioni sui compiti con i criteri di valutazione | sviluppare istruzioni che descrivono i ruoli e le aspettative dell’apprendimento cooperativo || produrre poster che elencano i 10 motivi per cui l’algebra è importante per il futuro degli studenti o i 20 errori di scrittura più comuni degli studenti delle scuole superiori, con brevi definizioni ed esempi | creare esempi risolti di problemi matematici, equazioni di chimica, ecc. con la spiegazione di ogni fase | costruire un organizzatore per la lettura preliminare o anticipata, estraendo il vocabolario critico e non familiare da un capitolo ed elencando le parole chiave con le relative definizioni | preparare delle flashcard con domande e risposte || semplificare la comunicazione con i genitori, i colleghi e le segreterie attraverso lettere di benvenuto alla classe, proposte di gite, programmi di assemblea e fogli di autorizzazione.
E se invece volessimo concentrarci sul monitoraggio e la valutazione:
liste di controllo: un chatbot può sviluppare una lista di attività e processi che aiuti lo studente nel percorso di metacognizione;
test: un chatbot può creare test su uno o più argomenti, con il numero e i tipi di quesiti che voi indicherete; potete richiedere anche le soluzioni con una breve spiegazione; rubriche: un chatbot sa comporre con facilità una rubrica per qualsiasi tipo di prestazione dello studente: analitica, olistica e di sviluppo; oppure suggerirvi scale e tabelle di valutazione.
3. Dimensione critica
La terza fase critica interessa infine la competenza del saper riconoscere e distinguere fra reale, verosimile e falso. La pratica del fact-checking è già in uso nelle scuole da tempo, eppure l’AI ci pone di fronte a sfideancora più complesse.
Una buona strategia è trasmettere agli studenti una semplice routine di domande (che adattiamo dal lavoro di B. Mastroianni, La disputa felice):
individuare la fonte: chi lo dice? data, luogo, circostanze: quando e dove?
verificabilità: qualcuno lo conferma?
autorevolezza: chi lo conferma?
confronto: ci sono altre versioni?
Parafrasando un valido contributo dei pedagogisti americani E.R. Mollick & L. Mollick, queste strategie promuovono una supervisione attiva e lo stimolo a combinare le capacità dell’AI con i contributi individuali, sfidando gli studenti a rimanere il “fattore umano” nel processo (human in the loop) per garantire che l’AI funzioni come uno strumento di supporto piuttosto che come un sostituto.
La valutazione dell’artefatto
La valutazione è spesso guardata con sospetto e diffidenza. Eppure è un processo che, se progettato ed eseguito con intelligenza, non è solo uno strumento diagnostico che consente al docente di evitare che le difficoltà degli studenti degenerino in insuccessi. Di più: se interpretata come relazione (e non già come la comunicazione arida di un voto), la valutazione è formazione dell’individuo che, in quanto tale, consente di conoscere sé stessi, interpretare il proprio presente e progettare il proprio futuro.
La valutazione in un processo di apprendimento arricchito dall’AI (AI-enhanced) deve possedere necessariamente alcune caratteristiche: ➀ essere formativa e integrata durante tutto il processo; ➁ offrire un feedback prospettico e costruttivo (che consenta cioè di visualizzare gli strumenti e le fasi dell’apprendimento); ➂ valorizzare la complessità di questa “prestazione epistemica” (che è quindi un insieme di informazioni disciplinari, pratiche di conoscenza, creatività).
Proponiamo qui in chiusura una semplice tabella che può servire come punto di partenza per qualsiasi pratica valutativa.
criteri descrizione punteggio *
Capacità di porre domande rilevanti
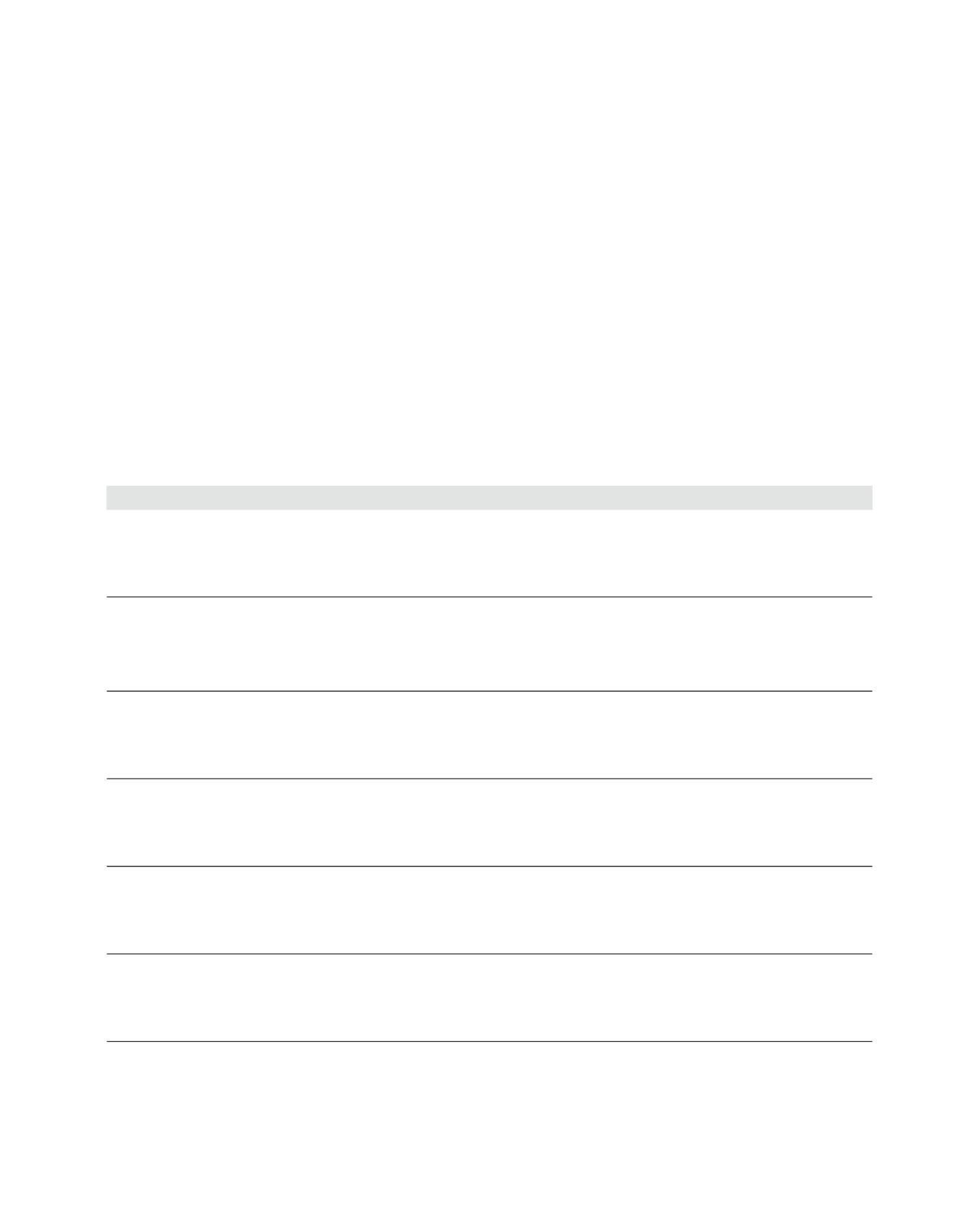
Capacità di strutturazione di ragionamenti complessi
Creatività nell’uso del chatbot
Autonomia nell’uso del chatbot
Riflessione critica
Presentazione del prodotto finale
= Non soddisfacente
La capacità di formulare domande pertinenti e ben strutturate per ottenere informazioni utili dal chatbot.
L’abilità di affinare continuamente le richieste e collegare le risposte del chatbot per costruire un discorso articolato e ben strutturato.
L’uso originale e innovativo del chatbot per esplorare soluzioni o punti di vista nuovi.
La capacità dello studente di utilizzare il chatbot in modo indipendente, senza costante supporto esterno.
L’abilità dello studente di riflettere criticamente sulle informazioni ricevute e di metterle in discussione.
La qualità della presentazione del lavoro finale derivato dall’interazione con il chatbot (chiarezza, coerenza, accuratezza).
= Adeguato
➀ ➁ ➂ ➃ ➄
➀ ➁ ➂ ➃ ➄
➀ ➁ ➂ ➃ ➄
➀ ➁ ➂ ➃ ➄
➀ ➁ ➂ ➃ ➄
➁ ➂ ➃ ➄
15 consigli per costruire prompt efficaci
11
stile
Se desideri una risposta formale, usa un linguaggio formale nel prompt; se preferisci uno stile informale o creativo, adattalo di conseguenza.
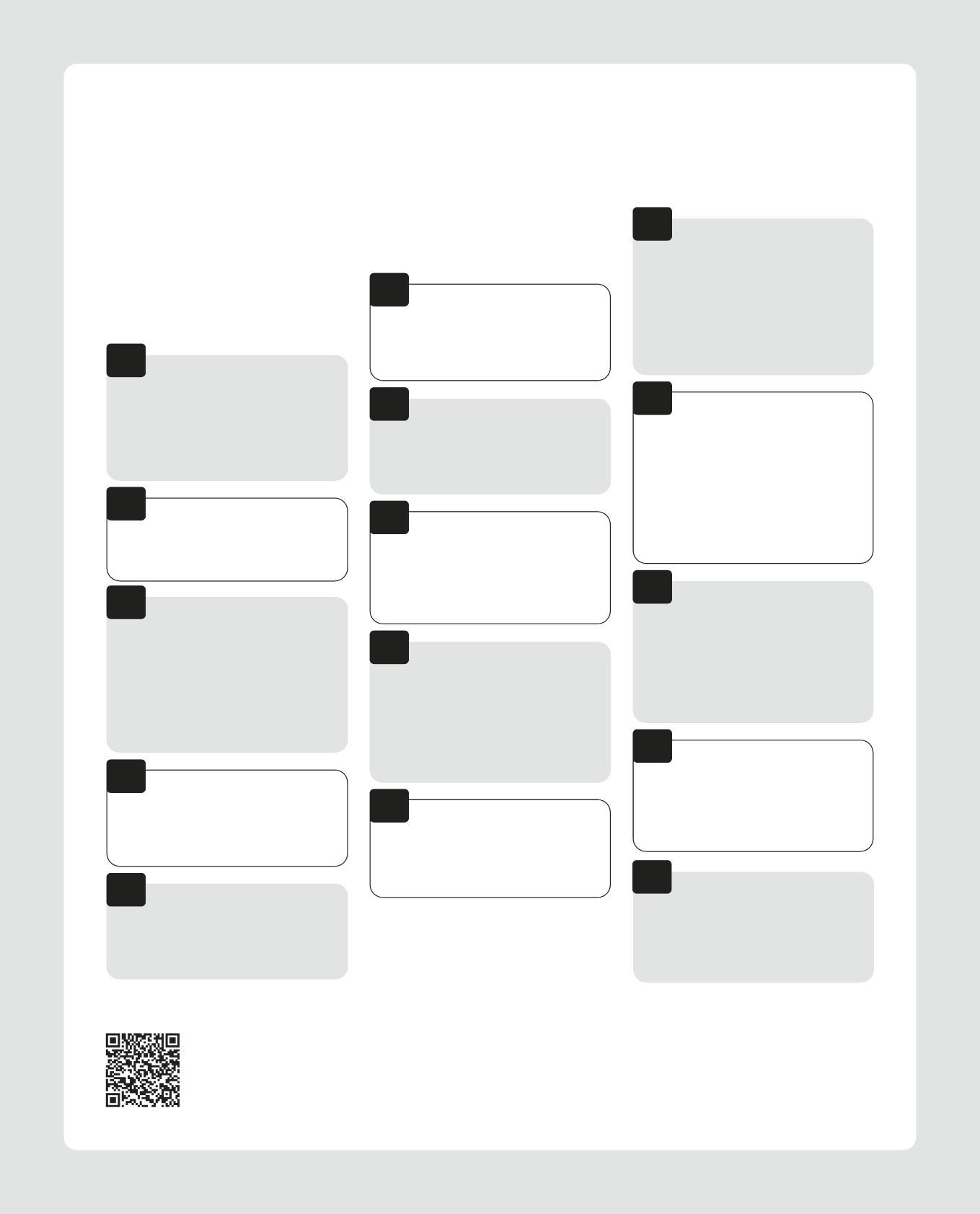
obiettivi
Prima di scrivere il prompt, è importante organizzare le idee e definire il tipo di risultato che vogliamo raggiungere. Per una richiesta sufficientemente completa, il prompt dovrà contenere almeno cinque parole.
target
Il prompt deve comunicare chiaramente ciò che si desidera ottenere: evita i convenevoli e le domande vaghe o ambigue.
istruzioni
È opportuno iniziare la richiesta utilizzando comandi diretti come “Spiega”,“Descrivi”, “Elabora”, “Indica” ecc.: questo aiuterà il modello a capire l’azione richiesta. Per ricevere risposte più elaborate, utilizza domande aperte invece di domande chiuse e inserisci istruzioni più lunghe e più complesse.
contesto
Fornisci dettagli o limitazioni per definire il contesto. Per esempio specifica l’età dei destinatari e il tipo di scuola che frequentano.
ruolo
Indica il ruolo che il bot dovrà assumere nella conversazione, per esempio un insegnante, un esperto in un argomento, un poeta.
07
dettagli
Se stai cercando una risposta basata su dati o informazioni specifiche, fornisci dettagli rilevanti come date, luoghi, nomi o simili.
formato
Se hai un formato particolare in mente per la risposta, come un elenco puntato, un paragrafo conciso o una spiegazione dettagliata, devi specificarlo nel prompt: “Elenca in formato elenco puntato…”.
esempi
lunghezza
Limita le risposte del bot a un certo numero di parole o di paragrafi. Potrebbe trattarsi di qualsiasi cosa, dal condensare le informazioni di quattro paragrafi in uno, o chiedere risposte con parole di otto caratteri o meno. Questo offre all’AI la flessibilità necessaria per generare una risposta che rientri nell’intervallo specificato.
12
limiti
Dato che esistono dei limiti precisi di input di token, quando la richiesta è particolarmente complessa, suddividila in passaggi più piccoli; per esempio, anziché chiedere “Parlami della rivoluzione industriale”, circoscrivi la richiesta in questo modo: “Spiega le cause e gli effetti della Rivoluzione industriale in Italia nel XIX secolo”.
13
remix
Tratti da: “Costruire il futuro. Linee guida sull’utilizzo dell’AI in ambito scolastico” - Rete di scuole FVG.
Fornisci esempi di testo che rispondano alla richiesta specifica. Per esempio, se vuoi generare un testo che descriva un prodotto, è utile fornirgli esempi di descrizioni di prodotti già esistenti. In questo modo, il bot capisce meglio cosa vuoi ottenere e genera un testo più preciso e pertinente.
09 sentiment
Quando è necessario, definisci i “sentiment” (cioè le emozioni, gli stati d’animo) per adattare la risposta alle emozioni richieste.
Puoi creare un prompt efficace anche ricorrendo al “copia e incolla”. Puoi chiedere al chatbot di semplificare un testo difficile, come la spiegazione di un concetto scientifico, oppure fargli tradurre un contenuto in diverse lingue, o ancora riscrivere un articolo con uno stile più accattivante.
14
coerenza
Ogni tanto l’AI perde il filo del discorso e se ricominci da zero (quindi se clicchi su new chat) tutto sarà dimenticato. Se invece resti nella stessa discussione puoi mantenere memoria di quanto è stato scritto.
15
allenamento
Un prompt efficace può richiedere pratica e adattamento per ottenere i risultati desiderati. Sperimenta e perfeziona le tue tecniche man mano che acquisisci familiarità con il modello.
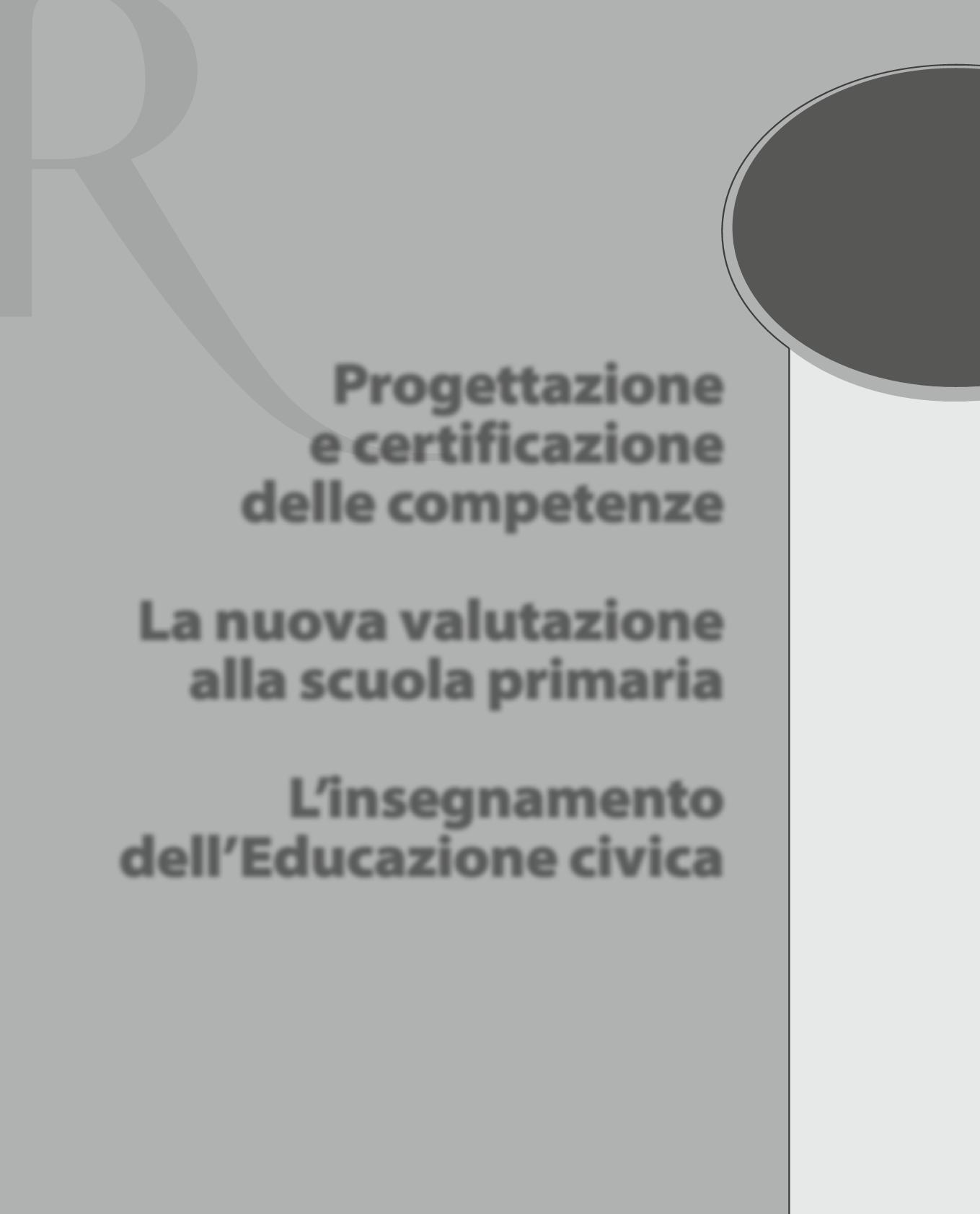
Progettazione e certificazione delle competenze
La nuova valutazione alla scuola primaria
L’insegnamento dell’Educazione civica
PROGETTAZIONE CURRICOLARE
E DIDATTICA E CERTIFICAZIONE
DELLE COMPETENZE

di Dino Cristanini
Le competenze come orizzonte formativo
«Le competenze chiave sono quelle di cui tutti hanno bisogno per la realizzazione e lo sviluppo personali, l’occupabilità, l’inclusione sociale, uno stile di vita sostenibile, una vita fruttuosa in società pacifiche, una gestione della vita attenta alla salute e la cittadinanza attiva» si afferma nella Raccomandazione del Consiglio dell’Unione europea del 22 maggio 2018 relativa alle competenze chiave per l’apprendimento permanente, che ha sostituito quella precedente del 18 dicembre 2006.
Le Indicazioni nazionali per il curricolo assumono le competenze chiave come l’«orizzonte di riferimento verso cui tendere», e individuano nel Profilo dello studente le competenze che un ragazzo dovrebbe avere sviluppato al termine del primo ciclo di istruzione, che saranno oggetto della certificazione prevista dall’art. 9 del D.Lgs n. 62/2017.
Si delinea così un percorso coerente tra progettazione, attività didattiche, valutazione e certificazione delle competenze, che trova concreta attuazione nelle proposte della Guida
La progettazione
Le scuole, affermano le Indicazioni nazionali, nella progettazione del curricolo assumono come riferimenti il Profilo dello studente al termine del primo ciclo di istruzione, i traguardi per lo sviluppo delle competenze e gli obiettivi di apprendimento specifici per ogni disciplina.
I traguardi, individuati nelle Indicazioni nazionali per ciascuna disciplina al termine della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado, descrivono lo sviluppo delle competenze che è ragionevole attendersi in corrispondenza di queste fasi evolutive. Al tempo stesso rappresentano una «garanzia dell’unità del sistema nazionale e della qualità del servizio» e perciò costituiscono «riferimenti ineludibili per gli insegnanti» e «nella loro scansione temporale, sono prescrittivi, impegnando così le istituzioni scolastiche affinché ogni alunno possa conseguirli».
Gli obiettivi di apprendimento, che nelle Indicazioni nazionali sono raggruppati per nuclei tematici, sono i mattoni con cui costruire lo sviluppo delle competenze, e definiscono le abilità e le conoscenze necessarie per il raggiungimento dei traguardi.
La progettazione dell’azione didattica ha poi il compito di individuare le scelte metodologiche e le esperienze di apprendimento più adeguate per il raggiungimento degli obiettivi e dei traguardi. Alle pagine 32-37, per evidenziare le connessioni tra tutti gli elementi della progettazione, vengono perciò allineati:
• i nuclei tematici di Matematica e Scienze in relazione ai quali sono raggruppati gli obiettivi nelle Indicazioni nazionali;
• i traguardi per lo sviluppo delle competenze previsti dalle Indicazioni nazionali al termine della scuola primaria, ciascuno connesso al nucleo maggiormente pertinente, fermo restando che alcuni traguardi possono essere connessi anche a più nuclei;
• gli obiettivi di apprendimento previsti dalle Indicazioni nazionali al termine della classe quinta della scuola primaria, correlati ai nuclei tematici pertinenti;
• i contenuti da utilizzare e le attività da svolgere per promuovere il raggiungimento degli obiettivi e dei traguardi da parte degli alunni.
La certificazione
Il modello
Il modello di certificazione per la scuola primaria adottato con D.M. n. 14 del 30 gennaio 2024 fa riferimento alle competenze chiave della Raccomandazione europea del 2018, descritte in base al Profilo dello studente declinato in relazione alla situazione attesa al termine di questo grado di scuola.
COMPETENZE CHIAVE COMPETENZE
Competenza alfabetica funzionale
Competenza multilinguistica
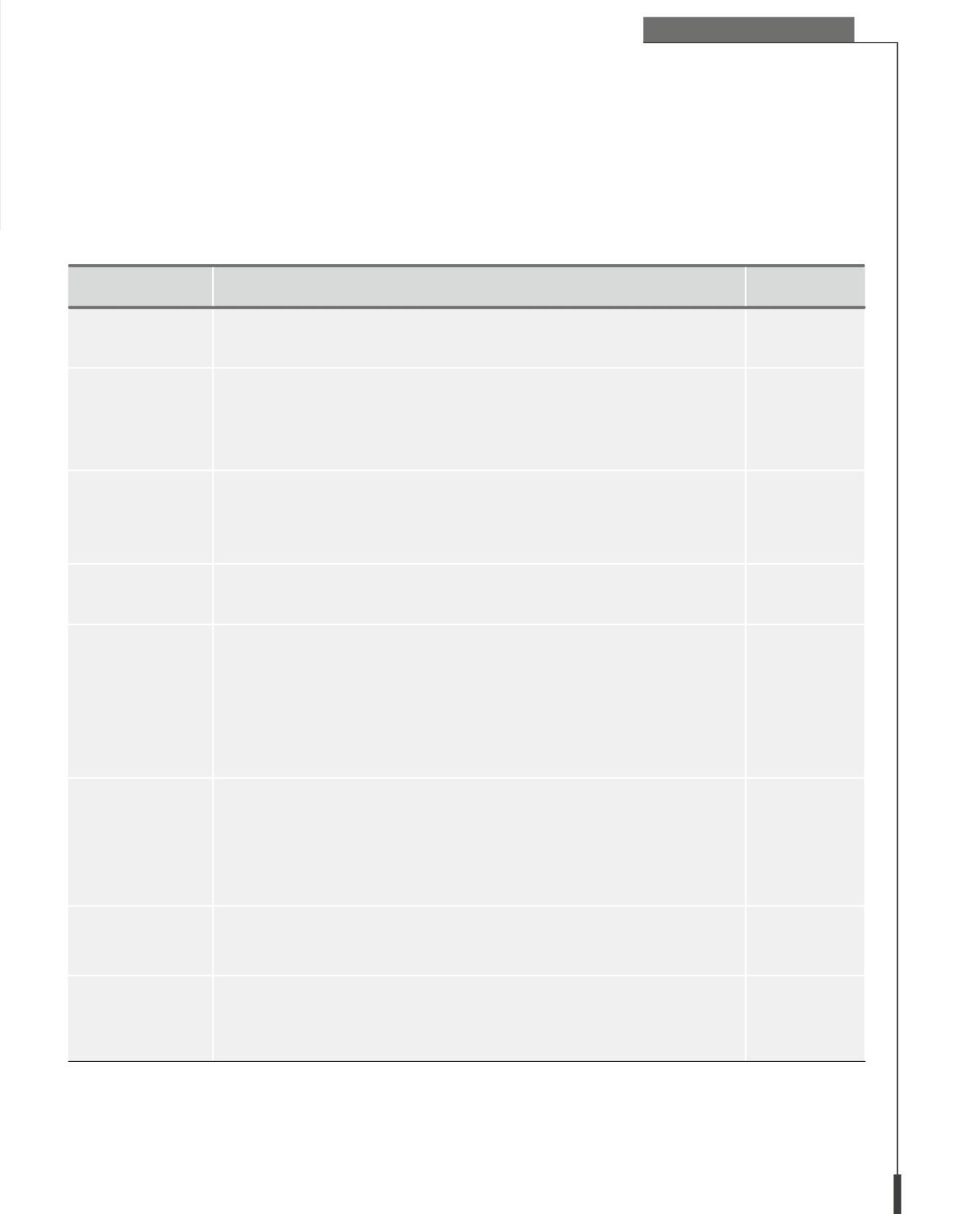
Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria
Padroneggiare la lingua di scolarizzazione in modo da comprendere enunciati, raccontare le proprie esperienze e adottare un registro linguistico appropriato alle diverse situazioni.
Utilizzare la lingua inglese a livello elementare in forma orale e scritta (comprensione orale e scritta, produzione scritta e produzione/interazione orale) in semplici situazioni di vita quotidiana in aree che riguardano bisogni immediati o argomenti molto familiari (Livello A1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue).
Avere consapevolezza che esistono lingue e culture diverse
Utilizzare le conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche per trovare e giustificare soluzioni a problemi reali.
Osservare comportamenti e atteggiamenti rispettosi verso l’ambiente, i beni comuni, la sostenibilità.
Competenza digitale Utilizzare con responsabilità le tecnologie digitali in contesti comunicativi concreti per ricercare informazioni e per interagire con altre persone, come supporto alla creatività e alla soluzione di problemi semplici.
Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare
Competenza in materia di cittadinanza
Avere cura e rispetto di sé, degli altri e dell’ambiente; affrontare positivamente i conflitti, collaborare con altri, empatizzare.
Esprimere le proprie personali opinioni e sensibilità nel rispetto di sé e degli altri.
Utilizzare conoscenze e nozioni di base per ricercare nuove informazioni. Accedere a nuovi apprendimenti anche in modo autonomo.
Portare a compimento il lavoro iniziato, da solo o insieme agli altri.
Rispettare le regole condivise e collaborare con gli altri per la costruzione del bene comune.
Partecipare alle diverse forme di vita comunitaria, divenendo consapevole dei valori costituzionali.
Riconoscere le diverse identità, le tradizioni culturali e religiose in un’ottica di dialogo e di rispetto reciproco.
Competenza imprenditoriale
Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali
Dimostrare originalità e spirito di iniziativa. Realizzare semplici progetti. Assumersi le proprie responsabilità, chiedere aiuto e fornirlo quando necessario.
Riflettere sulle proprie scelte.
Orientarsi nello spazio e nel tempo, osservando e descrivendo ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche, esprimendo curiosità e ricerca di senso.
In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento, esprimersi negli ambiti più congeniali: motori, artistici e musicali.
Nel modello è previsto anche un ulteriore spazio, per dar modo alla scuola di evidenziare anche eventuali significative competenze manifestate dall’alunno nello svolgimento di attività scolastiche e/o extrascolastiche.
I livelli
Per ciascuna delle competenze da certificare il modello prevede quattro possibili livelli:
A AVANZATOL’alunno/a svolge compiti e risolve problemi complessi, mostrando padronanza nell’uso delle conoscenze e delle abilità; propone e sostiene le proprie opinioni e assume in modo responsabile decisioni consapevoli.
B INTERMEDIOL’alunno/a svolge compiti e risolve problemi in situazioni nuove, compie scelte consapevoli, mostrando di saper utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite.
C BASE L’alunno/a svolge compiti semplici anche in situazioni nuove, mostrando di possedere conoscenze e abilità fondamentali e di saper applicare basilari regole e procedure apprese.
D INIZIALE L’alunno/a, se opportunamente guidato/a, svolge compiti semplici in situazioni note.
Data la dimensione promozionale e proattiva che la certificazione assume nel primo ciclo non si prevede un livello manifestamente negativo, ma si porta l’attenzione su ciò che l’alunno riesce comunque a fare.
Strumenti per valutare le competenze
Per accertare il possesso delle competenze servono strumenti diversi da quelli tradizionalmente utilizzati per la verifica dell’acquisizione di conoscenze e abilità. La letteratura scientifica in materia individua la strumentazione ottimale nell’integrazione di tre tipi di strumenti.
Compiti di realtà
Osservazioni sistematiche degli insegnanti
Narrazione dell’alunno del percorso cognitivo compiuto
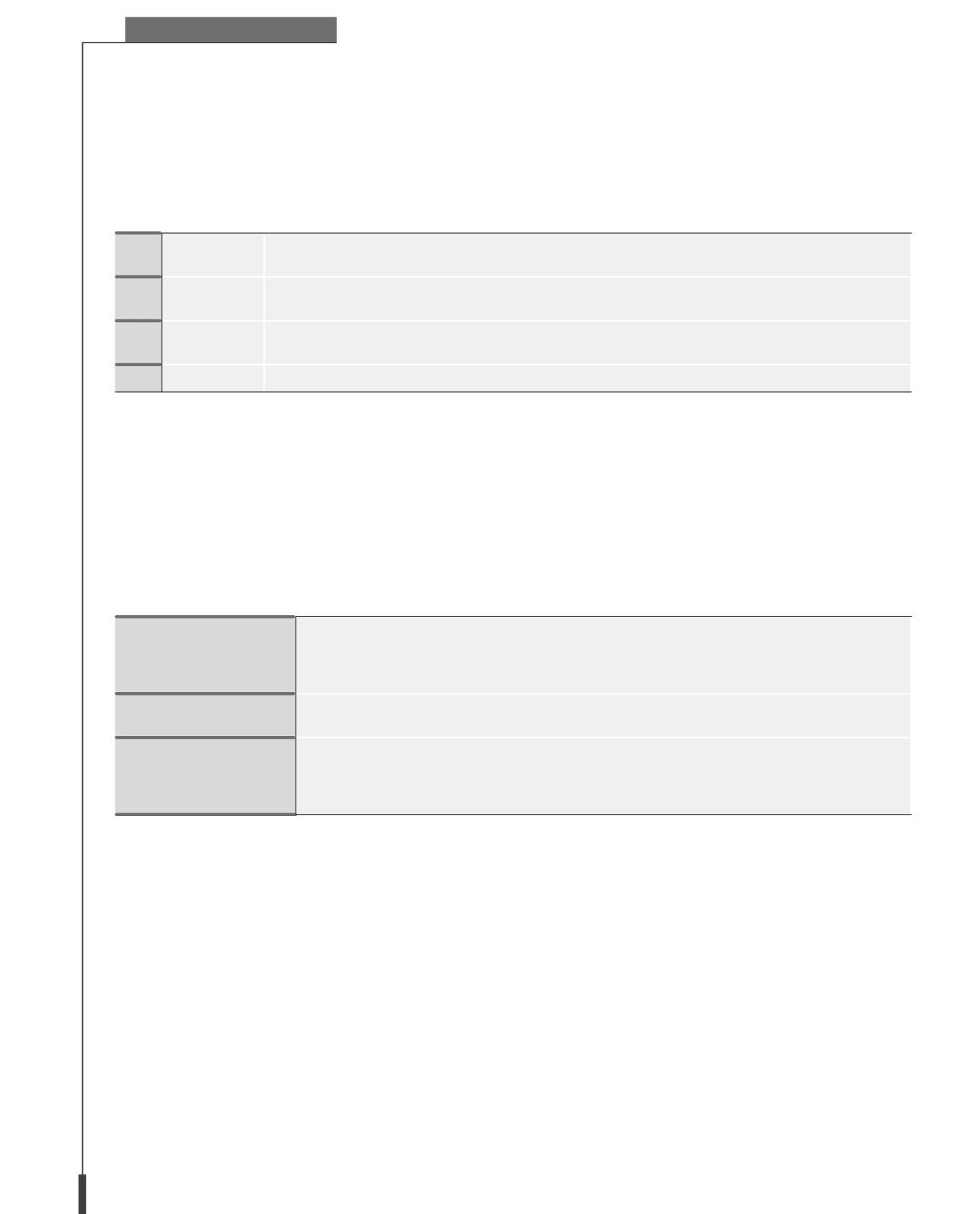
Richiesta all’alunno di risolvere una situazione problematica, complessa e nuova, quanto più possibile vicina al mondo reale, utilizzando conoscenze e abilità già acquisite e trasferendo procedure e condotte cognitive in contesti e ambiti di riferimento moderatamente diversi da quelli resi familiari dalla pratica didattica.
Rilevazione dei processi, delle operazioni che l’alunno compie per interpretare e svolgere il compito.
Racconto delle operazioni compiute, degli aspetti più interessanti, delle difficoltà incontrate e del modo in cui sono state superate, delle emozioni provate, autovalutazione del prodotto e del processo adottato.
Questi strumenti vanno utilizzati durante l’intero percorso della scuola primaria per acquisire informazioni sul grado di avvicinamento degli alunni ai traguardi definiti per ciascuna disciplina e alle competenze riportate nel modello di certificazione.
Competenze e traguardi
Nelle Indicazioni nazionali si afferma che «nella scuola del primo ciclo i traguardi costituiscono criteri per la valutazione delle competenze attese». Occorre perciò individuare nell’ambito delle varie discipline i traguardi che concorrono allo sviluppo delle diverse competenze.
Per facilitare questa operazione la tabella seguente presenta il quadro delle correlazioni tra i traguardi di Scienze e Matematica e le competenze da certificare al termine della scuola primaria.
Quadro
delle correlazioni tra i traguardi per lo sviluppo delle
competenze di Storia e Geografia e le competenze da certificare con il modello nazionale
COMPETENZE CHIAVE RACCOMANDAZIONE EUROPEA 2018
Competenza alfabetica funzionale
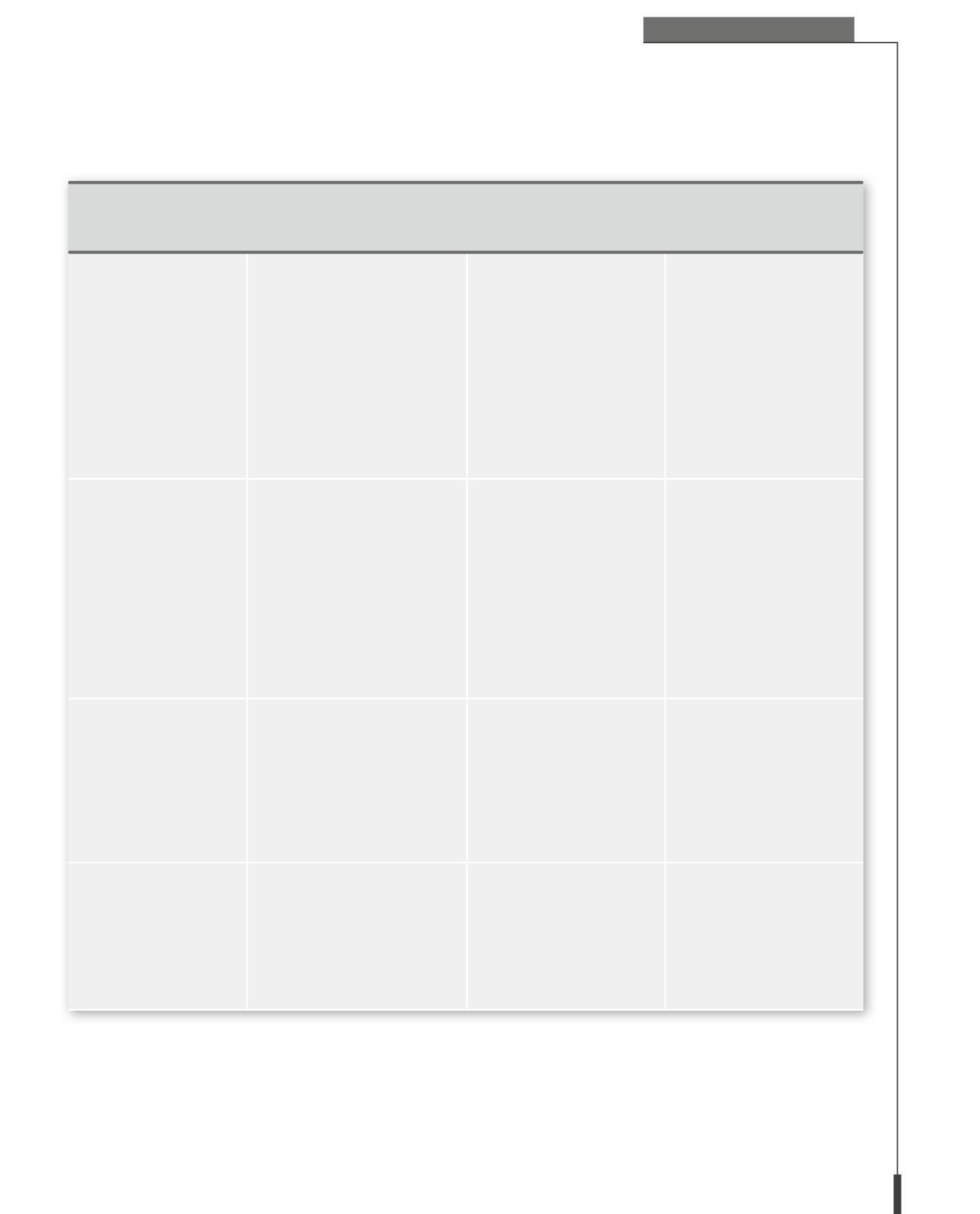
Competenza multilinguistica
Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria
Competenze da certificare Al termine della scuola primaria
• Padroneggiare la lingua di scolarizzazione in modo da comprendere enunciati, raccontare le proprie esperienze e adottare un registro linguistico appropriato alle diverse situazioni.
Traguardi per lo sviluppo delle competenze di Matematica declinati per la classe quarta
• Riconosce le principali caratteristiche dei testi storici (ricostruzione/narrazione di eventi e trasformazioni) e ne ricava informazioni utili alla comprensione dei fatti storici.
• Espone in forma orale e scritta, eventualmente utilizzando anche risorse digitali, gli elementi caratterizzanti delle civiltà studiate, gli avvenimenti e i cambiamenti nel tempo.
Traguardi per lo sviluppo delle competenze di Scienze declinati per la classe quarta
• Riconosce e denomina monti, colline, pianure, fiumi, laghi, mari, coste dei paesaggi geografici italiani.
Competenza digitale
• Utilizzare la lingua inglese a livello elementare in forma orale e scritta (comprensione orale e scritta, produzione scritta e produzione/ interazione orale) in semplici situazioni di vita quotidiana in aree che riguardano bisogni immediati o argomenti molto familiari (Livello A1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue).
• Avere consapevolezza che esistono lingue e culture diverse
• Utilizzare le conoscenze matematiche e scientificotecnologiche per trovare e giustificare soluzioni a problemi reali.
• Osservare comportamenti e atteggiamenti rispettosi verso l’ambiente, i beni comuni, la sostenibilità.
• Utilizzare con responsabilità le tecnologie digitali in contesti comunicativi concreti per ricercare informazioni e per interagire con altre persone, come supporto alla creatività e alla soluzione di problemi semplici.
• Espone in forma orale e scritta, eventualmente utilizzando anche risorse digitali, gli elementi caratterizzanti delle civiltà studiate, gli avvenimenti e i cambiamenti nel tempo.
• Ricava informazioni geografiche, con particolare riferimento al territorio italiano, mediante l’analisi di fonti di diverso genere, anche digitali.
Progettazione e certificazione
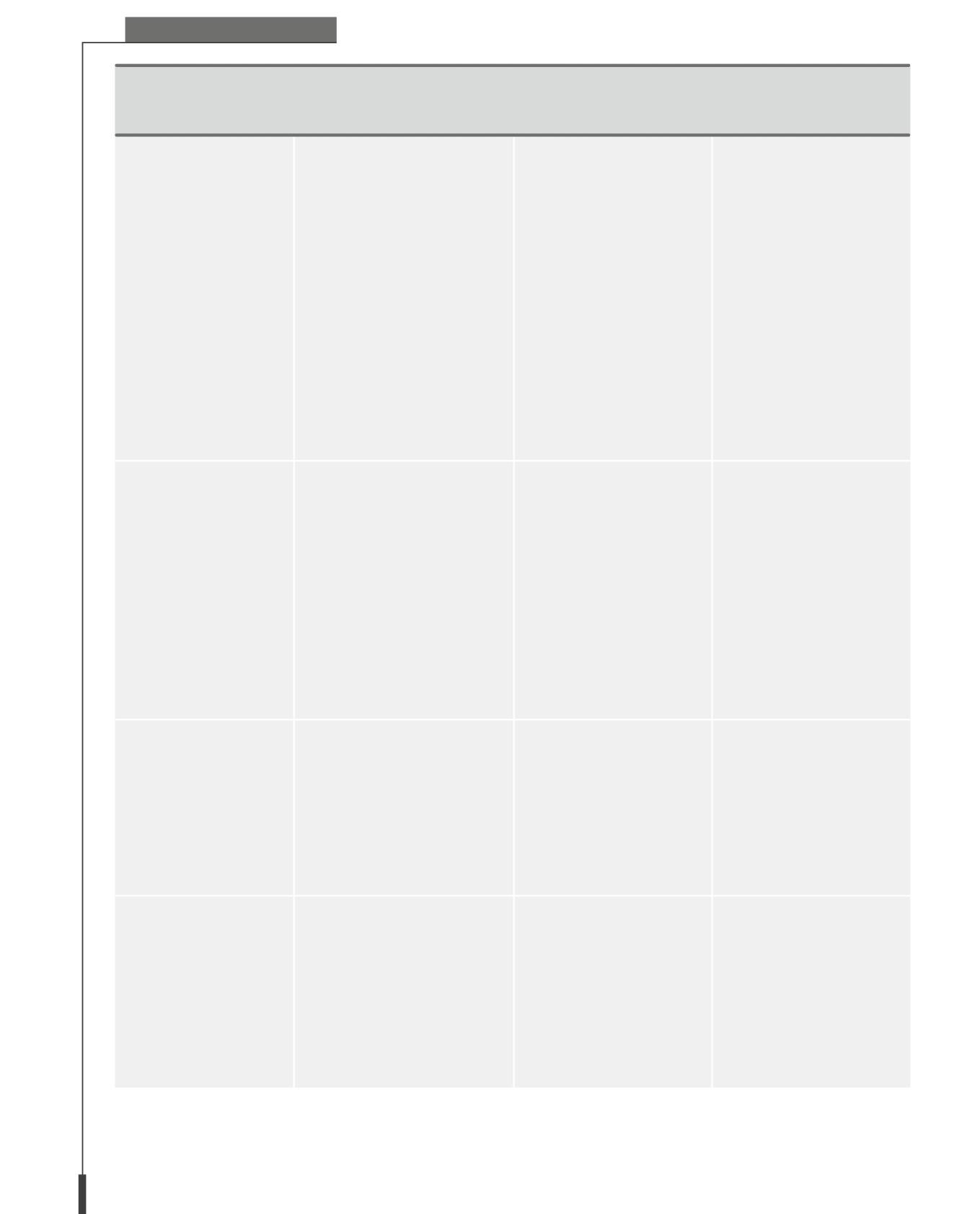
COMPETENZE CHIAVE RACCOMANDAZIONE EUROPEA 2018
Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare
Competenze da certificare Al termine della scuola primaria
• Avere cura e rispetto di sé, degli altri e dell’ambiente; affrontare positivamente i conflitti, collaborare con altri, empatizzare.
• Esprimere le proprie personali opinioni e sensibilità nel rispetto di sé e degli altri.
• Utilizzare conoscenze e nozioni di base per ricercare nuove informazioni.
• Accedere a nuovi apprendimenti anche in modo autonomo.
• Portare a compimento il lavoro iniziato, da solo o insieme agli altri.
Traguardi per lo sviluppo delle competenze di Matematica declinati per la classe quarta
• Usa la linea del tempo per organizzare informazioni, conoscenze, periodi e individuare successioni, contemporaneità, durate, periodizzazioni in relazione alle civiltà studiate.
• Individua le relazioni tra le civiltà studiate e i relativi contesti spaziali.
• Comprende avvenimenti, fatti e fenomeni delle società e civiltà che hanno caratterizzato le civiltà antiche (Mesopotamia, Egitto, India, Cina, civiltà cretese, fenicia ed ebraica) e li confronta con il quadro di civiltà del presente.
Traguardi per lo sviluppo delle competenze di Scienze declinati per la classe quarta
• Si orienta sia nello spazio circostante sia su carte geografiche di vario tipo relative in particolare al territorio italiano utilizzando sia riferimenti topologici sia i punti cardinali.
• Individua i principali caratteri dei paesaggi geografici e le analogie e differenze tra di essi.
• Riconosce e denomina monti, colline, pianure, fiumi, laghi, mari, coste dei paesaggi geografici italiani.
• Comprende il concetto di spazio geografico come esito dell’interdipendenza di elementi fisici e antropici.
Competenza in materia di cittadinanza
• Rispettare le regole condivise e collaborare con gli altri per la costruzione del bene comune.
• Partecipare alle diverse forme di vita comunitaria, divenendo consapevole dei valori costituzionali.
• Riconoscere le diverse identità, le tradizioni culturali e religiose in un’ottica di dialogo e di rispetto reciproco.
• Individua e interpreta le tracce del passato presenti nel territorio e comprende l’importanza della conservazione del patrimonio culturale.
• Comprende avvenimenti, fatti e fenomeni delle società e civiltà che hanno caratterizzato le civiltà antiche (Mesopotamia, Egitto, India, Cina, civiltà cretese, fenicia ed ebraica) e li confronta con il quadro di civiltà del presente.
• Individua e comprende le trasformazioni intervenute nei paesaggi italiani a seguito dell’attività e degli interventi umani.
• Comprende il concetto di spazio geografico come esito dell’interdipendenza di elementi fisici e antropici.
Competenza imprenditoriale
• Dimostrare originalità e spirito di iniziativa.
• Realizzare semplici progetti.
• Assumersi le proprie responsabilità, chiedere aiuto e fornirlo quando necessario.
• Riflettere sulle proprie scelte.
Competenza imprenditoriale
• Orientarsi nello spazio e nel tempo, osservando e descrivendo ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche, esprimendo curiosità e ricerca di senso.
• In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento, esprimersi negli ambiti più congeniali: motori, artistici e musicali.
• Conosce le caratteristiche delle carte geostoriche e la relativa simbologia e le utilizza per comprendere le vicende delle civiltà studiate.
• Organizza le informazioni e le conoscenze relative alle civiltà studiate utilizzando il concetto di quadro di civiltà e i relativi indicatori.
• Conosce e utilizza i simboli convenzionali del linguaggio geografico per interpretare carte geografiche di diverso genere.
• Ricava informazioni geografiche mediante l’analisi di fonti di diverso genere, anche digitali.
Programmazione annuale di Storia – Classe 4a
Nucleo tematico
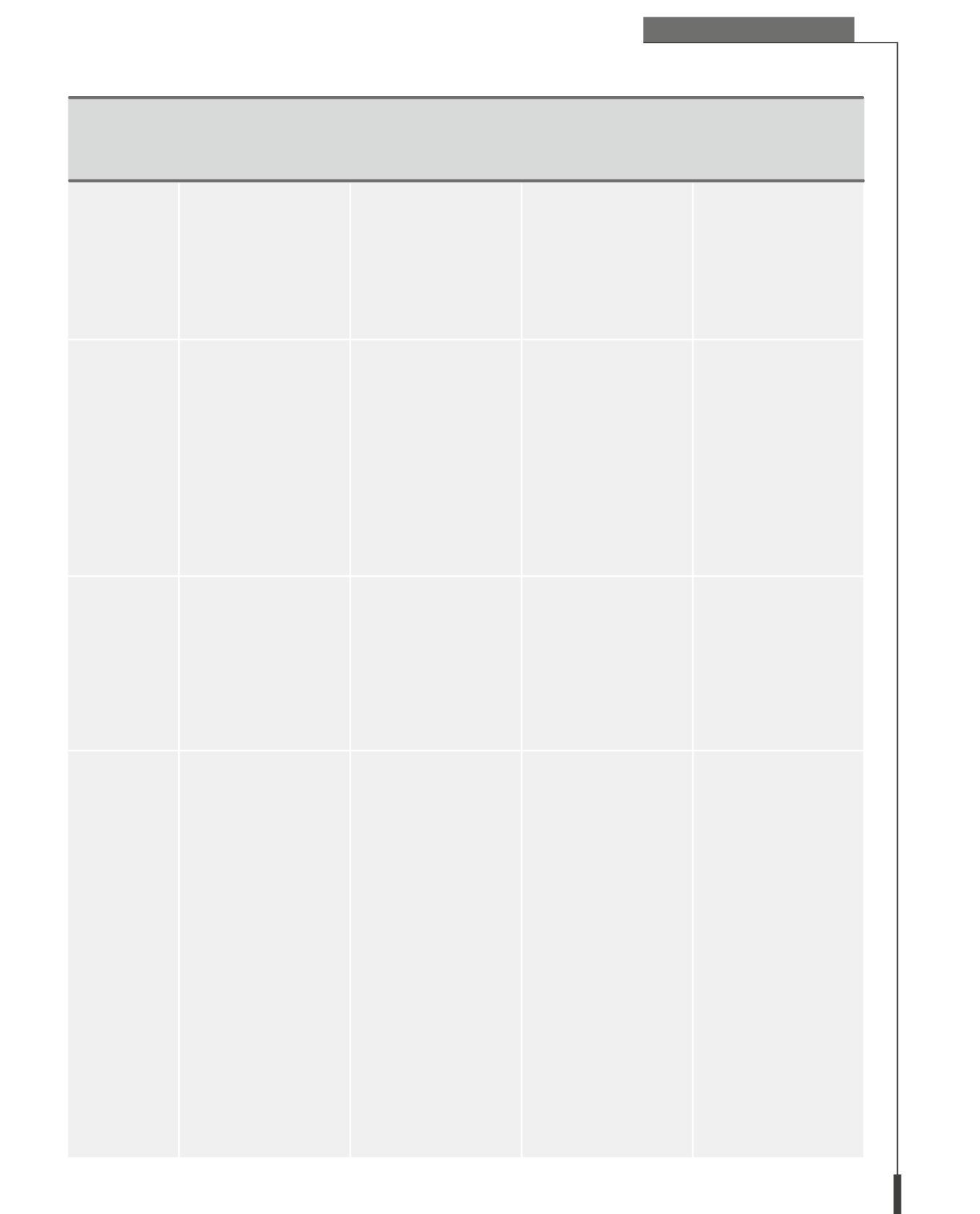
Uso delle fonti
Traguardo di sviluppo delle competenze al termine della scuola primaria (da indicazioni ministeriali)
• Riconosce elementi significativi del passato del suo ambiente di vita.
• Riconosce elementi e tracce storiche presenti nel territorio e inizia ad apprezzare il patrimonio artistico e culturale.
• Usa carte geostoriche, anche con l’ausilio di strumenti informatici.
• Individua le relazioni tra gruppi umani e contesti spaziali.
Organizzazione delle informazioni
Strumenti concettuali
• Organizza le informazioni e le conoscenze, tematizzando e usando le concettualizzazioni pertinenti.
• Usa la linea del tempo per organizzare informazioni, conoscenze, periodi e individuare successioni, contemporaneità, durate, periodizzazioni.
Traguardi declinati per la classe quarta
• Individua e interpreta le tracce del passato presenti nel territorio e comprende l’importanza della conservazione del patrimonio culturale.
Obiettivi di apprendimento declinati per la classe quarta
• Conoscere le tracce del passato presenti nel proprio ambiente di vita.
• Utilizzare le informazioni ricavate dalle fonti per ricostruire un quadro storico sociale da confrontare con quello presente e comprendere i cambiamenti avvenuti.
Contenuti e attività
• Ricostruzione del quadro di civiltà del tempo presente mediante l’utilizzo di fonti di tipo diverso.
Produzione scritta e orale
• Comprende i testi storici proposti e sa individuarne le caratteristiche.
• Comprende avvenimenti, fatti e fenomeni delle società e civiltà che hanno caratterizzato la storia dell’umanità dal Paleolitico alla fine del mondo antico con possibilità di apertura e di confronto con la contemporaneità.
• Comprende aspetti fondamentali del passato dell’Italia dal Paleolitico alla fine dell’Impero romano d’Occidente, con possibilità di apertura e di confronto con la contemporaneità.
• Racconta i fatti studiati e sa produrre semplici testi storici, anche con risorse digitali.
• Conosce le caratteristiche delle carte geostoriche e la relativa simbologia e le utilizza per comprendere le vicende delle civiltà studiate.
• Individua le relazioni tra le civiltà studiate e i relativi contesti spaziali.
• Organizza le informazioni e le conoscenze relative alle civiltà studiate utilizzando il concetto di quadro di civiltà e i relativi indicatori.
• Usa la linea del tempo per organizzare informazioni, conoscenze, periodi e individuare successioni, contemporaneità, durate, periodizzazioni in relazione alle civiltà studiate.
• Riconosce le principali caratteristiche dei testi storici (ricostruzione/ narrazione di eventi e trasformazioni) e ne ricava informazioni utili alla comprensione dei fatti storici.
• Comprende avvenimenti, fatti e fenomeni delle società e civiltà che hanno caratterizzato le civiltà antiche (Mesopotamia, Egitto, civiltà ebraica, India, Cina, civiltà fenicia e cretese) e li confronta con il quadro di civiltà del presente.
• Espone in forma orale e scritta, eventualmente utilizzando anche risorse digitali, gli elementi caratterizzanti delle civiltà studiate, gli avvenimenti e i cambiamenti nel tempo.
• Confrontare i quadri storici delle civiltà antiche studiate in relazione alla collocazione spaziale e temporale anche utilizzando le informazioni desunte dalle carte geostoriche.
• Comprendere il concetto di quadro di civiltà e gli indicatori di riferimento per l’organizzazione delle informazioni.
• Conoscere e utilizzare il sistema di misura del tempo storico e la periodizzazione occidentale.
• Collocare e ordinare sulla linea del tempo i periodi storici relativi alle civiltà studiate e individuare contemporaneità e successioni.
• Ricavare e produrre informazioni da fonti di diversa natura e da testi di genere diverso, manualistici e non, cartacei e digitali.
• Elaborare rappresentazioni sintetiche delle società studiate, mettendo in rilievo le relazioni fra gli elementi caratterizzanti mediante gli indicatori dei quadri di civiltà.
• Esporre le conoscenze apprese in modo coerente, rispettando le relazioni temporali e di causa-effetto e usando il linguaggio specifico della disciplina, in forma orale e scritta.
• Confronto dei quadri storici delle civiltà antiche.
• Presentazione del sistema di misura occidentale del tempo storico (avanti Cristo-dopo Cristo), a partire dall’esperienza personale.
• Ricostruzione –attraverso l’uso di fonti, testi, carte geostoriche e linee del tempo –dei quadri di civiltà dell’antichità relativi a Mesopotamia, Egitto, civiltà ebraica, India, Cina, civiltà fenicia e cretese.
• Individuazione degli elementi delle civiltà antiche che permangono nel tempo presente.
Programmazione annuale di Geografia – Classe 4a
Nucleo tematico Traguardo di sviluppo delle competenze al termine della scuola primaria (da indicazioni ministeriali)
• Si orienta nello spazio circostante e sulle carte geografiche, utilizzando riferimenti topologici e punti cardinali.
Orientamento
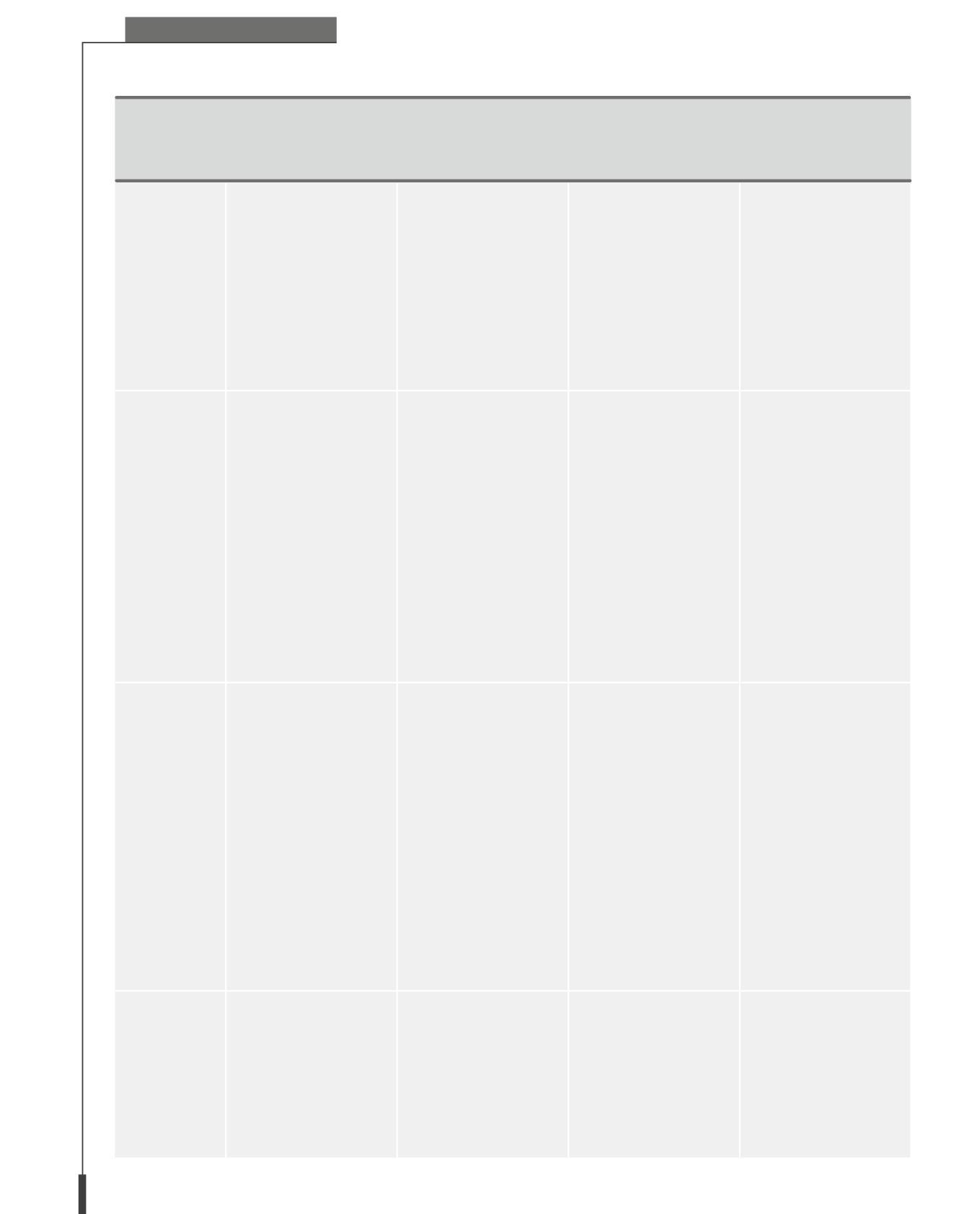
Linguaggio della geo-graficità
• Utilizza il linguaggio della geo-graficità per interpretare carte geografiche e globo terrestre, realizzare semplici schizzi cartografici e carte tematiche, progettare percorsi e itinerari di viaggio.
• Ricava informazioni geografiche da una pluralità di fonti (cartografiche e satellitari, tecnologie digitali, fotografiche, artistico-letterarie).
• Riconosce e denomina i principali “oggetti” geografici fisici.
• Individua i caratteri che connotano i paesaggi (di montagna, collina, pianura, vulcanici ecc.) con particolare attenzione a quelli italiani, e individua analogie e differenze con i principali paesaggi europei e di altri continenti.
• Coglie nei paesaggi mondiali della Storia le progressive trasformazioni operate dall’uomo sul paesaggio naturale.
Traguardi declinati per la classe quarta
• Si orienta sia nello spazio circostante sia su carte geografiche di vario tipo relative in particolare al territorio italiano, utilizzando sia riferimenti topologici sia i punti cardinali.
Obiettivi di apprendimento declinati per la classe quarta
• Orientarsi nello spazio circostante in riferimento alla posizione del Sole o della Stella Polare e ai punti cardinali.
• Orientarsi utilizzando la bussola.
• Orientarsi sulle carte usando punti cardinali e coordinate del reticolo.
• Ricavare informazioni geografiche da varie fonti.
• Conosce e utilizza i simboli convenzionali del linguaggio geografico per interpretare carte geografiche di diverso genere.
• Ricava informazioni geografiche mediante l’analisi di fonti di diverso genere, anche digitali.
• Localizzare sul planisfero e sul globo la posizione dell’Italia in Europa e nel mondo.
• Analizzare i caratteri fisici del territorio utilizzando fonti e strumenti di vario genere.
Contenuti e attività
• Riconosce e denomina monti, colline, pianure, fiumi, laghi, mari, coste dei paesaggi geografici italiani.
• Individua i principali caratteri dei paesaggi geografici e le analogie e differenze tra di essi.
• Individua e comprende le trasformazioni intervenute nei paesaggi italiani a seguito dell’attività e degli interventi umani.
• Elaborare il concetto di regione climatica.
• Localizzare sulla carta geografica dell’Italia le regioni climatiche.
• Conoscere gli elementi che caratterizzano i principali paesaggi mondiali e italiani.
• Modi e strumenti per orientarsi.
• Le caratteristiche delle diverse rappresentazioni cartografiche e il loro uso in contesti diversi.
• Le fonti da cui ricavare informazioni geografiche: filmati, fotografie, carte geografiche, grafici, tabelle e dati statistici.
• I simboli della cartografia geografica.
• Gli elementi del paesaggio.
Regione e sistema territoriale
• Si rende conto che lo spazio geografico è un sistema territoriale, costituito da elementi fisici e antropici legati da rapporti di connessione e/o di interdipendenza.
• Comprende il concetto di spazio geografico come esito dell’interdipendenza di elementi fisici e antropici.
• Riconoscere gli elementi naturali del paesaggio e quelli antropici.
• Individuare i problemi relativi alla tutela del patrimonio naturale ed eventualmente proporre soluzioni per la sua salvaguardia.
• I fattori che determinano il clima.
• Come analizzare le caratteristiche climatiche di una zona.
• Le caratteristiche fisiche dei diversi paesaggi del mondo e dell’Europa.
• Le caratteristiche delle regioni climatiche italiane.
• Le caratteristiche fisiche dei diversi paesaggi italiani, somiglianze e differenze.
• Individuazione delle relazioni esistenti tra ambiente e risorse.
• Elaborazione del concetto di economia.
• Attività umane e settori produttivi in Italia.
• Individuazione degli elementi del paesaggio da tutelare e valorizzare.
• Popolazione e densità abitativa in Italia.
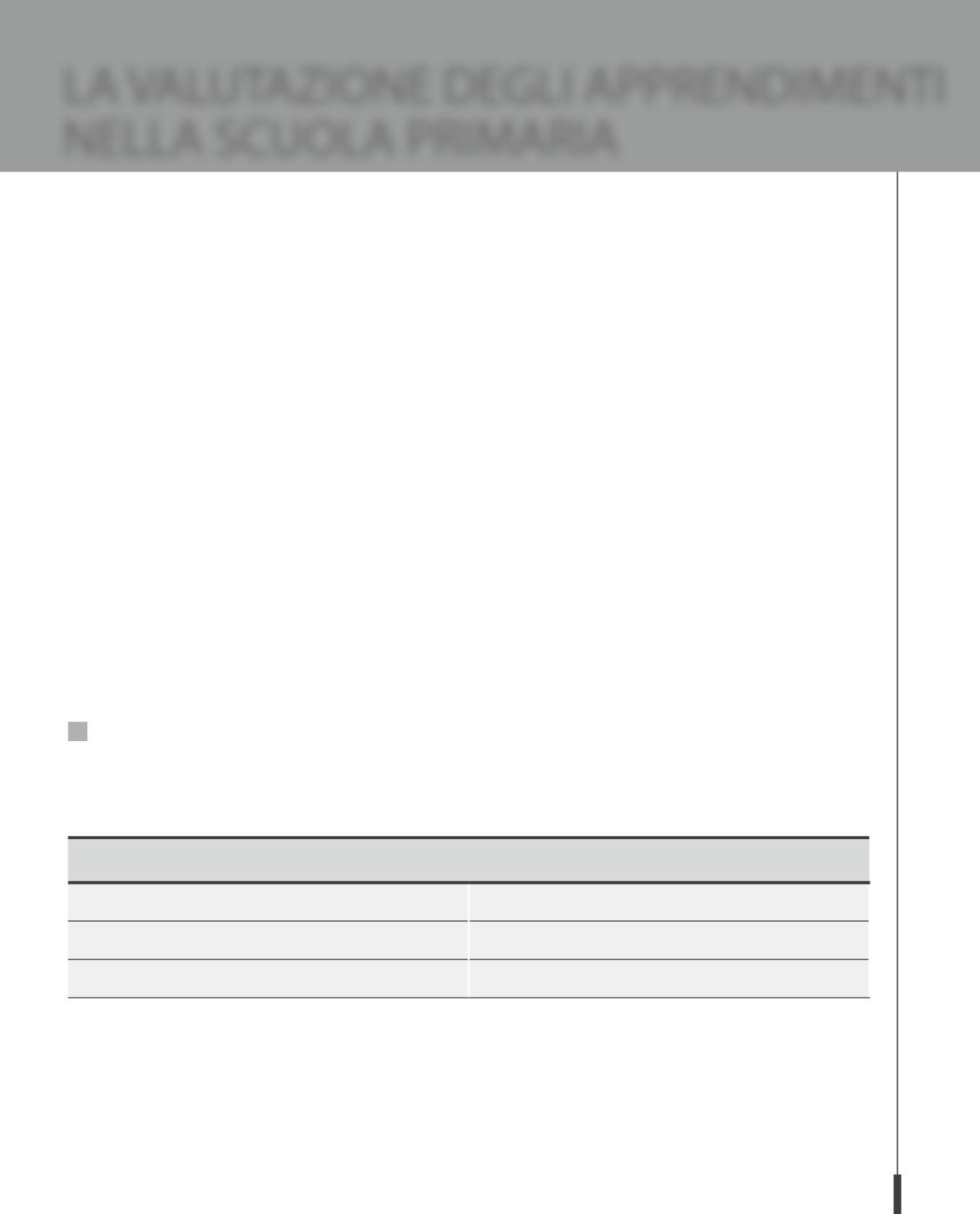
LA VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI NELLA SCUOLA PRIMARIA
a cura di Dino Cristanini
La valutazione, affermano le Indicazioni nazionali per il curricolo, «precede, accompagna e segue i percorsi curricolari». Si valuta nella fase d’ingresso per acquisire gli elementi di conoscenza relativi allo stato degli apprendimenti di alunne e alunni utili a definire gli obiettivi e a scegliere i metodi più adeguati in rapporto alle concrete e specifiche situazioni. Si valuta alla fine di determinati periodi per esprimere un giudizio complessivo sui processi attivati e sugli esiti conseguiti (funzione sommativa). Ma soprattutto si valuta sistematicamente in itinere (funzione formativa) sia per regolare l’azione didattica in base a quanto via via rilevato sia per restituire agli alunni e alle alunne informazioni idonee a renderli consapevoli degli apprendimenti raggiunti e delle criticità, unitamente ai suggerimenti su cosa fare per migliorare (feedback formativi). La legge n. 150/2024 ha modificato ancora una volta le norme relative alla valutazione degli apprendimenti nella scuola primaria, compresi quelli riguardanti l’insegnamento trasversale di educazione civica, prevedendo che dall’ a.s. 2024/2025 essa venga espressa con “giudizi sintetici correlati alla descrizione dei livelli di apprendimento raggiunti”, in base a modalità definite con definite con ordinanza del Ministro dell’istruzione e del merito.
È stato perciò avviato l’iter per l’emanazione dell’ordinanza, che ha portato alla presentazione di un testo sottoposto al parere obbligatorio ma non vincolante del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione (CSPI), parere che è stato espresso nella seduta plenaria del 18 novembre 2024. È a questo schema di ordinanza, non essendo al momento dell’andata in stampa ancora stato emanato il testo ufficiale, che facciamo riferimento per illustrare gli elementi di novità più rilevanti e significativi.
L’entrata in vigore
L’art. 7 dello schema di ordinanza prevede che, per consentire alle scuole di effettuare le operazioni relative alla transizione nel nuovo sistema, entreranno in vigore a partire dalla valutazione finale relativa all’a.s. 2024/2025.
I NUOVI LIVELLI
I giudizi sintetici sono espressi con aggettivi riferiti a sei livelli
A. ottimo B. discreto
C. ottimo D. sufficiente
A. ottimo F. non sufficiente
Si tratta di una scala ordinale, come in genere tutte o quasi le scale utilizzate nel campo scolastico, che consente di graduare i risultati di apprendimento secondo fasce distinte, ma nella quale gli intervalli tra l’una e l’altra non sono uguali e che di per sé non offre informazioni su quali sono gli apprendimenti corrispondenti a ciascun livello. Il compito di fornire queste informazioni è affidato alle descrizioni che dovranno essere elaborate dai collegi dei docenti facendo riferimento alla tabella allegata all’Ordinanza.
Le
descrizioni dei livelli di apprendimento corrispondenti ai giudizi
Il comma 5 dell’art. 3 dello schema di ordinanza prevede che «Le istituzioni scolastiche, nell’ambito dell’autonomia didattica di cui all’articolo 4, comma 4 del DPR n. 275/1999, elaborano i criteri di valutazione, da inserire nel Piano triennale dell’offerta formativa, declinando, altresì, per ciascun anno di corso e per ogni disciplina del curricolo la descrizione dei livelli di apprendimento correlati ai giudizi sintetici riportati nell’Allegato A alla presente ordinanza.»
Tabella 1 - Allegato A allo schema di ordinanza
Descrizione dei giudizi sintetici per la valutazione degli apprendimenti nella scuola primaria
OTTIMO
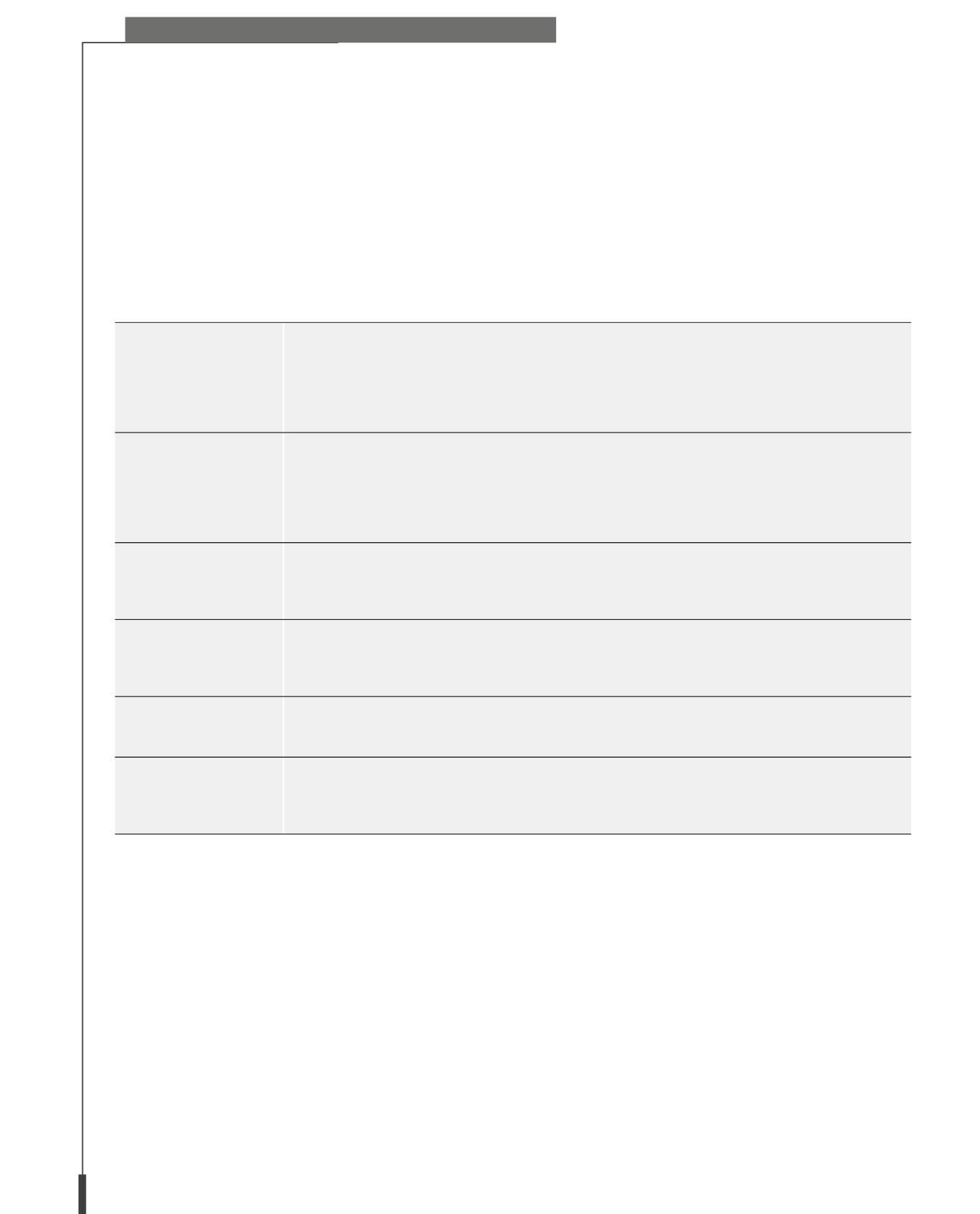
DISTINTO
L’alunno/a porta a termine con piena autonomia le attività servendosi di un’ampia varietà di risorse personali o disponibili nel contesto. Utilizza consapevolmente con continuità le conoscenze disciplinari e applica le abilità acquisite per svolgere compiti complessi e risolvere problemi anche riferiti a situazioni non affrontate in precedenza. È in grado di proporre analisi e sintesi personali in modo originale, collegando le informazioni, argomentando il proprio punto di vista ed esprimendosi con proprietà di linguaggio e in modo adeguato alla situazione.
L’alunno/a porta a termine con piena autonomia le attività servendosi di un’ampia varietà di risorse personali o disponibili nel contesto. Utilizza consapevolmente con continuità le conoscenze disciplinari e applica le abilità acquisite per svolgere compiti complessi e risolvere problemi anche riferiti a situazioni non affrontate in precedenza. È in grado di proporre analisi e sintesi personali in modo originale, collegando le informazioni, argomentando il proprio punto di vista ed esprimendosi con proprietà di linguaggio e in modo adeguato alla situazione.
BUONO
DISCRETO
SUFFICIENTE
NON SUFFICIENTE
L’alunno/a porta a termine le attività servendosi di alcune risorse personali o disponibili nel contesto. Fa ricorso ad alcune conoscenze disciplinari e abilità acquisite per svolgere compiti e risolvere problemi simili ad altri già affrontati. È in grado di collegare le informazioni, esprimendosi in modo adeguato alla situazione.
L’alunno/a porta a termine le attività se guidato nell’uso delle risorse personali o disponibili nel contesto. Fa ricorso ad alcune conoscenze disciplinari e abilità acquisite per svolgere semplici compiti e risolvere problemi se già affrontati in precedenza. Si esprime in modo abbastanza adeguato alla situazione.
L’alunno/a, solo se guidato, porta a termine le attività proposte, utilizzando alcune delle risorse messe a disposizione dal docente. Applica alcune regole e procedure basilari per svolgere semplici compiti già affrontati in precedenza. Si esprime in modo semplice e legato a situazioni concrete.
L’alunno/a, anche se guidato dal docente, non porta sempre a termine le attività proposte. Anche con l’ausilio del docente non è sempre in grado di applicare procedure basilari per svolgere semplici compiti con esempi forniti. Si esprime utilizzando un linguaggio povero ed essenziale, non sempre adeguato alla situazione.
La valutazione degli apprendimenti nella scuola primaria
L’analisi della tabella ministeriale porta a enucleare le dimensioni dell’apprendimento prese in considerazione e i relativi descrittori di livello (v. tabella 2).
TABELLA 2 – Dimensioni dell’apprendimento e descrittori di livello presenti nella tabella ministeriale
LIVELLI
DIMENSIONI
AUTONOMIA NEL PORTARE A TERMINE LE ATTIVITÀ
USO DI RISORSE PERSONALI O DISPONIBILI NEL CONTESTO
USO DELLE CONOSCENZE DISCIPLINARI E DELLE ABILITÀ ACQUISITE
COMPITI E PROBLEMI CHE RIESCE AD AFFRONTARE
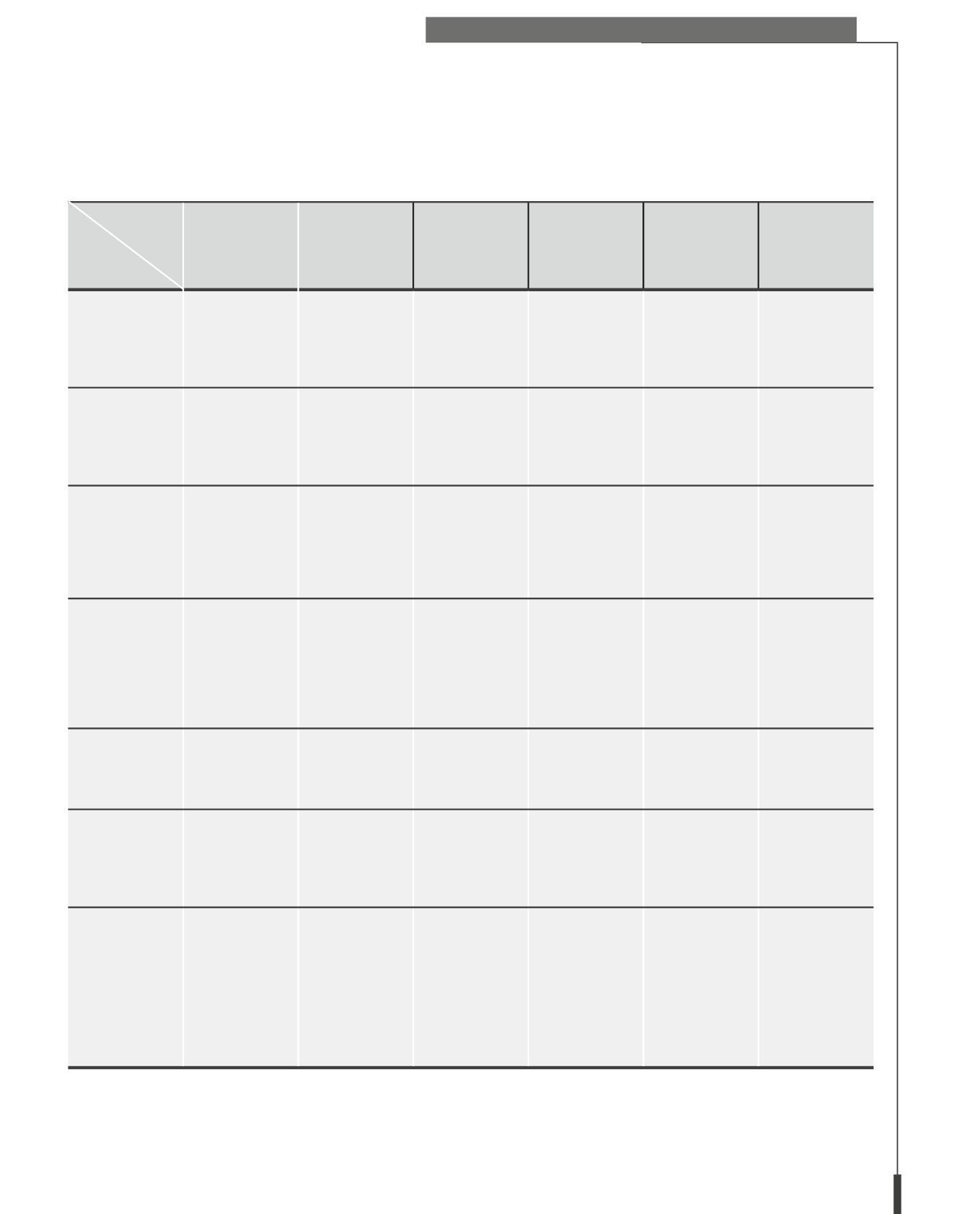
PROPOSTA DI ANALISI E SINTESI PERSONALI
CAPACITÀ DI COLLEGARE LE INFORMAZIONI
CAPACITÀ DI ESPRIMERE IL PROPRIO PENSIERO
Porta a termine le attività con piena autonomia
Uso di una ampia varietà di risorse
Uso consapevole e continuo delle conoscenze e abilità
Compiti complessi e problemi anche riferiti a situazioni non affrontate in precedenza
Propone analisi e sintesi personali originali
Collega le informazioni
Porta a termine le attività con autonomia
Uso di una varietà di risorse
Uso continuo delle conoscenze e abilità
Compiti e problemi anche riferiti a situazioni non affrontate in precedenza
Propone analisi e sintesi personali
Collega le informazioni
Uso di alcune risorse
Porta a termine le attività se guidato nell’uso delle risorse
Uso delle risorse disponibili
Porta a termine le attività solo se guidato
Uso di alcune risorse messe a disposizione dal docente
Uso di alcune conoscenze e abilità
Uso di alcune conoscenze e abilità
Non sempre porta sempre a termine le attività anche se guidato
Argomenta il proprio punto di vista esprimendosi con proprietà di linguaggio e in modo adeguato alla situazione
Esprime il proprio punto di vista con proprietà di linguaggio e in modo adeguato alla situazione
Compiti e problemi simili ad altri già affrontati in precedenza
Collega le informazioni
Compiti semplici e problemi già affrontati in precedenza
Applicazione di alcune regole e procedure basilari
Compiti semplici già affrontati in precedenza
Applicazione discontinua di alcune regole e procedure basilari
Compiti semplici con esempi forniti
Si esprime in modo adeguato alla situazione
Si esprime in modo abbastanza adeguato alla situazione
Si esprime in modo semplice e legato a situazioni concrete
Si esprime con un linguaggio povero ed essenziale, non sempre adeguato alla situazione.
Lo schema va perfezionato dalle scuole colmando i vuoti e graduando opportunamente le progressioni tra i livelli, ed eventualmente arricchito in base alla loro esperienza e competenza. Lo strumento così ottenuto costituirà la base per la elaborazione delle rubriche disciplinari relative alle diverse classi.
La
La valutazione in itinere
Nella bozza di ordinanza si ribadisce che «la valutazione in itinere resta espressa nelle forme che il docente ritiene opportune», precisando comunque che queste forme devono restituire «agli alunni, in modo pienamente comprensibile, il livello di padronanza dei contenuti verificati».
Le scuole sono perciò libere di utilizzare, nella valutazione in itinere, le modalità che ritengono più opportune. Il criterio principale dovrebbe essere quello di utilizzare la valutazione come risorsa per favorire l’acquisizione degli apprendimenti. La ricerca pedagogico-didattica e la normativa degli ultimi decenni concordano infatti nel privilegiare il valore formativo della valutazione, che trova concreta attuazione nella restituzione agli alunni delle informazioni idonee a renderli consapevoli sia degli apprendimenti raggiunti sia delle criticità, unitamente ai suggerimenti su cosa fare per migliorare (feedback formativi). I feedback efficaci presentano alcune fondamentali caratteristiche: tempestività, specificità, focalizzazione sulla prestazione e non sulla persona; comprensibilità.
Fig. 1 La valutazione come risorsa per l’apprendimento
RACCOLTA CONTINUA DI INFORMAZIONI SUGLI APPRENDIMENTI DEGLI ALUNNI E DELLE ALUNNE
CHE GLI E LE INSEGNANTI UTILIZZANO PER REGOLARE L’AZIONE DIDATTICA
CHE VENGONO RESTITUITE AGLI ALUNNI E ALLE ALUNNE (FEEDBACK) PER RENDERLI CONSAPEVOLI E ATTIVI SU COSA E COME MIGLIORARE]
La valutazione esercita un notevole influsso sul senso di autostima (ossia sulla percezione di sé che l’alunno si forma) e sul senso di autoefficacia (ossia sulla convinzione di essere più o meno capace di affrontare un’attività o un compito). Per sostenere la motivazione è quindi importante anche la funzione proattiva della valutazione, che «riconosce ed evidenzia i progressi, anche piccoli, compiuti dall’alunno nel suo cammino, gratifica i passi effettuati, cerca di far crescere in lui le “emozioni di riuscita” che rappresentano il presupposto per le azioni successive».1
La valutazione periodica e finale
Gli elementi conoscitivi in ordine al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento sono raccolti in itinere attraverso una varietà di strumenti: prove di vario genere, osservazioni, interazioni con gli alunni, analisi di materiali prodotti…
La valutazione periodica e finale costituisce non un calcolo quantitativo di una sorta di “media”, ma una sintesi interpretativa dell’insieme di elementi acquisiti nel periodo oggetto di valutazione, con l’attribuzione del livello corrispondente al giudizio descrittivo che più si avvicina a tale sintesi.
Fig. 2 Il percorso di valutazione
DEFINIZIONE DEGLIOBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
1 Linee guida
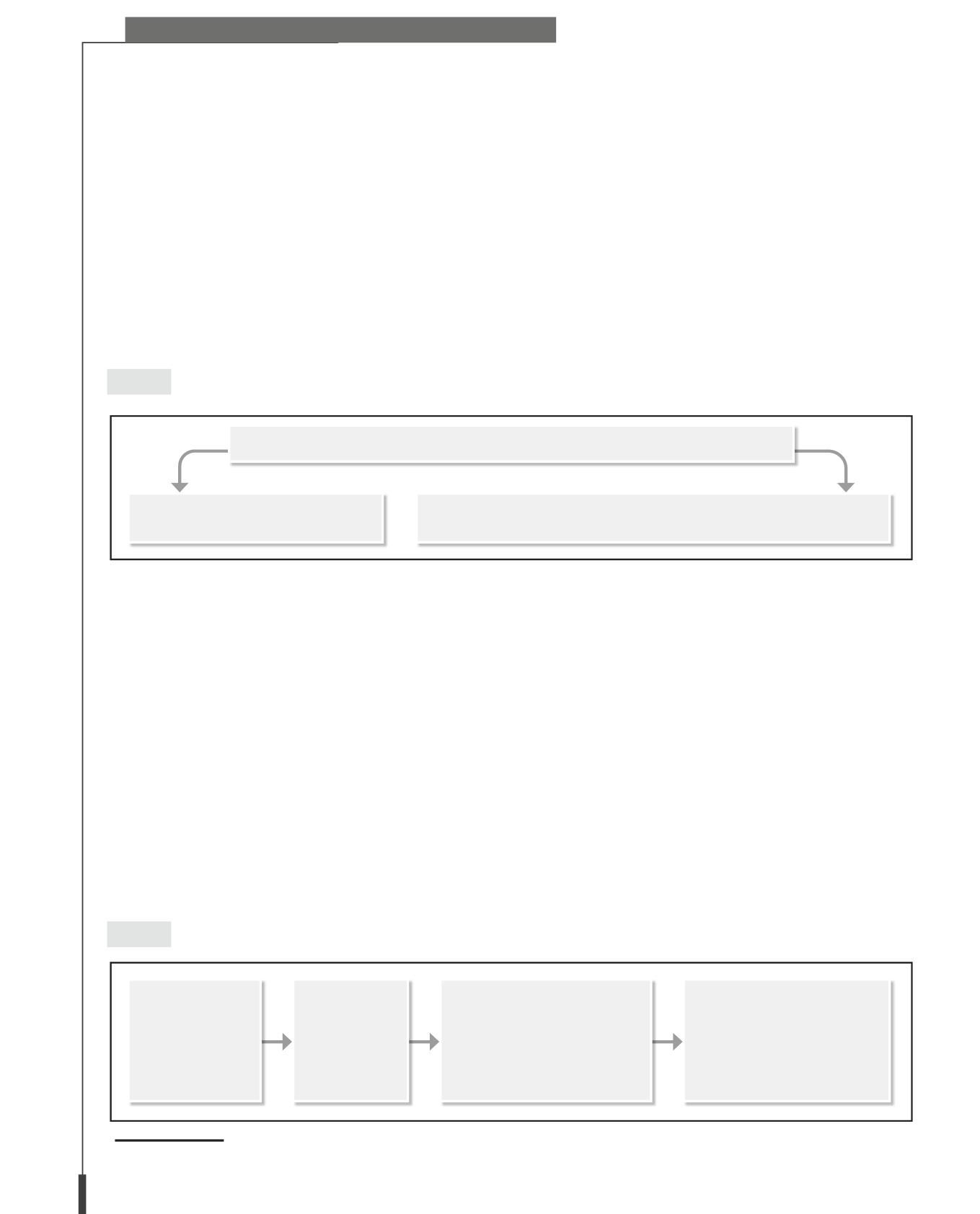
COSTRUZIONE DELLA RUBRICA VALUTATIVA DISCIPLINARE
RACCOLTA IN ITINERE DI ELEMENTI CONOSCITIVI IN RELAZIONE ALLE DIMENSIONI E AI DESCRITTORI DELLA RUBRICA VALUTATIVA DISCIPLINARE
ATTRIBUZIONE DEL GIUDIZIO SINTETICO CORRISPONDENTE AL PROFILO DESCRITTIVO PIÙ VICINO AL COMPLESSO DEGLI ELEMENTI CONOSCITIVI ACQUISITI

L’INSEGNAMENTO DELL’EDUCAZIONE CIVICA
a cura di Dino Cristanini
Il quadro normativo
La legge n. 92 del 20 agosto 2019, Introduzione dell’insegnamento scolastico dell’educazione civica, è entrata in vigore il 5 settembre 2019, con la finalità di contribuire a «formare cittadini responsabili e attivi e a promuovere la partecipazione piena e consapevole alla vita civica, culturale e sociale delle comunità, nel rispetto delle regole, dei diritti e dei doveri». Il nuovo insegnamento, che ha sostituito quello di Cittadinanza e Costituzione introdotto da una precedente legge del 2008, è stato disciplinato nei primi anni successivi all’entrata in vigore della legge (dall’a.s. 2020/2021 all’a.s. 2023/2024) dal decreto ministeriale n. 35 del 22 giugno 2020 e dalle Linee guida a esso allegate. Nel frattempo la legge n. 92/2019 è stata integrata da altre norme, in particolare dalla legge n. 21/2024 che ha previsto, tra le tematiche oggetto dell’educazione civica, anche quelle dell’educazione finanziaria e assicurativa e della pianificazione previdenziale, anche con riferimento all’utilizzo delle nuove tecnologie digitali di gestione del denaro e alle nuove forme di economia e finanza sostenibili, e lo sviluppo della cultura d’impresa.
A partire dall’ a.s. 2024-2025, con decreto ministeriale n. 183 del 7 settembre 2024, sono state adottate nuove Linee guida per attuare la disposizione della legge n. 92/2019 che prevede la definizione a livello nazionale, da parte del Ministro dell’istruzione (ora Ministro dell’istruzione e del merito), dei traguardi di sviluppo delle competenze e degli obiettivi specifici di apprendimento, e per recepire le nuove tematiche introdotte dai successivi provvedimenti normativi.
La struttura delle Linee guida
Le Linee guida entrate in vigore nell’a.s. 2024-2025 sono costituite da 10 punti, tra cui i principali riguardano i principi assunti come fondamento dell’educazione civica (nel cui ambito sono definiti anche i nuclei concettuali che aggregano le tematiche di questo insegnamento), i traguardi e gli obiettivi di apprendimento per ciascun grado di scuola, l’evidenziazione del carattere trasversale dell’insegnamento dell’educazione civica, le indicazioni metodologiche di tipo generale, le modalità di valutazione degli esiti di apprendimento.
I principi fondamentali
Il principio che sta alla base di tutti gli altri è la conoscenza della Costituzione italiana, che secondo le Linee guida va riconosciuta «non solo come norma cardine del nostro ordinamento, ma anche come riferimento prioritario per identificare valori, diritti, doveri, compiti, comportamenti personali e istituzionali finalizzati a promuovere il pieno sviluppo della persona e la partecipazione di tutti i cittadini all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese». Altri principi importanti riguardano: la centralità della persona, con i suoi diritti e doveri nei confronti della società, la cultura del rispetto verso ogni essere umano, l’inclusione, il senso di appartenenza alla comunità nazionale e alla civiltà europea. Senza dimenticare, a nostro avviso, il fatto di appartenere comunque a una “comunità di destino planetaria”.
Educazione civica
I nuclei concettuali e le tematiche
Le tematiche elencate nelle Linee guida sono raggruppate in base a tre nuclei concettuali. La tabella n. 1 riporta in forma sintetica tali tematiche, in relazione alle quali vanno selezionati i contenuti specifici per i diversi gradi scolastici, e, al loro interno, per i diversi livelli di classe in rapporto alle varie fasi evolutive.
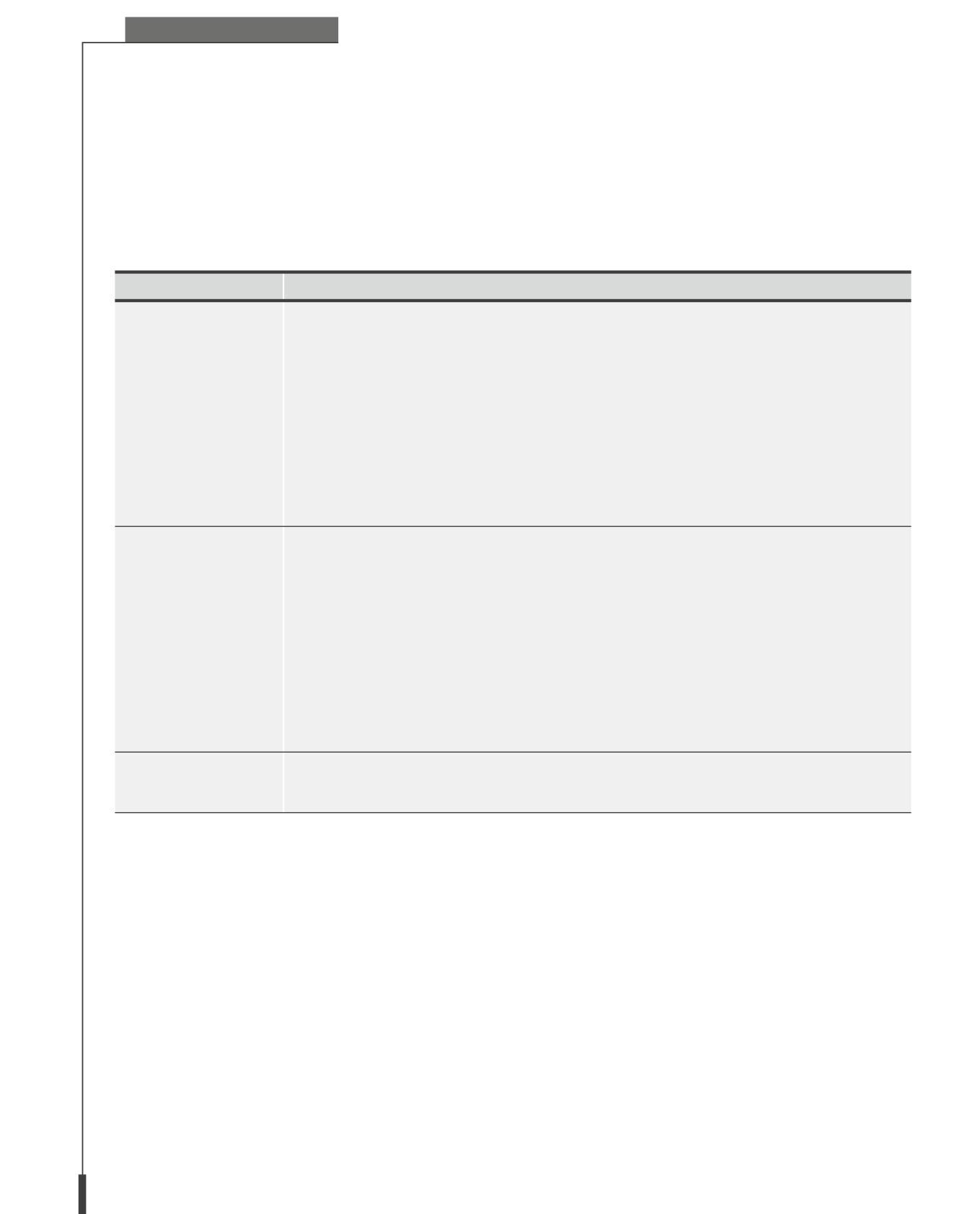
NUCLEI
COSTITUZIONE
SVILUPPOECONOMICO E SOSTENIBILITÀ
CITTADINANZA DIGITALE
TEMATICHE
• Artt. 1-12 della Costituzione (Principi generali).
• Altri articoli della Costituzione (connessi con le tematiche trattate).
• Diritti e doveri che conseguono alla partecipazione alla vita della comunità nazionale ed europea.
• Ordinamento e funzioni dello Stato, delle Regioni, degli Enti territoriali e delle Organizzazioni internazionali e sovranazionali, in particolare Unione Europea e Nazioni Unite.
• Inno e bandiera nazionali.
• Inno e bandiera europei.
• Bandiera della Regione.
• Stemma del Comune.
• Concetti di legalità, di rispetto delle leggi e delle regole comuni in tutti gli ambienti di convivenza.
• Contrasto a ogni forma di discriminazione e di bullismo.
• Contrasto a ogni forma di criminalità e illegalità.
• Educazione stradale.
• Agenda ONU 2030.
• Concetti di sviluppo e di crescita economica.
• Valore del lavoro e dell’iniziativa economica, cultura d’impresa.
• Conoscenze relative al mondo del lavoro.
• Tutela della sicurezza, della salute, della dignità e della qualità della vita delle persone.
• Tutela della natura e protezione dell’ambiente.
• Cultura della protezione civile.
• Educazione alla salute, educazione alimentare.
• Contrasto a tutte le forme di dipendenza (droghe, fumo, alcol, doping, uso patologico del web, gaming e gioco d’azzardo).
• Rispetto per i beni pubblici e tutela del decoro urbano.
• Conoscenza e valorizzazione del patrimonio culturale, artistico e monumentale dell’Italia.
• Educazione finanziaria e assicurativa.
• Uso corretto, consapevole e responsabile degli strumenti digitali.
• Valutazione critica di dati e notizie presenti in rete.
• Intelligenza Artificiale.
I
traguardi per lo sviluppo delle competenze e gli obiettivi di apprendimento per la
scuola primaria
Nucleo COSTITUZIONE
Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione
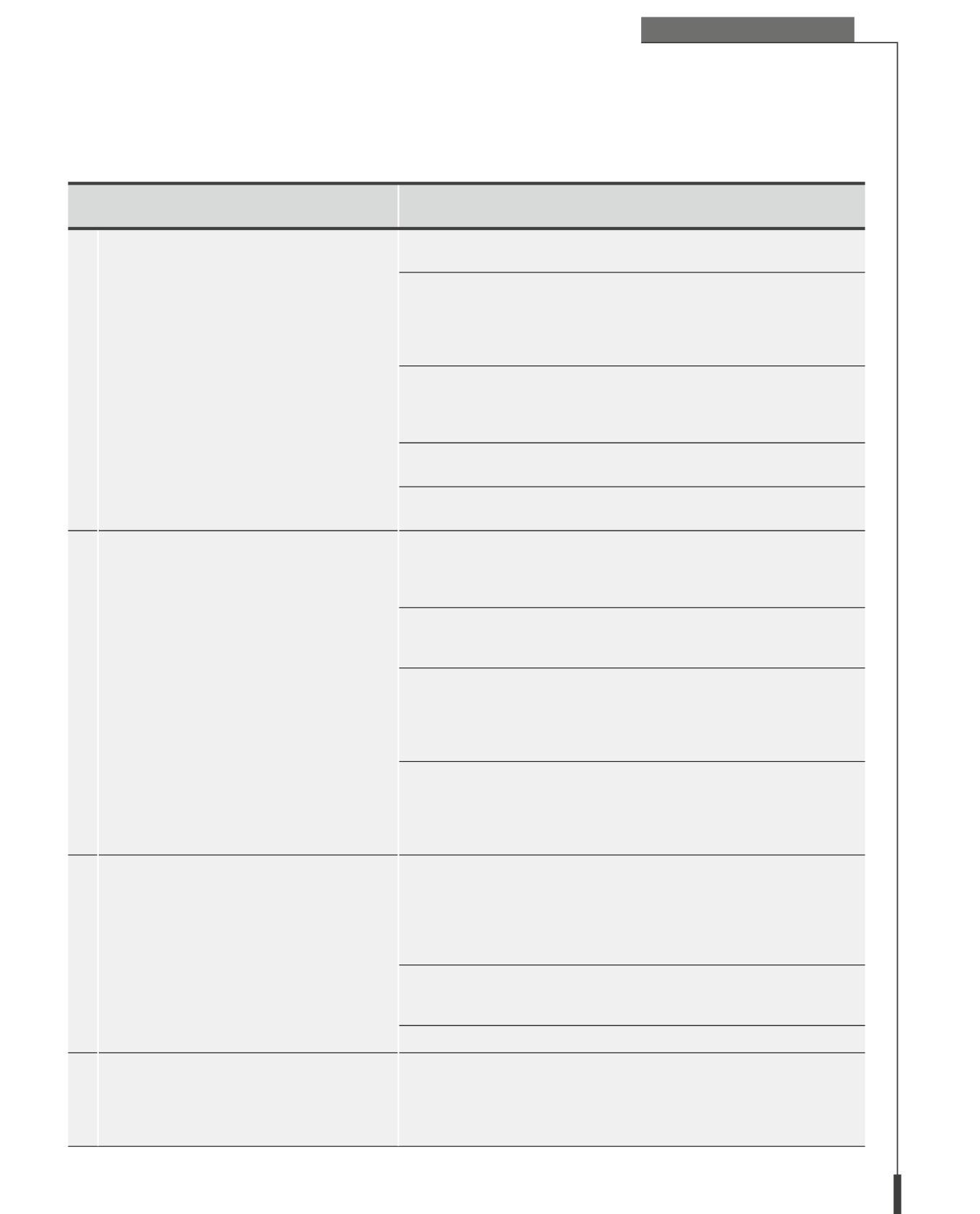
1
Sviluppare atteggiamenti e adottare comportamenti fondati sul rispetto di ogni persona, sulla responsabilità individuale, sulla legalità, sulla consapevolezza dell’appartenenza a una comunità, sulla partecipazione e sulla solidarietà, sostenuti dalla conoscenza della Carta costituzionale, della Carta dei Diritti fondamentali dell’Unione Europea e della Dichiarazione Internazionale dei Diritti umani.
Obiettivi di apprendimento al termine della scuola primaria
• Conoscere i principi fondamentali della Costituzione e saperne individuare le implicazioni nella vita quotidiana e nelle relazioni con gli altri.
• Individuare i diritti e i doveri che interessano la vita quotidiana di tutti i cittadini, anche dei più piccoli.
• Condividere regole comunemente accettate.
• Sviluppare la consapevolezza dell’appartenenza ad una comunità locale, nazionale ed europea.
• Rispettare ogni persona, secondo il principio di uguaglianza e di non discriminazione di cui all’articolo 3 della Costituzione.
• Riconoscere, evitare e contrastare forme di violenza e bullismo presenti nella comunità scolastica.
• Curare gli ambienti, rispettare i beni pubblici e privati così come le forme di vita (piante, animali) che sono state affidate alla responsabilità delle classi.
• Aiutare, singolarmente e in gruppo, coloro che presentino qualche difficoltà per favorire la collaborazione tra pari e l’inclusione di tutti.
Interagire correttamente con le istituzioni nella vita quotidiana, nella partecipazione e nell’esercizio della cittadinanza attiva, a partire dalla conoscenza dell’organizzazione e delle funzioni dello Stato, dell’Unione europea, degli organismi internazionali, delle Regioni e delle Autonomie locali. Essere consapevoli dell’appartenenza ad una comunità, locale e nazionale.
2
3 Rispettare le regole e le norme che governano la democrazia, la convivenza sociale e la vita quotidiana in famiglia, a scuola, nella comunità, al fine di comunicare e rapportarsi correttamente con gli altri, esercitare consapevolmente i propri diritti e doveri per contribuire al bene comune e al rispetto dei diritti delle persone.
• Conoscere l’ubicazione della sede comunale, gli organi e i servizi principali del Comune, le principali funzioni del Sindaco e della Giunta comunale, i principali servizi pubblici del proprio territorio e le loro funzioni essenziali.
• Conoscere gli Organi principali dello Stato (Presidente della Repubblica, Camera dei deputati e Senato della Repubblica e loro Presidenti, Governo, Magistratura) e le funzioni essenziali.
• Conoscere la storia della comunità locale, nazionale ed europea a partire dagli stemmi, dalle bandiere e dagli inni.
• Conoscere il valore e il significato dell’appartenenza alla comunità nazionale.
• Conoscere il significato di Patria.
• Conoscere l’Unione Europea e l’ONU.
• Conoscere il contenuto generale delle Dichiarazioni Internazionali dei diritti della persona e dell’infanzia.
• Individuare alcuni dei diritti previsti nell’ambito della propria esperienza concreta.
• Conoscere ed applicare le regole vigenti in classe e nei vari ambienti della scuola (mensa, palestra, laboratori, cortili) e partecipare alla loro eventuale definizione o revisione.
• Conoscere il principio di uguaglianza nella consapevolezza che le differenze possono rappresentare un valore quando non si trasformano in discriminazioni.
• Conoscere i principali fattori di rischio dell’ambiente scolastico, adottare comportamenti idonei a salvaguardare la salute e la sicurezza proprie e altrui e contribuire a definire comportamenti di prevenzione dei rischi.
• Conoscere e applicare le principali norme di circolazione stradale.
4 Sviluppare atteggiamenti e comportamenti responsabili volti alla tutela della salute e del benessere psicofisico.
• Conoscere e attuare le principali regole per la cura della salute, della sicurezza e del benessere proprio e altrui, a casa, a scuola, nella comunità, dal punto di vista igienico-sanitario, alimentare, motorio, comportamentale.
• Conoscere i rischi e gli effetti dannosi delle droghe.
5
Educazione civica
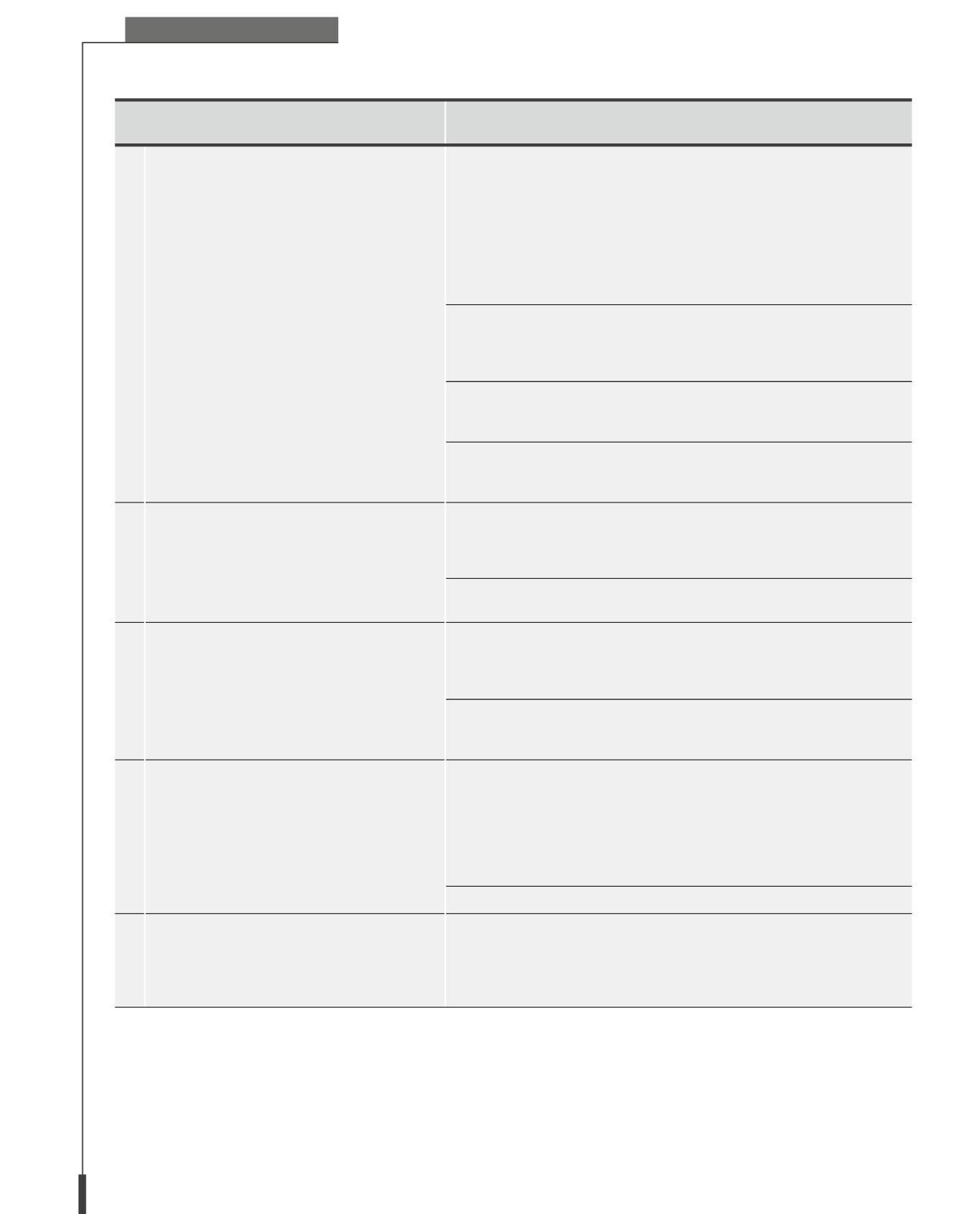
6
Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione
Comprendere l’importanza della crescita economica e del lavoro.
Conoscere le cause dello sviluppo economico e sociale in Italia ed in Europa, le diverse attività economiche. Sviluppare atteggiamenti e comportamenti responsabili volti alla tutela dell’ambiente, del decoro urbano, degli ecosistemi e delle risorse naturali per una crescita economica rispettosa dell’ambiente e per la tutela della qualità della vita.
Obiettivi di apprendimento al termine della scuola primaria
• Conoscere le condizioni della crescita economica. Comprenderne l’importanza per il miglioramento della qualità della vita e ai fini della lotta alla povertà.
• Individuare, con riferimento alla propria esperienza, ruoli, funzioni e aspetti essenziali che riguardano il lavoro delle persone con cui si entra in relazione, nella comunità scolastica e nella vita privata.
• Riconoscere il valore del lavoro.
• Conoscere, attraverso semplici ricerche, alcuni elementi dello sviluppo economico in Italia ed in Europa.
• Riconoscere, a partire dagli ecosistemi del proprio territorio, le trasformazioni ambientali ed urbane dovute alle azioni dell’uomo; mettere in atto comportamenti alla propria portata che riducano l’impatto negativo delle attività quotidiane sull’ambiente e sul decoro urbano.
• Individuare nel proprio territorio le strutture che tutelano i beni artistici, culturali e ambientali e proteggono gli animali, e conoscerne i principali servizi.
• Analizzare, attraverso l’esplorazione e la ricerca all’interno del proprio comune, la qualità degli spazi verdi e dei trasporti, il ciclo dei rifiuti, la salubrità dei luoghi pubblici.
Comprendere le cause dei cambiamenti climatici, gli effetti sull’ambiente e i rischi legati all’azione dell’uomo sul territorio. Comprendere l’azione della Protezione civile nella prevenzione dei rischi ambientali.
Maturare scelte e condotte di tutela dei beni materiali e immateriali.
7
8
Maturare scelte e condotte di tutela del risparmio e assicurativa nonché di pianificazione di percorsi previdenziali e di utilizzo responsabile delle risorse finanziarie.
9 Maturare scelte e condotte di contrasto all’illegalità.
• Conoscere ed attuare i comportamenti adeguati a varie condizioni di rischio (sismico, vulcanico, idrogeologico, climatico…) anche in collaborazione con la Protezione civile.
• Individuare alcune trasformazioni ambientali e gli effetti del cambiamento climatico.
• Identificare nel proprio ambiente di vita gli elementi che costituiscono il patrimonio artistico e culturale, materiale e immateriale, anche con riferimento alle tradizioni locali, ipotizzando semplici azioni per la salvaguardia e la valorizzazione.
• Riconoscere, con riferimento all’esperienza, che alcune risorse naturali (acqua, alimenti…) sono limitate e ipotizzare comportamenti di uso responsabile, mettendo in atto quelli alla propria portata.
• Conoscere e spiegare il valore, la funzione e le semplici regole di uso del denaro nella vita quotidiana.
• Gestire e amministrare piccole disponibilità economiche, ideando semplici piani di spesa e di risparmio, individuando alcune forme di pagamento e di accantonamento.
• Individuare e applicare nell’esperienza e in contesti quotidiani, i concetti economici di spesa, guadagno, ricavo, risparmio.
• Riconoscere l’importanza e la funzione del denaro.
• Conoscere le varie forme di criminalità, partendo dal rispetto delle regole che ogni comunità si dà per garantire la convivenza.
• Conoscere la storia dei vari fenomeni mafiosi, nonché riflettere sulle misure di contrasto.
• Conoscere il valore della legalità.
10
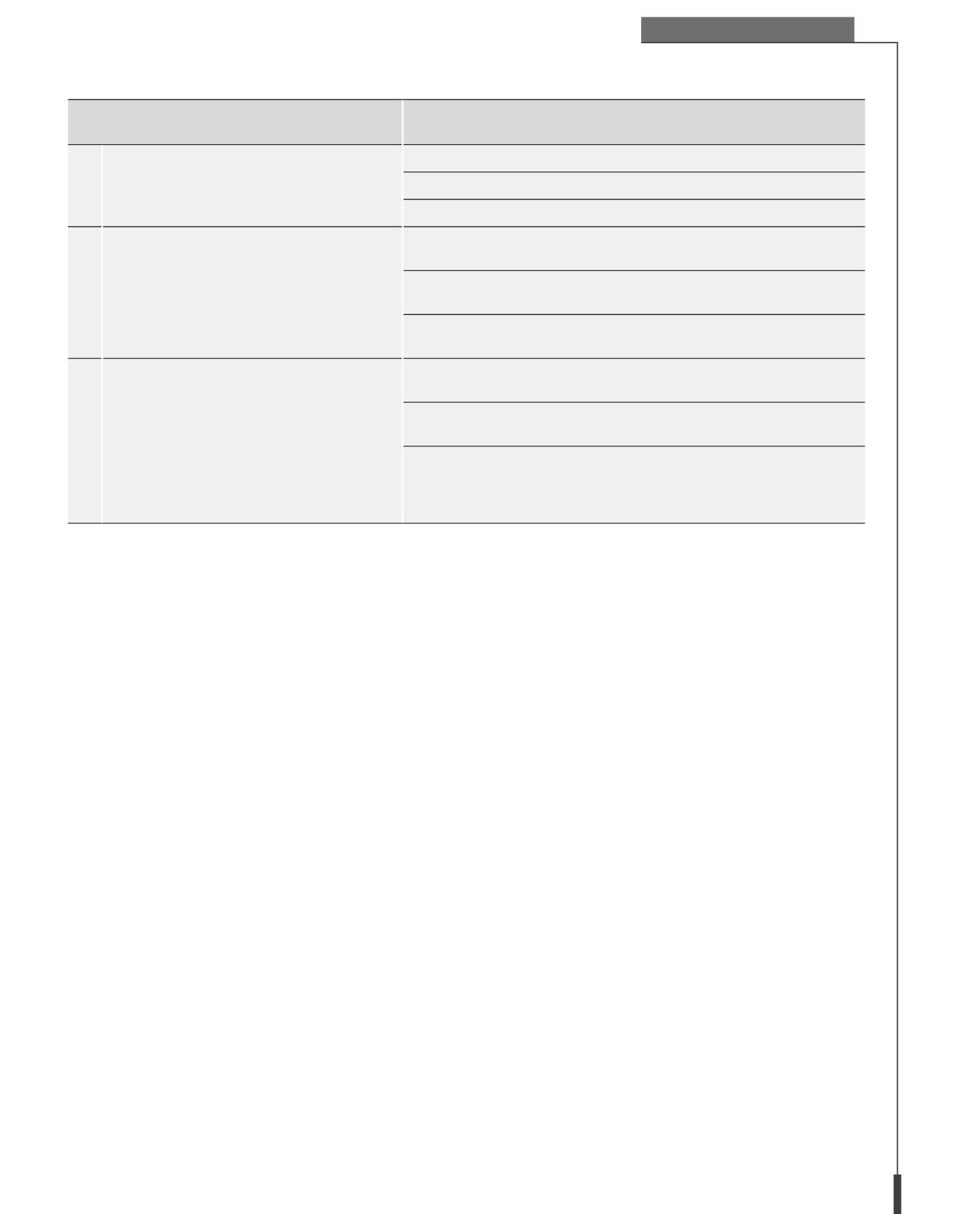
Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione
Sviluppare la capacità di accedere alle informazioni, alle fonti, ai contenuti digitali, in modo critico, responsabile e consapevole.
11
12
Interagire con gli altri attraverso le tecnologie digitali consentite, individuando forme di comunicazione adeguate ai diversi contesti di relazione, adottando e rispettando le regole comportamentali proprie di ciascun contesto comunicativo.
Gestire l’identità digitale e i dati della rete, salvaguardando la propria e altrui sicurezza negli ambienti digitali, evitando minacce per la salute e il benessere fisico e psicologico di sé e degli altri.
Obiettivi di apprendimento al termine della scuola primaria
• Ricercare in rete semplici informazioni, distinguendo dati veri e falsi.
• Utilizzare le tecnologie per elaborare semplici prodotti digitali.
• Riconoscere semplici fonti di informazioni digitali.
• Interagire con strumenti di comunicazione digitale, quali tablet e computer.
• Conoscere e applicare semplici regole per l’utilizzo corretto di strumenti di comunicazione digitale, quali tablet e computer.
• Conoscere e applicare le principali regole di partecipazione alle classi virtuali e alle piattaforme didattiche.
• Conoscere il significato di identità e di informazioni personali in semplici contesti digitali di uso quotidiano.
• Conoscere i rischi connessi con l’utilizzo degli strumenti digitali in termini di sicurezza personale.
• Conoscere semplici modalità per evitare rischi per la salute e minacce al benessere psico-fisico quando si utilizzano le tecnologie digitali.
• Riconoscere, evitare e contrastare le varie forme di bullismo e cyberbullismo.
Carattere trasversale dell’educazione civica e unitarietà dell’azione didattica
La trasversalità dell’educazione civica è affermata sin dalla definizione adottata dalla legge n.92/2019
(«è istituito l’insegnamento trasversale dell’educazione civica») ed è stata ben illustrata nelle Linee guida del 2020 in diversi passaggi:
«La norma richiama il principio della trasversalità del nuovo insegnamento, anche in ragione della pluralità degli obiettivi di apprendimento e delle competenze attese, non ascrivibili a una singola disciplina e neppure esclusivamente disciplinari. […]»
«La norma richiama il principio della trasversalità del nuovo insegnamento, anche in ragione della pluralità degli obiettivi di apprendimento e delle competenze attese, non ascrivibili a una singola disciplina e neppure esclusivamente disciplinari. […]»
«Ogni disciplina è, di per sé, parte integrante della formazione civica e sociale di ciascun alunno. […]»
«I nuclei tematici dell’insegnamento, e cioè quei contenuti ritenuti essenziali per realizzare le finalità indicate nella Legge, sono già impliciti negli epistemi delle discipline. […]»
«L’educazione civica […] supera i canoni di una tradizionale disciplina, assumendo più propriamente la valenza di matrice valoriale trasversale che va coniugata con le discipline di studio, per evitare superficiali e improduttive aggregazioni di contenuti teorici e per sviluppare processi di interconnessione tra saperi disciplinari ed extradisciplinari.»
Anche le nuove Linee guida del 2024 dedicano un paragrafo alla trasversalità dell’educazione civica, ribadendo che «i saperi hanno lo scopo di fornire agli allievi strumenti per sviluppare conoscenze, abilità e competenze per essere persone e cittadini autonomi e responsabili, rispettosi di sé, degli altri e del bene comune», «i nuclei concettuali […] per loro natura interdisciplinari, attraversano il curricolo e possono essere considerati in ogni argomento che tutti i docenti trattano quotidianamente»
e che «si tratta dunque di far emergere all’interno dei curricoli di istituto elementi già presenti negli attuali ordinamenti e di rendere più consapevole ed esplicita la loro interconnessione, nel rispetto e in coerenza con i processi di crescita dei bambini e dei ragazzi nei diversi gradi di scuola».
Il curricolo e i percorsi di apprendimento
La progettazione dei percorsi finalizzati al perseguimento degli obiettivi di apprendimento e dei traguardi per lo sviluppo delle competenze relativi all’educazione civica richiede pertanto di:
• analizzare gli obiettivi di apprendimento previsti al termine della scuola primaria e decidere come tradurli nei vari livelli di classe;
• individuare quali sono i contributi che le discipline possono offrire al perseguimento degli obiettivi;
• definire i percorsi e le esperienze di apprendimento in base alle discipline di volta in volta coinvolte.
L’attuazione dell’insegnamento trasversale di educazione civica richiede pertanto, come del resto tutto il curricolo, una forte azione unitaria del gruppo docente, soprattutto per quanto riguarda la formazione degli atteggiamenti, che, secondo la definizione presente nella Raccomandazione relativa alle competenze chiave per l’apprendimento permanente adottata nel 2018 dal Consiglio dell’Unione europea, «descrivono la disposizione e la mentalità per agire o reagire a idee, persone o situazioni».
NUCLEI CONCETTUALI TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA PRIMARIA
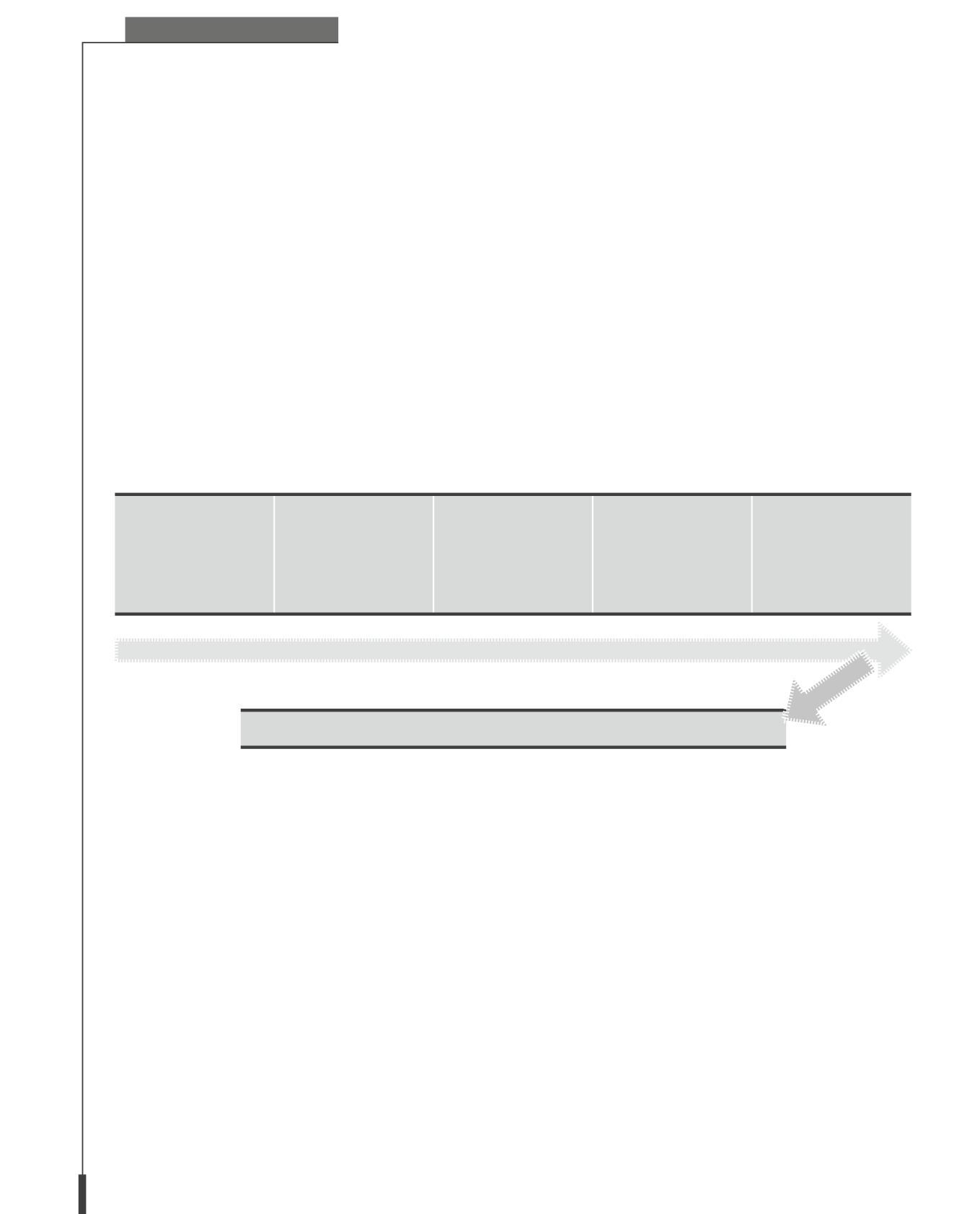
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO AL TERMINE DELLA SCUOLA PRIMARIA
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO SELEZIONATI E DECLINATI PER I VARI LIVELLI DI CLASSE
INDIVIDUAZIONE DEL CONTRIBUTO DI CIASCUNA DISCIPLINA
La valutazione
L’insegnamento trasversale dell’educazione civica è oggetto delle valutazioni periodiche e finali previste dal D.Lgs. n. 62 del 13 aprile 2017.
La valutazione deve ovviamente essere coerente con gli obiettivi dichiarati nella progettazione e con le attività didattiche svolte.
Per la formulazione dei giudizi occorre raccogliere in itinere gli elementi conoscitivi relativi al raggiungimento degli obiettivi e formulare il giudizio sul livello conseguito in base a una sintesi interpretativa degli stessi.
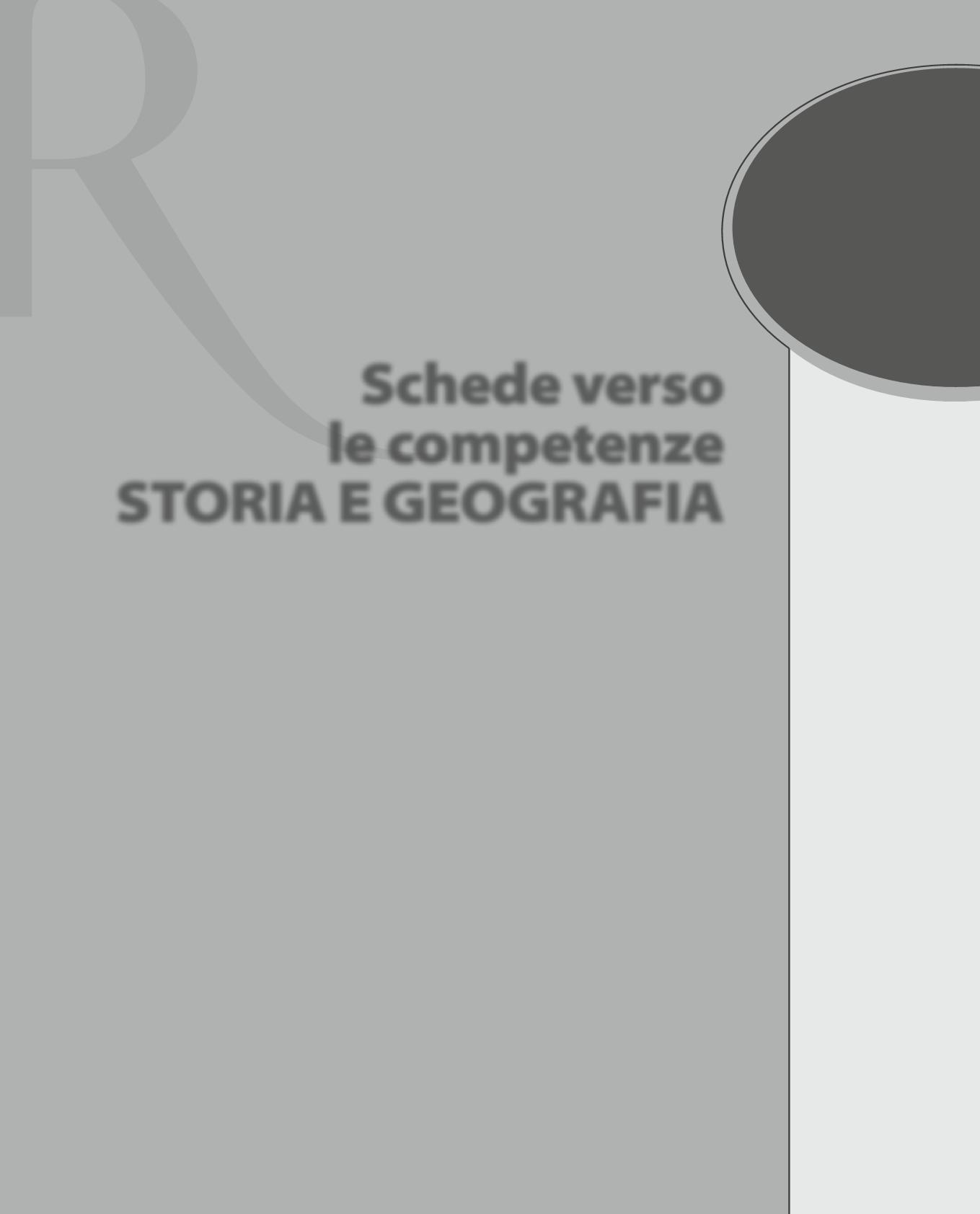
Schede verso l

STORIA E GEOGRAFIA
NOME
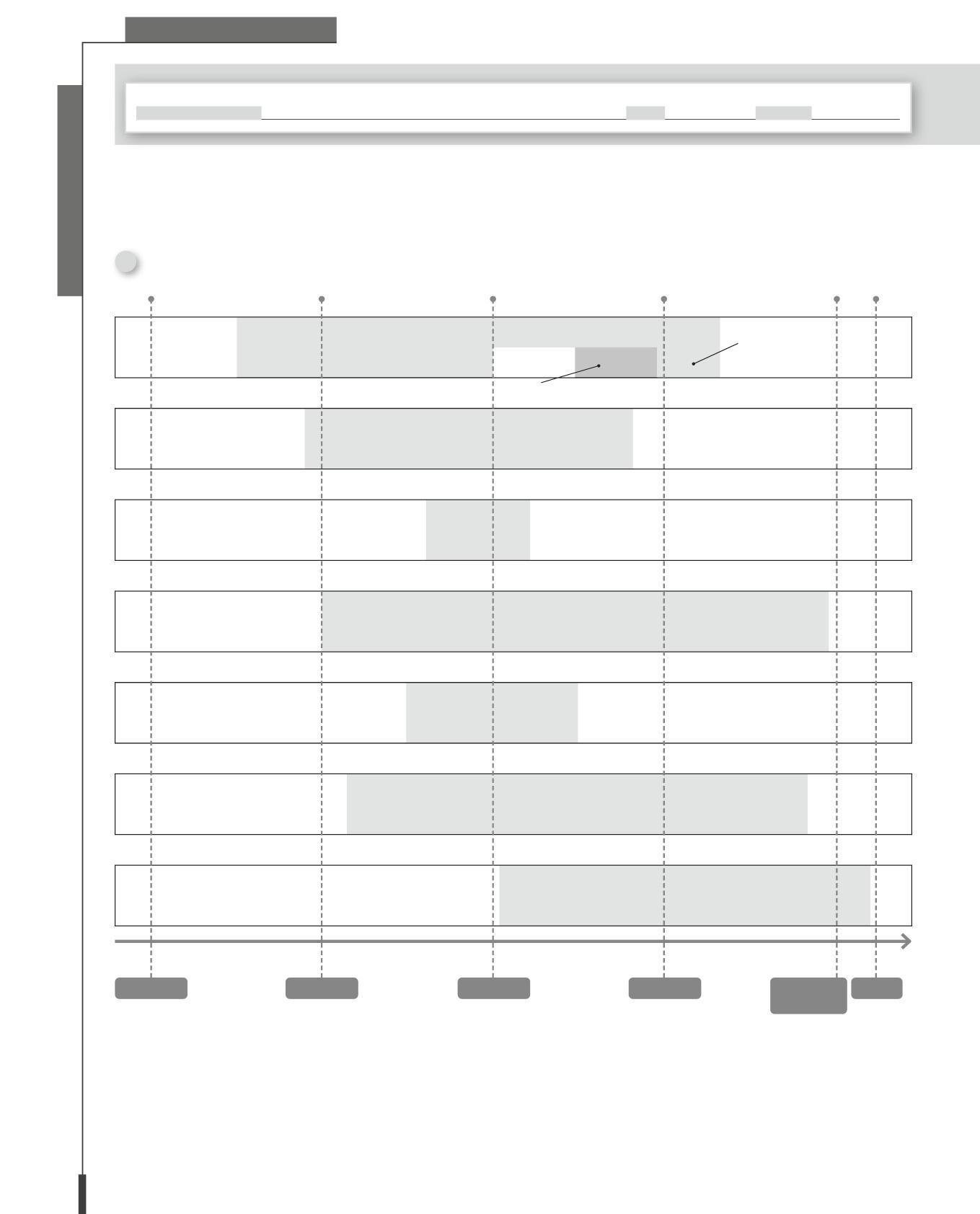
LE LINEE DEL TEMPO
1 Osserva le linee del tempo delle civiltà che conoscerai quest’anno. Poi rispondi alle domande.
• Qual è la civiltà più antica?
• Qual è la civiltà che dura più a lungo?
• Qual è la civiltà che dura di meno?
• In quale periodo coesistevano quasi tutte le civiltà? Dal al circa.
OBIETTIVI: Leggere una linea del tempo. • Riconoscere relazioni di successione e contemporaneità, durate e periodi.
NOME E COGNOME DATA CLASSE
LE POPOLAZIONI DELLA MESOPOTAMIA A CONFRONTO
1 Indica con una X se le seguenti affermazioni sono vere (V) o false (F).
I Sumeri V F
Furono la prima civiltà a svilupparsi in Mesopotamia.
Erano organizzati in tante città-stato.
Le città-stato sumere si unirono in un unico grande regno.
Crearono la prima forma di scrittura, chiamata cuneiforme.
Gli Ittiti V F
Erano una popolazione indoeuropea.
Erano molto abili a lavorare il ferro, con cui fabbrucavano armi robuste.
Formarono un vasto impero.
I loro sovrani venivano eletti da tutta la popolazione.
La società era divisa in uomini liberi e schiavi.
I Babilonesi V F
Non si unirono mai in un solo regno.
La civiltà babilonese prende il nome dalla capitale del regno, Babilonia.
Hammurabi mise per iscritto una raccolta di leggi già in uso presso i Sumeri.
Il Codice di Hammurabi era valido solo per gli abitanti di Babilonia.
Gli Assiri V F
Provenivano dalle regioni montuose dell’alta valle del Tigri.
Oltre che guerrieri, furono anche abili commercianti.
Lavoravano abilmente i metalli per costruire oggetti artistici.
Formarono un grande impero che ebbe come capitale Nininve.
L’imperatore Assurbanipal fece costruire una grande biblioteca per raccogliere tutto il sapere del suo tempo.
2 Cerchia le lettere che compaiono in tabella all’incrocio delle coordinate indicate. Uniscile e si formerà un nome, poi rispondi alla domanda seguente.
1C • 1E • 2B • 2D • 3C • 4A
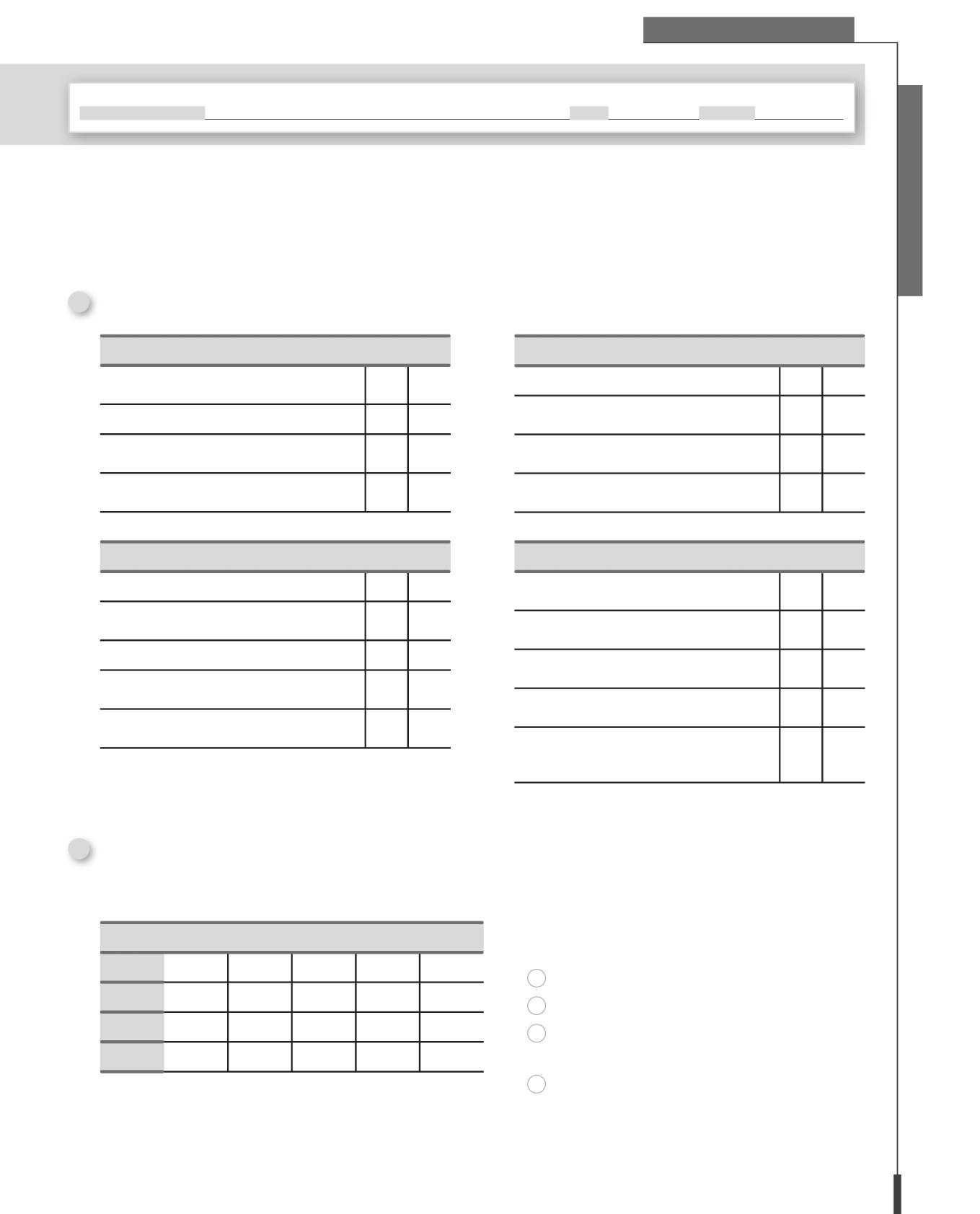
Che nome hai trovato?
Indica con una X la risposta corretta.
Il nome di un famoso re assiro.
Il nome di una divinità ittita.
Il nome di un funzionario che era capace di scrivere.
Il nome di chi inventò la scrittura.
OBIETTIVI: Conoscere aspetti specifici della storia di ciascuna delle civiltà studiate.
IL PAPIRO E LA SCRITTURA NEGLI EGIZI
1 Osserva l’immagine e completa lo schema: nella colonna grigia comparirà una parola legata alla scrittura egizia. Segui gli esempi.
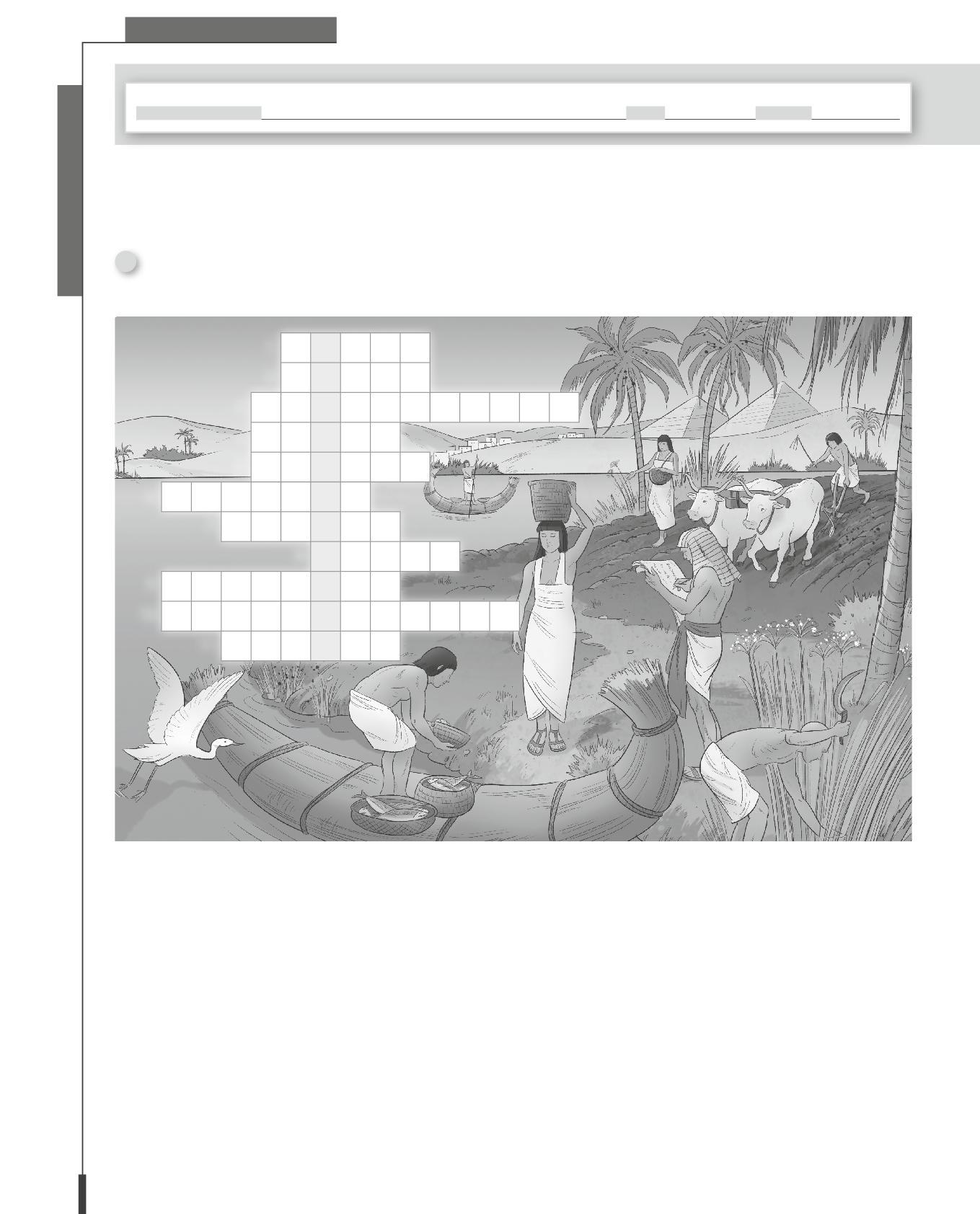
1 Il popolo che ha inventato la carta di papiro.
2 Contenitori per trasportare, realizzati con le foglie di papiro intrecciate.
3 Chi per lavoro coltiva i campi.
4 Una volta sbocciati, erano usati per preparare ghirlande e ornamenti.
5 Supporto per scrivere, formato da strisce del fusto del papiro sovrapposte.
6 Calzature leggere realizzate con le foglie di papiro intrecciate.
7 Parti inferiori della pianta del papiro che restano sott’acqua: erano usate come legna per il fuoco.
8 Parte della pianta che veniva tagliata a fette, per ottenere delle strisce sottili.
9 Piccoli strumenti, costruiti con le parti più dure delle piante.
10 Mezzi di trasporto che si potevano usare nei canali o lungo il Nilo.
11 La figura della società egizia che faceva il maggior uso del papiro.
L’IMPORTANZA DEI LIBRI
Gli scribi pieni di saggezza non hanno costruito piramidi, essi si sono fatti come eredi i libri e gli insegnamenti che hanno fatto. È pronunciato il loro nome a causa dei libri che hanno scritto, perché erano buoni, e il ricordo di colui che l’ha fatto rimane per sempre. Sii scriba, ponilo nel tuo cuore, affinché il tuo nome esista allo stesso modo: il libro è come una stele incisa, meglio d’un muro costruito saldamente. Ogni uomo muore, ma lo scritto farà sì che sia ricordato. Un libro è meglio d’una casa costruita. È più bello d’un castello costruito, più bello che una stele in un tempio.
1 Leggi la poesia che risale al Nuovo Regno e indica con una X le risposte corrette.
• Chi sono, secondo l’autore della poesia, gli eredi degli scribi?
I libri che hanno scritto.
Le parole che hanno detto.
I figli che hanno avuto.

• Perché un libro è come una stele incisa?
Perché i libri degli Egizi erano di pietra.
Perché chi scrive un libro viene ricordato dopo la sua morte.
Perché serve a dare informazioni
2 Indica con una X se le seguenti affermazioni sono vere (V) o false (F).
• Gli scribi hanno costruito le piramidi per i faraoni.
• Il nome degli scribi continua a essere pronunciato perché hanno scolpito stele importanti.
• Il nome degli scribi resta nel tempo a causa di ciò che hanno scritto.
• Un libro è come il muro di un tempio.
• Una stele è un libro.
• Una stele è una lastra di pietra con scritte e decorazioni incise.
V F
V F
V F
V F
V F
V F
LA STELE DI ROSETTA
1 Per molti secoli nessuno riuscì a decifrare la scrittura degli antichi Egizi.
Nel 1799 l’esercito francese aveva invaso l’Egitto; alcuni soldati francesi, nei pressi della città egiziana di Rosetta, scoprirono una stele che era stata scritta nel 196 a.C.
Si tratta di un blocco di basalto nero, sul quale Tolomeo V, uno degli ultimi faraoni, fece scolpire un decreto in tre lingue: greco antico, demotico e geroglifico
Alcuni studiosi cercarono di decifrare i geroglifici senza avere successo, fino a quando nel 1822 Jean-François Champollion, un appassionato di lingue, non provò a interpretarli.
Confrontando la scrittura greca, che lui conosceva, con quella egizia, identificò per primi i geroglifici del nome del re Tolomeo e della regina Cleopatra, poi preparò un elenco di altri simboli prendendoli da altri nomi.
Non riusciva però a capire se quei segni rappresentassero un’idea o un suono.
Finalmente ebbe un’intuizione geniale: la scrittura poteva essere un misto di ideogrammi (cioè di simboli che rappresentano un’idea) e segni fonetici (che rappresentano quindi un suono, come le nostre lettere A, B, C...).
Infatti era proprio così… e il mistero fu svelato
2 Indica con una X il completamento corretto.
• La stele di Rosetta fu scoperta: nel 1799. nel 196 a.C. nel 1822.
• Sul blocco di roccia c’era una scritta in tre lingue: francese, greco, geroglifico. francese, geroglifico, demotico. geroglifico, greco antico, demotico.
• Jean-François Champollion era: un appassionato di lingue. un soldato francese. uno studioso del tempo di Tolomeo.
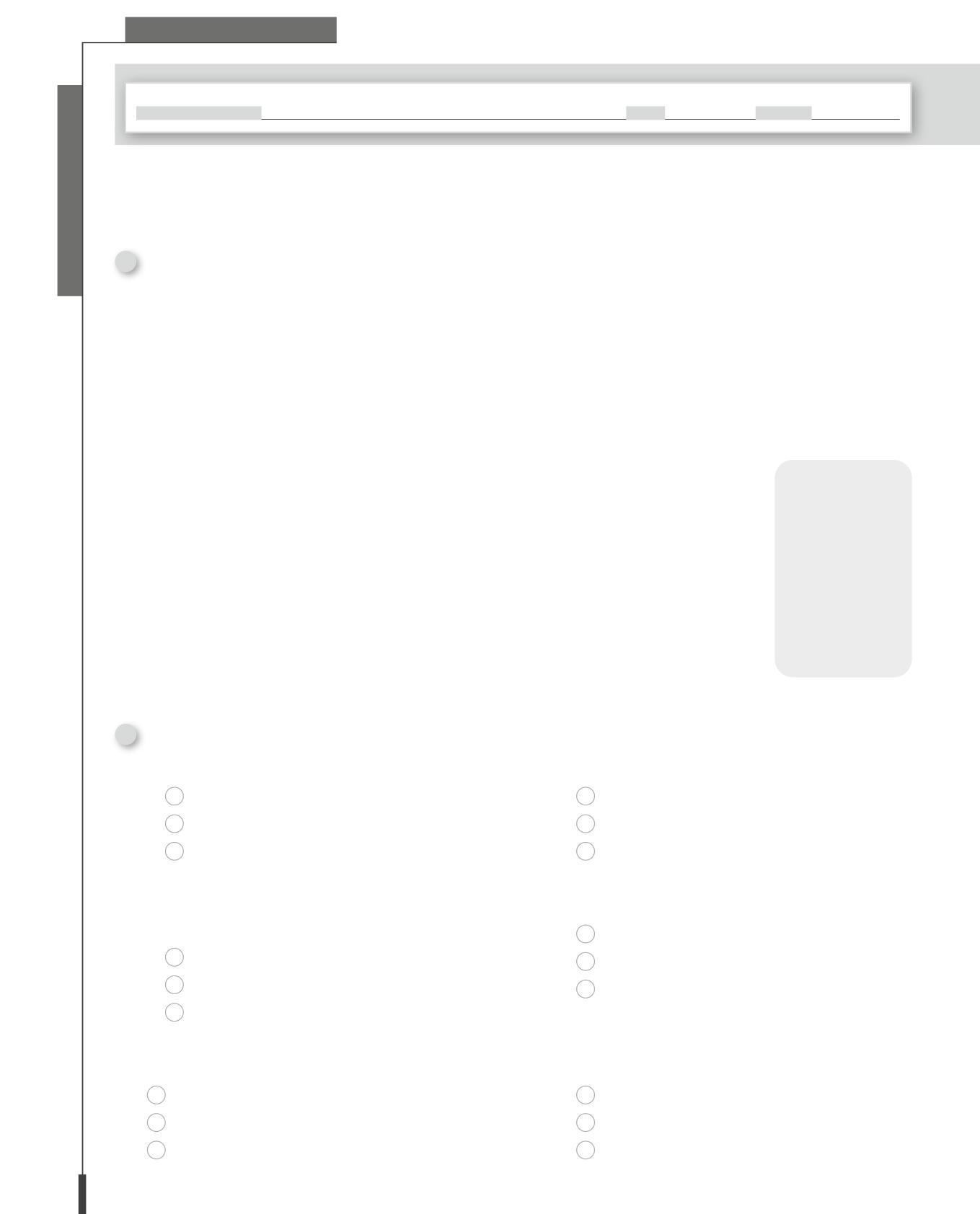
basalto Roccia nera di origine vulcanica. decreto Documento che contiene ordini o leggi stabiliti da un’autorità.
• I geroglifici furono decifrati: con molta fatica. senza successo. facilmente.
• I primi geroglifici identificati furono: il nome “Egitto”. il nome “Rosetta”. i nomi del re e della regina.
• I geroglifici furono decifrati quando si capì che i segni erano: tutti ideogrammi. tutti fonetici. un misto di ideogrammi e segni fonetici.
IL PAPIRO DI AHMES E LA MATEMATICA
1 Individua in questo testo le parole speciali aiutandoti con le domande di fianco al testo. Attenzione: non devi sottolineare intere frasi!
Il papiro di Ahmes, attualmente conservato al British Museum di Londra, è il più antico testo scritto di matematica. Risale infatti al 1650 a.C. circa.
Ahmes svolgeva un lavoro molto difficile e complicato, ma anche molto importante e invidiato: lo scriba.
Gli scribi erano al servizio del faraone, dei sacerdoti e dei funzionari del regno; sapevano scrivere e leggere i geroglifici e tutti gli altri simboli che formavano la scrittura egizia.
Gli scribi registravano e trascrivevano molte cose: le tasse da pagare, la quantità di grano e orzo presente nei magazzini, il raccolto dei contadini, le ricchezze accumulate in guerra… Perciò dovevano essere esperti anche di matematica.
Ahmes raccolse in questo documento molte regole, problemi, esercizi, operazioni matematiche con le loro soluzioni; tutto ciò risulta oggi molto utile per capire quali conoscenze di matematica avevano gli Egizi e quali erano i problemi che dovevano risolvere.
Questo è un esempio di un antico indovinello egizio.
I sette gatti
In un campo ci sono 7 case.
In ogni casa ci sono 7 gatti.
Ogni gatto acchiappa 7 topi.
Ogni topo mangia 7 spighe.
Ogni spiga dà 7 heqat di grano.
Quante cose ci sono in tutto in questa storia?
heqat
Misura di capacità egizia, pari a circa 4,7 litri.
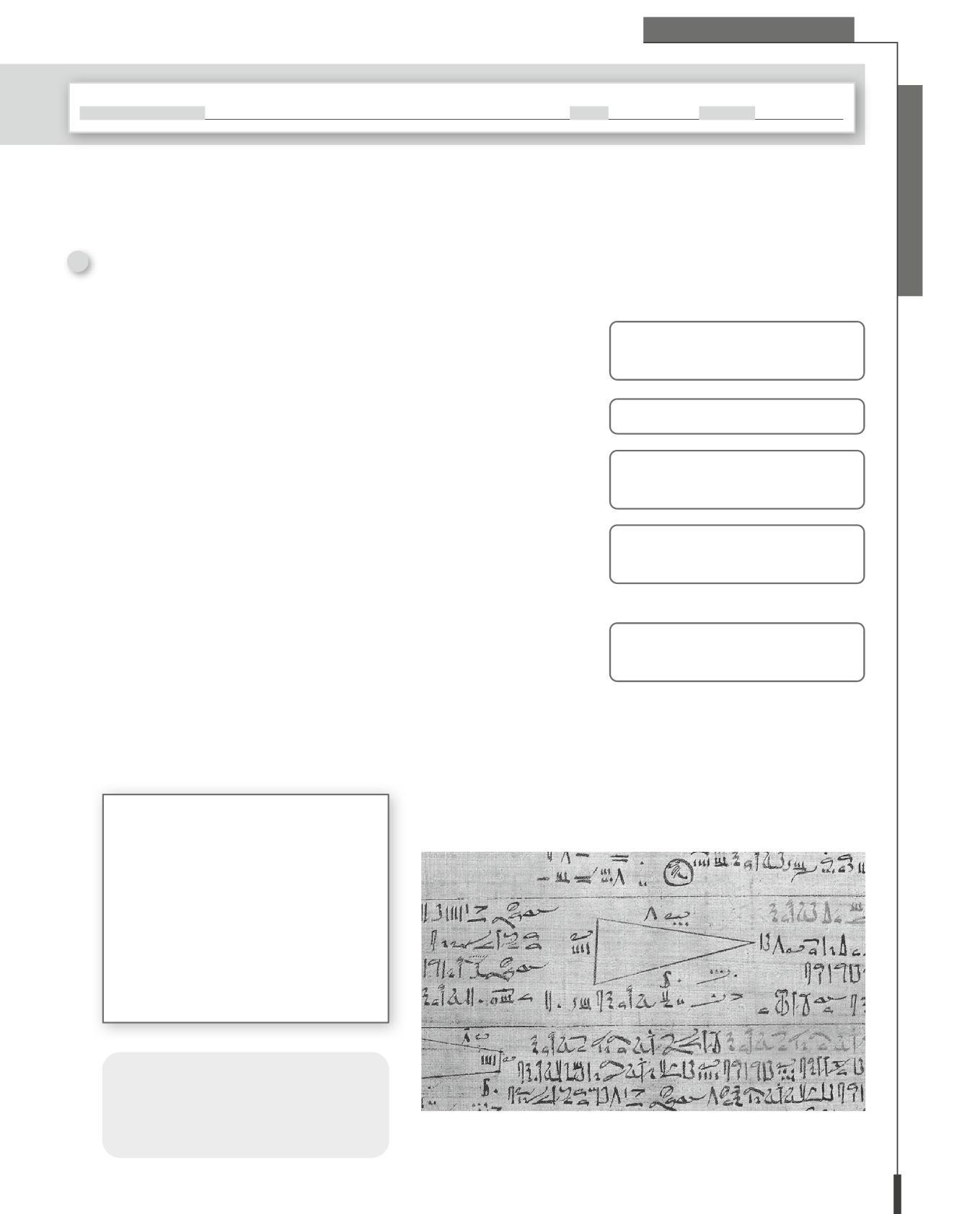
Che cos’è il papiro di Ahmes?
Quando è stato scritto?
Qual era il lavoro di Ahmes?
Che cosa sapevano fare gli scribi?
Che cosa dovevano registrare?
Che cosa contiene il documento?
LA TOMBA EGIZIA
1 Leggi con attenzione il testo e scegli l’alternativa corretta per completare le frasi. Da un papiro egizio, il racconto di un ladro che deruba una tomba
Aprimmo la tomba e trovammo la mummia del faraone. Al suo collo c’era una collana d’oro; la sua testa era ricoperta da una maschera d’oro. Le sue bende erano dorate all’interno e all’esterno ed erano adorne di pietre preziose. Strappammo l’oro dalla mummia di questo dio e gli ornamenti che portava al collo e sulle bende da cui era avvolto.
Nelle stesse condizioni trovammo la moglie del re e nello stesso modo togliemmo tutto quanto si trovava su di lei.
Rubammo gli oggetti posti accanto ai corpi: c’erano vasi d’oro, di argento e di bronzo.
Dividemmo in otto parti l’oro che avevamo trovato sulle mummie di queste due divinità, l’altro oro e gli ornamenti.
• Questo brano è:
un racconto tratto da un libro. un papiro trovato in una tomba. la confessione di un ladro di tombe scritta su una tavoletta d’argilla.
la trascrizione di un papiro con il racconto di un ladro.
• Quando fu aperta la tomba: il ladro era solo.
il ladro era con altre persone. il ladro era almeno con un’altra persona.
il ladro era con il faraone.
• La mummia del faraone aveva: una maschera d’oro e una collana d’oro al collo. diversi oggetti preziosi al collo, ma nessuna maschera d’oro.
la testa adorna di pietre preziose e una collana d’oro al collo. oro solo intorno al collo.
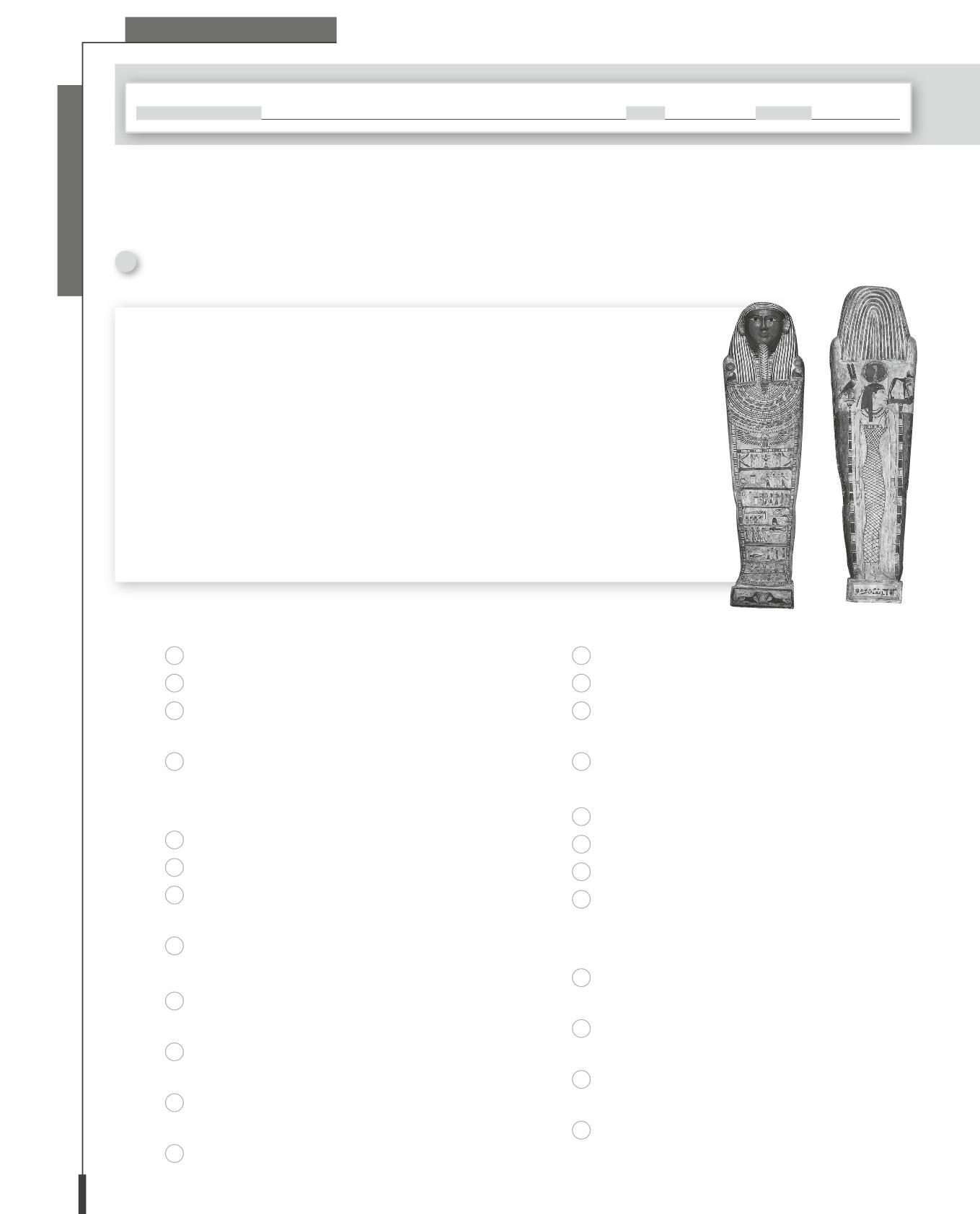
• Le bende della mummia del faraone erano: dorate solo all’esterno con tanti gioielli. dorate solo all’interno con pochi gioielli. dorate all’interno e all’esterno e ricche di pietre preziose.
bianche e con tante pietre preziose.
• Il ladro precisa che la mummia era: del faraone.
di un dio immortale. di una persona qualsiasi. di un personaggio importante.
• I ladri erano consapevoli che il faraone e la moglie erano considerati divinità: per questo motivo decisero di rubare le due mummie.
per questo motivo decisero di non derubare le mummie. nonostante ciò derubarono le mummie dei loro tesori. nonostante ciò rubarono le mummie.
NOME E COGNOME DATA CLASSE
• Alla moglie del re: non fu rubato niente.
furono rubati gli stessi oggetti del marito.
i ladri non poterono togliere l’oro. i ladri rubarono solo la collana.
• Furono rubati anche: vasi d’oro, d’argento e di bronzo. i corpi dei due defunti.
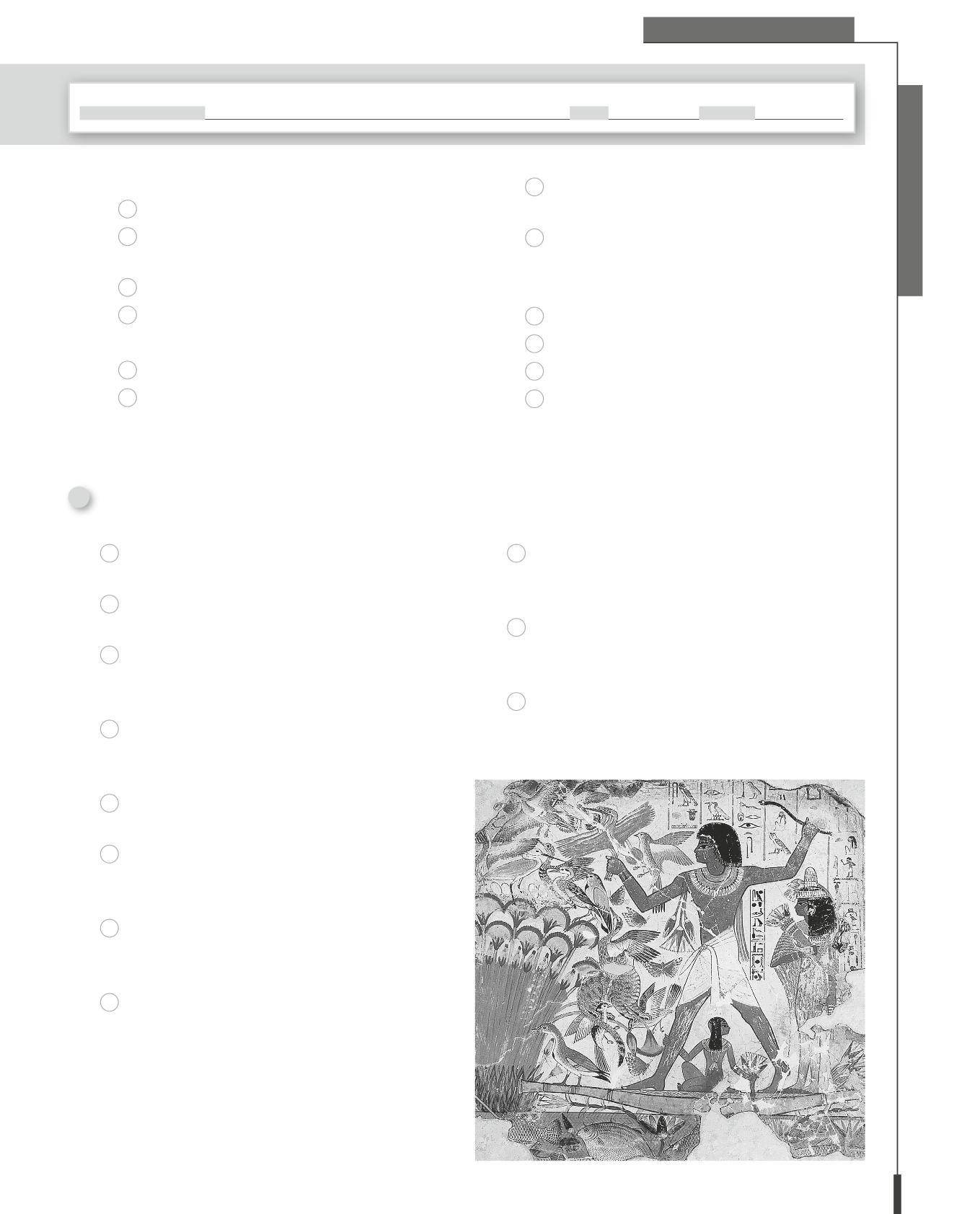
gli oggetti che si trovavano fuori dalla stanza delle mummie.
le bende dorate che avvolgevano i corpi dei due defunti.
• Il bottino: fu diviso otto volte. fu diviso tra gli otto ladri. fu diviso tra le due mummie. fu lasciato alle divinità come segno di rispetto.
2 Guarda la fonte visiva e leggi la didascalia. Le frasi seguenti sono tutte corrette. Quali vengono confermate da questa fonte visiva? Indicale con una X.
Le tombe dei faraoni erano destinate a contenere la sua mummia.
Il corpo del faraone e di sua moglie erano fasciati e conservati.
Anticamente l’imbalsamazione era riservata al solo faraone, poi venne estesa anche agli altri Egizi.
I poveri avvolgevano il cadavere in un lenzuolo con qualche oggetto e lo seppellivano nel deserto.
Gli Egizi ricchi o benestanti arredavano la tomba con dipinti, mobili, oggetti, cibi.
Sulle pareti delle tombe venivano dipinte scene che solitamente rappresentavano quello che al defunto piaceva fare in vita.
Nelle tombe venivano collocati oggetti preziosi. In quelle dei faraoni erano racchiusi veri tesori.
I dipinti nelle tombe sono molto importanti per chi vuole scoprire la vita quotidiana dell’antico Egitto.
A partire dal Nuovo Regno, i sovrani egizi cominciarono a farsi seppellire nella Valle dei Re.
Tra le tombe della Valle dei Re, l’unica a non essere saccheggiata dai ladri fu quella di Tutankhamon.
Le pitture rinvenute sulle pareti mostrano che le rive del Nilo erano popolate da molti uccelli.
LA CIVILTÀ DELL’INDO
1 Leggi le seguenti definizioni e completa lo schema: nella grigia colorata comparirà il nome della civiltà di cui si parla. Per aiutarti hai a disposizione anche la lettera iniziale di ciascuna risposta e alcune altre lettere.
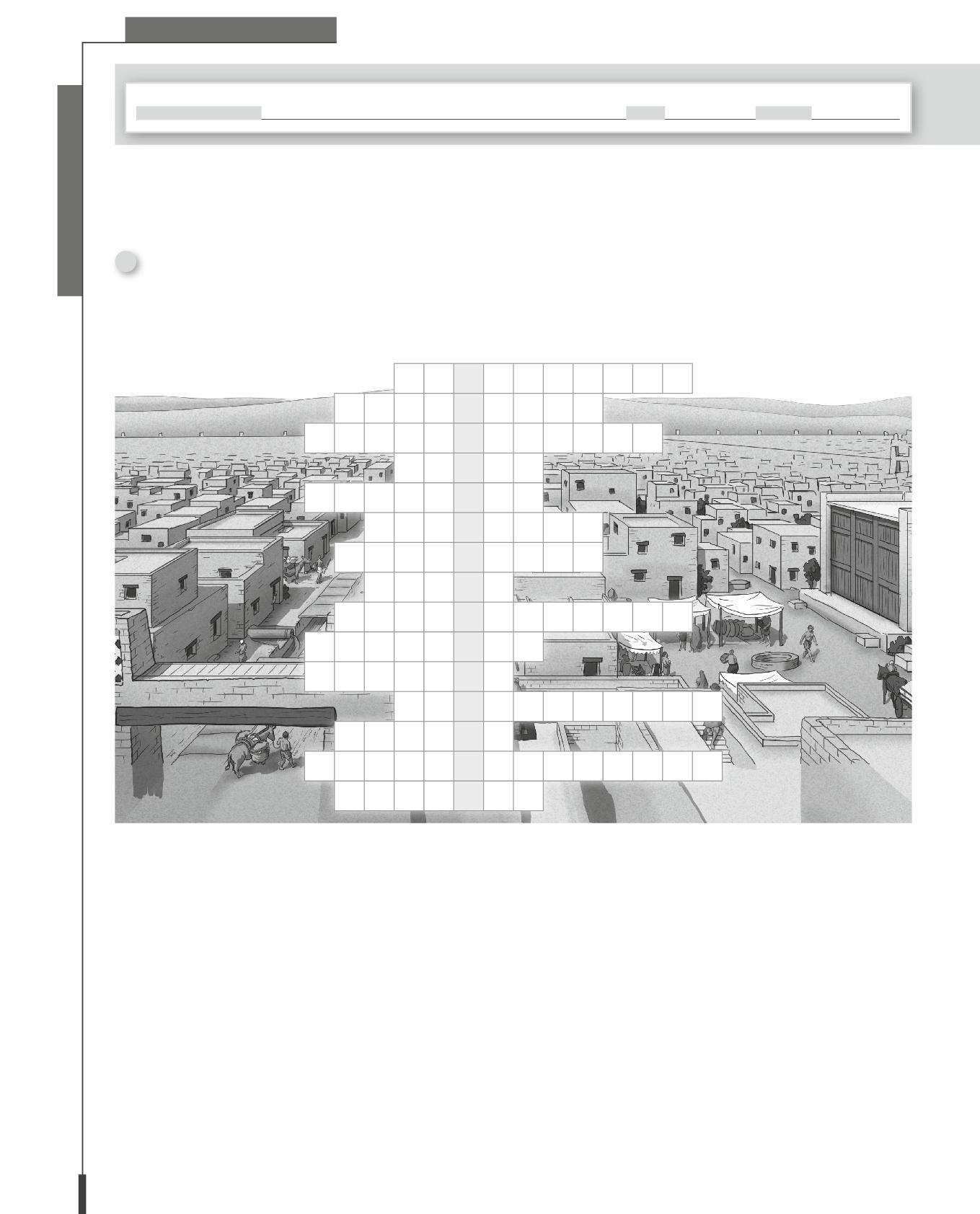
1 Quella di questa civiltà non è stata ancora decifrata.
2 Lo Stato attuale in cui sono stati scoperti i suoi insediamenti più importanti.
3 Una delle attività praticate dagli antichi abitanti.
4 Il nome del fango depositato dal fiume.
5 Servivano per contrassegnare le merci.
6 Venivano cotti in grandissime quantità.
7 La catena montuosa più alta del mondo.
8 Il nome di un fiume importante per questa civiltà.
9 Il nome di una delle città scoperte (2 parole).
10 Serviva per realizzare i mattoni.
11 Edifici di cui non sono stati ritrovati resti in nessuna città.
12 Il nome della parte alta delle città.
13 Quelle del fiume potevano essere pericolose.
14 Nome della grande vasca ritrovata in uno degli insediamenti (2 parole).
15 Pianta usata per fare i tessuti.
SCIENZA E TECNOLOGIA NELLA CIVILTÀ DELL’ANTICA CINA
1 Leggi alcuni dei risultati scientifici e tecnologici che la civiltà cinese raggiunse ben prima di altri popoli antichi. Poi per ognuno sottolinea una parola-chiave.
I Cinesi erano abili ingegneri: nel 606 a.C. avevano già costruito il primo bacino artificiale per l’irrigazione dei campi; nei primi secoli dopo Cristo erano diventati abili costruttori di ponti.
Erano molto abili nella lavorazione del ferro. Dopo averlo estratto dalle miniere, lo fondevano negli altiforni per forgiare armi e attrezzi. Eccellevano anche nella lavorazione del bronzo.
Dal 200 a.C. i Cinesi estraevano il sale dalle miniere: scavavano pozzi, vi versavano acqua per sciogliere il sale, poi l’acqua veniva fatta risalire ed evaporare, per ottenere i cristalli di sale.
I Cinesi furono eccellenti astronomi: determinarono l’orbita della Luna e individuarono più di mille stelle. Erano anche in grado di prevedere le eclissi.
I Cinesi allevavano i bachi da seta per produrre un filo leggerissimo con il quale tessevano la seta. Secoli dopo, questa lavorazione si diffuse anche in Occidente.
I Cinesi sapevano fabbricare la carta, inizialmente con fibre di canapa, poi con cortecce d’albero, stracci, canne e bambù. Nel resto del mondo si iniziò a produrre la carta solo alcuni secoli dopo.
I Cinesi scoprirono le proprietà di un particolare minerale, la magnetite, che usarono per costruire le prime bussole per orientarsi.
Leda Luise
eclissi
Fenomeni per cui un corpo celeste, per esempio la Luna, ne nasconde un altro, per esempio il Sole, perché si pone in mezzo tra quest’ultimo e la Terra.
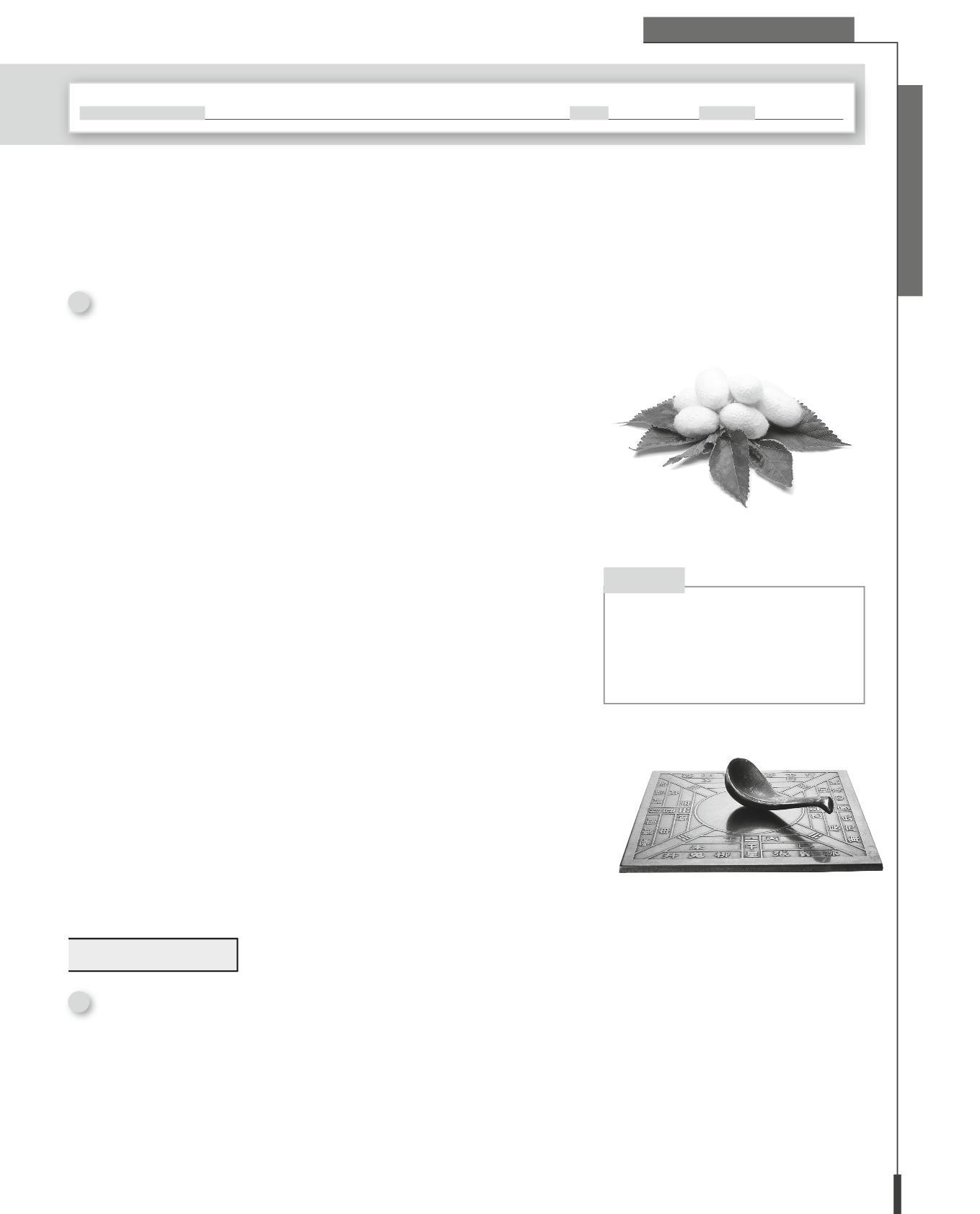
IMPARIAMO INSIEME
2 Confrontati con un compagno o una compagna e, insieme, scegliete il risultato che vi sembra il più importante di tutti. Motivate la vostra scelta.
Il risultato che riteniamo più significativo è perché
LE NAVI DEI CRETESI
1 Leggi il brano e osserva la fonte. Poi scrivi nell’immagine le lettere corrispondenti alla descrizione nel testo.
Le imbarcazioni cretesi erano molto varie. Nell’isola di Santorini è stato trovato un grande affresco che ne mostra alcuni bellissimi esempi. Le navi potevano avere dimensioni e aspetto diversi a seconda del loro uso. Il timoniere stava sempre a poppa A (cioè sul retro della nave) e, con l’aiuto di due lunghi remi B , governava la nave. La prua C (cioè la punta della nave) poteva essere decorata con una figura scolpita in legno.
Le imbarcazioni che andavano in mare aperto erano spinte dalla vela quando c’era vento, altrimenti era compito dei rematori D spingerle avanti. Alcune navi avevano dei ripari sostenuti da pali E sotto i quali stavano i passeggeri F . Si calcola che per andare da Creta all’Italia ci volesse circa un mese. I marinai cretesi per i viaggi commerciali potevano navigare soltanto in primavera e in estate; in autunno e in inverno ritornavano a casa a occuparsi di agricoltura.
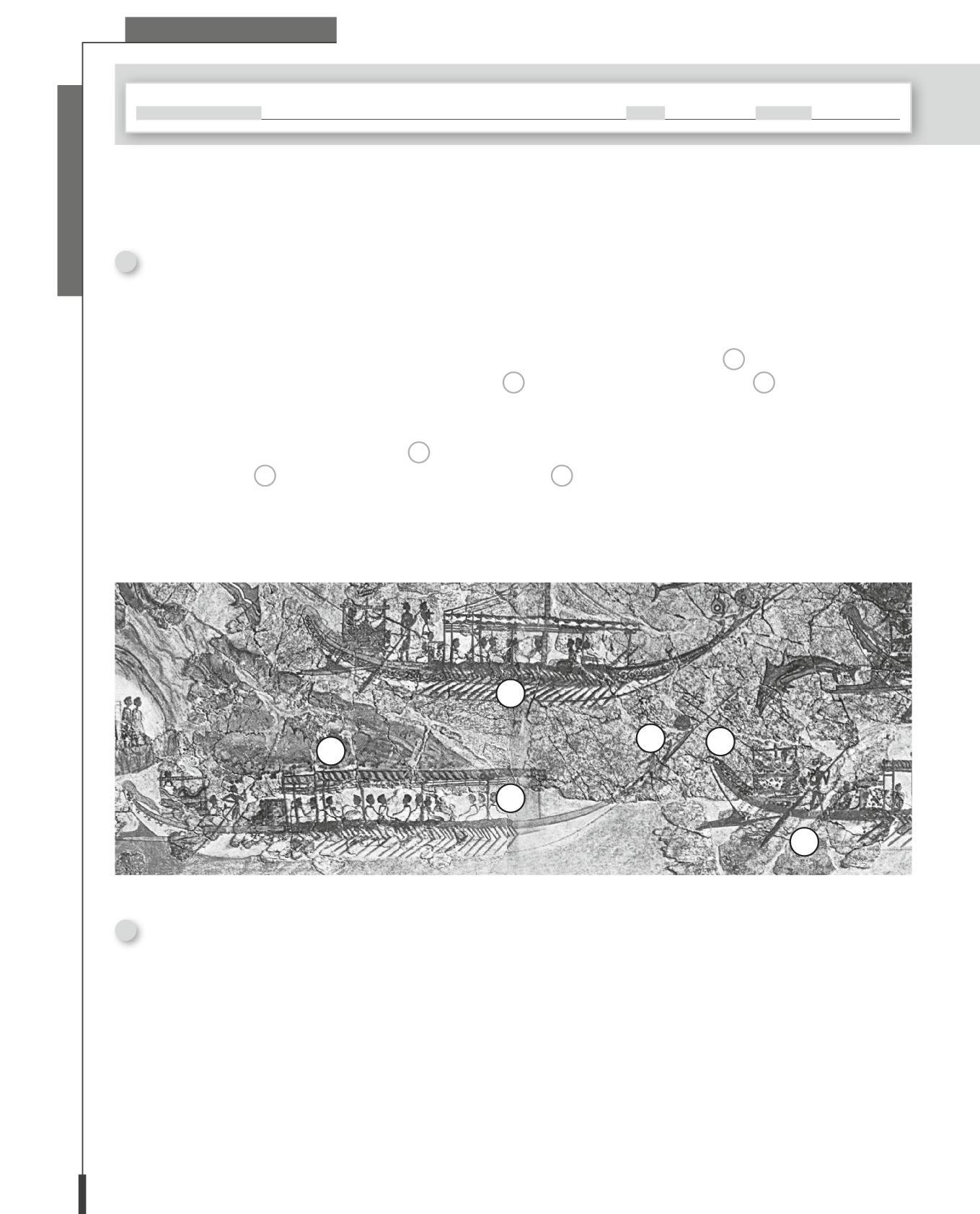
2 Rispondi alle domande.
• Sapresti spiegare come mai le navi viaggiavano soltanto in primavera e in estate?
• Che cosa significa la frase «in autunno e in inverno ritornavano a casa a occuparsi di agricoltura»?
NOME E COGNOME
CONSEGUENZE DEI COMMERCI DEI FENICI
1 Collega ciascun fatto alla causa corrispondente.
I Fenici inventarono l’alfabeto…
Il sistema dell’alfabeto si diffuse rapidamente tra le civiltà del Mar
Mediterraneo…
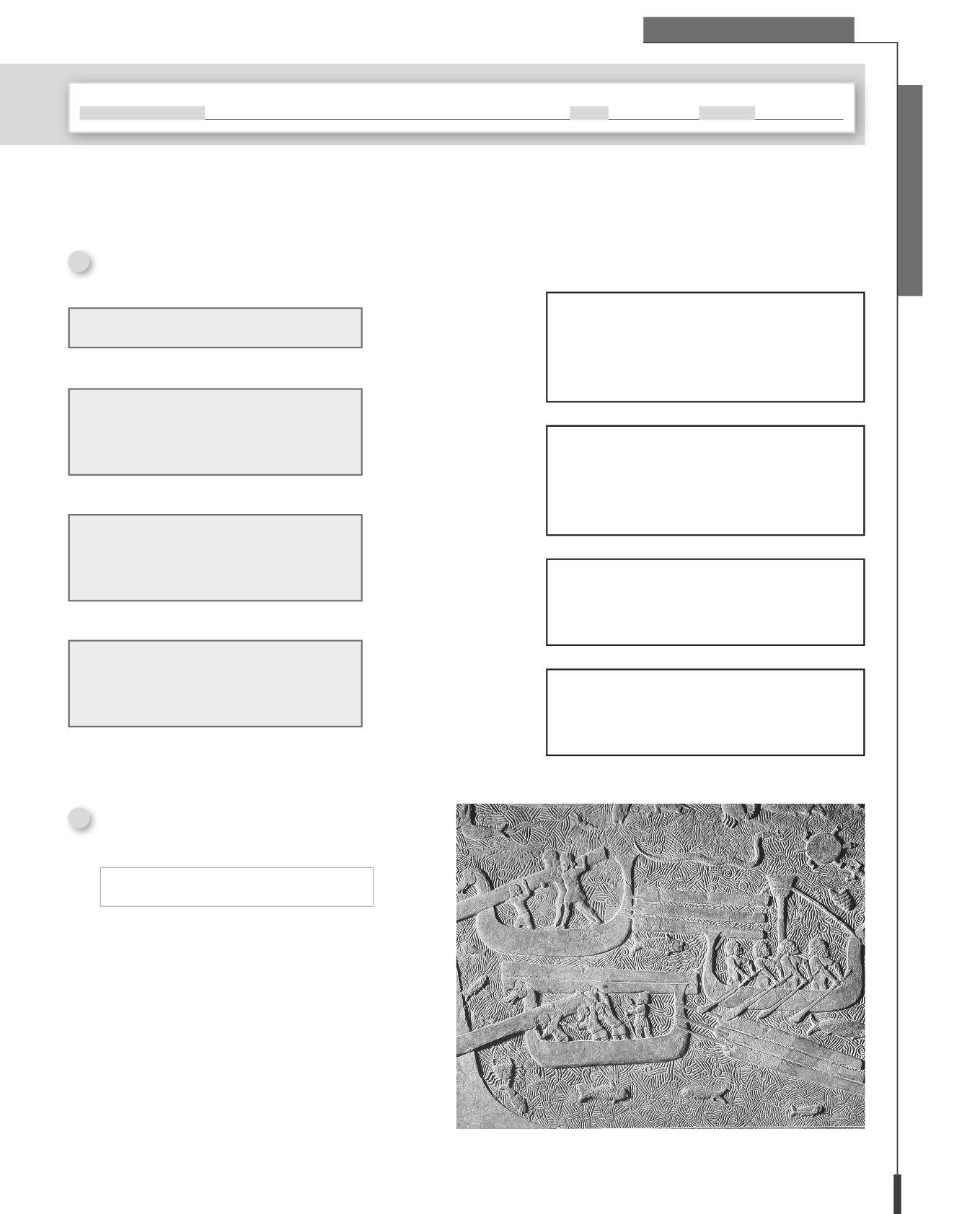
I Fenici ebbero contatti commerciali con le civiltà del Mar
Mediterraneo e del Mar Rosso…
Le antiche ed estese foreste della Fenicia (attuale Libano) non esistono più…
2 Osserva l’immagine e completa la didascalia con le seguenti parole.
legname • legno • navi • tronchi
Un bassorilievo trovato nel palazzo del re assiro Assurbanipal mostra alcuni marinai fenici che con le loro trainano lunghi di verso la Mesopotamia. Infatti in quel territorio il scarseggiava ed erano costretti ad acquistarlo dai Fenici.
… perché avevano a disposizione alcune materie prime, come il legno, e prodotti artigianali, come i tessuti di porpora, da scambiare.
… perché già a quel tempo i Fenici ne abbatterono la maggior parte per ricavare il legname per navi, costruzioni e commercio.
… perché era molto semplice e rapido da imparare e da scrivere; infatti era composto da soli 22 segni.
… perché i tipi di scrittura usati fino ad allora erano troppo difficili da scrivere.
LA CIVILTÀ DEGLI EBREI
1 Leggi le seguenti definizioni e completa lo schema: nella grigia colorata comparirà il nome della terra in cui si stabilirono gli antichi Ebrei.
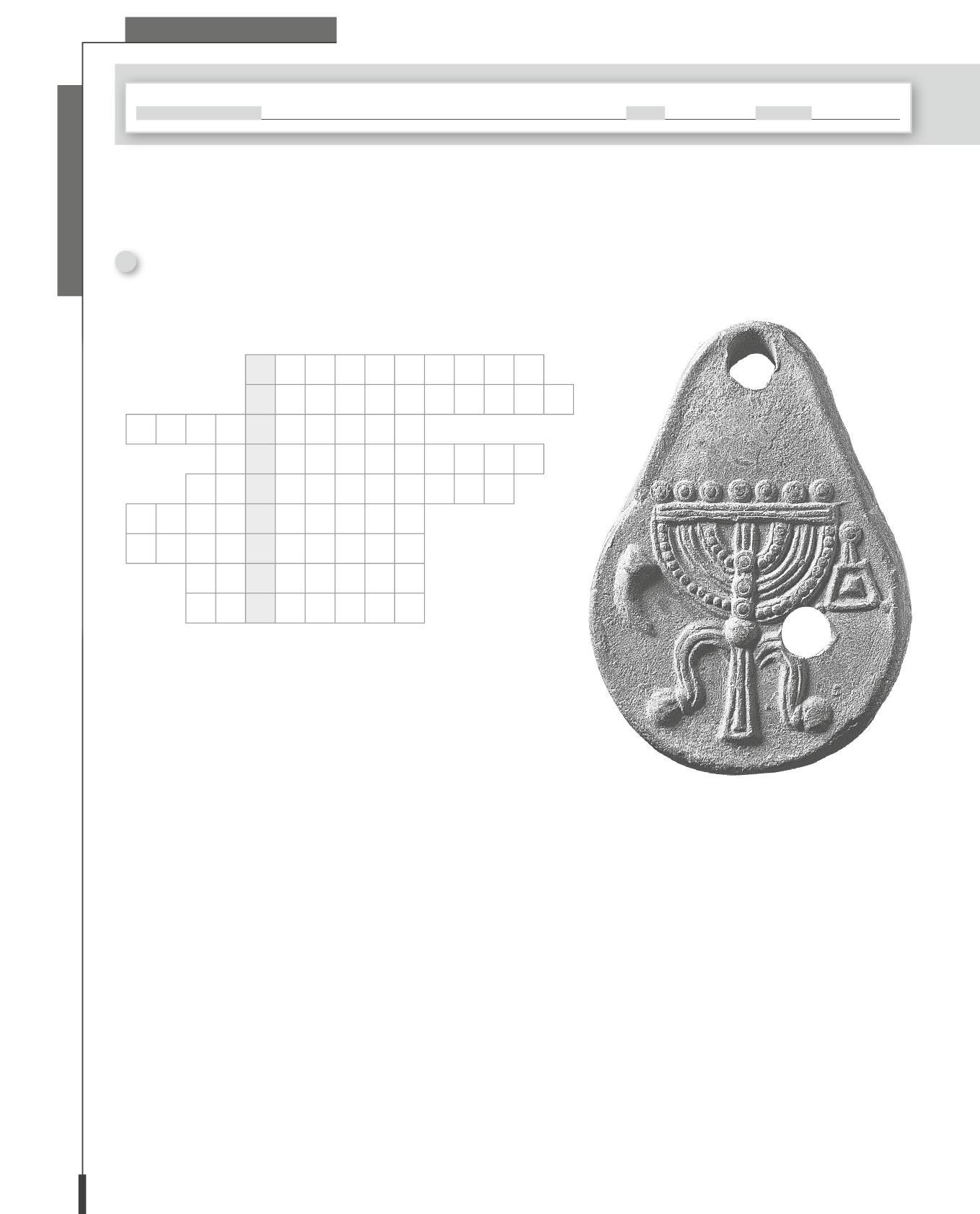
1 L’attività dei primi Ebrei.
2 Attività che si diffuse quando gli Ebrei si stabilirono in Palestina.
3 La popolazione che conquistò i regni degli Ebrei nel 586 a.C.
4 La città più importante del Regno di Israele.
5 La terra d’origine degli Ebrei.
6 La fede in un unico Dio.
7 I capi delle tribù ebraiche.
8 Il luogo in cui i bambini maschi andavano a istruirsi.
9 La parola che vuol dire “dispersione”.

LA LAVORAZIONE DEL VETRO
Una spiegazione molto diffusa sulla scoperta del vetro attribuisce questo merito ai Fenici, ma questa informazione è stata smentita.
In realtà sia gli Egizi sia gli abitanti della Mesopotamia conoscevano già il modo di fabbricare certi tipi di vetro. I più antichi oggetti di vetro degli Egizi erano ottenuti modellando argilla o terra per creare la forma di un vaso, che poi veniva immersa nel vetro fuso. Questa tecnica poteva servire solo per realizzare contenitori minuscoli, destinati a contenere balsami e profumi, oppure per creare perle e ornamenti.
I più antichi documenti riguardanti la lavorazione del vetro risalgono al 2200 a.C.
Fino all’invenzione del vetro soffiato, realizzata in Siria nel I secolo a.C., l’industria vetraria era molto limitata. I vasi erano realizzati soprattutto in ceramica. Grazie all’invenzione del vetro soffiato si poterono creare forme nuove e più larghe e vasi molto più grandi. Per realizzare il vetro soffiato l’artigiano immergeva una canna da soffio nel vetro fuso e soffiava aria nella goccia di vetro sospesa in fondo alla canna. Questa tecnica si usa ancora oggi.
I vasi venivano poi decorati con incisioni, con filamenti di altro vetro oppure con gocce colorate, che andavano applicate con la spatola mentre i vasi erano ancora caldi.
I Fenici vivevano in una terra povera di risorse naturali, ma erano in contatto con tutto il mondo civile di quel tempo e vivevano vicino a importanti vie di traffico commerciale. Quindi impiantarono ben presto una fiorente industria di articoli di lusso, come gioielli e ornamenti di metallo e di vetro, vasi, avorio e altri prodotti d’arte, che spesso, tuttavia, erano imitazione di quelli dell’Egitto e della Mesopotamia. rid. e adatt. da R.J. Forbes, L’uomo fa il mondo, Giulio Einaudi Editore
1 Leggi il testo e indica con una X l’alternativa corretta per completare le frasi.
• I primi a “inventare” il vetro sono stati: i Fenici. i popoli mesopotamici.
gli Egizi.
gli Egizi e i popoli mesopotamici.
• I primi oggetti in pasta di vetro sono stati creati:
circa 2200 anni fa.
circa 4200 anni fa.
nel I secolo a.C. in un periodo non precisato.
• I primi oggetti in vetro erano: contenitori minuscoli. contenitori di varie dimensioni. gioielli e contenitori per balsami, profumi. contenitori per acqua o altri liquidi.
• I primi contenitori erano fatti con:
terracotta rivestita di pasta di vetro. terracotta dipinta con il vetro fuso. vetro soffiato. vetro molto spesso.
• Il vetro soffiato è stato “inventato”:
nel I secolo d.C.
nel I secolo a.C. due millenni fa. nel 2200 anni a.C.
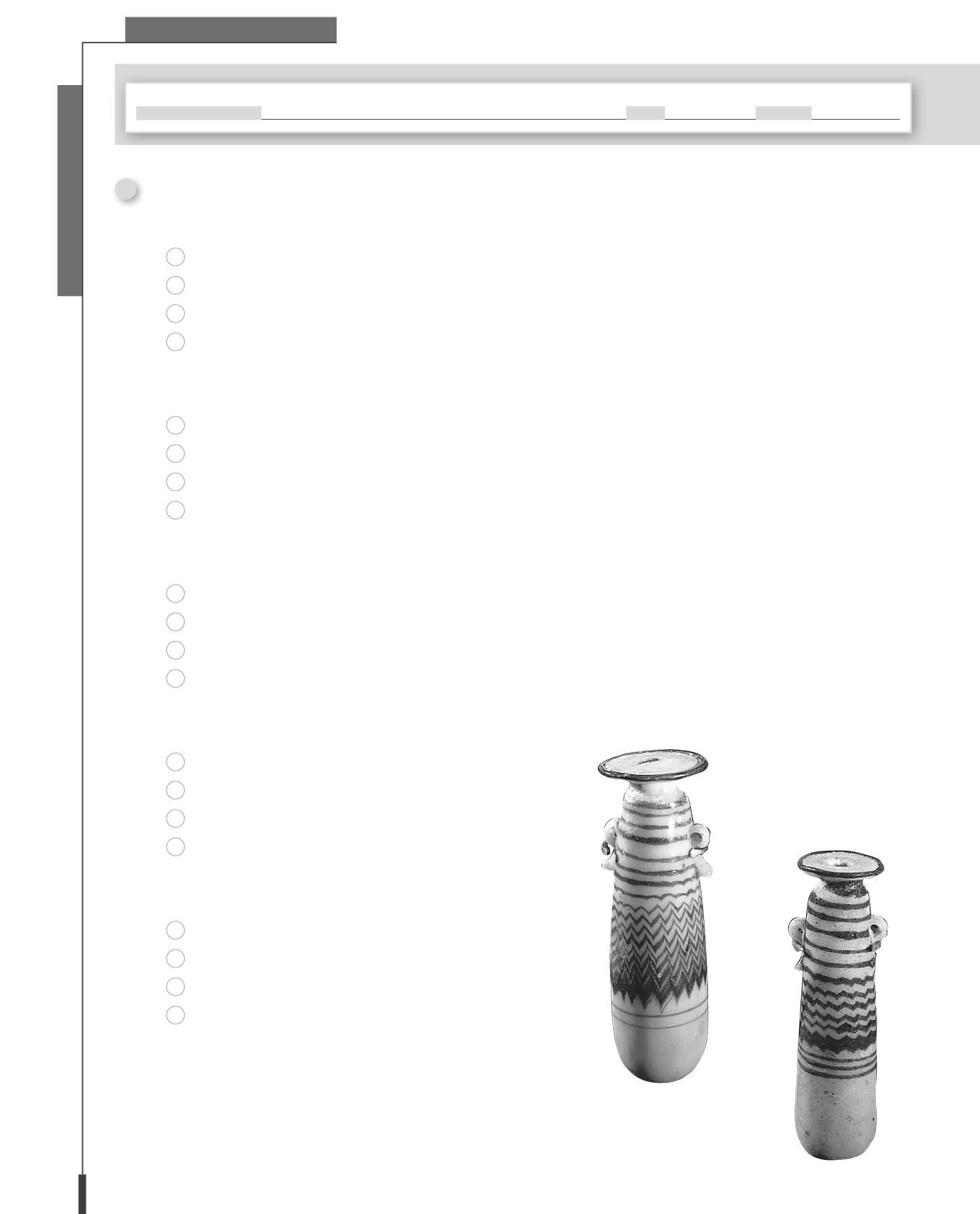
OBIETTIVI: Comprendere e ricavare le informazioni da un testo di carattere informativo.
NOME E COGNOME DATA CLASSE
• Il vetro soffiato è stato inventato in: Egitto.
Mesopotamia. Fenicia. Siria.
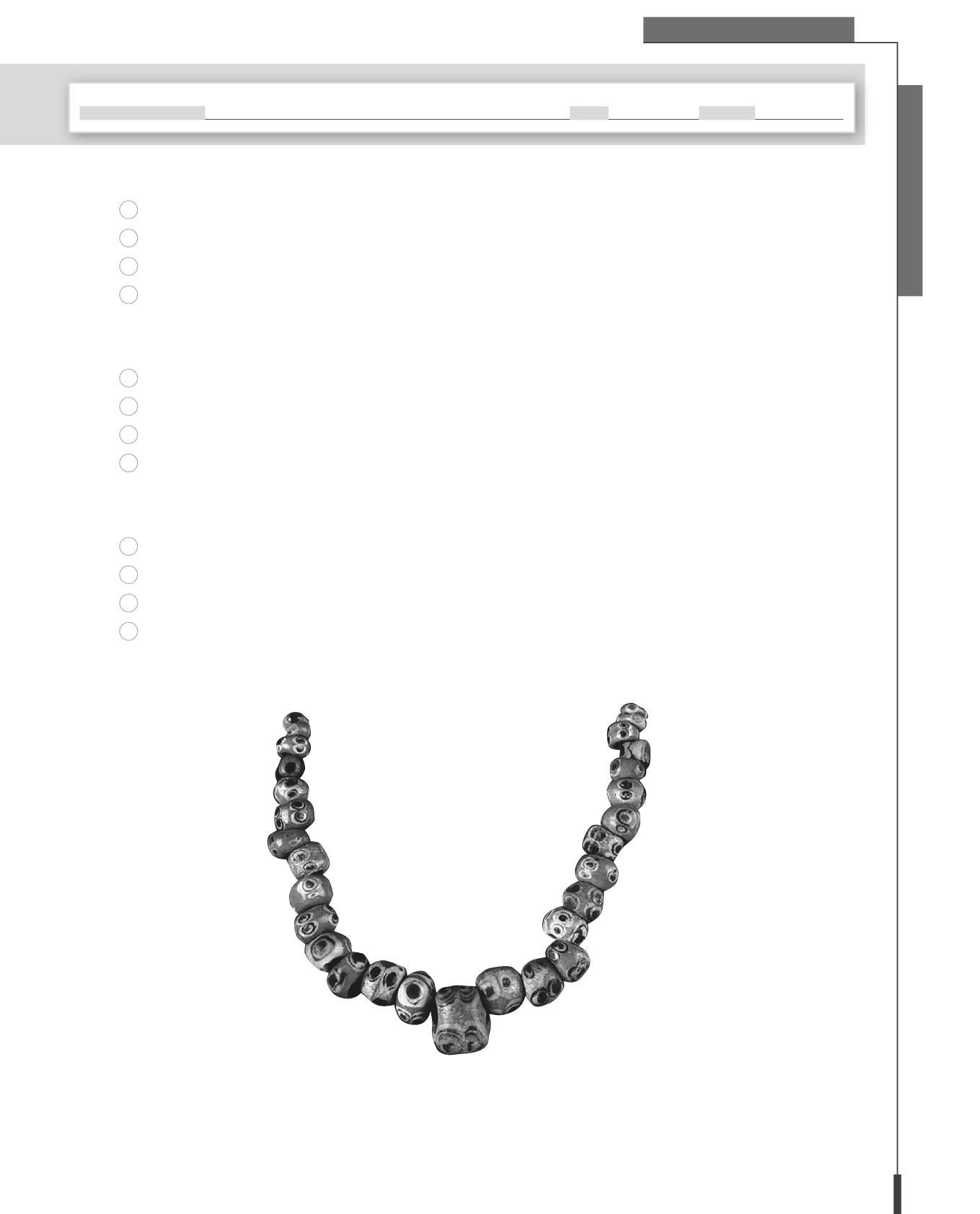
• I Fenici hanno imparato a lavorare il vetro: dagli Egizi. dai popoli mesopotamici. dai Cinesi.
dagli Egizi e dai popoli mesopotamici.
• Il vetro non è stato inventato dai Fenici, ma spesso si dice che è opera loro perché: lo hanno diffuso presso altri popoli. avevano imparato a lavorarlo bene.
gli archeologi e le archeologhe hanno trovato solo vetro prodotto dai Fenici. solo successivamente si è scoperto che non ne erano stati i primi inventori.
IL MONDO VERSO IL 2000 A.C.
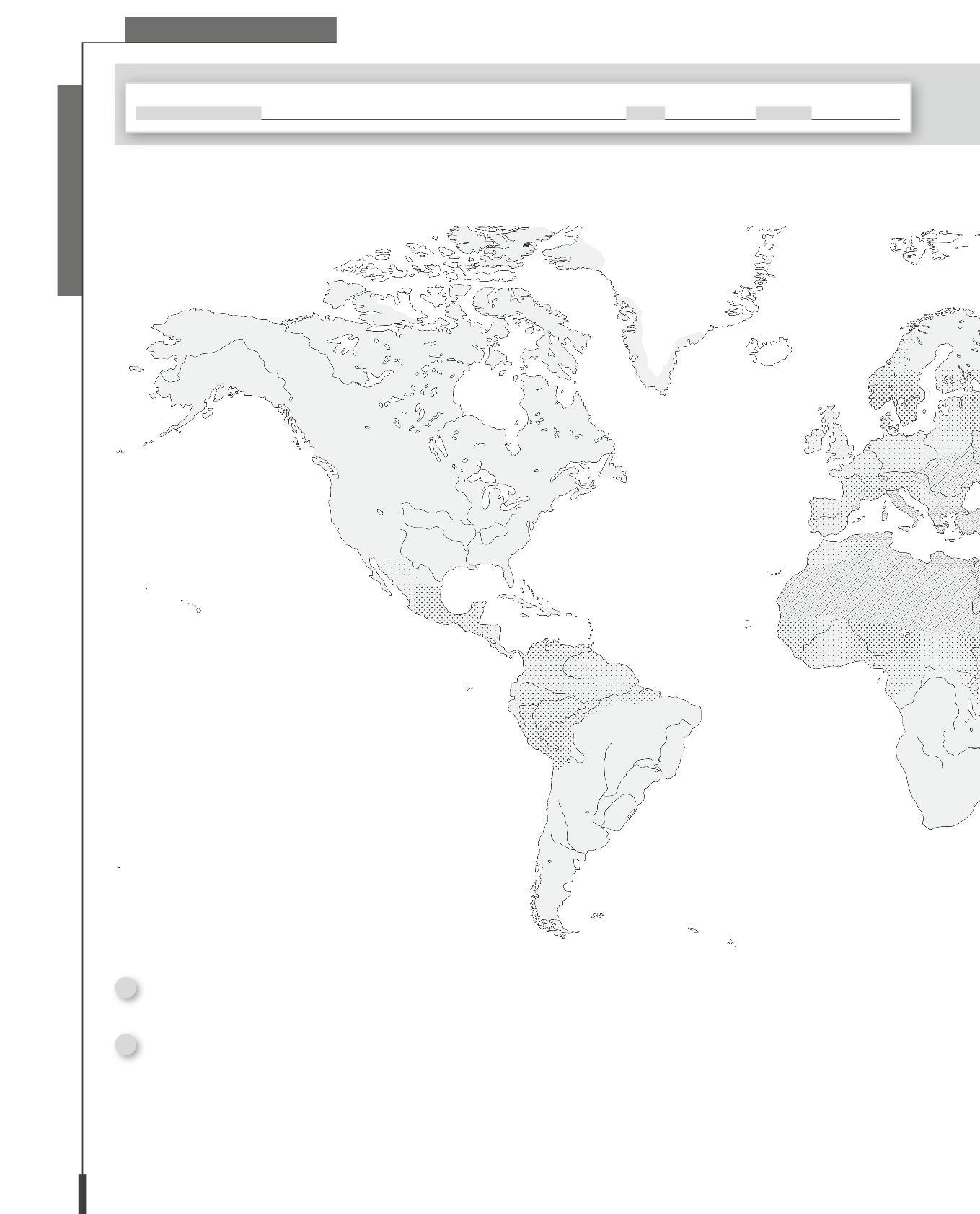
1 Il planisfero ti mostra com’era popolato il mondo intorno al 2000 a.C.: usa la legenda per colorarlo.
2 Osservando a colpo d’occhio il planisfero, sai dire in che modo viveva la grande maggioranza dell’umanità, cioè che attività svolgeva per vivere?
LEGENDA
= giallo Cacciatori e raccoglitori
= verde Pastori nomadi
= arancio Agricoltori
= rosso Società statali
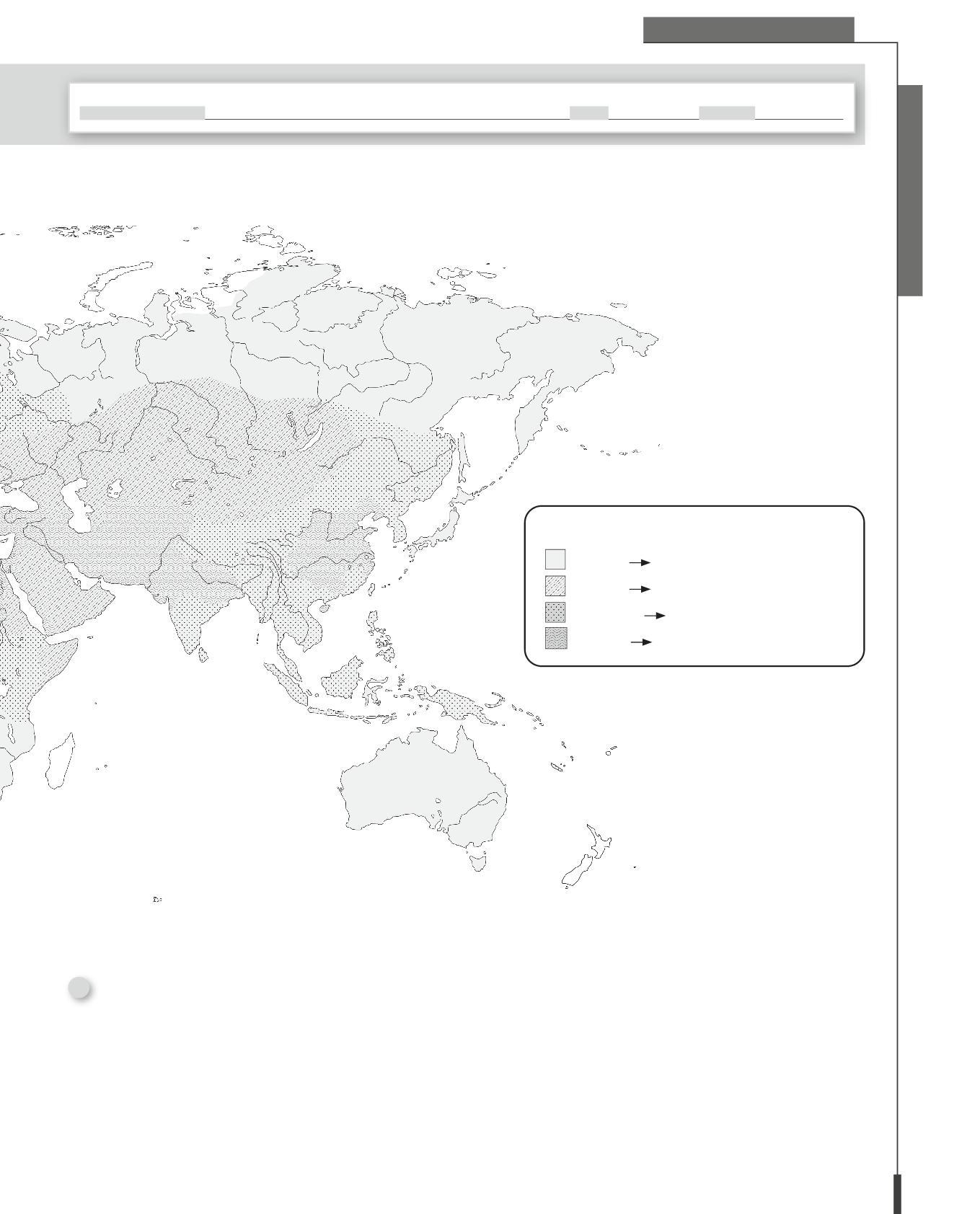
3 Quali civiltà esistevano in quel periodo? Scrivi qui di seguito quelle che conosci.
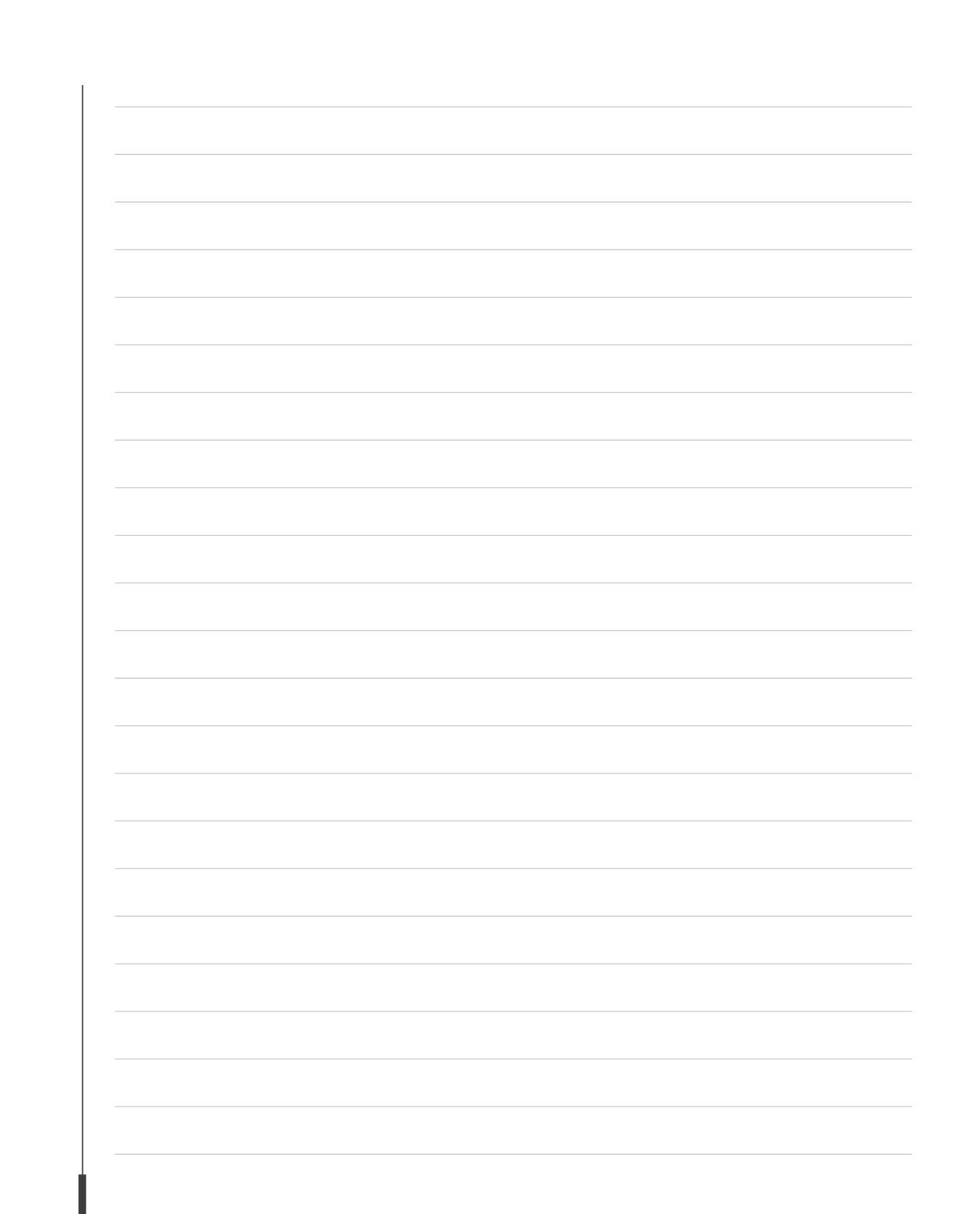
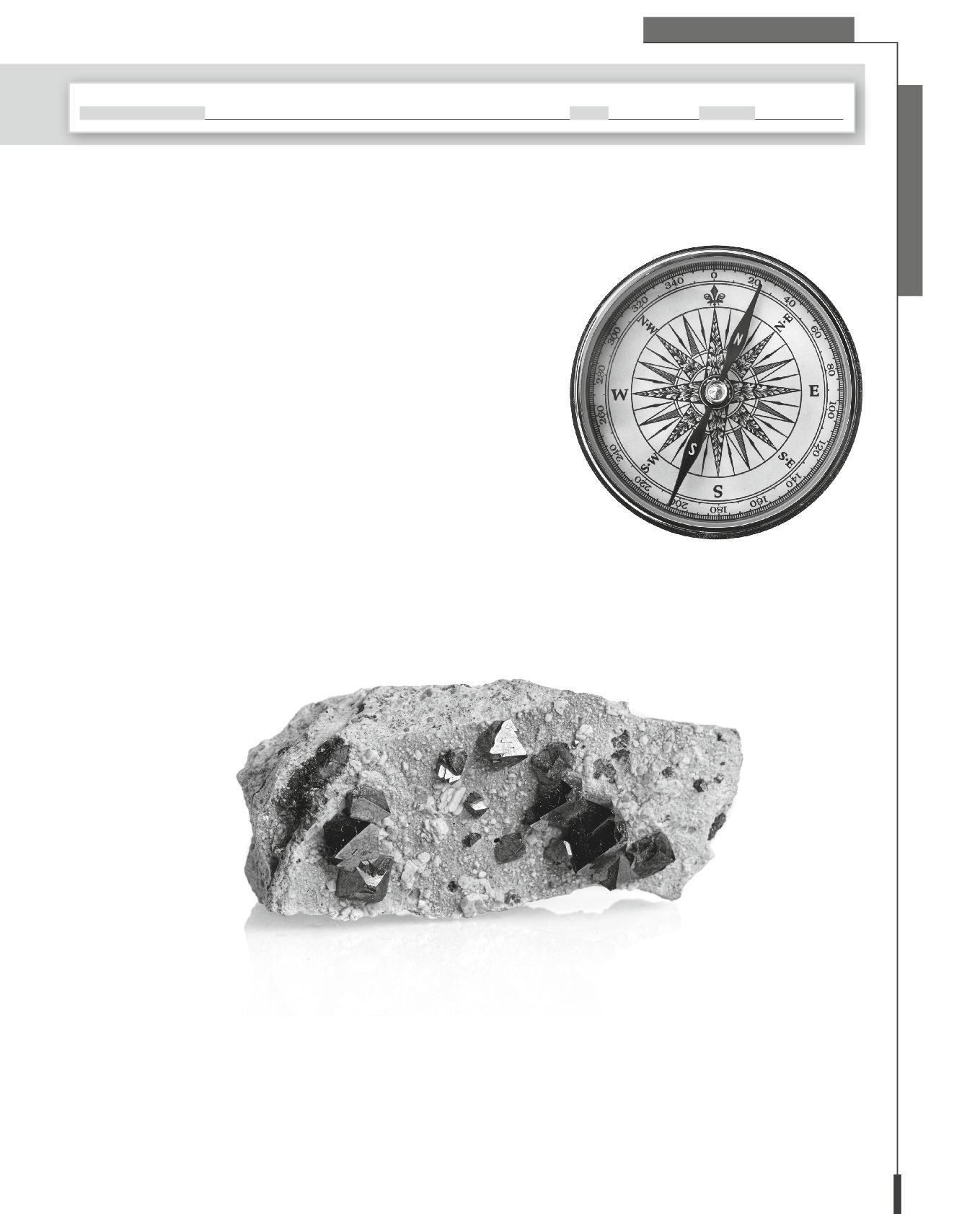
L’INVENZIONE DELLA BUSSOLA
La bussola è stata una delle più grandi invenzioni umane: ha consentito a marinai, esploratori, viaggiatori e aviatori di orientarsi sulla Terra.
Le proprietà della magnetite di attirare pezzi di ferro erano già note a molti popoli antichi. Nell’antica Cina, infatti, durante gli spettacoli, si stupiva il pubblico con frecce magnetizzate che si allineavano indicando il Nord. Questa proprietà fu utilizzata verso l’VIII secolo d.C. per realizzare le prime bussole: recipienti pieni d’acqua dove galleggiava un pezzo di legno a cui era fissato un ago magnetico che indicava sempre il Nord. Il nome “bussola” deriva proprio dal legno di bosso che era utilizzato in questi recipienti. Intorno al 1200 i marinai di Amalfi, una Repubblica marinara della Campania, perfezionarono la bussola, applicando sul suo fondo la rosa dei venti con riportati i quattro punti cardinali e le direzioni intermedie. Dopo di allora, l’invenzione si diffuse nel Mediterraneo e fu installata sul ponte di ogni nave.

1 Leggi il testo e indica con una X l’alternativa corretta per completare le frasi.
• La magnetite è un minerale che: lancia frecce. lancia pezzi di ferro. galleggia sull’acqua. attira pezzi di ferro.
• L’ago magnetico delle prime bussole: era montato su un pezzo di legno, quindi galleggiava sull’acqua. era sulla rosa dei venti. galleggiava sull’acqua. era sui ponti di tutte le navi.
• Le prime bussole furono utilizzate: fin dall’antichità.
dall’VIII secolo d.C.
dal 1100 d.C.
dal 1200 d.C.
• Il nome “bussola” deriva: dalla lingua cinese. dal pezzo di legno galleggiante. dal legno di bosso usato nelle prime bussole. dall’ago calamitato.
• I marinai di Amalfi: inventarono la bussola. perfezionarono la bussola. non usavano la bussola. usavano solo la rosa dei venti.
• Dopo il 1200 la bussola si diffuse: anche nel Mediterraneo. solo nel Mediterraneo. nelle Repubbliche marinare. ad Amalfi.
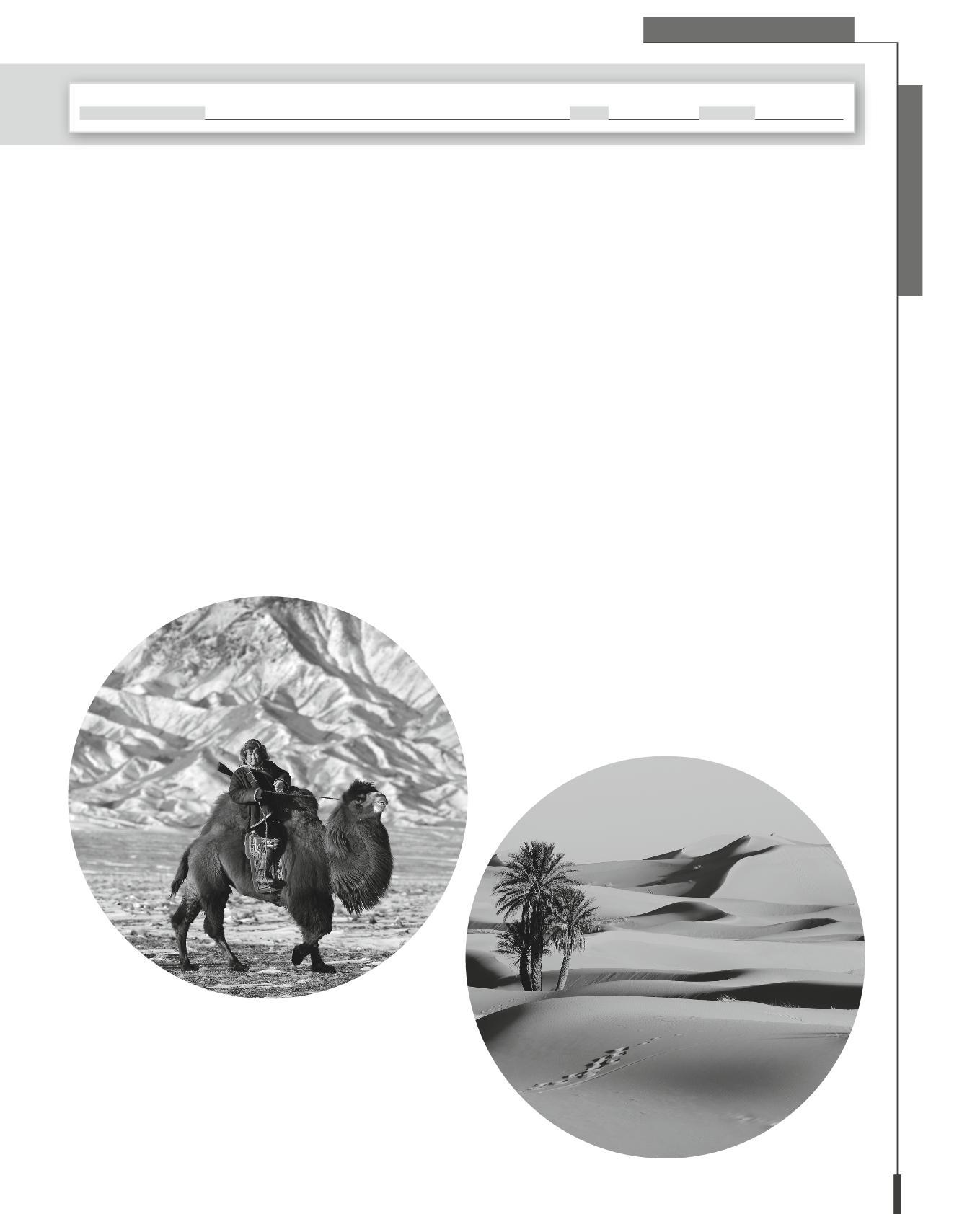
VIVERE NELLE ZONE DESERTICHE
Il deserto è un ambiente naturale dove il clima è talmente arido e privo di acqua da rendere difficile la vita delle piante e degli animali. Il fattore che ostacola la vita non è tanto il calore quanto la mancanza di umidità: infatti esistono deserti freddi, come quello del Gobi, in Cina.
I deserti più grandi e vicini a noi sono sabbiosi, con le tipiche dune, ma esistono anche deserti di roccia compatta e altri coperti di massi e ciottoli. Infatti è la lenta disgregazione delle rocce a formare i deserti, che siano di sabbia o di pietre.
La vita nel deserto è molto dura: gli animali e i vegetali che lo abitano hanno sviluppato, in millenni di evoluzione, particolari forme di adattamento. Le piante hanno rivestimenti esterni spessi e rigidi, per limitare l’evaporazione dei liquidi e conservare a lungo l’acqua immagazzinata all’interno. Gli animali vivono di giorno in tane sotterranee, per sfuggire ai raggi del Sole, ed escono solo di notte. adatt. da Enciclopedia dei Ragazzi, La Terra, “Corriere della Sera”
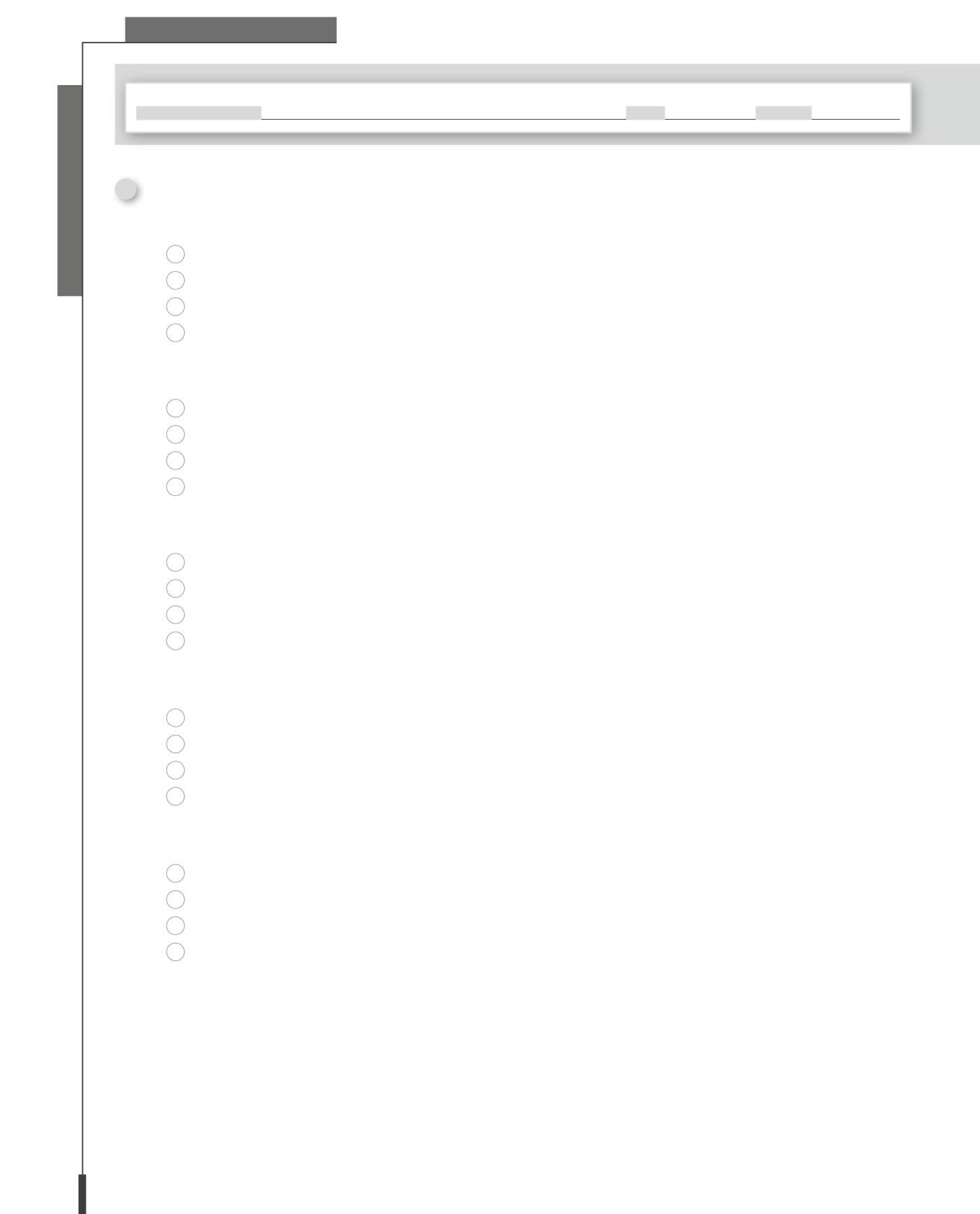
1 Leggi il testo e indica con una X l’alternativa corretta per completare le frasi.
• Il deserto è un ambiente naturale: ricco di piante e di animali. arido e privo di acqua. dove è facile la vita degli esseri viventi. pieno di oasi.
• Esistono deserti: solo caldi e nessuno freddo. freddi, come quello del Gobi. solo di sabbia e mai di rocce. umidi.
• Per vivere nel deserto, animali e vegetali: cercano l’acqua ovunque. vivono solo nelle vicinanze delle oasi. si sono adattati rapidamente. si sono adattati nel corso dei millenni.
• Le piante che vivono nei deserti hanno: rivestimenti duri e rigidi per evitare troppa traspirazione e perdita di umidità. rivestimenti spinosi per non farsi mangiare dagli animali. radici corte e molto diramate per poter raggiungere le falde acquifere. la capacità di produrre acqua.
• Gli animali nei deserti: vivono vicino alle piante con rivestimenti duri per sfruttarne l’umidità e l’ombra. vivono nelle oasi, da cui si spostano solo se sono rimasti senza cibo. vivono in tane sotterranee da cui escono solo di notte. dormono di notte in tane sotterranee dopo aver cacciato durante il giorno.
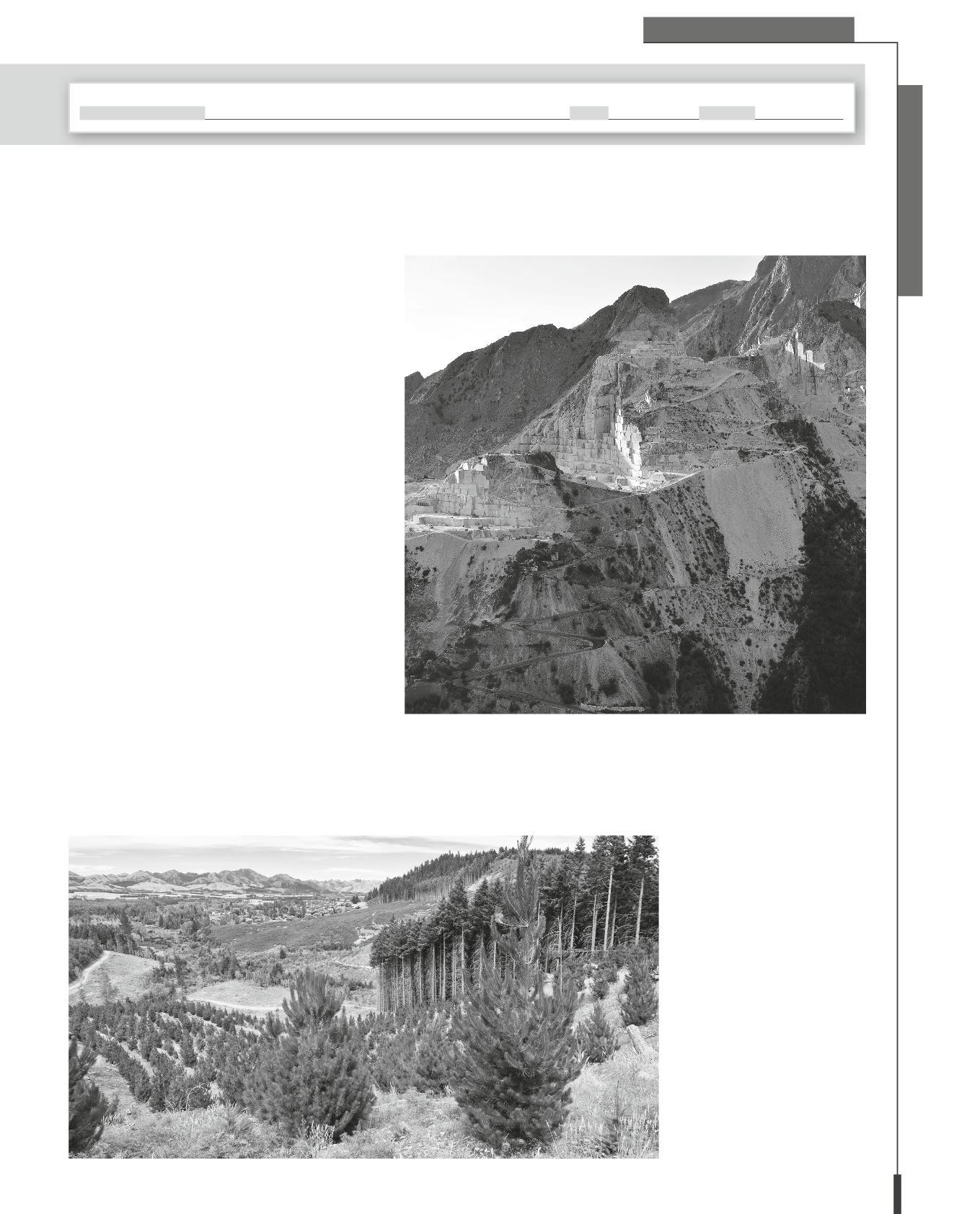
AMBIENTE E RISORSE
Ogni società umana vive in un ambiente e ne utilizza le risorse: l’acqua, il terreno coltivabile, i minerali del sottosuolo.
Con il loro lavoro gli esseri umani trasformano le materie prime esistenti in natura per ricavarne tutti i prodotti di cui hanno bisogno.
Lo sfruttamento eccessivo delle risorse naturali, però, impoverisce l’ambiente e influisce sul clima. I diboscamenti, gli scavi nel sottosuolo, le attività industriali non modificano solo l’aspetto di un ambiente, ma anche la temperatura dell’aria, l’umidità e altre caratteristiche del clima.
Le variazioni del clima o lo sfruttamento intenso dei territori hanno influito su molte civiltà del passato, causando migrazioni o scomparsa di popoli.
Le risorse dell’ambiente, infatti, non sono né infinite né immutabili. Per questo motivo nella nostra civiltà si sta diffondendo l’attenzione per uno sviluppo sostenibile. Oltre alla necessità di soddisfare le esigenze umane, occorre anche rispettare le risorse naturali che non sono rinnovabili.
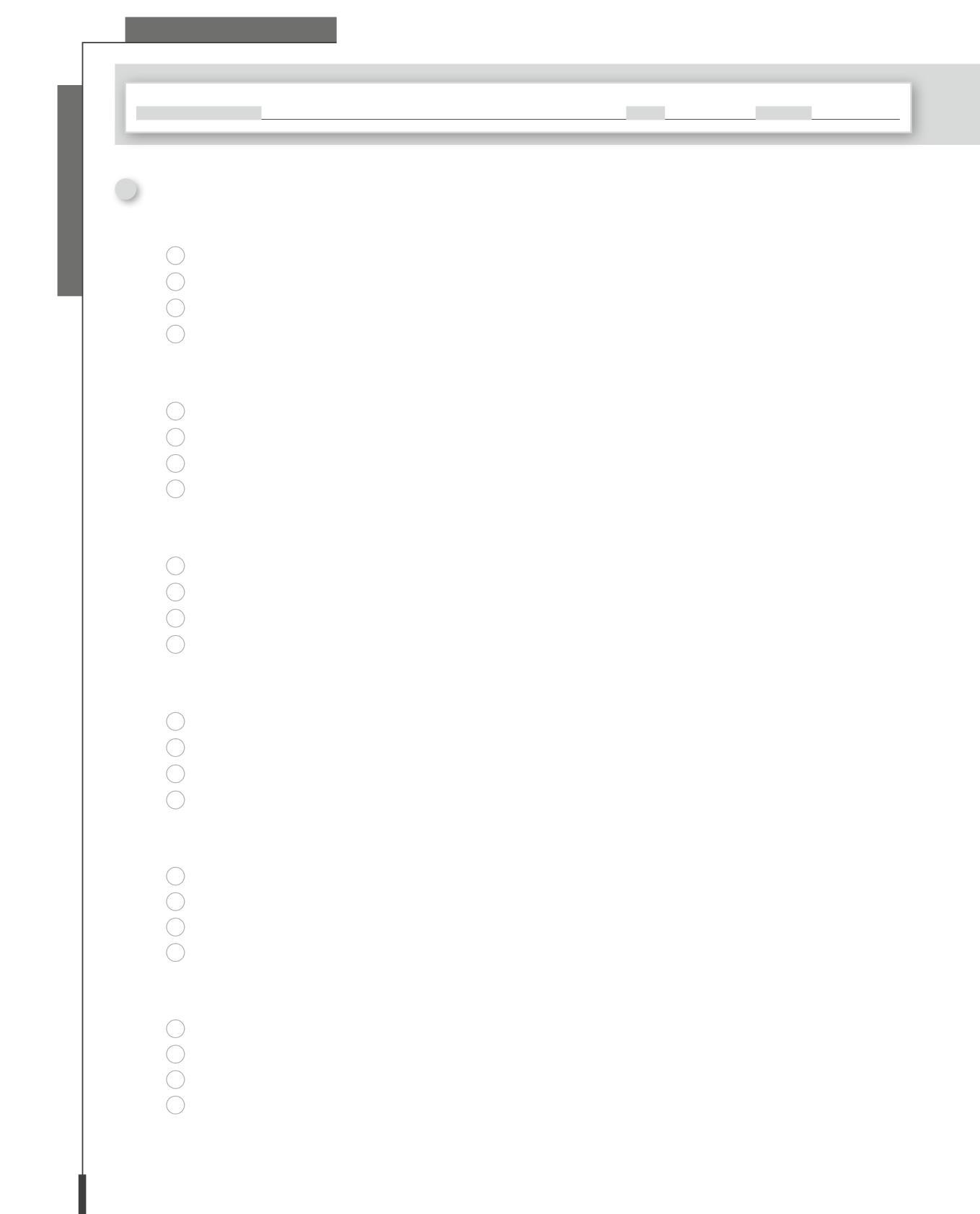
1 Leggi il testo e indica con una X l’alternativa corretta per completare le frasi.
• Le materie prime esistenti in natura: non sono molto utilizzate. vengono trasformate in prodotti. non richiedono lavoro. hanno avuto scarsa importanza per il progresso della civiltà.
• I diboscamenti, gli scavi nel sottosuolo, le attività industriali: non modificano l’aspetto di un ambiente. hanno poca influenza sull’ambiente. non influiscono sul clima. influiscono su temperatura e umidità.
• Lo sfruttamento eccessivo delle risorse naturali: non modifica l’ambiente. mantiene il clima costante. impoverisce l’ambiente e influisce sul clima. avviene solo scavando il sottosuolo.
• Nel passato lo sfruttamento intenso di interi territori: ha causato migrazioni di popoli o scomparsa di civiltà. non ha lasciato tracce sull’ambiente. ha causato solo piccoli problemi. non è stato rilevato dagli studiosi.
• Le risorse dell’ambiente: sono inesauribili. sono infinite. sono immutabili. possono esaurirsi.
• Lo sviluppo sostenibile: serve per soddisfare le esigenze umane. deve conciliare le necessità umane con il rispetto delle risorse naturali. deve sostenere lo sfruttamento delle materie prime necessarie. deve sostenersi senza l’aiuto dello Stato.
• L’attenzione per lo sviluppo sostenibile (riga 16): sta diminuendo. si sta diffondendo.
è ai minimi storici.
è altissima in tutti i Paesi.
• Un altro titolo per il brano potrebbe essere:
Per uno sviluppo sostenibile
Le materie prime
L’ambiente a rischio
Le variazioni del clima
2 Indica con una X solo le informazioni che si possono ricavare dal brano.
• L’acqua e il suolo sono risorse molto importanti per la nostra vita.
• L’acqua e il suolo non sono risorse equamente distribuite nel mondo.
• I cambiamenti climatici fanno aumentare la presenza di anidride carbonica, un gas dannoso per la salute.
• Le risorse dell’ambiente non sono né infinite né immutabili, per questo motivo c’è sempre più attenzione verso uno sviluppo sostenibile.
• Lo sfruttamento intenso delle risorse ha causato la scomparsa di popoli.
• Non bisogna sprecare l’acqua.
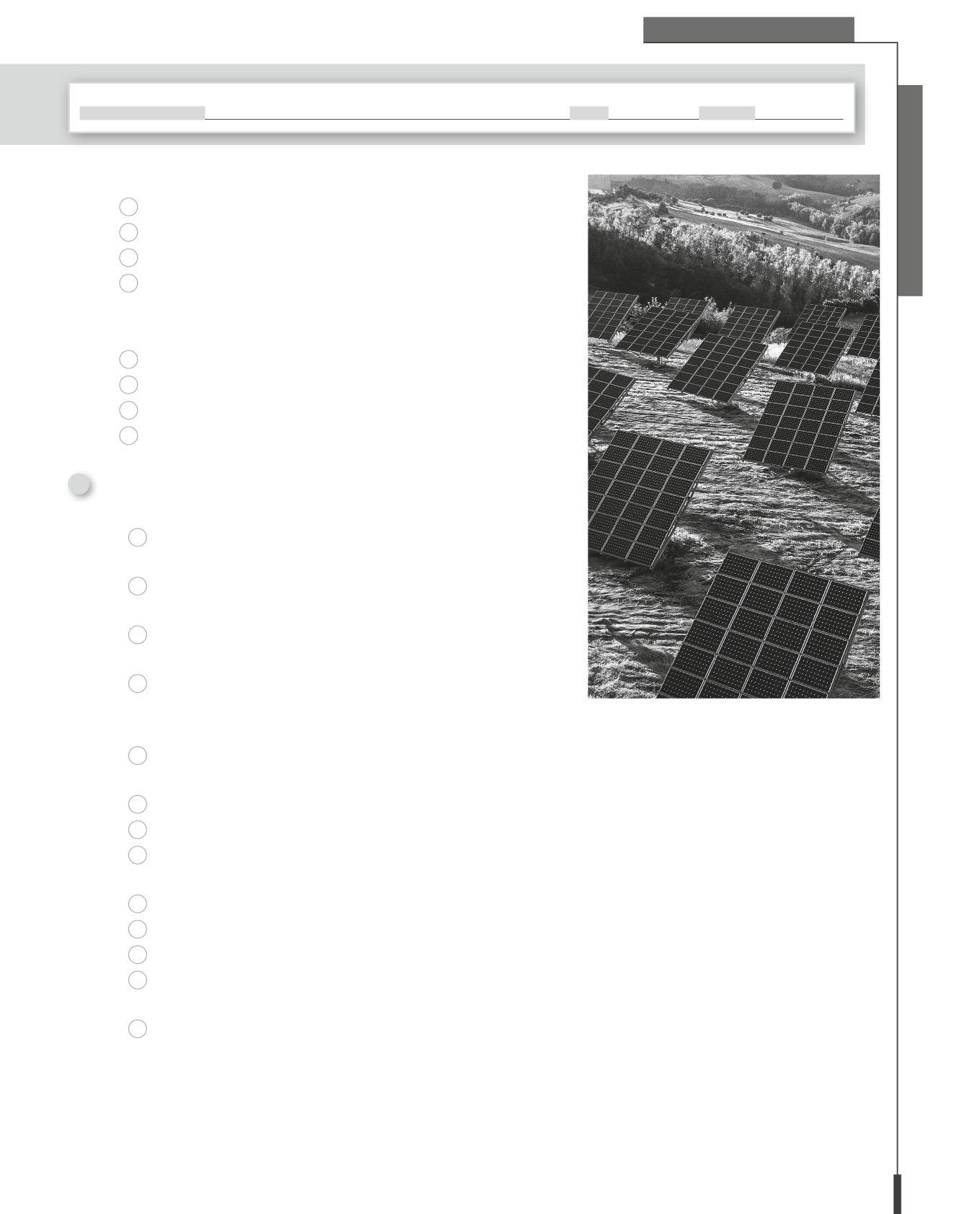
I pannelli solari catturano l’energia del Sole e la trasformano in energia elettrica.
• È importante rispettare le risorse naturali che non sono inesauribili.
• Le persone trasformano le materie prime esistenti in natura per ricavarne tutti i prodotti di cui hanno bisogno.
• Bisogna ridurre l’inquinamento dell’aria.
• È bene evitare gli sprechi energetici.
• Le centrali eoliche sfruttano l’energia del vento, che è rinnovabile.
• I diboscamenti sono una delle cause per cui i climi in certe zone del mondo stanno cambiando.
• L’effetto serra sta facendo alzare le temperature con effetti disastrosi sulla Terra.

LE MIGRAZIONI DEGLI ITALIANI E DELLE ITALIANE DALLA CAMPAGNA ALLA CITTÀ
Il flusso migratorio più importante che si è verificato in Italia è stato quello dalle campagne verso le città. Questo fenomeno ha interessato tutte le Regioni della penisola, ha trasformato ambienti e paesaggi e ha modificato abitudini di vita e di lavoro radicate da secoli.
Le città hanno sempre attirato la popolazione, ma questo fenomeno si è accentuato soprattutto nel 1970 e 1980: basti pensare che, mentre nel 1861 tre Italiani/e su quattro vivevano in campagna, all’inizio del 1990, invece, un quarto della popolazione totale viveva in città con più di 100000 abitanti.
Nell’ultimo decennio il mito della città ha perso forza, perché il vantaggio di avere molte cose a disposizione (e anche maggiori possibilità di lavoro) è stato pareggiato dagli svantaggi del traffico, dell’inquinamento e del degrado ambientale. Un altro problema è stato quello dei prezzi degli affitti e delle case troppo alti. Per questo motivo gli italiani e le italiane hanno cominciato ad abbandonare i centri cittadini, ma non sono tornati in campagna, bensì nelle zone intorno alle città, che sono ben collegate con il centro cittadino, ma più tranquille e quindi più vivibili. Questa è la ragione per cui, negli ultimi anni, stanno diminuendo gli abitanti e le abitanti dei centri cittadini e stanno aumentando quelli dei centri circostanti.
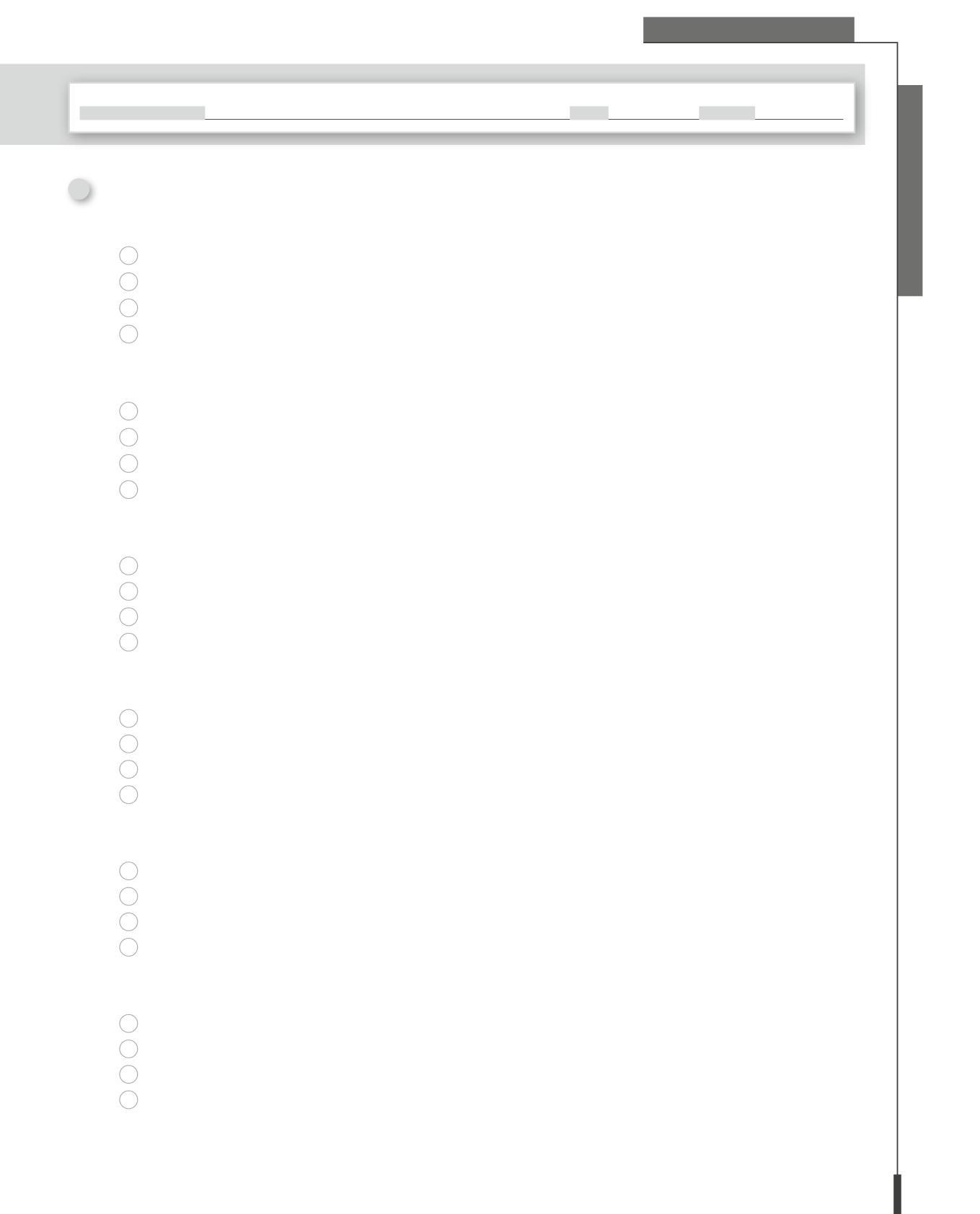
1 Leggi il testo e indica con una X l’alternativa corretta per completare le frasi.
• La frase “Il flusso migratorio... dalle campagne verso le città” significa che: i migranti e le migranti vanno a vivere in città. le persone si sono spostate dalla campagna verso la città. le persone si sono spostate dalla città verso la campagna. i migranti e le migranti importanti sono andati in città.
• Il fenomeno migratorio ha trasformato: le Regioni, rendendole molto più interessanti. la città, ma non la campagna, che è rimasta come prima. il paesaggio e le abitudini di vita e di lavoro. la campagna, ma non la città, che è rimasta come prima.
• Nel 1861 la maggioranza degli italiani e le italiane: viveva in città. viveva in campagna. era attirata dalla città. viveva tra città e campagna.
• Nel 1990: 100000 italiani e italiane vivevano in città. il totale della popolazione viveva in città. le campagne si erano ripopolate. molti Italiani e italiane si erano spostati verso le città.
• I vantaggi della città: sono sopravvalutati. si pagano a caro prezzo. consistono nelle maggiori possibilità di scambi economici. consistono nelle maggiori possibilità di trovare lavoro.
• Gli svantaggi della città: sono causati dal numero eccessivo di abitanti. sono il traffico, l’inquinamento, i prezzi troppo elevati. comprendono la difficoltà di acquistare case. comprendono la difficoltà di affittare case.
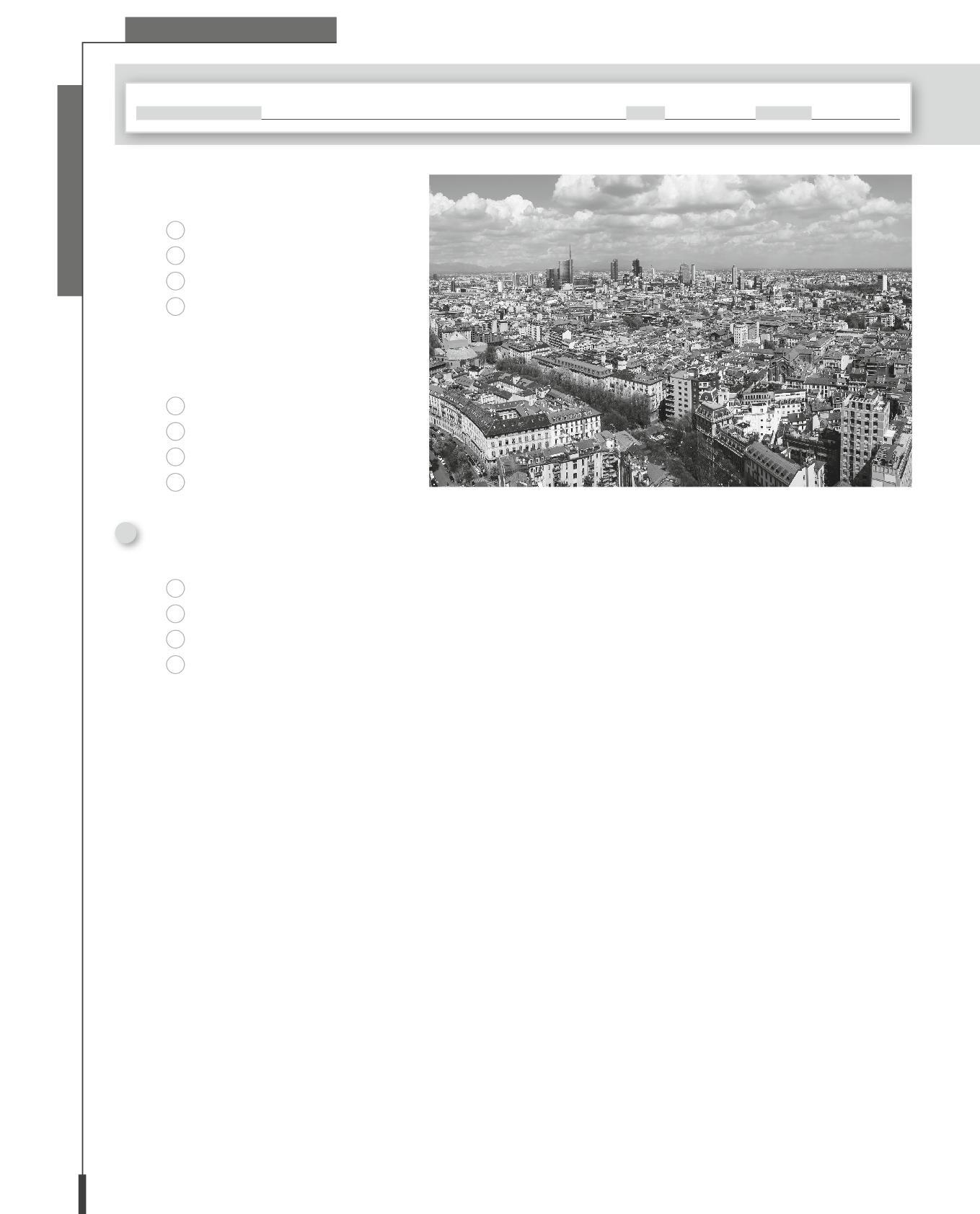
• Negli ultimi anni molti italiani e italiane:
hanno abbandonato le città. sono tornati in campagna. sono andati in una metropoli. sono rimasti in centro.
• Negli ultimi anni il numero di abitanti dei centri cittadini:
è rimasto invariato.
è aumentato.
è diminuito. non è noto.
2 Indica con una X solo le informazioni che si possono trovare nel brano.
• Le migrazioni degli italiani e delle italiane:
hanno modificato le loro abitudini di vita e di lavoro.
hanno spostato gli abitanti e le abitanti dalle campagne alle città. hanno riguardato in particolare il Veneto e le Regioni del Sud. negli ultimi anni hanno indebolito il mito della città.
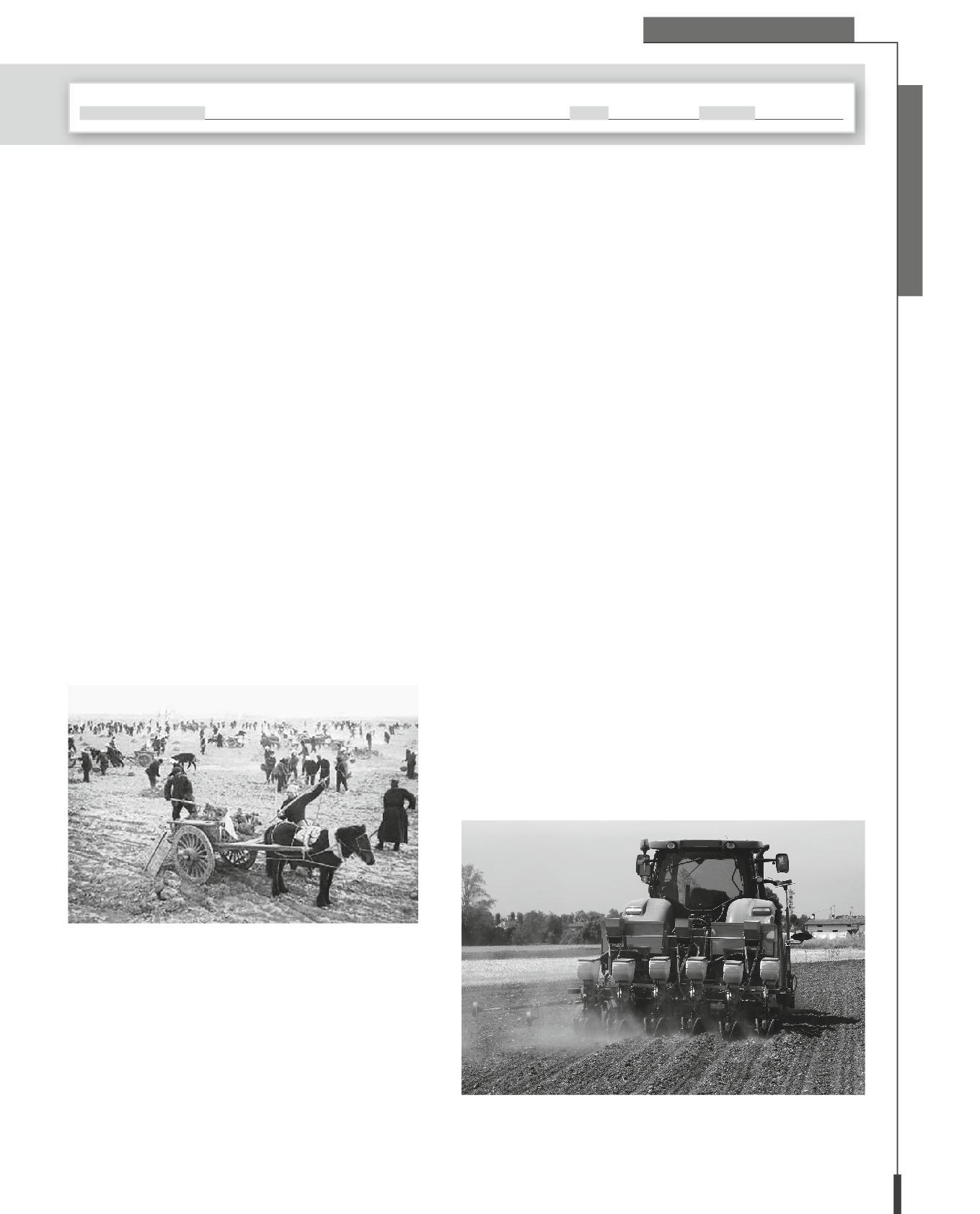
PASSATO E PRESENTE DEL LAVORO AGRICOLO
A metà dell’Ottocento i campi italiani erano pieni di contadini. A quell’epoca il 66% degli Italiani lavorava nei campi. Il cibo era il frutto del lavoro muscolare, umano e degli animali, quindi bisognava essere in tanti a lavorare. La percentuale altissima di contadini (il 66%) ci dice che due terzi della popolazione italiana dovevano lavorare nelle campagne per produrre il cibo per sé e per l’altro terzo dell’Italia.
Oggi la popolazione in età lavorativa che lavora nell’agricoltura è precipitata sotto il 5% e svolge un lavoro completamente diverso dal passato, utilizzando macchine di ogni tipo (come trattori, mietitrebbia, essiccatoi) e producendo enormemente di più.
Sono le macchine ad aver provocato questo terremoto nell’agricoltura, unitamente ad altre tecnologie della chimica (come i concimi), della conservazione dei prodotti (frigoriferi e congelamento) e del trasporto (camion, treni e navi). adatt. da P. Angela, La sfida del secolo, Mondadori

1 Leggi il testo e Indica con una X l’alternativa corretta per completare le frasi.
• La percentuale della popolazione italiana occupata in lavori agricoli alla metà dell’Ottocento erano:
sotto il 5% . il 66% . l’1% .
oltre il 5% .
• Nell’Ottocento i campi erano coltivati con: solo gli animali. strumenti di legno e animali. il lavoro muscolare di esseri umani e animali. le macchine agricole.
• Oggi in Italia lavora nel settore primario: il 50% della popolazione. un terzo della popolazione. meno del 5% della popolazione in età lavorativa. circa l’1% della popolazione.
• Oggi con l’uso delle macchine: si produce meno perché sono diminuiti i lavoratori e le lavoratrici agricoli. si produce di più anche se sono diminuiti i lavoratori e le lavoratrici agricoli. la produzione è rimasta uguale. si produce di più perché è aumentata la popolazione.
• La forte diminuzione dei lavoratori e delle lavoratrici agricoli è stata causata: dalla diminuzione della superficie dei campi da coltivare. solo dall’introduzione di macchine agricole che hanno reso inutile il lavoro di contadini e contadine. dal fatto che le persone giovani preferiscono fare altri lavori. dalle macchine agricole e dalle innovazioni nella chimica, nella conservazione e nel trasporto dei prodotti agricoli.
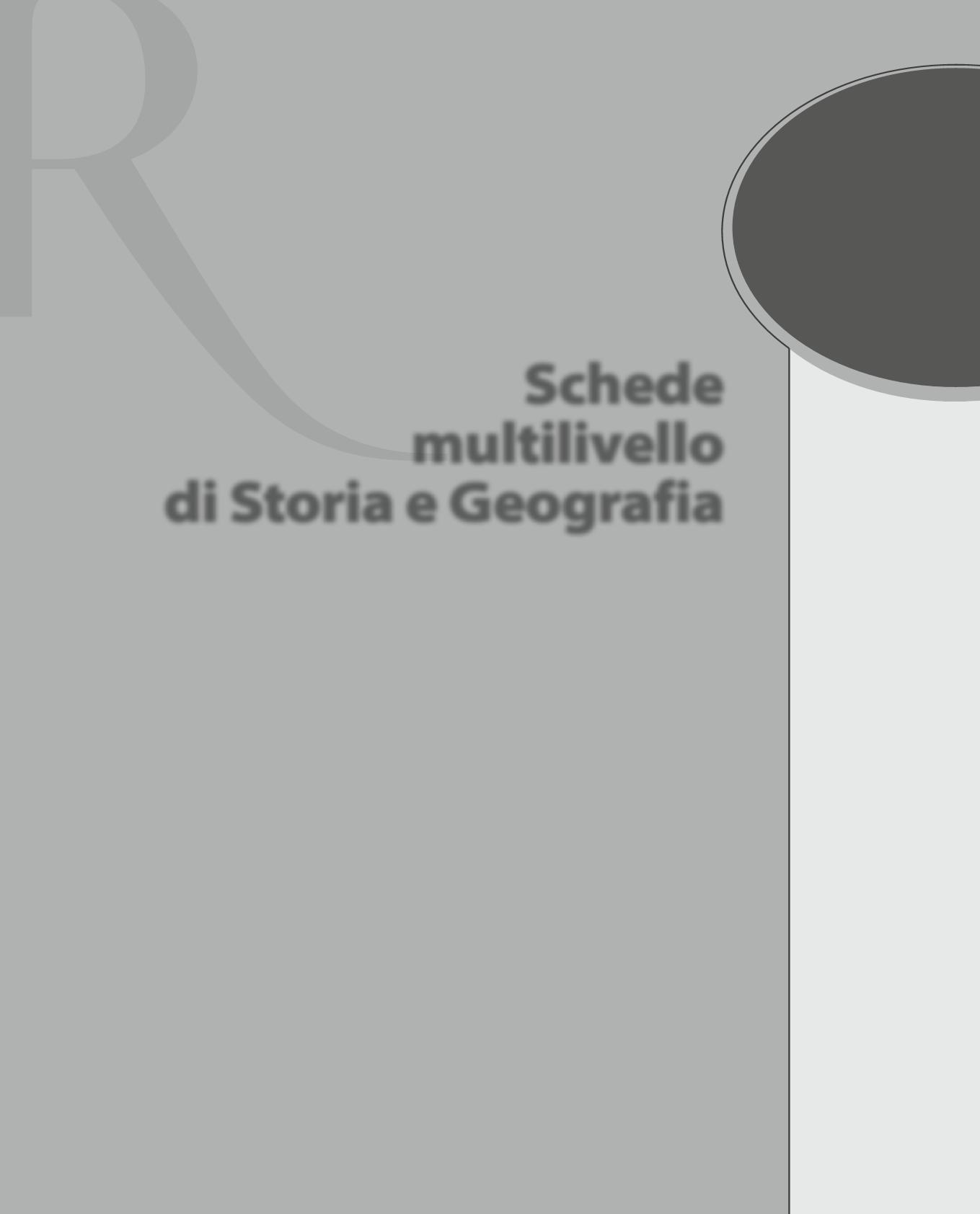
Schede m l ili ll

di Storia e Geografia
NOME E COGNOME DATA CLASSE
IL LAVORO DI STORICHE E STORICI
1 Metti in ordine le fasi del lavoro dello storico.
Scrivi i numeri da 1 a 5.
Scrive i risultati del suo lavoro.
Verifica se le fonti sono valide e le confronta.
Raccoglie altre notizie, consulta carte e linee del tempo.
Cerca di spiegare i fatti attraverso collegamenti di cause ed effetti.
Va alla ricerca di fonti storiche.
2 Scrivi il nome degli esperti di cui si serve lo storico per ricostruire il passato.
Cerca la presenza dell’uomo nel terreno, nelle abitazioni, nelle tombe.
Studia le scritture antiche.
Studia usi e costumi delle società.
Studia gli strati del terreno in cui sono stati ritrovati i reperti per stabilire il periodo.
3 Scrivi alcuni esempi per ogni tipo di fonte.
Fonti materiali:
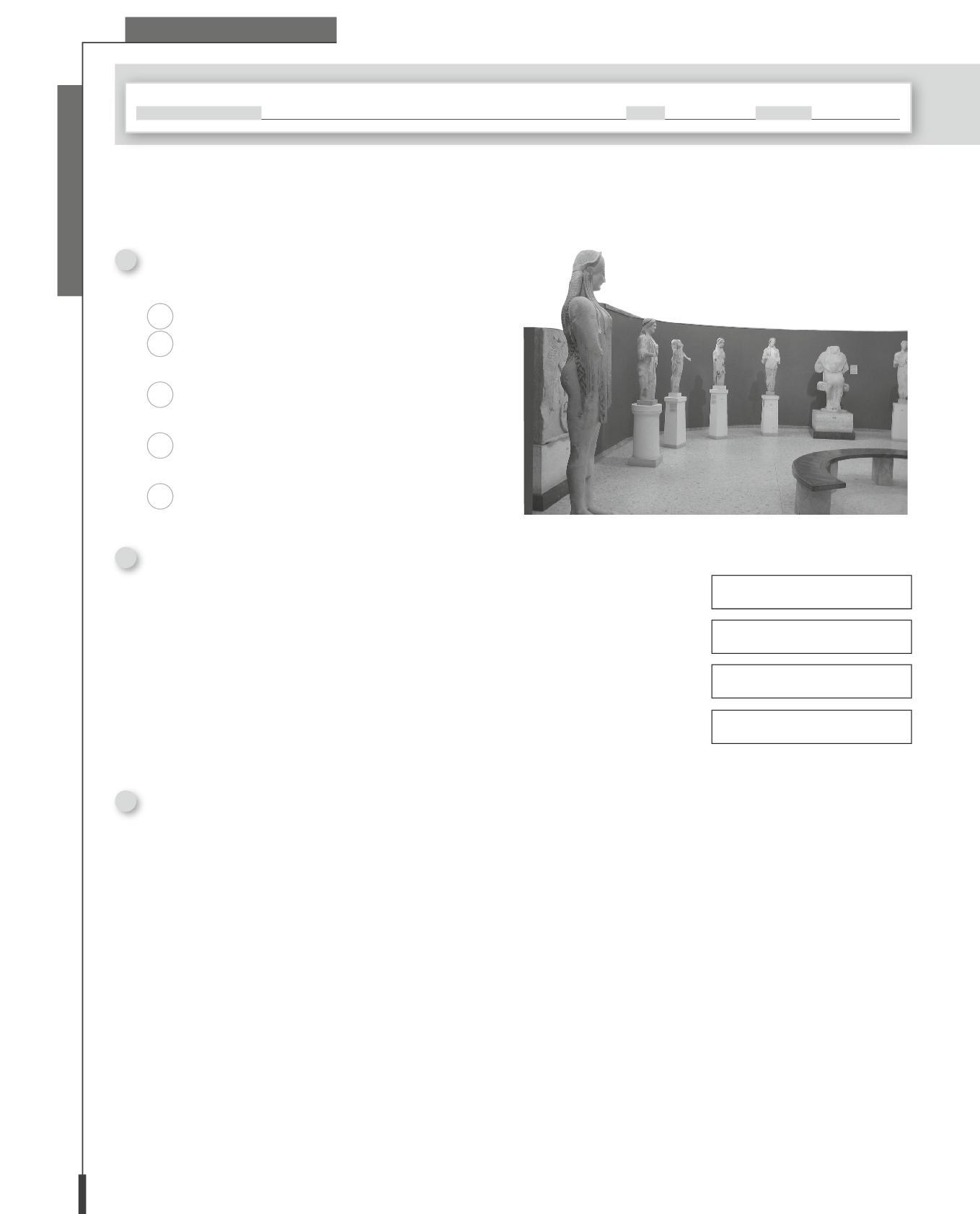
Fonti visive:
Fonti scritte:
Fonti orali:
IL LAVORO DI STORICHE E STORICI
1 Completa le fasi del lavoro dello storico con le parole seguenti. confronta • fatti • fonti • scrive • tempo
• Va alla ricerca di storiche.
• Verifica se le fonti sono valide e le
• Cerca di spiegare i attraverso i collegamenti di cause ed effetti.
• Raccoglie altre notizie, consulta carte e linee del .
• i risultati del suo lavoro.
2 Collega ogni esperto al suo compito.
archeologo
paleografo
antropologo
geologo

Studia usi e costumi delle società.
Studia gli strati del terreno in cui sono stati ritrovati i reperti per stabilire il periodo.
Cerca la presenza dell’uomo nel terreno, nelle abitazioni, nelle tombe.
Studia le scritture antiche.
3 Sotto ogni immagine, indica con una X che tipo di fonte rappresenta.
NOME E COGNOME DATA CLASSE
IL LAVORO DI STORICHE E STORICI
1 Scegli un titolo per ogni fase del lavoro dello storico e scrivilo nel riquadro corretto.
La conservazione
La datazione
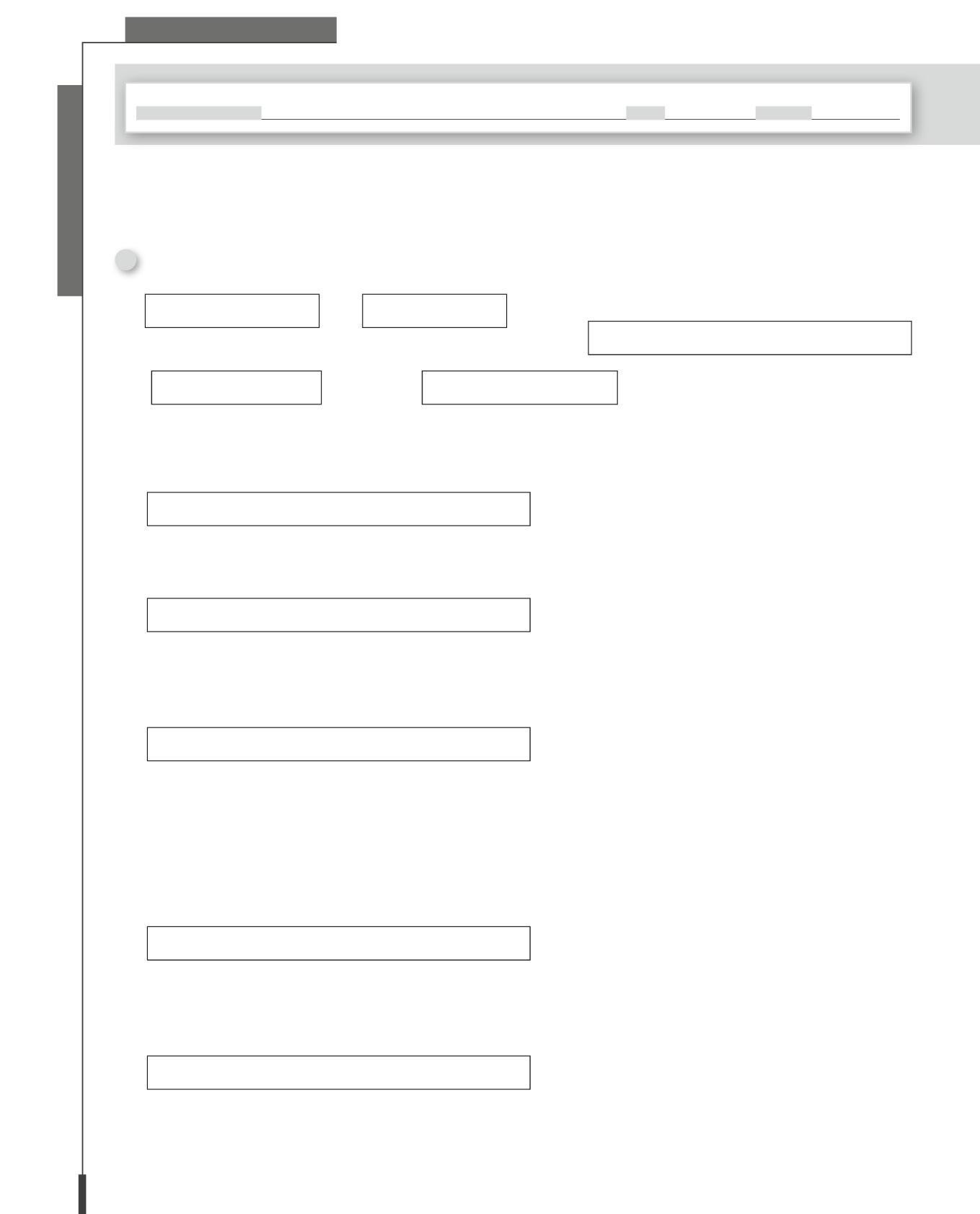
Le ricostruzioni
Lo scavo e i reperti
L’individuazione del sito archeologico
Il lavoro dello storico può essere diviso in varie fasi. In ogni fase, lo storico è aiutato da uno studioso che conosce bene ed è esperto in un determinato settore .
Dopo aver trovato reperti o aver studiato con attenzione le fonti, gli esperti individuano il luogo, cioè il sito, dove iniziare a scavare.
Gli archeologi, cioè gli studiosi della storia antica, dividono con le corde il terreno da scavare in quadrati con lati da un metro. Infatti, per capire a che cosa serviva un reperto, è importante sapere esattamente la sua posizione.
Gli storici possono datare i reperti, cioè collocarli nel tempo, con l’aiuto del Carbonio 14, una sostanza che è presente negli animali e nei vegetali. Con strumenti adatti, gli studiosi possono vedere quanto Carbonio 14 c’è nei reperti e quindi calcolarne l’età. Per stabilire la data di un reperto è importante anche osservare gli strati del terreno dove sono stati trovati i reperti: questo è il compito dei geologi. I paleontologi invece studiano i fossili, cioè i resti di antichi animali o vegetali chiusi sotto terra o nelle rocce.
Il lavoro degli antropologi aiuta gli storici a ricostruire come erano e come vivevano gli uomini antichi e come essi si servivano degli animali e degli oggetti ritrovati. Gli antropologi, infatti, studiano le abitudini dei gruppi umani.
Gli storici e gli altri specialisti scoprono e studiano diversi documenti. Questi documenti vengono poi conservati nei musei e negli archivi, dove sono curati e protetti.
OBIETTIVI: Leggere e comprendere
NOME E COGNOME DATA CLASSE
MISURARE IL TEMPO
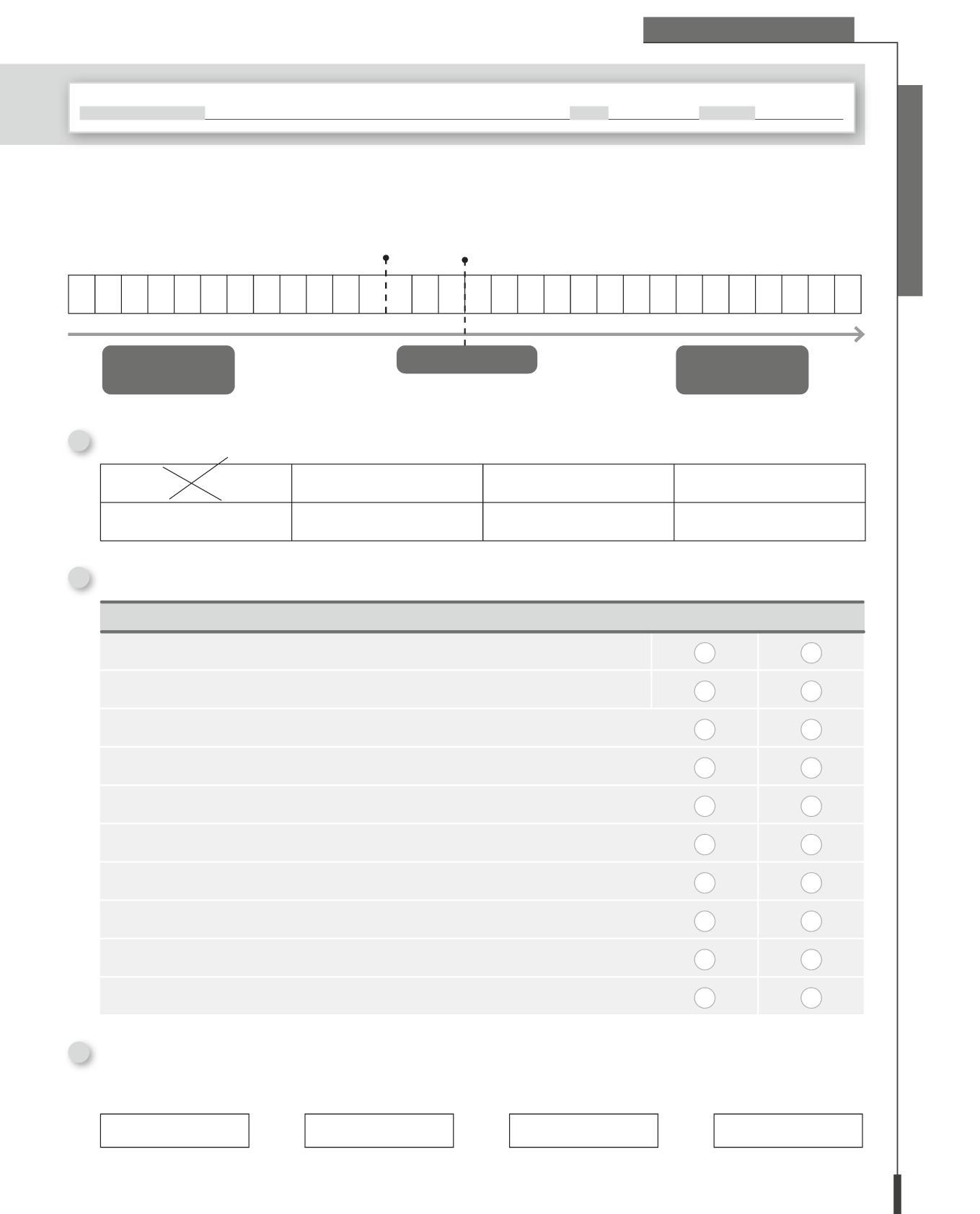
1 Inserisci sulla linea del tempo le seguenti date, come nell’esempio.
2 Indica con una X dove collocheresti queste date.
La tua data di nascita.
La data di nascita di uno dei tuoi amici.
La data di nascita dei tuoi genitori.
La data di nascita dei tuoi nonni.
Il Big Bang.
L’invenzione della ruota.
La scoperta dell’agricoltura.
L’invenzione del telefono.
L’invenzione del computer.
La scoperta del fuoco.
3 Scrivi come si chiamano i seguenti periodi. 10 anni 5 anni 100 anni 1 000 anni
NOME
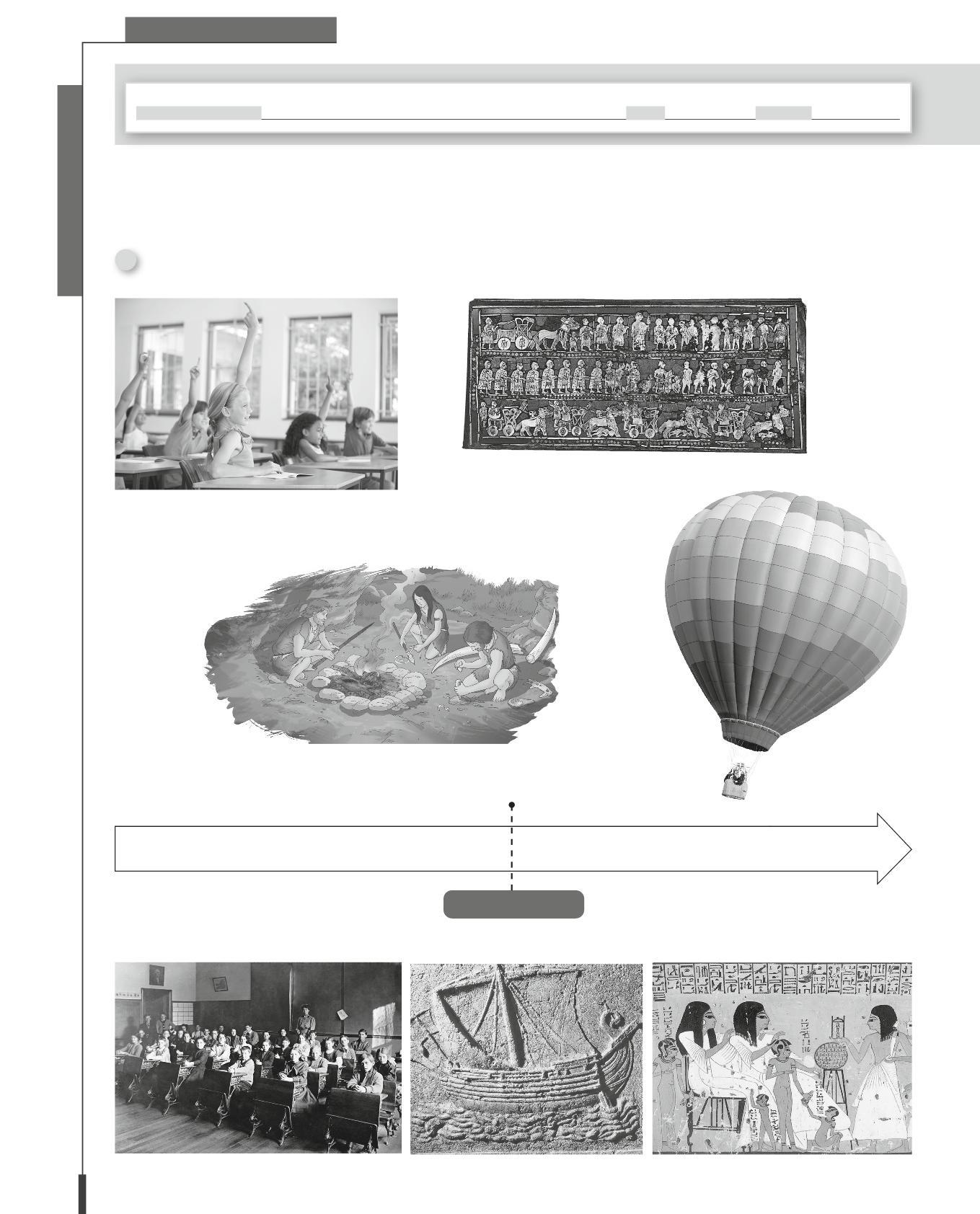
MISURARE IL TEMPO
1 Collega con una freccia ogni immagine alla linea del tempo, prima o dopo la nascita di Cristo.
OBIETTIVI: Riconoscere relazioni di successione e contemporaneità, durate e periodi.
NOME E COGNOME DATA CLASSE
MISURARE IL TEMPO
1 Scegli la linea del tempo che utilizzeresti per rappresentare i seguenti periodi. Colora allo stesso modo il riquadro del periodo e la linea del tempo che hai scelto.
La tua storia personale.
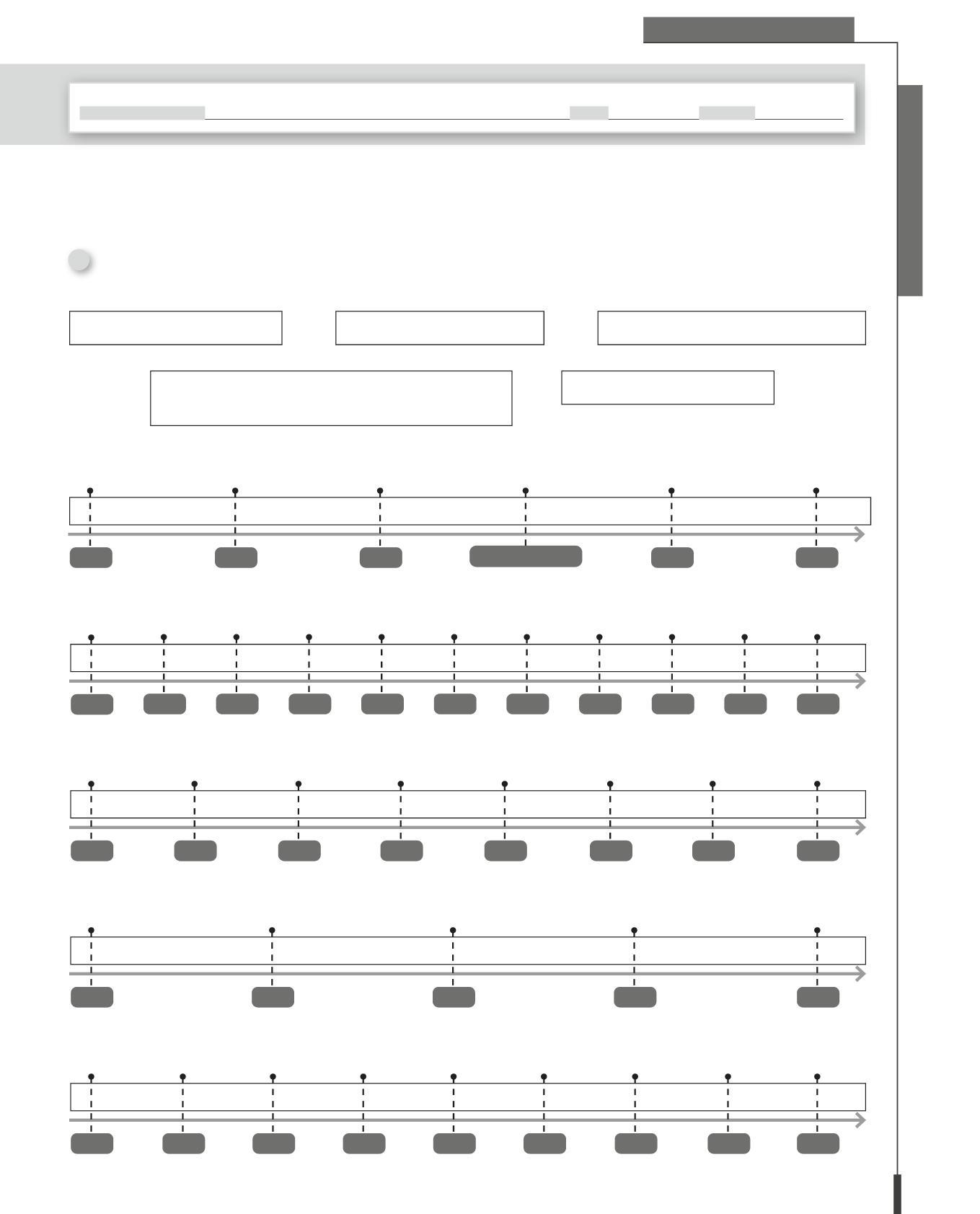
La storia dei tuoi nonni. La storia dei popoli del passato.
La storia di una scuola costruita verso la fine degli anni Ottanta del XX secolo.
La storia di un castello.
I POPOLI DELLA MESOPOTAMIA
1 Ripassa sulla carta con il blu i fiumi Tigri ed Eufrate e colora di verde il territorio della Mesopotamia.
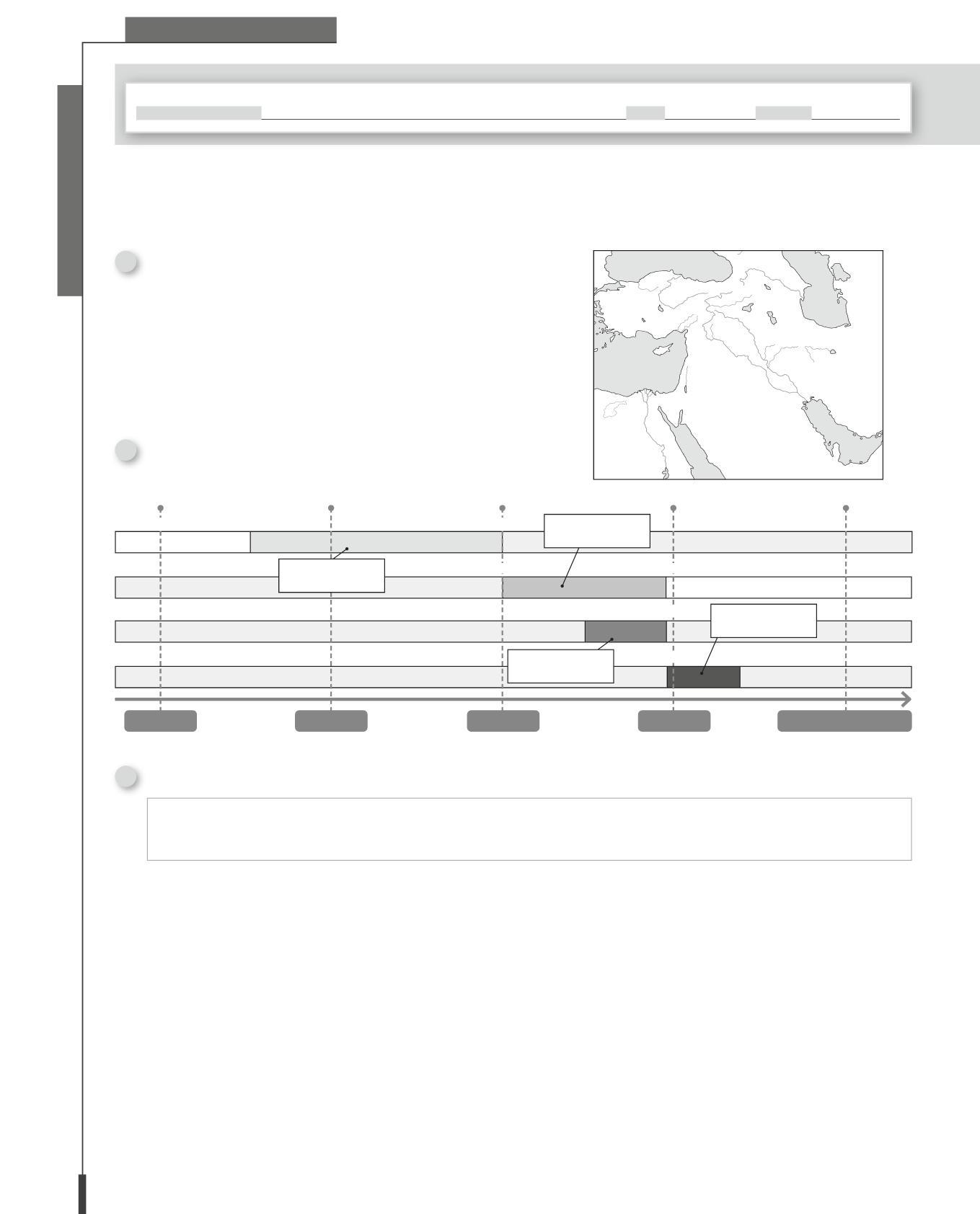
2 Scrivi su ogni linea del tempo il nome dei popoli che vissero in Mesopotamia.
3 Completa le frasi con le parole seguenti.
agricoltura • allevamento • argini • bovini • canali • cereali • città-stato • cuneiforme • dighe • Eufrate • fiumi • leggi • re • ruota • straripavano • umano
• I popoli della Mesopotamia vissero nella terra tra “due ”, una terra fertile che si estendeva tra il Tigri e l’ . In primavera e allagavano il territorio.
• Essi fondarono le prime , indipendenti, governate da un proprio e con proprie .
• Costruirono per i fiumi, per irrigare i campi e per regolare il passaggio dell’acqua.
• Svilupparono l’ , coltivando , come orzo e grano, legumi, come lenticchie e fave, frutti come fichi, datteri e olive e l’ di bovini, capre, pecore, maiali e asini.
• Inventarono la per i carri e la scrittura, detta
• Adoravano molte divinità dall’aspetto , che si comportavano in modo simile agli uomini.
OBIETTIVI: Leggere
I POPOLI DELLA MESOPOTAMIA
1 Ripassa sulla carta con il blu i fiumi Tigri ed Eufrate e colora di verde il territorio della Mesopotamia.
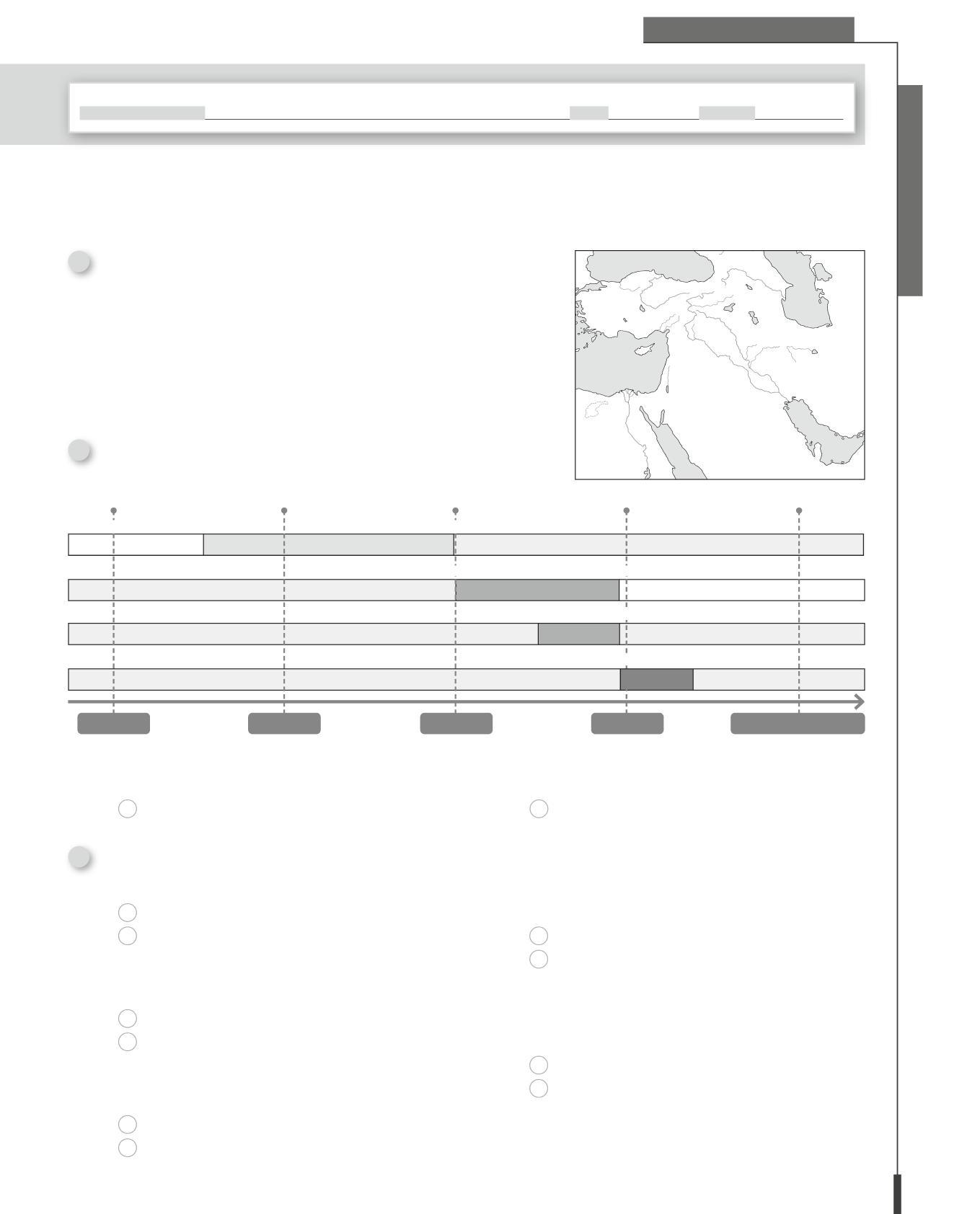
2 Osserva la linea del tempo e indica con una X la risposta corretta alla domanda.
4000 a.C. 3500 a.C.
2000 a.C.
a.C. 2000 a.C.
1100 a.C. 612 a.C.
• Quando si svilupparono le civiltà dei popoli della Mesopotamia?
Dal 4000 a.C. in poi. Dal 2000 a.C. in poi.
3 Per ogni affermazione indica con una X il completamento corretto.
• Mesopotamia significa: Mezzaluna fertile. terra “tra i fiumi“.
• Quali popoli vissero contemporaneamente in Mesopotamia?
Ittiti e Babilonesi. Ittiti e Assiri.
• La terra in Mesopotamia era fertile perché la zona: era calda e secca. era ricca d’acqua.
• I popoli della Mesopotamia riuscirono a controllare le acque, cioè costruirono: strade e case sopra i fiumi. argini, canali e dighe per regolare l’acqua dei fiumi.
• Le città-Stato fondate dai popoli della Mesopotamia erano: unite tra loro con a capo un solo re. indipendenti, governate da un proprio re e con proprie leggi.
OBIETTIVI: Leggere una carta storico-geografica. • Leggere la linea del tempo. • Conoscere gli aspetti essenziali delle civiltà della Mesopotamia.
LE ZIGGURAT

1 Le frasi che seguono sono tutte corrette. Indica con una X quelle che vengono confermate da questa immagine.
In tutte le città della Mesopotamia c’era una ziggurat.
La ziggurat era una grande costruzione formata da una serie di terrazze che si restringevano verso l’alto.
Le terrazze erano collegate tra loro da scalinate.
Le ziggurat erano costruite con mattoni seccati al sole.
Molte ziggurat sono andate distrutte perché i mattoni seccati al sole non durano nel tempo.
Le ziggurat erano considerate come montagne costruite dagli uomini per avvicinarsi alle divinità.
Sulla parte più alta c’era il tempio, dove il sommo sacerdote celebrava riti in onore degli dèi.
Dalle ziggurat gli astronomi osservavano di notte la Luna e le stelle.
Dall’alto le sentinelle avvistavano le inondazioni del Tigri e dell’Eufrate.
Intorno alle ziggurat c’erano le botteghe degli artigiani.
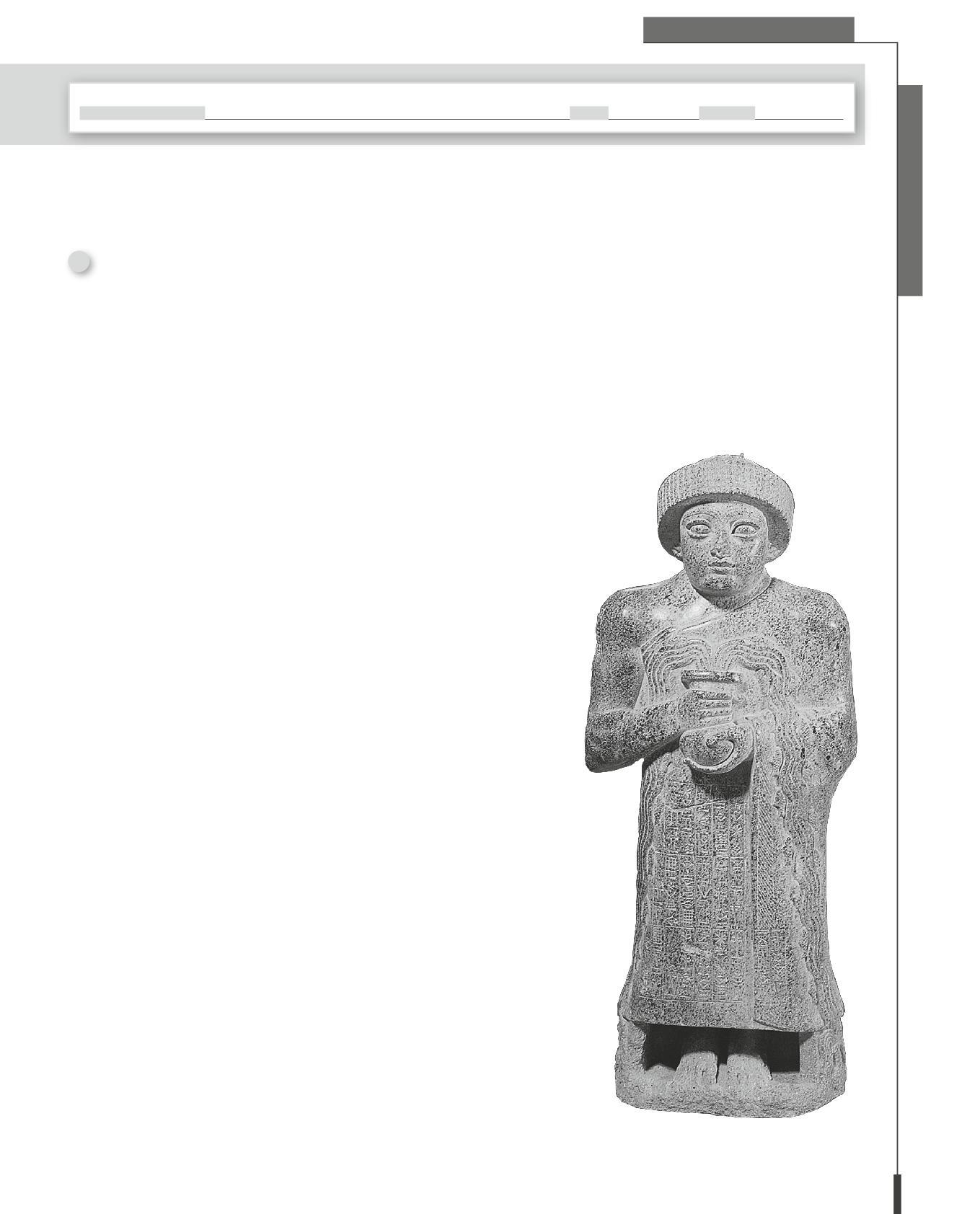
I SUMERI
1 Sottolinea l’alternativa corretta per completare le frasi.
• Il primo popolo che si stabilì in Mesopotamia intorno al 3500 a.C. fu quello dei Babilonesi / Sumeri
• Essi si stabilirono lungo i fiumi Tigri ed Eufrate perché l’acqua dolce impediva / garantiva la possibilità di coltivazioni e di allevamento.
• I due fiumi erano caratterizzati da numerosi periodi di piena / siccità
• Gli allagamenti favorivano / distruggevano i raccolti.
• Gli abitanti capirono che bisognava controllare / prosciugare le acque.
• I Sumeri costruirono ponti / argini per fare da sponda ai fiumi.
• Per far arrivare l’acqua fino ai campi i Sumeri costruirono sponde / canali.
• Per regolare il flusso dell’acqua i Sumeri costruirono dighe / recinzioni.
• I Sumeri costruirono le prime / uniche città-Stato della Storia.
• Ogni città-Stato era indipendente / dipendente, non aveva bisogno di / era governata da un proprio re ed era organizzata senza / con proprie leggi.
• Ogni città era circondata da mura / fossati
• Al centro sorgeva la ziggurat, un grande edificio a forma di torre a gradoni / grande terrazza
• Nella parte bassa della ziggurat si trovavano i magazzini / le case
• Sulla cima sorgeva il palazzo del sovrano / tempio.
• Intorno alla ziggurat c’erano campi coltivati e strade / botteghe artigiane.
I SUMERI
1 Collega ogni descrizione alle immagini corrispondenti.
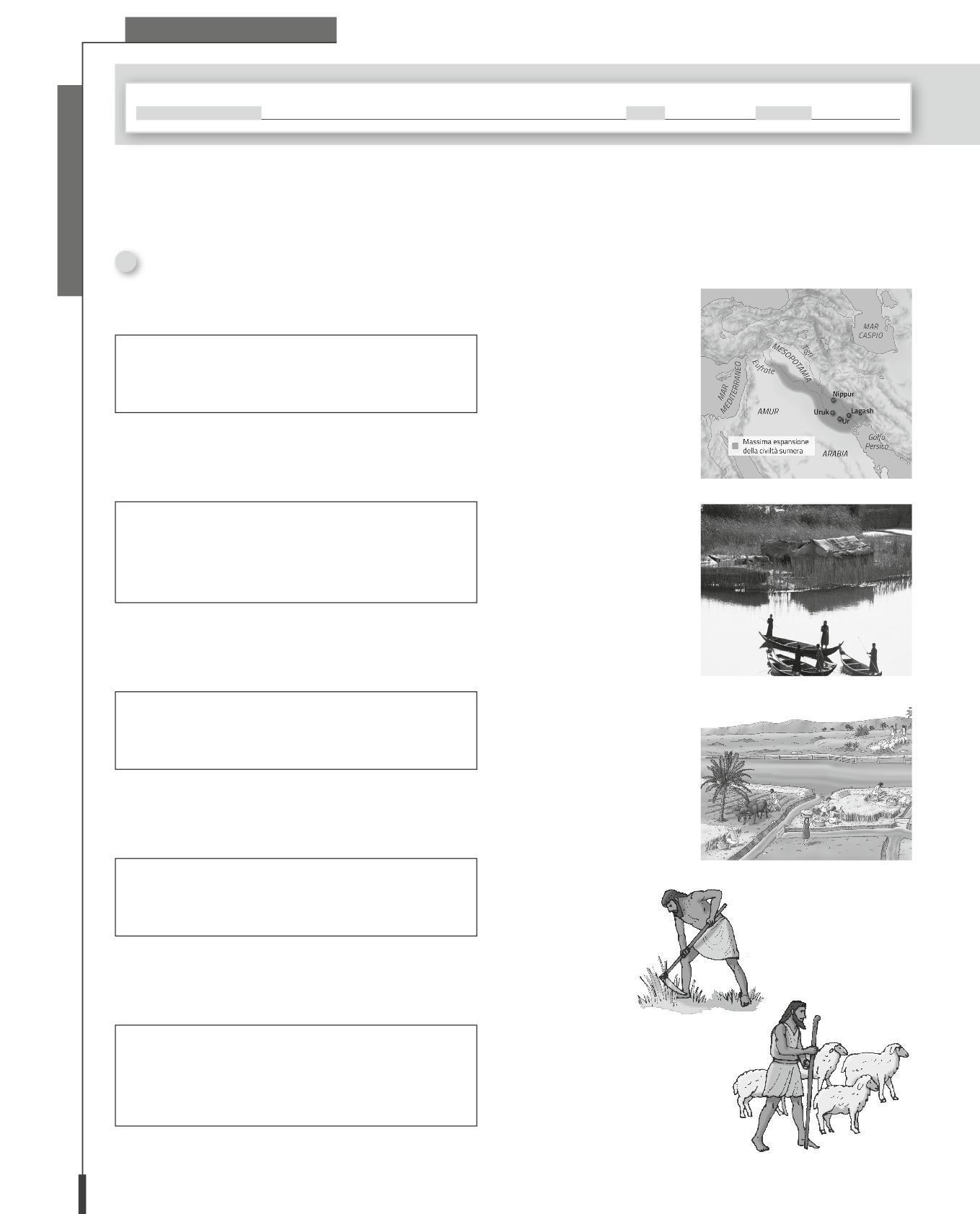
I contadini impararono a incanalare l’acqua per impedire le inondazioni e a raccoglierla per annaffiare i campi nei periodi di siccità.
Si allevavano capre, pecore, maiali, bovini, che erano utilizzati per ricavare carne e latte per il cibo, lana e pelle per fare vestiti, e asini per trainare i carri.
La Mesopotamia, nome che significa terra tra due fiumi, era una vasta pianura fertile tra il Tigri e l’Eufrate.
In primavera il Tigri e l’Eufrate straripavano e allagavano i terreni, lasciando un fango ricco che rendeva fertili i territori.
In Mesopotamia si coltivavano soprattutto cereali come orzo e grano, legumi come lenticchie e fave, frutti come fichi, datteri e olive, piante erbacee come il sesamo.
NOME E COGNOME
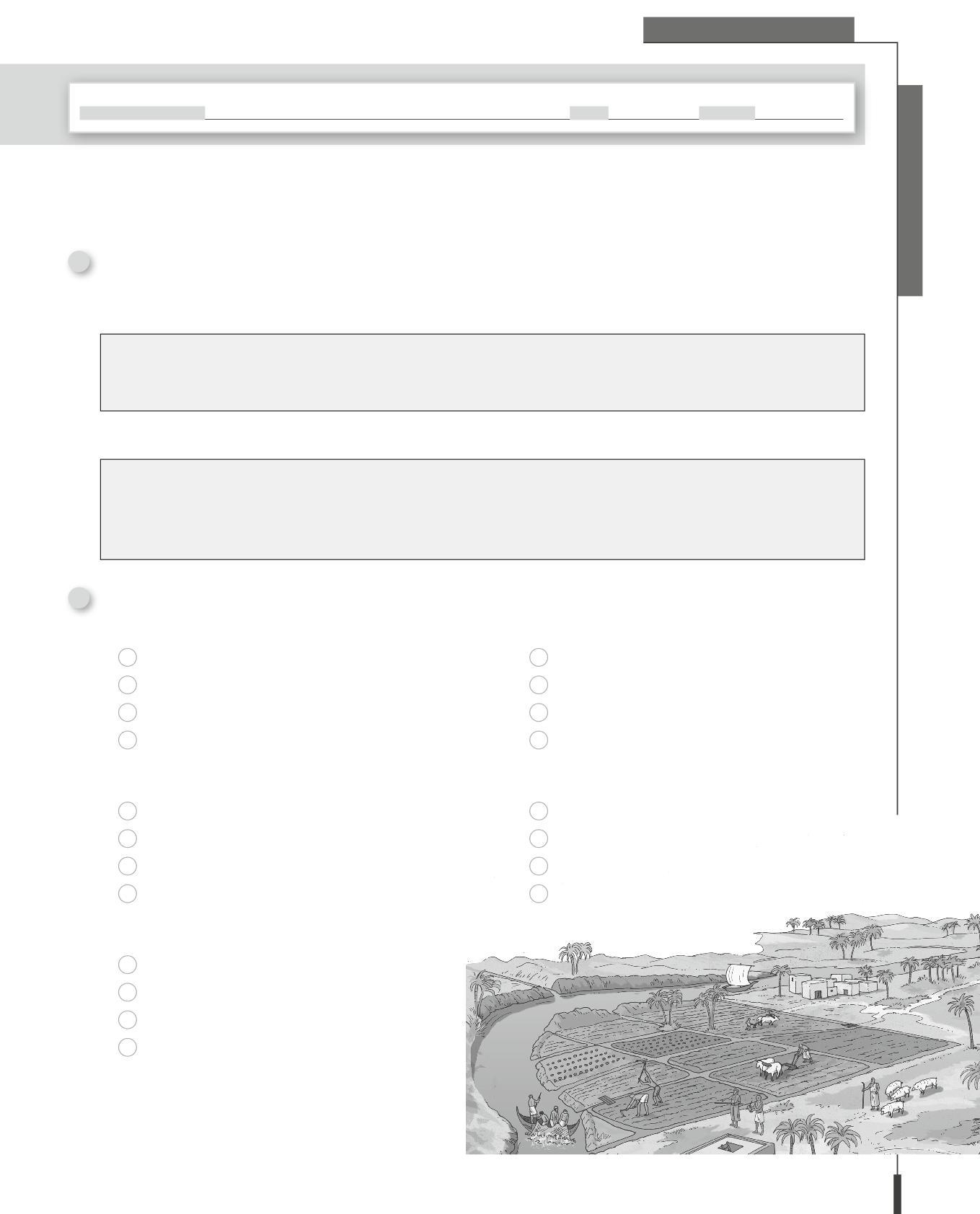
AGRICOLTORE O PASTORE?
1 Leggi la descrizione di un pastore fatta da un agricoltore e viceversa. I brani sono tratti da antichi documenti sumeri.
Punto di vista di un agricoltore
I pastori sono gente che non conosce metallo, gente che non conosce pietre preziose. Non costruiscono case, non costruiscono città. I loro cuori non conoscono pane cotto al forno, i loro stomaci non conoscono la birra.
Punto di vista di un pastore
Che cosa ha più di me l’agricoltore, l’uomo della diga, del canale, dell’aratro? Se egli versasse per me la sua birra migliore, io verserei per lui il mio latte, se egli mi desse il suo pane io in cambio gli darei il mio cacio al miele. Dopo che avrò bevuto e mangiato mi resterà ancora per lui crema e latte. Che cos’ha dunque più di me l’agricoltore?
2 Per ogni frase indica con una X i completamenti corretti. Attenzione: può essere più di uno.
• Le fonti esaminate sono: materiali. scritte. orali. visive.
• I pastori si alimentano con: pane cotto al forno. birra.
latte e crema. cacio al miele.
• Gli agricoltori si alimentano con: pane cotto al forno. birra.
latte e crema. cacio al miele.
• La principale attività dei pastori è: l’allevamento di animali da latte. l’allevamento di api. la costruzione di case. la costruzione di canali.
• Le principali attività degli agricoltori sono: la costruzione di dighe e di canali.
l’allevamento di animali.
la costruzione di case e città. la lavorazione di metalli e pietre preziose.
I BABILONESI
1 Per ogni capoverso, sottolinea nel testo la risposta alla domanda.
Da dove venivano i Babilonesi?

Perché i Babilonesi sono ricordati con questo nome?
Per quale motivo viene ricordato il re Hammurabi?
Intorno al 2000 a.C. un popolo di pastori nomadi proveniente dalle terre aride a nord-ovest della Mesopotamia s’impadronì del territorio che era stato abitato dai Sumeri. Oggi ricordiamo i nuovi conquistatori con il nome di Babilonesi: essi fecero propria la cultura dei Sumeri e fondarono nuove città.
Di che cosa trattava il Codice di Hammurabi?
Babilonia fu la città più importante e popolata del regno, tanto da dare il nome a questo popolo. La lingua parlata in tutto il regno fu il babilonese.
Quali erano le sanzioni previste?
Hammurabi fu il più famoso re dei Babilonesi.
Nel 1790 a.C. scelse Babilonia come capitale. Decise di raggruppare tutte le Leggi del suo impero in un solo codice, il Codice di Hammurabi, valido per tutti i suoi sudditi.
Le Leggi riguardavano aspetti della vita quotidiana: la famiglia, il matrimonio, le proprietà, i commerci e la vendita degli schiavi.
Per chi violava le Leggi erano previste pene molto severe, tra cui la pena di morte.
Quale fu l’importanza di avere Leggi scritte?
Avere Leggi valide per tutto il regno era molto importante perché tutta la popolazione le poteva conoscere e rispettare. Le leggi erano uguali per tutti e così anche le punizioni.
OBIETTIVI: Ricavare informazioni da un testo informativo. • Conoscere gli aspetti essenziali della civiltà babilonese.
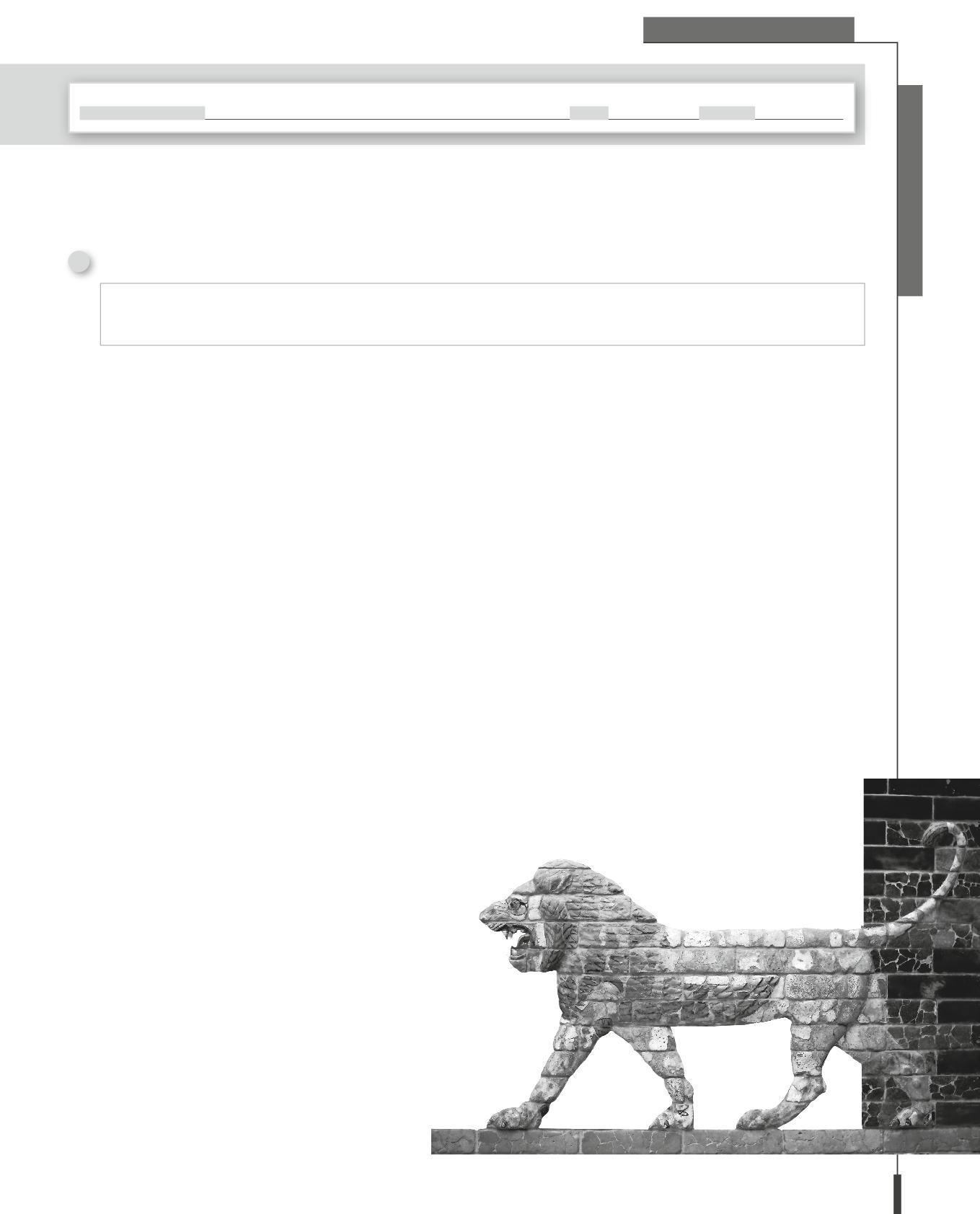
NOME E COGNOME DATA CLASSE
I BABILONESI
1 Completa il testo con le parole seguenti.
Babilonia • capitale • Codice • Hammurabi • Leggi • Mesopotamia • morte • quotidiana • regno • scritte • società • Sumeri • uguali
• Intorno al 2000 a.C. dalle terre aride a nord-ovest giunse un popolo di pastori nomadi che s’impadronì del territorio della
• I nuovi conquistatori fecero propria la cultura dei e fondarono nuove città.
• La città più importante e popolata del regno fu , tanto da dare il nome a questo popolo.
• Il più famoso re dei Babilonesi fu . Egli scelse Babilonia come .
• Hammurabi è ricordato soprattutto per aver messo per iscritto una raccolta di Leggi, il di Hammurabi, valido per tutti gli abitanti del regno.
• Le Leggi riguardavano aspetti della vita : la famiglia, il matrimonio, le proprietà, i commerci e la vendita degli schiavi.
• Per chi violava le Leggi erano previste pene molto severe, tra cui la pena di .
• Avere valide per tutto il regno era molto importante, perché tutta la popolazione le poteva conoscere e rispettare. Le leggi erano per tutti e così anche le punizioni.
IL CODICE DI HAMMURABI
Il Codice di Hammurabi, redatto nel 1750 a.C., contiene le Leggi che regolavano la vita del popolo babilonese. Esse sono giunte fino a noi perché incise su una stele di pietra, oggi conservata nel Museo del Louvre a Parigi (Francia). Ecco alcune delle norme che vi sono incise.
• Se un uomo non ha rinforzato il suo argine e questo cede e i campi vicini vengono spazzati via dall’acqua egli dovrà pagare per il grano che è andato perduto.
• Se nella casa di un uomo è scoppiato un incendio e un uomo accorso a spegnerlo prende un oggetto del padrone di casa, quell’uomo sarà buttato in quell’incendio.
• Se un nobile fa perdere un occhio a un suo pari gli si toglierà un occhio.
• Se un nobile fa perdere un occhio a un suo inferiore, pagherà una moneta d’argento.
• Se un uomo libero fa perdere un occhio a uno schiavo di un altro uomo libero, pagherà metà del suo prezzo.
• Se durante un intervento chirurgico un uomo muore o perde un occhio, il chirurgo sia condannato al taglio della mano.
• Se una casa crolla uccidendone il padrone e il crollo è dovuto all’architetto poco abile, sia ucciso l’architetto.
1 Indica con una X il completamento corretto di ogni frase.
• Le Leggi del Codice di Hammurabi furono stabilite: in un periodo che non si conosce. nel 1750 a.C. nel 1750 d.C. nel 1790 a.C.
• Se i campi vicini si allagavano perché i contadini non avevano rinforzato gli argini dei propri canali, essi: non avevano alcuna colpa. perdevano il loro raccolto e non ottenevano alcun pagamento da altri. dovevano ripagare il grano perduto dal vicino. venivano rimborsati.
• Se qualcuno accorso per spegnere un incendio in una casa portava via degli oggetti: veniva rimproverato. poteva tenerli come premio. veniva chiamato ladro. veniva punito con la pena di morte.

• La Legge era: diversa per gli uomini liberi e gli schiavi. uguale per tutti. a favore di chi era più simpatico. a favore dei più deboli.
• I lavoratori erano: perdonati se commettevano qualche errore.
considerati responsabili delle proprie azioni. intoccabili. considerati infallibili.
• Le Leggi del Codice di Hammurabi sono: uguali a quelle di oggi. quasi uguali a quelle di oggi. molto diverse da quelle di oggi. qualcuna uguale, qualcuna no.
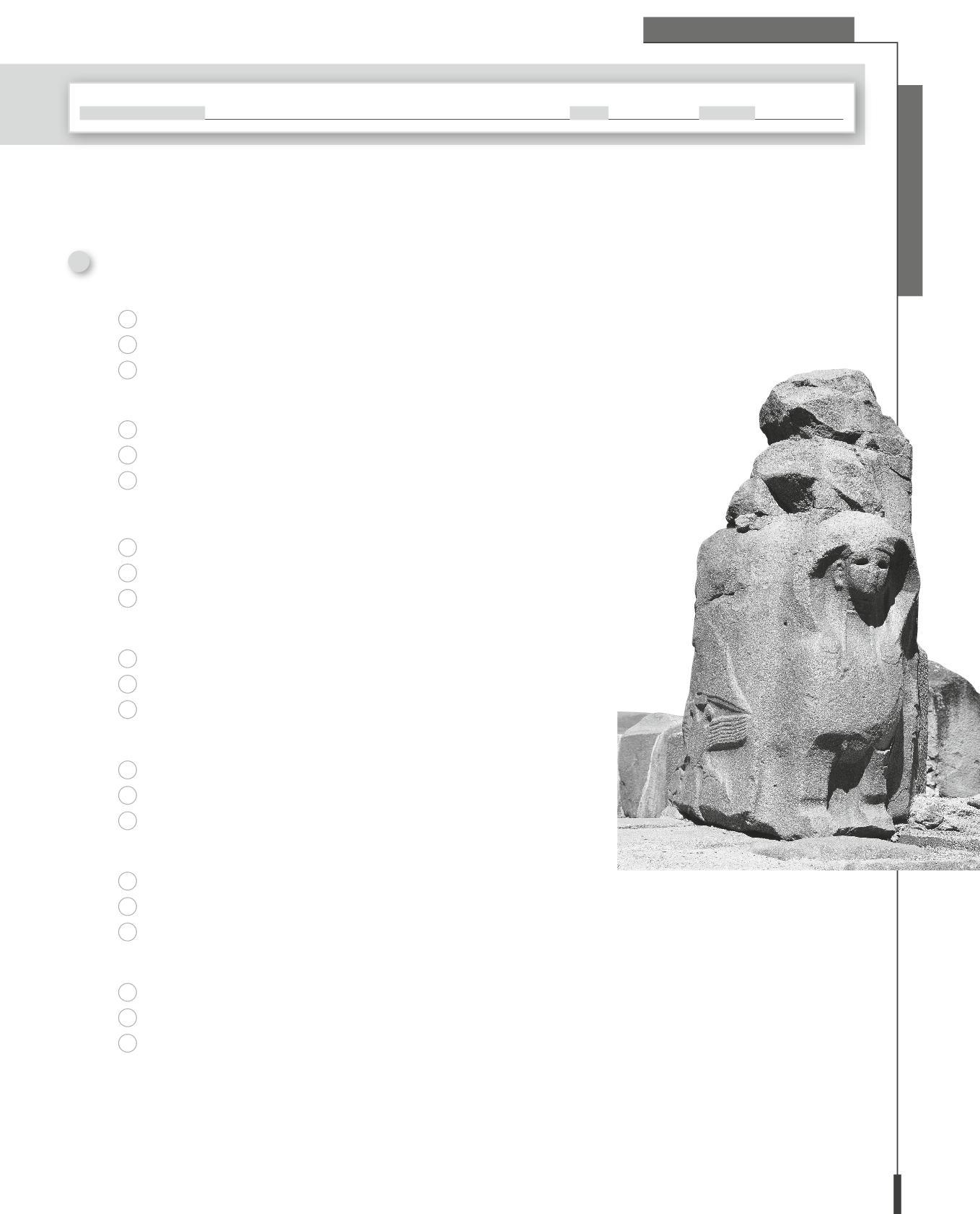
GLI ITTITI
1 Indica con una X il completamento corretto di ogni frase.
• Gli Ittiti erano un popolo di origine orientale che regnò in Anatolia (l’attuale Turchia). Essi: furono poi conquistati dai Turchi. raggiunsero e saccheggiarono Babilonia. furono poi conquistati dai Babilonesi.
• Gli Ittiti costruirono nel loro territorio: città fortificate. piccoli villaggi di capanne. edifici fatti solo di pietra.
• Il contatto con la civiltà mesopotamica li fece progredire soprattutto: nell’arte della guerra. nell’artigianato del ferro. per quanto riguarda l’arte e la scrittura.
• Inzialmente i re degli Ittiti venivano eletti da: un’assemblea di nobili guerrieri. da tutti i cittadini maggiorenni. dagli schiavi liberati.
• Erano abili artigiani, capaci di lavorare: il bronzo, con cui costruivano armi resistenti. il rame, metallo più resistente del bronzo. il ferro, metallo più resistente del bronzo.
• Spade, corazze e scudi di ferro rendevano: i soldati più esposti alle armi nemiche. certa la sconfitta in battaglia. più forti i guerrieri e più potenti gli eserciti.
• Gli Ittiti, con i loro carri da guerra leggeri e veloci, trainati da cavalli: riuscivano a vincere gli eserciti nemici. riuscivano a fuggire davanti agli eserciti nemici. non riuscivano a vincere gli eserciti nemici.
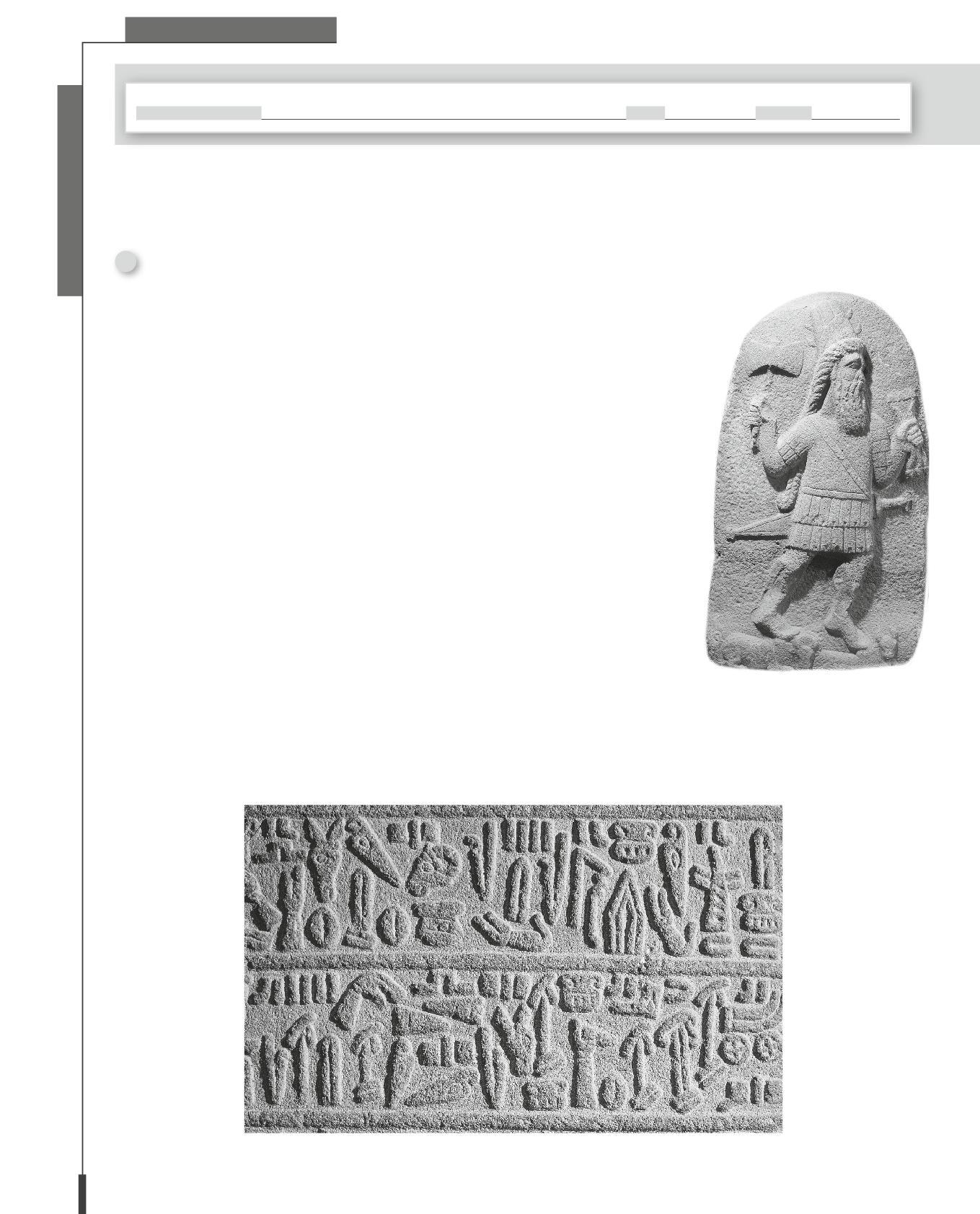
GLI ITTITI
1 Sottolinea l’alternativa corretta per completare le frasi.
• Gli Ittiti, popolo di origine orientale, che regnavano in Anatolia (oggi Turchia), raggiunsero e saccheggiarono Babilonia / Ur
• Gli Ittiti costruirono piccoli villaggi / città fortificate.
• Il contatto con la civiltà mesopotamica li fece progredire soprattutto per quanto riguarda l’agricoltura / la scrittura.
• I re degli Ittiti venivano eletti da un’assemblea di schiavi / nobili guerrieri.
• Gli Ittiti scambiavano con i popoli vicini principalmente metalli e legname / gioielli
• Gli artigiani avevano imparato a lavorare il rame / ferro, metallo più resistente del bronzo.
• Spade, corazze e scudi di ferro rendevano più pesanti / forti i guerrieri e più potenti gli eserciti.
• Gli Ittiti, con i loro carri da guerra leggeri e veloci, trainati da cavalli / asini, riuscivano a vincere gli eserciti nemici.
NOME E COGNOME
CARRI DA GUERRA A CONFRONTO
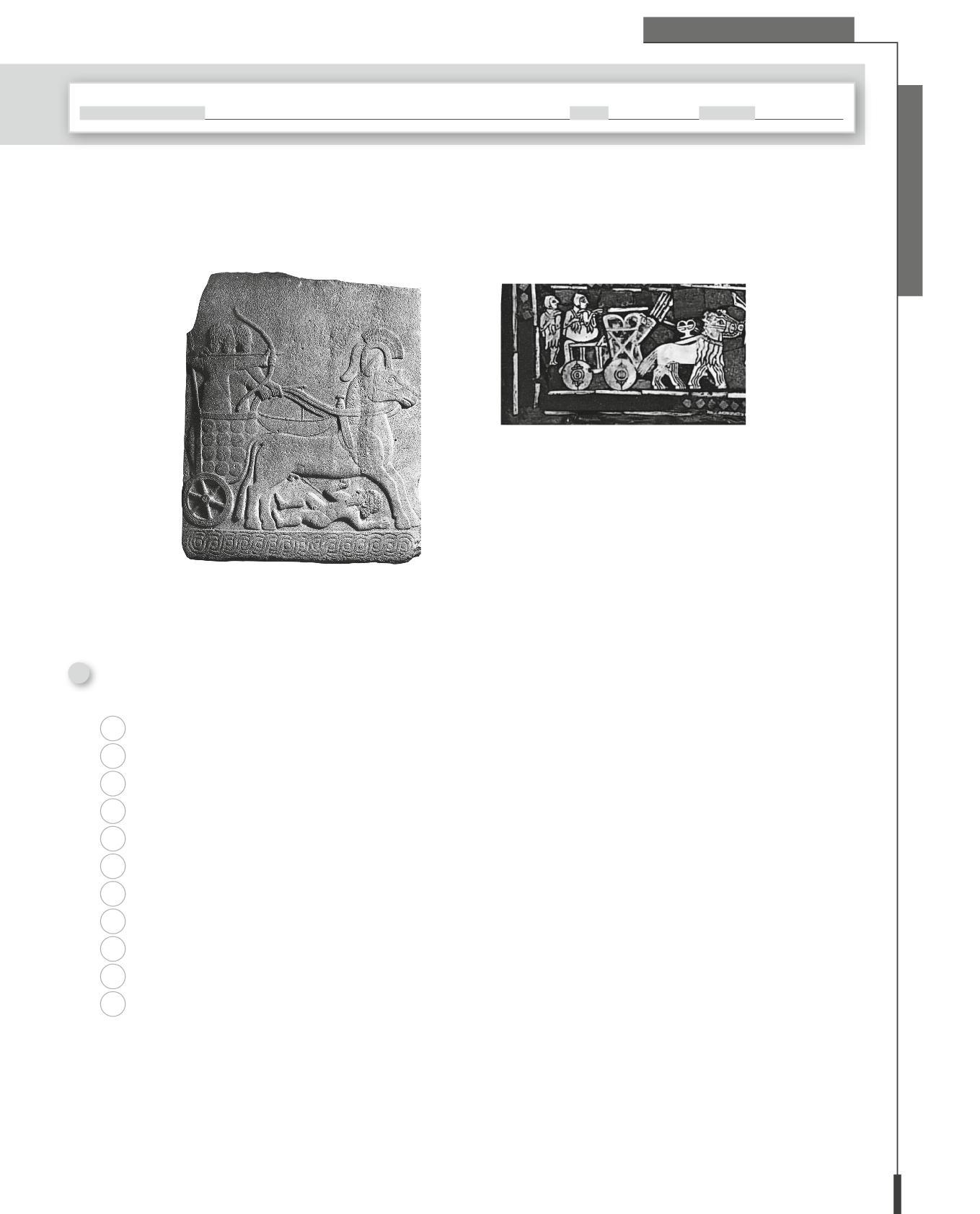
1 Osserva le due fonti visive, poi scrivi in ogni casella S se l’informazione è relativa al carro sumero, I se a quello ittita.
I carri erano pesanti e lenti, più adatti al trasporto che alla guerra.
I carri erano composti da una cesta intrecciata con un pianale e quattro ruote di legno piene.
Le ruote erano formate da due semidischi tenuti insieme da perni di legno.
La biga era un carro leggero a due ruote.
Le ruote erano snelle e leggere, a sei raggi.
Nella parte anteriore del carro si tenevano i giavellotti.
Sul pianale trovavano posto due soldati: l’auriga, cioè il guidatore, e il lanciatore dei giavellotti.
Il carro era trainato da due asini selvatici.
Il carro era trainato da cavalli.
Uno dei soldati guidava, l’altro scagliava lance e frecce.
Grazie all’uso di ruote a raggi, più leggere rispetto alle ruote piene utilizzate dagli altri popoli, i carri potevano essere manovrati facilmente.
GLI ASSIRI
1 Sottolinea l’alternativa corretta per completare il testo.
Verso il 2000 a.C. / 1100 a.C. la Mesopotamia fu occupata dagli Assiri.
Essi provenivano dalle regioni montuose / marittime dell’alta valle del fiume Tigri.
Gli Assiri erano una popolazione nomade, dedita soprattutto all’agricoltura / alla pastorizia
Gli Assiri erano molto abili nel lavorare il ferro. Con questo metallo costruirono armi / utensili resistenti.
Essi erano anche abili nel realizzare macchine da guerra / lavoro, formate da torri mobili e ponteggi che permettevano di attaccare / difendere le città.
Grazie al loro potente esercito, gli Assiri formarono un grande impero con capitale
Ninive / Babilonia.
Il re assiro più famoso fu Hammurabi / Assurbanipal. Egli rese la capitale / cittadina Ninive un centro di commercio, luogo di scienze, arte e cultura.
Assurbanipal fece costruire una grande biblioteca / ziggurat, che conteneva migliaia di tavolette di legno / argilla con iscrizioni.
Le tavolette, che sono state decifrate dagli esperti, sono preziose fonti di informazioni su questa civiltà / città
Per diversi secoli / millenni nessuno riuscì a resistere alla forza militare degli Assiri.
Nel 612 a.C. i Sumeri / Babilonesi si ribellarono agli Assiri, distrussero la loro capitale e ripresero il dominio su quelle terre.
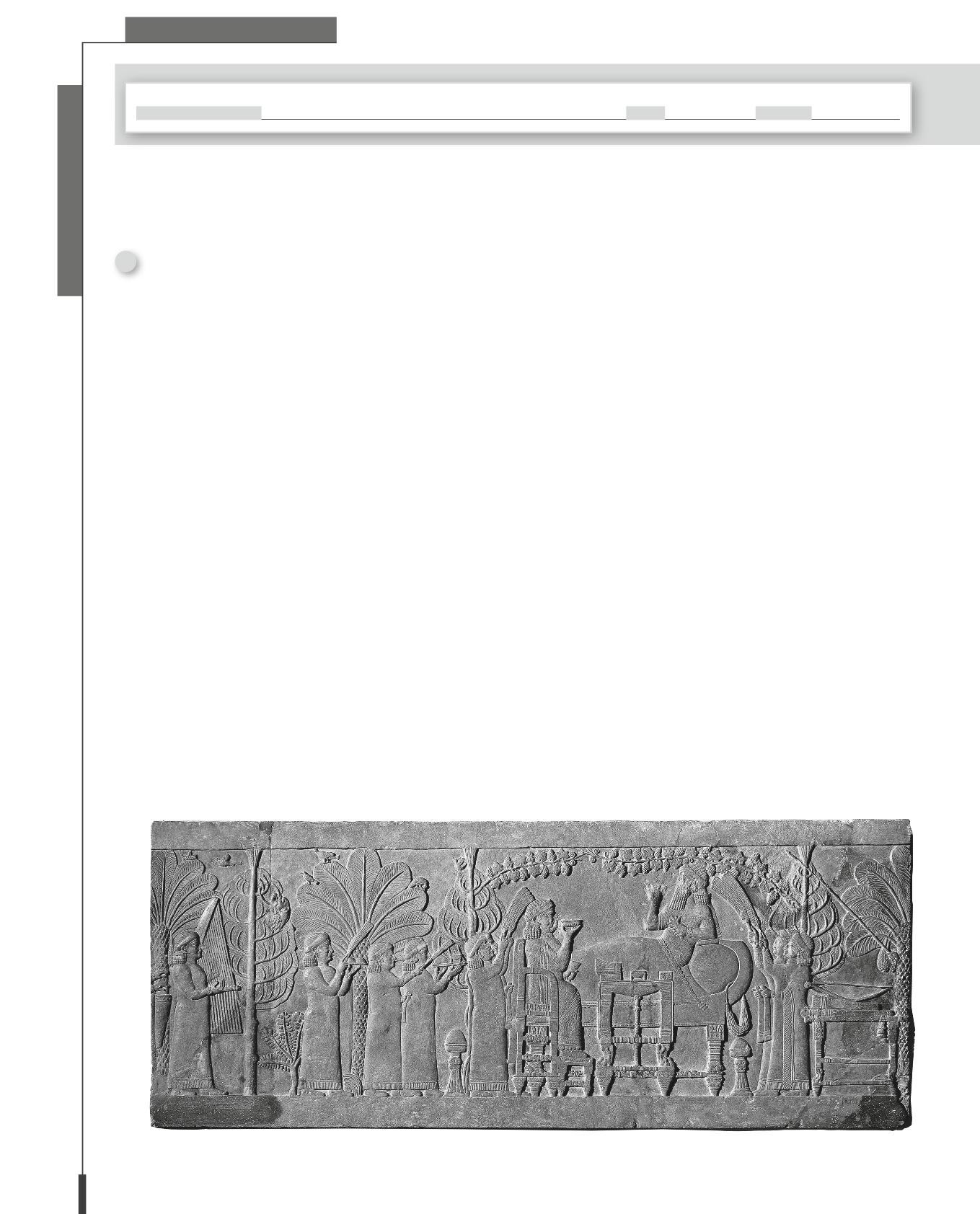
OBIETTIVI:

NOME E COGNOME DATA CLASSE
GLI ASSIRI
1 Completa il testo con le parole seguenti.
armi • 1100 a.C. • Assurbanipal • Babilonesi • biblioteca • circostanti • ferro • macchine • Ninive • pastori • vasti
Verso il la Mesopotamia fu occupata dagli Assiri. Essi provenivano dalle regioni montuose dell’alta valle del fiume Tigri e conquistarono i territori
Erano una popolazione nomade formata soprattutto da Erano molto abili nel lavorare i metalli, soprattutto il Con questo metallo costruivano resistenti.
Essi erano anche abili nel realizzare da guerra, con cui assediavano le città fortificate.
Grazie al loro potente esercito gli Assiri formarono un grande impero con capitale
Il re assiro più famoso fu . Egli fece costruire una grande che conteneva migliaia di tavolette con iscrizioni.
Per diversi secoli nessuno riuscì a resistere alla forza militare degli Assiri.
Nel 612 a.C. i si ribellarono agli Assiri, distrussero la loro capitale e ripresero il dominio su quelle terre.
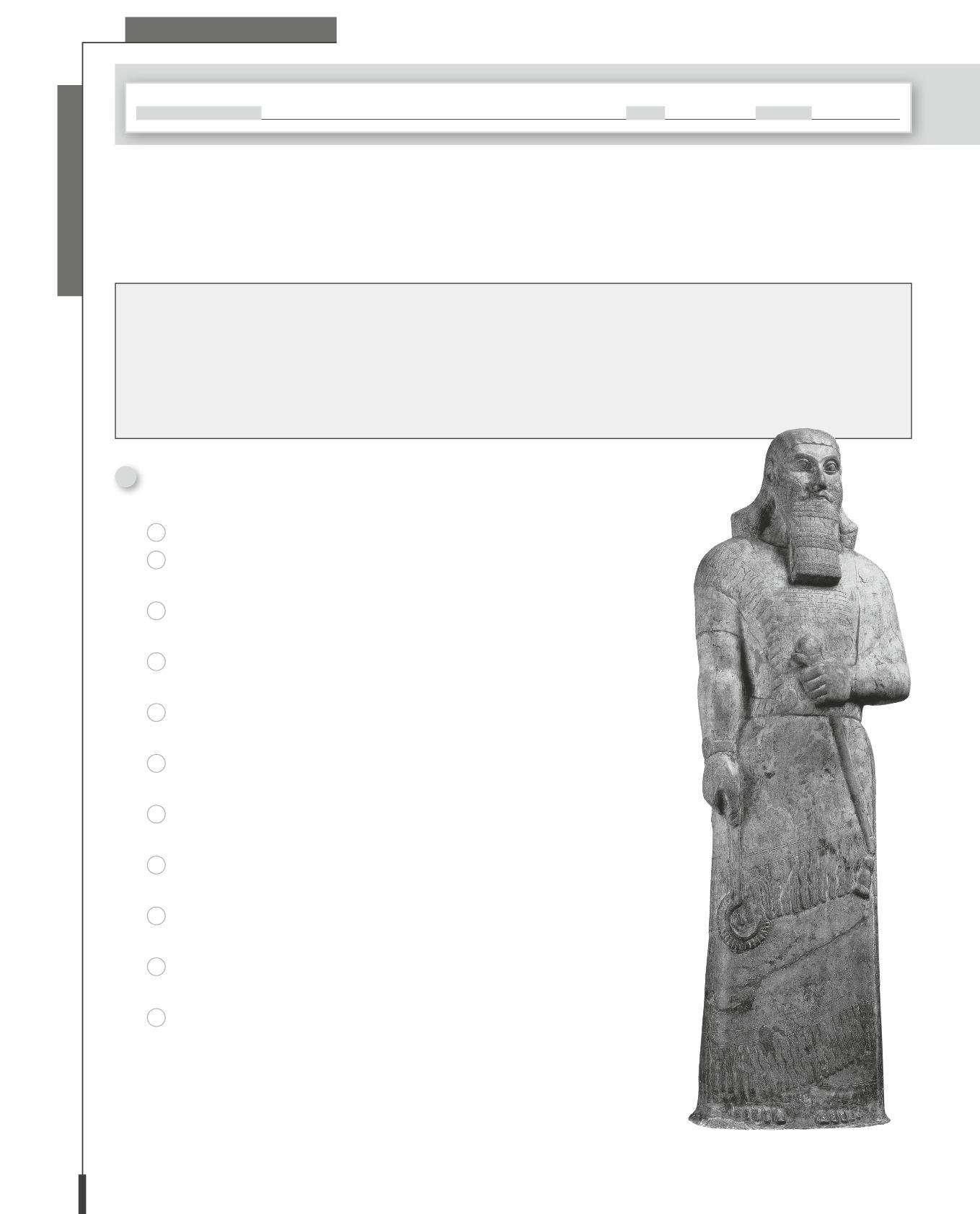
ASSURBANIPAL E LA CULTURA
Da una tavoletta assira.
Ordine del re Assurbanipal a Shanadu.
Il giorno stesso in cui tu vedrai questa mia tavoletta, prendi con te Shuma, Beletir, Aplà e gli altri eruditi di Borsippa che tu conosci. Raccogli tutte le tavolette che si trovano nella loro casa o che sono depositate nel tempio, per quanto numerose siano, nonché le tavolette rare che si trovano nei tuoi archivi, cerca anche queste e spediscimele. Se trovi inoltre qualche tavoletta che ritieni buona per il mio palazzo spediscimela.
1 Le frasi che seguono sono tutte corrette. Indica con una X quelle che vengono confermate da questa fonte.
L’imperatore Assurbanipal è ricordato come uomo di cultura. Egli rese la capitale Ninive un centro di commercio, luogo di scienze, arte e cultura.
Egli fece costruire a Ninive una grande biblioteca che conteneva ben trentamila tavolette d’argilla con iscrizioni.
Nelle tavolette vennero raccolte opere di medicina, matematica, astronomia, filosofia.
Anche le lettere e gli ordini dell’imperatore venivano scritti su tavolette.
In alcune tavolette sono stati ritrovati inni, cronache, opere letterarie.
Così è stato conservato anche il poema più importante dell’antichità: Gilgamesh.
In alcune tavolette è documentata la descrizione dei riti religiosi che si effettuavano nei templi.
Assurbanipal aveva tra i suoi collaboratori numerosi eruditi, cioè esperti in diversi settori della cultura.
L’imperatore aveva cura che i documenti fossero conservati in archivi, in modo da poterli recuperare e conservare.
Quando un grande incendio distrusse la biblioteca, molte di queste tavolette si salvarono perché il fuoco fece cuocere l’argilla, che diventò ancora più resistente.
NOME E COGNOME DATA CLASSE
CONFRONTA LE CIVILTÀ DELLA MESOPOTAMIA
1 Leggi le affermazioni e indica con una X se riguardano la civiltà dei Sumeri, dei Babilonesi, degli Ittiti o degli Assiri.
SumeriBabilonesi Ittiti Assiri
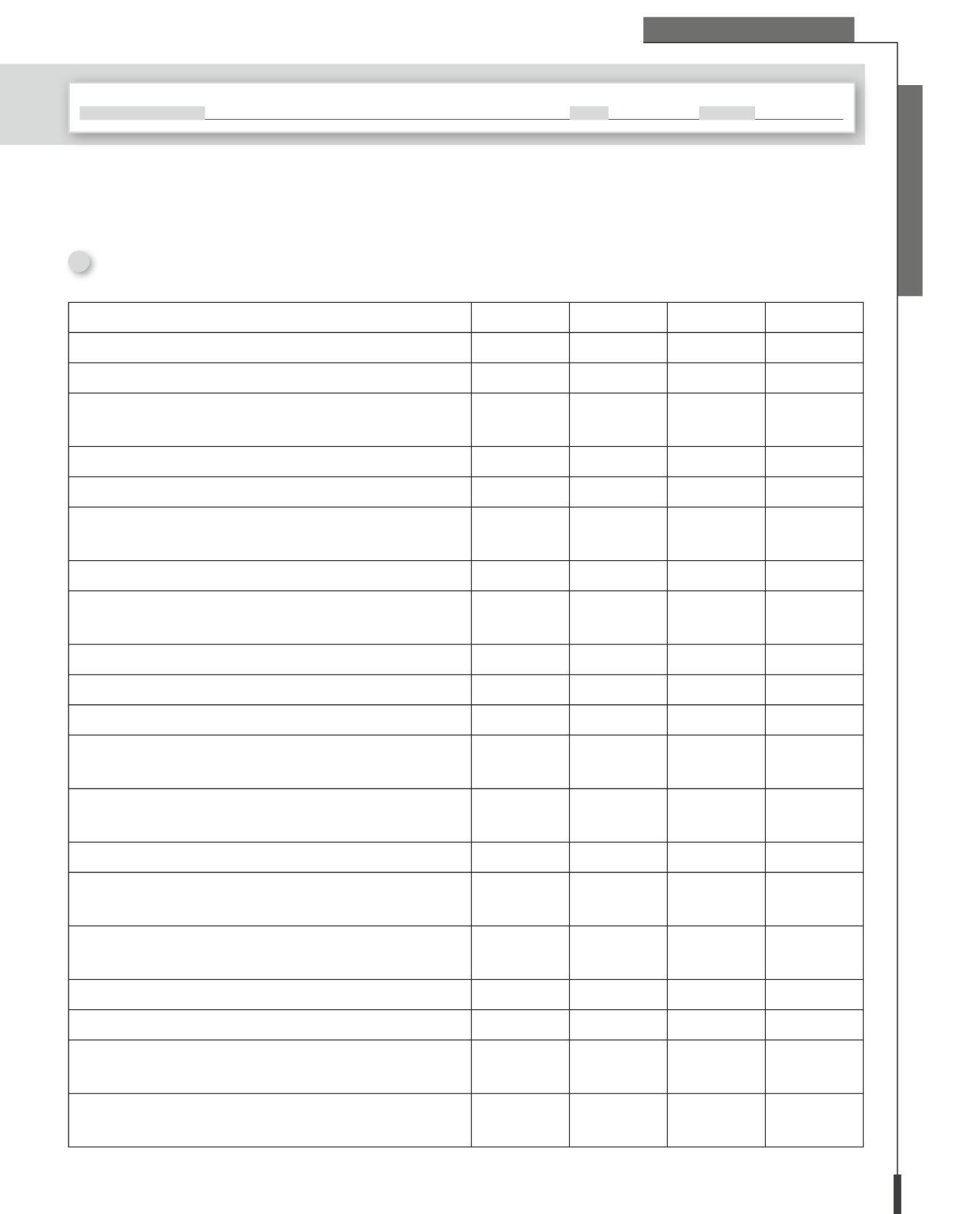
Costruirono le città di Ur e Uruk. Usavano armi di ferro.
Furono i primi a utilizzare l’aratro trainato da animali.
La loro città più importante era Babilonia.
Costruirono splendidi edifici con giardini pensili.
Durante le battaglie utilizzavano le macchine d’assedio.
La loro città più importante era Ninive.
Inizialmente il loro re veniva eletto da un’assemblea di nobili guerrieri.
Inventarono la ruota da vasaio.
Fondarono un impero.
Le città-stato erano tra loro indipendenti.
Il loro re creò la prima grande biblioteca della Storia.
Il loro re, Hammurabi, fu il primo a far scrivere le leggi che tutti dovevano rispettare.
Intorno al 1530 a.C. saccheggiarono Babilonia.
Per le battaglie usavano carri leggeri trainati da cavalli.
Inventarono i mattoni con cui costruirono i loro edifici.
Inventarono la vela per le imbarcazioni.
L’ultimo loro re fu Assurbanipal.
Hanno costruito una città di cui è famosa la porta di Ishtar.
Organizzarono il tempo in anni, giorni, minuti e secondi.
GLI EGIZI
1 Colora sulla carta in blu il mare e il fiume Nilo e in verde il territorio abitato e coltivato, cioè quello intorno al fiume. MAR MEDITERRANEO
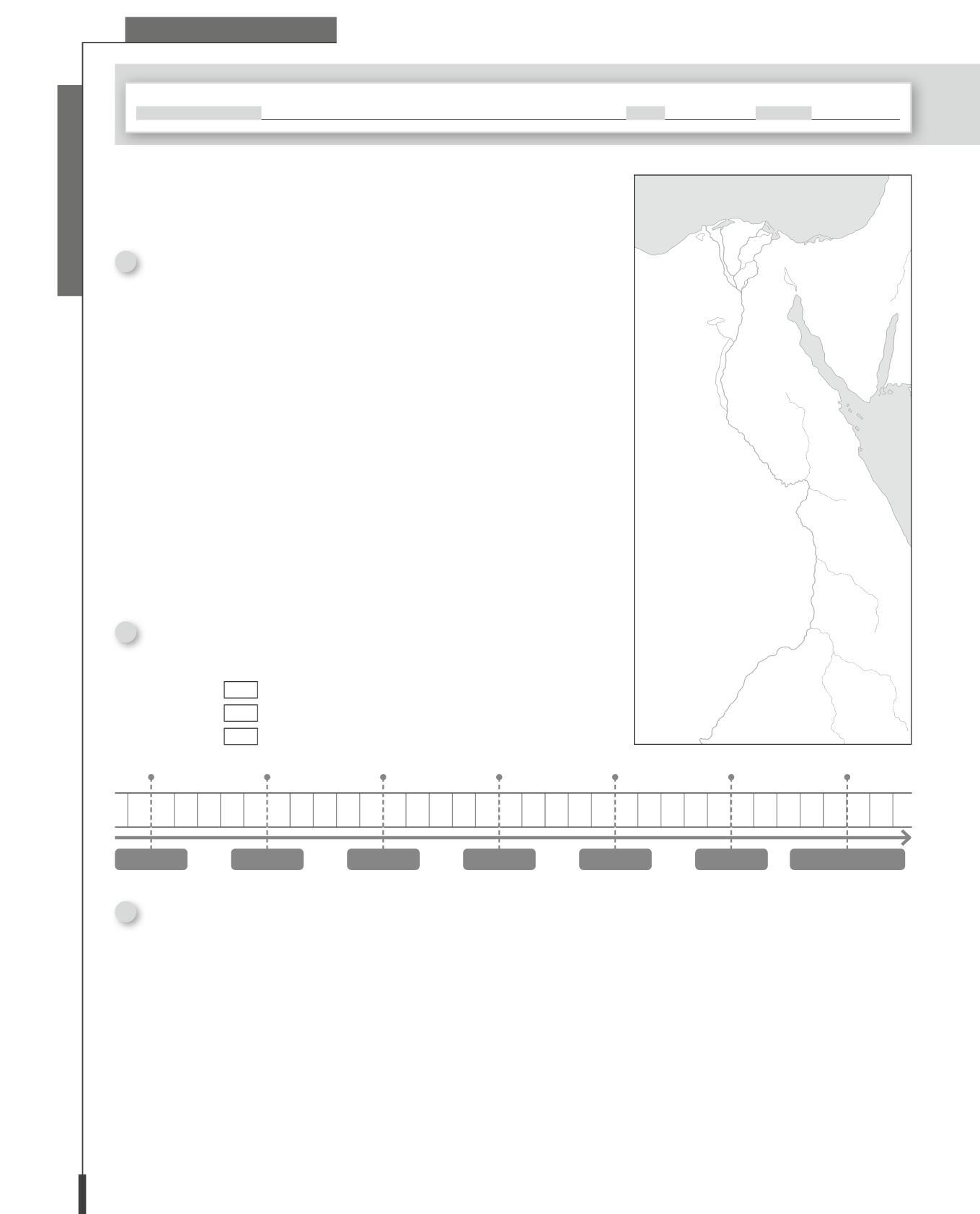
2 Completa la legenda e colora sulla linea del tempo i periodi in cui è suddivisa la storia degli Egizi.
Legenda:
3 Completa le frasi.
• Gli Egizi vissero lungo il fiume
• In Egitto comandava il che rappresentava gli sulla Terra.
• Il Nilo una volta all’anno straripava e depositava sul terreno . Con il tempo, i contadini impararono le acque del Nilo.
• La scrittura era formata da centinaia di disegni, detti ; si scriveva su fogli di
• Gli Egizi adoravano molte divinità e credevano che dopo la morte
OBIETTIVI: Leggere una carta storico-geografica. • Leggere la linea del tempo. • Conoscere gli aspetti essenziali della civiltà egizia.
NOME E COGNOME DATA
GLI EGIZI
1 Leggi le didascalie poi, per ogni immagine, scegli un titolo tra i seguenti.
Il faraone
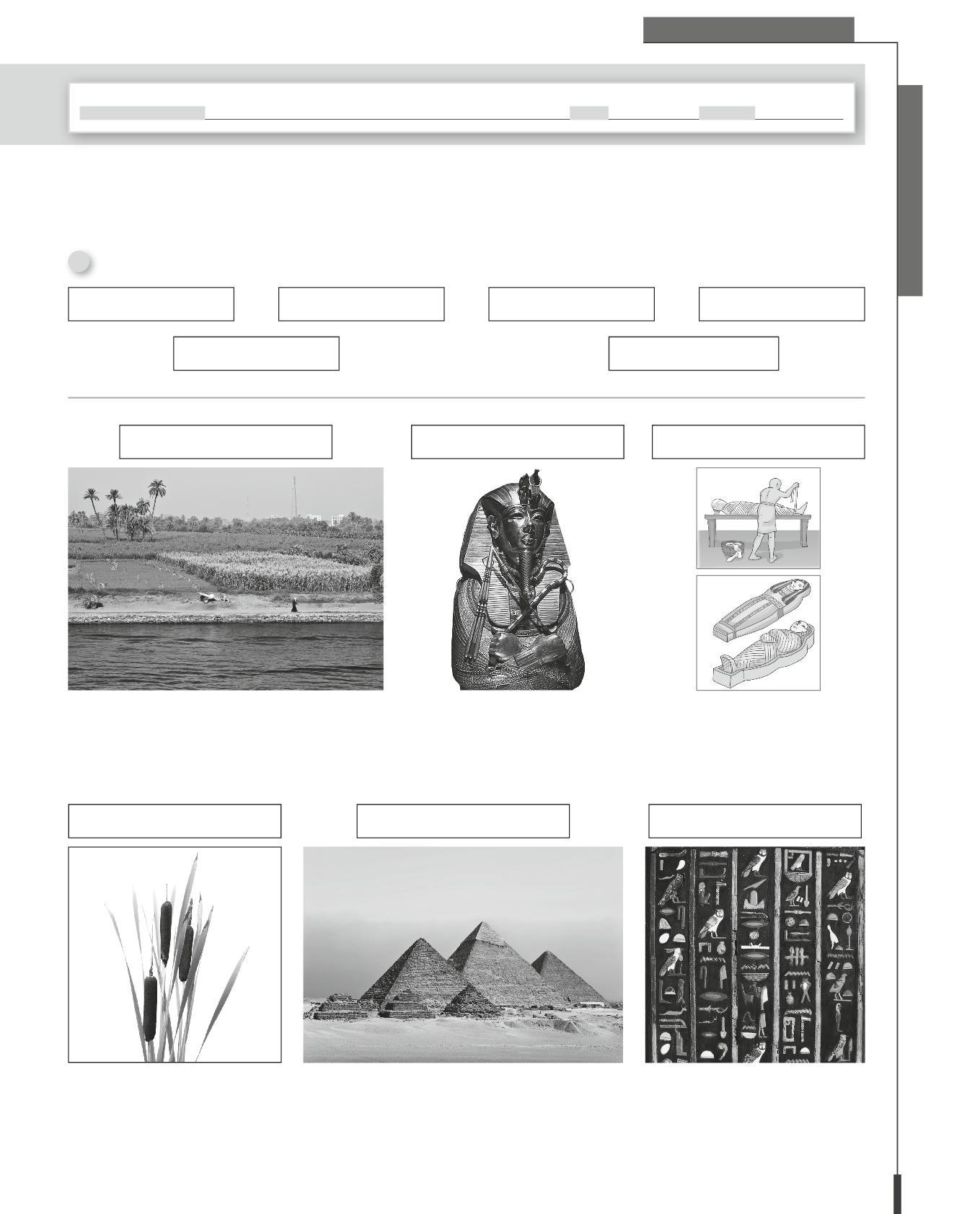
Il fiume Nilo
Le piramidi
Le mummie
I geroglifici
Il papiro
Ogni anno in primavera depositava sui campi un fango che li rendeva fertili. Per gli Egizi era sacro e adorato come un dio.
Governava l’Egitto e comandava su tutto e su tutti.
I corpi dei defunti venivano mummificati e avvolti in bende.
Con questa pianta, che cresceva lungo il Nilo, si fabbricavano i fogli su cui scrivere.
Erano tombe grandissime, costruite per i faraoni o per persone ricche e potenti.
Erano centinaia di piccole immagini, spesso colorate.
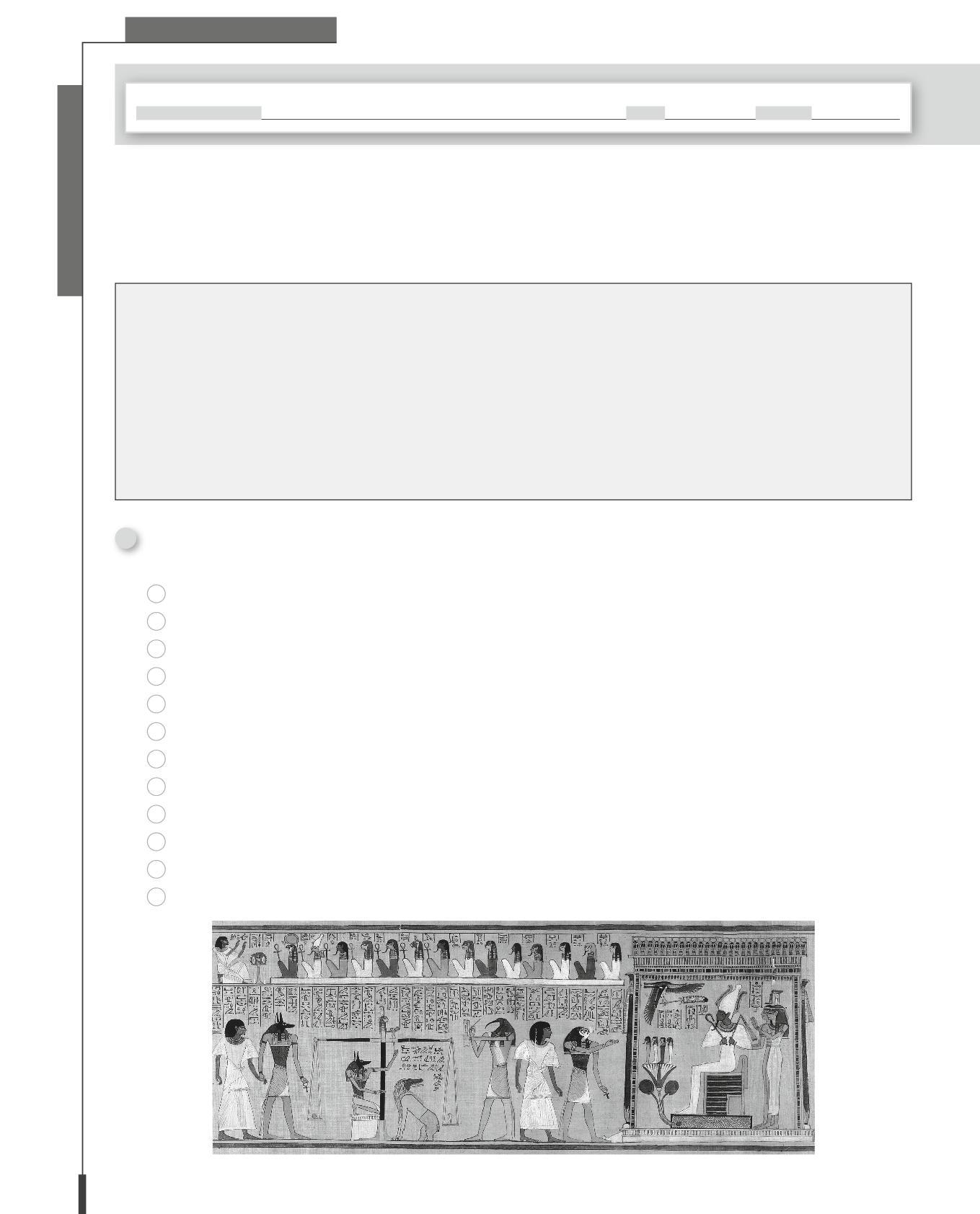
LA CONFESSIONE DI UN EGIZIO
Questo brano, tratto dal Libro dei morti, aiuta a capire i comportamenti ritenuti corretti dagli antichi Egizi.
Non ho fatto del male a nessuno, non ho fatto piangere nessuno. Non ho ucciso e non ho ordinato di uccidere. Non ho diminuito i doni destinati al tempio. Non ho portato in offerta agli dèi pani più piccoli del dovuto. Non ho truffato sulle misure del grano togliendone o sottraendone o aggiungendovi altre sostanze. Non ho imbrogliato nella misurazione dei campi riducendo quelli del vicino. Non ho manomesso i pesi della bilancia. Non ho maltrattato alcun animale.
Non ho rubato il nutrimento al bestiame.
Ho fatto ciò che gli uomini approvano e di cui gli dèi si rallegrano. Ho dato pane a chi aveva fame, acqua a chi aveva sete, abiti a chi era nudo. Ho portato offerte agli dèi e ai morti. Salvatemi, proteggetemi e non testimoniate contro di me davanti al dio Osiride. La mia bocca e le mie mani sono pure.
1 Tra questi comportamenti, ritenuti corretti dagli antichi Egizi, ce ne sono alcuni non descritti nella confessione. Indicali con una X.
Non uccidere e non ordinare di uccidere.
Porta doni al tempio.
Porta agli dèi pani di giusta misura.
Non rubare dalle tombe.
Non imbrogliare quando si pesa il grano.
Non imbrogliare sulla misura dei campi, togliendo terra ai campi vicini.
Paga le tasse.
Non manomettere i pesi della bilancia.
Non maltrattare gli animali.
Adora il faraone come una divinità.
Dai pane a chi ha fame, acqua a chi ha sete, abiti a chi è nudo.
Porta offerte agli dèi e ai morti.
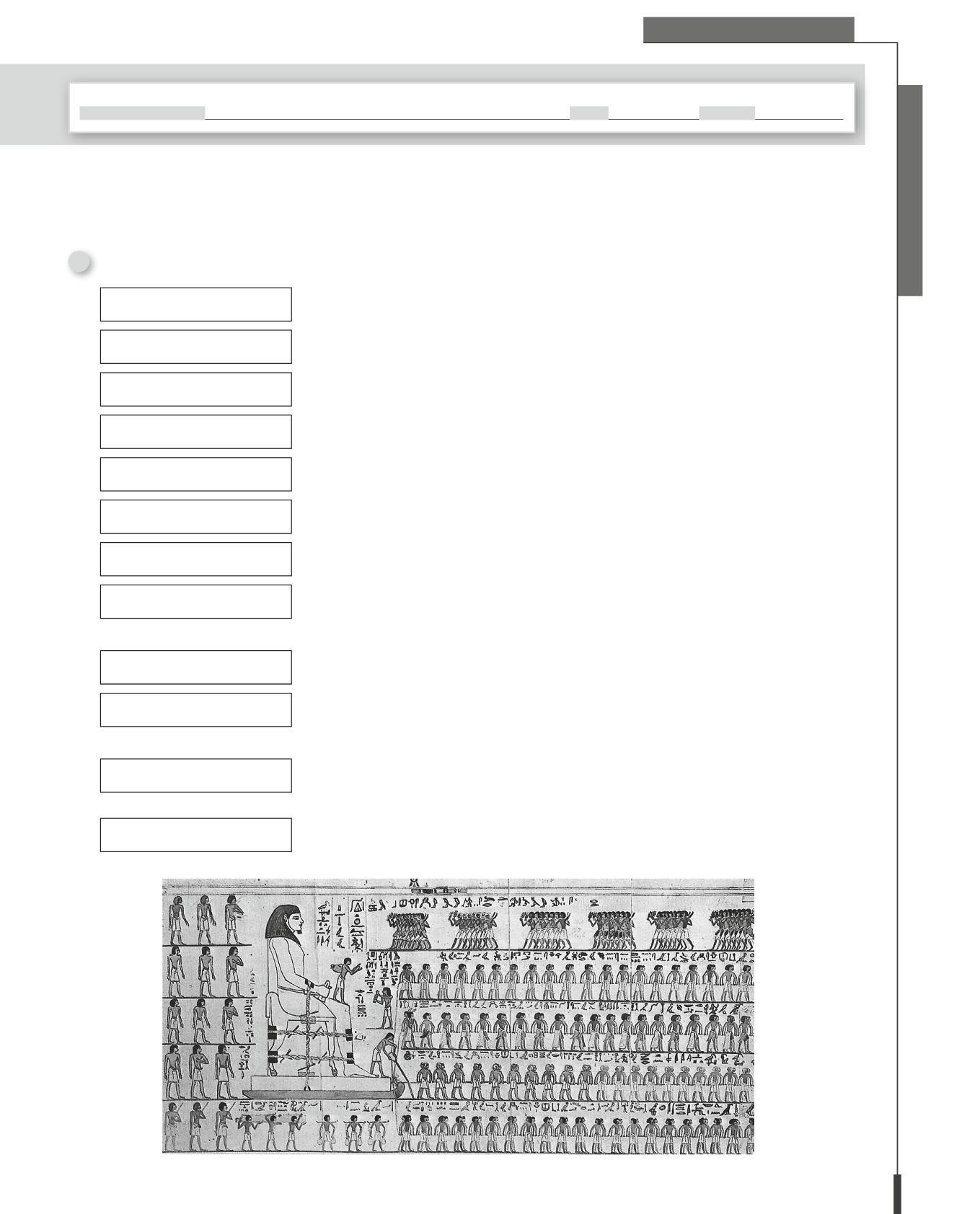
LA SOCIETÀ DEGLI EGIZI
1 Completa le affermazioni con il personaggio della società corretto.
erano di solito prigionieri di guerra: svolgevano lavori umili e faticosi.
lavoravano i campi, scavavano canali e costruivano dighe.
allevavano gli animali per i lavori agricoli e per l’alimentazione.
viaggiavano anche in Paesi lontani, compravano e vendevano prodotti.
erano vasai, tessitori, decoratori dei templi, fabbri, orafi.
era formato da professionisti ben addestrati ai combattimenti.
erano migliaia e si occupavano delle cerimonie religiose.
erano esperti nella scrittura. Trascrivevano le leggi e gli ordini del faraone, tenevano i conti del regno.
si occupavano del funzionamento dello Stato.
governavano i territori per conto del faraone. Avevano incarichi prestigiosi: per esempio erano ambasciatori, governatori di province o generali.
era il secondo uomo più potente d’Egitto: faceva eseguire le decisioni del faraone.
era il re e capo assoluto, era anche comandante dell’esercito e sommo sacerdote, ed era venerato come una divinità.
LA SOCIETÀ DEGLI EGIZI
IL VISIR I NOBILI
SACERDOTI
I FUNZIONARI E GLI SCRIBI L’ESERCITO
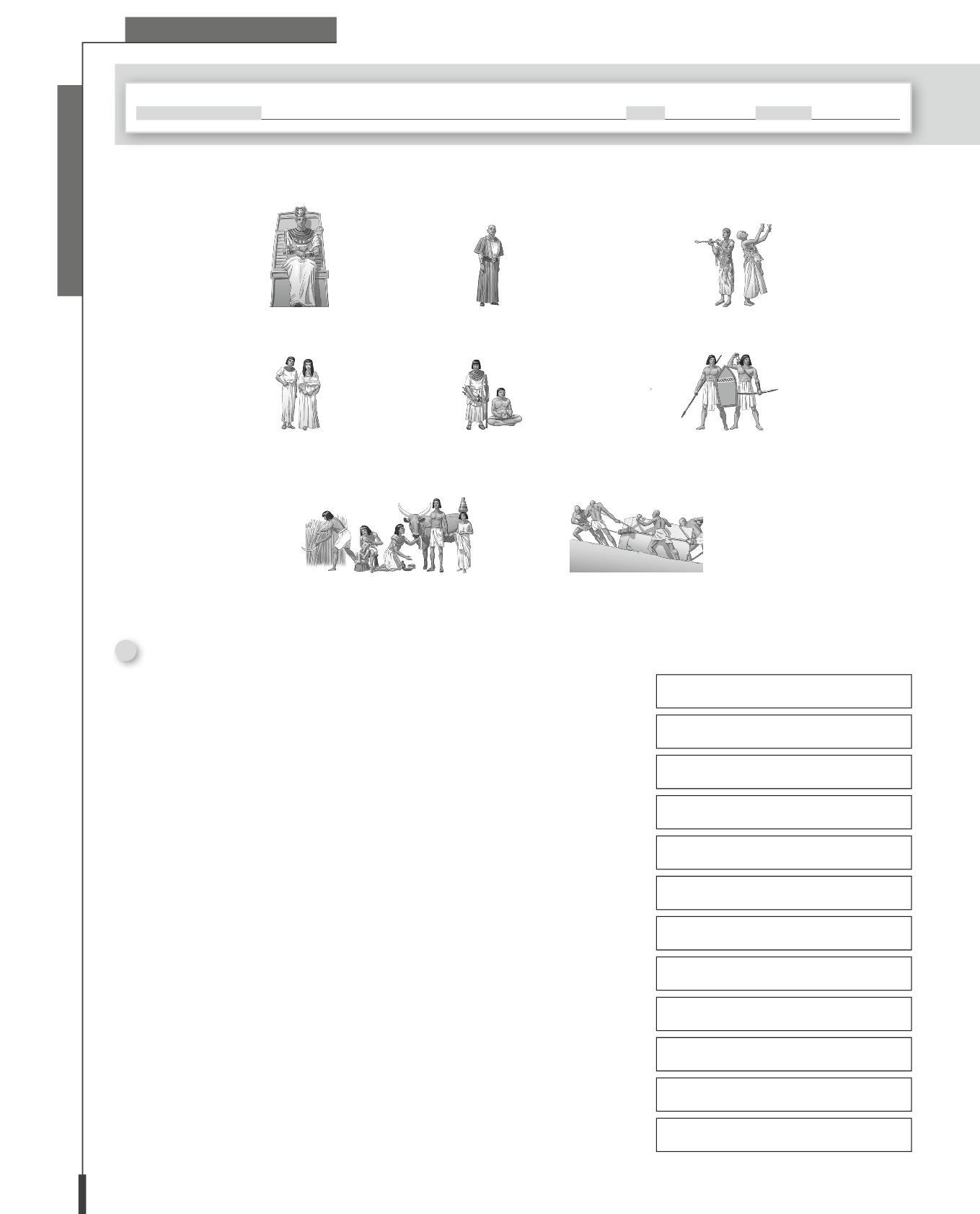
I CONTADINI, ALLEVATORI, SERVI, ARTIGIANI E COMMERCIANTI
GLI SCHIAVI
1 Per ogni affermazione scrivi a quali personaggi della società egizia si riferisce.
• Erano prigionieri di guerra.
• Allevavano gli animali.
• Coltivavano i campi, scavavano canali e costruivano dighe.
• Viaggiavano in Paesi lontani, compravano e vendevano prodotti.
• Avevano il compito di difendere il Paese dai nemici.
• Producevano vasi o tessuti o armi.
• Si occupavano del funzionamento dello Stato.
• Era il secondo uomo più potente d’Egitto.
• Tenevano i conti del regno, erano esperti nella scrittura.
• Comandava su tutto e tutti.
• Si occupavano delle cerimonie religiose.
• Governavano i territori dell’Egitto per conto del faraone.
OBIETTIVI: Conoscere gli aspetti essenziali della società degli Egizi.
GLI EGIZI E L’ISTRUZIONE
In questo documento il padre raccomanda al figlio di studiare per poi diventare un giorno uno scriba.
Voglio che tu ami la scrittura. Un ragazzo che conosce la scrittura appena cresce viene salutato e rispettato da tutti.
Io ho osservato il fabbro al lavoro: la pelle delle sue dita è ruvida come le scaglie di un coccodrillo.
Ogni falegname che lavora di pialla è più stanco di un contadino e la notte si sente le ossa rotte.
Se un tessitore trascorre una giornata lasciando inoperoso il suo telaio, riceve cinquanta frustate.
Vedi, non c’è lavoro in cui non si ricevano ordini, tranne quello dello scriba; lui è lì e dà ordini, e non c’è scriba senza cibo. Se tu impari a scrivere, ciò ti porterà vantaggio.
1 Indica con una X il completamento corretto di ogni frase.
• Il fabbro fa un duro lavoro perché: la pelle delle sue dita è forte e resistente.
la pelle delle sue dita è ruvida e screpolata. è forte come un coccodrillo. si copre di scaglie come un coccodrillo.
• Il falegname fa un duro lavoro perché: lavora quanto un contadino. lavora di notte. lavora con la pialla e si stanca molto. si rompe le ossa.
• Il tessitore fa un duro lavoro perché: il telaio va lasciato inoperoso. per tessere ci vuole la frusta. per tessere ci vuole una giornata intera. chi non tesse riceve cinquanta frustate.
• In tutti i lavori si ricevono ordini, ma non: nel lavoro dello scriba. nel lavoro di chi impara. nel lavoro di chi procura il cibo. li riceve chi non lavora.
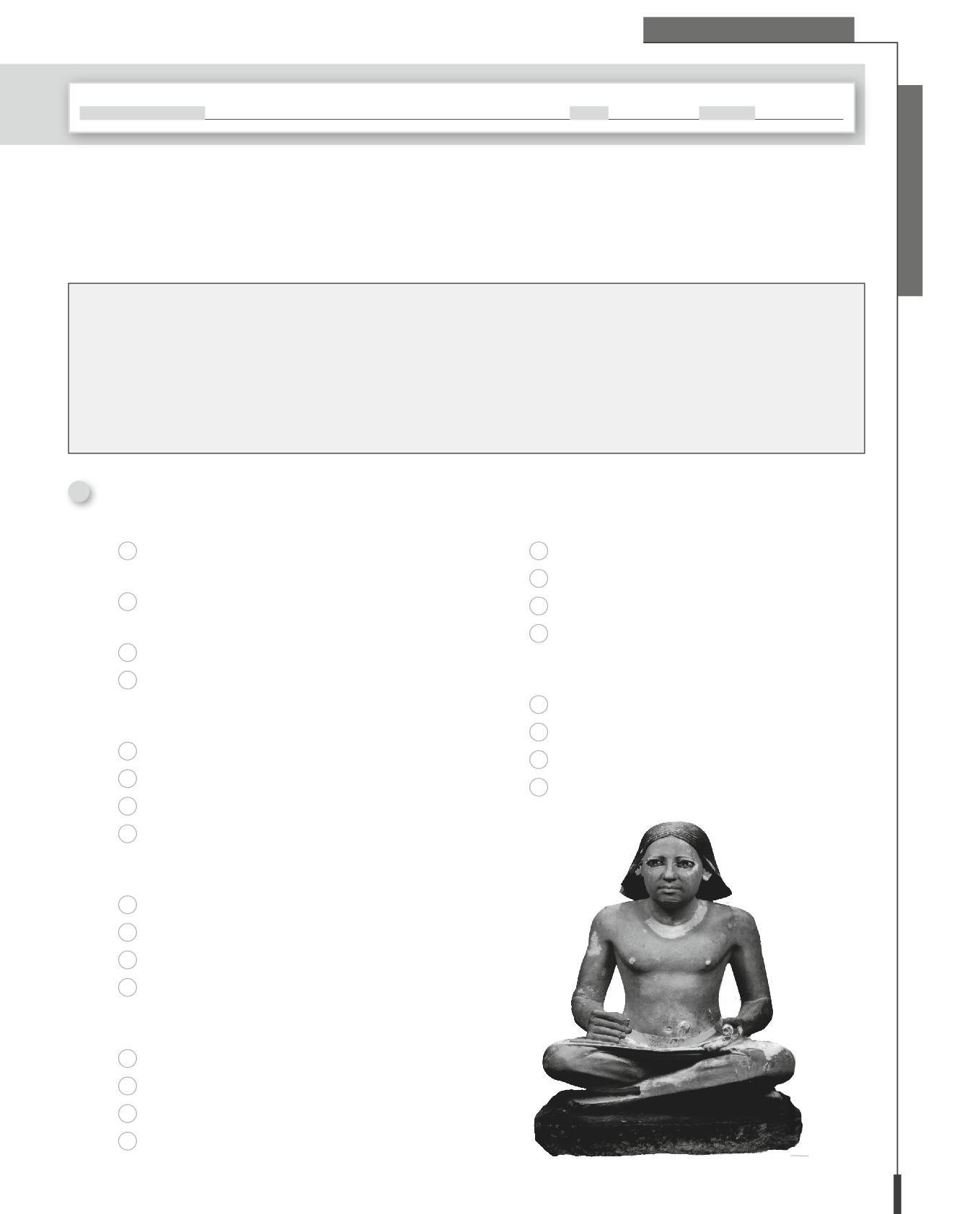
• Per diventare scriba: non è necessario imparare a scrivere. bisogna saper dare ordini. si deve rimanere senza cibo. bisogna imparare a scrivere.
• Il padre raccomanda al figlio di studiare per: crescere sano e forte. diventare un giorno uno scriba. imparare a salutare. imparare a rispettare.
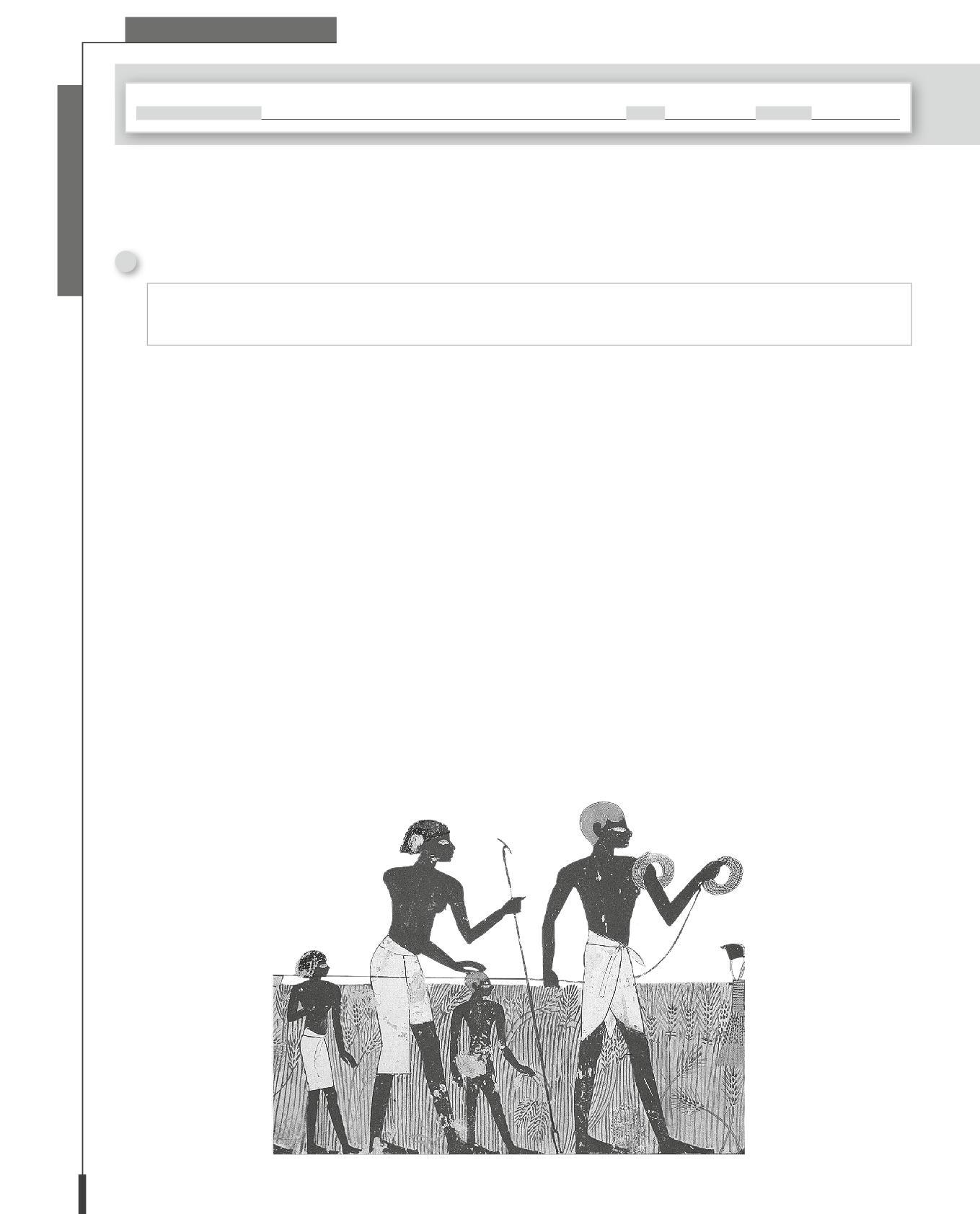
LE CONOSCENZE DEGLI EGIZI
1 Completa le frasi con le parole seguenti.
365 • astronomia • cure • dighe • ferro • geometria • geroglifica • Luna • matematica • medici • medicina • piramidi • scrittura • shaduf • utensili
• Gli Egizi realizzarono grandi opere idrauliche, come canali e , e grandiosi monumenti, come e templi. Per realizzare queste opere fu necessario sviluppare lo studio della e della
• Gli Egizi avevano molte conoscenze nel campo della . Alcuni dei loro testi sono giunti fino a noi e contengono informazioni su diverse malattie e sulle che si praticavano. Per alcune malattie esistevano dei specializzati.
• Gli Egizi svilupparono lo studio dell’ . Osservarono il Sole e le fasi della ; divisero quindi l’anno in giorni e il giorno in 24 ore.
• Anche se avevano solo e macchine semplici, gli Egizi riuscirono a costruire oggetti molto raffinati e monumenti grandiosi. Non conoscevano i , quindi i loro utensili erano fatti di rame, legno e pietra.
• Inventarono una loro forma di , costituita da circa 700 segni. I Greci in seguito la chiamarono , che significa “segno sacro”, perché la ritrovarono solo sulle pareti delle tombe e dei templi e sulle statue delle divinità.
LE CONOSCENZE DEGLI EGIZI
1 Scegli un titolo per ogni settore delle conoscenze degli Egizi e poi scrivilo nel riquadro corretto.
L’astronomia
La medicina
La scrittura geroglifica
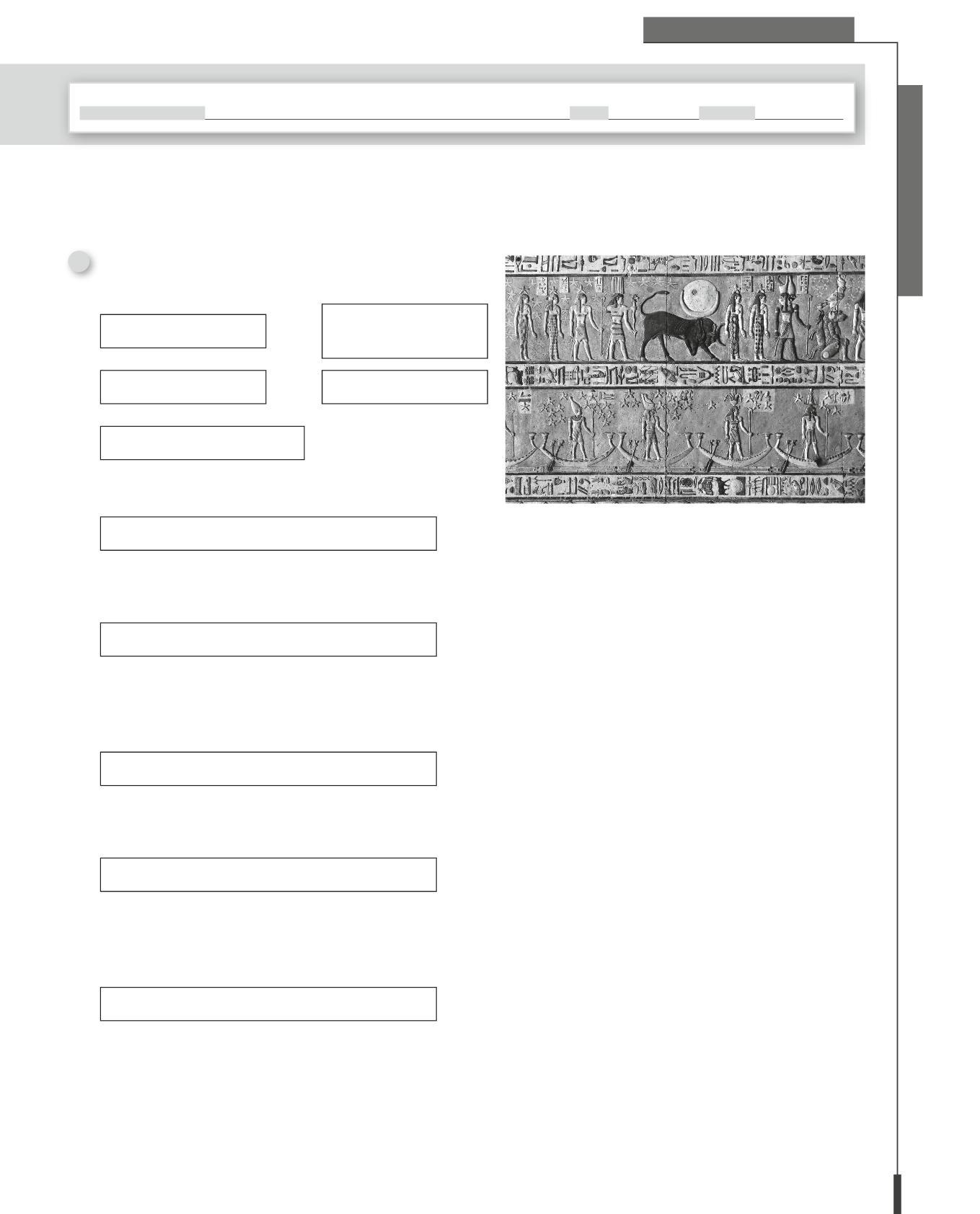
L’aritmetica e la geometria
La tecnica
Per realizzare canali, dighe e grandi monumenti come le piramidi gli Egizi svilupparono lo studio delle linee e delle misure.
Gli Egizi conoscevano bene il corpo umano grazie alla pratica della mummificazione. Alcuni testi egizi giunti fino a noi contengono informazioni su diverse malattie e sulle cure che si praticavano. Alcuni medici erano specializzati nella cura delle malattie degli occhi, dello stomaco e della pelle.
Gli Egizi svilupparono lo studio delle stelle e delle fasi della Luna; osservando il Sole divisero l’anno in 365 giorni e il giorno in 24 ore.
Anche se avevano solo strumenti e macchine semplici, gli Egizi riuscirono a costruire oggetti molto raffinati e monumenti grandiosi. Usavano utensili di pietra, rame o legno perché non conoscevano il ferro.
Gli Egizi inventarono una loro forma di scrittura costituita da circa 700 segni. Una parte di questi segni erano ideogrammi, usati per rappresentare un’idea o un concetto; altri erano segni sillabici. In seguito inventarono una scrittura semplificata, detta scrittura ieratica.
OBIETTIVI: Conoscere gli aspetti essenziali delle conoscenze degli Egizi.
LA PIRAMIDE DI CHEOPE
Erodoto, uno storico greco, racconta come avvenne la costruzione della piramide di Cheope. Egli visse circa duemila anni dopo, quindi la sua narrazione può non essere del tutto attendibile.
Quando Cheope salì al trono, gettò l’Egitto nella più completa miseria perché obbligò tutti a lavorare per lui. Ad alcuni ordinò di trascinare fino al Nilo grosse pietre dalle cave, che si trovavano nelle montagne d’Arabia; ordinò poi che altri ricevessero le pietre, trasportate oltre il fiume su zattere, e le portassero sul luogo della costruzione. Lavoravano a turni di centomila uomini che si alternavano senza interruzione ogni tre mesi.
Quanto al tempo, occorsero ben dieci anni solo per portare a termine la costruzione della strada, lungo la quale dovevano essere trascinate le pietre; venti anni furono necessari per erigere la piramide stessa. Sulla piramide è segnato in carattere egizio quanto fu speso in rafani, cipolle e aglio per i lavoratori: la somma spesa fu di 1600 talenti d’argento. Ma se questa cifra è esatta, quanti altri talenti saranno stati spesi per gli arnesi con i quali lavoravano, per il nutrimento e il vestiario dei lavoratori, dal momento che a costruire le opere impiegarono il tempo che si è detto!
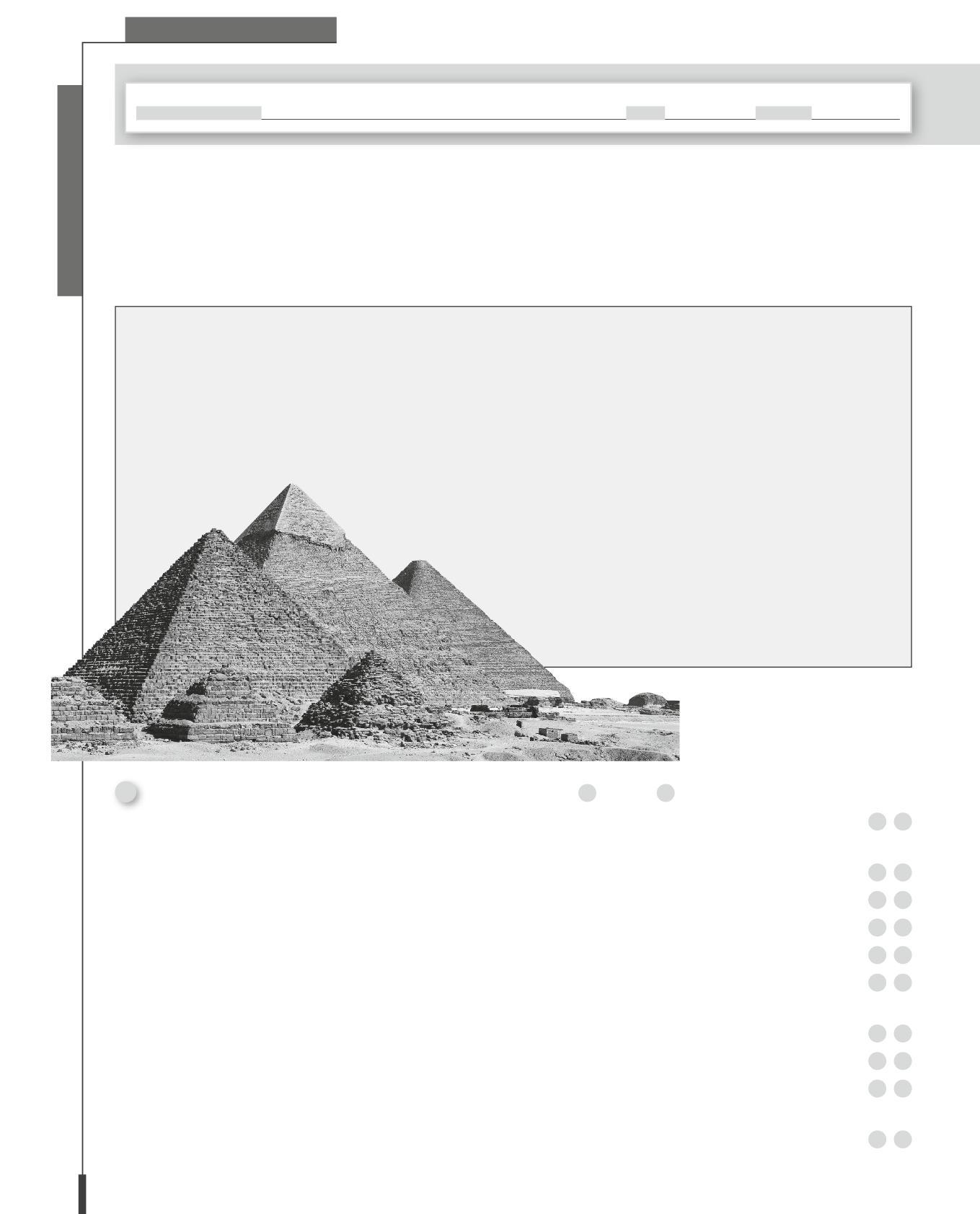
1 Indica con una X se le seguenti affermazioni sono vere V o false F .
• Lo storico greco Erodoto visse ai tempi della costruzione della piramide di Cheope.
• Tutte le sue affermazioni sono sicuramente vere perché Erodoto ha assistito agli eventi di persona.
• Il faraone Cheope obbligò tutti a lavorare per lui.
• Le grosse pietre con cui fu costruita la piramide arrivavano dall’Arabia.
• Le pietre venivano trasportate su zattere.
• Per costruire la piramide bastò il lavoro di cinquemila uomini.
• Per costruire la strada lungo la quale venivano trascinate le pietre servirono tre mesi.
• Per erigere la piramide furono necessari venti anni.
• I talenti d’argento erano le monete con cui fu acquistato cibo per i lavoratori. V F
• Per la costruzione della strada prima e della piramide poi furono impiegati trent’anni di lavoro.
NOME E COGNOME DATA CLASSE
LA CIVILTÀ DELL’INDO
1 Dove fiorì la civiltà dell’Indo? Colora sulla carta in azzurro il fiume Indo e in verde il territorio abitato e coltivato, cioè quello intorno al fiume.
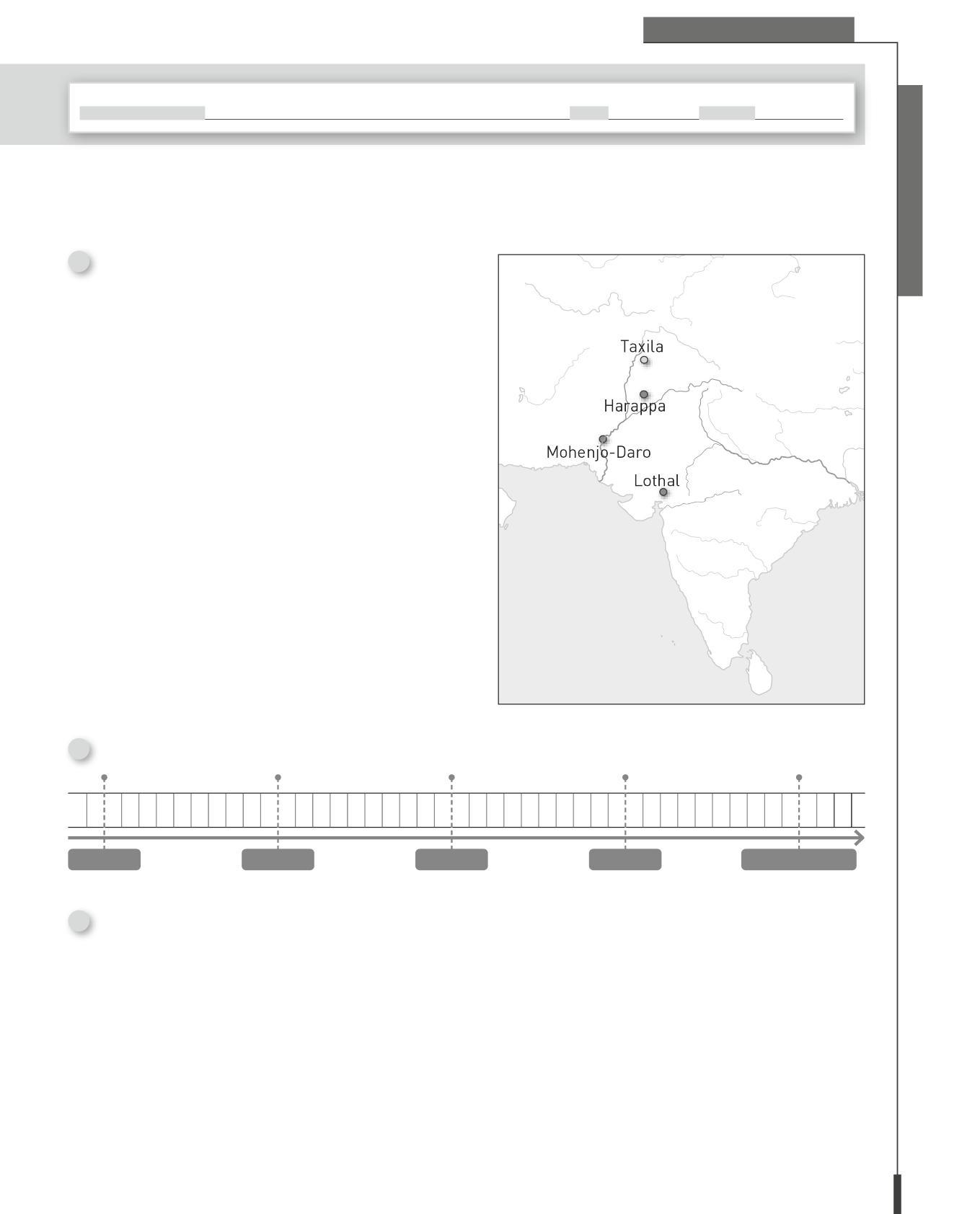
2 Osserva la linea del tempo, poi colora la durata della civiltà dell’Indo.
3 Completa le frasi.
• La civiltà dell’Indo ebbe origine lungo le rive del fiume
• Questa civiltà scomparve .
• L’agricoltura si sviluppò grazie a diversi fattori:
• I contadini coltivavano
• Il terreno argilloso e l’abbondanza di legname servirono per
• Altre attività furono .
OBIETTIVI: Leggere una carta storico-geografica. • Leggere la linea del tempo. • Conoscere gli aspetti essenziali della civiltà dell’Indo.
LA CIVILTÀ DELL’INDO
1 Collega ogni immagine alla descrizione corrispondente.
Gli artigiani producevano gli oggetti per la vita quotidiana con l’argilla e gli oggetti ornamentali con il metallo e le pietre preziose.
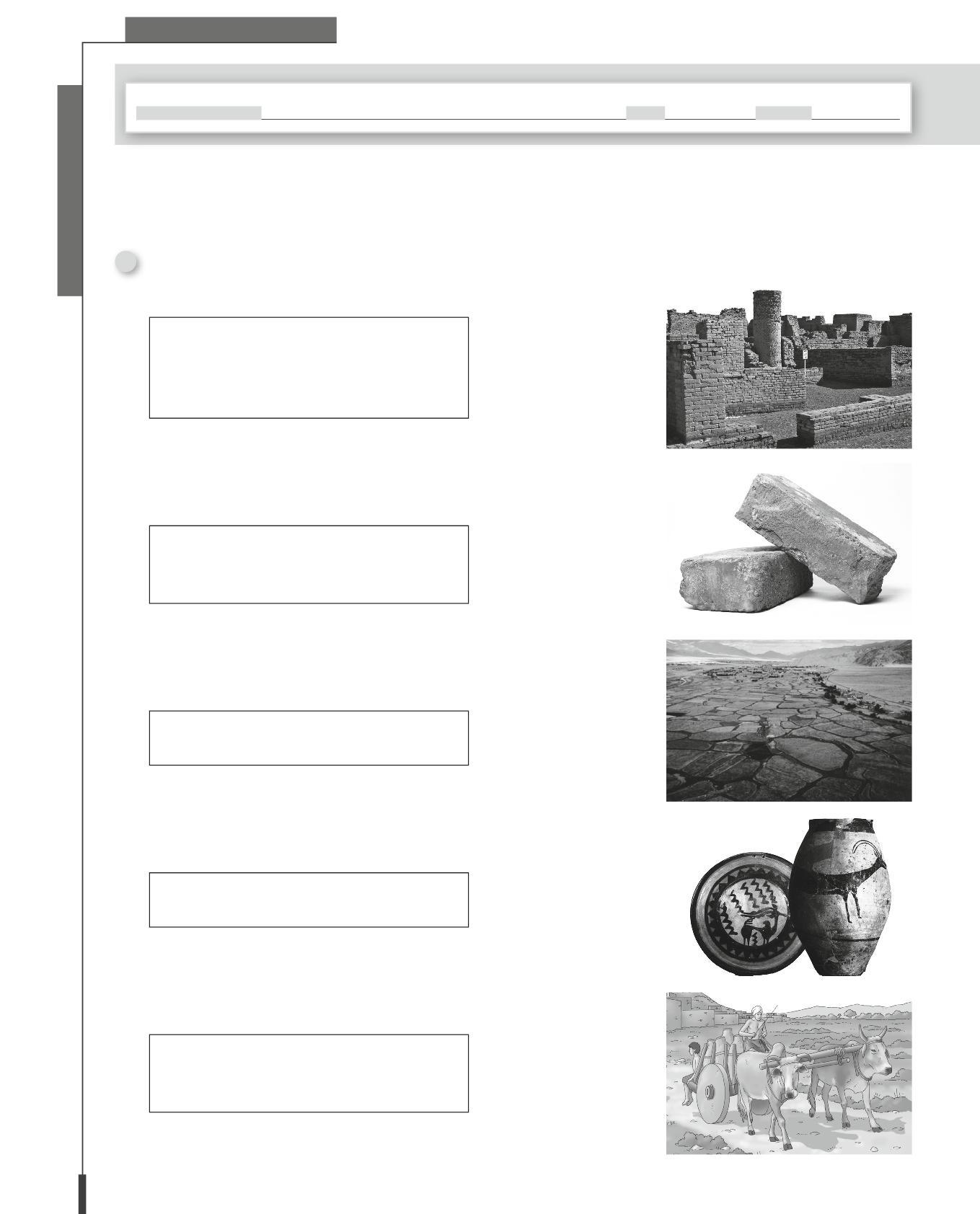
I mercanti scambiavano cereali e cotone in eccesso con metalli e pietre preziose.
Con l’argilla del fiume preparavano mattoni per costruire gli edifici.
Vicino al fiume Indo sono stati ritrovati resti di città ricche e molto sviluppate.
Gli abitanti sapevano controllare le acque del fiume e coltivavano grano, orzo, legumi, riso e cotone.
OBIETTIVI: Conoscere gli aspetti essenziali della civiltà dell’Indo. • Mettere in relazione testo e immagini.
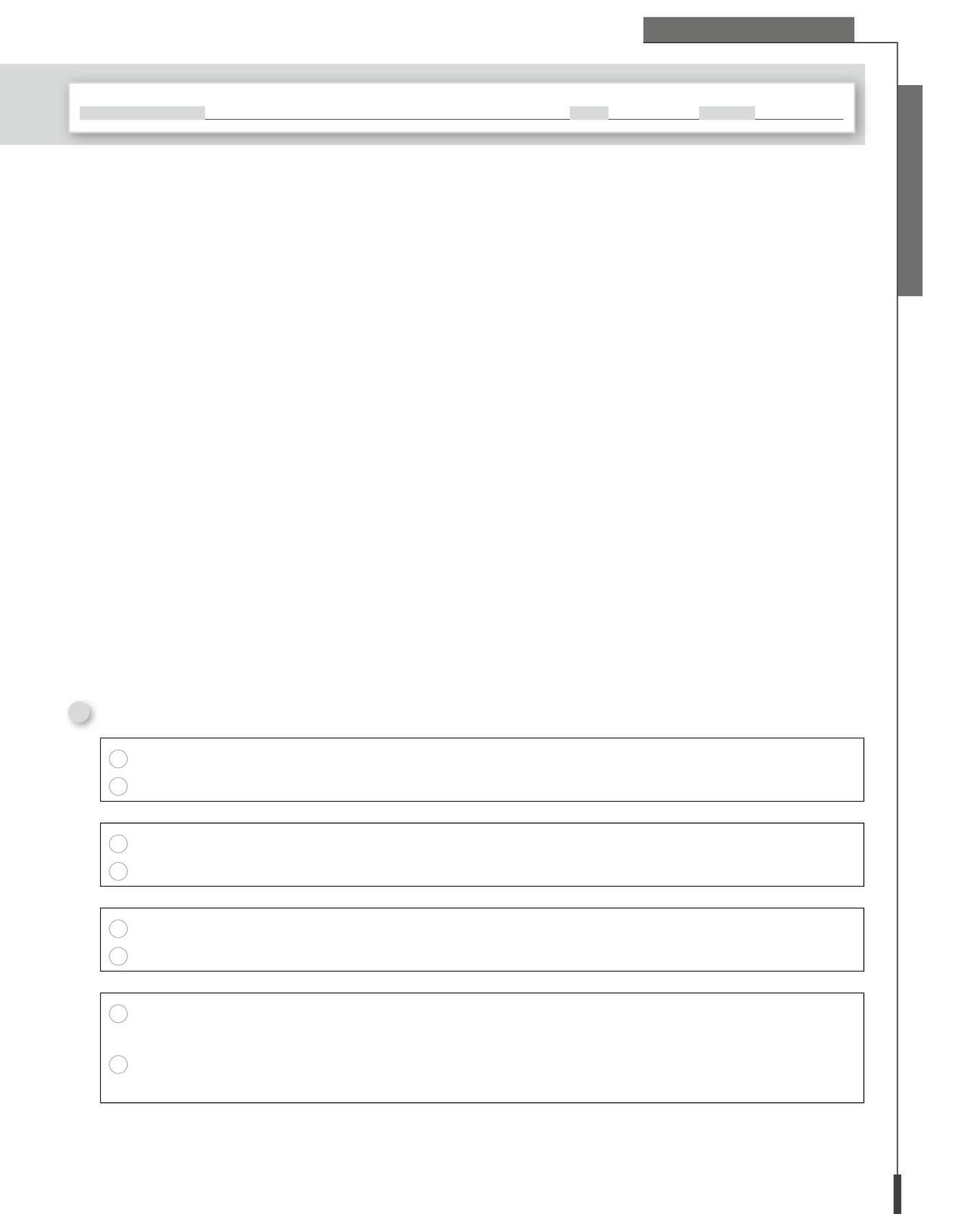
UNA BARZELLETTA DELLA VALLE DELL’INDO
Nelle antiche città ritrovate nella valle dell’Indo tutto era costruito con mattoni di argilla cotta. Tra gli archeologi impegnati negli scavi circolava una barzelletta.
Un ragazzino dell’antica Harappa entra in casa e dice: “Mamma, ho fame; dammi un po’ di pane!” La mamma risponde: “Oggi non si mangia: ho il forno pieno di mattoni in cottura…”.
Forse nella battuta c’è un pizzico di verità. Queste genti hanno davvero patito la fame “per colpa” dei mattoni.
Soprattutto a Harappa si ha l’impressione di trovarsi di fronte a una città industriale dove bisognava produrre in particolare mattoni e oggetti di ceramica.
In passato nella valle dell’Indo c’erano fitti boschi. Bruciando quegli alberi gli uomini hanno cotto innumerevoli mattoni. Abbattendo quei tronchi gli uomini hanno potuto venderne con profitto il legno pregiato ad altri popoli. Bruciando i boschi sono state ampliate le zone coltivabili. Il disboscamento ha avuto notevoli conseguenze: le piene del fiume si sono fatte più frequenti. Per prevenire i disastri occorrevano nuove opere di protezione, dunque nuovi mattoni, nuovi alberi abbattuti… fino all’impoverimento dell’ambiente.
Furono queste le cause dell’abbandono di quelle terre? È un’ipotesi. Quello che si sa con certezza è che la “nuova” civiltà indiana si sviluppò nella piana del fiume Gange e dei suoi affluenti… ma questa è un’altra storia di un’altra civiltà.
adatt. da G. Panini, Il grande libro delle civiltà antiche, Mondadori
1 Per ogni coppia di affermazioni indica con una X quella corretta.
Nelle città della valle dell’Indo, come Harappa, c’erano molte costruzioni in mattoni.
Le città della valle dell’Indo avevano molti spazi verdi e pochi edifici.
Nella valle dell’Indo non c’erano zone boscose.
In passato nella valle dell’Indo c’erano fitti boschi che sono stati bruciati.
Il disboscamento non ha avuto conseguenze sull’ambiente.
A causa del disboscamento è probabile che ci siano state frequenti inondazioni.
L’ipotesi del testo è che le città dell’Indo siano state abbandonate perché l’ambiente si era impoverito.
È sicuro che le città della valle dell’Indo sono state abbandonate perché l’ambiente non era più favorevole.
LA CIVILTÀ CINESE
1 Dove vissero gli antichi Cinesi?
Ripassa sulla carta il Fiume
Giallo in giallo e il Fiume
Azzurro in azzurro.
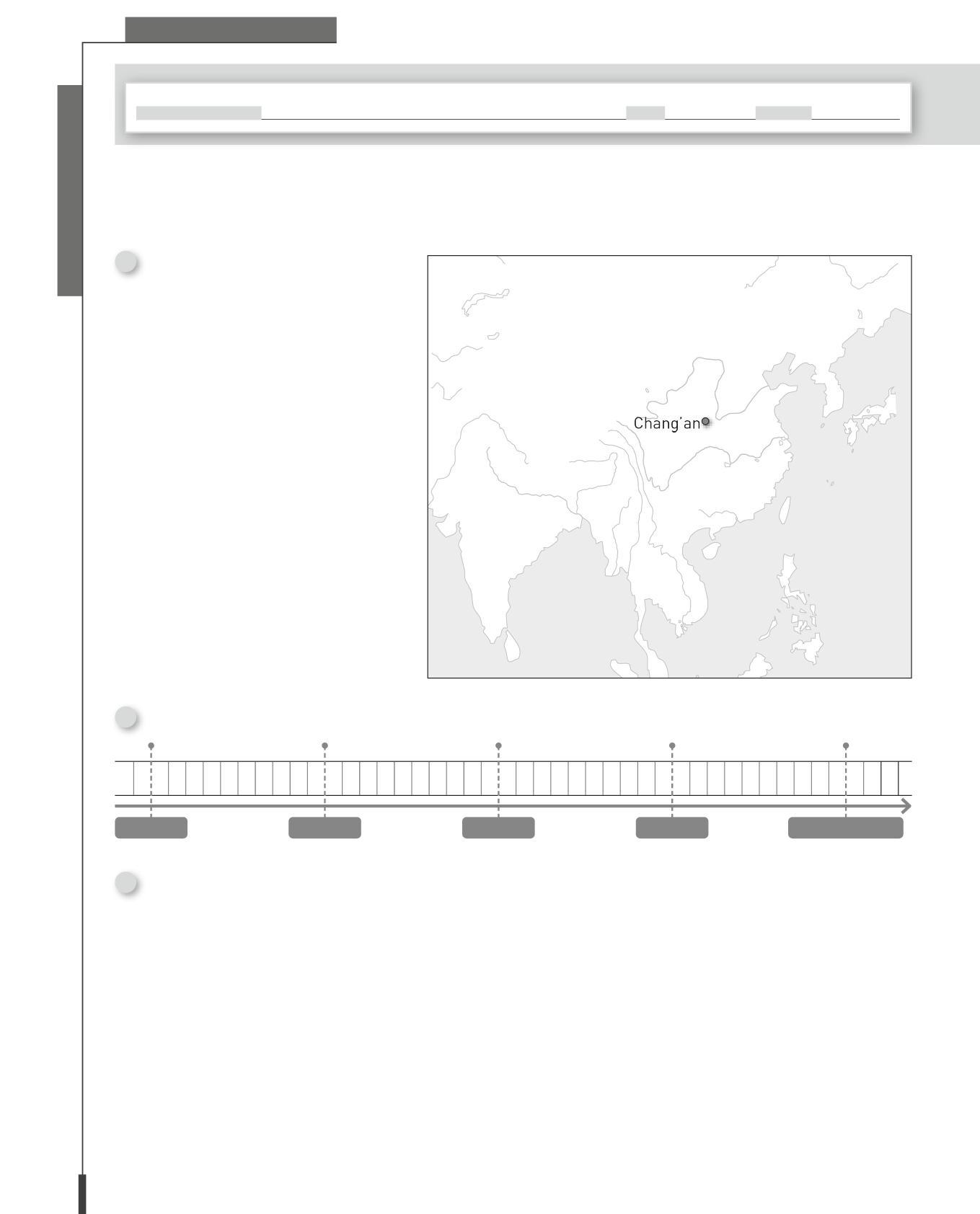
2 Colora sulla linea del tempo la durata della civiltà degli antichi Cinesi.
3 Completa le frasi.
• La civiltà cinese ebbe origine lungo le rive del Fiume Giallo, chiamato così perché
• Essi erano esperti nelle costruzione di canali per
• I Cinesi coltivavano
• Tra i Cinesi c’erano abili artigiani:
• Le invenzioni e conoscenze per cui sono ricordati sono:
• La loro scrittura era ed è ancora
OBIETTIVI: Leggere una carta storico-geografica. • Leggere la linea del tempo. • Conoscere gli aspetti essenziali della civiltà cinese.
NOME E COGNOME DATA CLASSE
LA CIVILTÀ CINESE
1 Completa le didascalie con le parole seguenti.
armi • Azzurro • ceramica • dighe • Giallo • ideogrammi • pittogrammi • seta • terrazzamenti
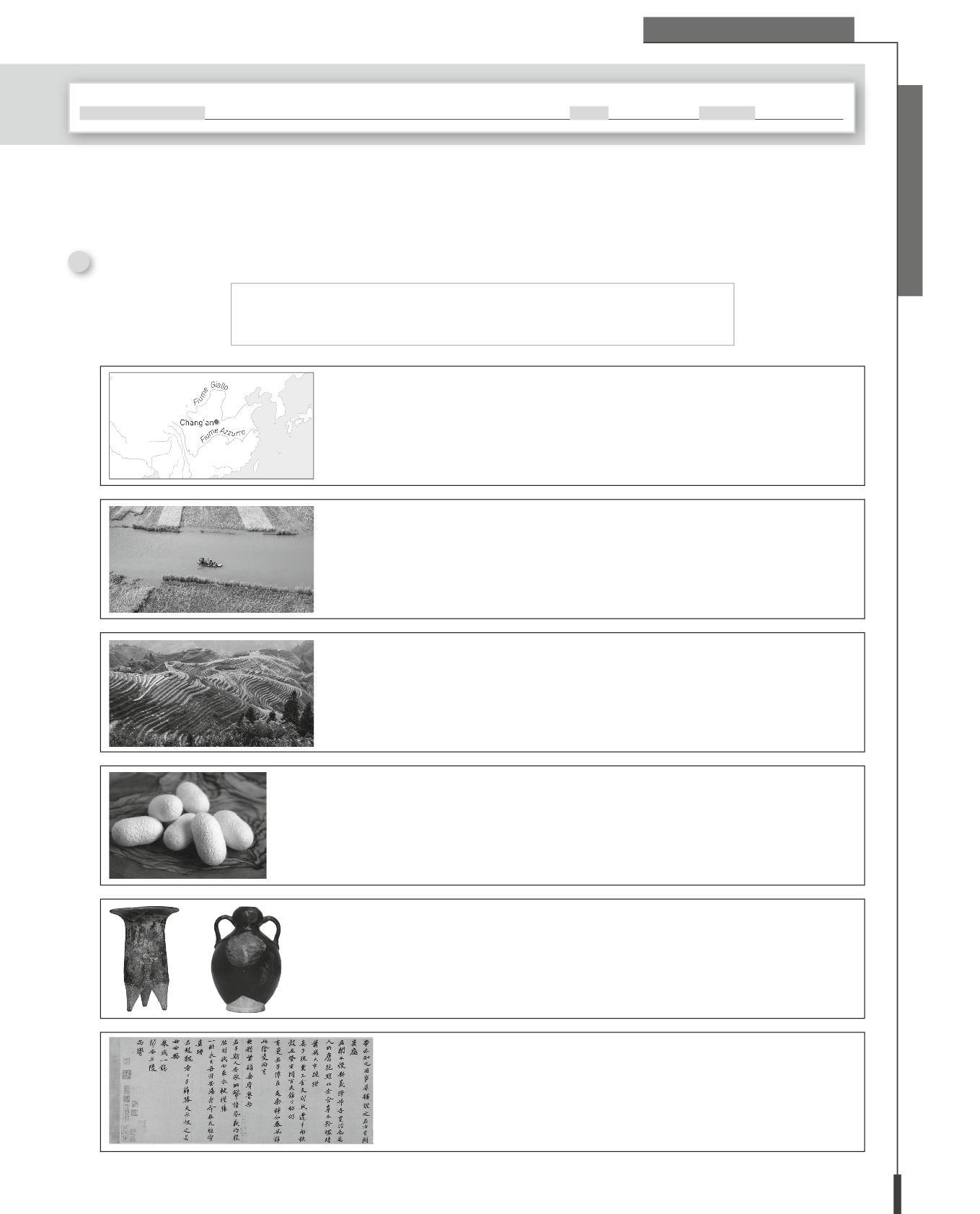
La civiltà cinese ebbe origine nelle valli dei fiumi e
I Cinesi controllavano le acque dei fiumi con canali e
Per rendere coltivabili i pendii delle montagne essi costruirono .
I Cinesi bachi da per produrre fili usati per tessere stoffe preziose.
I Cinesi erano ottimi artigiani: fabbricavano contenitori in , vasi, , attrezzi agricoli.
La loro scrittura era formata da , cioè disegni realistici, che poi diventarono , cioè disegni più semplici e stilizzati.
OBIETTIVI: Conoscere gli aspetti essenziali della civiltà cinese. • Mettere in relazione testo e immagini.

UN’INVENZIONE DEI CINESI: LA CARTA
La carta fu inventata dai Cinesi nel II secolo a.C. Era preparata con fibre di canapa e risultava ruvida e poco adatta alla scrittura. I Cinesi continuarono quindi per molto tempo a scrivere su seta, gusci di tartaruga, tavolette di legno, strisce di bambù, piccole lamine di metallo.
Oltre 300 anni dopo, all’inizio del II secolo d.C., fu perfezionata la tecnica della lavorazione e si riuscì a fabbricare una carta sottile, di qualità migliore.
Per prima cosa si mettevano a macerare in acqua e amido le fibre della canapa; l’impasto veniva messo a essiccare in uno strato sottile sopra un setaccio; una volta secco, veniva pressato e lisciato.
Nei secoli successivi vennero adoperate anche altre materie prime: corteccia d’albero, stracci, canna d’India e bambù.
Nel resto del mondo si imparò a fabbricare la carta molti secoli più tardi. In Italia, per esempio, la lavorazione cominciò a Fabriano nel 1276, cioè più di mille anni dopo!
1 Indica con una X il completamento corretto di ogni frase. Prima di rispondere alle domande, sottolinea nel testo le parole che possono esserti utili per individuare la soluzione.
• La carta inventata dai Cinesi nel II secolo a.C. era: ruvida e poco adatta alla scrittura. sottile, di buona qualità.
• Fino al II secolo d.C. i Cinesi scrivevano: su seta, gusci di tartaruga, tavolette di legno, strisce di bambù, piccole lamine di metallo. su carta preparata con filo di canapa.
• Le fasi della lavorazione della carta, in ordine, erano le seguenti: essiccazione, macerazione, pressatura e lisciatura. macerazione, essiccazione, pressatura e lisciatura.
• Nei secoli successivi per fare la carta vennero adoperati anche: corteccia d’albero, stracci, canna d’India e bambù.
seta, gusci di tartaruga, piccole lamine di metallo.
• Nel resto del mondo si imparò a fabbricare la carta:
circa 100 anni dopo. circa 1000 anni dopo.
NOME E COGNOME DATA CLASSE
LE CIVILTÀ DEI FIUMI A CONFRONTO
1 Indica con una X se le affermazioni riguardano la Mesopotamia, l’Egitto, la civiltà dell’Indo o l’antica Cina.
MesopotamiaEgitto Civiltà dell’Indo Antica Cina
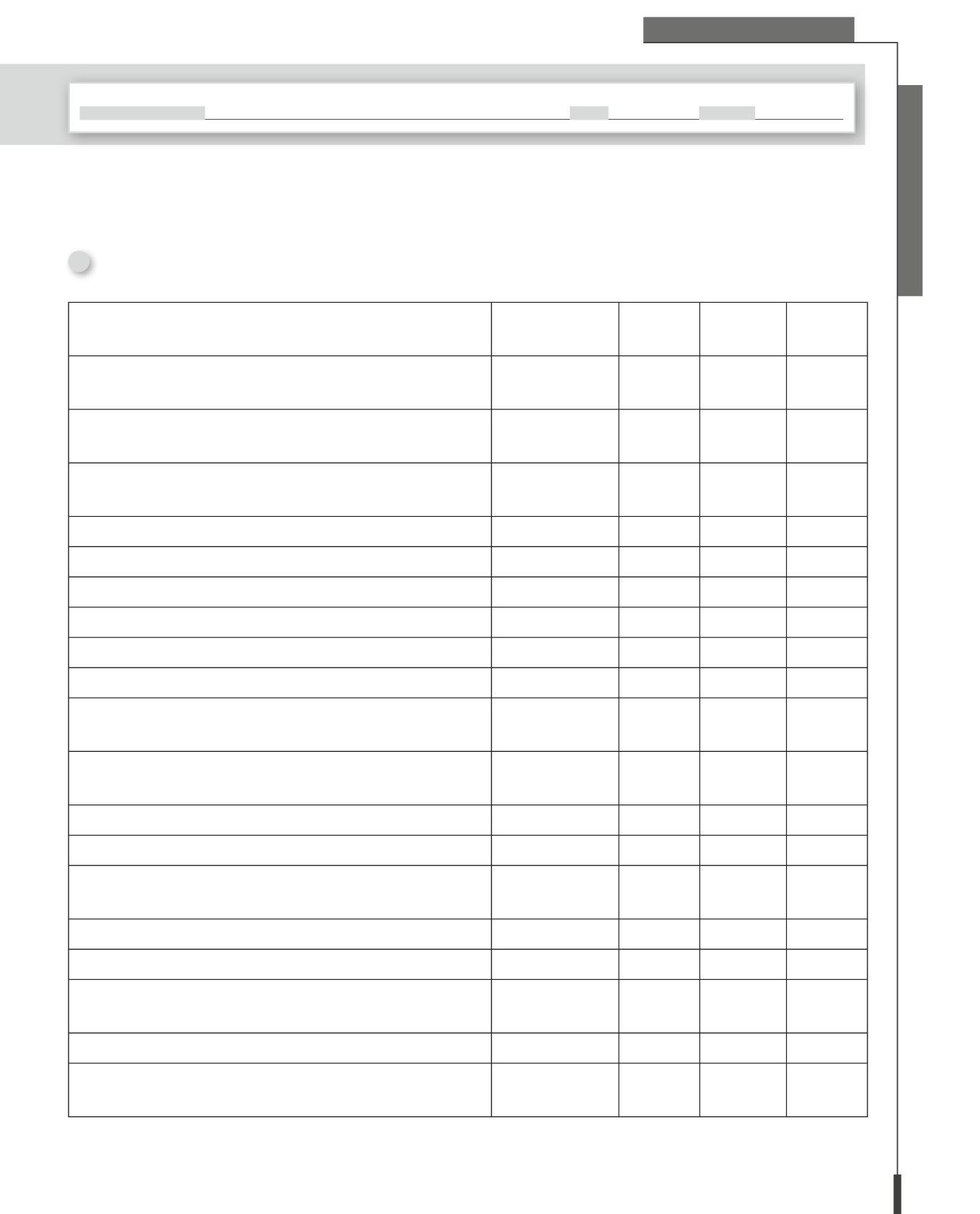
La civiltà si sviluppò nella terra attraversata dal Tigri e dall’Eufrate.
La civiltà si sviluppò nella zona che attualmente si trova tra Pakistan e India.
La civiltà si sviluppò prima lungo il Fiume Giallo e poi lungo il Fiume Azzurro.
La valle del Nilo fu la culla di questa civiltà.
I suoi abitanti impararono a produrre la seta.
I suoi abitanti furono i primi a fabbricare la carta.
Una delle sue più antiche città fu Ur.
Le città erano costruite con mattoni di argilla cotti.
Le città avevano un sistema di fognature.
Fu la prima civiltà ad avere una raccolta di leggi scritte.
Sono stati ritrovati sigilli di questa civiltà che servivano per marchiare le merci.
Il suo terreno era reso fertile dal limo.
Questa civiltà costruì la Biblioteca di Ninive.
La sua scrittura fu decifrata secoli più tardi, grazie alla Stele di Rosetta.
Questa civiltà usava la scrittura cuneiforme.
Gli abitanti scrivevano su fogli di papiro.
Uno dei suoi imperatori fece costruire la Grande Muraglia.
Vi si costruivano ziggurat.
Alcuni abitanti erano esperti nell’arte della mummificazione.
NOME E COGNOME DATA CLASSE
LA CIVILTÀ CRETESE
1 Dove vissero i Cretesi? Colora sulla cartina l’isola di Creta.
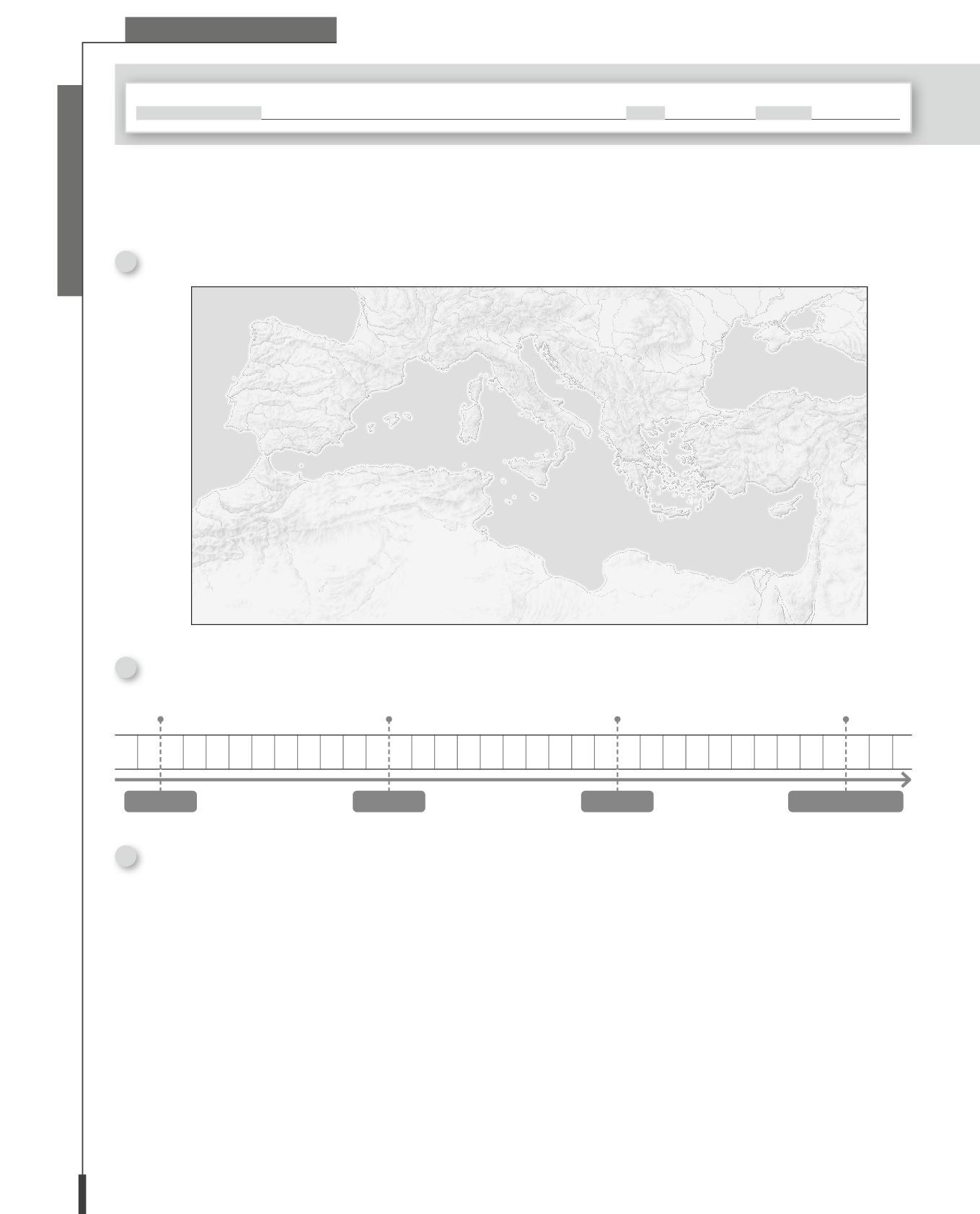
2 Colora con il rosa la durata della civiltà cretese sulla linea del tempo. Circonda con il rosso il periodo di massimo splendore (tra il 2000 e il 1450 a.C. circa).
3 Completa le frasi.
• Le città dei Cretesi sono chiamate città-palazzo perché
• Nel palazzo del re erano ospitati
• A capo della società cretese c’era
• I Cretesi furono soprattutto un popolo di : con il legno delle foreste dell’isola costruivano navi veloci con cui navigavano da marzo a ottobre.
• Essi furono anche un popolo di : erano molto abili nella fabbricazione di oggetti di ceramica.
• Furono anche : oltre agli oggetti di ceramica scambiavano gli altri loro prodotti, come cereali, legumi, olio d’oliva, tessuti.
• I Cretesi usavano tre tipi di scrittura:
OBIETTIVI: Leggere una carta storico-geografica. • Leggere la linea del tempo. • Conoscere gli aspetti essenziali della civiltà cretese.
NOME E COGNOME DATA CLASSE
LA CIVILTÀ CRETESE
1 Completa le didascalie con le parole seguenti.
botteghe • ceramica • commercio • isola • magazzini • metalli • navi • palazzo • re • scrittura
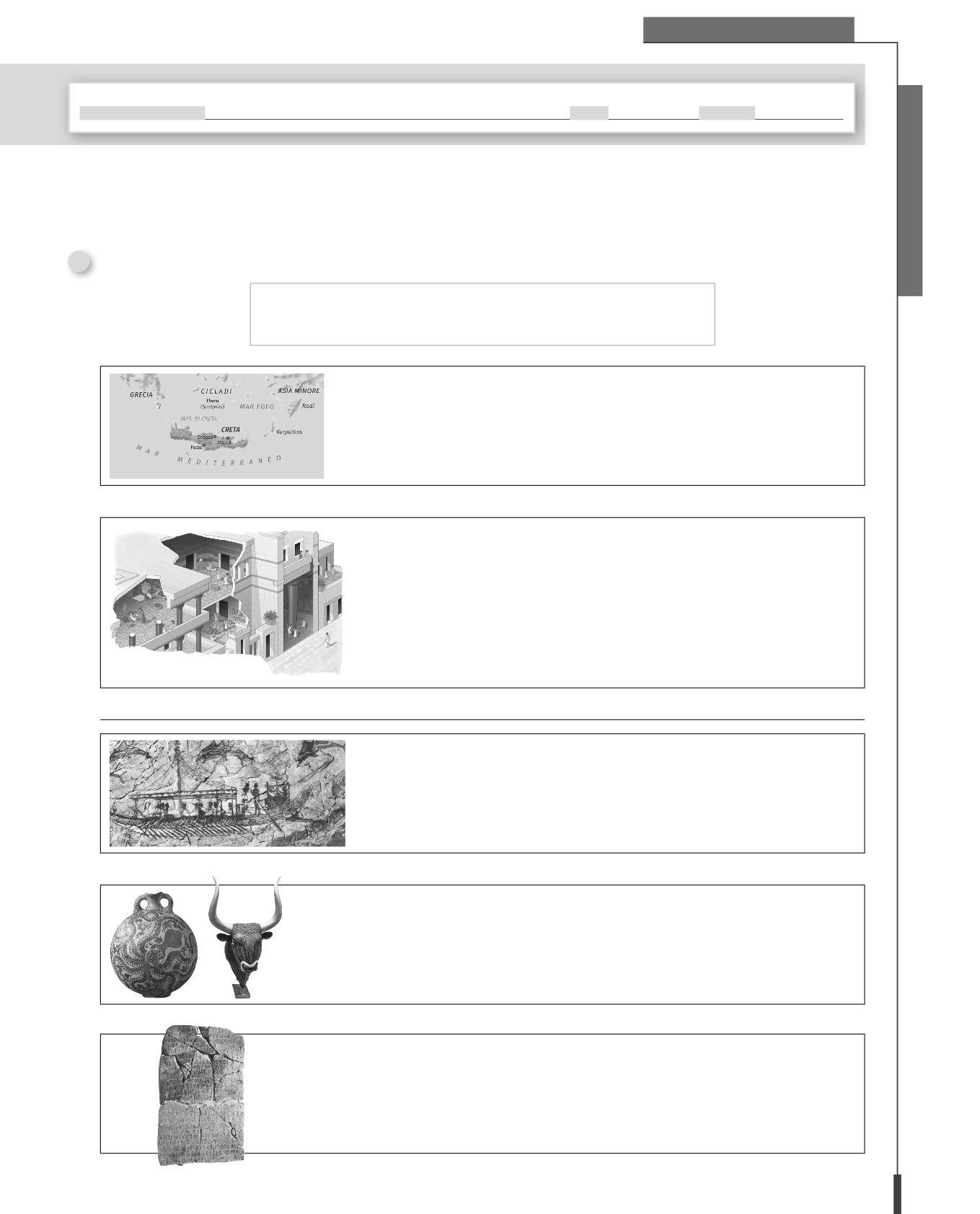
La civiltà cretese si sviluppò nell’ di Creta.
A Creta sorgevano numerose città, chiamate città- . Nelle città-palazzo c’erano le abitazioni del e della corte, ma anche i laboratori e le degli artigiani, oltre ai con le provviste.
Con il legno dell’isola i Cretesi costruivano robuste e veloci con cui svilupparono il dei loro prodotti.
I Cretesi esportavano tazze e vasi in e importavano come stagno e rame con cui fabbricavano oggetti preziosi e armi.
I Cretesi utilizzavano tre tipi di la scrittura geroglifica, la Lineare A e la Lineare B.
OBIETTIVI: Conoscere gli aspetti essenziali della civiltà cretese. • Mettere in relazione testo e immagini.
Verifica di recupero
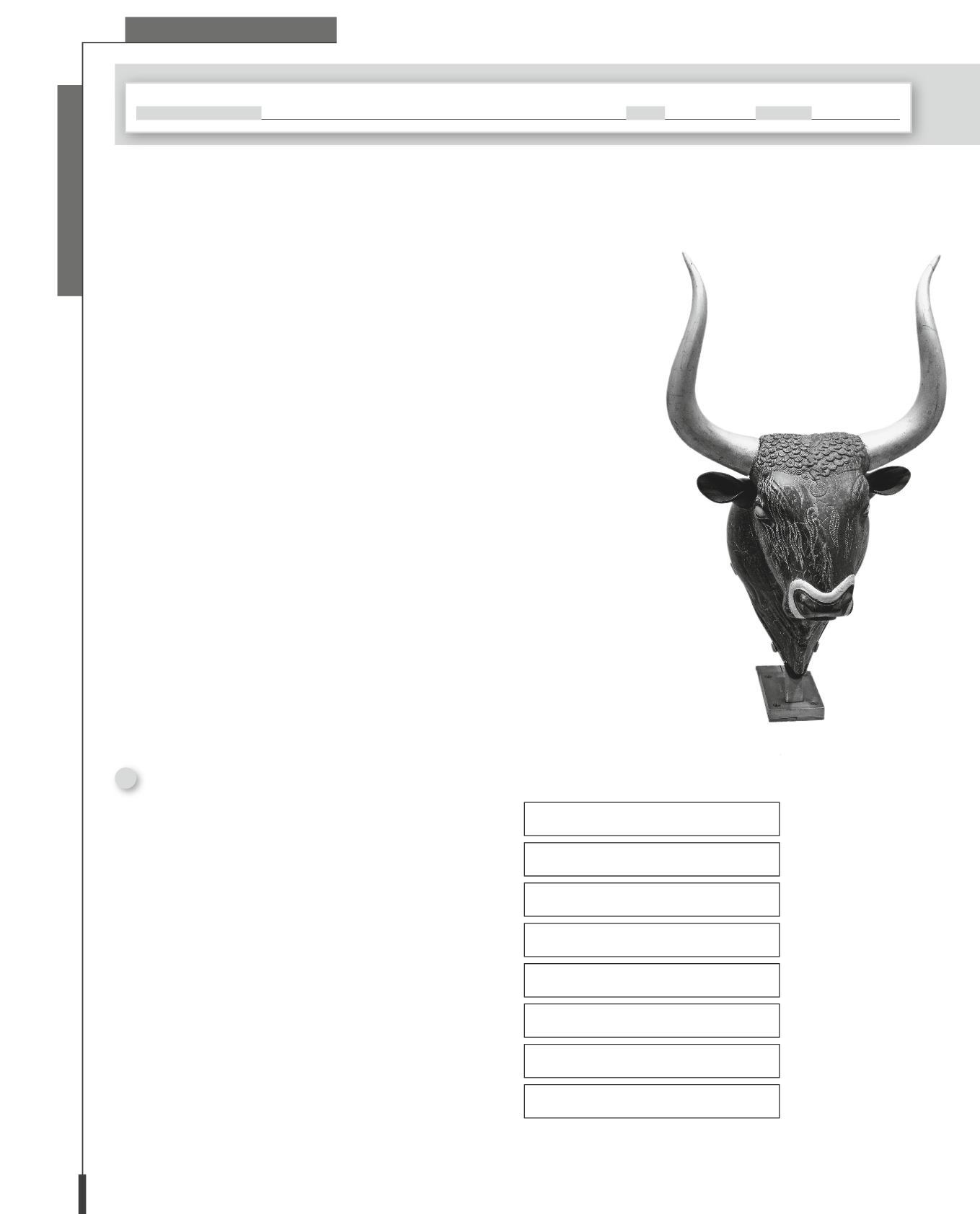
LA LEGGENDA DEL MINOTAURO
Una leggenda racconta che Zeus, il re degli dèi, si trasformò in toro e rapì una bellissima fanciulla che si chiamava Europa. Dalla loro unione nacque Minosse, che fu il primo re di Creta. Minosse e la moglie Pasifae ebbero un figlio con la testa di toro e il corpo umano: il Minotauro Egli era una creatura mostruosa che si nutriva di carne umana.
Il re Minosse incaricò quindi l’architetto Dedalo di costruire un palazzo in cui rinchiudere il Minotauro. Questo palazzo era un labirinto, formato da numerose stanze, corridoi, stradine e cortili così intrecciati che era impossibile uscirne.
Ogni otto anni la città di Atene era costretta a inviare a Creta sette ragazze e sette ragazzi da dare in pasto al Minotauro.
Per porre fine a questa prepotenza, Teseo, figlio del re di Atene, decise di affrontare e uccidere il Minotauro. L’impresa gli riuscì con l’aiuto di Arianna, figlia del re Minosse, che si era innamorata di lui.
Entrare nel palazzo, infatti, era facile, ma come uscirne? Per questo motivo Arianna consegnò a Teseo un gomitolo di filo perché, svolgendolo dietro di sé nel percorso di andata, potesse seguirlo per trovare la via d’uscita al ritorno Così Teseo entrò nel labirinto e, grazie al filo di Arianna, ritrovò l’uscita.
1 Scrivi il nome del personaggio a cui si riferiscono le affermazioni seguenti.
Il re degli dèi.
Una bellissima fanciulla rapita da Zeus.
Il primo re di Creta.
La moglie di Minosse.
Il figlio di Minosse e Pasifae.
L’architetto che costruì il labirinto.
Il figlio del re di Atene.
La figlia di Minosse.
NOME E COGNOME DATA CLASSE
LA CIVILTÀ FENICIA
1 Dove vissero gli antichi Fenici? Colora sulla cartina la Fenicia, scrivi il nome delle principali città fenicie e segna le rotte dei Fenici sul Mediterraneo.
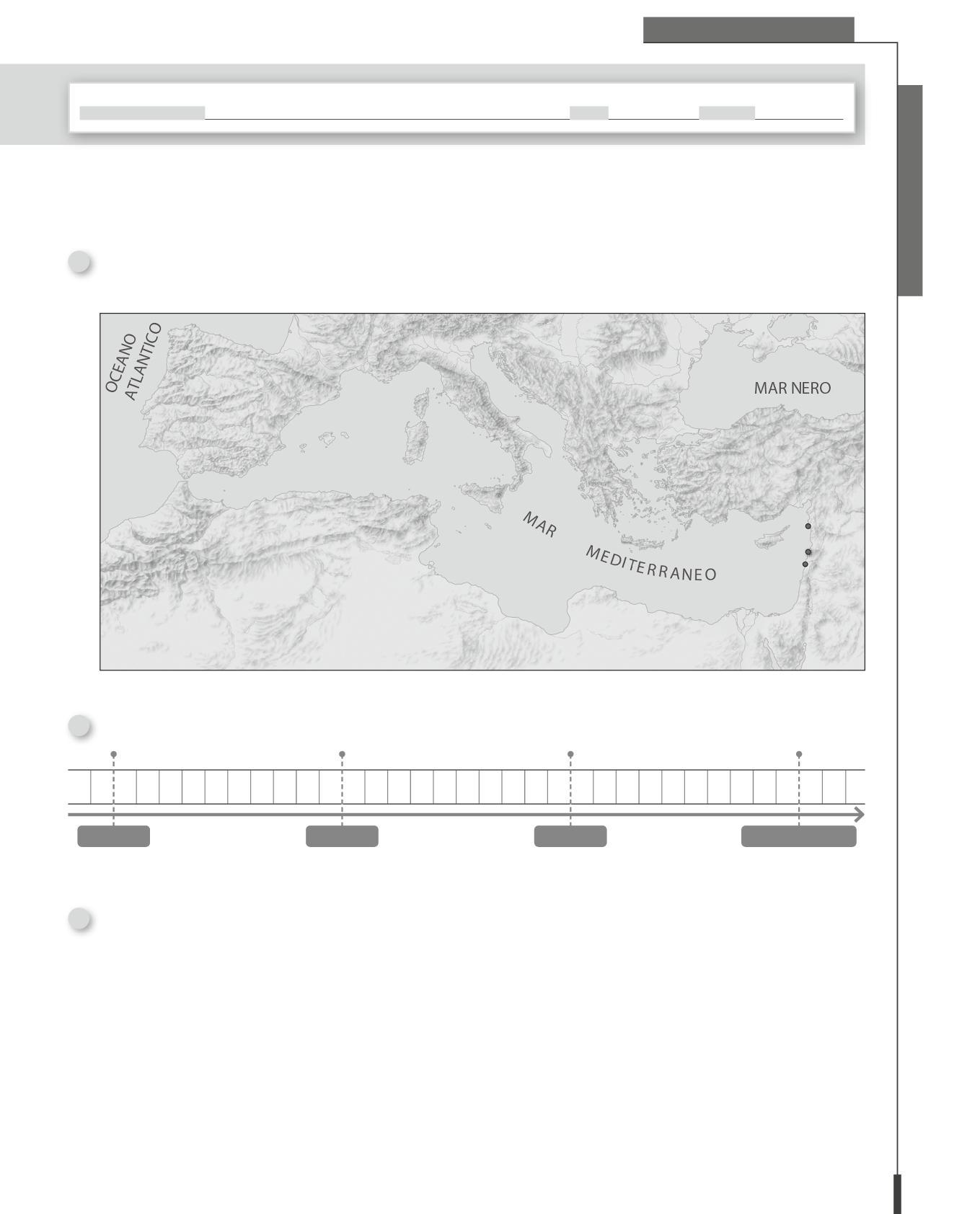
2 Colora sulla linea del tempo la durata della civiltà fenicia.
3 Completa le frasi.
• I Fenici erano organizzati in
• Essi furono un popolo di navigatori:
• Furono anche un popolo di mercanti:
• I Fenici erano chiamati “uomini di porpora” perché
• Erano artigiani assai abili nella soffiatura
• Fondarono le colonie perché
• I Fenici inventarono la scrittura alfabetica:
OBIETTIVI: Leggere una carta storico-geografica. • Leggere la linea del tempo. • Conoscere gli aspetti essenziali della civiltà fenicia.
LA CIVILTÀ FENICIA
1 Osserva le immagini e leggi le frasi. Poi scrivi di quale elemento caratteristico della civiltà dei Fenici si tratta.
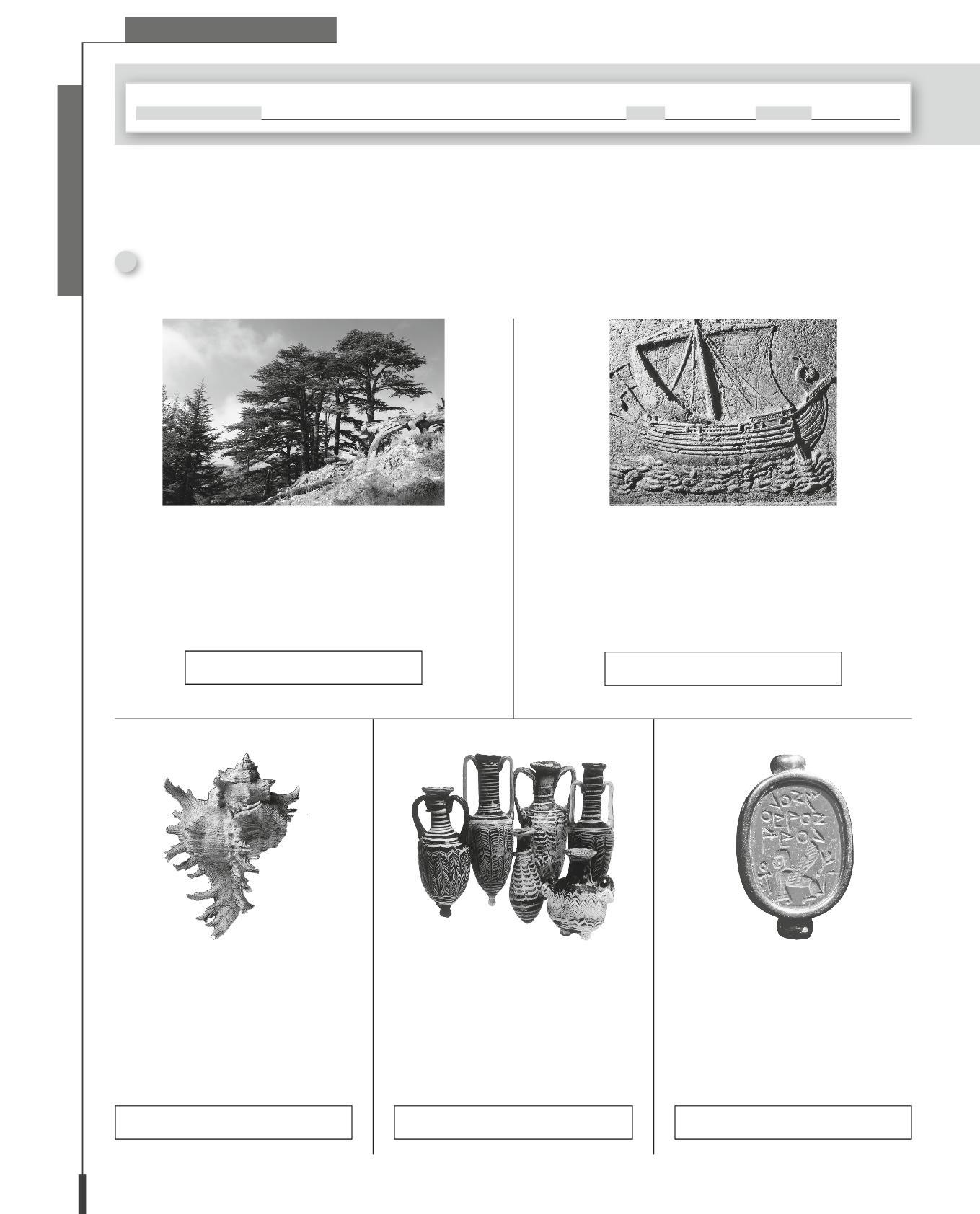
• Un prodotto che abbondava nell’antica Fenicia.
• Proveniva dai boschi ora scomparsi.
• Serviva per costruire navi.
• Erano usate per trasportare le merci o per la guerra.
• Avevano vele e remi, perciò erano veloci.
• Riuscivano a navigare anche in mare aperto.
• Era uno dei prodotti più ricercati.
• Si ricavava da un mollusco.
• Serviva per tingere le stoffe di rosso.
• Avevano imparato a produrlo da altri popoli.
• Con esso fabbricavano oggetti fragili e molto belli, come vasi e ciondoli per le collane.
• Serviva per scrivere in modo semplice.
• Era formato solo da consonanti.
• Si scriveva da destra a sinistra.
OBIETTIVI: Leggere una carta storico-geografica. • Leggere la linea del tempo. • Conoscere gli aspetti essenziali della civiltà fenicia.
I FENICI, OTTIMI COLONI
1 Leggi il testo su come i Fenici diffondevano le loro abilità artigianali.
I Fenici non furono solo grandi navigatori, ma anche ottimi coloni. Nelle regioni in cui approdavano e fondavano le loro città creavano laboratori per la lavorazione del bronzo e della ceramica, della pasta di vetro e delle stoffe dipinte.
In particolare divennero ricercatissime le loro vesti dipinte con la porpora, che ottenevano da una conchiglia.
Sui luoghi delle loro colonie, infatti, gli archeologi hanno trovato enormi ammassi di queste conchiglie e scorie della lavorazione del bronzo e del vetro, che testimoniano l’esistenza di numerosi e vari tipi di laboratori fatti costruire dai colonizzatori. adatt. da R. Bosi, Il libro dell’archeologia, Fabbri
2 Ora rispondi alle seguenti domande.
• Che cosa facevano i Fenici quando fondavano le loro colonie?
• Tra i loro prodotti artigianali uno in particolare divenne ricercatissimo: quale?
• Che cosa hanno ritrovato gli archeologi sui luoghi delle loro colonie?
• Che cosa testimoniano questi ritrovamenti?
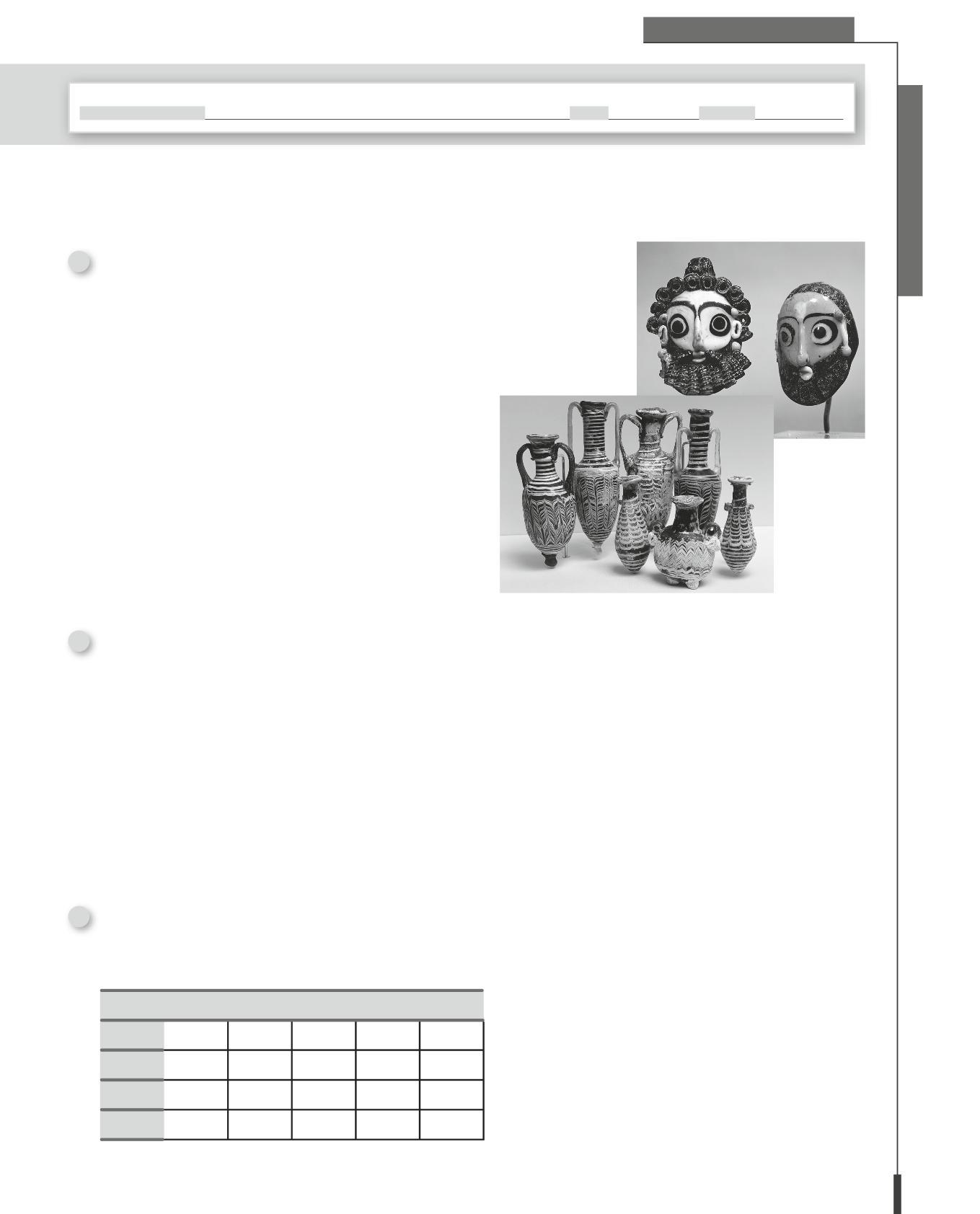
3 Cerchia le lettere che compaiono in tabella all’incrocio delle coordinate indicate. Uniscile e si formerà una parola, poi rispondi alle domande.
Che parola hai trovato?
• Da che cosa ricavavano i Fenici questo prodotto?
• Per che cosa lo utilizzavano?
NOME E COGNOME DATA CLASSE
GLI EBREI
1 Dove vissero gli antichi Ebrei? Colora sulla carta la Palestina.
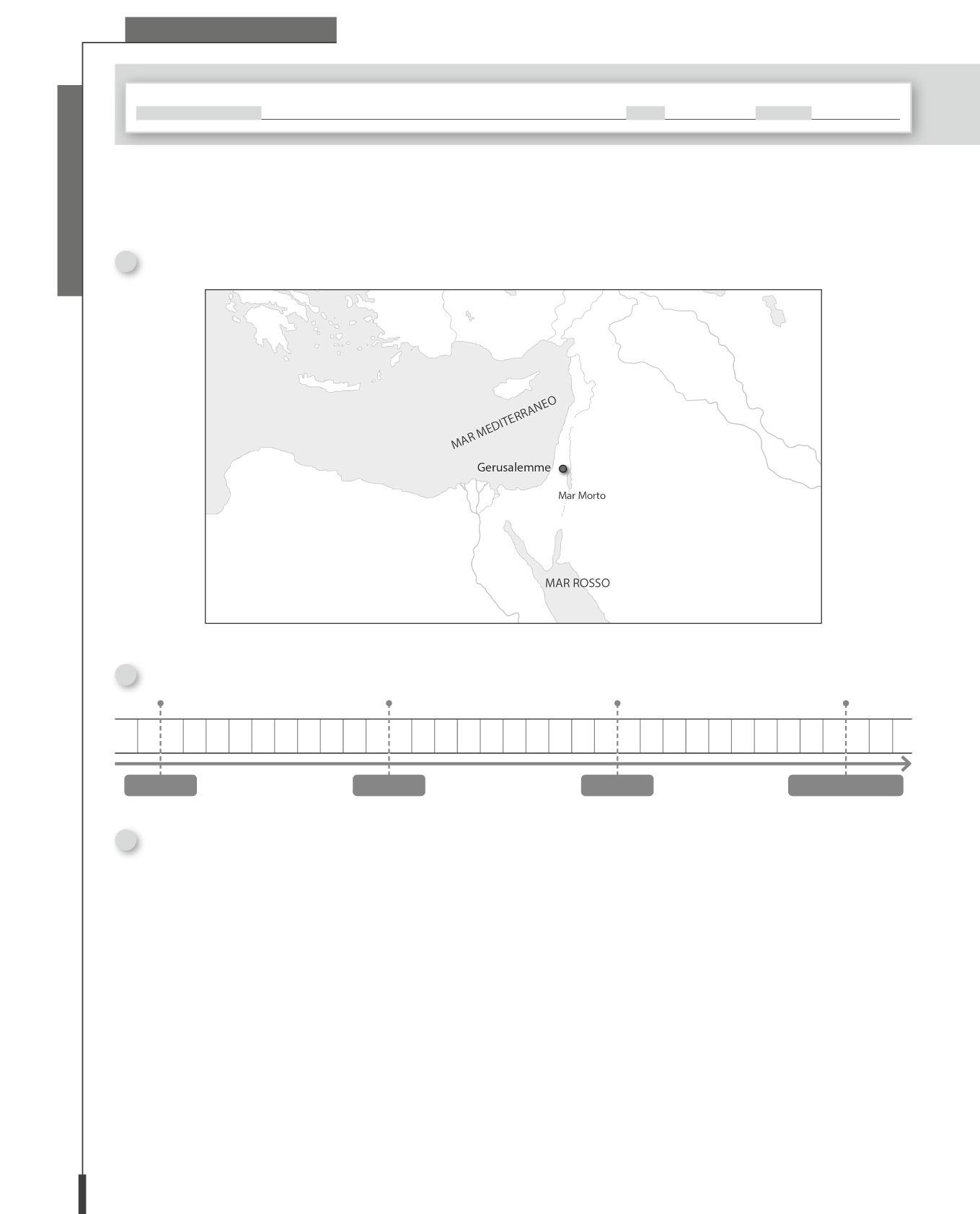
2 Quando vissero gli antichi Ebrei? Colora sulla linea del tempo la durata della civiltà ebrea.
3 Completa le frasi.
• Originariamente gli Ebrei furono un popolo nomade perché
• Una volta diventati un popolo sedentario, costruirono
• La famiglia era di tipo patriarcale, cioè
• Il patriarca era
• Furono un popolo monoteista, infatti
• Il testo sacro degli Ebrei, la Bibbia, contiene
• Come i Fenici, anche gli Ebrei usavano
NOME E COGNOME DATA CLASSE
GLI EBREI
1 Completa le frasi con le parole seguenti.
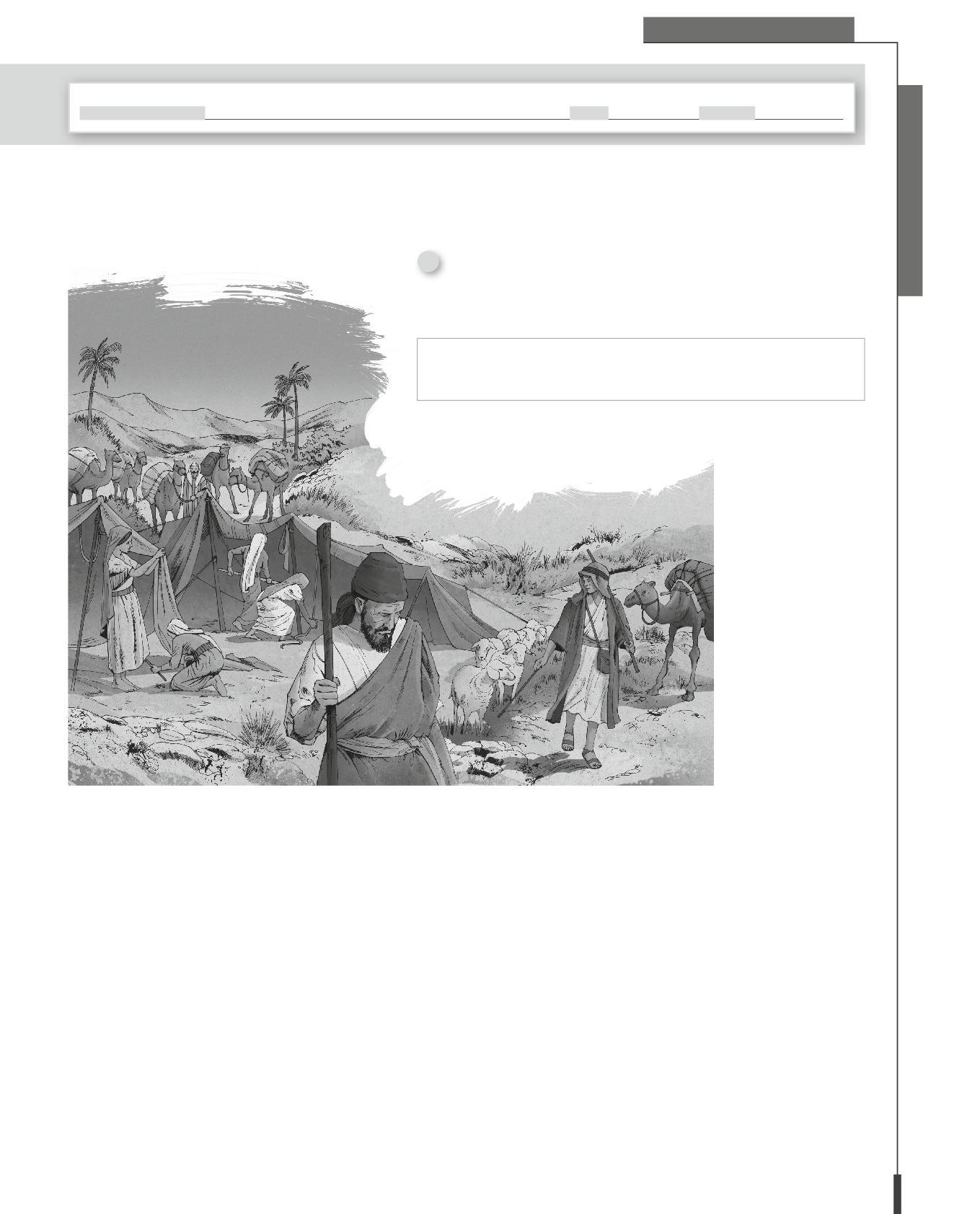
Bibbia • case • Dieci Comandamenti • Palestina • pastori • pozzo • schiavi • siccità • tende • vino
• Gli Ebrei erano che andarono in Palestina in cerca di terra da coltivare. Quando arrivavano in un posto, piantavano le e scavavano un per avere l’acqua.
• Dopo una lunga , la terra non produsse più nulla e il cibo iniziò a scarseggiare. Gli Ebrei andarono quindi in Egitto. Lì lavorarono quasi come
• Dopo un lungo viaggio, tornarono in e costruirono villaggi e città. Le avevano una sola stanza e avevano il tetto piatto.
• Il clima della Palestina era mite. Gli Ebrei poterono quindi coltivare il grano, e la vite per produrre il
• Il loro testo sacro è la . In questo libro sono narrate le vicende del popolo ebraico. La Bibbia contiene i , che sono un insieme di regole religiose e di condotta morale.
OBIETTIVI: Conoscere gli aspetti essenziali della civiltà degli Ebrei.
REGOLE DI COMPORTAMENTO NELLA BIBBIA
1 Nella Bibbia, oltre alla storia del popolo ebraico e alle leggi religiose, si trovano anche alcune regole di comportamento. Scrivi un titolo per alcune di queste regole, che trovi qui sotto.
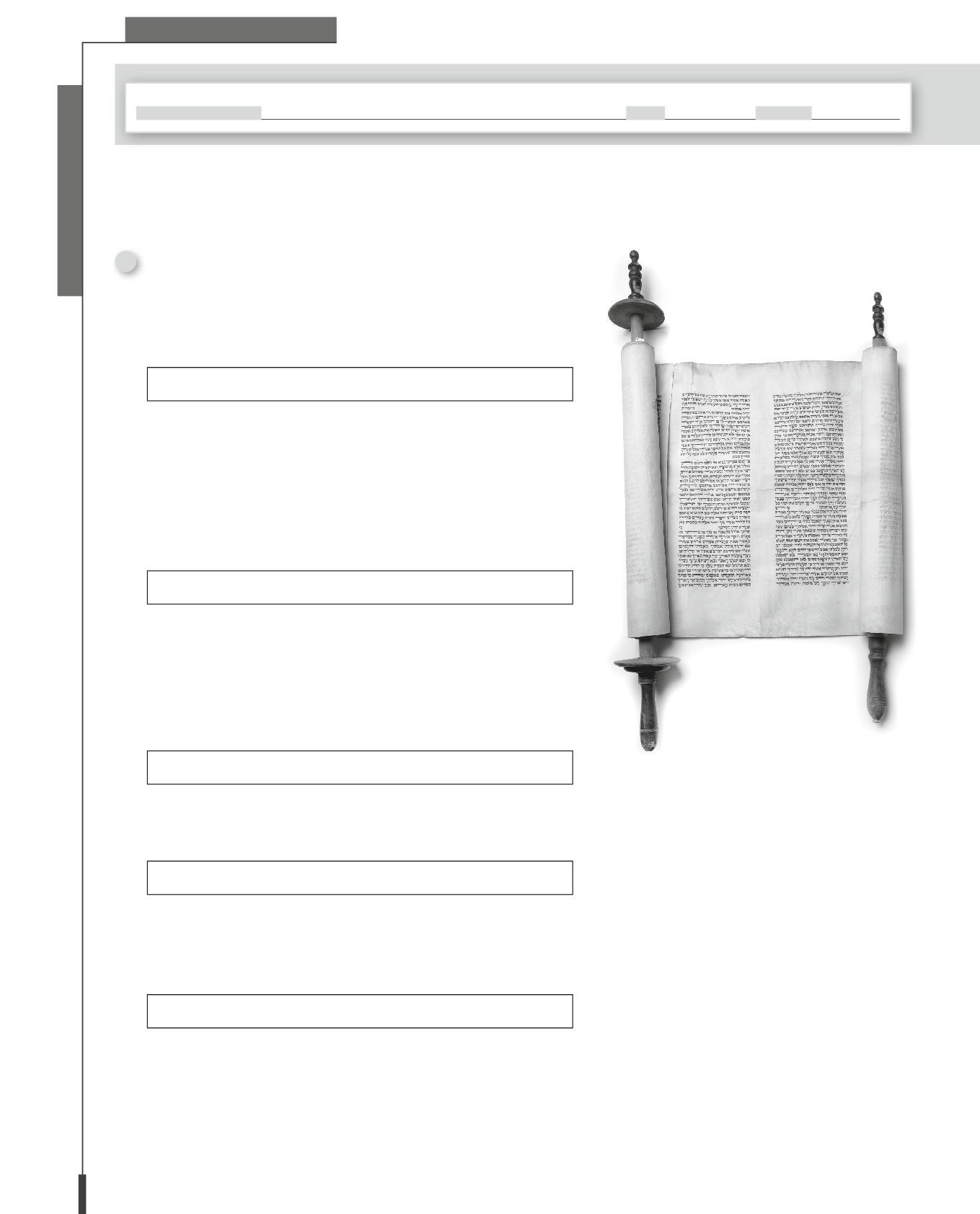
Il padre terrà presso di sé i figli, e le mogli dei figli, e i figli dei figli, e i discendenti, i nipoti e tutti i componenti della famiglia. A lui sarà riservato il massimo rispetto; e lui sarà il padrone di ogni cosa, colui che indicherà a tutti il giusto e l’ingiusto.
Se tu comprerai uno schiavo ebreo, il suo servizio durerà sei anni. Nel settimo anno potrà andarsene libero, senza compenso. Se è venuto solo, se ne uscirà solo; se era ammogliato, sua moglie uscirà con lui.
Non molestare il forestiero, né opprimilo, perché forestieri voi foste nel Paese d’Egitto.
Se presti denari ad alcuno del mio popolo, al povero tuo vicino, non ti comporterai con lui come un creditore; non gli imporrai usura.
Se togli in pegno il mantello del tuo prossimo, prima del tramontare del sole glielo restituirai; poiché è la sola sua coperta, la veste del suo corpo; in qual modo dormirebbe egli?
OBIETTIVI:
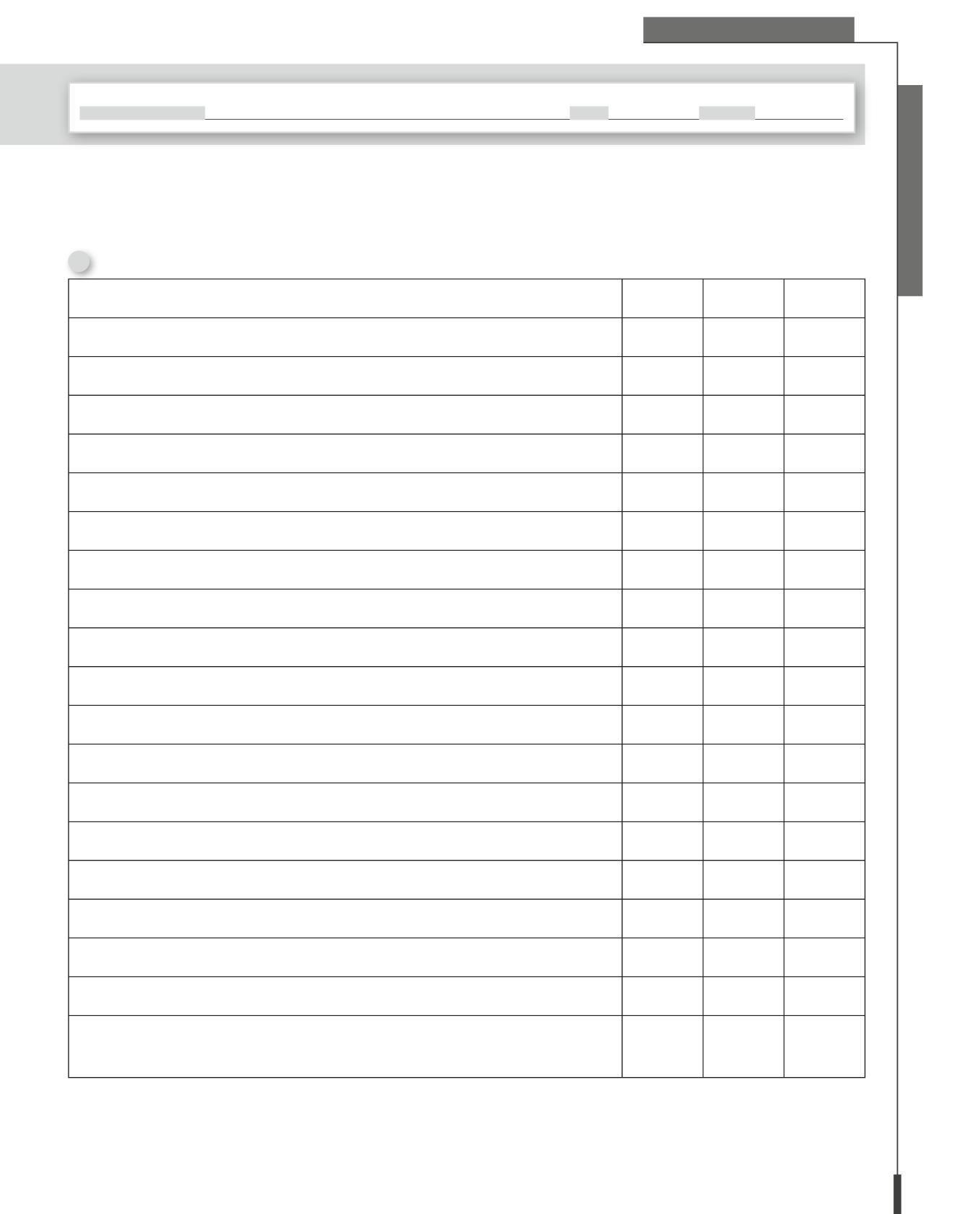
NOME E COGNOME DATA CLASSE
POPOLI IN VIAGGIO A CONFRONTO
1 Indica con una X quale delle caratteristiche elencate appartiene a ogni civiltà. CretesiFenici Ebrei
Vivevano in territori aridi e furono costretti spesso a una vita nomade.
La civiltà si sviluppò in un’isola del Mediterraneo.
Vivevano in una terra tra le montagne e il mare.
Abili navigatori, di notte seguivano la Stella Polare.
Furono monoteisti.
Le principali città erano Cnosso, Festo e Mallia.
Le città avevano grandi palazzi con pareti affrescate.
Furono costretti a disperdersi in tutto il mondo.
Al centro del palazzo di Cnosso si svolgevano feste e giochi.
Tingevano le stoffe di color rosso porpora.
Avevano nel Mar Mediterraneo molti scali per i loro commerci.
Erano bravi pescatori.
Si spostavano da un luogo all’altro in cerca di pascoli.
Diffusero l’alfabeto.
Non potevano realizzare dipinti o erigere statue.
Attraversarono il deserto per raggiungere la Palestina.
Inventarono strumenti per navigare meglio.
Dovevano seguire molte regole che erano scritte nel loro libro sacro.
Costruivano con il legname dell’isola navi con le quali raggiungevano i centri abitati del mar Egeo. OBIETTIVI: Individuare
NOME E COGNOME DATA CLASSE
LE CARTE GEOGRAFICHE
1 Collega ogni caratteristica delle carte geografiche alla sua spiegazione.
Le carte geografiche sono una rappresentazione del territorio:
… perché la superficie della Terra è sferica mentre la carta è piana.
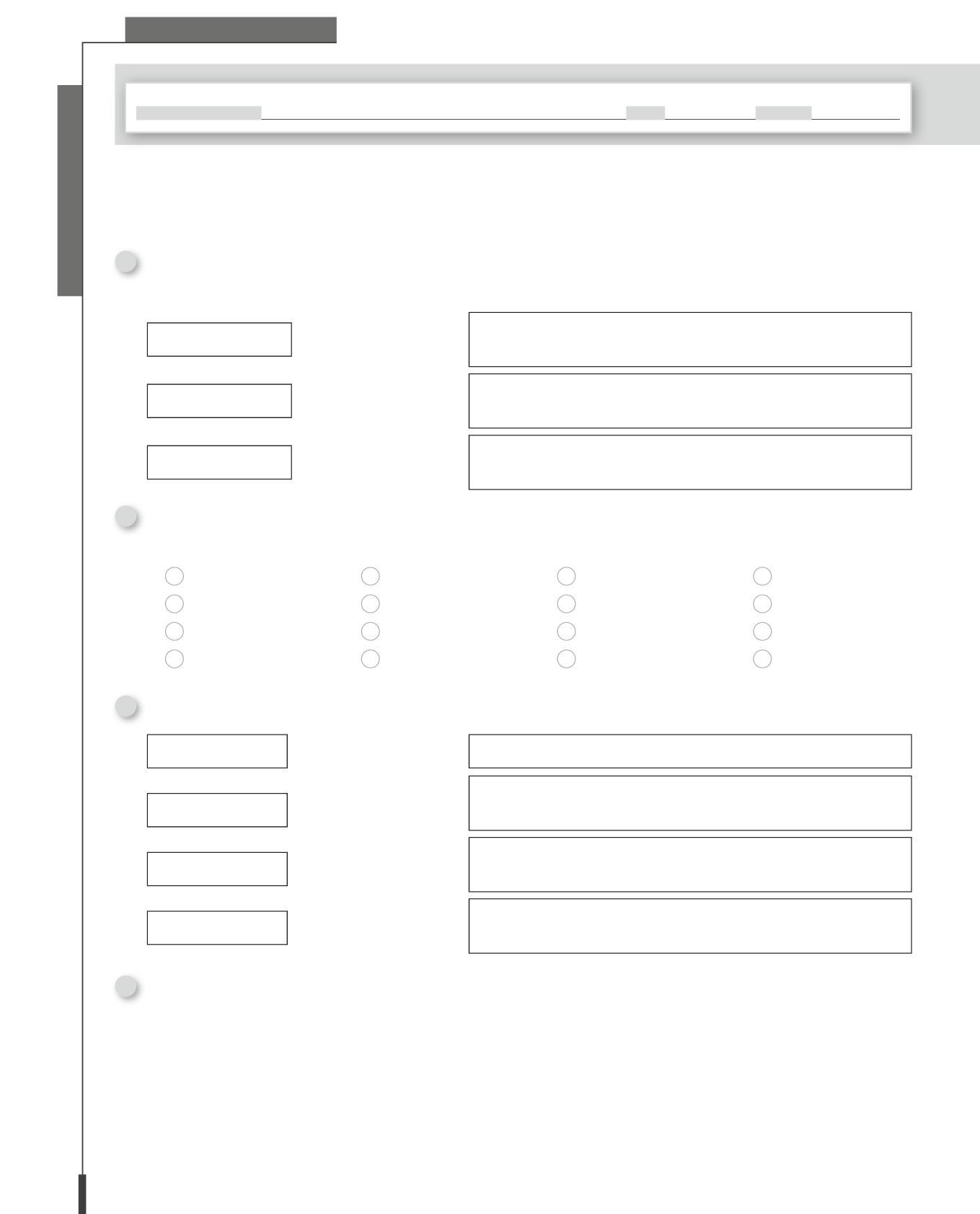
ridotta…
simbolica…
• Marrone: colline. montagne. pianure. acque.
… perché gli elementi del territorio sono indicati con simboli e colori convenzionali.
… perché non è possibile rappresentare una zona della Terra riproducendo le distanze reali sulla carta.
2 Indica con una X a che cosa corrisponde ogni colore nelle carte geografiche.
• Marrone chiaro: colline. montagne. pianure. acque.
3 Collega ogni termine alla sua definizione.
scala numerica
scala grafica
simbolo legenda
• Verde: colline. montagne. pianure. acque.
• Azzurro: colline. montagne. pianure. acque.
Segno grafico che rappresenta un elemento.
Tabella con spiegazioni che consentono di interpretare i simboli di una carta.
Indica attraverso i numeri quante volte è stata ridotta la rappresentazione del territorio.
Riga graduata che indica quanto è stata ridotta la rappresentazione del territorio.
4 Completa le frasi con il tipo di carta corretto.
• Nella carta sono rappresentati tutti gli elementi naturali del paesaggio.
• La carta rappresenta il territorio dal punto di vista amministrativo: confini, paesi, città…
• La carta rappresenta visivamente un fenomeno particolare o un argomento specifico.
• Il rappresenta su un piano tutta la superficie terrestre. approssimata…
OBIETTIVI: Classificare le carte geografiche. • Riconoscere gli elementi delle carte geografiche.
LE CARTE GEOGRAFICHE
1 Sottolinea l’alternativa corretta per completare il testo. Le carte geografiche sono una rappresentazione del territorio approssimata / ridotta perché la superficie sferica della Terra viene rappresentata sulla carta che è piana; simbolica / ridotta perché gli elementi del territorio sono indicati con simboli e colori convenzionali; approssimata / ridotta perché non è possibile rappresentare una zona della Terra riproducendo le distanze reali sulla carta.
2 Collega ogni termine alla sua definizione. scala numerica scala grafica legenda simbolo
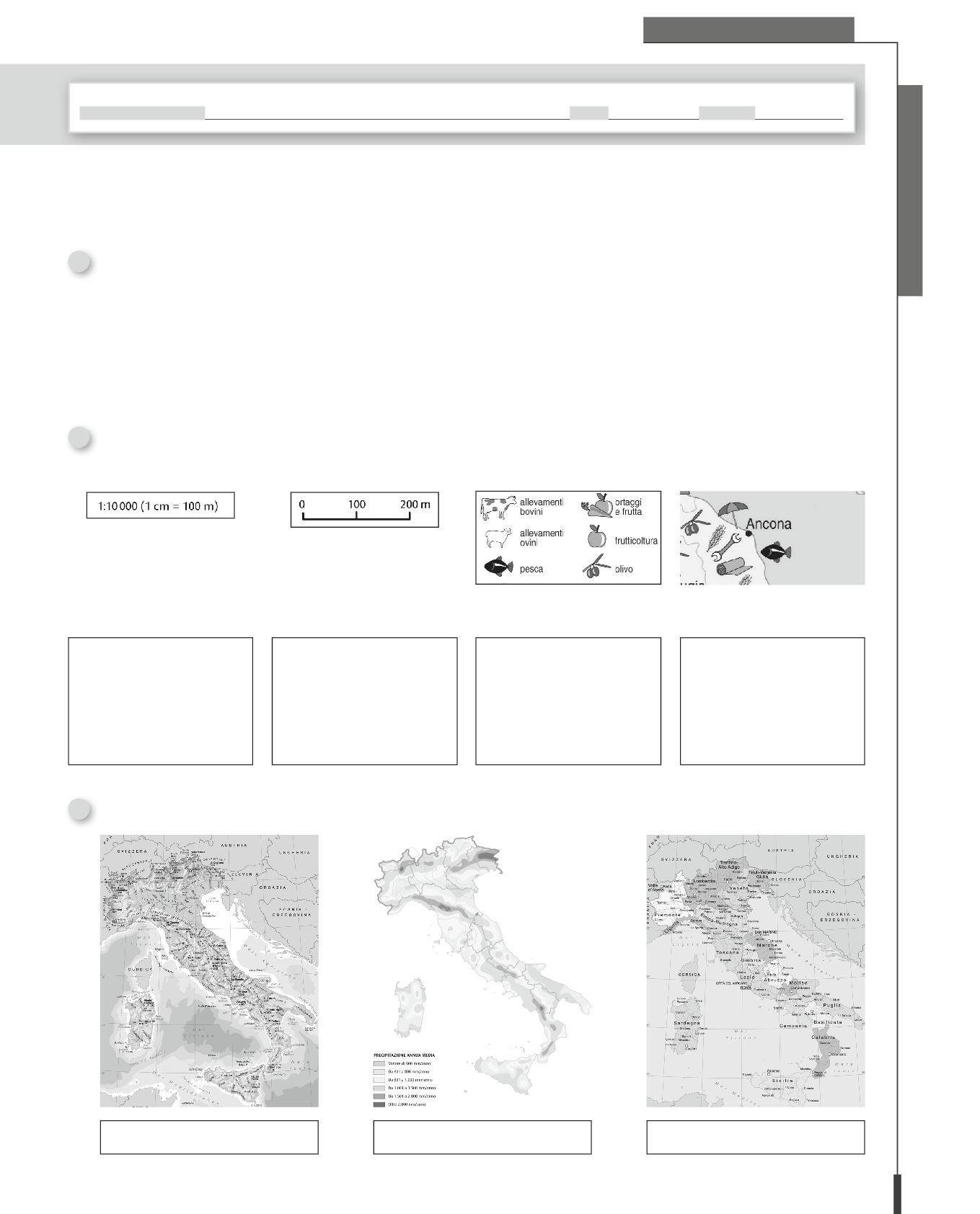
Segno grafico che rappresenta un elemento.
Tabella con spiegazioni che consentono di interpretare i simboli di una carta.
Indica attraverso i numeri quante volte è stata ridotta la rappresentazione del territorio.
Riga graduata che indica quanto è stata ridotta la rappresentazione del territorio.
3 Scrivi sotto ogni immagine che tipo di carta geografica è: carta fisica, carta politica, carta tematica.
OBIETTIVI: Classificare le carte geografiche. • Riconoscere gli elementi delle carte geografiche.
I PLANISFERI
I planisferi sono le carte geografiche che rappresentano tutta la Terra. La scala di riduzione non può essere inferiore a 1:100 000 000 (cento milioni). I planisferi, a differenza dei mappamondi, deformano un poco le reali estensioni dei continenti. È come se tu tentassi di spianare la buccia di un’arancia su un foglio piatto.
Per risolvere questi problemi i cartografi hanno fatto vari tentativi. Ecco i più noti:
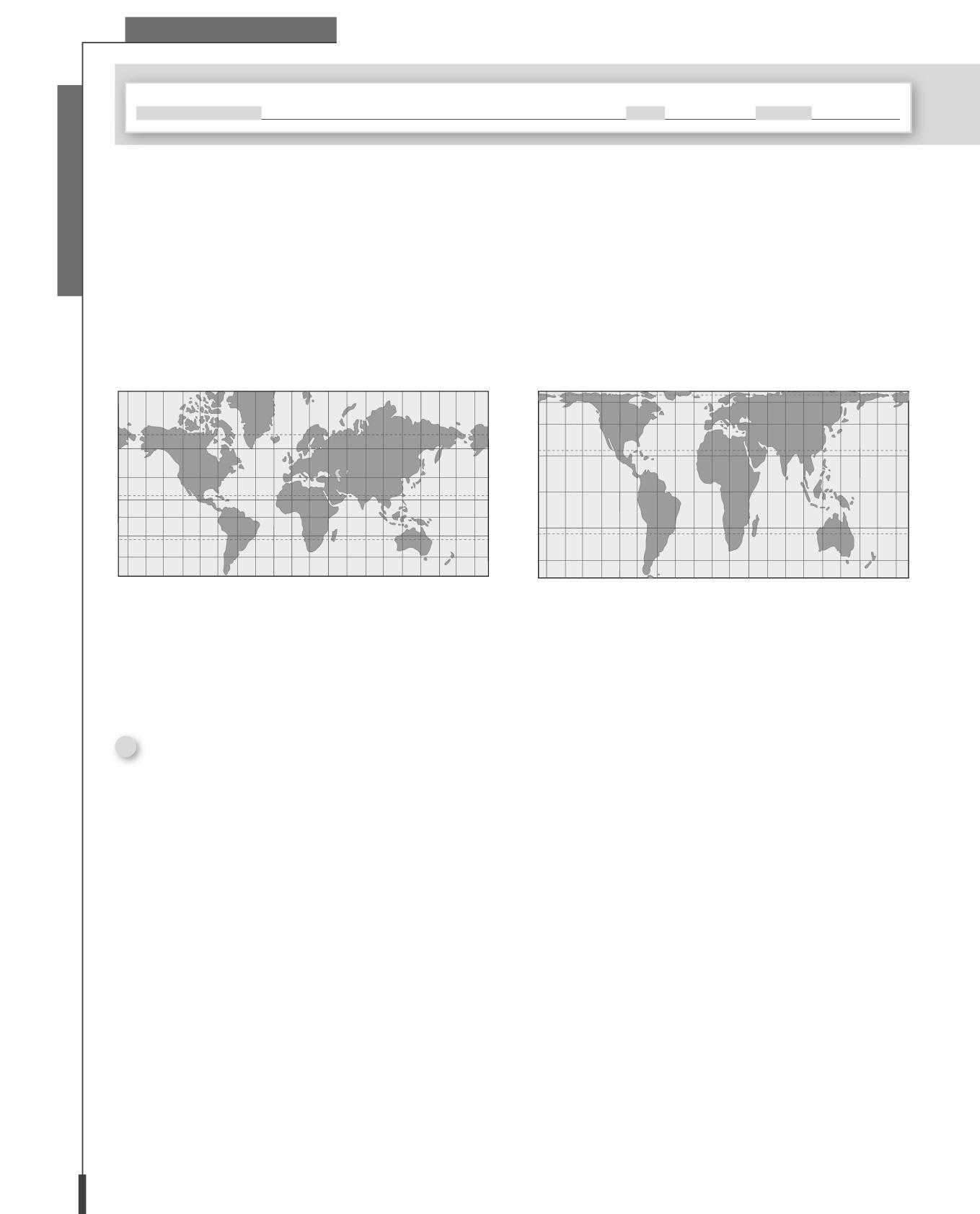
Gerardo Mercatore, un cartografo vissuto circa 500 anni fa, ha realizzato un modello che rispetta le forme dei continenti, ma non le loro dimensioni.
Arno Peters, un cartografo del secolo scorso, ha elaborato un altro modello di planisfero, che tiene maggiormente conto della reale estensione dei continenti, ma ne deforma l’aspetto.
1 Leggi il testo e osserva i due planisferi, poi sottolinea l’alternativa corretta per completare le frasi.
• La scala dei planisferi è superiore / inferiore a 1:100 000 000.
• I mappamondi rappresentano / deformano le reali estensioni dei continenti.
• Il planisfero di Mercatore è stato realizzato rispettando le forme / dimensioni dei continenti.
• Il planisfero di Peters è stato realizzato rispettando le forme / dimensioni dei continenti.
• Nel planisfero di Mercatore l’America del Nord, l’Europa e l’Asia sono rappresentate nella parte alta / al centro della carta.
• Nel planisfero di Peters l’America del Sud e l’Africa sono meno / più estese che in quello di Mercatore.
• Nel planisfero di Mercatore l’Asia è più / meno estesa che in quello di Peters.
• Nel planisfero di Peters l’Africa è più / meno estesa che in quello di Mercatore.
LE COORDINATE GEOGRAFICHE
1 Completa le frasi sulle coordinate geografiche.
• Sulle carte geografiche c’è una specie di rete formata da linee e orizzontali che si incrociano.
• Le linee verticali formano tanti spicchi e sono i .
• Le linee orizzontali che sembrano tagliare a fette la Terra sono i
• Meridiani e paralleli formano il geografico.
• Attraverso queste si può trovare la posizione di qualsiasi luogo sulla carta.
• Il meridiano più importante è quello che passa dall’osservatorio di , vicino a Londra, e si chiama meridiano 0.
• I paralleli vanno dall’ , che è il parallelo 0, verso i (Polo Nord e Polo Sud).
2 Scrivi nelle etichette i nomi esatti.

3 Completa il seguente testo.
La distanza di un luogo dall’Equatore si chiama ed è misurata in gradi, che possono essere o Sud.
La distanza di un luogo dal meridiano di Greenwich si chiama ed è misurata in gradi, che possono essere o Ovest.
LE COORDINATE GEOGRAFICHE
1 Sottolinea l’alternativa corretta per completare le frasi.
• Sulle carte geografiche c’è una specie di rete formata da linee verticali / parallele e orizzontali che si incrociano.
• Le linee verticali formano tanti spicchi e sono i meridiani / paralleli.
• Le linee orizzontali che sembrano tagliare a fette la Terra sono i meridiani / paralleli
• Meridiani e paralleli formano il reticolo / l’Equatore geografico.
• Attraverso queste linee / diversità si può trovare la posizione di qualsiasi luogo sulla carta.
• Il meridiano più importante è quello che passa dall’osservatorio di Equatore / Greenwich, vicino a Londra, e si chiama meridiano 0.
• I paralleli vanno dall’Equatore / dal Polo Nord, che è il parallelo 0, verso i tropici / poli (Polo Nord e Polo Sud).
2 Scrivi nelle etichette le parole seguenti. emisfero australe • emisfero boreale • Equatore • latitudine • paralleli • Polo Nord • Polo Sud
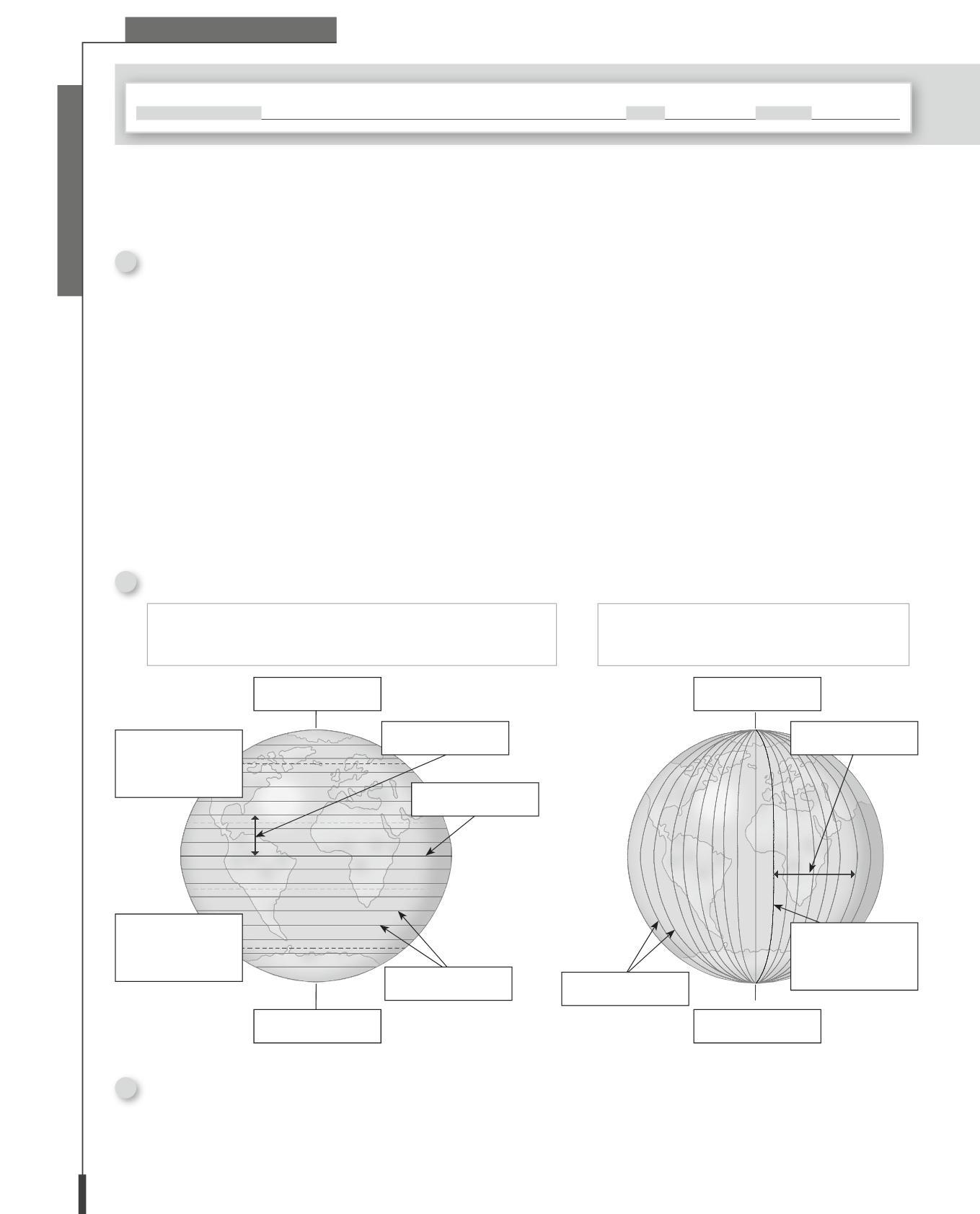
longitudine • meridiani • meridiano di Greenwich • Polo Nord • Polo Sud
3 Sottolinea l’alternativa corretta per completare le frasi.
• La distanza di un luogo dall’Equatore si chiama latitudine / longitudine
• La distanza di un luogo dal meridiano di Greenwich si chiama latitudine / longitudine
OBIETTIVI: Completare una carta muta. • Conoscere il reticolo geografico e i punti cardinali.
E COGNOME DATA CLASSE
TROVARE LA POSIZIONE DI UN LUOGO
1 Osserva questa carta politica dell’Italia. Come nella battaglia navale, scopri quali città sorgono vicino all’incrocio delle seguenti coordinate.
• 44 Latitudine Nord 8 Longitudine Est
• 41 Latitudine Nord 17 Longitudine Est
• 41 Latitudine Nord 9 Longitudine Est
• 39 Latitudine Nord 17 Longitudine Est
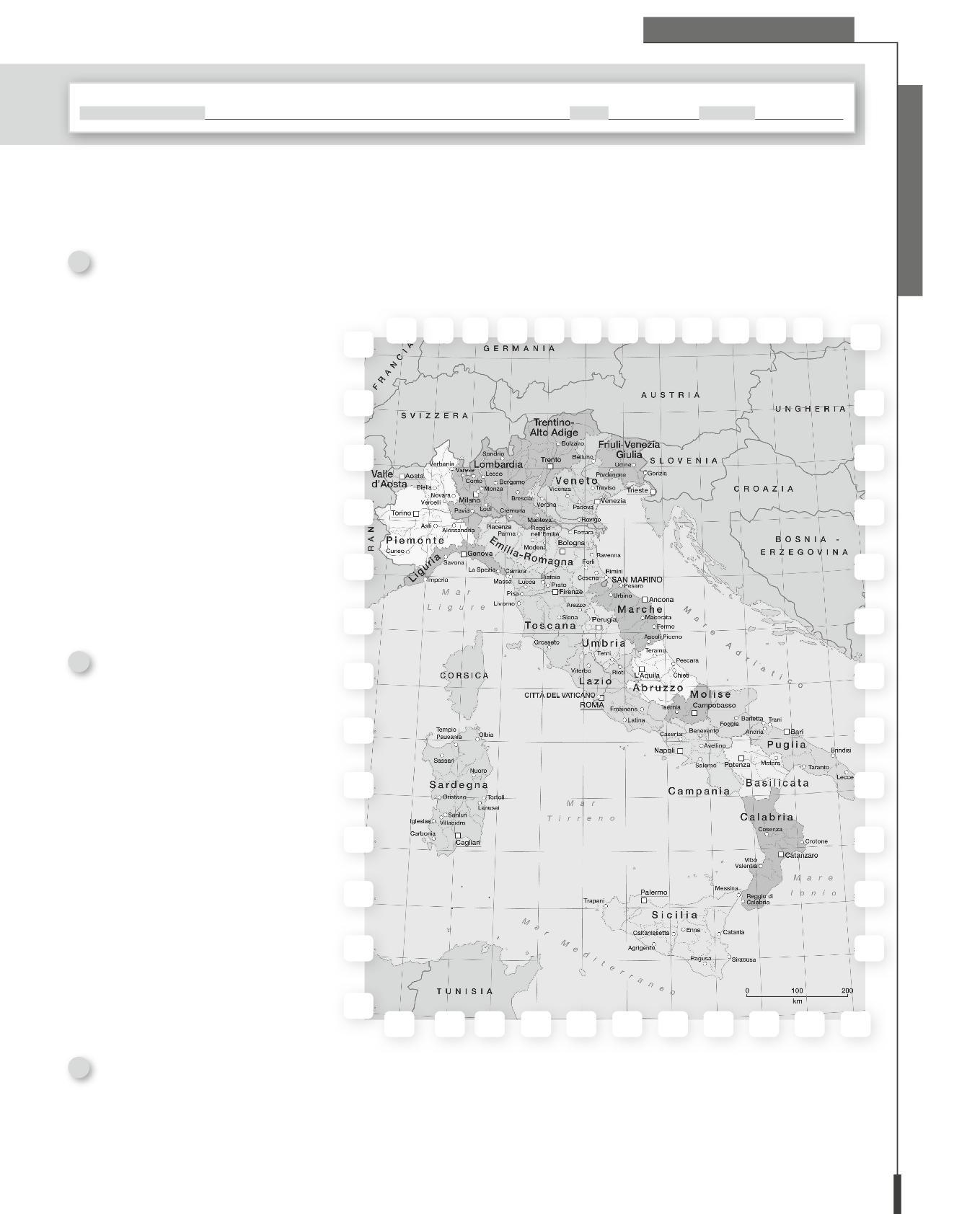
2 Ora scrivi le coordinate approssimate delle seguenti città:
• Pistoia (Toscana)
Latitudine Nord
Longitudine Est
• Carrara (Toscana)
Latitudine Nord
Longitudine Est
• Rovigo (Veneto)
Latitudine Nord
Longitudine Est
• Avellino (Campania)
Latitudine Nord
Longitudine Est
3 Rispondi alla domanda.
Perché la latitudine è “Nord” e la longitudine è “Est”?
ORIENTARSI
1 Per ogni affermazione indica con una X il completamento corretto.
• La parola orientarsi significa: trovare il Nord senza la bussola.
individuare l’Oriente, cioè il punto in cui sorge il Sole. conoscere i punti cardinali.
• Il Sole sembra cambiare posizione nel cielo, ma in realtà:
si muove solo da Nord a Ovest.
si muove solo quando lo vediamo.
è la Terra che si muove attorno al Sole.
2 Scrivi nei riquadri i nomi dei punti cardinali, anche quelli intermedi.
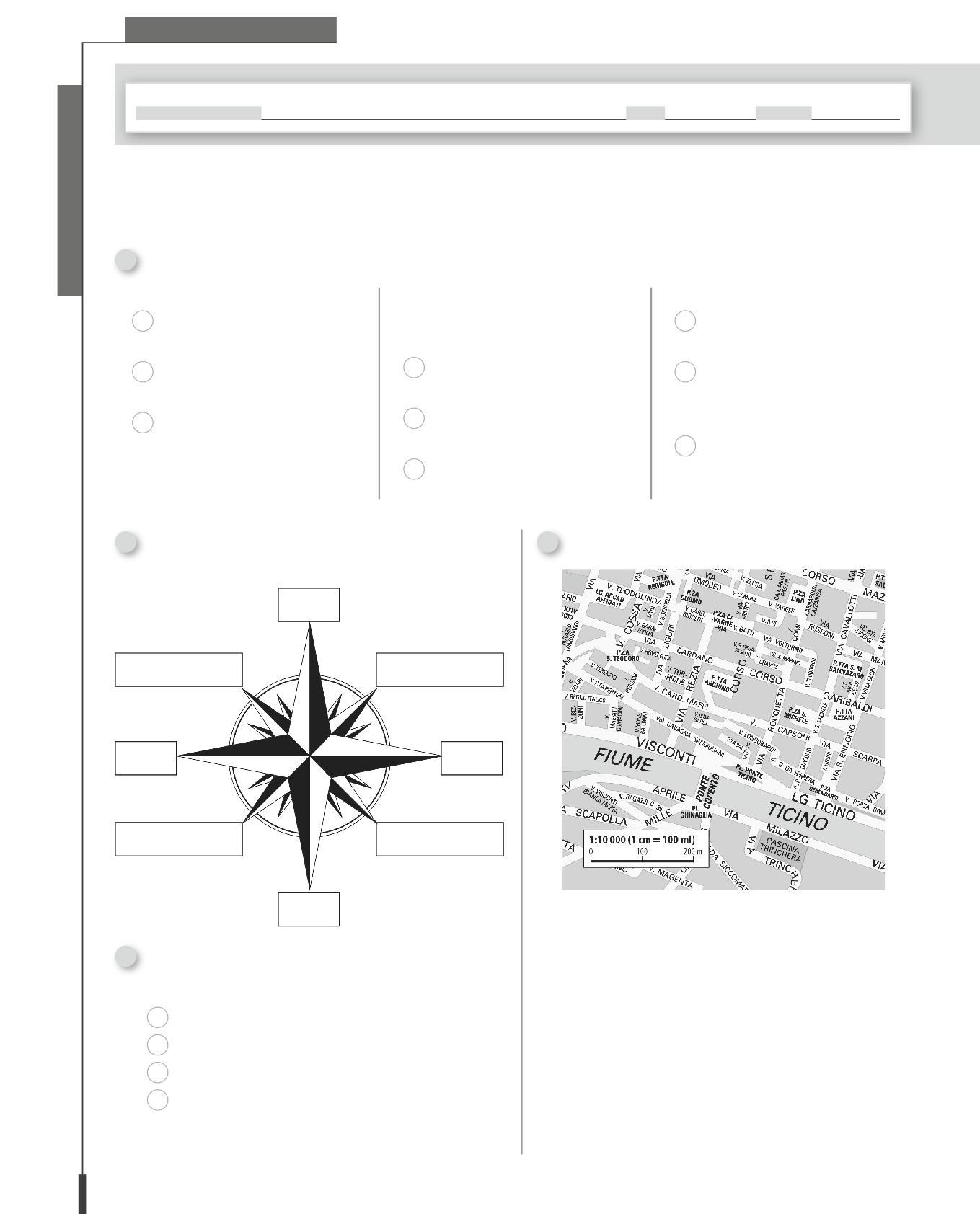
• È possibile orientarsi di notte: osservando la Stella Polare, che indica il Sud. guardando le stelle, perché ogni stella indica i punti cardinali. osservando la Stella Polare, che indica il Nord.
4 Completa il testo con i punti cardinali.
3 Indica con una X l’affermazione scorretta.
La bussola: è uno strumento utile per l’orientamento. ha un ago che indica sempre il Nord. ha un ago calamitato.
indica solo il Nord e non ci permette di conoscere la posizione degli altri punti cardinali.
• Piazza Lino è a di Piazza Duomo.
• Via Rezia è a di via Cavagna Sangiuliani.
• Cascina Trinchera è a di Piazza Berengario.
• Piazza San Teodoro è a di Corso Garibaldi.
• Se mi trovo all’incrocio di Corso Garibaldi e via Rocchetta, per arrivare in via Longobardi devo percorrere via Rocchetta verso
OBIETTIVI: Conoscere gli strumenti del geografo. • Leggere e interpretare le carte geografiche.
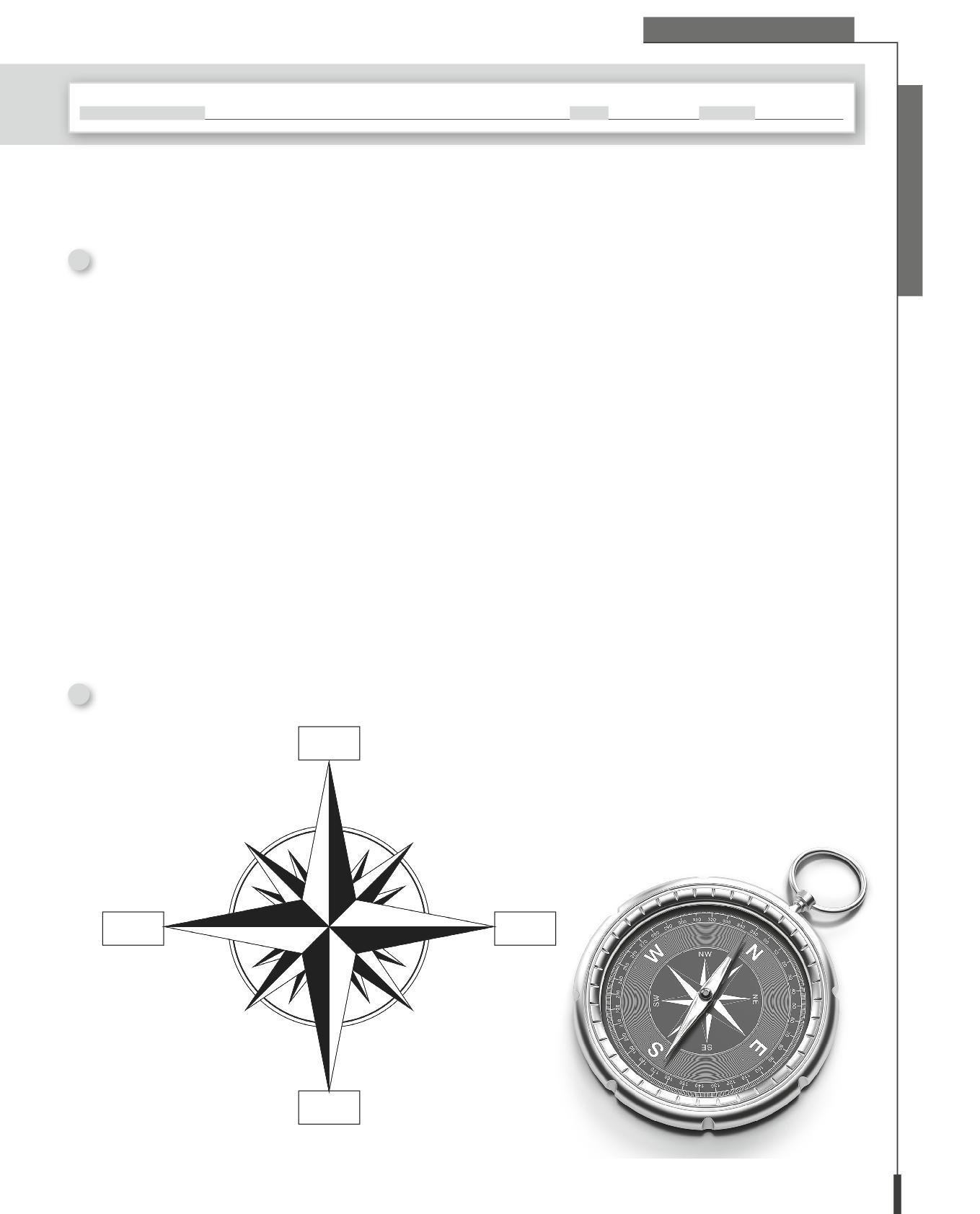
ORIENTARSI
1 Completa le frasi con Nord, Sud, Est, Ovest.
• La parola orientarsi significa individuare il punto in cui sorge il Sole, cioè l’Oriente, detto anche
• Per orientarsi si usano i punti cardinali: , , , .
• Il Sole sembra girare intorno alla Terra, ma in realtà è la Terra che in continuo movimento; la posizione che occupa a mezzogiorno viene definita Meridione o , mentre il punto opposto viene detto Settentrione o .
• Il punto in cui sorge il Sole si chiama Levante o , mentre il punto in cui la sera il Sole sembra scomparire dietro l’orizzonte è detto Occidente, Ponente o .
• Di notte è possibile orientarsi con la Stella Polare che, nell’emisfero settentrionale in cui viviamo, indica la posizione del .
• Nell’emisfero meridionale la Stella Polare non è visibile e ci si può orientare con le stelle della Croce del
• Uno strumento prezioso per l’orientamento è la bussola, che ha un ago calamitato che indica sempre il
2 Scrivi nei riquadri i nomi dei punti cardinali.
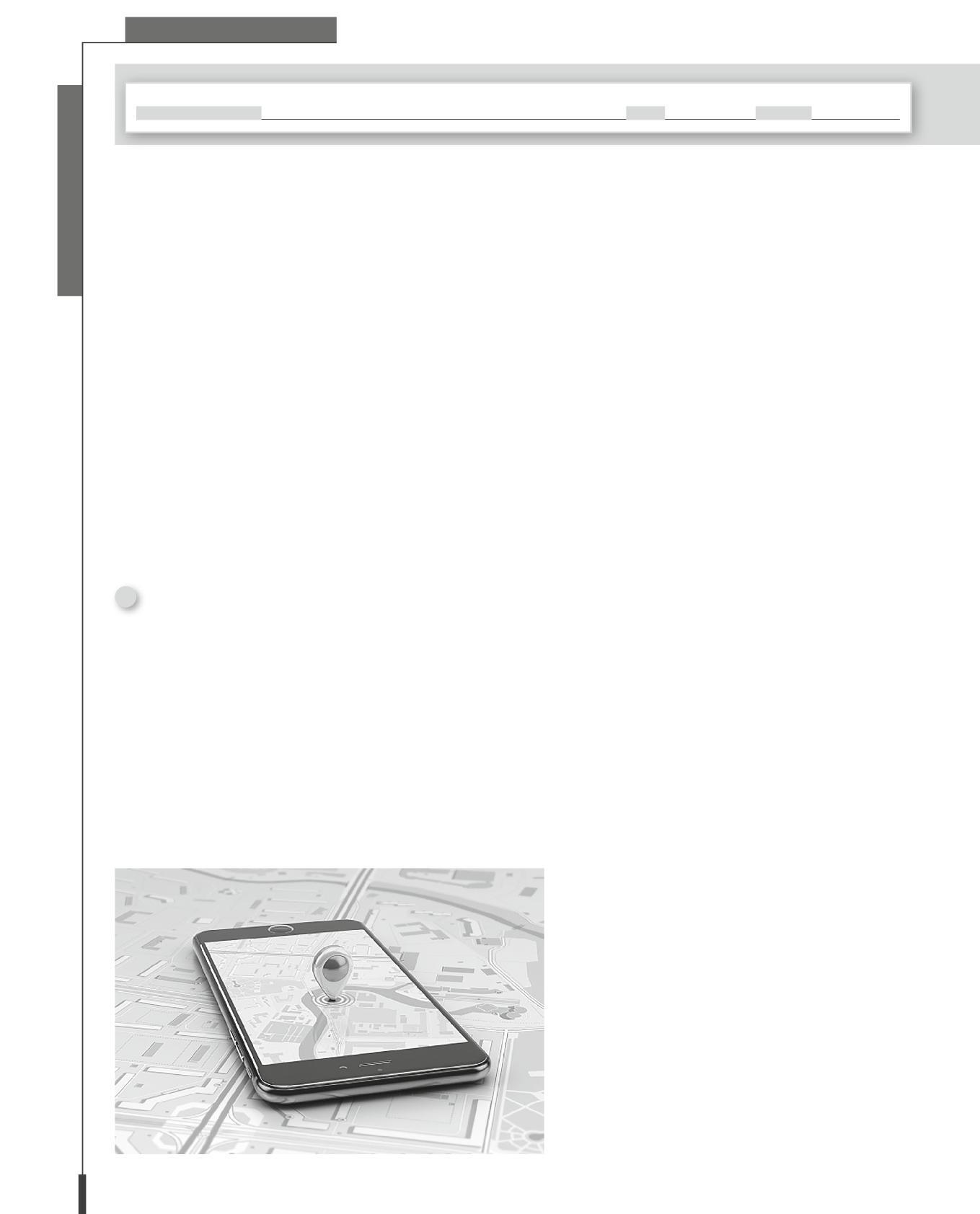
COME FUNZIONA IL GPS
Fin dall’antichità uno dei problemi dell’uomo è stato quello di orientarsi. Pensate a chi intraprendeva traversate transoceaniche o a chi esplorava nuovi e sterminati territori: saper leggere una mappa, una bussola oppure saper osservare le stelle era fondamentale.
Le cose oggi sono molto cambiate, infatti possiamo utilizzare un ricevitore GPS (Global Positioning System), che ci fornisce la nostra esatta posizione.
Il GPS è collegato a ventisette satelliti che orbitano intorno alla Terra, di cui ventiquattro effettivamente operativi e tre di riserva. Ogni satellite si trova a circa 20 km dalla Terra e compie due rotazioni al giorno intorno al pianeta. Le orbite dei satelliti fanno in modo che in qualsiasi punto ci si trovi sulla Terra il dispositivo si possa collegare ad almeno quattro satelliti in contemporanea.
In questo modo abbiamo la garanzia di ottenere una posizione affidabile.
Le stazioni terrestri si occupano poi di verificare costantemente lo stato dei satelliti per garantirne il funzionamento.
1 Sottolinea l’alternativa corretta per completare le frasi.
• Nel passato per viaggiare senza perdersi era indispensabile / utile saper leggere una mappa, una bussola o conoscere la posizione di alcune stelle.
• Il ricevitore GPS è uno strumento che fornisce a chi lo usa l’esatta posizione della / sulla Terra.
• I ventiquattro satelliti a cui è collegato il GPS compiono il giro della Terra due / ventiquattro volte al giorno.
• Ogni punto della terra raggiunto da almeno quattro satelliti successivamente / contemporaneamente.
• Quattro stazioni di controllo a terra verificano di tanto in tanto / costantemente lo stato dei satelliti.
• Senza le stazioni terrestri non sarebbe garantito il funzionamento / la posizione del GPS.
NOME E COGNOME

I CLIMI NEL MONDO
1 Osserva il planisfero e inserisci i seguenti termini nei cartellini corretti.
Circolo Polare Antartico • Circolo Polare Artico • Equatore • Tropico del Cancro Tropico del Capricorno • zona calda • zone fredde • zone temperate
2 Per ogni descrizione scrivi il clima del mondo corrispondente.
Clima
Al Polo Nord e al Polo Sud le temperature medie sono sotto lo zero e i ghiacci sono perenni. Vicino alle zone polari si trova la tundra.
Clima
Le zone a metà tra i Poli e l’Equatore hanno un clima temperato e quattro stagioni. Ci sono i boschi di conifere e di latifoglie, le praterie, la taiga e la vegetazione mediterranea.
Clima
All’Equatore invece non c’è l’alternarsi delle stagioni, le piogge sono costanti e la temperatura è sempre elevata. Ci sono le foreste equatoriali.
Clima
Un po’ più lontano dall’Equatore ci sono zone molto calde, con piogge concentrate in una sola stagione o in due periodi dell’anno. Ci sono le savane.
Clima
Ai tropici, dove le piogge sono scarse e la temperatura è elevata di giorno e bassa di notte, si estendono varie aree desertiche.
I CLIMI NEL MONDO
1 Osserva il planisfero e inserisci i seguenti termini nei cartellini corretti.
zona calda • zone fredde • zone temperate
Circolo Polare Artico
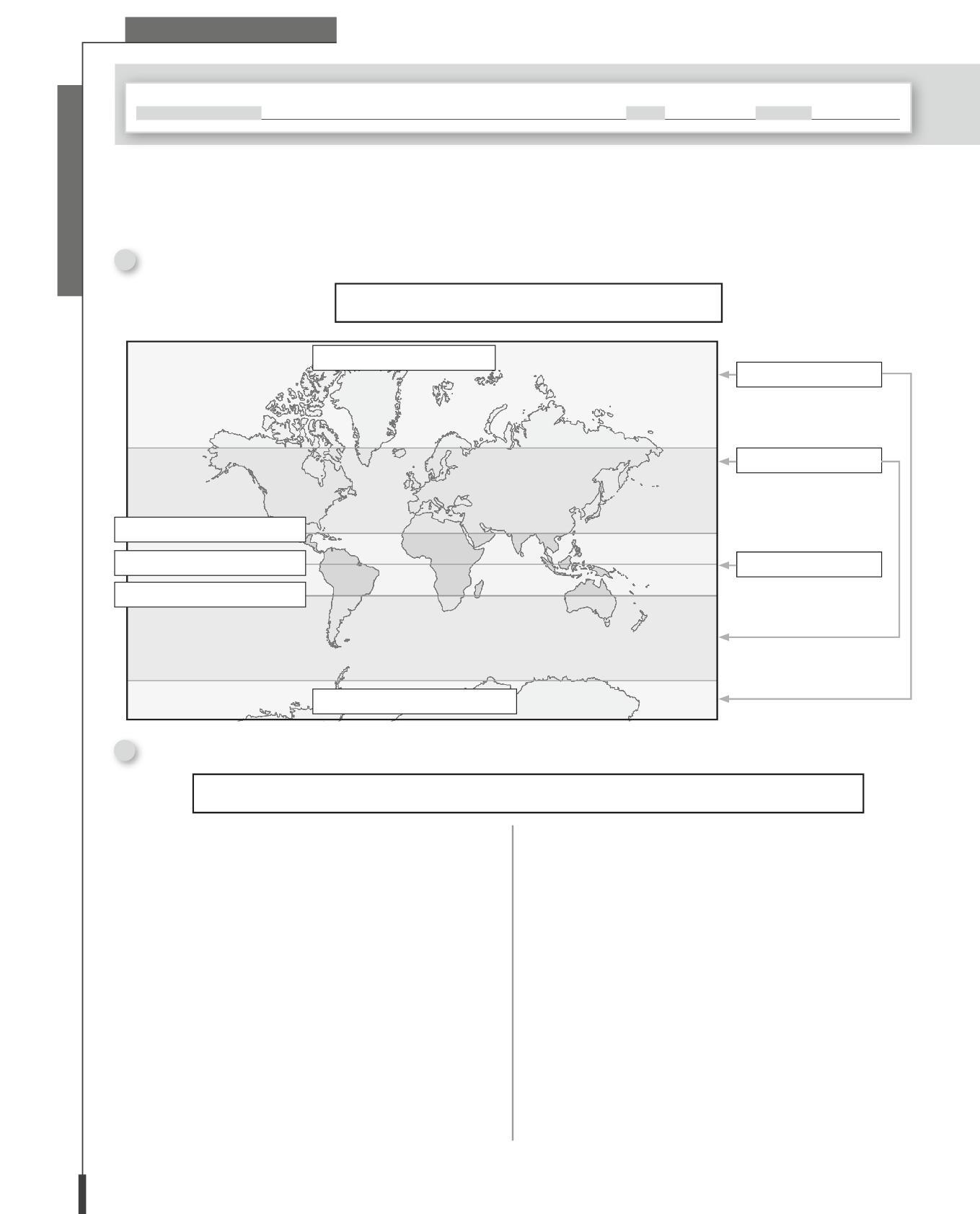
Tropico del Cancro
Equatore
Tropico del Capricorno
Circolo Polare Antartico
2 Per ogni descrizione scrivi il clima del mondo corrispondente.
caldo desertico • caldo equatoriale • caldo tropicale • freddo-nivale • temperato
Clima
Al Polo Nord e al Polo Sud le temperature medie sono sotto lo zero e i ghiacci sono perenni. Vicino alle zone polari si trova la tundra.
Clima
Le zone a metà tra i Poli e l’Equatore hanno un clima temperato e quattro stagioni. Ci sono i boschi di conifere e di latifoglie, le praterie, la taiga e la vegetazione mediterranea.
Clima
All’Equatore invece non c’è l’alternarsi delle
OBIETTIVI: Riconoscere le diverse aree climatiche
stagioni, le piogge sono costanti e la temperatura è sempre elevata. Ci sono le foreste equatoriali.
Clima
Un po’ più lontano dall’Equatore ci sono zone molto calde, con piogge concentrate in una sola stagione o in due periodi dell’anno. Ci sono le savane.
Clima
Ai tropici, dove le piogge sono scarse e la temperatura è elevata di giorno e bassa di notte, si estendono varie aree desertiche.
I CLIMI NEL MONDO
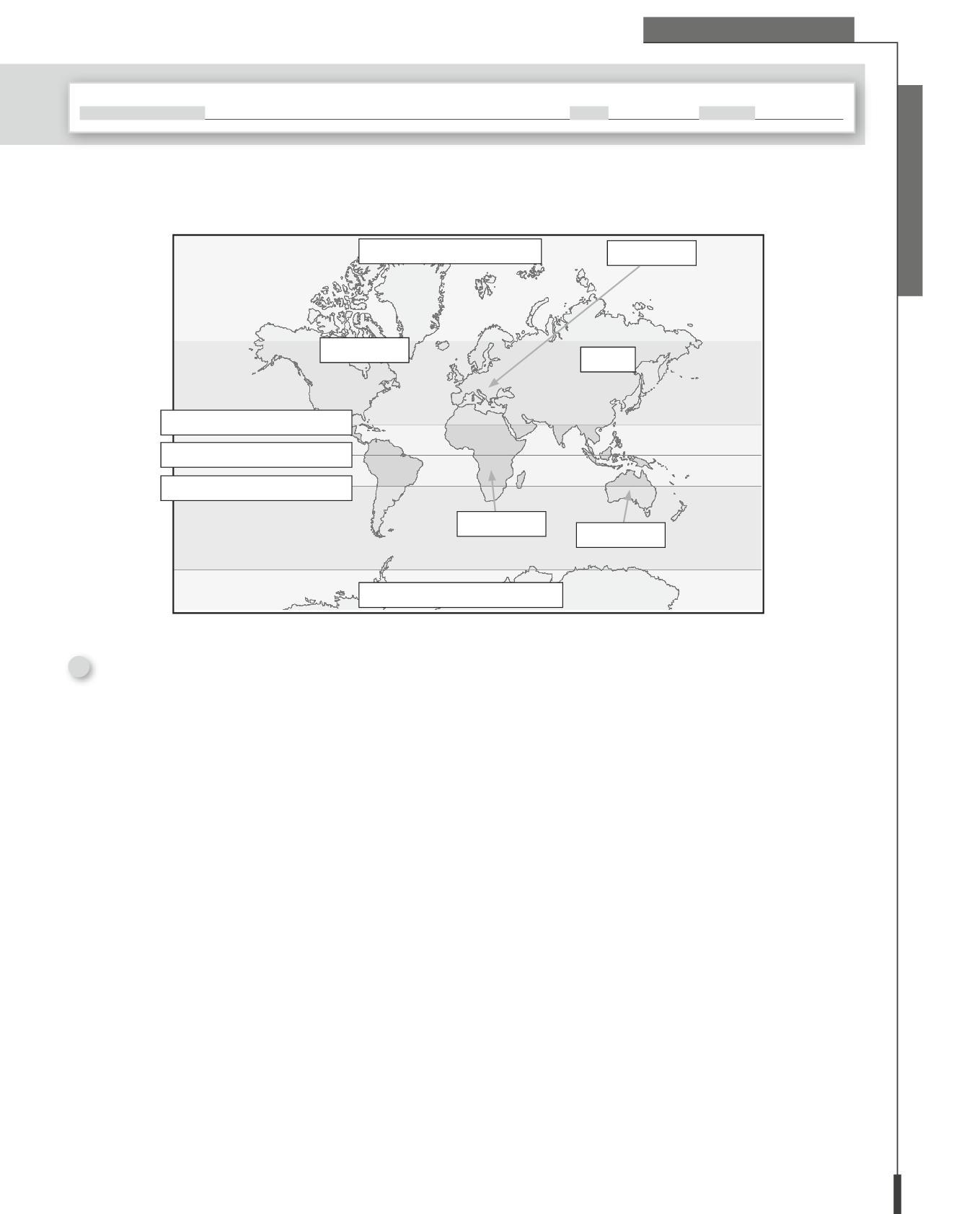
America
Tropico del Cancro
Equatore
Tropico del Capricorno
Africa
Circolo Polare Antartico
1 Osserva il planisfero, poi completa le frasi.
• Noi viviamo nel continente
• Il nostro continente si trova nella zona
• Un continente che si trova nell’emisfero opposto al nostro è
• Il nostro continente si trova a Nord dell’
• Il Circolo Polare Antartico si trova nella zona
Asia
Europa
Oceania
• Il continente che si estende completamente nell’emisfero australe è
• Esso si trova nelle zone
• Un continente che si estende completamente a Nord dell’Equatore è
• Esso si trova nelle zone
• L’Asia si trova nelle zone
• La maggior parte dell’Africa si trova nelle zone
IL CLIMA
1 Indica con una X la definizione corretta.
• Il clima:
indica le condizioni atmosferiche di un luogo che si possono rilevare e misurare in un periodo di tempo breve.
è l’insieme delle condizioni atmosferiche che si possono rilevare e misurare in un lungo periodo di tempo.
indica che tempo fa in un determinato luogo e in un determinato momento.
2 Collega ogni fattore climatico alla sua definizione.
temperatura precipitazioni atmosferiche venti pressione atmosferica umidità
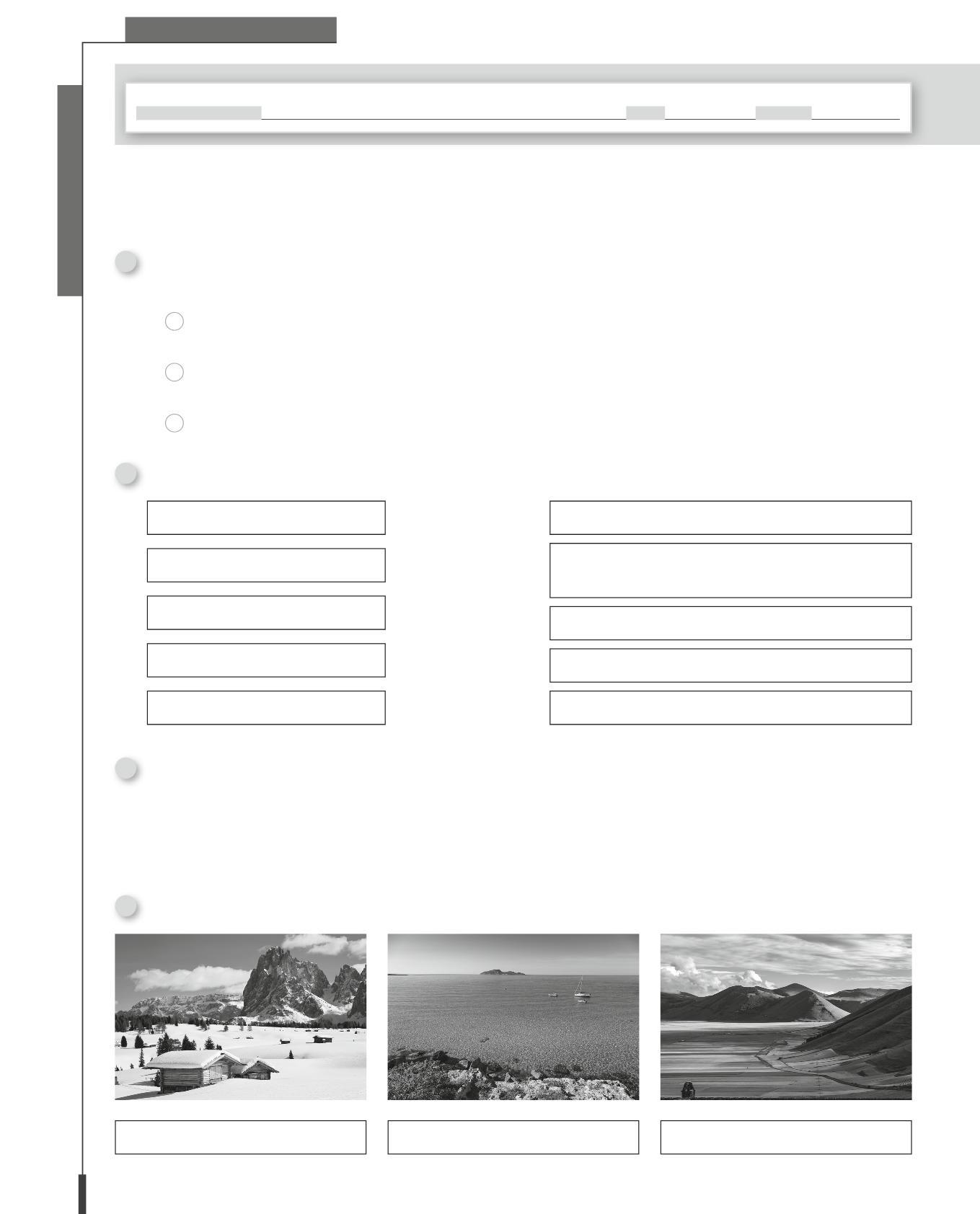
Masse d’aria calda o fredda che si spostano.
Peso esercitato dall’atmosfera sulla superficie terrestre.
Dipende dall’intensità dei raggi solari.
Quantità di vapore acqueo nell’aria.
Sono la pioggia, la neve e la grandine.
3 Completa con i nomi dei fattori climatici.
• è la posizione di un luogo sulla Terra rispetto all’Equatore.
• è l’altezza di un luogo rispetto al livello del mare.
• a oceani, mari, laghi influenza il clima.
4 Sotto a ogni immagine indica quale zona climatica italiana rappresenta.
IL CLIMA
1 Sottolinea l’alternativa corretta per completare la frase.
• Il clima indica le condizioni atmosferiche di un luogo / continente che si possono rilevare e misurare in un periodo di tempo breve / lungo
2 Completa le didascalie con le parole seguenti.
precipitazioni atmosferiche • pressione atmosferica • temperatura • umidità • venti
La dipende dall’intensità dei raggi solari. Le sono la pioggia, la neve e la grandine.
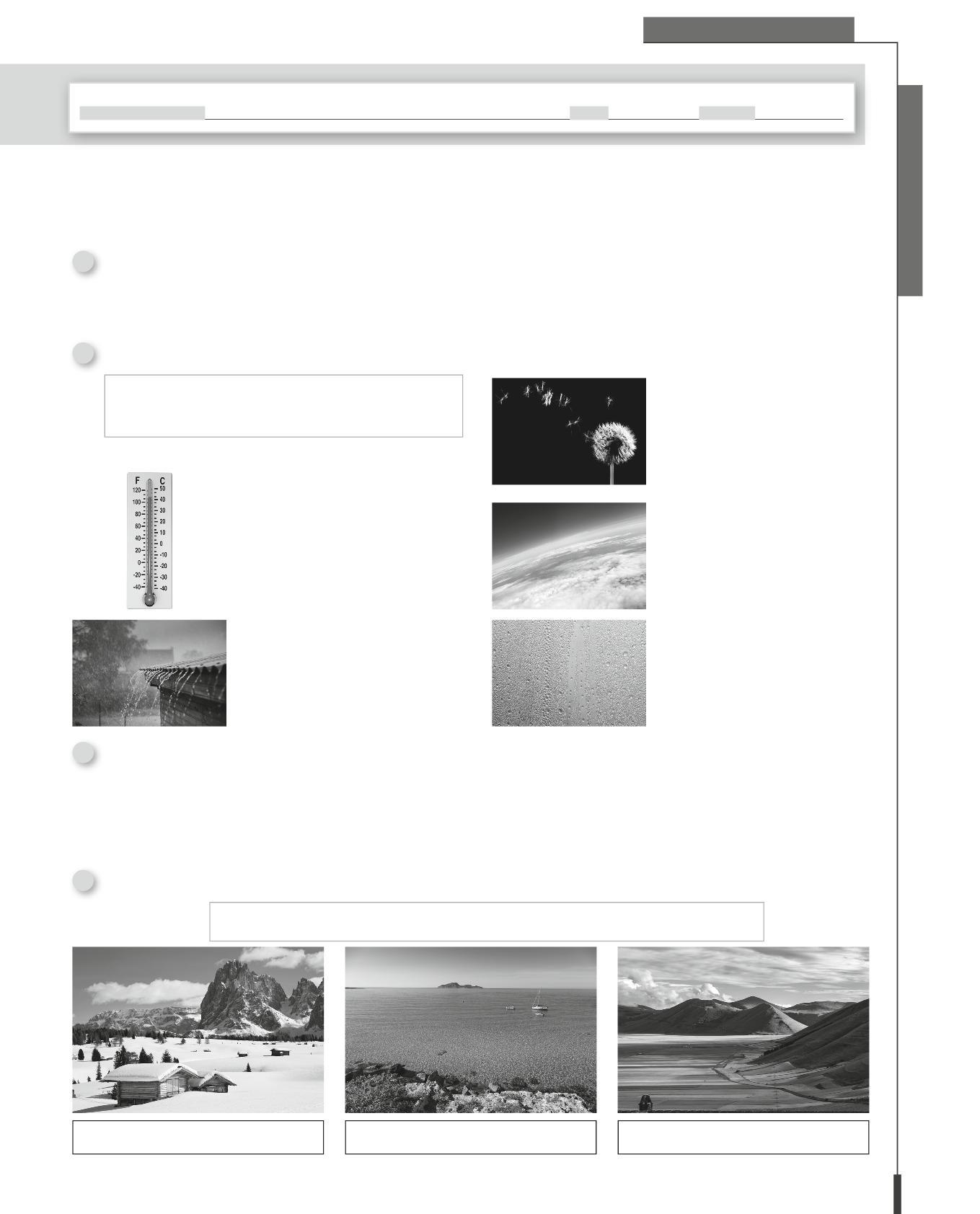
I sono masse d’aria calda o fredda che si spostano.
La è il peso esercitato dall’atmosfera sulla superficie terrestre.
L’ è la quantità di vapore acqueo presente nell’aria.
3 Sottolinea l’alternativa corretta per completare le frasi.
• La latitudine / L’altitudine è la posizione di un luogo della Terra rispetto all’Equatore.
• La latitudine / L’altitudine è l’altezza di un luogo rispetto al livello del mare.
• La vicinanza di un luogo a oceani, mari, laghi non influenza / influenza il clima.
4 Sotto a ogni immagine indica quale zona climatica italiana rappresenta. Scegli tra le seguenti.
zona appenninica • zona mediterranea • zona alpina

CAMBIAMENTI DI CLIMA
Durante la lunghissima storia della Terra ci sono state molte variazioni di clima: le glaciazioni si sono alternate a lunghi periodi in cui la temperatura si è alzata.
Attualmente le temperature stanno aumentando molto a causa di alcuni gas presenti nell’aria, tra cui l’anidride carbonica. Questi gas provengono dagli scarichi dei veicoli e delle industrie.
I gas lasciano passare i raggi che provengono dal Sole, ma trattengono nell’atmosfera terrestre il calore. Agiscono quindi come i vetri di una serra. Ecco perché questo fenomeno viene chiamato “effetto serra”.
In realtà l’effetto serra è un fenomeno naturale che consente di mantenere il calore del Sole intorno alla Terra e non sarebbe di per sé pericoloso. Quando però a questo calore naturale si aggiunge quello causato da certi gas, la temperatura della Terra aumenta troppo con gravi conseguenze per l’ambiente: scioglimento dei ghiacciai, siccità, tempeste, inondazioni.
Per prevenire questo rischio, 195 Paesi hanno firmato nel 2015 l’accordo di Parigi che prevede l’impegno a ridurre le emissioni di anidride carbonica in modo da far diminuire di due gradi la temperatura del pianeta.
1 Numera le frasi per ricostruire un riassunto del brano.
L’accordo di Parigi prevede l’impegno a far diminuire di due gradi la temperatura del pianeta.
L’effetto serra provoca gravi conseguenze per l’ambiente: scioglimento dei ghiacciai, siccità, tempeste, inondazioni.
L’aumento dell’anidride carbonica fa aumentare la temperatura del pianeta.
I gas provenienti dagli scarichi trattengono nell’atmosfera terrestre il calore, causando l’effetto serra.
L’aumento dell’anidride carbonica presente nell’aria è dovuto ai gas di scarico dei veicoli e delle industrie.
Nella lunghissima storia della Terra ci sono state molte variazioni di clima.
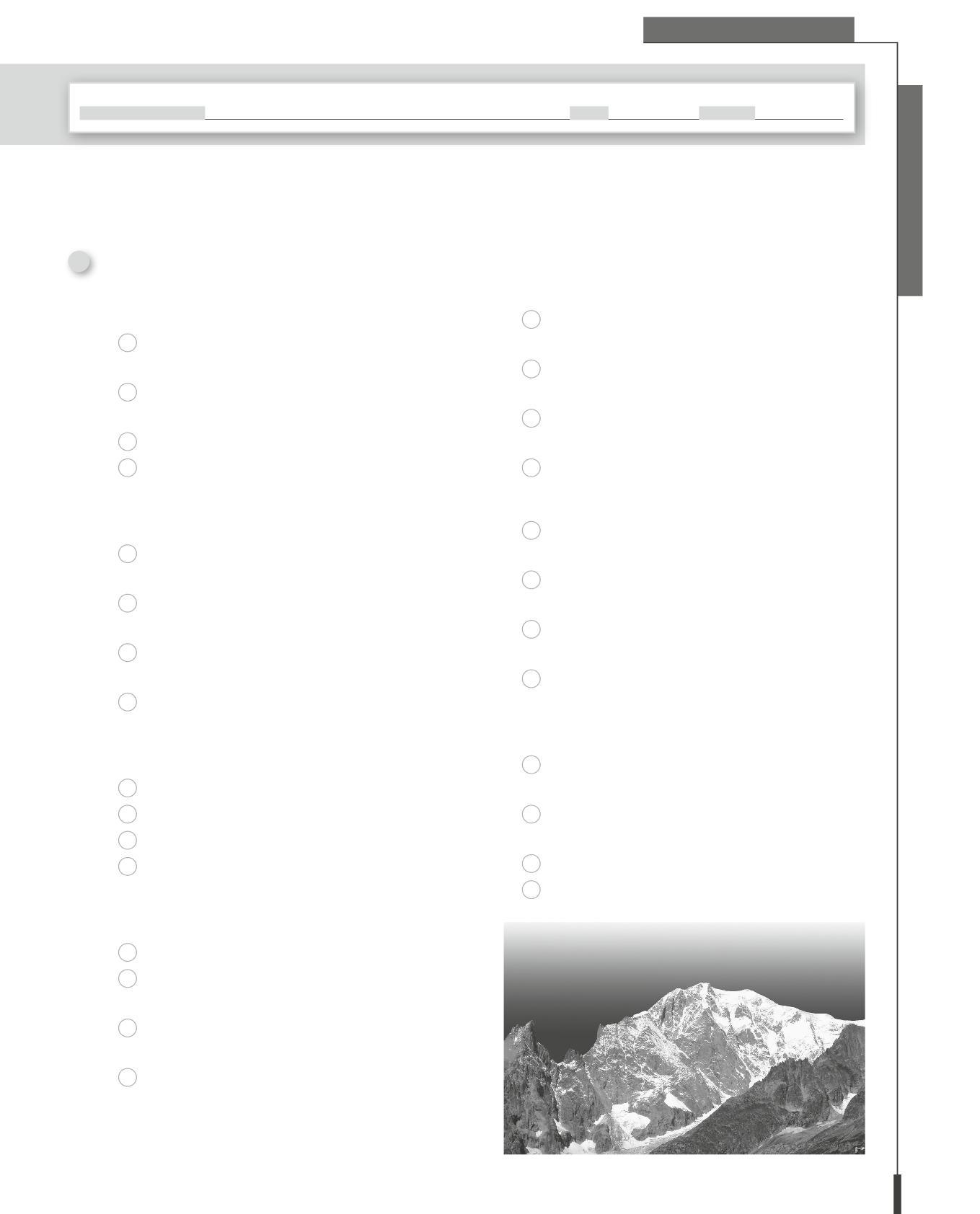
LE ALPI
1 Indica con una X le conclusioni corrette. Attenzione: sono più di una per ogni affermazione.
• Le Alpi sono una catena montuosa relativamente “giovane” perché:
le loro montagne non sono state ancora modellate da vento, pioggia, neve. sono composte da rocce dure e resistenti.
le cime sono alte, aspre, aguzze. le loro montagne sono state modellate dai fiumi.
• Le Alpi:
si trovano nella zona settentrionale della penisola. si trovano nella zona centrale della penisola. segnano il confine naturale con Francia, Svizzera, Austria e Slovenia. sono la più alta catena montuosa europea.
• Nella catena alpina: sono presenti numerosi ghiacciai. ci sono le sorgenti di numerosi fiumi. i ghiacciai sono quasi scomparsi.
ci sono le Prealpi, che digradano verso la pianura.
• Le valli alpine:
sono quasi inesistenti. hanno una forma a U se originate dal movimento di antichi ghiacciai. hanno una forma a V se originate dalla forza di fiumi e torrenti. sono ampie pianure tra una montagna e l’altra.
• La vegetazione delle Alpi:
è uguale a tutte le altitudini: abeti, larici, pini.
nelle zone meno alte è formata da latifoglie (querce, castagni e faggi).
tra i 1000 e i 2000 metri è costituita da aghifoglie (abeti, larici, pini).
nelle zone più elevate è inesistente.
• La fauna delle Alpi:
è inesistente: nei boschi non ci sono animali.
è formata fra gli altri, da stambecchi, caprioli, marmotte e aquile.
è costituita soprattutto da animali domestici.
è formata da animali che vivono allo stato naturale e da animali allevati.
• Le attività umane più diffuse sono:
legate alla ricchezza d’acqua, sfruttata per produrre energia elettrica.
soprattutto l’allevamento e il taglio degli alberi del bosco.
molto cambiate negli ultimi decenni. quelle relative al turismo.
1 Ricomponi le frasi spezzate.
Le Alpi sono una catena montuosa relativamente “giovane” perché…
Si trovano nella parte settentrionale della penisola italiana e…
Le valli alpine hanno una forma a U…
Le valli alpine hanno una forma a V…
La vegetazione alpina nelle zone meno alte è formata da…
La vegetazione alpina nelle zone più alte è formata da…
La fauna delle Alpi è costituita soprattutto da…
LE ALPI
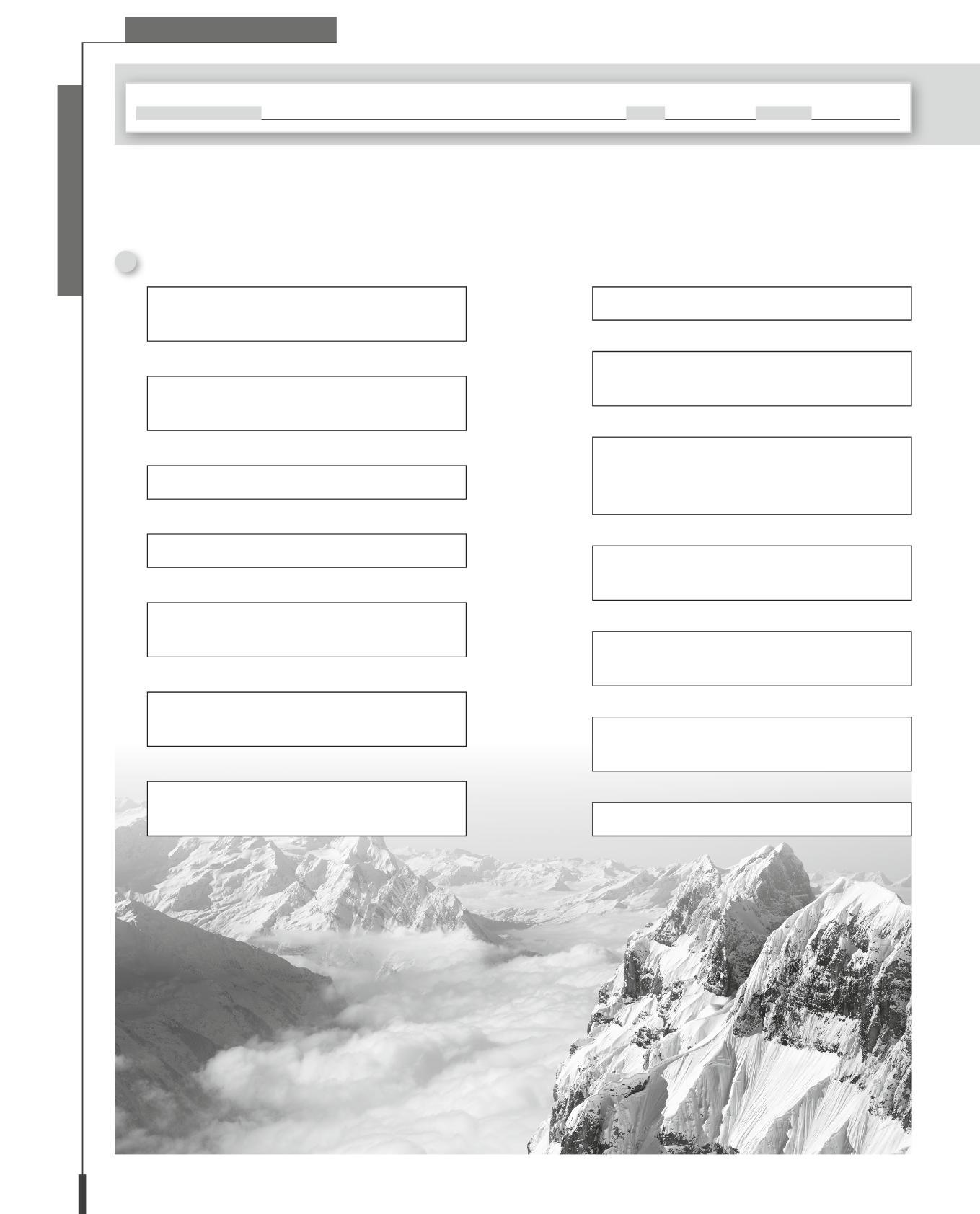
… latifoglie (querce, castagni e faggi).
… segnano il confine naturale con gli Stati a Nord.
… le sue montagne non sono state ancora modellate dal vento, dalla pioggia, dalla neve.
… stambecchi, caprioli, marmotte e aquile.
… se originate dalla forza di fiumi e torrenti.
… se originate dal movimento di antichi ghiacciai.
… aghifoglie (abeti, larici, pini).
IL MONTE BIANCO
Per molti la vetta del Monte Bianco è un mito, una cima leggendaria che domina l’Europa con il bianco delle sue nevi. Con i suoi 4810 m il Monte Bianco è la vetta più alta d’Europa.
Era l’8 agosto 1786 quando gli scalatori Balmat e Paccard intorno alle 18:00 misero per la prima volta piede sulla cima del Grande Monte: da allora migliaia di appassionati e alpinisti hanno sognato di raggiungere questa vetta, simbolo dell’alpinismo a livello mondiale.
La cima del Monte Bianco si presenta come una dolce calotta di ghiaccio e neve, da qui si dominano le Alpi e l’Europa e la sensazione che si ha è proprio quella di essere in vetta alle vette.
Da sempre la cima del Monte Bianco è stata oggetto di studio da parte di scienziati, di dispute geografiche e territoriali ma soprattutto di storie reali o immaginarie che l’hanno trasformata in un mito, basti pensare che ogni anno circa 20 000 persone cercano di raggiungerla.
Il Monte Bianco inoltre è l’unica montagna al mondo ad avere un cittadino onorario: era il 31 luglio 2010, quando i Sindaci di Courmayeur e Chamonix Mont Blanc hanno dato a Walter Bonatti, l’alpinista detto “il re delle Alpi”, questa onorificenza unica e prestigiosa. E proprio Walter Bonatti diceva: “Chi più alto sale, più lontano vede; chi più lontano vede, più a lungo sogna”. Interpretando le sue parole potremmo quindi dire che la cima del Monte Bianco è il luogo perfetto per tutti i sognatori del mondo.
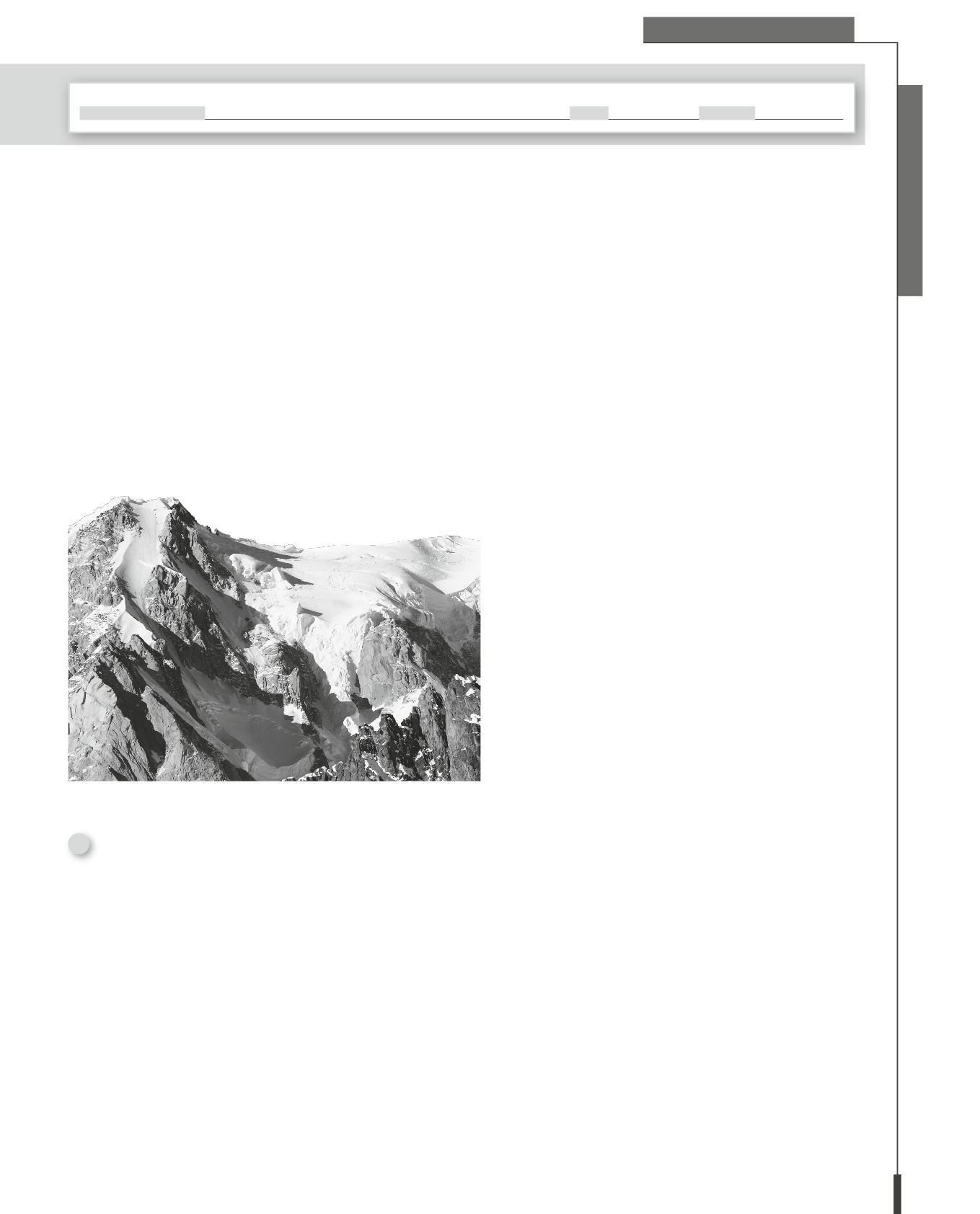
1 Sottolinea l’alternativa corretta per completare le frasi.
• Il Monte Bianco con i suoi 4810 m / 8410 m è la vetta più alta d’Europa.
• La sua cima fu scalata per la prima volta nel 1800 / 1786
• La cima si presenta come una calotta / piramide di ghiaccio e di neve.
• Dalla cima si dominano le Alpi e l’Italia / Europa
• La cima del Monte Bianco è oggetto di studio da parte di scienziati / storici
• Raggiungere la cima è un mito per poche / molte persone.
• A Walter Bonatti è stato dato il titolo di re delle Alpi / cittadino onorario
• Walter Bonatti diceva che: “… chi più lontano vede, più a lungo sogna / cammina”.
GLI APPENNINI
1 Collega l’inizio della frase al suo completamento corretto.
... dalla Liguria alla Calabria.
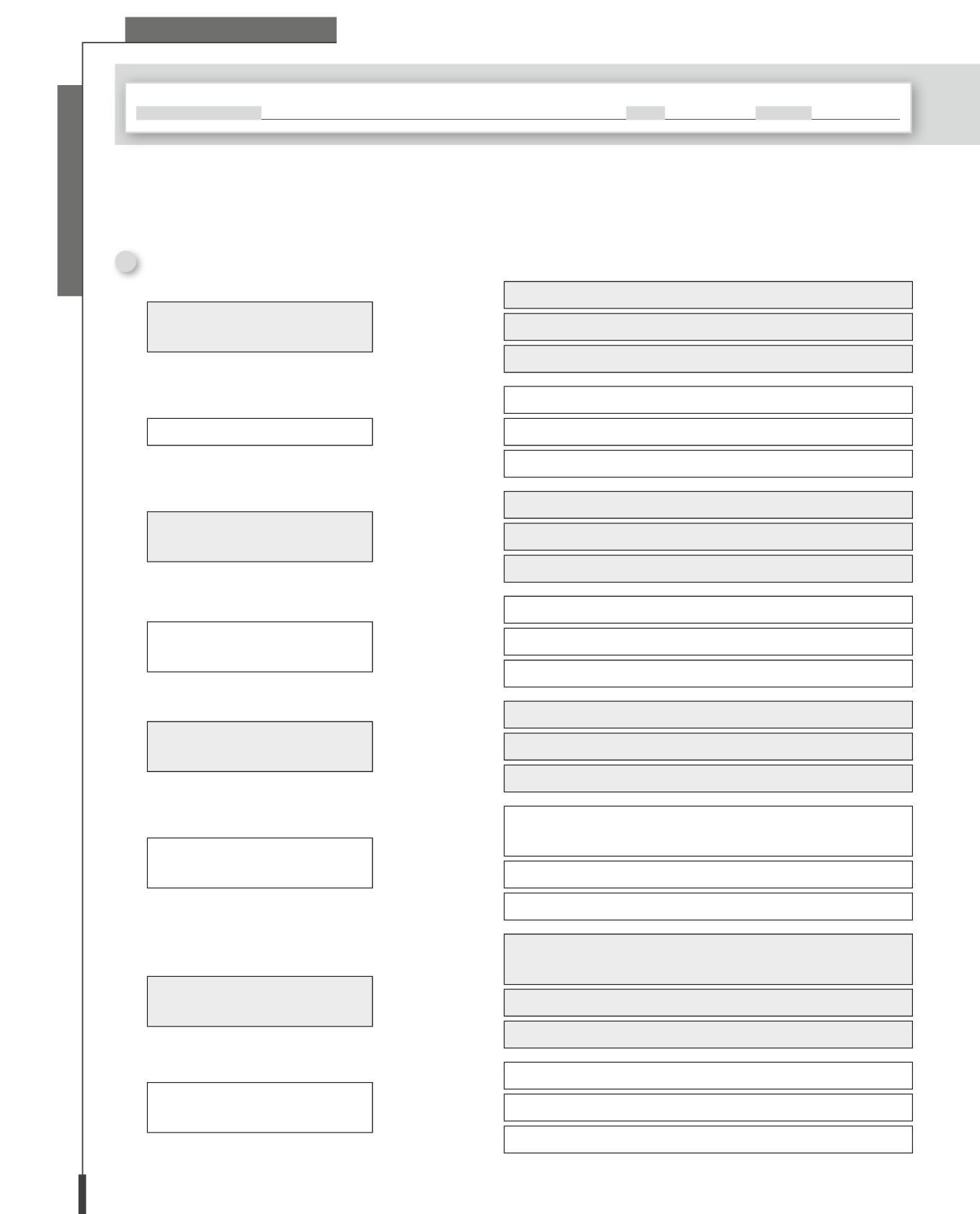
La catena montuosa degli Appennini si estende...
Le cime degli Appennini...
Gli Appennini sono caratterizzati da...
I paesaggi degli Appennini...
Sulle pendici più basse degli Appennini crescono...
Fino ai 1500 metri si trovano...
Le attività più diffuse sono...
Nel territorio appenninico...
... da Ovest a Est.
... dalla Liguria alla Sicilia.
... raggiungono i 4000 metri.
... non superano i 3000 metri tranne l’Etna.
... sono alte come quelle delle Alpi.
... due versanti con caratteristiche diverse.
... cime aguzze e valli a U.
... cime sempre innevate.
... sono monotoni e uniformi.
... presentano una grande varietà e climi differenti.
... sono simili a quelli alpini.
... gli ulivi.
... piante come la ginestra, l’oleandro e l’alloro.
... boschi di aghifoglie.
... boschi di querce e faggi, cinghiali, lontre, volpi, marmotte e lupi.
... solo rocce e nevai.
... campi coltivati e allevamenti di animali domestici.
... l’allevamento di ovini e caprini, l’agricoltura e il turismo.
... l’allevamento di ovini e caprini e l’industria.
... solo l’agricoltura e il turismo.
... sono presenti diversi parchi naturali.
... non sono presenti parchi naturali.
... sono presenti numerosi terrazzamenti.
GLI APPENNINI
1 Indica con una X il completamento corretto di ogni frase.
• La catena montuosa degli Appennini si estende: dalla Liguria alla Sicilia. da Ovest a Est.
• Le cime degli Appennini: sono alte come quelle delle Alpi. non superano i 3000 metri.
• Sugli Appennini i ghiacciai: sono pochi. mancano.
• Gli Appennini sono caratterizzati da: due versanti con caratteristiche diverse. cime sempre coperte di neve.
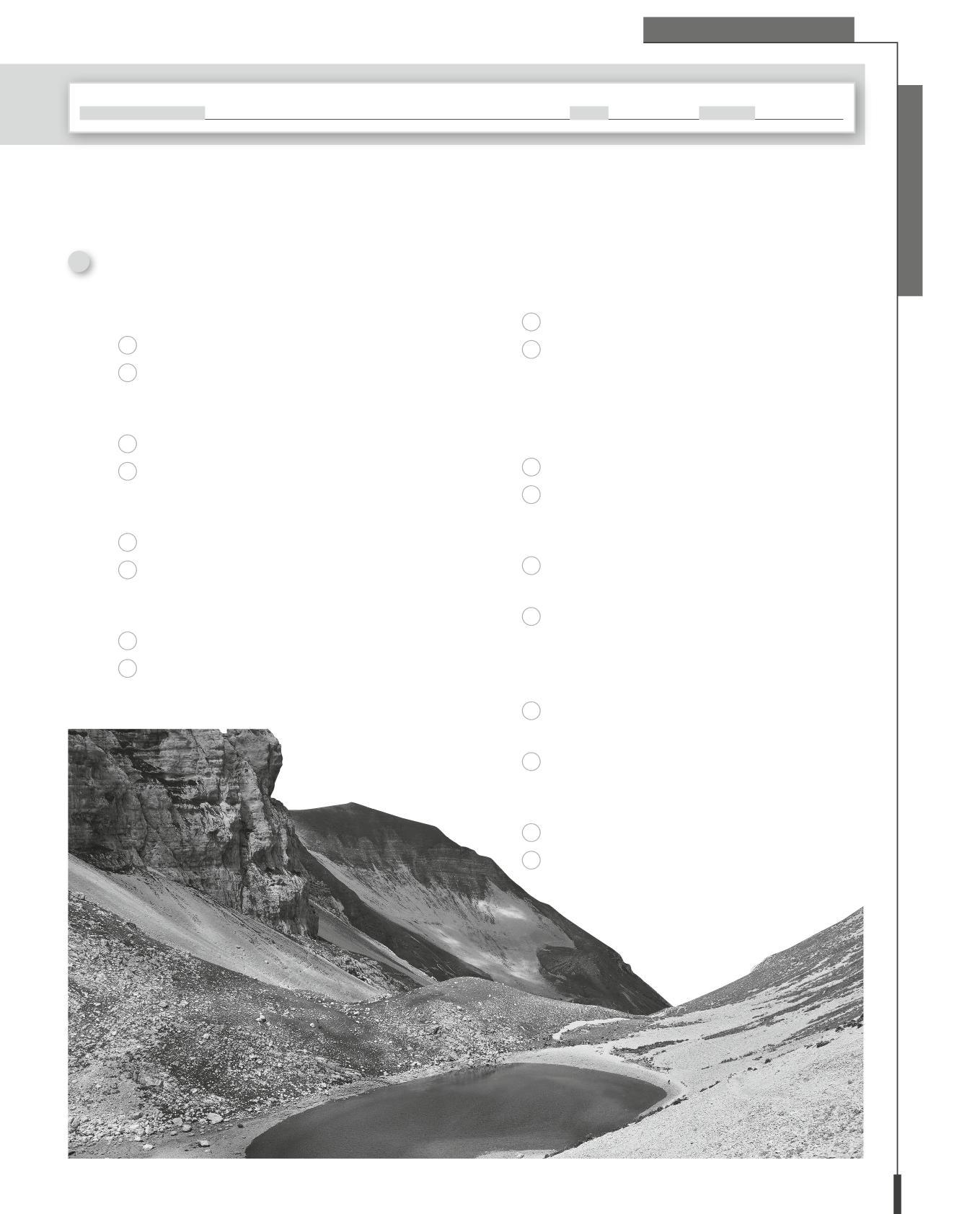
• I paesaggi degli Appennini: sono simili a quelli alpini. presentano una grande varietà e climi differenti.
• Nelle zone più basse degli Appennini crescono: pini e abeti. le piante della macchia mediterranea.
• Nelle fasce più elevate si trovano: boschi di querce e faggi, cinghiali, lontre, volpi, marmotte e lupi. campi coltivati e allevamenti di animali domestici.
• Le attività più diffuse sono: l’allevamento di ovini e caprini, l’agricoltura e il turismo. solo l’agricoltura e il turismo.
• Nel territorio appenninico: sono presenti parchi naturali. non sono presenti parchi naturali.
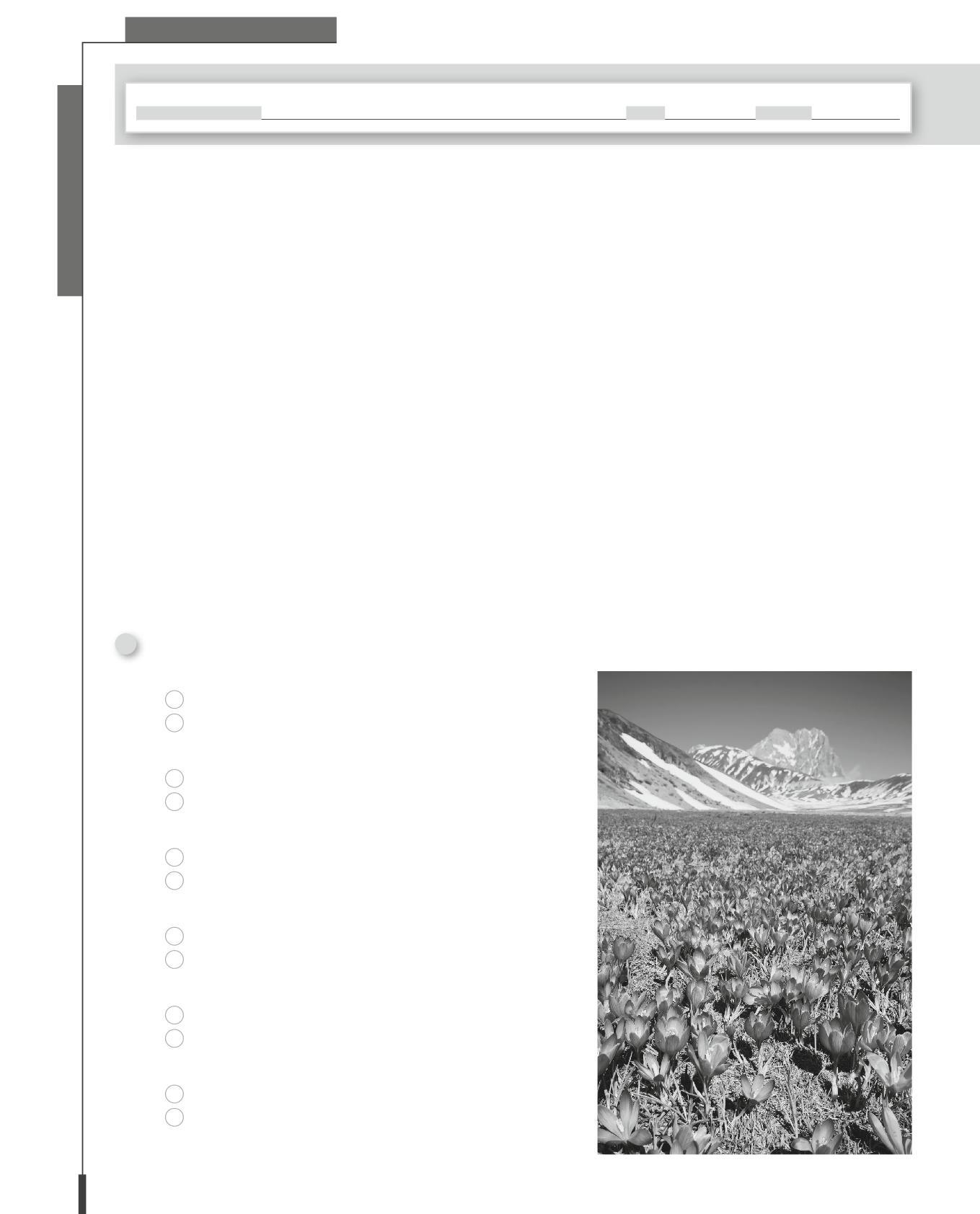
IL GRAN SASSO
Il Gran Sasso è il più alto massiccio montuoso degli Appennini, con la sua cima più alta, il Corno Grande (2912 m), sfiora i 3000 metri in altezza.
Questo maestoso massiccio è senza dubbio il rilievo paesaggisticamente più “alpino” degli Appennini.
L’incantevole scenario che troviamo sul Gran Sasso ci porta a vedere cime aguzze, valli profondamente incise, una miriade di sorgenti, laghetti di origine carsica e grotte di diversa estensione e profondità. Una particolare attenzione, sia per gli occhi sia per la cultura, dobbiamo riservarla al ghiacciaio del Calderone, posto sul versante settentrionale del Corno Grande a 2775 metri di quota. È l’unico ghiacciaio degli Appennini e il più meridionale d’Europa.
La fauna è tipica dell’Appennino centrale, e troviamo il tasso, la faina, la donnola, la volpe, la lepre, la puzzola, lo scoiattolo, il gatto selvatico, il lupo, il camoscio, il cinghiale, l’istrice e la martora. Tra gli uccelli non è difficile vedere il falco pellegrino, l’aquila, l’astore, lo sparviero e la poiana. Serbatoio naturale di acqua, il Gran Sasso dà vita a innumerevoli sorgenti, tra le più note abbiamo Fonte Vetica, le sorgenti del Ruzzo e del Vitello d’Oro, e fiumi tra cui il Vomano, il Fino, il Tavo e il Tirino. Non meno importanti e belli da vedere sono i vari laghetti che troviamo sparsi su tutto il territorio: il più grande è il lago di Campotosto.
1 Indica con una X il completamento corretto di ogni frase.
• Il Corno Grande è: la cima più alta degli Appennini. più alto del Gran Sasso.
• Il massiccio del Gran Sasso viene definito “alpino”: per le cime arrotondate e senza neve. per le cime aguzze, le valli incise, i laghetti.
• Il ghiacciaio del Calderone: si trova nelle Alpi. è l’unico degli Appennini.
• Si possono trovare: uccelli rapaci. uccelli, volpi, lupi, scoiattoli e gatti domestici.
• Il Vomano, il Fino, il Tavo e il Tirino: sono laghetti appenninici. sono fiumi appenninici.
• Il lago di Campotosto: è il più grande della zona. è l’unico della zona.
NOME E COGNOME DATA CLASSE
I VULCANI
1 Indica con una X le conclusioni corrette.
• I vulcani spenti:
hanno cessato ogni attività da più di 10 000 anni.
hanno cessato ogni attività da più di 5 000 anni. spesso si risvegliano in modo preoccupante.
• I vulcani attivi:
hanno cessato ogni attività da più di 5 000 anni.
non hanno ancora cessato la loro attività.
non esistono in Italia.
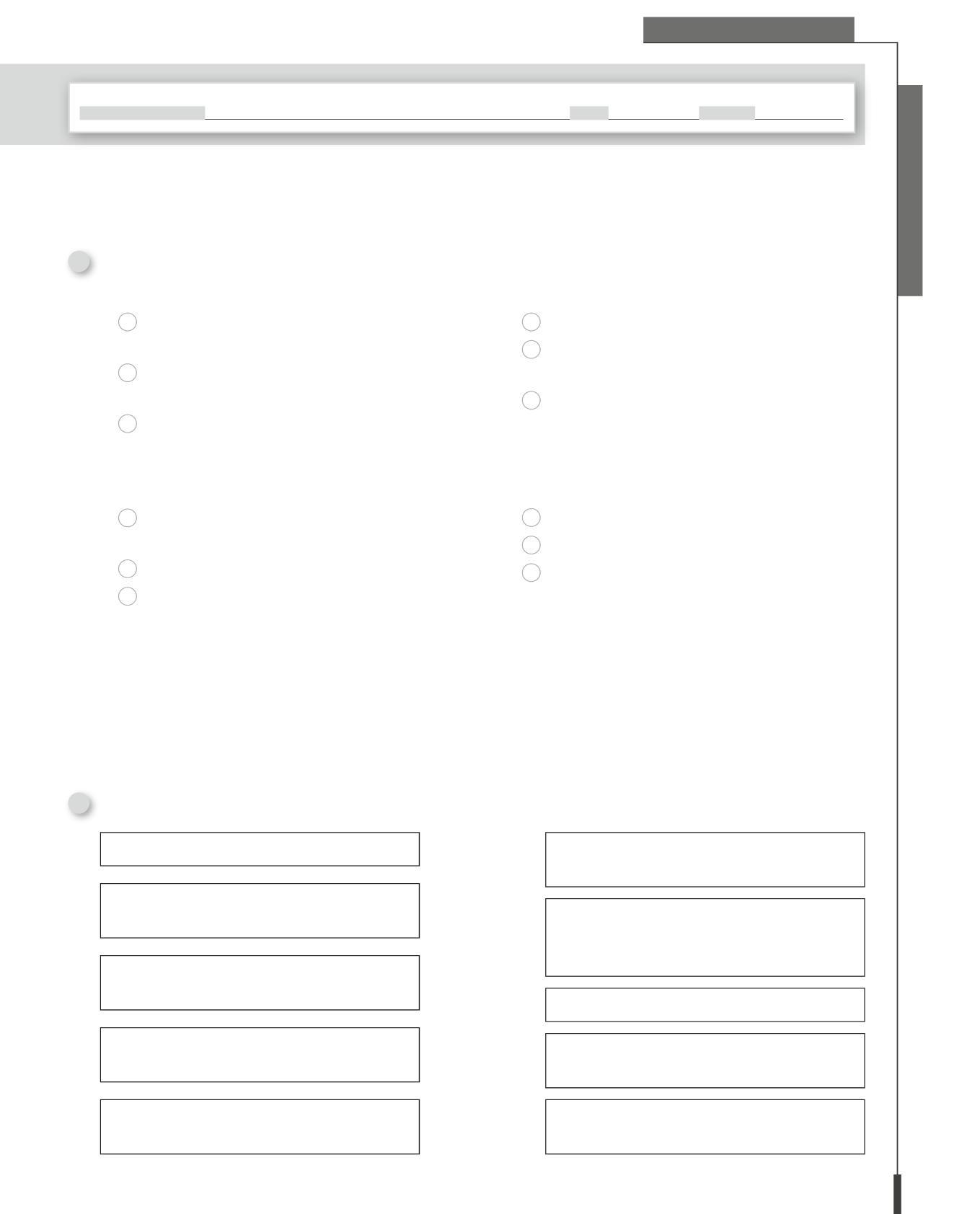
• I vulcani a risposo: sono spenti.
hanno cessato ogni attività da più di 5 000 anni.
hanno cessato ogni attività da meno di 10 000 anni.
• L’Etna e lo Stromboli: sono vulcani a riposo. sono vulcani attivi. sono vulcani spenti.
I TERREMOTI
2 Collega l’inizio della frase al suo completamento corretto.
I terremoti si verificano quando…
L’Italia è un Paese a elevata sismicità, cioè…
Le zone a rischio di terremoto sono presenti su tutto il territorio italiano…
Dal 1900 a oggi ci sono stati decine di terremoti molto forti…
La scienza non è ancora in grado di prevedere i terremoti…
… con l’eccezione della Sardegna e della Penisola Salentina.
… ma nelle zone a rischio si devono costruire edifici con norme antisismiche.
… e centinaia di altri meno intensi.
… le placche che si trovano sotto la crosta terrestre si scontrano tra loro.
… molto soggetto alle scosse di terremoto.
NOME E COGNOME DATA CLASSE
I VULCANI
1 Collega l’inizio di ogni frase al completamento corretto.
I vulcani spenti…
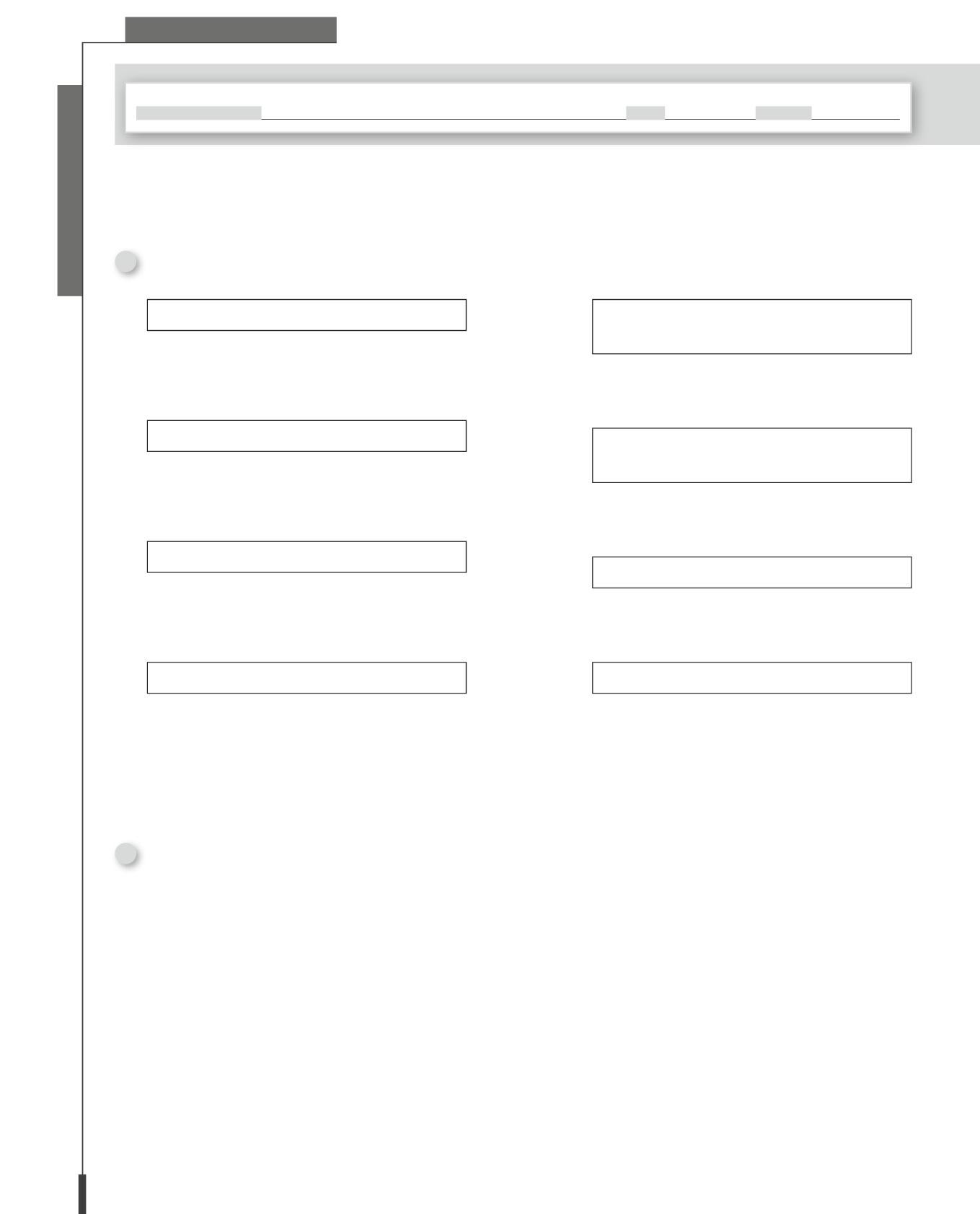
… hanno cessato ogni attività da più di 10 000 anni.
I vulcani attivi…
I vulcani a riposo…
L’Etna e lo Stromboli…
… non hanno ancora cessato la loro attività.
… sono spenti.
… sono vulcani attivi.
I TERREMOTI
2 Sottolinea l’alternativa corretta per completare le frasi.
• I terremoti si verificano quando le placche / montagne della crosta terrestre si scontrano tra loro.
• L’Italia è un Paese a elevata sistematicità / sismicità, cioè molto soggetto alle scosse di terremoto.
• Le zone a rischio di terremoto sono presenti su tutto il territorio italiano, Sardegna e Penisola Salentina escluse / comprese
• Dal 1900 a oggi ci sono stati una decina / trentina di terremoti molto forti e centinaia di altri meno intensi.
• La scienza non è ancora in grado di prevedere i terremoti, ma nelle zone a rischio si devono costruire edifici con norme sismiche / antisismiche
OBIETTIVI: Conoscere le caratteristiche dei vulcani italiani. • Conoscere il lessico specifico. • Conoscere il rischio sismico del territorio italiano.
NOME E COGNOME DATA
SCOPRO I VULCANI
1 Leggi il brano e poi completa l’immagine con le parole date.
La Terra è formata da diversi strati sovrapposti.
Lo strato più esterno, quello su cui camminiamo, si chiama crosta terrestre. Sotto la crosta c’è una zona detta mantello, che è formata dal magma, cioè roccia fusa.
Il vulcano è una spaccatura della crosta che permette la risalita in superficie del magma attraverso il camino. Quando questo accade, avviene un’eruzione vulcanica e dal cratere fuoriescono lava, cenere e lapilli, vapore e gas. A mano a mano che esce, la lava si raffredda e si solidifica.
camino • cenere e lapilli • cratere • lava • magma • vapore e gas
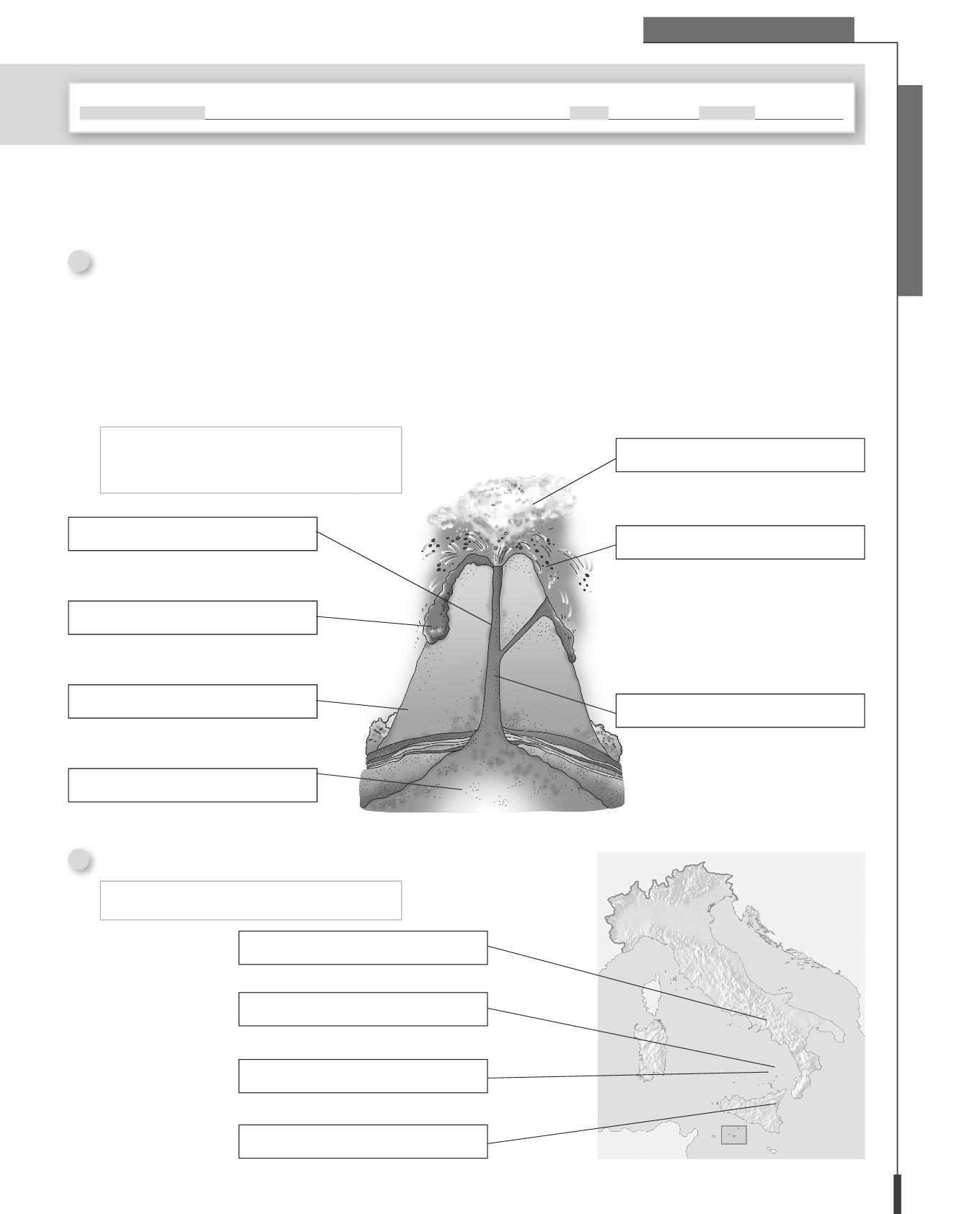
cono vulcanico
2 Inserisci i seguenti nomi dei vulcani italiani al posto corretto.
Etna • Stromboli • Vesuvio • Vulcano
LE COLLINE
1 Colora in giallo le caselle che contengono le caratteristiche delle colline, in marrone quelle riferite alle montagne.
Occupano il 35% del territorio italiano.
Hanno altezza inferiore ai 600 metri.
Hanno cime arrotondate.
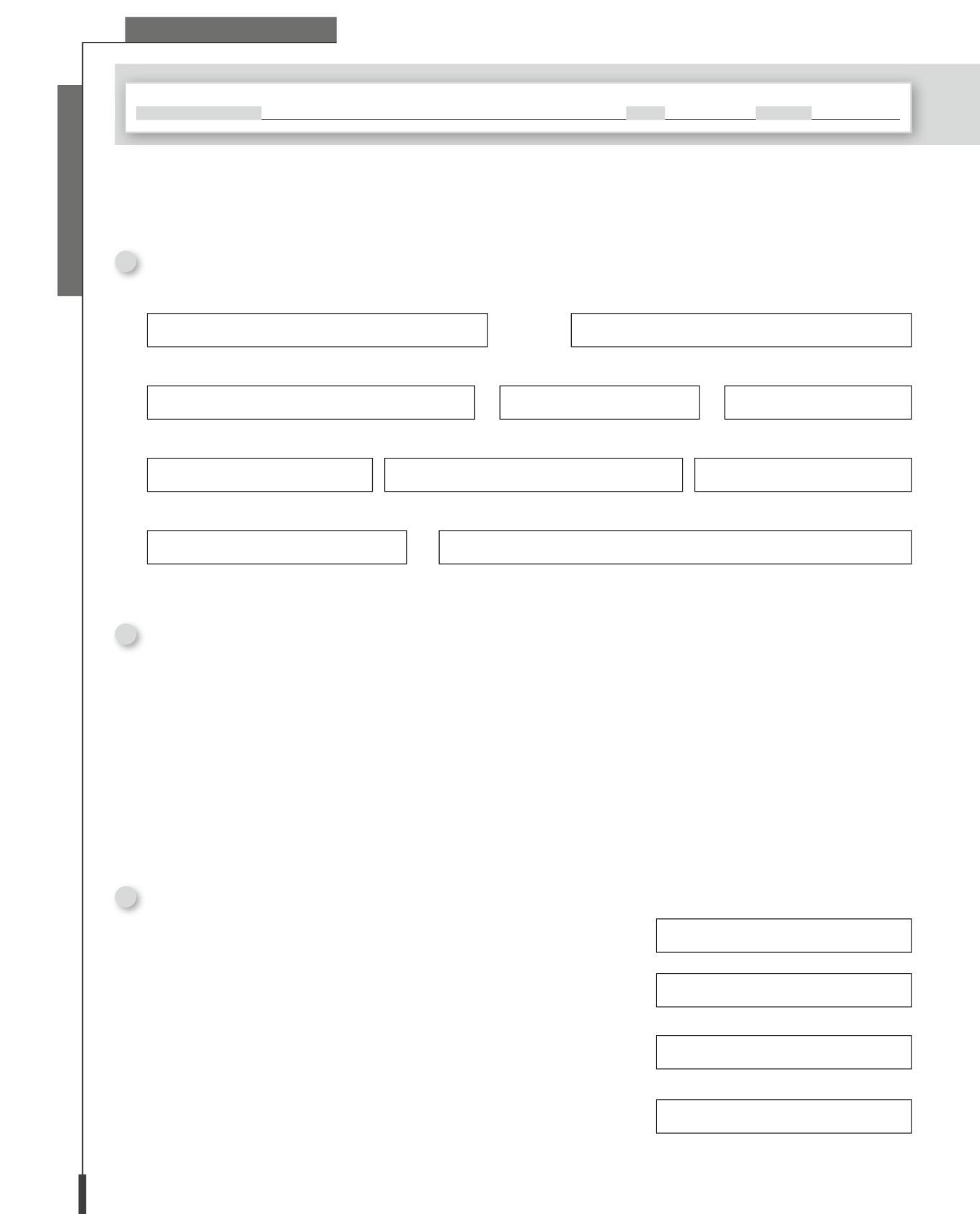
Occupano il 42% del territorio italiano.
Hanno altezze elevate. Hanno cime aguzze.
Hanno una vegetazione ricca. Forniscono materiali da costruzione Presentano dei ghiacciai.
Hanno una vegetazione scarsa oltre una certa altitudine.
2 Completa le frasi sull’origine delle colline.
• Le colline erano montagne che sono state erose nel corso del tempo e hanno assunto una forma arrotondata.
• Le colline si sono formate dall’accumulo di detriti lasciati dai ghiacciai scomparsi.
• Le colline erano vulcani che hanno cessato la loro attività.
• Le colline si sono formate dal sollevamento della crosta terrestre o dei fondali marini.
3 Scrivi qual è l’origine dei seguenti gruppi di colline.
• Colline del Chianti in Toscana e Colline Umbre.
• Serra d’Ivrea e Colline del Canavese, in Piemonte, e della Brianza in Lombardia.
• Colline del Monferrato e delle Langhe in Piemonte e delle Murge in Puglia.
• Colli Euganei e Monti Berici nel Veneto, e Colline Metallifere in Toscana.
NOME E COGNOME DATA CLASSE
LE COLLINE
1 Sottolinea l’alternativa corretta per completare le frasi.
• Le colline sono rilievi dalle forme aguzze / arrotondate.
• Le colline sono alte più / meno di 600 metri.
• Le colline occupano una gran / piccola parte del territorio italiano.
• Le colline italiane hanno origini uguali / diverse.
• Le colline italiane hanno un aspetto diverso / simile
2 Completa con le parole seguenti.
moreniche • strutturali • tettoniche • vulcaniche
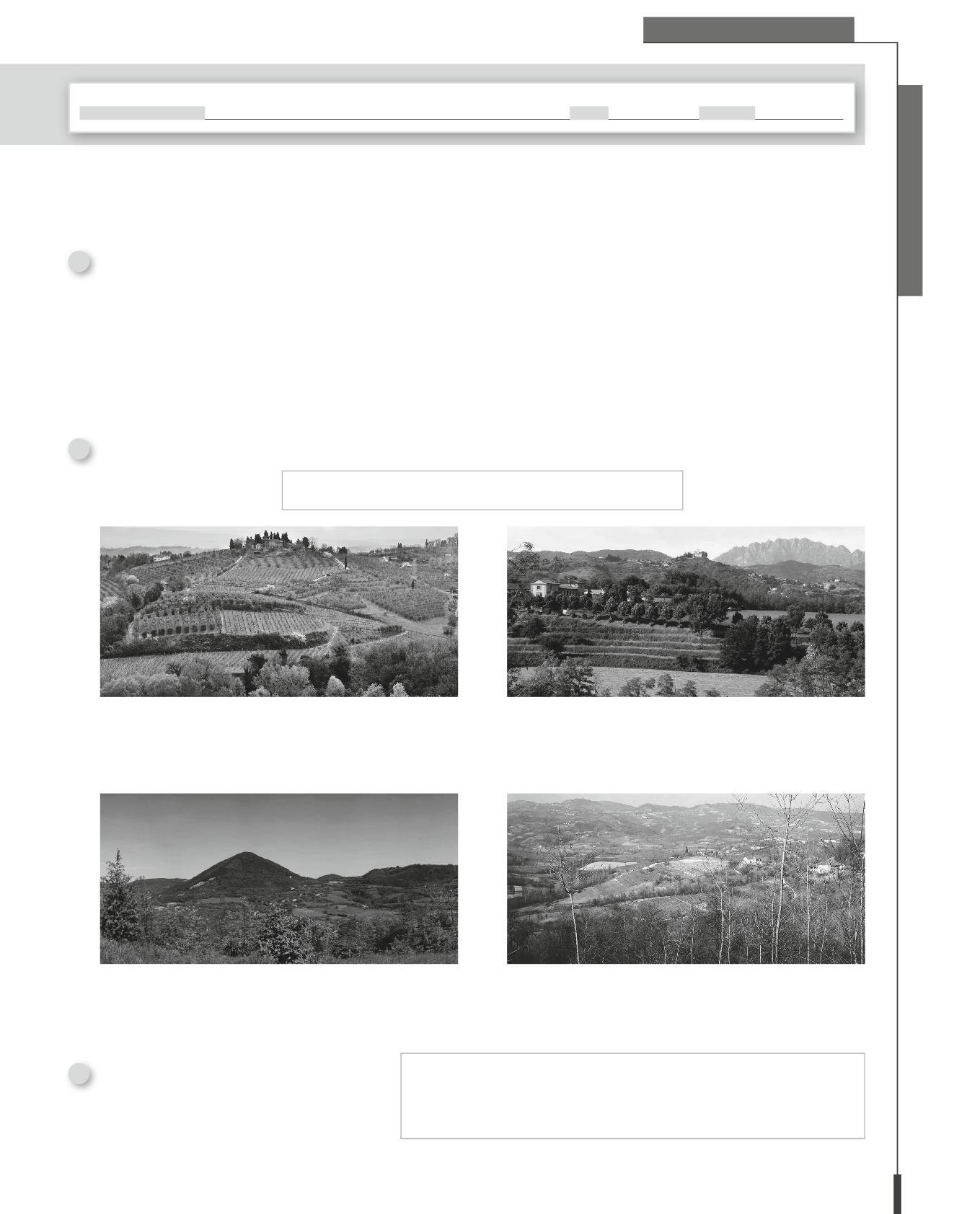
Le colline erano montagne Le colline si sono formate che sono state erose nel corso del tempo dall’accumulo di detriti lasciati dai ghiacciai e hanno assunto una forma arrotondata. scomparsi.
Le colline erano vulcani Le colline si sono formate che hanno cessato la loro attività. dal sollevamento della crosta terrestre o dei fondali marini.
3 Tra questi nomi di colline italiane ci sono alcuni nomi di montagne. Cancellali con un tratto di matita.
Adamello • Bernina • Colline della Brianza • Canavese • Chianti • Gran Sasso • Langhe • Metallifere • Monferrato • Monti Iblei • Murge • Terminillo

LE LANGHE, COLLINE PIEMONTESI
Colline e vigneti che si alternano a castelli e borghi storici: questo è il paesaggio che si propone allo sguardo dei visitatori delle Langhe.
La zona piemontese a cavallo tra Cuneo e Asti offre un susseguirsi di panorami spettacolari. Già solo attraversando la Strada Romantica, un percorso di undici tappe che si snoda su cento chilometri, si può assaporare la varietà di questi luoghi nella loro totalità.
Ci si imbatte negli scoscesi profili delle Rocche del Roero, entrati a far parte dei Patrimonio dell’Umanità dell’Unesco, nelle colline della Langa del Barolo e del Barbaresco e nei loro vigneti, fino agli scenari dell’Alta Langa, dove domina il verde rigoglioso dei boschi. I castelli medievali che sorgono nella zona rappresentano uno degli elementi caratterizzanti del paesaggio. Tra i più belli ci sono il Castello di Barolo, il Castello di Govone, il Castello di Grinzane Cavour e molti altri.
Impossibile pensare alle Langhe senza associarle alla gastronomia. Il territorio è un susseguirsi di vigneti: i vini sono tra i prodotti tipici locali. Altri prodotti tipici sono il tartufo, i salumi, i formaggi e le carni. Proprio grazie ai suoi prodotti tutta la zona è diventata meta di turismo enogastronomico.
1 Sottolinea l’alternativa corretta per completare le frasi.
• Le colline delle Langhe si visitano / si trovano a cavallo tra Cuneo e Asti.
• Nelle Langhe si possono ammirare colline e grandi centri / piccoli borghi storici.
• Il paesaggio delle Langhe è costituito da colline di aspetto uguale / diverso
• Le Rocche del Roero sono colline con profili arrotondati / scoscesi
• Le Rocche del Roero fanno parte del Patrimonio dell’Umanità dell’Onu / Unesco.
• La Strada Romantica è un percorso che si snoda per cento / undici chilometri.
• Il paesaggio è caratterizzato da numerosi musei / castelli
• I prodotti enogastronomici / economici delle Langhe sono il tartufo, i salumi, i formaggi, le carni, i vini.
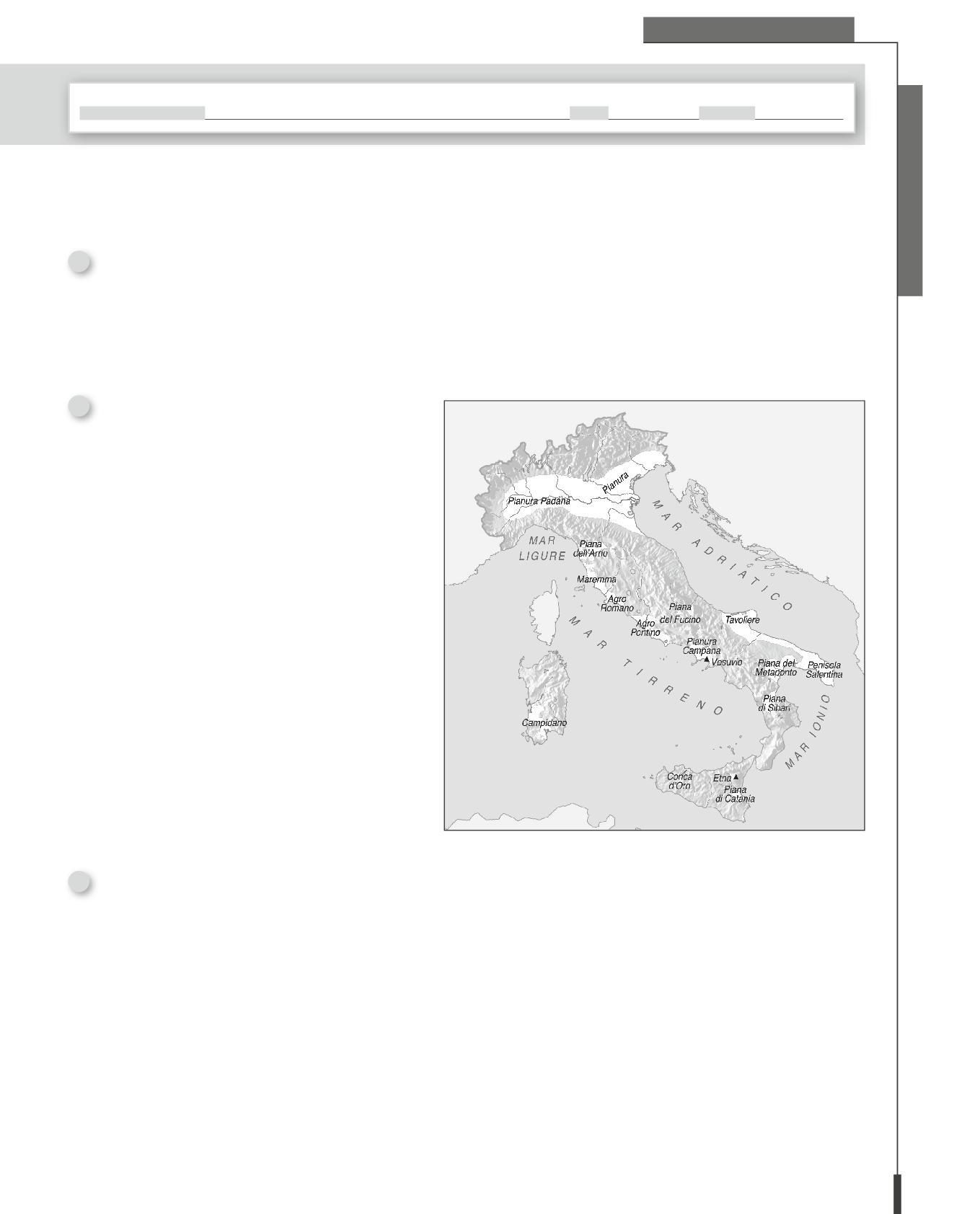
LE PIANURE
1 Scrivi la definizione relativa all’origine di ogni pianura.
• Pianura alluvionale:
• Pianura vulcanica:
• Pianura di sollevamento:
2 Leggi il testo, poi colora sulla carta le diverse pianure. Dovrai colorare in verde le pianure alluvionali, in blu le pianure di sollevamento e in rosso le pianure vulcaniche.
La pianura italiana più vasta è la Pianura Padano-Veneta, di origine alluvionale.
La seconda per estensione è il Tavoliere delle Puglie, che è una pianura di sollevamento come il Campidano in Sardegna.
Altre piccole pianure di origine alluvionale sono la Maremma, l’Agro Romano e l’Agro Pontino, la Piana di Sibari e la Piana di Metaponto.
Altre aree pianeggianti si trovano ai piedi di vulcani. Sono la Pianura Campana e la Piana di Catania.
3 Completa il testo sulla Pianura Padana.
La Pianura Padana si estende nelle regioni del Piemonte, della Lombardia, dell’Emilia-Romagna e del Veneto dove prende il nome di Pianura . È formata dal fiume Po, che anticamente era chiamato
A poco a poco si è riempita con i detriti trasportati dal e dai suoi affluenti, quindi è una pianura
Un tempo la pianura era coperta di e . In seguito le zone paludose sono state e rese coltivabili.
Oltre all’agricoltura, nella Pianura Padana, si pratica l’ e sono presenti molte
LE PIANURE
1 Collega il tipo di pianura alla sua definizione.
alluvionale
di sollevamento
vulcanica
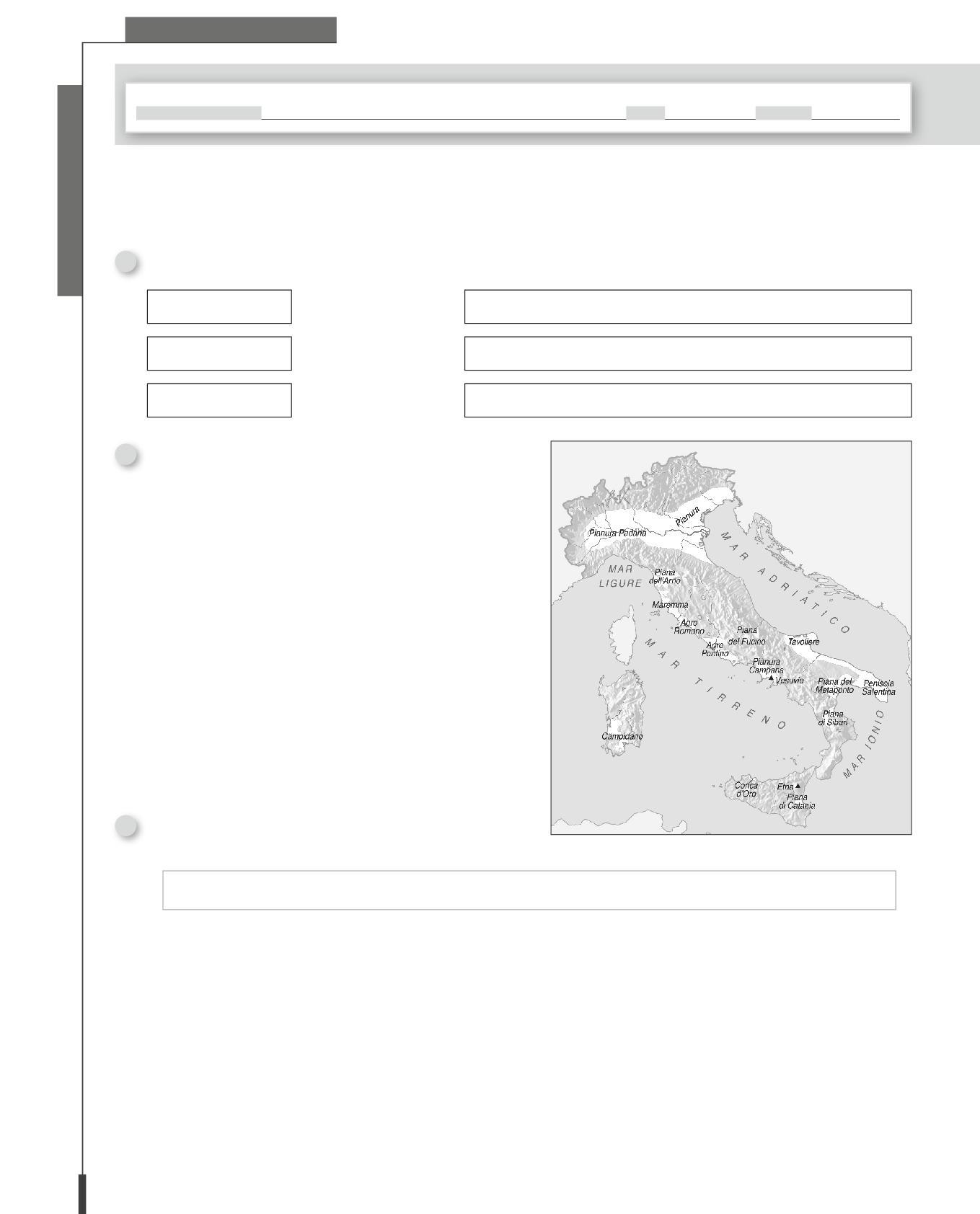
Formata in zone vulcaniche con un terreno fertile.
Formata dai detriti trasportati dai fiumi nel tempo.
Nata dal sollevamento dei fondali marini o del terreno.
2 Leggi il testo, poi colora sulla carta le diverse pianure. Dovrai colorare in verde le pianure alluvionali, in blu le pianure di sollevamento e in rosso le pianure vulcaniche.
La pianura italiana più vasta è la Pianura Padano-Veneta, di origine alluvionale.
La seconda per estensione è il Tavoliere delle Puglie, che è una pianura di sollevamento come il Campidano in Sardegna.
Altre piccole pianure di origine alluvionale sono la Maremma, l’Agro Romano e l’Agro Pontino, la Piana di Sibari e la Piana di Metaponto
Altre aree pianeggianti si trovano ai piedi di vulcani. Sono la Pianura Campana e la Piana di Catania
3 Completa il testo sulla Pianura Padana con le parole seguenti.
Veneto-Friulana
allevamento • bonificate • boschi • industrie • Padus • paludi • Po • Veneto-Friulana
La Pianura Padana si estende nelle regioni del Piemonte, della Lombardia, dell’Emilia-Romagna e del Veneto dove prende il nome di Pianura .
È formata dal fiume Po, che anticamente era chiamato .
A poco a poco si è riempita con i detriti trasportati dal e dai suoi affluenti, quindi è una pianura
Un tempo la pianura era coperta di e . In seguito le zone paludose sono state e rese coltivabili.
Oltre all’agricoltura, nella Pianura Padana, si pratica l’ e sono presenti molte .
IL LABIRINTO DELLA PIANURA PADANA
Il labirinto più grande del mondo si trova a Fontanellato, in provincia di Parma, un borgo ricco di storia, grazie a un’idea di Franco Maria Ricci, editore, designer, collezionista d’arte, bibliofilo.
Il labirinto è fatto di bambù. Ricci ha piantato in questi anni più di 20 000 bambù e, nel parco, se ne possono trovare circa 20 specie differenti, da quelle nane a quelle giganti.
Il labirinto è un luogo multiforme e originale, a partire dall’architettura dell’intero progetto.
Il perimetro è a stella. All’interno del labirinto, che comprende 3 chilometri di percorsi, c’è anche una cappella a forma di piramide.
Fontanellato, con il suo splendido centro storico, la Rocca Sanvitale e gli affreschi del Parmigianino, racchiude in sé uno straordinario patrimonio artistico.
Ad affascinare Ricci, oltre alla vicinanza a un luogo così ricco di bellezza, è anche l’affetto per la natura campestre della zona, nello specifico la tenuta, che appartiene alla sua famiglia da generazioni. Quello di Ricci è un dedalo elegante e seducente. Un luogo di cultura, disteso su otto ettari di terreno, da lui progettato con gli architetti Pier Carlo Bontempi, che ha eseguito gli edifici, e Davide Dutto, che ha progettato la geometria del parco.
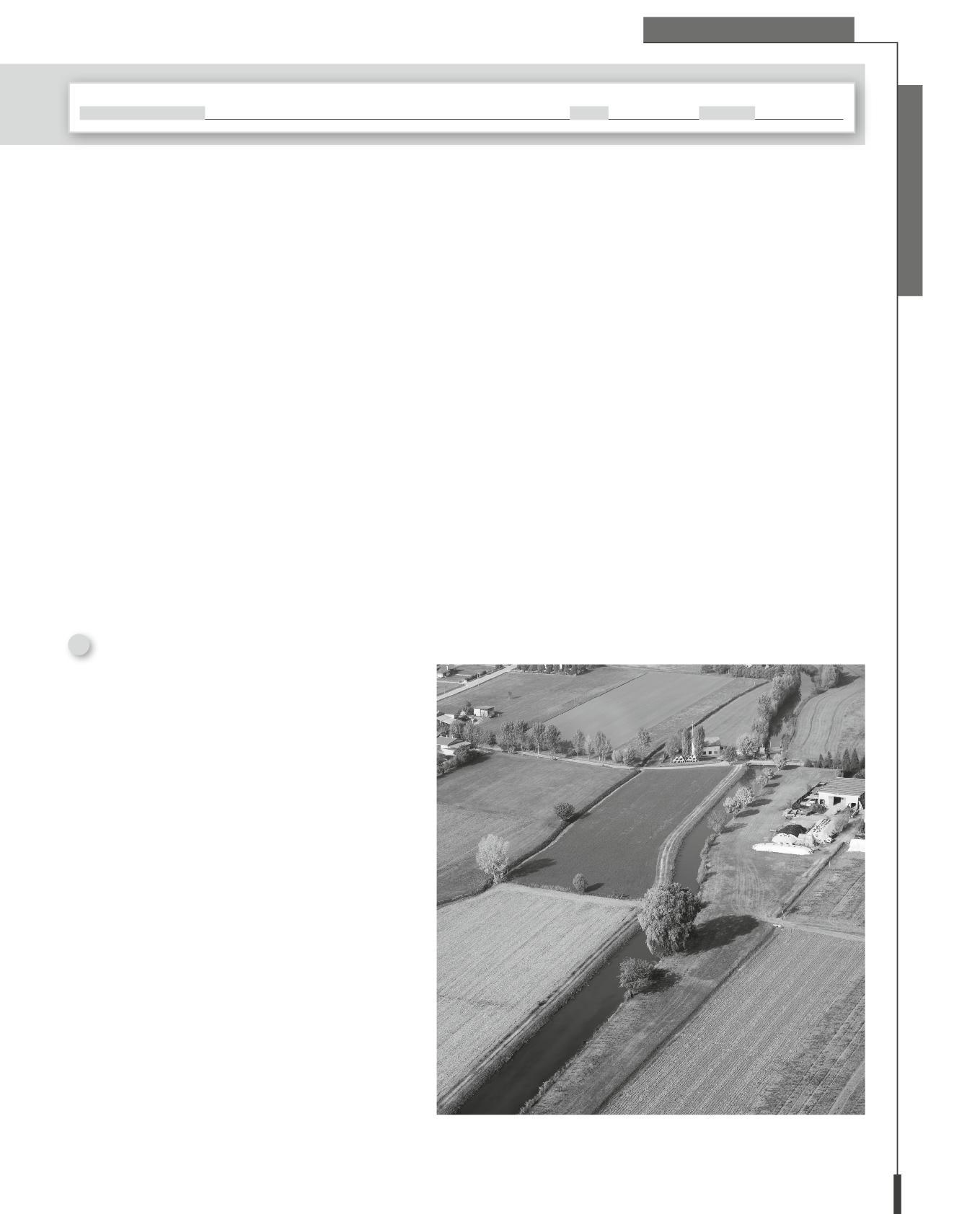
1 Leggi il testo e completa le frasi.
• Il labirinto più grande del mondo si trova a
• Il labirinto è costituito da piante di
• Il suo ideatore, Franco Maria Ricci, ha piantato
• Il labirinto ha la forma di una
• Il labirinto ha un percorso lungo
• All’interno c’è una
• Si trova in un luogo ricco di
• Ricci progettò il labirinto con
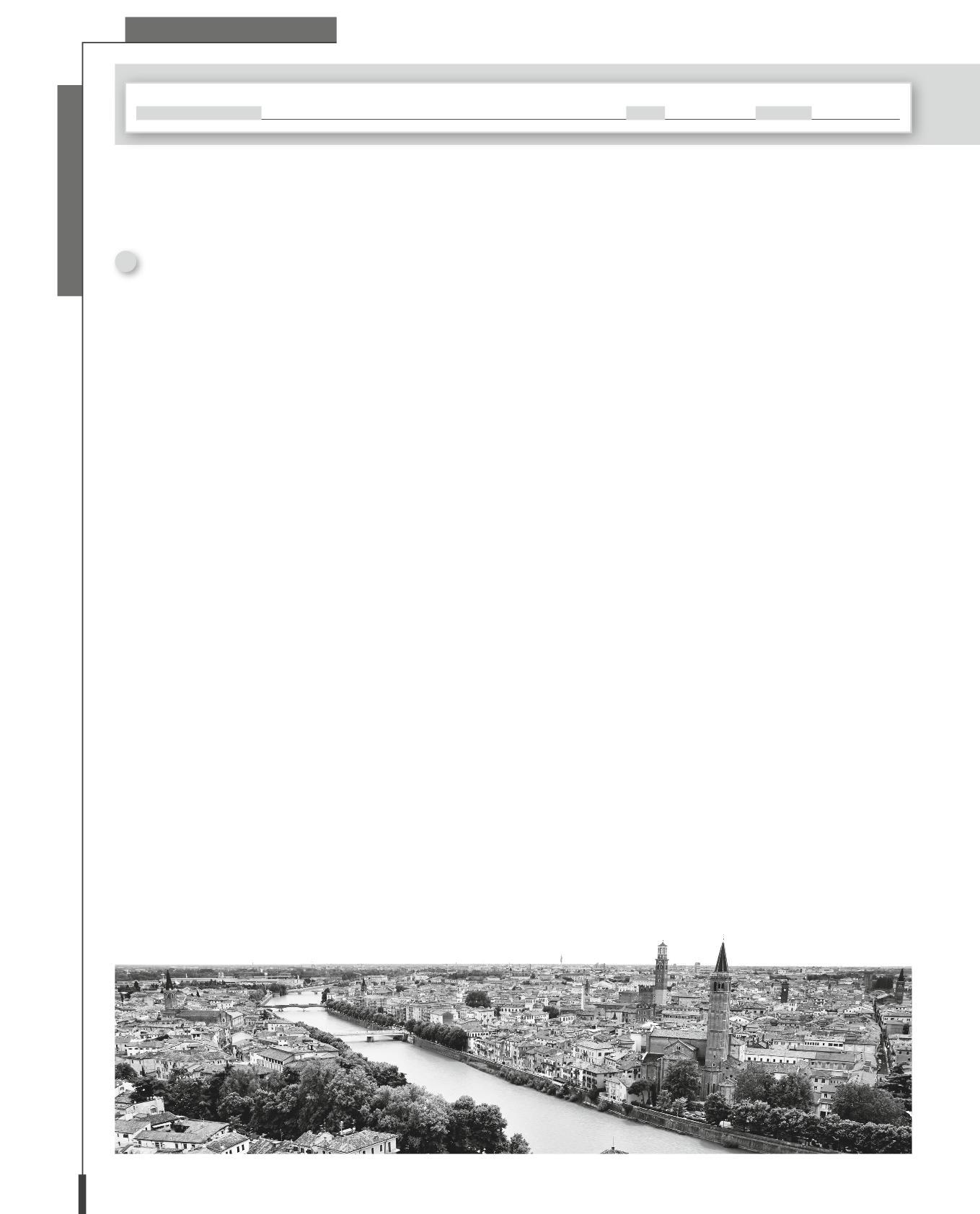
VIVERE LUNGO I CORSI D’ACQUA
1 Completa le risposte alle seguenti domande.
• Dove nasce un fiume?
I fiumi italiani nascono dalle e dagli
I fiumi alpini sono alimentati dallo scioglimento delle nevi e dei nelle stagioni calde, e dalla pioggia nelle stagioni
I fiumi appenninici sono alimentati solo dalle e sono a carattere
• Dove sfocia un fiume?
Un fiume che confluisce in un altro fiume si chiama .
I fiumi che si gettano direttamente nel mare hanno la a delta oppure a estuario.
• Quali sono i principali fiumi italiani?
Il fiume italiano più lungo è il . Nasce sul , una cima delle
Alpi Occidentali, e sfocia nel Mar con una foce a Il secondo fiume italiano è l’ , che nasce nelle Orientali.
I fiumi più lunghi che hanno origine dagli Appennini sono il che attraversa Roma, e l’ che bagna Firenze.
• Perché gli esseri umani nel passato hanno costruito città lungo i fiumi?
Le città sono state costruite lungo i fiumi perché era più semplice procurarsi
l’ da bere e da utilizzare per i cibi, irrigare i , abbeverare gli
• Perché ancora oggi il fiume è importante per gli esseri umani?
L’acqua è fondamentale per l’ e per l’ ; la sua forza è utilizzata per produrre elettrica e per alimentare gli

NOME E COGNOME DATA CLASSE
VIVERE LUNGO I CORSI D’ACQUA
1 Completa le risposte alle domande con le parole seguenti.
acqua • acquedotti • Adige • Adriatico • affluente • agricoltura • Alpi • animali • Appennini • Arno • campi • delta • energia • foce • fredde • ghiacciai • industria • Monviso • piogge • Po • Tevere • torrentizio
• Dove nasce un fiume?
I fiumi italiani nascono dalle e dagli
I fiumi alpini sono alimentati dallo scioglimento delle nevi e dei nelle stagioni calde, e dalla pioggia nelle stagioni .
I fiumi appenninici sono alimentati solo dalle e sono a carattere
• Dove sfocia un fiume?
Un fiume può confluire in un altro fiume e si chiama . I fiumi che si gettano direttamente nel mare hanno la a delta oppure a estuario.
• Quali sono i principali fiumi italiani?
Il fiume italiano più lungo è il . Nasce sul , una cima delle Alpi Occidentali, e sfocia nel Mar con una foce a .
Il secondo fiume italiano è l’ , che nasce nelle Alpi Orientali.
I fiumi più lunghi che hanno origine dagli Appennini sono il che attraversa Roma, e l’ che bagna Firenze.
• Perché gli esseri umani nel passato hanno costruito città lungo i fiumi?
Le città sono state costruite lungo i fiumi perché era più semplice procurarsi l’ da bere e da utilizzare per i cibi, irrigare i , abbeverare gli
• Perché ancora oggi il fiume è importante per gli esseri umani?
L’acqua è fondamentale per l’ e l’ ; la sua forza è utilizzata per produrre elettrica e per alimentare gli
Conoscere
PARCHI E OASI NATURALI LUNGO IL PO
Lungo il corso del fiume Po si trovano 8 parchi e 50 oasi naturalistiche. Ogni parco è a suo modo speciale e, oltre alle diversità di fauna e ambiente, è possibile percorrerlo e scoprirlo in vari modi: in navigazione, a cavallo, a piedi o in bicicletta. Complessivamente ci sono 380 km2 di territorio del delta compresi nel Parco Regionale del Delta del Po dell’Emilia-Romagna e nel Parco del Delta del Veneto. Altri tre parchi si trovano in Piemonte e cinque in Lombardia. Nel vastissimo Parco del Ticino, compreso tra Piemonte e Lombardia, ci sono circa 780 km di percorsi ciclo-pedonali.
Sconfinando in Emilia, il Po a Piacenza scorre attraverso una serie di parchi dove sopravvivono e vengono salvaguardate specie botaniche ormai quasi del tutto estinte, per esempio la quercia palustre. La presenza di estese zone umide e sabbioni richiama numerose specie di uccelli sia stanziali che migratori: rondini di mare, fraticelli, falchi, gufi, picchi, gruccioni.
Negli ultimi chilometri di fiume si snoda il Parco del Delta del Po, compreso tra le province di Rovigo del Veneto e Ferrara e Ravenna dell’Emilia-Romagna: qui oltre 300 specie di uccelli, insieme ad alcuni mammiferi come il “cervo delle dune” del Bosco della Mesola, costituiscono un patrimonio di fauna di elevato valore.
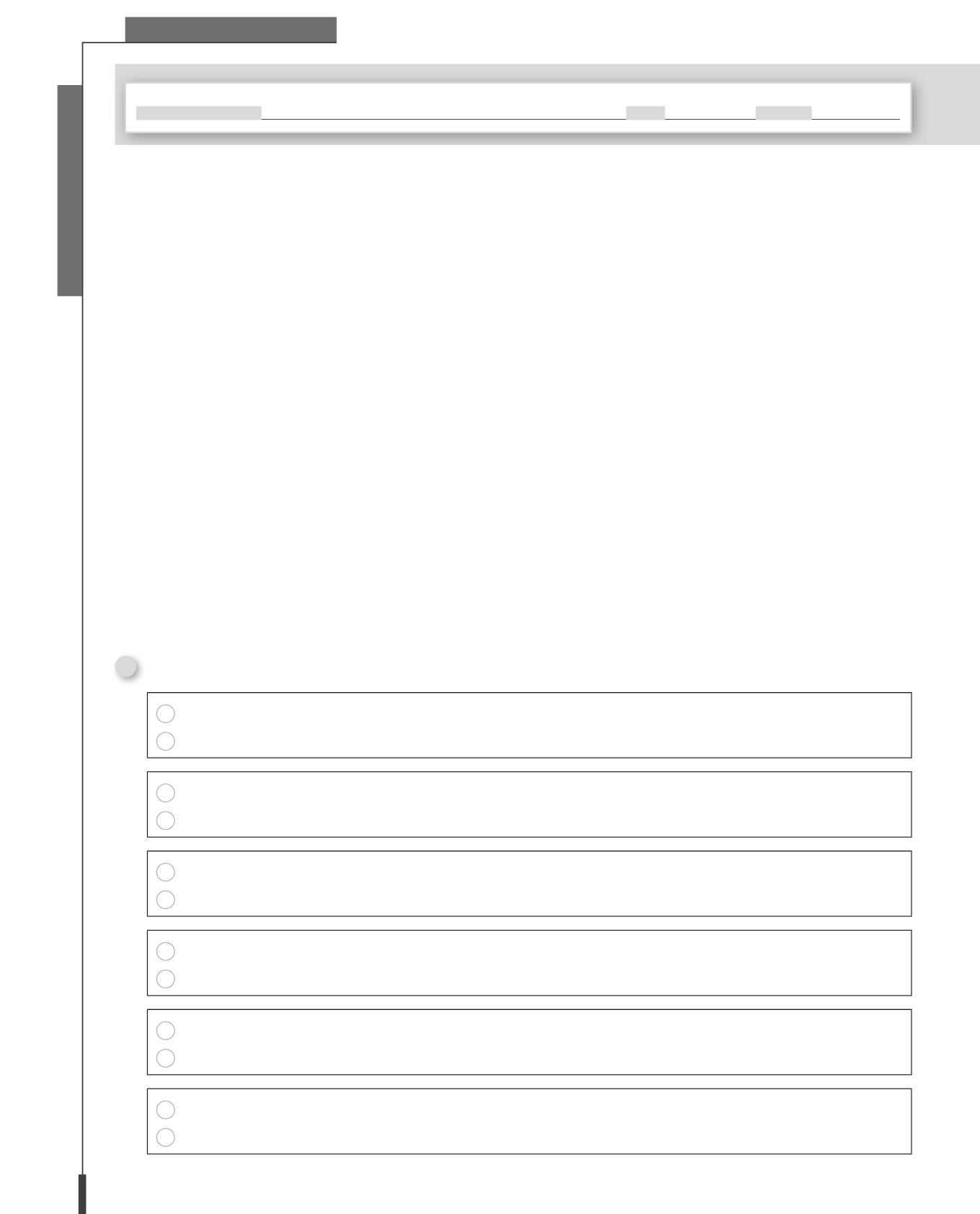
1 Indica con una X l’affermazione corretta.
Lungo il corso del fiume Po si trovano numerosi parchi e oasi naturalistiche.
Lungo il corso del fiume Po si trovano 8 parchi e 50 oasi naturalistiche.
I parchi sono visitabili in autobus, in automobile, in treno.
I parchi sono visitabili in battello, a cavallo, a piedi o in bicicletta.
I parchi del Po si trovano in Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna, Veneto.
I parchi del Po si trovano in Piemonte, Liguria, Emilia-Romagna, Veneto.
Nei parchi crescono specie di piante estinte in altri luoghi.
Nei parchi crescono specie di piante frequenti in pianura.
Nelle zone umide ci sono numerosi uccelli sia stanziali sia migratori.
Nelle zone umide ci sono numerosi uccelli che ci vivono tutto l’anno.
Negli ultimi chilometri del fiume si trova il Parco dell’Emilia-Romagna e del Veneto.
Negli ultimi chilometri del fiume si trova il Parco del Delta del Po.
NOME E COGNOME
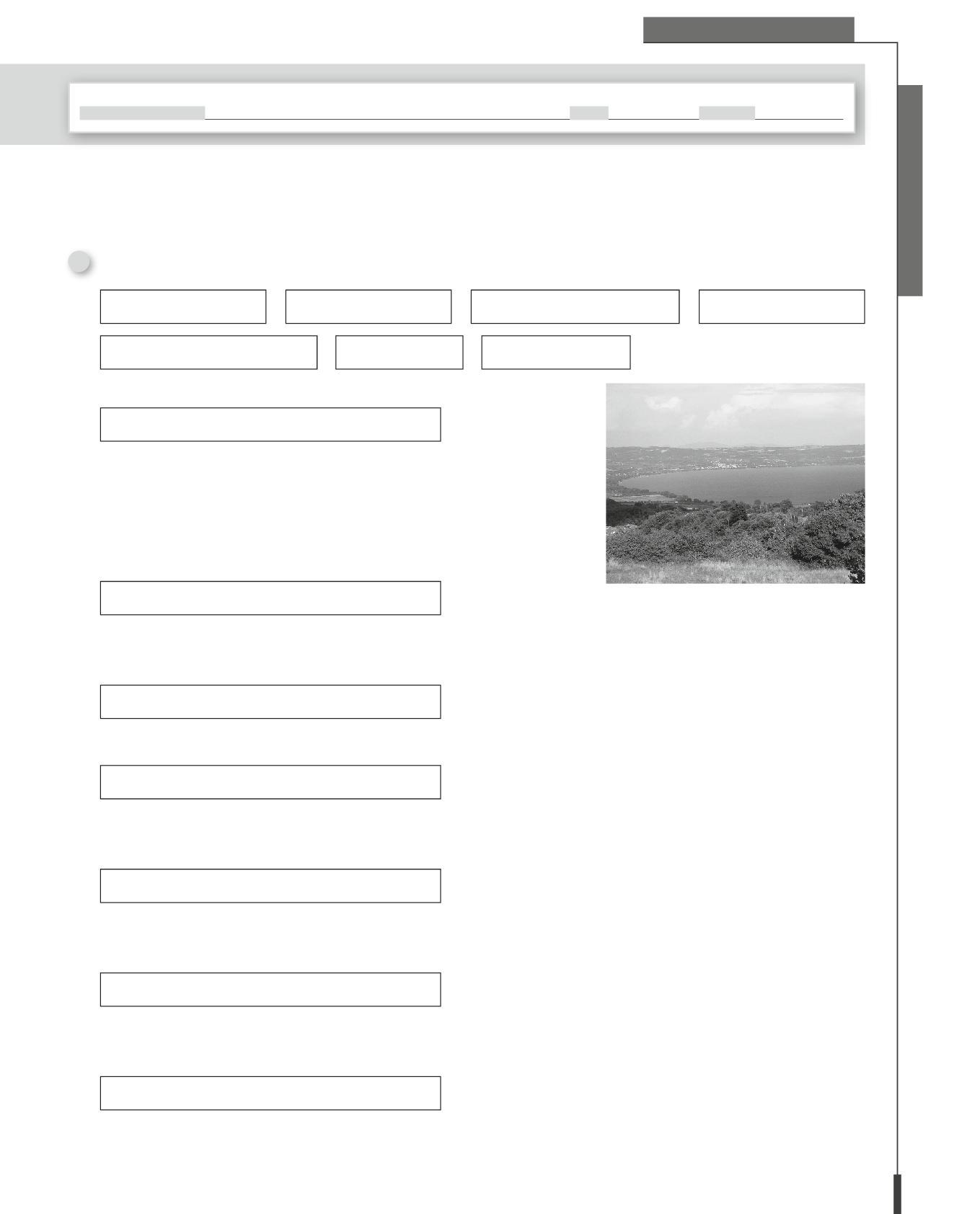
VIVERE SUI LAGHI
1 Scegli un titolo per ogni paragrafo, poi scrivilo nel riquadro corretto.
Laghi artificiali Laghi costieri Laghi vulcanici Laghi di origine glaciale
Laghi di origine tettonica
Le attività
Il clima sui laghi
Le acque dei laghi che si trovano nell’Italia del Nord occupano le conche dove un tempo c’erano i ghiacciai. I più grandi sono il Lago di Garda, il Lago Maggiore, il Lago di Como, il Lago d’Iseo. Ci sono poi molti piccoli laghi alpini che hanno la stessa origine.
Nell’Italia centrale ci sono laghi formati in crateri di vulcani ormai spenti che sono stati riempiti dall’acqua delle piogge. Sono i laghi di Vico, Bracciano, Bolsena e Albano.
Nell’Italia centro-meridionale c’è il lago Trasimeno, che è formato da un abbassamento del suolo.
Ci sono poi laghi come quelli di Varano e Lesina, che si trovano nell’Italia meridionale e che hanno avuto origine dall’accumularsi di sabbia portata dalle onde del mare.
Per la produzione di energia elettrica o per irrigare i campi, sono stati creati numerosi laghi artificiali attraverso dighe che sbarrano i corsi d’acqua.
I laghi di grandi dimensioni hanno un benefico influsso sul clima, che è più mite. Ciò permette di coltivare piante ornamentali e da frutto.
Oltre al clima, la bellezza delle coste e della flora attira numerosi turisti. La pesca, che una volta era un’attività tipica dei laghi, si è ridotta per la diminuzione dei pesci.
OBIETTIVI: Conoscere gli elementi geografici e le caratteristiche dei laghi italiani.
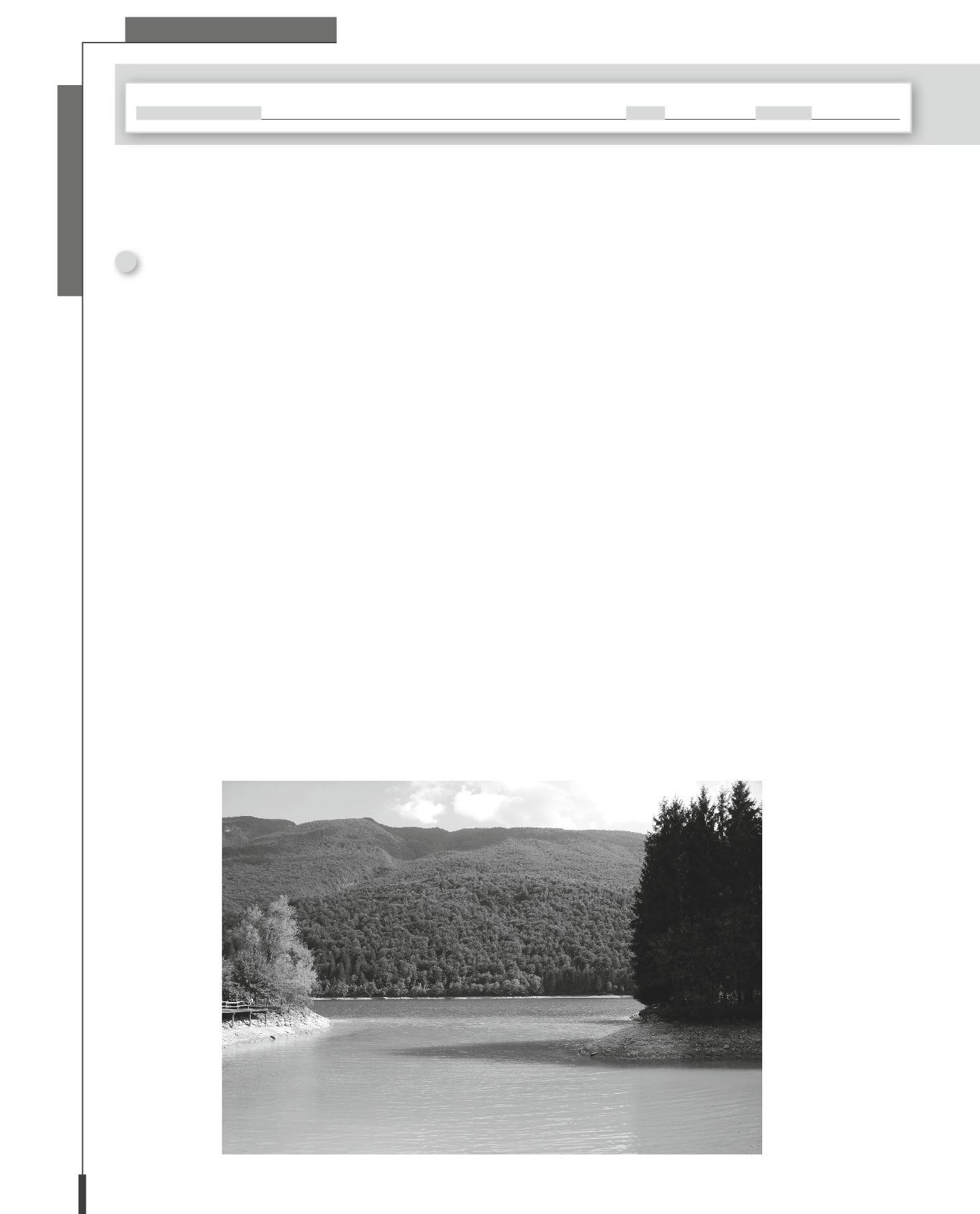
VIVERE SUI LAGHI
1 Sottolinea l’alternativa corretta per completare le frasi.
• I laghi italiani hanno origini uguali / diverse.
• I laghi che si trovano nell’Italia del Nord sono di origine tettonica / glaciale, perché le acque occupano le valli dove un tempo c’erano i ghiacciai. I più grandi / piccoli sono il Lago di Garda, il Lago Maggiore, il Lago di Como, il Lago d’Iseo. Ci sono poi pochi / molti piccoli laghi alpini.
• Nell’Italia centrale ci sono laghi artificiali / di origine vulcanica, formati in crateri di vulcani ormai spenti. Sono laghi craterici / vulcanici i laghi di Vico, Bracciano, Bolsena e Albano.
• Nell’Italia centro-meridionale c’è il lago Trasimeno, che è un lago di origine tettonica / glaciale, perché formato da un abbassamento del suolo.
• Ci sono poi laghi di origine sabbiosa / costiera, come quelli di Varano e Lesina che si trovano lungo le coste dell’Italia meridionale.
• Per la produzione di energia elettrica o per irrigare i campi, sono stati creati anche numerosi laghi naturali / artificiali attraverso dighe che sbarrano i corsi d’acqua.
• Il clima mite / rigido sui laghi permette di coltivare alberi da frutto e fiori.
• Oltre al clima, la bellezza delle cime / coste e della flora attira molti turisti.
IL LAGO TRASIMENO
Nel cuore verde dell’Umbria, tra i canneti e l’incantevole ninfea bianca, si stende il lago Trasimeno, un vero e proprio paradiso naturale in cui si affollano anatre selvatiche, cormorani, il nibbio, il martin pescatore. A fare da cornice, al di là del declivio pianeggiante, dolci colline con boschi che si alternano a campi di girasole e di mais, vigneti e distese di ulivi.
Gli amanti della buona cucina tradizionale sono capitati nel posto giusto. Condito con il pregiato olio dei colli del Trasimeno non bisogna perdere il brodo di pesce, né rinunciare al riso con il sugo bianco a base di filetti di persico e di anguilla. Non a caso, la sagra del pesce che si svolge a settembre attira numerosi turisti. In questa occasione viene usata la padella più grande del mondo, in grado di friggere due quintali di pesce l’ora.
Tra i prodotti tipici da segnalare: olio di oliva, vini, formaggi e miele. Da non perdere infine il dolce
Torciglione e lo zafferano.
Ancora molto forte è la vocazione artigianale: tutto il mondo conosce i merletti dell’Isola Maggiore, la ceramica e gli oggetti in ferro e rame del Trasimeno.
1 Leggi il testo e completa le frasi.
• Il lago Trasimeno si trova in .
• Il paesaggio è caratterizzato da colline,
• Tra i canneti e la ninfea bianca si possono ammirare numerosi uccelli:
• Gli amanti della buona cucina possono gustare
• I prodotti tipici sono
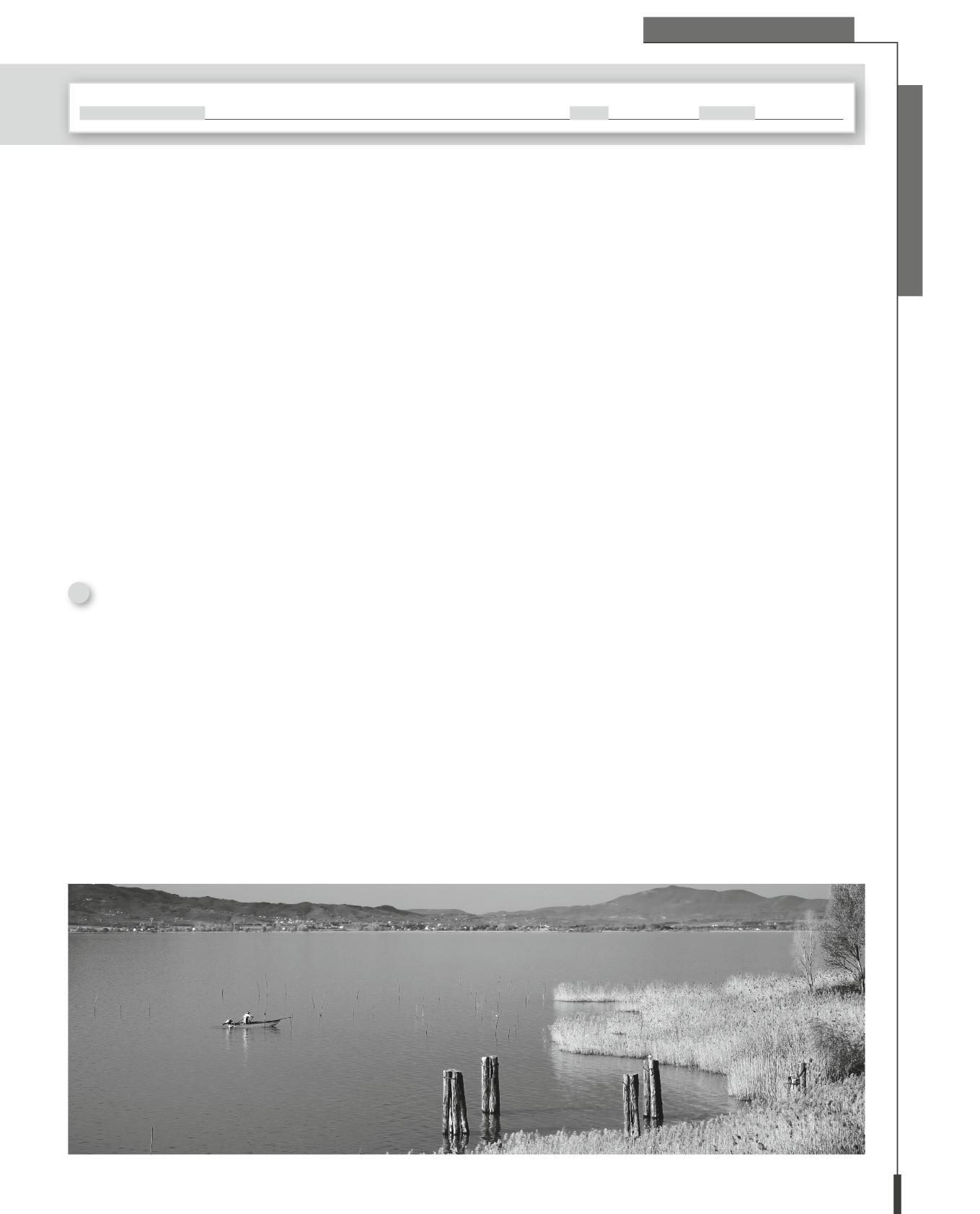
.
VIVERE LUNGO I MARI
1 Osserva la carta e completa le seguenti affermazioni.
• L’Italia è una penisola, cioè
• L’Italia si trova al centro del Mar
• I mari che la bagnano sono:
• Le coste italiane sono di due tipi:
• Le due isole italiane più grandi sono la e la
• Più isole raggruppate formano un
• Nel Mar Tirreno ci sono gli arcipelaghi
• L’unico arcipelago del Mar Adriatico
• Vicino alle coste della Sardegna ci sono l’arcipelago e
• Vicino alla Sicilia ci sono gli arcipelaghi
• Più lontane dalle coste siciliane si trovano le isole di
• Nei centri abitati lungo le coste l’attività più diffusa è
• Un tempo l’attività più fiorente era
• In molte località marine sono stati realizzati porti, utilizzati per

OBIETTIVI: Leggere una carta geografica. • Conoscere i mari, gli oceani, i tipi di coste, le isole, gli arcipelaghi.
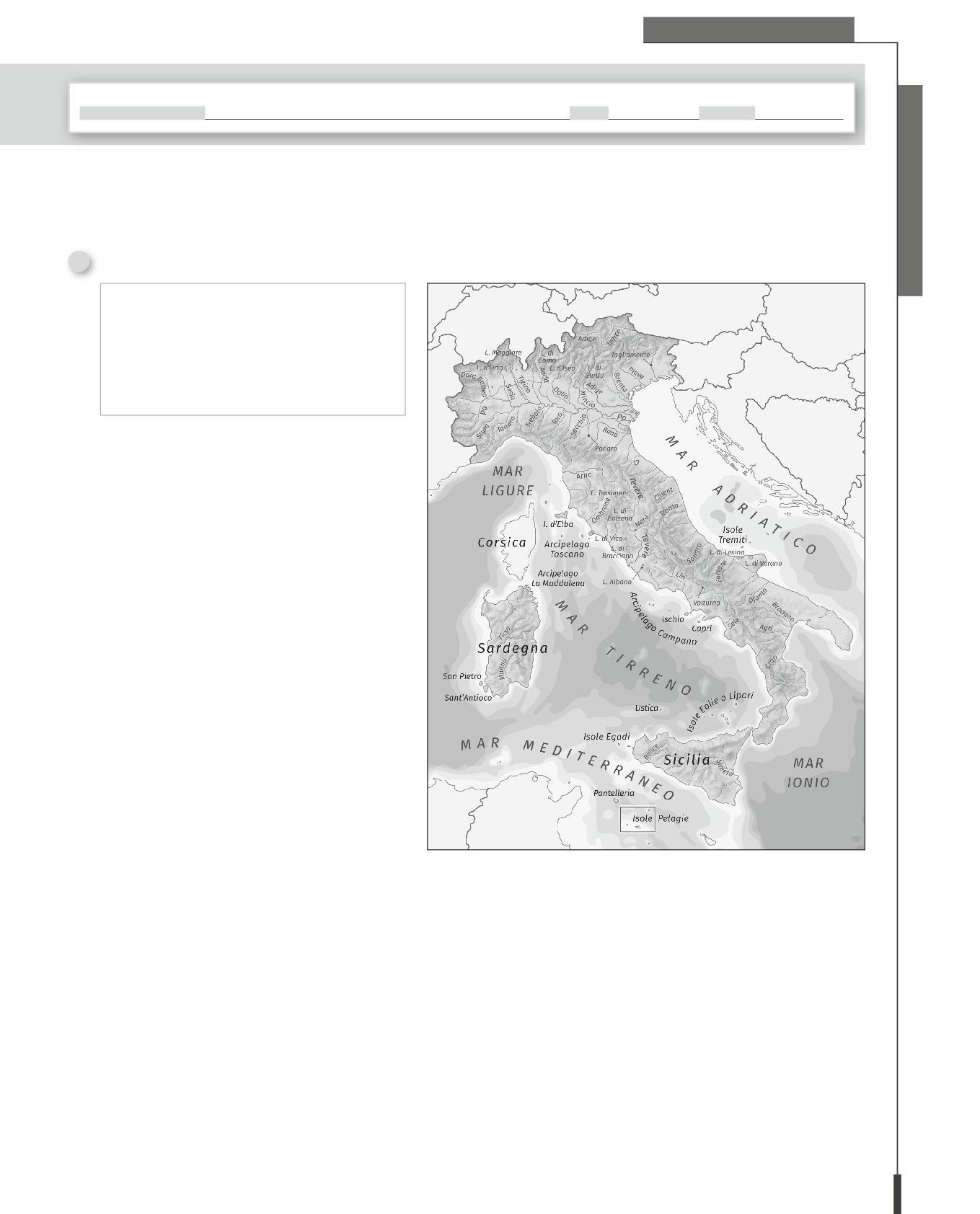
NOME E COGNOME DATA
VIVERE LUNGO I MARI
1 Osserva la carta e completa le seguenti affermazioni.
Adriatico • arcipelago • Campano • Egadi • Ligure • Maddalena • Pantelleria • penisola • pesca • porti • San Pietro • Sardegna • Sicilia
• Toscano • Tremiti • turistica
• L’Italia è una , cioè una terra circondata dal mare su tre lati.
• I mari che la bagnano sono Mar , Mar Tirreno, Mar , Mar Ionio.
• Le due isole italiane più grandi sono la e la .
• Più isole raggruppate formano un .
• I principali arcipelaghi del Mar Tirreno sono: l’arcipelago con l’isola d’Elba e l’arcipelago
• L’unico arcipelago del Mar Adriatico sono le isole
• Vicino alle coste della Sardegna ci sono l’arcipelago della e le isole dell’Asinara, di e di Sant’Antioco.
• Nei mari vicini alla Sicilia ci sono gli arcipelaghi delle Eolie, delle e delle Pelagie.
• Più lontane dalle coste siciliane si trovano le isole di Ustica e
• Nei centri lungo le coste l’attività più diffusa è quella
• Un tempo l’attività più fiorente era la , ma ora viene praticata da un numero ridotto di persone.
• In molte località marine sono stati realizzati da cui partono navi per il trasporto di merci e passeggeri.
LE ISOLE TREMITI
Le isole Tremiti si trovano al largo del Gargano in Puglia. A causa della loro bellezza sono state definite “le perle dell’Adriatico”.
L’arcipelago è formato dalle isole di San Nicola, San Domino, Cretaccio, Capraia e Pianosa. Le isole Tremiti appaiono come un grande museo a cielo aperto: il mare, i luoghi e gli eventi che si svolgono sulle cinque isole attirano ogni anno migliaia di turisti.
Tra le mete turistiche spiccano il centro storico dell’isola di San Nicola, con l’abbazia di Santa Maria e il Castello dei Badiali. Sull’isola di Capraia, la seconda dell’arcipelago per estensione, non vi è traccia umana, mentre l’isola di Pianosa, anch’essa disabitata, è una riserva naturale.
Le isole Tremiti presentano molte grotte, spiagge, calette, rocce, scogli e faraglioni che incorniciano le cinque isole dell’arcipelago. L’acqua molto limpida offre un’ottima visuale del fondale marino. Sono presenti numerose grotte marine: la Grotta delle Rondinelle, chiamata così perché in primavera vi nidificano le rondini; la Grotta delle Viole, che riproduce colori meravigliosi, e la Grotta del Sale, dove si raccoglie una gran quantità di sale bianchissimo.
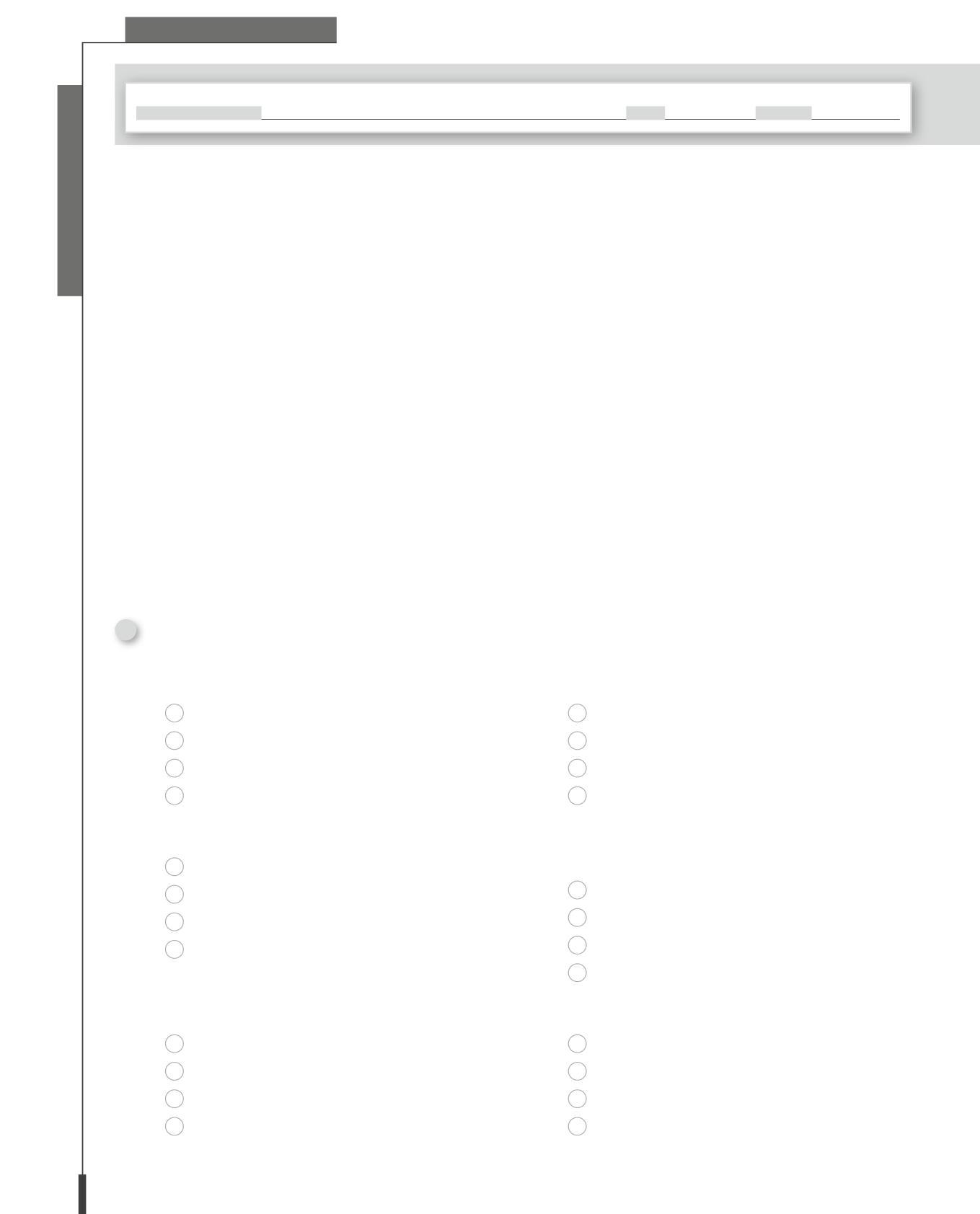
1 Indica con una X le conclusioni corrette. Attenzione: possono essere più di una per ogni affermazione.
• Le isole Tremiti si trovano: nel Tirreno. nell’Adriatico. al largo del Gargano. in Puglia.
• L’arcipelago è formato da: sette isole. cinque isole. un numero imprecisato di isole. San Nicola, San Domino e Capraia.
• Le isole Tremiti sono un museo a cielo aperto: perché ci vanno tanti turisti. per la bellezza del mare. per i luoghi storici. per gli avvenimenti.
• Alle isole Tremiti si può ammirare: un’abbazia. un castello.
solo la bellezza del mare. la bellezza del paesaggio e monumenti storici.
• Delle cinque isole: due sono disabitate. una sola è abitata. Pianosa è una riserva naturale. Capraia non è abitata.
• Sono presenti molte grotte marine: Grotta delle Viole. Grotta delle Rose. Grotta delle Rondinelle. Grotta del Sale.
NOME E COGNOME
L’ITALIA, GLI ITALIANI, LE ITALIANE E IL LAVORO
1 Collega ogni numero all’affermazione corretta.
circa 60 milioni
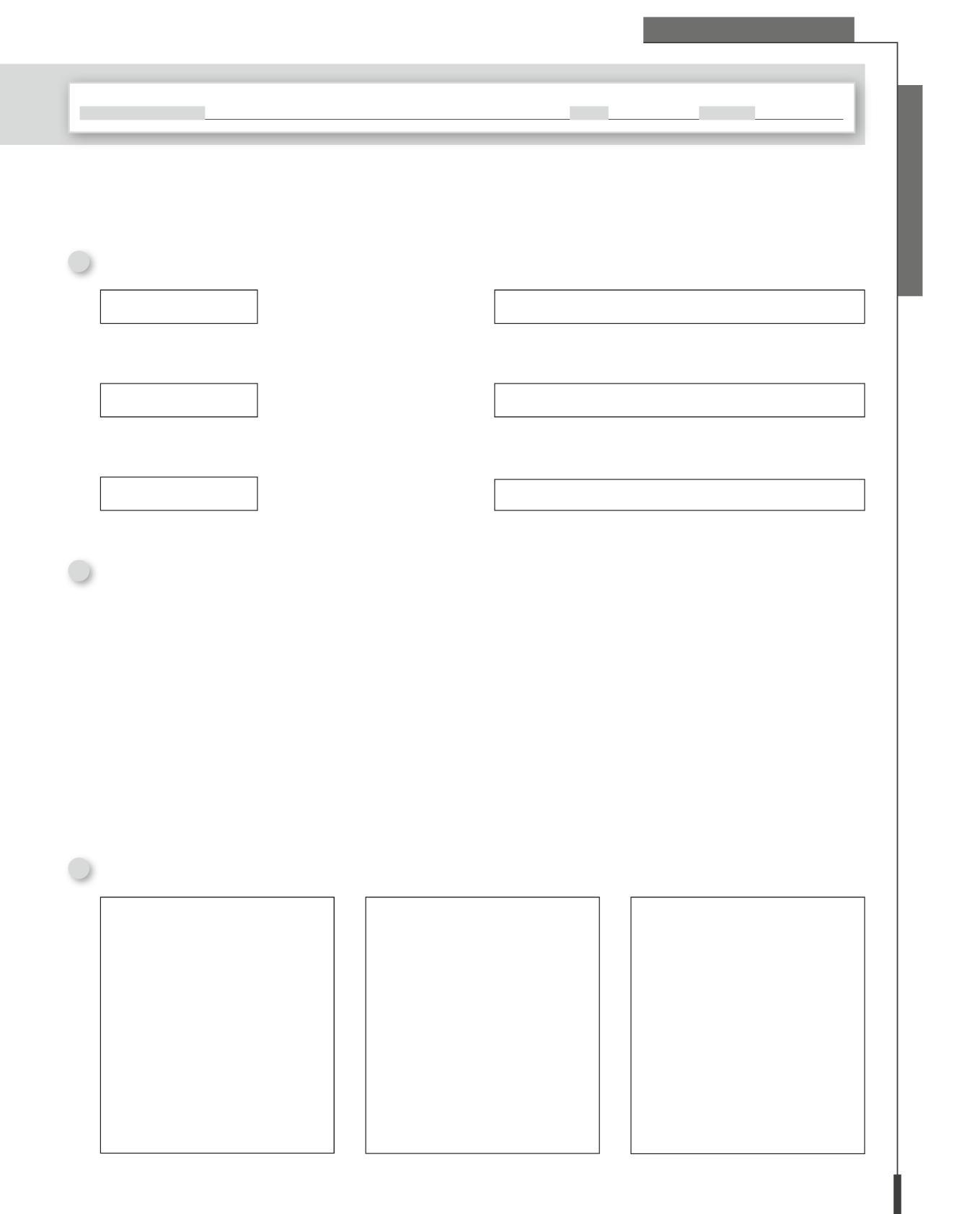
circa 22 milioni
5 milioni
2 Completa il seguente testo.
Erano gli abitanti del Regno d’Italia nel 1861.
Sono i cittadini stranieri presenti in Italia.
Sono gli abitanti italiani al 1° gennaio 2019.
In Italia esistono circa Comuni. Si va da centri abitati con poche di persone, fino a città vere e proprie con centinaia di migliaia oppure di abitanti.
La maggior parte della popolazione italiana attualmente vive in Questo significa che la pianura è il territorio con la più alta di popolazione, cioè il più alto numero di abitanti per chilometro quadrato.
La più grande città italiana è , che è la d’Italia e ha quasi tre milioni di abitanti. Le città offrono molti , come scuole, ospedali, uffici postali, banche.
3 Scrivi almeno quattro attività per ogni settore.
settore primario
settore secondario
settore terziario
L’ITALIA, GLI ITALIANI, LE ITALIANE E IL LAVORO
1 Sottolinea l’alternativa corretta per completare le frasi.
• Al 1° gennaio 2019, gli Italiani erano circa 60 / 30 milioni.
• Gli stranieri che vivono in Italia sono circa 10 / 5 milioni.
• Nel 1861, quando si costituì il Regno d’Italia e fu fatto il primo grafico / censimento della popolazione, gli abitanti erano 22 milioni.
2 Completa il testo con le parole seguenti.
8000 • capitale • centinaia • città • densità • milioni
• pianura • Roma • servizi
In Italia esistono circa Comuni. Si va da centri abitati con poche di persone, fino a città vere e proprie con centinaia di migliaia oppure di abitanti.
La maggior parte della popolazione italiana attualmente vive in . Questo significa che la pianura è il territorio con la più alta di popolazione, cioè il più alto numero di abitanti per chilometro quadrato.
La più grande città italiana è , che è la e ha quasi tre milioni di abitanti. Le città offrono molti , come scuole, ospedali, uffici postali, banche.
3 Scrivi il nome di ogni categoria di lavoratori nel settore di appartenenza.
agricoltori • allevatori • artigiani • bancari • commercianti • infermieri • insegnanti • medici • minatori • muratori • operai • pescatori
settore primario
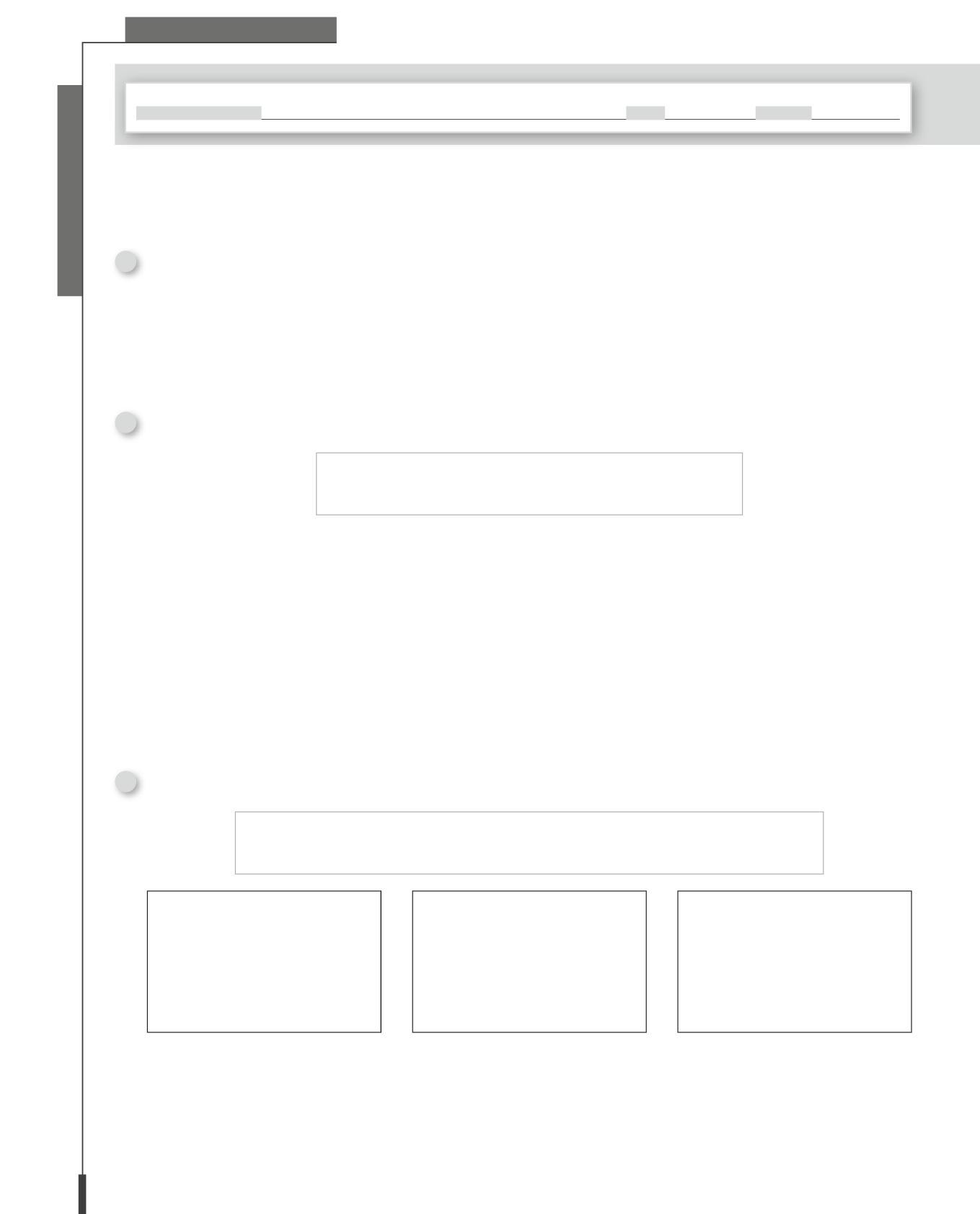
settore secondario
settore terziario
IL LAVORO NEL TEMPO
1 I testi riassumono la storia della formazione dei principali settori economici. Usa i numeri per riordinarli e collega ogni testo al settore corrispondente. Poi completa ogni riquadro con le attività che puoi dedurre dai testi.
Attualmente esiste un altro gruppo di attività che viene definito “avanzato”. Sono legate al progresso dell’elettronica e dell’informatica e destinate soprattutto alla comunicazione. Esse sono per esempio i programmi per i computer, Internet, la posta elettronica, i programmi televisivi, le agenzie di stampa che diffondono informazioni da e in tutto il mondo.
Gli uomini compresero l’importanza dello scambio delle merci, che poteva avvenire anche a lunga distanza dal luogo in cui abitavano ed erano state prodotte. Si sentì anche l’esigenza di altri tipi di lavoro: di chi insegnasse ai più giovani, di chi curasse gli ammalati, di chi scrivesse per conservare traccia di quel che accadeva per il presente o per il futuro.
Le prime attività praticate dall’uomo furono la caccia e la pesca. Conoscevano molte piante commestibili che la natura offriva, ma si limitavano a raccoglierle dove le trovavano. Gli uomini e le donne successivamente scoprirono che potevano far crescere le piante in grande quantità piantandone i semi. Cominciarono anche ad addomesticare e ad allevare gli animali.
Poi l’uomo sviluppò la capacità di rendere più agevole la vita attraverso i prodotti artigianali. Costruì contenitori in ceramica, arnesi e strumenti di metallo, imparò a produrre tessuti di lino e di canapa…
Molti secoli più tardi le attività artigianali, praticate con maggiore specializzazione e con minore impiego di tempo, diedero luogo alle industrie.
settore primario
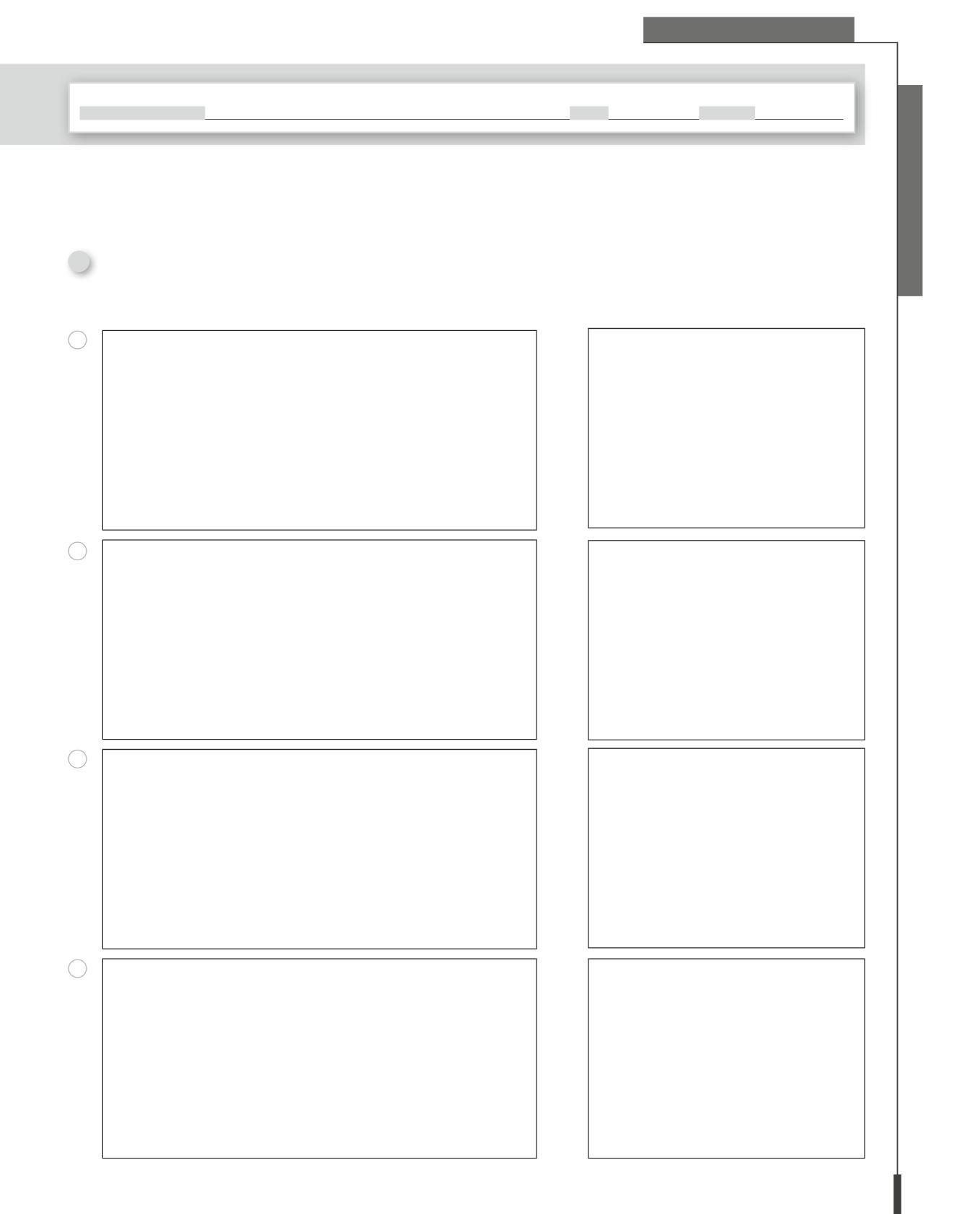
settore secondario
settore terziario
settore avanzato
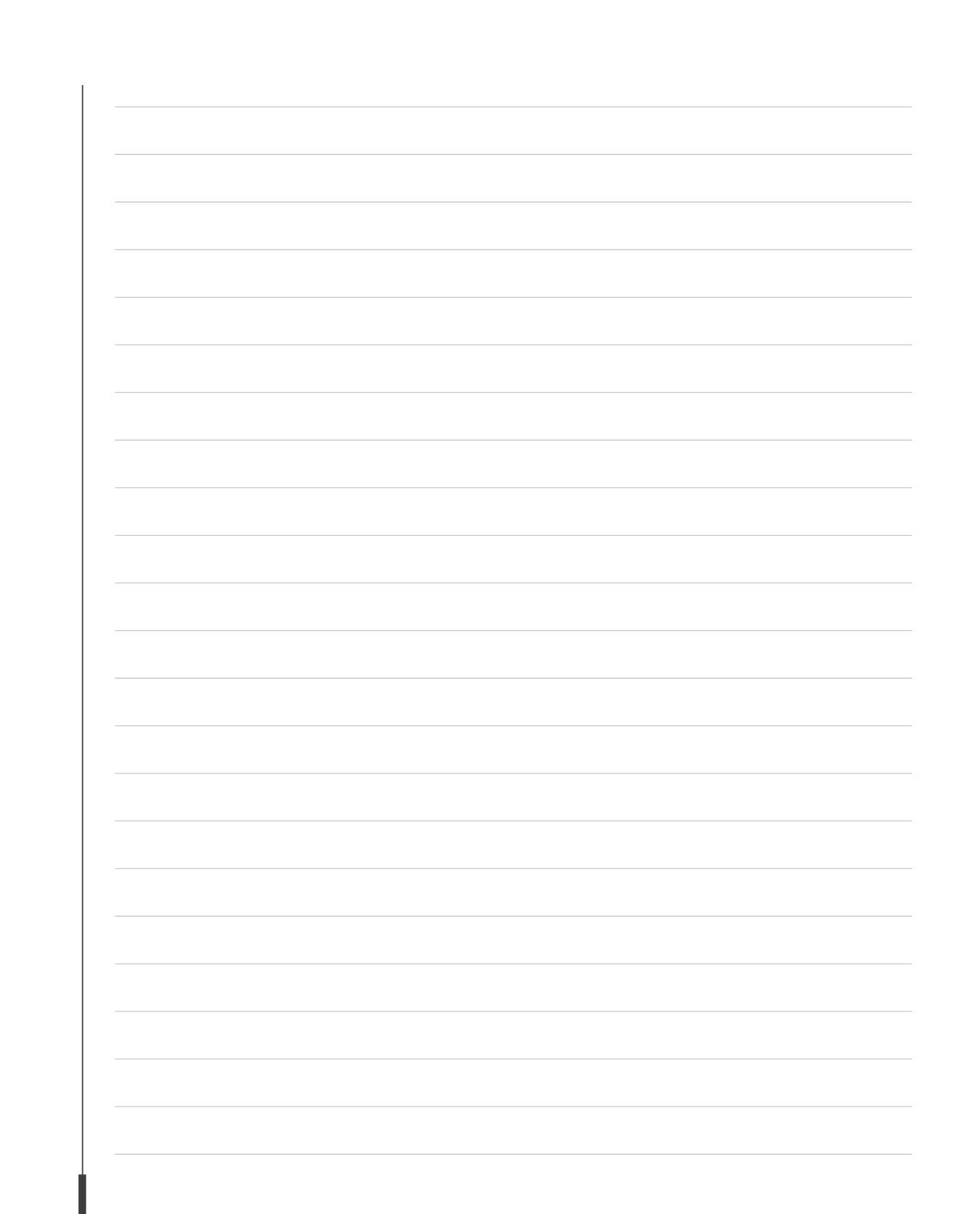
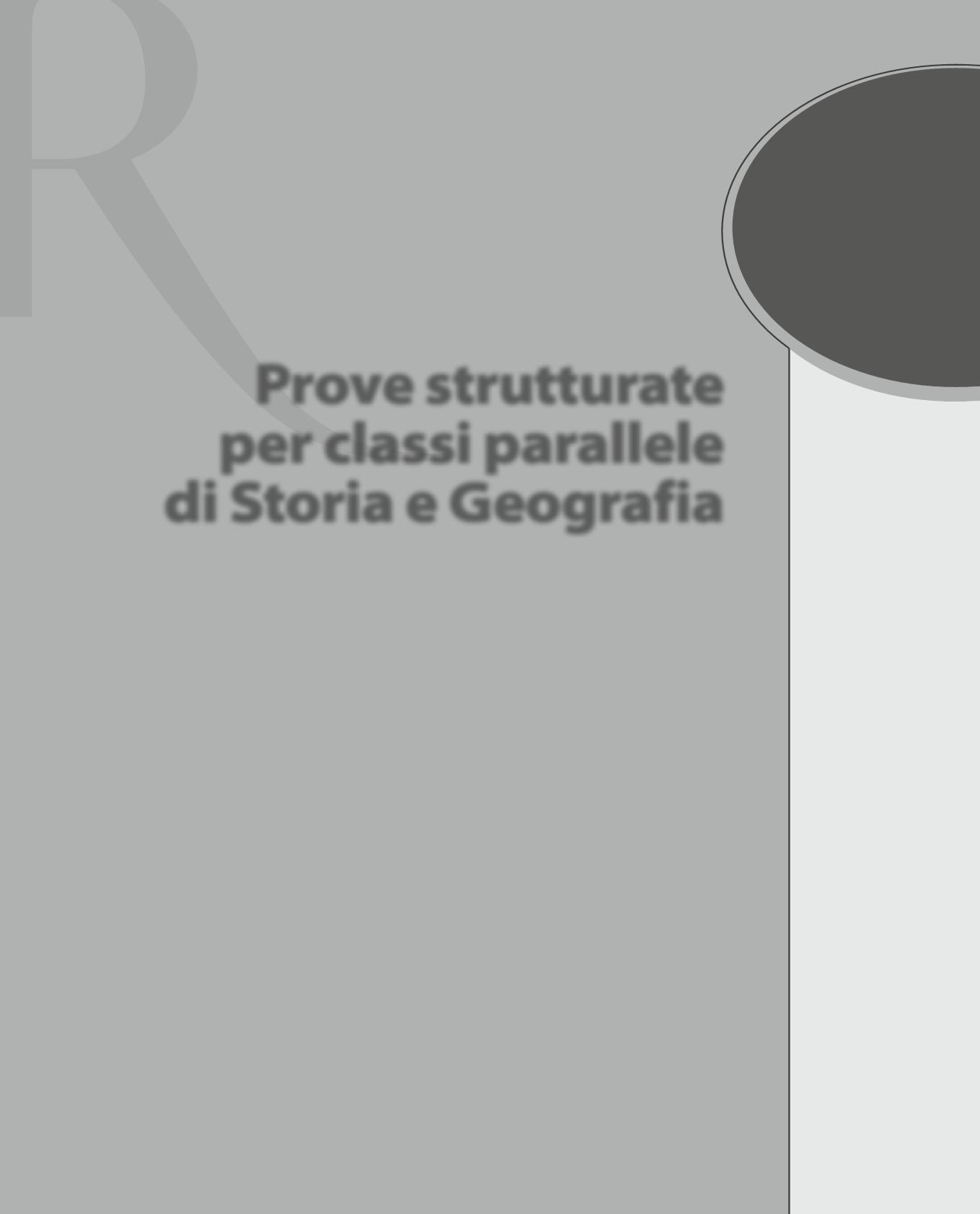
Prove strutturate per classi parallele di Storia e Geografia
PROVE STRUTTURATE PER CLASSI PARALLELE
introduzione a cura di Dino Cristanini
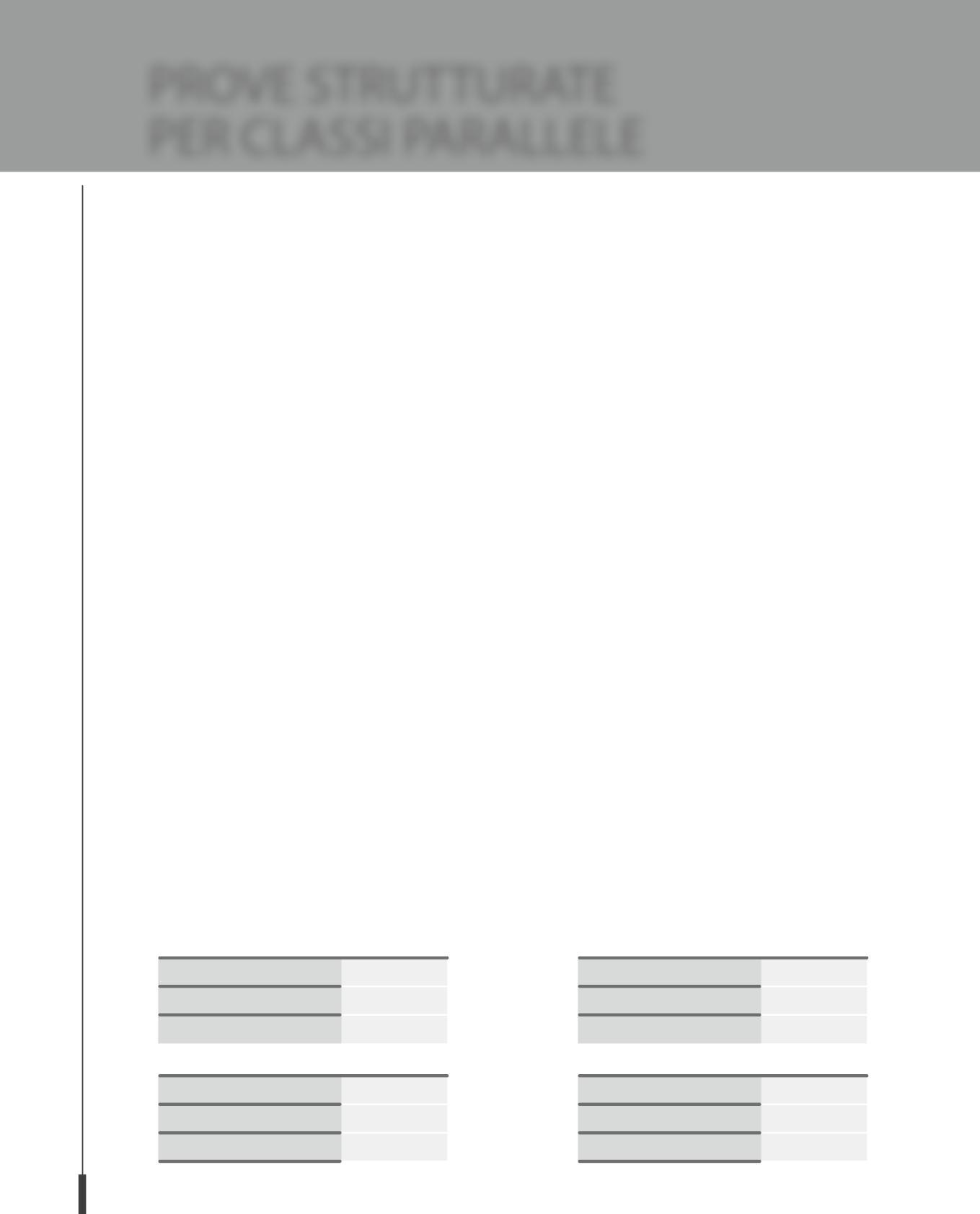
L’utilizzo sistematico di prove strutturate comuni è uno degli elementi che, secondo la Guida alla predisposizione del Rapporto di autovalutazione (RAV) pubblicata dal MIUR, qualificano la situazione di una scuola come eccellente nell’area Curricolo, progettazione e valutazione
Le prove comuni possono riguardare le varie fasi dello sviluppo del curricolo:
• le prove d’ingresso hanno la funzione di rilevare la situazione iniziale degli alunni in modo da calibrare opportunamente gli obiettivi di apprendimento;
• le prove intermedie svolgono soprattutto una funzione formativa, fornendo informazioni sugli obiettivi di apprendimento raggiunti dagli alunni e sulle difficoltà che invece richiedono diverse attenzioni metodologiche;
• le prove finali consentono di fare il punto al termine dell’anno scolastico.
L’uso di prove comuni a livello di classi parallele risponde a diverse esigenze.
Innanzitutto contribuisce a migliorare l’equità dell’offerta formativa, ossia la capacità della scuola di assicurare a tutti gli alunni la stessa qualità d’istruzione. Ciò avviene attraverso una progettazione comune per classi parallele e un monitoraggio periodico sull’andamento degli apprendimenti rilevati mediante strumenti omogenei e idonei a permettere la confrontabilità, in modo da poter effettuare per tempo le opportune regolazioni nel caso di eccessivi scostamenti. Si tratta di pratiche efficaci per ridurre una criticità abbastanza diffusa per quanto riguarda gli esiti di apprendimento, ossia la varianza tra le classi della stessa istituzione scolastica.
In secondo luogo favorisce il confronto e la condivisione tra i docenti dei criteri di valutazione, delle strategie metodologiche e delle pratiche didattiche. Infine concorre a sviluppare una cultura della valutazione in cui i dati diventano il punto di partenza per riflessioni orientate al miglioramento.
Per tutte queste ragioni le seguenti pagine intendono offrire ai docenti un utile supporto, costituito dalla proposta di prove comuni iniziali, intermedie e finali relative alle principali discipline. Si tratta di prove strutturate che consentono di rilevare abilità e conoscenze riferite agli obiettivi di apprendimento previsti dalle Indicazioni nazionali per il curricolo.
STORIA
Prova d’ingresso pag. 173
Prova intermedia pag. 175
Prova finale pag. 177
SOLUZIONI-STORIA
Prova d’ingresso pag. 185
Prova intermedia pag. 187
Prova finale pag. 189
GEOGRAFIA
Prova d’ingresso pag. 179
Prova intermedia pag. 181
Prova finale pag. 183
SOLUZIONI-GEOGRAFIA
Prova d’ingresso pag. 191
Prova intermedia pag. 193
Prova finale pag. 195
NOME E COGNOME
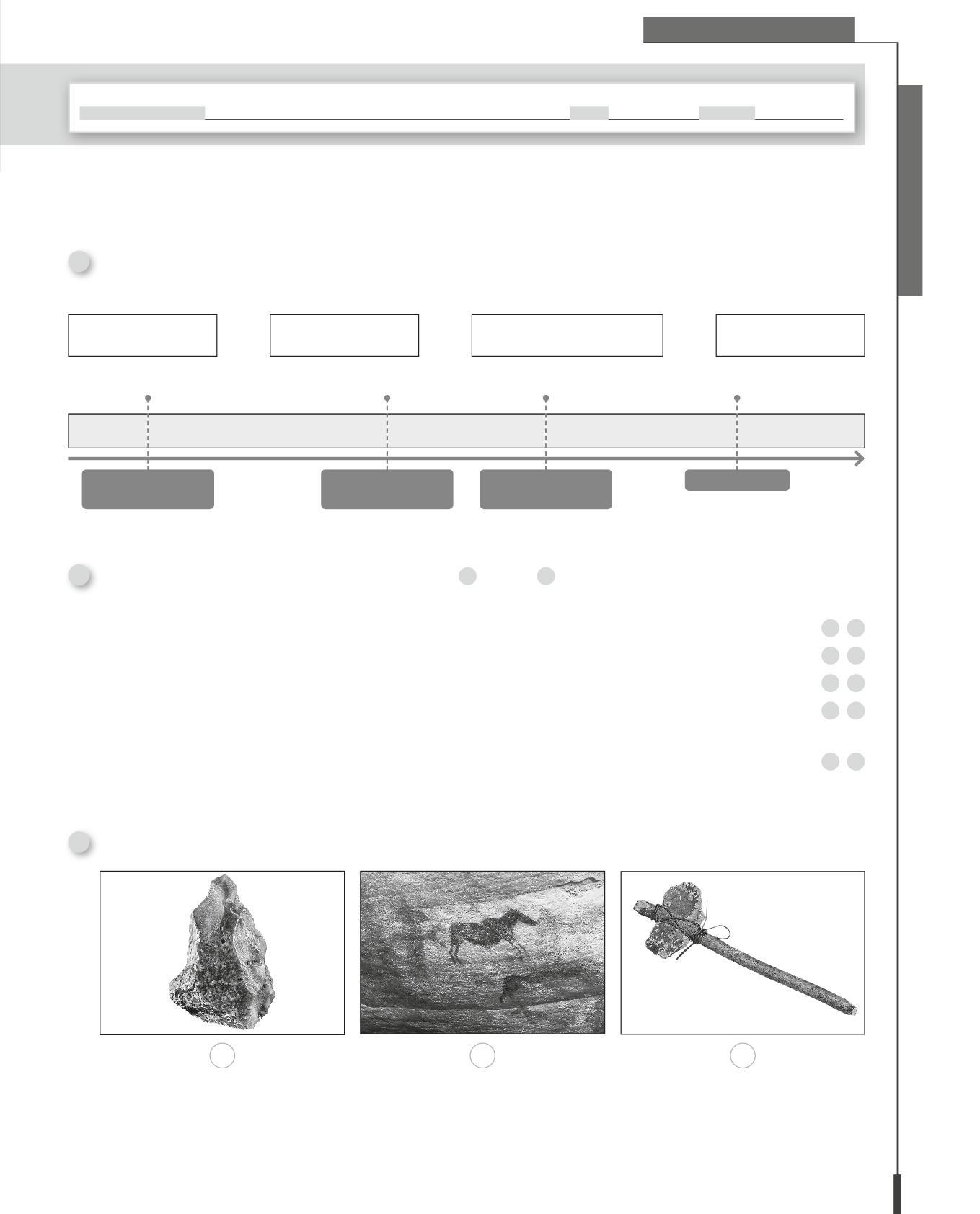
PROVA D’INGRESSO DI STORIA
1 Quando sono vissute le diverse specie di ominidi nella Preistoria? Collega con le frecce i nomi nei cartellini con i pallini sulla linea del tempo.
Homo habilis Australopiteco Uomo di Neanderthal Homo erectus
3 milioni e mezzo di anni fa
2 Indica con una X se le affermazioni sono vere V o false F .
• Gli Australopitechi erano onnivori: infatti si nutrivano sia di vegetali, sia di piccoli mammiferi e insetti.
• L’Homo habilis viveva in grandi villaggi e cacciava con l’arco e le frecce.
• L’Homo erectus è stato il primo ominide a saper accendere il fuoco.
• L’Uomo di Neanderthal cacciava in gruppo anche animali di grandi dimensioni.
• L’Homo sapiens non conosceva il fuoco. L’unico utensile che sapeva costruire era il chopper
3 Indica con una X il reperto storico più antico.
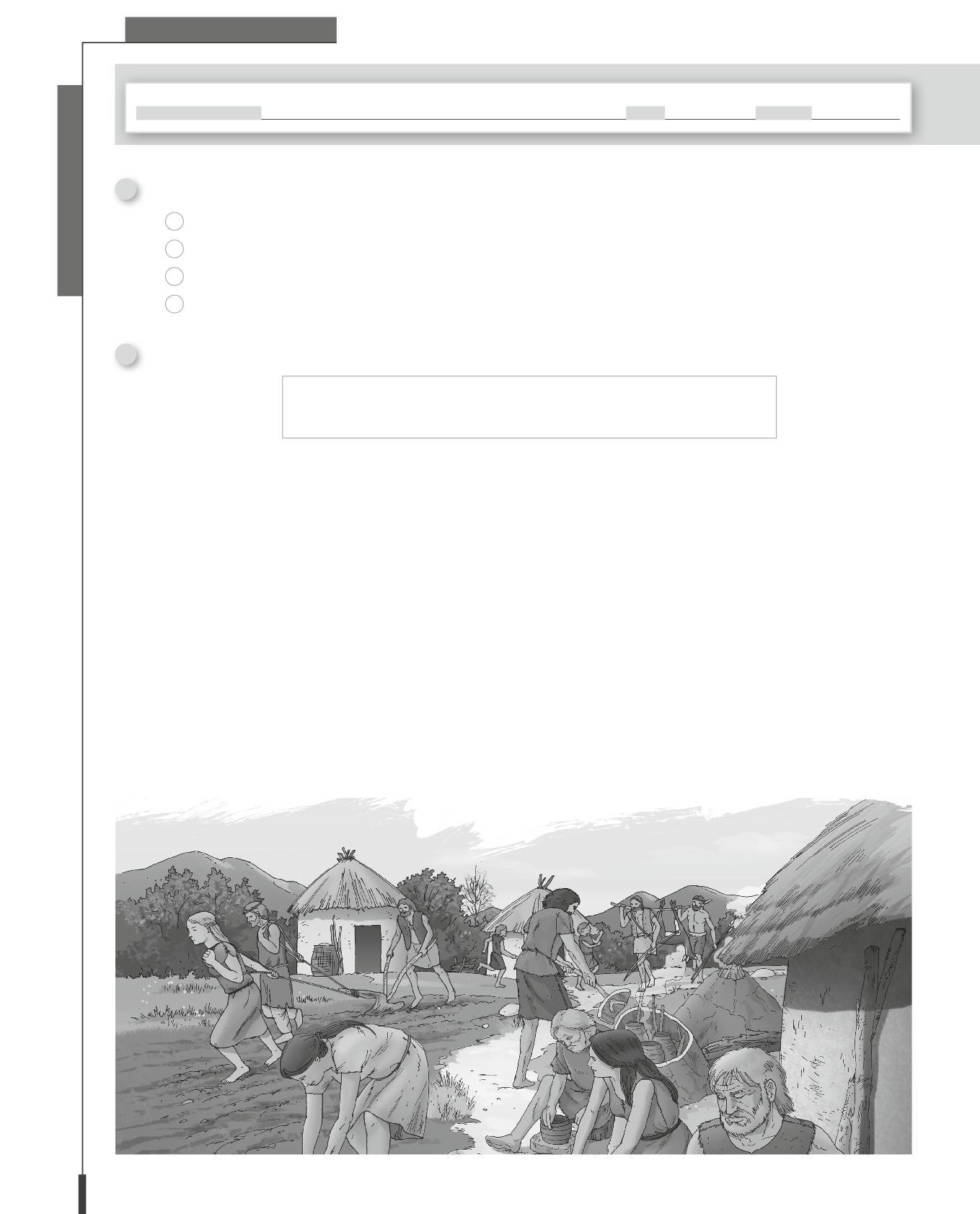
4 Indica con una X quando iniziò il periodo che gli studiosi e le studiose hanno chiamato Neolitico.
A. 1 200 anni fa.
B. 1 200 000 di anni fa.
C. 12 000 anni fa.
D. 120 000 anni fa.
5 Riscrivi le parole al posto giusto nel testo.
agricoltura • allevamento • baratto • capanne • Neolitico • raccogliere • sedentario • villaggi
Con l’inizio del , l’uomo smise di essere nomade e divenne , cioè si fermò a vivere in un luogo a lui favorevole.
Una delle principali attività, oltre alla caccia e alla pesca, divenne l’
Per questa ragione si stabilì in un luogo e, dopo aver seminato, aspettava la stagione giusta per i frutti della terra.
Oltre all’agricoltura, un’altra attività molto importante fu quella dell’ degli animali addomesticati, che forniva latte, formaggio e carne in abbondanza.
I prodotti della terra (frutti, cereali, legumi e ortaggi) e i prodotti dell’allevamento (latte, formaggi e carne), potevano essere scambiati attraverso il , perché in quel periodo la moneta non esisteva.
Divenuto sedentario, l’uomo non ebbe più bisogno di ripararsi nelle caverne e costruì le circolari, disposte le une vicine alle altre, formando dei veri e propri
NOME E COGNOME
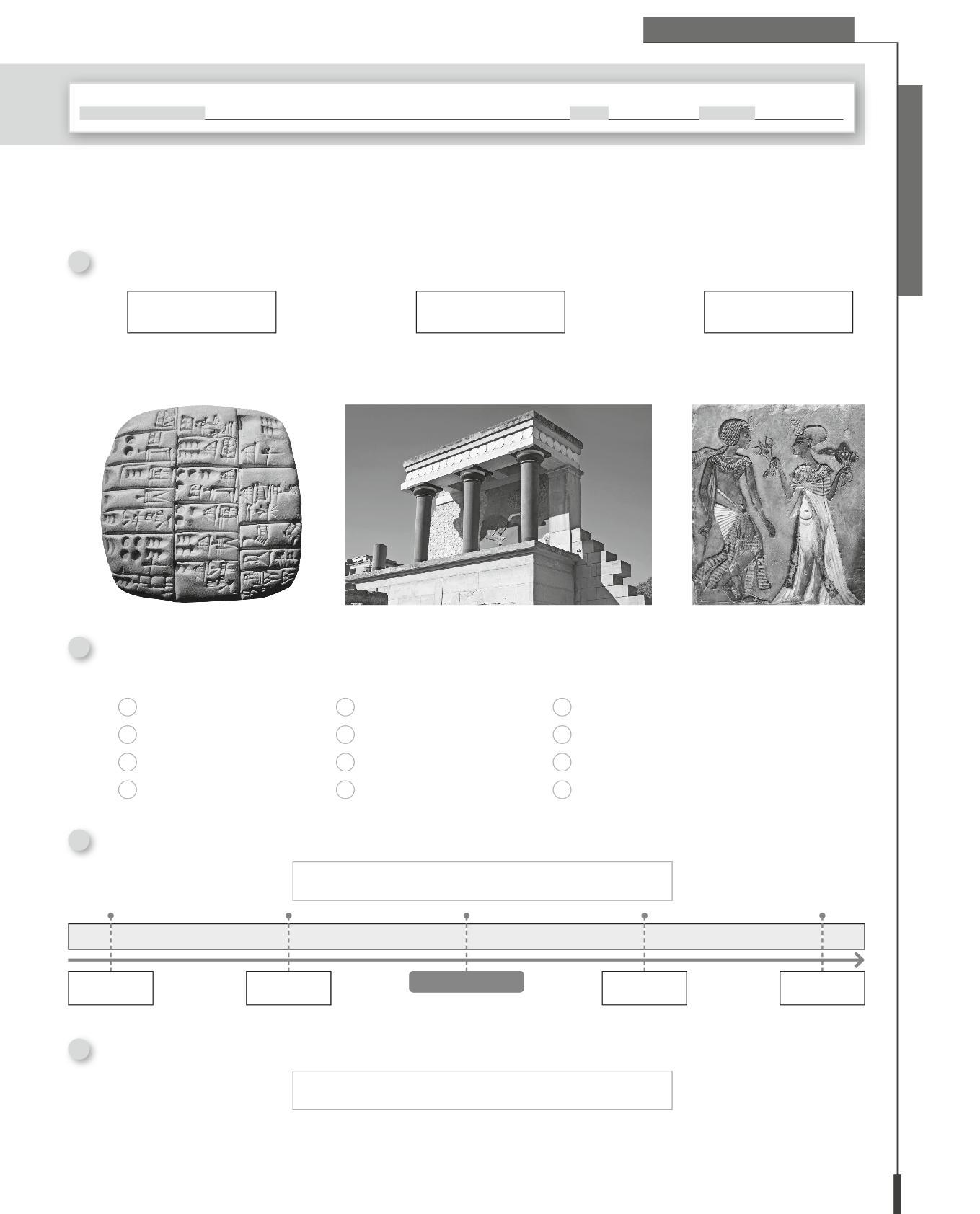
PROVA INTERMEDIA DI STORIA
1 Collega con le frecce ogni cartellino all’immagine corrispondente.
materiale
2 Quale numero manca per completare le uguaglianze? Indicalo con una X.
1 secolo = ? anni 1 millennio = ? anni 1 millennio = ? secoli
3 Scrivi le seguenti date sulla linea del tempo.
4 Riscrivi le seguenti date in ordine cronologico.
1500 a.C. • 300 d.C. • 125 d.C. • 930 a.C.
5 Indica con una X la risposta corretta.
• Quali fiumi attraversavano la Mesopotamia?
A. Indo e Gange.
B. Nilo ed Eufrate.
C. Tigri ed Eufrate.
D. Fiume Giallo e Fiume Azzurro.
• Chi furono i primi abitanti della Mesopotamia?
A. Gli Assiri.
B. I Sumeri.
C. Gli Ittiti.
D. I Babilonesi.
• Che cos’era la ziggurat?
A. Un magazzino per la raccolta del grano.
B. Il palazzo del re.
C. L’abitazione dei contadini.
D. Un edificio a gradoni con un tempio sulla cima.
6 Collega ciascuna affermazione al nome del popolo antico corrispondente.
Erano un popolo di guerrieri e saccheggiarono Babilonia.
La loro più importante invenzione fu la loro scrittura, detta cuneiforme.
Il loro re, Hammurabi, conquistò molte delle città-stato sumere e unificò in un solo impero la Mesopotamia.
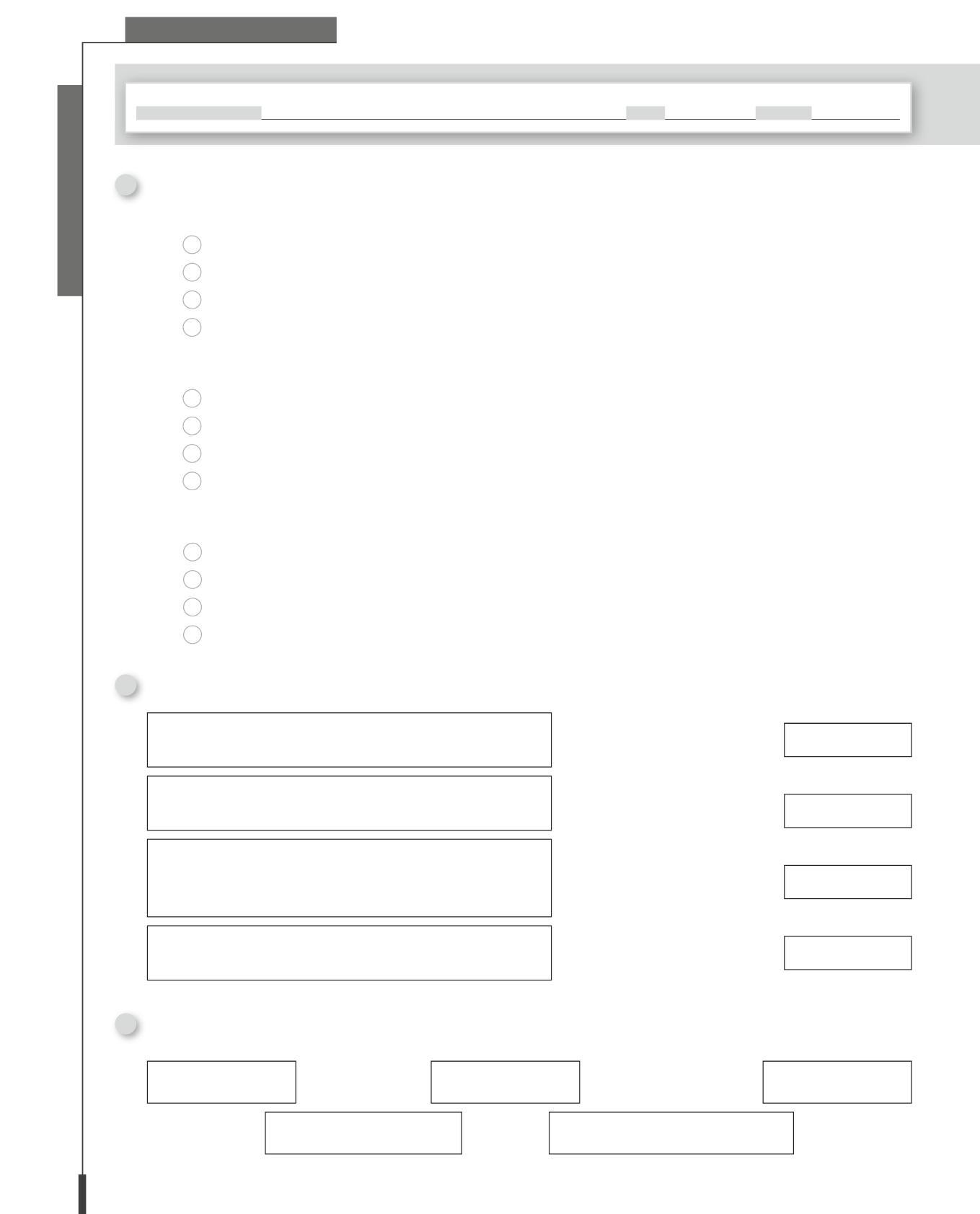
Sumeri
Ittiti
Assiri Babilonesi
7 I popoli della Mesopotamia svilupparono diverse conoscenze e attività. Cancella l’intruso con una X.
Il loro re, Assurbanipal, fece realizzare una grande biblioteca nel palazzo reale di Ninive. astronomia
scrittura su carta agricoltura guerra commercio con il baratto
OBIETTIVI: Conoscere i principali aspetti che caratterizzano le antiche civiltà della Mesopotamia.
PROVA FINALE DI STORIA
1 Collega con le frecce ogni data all’avvenimento corrispondente della storia della civiltà egizia.
2050 a.C.
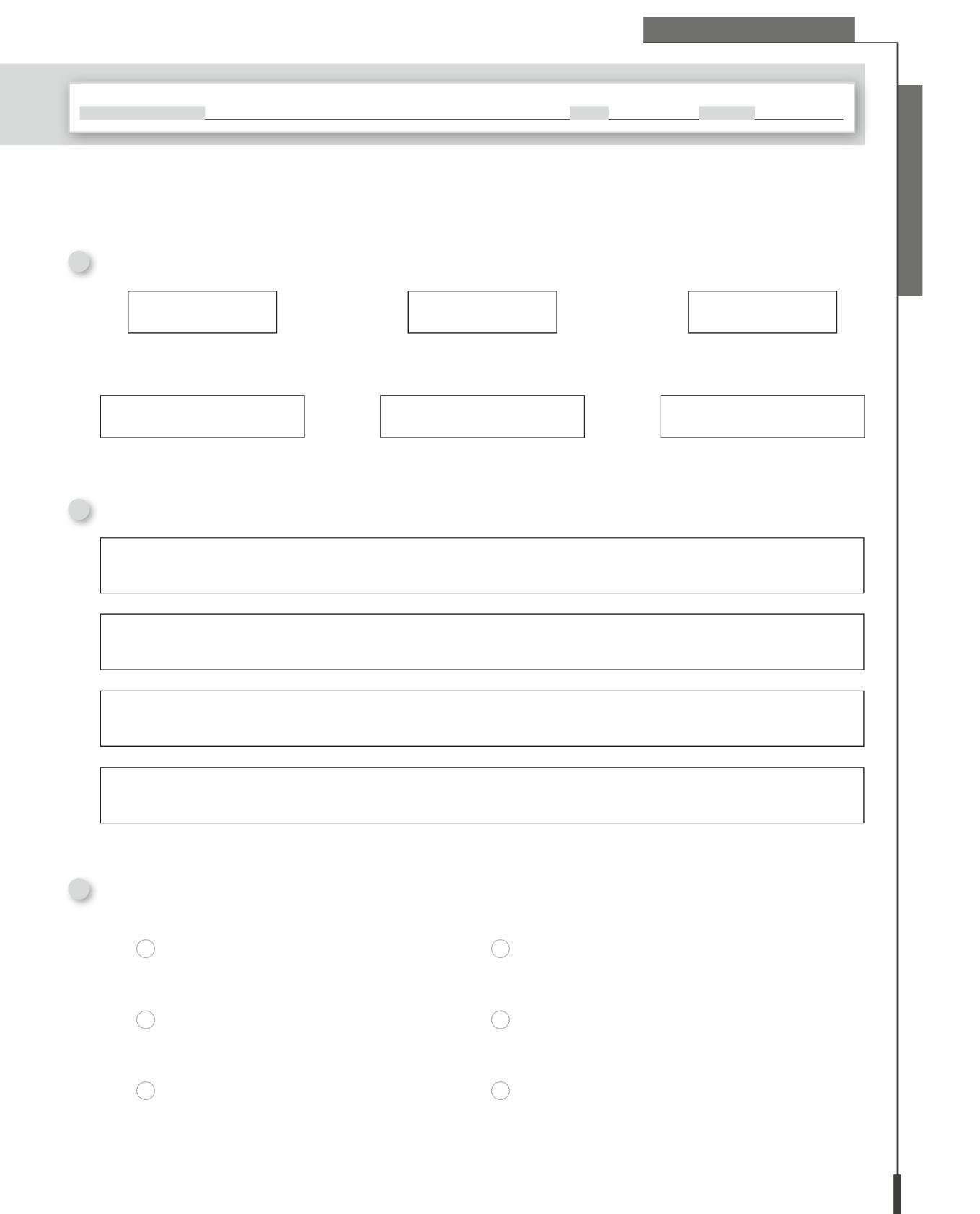
1550 a.C.
3100 a.C.
inizio dell’Antico Regno
inizio del Medio Regno
inizio del Nuovo Regno
2 Sottolinea in rosso l’errore contenuto in ogni testo.
Sovrano e capo assoluto degli antichi Egizi era il Grande Scriba, che veniva adorato dal popolo come se fosse un dio.
Gli antichi Egizi erano un popolo monoteista. Infatti essi adoravano numerosi dèi, fra i quali Iside, Osiride e Anubi.
La scrittura degli antichi Egizi, detta geroglifica, era composta da tanti segni: l’alfabeto.
Per costruire le piramidi furono utilizzati grandi blocchi di legno. Non sappiamo come fecero gli Egizi a sollevare e trasportare questi grandi blocchi.
3 Indica con una X la conclusione corretta per ogni affermazione.
• Nell’antico Egitto il faraone era:
A. un funzionario esperto di calcoli. B. il re, capo assoluto del regno.
• Nell’antico Egitto contadini, allevatori, artigiani, commercianti e servi erano:
A. la parte più numerosa del popolo. B. pochissimi e molto ricchi.
• Nell’antico Egitto i nobili:
A. governavano i territori. B. trascrivevano gli ordini del faraone.
OBIETTIVI: Conoscere la periodizzazione di avvenimenti storici. • Conoscere gli aspetti principali della civiltà egizia.
4 Indica con una X la risposta corretta.
• Quale civiltà si sviluppò lungo il corso del Fiume Giallo e del Fiume Azzurro?
A. La civiltà egizia.
B. La civiltà cinese.
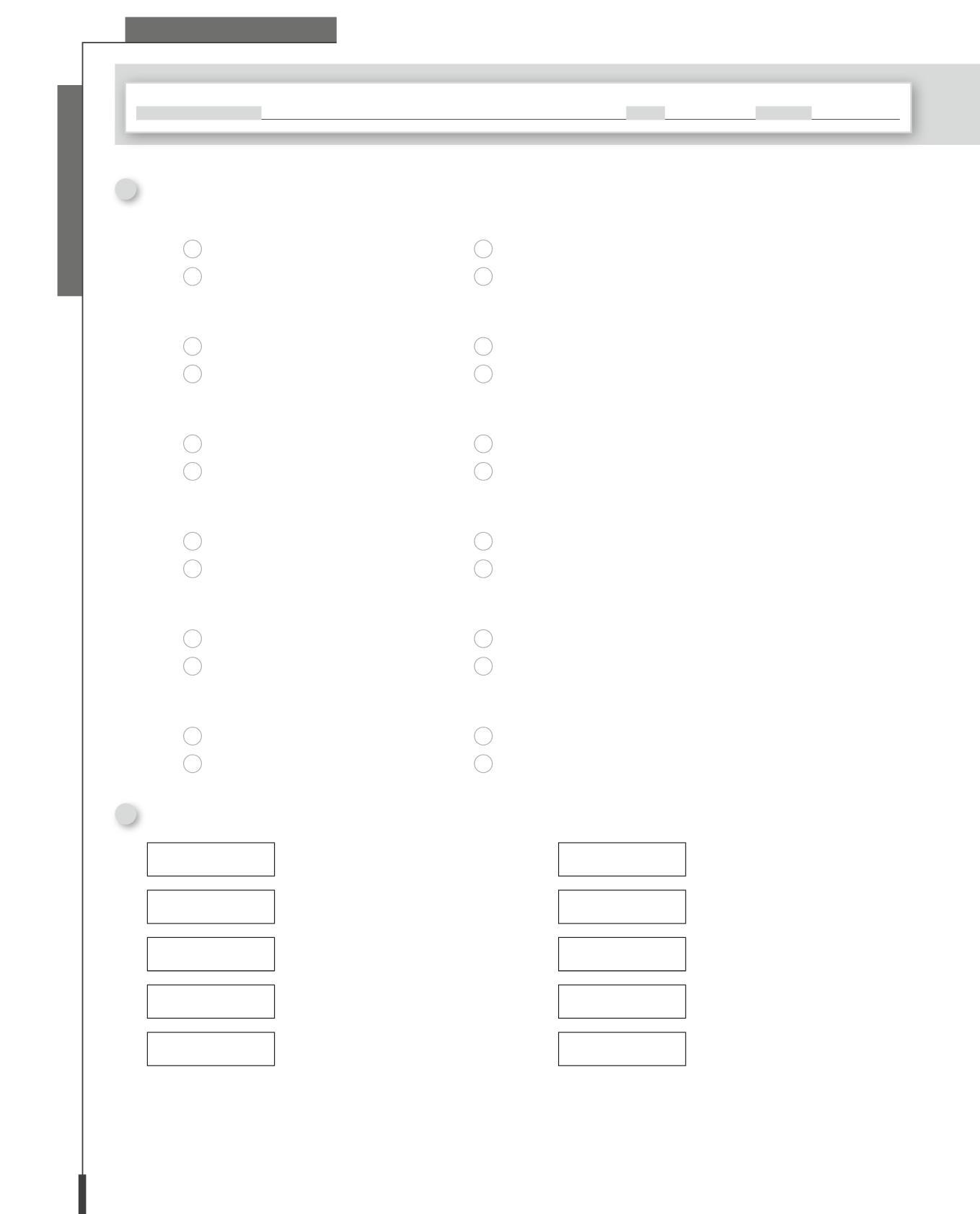
C. La civiltà cretese.
D. La civiltà fenicia.
• Quale civiltà inventò la scrittura alfabetica e sviluppò il commercio nel Mar Mediterraneo?
A. La civiltà ebraica.
B. La civiltà egizia.
C. La civiltà fenicia.
D. La civiltà cinese.
• Quale civiltà praticava una religione monoteista?
A. La civiltà egizia.
B. La civiltà cretese.
C. La civiltà fenicia.
D. La civiltà ebraica.
• Quale civiltà si sviluppò su un’isola dove sorgevano numerose città-palazzo?
A. La civiltà cretese. C. La civiltà dell’Indo.
B. La civiltà ebraica. D. La civiltà egizia.
• Quale civiltà credeva nell’aldilà e mummificava i corpi dei defunti?
A. La civiltà fenicia.
C. La civiltà egizia.
B. La civiltà cinese. D. La civiltà ebraica.
• Quale civiltà non si sviluppò lungo le coste del Mar Mediterraneo?
A. La civiltà ebraica. C. La civiltà fenicia.
B. La civiltà cretese. D. La civiltà dell’Indo.
5 Collega con le frecce ogni termine al popolo corrispondente.
papiro Cinesi
Bibbia Cretesi
bachi da seta Egizi
tauromachia Fenici
colonie Ebrei
NOME E COGNOME DATA
PROVA D’INGRESSO DI GEOGRAFIA
1 Indica con una X se le affermazioni sono vere V oppure false F .
• Nello spazio celeste ci sono solo pianeti e satelliti. V F
• La città è un ambiente naturale. V F
• Le case sono un elemento antropico. V F
• Pioggia e vento sono fenomeni naturali. V F
• Il mare modifica l’ambiente frantumando le rocce e trasformandole in sassi e sabbia. V F
• La costruzione di un ponte non modifica l’ambiente naturale di un fiume. V F
2 Osserva la carta geografica e scrivi nei riquadri i punti cardinali al posto giusto.
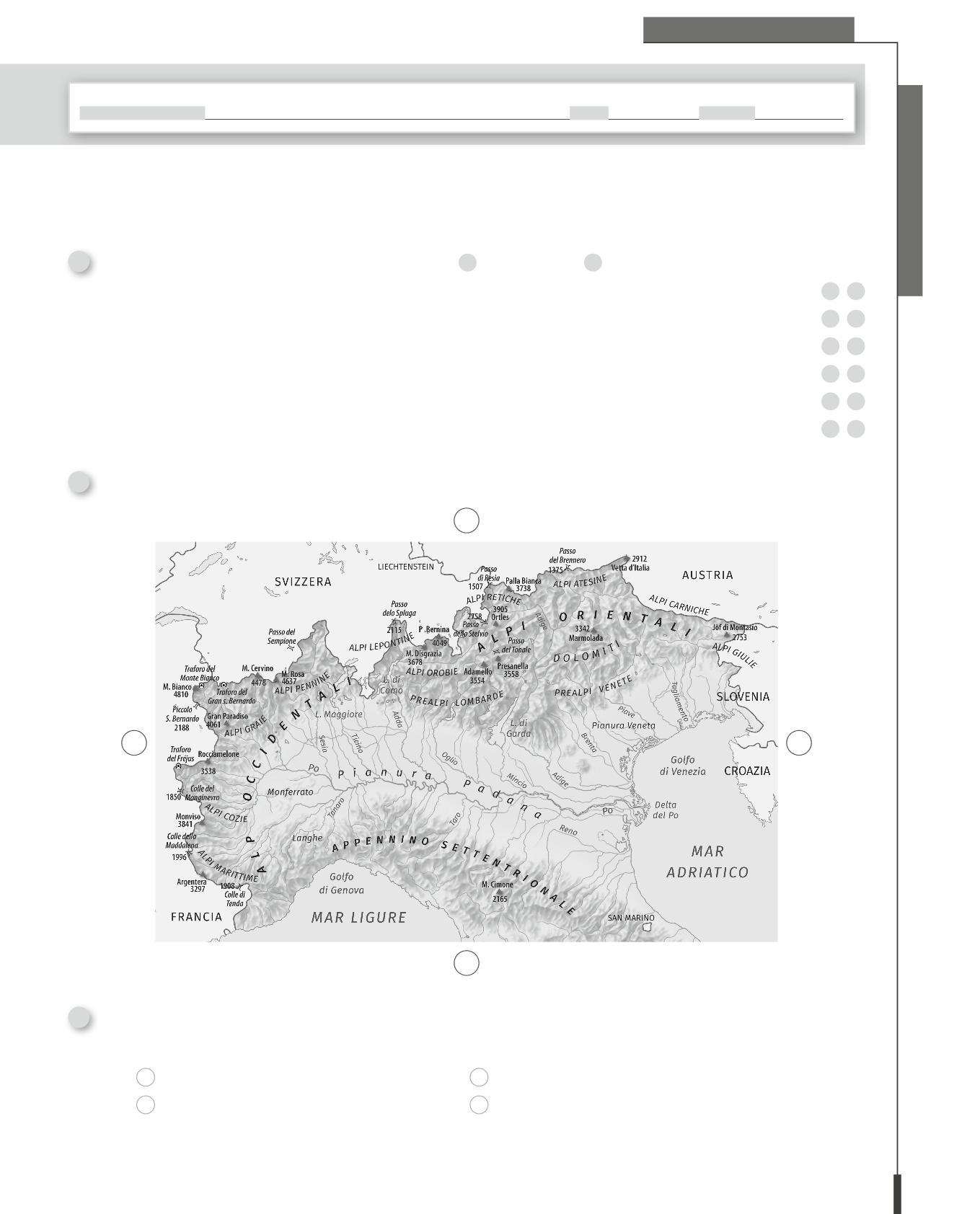
3 Indica con una X la conclusione corretta della frase.
• L’immagine riportata nell’esercizio 2 è:
A. una mappa dell’Italia.
C. una carta geografica dell’Italia.
B. una carta stradale dell’Italia. D. un planisfero dell’Italia.
CONOSCENZE: Spazio geografico. • Orientamento e cartografia.
ABILITÀ: Distinguere i diversi tipi di spazio geografico. • Conoscere i punti cardinali. • Saper riconoscere una carta geografica.
NOME E COGNOME DATA CLASSE
funivia ruscello ponte valle strada Geografia
4 Associa ogni termine alla definizione corretta. Usa i numeri.
isola collina montagna pianura
1 È un rilievo naturale la cui altitudine supera i 600 metri sul livello del mare.
2 È una terra completamente circondata dall’acqua.
3 È una vasta distesa di terreno senza rilievi, che non supera i 200 metri sul livello del mare.
4 È un rilievo naturale la cui altitudine è compresa fra i 200 e i 600 metri sul livello del mare.
5 Completa le frasi con le seguenti parole.
fiume • lago • mare
Il è uno specchio d’acqua che riempie lo spazio di un avvallamento del terreno.
Il è un corso d’acqua dolce che nasce da una sorgente.
Il è una vastissima distesa d’acqua salata.
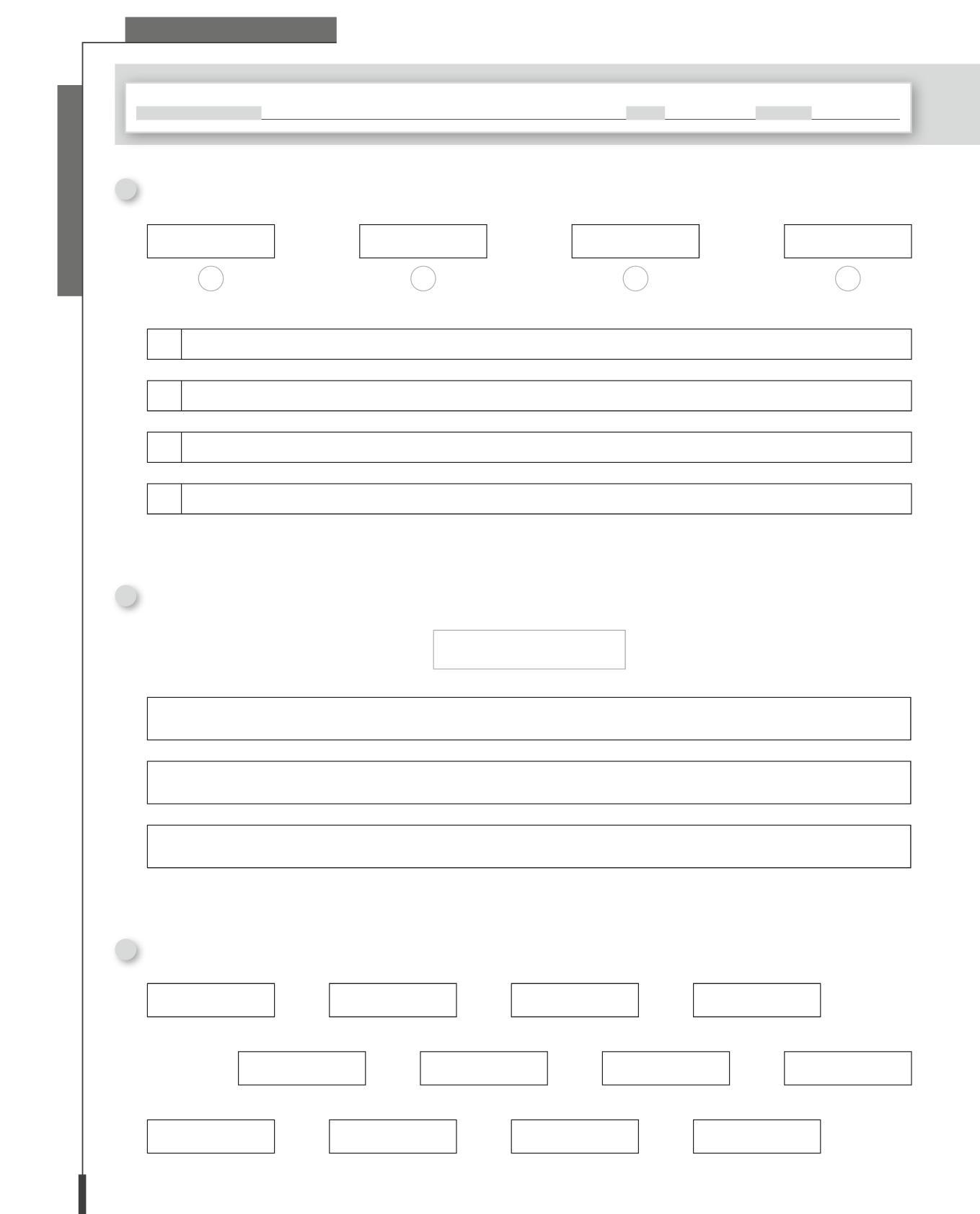
6 Indica con una X gli elementi antropici che si possono osservare in montagna.
baita
mucca ghiacciaio
rifugio vetta cascata albergo
OBIETTIVI: Saper definire un ambiente. • Distinguere gli elementi antropici da quelli naturali.
NOME E COGNOME DATA CLASSE
PROVA INTERMEDIA DI GEOGRAFIA
1 Indica con una X se le affermazioni sono vere V oppure false F .
• Le carte fisiche rappresentano gli aspetti naturali di un territorio. V F
• Le carte tematiche rappresentano il territorio da un punto di vista politico. V F
• In una carta politica si possono osservare i confini di una nazione e delle Regioni. V F
• Le piante e le mappe sono carte utilizzate per rappresentare grandi territori. V F
• Il planisfero è la rappresentazione su carta di tutta la Terra. V F
2 Scrivi sotto ogni carta la tipologia corrispondente.
carta fisica • carta politica • carta tematica
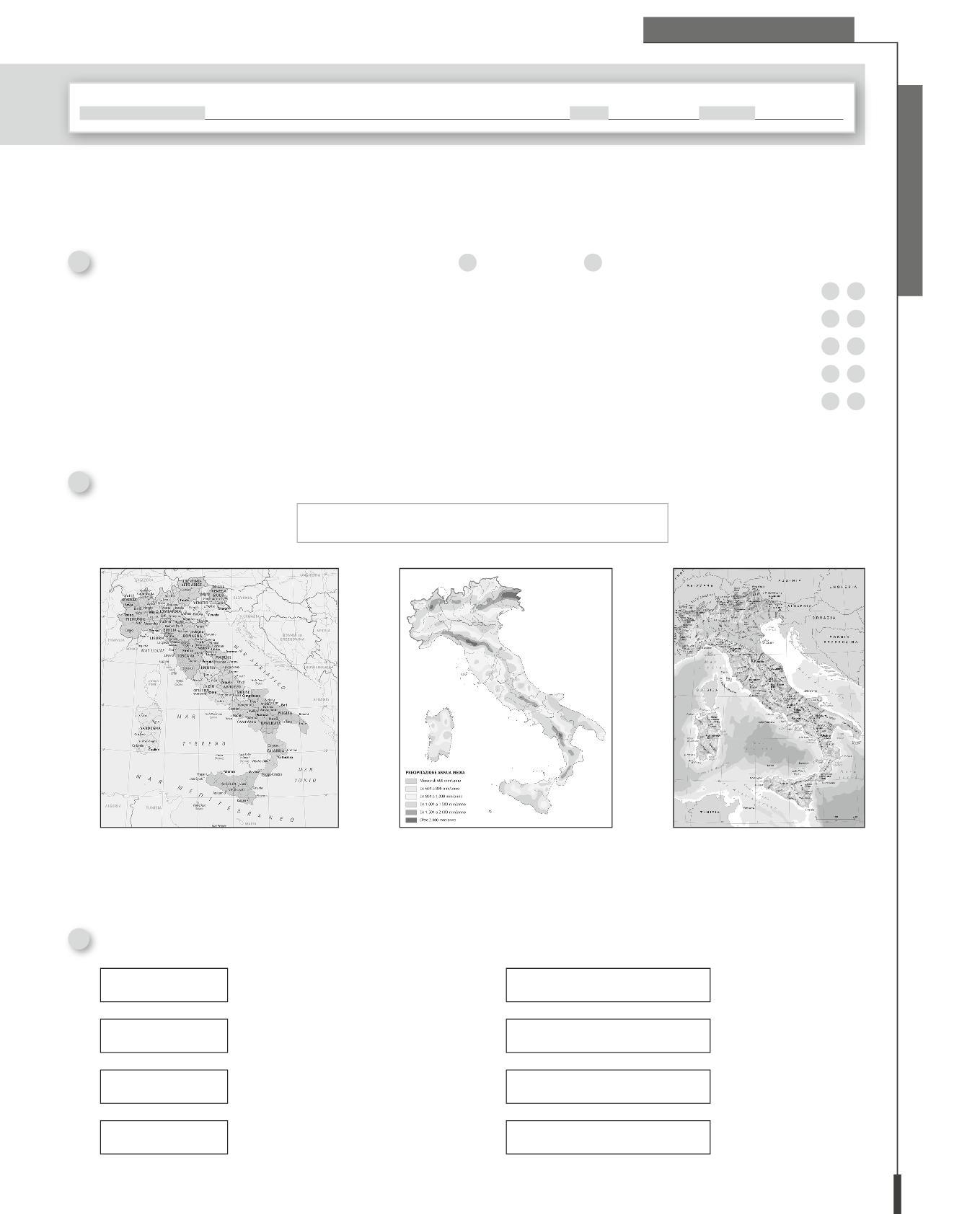
3 Collega ogni punto cardinale al suo sinonimo.
Nord Levante
Est Meridione
Sud Ponente
Ovest Settentrione
OBIETTIVI: Classificare le carte geografiche. • Conoscere i punti cardinali.
4 Completa il testo con le parole seguenti.
i venti • l’umidità • la temperatura • la pressione atmosferica • le precipitazioni
Diversi fenomeni atmosferici determinano il clima di un territorio. misura il calore dell’aria, che dipende dall’intensità dei raggi del Sole. caldi o freddi soffiando possono riscaldare o raffreddare l’ambiente. Pioggia, neve e grandine, cioè , dell’aria e sono altri importanti fenomeni che influiscono sul clima.
5 Collega ogni tipo di clima alla sua descrizione.
clima freddo polare artico e antartico
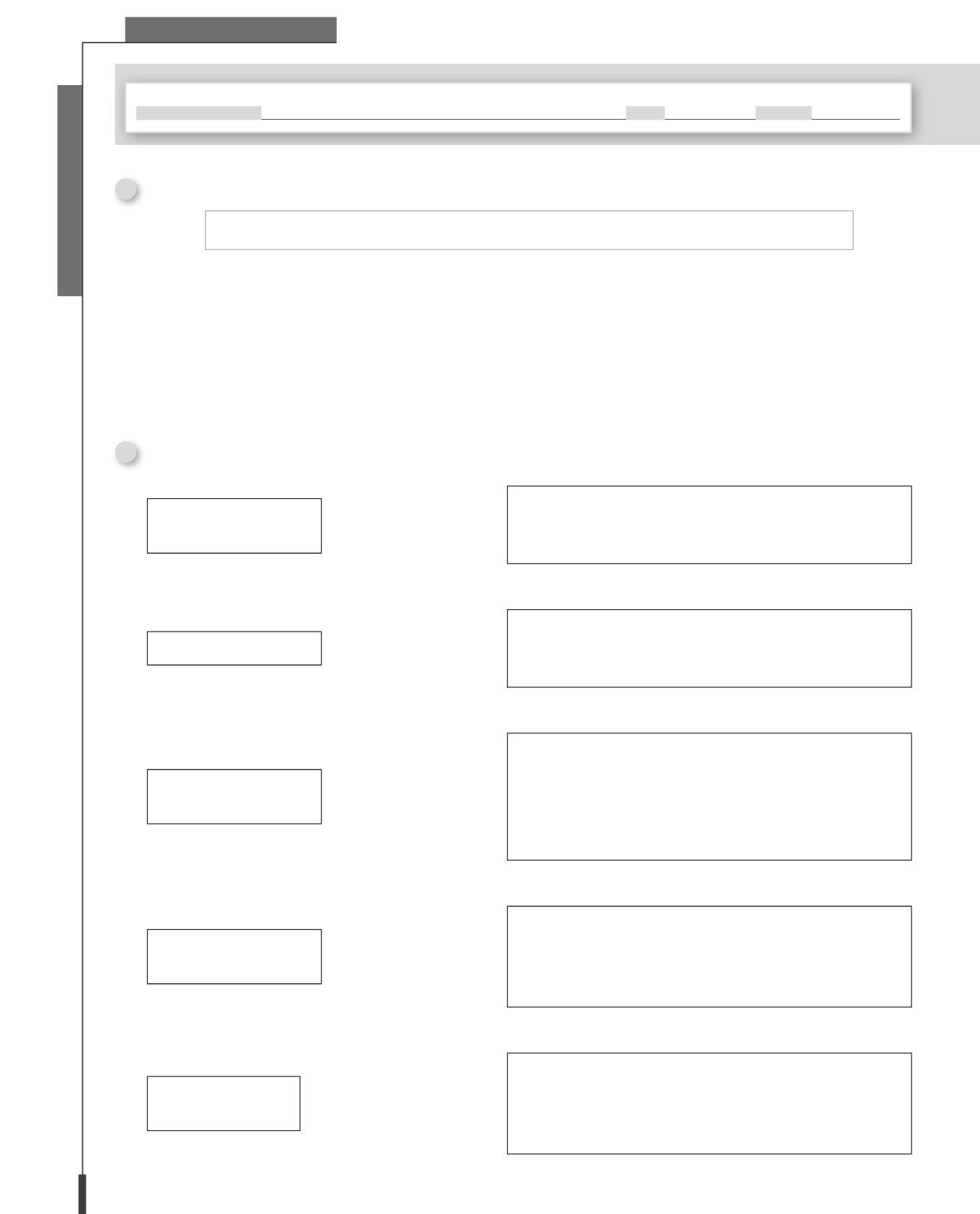
clima temperato
Piove frequentemente. Nelle foreste pluviali vivono molte specie vegetali e animali, come ippopotami, scimmie, tucani...
Non piove quasi mai. Fa molto caldo di giorno e molto freddo di notte. A volte l’acqua affiora in superficie e forma delle oasi.
clima caldo dei deserti
Le zone polari sono ricoperte dai ghiacci per gran parte dell’anno e hanno solamente due stagioni: l’estate, in cui il Sole non tramonta mai ma è debolissimo, e l’inverno, in cui la luce è scarsa e il freddo molto intenso.
clima caldo tropicale
clima equatoriale
Il clima è mite e caratterizzato dall’alternarsi delle quattro stagioni. Il clima favorisce la diffusione di boschi di conifere e latifoglie, praterie e vegetazione mediterranea.
A cavallo dell’Equatore fa molto caldo e piove in una sola stagione o in due periodi dell’anno. Sul territorio si estende la savana, dove vivono animali come leoni, giraffe, elefanti, zebre.
OBIETTIVI: Conoscere i fenomeni atmosferici. • Riconoscere le diverse aree climatiche.
NOME E COGNOME
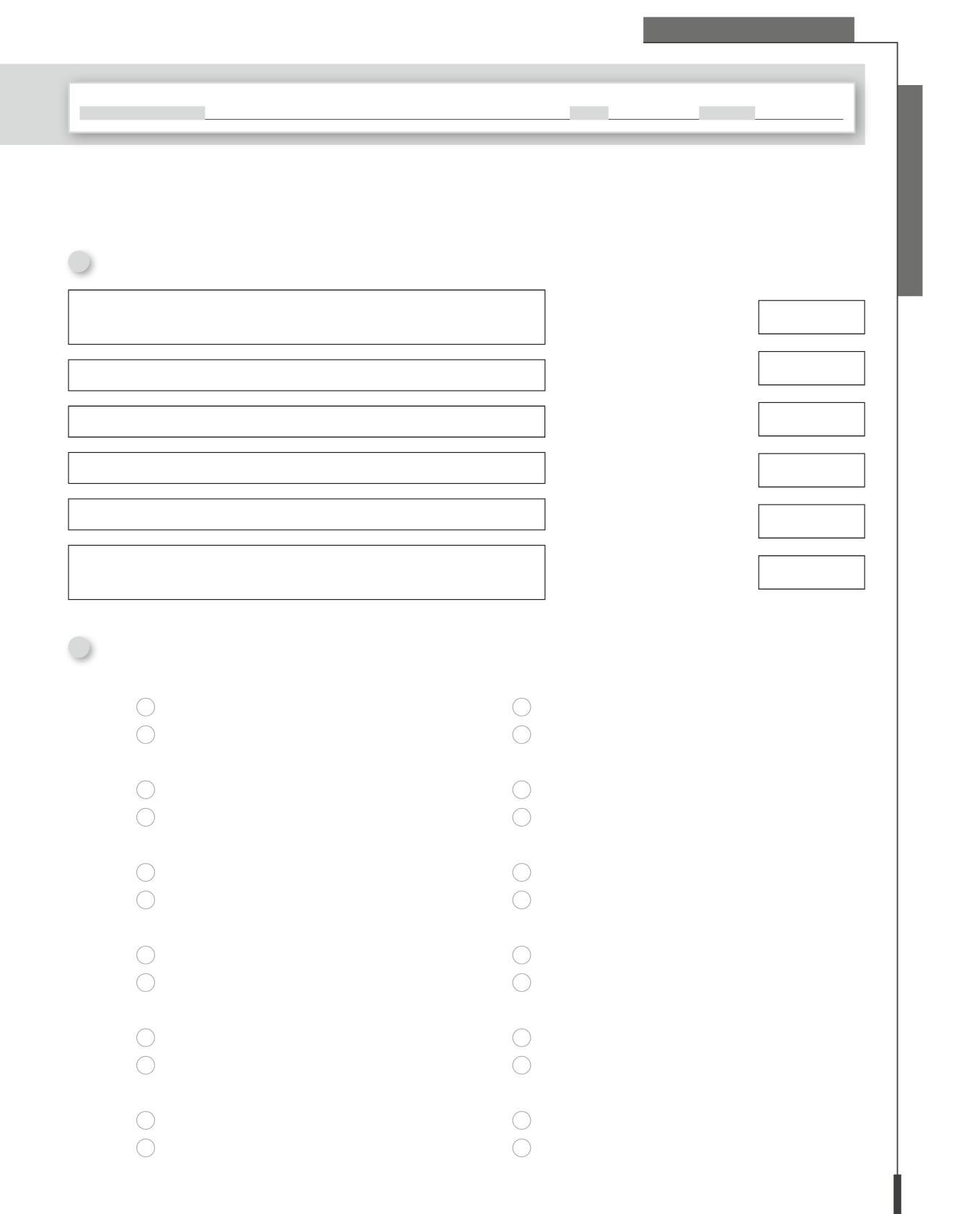
PROVA FINALE DI GEOGRAFIA
1 Collega ogni descrizione al termine corrispondente.
Nascono da una sorgente e terminano in una foce, che può essere a delta o a estuario.
Hanno coste alte e rocciose oppure basse e sabbiose.
Nell’Italia Settentrionale sono in genere di origine glaciale.
Sono rilievi poco elevati e dalle forme arrotondate.
Possono essere attivi, a riposo oppure spenti.
Sono di origine alluvionale o vulcanica, oppure create dal sollevamento dei fondali marini.
2 Indica con una X il completamento corretto di ogni frase.
• La catena delle Alpi si trova:
A. a sud dell’Italia.
B. a est dell’Italia.
• La catena degli Appennini si estende:
C. a nord dell’Italia.
D. a ovest dell’Italia.
A. dal Piemonte al Trentino-Alto Adige. C. dalla Toscana alla Puglia.
B. dalla Liguria al Veneto. D. dalla Liguria alla Sicilia.
• La pianura italiana più estesa è:
A. il Tavoliere delle Puglie. C. la Pianura Padana.
B. la Maremma.
• Il fiume Po sfocia:
A. nel Mar Ligure.
B. nel Mar Adriatico.
• Il lago di Garda è di origine:
A. glaciale.
B. vulcanica.
• Le colline di origine morenica sono dovute:
A. alle eruzioni vulcaniche.
B. all’opera dell’essere umano.
D. il Campidano.
C. nel Mar Tirreno.
D. nel Mar Ionio.
C. tettonica.
D. artificiale.
C. ai detriti lasciati dai ghiacciai.
D. all’abbassamento del suolo.
OBIETTIVI: Conoscere gli elementi principali che caratterizzano i paesaggi italiani.
3 Sottolinea l’alternativa corretta per completare le frasi.
• I centri abitati in Italia hanno tutti dimensioni molto simili / diverse
• La maggior parte delle città italiane ha più / meno di un milione di abitanti.
• Le città sono formate quasi esclusivamente da elementi naturali / antropici
• La capitale d’Italia è Milano / Roma
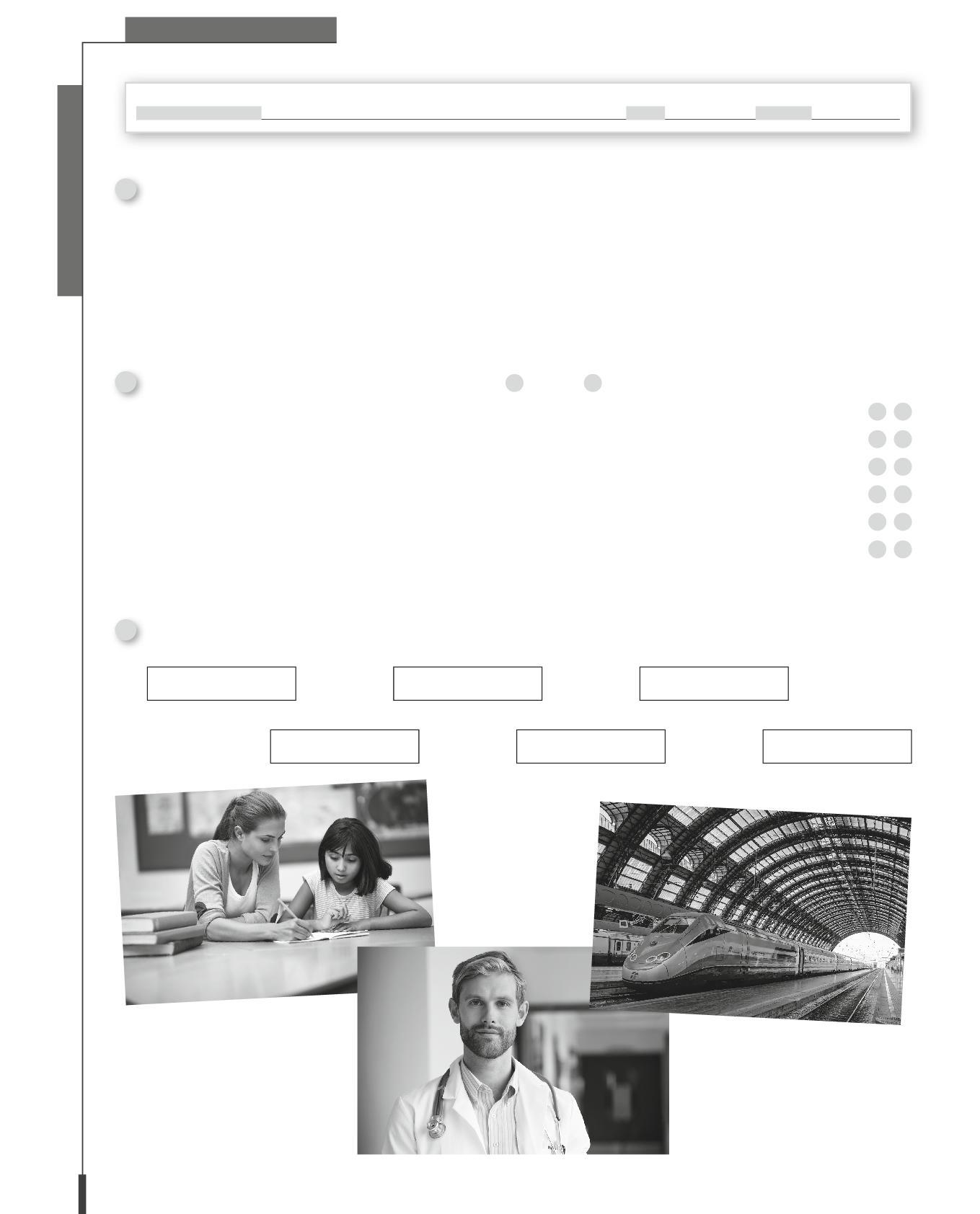
4 Indica con una X se le affermazioni sono vere V o false F .
• Le attività produttive sono divise in tre grandi settori: primario, secondario, terziario.
• Agricoltura, allevamento e pesca fanno parte del settore primario.
• L’industria fa parte del settore terziario.
• L’Italia è fra le nazioni più industrializzate del mondo.
• Il settore terziario comprende tutte le attività che forniscono servizi.
• Il settore terziario in Italia è poco sviluppato.
5 Indica con una X l’intruso nelle attività del settore terziario.
sanità commercio turismo scuola pesca comunicazioni
NOME E COGNOME DATA CLASSE
PROVA D’INGRESSO DI STORIA
1 Quando sono vissute le diverse specie di ominidi nella Preistoria? Collega con le frecce i nomi nei cartellini con i pallini sulla linea del tempo.
Homo habilis Australopiteco Uomo di Neanderthal Homo erectus
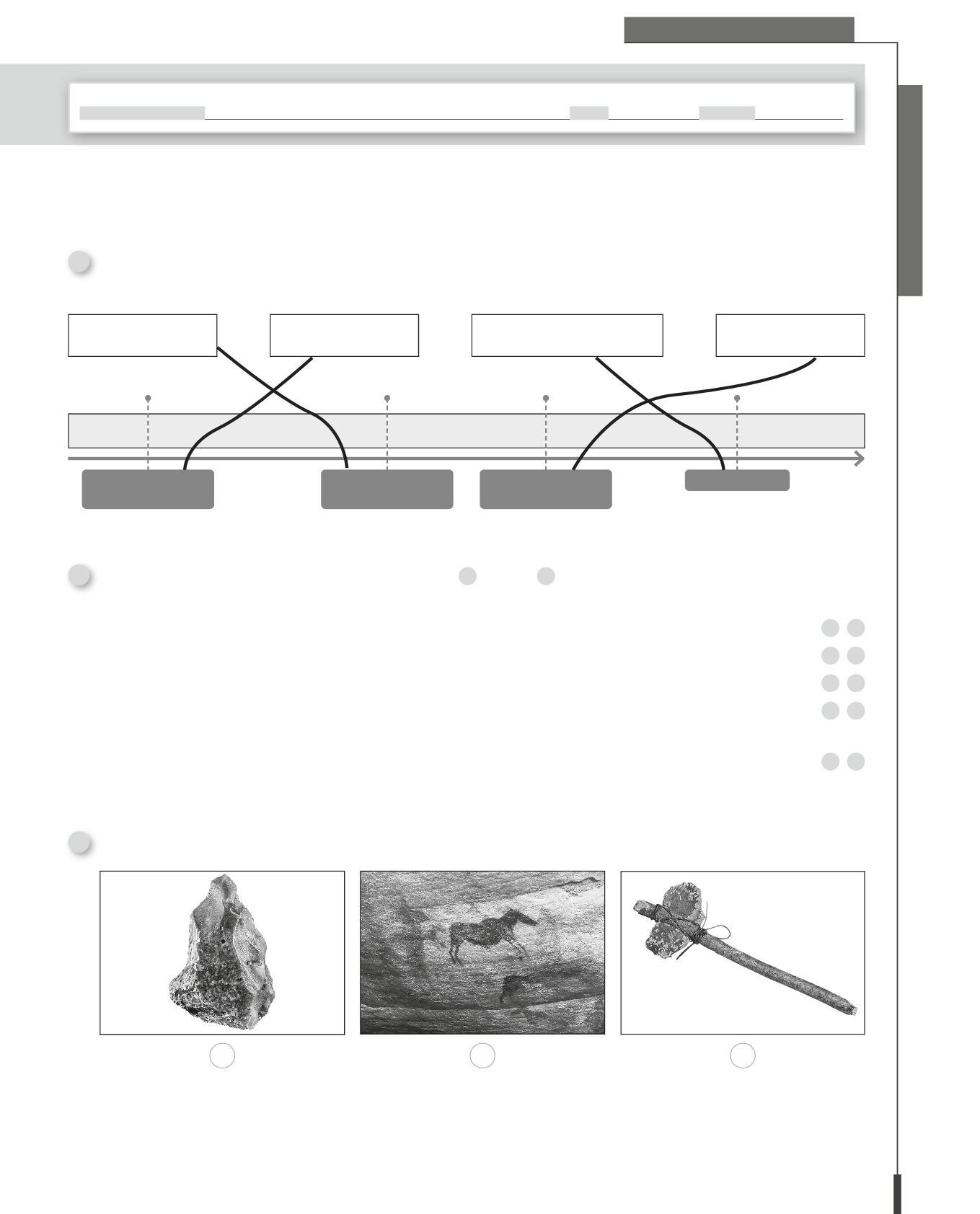
3 milioni e mezzo di anni fa
milioni e mezzo di anni fa
milione e mezzo di anni fa
2 Indica con una X se le affermazioni sono vere V o false F .
000 anni fa
• Gli Australopitechi erano onnivori: infatti si nutrivano sia di vegetali, sia di piccoli mammiferi e insetti.
• L’Homo habilis viveva in grandi villaggi e cacciava con l’arco e le frecce.
• L’Homo erectus è stato il primo ominide a saper accendere il fuoco.
• L’Uomo di Neanderthal cacciava in gruppo anche animali di grandi dimensioni.
• L’Homo sapiens non conosceva il fuoco. L’unico utensile che sapeva costruire era il chopper
3 Indica con una X il reperto storico più antico.
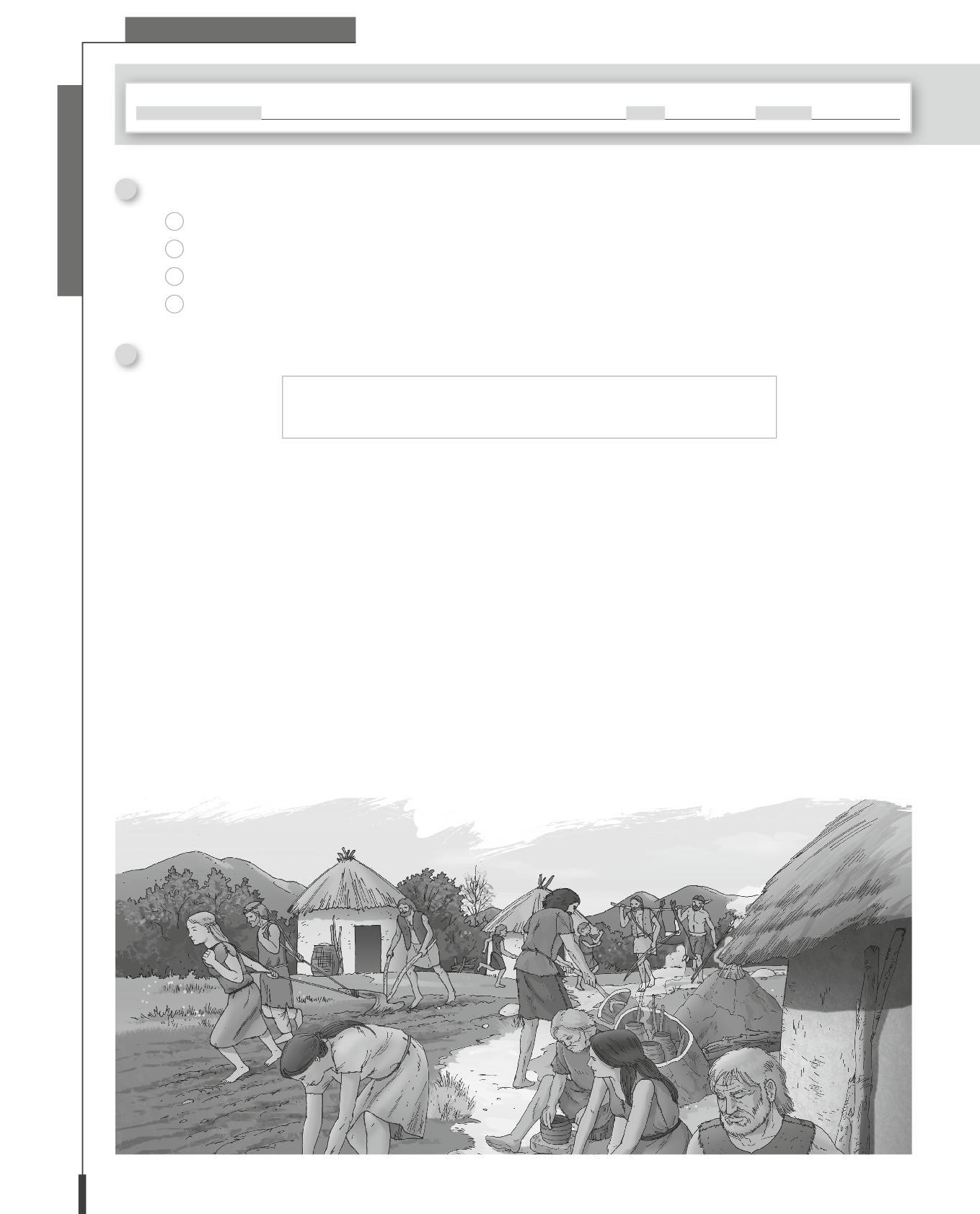
4 Indica con una X quando iniziò il periodo che gli studiosi e le studiose hanno chiamato Neolitico.
A. 1 200 anni fa.
B. 1 200 000 di anni fa.
C. 12 000 anni fa.
D. 120 000 anni fa.
5 Riscrivi le parole al posto giusto nel testo.
agricoltura • allevamento • baratto • capanne • Neolitico • raccogliere • sedentario • villaggi
Neolitico sedentario
Con l’inizio del , l’uomo smise di essere nomade e divenne , cioè si fermò a vivere in un luogo a lui favorevole.
Una delle principali attività, oltre alla caccia e alla pesca, divenne l’
raccogliere
Oltre all’agricoltura, un’altra attività molto importante fu quella dell’ degli animali addomesticati, che forniva latte, formaggio e carne in abbondanza.
baratto
agricoltura allevamento
Per questa ragione si stabilì in un luogo e, dopo aver seminato, aspettava la stagione giusta per i frutti della terra.
I prodotti della terra (frutti, cereali, legumi e ortaggi) e i prodotti dell’allevamento (latte, formaggi e carne), potevano essere scambiati attraverso il , perché in quel periodo la moneta non esisteva.
Divenuto sedentario, l’uomo non ebbe più bisogno di ripararsi nelle caverne e costruì le circolari, disposte le une vicine alle altre, formando dei veri e propri X
capanne villaggi
PROVA INTERMEDIA DI STORIA
1 Collega con le frecce ogni cartellino all’immagine corrispondente.
fonte materiale
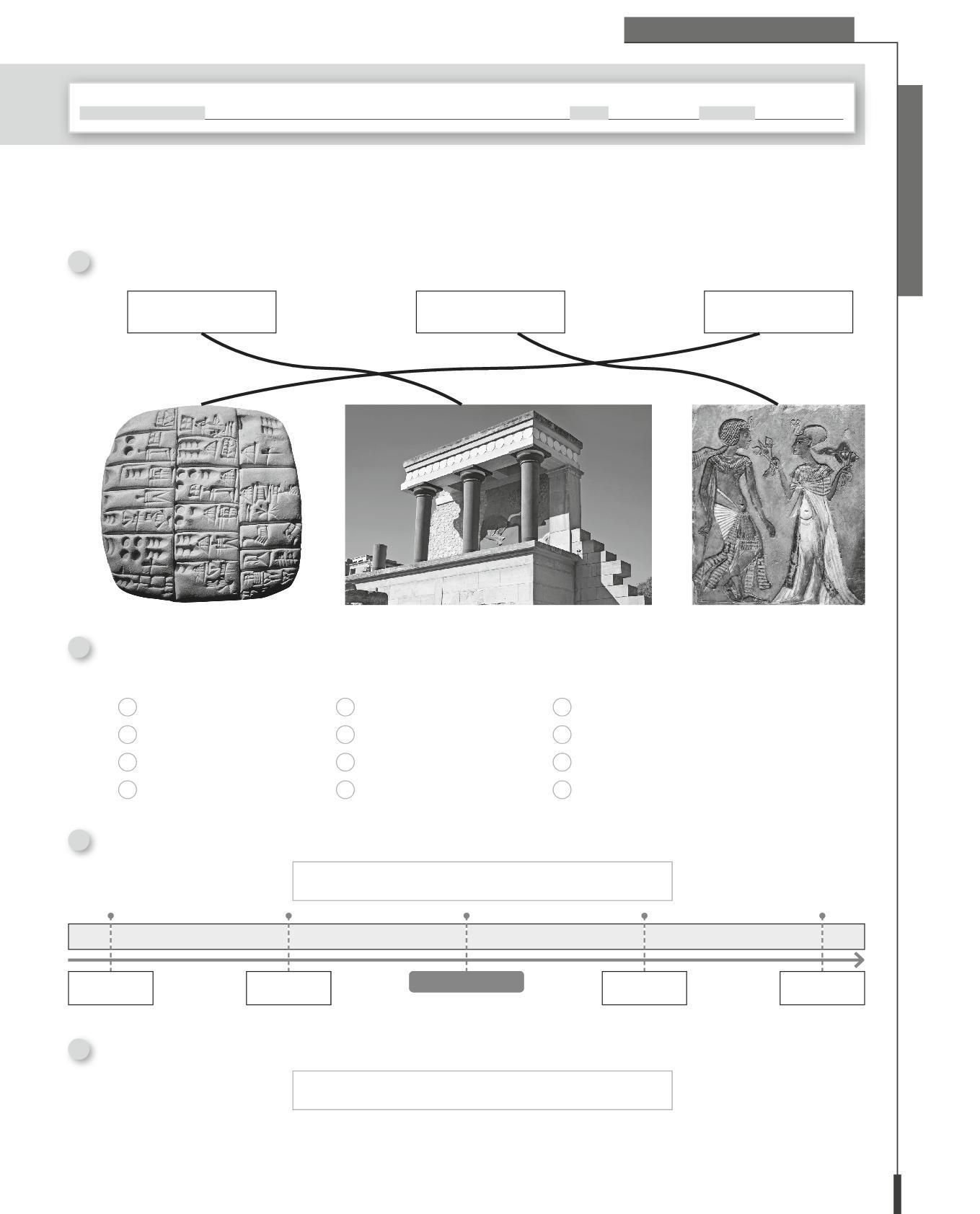
fonte visiva
2 Quale numero manca per completare le uguaglianze? Indicalo con una X.
1 secolo = ? anni 1 millennio = ? anni 1 millennio = ? secoli
fonte scritta
3 Scrivi le seguenti date sulla linea del tempo.
4 Riscrivi le seguenti date in ordine cronologico.
5 Indica con una X la risposta corretta.
• Quali fiumi attraversavano la Mesopotamia?
A. Indo e Gange.
B. Nilo ed Eufrate.
C. Tigri ed Eufrate.
D. Fiume Giallo e Fiume Azzurro.
• Chi furono i primi abitanti della Mesopotamia?
A. Gli Assiri.
B. I Sumeri.
C. Gli Ittiti.
D. I Babilonesi.
• Che cos’era la ziggurat?
A. Un magazzino per la raccolta del grano.
B. Il palazzo del re.
C. L’abitazione dei contadini.
D. Un edificio a gradoni con un tempio sulla cima.
6 Collega ciascuna affermazione al nome del popolo antico corrispondente.
Erano un popolo di guerrieri e saccheggiarono Babilonia.
La loro più importante invenzione fu la loro scrittura, detta cuneiforme.
Il loro re, Hammurabi, conquistò molte delle città-stato sumere e unificò in un solo impero la Mesopotamia.
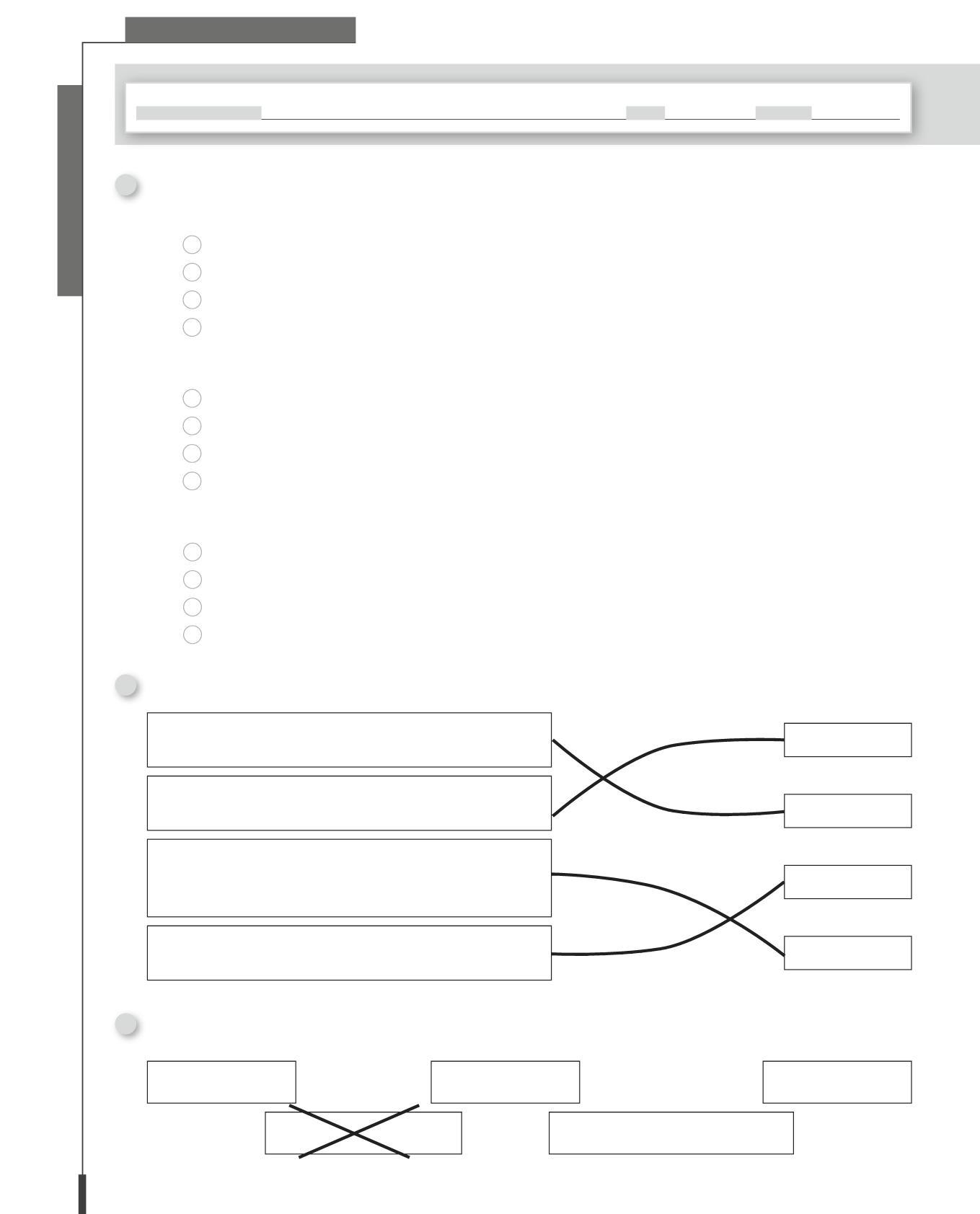
Sumeri
Ittiti Assiri Babilonesi
7 I popoli della Mesopotamia svilupparono diverse conoscenze e attività. Cancella l’intruso con una X.
Il loro re, Assurbanipal, fece realizzare una grande biblioteca nel palazzo reale di Ninive. astronomia scrittura su carta agricoltura guerra commercio con il baratto
OBIETTIVI: Conoscere i principali aspetti che caratterizzano le antiche civiltà della Mesopotamia.
NOME
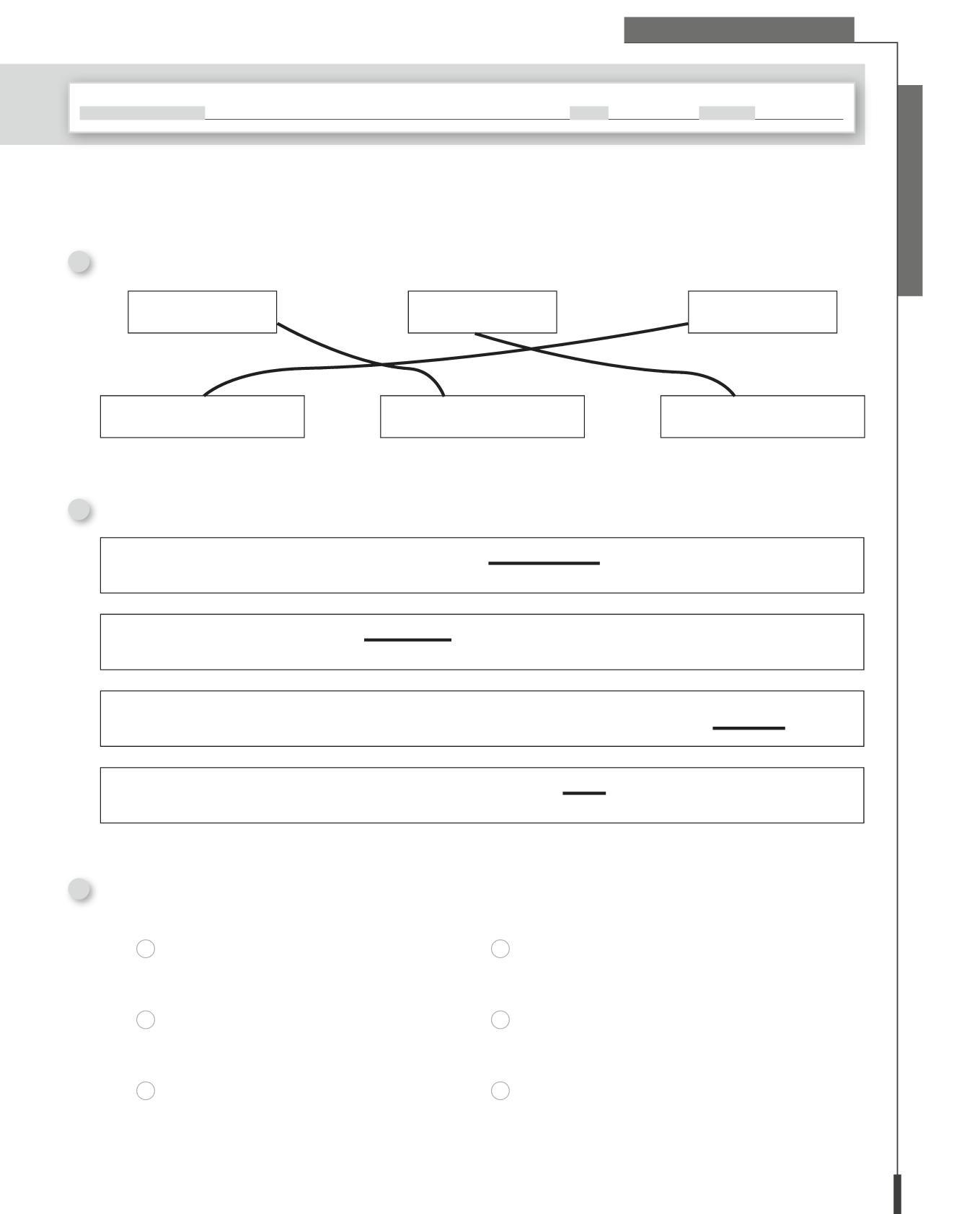
PROVA FINALE DI STORIA
1 Collega con le frecce ogni data all’avvenimento corrispondente della storia della civiltà egizia.
2050 a.C.
inizio dell’Antico Regno
1550 a.C.
3100 a.C.
inizio del Medio Regno
inizio del Nuovo Regno
2 Sottolinea in rosso l’errore contenuto in ogni testo.
Sovrano e capo assoluto degli antichi Egizi era il Grande Scriba, che veniva adorato dal popolo come se fosse un dio.
Gli antichi Egizi erano un popolo monoteista. Infatti essi adoravano numerosi dèi, fra i quali Iside, Osiride e Anubi.
La scrittura degli antichi Egizi, detta geroglifica, era composta da tanti segni: l’alfabeto.
Per costruire le piramidi furono utilizzati grandi blocchi di legno. Non sappiamo come fecero gli Egizi a sollevare e trasportare questi grandi blocchi.
3 Indica con una X la conclusione corretta per ogni affermazione.
• Nell’antico Egitto il faraone era:
A. un funzionario esperto di calcoli. B. il re, capo assoluto del regno.
• Nell’antico Egitto contadini, allevatori, artigiani, commercianti e servi erano:
A. la parte più numerosa del popolo. B. pochissimi e molto ricchi.
• Nell’antico Egitto i nobili:
A. governavano i territori. B. trascrivevano gli ordini del faraone. X X X
OBIETTIVI: Conoscere la periodizzazione di avvenimenti storici. • Conoscere gli aspetti principali della civiltà egizia.
4 Indica con una X la risposta corretta.
• Quale civiltà si sviluppò lungo il corso del Fiume Giallo e del Fiume Azzurro?
A. La civiltà egizia.
B. La civiltà cinese.
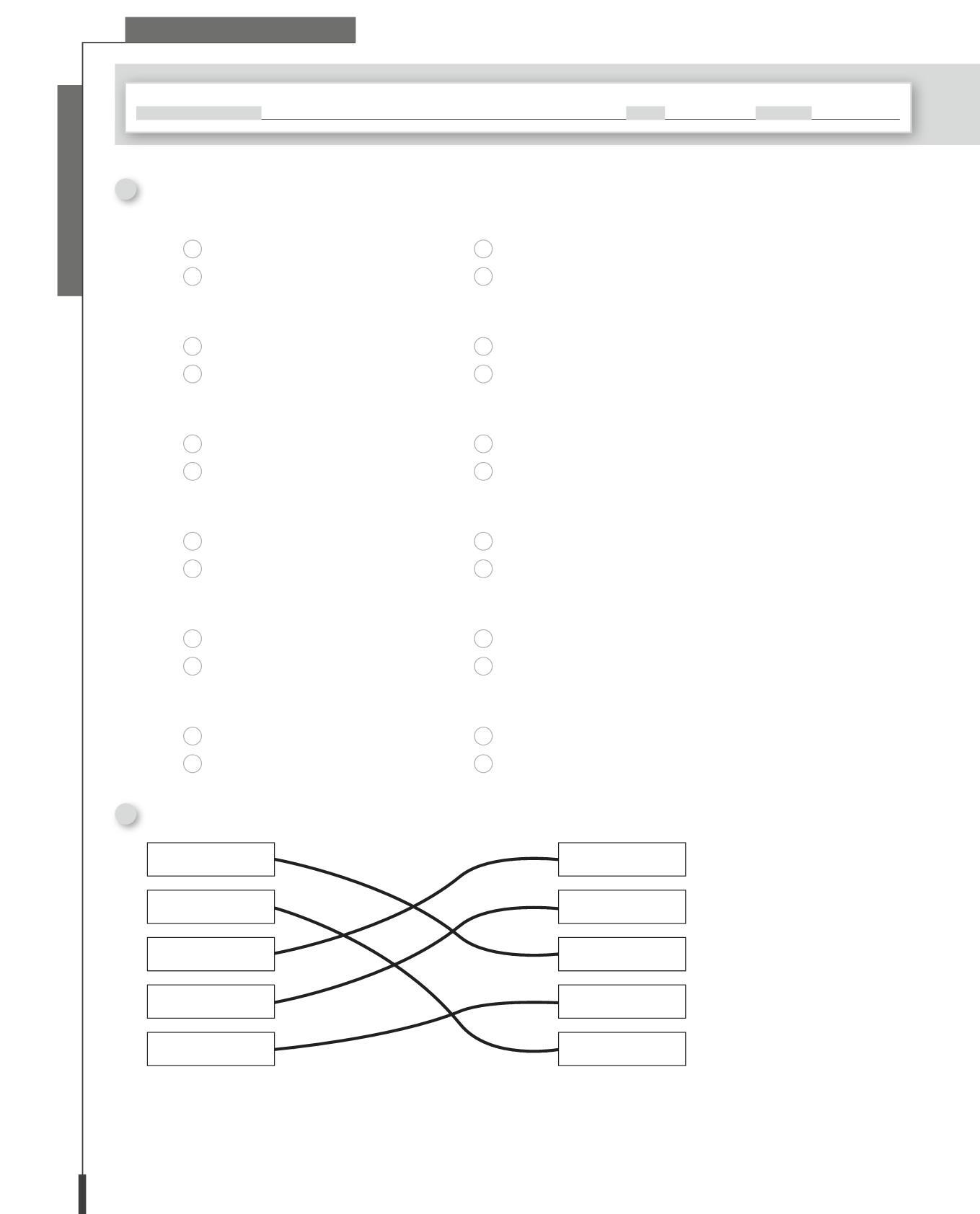
C. La civiltà cretese.
D. La civiltà fenicia.
• Quale civiltà inventò la scrittura alfabetica e sviluppò il commercio nel Mar Mediterraneo?
A. La civiltà ebraica.
B. La civiltà egizia.
C. La civiltà fenicia.
D. La civiltà cinese.
• Quale civiltà praticava una religione monoteista?
A. La civiltà egizia.
B. La civiltà cretese.
C. La civiltà fenicia.
D. La civiltà ebraica.
• Quale civiltà si sviluppò su un’isola dove sorgevano numerose città-palazzo?
A. La civiltà cretese.
B. La civiltà ebraica.
C. La civiltà dell’Indo.
D. La civiltà egizia.
• Quale civiltà credeva nell’aldilà e mummificava i corpi dei defunti?
A. La civiltà fenicia.
B. La civiltà cinese.
C. La civiltà egizia.
D. La civiltà ebraica.
• Quale civiltà non si sviluppò lungo le coste del Mar Mediterraneo?
A. La civiltà ebraica.
B. La civiltà cretese.
C. La civiltà fenicia.
D. La civiltà dell’Indo.
5 Collega con le frecce ogni termine al popolo corrispondente.
papiro Cinesi
Bibbia Cretesi
bachi da seta Egizi
tauromachia Fenici
colonie Ebrei
NOME E COGNOME DATA CLASSE
PROVA D’INGRESSO DI GEOGRAFIA
1 Indica con una X se le affermazioni sono vere V oppure false F .
• Nello spazio celeste ci sono solo pianeti e satelliti.
• La città è un ambiente naturale.
• Le case sono solo un elemento antropico.
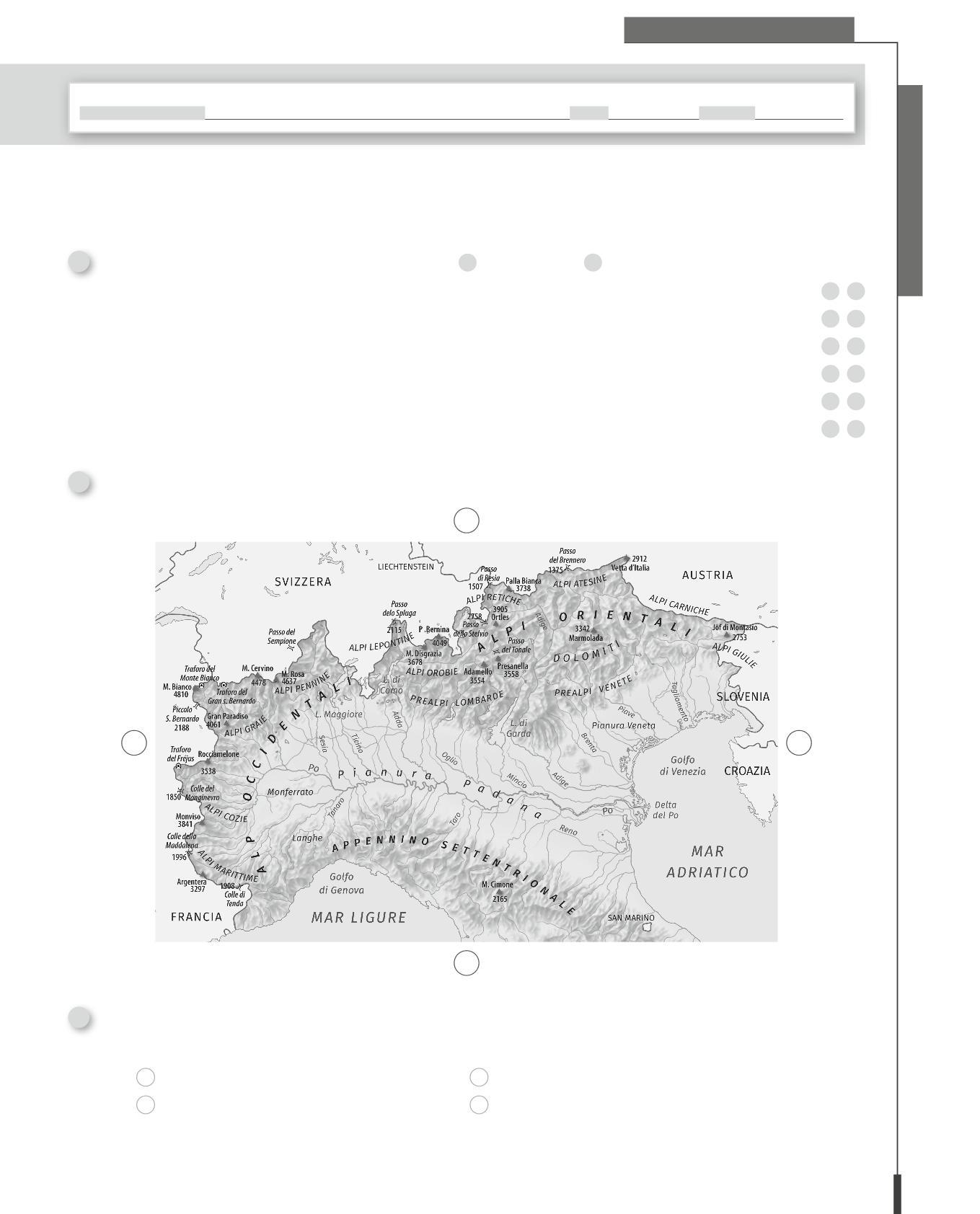
V F
V F
V F
• Pioggia e vento sono fenomeni naturali. V F
• Il mare modifica l’ambiente frantumando le rocce e trasformandole in sassi e sabbia. V F
• La costruzione di un ponte non modifica l’ambiente naturale di un fiume. V F
2 Osserva la carta geografica e scrivi nei riquadri i punti cardinali al posto giusto.
3 Indica con una X la conclusione corretta della frase.
• L’immagine riportata nell’esercizio 2 è:
A. una mappa dell’Italia. C. una carta geografica dell’Italia.
B. una carta stradale dell’Italia. D. un planisfero dell’Italia.
CONOSCENZE: Spazio geografico. • Orientamento e cartografia.
Distinguere i diversi tipi di spazio geografico. • Conoscere i punti cardinali. • Saper riconoscere una carta geografica.
4 Associa ogni termine alla definizione corretta. Usa i numeri.
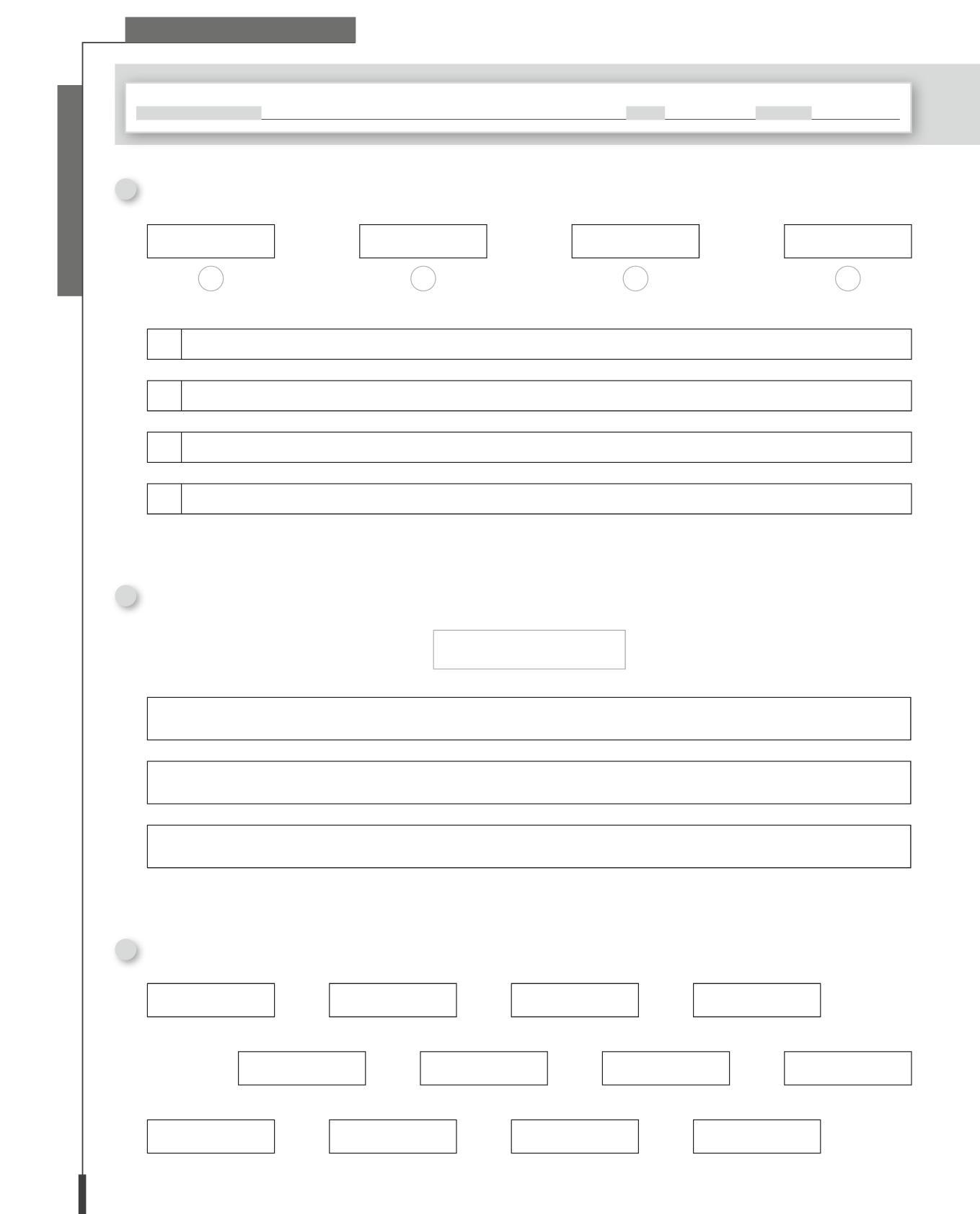
1 È un rilievo naturale la cui altitudine supera i 600 metri sul livello del mare.
2 È una terra completamente circondata dall’acqua.
3 È una vasta distesa di terreno senza rilievi, che non supera i 200 metri sul livello del mare.
4 È un rilievo naturale la cui altitudine è compresa fra i 200 e i 600 metri sul livello del mare.
5 Completa le frasi con le seguenti parole.
fiume • lago • mare
Il è uno specchio d’acqua che riempie lo spazio di un avvallamento del terreno.
Il è un corso d’acqua dolce che nasce da una sorgente.
Il è una vastissima distesa d’acqua salata.
6 Indica con una X gli elementi antropici che si possono osservare in montagna.
NOME E COGNOME DATA CLASSE
PROVA INTERMEDIA DI GEOGRAFIA
1 Indica con una X se le affermazioni sono vere V oppure false F .
• Le carte fisiche rappresentano gli aspetti naturali di un territorio. V F
• Le carte tematiche rappresentano il territorio da un punto di vista politico. V F
• In una carta politica si possono osservare i confini di una nazione e delle Regioni. V F
• Le piante e le mappe sono carte utilizzate per rappresentare grandi territori. V F
• Il planisfero è la rappresentazione su carta di tutta la Terra. V F
2 Scrivi sotto ogni carta la tipologia corrispondente.
carta fisica • carta politica • carta tematica
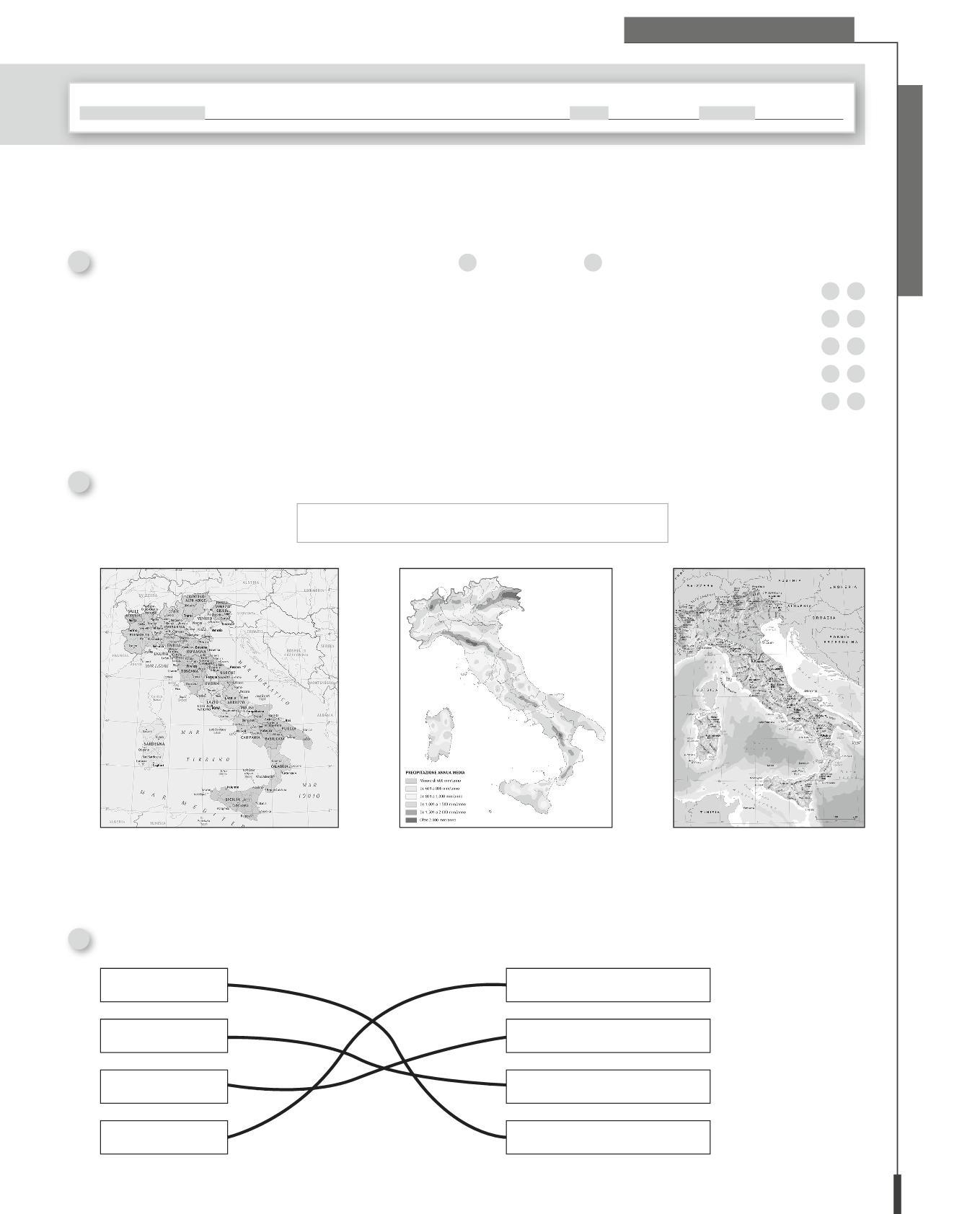
carta politica
carta tematica
3 Collega ogni punto cardinale al suo sinonimo.
Nord Levante
Est Meridione
Sud Ponente
Ovest Settentrione
carta fisica
OBIETTIVI: Classificare le carte geografiche. • Conoscere i punti cardinali.
4 Completa il testo con le parole seguenti.
i venti • l’umidità • la temperatura • la pressione atmosferica • le precipitazioni
Diversi fenomeni atmosferici determinano il clima di un territorio. misura il calore dell’aria, che dipende dall’intensità dei raggi del Sole. caldi o freddi soffiando possono riscaldare o raffreddare l’ambiente. Pioggia, neve e grandine, cioè , dell’aria e sono altri importanti fenomeni che influiscono sul clima.
la temperatura i venti
le precipitazioni l’umidità
5 Collega ogni tipo di clima alla sua descrizione.
la pressione atmosferica
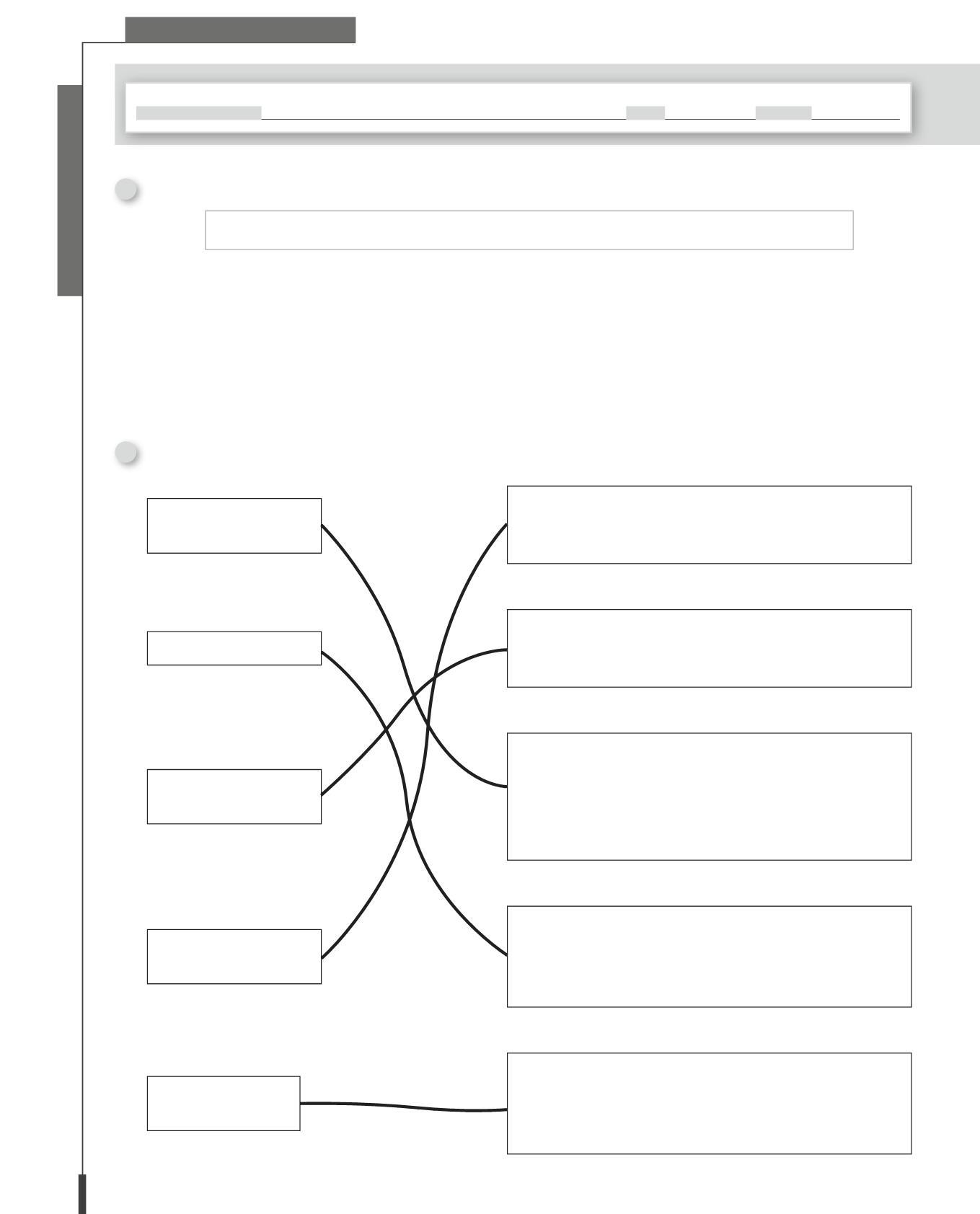
clima freddo polare artico e antartico
clima temperato
clima caldo tropicale clima caldo dei deserti
clima equatoriale
Piove frequentemente. Nelle foreste pluviali vivono molte specie vegetali e animali, come ippopotami, scimmie, tucani...
Non piove quasi mai. Fa molto caldo di giorno e molto freddo di notte. A volte l’acqua affiora in superficie e forma delle oasi.
Le zone polari sono ricoperte dai ghiacci per gran parte dell’anno e hanno solamente due stagioni: l’estate, in cui il Sole non tramonta mai ma è debolissimo, e l’inverno, in cui la luce è scarsa e il freddo molto intenso.
Il clima è mite e caratterizzato dall’alternarsi delle quattro stagioni. Il clima favorisce la diffusione di boschi di conifere e latifoglie, praterie e vegetazione mediterranea.
A cavallo dell’Equatore fa molto caldo e piove in una sola stagione o in due periodi dell’anno. Sul territorio si estende la savana, dove vivono animali come leoni, giraffe, elefanti, zebre.
OBIETTIVI: Conoscere i fenomeni atmosferici. • Riconoscere le diverse aree climatiche.
NOME E COGNOME DATA CLASSE
PROVA FINALE DI GEOGRAFIA
1 Collega ogni descrizione al termine corrispondente.
Nascono da una sorgente e terminano in una foce, che può essere a delta o a estuario.
Hanno coste alte e rocciose oppure basse e sabbiose.
Nell’Italia Settentrionale sono in genere di origine glaciale.
Sono rilievi poco elevati e dalle forme arrotondate.
Possono essere attivi, a riposo oppure spenti.
Sono di origine alluvionale o vulcanica, oppure create dal sollevamento dei fondali marini.
2 Indica con una X il completamento corretto di ogni frase.
• La catena delle Alpi si trova:
A. a sud dell’Italia.
B. a est dell’Italia.
• La catena degli Appennini si estende:

C. a nord dell’Italia.
D. a ovest dell’Italia.
A. dal Piemonte al Trentino-Alto Adige. C. dalla Toscana alla Puglia.
B. dalla Liguria al Veneto.
• La pianura italiana più estesa è:
D. dalla Liguria alla Sicilia.
A. il Tavoliere delle Puglie. C. la Pianura Padana.
B. la Maremma.
• Il fiume Po sfocia:
A. nel Mar Ligure.
B. nel Mar Adriatico.
• Il lago di Garda è di origine:
A. glaciale.
B. vulcanica.
• Le colline di origine morenica sono dovute:
A. alle eruzioni vulcaniche.
B. all’opera dell’essere umano.
D. il Campidano.
C. nel Mar Tirreno.
D. nel Mar Ionio.
C. tettonica.
D. artificiale.
C. ai detriti lasciati dai ghiacciai.
D. all’abbassamento del suolo.
OBIETTIVI: Conoscere gli elementi principali che caratterizzano i paesaggi italiani.
3 Sottolinea l’alternativa corretta per completare le frasi.
• I centri abitati in Italia hanno tutti dimensioni molto simili / diverse
• La maggior parte delle città italiane ha più / meno di un milione di abitanti.
• Le città sono formate quasi esclusivamente da elementi naturali / antropici
• La capitale d’Italia è Milano / Roma
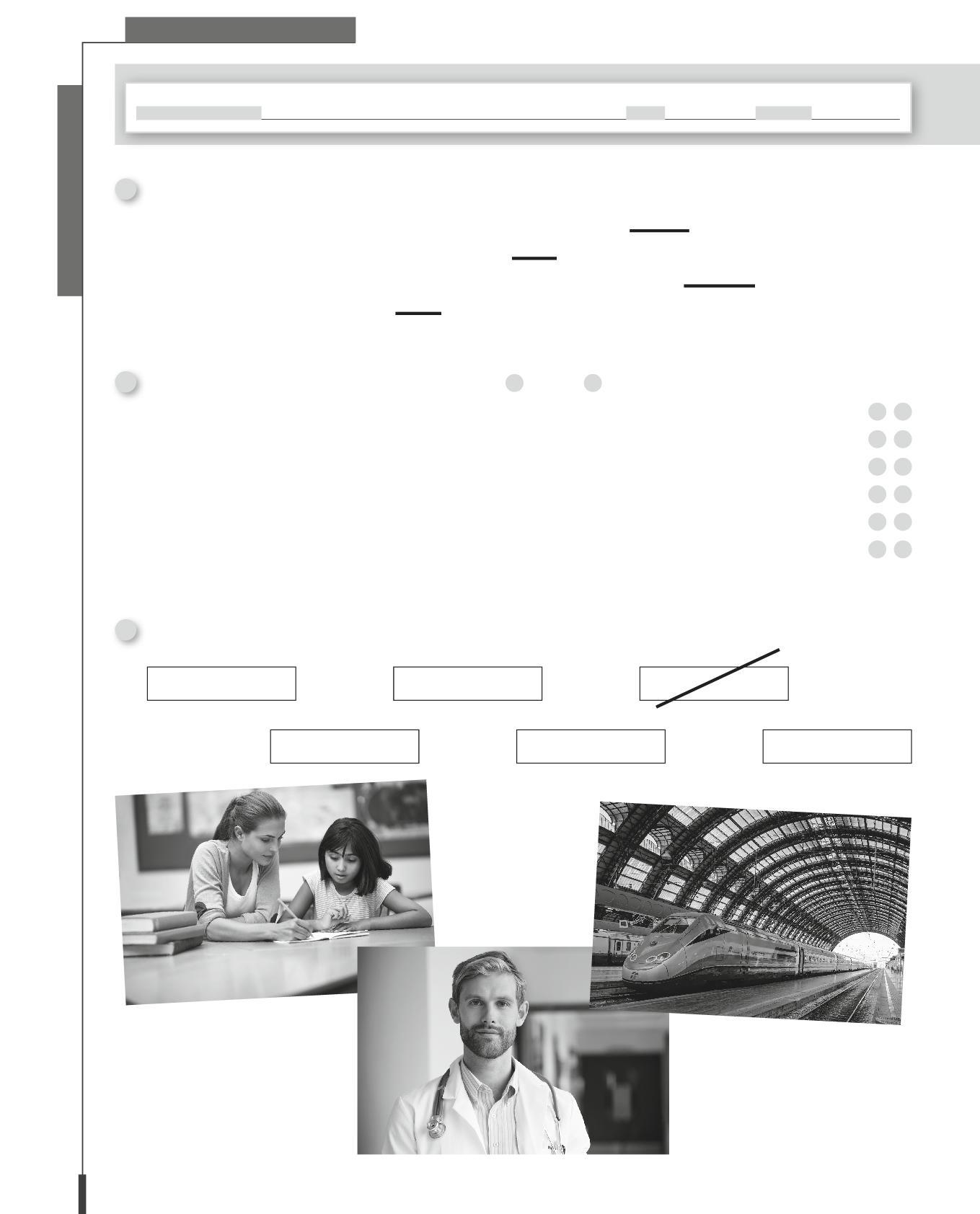
4 Indica con una X se le affermazioni sono vere V o false F .
• Le attività produttive sono divise in tre grandi settori: primario, secondario, terziario.
• Agricoltura, allevamento e pesca fanno parte del settore primario.
• L’industria fa parte del settore terziario.
• L’Italia è fra le nazioni più industrializzate del mondo.
• Il settore terziario comprende tutte le attività che forniscono servizi.
• Il settore terziario in Italia è poco sviluppato.
5 Indica con una X l’intruso nelle attività del settore terziario.
Contributi e percorsi a cura di Ricerca e Sviluppo Erickson
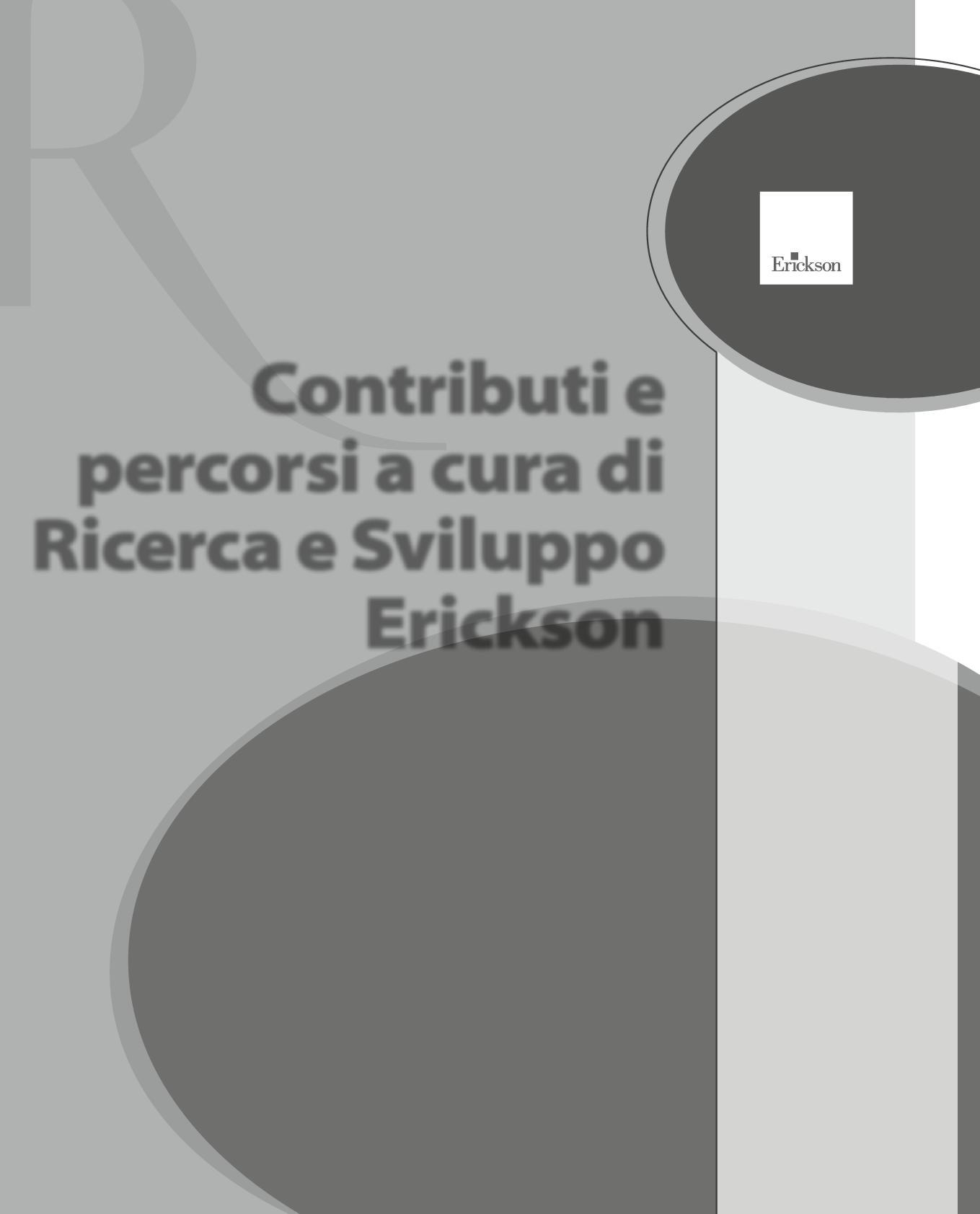
• Costruire inclusione in una prospettiva universale
• Il Piano Educativo Individualizzato in prospettiva bio-psico-sociale
• Piano Didattico Personalizzato: ridare centralità alla didattica
• I materiali per una didattica inclusiva ne I mondi di GEA – Storia e Geografia
• Progetto CheFacile!
COSTRUIRE INCLUSIONE
IN UNA PROSPETTIVA
UNIVERSALE
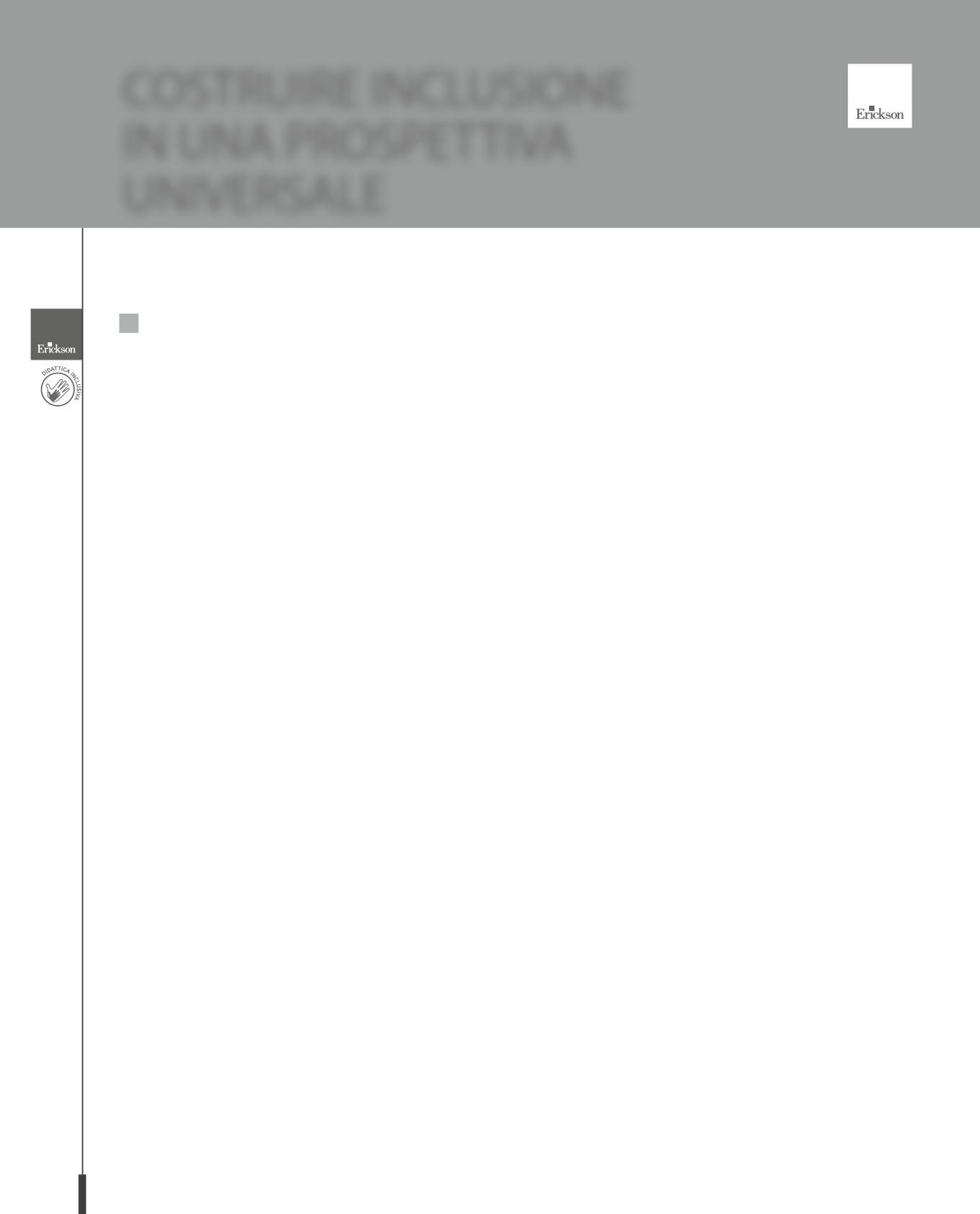
Il vero significato di una scuola inclusiva
Quando parliamo di inclusione in termini generali e quando pensiamo allo sviluppo di un contesto scolastico inclusivo, dobbiamo in primis evitare un errore fondamentale: pensare all’inclusione come a qualcosa che riguarda le categorie svantaggiate. Al contrario, l’inclusione riguarda tutte le persone, tutti i membri della comunità scolastica, siano essi studenti e studentesse o docenti e altre figure professionali presenti nel contesto scolastico.
L’inclusione, infatti, si concretizza in azioni pedagogiche e didattiche nel momento in cui mira a costruire una comunità scolastica inclusiva, basata sulla valorizzazione delle differenze e sulla partecipazione sociale di tutti e tutte. Una finalità ben più ampia di quella che a volte viene indicata rispetto alle attenzioni specifiche rivolte a categorie che presentano Bisogni Educativi Speciali (BES). L’inclusione riguarda le politiche scolastiche, le scelte di indirizzo di un istituto, le relazioni tra il personale e tra docenti e il gruppo studentesco, ma anche le relazioni con le famiglie e il contesto extrascolastico. Riguarda poi ovviamente anche le scelte personali che ogni docente si trova liberamente a esercitare nella selezione delle metodologie didattiche, dei materiali, dell’organizzazione del contesto di classe, nello stile relazionale che ognuno adotta nei confronti della classe nell’esercizio della propria autorità di docente. Sono molti i gradi di libertà che ciascuno può attivare per dare forma a una didattica più inclusiva e più capace di tenere conto delle differenze individuali che formano il gruppo classe.
La finalità della didattica inclusiva
La didattica inclusiva ha come finalità il raggiungimento del maggior grado possibile di apprendimento e della partecipazione di tutti e tutte, tenendo conto delle condizioni di ciascuno. Se analizziamo queste poche parole, scopriamo già alcuni elementi di particolare importanza. Innanzitutto, vediamo subito come la didattica inclusiva contenga in sé il concetto di personalizzazione. Le “condizioni di ciascuno” ci mettono subito sulla pista delle differenze individuali, cioè il punto di partenza che non può essere ignorato. Per anni la didattica tradizionale ha cercato di eliminare questa eterogeneità, impostando la propria azione su una fantomatica “normalità” o un’altrettanto illusoria media di competenza. La didattica inclusiva riporta invece la complessità delle differenze umane al centro della propria azione. Se io docente voglio programmare la mia azione, il mio curricolo, le mie strategie e i miei strumenti, devo comprendere le condizioni di partenza del mio gruppo classe e dei singoli e monitorarle nel corso del tempo. Non solo le condizioni “speciali” (per dirla con un termine ormai desueto) di alunni e alunne con disabilità e Bisogni Educativi Speciali o con specifiche situazioni di difficoltà, ma di tutto il gruppo
Differenziazione al centro della didattica inclusiva
La definizione di inclusione ci dice anche che i traguardi e i percorsi possono essere differenti: la finalità è che tutti arrivino a sviluppare il massimo grado possibile di apprendimento e partecipazione, ma questo grado non può essere uguale per tutti, perché diverse sono le condizioni di partenza e le situazioni che possono accadere nel tempo. Questo apre la strada a un concetto chiave che è quello della differenziazione didattica.
Che cosa si intende per differenziazione?
La differenziazione è una prospettiva metodologica capace di promuovere processi di apprendimento significativi per tutti gli allievi presenti in classe, volta a proporre attività educative didattiche mirate, progettate per soddisfare le esigenze dei singoli in un clima educativo in cui è consuetudine affrontare il lavoro didattico con modalità differenti (D’Alonzo, 2017).
Riconoscere e porre al centro dell’azione educativa la differenza del singolo e del gruppo significa, infatti, differenziare i modi di fare lezione, i materiali, le modalità di lavoro e di espressione di alunni e alunne, affinché diventi normale lavorare in classe in maniera differente, utilizzando anche strumenti differenti. Come si vede nell’immagine seguente, in una scuola inclusiva gli aiuti non sono distribuiti a tutti in modo uguale (1), ma in base alle necessità e alle differenze di ogni individuo (2). Tuttavia, l’azione più efficace è quella che prevede di modificare il contesto generale eliminando le barriere e rendendo gli aiuti non sempre necessari (3).

L’evoluzione necessaria: la prospettiva universale per la piena inclusione
Partire dalla comprensione dei bisogni di tutto il gruppo classe, superare la logica dell’inclusione riferita ai soli Bisogni Educativi Speciali: una sfida certamente difficile. Sappiamo che nella quotidianità scolastica è ancora molto complesso compiere questo passo. Sappiamo che ci sono normative e figure di sistema per l’inclusione che sono riferite appunto alla tutela dei diritti di apprendimento di categorie ancora considerate svantaggiate. Se è vero che la definizione di inclusione, come abbiamo visto, si rivolge al 100% di alunni e alunne, è pur vero che la quotidianità ci mostra un panorama diverso. È necessario quindi un salto in avanti, una spinta a far evolvere le azioni didattiche per cercare la piena inclusione. Per questo motivo, è necessario assumere una prospettiva universale per programmare la propria didattica disciplinare.
La dimensione universale della didattica propone un superamento deciso della logica per cui l’inclusione sia necessaria per rispondere a bisogni specifici di alcuni e si pone, al contrario, come azione programmatica di base per la scuola in ogni situazione, per pianificare un percorso di apprendimento significativo, realmente inclusivo e fondato sulle caratteristiche del gruppo a cui si rivolge (Zambotti e Franch, 2022, p. 7)1. Come scrive Ianes, «se vogliamo davvero muoverci verso l’universalità dovremmo essere ossessionati dallo scoprire, comprendere e valorizzare in ogni modo le differenze dei nostri alunni» (Canevaro e Ianes, 2021 p. 112).
1 Zambotti F. e Franch S., in Sciapeconi I., Pigliapoco E., R&S Erickson, Didattica universale: italiano per le classi 1,2,3, Trento, Erickson, 2022.
2 Canevaro A., Ianes D., Un’altra didattica è possibile, Trento, Erickson, 2021.
Il modello DAII come azione concreta della prospettiva universale
Pianificare la propria didattica avendo come finalità l’apprendimento e la partecipazione di tutti, partendo dalle caratteristiche del gruppo classe, può essere concretizzato attraverso un modello didattico specifico.
Il modello di Didattica Aumentata per l’Inclusione e l’Innovazione (DAII), che abbiamo proposto nell’ambito della collaborazione con Rizzoli Education e di cui anche questo corso fa parte, ha lo scopo di organizzare curricoli e materiali per rispondere alle sfide che la prospettiva universale ci pone. Il modello DAII prevede infatti sette dimensioni didattiche particolarmente rilevanti per una pianificazione pienamente inclusiva e pone l’attenzione sui contesti di azione e relazione strategici per l’innovazione della didattica.
L’intreccio tra innovazione e inclusione è determinante: non c’è innovazione se non c’è un miglioramento della dimensione inclusiva, ma allo stesso tempo non si può migliorare la condizione di inclusione universale senza innovare gli stili di insegnamento, i contesti di apprendimento e l’uso significativo dei materiali didattici.
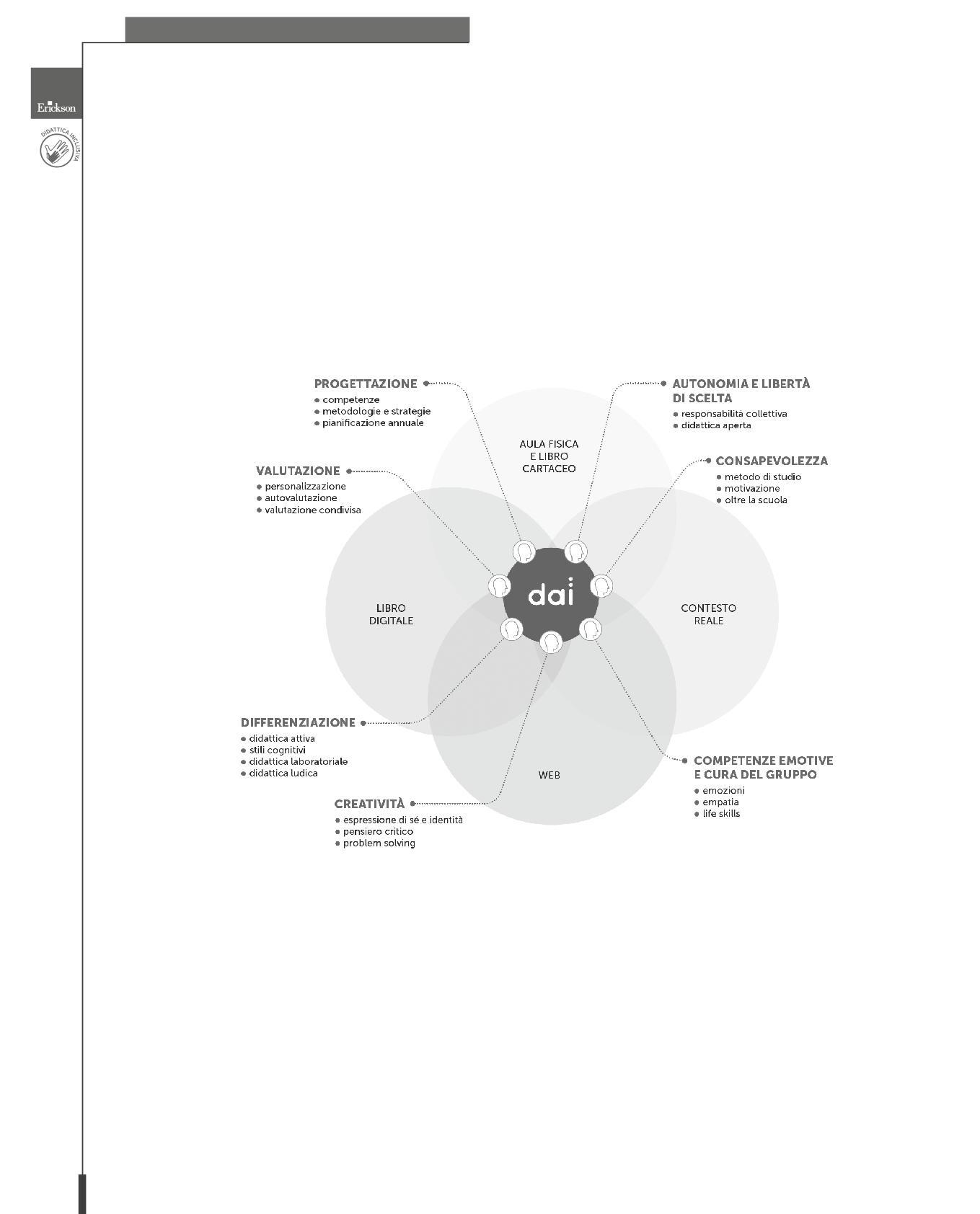
I contesti di apprendimento
Abbiamo sottolineato in primis l’importanza dei contesti:
■ spazio d’aula e spazi formali dell’istituto;
■ spazi informali dell’istituto;
■ spazi digitali di apprendimento;
■ spazi extrascolastici.
In questi quattro contesti gli alunni e le alunne interagiscono e costruiscono i propri percorsi di apprendimento e partecipazione, a volte con la mediazione dell’insegnante e dei materiali didattici, a volte in maniera indipendente, a volte con la mediazione di altre figure professionali, ma sempre nel confronto (a volte positivo, a volte negativo) con il contesto familiare.
Un libro di testo pensato in ottica universale e realmente inclusiva può attivare in maniera significativa questi diversi contesti, permettendo modalità di lavoro differenti, incentivando la collaborazione, aumentandone l’uso significativo, l’accessibilità e la personalizzazione grazie all’uso degli strumenti
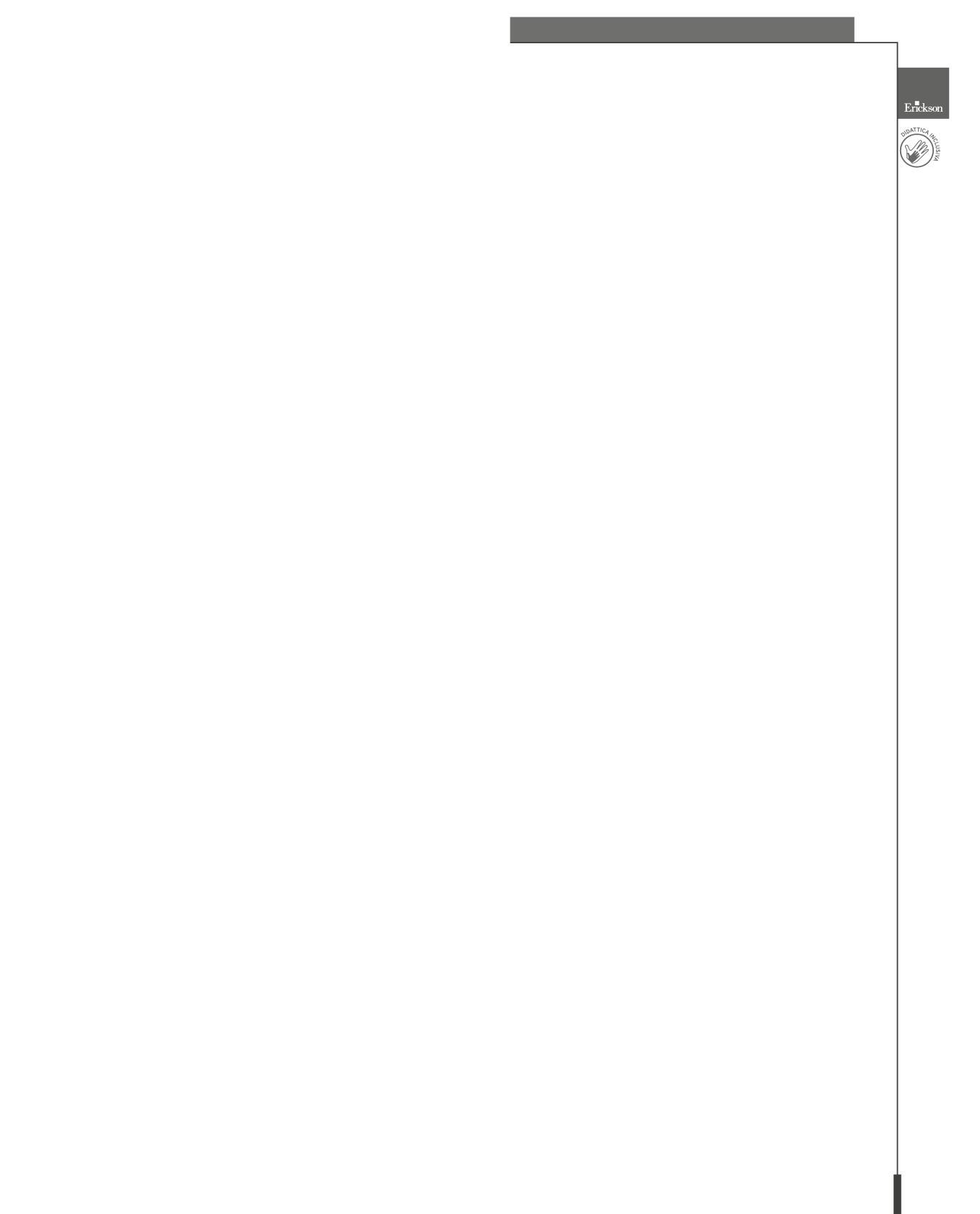
digitali, incentivando la dimensione laboratoriale ed euristica dell’apprendimento. Inoltre, può aprire gli spazi dell’extrascuola, invitando alla scoperta del territorio, valorizzando il contributo di figure professionali extrascolastiche e stimolando la ricerca autonoma e condivisa.
Le sette dimensioni didattiche del DAII
Quali azioni didattiche deve mettere al centro della propria azione l’insegnante per promuovere una didattica disciplinare davvero capace di valorizzare tutte le differenze che compongono il gruppo classe?
Questa domanda chiave regge lo scheletro del modello didattico del DAII. Abbiamo individuato sette dimensioni didattiche chiave per la promozione di una didattica universale:
1. progettazione didattica;
2. didattica sensibile alle differenze;
3. valutazione, monitoraggio e autovalutazione;
4. crescita dell’autonomia, autodeterminazione e libertà di scelta;
5. crescita della consapevolezza;
6. competenze emotive e cura del gruppo;
7. sviluppo della creatività.
Le sette dimensioni didattiche del modello universale e l’attenzione ai diversi contesti di apprendimento hanno come finalità concrete due grandi miglioramenti, uno relativo all’ambiente di studio e l’altro relativo allo sviluppo delle competenze di alunni e alunne:
1. creare uno spazio didattico di insegnamento e apprendimento maggiormente flessibile; 2. sviluppare alunni e alunne maggiormente consapevoli e responsabili.
La flessibilità è la base di una didattica in cui possano concretizzarsi azioni legate alla differenziazione, alla personalizzazione e alla individualizzazione. Se impostiamo lo studio su un curricolo rigido, su un unico metodo di studio, su un unico modo di insegnare, su un unico modo di valutare, non facilitiamo lo sviluppo di un’azione inclusiva nei termini che abbiamo indicato precedentemente. Per poter essere attuata, la flessibilità richiede materiali e strumenti Per questo motivo, i nostri corsi e i materiali che li compongono mettono al centro il concetto di valorizzazione delle differenze, della molteplicità dei canali e dei codici linguistici, delle strategie metacognitive e collaborative, così come la valorizzazione delle risorse digitali e delle funzioni di personalizzazione a esse connesse. La consapevolezza è la grande sfida della scuola di oggi. Che si tratti di una maggiore consapevolezza, autonomia e capacità di organizzazione rispetto al proprio metodo di studio o che si tratti di una maggiore responsabilità nel confronto degli altri (dal gruppo classe alla collettività più estesa), questa è certamente una grande sfida che tutti sentono come urgente. Non si può parlare di apprendimento significativo se non si lavora sull’ambito della consapevolezza. Allo stesso tempo, lo sviluppo di un contesto inclusivo richiede una crescita di consapevolezza, in primis nel sapere guardare alla differenza dell’altro come valore ma anche, più concretamente, nell’assumere una maggiore responsabilità nel modo di apprendere, nelle relazioni con gli altri, nel proporre le proprie idee creative, nell’imparare a conoscersi sviluppando in modo positivo e consapevole la propria identità personale e la propria identità collettiva di gruppo. Consapevolezza e responsabilità che si sostanziano anche nel sentirsi parte della comunità scolastica partecipando attivamente e nell’essere cittadini e cittadine attive nel proprio contesto di vita.
L’attenzione ai Bisogni Educativi Speciali nella prospettiva inclusiva
Il contesto di apprendimento favorito dal modello didattico universale, anche tramite l’uso degli strumenti del DAII, consente di rispondere ai bisogni specifici di alunni e alunne con particolari caratteristiche in maniera più efficace. È infatti indubbio che un ambiente di apprendimento flessibile e consapevole favorisca i processi di individualizzazione e personalizzazione e crei un contesto di rispetto e valorizzazione reciproca in cui le differenze individuali non sono viste come un “problema”. Senza sottovalutare le difficoltà che la disabilità o le caratteristiche personali a volte comportano nella gestione del gruppo classe e nelle relazioni interpersonali, un contesto inclusivo sarà sicuramente più competente nell’affrontare la discussione, la gestione dei problemi e le relative risoluzioni, sia didattiche, sia relazionali.
Alunni con Disabilità (certificata secondo la Legge 104/92)
• Disabilità intellettiva
• Disabilità motoria
• Disabilità sensoriale
• Pluridisabilità
• Disturbi neuro-psichiatrici
prevede
Piano Educativo Individualizzato (PEI)
tiene conto del Profilo di Funzionamento stilato su base ICF da parte dell’Unità di Valutazione Multidisciplinare
è elaborato e approvato dal GLO – Gruppo di Lavoro Operativo per l’Inclusione –con la partecipazione dei genitori e delle figure professionali interne ed esterne alla scuola che interagiscono con la classe e con l’alunno con disabilità assicurando la partecipazione attiva dei genitori e dello studente/della studentessa
• individua obiettivi individualizzati nell’ambito degli apprendimenti, della socializzazione, delle autonomie e della comunicazione
• individua strumenti e strategie didattiche efficaci per la realizzazione degli stessi
• individua le modalità in cui il lavoro a scuola si coordina con il lavoro extrascolastico
ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI (BES)
Alunni con Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA, certificati secondo la Legge 170/2010)
• Dislessia evolutiva
• Disortografia
• Disgrafia
• Discalculia
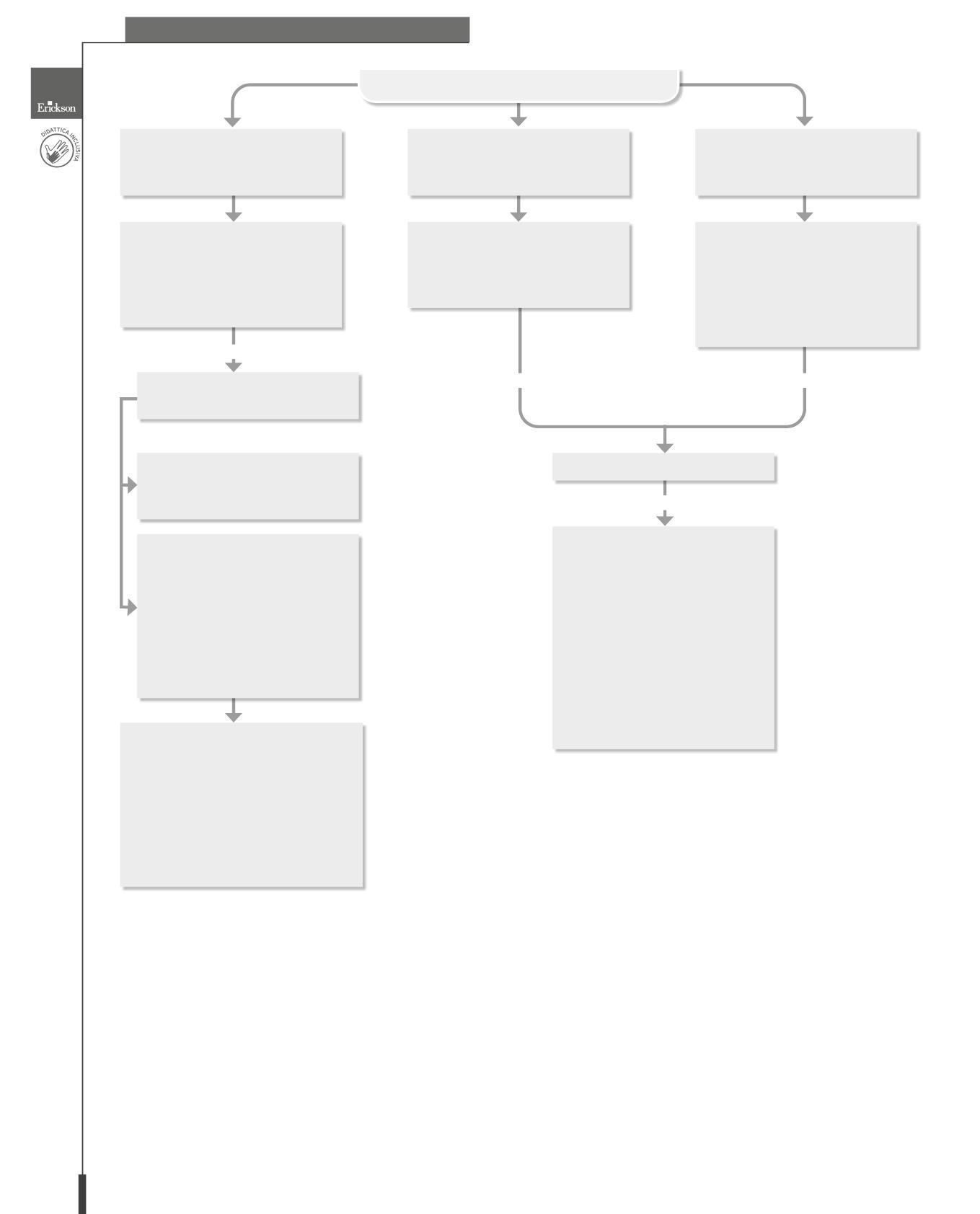
Alunni con altri Bisogni Educativi Speciali (DM 27/12/2012 e CM n. 8/2013)
• Altre tipologie di disturbo non previste nella Legge 170/2010
• Alunni con iter diagnostico di DSA non ancora completato
• Alunni con svantaggio socio-economico
• Alunni con svantaggio socio-culturale
previsto sempre dalla Norma deciso dal consiglio di classe
contiene indicazioni su
• strategie compensative
• uso di strumenti compensativi digitali
o analogici
• misure compensative di adattamento di tempi e spazi
• eventuali misure dispensative
• eventuali misure rispetto alla lingua straniera
• ogni forma di personalizzazione didattica utile al miglioramento dei processi di apprendimento
In questo contesto, per il corpo docente sarà più funzionale programmare le azioni rivolte ad alunni e alunne con disabilità tramite una gestione condivisa e corresponsabile del Piano Educativo Individualizzato, così come delle azioni didattiche previste nei Piani Didattici Personalizzati previsti per persone con Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA) o altre possibili situazioni di svantaggio socio-culturale. È importante quindi connettere le azioni mirate al miglioramento dell’apprendimento e della partecipazione degli alunni con BES all’ambito più ampio della didattica universale, perché la classe è il contesto in cui la scuola agisce e in cui si possono limitare i fenomeni di delega alle figure di sostegno. La classe è anche il luogo dove si possono contrastare l’isolamento e la penalizzazione di alunni e alunne che necessitano di maggiori gradi di differenziazione e di adattamento didattico. Nelle prossime pagine proponiamo quindi un approfondimento specifico sulla visione e sulle modalità esecutive relative al nuovo PEI su base ICF per le persone con disabilità, così come un approfondimento dedicato ai bisogni degli alunni con BES.
IL PIANO EDUCATIVO
INDIVIDUALIZZATO
IN PROSPETTIVA BIO-PSICO-SOCIALE
di Sofia Cramerotti, Ricerca e Sviluppo Erickson

Che cos’è il PEI?
Il Piano Educativo Individualizzato (PEI) è il documento programmatico mediante il quale viene descritto, progettato e organizzato un intervento didattico ed educativo individualizzato e multidimensionale sulla base del funzionamento dello studente con disabilità, per realizzare il diritto di istruzione e apprendimento (Legge n. 104/1992).
Il Decreto legislativo n. 66/2017 Norme per la promozione dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità dice che «l’inclusione scolastica è attuata attraverso la definizione e la condivisione del Piano Educativo Individualizzato (PEI), parte integrante del Progetto individuale». Il Decreto legislativo n. 66/2017 e il successivo Decreto correttivo n. 96/2019, nonché il Decreto interministeriale 182/2020 Adozione del modello nazionale di piano educativo individualizzato e delle correlate linee guida, nonché modalità di assegnazione delle misure di sostegno agli alunni con disabilità sottolineano la necessità di assunzione di una prospettiva bio-psico-sociale nella stesura del PEI (con le disposizioni correttive del DM 153/2023).
Nell’articolo 2 del Decreto legislativo n. 66/2017, Formulazione del Piano educativo individualizzato, si riporta, tra le altre cose, che il PEI:
■ tiene conto dell’accertamento della condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell’inclusione scolastica, con particolare attenzione all’indicazione dei facilitatori e delle barriere, secondo la prospettiva bio-psico-sociale;
■ è redatto a partire dalla scuola dell’infanzia ed è aggiornato in presenza di nuove e sopravvenute condizioni di funzionamento della persona;
■ è strumento di progettazione educativa e didattica e ha durata annuale con riferimento agli obiettivi educativi e didattici, a strumenti e strategie da adottare al fine di realizzare un ambiente di apprendimento che promuova lo sviluppo delle facoltà degli alunni con disabilità e il soddisfacimento dei bisogni educativi individuati;
■ nel passaggio tra i gradi di istruzione e in caso di trasferimento, è accompagnato dall’interlocuzione tra i docenti dell’istituzione scolastica di provenienza e i docenti della scuola di destinazione e, nel caso di trasferimento, è ridefinito sulla base delle diverse condizioni contestuali e dell’ambiente di apprendimento dell’istituzione scolastica di destinazione;
■ esplicita le modalità di sostegno didattico, le modalità di verifica, i criteri di valutazione, gli interventi di inclusione svolti dal personale docente nell’ambito della classe e in progetti specifici, la valutazione in relazione alla programmazione individualizzata, nonché gli interventi di assistenza igienica e di base, svolti dal personale ausiliario nell’ambito del plesso scolastico, e la proposta delle risorse professionali da destinare all’assistenza, all’autonomia e alla comunicazione. Questo significa che la finalità educativo-didattica dell’intervento rivolto agli studenti con disabilità ci invita a riflettere in modo interconnesso, in ottica multidimensionale e bio-psico-sociale per la valorizzazione delle capacità dello studente, non certo “classificandolo”, ma guardando al suo funzionamento all’interno dei suoi vari contesti di vita e all’influenza, positiva e/o negativa, che tali contesti esercitano. Infatti, di fronte alle oggettive difficoltà dello studente con disabilità nel seguire la programmazione rivolta alla classe e altre forme di partecipazione sociale ai vari ruoli della vita scolastica, gli insegnanti si trovano nella necessità di elaborare forme di didattica individualizzata.
Il
In generale, ciò significa costruire obiettivi, attività didattiche e atteggiamenti educativi “su misura” per la singola e specifica peculiarità di quello studente, ponendo particolare attenzione ai suoi punti di forza, al suo funzionamento, dai quali si potrà partire per impostare una progettualità e un lavoro efficaci.
Il PEI su base ICF
Il Profilo di funzionamento dell’alunno su base ICF1 è il documento fondamentale per la stesura del PEI. Questo documento si pone come obiettivo fondamentale la conoscenza più estesa e la comprensione più approfondita possibile dell’alunno in difficoltà. Questa conoscenza deve però essere utile alla realizzazione concreta e quotidiana di attività didattiche ed educative che devono essere appropriate, significative ed efficaci. Tramite questa conoscenza si mira a esplorare la situazione globale dell’alunno, a conoscerne i vari aspetti, le varie interconnessioni, i punti di forza e di debolezza, le risorse, i vincoli, ciò che facilita e ciò che invece ostacola. I ruoli della scuola, della famiglia e dell’alunno nel suo diritto di autodeterminazione devono essere centrali. Gli insegnanti possono ormai utilizzare una vasta gamma di strumenti di raccolta di dati e di conoscenze per la comprensione profonda e utile dell’alunno in difficoltà, attivando direttamente una regia e un coordinamento nel gruppo di lavoro a livello di scuola che integri i vari contributi che provengono dagli ambiti sanitario, familiare e sociale in un’ottica co-costruttiva e di corresponsabilità educativa. Il modello ICF offre una modalità conoscitiva dell’alunno che aiuta adeguatamente nella progettazione individualizzata. Pensare al PEI in prospettiva bio-psico-sociale significa perciò abbracciare la filosofia di ICF che ci aiuta a guardare il nostro studente secondo una visione globale, leggendo i suoi bisogni educativi in un’ottica di salute, di funzionamento e di partecipazione, frutto di relazioni tra vari ambiti (Figura 1). Infatti, la situazione di salute di una persona, nel nostro caso il suo funzionamento educativo e di apprendimento, è la risultante globale delle reciproche influenze tra i fattori rappresentati.
Fig. 1 La situazione globale di una persona (il suo “funzionamento”).
Condizioni fisiche (input biologico)
Corpo
Funzioni corporee
Strutture corporee
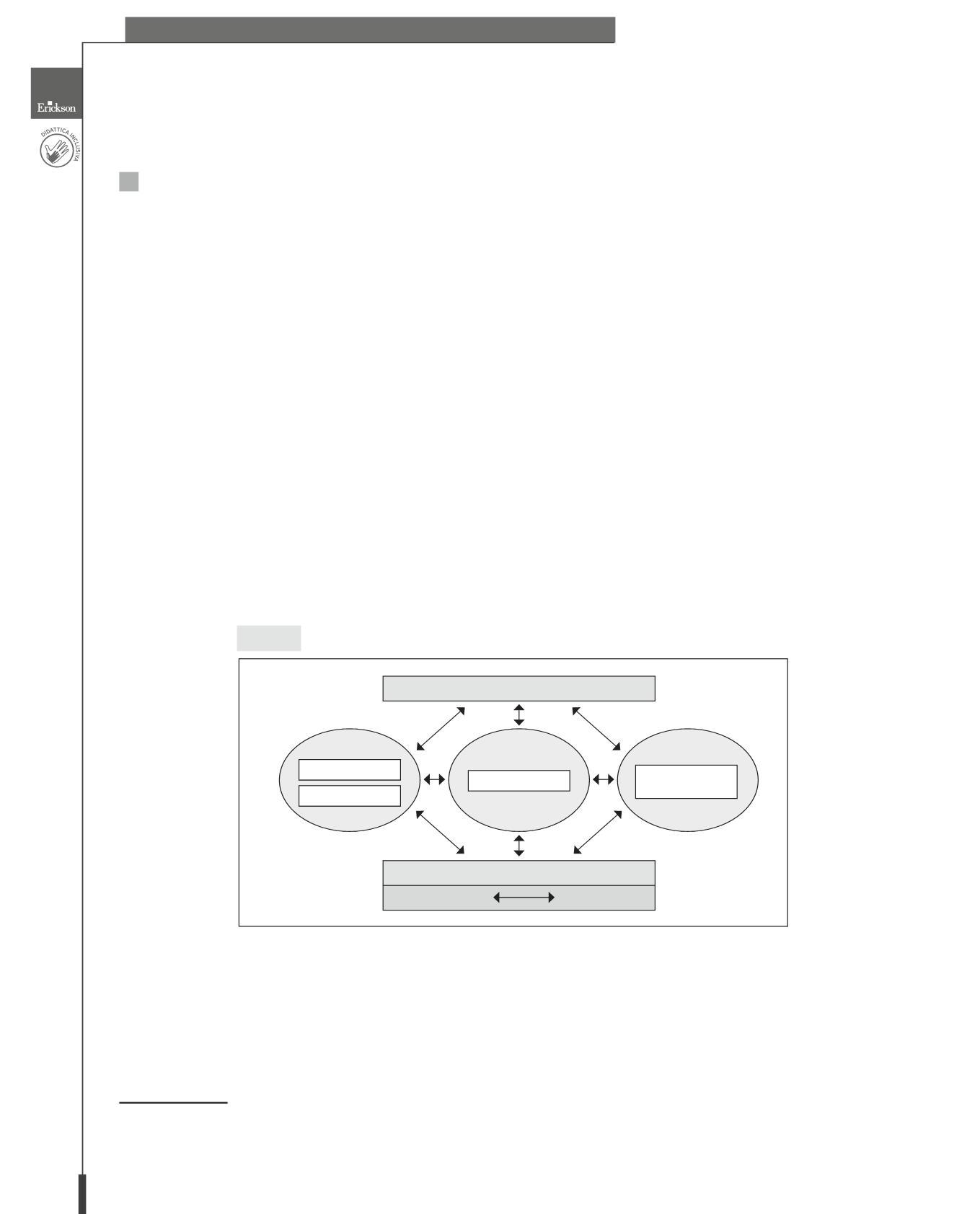
Capacità Performance
Ruoli sociali
Attività personali
Partecipazione sociale
Fattori contestuali (input contestuale)
Ambientali Personali
L’ICF, al di là delle condizioni fisiche, individua quindi quattro componenti principali:
1. funzioni e strutture corporee; 2. attività personali;
3. partecipazione sociale;
4. fattori contestuali.
Ogni componente poi è suddivisa, in modo specifico, in vari domini.
1 ICF è la Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute ed è una classificazione che descrive lo stato di salute delle persone in relazione ai loro ambiti (sociale, familiare, lavorativo) al fine di cogliere tutte quelle criticità che nel contesto di riferimento possono causare difficoltà.
Il
In uno qualsiasi di questi ambiti si può generare una causa o concausa di bisogno educativo speciale, che interagisce in maniera sistemica con gli altri elementi, favorevoli o avversi (Figura 2):
1. nelle funzioni e nelle strutture corporee ci possono essere delle menomazioni;
2. nelle attività personali ci possono essere delle limitazioni alle capacità e alle performance;
3. nell’ambito della partecipazione sociale ci possono essere delle restrizioni; 4. tra i fattori contestuali (sia ambientali sia personali) ci possono essere delle barriere o dei facilitatori
Fig. 2 Interazioni tra gli elementi del modello bio-psico-sociale ICF.
PROFILO DI FUNZIONAMENTO
su base
MENOMAZIONI
Corpo
funzioni
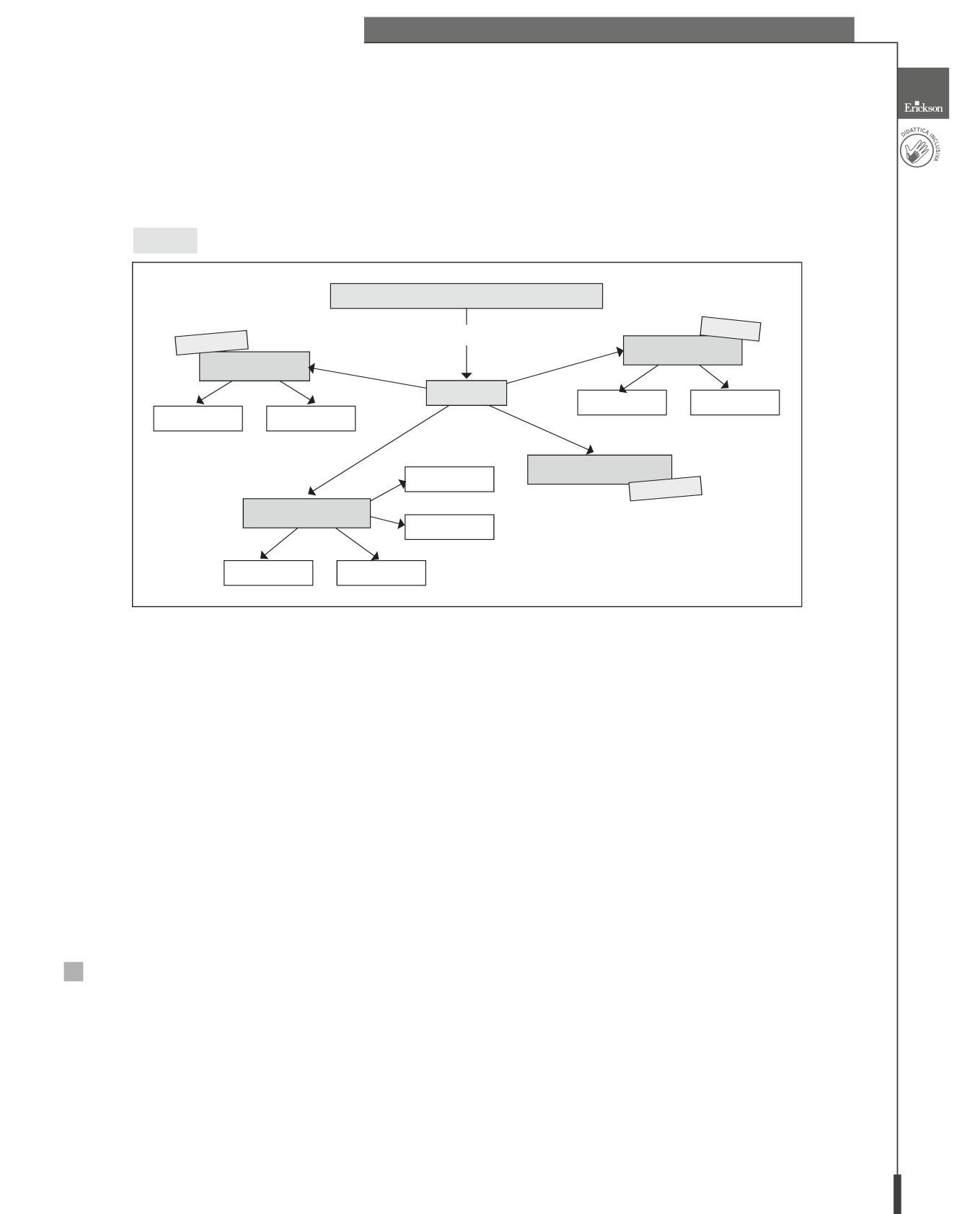
ambientali strutture personali
Fattori contestuali
facilitatori
LIMITAZIONI
Attività personali
RESTRIZIONI ICF
barriere
capacità performance
Partecipazione sociale
Attraverso queste interazioni complesse si produrrà il funzionamento educativo-apprenditivo dell’alunno. Ovviamente, il peso dei singoli ambiti varierà da alunno ad alunno, anche all’interno della stessa condizione biologica originaria.
In questo modo, adottare una prospettiva bio-psico-sociale aiuta a definire le diverse situazioni di bisogno educativo speciale degli alunni: alcune di esse saranno caratterizzate da problemi biologici, corporei e di attività personali, altre principalmente da problemi contestuali ambientali, di capacità e di partecipazione, altre primariamente da fattori contestuali ambientali, altre in misura maggiore da difficoltà di partecipazione sociale ecc. Un bisogno educativo speciale può dunque scaturire da moltissime combinazioni di fattori sfavorevoli per l’alunno.
Nel nostro caso cerchiamo quindi un modo globale, più comprensivo, più bio-psico-sociale e più rispondente a quella che è una reale situazione di bisogno educativo speciale e di difficoltà. Questo tipo di valutazione del bisogno educativo speciale serve dunque per cogliere globalmente tutte le condizioni di bisogno educativo speciale stesso, per poterci costruire una didattica realmente inclusiva, attraverso un Piano Educativo Individualizzato che guarda nella direzione del Progetto di vita.
Le quattro dimensioni del PEI
Come sottolineato nel DI 182/2020 e correttivo 153/2023, la stesura del PEI parte quindi dal raccordo con l’Unità di Valutazione Multidisciplinare (UVM) per individuare gli elementi cardine desunti dal Profilo di funzionamento dell’alunno e integrarli poi con le osservazioni a livello di scuola, necessarie per progettare e impostare gli interventi educativi di sostegno didattico. Questo lavoro è infatti propedeutico alla definizione di obiettivi educativo-didattici a lungo, medio e breve termine e all’individuazione di strategie, strumenti e modalità di lavoro per l’attuazione degli interventi didattici e metodologici più adatti e realmente efficaci per quello specifico studente (anche in riferimento al suo percorso curricolare).
Il Piano Educativo
Tutto questo si colloca all’interno di una cornice di riferimento più ampia volta alla realizzazione di un ambiente di apprendimento che sia realmente inclusivo per tutti gli alunni, non escludendo nessuno, ma dando invece a tutti pieno accesso alla partecipazione e all’apprendimento. Questo è strettamente legato all’organizzazione di un più ampio e generale progetto di inclusione in cui si individuano, assegnano, attivano e utilizzano le risorse di cui effettivamente lo studente ha bisogno.
Tutto questo è accompagnato da una continua verifica in itinere per evidenziare tempestivamente eventuali cambiamenti nel funzionamento dello studente, l’emergere di nuovi bisogni o la loro modificazione, l’adeguatezza e la significatività degli obiettivi individuati e degli interventi attuati. Ricordiamo infatti che il PEI non è un documento statico, ma un progetto dinamico, in continua evoluzione che accompagna passo passo lo studente nel suo percorso scolastico, senza dimenticarci di guardare sempre nella direzione della sua vita adulta.
Un modello di PEI in linea con i Decreti 66/17, 96/19, 182/2020 e correttivo 153/2023 fa riferimento alle quattro dimensioni fondamentali descritte in Tabella 1
Tabella 1 Le quattro dimensioni fondamentali per la stesura di un PEI.
1. Dimensione della relazione, dell’interazione e della socializzazione
2. Dimensione della comunicazione e del linguaggio
3. Dimensione dell’autonomia e dell’orientamento
4. Dimensione cognitiva, neuropsicologica e dell’apprendimento

Fa riferimento alla sfera affettivo-relazionale, considerando l’area del sé, il rapporto con gli altri, la motivazione verso la relazione consapevole, anche con il gruppo dei pari, le interazioni con gli adulti di riferimento nel contesto scolastico, la motivazione all’apprendimento.
Fa riferimento alla competenza linguistica, intesa come comprensione del linguaggio orale, alla produzione verbale e al relativo uso comunicativo del linguaggio verbale o di linguaggi alternativi o integrativi, comprese tutte le forme di comunicazione non verbale, artistica e musicale. Si consideri anche la dimensione comunicazionale, intesa come modalità di interazione, presenza e tipologia di contenuti prevalenti, utilizzo di mezzi privilegiati.
Fa riferimento all’autonomia della persona e all’autonomia sociale, alle dimensioni motorio-prassica (motricità globale, motricità fine, prassie semplici e complesse) e sensoriale (funzionalità visiva, uditiva, tattile).
Fa riferimento alle capacità mnesiche, intellettive e all’organizzazione spazio-temporale, al livello di sviluppo raggiunto in ordine alle strategie utilizzate per la risoluzione di compiti propri per la fascia d’età, agli stili cognitivi, alla capacità di integrare competenze diverse per la risoluzione di compiti, alle competenze di lettura, scrittura, calcolo, decodifica di testi o messaggi.
1. Dimensione della relazione, dell’interazione e della socializzazione
Questa dimensione trova il suo collegamento più diretto con il modello bio-psico-sociale ICF, in particolare in relazione alla componente Attività personali e partecipazione sociale e al dominio Interazioni e relazioni interpersonali. Si tratta della parte che riguarda «l’esecuzione delle azioni e dei compiti richiesti per le interazioni semplici e complesse con le persone (estranei, amici, parenti, membri della propria famiglia, partner ecc.) in un modo contestualmente e socialmente adeguato» (OMS, 2007).
In questa parte vengono prese in considerazione interazioni interpersonali sia semplici – interagire con le persone in un modo contestualmente e socialmente adeguato – sia complesse – regolare le emozioni e gli impulsi, controllare l’aggressione verbale e fisica, agire in maniera indipendente nelle interazioni sociali, secondo i ruoli e le convenzioni sociali.
Nella prospettiva del Progetto di vita lo sguardo va però fin da subito allargato all’ambito della vita sociale, civile e di comunità, che riguarda le azioni e i compiti richiesti per impegnarsi nella vita sociale al di fuori di quelli più consueti che possono essere quello familiare e scolastico. Ne sono un esempio la partecipazione ad attività extrascolastiche e del tempo libero.
Infine, in riferimento ai fattori contestuali, giocano un ruolo di rilievo sia quelli ambientali, sia quelli personali.
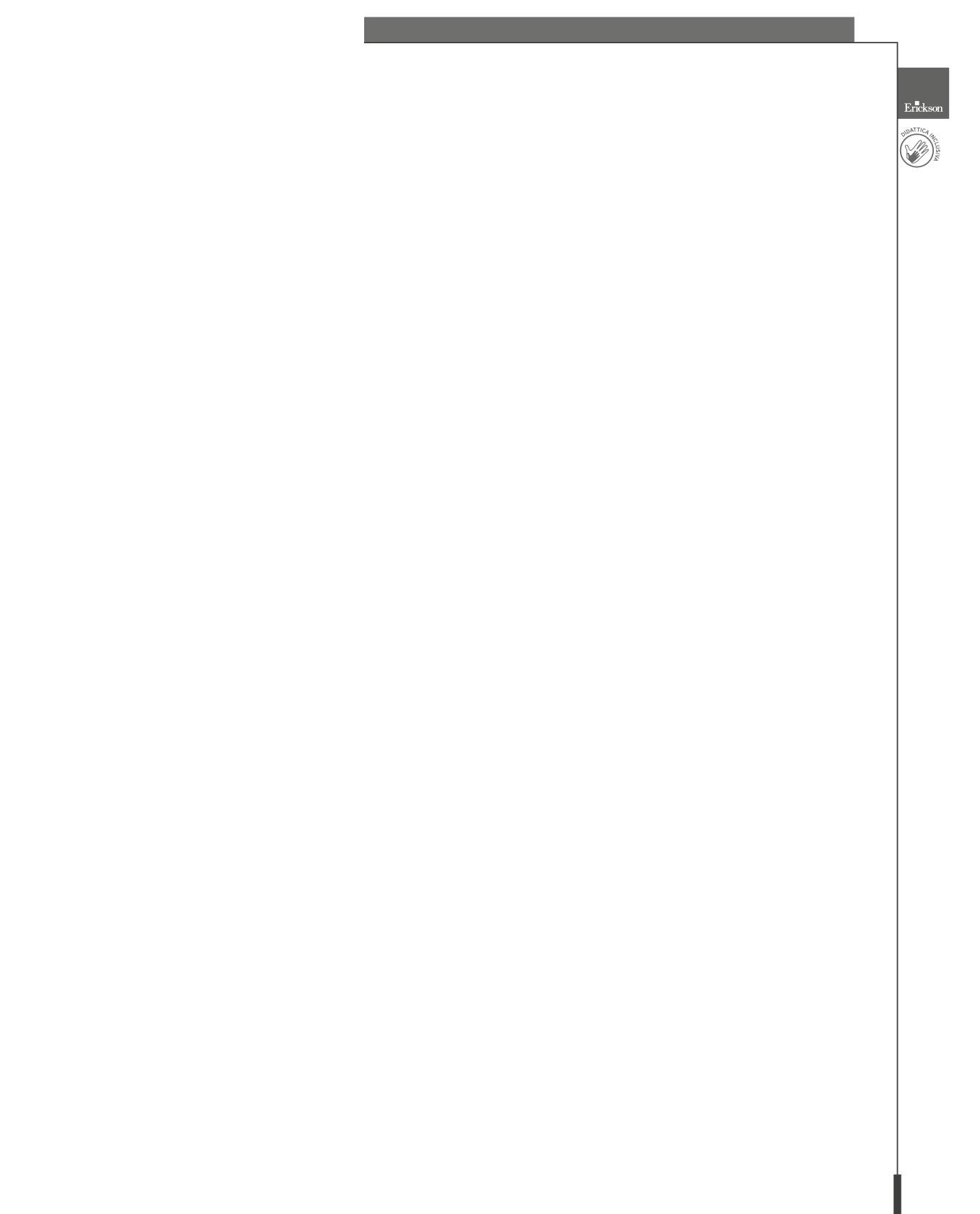
È importante, a questo proposito, mettere in luce quella che è la rete attorno all’alunno che costituisce l’insieme delle sue relazioni e del sostegno sociale, fisico ed emotivo, ma anche dei diversi atteggiamenti presenti nel proprio contesto di appartenenza. Questa rete coinvolge i familiari, gli amici, i compagni di classe, gli insegnanti, i membri della propria comunità, i professionisti che seguono lo studente, altre persone significative del contesto extrascolastico ecc.
2. Dimensione della comunicazione e del linguaggio
Questa dimensione, in relazione a ICF, fa riferimento in primis agli aspetti delle strutture e delle funzioni corporee (Funzioni mentali del linguaggio) specificatamente coinvolti nella comprensione e produzione linguistica. La parte più consistente per una riflessione in ottica bio-psico-sociale la troviamo però nella componente Attività personali e partecipazione sociale, che riguarda «le caratteristiche generali e specifiche della comunicazione attraverso il linguaggio, i segni e i simboli, inclusi la ricezione e la produzione di messaggi, portare avanti una conversazione, usare strumenti e tecniche di comunicazione» (OMS, 2007).
Questa parte include quindi la ricezione e produzione di messaggi verbali, non verbali, scritti, uso del linguaggio dei segni, ma anche azioni come il parlare (produrre parole e frasi), raccontare o anche la vocalizzazione prelinguistica tipica dei primi anni di vita del bambino.
3. Dimensione dell’autonomia e dell’orientamento
La parte sull’autonomia personale e sociale è strettamente legata a quella delle interazioni interpersonali (che abbiamo già visto nella prima dimensione). In riferimento a ICF, essa comprende i domini:
■ mobilità: è la componente che va necessariamente letta in relazione alle corrispondenti funzioni e strutture corporee implicate nella motricità fine e grosso-motoria;
■ cura della propria persona: comprende azioni come lavarsi, prendersi cura del proprio corpo, gestire i bisogni corporali, mangiare, bere, prendersi cura della propria salute e badare alla propria sicurezza;
■ autonomia della vita domestica: prepararsi i pasti, prendersi cura del posto in cui si vive e degli oggetti in esso presenti, fare i lavori di casa ecc.;
■ partecipazione sociale: lo svolgimento dei compiti e delle azioni necessarie per la partecipazione all’interno del proprio contesto scolastico, oppure lavorativo, oppure di gioco, nonché il sapere gestire anche aspetti inerenti alla vita economica;
■ compiti e richieste generali: la capacità di intraprendere un compito singolo o articolato (con differenti gradi di complessità) completandolo in modo autonomo, con l’aiuto di un compagno o di un adulto di riferimento, oppure all’interno di un gruppo di lavoro. Questo è strettamente connesso anche alla capacità di autoregolare il proprio comportamento, approcciandosi in modo corretto alle persone e alle situazioni.
Altri aspetti molto importanti su cui focalizzarsi sono l’esecuzione e la gestione delle varie routine quotidiane, fortemente connesse anche alla capacità di adattarsi ai cambiamenti e alle diverse richieste.
4. Dimensione cognitiva, neuropsicologica e dell’apprendimento
Questa ultima dimensione comprende gli aspetti fondanti del funzionamento della persona che riguardano l’ambito cognitivo, neuropsicologico e dell’apprendimento dell’alunno e vanno esaminati attraverso il suo modo abituale e quotidiano di operare nei principali processi mentali e non solo.
Nella componente delle Funzioni mentali di ICF troviamo due domini: Funzioni mentali globali (es. funzioni della coscienza, funzioni dell’orientamento, funzioni intellettive ecc.) e Funzioni mentali specifiche (es. funzioni dell’attenzione, funzioni della memoria, funzioni percettive, funzioni del pensiero, funzioni cognitive di base e di livello superiore ecc.).
Nella componente delle Attività personali viene dato ampio spazio all’analisi dell’Apprendimento e
Il Piano Educativo
applicazione delle conoscenze sia relativamente agli apprendimenti di base (es. copiare, imparare attraverso le azioni con gli oggetti, acquisire informazioni, imparare a leggere-scrivere-calcolare ecc.), sia relativamente all’applicazione delle conoscenze (es. focalizzare e dirigere l’attenzione, pensare, leggere, scrivere, calcolare, risolvere problemi, prendere decisioni ecc.).
In questo ambito è più che mai importante fare nostra una distinzione fondamentale all’interno dell’approccio bio-psico-sociale, ossia quella tra capacità e performance:
■ la capacità è ciò che un alunno, rispetto a un’azione, esecuzione di un compito o funzione, è in grado di fare senza alcuna influenza, positiva o negativa, di fattori contestuali ambientali o personali;
■ la performance è quello che invece il soggetto fa sotto l’influenza dei fattori contestuali (OMS, 2007; Ianes, Cramerotti e Scapin, 2019).
In conclusione, della riflessione fatta in queste pagine si sottolinea l’importanza di guardare sempre a queste quattro dimensioni in modo strettamente interconnesso e complementare, secondo una direzione circolare continua e non sequenziale per step
Questo approccio di interconnessione circolare, in cui tutti gli aspetti sono collocati sullo stesso piano, è infatti quello che ci garantisce l’assunzione e l’applicazione di un approccio bio-psico-sociale realmente funzionale nella progettazione educativo-didattica per l’alunno.
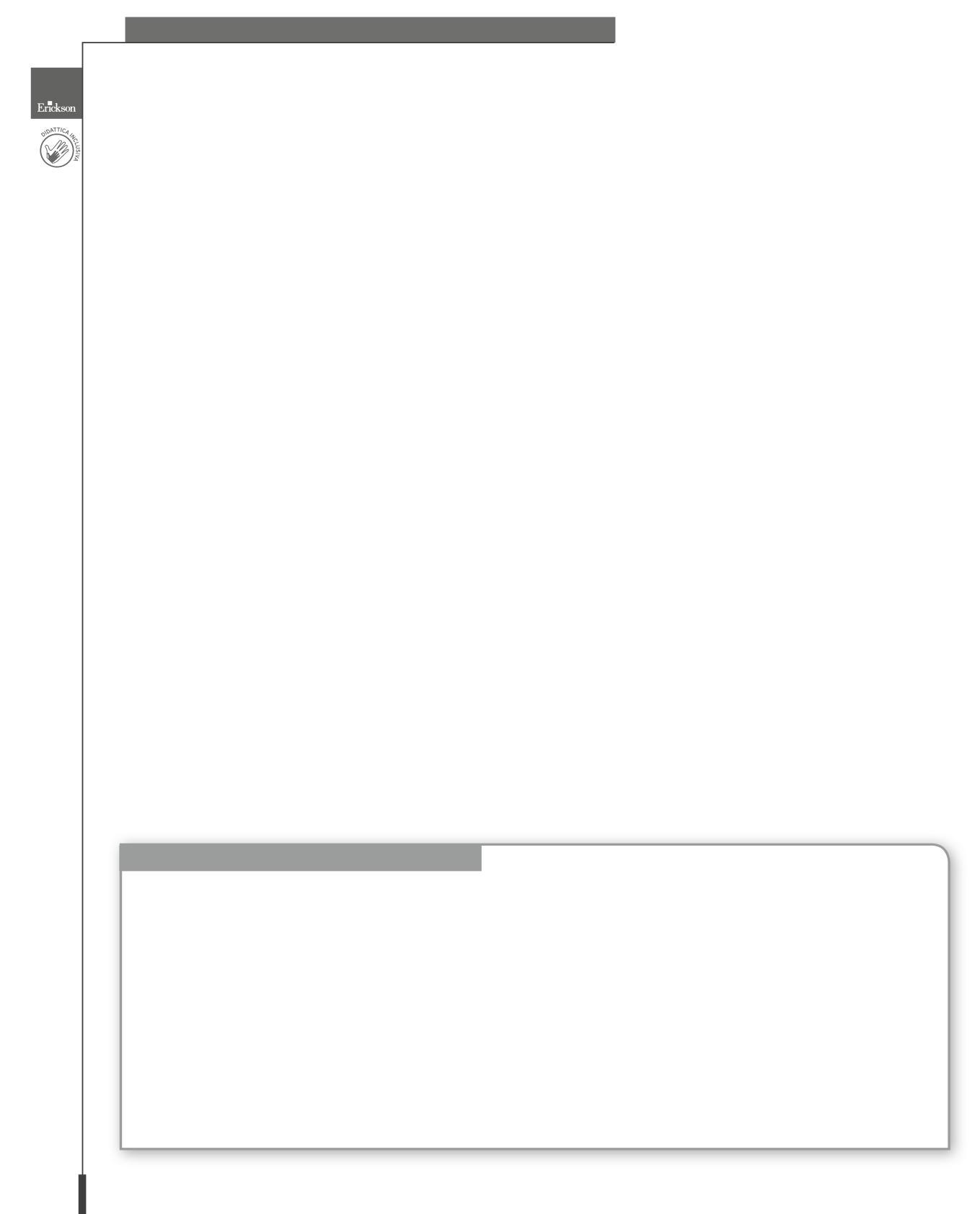
Bibliografia di riferimento e approfondimento
Cramerotti S., Ianes D., Fogarolo F. e Zagni B., PEI inclusivo (Infanzia, Primaria, Secondaria di primo grado). Trento, Erickson, 2023; 2024.
Fogarolo G. e Onger G., Inclusione scolastica: domande e risposte, Trento, Erickson, 2018.
Ianes D. e Cramerotti S., Alunni con BES, Trento, Erickson, 2013.
Ianes D., Cramerotti S. e Fogarolo F., Costruire il nuovo PEI (Infanzia, Primaria, Secondaria di primo grado, Secondaria di secondo grado), Trento, Erickson, 2021.
Ianes D., Cramerotti S. e Fogarolo F., Il Nuovo PEI in prospettiva bio-psico-sociale ed ecologica, Trento, Erickson, 2021.
Ianes D., Cramerotti S. e Fogarolo F., PEI in pratica (Infanzia, Primaria, Secondaria di primo grado, Secondaria di secondo grado), Trento, Erickson, 2022.
Ianes D., Cramerotti S., Fogarolo F. e Zagni B., PEI e classe inclusiva, Trento, Erickson, 2024.
Ianes D., Cramerotti S. e Scapin C., Profilo di funzionamento su base ICF-CY e Piano educativo individualizzato, Trento, Erickson, 2019.
OMS – Organizzazione Mondiale della Sanità, ICF-CY. Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute – Versione per bambini e adolescenti, Trento, Erickson, 2007.
PIANO DIDATTICO
PERSONALIZZATO: RIDARE
CENTRALITÀ ALLA DIDATTICA

Sono passati parecchi anni dall’ottobre 2010, momento in cui il Parlamento ha ratificato la Legge 170/2010 “Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico” che per la prima volta introdusse nelle prassi programmatiche della scuola la redazione di un Piano Didattico Personalizzato (PDP) rivolto agli alunni con DSA. Il 6 marzo 2013 veniva emanata una Circolare Ministeriale che estendeva la possibilità della stesura del PDP (su indicazione del Consiglio di classe) anche ad altre tipologie di BES, riconoscendone il valore didattico generale, e non solamente una misura rivolta a disturbi specifici.
In tutti questi anni la scuola si è sostanzialmente mossa tra due poli:
■ chi cerca di massimizzare il valore didattico della personalizzazione cercando di introdurre strumenti e misure che facilitino l’apprendimento di alunni e alunne tramite la riduzione di barriere e favorendo accessibilità linguistiche, esecutive e operative;
■ chi adempie l’obbligo burocratico del PDP prevendendo in maniera più o meno standardizzata un elenco di strumenti e misure uguali per tutti gli alunni con DSA, senza riconoscere il pieno valore didattico dell’attenzione ai diversi modi di apprendere.
Purtroppo, l’implementazione didattica delle norme previste dalla Legge 170 è ancora molto incostante, a macchia di leopardo sul territorio, con un grado ancora elevato di scetticismo nei confronti delle barriere e delle risorse specifiche che i DSA portano con sé, ma anche nell’efficacia delle azioni didattiche legate alla personalizzazione (per un’analisi multiprofessionale dello stato dell’arte a dieci anni dalla promulgazione della legge 170, si veda Aquino et al., 20221). La prospettiva universale che guida la nostra proposta inclusiva non può che estendere il concetto di personalizzazione all’intero gruppo classe. Cercare di garantire a ciascuno la scoperta del metodo di studio più efficace, di costruire saldamente la propria identità, è naturalmente connesso al concetto di personalizzazione didattica. La flessibilità di tempi, spazi, strumenti è alla base della differenziazione e quindi non può essere esclusivo appannaggio di alunni e alunne con BES. Tuttavia, sappiamo bene come questa prospettiva faccia fatica a concretizzarsi nella quotidianità, laddove piuttosto sono ancora negati diritti basilari di personalizzazione didattica e si fatica a ricostruire il senso didattico reale degli strumenti compensativi e delle eventuali misure dispensative.
Il reale valore didattico del PDP
Oltre dieci anni di PDP nelle scuole italiane ci portano alcune evidenze. Innanzitutto, l’efficacia degli strumenti e delle misure compensative è direttamente connessa alla didattica compensativa che i docenti sanno sviluppare in classe. Se gli strumenti e le misure compensative vengono lasciate al solo alunno o alla sola alunna con DSA e non vengono conosciute e sperimentate in classe anche dal gruppo dei pari, queste risulteranno inefficaci e verranno presto abbandonate, specie in età adolescenziale. È necessario partire da un clima realmente inclusivo in cui è “normale” che ognuno lavori in maniera differente, anche con strumenti differenti, e dove questo non vuol dire che ci siano gradi differenti di competenza. Capire perché si lavora in un certo modo per valorizzare le caratteristiche
1 Aquino G., Mammarella I.C., Trentin A., Ventriglia L., La gestione di DSA dalla Legge 170/2010 alla Linea Guida ISS 2022, Trento, Erickson, 2022.
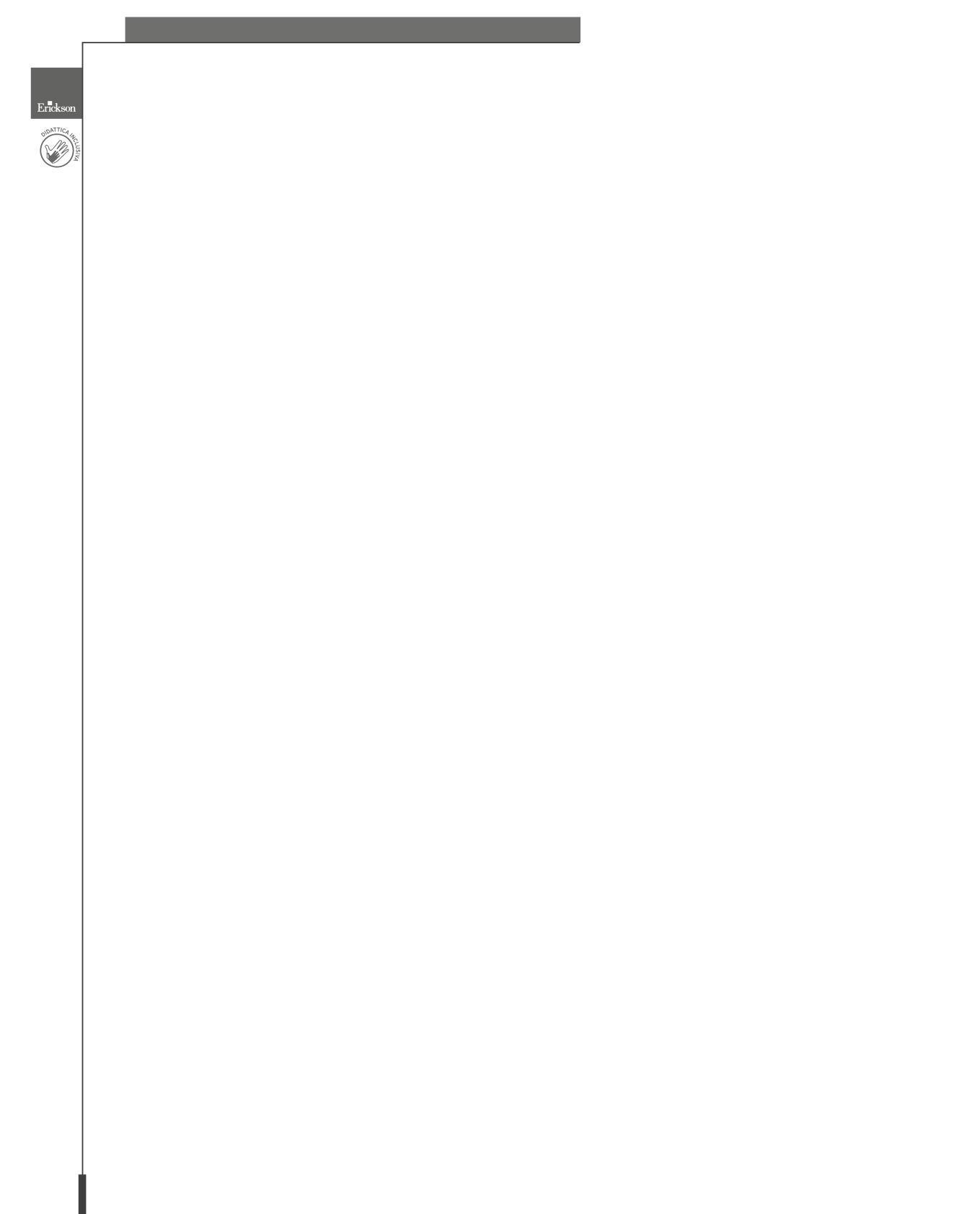
personali è il primo passo indispensabile da compiere nel gruppo: se non viene percorso, o peggio viene nascosto, porterà solamente ad un ulteriore peggioramento delle prestazioni.
Altra evidenza è che fortunatamente la maggior parte delle misure didattiche compensative portano vantaggio all’intero gruppo classe. L’esempio più evidente è, ad esempio, quello legato agli strumenti di logica visiva, alla schematizzazione e alle mappe cognitive. Chi adempie in maniera burocratica all’obbligo di legge spesso assegna mappe come strumento di aiuto, senza valutare il valore didattico delle mappe stesse e senza approfondirne l’uso condiviso in classe. Si ritiene, in maniera peraltro stupefacente, che l’aiuto per un allievo o un’allieva in difficoltà possa arrivare in maniera automatica dall’uso di uno schema magari scaricato da Internet, senza che quest’azione sia legata al metodo di studio sviluppato in classe con il gruppo e senza che si conosca la logica di base delle mappe. Sappiamo invece come puntare sulla creazione delle mappe in classe, sulla valorizzazione delle molte e diverse tipologie di mappe presenti nei libri di testo, sulla comprensione della logica di composizione delle stesse costituisca il primo passo importante per rendere efficace questo strumento di organizzazione logica che porta vantaggi a tutti e tutte in classe e spesso in particolare ad alunni con dislessia evolutiva.
Discorso analogo potremmo fare per l’uso del computer, che spesso viene trattato non come occasione per massimizzare lo sviluppo di competenze digitali per tutti (peraltro previste dalle Indicazioni Nazionali e dalle competenze di cittadinanza europea), ma come ausilio speciale per lo studente in difficoltà. Se si accoglie l’ottica della differenziazione didattica, anche l’uso degli strumenti digitali si arricchirà di significato. Non verrà più visto come una “concessione” allo studente in difficoltà, ma come un’opportunità per tutti per esprimere la propria creatività, per approfondire il proprio metodo di studio, per avere uno strumento alternativo alla scrittura a mano libera (che non verrà mai abbandonata a scuola) e per imparare a gestire con competenza lo spazio digitale.
Questi sono solo alcuni esempi di evoluzione necessaria per tornare a dare centralità didattica alle misure di personalizzazione legate al PDP in un contesto pienamente inclusivo. Passare da una logica di strumento individuale ad una logica di condivisione e opportunità nel gruppo classe è un’evoluzione didattica significativa, che porta benefici a tutto il gruppo.
Gli strumenti di facilitazione del corso
Sono molti gli strumenti presenti nel corso che possono assumere un valore di facilitazione per gli alunni con DSA e per l’intero gruppo classe. Certamente tra questi particolare rilievo assumono le diverse forme di schematizzazioni e mappe che costellano l’intero corso. Questi elementi in particolare possono avere un duplice valore:
■ orientare lo studente/la studentessa nella costruzione logica dell’argomento. Ricostruiscono cioè in una visione unitaria la complessità dell’argomento affrontato, fornendo una vera e propria mappa per recuperare le connessioni tra i concetti, le parole chiave, i termini più importanti da ricordare, gli elementi caratteristici. Sono quindi un supporto indispensabile per comprendere, memorizzare ed esporre i contenuti delle unità.
■ essere un modello per la produzione autonoma delle proprie mappe. Imparare a produrre in autonomia le proprie mappe è sicuramente indispensabile per sviluppare un efficace metodo di studio. Si impara se si hanno a disposizione delle mappe ben strutturate e curate anche all’interno dei materiali dei libri di testo. In questo senso le mappe sono un vero e proprio modello a cui fare riferimento (anche personalizzandolo o cambiandolo) per iniziare a creare i propri schemi, le proprie mappe. Questo è tanto più significativo quanto più questo tipo di lavoro viene svolto anche in classe in maniera condivisa e quando il testo diventa un attivatore di un processo di studio che non è solo individuale a casa, ma è un’azione di co-costruzione in classe. Passare dalla mappa del libro alla mappa del gruppo è certamente una strategia efficace per imparare a studiare, per sentirsi attivi costruttori del proprio apprendimento, ma anche per rendere universale uno strumento che non è pensato solo per gli alunni con DSA.
I materiali per la didattica inclusiva ne I mondi di GEA - Storia e Geografia
MATERIALE
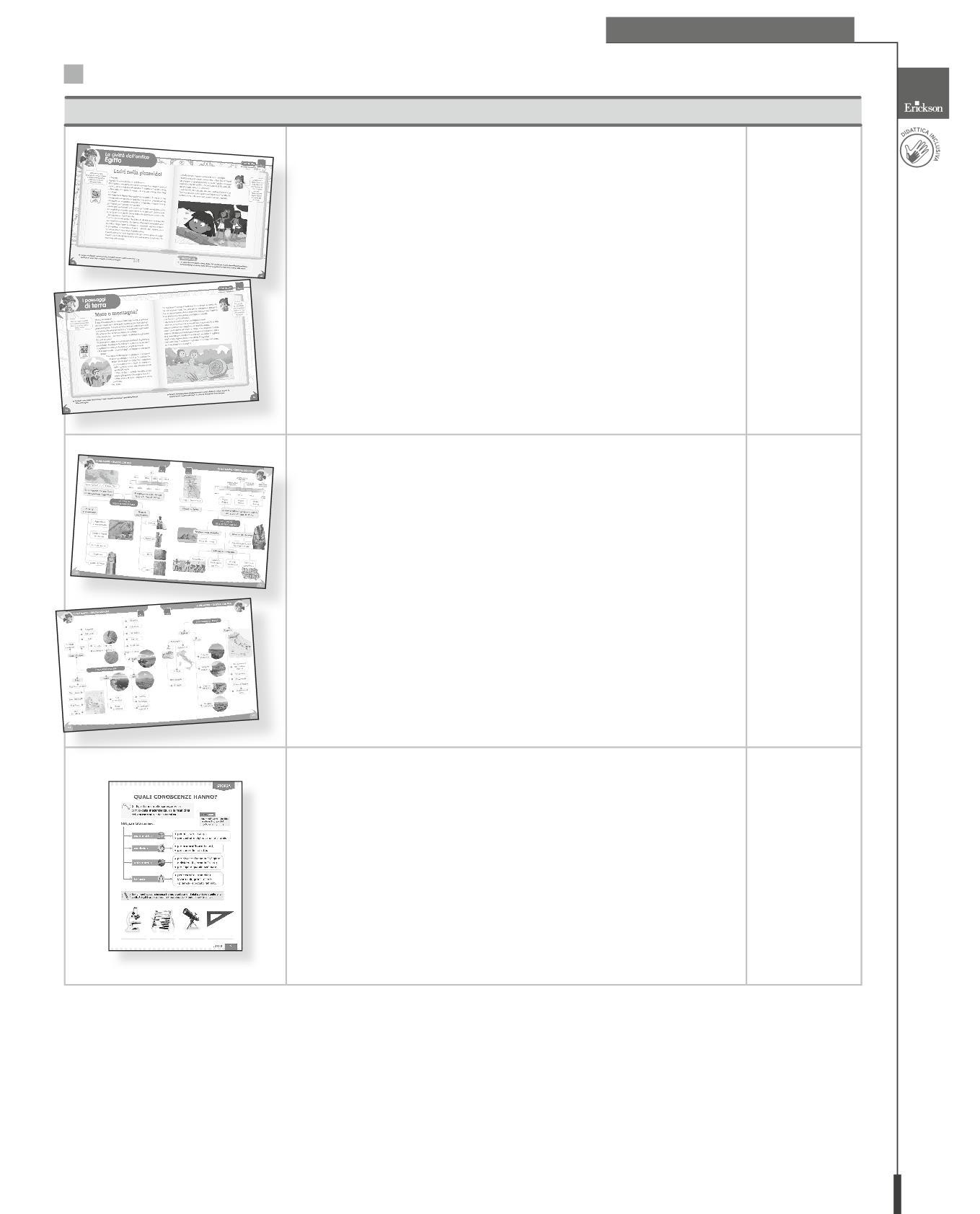
Tutte le unità dei volumi di Storia e Geografia sono introdotte da una doppia pagina di Storytelling. La narrazione permette un approccio originale all’argomento trattato e favorisce l’apprendimento disciplinare perché coinvolge, stimola le emozioni e attiva ciò che bambine e bambini già sanno a un livello non strutturato.
Le storie, inoltre, sono un modo per differenziare la didattica e raggiungere il maggior numero di bambini e bambine.
(di Giorgia Cappelletti)
Nell’eserciziario, la sezione Il mio atlante - Ripassa con Gea presenta mappe illustrate utili per il ripasso delle civiltà storiche (per le classi 4 e 5) e dei principali argomenti della Geografia (per la classe 4). La sezione è a cura di Erickson.
DOVE
Volumi Storia e Geografia 4 e 5
Il volume CheFacile! Storia Geografia Scienze 4 propone testi semplificati e una struttura facilitante per l’apprendimento dei contenuti disciplinari per gli alunni e le alunne con Bisogni Educativi Speciali. Ogni argomento presenta una struttura a domanda e risposta con testi molto sintetici e chiari, corredati di illustrazioni e immagini significative, tabelle e schemi. Completano i vari argomenti domande stimolo, esercizi operativi e piccoli esperimenti/laboratori pratici per un apprendimento attivo.
(di Sara Angelicchio, Federica Biella, Alessandra Casiraghi e Silvia Riboldi, con la supervisione scientifica di Carlo Scataglini)
Volumi Storia e Geografia 4 e 5
Volume CheFacile! Storia Geografia Scienze 4 Guida (pagg. 213-215) Hub Kids
Materiali per la didattica inclusiva
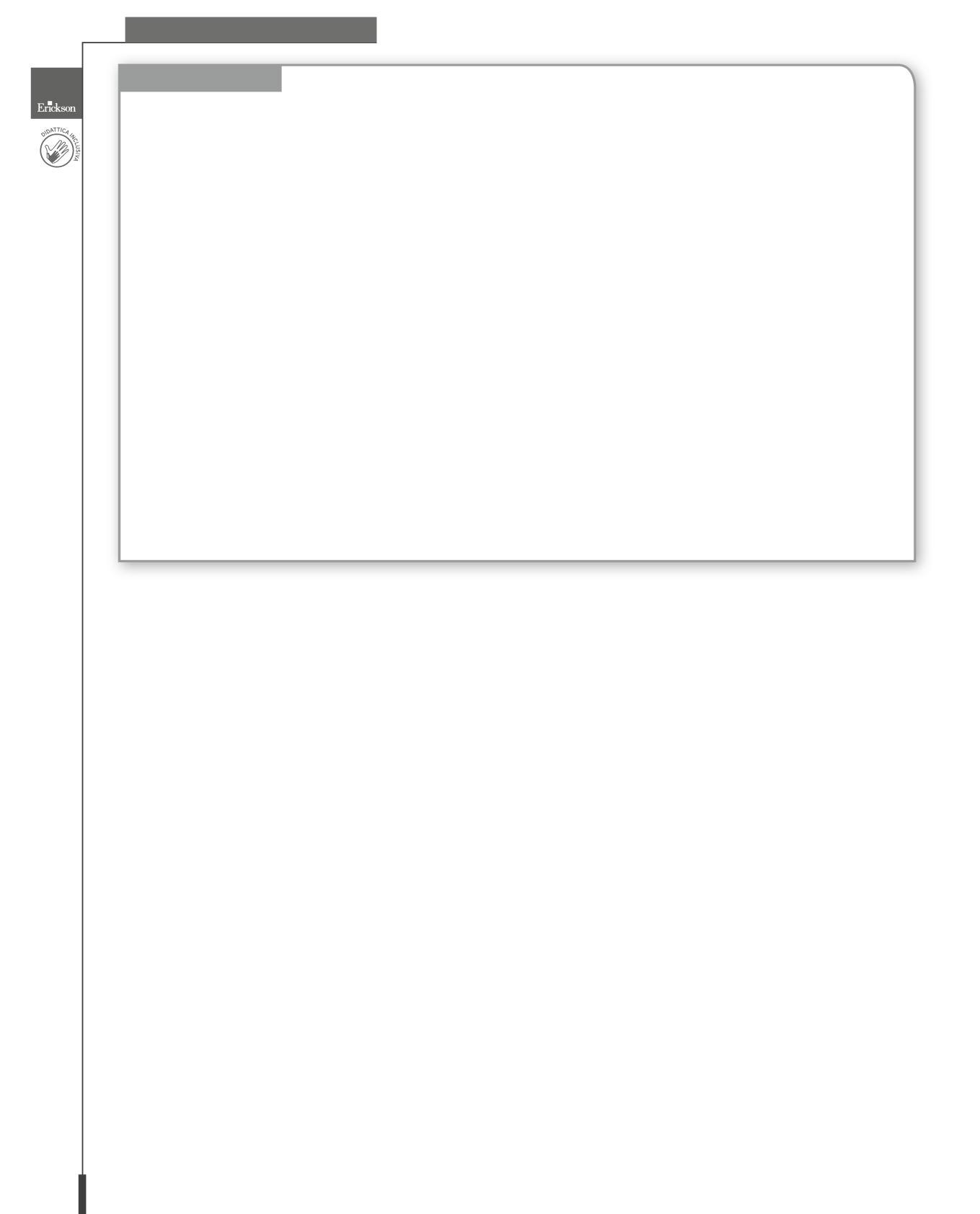
Giorgia Cappelletti, archeologa, è autrice di scolastica per gli editori Erickson, Rizzoli e Mondadori. Per Erickson ha pubblicato anche la serie per bambini 8+ “Viaggi nel passato con l’archeologa Jeanne”. Come membro di Archeostorie® scrive testi per i musei e insegna scrittura creativa e comunicazione nel master PAST dell’Università di Macerata.
Sara Angelicchio, psicologa e psicoterapeuta cognitivo comportamentale. Ha lavorato per diversi anni nell’educativa scolastica e domiciliare con bambini e ragazzi con disabilità lievi e medie. Attualmente lavora come psicoterapeuta cognitivocomportamentale dell’adolescenza e dell’età adulta, tiene percorsi di tutoring dell’apprendimento per l’età evolutiva e percorsi di sostegno alla genitorialità.
Federica Biella, psicoterapeuta cognitivo-comportamentale, è laureata in Psicologia clinica, dello sviluppo e Neuropsicologia ed è specializzata nei disturbi specifici dell’apprendimento. Ha lavorato per alcuni anni come educatrice e ha condotto diversi corsi di formazione presso alcune scuole della provincia di Monza e Brianza. Attualmente svolge attività clinica e riabilitativa presso un centro di riabilitazione per minori con disabilità e lavora come psicoterapeuta presso alcuni studi privati, dove si occupa anche di formazione.
Alessandra Casiraghi è psicologa dello sviluppo, specializzata in Psicoterapia cognitivo-comportamentale. Svolge attività riabilitativa e di counseling nei disturbi dello spettro autistico. Si occupa anche di formazione, di riabilitazione dei disturbi del neurosviluppo e di sostegno psicologico nelle diverse fasi del ciclo di vita.
Silvia Riboldi, laureata in Psicologia clinica, dello sviluppo e Neuropsicologia, è specializzata in Analisi del comportamento e in Psicoterapia. Svolge attività clinica e riabilitativa presso un Centro di Riabilitazione per minori con disabilità e si occupa anche di sostegno psicologico, formazione e supervisione di trattamenti riabilitativi.
Carlo Scataglini è insegnante di sostegno e formatore per le strategie didattiche di facilitazione e inclusione. Per le Edizioni Erickson è autore di numerosi testi di didattica facilitata tra i quali Storia facile, Geografia facile e Scienze facili (per le classi terza, quarta e quinta), dei raccoglitori della collana “Gli Essenziali” (per le classi terza, quarta e quinta) e della Guida Facilitare e semplificare libri di testo
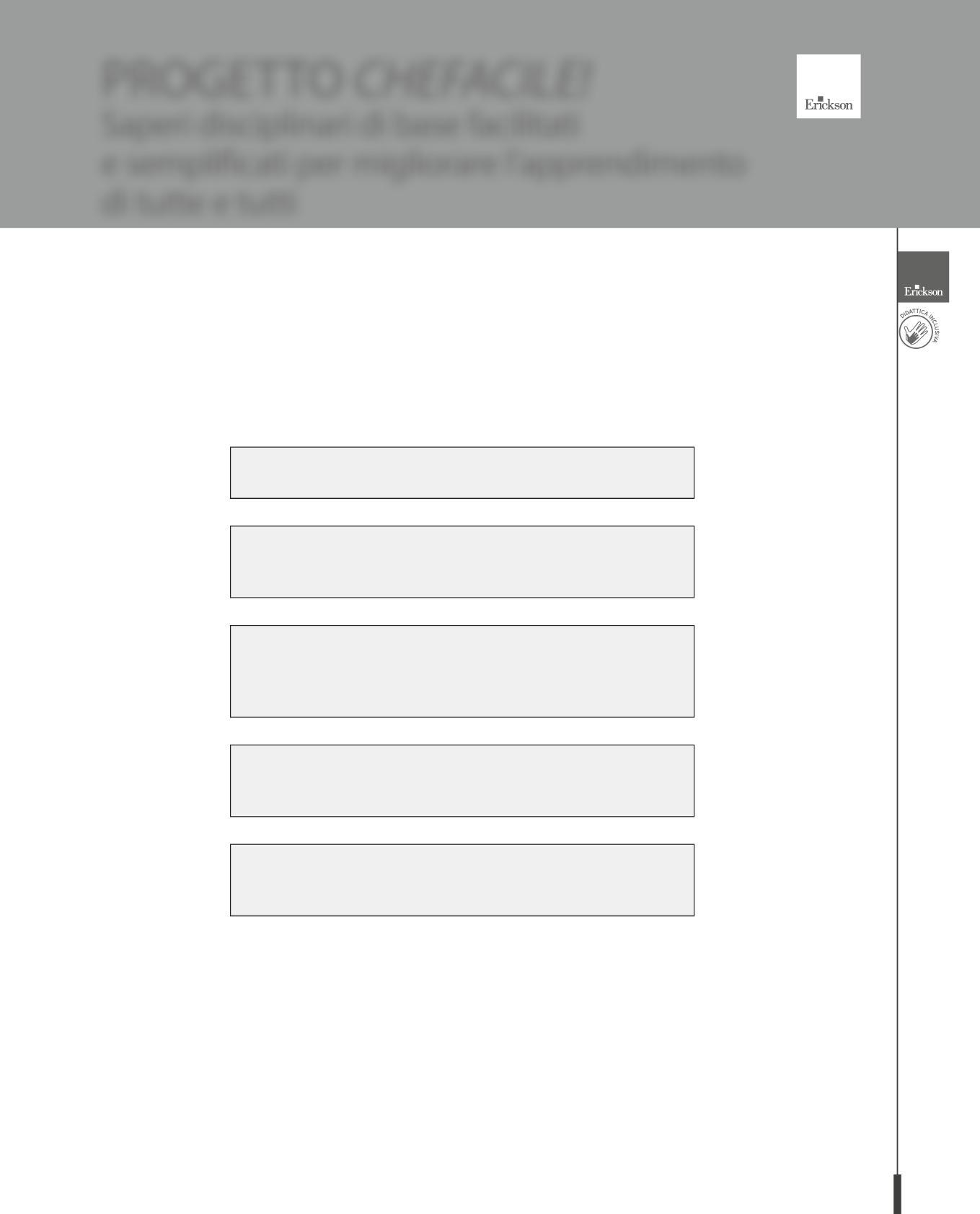
PROGETTO CHEFACILE!
Saperi disciplinari di base facilitati
e semplificati per migliorare l’apprendimento di tutte
e tutti
Il corso I mondi di Gea è corredato dei quattro volumi del progetto CheFacile!:
• CheFacile! Saperi di base 4 e CheFacile! Saperi di base 5 (per Storia, Geografia e Scienze delle classi quarta e quinta) di Sara Angelicchio, Federica Biella, Alessandra Casiraghi e Silvia Riboldi, con la supervisione scientifica di Carlo Scataglini;
• CheFacile! Matematica 4 e CheFacile! Matematica 5 di Cristina Caciolo.
Ogni volume del progetto è pensato per facilitare l’apprendimento a partire da cinque chiavi diverse di facilitazione:
1) lessico di base e struttura sintattica semplificata, per facilitare la comprensione
2) selezione degli argomenti, dei concetti e degli eventi, per rendere subito evidenti il significato del testo e le informazioni principali
3) organizzazione delle informazioni, schematizzazione e utilizzo del codice colore, per rendere immediatamente chiari i nessi logici, i concetti chiave e gli eventi, grazie anche a un’impaginazione facilitante
4) immagini, illustrazioni e aiuti visivi semplici, per valorizzare la parte iconica del testo e renderlo più significativo
5) attività operative semplificate, mirate alla comprensione del testo e alla rielaborazione personale dell’alunno, per capire meglio gli argomenti
CheFacile! è utile per alunni e alunne con disabilità intellettiva, perché semplifica il lessico e la struttura della frase, rende più schematici gli argomenti, propone illustrazioni e aiuti visivi facilitanti per la comprensione dei contenuti e la rielaborazione personale.
CheFacile! è utile per alunni e alunne con Disturbi Specifici dell’Apprendimento, perché facilita la lettura riducendo la lunghezza e la complessità dei testi, organizza al meglio i nessi logici, facilita la memorizzazione grazie all’uso di immagini significative e aiuta l’esposizione orale attraverso schemi e aiuti visivi.
CheFacile! è utile per tutta la classe, perché fornisce una base di partenza più semplice per i lavori collaborativi e di coppia, facilitando il lavoro tra compagni (anche quelli che hanno maggiori difficoltà) e realizzando un apprendimento realmente inclusivo.
I volumi CheFacile! Saperi di base
I volumi CheFacile! Saperi di base per le classi quarta e quinta sono composti da una selezione degli argomenti principali di Storia, Geografia e Scienze.
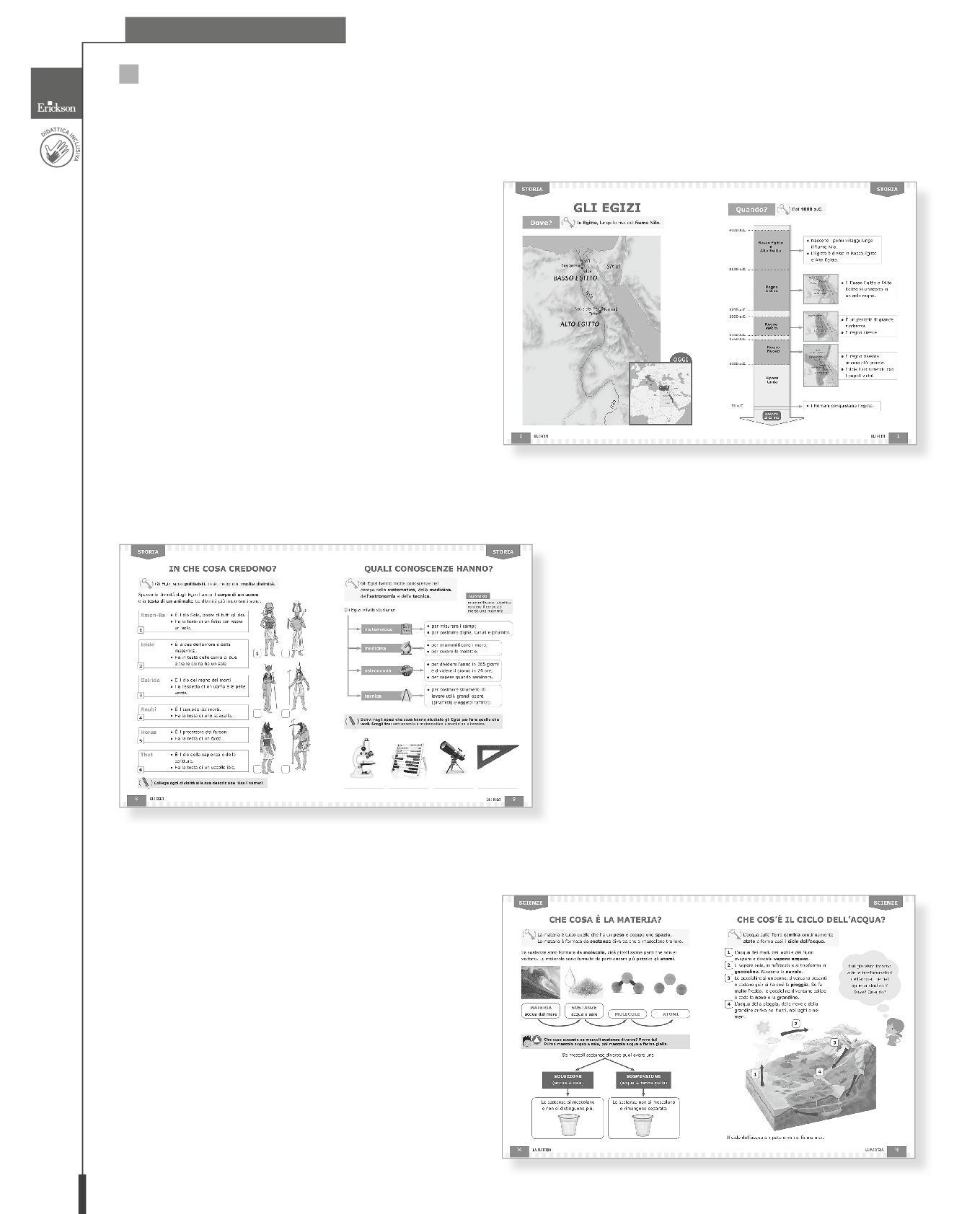
Ogni civiltà di Storia è introdotta da due pagine che indicano DOVE e QUANDO si è sviluppata, rispettivamente con delle cartine geostoriche molto pulite e una linea del tempo che identifica i principali eventi.
Gli argomenti di Geografia e Scienze, invece, si aprono ciascuno con una pagina che funge da “aggancio” alle pagine successive e dà una visione d’insieme di ciò che l’alunno studierà.
Le informazioni nelle varie pagine sono sempre molto brevi e focalizzano l’attenzione su termini e concetti chiave. Numerosi elementi visivi facilitano poi la lettura, la comprensione e lo studio. Così, il codice colore, le parole in neretto e le icone aiutano a identificare immediatamente le domande chiave e le principali informazioni da tenere a mente, mentre le immagini completano, esemplificano e approfondiscono l’argomento trattato.

Seguono le pagine che contengono le informazioni e i concetti principali di ciascun argomento, presentato utilizzando un lessico di base e una struttura sintattica semplice. Ogni concetto è introdotto da una domanda specifica (il titolo della pagina), che trova una prima breve risposta nel box con la chiave. A questa risposta seguono brevi testi, schemi, elenchi, immagini e tabelle che chiariscono l’
Ogni pagina diventa così una scheda semplice e sintetica, che l’alunno può imparare con facilità e utilizzare come strumento compensativo.
Alcune icone infine accompagnano l’alunno nello studio e lo aiutano a identificare gli elementi che può trovare nelle varie pagine.
Identifica le informazioni chiave della pagina, quelle che rispondono in modo chiaro e sintetico alla domanda del titolo.
Indica gli esercizi, semplificati e facilitati, per rendere attivo lo studio.
Rappresentano un momento di riflessione e/o di ricognizione delle conoscenze pregresse su un particolare aspetto o argomento.
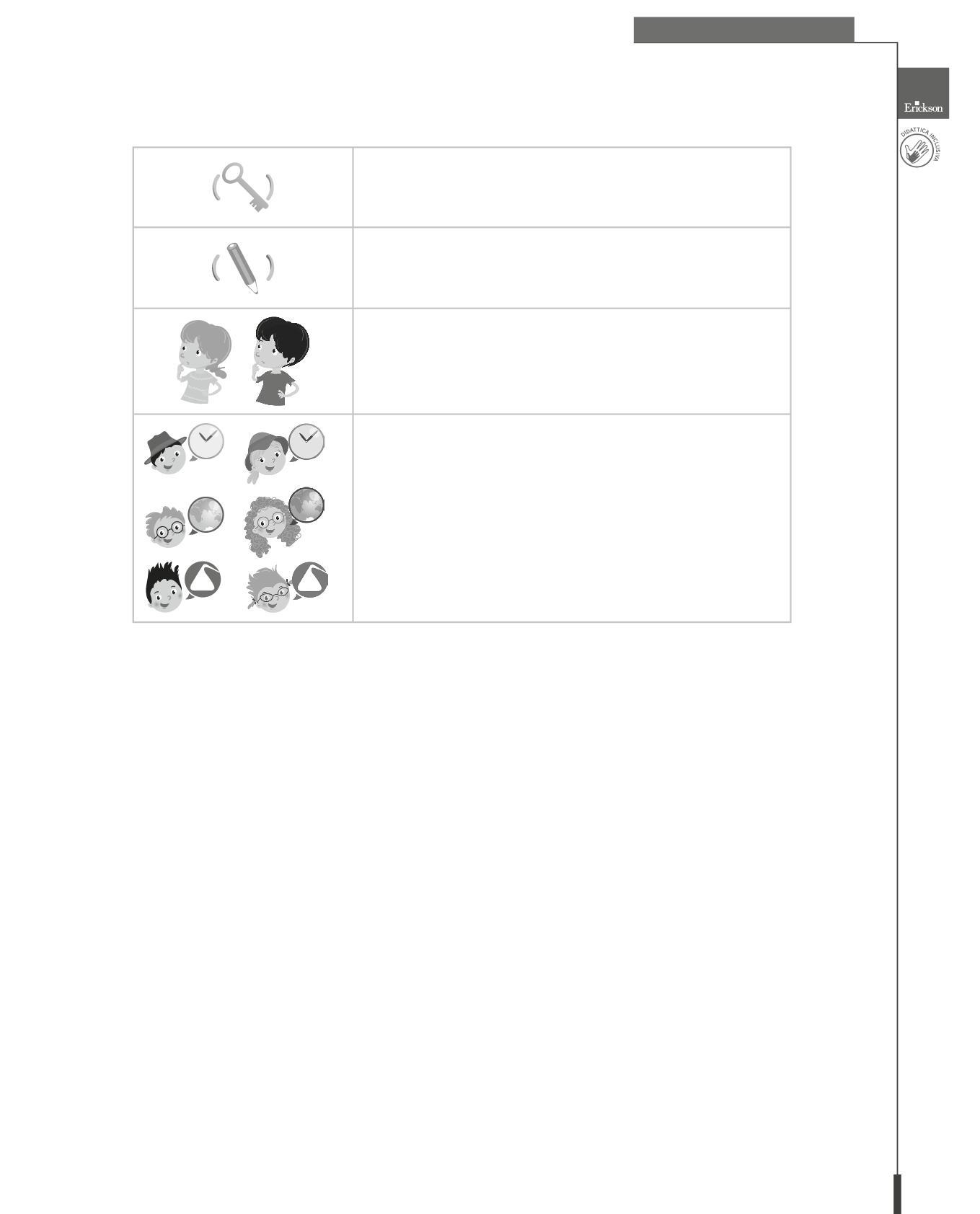
Rappresentano rispettivamente uno storico/una storica, un geografo/una geografa e uno scienziato/una scienziata e introducono semplici esperimenti oppure attività pratiche legate alle tre discipline.
I volumi CheFacile! Saperi di base per le classi quarta e quinta sono dunque uno strumento innovativo ed efficace per facilitare l’apprendimento degli alunni con Bisogni Educativi Speciali. Un valido aiuto per organizzare al meglio lo studio e imparare con più facilità le discipline.