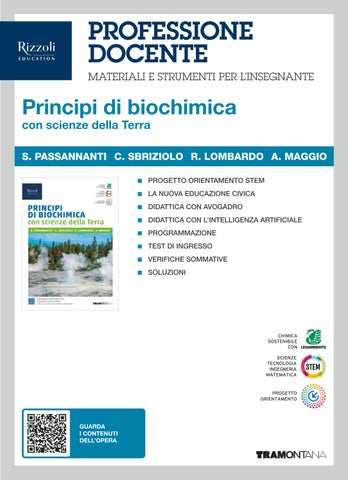Principi di biochimica
con scienze della Terra
S. PASSANNANTI C. SBRIZIOLO R. LOMBARDO A. MAGGIO
■ PROGETTO ORIENTAMENTO STEM
■ LA NUOVA EDUCAZIONE CIVICA
■ DIDATTICA CON AVOGADRO
■ DIDATTICA CON L’INTELLIGENZA ARTIFICIALE
■ PROGRAMMAZIONE
■ TEST DI INGRESSO
■ VERIFICHE SOMMATIVE
■ SOLUZIONI
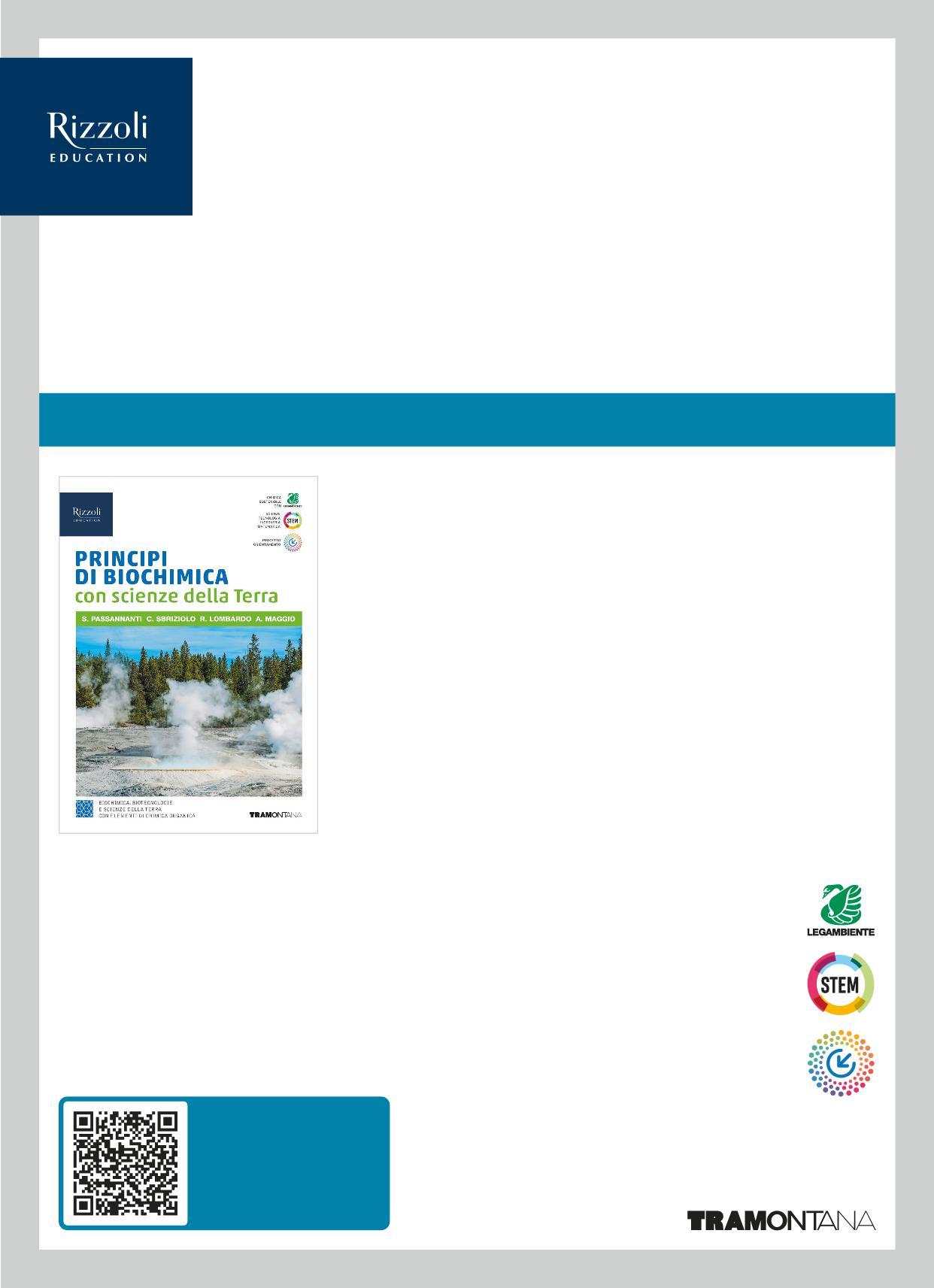
SCIENZE TECNOLOGIA INGEGNERIA MATEMATICA CHIMICA SOSTENIBILE CON
PROGETTO ORIENTAMENTO
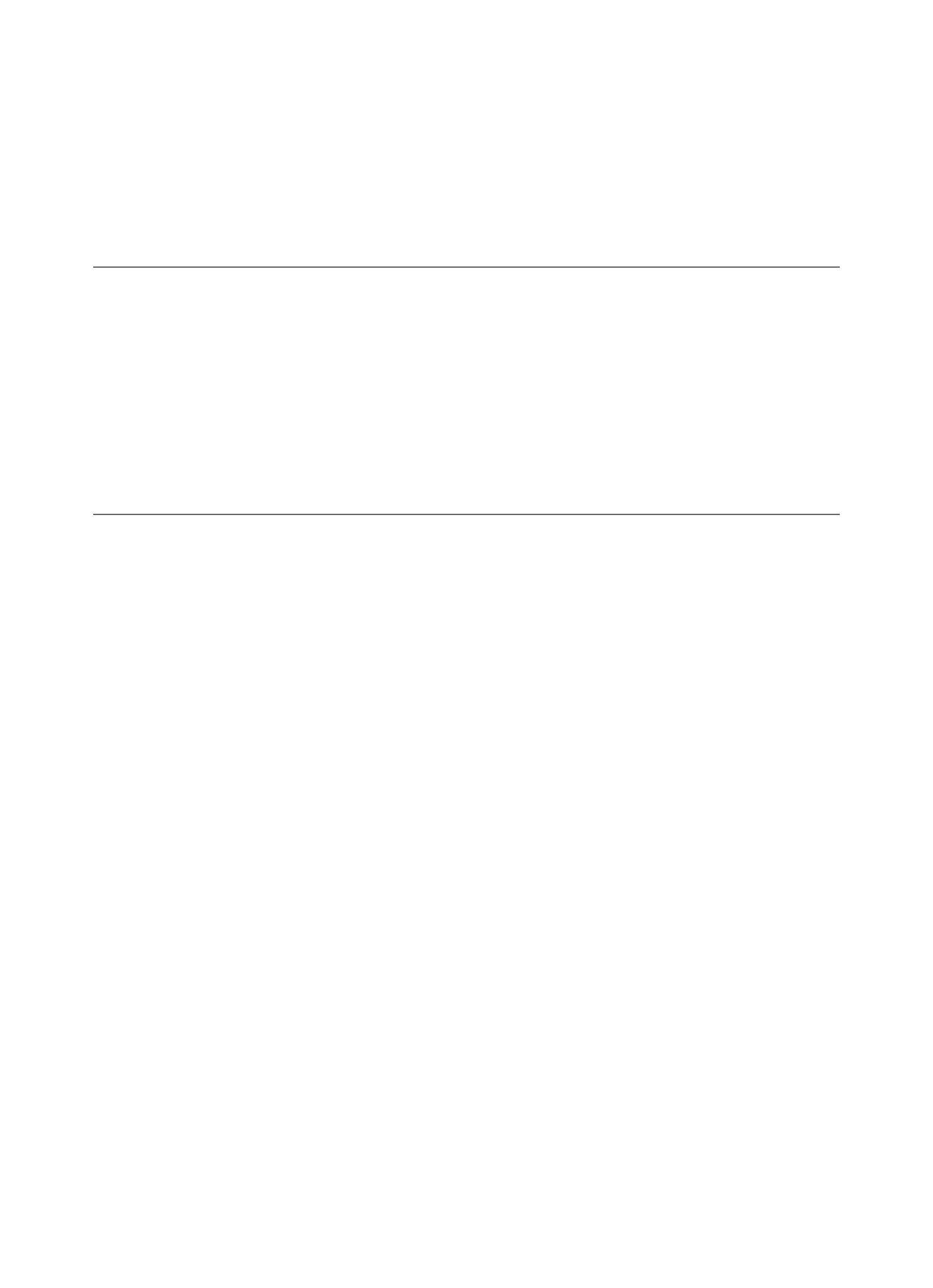
ISBN 978-88-233-8229-9
© 2025 Rizzoli Education S.p.A. – Milano
Prima edizione: gennaio 2025
Tutti i diritti riservati
Ristampe:
9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
2029 2028 2027 2026 2025
Stampa: Star7 Printing s.r.l - Asti (AT)
Coordinamento redazionale: Anna Spinelli
Progetto grafico: Studio Mizar, Bergamo
Progetto grafico copertina: zampediverse, Carate Brianza (MB)
Impaginazione copertina: Apilab, Azzano San Paolo (BG)
Redazione: Cinzia Porfiri, Anna Spinelli
Elaborazione digitale testo e immagini e impaginazione: Emmegi Group s.r.l., Milano
Progettazione contenuti digitali: Fabio Ferri, Vincenzo Belluomo
Redazione e realizzazione contenuti digitali: IMMAGINA srl (videoesperienze, videolab, video molecole Avogadro audio); Giovanna Fonda (videotutorial); Salvatore Passannanti e Carmelo Sbriziolo (videolab - modelli molecolari); Kilda video (biografie), Lumina Datamatics (mappe); Antonio Martino (lezioni LIM, Attività Avogadro); Remedios Cortese (Attività Avogadro); Eicon (esercizi, realizzazione Laboratorio visuale interattivo); Dedita (Google Moduli); Bianca Franchi, Hilary Creek, Rosa Guzzetti (CLIL module); Lelia Parisi, Eleonora Palumbo (redazione CLIL module); Publi&Stampa, Conselice - RA (impaginazione CLIL module); Alessandro Cavallo, (ideazione Laboratorio visuale interattivo).
Si ringrazia l’ufficio scientifico di Legambiente per la stesura dei Compiti di realtà. Si ringrazia la Prof.ssa Luisa Bagiotti per le soluzioni delle schede Collega. Si ringrazia Emanuele Biolcati per la scrittura delle attività AI. Si ringrazia Francesco Scarel per le Verifiche sommative di fine Unità (U1-U6); Viola Bachini e Marinella Torri per le Verifiche Sommative di fine Unità (U7-U9).
In copertina: Sorgenti calde e geyser, il Parco Nazionale di Yellowstone, Wyoming USA @ Bruce Montagne / Dembinsky Photo Associates / Alamy Foto Stock.
The content of this publication has not been approved by the United Nations and does not reflect the views of the United Nations or its officials or Member States https://www.un.org/sustainabledevelopment/
I diritti di traduzione e riproduzione, totali o parziali anche ad uso interno e didattico con qualsiasi mezzo, sono riservati per tutti i Paesi. Le fotocopie per uso personale del lettore possono essere effettuate nei limiti del 15% di ciascun volume/fascicolo di periodico dietro pagamento alla SIAE del compenso previsto dall’art. 68, commi 4 e 5, della legge 22 aprile 1941 n. 633.
Le riproduzioni effettuate per finalità di carattere professionale, economico o commerciale o comunque per uso diverso da quello personale possono essere effettuate a seguito di specifica autorizzazione rilasciata da CLEARedi, Corso di Porta Romana 108, 20122 Milano, e-mail autorizzazioni@clearedi.org
La realizzazione di un libro presenta aspetti complessi e richiede particolare attenzione nei controlli: per questo è molto difficile evitare completamente errori e imprecisioni.
L’Editore ringrazia sin da ora chi vorrà segnalarli alle redazioni. Per segnalazioni o suggerimenti relativi al presente volume scrivere a: supporto@rizzolieducation.it
L’Editore è presente su Internet all’indirizzo: www.rizzolieducation.it Indicazioni e aggiornamenti relativi al presente volume saranno disponibili sul sito.
L’Editore è a disposizione degli aventi diritto con i quali non gli è stato possibile comunicare per eventuali involontarie omissioni o inesattezze nella citazione delle fonti dei brani o delle illustrazioni riprodotte nel volume. L’Editore si scusa per i possibili errori di attribuzione e dichiara la propria disponibilità a regolarizzare. I nostri testi sono disponibili in formato accessibile e possono essere richiesti a: Biblioteca per i Ciechi Regina Margherita di Monza (http://www.bibliotecaciechi.it) o Biblioteca digitale dell’Associazione Italiana Dislessia “Giacomo Venuti” (http://www.libroaid.it).
Le immagini utilizzate in questo libro non vanno interpretate come una scelta in merito da parte dell’Editore, né come invito all’acquisto di prodotti. Le illustrazioni o riproduzioni sono state riportate a scopo esclusivamente didattico. Nomi e marchi citati nel testo sono generalmente depositati o registrati dalle rispettive case produttrici. Il processo di progettazione, sviluppo, produzione e distribuzione dei testi scolastici dell’Editore è certificato UNI EN ISO 9001.

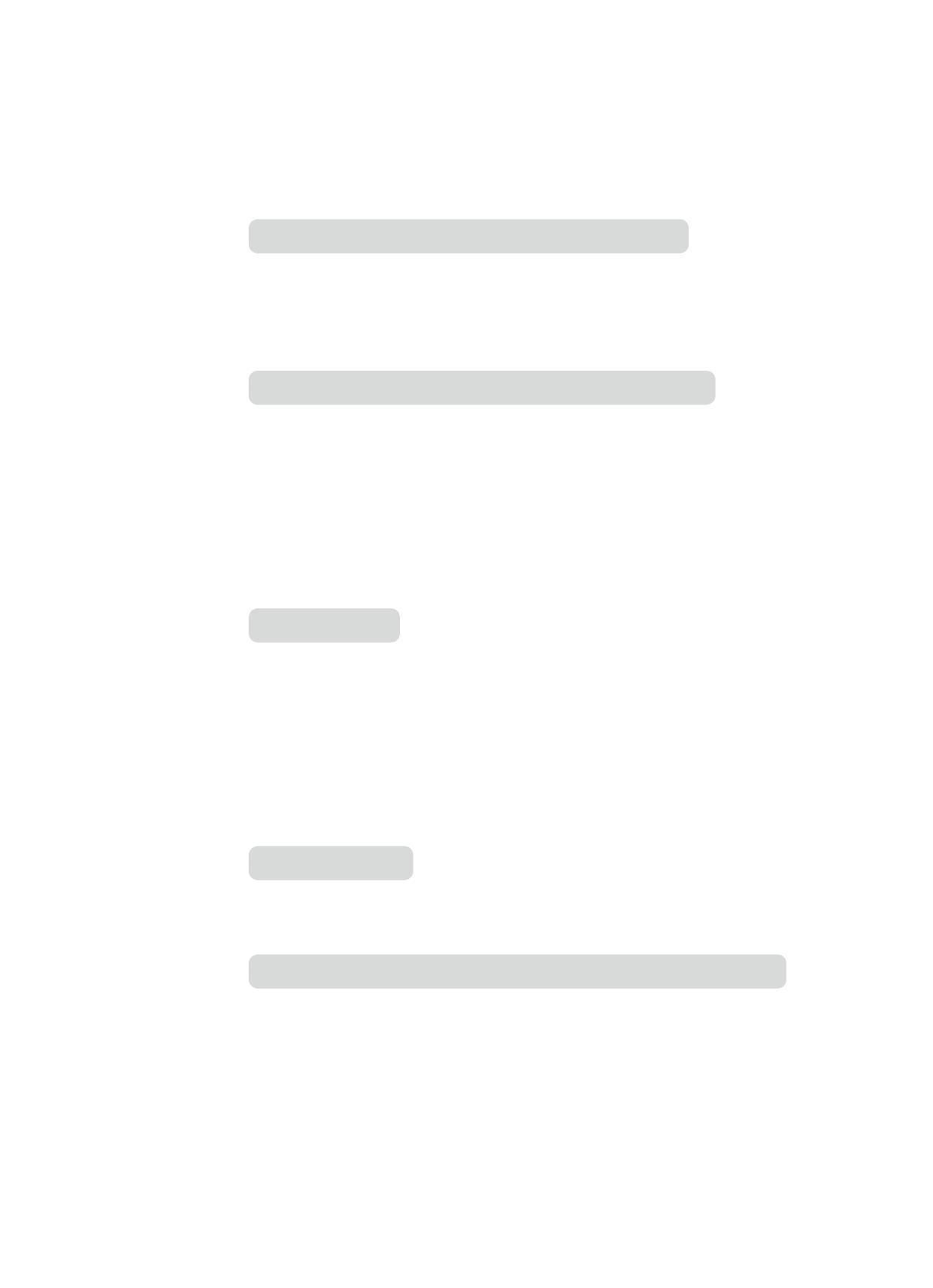
1
Presentazione del corso
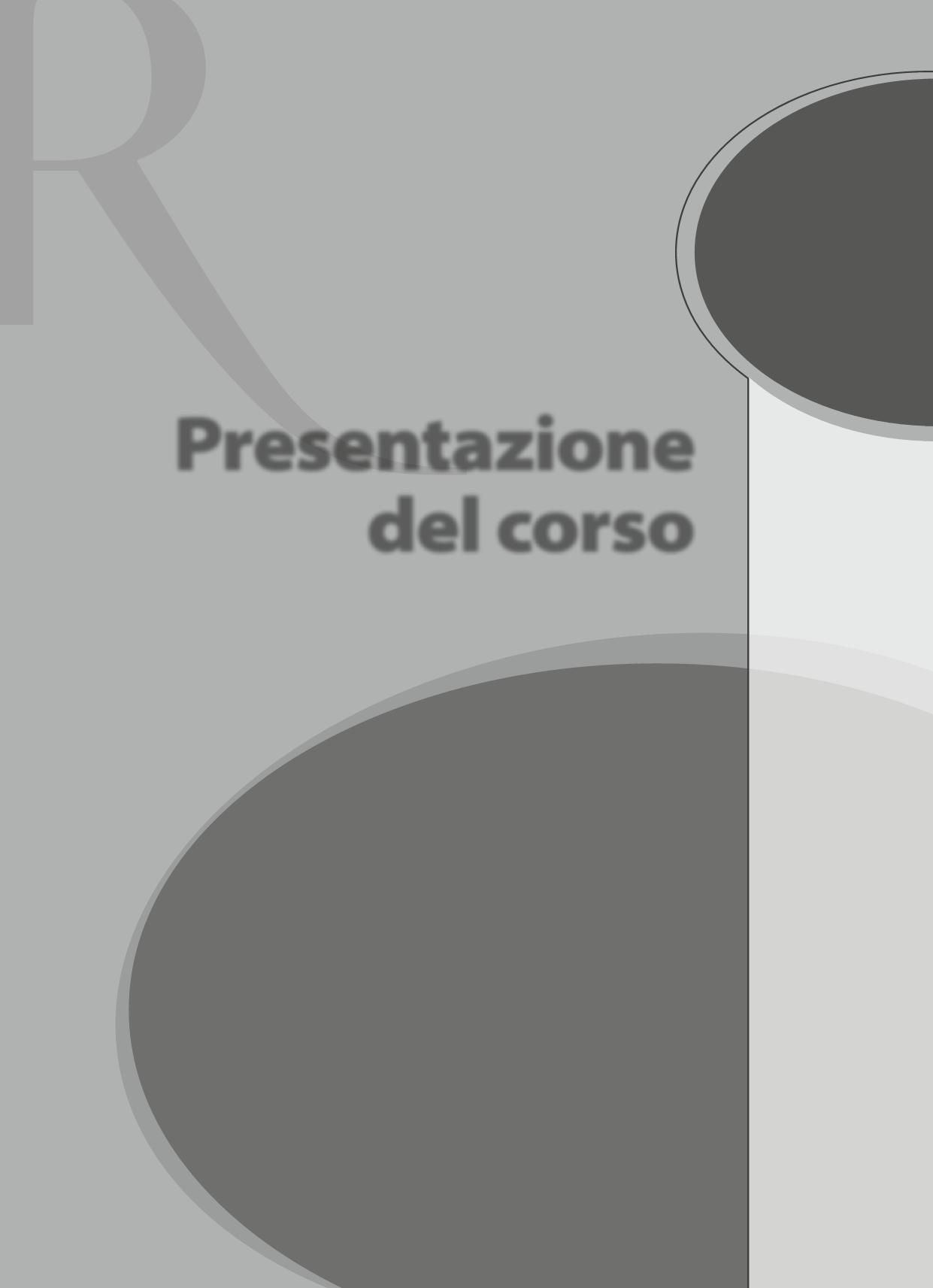
• Indice del volume
• Struttura del corso
• Materiali digitali per il docente: il percorso
• Struttura della Guida docente
L’INDICE DEL VOLUME
La parte teorica è esposta in maniera rigorosa e graduale. Il volume è infatti suddiviso in Unità che afferiscono a quattro Temi. Le Unità sono costituite da paragrafi e sottoparagrafi che permettono una visione schematica e progressiva dei vari argomenti della teoria. Di seguito è riportato l’indice dove sono evidenziati i principali punti di forza:
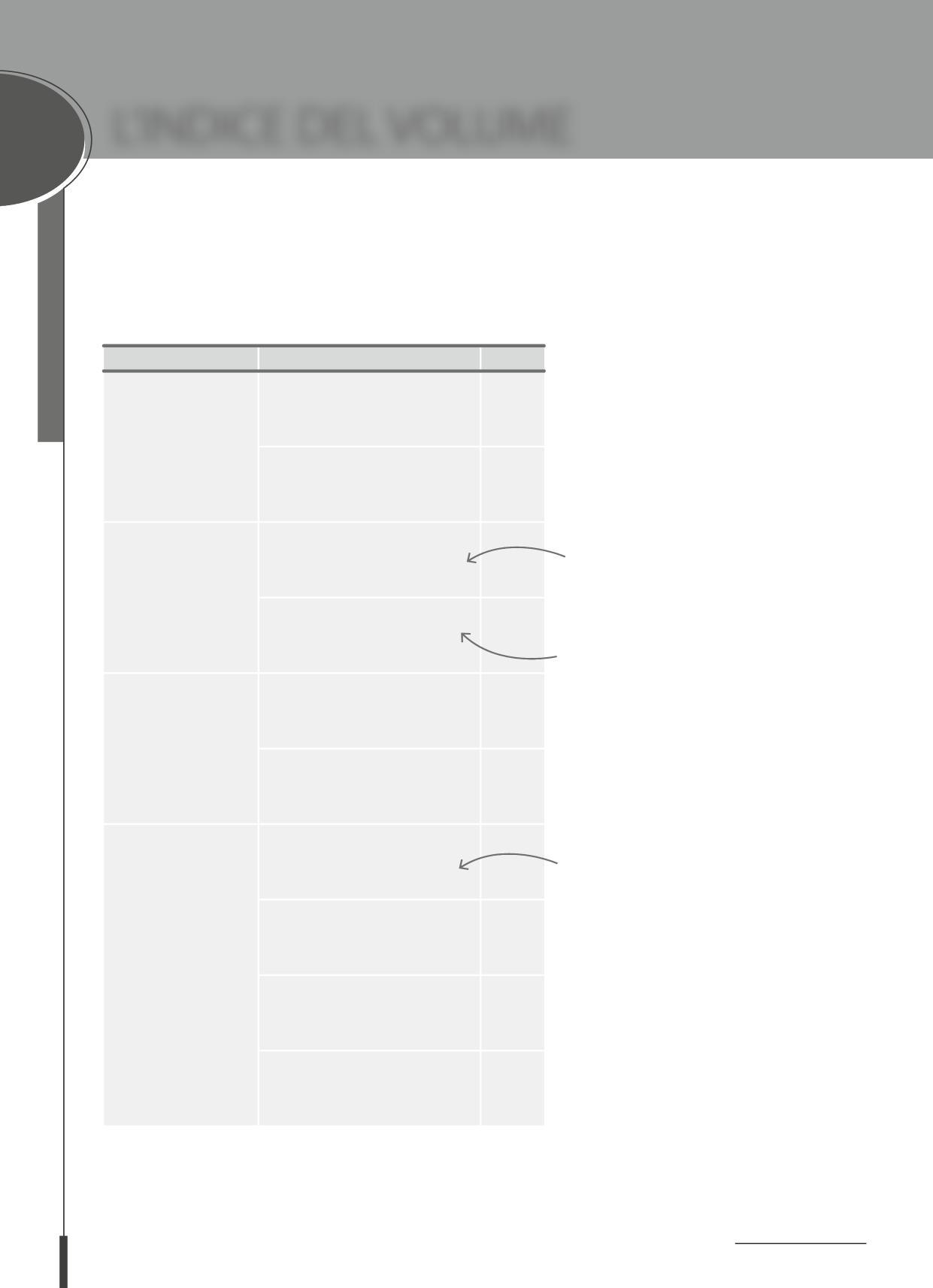
Lo studio della chimica organica non è fine a se stesso ma è affrontato anche alla luce delle unità successive dedicate alla biochimica. La trattazione è graduale e affronta prima i composti del carbonio e poi i suoi principali derivati.
In questa unità sono presenti anche paragrafi dedicati a una particolare classe di proteine, gli enzimi, e alla loro regolazione.
La fotosintesi è inserita nel contesto più ampio del metabolismo cellulare, per sottolineare l’integrazione di questa via metabolica all’interno del network.
Sismologia e la vulcanologia trovano maggiore spazio all’interno della trattazione della struttura interna della Terra.
STRUTTURA DEL CORSO
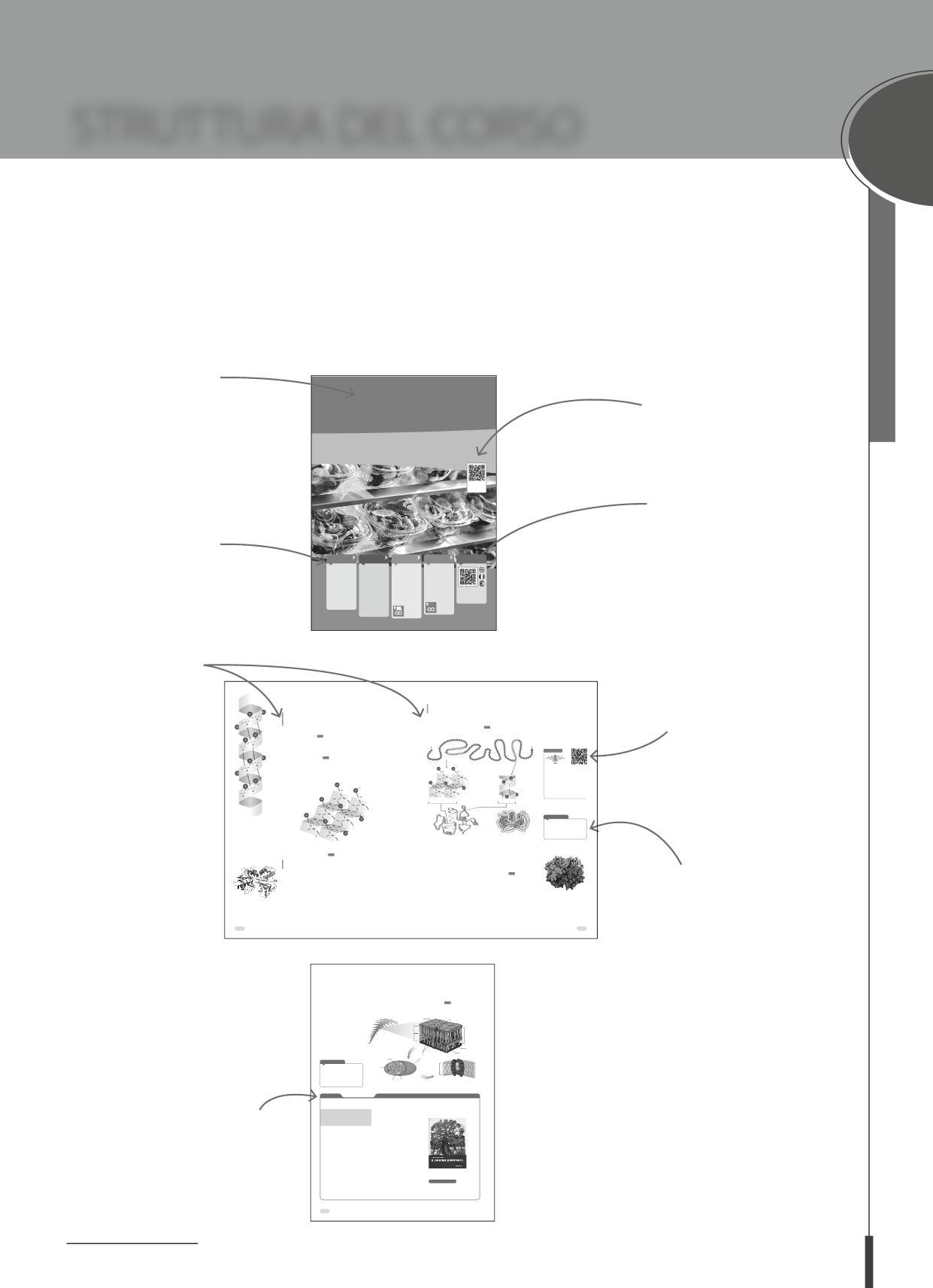
In queste pagine descriviamo come è strutturato il corso Principi di biochimica con scienze della Terra, e quali sono le risorse digitali che lo accompagnano.
La teoria
Ogni Tema si apre con una grande immagine che propone un fenomeno quotidiano e conosciuto accompagnata da un breve testo di avvio della lezione in classe.
In apertura è proposto il percorso didattico del tema e la presentazione delle diverse schede di approfondimento.
Definizioni e concetti importanti sono messi in evidenza.
Dal QR si accede alle presentazioni LIM delle unità appartenenti al Tema.
Dal QR nel box CLIL si accede alle sintesi delle unità in inglese, francese e spagnolo.
1
Podcast con accesso immediato da QR sui premi Nobel che hanno cambiato le nostre vite. Domande in itinere per esercitarsi all’esposizione orale dei concetti chiave del paragrafo.
Gli esercizi
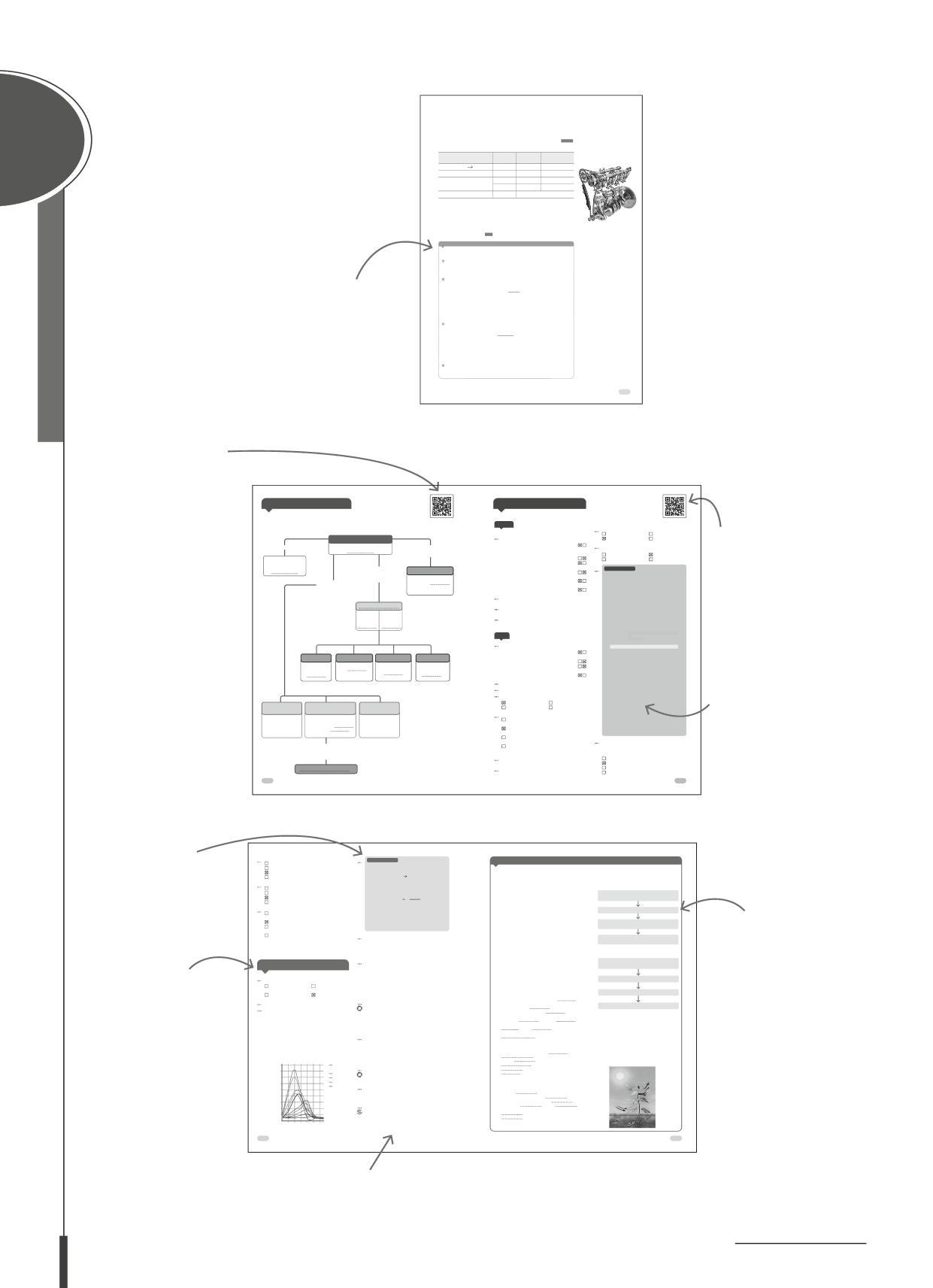
Mappa concettuale di fine unità da completare su carta. Dal QR in pagina sono disponibili: la mappa scaricabile e personalizzabile e la sintesi dell’unità.
Problemi guidati mostrano i passi della risoluzione per meglio comprendere quanto studiato nella teoria.
Tramite il QR code disponibili esercizi aggiuntivi su HubTest
Esercizi di conoscenze e abilità divisi per paragrafo.
Esercizi mirati per costruire le competenze
Competenze
Alcune unità presentano esercizi di competenze che prevedono l’utilizzo dell’intelligenza artificiale e stimolano verso un uso critico e responsabile di questo strumento.
Ogni unità chiude con la sezione Guida all’esposizione orale che presenta diverse tipologie di esercizi in preparazione al colloquio dell’esame di Stato
Le rubriche
Le linee del tempo
Storie e idee mostrano come il sapere scientifico sia costruito nel tempo grazie al contributo di scienziate e scienziati vissuti in epoche diverse.
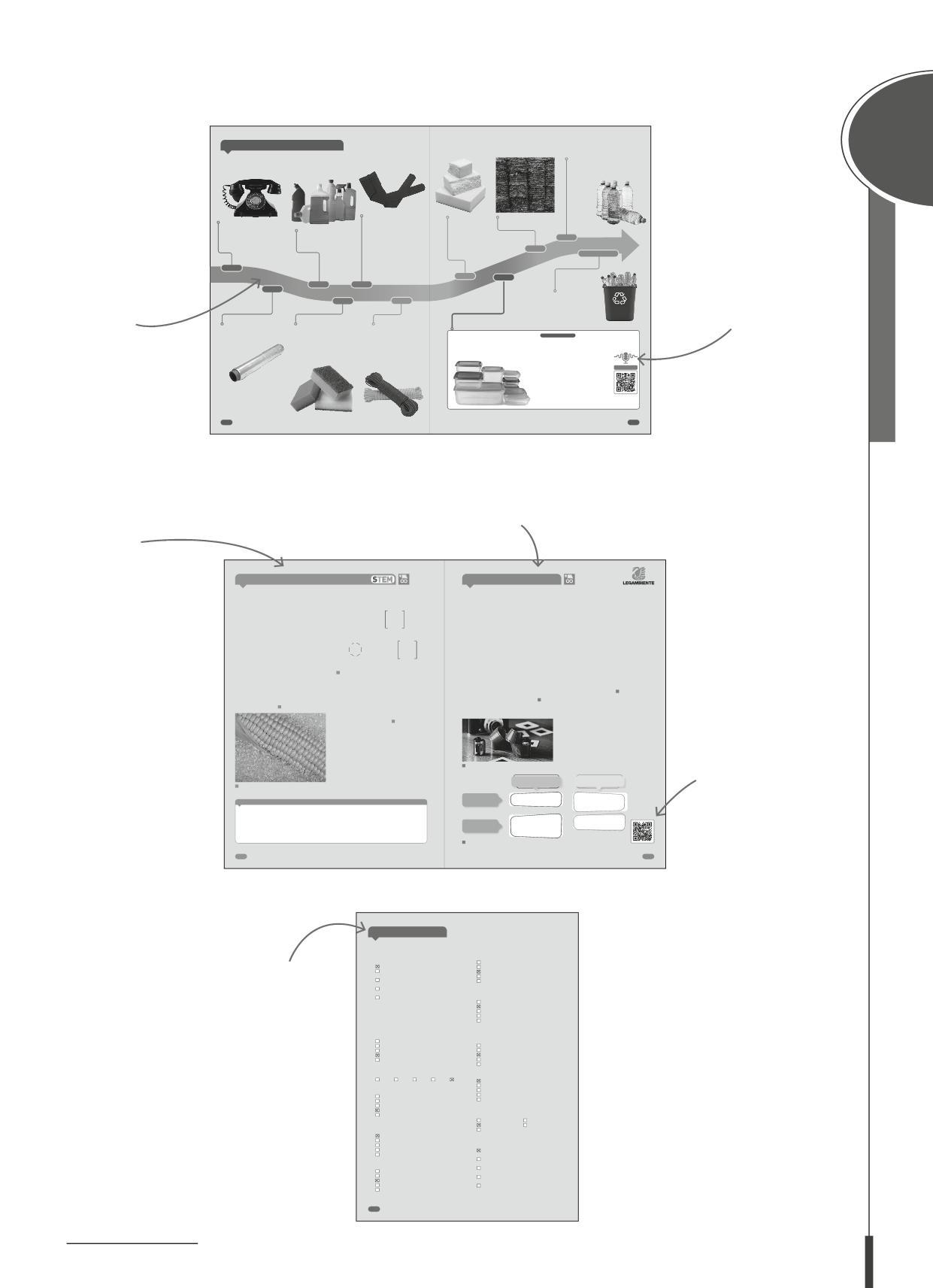
Le schede
Understanding Our World With STEM, in lingua inglese, propongono una lettura su un argomento di stretta attualità, e due proposte di attività da svolgere anche in forma cooperativa, per stimolare il ragionamento e il pensiero critico.
Un’autoverifica con i test di ingresso all’Università fruibile anche in modalità autocorrettiva su HUB young.
Educazione civica: un percorso attraverso gli obiettivi dell’Agenda 2030 in collaborazione con Legambiente.
A ogni linea del tempo è associata una puntata podcast dedicata a un Nobel della chimica o della fisica.
come l’amido. Quest’ultimo è degradato per riduzione chimica in glucosio e trasformato poi in acido lattico, il monomero da cui per polimerizzazione si ottiene PLA. Un’altra fonte tra le più impiegate per produrre bioplastica è la canna da zucchero da cui si ottiene l’etanolo, trasformato in etilene e poi in bio-polietilene (bio-PE). In generale possiamo classificare le plastiche seconda e del grado di biodegradabilità 2 È importante, tuttavia, non confondere termini biodegradabile e compostabile. Un materiale si dice biodegradabile quando, per azione di batteri agenti fisici, come la luce del Sole e l’erosione, si degrada in diossido di carbonio, acqua e metano. Si parla invece
Un semplice compito di realtà da svolgere in modalità cooperativa.
MATERIALI DIGITALI
PER IL DOCENTE: IL PERCORSO
I materiali per il docente non si trovano solo in questa guida cartacea, ma anche in formato digitale. Esplora tutte le risorse a disposizione per insegnare!
Puoi accedere ai materiali digitali dedicati al docente dalla nuova piattaforma HUB Scuola
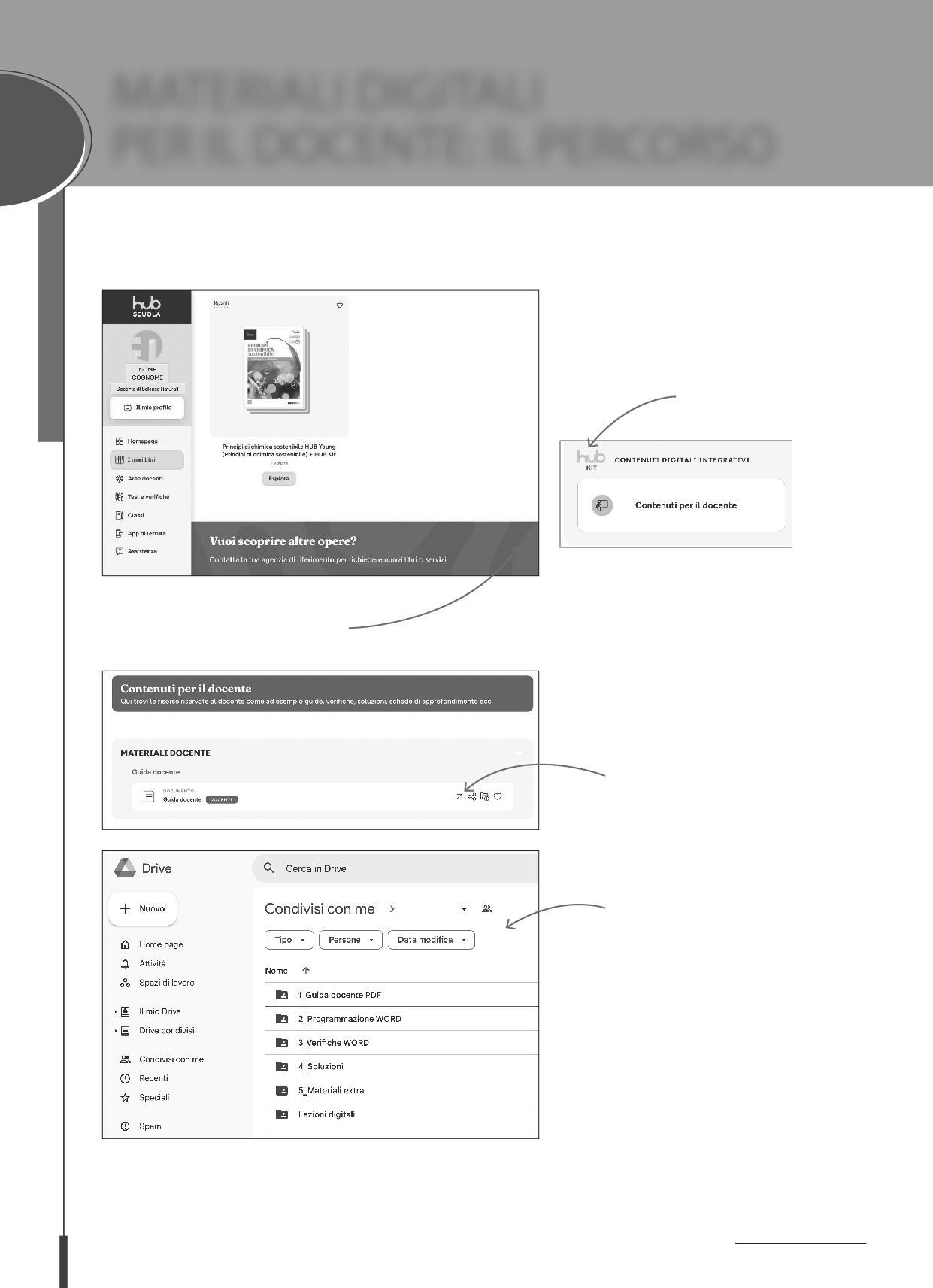
2. Clicca su Contenuti per il docente
1. Cerca il volume di interesse in Homepage oppure nella sezione I miei libri, poi clicca su Esplora
Grazie al QR code in copertina hai un accesso diretto alla cartella Drive. Se è prevista per l'opera, trovi i materiali digitali anche sulla chiavetta USB
3. Per accedere alla cartella in ambiente Drive con tutte le risorse digitali clicca sulla freccina. Per condividere (su Teams, Classroom o per copiare il link) clicca sul simbolo di condivisione a fianco.
4. Si accede così alla cartella Drive dove trovi la guida in formato pdf programmazioni in word verifiche in word le soluzioni degli esercizi le lezioni digitali tutti gli altri eventuali materiali extra dell'opera!
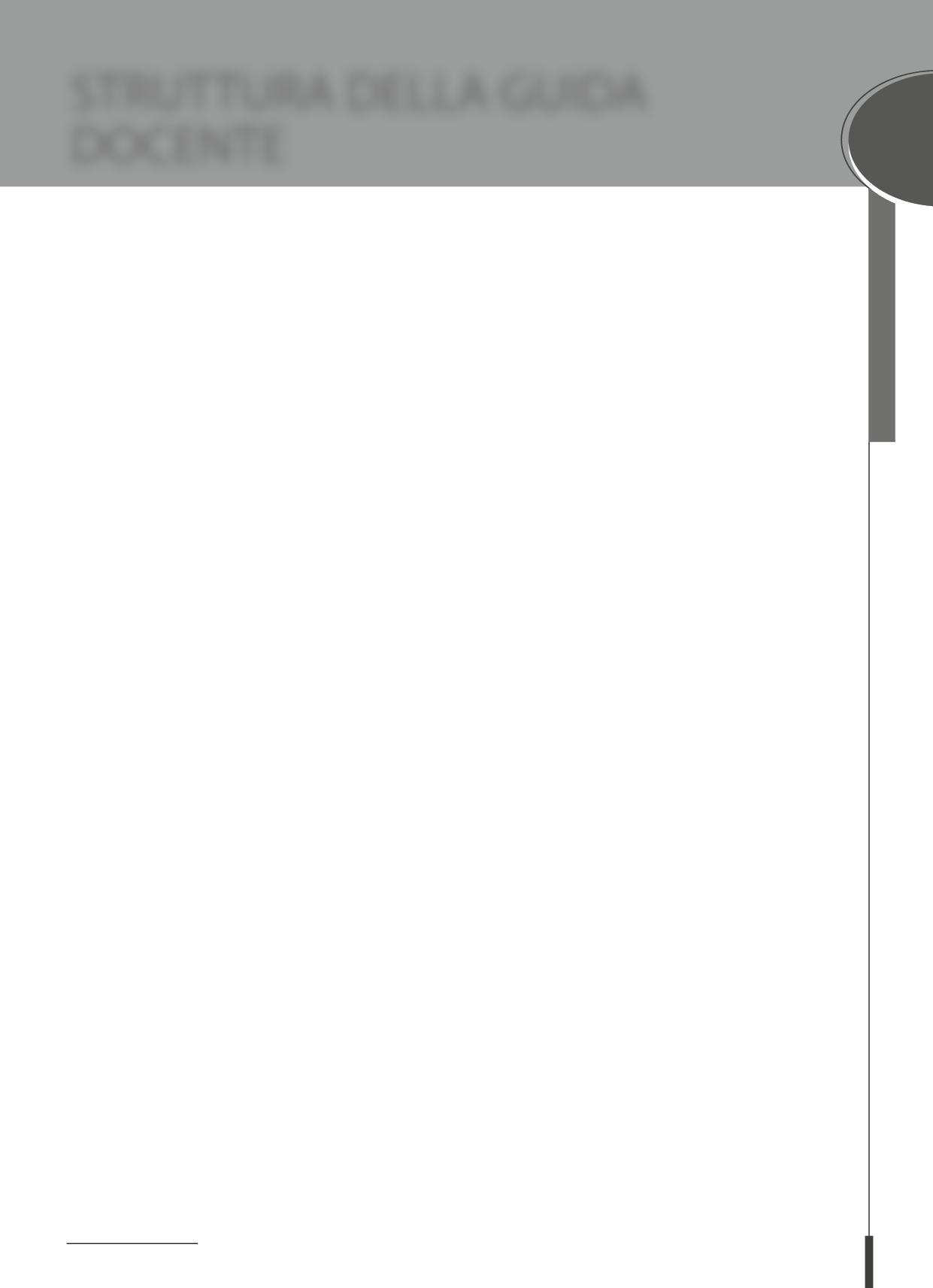
STRUTTURA DELLA GUIDA DOCENTE 1
La Guida è suddivisa in sezioni tematiche.
• La sezione Programmazione didattica mette a disposizione dell’insegnante due tipologie di tabelle di programmazione.
Le programmazioni per nuclei fondamentali forniscono delle tracce sintetiche, in cui sono evidenziati i prerequisiti e gli obiettivi di apprendimento fondamentali per ogni blocco di apprendimento.
Le programmazioni per Unità propongono una descrizione complessiva degli argomenti e delle attività presenti in ciascuna Unità. Si va dai prerequisiti necessari per affrontare la lezione, ai contenuti presenti nella teoria, alle competenze che ci si aspetta vengano acquisite. Le dieci pagine di programmazione, una per Unità, accompagnano il docente nella pianificazione delle lezioni e nell’uso delle risorse su carta e in digitale articolate secondo i diversi momenti didattici: Spiegazione in classe, Approfondimenti, Didattica inclusiva, CLIL, Esercizi formativi e di autovalutazione, Sviluppo e verifica delle competenze.
• La sezione Orientamento STEM illustra l’approccio STEM applicato alle scienze naturali, sia come proposte per l’orientamento in uscita sia come didattica STEM, proposta attraverso attività e approfondimenti tecnici e sperimentali.
• La nuova educazione civica (linee guida 2024) e parità di genere illustra i materiali presenti nel volume e nella guida utilizzabili da studenti e docenti per affrontare in modo esaustivo i temi legati all’insegnamento dell’educazione civica. Oltre a una breve presentazione della normativa sull’educazione civica, aggiornata con le nuove linee guida del 2024, è proposta una tabella riassuntiva dei contenuti Agenda 2030 presenti nel volume. È inoltre presente con un focus sull’impegno di Rizzoli Education per la parità di genere e la multiculturalità.
• La sezione Materiali per la lezione fornisce indicazioni per la didattica, tra cui le attività con il programma Avogadro e con i modelli molecolari, la metodologie e i moduli CLIL, le schede per il docente e per lo studente dei compiti di realtà, le griglie di valutazione dei prodotti multimediale e l’uso dei podcast.
• Didattica con Intelligenza Artificiale fornisce utili spunti per l’utilizzo dell’intelligenza artificiale nella didattica, con un focus particolare sull’insegnamento delle materie scientifiche.
• La sezione Test d’ingresso e prove di valutazione fornisce test d’ingresso (anche per obiettivi minimi) per valutare il livello di conoscenze degli studenti che si apprestano ad affrontare il quinto anno di studi. Segue una raccolta di prove di verifica utilizzabili per la valutazione, suddivise per Unità e declinate in tre tipologie: Fila A, Fila B e per obiettivi minimi.
• La sezione Soluzioni comprende le soluzioni delle prove di valutazione, dei test d’ingresso nella guida cartacea e degli esercizi del volume.
• Nella sezione Traduzioni sono presenti le traduzioni in italiano delle schede in inglese Understanding Our World With STEM.
• Infine, nella sezione Didattica Digitale Integrata con HUB Scuola sono forniti: una breve introduzione alla didattica digitale integrata, il sillabo delle Lesson Plan e i Moduli Google.

2
Programmazione didattica
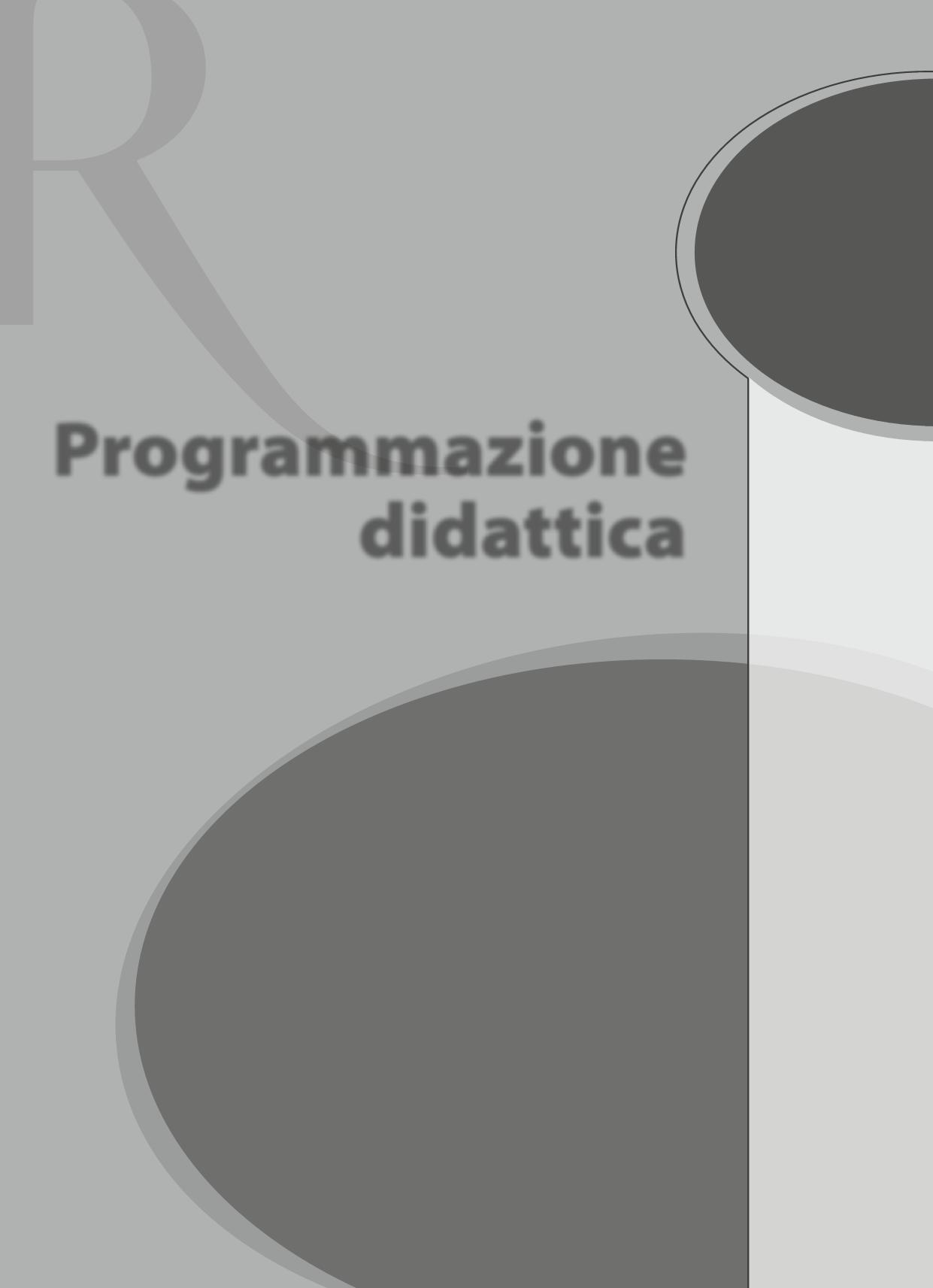
• Programmazione per Nuclei fondamentali
• Programmazione per Unità
PROGRAMMAZIONE PER NUCLEI FONDAMENTALI
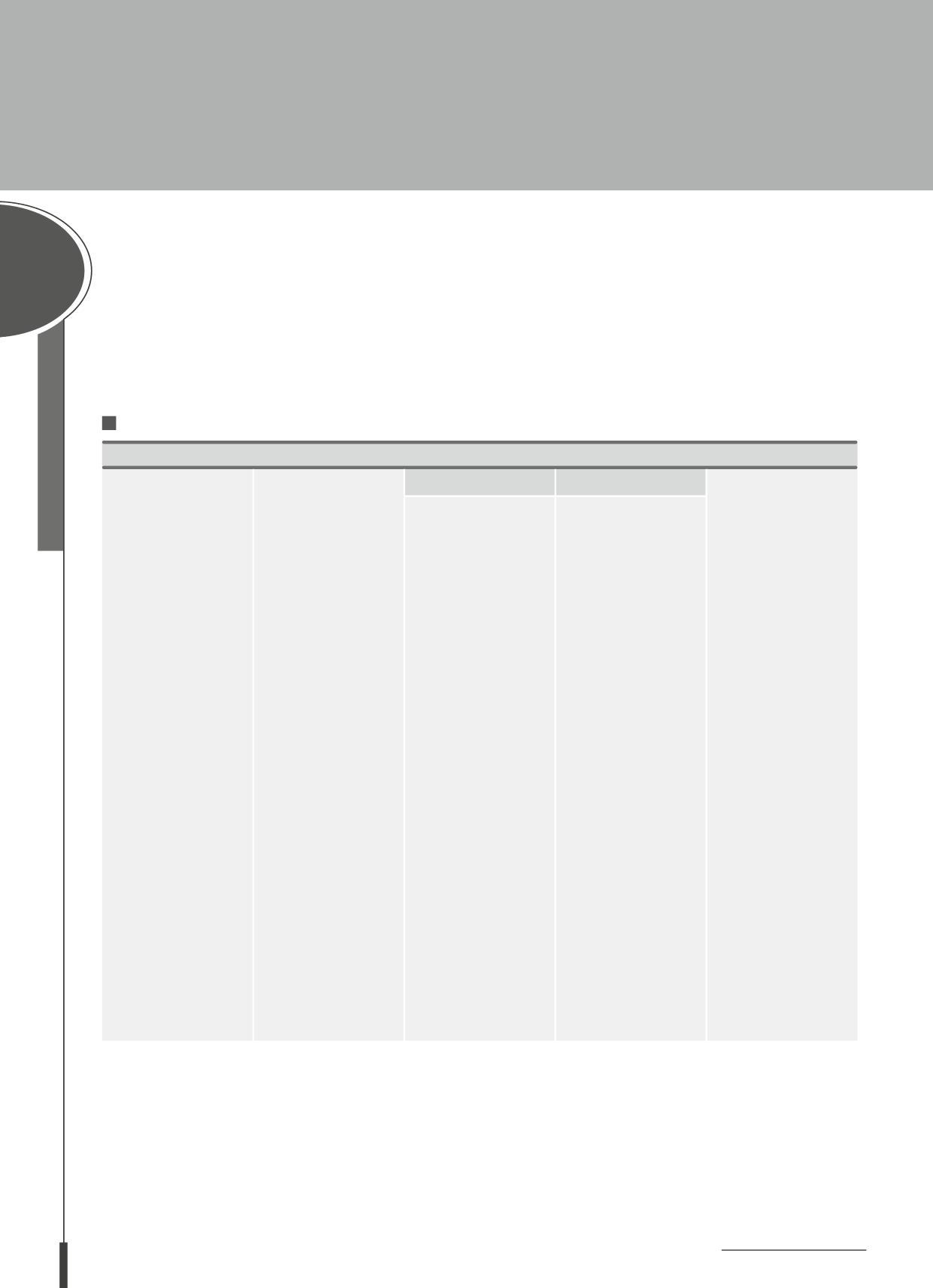
Di seguito, sono fornite delle griglie con spunti di programmazione che evidenziano i nuclei fondamentali delle Scienze Naturali (Chimica, Biologia e scienze della Terra). Individuare i nuclei fondamentali è basilare per progettare al meglio e in modo flessibile i percorsi di apprendimento e il programma da svolgere, anche nei casi in cui è necessario un percorso più agile e rapido.
1. Chimica organica
Contenuti
• Composti organici e ibridizzazione
• Isomeria
• Reazioni organiche
• Idrocarburi saturi, insaturi e aromatici
• Gruppi funzionali
Percorso agile Obiettivi di apprendimento Prerequisiti
Per ottimizzare i tempi:
si potrebbero delineare i concetti chiave dei vari contenuti (p.es. vari tipi di ibridazione, definizione di isomeria, schema delle reazioni organiche, ecc.) senza entrare nel dettaglio teorico, allo scopo di far acquisire le basi necessarie per correlare gruppi funzionali e reattività
Conoscenze Competenze Chimica
• Ibridizzazione e legami tra atomi di carbonio
• Isomeri e stereoisomeri
• Classificazione delle reazioni organiche
• Classificazione, nomenclatura, proprietà e reattività degli idrocarburi saturi, insaturi e aromatici
• Classificazione, nomenclatura, proprietà e reattività dei composti con diversi gruppi funzionali
• Identificare le differenti ibridizzazioni del carbonio
• Determinare i diversi tipi di isomeri
• Classificare le reazioni organiche
• Identificare i diversi idrocarburi, attribuire la corretta nomenclatura e descriverne proprietà e reattività
• Identificare i diversi gruppi funzionali e attribuire la corretta nomenclatura
• Correlare gruppi funzionali e reattività dei composti organici e utilizzare i concetti di elettrofilo e nucleofilo per interpretare le reazioni organiche
• Legami chimici primari e secondari
• Orbitali atomici e configurazione elettronica
• Orbitali ibridi
• Reazioni chimiche
• Velocità e meccanismo di reazione
• Equilibrio chimico
• Acidi e basi
2. Metabolismo
energetico ed enzimatico
Nucleo tematico fondamentale QdR Esame di Stato
Contenuti Percorso agile Obiettivi di apprendimento
• Macromolecole biologiche
• Enzimi e cinetica enzimatica*
• Principali vie metaboliche**
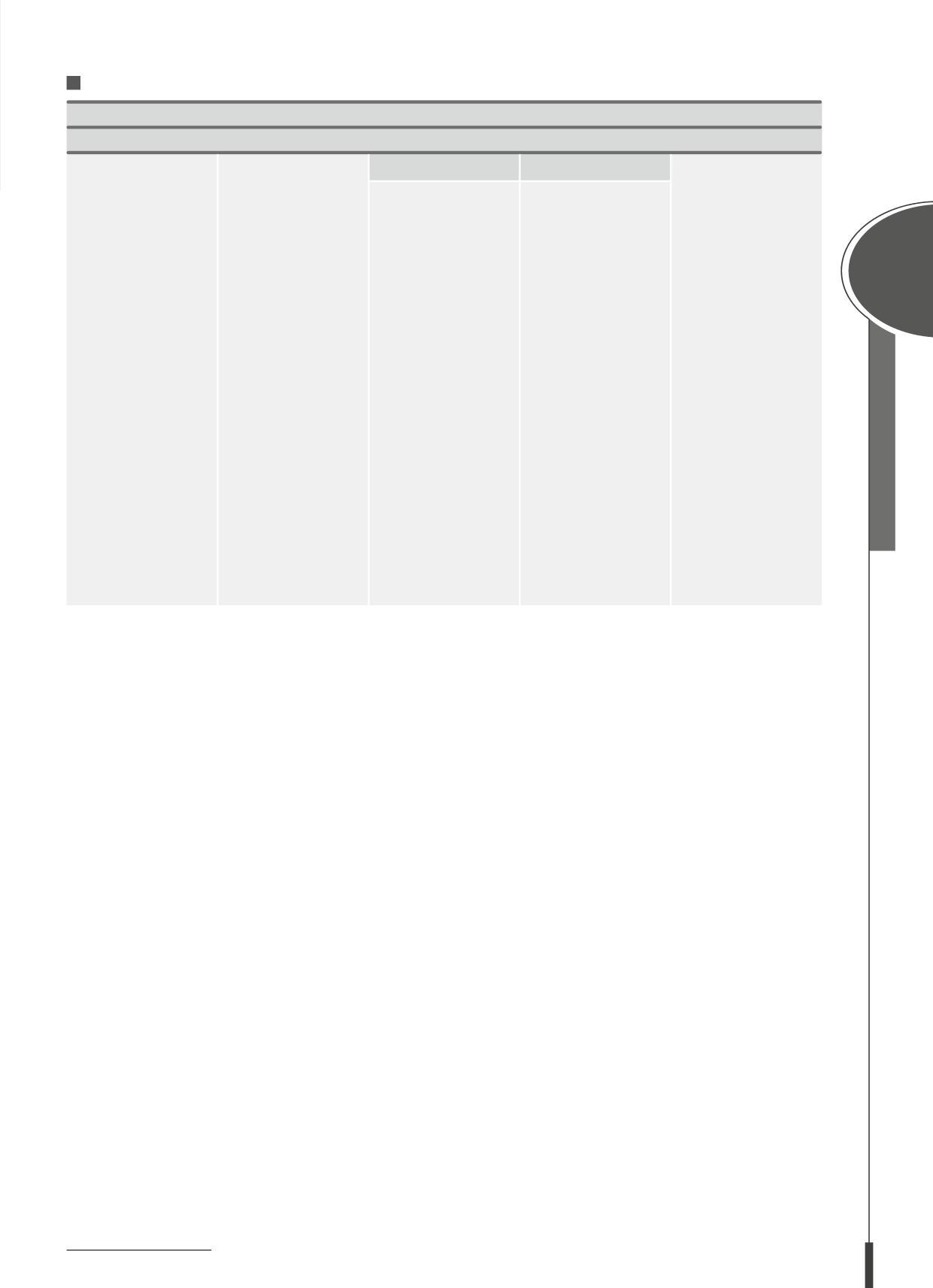
Per ottimizzare i tempi:
*trattare la cinetica di Michaelis-Menten solo attraverso le definizioni di KM e V max
**non trattare la via dei pentoso fosfati, la sintesi del colesterolo, la chetogenesi e la gluconeogenesi; trattare in maniera superficiale il metabolismo dei lipidi e quello delle proteine
Prerequisiti
Conoscenze Competenze Matematica
• Carboidrati
• Lipidi
• Proteine
• Acidi nucleici
• Vitamine
• ATP
• Enzimi e coenzimi
• Modello di Michaelis-Menten*
• Inibitori enzimatici
• Regolazione allosterica
• Glicogenolisi e glicogenesi
• Glicolisi
• Ciclo di Krebs
• Fosforilazione ossidativa
• Metabolismo dei lipidi**
• Metabolismo delle proteine**
• Fotosintesi
• Fotorespirazione
• Saper riconoscere e classificare le principali biomolecole
• Mettere in relazione la cinetica chimica con i meccanismi di catalisi
• Interpretare correttamente
i valori di KM in relazione all’affinità enzimatica*
• Riconoscere i diversi punti di contatto tra le varie vie metaboliche
• Confrontare la resa energetica del metabolismo aerobico del glucosio e di quello anaerobico
• Equazioni di primo grado
• Grafici di funzioni
Biologia
• Cellule procariotiche ed eucariotiche
Chimica
• Principi della termodinamica
• Energia libera
• Legami chimici
• Elementi di chimica organica
3. Biologia molecolare e ingegneria genetica
Nucleo tematico fondamentale QdR Esame di Stato Contenuti Percorso agile Obiettivi di apprendimento Prerequisiti
• Regolazione dell’espressione genica
• DNA ricombinante e altre tecniche della biologia molecolare*
• Biotecnologie**
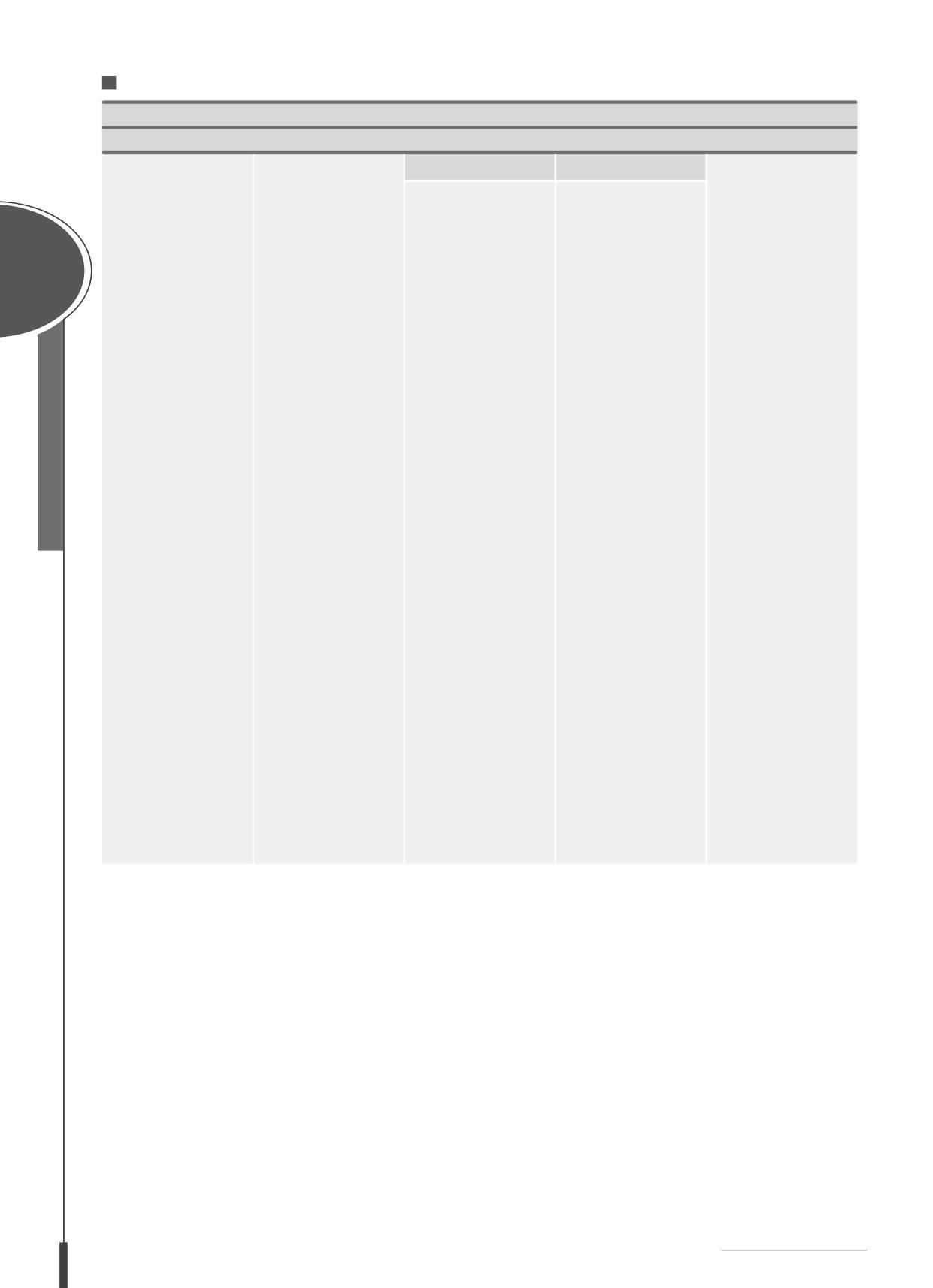
Per ottimizzare i tempi:
*non trattare le diverse scienze omiche
**trattare in maniera poco approfondita questo argomento
Conoscenze Competenze Biologia
• Regolazione genica nelle cellule procariotiche
• Regolazione genica nelle cellule eucariotiche
• Trasferimento genico orizzontale nei procarioti
• Fagi e virus eucariotici
• Ciclo litico e lisogeno
• Elementi genetici mobili
• DNA ricombinante
• Clonaggio
• Librerie a DNA
• PCR
• Elettroforesi
• Sequenziamento
• Genomica e scienze omiche*
• OGM
• Biotecnologie industriali**
• Biotecnologie agrarie**
• Biotecnologie ambientali**
• Biotecnologie mediche**
• Clonazione
• Mettere in relazione la struttura dinamica del DNA con i meccanismi di regolazione
• Distinguere un operone inducibile da uno reprimibile
• Riconoscere i vari livelli di regolazione dell’espressione genica negli eucarioti
• Confrontare le modalità di replicazione dei diversi virus eucariotici
• Risalire a un determinato enzima di restrizione in base alla sequenza del frammento di restrizione
• Distinguere tra librerie genomiche e a cDNA e scegliere la più appropriata in funzione della necessità
• Individuare e scegliere le tecniche di ingegneria genetica da utilizzare in una specifica applicazione
• Cellule procariotiche ed eucariotiche
• Struttura e organizzazione del DNA
• Duplicazione, trascrizione e traduzione
4. Dinamica dell’atmosfera e del clima
Nucleo tematico fondamentale QdR Esame di Stato Contenuti Percorso agile Obiettivi di apprendimento
• L’atmosfera*
• I fenomeni meteorologici*
• Il clima*
• Il cambiamento climatico
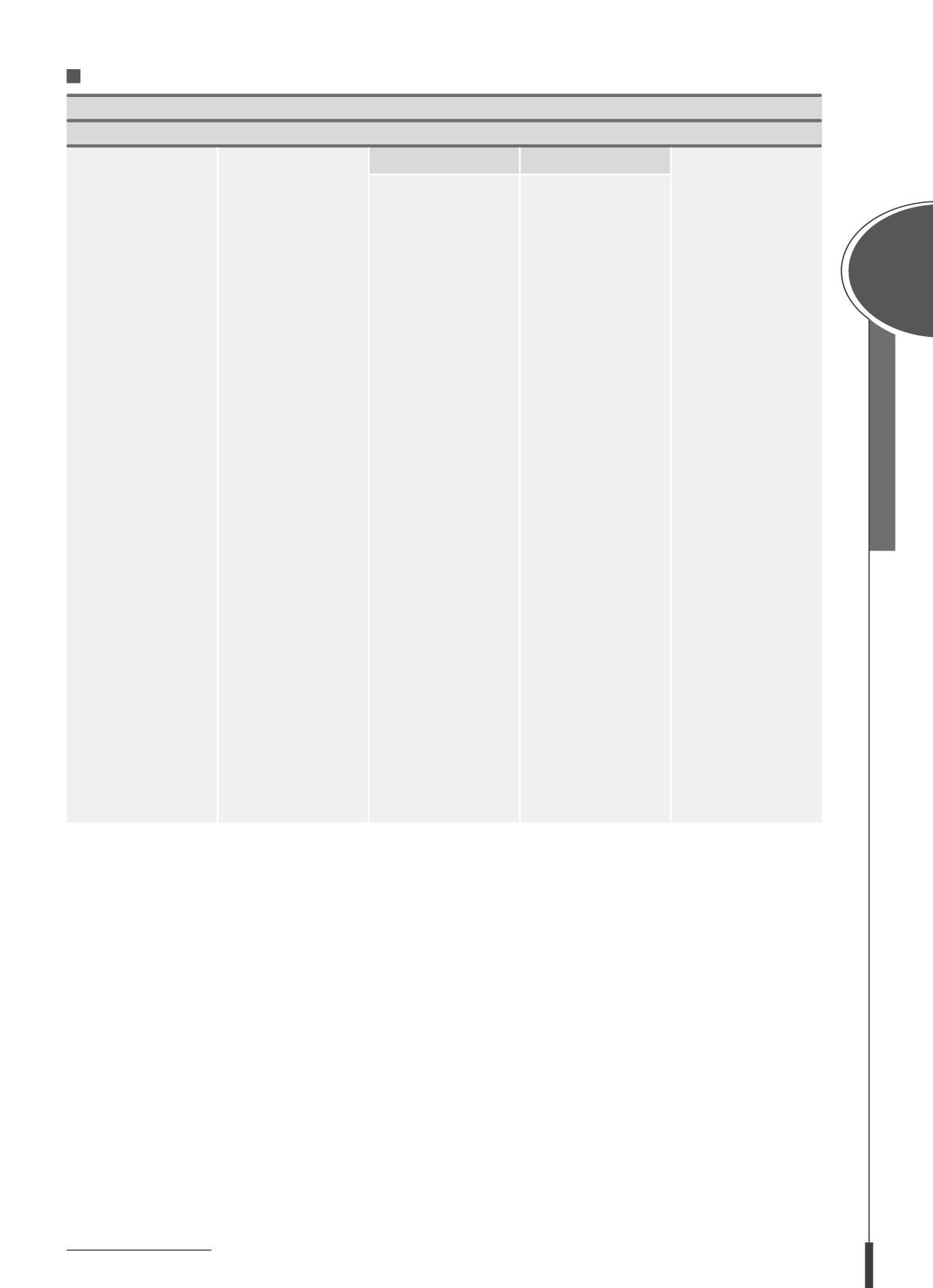
Per ottimizzare i tempi:
*se atmosfera, fenomeni
meteorologici e clima sono stati già affrontati in classe 1a, riprendere i fondamenti in maniera succinta per affrontare direttamente i fenomeni meteorologici complessi e il cambiamento climatico
Conoscenze Competenze
• Composizione e struttura dell’atmosfera
• Il bilancio radiativo (o termico) della Terra
• La temperatura dell’aria
• La pressione atmosferica
• I venti e la circolazione atmosferica
• L’umidità atmosferica e i fenomeni al suolo
• Le nubi, le precipitazioni e le perturbazioni atmosferiche
• Le previsioni del tempo
• Il clima e i suoi fattori
• La classificazione dei climi
• Il cambiamento climatico
• Gli impatti del cambiamento climatico
• Le politiche nazionali e le azioni locali per il contrasto al cambiamento climatico
• Descrivere la struttura dell’atmosfera
• Illustrare il concetto di pressione e
• la circolazione dei venti
• Costruire modelli meteorologici a partire da dati sperimentali
• Leggere carte meteorologiche
• Illustrare il concetto di clima e la sua classificazione
• Conoscere la differenza fra clima e tempo meteorologico
Prerequisiti
Matematica
• Conversione tra unità di misura
• Notazione scientifica
• Proprietà delle potenze
• Proporzionalità diretta e inversa
• Assi cartesiani
Fisica
• Oscillazioni e moto armonico
Chimica
• Stati di aggregazione della materia
• Pressione e mmHg
Biologia
• Le interazioni uomo ambiente e la biosfera
Scienze della Terra
• Il ciclo dell’acqua e l’idrosfera
• I cicli biogeochimici
5. Modelli della tettonica globale
Nucleo tematico fondamentale QdR Esame di Stato Contenuti Percorso agile Obiettivi di apprendimento
• La dinamica della litosfera
• La tettonica delle placche
• L’orogenesi
• La storia geologica della Terra*
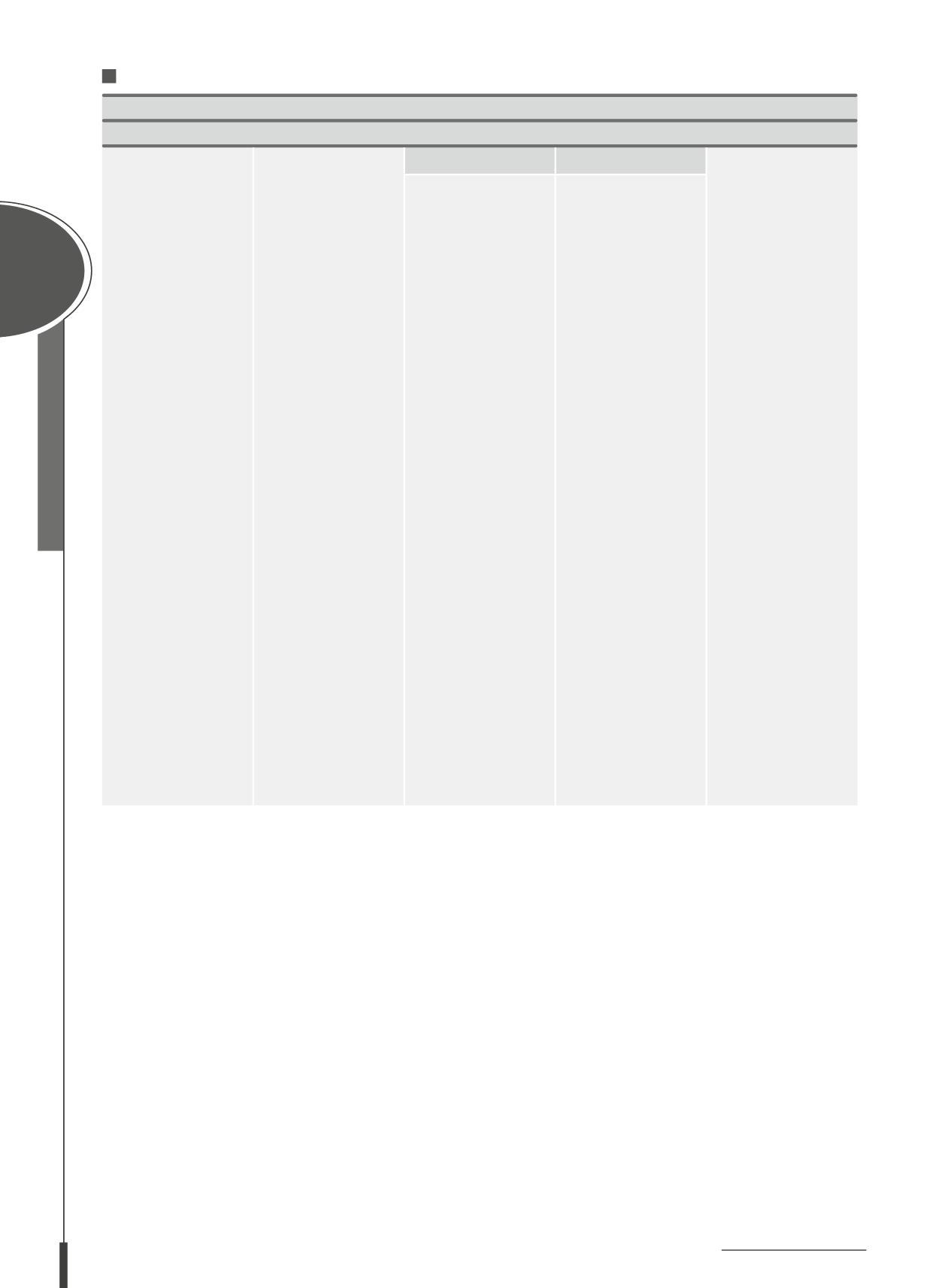
Per ottimizzare i tempi:
*saltare la storia geologica della Terra
Conoscenze Competenze
• La struttura interna della Terra
• Le teorie fissiste
• La teoria della deriva dei continenti
• La morfologia dei fondali oceanici
• Gli studi di paleomagnetismo
• L’espansione dei fondali oceanici
• Le anomalie magnetiche
• La struttura delle dorsali oceaniche
• L’età delle rocce del fondale
• La teoria della tettonica a placche
• I margini di placca e i margini continentali
• Le caratteristiche generali delle placche
• La formazione degli oceani
• I punti caldi
• L’orogenesi
• La struttura dei continenti
• La storia geologica della Terra*
• Cenni alla storia geologica italiana
• Individuare le aree attive del Pianeta caratterizzandole dal punto di vista sismico e vulcanico
• Utilizzare la magnetizzazione delle rocce come strumento per ricostruire i movimenti delle placche nel tempo
• Interpretare, alla luce della teoria della Tettonica globale, i fenomeni geologici ai margini di placca
Prerequisiti
Matematica
• Conversione tra unità di misura
• Notazione scientifica
• Proprietà delle potenze
• Proporzionalità diretta e inversa
• Assi cartesiani
Fisica
• Il campo magnetico
• Funzionamento della dinamo
Chimica
• Stati di aggregazione della materia
• Modelli atomici
• Ioni
• Numero atomico, numero di massa e isotopi
• Legami chimici
Scienze della Terra
• Le rocce (caratteristiche e formazione)
• Il ciclo litogenetico
• Vulcanismo e Sismologia (caratteristiche e localizzazione di vulcani e terremoti)
PROGRAMMAZIONE PER UNITÀ
U1 – Il carbonio e gli idrocarburi
Prerequisiti
Regole di configurazione elettronica • Legami chimici • Teorie di geometria molecolare • Numeri di ossidazione • Rappresentazione di molecole e composti • Ibridizzazione e geometrie molecolari
Contenuti
Il carbonio nei composti organici • Ibridizzazione del carbonio • Tipi di legami tra atomi di carbonio • Isomeri costituzionali e stereoisomeri • Enantiomeri • Reazioni organiche: classificazione • Caratteristiche e classificazione degli idrocarburi • Nomenclatura, proprietà e tipi di reazione degli alcani e dei cicloalcani • Nomenclatura, proprietà e tipi di reazione degli alcheni e dei cicloalcheni • Nomenclatura, proprietà e tipi di reazione degli alchini • Nomenclatura, proprietà e tipi di reazione degli idrocarburi aromatici
Traguardo competenze
Identificare le ibridizzazioni del carbonio • Determinare i diversi tipi di isomeri • Spiegare in che modo gli intermedi influenzano l’andamento delle reazioni organiche • Classificare le reazioni organiche
Momento didattico
Spiegazione in classe
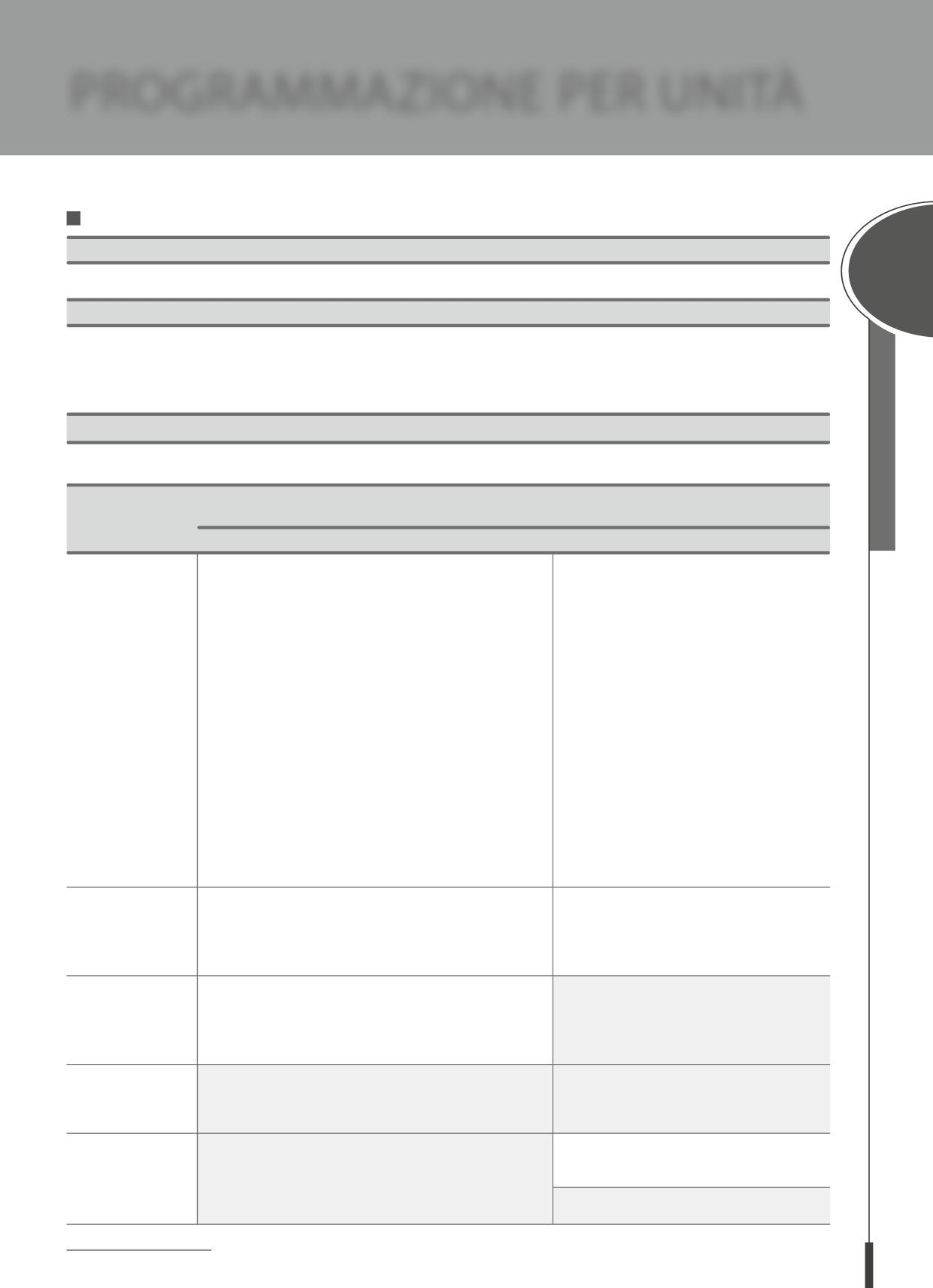
Attività formative (consolidamento delle conoscenze)
Approfondimenti e didattica cooperativa (sviluppo delle competenze)
Valutazione
Risorse (in grigio chiaro i contenuti specifici per il docente)
Volume e Guida per il docente
• Paragrafi:
1.1 Il carbonio nei composti organici
1.2 Il carbonio: un elemento versatile
1.3 Gli idrocarburi
1.4 Gli alcani
1.5 I cicloalcani
1.6 La stereoisomeria
1.7 Gli alcheni
1.8 Gli alchini
1.9 Gli idrocarburi aromatici
1.10 Proprietà fisiche e reattività degli idrocarburi
In digitale
• Presentazione LIM dell’unità
• Video: Friedrich Wöhler; Idrocarburi; Modelli molecolari: il metano; Modelli molecolari: gli alcani superiori; L’isomeria di struttura; Assegna il nome a un alcano; Modelli molecolari: i cicloalcani; La stereoisomeria; Modelli molecolari: la stereoisomeria; Assegna il nome a un alchene; Gli isomeri ottici; Michael Faraday e Dame Kathleen Lonsdale; Benzene: dalla scoperta all’utilizzo; Gli idrocarburi aromatici.
• Avogadro: Gli isomeri di struttura; Le caratteristiche geometriche dei conformeri del cicloesano; Gli stereoisomeri: un esempio di isomeri geometrici; Gli stereoisomeri: un esempio di isomeri ottici; Alcano, alchene, alchino: una questione di legami
• Risposta breve: domande in itinere per l’esposizione orale
• Problemi guidati dell’Unità
• Ripassa con metodo di fine Unità
• Conoscenze e abilità di fine Unità
• Costruisci le competenze di fine Unità
• Guida all’esposizione orale
• Scheda Collega: approfondimento multidisciplinare
• Soluzione degli esercizi proposti nel volume
• Prove di valutazione
• Soluzione delle prove di valutazione
Didattica Inclusiva • Prove di valutazione per obiettivi minimi
• Soluzione delle prove di valutazione per obiettivi minimi
• Esercizi aggiuntivi sulla piattaforma HUB Test versione studente
• Lezioni digitali
• Prove di valutazione modificabili
• Verifica in Moduli Google
• HUB Test versione docente
• Sintesi e audiosintesi in italiano
• Sintesi in inglese, francese e spagnolo
• Mappa modificabile e personalizzabile
• Prove di valutazione per obiettivi minimi modificabili
U2 – I derivati degli idrocarburi e i polimeri
Prerequisiti
Rappresentazione di molecole e composti • Ibridizzazione e geometrie molecolari • Tipologie di reazioni organiche • Fattori che determinano la reattività dei composti • Nomenclatura degli idrocarburi • Concetto di polarità, di risonanza, di acido e di base • Meccanismi di reazione degli idrocarburi
Contenuti
Le principali classi di composti organici e i loro gruppi funzionali • Nomenclatura e proprietà degli alogenoderivati • Nomenclatura e proprietà alcoli e dei fenoli • Nomenclatura, preparazione e proprietà degli eteri • Nomenclatura, preparazione, proprietà e tipi di reazione di aldeidi e chetoni • Nomenclatura e proprietà degli acidi carbossilici • Nomenclatura e proprietà delle ammine • Nomenclatura e caratteristiche dei composti eterociclici • Struttura e proprietà dei polimeri sintetici
Traguardo competenze
Identificare gli idrocarburi a partire dai legami presenti • Scrivere le formule degli idrocarburi e attribuire i nomi IUPAC • Descrivere le caratteristiche, le proprietà e le principali reazioni delle classi di idrocarburi • Identificare i composti organici a partire dai gruppi funzionali • Scrivere le formule dei composti organici e attribuire loro i nomi IUPAC • Descrivere le principali caratteristiche e reazioni delle più importanti classi di composti organici
Momento didattico
Spiegazione in classe
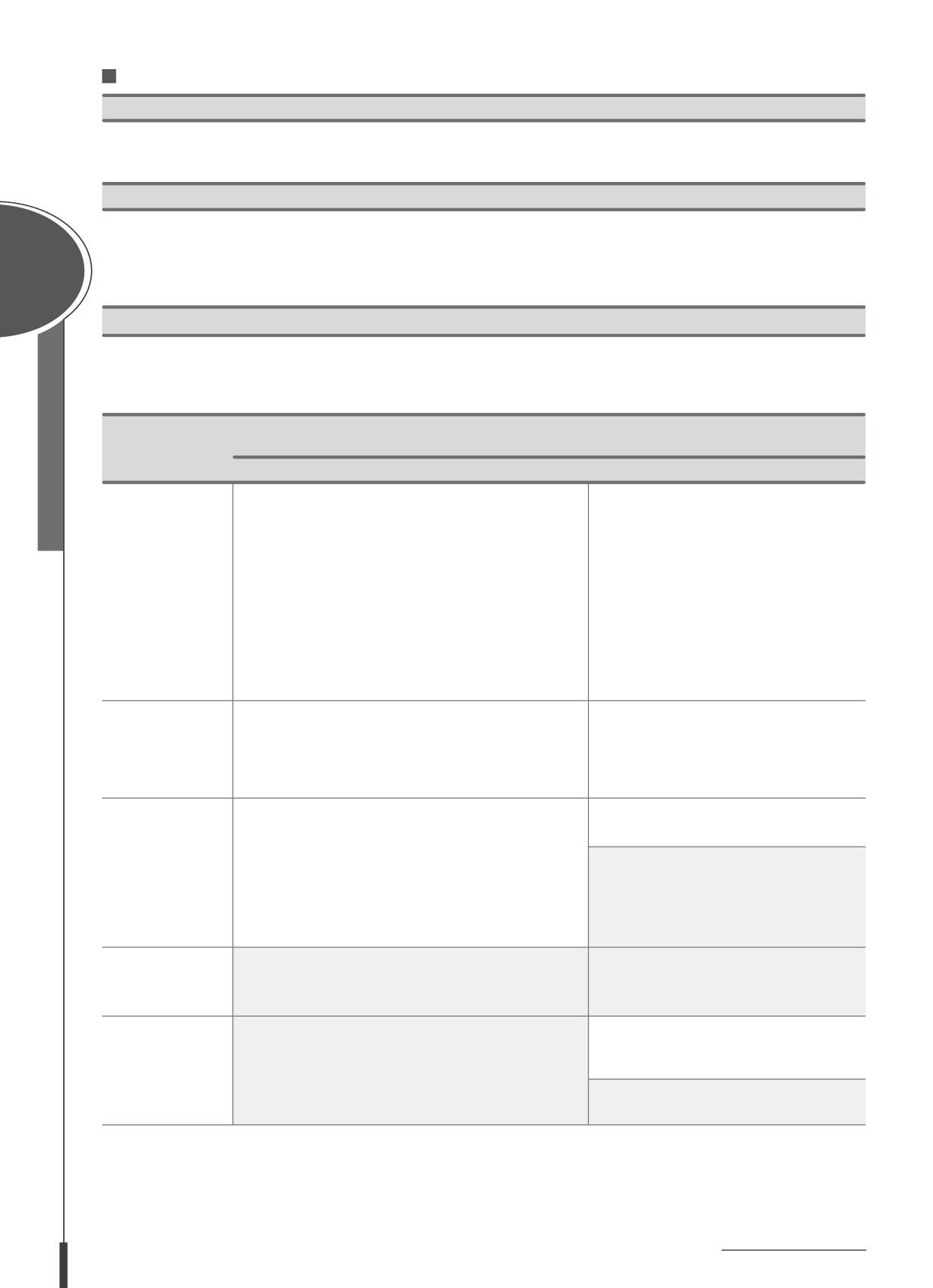
Attività formative (consolidamento delle conoscenze)
Approfondimenti e didattica cooperativa (sviluppo delle competenze)
Risorse (in grigio chiaro i contenuti specifici per il docente)
Volume e Guida per il docente In digitale
• TEMA A: La chimica del carbonio
• Paragrafi:
2.1 I gruppi funzionali
2.2 Gli alcoli e i fenoli
2.3 Gli eteri
2.4 Le aldeidi e i chetoni
2.5 Gli acidi carbossilici
2.6 I derivati degli acidi carbossilici
2.7 Le ammine
2.8 I composti eterociclici
2.9 I polimeri
2.10 La reattività dei composti organici
• Risposta breve: domande in itinere per l’esposizione orale
• Ripassa con metodo di fine Unità
• Conoscenze e abilità di fine Unità
• Autoverifica di fine Tema
• Costruisci le competenze di fine Unità
• Guida all’esposizione orale
• Collega: attività di consolidamento multidisciplinare
• Linea del tempo di fine Tema Storie e idee della chimica: Breve storia della plastica
• Scheda Understanding Our World With STEM di fine Tema: Turning the tide with compostable PLA
• Scheda Educazione civica di fine Tema: Plastiche verdi
Valutazione • Soluzione degli esercizi proposti nel volume
• Prove di valutazione
• Soluzione delle prove di valutazione
Didattica Inclusiva • Prove di valutazione per obiettivi minimi
• Soluzione delle prove di valutazione per obiettivi minimi
• Video: Modelli molecolari: i gruppi funzionali; La nomenclatura degli alcoli; La nomenclatura delle ammine
• Avogadro: Gruppi funzionali: aldeidi e chetoni; Gruppi funzionali: acidi organici e derivati
• Podcast: Giulio Natta
• Esercizi aggiuntivi sulla piattaforma HUB Test
• Autoverifica di fine Tema in modalità autocorrettiva
• Compito di realtà versione studente
• Compito di realtà versione docente
• Lezioni digitali
• Prove di valutazione modificabili
• Verifica in Moduli Google
• HUB Test versione docente
• Sintesi e audiosintesi in italiano
• Sintesi in inglese, francese e spagnolo
• Mappa modificabile e personalizzabile
• Prove di valutazione per obiettivi minimi modificabili
U3 – Le biomolecole
Prerequisiti
Rappresentazione delle molecole organiche • Reattività e caratteristiche dei derivati degli idrocarburi • Isomeria nei composti organici
Contenuti
I componenti delle macromolecole biologiche • Struttura e funzione dei carboidrati • Struttura e funzione dei lipidi • Struttura e funzione degli acidi nucleici • Amminoacidi e legame peptidico • Struttura e funzione delle proteine • Nomenclatura e meccanismo d’azione degli enzimi • I cofattori • La cinetica enzimatica • Le vitamine
Traguardo competenze
Dedurre il ruolo delle biomolecole dalla loro struttura • Classificare i tipi di carboidrati e metterne in relazione la struttura con la funzione • Classificare i tipi di lipidi • Classificare i tipi di acidi nucleici • Descrivere la struttura di DNA ed RNA • Classificare i tipi di amminoacidi • Spiegare come si forma il legame peptidico • Descrivere la struttura delle proteine e le loro molteplici funzioni • Analizzare i meccanismi della catalisi enzimatica • Identificare i fattori di regolazione della cinetica enzimatica e illustrarne i meccanismi di azione
Momento didattico
Spiegazione in classe
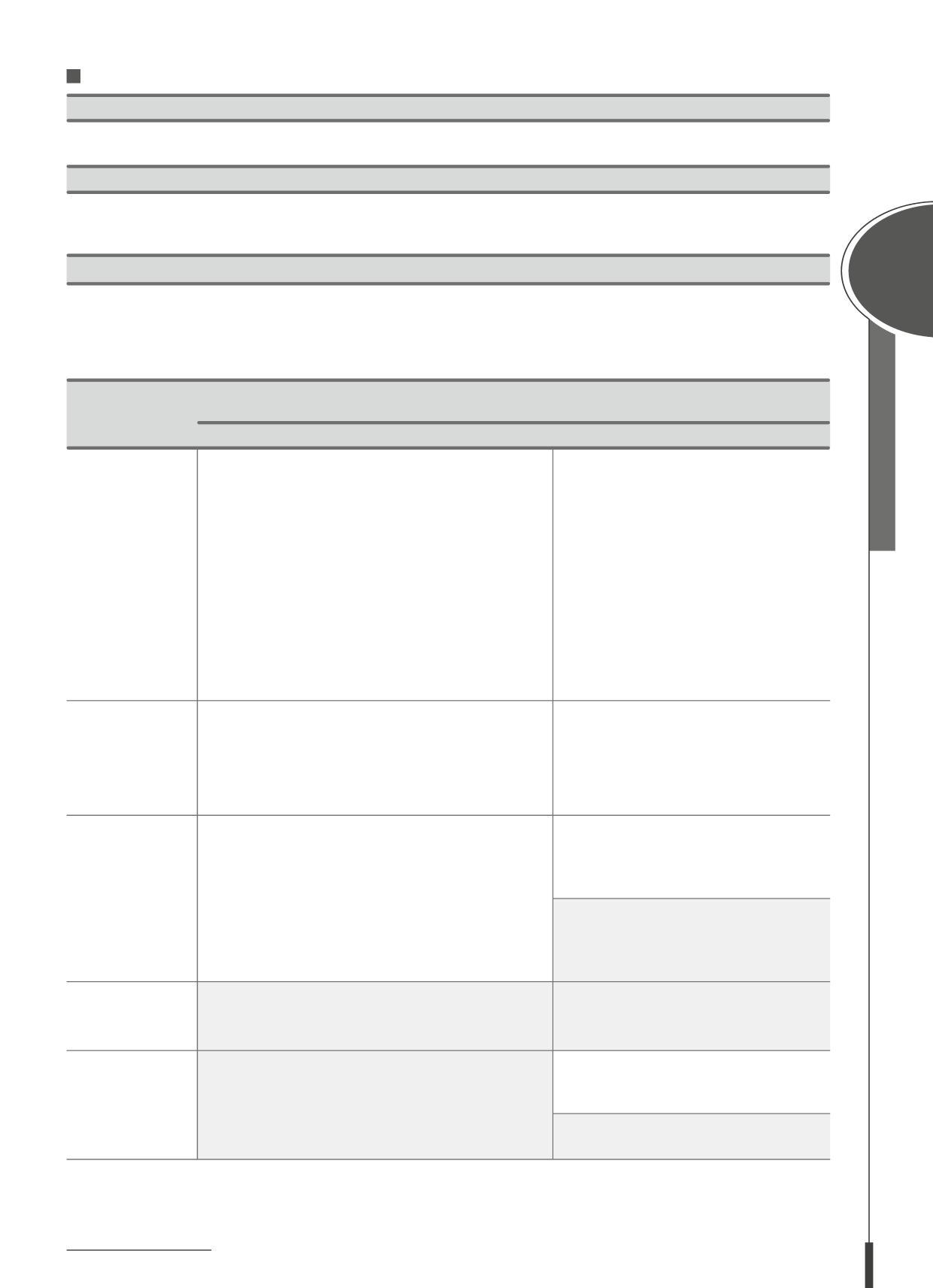
Risorse (in grigio chiaro i contenuti specifici per il docente)
Volume e Guida per il docente
• TEMA B: La chimica della vita
• Paragrafi:
3.1 La biochimica e le biomolecole
3.2 I carboidrati
3.3 I lipidi
3.4 Gli amminoacidi, i peptidi e le proteine
3.5 Gli enzimi e la catalisi
3.6 Le vitamine
3.7 Gli acidi nucleici
Attività formative (consolidamento delle conoscenze)
Approfondimenti e didattica cooperativa (sviluppo delle competenze)
• Risposta breve: domande in itinere per l’esposizione orale
• Problemi guidati dell’Unità
• Ripassa con metodo di fine Unità
• Conoscenze e abilità di fine Unità
• Autoverifica di fine Tema
• Costruisci le competenze di fine Unità
• Guida all’esposizione orale
• Collega: attività di consolidamento multidisciplinare
• Linea del tempo di fine Tema Storie e idee della biochimica: Breve storia delle vitamine
• Scheda Understanding Our World With STEM di fine Tema: How to industrially produce a vitamin
• Scheda Educazione civica di fine Tema: Proteggersi dall’inquinamento con l’alimentazione
Valutazione • Soluzione degli esercizi proposti nel volume
• Prove di valutazione
• Soluzione delle prove di valutazione
Didattica Inclusiva • Prove di valutazione per obiettivi minimi
• Soluzione delle prove di valutazione per obiettivi minimi
In digitale
• Video: L’isomeria nei monosaccaridi; Allergie vs intolleranze; I legami alfa e beta del glucosio; La nomenclatura degli acidi grassi; Gli acidi grassi cis e trans
• Avogadro: Monosaccaridi e stereoisomeria; Monosaccaridi e anomeria; Fluidità di membrana: saturi o insaturi?; Fluidità di membrana: cis o trans?; Il legame peptidico: costruisci un tripeptide; Proteine: le strutture; Proteine: alfa elica, beta foglietto e loop; Gli acidi nucleici: DNA e RNA
• Podcast: Dorothy Crowfoot Hodgkin; Sir Walter Norman Haworth
• Esercizi aggiuntivi sulla piattaforma HUB Test
• Autoverifica di fine Tema in modalità autocorrettiva
• Compito di realtà versione studente
• Compito di realtà versione docente
• Lezioni digitali
• Prove di valutazione modificabili
• Verifica in Moduli Google
• HUB Test versione docente
• Sintesi e audiosintesi in italiano
• Sintesi in inglese, francese e spagnolo
• Mappa modificabile e personalizzabile
• Prove di valutazione per obiettivi minimi modificabili
U4 – Il metabolismo e la fotosintesi
Prerequisiti
Caratteristiche e reattività di carboidrati e lipidi • La molecola di ATP • Il ruolo di enzimi e coenzimi • Reazioni di ossidoriduzione • Assorbimento ed emissione di energia da parte degli atomi • I carboidrati
Contenuti
Significato di via metabolica e network metabolico della cellula • Le vie metaboliche del glucosio • La glicolisi • Le fermentazioni lattica e alcolica • Le reazioni del ciclo di Krebs e della fosforilazione ossidativa • La via del pentosio fosfato, la glicogenesi e la glicogenolisi • Panoramica sul metabolismo di lipidi e proteine • Che cos’è la fotosintesi • La fase luminosa, I sistemi antenna e i fotosistemi, la catena di trasporto degli elettroni e la fotofosforilazione • La fase oscura: il ciclo di Calvin • Gli adattamenti delle piante
Traguardo competenze
Prendere in esame le vie metaboliche distinguendo vie anaboliche e cataboliche • Spiegare le vie metaboliche dei glucidi e riconoscere le differenze tra respirazione e fermentazione • Spiegare le vie metaboliche dei lipidi • Spiegare le vie metaboliche degli amminoacidi • Illustrare il processo della fotosintesi descrivendo le diverse fasi • Riconoscere le reazioni chimiche che caratterizzano le varie fasi della fotosintesi • Riconoscere le proprietà dei composti organici e metterle in relazione con le interazioni tra le molecole e gli altri fattori che influenzano la reattività • Descrivere e confrontare i metabolismi C3, C4 e CAM
Momento didattico
Spiegazione in classe
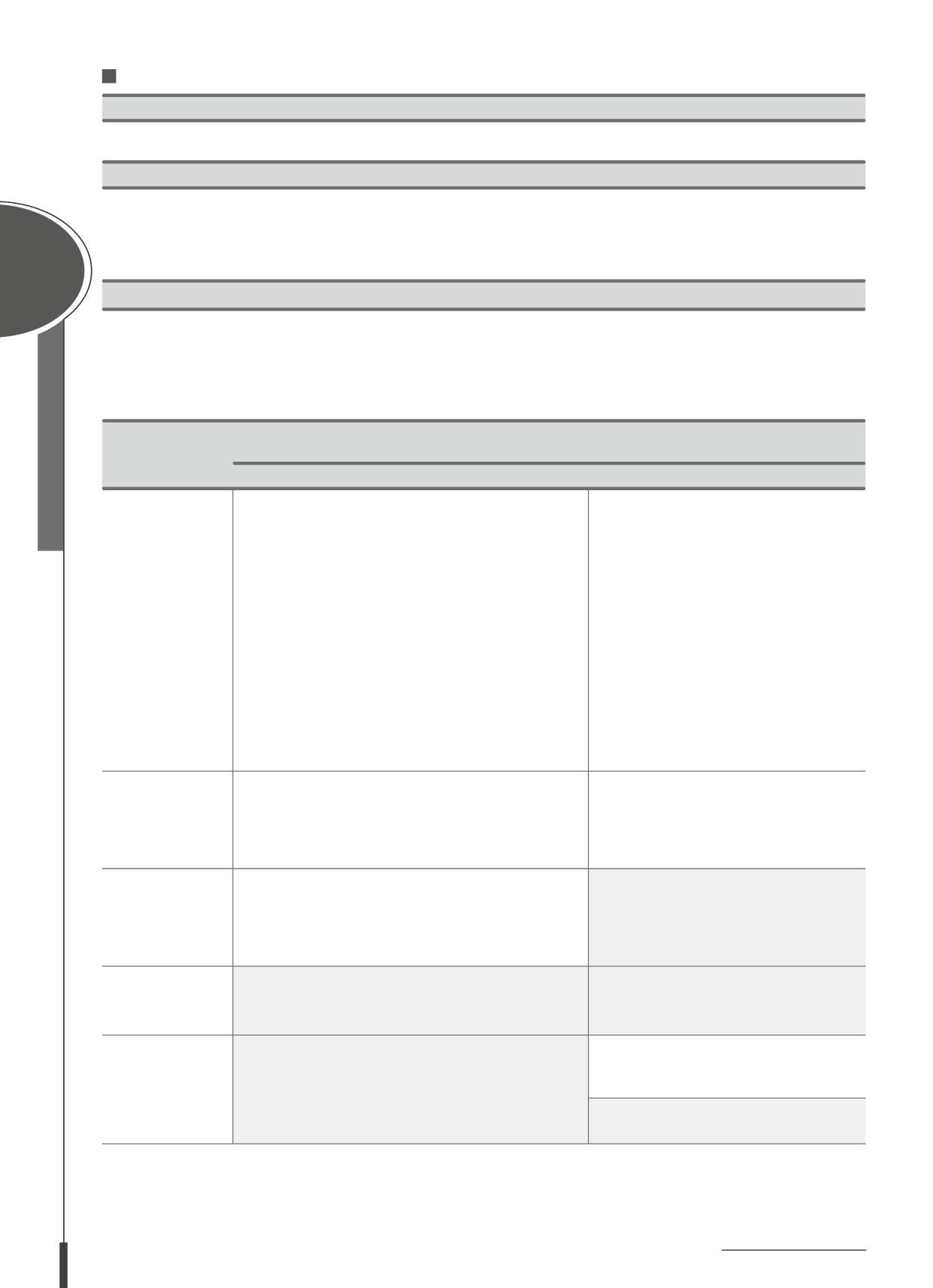
Attività formative (consolidamento delle conoscenze)
Approfondimenti e didattica cooperativa (sviluppo delle competenze)
Valutazione
Didattica Inclusiva
Risorse (in grigio chiaro i contenuti specifici per il docente)
Volume e Guida per il docente
• Paragrafi:
4.1 Il metabolismo cellulare
4.2 Il ciclo dell’ATP
4.3 Il metabolismo dei carboidrati: una panoramica
4.4 Il metabolismo del glicogeno
4.5 La glicolisi
4.6 Il metabolismo aerobico del glucosio
4.7 Il metabolismo anaerobico del glucosio
4.8 La resa energetica complessiva del metabolismo del glucosio
4.9 Altre vie metaboliche del glucosio
4.10 Il metabolismo di lipidi e proteine: una panoramica
4.11 Che cos’è la fotosintesi
4.12 La fase luminosa
4.13 La fase oscura: il ciclo di Calvin
4.14 Gli adattamenti delle piante
• Risposta breve: domande in itinere per l’esposizione orale
• Problemi guidati dell’Unità
• Ripassa con metodo di fine Unità
• Conoscenze e abilità di fine Unità
• Costruisci le competenze di fine Unità
• Guida all’esposizione orale
• Collega: attività di consolidamento multidisciplinare
• Soluzione degli esercizi proposti nel volume
• Prove di valutazione
• Soluzione delle prove di valutazione
• Prove di valutazione per obiettivi minimi
• Soluzione delle prove di valutazione per obiettivi minimi
In digitale
• Presentazione LIM dell’unità
• Video: Il metabolismo; Acetil-CoA: il punto di snodo della respirazione cellulare; La catena respiratoria; La catalisi rotazionale dell’ATP; La fase luminosa della fotosintesi
• Esercizi aggiuntivi sulla piattaforma HUB Test
• Lezioni digitali
• Prove di valutazione modificabili
• Verifica in Moduli Google
• HUB Test versione docente
• Sintesi e audiosintesi in italiano
• Sintesi in inglese, francese e spagnolo
• Mappa modificabile e personalizzabile
• Prove di valutazione per obiettivi minimi modificabili
U5 – I geni e la loro regolazione
Prerequisiti
Gli acidi nucleici • I legami intermolecolari • Le proteine
Contenuti
Concetto di gene e di regolazione genica • Geni regolatori e costitutivi • Meccanismo di duplicazione del DNA • Fattori di regolazione genica • Regolazione dell’espressione genica nei procarioti: operone lac e operone trp, altri meccanismi • Regolazione dell’espressione genica negli eucarioti • Regolazione dell’espressione genica nei virus • SARS-CoV-2 • Trasferimento genico orizzontale nei procarioti • Plasmidi e trasposoni
Traguardo competenze
Riconoscere i meccanismi associati alla duplicazione del DNA e alla sintesi proteica • Descrivere i meccanismi di regolazione genica dei procarioti e degli eucarioti • Descrivere i virus • Descrivere il meccanismo di riproduzione dei virus • Descrivere le diverse modalità di trasferimento genico nei procarioti
Momento didattico
Spiegazione in classe
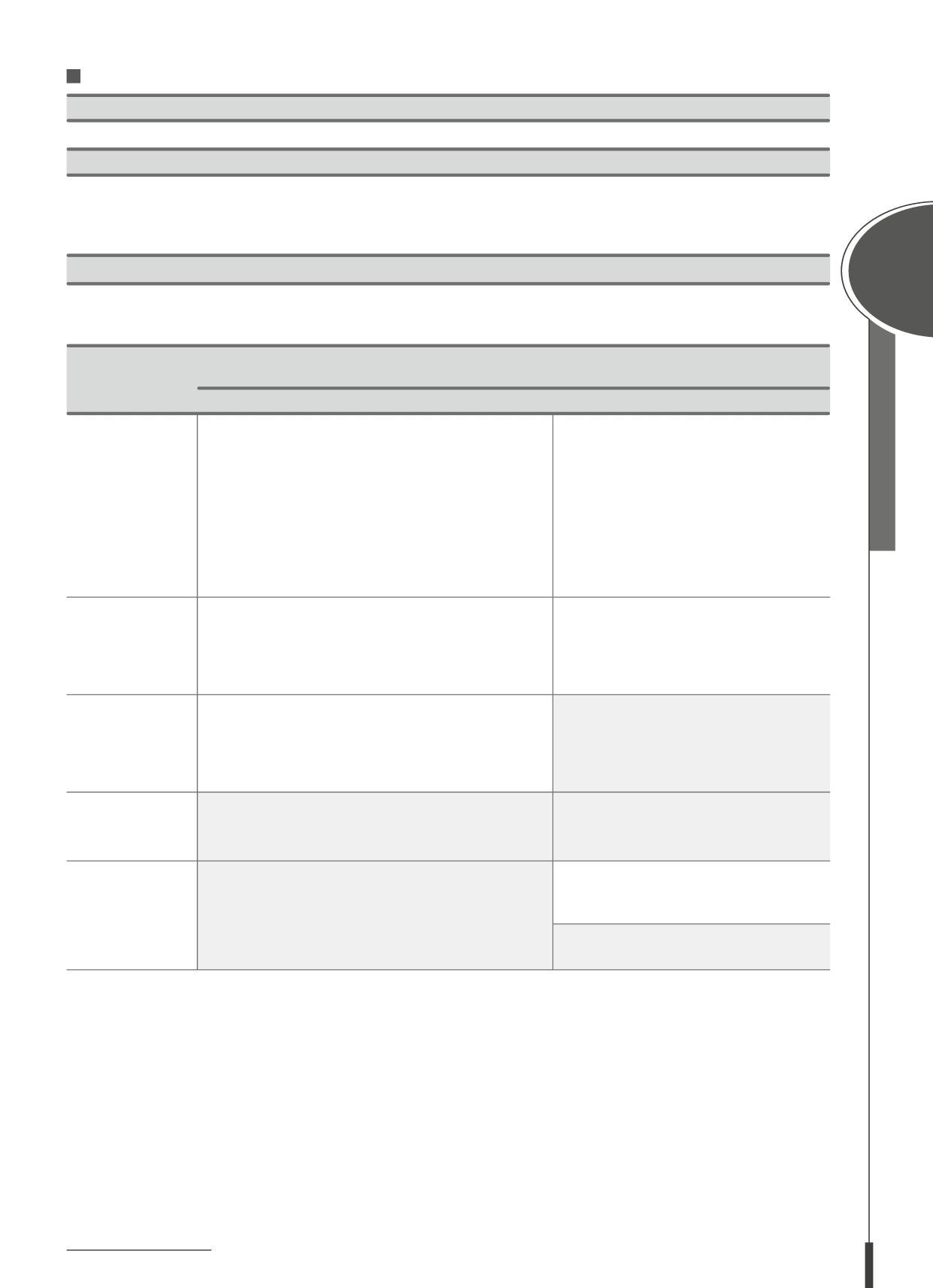
Attività formative (consolidamento delle conoscenze)
Approfondimenti e didattica cooperativa (sviluppo delle competenze)
Risorse (in grigio chiaro i contenuti specifici per il docente)
Volume e Guida per il docente
• Paragrafi: 5.1 La replicazione del DNA
5.2 L’espressione genica: trascrizione e traduzione
5.3 La regolazione dell’espressione genica nei procarioti
5.4 La regolazione dell’espressione genica negli
eucarioti
5.5 I virus
5.6 SARS-CoV-2
5.7 Il trasferimento genico orizzontale nei procarioti
5.8 Gli elementi genetici mobili
• Risposta breve: domande in itinere per l’esposizione orale
• Problemi guidati dell’Unità
• Ripassa con metodo di fine Unità
• Conoscenze e abilità di fine Unità
• Costruisci le competenze di fine Unità
• Guida all’esposizione orale
• Collega: attività di consolidamento multidisciplinare
Valutazione • Soluzione degli esercizi proposti nel volume
• Prove di valutazione
• Soluzione delle prove di valutazione
Didattica Inclusiva • Prove di valutazione per obiettivi minimi
• Soluzione delle prove di valutazione per obiettivi minimi
In digitale
• Video: Duplicazione del DNA; Il codice genetico; La regolazione dell’espressione genica; La scoperta degli introni; Viruses (online); Il ciclo riproduttivo di SARS-CoV-2
• Esercizi aggiuntivi sulla piattaforma HUB Test
• Lezioni digitali
• Prove di valutazione modificabili
• Verifica in Moduli Google
• HUB Test versione docente
• Sintesi e audiosintesi in italiano
• Sintesi in inglese, francese e spagnolo
• Mappa modificabile e personalizzabile
• Prove di valutazione per obiettivi minimi modificabili
U6 – Dal DNA ricombinante alle biotecnologie
Prerequisiti
I plasmidi • Le proteine • Il trasferimento genico • DNA e RNA • I geni • Virus e batteri
Contenuti
Gli strumenti della biologia molecolare e dell’ingegneria genetica: la tecnologia del DNA ricombinante, gli enzimi di restrizione, i vettori, la DNA ligasi, il clonaggio molecolare • Caratteristiche e significato delle librerie genomiche • Metodi per amplificare e identificare le sequenze di DNA: PCR ed elettroforesi • Metodo dei terminatori di catena o metodo di Sanger • Le tecniche per lo studio dei geni: knock-out e modificazioni geniche, scienze omiche • Editing genomico e CRISPR-Cas9 • La bioinformatica nel contesto della genetica • Definizione di biotecnologie e prodotti ottenibili con processi biotecnologici • Organismi geneticamente modificati • Biotecnologie utilizzate in agricoltura • Biotecnologie usate nei processi industriali • Biotecnologie per l’ambiente • Biotecnologie in campo medico • Caratteristiche delle cellule staminali e loro utilizzi • Organismi clonati
Traguardo competenze
Spiegare cosa sono e come funzionano la tecnologia del DNA ricombinante, gli enzimi di restrizione e il clonaggio molecolare • Spiegare i metodi per amplificare e identificare sequenze di DNA • Descrivere il significato di genomica e delle altre scienze omiche • Classificare le biotecnologie • Descrivere le biotecnologie in campo agroalimentare • Descrivere le biotecnologie in campo industriale e ambientale e individuarne le applicazioni • Descrivere le biotecnologie in campo biomedico e individuarne le applicazioni
Momento didattico
Spiegazione in classe
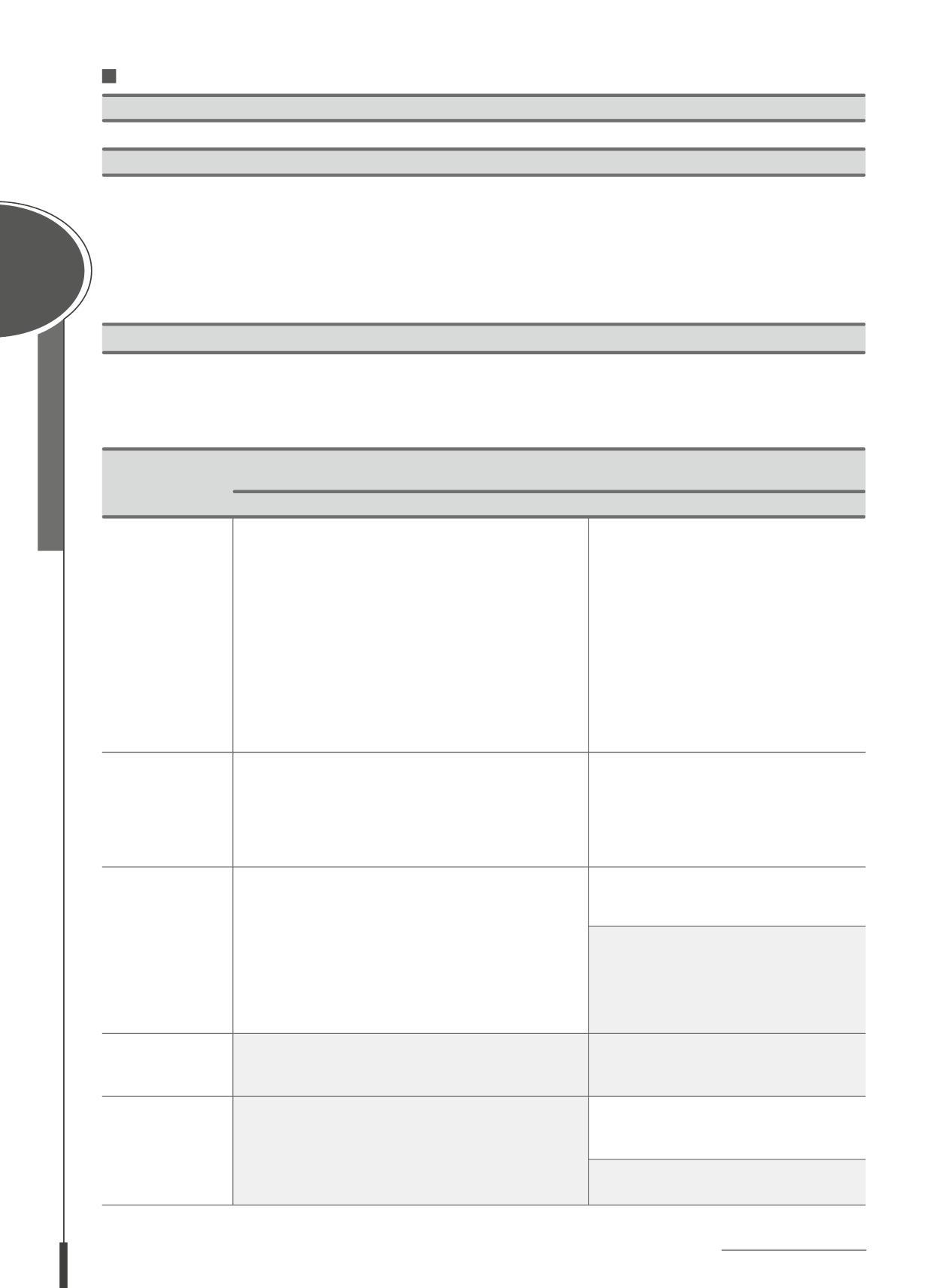
Attività formative (consolidamento delle conoscenze)
Risorse (in grigio chiaro i contenuti specifici per il docente)
Volume e Guida per il docente
• TEMA C: Le tecnologie per la vita
• Paragrafi:
6.1 Le biotecnologie
6.2 Dal DNA ricombinante al clonaggio
6.3 La reazione a catena della polimerasi
6.4 Estrazione e separazione del DNA
6.5 Il DNA e le analisi forensi
6.6 Il sequenziamento del DNA
6.7 Dalla genomica alle altre scienze omiche
6.8 Le piante e gli animali geneticamente modificati
6.9 Biotecnologie ambientali e applicazioni industriali
6.10 Biotecnologie per la salute umana
6.11 Editing genomico e CRISPR-Cas9
• Risposta breve: domande in itinere per l’esposizione orale
• Problemi guidati dell’Unità
• Ripassa con metodo di fine Unità
• Conoscenze e abilità di fine Unità
• Autoverifica di fine Tema
Approfondimenti e didattica cooperativa (sviluppo delle competenze)
Valutazione
Didattica Inclusiva
• Costruisci le competenze di fine Unità
• Guida all’esposizione orale
• Collega: attività di consolidamento multidisciplinare
• Linea del tempo di fine Tema Storie e idee della biologia: Breve storia dell’editing genomico
• Scheda Understanding Our World With STEM di fine Tema: CRISPR/Cas9 applied to gene therapy
• Scheda Educazione civica di fine Tema: L’impatto delle piante GM sulla biodiversità
• Soluzione degli esercizi proposti nel volume
• Prove di valutazione
• Soluzione delle prove di valutazione
• Prove di valutazione per obiettivi minimi
• Soluzione delle prove di valutazione per obiettivi minimi
In digitale
• Video: La tecnologia del DNA ricombinante; Clonaggio molecolare; Kary Banks Mullis; La reazione a catena della polimerasi; Il DNA e le scienze forensi; Scienze forensi: applicazioni ed esempi; Il DNA fingerprinting; Il sequenziamento del DNA; I microarray di DNA; Ibridi, chimere e OGM; Molecole organiche: energia dalle biomasse; La terapia genica; Editing genetico con sistema CRISPR/Cas9
• Podcast: Kary Banks Mullis; Jennifer Doudna ed Emmanuelle Charpentier
• Esercizi aggiuntivi sulla piattaforma HUB Test
• Autoverifica di fine Tema in modalità autocorrettiva
• Compito di realtà versione studente
• Compito di realtà versione docente
• Lezioni digitali
• Prove di valutazione modificabili
• Verifica in Moduli Google
• HUB Test versione docente
• Sintesi e audiosintesi in italiano
• Sintesi in inglese, francese e spagnolo
• Mappa modificabile e personalizzabile
• Prove di valutazione per obiettivi minimi modificabili
U7 – La struttura interna della Terra
Prerequisiti
Concetti di base di chimica e di Scienze della Terra
Contenuti
Definizione delle caratteristiche di un minerale e descrizione delle diverse proprietà fisiche dei minerali • Definizione dei diversi tipi di rocce in base ai processi che portano alla loro formazione • Descrizione del campo magnetico • Descrizione della struttura interna della Terra • Descrizione della struttura tipica di un vulcano e illustrazione dei meccanismi eruttivi di vulcani con attività esplosiva ed effusiva • Descrizione dei vulcani centrali e lineari • Illustrazione dei principali vulcani italiani • Descrizione della manifestazione di un evento sismico e caratteristiche delle onde sismiche • Illustrazione delle scale Richter e MCS per misurare l’energia liberata e l’intensità di un terremoto • Descrizione del rischio sismico nel territorio italiano
Traguardo competenze
Riconoscere le principali proprietà fisiche dei minerali e i principali tipi di minerali • Distinguere tra i diversi tipi di rocce • Individuare le componenti di un vulcano e riconoscere i diversi tipi di eruzione e di attività vulcanica • Individuare i vulcani presenti sul territorio italiano • Spiegare come si genera un terremoto e quali sono le caratteristiche delle diverse onde sismiche • Illustrare i metodi per misurare i terremoti, l’energia da essi liberata e l’intensità della scossa • Saper calcolare il rischio sismico di un’area
Momento didattico
Spiegazione in classe
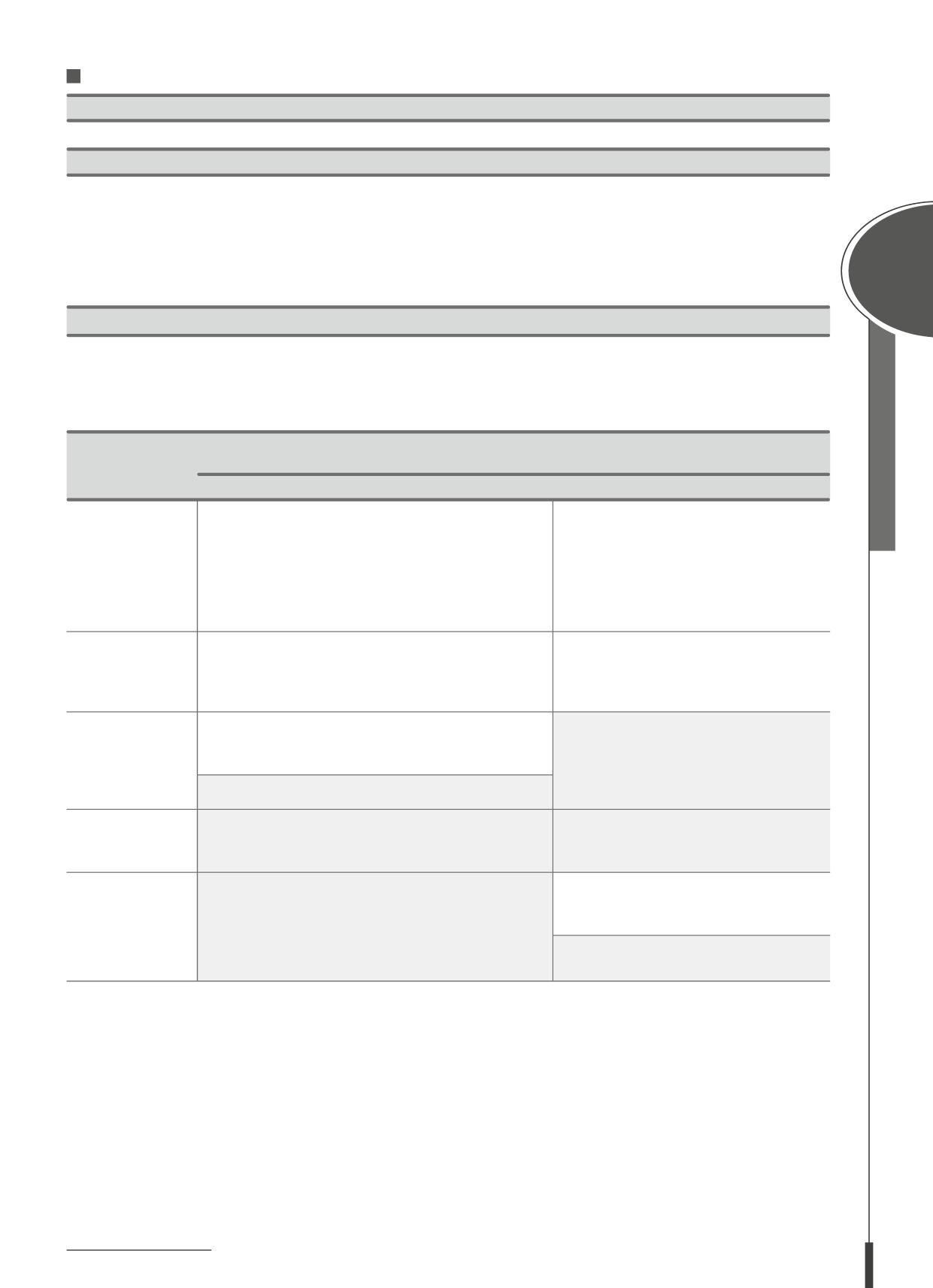
Attività formative (consolidamento delle conoscenze)
Approfondimenti e didattica cooperativa (sviluppo delle competenze)
Valutazione
Didattica Inclusiva
Risorse (in grigio chiaro i contenuti specifici per il docente)
Volume e Guida per il docente
• Paragrafi:
7.1 La Terra, un sistema da conservare
7.2 Densità e composizione dei materiali terrestri
7.3 La struttura interna del pianeta e la sismologia
7.4 Il calore terrestre
7.5 Il vulcanismo
7.6 Il campo magnetico
• Risposta breve: domande in itinere per l’esposizione orale
• Ripassa con metodo di fine Unità
• Conoscenze e abilità di fine Unità
• Costruisci le competenze di fine Unità
• Guida all’esposizione orale
• Collega: attività di consolidamento multidisciplinare
• Prove di valutazione
• Soluzione degli esercizi proposti nel volume
• Prove di valutazione
• Soluzione delle prove di valutazione
• Prove di valutazione per obiettivi minimi
• Soluzione delle prove di valutazione per obiettivi minimi
In digitale
• Video: I minerali e le rocce; Cosa sono i terremoti; I terremoti; Come difendersi dai terremoti; I vulcani
• Approfondimenti: I minerali; Le rocce ignee; I fenomeni vulcanici
• Esercizi aggiuntivi sulla piattaforma HUB Test
• Lezioni digitali
• Prove di valutazione modificabili
• Verifica in Moduli Google
• HUB Test versione docente
• Sintesi e audiosintesi in italiano
• Sintesi in inglese, francese e spagnolo
• Mappa modificabile e personalizzabile
• Prove di valutazione per obiettivi minimi modificabili
U8 – La dinamica terrestre
Prerequisiti
Struttura interna della Terra • Minerali e rocce • Vulcani e terremoti • La deriva dei continenti • La teoria della tettonica delle placche • Teoria dell’espansione dei fondali • Orogenesi
Contenuti
Spiegazione del comportamento meccanico delle rocce e definizione di pieghe e faglie
Traguardo competenze
Riconoscere le pieghe e le faglie presenti sul territorio e spiegarne la genesi • Distinguere le diverse teorie che spiegano il movimento della crosta terrestre
Momento
didattico Risorse (in grigio chiaro i contenuti specifici per il docente)
Spiegazione in classe
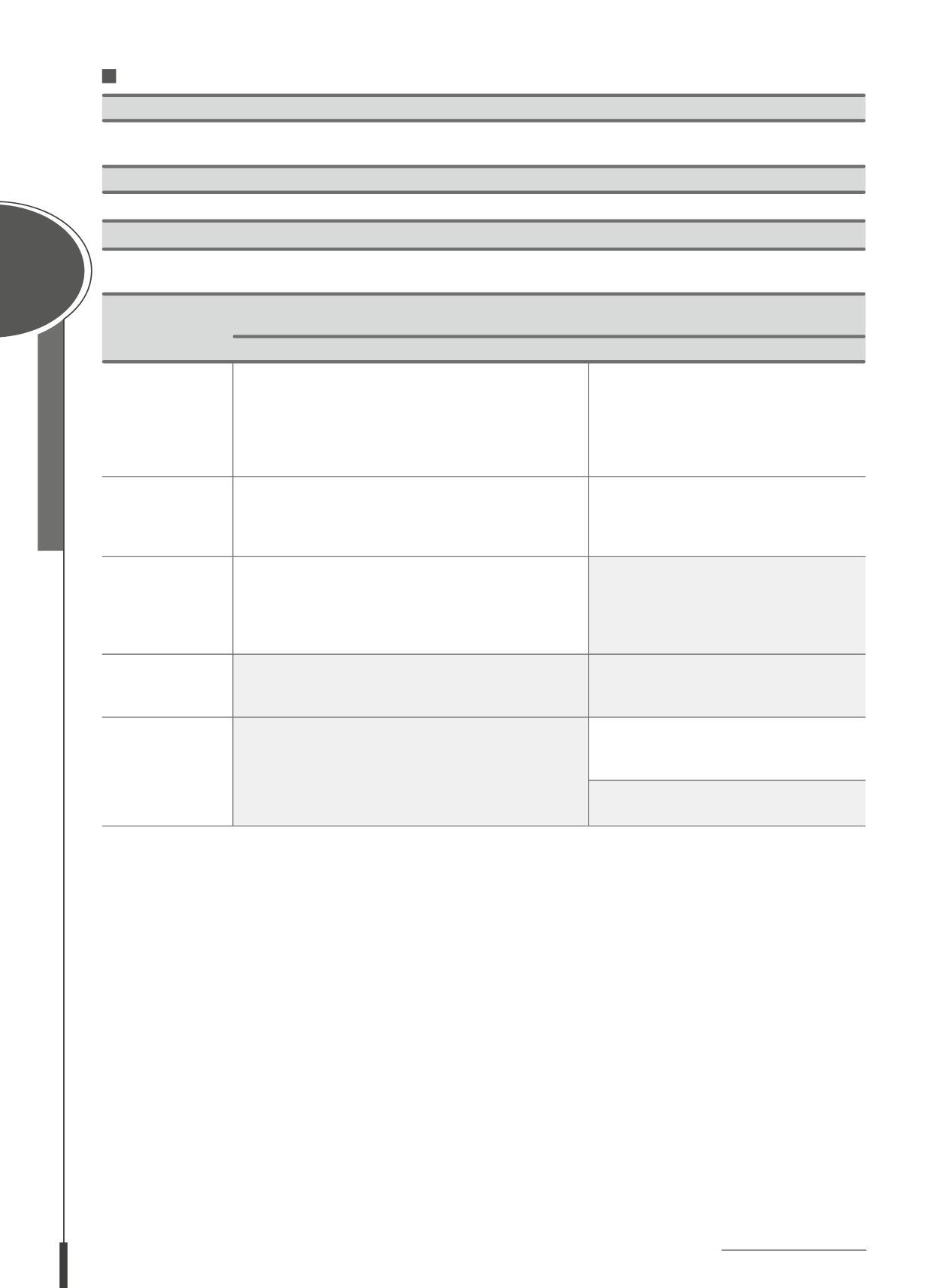
Attività formative (consolidamento delle conoscenze)
Approfondimenti e didattica cooperativa (sviluppo delle competenze)
Valutazione
Didattica Inclusiva
Volume e Guida per il docente
• Paragrafi:
8.1 La teoria della deriva dei continenti
8.2 L’esplorazione degli oceani e la teoria dell’espansione dei fondali
8.3 La teoria della tettonica delle placche
8.4 Le forze che muovono le placche
• Risposta breve: domande in itinere per l’esposizione orale
• Ripassa con metodo di fine Unità
• Conoscenze e abilità di fine Unità
• Costruisci le competenze di fine Unità
• Guida all’esposizione orale
• Collega: attività di consolidamento multidisciplinare
• Soluzione degli esercizi proposti nel volume
• Prove di valutazione
• Soluzione delle prove di valutazione
• Prove di valutazione per obiettivi minimi
• Soluzione delle prove di valutazione per obiettivi minimi
In digitale
• Video: La dinamica terrestre
• Approfondimenti: La scala cronostratigrafica; Le rocce sedimentarie; Le rocce metamorfiche
• Esercizi aggiuntivi sulla piattaforma HUB Test
• Lezioni digitali
• Prove di valutazione modificabili
• Verifica in Moduli Google
• HUB Test versione docente
• Sintesi e audiosintesi in italiano
• Sintesi in inglese, francese e spagnolo
• Mappa modificabile e personalizzabile
• Prove di valutazione per obiettivi minimi modificabili
U9 – La dinamica dell’atmosfera
Prerequisiti
Caratteristiche dei gas • Radiazioni elettromagnetiche • Caratteristiche e dinamica dell’atmosfera
Contenuti
Struttura dell’atmosfera • Bilancio radiativo Terra-atmosfera • Principali tipi di inquinamento atmosferico e dell’effetto serra • Temperatura dell’aria e pressione atmosferica • Dinamiche della circolazione atmosferica • Umidità atmosferica • Diversi tipi di nubi • I diversi tipi di precipitazioni e perturbazioni atmosferiche • Previsioni del tempo • Definizione di clima e classificazione dei climi sulla Terra • Cambiamento climatico • Mitigazione climatica e adattamento
Traguardo competenze
Argomentare la validità delle prove a supporto del cambiamento climatico • Argomentare i diversi scenari sugli effetti del cambiamento climatico • Proporre misure di mitigazione e adattamento al cambiamento climatico • Schematizzare il funzionamento dei principali tipi di impianti energetici da fonti rinnovabili e non rinnovabili • Individuare i tipi di fonti rinnovabili più adatti ai diversi luoghi e le diverse possibilità di implementazione • Riflettere sulla propria impronta ecologica
Momento didattico
Spiegazione in classe
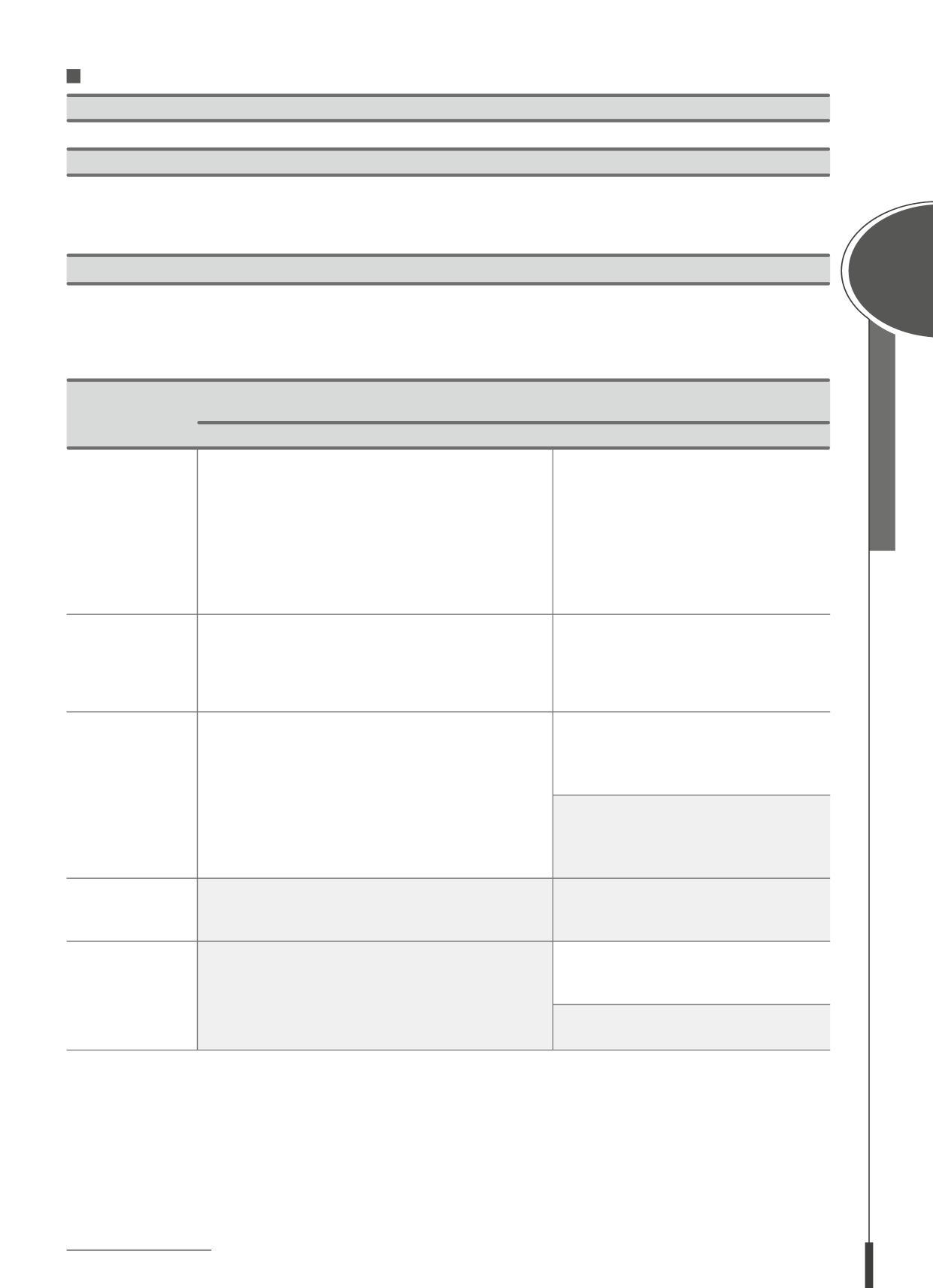
Attività formative (consolidamento delle conoscenze)
Approfondimenti e didattica cooperativa (sviluppo delle competenze)
Risorse (in grigio chiaro i contenuti specifici per il docente)
Volume e Guida per il docente In digitale
• TEMA D: Dinamica e risorse del sistema Terra
• Paragrafi:
9.1 Le caratteristiche dell’atmosfera
9.2 Il riscaldamento dell’atmosfera
9.3 Tempo e fenomeni meteorologici complessi
9.4 I climi della Terra
9.5 Il cambiamento climatico
9.6 Mitigazione climatica e adattamento
• Risposta breve: domande in itinere per l’esposizione orale
• Ripassa con metodo di fine Unità
• Conoscenze e abilità di fine Unità
• Autoverifica di fine Tema
• Costruisci le competenze di fine Unità
• Guida all’esposizione orale
• Collega: attività di consolidamento multidisciplinare
• Linea del tempo di fine Tema Storie e idee di Scienze della Terra: Breve storia degli accordi sul clima
• Scheda Understanding Our World With STEM di fine Tema: The climate puzzle solved by attribution science
• Scheda Educazione civica di fine Tema: Agire contro il cambiamento climatico
Valutazione • Soluzione degli esercizi proposti nel volume
• Prove di valutazione
• Soluzione delle prove di valutazione
Didattica Inclusiva • Prove di valutazione per obiettivi minimi
• Soluzione delle prove di valutazione per obiettivi minimi
• Video: L’effetto serra; Le precipitazioni; Le previsioni del tempo; APPassionati di meteo; Gli ambienti e i biomi; I cambiamenti climatici
• Approfondimenti: Lo spettro elettromagnetico; I venti
• Podcast: Mario José Molina; Giorgio Parisi; Syukuro Manabe e Klaus Hasselmann
• Esercizi aggiuntivi sulla piattaforma HUB Test
• Autoverifica di fine Tema in modalità autocorrettiva
• Compito di realtà versione studente
• Compito di realtà versione docente
• Lezioni digitali
• Prove di valutazione modificabili
• Verifica in Moduli Google
• HUB Test versione docente
• Sintesi e audiosintesi in italiano
• Sintesi in inglese, francese e spagnolo
• Mappa modificabile e personalizzabile
• Prove di valutazione per obiettivi minimi modificabili
U10 – Le scienze per la sostenibilità
Prerequisiti
Caratteristiche e dinamica dell’atmosfera • Tipi di energia • Interazioni tra le sfere che compongono la Terra • Concetti di base di ecologia
Contenuti
Antropocene • Diverse fonti di energia rinnovabili e non rinnovabili • Processo di formazione, modalità di utilizzo e degli impatti dei combustibili fossili • Modalità di produzione dell’energia nucleare • Fonti di energia rinnovabili • Concetti di sviluppo sostenibile e di economia circolare • Transizione energetica
Traguardo competenze
Definizione del termine Antropocene • Argomentare vantaggi e svantaggi delle fonti di energia non rinnovabili e rinnovabili • Individuare i tipi di fonti rinnovabili più adatti ai diversi luoghi e le diverse possibilità di implementazione • Spiegare il significato di sviluppo sostenibile e di economia circolare ponendoli nell’attuale contesto socio-economico e ambientale
Momento didattico
Spiegazione in classe
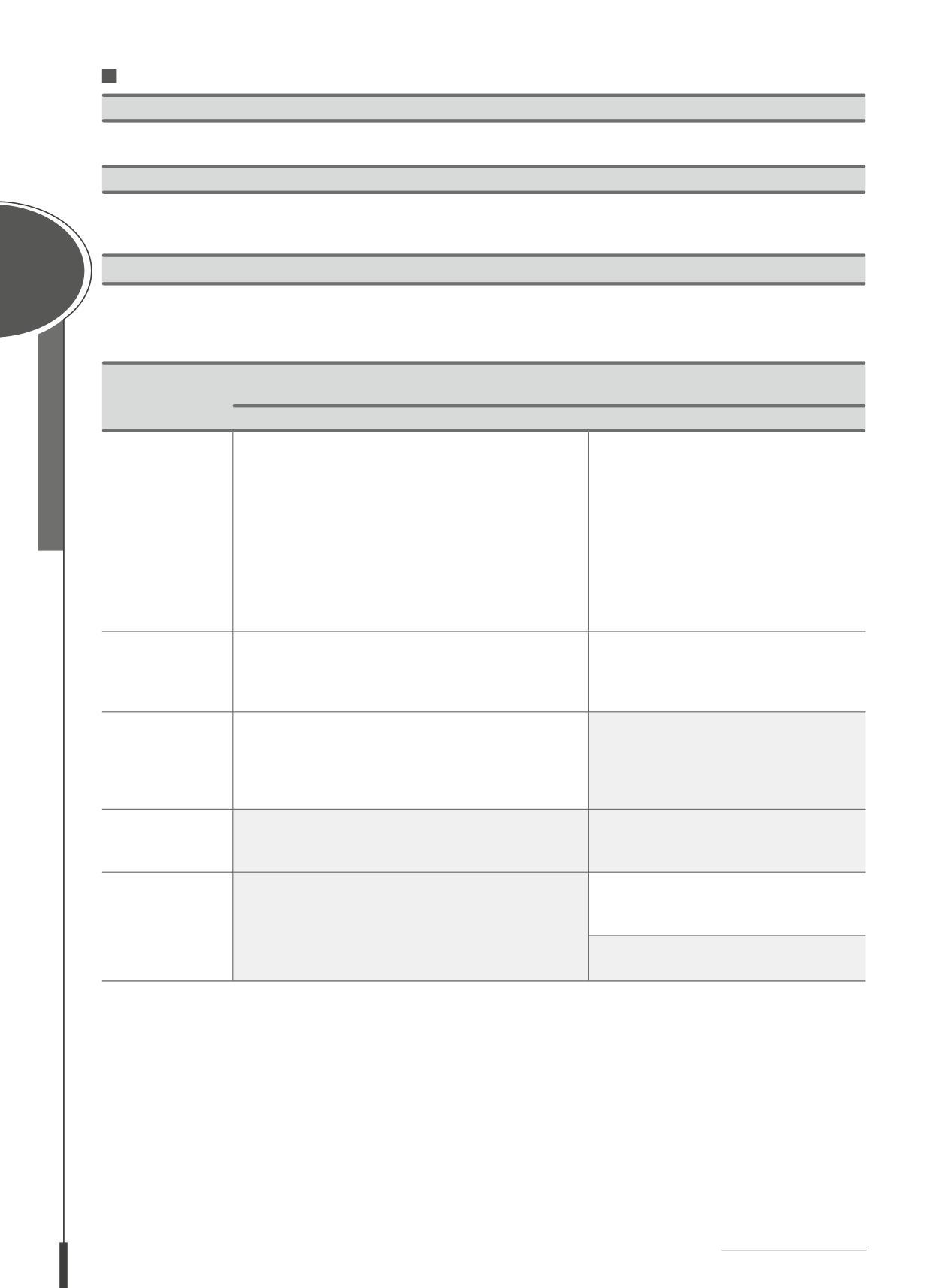
Attività formative (consolidamento delle conoscenze)
Approfondimenti e didattica cooperativa (sviluppo delle competenze)
Valutazione
Didattica Inclusiva
Risorse (in grigio chiaro i contenuti specifici per il docente)
Volume e Guida per il docente
• Paragrafi:
10.1 L’Antropocene
10.2 Le fonti di energia non rinnovabili
10.3 Le fonti di energia rinnovabili
10.4 Le risorse minerarie
10.5 Sviluppo sostenibile e Agenda 2030
10.6 Economia circolare e transizione energetica
• Risposta breve: domande in itinere per l’esposizione orale
• Ripassa con metodo di fine Unità
• Conoscenze e abilità di fine Unità
• Costruisci le competenze di fine Unità
• Guida all’esposizione orale
• Collega: attività di consolidamento multidisciplinare
• Soluzione degli esercizi proposti nel volume
• Prove di valutazione
• Soluzione delle prove di valutazione
• Prove di valutazione per obiettivi minimi
• Soluzione delle prove di valutazione per obiettivi minimi
In digitale
• Video: Le fonti energetiche; Energie non rinnovabili; Energie rinnovabili; La sostenibilità; Ambiente e sviluppo sostenibile; 17 video sugli obiettivi dell’Agenda 2030; L’economia circolare
• Approfondimenti: La scala cronostratigrafica; Le rocce sedimentarie; I cicli biogeochimici; Una guida all’energia della Terra
• Podcast: Stanley Whittingham, Akira Yoshino e John Bannister Goodenough
• Esercizi aggiuntivi sulla piattaforma HUB Test
• Lezioni digitali
• Prove di valutazione modificabili
• Verifica in Moduli Google
• HUB Test versione docente
• Sintesi e audiosintesi in italiano
• Sintesi in inglese, francese e spagnolo
• Mappa modificabile e personalizzabile
• Prove di valutazione per obiettivi minimi modificabili
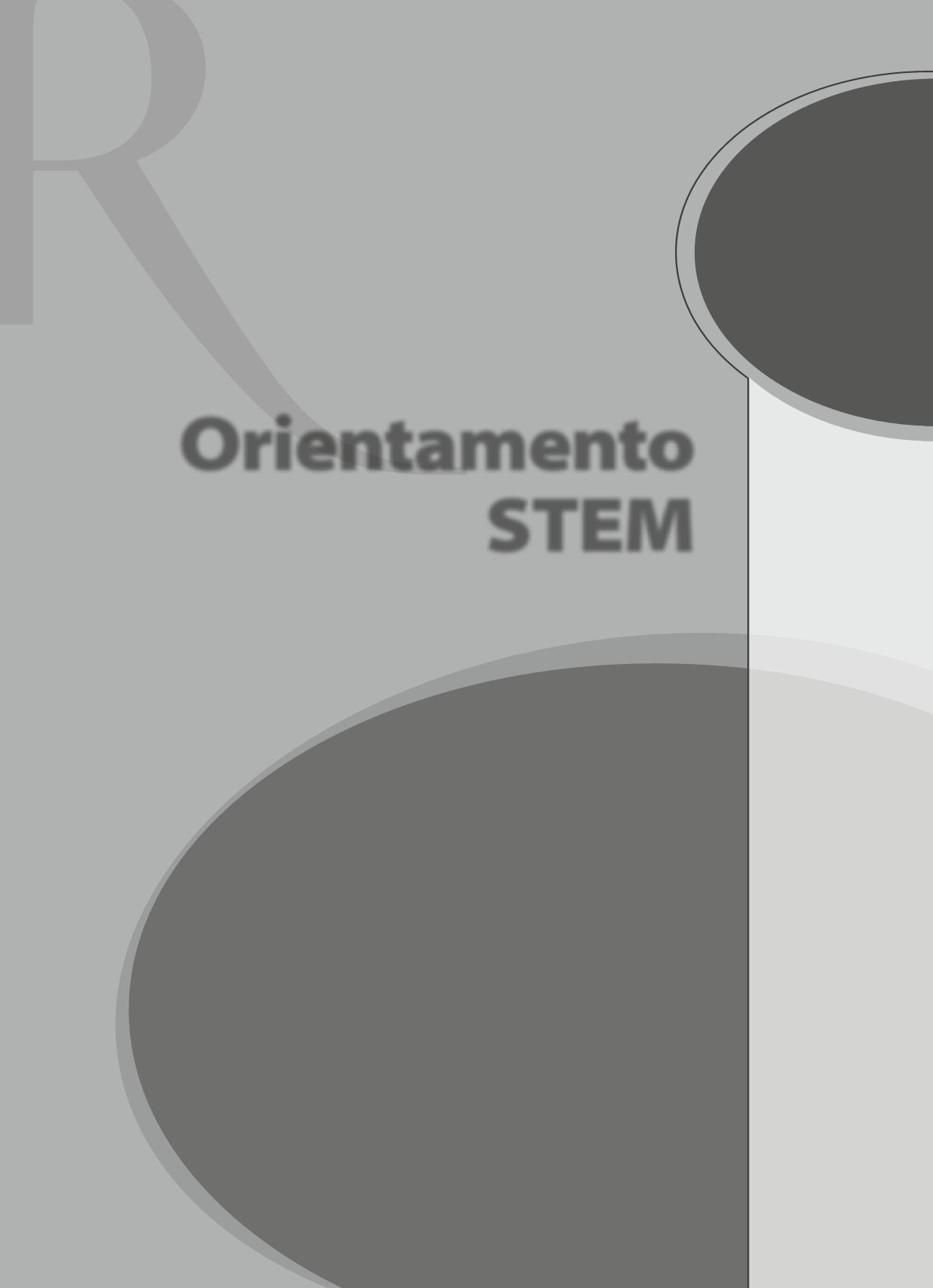
3
Orientamento STEM
RiGenerazione Scuola e Orientamento scolastico
3.1 RiGenerazione Scuola
Nel 2021 il Ministero dell’Istruzione ha approvato il Piano RiGenerazione Scuola per la transizione ecologica e culturale, con l’obiettivo principale di educare le studentesse e gli studenti a nuovi modelli e a comportamenti che non siano dannosi per la natura, per la nostra salute, per la Terra. RiGenerazione Scuola si propone di contribuire all’attuazione degli obiettivi dell’Agenda 2030, con lo scopo di dare vita ad azioni concrete per lo sviluppo sostenibile e valorizzare l’insegnamento dell’Educazione civica con finanziamenti, progetti e iniziative. Il Ministero dell’Istruzione ha istituito, innanzi tutto, la GreenCommunity, cioè un gruppo di enti, associazioni pubbliche e private, amministrazioni pubbliche, istituzioni culturali e scientifiche, per dare un contributo alle scuole nella realizzazione dei progetti e delle iniziative del Piano RiGenerazione Scuola.
I pilastri
RiGenerazione Scuola poggia su quattro pilastri, cioè su quattro campi di azione, ciascuno dei quali ha proprie finalità e propri contenuti.
1. RiGenerazione dei saperi
Ampliare i saperi attuali, i contenuti, le attività verso lo sviluppo sostenibile.
2. RiGenerazione dei comportamenti
Educare ragazze e ragazzi alla cittadinanza alimentare, alla raccolta differenziata e al riciclo dei rifiuti, alla limitazione delle emissioni di gas serra prodotte dal traffico urbano
3. RiGenerazione delle infrastrutture fisiche e digitali
Realizzare nuove scuole sostenibili, con ampi spazi verdi e ambienti didattici in linea con le esigenze ecologiche e ambientali: scuole nuove, sane, verdi, digitali.
4. RiGenerazione delle opportunità
Istituire nuovi percorsi di studio, come Licei Ambientali e Istituti Tecnici Superiori a indirizzo Sviluppo sostenibile, e implementare l’orientamento verso i lavori green.
Gli obiettivi
• Recuperare il rispetto delle persone attraverso il rispetto dell’ambiente.
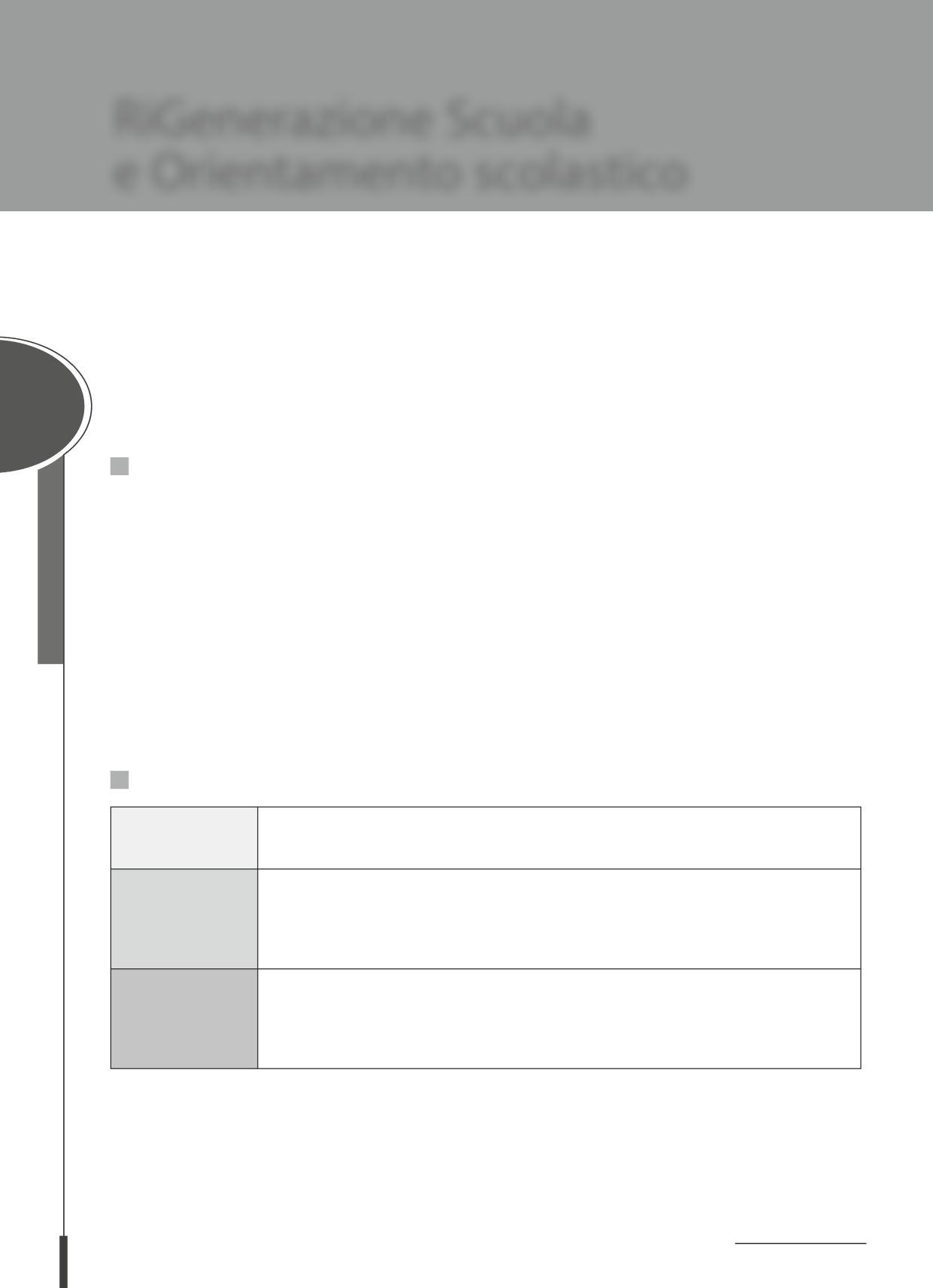
SOCIALI
AMBIENTALI
ECONOMICI
• Superare il pensiero che vede l’essere umano al centro di tutto.
• Abbandonare la cultura dello scarto a vantaggio della cultura del riciclo.
• Convincersi che l’umanità non deve procurare danni all’ambiente e alla natura.
• Maturare la consapevolezza che tutti gli esseri viventi (esseri umani, animali, piante) hanno il medesimo diritto a una vita sana e rispettosa di tutti.
• Diventare consapevoli che i problemi ambientali vanno affrontati in modo globale.
• Imparare a ridurre drasticamente gli impatti dell’azione umana sulla natura.
• Conoscere la bioeconomia.
• Conoscere il sistema dell’economia circolare.
• Acquisire la consapevolezza che gli sconvolgimenti climatici sono anche un problema economico.
• Imparare a costruire i mestieri e le imprese del futuro a zero emissioni, circolari e rigenerative.
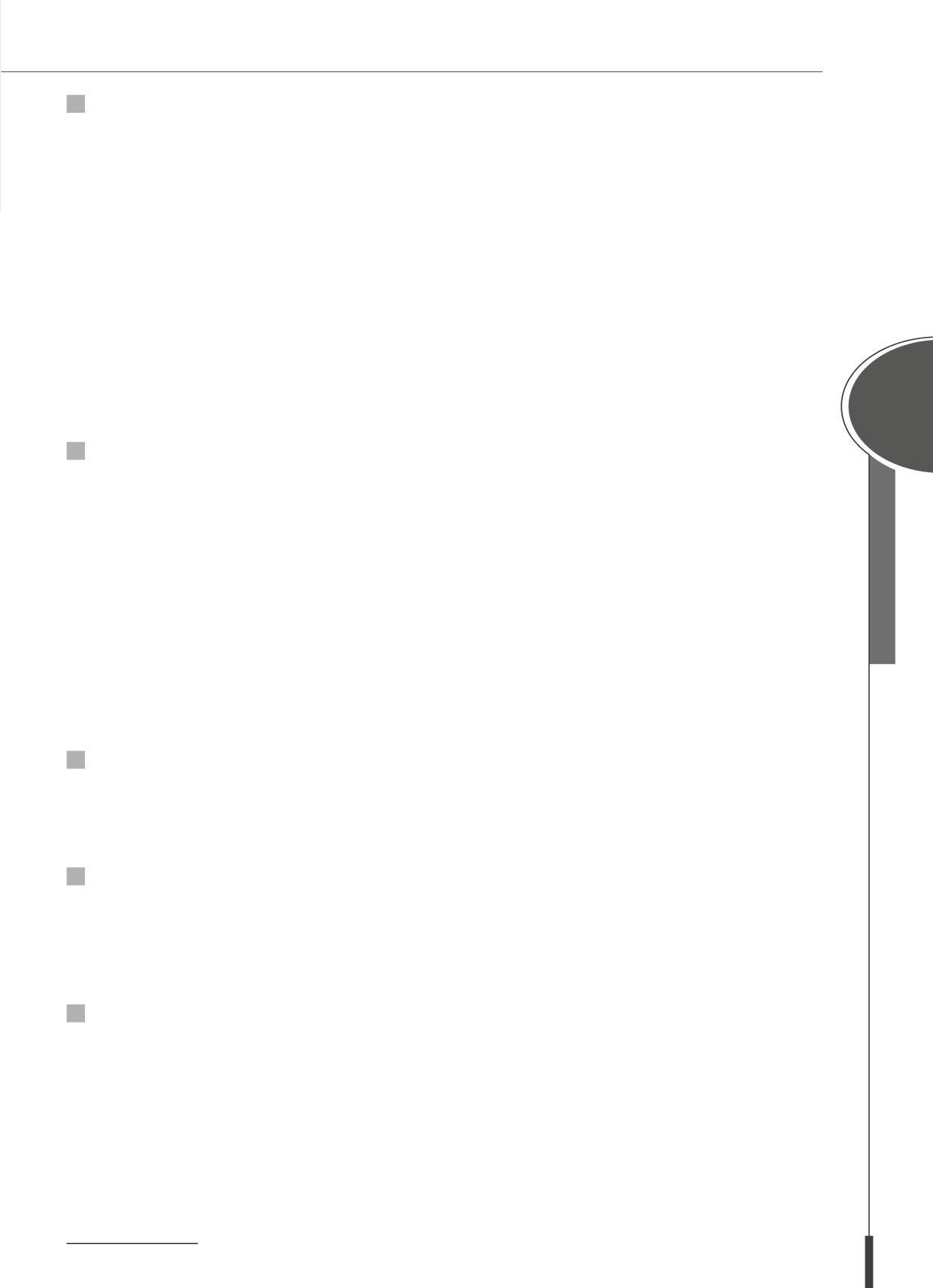
Il Piano
Grazie al Piano RiGenerazione, la scuola si trasforma in un luogo nel quale si impara a crescere in modo sostenibile, il che significa, di fatto, avviare una serie di attività che, se fossero realizzate in tutto il Pianeta, indicherebbero la strada che porta allo sviluppo sostenibile e a una nuova cultura fondata su valori ambientalistici.
Nella fase di elaborazione del Piano triennale dell’offerta formativa per il triennio 2022-2025, le scuole potranno inserire, nel curricolo di istituto, le attività relative ai temi della transizione ecologica e culturale, collegandole ai quattro pilastri e agli obiettivi di RiGenerazione Scuola. Per dare un aiuto concreto, il Piano RiGenerazione Scuola suggerisce attività che alcune scuole hanno già messo in campo, come per esempio: creare orti biologici senza uso di pesticidi e diserbanti e sistemi di protezione per insetti impollinatori, come le api; creare una compostiera per gli avanzi di cibo, dove c’è il servizio mensa; creare detersivi ecologici, cioè senza coloranti e profumi chimici; provvedere alla raccolta delle plastiche abbandonate e alla promozione dei valori di salvaguardia ambientale.
Orientamento scolastico
Riferimenti normativi
Il 23 dicembre 2022 il Ministro dell’Istruzione e del Merito ha firmato il decreto che approva le Linee guida per l’Orientamento scolastico, riforma prevista dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), in vigore dall’anno scolastico 2023-2024.
La riforma prevede 30 ore di Orientamento all’anno, da organizzare nelle scuole secondarie di primo e secondo grado, che potranno essere gestite in modo flessibile nel rispetto dell’autonomia scolastica e non necessariamente ripartite in ore settimanali prestabilite. Le 30 ore saranno extracurricolari per il primo grado e il biennio del secondo grado e curricolari per il triennio.
Le linee guida perseguono tre obiettivi principali:
• rafforzare il raccordo tra primo e secondo ciclo di istruzione e formazione, per consentire a studentesse e studenti una scelta consapevole e ponderata che valorizzi i loro talenti e le loro potenzialità;
• contrastare la dispersione scolastica;
• favorire l’accesso all’istruzione terziaria.
Il docente tutor
Ogni scuola individua e forma i docenti tutor, il cui ruolo è di supporto agli studenti, alle studentesse e alle loro famiglie durante tutto il percorso orientativo, dall’individuazione delle attitudini e delle inclinazioni di ciascuno fino ad arrivare alla scelta del percorso didattico o professionale più adatto.
L’e-portfolio
Uno strumento fondamentale di supporto all’attività di orientamento è l’e-portfolio, un apposito registro digitale in cui sono riportati tutti i lavori e le attività extracurricolari più significativi di ogni studente. Il docente tutor è a disposizione degli studenti per rivedere le parti fondamentali che contraddistinguono ogni e-portfolio personale, per individuare e valorizzare le attitudini di ciascuno.
La piattaforma digitale unica per l’Orientamento
Inoltre, studenti e famiglie hanno a disposizione una piattaforma digitale in cui è possibile visualizzare informazioni e dati utili alla selezione di un percorso di studi o di lavoro che sia frutto di una scelta consapevole e che soddisfi appieno le caratteristiche e i talenti di ciascuno studente.
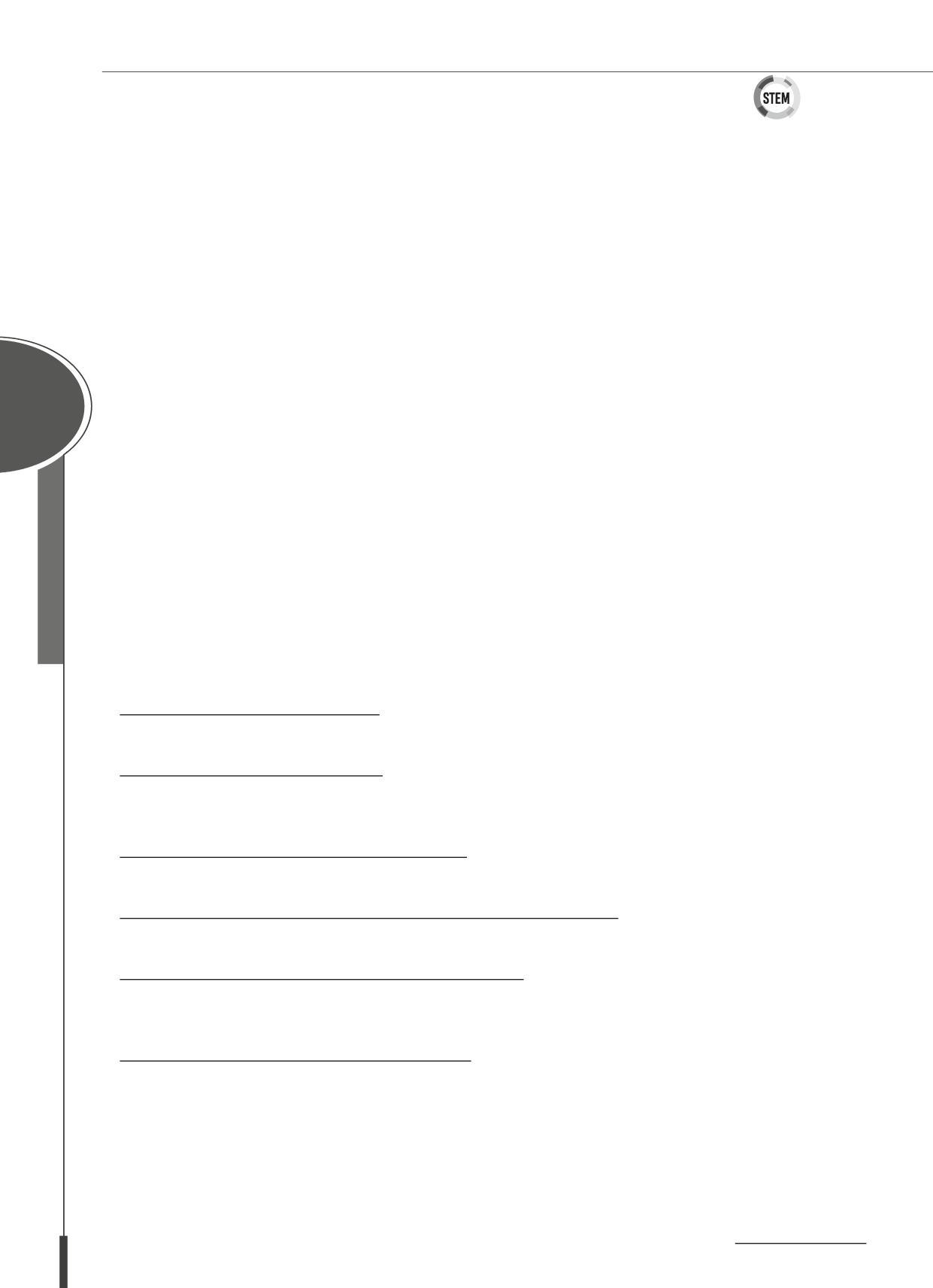
3.2 Le discipline STEM
L’acronimo STEM deriva dall’inglese Science, Technology, Engineering e Mathematics. Questa sigla indica quindi le discipline scientifico-tecnologiche, vale a dire tutti i campi della scienza (non medica) e dell’ingegneria.
Il termine STEM (in origine SMET) diventa popolare agli inizi degli anni 2000, quando viene citato in una conferenza della National Science Foundation (NSF), agenzia governativa degli USA che si occupa di ricerca e formazione scientifica. Da quel momento, il termine inizia a diffondersi e prende piede in ambito scolastico e universitario, ma anche e soprattutto politico ed economico.
Le nuove linee guida per l’insegnamento delle discipline STEM
La scelta (o mancata scelta) di un percorso di studio STEM e il gap di genere in queste discipline sono legati a forti influenze culturali e sociali. A scuola è possibile intervenire per avvicinare le ragazze e i ragazzi alla scienza e alla tecnologia e ridurre le disuguaglianze di genere.
Parallelamente agli stanziamenti di fondi previsti dal PNRR, il Ministro dell’istruzione e del merito ha approvato delle nuove linee guida, a partire dall’anno scolastico 2023-2024, per valorizzare e potenziare l’insegnamento delle discipline STEM. In esse sono fornite indicazioni metodologiche per l’insegnamento di queste discipline. Si legge sulle linee guida: «L’approccio STEM parte dal presupposto che le sfide di una modernità sempre più complessa e in costante mutamento non possono essere affrontate che con una prospettiva interdisciplinare, che consente di integrare e contaminare abilità provenienti da discipline diverse (scienza e matematica con tecnologia e ingegneria) intrecciando teoria e pratica per lo sviluppo di nuove competenze, anche trasversali.»
Sono indicate con “4C” le competenze potenziate nell’approccio integrato STEM: Critical thinking (pensiero critico), Communication (comunicazione), Collaboration (collaborazione), Creativity (creatività). Per promuovere l’insegnamento delle discipline STEM e renderle più attrattive per gli studenti è importante intervenire sui contenuti proposti e, soprattutto, sui metodi usati per proporli. Le discipline scientifiche si prestano perfettamente all’introduzione di metodologie di insegnamento meno top-down e più innovative, che favoriscano un approccio multidisciplinare e la contaminazione tra teoria e pratica. A titolo di esempio, sulle linee guida sono riportate le metodologie che seguono.
• Laboratorialità e Learning by doing: il coinvolgimento in attività pratiche e progetti consente di porre gli studenti al centro del processo di apprendimento, favorendo un approccio collaborativo alla risoluzione di problemi concreti.
• Problem solving e metodo induttivo: l’apprendimento basato sul problem solving e su sfide progettuali consente agli studenti di sviluppare competenze pratiche e cognitive attraverso l’elaborazione di un progetto concreto. Gli studenti possono identificare un problema, pianificare, implementare e valutare soluzioni.
• Attivazione dell’intelligenza sintetica e creativa: la ricerca di soluzioni innovative a problemi reali stimola il ragionamento attraverso la scomposizione e ricomposizione dei dati e delle informazioni, attiva il pensiero divergente, favorendo lo sviluppo della creatività.
• Organizzazione di gruppi di lavoro per l’apprendimento cooperativo: promuovere l’apprendimento tra pari, in cui gli studenti si insegnano reciprocamente, è un’efficace strategia didattica, perché favorisce la condivisione della conoscenza.
• Promozione del pensiero critico nella società digitale: l’utilizzo di risorse digitali interattive, come simulazioni, giochi didattici o piattaforme di apprendimento online, può arricchire l’esperienza di studio degli studenti. L’utilizzo delle nuove tecnologie deve essere mirato a incentivare gli studenti a sviluppare il pensiero critico al fine di diventare cittadini digitali consapevoli.
• Adozione di metodologie didattiche innovative: per sviluppare la curiosità e la partecipazione attiva degli studenti, la scuola dovrebbe superare i modelli trasmissivi, ricorrendo anche alle tecnologie, adottando una didattica attiva che pone gli studenti in situazioni reali.
Sulle nuove linee guida vengono date indicazioni anche per la valutazione delle competenze. L’acquisizione di competenze, in particolare in ambito STEM, può essere accertata ricorrendo soprattutto a compiti di realtà (prove autentiche, prove esperte, ecc.) e a osservazioni sistematiche. Con un compito di realtà lo studente è chiamato a risolvere una situazione problematica, aderente al mondo reale, applicando conoscenze e abilità già acquisite a contesti e ambiti di riferimento diversi da quelli noti.
La soluzione del compito di realtà costituisce così l’elemento su cui si può basare la valutazione dell’insegnante e l’autovalutazione dello studente. Le osservazioni sistematiche consentono di rilevare il processo seguito per interpretare correttamente il compito assegnato.
Le linee guida trattano ovviamente anche il pensiero computazionale e il coding. Già sul PNRR l’approccio all’apprendimento della programmazione è indicato come “priorità nazionale”. A partire dall’anno scolastico 2025/2026, «nelle scuole di ogni ordine e grado si dovrà perseguire lo sviluppo delle competenze digitali, anche favorendo gli apprendimenti della programmazione informatica (coding), nell’ambito degli insegnamenti esistenti». Il coding, il pensiero computazionale e l’informatica offrono strumenti e conoscenze necessarie per comprendere, utilizzare e contribuire al progresso tecnologico. L’inclusione delle competenze connesse al coding, al pensiero computazionale e all’informatica nel percorso educativo può preparare gli studenti alle sfide e alle opportunità offerte dal mercato del lavoro digitale.
La didattica STEM in Principi di biochimica con Scienze della Terra
La didattica in chiave STEM è presentata a fine Tema attraverso schede tecnologiche di approfondimento in lingua inglese Understanding Our World With STEM a carattere divulgativo. L’elenco delle schede è riportato nella tabella sottostante.
Inoltre, all’interno della teoria è possibile accedere attraverso QR ad attività sperimentali di modellizzazione e manipolazione chimica con il software Avogadro. L’elenco delle diciassette attività di modellizzazione molecolare con Avogadro è presente in questa Guida nella sezione Materiali per la lezione.
Approfondimenti UnderstandingOurWorldWithSTEM
Tema A - La chimica del carbonio
Tema B - La chimica della vita
Tema C - Le tecnologie per la vita
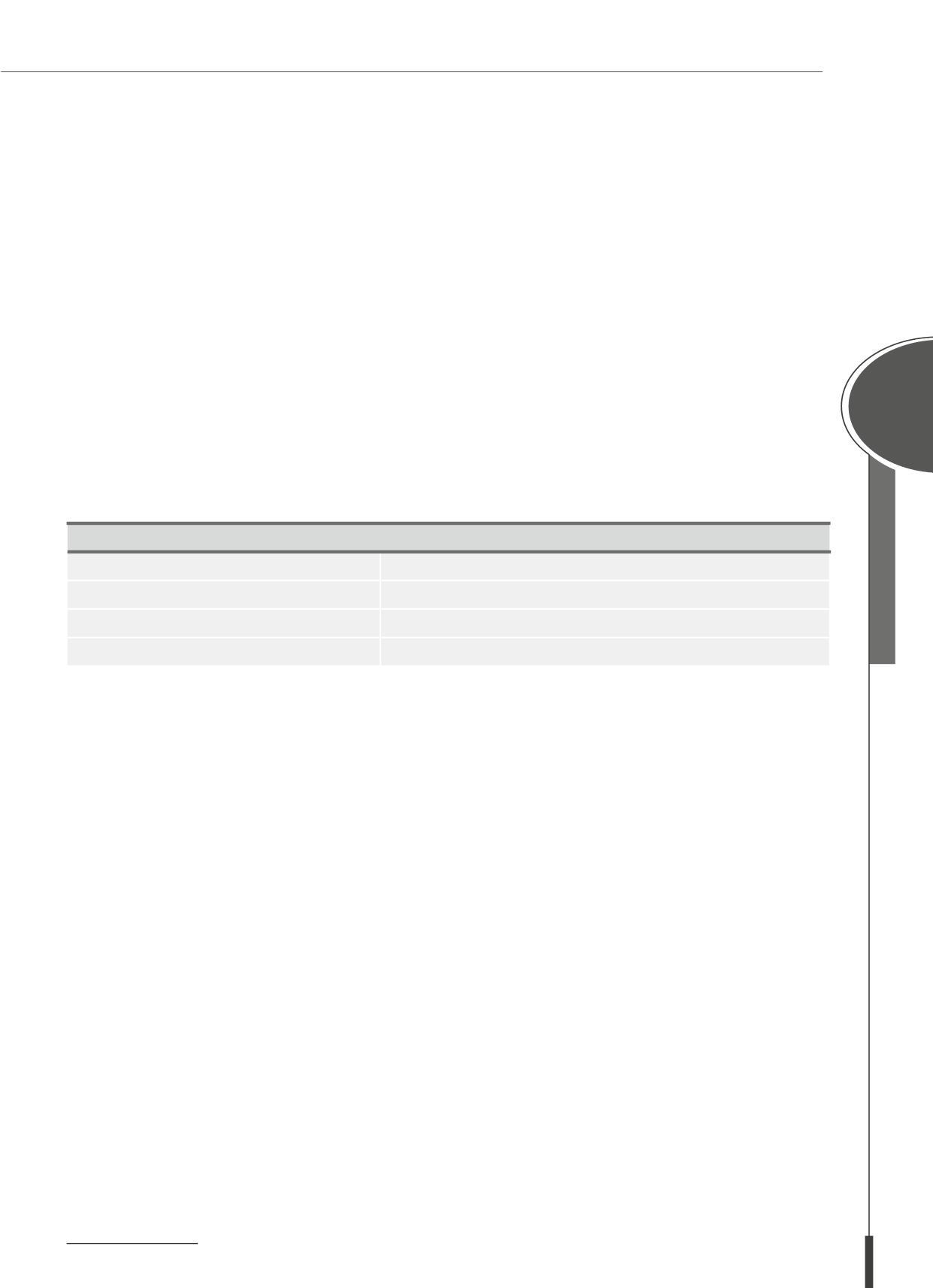
Turning the tide with compostable PLA
How to industrially produce a vitamin
CRISPR/Cas9 applied to gene therapy
Tema D - Dinamica e risorse del sistema Terra The climate puzzle solved by attribution science
3.3 Rizzoli Education con
Generazione STEM per l’orientamento
Nelle iniziali del volume è presente una doppia pagina dedicata al progetto di Orientamento Viaggio nelle STEM, nato dalla collaborazione tra Rizzoli Education e Generazione Stem. L’obiettivo è supportare le ragazze e i ragazzi nella scelta formativa più adatta a loro e in linea con le richieste del mondo del lavoro. Generazione Stem è una community social dedicata alle discipline STEM e attenta ai temi di uguaglianza di genere (generazionestem.it). Accedi alla pagina del sito di Rizzoli Education dedicata all’orientamento per trovare spunti, riflessioni e materiali per una efficace didattica orientativa.
In queste pagine è proposta un’attività in cui lo studente è invitato a riflettere sulle proprie Ambizioni, Abilità e competenze e Passioni e interessi selezionando quelle che più lo rispecchiano all’interno di un insieme di proposte. A seconda delle risposte date, lo studente è poi indirizzato ad esplorare una delle quattro aree STEM e, in particolare, potrà accedere tramite QR a una collezione di videopillole, tre per ognuna della quattro aree. In ogni videopillola, le ragazze e i ragazzi di Generazione Stem illustrano alcuni aspetti riguardanti i percorsi post-diploma e universitari, oltre ai possibili sbocchi lavorativi di tre principali settori per ogni area. Di seguito un elenco delle videopillole.
Science
• Scienze biologiche vs biotecnologie: scopri la differenza!
• Mille sfumature di chimica
• La fisica che non ti aspetti!
Technology
• Con l’AI puoi lavorare dove vuoi!
• Ti piacerebbe lavorare nel mondo del digital marketing?
• Biorobotica e bionica: la scienza e la tecnologia superano l’immaginazione
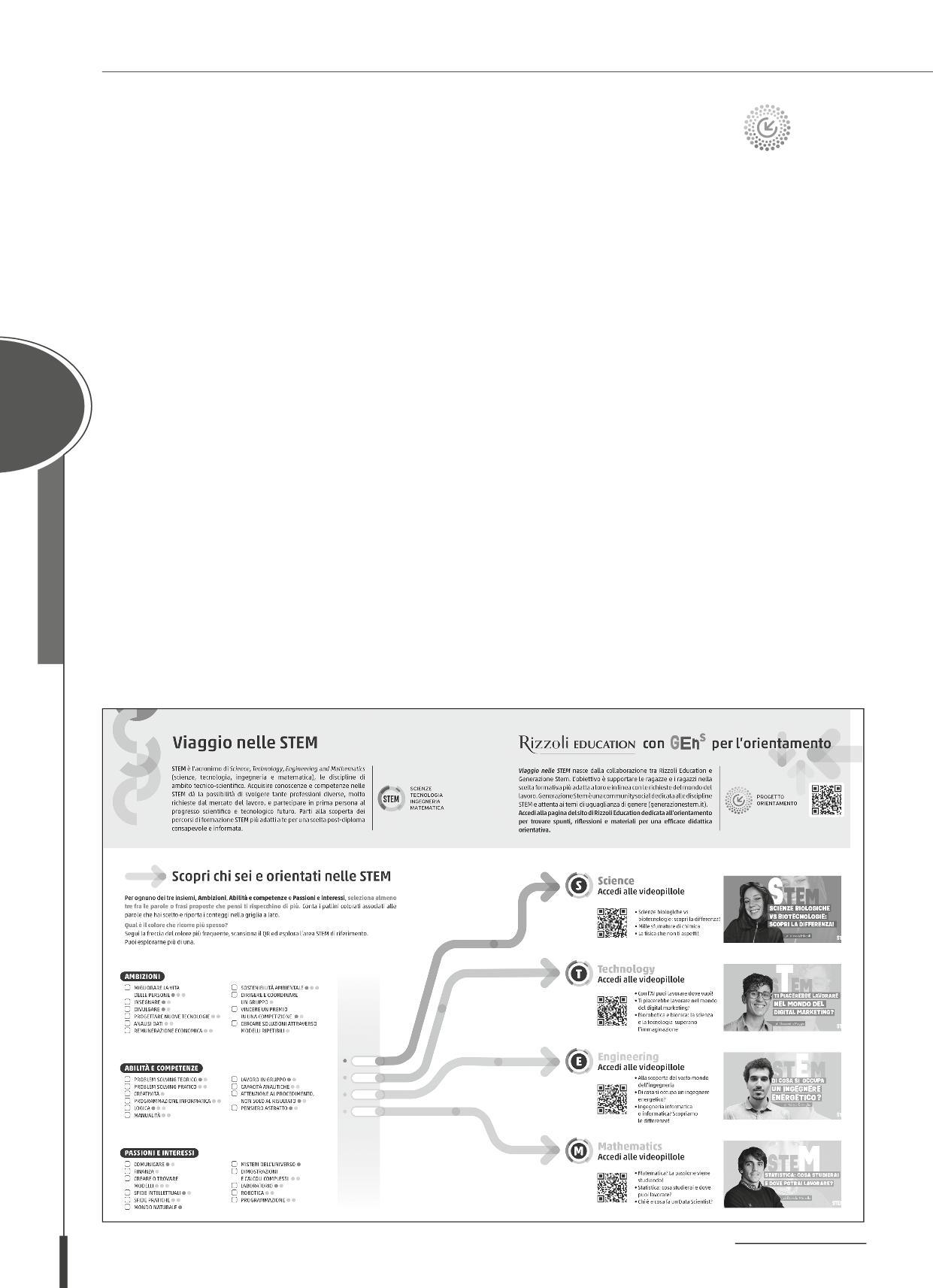
Engineering
• Alla scoperta del vasto mondo dell’ingegneria
• Di cosa si occupa un ingegnere energetico?
• Ingegneria informatica o informatica? Scopriamo le differenze!
Mathematics
• Matematica? La passione viene studiando!
• Statistica: cosa studierai e dove potrai lavorare?
• Chi è e cosa fa un Data Scientist?
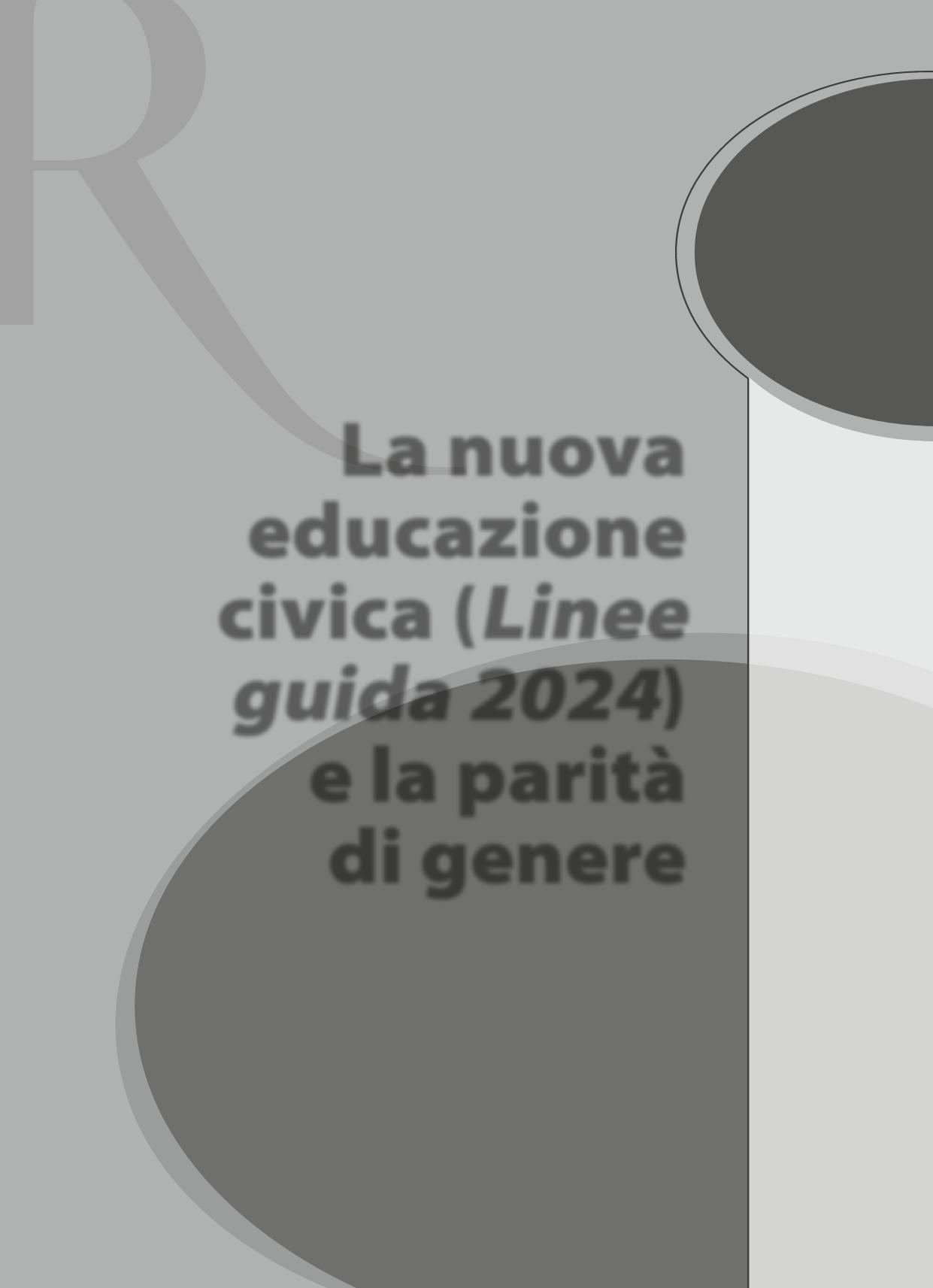
4
La nuova educazione civica (Linee guida2024) e la parità di genere
• L’insegnamento dell’educazione civica
• Rizzoli Education per la parità di genere e la multicultura

L’INSEGNAMENTO DELL’EDUCAZIONE CIVICA
Il percorso di educazione civica in evoluzione
La Legge n. 92 del 20 agosto 2019 ha (re)introdotto l’educazione civica nell’insegnamento scolastico. Dall’anno scolastico 2024/2025 le Linee guida proposte dal decreto ministeriale n. 35 del 22 giugno 2020 verranno sostituite da quelle del nuovo decreto n. 183 del 7 settembre 2024 che mirano a garantire che curricoli di educazione civica si riferiscano a traguardi e obiettivi di apprendimento definiti a livello nazionale.
Le nuove Linee guida prestano particolare attenzione a tre tematiche principali: tutela dell’ambiente, educazione stradale e promozione dell’educazione finanziaria. Tuttavia, si configurano come strumento di supporto e sostegno ai docenti anche di fronte ad alcune gravi emergenze educative e sociali del nostro tempo quali, ad esempio, l’aumento di atti di bullismo, di cyberbullismo e di violenza contro le donne, la dipendenza dal digitale, il contrasto all’uso delle sostanze stupefacenti, l’educazione alimentare, alla salute, al benessere della persona e allo sport.
Principi a fondamento dell’educazione civica
I tre pilastri proposti dalle Linee guida del decreto ministeriale n. 35 del 22 giugno 2020 diventano i tre nuclei concettuali delle nuove Linee guida del decreto n. 183 del 7 settembre 2024, integrati e ampliati come segue.
1. COSTITUZIONE
All’interno di questo nucleo sono racchiusi: la comprensione del dettato costituzionale, la sua storia e le scelte dell’Assemblea costituente, lo studio delle funzioni di Stato, Regioni, Enti territoriali e organizzazioni internazionali come UE e ONU e la promozione della legalità e del rispetto delle regole, dove le leggi non sono prescrizioni etiche o morali, ma servono a regolare i rapporti tra autorità e libertà, sempre nell’interesse comune. Si parla anche di approfondire il legame tra diritti e doveri del cittadino, favorire il rispetto delle norme per il benessere collettivo e contrastare discriminazioni, bullismo, criminalità e illegalità – inclusa quella organizzata – e insegnare comportamenti responsabili e sicuri come utenti della strada.
Questo nucleo contiene le competenze chiave personali discusse all’interno del LifeComp.
2. SOSTENIBILITÀ E SVILUPPO ECONOMICO
Le nuove Linee guida ampliano il nucleo della sostenibilità presente nelle precedenti Linee guida con l’inclusione dell’importanza del lavoro e dell’iniziativa economica privata come pilastri della società; la cultura d’impresa permette agli studenti di acquisire competenze sul mondo del lavoro e sull’autoimprenditorialità e sensibilizza sull’importanza della gestione del denaro, della tutela del risparmio e della pianificazione previdenziale, anche attraverso le tecnologie digitali.
Lo sviluppo economico deve essere compatibile con la tutela della salute, della dignità umana, dell’ambiente e della biodiversità, in linea con i principi della Costituzione (art. 9).
Rientrano in questo ambito anche l’educazione alla salute, la protezione della biodiversità e la bioeconomia. Questo nucleo sottolinea l’importanza di una corretta alimentazione, dell’attività sportiva e del benessere psicofisico. Affronta i rischi delle dipendenze da droghe, fumo, alcool, doping, web e gioco d’azzardo e promuove la prevenzione e il contrasto alla tossicodipendenza.
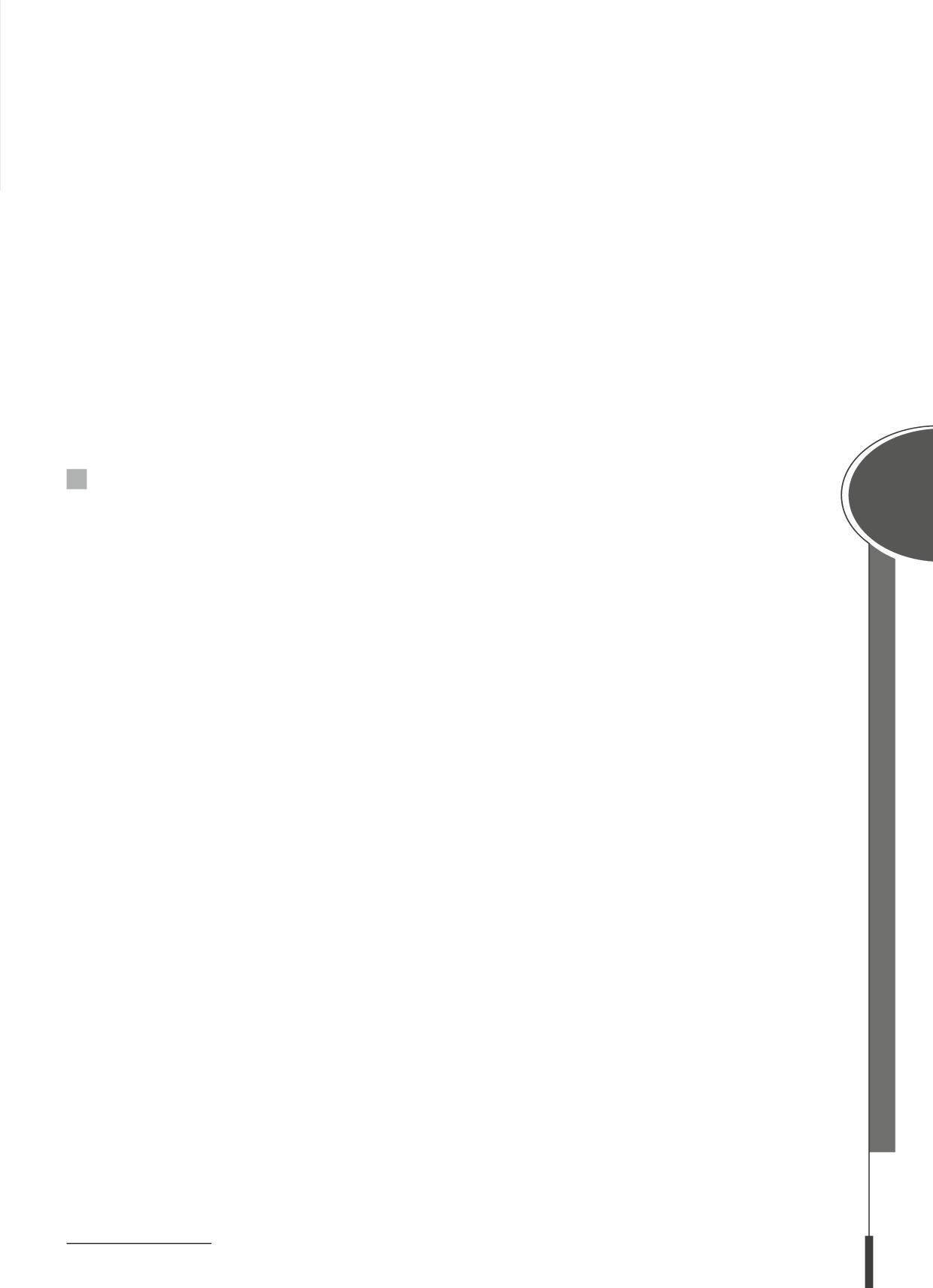
Inoltre, sono presenti temi come la cultura della protezione civile per sensibilizzare i giovani sui temi di autoprotezione e salvaguardia del territorio, il rispetto per le strutture scolastiche, il decoro urbano e la valorizzazione del patrimonio culturale, artistico e monumentale italiano. Questo nucleo aggiornato racchiude i principi dell’Agenda ONU 2030 e del quadro europeo delle competenze per la sostenibilità (GreenComp).
3. CITTADINANZA DIGITALE
Questo nucleo promuove lo sviluppo di un utilizzo consapevole e responsabile delle tecnologie digitali nei giovani, come indicato nell’articolo 5 della Legge, attraverso curricoli che considerino l’età degli studenti.
L’educazione alla cittadinanza digitale non riguarda solo l’uso della tecnologia, ma richiede un approccio condiviso tra tutti i docenti della classe che possono utilizzare il Quadro delle Competenze Digitali per i Cittadini (DigComp2.2) per strutturare le lezioni che includano Pensiero critico e sicurezza online e Intelligenza Artificiale (AI). L’obiettivo è insegnare agli studenti a valutare criticamente dati e notizie online, a riconoscere fonti affidabili e a proteggere la propria privacy e identità digitale, prevenire fenomeni come il cyberbullismo e approfondire il ruolo dell’intelligenza artificiale nell’educazione e nella personalizzazione dell’apprendimento, con focus su opportunità e rischi.
La valutazione
Come menzionato nelle nuove Linee guida: «I nuclei concettuali dell’insegnamento dell’educazione civica sono già impliciti nelle discipline previste nei curricoli dei diversi percorsi scolastici. Si tratta dunque di far emergere all’interno dei curricoli di istituto elementi già presenti negli attuali ordinamenti e di rendere più consapevole ed esplicita la loro interconnessione, nel rispetto e in coerenza con i processi di crescita dei bambini e dei ragazzi nei diversi gradi di scuola. La trasversalità dell’insegnamento si esprime, quindi, nella capacità di dare senso e significato a ogni contenuto disciplinare».
È fondamentale che le tematiche trattate siano sempre coerenti e integrate nel curricolo e siano funzionali allo sviluppo delle conoscenze, abilità e competenze riviste per ogni tipologia di istituto secondario. Riportiamo qui solo le competenze e gli obiettivi di apprendimento in cui è coinvolta, in modo più o meno esplicito, la didattica delle scienze.
L’educazione civica in Principi di biochimica con scienze della Terra
Il corso di Principi di biochimica con scienze della Terra presenta materiali differenziati per approfondimento e didattica, tutti collegati a un obiettivo dell’Agenda 2030. Ognuno di questi materiali può essere proposto al Consiglio di Classe per la creazione di un percorso multidisciplinare di educazione civica.
Le risorse sul libro di testo che concorrono principalmente a questo scopo sono:
• quattro schede Understanding Our World With STEM che collegano argomenti di frontiera delle discipline STEM anche con la sostenibilità;
• quattro schede Educazione civica scritte in collaborazione con Legambiente collegate ad altrettanti Compiti di realtà proposti attraverso il QR, in cui è anche possibile accedere a una sitografia ragionata per l’approfondimento;
• esercizi di competenze nelle pagine di verifica di fine Unità sono dedicati a sostenibilità, cittadinanza, digitale e intelligenza artificiale.
Di seguito sono elencate le attività legate all’educazione civica presenti in questo corso.
Approfondimenti
Tema A – La chimica del carbonio Turning the tide with compostable PLA
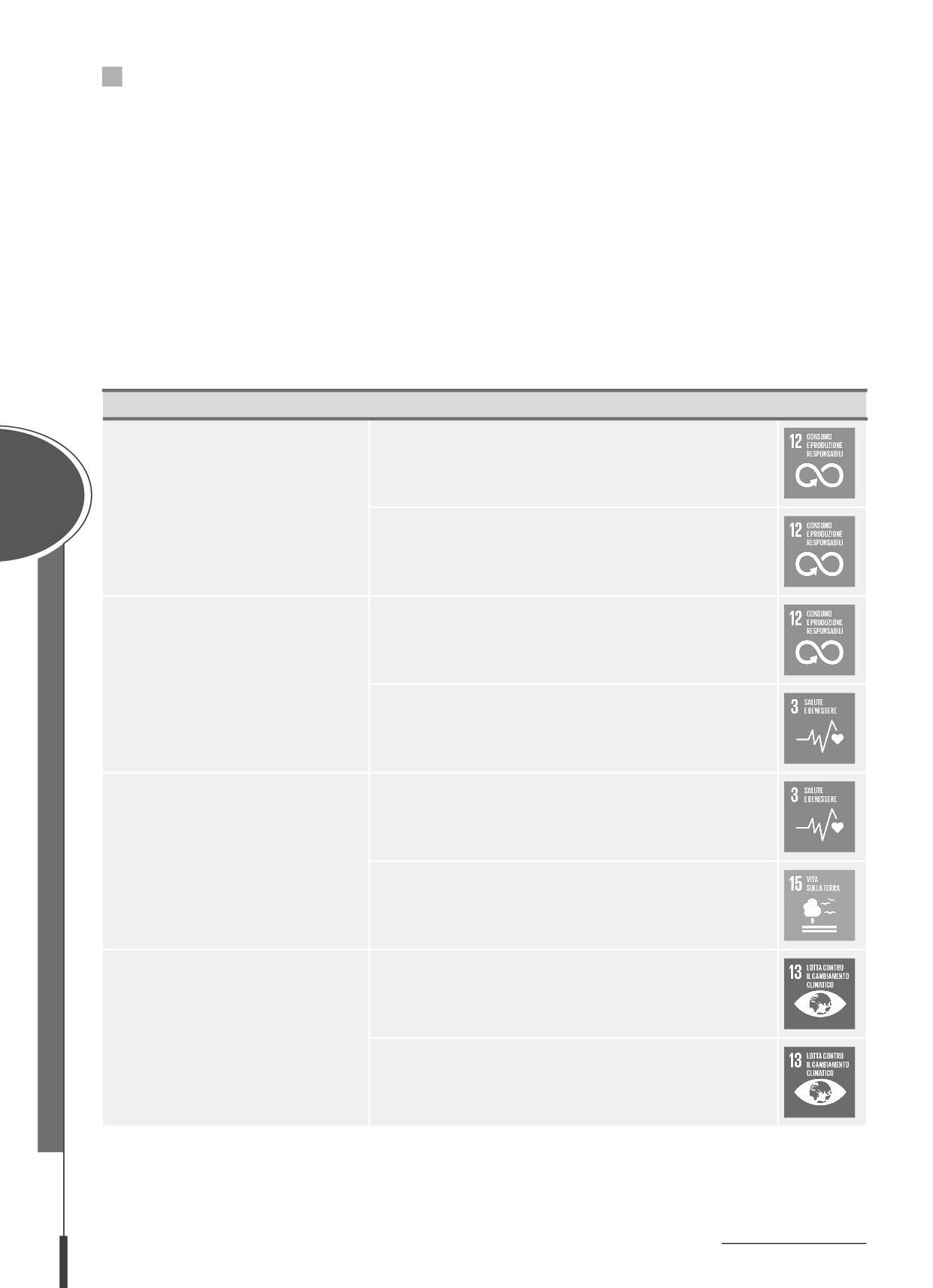
Tema B – La chimica della vita
How to industrially produce a vitamin
Proteggersi dall’inquinamento con l’alimentazione
Tema C – Le tecnologie per la vita
CRISPR/Cas9 applied to gene therapy
L’impatto delle piante GM sulla biodiversità
Tema D – Dinamica e risorse del sistema Terra
The climate puzzle solved by attribution science
Agire contro il cambiamento climatico
Solo per il docente, sono presenti in questa guida, nella sezione Materiali per il docente, le schede docente dei quattro Compiti di Realtà con suggerimenti didattici e per la valutazione. Queste schede sono disponibili tra i contenuti digitali integrativi per il docente nel sito libro dell’Opera su HUB Scuola.
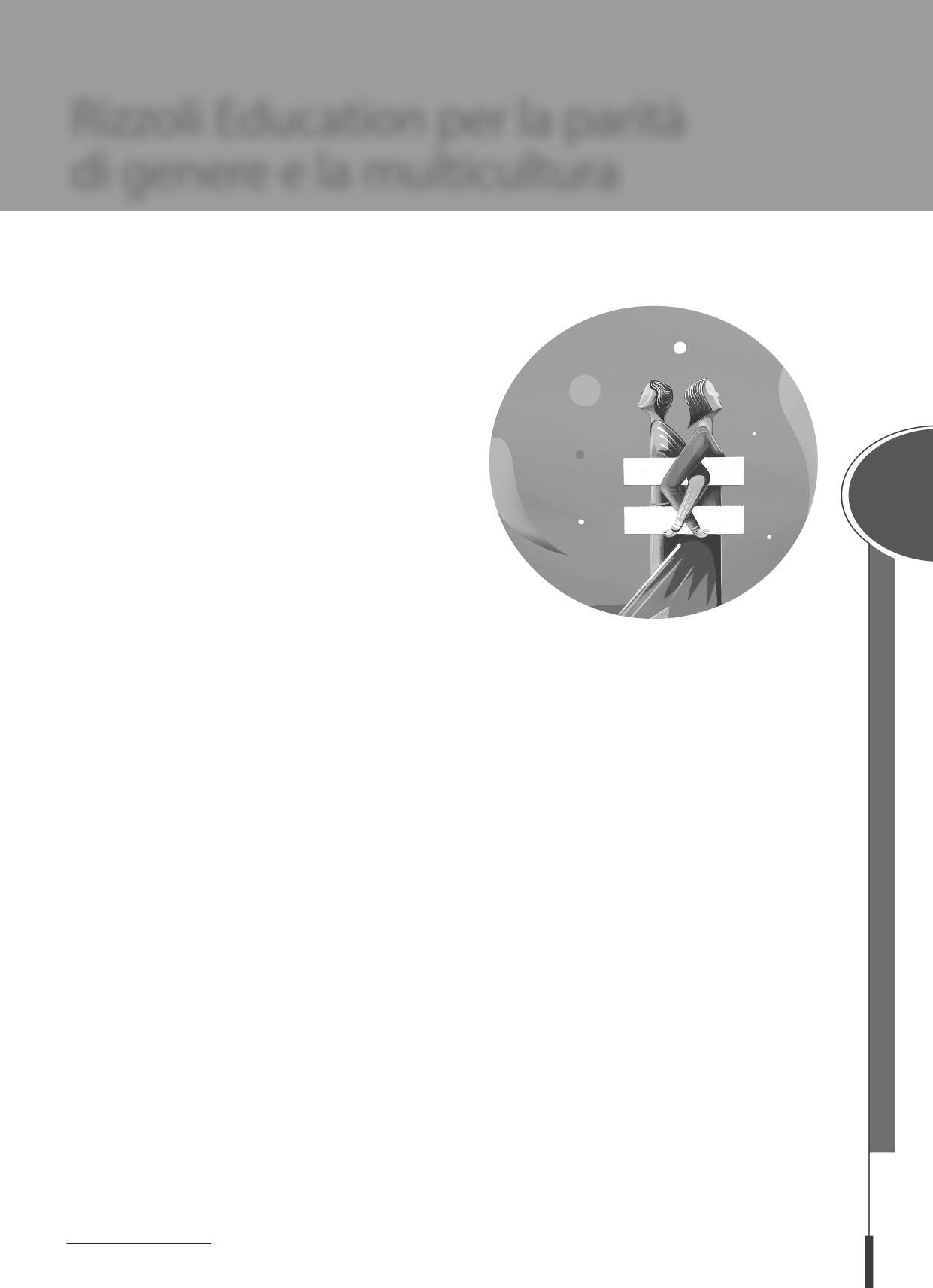
Rizzoli Education per la parità di genere e la multicultura
Rizzoli Education è consapevole della responsabilità legata alla produzione di materiali didattici, nei confronti degli studenti e delle studentesse, delle docenti e dei docenti e delle famiglie. Per questo abbiamo intrapreso un percorso su alcuni temi centrali del dibattito culturale odierno: la parità di genere, la pluralità e la multicultura. Ne condividiamo qui i principi ispiratori, che abbiamo maturato anche grazie alla collaborazione scientifica con Irene Biemmi, docente di Pedagogia di genere presso l’Università di Firenze, e con Sara Bin, geografa e collaboratrice presso l’Università di Padova.
In che cosa crediamo
No
agli stereotipi, ai pregiudizi di genere e alle generalizzazioni
Crediamo che non esistano ruoli predeterminati, solo femminili o solo maschili, e crediamo che donne e uomini siano alla pari nella società, nelle professioni, nei ruoli familiari e in qualunque altro ambito esprimano le proprie capacità e la propria personalità. Conoscere significa non semplificare, non trascurare la complessità e tenere presente il contesto nel quale avviene la comunicazione.
Guardiamo alla pluralità e all’inclusività
Cerchiamo di assumere un punto di vista che rappresenti e valorizzi le differenze e rifletta un mondo plurale e multiforme, in linea con i principi di equità e uguaglianza, pari opportunità e non discriminazione sanciti anche dalla nostra Costituzione.
Vogliamo contribuire a ripopolare l’immaginario delle giovani generazioni
Ci impegniamo a proporre rappresentazioni femminili e maschili non sessiste e ad evitare altre forme di stereotipo, pregiudizio e discriminazione affinché le giovani generazioni, alla cui formazione i nostri libri offrono un contributo, possano ampliare le possibilità di costruire la propria identità e di progettare il proprio futuro.
Crediamo che il linguaggio incida sulla realtà
Il modo in cui ci esprimiamo è uno strumento potente di percezione ed espressione di sé e delle altre persone. Per questo ci impegniamo a utilizzare nei nostri libri un linguaggio, sia verbale sia visivo, non discriminatorio, che contribuisca a decostruire gli stereotipi veicolati dalla lingua.
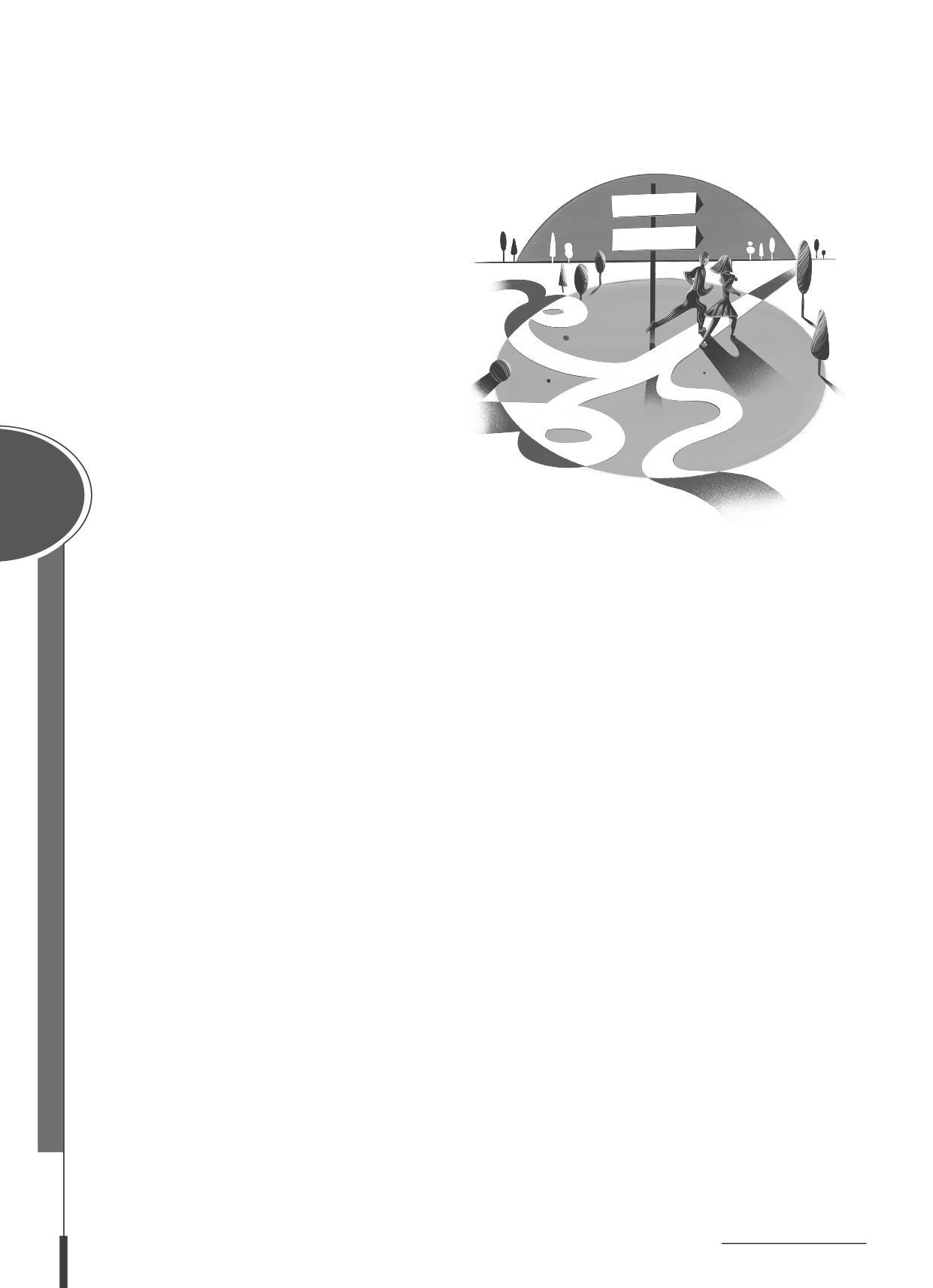
Che cosa stiamo facendo, che cosa faremo
Individuazione di criteri guida fondamentali, quali:
• rappresentazione equilibrata dei generi;
• soluzioni linguistiche inclusive e neutre;
• attenzione all’iconografia, alle illustrazioni e alle descrizioni delle immagini, per garantire a femmine e maschi spazi di rappresentazione paritari;
• attenzione nell’evitare una rappresentazione stereotipata delle minoranze etniche attribuendo loro solo determinati ruoli, per scongiurare il rischio che una storia sia letta come l’unica storia possibile;
• proposta di nuovi ruoli e di nuovi contesti per costruire un immaginario più vario e inclusivo che consideri la diversità come una ricchezza.
Condivisione delle linee guida
Chiediamo a tutte le persone che sono coinvolte nella realizzazione dei nostri libri (autrici e autori, illustratori e illustratrici, ricercatrici e ricercatori iconografici, redattrici e redattori) di condividere il pensiero della Casa Editrice in materia di parità di genere e di attenzione alle differenze etniche e culturali.
Consulenza scientifica
Ci avvaliamo della consulenza di figure scientifiche esperte in questioni linguistiche di genere e sui temi della pluralità e della non discriminazione, fra cui, in particolare, Irene Biemmi, che abbiamo coinvolto con la collaborazione di Edizioni Erickson.
Formazione
Organizziamo appuntamenti di formazione per lo staff della Casa Editrice e per le professionalità esterne, oltre a percorsi formativi dedicati anche a docenti e genitori.
Controllo dei contenuti
Prevediamo fasi di controllo e revisione redazionale sui testi scritti e visivi dedicate alle questioni di genere, alla pluralità e alle differenze etnico-culturali. Nelle nostre pubblicazioni per la scuola primaria, già dal 2018 portiamo avanti il progetto Obiettivo Parità, in collaborazione con Edizioni Erickson.
5
Materiali per la lezione
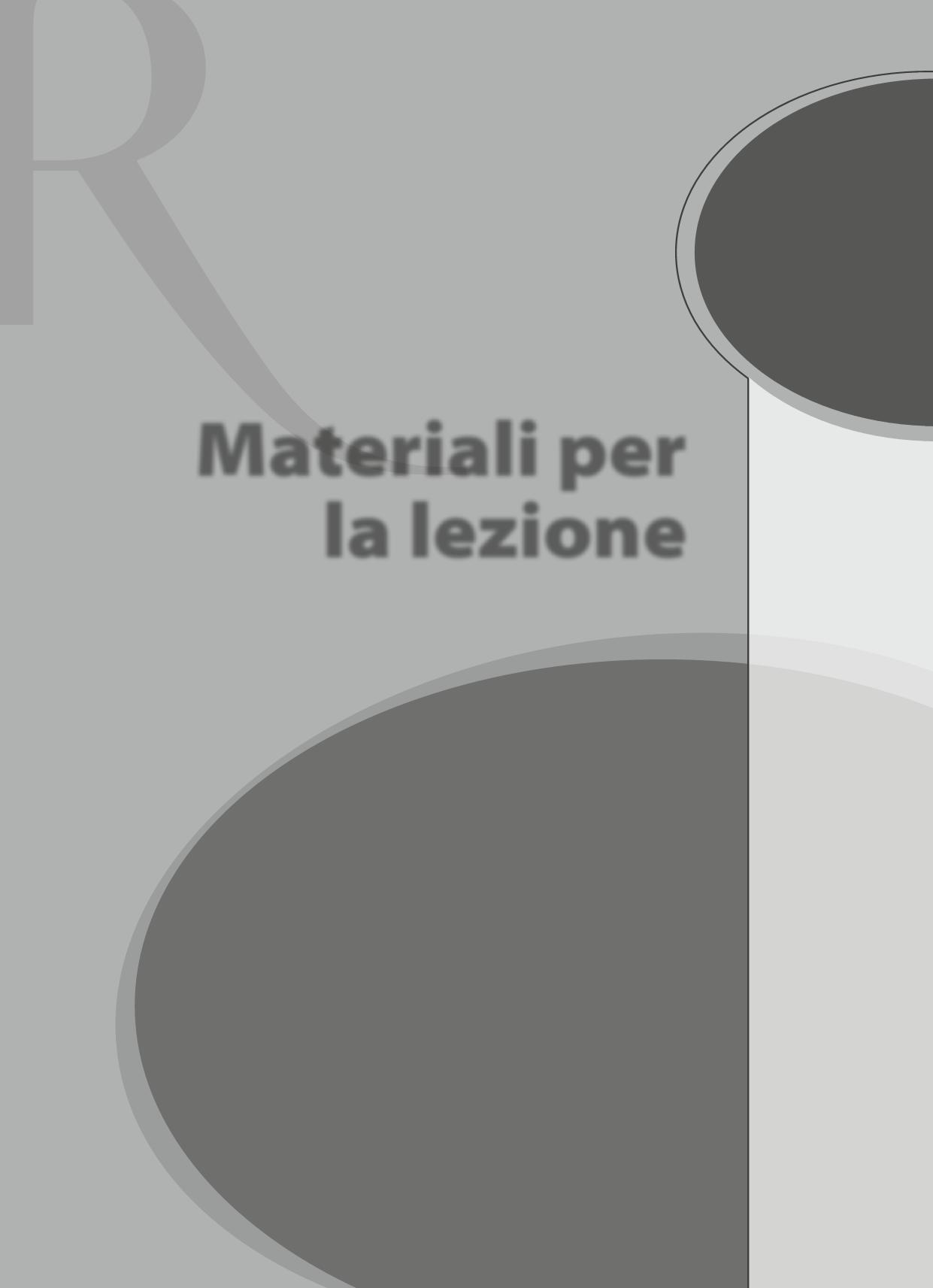
• Didattica con Avogadro e i modelli molecolari
• Compiti di realtà: schede per il docente e per lo studente
• Griglie di valutazione per i prodotti multimediali
• Uso del podcast nella didattica
• Metodologia CLIL
DIDATTICA CON AVOGADRO E I MODELLI MOLECOLARI
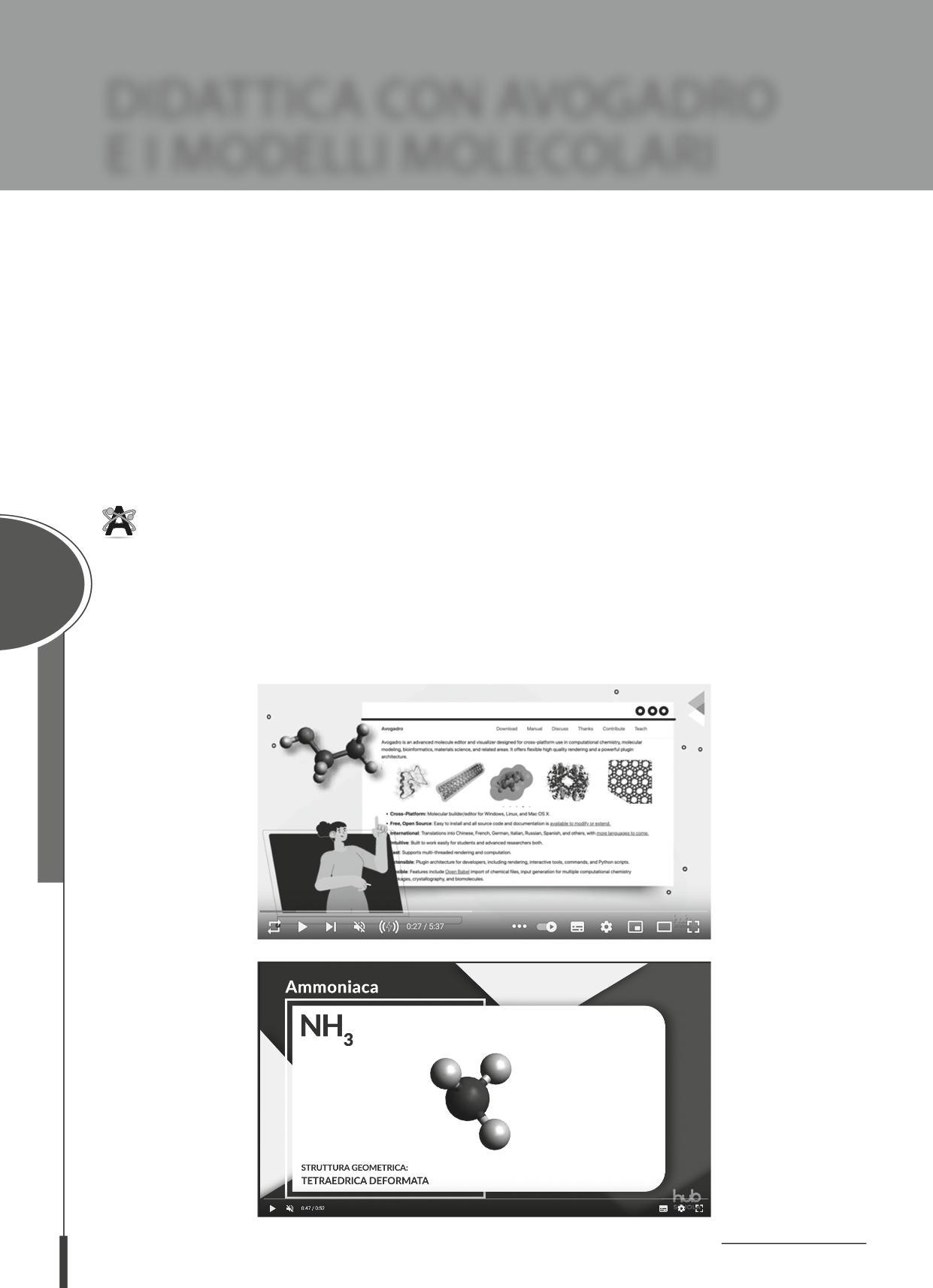
Un modello fornisce una rappresentazione semplificata di un fenomeno, permettendo di coglierne gli aspetti essenziali. Nella didattica della Chimica, qualunque rappresentazione di una molecola, dalla formula di struttura, alla rappresentazione digitale, ai modellini fisici, costituisce un modello molecolare. Nel volume Principi di biochimica con scienze della Terra, la didattica con i modelli molecolari è realizzata grazie all’impiego di due diverse tipologie di contenuti digitali:
• le schede attività studente che prevedono l’utilizzo del software Avogadro;
• i videolab, realizzati con i kit dei modelli molecolari fisici.
5
vogadro
Il software Avogadro è un editor open source, progettato per disegnare, costruire e osservare e manipolare nello spazio molecole tridimensionali di vario tipo, dalle più semplici, come l’acqua, a quelle più complesse, come la clorofilla. Per utilizzare questa applicazione, ciascun docente può visitare la sezione “Teach” della pagina https://q3.hubscuola.it/avogadro, dove è possibile trarre numerosi spunti per la progettazione delle lezioni e delle verifiche. Avogadro rappresenta inoltre, per lo studente, un valido strumento per la comprensione, lo studio e il ripasso della chimica organica e della biochimica.
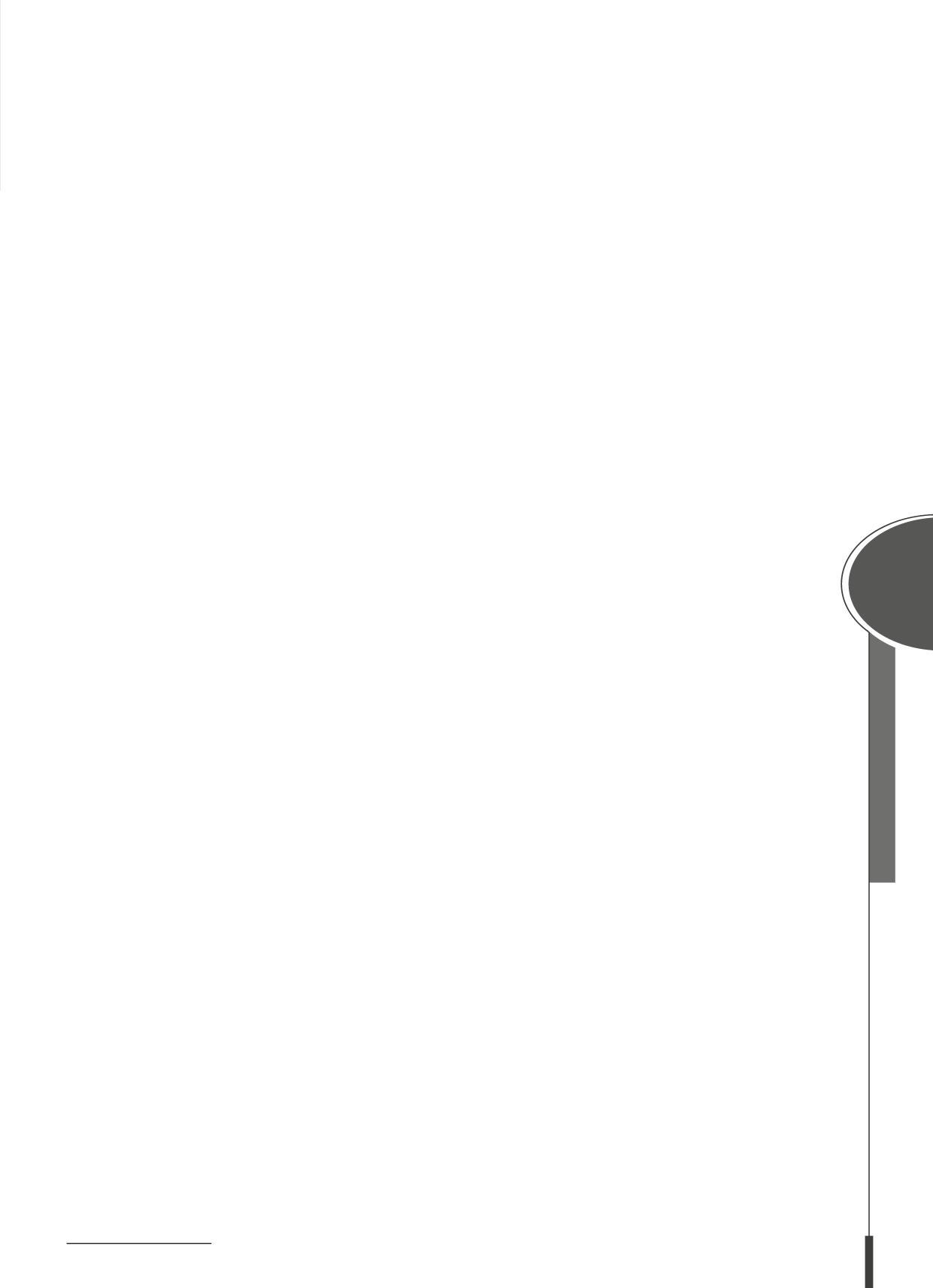
1. Le formule di Lewis
2. La molecola di idrogeno e i suoi orbitali
3. I legami multipli
4. La geometria delle molecole e la teoria VSEPR
5. Polarità delle molecole
6. La struttura del cloruro di sodio
7. La struttura della grafite
8. Struttura e proprietà dell'acqua
9. Costruire una molecola dal nome e viceversa
10. Costruisci un isomero di struttura
11. Gli stereoisomeri: un esempio di conformeri
12. Gli stereoisomeri: un esempio di isomeri geometrici
13. Gli stereoisomeri: un esempio di isomeri ottici
14. Le caratteristiche geometriche dei conformeri del cicloesano
15. Alcano, alchene, alchino: una questione di legami
16. Gruppi funzionali: aldeidi e chetoni
17. Gruppi funzionali: acidi organici e derivati
Trovi le schede Avogadro nella versione docente, complete di suggerimenti e griglia di valutazione, nella sezione Contenuti per il Docente sulla piattaforma HUB Scuola. Di seguito è illustrato l’elenco delle attività “passo per passo” proposte con l’utilizzo di Avogadro:
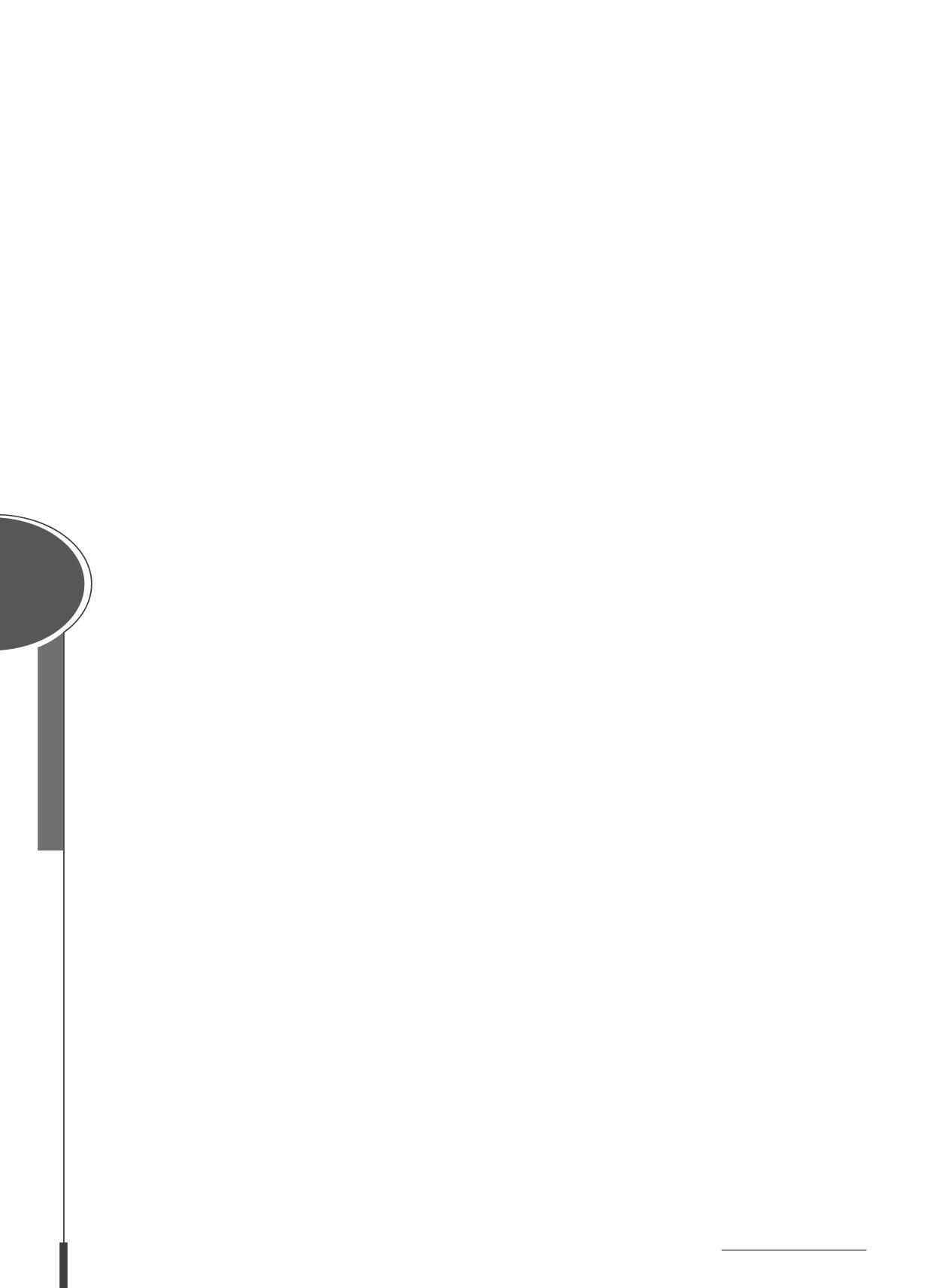
I modelli molecolari fisici
I modelli molecolari fisici sono dei kit attraverso i quali le molecole acquisiscono una vera e propria fisicità. Questi kit includono una serie di centri di plastica di forma approssimativamente sferica, ciascuno provvisto di un certo numero di dentini posti ad angoli ben determinati in accordo con gli angoli di legame che dovranno raffigurare.
I centri sono caratterizzati da un colore diverso in base all’elemento che rappresentano. Inoltre, se l’elemento è monovalente, la pallina che lo rappresenta avrà un solo dentino, come nel caso dell’idrogeno; se è bivalente ne avrà due, come nel caso dell’ossigeno; l’azoto trivalente e il carbonio tetravalente ne avranno, rispettivamente, tre e quattro. Nel volume Principi di biochimica con scienze della Terra si propongono dei videolab ideati dagli autori in cui sono illustrati degli esempi di attività con un kit di modelli molecolari; questi video sono corredati da schede descrittive fornite nella guida per il docente.
1. Che cosa sono i modelli molecolari?
2. Il metano
3. Gli alcani superiori
4. La conformazione degli alcani
5. I cicloalcani
6. La stereoisomeria
7. I gruppi funzionali
I videolab sono fruibili tramite codice QR dalle pagine del volume.
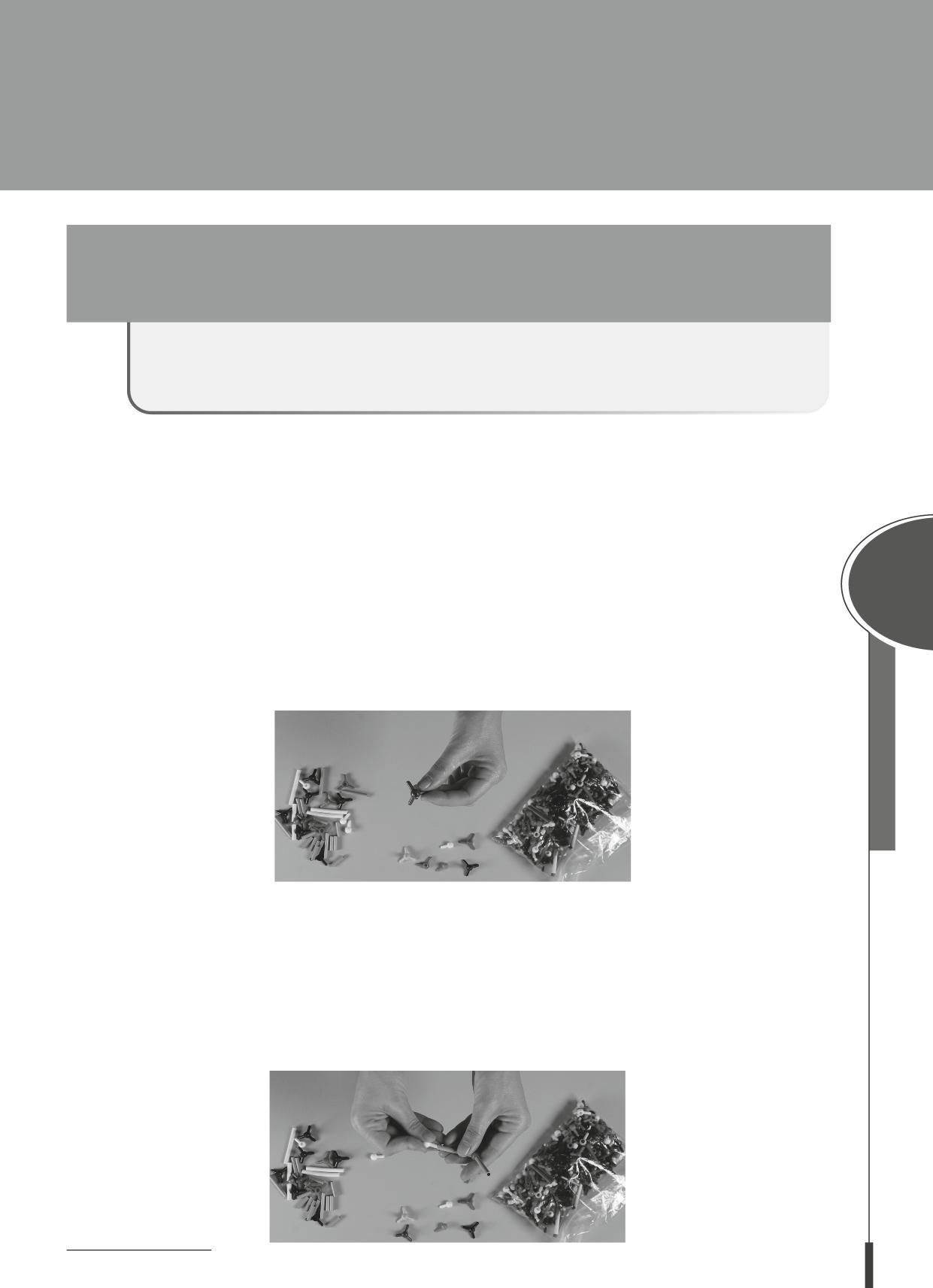
DIDATTICA CON I MODELLI MOLECOLARI
1. Che cosa sono i modelli molecolari?
Attività 1
Scopo: spiegare i vantaggi dell’uso dei modelli molecolari e illustrare in che modo vengono costruiti con i pezzi del kit didattico
Durante lo studio della chimica, uno dei principali problemi è quello di rappresentare le strutture reali delle molecole, dal momento che le sole formule molecolari non sono sufficienti a indicare i tipi di legame che tengono uniti gli atomi e tanto meno le relative geometrie molecolari. Le scritture H2O, NH3, CH4 o C4H10 non forniscono allo studente alcuna informazione su come siano legati tra loro gli atomi. Grazie ai modelli molecolari le molecole assumono “concretezza” e la loro rappresentazione viene memorizzata con facilità dagli studenti. Inoltre, con l’uso dei modelli molecolari si può invertire l’ordine dell’apprendimento: anziché associare a un nome una formula, risulta molto più efficace costruire prima il modello, poi assegnare un nome e infine ricavare una rappresentazione grafica, cioè la formula di struttura. I modelli molecolari contenuti nel kit sono costituiti da un insieme di centri di plastica di forma approssimativamente sferica, ciascuno munito di un certo numero di dentini posti ad angoli ben determinati in accordo con gli angoli di legame che dovranno raffigurare.
I centri sono di colore diverso a seconda dell’elemento che rappresentano: bianco = idrogeno
rosso = ossigeno
blu = azoto
giallo = zolfo
nero = carbonio
verde = alogeni verde chiaro = fluoro viola = fosforo argento = metallo
Se l’elemento è monovalente la pallina che lo rappresenta ha un solo dentino, come per l’idrogeno; se è bivalente ne ha due, come per l’ossigeno, tre per l’azoto trivalente e quattro per il carbonio tetravalente. Si noti, tuttavia, che per molti elementi sono presenti palline (centri colorati) con un numero diverso di dentini e/o con angoli di legame diversi. Ciò è utile per rappresentare con i dentini non solo gli elettroni di legame ma anche i doppietti di non legame che concorrono a determinare la geometria molecolare e/o per discutere i diversi tipi di ibridazione. Per esempio, per l’ossigeno si userà il centro con due dentini disposti “a V” (a 120°) quando si voglia semplicemente rappresentare la bivalenza, per esempio se si deve costruire il gruppo OH di un alcol:
L’impiego del centro con quattro dentini a tetraedro (110°) permetterà al docente di sottolineare la presenza di doppietti elettronici che concorrono a schiacciare l’angolo di legame, come previsto dalla teoria VSEPR per molecole AX2E2
Il docente che volesse approfondire la trattazione della teoria VSEPR mostrando geometrie molecolari complesse non discusse nel testo, come quella bipiramidale trigonale o quella ottaedrica, potrà farlo ricorrendo ai centri colorati con il numero opportuno di dentini: per esempio, il centro viola (P) con cinque dentini a 120° e a 90° servirà per mostrare la molecola bipiramidale trigonale di PCl5, quello giallo (S) con 6 dentini a 90° permetterà di rappresentare la molecola ottaedrica di SF6, e così via.
Analogamente, per elementi come il carbonio si potrà utilizzare un centro con tre dentini disposti a 120° quando si debbano rappresentare molecole insature in cui il carbonio presenta ibridazione sp2 , mentre si ricorrerà al centro con due dentini disposti a 180° quando di debbano rappresentare alchini, in cui il carbonio presenta ibridazione sp
Per i legami si utilizzano invece dei tubicini che vengono inseriti nei dentini per legare tra loro gli atomi. Le molecole sono realizzate inserendo i tubicini di plastica da 2 e 3,5 centimetri di lunghezza, in base al tipo di legame che devono simulare.
Per i legami semplici covalenti si utilizzano tubicini di colore grigio, mentre per i legami multipli si usano tubicini flessibili di colore bianco.
L’utilizzo sistematico dei modelli molecolari aiuta lo studente a memorizzare le valenze degli elementi e il codice colore che viene utilizzato nel libro di testo per rappresentarli graficamente.
Nella seguente tabella è riportato l’elenco dei pezzi contenuti nel kit.
Caratteristiche dei
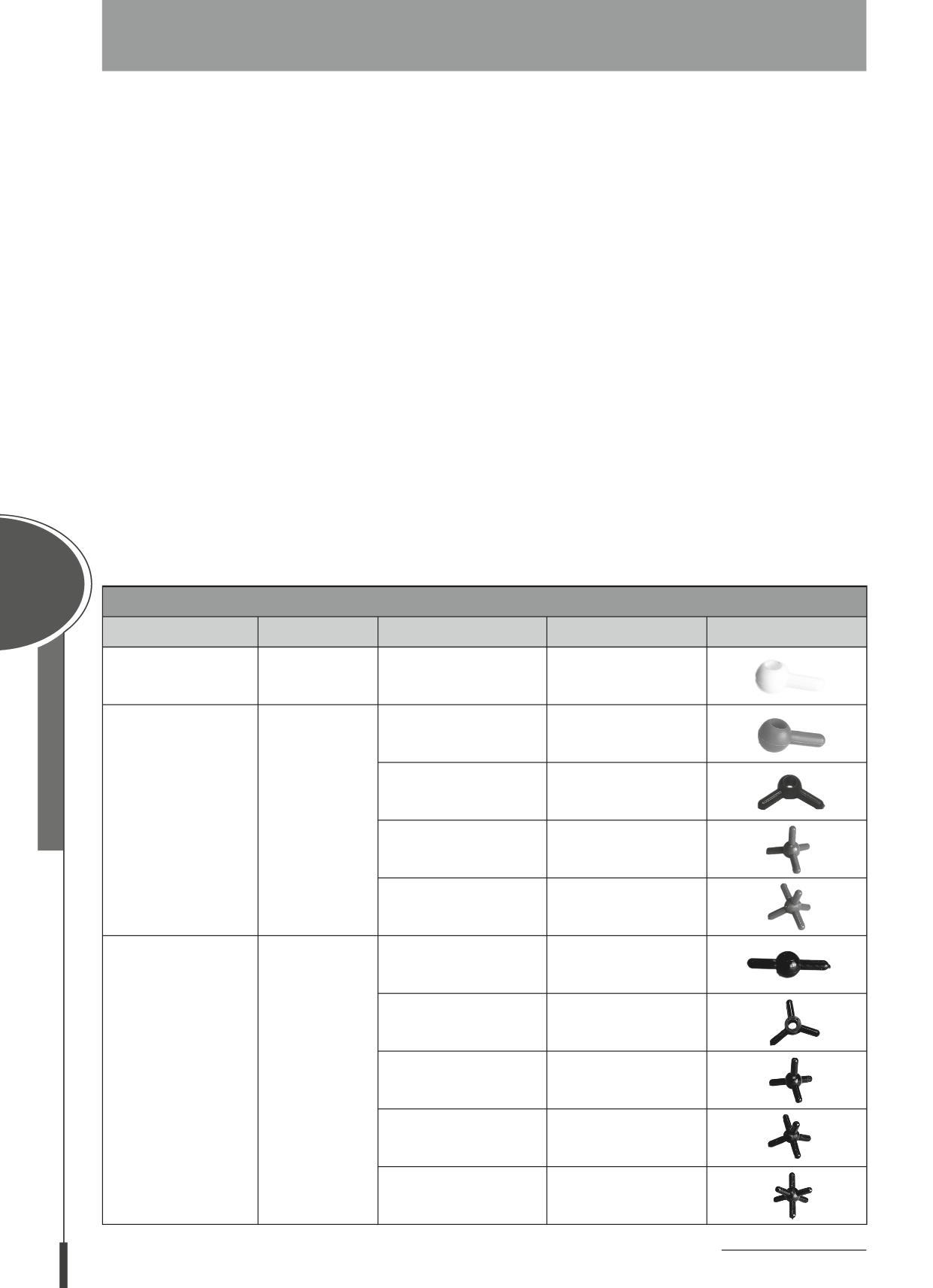
Idrogeno, H bianco
Ossigeno, O rosso
Carbonio, C nero
trigonale
Azoto, N blu
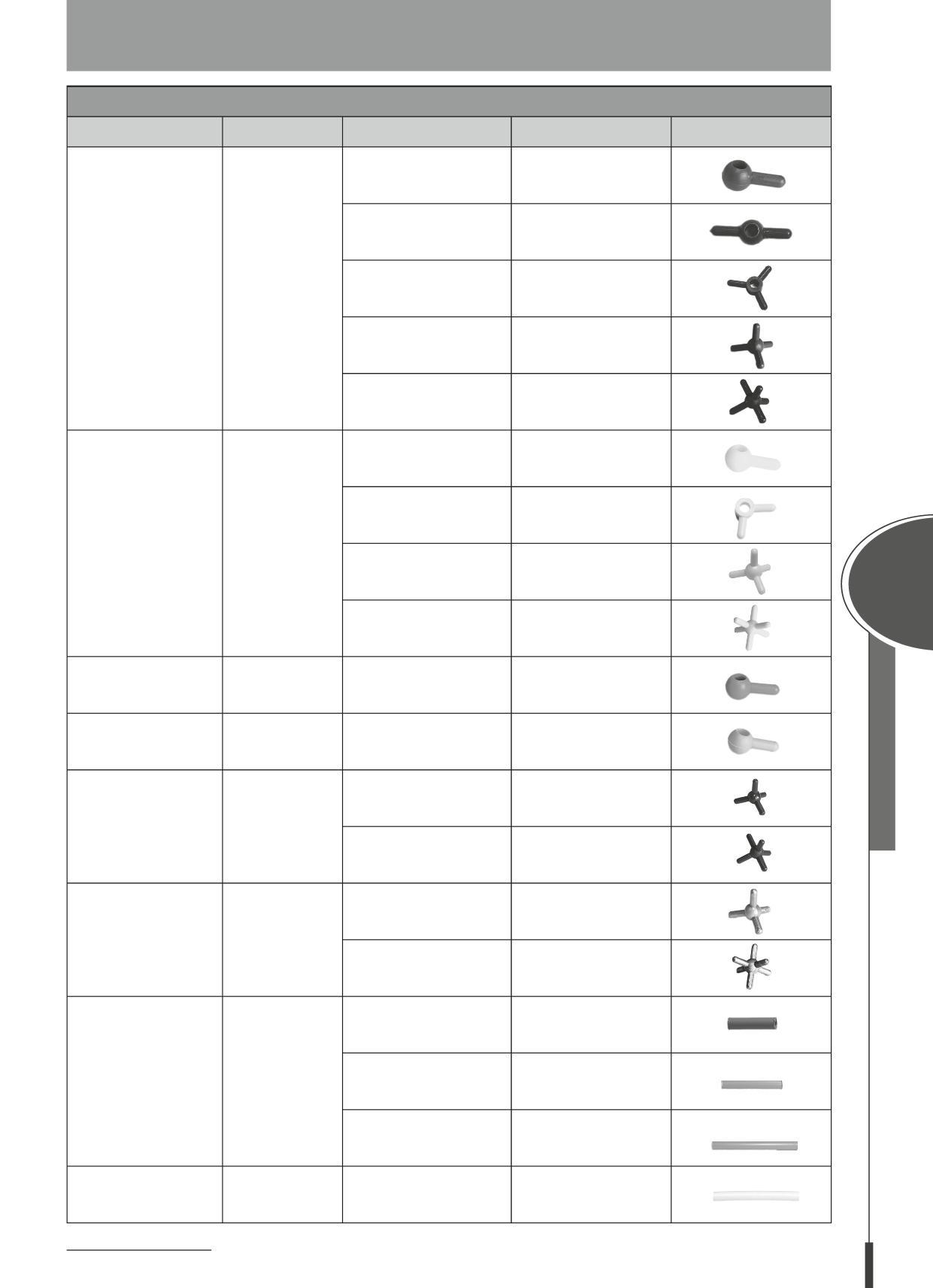
Zolfo, S giallo
Caratteristiche
monovalente 180° lineare 180° trigonale 120°
tetraedrico 110°
bipiramidale trigonale 120°/90°
monovalente 180°
Cloro, Cl (alogeni)verde monovalente 180°
Fluoro, F verde chiaromonovalente 180°
tetraedrico 110°
Fosforo, P viola
Metalli argento
bipiramidale trigonale 120°/90°
tetraedrico 110° ottaedrico 90°
Attività 2
Scopo: costruire modelli molecolari di difficile rappresentazione sulla carta (su un piano bidimensionale)
Pezzi occorrenti: per CH4: 1 centro nero con quattro dentini • 4 centri bianchi • 4 tubicini da 2 cm; per i cloroderivati: 4 centri verdi
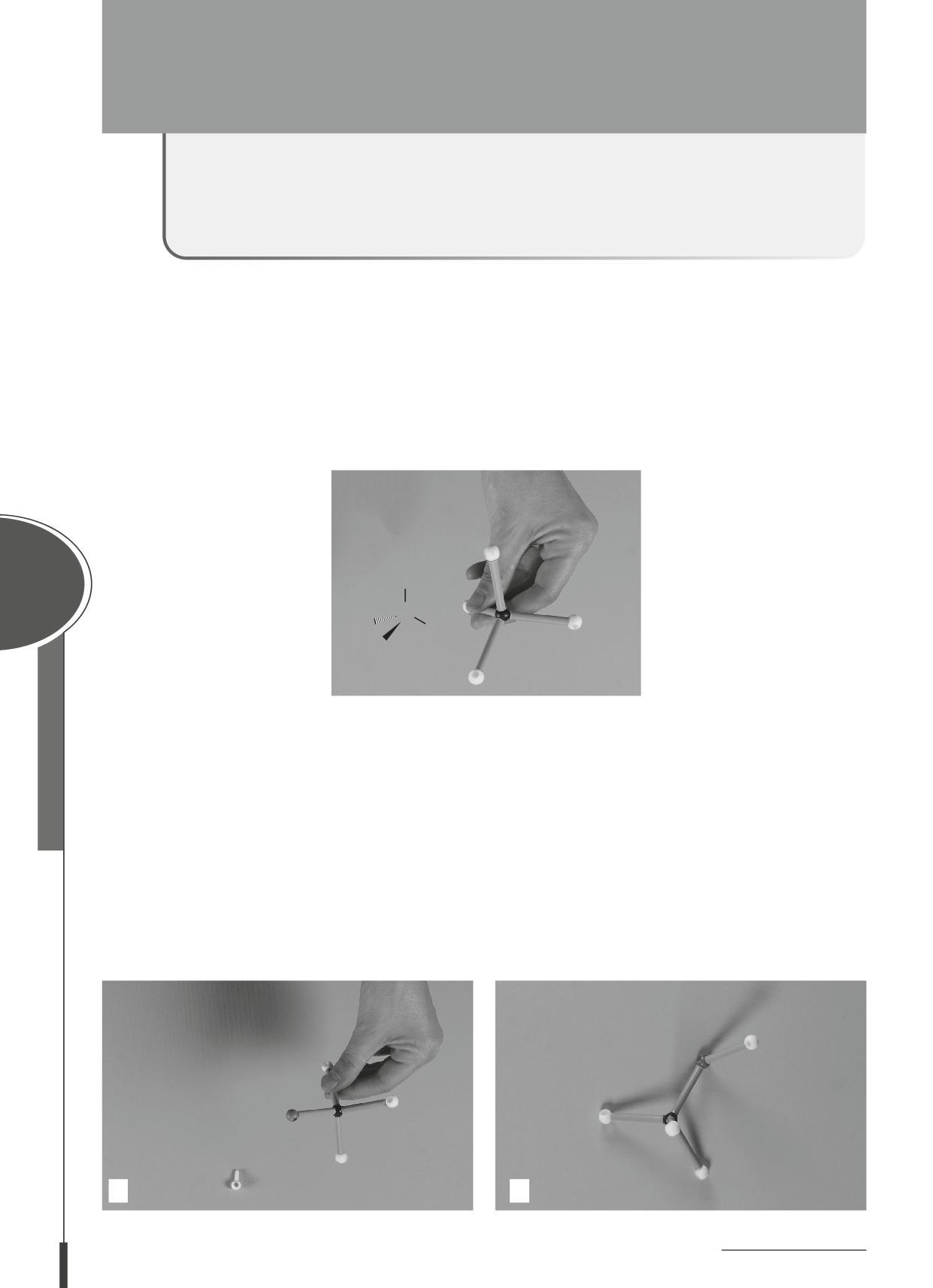
Osservazioni
Una volta realizzato il modello spieghiamo che per convenzione si usano linee piene per disegnare i legami che giacciono sul piano, linee tratteggiate per quelli che giacciono al di sotto del piano e linee a cuneo per quelli che si trovano al di sopra del piano: chiediamo agli studenti di provare a disegnare da soli il metano in proiezione, correggendo poi il disegno alla lavagna o alla LIM.
Ulteriori considerazioni
Una volta costruito il metano è interessante costruirne via via i cloroderivati e ragionare con gli studenti sulla nomenclatura. Sostituendo gli atomi di idrogeno con altrettanti di cloro si costruiscono in sequenza il clorometano (a), il diclorometano, il triclormetano (cloroformio) e il tetraclorometano.
Se invece si riparte dal metano e si sostituisce un atomo di idrogeno con un ossidrile, che si farà trovare già pronto, si costruisce il metanolo (b).
I modelli molecolari sono particolarmente indicati per lo studio dei composti organici. È difficile, infatti, visualizzare sul piano le loro strutture tridimensionali. La formula molecolare del metano è molto semplice: CH4, ma la formula di struttura è di difficile rappresentazione nel piano, in quanto il carbonio orienta i suoi legami lungo i vertici di un tetraedro. Per realizzare il modello molecolare si parte da un una pallina nera con quattro dentini, il carbonio tetraedrico, sulla quale si innestano quattro legami mediante tubicini da 2 cm. Sui legami così predisposti si innestano infine quattro palline bianche che rappresentano i quattro idrogeni. a b
3. Gli alcani superiori
Attività 3a
Scopo: ricavare in maniera empirica la formula generale degli alcani Pezzi occorrenti: per ciascun modellino di metano: 1 centro nero • 4 centri bianchi • 4 tubicini da 2 cm per l’etano: 2 modellini di metano • 1 tubicino da 3,5 cm per il propano e il butano: si aggiunge ogni volta un modellino di metano utilizzando un tubicino da 3,5 cm
La lezione può partire dall’esame delle formule di struttura semplificate e condensate degli alcani e dalla constatazione che la geometria può essere rappresentata e compresa meglio facendo ricorso a modelli tridimensionali delle molecole in esame.
Ricordando che il carbonio, oltre che agli idrogeni, può legarsi anche ad altri atomi di carbonio, si prendono due molecole di metano precedentemente predisposte e da ciascuna di esse si staccano due atomi di idrogeno (a).
Dopodiché si legano tra loro i due atomi di carbonio tramite un tubicino da 3,5 cm. Si ottiene così l’etano (b).
Con lo stesso procedimento, staccando un atomo di idrogeno dall’etano e collegando tramite un tubicino da 3,5 cm. un altro metano privato di un idrogeno, si ottiene il propano (c).
Procedendo allo stesso modo ancora una volta si ottiene il butano (d).
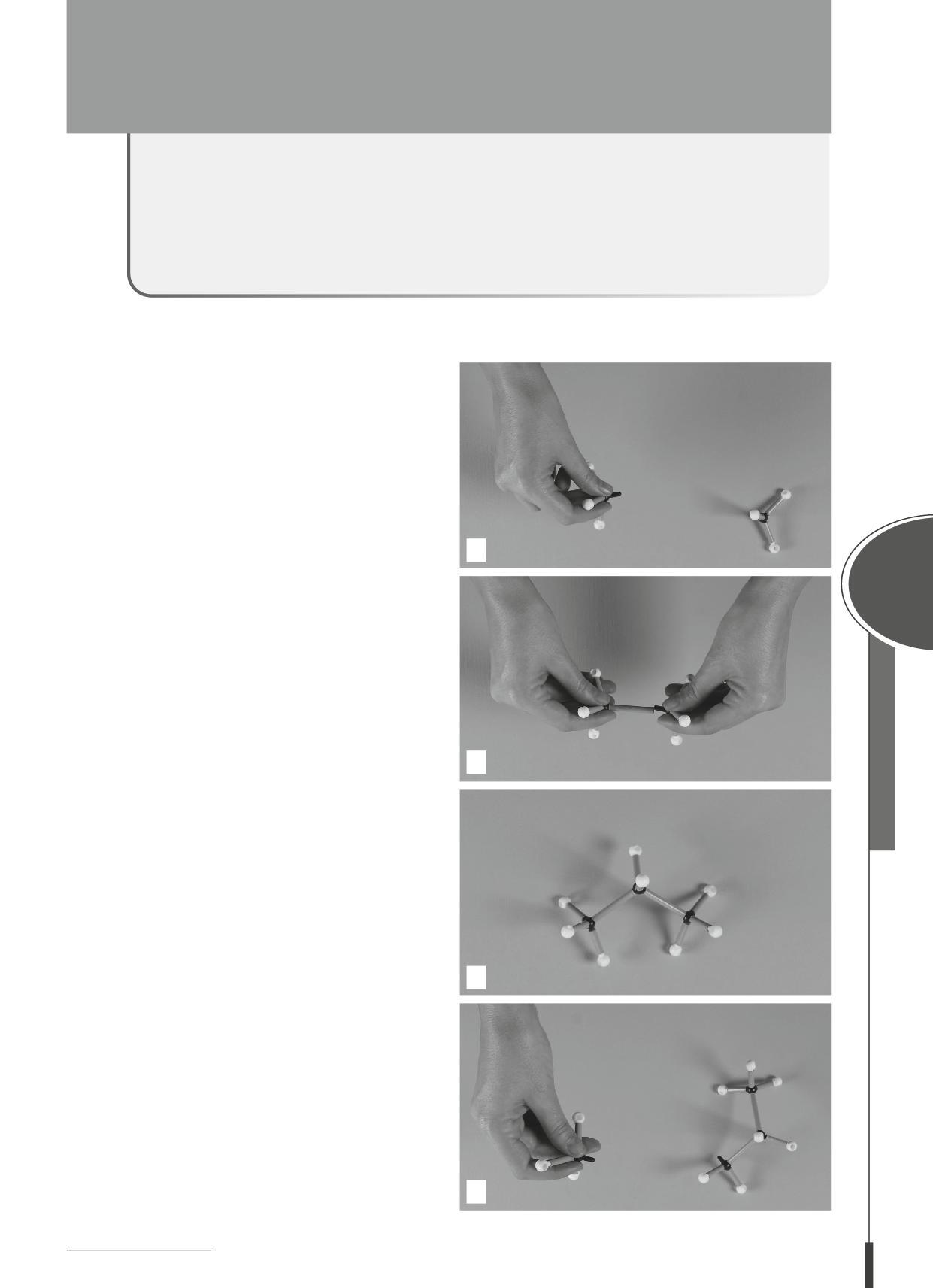
Osservazioni
Una prima riflessione, con i modelli molecolari alla mano, può essere quella di far ricavare in maniera empirica la formula generale degli alcani CnH2n + 2: basta far contare gli atomi per ciascun alcano e far notare che tutte le formule rispondono a quella formula generale.
Ulteriori considerazioni
Dal confronto di due idrocarburi consecutivi inoltre, etano-propano e propano-butano, si può pure far osservare che ciascun termine differisce dal precedente per un gruppo CH2 ed è per questo che si usa il termine serie omologa
Attività 3b
Scopo: ricavare in maniera empirica il concetto di isomeria di struttura
Pezzi occorrenti: 15 modellini di metano (1 centro nero, 4 centri bianchi, 4 tubicini da 2 cm) già pronti prima di cominciare l’attività • 12 tubicini da 3,5 cm
Disponendo di cinque modellini di metano si può cominciare la lezione chiedendo alla classe in quanti modi è possibile costruire una sequenza che leghi cinque metani tra loro.
L’insegnante costruirà poi i modelli delle sequenze individuate dagli studenti e li metterà a confronto (n-pentano, 2-metilbutano, dimetilpropano):
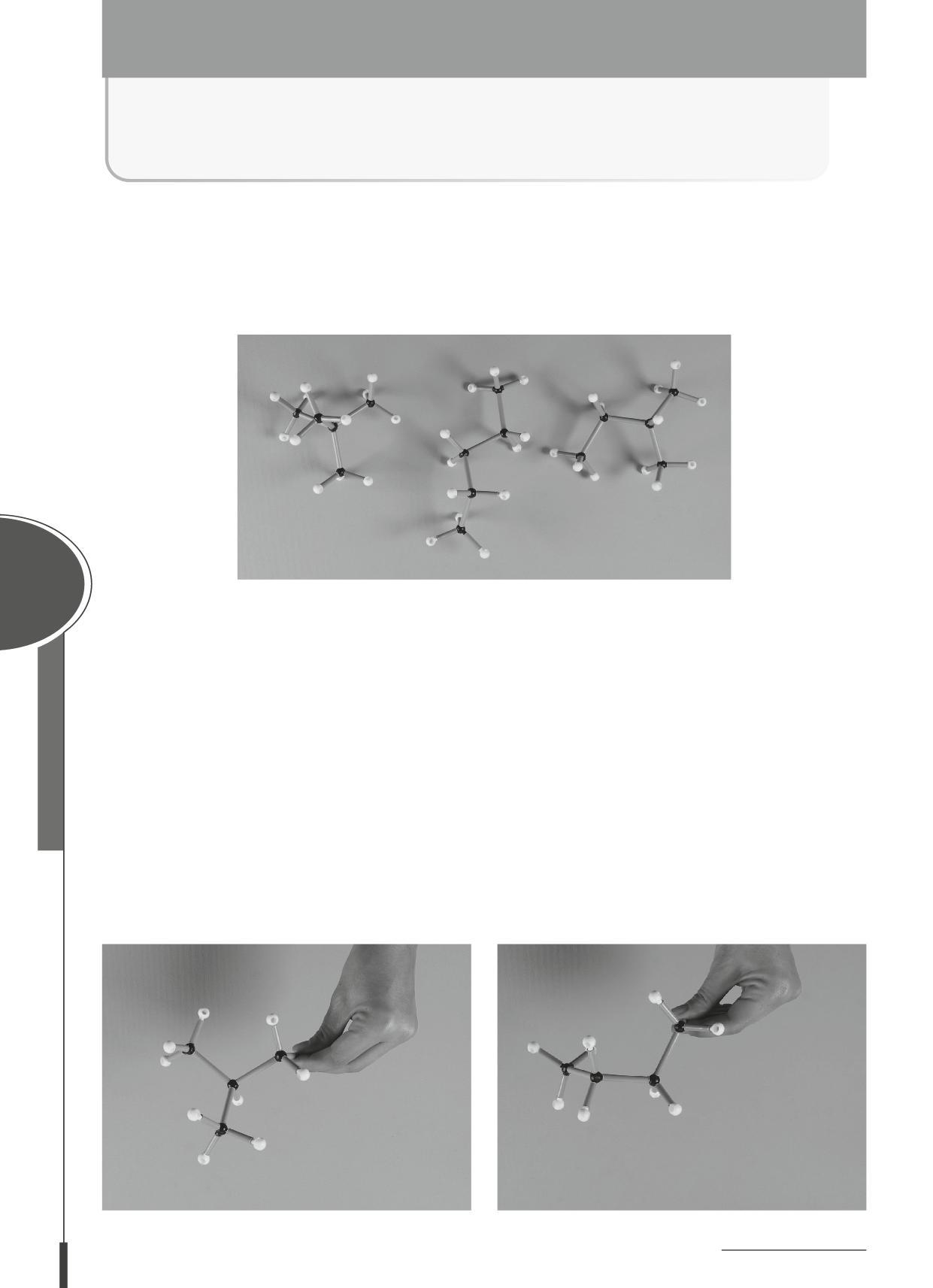
Osservazioni
Con i modelli molecolari alla mano, l’insegnante guiderà gli studenti a concludere che la formula molecolare C5H12, che è la stessa per tutti i tre i modelli, da sola non dà alcuna indicazione sulla geometria della catena, che nel primo caso è lineare, nel secondo ha una ramificazione e nel terzo due ramificazioni. Le diverse strutture che si possono ottenere aumentando il numero di atomi di carbonio sono i diversi isomeri di struttura di una molecola. Si può chiedere alla classe di formulare una definizione di isomeri di struttura (molecole con la stessa formula molecolare ma diversa formula di struttura dovuta a una diversa sequenza degli atomi di carbonio).
Ulteriori considerazioni
Si può far notare alla classe che, poiché per passare da una struttura all’altra è necessario rompere dei legami e crearne di nuovi, siamo in presenza di sostanze diverse.
Domande per la classe:
• A partire da quanti atomi di carbonio è possibile formare isomeri di struttura?
• Quanti isomeri di struttura si possono costruire con 4 atomi di carbonio e 10 atomi di idrogeno?
4. La conformazione degli alcani
Attività 4
Scopo: scoprire empiricamente il concetto di conformazione
Pezzi occorrenti: 2 modellini di metano già pronti • 1 tubicino di 3,5 cm • modellino del normalbutano (si può utilizzare quello costruito come esercizio alla fine dell’attività precedente) per il cicloesano: 6 centri neri con quattro dentini • 12 centri bianchi • 12 tubicini da 2 cm • 6 tubicini da 3,5 cm
Si comincia costruendo l’etano a partire da due metani. Per unire i due metani si utilizza un tubicino da 3,5 cm (a).
Osservazioni
L’insegnante mostra alla classe che è possibile effettuare una rotazione attorno al legame C—C senza spezzarlo.
Ruotando lentamente un carbonio rispetto all’altro si fanno notare, tra le tante, due particolari posizioni che si chiamano conformazioni.
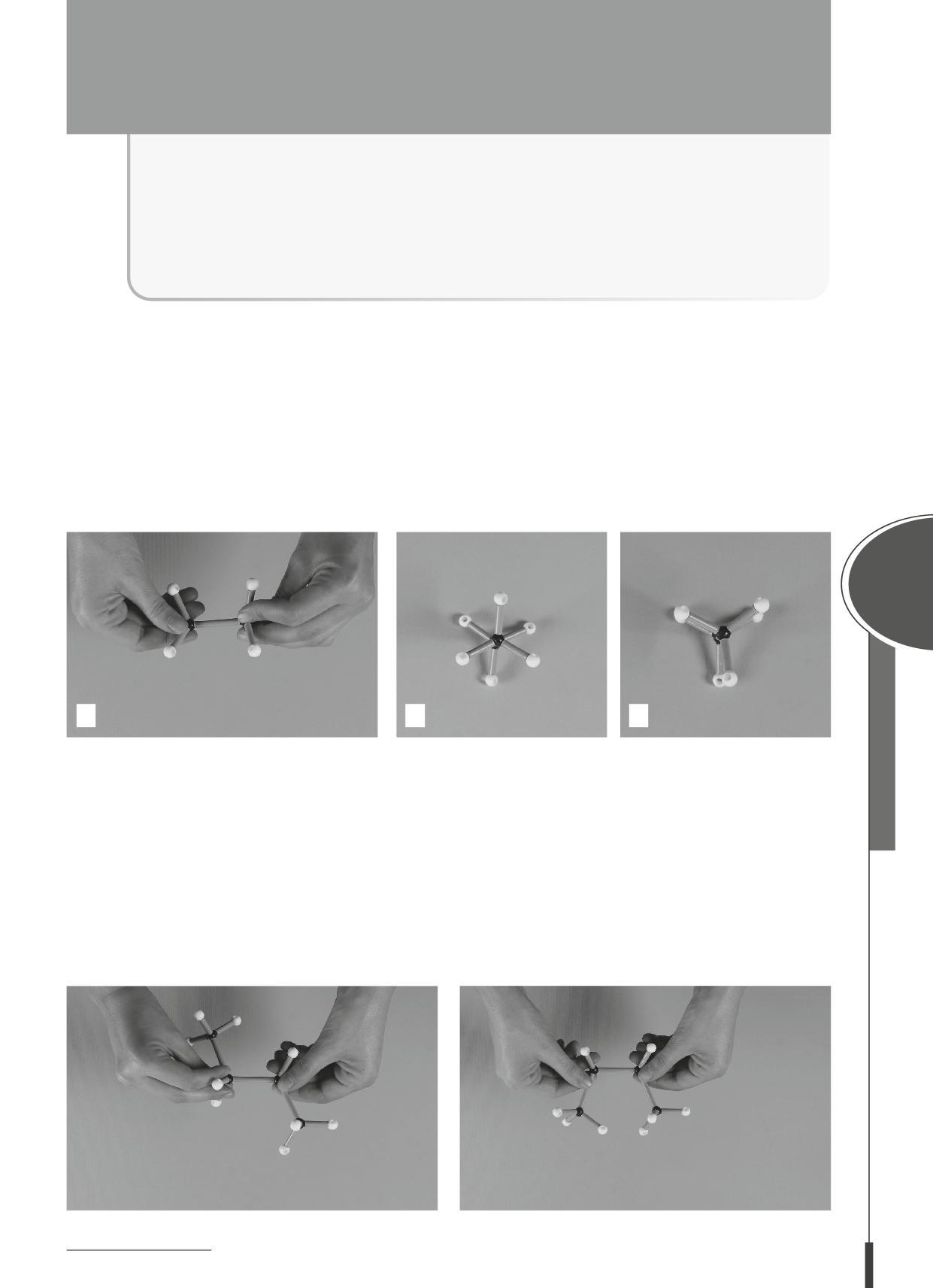
a c b
A questo punto si può chiedere ai ragazzi se, a loro avviso, le conformazioni sono sostanze diverse.
L’insegnante porterà l’attenzione sul fatto che per passare da una conformazione sfalsata (b) a una eclissata (c), e viceversa, non è necessario rompere legami. Si farà notare la differenza con il caso degli isomeri che sono a tutti gli effetti sostanze diverse anche se simili.
Ulteriori considerazioni
Si possono mostrare alla classe le rappresentazioni grafiche dei due conformeri mediante normali proiezioni sul piano oppure mediante proiezioni di Newman. Si possono scoprire insieme alla classe le conformazioni che può assumere il normal-butano operando una rotazione attorno al legame tra il carbonio 2 e il carbonio 3.
L’insegnante indicherà alla classe quale delle due conformazioni è favorita (ANTI) e quale sfavorita (SYN) e può provare a chiedere ai ragazzi se riescono a ipotizzare il perché (nella conformazione ANTI i due metili sono alla massima distanza reciproca).
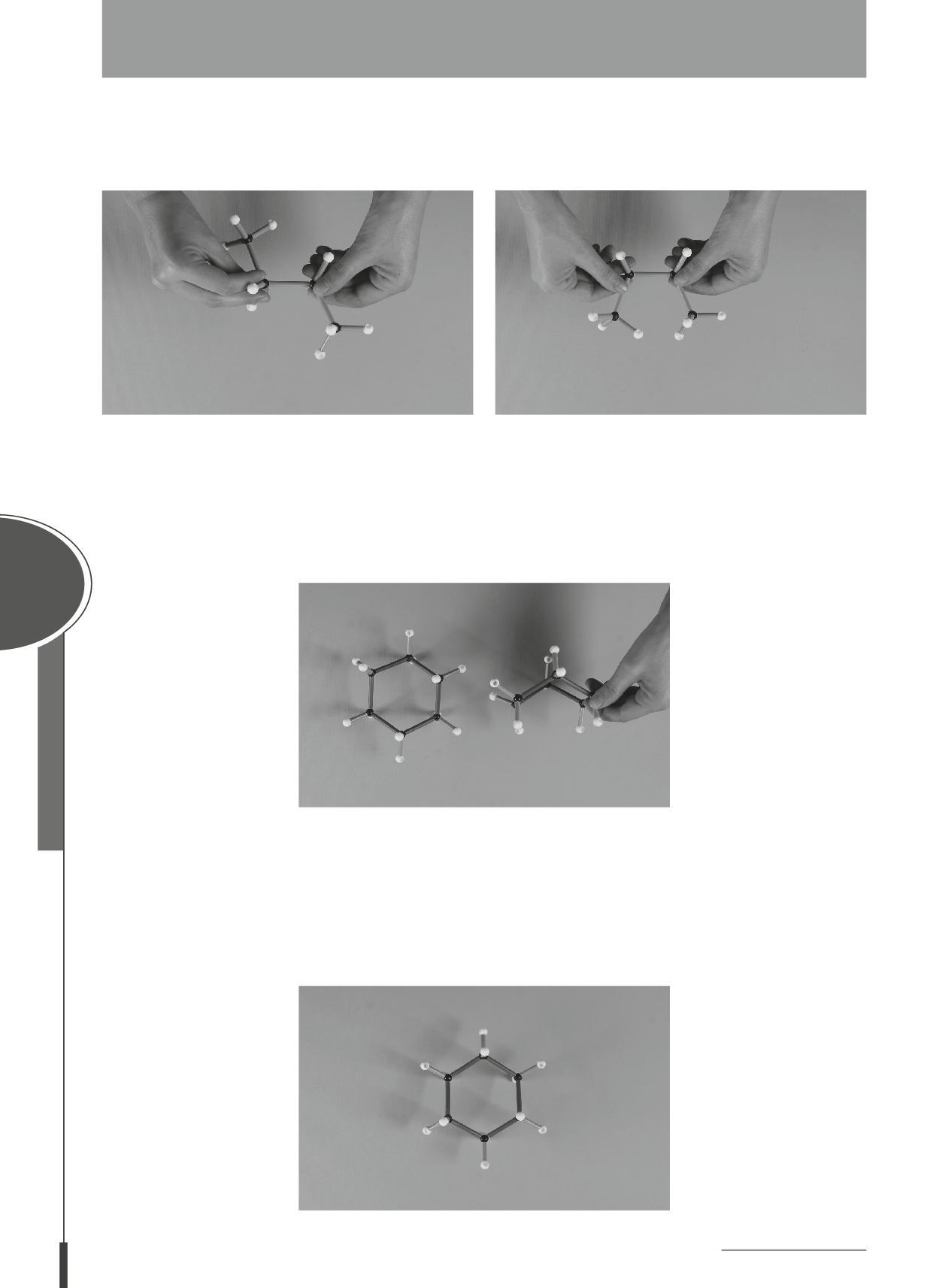
Un approfondimento in merito alle conformazioni riguarda in particolare il cicloesano che presenta la conformazione a barca e a sedia, che l’insegnante può costruire insieme ai ragazzi o preparare già costruiti prima della lezione. Lo scopo dell’attività non è infatti la costruzione di alcani ciclici ma mostrare che la stabilità della conformazione dipende dai legami C—H che sono eclissati nel caso della barca e sfalsati nel caso della sedia. In questo secondo caso si verifica la situazione in cui i dodici atomi di idrogeno sono meno ravvicinati nello spazio.
Con il modello tridimensionale della conformazione a sedia alla mano si potrà introdurre la nomenclatura dei legami in modo più agevole rispetto al mostrare le figure bidimensionali sul libro di testo:
• i sei legami C—H che si trovano perpendicolari al piano mediano della molecola si chiamano assiali
• i tre legami assiali al di sopra del piano si chiamano alfa
• i tre legami assiali al di sotto del piano si chiamano beta
• i sei legami orientati verso l’esterno della molecola si chiamano equatoriali
5. I cicloalcani
Attività 5
Scopo: investigare la geometria e gli angoli di legame di alcani ciclici
Pezzi occorrenti: per il ciclopropano: 3 centri neri • 6 centri bianchi • 6 tubicini grigi da 2 cm • 3 tubicini grigi da 3,5 cm • 3 tubicini bianchi flessibili
per il ciclobutano: 4 centri neri • 8 centri bianchi • 8 tubicini grigi da 2 cm • 4 tubicini grigi da 3,5 cm • 4 tubicini bianchi flessibili
per il ciclopentano: 5 centri neri • 10 centri bianchi • 10 tubicini grigi da 2 cm • 5 tubicini grigi da 3,5 cm • 5 tubicini bianchi flessibili
per il cicloesano: 6 centri neri con quattro dentini • 12 centri bianchi • 12 tubicini da 2 cm • 6 tubicini da 3,5 cm
Per cominciare l’attività si prepara un modellino del propano, utilizzando tubicini grigi rigidi e si prova a eliminare un idrogeno terminale per richiudere la struttura su se stessa a formare un alcano ciclico (a).
Ovviamente con i legami rigidi risulta impossibile ottenere il risultato. Per il ciclopropano si dovrebbe infatti forzare l’angolo tetraedrico dai 109° iniziali fino ad arrivare a 60°, l’angolo interno di un triangolo equilatero.
Sostituiamo adesso i legami C—C con dei tubicini bianchi flessibili e riproviamo (b).
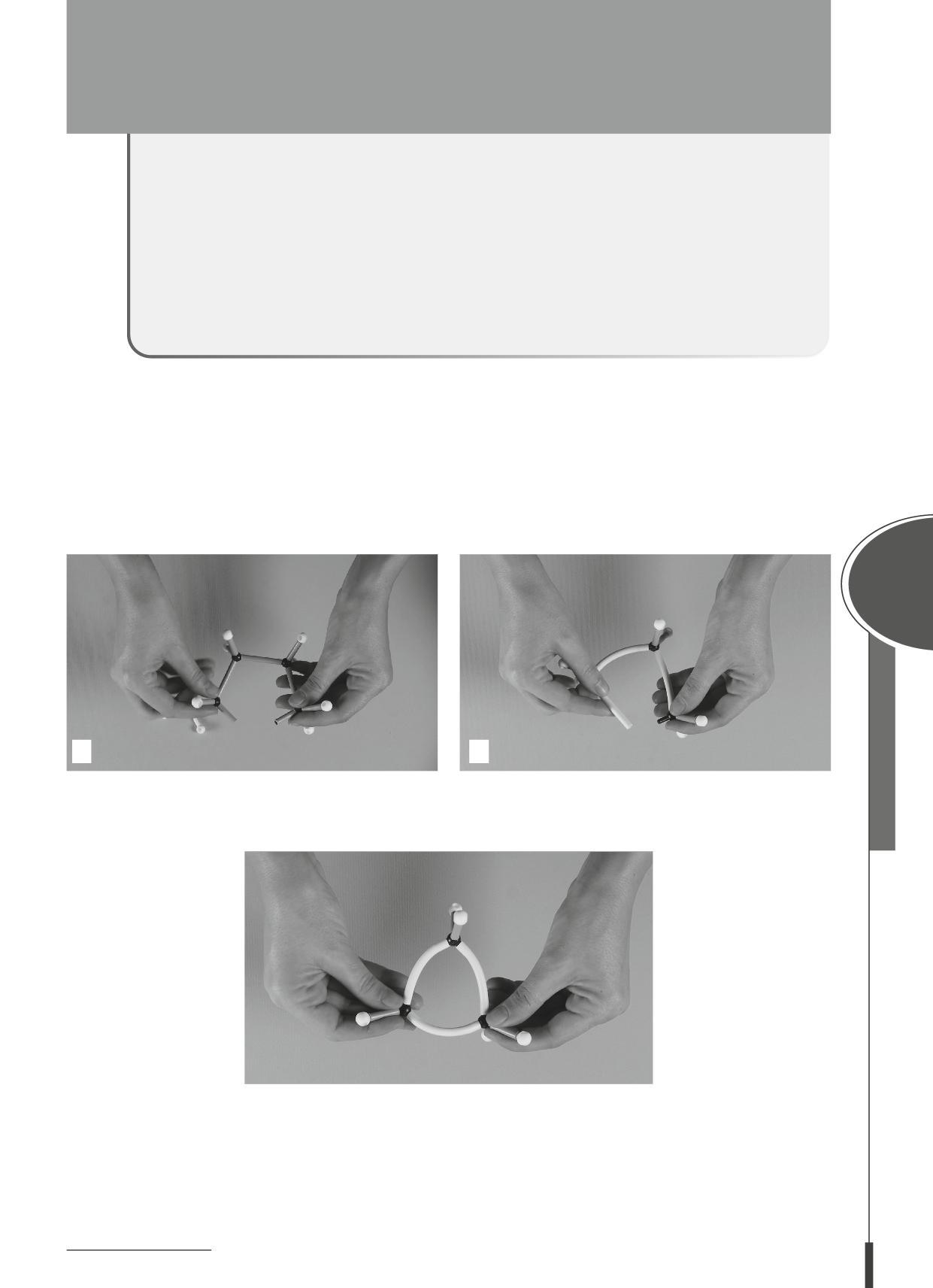
Il risultato è facilmente ottenibile grazie alla flessibilità del materiale plastico e porta al modello molecolare del ciclopropano.
Osservazioni
Una volta costruito il modello l’insegnante può completare le informazioni su questa molecola, informando la classe che in realtà essa è alquanto instabile dal momento che gli orbitali non si trovano più nella direzione che permette di sovrapporsi. Il ciclopropano presenta allora una certa tensione, nota come tensione di Bayer, che induce l’anello ad aprirsi e a ripristinare il propano.
Ulteriori considerazioni
Si possono ripetere le stesse considerazioni a partire dal normal-butano per ottenere il ciclobutano.
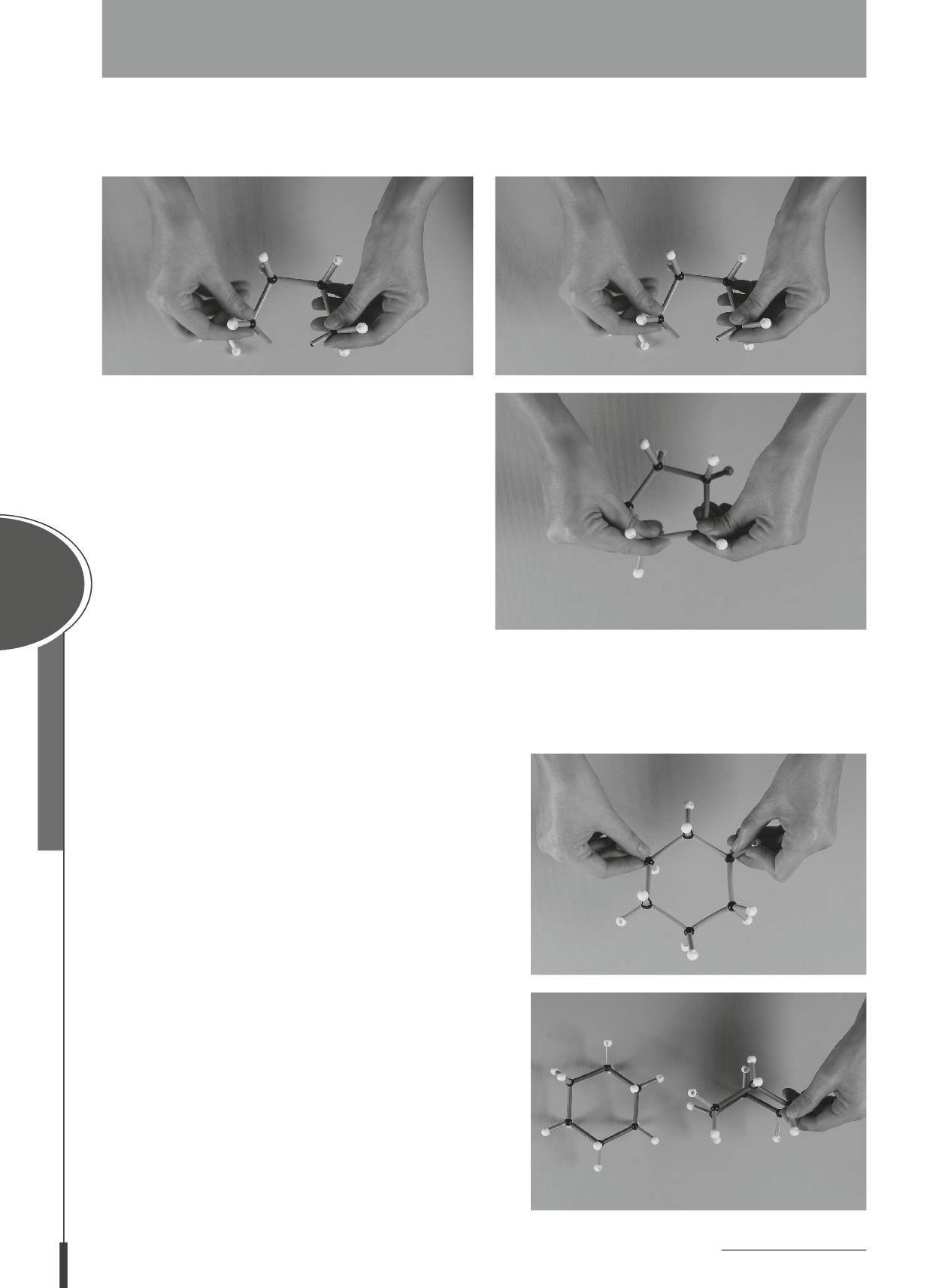
L’insegnante chiederà alla classe di calcolare (anche approssimativamente) l’angolo di legame finale tra i carboni. Una volta stabilito che l’angolo è di 90° si chiederà ai ragazzi se a loro avviso il ciclobutano è più o meno stabile del ciclopropano e perché (la compressione da 109° a 90° è minore di quella richiesta per piegare da 109° a 60° l’angolo nel caso del propano). Alla risposta gli studenti possono anche arrivare semplicemente dalla maggiore o minore difficoltà riscontrata nel richiudere il modellino su se stesso nei due casi, seppur in presenza di tubicini flessibili.
Prima di costruire il ciclopentano si analizzi con la classe la situazione dal punto di vista geometrico, essendo l’angolo interno di un pentagono regolare di 108°: quali conclusioni si possono trarre a priori?
Osservando il modello con più attenzione l’insegnante farà notare alla classe che il modello non è quello di un pentagono perfetto, in quanto quattro carboni giacciono su un piano mentre il quinto tende a spostarsi leggermente dal piano per ripristinare l’angolo tetraedrico.
La stessa osservazione può essere fatta sul modello del ciclobutano, per il quale tre carboni giacciono su un piano e il quarto fuori.
Infine si prenderà in esame il caso del cicloesano, per il quale la previsione della classe sicuramente sarà di maggiore tensione angolare, dovendo forzare un angolo di 109° ad assumere l’ampiezza di 120°. In effetti invece si mostrerà alla classe che il cicloesano è il più facile dei cicloalcani da ottenere e il più stabile.
Come di consueto, prima di dare alla classe la risposta sul perché ciò accada, è bene provare a far esaminare agli studenti il modello per lasciar tentare di spiegare a loro cosa succede, in base alla geometria del modello. Se la risposta non scaturisce dagli studenti, l’insegnante porrà l’attenzione dei ragazzi sul fatto che i sei carboni non si assestano sullo stesso piano e non descrivono un esagono regolare.
Gli atomi di carbonio si trovano su piani diversi e riescono a mantenere un angolo di 109° tra l’uno e l’altro assumendo diverse conformazioni spaziali: la sedia e la barca.
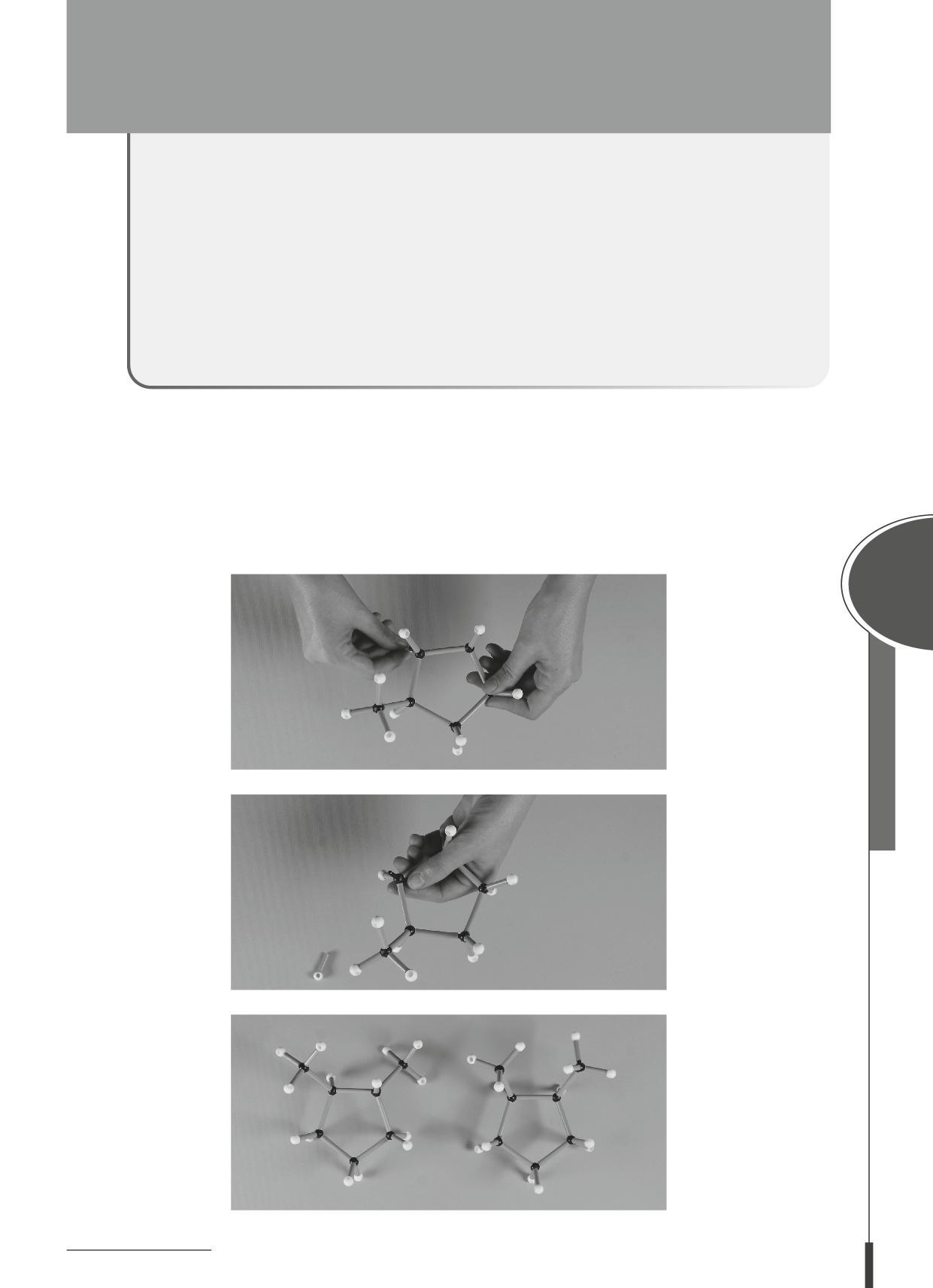
6. La stereoisomeria
Attività 6
Scopo: costruire stereoisomeri di alcune molecole organiche
Pezzi occorrenti: un modellino del ciclopentano (si veda l’attività 5) • un modellino del n-butano (si veda l’attività 3) per ciascun gruppo metile: 1 centro nero • 3 centri bianchi • 3 tubicini da 2 cm per ciascun 2-butene: 4 centri neri • 8 centri bianchi • 8 tubicini grigi da 2 cm • 2 tubicini grigi da 3,5 cm • 2 tubicini bianchi flessibili (per il doppio legame) per la rappresentazione della coppia di enantiomeri: 2 centri neri • 2 centri bianchi • 2 centri rossi con un dentino • 2 centri blu con un dentino • 2 centri verdi • 8 tubicini grigi per la rappresentazione della coppia di molecole achirali: 2 centri neri • 2 centri bianchi • 2 centri rossi con un dentino • 4 centri verdi • 8 tubicini grigi
Per cominciare l’attività si prepara un modello molecolare del metilciclopentano, partendo dal ciclopentano utilizzato nell’attività precedente e sostituendo a un idrogeno un gruppo metile CH3
Per costruire il modello dell’1,2-dimetilciclopentano, si deve sostituire un idrogeno con un secondo metile, in posizione adiacente al gruppo metile presente. L’insegnante può cogliere a questo punto l’opportunità di richiamare le regole della nomenclatura per gli alcani a catena lineare e ad anello (cicloalcani), di modi da dare significato ai numeri 1 e 2 che compaiono nel nome IUPAC.
Le possibilità per inserire un metile in posizione 2 sono due: quale idrogeno scegliere?
Osservazioni
Con i due modelli alla mano l’insegnante può chiedere alla classe di scrivere le due formule molecolari brute per far constatare che sono uguali: C7H14. Si scrivono poi le due formule di struttura e si constata ugualmente che sono uguali, essendo i metili in posizione 1,2 in entrambi i casi.
Le due molecole sono però differenti e non è possibile passare dall’una all’altra senza rompere legami e formarne di nuovi, il che in condizioni normali non può avvenire.
I due modelli rappresentano due diverse configurazioni spaziali cioè due stereoisomeri dell’1,2-dimetilciclopentano. Si chiama cis l’isomero che porta i due metili dalla stessa parte rispetto al piano della molecola e trans l’isomero che porta i metili da parti opposte rispetto al piano della molecola.
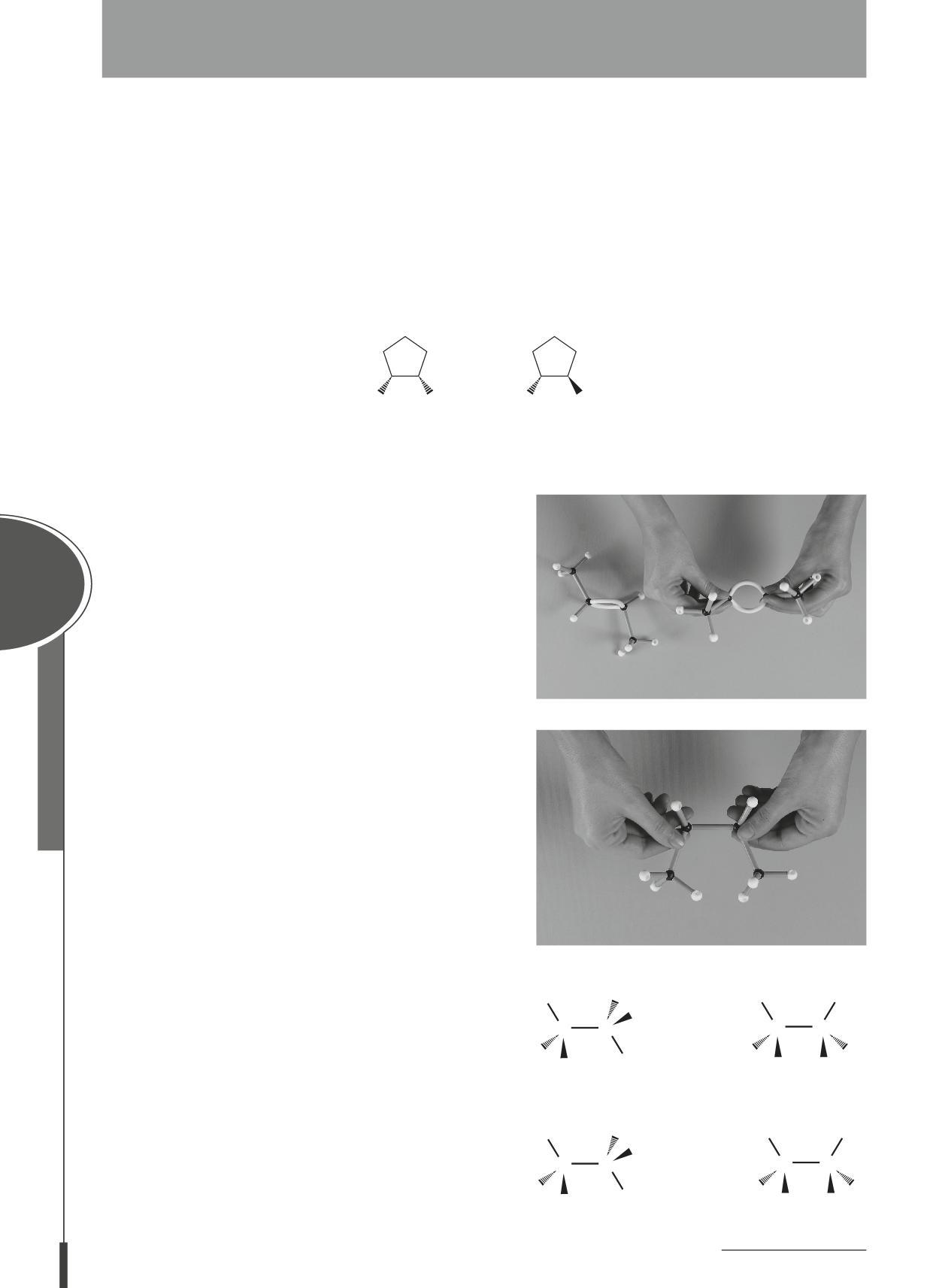
Ulteriori considerazioni
L’insegnante potrebbe chiedere alla classe di disegnare le formule prospettiche dei due stereoisomeri (con cunei pieni e cunei tratteggiati) per rappresentare la tridimensionalità sul foglio bidimensionale. Se la rappresentazione non è ancora stata spiegata, questo può essere un momento opportuno per proporla alla classe.
Lo stesso tipo di stereoisomeria ha luogo con gli alcheni. L’insegnante può mostrare alla classe la formula di struttura chiedere del 2-butene, CH3—CH CH—CH3, cioè l’isomero che porta il doppio legame in posizione 2, e chiedere di costruire i due isomeri cis e trans
Il modello del cis-2-butene deve portare i due metili dalla stessa parte rispetto al piano della molecola e il modello del trans-2-butene li deve avere da parti opposte rispetto al piano della molecola.
Il passo successivo è proporre il confronto con il normalbutano e sollecitare negli studenti l’osservazione che nel 2-butene la presenza del doppio legame impedisce la libera rotazione mentre nel normal-butano la libera rotazione intorno ai legami semplici permette alla molecola di assumere diversi assetti, dando quindi luogo non a stereoisomeri bensì a diverse conformazioni.
È facile infatti mostrare come il modello molecolare ruota, cosa molto complicata da mostrare facendo ricorso alle complesse rappresentazioni bidimensionali (che l’insegnante può mostrare per confronto).
Un altro tipo di stereoisomeria è l’isomeria ottica, nota anche come enantiometria. Lo studio dell’isomeria ottica diventa facile se il docente costruisce le strutture di due enantiomeri, applicando al carbonio tetraedrico quattro palline di diverso colore e invitando poi la classe a esaminarli uno rispetto all’altro. Si chiede alla classe se si tratta di molecole della stessa sostanza. Si pone un modello davanti allo specchio e si chiede agli studenti di costruire l’immagine che lo specchio riflette. Infine, si invitano i ragazzi a provare a sovrapporre i due modelli, così da accorgersi che non sono sovrapponibili in quanto i colori delle sferette non corrispondono.
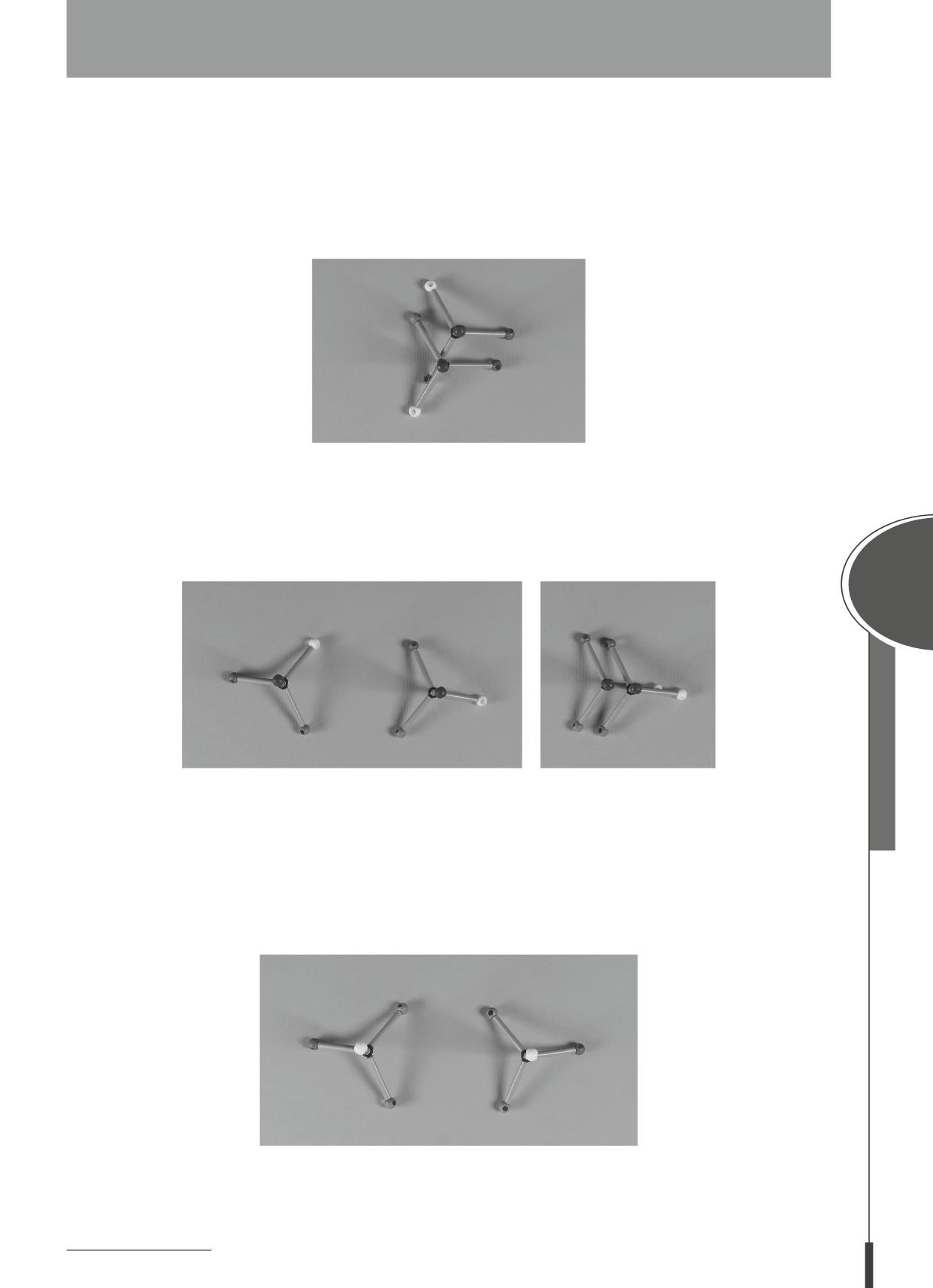
Le due diverse configurazioni sono una l’immagine speculare dell’altra ma non sono sovrapponibili quindi si tratta di sostanze diverse perché non interconvertibili. Se mediante rottura e successiva formazione di nuovi legami cambiamo di posto a due qualsiasi sostituenti, le due molecole diventano sovrapponibili ma non sono più speculari: si tratta allora di due molecole uguali.
Un carbonio come quello utilizzato nell’esempio, che porta quattro sostituenti diversi viene detto carbonio chirale, mentre non è chirale un carbonio che porta almeno due sostituenti uguali. In questo caso la sua immagine speculare è sovrapponibile, pertanto si tratta di due molecole identiche. Il docente che desideri approfondire gli aspetti di stereochimica potrà inoltre costruire molecole con più centri chirali per mostrare alla classe i vari diasteroisomeri possibili, invitando gli studenti a individuare le forme meso che presentano nella loro struttura un piano di simmetria.
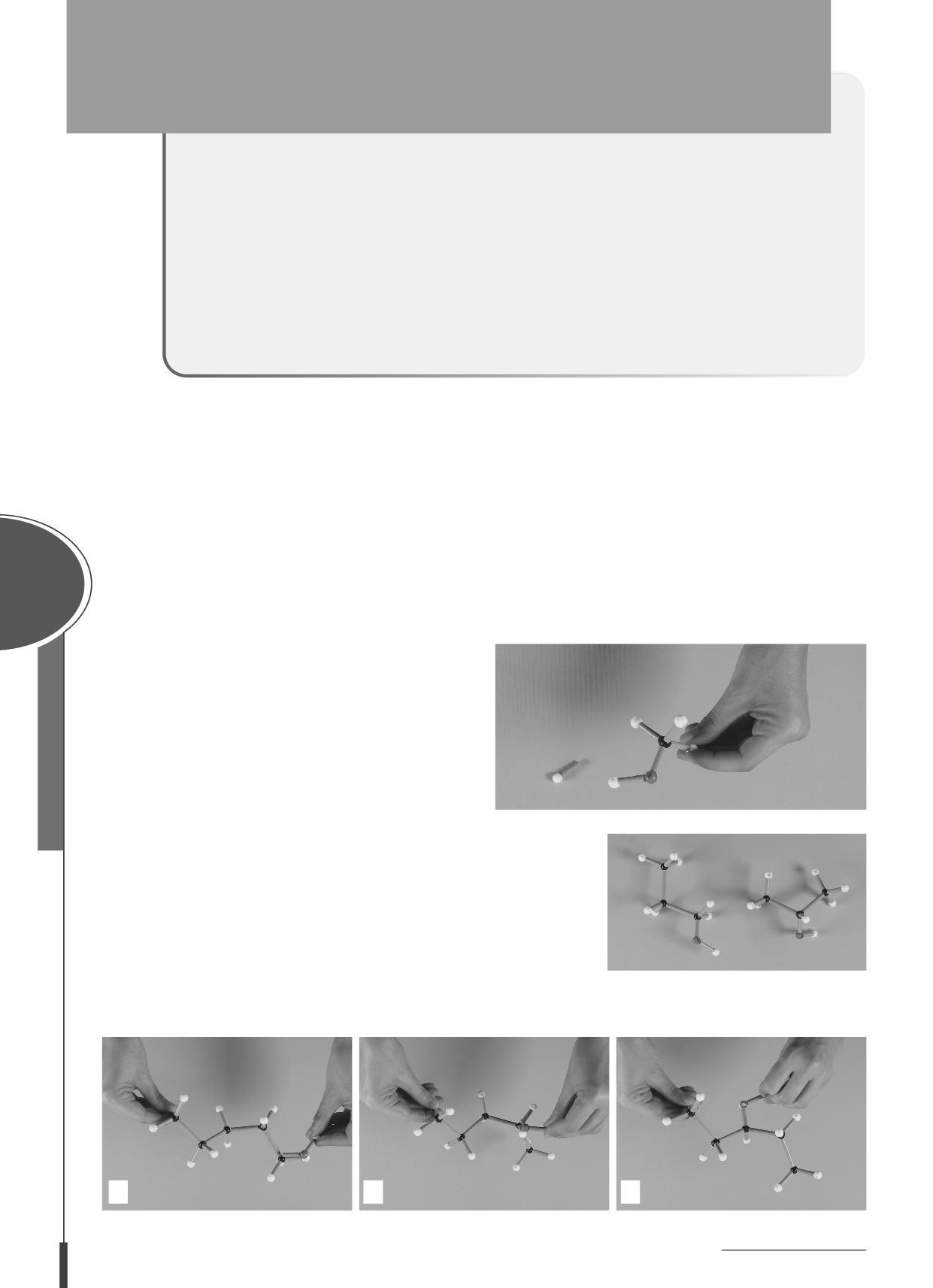
7. I gruppi funzionali
Attività 7
Scopo: carrellata sui gruppi funzionali
Pezzi occorrenti: modellini degli alcani già preparati (si veda l’attività 3) per ciascun gruppo OH: 1 centro rosso con due dentini e 1 bianco • 1 tubicino grigio per l’alogeno: 1 centro verde • 1 tubicino per il gruppo carbonile: 1 centro nero con tre dentini • 1 centro rosso con un dentino • 1 bianco • 3 tubicini per l’amminogruppo: 1 centro blu con quattro dentini • 2 bianchi • 3 tubicini per il gruppo carbossile: 1 centro nero con tre dentini • 1 centro rosso con un dentino e 1 centro rosso con due dentini • 1 centro bianco • 3 tubicini da 3,5 cm e 1 da 2 cm per il gruppo etere: 1 centro rosso con due dentini • 2 tubicini da 3,5 cm
L’insegnante mostra alla classe dei modelli molecolari precedentemente preparati che rappresentano diversi idrocarburi. Tutti hanno in comune l’appartenenza alla stessa classe di composti, gli alcani, che condividono la stessa formula molecolare generale CnH2n + 2
Con l’aumentare del numero di atomi di carbonio sembra aumentare la complessità delle strutture. Così, la struttura del normal-pentano sembra decisamente più complessa di quella del metano.
Al pentano inoltre corrispondono altre strutture isomere: l’isopentano e il neo pentano che differiscono per la sequenza degli atomi di carbonio, lineare per il normal-pentano, con una ramificazione per l’isopentano e con due ramificazioni per il neopentano.
A questa grande diversità nelle strutture non corrispondono differenze sostanziali nelle proprietà chimiche, mentre si riscontrano grandi differenze per quanto riguarda quelle fisiche, passando da un metano gassoso fino a idrocarburi solidi passando per quelli liquidi.
Basta però sostituire, nella più semplice molecola del metano, un solo idrogeno con un gruppo funzionale ossidrile per ottenere un composto del tutto diverso: il metanolo, un liquido che bolle a 65 °C e che, a differenza del metano, è totalmente solubile in acqua e possiede notevole reattività.
Si può riprendere con la classe a questo punto la nomenclatura, legando la presenza del gruppo ossidrile –OH alla denominazione degli alcoli.
In qualunque altro idrocarburo è possibile sostituire un idrogeno con un ossidrile. L’insegnante può proporre alla classe di costruire il modello dell’etano gassoso e di operare la sostituzione, ottenendo l’etanolo che bolle a 78 °C.
La carrellata prosegue mostrando il propano e i due alcoli che si ottengono sostituendo due idrogeni con due ossidrili sui carboni 1 o 2 (1-propanolo e 2-propanolo).
Analogamente dal normal-pentano si ottengono tre alcoli: l’1-pentanolo (a), il 2-pentanolo (b) e il 3-pentanolo (c).
Dall’isopentano ne otteniamo quattro a seconda della posizione che occupa l’ossidrile: nel carbonio 1 o nel carbonio 2 o nel carbonio 3 oppure in uno dei metili.
Mentre il neopentano, con la sua struttura apparentemente complessa può dar luogo a un solo alcol; i nove idrogeni infatti sono equivalenti.
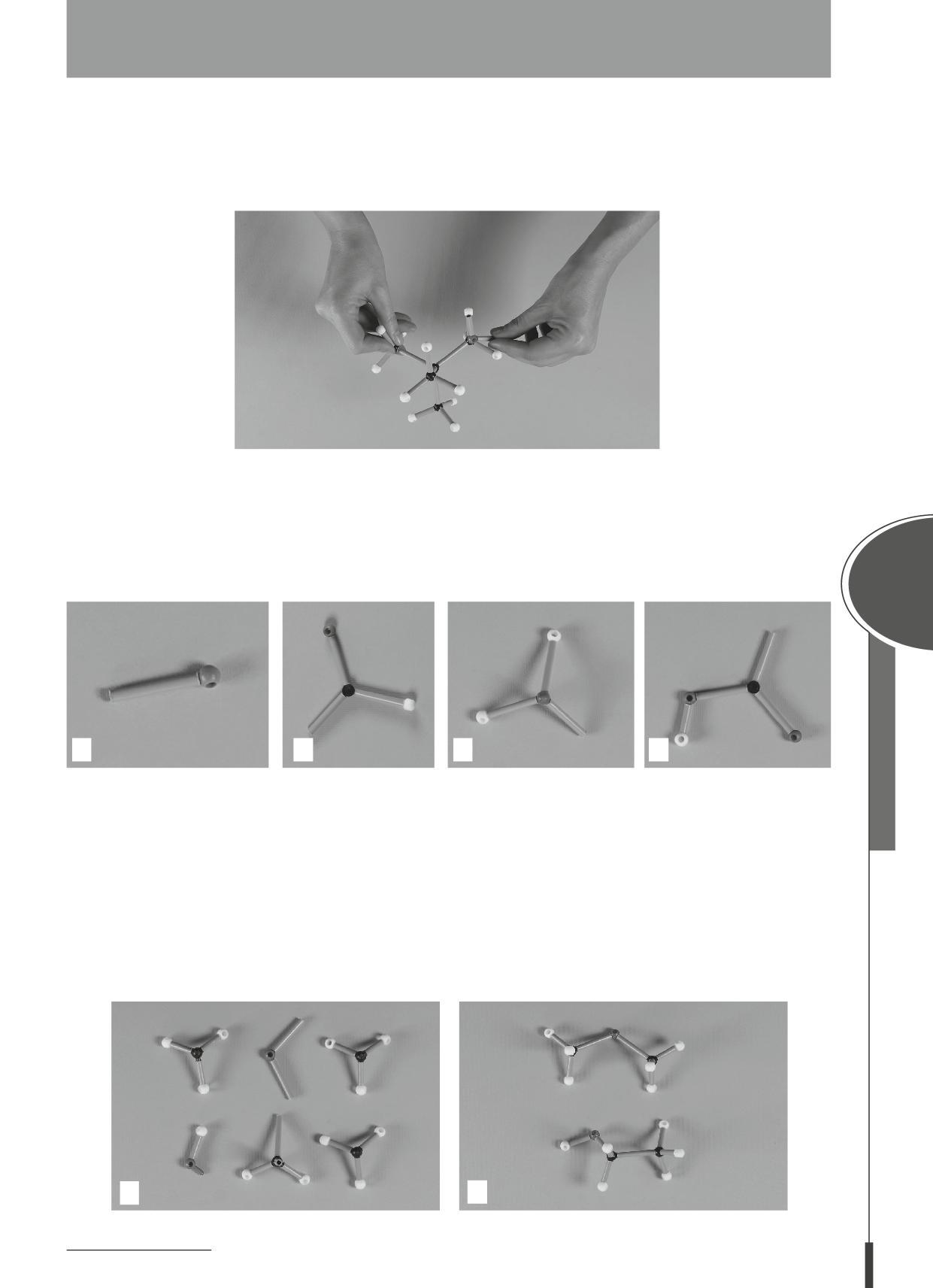
Tutti questi alcoli hanno strutture diverse ma proprietà analoghe perché in tutti è presente l’ossidrile il gruppo funzionale che li contraddistingue.
Oltre all’ossidrile possiamo introdurre altri gruppi funzionali da ciascuno dei quali scaturisce una classe di composti. Se il gruppo funzionale è un alogeno si ha la classe degli alogenuri alchilici (a), se il gruppo è un carbonile si hanno le aldeidi e i chetoni (b), col gruppo NH2 si hanno le ammine (c), con il carbossile infine gli acidi carbossilici (d).
Non sempre accade che gli isomeri di struttura presentino proprietà fisiche e chimiche affini, come si riscontra negli idrocarburi. Nel caso in cui, oltre a carbonio e idrogeno, siano presenti atomi diversi, a strutture diverse corrispondono proprietà nettamente diverse.
Costruiamo le diverse strutture corrispondenti alla formula molecolare C2H6O (a).
Dovendo sistemare in sequenza due atomi di carbonio e un ossigeno abbiamo due possibilità, collocare l’ossigeno a un estremo: CH3—CH2—OH oppure collocarlo in mezzo: CH3—O—CH3. Pur essendo due strutture derivate dalla stessa formula molecolare, si tratta di due composti, l’etanolo e il dimetil etere, dalle proprietà nettamente diverse (b).
L’etanolo bolle a 78 °C mentre il dimetil etere, gassoso a temperatura ambiente, bolle a –24 °C. Dai gruppi funzionali infatti, dipendono le proprietà fisiche e chimiche dei composti organici.
a a c b b d
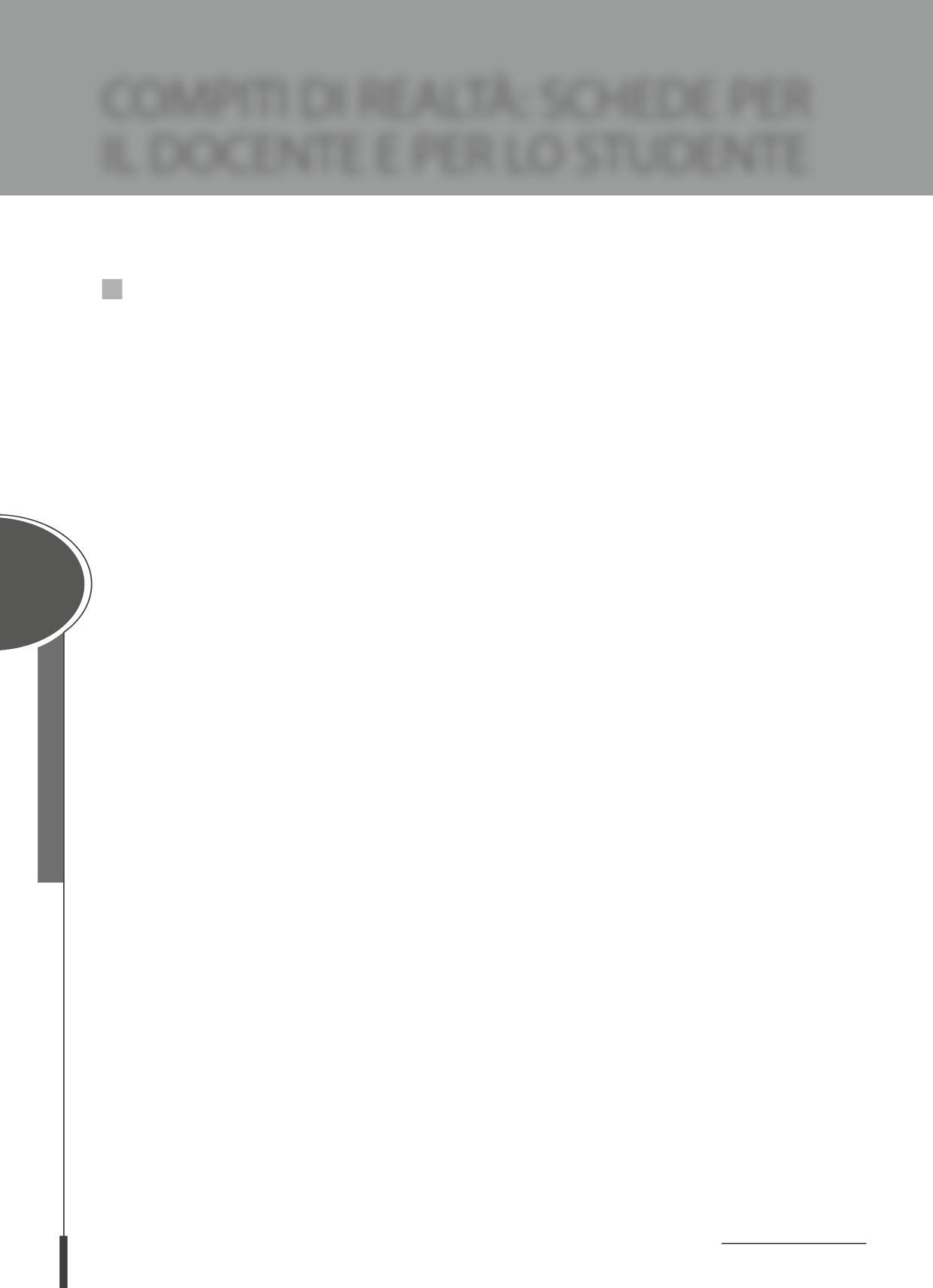
Compiti di realtà: schede per il docente e per lo studente
COMPITI DI REALTÀ: SCHEDE PER IL DOCENTE E PER LO STUDENTE
Introduzione
I compiti di realtà sono momenti fondamentali del modello di apprendimento CSSC (CSSC learning) che si va affermando con forza sempre maggiore in ambito internazionale.
Questo paradigma prevede un apprendimento:
• costruttivo (constructive), conquistato attraverso l’esplorazione attiva e la rielaborazione di modelli mentali;
• autoregolato (self-regulated) cioè guidato dalla metacognizione, dalla riflessione, e volto all’autoconsapevolezza dei processi vissuti;
• collaborativo (collaborative), facilitato dalla collaborazione (co-costruzione, negoziazione sociale);
• situato (situated) inserito in contesti realistici, significativi e basato su situazioni autentiche, che chi apprende possa sentire vicine alla propria esperienza.
I compiti di realtà presentati in questa Guida vanno in questa direzione: si tratta di prove articolate, che non si basano solo sulla disciplina oggetto del corso, ma utilizzano il contributo che altre discipline possono fornire in termini di abilità e di conoscenze, per permettere allo studente di leggere e di interpretare situazioni problematiche nuove in autonomia.
Esse devono essere intese come percorsi di lavoro che possono anche essere integrati, modificati e adattati al contesto di ciascuna classe.
Nelle pagine seguenti, per ognuno dei compiti il docente può trovare una scheda per il docente, una scheda per lo studente che si può fornire agli studenti per svolgere le attività e una griglia di valutazione finale.
Compiti di realtà: schede per il docente e per lo studente
TEMA A • LA CHIMICA DEL CARBONIO
Compito di realtà • Riconoscere le bioplastiche
Per il docente
1. Consegna agli studenti
Dopo aver effettuato un ripasso sui polimeri naturali e artificiali, introdurre la tematica delle bioplastiche e della chimica verde. Si legga la consegna del compito di realtà agli studenti, evidenziando che le informazioni sono facilmente reperibili su Internet. Dividere gli studenti in gruppi e aiutarli nella ricerca delle informazioni riguardo alle proprietà fisiche e chimiche delle differenti bioplastiche.
2. Tempi di realizzazione
La ricerca delle informazioni sulle diverse tipologie di bioplastiche, le materie prime da cui derivano, gli oggetti di uso comune e lo smaltimento può essere svolta come compito a casa, mentre la parte riguardante le proprietà fisiche e chimiche può essere eseguita in classe con l’aiuto dell’insegnante. Il tutto potrebbe richiedere circa tre ore, includendo anche la presentazione delle informazioni alla classe. La ricerca sulle differenze tra bioplastica e plastica tradizionale e il relativo dibattito possono essere svolti in classe, impiegando un paio d’ore circa. La realizzazione della campagna informativa richiede una suddivisione dei ruoli e dei compiti al fine di ottimizzare i tempi e può essere svolta in parte in aula e in parte a casa.
3. Strumenti
Gli unici strumenti necessari per completare il compito sono un personal computer, una connessione Internet e software grafici come Power Point.
4. Suggerimenti e soluzioni
Tutte le informazioni sono facilmente reperibili in Internet. Il docente potrebbe fornire una lista di siti Internet affidabili da cui ricavare le informazioni. Il dibattito in aula può essere organizzato nel modo seguente: vengono identificate due squadre, a favore e contro; il professore si occupa di regolare il tempo degli interventi; viene costituita una giuria di studenti, i quali dovranno valutare gli interventi e decretare chi ha vinto il dibattito. Per la presentazione della campagna di sensibilizzazione, gli studenti potrebbero realizzare un contenuto social da diffondere sui principali canali di comunicazione della scuola.
Griglia di valutazione
Competenza attivataIndicatore
Analizza È in grado di osservare, descrivere e analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale. È capace di riconoscere e stabilire relazioni.
Comunica Espone efficacemente il proprio lavoro in classe usando un linguaggio specifico.
Partecipa attivamente alle attività del gruppo.
Rispetta i tempi di consegna.
Indaga Sa acquisire e interpretare le informazioni.
È in grado di formulare ipotesi in base ai dati forniti.
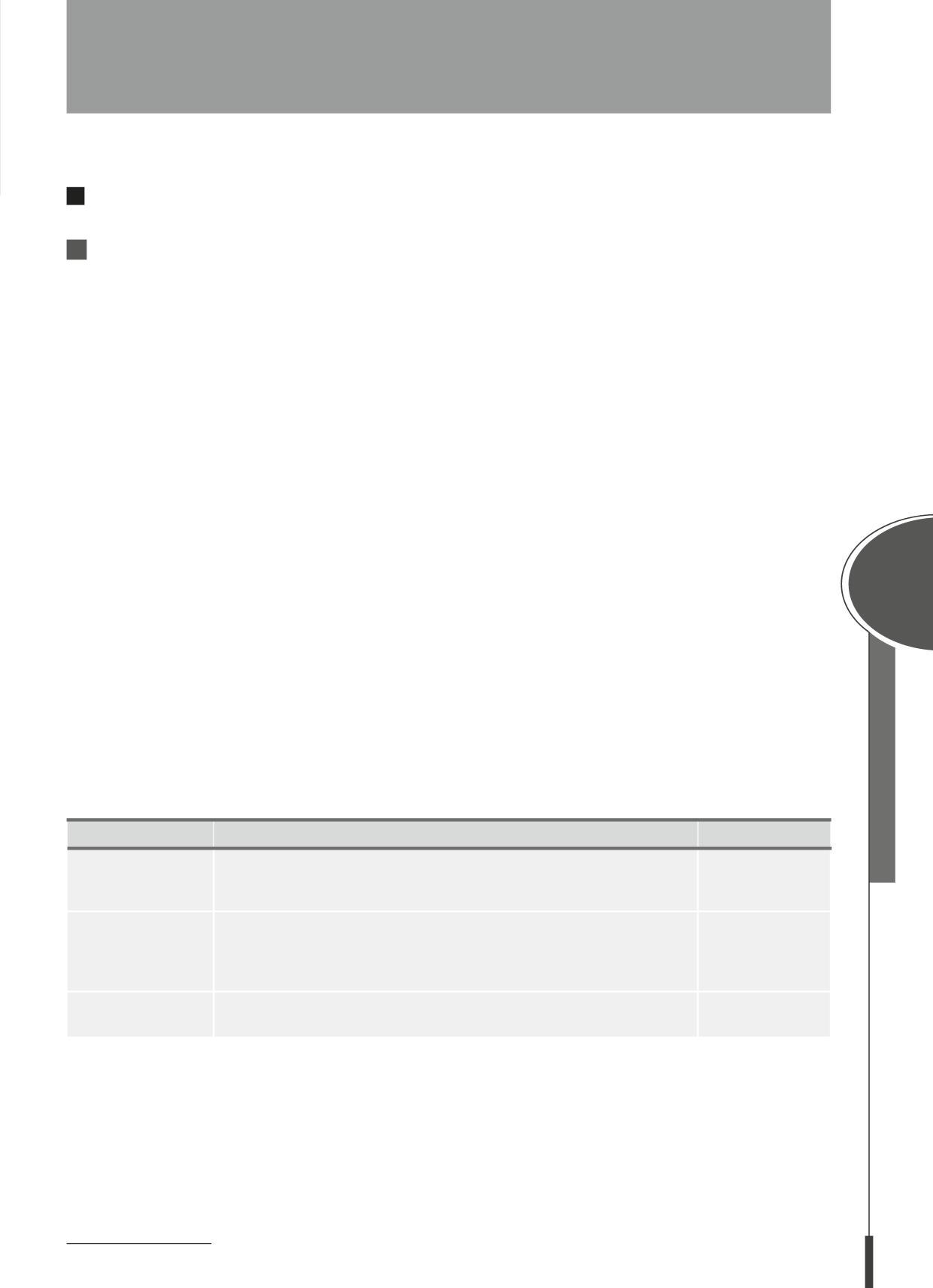
Livello [A/B/C/D]
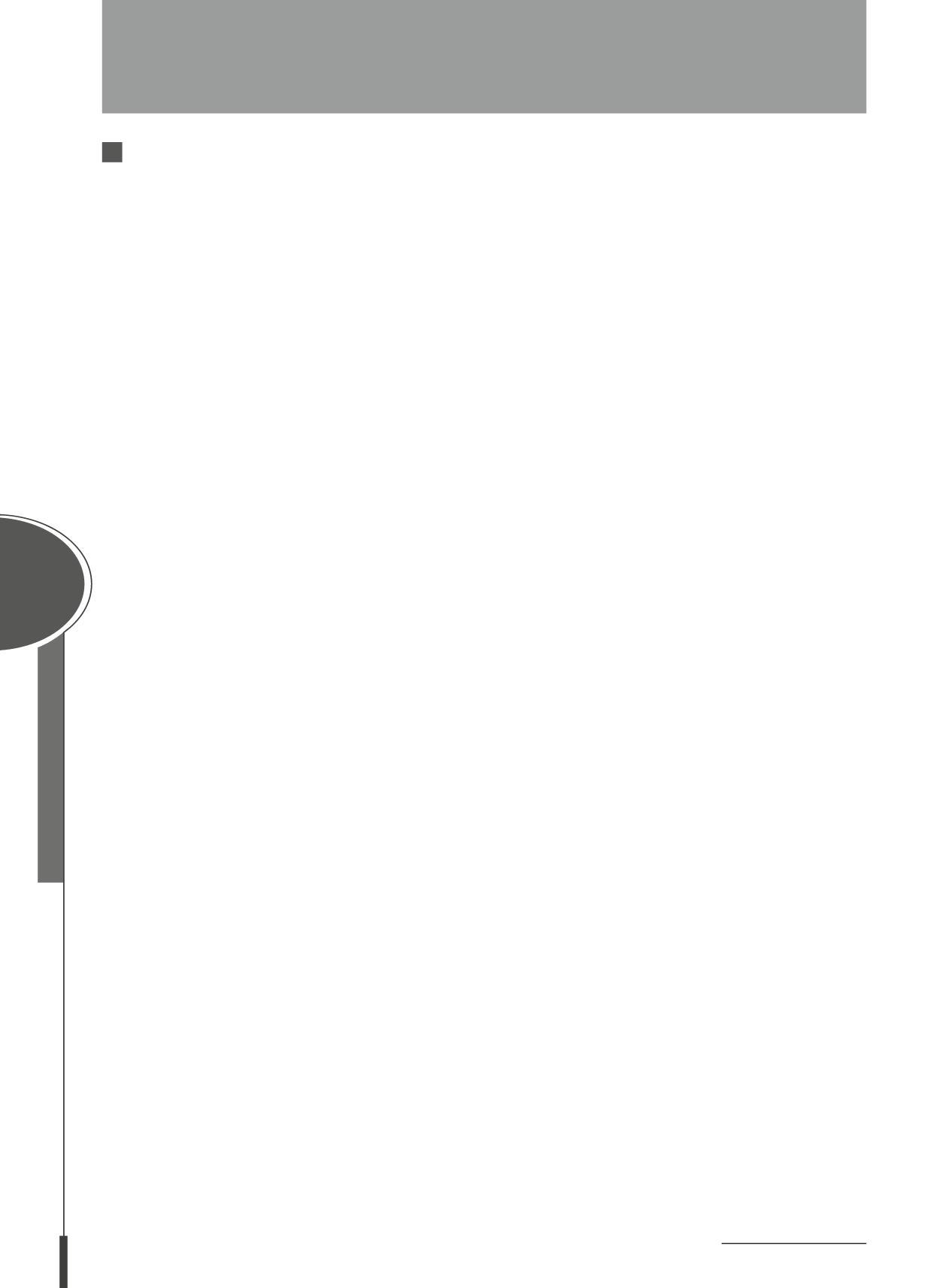
Compiti di realtà: schede per il docente e per lo studente
Per lo studente
Perché è importante sapere di cosa sono fatte le bioplastiche? Quali sono i benefici che il loro utilizzo apporta e quali invece i limiti? Quali oggetti di uso comune sono prodotti con la bioplastica?
Prerequisiti: polimeri, circolarità dei modelli di produzione, Agenda 2030 e sviluppo sostenibile, biomassa e combustibili fossili
Competenze attivate: analizza, indaga, comunica, digitali
Contesto: Il settore delle bioplastiche è fortemente in crescita, soprattutto in Italia. Le tipologie sono numerose e possono essere destinate a vari utilizzi. È importante conoscere le proprietà di ogni materiale in modo da poterlo impiegare e smaltire in maniera corretta, riducendo l’impatto sull’ambiente. Infatti, nonostante le bioplastiche costituiscano una valida alternativa alla plastica tradizionale non devono sostituirla, ed è necessario favorire una transizione verso modelli più circolari, che sostengano il riutilizzo e il riciclo dei prodotti. Per questo motivo, è importante che le informazioni su tali materiali e il loro smaltimento siano facilmente accessibili e chiare al consumatore.
Approfondisci la tua conoscenza delle bioplastiche, analizzando le diverse tipologie e le loro caratteristiche, scoprendo quali oggetti di uso comune possono essere realizzati.
Risolvi i quesiti
1. Suddividete la classe in tre gruppi, sulla base della classificazione presentata nella scheda Chimica verde e bioplastiche (non biodegradabili; biodegradabili a base bio; fossili e biodegradabili). Ogni gruppo risponda ai seguenti quesiti in riferimento alla categoria assegnata.
• Per ogni gruppo, quali sono le diverse tipologie di bioplastiche (come PLA, bio-PET ecc.) e le materie prime da cui derivano?
• Quali sono le caratteristiche di ogni tipologia? Con l’aiuto dell’insegnante, individua le principali proprietà chimiche e fisiche (come resistenza e permeabilità).
• Quali oggetti di uso comune sono prodotti con tali bioplastiche?
• Sulla base delle disposizioni del tuo Comune, come devono essere smaltiti gli oggetti che hai trovato e, in generale, le bioplastiche che lo compongono?
2. Utilizzando un foglio di calcolo Excel condiviso con il resto della classe, ogni gruppo registra le informazioni che ha raccolto. Un esponente per ogni gruppo riporta alla classe i risultati della ricerca.
3. Identifica quali sono le differenze tra bioplastica e plastica tradizionale. Quali sono i relativi vantaggi e svantaggi associati al loro processo produttivo e smaltimento?
4. Dopo che ciascuno si è fatto un’idea della propria posizione circa le bioplastiche, suddividete la classe in due gruppi e avviate un dibattito sul loro impatto positivo o negativo.
Presentazione: Condividi le tue nuove conoscenze con il resto della scuola, organizzando una campagna informativa di sensibilizzazione sulle bioplastiche e sul modo corretto di smaltirle. Utilizza materiali di supporto quali presentazioni Power Point o video informativi.
Approfondimenti: Con le informazioni che hai acquisito sei più consapevole dell’impatto ambientale causato da uno scorretto smaltimento dei rifiuti, a prescindere dal materiale di cui sono costituiti. Infatti, è importante sensibilizzare la popolazione e coinvolgerla in attività di cittadinanza attiva, come i monitoraggi di Citizen Science, che vedono i semplici cittadini impegnati in attività correlate alla ricerca scientifica in collaborazione con la comunità scientifica. Da anni, Legambiente si dedica con impegno alla raccolta e alla catalogazione dei rifiuti abbandonati lungo gli argini dei fiumi, sulle spiagge e nei parchi cittadini. Ricerca i risultati degli ultimi monitoraggi per scoprire quai sono i rifiuti prodotti maggiormente nella tua città e verifica se sono presenti iniziative a cui partecipare.
Autovalutazione: Sei soddisfatto del risultato ottenuto? Quali difficoltà hai incontrato nello svolgimento del compito? Quale parte del compito ti è piaciuta di più? Se il lavoro è stato fatto in gruppo, sei soddisfatto del contributo che hai dato? Che cosa avresti potuto migliorare nello svolgimento del compito?
Compiti di realtà: schede per il docente e per lo studente
TEMA B • LA CHIMICA DELLA VITA
Compito di realtà • Vitamine in aiuto contro i radicali liberi
Per il docente
1. Consegna agli studenti
Dopo aver ripassato i temi legati alla biochimica, introdurre il tema dell’inquinamento atmosferico, dei radicali liberi e delle vitamine. Si legga la consegna del compito di realtà agli studenti, evidenziando che le informazioni sono facilmente reperibili su Internet. Dopo una prima fase di reperimento individuale di informazioni, dividere gli studenti in gruppi e aiutarli nella ricerca delle informazioni riguardo agli alimenti e alle corrette abitudini alimentari che bisognerebbe adottare.
2. Tempi di realizzazione
La ricerca delle informazioni sull’inquinamento atmosferico, sugli inquinanti e sui settori emissivi può essere svolta come compito a casa, mentre la parte riguardante i radicali liberi, l’alimentazione, gli stili di vita e le abitudini quotidiane può essere eseguita in classe con l’aiuto dell’insegnante. Il tutto potrebbe richiedere circa tre ore, includendo anche la parte di condivisione delle abitudini adottate in classe. La ricerca in gruppi per la realizzazione della campagna informativa richiede una suddivisione dei ruoli e dei compiti, al fine di ottimizzare i tempi e può essere realizzata in parte in aula e in parte a casa.
3. Strumenti
Gli unici strumenti necessari per completare il compito sono un personal computer, una connessione Internet e software grafici come Power Point.
4. Suggerimenti e soluzioni
Tutte le informazioni sono facilmente reperibili in Internet. Il docente potrebbe fornire una lista di siti Internet affidabili da cui ricavare le informazioni. Il dibattito in aula può essere organizzato nel modo seguente: vengono identificate due squadre, a favore e contro; il professore si occupa di regolare il tempo degli interventi; viene costituita una giuria di studenti, i quali dovranno valutare gli interventi e decretare chi ha vinto il dibattito. Per la presentazione della campagna di sensibilizzazione, gli studenti potrebbero realizzare un contenuto social da diffondere sui principali canali di comunicazione della scuola.
Griglia di valutazione
Competenza attivataIndicatore
Analizza È in grado di osservare, descrivere e analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale.
È capace di riconoscere e stabilire relazioni.
Comunica Espone efficacemente il proprio lavoro in classe usando un linguaggio specifico.
Partecipa attivamente alle attività del gruppo.
Rispetta i tempi di consegna.
Indaga Sa acquisire e interpretare le informazioni.
È in grado di formulare ipotesi in base ai dati forniti
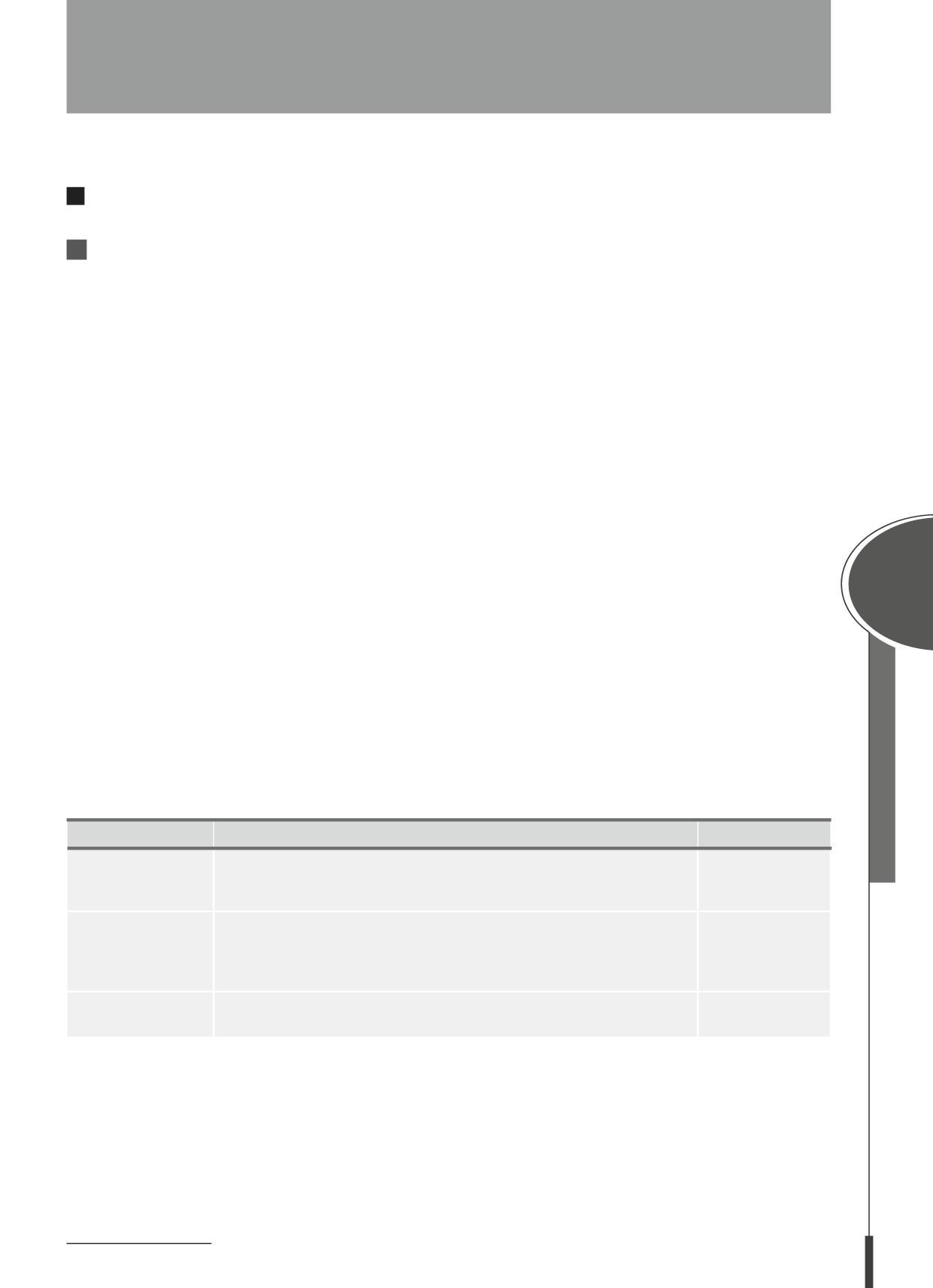
Livello [A/B/C/D]
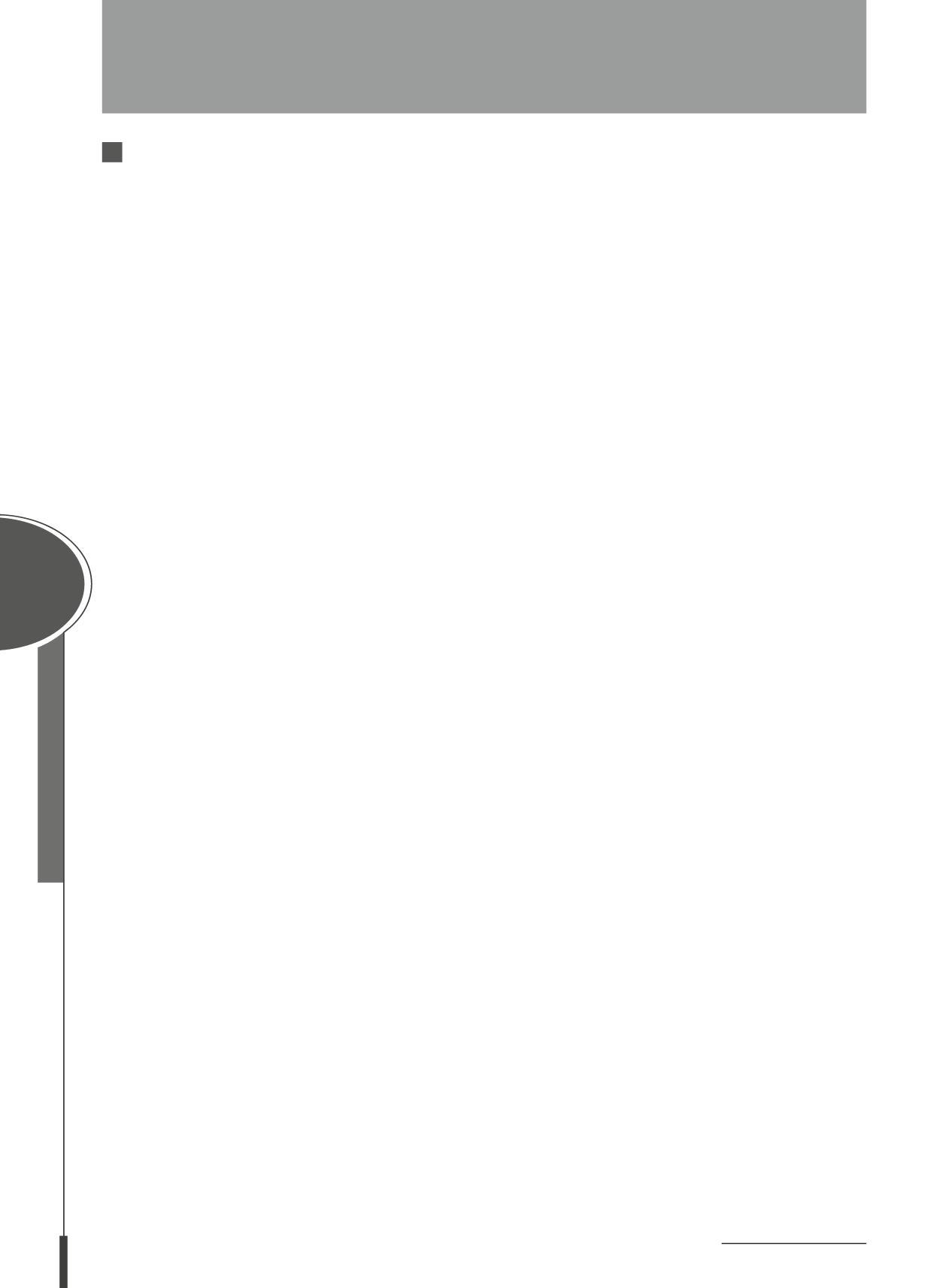
Compiti di realtà: schede per il docente e per lo studente
Per lo studente
Cosa sono i radicali liberi? Perché è importante conoscerli? Cosa puoi fare per contrastare gli effetti che generano nel lungo periodo sulla salute delle persone?
Prerequisiti: Inquinamento atmosferico, alimentazione, vitamine, ossidazione, stili di vita
Competenze attivate: Analizza, indaga, confrontati, comunica, digitali
Contesto: L’inquinamento atmosferico ha degli effetti sulla salute delle persone. Oltre alle problematiche più note – per esempio malattie polmonari e cardiache – ci sono ulteriori effetti indotti sulla salute dall’inquinamento, come per l’appunto la formazione dei radicali liberi. Conoscere cosa sono, come si formano e che effetti hanno sulla salute è fondamentale per prevenire la loro formazione, ma soprattutto per adottare contromisure utili a tutelare il nostro organismo.
Approfondisci la tua conoscenza dei radicali liberi, analizzando la loro genesi nel corpo umano, i fattori che li hanno generati e gli effetti che determinano sulla salute, scoprendo come prevenire la loro insorgenza e mitigarne gli effetti, attraverso scelte individuali e stili di vita sostenibili.
Risolvi i quesiti
1. Singolarmente approfondisci il tema dell’inquinamento atmosferico, degli inquinanti tipici dell’aria che respiriamo e degli effetti sulla salute umana.
• Quali sono gli inquinanti che possono dare origine ai radicali liberi? Quali sono le fonti che possono determinare la produzione di queste sostanze?
• Individua le possibili fonti di inquinamento atmosferico che quotidianamente potresti intercettare nello svolgimento delle tue attività.
• Quali azioni preventive o cambiamenti di abitudini pensi possano essere messi in atto affinché il nostro organismo sia meno esposto all’inquinamento?
2. Lavorando in gruppo, individuate quali alimenti e quali vitamine aiutano a prevenire la formazione di radicali liberi nel nostro organismo.
• Quali di questi cibi fanno parte della vostra dieta quotidiana?
• Con l’aiuto di un esperto (un medico, un nutrizionista, un dietologo) stilate un menu settimanale da osservare che sia efficace non solo da un punto di vista nutritivo, ma anche utile per evitare la formazione di radicali liberi e, più in generale, per prevenire patologie sanitarie.
Presentazione: In classe condividete con gli altri gruppi tutte le informazioni che avete raccolto e discusso, sia relative all’inquinamento atmosferico che all’alimentazione. Preparate un opuscolo o una presentazione da diffondere e spiegare alle altre classi della vostra scuola, per rendere gli altri studenti consapevoli del problema che avete affrontato.
Approfondimenti: Oltre a causare la produzione di radicali liberi, l’inquinamento atmosferico incide sulla salute delle persone anche in altri modi. Analizza le patologie e gli organi del corpo umano più sensibili all’inquinamento atmosferico e approfondisci su quali sono le misure più idonee per mitigare la vostra esposizione all’inquinamento.
Autovalutazione: Sei soddisfatto del risultato ottenuto? Quali difficoltà hai incontrato nello svolgimento del compito? Quale parte del compito ti è piaciuta di più? Se il lavoro è stato fatto in gruppo, sei soddisfatto del contributo che hai dato? Che cosa avresti potuto migliorare nello svolgimento del compito?
Compiti di realtà: schede per il docente e per lo studente
TEMA C • LE TECNOLOGIE PER LA VITA
Compito
di realtà • Che cos’è un OGM?
Per il docente
1. Consegna agli studenti
Dopo aver effettuato un ripasso su DNA, editing genetico e CRISPR-Cas9, introdurre la tematica degli OGM tradizionali e di nuova generazione. Si legga la consegna del compito di realtà agli studenti, evidenziando che le informazioni sono facilmente reperibili su Internet. Aiutare gli studenti nella ricerca delle informazioni riguardo alle tecnologie di modifica genetica e relative a pro e contro degli OGM.
2. Tempi di realizzazione
La ricerca delle informazioni relative alle diverse tipologie di OGM, alle tecniche di modifica genetica, ai vantaggi e agli svantaggi può essere svolta come compito a casa, mentre la parte riguardante il dibattito può essere eseguita in classe con l’aiuto dell’insegnante. Il tutto potrebbe richiedere circa tre ore, includendo anche la presentazione delle informazioni alla classe. La realizzazione della campagna informativa richiede una suddivisione dei ruoli e dei compiti al fine di ottimizzare i tempi e può essere svolta in parte in aula e in parte a casa.
3. Strumenti
Gli unici strumenti necessari per completare il compito sono un personal computer, una connessione Internet e software grafici come Power Point.
4. Suggerimenti e soluzioni
Tutte le informazioni sono facilmente reperibili in Internet. Il docente potrebbe fornire una lista di siti Internet affidabili da cui ricavare le informazioni. Il dibattito in aula può essere organizzato nel modo seguente: vengono identificate due squadre, a favore e contro; il professore si occupa di regolare il tempo degli interventi; viene costituita una giuria di studenti, i quali dovranno valutare gli interventi e decretare chi ha vinto il dibattito. Per la presentazione della campagna di sensibilizzazione, gli studenti potrebbero realizzare un contenuto social da diffondere sui principali canali di comunicazione della scuola.
Griglia di valutazione
Competenza attivataIndicatore
Analizza È in grado di osservare, descrivere e analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale. È capace di riconoscere e stabilire relazioni.
Comunica Espone efficacemente il proprio lavoro in classe usando un linguaggio specifico.
Partecipa attivamente alle attività del gruppo. Rispetta i tempi di consegna.
Indaga Sa acquisire e interpretare le informazioni. È in grado di formulare ipotesi in base ai dati forniti.
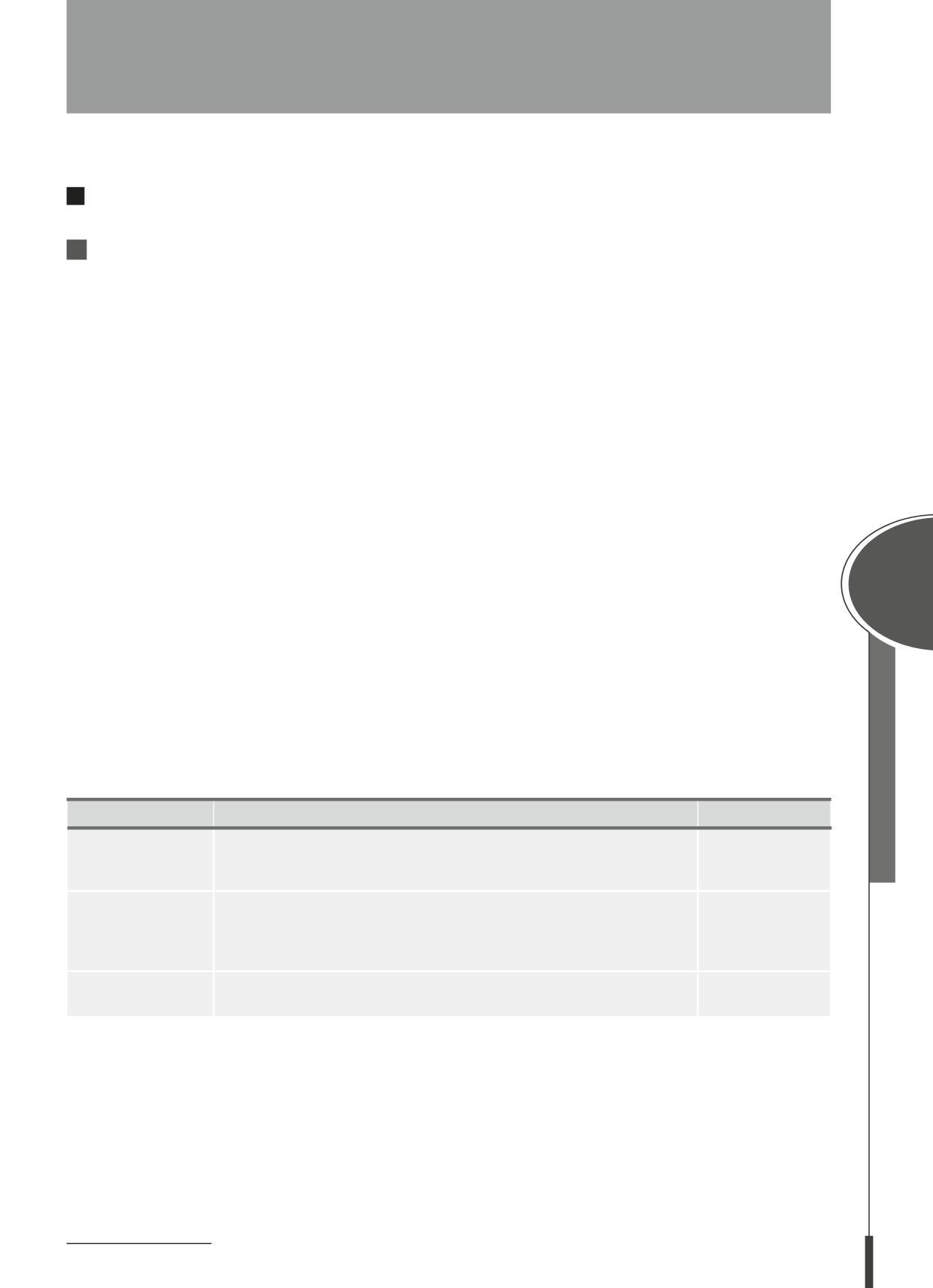
Livello [A/B/C/D]
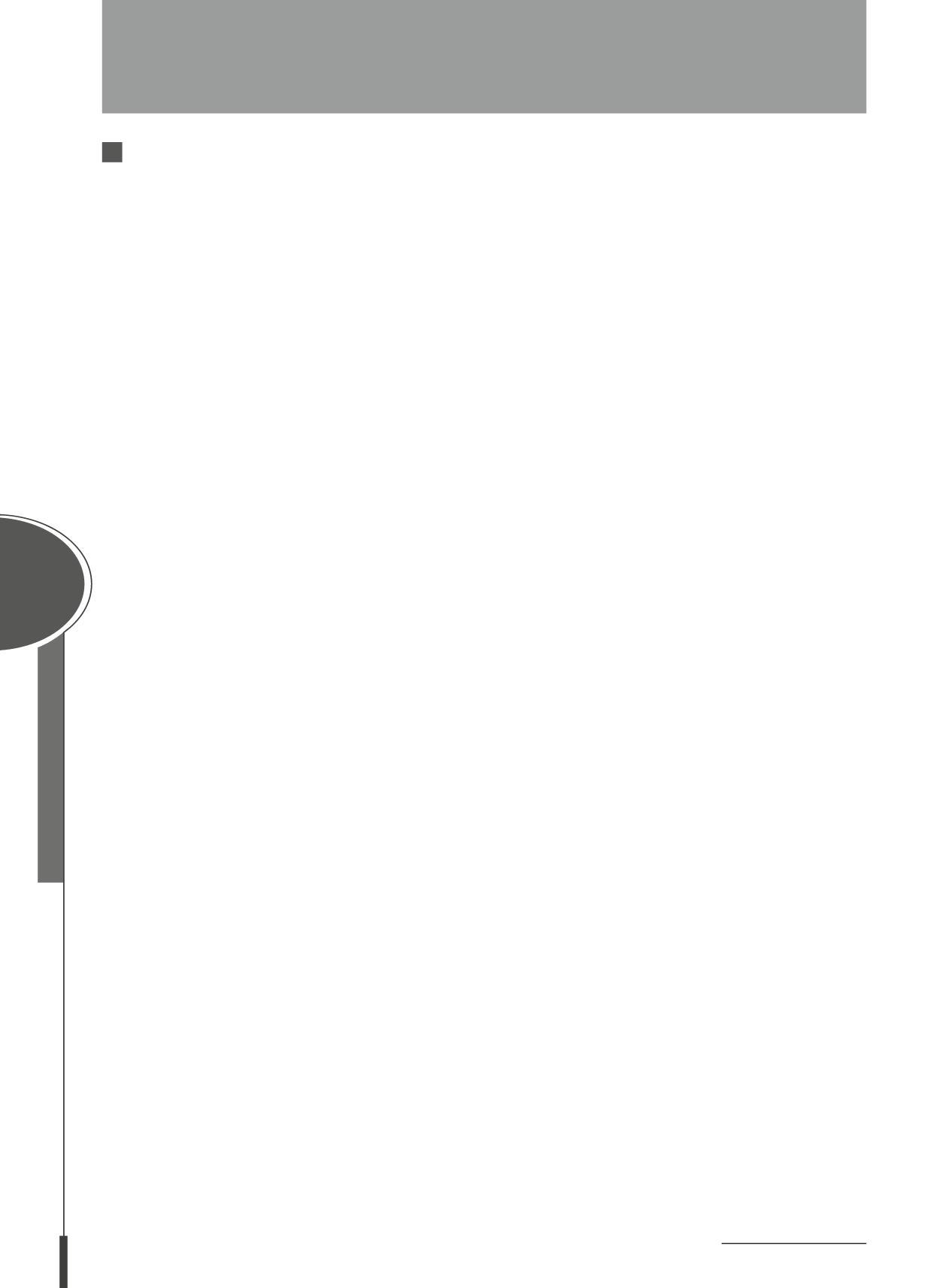
Compiti di realtà: schede per il docente e per lo
studente
Per lo studente
Che cosa sono gli OGM? Quali sono i pro e i contro del loro utilizzo?
Prerequisiti: DNA, editing genetico, CRISPR-Cas9
Competenze attivate: analizza, indaga, confrontati, comunica
Contesto: Le nuove tecniche di modifica genetica sono definite New breeding techniques (Nbt) e la loro caratteristica principale è quella di generare un prodotto finale che non presenta DNA di specie diverse da quella di partenza. Se da un lato ci sono genetisti che difendono tale tecnologia in quanto considerata altamente prevedibile, vi è un’altra parte della comunità scientifica che equipara questi prodotti ai tradizionali OGM, in termini di rischi e impatti sulla biodiversità. Inoltre, vi è un’accesa discussione anche in campo legislativo in Italia e in Europa sulla possibilità di applicare o meno la legislazione in materia di OGM ai prodotti di queste nuove tecniche.
Approfondisci la tua conoscenza sugli OGM tradizionali e di nuova generazione, indagando i pro e i contro di entrambi.
Risolvi i quesiti
1. Singolarmente effettua una ricerca approfondita sugli OGM, rispondendo a questi quesiti.
• Quali sono le principali tecnologie di modifica genetica di organismi viventi? Ricerca sia le metodologie tradizionali che quelle più recenti.
• Individua quali sono i principali vantaggi e svantaggi degli OGM, analizzandoli in relazione alla loro sostenibilità economica, ambientale e sociale.
• Informati sulla legislazione in materia e su quali leggi vengono applicate a questi prodotti.
2. Dopo che ciascuno si è fatto un’idea sulla propria posizione al riguardo, suddividete la classe in due gruppi, ossia i favorevoli e i contrari.
3. Avviate un dibattito in classe.
Presentazione: Condividi le tue nuove conoscenze con il resto della scuola, organizzando una campagna informativa sugli OGM e sul loro impatto sull’agricoltura e sull’ambiente. Utilizza materiali di supporto quali presentazioni Power Point o video informativi.
Approfondimenti: La perdita di biodiversità e il declino degli insetti impollinatori, come le api, rappresentano una grave minaccia per l’equilibrio degli ecosistemi. Questi insetti svolgono un ruolo cruciale nell’impollinazione di molte piante, contribuendo alla biodiversità e alla nostra salute. Tuttavia, sono a rischio a causa di vari fattori, tra cui l’uso di pesticidi, la perdita di habitat e il cambiamento climatico. In risposta a questa crisi, Legambiente ha lanciato la campagna “Save the Queen” per salvare le api dal rischio di estinzione. Questa iniziativa mira a informare e sensibilizzare i cittadini e a creare una rete di alleanze con gli apicoltori che svolgono un ruolo fondamentale per la custodia della natura. Tra le azioni proposte ci sono il biomonitoraggio, l’adozione di arnie e la promozione di orti urbani. Ricerca informazioni sulla campagna e con la tua classe informati sulla possibilità di creare un orto urbano o adottare un’arnia presso la tua scuola.
Autovalutazione: Sei soddisfatto del risultato ottenuto? Quali difficoltà hai incontrato nello svolgimento del compito? Quale parte del compito ti è piaciuta di più? Se il lavoro è stato fatto in gruppo, sei soddisfatto del contributo che hai dato? Che cosa avresti potuto migliorare nello svolgimento del compito?
Compiti di realtà: schede per il docente e per lo studente
TEMA D • DINAMICA E RISORSE DEL SISTEMA TERRA
Compito di realtà • Mappare il cambiamento climatico
Per il docente
1. Consegna agli studenti
Dopo aver effettuato un ripasso sulla composizione e sulla struttura dell’atmosfera, sui fenomeni meteorologici e sui climi della Terra, introdurre la tematica dei cambiamenti climatici. Si legga la consegna del compito di realtà agli studenti, evidenziando che le informazioni sono facilmente reperibili su Internet. Dividere gli studenti in gruppi e aiutare gli studenti nella ricerca delle informazioni riguardo alle tendenze climatiche e alle precipitazioni nelle diverse aree geografiche.
2. Tempi di realizzazione
La ricerca delle informazioni sui diversi tipi di clima delle città, le differenze tra il clima attuale e i climi del passato può essere svolta a casa, impiegando un paio d’ore circa. La parte riguardante l’analisi dei dati sulle precipitazioni e le temperature può essere eseguita in classe con l’aiuto dell’insegnante. Il tutto potrebbe richiedere circa tre ore. La realizzazione della presentazione richiede una suddivisione dei ruoli e dei compiti, al fine di ottimizzare i tempi e può essere svolta in parte in aula e in parte a casa.
3. Strumenti
Gli unici strumenti necessari per completare il compito sono un personal computer, una connessione Internet e software grafici come Power Point.
4. Suggerimenti e soluzioni
Tutte le informazioni sono facilmente reperibili in Internet. Il docente potrebbe fornire una lista di siti Internet affidabili da cui ricavare le informazioni. Per la presentazione delle informazioni, gli studenti potrebbero realizzare una presentazione standard, un video o anche un contenuto social.
Griglia di valutazione
Competenza attivataIndicatore
Analizza
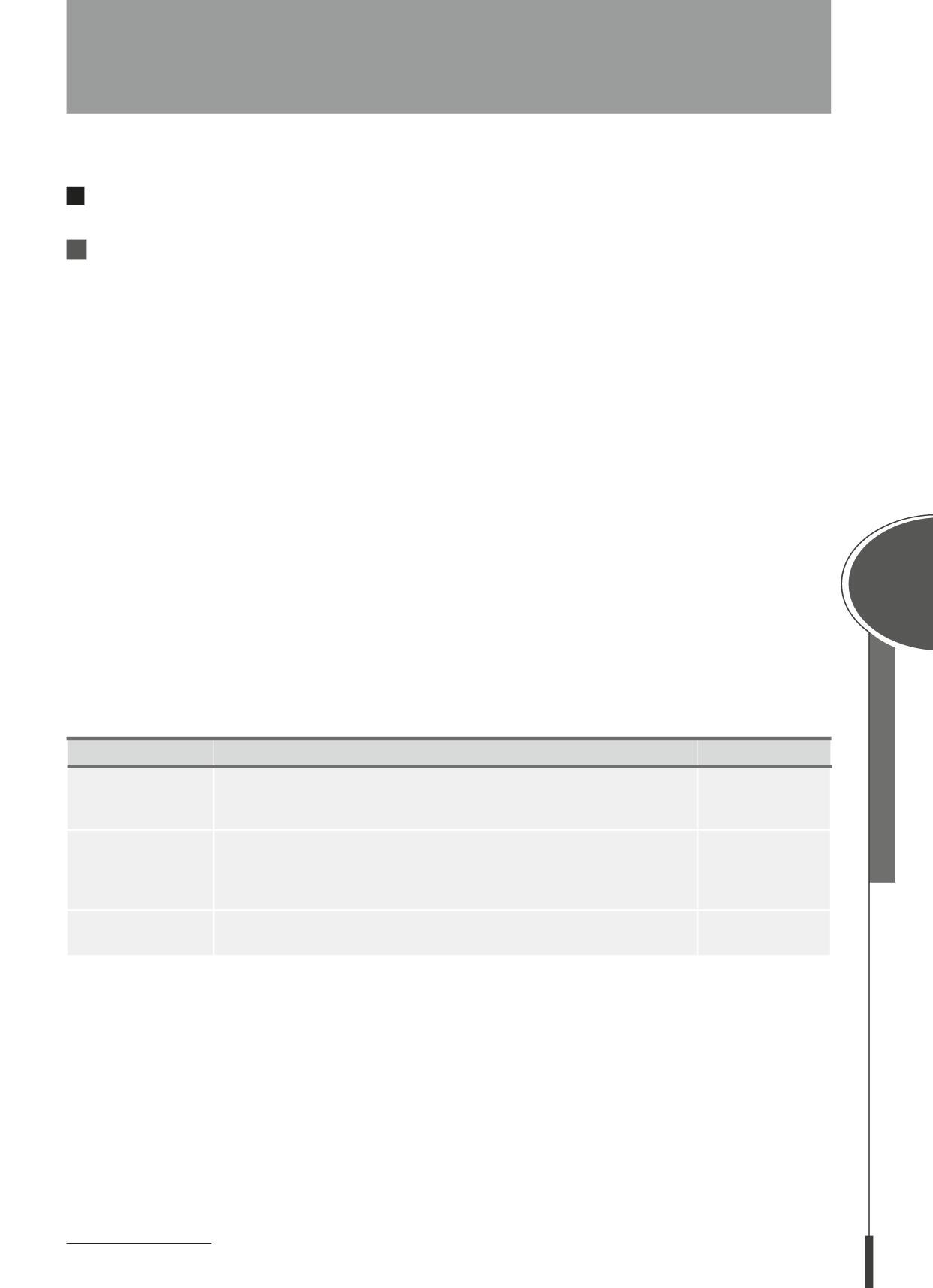
È in grado di osservare, descrivere e analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale.
È capace di riconoscere e stabilire relazioni.
Comunica Espone efficacemente il proprio lavoro in classe usando un linguaggio specifico.
Partecipa attivamente alle attività del gruppo.
Rispetta i tempi di consegna.
Indaga Sa acquisire e interpretare le informazioni.
È in grado di formulare ipotesi in base ai dati forniti.

Compiti di realtà: schede per il docente e per lo studente
Per lo studente
Com’è cambiato il clima del nostro Pianeta negli anni? Quali sono le aree maggiormente soggette ai cambiamenti? Di chi è la responsabilità del cambiamento climatico nelle trasformazioni a cui stiamo assistendo?
Prerequisiti: Composizione e struttura dell’atmosfera, fenomeni meteorologici, climi della Terra, cambiamento climatico
Competenze attivate: analizza, indaga, comunica, confronta
Contesto: I cambiamenti climatici sono un fenomeno globale che sta causando un aumento delle temperature medie della Terra. Questo riscaldamento globale porta a estati più calde e inverni più miti, alterando i modelli di precipitazioni, che possono diventare più intense in alcune aree, mentre in altre zone si può verificare siccità. Questi cambiamenti hanno un impatto significativo sugli ecosistemi e sulla vita umana ed è importante agire per limitare i danni. Se da un lato il clima è sempre cambiato nei vari periodi storici, ciò non è mai avvenuto così velocemente.
Approfondisci i dati e le osservazioni sui cambiamenti climatici. Ricerca e confronta il clima attuale con i climi del passato, indagando i cambiamenti nelle temperature e le precipitazioni.
Risolvi i quesiti
1. Suddividete la classe in gruppi in modo tale da rappresentare tutti i continenti. Ogni gruppo sceglie la capitale di uno Stato presente nel Continente scelto.
• Ricerca le informazioni sulla classificazione del clima della città scelta, dello Stato in cui si trova e del Continente.
• Analizza i dati storici sulle precipitazioni e le temperature.
• Crea un grafico che mostra le tendenze nel corso del tempo e discuti come queste tendenze potrebbero essere collegate al cambiamento climatico.
Presentazione: Condividi le tue nuove conoscenze con il resto della classe, creando una presentazione in cui mostri una panoramica sulla città e le sue caratteristiche climatiche, evidenziando i mutamenti negli anni e come il cambiamento climatico abbia influito su di essi. Utilizza materiali di supporto quali presentazioni Power Point o video informativi.
Approfondimenti: Il riscaldamento globale sta causando una riduzione visibile dei ghiacciai alpini, con la previsione che entro il 2050, tutti i ghiacciai sotto i 3500 metri scompariranno. Questo fenomeno allarmante si verifica a livello globale. La rapida ritirata dei ghiacciai non solo comporta la perdita di paesaggi e biodiversità, ma anche la scomparsa di servizi ecosistemici essenziali. Per raccontare cosa sta accadendo ai ghiacciai dell’arco alpino, Legambiente organizza la campagna “Carovana dei Ghiacciai” per monitorare i ghiacciai e comprendere i rischi dei cambiamenti climatici nei nostri territori.
Visita il sito della campagna (al link https://q3.hubscuola.it/cdr-sdt), approfondisci le tue conoscenze tramite i report dell’associazione e guarda con la tua classe il documentario girato per raccontare ciò che sta accadendo in alta quota tramite le voci di chi studia e vive la montagna.
Autovalutazione: Sei soddisfatto del risultato ottenuto? Quali difficoltà hai incontrato nello svolgimento del compito? Quale parte del compito ti è piaciuta di più? Se il lavoro è stato fatto in gruppo, sei soddisfatto del contributo che hai dato? Che cosa avresti potuto migliorare nello svolgimento del compito?
GRIGLIE DI VALUTAZIONE PER I PRODOTTI MULTIMEDIALI
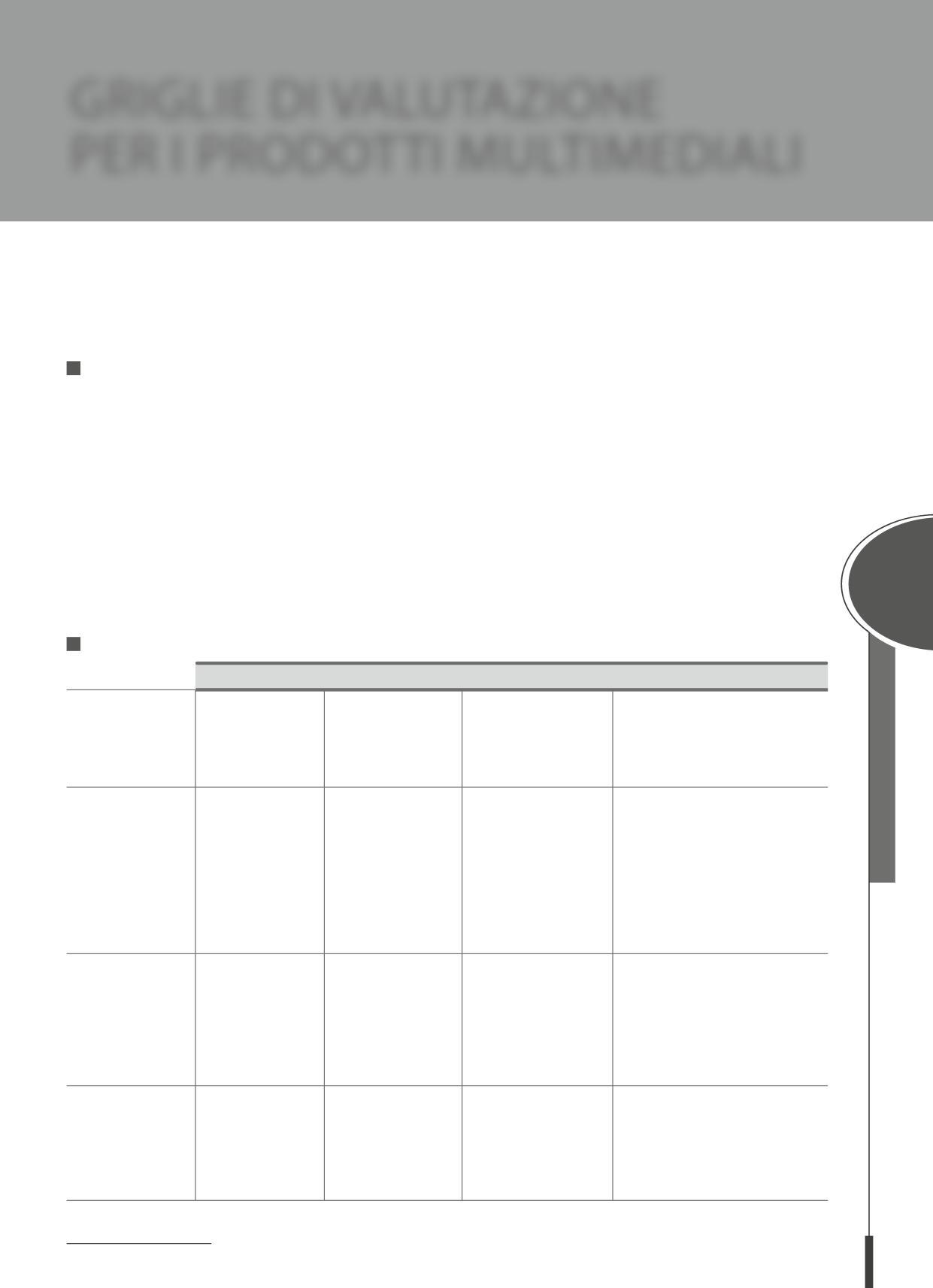
Griglie di valutazione
Le griglie di valutazione sono tabelle sinottiche che descrivono una serie di variabili: servono a esplicitare le dimensioni delle competenze su cui si vuole lavorare e guidare l’analisi e la valutazione dei risultati raggiunti. La preventiva definizione dei criteri di analisi consente all’insegnante di focalizzare l’osservazione sugli aspetti rilevanti e fornisce agli studenti indicazioni trasparenti su ciò che verrà considerato nella valutazione. Valutare gli artefatti digitali degli studenti significa valutare sia il prodotto dell’attività ma anche il processo che l’ha resa possibile, soprattutto nel caso di attività svolte in gruppo.
Forniamo quindi le griglie di valutazione:
• dell’apprendimento cooperativo;
• della gestione delle fonti individuate, usate e citate;
• di alcuni prodotti: presentazioni, video, elaborati visuali (per esempio, poster o i pannelli di una ipotetica mostra), testi scritti la cui realizzazione è richiesta nelle numerose rubriche dei volumi.
Griglia di valutazione dell’apprendimento cooperativo
Livello 1
Contributo alla conoscenza Condivide informazioni con il gruppo solo quando invitato a farlo.
Lavoro e condivisione con gli altri
Condivide costantemente e attivamente conoscenza, opinioni e capacità senza essere sollecitato.
Contributo al raggiungimento degli obiettivi
Considerazione degli altri
Lavora per gli obiettivi del gruppo solo quando invitato a farlo.
Ha bisogno di essere sollecitato a prestare attenzione ai sentimenti degli altri.
Livello 2
Condivide informazioni con il gruppo con occasionali sollecitazioni.
Partecipa ai cambiamenti richiesti con occasionali sollecitazioni; ha spesso bisogno di essere sollecitato a svolgere il lavoro assegnato.
Lavora per gli obiettivi del gruppo con occasionali sollecitazioni.
Mostra sensibilità per i sentimenti degli altri.
3
Condivide conoscenza, opinioni e capacità senza essere sollecitato.
Partecipa volentieri ai cambiamenti necessari; di solito svolge il lavoro assegnato e raramente ha bisogno di essere sollecitato.
Lavora per gli obiettivi del gruppo senza sollecitazioni; accetta e svolge il proprio ruolo individuale all’interno del gruppo.
Mostra ed esprime sensibilità per i sentimenti degli altri; incoraggia la partecipazione degli altri.
4
Condivide costantemente e attivamente conoscenza, opinioni e capacità senza essere sollecitato.
Aiuta il gruppo a identificare i cambiamenti richiesti e incoraggia le azioni del gruppo che favoriscono il cambiamento; svolge il lavoro assegnato senza essere sollecitato.
Lavora costantemente e attivamente per gli obiettivi del gruppo; svolge volentieri il proprio ruolo all’interno del gruppo.
Mostra sensibilità per i sentimenti e per i bisogni formativi degli altri; valorizza la conoscenza, le opinioni e le capacità di tutti i membri del gruppo.
Rielaborata da Chad Manis, Teacher-Written Eduware LLC, 2012
Ricerca, valutazione e dichiarazione delle fonti (cittadinanza digitale)
Livello insufficiente (1-4)
Fonti • Fonti non citate.
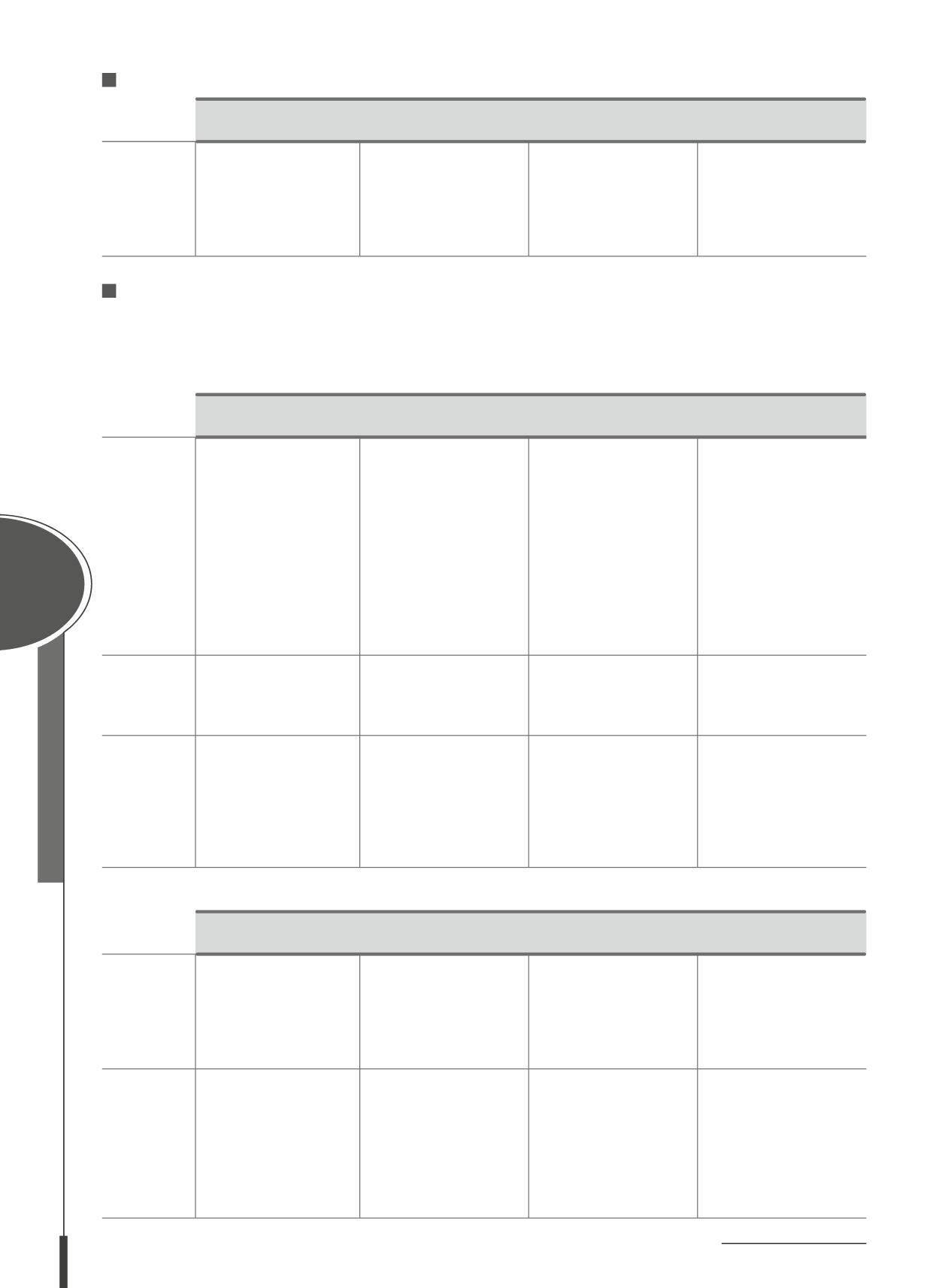
Livello base (5-6)
• Fonti citante male, scarsamente attendibili oppure di attendibilità non verificabile.
Presentazione: griglia di valutazione
Livello intermedio (7-8)
• Fonti citate correttamente e attendibili.
Livello alto (9-10)
• Fonti citate correttamente e che possono essere considerate di riferimento per il tema trattato.
Nella fase di valutazione, per aiutare lo studente a focalizzare i propri sforzi, è importante separare i giudizi sulla realizzazione della presentazione (fase produttiva) e sulla restituzione (fase espositiva).
Fase produttiva
Livello insufficiente (1-4)
Testi
Immagini e Multimedia
Storytelling
• Assenza dell’informazione/ consegna richiesta.
• Presenza di errori ortografici, di lessico e sintassi.
• Sovrabbondanza o insufficienza di testo scritto.
Livello base (5-6)
• Presenza parziale o non del tutto corretta dell’informazione/ consegna richiesta.
• Testo chiaro e corretto ma privo di complessità.
• Discreta capacità di sintesi.
• Sovrabbondanza o insufficienza di testo scritto.
• Immagini e contenuti multimediali assenti.
• Contenuto non coerente con la consegna.
• Scarsa leggibilità e scarsa efficacia comunicativa.
Fase espositiva
insufficiente (1-4)
Conoscenza argomento
• Immagini presenti e pertinenti.
• Contenuti multimediali assenti.
• Contenuto complessivamente coerente con la consegna.
• Discreta leggibilità e discreta efficacia comunicativa.
• Presenza dell’informazione/ consegna richiesta.
• Testo chiaro e corretto.
• Uso significativo di parole chiave e buona capacità di sintesi.
• Presenza dell’informazione/ consegna richiesta.
• Testo chiaro e corretto.
• Scelta lessicale precisa e ragionata.
• Ottima capacità di sintesi.
Capacità espositiva
• Conoscenza scarsa e approssimativa del tema.
• Scarsa proprietà del lessico specifico.
• Grave scorrettezza morfosintattica del linguaggio.
• Scarsa capacità di organizzare verbalmente i contenuti.
base (5-6)
• Conoscenza generica ma essenziale del tema.
• Proprietà del lessico specifico più comune.
• Sostanziale correttezza morfosintattica del linguaggio.
• Coerenza logica nell’esposizione dei contenuti.
• Debolezza nell’argomentazione.
• Immagini e contenuti multimediali presenti e pertinenti.
• Contenuto ricco e coerente con la consegna.
• Buona leggibilità e buona efficacia comunicativa
• Immagini e contenuti multimediali pertinenti e con una coerenza grafica significativa.
• Contenuto completo, preciso, coerente con la consegna e arricchito con scelte personali e originali.
• Ottima efficacia comunicativa.
intermedio (7-8)
• Conoscenza precisa del tema.
• Buona proprietà del lessico specifico, anche nei termini più tecnici.
• Correttezza morfosintattica e proprietà di linguaggio.
• Coerenza logica nell’esposizione dei contenuti.
• Buona fluidità nell’argomentazione.
• Conoscenza precisa e approfondita del tema.
• Ottima proprietà del lessico specifico.
• Ottima proprietà di linguaggio, anche specialistico.
• Ottima fluidità nell’argomentazione, con collegamenti originali e brillanti.
Performance • Sviluppo dell’esposizione in disaccordo con la presentazione.
• Non riesce a coinvolgere la classe sul tema.
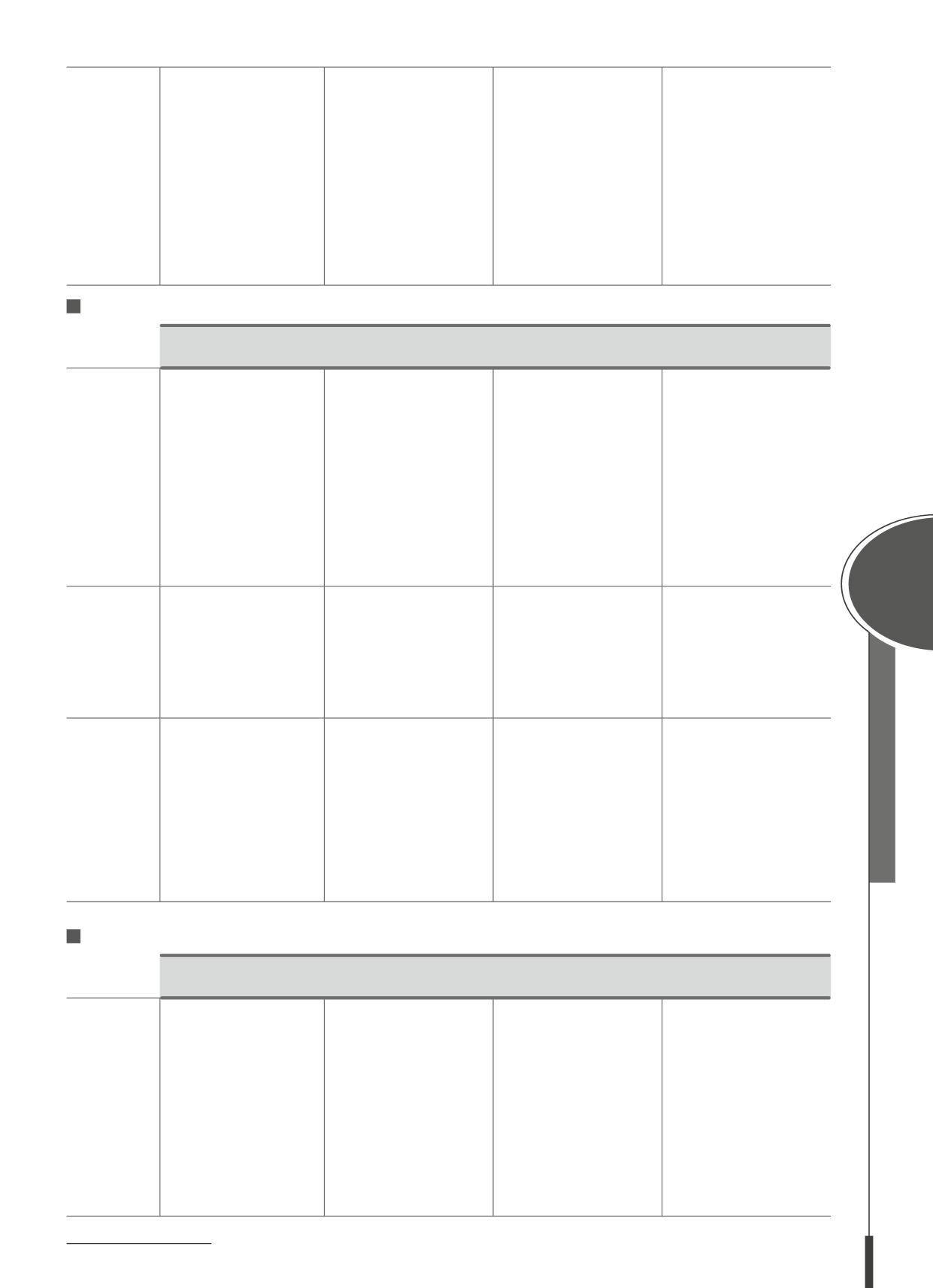
• Coerenza logica essenziale tra l’esposizione e la presentazione.
• Utilizzo delle slide come supporto per la lettura di definizioni e concetti chiave.
• Riesce solo a tratti a coinvolgere la classe sul tema.
• Coerenza logica precisa tra l’esposizione e la presentazione.
• Commento ragionato sulla scelta delle immagini e dei contenuti multimediali.
• Riesce discretamente a coinvolgere la classe sul tema.
Elaborato in forma visuale (volantino, poster...): griglia di valutazione
Livello insufficiente (1-4)
Testi • Contenuto non coerente con la consegna.
• Presenza di errori ortografici, di lessico e sintassi.
• Sovrabbondanza o insufficienza di testo scritto.
Livello base (5-6)
• Contenuto complessivamente coerente con la consegna.
• Testo chiaro e corretto ma privo di complessità.
• Discreta capacità di sintesi.
• Sovrabbondanza o insufficienza di testo scritto.
Livello intermedio (7-8)
• Contenuto ricco e coerente con la consegna.
• Testo chiaro e corretto.
• Uso significativo di parole chiave e buona capacità di sintesi.
• Coerenza logica precisa tra l’esposizione e la presentazione.
• Capacità di contestualizzare collegamenti a risorse esterne, citazioni, immagini o video.
• Riesce con successo a coinvolgere la classe sul tema.
Livello alto (9-10)
• Contenuto completo, preciso, coerente con la consegna e arricchito con scelte personali e originali.
• Testo chiaro e corretto.
• Scelta lessicale precisa e ragionata.
• Ottima capacità di sintesi.
Immagini/ Grafici
• Immagini assenti.
• Grafici/infografiche assenti (se richiesti nella consegna).
Grafica
• Assenza di attenzione grafica ed estetica, non leggibilità.
• Organizzazione caotica e scarsa coerenza di testo e immagini.
• Mancanza totale di efficacia comunicativa.
Video: griglia di valutazione
• Immagini presenti ma non sempre pertinenti.
• Grafici/infografiche presenti ma con errori o poco pertinenti (se richiesti nella consegna).
• Scarsa attenzione grafica ed estetica, sufficiente leggibilità.
• Sufficiente organizzazione e coerenza di testo e immagini.
• Accettabile efficacia comunicativa.
• Immagini pertinenti.
• Grafici/infografiche presenti ma con alcune imprecisioni o non efficaci (se richiesti nella consegna).
• Discreta attenzione grafica ed estetica, discreta leggibilità.
• Buona organizzazione e coerenza di testo e immagini.
• Buona efficacia comunicativa.
• Immagini pertinenti e con una coerenza grafica significativa.
• Grafici/infografiche presenti, pertinenti ed efficaci (se richiesti nella consegna).
• Grande attenzione grafica ed estetica, perfetta leggibilità.
• Ottima organizzazione e coerenza di testo e immagini.
• Efficacia comunicativa molto buona.
Contenuto (testo)
• Contenuto non coerente con la consegna.
• Sovrabbondanza o insufficienza di testo scritto/speakerato.
• Presenza di errori ortografici, di lessico e sintassi.
• Contenuto complessivamente coerente con la consegna.
• Testo scritto/ speakerato chiaro e corretto ma privo di complessità.
• Discreta capacità di sintesi.
• Contenuto ricco e coerente con la consegna.
• Testo scritto/ speakerato chiaro e corretto.
• Uso significativo di parole chiave e buona capacità di sintesi.
• Contenuto completo, preciso, coerente con la consegna e arricchito con scelte personali e originali.
• Testo scritto/ speakerato chiaro e corretto.
• Scelta lessicale precisa e ragionata.
• Ottima capacità di sintesi.
Montaggio • Scarsa sincronizzazione di testo e immagini.
• Scarsa qualità audio.
• Il video non rispetta i limiti di durata assegnati.
Grafica • Assenza di attenzione grafica ed estetica, non leggibilità.
• Immagini assenti o mai pertinenti.
• Grafici/infografiche assenti (se richiesti nella consegna).
• Mancanza totale di efficacia comunicativa.
• Discreta sincronizzazione di testo e immagini.
• Scarsa qualità audio.
• Il video non rispetta per pochi secondi i limiti di durata assegnati.
• Scarsa attenzione grafica ed estetica, sufficiente leggibilità.
• Immagini presenti ma non sempre pertinenti.
• Grafici/infografiche presenti ma con errori o poco pertinenti (se richiesti nella consegna).
• Accettabile efficacia comunicativa.
Testo scritto: griglia di valutazione
Contenuto • Assenza dell’informazione/ consegna richiesta.
• Lo scritto non ha un tema centrale evidente e chiaro; è faticoso estrarne il significato dal testo e bisogna ricorrere a inferenze.
Organizzazione
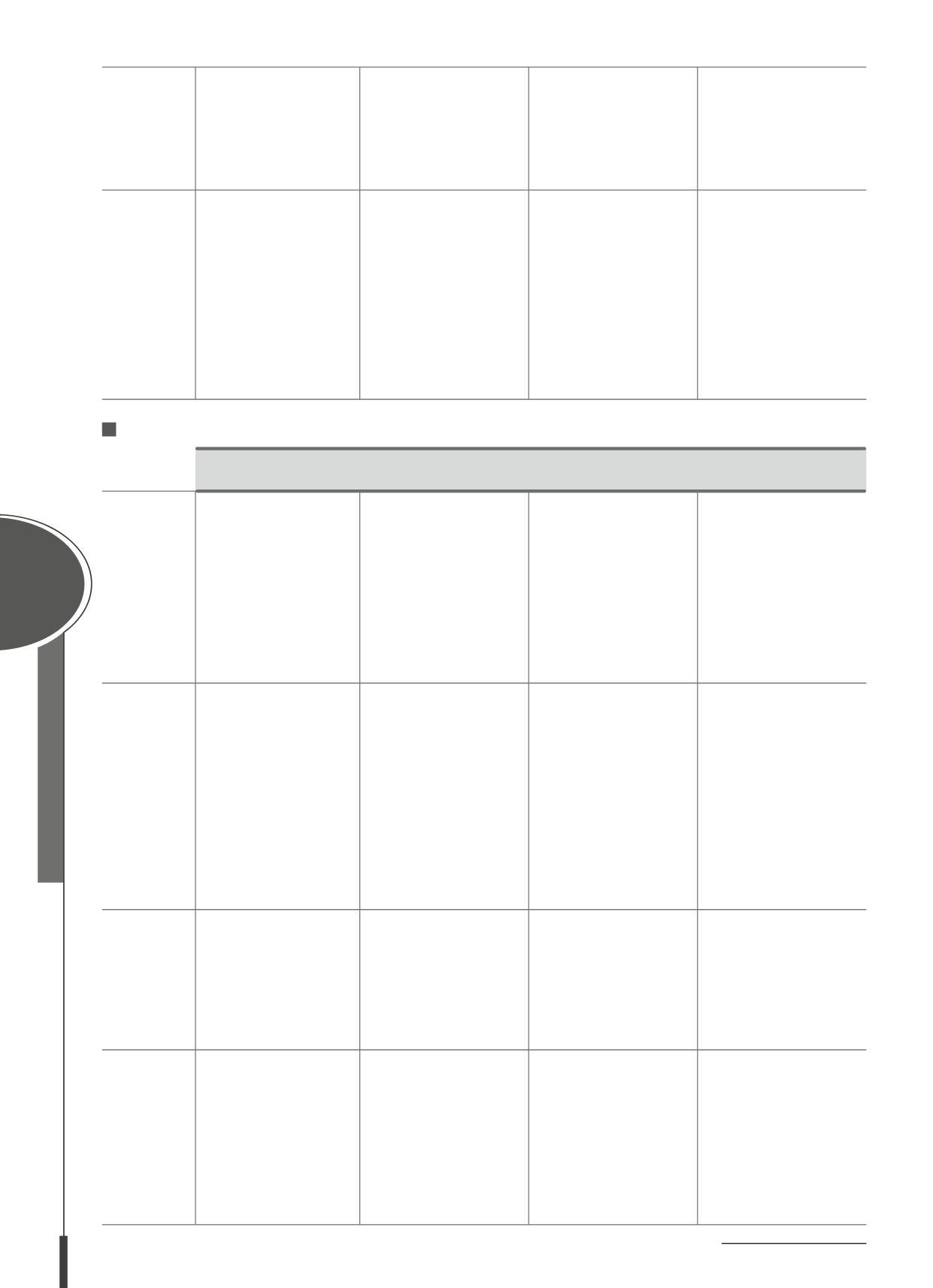
• Le informazioni date sul tema sembrano non avere un ordine logico.
• Lo scritto non ha introduzione, nessuna conclusione e nessuna struttura interna.
• Il testo non rispetta i limiti di lunghezza assegnati.
Lessico • Si ripetono parole semplici e banali, oppure si usano termini inappropriati, imprecisi o non idonei.
• Il lessico scientifico corretto è assente.
Stile
• Il testo non è aderente allo stile/alla tipologia assegnata (per esempio articolo divulgativo, saggio breve, short news...).
• Il ritmo è assente, il testo è un elenco di fatti tecnici, senza coinvolgimento.
• Buona sincronizzazione di testo e immagini.
• Buona qualità audio.
• Il video rispetta i limiti di durata assegnati.
• Discreta attenzione grafica ed estetica, discreta leggibilità.
• Immagini pertinenti.
• Grafici/infografiche presenti ma con alcune imprecisioni o non efficaci (se richiesti nella consegna).
• Buona efficacia comunicativa.
• Presenza parziale o non del tutto corretta dell’informazione/ consegna richiesta.
• Lo scritto non ha un tema centrale chiaro e la lettura non è sempre scorrevole.
• Si alternano frasi principali e dettagli senza un motivo preciso.
• Le informazioni date sul tema mancano di un chiaro. senso di direzione.
• Lo scritto manca di una introduzione o di una conclusione.
• Le idee, i dettagli o i fatti sembrano legati insieme in modo casuale.
• Il testo non rispetta per poche battute i limiti di lunghezza assegnati.
• Vi è un uso corretto ma ripetitivo delle stesse parole. Il vocabolario è ristretto e limitato a parole comuni.
• Il lessico scientifico corretto è presente solo in alcuni punti.
• Il testo è aderente solo in parte allo stile/alla tipologia assegnata (per esempio articolo divulgativo, saggio breve, short news...).
• Il ritmo non è scorrevole, il testo non è fluido.
• Perfetta sincronizzazione di testo e immagini.
• Ottima qualità audio.
• Il video rispetta i limiti di durata assegnati.
• Grande attenzione grafica ed estetica.
• Immagini pertinenti e con una coerenza grafica significativa.
• Grafici/infografiche presenti, pertinenti ed efficaci (se richiesti nella consegna).
• Efficacia comunicativa molto buona.
• Presenza dell’informazione/ consegna richiesta.
• Lo scritto ha un senso dello scopo ma a volte è difficile ricondurre ciò che si legge al tema centrale. La comprensione non è sempre facile.
• Le informazioni date sul tema hanno una organizzazione chiara abbastanza da condurre chi legge senza confusione, ma l’introduzione (o la conclusione) è incompleta o ripetitiva.
• Il testo rispetta i limiti di lunghezza assegnati.
• Vi è un uso corretto e una varietà di parole e sinonimi.
• Il lessico scientifico corretto è presente.
• Il testo è aderente allo stile/alla tipologia assegnata (per esempio articolo divulgativo, saggio breve, short news...).
• Il ritmo è scorrevole, il testo è fluido ma non coinvolge abbastanza.
• Presenza dell’informazione/ consegna richiesta.
• Lo scritto è chiaro nel suo scopo o nel tema centrale.
• Lo si legge dall’inizio alla fine senza fatica. Fatti e dettagli interessanti lo arricchiscono.
• La parte iniziale del testo introduce ed evidenza il tema. Le informazioni date sono arricchite con esempi adatti.
• La conclusione offre una sintesi, ma senza essere ripetitiva.
• Il testo rispetta i limiti di lunghezza assegnati.
• Il lessico è vario e piacevole alla lettura. Le parole scelte arricchiscono il messaggio.
• Il lessico scientifico corretto è presente.
• Il testo è perfettamente aderente allo stile/alla tipologia assegnata (per esempio articolo divulgativo, saggio breve, short news...).
• Il ritmo è scorrevole, il testo è espressivo e coinvolgente.
USO DEL PODCAST NELLA DIDATTICA
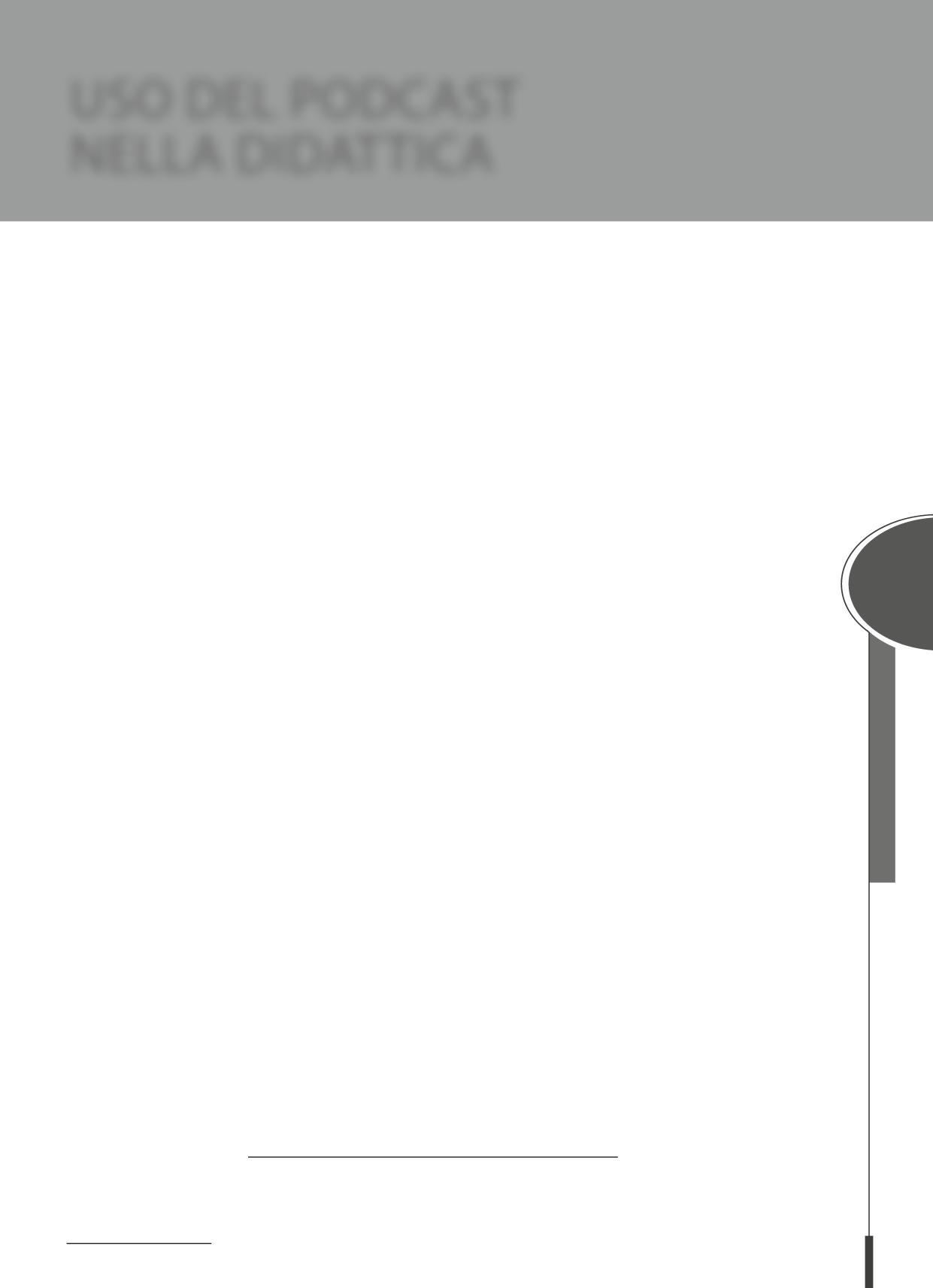
Negli ultimi anni i podcast stanno diventando uno strumento sempre più diffuso di divulgazione anche nel nostro Paese. Cercando in Internet si possono trovare podcast praticamente su ogni argomento, compresi temi scientifici ad alto valore formativo, affrontati in modo alternativo rispetto ai canoni della lezione frontale e del libro di testo e narrati con linguaggi più vicini all’età di chi ascolta.
I podcast sono quindi un potente strumento didattico che può arricchire l’esperienza di apprendimento degli studenti. La loro efficacia si basa su alcuni vantaggi.
Accessibilità e flessibilità: i podcast possono essere ascoltati in qualsiasi momento e luogo, permettendo agli studenti di sfruttare momenti al di fuori dell’orario scolastico. In questo aspetto, i podcast sono più vantaggiosi rispetto alla fruizione di un video, essendo ascoltabili anche in situazioni in cui l’attenzione potrebbe venire meno (es. in autobus, camminando verso casa ecc.). Ciò facilita quindi un apprendimento personalizzato e autonomo.
Multimodalità: integrare l’ascolto individuale con quello in classe durante le lezioni, insieme alla lettura e all’uso di altri contenuti digitali stimola differenti modalità di apprendimento, favorendo la comprensione e la memorizzazione dei contenuti. I contenuti audio, inoltre, stimolano l’immaginazione e la concentrazione, oltre a migliorare la capacità di comprensione e di analisi uditiva, competenze fondamentali nel mondo moderno.
Aggiornamento: l’offerta di podcast è costantemente rinnovata da nuove collane con contenuti di attualità che consentono ai docenti di portare in classe temi attuali e pertinenti agli argomenti di studio, arricchendo il curriculum scolastico con proposte differenziate di anno in anno e di classe in classe.
Alcuni suggerimenti per integrare l’uso dei podcast nella didattica
Ascolto: invece dei tradizionali compiti scritti, si possono assegnare podcast da ascoltare come compito a casa. Per far sì che il compito non venga preso sottogamba dagli studenti, è bene informare la classe che l’ascolto autonomo sarà seguito da un lavoro, che potrà essere o di discussione collettiva o di produzione di riflessioni scritte.
Debate: alcuni podcast, in particolare sui temi di attualità, si prestano molto bene all’ascolto in classe e servono come spunto per promuovere attività di dibattito e discussione, favorendo lo sviluppo del pensiero critico e delle abilità oratorie.
Recensioni: è possibile chiedere agli studenti di ascoltare un podcast e poi scrivere una recensione o un riassunto, migliorando le loro capacità di sintesi e analisi.
Creazione di podcast: incoraggiare gli studenti a creare i propri podcast su argomenti di studio può stimolare la loro creatività e capacità di sintesi, oltre a migliorare le competenze digitali (e la collaborazione nel caso si assegni un lavoro di gruppo).
Incorporare i podcast nella didattica offre dunque un’opportunità unica per rendere l’apprendimento più dinamico e coinvolgente. Provare questo strumento può portare significativi benefici sia per gli studenti che per i docenti, creando un ambiente educativo moderno e stimolante. Rizzoli Education ti propone di sperimentare l’uso del podcast nella didattica con le sue collane, create ad hoc per la scuola. Accedi alla pagina dedicata del sito (https://www.rizzolieducation.it/ss2/area-scientifica/), dove puoi ascoltare i trailer dei podcast originali Rizzoli Education a cura dei nostri autori.
PER CASO, le scoperte della chimica
Le scoperte casuali non sono una semplice questione di fortuna: trovano sempre dall’altra parte una mente attenta e accorta che sa interpretare quel che ha di fronte e formulare una spiegazione e un utilizzo per questo fenomeno inatteso: Eva Munter (@chimicainpillole) ci porta in viaggio tra fortuna e sagacia attraverso le principali invenzioni casuali della storia.
I
NOBEL
PER LA FISICA e I NOBEL PER LA CHIMICA
Le grandi scoperte della fisica e della chimica hanno reso il mondo un posto migliore. Dietro queste scoperte ci sono grandi uomini e grandi donne, che hanno dedicato la loro vita al progresso scientifico, e hanno ricevuto il premio Nobel per i benefici resi all’umanità. Scopriamo le loro storie nei podcast scritti da Laura Paganini, astrofisica e ricercatrice, e Grazia Battiato, chimica farmaceutica e giornalista scientifica.
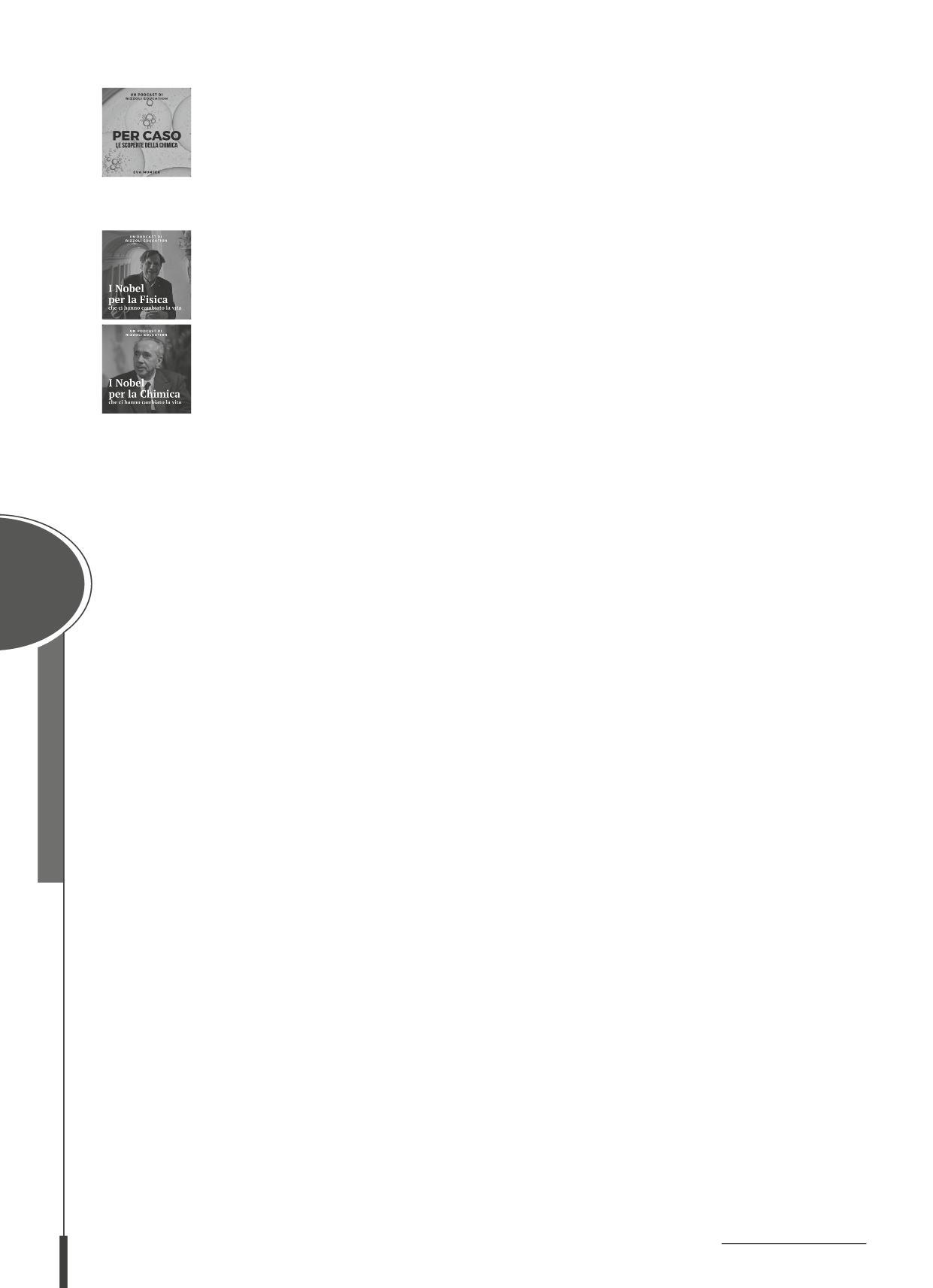
I Nobel per la Fisica
1. 1978 Arno Penzias & Robert Wilson
2. 2000 Jack Kilby
3. 2009 Charles Kuen Kao
4. 2009 Boyle Smith
5. 2013 Francois Englert & Peter Ware Higgs
6. 2014 Nakamura Akasaki Amano
7. 2017 Kip Thorne
8. 2019 Michel Mayor & Didier Queloz
9. 2021 Manabe Hasselmann
10.2021 Giorgio Parisi
I Nobel per la Chimica
1. 1935 Irène Joliot-Curie
2. 1937 Sir Walter Norman Haworth
3. 1963 Giulio Natta
4. 1964 Dorothy Crowfoot Hodgkin
5. 1993 Kary Mullis
6. 1995 Mario Molina
7. 2016 Jean-Pierre Sauvage, Fraser Stoddart e Bernard Feringa
8. 2019 Whittingham, Goodenough e Yoshino
9. 2020 Doudna, Charpentier
METODOLOGIA CLIL
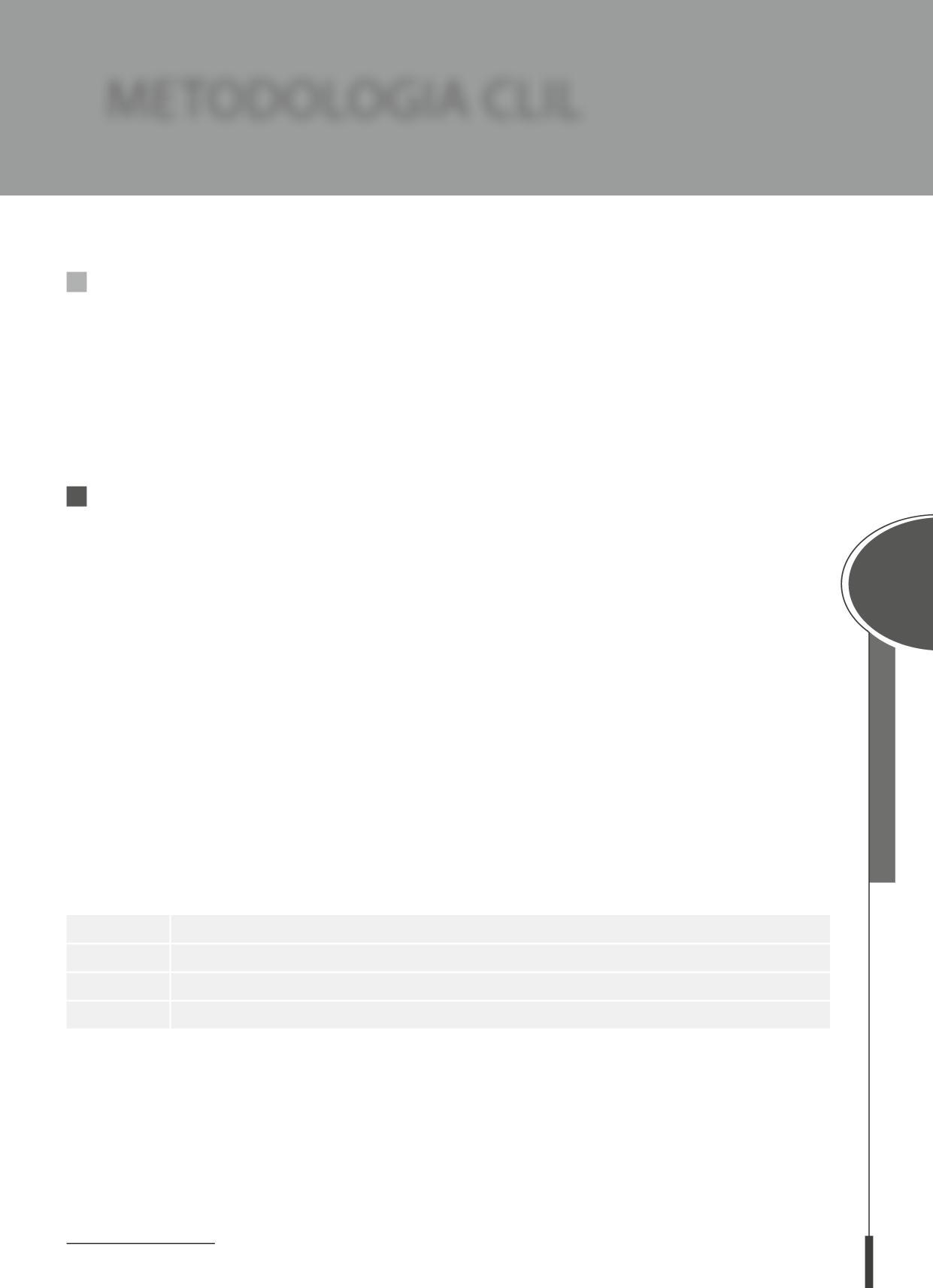
La didattica
La metodologia CLIL (Content and Language Integrated Learning) per l’insegnamento di una disciplina non linguistica (DNL) in lingua straniera nasce all’inizio degli anni Novanta e nel nostro Paese riceve crescente attenzione nel decennio successivo, fino a ottenere un’esaustiva regolamentazione giuridica a partire dal 20101
Il punto di forza di questo innovativo metodo di insegnamento è l’uso veicolare della lingua straniera, che non rappresenta più l’obiettivo di apprendimento in sé ma diventa il mezzo linguistico per trasmettere contenuti appartenenti a una seconda disciplina curricolare. I vantaggi sono duplici: la lingua straniera è appresa in modo più naturale e autentico, poiché i costrutti linguistici sono calati in un contesto cognitivo che si discosta da quello prettamente linguistico.
I riferimenti normativi
Il Ministero, oltre allo studio della Seconda lingua comunitaria nella scuola media inferiore, promuove con il Progetto Lingue 2000 l’uso veicolare della lingua straniera. In precedenza, con la legge 440/97 sull’autonomia scolastica le scuole avevano già potuto sperimentare nuove metodologie didattiche, aprendo fruttuose prospettive per l’insegnamento CLIL.
Alcuni anni dopo, il Decreto Legislativo n.226 del 2005 dà un notevole impulso alla didattica CLIL, preludendo alle indicazioni ministeriali del 2010. È infatti con la legge di riforma “Gelmini” (DPR 89/2010) che, per quanto riguarda la scuola secondaria superiore, si stabilisce che ogni Liceo debba attuare nel quinto anno l’insegnamento di una Disciplina Non Linguistica (DNL) in lingua straniera. Fanno eccezione i Licei Linguistici, in cui l’insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera coinvolge due lingue straniere a partire rispettivamente dal terzo e dal quarto anno.
Le Norme transitorie a.s. 2014/15 del 25 luglio 2014 offrono infine alle istituzioni scolastiche un quadro riassuntivo della normativa che regola l’insegnamento di una DNL in lingua straniera secondo la metodologia CLIL nella scuola secondaria superiore.
CLIL for science
Quattro argomenti, suddivisi in moduli e fruibili in digitale a partire da codici QR sul sommario della copia cartacea, sono affrontati seguendo la metodologia CLIL (letture, attività di comprensione dei testi e attività CLIL).
MODULE 1 Isomers and isomerism
MODULE 2 DNA
MODULE 3 Biotechnology
MODULE 4 Dynamics of Earth’s atmosphere
1 Quadro normativo di riferimento: MIUR, DM 10 settembre 2010, n. 249 art. 14. MIUR, DD 16 aprile 2012, n. 6. MIUR, DD 20 novembre 2013, n. 89. MIUR, Nota Ministeriale 25 luglio 2014 Avvio in ordinamento dell’insegnamento di Discipline non linguistiche in lingua straniera secondo la metodologia Clil, Norme transitorie 2014-2015

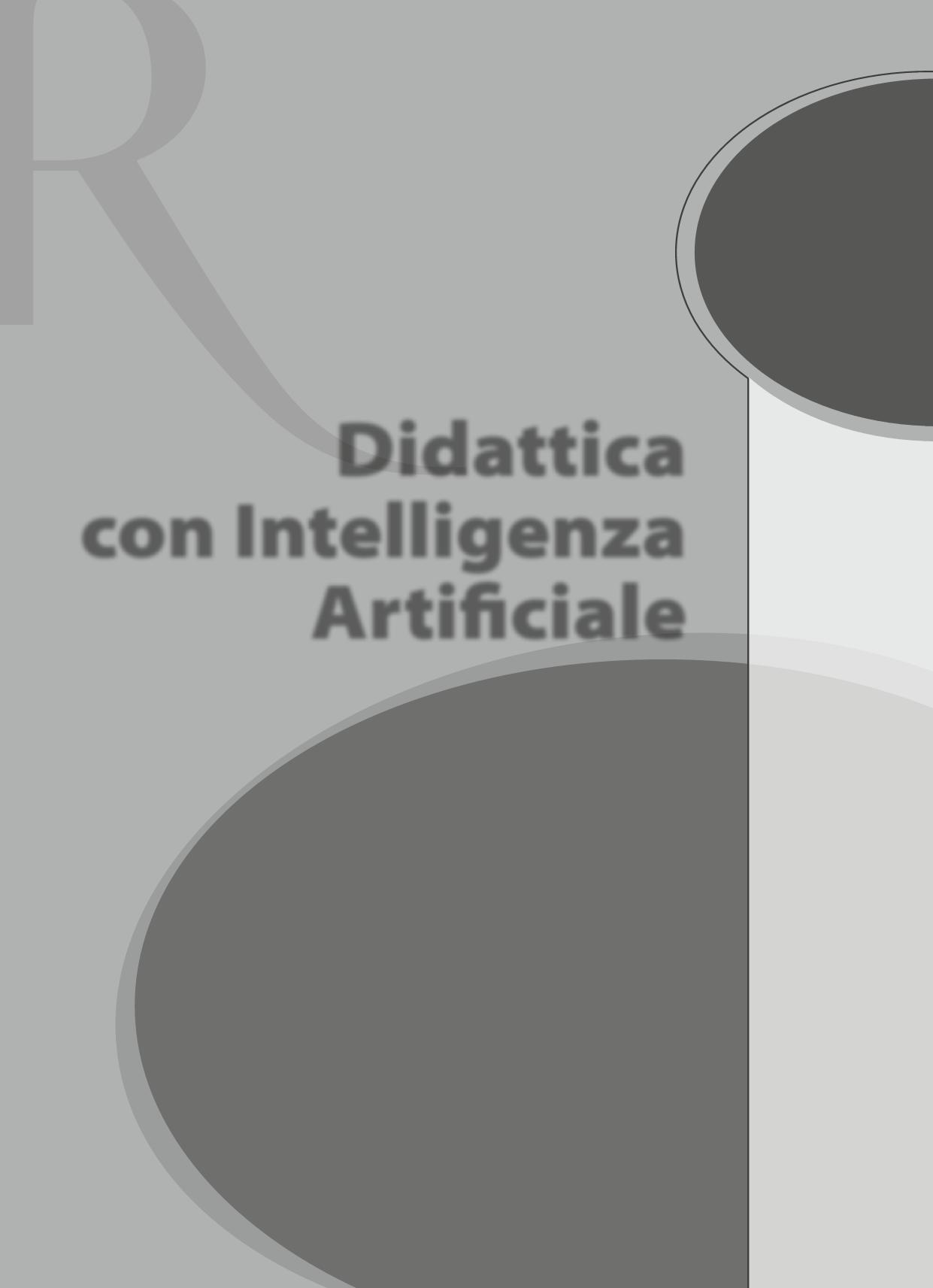
6
Didattica con Intelligenza Artificiale

Intelligenza artificiale: istruzioni per l’uso!
L’Intelligenza artificiale (per comodità AI) è una rivoluzione tecnologica ma anche culturale e sociale. L’assegnazione dei Premi Nobel del 2024 sancisce in una duplice maniera questo dato di fatto.
Con il Nobel per la Fisica a John Hopfield e Geoffrey Hinton si celebra il grande sforzo che ha portato allo sviluppo delle reti neurali e dunque reso possibile l’apprendimento automatico (o machine learning), cioè la possibilità per una macchina, grazie a degli algoritmi, di migliorare e affinare le proprie capacità di elaborazione man mano che acquisisce nuovi dati, arrivando a svolgere anche compiti non assegnati all’inizio.

Da qui puoi accedere al sito della Casa editrice per materiali nuovi e aggiornati.
Con il Nobel per la Chimica a David Baker e Demis Hassabis and John Jumper si testimonia la potenzialità dell’AI di migliorare concretamente le nostre vite: la ricerca sulle proteine e la loro complessa struttura, la progettazione in laboratorio di nuove proteine e la successiva realizzazione sono di fatto il primo passo verso la comprensione e la cura (tramite nuovi farmaci e nuove terapie) di molte malattie.
L’emozione di fronte a tali importanti conseguimenti non deve lasciare spazio a un ingenuo ottimismo: accanto alle “magnifiche sorti e progressive” di questa tecnologia, esistono criticità o comunque situazioni che è bene indagare con attenzione e senza pregiudizi. A maggior ragione questo deve accadere nella Scuola, dove gli e le studenti stanno costruendo quella “cassetta degli attrezzi” che consentirà loro di essere cittadini consapevoli e professionisti capaci e, in definitiva, di vivere una vita serena.
Queste poche pagine servono dunque a questo: individuare alcune prime linee guida per impiegare con profitto l’AI a scuola, offrire dei consigli sempre pratici e costruire strategie risolutive che sappiano accogliere, senza timori, le sfide presenti e future cui l’AI ci chiama.
Un framework per l’AI a Scuola
Una strategia usata da molti esperti di fronte a problemi complessi e all’apparenza inattaccabili è quella del drill down: in parole più semplici e senza inutili tecnicismi, significa scomporre il problema in sotto-problemi più piccoli che quindi possono essere compresi e risolti con più facilità.
La stessa intuizione hanno avuto M. Ranieri, S. Cuomo e G. Biagini nello stendere il loro saggio Scuola e intelligenza artificiale: in questo valido contributo, gli autori costruiscono un framework che serve alla Scuola per scomporre il problema AI. Qui sotto ne riproponiamo una versione semplificata e, a nostro giudizio, più funzionale:
0. AI literacy (o alfabetizzazione)
1. dimensione conoscitiva
2. dimensione operativa
3. dimensione critica
0. AI literacy
“Cercando le parole, si trovano i pensieri”: così ammoniva con sagacia il filosofo francese Joseph Joubert. E quindi il punto di partenza di qualsiasi indagine non può che essere il lessico.
Ecco quindi un primo vocabolario di base:
intelligenza artificiale generativa
Si tratta di un tipo di intelligenza artificiale che è in grado di creare nuovi contenuti, come immagini, testi e suoni, che possono essere indistinguibili da quelli creati da esseri umani.
Esempio:
un software che produce nuove composizioni musicali dopo aver appreso lo stile di vari compositori classici, generando pezzi originali che rispecchiano il gusto e la complessità delle opere apprese.
intelligenza artificiale generale (agi)
Una forma di intelligenza artificiale che può comprendere, imparare ed eseguire compiti intellettuali su un livello paragonabile all’intelligenza umana. L’AGI sarebbe in grado di applicare la conoscenza e le abilità di problem solving in una vasta gamma di contesti diversi, mostrando adattabilità e comprensione del mondo su scala umana. Si ritiene che la realizzazione di un’AGI sia ancora molto lontana.
Esempio:
un sistema AGI potrebbe essere utilizzato per condurre ricerche mediche autonome, formulando ipotesi, conducendo esperimenti virtuali, analizzando dati di studi clinici, e sviluppando nuovi farmaci, adeguandosi alle scoperte emergenti e regolamenti in tempo reale, senza bisogno di direttive specifiche da parte di ricercatori umani.
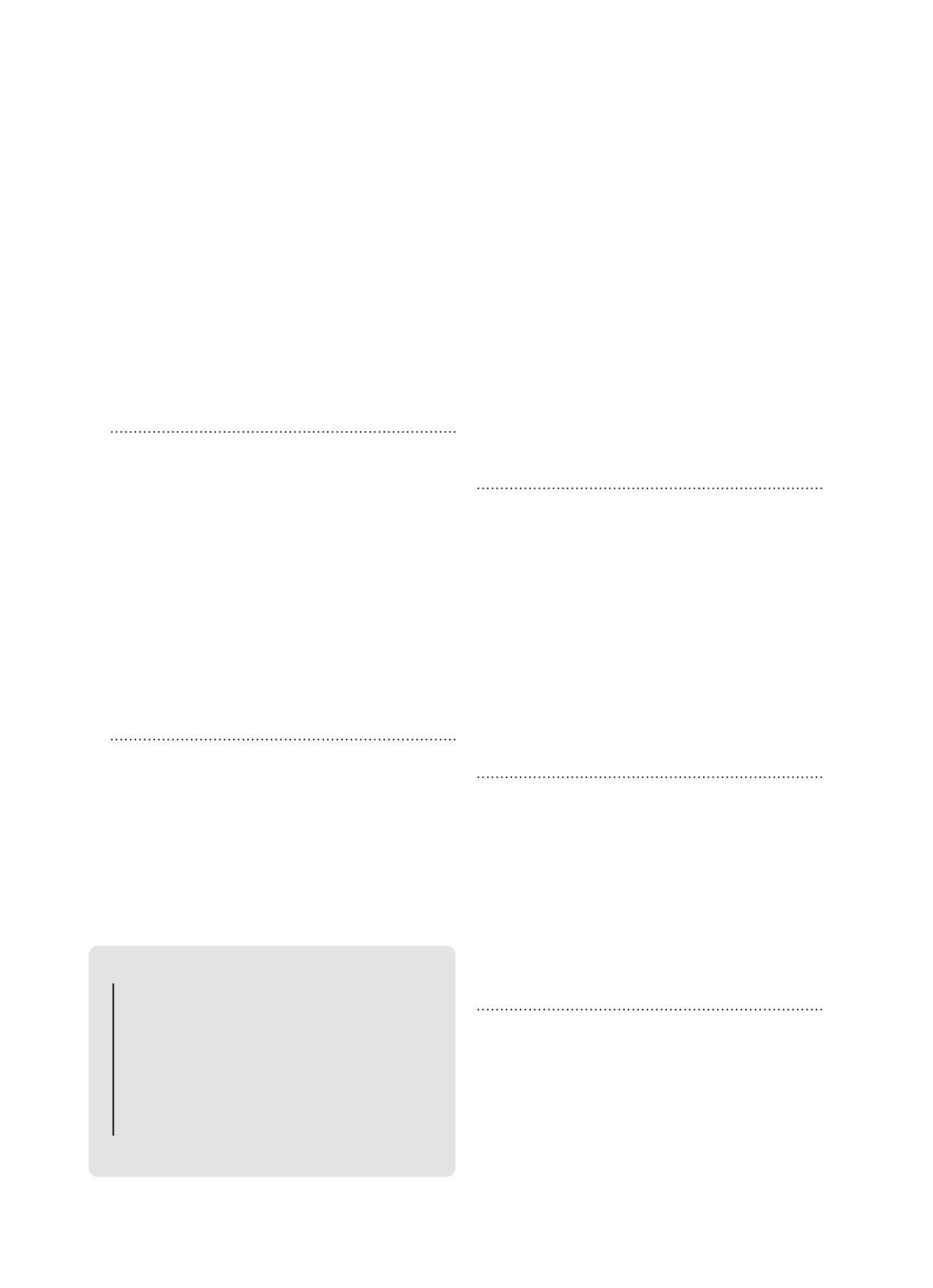
large language models (llms)
I modelli di linguaggio di grandi dimensioni sono sistemi di intelligenza artificiale addestrati su vasti corpus di testo che possono comprendere e generare lingua naturale in modo coerente e contestualizzato. Questi modelli sono alla base di molte applicazioni moderne, dalla traduzione automatica ai sistemi di assistenza virtuale.
Esempio:
un assistente digitale che può svolgere compiti complessi come scrivere e-mail, comporre poesie o codificare programmi, basandosi sulla sua comprensione del linguaggio acquisita tramite l’analisi di una grande quantità di testi.
chatbot
Programmi informatici avanzati capaci di condurre una conversazione con gli utenti umani, tipicamente via testo. Questi sistemi sono spesso alimentati da algoritmi di machine learning e intelligenza artificiale per migliorare la capacità di risposta e apprendere dalle interazioni precedenti.
Esempio:
un servizio di assistenza clienti online che utilizza una chatbot per rispondere alle domande frequenti dei clienti, alleggerendo il carico di lavoro del personale di supporto.
allucinazione
Un’allucinazione in un chatbot avviene quando esso fornisce una risposta non accurata o inventata, senza alcuna base nei dati reali o nelle informazioni di cui dispone.
Esempio:
un utente chiede a un chatbot “Qual è la capitale della Svizzera?” e la risposta ottenuta è “La capitale della Svizzera è Zurigo.”
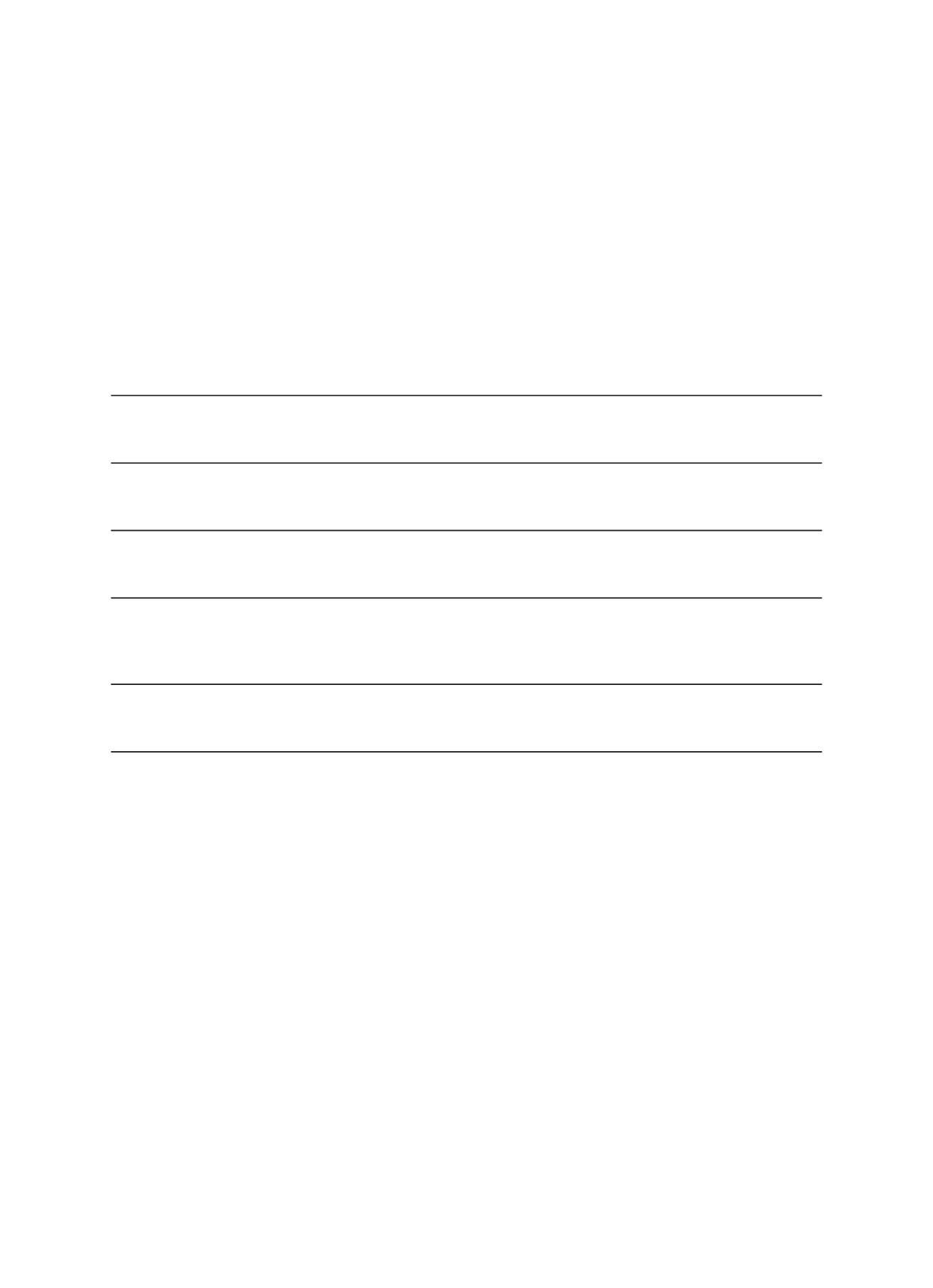
1. Dimensione conoscitiva
In questa prima fase, l’AI è l’oggetto della lezione. Questo passaggio assolve, per lo meno, a un duplice compito: ➀ dare contesto e rendere conto della complessità, anche storica e sociale, di quello che in maniera riduttiva definiamo “software”; ➁ in virtù di questo contesto, rendere più consapevoli gli studenti delle potenzialità e dei limiti dello strumento che useranno in una fase successiva.
I punti di vista possono essere molteplici e ciascuno sceglierà in base alla propria sensibilità e alle proprie competenze:
a → storico: i concetti di analogico e digitale, la costruzione e trasmissione del sapere dalle enciclopedie al web semantico, la storia delle macchine “intelligenti” (una buona sintesi si legge in G. Roncaglia, L’architetto e l’oracolo);
b → storico-sociale: il rapporto uomo-macchina (si veda per esempio: A. Longo, G. Scorza, Intelligenza artificiale. L’impatto sulle nostre vite, diritti e libertà) e il ruolo della macchina nel lavoro (ottimi spunti, anche se solo in inglese, in M. Pasquinelli, The Eye of the Master: A Social History of Artificial Intelligence);
c → filosofico: i concetti di autorialità (il punto di partenza fondamentale resta l’articolo di M. Foucault, Che cos’è un autore) e di creatività (stimolante la lettura di F. D’Isa, La rivoluzione algoritmica. Arte e intelligenza artificiale);
d → giuridico: una lettura attenta del Bejing Consensus (un documento Unesco il cui tentativo è stabilire come l’intelligenza artificiale possa essere utilizzata in modo sicuro, equo ed efficace per promuovere l’educazione a livello globale) e EU AI Act (una proposta di regolamento dell’Unione europea che mira a regolamentare lo sviluppo, l’uso e la diffusione delle tecnologie di intelligenza artificiale);
e → informatico: il funzionamento dell’apprendimento automatico (o machine learning) e la sua explainability (XAI) (si può fare riferimento a N. Cristianini, La scorciatoia. Come le macchine sono diventate intelligenti senza pensare in modo umano).
Al di là delle specifiche pratiche disciplinari, ci sono due istanze di cui ogni docente dovrebbe farsi carico:
etica per l’ai fissa i principi che possono guidare l’uso degli algoritmi nella società e nelle organizzazioni: beneficenza, non maleficenza, autonomia, giustizia, esplicabilità.
etica dell’ai definisce i problemi etici che gli algoritmi nel loro funzionamento comportano, ovvero l’equità (fairness) e l’iniquità (unfairness): un sistema di AI è considerato equo quando le sue previsioni e decisioni non sono influenzate da pregiudizi o discriminazioni verso gruppi o individui, e quando queste sono chiare, trasparenti e ugualmente applicabili a tutti.
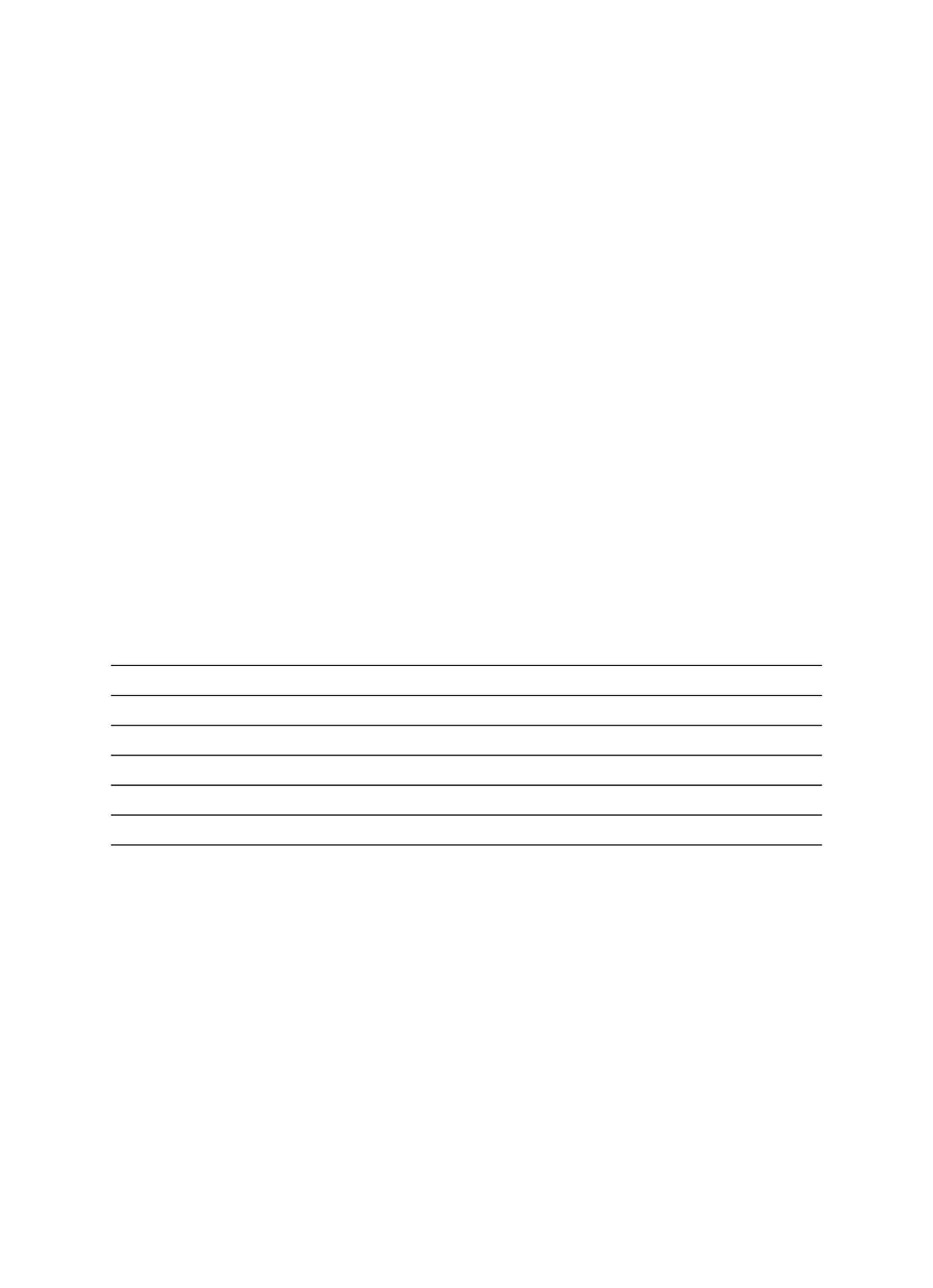
2. Dimensione operativa
In questa seconda fase, l’AI è lo strumento della lezione: grazie a un semplice chatbot gratuito, oggi è infatti possibile generare una molteplicità di artefatti (testo, immagini, video, audio). Più che resistere a questa possibilità e dunque organizzare la propria didattica come “uno strumento di una vera e propria controcultura” (secondo l’espressione del filosofo tedesco Gernot Böhme), la Scuola otterrà maggiori e più utili risultati se insegnerà agli e alle studenti a usare con saggezza questo strumento, affidandogli i compiti per cui è progettato eppure restando sempre in controllo del processo e del prodotto. Non sarà infatti un caso che, una delle più importanti aziende informatiche del pianeta, abbia scelto per i propri servizi AI la metafora del co-pilota Non si tratta solo di una banalità pedagogica. Si ricordi infatti ciò che sancisce quella che gli esperti hanno chiamato la legge di Kasparov (in onore del grande scacchista russo e delle sue leggendarie sfide contro il supercomputer IBM Deep Blue): una combinazione efficace di intelligenza umana e intelligenza artificiale lavora meglio di ciascuna delle due intelligenze (umana o artificiale) presa singolarmente.
Lo strumento AI più diffuso e che ciascuno di noi usa quotidianamente è un chatbot, cioè un software AI che risponde a domande e interagisce con gli utenti, adattandosi al contesto delle conversazioni.
la prima cautela ricordare che un chatbot è un motore di ragionamento (reasoning engine) e non un semplice archivio di dati (fact database): per esempio, eccelle nel brainstorming creativo, ma non sempre è attendibile nelle ricerche di dati.
la seconda cautela sapere che la qualità dell’artefatto dipenderà dalla nostra capacità di porre in modo efficiente le giuste domande (ricordate la legge di Kasparov?). Ecco quindi alcune buone pratiche per dialogare (il cosiddetto prompting) con profitto con un chatbot:
➊ esprimersi in modo grammaticalmente corretto;
➋ essere chiari e specifici;
➌ fornire contesto e vincoli;
➍ utilizzare suggerimenti ed esempi;
➎ fare una richiesta alla volta;
➏ rivedere e affinare la propria richiesta.
In termini concreti, potete chiedere al chatbot di generare un testo su qualsiasi argomento e ci sono buone probabilità che il testo che riceverete come risposta non sarà soddisfacente. Sarà importante quindi, per esempio, dare indicazioni su: la forma (un punto elenco, dialogo; perché no, una breve poesia); la lunghezza; la difficoltà oppure la competenza del destinatario (una cosa è chiedere un testo destinato agli studenti e un’altra è chiedere un testo destinato ai colleghi); il tono (formale o informale) e lo stile; la lingua (i chatbot sembrano cavarsela particolarmente bene nelle attività di traduzione, per esempio). Insomma, come scrive P.C. Rivoltella: “l’IA si può rivelare una validissima alleata nel lavoro di produzione creativa e di presa di decisione; imparare a servirsene, in una logica di co-creazione, fa parte di sicuro della nuova literacy che occorre sviluppare”.
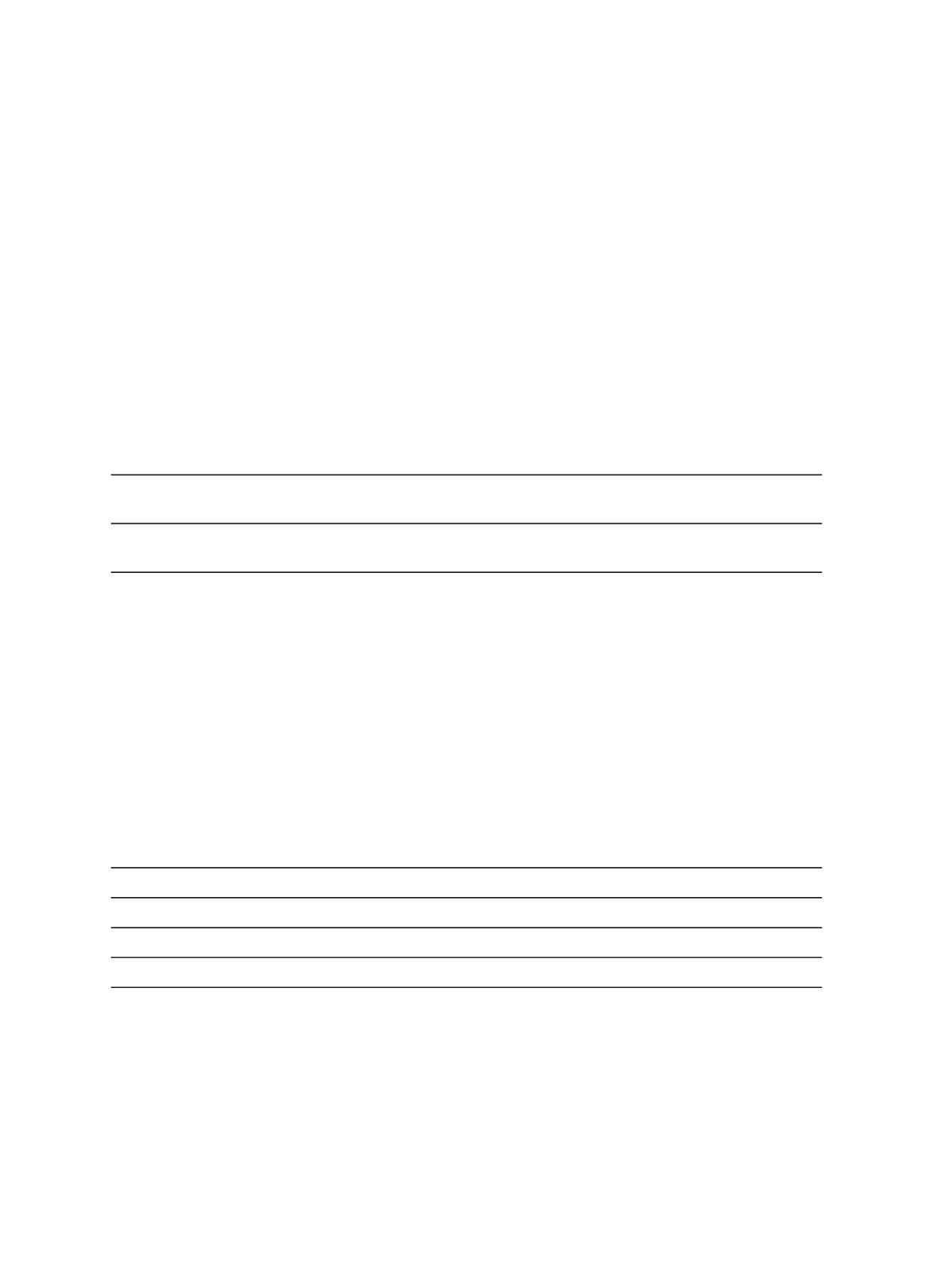
Da quanto detto fin qui, emerge che l’AI potrà essere un valido aiuto anche per il docente, nelle molteplici attività che svolge prima della lezione, durante la lezione, dopo la lezione: (a) progettare e pianificare; (b) spiegare e presentare; (c) personalizzare e supportare; (d) erogare e gestire
Proviamo a elencare qualche esempio: generare indicazioni sui compiti con i criteri di valutazione | sviluppare istruzioni che descrivono i ruoli e le aspettative dell’apprendimento cooperativo || produrre poster che elencano i 10 motivi per cui l’algebra è importante per il futuro degli studenti o i 20 errori di scrittura più comuni degli studenti delle scuole superiori, con brevi definizioni ed esempi | creare esempi risolti di problemi matematici, equazioni di chimica, ecc. con la spiegazione di ogni fase | costruire un organizzatore per la lettura preliminare o anticipata, estraendo il vocabolario critico e non familiare da un capitolo ed elencando le parole chiave con le relative definizioni | preparare delle flashcard con domande e risposte || semplificare la comunicazione con i genitori, i colleghi e le segreterie attraverso lettere di benvenuto alla classe, proposte di gite, programmi di assemblea e fogli di autorizzazione.
E se invece volessimo concentrarci sul monitoraggio e la valutazione:
liste di controllo: un chatbot può sviluppare una lista di attività e processi che aiuti lo studente nel percorso di metacognizione;
test: un chatbot può creare test su uno o più argomenti, con il numero e i tipi di quesiti che voi indicherete; potete richiedere anche le soluzioni con una breve spiegazione;
rubriche: un chatbot sa comporre con facilità una rubrica per qualsiasi tipo di prestazione dello studente: analitica, olistica e di sviluppo; oppure suggerirvi scale e tabelle di valutazione.
3. Dimensione critica
La terza fase critica interessa infine la competenza del saper riconoscere e distinguere fra reale, verosimile e falso. La pratica del fact-checking è già in uso nelle scuole da tempo, eppure l’AI ci pone di fronte a sfide ancora più complesse.
Una buona strategia è trasmettere agli studenti una semplice routine di domande (che adattiamo dal lavoro di B. Mastroianni, La disputa felice):
individuare la fonte: chi lo dice?
data, luogo, circostanze: quando e dove?
verificabilità: qualcuno lo conferma?
autorevolezza: chi lo conferma?
confronto: ci sono altre versioni?
Parafrasando un valido contributo dei pedagogisti americani E.R. Mollick & L. Mollick, queste strategie promuovono una supervisione attiva e lo stimolo a combinare le capacità dell’AI con i contributi individuali, sfidando gli studenti a rimanere il “fattore umano” nel processo (human in the loop) per garantire che l’AI funzioni come uno strumento di supporto piuttosto che come un sostituto
La valutazione dell’artefatto
La valutazione è spesso guardata con sospetto e diffidenza. Eppure è un processo che, se progettato ed eseguito con intelligenza, non è solo uno strumento diagnostico che consente al docente di evitare che le difficoltà degli studenti degenerino in insuccessi. Di più: se interpretata come relazione (e non già come la comunicazione arida di un voto), la valutazione è formazione dell’individuo che, in quanto tale, consente di conoscere sé stessi, interpretare il proprio presente e progettare il proprio futuro.
La valutazione in un processo di apprendimento arricchito dall’AI (AI-enhanced) deve possedere necessariamente alcune caratteristiche: ➀ essere formativa e integrata durante tutto il processo; ➁ offrire un feedback prospettico e costruttivo (che consenta cioè di visualizzare gli strumenti e le fasi dell’apprendimento); ➂ valorizzare la complessità di questa “prestazione epistemica” (che è quindi un insieme di informazioni disciplinari, pratiche di conoscenza, creatività).
Proponiamo qui in chiusura una semplice tabella che può servire come punto di partenza per qualsiasi pratica valutativa.
criteri descrizione punteggio *
Capacità di porre domande rilevanti
Capacità di strutturazione di ragionamenti complessi
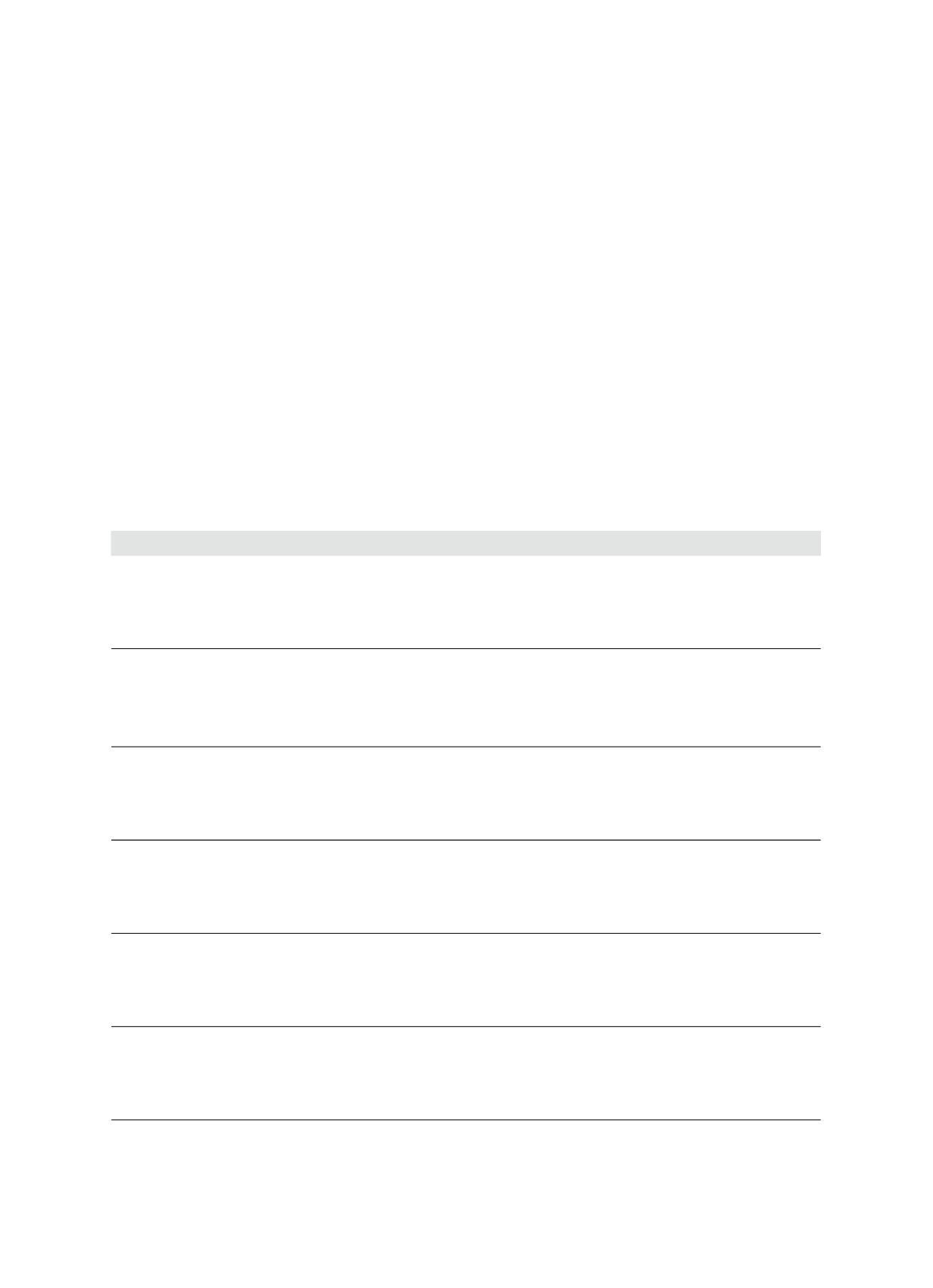
Creatività nell’uso del chatbot
Autonomia nell’uso del chatbot
Riflessione critica
Presentazione del prodotto finale
La capacità di formulare domande pertinenti e ben strutturate per ottenere informazioni utili dal chatbot.
L’abilità di affinare continuamente le richieste e collegare le risposte del chatbot per costruire un discorso articolato e ben strutturato.
L’uso originale e innovativo del chatbot per esplorare soluzioni o punti di vista nuovi.
La capacità dello studente di utilizzare il chatbot in modo indipendente, senza costante supporto esterno.
L’abilità dello studente di riflettere criticamente sulle informazioni ricevute e di metterle in discussione.
La qualità della presentazione del lavoro finale derivato dall’interazione con il chatbot (chiarezza, coerenza, accuratezza).
➀ ➁ ➂ ➃ ➄
➀ ➁ ➂ ➃ ➄
➀ ➁ ➂ ➃ ➄
➀ ➁ ➂ ➃ ➄
➀ ➁ ➂ ➃ ➄
➀
➁ ➂ ➃ ➄
* ➀ = Non soddisfacente | ➁ = Migliorabile | ➂ = Adeguato | ➃ = Buono | ➄ = Eccellente
15 consigli per costruire prompt efficaci
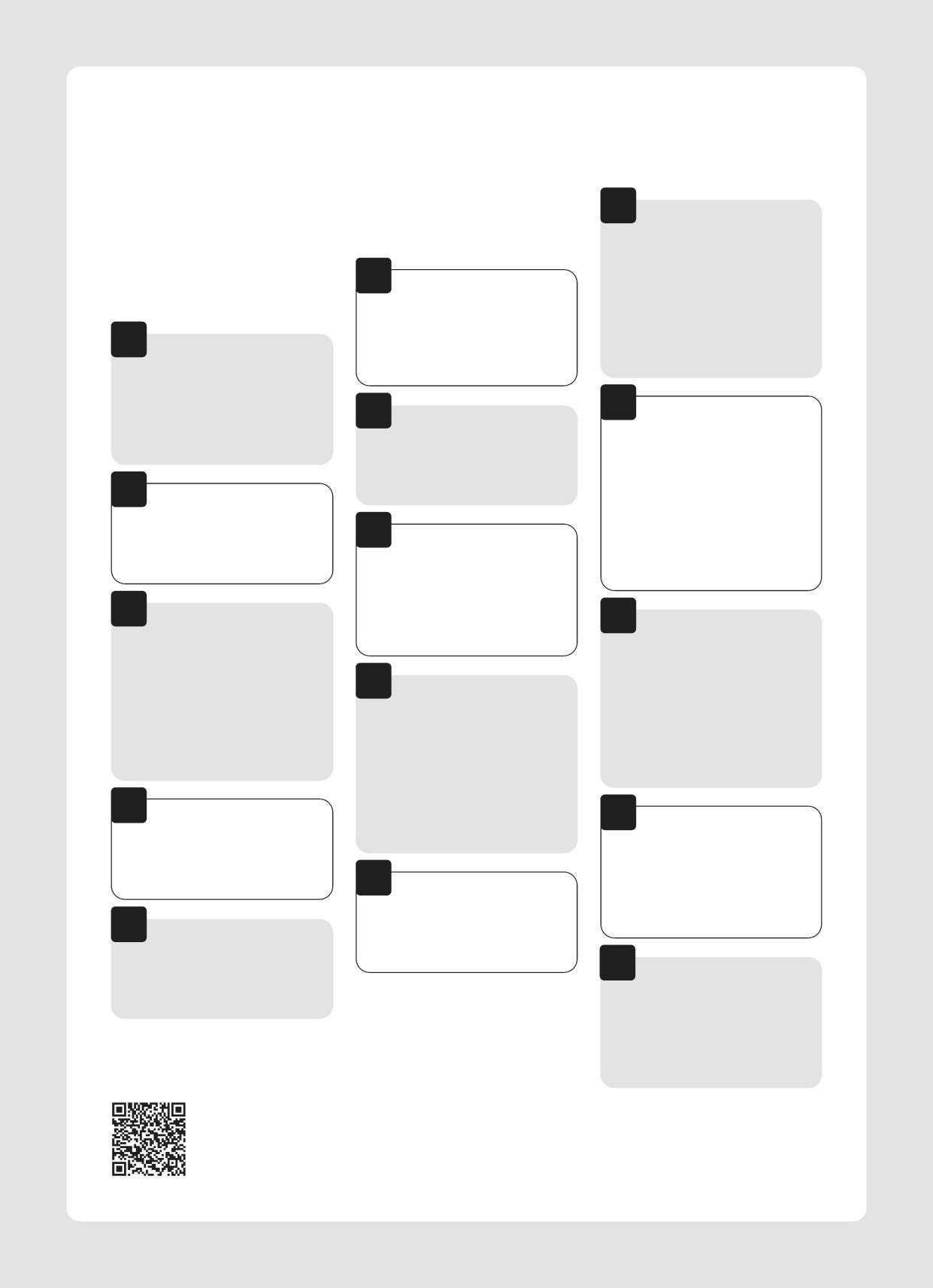
obiettivi
Prima di scrivere il prompt, è importante organizzare le idee e definire il tipo di risultato che vogliamo raggiungere. Per una richiesta sufficientemente completa, il prompt dovrà contenere almeno cinque parole.
02
11
stile
Se desideri una risposta formale, usa un linguaggio formale nel prompt; se preferisci uno stile informale o creativo, adattalo di conseguenza.
Se stai cercando una risposta basata su dati o informazioni specifiche, fornisci dettagli rilevanti come date, luoghi, nomi o simili. 07
dettagli
target
Il prompt deve comunicare chiaramente ciò che si desidera ottenere: evita i convenevoli e le domande vaghe o ambigue.
03
istruzioni
È opportuno iniziare la richiesta utilizzando comandi diretti come “Spiega”,“Descrivi”, “Elabora”, “Indica” ecc.: questo aiuterà il modello a capire l’azione richiesta. Per ricevere risposte più elaborate, utilizza domande aperte invece di domande chiuse e inserisci istruzioni più lunghe e più complesse.
Fornisci dettagli o limitazioni per definire il contesto. Per esempio specifica l’età dei destinatari e il tipo di scuola che frequentano. 04
contesto
formato
Se hai un formato particolare in mente per la risposta, come un elenco puntato, un paragrafo conciso o una spiegazione dettagliata, devi specificarlo nel prompt: “Elenca in formato elenco puntato…”. 08
09
esempi
Fornisci esempi di testo che rispondano alla richiesta specifica. Per esempio, se vuoi generare un testo che descriva un prodotto, è utile fornirgli esempi di descrizioni di prodotti già esistenti. In questo modo, il bot capisce meglio cosa vuoi ottenere e genera un testo più preciso e pertinente.
10
ruolo
Indica il ruolo che il bot dovrà assumere nella conversazione, per esempio un insegnante, un esperto in un argomento, un poeta.
Tratti da: “Costruire il futuro. Linee guida sull’utilizzo dell’AI in ambito scolastico” - Rete di scuole FVG.
sentiment
Quando è necessario, definisci i “sentiment” (cioè le emozioni, gli stati d’animo) per adattare la risposta alle emozioni richieste.
lunghezza
Limita le risposte del bot a un certo numero di parole o di paragrafi. Potrebbe trattarsi di qualsiasi cosa, dal condensare le informazioni di quattro paragrafi in uno, o chiedere risposte con parole di otto caratteri o meno. Questo offre all’AI la flessibilità necessaria per generare una risposta che rientri nell’intervallo specificato.
12
limiti
Dato che esistono dei limiti precisi di input di token, quando la richiesta è particolarmente complessa, suddividila in passaggi più piccoli; per esempio, anziché chiedere “Parlami della rivoluzione industriale”, circoscrivi la richiesta in questo modo: “Spiega le cause e gli effetti della Rivoluzione industriale in Italia nel XIX secolo”.
13
remix
Puoi creare un prompt efficace anche ricorrendo al “copia e incolla”. Puoi chiedere al chatbot di semplificare un testo difficile, come la spiegazione di un concetto scientifico, oppure fargli tradurre un contenuto in diverse lingue, o ancora riscrivere un articolo con uno stile più accattivante.
14
coerenza
Ogni tanto l’AI perde il filo del discorso e se ricominci da zero (quindi se clicchi su new chat) tutto sarà dimenticato. Se invece resti nella stessa discussione puoi mantenere memoria di quanto è stato scritto.
15
allenamento
Un prompt efficace può richiedere pratica e adattamento per ottenere i risultati desiderati. Sperimenta e perfeziona le tue tecniche man mano che acquisisci familiarità con il modello.
AI PER LE DISCIPLINE
SCIENTIFICHE

L›integrazione della scienza dei dati e di chatbot di intelligenza artificiale generativa (AI) nei curricula scolastici non solo migliora le competenze tecniche, ma stimola anche il pensiero critico e la creatività, elementi essenziali nelle discipline scientifiche. L›AI può contribuire a creare ambienti di apprendimento che promuovono la curiosità e la riflessione, elementi chiave per un›efficace educazione scientifica.
Tra le numerose attività possibili che possono essere attuate avvalendosi dell’AI, ne proponiamo quattro che sono applicabili a tutte le discipline scientifiche:
1. Realizzazione di una presentazione
2. Analisi dello svolgimento di un problema o di un esercizio
3. Redazione di un articolo scientifico
4. Creazione di un programma o di una pagina web
Sono idealmente ordinate dalla più semplice alla più complessa, ma questa classificazione può variare in base al contesto classe e al modus operandi del docente. Per esempio, un insegnante che privilegia lo svolgimento degli esercizi e ha studenti più forti in tal senso, troverà più congeniale la seconda attività. In ogni caso, nulla toglie che possa avvalersi delle altre due per completare il processo di apprendimento. Ogni attività poggia sullo sviluppo del pensiero critico in relazione a conoscenze e competenze acquisite o in via di acquisizione della disciplina, tuttavia ognuna di esse ha obiettivi peculiari che richiedono differenti approcci didattici.
1. Realizzazione di una presentazione
Questa attività rappresenta un’evoluzione di una già consolidata metodologia didattica, l’assegnazione di una ricerca, che negli anni ha visto la transizione dalla modalità con macchina per scrivere e cartelloni a slide multimediali con effetti di transizione, videoclip e animazioni psichedeliche. L’AI fornisce a questa modalità almeno tre tipi di aiuto:
a. agevola la sistemazione dei contenuti in modo più logico e attento: gli studenti faticano moltissimo a mettere ordine in ciò che vogliono esporre, ma possono chiedere all’AI di scrivere svariate scalette della presentazione;
b. migliora l’efficienza della ricerca delle fonti: invece che naufragare nella rete limitandosi a cercare su un motore di ricerca, gli studenti possono farsi accompagnare dall’AI e approfondire autonomamente sui link e sui testi suggeriti;
c. rafforza le capacità discorsive nell’esposizione orale: gli studenti faticano ad argomentare in modo chiaro e sintetico temi scientifici, ma possono chiedere all’AI infiniti esempi di discorso e migliorare le proprie abilità per confronto.
A una prima lettura può sembrare che l’AI svolga i compiti al posto dello studente, ma è a questo punto che si attua il processo didattico-educativo. Il risultato dell’AI probabilmente non sarà il migliore e al contempo non il più adeguato per i temi studiati in classe o per come narrarli ai compagni. Il lavoro degli studenti, possibilmente divisi in gruppi, sarà pertanto quello di usare l’AI come punto di partenza, di confrontare i risultati da essa forniti e poi di mettere in campo le proprie conoscenze, abilità e competenze per fare proprio il prodotto.
Si noti quindi che l’affiancamento dell’AI non semplifica o banalizza il lavoro della “ricerca”, ma aggiunge alle consuete necessità didattiche, lo sviluppo di competenze legate alla valutazione delle fonti, del confronto tra differenti proposte, la capacità di lavorare in gruppo e cooperare insieme per, in un certo senso, fare meglio dell’AI.
Nelle successive attività 1a e 1b si propongono due esempi di questa attività declinata per le discipline scienze della Terra e biologia.

2. Analisi dello svolgimento di un problema o di un esercizio
Questo tipo di attività si applica bene ai contesti che richiedono lo svolgimento di esercizi o la risoluzione di problemi, come fisica o chimica. L’AI è in grado di lavorare su più livelli: inventare esercizi/problemi, risolverli, mostrare lo svolgimento passo passo e aggiungervi degli errori. L›attività proposta prevede di usarli tutti, contestualmente tanto al livello della classe, quanto alle capacità del singolo. Si apre così la strada alla didattica personalizzata: per gli studenti in difficoltà, sarà utile controllare lo svolgimento dell’esercizio, per le eccellenze invece si potrà far lavorare sugli errori commessi dall’AI o su come migliorare gli approcci risolutivi. Il primo livello citato, inoltre, rende possibile che ogni studente abbia un suo esercizio, riducendo così la copiatura e spronando al confronto. Ad esempio: “Io ho questo problema e l’ho risolto così. Tu cosa hai? Ah, la soluzione è diversa, ma funziona, non ci avevo pensato” è una delle frasi che stimola il pensiero creativo e che difficilmente viene messa in luce se tutti gli studenti hanno i medesimi esercizi, perché si adatteranno alla soluzione più semplice.
Anche in questo caso, è facile trarre la conclusione che è l’AI a svolgere i compiti dei ragazzi, ma nuovamente bisogna spostare il processo educativo. Non si vuole rafforzare (e conseguentemente valutare) le abilità risolutive, ma si vuole sottolineare i diversi approcci al problema o all’esercizio, per non limitarsi all’apprendimento di un solo procedimento meccanico, ma per rendere la conoscenza più approfondita e sviluppare così competenze di più alto livello.
Nelle attività 2a e 2b compaiono due esempi di questo approccio legati alla fisica e alla chimica.
3. Redazione di un articolo scientifico
Questa tipologia può essere considerata come di livello più alto e potrebbe richiedere anche più tempo per lo svolgimento, come qualche settimana o un intero periodo didattico, alternando parti in classe e lavoro autonomo a casa. Nella redazione di un articolo scientifico, lo studente della scuola secondaria di secondo grado si avvicina al futuro fuori dall’istituzione scolastica, perché si cimenta con un lavoro “da grandi”, pur non avendo ancora tutti gli strumenti necessari. Tali strumenti sono forniti dall’AI che può aiutare su più fronti: sul reperimento delle fonti, sull’uso di un linguaggio scientificamente corretto, eventualmente anche in lingua inglese, sulla creazione di immagini e sulla stesura della bibliografia.
La differenza tra questa attività e la prima, la preparazione di una presentazione, sta nel taglio che viene dato al lavoro (deve rivolgersi ad addetti ai lavori) e nella esaustività (deve comprendere ogni aspetto utile alla tesi finale). Lavori di questa portata non possono essere generati in toto dall’AI, ma questa può svolgerne alcune parti (creare la scaletta, creare i grafici, redigere il testo, confutare le teorie, etc.) e sarà ruolo dello studente metterle insieme per la stesura di un elaborato finale. Sarà poi questo prodotto a essere valutato dal docente, previa esposizione orale o scritta e sarà possibile scorgere in esso tanto le competenze inerenti l’argomento quanto quelle trasversali relative alla stesura di un testo e alla commistione di elementi differenti.
Nelle attività 3a e 3b proponiamo due esempi relativi ad argomenti di fisica e di biologia, sebbene la modalità sia tanto aperta all’interdisciplinarietà, da essere fortemente consigliata in una collaborazione con i docenti di italiano, di lingua straniera e nell’ottica dell’educazione civica.
4. Creazione di un programma o di una pagina web
Esiste un ambito in cui l’AI non commette errori e spesso supera le capacità umane: la programmazione. È sempre più diffuso, anche nel mondo del lavoro e della ricerca, avvalersi dell’AI per scrivere linee di codice e creare contenuti multimediali, tanto che nei più moderni software dedicati a questi compiti sono già presenti suggerimenti dell’intelligenza artificiale.
Un docente può far lavorare i propri studenti alla scrittura di codice o alla realizzazione di contenuti web, anche se il percorso di studi non prevede l’insegnamento dell’informatica. Si ha pertanto l’occasione di introdurre applicazioni digitali, sempre più richieste dalle linee guida nazionali ed europee, in modo trasversale nell’insegnamento di altre discipline STEM quali fisica, biologia, chimica o scienze della Terra.
Uno degli aspetti interessanti è l’approccio che potremmo chiamare “meta-informatico”, perché per la prima volta (forse) gli studenti sono spinti a usare programmi per generare nuovi programmi, possono così rendersi conto dell’utilità di un software creato da loro stessi, capirne limiti e punti di forza.
Nella tabella 4a proponiamo un esempio di questa attività per l’insegnamento di chimica, ma la cui struttura è facilmente adattabile a qualsiasi disciplina.
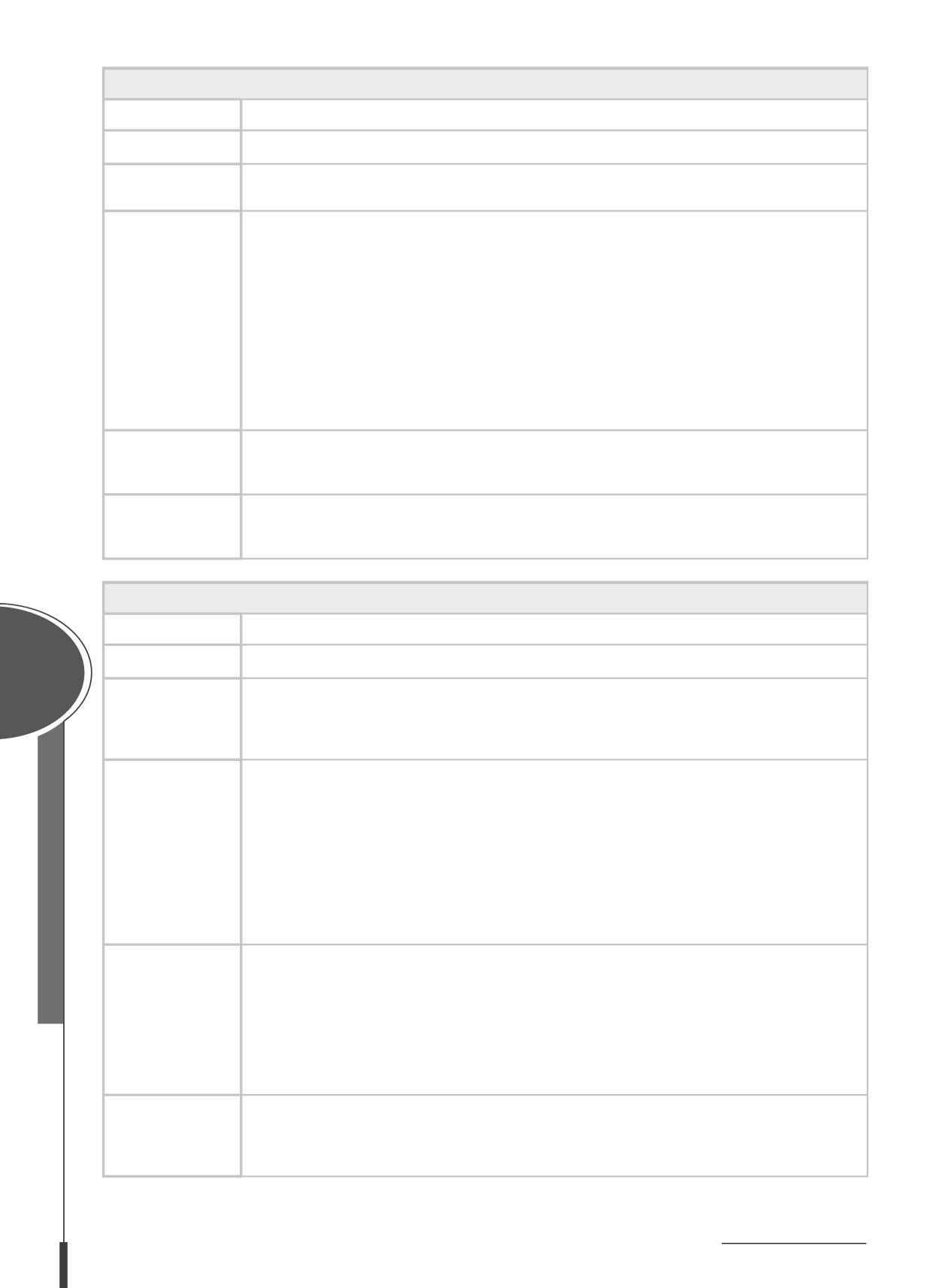
1a: Realizzazione di una presentazione di biologia
Titolo Esplorando la cellula
Contesto Primo biennio licei e tecnici
Obiettivi - Essere in grado di descrivere e identificare le strutture fondamentali della cellula. - Saper utilizzare il linguaggio specifico delle scienze naturali.
Attività Si divide la classe in gruppi e si assegna a ognuno un organulo della cellula. Ogni gruppo deve preparare una presentazione di non più di 4 slide sull’organulo assegnato, rispettando i seguenti punti fondamentali: a) descrizione b) storia della scoperta c) funzione d) patologie ad esso collegato Si dedicano da 1 a 2 ore di lavoro che può essere svolto in classe usando dispositivi elettronici (tablet, smartphone, etc.) oppure in aula informatica; si lascia una settimana di tempo per sistemare la presentazione a casa e poi si dedica un’altra ora alla restituzione di ogni gruppo di fronte alla classe che dovrà avere dei tempi rigidi stabiliti (es. 5 minuti).
Ogni gruppo dovrà avvalersi dell’AI soprattutto per reperire informazioni (non presenti sul libro di testo) e per organizzare il discorso affinché sia esaustivo e rispetti i tempi previsti.
Valutazione Mediante griglia appositamente creata per le attività di gruppo, il docente considera il lavoro degli studenti durante il lavoro di “ricerca”, premiando soprattutto le competenze trasversali.
Esempio prompt “Quale patologia è legata ai ribosomi?”
“Come posso raccontare le funzioni dei mitocondri in 200 parole?”
“Quali sono gli aspetti più importanti da sapere riguardo all’apparato di Golgi?”
1b: Realizzazione di una presentazione di scienze della Terra
Titolo Terremoti tra fascino e spavento
Contesto Secondo biennio licei, primo biennio tecnici
Obiettivi - Saper inquadrare nel modello della teoria della tettonica delle placche la dinamica endogena della Terra.
- Saper interpretare le modificazioni ambientali di origine antropica e comprenderne le ricadute future.
Attività La prima fase prevede una ricerca partecipata in classe. Il docente, insieme agli studenti, chiede all’AI di elencare i nove (nel caso di una classe da 27 studenti) terremoti più famosi o più forti o più distruttivi della storia. Chiede poi di individuare nove caratteristiche di un terremoto qualsiasi.
La classe si divide in gruppi, a ciascuno è assegnato un terremoto accaduto e una caratteristica. Ogni gruppo dovrà preparare, aiutandosi con l’AI, una presentazione (da iniziare a scuola e concludere come compito a casa) di non più di 4 slide in cui approfondisce la caratteristica in relazione al terremoto.
Nell’ultima ora si ascoltano tutte le presentazioni in modo che la conoscenza si diffonda tra tutta la classe.
Valutazione Mediante griglia appositamente creata per le attività di gruppo, il docente considera il lavoro degli studenti durante il lavoro di “ricerca”, premiando soprattutto le competenze trasversali.
Durante la restituzione, valuta le conoscenze acquisite, il linguaggio usato, il rispetto delle consegne e la correttezza del prodotto.
Nella successiva verifica sommativa, scritta o orale, potrà porre a ogni studente domande su qualsiasi terremoto o caratteristica tra quelle studiate e apprese e durante la restituzione delle presentazioni.
Esempio prompt “Elenca i nove terremoti più devastanti avvenuti in Europa” “Elenca nove caratteristiche specifiche di un terremoto”
“Scrivi una traccia di presentazione per una serie di slide riferite alla propagazione di onde sismiche causate da un terremoto di magnitudo 9.1”
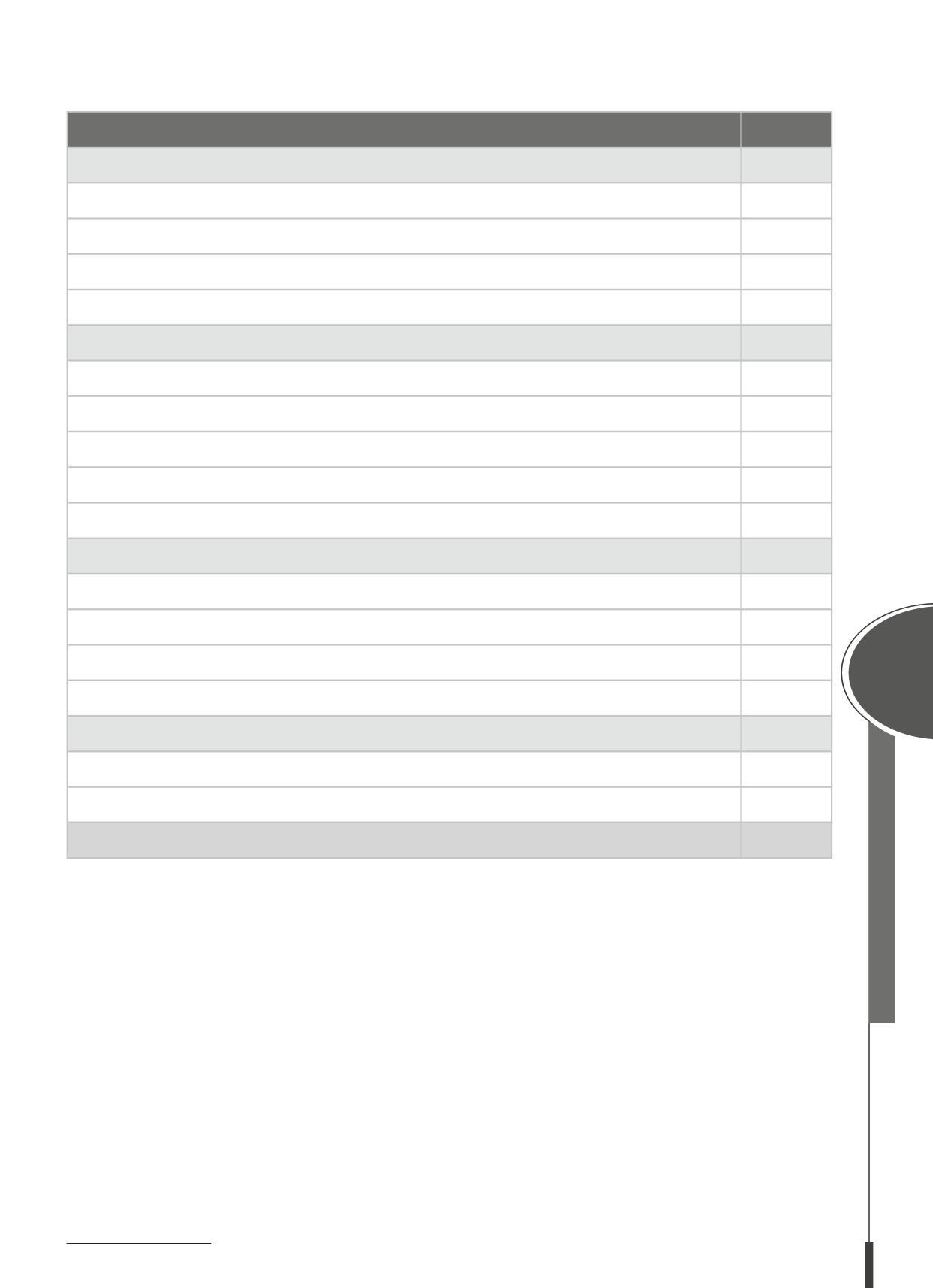
GRIGLIA DI VALUTAZIONE
Criteri
Contributo individuale (20 punti)
Partecipazione attiva alle discussioni e alle attività di grupppo
Condivisione di idee, informazioni e conoscenze
Assunzione di responsabilità e rispetto delle scadenze
Disponibilità ad aiutare e supportare i compagni
Qualità del lavoro di gruppo (30 punti)
Capacità di lavorare in modo collaborativo e costruttivo
Risoluzione efficace dei conflitti e delle differenze
Organizzazione e pianificazione del lavoro
Coesione e coordinamento del gruppo
Qualità del prodotto finale
Presentazione (20 punti)
Chiarezza e organizzazione della presentazione
Uso efficace di supporti visivi e multimediali
Capacità di rispondere alle domande e di coinvolgere l’audience
Professionalità e sicurezza nella presentazione
Riflessione e autovalutazione (10 punti)
Capacità di riflettere sul processo di apprendimento 0-5
Autovalutazione costruttiva del proprio contributo
2a: Analisi dello svolgimento di un problema di fisica
Titolo Forze o energia? Approcci alla meccanica
Contesto Secondo biennio licei
Obiettivi - Saper risolvere un problema di meccanica con più metodi a confronto.
- Sapere come e quando applicare le leggi di conservazione e/o la scomposizione vettoriale a problemi di meccanica.
Attività Si divide classe in coppie o piccoli gruppi. Si consegna loro una scheda (cartacea o digitale) che mostri le varie fasi dell’attività:
a. chiedere all’AI di inventare un problema di fisica, senza risolverlo, su un argomento affrontato a lezione (es. piano inclinato con attrito);
b. risolvere il problema scrivendo nei dettagli il procedimento usato;
c. chiedere all’AI di risolvere il problema e confrontare la soluzione e lo svolgimento con quanto fatto;
d. chiedere all’AI di risolvere il problema in modo alternativo (es. usando l’energia);
e. scrivere un commento sul confronto tra i metodi;
f. inventare un problema analogo e farlo risolvere all’AI;
g. commentare la soluzione ed evidenziare differenze rispetto a quanto ci si aspettava
Le schede saranno raccolte e corrette dal docente. Nella successiva lezione, saranno evidenziate eventuali strategie risolutive errate e/o non affrontate precedentemente durante la lezione.
Valutazione Il docente valuta la scheda sulla base della correttezza lessicale, della completezza dei commenti e dell’originalità dei problemi inventati. Nella successiva verifica sommativa, scritta o orale, sull’argomento, potrà eventualmente premiare l’uso di strategie risolutive emerse dall’attività con l’AI.
Esempio prompt “Inventa un problema di fisica sul piano inclinato adatto a studenti di liceo senza risolverlo”
“Risolvi il problema appena inventato usando forze e vettori”
“Risolvi lo stesso problema usando le leggi di conservazione dell’energia”
2b: Analisi dello svolgimento di un problema o di un esercizio
di chimica
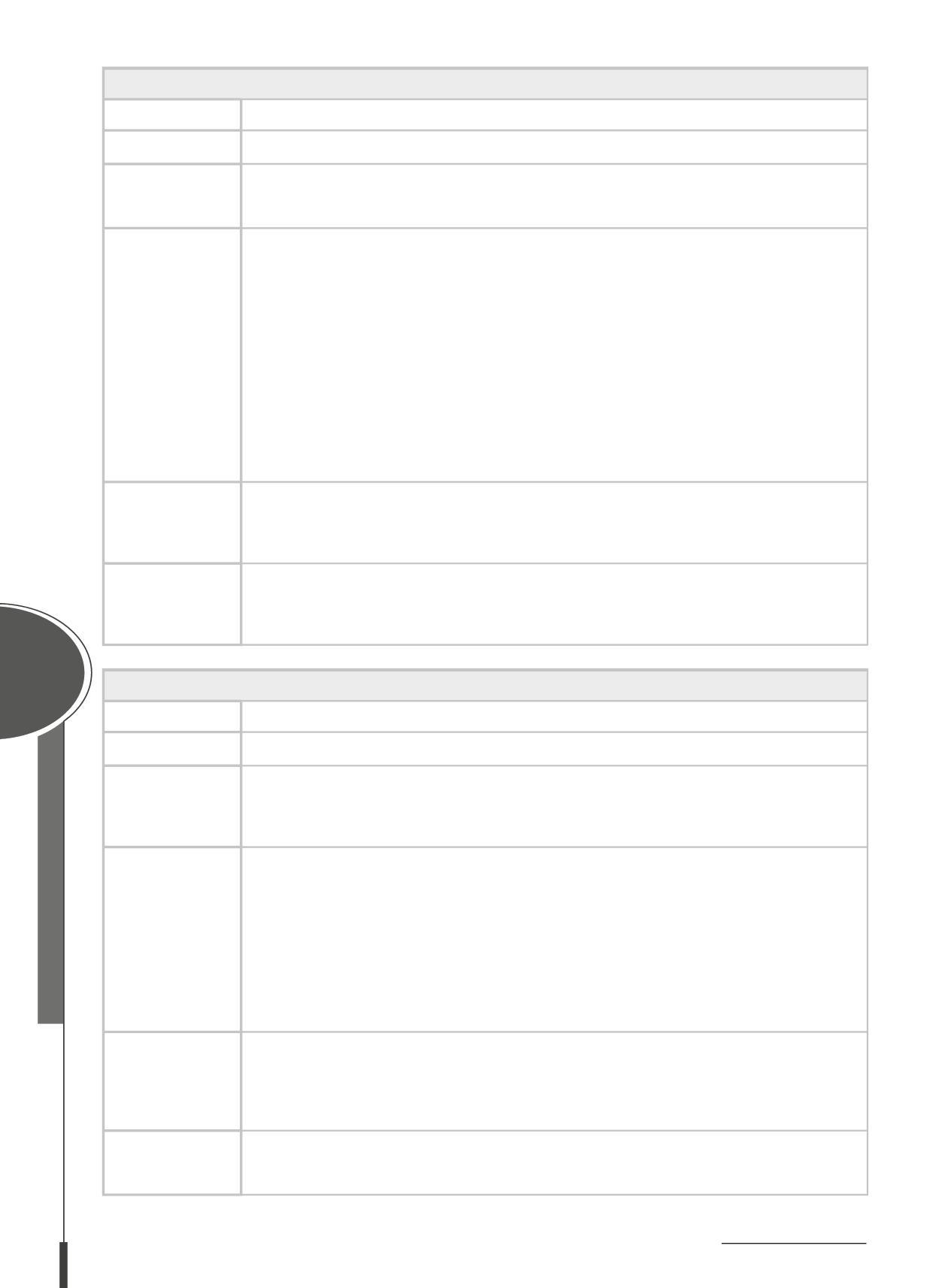
Titolo Bilanciare o sbilanciare reazioni
Contesto Secondo biennio licei, primo biennio tecnici
Obiettivi - Saper correlare il concetto il “bilanciamento” di una reazione chimica con le leggi ponderali.
- Saper determinare i coefficienti stechiometrici di una semireazione di ossidazione e di riduzione e saper bilanciare una reazione di ossido-riduzione.
Attività L’attività si suddivide in due fasi.: nella prima si testa l’AI, nella seconda la si usa per testare i compagni.
Nella prima fase, gli studenti divisi a coppie o piccoli gruppi chiedono all’AI di inventare un esercizio di ossido-riduzione e di risolverlo. Quindi controllano la soluzione ed evidenziano eventuali errori o omissioni.
Nella seconda fase, ogni gruppo chiede all’AI di inventare un esercizio di ossidoriduzione svolto, inserendo qualche errore. Quindi si propone l’esercizio a un altro gruppo che dovrà individuare gli errori, correggerli e risolvere l’esercizio.
Tutto il materiale prodotto sarà consegnato al docente in formato cartaceo o digitale, ma non valutato, altrimenti ogni studente si limiterebbe a copiare dall’AI.
Valutazione In una verifica dedicata o in una parte di una curricolare, il docente chiederà agli studenti di commentare l’attività con l’AI mettendo in luce punti di forza e di debolezza, errori o omissioni del software, aspetti inattesi. Lo studente, nel prepararsi a questa verifica, dovrà necessariamente comprendere a fondo i meccanismi di risoluzione degli esercizi, i possibili errori e le correzioni.
Esempio prompt “Inventa un esercizio di ossido-riduzione adatto a studenti del liceo e risolvilo” “Inventa un nuovo esercizio di ossido-riduzione adatto a studenti del liceo e risolvilo inserendo 3 errori nello svolgimento”
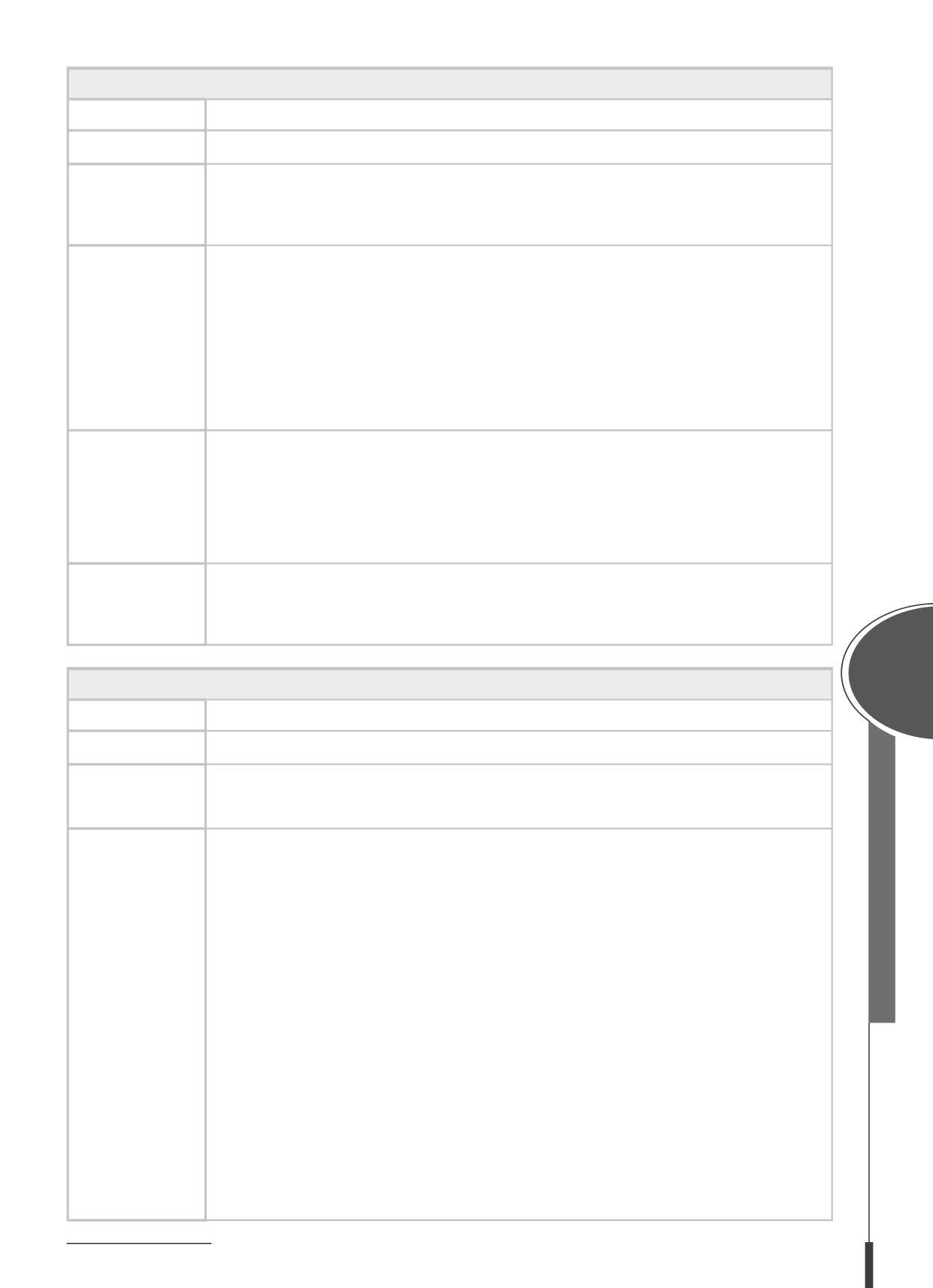
Realizzazione
Titolo Fumare fa bene? Demoliamo le fake news
Contesto Secondo biennio licei
Obiettivi - Comprendere che l›essere umano è un sistema complesso che necessita di adeguati comportamenti per mantenersi in stato di salute.
- Saper applicare le conoscenze acquisite in relazione a fisiologia e anatomia umane a situazioni della vita reale.
Attività Nella prima fase, il docente, insieme agli studenti, chiede all’AI di inventare quattro ragioni per cui fumare faccia bene alla salute. Poi, divide la classe in otto gruppi: quattro di questi saranno i sostenitori delle ragioni false, una ciascuno; gli altri quattro saranno gli oppositori.
Ogni gruppo dovrà scrivere, facendosi aiutare dall’AI, un articolo scientifico che provi la propria teoria. Dovrà inventare false statistiche o falsi benefici, usare vere stime e autentiche prove scientifiche a sostegno della propria tesi. I lavori saranno svolti in parte in classe, soprattutto nelle prime fasi, e in buona parte a casa, anche sul lungo periodo. Al termine, tutti gli articoli dovranno essere inviati al docente che, previa correzione e commento, li condividerà poi con tutto il resto della classe.
Valutazione Il docente valuterà il lavoro di gruppo svolto in classe, verificando conoscenze e competenze degli studenti sugli argomenti di biologia trattati. Successivamente, valuterà gli articoli verificando correttezza morfosintattica esaustività, linguaggio scientifico e originalità. Dopo la condivisione, potrà inserire nella verifica sommativa eventuali domande su argomenti approfonditi per l’occasione degli articoli (es. patologie non trattate sul libro di testo, effetti di test statistici, etc.)
Esempio prompt “Inventa quattro motivi per cui fumare faccia bene alla salute” “Elenca tutte le patologie che interessano i polmoni legate al tabagismo”
“Inventa i dati di uno screening su pazienti fumatori e non fumatori in relazione allo sviluppo del cancro ai polmoni”
3b: Redazione di un articolo scientifico di fisica
Titolo Induzione elettromagnetica tra ospedali e concerti
Contesto Licei, ultimo anno
Obiettivi - Saper individuare gli effetti delle scoperte scientifiche sulla società.
- Saper interpretare il funzionamento di strumenti dell’uso quotidiano sulla base delle conoscenze di fisica e matematica.
Attività Il docente divide la classe in due gruppi, il primo si occuperà degli ospedali e il secondo dei concerti.
In ognuno dei gruppi, avverrà una ulteriore suddivisione relativa alla stesura di differenti parti dell’articolo scientifico:
a. abstract e bibliografia
b. introduzione
c. aspetti matematici
d. dati sperimentali
e. conclusioni e continuazioni
L’obiettivo sarà scrivere due articoli scientifici che mettano in luce l’utilità della legge di Faraday-Neumann-Lenz nell’ambito sanitario e in relazione agli strumenti musicali e amplificazioni usati nei concerti.
Gli argomenti sono ampi e difficili, per questo gli studenti dovranno ricorrere all’AI (in parte in classe e poi anche a casa) ma il lavoro di scelta, di unione, di sintesi e di stesura è interamente affidato a loro e farà leva sulle loro conoscenze e competenze di matematica e fisica.
Gli articoli, una volta conclusi, saranno poi scambiati tra i due gruppi che faranno un’operazione di peer review evidenziando errori, incongruenze, lacune e punti di forza. Articoli e commenti saranno inviati al docente. Si noti che i gruppi non omogenei consentono una didattica personalizzata: il docente assegnerà i ruoli sugli aspetti matematici agli studenti più abili in questo campo, i ruoli riferiti ad aspetti più discorsivi agli studenti di estrazione più umanistica, etc.
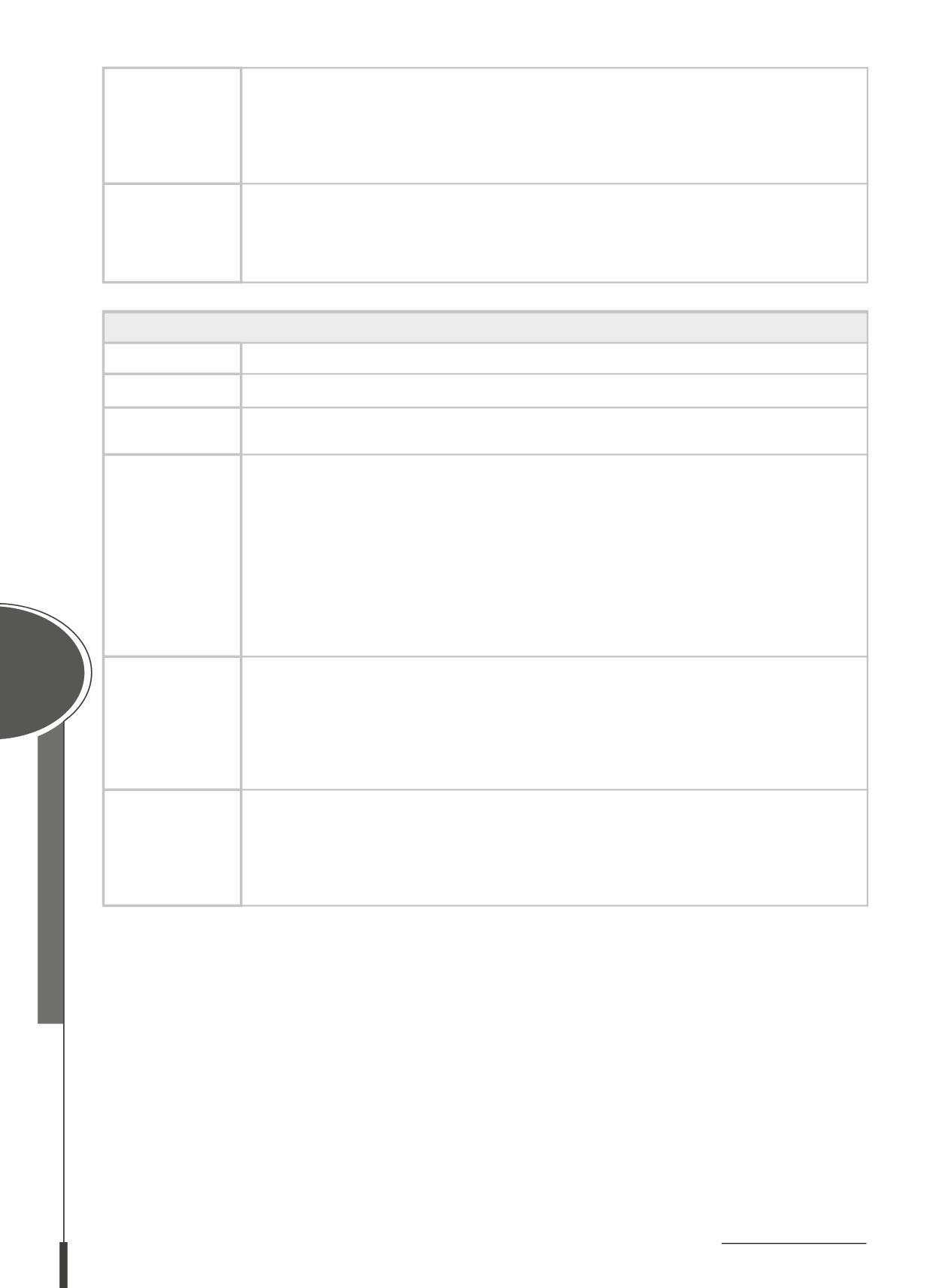
Valutazione Il docente valuterà il lavoro di gruppo svolto in classe e correggerà gli articoli. Essendo un lavoro di gruppo, tuttavia, sarà necessaria una valutazione individuale, mediante verifica sommativa, che includerà domande specifiche su argomenti, dati, teoria affrontati negli articoli. Ogni studente dovrà studiare in modo approfondito non solo quanto fatto dal suo piccolo gruppo, ma anche dagli altri e rafforzare le conoscenze curricolari dell’argomento.
Esempio prompt “Indica quali strumenti sanitari si basano sull’induzione elettromagnetica”
“Inventa dei dati sperimentali che attestino come l’ECG abbia migliorato la medicina moderna”
“Inventa una possibile bibliografia relativa a un articolo scientifico sulla fisica dei pick-up delle chitarre elettriche”
4a: Creazione di un programma o di una pagina web di chimica
Titolo Scopri quanto sei acido
Contesto Secondo anno licei e tecnici
Obiettivi - Saper valutare acidità e basicità delle sostanze della vita quotidiana.
- Saper associare a sostanze acide e basiche applicazioni e utilizzi.
Attività Il docente divide la classe in cinque gruppi ai quali viene assegnato un preciso argomento:
a. differenti definizioni di acidi e basi
b. acidi forti e basi forti
c. acidi deboli e basi deboli
d. costante di equilibrio e soluzioni tampone
e. effetti degli acidi e delle basi sull’ambiente e sull’uomo
Ogni gruppo dovrà chiedere all’AI di scrivere il codice necessario per sviluppare una pagina web sull’argomento. I cinque codici saranno poi messi insieme dal docente in un unico sito di classe che sarà messo a disposizione di tutti. In questo modo gli studenti di altri gruppi andranno a scoprire gli approfondimenti di altri argomenti, eventualmente con un compito di realtà assegnato nella lezione successiva dal docente.
Valutazione Il docente valuterà il lavoro di gruppo svolto in classe e correggerà le pagine web. Essendo un lavoro di macrogruppo, tuttavia, sarà necessaria una valutazione individuale, mediante, verifica sommativa, che includerà domande specifiche su argomenti, dati e teoria affrontati nelle pagine web. Ogni studente dovrà studiare in modo approfondito non solo quanto fatto dal suo piccolo gruppo, ma anche dagli altri e rafforzare le conoscenze curricolari sull›argomento.
Esempio prompt “Scrivi il codice html per realizzare una pagina web che illustri le differenze tra le definizioni di acidi e basi in chimica” “Crea una pagina web dinamica in cui inserita una sostanza, il codice dica se si tratta di un acido o di una base e a cosa possa servire in natura” “Crea una pagina web con un quiz su quali sostanze acide siano dannose per l’uomo”
Test d’ingresso e prove di valutazione
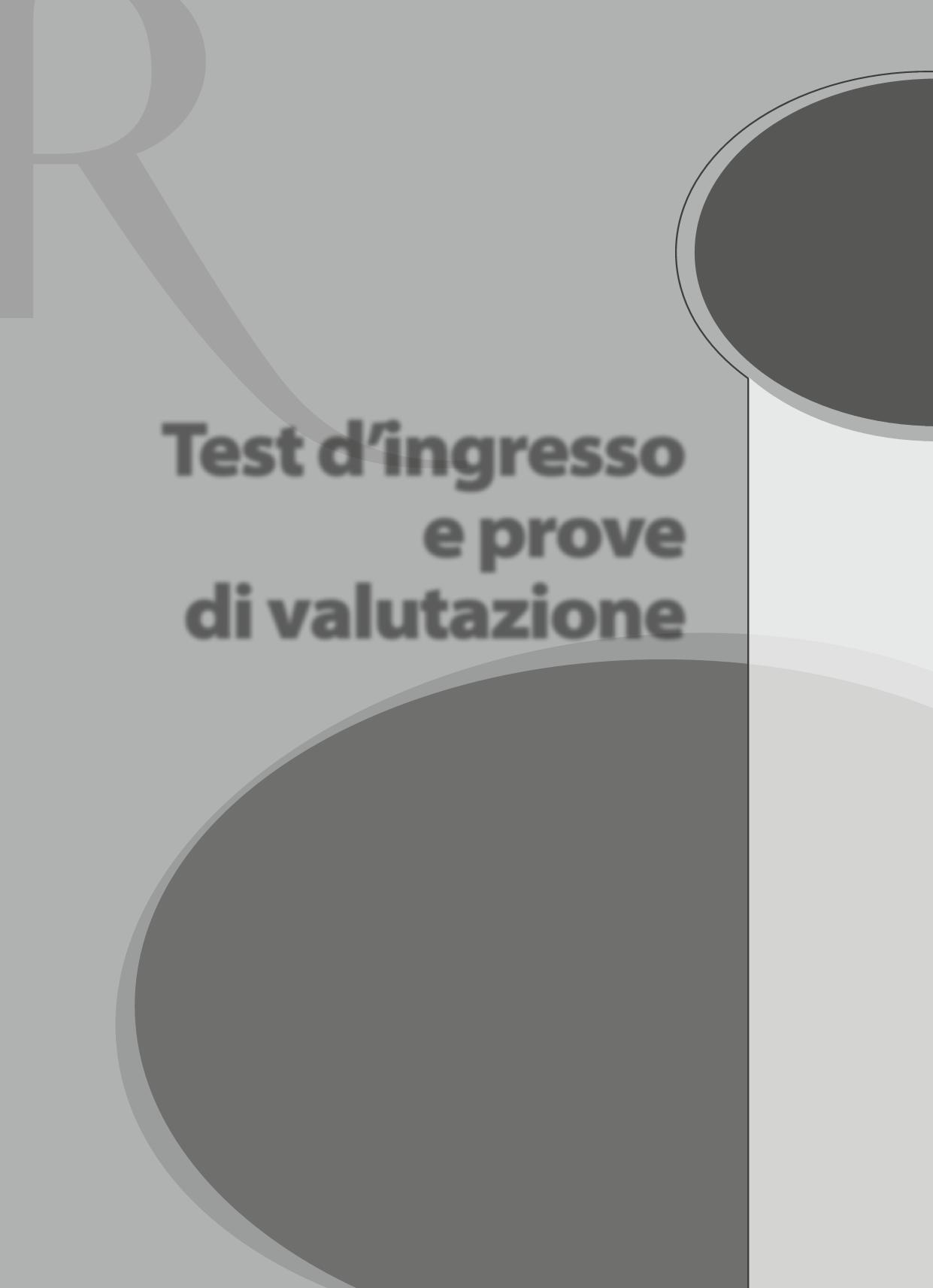
• Test d’ingresso
• Test d’ingresso semplificato
• Verifiche sommative di fine Unità
Fila A – Fila B
• Verifiche sommative di fine Unità semplificate
Test d’ingresso • Chimica e Biologia • Quinto anno
Nome e cognome
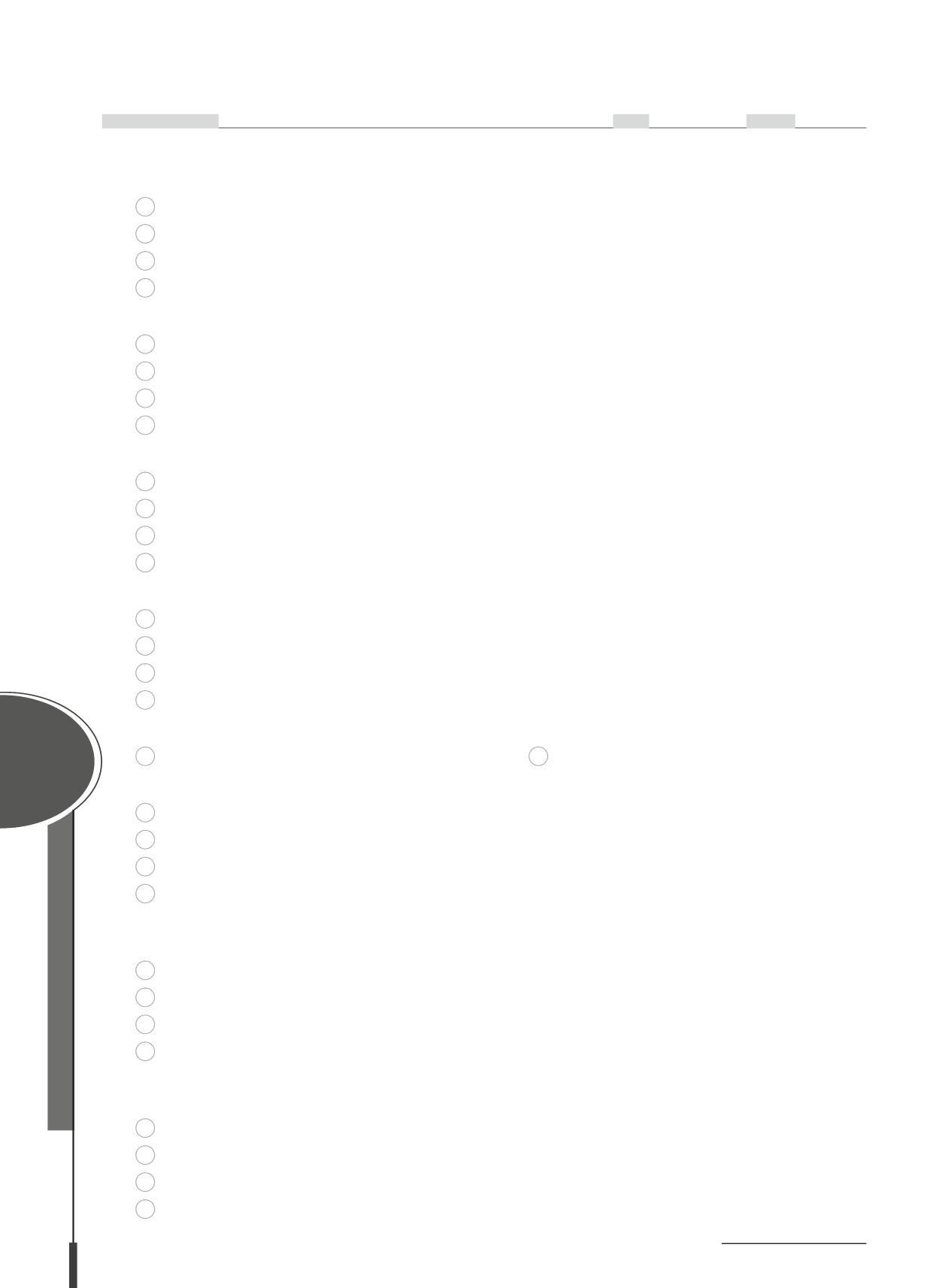
Data Classe
1. Gli oli:
a) sono miscele solide di trigliceridi
b) sono costituiti da trigliceridi con acidi grassi saturi ad alto peso molecolare
c) sono miscele liquide di trigliceridi
d) sono costituiti da trigliceridi con acidi grassi insaturi ad alto peso molecolare
2. La replicazione del DNA è definita semiconservativa perché:
a) gli enzimi che intervengono nel processo sono in parte cellulari e in parte extracellulari
b) solo parte del singolo filamento di DNA viene copiata
c) ogni nuova elica possiede un filamento parentale e uno sintetizzato ex novo
d) la copia del DNA non è identica all’originale a causa di diversi errori di copiatura
3. La struttura terziaria delle proteine è dovuta:
a) all’instaurarsi di legami idrogeno tra i vari residui amminoacidici
b) alla conformazione tridimensionale della catena polipeptidica
c) alla presenza di gruppi amminici nella catena polipeptidica
d) alla presenza di ponti dicloruro
4. Il saccarosio, il glicogeno e il lattosio:
a) sono tutte molecole che contengono fruttosio
b) sono tutti disaccaridi
c) sono prodotti mediante condensazione di monosaccaridi
d) il primo è un monosaccaride, gli altri sono polisaccaridi
5. I due filamenti che costituiscono la molecola di DNA sono legati attraverso legami covalenti.
a) Vero b) Falso
6. Quale di queste affermazioni relative al codice genetico non è vera?
a) Un codone corrisponde a un solo amminoacido
b) Un amminoacido corrisponde a un solo codone
c) Vi sono più codoni che amminoacidi
d) Vi sono codoni che non corrispondono a un amminoacido
7. Considerati gli equilibri gassosi: 1) H2(g) + Cl2(g) 2 HCl(g) 2) N2(g) + 3H2(g) 2 NH3(g) un aumento di pressione:
a) sposta il primo equilibrio a destra e il secondo a sinistra
b) sposta il primo equilibrio a sinistra e il secondo a destra
c) non sposta il primo equilibrio e sposta il secondo a destra
d) non sposta il primo equilibrio e sposta il secondo a sinistra
8. Le reazioni chimiche si verificano quando i reagenti si scontrano. Quale tra quelli elencati di seguito non è un fattore che permette a una collisione di essere efficace e determinare una reazione chimica?
a) L’angolo d’urto
b) L’energia con cui avvengono gli urti
c) L’orientamento delle molecole che si urtano
d) La massa delle molecole che si urtano
Test d’ingresso • Chimica e Biologia • Quinto anno
Nome e cognome
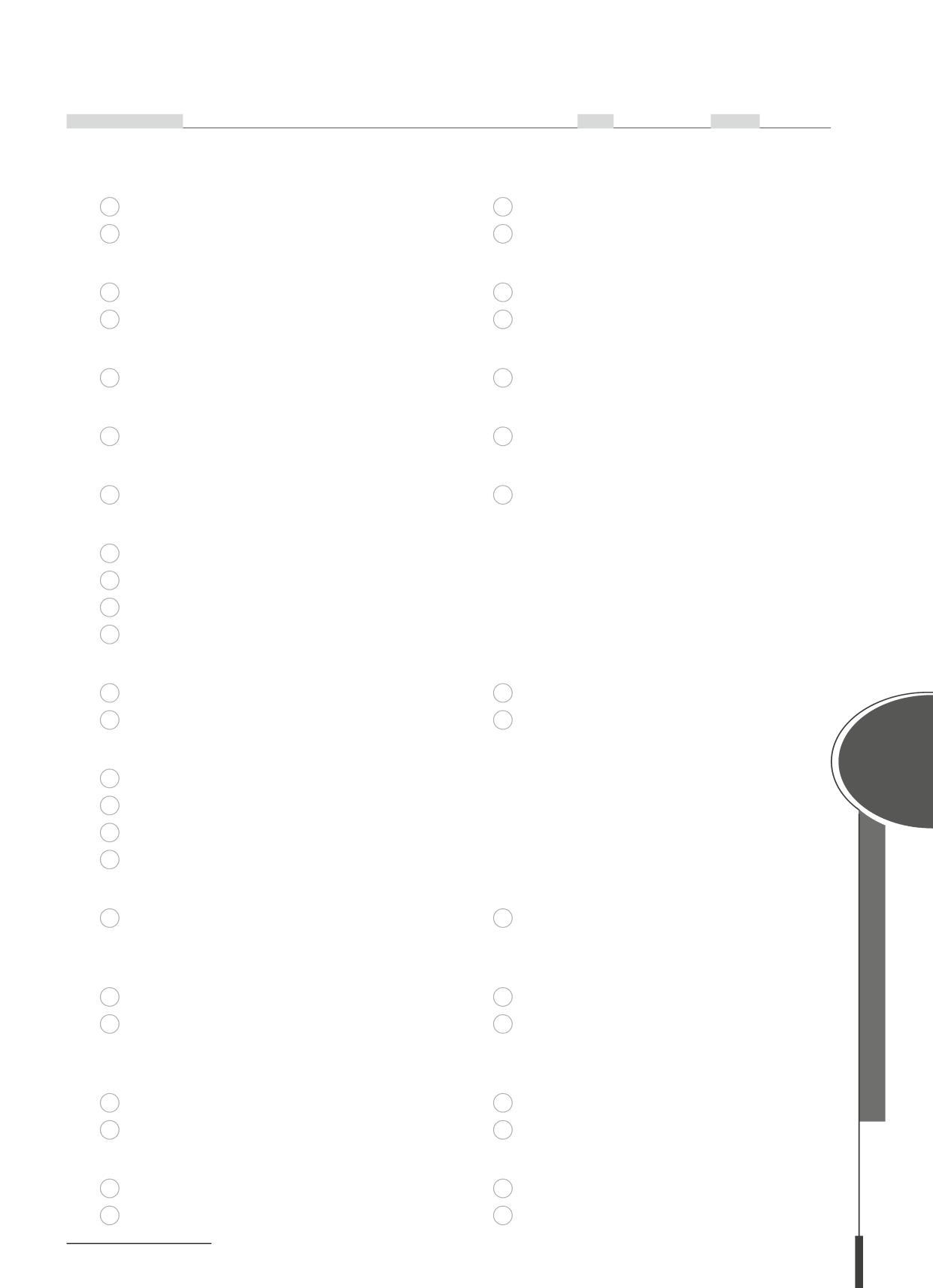
Data Classe
9. Quando si titola una soluzione di NaOH con HCl il punto equivalente si raggiunge quando il pH:
a) è maggiore di 7
b) è uguale a 0
10. Una reazione acido-base secondo Brønsted e Lowry è:
a) una dissociazione ionica
b) una ionizzazione
c) è minore di 7
d) è uguale a 7
c) un trasferimento di protoni
d) un trasferimento di elettroni
11. Durante la trascrizione è sintetizzato un filamento di tRNA.
a) Vero b) Falso
12. La DNA polimerasi sintetizza il filamento lento procedendo in direzione 3′ → 5′
a) Vero
b) Falso
13. Un catalizzatore non influenza la velocità di una reazione chimica, ma ne modifica soltanto il percorso.
a) Vero
14. Che differenza c’è tra un acido forte e un acido debole?
b) Falso
a) La concentrazione di un acido debole è minore di quella degli ioni H+
b) La concentrazione di un acido forte coincide con quella degli ioni H+
c) Un acido debole non è corrosivo
d) Un acido forte è più concentrato
15. Il pH di una soluzione di NaOH 10−5 M è:
a) 5
b) 7
16. Quale tra le seguenti affermazioni non è vera?
a) Riduzione è sinonimo di acquisto di elettroni
b) Un buon ossidante ha grande tendenza a ridursi
c) Ossidazione equivale a perdita di elettroni
c) 9
d) 14

d) La specie che si ossida diminuisce il suo numero di ossidazione
17. Una soluzione di NaCl e HCl in quantità equimolari è una soluzione tampone.
a) Vero
b) Falso
18. Nella reazione: Mg(s) + HCl(aq) → MgCl2(aq) + H2(g) con ΔH < 0 sono favorevoli alla spontaneità della reazione i fattori:
a) entropico
b) né entalpico, né entropico
c) entalpico
d) sia entalpico sia entropico
19. Data la reazione: 2NO(g) + O2(g) → 2NO2(g) e sapendo che: ΔfH°NO = 90,25 kJ/mol e ΔfH°NO2 = 33,18 kJ/
mol, quanto vale la variazione di entalpia di reazione?
a) –114,14kJ
b) +114,14kJ
20. All’anodo di una pila si realizza il processo di:
a) riduzione
b) ossido-riduzione
c) +123,43 kJ
d) –57,07 kJ
c) ossidazione
d) diluizione
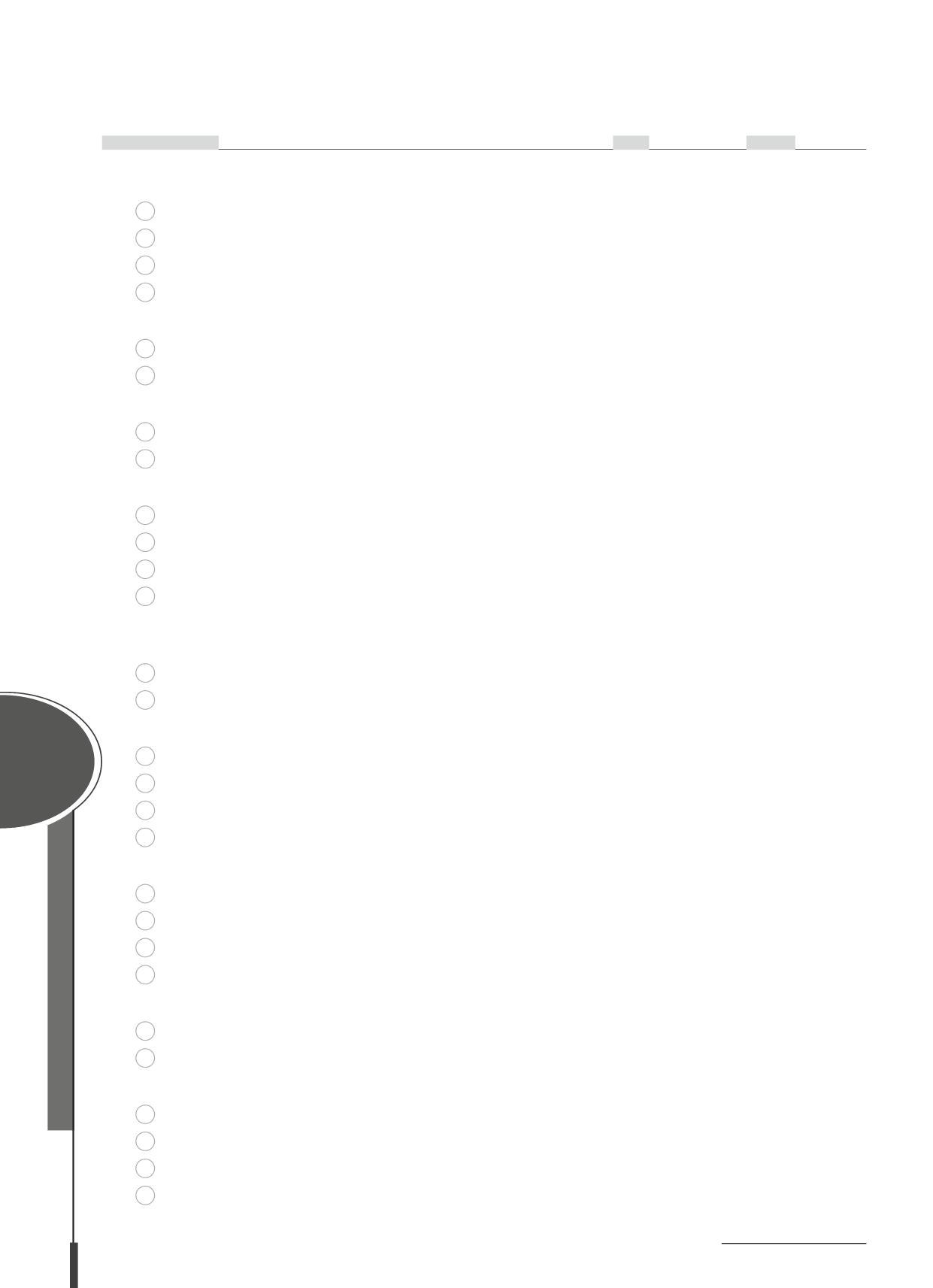
Test d’ingresso • Scienze della Terra • Quinto anno
Nome e cognome Data Classe
1. La roccia coerente derivante dalla cementazione delle ceneri grossolane è:
a) la cinerite
b) il tufo a lapilli
c) la breccia vulcanica
d) il tufo cineritico
2. I batoliti sono plutoni basici stratificati.
a) Vero
b) Falso
3. Il mantello è lo strato di maggiore spessore all’interno del pianeta Terra.
a) Vero
b) Falso
4. La zona in cui le onde sismiche hanno bassa velocità è denominata:
a) litosfera
b) mesosfera
c) nucleo
d) astenosfera
5. Secondo la teoria della tettonica a placche la litosfera è fratturata in placche che si muovono scontrandosi o allontanandosi l’una dall’altra.
a) Vero
b) Falso
6. Oceani e mari contengono insieme circa:
a) il 30% dell’acqua presente sulla Terra
b) il 71% dell’acqua presente sulla Terra
c) il 97% dell’acqua presente sulla Terra
d) la metà dell’acqua presente sulla Terra
7. Il sale più abbondante nelle acque marine è:
a) cloruro di magnesio
b) cloruro di sodio
c) carbonato di calcio
d) solfato di magnesio
8. Le correnti oceaniche sono generate dal vento o dalle differenze di densità delle acque.
a) Vero
b) Falso
9. Le dorsali oceaniche sono:
a) strette e lunghe depressioni che bordano alcuni margini continentali
b) lunghe catene montuose sottomarine
c) una porzione di fondale marino che circonda le terre emerse
d) edifici calcarei costituiti anche da alghe fotosintetiche
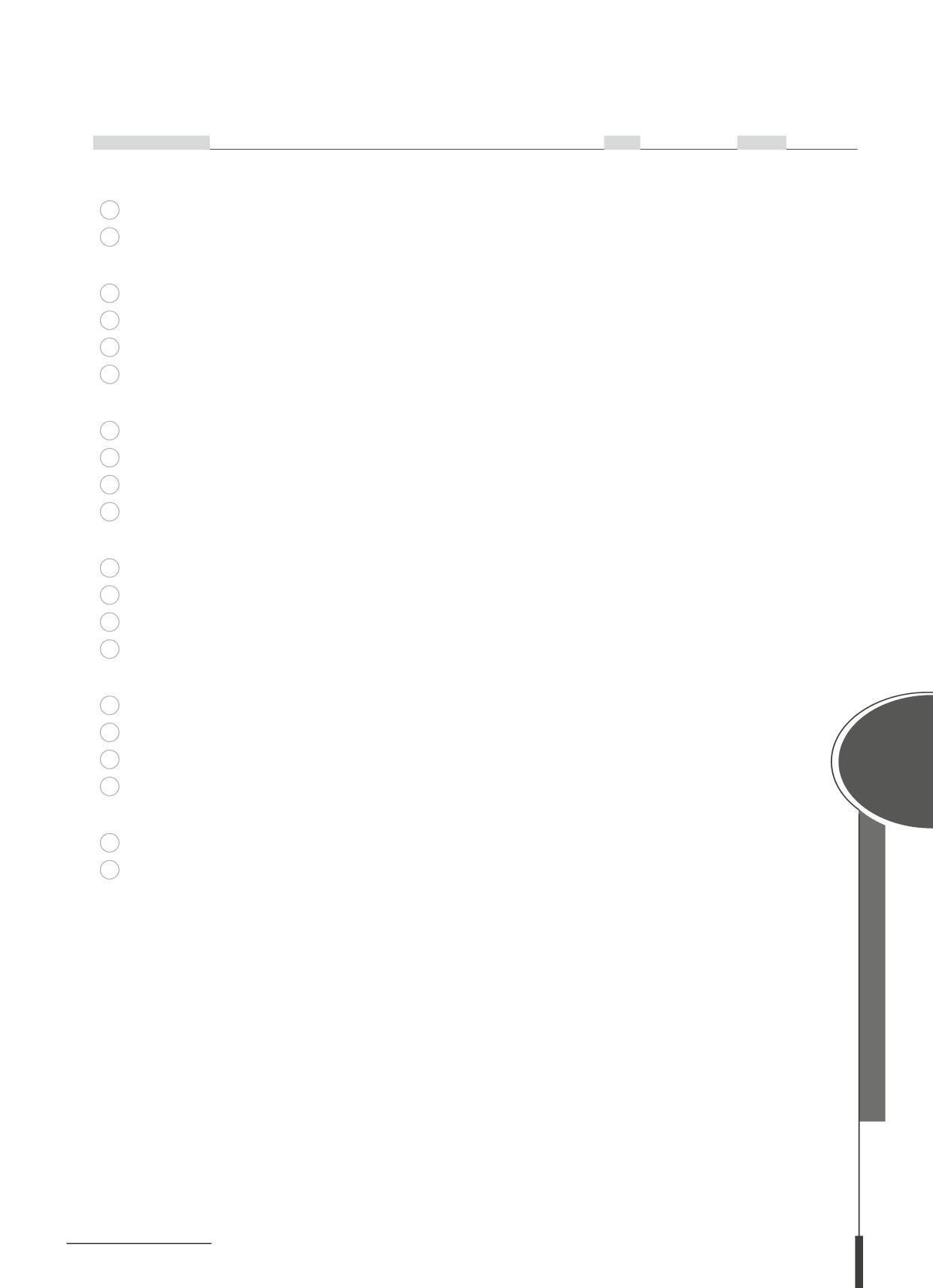
Test d’ingresso • Scienze della Terra • Quinto anno
Nome e cognome Data Classe
10. Il clima è rappresentato dalle condizioni meteorologiche momentanee.
a) Vero
b) Falso
11. La classificazione dei climi secondo Köppen:
a) suddivide i climi in umidi e aridi
b) suddivide i climi in 3 grandi gruppi climatici
c) utilizza come criterio guida l’analisi delle associazioni vegetali
d) utilizza come criterio guida la distanza dal mare
12. Partendo dal basso e proseguendo verso l’alto, gli strati di atmosfera che si incontrano sono:
a) esosfera, troposfera, stratosfera, mesosfera, termosfera
b) troposfera, stratosfera, termosfera, mesosfera, esosfera
c) troposfera, stratosfera, mesosfera, termosfera, esosfera
d) mesosfera, termosfera, troposfera, stratosfera, esosfera
13. La foresta di conifere è il bioma tipico del clima:
a) monsonico
b) desertico
c) temperato freddo-secco
d) polare
14. L’ozonosfera si trova, a partire dalla crosta terrestre:
a) tra i 300 e i 600 km di altitudine
b) tra i 10 e i 20 km di altitudine
c) tra i 30 e i 60 km di altitudine
d) oltre i 100 km di altitudine
15. Il bilancio termico della Terra è variabile.
a) Vero
b) Falso
16. Indica quali sono le principali discontinuità sismiche.
17. Qual è il tipo climatico di una zona in cui le escursioni termiche sono elevate e le precipitazioni sono inferiori a 250 mm di pioggia?
18. Che cosa è il termoclino?
19. Riporta come varia la temperatura all’interno dei vari strati dell’atmosfera.
20. Quali sono i fattori che causano la variazione della pressione atmosferica?
Nome e cognome Data Classe
1. Gli oli sono:
a) miscele solide di trigliceridi
b) costituiti da trigliceridi con acidi grassi saturi ad alto peso molecolare
c) costituiti da trigliceridi con acidi grassi insaturi ad alto peso molecolare
d) miscele liquide di trigliceridi
2. La replicazione del DNA è definita semiconservativa perché:
a) ogni nuova elica possiede un filamento parentale e uno sintetizzato ex novo
a) gli enzimi che intervengono nel processo sono in parte cellulari e in parte extracellulari
c) solo parte del singolo filamento di DNA viene copiata
d) la copia del DNA non è identica all’originale a causa di diversi errori di copiatura
3. La struttura terziaria delle proteine è dovuta alla presenza di gruppi amminici nella catena polipeptidica.
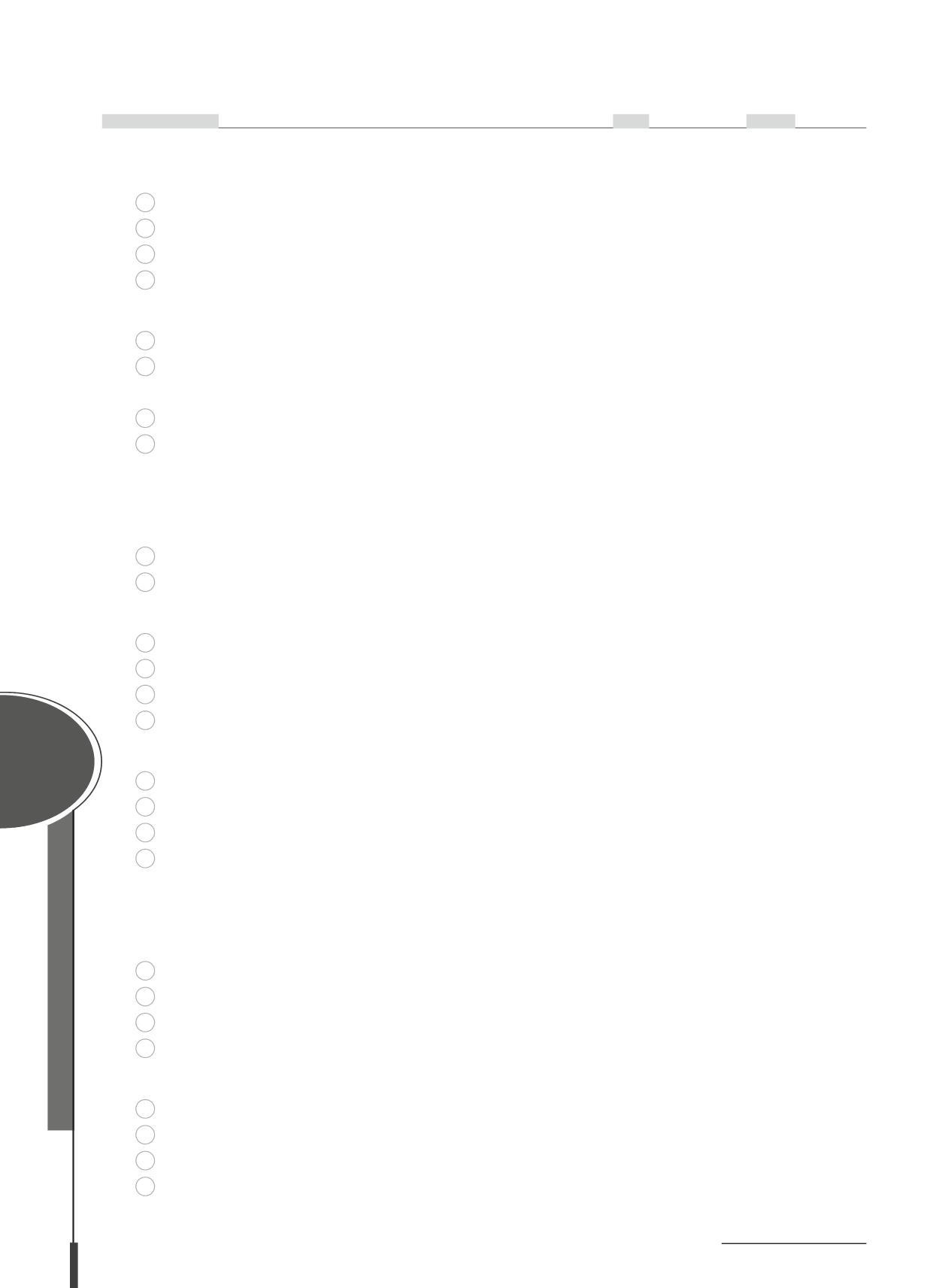
4. Il saccarosio, il glicogeno e il lattosio:
a) sono tutte molecole che contengono fruttosio
b) sono tutti disaccaridi
c) sono prodotti mediante condensazione di monosaccaridi
d) Il primo è un monosaccaride, gli altri sono polisaccaridi
5. Quale di queste affermazioni relative al codice genetico NON è vera?
a) Un codone corrisponde a un solo amminoacido.
b) Un amminoacido corrisponde a un solo codone.
c) Vi sono più codoni che amminoacidi.
d) Vi sono codoni che non corrispondono a un amminoacido.
6. Considerati gli equilibri gassosi
1) H2(g) + Cl2(g) 2 Hcl(g) e 2) N2(g) + 3H2(g) 2 NH3(g) un aumento di pressione:
a) sposta il primo equilibrio a destra e il secondo a sinistra
b) sposta il primo equilibrio a sinistra e il secondo a destra
c) non sposta il primo equilibrio e sposta il secondo a sinistra
d) non sposta il primo equilibrio e sposta il secondo a destra
7. Una reazione acido-base secondo Brønsted e Lowry è:
a) una dissociazione ionica
b) una ionizzazione
c) un trasferimento di protoni
d) un trasferimento di elettroni
Test d’ingresso semplificati • Chimica e Biologia
Nome e cognome Data Classe
8. Durante la trascrizione è sintetizzato un filamento di tRNA.
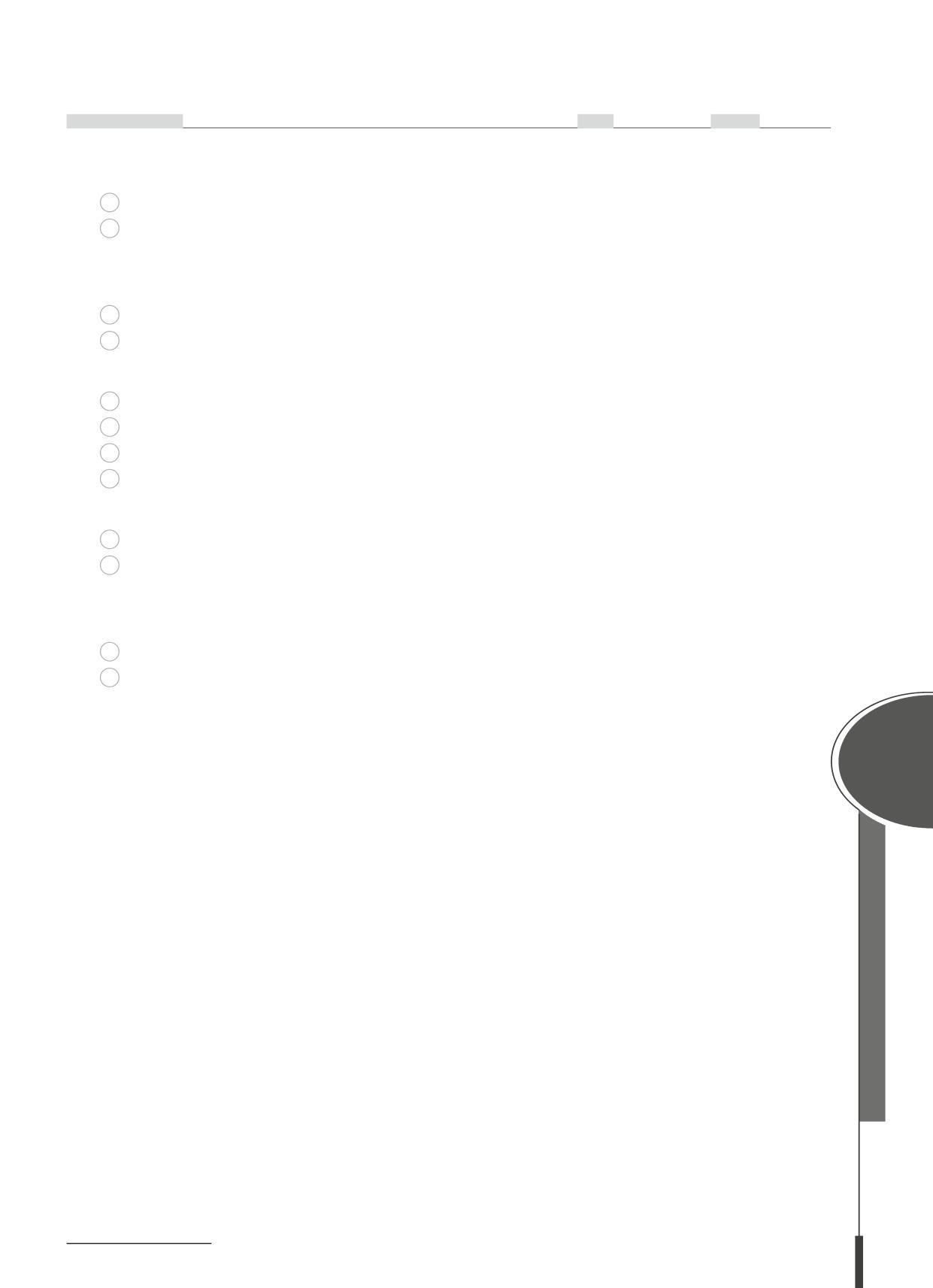
9. La DNA polimerasi sintetizza il filamento lento procedendo in direzione 3′ → 5′.
10.Che differenza c’è tra un acido forte e un acido debole?
a) La concentrazione di un acido debole è minore di quella degli ioni H+ .
b) Un acido debole non è corrosivo.
c) Un acido forte è più concentrato.
d) La concentrazione di un acido forte coincide con quella degli ioni H+ .
11.La specie che si ossida diminuisce il suo numero di ossidazione.
12.Una soluzione di NaCl e HCl in quantità equimolari è una soluzione tampone. V F
13.Che tipo di legami si instaurano tra i due filamenti che costituiscono la molecola di DNA?
14.Qual è il valore del pH di una soluzione di NaOH 10−5 M?
15.Data la reazione 2NO(g) + O2(g) → 2NO2(g) e sapendo che: Δf H°NO = 90,25 kJ/mol e ΔfH°NO2 = 33,18 kJ/mol, quanto vale la variazione di entalpia di reazione?
Nome e cognome Data Classe
1. Il mantello è lo strato di maggiore spessore all’interno del pianeta Terra.
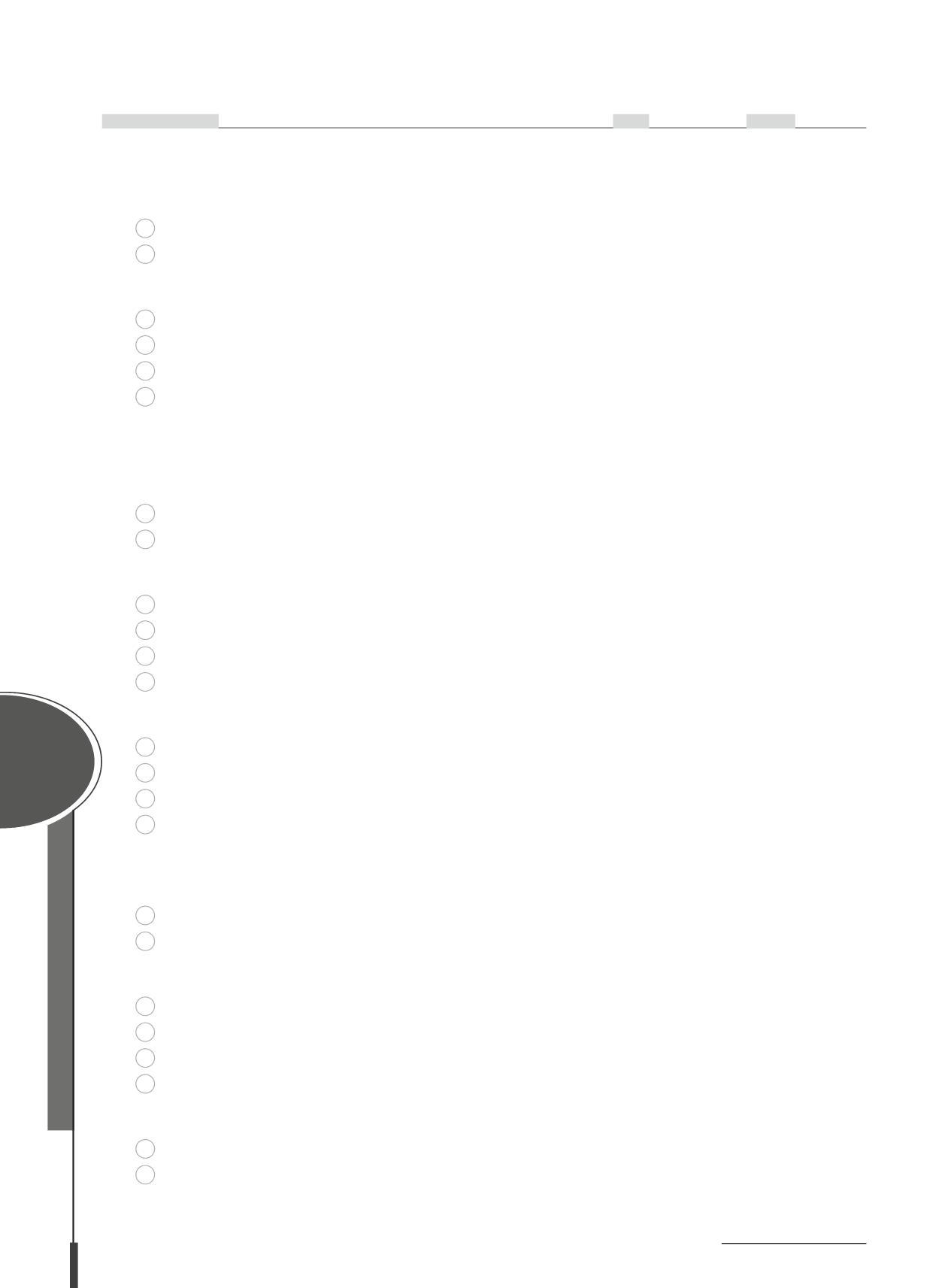
2. La zona in cui le onde sismiche hanno bassa velocità è denominato:
a) litosfera
b) mesosfera
c) nucleo
d) astenosfera
3. Secondo la teoria della tettonica a placche la litosfera è fratturata in placche che si muovono scontrandosi o allontanandosi l’una dall’altra.
4. Oceani e mari contengono insieme circa:
a) il 30% dell’acqua presente sulla Terra
b) il 71% dell’acqua presente sulla Terra
c) il 97% dell’acqua presente sulla Terra
d) la metà dell’acqua presente sulla Terra
5. Il sale più abbondante nelle acque marine è:
a) cloruro di magnesio
b) cloruro di sodio
c) carbonato di calcio
d) solfato di magnesio
6. Le correnti oceaniche sono generate dal vento o dalle differenze di densità delle acque.
7. Le dorsali oceaniche sono:
a) strette e lunghe depressioni che bordano alcuni margini continentali
b) lunghe catene montuose sottomarine
d) una porzione di fondale marino che circonda le terre emerse
d) edifici calcarei costituiti anche da alghe fotosintetiche
8. Il clima è rappresentato dalle condizioni meteorologiche momentanee.
Test d’ingresso semplificati • Scienze della Terra • Quinto
Nome e cognome Data Classe
9. La foresta di conifere è il bioma tipico del clima:
a) monsonico
b) desertico
c) clima temperato freddo-secco
d) clima polare
10.Partendo dal basso, qual è il primo strato di atmosfera che si incontra?
a) esosfera
b) stratosfera
c) troposfera
d) termosfera
11.L’ozonosfera si trova, a partire dalla crosta terrestre:
a) tra i 300 e i 600 km di altitudine
b) tra i 10 e i 20 km di altitudine
c) tra i 30 e i 60 km di altitudine
d) oltre i 100 km di altitudine
12.Il bilancio termico della Terra è variabile.
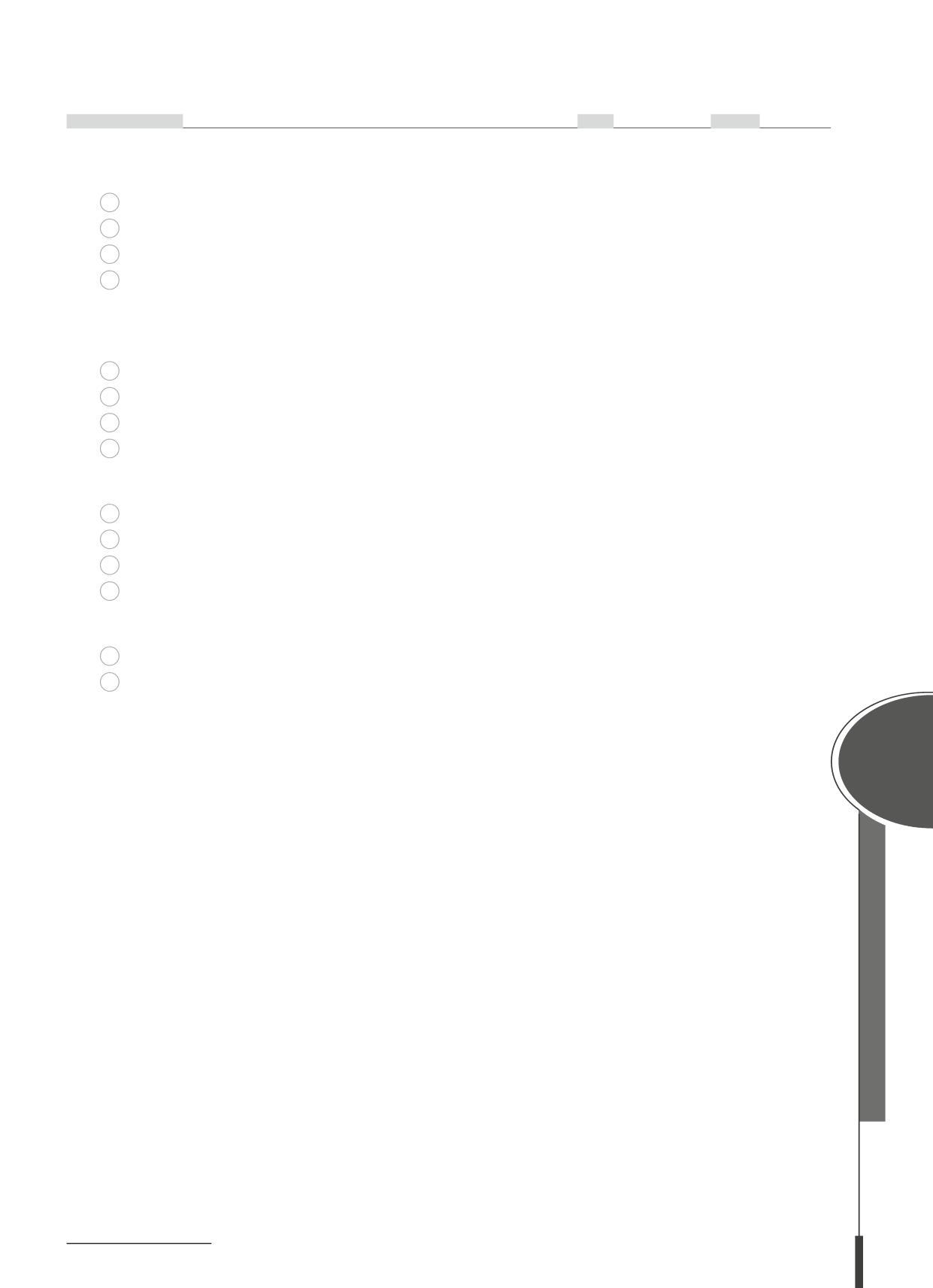
13.Qual è il tipo climatico di una zona in cui le escursioni termiche sono elevate e le precipitazioni sono inferiori a 250 mm di pioggia?
14.Che cosa è il termoclino?
15.Quali sono i fattori che causano la variazione della pressione atmosferica?
Unità
VERIFICHE SOMMATIVE DI FINE UNITÀ
1 • Il carbonio e gli idrocarburi
Nome e cognome
1 Indica se le seguenti affermazioni sono vere o false
1. L’ibridizzazione sp3 dell’atomo di carbonio si ottiene dalla combinazione di un orbitale s e tre orbitali p V F
2. La formula generale degli alcheni è C n H2n V F
3. Negli alcheni, gli orbitali sp2 si dispongono a 120° per minimizzare la reciproca repulsione. V F
4. Negli alcani, un carbonio secondario può legarsi ad altri atomi attraverso 4 legami sigma. V F
5. L’atomo di carbonio ha una spiccata tendenza a cedere i suoi elettroni a un altro atomo di carbonio. V F
2 Indica con una crocetta la risposta corretta
6. Il cis-1,2-dietilciclopentano e il trans-1,2-dietilciclopentano sono:
a) isomeri costituzionali
b) diastereoisomeri
c) isomeri geometrici
d) cicloalcheni
7. Un triplo legame tra 2 atomi di carbonio contiene:
a) solo un legame π
b) due legami π
c) tre legami π
d) due legami σ
8 Gli stereoisomeri sono:
a) sostanze con la stessa formula molecolare
b) sostanze con la stessa formula molecolare e le stesse connessioni tra gli atomi
c) sostanze con la stessa formula molecolare e le stesse connessioni tra gli atomi ma diversa disposizione degli atomi nello spazio
d) molecole achirali
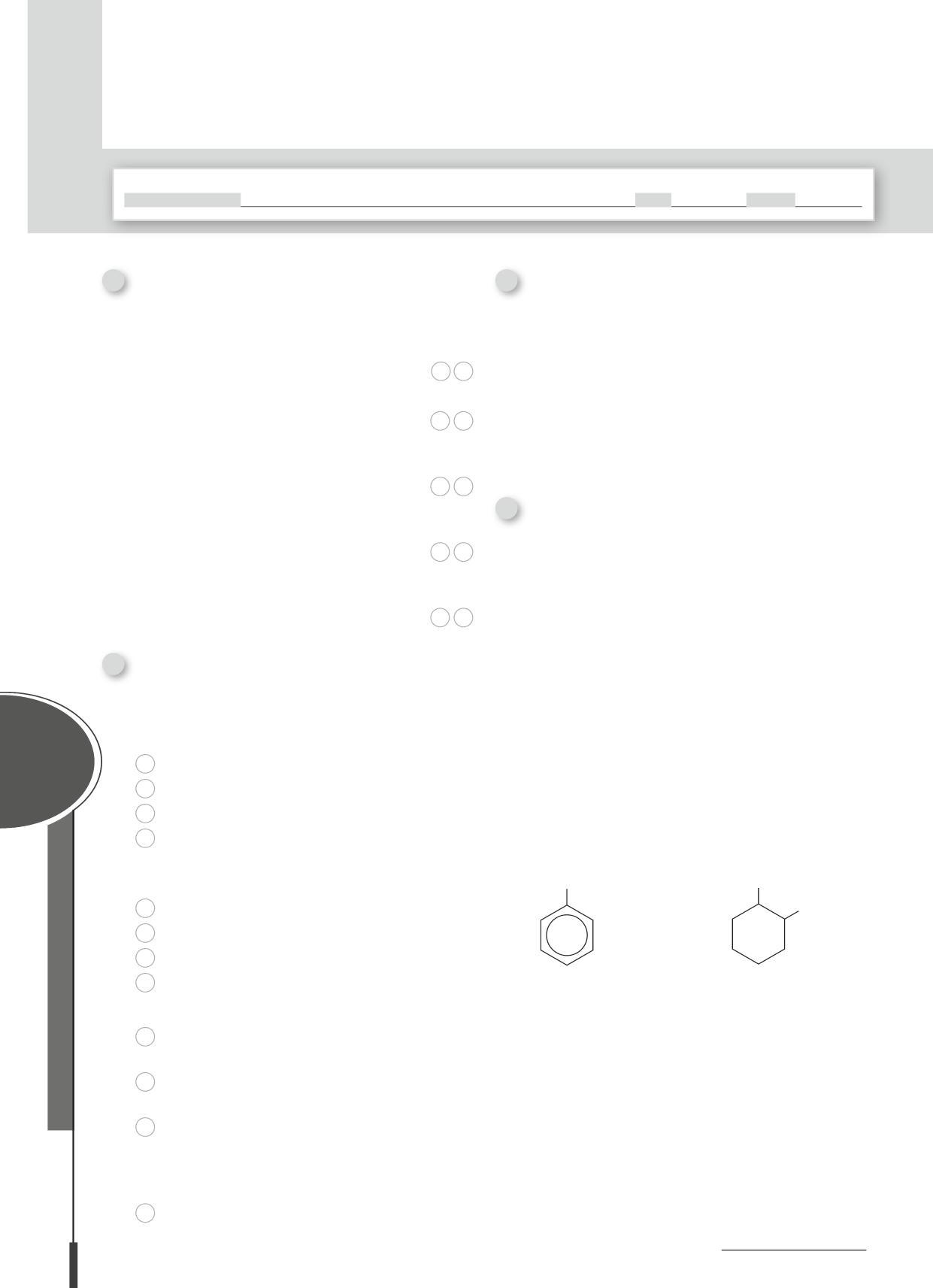
Data Classe
3 Rispondi
alle seguenti domande
9. Descrivi la molecola del benzene e spiega, attraverso la teoria degli orbitali, perché si disegna come un esagono con all’interno un cerchio.
10 Spiega brevemente che cosa si intende per attività ottica di due enantiomeri.
11 Descrivi la struttura del triplo legame carbonio-carbonio tipico degli alchini.
4 Risolvi i seguenti problemi
12 Qual è la formula molecolare del composto 3-etil-4-isopropil-2-metileptano? Disegnane la struttura molecolare.
13 Scrivi le possibili strutture molecolari del dibromobenzene e nominale secondo le regole IUPAC e secondo la denominazione orto- meta- para-.
14 Di quale classe di composti organici fanno parte le seguenti molecole? Assegna il nome a ciascun composto.
VERIFICHE SOMMATIVE DI FINE UNITÀ
Unità 1 • Il carbonio e gli idrocarburi
Nome e cognome
1 Indica se le seguenti affermazioni sono vere o false
1. L’ibridizzazione sp2 dell’atomo di carbonio è tipica dei composti organici denominati alchini. V F
2 Negli alcheni i carboni che formano tra loro un doppio legame sono ibridizzati sp2 V F
3. Un triplo legame tra due atomi di carbonio contiene solamente un legame π debole. V F
4. Negli alcani, un carbonio terziario può legarsi solamente a tre altri atomi attraverso legami sigma. V F
5. L’atomo di carbonio ha una spiccata tendenza a condividere i suoi elettroni con un altro atomo di carbonio. V F
2 Indica con una crocetta la risposta corretta
6. La formula generale dei cicloalcani è la stessa di quale classe di idrocarburi, a parità di numero di carboni?
a) alcheni
b) alchini
c) alcani
d) aromatici
7. I diastereoisomeri sono:
a) due configurazioni stereoisomere che sono l’una l’immagine speculare dell’altra
b) molecole che non hanno centri chirali
c) isomeri costituzionali
d) molecole con più centri chirali
8. Gli isomeri geometrici:
a) possiedono simili proprietà chimiche e fisiche
b) possiedono simili proprietà fisiche e diverse proprietà chimiche
c) devono essere considerati due diversi composti
d) hanno lo stesso punto di fusione
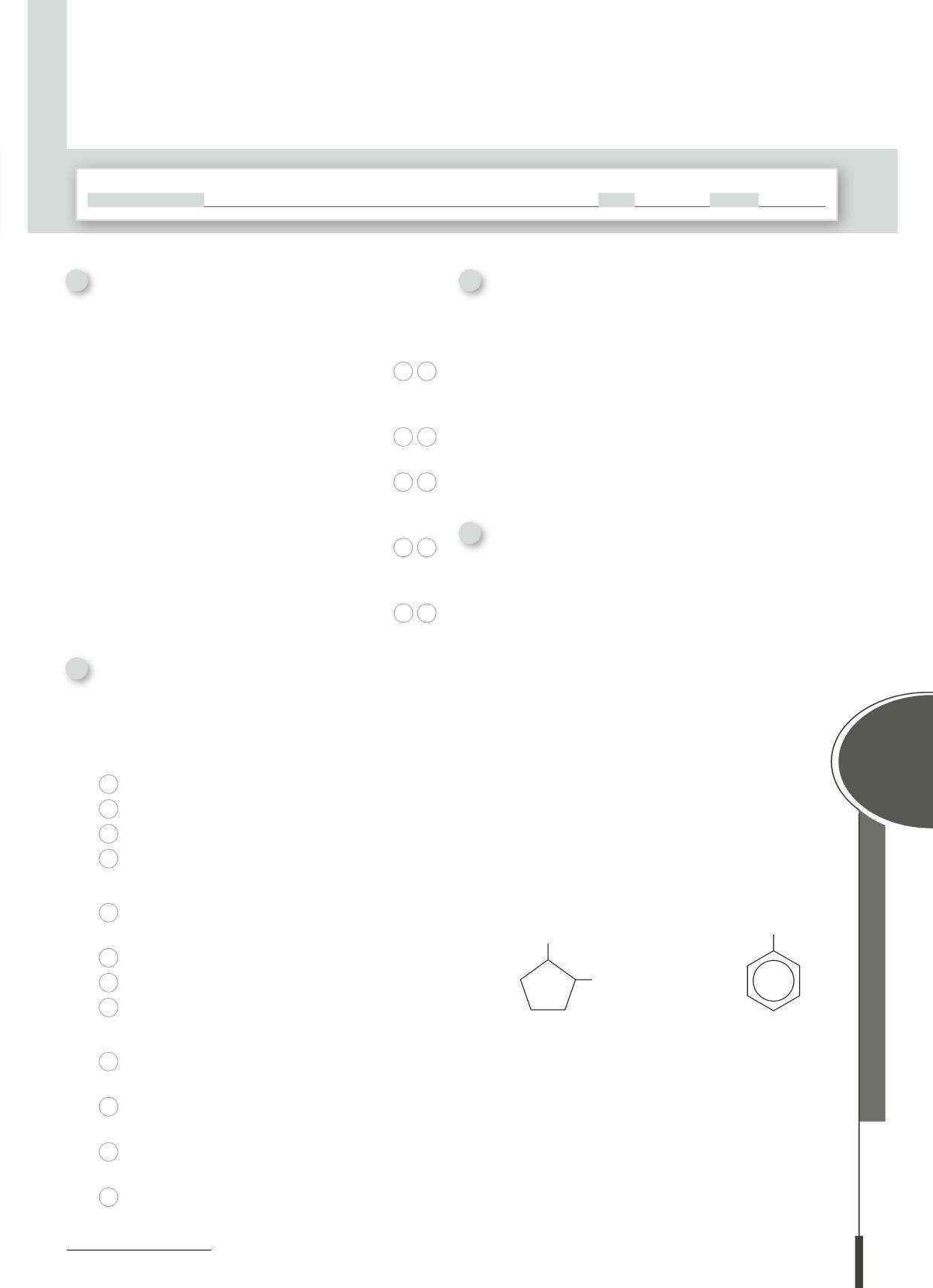
Fila B
Data Classe
3 Rispondi alle seguenti domande
9. Descrivi il concetto di risonanza disegnando le strutture di Kekulé della molecola di benzene e il corrispondente ibrido di risonanza.
10. Spiega la differenza tra i due alcheni isomeri geometrici cis-3-esene e trans-3-esene.
11. Quali sono i tipi di ibridizzazione degli orbitali dell’atomo di carbonio? In quali classi di idrocarburi sono presenti rispettivamente?
4 Risolvi i seguenti problemi
12. Qual è la formula molecolare del composto 5-etil-2,2-dimetilottano? Disegnane la struttura molecolare.
13. Scrivi le possibili strutture molecolari dell’etilfenolo e nominale secondo le regole IUPAC e secondo la denominazione ortometa- para-.
14. Di quale classe di composti organici fanno parte le seguenti molecole? Assegna il nome a ciascun composto.
VERIFICHE SOMMATIVE DI FINE UNITÀ
Unità 2 • I derivati degli idrocarburi e i polimeri
Nome e cognome
1 Indica se le seguenti affermazioni sono vere o false
1. Il 2-cloropropano è un alogenuro secondario. V F
2. I fenoli sono alcoli in cui il gruppo ossidrilico è legato a un atomo di carbonio appartenente a un anello aromatico. V F
3. Gli eteri possono essere considerati derivati dall’acqua, per sostituzione di uno solo degli atomi di idrogeno con un gruppo alchilico o arilico. V F
4. Il furano è un composto eterociclico aromatico. V F
5. Il polivinilcloruro PVC è un omopolimero. V F
2 Indica con una crocetta la risposta corretta
6. Quale caratteristica distingue chetoni e aldeidi?
a) I chetoni hanno il gruppo carbonilico terminale.
b) Le aldeidi hanno due gruppi carbonilici.
c) Le aldeidi hanno almeno un atomo di idrogeno legato al carbonio carbonilico.
d) I chetoni hanno il gruppo carbossilico legato a un carbonio non terminale.
7. Come si chiama il carbonio che è parte del gruppo funzionale COOH negli acidi carbossilici?
a) Carbonio alfa
b) Carbonio acido
c) Carbonio carbonilico
d) Carbonio carbossilico
8 La gomma naturale è costituita perlopiù da:
a) isoprene
b) silicone
c) zolfo
d) polisolfuri
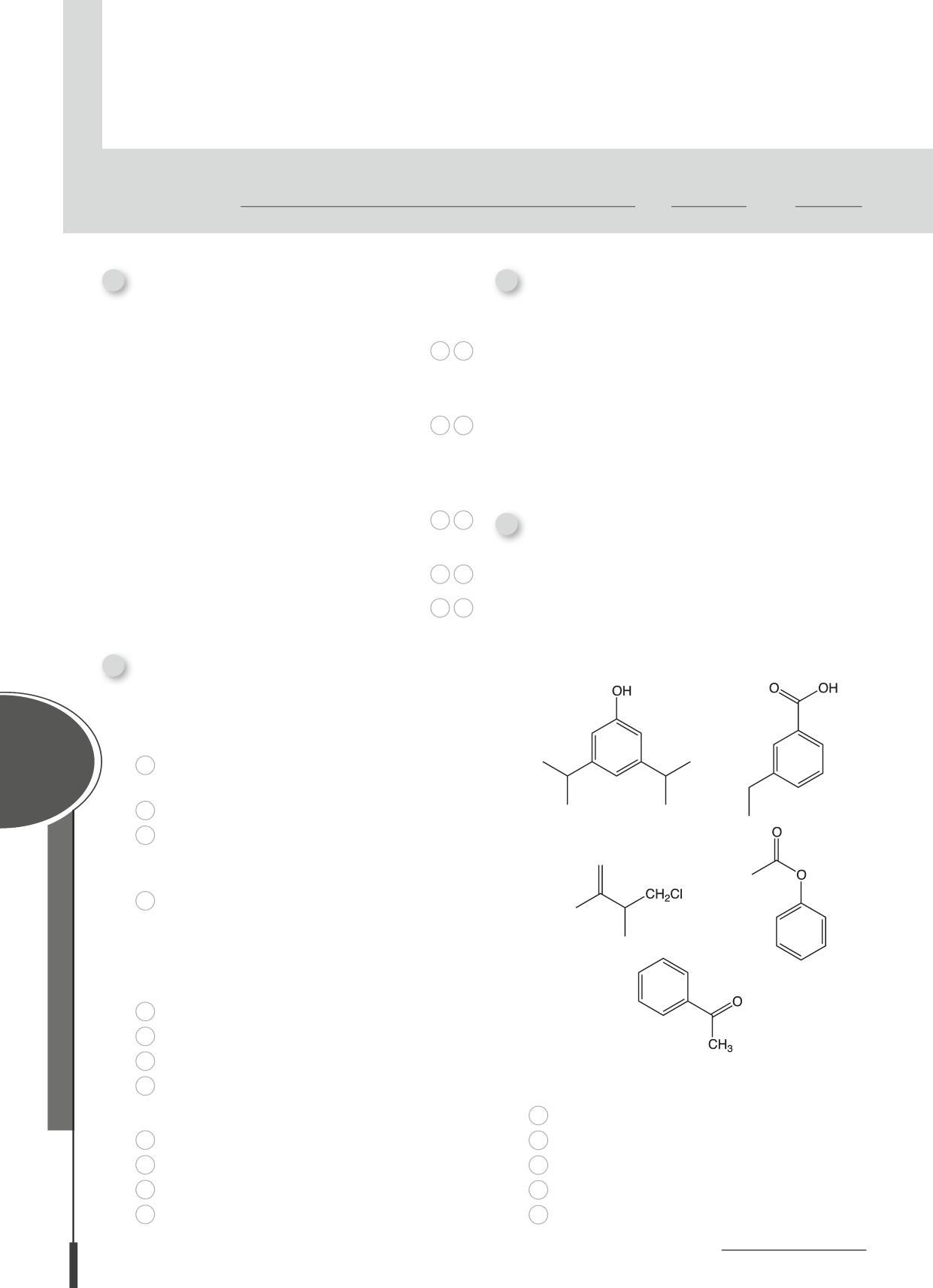
Fila A
Data Classe
3
Rispondi alle seguenti domande
9. Spiega secondo quale criterio le ammine si distinguono in primarie, secondarie e terziarie.
10. In quali classi possono essere distinti i polimeri? Secondo quali caratteristiche?
11. Spiega cosa si intende per reazione di addizione e fornisci un esempio di quale classe di composti può essere ottenuta per addizione.
4 Risolvi i seguenti problemi
12 Disegna i diversi isomeri di struttura dalla seguente formula molecolare: C3H8O. Quale delle molecole disegnate è un etere?
13. Di quale classe di composti organici fanno parte le seguenti molecole? Indica e nomina i gruppi funzionali di ciascun composto.
AC E
14. Disegna le formule di struttura dei seguenti composti:
a) 1-metossi-2-metilbutano
b) N-etil-1-propanammina
c) 4-bromo-3-eptanone
d) 4-fenil-2-metilpentanale
e) 1-etil-2,3-diiodociclopentano
VERIFICHE SOMMATIVE DI FINE UNITÀ
Unità 2 • I derivati degli idrocarburi e i polimeri Fila
B
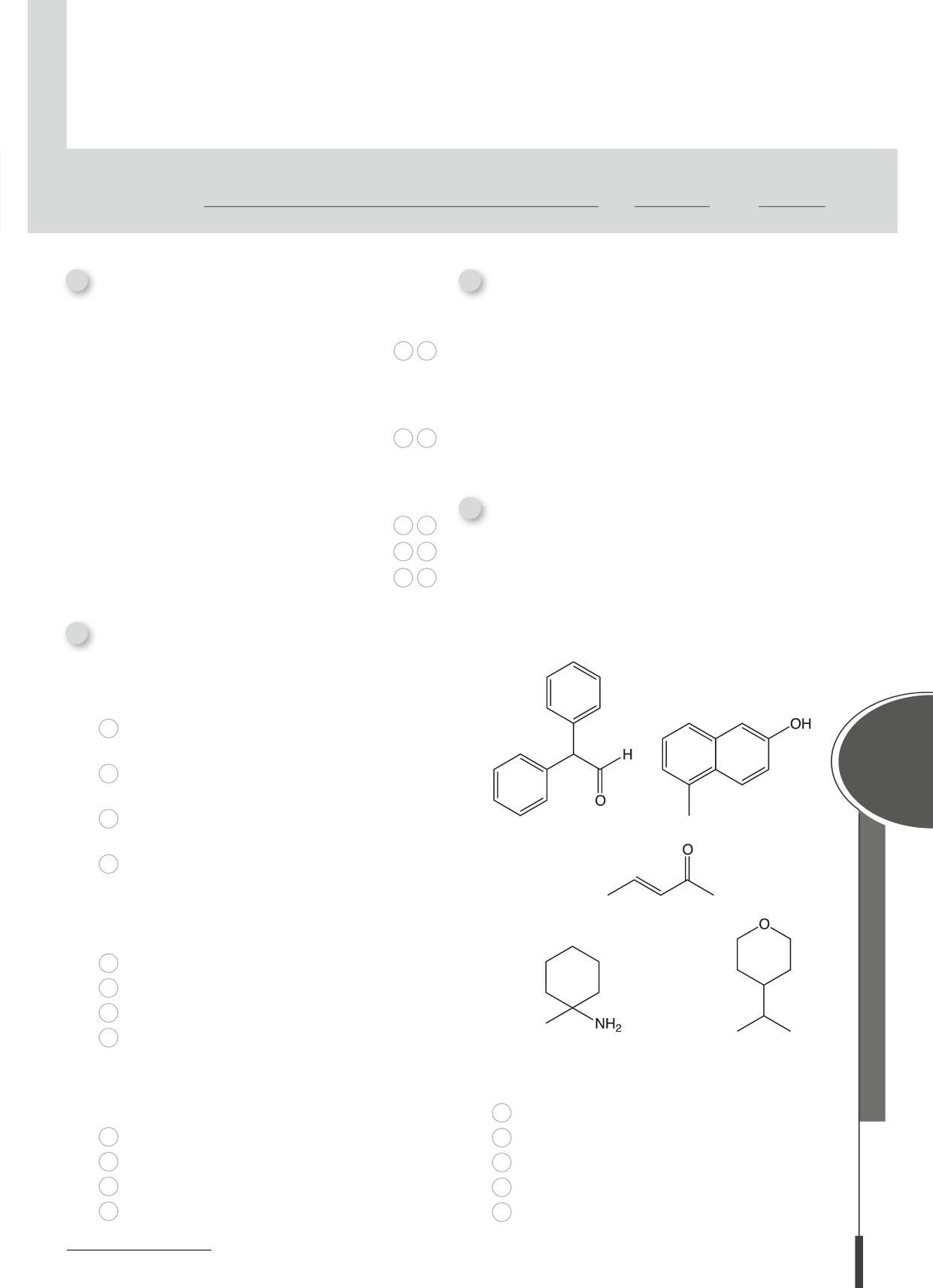
Nome e cognome
1 Indica se le seguenti affermazioni sono vere o false
1. Il 2-cloropropano è un alogenuro terziario. V F
2. L’anilina è una ammina il cui il gruppo amminico è legato a un atomo di carbonio appartenente a un anello aromatico. V F
3. Gli eteri possono essere considerati derivati dall’acqua, con entrambi gli atomi di idrogeno sostituiti da gruppi alchilici o arilici. V F
4. Il furano è un eterociclo pentatomico. V F
5. Il nylon 6,6 è un omopolimero. V F
2 Indica con una crocetta la risposta corretta
6. Qual è la differenza principale tra aldeidi e chetoni?
a) Le aldeidi hanno il gruppo carbonilico legato a due gruppi alchilici
b) Le aldeidi hanno almeno un atomo di idrogeno legato al carbonio carbonilico
c) I chetoni hanno il gruppo carbonilico terminale
d) I chetoni hanno il gruppo carbonilico legato a un solo atomo di idrogeno
7. Quale tra le seguenti classi di composti non è un derivato di un acido carbossilico?
a) Ammidi
b) Anidridi
c) Esteri
d) Eteri
8. Nella sintesi dei poliesteri, che sono polimeri di condensazione, si elimina:
a) acqua
b) alcol
c) acido cloridrico
d) non vi è nessuna eliminazione
Data Classe
3 Rispondi alle seguenti domande
9. Spiega secondo quale criterio gli alcoli si distinguono in primari, secondari e terziari.
10. Qual è la differenza tra polietilene a bassa densità e polietilene ad alta densità?
11. Spiega cosa si intende per reazione di sostituzione e fornisci un esempio di quale classe di composti può essere ottenuta per addizione.
4 Risolvi i seguenti problemi
12. Disegna i diversi isomeri di struttura dalla seguente formula molecolare: C3H8O. Quante e quali di queste molecole sono alcoli?
13. Di quale classe di composti organici fanno parte le seguenti molecole? Indica e nomina i gruppi funzionali di ciascun composto.
14. Disegna le formule di struttura dei seguenti composti:
a) acido 2-etilbutanoico
b) N-etil-3-esanammina
c) 2-cloro-3-pentanolo
d) 4-etil-6-metilottanale
e) difenilchetone
VERIFICHE SOMMATIVE DI FINE UNITÀ
Unità 3 • Le biomolecole Fila A
Nome e cognome Data Classe
1 Indica se le seguenti affermazioni sono vere o false
1. Il saccarosio deriva dall’unione tra una molecola di α-D-glucosio e una di β-D-fruttosio. V F
2. I fosfolipidi sono componenti ideali per la formazione di membrane cellulari. V F
3. La struttura primaria delle proteine è data dai legami H che si instaurano all’interno della catena polipeptidica. V F
4. I due filamenti che costituiscono la molecola di DNA sono legati attraverso legami covalenti. V F
5. Il ribosio è alla base della molecola dell’RNA. V F
2 Indica con una crocetta la risposta corretta
6. Le quattro classi di biomolecole sono:
a) i chetoni, i lipidi, le proteine e gli acidi nucleici
b) i carboidrati, i lipidi, le proteine e gli acidi nucleici
c) i carboidrati, i lipidi, le proteine e i minerali
d) i carboidrati, le vitamine, le proteine e i lipidi
7. Gli amminoacidi sono composti organici bifunzionali perché contengono:
a) un gruppo aldeidico e un gruppo alcolico
b) un gruppo idrofilo e un gruppo lipofilo
c) un gruppo carbossilico e un gruppo amminico
d) un gruppo alchilico e un gruppo amminico
8. La struttura terziaria delle proteine è dovuta:
a) all’instaurarsi di legami idrogeno tra i vari residui amminoacidici
b) alla conformazione tridimensionale della catena polipeptidica
c) alla presenza di gruppi amminici nella catena polipeptidica
d) alla presenza di ponti dicloruro
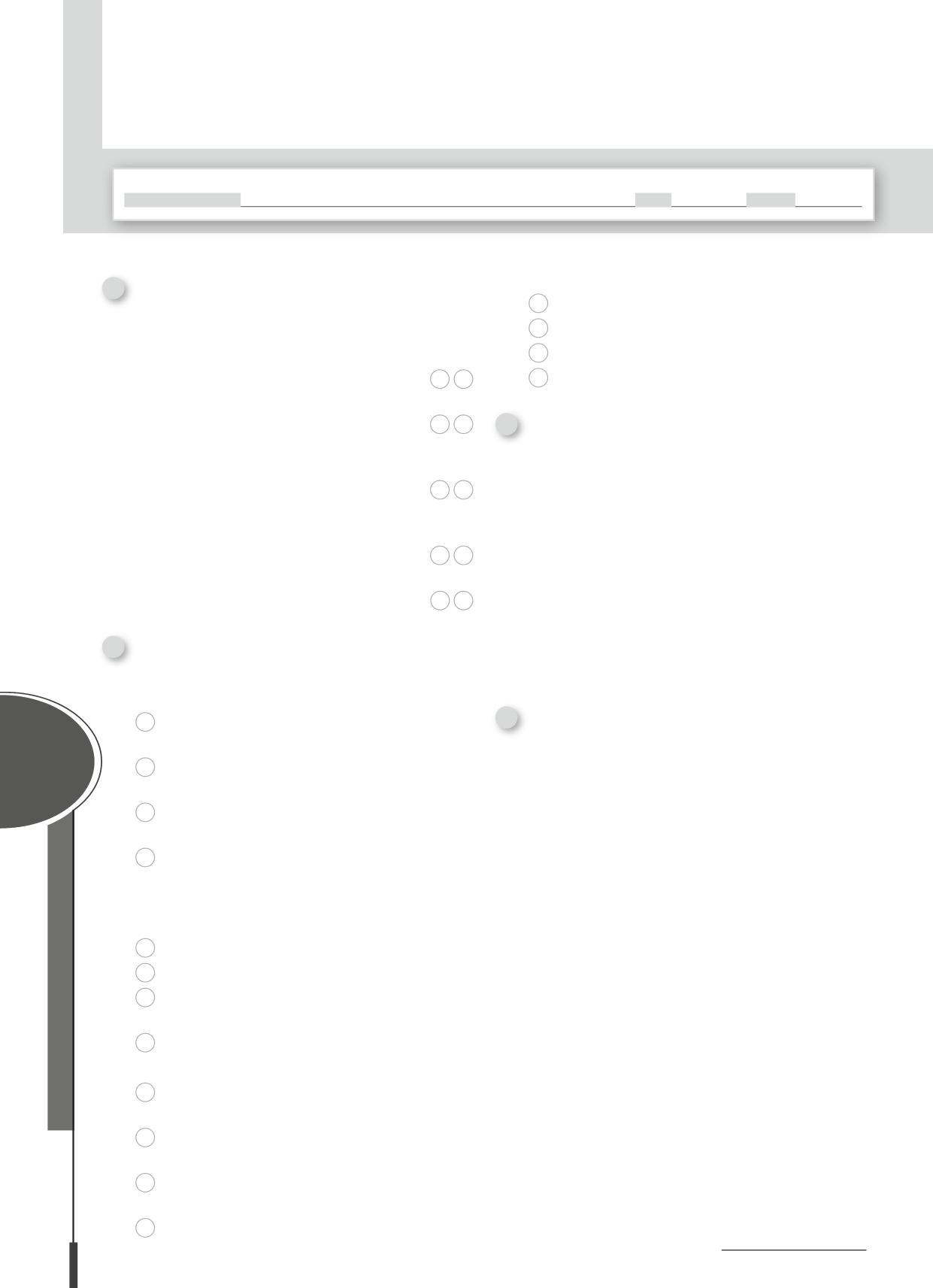
9. La citosina è:
a) un amminoacido apolare
b) una base purinica
c) una base pirimidinica
d) un amminoacido polare
3 Rispondi alle seguenti domande
10. Quali sono le più importanti funzioni biologiche dei carboidrati?
11. Spiega la differenza tra i due anomeri del D-glucosio in forma ciclica piranosica e disegnali secondo la proiezione di Fischer.
12. Spiega cosa sono i polisaccaridi e qual è la fondamentale differenza dei i due polimeri che costituiscono l’amido: amilosio e amilopectina.
13. Descrivi la struttura secondaria delle proteine e in particolare la struttura a β-foglietto.
4
Risolvi i seguenti problemi
14. Scrivi la proiezione di Fischer del D-ribosio nella sua forma aperta e la struttura ciclica delle sue due forme furanosiche.
15. I trigliceridi sono costituiti da una molecola di glicerolo i cui gruppi —OH sono esterificati da tre acidi grassi. Scrivi la reazione di formazione del trigliceride dell’acido caprilico, avente formula molecolare C8H16O2
16. Indica la formula generale che descrive un amminoacido. Scrivi la reazione di condensazione tra i due amminoacidi alanina e serina.
17. Stabilisci se la seguente sequenza di basi azotate è parte della struttura del DNA o dell’RNA e scrivi la struttura a essa complementare: AAAAATTACGAAGTAAAGCCCAAT
VERIFICHE SOMMATIVE DI FINE UNITÀ
Unità 3 • Le biomolecole
Nome e cognome Data Classe
1 Indica se le seguenti affermazioni sono vere o false
1. Il maltosio è il disaccaride formato dalla condensazione di due molecole di α-D-glucosio. V F
2. Gli steroidi appartengono alla classe dei lipidi a causa delle loro affinità strutturali. V F
3. I fosfolipidi sono molecole strettamente lipofile. V F
4. Il ribosio è alla base della molecola del DNA. V F
5. I due filamenti che costituiscono la molecola di DNA sono legati attraverso legami a ponte di idrogeno. V F
2 Indica con una crocetta la risposta corretta
6. Le quattro classi di biomolecole sono:
a) le aldeidi, i lipidi, le proteine e gli acidi nucleici
b) i carboidrati, i lipidi, le proteine e i minerali
c) i carboidrati, i lipidi, le proteine e gli acidi nucleici
d) i carboidrati, le vitamine, le proteine e i lipidi
7. Gli amminoacidi basici sono:
a) lisina, arginina, istidina
b) lisina, alanina, glicina
c) lisina, arginina, asparagina
d) lisina, arginina, alanina
8. La struttura secondaria delle proteine è dovuta:
a) all’instaurarsi di legami idrogeno tra i vari residui amminoacidici
b) alle sequenze ordinate degli amminoacidi che la compongono
c) alla presenza di gruppi amminici nella catena polipeptidica
d) alla presenza di ponti dicloruro
Fila B
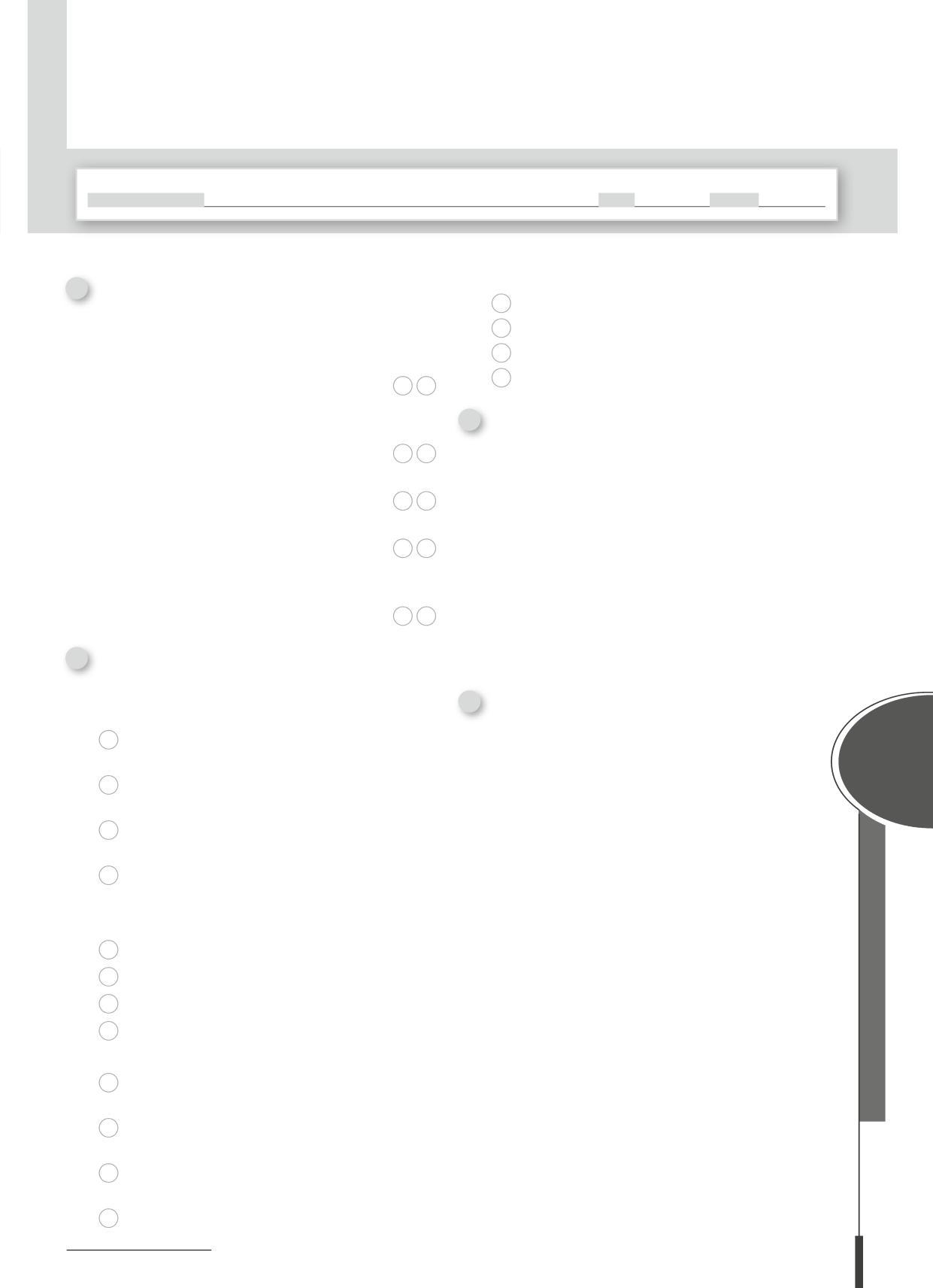
9. La guanina è:
a) un amminoacido apolare
b) una base purinica
c) una base pirimidinica
d) un amminoacido polare
3 Rispondi alle seguenti domande
10. Come si possono classificare i carboidrati sulla base della loro complessità strutturale?
11. Spiega la differenza tra i due anomeri del D-mannosio in forma ciclica piranosica e disegnali secondo la proiezione di Fischer.
12. Spiega cosa sono i lipidi e descrivi le loro quattro funzioni principali.
13. Descrivi la struttura secondaria delle proteine e in particolare la struttura a α-elica.
4 Risolvi i seguenti problemi
14. Scrivi la proiezione di Fischer del D-2desossiribosio nella sua forma aperta e la struttura ciclica della sua forma furanosica.
15. I trigliceridi sono costituiti da una molecola di glicerolo i cui gruppi —OH sono esterificati da tre acidi grassi. Scrivi la reazione di formazione del trigliceride dell’acido caprico, avente formula molecolare C10H20O2
16. Indica la formula generale che descrive un amminoacido. Scrivi la reazione di condensazione tra i due amminoacidi cisteina e fenilalanina.
17. Stabilisci se la seguente sequenza di basi azotate è parte della struttura del DNA o dell’RNA e scrivi la struttura a essa complementare: AAAACCCGAUUUAACGAAGGUUG
Unità
VERIFICHE SOMMATIVE DI FINE UNITÀ
4 • Il metabolismo e la fotosintesi Fila A
Nome e cognome Data Classe
1 Indica se le seguenti affermazioni sono vere o false
1. Tramite l’anabolismo vengono sintetizzate molecole complesse. V F
2. Il sito attivo di un enzima ha una forma complementare al substrato. V F
3. Gli organismi autotrofi si distinguono per la capacità di sintetizzare autonomamente le sostanze nutritive necessarie alla sopravvivenza. V F
4. L’ATP sintasi è un complesso enzimatico che produce ATP localizzato nella membrana citoplasmatica di cellule eucariote. V F
5. L’acido lattico prodotto nella muscolatura scheletrica deriva dall’ossidazione del piruvato con O2 V F
2 Indica con una crocetta la risposta corretta
6. I cloroplasti
a) sono organuli cellulari contenuti nel citoplasma di cellule vegetali
b) sono organuli cellulari contenuti nei mitocondri
c) sono tipicamente contenuti negli archeobatteri
d) sono contenuti nel lume dei tilacoidi
7. Il processo di glicolisi avviene:
a) nei mitocondri
b) nel citoplasma
c) solamente nelle cellule eucariote
d) solamente negli organismi procarioti
8. Il coenzima Q è coinvolto:
a) nella sintesi di ATP
b) nella catena respiratoria della fosforilazione ossidativa
c) nel metabolismo anaerobico del glucosio
d) nella fermentazione alcolica
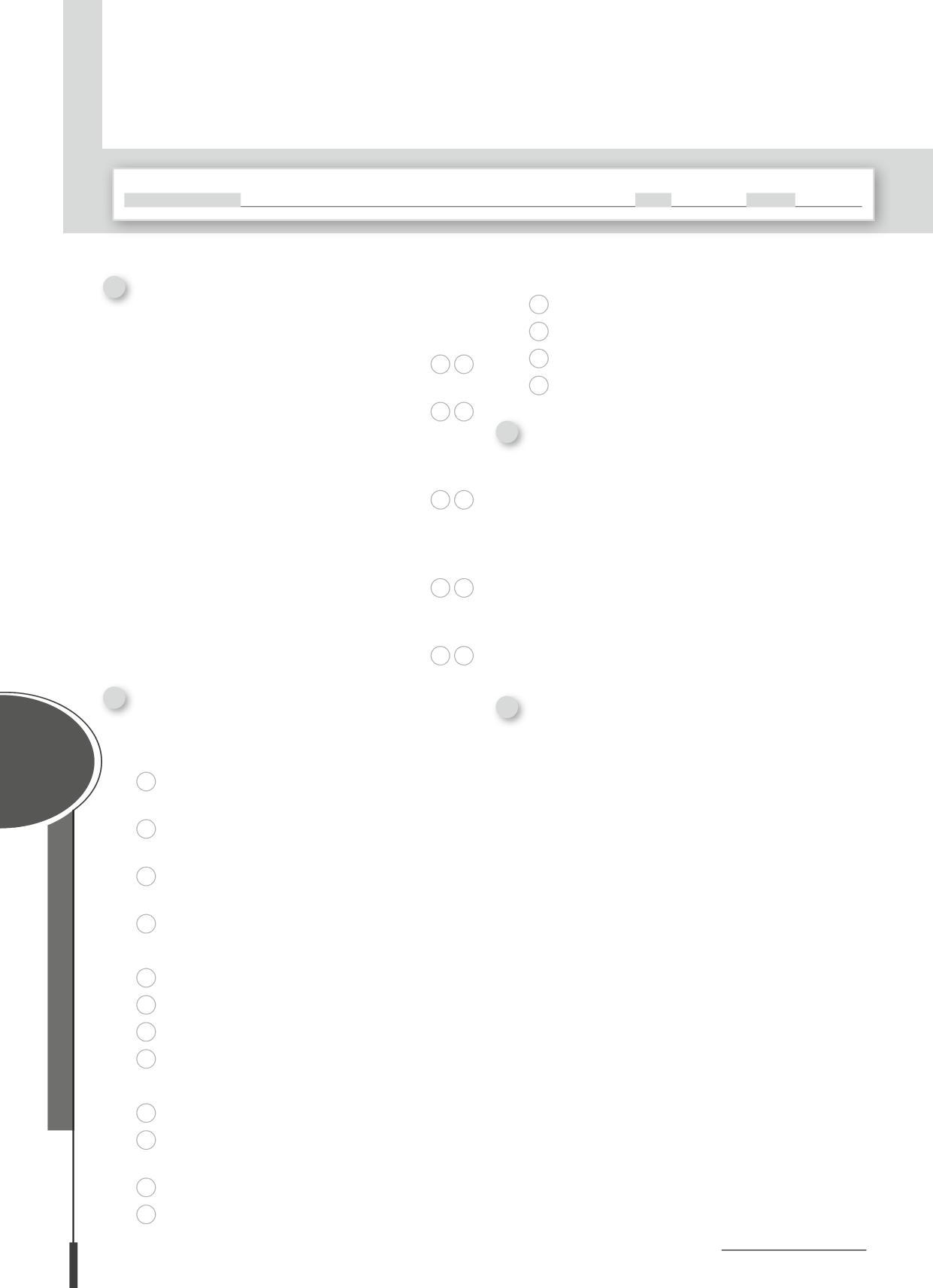
9. La via del pentosio fosfato produce:
a) NADH per la sintesi dei lipidi
b) NADH per la sintesi di nucleotidi
c) ribosio per la sintesi di nucleotidi
d) desossiribosio per la gluconeogenesi
3 Rispondi alle seguenti domande
10. Disegna e descrivi la struttura molecolare di una molecola di ATP. Quali sono le due principali vie di sintesi di questa molecola nelle cellule eucariote?
11. Quali sono le caratteristiche tipiche della clorofilla e qual è la sua struttura?
12. Descrivi brevemente la funzione del ciclo di Krebs, dove avviene e i prodotti di reazione principali che lo caratterizzano. Perché questo processo è definito un “ciclo”?
4 Risolvi i seguenti problemi
13. Considera queste due reazioni accoppiate:
a. A + B → C con Δ r G = −36,3 kJ/mol
b. C → D + E con Δ r G = −11,5 kJ/mol Il processo A + B → D + E è spontaneo?
14. Uno zucchero viene fosforilato due volte utilizzando una molecola di ATP e il Δ r G° della reazione è 30,3 kJ/mol. Quale sarebbe la variazione di energia libera standard per la doppia fosforilazione dello stesso zucchero senza l’aiuto della molecola di ATP?
15. Per una quantità iniziale di 8 moli di acetilCoA, quante moli di FADH2 vengono prodotte durante la sola fosforilazione ossidativa? Scrivi le reazioni complessive delle specie coinvolte.
VERIFICHE SOMMATIVE DI FINE UNITÀ
Unità 4 • Il metabolismo e la fotosintesi
Nome e cognome Data Classe
1 Indica se le seguenti affermazioni sono vere o false
1. Nel catabolismo vengono solitamente prodotte molecole di grandi dimensioni, come le proteine. V F
2. Per svolgere la propria funzione catalitica, l’enzima si lega a una molecola di substrato tramite legami covalenti. V F
3. La fotorespirazione è una via alternativa del ciclo di Calvin. V F
4. I citocromi sono proteine coinvolte nella fosforilazione ossidativa contenenti ioni Cu. V F
5. I prodotti della glicolisi sono 6 molecole di H2O e sei molecole di CO2 V F
2 Indica con una crocetta la risposta corretta
6. La RuBisCO può agire in due modi:
a) come carbossilasi e come ligasi
b) come carbossilasi e come ossigenasi
c) come ossigenasi e come sintasi
d) come sintasi e come carbossilasi
7. Durante la fase endoergonica della glicolisi:
a) si producono solo due molecole di ATP
b) si producono due molecole di acido piruvico
c) si consumano due molecole di ATP
d) si ha una dispersione di energia libera
8. La glicogenolisi e la glicogenesi sono reazioni enzimatiche regolate da:
a) acqua e diossido di carbonio
b) NADH e ATP
c) insulina e glucagone
d) glucosio e ossigeno
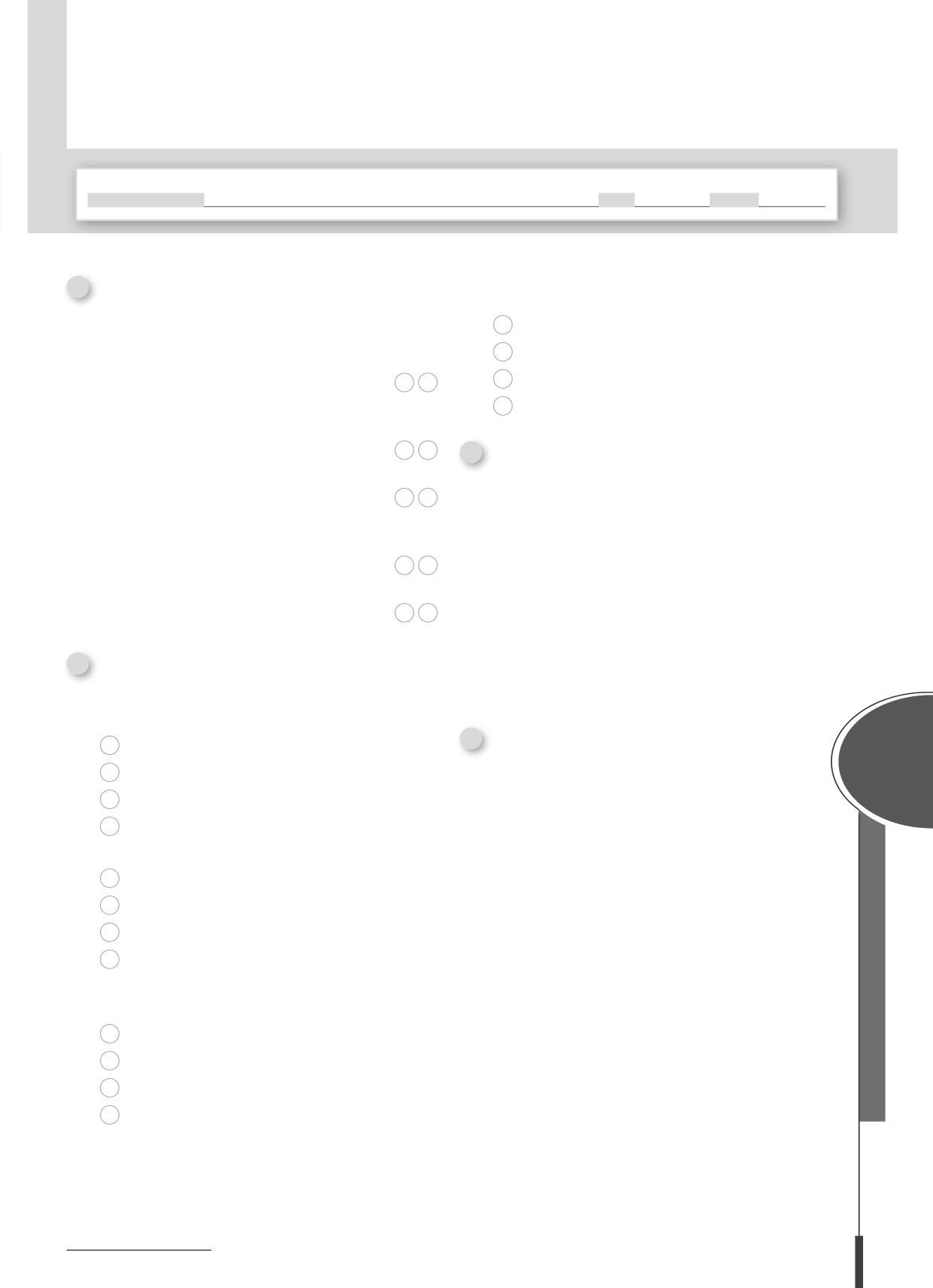
Fila B
9. La catena respiratoria e la catalisi rotazionale dell’ATP fanno parte:
a) della fosforilazione ossidativa
b) del ciclo di Krebs
c) della glicolisi
d) della fermentazione alcolica
3 Rispondi alle seguenti domande
10. Disegna la struttura molecolare di una molecola di ADP e descrivi il suo ruolo nel ciclo dell’ATP.
11. Quali sono i due tipi di fotosistemi che si sono evoluti nelle piante?
12. Qual è la funzione della G3P e in quale fase del ciclo di Calvin è prodotta?
13. Descrivi brevemente il metabolismo anaerobico del glucosio che porta alla produzione di alcol etilico e di lattato.
4 Risolvi i seguenti problemi
14. Considera queste due reazioni accoppiate:
a. A + B → C con Δ r G = −21,6 kJ/mol
b. C → D con Δ r G = +5 kJ/mol Il processo A + B → D è spontaneo?
15. Uno zucchero viene fosforilato con una reazione avente Δ r G° +18,6 kJ/mol. Quale sarebbe la variazione di energia libera standard per la fosforilazione dello stesso zucchero con l’aiuto della molecola di ATP?
16. Per una quantità iniziale di 10 moli di acetilCoA, quante moli di NADH vengono prodotte durante la sola fosforilazione ossidativa? Scrivi le reazioni complessive delle specie coinvolte.
VERIFICHE SOMMATIVE DI FINE UNITÀ
Unità 5 • I geni e la loro regolazione
Nome e cognome
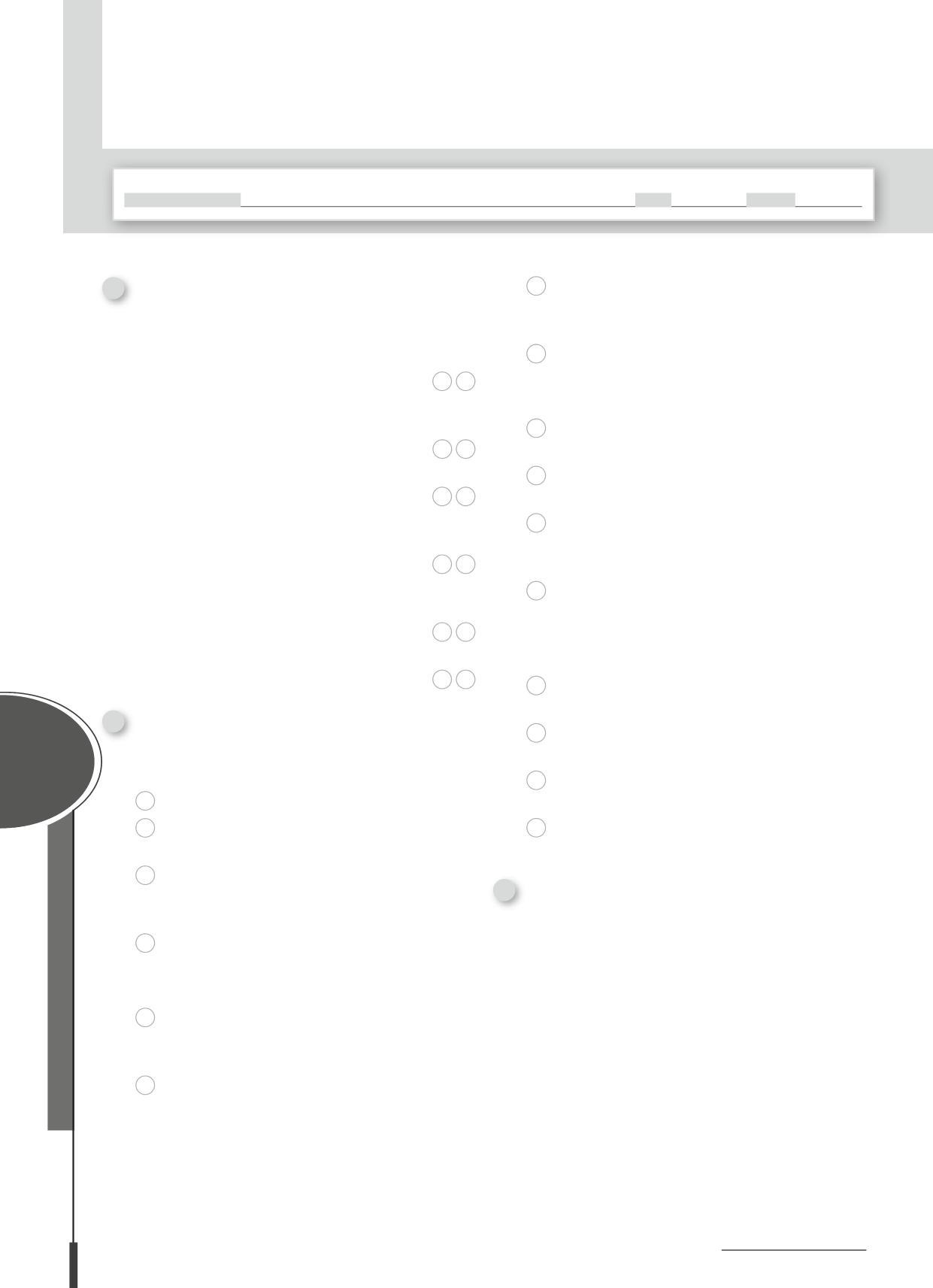
1 Indica se le seguenti affermazioni sono vere o false
1. Il DNA dei procarioti è un’unica molecola circolare a doppia elica detta plasmide.
2. Le sequenze enhancer sono coinvolte nella promozione dell’espressione genica.
3. I microRNA sono in grado di bloccare la traduzione.
F
F
F
4. Le proteine marcate con ubiquitina possono raggiungere qualsiasi compartimento cellulare. V F
5. Un fago in grado di riprodursi con ciclo litico o lisogenico è detto temperato.
6. Il plasmide F è coinvolto nella coniugazione batterica.
2 Indica con una crocetta la risposta corretta
7. Il fenotipo:
F
F
a) è esclusivamente il prodotto del genotipo
b) è una caratteristica osservabile di un organismo
c) è l’insieme dei geni responsabili di una certa caratteristica visibile o metabolica di un organismo
d) non è influenzato dall’ambiente esterno
8. La replicazione del DNA è definita semiconservativa perché:
a) gli enzimi che intervengono nel processo sono in parte cellulari e in parte extracellulari
b) solo parte del singolo filamento di DNA viene copiato
Data Classe
c) ogni nuova doppia elica possiede un filamento parentale e uno sintetizzato exnovo
d) la copia del DNA non è identica all’originale a causa di diversi errori di copiatura
9. Il processo di splicing:
a) è un meccanismo di controllo posttraduzionale presente negli eucarioti
b) determina l’inattivazione genica per effetto di tagli nella sequenza codificante
c) consiste nella rimozione degli introni e nella saldatura degli esoni in un filamento di mRNA continuo e codificante
d) è finemente controllato da enzimi che metilano e demetilano il DNA
10. Quale di queste affermazioni sull’operone lac è falsa?
a) Possiede una regione di controllo e una regione di codifica
b) Determina la capacità di metabolizzare il lattosio in E. coli
c) È un operone reprimibile in quanto la sua sintesi è repressa in assenza di lattosio
d) Può non essere espresso significativamente in presenza di lattosio
3 Rispondi alle seguenti domande
11. Descrivi le fasi più importanti del meccanismo di replicazione del DNA, facendo riferimento alle proteine e agli enzimi coinvolti.
12. Come può una cellula eucariotica regolare l’espressione genica a monte del processo trascrizionale?
13. Quali sono le fasi del ciclo lisogeno di un virus?
14. Che cosa si intende per trasferimento genico orizzontale?
VERIFICHE SOMMATIVE DI FINE UNITÀ
Unità 5 • I geni e
la loro regolazione
Nome e cognome Data Classe
1 Indica se le seguenti affermazioni sono vere o false
1. Negli eucarioti il DNA è associato ad alcune molecole di origine lipidica dette istoni. V F
2. Le sequenze silencer sono coinvolte nella promozione dell’espressione genica. V F
3. Per svolgere la loro funzione regolatoria, i miRNA si associano a proteine dette argonaute. V F
4. La fosforilazione di una proteina può essere un segnale per la sua degradazione. V F
5. Il pericapside è la struttura proteica che avvolge il genoma virale. V F
6. Una cellula competente è una cellula in grado di assorbire materiale genetico dall’esterno.
2 Indica con una crocetta la risposta corretta
V F
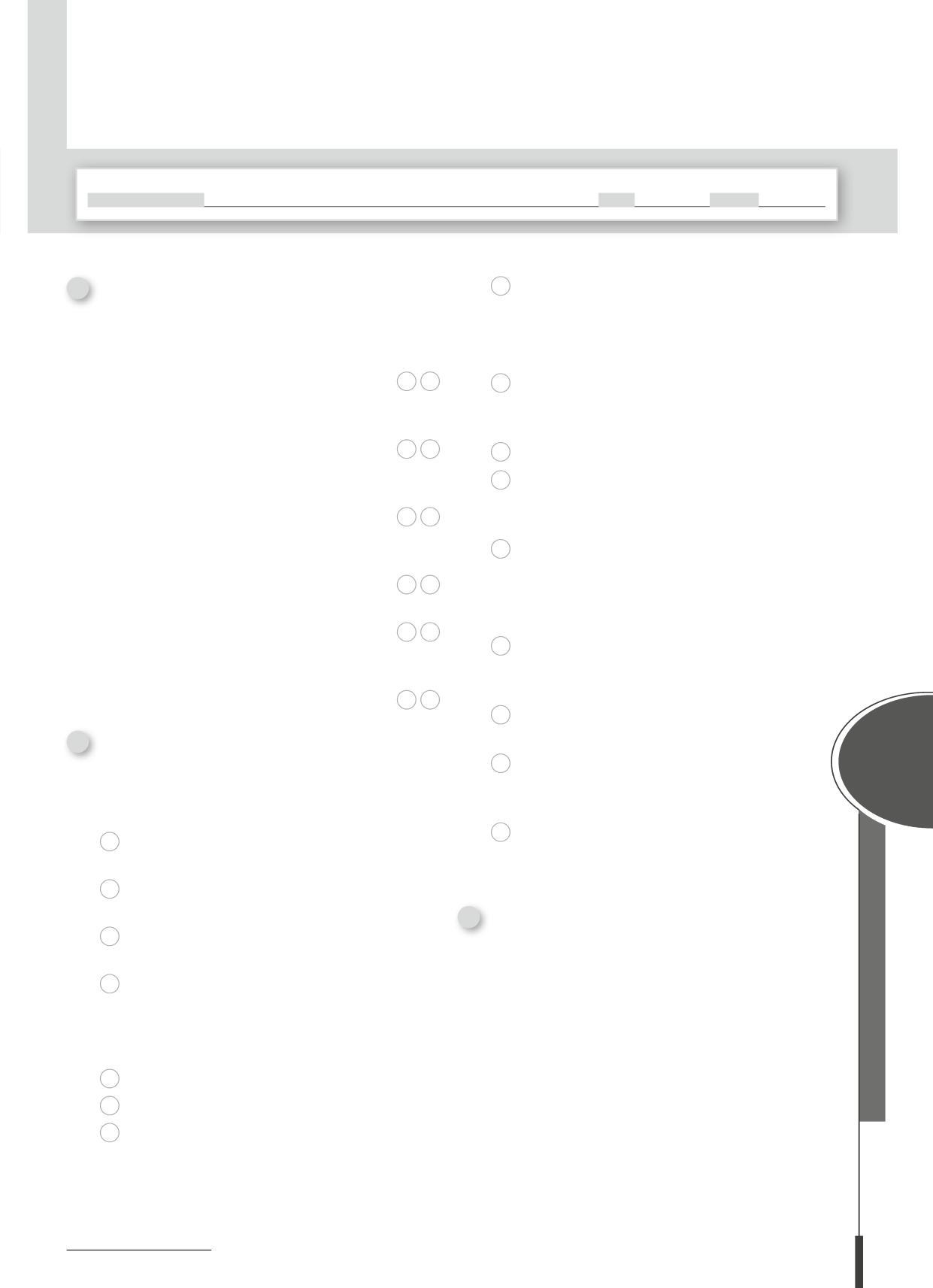
7. Quale affermazione sui frammenti di Okazaki è falsa?
a) Vengono prodotti dall’enzima DNA polimerasi
b) Prendono il nome dallo scienziato che per primo li scoprì
c) Vengono saldati insieme in un unico pezzo da una DNA ligasi
d) Si formano sul filamento con estremità libera in 3’
8. Quale di questi meccanismi di regolazione genica avviene dopo la traduzione?
a) Alterazione epigenetica del DNA
b) Splicing alternativo
c) Aggiunta di ubiquitina
Fila B
d) Regolazione mediante sequenze enhancer e silencer
9. Quale di queste affermazioni sull’operone del triptofano è vera?
a) Il triptofano induce la trascrizione dell’operone legandosi direttamente al promotore
b) È un operone inducibile
c) In assenza di triptofano la trascrizione dei geni dell’operone è un inutile dispendio energetico
d) Il triptofano si comporta da corepressore facilitando il legame del repressore all’operatore
10. I virus:
a) non sono in grado di produrre energia metabolica ma sono in grado di riprodursi
b) non sono in grado di riprodursi ma sono in grado di produrre energia metabolica
c) non sono in grado di produrre energia metabolica ma sono in grado di riprodursi all’interno di una cellula
d) non sono in grado di riprodursi ma sono in grado di produrre energia metabolica all’interno di una cellula
3 Rispondi alle seguenti domande
11. Descrivi le fasi più importanti del meccanismo di trascrizione e traduzione del DNA, facendo riferimento alle proteine e agli enzimi coinvolti.
12. Descrivi i principali meccanismi di regolazione genica nei procarioti.
13. Quali sono le fasi del ciclo litico di un virus?
14. Che cosa si intende per elementi genetici mobili?
VERIFICHE SOMMATIVE DI FINE UNITÀ
Unità 6 • Dal DNA ricombinante alle biotecnologie
Nome e cognome
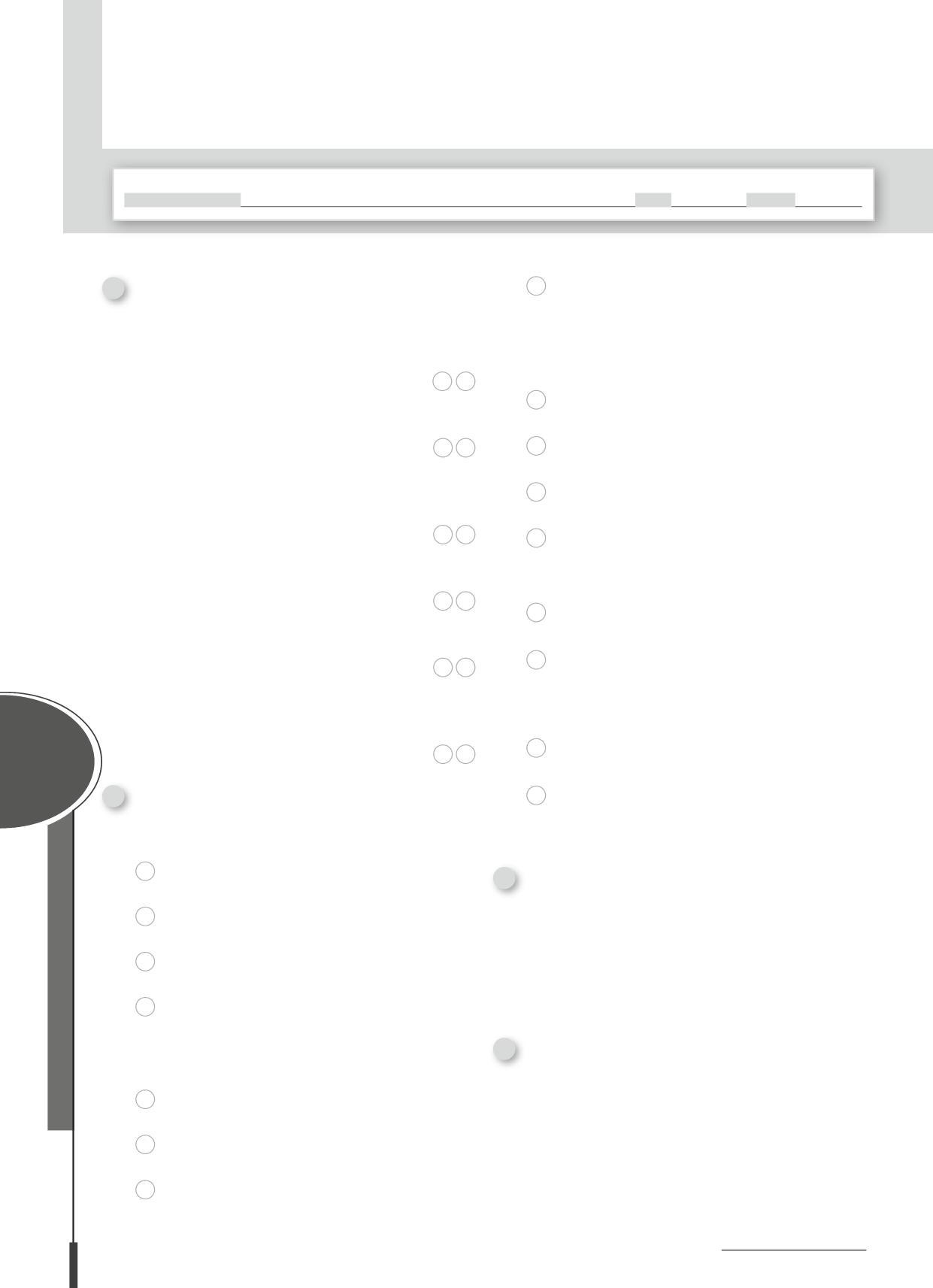
1 Indica se le seguenti affermazioni sono vere o false
1. Sfruttare l’azione dei lieviti per produrre pane e birra è un esempio di biotecnologia. V F
2. Nel clonaggio genico, ci si avvale dell’enzima DNA ligasi per saldare il plasmide al DNA nucleare della cellula ospite. V F
3. Si dice che un enzima di restrizione genera estremità asimmetriche quando taglia uno solo dei due filamenti di DNA.
F
4. Il sito di clonaggio multiplo è una porzione di DNA in cui possono essere inseriti una molteplicità di geni. V F
5. Durante l’estrazione del DNA vengono impiegati enzimi proteolitici allo scopo di degradare la componente proteica. V F
6. I didesossinucleotidi impiegati nel sequenziamento del DNA sono analoghi dei nucleotidi ma mancano del gruppo 3’-OH.
2 Indica con una crocetta la risposta corretta
7. Per biotecnologie si intendono:
V F
a) tutte le tecniche sperimentali utilizzate in biologia
b) tutte le tecniche utilizzate per lo studio della riproduzione sessuale
c) tutte le tecniche utilizzate per lo studio della riproduzione asessuale
d) tutte le tecniche che impiegano esseri viventi o sostanze da essi prodotte per sviluppare e produrre beni
8. Le librerie di cDNA:
a) contengono sequenze di DNA direttamente riconducibili al genoma di un organismo
b) sono raccolte di frammenti genici ospitate all’interno di una popolazione di batteri
c) rappresentano l’insieme dei vettori plasmidici adatti al clonaggio genico
Data Classe
d) sono composte da frammenti di DNA ottenuti per trascrizione inversa a partire da RNA messaggeri
9. Durante un ciclo di PCR si susseguono i seguenti step:
a) denaturazione, sintesi primer, amplificazione
b) denaturazione, appaiamento primer, amplificazione
c) denaturazione, appaiamento primer, allungamento filamenti parentali
d) sintesi primer, allungamento DNA stampo, denaturazione
10. La trascrittomica è la disciplina che si occupa:
a) dello studio della struttura, della composizione e dell’evoluzione dei genomi
b) dello studio dell’mRNA presente nella cellula, e cerca di comprendere i geni espressi in particolari condizioni o in particolari organismi
c) dello studio dell’influenza dei fattori ambientali sull’evoluzione del genoma
d) dello sviluppo di strumenti computazionali per risolvere problemi tipici della ricerca biologica
3 Rispondi alle seguenti domande
11. Quali sono e in cosa consistono le fasi sperimentali del clonaggio molecolare?
12. Quali sono e in cosa consistono le fasi sperimentali del sequenziamento genico?
13. Descrivi un approccio di terapia genica.
4 Risolvi i seguenti problemi
14. In un esperimento di elettroforesi su DNA, un frammento da 100 kb si sposta sulla piastra di gel di 4 cm. Quale sarà lo spazio percorso nello stesso tempo da un frammento di 1000 kb?
15. Partendo da 12 copie di un doppio filamento di DNA, quante copie si otterrebbero impiegando la tecnica della PCR per cinque cicli?
VERIFICHE SOMMATIVE DI FINE UNITÀ
Unità 6 • Dal DNA ricombinante alle biotecnologie
Nome e cognome
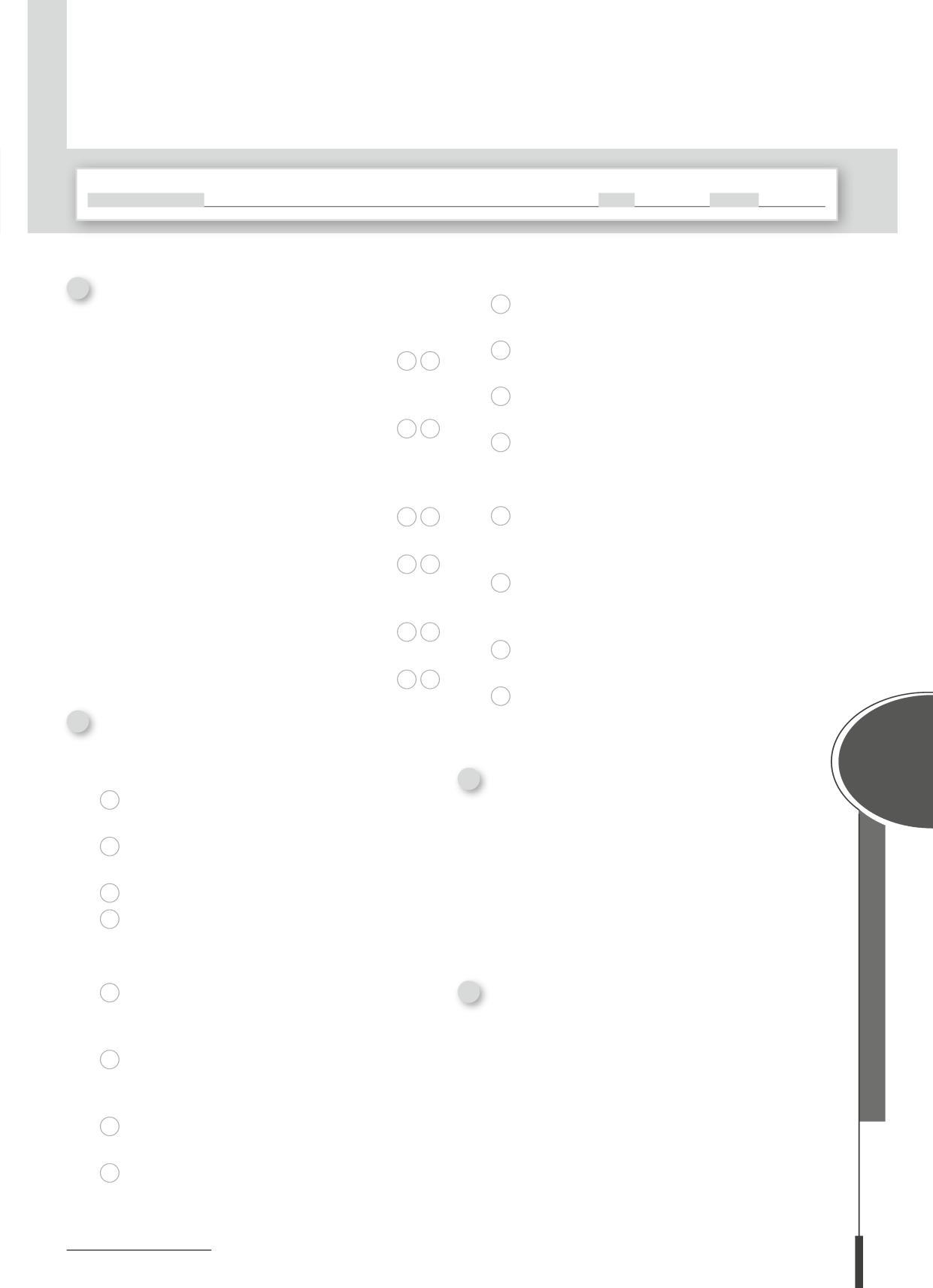
Fila B
Data Classe
9. La Taq polimerasi:
1 Indica se le seguenti affermazioni sono vere o false
1. Le biotecnologie moderne sono incentrate sulla salute umana. V F
2. Nel clonaggio genico, per tagliare l’inserto e il plasmide si scelgono due enzimi di restrizione compatibili. V F
3. Grazie al sito di origine della replicazione, un plasmide può replicarsi indipendentemente dal cromosoma batterico. V F
4. L’elettroforesi su gel può essere impiegata anche per separare le proteine. V F
5. Il DNA amplificato mediante PCR viene recuperato arrotolandolo intorno a uno stecchino di legno. V F
6. Il primo genoma a essere completamente sequenziato fu quello umano. V F
2 Indica con una crocetta la risposta corretta
7. I vettori di clonaggio plasmidico:
a) possono essere impiegati per il solo clonaggio di geni procariotici
b) consentono di clonare frammenti genici di dimensioni maggiori rispetto a quelli virali
c) vengono estratti dai batteri
d) sono la tipologia di vettore di clonaggio più comunemente impiegata
8. L’elettroforesi:
a) è una tecnica di separazione di molecole che si basa sulle differenti masse dei campioni analizzati
b) richiede l’utilizzo di soluzioni tampone che amplifichino la forza ionica dei campioni da analizzare
c) permette di separare tra loro i frammenti di DNA in base al loro rapporto carica/massa
d) richiede l’utilizzo di un gel di agarosio che funge da colorante per le varie bande di DNA
a) è un enzima estratto da un batterio termofilo e usato nella PCR
b) è il colorante che serve a visualizzare le bande di DNA nell’elettroforesi
c) è un enzima che interviene nella replicazione del DNA
d) è un marcatore usato nell’elettroforesi
10. La proteomica è la disciplina che si occupa dello studio:
a) dell’mRNA presente in cellula, e cerca di comprendere i geni espressi in particolari condizioni o in particolari organismi
b) del proteoma, ossia dell’insieme di tutte le proteine di una cellula, di un tessuto o di un intero organismo
c) della struttura, della composizione e dell’evoluzione dei genomi
d) delle caratteristiche delle proteine ricombinanti ricavabili mediante ingegneria genetica
3 Rispondi alle seguenti domande
11. In base a quali caratteristiche della tecnica della elettroforesi su gel è possibile separare molecole di DNA differenti?
12. Che cosa sono e di cosa si occupano le scienze omiche?
13. Quali sono le applicazioni in campo biomedico degli animali transgenici?
4 Risolvi i seguenti problemi
14. Un filamento di DNA di 700 pb (paia di basi) è digerito con un enzima di restrizione che possiede due siti di taglio al suo interno. I siti di taglio A e B sono disposti, rispettivamente, a 250 pb e 600 pb dall’estremità 5’. Disegna la mappa di restrizione e determina il numero e la dimensione dei relativi frammenti.
15. Quante copie si otterrebbero, a partire da dodici copie di un doppio filamento di DNA, impiegando la tecnica della PCR per cinque cicli?
VERIFICHE SOMMATIVE DI FINE UNITÀ
Unità 7 • La struttura interna della Terra Fila
A
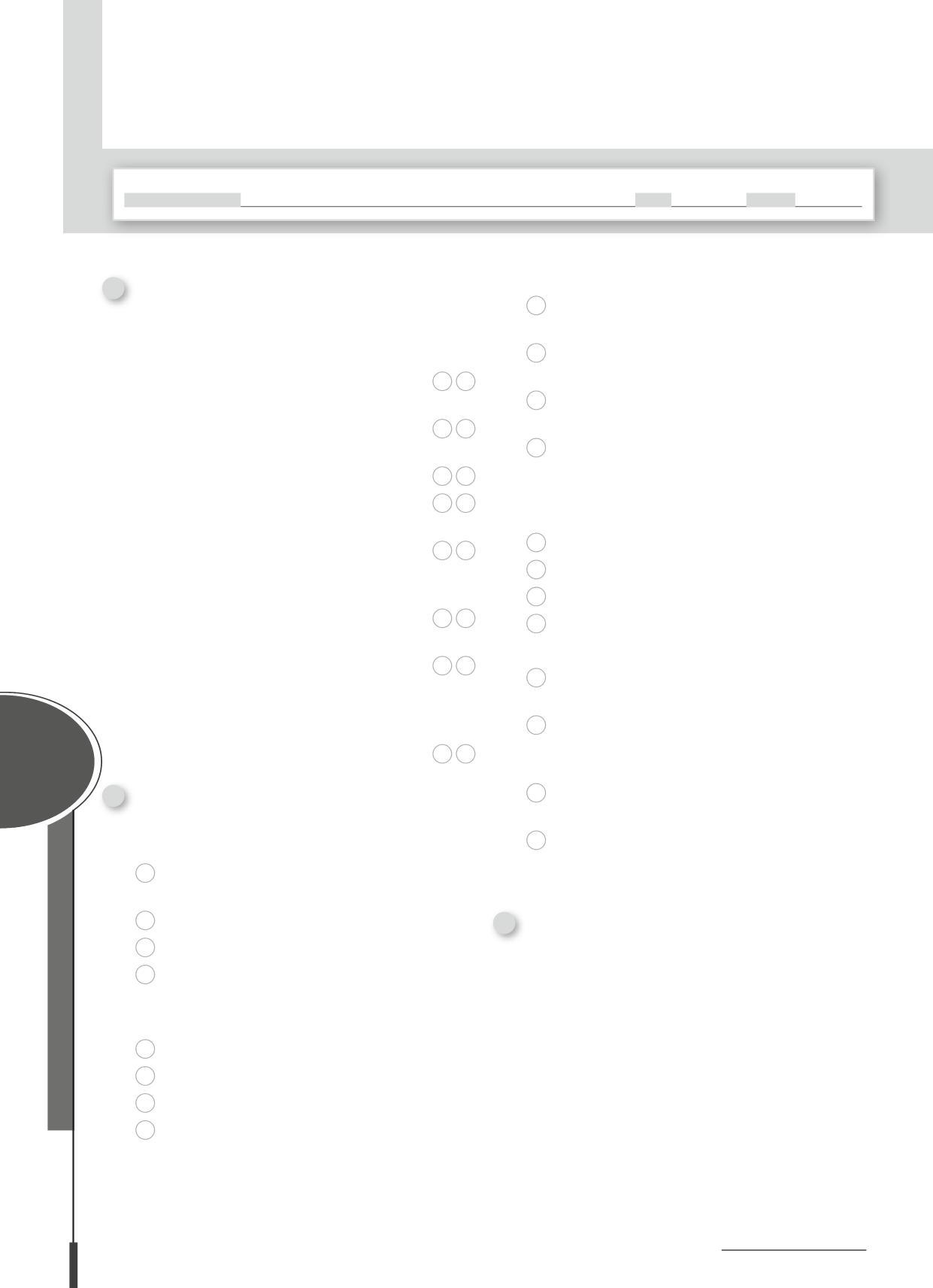
Nome e cognome
1 Indica se le seguenti affermazioni sono vere o false
1. Le rocce degli strati più superficiali della Terra hanno densità di circa 2,85 g/cm3
V F
2. L’epicentro è la proiezione dell’ipocentro sulla superficie terrestre. V F
3. La scala sismometrica ideata da Richter è divisa in 12 valori di intensità. V F
4. La litosfera si comporta in modo rigido. V F
5. Il gradiente geotermico è pari a circa 3 °C ogni 2000 m di profondità. V F
6. La geoterma è la curva che mette in relazione la temperatura con la viscosità.
V F
7. I Campi Flegrei sono localizzati all’interno di una vasta caldera. V F
8. L’intensità del campo magnetico esprime la forza esercitata su ogni punto della superficie terrestre e nell’atmosfera sovrastante.
V F
2 Indica con una crocetta la risposta corretta
9. Le rocce della parte più interna del pianeta:
a) sono più leggere rispetto a quelle che formano la crosta
b) sono ricche di alluminio, sodio e potassio
c) sono ricche di ferro, calcio e magnesio
d) si studiano attraverso i metodi di indagine diretta
10. Le onde P:
a) sono dette anche longitudinali
b) possono attraversare solo i liquidi
c) producono solo variazioni di forma
d) vibrano perpendicolarmente alla direzione di propagazione delle onde
Data Classe
11. La pericolosità sismica di un territorio:
a) è determinata sulla base della frequenza dei sismi e dell’energia che liberano
b) è la predisposizione delle costruzioni ad essere danneggiati dalle scosse simiche
c) è la combinazione dei fattori vulnerabilità ed esposizione
d) è determinata sulla base della maggiore o minore presenza di beni a rischio
12. Sono prodotti di eruzioni di magmi molto
acidi e viscosi:
a) colate di lava fluida
b) plateaux basaltici
c) vulcani a scudo
d) nubi ardenti
13. Nel campo magnetico terrestre:
a) il polo Nord magnetico coincide con il Nord geografico
b) le linee di forza del campo magnetico escono dall’emisfero Nord ed entrano nell’emisfero Sud
c) il Nord della bussola si orienta verso il polo di segno opposto
d) per definire esattamente il campo magnetico terrestre è sufficiente conoscere l’inclinazione magnetica
3 Rispondi alle seguenti domande
14. Che cos’è un sismografo?
15. Descrivi brevemente la struttura del nucleo terrestre.
16. Che cosa sono i moti convettivi?
17. In che modo è possibile determinare la posizione dell’epicentro di un sisma?
VERIFICHE SOMMATIVE DI FINE UNITÀ
Unità 7 • La struttura interna della Terra
Nome e cognome Data Classe
1 Indica se le seguenti affermazioni sono vere o false
1. La densità media della Terra risulta essere 5,52 g/cm3 V F
2. La scala Richter utilizza come unità di misura l’intensità dei sismi. V F
3. La discontinuità di Moho separa la crosta dal mantello. V F
4. L’astenosfera ha un comportamento di tipo plastico. V F
5. Il gradiente geotermico è circa 10 °C ogni 100 m di profondità. V F
6. La geoterma è la curva che mette in relazione la temperatura con la pressione. V F
7. Magmi basici danno origine a eruzioni effusive. V F
8. Il bradisismo è un fenomeno direttamente collegato al vulcanismo dell’area dei Campi Flegrei. V F
2 Indica con una crocetta la risposta corretta
9. Le rocce che formano la crosta:
a) sono più pesanti rispetto a quelle più interne
b) sono ricche di alluminio, sodio e potassio
c) sono ricche di ferro, calcio e magnesio
d) si studiano con metodi di indagine indiretti
10. Le onde S:
a) sono dette anche longitudinali
b) vibrano avanti e indietro nella stessa direzione di propagazione delle onde
c) producono modificazioni di volume e di forma nei materiali attraversati
d) vibrano perpendicolarmente alla direzione di propagazione delle onde
Fila B
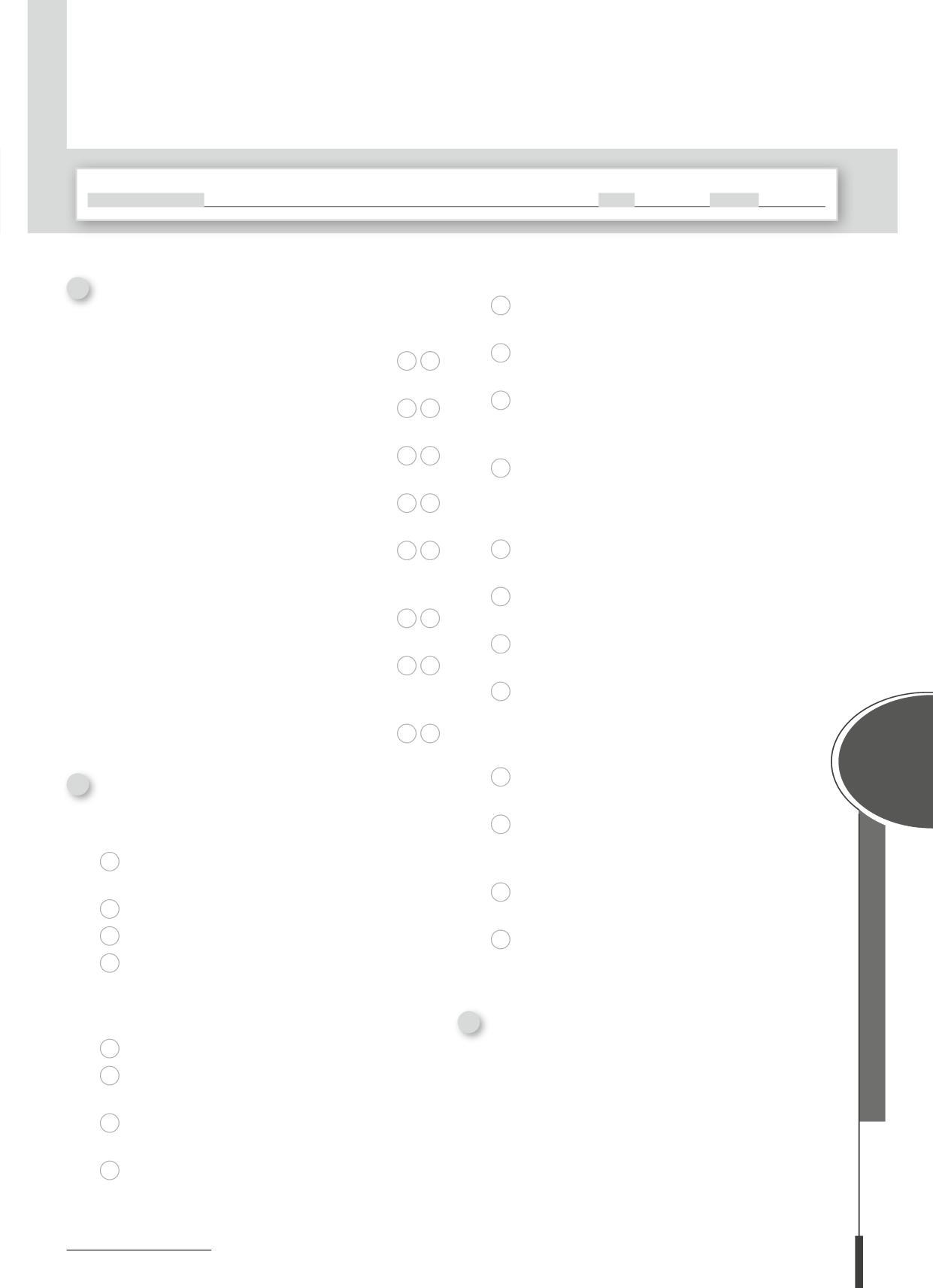
11. Il rischio sismico:
a) è determinato sulla base della frequenza dei sismi e dell’energia che liberano
b) è la predisposizione delle costruzioni ad essere danneggiati dalle scosse simiche
c) è determinato dalla combinazione di pericolosità sismica, vulnerabilità e dell’esposizione
d) è determinata sulla base della maggiore o minore presenza di beni a rischio
12. Le nubi ardenti:
a) sono fenomeni che accompagnano le eruzioni effusive
b) si formano quando i magmi sono poveri di silice
c) si formano quando i magmi molto basici e fluidi
d) sono fenomeni che accompagnano le eruzioni di magmi molto acidi e viscosi
13. Nel campo magnetico terrestre:
a) il polo Nord magnetico coincide con il Sud geografico e viceversa
b) le linee di forza del campo magnetico escono dall’emisfero Nord ed entrano nell’emisfero Sud
c) il Nord della bussola si orienta verso il polo Nord geografico
d) per definire esattamente il campo magnetico terrestre è sufficiente conoscere l’inclinazione magnetica
3 Rispondi alle seguenti domande
14. Che cos’è e a cosa serve un sismogramma?
15. Descrivi brevemente la struttura del mantello terrestre.
16. Quali sono i principali tipi di magmi?
17. Che cosa sono le dromocrone?
A cosa servono?
VERIFICHE SOMMATIVE DI FINE UNITÀ
Unità 8 • La dinamica terrestre Fila A
Nome e cognome
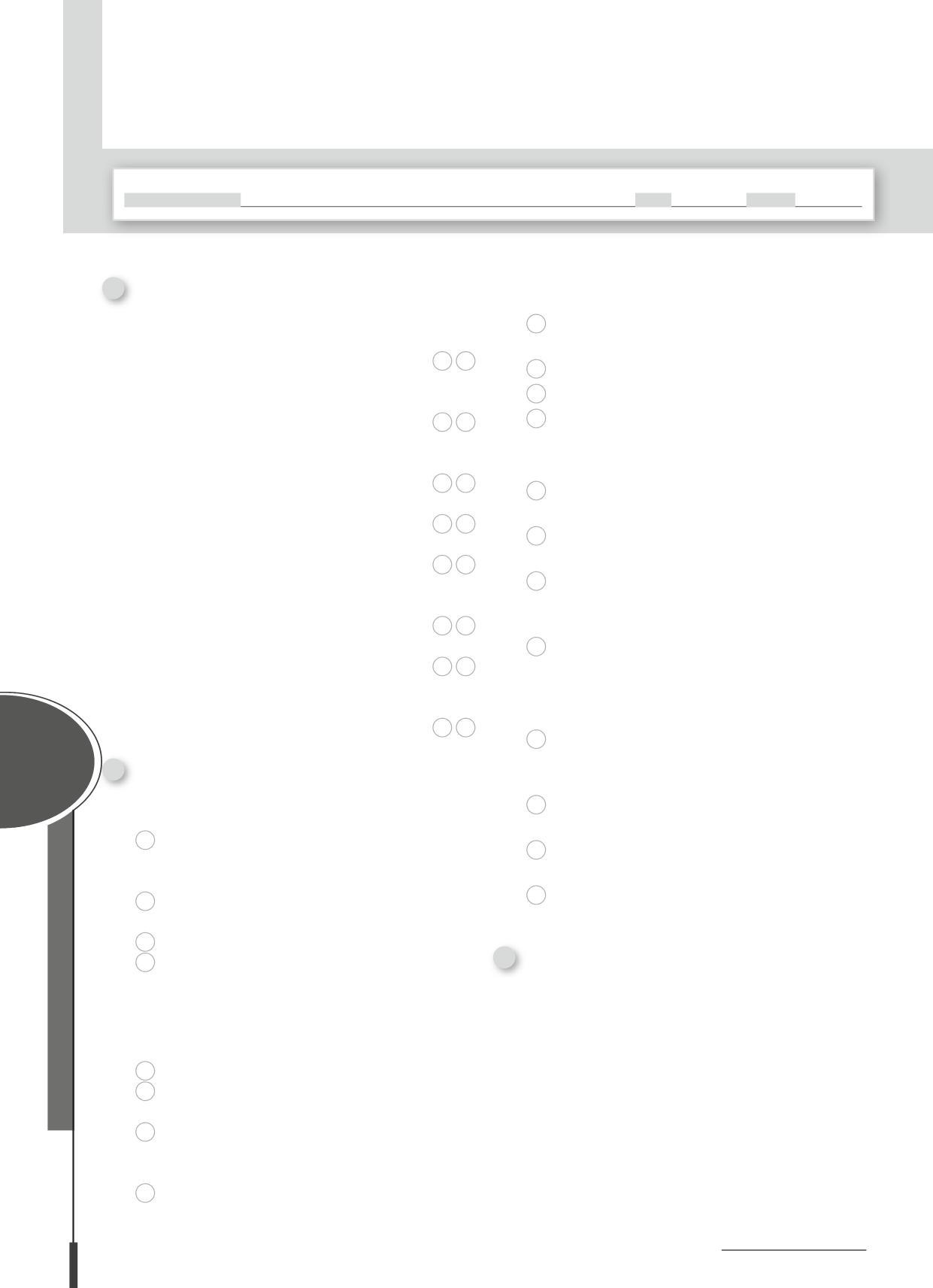
1
Indica se le seguenti affermazioni sono vere o false
1. La Tetide separava i continenti di Laurasia dal Gondwana. V F
2. La piattaforma continentale si estende fino 1000 m di profondità sotto le acque oceaniche. V F
3. I fenomeni sismici e vulcanici si localizzano in prevalenza lungo i margini delle placche litosferiche. V F
4. Il tetto è il blocco roccioso posto sopra il piano di faglia. V F
5. In una anticlinale la convessità è rivolta verso il basso. V F
6. L’orogenesi della catena andina è il risultato della collisione tra la placca di Nazca e quella sudamericana. V F
7. Lungo un margine conservativo non si verificano fenomeni sismici. V F
8. I punti caldi sono alimentati da lave che provengono da zone profonde del mantello. V F
2 Indica con una crocetta la risposta corretta
9. Il fenomeno dell’isostasia:
a) è stato identificato grazie alla registrazione delle anomalie gravitazionali
b) è determinato dal galleggiamento della crosta oceanica sul mantello
c) rimane costante nel tempo
d) è determinato dallo sprofondamento delle masse continentali nel nucleo esterno
10. La teoria dell’espansione dei fondali oceanici:
a) fu proposta dal geologo Herry H. Hess
b) ipotizza che il magma risalga lungo le fosse oceaniche
c) spiega perché lo spessore dei sedimenti diminuisca allontanandosi dalle dorsali oceaniche
d) ipotizza che i continenti galleggino sul mantello
Data Classe
11. Quale affermazione sulle placche litosferiche è falsa?
a) sono costituite sia da crosta continentale sia da crosta oceanica
b) sono per la maggior parte in movimento
c) hanno dimensioni variabili
d) sono circa 20
12. In corrispondenza della convergenza tra una placca oceanica e una continentale:
a) nessuna delle due placche riesce ad andare in subduzione
b) la placca continentale più densa affonda sotto a quella oceanica
c) si forma un arco vulcanico e una catena di vulcani allineati lungo il margine del continente
d) si verifica il sollevamento di una catena montuosa
13. Quale affermazione riguardante la catena alpino-himalayana è falsa?
a) iniziò il processo orogenetico circa 200 milioni di anni fa con la separazione della Pangea in due continenti
b) fu sollevata a causa della collisione tra Africa e India ed Europa e Asia
c) si concluse circa 7 milioni di anni con il sollevamento della catena appenninica
d) si formò per collisione di numerosi blocchi di accrezione
3 Rispondi alle seguenti domande
14. Quali furono le prove litologiche che Wegener portò in sostegno della teoria della deriva dei continenti?
15. Dove si trovano le faglie trasformi?
Quale disposizione presentano?
16. Quali informazioni fornisce la lettura della scala geomagnetica?
17. Che cosa sono le sequenze ofiolitiche?
Perché costituiscono un’importante prova del processo orogenetico?
VERIFICHE SOMMATIVE DI FINE UNITÀ
Unità 8 • La dinamica terrestre Fila B
Nome e cognome Data Classe
1 Indica se le seguenti affermazioni sono vere o false
1. Laurasia dal Gondwana erano i blocchi continentali che formavano la Panthalassa. V F
2. La piattaforma continentale si estende fino 200 m di profondità sotto le acque oceaniche. V F
3. I fenomeni sismici e vulcanici si localizzano in prevalenza all’interno delle placche litosferiche. V F
4. Il rigetto è il blocco roccioso posto sopra il piano di faglia. V F
5. In una anticlinale la convessità è rivolta verso l’alto. V F
6. L’orogenesi andina ha dato origine a due cordigliere. V F
7. Lungo un margine conservativo non si forma né si distrugge la crosta. V F
8. I punti caldi sono caratterizzati da eruzioni di lave profonde molto acide. V F
2 Indica con una crocetta la risposta corretta
9. Gli aggiustamenti isostatici:
a) sono movimenti verticali delle masse continentali
b) sono provocati dal galleggiamento della crosta oceanica sul mantello
c) non interessano la crosta oceanica
d) sono provocati dallo sprofondamento delle masse continentali nel nucleo esterno
10. La teoria dell’espansione dei fondali oceanici:
a) fu proposta dai geofisici Fred Vine e Drummond Matthews
b) ipotizza che il magma risalga in corrispondenza delle dorsali oceaniche
c) spiega perché lo spessore dei sedimenti diminuisca allontanandosi dalle dorsali oceaniche
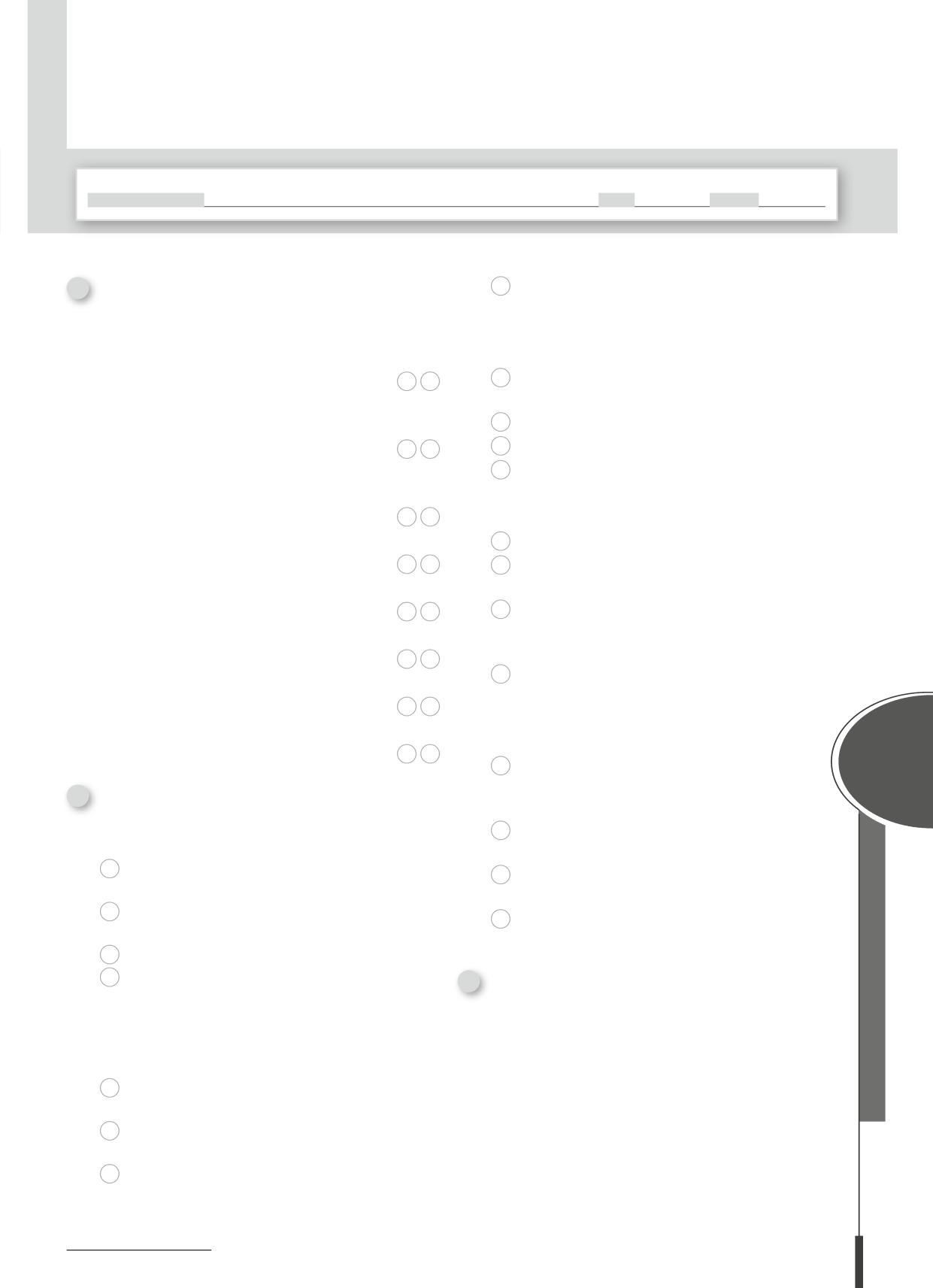
d) ipotizza che i continenti galleggino sul mantello
11. Quale affermazione sulle placche litosferiche è falsa?
a) sono costituite sia da crosta continentale sia da crosta oceanica
b) sono circa 12
c) hanno dimensioni variabili
d) si muovono sopra l’astenosfera
12. In corrispondenza della convergenza tra due placche oceaniche:
a) non si forma un piano di Benioff
b) la placca oceanica più vecchia e densa affonda sotto l’altra
c) si forma un arco vulcanico e una catena di vulcani allineati lungo il margine del continente
d) si verifica il sollevamento di una catena montuosa
13. Quale affermazione riguardante la catena alpino-himalayana è falsa?
a) iniziò il processo orogenetico circa 200 milioni di anni fa con la separazione della Pangea in due continenti
b) fu sollevata a causa della collisione tra Africa e India ed Europa e Asia
c) si concluse circa 45 milioni di anni con il sollevamento della catena alpina
d) è caratterizzata dalla presenza di sequenze ofiolitiche
3 Rispondi alle seguenti domande
14. Quali furono le prove paleontologiche che Wegener portò in sostegno della teoria della deriva dei continenti?
15. In corrispondenza di quali margini di placca si trovano le faglie trasformi?
16. Quali informazioni fornisce la lettura della scala delle polarità magnetiche?
17. Che cosa sono le sequenze ofiolitiche?
Perché costituiscono un’importante prova del processo orogenetico?
VERIFICHE SOMMATIVE DI FINE UNITÀ
Unità 9 • La dinamica dell’atmosfera
Nome e cognome
1 Indica se le seguenti affermazioni sono vere o false
1. L’aria secca è composta per circa il 78% di ossigeno. V F
2. Il gradiente termico verticale è pari a circa 0,6°C ogni 100 m di altezza. V F
3. Il tempo atmosferico descrive fenomeni che avvengono su tempi lunghi. V F
4. La pressione normale è pari a 101 325 Pa. V F
5. I monsoni sono venti locali periodici. V F
6. Le celle di Hadley si sviluppano alle latitudini tropicali. V F
7. I cicloni extratropicali si verificano alle basse latitudini. V F
8. Aumentare la copertura vegetale nello spazio urbano rappresenta un efficace intervento di mitigazione climatica. V F
2 Indica con una crocetta la risposta corretta
9. Nella troposfera:
a) si trova lo strato di ozono che protegge la Terra dalle radiazioni ultraviolette
b) hanno luogo le aurore polari
c) avvengono i fenomeni meteorologici
d) l’atmosfera sfuma nello spazio
10. L’insolazione:
a) è maggiore alle basse latitudini
b) è costante in tutto il globo
c) è maggiore alla alte latitudini
d) non incide sul bilancio termico del pianeta
11. Gli alisei:
a) spirano verso le aree cicloniche equatoriali
b) spirano verso le aree cicloniche subpolari
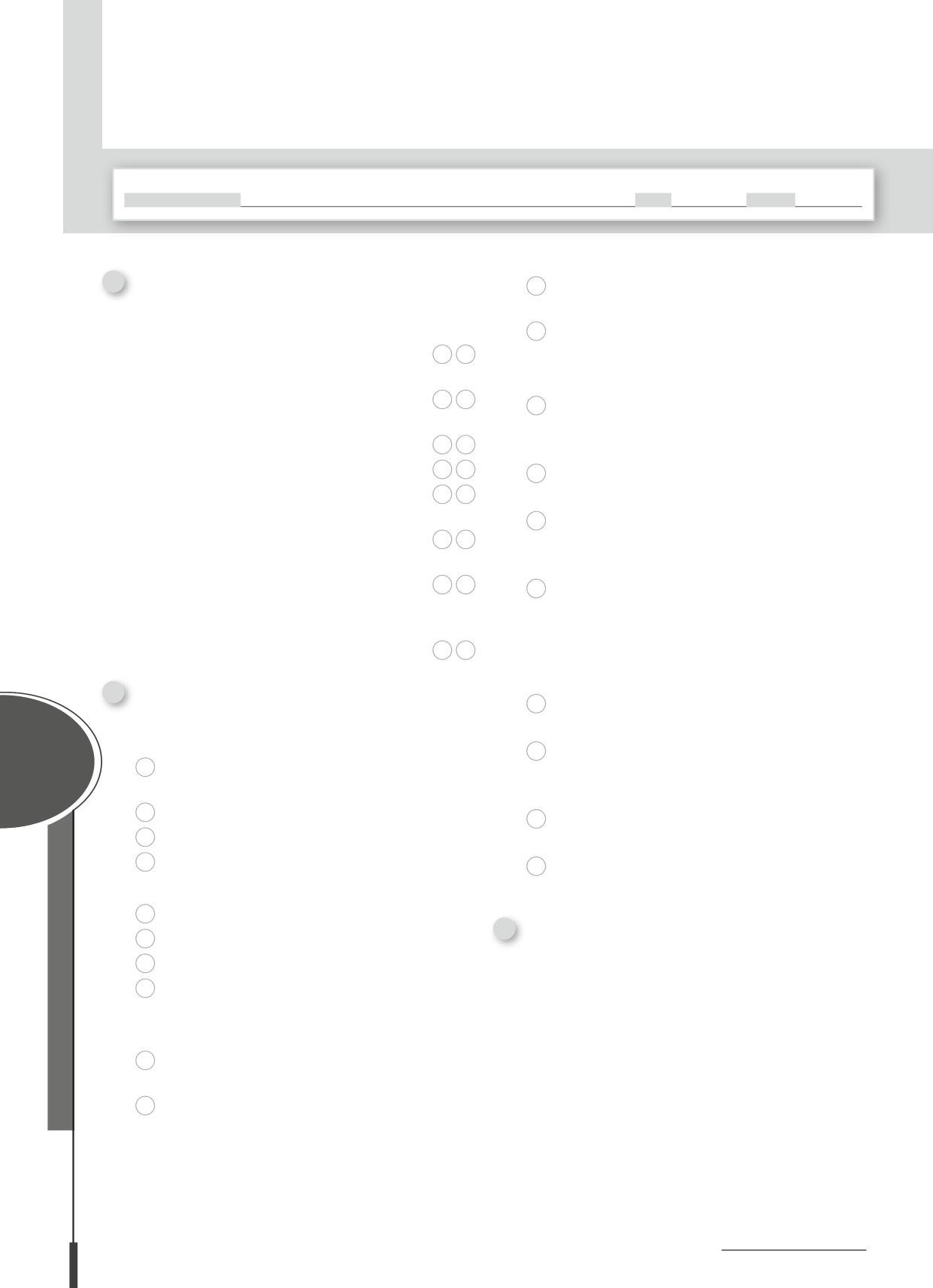
Data Classe
c) hanno origine dalle aree delle alte pressioni polari
d) si spostano dalle zone di bassa pressione verso le zone ad alta pressione
12. Scegli l’affermazione falsa:
a) gli aumenti delle concentrazioni di gas serra a partire dal 1750 sono causati dalle attività umane
b) il livello del mare si è abbassato di 0,20 m tra il 1901 e il 2018
c) molti cambiamenti dovuti alle emissioni, passate e future, di gas serra sono irreversibili per secoli o millenni
d) a partire dal 1970, la temperatura superficiale globale è aumentata più velocemente che in qualsiasi altro periodo di 50 anni degli ultimi 2000 anni
13. La mitigazione del clima:
a) è un processo di adeguamento al clima e ai suoi effetti
b) è un concetto ormai superato, che non rientra negli accordi più recenti in materia di clima
c) comprende tutte le azioni volte a ridurre la quantità di gas serra nell’atmosfera
d) produce effetti immediati sul clima del pianeta
3 Rispondi alle seguenti domande
14. Quali sono le conseguenze dell’effetto serra?
15. Come influisce l’altitudine sulla pressione atmosferica?
16. Qual è la differenza tra umidità assoluta e relativa?
17. Quali sono i fattori naturali che influenzano il clima della Terra?
VERIFICHE SOMMATIVE DI FINE UNITÀ
Unità 9 • La dinamica dell’atmosfera Fila B
Nome e cognome
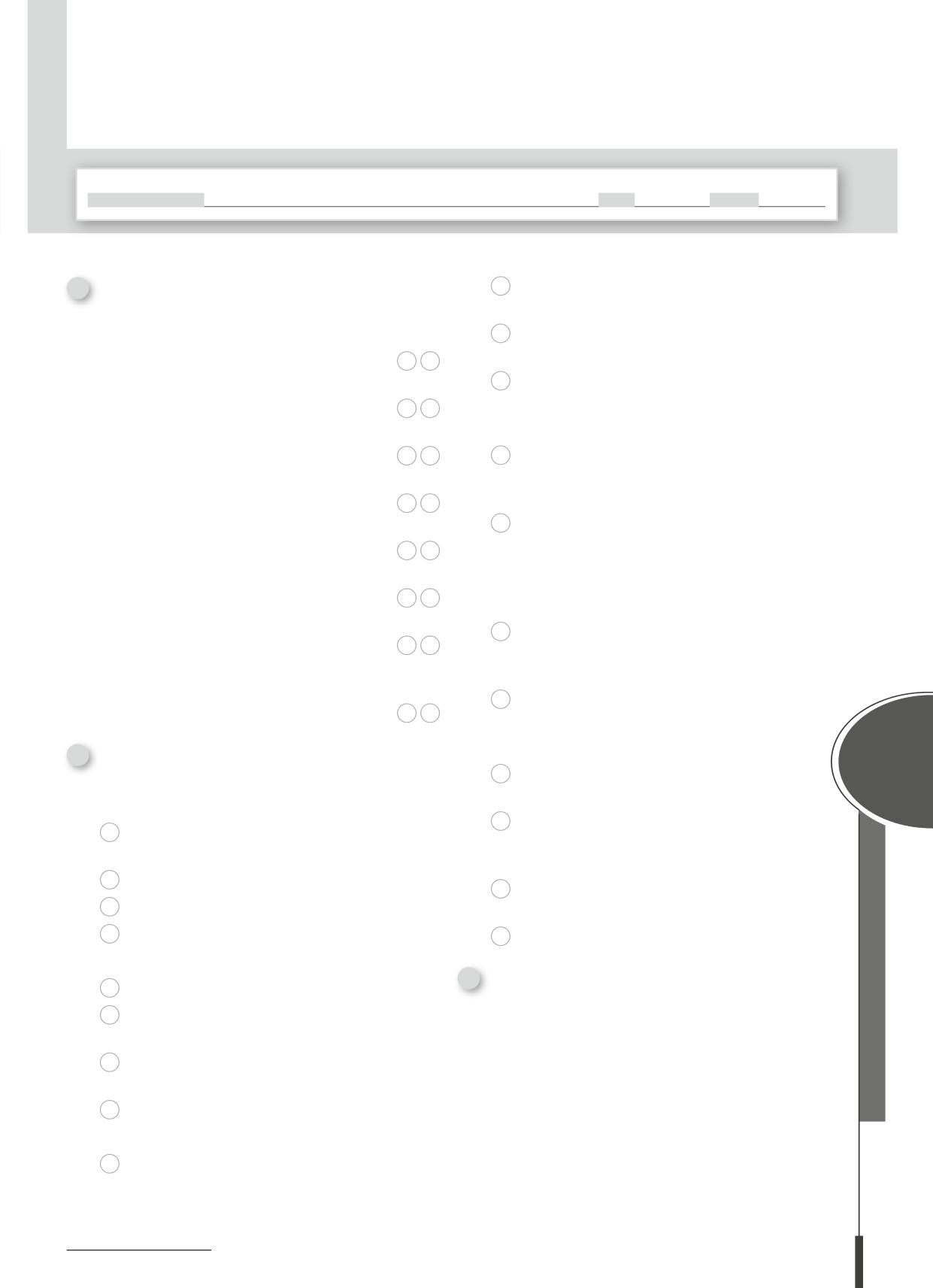
1 Indica se le seguenti affermazioni sono vere o false
1. L’aria secca è composta da circa il 78% di azoto molecolare. V F
2. Il gradiente termico verticale è pari a circa 6°C ogni 100 m di altezza. V F
3. Il tempo atmosferico descrive fenomeni che avvengono su tempi brevi. V F
4. La pressione normale è pari a 760 mmHg. V F
5. Le brezze di mare sono venti regionali variabili. V F
6. Le celle di Ferrel si sviluppano alle medie latitudini. V F
7. I cicloni tropicali sono perturbazioni che riguardano le basse latitudini. V F
8. Le aree urbane risentono maggiormente delle conseguenze del cambiamento climatico. V F
2 Indica con una crocetta la risposta corretta
9. Nella termosfera:
a) si trova lo strato di ozono che protegge la Terra dalle radiazioni ultraviolette
b) hanno luogo le aurore polari
c) avvengono i fenomeni meteorologici
d) l’atmosfera sfuma nello spazio
10. Il calore emesso dalla Terra:
a) è omogeneo in tutto il globo terrestre
b) non risente né delle correnti marine né dei movimenti delle masse d’aria
c) dipende dalla distribuzione delle terre emerse e dei mari
d) non influenza il bilancio termico della Terra
11. I venti:
a) sono flussi prevalentemente verticali di masse d’aria
Data Classe
b) si spostano dalle zone di bassa pressione verso quelle di alta pressione
c) evidenziano che l’interno della Terra è omogeneo
d) si muovono con una velocità che dipende dal gradiente di pressione
12. Scegli l’affermazione falsa:
a) negli ultimi 100 anni, l’oceano si è riscaldato più velocemente che dalla fine dell’ultima glaciazione
b) a partire dal 1970, la temperatura superficiale globale ha avuto un decremento più rapido che in qualsiasi altro periodo di 50 anni degli ultimi 2000 anni
c) negli ultimi 100 anni, il livello medio del mare è aumentato più rapidamente che in ogni secolo precedente
d) nel periodo 2011-2020, la massa dello strato di ghiaccio è diminuita
13. La strategia dell’adattamento:
a) è un processo di adeguamento al clima e ai suoi effetti
b) è un concetto ormai superato, che non rientra negli accordi più recenti in materia di clima
c) comprende tutte le azioni volte a ridurre la quantità di gas serra nell’atmosfera
d) può produrre effetti solo a lungo termine
3 Rispondi alle seguenti domande
14. Che cos’è l’effetto serra?
15. Come influiscono temperatura e umidità sulla pressione atmosferica?
16. Come si forma la rugiada?
17. Quali sono i processi di feedback oggetto degli studi dei climatologi che si occupano di cambiamento climatico?
VERIFICHE SOMMATIVE DI FINE UNITÀ
Unità 10 • Le scienze per la sostenibilità
Nome e cognome
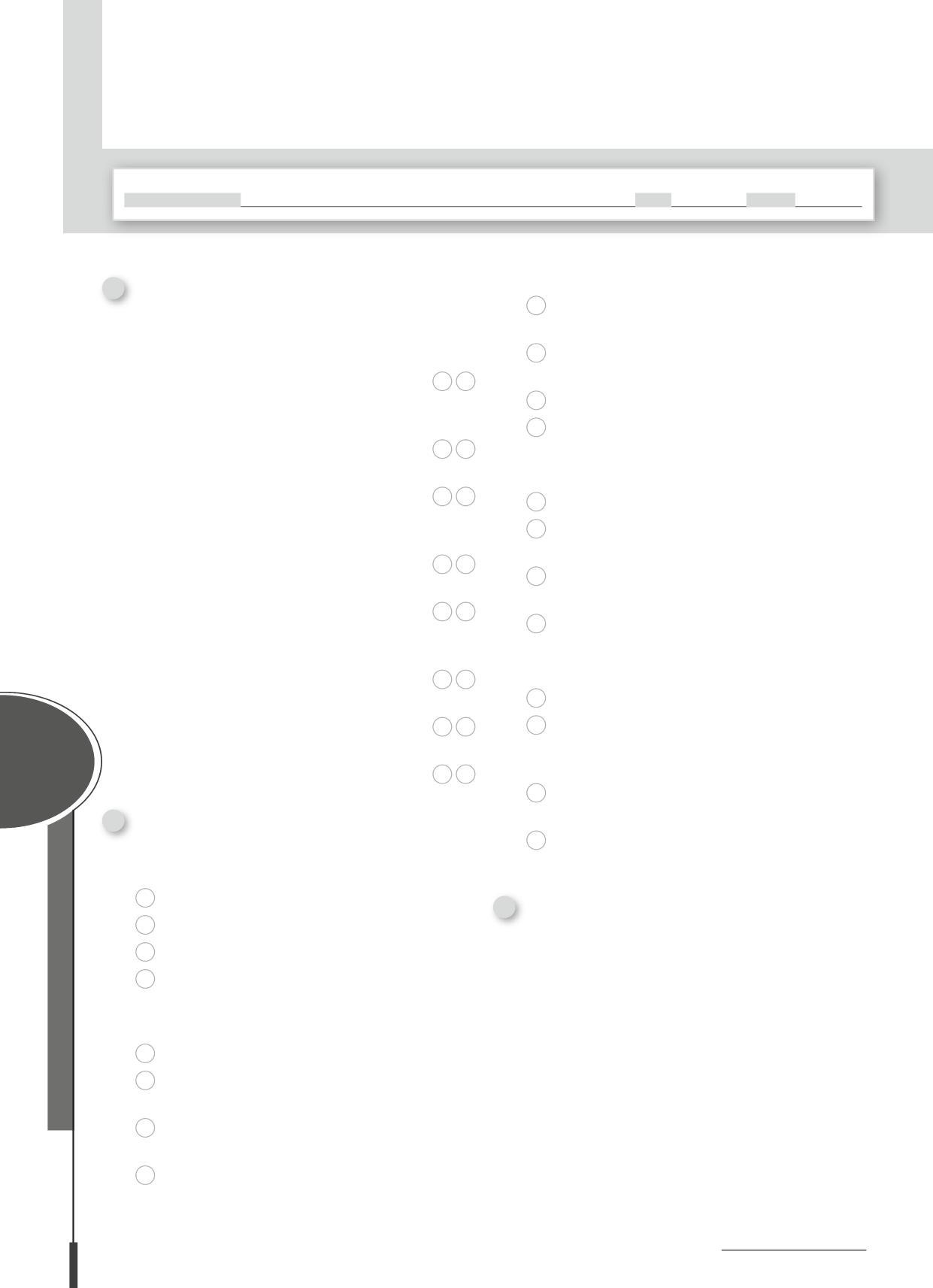
1 Indica se le seguenti affermazioni sono vere o false
1. Diversamente da ogni altra epoca della storia della Terra, l’Antropocene non ha ancora una data di inizio ufficiale. V F
2. La scala cronostratigrafica ricostruisce la storia della Terra e conserva i segni degli eventi geologici avvenuti nel passato. V F
3. I combustibili fossili soddisfano oggi circa il 40% del fabbisogno di energia. V F
4. La formazione dei depositi di combustibili fossili sarebbe avvenuta in periodi più caldi di quello attuale. V F
5. L’energia nucleare proviene dalla rottura di un legame chimico. V F
6. L’energia geotermica ha origine dal calore interno della Terra e dalla circolazione delle acque calde sotterranee. V F
7. La Cina è il primo produttore al mondo di terre rare. V F
8. Gli obiettivi dell’Agenda 2030 riguardano solo l’eliminazione della povertà. V F
2 Indica con una crocetta la risposta corretta
9. Le fonti di energia non rinnovabili:
a) hanno un basso rapporto energia/volume
b) sono difficili da trasportare e stoccare
c) hanno un costo relativamente basso
d) sono in grado di rigenerarsi in tempi brevi
10. La fusione nucleare:
a) è lo stesso processo che si verifica nel Sole
b) non necessita di temperature troppo elevate
c) da un punto di vista ecologico, risulta meno vantaggiosa rispetto alla fissione
d) è una tecnologia che si studia solo dagli anni 2000
Data Classe
11. L’energia da biomasse:
a) si può produrre solo per combustione diretta
b) non aumenta il livello di diossido di carbonio in atmosfera
c) si produce a partire da resti inorganici
d) copre una percentuale piccolissima del fabbisogno nazionale, sotto all’1%
12. Le terre rare:
a) sono sempre più richieste dal mercato
b) si trovano soprattutto in Europa e in Giappone
c) sono legate a settori tradizionali dell’economia
d) sono diffuse in tutto il mondo, con alte concentrazioni in tutte le rocce
13. L’economia circolare:
a) prevede la crescita illimitata dei prodotti
b) si occupa delle attività volte alla manutenzione e al riuso di beni di consumo già esistenti
c) richiede materie prime ed energia in ogni tappa dei processi di produzione
d) prevede che ogni bene di consumo passi direttamente “dalla culla alla tomba”
3 Rispondi alle seguenti domande
14. Come si sono formati i carboni fossili?
15. Descrivi i metodi di sfruttamento dell’energia idroelettrica.
16. Che cosa si intende per “sviluppo sostenibile”?
17. Quali sono i risultati più importanti della COP 26?
Unità
VERIFICHE SOMMATIVE DI FINE UNITÀ
10 • Le scienze per la sostenibilità
Nome e cognome
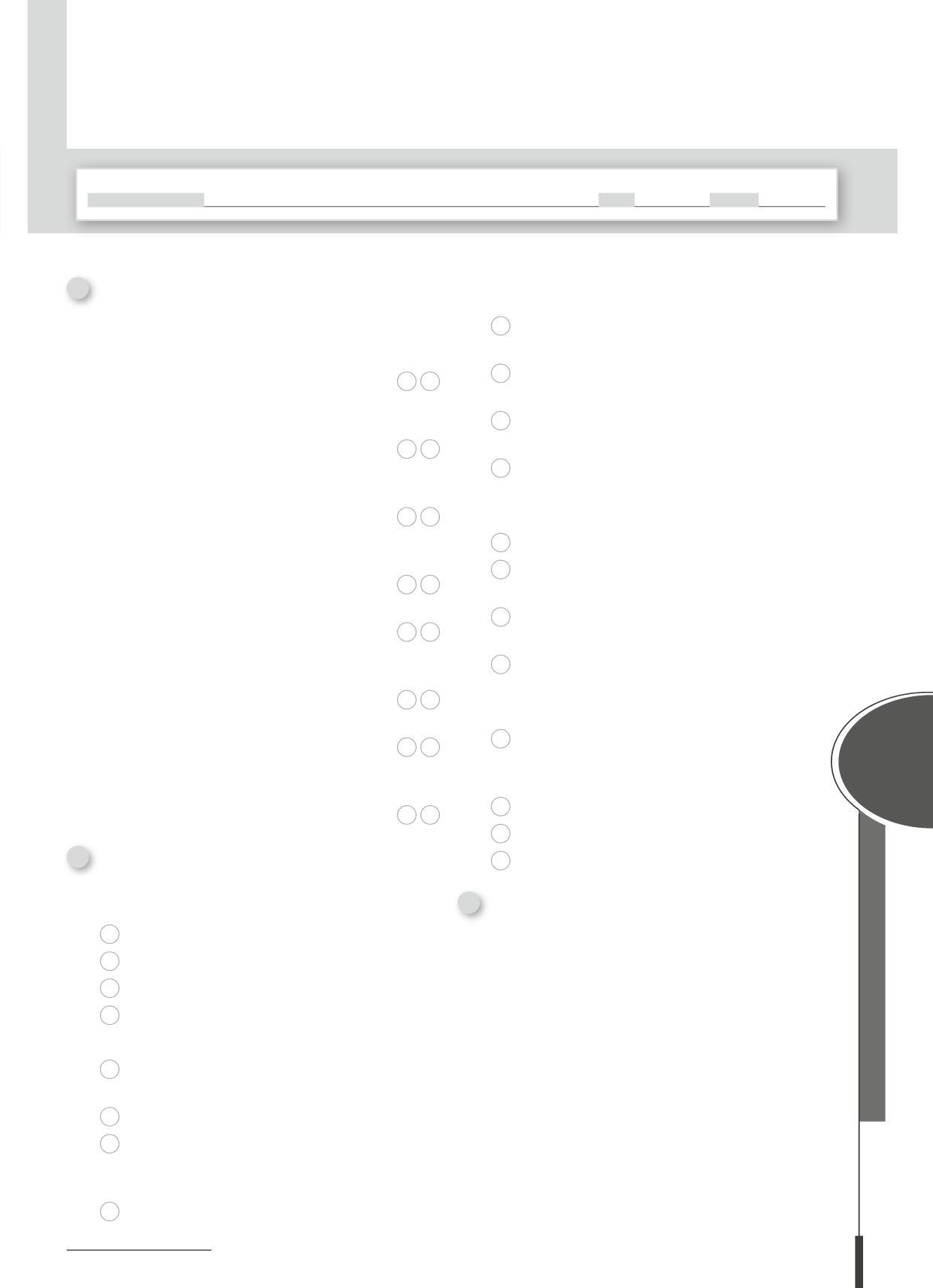
1 Indica se le seguenti affermazioni sono vere o false
1. L’Antropocene è collegato alle modificazioni della composizione dell’atmosfera indotte dalle attività umane. V F
2. A partire dal 1958, la curva di Keeling ha mostrato un costante aumento della concentrazione di diossido di carbonio. V F
3. I combustibili fossili derivano da resti di animali e piante accumulatesi qualche secolo fa. V F
4. I più grandi depositi di combustibili fossili si sono formati negli stessi periodi di tempo in tutti i continenti. V F
5. L’energia nucleare rientra tra le energie non rinnovabili. V F
6. L’energia geotermica può essere utilizzata direttamente oppure può essere sfruttata per produrre energia elettrica. V F
7. La Cina è il secondo produttore al mondo di terre rare. V F
8. In seguito alla pandemia da COVID-19, l’ONU non ha modificato i 17 obiettivi dell’Agenda 2030. V F
2 Indica con una crocetta la risposta corretta
9. Le fonti di energia non rinnovabili:
a) hanno un alto rapporto energia/volume
b) sono difficili da trasportare e stoccare
c) hanno un costo relativamente alto
d) sono in grado di rigenerarsi in tempi brevi
10. La fissione nucleare:
a) è considerata, tra le non rinnovabili, l’energia a più alto impatto ambientale
b) produce gas responsabili dell’effetto serra
c) non presenta particolari problemi ambientali legati ai processi di lavorazione
d) prevede la rottura di nuclei di uranio-235
Data Classe
Fila B
11. Scegli l’affermazione falsa riguardo l’energia a biomasse:
a) aumenta il livello di gas serra in atmosfera
b) è prodotta a partire dai residui delle coltivazioni
c) si può produrre anche attraverso le fermentazione controllata delle biomasse
d) può utilizzare anche resti di animali, immondizia, scarichi fognari
12. Le terre rare:
a) sono sempre meno richieste dal mercato
b) si trovano soprattutto in Europa e negli Stati Uniti
c) sono indispensabili per i settori high tech e green
d) sono diffuse in tutto il mondo, con alte concentrazioni in tutte le rocce
13. L’economia lineare:
a) si occupa delle attività volte alla manutenzione e al riuso di beni di consumo già esistenti
b) pensa al recupero delle materie prime
c) prevede l’utilizzo di materie seconde
d) prevede la crescita illimitata dei prodotti
3 Rispondi alle seguenti domande
14. Come si formano gli idrocarburi?
15. Descrivi i metodi di sfruttamento dell’energia solare.
16. Che cos’è l’Agenda 2030?
17. Descrivi il modello di economia circolare.
VERIFICHE SEMPLIFICATE
Unità
1 • Il carbonio e gli idrocarburi
Nome e cognome
1. Indica se le seguenti affermazioni sono vere o false
1. La formula generale degli alcheni è Cn H2n . V F
2. L’atomo di carbonio tende a cedere i suoi elettroni a un altro atomo di carbonio. V F
3. Negli alcani, 1 carbonio terziario può legarsi solo ad altri 3 atomi con legami sigma. V F
4. Negli alcheni, gli orbitali sp2 si dispongono a 120 gradi per ridurre la repulsione reciproca. V F
5. Negli alcani, 1 carbonio secondario può legarsi ad altri atomi con 4 legami sigma. V F
2. Indica con una crocetta la risposta corretta
6. Il cis-1,2-dietilciclopentano e il trans-1,2-dietilciclopentano
sono:
a. isomeri costituzionali
b. diastereoisomeri
c. isomeri geometrici
d. cicloalcheni
7. Gli stereoisomeri:
a. hanno la stessa formula molecolare
b. hanno la stessa formula molecolare e le stesse connessioni tra gli atomi
c. hanno la stessa formula molecolare e le stesse
Data Classe
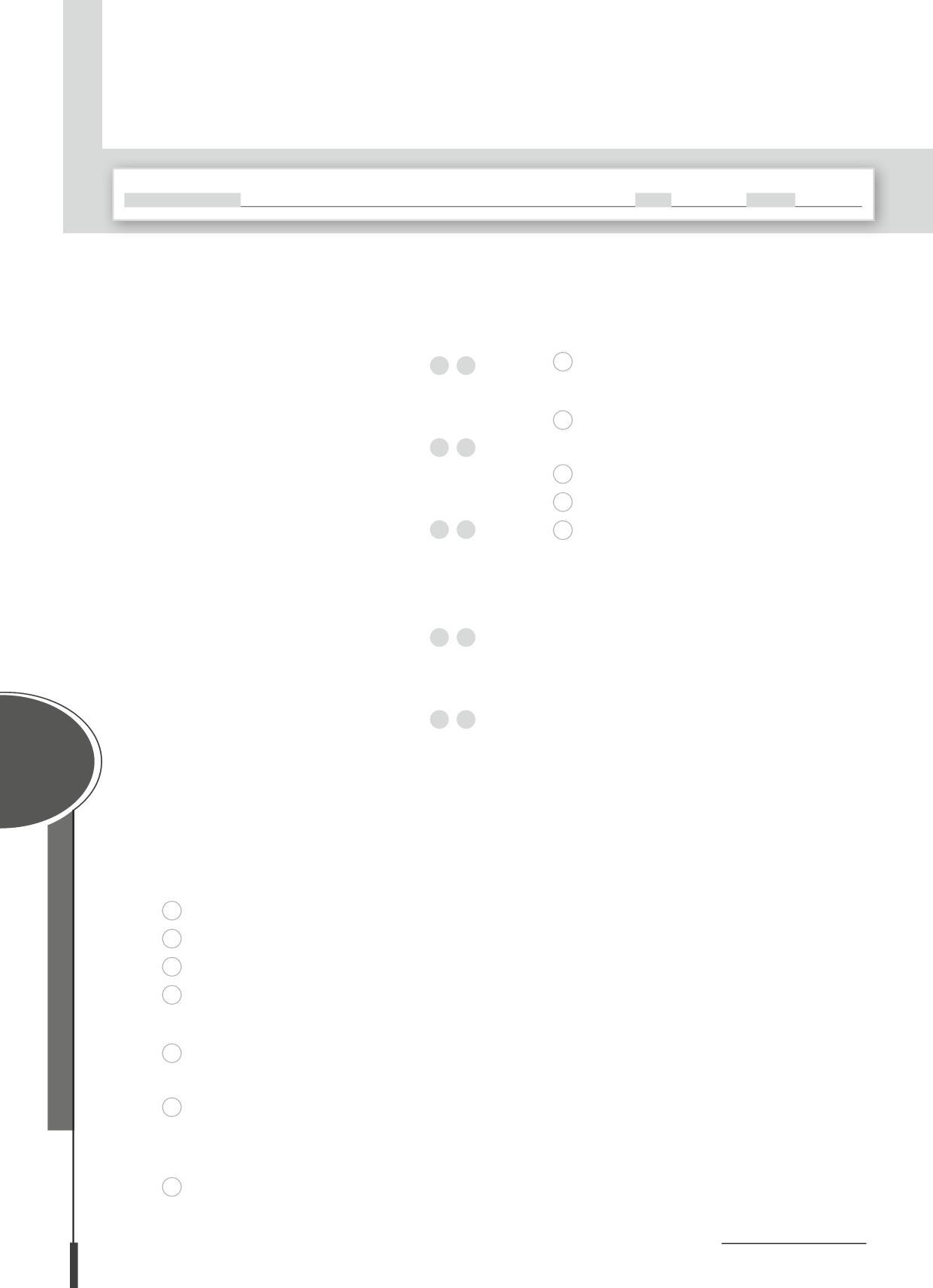
connessioni tra gli atomi, ma gli atomi sono disposti in maniera diversa nello spazio
d. sono molecole achirali
8. I diastereoisomeri sono:
a. due stereoisomeri speculari l’uno all’altro
b. molecole senza centri chirali
c. isomeri costituzionali
d. molecole con molti centri chirali
3. Completa le frasi scegliendo i termini corretti tra quelli proposti sotto
9. Gli devono essere considerati 2 composti .
10. In base agli angoli di legame, le molecole dei cicloalcani hanno diversa .
11. L’attività ottica di due enantiomeri fa ruotare il piano della verso destra o verso sinistra.
12. La descrive la posizione degli elettroni dentro una struttura molecolare.
13. Negli alchini, gli atomi di carbonio che formano il possiedono due orbitali p con un elettrone ciascuno. isomeri geometrici – tensione angolare – triplo legame – risonanza – luce polarizzata – diversi
VERIFICHE SEMPLIFICATE
Unità
2 • I derivati degli idrocarburi e i polimeri
Nome e cognome Data Classe
1. Indica se le seguenti affermazioni sono vere o false
1. Il 2-cloropropano è un alogenuro secondario.
V F
2. L’anilina è una ammina il cui il gruppo amminico è legato a un atomo di carbonio appartenente a un anello aromatico. V F
3. Gli eteri possono essere considerati derivati dall’acqua, per sostituzione di uno solo degli atomi di idrogeno con un gruppo alchilico o arilico.
4. Il furano è un eterociclo esatomico.
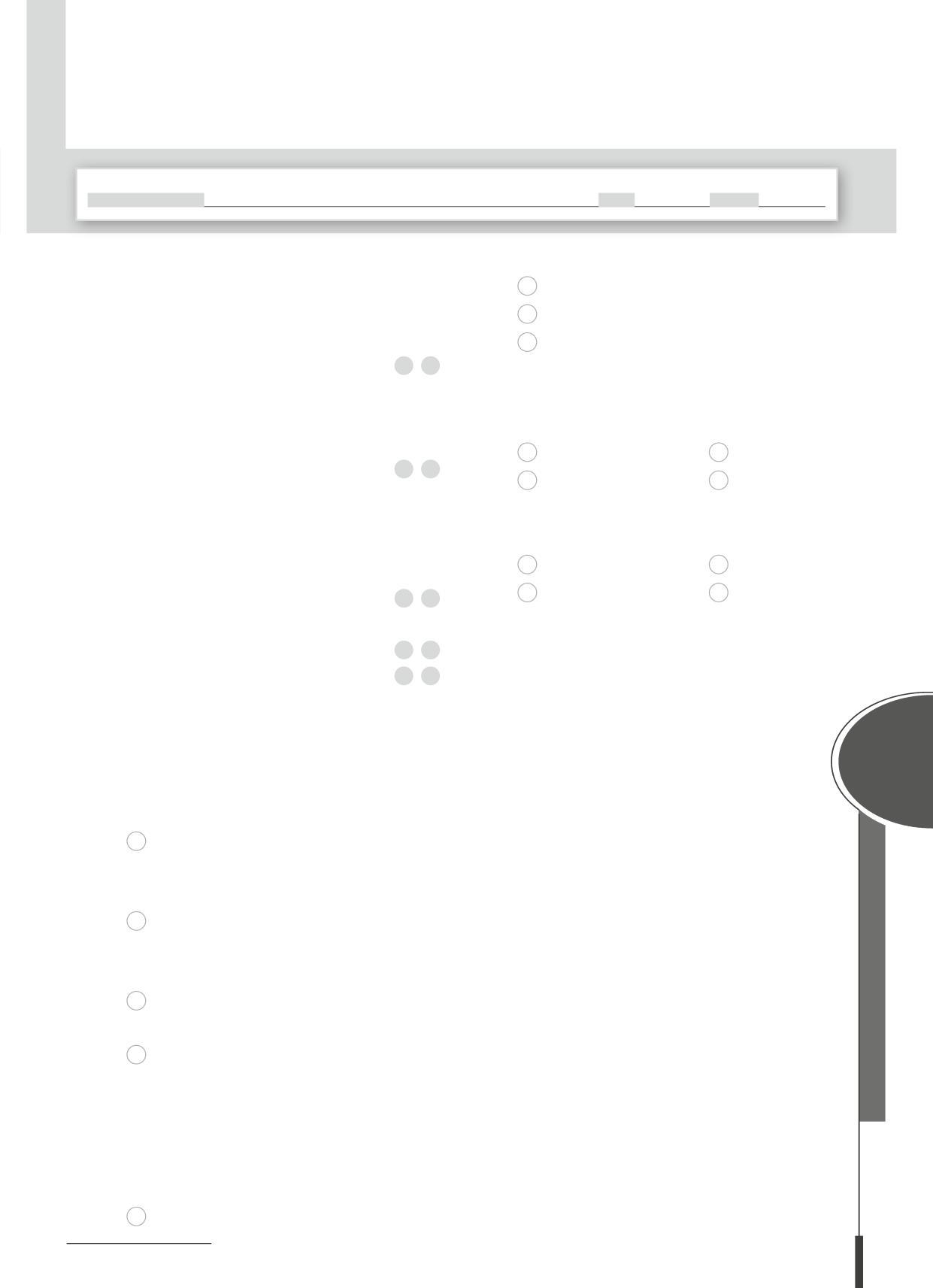
V F
V F
5. Il nylon 6,6 è un omopolimero. V F
2. Indica con una crocetta la risposta corretta
6. Qual è la differenza principale tra aldeidi e chetoni?
a. Le aldeidi hanno il gruppo carbonilico legato a due gruppi alchilici
b. Le aldeidi hanno almeno un atomo di idrogeno legato al carbonio carbonilico
c. I chetoni hanno il gruppo carbonilico terminale
d. I chetoni hanno il gruppo carbonilico legato a un solo atomo di idrogeno
7. Come si chiama il carbonio che è parte del gruppo funzionale COOH negli acidi carbossilici?
a. Carbonio alfa
b. Carbonio acido
c. Carbonio carbonilico
d. Carbonio carbossilico
8. Quale tra le seguenti classi di composti non è un derivato di un acido carbossilico?
a. Ammidi
b. Anidridi c. Esteri d. Eteri
9. La gomma naturale è costituita perlopiù da:
a. isoprene
b. silicone c. zolfo d. polisolfuri
3. Completa le frasi scegliendo i termini corretti tra quelli proposti sotto
10. Metanolo, etanolo e propanolo hanno in comune il gruppo .
11. Il nome degli si ottiene sostituendo la desinenza -o dell’idrocarburo con il suffisso -oico e premettendo la parola ............................... .
12. Gli ............................... sono composti in cui un atomo di ossigeno è inserito in un anello ciclico.
13. Le reazioni di si verificano quando un legame all’interno di una molecola è spezzato dall’aggiunta di una molecola d’acqua; la reazione opposta è la . ossidrile – acido – epossidi – idrolisi – alcoli – condensazioneacidi –carbossilici
VERIFICHE SEMPLIFICATE
Unità 3 • Le biomolecole
Nome e cognome
1. Indica se le seguenti affermazioni sono vere o false
1. Il saccarosio deriva dall’unione tra una molecola di α-D-glucosio e una di β-D-fruttosio. V F
2. I fosfolipidi sono componenti ideali per la formazione di membrane cellulari. V F
3. I fosfolipidi sono molecole strettamente lipofile. V F
4. I due filamenti che formano la molecola di DNA sono legati con legami a ponte di idrogeno. V F
5. Il ribosio è alla base della molecola dell’RNA. V F
2. Indica con una crocetta la risposta corretta
6. Le quattro classi di biomolecole sono:
a. le aldeidi, i lipidi, le proteine e gli acidi nucleici
b. i carboidrati, i lipidi, le proteine e i minerali
c. i carboidrati, i lipidi, le proteine e gli acidi nucleici
d. i carboidrati, le vitamine, le proteine e i lipidi
7. Gli amminoacidi basici sono:
a. lisina, arginina, istidina
b. lisina, alanina, glicina
c. lisina, arginina, asparagina
d. lisina, arginina, alanina
8. La citosina è:
a. un amminoacido apolare
b. una base purinica
c. una base pirimidinica
d. un amminoacido polare
Data Classe
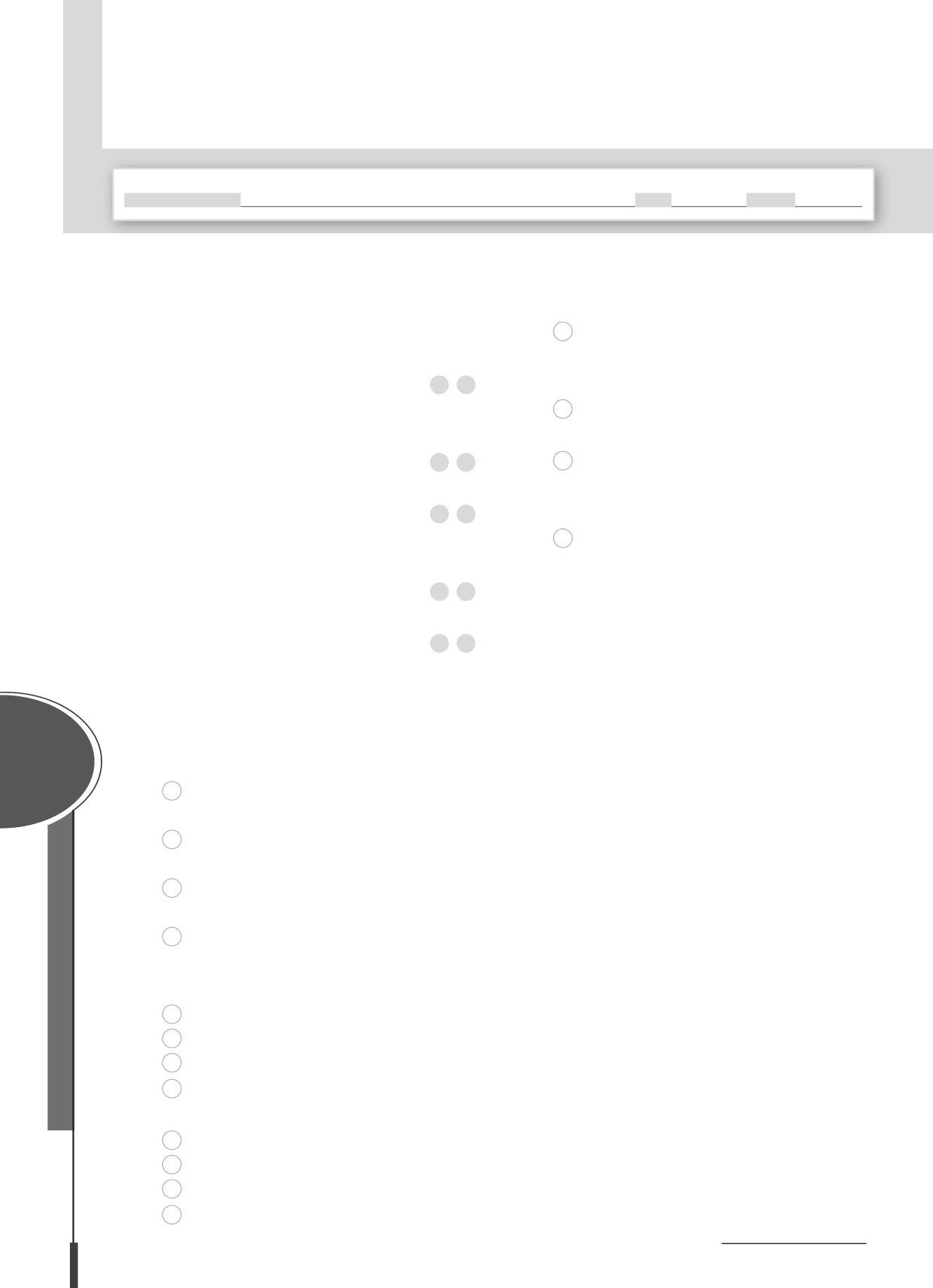
9. La struttura secondaria delle proteine dipende:
a. dalla presenza di legami idrogeno tra i vari residui amminoacidici
b. dalle sequenze ordinate degli amminoacidi che la formano
c. dalla presenza di gruppi amminici nella catena polipeptidica
d. dalla presenza di ponti dicloruro
3. Completa le frasi scegliendo i termini corretti tra quelli proposti sotto
10. I ................................ sono composti organici ternari, cioè formati da tre elementi: carbonio, idrogeno e ossigeno
11. L’amilosio e l’ (i due polimeri dell’amido) sono diversi perché l’amilosio è , mentre l’amilopectina è ramificata.
12. I sono messaggeri chimici per la comunicazione e la regolazione cellulare.
13. I carboidrati sono classificati in monosaccaridi, ................................ e polisaccaridi.
14. In base alla ................................ di Fischer, gli OH legati agli altri atomi di carbonio posso essere scritti a destra o a sinistra della catena. lipidi – ossigeno – carboidrati –proiezione – lineare – oligosaccaridi –amilopectina
VERIFICHE SEMPLIFICATE
Unità 4 • Il metabolismo
e la fotosintesi
Nome e cognome Data Classe
1. Indica se le seguenti affermazioni sono vere o false
1. Le molecole complesse sono sintetizzate tramite l’anabolismo.
2. Per svolgere la propria funzione catalitica, l’enzima si lega a una molecola di substrato tramite legami covalenti.
3. L’acido lattico prodotto nella muscolatura scheletrica deriva dall’ossidazione del piruvato con O2
V F
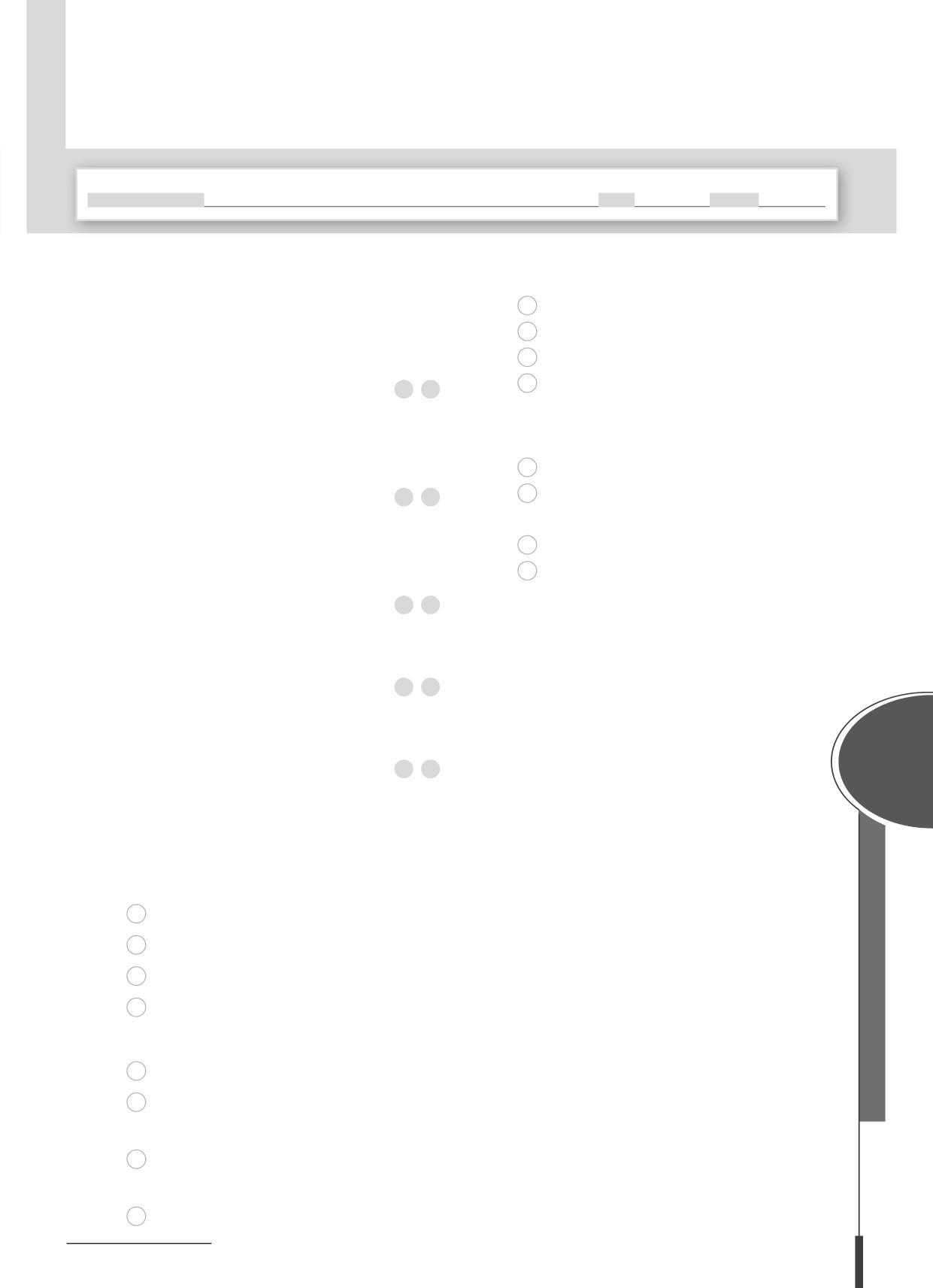
V F
8. La via del pentosio fosfato produce:
a. NADH per la sintesi dei lipidi
b. NADH per la sintesi di nucleotidi
c. ribosio per la sintesi di nucleotidi
d. desossiribosio per la gluconeogenesi
9. La RuBisCO può agire in due modi:
a. come carbossilasi e come ligasi
b. come carbossilasi e come ossigenasi
c. come ossigenasi e come sintasi
d. come sintasi e come carbossilasi
V F
4. I citocromi sono proteine coinvolte nella fosforilazione ossidativa contenenti ioni Cu.
V F
5. I prodotti della glicolisi sono 6 molecole di H2O e 6 molecole di CO2.
V F
2. Indica con una crocetta la risposta corretta
6. Il processo di glicolisi avviene:
a. nei mitocondri
b. nel citoplasma
c. solo nelle cellule eucariote
d. solo negli organismi procarioti
7. Il coenzima Q è coinvolto:
a. nella sintesi di ATP
b. nella catena respiratoria della fosforilazione ossidativa
c. nel metabolismo anaerobico del glucosio
d. nella fermentazione alcolica
3. Completa le frasi scegliendo i termini corretti tra quelli proposti sotto
10. Nelle cellule ................................, le due vie principali di sintesi dell’ATP sono la fosforilazione a livello di substrato e la fosforilazione ossidativa.
11. l è chiamato anche ciclo dell’acido citrico.
12. I sono organuli cellulari contenuti nel citoplasma di cellule vegetali.
13. La possiede un anello porfirinico con uno ione magnesio al centro, in grado di assorbire la luce.
14. La ................................ è una fase del ciclo di Calvin.
15. Uno viene fosforilato due volte utilizzando una molecola di ATP.
G3P – ciclo di Krebs – cloroplasti –fosforilazione ossidativa – clorofilla –zucchero – luce – eucariote
VERIFICHE SEMPLIFICATE
Unità
5 • I geni e la loro regolazione
Nome e cognome
1. Indica se le seguenti affermazioni sono vere o false
1. I microRNA sono in grado di bloccare la traduzione. V F
2. Il plasmide F è coinvolto nella coniugazione batterica. V F
3. Il pericapside è la struttura proteica che avvolge il genoma virale.
V F
4. Una cellula competente è una cellula capace di assorbire materiale genetico dall’esterno. V F
5. Il DNA dei procarioti è un’unica molecola circolare a doppia elica detta plasmide.
V F
6. L’operone lac ha una regione di controllo e una regione di codifica.
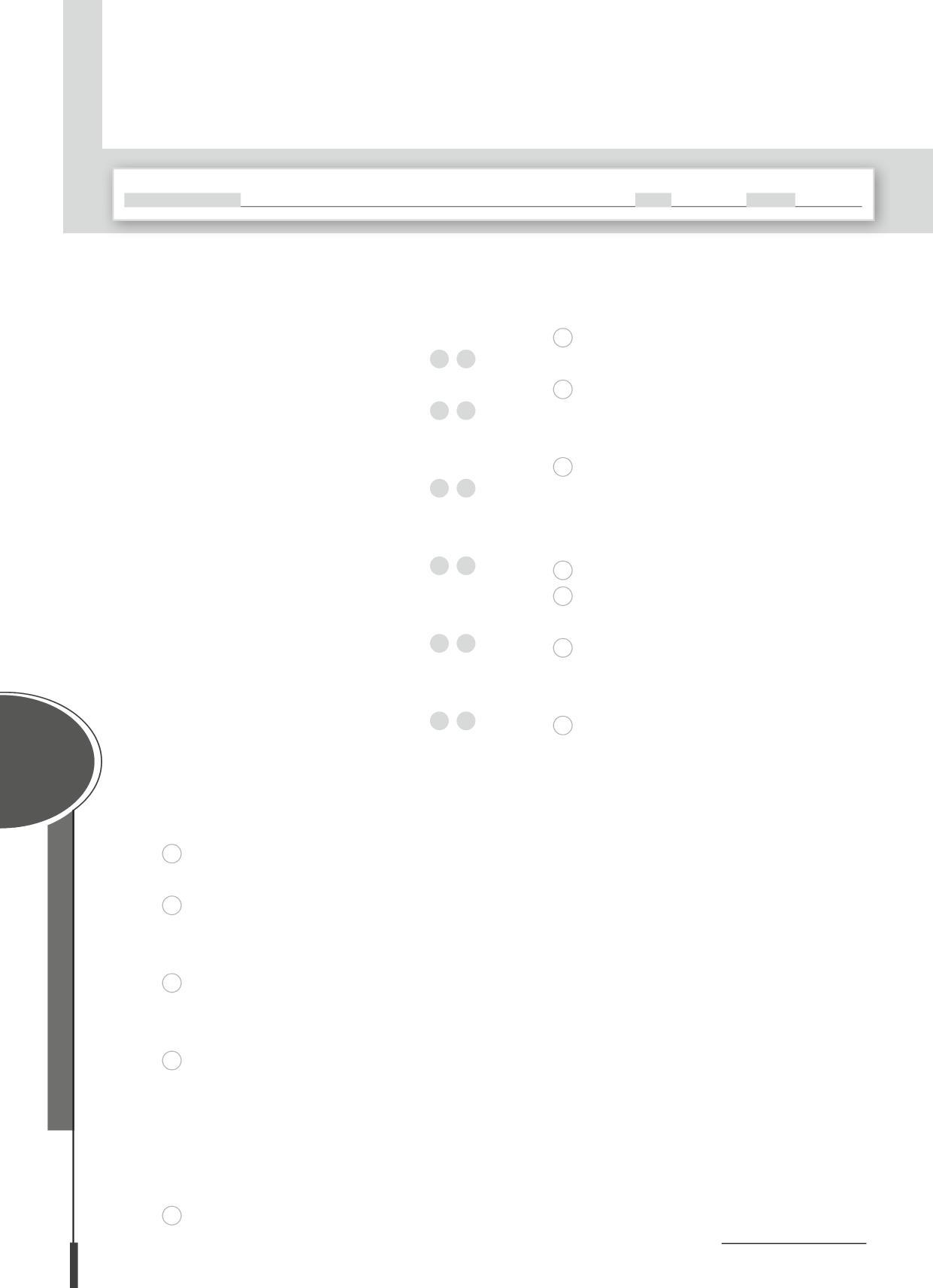
V F
2. Indica con una crocetta la risposta corretta
7. I virus:
a. non possono produrre energia metabolica ma possono riprodursi
b. non possono riprodursi ma possono produrre energia metabolica
c. non possono produrre energia metabolica ma possono riprodursi all’interno di una cellula
d. non possono riprodursi ma possono produrre energia metabolica all’interno di una cellula
8. La replicazione del DNA è semiconservativa perché:
a. gli enzimi coinvolti nel processo
Data Classe
sono in parte cellulari e in parte extracellulari
b. viene copiata solo una parte del singolo filamento di DNA
c. ogni nuova doppia elica ha un filamento parentale e uno sintetizzato ex novo
d. la copia del DNA non è identica all’originale a causa di diversi errori di copiatura
9. Il fenotipo:
a. è il prodotto del genotipo
b. è una caratteristica di un organismo
c. è l’insieme dei geni responsabili di una caratteristica visibile o metabolica di un organismo
d. non è influenzato dall’ambiente esterno
3. Completa le frasi scegliendo i termini corretti tra quelli proposti sotto
10. L’ubiquitina serve alla delle proteine.
11. Nel ciclo il virus infetta la cellula ospite iniettando il proprio materiale genetico.
12. Il trasferimento genico è il trasferimento di materiale genetico tra cellule che non discendono l’una dall’altra.
13. Nei , il controllo traduzionale regola la traduzione dell’mRNA in ................................. Orizzontale – polipeptide –degradazione – litico – procarioti
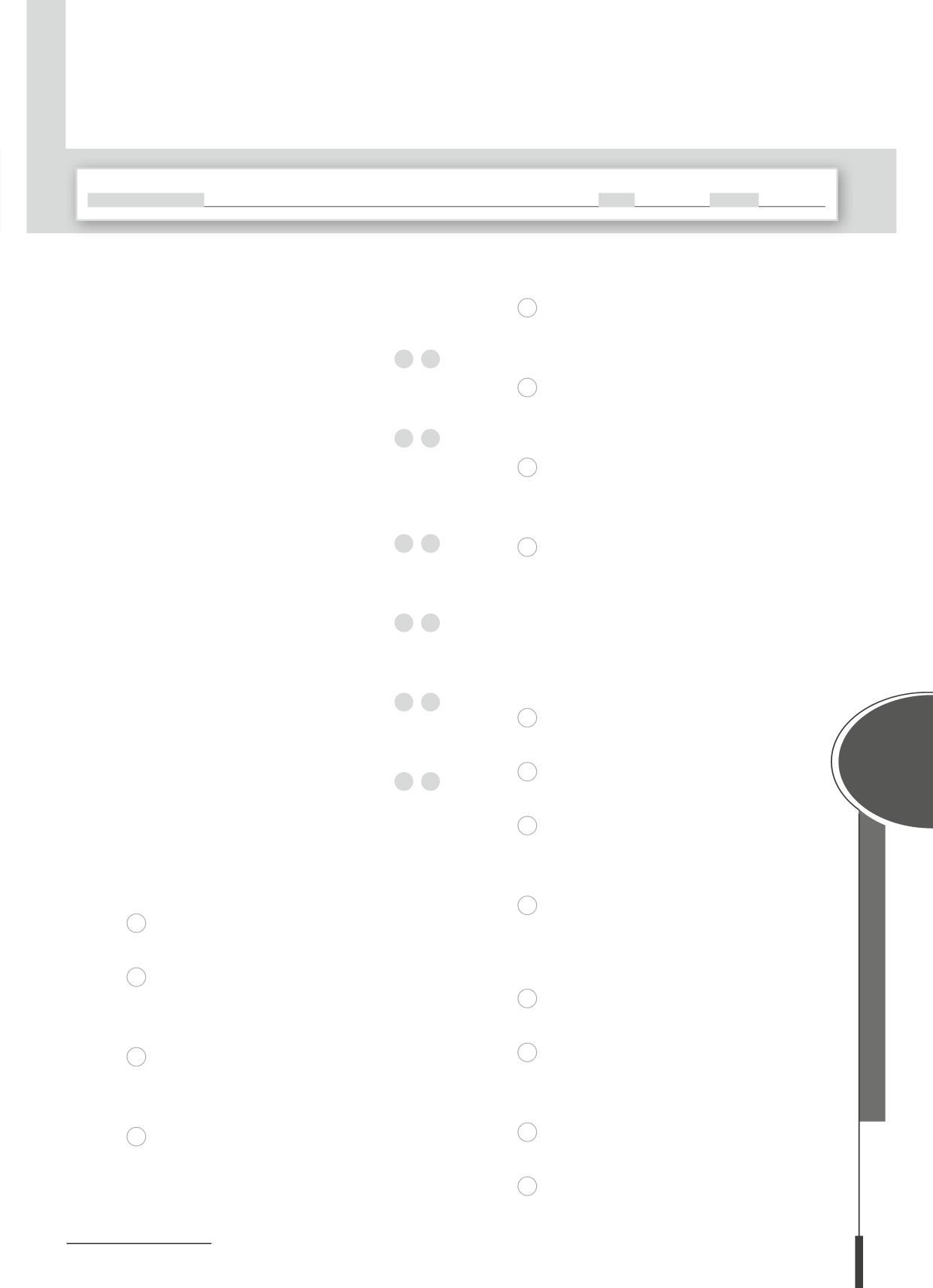
VERIFICHE SEMPLIFICATE
Unità
6 • Dal DNA ricombinante alle biotecnologie
Nome e cognome Data Classe
1. Indica se le seguenti affermazioni sono vere o false
1. Le biotecnologie moderne riguardano la salute umana. V F
2. Sfruttare l’azione dei lieviti per produrre pane e birra è un esempio di biotecnologia. V F
3. Grazie al sito di origine della replicazione, un plasmide può replicarsi a prescindere dal cromosoma batterico. V F
4. L’elettroforesi su gel può essere impiegata anche per separare le proteine. V F
5. Il DNA amplificato mediante PCR viene recuperato arrotolandolo intorno a uno stecchino di legno. V F
6. Il primo genoma a essere completamente sequenziato è stato quello umano. V F
2. Indica con una crocetta la risposta corretta
7. Le biotecnologie sono:
a. tutte le tecniche sperimentali usate in biologia
b. tutte le tecniche usate per lo studio della riproduzione sessuale
c. tutte le tecniche usate per lo studio della riproduzione asessuale
d. tutte le tecniche che impiegano esseri viventi o sostanze prodotte da essi per sviluppare e produrre beni
8. La trascrittomica:
a. studia la struttura, la composizione e l’evoluzione dei genomi
b. studia l’mRNA presente nella cellula e i geni in particolari condizioni o organismi
c. studia l’influenza dei fattori ambientali sull’evoluzione del genoma
d. studia lo sviluppo di strumenti informatici per risolvere problemi tipici della ricerca biologica
9. Cosa accade durante un ciclo di PCR?
a. Denaturazione, sintesi primer, amplificazione
b. Denaturazione, appaiamento primer, amplificazione
c. Denaturazione, appaiamento primer, allungamento filamenti parentali
d. Sintesi primer, allungamento DNA stampo, denaturazione
10. La Taq polimerasi:
a. è un enzima utilizzato nello svolgimento della PCR
b. è il colorante che serve a visualizzare le bande di DNA nell’elettroforesi
c. è un enzima che interviene nella replicazione del DNA
d. è un marcatore usato nell’elettroforesi
VERIFICHE SEMPLIFICATE
Unità 7 • La struttura
interna della
Terra
Nome e cognome Data Classe
1. Indica se le seguenti affermazioni sono vere o false
1. Le rocce più superficiali della Terra hanno una densità di circa 2,85 g/cm3 .
2. I magmi acidi causano eruzioni effusive.
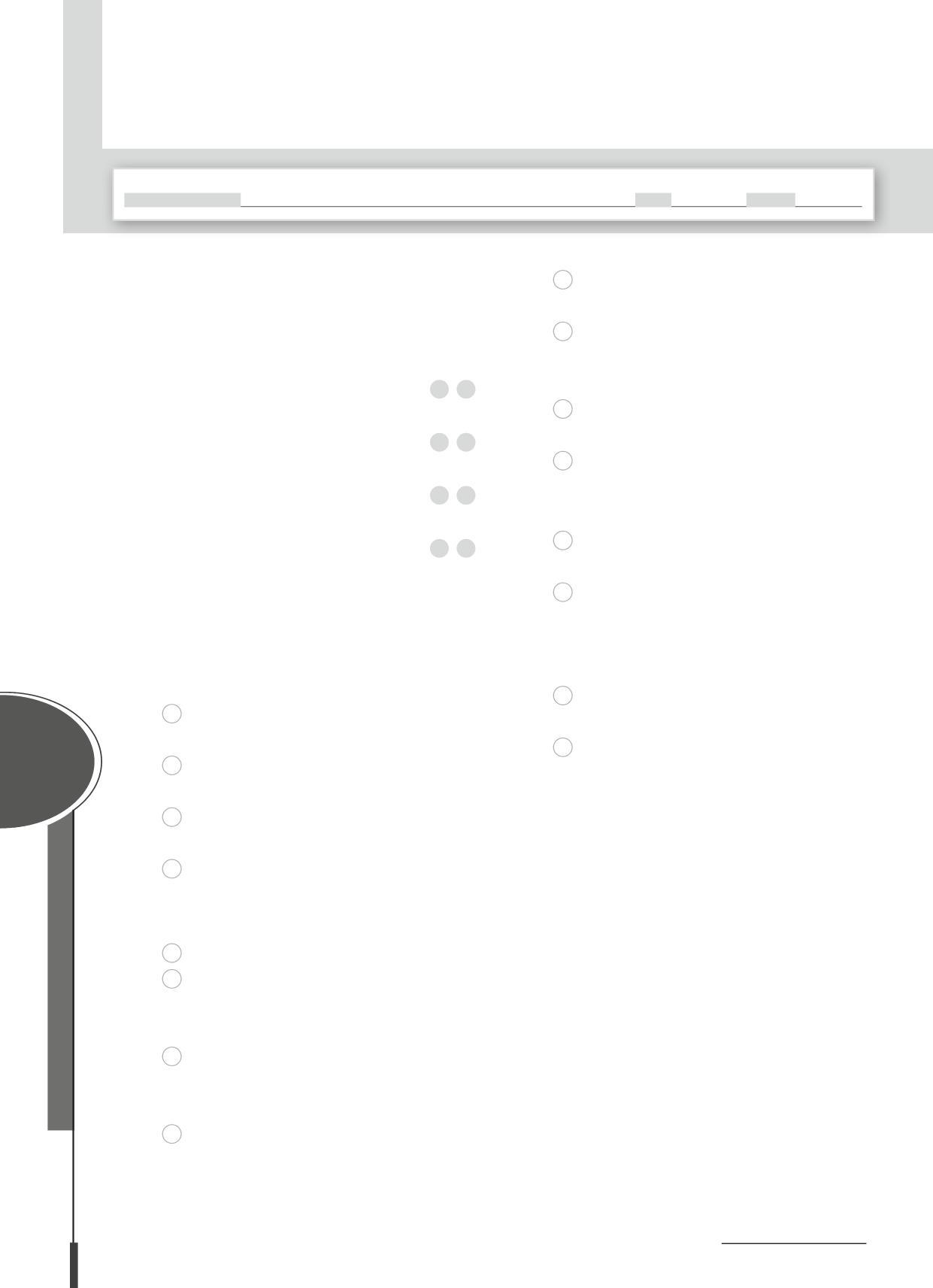
F
F
3. La discontinuità di Moho separa la crosta dal mantello. V F
4. L’astenosfera ha un comportamento plastico. V F
2. Indica con una crocetta la risposta corretta
5. Le rocce che formano la crosta continentale:
a. sono più pesanti rispetto alle rocce più interne
b. sono ricche di alluminio, sodio e potassio
c. sono ricche di ferro, calcio e magnesio
d. vengono studiate con metodi di indagine indiretti
6. Le onde S:
a. sono dette anche longitudinali
b. vibrano avanti e indietro nella stessa direzione di propagazione delle onde
c. producono modificazioni di volume e di forma nei materiali attraversati
d. vibrano perpendicolarmente alla direzione di propagazione delle onde
7. Le superfici di discontinuità:
a. separano strati rocciosi con diverse caratteristiche fisiche
b. sono state scoperte grazie allo studio della propagazione delle onde nel sottosuolo
c. in totale sono due: discontinuità di Lehmann e discontinuità di Moho
d. mostrano che l’interno della Terra è omogeneo
8. Nel campo magnetico terrestre:
a. il polo Nord magnetico coincide con il Nord geografico
b. le linee di forza del campo magnetico escono dall’emisfero Nord ed entrano nell’emisfero Sud
c. il Nord della bussola si orienta verso il polo di segno opposto
d. per definire il campo magnetico terrestre è sufficiente conoscere l’inclinazione magnetica
3. Completa le frasi scegliendo i termini corretti tra quelli proposti sotto
9. La di Moho separa la crosta dal mantello.
10. Lo strumento che registra le onde sismiche è il
11. I vulcani che eruttano lave basiche danno origine ad eruzioni .
12. Il valore di del campo magnetico si misura con il magnetometro. sismografo – discontinuità – effusive –intensità
VERIFICHE SEMPLIFICATE
Unità 8 • La dinamica terrestre
Nome e cognome Data Classe
1. Indica se le seguenti affermazioni sono vere o false
1. I fenomeni sismici e vulcanici si registrano in prevalenza lungo i margini delle placche litosferiche. V F
2. Il tetto è il blocco roccioso posto sopra il piano di faglia. V F
3. In una anticlinale la convessità è rivolta verso il basso. V F
4. L’orogenesi andina ha dato origine a due cordigliere. V F
2. Indica con una crocetta la risposta corretta
5. Il fenomeno dell’isostasia:
a. è stato identificato grazie alle anomalie gravitazionali
b. è determinato dal galleggiamento della crosta oceanica sul mantello
c. rimane costante nel tempo
d. è determinato dallo sprofondamento delle masse continentali nel nucleo esterno
6. La teoria dell’espansione dei fondali oceanici:
a. fu proposta dai geofisici Fred Vine e Drummond Matthews
b. ipotizza che il magma risalga in corrispondenza delle dorsali oceaniche
c. spiega perché lo spessore dei sedimenti diminuisca allontanandosi dalle dorsali oceaniche
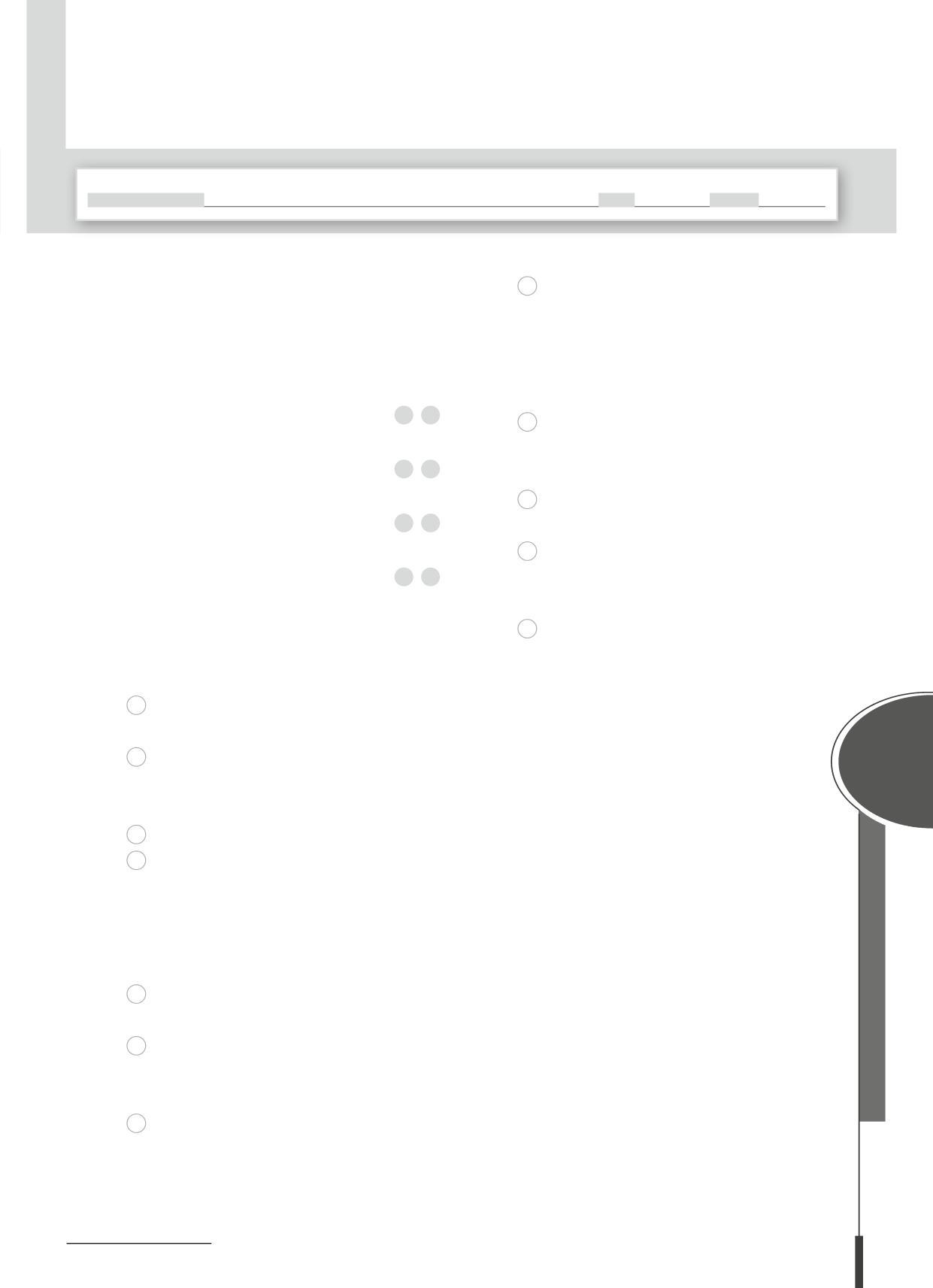
d. ipotizza che i continenti galleggino sul mantello
7. In corrispondenza della convergenza tra una placca oceanica e una continentale:
a. avviene la collisione ma nessuna delle due placche riesce ad andare in subduzione
b. la placca continentale più densa affonda sotto a quella oceanica
c. si forma un arco vulcanico e una catena di vulcani allineati lungo il margine del continente
d. si verifica un ispessimento della litosfera che provoca il sollevamento di una catena montuosa
3. Completa le frasi scegliendo i termini corretti tra quelli proposti sotto
8. Alfred Wegener ideò la teoria della deriva dei .
9. Circa 300 milioni di anni fa i continenti erano riuniti in un unico blocco chiamato .
10. Lungo un margine due placche si allontanano l’una dall’altra.
11. Il processo di porta al sollevamento di una catena montuosa.
divergente – orogenesi – Panthalassa – deriva dei continenti – tettonica delle placche – convergente
VERIFICHE SEMPLIFICATE
Unità 9 • La dinamica dell’atmosfera e il cambiamento climatico
Nome e cognome
1. Indica se le seguenti affermazioni sono vere o false
1. L’aria secca è composta per circa il 78% di ossigeno. V F
2. Il gradiente termico verticale è pari a circa 0,6 °C ogni 100 m di altezza.
3. Il tempo atmosferico descrive fenomeni che avvengono su tempi lunghi.
4. La pressione normale è pari a 101.325 Pa.
5. I monsoni sono venti locali periodici.
V F
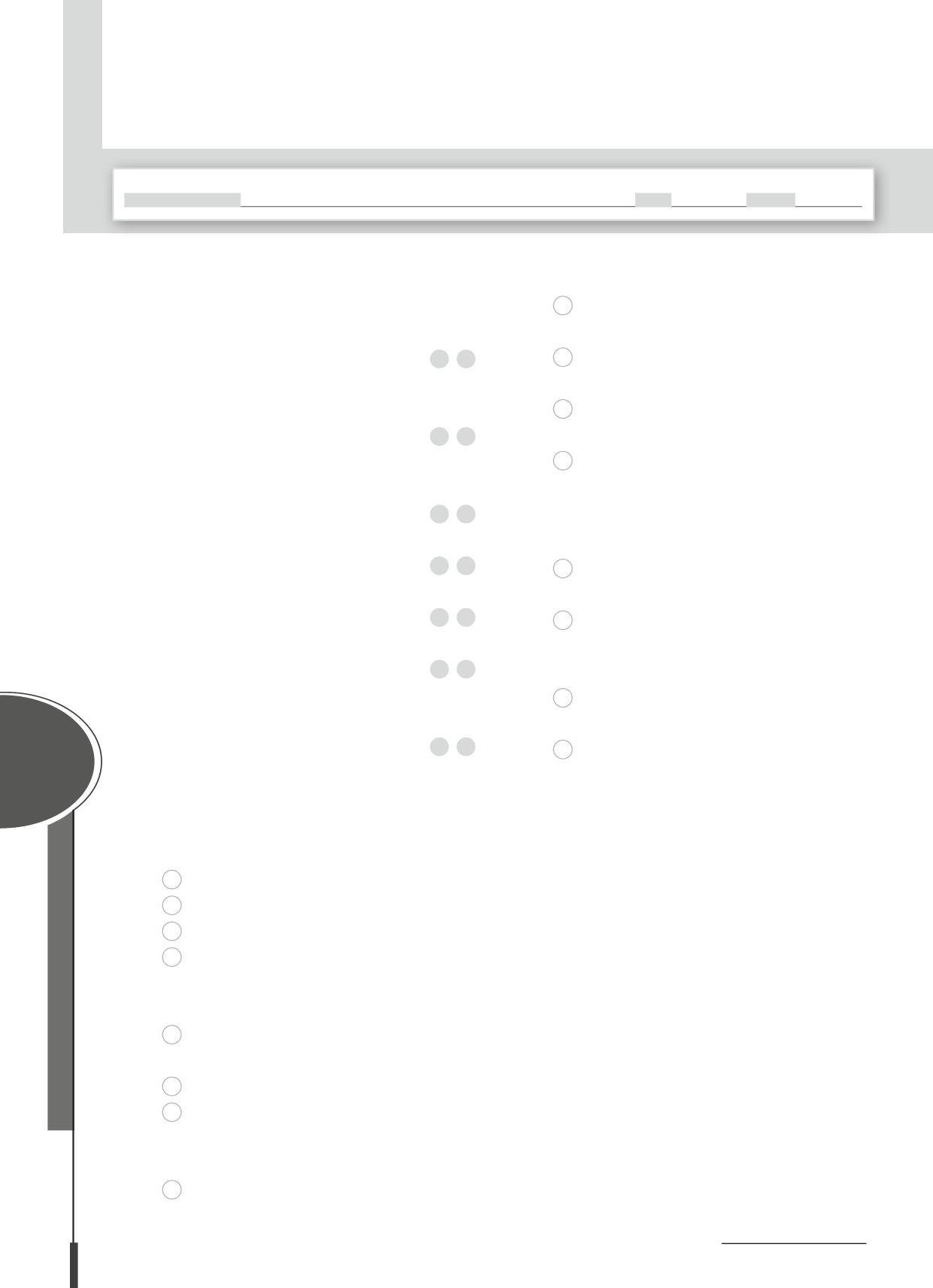
V F
V F
V F
6. I cicloni extratropicali si verificano alle basse latitudini. V F
7. Le aree urbane risentono di più delle conseguenze del cambiamento climatico. V F
2. Indica con una crocetta la risposta corretta
8. L’insolazione:
a. è maggiore alle basse latitudini
b. è costante in tutto il globo
c. è maggiore alla alte latitudini
d. non influenza il bilancio termico del pianeta
9. La mitigazione del clima:
a. è l’adeguamento al clima e ai suoi effetti
b. è un concetto ormai superato
c. comprende tutte le azioni volte a ridurre la quantità di gas serra nell’atmosfera
d. produce effetti immediati sul clima del pianeta
Data Classe
10. Gli alisei:
a. soffiano verso le aree cicloniche equatoriali
b. soffiano verso le aree cicloniche subpolari
c. hanno origine dalle aree delle alte pressioni polari
d. si spostano dalle zone di bassa pressione verso le zone ad alta pressione
11. Il calore emesso dalla Terra:
a. è omogeneo in tutto il globo terrestre
b. non risente né delle correnti marine né dei movimenti delle masse d’aria
c. dipende dalla distribuzione delle terre emerse e dei mari
d. non influenza il bilancio termico della Terra
3. Completa le frasi scegliendo i termini corretti tra quelli proposti sotto
12. Nella c’è una crescente rarefazione dei gas più leggeri.
13. Lo strumento usato per misurare la pressione atmosferica è il .................................
14. L’................................ è molto importante per mantenere le condizioni termiche adatte alla vita.
15. Le uniscono i punti con pressione atmosferica uguale corretti rispetto al livello del mare e alla temperatura di 0 °C. barometro – isobare – mesosfera –effetto serra – ionosfera
VERIFICHE SEMPLIFICATE
• Le scienze per la sostenibilità
Nome e cognome
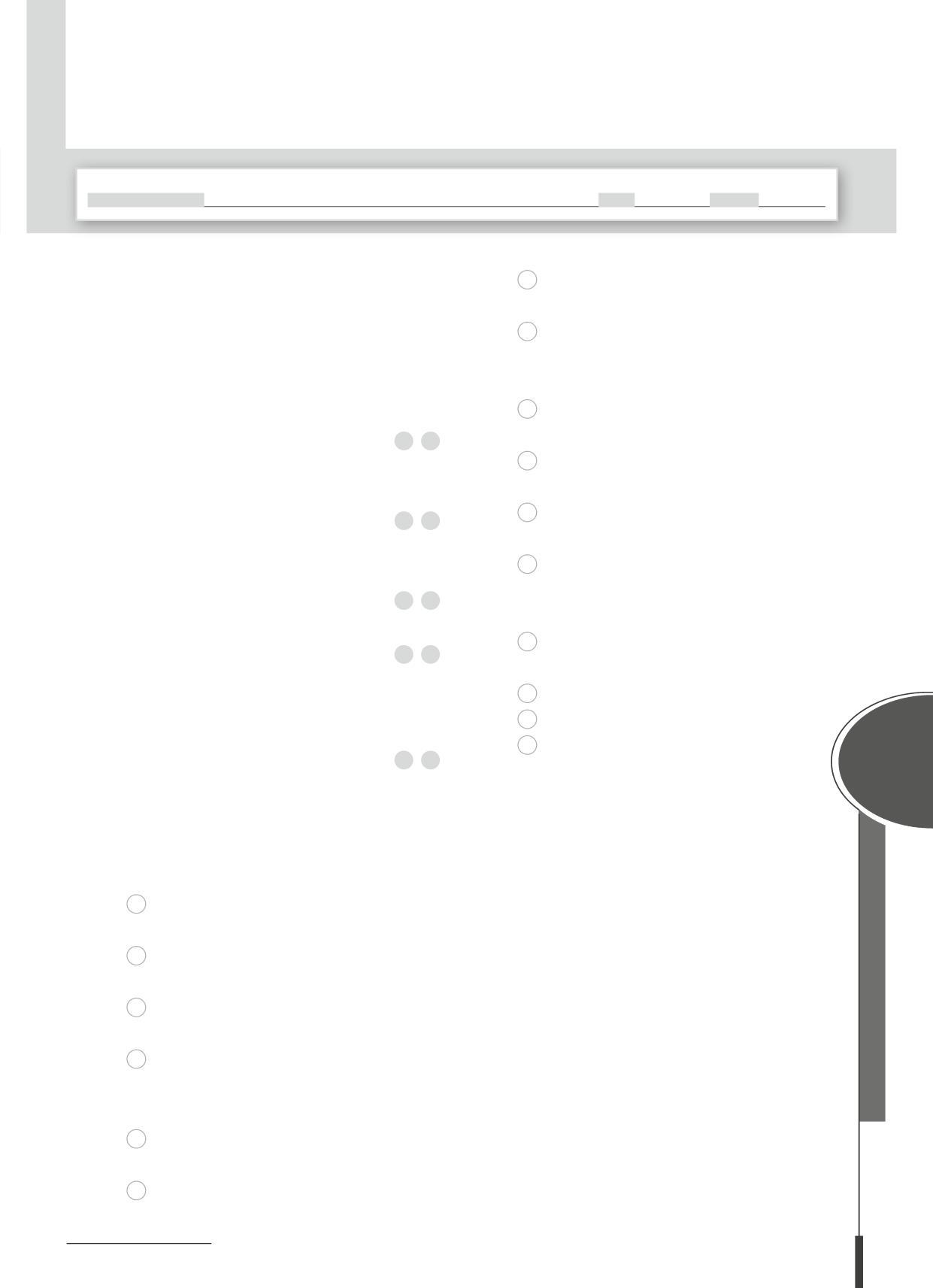
1. Indica se le seguenti affermazioni sono vere o false
1. La scala cronostratigrafica ricostruisce la storia della Terra e conserva i segni degli eventi geologici avvenuti nel passato.
V F
2. I combustibili fossili soddisfano circa il 40% del fabbisogno di energia.
V F
3. I depositi di combustibili fossili si sarebbero formati in periodi più caldi di quello attuale. V F
4. L’energia nucleare proviene dalla rottura di un legame chimico. V F
5. L’energia geotermica ha origine dal calore interno della Terra e dalla circolazione delle acque calde sotterranee.
V F
2. Indica con una crocetta la risposta corretta
6. Le fonti di energia non rinnovabili:
a. hanno un basso rapporto energia/volume
b. sono difficili da trasportare e immagazzinare
c. hanno un costo relativamente basso
d. possono rigenerarsi in tempi brevi
7. La fusione nucleare:
a. è lo stesso processo che si verifica nel Sole
b. non ha bisogno di temperature troppo elevate
Data Classe
c. da un punto di vista ecologico è meno vantaggiosa della fissione
d. è una tecnologia che si studia solo dagli anni 2000
8. Le terre rare:
a. sono sempre meno richieste dal mercato
b. si trovano soprattutto in Europa e negli Stati Uniti
c. sono indispensabili per i settori high tech e green
d. sono diffuse in tutto il mondo, concentrate in tutti i tipi di roccia
9. L’economia lineare:
a. si occupa del riuso di beni di consumo esistenti
b. recupera le materie prime
c. utilizza materie seconde
d. prevede la crescita illimitata dei prodotti
3. Completa le frasi scegliendo i termini corretti tra quelli proposti sotto
10. Oggi viviamo nell’era , iniziata circa di anni fa.
11. La ................................ del 2021 ha introdotto la necessità di ridurre il consumo di carbone.
12. Il modello di economia che recupera le materie prime e ricicla i rifiuti si chiama .
13. L’energia solare può essere sfruttata con le celle . eoliche – circolare – 85 milioni –fotovoltaiche – 65 milioni – cenozoica – COP 26 – quaternaria

8
Soluzioni
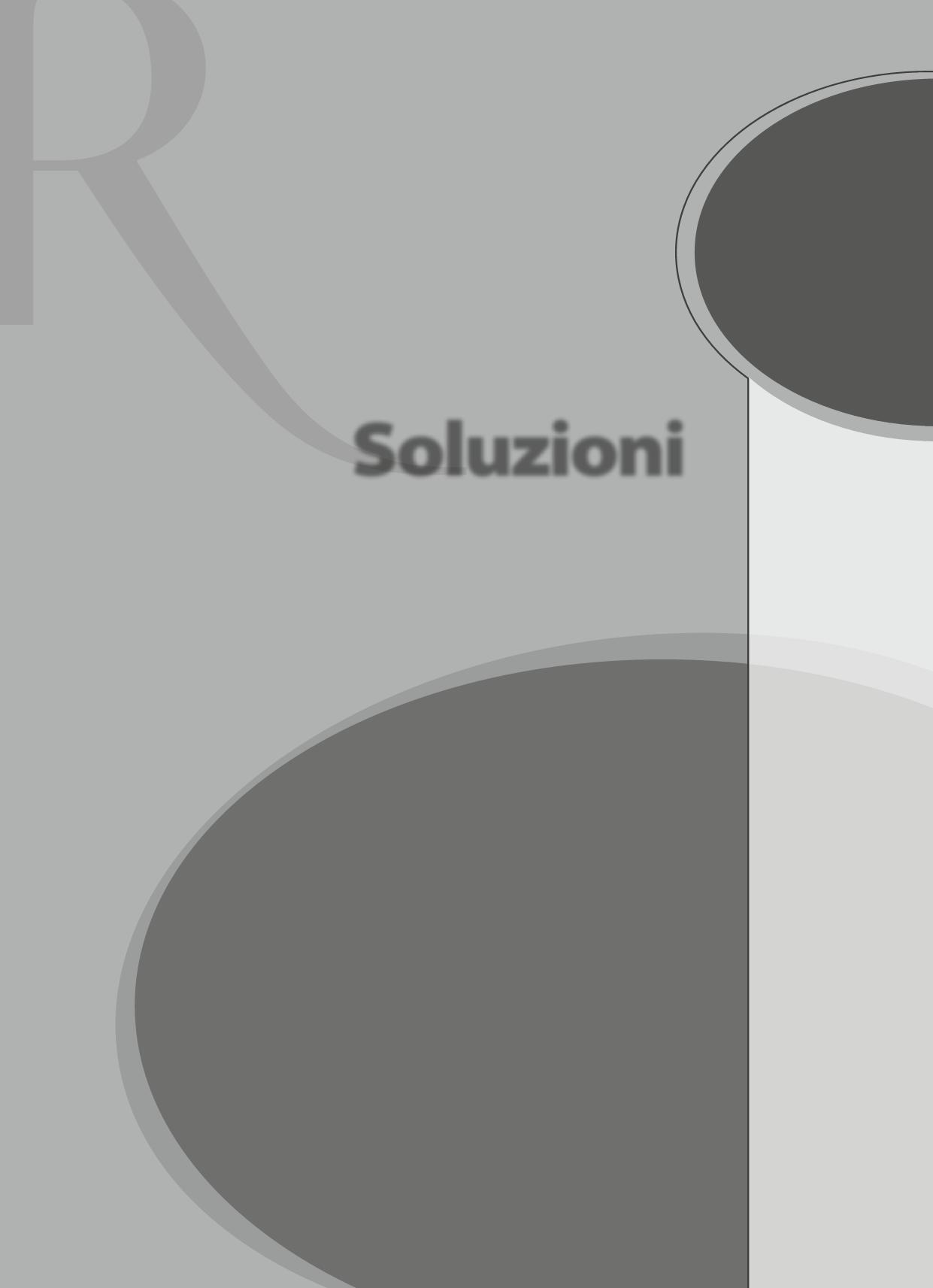
• Soluzioni dei test d’ingresso e delle verifiche della Guida
• Soluzioni degli esercizi del volume
• Soluzioni degli esercizi “Collega” e “Guida all’esposizione orale”
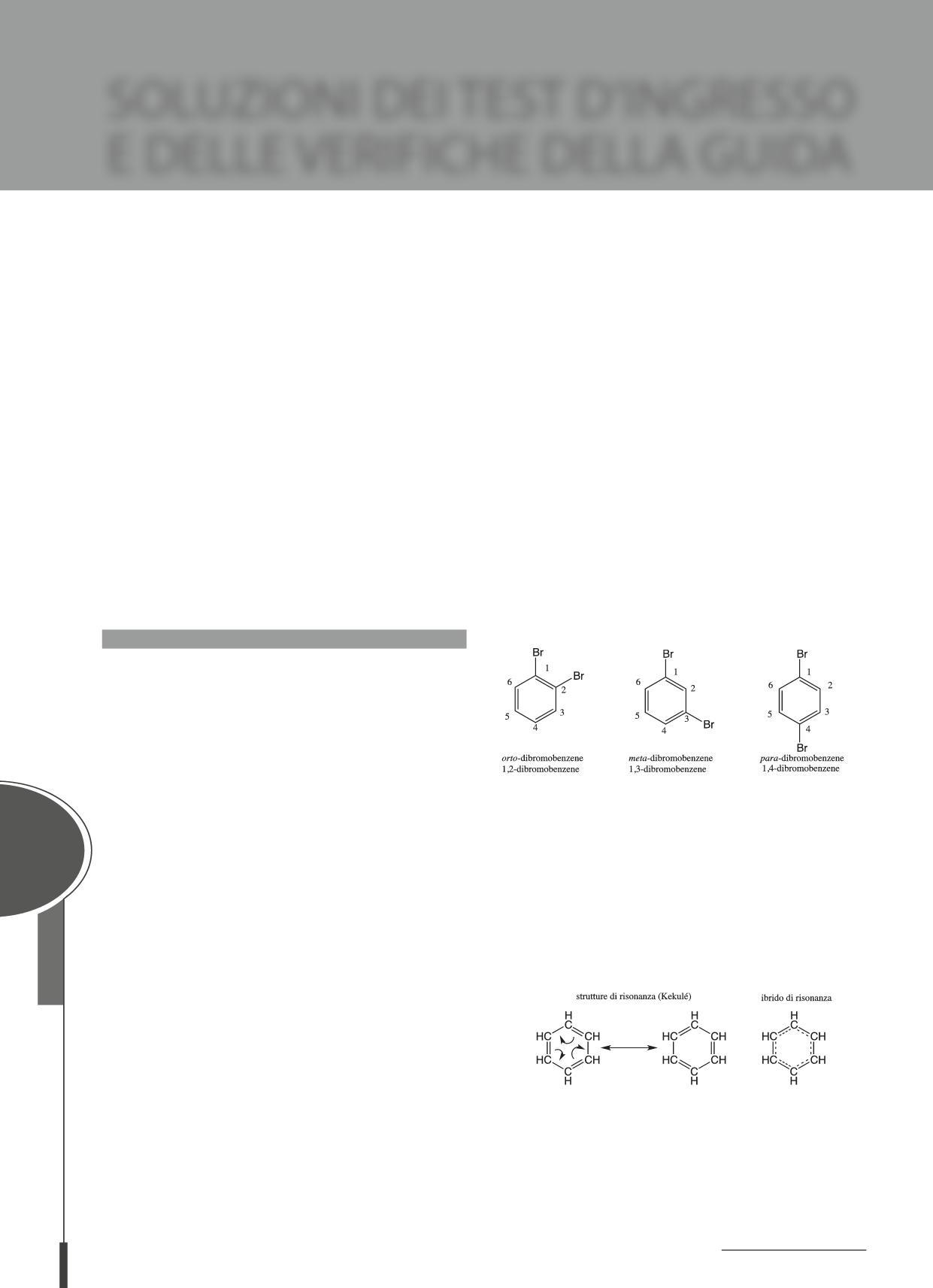
SOLUZIONI DEI TEST D’INGRESSO
E DELLE VERIFICHE DELLA GUIDA
Soluzioni
del test d’ingresso di Chimica e Biologia
Soluzioni del test d’ingresso di Scienze della Terra
Mohoroviˇcic´(o Moho) Gutenberg, Lehmann 17. Desertico freddo 18. Risposta aperta 19. Risposta aperta 20. Risposta aperta
Soluzioni del test d’ingresso semplificato di Chimica e Biologia
Soluzioni del test d’ingresso semplificato di Scienze della Terra
Desertico freddo 14. Risposta aperta 15. Risposta aperta 1.
Soluzioni delle verifiche sommative
Unità 1
FILA A
1. V. 2. V. 3. V. 4. V. 5. F. 6. c. 7. b. 8. c.
9. Il benzene possiede sei atomi di C ibridizzati sp2 con angoli di legame di 120°. Ogni C utilizza due orbitali sp2 per legarsi ai due C adiacenti. Il terzo orbitale sp2 è utilizzato per legare un atomo di H. Rimangono così sei orbitali p orientati a 90° rispetto al piano dell’esagono regolare, che si sovrappongono per formare un orbitale molecolare a forma di anello. I sei elettroni p quindi sono delocalizzati tra tutti e sei gli atomi di carbonio del benzene e definiscono il sestetto aromatico.
10. L’attività ottica è la proprietà di far ruotare il piano della luce polarizzata verso destra o verso sinistra. È una proprietà chirale in grado di distinguere due enantiomeri; quello che fa ruotare in senso orario il piano della luce polarizzata è detto destrogiro, l’altro è detto levogiro. Una miscela al 50% dei due enantiomeri è chiamata miscela racemica o racemo. Tale miscela non presenta più il fenomeno dell’attività ottica, in quanto si ha una compensazione dei due poteri rotatori opposti.
11. Gli atomi di carbonio che formano il triplo legame sono ibridizzati sp e possiedono quindi due orbitali p contenenti ciascuno un elettrone. Ogni orbitale sp contiene un elettrone spaiato che può formare un legame covalente σ. I rimanenti orbitali p dei due atomi di C coinvolti sono perpendicolari al legame σ e si sovrappongono lateralmente per dare luogo a due legami π. In totale abbiamo un legame σ e due legami π, cioè un triplo legame.
12.
14. A. alchene, 2-etil-1-butene; B. alchene aromatico, 2-propenilbenzene; C. alchino, 4-etil-4-metil-2-eptino; D. alcano, 3-metilpentano; E. cicloalcano, 1-metil-2propilcilcloesano.
FILA B
1. F. 2. V. 3. F. 4. F. 5. V. 6. a. 7. d. 8. c.
9. La risonanza descrive la disposizione degli elettroni all’interno di una struttura molecolare. Due strutture di risonanza avranno quindi la stessa disposizione di atomi ma diversa disposizione degli elettroni.
10. La rotazione attorno al doppio legame non è consentita a temperatura ambiente, di conseguenza un alchene come il 3-esene può esistere in due forme distinte. Questi isomeri geometrici sono denominati cis e trans a seconda della disposizione degli idrogeni attaccati al doppio legame, rispettivamente quando gli idrogeni sono dalla stessa parte e da parti opposte rispetto al doppio legame.
11. Ibridizzazione sp3: si ottiene dalla combinazione di un orbitale s e tre orbitali p per dar luogo a quattro nuovi orbitali ibridi identici sp3, contenenti ciascuno un elettrone (negli alcani). Ibridizzazione sp2: si ottiene dalla combinazione di un orbitale s e due orbitali p per dar luogo a tre nuovi orbitali identici sp2, contenenti ciascuno un elettrone (negli alcheni). Ibridizzazione sp: si ottiene dalla combinazione di un orbitale s e un orbitale p per dar luogo a due nuovi orbitali ibridi identici sp, contenenti ciascuno un elettrone (negli alchini).
12. Formula molecolare: C12H26. Struttura:
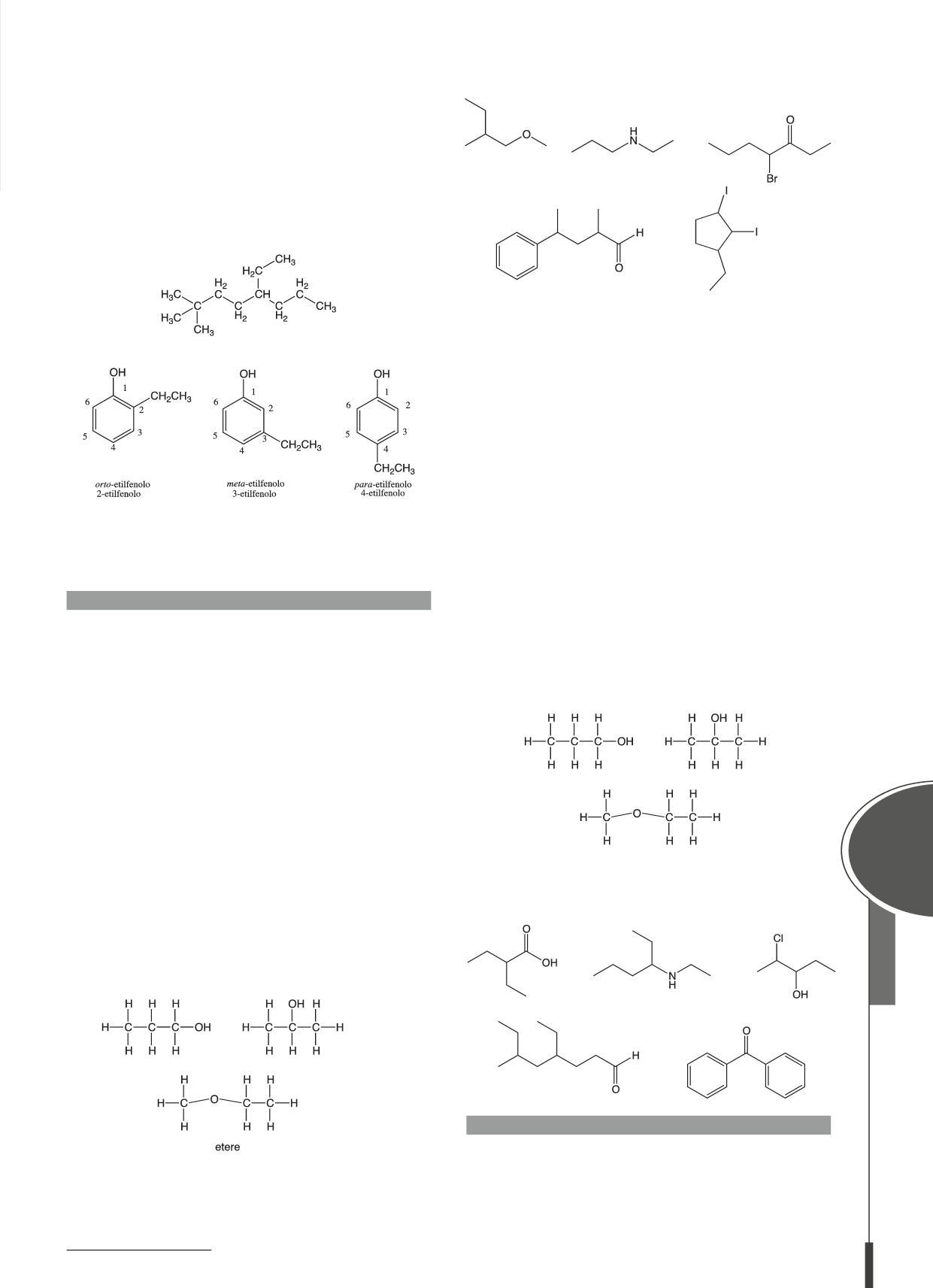
13.
14. A. alcano, 4-etil-3,4-dimetileptano; B. cicloalcano, 1-etil2-metilciclopropano; C. alcano aromatico, isopropilbenzene; D. alchino, 3-metil-1-pentino; E. alchene, 2,5-dimetil-3eptene.
Unità 2
FILA A
1. V. 2. V. 3. F. 4. V. 5. V. 6. c. 7. d. 8. a.
9. Le ammine si distinguono in primarie, secondarie e terziarie in base al numero di gruppi alchilici o arilici legati all’atomo di azoto. Nelle ammine primarie, l’azoto è legato a un solo gruppo alchilico o arilico e a due atomi di idrogeno. Nelle ammine secondarie, l’azoto è legato a due gruppi alchilici o arilici e a un atomo di idrogeno. Nelle ammine terziarie, l’azoto è legato a tre gruppi alchilici o arilici e nessun atomo di idrogeno.
10. Un primo criterio per classificare i polimeri è secondo la loro origine: si distinguono così polimeri naturali e sintetici. Una seconda classificazione si basa sul tipo di reazione di polimerizzazione con la quale sono prodotti: di addizione o di condensazione. Infine, i polimeri si possono distinguere in omopolimeri, formati da un unico tipo di monomero, e copolimeri, costituiti da due o più monomeri diversi.
11. Una reazione di addizione è un processo chimico si assiste alla rottura di un legame multiplo in una molecola insatura. Un esempio è la reazione che porta da un alchene a un alcano.
12.
13. A. ossidrile, fenoli; B. carbossile, acidi; C. alogeno, alogenoderivati insaturi; D. estere, esteri; E. carbonile, chetoni.
FILA B
1. F. 2. V. 3. V. 4. V. 5. F. 6. b. 7. d. 8. a.
9. Gli alcoli si distinguono in primarie, secondarie e terziarie in base al numero di gruppi alchilici legati all’atomo di carbonio che porta il gruppo ossidrilico. Negli alcoli primari, il carbonio che lega il gruppo —OH è legato a un solo altro atomo di carbonio e due atomi di idrogeno. Negli alcoli secondari, il carbonio che lega il gruppo —OH è legato a due atomi di carbonio e un atomo di idrogeno. Negli alcoli terziari, il carbonio che lega il gruppo —OH è legato a tre atomi di carbonio e nessun atomo di idrogeno.
10. Il polietilene a bassa densità (LDPE) differisce dal polietilene ad alta densità (HDPE) per la struttura delle catene polimeriche. L’LDPE ha catene ramificate che impediscono un impacchettamento stretto, rendendolo più morbido e flessibile. L’HDPE, invece, ha catene lineari e poco ramificate, permettendo un impacchettamento più compatto, il che lo rende più rigido e resistente.
11. Una reazione di sostituzione è un processo chimico si assiste alla rottura di un legame covalente polare singolo e il successivo legame con un’altra molecola. Un esempio è la reazione che porta da un alcano a un aloalcano.
12.
13. A. carbonile, aldeidi; B. ossidrile, fenoli; C. carbonile, chetoni insaturi; D. amminico, ammine primarie; E. etereo, eteri. 14.
Unità 3
10. I carboidrati sono fonte di energia metabolica, hanno un importante ruolo strutturale e sono coinvolti in fenomeni di adesione, riconoscimento e scambio informazionale se legati a proteine e lipidi.
11. Le aldeidi e i chetoni possono reagire con gli alcoli per formare un emiacetale. Il D-glucosio possiede sia la funzione aldeidica sia vari ossidrili, di conseguenza questa reazione può avvenire in maniera intramolecolare determinando la ciclizzazione dello zucchero. Si possono formare così anelli a cinque atomi detti furanosici e a sei atomi chiamati piranosici. L’anello a sei atomi rappresenta la forma più stabile. In seguito alla reazione, il C che nella forma aperta era carbonilico è diventato un nuovo centro chirale ed è chiamato carbonio anomerico. Rappresentando questi anomeri con le proiezioni di Fischer, troviamo l’anomero a e l’anomero b:
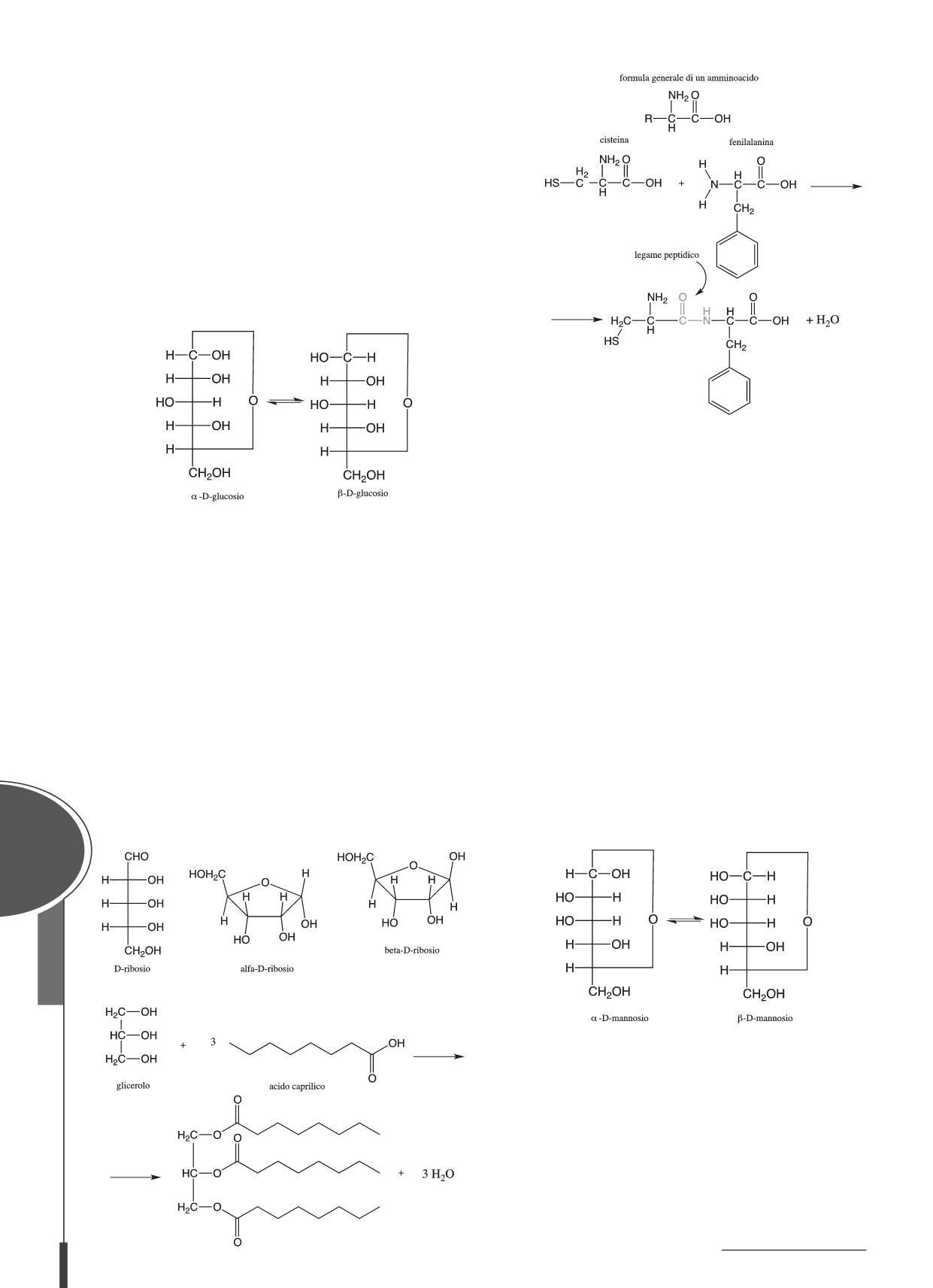
12. I polisaccaridi sono polimeri naturali derivati dall’unione di numerose molecole di monosaccaridi aldosi o chetosi, con perdita di una molecola di acqua per ogni legame glicosidico formatosi. L’amido è un polimero dell’α-D-glucosio e costituisce la riserva energetica delle piante; è composto da due polimeri diversi per struttura e proporzione: il polimero lineare è l’amilosio, mentre quello ramificato è l’amilopectina. Le unità di α-D-glucosio nelle catene lineari sono legate fra loro da legami 1,4-α-glucosidici, mentre nei punti di ramificazione dell’amilopectina sono presenti i legami 1,6-α-glucosidici. 13. La struttura secondaria delle proteine è data dalla disposizione che porzioni della catena peptidica assumono nello spazio grazie all’instaurarsi di legami a idrogeno tra i vari residui amminoacidici. Le principali sono la struttura a β-foglietto e ad α-elica. La struttura a β-foglietto si ha quando le catene proteiche giacciono una accanto all’altra, unite tra loro da legami a idrogeno e disposte a formare delle pieghe in maniera da poter accomodare i gruppi R trasversali al piano del foglietto. 14.
17. La sequenza fa parte della struttura del DNA perché è presente la timina. La struttura complementare è: TTTTTAATGCTTCATTTCGGGTTA.
FILA B
1. V. 2. F. 3. F. 4. F. 5. V. 6. c. 7. a. 8. a. 9. b. 10. I monosaccaridi sono gli zuccheri semplici, che non possono essere ulteriormente idrolizzati; gli oligosaccaridi sono zuccheri formati da una catena corta di monosaccaridi (2-20); i polisaccaridi sono lunghi polimeri che contengono più di venti monomeri e possono raggiungere anche il migliaio.
11. Le aldeidi e i chetoni possono reagire con gli alcoli per formare un emiacetale Il D-mannosio possiede sia la funzione aldeidica sia vari gruppi OH, di conseguenza questa reazione può avvenire in maniera intramolecolare determinando la ciclizzazione dello zucchero.
Si possono formare così anelli a cinque atomi detti furanosici e a sei atomi chiamati piranosici.
L’anello a sei atomi rappresenta la forma più stabile. In seguito alla reazione, il C che nella forma aperta era carbonilico è diventato un nuovo centro chirale ed è chiamato carbonio anomerico.
Rappresentando questi anomeri con le proiezioni di Fischer, troviamo l’anomero α e l’anomero β:
12. I lipidi sono un gruppo di sostanze eterogenee dal punto di vista della struttura chimica, ma tutte accomunate dalla stessa proprietà fisica: sono insolubili in acqua (idrofobe) ed estraibili con solventi non polari (lipofili) quali etere, cloroformio e benzene. I lipidi possono essere distinti in lipidi saponificabili e insaponificabili. Dal punto di vista biologico le funzioni dei lipidi sono essenzialmente quattro: riserva energetica, componente delle membrane biologiche, isolamento termico e impermeabilizzazione in diverse specie animali, messaggeri chimici per la comunicazione e la regolazione cellulare.
13. La struttura secondaria delle proteine è data dalla disposizione che porzioni della catena peptidica assumono nello spazio grazie all’instaurarsi di legami a idrogeno tra i vari residui amminoacidici. Le principali sono la struttura a b-foglietto e ad a-elica.
Nella struttura ad a-elica la catena si avvolge su se stessa a forma di elica destrorsa, lasciando i gruppi –R rivolti verso l’esterno. I legami a idrogeno uniscono parti diverse di una stessa catena, collegando tra loro le spire; tali legami si stabiliscono tra gruppi CO e NH di differenti residui amminoacidici. La a-elica consente il maggior numero di legami, quindi la massima stabilità della molecola. 14. 15. 16.
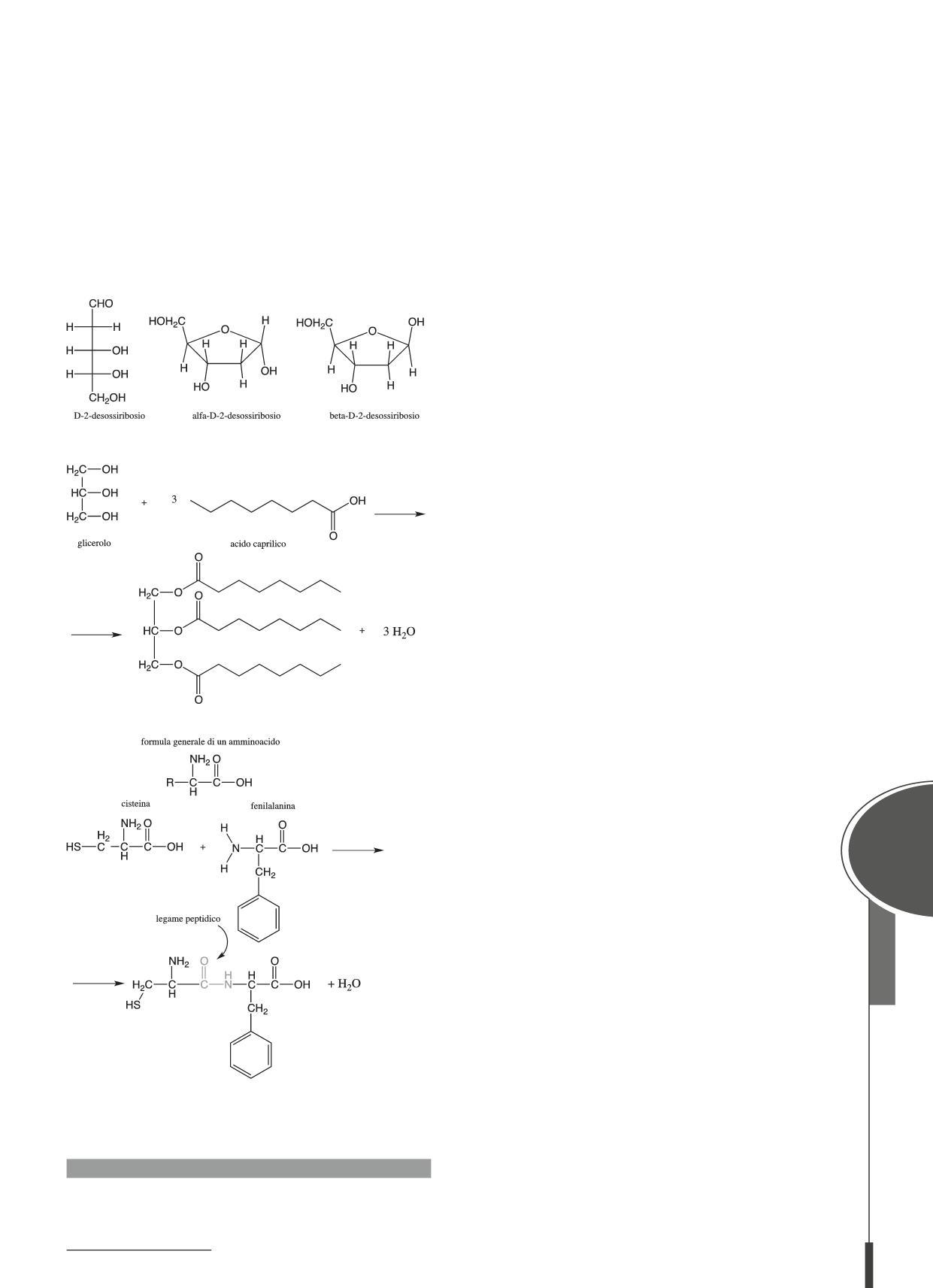
17. La sequenza fa parte della struttura del RNA perché è presente l’uracile. La struttura complementare è: UUUUGGGCUAAAUUGCUUCCAAC. Unità 4
10. Nelle cellule eucariote esistono due vie principali di sintesi dell’ATP: la fosforilazione a livello di substrato, nella quale si sfrutta una reazione in grado di fornire direttamente energia sufficiente per la sintesi di una molecola di ATP; la fosforilazione ossidativa, una serie di reazioni redox che liberano l’energia necessaria alla sintesi dell’ATP.
11. Negli organismi vegetali si trovano diversi tipi di pigmenti. Uno dei più noti è la clorofilla, che negli eucarioti è presente in due forme: la clorofilla a assorbe soprattutto le lunghezze d’onda del blu-violetto e del rosso; la clorofilla b assorbe le lunghezze d’onda del blu e dell’arancio. Sono responsabili del colore delle piante perché riflettono il colore verde e giallo. La sua molecola contiene una struttura detta anello porfirinico, al cui centro troviamo un atomo di magnesio. Inoltre, è presente una coda idrofobica (fitolo).
12. Il ciclo di Krebs fa parte del metabolismo aerobico del glucosio. Il piruvato che deriva dalla glicolisi ha un contenuto energetico ancora molto alto ed è sfruttato per produrre ulteriore ATP. Per rendere possibile la degradazione completa del piruvato è necessaria la presenza di ossigeno. L’ossidazione completa del piruvato a CO2 e H2O avviene nei mitocondri con il ciclo di Krebs. Qui il piruvato viene ossidato da un enzima chiamato NAD+, che a sua volta si riduce in NADH liberando una molecola di CO2. Il gruppo acetilico rimanente è trasferito sul coenzima A e si forma l’acetil-CoA: piruvato + NAD+ + CoA → acetil-CoA + NADH + H+ + CO2
A questo punto, l’acetil-CoA può entrare in una complessa via metabolica chiamata ciclo di Krebs, attraverso una prima reazione che coinvolge una molecola di ossalacetato. Nelle diverse tappe vengono prodotte tre molecole di NADH, una di FADH2 e una di GTP (convertita poi in ATP). Nel corso del processo sono eliminate due molecole di CO2. Questo processo è ciclico perché sia il coenzima A che l’ossalacetato vengono ripristinati e impiegati per un nuovo ciclo.
13. Sì.
14. Δ r G° = 14,7 kJ/mol
15. Per ogni mole di acetil-CoA si forma una mole di FADH2: acetil-CoA + GDP + Pi + 3NAD+ + FAD + 2H2O → CoA + 2CO2 + 3NADH + 3H+ + FADH2 + GTP
Sapendo che si formano 1,5 moli di ATP per mole di FADH2 a livello della catena respiratoria, il numero di moli di ATP = 8 mol × 1,5 = 12 mol
FILA B
1. F. 2. F. 3. F. 4. F. 5. F. 6. b. 7. c. 8. c. 9. a.
10. L’ATP viene continuamente consumato e prodotto in un ciclo ben regolato, noto come ciclo dell’ATP. L’ADP si forma dalla reazione spontanea di idrolisi dell’ATP che perde un gruppo fosfato dopo essere coinvolta in reazioni metaboliche endoergoniche. Se invece le molecole di ADP sono coinvolte nelle reazioni delle vie cataboliche esoergoniche, esse sfruttano nutrienti esterni per fosforilarsi e trasformarsi quindi in ATP.
11. Fotosistema I (detto P700): nel suo centro di reazione si trova una molecola di clorofilla che ha il picco di assorbimento della luce a 700 nm. Fotosistema II (detto P680): nel suo centro di reazione si trova una molecola di clorofilla che ha il picco di assorbimento della luce a 680 nm.
12. Il ciclo di Calvin produce una molecola assai versatile, la G3P (gliceraldeide-3-fosfato). Da essa la cellula vegetale trae il glucosio per consumarlo nei mitocondri, oppure attiva la condensazione di saccarosio o la sintesi dei polisaccaridi amido e cellulosa. Durante la seconda fase del ciclo di Calvin, detta riduzione, l’ATP e il NADPH + H+ prodotti durante la fase luminosa permettono la riduzione del 3-fosfoglicerato a G3P.
13. Gli organismi anaerobi trasformano il piruvato proveniente dalla glicolisi per ottenere energia, ma non utilizzano ossigeno. Il processo che porta alla formazione di etanolo è detto fermentazione alcolica: il piruvato è decarbossilato ad acetaldeide liberando diossido di carbonio e l’acetaldeide è ridotta a etanolo a spese dell’ossidazione del NADH formato durante la glicolisi, rigenerando NAD+. Nel processo che porta alla fermentazione lattica il piruvato è ridotto a lattato a opera dell’enzima lattato deidrogenasi che riossida il NADH formatosi durante la glicolisi. L’acido lattico è responsabile del sapore acidulo dello yogurt. La fermentazione lattica avviene anche nei muscoli scheletrici se sottoposti a sforzo breve e intenso.
14. No.
15. Δ r G° = −11,9 kJ/mol
16. Per ogni mole di acetil-CoA si formano 3 moli di NADH: acetil-CoA + GDP + Pi + 3NAD+ + FAD + 2H2O → CoA + 2CO2 + 3NADH + 3H+ + FADH2 + GTP
Sapendo che si formano 2,5 moli di ATP per mole di NADH a livello della catena respiratoria, il numero di moli di ATP = 30 mol × 2,5 = 75 mol
Unità 5
A
1. F.
2. V.
3. V
4. F.
5. V.
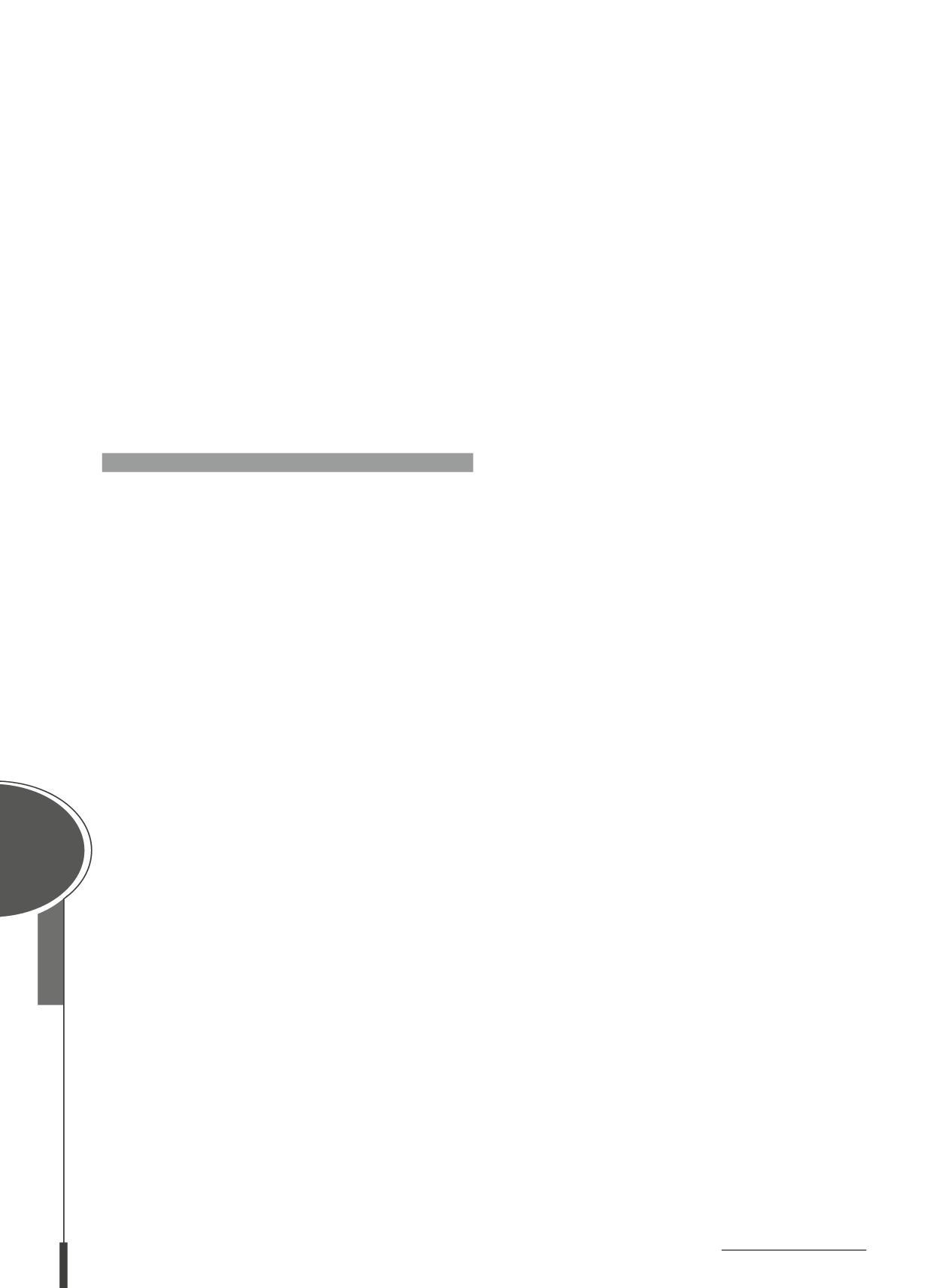
6. V.
7. b.
8. c.
9. c.
10. c.
11. La replicazione del DNA è il processo biologico di produzione di due copie identiche di DNA a partire da una molecola di DNA originale. Si verifica prima della divisione cellulare con meccanismo semiconservativo: le due nuove doppie eliche di DNA sono formate da uno dei vecchi filamenti e da un nuovo filamento complementare. Grazie alla replicazione, la cellula raddoppia il proprio materiale genetico per trasmetterne una copia a ognuna delle due cellule figlie. Durante la replicazione, i due filamenti stampo sono separati originando la forcella di replicazione. I due nuovi filamenti sono poi sintetizzati dall’enzima DNA polimerasi. Quest’ultima, a partire da un breve innesco di RNA detto primer, legge la sequenza di basi del filamento stampo e inserisce i nucleotidi complementari sintetizzando il nuovo filamento in direzione 5′ → 3′
La replicazione del DNA procede quindi in maniera differente sui due filamenti, che sono antiparalleli.
Su un filamento la DNA polimerasi si muove nella stessa direzione della forcella di replicazione e la sintesi del filamento complementare (filamento veloce) avviene in maniera continuativa. Sull’altro filamento, la direzione di sintesi è opposta rispetto a quella della forcella e il filamento nascente (filamento lento) è sintetizzato un frammento alla volta con più primer. I vari frammenti di DNA sono chiamati frammenti di Okazaki e vengono infine uniti in un unico pezzo da una DNA ligasi. 12. Le cellule eucariotiche hanno meccanismi di regolazione genica complessi che comprendono anche la possibilità di modulare le fasi pre-trascrizionali. Il DNA eucariotico, infatti, si trova complessato con gli istoni a formare la cromatina il cui grado di impacchettamento influenza la trascrizione. L’impacchettamento del DNA può essere tale da impedire all’RNA polimerasi e alle proteine del complesso di trascrizione di legarvisi e iniziare la trascrizione. Il DNA densamente impacchettato è detto eterocromatina. Al contrario, se le porzioni di DNA sono meno condensate saranno più accessibili e
verranno trascritte più facilmente; si parla in questo caso di eucromatina. Le cellule eucariotiche sono in grado di modificare la struttura della cromatina mediante reazioni di acetilazione-deacetilazione degli istoni. Una ulteriore forma di regolazione pre-trascrizionale prevede la metilazione del DNA. Questa modificazione regola l’espressione genica inibendo l’interazione tra il DNA e le proteine che favoriscono la trascrizione e stimolando, allo stesso tempo, il legame di alcuni repressori.
13. La prima fase del ciclo lisogeno, comune a quello litico, è caratterizzata dallo stabilirsi di un legame fra le proteine del capside e specifici recettori situati sulla parete del batterio ospite. Tale fase si conclude con l’iniezione dell’acido nucleico del fago attraverso la parete del batterio ospite. A questo punto, i virus che compiono un ciclo lisogeno integrano il proprio genoma nel cromosoma batterico. Il virus così integrato non è infettivo ed è detto profago. Il profago può rimanere inattivo all’interno del genoma batterico per molti cicli di divisione cellulare. Tuttavia, a volte, un batterio lisogeno può essere indotto a innescare il proprio profago. Tale attivazione dà origine a un ciclo litico, in cui il profago lascia il cromosoma batterico e genera nuove particelle virali.
14. Per trasferimento genico orizzontale si intendono quei meccanismi che determinano il trasferimento dell’informazione genetica tra cellule che non discendono l’una dall’altra. Si tratta di meccanismi batterici e comprendono la coniugazione, la trasformazione e la trasduzione. La coniugazione permette il trasferimento di materiale genetico da un batterio donatore a uno ricevente. I due batteri entrano in contatto mediante una struttura detta pilo di coniugazione, attraverso cui passa uno dei due filamenti di DNA della molecola del donatore (il filamento restante funge da stampo per ricostruire l’intera molecola). I geni responsabili di questo processo si trovano nel plasmide F, che non è presente in tutti i batteri. I batteri possono anche assorbire materiale genetico dall’ambiente esterno, mediante un processo detto trasformazione. Un batterio capace di attuare tale processo è detto competente; il DNA assorbito può essere degradato o stabilirsi nel batterio come plasmide o nel cromosoma. La trasduzione avviene infine a opera di batteriofagi. Può succedere, infatti, che durante il ciclo litico fagico, in un capside vuoto si inserisca, per errore, un frammento di DNA batterico; quando il nuovo virione infetta un’altra cellula batterica, il frammento di DNA estraneo sarà iniettato al suo interno e potrà ricombinarsi con il cromosoma ospite.
B
1. F.
2. F.
3. V.
4. V.
5. F.
6. V.
7. d.
8. c.
9. d.
10. c.
11. La trascrizione e la traduzione del DNA, noti nel complesso come espressione genica, sono i processi con cui l’informazione contenuta nel DNA viene impiegata per la sintesi di RNA e proteine. La prima fase è la trascrizione: l’informazione contenuta nel DNA viene copiata in un filamento di RNA complementare. Ciò avviene a opera dell’enzima RNA polimerasi che si lega alla sequenza del promotore e inizia la trascrizione in direzione 5’-3’. Durante la fase di traduzione, la sequenza di basi dell’RNA viene convertita in una sequenza amminoacidica. Tale fase si svolge sui ribosomi, strutture costituite da proteine e RNA ribosomiale, con il supporto di tRNA. La traduzione si basa
sul codice genetico che garantisce la corrispondenza tra la sequenza di basi dell’RNA e gli amminoacidi che costituiscono il polipeptide nascente.
12. Nei procarioti la regolazione dell’espressione genica avviene a vari livelli: trascrizionale; post-trascrizionale; traduzionale e post-traduzionale. Tra questi, il più importante è il trascrizionale, basato sul modello dell’operone. L’operone è una porzione del DNA in cui sono raggruppati i geni che codificano per proteine correlate; in tal modo possono essere regolati insieme. Il promotore contiene: il sito di legame della RNA polimerasi, detto promotore; un operatore, sito in cui si lega il repressore per impedire che la RNA polimerasi interagisca con il promotore; una regione contenente i geni strutturali e un terminatore che determina la fine della trascrizione. Questa disposizione fa sì che i geni strutturali vengano trascritti in un’unica ininterrotta molecola di mRNA, così che la cellula avrà a disposizione tutte le proteine coinvolte nello stesso processo. L’operone più noto è quello del lattosio (operone lac); i batteri lo impiegano per regolare l’espressione dei geni coinvolti nel metabolismo del lattosio. In assenza di lattosio questo sistema di regolazione fa sì che i geni coinvolti nel metabolismo del lattosio non vengano prodotti: è una sorta di risparmio energetico per il batterio. Al contrario, in presenza di lattosio, la trascrizione dell’operone si attiva, in maniera tale che il batterio possa impiegare il lattosio come fonte energetica.
13. La prima fase del ciclo litico, comune a quello lisogeno, è caratterizzata dallo stabilirsi di un legame fra le proteine del capside e specifici recettori situati sulla parete del batterio ospite. Tale fase si conclude con l’iniezione dell’acido nucleico del fago attraverso la parete del batterio ospite. A questo punto, i virus che compiono un ciclo litico entrano nella fase vegetativa, caratterizzata a sua volta da due fasi: precoce e tardiva. Nella fase precoce il virus sfrutta i sistemi di trascrizione e traduzione della cellula ospite per replicare il proprio DNA e distruggere quello batterico. Nella fase tardiva vengono assemblati i nuovi virioni, che lisano la cellula ospite e fuoriescono.
14. Per elementi genetici mobili si intendono delle porzioni di DNA in grado di muoversi all’interno del genoma grazie a specifici enzimi. Rientrano tra questi anche i plasmidi e i genomi fagici. Sono presenti sia nelle cellule procariotiche che in quelle eucariotiche e il meccanismo grazie al quale avviene il movimento è detto trasposizione. La sequenza genetica mobile, il trasposone, è spesso associata al gene che codifica per una proteina, la trasposasi, che ne favorisce l’escissione da un sito e l’inserzione in un nuovo sito. I trasposoni si dividono in due categorie principali: i trasposoni a DNA e i retrotrasposoni. I primi si muovono nel genoma con un meccanismo di “taglia e incolla”, vengono tagliati da un punto e vanno a inserirsi in un altro. I secondi derivano invece da precedenti infezioni retrovirali, ma hanno perso la capacità di produrre virioni. I retrotrasposoni sono comunque trascritti in RNA che viene copiato in cDNA, che può andare a inserirsi in nuovi siti del genoma.
Unità 6
FILA A
1. V.
2. F.
3. F.
4.
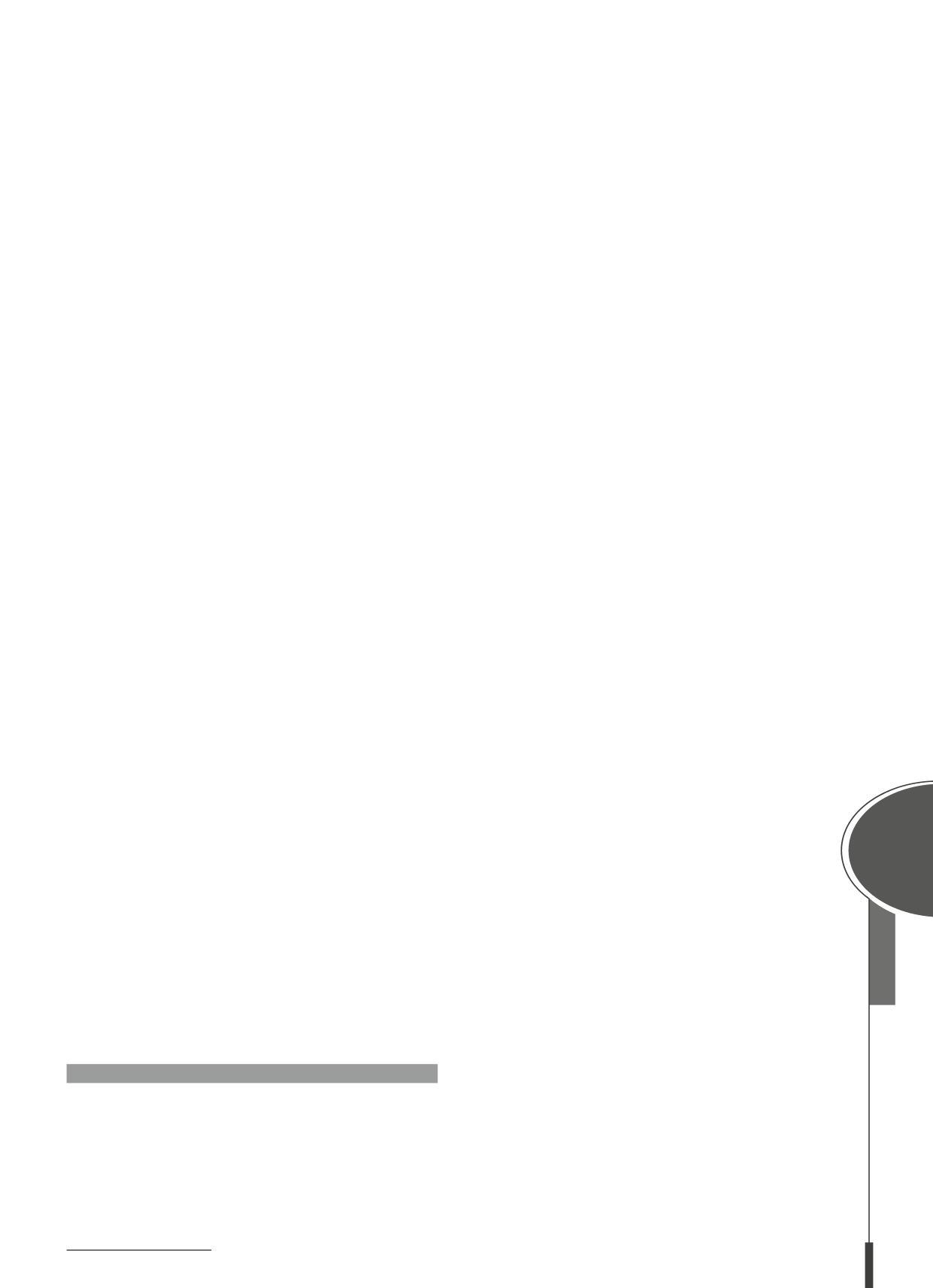
11. Nella tecnica del clonaggio, una molecola di DNA ricombinante contenente un gene di interesse o un suo frammento è inserita all’interno di una cellula ricevente, di solito un batterio. Per poter clonare un frammento di DNA, questo deve essere inserito all’interno di un vettore. A tale scopo, l’inserto e il vettore sono trattati con la medesima endonucleasi, in modo che le loro estremità siano complementari e possano essere poi unite tramite l’enzima DNA ligasi. L’ingresso del DNA ricombinante nella cellula bersaglio può avvenire impiegando diverse metodologie, a seconda del tipo di vettore e di cellula ospite. Una volta completato questo passaggio, è necessario verificare quali cellule contengono il DNA ricombinante avvalendosi di una caratteristica dei vettori, la presenza di uno o più geni reporter. 12. Il sequenziamento genico è la tecnica che permette di leggere la sequenza di un filamento di DNA mediante il metodo dei terminatori di catena o di Sanger. Dopo aver amplificato il filamento di DNA da analizzare, lo si suddivide in quattro aliquote e in ogni recipiente si aggiunge: l’enzima DNA polimerasi, i quattro deossi-nucleotidi-trifosfati (dATP, dCTP, dGTP, dTTP) e opportuni primer. Si aggiunge anche una certa quantità di un didesossinucleotide specifico, un analogo del nucleotide ma che manca del gruppo 3’-OH e quindi non è in grado di legarsi a un successivo nucleotide, impedendo l’allungamento ulteriore del filamento. Questo analogo è legato a un fluoroforo specifico dotato della proprietà di emettere luce. La DNA polimerasi ricopia fedelmente il filamento. Ogni tanto, però, anziché incorporare un nucleotide “normale”, usa un nucleotide modificato interrompendo la sintesi. Di conseguenza, si genera una serie di frammenti di lunghezza differente, ciascuno dei quali termina in corrispondenza del relativo nucleotide modificato. Le quattro miscele di frammenti ottenute in provetta vengono poi separate in base alla lunghezza, ricorrendo a una particolare elettroforesi capillare. Per ogni frammento, grazie al colore della relativa sonda fluorescente, è identificato il nucleotide terminale. Mettendo in ordine i frammenti ottenuti nelle quattro provette in base alla lunghezza e leggendo il relativo nucleotide modificato, è possibile ricostruire la sequenza complessiva. 13. La terapia genica mira a sostituire i geni responsabili di malattie con le rispettive copie funzionanti. I geni funzionanti possono essere introdotti nelle cellule del paziente attraverso diverse strategie. Una possibilità è l’utilizzo di vettori virali. In una particolare tecnica, chiamata AAVGT (associated adenovirus gene transfer), sono eliminate le sequenze geniche patogene dal genoma del virus e al loro posto è inserito il gene umano richiesto. Un altro metodo di trasferimento genico fa uso di liposomi, vescicole sferiche costituite da un doppio strato di fosfolipidi che, in un ambiente acquoso, tendono a delimitare un volume interno che può contenere il gene di interesse. I liposomi, avendo una struttura simile a quella della membrana cellulare, possono fondersi con essa rilasciando all’interno della cellula il proprio contenuto oppure possono entrare nella cellula per endocitosi. Il DNA, una volta entrato nella cellula, può arrivare fino al nucleo e integrarsi con il DNA genomico cellulare grazie a meccanismi di ricombinazione.
14. S = 4 · Log100/Log 1000 = 2,6 cm
15. 12 · 25 = 384.
FILA B
1. F. 2. F. 3. V.
F.
11. Con la tecnica dell’elettroforesi su gel un campione di DNA è fatto correre attraverso una matrice gelatinosa che agisce come un setaccio, separando i vari frammenti in funzione della loro dimensione. La scelta del gel dipende dal tipo di esperimento, anche se in genere l’agarosio è il più usato. La poliacrilammide, infatti, costituisce un setaccio più fine e permette quindi di separare frammenti di DNA di piccole dimensioni. La soluzione con il campione di DNA è posta all’interno di alcuni pozzetti situati a un’estremità del gel; poi sul gel è applicato un campo elettrico tramite due elettrodi: il catodo, carico negativamente, si trova in prossimità del campione e l’anodo, carico positivamente, si trova all’estremità opposta. Gli acidi nucleici sono caratterizzati dalla presenza di numerose cariche negative dovute al gruppo fosfato di ogni nucleotide. Essi quindi tendono a muoversi sotto l’azione del campo elettrico, migrando verso l’anodo.
12. Le scienze “omiche” si occupano dello studio di pool di molecole biologiche (acidi nucleici, proteine ecc.) che coinvolgono vari aspetti della complessa macchina metabolica di ogni essere vivente. Le scienze omiche analizzano, nel loro insieme: i geni del DNA (genomica) e le loro funzioni (genomica funzionale); i trascritti del DNA, cioè l’RNA (trascrittomica); le proteine (proteomica); i metaboliti all’interno di un organismo (metabolomica) e la lipidomica (che invece si occupa di studiare i lipidi).
13. Lo sviluppo di animali transgenici in ambito biomedico ha svariati scopi. Innanzitutto, è promettente per la produzione di sostanze di interesse farmaceutico. Si è riusciti, ad esempio, a inserire nel genoma di una gallina i geni umani responsabili della sintesi di proteine essenziali per il nostro sistema immunitario, di aiuto nella lotta ad alcuni tumori. In altri casi si è intervenuti sul genoma di mammiferi affinché secernessero nel latte molecole di interesse farmacologico. Un’altra applicazione riguarda l’utilizzo degli stessi come modelli di studio per alcune malattie genetiche. Rientrano in questa tipologia i topi knock-out, in cui uno o più geni sono stati inattivati. Questi animali permettono, pertanto, lo studio dell’inattivazione genica (che può essere correlata all’insorgenza di una patologia) sul metabolismo, sullo sviluppo e sul comportamento dell’animale in questione.
14. Tre frammenti di restrizione di 250, 350 e 100 pb. 15. 12 · 25 = 384.
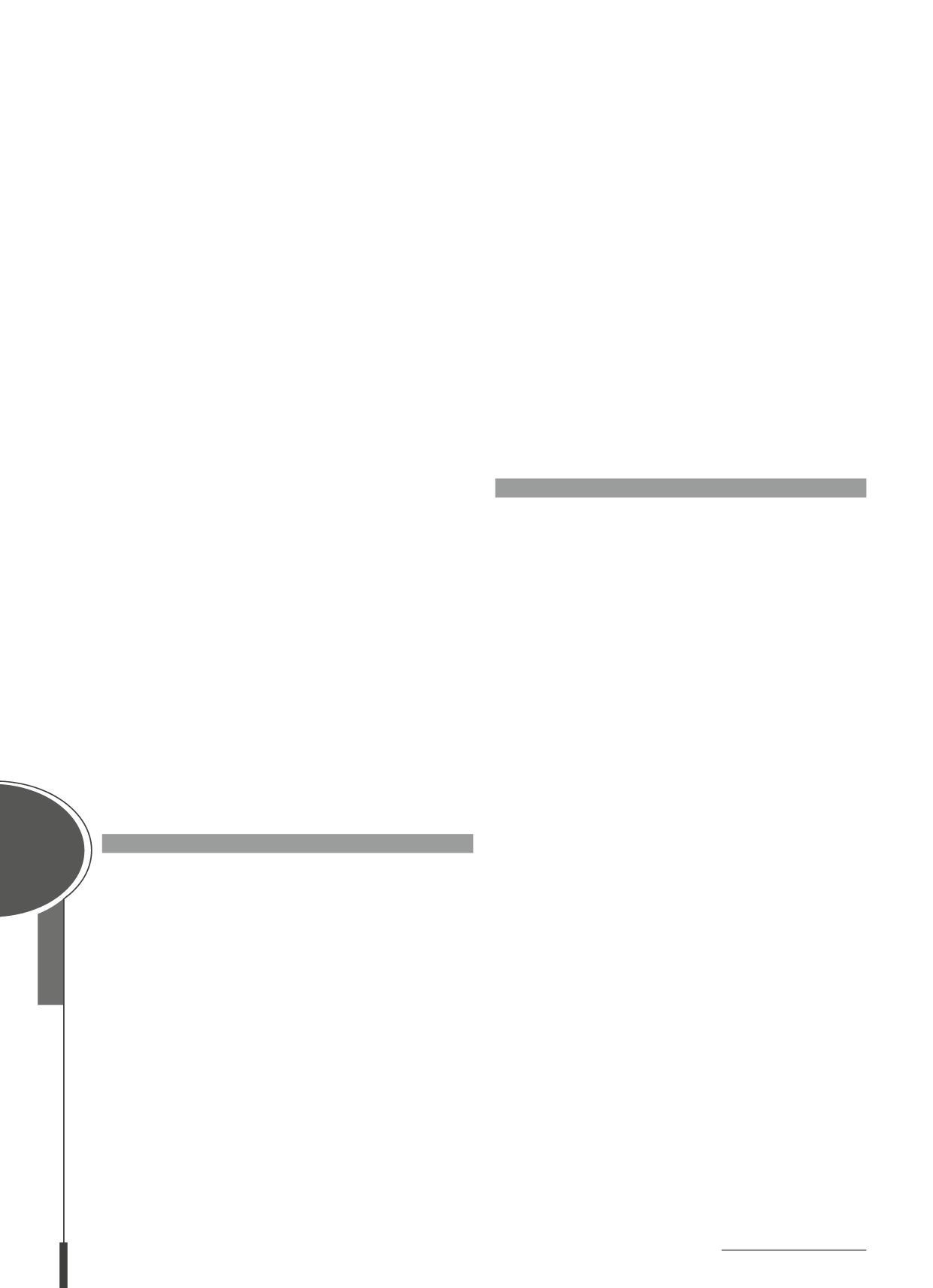
1. V. 2. V. 3. F. 4. V. 5. F. 6. F. 7. F. 8. V. 9. c. 10. a. 11. a. 12. d. 13. c.
14. È uno strumento costruito sul principio del pendolo installato nelle stazioni sismiche per registrare le onde liberate da un terremoto.
15. Il nucleo terrestre si estende dalla discontinuità di Gutemberg posta a 2900 km di profondità; costituisce circa il 16% del volume della Terra; presenta uno strato esterno liquido diviso da quello solido più interno dalla discontinuità di Lehmann. La temperatura interna raggiunge i 4000 °C, la pressione è di 3600 kbar. È composto da una lega di ferro e nichel con la presenza di zolfo e silicio, elementi più leggeri che determinano una densità del nucleo compresa tra 10 e 13,5 g/cm3
16. Sono movimenti di materiali fluidi che avvengono all’interno del mantello che permettono al calore endogeno di risalire in superficie.
17. Dall’elaborazione dei sismogrammi registrati in diverse stazioni sismiche si costruiscono le curve dei tempi di
propagazione delle onde P e S, le dromocrone, per risalire alla distanza tra il punto di rilevazione e l’epicentro del sisma.
FILA B
1. V. 2. F. 3. V. 4. V. 5. F. 6. F. 7. V. 8. V. 9. b. 10. d. 11. c. 12. d. 13. a.
14. Il sismogramma è il tracciato di un pennino su un rotolo di carta fissato su un cilindro rotante che è parte della struttura di un sismografo; dalla sua lettura è possibile misurare la durata e l’intensità di un sisma.
15. Si estende dalla discontinuità di Moho, che la divide dalla crosta, fino alla discontinuità di Gutemberg, ed è lo strato più esteso della Terra. È composta da rocce ricche di Fe e Mg e per questo molto dense, circa 5,6 g/cm3
16. I magmi sono classificati, in base al loro contenuto in SiO2, in basici, con meno del 50% di SiO2, acidi, con oltre il 70% SiO2, intermedi, con percentuali di silice intorno al 60%.
17. Sono le curve dei tempi di propagazione delle onde P e S, costruite sulla base dell’elaborazione dei sismogrammi registrati nelle diverse stazioni sismiche; servono per risalire alla distanza tra il punto di rilevazione e l’epicentro del sisma.
Unità 8
FILA A
1. V. 2. F. 3. V. 4. V. 5. F. 6. V. 7. F. 8. V. 9. a. 10. a. 11. b. 12. c. 13. d.
14. Il ritrovamento di rocce dello stesso tipo e della stessa età che affiorano lungo le coste di continenti oggi separati dall’oceano.
15. Si trovano in corrispondenza dei margini divergenti, dove sono disposte parallele tra loro e perpendicolari all’asse delle dorsali oceaniche, e in corrispondenza dei margini conservativi dove le placche scivolano l’una accanto all’altra con movimenti orizzontali.
16. Fornisce informazioni sulle anomalie magnetiche, sia positive sia negative, che si sono succedute nel passato della Terra e permette di datare le rocce che contengono materiali ferromagnetici.
17. Le sequenze ofiolitiche sono formate da frammenti di crosta continentale e di crosta oceanica con le relative coperture sedimentarie. Costituiscono la prova dell’esistenza di un oceano che un tempo separava i continenti.
B
1. V. 2. V. 3. F. 4. F. 5. V. 6. V. 7. V. 8. F. 9. a. 10. b. 11. b. 12. b. 13. c.
14. Il ritrovamento di resti fossili delle stesse piante e degli stessi animali nelle rocce affioranti in continenti oggi separati dall’oceano.
15. Si trovano in corrispondenza dei margini divergenti, dove suddividono le dorsali oceaniche in tanti tronconi che scivolano gli uni rispetto agli altri, e in corrispondenza dei margini conservativi.
16. Fornisce informazioni sulle anomalie magnetiche, sia positive sia negative, che si sono succedute nel passato della Terra e permette di datare le rocce che contengono materiali ferromagnetici.
17. Le sequenze ofiolitiche sono formate da frammenti di crosta continentale e di crosta oceanica con le relative coperture sedimentarie. Costituiscono la prova dell’esistenza di un oceano che un tempo separava i continenti.
1. F. 2. V. 3. F. 4. V. 5. F. 6. V. 7. F. 8. V. 9. c. 10. a. 11. a. 12. b. 13. c.
14. L’effetto serra è di grande importanza per il mantenimento delle condizioni termiche adatte alla vita: tuttavia se le concentrazioni di gas serra aumentano, il fenomeno subisce un incremento e le temperature dell’atmosfera terrestre aumentano. Dalla fine del XIX secolo ad oggi la temperatura della troposfera è aumentata di circa 0,6 °C ed entro la fine del secolo attuale l’innalzamento della temperatura potrebbe attestarsi tra 1,1 °C e 6,4 °C.
15. Più ci si allontana dalla superficie terrestre, minore è la quantità di aria sovrastante; di conseguenza la pressione diminuisce con la quota. Inoltre, poiché una maggiore pressione implica una compressione dei gas in un volume minore, a quote via via più elevate avremo anche una diminuzione della densità delle masse d’aria.
16. L’umidità assoluta è la quantità in grammi di vapore d’acqua contenuta in un metro cubo d’aria ad una determinata temperatura. L’umidità relativa è il rapporto tra l’umidità assoluta e la quantità di vapor d’acqua che lo stesso volume d’aria potrebbe contenere, in condizione di saturazione, alla stessa temperatura.
17. Fluttuazioni nella quantità di radiazione emessa dal Sole: la radiazione dipende dalle esplosioni che si verificano sulla superficie solare, a loro volta connesse con la comparsa delle macchie solari; variazioni nei parametri orbitali: la quantità di radiazione che giunge sulla Terra dipende anche da tre parametri orbitali terrestri che variano ciclicamente: direzione verso cui è inclinato l’asse terrestre, obliquità dell’asse, eccentricità dell’orbita terrestre; attività vulcanica: immissione di gas e ceneri in atmosfera.
FILA B
1. V. 2. F. 3. V. 4. V. 5. F. 6. V. 7. V. 8. V. 9. b. 10. c. 11. d. 12. b. 13. a.
14. L’effetto serra è un fenomeno che avviene nell’atmosfera: l’aria si lascia attraversare dalle radiazioni a onda corta provenienti dal Sole e intercetta e riflette la maggior parte delle radiazioni a onda lunga emesse dalla superficie terrestre.
15. Temperatura: l’aumento di energia cinetica associato al riscaldamento di una massa d’aria la fa espandere, ne riduce la densità e la fa salire verso l’alto, con una conseguente diminuzione della pressione. Umidità: a parità di temperatura, un volume di aria umida è meno denso di uno di aria secca, per cui l’aumento di vapore acqueo provoca una risalita della massa d’aria e una diminuzione di pressione.
16. La temperatura alla quale il vapore comincia a condensare si chiama punto di rugiada. La condensazione (o il brinamento qualora il vapore passi direttamente allo stato solido) può avvenire solo in presenza di particelle di pulviscolo atmosferico che diventano nuclei di condensazione attorno ai quali si aggregano le goccioline di acqua liquida.
17. Cambiamento nell’albedo della Terra; variazioni del vapore acqueo; alterazioni delle correnti oceaniche; fusione del permafrost; aumento della temperatura degli oceani.
Unità 10
di materia organica vegetale terrestre accumulatasi prevalentemente circa 345 milioni di anni fa. Il clima caldoumido di quel periodo favoriva l’espansione delle paludi nelle zone costiere e la crescita di immense foreste, e le periodiche inondazioni provocavano la morte di enormi porzioni di foresta con la ricrescita della copertura vegetale non appena le zone costiere riemergevano. I resti organici delle piante accumulatisi nelle zone paludose, coperte da strati di fango e sabbia, iniziavano il loro processo di diagenesi, ma il poco ossigeno presente nelle acque interstiziali veniva rapidamente consumato dalle prime fasi di decomposizione. Ben presto, quindi, entravano in gioco batteri anaerobi che riducevano progressivamente le quantità di idrogeno, azoto e ossigeno, determinando l’aumento della concentrazione di carbonio. Tale processo è detto di carbogenesi.
15. L’energia idroelettrica si ottiene per trasformazione dell’energia potenziale di una massa di acqua in quiete o dell’energia cinetica di una corrente d’acqua in energia meccanica, e da questa in energia elettrica. Un flusso d’acqua aziona delle turbine e, a seguire, dei generatori che producono elettricità. Esistono impianti idroelettrici che possono o meno regolare il flusso dell’acqua: nel primo caso sono sfruttati bacini (naturali o artificiali) la cui capienza viene aumentata con la costruzione di dighe. Gli impianti idroelettrici collegati alle dighe regolano la portata del deflusso e quindi la quantità di energia prodotta; regolando i flussi dell’acqua, le dighe possono controllare le inondazioni o essere utilizzate per l’irrigazione ma, d’altro canto, possono apportare effetti negativi all’ecologia della regione.
16. Per sviluppo sostenibile si intende una crescita economica che salvaguardi l’ambiente e le risorse della Terra per le generazioni future, estendendo una qualità di vita accettabile a tutta la popolazione mondiale. Si tratta dell’unica strada percorribile per la sopravvivenza della Terra e della comunità umana ed è proprio per questo che si cerca di mettere a punto nuovi sistemi produttivi che garantiscano lo sviluppo delle attività umane e dell’economia, ma con il minor impatto possibile per il pianeta.
17. La COP 26 ha introdotto per la prima volta un riferimento alla riduzione del consumo di carbone, le cui emissioni rappresentano quasi il 40% del CO2 emesso su scala globale. Alla COP 26 quasi tutti i partecipanti hanno inserito un obiettivo di raggiungimento della neutralità carbonica: per l’Unione Europea, gli Stati Uniti e un altro gruppo di Paesi tale scadenza è il 2050, mentre la Cina e l’India hanno proposto rispettivamente il 2060 e il 2070.
FILA B
1. V. 2. F. 3. F. 4. V. 5. V. 6. V. 7. F. 8. F. 9. a. 10. d. 11. a. 12. c. 13. d.
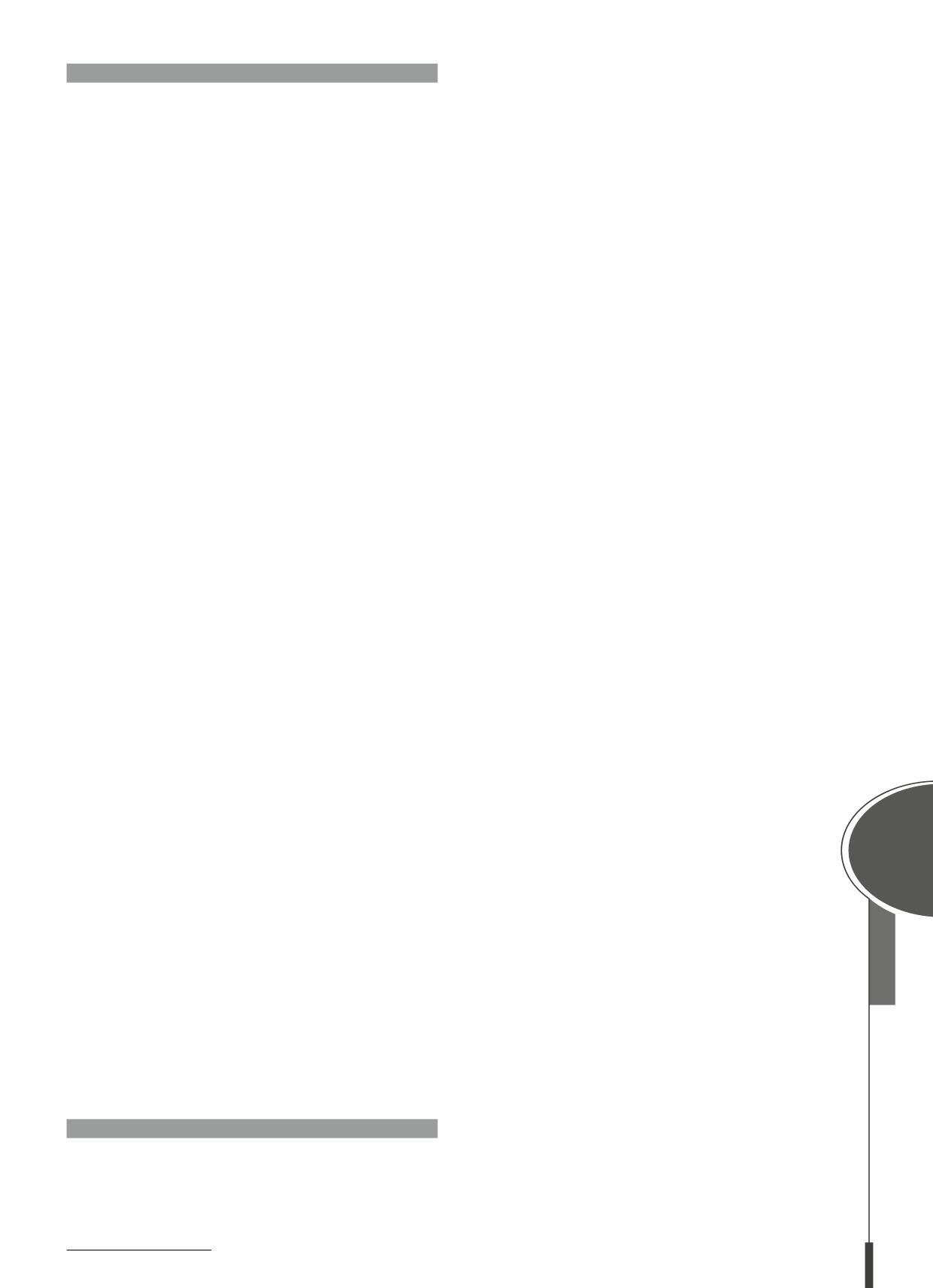
FILA A
1. V. 2. F. 3. F. 4. V. 5. F. 6. V. 7. V. 8. F. 9. c. 10. a. 11. b. 12. a. 13. b.
14. I carboni fossili sono il prodotto della maturazione
14. Petrolio e gas naturali sono i prodotti finali della maturazione di particolari rocce, dette rocce madri di idrocarburi. Queste rocce si formarono, prevalentemente durante l’era mesozoica, per accumulo di materia organica di origine marina. Si ritiene che le condizioni riducenti siano state innescate dall’elevato contenuto di CO2 atmosferico e che la materia organica si sia poi accumulata principalmente in piccoli bacini chiusi o sui margini continentali. Quando la materia organica raggiunge il fondo di questi ambienti subisce solo in parte la decomposizione ad opera dell’ossigeno libero, mentre il resto dei materiali è rapidamente seppellito dai sedimenti che si depositano successivamente. Nei primi decimetri sotto l’interfaccia acqua/sedimento, tuttavia, continuano i processi di ossidazione della materia organica a opera di batteri anaerobi. Così, a bassa profondità, si forma il metano, mentre in uno specifico intervallo di temperatura/profondità,
detta oil window, la materia organica si trasforma in petrolio.
15. L’energia solare che raggiunge la Terra è pari a quella prodotta da 115 milioni di centrali nucleari. Questa energia può essere sfruttata in due modi: tramite i pannelli solari, dispositivi in grado di intercettare le radiazioni solari, concentrarle e trasferire il calore con lo scopo di produrre acqua calda o riscaldare gli edifici, oppure tramite celle fotovoltaiche che si basano sulla capacità di alcuni materiali di produrre energia elettrica quando sono esposti ai raggi solari. Entrambi questi sistemi di utilizzo dell’energia solare necessitano però di ampi spazi per la loro installazione.
16. Nel 2015, in occasione del Summit sullo Sviluppo
Sostenibile, i Capi di Stato di 193 paesi membri dell’ONU hanno approvato l’Agenda Globale per lo Sviluppo
Sostenibile, che fissa gli impegni da realizzare entro il 2030 da parte di tutti i Paesi aderenti. L’Agenda propone un programma d’azione internazionale per le persone, il pianeta e la prosperità, perché riconosce il legame tra benessere umano, salute dei sistemi naturali e sfide comuni
che tutti i Paesi sono chiamati ad affrontare. Gli obiettivi dell’Agenda 2030 toccano diversi ambiti, dalla lotta alla fame all’eliminazione delle disuguaglianze, dalla tutela delle risorse naturali all’affermazione di modelli di produzione e consumo sostenibili, includendo anche il concetto di sostenibilità sociale e lo sradicamento della povertà in tutte le sue forme.
17. L’economia circolare si occupa delle attività volte alla manutenzione e al riuso di beni di consumo già esistenti e al recupero delle materie prime. Nei sistemi produttivi dell’economia circolare, gli oggetti devono essere progettati per non avere mai fine, per essere reintrodotti nel ciclo produttivo come materie prime o reintegrati nei cicli naturali. Accanto alle materie prime tradizionali, si stanno affermando le materie prime seconde, costituite dai residui della lavorazione delle materie prime o da quelli provenienti dal riciclo e dal recupero dei rifiuti. L’economia circolare richiede, naturalmente, un deciso cambiamento anche nella produzione di energia, che deve derivare esclusivamente da fonti di energia rinnovabili.
Soluzioni delle verifiche sommative semplificate
Unità 1
1. V. 2. F 3. V 4. V 5. F 6. b 7. c 8. d
9. isomeri geometrici – diversi
10. triclorometano
11. luce polarizzata
12. risonanza
13. triplo legame

Unità 2
1. V 2. V 3. F 4. F 5. F 6. b 7. d 8. d 9. a
10. ossidrile, alcoli
11. acidi carbossilici, acido
12. epossidi
13. idrolisi, condensazione
Unità 3
1. V 2. V 3. F 4. V 5. V 6. b 7. a 8. c 9. a
10. carboidrati
11. amilopectina – lineare
12. lipidi
13. oligosaccaridi
14. proiezione
Unità 4
1. V 2. F 3. F 4. F 5. F 6. b 7. b 8. c 9. b
10. eucariote – fosforilazione ossidativa.
11. ciclo di Krebs
12. cloroplasti
13. clorofilla – luce.
14. G3P
15. zucchero
Unità 5
1. V 2. V 3. F 4. V 5. F 6. V 7. c 8. c 9. b
10. degradazione
11. litico
12. orizzontale
13. procarioti – polipeptide
Unità 6
1. V 2. V 3. F 4. F 5. V 6. V 7. d 8. b 9. b 10. a
11. elettroforesi
12. proteomica
13. agarosio.
14. estrazione del DNA – proteolitici
Unità 7
1. V 2. F 3. V 4. V 5. c 6. d 7. d 8. c
9. discontinuità
10. sismografo
11. effusive
12. intensità
Unità 8
1. V. 2. V. 3. F. 4. V. 5. a. 6. b. 7. c.
8. deriva dei continenti.
9. Panthalassa. 10. divergente. 11. orogenesi.
Unità 9
1. F 2. V 3. F 4. V 5. F 6. F 7. V 8. a 9. c 10. a 11. c
12. mesosfera
13. barometro
14. effetto serra
15. isobare
Unità 10
1. F 2. F 3. V 4. F 5. V 6. c 7. a 8. c 9. d
10. cenozoica – 65 milioni
11. COP 26
12. circolare
13. fotovoltaiche
SOLUZIONI DEGLI ESERCIZI
DEL VOLUME
Unità 1
Risposta breve
Pag. 5
1. Eteroatomi. 2. Modello degli orbitali ibridi. 3. Per fusione di tre orbitali p e un orbitale s 4. Una modalità di rappresentazione delle molecole organiche, in cui una linea spezzata simboleggia una catena carboniosa, con un atomo di carbonio per ogni angolo che forma la linea. Gli atomi di idrogeno sono impliciti, mentre eventuali eteroatomi vanno esplicitati. 5. Quando lega direttamente tre atomi di carbonio.
Pag. 11
1. C n H2n+2 2. C10H22 3. Butano. 4. È un sostituente di una molecola organica, formato solo da atomi di carbonio e idrogeno.
Pag. 14
1. C n H2n 2. Avendo un maggior numero di atomi appartenenti al ciclo, il cicloesano ha una tensione di anello minore, corrispondente a una minore energia potenziale.
Pag. 18
1. I punti di fusione e di ebollizione, la solubilità, la reattività verso composti achirali sono identiche. Variano invece le proprietà “chirali”, cioè, ad esempio, la capacità di ruotare la luce piano-polarizzata e il comportamento verso sostanze chirali.
2. Per la nomenclatura degli enantiomeri vige il sistema R/S, che si basa sulle regole di priorità CIP.
Pag. 22
1. Il doppio legame si forma per fusione tra due orbitali ibridi sp2 (per dare il legame σ) e per fusione tra due orbitali non ibridi p (per dare il legame π).
2. Perché il doppio legame non è liberamente rotabile, e i gruppi che lega sono vincolati a un solo lato del doppio legame. Possono quindi esistere isomeri geometrici, in cui i sostituenti ai due lati del doppio legame sono disposti in posizioni reciproche diverse.
Pag. 23
1. L’ibridizzazione sp. In particolare, nel triplo legame c’è la fusione di due orbitali sp, e di due coppie di orbitali p. 2. 180°.
Pag. 26
1. Il benzene ha due strutture limite di risonanza.
2. Nella sua accezione moderna, il termine “aromatico” si attribuisce a sostanze insature che hanno determinate proprietà strutturali e chimiche. Il termine origina dal fatto che molti composti aromatici sono effettivamente dotati di odori caratteristici e intensi.
RIPASSA CON METODO
Dall’alto verso il basso e da sinistra a destra carbonio – per sintesi – fisiche
IDROCARBURI – aperta – chiusa
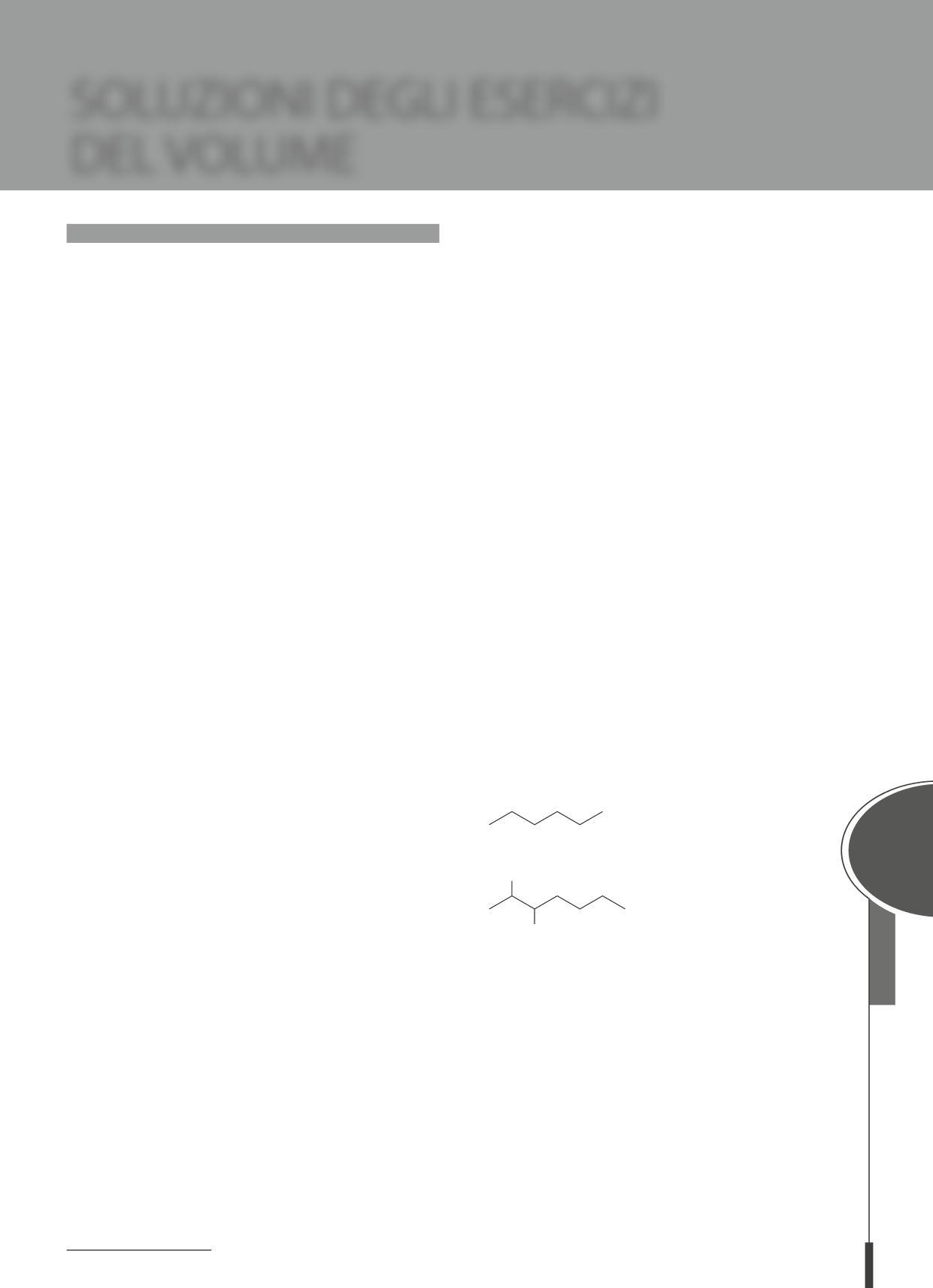
singoli – doppio – triplo legame – benzene linee – solitarie
ISOMERI DI STRUTTURA
CONOSCENZE E ABILITÀ
1. V, F, V, F, V, V.
2. La chimica organica si occupa dei composti contenenti carbonio.
3. Carbonio e idrogeno.
4. Idrocarburi saturi e insaturi.
5. V, F, F, V.
6. C n H2n+2
7. Sono composti che hanno la stessa formula molecolare, e che differiscono per il modo in cui i loro atomi sono connessi tra loro. Hanno quindi una diversa formula di struttura.
8. A.
9. B.
10. Primario: legato a 1 solo atomo di C, quaternario: legato a 4 atomi di C.
11. Attribuire ai carboni con i sostituenti (o col maggior numero di sostituenti) i numeri più bassi possibili.
12. B.
13. C.
14. Problema svolto con soluzione presente sul volume.
15. B.
16. a. 3-metilesano; b. 2, 2, 4-trimetilpentano; c. 3-etil-2,4dimetilesano; d. 3,4-dimetilesano.
17. 18.
19. V, F.
20. Formula dei cicloalcani: C n H2n; formula degli alcani: Cn H2n+2
21. C7H14
22. D.
23.
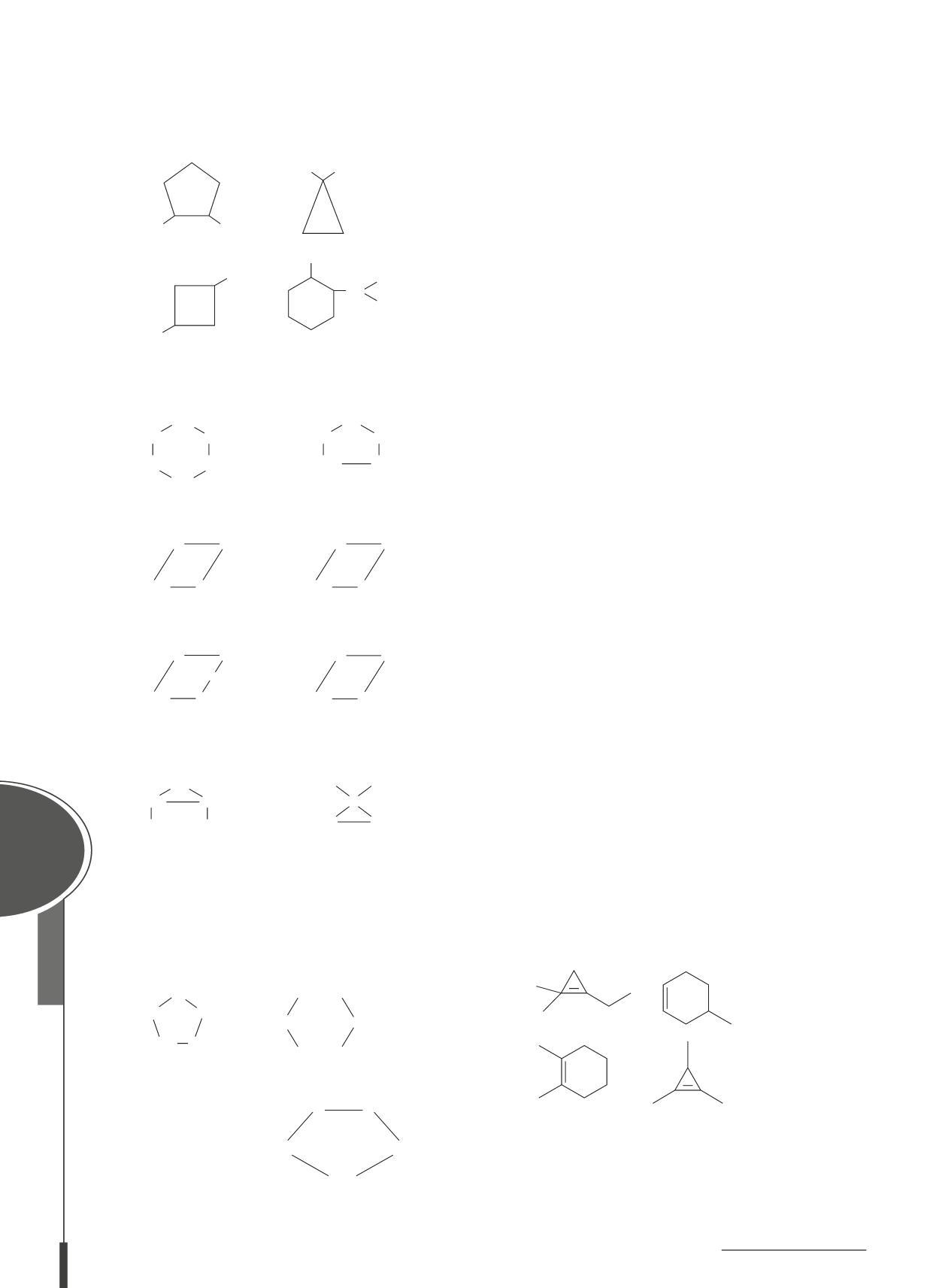
28. achirali, configurazione.
29. Tutti hanno la stessa composizione elementare, cioè la stessa formula molecolare. Gli isomeri di struttura, o costituzionali, hanno una diversa connettività tra gli atomi. Gli isomeri conformazionali hanno la stessa connettività atomica, ma una diversa disposizione degli atomi nello spazio, e sono liberamente interconvertibili per semplice rotazione dei legami. Anche gli isomeri geometrici dispongono diversamente gli atomi, ma non sono tra loro interconvertibili, a meno di rompere e riformare legami covalenti. Gli isomeri ottici, invece, sono caratterizzati dalla presenza di almeno un centro chirale, e dalla differente configurazione di esso.
a. 1,2-dimetilciclopentano; b. 1,3-dimetilciclobutano; c. 1,1-dimetilciclopropano; d. 1-isopropil-2-metilcicloesano.
24.
CH3
g. CH CH CH3 CH CH3 CH3 C CH3 CH2 H C CH3 CH2 H e. 3 CH2 C CH C C H 3 C CH H cicloesano
cis-1,2-dimetilciclobutano d. C CH3 CH2 H C H CH3 CH2 trans-1,2-dimetilciclobutano
cis-1,3-dimetilciclobutano
1,2,3-trimetilciclopropano h. f. 3 CH2 C CH H C H 3CH trans-1,3-dimetilciclobutano metilciclopentano C CH CH CH3
CH3 CH3
1,1,2-trimetilciclopropano
Inoltre è possibile disegnare: 1,1- dimetilciclobutano, etilciclobutano,1-etil-1-metilciclopropano, 1-etil-2-metilciclopropano, propilciclopropano, isopropilciclopropano.
25. Problema svolto con soluzione presente sul volume.
26.
a. CH3 CH CH2
CH2 CH2 CH2
b. CH2 CH CH3 CH3 — — CH d. c. H H
CH2 CH3 C CH3
27. F, V, V.
40. a. cis-; b. trans-; c. non è un isomero geometrico. 41. F, V, F, V. 42. sp. 43. B. a.
30. Deve avere una ibridazione sp3, e deve essere legato a quattro atomi o sostituenti differenti. Se l’atomo appartiene a un ciclo, le due metà del ciclo non devono essere simmetriche.
31. C.
32. V, V, F.
33. Due isomeri geometrici, il cis- e il trans-2-butene.
34. La sovrapposizione di due orbitali sp2 di due diversi atomi di carbonio crea il legame σ, mentre l’orbitale p normale al piano interagisce con un altro orbitale p per creare un legame π
35. Problema svolto con soluzione presente sul volume.
36. 1-eptene, 2-eptene, 3-eptene; 1-esene con gruppo metilico in posizione 2 o 3 o 4 o 5; 2-esene con gruppo metilico in posizione 2 o 3 o 4 o 5; 3-esene con gruppo metilico in posizione 2 o 3; poi le varie combinazioni di 1-pentene o 2 pentene con 2 gruppi metilici come gruppi sostituenti o un gruppo etile. 1-eptene / 2-eptene (*) / 3-eptene (*) / 2-metil-1-esene / 3-metil-1-esene / 4-metil-1-esene / 5-metil-1-esene / 2-metil-2-esene / 3-metil-2-esene (*) / 4-metil-2-esene (*)/ 5-metil-2-esene (*) / 2-metil-3-esene (*) / 3-metil-3esene (*) / 2,3-dimetil-1-pentene / 2,4-dimetil-1-pentene / 2-etil-1-pentene / 3-etil-1-pentene / 2,3-dimetil-2-pentene / 3,4-dimetil-2-pentene (*) / 2,4-dimetil-2-pentene / 3-etil-2pentene / 2-etil-3-metil-1-butene / 2,3,3-trimetil-1-butene. Le strutture che hanno isomeri geometrici sono evidenziate con “(*)”
37. B.
38.
CH2 CH3
CH3 CH=C CH2 CH3
39.
CH2 C CH3 H C CH3 H C CH2 CH2 CH2
CH3 C C=C CH2 CH2 CH3 a. b. CH3 CH3 H CH3 d. b. c. a.
CH2 CH2
44. D.
45. 46. F, V.
47. sp2
48. L’aromaticità si ha in sostanze aventi una particolare struttura elettronica, che le rende particolarmente stabili e gli conferisce una peculiare reattività.
49. A.
50. C.
51. A.
52. A.
53. V, F.
54. La combustione è una reazione esotermica tra l’ossigeno e una sostanza combustibile, come ad esempio un idrocarburo. La reazione produce acqua e anidride carbonica, ed eventualmente delle quantità di monossido di carbonio.
55. Consideriamo ad esempio l’n-pentano, il 2-pentene e l’1-pentino, aventi rispettivamente formula: C5H12, C5H10 e C5H8
Le tre reazioni bilanciate di combustione completa sono:
C5H12 + 8O2 → 5CO2 + 6H2O
2C5H10 + 15O2 → 10CO2 + 10H2O
C5H8 + 7O2 → 5CO2 + 4H2O.
COMPETENZE
56.
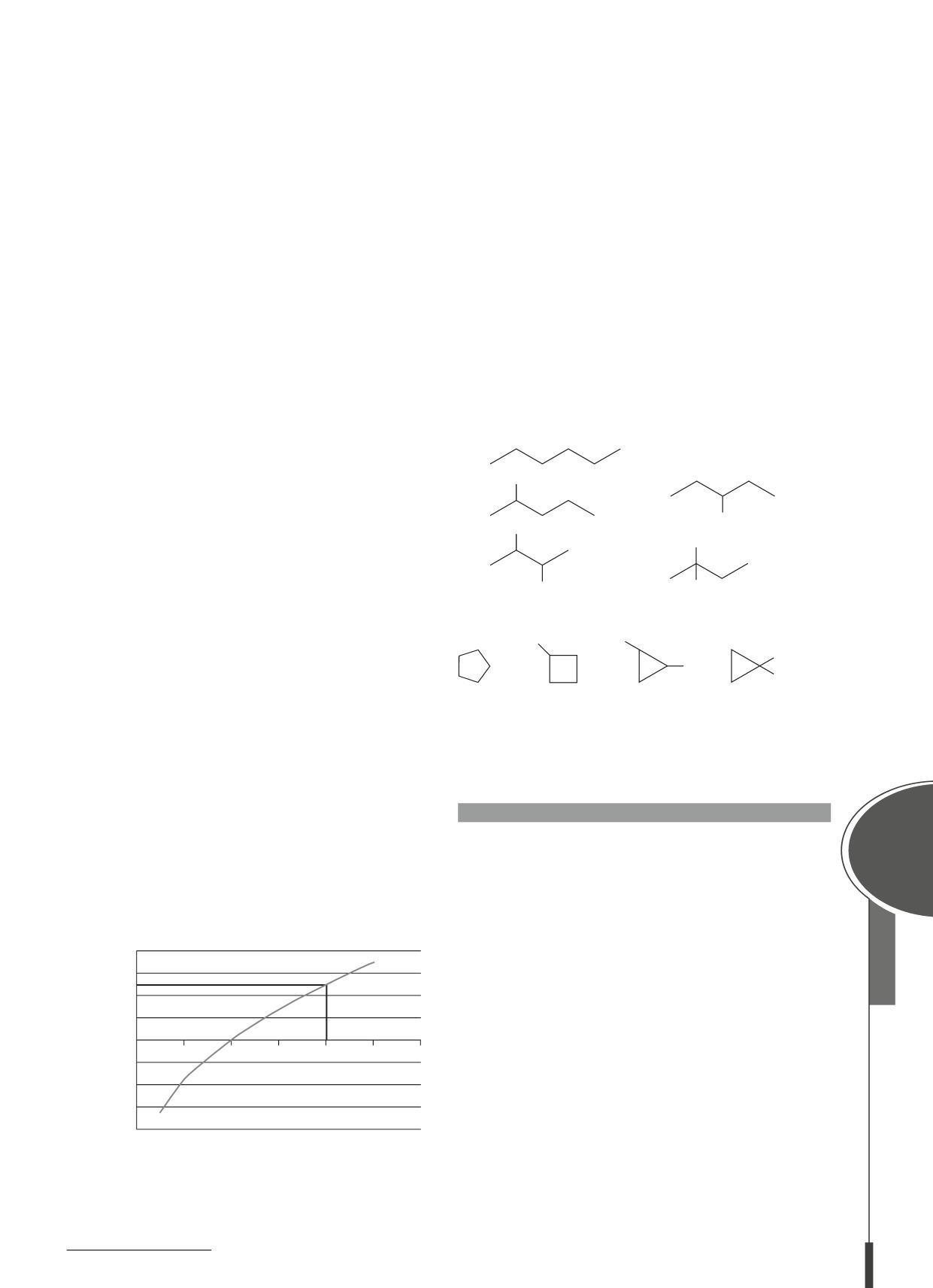
57. a. CH3—CH=CH—CH2—CH2—CH3
b. CH2 =CH—CH2—CH2—CH2—CH2—CH2—CH3
58. A hybrid orbital is formed by the combination of atomic orbitals to create new orbitals for bonding. These hybrid orbitals have different shapes and orientations compared to the original atomic orbitals. The type of hybridization (sp, sp², sp³) depends on the number and arrangement of electron pairs around the atom, influencing molecular geometry.
59. Risposta aperta.
60. Risposta aperta.
61.
All’aumentare della massa molecolare dell’idrocarburo, i punti di ebollizione crescono. Per interpolazione dal grafico si ottiene per il n-ottano un valore di temperatura di ebollizione (125 °C) in ottimo accordo con il valore effettivo di 125,5 °C.
62. razionali
CH3 CH2 CH2 CH2 CH2 CH3 CH3 CH CH2 CH2 CH3 CH3 CH2 CH CH2 CH3 CH3 CH3
4. CH3CH(CH3)CH(CH3)CH3 5. CH3C(CH3)2CH2CH3
CH3CH2CH(CH3)CH2CH3
topologiche
63. A un cicloalcano.
Si tratta, da sinistra a destra, del ciclopentano, metilciclobutano, 1,2-dimetilciclopropano e 1,1-dimetilciclopropano.
64. Risposta aperta.
65. Risposta aperta.
Unità 2
Risposta breve
Pag. 36
1. Il gruppo ossidrile, –OH.
2. Si nominano partendo dal nome dell’idrocarburo da cui derivano, sostituendo all’ultima lettera il suffisso -olo. Nella numerazione della catena carboniosa di alcoli con sostituzioni o ramificazioni, occorre assegnare il più basso numero possibile al carbonio che lega l’ossidrile.
3. Sono composti aventi il gruppo –OH direttamente legato a un anello aromatico.
Pag. 37
1. Gli eteri hanno due gruppi alchilici e/o arilici legati allo stesso atomo di ossigeno.
2. Sono eteri ciclici a tre termini.
3. Si nominano “spezzando” idealmente l’etere (R–O–R’) in due parti (R–) e (–O–R’), facendo in modo che la parte che perde l’ossigeno (R–) sia quella col maggior numero di atomi di carbonio. Questa parte, che è un gruppo alchilico, prende il nome dell’alcano da cui deriva. L’altra parte (–O-R’), che è genericamente definita “sostituente alcossilico”, prende il nome del gruppo alchilico da cui deriva, per sostituzione del
suffisso -ile col suffisso -ossi. Il nome dell’etere si ottiene unendo il nome del sostituente alcossilico col nome dell’alcano, in questo ordine.
Pag. 38
1. È il gruppo carbonilico.
2. La desinenza è “-ale”.
3. Acetone.
Pag. 40
1. Il carbossile, –COOH.
2. Il Calpha equivale al C2.
3. Sono acidi carbossilici che possiedono, almeno un gruppo –OH legato alla catena carboniosa.
Pag. 41
1. Sono gruppi funzionali contenenti azoto, formalmente derivati dall’ammoniaca per sostituzione di uno o più dei suoi atomi di idrogeno con altrettanti gruppi alchilici o arilici.
2. Possono essere classificate in base al numero di gruppi alchilici o arilici che lega l’azoto: se l’azoto lega un solo gruppo alchilico o arilico l’ammina è primaria, se due secondaria, se tre terziaria.
3. È la principale ammina aromatica. Il suo nome IUPAC è fenilammina.
Pag. 44
1. Sono molecole (macromolecole) che si formano per unione ripetuta di un gran numero di unità di base, definite monomeri.
2. Le proteine sono dei polimeri naturali, presenti in ogni organismo vivente. Il polipropilene è, invece, un importante polimero di sintesi.
RIPASSA CON METODO
Dall’alto verso il basso e da sinistra a destra
GRUPPI FUNZIONALI – fisiche e chimiche
ETEROCICLI
unità strutturali – monomeri
—X
—OH
ETERI
—NH2
ALDEIDI E CHETONI
—COOH
ANIDRIDI
—CO—NH2
—COO—C
—OH
CONOSCENZE E ABILITÀ
1. F, V, F.
2. È un determinato atomo o gruppo di atomi che caratterizza una classe di composti e da cui dipendono le proprietà chimiche e fisiche della classe stessa.
3. C.
4. A seconda del tipo di atomo di carbonio (primario, secondario o terziario) a cui è legato l’alogeno.
5. A.
6. a. –NH2; b. –X; c. –O–; d. C=O.
7. a. alcol; b. aldeide; c. chetone; d. acido carbossilico; e. estere; f. etere.
8. F, V.
9. ossidrile, alcoli.
10. Gli alcoli hanno formula generale R—OH, dove R è un gruppo alchilico, mentre i fenoli hanno formula Ar—OH, dove Ar è un gruppo arilico (aromatico).
11. Il tipo di atomo di C a cui è legato l’ossidrile.
12. Gli alcoli sono composti formalmente derivati dall’acqua H—O—H per sostituzione di un atomo di idrogeno con un gruppo alchilico R, gli eteri per sostituzione di entrambi gli atomi di idrogeno con altrettanti gruppi R e/o Ar.
13. d.
14. a.
15. d.
16. 2,2-dimetilpropanolo. È un alcol primario.
17.
a) 2-metil-3-propanolo, secondario; b) 1-pentanolo, primario; c) 2-pentanolo, secondario; d) 3-pentanolo, secondario.
18.
a) 3-metilbutanolo;
b) 2-metil-2-propanolo (detto anche alcol t-butilico);
c) 4-penten-2-olo;
d) 2-metil-1,4-butandiolo; e) ciclopentanolo.
19.
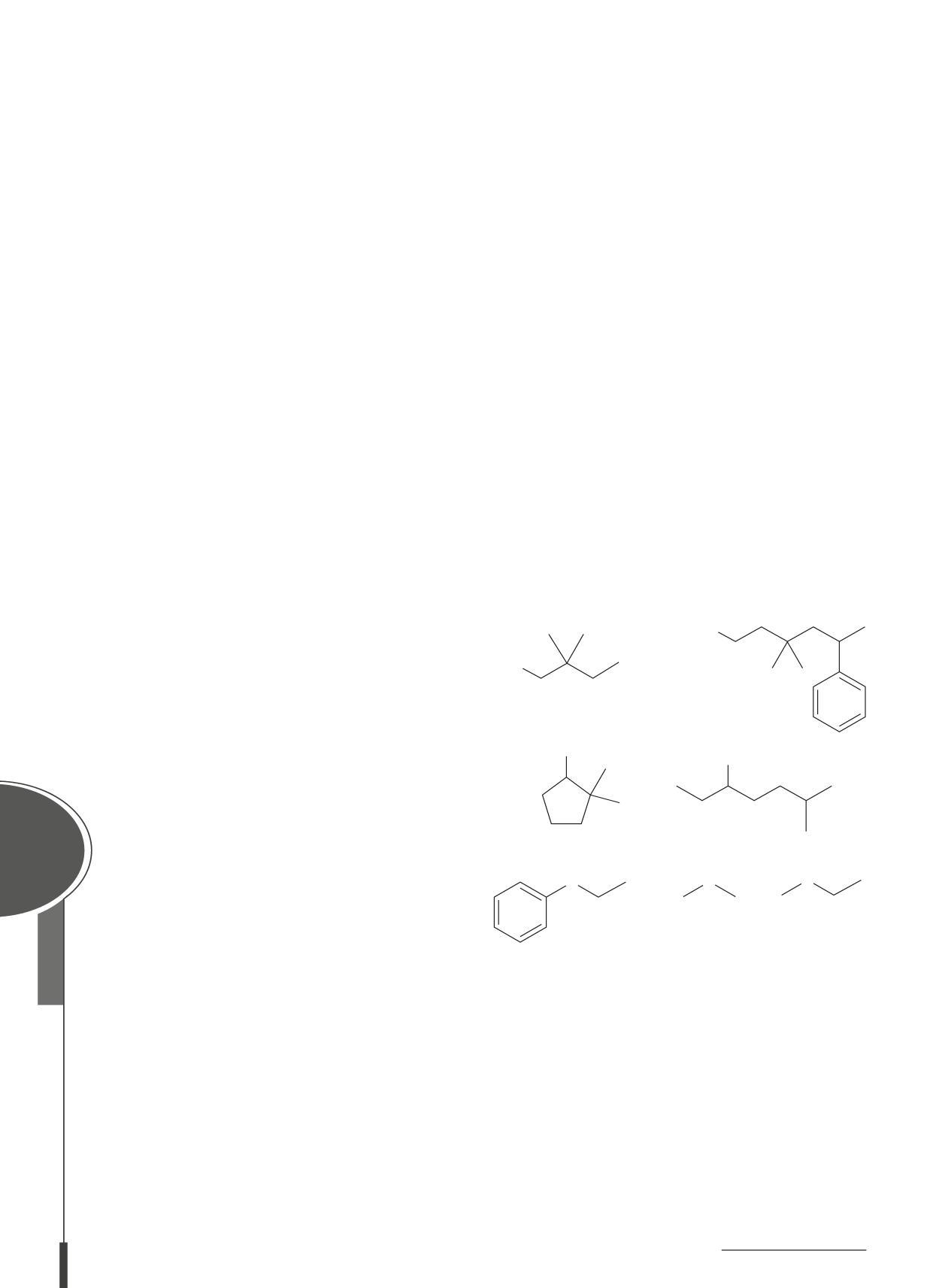
20. V, V.
21. Il gruppo carbonilico, –CO–.
22. metanale; etanale.
23. – ale per le aldeidi, -one per i chetoni.
24. butanale.
25. A.
26. C.
27. A.
28.
a) 3-metilbutanale; b) 4-metilpentanale; c) 3-metil-2-butanone; d) 2-metil-3-pentanone.
31. F, V, V, F.
32. Il carbossile è un gruppo carbonilico a cui è legato anche un ossidrile.
33. Etanammide
34. B.
35. B.
36. C.
37. C.
38.
a) Acido metilpropanoico; b) Acido 3-metilesanoico; c) Acido 3-cloropentanoico.
39. Anidride;
a) Estere; b) Etere; c) Cloruro acilico; d) Ammide.
40. CH3—CHOH—COOH.
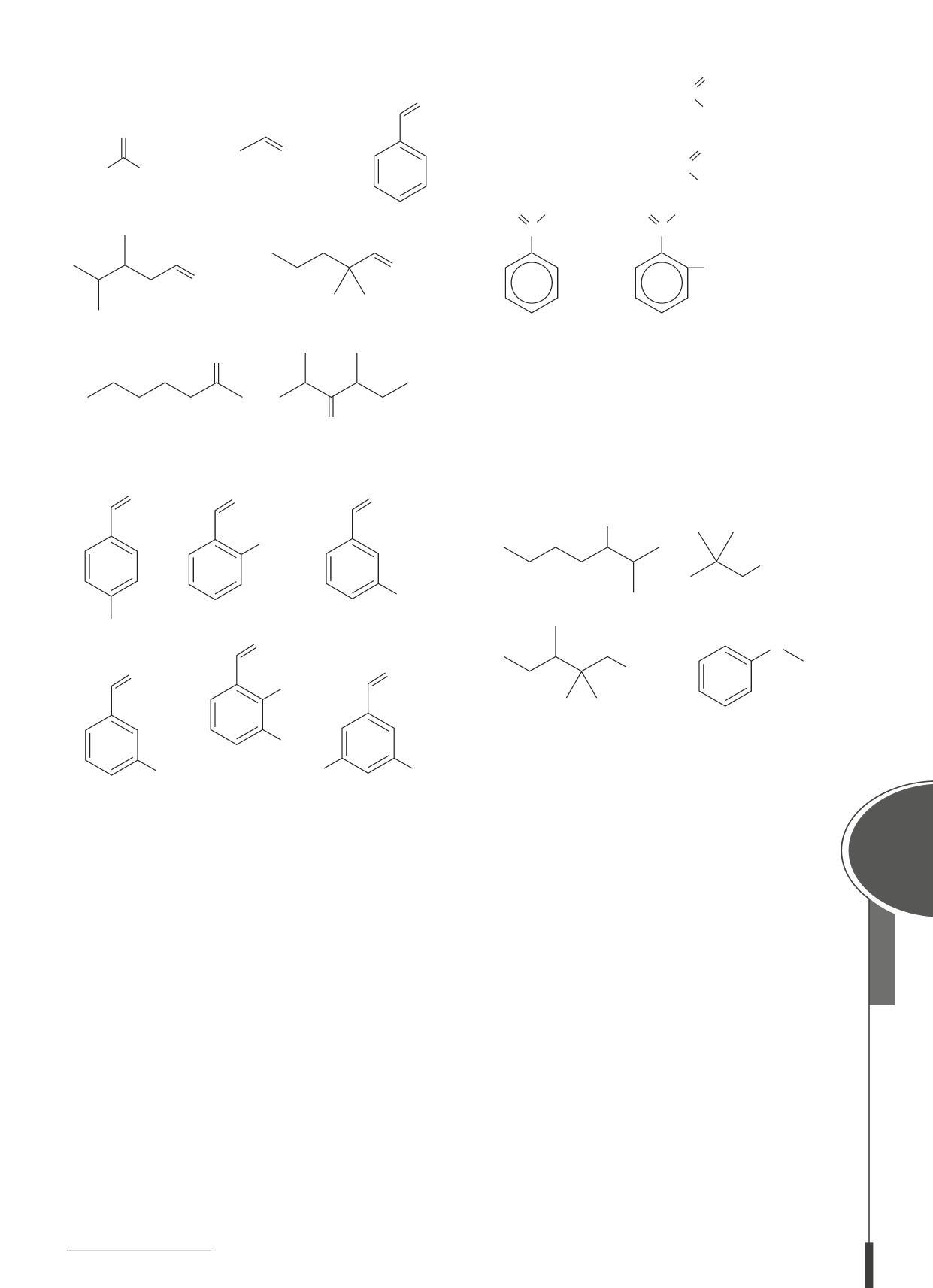
42. F, V.
43. Problema svolto con soluzione presente sul volume.
44. B.
45.
46. B.
47.
48. V, F.
49. azoto, ossigeno e zolfo.
50. Non aromatico: piperidina. Aromatico: pirimidina.
51. C.
52. V, V, V, F.
53. omopolimero = polimero derivato dall’unione dello stesso monomero; copolimero = polimero derivato dall’unione di due diversi monomeri.
54. Si tratta di un’addizione al doppio legame dell’etilene.
55. I polimeri di condensazione si formano tramite la perdita di una molecola d’acqua o di un altro piccolo gruppo molecolare, solitamente per reazione tra monomeri diversi o tra monomeri polifunzionali. I polimeri di addizione si formano per reazione diretta tra monomeri che contengono gruppi che tendono a dare addizione, come gli alcheni.
56. D.
57. C.
58. A.
59. F.
60. Gli eteroatomi sono in grado di attrarre o respingere elettroni da zone adiacenti, polarizzando i legami covalenti e facilitando le reazioni.
61. D.
62. Le reazioni di addizione, eliminazione, sostituzione, di riduzione e ossidazione, di idrolisi. Alcuni composti organici possono poi partecipare in reazioni acido/base.
63. Gli alcheni sono convertiti in alcani per addizione di idrogeno (H2).
COMPETENZE
64. Functional group: atom or group of atoms that strongly influences the chemical and physical properties of the molecules.
65. C.
66. C.
67. Risposta aperta.
68.
a)
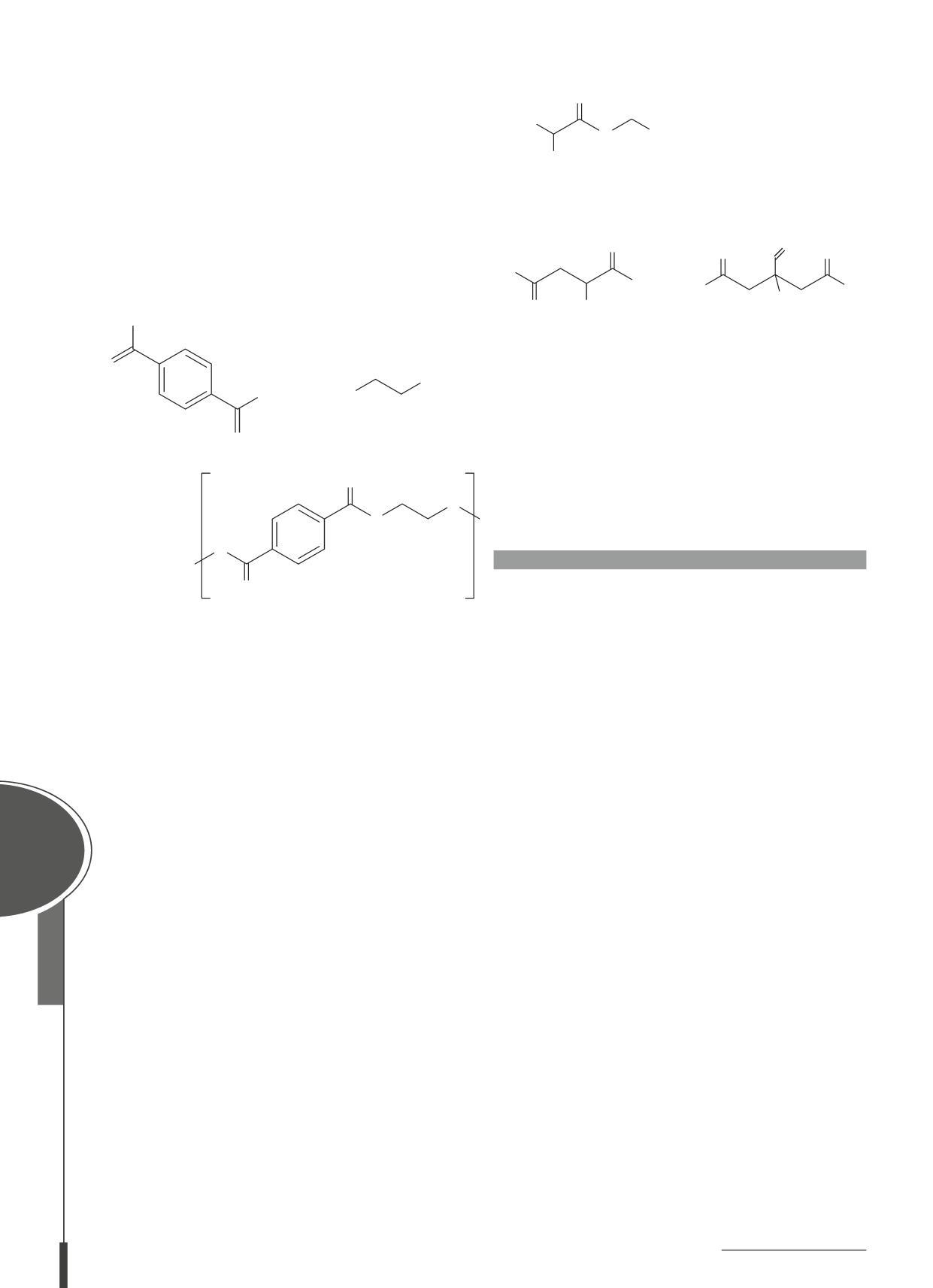
b) La presenza dei due carbossili nell’acido tereftalico e di due ossidrili nel glicole etilenico è necessaria alla polimerizzazione. Infatti consente che la reazione tra l’alcol del glicole e l’acido carbossilico del tereftalico si ripeta numerose volte, lasciando esposti, dopo ogni condensazione, un acido carbossilico da un lato e un gruppo alcolico dall’altro del polimero nascente, gruppi liberi di reagire con i successivi monomeri.
69.
a) L’etanolo è contenuto in una grande varietà di prodotti alimentari e bevande alcoliche (vino, birra, liquori, distillati, etc.), nei quali viene normalmente prodotto per fermentazione alcolica di vari materiali dell’industria alimentare. È inoltre molto usato come solvente, sia in ambito domestico che professionale, come disinfettante, e come un importante reagente e solvente nella pratica scientifica. È anche usato come combustibile.
b) Industrialmente l’etanolo si produce per via strettamente chimica, tramite idratazione dell’etene (che è un prodotto dell’industria petrolchimica), o per via fermentativa, specialmente tramite l’azione di lieviti su terreni zuccherini. Si purifica poi per distillazione.
c) In natura l’etanolo viene prodotto per fermentazione alcolica dello zucchero, tramite l’ossidazione enzimatica del glucosio, ad acido piruvico (glicolisi), che poi viene trasformato in acetaldeide la quale, infine, viene ridotta a etanolo. I due importanti enzimi che mediano questa fermentazione sono la piruvato decarbossilasi e l’alcol deidrogenasi.
a)
d) Bioetanolo è un termine che indica l’etanolo usato come combustibile. Chimicamente non differisce dall’etanolo, ed è normalmente prodotto per fermentazione di materie prime di origine biologica. Si usa sempre più come combustibile e come carburante per motori, specialmente come additivo della benzina. 70.
b) È un estere, cioè un derivato degli acidi carbossilici.
c) Sì, il carbonio che lega l’ossidrile.
71.
acido malico citrico limone, arancia
L’acido malico è abbondante nelle mele, ma anche in molti altri frutti (albicocche, uva, ciliegie, pesche, etc.). L’acido citrico è contenuto in grandi quantità negli agrumi, e specialmente nel limone. L’acido acetico è caratteristico dell’aceto, e in generale di tutti i prodotti alcolici su cui è avvenuta una fermentazione acetica dell’alcol etilico. L’acido oleico, come intuibile dal nome, è abbondante nell’olio di oliva, ma anche in molti altri grassi (animali e vegetali).
72. Risposta aperta.
Unità 3
Risposta breve
Pag. 63
1. sp3
2. Due.
3. Nel ciclo sono contenuti quattro atomi di carbonio.
Pag. 65
1. Il saccarosio.
2. Tra l’ossidrile emiacetalico di una molecola e uno degli ossidrili dell’altra molecola legante.
3. I due legami differiscono per il carbonio alcolico impegnato nella formazione del legame glicosidico: nel primo caso è il C4, nel secondo è il C6.
Pag. 67
1. Sono tutte sostanze che tendono ad essere insolubili in acqua, e solubili in solventi apolari.
2. Sono lipidi contenenti acidi grassi (trigliceridi, fosfolipidi, glicolipidi), in grado di reagire con l’idrossido di sodio (o di potassio) per produrre dei sali di acidi grassi, cioè dei saponi.
3. Trioleina (un trigliceride); fosfatidilserina (un fosfolipide).
Pag. 68
1. Da 4 a 36 atomi di carbonio, in natura.
2. Si usa prevalentemente per indicare la posizione dell’ultima insaturazione dell’acido grasso: x è il primo atomo di carbonio contenente l’insaturazione, numerato a partire dall’estremità metilica dell’acido (opposta a quella carbossilica). Un acido grasso ω-3, ad esempio, possiede un doppio legame tra il terzultimo e il quartultimo atomo di carbonio. Si tratta comunque di un sistema poco preciso, a cui è da preferire la nomenclatura IUPAC.
3. Maggiore è il numero di insaturazioni, minore è la temperatura di fusione. Le insaturazioni riducono la linearità della catena di acido grasso, e la possibilità di questo di impaccarsi strettamente e stabilmente: come conseguenza, acidi
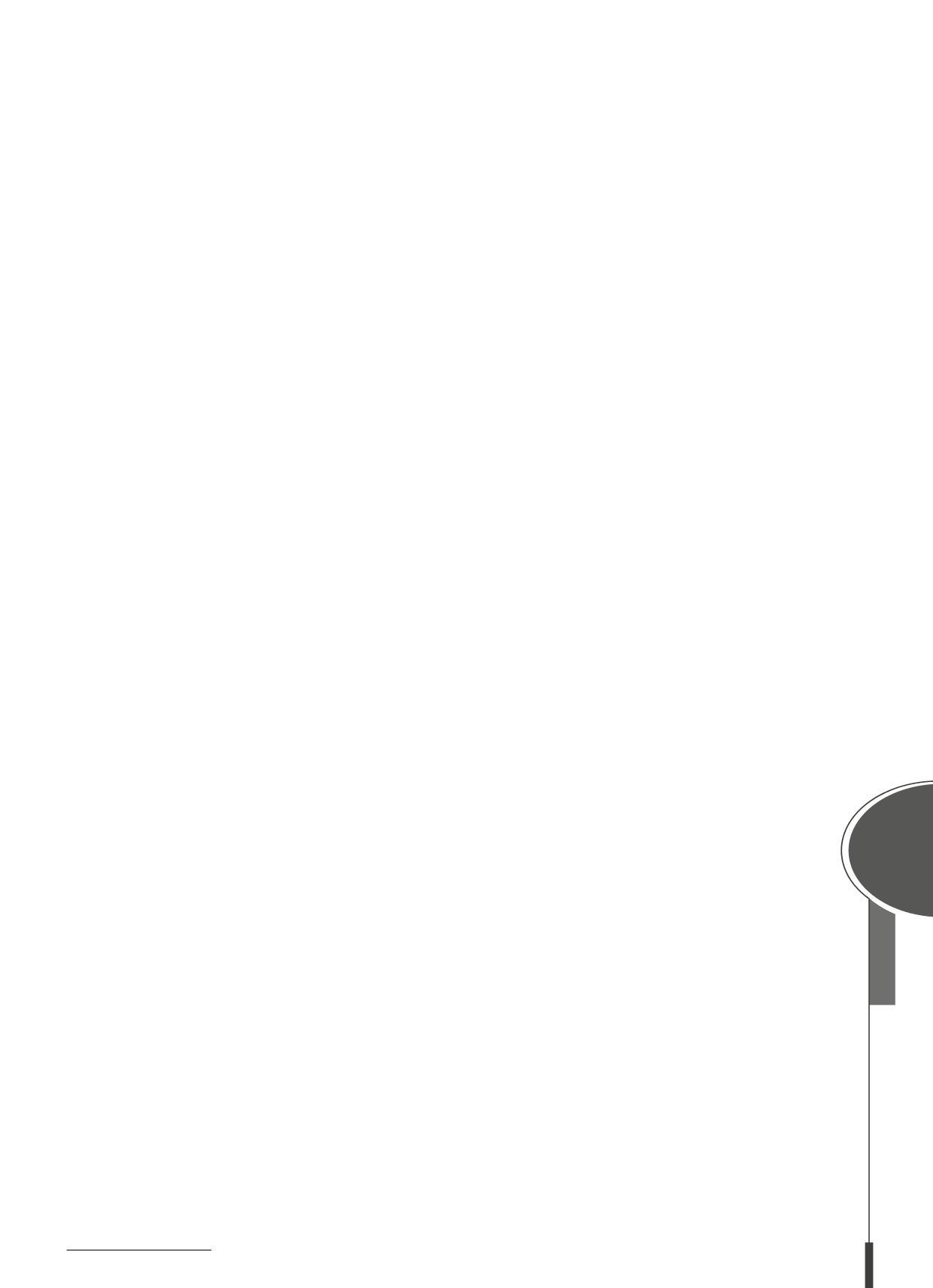
grassi insaturi tendono ad essere più fluidi. Questo soprattutto se le insaturazioni sono di tipo cis, perché determinano la curvatura nella catena, impedendo l’impacchettamento stretto e riducendo le forze di attrazione tra molecole.
Pag. 69
1. Un trigliceride è formato da una molecola di glicerolo esterificata, sulle sue tre funzioni ossidriliche, da tre acidi grassi (uguali o diversi tra loro).
2. Nello stato fisico a temperatura ambiente: gli oli sono liquidi, i grassi sono solidi o semisolidi.
Pag. 72
1. Nei fosfolipidi, il terzo ossidrile del glicerolo è esterificato non con un acido grasso, ma con un gruppo fosfato a cui è legato un aminoalcol.
2. Prevalentemente da fosfolipidi, organizzati in un doppio strato. In questo doppio strato sono poi immerse diverse molecole, come steroidi e proteine.
Pag. 76
1. La posizione del gruppo amminico in posizione di Fischer: se l’amminoacido disegnato in posizione di Fischer (cioè con il carbossile in alto e la catena laterale in basso) ha il gruppo amminico a destra, appartiene alla serie D. Se a sinistra, è della serie L.
2. È lo stato di ionizzazione di un amminoacido quando il pH di una sua soluzione è pari al suo punto isoelettrico. Nella pratica, è una specie ionizzata neutra, in cui sia il gruppo amminico che il carbossilico sono ionizzati.
Pag. 79
1. La maggiore differenza è funzionale: le proteine fibrose sono tendenzialmente strutturali (cheratina e collagene, in particolare), mentre le proteine globulari hanno funzioni non strettamente strutturali. A differenza delle proteine globulari, inoltre, la solubilità in acqua delle proteine fibrose è scarsa.
2. È la semplice sequenza lineare degli amminoacidi che le compongono.
3. No, solo alcune proteine, e in particolare quelle composte da più subunità proteiche.
Pag. 83
1. Gli enzimi catalizzano le reazioni biologiche, permettendone lo svolgimento in tempi compatibili con la vita. Inoltre, sono fortemente regolati, in funzione delle necessità dell’organismo.
2. È una teoria che spiega il meccanismo di legame del substrato all’enzima: sia la struttura del substrato che quella del sito attivo (o allosterico) dell’enzima si modificano leggermente, sotto un’azione reciproca. Questo aumenta la forza del legame finale.
3. All’aumentare della concentrazione del substrato, la velocità iniziale della reazione enzimatica aumenta linearmente in una prima fase, per poi rallentare e raggiungere un plateau, che indica il raggiungimento di una condizione di saturazione dei siti catalitici.
Pag. 84
1. A seconda del sistema di classificazione, si hanno inibitori reversibili o irreversibili. Oppure, si possono avere degli inibitori competitivi o non competitivi.
2. L’inibizione irreversibile è solitamente caratterizzata dalla formazione di un legame covalente, stabile, tra l’inibitore e l’enzima, e comporta l’inattivazione permanente dell’enzima colpito. L’inibizione reversibile si ha quando il legame tra l’inibitore e l’enzima è relativamente debole, e quindi è soggetto a un equilibrio ed è contemplata la dissociazione dei due componenti.
3. Gli inibitori competitivi competono con il substrato per il legame al sito attivo, essendo spesso simili al substrato o a parte di esso: il loro effetto, quindi, può teoricamente essere alleviato se si aumenta la concentrazione di substrato, che “scalza” l’inibitore. Gli inibitori non competitivi, invece, legano dei siti enzimatici che non prendono un contatto diretto col substrato, e li influenzano al punto da ridurre la loro affinità per il substrato: non c’è quindi una competizione diretta col substrato.
Pag. 87
1. Liposolubili: A, D, E, K; Idrosolubili: B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12, C.
2. Il cofattore è una porzione non proteica legata all’enzima, e che in qualche modo ne assiste la catalisi. Può essere uno ione metallico, oppure una molecola organica non polimerica: in quest’ultimo caso si parla di coenzima.
Pag. 91
1. Un nucleotide è una molecola formata da una base azotata, legata a uno zucchero pentoso, legato a sua volta a uno o più gruppi fosfato.
2. Ne esistono tre diverse forme principali: l’RNA messaggero (mRNA), l’RNA di trasporto (tRNA) e l’RNA ribosomale (rRNA).
3. Sono accoppiate tramite legami a idrogeno, con uno schema di appaiamento ben preciso, che segue le regole di Chargaff: l’adenina si appaia con la timina (con l’uracile nell’RNA), mentre la citosina si appaia con la guanina.
RIPASSA CON METODO
Dall’alto verso il basso e da sinistra a destra
ternari
LIPIDI
amminoacidi – carbonio – idrogeno – ossigeno e azoto
VITAMINE
DNA e RNA
monosaccaridi, disaccaridi e polisaccaridi
fosfolipidi, glicolipidi
ENZIMI
conservazione e trasmissione
ioni metallici
COENZIMI
CONOSCENZE E ABILITÀ
1. F, V, V.
2. Le biomolecole sono molecole esclusivamente prodotte dagli organismi biologici, che le usano per formare le loro strutture e per alimentare e gestire i loro processi vitali. Le maggiori classi di biomolecole sono: carboidrati, lipidi, proteine e acidi nucleici.
3. Il primo contiene una funzione aldeidica e il secondo una funzione chetonica.
4. Il primo ha l’OH legato al C chirale più distante dal C carbonilico a sinistra, mentre il secondo a destra.
5. Legame acetalico tra il C anomerico di un monosaccaride e un gruppo OH di un altro.
6. D.
7. B.
8. D.
9. D.
10. C.
L’aldoesosio ha quattro C chirali mentre il chetoesosio ne ha 3.
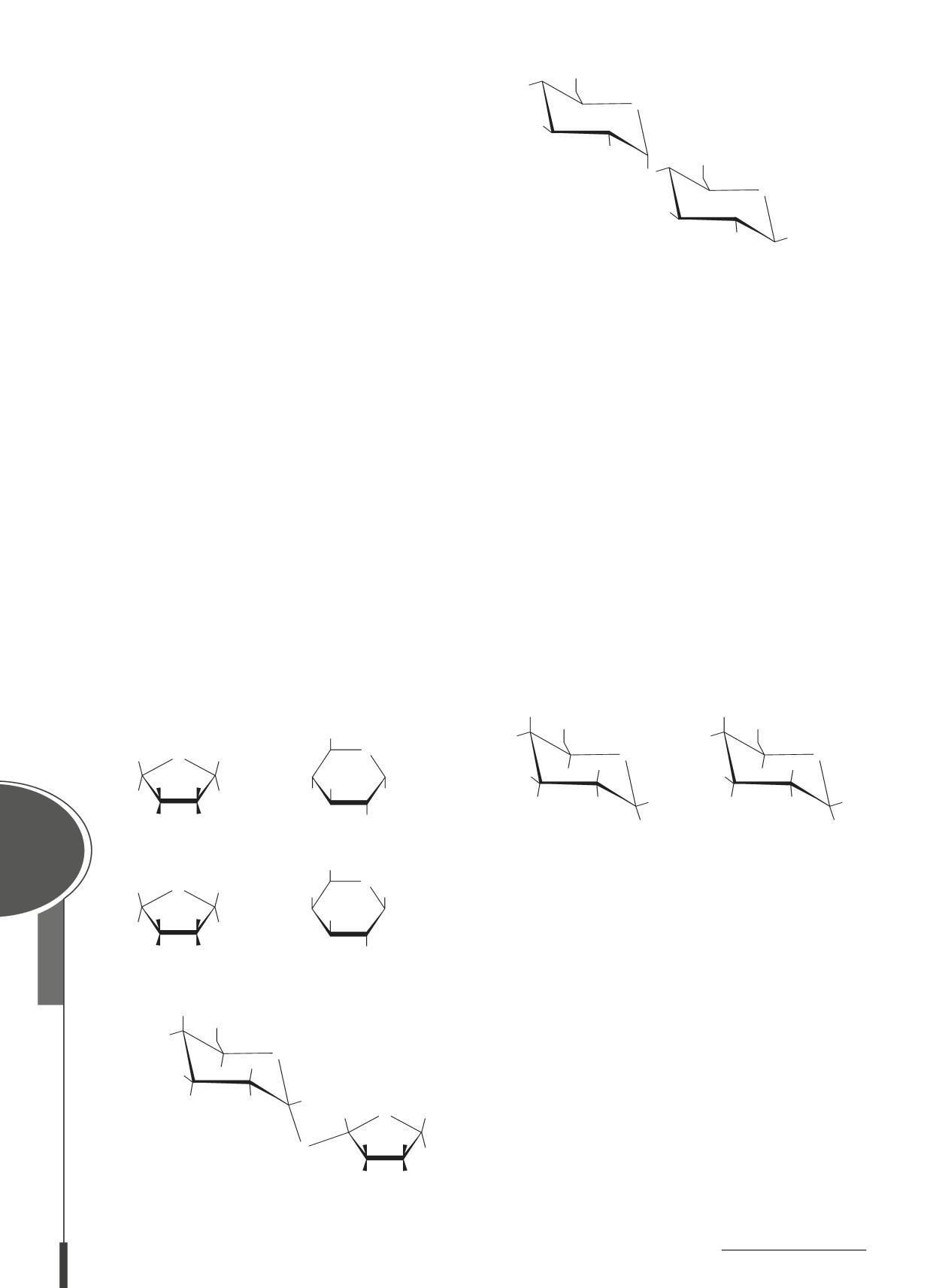
15. Il glucosio ha 16 isomeri ottici (24), mentre il fruttosio ne ha 8 (23).
16. L’amido ha una struttura elicoidale e ramificata grazie alla presenza di numerosi legami a idrogeno formatisi tra i gruppi –OH all’interno di amilosio e amilopectina, i quali sono costituiti da legami α-1,4 e α-1,6 glucosidici (che producono le ramificazioni). La cellulosa, invece, è un polimero lineare che forma legami a idrogeno intermolecolari. La linearità della cellulosa è garantita dal tipo di legame glucosidico, che è di tipo β-1,4. Ne deriva una struttura rigida a strati, insolubile in acqua.
17. La funzione alcolica legata al C-5 forma un legame con il C del carbonile (emiacetale ciclico).
18. F, V, V, F.
19. Costituiscono una classe eterogenea di molecole idrofobe e solubili in solventi apolari.
20. La lunghezza della catena carboniosa. A rigore, comunque, un acido grasso è un acido carbossilico.
21. Uno sterolo che si trova nei tessuti animali (zoosterolo).
22. Sono formati entrambi da trigliceridi, ma gli acidi grassi che li compongono hanno diversi livelli di saturazione; per questo a temperatura ambiente i grassi sono solidi e gli oli sono liquidi.
23. B.
24. C.
25. A.
26. B.
27. B.
28. A.
29. C.
31. La formula rappresenta la struttura di base degli steroidi.
colesterolo
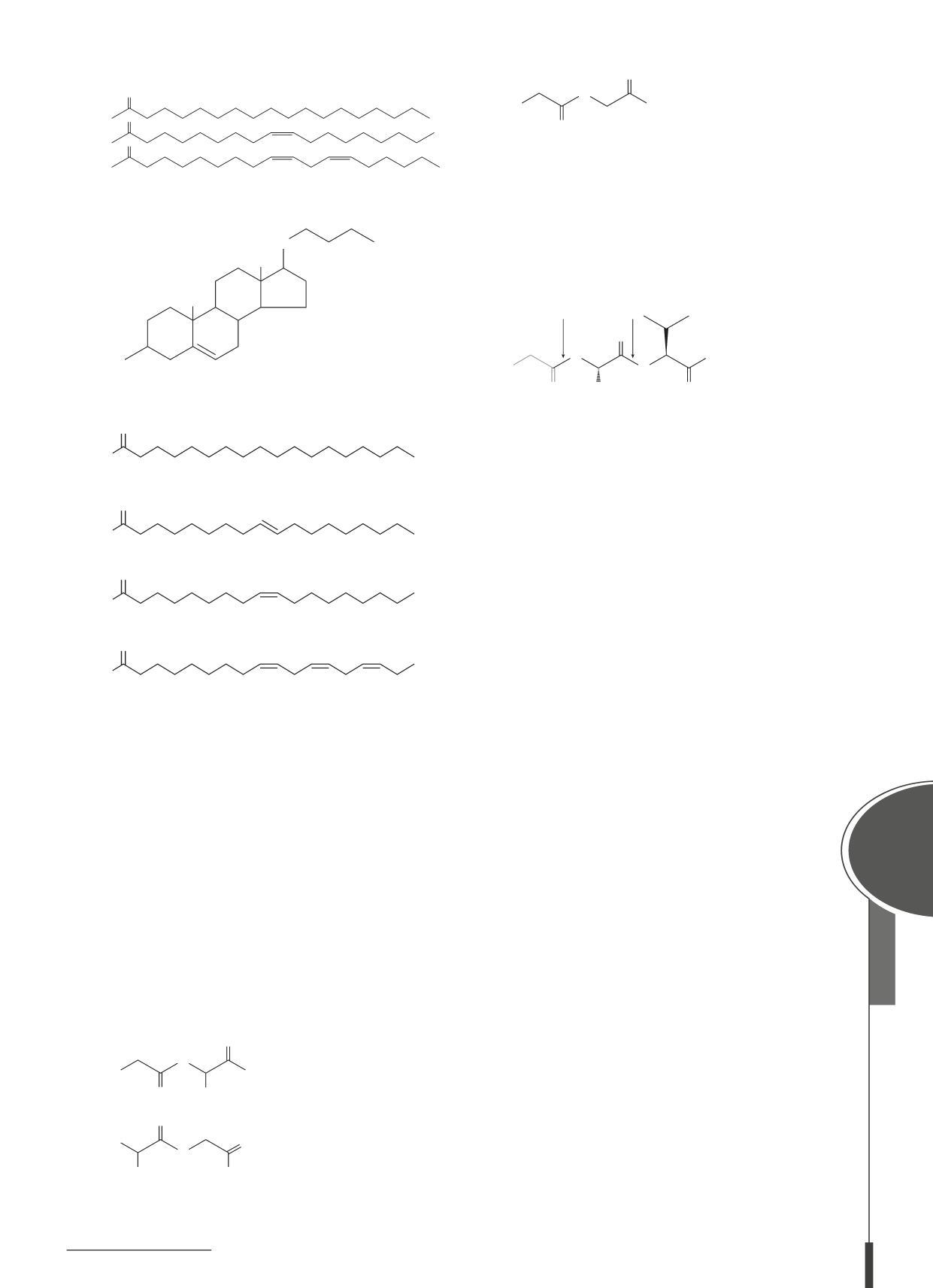
32. A causa della natura apolare delle catene carboniose.
33. O HO a) acido stearico
HO b) acido trans-9-ottadecenoico
HO c) acido cis-9-ottadecenoico
HO d) acido α-linolenico
34. F, F.
35. Legame ammidico tra il gruppo carbossilico di un amminoacido e il gruppo amminico di un altro.
36. D.
37. B.
38. A.
39. C.
40.
41. Problema svolto con soluzione presente sul volume.
42. 43.
44. Gly/Phe/Leu; Gly/Leu/Phe; Phe/Gly/Leu; Phe/Leu/Gly; Leu/ Gly/Phe; Leu/Phe/Gly.
45. I venti amminoacidi possono essere uniti in moltissime differenti combinazioni, e le catene proteiche possono avere lunghezze molto diverse tra loro.
46.
Al tripeptide bisogna aggiungere 2 molecole di acqua, in seguito alla formazione dei 2 legami peptidici.
47. A.
48. Compromissione della struttura terziaria.
49. Le principali sono il β-foglietto e l’α-elica.
50. V, V, F, V.
51. B.
52. Gli enzimi aumentano notevolmente la velocità delle reazioni biochimiche nelle condizioni di temperatura e pH dell’organismo. Gli enzimi soddisfano quindi la necessità di avere una veloce conversione tra le molecole biologiche, in condizioni controllate.
53. Inibitori competitivi: con struttura simile a quella del substrato, si legano al sito attivo dell’enzima. Inibitori non competitivi: si legano all’enzima in corrispondenza di porzioni diverse della molecola rispetto al sito attivo e l’effetto di inibizione è dovuto al fatto che la formazione del complesso enzima-inibitore altera la struttura complessiva dell’enzima.
54. Legami covalenti o non covalenti forti gli inibitori irreversibili, non covalenti deboli i reversibili.
55. Deve essere simile al substrato in quanto si lega al sito attivo, così come il substrato.
56. B.
57. C.
58. Quando il substrato si lega al sito attivo, l’enzima cambia conformazione e inizia la sua attività catalitica.
59. Ha un andamento sigmoide.
60. F, V, V, F.
61. C.
62. B.
63. Liposolubili: E (olive); D (olio di fegato di merluzzo); A (carote, albicocche); K (spinaci).
Idrosolubili: (B1; B2; B3 [PP]; B5; B6; B7; B12) (Tutte le vitamine del complesso B sono contenute in quasi tutti gli alimenti di origine animale e vegetale. C (alimenti vegetali, solo se freschi).
64. V, V, F, V.
65. Desossiribosio nel DNA, ribosio nell’RNA.
66. DNA: contiene desossiribosio e timina, è formato da due filamenti. RNA: contiene ribosio e uracile, è a filamento singolo.
67. Legami a idrogeno
68. B.
C. 70. C. 71. C. 72. B. 73. B.
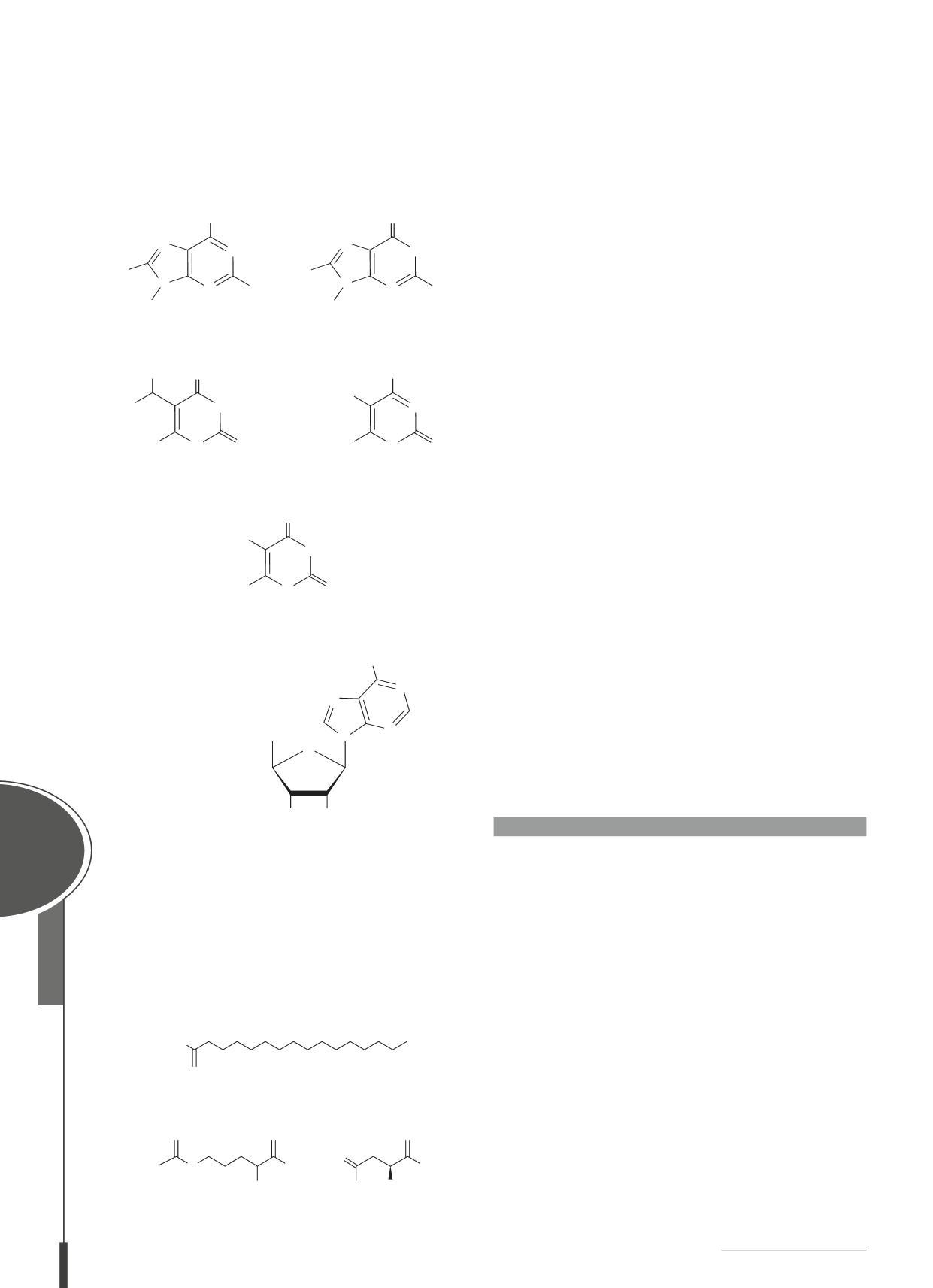
79. O P O P O P
80 a. In un filamento non ci sono legami a idrogeno; b. Nel doppio filamento, le basi azotate dei due filamenti antiparalleli di DNA sono legate da legami a idrogeno (C-G e A-T). I legami a idrogeno stabilizzano la struttura del DNA.
COMPETENZE
81. Risposta aperta.
82. Palmitic acid is a saturated fatty acid with 16 C and no unsaturations.
84. Il risultato rispecchia la regola di Chargaff sull’appaiamento standard delle basi azotate, ed è quindi compatibile con la tipica struttura a doppia elica del DNA, senza porzioni a singolo filamento.
85. a. Carboidrati: funzione aldeidica, funzione alcolica e funzione chetonica. Proteine: polimeri degli amminoacidi con gruppi amminici e gruppi carbossilici. Acidi nucleici: gruppi alcoolici e gruppi amminici; b. Carboidrati: interazioni intramolecolari e intermolecolari. Proteine: interazioni intramolecolari. Acidi nucleici: interazioni intramolecolari; c. Carboidrati: fonte di energia e (nelle piante) funzione strutturale. Proteine: ruolo nei processi biologici di un organismo; crescita e riparazione dei tessuti; catalisi. Acidi nucleici: per l’RNA diverse funzioni (ad esempio, sintesi proteica), per il DNA conservazione e trasmissione del patrimonio genetico.
87. I numerosi gruppi ossidrili che caratterizzano i carboidrati consentono la formazione di legami a idrogeno intermolecolari (a volte anche intramolecolari), e l’interazione con i solventi polari (inclusa l’acqua). Questo aumenta l’energia necessaria per rompere i reticoli cristallini che formano (per far ciò occorre infatti rompere anche i legami a idrogeno). Nel caso degli idrocarburi, la semplice catena idrocarboniosa non consente la formazione di legami a idrogeno, e ciò facilita di molto la loro fusione (che avviene, quindi, a temperatura più basse di quelle dei carboidrati aventi un uguale numero di atomi di carbonio).
88. Il calore estremo comporta la denaturazione irreversibile delle proteine, inclusi gli enzimi ad attività litica (enzimi digestivi prodotti dal vegetale stesso). La denaturazione annulla la funzionalità degli enzimi, e quindi preserva il vegetale dalla loro azione.
89. Alla luce di una pregressa malattia cardiovascolare, è preferibile evitare i lipidi di origine animale a favore di quelli vegetali, assunti sempre in quantità moderate, per via dell’assenza di colesterolo e dell’effetto preventivo nei confronti dell’aterosclerosi. In realtà, un uso bilanciato e molto moderato di grassi di origine animale è nutrizionalmente accettabile, a meno di particolari condizioni metaboliche.
90. Risposta aperta.
Unità 4
Risposta breve Pag. 100
1. I processi a cui è associata una variazione negativa dell’energia libera di Gibbs (G) sono esoergonici, e spontanei. Al contrario, processi con variazioni positive di G necessitano, per poter avvenire, di energia esterna (e non sono, chiaramente, spontanei).
2. Dal punto di vista energetico, le reazioni esoergoniche degli esseri viventi sono spesso accoppiate a reazioni endoergoniche.
83. Arginine is a basic aminoacid, asparagine is a polar aminoacid. arginine
3. È una rete di reazioni in cui i composti biologici sono interconvertiti (degradati, trasformati, sintetizzati). Queste reazioni sono fittamente interconnesse, e molti metaboliti sono condivisi da più processi, e hanno molteplici origini e destini metabolici.
4. L’acetil-CoA è coinvolto in moltissime vie, ed è un importante punto di snodo metabolico. In particolare (ma non solo) è la molecola che alimenta il ciclo di Krebs.
Pag. 101
1. L’ATP funge da “moneta di scambio” dell’energia metabolica, perché contiene un legame ad alta energia che può essere
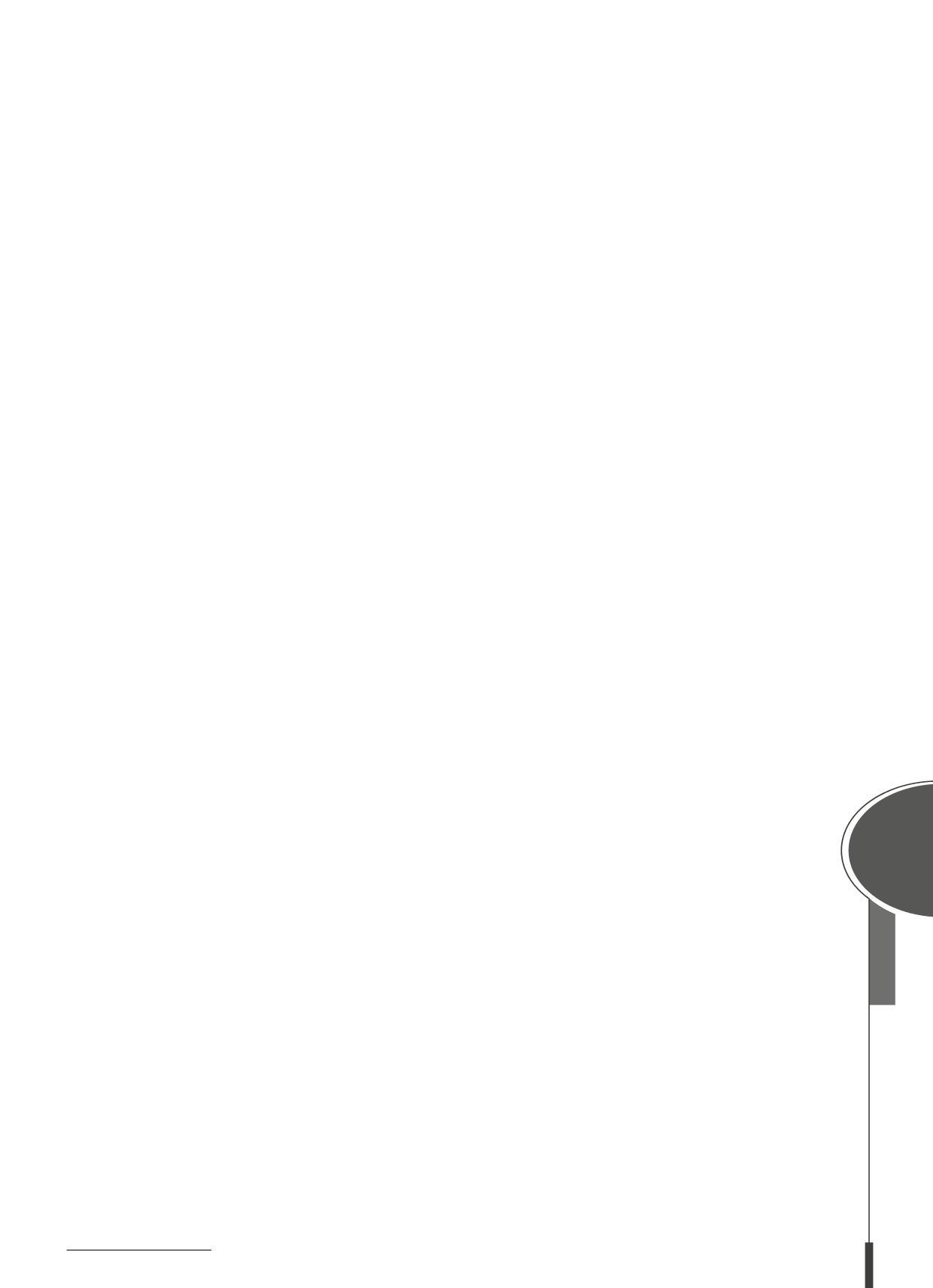
rotto quando occorra energia. Allo stesso modo, l’ADP (prodotto di questa reazione di idrolisi) può incamerare altra energia (prodotta dal metabolismo cellulare) riformando ATP.
2. La fosforilazione a livello di substrato e la fosforilazione ossidativa.
Pag. 103
1. L’ossidazione completa del glucosio porta a CO2 e acqua, tramite i processi di glicolisi, sintesi di acetil-CoA, ciclo di Krebs e infine fosforilazione ossidativa.
2. Nella fosforilazione ossidativa.
Pag. 104
1. È la concentrazione di glucosio nel sangue, espressa in mg/dL.
2. Sono prevalentemente insulina e glucagone.
3. Crea dei punti di ramificazione nella catena del glicogeno, aumentando la compattezza della molecola (quindi l’efficienza di stoccaggio del glucosio) e la rapidità con cui si potrà poi fare la glicogenolisi.
Pag. 107
1. Il glucosio, convertito in glucosio 6-fosfato.
2. Due.
Pag. 113
1. Nel mitocondrio, in particolare nella matrice mitocondriale.
2. Oltre a NADH e FADH2, partecipano le proteine ferro-zolfo e ferro-rame, il coenzima Q, e i citocromi.
3. È un meccanismo in cui l’energia associata alla rotazione dell’asse centrale (rotore) dell’ATP sintasi viene trasferita allo statore, e usata per formare un legame ad alta energia tra ADP e Pi (e, quindi, ATP).
Pag. 114
1. Le fermentazioni sono favorite dall’assenza o dalla scarsità di ossigeno.
2. L’acido lattico, e il NAD+ che può essere usato per riformare NADH durante il processo glicolitico.
Pag. 116
1. Circa 32 molecole.
2. Perché consente l’ossidazione completa del glucosio, tramite il ciclo di Krebs e la fosforilazione ossidativa. In assenza di ossigeno questi due processi sono inibiti.
Pag. 120
1. Nello stomaco e nell’intestino, a diversi pH di funzionamento.
2. Perché la loro ossidazione è enormemente più produttiva, in termini di ATP, dell’ossidazione delle altre biomolecole di accumulo (proteine e carboidrati). Inoltre, hanno proprietà tali da consentirne una forte compattazione e un facile accumulo.
3. È l’insieme dei processi di sintesi e di degradazione della proteina. In una cellula sana, questi processi sono ben bilanciati.
Pag. 122
1. Si tratta dell’assimilazione del carbonio inorganico (prelevato sotto forma di anidride carbonica) da parte della pianta. Tale carbonio viene incorporato in molecole organiche, destinate ai processi biologici.
2. A cavallo della membrana tilacoidale.
Pag. 126
1. In particolare, allo spettro di assorbimento delle clorofille in esse contenute.
2. È una schematizzazione del modo in cui gli elettroni, eccitati dalla luce nel P680, vengono prima ceduti alla catena
di trasporto degli elettroni con lo scopo di produrre ATP, poi al P700 per essere nuovamente eccitati dalla luce e ceduti a un’altra catena di trasporto, che culmina con la riduzione del NADP+.
Pag. 128
1. La fissazione del carbonio, la riduzione del 3-fosfoglicerato a gliceraldeide 3-fosfato, e la conversione di parte della gliceraldeide 3-fosfato in ribulosio 1,5-bisfosfato.
2. È l’enzima che effettivamente svolge la fissazione del carbonio, tramite la carbossilazione del ribulosio 1,5-bisfosfato.
La reazione produce, per ogni molecola di ribulosio 1,5-bisfosfato carbossilata, due molecole di 3-fosfoglicerato. 3. 12 molecole, ogni 6 molecole di RuBP entrate nel ciclo.
4. Possono essere ossidate nel ciclo di Krebs dopo essere convertite in piruvato, o usate per la sintesi di glucosio, e quindi di amido e altri polisaccaridi. Inoltre, a seconda delle esigenze della pianta, possono essere usate per la sintesi di lipidi e amminoacidi.
RIPASSA CON METODO
Dall’alto in basso e da sinistra a destra precursori – intermedi – metaboliti la sintesi di ATP turnover – amminoacidi
ANABOLISMO
glucosio o zuccheri semplici trigliceridi
FOTOSINTESI
VIA DEL PENTOSIO FOSFATO
ATP e NADH
LIPOGENESI
CICLO DI KREBS
fermentazione alcolica – fermentazione lattica
CONOSCENZE E ABILITÀ
1. V, F, V.
2. Catabolismo: vie di demolizione delle sostanze complesse. Anabolismo: vie di sintesi di molecole complesse. Reazioni metaboliche: sono veloci e plastiche; hanno resa massima, con minimi sprechi e ridotto accumulo di sostanze indesiderate; sono modulabili qualitativamente o quantitativamente; sono strettamente integrate.
3. È possibile far avvenire una reazione endoergonica se essa viene accoppiata con un’altra sufficientemente esoergonica. L’accoppiamento avviene, per esempio, se due processi condividono una o più specie chimiche.
4. Sì, i metaboliti sono normalmente condivisi da più vie, e sono spesso substrati e/o prodotti di differenti enzimi.
5. B. 6. C. 7. C.
8. No, la variazione complessiva di G è positiva.
9. Sì, la variazione complessiva di G è negativa.
10. V, F, F.
11. La fosforilazione a livello di substrato, che accoppia reazioni esoergoniche alla fosforilazione dell’ADP, o la fosforilazione ossidativa, che sfrutta i complessi respiratori e il complesso dell’ATP sintasi.
12. A.
13. C.
14. V, F, V.
15. I principali carboidrati digeribili dall’essere umano sono l’amido, il glicogeno, il saccarosio, il lattosio, il maltosio. Tutti si riducono, per digestione, a unità di glucosio, fruttosio, galattosio.
16. È un ormone iperglicemizzante. Ha come effetto principale la mobilitazione del glucosio tramite attivazione della glicogenolisi. È l’ormone antagonista dell’insulina.
17. A.
18. B.
19. D.
20. F, V.
21. Un esempio è dato dalla regolazione della fosfofruttochinasi, che è attivata dalla scarsità di ATP (indicata indirettamente dall’abbondanza di AMP). Al contrario, è inibita dall’accumulo di ATP. Questo, insieme ad altri passaggi regolativi, consente di mantenere le riserve di glicogeno/ glucosio in assenza di necessità energetiche.
22. Le tappe più rilevanti dal punto di vista energetico sono: quella mediata dall’esochinasi, che porta alla fosforilazione del glucosio e al consumo di una molecola di ATP; la fosforilazione del fruttosio 6-fosfato, con consumo di un’altra molecola di ATP; l’ossidazione della gliceraldeide 3-fosfato, operata dalla gliceraldeide 3-fosfato deidrogenasi, che introduce un ulteriore gruppo fosfato nella via; la defosforilazione dell’1,3bisfosfoglicerato, con produzione di due molecole di ATP, e la defosforilazione del fosfoenolpiruvato, con produzione di ulteriori due molecole di ATP.
23. B.
24. C.
25. A.
26. Problema svolto con soluzione presente sul volume.
27. 16 10–6 mol.
28. 8,8 g.
29. V, F.
30. È un processo in cui un gruppo fosfato viene trasferito da una molecola ad alta energia all’ADP, per formare ATP.
31. Il piruvato deve essere convertito ad acetil-CoA, tramite il complesso della piruvato deidrogenasi. Esso agisce decarbossilando il piruvato, e trasferendo l’acetile che si produce al CoA-SH. Nella reazione si produce anidride carbonica.
32. Gli elettroni, conservati dal NADH e dal FADH2 provenienti dal ciclo di Krebs, vengono ceduti ai complessi respiratori I e II. Da qui, subiscono una serie di trasferimenti, dal complesso III al complesso IV. Questi passaggi determinano l’attivazione di pompe protoniche interne ai complessi I, III e IV, e il pompaggio di protoni dalla matrice allo spazio intermembrana. Il gradiente protonico elettrochimico formatosi viene dissipato dall’ATP sintasi, che sfrutta l’energia associata al passaggio dei protoni (secondo il loro gradiente) per fosforilare delle molecole di ADP.
33. Perché i suoi elettroni vengono ceduti al complesso II, che non ha (a differenza del complesso I) attività di pompa protonica.
34. È un meccanismo di produzione di energia che si basa sul pompaggio di protoni a cavallo di una membrana per formare un gradiente, e prevede la dissipazione di questo gradiente e lo sfruttamento dell’energia associata a questa dissipazione per fosforilare ADP.
35. Tra i microorganismi anaerobi più noti sono i lattobacilli,
che producono ATP per glicolisi e rigenerano il NAD+ consumato grazie alla riduzione del piruvato in acido lattico. Altri organismi di grande rilevanza sono i lieviti, in particolare il S. cerevisiae, che opera la fermentazione alcolica: il NAD+ consumato nella glicolisi viene rigenerato dalla riduzione dell’acetaldeide, a sua volta prodotta per decarbossilazione del piruvato, ad alcol etilico.
36. La resa è enormemente maggiore nel catabolismo aerobico. In presenza di ossigeno si ha l’ossidazione completa del glucosio, che produce circa 32 moli di ATP per ogni mole di glucosio ossidata. In assenza di ossigeno, la fosforilazione ossidativa e il ciclo di Krebs sono impediti, e il glucosio viene solo parzialmente ossidato (a piruvato), con produzione di due sole moli di ATP per ogni mole di glucosio.
37. C.
38. D.
39. B.
40. C.

41. A.
42. A.
43. B.
44. Il ciclo di Krebs produce 3 moli di NADH per ogni acetilCoA entrante, quindi 6 moli per ogni mole di glucosio ossidata. Si producono quindi 24 mmol di NADH.
45. Per ogni mole di NADH entrante in catena respiratoria si pompano 10 moli di protoni. Quindi, la risposta è 0,016 mmol.
46. Per ogni mole di NADH entrante in catena respiratoria si producono circa 2.5 mol di ATP. Quindi, la risposta è circa 5,7 mmol.
47. F, F, V, F.
48. I trigliceridi hanno proprietà chimico fisiche tali da consentirne un estremo impaccamento, che massimizza l’efficienza di stoccaggio. Il glicogeno, invece, è ramificato e idratato, e occupa, a parità di contenuto molare di molecole, un volume maggiore. Inoltre, la resa energetica dell’ossidazione completa di un acido grasso è molto maggiore di quella associata all’ossidazione di una molecola di glucosio.
49. Gli amminoacidi derivati dalla degradazione delle proteine possono essere utilizzati per la produzione di altre proteine o polipeptidi, trasformati in intermedi per la produzione di altre sostanze o degradati a prodotti di scarto come l’urea.
50. C.
51. D.
52. A.
53. F, V, F.
54. In estrema sintesi, si possono individuare una fase luminosa, in cui la luce solare è direttamente fruttata per produrre ATP e NDAPH, e una fase oscura, in cui l’ATP e il NADPH prodotti sono usati per reazioni anaboliche utili alla pianta.
55. Sono organelli cellulari deputati allo svolgimento dei processi fotosintetici.
56. La clorofilla a e la clorofilla b.
57. Dal picco di assorbimento delle clorofille in essi contenute.
58. Nello stroma del cloroplasto.
59. La RuBisCO partecipa al ciclo di Calvin, catalizzando l’incorporazione del carbonio, proveniente dall’anidride carbonica, nel ribulosio 1,5-bisfosfato. Il legame avviene sul C2, e la molecola che si genera collassa in due molecole di gliceraldeide 3-fosfato.
60. Per resistere a particolari condizioni climatiche, e in particolare alle alte temperature. In questi contesti, infatti, le piante chiudono gli stomi, e l’ossigeno prodotto dalla fotosintesi si accumula nei tessuti vegetali, impedendo l’ingresso di
anidride carbonica. Ciò stimola la fotorespirazione e inibisce il ciclo di Calvin. Per superare questo ostacolo, alcune piante hanno evoluto dei sistemi alternativi, che in prevalenza hanno l’effetto di pompare anidride carbonica dall’esterno della pianta alle sedi in cui avviene la fotosintesi.
61. Il ciclo di Calvin avviene comunque nello stroma del cloroplasto, ma l’anidride carbonica che viene usata proviene dalla decarbossilazione di derivati dell’ossalacetato, il quale è stato prodotto dai tessuti fogliari più superficiali tramite incorporazione dell’anidride carbonica nel fosfoenolpiruvato (ad opera della PEP carbossilasi).
62. Nel meccanismo CAM, la produzione di energia avviene di giorno, mentre la fissazione del carbonio avviene di notte. Questo consente di aprire gli stomi (per far entrare anidride carbonica) solo quando le temperature si abbassano e il sole cala, e di evitare quindi inutili dispersioni di acqua.
63. D.
64. C.
65. A.
66. B
67. C.
68. C.
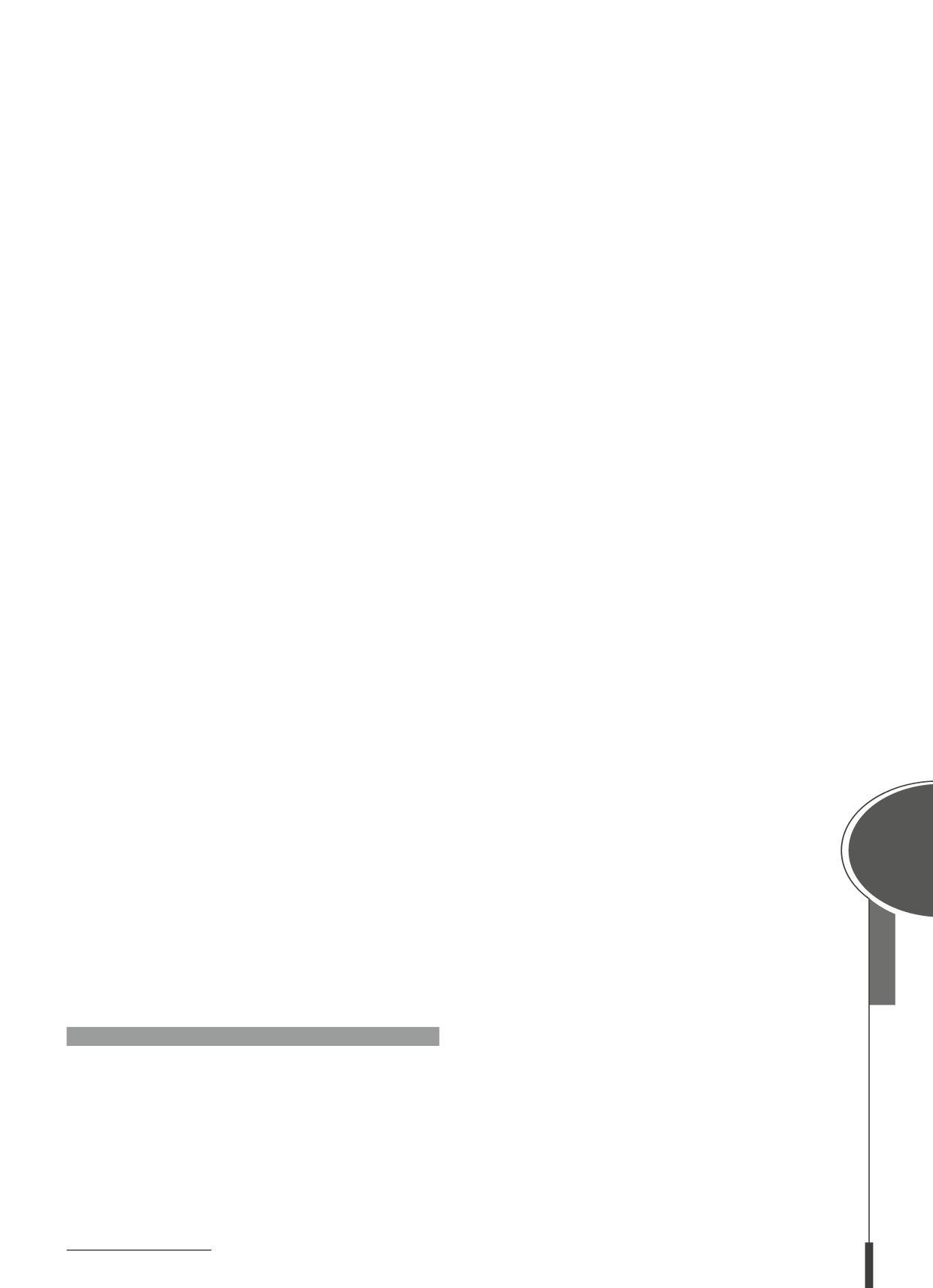
69. C.
70. A.
71. A.
72. C.
73. C.
74. B.
75. Problema svolto con soluzione presente sul volume.
76. 47,3 mmol.
COMPETENZE
77. D.
78. Water is splitted into oxygen, hydrogen ions and free electrons. These electrons enter in the P680 photosystem, in which they are excited by light and used to reduce NADP+ and to produce ATP. Thus, water constitutes an essential supply of electron for the photosynthesis light-dependent stage. Moreover, this reaction produces oxygen, which is an important side product of the photosynthesis.
79. Risposta aperta.
80. Usando acqua con ossigeno marcato si avrebbe una corrispondente marcatura dell’ossigeno prodotto dalla reazione di fotolisi dell’acqua. Usando invece anidride carbonica con carbonio marcato, si avrebbe la marcatura di prodotti organici della fotosintesi, come ad esempio la G3P, il glucosio, e il ribulosio 1,5-bisfosfato nel ciclo di Calvin. A seconda delle necessità metaboliche della cellula, la marcatura può estendersi ad altri metaboliti.
81. Risposta aperta.
82. Risposta aperta.
83. Risposta aperta.
84. Risposta aperta.
85. Risposta aperta.
Unità 5
Risposta breve
Pag. 142
1. È la manifestazione osservabile dell’utilizzo dell’informazione genetica.
2. Sono proteine multimeriche su cui il DNA si compatta, si stabilizza e si organizza.
3. Sono molecole circolari di DNA, molto diffuse nei batteri e largamente usate nella ricerca biotecnologica.
Pag. 143
1. È un piccolo oligonucleotide, che fornisce, in sede di replicazione del DNA, il 3’-OH utile ad innescare la reazione della DNA polimerasi.
2. Nel filamento veloce la DNA polimerasi procede in modo processivo, senza interruzioni, perché polimerizza nel senso di avanzamento della forca replicativa. Nel filamento lento, invece, la polimerasi è costretta a polimerizzare in senso opposto a quello di apertura della doppia elica, e quindi la sua azione richiede l’apposizione di più primers, aggiunti al livello della forca man mano che questa si apre: a questo punto può polimerizzare, ma lo fa solo per il breve tratto tra il nuovo primer e il filamento già sintetizzato; poi è costretta a dissociarsi, e riprendere la replicazione più a valle su un nuovo primer.
Pag. 145
1. L’RNA.
2. I codoni, composti da sequenze nucleotidiche di tre basi, si traducono in amminoacidi sulla base di uno specifico codice (il codice genetico). L’accoppiamento tra un codone e il rispettivo amminoacido tradotto è mediato dal tRNA, e dal ribosoma entro cui esso agisce.
Pag. 148
1. È una unità trascrizionale tipica dei batteri, nella quale più geni, normalmente utili a una funzione comune (ad esempio, codificanti enzimi di una stessa via metabolica), vengono cotrascritti a partire da un unico promotore. La trascrizione dell’operone è regolata da un operatore, e terminata da una sequenza “terminatore”.
2. Il lattosio, sostanza catabolizzata dai geni contenuti nell’operone lac, quando si accumula nella cellula viene convertito in allolattosio, il quale lega il repressore Lac, rimuovendolo dall’operatore. In questo modo, la RNA polimerasi è libera di legare il promotore e di procedere alla trascrizione.
3. Un operone inducibile è normalmente non trascritto (represso), e si attiva solo in condizioni che rimuovono il repressore. Un operone reprimibile, invece, è normalmente trascritto (indotto), e si reprime in presenza di sostanze che bloccano la trascrizione.
Pag. 151
1. Il controllo pre-trascrizionale si basa primariamente sulla modificazione della compattezza della cromatina. Ciò si realizza tramite modificazione (metilazione e acetilazione) delle proteine istoniche, o tramite metilazione delle citosine in specifiche regioni genomiche.
2. È una sequenza ricca in timine e adenine, posta circa 25 nucleotidi a monte del sito di inizio della trascrizione nei geni eucarotici. Viene legata dalla TBP (TATA Binding Protein), che dà inizio all’assemblaggio del complesso di trascrizione.
3. Anche a notevole distanza, considerando che può legare fattori ed avvicinarsi al promotore del gene regolato grazie a ripiegamenti ad ansa del DNA.
Pag. 154
1. Tratta i meccanismi di regolazione e modificazione dell’espressione genica che non comportano variazioni dirette nella sequenza genetica.
2. Serve soprattutto a massimizzare la varietà di proteine che si possono produrre da un singolo gene: tramite splicing alternativo, da un solo gene è possibile tradurre anche numerose isoforme proteiche (definite isoforme di splicing). Inoltre, è un importante punto su cui possono agire i meccanismi di regolazione dell’espressione genica.

3. Sono dei piccoli RNA non codificanti, molto usati dalle cellule eucariotiche per regolare, a livello post-trascrizionale, l’espressione genica.
Pag. 155
1. È codificata da DNA o RNA, incapsulati in un involucro proteico più o meno complesso.
2. È una particella virale matura, formata dall’unione di DNA o RNA, capside ed eventuale pericapside.
3. Da proteine, normalmente ripetute in numerose unità (chiamate capsomeri) per formare una struttura complessa e regolare.
Pag. 156
1. Il fago T4 ha una testa, icosaedrica, e una coda, formata da una piastra basale e da fibre che aderiscono alle pareti batteriche.
2. I virioni si producono nel ciclo litico della vita virale, quando le proteine virali del capside vengono attivamente tradotte dai macchinari della cellula ospitante.
3. La replicazione del genoma virale (profago), sfruttando i macchinari replicativi della cellula ospitante.
Pag. 158
1. Consiste nell’inglobamento di una particella esterna alla cellula, grazie a un affossamento della membrana cellulare e alla conseguente chiusura di questa invaginazione.
2. È un enzima in grado di produrre DNA (definito cDNA), a partire da molecole di RNA. È un enzima virale, utile all’integrazione del genoma dei retrovirus.
3. È un retrovirus.
Pag. 160
1. Il genoma di SARS-CoV-2 codifica per 29 proteine.
2. In particolare, il sovrappopolamento, la diffusione dei trasporti intercontinentali, l’espansione delle aree urbane, le condizioni ambientali di contorno (in particolare, inquinamento e cambiamento climatico).
3. Può essere infettato e, specialmente se usato come cibo, infettare l’essere umano o un altro animale. Facilita quindi il contatto tra l’areale naturale del virus selvatico e l’uomo.
Pag. 163
1. Nelle cellule competenti, che hanno un particolare indebolimento delle membrane.
2. Il fago funge da vettore del frammento di DNA batterico che viene trasferito (trasdotto) nel batterio ricevente.
Pag. 165
1. È una sequenza genetica che ha la tendenza a spostarsi in altre sedi genomiche tramite trasposizione.
2. Generalmente i trasposoni a DNA sfruttano, per le loro trasposizioni, delle sequenze ripetute e invertite poste alle loro estremità. Queste sono riconosciute dalla trasposasi (specifica per il trasposone in oggetto), che media la trasposizione.
3. I retrotrasposoni sono elementi genetici di origine solitamente virale, integrati nel genoma e resi inattivi (in termini di capacità di produrre virus) nel corso dell’evoluzione.
RIPASSA CON METODO
Dall’alto verso il basso e da sinistra a destra pericapside
TRASCRIZIONE
cromatina
BATTERIOFAGI
una tripletta di nucleotidi – codice genetico
operone
acido nucleico
maturazione – splicing alternativo – regolazione del trasporto
TRADUZIONALE
trasposoni a DNA – retrotrasposoni
TRASFERIMENTO GENICO ORIZZONTALE – trasformazione e trasduzione
POST-TRADUZIONALE
dagli animali all’essere umano – SARS-CoV-2
CONOSCENZE
E ABILITÀ
1. F, V, F, F.
2. Dall’insieme di DNA e istoni.
3. La replicazione del DNA durante la quale ognuno dei due filamenti funge da stampo per la produzione del filamento complementare.
4. A.
5. C.
6. 5′-AGTAGCGTATCAGAATCT-3′
7. V, F.
8. RNA.
9. 3.
10. Un gene costitutivo viene espresso in maniera costante da tutte le cellule, indipendentemente dagli stimoli. un gene non costitutivo può essere più o meno espresso in funzione degli stimoli ricevuti dalla cellula.
11. C.
12. B.
13. 5′-AGUAGCGUAUCAGAAUCU-3′
14. Ser-Ser-Val-Ser-Glu-Ser.
15. 3’-CAUUGCCUAC-5’; 5’-GUAACGGAUG-3’.
16. F, F, V, F.
17. Promotore, operatore, uno o più geni, terminatore. 18. Si evita alla cellula di sintetizzare molecole superflue.
19. In presenza di lattosio e la sua espressione accelera in presenza di cAMP.
20. C.
21. C.
22. A.
23. C.
24. Problema svolto con soluzione presente sul volume.
25. La proteina AraC, in assenza di arabinosio, funge da repressore, legandosi all’operatore e impedendo l’aggancio della RNA polimerasi. In casi di carenza di fonti di energia, in cellula si accumula cAMP, che si lega a un attivatore che, a sua volta, si lega con una porzione del DNA vicino al promotore. Ciò favorisce il legame della RNA polimerasi e quindi la trascrizione avviene a velocità maggiore.
26. V, V, F.
27. Una proteina che interagisce con il DNA e regola la trascrizione.
28. In funzione del suo impacchettamento, il filamento di DNA è accessibile (oppure non lo è) al complesso proteico della trascrizione.
29. Negli eucarioti esistono sequenze regolatrici molto distanti dal punto di inizio della trascrizione.
30. Un gene presenta delle sequenze codificanti, gli esoni, e delle sequenze non codificanti, gli introni. La sequenza codificante è continuamente interrotta dagli introni, che vanno rimossi per avere il prodotto maturo di trascrizione.
31. I miRNA sono prodotti a partire da un RNA sintetizzato dalla cellula, mentre i siRNA sono RNA esogeno, solitamente virale, che viene processato per essere usato come sequenza di riconoscimento di ulteriore materiale genetico virale, che viene, a seguito del riconoscimento, degradato.
32. La trascrizione avviene nel nucleo, poi all’mRNA, ancora non maturo (pre-mRNA) vengono aggiunti il cap e la coda poli-A che permettono il trasferimento nel citoplasma, dove avviene la traduzione a opera dei ribosomi.
33. B.
34. C.
35. B.
36. A.
37. C.
38. A.
39. D.
40. B.
41. F, V, V, F.
42. Virione.
43. Il pericapside è un doppio strato fosfolipidico, in cui sono immerse spesso numerose proteine virali, normalmente glicosilate.
44. Nella distruzione delle cellule a causa della rapida produzione di particelle virali.
45. D.
46. A.
47. C.
48. A.
49. Solo i virus dotati di pericapside, costituito da un doppio strato lipidico, possono fondersi con la membrana cellulare.
50. F, F, F.
51. È dotato di un RNA a singolo filamento.
52. Le spike sono formate da trimeri di glicoproteina S.
53. L’interazione tra la proteina S e il recettore ACE2, di localizzazione prevalentemente polmonare.
54. Le zoonosi sono patologie infettive trasmesse, direttamente o indirettamente, dagli animali all’essere umano.
55. B.
56. V, V.
57. Una molecola di DNA batterico circolare contenente un piccolo numero di geni.
58. Sul plasmide F.
59. Trasferimento genico orizzontale mediante il quale un batterio assorbe e integra nel proprio genoma un filamento di DNA nudo.
60. È in grado di assorbire il materiale genetico attraverso la parete cellulare.
61. B.
62. B.
63. C.
64. Succede se il pilo di coniugazione è interrotto prima che tutto il plasmide sia stato duplicato nella cellula ricevente.
65. V, F.
66. In un trasposone sono riconosciute dall’enzima trasposasi, responsabile della escissione del trasposone.
67. Sul trasposone.
68. Si rischierebbe la distruzione del genoma stesso.
69. I retrotrasposoni derivano da precedenti infezioni di retrovirus.
70. C.
71. C.
COMPETENZE
72. The operator is a part of the operon and is important for the control of the transcription by an activator or a repressor.
73. Transcriptional control regulates RNA production while translational control regulates protein production.
74. Different mRNAs may be produced by a single RNA transcript, selectively including different exons.
75. miRNAs bind to complementary regions of mRNA preventing them to be translated.
76. B.
77. In eukaryotic cells mRNA usually has a much longer life.
78. Modifica post-traduzionale mediata da ubiquitina.
L’ubiquitina recluta enzimi degradativi, che distruggono la proteina etichettata.
79. All’inizio con l’abbondanza di glucosio la crescita è rapida. Finito il glucosio, ci vuole un po’ di tempo perché vengano espressi i geni nell’operone lac. Il metabolismo del lattosio è meno efficiente e la crescita della popolazione più lenta.
80. Splicing alternativo.
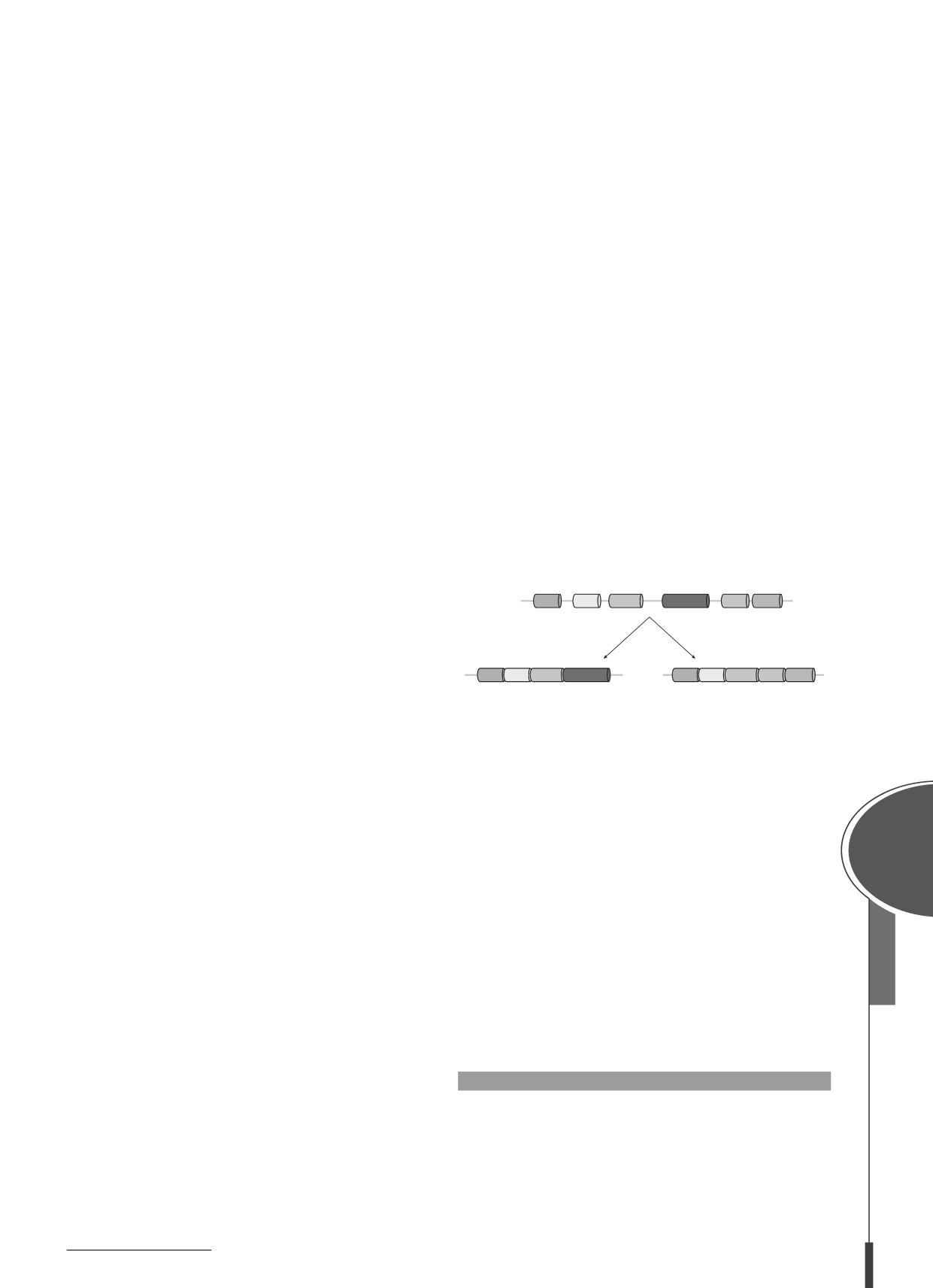
81. Risposta aperta.
82. Risposta aperta.
83. Risposta aperta.
84. In generale, il numero di sequenze diverse di lunghezza N che si possono costruire a partire da M diverse lettere è MN. Nel nostro caso, M = 2 (i due possibili valori del codice binario): dobbiamo quindi trovare un valore di N tale che 2N ≥20. Osservando la serie delle potenze di 2, ci accorgiamo che ogni codone dovrà avere una lunghezza di almeno 5 nucleotidi: 25 = 32. Infatti, 4 nucleotidi sarebbero stati troppo pochi, dato che si possono generare al massimo 24 = 16 sequenze differenti. Il codice così ottenuto è degenerato, dato che esistono 32-20 = 12 sequenze in più del necessario. Alcune di queste potranno codificare per alcuni amminoacidi, altre invece potrebbero avere altri compiti, come segnalare l’inizio o la fine di un gene.
85. Risposta aperta.
86. 23 = 8.
87. Risposta aperta.
Risposta breve
Pag. 173
Unità 6
1. In generale, consistono nelle applicazioni tecnologiche (in special modo produzione di beni o servizi, o di utilità in genere) degli esseri viventi. Si sviluppano perlopiù con lo sfruttamento dei microorganismi, o il miglioramento delle specie vegetali utili all’uomo.

2. Il sequenziamento completo del genoma umano è tra i maggiori avanzamenti delle biotecnologie moderne.
Pag. 177
1. È un plasmide sfruttato, in biotecnologia, come vettore per inserire informazioni genetiche eterologhe nei batteri.
2. Idrolizzano il DNA a livello di specifiche sequenze, consentendo di introdurre, in posizioni definite, delle sequenze di interesse.
3. Taglia tra la prima e la seconda base della sequenza: 5’-GAATCC-3’
Pag. 180
1. Una forma di DNA polimerasi termostabile, derivata da batteri termofili.
2. A denaturare il doppio filamento del DNA, per consentire poi l’appaiamento di primer e polimerasi.
Pag. 182
1. Le cellule vegetali, similmente a quelle batteriche, hanno robuste pareti. Richiedono quindi metodi di lisi drastici, basati sulla rottura meccanica e per shock termico. A volte è necessaria l‘aggiunta di enzimi litici.
2. I più corti.
3. È il rapporto tra la carica elettrica netta e la massa molecolare del DNA, ed è dovuto, chiaramente, alla presenza di gruppi fosfato (carichi negativamente) lungo tutto il filamento di DNA. È costante, e non dipende dalla lunghezza del filamento.
Pag. 183
1. Sono corte sequenze di DNA ripetuto, sparse nel genoma e altamente variabili tra gli individui.
2. Nel confronto univoco e non ambiguo della sequenza genetica a livello del DNA minisatellite.
3. Sono specialmente rilevanti per la biologia forense, e per le attribuzioni di paternità.
Pag. 188
1. Sono dei terminatori di catena: interrompono la polimerizzazione del filamento complementare e, essendo marcati, permettono di identificare la natura del nucleotide presente nel momento in cui il dideossinucleotide è stato aggiunto.
2. Serve a sequenziare il DNA, e sfrutta la frammentazione del filamento di DNA da analizzare, il sequenziamento dei frammenti e la ricostruzione della sequenza originaria tramite sovrapposizione delle sequenze ottenute.
3. È stato completato nel 2003, e si proponeva di sequenziare interamente (salvo regioni non sequenziabili) il genoma umano.
Pag. 194
1. È una tossina ad attività insetticida
2. Nella modificazione biotecnologica del riso, per produrre la varietà Golden Rice. Un gene di narciso vi è stato inserito per avere la produzione di beta-carotene.
Pag. 195
1. Hanno una maggior produzione di ormone della crescita, e quindi raggiungono dimensioni maggiori.
2. Alcune capre sono state modificate in modo da far produrre, nel loro latte, una proteina simile alla seta, potenzialmente utile alla produzione di nuovi materiali.
Pag. 198
1. Si produce a partire dall’olio vegetale (da soia, colza, palma, girasole) esausto o eccedente.
2. Per digestione anaerobica e metanogenesi degli scarti dell’industria zootecnica, agraria e alimentare.
3. Oltre alle tecniche meccaniche e chimiche (basate prevalentemente sull’uso di tensioattivi disperdenti), si usano microrganismi in grado di usare il petrolio come fonte nutritiva.
4. Sono supporti, derivati da materiale di scarto prevalentemente dell’industria del legno, su cui sono immobilizzati batteri in biofilm.
Pag. 201
1. È possibile inserire, modificare e potenziare le vie biosintetiche degli antibiotici nei microorganismi più adatti, coltivarli e raccogliere, poi, l’antibiotico prodotto.
2. È il prodotto cellulare della fusione tra plasmacellule, estratte da un coniglio immunizzato con l’antigene di interesse, e cellule di mieloma.
3. Perché derivano tutti da un unico clone di ibridoma, e riconoscono tutti lo stesso antigene sulla stessa porzione.
Pag. 205
1. Nanoparticelle lipidiche.
2. Di studiare l’influenza che il genoma individuale può avere sulla risposta a una certa terapia farmacologica.
3. Dipende dalla patologia. Nel caso delle leucemie, si usano cellule ematopoietiche sane da donatori compatibili, si ingegnerizzano e si trapiantano nel paziente. Ciò allo scopo di rimpiazzare la parte cellulare malata del midollo osseo.
RIPASSA CON METODO
Dall’alto in basso e da sinistra a destra esseri viventi o sostanze da essi prodotte
INSERTO clonaggio – espressione ingegneria genetica – clonaggio
ENZIMI DI RESTRIZIONE reazione a catena della polimerasi
DNA LIGASI
genomiche – di cDNA OGM
ELETTROFORESI SU GEL
AGROALIMENTARE
antibiotici – vaccini – anticorpi – cellulare e genica – staminali inquinamento – biocarburanti bioinformatica – proteomica – trascrittomica – metabolomica
CONOSCENZE E ABILITÀ
1. F, V.
2. L’insieme di processi che utilizzano esseri viventi o loro derivati per produrre beni.
3. Sia il vettore sia l’inserto sono tagliati con lo stesso enzima di restrizione, in modo che le estremità combacino, poi si utilizza l’enzima DNA ligasi per saldare i due DNA in un’unica molecola, che è appunto detta ricombinante.
4. Tagliare un filamento di DNA in corrispondenza di una specifica sequenza nucleotidica.
5. Possiamo distinguere gli enzimi che operano un taglio simmetrico nella sequenza bersaglio, lasciando le estremità piatte, e quelli che invece fanno un taglio asimmetrico, lasciando le estremità coesive.
6. Un vettore deve contenere: un’origine di replicazione, un sito multiplo di clonaggio e uno o più geni reporter.
7. Il vettore di espressione contiene le sequenze che permettono la trascrizione e la traduzione dell’inserto, mentre il vettore di clonaggio permette di mantenere il DNA esogeno all’interno della cellula ospite e di farlo replicare insieme al suo genoma.
8. È una raccolta dei frammenti di DNA derivati dal genoma di un organismo, conservati all’interno di cellule batteriche.
9. B.
10. C.
11. A.
12. A.
13. B.
14. Due frammenti: a. 5′-ATTGAG-3′, 3′-TAACTCCTAG-5′ ;
b. 5′-GATCCGTAATGTGTCCTGATCACGCTCCACG-3′ ;
3′-GCATTACACAGGACTAGTGCGAGGTGC-5′
15. Due frammenti: a. 5′-ATCCCAGCTGCGTATGTT-3′ ,
3′-TACCGTCGACGCATACAA-5′ ; b. 5′-AACATCAGCTGTCCACG-3′ ,
3′-TTGTAGTCGACAGGTGC-5′
16. La sequenza palindromica inizia dal tredicesimo nucleotide e finisce con il ventiseiesimo nucleotide.
5′-TAGTACCTTATGTTAGCACCACGATTCG-3′ ,
3′-ATCATGGAATACAATCGTGGTGCTAAGC-5′
Le estremità di taglio di due ipotetici enzimi di restrizione potrebbero essere: a. Taglio simmetrico TAGTACCTTATGTTAGC ACCACGATTCG, ATCATGGAATACAATCG TGGTGCTAAGC; b. Taglio asimmetrico TAGTACCTTATGTTA GCACCACGATTCG, ATCATGGAATACAATCGTGGTGC TAAGC.
17. F, V.
18. DNA stampo; due primer a DNA; Taq polimerasi; dATP, dGTP, dCTP, dTTP.
19. a) Denaturazione del DNA stampo; b) abbassamento della temperatura per permettere l’appaiamento dei primer; c) la Taq polimerasi allunga i filamenti a partire dai primer; d) il processo si ripete dal punto a 20. B.
21. D.
22. 12 ⋅ 25 = 384.
23. F, V, V.
24. Si devono lisare le cellule e il loro contenuto deve essere filtrato e sottoposto all’azione delle proteasi. Il DNA è poi fatto precipitare tramite l’aggiunta di sali e, dopo essere stato raccolto, può essere ulteriormente purificato.
25. L’elettroforesi su gel è una tecnica che permette di separare frammenti di DNA o proteine in base al loro rapporto massa/carica.
26. L’agarosio (il più utilizzato per l’elettroforesi del DNA) e la poliacrilammide (che è scelta obbligata nel caso di elettroforesi di proteine).
27. Nell’analisi, per restrizione e rilevazione delle bande sul tracciato elettroforetico, del DNA minisatellite. Esso è molto variabile tra gli individui, e il confronto tra sequenze minisatellite di diversi campioni di DNA consente di stabilire con certezza se provengono dalla stessa persona.
28. Sono prevalentemente diagnostiche, allo scopo di individuare malattie genetiche.
29. A.
30. C.
31. C.
32. V, F.
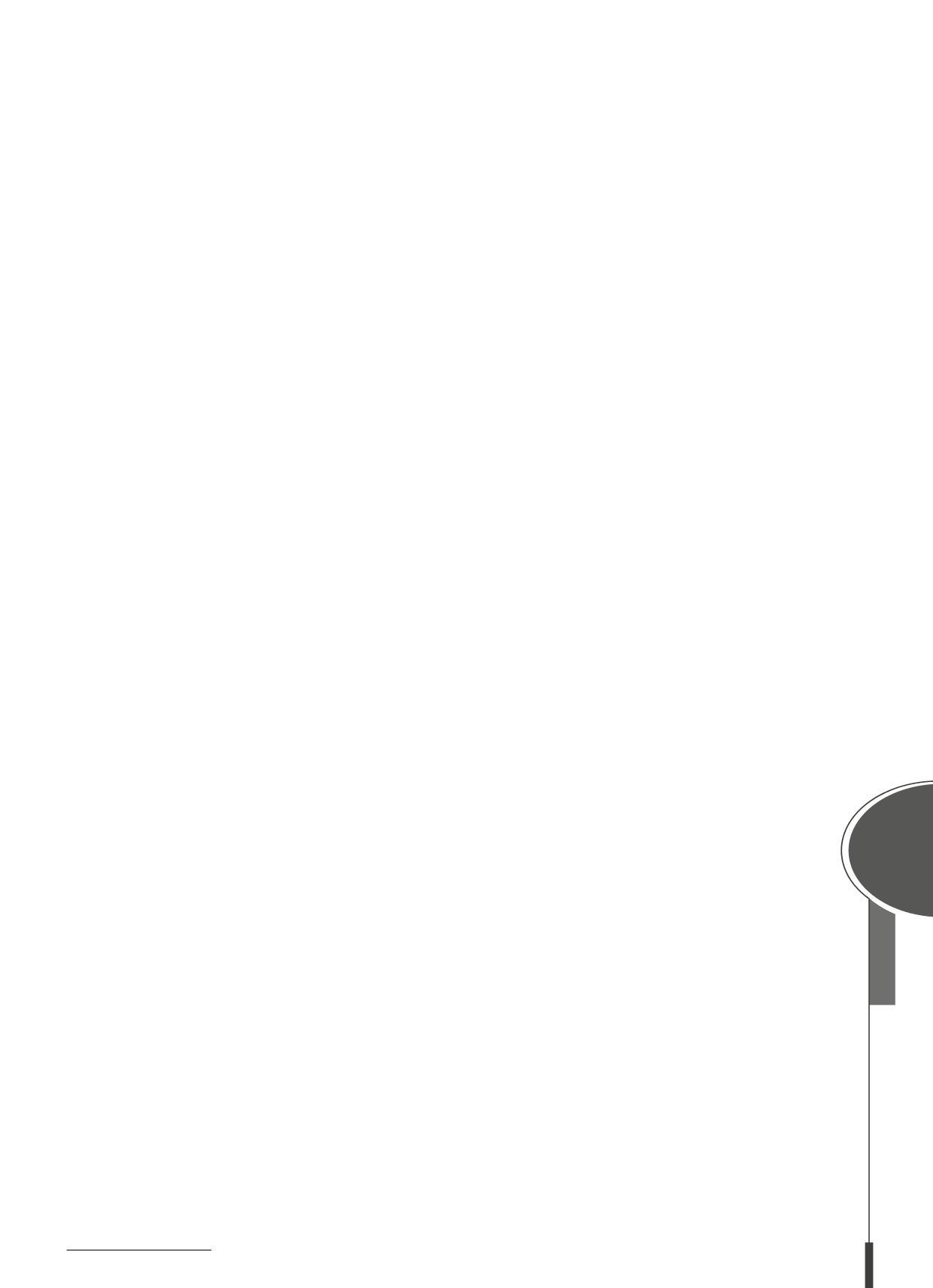
33. Perché l’aggiunta di un didesossinucleotide da parte della DNA polimerasi causa, di fatto, la terminazione dell’allungamento della catena nucleotidica.
34. a) il DNA da sequenziare è diviso in 4 contenitori e a ciascuno di essi si aggiunge la DNA polimerasi, i primer e i nucleosidi trifosfati; b) a ogni contenitore si aggiunge un diverso tipo di didesossinucleotide ognuno legato a uno specifico fluoroforo; c) la DNA polimerasi incorpora nella catena nascente i didesossinucleotidi in posizione casuale, interrompendo la sintesi; d) i vari frammenti sono separati in base alla loro lunghezza e grazie ai fluorofori si individua il terminatore di catena di ogni frammento.
35. Nella prima si analizza il genoma alla ricerca di sequenze note (promotori, codoni di inizio ecc.); nella seconda, invece, lo si analizza cercando sequenze ottenute da prove sperimentali (come un determinato trascritto).
36. C.
37. B.
38. D.
39. 5′-TA-3′; 5′-TAA-3′; 5′-TAAGCA-3′; 5′-TAAGCATA-3′ ; 5′-TAAGCATATA-3′; 5′-TAAGCATATAA-3′ ; 5′-TAAGCATATAACTCT-3′
40. 5′-TAAGCATATAACTCT-3′ lungo 15 nucleotidi.
41. F, V.
42. È lo studio della struttura, della composizione e dell’evoluzione dei genomi.
43. Il proteoma è l’insieme delle proteine presenti in una cellula, un tessuto o un organismo. Di conseguenza, il trascrittoma consiste nell’insieme dell’RNA presente in una cellula, un tessuto o un organismo.
44. a) estrazione e purificazione dell’RNA dei due campioni; b) produzione del cDNA corrispondente, che è poi marcato con molecole fluorescenti; c) ibridizzazione dei cDNA con le sonde del microarray; d) lettura del microarray grazie a un laser che stimola l’emissione di fluorescenza.
45. A.
46. C.
47. C.
48. V, V.
49. Sono organismi il cui patrimonio genetico è stato modificato.
50. Perché la procedura è più complessa e richiede più tempo. Inoltre, le implicazioni etiche della manipolazione genetica degli animali sono molto più serie.
51. A.
52. C.
53. Sebbene l’uso di animali transgenici come fabbriche di materiale farmacologico sia raro, si menzionano le galline transgeniche, modificate per produrre (con accumulo nelle loro uova) grandi quantità di utili farmaci di natura proteica (come, ad esempio, l’interferone).
54. Un topo knock-out è un animale transgenico in cui sono stati inattivati uno o più geni. Si tratta di una specifica tipologia di OGM realizzata per fini scientifici.
55. C.
56. V, F.
57. È una tecnica che prevede l’utilizzo di microrganismi per la rimozione di contaminanti ambientali.
58. È una miscela di metano e diossido di carbonio prodotta grazie alla digestione di biomasse da parte di microrganismi.
59. È un filtro costituito da microrganismi che rimuovono contaminanti da acqua e aria.
60. B.
61. B.
62. D.
63. V, V, F, F.
64. Impedisce la polimerizzazione del peptidoglicano, interferendo con la sintesi della parete cellulare dei batteri.
65. Sono prodotti grazie all’iniezione di sostanze antigeniche in animali.
66. La farmacogenetica studia come le differenze individuali in un dato gene influiscono nella risposta a un determinato farmaco; la farmacogenomica si occupa dell’effetto che l’intero genoma ha sulla risposta di un individuo a un farmaco.
67. È un tessuto ottenuto a partire da cellule coltivate in vitro fatte crescere su un supporto detto scaffold.
68. È la sostituzione di un gene difettoso, responsabile di una malattia, con uno funzionante.
69. L’affermazione è falsa: solamente le cellule staminali totipotenti possono differenziarsi in qualsiasi tipo cellulare. Tutte le altre possono originare almeno un tipo diverso di cellula adulta.
70. C.
71. A.
72. A.
73. C.
74. F, V.
75. A.
76. B.
COMPETENZE
77. It is a genetically modified plant that produces rice rich in beta-carotene.
78. They are proteins able to recognize and bind a specific antigen.
79. C.
80. D.
81. Un vettore ricombinante contiene al suo interno un frammento di DNA esogeno. Per ottenerlo, i DNA (del vettore e genomico) vengono tagliati con lo stesso enzima di restrizione e poi, grazie all’enzima DNA ligasi, le estremità libere vengono saldate. Una prima strategia per poter stabilire se il vettore è ricombinante o meno è impiegare lo stesso enzima di restrizione usato nel clonaggio. Il taglio dovrebbe generare due frammenti di DNA: uno delle dimensioni del vettore e l’altro corrispondente al segmento di DNA esogeno in esso inserito. Questi ultimi sono separabili e identificabili mediante elettroforesi su gel. In alternativa, si può impiegare una reazione di amplificazione mediante PCR. I primer dovrebbero essere disegnati in maniera tale da appaiare all’interno della sequenza del DNA inserito e (per quanto riguarda l’altro primer) all’esterno di essa (in una sequenza propria del vettore). In questo caso, l’assenza di amplificazione indicherebbe che il vettore si è richiuso senza aver incorporato l’inserto mentre, al contrario, la presenza di un amplificato sarebbe un segnale della presenza dell’inserto nel vettore.
82. Impiegando un approccio di tipo biotecnologico, gli scarti vegetali possono essere adoperati per la produzione di biocombustibili come il bioetanolo. Infatti, grazie alla fermentazione alcolica condotta da alcune tipologie di
microrganismi, gli zuccheri contenuti negli scarti vegetali possono essere efficacemente trasformati. Inoltre, sfruttando le più recenti innovazioni biotecnologiche, ci si può servire di microorganismi, solitamente lieviti, in grado di effettuare la fermentazione alcolica a partire direttamente dal materiale di scarto, senza pretrattamenti, anche se esso contiene lignina. Il bioetanolo costituisce quindi una risorsa energetica rinnovabile, con un impatto ambientale ridotto rispetto ai comuni combustibili fossili.
83. Enzima A. La digestione con l’enzima B avrebbe fornito frammenti da 1,0 kb assenti nel campione.
84. La PCR è una tecnica che consente l’amplificazione del DNA e consta di una serie di fasi, a temperature differenti, che si ripetono ciclicamente. Il termociclatore è uno strumento in grado di far variare ciclicamente la temperatura e i tempi per cui è mantenuta costante; esso consente di ridurre i tempi e aumentare l’efficienza. In alternativa, nei laboratori scolastici, si possono impiegare bagnetti termostatati o blocchi termici, andando a spostare la miscela di reazione in recipienti tenuti a temperature diverse e stabili.
85. 3′-CAGGAGGCCTACCATGAA-5′. La sequenza ottenuta è quella complementare 5′-GTCCTCCGGATGGTACTT-3′
86. Risposta aperta.
87. Il soggetto A, avendo il frammento di restrizione di 15 kpb in comune con la madre e i due frammenti di 11 e 6 kpb uguali a quelli del padre, può essere un figlio della coppia. Il soggetto B, invece, ha due frammenti in comune con la madre (8 e 5 kpb) e un frammento (13 kpb) non presente nei due ipotetici genitori, questo soggetto potrebbe essere un figlio della madre analizzata, ma sicuramente non del padre. Il soggetto C, non avendo nessun frammento di restrizione in comune con i presunti genitori, non può essere un figlio della coppia.
MADREPADRESOGGETTO ASOGGETTO BSOGGETTO C 15
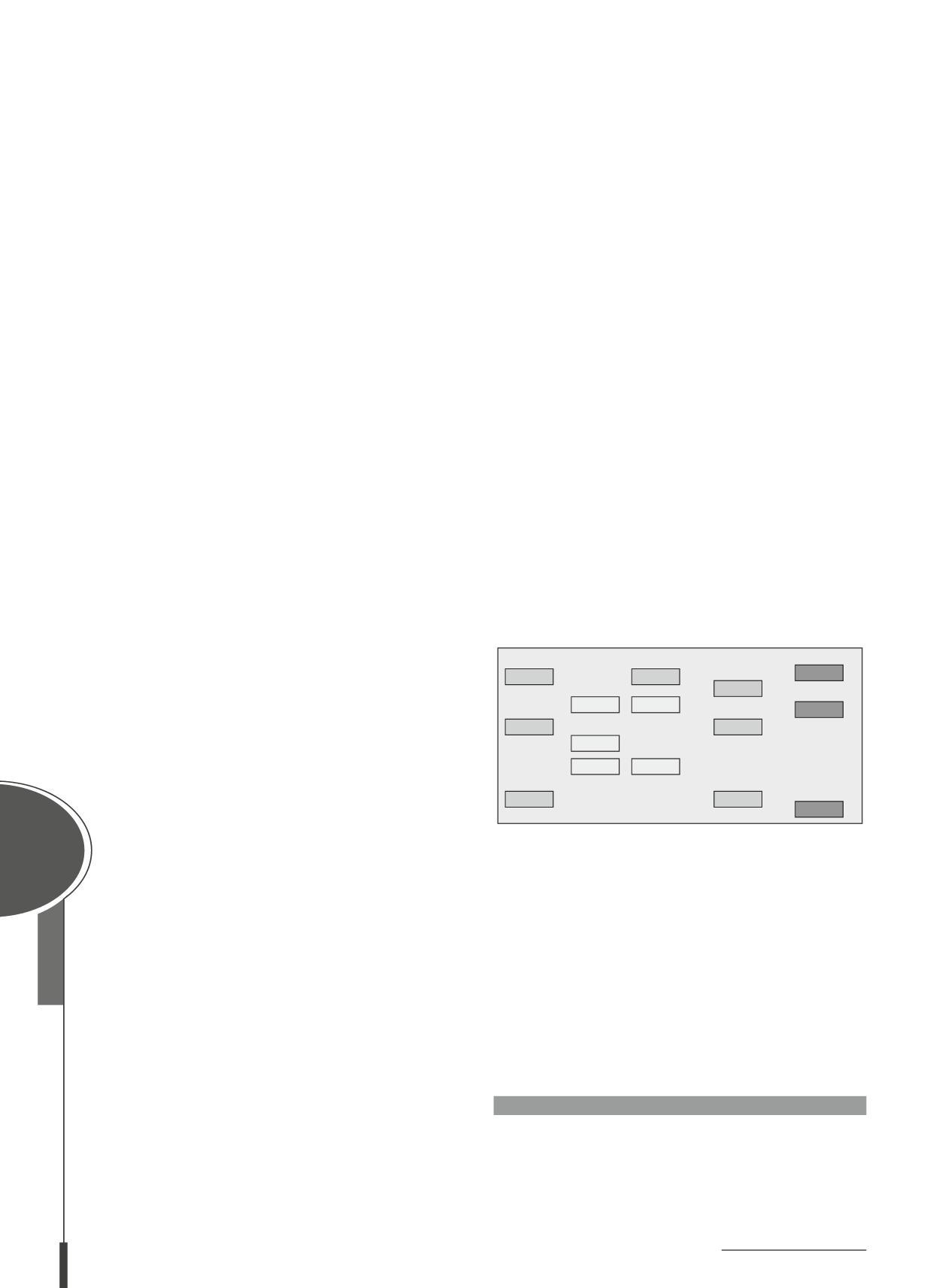
88. Risposta aperta.
89. Risposta aperta.
90. Si tagliano i due plasmidi con due enzimi di restrizione (gli stessi per entrambi), che non riconoscano sequenze contenute in nessuno dei due geni. Da entrambi i plasmidi si ottengono 2 frammenti, uno contenente il gene di interesse e l’altro no. Una corsa elettroforetica potrebbe aiutarci a escludere i frammenti non contenenti i geni di interesse dalla successiva fase che prevede l’utilizzo di una DNA ligasi. Visti i 2 diversi siti di restrizione e l’esclusione dei frammenti non contenenti i geni, l’unica combinazione possibile sarebbe quella di interesse.
91. Risposta aperta.
Unità 7
Risposta breve
Pag. 223
1. 5527 kg/m3
2. La presenza di materiali di maggiore densità negli strati inferiori.
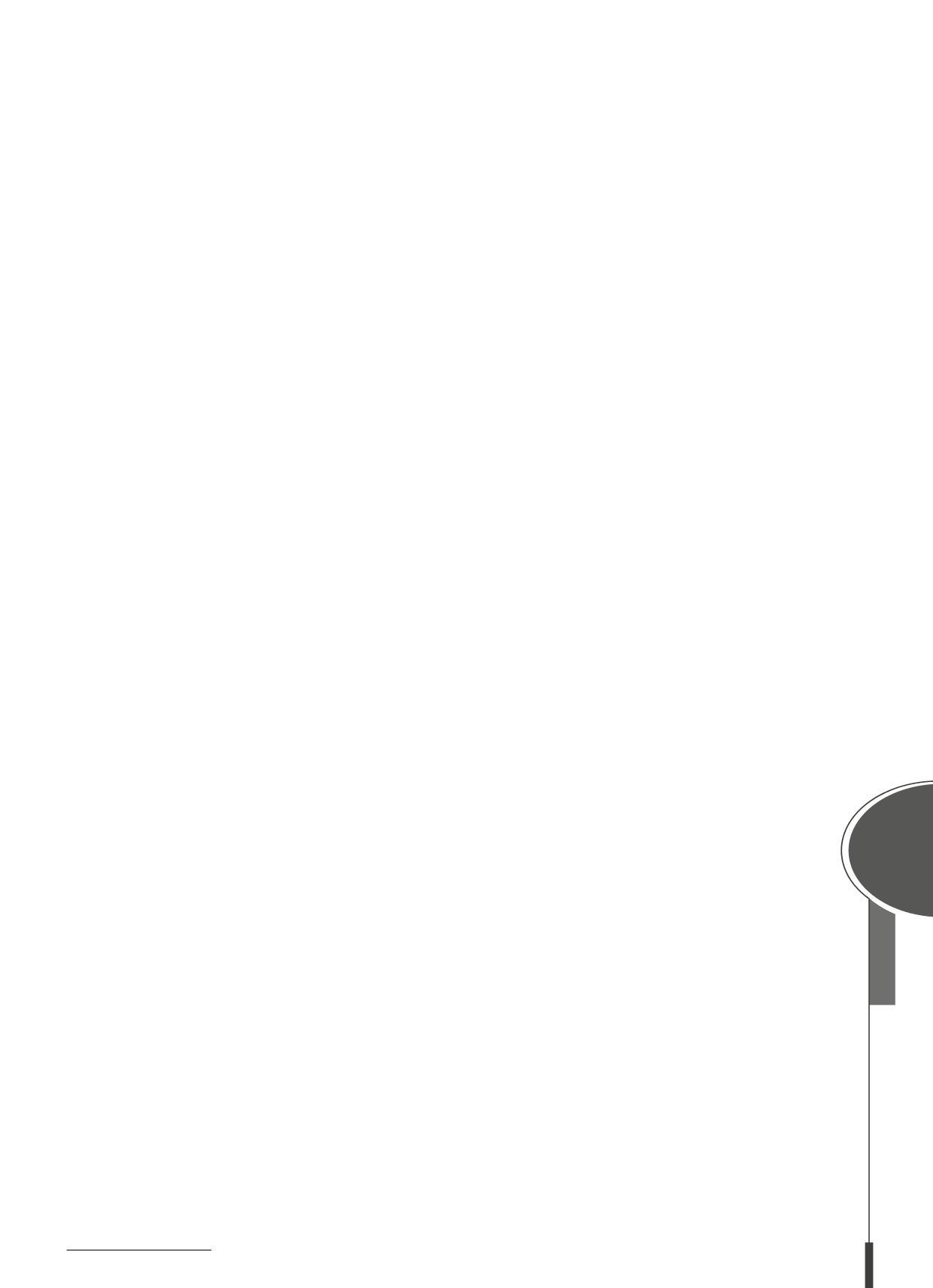
3. Perché le meteoriti differenziate hanno subìto lo stesso processo di differenziamento della Terra.
4. La differente densità dei materiali.
Pag. 227
1. Perché è basata sulla percezione del sisma e sui danni provocati a edifici e infrastrutture: per questo motivo due eventi di pari intensità possono avere gravità diverse.
2. Si basano sulla percezione da parte degli esseri umani e sui danni provocati: il livello I corrisponde a un sisma percepito solo dagli strumenti di misurazione, il livello XII corrisponde a un sisma che distrugge quasi tutti i manufatti umani e cambia la morfologia del paesaggio.
3. Sono le linee che congiungono tutti i punti nei quali il terremoto ha avuto la stessa intensità.
4. La quantità di energia liberata in corrispondenza dell’epicentro.
5. Non ha un limite superiore.
Pag. 228
1. La frequenza e l’intensità dei fenomeni sismici che si verificano, la fragilità del patrimonio edilizio e delle infrastrutture, l’alta densità abitativa e la presenza di un enorme patrimonio storico e artistico.
2. È la probabilità che, in un intervallo di tempo considerato, si verifichi un terremoto di una certa magnitudo.
3. Scarsa qualità dei materiali, modalità di costruzione inadeguate, scarsa manutenzione.
4. Per l’alta densità abitativa e la presenza di beni storici e artistici.
Pag. 229
1. Ipocentro, epicentro, il piano di faglia (che spesso si crea a seguito della rottura a livello dell’ipocentro) e la magnitudo.
2. Si propagano in tutte le direzioni.
3. Le onde di Rayleigh conferiscono un movimento ellittico alle particelle del mezzo che attraversano; le onde di Love provocano movimenti trasversali rispetto alla direzione di propagazione dell’onda.
Pag. 230
1. Sono involucri concentrici che separano strati rocciosi con diverse caratteristiche chimico-fisiche.
2. Attraverso lo studio delle onde sismiche, osservando le variazioni di velocità e traiettoria della loro propagazione.
3. La Moho si trova a 30-70 km sotto i continenti, la discontinuità di Gutenberg si trova a 2900 km di profondità, la discontinuità di Lehman si trova a 5170 km di profondità.
4. La crosta continentale è formata da rocce leggere (graniti in superficie e, più in profondità, rocce metamorfiche via via più basiche) mentre la crosta oceanica è formata da rocce più dense e pesanti (a composizione basica).
Pag. 231
1. Il mantello è caratterizzato da un forte incremento di temperatura e pressione con l’aumentare della profondità ed è formato da peridotiti.
2. È diviso in due parti: nucleo liquido (più esterno) e nucleo solido (interno).
3. 4000 °C.
4. Sulla differenza di composizione delle rocce, che determina anche differenze nella solidità e nella densità.
Pag. 234
1. La quantità di energia termica che si allontana dalla Terra per unità di area nell’unità di tempo.
2. La catastrofe del ferro e il decadimento degli isotopi radioattivi.
3. Mostra l’andamento del gradiente termico.
4. Convezione.
Pag. 237
1. Formazione del magma, risalita, formazione della camera magmatica, formazione di gas, eruzione.
2. Sulla quantità di silice che contengono.
3. Fino a 1200 °C.
4. Dalla composizione chimica e dalla temperatura.
5. È composto da una camera magmatica, da cui parte un condotto vulcanico che si apre sulla superficie con un cratere.
Pag. 239
1. Perché la lava molto fluida scorre lungo i pendii, dove si raffredda.
2. La nube ardente è composta da una sospensione di frammenti roventi, gas e vapori ad altissima temperatura.
3. Sono il prodotto di eruzioni alimentate da magma acido o intermedio, generalmente esplosive.
4. I vulcani lineari si aprono sulla superficie con una lunga fessura, invece che da un punto ristretto.
Pag. 241
1. Si tratta di un supervulcano costituito da una trentina di vulcani.
2. L’alternanza di fasi di lento abbassamento (subsidenza) e più rapido sollevamento del livello del suolo in corrispondenza della caldera.
3. È un vulcano composto, emerso dal mare con il progressivo sedimento dei materiali eruttivi. La sua storia è caratterizzata prevalentemente da eruzioni effusive, ma si registrano anche eventi esplosivi.
4. Per il rischio di maremoto connesso alle eruzioni.
Pag. 244
1. Gauss ipotizzò che il campo magnetico terrestre fosse prodotto da un dipolo magnetico posizionato nel centro della Terra dovuto alla presenza di minerali ferromagnetici.
2. Conferisce al campo magnetico terrestre una forma a goccia con la coda allungata in direzione opposta al Sole.
3. Secondo il modello della dinamo ad autoeccitazione, il nucleo esterno si comporta, per effetto del flusso dei suoi materiali, come un elettromagnete. I movimenti nel nucleo fuso inducono una corrente che produce un campo magnetico che, a sua volta, induce una nuova corrente nel nucleo, quindi un nuovo campo magnetico e così via.
4. La declinazione e l’inclinazione magnetica.
RIPASSA CON METODO
Dall’alto in basso e da sinistra a destra chiuso – litosfera
FLUSSO DI CALORE
crosta – mantello – esterno – interno calore fossile primordiale – isotopi magmi – convettivi
ANALISI GEOCHIMICHE – diretta – indiretta
FENOMENI SISMICI – epicentro sismogramma
empirica – dodici
SCALA RICHTER – magnitudo

CONOSCENZE E ABILITÀ
1. F, V.
2. La formazione della componente liquida dell’idrosfera per condensazione del vapore acqueo atmosferico, la formazione dell’atmosfera che ha protetto le prime forme di vita dalle radiazioni UV, il mantenimento sulla superficie terrestre di una temperatura adatta alla vita grazie alla particolare distanza dal Sole e alla composizione dell’atmosfera.
3. Le attività umane che sfruttano in maniera intensiva i combustibili fossili hanno fatto aumentare la concentrazione del diossido di carbonio e i rifiuti provenienti dai processi produttivi industriali e agricoli hanno alterato tutte le sfere biogeochimiche del sistema Terra.
4. F, V, V.
5. La densità della Terra è calcolata dividendo il valore della massa terrestre, a sua volta calcolata applicando la legge di gravitazione universale, e il volume risultato dalla formula del volume di una sfera.
6. La geochimica si occupa di determinare la composizione chimica dei materiali che formano la Terra.
7. C.
8. A.
9. V, F, F.
10. I terremoti sono vibrazioni della superficie terrestre provocate da un’improvvisa liberazione di energia in un punto all’interno della crosta.
11. È formato da crosta, mantello e nucleo.
12. Perché le variazioni delle modalità di propagazione delle onde sismiche corrispondono variazioni della densità, cambiamenti della composizione delle rocce e passaggi di stato dei materiali.
13. Ipocentro ed epicentro.
14. È possibile localizzare epicentro, ipocentro, potenza e durata del sisma.
15. La suddivisione in crosta, mantello e nucleo è realizzata sulla base della composizione dei materiali che formano gli strati mentre la suddivisione reologica in litosfera, astenosfera e mesosfera si basa sul comportamento dei materiali alle sollecitazioni meccaniche.
16. La litosfera è lo strato formato dalla crosta e dalla porzione superficiale del mantello (detto mantello litosferico).
17. D.
18. C.
19. D.
20. D.
21. b.
22. C.
23. B.
24. V, F, V.
25. Si ipotizza una temperatura nel nucleo terrestre compresa tra 3700 e 4300 °C, con un gradiente geotermico che diminuisce via via fino a raggiungere valori di circa 0,7- 0,8 °C/km.
26. Il flusso di calore è la quantità di energia termica che si allontana dalla Terra per unità di area nell’unità di tempo.
27. Nelle prime fasi di formazione della Terra la temperatura raggiunse 1200 °C e determinò la fusione dei materiali terrestri, denominata catastrofe del ferro. La dislocazione di materiali con diversa densità determinò la liberazione di energia che ancora oggi è responsabile di circa il 30% del calore interno della Terra.
28. Il decadimento degli isotopi radioattivi avviene all’interno delle rocce della crosta che contengono elementi come uranio, torio e potassio. I nuclei instabili di questi elementi emettono particelle subatomiche ed energia per raggiungere la stabilità e trasformarsi in isotopi o in altri elementi.
29. A.
30. B.
31. C.
32. V, F, F, V.
33. I magmi si classificano in base al chimismo e alla percentuale di SiO2, silice: magmi acidi (con oltre il 70% di silice), basici (con meno del 50% di silice) e intermedi (con circa il 60% di silice).
34. Nelle camere magmatiche si formano celle convettive di materiali fluidi ad alta temperatura, che rimescolano continuamente i magmi e favoriscono la formazione di grosse bolle di gas.
35. Le correnti di convezione del mantello trasferiscono energia dall’interno della Terra verso l’esterno. Nella crosta e nella parte superiore del mantello si possono creare localmente le condizioni termiche che provocano la fusione delle rocce e la formazione di magmi.
36. Se l’energia dei gas non supera la resistenza delle rocce sovrastanti, il magma rimane dentro la crosta; se, invece, la spinta dei gas è sufficiente, il magma risale in superficie e dà origine a un’eruzione.
37. D.
38. D.
39. V, F, F.
40. Gauss ipotizzò il campo magnetico terrestre come un dipolo magnetico posizionato nel centro della Terra che genera una serie di linee di forza che si estendono nello spazio.
41. L’angolo tra le linee di forza e la superficie terrestre, misurato con una bussola dotata di un ago libero di muoversi nelle tre dimensioni, fornisce il valore dell’inclinazione magnetica. In una determinata località, la declinazione magnetica corrisponde all’angolo che si forma tra la direzione indicata dall’ago della bussola e la direzione del Nord geografico. 42. Il punto di Curie è la temperatura sopra la quale i metalli perdono le loro proprietà magnetiche. 770 °C è il punto di Curie del ferro: poiché nelle zone più interne della Terra le temperature variano tra 3700 a 4300 °C, i materiali ricchi di ferro che formano il nucleo non possano mantenere le loro proprietà magnetiche.
43. D.
44. D.
45. A.
46. Secondo il modello della dinamo ad autoeccitazione, il nucleo esterno si comporta, per effetto del flusso dei suoi materiali, come un elettromagnete. I movimenti nel nucleo fuso inducono una corrente che produce un campo magnetico che, a sua volta, induce una nuova corrente nel nucleo, quindi un nuovo campo magnetico e così via.
47. Produce correnti elettriche che generano campi magnetici.
COMPETENZE
48. The formation of the liquid component of the hydrosphere through the condensation of atmospheric water vapor, the formation of the atmosphere that protected the first forms of life from UV radiation, the maintenance of a temperature suitable for life on the Earth’s surface thanks to the particular distance from the Sun and the composition of the atmosphere.
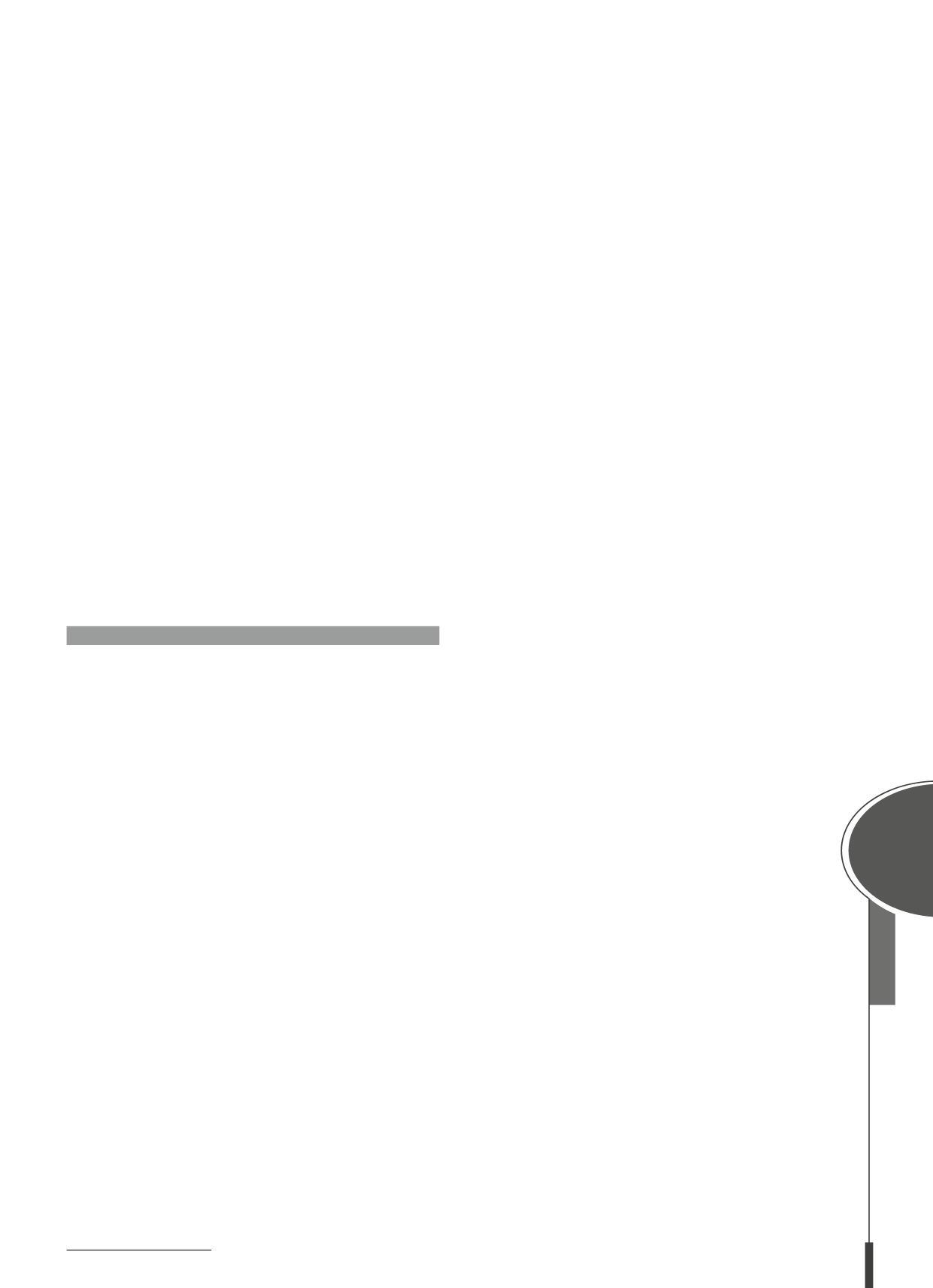
49. The Earth is a closed system because it receives energy from the Sun and recycles the matter it is composed of through cyclic processes that occur within it, the most important of which are the water cycle and the carbon cycle.
50. The information obtained from meteorites allows us to formulate a hypothesis about the arrangement of materials inside the planet because the materials are arranged in overlapping layers according to their density.
51. Seismic events are vibrations of the Earth’s surface caused by a sudden release of energy at a point within the crust. The hypocenter, or focus, is the point located deep beneath the Earth’s crust where the rupture originates, leading to the formation of the fault plane, while the epicenter is the projection of the hypocenter onto the Earth’s surface.
52. D.
53. A.
54. a. La curva più bassa si riferisce alle onde P, quella più alta alle onde S; b. Sono più lente le onde S; c. Serve per determinare la posizione dell’epicentro.
55. Risposta aperta.
56. a. Magma acido, ad alto contenuto di silice, spesso associato a eruzioni esplosive; b. Si tratta di uno stratovulcano, tipicamente prodotto da eruzioni di magma acido.
57. a. Un flusso di magma e gas ad alta temperatura; b. Si prevede una eruzione esplosiva; c. Il differente rischio vulcanico di ogni zona.
58. Si tratta di uno stratovulcano, più precisamente il Fujiyama, caratteristico per la forma a cono.
Unità 8
Risposta breve
Pag. 253
1. È il fenomeno per cui le masse continentali “galleggiano” in una situazione di equilibrio sulle rocce più plastiche del mantello.
2. Secondo Wegener, circa 300 milioni di anni fa, i continenti formavano una singola massa, chiamata Pangea, circondata da un unico grande oceano, la Panthalassa. Successivamente, la Pangea si sarebbe frammentata e i frammenti si sarebbero allontanati.
3. Le somiglianze litologiche, gli studi paleontologici e le somiglianze paleoclimatiche.
4. Perché i meccanismi proposti per giustificare la “deriva” non venivano ritenuti tali da permettere lo spostamento di masse continentali.
5. Wegener fu il primo a proporre un meccanismo in grado di spiegare il movimento dei continenti e associò la formazione delle catene montuose allo scontro tra continenti.
Pag. 256
1. Le dorsali presentano una stretta depressione in corrispondenza di un asse centrali rispetto al quale sono simmetriche, le rift valley, e delle serie di fratture trasversali fra loro parallele e perpendicolari alla dorsale stessa, chiamate faglie trasformi.
2. In prossimità di alcuni margini continentali o di archi insulari.
3. La piattaforma continentale sotto questo aspetto appartiene alle terre emerse ed è coperta da uno spesso strato di sedimenti di origine continentale.
4. Sono distese uniformi che coprono la maggior parte dei
fondali oceanici e sono interrotte in vari punti dalla presenza di avvallamenti e rilievi sottomarini.
Pag. 258
1. Le inversioni di polarità.
2. Attraverso lo studio degli strati di roccia.
3. Datazione radiometrica.
4. Che le dorsali oceaniche fossero zone di risalita di magma che, solidificando, formava nuova crosta e provocava l’allontanamento dei due settori di crosta oceanica adiacenti alla dorsale.
Pag. 260
1. Sono porzioni di litosfera in continuo e lento movimento le une rispetto alle altre; attualmente si contano circa 20 placche, 12 placche principali e altre secondarie.
2. Sismi e vulcani.
3. Possono essere: attivi (se sono anche limiti di placca) e presentare fenomeni sismici e vulcanici; passivi; trasformi, che formano scarpate lungo la piattaforma continentale.
4. Divergenti, convergenti e conservativi.
Pag. 264
1. Formazione di un rift continentale, formazione di un lago tettonico, apertura di un nuovo oceano.
2. Perché determinano la formazione di nuova crosta.
3. Porzioni di litosfera composte da materiali più densi vanno in subduzione, cioè scivolano al di sotto di altre porzioni di litosfera meno densa.
4. La struttura a piano inclinato.
5. Quella che coinvolge una placca oceanica e un’altra placca, oceanica o continentale.
Pag. 265
1. Si forma un margine convergente attivo, con una zona di subduzione dove i sedimenti deposti in profondità iniziano a fondere.
2. È un limite di placca e presenta attività sismica.
3. Piano di faglia, tetto e letto.
4. Dirette, inverse e trasformi.
5. Quando le rocce sono sottoposte a forte pressione, alta temperatura e sollecitazioni.
6. È la struttura in cui affiorano le rocce sottostanti in caso di sovrascorrimento.
Pag. 268
1. Si sono verificati due sollevamenti associati alla formazione di archi vulcanici. Infine il bacino tra le due cordigliere si è riempito di sedimenti.
2. Circa 130 milioni di anni fa la formazione dell’Atlantico ha fatto avvicinare la placca africana al Gondwana. 45 milioni di anni fa la collisione ha dato origine alle catene che vanno dalla Spagna all’Himalaya. Gli Appennini si sono formati 7 milioni di anni fa, nella parte finale di questo processo.
3. Frammenti e sedimenti originati nei fondali oceanici.
4. Movimenti relativi tra placche adiacenti.
Pag. 270
1. Fanno risalire materia calda e ridiscendere materia più densa.
2. L’emissione di calore dal nucleo, e la conseguente attività delle celle convettive e dei pennacchi termici.
3. In corrispondenza di pennacchi termici alimentati da lave provenienti dal mantello.

RIPASSA CON METODO
Dall’alto verso il basso e da sinistra verso destra ISOSTASIA – verticali
Alfred Wegener – orizzontali
Pangea – Panthalassa
litologiche – paleoclimatiche – paleontologici
c.m.t.
paleomagnetismo
TEORIA DELLA TETTONICA DELLE PLACCHE
PLACCHE LITOSFERICHE
OROGENESI – MARGINI
dorsali oceaniche
CONOSCENZE E ABILITÀ
1. V, V, F, V, V.
2. Wegener ipotizzò che la rotazione della Terra generasse forze centrifughe e di marea in grado di far spostare i continenti rispetto ai sottostanti fondali oceanici.
3. La coincidenza tra le linee di costa sulle due sponde dell’Atlantico.
4. D.
5. D.
6. A.
7. V, F, F, F, V, F.
8. Quelli derivanti dallo studio dei fondali oceanici: sia quelli sulla composizione del fondo, sia la misura del flusso di calore.
9. L’analisi della composizione e degli spessori delle coperture sedimentarie, che diventano più spesse allontanandosi dalla dorsale oceanica; l’analisi dei flussi di calore nei diversi punti del fondale; lo studio delle anomalie magnetiche e delle inversioni del campo magnetico registrate all’interno delle rocce basaltiche e dei sedimenti dei fondali oceanici.
10. La scala delle polarità magnetiche è lo schema che riporta le inversioni di polarità registrate in tutto il mondo e datate con metodi di datazione radiometrica. Il colore nero indica la polarità normale, cioè con il polo Nord magnetico orientato come quello attuale, e il bianco la polarità inversa.
11. Lungo il tratto di faglia trasforme compreso tra due tronconi il fondale oceanico si muove in direzioni opposte, ma allontanandosi dalla dorsale lungo le faglie, i blocchi di fondale oceanico a contatto prendono a muoversi nella stessa direzione e allontanano tra loro i continenti che si trovano ai margini dell’oceano.
12. C.
13. A.
14. D.
15. B.
16. F, V, V, F, F, F, F, V, V.
17. Sono porzioni di litosfera in continuo e lento movimento le une rispetto alle altre; sono circa 20, 12 principali e altre secondarie.
18. Mettendo a confronto la carta della distribuzione dei sismi con quella dei fenomeni vulcanici: i margini corrispondono agli allineamenti degli ipocentri e dei vulcani.
19. La formazione di una catena montuosa.
20. In caso di sovrascorrimento molto esteso.
21. Modello delle celle convettive: le placche si muovono per effetto delle celle convettive dell’astenosfera; le placche si muovono in risposta alla spinta esercitata da una dorsale
in espansione e alla forza di trazione da parte dello slab in subduzione; le placche sono la parte superiore, fredda e rigida, di una cella convettiva; modello dei pennacchi termici: i pennacchi avrebbero il ruolo di motore delle placche in quanto, risalendo dal mantello verso la litosfera, sarebbero in grado di generare delle spinte orizzontali tra le stesse celle convettive.
22. È la struttura in cui affiorano le rocce sottostanti in caso di sovrascorrimento.
23. C.
24. D.
25. B.
26. D.
27. D.
28. B.
29. B.
30. A.
31. B.
32. D.
33. C.
34. C.
35. D.
36. D.
37. L’ipotesi che i continenti avessero formato una singola massa, la Pangea, circondata da un unico grande oceano, la Panthalassa; l’esistenza, all’interno della Pangea, di due grandi aree, separate da un grande golfo, la Tetide: a nord Laurasia, comprendente Nord America, Europa e Asia, a sud, Gondwana, comprendente Sud America, Africa, Antartide, Madagascar, India e Australia; la fratturazione della Pangea, circa 200 milioni di anni fa, e i successivi spostamenti dei blocchi continentali.
38. Perché i magmi che fuoriescono dalle dorsali arrivano direttamente dal mantello e hanno composizione basica, mentre quelli delle zone di subduzione sono il risultato della fusione dei materiali rocciosi trascinati in profondità lungo il piano di Benioff.
39. Alpi e Appennini furono sollevati nel corso dell’orogenesi alpino-himalayana, nella prima fase le Alpi, in seguito gli Appennini. In entrambe le catene sono presenti falde di ricoprimento e sequenze ofiolitiche che provano la collisione tra placche continentali e placche oceaniche, in parte ancora in atto in corrispondenza degli Appennini.
40. Gli studi su questa catena hanno dato informazioni sugli effetti dei punti caldi. In questo caso si è evidenziato che il punto caldo resta fermo mentre la placca sovrastante si sposta. Via via che la placca si sposta, il punto caldo genera nuovi vulcani.
41. Uno dei principali meccanismi teorizzati è connesso alla continua emissione di calore da parte del nucleo interno molto caldo. Il calore si trasferisce dal nucleo agli strati più superficiali determinando la formazione di moti convettivi nell’astenosfera, mediante i quali porzioni di materia più calda risalgono per effetto della minore densità.
COMPETENZE
42. Isostatic adjustments cause vertical movements.
43. According to Wegener, about 300 million years ago, the continents formed a single landmass, called Pangea, surrounded by a vast ocean, Panthalassa. Subsequently, Pangea would have broken apart, and the fragments drifted away.
44. The data derived from the study of the ocean floors: both those on the composition of the seabed and the measurement of heat flow.
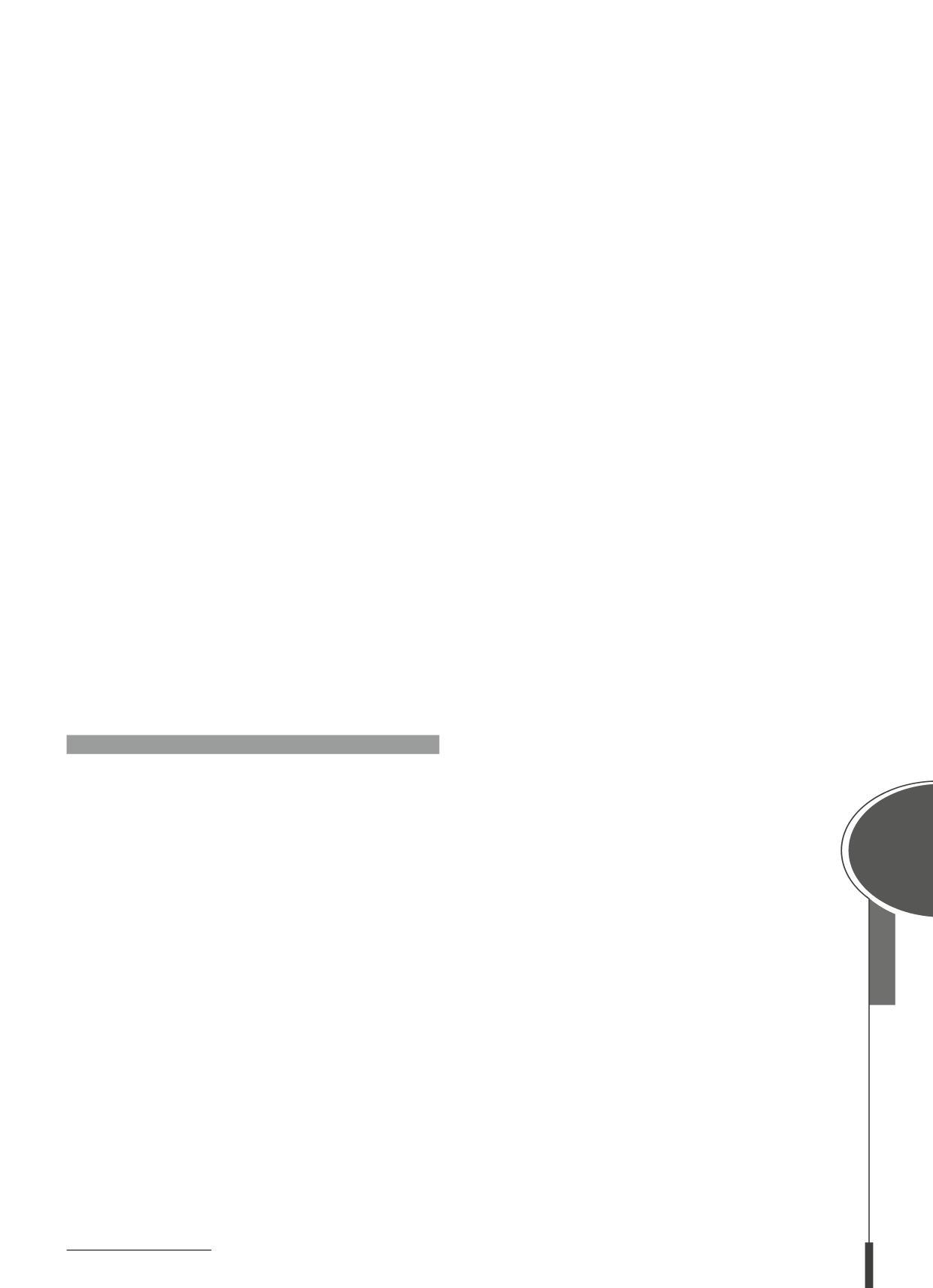
45. Convergent, divergent, and transform.
46. C.
47. a. Il disegno mostra un margine continentale passivo, tettonicamente inattivo ma caratterizzato da un’intensa deposizione di sedimenti; b. È tipico delle prime fasi del processo orogenetico e si forma ai margini di un oceano in espansione; c. Al termine della fase di apertura, l’oceano comincia a chiudersi e il margine continentale diventa attivo, con la formazione di una zona di subduzione dove i sedimenti depositati subiscono profonde trasformazioni e deformazioni.
48. a. Utilizza la carta dei fondali oceanici: puoi notare che l’Islanda si trova in corrispondenza della parte settentrionale della dorsale medio-atlantica e ne costituisce una parte emersa; b. Le dorsali sono aree di distensione: l’assottigliamento della crosta determina la formazione di fosse tettoniche dalle quali risale magma basico che forma nuova crosta e allontana le placche l’una dall’altra; c. Lo specchio d’acqua dalla forma allungata non può che trovarsi all’interno di una fossa tettonica. Si tratta di un rift delimitato da pareti verticali di rocce ultrabasiche, riconoscibili per il colore scuro.
49. a. Placca europea e placca africana; b. Che i blocchi scivolano in modo tale che il letto sale; c. Comprendere l’attività della faglia nel passato; d. Consentono di prevedere i tempi di attivazione della faglia.
50. a. Le bande nere indicano la polarità normale delle rocce, le bande bianche la polarità inversa; b. Le bande sono disposte in maniera simmetrica rispetto alla dorsale. Le due carote, prelevate alla stessa distanza dalla dorsale, presenteranno le stesse caratteristiche paleomagnetiche; c. La carota C, prelevata vicino alla dorsale, presenta un minore spessore dei sedimenti, mentre la carota A, prelevata a una distanza maggiore dalla dorsale, presenta un maggiore spessore di sedimenti, in quanto depositatisi su una crosta oceanica di più antica formazione; d. La crosta oceanica da cui è stata prelevata la carota ha circa 3,22 milioni di anni, di conseguenza i sedimenti soprastanti si sono depositati in seguito e sono più recenti.
Unità 9
Risposta breve
Pag. 277
1. 78% di azoto, il 21% di ossigeno, lo 0,9% di argon e lo 0,04% di diossido di carbonio.
2. All’aumentare dell’altitudine, i gas diventano più rarefatti. Gli strati superiori dell’atmosfera, con il loro peso, comprimono i gas a bassa quota, facendo diventare l’aria più densa. Anche la composizione della miscela gassosa si modifica con l’aumento dell’altitudine.
3. Gas serra e polveri sottili.
4. È caratterizzata da una crescente rarefazione dei gas più leggeri e dall’assenza di vapore acqueo. Il gradiente termico verticale ritorna negativo in quanto non si forma più l’ozono.
5. Nell’esosfera.
Pag. 279
1. Si definisce insolazione la quantità di energia solare che raggiunge la superficie terrestre.
2. La differenza tra energia solare in entrata ed energia terrestre in uscita costituisce il bilancio termico, o bilancio radiativo della Terra.
3. Il 31% delle radiazioni è riflessa da nubi, pulviscolo atmosferico e molecole di gas atmosferici, mentre il 4% da specchi d’acqua, ghiacciai e vegetazione.
4. Principalmente dall’insolazione. Ma anche dalla
distribuzione delle terre emerse e dei mari: l’acqua, infatti, si scalda pi. lentamente rispetto alle terre emerse e altrettanto lentamente cede il calore accumulato.
5. L’effetto serra è un fenomeno che avviene nell’atmosfera: l’aria si lascia attraversare dalle radiazioni a onda corta provenienti dal Sole e intercetta e riflette la maggior parte delle radiazioni a onda lunga emesse dalla superficie terrestre.
6. L’effetto serra è di grande importanza per il mantenimento delle condizioni termiche adatte alla vita: se le concentrazioni di gas serra aumentano, il fenomeno subisce un incremento e le temperature dell’atmosfera terrestre crescono.
Pag. 284
1. Il tempo atmosferico è l’insieme dei fenomeni meteorologici che avvengono in modo irregolare nella troposfera in intervalli di tempo piuttosto brevi.
2. Altitudine, temperatura e umidità.
3. L’umidità relativa è il rapporto tra l’umidità assoluta e la quantità di vapor d’acqua che lo stesso volume d’aria potrebbe contenere, in condizione di saturazione, alla stessa temperatura.
4. Una nube può formarsi o per afflusso di vapore acqueo o perché la temperatura di una massa d’aria scende al di sotto della temperatura di condensazione. Non appena le goccioline d’acqua diventano abbastanza grandi e pesanti, vincono le correnti ascensionali cadono al suolo in forma di pioggia. Se invece la diminuzione della temperatura implica un brinamento da vapore a ghiaccio, si ha la formazione dei cristalli di neve. La grandine invece è formata da cristalli di ghiaccio a strati formati nei cumulonembi per effetto di moti convettivi.
Pag. 286
1. Celle di Hadley (tropicali), le celle di Ferrel (di media latitudine) e le celle polari.
2. Fiumi d’aria profondi alcuni kilometri e larghi fino a 500 km, che circolano con andamento sinuoso attorno al globo.
3. Le onde di Rossby, approfondendosi fino a una certa ampiezza, possono spezzarsi e provocare la formazione di aree cicloniche e anticicloniche isolate.
Pag. 287
1. Stazioni meteorologiche e palloni sonda per raccogliere dati e modelli matematici e probabilistici per interpretarli.
2. Rappresentazioni grafiche che indicano fronti, copertura nuvolosa e precipitazioni.
Pag. 289
1. Il clima comprende le condizioni atmosferiche che si verificano mediamente in una determinata e vasta area e in un periodo di almeno 30 anni.
2. Tipi climatici, biomi e temperatura.
3. Studio delle coperture vegetali, insieme alla raccolta dei dati relativi a temperatura, pressione, piovosità mensili e annuali delle diverse regioni della Terra, mediati su più anni.
Pag. 291
1. Monitorare i cambiamenti climatici in atto e di formulare previsioni per il futuro.
2. Il cambiamento climatico è “un cambiamento dello stato del clima che può essere identificato (per esempio, utilizzando test statistici) da cambiamenti nella media e/o nella variabilità delle sue proprietà”.
3. 420 ppm
4. +1,59% sulle terre emerse, +0,88% sui mari.
5. L’aumento delle temperature.
294
1. Fluttuazione della radiazione solare e dei parametri orbitali, attività vulcanica.
2. Sono la causa principale.
3. Cambiamento dell’albedo, variazioni del vapore acqueo, alterazione delle correnti oceaniche, fusione del permafrost, aumento della temperatura degli oceani.
4. Rilascio di metano e altri gas. Pag. 296
1. Avere impatto climatico zero.
2. La mitigazione comprende tutte le azioni volte a ridurre la quantità di gas serra nell’atmosfera intervenendo direttamente sulle cause, con lo scopo di diminuire le fonti di rilascio dei gas e potenziarne le fonti di assorbimento. L’adattamento è un processo di adeguamento al clima e ai suoi effetti presenti e futuri.
3. L’aumento dell’efficienza energetica, l’utilizzo di tecnologie a basse emissioni di carbonio, il rimboschimento e la salvaguardia delle foreste fanno parte di un sistema di approcci diversi volto al raggiungimento degli obiettivi della mitigazione climatica.
4. Una base di conoscenze e di interazioni per intervenire sulla struttura delle e del territorio (greenbuilding e sistemi di recovery in casi di emergenze ed eventi estremi), efficienza energetica, rimboschimento.
RIPASSA CON METODO
Dall’alto verso il basso e da sinistra a destra gas – radiazioni
N2 – 21% – CO2 esosfera – termosfera – vicina temperatura
CLIMA – 30
RISCALDAMENTO GLOBALE
PRESSIONE – altitudine igrometro – relativa
CONOSCENZE E ABILITÀ
1. V, F, V.
2. Diossido di carbonio (CO2), diossido di zolfo (SO2), ammoniaca (NH3), metano (CH4) e vapore acqueo (H2O).
3. Si ritiene che la formazione dell’azoto, il gas più abbondante nell’atmosfera, sia dovuta ai processi di decomposizione della materia vivente, in particolare dei vegetali.
4. Bassa e alta atmosfera sono distinte sulla base della diversa composizione gassosa degli strati che le formano: la bassa atmosfera ha una composizione determinata dal contatto diretto con la superficie terrestre mentre i gas che formano l’alta atmosfera sono più rarefatti.
5. La temperatura riprende a diminuire fino a raggiungere valori tra –70 e –90 °C a circa 90 km di altezza; i gas diventano più rarefatti e iniziano a ionizzarsi; vapore acqueo e ozono sono assenti; gran parte delle meteore sono bruciate; avviene il fenomeno delle nubi nottilucenti.
6. La frangia dell’atmosfera è la zona più esterna che sfuma verso lo spazio. È composta da particelle gassose di idrogeno e elio, che non risentono più dell’attrazione gravitazionale terrestre e non partecipano alla rotazione del pianeta.
7. C.
8. C.

9. D.
10. C.
11. La principale differenza consiste nella presenza di una rilevante concentrazione di ossigeno molecolare. Si tratta di un gas molto reattivo che tende a reagire con i composti che formano le rocce superficiali, ossidandoli: in questo modo si ridurrebbe progressivamente, come accade sugli altri pianeti simili alla Terra. Sul nostro pianeta, invece, la concentrazione di ossigeno rimane costante perché risultato dell’attività metabolica degli organismi che formano la biosfera.
12. L’inquinamento atmosferico provocato dalle attività umane consiste in composti gassosi prodotti della combustione degli idrocarburi (ossidi di carbonio, zolfo e azoto) e polveri sottili derivate da processi industriali e traffico veicolare.
13. All’origine dei moti convettivi dei gas troposferici ci sono il differente spessore della troposfera e le temperature raggiunte al limite superiore della sfera (circa –50 °C sopra l’equatore e –80 °C sopra i poli) che generano uno squilibrio termico.
14. Il pulviscolo atmosferico, fondamentale per l’innesco della coalescenza all’interno delle nubi, è formato da microscopiche particelle solide: ceneri vulcaniche, spore di funghi o batteri, pollini e fuliggini originate dalla combustione.
15. Le pause sono zone di transizione che separano le sfere, nelle quali la temperatura tende ad invertire l’andamento rispetto alla sfera sottostante.
16. A.
17. V, F, F, F, F.
18. D.
19. A.
20. Circa il 35% della radiazione solare costituisce l’albedo terrestre di cui il 31% è riflessa da nubi, pulviscolo atmosferico e molecole di gas atmosferici, il 4% da specchi d’acqua, ghiacciai e vegetazione. Del restante 65% di radiazione, il 18% è assorbito dall’atmosfera, principalmente da ozono, diossido di carbonio e vapore acqueo e il 47% da terre emerse, acqua e vegetazione.
21. Le basse latitudini equatoriali ricevono più calore poiché l’angolo di incidenza dei raggi solari con la superficie terrestre è maggiore.
22. Vapore acqueo, diossido di carbonio, ossidi di azoto e metano si comportano da gas serra perché le loro molecole sono formate da atomi diversi in grado di intercettare le radiazioni infrarosse, entrando in vibrazione e aumentando la loro energia cinetica.
23. Le attività antropiche, con l’aumento della produzione di diossido di carbonio e quindi della concentrazione di gas in atmosfera.
24. V, V, F, V, F, F, V, F, F.
25. Gli elementi che caratterizzano il tempo atmosferico, cioè le grandezze fisiche che determinano le condizioni meteorologiche in una località sono temperatura, pressione, umidità, precipitazioni, venti.
26. A livello del mare, a 0 °C e alla latitudine di 45° la pressione atmosferica equivale alla pressione esercitata da una colonna di mercurio alta 760 mm e con sezione di 1 cm2. La pressione così misurata si esprime in atmosfere per cui
1 atm = 760 mmHg o torr.
27. Il gradiente di pressione è la variazione di pressione per unità di lunghezza e si esprime in Pa/m.
28. I venti permanenti, come alisei, venti occidentali e venti polari, sono determinati dalla presenza di aree stabili di bassa e alta pressione; le variazioni periodiche dei gradienti di
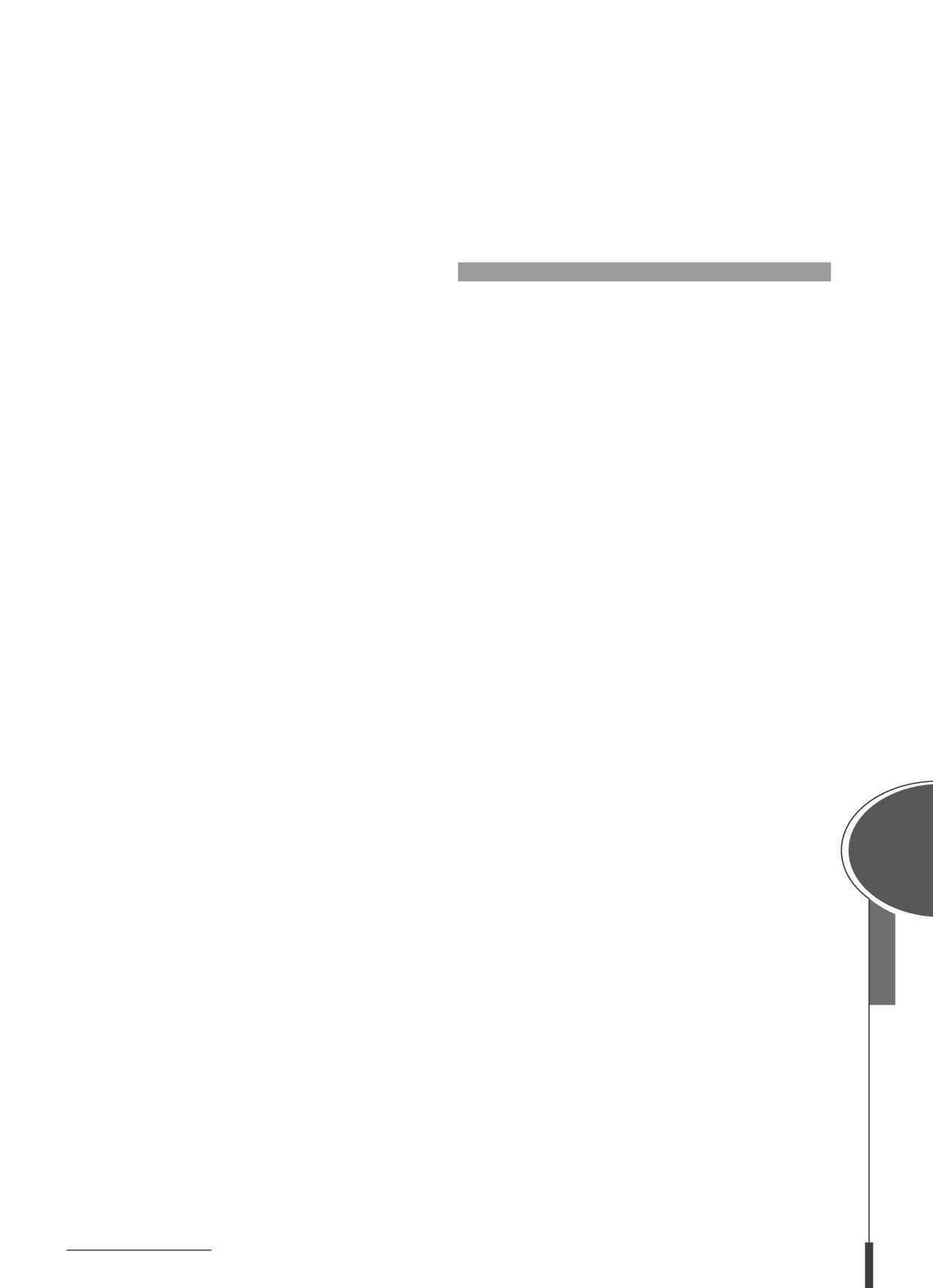
pressione sono all’origine dei venti regionali periodici, come per esempio i monsoni, dei venti locali periodici, come le brezze di mare e di terra, e dei venti locali irregolari.
29. C.
30. C.
31. C.
32. A.
33. C.
34. La copertura vegetale.
35. Le correnti a getto sono correnti occidentali che spirano alle medie latitudini: sono profonde alcuni kilometri e larghe fino a 500 km, e circolano con andamento sinuoso attorno al globo determinando la formazione di aree cicloniche e anticicloniche.
36. Secondo il modello termico, masse d’aria a diversa temperatura si spostano mediante moti convettivi all’interno della troposfera. Secondo il modello dinamico, sono le correnti a getto e i loro spostamenti stagionali, a provocare la formazione di aree cicloniche e anticicloniche.
37. L’umidità assoluta è la quantità in grammi di vapore d’acqua contenuta in un metro cubo d’aria ad una determinata temperatura. L’umidità relativa è il rapporto tra l’umidità assoluta e la quantità di vapor d’acqua che lo stesso volume d’aria potrebbe contenere, in condizione di saturazione, alla stessa temperatura.
38. C.
39. F, F, V, V.
40. Bioma: foresta pluviale; savana; giungla. Temperatura media maggiore di 18 °C.
41. Gruppo climatico C.
42. V, F, V, V, F, V, F.
43. Le basi fisico-scientifiche del cambiamento climatico, temi relativi a impatti, vulnerabilità, adattamento e mitigazione, e un documento di sintesi.
44. B.
45. D.
46. C.
COMPETENZE
47. The energy absorbed by the Earth’s surface is partly used to heat the overlying atmosphere, which in turn disperses the energy into space, and partly for the evaporation of surface water. When water vapor condenses in the atmosphere and forms clouds, latent heat is released, which is also dispersed into space.
48. Relative humidity is the ratio between absolute humidity and the maximum humidity the same amount of air could bear at the same temperature.
49. It’s because water vapour acts as a greenhouse gas.
50. The warm waters of surface currents move toward higher latitudes, become colder and denser, and sink into the depths; the cold, salty waters of deep currents flow along the ocean floor and rise to the surface at lower latitudes, where they rejoin the surface waters.
51. A.
52. B.
53. Inizialmente una corrente d’aria fredda e una d’aria calda scorrono parallelamente lungo un fronte stazionario; in seguito, si forma un’ondulazione che si trasforma in una saccatura; si formano un fronte caldo e un fronte freddo che ruotano in senso antiorario; lungo le superfici si formano dei sistemi nuvolosi che provocano delle precipitazioni; il fronte freddo più veloce
raggiunge quello caldo, si forma un fronte occluso e l’aria calda perde il contatto con il suolo, scaricando le ultime precipitazioni.
54. Risposta aperta.
55. Risposta aperta.
56. a) La Scozia è vicina al centro di bassa pressione indicato dalla lettera B, quindi il vento dovrebbe soffiare da sud-ovest verso nord-est. b) Londra si trova a sud del centro di bassa pressione, quindi, ci si può aspettare un tempo perturbato, con nubi e precipitazioni. c) Nelle aree di bassa pressione, come quella indicata dalla lettera B.
Unità 10
Risposta breve
Pag. 302
1. La scala cronostratigrafica ricostruisce la storia della Terra sulla base dello studio e del riconoscimento dei fossili e sul confronto tra serie stratigrafiche di tutto il mondo.
2. Nell’era cenozoica, periodo quaternario, epoca Olocene.
3. Osservando i cambiamenti in atto in particolare nell’atmosfera.
Pag. 305
1. Perché si esauriscono e poi riscostruiscono in tempi molto lunghi.
2. Diagenesi e maturazione di materia organica.
Pag. 306
1. Durante il Carbonifero, i resti organici iniziavano il loro processo di diagenesi, ma il poco ossigeno presente nelle acque interstiziali veniva consumato presto. Quindi, entravano in gioco batteri anaerobi che riducevano progressivamente le quantità di idrogeno, azoto e ossigeno contenuti nella materia organica vegetale, determinando l’aumento della concentrazione di carbonio.
2. In base al contenuto di carbonio: torba, con C da 45 a 60%; lignite, con C da 60 a 75%; litantrace, con C da 75 a 92%; antracite, con C da 92 a 95%.
3. Si sono formate nel Mesozoico per accumulo di materia organica di origine marina.
4. Una volta completati i processi di formazione, gli idrocarburi lasciano la roccia madre e migrano attraverso faglie o fratture fino ad accumularsi in una roccia serbatoio a contatto con una roccia trappola.
5. Il processo di fissione nucleare utilizzato nelle centrali nucleari prevede la rottura, mediante l’azione di neutroni opportunamente rallentati, di nuclei di isotopi radioattivi pesanti. Nella fusione, invece, il processo è lo stesso che si verifica nel Sole e nelle stelle, per cui nuclei molto leggeri fondono tra di loro per generare nuclei più pesanti con emissione di energia, oltre a uno o più neutroni.
Pag. 308
1. Con pannelli solari e celle fotovoltaiche.
2. Impatto visivo e rischi per flora e fauna.
3. Un flusso d’acqua aziona delle turbine e, a seguire, dei generatori che producono elettricità.
4. Gli impianti sfruttano alta e bassa marea per convogliare acqua marina e poi riversarla facendola passare attraverso le turbine.
5. Quella del calore interno della Terra, che scala le acque sotterranee, che formano così geyser e soffioni.
6. L’utilizzo dell’energia da biomasse non aumenta il livello di gas serra nell’atmosfera in quanto le quantità di CO2 utilizzate dai vegetali per la fotosintesi equivalgono a quelle emesse in

atmosfera dall’utilizzo di energia da biomassa, senza alterazioni del ciclo del carbonio.
Pag. 309
1. Minerali metallici e minerali non metallici.
2. Rame, alluminio e ferro.
3. Hanno proprietà semiconduttrici.
4. Il Sudafrica produce platino e rodio, la Russia di palladio, gli Stati Uniti berillio, il Brasile produce niobio, la Turchia il boro, il Ruanda il tantalio, la Repubblica Democratica del Congo di cobalto. La Cina è il primo produttore di 28 delle risorse minerarie indispensabili per l’economia mondiale.
Pag. 310
1. Per sviluppo sostenibile si intende una crescita economica che salvaguardi l’ambiente e le risorse della Terra per le generazioni future, estendendo una qualità di vita accettabile a tutta la popolazione mondiale.
2. 17 obiettivi che compongono un programma d’azione internazionale per le persone, il pianeta e la prosperità, perché riconosce il legame tra benessere umano, salute dei sistemi naturali e sfide comuni che tutti i Paesi sono chiamati ad affrontare.
Pag. 312
1. Produzione, distribuzione, consumo.
2. Gli oggetti devono essere progettati per non avere mai fine, per essere reintrodotti nel ciclo produttivo come materie prime o reintegrati nei cicli naturali.
3. Sono quelle costituite dai residui della lavorazione delle materie prime o da quelli provenienti dal riciclo e dal recupero dei rifiuti.
4. Zero emissioni di CO2
5. Può essere trasportato nelle reti di gasdotti già esistenti, anche mescolato al metano, e può essere accumulato con relativa facilità.
RIPASSA
CON METODO
Dall’alto verso il basso e da sinistra a destra calore – elettricità
RISORSE MINERARIE
2015 – 17 – 169 coltan
ECONOMIA CIRCOLARE – lineare (aperto)
FONTI NON RINNOVABILI – milioni
FONTI RINNOVABILI fissione
COMBUSTIBILI FOSSILI
EOLICA
fotovoltaiche
IDROELETTRICA – cinetica
GEOTERMICA fermentazione
CONOSCENZE E ABILITÀ
1. V, F, F, V.
2. Producono energia elettrica, grazie alle proprietà di alcuni materiali di produrre elettricità quando sono esposti alla luce solare.
3. Si tratta di impianti localizzati in mare o su laghi.
4. L’utilizzo dell’energia da biomasse non aumenta il livello di gas serra nell’atmosfera in quanto le quantità di CO2 utilizzate dai vegetali per la fotosintesi equivalgono a quelle emesse in atmosfera dall’utilizzo di energia da biomassa, senza alterazioni del ciclo del carbonio.
5. Sono tutti buoni conduttori di elettricità.
6. D.
7. C.
8. B.
9. B.
10. Sono combustibili in quanto il loro elevato contenuto in carbonio fa sì che reagiscano facilmente con l’ossigeno liberando una notevole quantità di energia termica; sono fossili in quanto sono il risultato della lenta fossilizzazione di materia organica vegetale e animale avvenuta in ambienti poveri di ossigeno e grazie all’azione di batteri anaerobi.
11. Lo sfruttamento intensivo dei giacimenti di idrocarburi comporta che enormi quantità di carbonio rimaste intrappolate per milioni di anni nella crosta terrestre siano liberate in atmosfera attraverso la combustione, provocando un aumento dell’effetto serra. Inoltre, si esauriscono in pochi anni giacimenti che si sono formati in tempi geologici molto lunghi.
12. È una terra rara che contiene columbite e tantalite. Il tantalio estratto dal coltan serve per ottimizzare il consumo di energia nei chip.
13. V, F, F, V, F.
14. Quella di una disponibilità infinita di risorse.
15. A partire dalla seconda metà del secolo scorso.
16. D.
17. C.
18. A.
19. B.
20. C.
21. La decarbonizzazione e la sostenibilità sociale devono andare di pari passo: per questo occorre mettere in atto metodi sostenibili di estrazione e sfruttamento delle risorse minerarie e creare una rete che connetta tutte le energie, favorendo l’utilizzo delle energie rinnovabili.
22. L’idrogeno, prodotto per elettrolisi dell’acqua sfruttando esclusivamente energie rinnovabili, può essere usato da solo o mescolato con il metano, come avverrà nelle prime fasi della transizione energetica. Per queste sue caratteristiche costituisce la migliore connessione tra energie non rinnovabili e energie rinnovabili.
23. Risposta aperta.
COMPETENZE
24. Renewable energy sources are able to regenerate and not deplete within the timescale of human life.
25. It has increased the demand for rare minerals.
26. Sustainable development is the economic growth that protects the environment and Earth’s resources for future generations, while extending an acceptable quality of life to the entire global population.
27. Because the circular economy focuses on activities aimed at the maintenance and reuse of existing consumer goods and the recovery of raw materials.
28. Le condizioni ambientali che hanno determinato la formazione dei giacimenti di combustibili sono in parte simili a quelle che si stanno creando a causa dell’aumento delle emissioni di CO2 in atmosfera provocato dalle attività umane. Lo studio dei fenomeni avvenuti nel passato della storia della Terra può fornirci indicazioni sulla possibile evoluzione futura del pianeta.
29. Risposta aperta.
30. Risposta aperta.
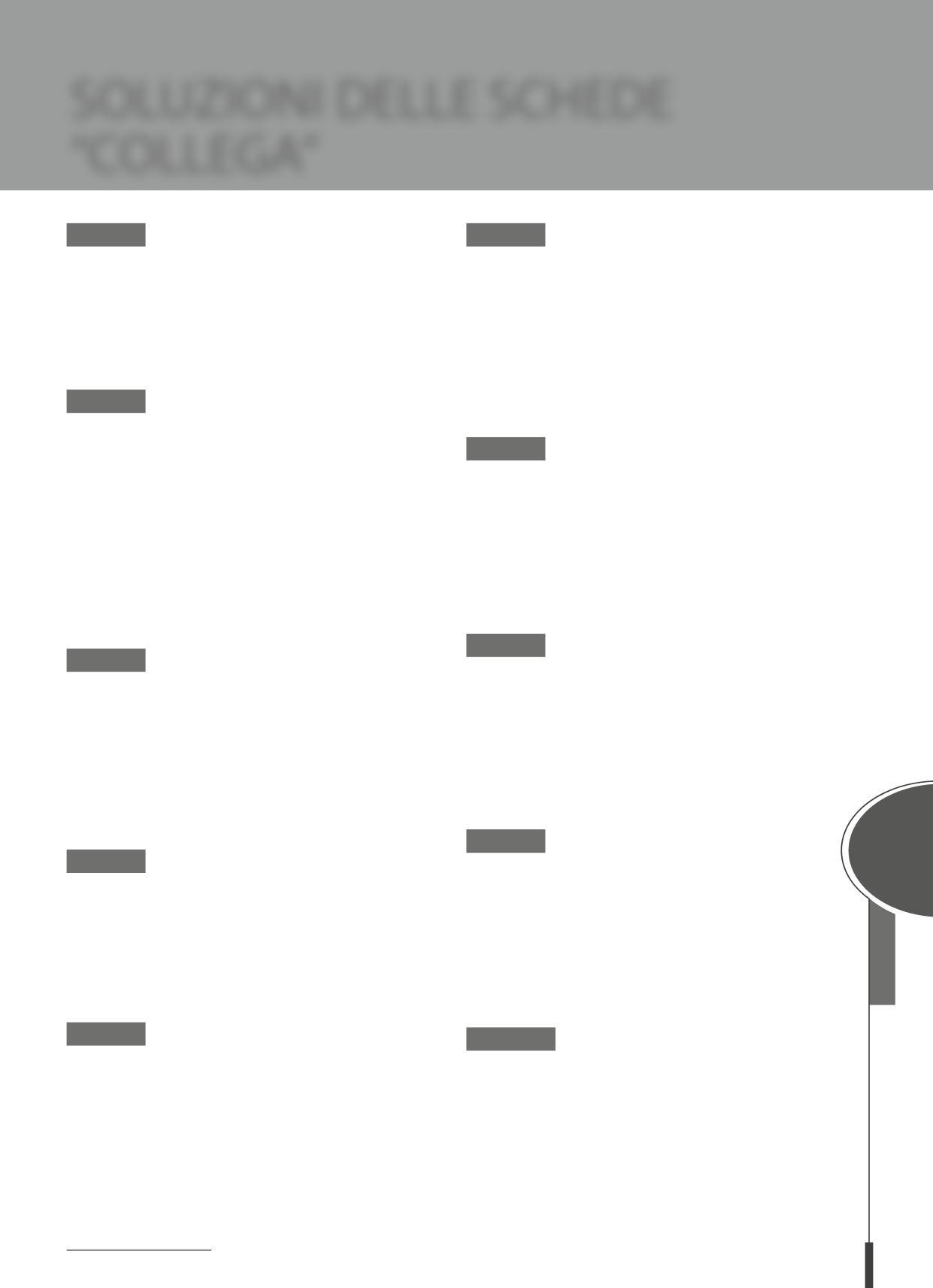
SOLUZIONI DELLE SCHEDE “COLLEGA”
Unità 1
Petrolio, una risorsa contesa
Collegamento alla terza disciplina: Educazione civica
Sostenibilità ambientale e sociale degli impianti di estrazione del petrolio nel mondo; transizione ecologica verso l’abbandono delle risorse energetiche non rinnovabili.
Unità 2
Moplen, la plastica che partecipò allo sviluppo economico
Collegamento alla terza disciplina: Arte Il movimento artistico Pop-Art è nato negli anni Cinquanta negli Stati Uniti e in Gran Bretagna e caratteristico anche degli anni Sessanta del secolo scorso. Questo movimento ha utilizzato assiduamente la plastica come simbolo di modernità e progresso, per i suoi colori vivaci e per la sua caratteristica di essere un materiale “di massa”, simbolo del consumismo.
Unità 3
Pellagra: l’importanza di una vitamina
Collegamento alla terza disciplina: Educazione fisica
L’importanza delle vitamine nel metabolismo e nella performance atletica. Praticare sport richiede un maggior apporto di nutrienti, compresi i micronutrienti come le vitamine. Una dieta equilibrata permette una maggiore resistenza e un miglior recupero dopo un allenamento.
Unità 4
Le piante e la vita sugli alberi raccontate da Calvino
Collegamento alla terza disciplina: Arte Il tema della luce e della sua rappresentazione nel movimento artistico Impressionista.
Unità 5
Resistere al contagio in tempi di pandemia
Collegamento alla terza disciplina: Letteratura italiana
I temi dell’assurdo, dell’ineluttabilità della condizione umana e del crollo delle certezze sono trattati anche da Luigi Pirandello in “Sei personaggi in cerca d’autore” e “Uno, nessuno e centomila”, dove sono messa in evidenza l’assurdità della condizione umana e la fragilità dell’esistenza.
Unità 6
Progresso scientifico e visione del mondo, tra speranze e paure
Collegamento alla terza disciplina: Filosofia
Il filosofo Friedrich Nietzsche critica in modo aspro la società del mondo moderno proprio come Aldous Huxley. Entrambi descrivono una società nichilista, che perde i propri valori per un appagamento superficiale.
Unità 7
Il Vesuvio e la prima eruzione pliniana mai descritta
Collegamento alla terza disciplina: Letteratura italiana Il Vesuvio è presente ne “La ginestra” di Leopardi come simbolo della potenza distruttiva della natura e dell’indifferenza di quest’ultima verso la vita umana.
Unità 8
Da esplorazioni geologiche ad avventure
letterarie e ritorno
Collegamento alla terza disciplina: Fisica
La struttura della Terra può essere paragonata per analogia alla struttura dell’atomo, in particolare in riferimento al concetto di nucleo.
Unità 9
La natura inviolabile che si ribella all’essere umano
Collegamento alla terza disciplina: Letteratura italiana
I temi della colpa e dell’espiazione presenti in “The Rime of the Ancient Mariner” sono presenti anche ne “La coscienza di Zeno” di Italo Svevo.
Unità 10
Tempi difficili per il Pianeta
Collegamento alla terza disciplina: Letteratura italiana
La trasformazione del mondo rurale e l’impatto dell’industrializzazione e l’alienazione che ne deriva sono un tema presente nel romanzo “La luna e i falò” di Cesare Pavese.
SOLUZIONI DEGLI ESERCIZI DI
GUIDA ALL’ESPOSIZIONE ORALE
Unità 1
Cura le parole
1. Risposta aperta.
2. Risposta aperta.
3. Risposta aperta.
4. Risposta aperta.
5. Risposta aperta.
Prova a partire così
6. formula molecolare, formule di struttura o di Lewis, la formula condensata e la formula a linee di legame (o topologica).
7. carbonio e idrogeno, il metano.
8. formula molecolare, ma differiscono per la formula di struttura.
9. due atomi di idrogeno da parte degli atomi di carbonio che si uniscono tra loro.
10. contengono almeno un doppio o triplo legame carbonio-carbonio.
11. il benzene, strutture in equilibrio tra loro dette ibridi di risonanza, una particolare distribuzione degli elettroni.
Organizza il discorso
12. Risposta aperta.
13. Risposta aperta.
14. Risposta aperta.
Simula un colloquio di esame
15.
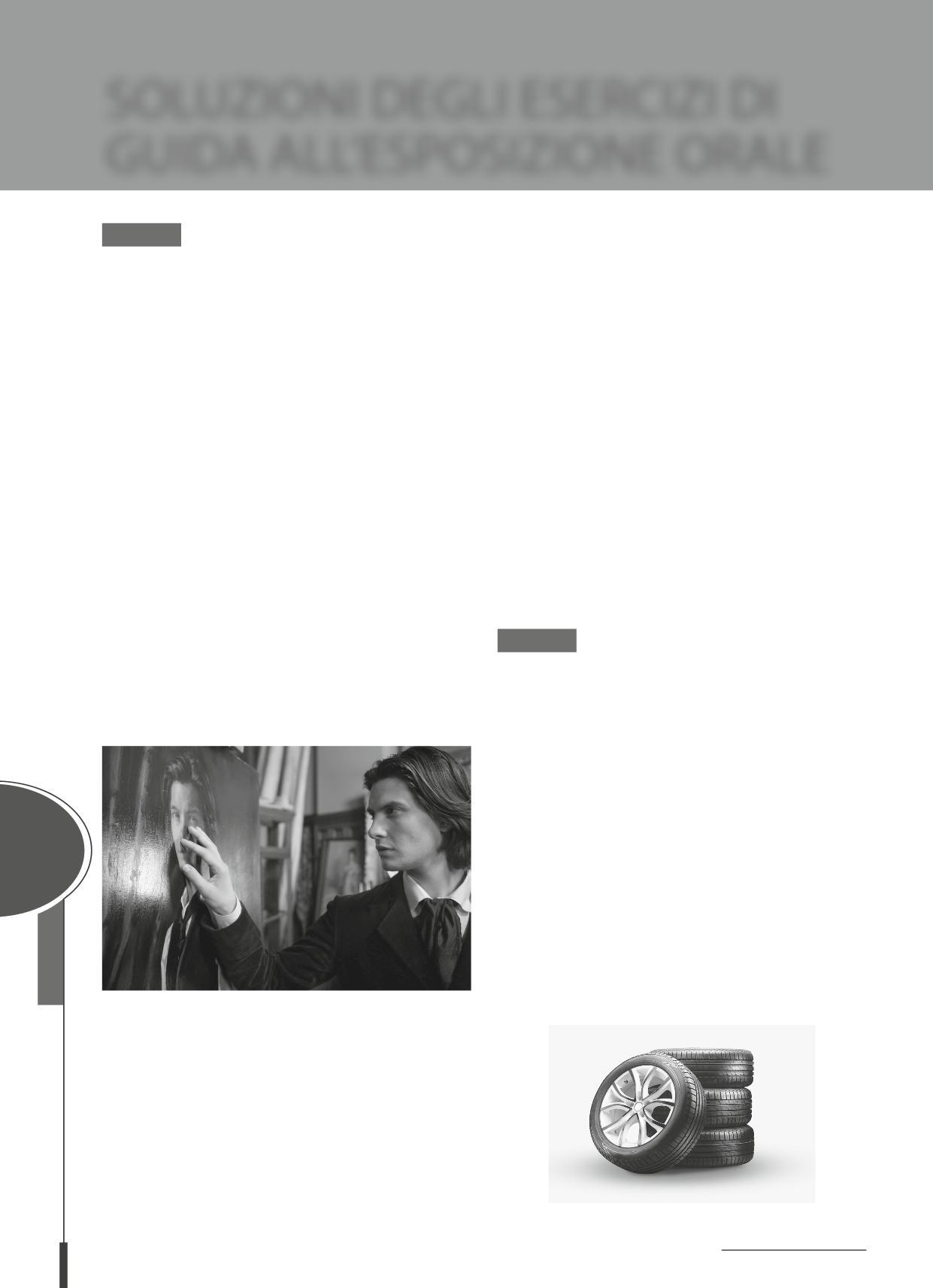
Immagine da: © Keystone Pictures Usa/Mondadori Portfolio
ANALISI DEL DOCUMENTO
Il disegno mostra una scena del film “The Picture of Dorian Gray” (2009).
Scienze Naturali (Chimica organica)
Stereoisomeri, enantiomeri, chiralità
Il concetto di chiralità e isomeria in chimica organica: esempi e funzioni biologiche.
Inglese
Oscar Wilde, “The Picture of Dorian Gray”
COLLEGAMENTI
Matematica
Simmetrie nel piano cartesiano e proprietà delle funzioni simmetriche
Storia dell’Arte
L’astrattismo geometrico, Piet Mondrian
Storia
Il doppio volto di Giolitti, l’età giolittiana
Filosofia
Il tempo della scienza e il tempo della coscienza
Fisica
Il tempo per Einstein. La relatività
Italiano
Luigi Pirandello, “Uno, nessuno e centomila” e “Il fu Mattia Pascal”
Latino
Petronio, “Satyricon”
Unità 2
Cura le parole
1. Risposta aperta.
2. Risposta aperta.
3. Risposta aperta.
4. Risposta aperta.
5. Risposta aperta.
Prova a partire così
6. alcoli e fenoli, alcoli, fenoli, gruppo carbossilico o carbossile, acidi carbossilici.
7. carbonilico, idrogeno, alchilici, arilici, ossidrile o alcolico.
8. terziarie, ammoniaca, sostituzione, tre, gruppi alchilici o arilici, idrogeno, azoto.
Organizza il discorso
9. Risposta aperta.
10. Risposta aperta.
11. Risposta aperta.
Simula un colloquio di esame 12.
ANALISI DEL DOCUMENTO
Il disegno mostra una pila di pneumatici di gomma.
Scienze Naturali (Chimica organica)
Polimeri e loro classificazione
COLLEGAMENTI
Scienze Naturali (Biologia) Biomolecole
Storia
Seconda rivoluzione industriale
Arte
Pop Art e architettura moderna
Filosofia
Il principio di responsabilità e l’etica ambientale, Hans Jonas e Martin Heidegger
Fisica
Polimeri utilizzati come materiale isolante, fisica dei dielettrici
Italiano
Italo Calvino, “La città smarrita nella neve”
Unità 3
Cura le parole
1. Risposta aperta.
2. Risposta aperta.
3. Risposta aperta.
4. Risposta aperta.
5. Risposta aperta.
Prova a partire così
6. insaturazioni, basso, grassi, oli.
7. amminoacidi, bifunzionali, carbossilico, amminico, catena laterale, polare, apolare, acida, basica.
8. enzima-substrato, adattamento indotto, sito attivo, massime.
Organizza il discorso
9. Risposta aperta.
10. Risposta aperta.
11. Risposta aperta.
Simula un colloquio di esame
12.
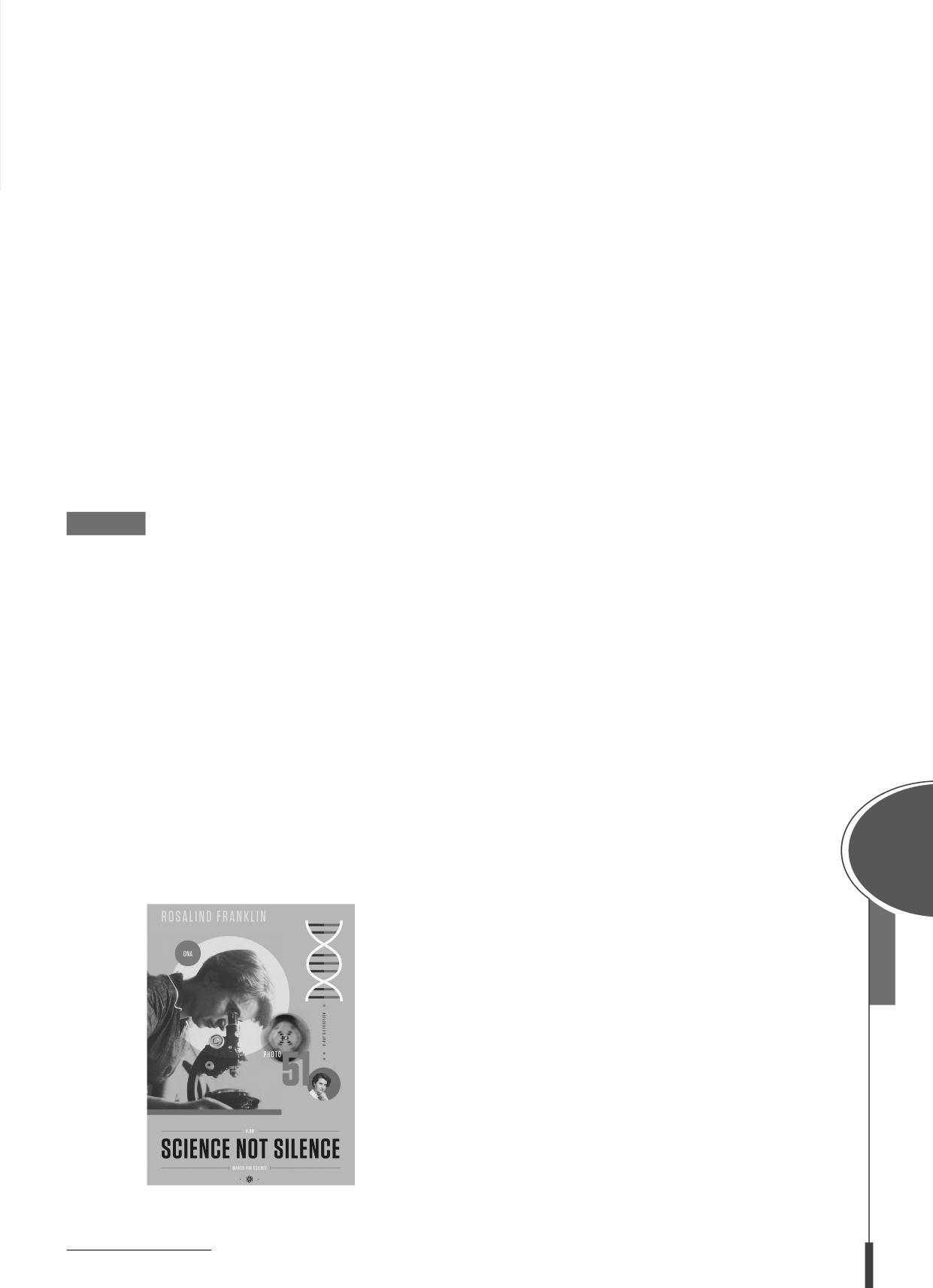
Immagine: Amanda Phingbodhipakkiya/Wikimedia commons
Fonte: https://q3.hubscuola.it/1hrb
ANALISI DEL DOCUMENTO
Il poster raffigura la scienziata Rosalind Franklin all’opera nel suo laboratorio. Nel poster è ben visibile anche la famosa foto 51, realizzata dalla Franklin e grazie alla quale è stata ricostruita la struttura del DNA.
Scienze Naturali (Biologia)
Il ruolo di Rosalind Franklin nella definizione della struttura del DNA e il Nobel mancato
I dati sperimentali di proprietà della Franklin furono trafugati da Watson e Crick per poter sostenere sperimentalmente le loro deduzioni sul famoso articolo pubblicato su Nature nel 1953. I due vinsero il Nobel qualche anno dopo assieme a Wilkins (il capo della Franklin). La Franklin, già deceduta, non ebbe alcun riconoscimento postumo.
COLLEGAMENTI
Latino
Seneca, “Medea”
Oltre a essere una versione latina della celebre tragedia greca, la Medea di Seneca dà una rilettura del personaggio femminile in chiave negativa, cogliendone solo la ferocia vendicativa.
Greco
Euripide, “Medea”
La tragedia propone uno scontro tra culture diverse, una considerata più moderna e civile (Corinto), l’altra più barbara e arretrata (la Colchide). Questa contrapposizione doveva apparire evidente dall’uso da parte di Medea della magia, forza inquietante e barbara per eccellenza, e dal fatto che la donna fosse vestita in scena con un abbigliamento di tipo orientale.
Inglese
Virginia Woolf, “Orlando”
Il protagonista, da androgino, diventa una donna: tutto il romanzo è incentrato sui rapporti di genere nella società inglese attraverso i tre secoli lungo i quali si articola la trama.
Italiano
Grazia Deledda e Sibilla Aleramo
Grazia Deledda fu insignita, nel 1926, del Premio Nobel per la letteratura; Sibilla Aleramo, invece, nel suo romanzo autobiografico Una donna (1906) racconta di come iniziò il suo interesse per la condizione femminile.
Storia
L’emancipazione femminile
Dai movimenti di suffragiste dei primi del Novecento, fino al suffragio universale e ai movimenti femministi del 1968.
Fisica
Marie Curie
Il ruolo della donna nella scienza. Marie Curie, la radioattività naturale (la legge del decadimento radioattivo) e il primo Nobel della storia a una donna (ma anche la prima personalità scientifica a vincere due premi Nobel per due materie diverse).
Unità 4
Cura le parole
1. Risposta aperta.
2. Risposta aperta.
3. Risposta aperta.
4. Risposta aperta.
5. Risposta aperta.
Prova a partire così
6. NAD+, L’acetil-CoA, ciclo di Krebs, mitocondri, otto, ATP, FADH2, fosforilazione ossidativa.
7. la matrice, lo spazio intermembrana, chemiosmotica, catena respiratoria, protonmotrice, ATP sintasi.
8. organiche, eterotrofi, autotrofi, fotosintesi, sei, sei, glucosio.
Organizza il discorso
9. Risposta aperta.
10. Risposta aperta.
11. Risposta aperta.
Simula un colloquio di esame
12.

Immagine da: © Andreus/Gettyimages
ANALISI DEL DOCUMENTO
Il disegno rappresenta lo schema sintetico della fotosintesi in una pianta.
Scienze Naturali (Biologia)
Fotosintesi come processo metabolico per la produzione di energia e ossigeno a partire da luce e diossido di carbonio da parte di organismi autotrofi come le piante
COLLEGAMENTI
Fisica
I fotoni e la fisica quantistica
Storia dell’Arte
Impressionismo
Filosofia
Vitalismo, Henri Bergson
Italiano
Calvino, “Il barone rampante
Latino
Virgilio, “Georgiche”
Francese
Victor Hugo, “Les Misérables”
Unità 5
Cura le parole
1. Risposta aperta.
2. Risposta aperta.
3. Risposta aperta.
4. Risposta aperta.
Prova a partire così
5. differenziamento cellulare, pre-trascrizionale, cromatina, trascrizionale, maturazione, pre-mRNA, trasporto, citoplasma, post-traduzionale.
6. parassiti endocellulari obbligati, batteriofagi virus, genoma.
Organizza il discorso
7. Risposta aperta.
8. Risposta aperta.
9. Risposta aperta.
Simula un colloquio di esame
10.
Immagine da: © mixetto/Gettyimages
ANALISI DEL DOCUMENTO
Foto di cartelli che invitano all’uso di mascherine e al distanziamento sociale in modo da scongiurare il diffondersi della pandemia da COVID19, causata dal virus SARSCoV-2.
Scienze Naturali (Biologia)
Virus, replicazione virale, pandemie e zoonosi
COLLEGAMENTI
Italiano
Pirandello e i temi dell’assurdo, dell’ineluttabilità della condizione umana e del crollo delle certezze in “Sei personaggi in cerca d’autore” e “Uno, nessuno e centomila”
Cesare Pavese e il tema della solitudine e dell’isolamento in “La casa in collina”
Storia
Pandemia di influenza spagnola, 1918-1919
Francese
Albert Camus, “La peste”
Inglese
Mary Shelley, “The last man” e il tema della pandemia apocalittica
George Orwell, “1984” e il tema del monitoraggio
Latino
Tucidide e la peste di Atene
Unità 6
Cura le parole
1. Risposta aperta.
2. Risposta aperta.
3. Risposta aperta.
4. Risposta aperta.
5. Risposta aperta.
Prova a partire così
6. pozzetti, setaccio, poliacrilammide, campo elettrico, catodo, negativamente, positivamente dimensione, velocemente, intercala, UV.
7. gene, copia, vettori virali, AAVGT, liposomi, staminali.
8. gene, copia, vettori virali, AAVGT, liposomi, staminali.
Organizza il discorso
9. Risposta aperta.
10. Risposta aperta.
11. Risposta aperta.
Simula un colloquio di esame
12.
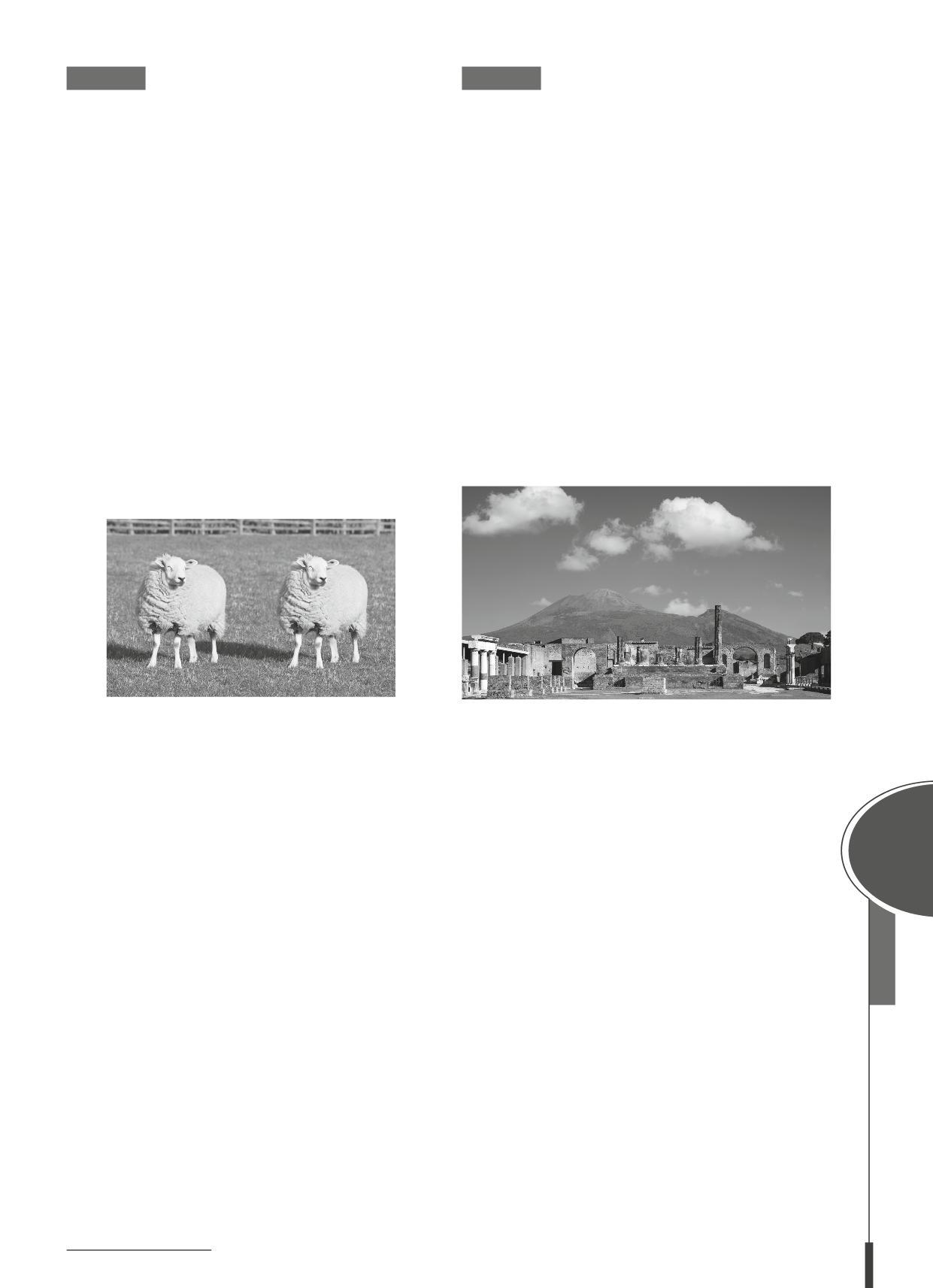
Immagine: © jasonbennee/Gettyimages
ANALISI DEL DOCUMENTO
Foto che raffigura due pecore identiche.
Scienze naturali (Biologia)
La clonazione di primati: aspetti tecnici e bioetici
COLLEGAMENTI
Italiano
Gabriele D’Annunzio: il superuomo nel romanzo Il trionfo della morte.
Filosofia
Il Nichilismo: l’Übermensch di Nietzsche in contrapposizione con il superuomo dannunziano.
Inglese
George Orwell: leadership e manipolazione delle masse nei romanzi Animal Farm e 1984
Storia
Nazionalismi e totalitarismi del Novecento: Hitler, Mussolini e Stalin.
Unità 7
Cura le parole
1. Risposta aperta.
2. Risposta aperta.
3. Risposta aperta.
4. Risposta aperta.
Prova a partire così
5. zone sferiche, chimica, fisiche.
6. crosta, acida, crosta continentale, crosta oceanica, mantello, ultrabasiche, nucleo, nucleo esterno, nucleo interno, fisico.
7. catastrofe del ferro, fusione, decadimento radioattivo.
8. declinazione, geografico, inclinazione, le linee di forza, intensità.
Organizza il discorso
9. Risposta aperta.
10. Risposta aperta.
11. Risposta aperta.
Simula un colloquio di esame
12.
Immagine: © Buena Vista Images/Gettyimages
ANALISI DEL DOCUMENTO
Foto delle rovine della città di Pompei con il vulcano Vesuvio sullo sfondo.
Scienze Naturali (Scienze della Terra)
Vulcanologia
COLLEGAMENTI
Italiano
Leopardi, “La ginestra”
Arte
Romanticismo, la potenza della natura e il sublime, Caspar David Friedrich e William Turner
Storia
1815, l’anno senza estate e l’eruzione del monte Tambora
Inglese
Lord George Gordon Byron, “Darkness”
Latino
Plinio il Giovane, “Lettere”, libro VI, n. 16 e 20
Unità 8
Cura le parole
1. Risposta aperta.
2. Risposta aperta.
3. Risposta aperta.
4. Risposta aperta.
Prova a partire così
5. placche litosferiche, 20, margini.
6. oceanica, oceani.
7. nuovo oceano, passivi, sedimentazione, convergente, subduzione, vulcani.
8. placca, subduzione, dorsali oceaniche, vulcanismo interplacca, Hawaii.
Organizza il discorso
9. Risposta aperta.
10. Risposta aperta.
11. Risposta aperta.
Simula un colloquio di esame
12.

Immagine: © Rainer Lesniewski/Gettyimages
ANALISI DEL DOCUMENTO
L’immagine rappresenta la Faglia di San Andreas (CA).
Scienze Naturali (Scienze della Terra)
Deriva dei continenti (teoria di Wegener).
Prove paleomagnetiche del magnetismo terrestre.
COLLEGAMENTI
Fisica
Magnetismo
Materiali diamagnetici, ferromagnetici, dal magnetismo all’elettromagnetismo, induzione elettromagnetica.
Filosofia
Positivismo
Si caratterizza per la fiducia nel progresso scientifico e per il tentativo di applicare il metodo scientifico a tutte le sfere della conoscenza e della vita umana.
Letteratura italiana
Prima che tu dica «Pronto» (1993)
Italo Calvino in questa raccolta di racconti allude anche ai fenomeni della glaciazione e della deriva dei continenti.
Storia dell’arte
J. M. William Turner, Eruzione del Vesuvio (1817)
Pittore appartenente al movimento romantico, è considerato l’artista che perfezionò la pittura paesaggistica.
Unità 9
Cura le parole
1. Risposta aperta.
2. Risposta aperta.
3. Risposta aperta.
4. Risposta aperta.
Prova a partire così
5. fenomeni atmosferici, troposfera, breve, elementi, concentrazione.
6. pressione, riferimento, millibar, cicloniche, aumentano, anticicloniche.
7. alta, anticicloni, bassa, precipitazioni, perturbazioni, latitudine, tropicali.
Organizza il discorso
8. Risposta aperta.
9. Risposta aperta.
10. Risposta aperta.
Simula un colloquio di esame 11.
Immagine: Ed Hawkins, climate scientist at University of Reading. CarlinMack created SVG version/Wikimedia commons Fonte: https://q3.hubscuola.it/zt3j
ANALISI DEL DOCUMENTO
Warming Stripes (barre di calore), immagine creata professor Ed Hawkins presso l’Università di Reading nel 2018. L’immagine mostra una striscia di colore diverso a seconda della temperatura media registrata quell’anno; mostra in modo chiaro come le temperature medie globali sono aumentate negli ultimi due secoli.
Scienze Naturali (Scienze della Terra)
Il cambiamento climatico globale.
– Analisi delle cause naturali e antropiche.
– Le prospettive future.
COLLEGAMENTI
Storia
La Seconda rivoluzione industriale
Filosofia
Karl Marx
Storia dell’arte
Giuseppe Pellizza da Volpedo, Il quarto Stato
Italiano
Giovanni Verga, I Malavoglia
Inglese
Charles Dickens, Hard Times
Descrizione dell’immaginaria città di Coketown in cui sono ambientate le vicende del romanzo.
Fisica
L’energia di un’onda elettromagnetica e i quanti di luce I gas serra trattengono nell’atmosfera l’energia della radiazione infrarossa emessa dalla Terra. Le onde luminose trasportano infatti energia. Il modello corpuscolare della luce formulato dalla meccanica quantistica permette di quantificare in modo discreto questa energia.
Matematica
Pendenza e concavità di una funzione. Le derivate.
Unità 10
Cura le parole
1. Risposta aperta.
2. Risposta aperta.
Prova a partire così
3. diagenesi, maturazione, decomposizione, milioni, carboni fossili, carbogenesi (carbonificazione), idrocarburi, madri di idrocarburi.
4. rifiuti, ciclo produttivo, seconde.
Organizza il discorso
5. Risposta aperta
6. Risposta aperta
Simula un colloquio d’esame
7.
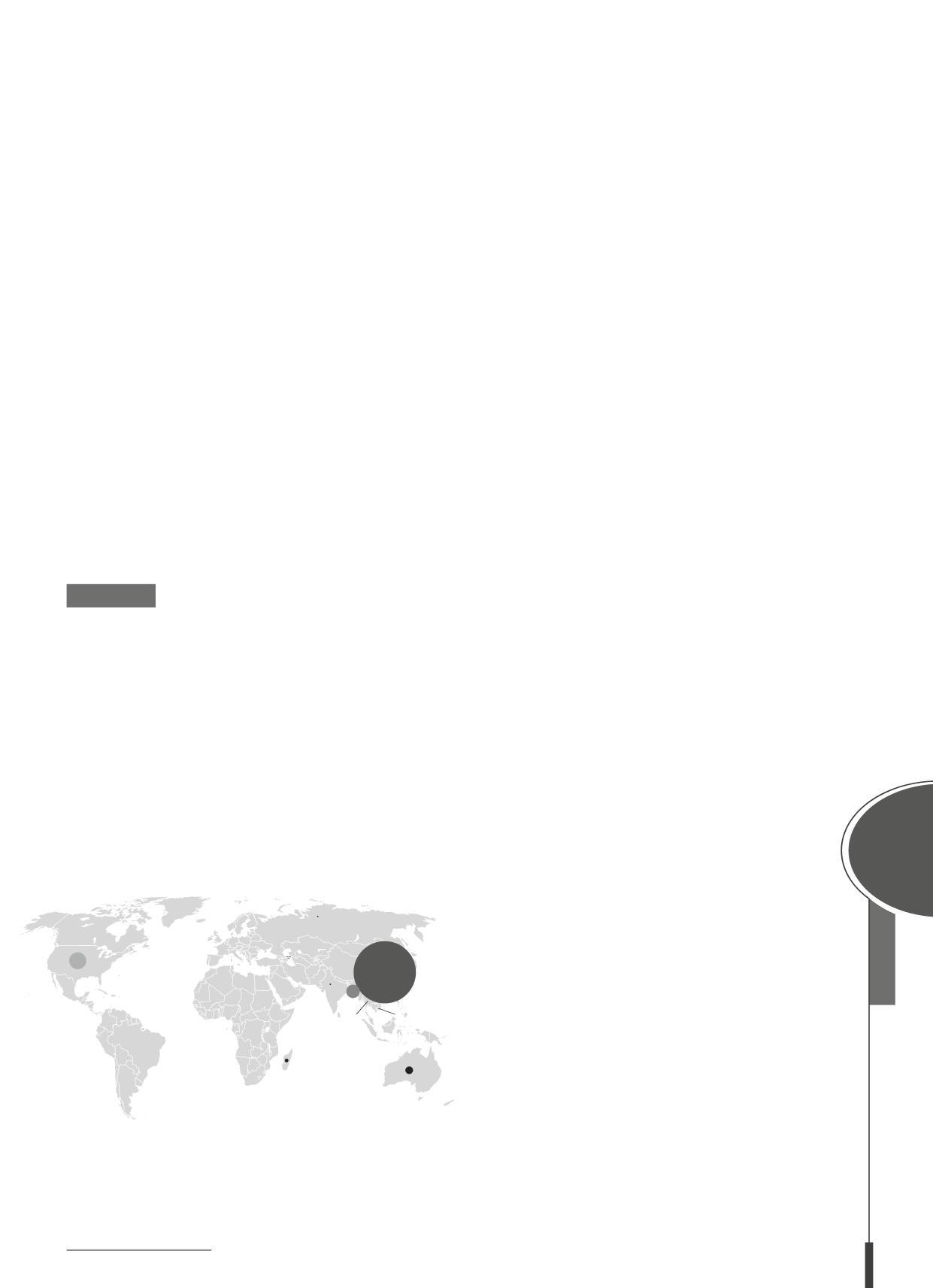
ANALISI DEL DOCUMENTO
Il planisfero mostra i principali paesi produttori di terre rare al mondo.
Scienze Naturali (Scienze della Terra)
La produzione di energia alternativa, ad esempio da solare fotovoltaico o da turbine eoliche, non può prescindere dall’estrazione e dallo sfruttamento delle terre rare, un insieme di 17 elementi chimici tra cui 15 lantanidi oltre a scandio e ittrio.
COLLEGAMENTI
Fisica
Le terre rare possiedono invidiabili proprietà fisiche tra cui la stabilità termica, l’alta conducibilità elettrica, le proprietà magnetiche che le rendono preziose in applicazioni tecnologiche avanzate. Terre rare sono alla base del funzionamento di smartphone, touchscreen, di apparecchiature laser, dei convertitori catalitici.
Storia
Lo sviluppo industriale della Cina e dei paesi emergenti a partire dal XXI secolo muta lo scenario geopolitico globale. La società post-industriale, la globalizzazione e lo scambio delle merci nell’epoca moderna.
Educazione civica
La necessità di una transizione ecologica legata alla sostenibilità ambientale e alla salvaguardia delle risorse, ha spinto diversi governi, tra cui il governo Draghi nel 2021, alla costituzione di un apposito dicastero, il Ministero della Transizione ecologica.


9
Traduzioni

Traduzioni delle schede
Understanding Our World With STEM
TEMA A Invertire la tendenza con il PLA compostabile
Molti oggetti che usiamo nella nostra vita quotidiana sono fatti di plastica, la maggior parte della quale deriva dal petrolio greggio. Sebbene questo materiale sia molto utile e versatile, la sua produzione presenta numerosi problemi:
• produce inquinanti, come l’anidride carbonica, che contribuiscono al cambiamento climatico;
• quando viene disperso nell’ambiente, è esso stesso un inquinante poiché non si degrada;
• il petrolio greggio è una risorsa molto richiesta in tutto il mondo, ma è limitata e non rinnovabile. Per affrontare tutti questi problemi, negli ultimi due decenni gli scienziati hanno cercato nuovi modi per produrre materiali plastici più sostenibili, portando allo sviluppo delle bioplastiche. Questi nuovi materiali potrebbero costituire il 2-3% del mercato delle plastiche entro il 2027.
Bioplastiche a base biologica: PLA
Un esempio di bioplastica è l’acido polilattico (PLA). Questo materiale è prodotto convertendo lo zucchero presente nelle piante, più comunemente nel mais, in plastica (1). Nel PLA, l’acido lattico ottenuto dalla fermentazione batterica del destrosio costituisce il monomero di base. Tuttavia, l’acido lattico non può essere direttamente polimerizzato in PLA. La reazione chimica che unisce due molecole di acido lattico genera anche molecole di acqua, che impediscono alla catena in crescita di molecole di acido lattico di restare coesa; perciò, quest’acqua viene poi eliminata. Invece di una lunga catena di molecole di acido lattico, si formano molti oligomeri che vengono poi trasformati con una reazione chimica che porta a molecole di lattide più piccole (2). Le molecole di lattide agiscono come monomeri e vengono polimerizzate in PLA in un processo simile alla polimerizzazione dell’etilene in polietilene.
Compostaggio delle bioplastiche
Alcune bioplastiche, incluso il PLA, potrebbero essere compostabili in impianti industriali specifici: fornendo loro calore, umidità e microrganismi, questi ultimi le decompongono in materiale vegetale, anidride carbonica e acqua. Tuttavia, quasi tutta la plastica compostabile finisce in discarica anziché essere compostata. Come altre plastiche, in queste condizioni, le bioplastiche rimangono intatte, sepolte nell’ambiente privo di ossigeno delle discariche. Alcuni scienziati temono che, nel corso degli anni, le bioplastiche si decomporranno lentamente invece di compostarsi, rilasciando metano, un gas serra 20 volte più potente dell’anidride carbonica.
Didascalie:
1. Primo piano di pellet di plastica a base di mais, ottenuti dall’amido di mais.
2. Reazione chimica che porta alla formazione di molecole di lattide e PLA.
Pensiero critico:
• L’inquinamento da plastica è un problema globale: viviamo immersi nella plastica, un problema sempre più acuto. Le bioplastiche potrebbero essere la soluzione a questo problema? Dopo aver letto questo articolo scientifico, presenta i punti principali alla classe.
• Il termine plastica copre una vasta gamma di materiali sintetici o semi-sintetici che usiamo nella vita quotidiana, la maggior parte dei quali finisce nell’ambiente marino a causa delle attività umane; cerca online vari esempi di megaplastiche, macroplastiche, mesoplastiche, microplastiche e nanoplastiche e inserisci queste informazioni in una tabella indicandone dimensioni e origine.
• L’acido polilattico (PLA) è considerato un sostituto promettente dei polimeri derivati dal petrolio. Trova online le principali applicazioni di questo poliestere ecologico e riassumile ai tuoi compagni di classe.
• Scopri in rete i dettagli del processo di trasformazione dell’acido lattico in PLA, direttamente o tramite il suo estere ciclico (lattide). Presta particolare attenzione al problema della stereoregolamentazione.

TEMA B Come produrre una vitamina a livello industriale
Nel corso della storia, la produzione industriale di vitamine è stata condotta con diversi metodi, partendo dall’estrazione animale e vegetale per passare alla fermentazione e alla sintesi chimica. Per meglio comprendere come è cambiata nel tempo la produzione industriale di vitamine, un esempio interessante è dato dalla vitamina C, anche conosciuta come acido ascorbico.
Primi tentativi di produzione su larga scala della vitamina
La vitamina C fu isolata per la prima volta nel 1931 tramite estrazione da tessuti vegetali o, in pochi casi, da animali, ma il processo di estrazione era ancora troppo costoso per una produzione su larga scala. Nel 1933, il chimico britannico Sir Norman Haworth sviluppò il primo processo di sintesi chimica, per il quale vinse il Premio Nobel per la Chimica nel 1937. Tuttavia, questo metodo non ebbe mai un interesse commerciale a causa degli alti costi e della bassa resa. L’anno successivo, il chimico svizzero Tadeus Reichstein sviluppò un processo multi-step che combinava fermentazione microbica e sintesi chimica (1a): l’ossidazione del glucosio da parte dei batteri, seguita da reazioni chimiche, consentì alte rese, costi ridotti e rese il processo utile per l’industria. Negli anni ’70, fu brevettato da una casa farmaceutica un nuovo metodo di produzione basato quasi interamente sulla fermentazione microbica e con meno passaggi chimici.
Fabbriche biologiche per la produzione di vitamina
Negli ultimi anni, l’obiettivo degli scienziati è stato quello di produrre vitamina C dal glucosio con alta resa, a basso costo e utilizzando esclusivamente la sintesi biologica, senza reazioni chimiche successive. La spinta a ottimizzare ulteriormente la produzione di vitamina C e a superare questa limitazione, insieme alla necessità di utilizzare materie prime rinnovabili, ha portato recentemente a sviluppare nuovi microrganismi ottimizzati utilizzando nuove tecnologie come l’ingegneria genetica. Gli scienziati hanno inserito nelle cellule di batteri Escherichia coli le istruzioni genetiche per eseguire il percorso biosintetico dell’acido ascorbico della pianta Arabidopsis thaliana, che è in grado di produrre vitamina C direttamente dal glucosio. Questo microrganismo modificato può essere quindi coltivato su larga scala per produrre il composto desiderato (1b). Sebbene questa tecnologia sia ancora sperimentale e non garantisca ancora alte rese, ha dimostrato di essere efficace, superando gli svantaggi dei metodi tradizionali. Vale la pena notare che queste nuove tecnologie hanno influenzato la produzione industriale di molte altre biomolecole, utili per applicazioni mediche; non solo vitamine, ma anche proteine e lipidi.
Didascalia:
1. Metodi di produzione dell’acido ascorbico: (a) il metodo Reichstein, con fermentazione e reazioni chimiche; (b) batteri geneticamente modificati per la produzione diretta via fermentazione.
Pensiero critico:
• La disponibilità su larga scala di vitamine prodotte industrialmente ha avuto un impatto significativo sulla salute pubblica. Le persone possono facilmente accedere agli integratori vitaminici, che possono aiutare a prevenire malattie come scorbuto, pellagra e rachitismo, soprattutto quando non è possibile seguire una dieta equilibrata. In gruppi, cercate informazioni online utilizzando fonti affidabili e scrivete un episodio di podcast sull’uso terapeutico di una vitamina a vostra scelta.
• L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) realizza programmi di sorveglianza nutrizionale incentrati sulla carenza di vitamina A, che causa circa 500.000 casi di cecità tra i bambini nel mondo. In gruppi di due o tre membri, preparate una breve presentazione descrivendo la storia della produzione industriale della vitamina A, poi presentatela alla classe. Cercate informazioni online utilizzando fonti affidabili.
• Le vitamine sono comunemente usate come integratori alimentari per compensare le carenze nella dieta. Tuttavia, queste molecole sono utili anche in altri settori industriali, non solo per scopi sanitari e biomedici. Cercate online, utilizzando fonti affidabili, in quali processi industriali vengono impiegate le vitamine. Preparate una breve presentazione per mostrare le informazioni trovate e poi presentatela alla classe.

TEMA C CRISPR/Cas9 applicato alla terapia genica
Il sistema CRISPR/Cas9 è una tecnica potente e innovativa con applicazioni che spaziano dagli scopi industriali alla ricerca biologica di base. Nel campo biomedico, le sue applicazioni sono altamente limitate e regolamentate dal punto di vista bioetico; una di queste è la terapia genica.
La prima terapia genica che utilizza CRISPR/Cas9
Sebbene la tecnica di editing genomico con il sistema CRISPR/Cas9 sia stata sviluppata nel 2012, la prima terapia basata su di essa è diventata disponibile solo nel novembre 2023, con l’approvazione della terapia Casgevy da parte della Commissione Europea. Questa terapia può trattare la beta-talassemia trasfusione-dipendente (TDT) e l’anemia falciforme grave (SCD), entrambi comuni disturbi genetici ereditari. TDT e SCD sono entrambe condizioni causate da diverse mutazioni nel gene HBB, che codifica per la catena beta dell’emoglobina, la proteina responsabile del trasporto di ossigeno nei globuli rossi. Queste mutazioni portano a una produzione ridotta o assente di emoglobina, con conseguente insufficiente apporto di ossigeno ai tessuti e sintomi quali affaticamento cronico, difficoltà respiratorie e dolore intenso. La terapia classica per queste condizioni prevede spesso le trasfusioni (1).
Come funziona Casgevy?
La terapia Casgevy prevede la raccolta di cellule staminali dal midollo osseo del paziente, da cui si producono i globuli rossi. Queste cellule vengono geneticamente modificate usando il sistema CRISPR/Cas9 e poi reintrodotte nel paziente. L’obiettivo non è sostituire il gene HBB difettoso con uno funzionante, ma mantenere attivo il gene che codifica per l’emoglobina fetale. Questa proteina è tipicamente espressa solo durante lo sviluppo fetale e viene sostituita dopo la nascita dall’emoglobina adulta. Gli scienziati hanno sintetizzato un RNA guida singolo (sgRNA) che prende di mira il gene BCL11A, il quale codifica per un repressore del gene dell’emoglobina fetale (2). Attraverso il legame dell’sgRNA sintetico, la proteina Cas9 taglia la sequenza bersaglio e la disattiva. Senza il repressore, l’emoglobina fetale, che non presenta le anomalie dell’emoglobina adulta, viene prodotta e risulta funzionale. Questo consente ai globuli rossi di recuperare la loro normale funzione e di ripristinare i livelli di ossigeno nel sangue.
Didascalie:
1. Primo piano di una sacca di sangue per trasfusioni.
2. Proteina BCL11A
Pensiero critico:
• Casgevy è il primo trattamento di terapia genica basato sulla tecnologia CRISPR/Cas9 e segna un importante traguardo nella lotta contro le malattie genetiche. Questo metodo potrebbe essere utilizzato in futuro per curare molte altre malattie genetiche. Cerca online informazioni su altre nuove terapie geniche basate su CRISPR/Cas9, anche se ancora nelle prime fasi sperimentali della ricerca, e descrivile brevemente.
• L’avvento delle terapie geniche ha aperto un capitolo importante nella storia della medicina. Tuttavia, il costo di questi trattamenti rimane un ostacolo. Il costo della terapia Casgevy è di circa due milioni di euro per trattamento. Di conseguenza, una gestione attenta di queste terapie è fondamentale per evitare disparità socioeconomiche nell’accesso ai trattamenti, ossia che i pazienti economicamente svantaggiati non possano permettersi la terapia Casgevy. Quale potrebbe essere una soluzione possibile? In classe, coordinati dall’ insegnante, discutete di questo tema, poi preparate una campagna di sensibilizzazione su questo argomento.

TEMA D Il puzzle climatico risolto dalla scienza dell’attribuzione
Negli ultimi anni si discute del rapporto tra riscaldamento globale ed eventi meteorologici estremi, poiché la sfida consiste nell’attribuire con precisione eventi specifici al cambiamento climatico.
È sempre colpa del riscaldamento globale?
Molti studi scientifici dimostrano che le attività umane hanno causato un aumento della temperatura media globale e che ciò, a sua volta, ha portato a un incremento della frequenza e dell’intensità degli eventi meteorologici estremi (1). Tuttavia, questo non significa che tutti gli eventi estremi, come uragani, inondazioni, ondate di caldo e siccità, possano essere sempre attribuiti al riscaldamento globale. Per dimostrare tale correlazione sono necessarie analisi specifiche. È indispensabile provare che l’intensità, la frequenza o il momento di un particolare evento atmosferico siano così significativamente devianti dalla media da far supporre che esso sia causato o aggravato dal cambiamento climatico. Fino a pochi anni fa, gli scienziati descrivevano il cambiamento climatico solo come tendenza globale, evitando di collegare un singolo evento estremo al riscaldamento globale, poiché mancavano prove concrete. Recentemente, tuttavia, è emersa una nuova branca di ricerca chiamata scienza dell’attribuzione, che indaga su possibili connessioni tra singoli eventi atmosferici estremi e riscaldamento globale. Con la scienza dell’attribuzione, ora possiamo calcolare se, e in che misura, un evento specifico sia stato più o meno probabile o intenso a causa del cambiamento climatico o se non vi sia alcuna correlazione.
Come aiutano i modelli climatici
Il primo passo per comprendere le cause di un dato evento è definirne le caratteristiche, come la durata e l’intensità di un’ondata di caldo eccezionale, il volume di pioggia registrato durante una tempesta o la gravità di un uragano, in relazione alla località e alla stagione in cui si è verificato. Vengono quindi utilizzati modelli climatici sofisticati, simulazioni complesse dell’atmosfera, degli oceani e delle masse terrestri realizzate con supercomputer. Questi modelli possono simulare come sarebbe il clima se l’atmosfera fosse nello stato pre-emissioni di gas serra, cioè prima delle alterazioni causate dall’uomo. Questo permette agli scienziati di valutare se un evento estremo avrebbe potuto verificarsi in quelle condizioni e, in tal caso, con quale probabilità o frequenza. Ad esempio, se in realtà un evento estremo si è verificato cinque volte in dieci anni e i modelli climatici suggeriscono che dovrebbe accadere solo una volta ogni due secoli, è possibile dedurre che l’evento sia una conseguenza diretta del riscaldamento globale. In altri casi, questi studi possono rivelare che un particolare evento estremo non è correlato al cambiamento climatico, poiché rientra nella variabilità naturale del clima di una specifica regione.
Didascalia:
1. Numero di disastri naturali dovuti a condizioni meteorologiche estreme, inondazioni o siccità dal 1900 al 2023.
Pensiero critico:
• Il termine “evento estremo” suggerisce la sua rarità. Scegli uno dei tipi di eventi citati nella lettura e ricerca online quanto siano frequenti nella tua Regione e quanto la loro frequenza sia cambiata negli ultimi anni. Crea una campagna di sensibilizzazione volta a informare i tuoi concittadini sulle cause dell’aumento di frequenza e sulle conseguenze che questi eventi estremi comportano. Suggerimento: prova a utilizzare il sito web Our World in Data
• In classe, divisi in due gruppi, cercate di proporre alcune idee per un piano di mitigazione o adattamento che la vostra Regione potrebbe implementare per contrastare eventi meteorologici estremi, come siccità, inondazioni o uragani. Preparate una proposta di azioni che i politici locali potrebbero attuare, sotto forma di discorso pubblico.
• Le emissioni di gas serra sono più elevate in pochi Paesi ricchi, ma il cambiamento climatico sta colpendo tutto il mondo e in misura maggiore alcuni Paesi poveri le cui emissioni sono significativamente inferiori. Inoltre, mentre i Paesi ricchi possono permettersi di agire contro il cambiamento climatico e gli eventi estremi, i Paesi poveri non possono. Questo comporta disuguaglianze. Organizzate un dibattito in classe sulle principali conseguenze di questa disuguaglianza e su quali soluzioni siano possibili.

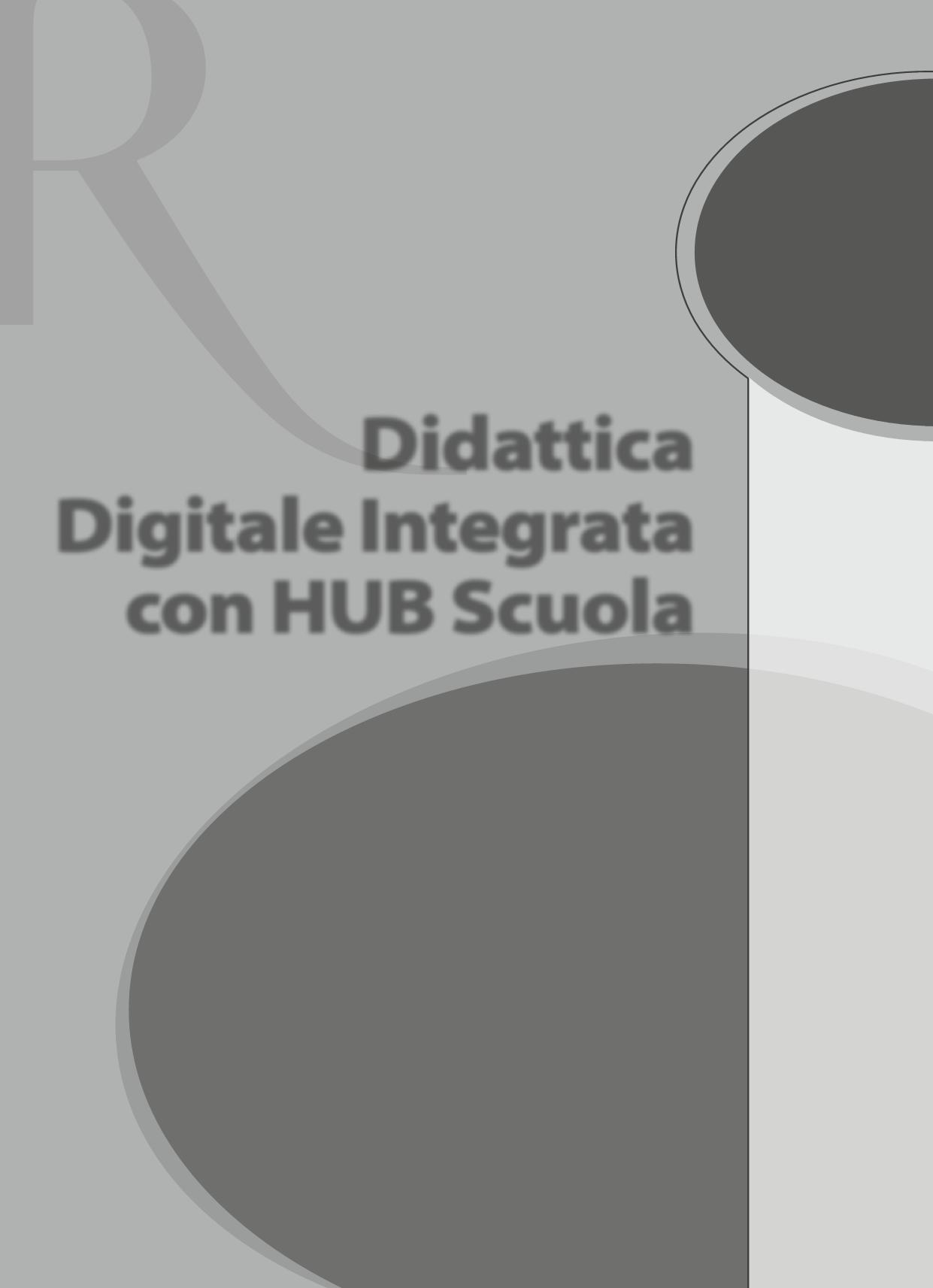
10
Didattica Digitale Integrata con HUB Scuola
Accendi la conoscenza con HUB Scuola
Nuova, intuitiva, dinamica.
HUB Scuola è la piattaforma che accompagna docenti, studentesse e studenti nel loro percorso educativo. È l’alleato ideale per le sfide di ogni giorno, sempre più ricca di risorse, percorsi e strumenti per una didattica digitale efficace e coinvolgente.
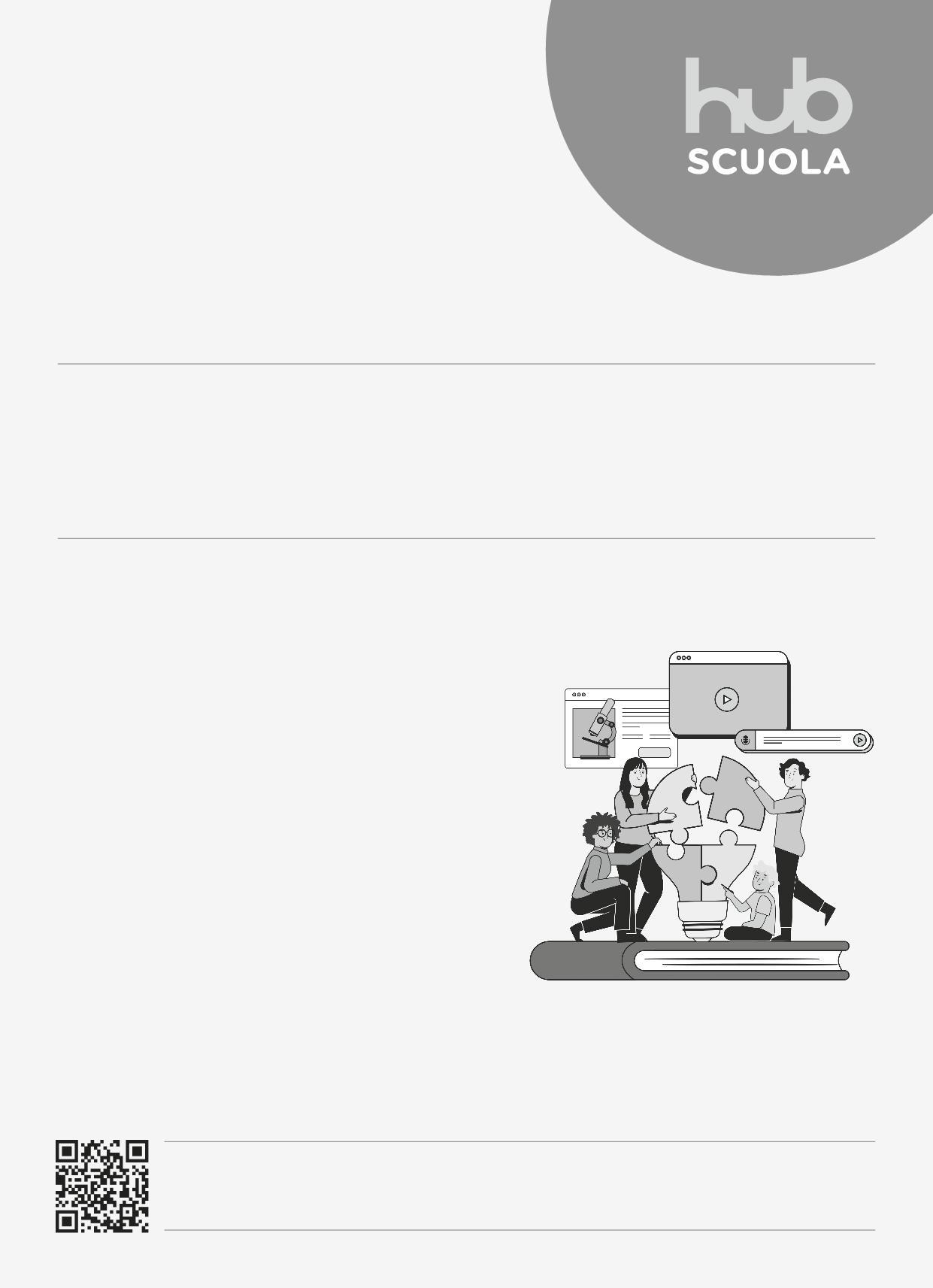
Tutta l’autorevolezza di Mondadori Education, Rizzoli Education e Deascuola in un solo ambiente digitale: HUB Scuola rappresenta la sinergia di tre grandi editori attenti alle esigenze di una scuola in continua evoluzione.
Esplora il Sito libro, il luogo dove i tuoi libri prendono vita Qui puoi immergerti nella versione digitale dei volumi e scoprire tutti i materiali, le app e gli strumenti correlati.
Se sei docente, nelle Aree Docenti trovi l’ambiente perfetto per personalizzare le lezioni grazie a proposte, approfondimenti e strumenti specifici per ogni tua materia.
Anche la sezione Test e Verifiche è una miniera di risorse: gli studenti vi trovano materiali per esercitarsi, mentre i docenti possono attingere a vasti database e creare test per ogni materia e grado scolastico.
HUB Scuola ti offre i contenuti digitali dei tre editori, integrati in un’unica piattaforma e accessibili con un’unica email e password. Entra in HUB Scuola!
Scopri di più su HUB Scuola inquadrando il QR code.
Scopri un mondo di risorse su misura per te

Aree Docenti
Percorsi didattici e materiali pronti all’uso per ogni materia che insegni.
Sito libro
La versione digitale del tuo libro cartaceo con tutti i contenuti extra.
Test e Verifiche
Un ampio database di quesiti ed esercizi per creare verifiche e allenarsi.

La DDI, ovvero la Didattica Digitale Integrata
L’obiettivo di Rizzoli Education è quello di supportare l’insegnante nella DDI offrendo un servizio di contenuti digitali, piattaforme e guide alla programmazione mista con libro cartaceo e strumenti digitali.
Ogni volume della Casa Editrice è progettato per affiancare e integrare la lezione tradizionale con una serie di contenuti digitali che possano arricchire, approfondire o sintetizzare l’argomento del giorno. Suggerendo, magari, una prospettiva differente: l’informazione lineare e statica è affiancata a quella particellare tipica della Rete, con i suoi “salti” e rimandi multidisciplinari per un approccio e un punto di vista più completo e ampio degli argomenti trattati.
Non si tratta solo di avere molti contenuti, che pure ci sono (audio, video, mappe concettuali personalizzabili e via discorrendo), e di mettere a disposizione degli utenti una piattaforma, come HUB Scuola, che li racchiuda, insieme ai libri digitali, ai molti test e verifiche, alla Classe virtuale. Ciò che rende solido il lavoro dell’Editore è, per l’appunto, il progetto editoriale: ogni contenuto digitale è costruito con l’aiuto di esperti ed è appoggiato, sul libro di carta, là dove è più utile e porta maggiore senso. Tutti i materiali digitali del volume sono disponibili attraverso codice QR in pagina sul libro di carta, sul libro digitale e nell’area docente di Scienze Naturali di HUB Scuola. Nell’area docente troverai anche tantissime altre risorse per l’insegnamento dedicate alle tre discipline: Chimica, Biologia e Scienze della Terra.
In aggiunta, i LessonPlansono una guida alla programmazione mista che propone lezioni-tipo che impiegano con intelligenza le risorse digitali insieme a quelle cartacee. A queste risorse vi si accede con immediatezza dall’area docente di Scienze Naturali.
Un particolare rilievo è infine dato alla valutazione, grazie alla piattaforma HUB Test (che comprende anche la Classe virtuale) e al grande numero di verifiche realizzate con Moduli Google.
La tecnologia è il linguaggio della contemporaneità che ogni persona che voglia capire il mondo deve iniziare a parlare. E dunque è ancora una volta alla Scuola, con le sue e i suoi insegnanti, che la società guarda per traghettare i ragazzi e le ragazze verso il percorso più corretto.
Sillabo dei Lesson Plan

V ANNO
Chimica e Biologia
• Il carbonio: ibridazione e isomeria
• La reattività delle molecole organiche
• Alcani e cicloalcani: nomenclatura, proprietà fisiche e chimiche
• Alcheni, alchini e idrocarburi aromatici: nomenclatura, proprietà fisiche e chimiche
• Alogenuri alchilici: nomenclatura, proprietà fisiche e chimiche
• Alcoli, fenoli ed eteri: nomenclatura, proprietà fisiche e chimiche
• Aldeidi e chetoni: nomenclatura, proprietà fisiche e chimiche
• Acidi carbossilici: nomenclatura, proprietà fisiche e chimiche
• Ammine e composti eterociclici: nomenclatura, proprietà fisiche e chimiche
• Polimeri di sintesi e condensazione
• I carboidrati: struttura e funzioni
• I lipidi: struttura e funzioni
• Le proteine: struttura, funzioni
• Gli acidi nucleici: struttura, funzioni
• Il metabolismo e gli enzimi
• La cinetica enzimatica
• I meccanismi della catalisi enzimatica
• Vitamine e coenzimi
• La glicolisi e le fermentazioni
• La respirazione cellulare
• Il metabolismo dei glucidi
• Il metabolismo dei lipidi e delle proteine
• Fotosintesi: la fase luminosa
• Fotosintesi: il ciclo di Calvin e la sintesi degli zuccheri
• I virus e la loro riproduzione
• Il trasferimento genico nei procarioti e con elementi mobili
• La regolazione genica nei procarioti: gli operoni
• La struttura del genoma eucariotico e la sua regolazione
• La tecnologia del DNA ricombinante e il clonaggio
• Isolamento dei geni e amplificazione
• Il sequenziamento del DNA e la bioinformatica
• Le scienze omiche (genomica, trascrittomica, proteomica)
• Le biotecnologie per l’agricoltura, l’ambiente e l’industria
• Le biotecnologie mediche
Scienze della Terra
• La dinamica della litosfera: la teoria di Wegener
• La dinamica della litosfera: le prove
• La tettonica a placche
• L’orogenesi
• Il tempo geologico e la storia della Terra
• L’atmosfera: struttura e caratteristiche
• La dinamica dell’atmosfera (livello 5°anno)
• Il cambiamento climatico
• Risorse energetiche e sostenibilità
• L’interno della Terra
• La dinamica della litosfera
• La tettonica a placche
• L’orogenesi
• L’atmosfera e la circolazione dei venti
• I fenomeni meteorologici e le previsioni del tempo
• Il clima e il suo cambiamento
I Moduli Google
Una delle sfide costanti dell’attività didattica (in particolar modo di quella non in presenza) è certamente la valutazione. È un problema di tempi, di modalità di somministrazione, di facilità di correzione e di qualità della misurazione.
Proprio per questo Rizzoli Education mette a disposizione diverse soluzioni: l’insegnante saprà trovare quella più adatta (o quelle più adatte) alle proprie esigenze.
Oltre alla piattaforma HUB Test e agli esercizi presenti nelle pagine del libro digitale, è stata aggiunta un’ulteriore soluzione veloce e pratica: i Moduli Google.
Inizialmente nati per gestire sondaggi e questionari, oggi sono uno strumento usatissimo dal corpo docente. Per questo, sono stati impiegati in modo costante e sistematico nei lesson plan
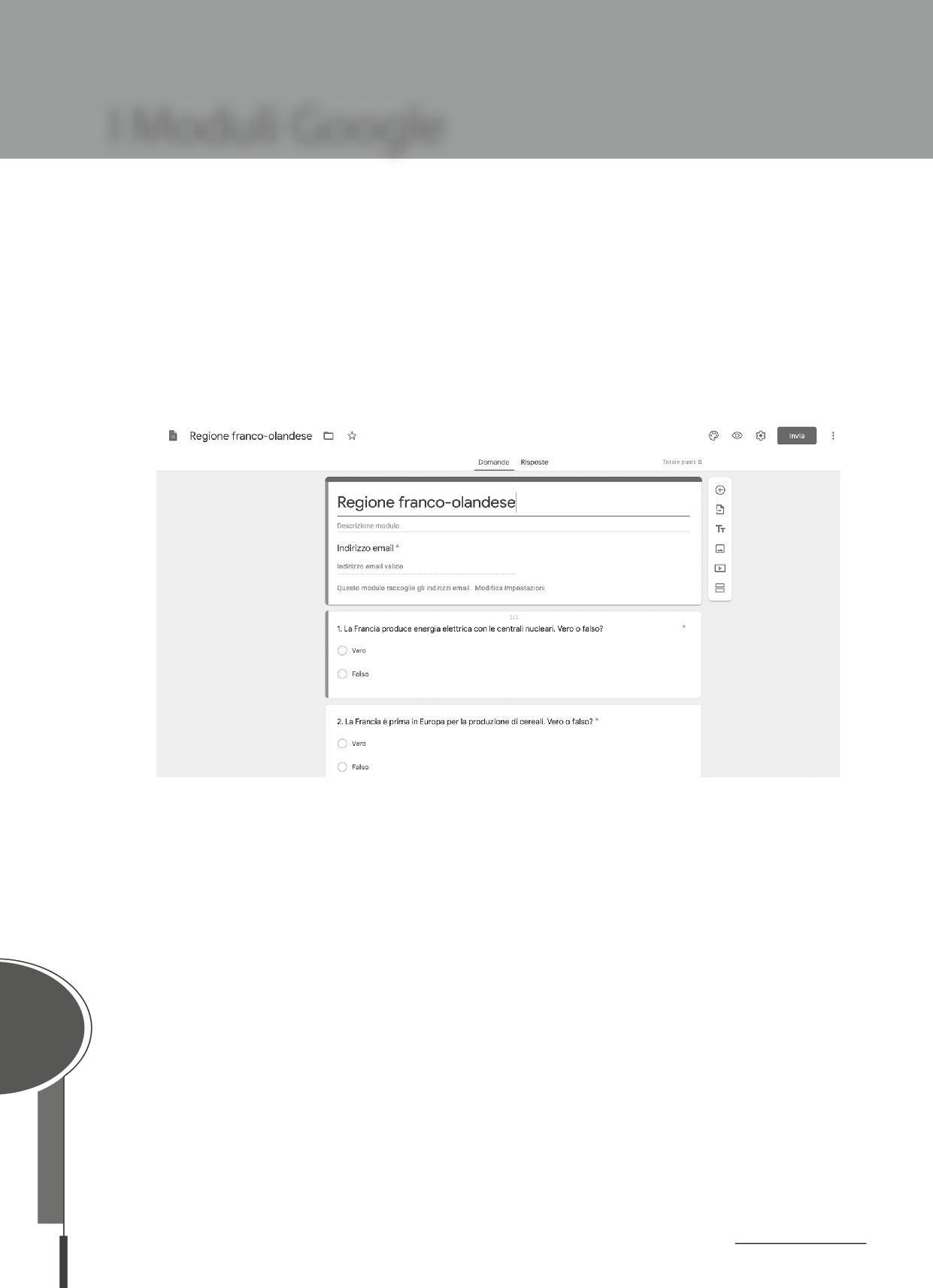
Una volta effettuata una copia del documento (basterà cliccare su “Crea una copia”), il test comparirà nella vostra cartella di Google Drive.
È interamente modificabile, dal titolo al colore di sfondo; dal carattere (font) alle risposte.
Una volta pronto il test, può essere inviato via email oppure condividendo un link sui principali sistemi di messaggistica istantanea.
Un’opzione importante riguarda il feedback: chi esegue il test può riceverlo immediatamente alla fine oppure dopo la revisione dell’insegnante.
Consigli utili
• Se decidi di creare un tuo Modulo, accertati di selezionare “Limita a una risposta” e “Raccogli indirizzo mail”: così facendo potrai associare il test a uno studente o a una studentessa.
• Prova a rendere un test autocorrettivo meno banale e più completo, inserendo immagini o video.
• Google Drive funziona perfettamente anche sullo smartphone! È la soluzione ideale se si impiega una chat di classe.

Elenco dei Moduli Google per il V anno
• Il carbonio: ibridazione e isomeria
• La reattività delle molecole organiche
• Alcani e cicloalcani
• Alcheni, alchini e idrocarburi aromatici
• Alogenuri alchilici
• Alcoli, fenoli ed eteri
• Aldeidi e chetoni
• Acidi carbossilici
• Ammine e composti eterociclici
• Polimeri di sintesi e condensazione
• I carboidrati: struttura, funzioni
• I lipidi: struttura, funzioni
• Le proteine: struttura, funzioni
• Gli acidi nucleici: struttura, funzioni
• Il metabolismo e gli enzimi
• La cinetica enzimatica
• Vitamine e coenzimi
• La glicolisi e le fermentazioni
• La respirazione cellulare
• Il metabolismo dei glucidi
• Il metabolismo di lipidi e proteine
• Fotosintesi: la fase luminosa
• Fotosintesi: il ciclo di Calvin e la sintesi degli zuccheri
• I virus e la loro riproduzione
• La regolazione genica nei procarioti: gli operoni
• La struttura del genoma eucariotico e la sua regolazione
• La tecnologia del DNA ricombinante e il clonaggio
• Isolamento dei geni e amplificazione
• Il sequenziamento del DNA e la bioinformatica
• Le scienze omiche (genomica, trascrittomica, proteomica)
• Le biotecnologie per l’agricoltura, l'ambiente e l’industria
• Le biotecnologie mediche