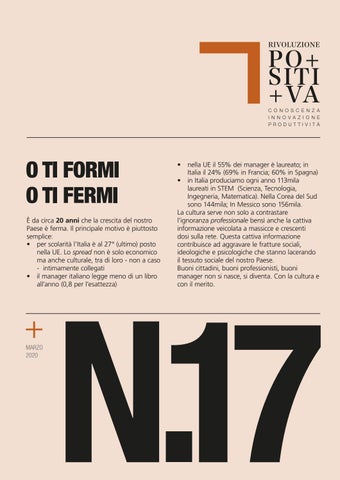4 minute read
La comprensione del clima ci chiede basi scientifiche più rigorose APPROFONDISCI
Ogni giorno assistiamo al rito di attribuire ogni genere di colpa al riscaldamento globale. Al contrario, nella comunità scientifica che si occupa di studiare i cambiamenti climatici, le cose sembrano avere una diversa prospettiva. Da una parte il problema di base del riscaldamento globale sembra risolto ormai da più di quaranta anni; infatti nel 1978 venne pubblicato il rapporto Charney (dal nome di Jule Charney, allora professore al MIT) che stabiliva già cosa ci saremmo dovuti aspettare a livello globale da un’aumentata concentrazione dei gas di serra in atmosfera. Gli effetti si possono riassumere con un aumento continuo delle temperature medie (più pronunciato alle alte latitudini) e in un conseguente aumento del livello dei mari (dovuto in parte alla dilatazione termica e, in parte, allo scioglimento dei ghiacciai). Le previsioni vengono confermate oggi dai dati con un aumento della temperatura di circa 1 grado /100 anni e un aumento del livello dei mari di circa 2 mm/anno. Il resto delle attribuzioni, aumento delle piogge, della frequenza dei fenomeni estremi etc., non solo non è previsto da tutti i modelli ma ha dato inizio a un ramo indipendente della ricerca detto proprio detection and attribution che con grandi incertezze sembra indicare un aumento dei fenomeni severi col passare degli anni.
Le incertezze sono dovute al fatto che l’aumento di temperatura media della Terra è legato a un aumento della forzante, cioè l’aumento dei gas di serra comporta un maggiore assorbimento di energia da parte del sistema climatico. Al contrario, le conseguenze a livello geografico regionale dipendono dalle variazioni della circolazione - cioè le correnti - oceanica e atmosferica. Questo aspetto è assai più difficile da studiare tanto è vero che già dalle previsioni dei modelli si nota una netta distinzione nella distribuzione di temperatura di oggi rispetto a quella che ci sarà fra un secolo mentre le differenze fra le pressioni atmosferiche e le precipitazioni, nello stesso periodo, sono molto marginali.
Advertisement
Tutto ciò sta a indicare che gli strumenti usati per la previsione, i cosiddetti Modelli di Circolazione Generale (GCM), sono strumenti imperfetti che, mentre risentono egregiamente delle variazioni di energia assorbita, sono molto meno sensibili riguardo le variazioni della circolazione. Occorre quindi una riformulazione dei programmi di ricerca per migliorare gli aspetti della previsione regionale e il principale imputato è la scarsa risoluzione dei GCM. In pratica questi modelli sono dei simulatori della circolazione oceanica e atmosferica su delle griglie, o maglie numeriche, che avvolgono l’intera l’atmosfera e l’oceano. La dimensione minima della maglia che si usa oggi è dell’ordine di poche decine di km quanto invece bisognerebbe spingerla a dimensioni dell’ordine di 1km o meno. Ciò è necessario per risolvere e simulare fenomeni a piccola scala come, ad esempio, i temporali che sono determinanti nello stabilire il clima a livello regionale. Un miglioramento del genere va a creare delle esigenze crescenti nella capacità di calcolo con elaboratori che siano in grado di effettuare il cosiddetto calcolo exascale, cioè un miliardo di miliardi di operazioni al secondo.
Parallelamente vanno impostati dei programmi sperimentali per la raccolta e la verifica dei dati basati soprattutto su tecnologie spaziali che devono coprire periodi decennali al fine di raggiungere una precisione significativamente adeguata.
Un cambio di passo di questo genere necessita del contribuito di forze nuove, soprattutto di fisici sperimentali che finora sono rimasti alla finestra di questo problema e che, non a caso, mostrano quasi sempre un certo scetticismo sulle teorie del riscaldamento globale.
È ovvio che un programma di ricerca di questa portata richiederà investimenti non indifferenti che possono essere forniti solo da Paesi economicamente prosperi e che quindi sono probabilmente i principali contributori all’aumento dei gas di serra. Questo potrebbe creare un conflitto di interessi per i ricercatori che lavorano per gli stessi governi: le conclusioni delle loro ricerche potrebbero non essere gradite ai loro datori di lavoro e ai loro finanziatori.
Effettivamente questi problemi vengono agitati nella comunità scientifica da pochi ma autorevoli esponenti mentre la maggior parte si trova di fronte ad un dilemma di non facile soluzione. In pratica si tratterebbe di esporre onestamente che i risultati delle attuali previsioni al livello regionale sono ancora incerte mentre la controparte politica potrebbe interpretare questa ammissione come una grave carenza della scienza del clima che la incoraggerebbe a continuare una politica di consumi energetici senza controllo.
Le difficoltà non sono limitate alle obiezioni politiche ma potrebbero nascere da settori di ricerca concorrenti. Ad esempio, nelle applicazioni delle tecnologie spaziali viene percepita una forte concorrenza che metterebbe a rischio gli investimenti sui satelliti meteorologici. Si consideri poi, sempre nello stesso settore, che la comunità astronomica fino ad oggi ha ottenuto fondi rilevanti per le sue ricerche pur avendo possibilità applicative assai inferiori.
Ciò che si nota è un quasi totale disinteresse a queste problematiche da parte della comunità scientifica che finora non ha mostrato di avere le doti per convincere la politica ad adottare misure drastiche per la riduzione dei gas di serra. Al contrario continua ad insistere sul fatto che la scienza climatica è in qualche modo “settled” cioè non richiede aggiornamenti o ridiscussione dei propri principi. Questo corrisponde ad adagiarsi sui risultati finora raggiunti che come abbiamo visto sono assai parziali e di carattere generale. Un prova evidente di quanto sia poco producente questo atteggiamento è il fatto che in quasi mezzo secolo la politica deve ancora convincersi di certe evidenze.
La comunità scientifica che si occupa dello studio del clima deve invece ribadire e convincere che lo stato delle conoscenze è sufficiente per promuovere e imporre misure drastiche sulla produzione e consumo di energia.
Guido Visconti