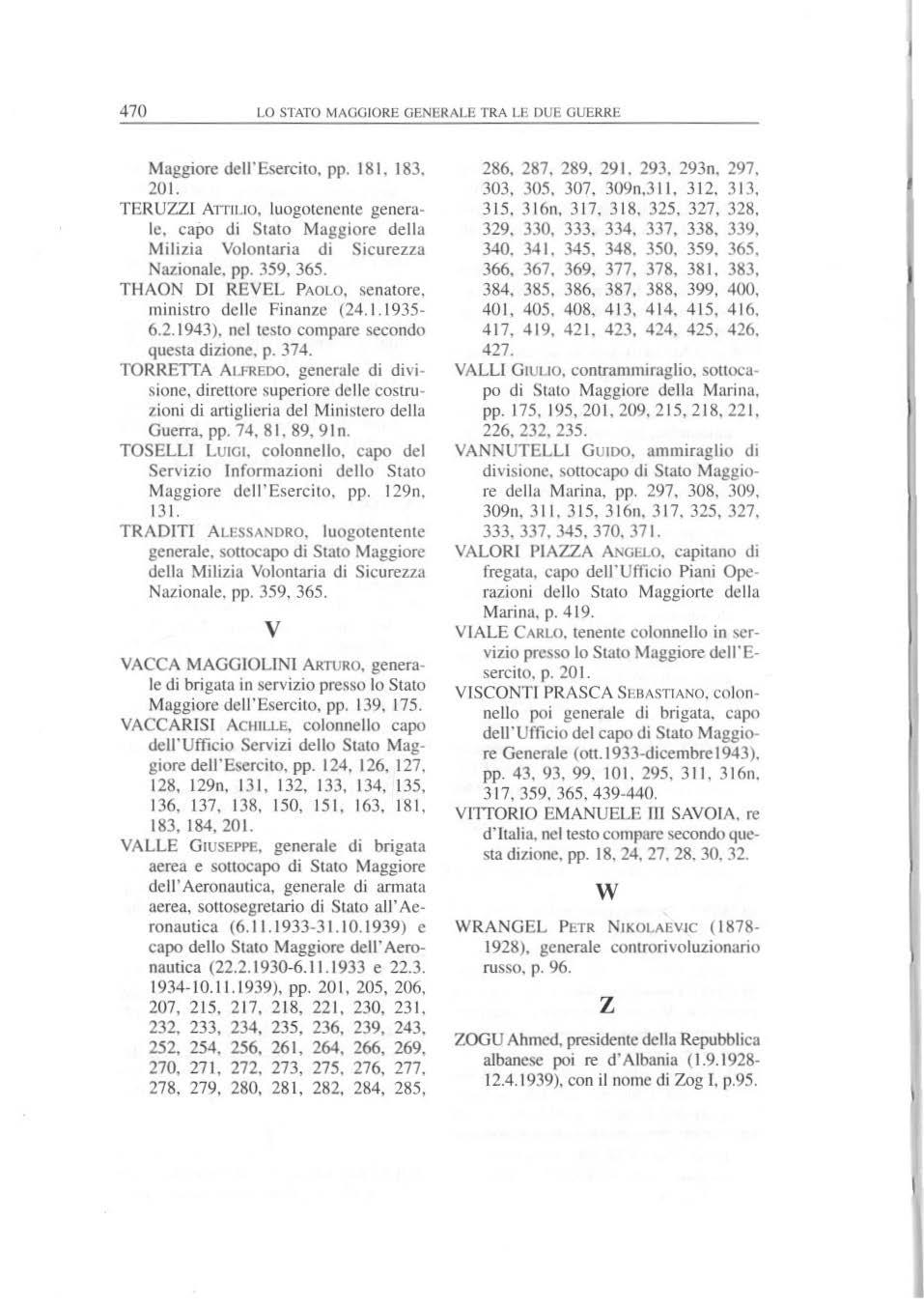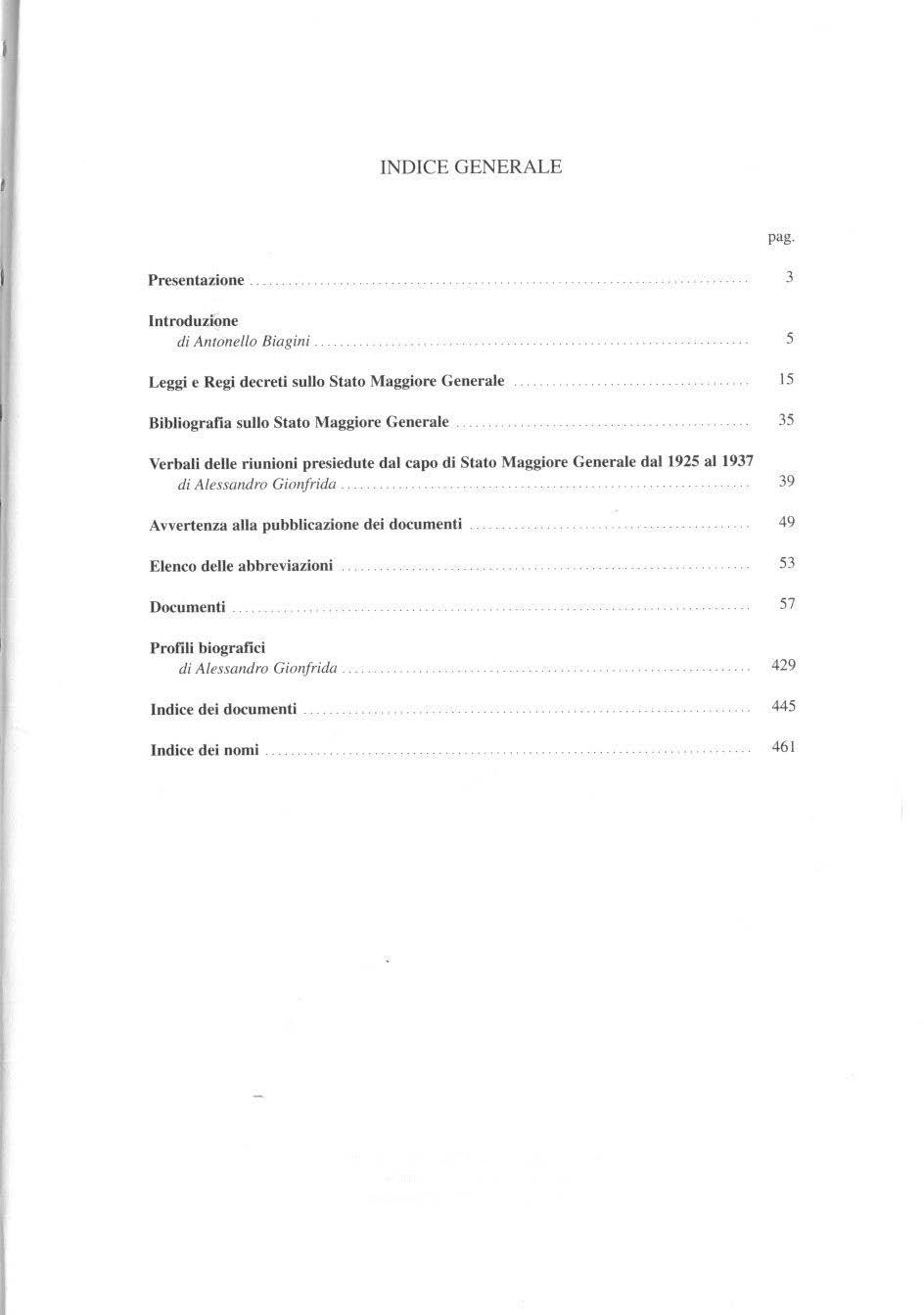ANTONELLO BIAGINI ALESSANDRO GIONFRIDA
LO STATO MAGGIORE GENERALE TRA LE DUE GUERRE
(VERBALI DELLE RIUNIONI PRESIEDUTE DA BADOGLIO DAL 1925 AL 1937)

Tuili i dirilfi riser!lnti. Vielnta In riprod11zio11e a11c/Je parziale senza autorizzazione
 © By SME - Ufficio Storico Roma 1997
© By SME - Ufficio Storico Roma 1997
L'Ufficio Storico dello Stato Maggiore de/l'Esercito, nell'ambito specifico degli studi di storia militare na zionale, da lungo tempo patrocina la pubblica zione di opere che rendano accessibili agli addetti ai lavori , ma anche al grande pubblico, il ricco patrimonio documentario, conservato nel suo stesso archivio. Da questa esigenza è nata la raccolta dei « Verbali delle riunioni tenute dal capo di Stato Maggiore Generale dal 1939 al 1943 », curata dal professor Biagini e pubblicata
Quella raccolta si completa oggi con la presente edizione critica dei verbali dal 1925 al 1937, quasi tutti inediti.
L'istituzione della carica di capo di Stato Maggiore Generale, affidata, il 4 maggio 1925 a Badoglio , allora generale dell'Es ercito e in seguito Maresciallo d'ltalia, fu una delle grandi innovazioni della politica militare fascista. Con essa il capo di Stato Maggiore Generale veniva ad assumere una moderata ma esplicita funzione di coordinamento interforze .

l verbali qui pubblicati, documentano quindi, le varie attività inte,forze tra cui spiccano quelle relative alla pianificazione operativa e di raccordo tra gli Stati Maggiori dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica nei diversi piani di guerra, al coordinamento di tutte le Forze Armate nella campagna in Africa Orientale, ai vari studi sulla difesa dello Stato ed alla organizzazione militare dei territori d'oltremare.
È quindi un'opera che si presenta con grande valenza storica e con estrema attualità, trattando del funzionamento delle Forze Armate in tempo di pace.
Agli autori di questo interessantissimo volume va il ringraziamento dell'Ufficio per aver voluto e saputo realizzare un 'opera che, nel rendere disponibile un complesso numero di fonti, evidenzia la politica militare del regime ed alcuni fondi dell'archivio di questo Ufficio.
IL CAPO UFFICIO (Col.e. s.S M Ri ccardo Treppiccione)
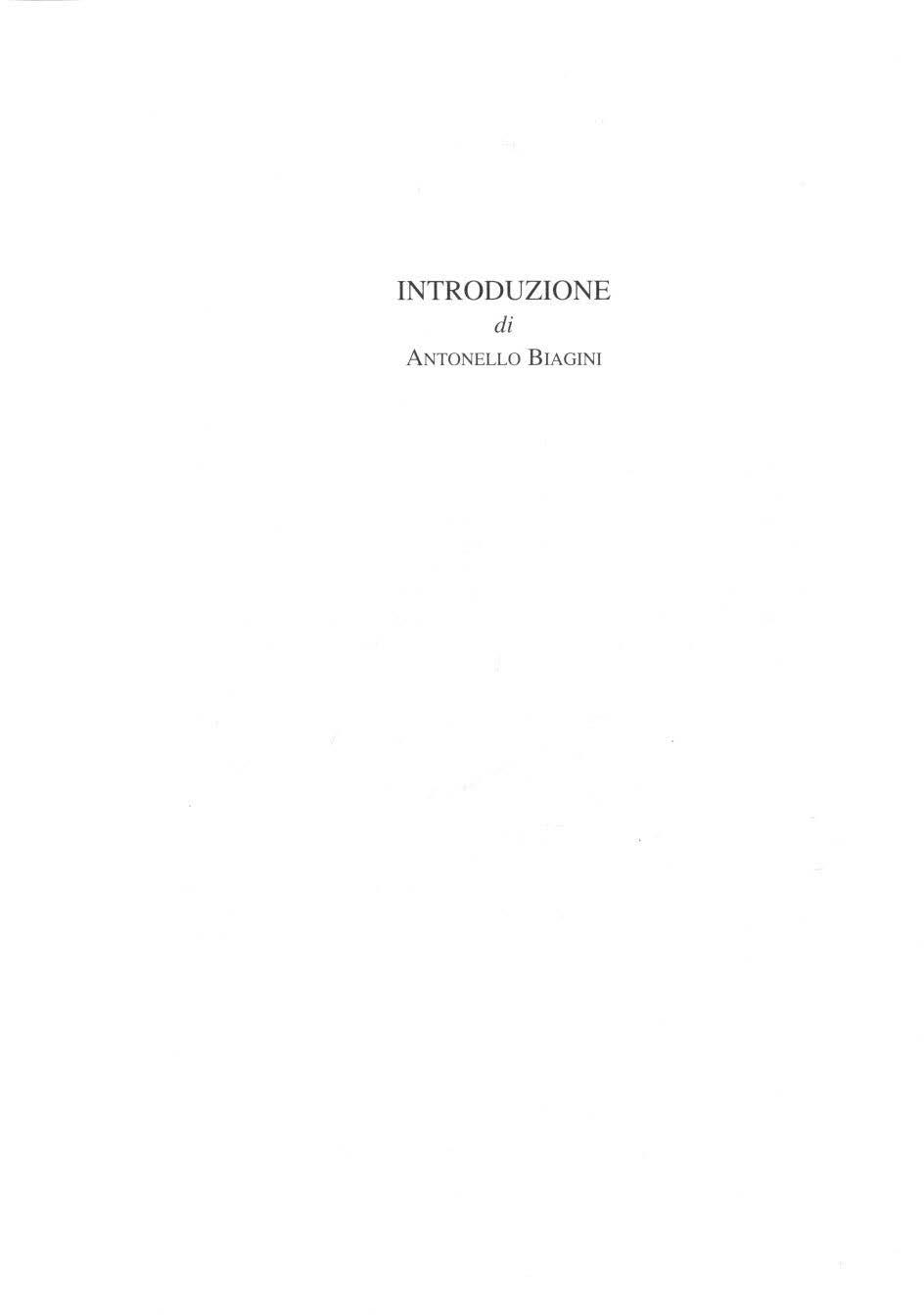

Sono passati giusto dieci anni da quando l'allora capo dell'Ufficio Storico dell'Esercito, accogliendo un progetto di chi scrive, delle vita alla collana <<La difesa nazionale. Il problema della preparazione nell'Italia contemporanea». L'idea era, ed è quella di ricostruire le linee interne attraverso le quali si sono determinate, in Italia , le scelte relative alla politica militare 1• Si trattava di superare l 'histoire bataille per esplorare sistematicamente il retroterra culturale, sociale, economico e tecnologico che costituisce la base di qualsiasi scelta politica. Affermazione, questa, apparentemente ovvia nel 1995 quando alcuni cambiamenti epocali hanno fatto finalmente giustizia dei luoghi comuni che una cultura pigra e appiattita aveva eretto a «sistema» interpretativo, come se le «questioni» militari fossero qualcosa di estraneo alla realtà del Paese.
In tale ottica La lettura della storia militare e delle vicende belliche non poteva che essere negativa, lasciando quasi esclusivamente ai militari il peso e la responsabilità degli avvenimenti, mentre il potere politico rimaneva confinato in una sorta di Limbo, come se le decisioni relative ai conflitti, alle riforme istituzionali, agli armamenti ecc. fossero espressione autonoma ed esclusiva del così detto «potere» militare. Sulla base di questo equivoco si è costruita una mentalità collettiva che non riesce a collegare gli obiettivi da raggiungere (politica estera) alle risorse da impiegare (bilancio), e in questo modo, come ho già scritto in diverse occasioni, la politica militare in Italia è di fatto condizionata e determinata dai tagli di bilancio piuttosto che da una razionalizzazione, condivisa da una opinione pubblica cosciente, degli investimenti e delle risorse economiche2
1 Preferi sco questa dizione «c lassica>>, di ampio respiro rispetto a quelle, attualmente in voga, di «politica di s icurezza», «politica di difesa», ecc., che a mio giudizio hanno un contenuto limitativo rispeuo alla complessità de ll e forze annate che rappresentano, sempre, uno «spaccato» della società che le produce attraverso scelte di carattere giuridico-istituziona le, politico-ideo log ico, economico- industriale, di politica interna ed estera.
2 Cfr. A. Biagini, Politica estera e politica militare, Alli del Co nvegno «Il nuovo concetto di dife sa e l a condizione militare», Rivi s ta Militare, n 6, 1994, pp. 38-45.

Non fa ecce::,ione il ve11te1111io fascista che sembra ai più, erro11eame11te o supeificialme11te, fortemente compreso dei problemi militari, mentre tende ad 1111a «militari-::.zazione» della società che mortificaattraverso la politiciz:..azione esasperata - la «professionalità ».
La poli1ica estera fascista - come è noto - è caratterizzata, fino alla guerra d'Etiopia, da w1 «dinamismo » diplomatico volto alla revisione dell'assetto internazionale sancito dai trattati di pace del 1919 con i quali le Poten-;:,e vincitrici a1 •eva110 tentato, in maniera non concorde, di disegnare un nuovo assetto europeo e internazionale avente come obiettil'o La costitw::.ione di un nuovo «sistema » di rela:..ioni internazionali che vanificasse, in maniera definitiva, l'uso dello strumento bellico quale elememo risolutore dei conflitti politici.
La dissoluzione dei grandi imperi plurinazionali, la costituzione (o ricosti1uzione) degli S1a1i nazionali, secondo schemi solo in parie rispettosi del «principio di nazionalità», e la tensione ideologica detenninata dall'affenna-::.ione della rivoluzione bolscevica in Russia, produssero fra le due guerre una sostanziale «ingovernabilità» dei rapporti politici i111ernazionali. La politica franco-inglese, enfati-::,zata dallo spirito di crociata contro il militarismo prussiano, aprì nell'Europa centrale una fase di forte instabilità, penalizzando nel contempo le a~pirazioni italiane nei Balcani e nel Mediterraneo.
La vitloria mutilata fu, allora, molto più di uno slogan e la rivendica-::.ione di un diverso ruolo internazionale costituì uno degli elementi del successo della propaganda fascista. Se la sistemazione della «questione adriarica» e La costiruzione dell'impero furono gli elementi portami della politica estera fascista, a questi non corrisposero adeguati investimenti dal pufllo di vista militare (tranne che per l'impulso dato all'Arma aeronautica).
Mentre, d'altra parte, il mantenimento della Milizia Volontaria di Sicurezza Nazionale (inutile e costoso doppione dell'Esercito), il ritardo tecnologico (meccanizzazione de/l'Esercito), la politicizzazione (peraltro parzialmente riuscita) dei quadri, gli impegni internazionali sovradimensionati (guerra d'Etiopia, guerra di Spagna, seconda guerra rnondiale) dimostrano ampiamente l'alto tasso di improvvisazione della politica estera del fascismo. Se questo non <<assolve» i vertici militari, certo ne ridimensiona le responsabilità, che pure esistono, ma che debbono essere ricondotte allo stretto ambito professionale.
La storia dello Stato Maggiore Generale e più generalmenre quella dell'Esercito italiano fra Le due guerre, è, per molti aspetti, emblematica e costituisce un ulteriore paradigma attraverso il quale studiare la politica militare italiana, una politica ricca di idee e di buone intenzioni, alla quale è mancato, in fase di applicazione pratica, il sostegno decisionale dei governi e del Parlamento.

L'armistizio concluso nel 1918, pone fine - formalmente - alla guerra con gli imperi centrali e segna l'inizio del processo di smobilitazione per ricondurre gli organici alle necessità di un esercito non più operante. Alcuni impegni di carattere internazionale, relativi anche all'applicazione dei trattati di pace, e problemi di carattere economicosociale, imposero una smobilitazione lenta e progressiva che si conclude solo nel 1920. La prima guerra mondiale aveva d'altra parte determinato negli eserciti belligeranti, compreso quello italiano, una consistente evoluzione dei sistemi d 'a rma, degli apparati logistici e, infine , della dottrina tattica e strategica.

Sul teatro europeo, dopo xli iniziali scontri franco-tedeschi sulla Marna, il conflitto aveva assunto le caratteristiche di una guerra statica e di posizione, dove la vittoria in ultima analisi sarebbe stata dec isa dal logoramento delle risorse umane ed economiche dell 'avve rsario. Dalle esperienze della guerra di trincea e dalle elaborazioni degli alti comandi di entrambi gli schieramenti era scaturita la necessità tattica di sviluppare, in tutte le unità combattenti, una considerevole poten za di.fuoco in grado di spezzare il fronte avversario. Su queste basi anche Le unità minori di fanteria furono dotate, durante la guerra, di mezz i di fuoco e conseguentemente le loro forma zioni organiche subirono un notevole riordinamento. Il binomio fanteria-artiglieria divenne quindi un elemento basilare e inscindibile per lo svolgimento di una qualsiasi azione tattica di rilievo, naturalmente a scapito della mobilità e della rapidità di manovra che erano state, da sempre, le caratteristiche principali della fanteria; queste realisticamente, furono sacrificate in un confronto bellico dove i sistemi d'arma difensivi avevano una netta superiorità ed efficacia rispetto a quelli offensivi.
L'Esercito italiano al termine della prima guerra mondiale era quindi formato da divisioni quaternarie, con un formale quanto ingannevole rapporto di quattro reggimenti a uno fra fanteria e artiglieria, dove La prima era dotata in proprio di molti elementi di fuoco.
Nel 1919, dopo Vittorio Veneto , viene adottato l'ordinamento Albricci, il cui scopo era quello di realizzare un ordinamento funzionale economicamente compatibile con le risorse a disposi z ione attraverso l'eliminazione degli elementi superflui e costosi. L'Esercito fu così ordinato in 15 corpi d'armata territoriali, 30 divisioni di fanteria ( quaternarie) e due di cavalleria; la forza bilanciata fu ponata a 210.000 uomini, inferiore a quella prevista nell'ordinamento pre-bellico; la ferma, obbligatoria, fu ridotta a un anno, con una possibile riduzione a otto mesi. Ulteriori tagli di bilancio imposero a breve scadenza l'elaborazione di un nuovo ordinamento ( ordinamento Bonomi, D.L. n. 451 del 20 aprile 1920) che riduceva La for za bilanciata a 175.000 uomini, La ferma a otto mesi e i corpi territoriali a dieci, su tre divisioni quaternarie. Fu
prevista una sola divisione di cavalleria, e i reggimenti di fanteria rimasero fermi al numero di 106, come prima della guerra, ma vennero ridotti a due soli hartaglioni, dividendo il terzo in un «battaglione quadro» da costituirsi e completarsi in occasione di richiami. Altri tagli furono operati nelle armi a cavallo, in artiglieria e in talune specialità del genio assegnate ai corpi d'armara, analogamente fitrono ridotti molti organi giurisdi-:,ionali territoriali e gli stabilimenti militari, adottando per quest'ultimi il criterio di ricorrere largamente all'industria civile.
D'altra parte, il 25 luglio /920 11enne nominata la Commissione parlamentare consultiva incaricata di coadiuvare il ministro della Guerra nella prepara:ione dei disegni di legge relarivi definitivo al reclutamento delle truppe e alla preparazione militare, nonché alla elabora-:,ione di un progetto di «Na:ione armata» che consentisse di alleviare l'onere del servizio militare e quello delle spese, conciliando le esigenze economiche e sociali con le necessità della difesa na-;.ionale.

L'avvento del fascismo e l'ordinamento Diaz del gennaio /923, nel ripudio delle politiche militari precedenti, segnarono un punto di svolta nell'organizzazione dell'Esercito:ferrna di diciotto mesi.forza bilanciata di 250 mila uomini e divisione quaternaria, cos1iluiva110 gli elemellli essenziali di un programma di difficile realizzazione, tanto che si dovettero escogilare alcuni espedienti, quali ritardi nella chiamata alle armi, congedi an1icipati e reggimenti a ranghi ridotti per far quadrare il bilancio, senza poi contare l'inefficienza di quei reparti dove, con le disposizioni Diaz, divenne più forte la sproporzione fra organici e forza bilanciata.
I guasti prodotti da/l'ordinamento Diaz furono i11 breve tempo chiaramente visibili anche a chi quel disegno aveva caldamente appoggiato e tendeva, per convinzione, a propugnare un grande esercito «i11telaiatura» e di massa piuttosto che un esercito, come si scriveva allora, «scudo e lancia» ricco di mezzi, ad alta professionalità e conseguenteme11te poco 11umeroso.
Fin dal 1924, con il progetto Di Giorgio si cercò di porre rimedio alla situazione e L'anno successivo fu srilato l'ordinamento Mussolini, rhe - con lievi modifiche apportate dall'ordinamento del '34 - restò sostanzialmenre i11 vigore fino a/l'ordinamento ?ariani del dicembre 1938.
L'ordinamento Mussolini nasceva comunque da una serie di compromessi, fra una concezione di esercito di massa, ereditata dalla prima guerra mondiale e L'idea di un esercito in qualche modo di élite.fra una dottrina tattira - che teorizzava il ritorno alle classiche guerre di movimento - e La convinzione di molti che un futuro conflitto sarebbe rimasto stalico e di trincea, fra «na:io11i murate» nelle p1vprie linee difensive.
Nelle disfunzioni e nelle incertez.ze di questo ordinamento, la prova più evidente delle contraddizioni già accennate, fu quella fra una politica estera dinamica e di grande potenza - che doveva prevedere, per forza di cose, un appropriato e valido strumento militare - e una struttura economico-produttiva sostanzialmente arretrata e quindi incapace di sostenere e finanziare un esercito adeguato a quella politica.

La mancata congruenza fra potenzialità, strumenti economici e militari e politica estera, costituisce la base fondamentale di quella insufficiente «mobilitazione» del Pa ese durante la seconda guerra mondiale fino alla sostanziale perdita di «identità» e dunque alla lacerazione, profonda e difficilmente rimarginabile, della guerra civile. Il recente dibattito tra storici, politologi e sociologi su questo tema non rientra nell'economia di queste brevi nore, anche se ad esso ci si deve riferire per una ragionevole comprensione della recente storia italiana.
Nell'ordinamento Mussolini, l'esperienza accumulata durante gli anni di guerra aveva dimostrato la necessità di un sempre maggiore coordinamento inrerforze ( Esercito, Marina e il ruolo ancora non ben definito ma di cui si intuiva l'utilizzazione «rivoluzionaria» dell'Aeronautica); si giunse così all'istituzione della carica di capo di Stato Maggiore Generale, la cui mancata definizione di ruoli e attribuzioni vanificò una intuizione sicuramente originale, relegando tale carica a un ruolo meramente consultivo anche nella stessa coordinazione fra le varie a rmi3 • Si scelse d'altro canto la divisione ternaria, che si credeva più adatta alla guerra di movimento, si istituirono i ruoli di comando e di mobilitazione, in modo da conferire più efficienza alle strutture di coma ndo, operative e logistiche.
Nel frattempo se dal punto di v ista dottrinale tattico si teorizzava una guerra di movimento. dall'altro si continuava a ripetere che l'azione offensiva fosse ancora tutta imperniata sul binomio fanteria-artiglieria, esaltando nel co ntempo la presunta azione risolutiva nello scontro delle masse di fanteria, le quali, a tale scopo, venivano dotate di nuovi mezzi offensivi - quali il tromboncino - che si riveleranno, col tempo, del tutto inutili. D'altra parte i mezzi corazzati erano considerati, e non solo in Italia , come arma di mero accompagnamento dell'azione offensiva della fanteria, per azioni di sorp resa e di sostegno e non come facevano - negli stessi anni - i tedeschi come massa di manovra e punta di diamante dell'azione offensiva, cuneo atto a spezzare il.fronte nemico e mezzo per realizzare azioni in profondità per aggirare lo schieramento avversario.
3 Il problema rimane apeno nel dopoguerra e solo in questi ultimi tempi sono in corso di clab<1razione no rm e pe r defini re i compili del capo di Stato Maggiore della Difesa.
L'esperienza fatta n ella guerra d'Etiopia, contro un esercito disorganizzato e scarsamente annato, rim•igorì nel campo strategico-tatlico la convinzione della guerra di movim ento, spingendola fino a concezioni che prevedevano forme ulrradinamiche e all'affennazio11e che per l'avvenire si intendeva fare una «guerra di rapido corso». Lo stesso Badoglio sulla base della propria esperienza africana giudicò, per lo meno i11 quel teatro, troppo pesante e poco manovrabile la divisione ternaria che risultava di difficile coma 11do e impiego.
Si giunse così, con l'ordinamento Pariani, all'introduzione della divisione binaria, c he non fu un semplice mutamento o rgan ico ma una radicale modificazione delle fun:ioni del! 'unità divisionale che perdeva la sua capacità di manovra per trasformarsi in una colonna d'urto e di penetra:ione, la manovra divenil'a così unafurdone specifica del corpo d'armata.
La nuova divisione binaria, formata da due reggimenti di fanteria e da uno di artiglieria, risultò, alla prova dei fatti, priva di mezz i di fuoco pesanti, quali le modeme artiglierie, e con insufficienti elementi di manovra, fa nterie; questa lacuna apparve tanto grave che nel nuovo ordinamento del marzo 1940 fu disposto che venisse assegnata a ogni divisione una legione della Milizia, un provvedimento questo che non risolse com unque le gravi deficienze della nuova divisione binaria, mentre produsse una conflittualità «intenza » decisamente negativa ai fini operati vi
Contemporaneamente la partecipazione alla guerra civile spagnola e l'ammodernamento della flotta diminuivano, in termini relativi, il budget dell'esercito che non poté quindi procedere a un adeguato ammodernamento delle artiglierie di medio e grosso ca libro, all'introduzione di pezzi semoventi, allo sviluppo dell'armamento controcarro, ant ia ereo e, cosa importante, all'accumulo di suffic ienti scorre indispensabili per una g uerra che si vo leva e si credeva di «rapido corso » e di movimento.
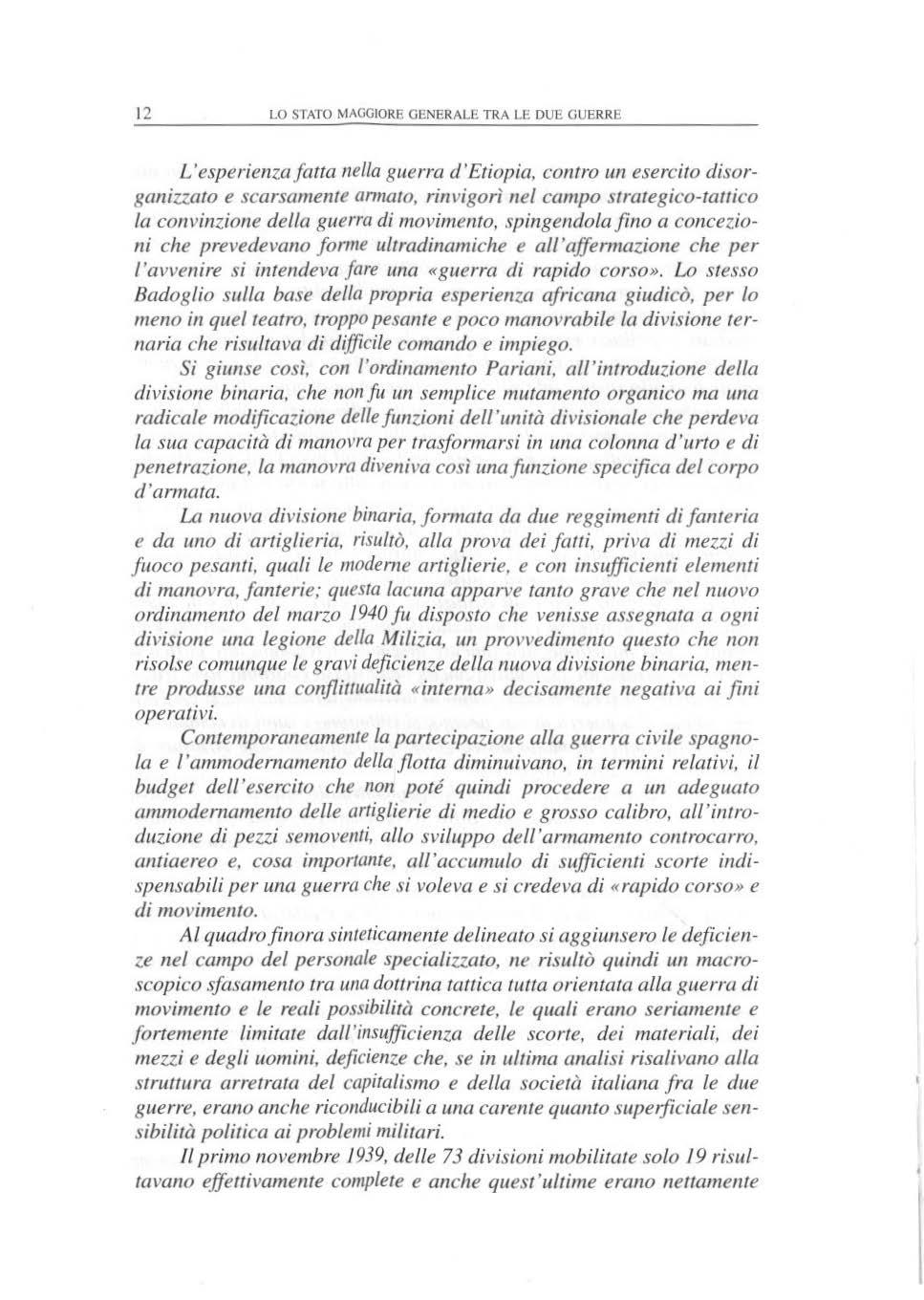
AL quadro finora sinteticamente delin ea to si aggiunsero le deficienze nel campo del personale specializzato, ne risultò quindi un macroscopico sfasamento tra una dottrina tattica tutta orientata alla g uerra di movimento e le reali possibilità concrete, le quali erano seriamente e fortemente limitate dall'insufficienza delle scorte, d ei materiali, dei mezzi e degli uomini, deficienze che, se in ultima analisi risalivano alla st ruttura arretrata del capitalismo e della società italiana fra le due g uerre, erano anche riconducibi li a una care nt e quanto supe rficiale sensibilità politica ai problemi militari.
Il primo novembre 1939, delle 73 divisioni mobilitate solo 19 risultavano effet1ivame11te complete e anche quest 'ultime erano nettamente
inferiori non solo rispetto alle omologhe unità francesi e tedesche, ma addirittura, in taluni elementi, a quelle jugoslave.
L'inferiorità nel numero dei battaglioni, sia quantitativa che qualitativa, nei gruppi d'artiglieria- che rimanevano sostanzialmente quelli della prima guerra mondiale - nelle armi di accompagnamento, anticarro, antiaeree e, infine, nelle scorte, impedivano al nostro esercito non solo di concepire a z ioni di largo raggio ma in definitiva di affrontare un confronto armato con sufficienti probabilità di successo.


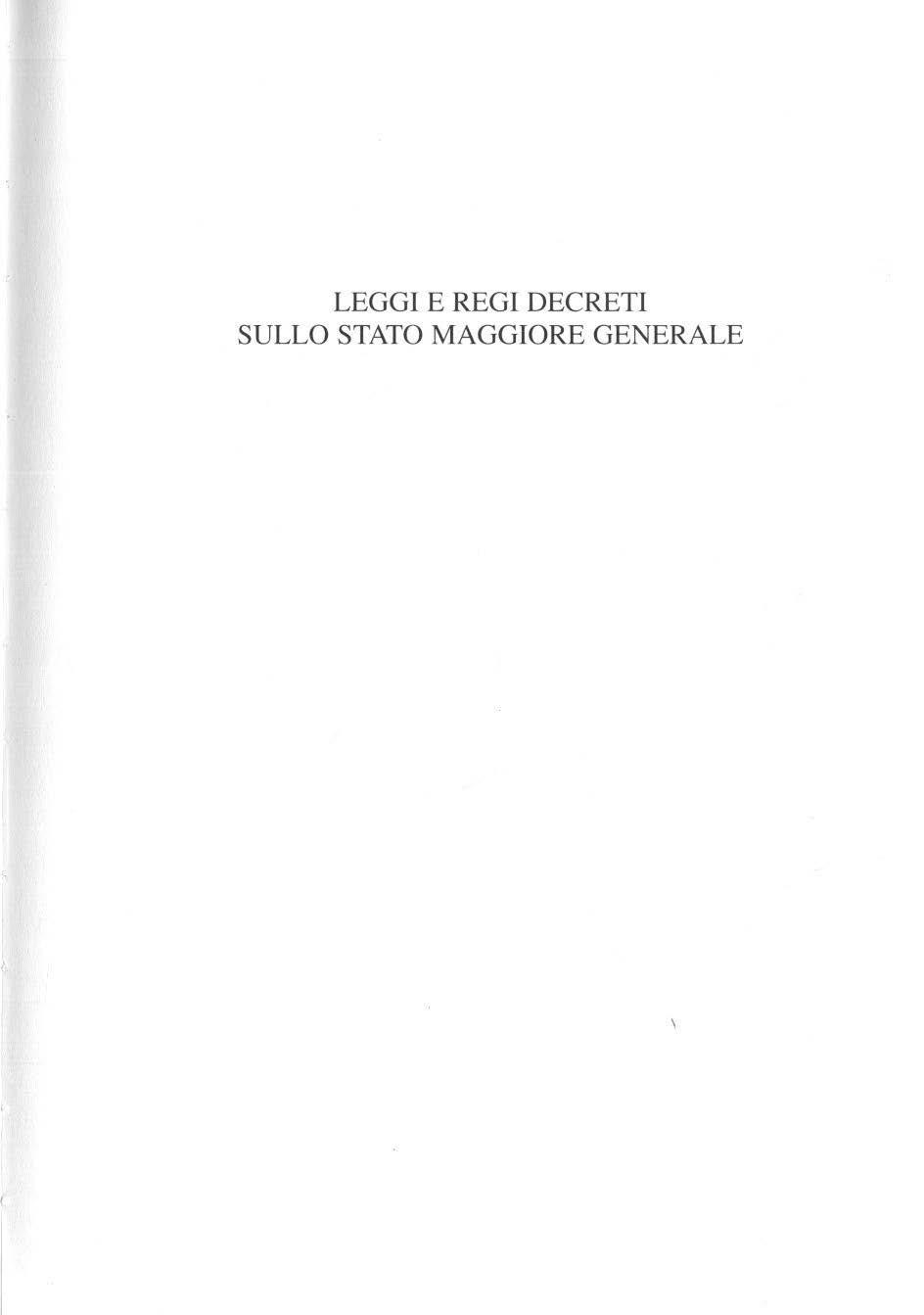

Vengono qui pubblicati, in ordine cronologico, le principali leggi e regi decreti che istituirono e regolarono fino al 1939 la carica di capo di Stato Maggiore Generale. Essi, tratti dai Giornali militari dell'epoca , sono:
l) Legge n. 866 del 8 giugno 1925 ( Giornale militare del 1925, circolare n. 299).
2) Regio Decreto-Legge n. 68 del 6 febbraio 1927 (Giornale militare del 1927, circolare n. 89).

3) Legge n. I 989 del 28 dicembre 1933 ( Giornale militare del 1934, circolare n. 129).
4) Legge n. 806 del 30 marzo 1936 (Giornale militare del 1936, circolare n. 392).
5) Legge n. 1193 del 26 luglio 1939 (Giornale militare del 1939, circolare n. 662).
6) Legge n. 1178 del 24 agosto 1939 (Giornale militare del 1939, circolare n. 666).
N. 299. - ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. - Legge n. 866
- Ordinamento dell'Alto Comando dell'Esercito. - (Gabinetto - Stato Maggiore CentraJe). - 8 giugno 1925. - (Gazzetta ufficiale n. 139, del 17 giugno 1925 ).
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA
Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; Noi abbiamo sa nzionato e promulghiamo quanto segue:
Del capo di Stato Ma ggiore Generale.
Art. I.
La carica di capo di Stato Maggiore Generale può essere ricoperta esclusivamente da ufficiale che rivesta il grado di maresciallo d' Italia, di generale d'esercito o di generaJe d'armata.
Egli è nominato con decreto reale, udito il Consiglio dei Ministri.
Art. 2.
li capo di Stato Ma ggiore Generale, per quanto riguarda, nell'ambito delle sue attribuzioni , la esecuz ione delle deliberazioni de ll a Commissione Suprema di Di fesa, e per le even tual i operazio ni di g uerra, è alla diretta dipendenza de l presidente del Consiglio. E perciò egli concreta gli studi e le disposizioni necessar i per la coordinazione dell'organizzazione dife nsiva dello Stato, ed i piani di guerra, dando ai capi di Stato Maggiore della Regia Mar ina e della Regia Aeronautica le direttive di massima per il concorso della Regia Marin a e della Regia Aeronautica nel raggiungimento di obb iettivi comuni.

Il ca po di Stato Ma ggio re Ge nerale dipende in vece dal ministro per la Gu erra per quanto riguarda il Reg io Eserc ito. E perciò egli presiede in tempo di pace alla preparazione alla gue rra dei quadri , de ll e truppe e dei relativi me zzi.
Esercita l'alta azio ne ispettiva sull e trupp e, sui servizi e su ll e scuole.
Egli deve essere con su ltato dal ministro sulle principali questioni re lati ve alla destinazione degli ufficiali ge neral i e su ll e questioni di massima riflettenti avanzamento , stato e governo di sc iplinare dei quadri dell'Esercito.
Il ca po di Stato Maggiore Generale, pertanto, in dipendenza di tali attribuz ioni:
a) stabilisce i concetti fondamentali in base ai quali deve essere informata la preparazione alla guerra e comunica, fin dal tempo di pace, alle autorità interessate le direttive generali per l'organizzazione difensiva del territorio e per la determinazione dei compiti dei comandanti delle grandi unità durante il periodo della mobilitazione e della radunata, e all'inizio delle operazioni;
b) determina la formazione di guerra dell'Esercito e i criteri in base ai quali debbono essere effettuati gli studi e i provvedimenti esecutivi per la mobilitazione delle truppe, la predisposizione dei materiali, la organizzazione dei servizi;
e) predispone l'impiego degli ufficiali generali presso l'Esercito operante;
d) in relazione ai fondi stanziati in bilancio, stabilisce le esercitazioni annuali, comprese quelle combinate fra Esercito, Marina e Aeronautica, sempre quando l'azione della flotta o delle forze aeree non rappresenti che il necessario concorso alle operazioni delle forze di terra. In veste caso per caso dell'alta direzione delle esercitazioni, qualora non l ' assuma egli stesso, altro ufficiale generale.
Sono comprese più particolarmente nelle attribuzioni del capo di Stato Maggiore Generale:
a) la comp ilazione degli studi riflettenti la sistemazione difensiva del territorio e le eventuali operaz ioni di guerra;
b) la comp il azione dei documenti relativi alla formazione di guerra, alla mobilitazione, alla radunata dell'Esercito ed all'impianto e al funzionamento dei servizi;
e) le predisposizioni, con il concorso delle autorità interessate, per la protezione delle vie di comunicazione e le loro eventuali intem1zioni, e per la v ig ilan za e la protezione costiera ed antiaerea;
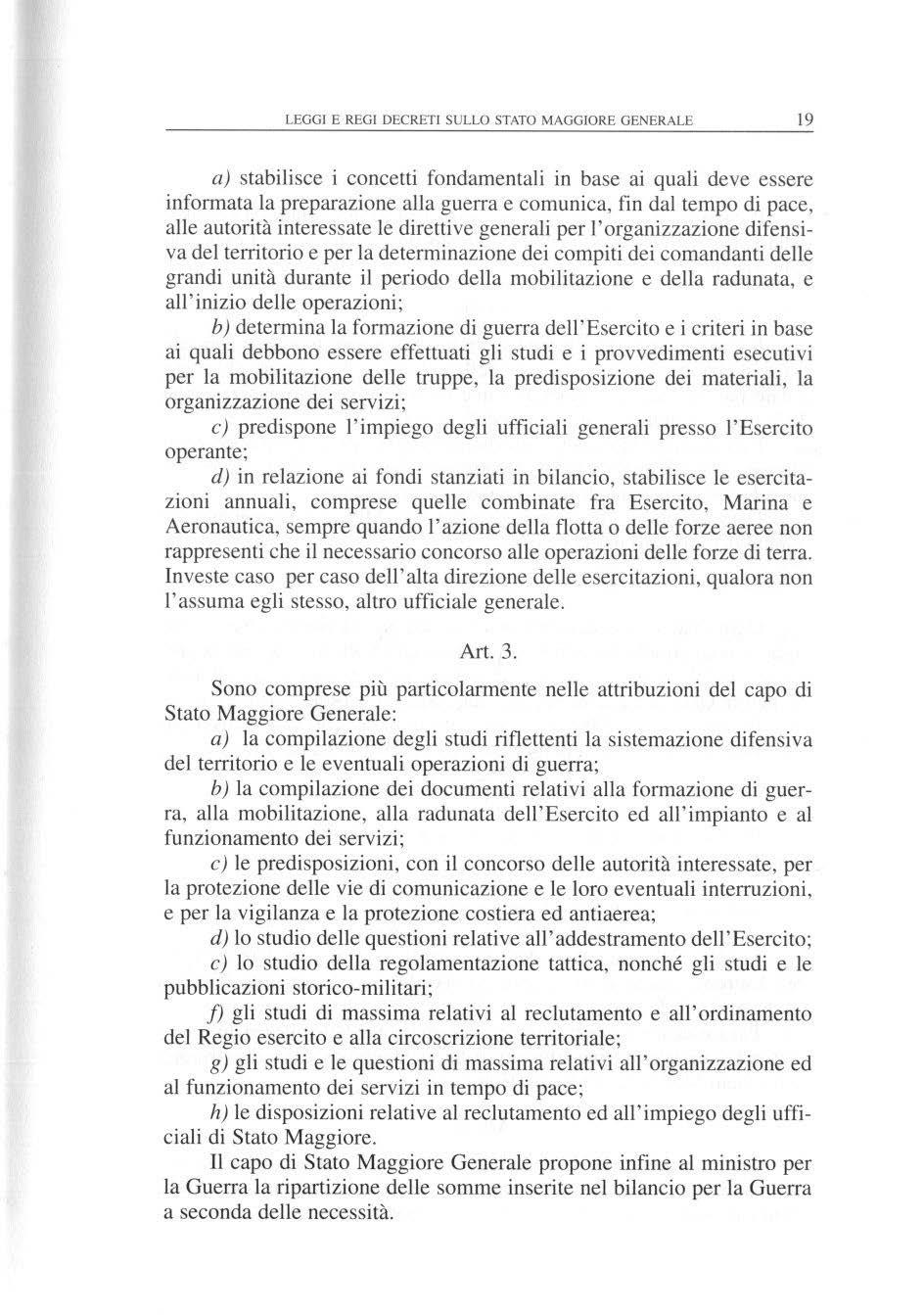
d) lo studio delle questioni relative all'addestramento dell'Esercito;
e) lo studio della regolamentazione tattica, no nché gli studi e le pubblicazioni sto1ico-mi litari;
fJ gl i s tudi di massima relativi al reclutamento e all'o rdin ame nto del Regio esercito e alla circosc ri zione territoriale;
g) gli studi e le questioni di massima relativi all'organizzazione ed al funzionamento dei servizi in tempo di pace;
h) le disposizioni relative al reclutamento ed all'impiego degli uffic iali di Stato Maggiore.
Il capo di Stato Magg iore Generale propone infine al ministro per la Guerra la ripartizione delle somme inserite nel bilancio per la Guerra a seconda delle necessità.
Art. 4.
n capo di Stato Maggiore Generale deve essere tenuto al corrente della situazione politica, per tutto quanto possa interessare l'esercizio delle sue attribuzioni.
Art. 5.
Il capo di Stato Maggiore Generale deve essere tenuto al corrente della situazione politica e militare delle colonie, e deve es se re chiamato a dare parere sulle più importanti questioni relative all'organizzazione delle truppe coloniali e alla difesa delle colonie.
Egli dovrà inoltre essere informato e consultato circa le operazioni militari coloniali che per la loro importanza richiedano o lasciano presumere la partecipaLione di reparti e mezzi metropolitani.
Dette questioni gli saranno segnalate dal Mini s tro competente pel tramite del ministro per la Guerra.
Art. 6.
Ogni qualvolta il Governo o il ministro per la Guerra convochino commissioni straordinarie per lo studio di questioni interessanti la preparazione della naLione alla guerra, faranno parte di esse il capo di Stato Maggiore Generale e le persone da lui designate a titolo consultivo.
Il capo di Stato Maggiore Generale fa parte, con voto consultivo del Comitato deliberativo della Commissione Suprema di Difesa.
Art. 7.
Per l'esercizio delle sue funzioni il capo di Stato Maggiore Generale ha alla sua dipendenza:
a) gli ufficiali generali comandanti designati d'armata;
b) il so ttocapo di Stato Maggiore Generale;
e) i generali a disposizione per le varie armi.
Egli potrà inoltre valersi dell'opera degli altri membri del Consiglio dell'Esercito, di cui al s uccessivo art. 11, per quegli altri incarichi che credesse di affidare loro.
Per l'esecuzione degli studi e la emanazione delle disposizioni inerenti alle sue attribuzioni, il capo di Stato Maggiore Generale dispone dello Stato Maggiore del Regio Esercito.
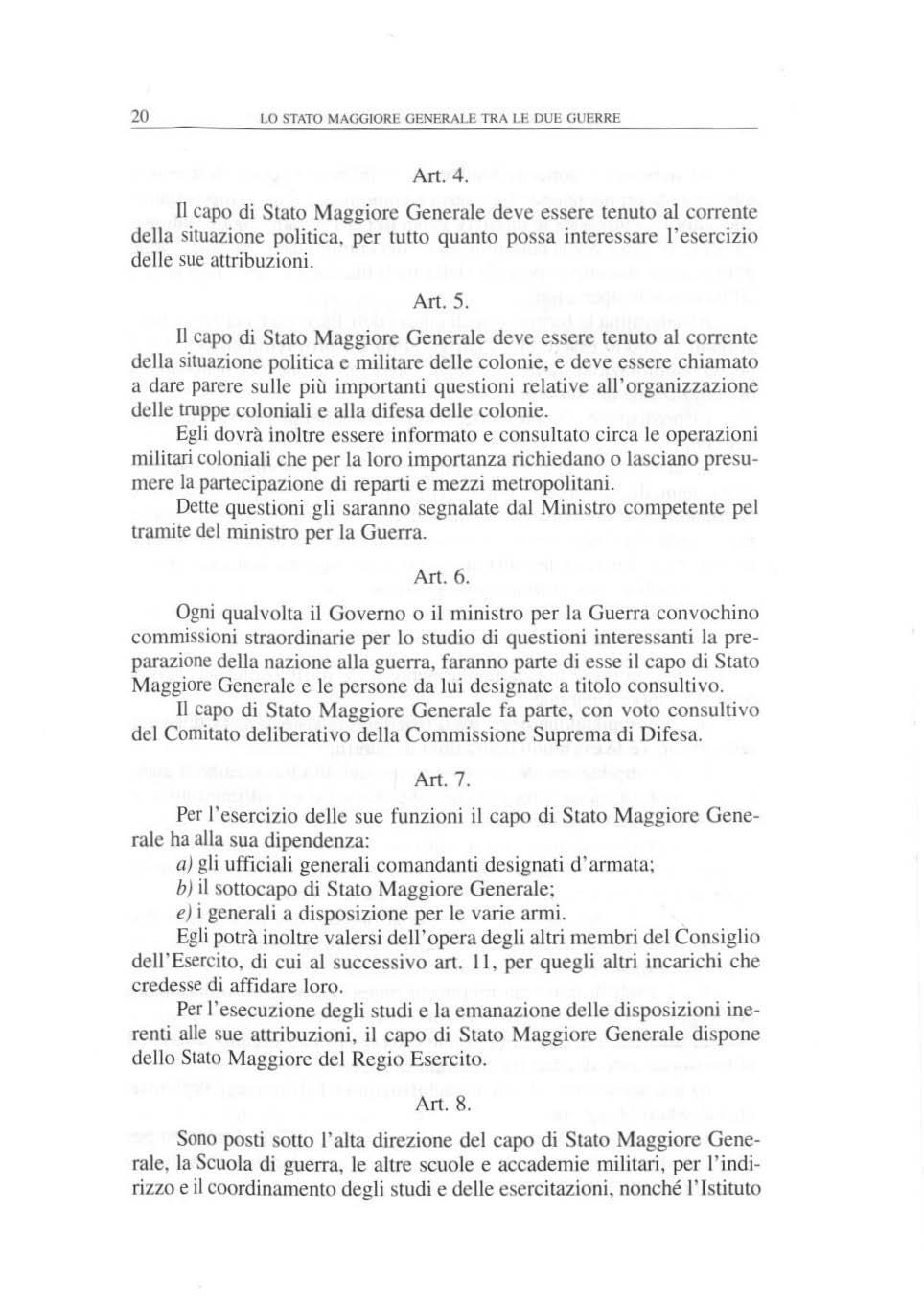
Art. 8.
Sono posti otto l'alta direzione del capo di Stato Maggiore Generale, la Scuota di guerra, le altre scuole e accademie militari, per l'indirizzo e il coordinamento degli studi e delle esercitazioni, nonché l'Istituto
geografico militare per quanto riguarda l 'indirizzo dei lavori che vi si compiono.
Art. 9.
Il capo di Stato Maggiore Generale in tempo di guerra esercita le attribuzioni stabilite per la sua carica dal regolamento sul servizio in guerra.
Egli lascia presso il Ministero della Guerra gli organismi neces sari a provvedere alla continuità d ' indirizzo delle funzioni territoriali dello Stato Maggiore del Regio Esercito.
Del sottocapo di Stato Maggiore Generale
Art. 10.
Il sottocapo di Stato Maggiore Generale coadiuva il capo di Stato Maggiore Generale nel disimpegno delle sue attribuzioni e compie gli speciali incarichi, relativi a tali attribuzioni, che gli vengono affidati dal capo di Stato Maggiore Generale.
Sostituisce il capo di Stato Maggiore Generale in caso di assenza o di impedimento di questo e lo rappresenta per quanto riguarda l'Esercito. Deve avere almeno i l grado di generale di corpo d'armata e sarà nominato con decreto reale udito il Consiglio dei Ministri.

Del Consiglio dell'Esercito
Art. 11.
Il Consiglio dell ' Esercito si compone:
a) del capo di Stato Maggiore Generale, presidente;
b) dei quattro generali comandanti designati d ' armata;
e) di tre altri generali d ' esercito, d'armata o di corpo d'armata:
d) del sottocapo di Stato Maggiore Generale.
Gli ufficiali generali di cui aJJa lettera e) sono nominati per decreto reale su proposta del ministro per la Guerra alla fine di ogni anno e durano in carica per l'anno successivo. Essi possono essere riconfermati.
Al Consiglio dell'Esercito è addetto un ufficio di segreteria che sarà formato volta per volta con ufficiali dello Stato Maggiore del Regio Esercito.
Art. 12.
Il Consiglio dell ' Esercito è l 'organo consulente del capo di Stato Maggiore Generale sulle più importanti questioni relative all'organizzazione, al funzionamento, alla mobilitazione dell'Esercito e alla difesa nazionale.
Art. 13.
Indipendentemente dalla consulenza del Consiglio dell'Esercito, il capo di Stato Maggiore Generale potrà consultare, per questioni di importanza eccezionale, i marescialli d'Italia ed il grande ammiraglio.
Art. 14.
Ogni qualvolta debban s i trattare questioni attinenti alla difesa delle coste e al coordinamento della preparazione e dell'impiego delle forze di terra e di mare, o questioni attinenti ad ordinamenti militari che possano interessare contemporaneamente oltre il Regio Ese rcito , anche la Regia Marina e la Regia Aeronautica (o una di queste), il Consiglio dell 'Esercito si riunirà in assemblea plenaria col Comitato degli Ammiragli e col Consiglio dell'Aeronautica (o con quello solo intere ssato di tali consess i) per deliberazione presa di concerto tra i ministri interessati.
Per la trattazione di determinate questioni potranno di volta in volta essere chiamati a far parte del Consiglio dell'Esercito, con voto consultivo, ufficiali del Regio Ese rcito , della Regia Marina e della Reg ia Aeronautica ed event ualmente funzionari di altri ministeri e personalità civili che abbiano speciale competenza in materia.
Art. 15.
Il Consiglio dell'Esercito è convocato dal capo di Stato Maggiore Generale ogni volta egli reputi necessario averne il parere. Il capo di Stato Maggiore Generale stabilisce gli argomenti da di sc utere e l'ordine dei lavori. Quando egli non possa interve nire alla seduta, la presidenza è assunta dal più elevato in grado o più anziano dei presenti.
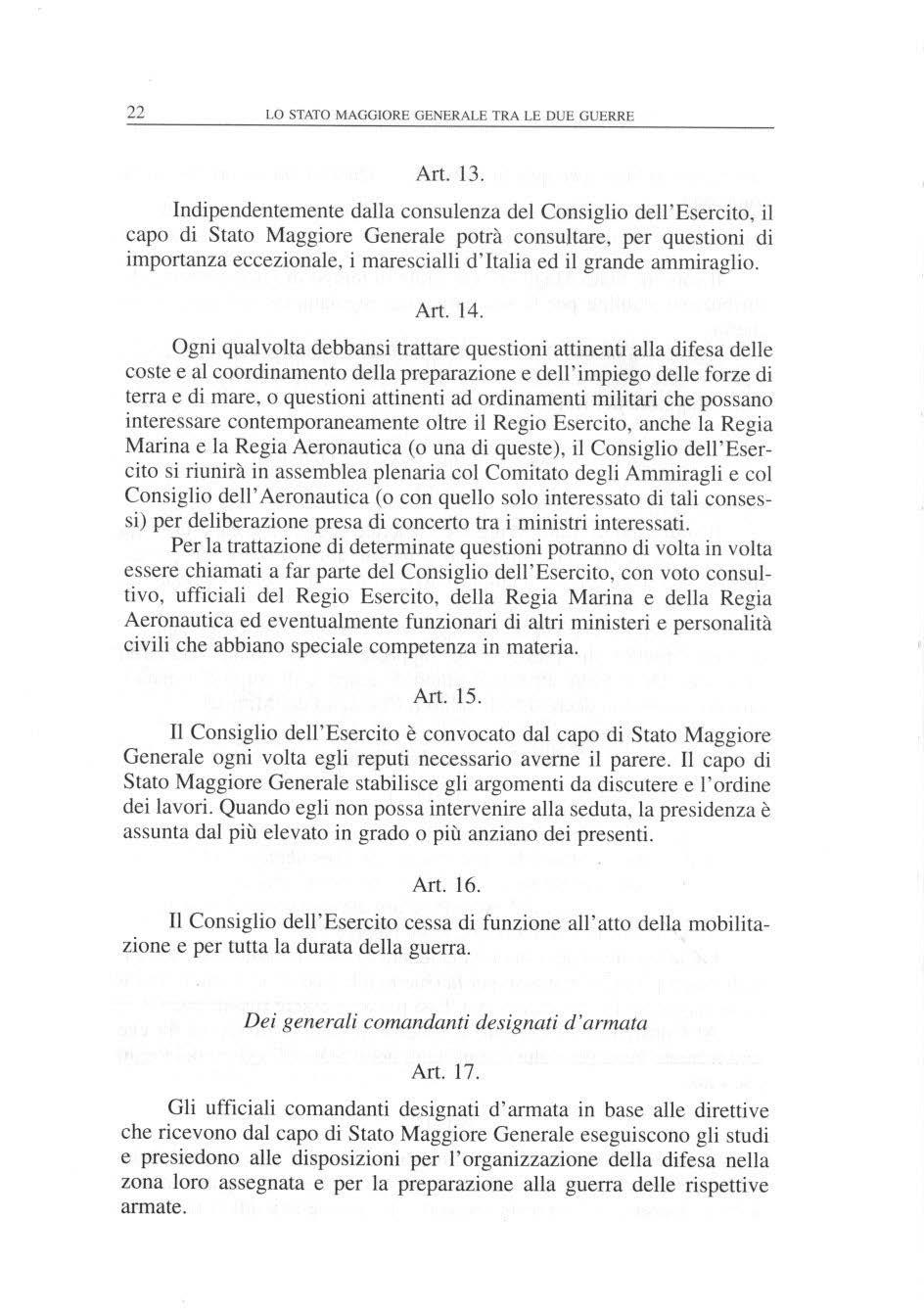
Art. 16.
Il Consiglio dell 'Esercito cessa di funzione ali' atto della mobilitazione e per tutta la durata della guerra.
Dei generali comandan ti designati d'armata
Art. 17.
Gli ufficiali comandanti designati d 'armata in base alle direttive che ricevono dal capo di Stato Maggiore Generale eseguisco no gli studi e presiedono alle disposizioni per l 'o rganizzazione della difesa nella zona loro as segnata e per la preparazio ne alla guerra delle ri s pettive armate.
Essi svolgono inoltre azione ispettiva sulla preparazione dei quadri e delle truppe delle grandi unità territoriali poste alla loro dipendenza, su ll 'efficienza dei se rvizi e sulle predisposizioni di mobilitazione delle unità stesse.
Di simpegna no inoltre quegli eventuali incarichi che sono loro affidati dal ministro per la Guerra o dal capo di Stato Maggiore Generale.
Art. 18.
L'ordinamento dello Stato Maggiore del Regio Esercito è stabilito con decreto reale su proposta del ministro per la Guerra, udito il capo di Stato Maggiore Generale.
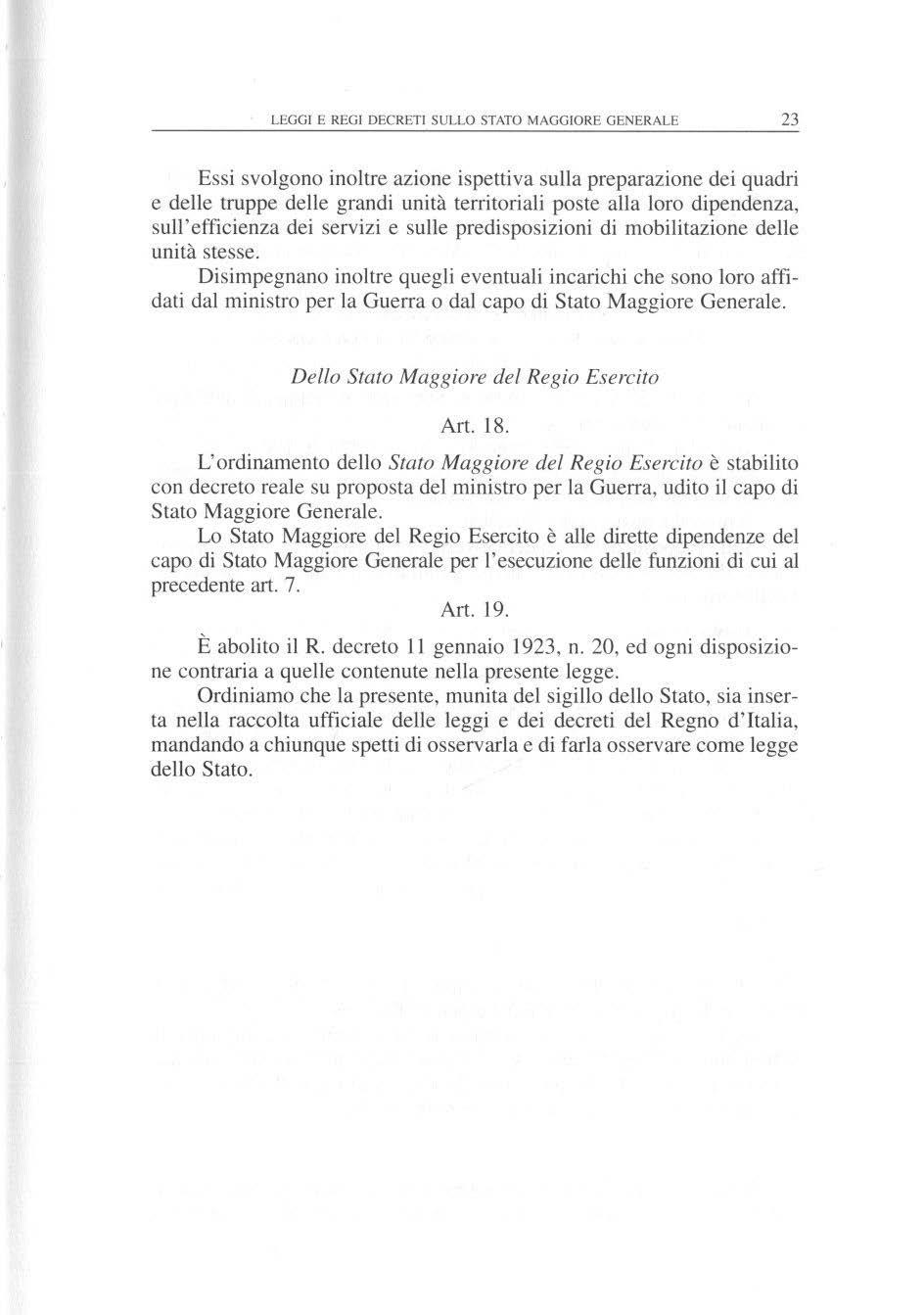
Lo Stato Maggiore del Regio Esercito è alle dirette dipendenze del capo di Stato Maggiore Generale per l'esecuzione delle funzioni di cui al precedente art. 7.
Art. 19.
È abolito il R. decreto 11 gennaio 1923, n. 20, ed ogni disposizione contraria a quelle contenute nella presente legge.
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del R egno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
N. 89. - LEG GI E DECRETI RIFLETTENTI JL SERVIZ IO GENERALE DELLO STATO . - R. decreto-legge n. 68 che istituisce la carica di capo di Stato Maggiore Generale e ne determina le attribuzioni. - ( Gabinetto). - 6 febbraio l 927 - Anno V. - (Gaz;,etta ufficiale n. 30 del 7 febbraio 1927 -Anno V).

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NA710NE RE D' ITALIA
Vista la legge 8 giugno 1925, n. 866, s ull'ordinamento dell ' Alto Comando del Regio Esercito;
Visto r art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta la necessità urgeme ed assoluta di provvedere in merito all'ordinamento de11' Allo Comando predetto;
Sentito il Consig li o dei Mini stri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Mini stro Segretario di Stato e Mini stro Segretario di Stato per gli affari della Guerra, della Marina e dell ' Aeronautica;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Art. I.
La carica di capo di Stato M aggiore Generale è istituita allo scopo di assicurare il coo rdin amento nell'organizzazione militare dello Stato.
li capo d i Stato Maggiore Generale è scelto tra i maresc ialli d' Italia cd i grandi ammiragli o fra i generali di armata (o generali comandanti designati di armata) e gli ammiragli d'armata, ed è nominato con decreto reale, udito il Consiglio dei Mini s tri. Egli è il consulente tecnico del capo del Governo per quanto concerne la coordinazione della sistemazione difen siva dello Stato e dei progetti per eventuali operazioni di guerra
Art. 2.
Per l 'ese rcizio delle sue funzioni il capo di Stato Maggiore Generale dipende direttamente dal capo del Governo.
E gli fa parte, con voto consultivo, della Commissione Suprema di Difesa nonché di ogni commissione s traordinaria che s ia co n vocata dal Governo per lo studio di questioni riflettenti la difesa dello Stato, nelle quali s iano interessate due o più delle forze armate.
Art. 3.
li capo di Stato Maggiore Generale propone al capo del Governo le disposizioni per la coord in azione della sistemaz ione difensiva dello
Stato. Tali disposizioni vengono trasmesse dal capo del Governo ai ministri intere ss ati.
Art. 4.
Il capo di Stato Maggiore Generale propone al capo del Governo le linee generali del piano complessivo di guerra con la specificazione dei compiti di massima spettanti a ciascuna forza armata per il raggiungimento degli obiettivi comuni a due o più di tali forze. Queste diretti ve vengono, dopo l'approvazione, comunicate dal capo del Governo ai minis tri che le rimettono ai capi di Stato Maggiore delle forze armate perché le rendano esecutive nella compilazione dei piani relativi a ciascuna forza armata.
Art. 5.
Il capo di Stato Maggiore Generale esercita il coordinamento della preparazione militare delle forze armate:

l O proponendo al capo del Governo , dopo aver consultato i capi di Stato Maggiore delle forze armate, i programmi delle esercitazioni combinate fra due o più forze armate dello Stato ; 2 ° assistendo alle predette esercitazioni combinate e riferendo sul loro in s ieme al capo del Governo , che, per il tramite d ei rispettivi ministri, farà conoscere le proprie osservazioni e deci s ioni ai capi di Stato Maggiore delle forze armate.
Art. 6.
Nell'esercizio delle s ue funzioni il capo di Stato Maggiore Generale corrisponde coi capi di Stato Maggiore delle singole forze armate per il tramite dei rispettivi Mini s teri.
Art. 7 .
Il capo di Stato Maggiore Generale è tenuto al corrente dal capo del Governo della s ituazione politica per tutto quanto po ssa intere ss are l'esercizio delle sue attribuzioni.
I Ministeri della Guerra , della Marina e dell ' Aeronautica terranno i l capo di Stato Maggiore Generale al corrente dei principali argomenti che riguardano l'efficienza bellica delle rispettive forze.
Art. 8.
Il capo di Stato Maggiore Generale è consultato dal capo del Governo sulle principali questio n i mi litari coloniali.
Art. 9.
Il capo di Stato Maggiore Generale sarà tenuto continuamente al corrente degli elementi della situazione generale militare estera per cura del servizio informazioni militare , il quale rimane alla dipendenza del Ministero della Guerra, pur rimanendo sempre devoluto a ciascun capo di Stato Maggiore delle forze armate il coordinamento e la raccolta delle informazioni di carattere tecnico.
Art. 10.
Per l'esercizio delle sue attribuzioni il capo di Stato Maggiore Generale dispone di un proprio ufficio retto da un colonnello del Corpo di Stato Maggiore del Regio Esercito (o da ufficiale di grado corrispondente della Regia Marina o della Regia Aeronautica).
L'ufficio è composto complessivamente di sei ufficiali s celti fra quelli delle diverse forze armate.
Detti ufficiali sono compresi fra quelli stabiliti nelle tabelle organiche previste dalla legge di ordinamento di ciascuna forza armata , e s ono designati per ciascuna di tali forze dal rispettivo ministro.
Art. 12.
Gli asseg ni ed ogni altra competenza per il capo di Stato Maggiore Generale sono a carico del bilancio della forza armata cui egli appartiene: così pure tutte le spese per il suo ufficio.
Gli assegni per il personale addetto all'ufficio medesimo sono a carico del bilancio delle singole forze armate alle quali detto personale rispettivamente appartiene.
Art. 13.
È abrogata la legge 8 giugno 1925 , n. 866, sull'ordinamento dell ' Alto Comando del Regio Esercito ed ogni altra disposizione contraria al presente decreto.

Il presente decreto entra in vigore dal I O febbra io 1927, e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.
Ordini amo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Circolare N. 129. - LEGGI E DECRETI RTFLEITENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. - Legge n. 1989. -Modificazioni al 2 ° co mma dell'art. I del R. decreto-legge 6 febbraio 1927, n. 68, circa la scelta del capo di Stato Maggiore Generale. - (Gabinetto; Segreteria militare). - 28 dicembre 1933-Anno XII. - (Gazzetta ufficiale n. 36, del 13 febbraio 1934 - Anno XII).
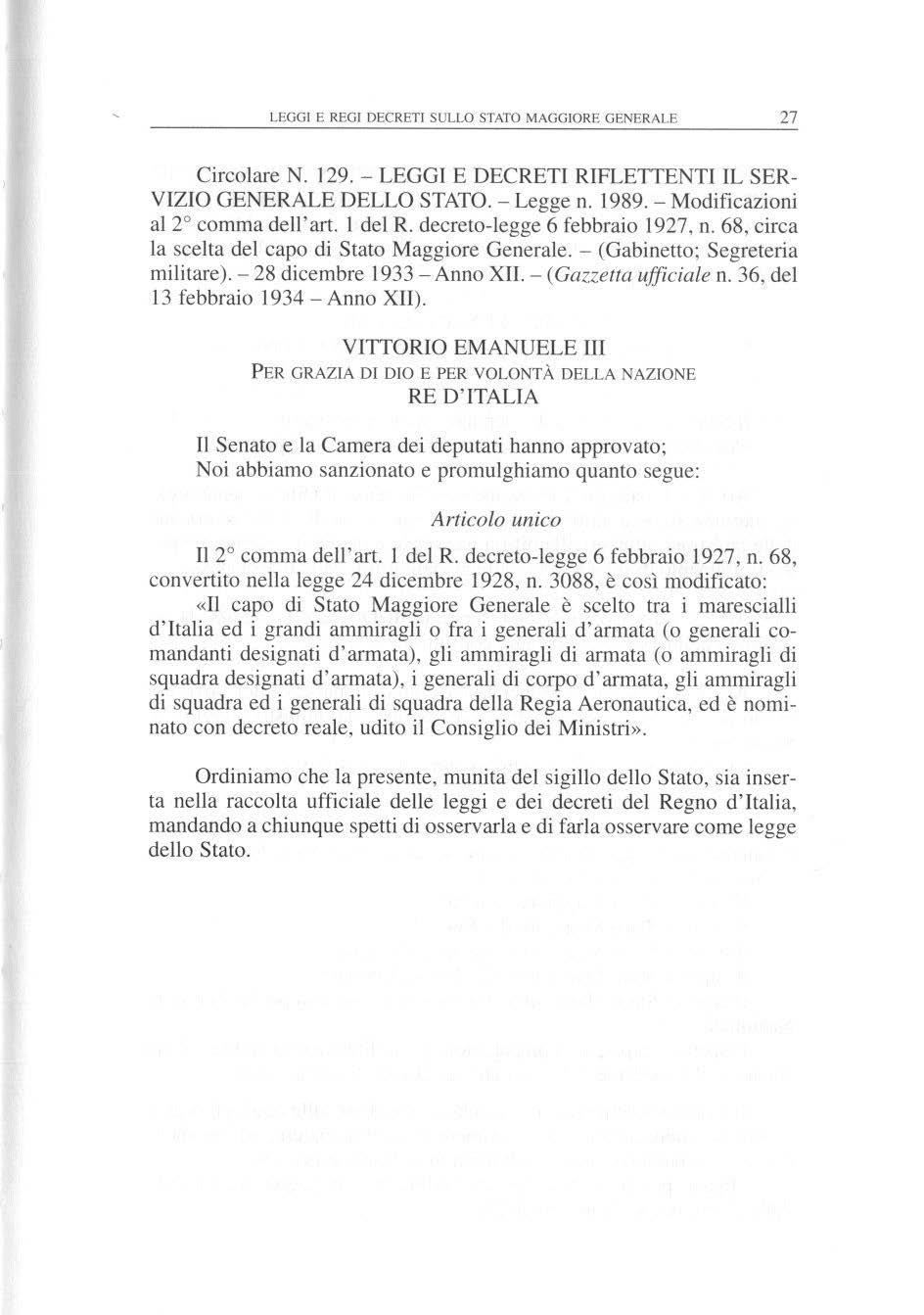
P ER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D' ITALIA
Jl Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
Articolo unico
Il 2 ° comma dell'art. 1 del R. decreto-legge 6 febbraio 1927, n. 68, convertito nella legge 24 dicembre 1928, n. 3088, è così modificato: «Il capo di Stato Maggiore Generale è scelto tra i marescialli d'Italia ed i grandi ammiragli o fra i generali d'armata (o generali comandanti designati d'armata), gli ammiragli di armata (o ammiragli di sq uadra designati d'armata), i generali di corpo d'armata, gli ammiragli di squadra ed i generali di squadra della Regia Aeronautica, ed è nominato con decreto reale, udito il Consiglio dei Ministri».
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, s ia in serta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
N. 392. - LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. - Legge n. 806 - Modificazioni all'ordinamento della Commissione suprema di difesa. - (Gabinetto). - 30 marzo 1936 - Anno XIV. - (Ga zz etta ufficiale n. 112, del 14 maggio 1936 - Anno XIV).
P E R GR AZIA DI DIO E PER VOLONT À DELLA NAZIONE RE D ' ITALIA
Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato ; Noi abbiamo s anzionato e promulghiamo quanto segu e :
Art. 1. - È istituita la Commissione Suprema di Difes a, quale organo interministeriale, allo s copo di coordinare lo s tudio e la ri s oluzione delle questioni attinenti alla dife s a nazionale e di stabilire le norme per lo s fruttamento di tutte le attività nazionali ai fini della difes a stess a.
Art. 2. - La Commi ss ione Supre ma di Difes a è co s tituita da un comitato deliberativo e da organi con s ultivi.
Art. 3. -Il Comitato deliberativo è composto dal capo del Gove rno , primo ministro segretario di Stato, presidente , e dai mini s tri segretari di Stato, membri.
Vi intervengono, quali membri con voto con sultivo:
il segretario del Partito Nazionale Fascista;
i marescialli d'Italia, i grandi ammiragli ed i marescialli dell'Aria, fin quando non raggiungano il limite di età stabilito per la loro di s pen sa da ogni onere di impiego o di servizio;
il capo di Stato Maggiore Generale;
il capo di Stato Maggiore del Regio Esercito;
il capo di Stato Maggiore della Regia Marina;
il capo di Stato Maggiore della Regia Aeronautica;
il capo di Stato Maggiore della Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale;
l'ispettore capo per la preparazione premilitare e post-militare della Nazione; il presidente del Comitato per La mobilitazione civile.
II Comitato deliberativo formula le questioni sulle quali gli organi consultivi sono chiamati ad esprimere il proprio parere, ed emana le decisioni concernenti i provvedimenti di carattere esecutivo.
Organo per la notifica dei provvedimenti è la Segreteria generale della Commissione Suprema di Difesa.
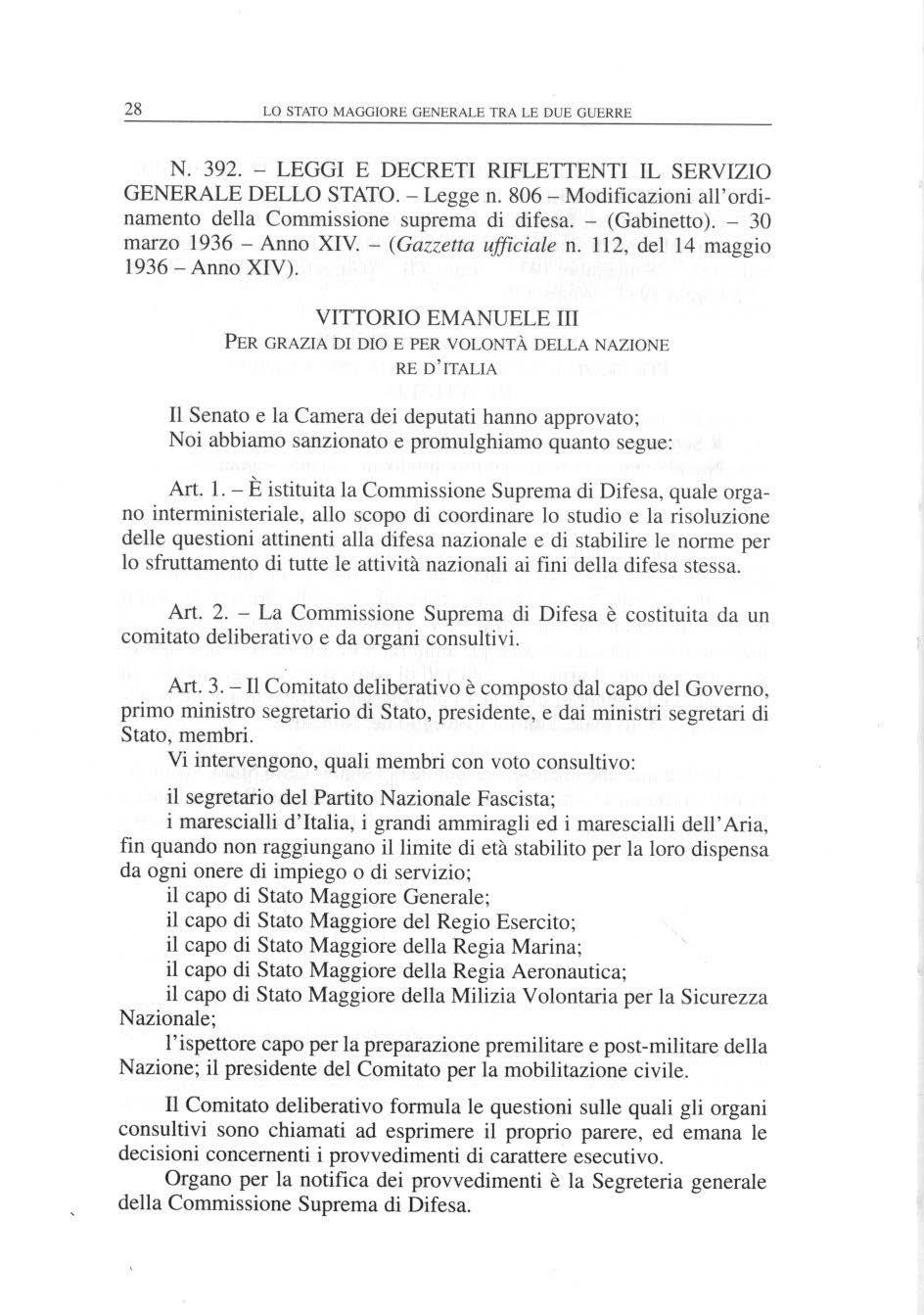
Art. 4. - Sono organi consultivi della Commissione Suprema di Difesa, ciascuno, per le questioni attinenti alla rispetti va competenza:

a) il Consiglio dell'Esercito;
b) il Comitato degli ammiragli;
c) li Comitato tecnico di aeronautica;
d) il Comitato per la mobilitazione civile.
Art. 5. - La Segreteria generale, in base agli ordini ricevuti dal presidente della Commissione, raccoglie e coordina le questioni che devono essere sottoposte agli organi consultivi e quindi al Comitato deliberativo e notifica ai vari ministeri le decisioni del Comitato medesimo.
La Segreteria generale è retta da un ufficiale superiore di Stato Maggiore del Regio Esercito o della R egia Marina o della Regia Aeronautica e vi sono addetti tre ufficiali superiori, rispettivamente comandati dai Ministeri della Guerra, della Marina e dell'Aeronautica. Essa è posta alle dipendenze amministrative della presidenza del Consiglio dei Ministri.
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato , sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia , mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
N. 662. - LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO - Legge n. 1193. - Organizzazione bellica delle terre italiane d'oltremare. - (Gabinetto). - 26 luglio 1939Anno XVII. - Ga ue tta ufficiale n. 198 , del 25 agosto 1939 - Anno XVII).

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLO NTÀ D ELLA NAZIO N'E RE D ' ITALIA E DI ALBANIA IMPERATORE D 'ETIOPIA
Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato; Noi abbiamo sanz ionato e promulghiamo quanto segue:
Art. 1.
La preparazione bellica delle terre italiane d'oltremare spetta al capo di Stato Maggiore Generale, presi gli ordini dal Duce e sentito il Ministero dell'Africa Italiana.
Le direttive conseguenti sono impartite ai capi di Stato Maggiore dell'Esercito, della Marina e dell ' Aeronautica, ai quali spetta - per mandato del capo di Stato Maggiore Generale - il compito esecutivo della preparazione alla guerra nelle rispettive sfere d'azione.
Art. 2.
I comandi superiori delle forze armate ricevono direttive:
per operazioni di polizia ed esigenze di ordine interno , dai rispettivi governi generali;
per la preparazione alla guerra, dai capi di Stato Maggiore dell' Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, in collegamento col Ministero dell'Africa Italiana;
per lo svolgimento di operazioni di guerra, direttamente dal capo di Stato Maggiore Generale che ne terrà informato il Ministero dell'Africa Italian a.
Art. 3 .
I mezzi finanziari di carattere straordinario stabiliti per la preparazione alla guerra e per lo svolgimento delle operazioni nei territori dell'Africa Italiana sono assegnati direttamente al bilancio del Mini stero dell'Africa Italiana e successivamente ripartiti in appositi stanziamenti del bilancio del Ministero medesimo e di quelli dei governi dell'Africa Italiana distintamente per ogni fo rza armata.
I mezzi finanziari di carattere ordinario riflettenti l'efficienza delle forze militari terrestri dei territori dell'Africa I taliana sono stanziati nei bilanci dei rispettivi governi.
Fanno eccezione i mezzi finanziari di carattere ordinario e straordinario interessanti Je unità dell'esercito metropolitano dislocate in Libia e quelle per l 'o rganizzazione difensiva e logistica del territorio della Libia stessa che sono assegnati al bilancio del Ministero della Guerra, nonché i mezzi finanziari di carattere straordinar io relativi all 'efficienza delle forze aeree della Libia, che sono assegnati al bilancio del Ministero del1' Aeronautica.
1 mezzi finanziari di carattere ordinario riflettenti l 'e fficienza delle forze marittime ed aeree dei territori dell'Africa Italian a sono stanziati, ri s pettivamente, nei bilanci dei Ministeri della Marina e dell ' Aeronautica ai quali il Ministero del!' Africa I taliana corrisponde i contributi stabiliti con particolari norme od accordì.
L'entità d eg li stanziamenti di cui al primo comma del presente articolo viene valutata dai Mini s teri militari competenti d'inte sa con i Ministeri d ell' Africa Italiana e delle Finanze.
Art. 4.
Il mini stro per le Finanze è autorizzato a provvedere con proprio decreto alle variazioni di bilancio occorrenti per l'esecuzione della presente legge.
Art. 5.
Sono abrogate tutte le v igenti dispo s izioni in contrasto con quelle della presente legge.
Disposizioni transitorie
Art. 6.
Le disposizioni della presente legge saranno applicate nei territori dipendenti dal Ministero dell'Africa Italiana dalle date che saranno stabilite con decreto del duce del Fasc is mo, capo del Governo . Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato , sia inserta nella Raccolta ufficiale delle legg i e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

N. 666. - LEGGJ E DECRETI RIFLETTENTJ lL SERV IZ IO
GENERALE DELLO STATO. - Leg ge n. 1178. - Aggiornamenti al R decreto-legge 6 febbraio 1927-V, n. 68, relativo alle attribuzioni del capo di Stato M aggiore Generale. - (Gab in etto). - 24 agosto 1939 - Anno XVI I. -(Ga zze tta ufficiale n. 197, del 24 agosto 1939-Anno XV II ).
PLR GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA E DI AL BANIA IMPERATOR E D ' ETIOPIA
Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro commissioni legislative, hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo, quanto segue:
Art. 1
L'art. l del R . decreto-legge 6 febbra io 1927-V, n. 68, che istitu ìsce la carica dì capo dì Stato Maggi ore Generale e ne determina le attribuzioni, convertito in legge con la legge 24 dicembre 1928-V ll , n. 3088. è sostituito dal segue nte:

« La carica di capo di Stato M aggiore Generale è istituita allo scopo di assicurare il coordinam en to nell 'organ izzazio ne militare dello Stato e delle terre italiane d'oltremare.
« Il capo di Stato Maggiore Generale è scelto tra i marescialli d' I talia, i grandi ammiragli e i marescialli dell'aria o fra i ge nerali d'armata (o generali comandanti designati d'armata), gli ammiragli d'armata (o ammiragli di squadra designati d'armata), generali d'armata aerea (o ge nerali di squadra designati d'armata aerea), i generali di corpo d'armata, gli ammiragli di squadra e i ge neral i di squadra aerea, ed è nominato con decre to reale , udito il Consiglio dei Mini stri.
«Eg li è il cons ulente tecnko del capo del Governo per quanto concerne la coordinazione della sistemazio ne difensiva dell o Stato e delle terre italiane d'oltremare, nonché dei progetti per eventuali operazioni di guerra».
Art. 2.
Il secondo comma dell'art. 2 del predetto Regio decreto-legg e è sostituito dal segue nte:
« Egli fa parte, con voto co nsul tivo , della Commissione Sup rema di Difesa non ché di ogni Commissione straordinaria che sia co nvocata dal Governo per lo studio di questioni r iflette nti la difesa dello Stato e dell e
terre italiane, d'oltremare, nelle quali sia-no interessate due o più delle forze armate » .
Art. 3.
Nella prima parte dell ' art. 3 del precitato Regio decreto - legge , dopo la parola «Stato », è aggiunto quanto segue: << e delle terre italiane d'oltremare » .
Art. 4.
È abrogato l'art. 8 del R. decreto-legge 6 febbraio 1927 - V, n. 68. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato. sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
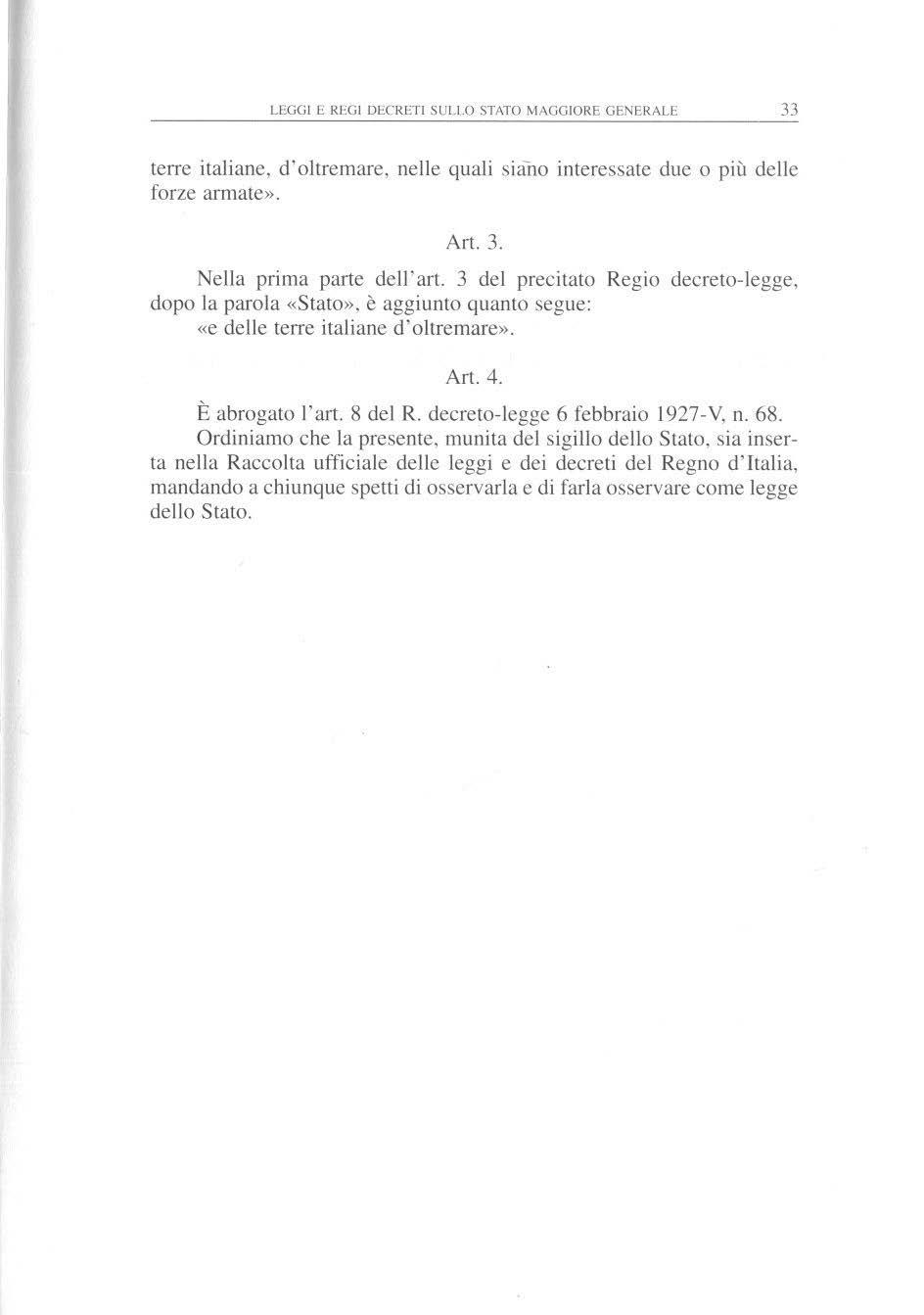



RELAT fVA ALLO STATO MAGG IORE GENERALE
Vengono qui elencati i principali testi (e le pagine specifiche) relativi all'ordiname n to e alla storia dello Stato Maggiore Generale.
F. Borrr, Comando unico e coordinamento intetforze nel pensiero militare italiano dei primi anni venti, in « I nformazioni Parlamentari Difesa», n. 8-9, 15 maggio 1984, pp. 74-77.
F. Borrr e V. I LARI, // pensiero militare italiano dal Primo al Secondo dopoguerra, Stato Maggiore Esercito - Ufficio Storico , Roma 1982 (pp. 70 -78, il prob lema del comando unico e del coordinamento interforze).

E. CANEVARI, La guerra italiana retroscena di una disfatta, 2 volumi , Roma 1948 (voi. I , pp. 148-51, 157-64, 176-77, 200, 206, 210-11, 242-43, 548-50, 594-99).
L. CEVA, Costituzione e fun-;,ionamento del comando dell'Esercito dal 1918 al 1943, pp. 167 -223, in Il problema dell ' alto comando dell'Esercito italiano dal Risorgimento al Patto atlantico, atti del convegno indetto dalla Società Solferino e S. Martino - 18 e I 9 settembre 1982, Stato Maggiore Esercito - Ufficio S torico, Roma 1985.
ID., La condotta italiana della guerra - Cavallero e il Comando Supremo 1941 -42. Milano 1975 (pp. 17-26).
Io., Le forze armare, Torino 198 1 (pp . 207-13, 249-54, 5 12-16).
I o .. Appunri per una s toria dello Stato Maggiore Generale fino alla vigilia della non belligeran-;,a (giugno 1925- luglio 1939), pp. 207-52, in «Sto r ia co n te m pora nea» a n no X, n 2, aprile 1979.
E. FALDELLA, L'Italia nella Seconda guerra mondiale - revisione di giudizi, B olog na 1959 (I' alto comando e i piani di guerra , cap. V, pp. 11962).
F. GELJCH , L'Alto comando delle FFAA. italiane . pp. 12 19 - 1249, 13611372, in <<Rivista militare>>, novembre 1946, anno IL n. 11.
L.E. LONGO, Francesco Saverio Gra z io/i, Stato M aggiore EsercitoUfficio Storico, R oma 1989 (pp. 359-7 1).
M. MONTANARI, L 'Esercito italiano alla vigilia della Seconda guerra mondiale, Roma 1982 (pp. 319-60).
P. P1ERI-G. RocH ,\T, Pietro Badoglio, Torino 1974 (pp. 538-54, 563-89, 737-70).
G. ROCHAT-G. MASSOBRIO, Bre1 ·e storia dell'Esercito italiano dal 1861 al 1943, Torino 1978 (pp. 204-68).
G. ROCHAT, L'Esercito italiano da Vittorio Veneto a Mussolini ( /9191925), Bari 1967 (pp. 564-75).
Io., Militari e poi itic i nella preparazione della campagna d'Etiopiastudi e documenti 1932-1936, Milano 1971 (pp. 59-61).

Stato Maggiore faercito - Ufficio Storico, L'Esercito italiano tra la 1 ° e la 2° Guerra mondiale, 1101•embre 1918-giugno /940, Roma 1954 (pp. 62-66. 76 e 77-78).
Io., In Africa settentrionale la preparazione al conflitto - l'avan za ta su Sidi El Barrani (ottobre 1935-sellembre 1940), Roma 1955 (pp. 4469).
F. STEFAN I, Storia della do/frina e degli ordi11amenti dell'Esercito italiano, volumi 1- lll , Stato Maggiore dell'Esercito - Ufficio Storico, Roma 1985-1989 (vo lum e 11 , tomo I 0 , pp. 76-79 e pp. 205-11 ).
DAL CAPO DI STATO MAGGIORE GENERALE
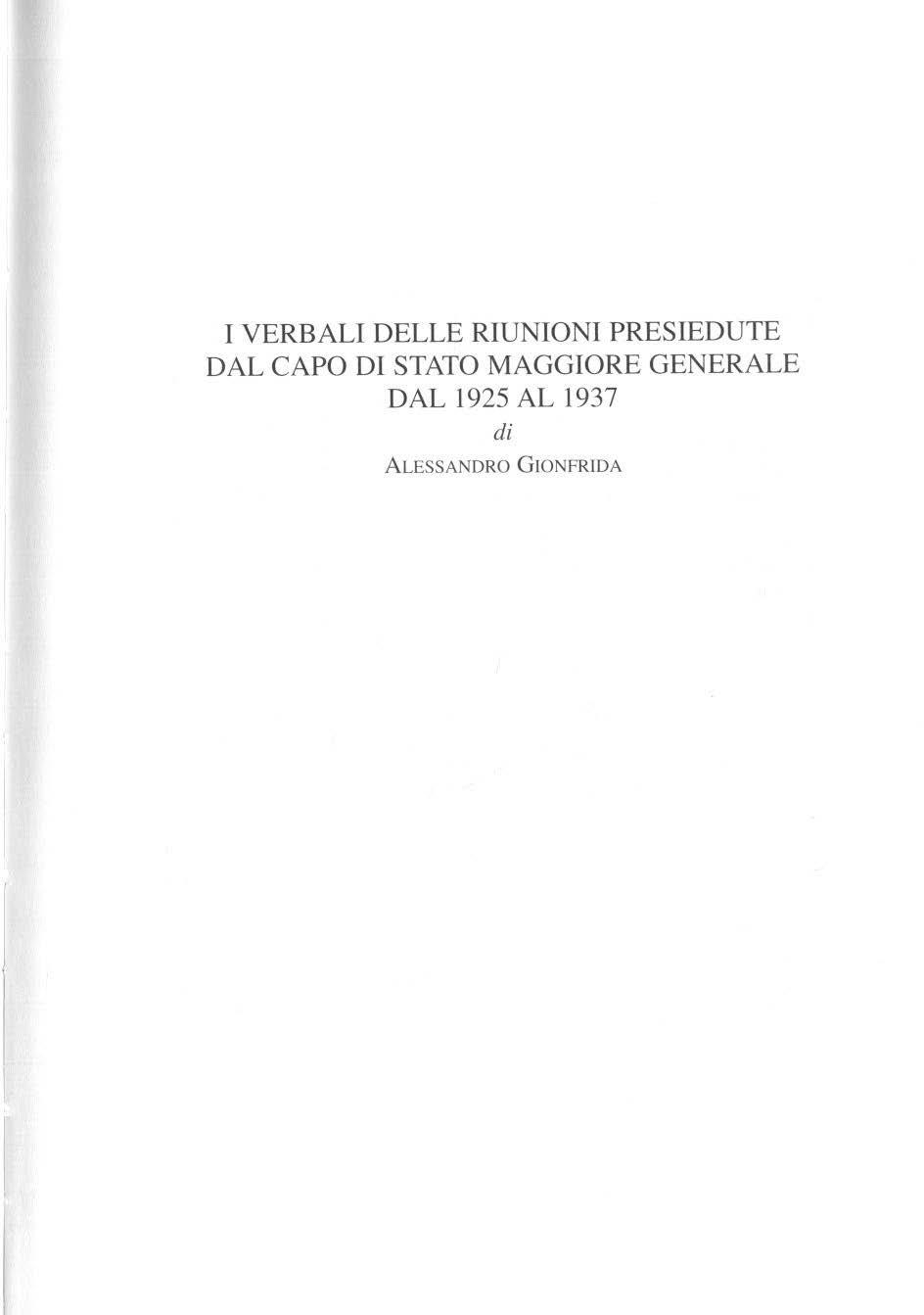
DAL 1925 AL 1937
di
ALESSANDRO GIONFRIDA

Una delle g randi novità della politica militare fascista fu l 'is tituz ione della carica di capo di Stato Maggiore Generale 1 , affidata il 4 maggio 1925 all'allora generale dell'Esercito e futuro maresciallo d'Italia Pietro Badoglio2 Que sti tenne l ' incarico, ininterrottamente, fino al 4 dicembre 1940.
Il capo di Stato Maggiore Generale, sia secondo la legge n. 866 dell'8 giugno 1925, che seco ndo il R. decreto-legge n. 68 del 6 febbraio 19273, aveva una moderata ma esplicita funzione di coordinamento interf'orze, che rappresentava un'assoluta novità nell'ordinamento militare italiano.
La legge n 866, infatti , sanciva che il capo di Stato Maggiore Generale era respon sa bile degli studi e delle disposizioni nece ssarie per coordinare la difesa dello Stato e i piani di guerra.
Egli poteva dare ai capi di Stato Maggiore della Marina e dell 'Aeronautica le direttive di base per il concorso di tutte le forze armate al raggiungimento degli obiettivi comuni. Per quelle attribuzioni il capo di Stato Maggiore Generale veniva a dipendere direttamente dal presidente del Con s igl io4 •
Anche nel R.D.L. n. 68 si ribadiva che <<la carica di capo di Stato Maggiore Generale è istitu ita allo scopo di assicurare il coordinamen to nell'organizzazione militare dello Stato»5 e che quell 'alto ufficiale, alle dirette dipendenze del capo del governo, come suo consulente tecnico , proponeva le direttive per l'organizzazione del sistema difensivo di tutto il territorio nazionale (difesa delle frontiere terrestri, difesa costiera, difesa aerea, ecc.)6, le linee generali del piano complessivo di guerra,
1 Sullo Stato Maggiore G e nerale, dr. la relat iva appendjcc bib liografica, pp. 37-38.
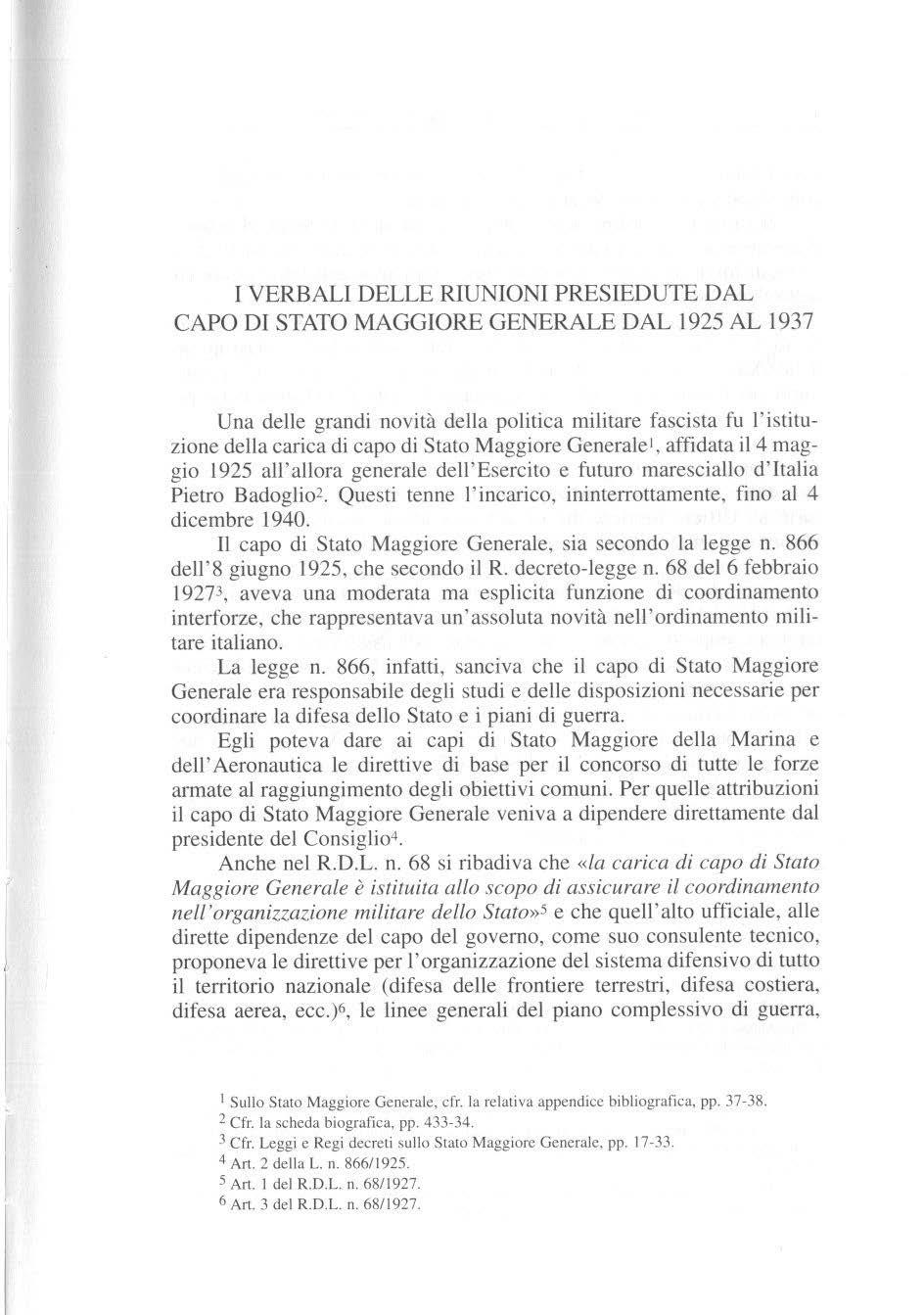
2 Cfr. la scheda biografica. pp. 433-34 .
3 Cfr. Leggi e Regi dec re ti s ullo Stato Maggiore Generale. pp. 17-33
4 Art. 2 del la L. n. 86611925.
5 Art. I del R.D.L. n. 68/1927.
6 Art. 3 del R.D.L. n. 68/1927
specificando i rispettivi compiti delle tre forze armate7 e le esercitazioni combinate tra Esercito, Marina e Aeronautica.
TI ruolo di coordinamento interforze del capo di Stato Maggiore Generale è documentato dalla serie dei verbali delle riunioni, dal I 925 al I 939, da lui presiedute e conservati presso l'archivio dell'Ufficio Storico dello Stato Maggiore dell'Escrcitos.
Nel fondo denominato H - 10 «Verbali riunioni 1924-1943», composto da 11 buste, si trovano appunto i verbali e le relazioni riassuntive delle riunioni tenute da Badog lio e dai suoi successori al Comando Supremo, nonché quelli del sottosegretario di Stato alla Guerra. del capo di Stato Maggiore del Regio Esercito e del capo del governo9
Dal punto di vista archivistico per l'H-10 non si può parlare di un vero e proprio fondo organico. cioè di un archivio unitario prodotto dal!' attività istin1zionalc di un enteio, il quale in seguito ha versato le sue carte ali' Ufficio Storico, ma di una raccolta di documenti (i verbali appunto). formata probabilmente in modo artificiale.
l documenti della serie H- IO appartengono a vari uffici dello Stato Maggiore del Regio Esercito (soprallulto all'Ufficio Operazioni) e all'Ufficio del capo di Stato Maggiore Generale, ma in quest'ultimo caso sembrano copie trasmesse da quest'ufficio all'Ufficio Operazioni. Copie dei verbali si trovano anche in altri fondi dell'archivio dell'Ufficio Storico e precisamente nel fondo D-1 «Cartef?gio sussidiario Africa orientale italiana; Guerra italo-etiopica, 1934-/936» (busta 13, fascicolo 3 e busta 198 ), formato dalla serie delle carte del Gabinetto del Ministero della Guerra, nel fondo H-9 «Ca rteggio del Capo del governo, 1926-/943» (busta 2. fascicolo 3), e nel fondo 1-4 «Carteggio dello Stato Maggiore Generale - Comando Supremo Stato Maggiore Difesa, I 924-1948» (busta 2, fascicolo I).

7 Art. 4 del R.D.L n. 68/1927.
8 Sul l'Ufficio Swrico e il suo archivio cfr.: Ministero della Guerra· Comando del Corpo di Staio Maggiore, l'Ufficio Swrim - ce1111i mo11ogr11Jici, a cura di C'. Cesari. Roma 1930: O Bo\io. l'Ufficio SI/Irico de/l'Esernto · 1111 fecola di s1orio11rafia mil1111re. Roma 1987: A. Brug1oni-M. Saporiti, Ma1111ole delle ricerche 11ell'U{ficio Stonco dello Stato Maggiore de/l'Eserdt<1, Roma 1987; E. Lodolini, Organizzazione e lefiisl11:io11e arC'hivistica italiu11a, Bologna 1989 (pp. 155-156); P. Bcrtinaria. l'Ufficio Storico dello Stato Magf/111re del/'faerdto. pp. JJ 36. in M B.C.A. · Pubblic.vioni degli Archi\ 1 di Stato. le fonti per la S111ria mililllrt' 1111/iana m t·tti co111empor1111ea · Atti del lii seminario. Rom11 16-17 d1n'mhre 1988, a cura di A. Arpino e A. 81agini, Città d1 Ca,1ello 1993.
9 1 verba l i del capo di Stato Maggiore Generale dal 1939 al 19-n e quelli del capo del gO\crno sono stati pubblicati dal I' lifficio Storico dello Stato Maggiore dell'Esercito a cura d1 A 81agim e I. Frauolillo ( Verbali delle riunioni 1e11111e dal capo di Sraro m,1.~f/111re Generale. voli. I- IV, Roma 1982 85).
IO Cfr. E. Lodolin1. Archivistirn principi e problemi, Milano 1990; P. Carucci. '"' fnmi 11rl'l1i1·isriche onliname11to e consen·a~ume. Roma 1990.
Dal punto di vista formale questi verbali 11 si presentano, secondo la normale prassi amministrativa, con l 'indicazione della data. del luo go dove si è svolta la riunione, dei presenti, dell'ora di apertura e di chiusura della stessa seduta e in maniera più o meno dettagliata sono riportati i singoli interventi (in forma indiretta) dei partecipanti. Di alcune riunioni non sono conservati i verbali ma solo delle brevi relazioni riassuntive in cui vengono indicati gli argomenti trattati e le relative conclusioni raggiunte.
Le Carte dell'Ufficio del capo di Stato Maggiore Generale
Oltre ai verbali delle riunioni un'altra importante fonte per ricostruire la storia dell'attività del capo di Stato Maggiore Generale dal 1927 al 1940 è sicuramente rappresentata dalle carte del suo ufficio, anche queste versate ali' Ufficio Storico dello Stato Maggiore dell'Esercito.
Nel 1925 fu costituita la carica di capo di Stato Maggiore Generale che incorporava anche quella di capo dello Stato Maggiore dell'Esercito in modo che il generale Badoglio aveva a disposizione tutti gli uffici appartenenti a quest'ultimo. Tracce dell'attività del capo di Stato Maggiore Generale dal 1925 al 1927 si trovano nel fondo L-1 O «Stato Ma ggiore del R egio Esercito - vari uffici». conservato sempre nell'Ufficio Storico.
Con il R.D.L. n . 68/1927 venne distinta la carica di capo di Stato Maggiore dell'Esercito, che ven ne ripristinata 12, da quella di capo di Stato Maggiore Generale, e fu creato un appos ito ufficio dipendente da quest'ultimo 13.
L'Ufficio del capo di Stato Maggiore Generale poteva essere retto da un co lonn ello del Corpo di Stato Maggiore o da un ufficiale di grado corrispondente della Marina o dell'Aeronautica e complessivamente era composto da sei ufficiali delle tre forze armate. Le funzioni di capo ufficio furono svo lte da colonnelli di Stato Maggiore scelti tra i migliori dell'Esercito: essi furono, dal 1927 al 1940, i colonnelli Alberto P onza di San Martino, Efisio Marras, Sebastiano Visconti Prasca, Ottavio Bo/Lea e Antonio Gandin 14 • Alle dirette dipendenze dei capi uffici c'era -
11 Cfr P Carucci, // dorn111e11to comempnraneo diplomatica e criteri di edizione. Roma 1987, p. 148.
12 R.D.L. n. 69 del 6 febbraio 1927.
13 Arr. 11 del R.D.L. n. 68/1927.
14 Cfr. le schede biografiche , pp. 437-446
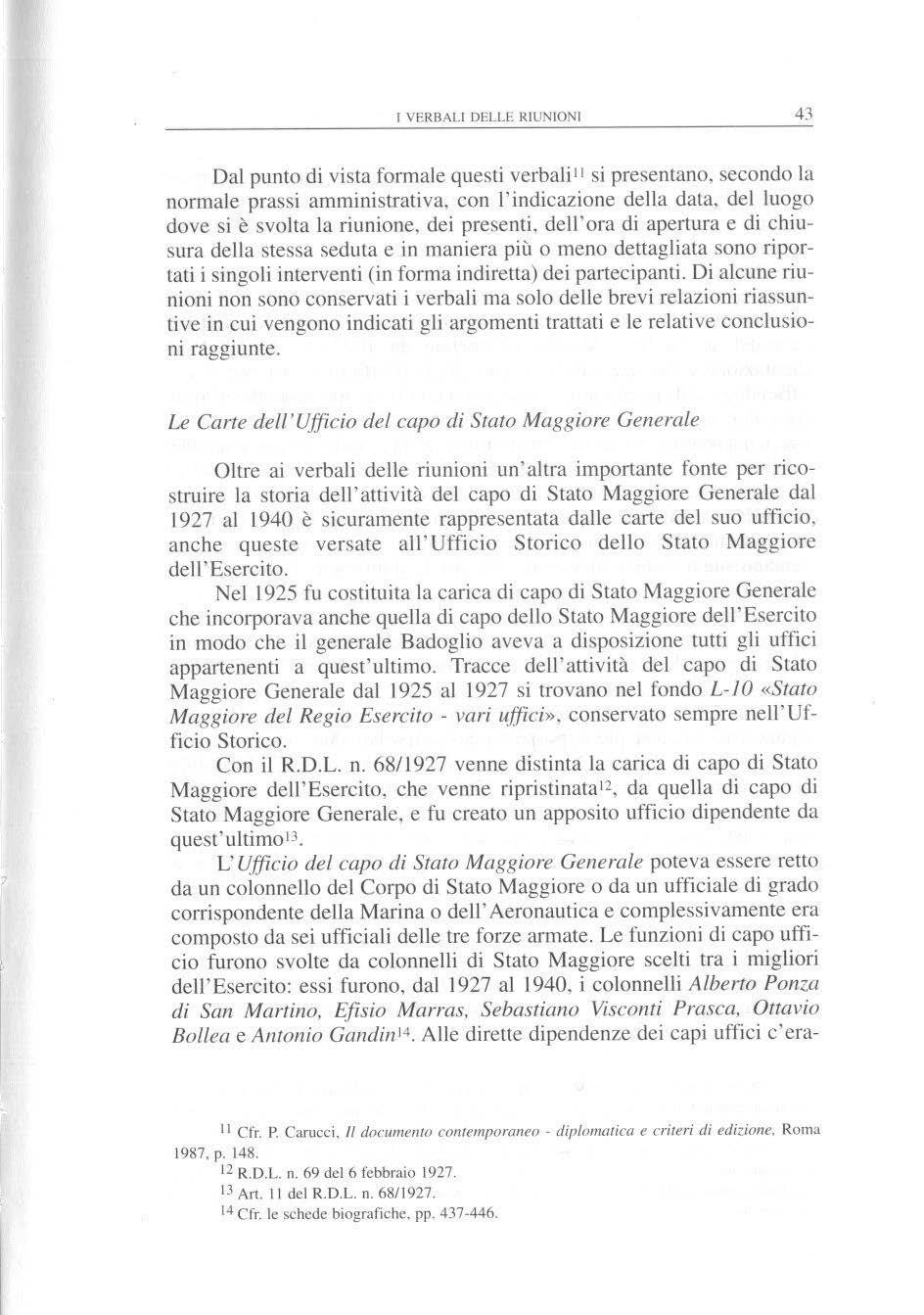
no in genere un capitano di vascello e un colonnello pilota i quali erano responsabili rispettivamente di due sez ioni, il primo della sez ione che si occupava delle que s tioni relative alla Marina , il secondo di quella competente per l'Aeronauticai s.
Nel fondo 1-4 « Cartegg io Stato Mag g iore Gen era le - Comando Supremo - Stato Ma gg iore Difesa , 1924-/948 "'» ( 76 buste), conservato nell'Ufficio Storico, si trovano parte delle car te dell'archivio dell'Ufficio del ca po di Sta to Maggiore Gen e rale. dal 1927 al 1940. La documentazione è formata dal carteggio tra quell'ufficio e vari enti (i vari uffici de gl i stati maggiori di forza armata, i Gabinetti dei mini s teri militari e del capo del governo, g li addetti militari, il Servizio Inform azioni, ccc.), ma so prattutto da num erosi promemoria e s tudi (s pe sso so no allegati s chiui e carte topografiche ) compilati dai capi uffi c i per lo s te sso Badoglio, nei quali sono trattate in modo conciso ma abbastanza esauriente le più importanti questioni del momento. Inol tre quasi lutti ques ti promemoria ri s ultano s ig lati per sona lmente da Badog lio e molti presentano sue annotazioni manoscritte con le dire ttive e decisioni da lui prese.
Conviene comunque esaminare le più importanti materie trattate in quelle carte. Es se sono essenzialmente tre: le questioni in erenti all'organizzazione delle forze armate, la situazio ne militare delle terre d ' oltremare e di alcuni Stati esteri
Una g ran parte dei promemoria e relél7ioni compilati per B adoglio riguardano infatti le più importanti questioni relative all'organizzazione militare italiana. Una di queste è rappresentata dal complesso dei problemi attinenti alla dife sa (contraerei. costiera, terre s tre): circolari dal 1927 al I 940 relative ai lavori per le fortificazioni permanenti alla frontiera (b usta 64, fascicolo 6), promemoria e carteggio s ull e esercitazioni di difes a aerea nel 1931-1932 , sulla milizia per la dife sa contraerei e da costa nel 1934, su l progetto del generale Nobili de l 1935-36, s ulla difesa contraerea degli obiettivi di intere ss e aeronautico nel 19 39 (busta 73 , fascicolo 2), sulla fortezza cost iera di M essina- R eggio Calabria nel 19 36- 39, s ull'organizzazione della difesa cos ti era e s ulla protezione delle vie di comunicazione nel 1936-39 (bu s ta 73, fascico lo 3), sulle s istemazio ne difen s iva della frontiera se ttentri ona le nel 19 38 (bus ta 69,

15 And1c qu i furono ~ce lti o llimi ufficia li; ricordiamo per la Marina Raffael e Dc C'ourten. allora capitano <li fregata e i l capitano <li vascello Gu,tavo Stro11cri, per l'Aeronautica il colonnello Vincenlo Magliocco.
l6 La storia di come questo fon<lo ,ia stato \Cn,a10 all'Ufficio Storico è abbaslanLa incerta. comu nqu e ,ccon do alcune no tizi e ri cav abili da un e le nco <lello fo ndo 1 -4. co nse rvat o p resso I' Uflìcio Storico, risu lta che quelle carte furono recuperate presso vari uflìc1 dello Staio Maggior.: <lcll'Eserci10.
fascicolo l ), e sulle frontiere occidentale e orientale nel 1938-40 (busta 5, fascicolo 3 e busta 69, fascicolo 7).
Numerose sono anche le carte relative alla leva, ai richiami per istruzioni di ufficiali, sottufficiali e truppa nel 1937-40 (busta 2, fascicolo 4 e busta 7, fascicolo l ), all'approntamento di alcune di visioni nel 1930-32 (busta 64, fascicolo 8) e di unità per l'Albania nel 1937-40 (busta 7, fascicolo 2) e infine ai provvedimenti di mobilitazione ordinati nel 1938 (busta 69, fascicolo 2).
Un problema ampiamente trattato relativo all'organizzazione delle nostre forze armate è quello sull'ordinamento dell'Esercito e in particolare sul riordinamento di grandi unità e loro impiego nel 1934, sull'educazione premilitare nel 1933-37 (busta 67, fascicolo 2), sulla riforma Pariani 17 nel 1938-39 (busta 4, fascicolo 5) e sull'ordinamento della Guardia a ll a frontiera nel 1938-40 (busta 6, fascicolo 9).
Ricordiamo anche la numerosa documentazione relativa agli studi sui piani di gue1Ta (contro la Jugoslavia isolata e contro la Jugoslavia e la Francia alleate, contro la Germania, ecc.), su lla mobilitazione (occulta, generale e periodo di sicurezza, studi sui relativi trasporti), sulla radunata e copertura (terrestre, alla frontiera est ed ovest, copertura ad opera dell'aviazione, copertura della Sardegna e della Sicilia), sulle manovre con i quadri, sulle regioni di confine, sulla esigenza ES progettata dalla Marina nel 1931 (sbarco a Durazzo e Valona), su un possibile sbarco ad Antivari 18 in funzione anti-jugoslava nel 1927 e in generale tutti gli studi riguardanti le operazioni svolte dagli stati maggiori delle tre forze armate dal 1929 al l 937 (busta 64, fascicoli 4, 5, 9 e 10; busta 65, fascicolo 4; busta 66, fascicoli 1, 3, 4, 8 e 12; busta 69, fascicoli 2, 6 e 7).

Ricordiamo ancora il carteggio relativo al funzionamento delle intercettazioni telegrafiche in tempo di guerra nel 1927 (busta 64, fascicolo 7), al Servizio chimico nel 1932-38 (busta 66, fascicolo 11 ) e sul Servizio informazioni presso le unità operanti e la sua unificazione nel S .l.M. (Servizio Informazioni Militare) del 1934 (busta 66, fascicolo 10).
In ultimo merita un particolare cenno uno studio, datato maggio J 933, sulla costituzione e funzionamento dell'Ufficio del capo di Stato
17 Sulle riforme di Alberto Pariani (capo di Staio Maggiore dell"Esercilo dal 1936 a l 1939 che portò ad una radicale modifica di 1ucto l'ordinamento dell"Esercito italiano con la trasformazione delle d ivisi oni su tre reggimenti di fanteria (ternarie). in divisione strutturate su due divisioni di fanteria (binarie), ricordiamo: M. Montanari, L "Esercito italiano alla vigilia della Seconda guerra mondiale, Roma 1982. pp . 9-30 .
18 Tra queste cane è co nse r vata anche una leuera (manoscritta) di Mussolini del 14-4-1927 sutropportuni tà dello sbarco e la relativa risposta di Badoglio del 28-4- 1927 (bus ta 64, fascicolo 5).
Maggiore Generale in caso di guerra, con uno schema del decreto e vari specchi annessi (busta 67, fascicolo 1).

TI secondo importante argomento è, come abbiamo detto, quello relativo alla situazione militare deJJe terre d'oltremare: Africa orientale, Isole dell'Egeo e la Libia.
Numerosi promemoria, relazioni e documenti vari (soprattutto dell'Ufficio militare del Ministero dell'Africa Italiana) riguardano appunto le operazioni di grande polizia coloniale e la situazione politico-militare e sanitaria dell'Africa orientale nel 1937-1940 (busta l, fascicolo 8; busta 2, fascicolo 2; busta 4, fascicoli 1 e 6; busta 6, fascicolo 6), il piano del generale Cavallero per la sistemazione del Goggiam nel 1938 (busta 4, fascicolo 4), la situazione delle forze presenti in colonia , la dislocazione dei comandi e delle truppe, l'ordinamento delle forze terrestri nel 1937-40 (busta 2, fascicolo 3; busta 4, fascicolo 2; busta 6, fascicolo I) , i dati relativi ai caduti nella guerra italo-etiopica (busta 1, fascicolo 11), un rapporto redatto dall'addetto militare U.S.A. nel 1936 (busta J, fascicolo 9) e le recensioni sulle numerose pubblicazioni della stampa estera e di alcuni autori stranieri nel 1937-38, relative sempre alla campagna italo-abissina (busta 3, fascicoli l e 2).
Di notevole interesse è anche il carteggio riguardante le isole italiane dell 'Egeo: i precedenti sull'organizzazione militare delle isole (idroscalo dell'Aeronautica e unità dell'Esercito a Lero) nel 1927-193 l , gli studi dello Stato Maggiore cieli' Aeronautica sulle funzioni strategiche del Dodecanneso e sull'organizzazione militare aerea, la memoria della Marina sul problema militare marittimo, sull'organizzazione aifensiva e offensiva delle isole e gli studi del Corpo di Stato Maggiore sull'organizzazione militare terrestre, tutti del 1936 , la questione relativa alla sistemazione del comando di tutte le forze dislocate nelle isole nel 1937, la difesa contraerei dei campi d'aviazione e le disposizioni relative al nuovo ordinamento militare dell 'Egeo conseguente alle decisioni adottate nella riunione del 26-2-1937, le esercitazioni di sbarco nel 1938 (busta 65, fascicolo 2), l'invio di unità navali nel 1938-39, e disposizioni sulla difesa delle isole nel 1940 (busta 5, fascicolo 1).
Particolarmente ampia è la serie dei promemoria e documentazione varia sulla Libia, in pai1icolare riguardanti l 'orga nizzazione militare e la difesa della base di Tobruk nel 1936-38 (busta 68, fascicolo 5), l'unificazione dei comandi d'arma e dei servizi nel 1938 (busta 5, fascicolo 11), i trasporti marittimi di mezzi e truppe in colonia e lo studio per il trasporto di un corpo di spedizioni in Africa settentrionale (documento Piano Radunata 12 dell'Esercito e della Aeronautica) nel 1939 (busta 6, fascicoli 2 e 3), i distretti militari in Libia nel 1939 (busta 6, fascicolo 7), la situazione delle forze, iI rapporto n. 42 I 2 del 2 marzo 1939 e n. 4494 del 13 giugno 1939 inviati da Badoglio a Mussolini sulla preparazione
bellica della Libia occidentale, le direttive di Badoglio ai capi di Stato Maggiore di carattere operativo in dipendenza della situazione internaLionale e per la preparazione bellica delle terre d'oltremare nel 1939-40 (busta 6, fascicoli 11 e 13), la sistemazione difensiva alle frontiere della Libia (con una memoria sullo stato della preparazione militare della Libia occidentale, in data 15 febbraio 1939, del Ministero Africa it aliana), le direttive per l'offensiva contro l'Egitto e in generale situazione militare della Libia (con allegati le sintesi generali del Comando Superiore Forze Armate in Africa settentr ionale dal 31 dicembre 1939 al 29 febbraio 1940) nel 1939-40 (busta 7, fasci col i 3, 4, 6 e 8).
La terza ed ultima questione trattata nelle carte dell'Ufficio del capo di Stato Maggiore Generale è quella relativa alla situazione politica e alla preparazione militare di alcuni Stati esteri. Numerosi promemoria, compilati sulla base dei notiziari mensili Stati esteri del Servizio Informazioni Militare, riguardano il Belgio nel 1938-1940 (busta 5, fascicolo 9), la Bulgaria nel 1938-39 (busta 5, fascicolo 8), la Cecoslovacchia nel 1938-39 (busta 5, fascico lo 7), il Sudan anglo-egiziano nel 1935-39 (busta 1, fascicolo 6), la Francia nel I931-40 (busta l, fascicoli 7 e 12; busta 3, fascicolo 4; busta 66, fascicolo 9; busta 69, fascicolo 3), la Gran Bretagna nel 1930-40 (busta 3 , fascicolo 5; busta 66, fascicolo 5), l'Iran nel 1938-39 (busta 5, fascicolo 2), la Ju goslavia nel 1939 (busta 6 , fascicolo 5), la Germania nel 1937-39 (busta 3, fascicolo 3) e la situazione in Alto Adige (busta 64, fascicolo 3), il ManciùKuo nel 1938 (busta 5, fascicolo 4), la P olonia nel 1938-39 (busta 5, fascicolo 6), la Romania nel 1927-39 (busta 1, fascicolo 2), la Svizzera nel 1930-39 (busta l, fascicolo 4), la Turchia e possibili azioni italiane in Ci li cia nel 1927 (busta 1, fascico lo I), l'Unione Sovietica nel l 93439 (busta I, fascicolo 3) e in ultimo l'Ungheria nel 1938-39 (busta 5, fascicolo I 0).
Ri cordiamo infine la serie dei promemoria sui più importanti avvenimenti politici e militari internazionali e relativi a più Stati nel 1936-40 (busta 1, fascicolo I O; busta 5, fascicolo 5; busta 6, fascicoli l O e 12; busta 7, fascico lo 5; busta 68, fascicolo 4) e quella riguardante le conferenze per il disarmo nel I 929-1932 (busta 65, fascico li I e 3; busta 66, fascicoli 2, 6 e 7; busta 69, fascicoli 4, 5 e 6).


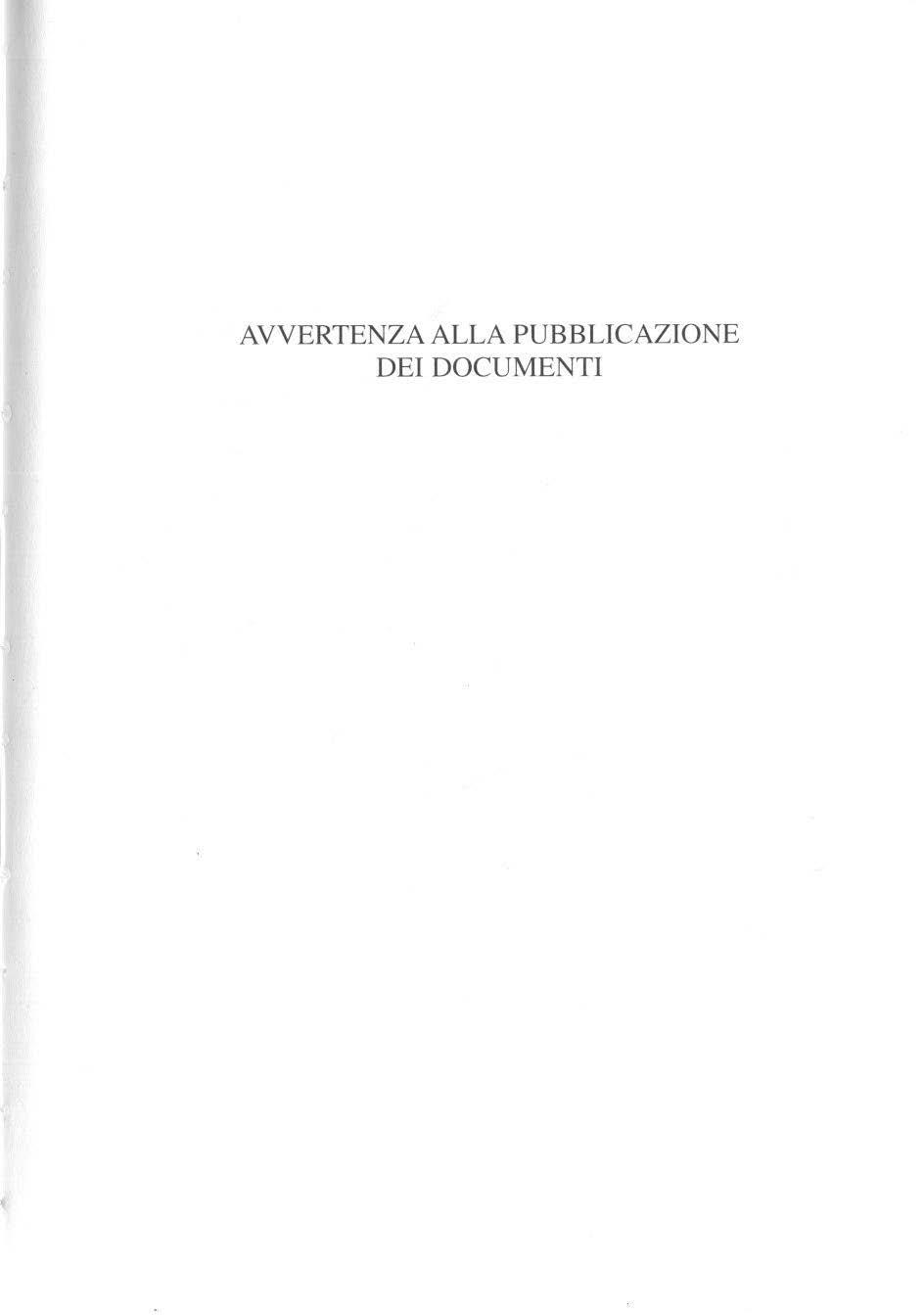

I documenti qui pubblicati, eccetto il verbale della riunione del 511-1936, sono tratti dai fondi dell'archivio del!' Ufficio Storico dello Stato Maggiore dell'Esercito (abbreviato in A.U.S.S.M.E.).
Essi sono corredati di una breve introduzione (in corsivo) in cui sono riassunti i principali argomenti trattati nelle riunioni.
Nella nota generale ad ogni documento viene indicato il fondo, la busta e il fascicolo di provenienza, oltre all'istituto, che, come si è detto, è sempre lo stesso.
Le note dell'apparato critico (in corsivo) sono contraddistinte dalle lettere del!' alfabeto latino, per differenziarle dalle note nel testo originale dei documenti, le quali, invece, sono indicate con le cifre arabe.
Nei verbali sono presenti molte abbreviazioni. Esse sono state sciolte ed elencate in un'apposita tavola.
In generale per i criteri di edizione questo lavoro si basa essenzialmente sulle indicazioni di P. Carucci in // documento contemporaneodiplomatica e criteri di edizione, Roma. 1987.


Sono qui elencate, in ordine alfabetico, le abbreviazioni che compaiono nel testo dei documenti pubblicati. Esse sono state quasi tutte sciolte basandosi su ll'opu scolo Segni convenzionali ed abbreviazioni del Ministero della Guerra, nelle edizioni del 1929, del 1935 (n. 2548) e del 1939 (n. 3487) 1 Alcune abbreviazioni, segnate con un asterisco(*), che non sono elencate nell'opuscolo sopracitato, sono state sciolte secondo la logica interpretazione del testo. TI significato dato non ha quindi un valore assoluto.
A., d' Arm. = armata, di armata
A.A. = arma aeronautica
a.a. = antiaerea
A.A. r.n. = arma aeronautica ruolo naviganti
A.C. = alto commissario per l'Africa orientale
accomp. = accompagnamento
Aeron. = Aeronautica
alp. = alpina
amm., ammir., ammiragl. = ammiraglio
A.O. = Africa orientale
A.O.I.= Africa orientale italiana
app. = apparecchio
art., artgl, artigl. = artiglieria
a.s. = antisommergibile
A.U., a.u. = austroungarico
A.U.S.S.M.E. = Archivio Ufficio Storico Stato Maggiore Esercito
aut., auton. = autonomo
B. , Brig., brig. = brigata
B.M. = bombardamento marittimo
bomb. = bombardieri
B.T. = bombardamento terrestre
1 Per le abbreviazioni in uso nel la R. Marina si è fatto riferimento alle tavole riportate nei Bolleuini d'Archivio de/l'Ufficin Storico d(,[/a Marina Miliwre del dicembre 1987 (anno I. n. 2, pp. 1921 ), del marzo-giugno 1989 (anno m, pp. 15-17) e del mano 1991 (anno V. pp. 13-14).

btg. = battaglione
btr. = batteria
btr. da pos. cost. = batteria da posizione costiera
C.A., C. d' A. , c. d'a., C. d'Arrn. = corpo d'annata
e.a., e/a = contraerea
camp. = campale
cann. = cannoni
cap. = capitano
cap. di V., C.V. = capitano di vascello
C.A.T. = contraerea territoriale
cav. = cavalleria
CC.NN. = camicie nere
CC.RR. = carabinieri reali
*C.D. = depositi centrali (documento n. 18)
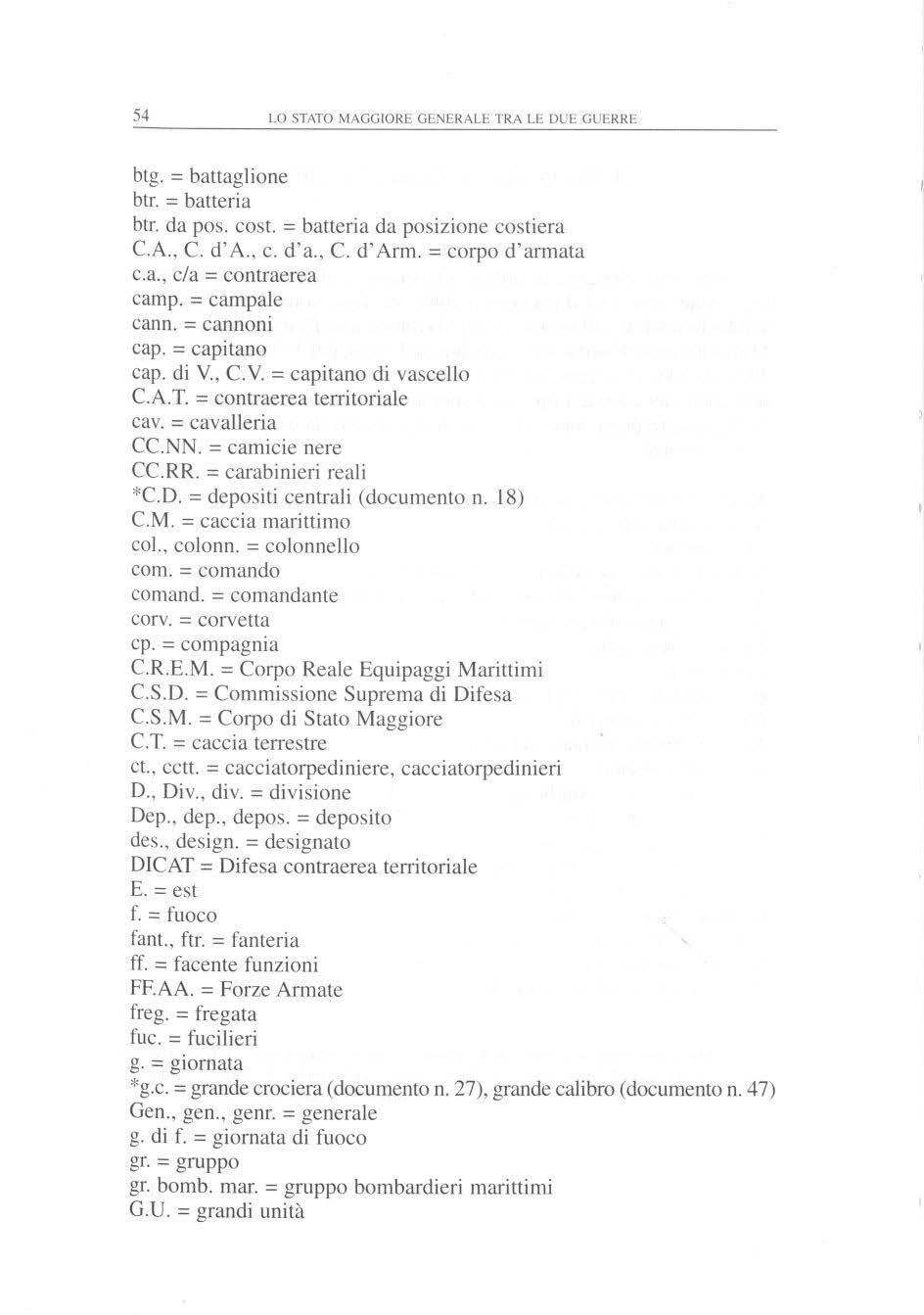
C.M. = caccia marittimo
col., colonn. = colonnello
com. = comando
comand. = comandante
corv. = corvetta
cp. = compagnia
C.R.E.M. = Corpo Reale Equipaggi Maiittimi
C.S.D. = Commissione Suprema di Difesa
C.S.M. = Corpo di Stato Maggiore
C.T. = caccia terrestre
et., cctt. = cacciatorpediniere, cacciatorpcdinieri
D. , Div. , div. = divisione
Dep., dep., depos. = deposito
des., design. = designato
DICAT = Difesa contraerea territoriale
E.= est
f.= fuoco
fant., ftr. = fanteria
ff. = facente funzioni
FF.AA. = Forze Annate
freg. = fregata
fuc. = fucilieri
g. = giornata
*g.c. = grande crociem (documento n. 27), grande calibro (documento n. 47)
Gen., gen., genr. = generale
g. di f. = giornata di fuoco
gr. = gruppo
gr. bomb. mar. = gruppo bombardieri marittimi
G.U. = grandi unità
inter. = interinale
LL.EE. = loro eccellenze
M. = Milizia
m. = mortai
*M.A. = magazzini delle armate (documento n. 18)

mar. = marittimi
* m.c. = mortai costieri (documento n. 44 e documento n. 47)
M. da COS = Milizia da costa
mg.= miglia
Mil. = militare
Minist. = ministero
Ministero LL.PP. = Ministero lavori pubblici
M.M., MM.= militare marittimo
M.O. = mobilitazione occulta
Mob. , mob. = mobilitazione
Mod. , mod. = modello
mont. = montagna
mitr., mitragl., mitrgl. = mitragliatrice, mitraglieri
M.V.S.N. = Milizia Volontaria di Sicurezza Nazionale
O. = orienta le
O.M. = o lt remare (spedizione oltremare)
Op., op., operaz. = operazioni
Ord., ord., ordin. = ordinamento
P. B. = preda bellica
P.C. = pesante campale
* (batterie di) p.c. = posizione costiera (documento n. 47)
pl. = plotone
pos. cost. = posizione costiera
p. v. = prossimo venturo
R ., RR. = regio, regi
R.A. = R egia Aeronautica
R.C.T.C. = R egio Corpo Truppe Coloniali
R.E. = Regio Esercito
rep. = reparto
R.G. = riparazioni di guerra
R.G.F. = Regia Guardia di Finanza
rgt. = reggimento
ricogn. = ricognitori
r.l. = ricognizione lontana
R.M. = ricognizione marittima (vedi sotto sq. aut. R.M.)
R.M . = Regia Marina
R.T. = radiotelegrafi, radiotelegrafica
s. capo, sottoc. = sottocapo
S.E. = sua eccellenza
Sez. o sez. = sezione
S.H.S. = serbo -croato-sloveno (Jugoslavia)
S.l.M. = Servizio Informazioni Militare
S.M., SS.MM. = Stato Maggiore, Stati Maggiori
S.M. per la Dif. Terr. = Stato Maggiore per la Difesa territoriale
S.M.G. = Stato Maggiore Generale
S.M.R.A. = Stato Maggiore Regia Aeronautica
S.M.R.E. = Stato Maggiore Regio Esercito
S.M.R.M. = Stato Maggiore Regia Marina
S.p.e. = serv i zio permanente effettivo
sq. = squadra
sq. aut. C.M. = squadra autonoma caccia marittima
sq. aut. R.M. = squadra autonoma ricognizione marittima
SS., S.S.S., S. Segretario= sottosegretario di Stato
T. col., T. colon., ten. col. = tenente colonnello
Ten., T. = tenente
T.M = territoriale mobile
Tonn., tonn., T., t. = tonnellate
T.S.L. = tonnellata stazza lorda
Uff., uff. = ufficio
Uff. Piani Op. S.M. R. Marina = Ufficio Piani cli Operazioni Stato Maggiore Regia Marina

u.s. = ultimo scorso
V. = Veglia (spediz ione oltremare Zara e Veglia)
V.A., V. = Veglia Arbe (spedizione oltremare)
Z. = Zara (spedizioni oltremare Zara e Veglia)
W., w. = ovest
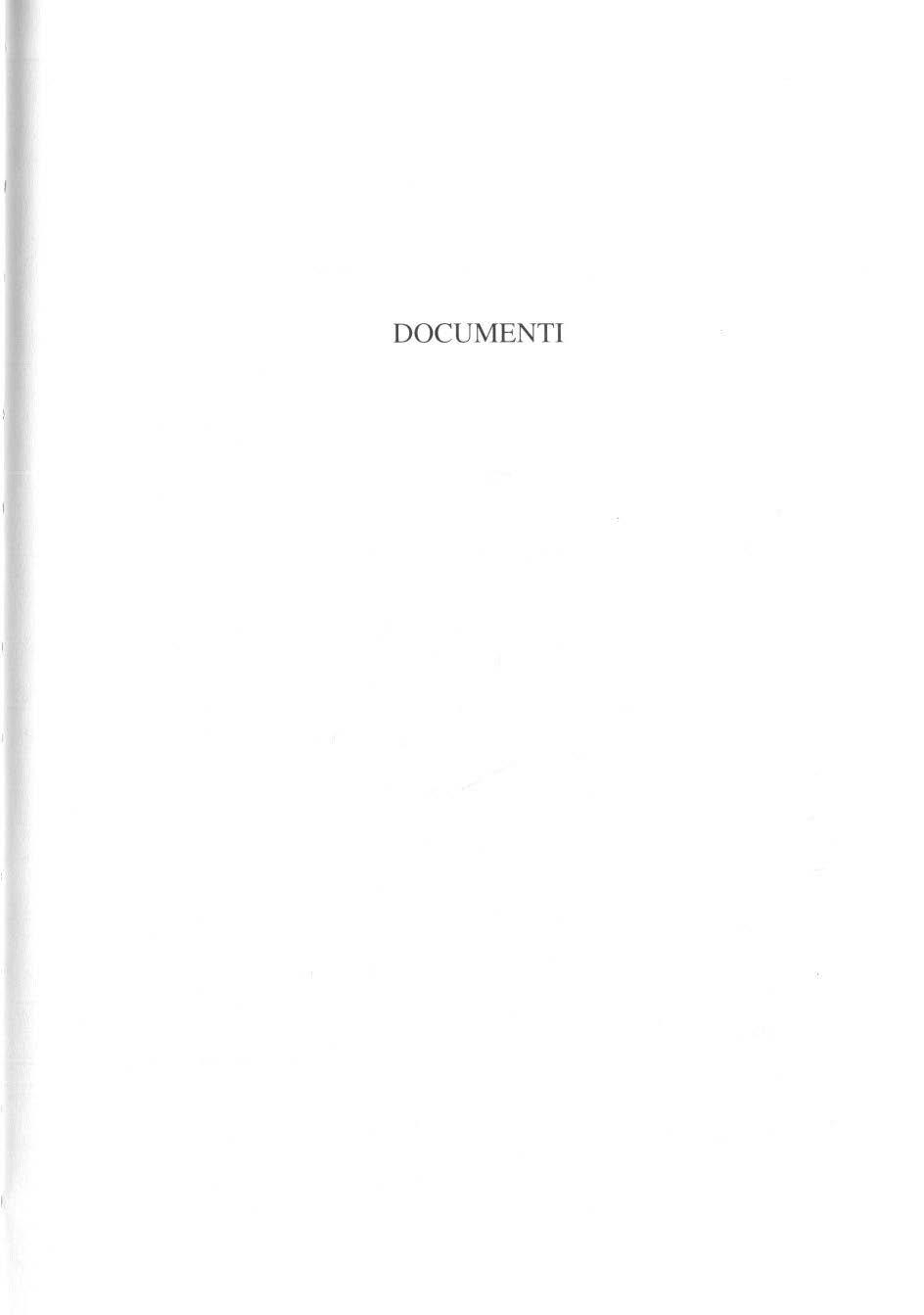

« Dota::,ioni per l'Esercito e relatii·e tfoposboni di Badoglio: ridu::,ione delle spese per alcuni lavori di difesa alla frontiera e per la difesa costiera, revisione di tutto il bilancio straordinario, direttive relative ai lal'Ori ferroi•iari per w1 veloce radunata dell'Esercito e alle costru::,io11i di armi, ridu::,ione spese del genio e dei servi:i, compila::,ione di 1111 bilancio basalo su un assegno non superiore ai 300 milioni per w1 periodo di 10 an n i».
Decisioni di S.E. il Capo di S.M. Generale nella seduta del 18 giug no 1925, presenti:
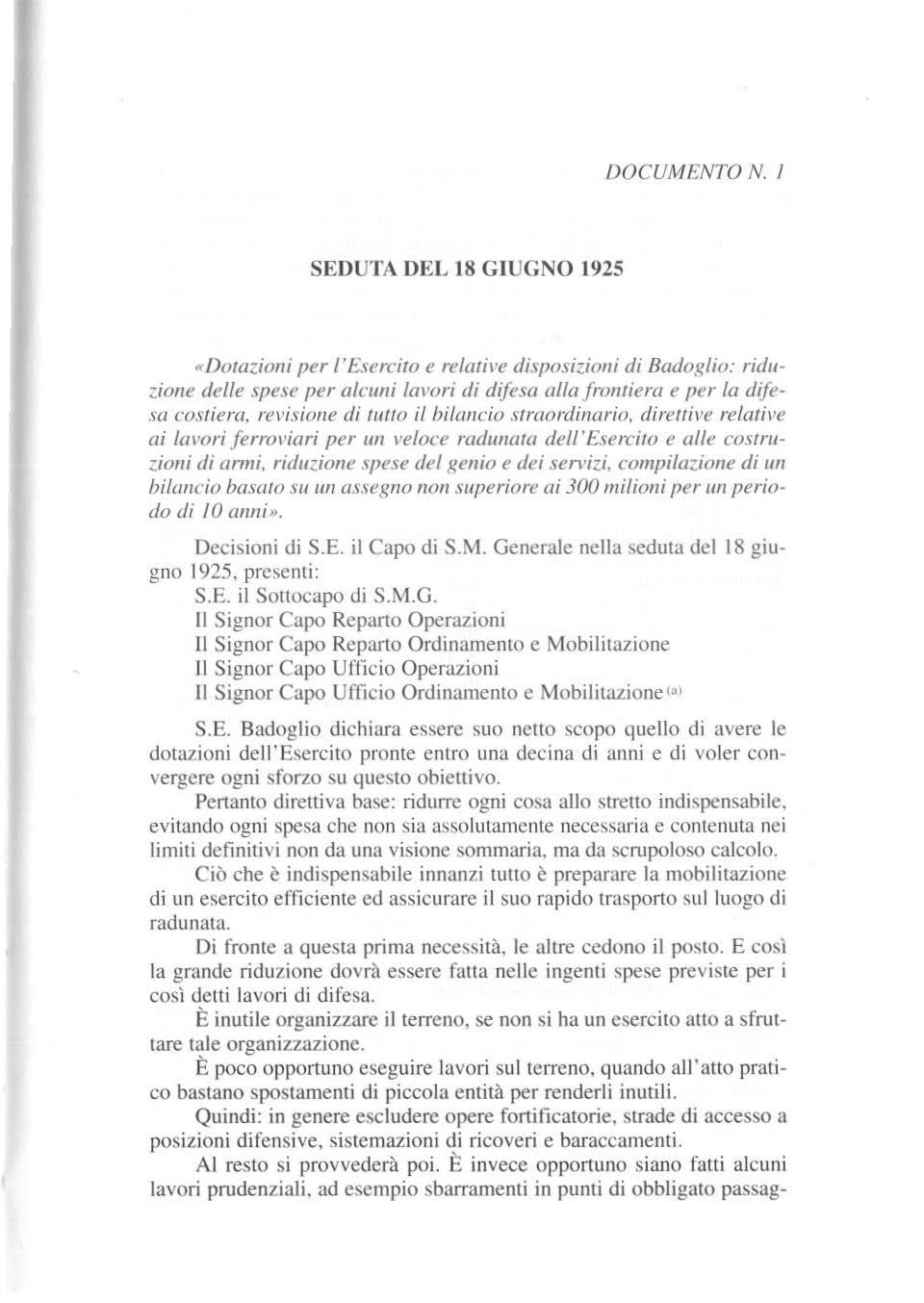
S.E. il Sottocapo di S.M .G .
Il Signor Capo Reparto Operazioni
li Signor Capo R eparto Ordinamento e Mobilitazione
Il Signor Capo Uffi c io Op erazio ni
Il S ignor Capo Ufficio O rdinamento e Mobilitalione '"'
S.E. Bad og lio dichiara essere s uo netto scopo quello di avere le dotazioni dell'Esercito pronte entro una decina di anni e di vo le r conve rge re ogni sforzo su questo obiettivo.
Pertanto di rettiva base: ridurre ogni cosa allo stretto indispensabile. evitando ogni spesa che non sia assolutamente nec essaria e co nte nuta nei limiti defin iti vi non da una v is io ne (;O mm aria, ma da scrupoloso calco lo.
Ciò che è indispen sab ile innan7i tutto è preparare la mobilitazione di un ese rcito e fficiente cd assicurare il s u o rapido tras porto su l luo go di radunata.
Di fronte a questa prima necessi tà, le altre cedo no il po!'>to. E così la g rande ridu z io ne do v r à essere fatta ne ll e ingenti spese previste per i così detti lavori di dife sa.
È inutil e orga njzzare il terreno, se non s i ha un esercito atto a s fru ttare tale organizzazione.
È poco opportuno eseg uire lavori sul te rreno, quando all'atto pra tico bastano s po stamenti di piccola e ntità per ren derli inutili.
Quindi: in ge nere escl ude r e ope re fortificatone, strade di accesso a po s izioni difen s ive, s is te mazioni di ricoveri e barac came nti.
Al resto s i provv e derà poi. È invece o pportun o s iano fatti alcuni lavori prudenziali. ad e!'>cmpio sbarra menti in punti di obbligato pa ssag-
gio, baraccamenti per ricovero di materiale ed artiglierie a piè d'opera, nonché una sistemazione di osservatori. Ma tutti questi lavori dovrebbero essere contenuti «grosso modo» per stare nel pratico raggiungibile in un centinaio di milioni. Per quanto riguarda la difesa costiera, anche su di essa dovranno essere attuate forti riduzioni rispetto ai preventivi, ma occorre anzitutto definire la questione relativa alla responsabilità di tale azione e cioè precisare a chi spetti il comando per tale delicata funzione.
Per quanto riguarda il resto del bilancio straordinario, occorre:
l) rivedere ciascun capito lo (artiglieria, commissariato, sanitari, ecc.) e rifare i calcoli tenendo per base 30 divisioni e le relative aliquote di truppe e servizi di armata e di corpo di armata.
2) nella formulazione del fabbisogno, tener presente ciò che può trovarsi in paese, acquistando al momento del bisogno e ridurre le dotazioni a quanto non si può ottenere dal commercio.
I n particolare:
- per i lavori ferroviari concretare un piano di base alla necessità di facile concentramento dell'Esercito alle frontiere est ed ovest con un determinato numero di treni giornalieri;
- per il capitolo armamento non fare costruzioni nuove, eccetto quanto riguarda le mitragliatrici leggere, l'artiglieria controaerei, qualche bocca da fuoco o proietto di speciale importanza. Rimettere invece in efficienza ciò di cui si dispone, dopo avere esaminato accuratamente se convenga o no mantenerlo in servizio. Occorrendo ricorrere ad armamento di ripiego, distribuire ad esempio fucili in luogo di moschetti, che mancano.
Non tralasciare tuttavia gli studi e le esperienze, in base ad un preciso programma e seguire quanto si fa all'estero. Per i capitoli genio, catTeggi e bardature, sanitado dvedere i calcoli in base alle nuove unità e ridun-e ciò che non è assolutamente indispensabile.
In conclusione compilare un bilancio di carattere pratico, considerando che assai difficilmente si potrà disporre di un assegno straordinario annuo superiore ai 300 milioni per un periodo di 10 anni.
Archivio Ufficio Storico Staio Maggiore Esercito (dn adesso in poi A.U.S.S.M.E.),fondo H-10
«Verbali ri1111io11i 1924 - 1943 », busw 11. 2. .fascimlo 11. I.
Il documento 11011 è il ,•ero e proprio verbale della riunione, bensì ww rela::,ione ria.1 s1111ti1 •a, compilata da/l'Ufficio Ordi11ame11to e Mobilita:ione dello Stato Maggiore del Regio Esercito sulle decisioni prese da Badoglio.
a ) Nel documento originale 11011 sono indicati i nominativi dei presenti ma solo i loro incarichi, essi erano: Il capo di Stato Maggiore Generale generale Pietro Badoglio, il sot · tocopo di Stato Maggiore Generale. generale di corpo d'armata Francesco Sa1•erio Gra zio/i, il rnpo Reparto Opera~ioni. generale di brigata l.uigi A111a111ea, il capo Reparto Ordù1ame1110 e Mobilitazione, generale di brigaw Ruggero Santini, il capo Ufficio Opera~inni. colonnPlln Alberto ?ariani, il capo Ufficio Ordinamento e Mobilitazione, colonnello Curio Barbase11i. 1111ti de/In Stato Maggiore del Regio Esercito.
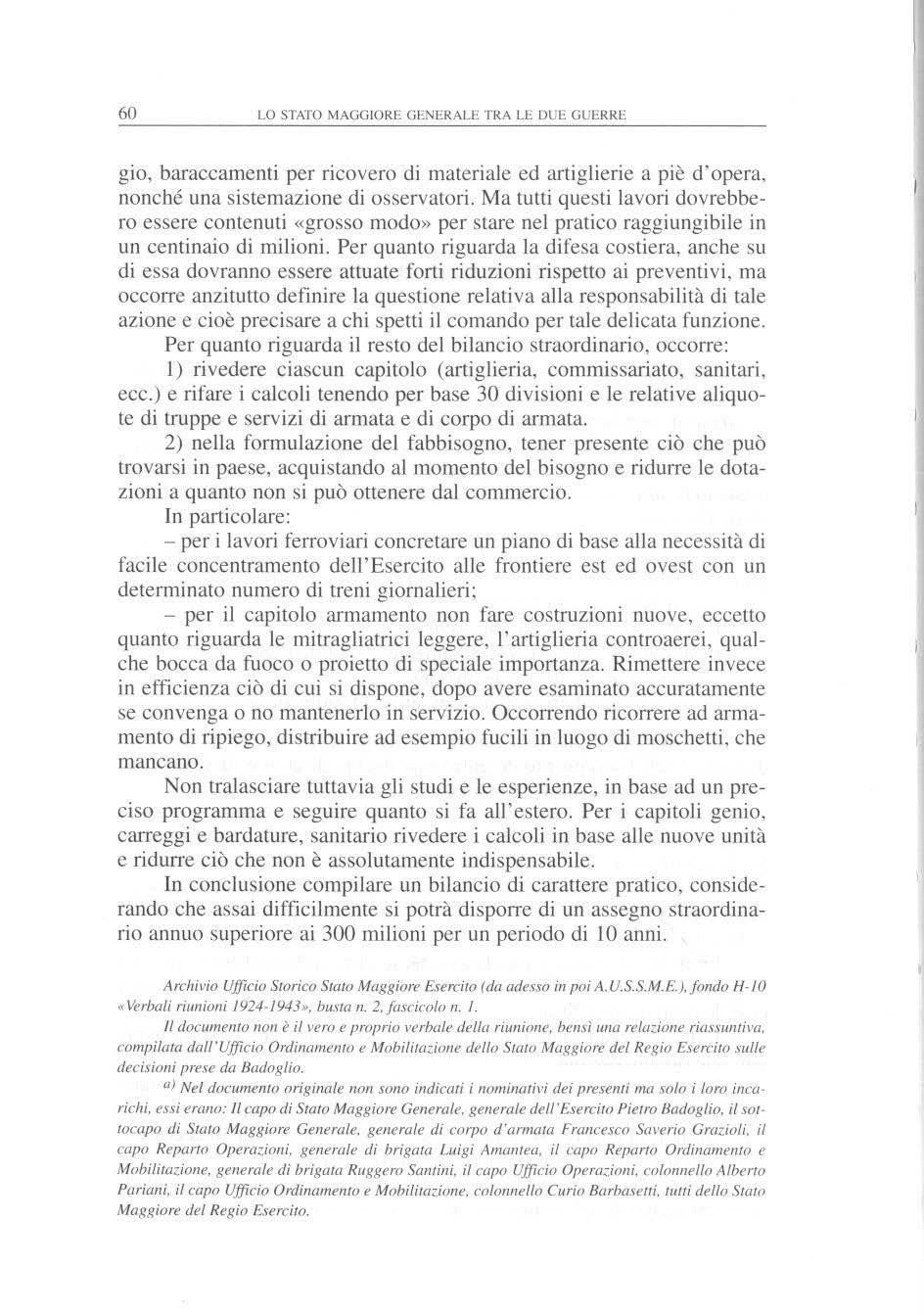
«Co nsiderazioni sulle possibilità finan-;.iarie dello Stato e relatil •a organiz-;.azione dell'Esercito: necessità primarie (mobilitazione di 1111 esercito efficiente, funzionomento di rapidi trasporti di radunata, difesa dei confini) e armamento (impossibilità di costruzione di nuove armi eccetto che per le mitragliatrici leggere e l'artiglieria contraerea).
Studio sulla frontiera settentrionale de/I· Ufficio Operaz,ioni ( confine italo-austriaco) disposizioni finali di Badoglio (ripartizione e radunata delle for-;.e, preparazione di una mano,·ra strategica in Alto Adige, lavori alla frontiera e studio sulla rete ferrol'iaria nord-orientale ) »
Decisioni di S.E. il Capo di Stato Ma gg iore Generale ne lla seduta del 3 Luglio 1925, pres enti:
S.E. il Sottocapo di Stato Ma gg iore Generale 1°1
Il Generale a Disposiz ione per l'arma del Genio, Generale di D. Nicoletti Altimari.
li Generale a dispos izione per l'arma di Artiglieria, Generale di D. Buffa di Perrero.
Il Capo Reparto Ordinamento e Mobilitazione, Generale di B. Santini
li Capo Reparto Operazioni, Generale di B. Amantea
li Capo Ufficio Operazioni, Colonnello in servizio di S.M. Pariani
I l Capo Ufficio Difesa Aerea. Colonnello di Artig l ieria Musso <01 •
S.E. Badoglio, premesso che i Generali a disposizione per l'arma del Genio e di Artiglieria devono ritenersi enti operanti dello S.M.R.E., conferma quanto ebbe g ià ad esporre altra volta, che l'organizzazione dell'Esercito non debba essere considerata astrattamente e teoricamente. ma in base al fattore concreto delle possibilità finanziarie dello Stato.

È evidente pertanto che, in base a tale fattore, occorre fare una discriminante delle varie necessità , che classifica:
I) Mettersi in grado di poter effettuare la mobilitazione di un esercito efficiente.
2) Assicurare i rapidi trasporti ferroviari di radunata.
3) Pro vvedere a rendere più solido il nostro confine in pochissimi punti singolruissimi e del la massima importanza.
Conferma ancora, per quanto riguarda l'armamento, che, pur non dovendosi tralasciare studi ed esperienze, non è possibile, per ragioni finanziru·ie, pensare per ora a costruzioni nuove, eccetto quanto riguarda mitragliatrici leggere, artiglieria controaerei, qualche bocca da fuoco e qualche proietto di speciale importanza.
Dà quindi la parola al Capo Ufficio Operazioni, che espone le linee generali dello studio sulla frontiera nord (limitatamente alla frontiera italoaustriaca).
S.E. il Capo di Stato Maggiore approva le lin ee generali di tale studio e dispone che in base ad esse si proceda:
1) allo studio della ripartizione e radunata delle forze
2) alla preparazione di una manovra strategica (viaggio di S.M. da attuarsi nel L926) riguru·dante le azioni da svolgersi nell'alto Adige (nel 1927 sarà svolta altra manovra per quanto riguarda l'Alta Drava)
3) da parte del Generale a disposizione per l'arma del Genio, in relazione ai concetti operativi esposti, agli studi già effettuati e tenendo presenti la necessità di ridurre al minimo i lavori:
a) sistemazione del gruppo Sarentino, col criterio che, dove la strada può servire anche per g li usi civili e può provvedersi dagli enti locali alla sua manutenzione, sia fatto completamento. Negli altri tratti siano invece costruite le so le opere d'arte e semp lici tracciuoli da completare al momento del bisogno
b) organizzazione delle zone ai paesi del Re sia, del Rombo , del Brennero e di Vizzo allo scopo di migliorarne la forza difensiva
4) da parte dell'Ufficio Trasporti:
allo studio per un più intenso sfr uttamento della rete ferroviaria sia verso l'Alto Adige, sia verso la conca di Tarvi sio, adottando tra l'altro il s is tema di blocco s ulla ferrovia del Brennero.
A.U.S.S.M.E.,fondo H-10 « Verbali riunioni 1924-/943», busta 11. 2,fascicolo n. I.
li documento è una relazione riassumiva dell'Ufficio Opera zioni dello Stato Maggiore del Regio Esercito. 11011 il vero e proprio verbale della riunio11e.

a ) li sottocapo di Stato Maggiore Ge11e rale era il generale di c orpo d'armata Frances co Saverio Grazio/i.
b) I presenti erano tu/li ufficiali dell'Eserci10 e dirigevano e11ti ed uffici del Ministero della Guerra (i generali Nico/e/li e Buffa) e uffici dello Stato Maggiore del Regio Esercito (i generali Santini e Amantea e i colonnelli Pariani e Musso)
((Alcune questioni relatÌl'e al riordinamento dell'Arma d'Artiglieria: obice da 149 M od. 14 e cli preda bellica ( P.8 .); pe~i da 75 Mod. 9 1 I , da 65 montagna, da 77 P.B ., da 75 A., da 751 13; obice da 100; cannoni da 105; artiglieria pesante; gruppi autoportati ciel reggimento artiglieria a ca\'allo; muni-;.ioni; materiali collfraerei; cannone da fanteria».
Seduta del 10 luglio 1925 presso S.E. il Capo di Stato Maggiore Generale.
OGGETIO: decisioni di S.E. il Capo di Stato Maggiore Generale s u a lcu ne que s tioni rifl ettenti il riordinamento dell'artiglieria.
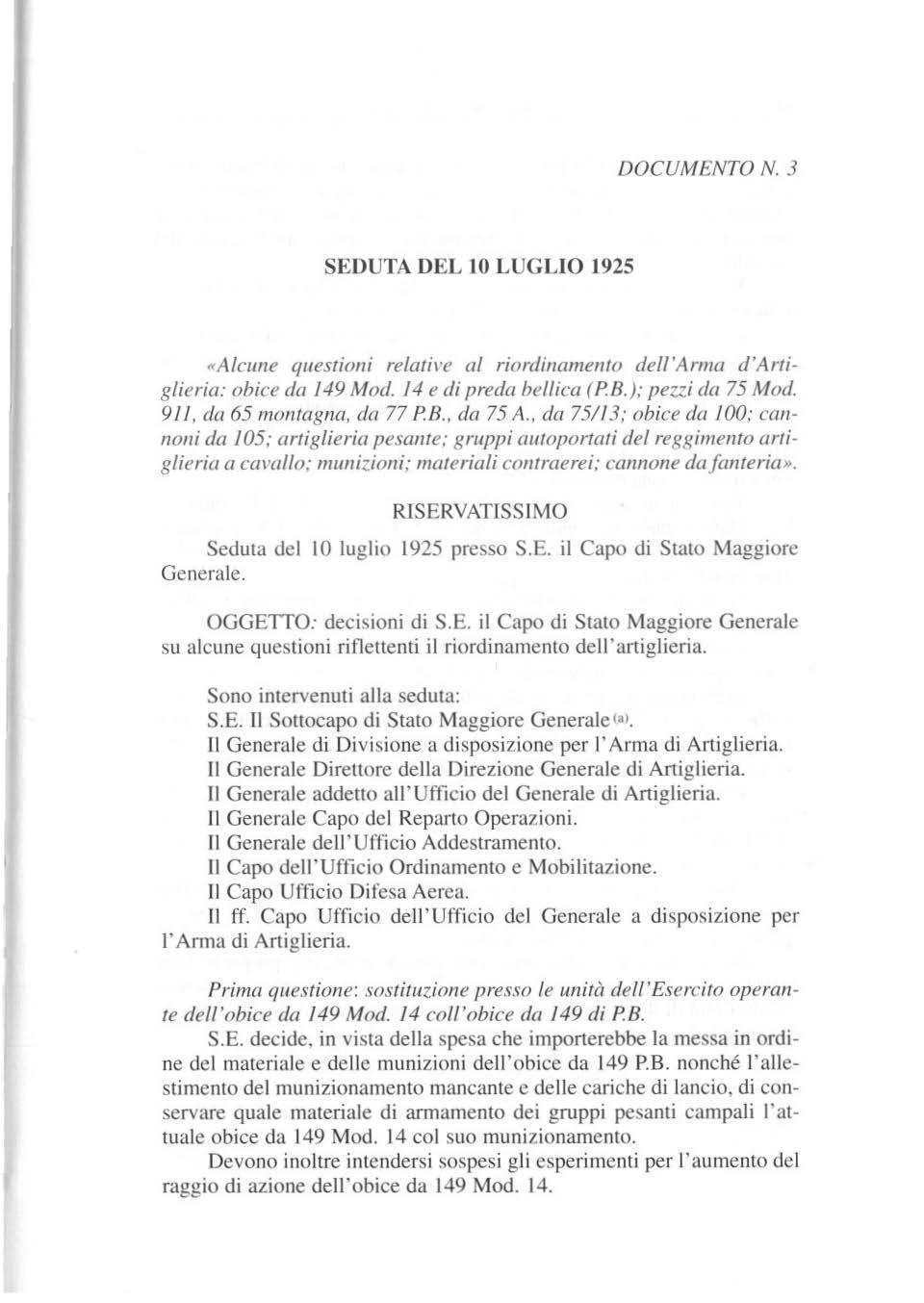
Sono intervenu ti alla seduta:
S.E. Il Sottocapo di Stato Magg iore G enerale<a>.
li Generale di Divi s ion e a di s posi z ion e per l'Arma di Artiglieria.
li Generale Direttore della Direzi one Generale di Artiglie1ia.
II Generale addetto all'Ufficio del Generale di Artiglieria.
11 Generale Capo del Reparto Operaz ioni.
Il Generale dell'Ufficio Addestramento.
li Capo dell'Ufficio Ordinam en to e M obi litazio ne .
Il Capo Ufficio Difesa Aerea.
li ff. Capo Ufficio dell'Ufficio de l General e a di spos iz ione pe r l'Arma di Artiglieria.
Prima questione: sostituz ione presso le unità dell'Esercito operante dell'obice da 149 M od. 14 coll'obice da 149 di P.8.
S.E. decide. in vista della s pesa c he importerebbe la messa in ordine del material e e dell e muni zio ni dell 'ob ice da 149 P B no nc hé l 'a ll estimento del munizionamento mancante e delle ca ri c he di lan cio, di conservare quale mate rial e di armamento dei g ruppi pesanti cam pali l'attual e obice da 149 Mod. 14 col s uo muni z ionamento.
Devo no inoltre inte ndersi sos pesi g li esper im e nti per l'a umento d e l raggio di azione dell 'obice da 149 Mod. 14.
Cogli obici da 149 P.B., dato che ne esistono 93 in buono stato, dovranno essere costituite 20 batterie circa (che impiegheranno il munizionamento del 149 P.B. esistente), i rimanenti obici devono essere messi a disposizione degli stabilimenti militari per l'utilizzazione del metallo.
Seconda questione: materiale da 75 Mod. 911, ne esiste ad esuberanza rispetto a l fabbisogno per le 40 divi s ioni previste.
Terza questione: materiale da 65 Montagna , servirà per la costituzione dei gruppi someggiati delle I O divisioni di secondo tempo; il resto rimanà a disposizione per le Colonie e per la difesa.
Quarta questione: materiale da 77 di PB. , messo a parte il materiale per le Colonie, i restanti pezzi , dopo ottenuto il benestare del Ministero degli Esteri, dovranno essere ceduti agli stabilimenti militari per l'utilizzazione del metallo.
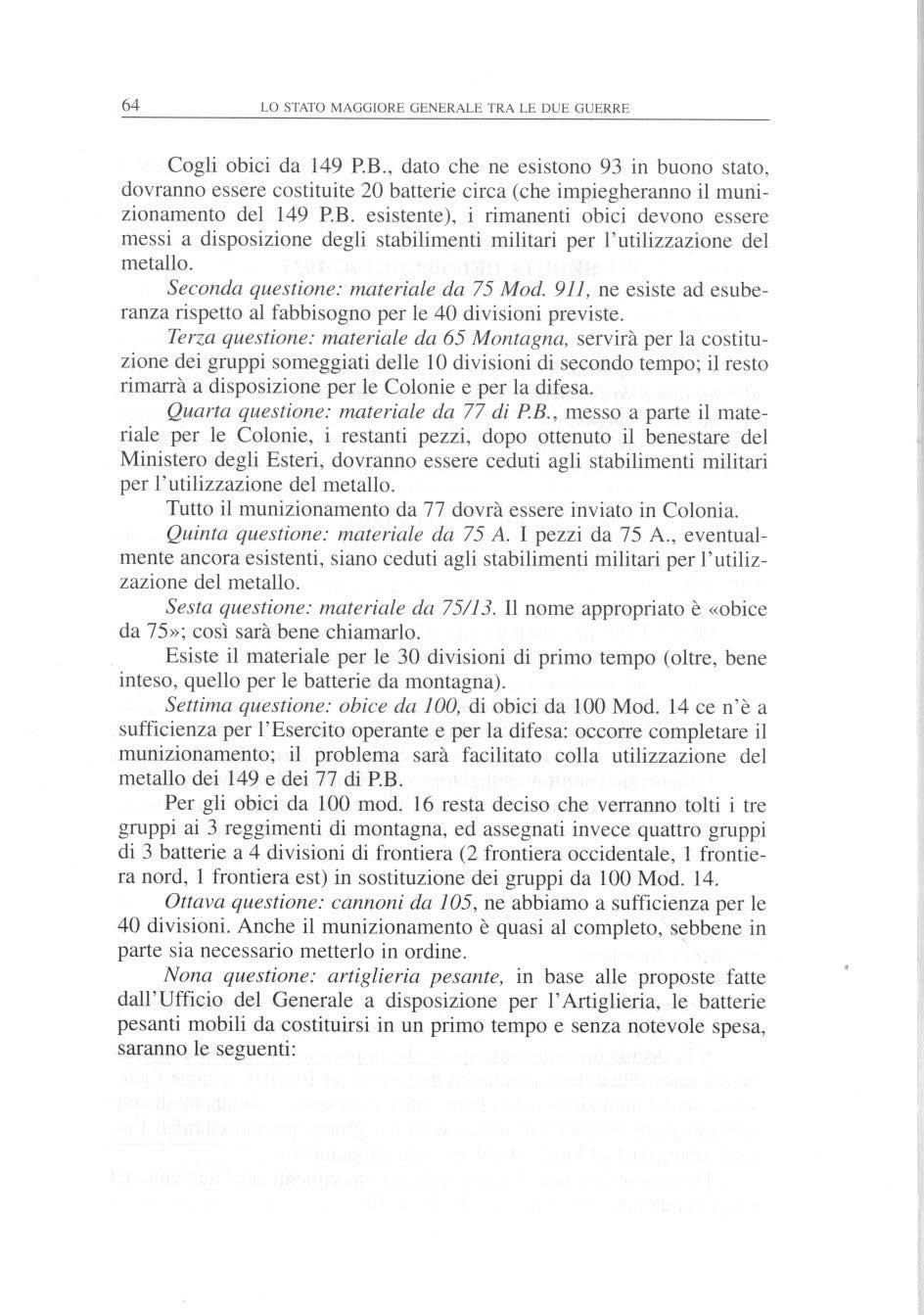
Tutt o il munizionamento da 77 dovrà essere inviato in Colonia.
Quinta questione: ma1 e riale da 75 A. I pezzi da 75 A., eventualmente ancora esistenti, siano ceduti agli stabilimenti militari per l'utilizzazione del metallo.
Sesta questione: materiale da 75113. Il nome appropriato è «obice da 75 » ; così sarà bene chiamarlo.
Esiste il materiale per le 30 divisioni di primo tempo (oltre, bene inteso, quello per le batterie da montagna).
Settima questione: obice da 100, di obici da 100 Mod. 14 ce n'è a sufficienza per l'Esercito operante e per la difesa: occorre completare il munizionamento; il problema sarà facilitato colla uti li zzazione del metallo dei 149 e dei 77 di P.B.
P er g li obici da 100 mod. 16 resta deciso che verranno tolti i tre gruppi ai 3 reggimenti cli montagna, ed assegnati invece quattro gruppi di 3 batterie a 4 divisioni di frontiera (2 frontiera occidentale, I frontiera nord, I frontiera est) in sostituzione dei gruppi da 100 Mod. 14.
Ottava questione: cannoni da 105, ne abbiamo a sufficienza per le 40 divisioni. Anche il munizionamento è quasi al comp leto, sebbene in parte sia necessario metterlo in ordine.
Nona questione: artiglieria pesante, in base alle proposte fatte dal l'Ufficio del Generale a dispo s izione per l'Artiglieria, le batterie pesanti mobili da costituirsi in un primo tempo e se nza notevole spesa, sara nno le seguenti :
8 gruppi di grande potenza I
9 batterie obici da 305 su 2 pezzi
16 » mortai >> 260 » 4 »
27 gruppi da 149 A. 81 » cannoni » 149A » 4 »
batterie di obici da 152 I. su 4 pezzi
7 gruppi da 152 » da 152/37 » 4 »
» da 152/45 » 4 >>
7 gruppi mortai da 21 O = 21 batterie mortai da 210
In totale: 144 batterie pesanti mobili.
Sempre che per questioni di for z a possano costituirsi altre 24 batterie, esse dovranno essere le seguenti:
15 batterie di mortai da 210 (che è possibile costituire con piccola spesa),
9 batterie di obici da 152 I. (per le quali occorre una certa s pesa per la messa in efficienza).
Gli obici da 2031., coi quali si potrebbero costituire 7 batterie, dato il pessimo stato di conservazione, la mancanza di parti essenz iali e le conseguenti forti spese per rimetterli in efficienza, non saranno riparati.
T rimanenti materiali pesanti che risult eranno ancora in effic ienza, dopo aver messo in ordine le batterie sopra menzionale, saranno utilizzati per la costituzione di batterie pesanti mobili di 2 ° tempo. Per queste batterie potranno anche impiegarsi materiali da riparare.
L'Ufficio del Generale di Artiglieria è incaricato di computare quale spesa importerebbe la loro messa in efficienza.
Decima questione: gruppi auto, gruppi autoportaTi del reggimento artiglieria a cavallo, i gruppi autoportati del reggimento artiglieria a cavallo resteranno a disposizione del Comando Supremo.
Undicesima questione: muni zionamento, S.E. incarica lo S.M. di raccogliere i dati pratici necessari per calcolare le giornale di fuoco che occorrerà tener pronte fin da l tempo di pace. Per i computi del momento si tengano come base le giornate di fuoco oggi stabilite.
Provvedimenti da attuarsi per il munizionamento:
a) sia messo in ordine e ricoverato il munizionamento occorrente: la Direzione Generale di Artiglieria farà il computo della spesa necessari per il rip1i stino delle munizioni,
b) lo Stato Maggiore ne studi la dislocazione,
c) s i proceda, contemporaneamente alla mes sa in efficienza delle munizioni alla loro distribuzione dal nord al sud e dall'est all'ovest, informando periodicamente S.E. dei provvedimenti.

Dodicesima questione: materiali contraerei, S.E. decide:
a) sia portato a 40 il numero delle batterie da 75 C.K.
b) siano messe in efficienza le 130 batterie controaerei di materiali diversi esistenti per la difesa territoriale.
L'Ufficio Difesa Aerea faccia il computo della spesa che importa l'attuazione dj tale programma.
Tredicesima questione: cannone da fanteria, S.E. si riserva ogni decisione al riguardo.
Quattordicesima questione: studi ed esperienze, S.E. si riserva ogni decisione al riguardo, ma raccomanda che per il momento ogni studio sia dedicato a mettere in efficienza il materiale previsto per l 'armamento delle unità di l O e 2° tempo.
A.U.S.S.M.E..fondo H - 10 « Verbali riunioni 1924-1943 ». busta 11. 2.fascicolo n. I.
li doc:11111e1110 è una relaz ione riassuntil'a. compilaw dall ' Ufficio Operaz ioni (è siglato dal colonnello Pariani, capo di quell'ufficio) dello Stato Maggiore del Regio Esercito. 11011 il ,•e ro e proprio verbale della riunione.
a/ Nell'origina/e 11011 vengono indicati i nomi dei partecipanti alla seduta, solo i loro incarichi. essi erano: il sottocapo di Stato Maggiore Generale, generale di corpo d'armata Francesco Sa1·erio Graz io/i, il generale di divisione a disposizione dell'Arma d'Artiglieria del Ministero della Guerra, Vi/Iorio Buffa di Perrero, il genera le di brigata addeuo all'Ufficio del generale a disposi~ione dell"Arma d'Arriglieria del Ministero della Guerra, 7ito Mo11tefi11ale. il generale di brigata capo del Reparto Opera z ioni dello Stato Ma ggiore del Regio Esercito, luigi Amantea, il generale di Brigata capo del Reparro Ordiname,uo e Mobilitazione dello Stato Maggiore del Regio Esercito, Ruggero Sa111i11i. il co/01111ello capo dell'Ufficio Operazioni dello Stato Maggiore del Regio Esercito. Alberto Pariani, il colonnello capo de//'U}Jicio Addestrame1110 e Mobilitazione dello Stato Maggiore del Regio Esercito, Pie1ro Pi111or, il colonnello capo dell'Ufficio Ordinamento e Mobilitazione dello Swto Maggiore del Regio Esercito. Curio Barbasetti, il colonnello capo de/l'Ufficio Difesa Aerea dello Stato Maggiore del Regio Esercito. tenente co lonnello Carlo Musso. Non si è riusciti a ide111ificare l'ujjiciale face111e le fim z ioni di capo Ufficio del generale a disposizione dell'Arnia di Artiglieria.

«Ordinamento della difesa costiera: diverso interesse tra Esercito e Marina relativo alla protezione della varie zone, dipendenza dei mezzi che intervengono nella difesa delle coste, reparti di artiglieria dell'Esercito per la Marina, unificazione dei procedimenti per le batterie di artiglieria da costa»
Riunione del 23 luglio 1925 presso S.E. Il Capo di Stato Maggiore Generale

OGGETTO: Ordinamento della difesa costiera.
Inter vengono:
S.E. il Generale Graziali Sottocapo di S.M. Generale.
Il Generale di Divisione Nicoletti Altimari, a disposizione per l'Arma del Genio.
Il Generale di Divisione Buffa di Perrero, a disposizione per l'Arma di Artiglieria.
Il Generale di Brigata Amantea, Capo Reparto Operazioni.
Il Generale di Brigata Santini, Capo Reparto Ordinamento e Mobilitazione.
Il Colonnello Musso Capo Ufficio Difesa aerea.
Il Colonnello Pariani Capo Ufficio Operazioni.
Il Ten. Colonnello Barbasetti Capo Ufficio Ordinamento e Mobilitazione (al.
Viene premessa un'esposizione riassuntiva delle proposte e degli studi relativi all'ordinamento della difesa costiera.
Sono messi in rilievo i seguenti punti:
a) il diverso interesse c he Esercito e Marina hanno alla protezione diretta delle varie zone costiere;
b) l 'i nteresse che l'Esercito deve rivolgere agli sbarchi, qual unqu e sia l'ordinamento della d ifesa costiera, dato che uno sbarco può chiamare l'Esercito a intervenire i mprovvisamente con forze notevoli;
c) la necessità di una netta definizione dei compiti e delle responsabilità;
d) la necessità di una precisa definizione delle dipendenze, data la promiscuità dei mezzi (te1Testri e marittimi) che intervengono nella difesa diretta delle coste;
e) l'oppo1tunità (specie in relazione al personale) che l'Esercito continui ancora a fornire alla Marina reparti di artiglieria per il servizio delle batterie costiere, oltre che reparti di fanteria;
t) la convenienza che vengono unificati i procedimenti delle batterie costiere servite dall'Esercito e di quelle servite dalla Marina.
S.E. il Capo di Stato Maggiore Generale, osservato che la complessità del problema dà luogo ad una notevole disparità di vedute fra l'Esercito e la Marina, ritiene che la sol uzione della questione debba essere ricercata in una discussione diretta, nella quale i due Stati Maggiori trarranno elementi persuasivi per una soluzione concorde dai risultati pratici di un'applicazione concreta.

Determina pertanto che venga proposta a S.E. il Capo di Stato Maggiore della Marina una riunione nella quale saranno concordati gli elementi di base per una manovra costiera di ampio sviluppo con partecipazione di quadri dell'Esercito e della Marina. A questa manovra potrebbero seguire esercitazioni combinate con intervento di forze terrestri e navali.
Costituiranno pregiudiziale concreta per le discussioni e per l'impianto della manovra le seguenti constatazioni:
a) l'E sercito ha interesse preminente alla difesa delle regioni costiere adiacenti alle zone di schieramento e di quelle esposte a grandi sbarchi. In queste ultime esso dislocherà sin dall'inizio delle ostilità alcune grandi unità. La difesa costiera diretta di queste regioni venà senz'a ltro posta sotto il comando di autorità dell'Esercito, le quali avranno pertanto alla loro dipendenza tutti i mezzi ten-estri e marittimi destinati a tale funzione di difesa;
b) la Marina ha interesse preminente alla difesa delle proprie basi; in queste il comando viene assunto da autorità della Marina, le quali avranno a loro volta alla propria dipendenza anche i mezzi terrestri occorrenti per la difesa delle piazze;
c) per le coste rimanenti mancano invece elementi certi che consentano di determinare a priori la preminenza di interessi di uno piuttosto che di altro ente.
Lo svolgimento della manovra deve condurre a eliminare gli elementi di dubbio portando a determinare i due punti capitali:
- a chi debba essere affidata in tempo di pace l'organizzazione suprema delle difese delle varie zone;
- come debba essere regolato l'eventuale passaggio di dipendenza, durante le operazioni, da uno ad altro ente.
A.U.S.S.M.E., fondo 1-4 «Carteggio Stato Maggiore Generale· Comando Supremo· Stato Maggiore Difesa 1924-/948». busta 11. 77, fascicolo n. 4. li docume11w è una 111i11111a di 1111 verbale del/'U/]ìcio Operazione dello Stato Maggiore del Regio Esercito La riunione del 23 luglio era interna al/"Esercito e preliminare a quella del I agosro (vedi verbale n. 6).
a) I presenri erano tutti ufficiali e dirigevano enti del Ministero della Guerra (generali Nico/e11i e Buffa) e uffici dello Staro Maggiore del Regio Eserciro (generale Amantea e Santini. colo11nelli Musso. Pariani e Barbasetti).
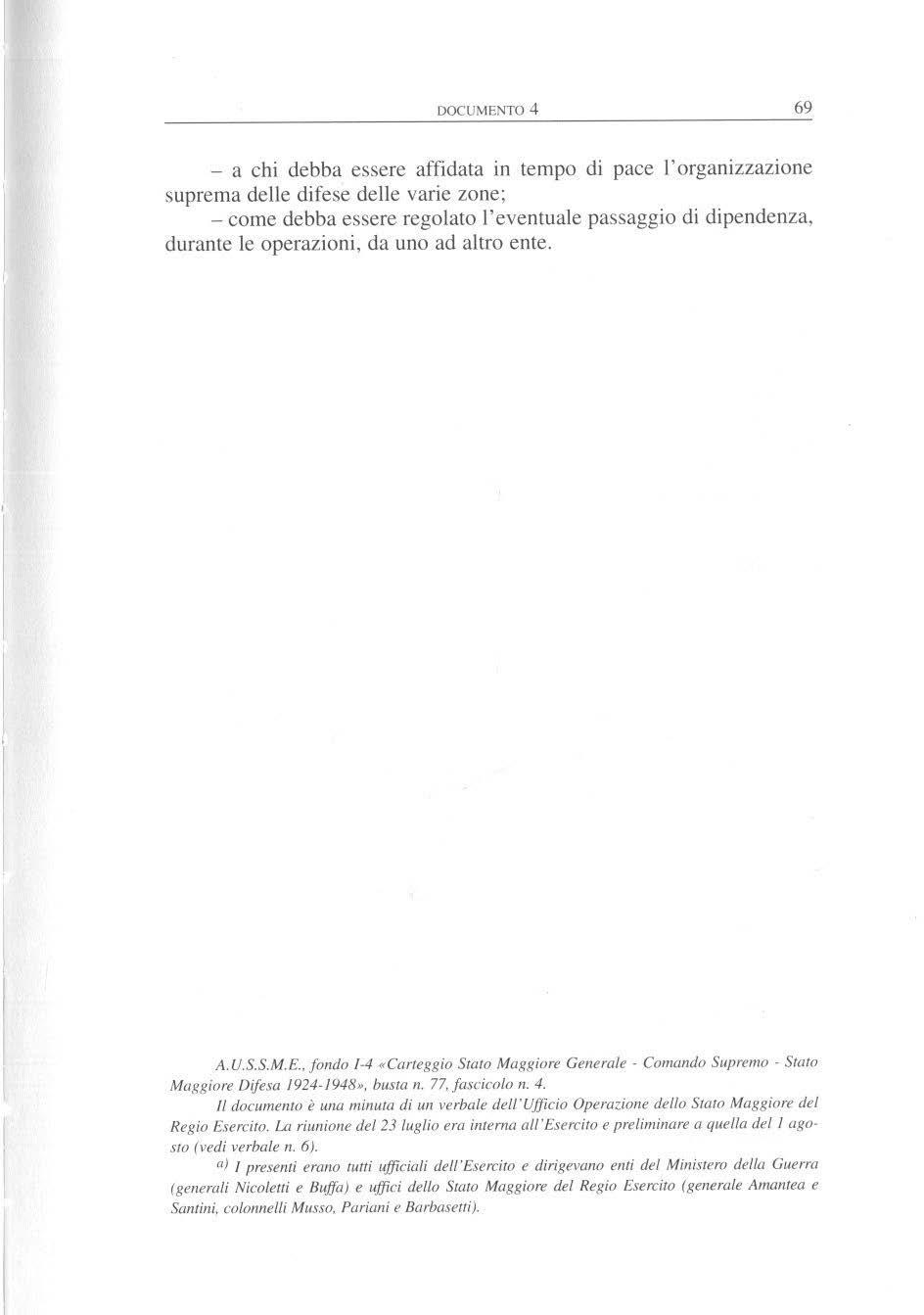

«Ripartiz ione generale e sistemaz ione dei materiali e delle munizioni di artiglieria: programma per la definiz ione delle quantità di specie occorrenti all ' Esercito e delle dota z ioni di mobilita z ione di artiglieria, programma di riordinamento dei depositi per le munizioni da conservare; situa zione e spese per il riordinamento delle artiglierie delle unità mobili, delle artiglierie da posi zione delle frontiere terrestri, delle artiglierie costiere , contraeree e coloniali »
Riunione del 27 luglio 1925 presso S.E. il Capo di Stato Maggiore Generale per ripartizione generale e sistemazione dei materiali e delle munizioni di artiglieria
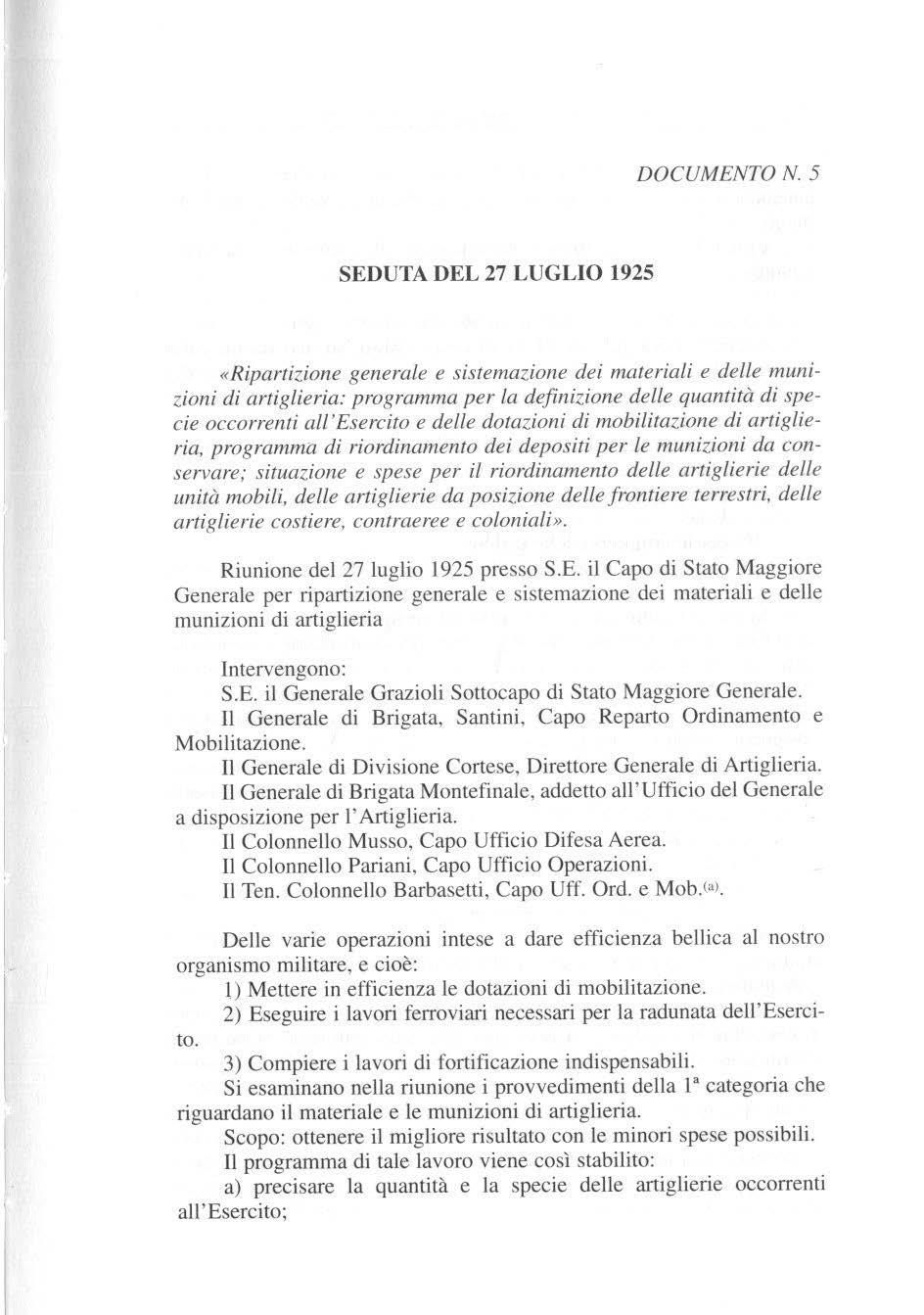
Intervengono:
S.E. il Generale Grazioli Sottocapo di Stato Maggiore Generale.
li Generale di Brigata, Santini, Capo Reparto Ordinamento e Mobilitazione.
Il Generale di Divisione Cortese, Direttore Generale di Artiglieria.
Il Generale di Brigata Montefinale, addetto all'Ufficio del Generale a disposizione per l ' Artiglieria.
li Colonnello Musso, Capo Ufficio Difesa Aerea.
Il Colonne ll o Pariani, Capo Ufficio Operazioni.
Il Ten. Colonnello Barbasetti, Capo Uff. Ord. e Mob. <a> .
Delle varie operazioni intese a dare efficienza bellica al nostro organismo militare, e cioè:
l) Mettere in efficienza le dotazioni di mobilitazione.
2) Eseguire i lavori ferroviari necessari per la radunata dell'Esercito.
3) Compiere i lavori di fortificazione indispensabili.
Si esaminano nella riunione i provvedime nti della l • categoria che riguardano il materiale e le munizioni di artiglieria.
Scopo: otte nere il migliore risultato con le minori spese possibili.
Il programma di tale lavoro viene così stab ilito:
a) precisare la quantità e la specie delle artigl ierie occorrenti all'Esercito;
b) stabilire le dotazioni di mobilitazione per le artiglierie anzidette, adeguandole al numero delle artiglierie ed alle effettive necessità d'impiego;
c) stabilire il programma di riordinamento dei depositi per le munizioni da conservare .

A) Situazione e spese per il riordinamento artiglierie.
Secondo i computi dell'Ufficio Ord. e Mob. su dati forniti dalla Direzione Ge nerale di Artiglieria, la spesa prevista per il ripristino dei materiali e le munizioni ( 12 giornate di fuoco) ascenderebbe a l 281 milioni, così ripartiti:
436 per le artig li erie e munizioni delle unità mobili (40 divisioni).
353 per le art iglierie da posizione.
181 per le artiglierie della difesa costiera nella Penisola e per le Isole.
95 pe r le artiglierie del le Colonie.
36 per riparazioni ai materiali di riserva esuberanti agli impieghi previsti.
Si nota anzitutto che da tale spesa si può stralciare quella riguardante le Colonie (95 milioni) , poiché gli oneri per le rutiglierie e munizioni destinate alle Colonie vanno totalmente a cru·ico del bilancio relativo. Pe,tanto l'Amministrazione della Guerra deve essere, se mai, rimborsata anche delle spese di riparazioni e rip,istino che eventualmente debba sostenere per tali materiali.
S.E. il Capo di S.M. decide inoltre che i materiali di artiglieria esuberanti agli impieghi di mob ilit azione e alla riserva generale po ssono essere conservati come si trovano , senza affrontare per essa ne ssu na spesa di riparazione, sempre quando non sia possibile alienarli e non convenga addirittura utili zzarli come rottame.
Entrando poi in merito alle singo le altre voci di spesa si osserva:
a) Per le artiglierie delle unità mobili:
Nei 436 milioni previsti sono compresi 196 milioni per artiglierie e munizioni che potrebbero servire alla costituzione cli una riserva generale mobile.
Tale riserva non occorre nei primi tempi di mobilitazione, né come riserva <li materiali (per i quali vi sono altre sufficienti riserve), né per la costituzione di nuove unità, mancando allora il personale necessario. Tanto vale quindi limitarsi a mettere a posto il materiale e i caricamenti, mentre per quanto concerne il munizionamento, si possono rimandare i lavori necessari ai primi mesi dopo la mobilitazione, se allora sarà confermata l'opportunità di effettuarli. Quindi la spesa relativa sarà ridotta ai 35 milio ni circa richiesti per la rip arazione dei mezzi e il completamento dei caricamenti, economizzando in ogni caso i rimanenti 16 milioni.
B) Per le artiglierie da posizione delle.frontiere terrestri.

Tali artiglierie ripartite fra i vari scacchieri in base ad un concetto prudenziale di sicurezza comprendono, in ciascuno scacchiere, due aliquote: la prima, costituita dalle batterie idonee (per l'immediata disponibilità del personale) a entrare in azione fin dal I giorno di mobilitazione e denominate perciò di / Tempo; la seconda, costituita da batterie mobilitabili prute col personale da trarre dagli altri centri di mobilitazione, parte con quello proveniente dalle frontiere non minacciate, e denominate perciò di Il Tempo.
Mentre per tutte le batterie di I Tempo, prese nel loro complesso, è assicurata la tempestiva disponibilità del personale, per quelle di II Tempo invece la disponibilità complessiva del personale non consente di armare più di 1/3 circa delle batterie assegnate al complesso degli scacchieri, sempre che tale personale sia impiegato esclusivamente per tali batterie. È quindi inutile accantonare munizioni anche per i rimanenti 2/3 di tali batterie necessariamente destinate a costituire riserva.
Basterà pertanto assegnare 4 giornate di fuoco per le 100 circa batterie di 11 Tempo, mentre quelle di I Tempo dovranno avere 12 giornate.
Tale riduzione importa un'economia di un centinaio di milioni, rispetto alla previsione dell'Ufficio Ordinamento e Mobilitazione.
C) Per le artiglierie cos1iere.
La previsione di spesa ha un valore molto relativo, tanto per la parte concernente le artiglierie dei fronti a mare quanto per quelle relative alle artiglierie destinate all'azione ten-estre. Ciò perché il numero definitivo delle prime dipenderà, nei riguardi dell'Esercito, dalla ripartizione della difesa costiera tra Esercito e Marina, non ancora fissata, quella delle seconde dovrà essere riesaminato con criteri più economici in relazione sia alla disponibilità del personale, sia al concorso delle artiglierie delle unità mobili che saranno destinate allo scacchiere costiero.
D) Per le artiglierie contraeree.
La spesa prevista (179 milioni) può essere sensibilmente diminuita riducendo da 12 a 4 giornate di fuoco previste per le batterie contraerei da posizione, in considerazione del logoramento che già presentano parecchie di tali artiglierie, e della maggiore facilità di rifornimento di cui godono le batterie controeree in zona territoriale in ragione della brevità e saltuarietà delle azioni contraeree in detta zona, eccetto che per le batterie da 40, per le quali possono tenersi l O giornate.
Tali circostanze non si verificano in egual misura per le batterie controaeree autocampali (che converrà sfruttare al massimo grado anche in ragione del numero limitato) alle quali è sufficiente la dotazione di 8 giornate di fuoco.
Tale riduzione importerebbe un'economia su questo capitolo di spesa, che si può valutare in 60-70 milioni.
In conclusione, si ritiene che una somma di 900 milioni sia sufficiente a mettere in efficienza il materiale e le muruzioni in misura rispondenti al fabbisogno dell'Esercito operante e della difesa. Ripartendo i lavori relativi in 10 esercizi, ne risulterebbe un onere annuo di 90 milioni, e che può accettarsi come base delle richieste finanziarie relative al capitolo considerato.
La questione del riordinamento dei depositi munizioni viene rimandata ad ulteriore riunione , ritenendosi all'uopo necessaria la presenza del Generale Torretta, quale presidente della Commissione permanente per la sistemazione dei depositi.
A.U.S.S.M.E fondo H - /0 «Verbali riunioni 1924- 1943 », busto 11. 2.fascicolo 11. I.
Il documento è un origùwle dell'Ufficio Operazioni dello Sraro Maggiore del Regio Esercito ed è siglaro sia da Badoglio che dal colo1111e/lo Pariani, capo di Anche quesro è una relazione riassu111i1•a della riunione, non w1 vero e proprio verbale.
a) I presemi erano Ili/li ufficiali de/l'Eserciro e dirigevano enti del Ministero della Guerra (generali Correse e Mo111efi11ale) o uffici dello Staro Maggiore del Regio Eserciro (generali Sa111i11i e i colo1111elli Musso. Pariani e Barbase/fi).

«Ordinamento della difesa costiera: organizzazione e dipenden-::.a dei mezzi (difese nwrittime mobili e fisse, reparti di protezione, difesa contraerei, organi di avvistamento e colle..gamento, batterie costiere fisse e mobili), riparti:ione dei compiti e delle responsabilità tra Esercito e Marina, ordinamento complessivo delle difesa costiera, manovre costiere inte(forze, riflessioni finali del sottocapo di Stato Maggiore della Regia Marina sui compiti specifici della flotta »
Riunione preliminare relativa all'ordinamento della dife~a costiera tenuta il 1° agosto 1925
I ntervcngono:
S.E. il Generale Grazioli Sottocapo di Stato Maggiore Generale.
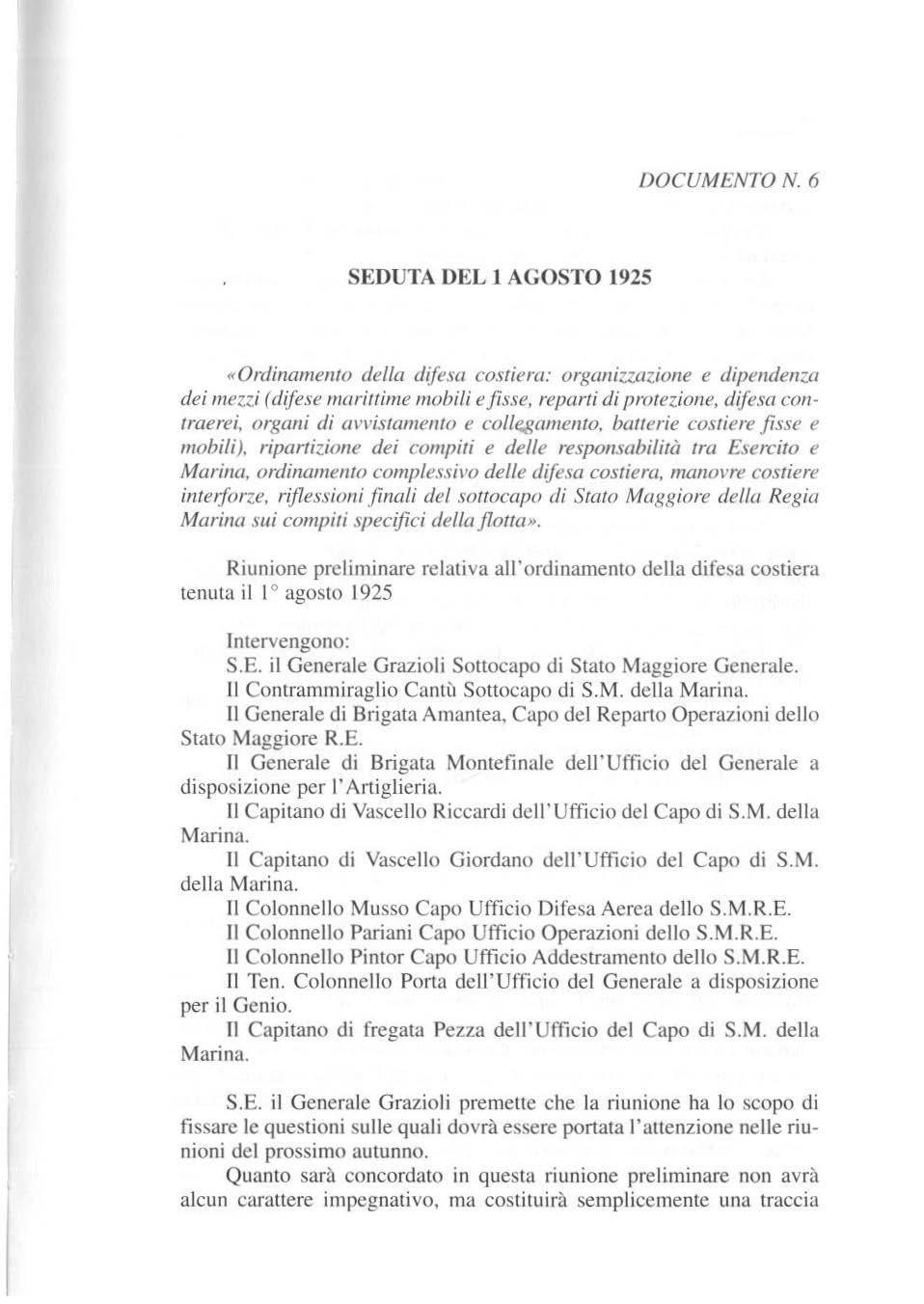
11 Contrammiraglio Cantù Sottocapo di S.M. della Marina.
Il Generale di Brigata Amantea, Capo del Reparto Operazioni dello Stato Maggiore R.E.
TI Generale di Brigata Montefinale dell'Ufficio del Generale a disposizione per l'Artiglieria.
Il Capitano di Vascello Riccardi dell'Ufficio del Capo di S.M. della Marina.
Il Capitano di Vascello Giordano dell'Ufficio del Capo di S.M. della Marina.
Il Colonnello Musso Capo Ufficio Difesa Aerea dello S.M.R.E.
Il Colonnello Pariani Capo Ufficio Operazioni dello S.M.R.E.
Il Colonnello Pintor Capo Ufficio Addestramento dello S.M.R.E.
Il Ten. Colonnello P orta dell'Ufficio del Generale a disposizione per il Genio.
TI Capitano di fregata Pezza dell'Ufficio del Capo di S.M. della Marina.
S.E. il Generale Grazioli premette che la riunione ha lo scopo di fissare le questioni sulle quali dovrà essere portata l'attenzione nelle riunioni del prossimo autunno.
Quanto sarà concordato in questa riunione preliminare non avrà alcun carattere impegnativo, ma costituirà semplicemente una traccia
per preparare le future discussioni, in modo che queste possano procedere speditamente e condurre a risultati conclusivi.
Ciò premesso, S.E. il Generale Grazioli indica quali siano gli elementi da tenere presenti nelle future riunioni.
Limiti della discussione: Pur senza perdere di vista il carattere unitario che riveste il problema della difesa delle frontiere marittime, le future riunioni si propongono essenzialmente di definire l'ordinamento della difesa diretta delle coste che costituisce una parte del problema più ampio ora accennato.
Sembra infatti fuori di discussione che:
la protezione indiretta al largo sia di esclusiva competenza delle forze navali e quindi della Marina;
la protezione contro nemico già sbarcato sia di competenza dell'Esercito.
Nella difesa diretta delle coste invece la promiscuità degli elementi che vi concorrono e la diversa funzione dei vari tratti di costa (appoggio alle forze navali, teste di linea o elemento di appoggio per il traffico marittimo, vie di facilitazione all'invasione nemica) determinano l'attuale incertezza nella ripartizione dei compiti e delle responsabilità.
Risolvere questi elementi d'incertezza con opportuni accordi è appunto lo scopo essenziale delle future discussioni.
Organizzazione e dipendenza dei mezzi: Premesso che gli elementi della difesa diretta delle coste sono:
a) difese marittime mobili (siluranti e sommergibili costieri);
b) difese marittime fisse (ostruzioni, sbarramenti, batterie lanciasiluri);
c) organi di avvistamento e di collegamento;
d) batterie costiere, fisse e mobili;
e) reparti di protezione (difesa terrestre fissa e mobile);

f) difesa contraerea;
si osserva che il sistema di tali mezzi può essere considerato da un duplice punto di vista: quello organico e quello
Dal punto di vista organico sembra che gli elementi delle tre prime categorie debbano, per la loro natura stessa, venire costituiti dalla Marina. Per gli elementi delle categorie d) ed e) invece possono prendersi in esame soluzioni diverse. Considerazioni di ordine vario, riflettenti in particolar modo l'economia generale dell'organizzazione, farebbero propendere ad affidare la costituzione di tali elementi all'Esercito, ad eccezione delle batterie antisiluranti e di passo che, per ragioni d'impiego, sarebbero più opportunamente affidate alla Marina.
Quanto agli organi della difesa contraerea, la loro costituzione può essere regolata in base alla preminenza d'interessi.
Il problema della dipendenza d'impiego non è vincolato a quello organico, perché alla sua soluzione contribuiscono altre considerazioni.
Elementi terrestri costituiti dall'Esercito possono venire messi alla dipendenza di autorità della Marina e viceversa. Questa dipendenza relativa all'impiego può venire applicata all'atto della mobilitazione o durante le esercitazioni ovvero anche funzionare in modo permanente fin dal tempo di pace (ad esempio per le batterie da costa delle piazze marittime).
Ripa rti z ion e d e i co mpiti e d ell e res po n sa bili tà tr a Ese rcito e Ma rina
Non sembra possa sussistere alcun dubbio sulla necessità che in ogni Lona costiera sia assicurata l'unità di comando e vengano evitati i passaggi di dipendenza durante l'azione.
Ora. in linea generale si può osservare che:
a) vi sono regioni nelle quali l'Esercito ba interesse preminente a difendere anche le coste (ad esempio quelle adiacenti alle zone di schieramen to e quelle esposte a grandi sbarchi). ln tali regioni verranno dislocate grandi unità fin dall'inizio di un connilto.
La difesa costiera diretta di queste regioni dovrebbe perciò essere posta sotto il comando di autorità dell'Esercito, le quali avrebbero pertanto alla loro dipendenza tutti i mezzi terrestri e marittimi locali destinati a tale funzione di difesa;
b) in altre regioni invece la Marina ha interesse preminente alla difesa costiera, ad esempio per le basi navali; in queste il comando spetta alla Marina, la quale ha alla propria dipendenza anche i mezii terrestri occorrenti:
c) vi sono poi estesi tratti di costa, in generale di minore importanza, per i quali mancano elementi certi che consentano di determinare a priori la prerninenia di interessi di uno piuttosto che di altro ente e quindi per stabilire se la loro difesa debba essere affidata all'Esercito ovvero alla Marina.

Lo scambio di vedute predisposto per il prossimo mese di ottobre dovrà fissarsi in particolar modo su queste premesse e tradur le in una ripartizione concreta delle grandi zone o regioni costiere.
Questa ripartizione non avrà naturalmente un carattere rigido, perché non si può escludere che in determinate ipotesi di conflitto e in date eventualità di guerra il comando di certe zone costiere possa venire trasferito dall'uno all'altro e nte.
Ordinamento complessivo della difesa costiera: dalla determinazione degli elementi finora accennati scaturiranno le linee generali dell'ordinamento costiero.
E poiché questo richiede il concorso di elementi dell'Esercito e deUa Marina e dato che la preminenza di interessi di uno dei due enti non esclude gli interessi dell'altro ente, occorre assicurare l'unità di indirizzo della difesa costiera e il coordinamento degli interessi e dei mezzi. Ciò sembra possa ottenersi mediante direttive uniche concordate tra i due Stati Maggiori e mediante una opportuna costituzione dei comandi costieri.
Manovre costiere: Per ricavare dati concreti circa l'organizzazione difensiva dei vari tratti di costa si ritiene necessario iniziare una serie di manovre da svolgersi con i quadri del R. Esercito e della R. Marina.
Scopo essenziale di queste manovre sarà quello di determinare l'entità dei mezzi con i quali ciascuno dei due enti dovrà concorrere alla difesa di ciascuna regione costiera.
li contrammiraglio Cantù Sottocapo di Stato Maggiore della Marina dichiara di associarsi al concetto di base contenuto neJJa premessa della memoria ora letta, restando inteso che l 'app licazione di questo concetto deve intender s i assoluta e che perciò nelle zone nelle quali il comando è devoluto all'Esercito, la Marina metterà (per il tramite di un suo proprio comando) agli ordini diretti del comando dell'Esercito tutte le organizzazioni fisse (batterie, sba rTamenti , ecc.) che essa ha nella zona che s i considera, compreso l'uso dei soli mezzi mobili sussidiari (1imorchiatori, dragamine, piccoli mezzi da trasporto) connessi alla protezione ravvicinata, ma escluso quanto ha carattere di maggiore mobilità ed impiego guerresco.
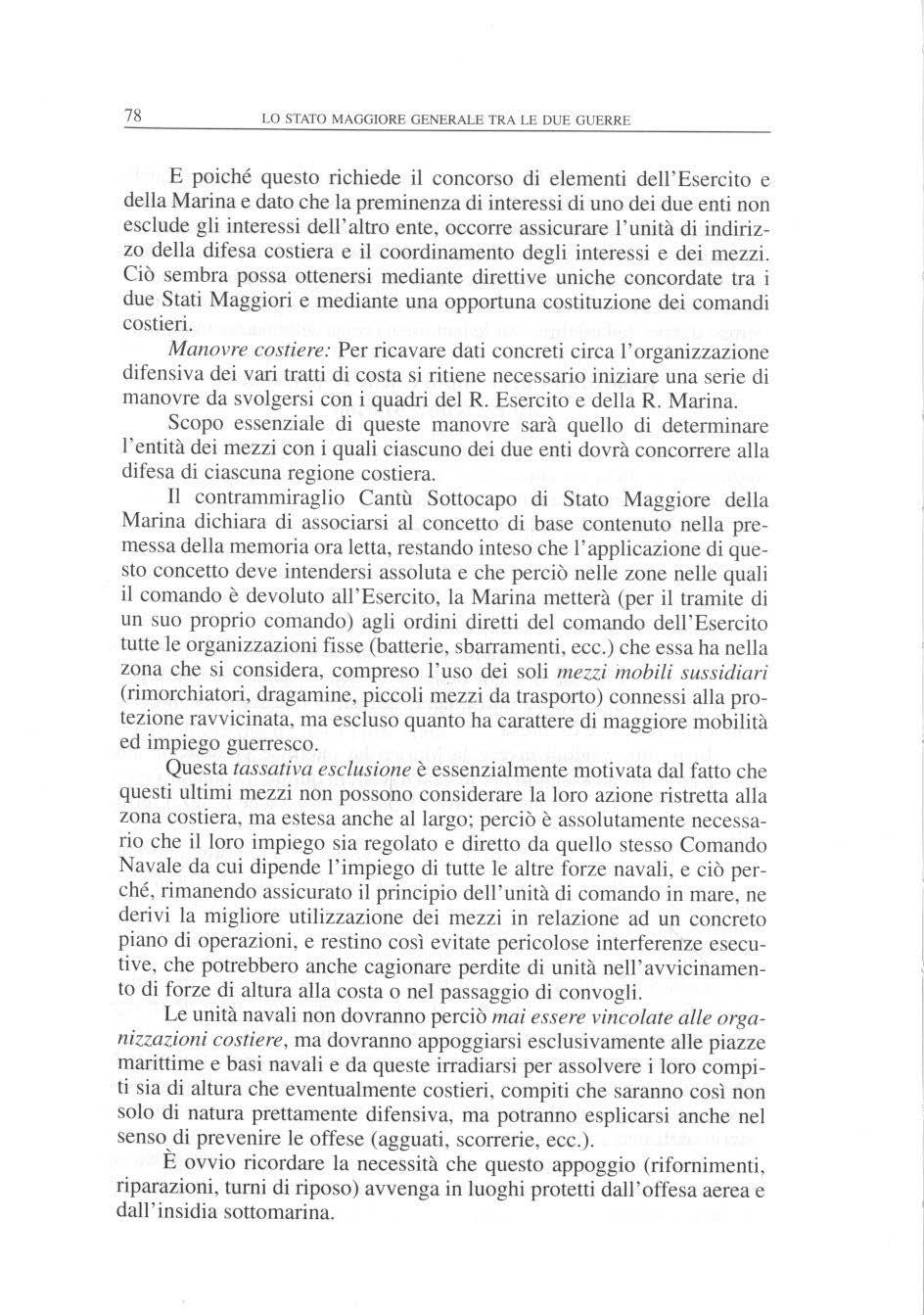
Questa tassativa esclusione è essenzialmente motivata dal fatto che questi ultimi mezzi non possono considerare la loro azione ristretta alla zona costiera, ma estesa anche al largo; perciò è assolutamente necessario che il loro impiego sia regolato e diretto da quello stesso Comando Navale da cui dipende l'impiego di tutte le altre forze navali, e ciò perché, rimanendo assicurato il principio dell'unità di comando in mare , ne derivi la migliore utilizzazione dei mezzi in relazione ad un concreto piano di operazioni, e restino così evitate pericolose interferenze esecutive, che potrebbero anche cagionare perdite di unità nell 'avvic inamento di forze di altura alla costa o nel passaggio di convogli.
Le unità navali non dovranno perciò mai essere vincolate alle organizzazioni costiere, ma dovranno appoggiarsi esclusivamente alle piazze marittime e basi navali e da queste irradiarsi per assolvere i loro compiti sia di altura che eventualmente costieri, compiti che saranno così non solo di natura prettamente difensiva, ma potranno esplicarsi anche nel senso di prevenire le offese (agguati, scorrerie, ecc.).
È ovvio ricordare la necessità che questo appoggio (rifornimenti, riparazioni, turni di riposo) avvenga in luoghi protetti dall 'offesa aerea e dal!' insidia sottomarina.
li numero delle basi navali e piazze marittime e la loro ubicazione è tale da dare affidamento del tempestivo accorrere delle forze navali nei luoghi minacciati da vitali offese, con efficacia maggiore di quella che si potrebbe ottenere avendo le forze disseminate lungo le coste. Basta ricordare il grandissimo aiuto che le basi di Trapani , Cagliari ed Elba, ora in corso di formazione, daranno alla protezione non solo delle isole ma anche a quella di tutta la costa del Basso Tirreno.
Un altro fattore da tenere presente per il rapido dislocarsi delle unità navali è l'aumentata velocità del naviglio in genere, ed il minor tempo necessario per approntarsi alla navigazione e sviluppare la massima velocità.
Ammesso il concetto della preminenza di interessi la Marina dichiara di avere questa preminenza a La Spezia, La Maddalena, Cagliari, Elba, Mes si na, Augusta, Trapani , Taranto, Brindi si, Venezia e Pola. Per tutte le rimanenti località ritiene e chiede che il comando continui a rimanere al R. Esercito.
Cade perciò la necessità di definire a chi spetti l'azione del comando in qualunque altro punto costiero e quindi la manovra con i quadri servirà a definire l 'efficac ia del concorso che la Marina, anche operando al largo, porterà alla difesa delle coste. Nelle piazze marittime e basi navali la Marina propone che la ripartizione delle batteria sia fatta col concetto di lasciare al R. Esercito (come del resto è già in atto quasi dappertutto) le batterie di obici e quelle di grosso calibro ed alla Marina le batterie di medio calibro antisiluranti e dei passi.
Anche i treni armati potrebbero essere ceduti al R. Esercito.
Ultimata l 'esposiz ione dei punti di vista dei due Stati Maggiori rimane convenuto che s ulla base delle dichiarazioni fatte in questa riunione preliminare, i due Stati Maggiori prepareranno gli elementi per le future riunioni.
A.U.S.S.M.E., fondo 1-4 « Carteggio Stato Maggiore Generale - Comando Supremo · Stato MagRiore Difesa 1924-/948» busta t1. 77.fascicolo 11. 4. Il documet1to è probabilmente una copia dell'Ufficio Opera zioni dello Stato Maggiore del Re!!iO Esercito Anche questa riunione, come quella del 23 luglio 1925 (vedi verbale 11. 5). era preliminare a 1m'al1ra che si sarebbe dovuta renere dal capo di S1a10 Maggiore della Marina (si veda la lerrera del capo di Sraw MagRiore della Marina 11. 19326 di pro/. al capo di S1a1o Maggiore Generale, in dota 29.7.1925 e sua risposta in data 30.7.1925; in /-4, busra 11. 77.fascicolo t1. 4).
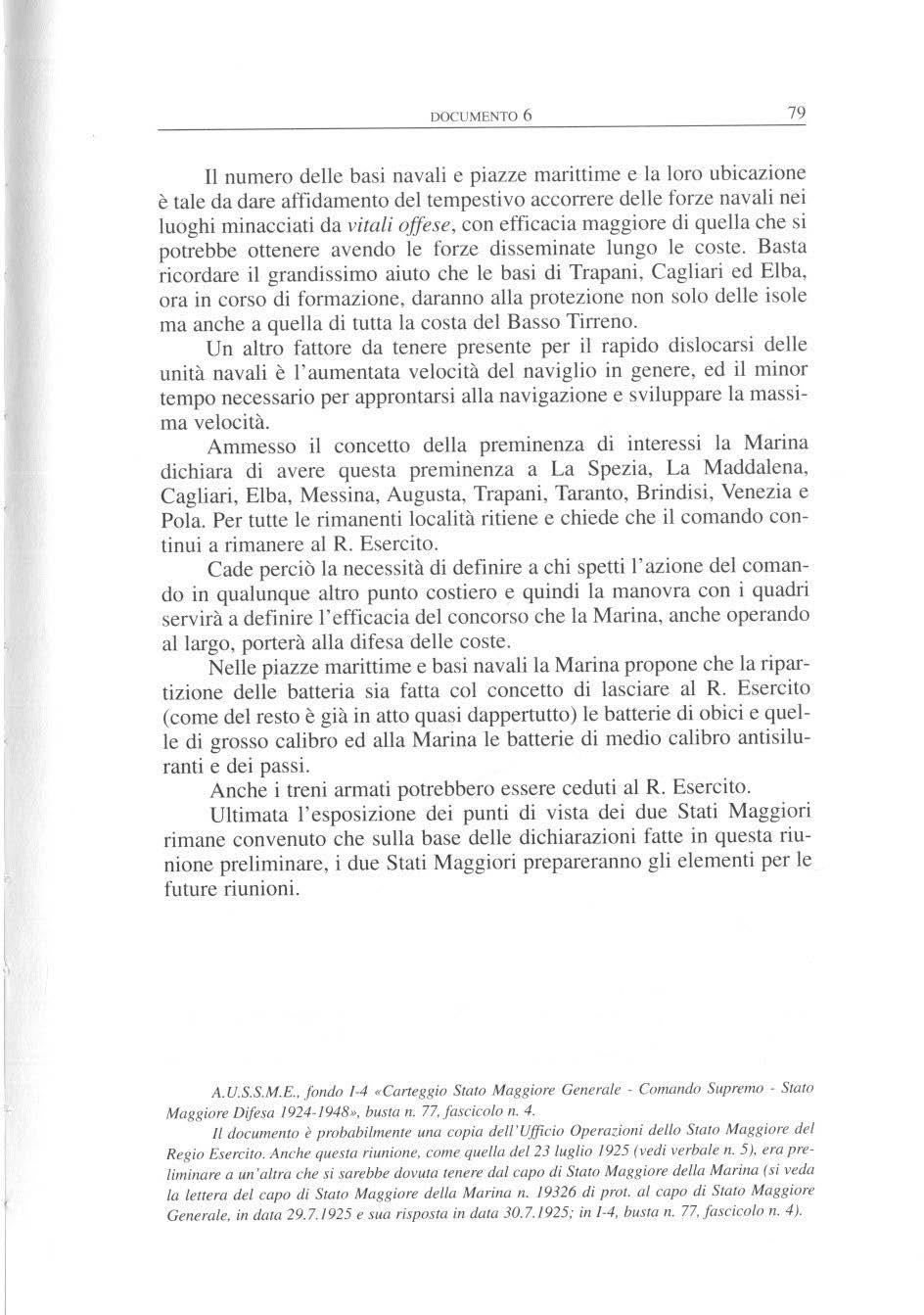
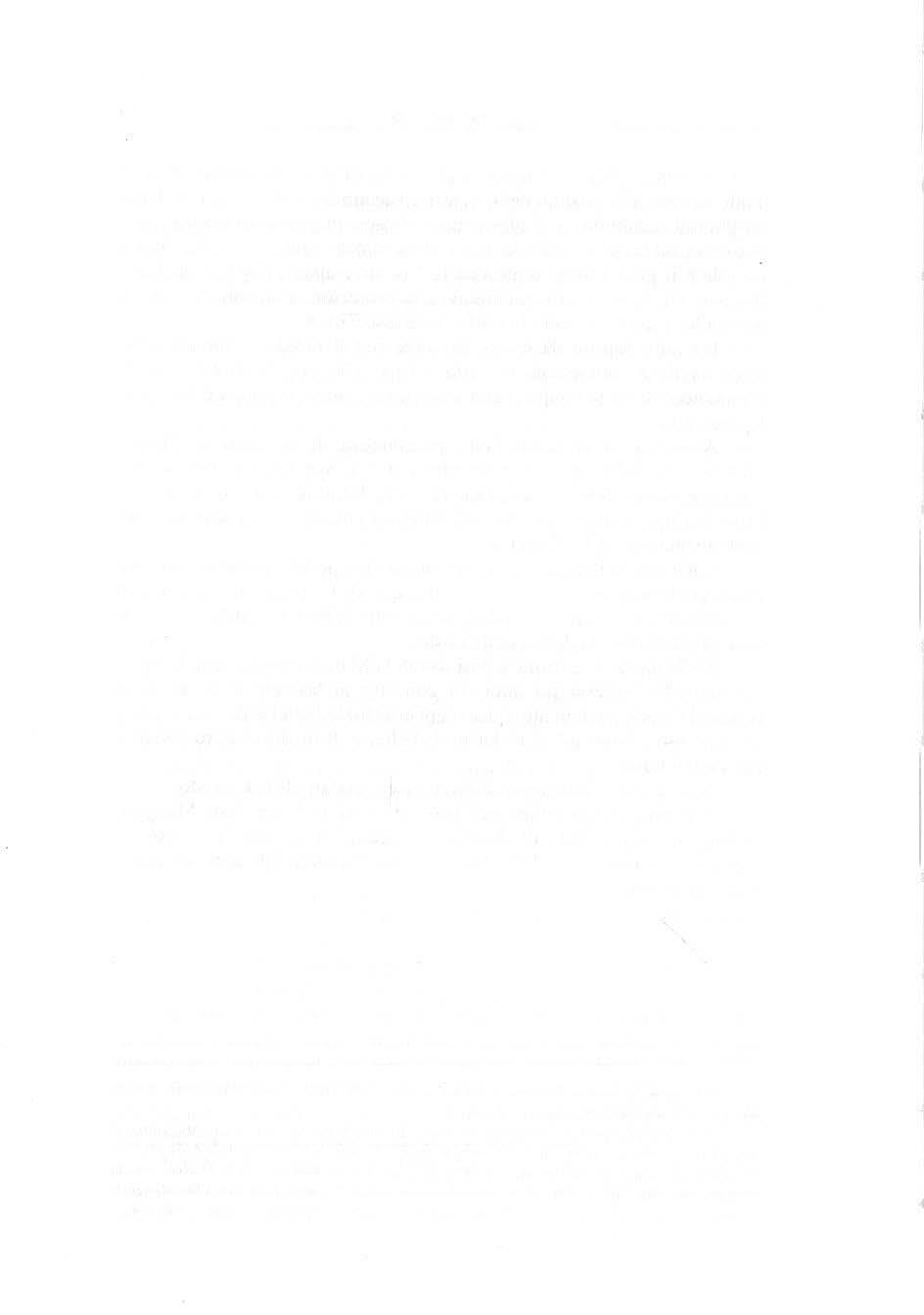
«Sistemazione dei depositi di munizioni e di esplosivi: situazione attuale e progetti di sistemazione da attuare, direttive generali per il riordinamento delle dotazioni (dotazioni di primo rifornimento per i corpi d'armata comprendenti i depositi reggimentali e di frontiera, dotazioni per le ba/ferie di primo e secondo tempo, dotazioni di secondo rifornimento) e dei depositi per esplosivi di lancio, di scoppio e per proietti».
Riunione del 5 agosto 1925 presso S.E. il Capo di Stato Maggiore Generale relativa alla sistemazione dei depositi munizioni ed esplosivi

Intervengono:
il Generale di Divisione Torretta, Direttore Superiore delle Costruzioni di Artiglieria
il Gen. di Div. Cortese, Direttore Generale dì Artiglieria
il Gen. dì Div. D'Havet, Direttore Superiore delle Costruzioni del Genio
il Gen. dì Brigata Amantea , Capo Reparto Operazioni
il Gen. di Brigata Santini, Capo del Rep. Ord. e Mobilitazione
il Gen. di Brigata Montefinale, addetto all'Ufficio del Gen. a disposizione per l' Artigl ìerìa
il Colonnello Pariani, Capo Ufficio Operazioni
il Ten. ColonneJlo Frìcchione dell'Uff. Ord. e Mob.
il Ten. Colonnello Maritano dell 'Uff. Servizi
Elemento fondamentale per la valutazione dei problemi da risolvere per la sistemazione delle dotazioni e dei depositi munizioni è l'esatta conoscenza del fabbisogno dì munizioni ed esplosivi per le artiglierie assegnate alle unità mobili e alla difesa. Poiché tale accertamento non è ancora stato fatto, occorre sollecitarlo 1 •
1 Come norma, per la determinazione delle graninire occorrenti alla costituzione delle dotazioni di esplosivi di lancio, si assume la seguente proporzion e media per le cariche corrispondenti a 100 colpi: IO cariche massime; 85 cariche medie: 15 cariche minime.
Ciò posto la questione della spesa non può essere affrontata con piena cognizione di causa nella presente riunione, che si limita pertanto a stabilire le linee generali del programma di riordinamento dei depositi munizioni ed esplosivi, programma la cui attuazione deve essere preceduta dalla precisa determinazione del munizionamento da radiare 2 e da co nservare.
E poiché le direttive per la sistemazione dei depositi non possono astrarre dalla situalione di fatto e dai provvedimenti adottati o in corso di attuazione, anche questo argomento s arà oggetto di esame.
Si dà quindi lettura di un promemoria compilato in seguito ad una recente riunione degli Uffici Operazioni, Ord. e Mob., Servizi e qui di seguito riportato nella parte concernente i seguenti argomenti:
A) Situazione attuale delle dotazioni e dei depositi; progetti e provvedimenti in corso di attuazione.
B) Direttive generali per il riordinamento delle dotazioni e dei depositi.
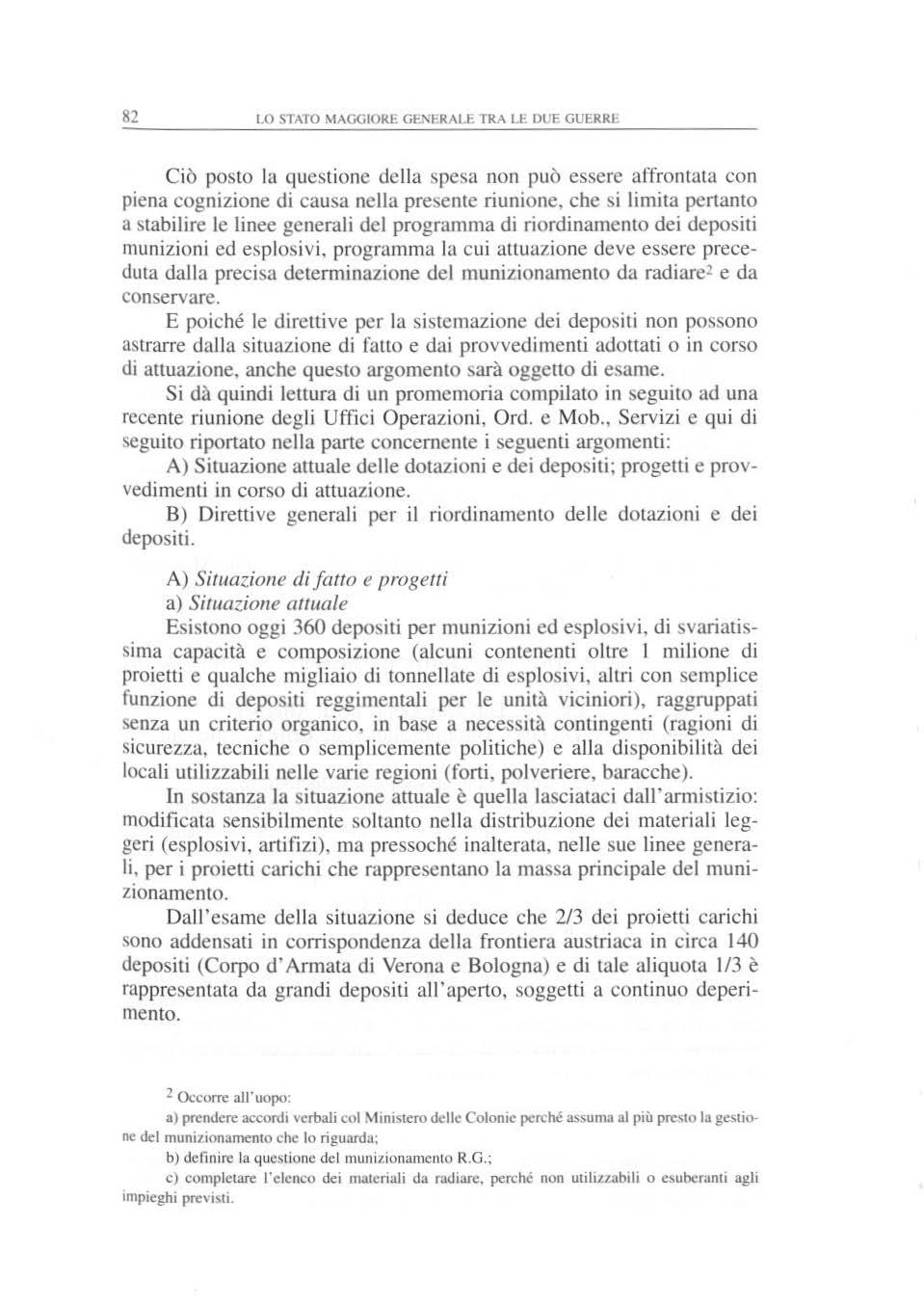
A) Situazione di fatto e progetti
a) Situazione attuale
Esistono oggi 360 depo siti per munizioni e d esplosivi, di svaria ti ss ima capacità e composizione (alcuni contenenti oltre 1 milione di proietti e qualche migliaio di tonnellate di esplosivi, altri con se mplice funzione di depo s iti reggim e ntali per le unità viciniori), raggruppati se nza un criterio organico, in base a necessità contingenti (ragioni di s icurezza, tecn iche o semplicemente politiche) e alla disponibilità dei locali utilizzabili nelle varie regioni (fo rti, polveriere, baracche).
In sos tanza la s ituazione attuale è quella lasciataci dalranni stizio: modificata sensibilmente soltanto nella distribuzione dei materiali leggeri (esplosivi, artifizi), ma pressoché inalterata, nelle sue linee generali, per i proietti carichi che rappresentano la massa principale del munizionamento.
Dal l'esame della situazione si deduce che 2/3 dei proietti carichi so no addensati in corrispondenza della frontiera austria ca in circa 140 depositi (Corpo d ' Armata di Verona e Bologna) e di tale aliquota 1/3 è rappresentata da grandi depositi all'aperto, soggetti a continuo deperimento.
2 Occorre ali' uopo :
a) prendere accordi \'erbati col \,lintstcro delle Colonie perché ~suma al più presto la ge\tione del munizionamento che lo riguarda;
b
) dclinire la quc:.tione del muni,ionamcnto R.G.;
e) completare l'elenco dei materiali da radiare, perch é non utili11abili o esuberanti agli impieghi prev1s11.
L'unico provvedimento organico in corso di attuazione consiste nell'allestimento di 17 nuovi depositi razionali per esplosivi di lancio, ripartiti fra i vari corpi d'armata3, con una capacità complessiva di 12.800 tonnellate di esplosivo (1/2 circa della disponibilità).
Per tali depositi, pressoché ultimati, sono stati spesi 30 milioni stanziat i nel 1922.
La Commissione permanente per la sistemazione dei depositi, nominata alla fine del 1923, presentava l'anno scorso un progetto di riordinamento razionale dei depositi, per il quale era prevista una spesa comp le ssiva di 220 milioni così ripartiti:

120 milioni per la sistemazione dei proietti;
40 milioni per completamento di sistemazione esplosivi lancio e scoppio;
60 milioni per la sistemazione dei centri caricamento proietti.
Non avendo potuto essere accolto il progetto anzidetto per ragioni di bilancio, la Commissione stessa, per invito del Ministero delle Finanze, studiava al principio di quest'anno un progetto ridotto di sistemazione dei depositi, corrispondente «alle necessità più urgenti e improrogabili» specialmente in rapporto con la pubblica incolumità.
Tale progetto, integralmente accettato dal Ministero delle Finanze qualche mese addietro, importa una spesa complessiva di 88 milioni da spendersi in tre anni, così ripartita:
- per sis temazione delle dotazioni corrispondenti a 4 giornate di fuoco per le artiglierie mobili dell'Esercito operante . . . .... . . . .... ..... . 30.000.000
- per la sistemazione di 4.500 tonnellate di esp losiv i di scoppio. . 7.000.000
- per 1 o 2 depositi centrali proietti carichi nella Valle Padana I 0.000.000
- per 2 depositi centrali proietti in Sicilia e in Sardegna 4.000.000
- per impianto di parafulmini a rete ai depositi esistenti 8.000.000
- per attivare e completare lo scaricamento dei proietti avariati o radiati ... . .... . . . . .. . . .. .
- per l'esecuzione dei trasporti inerenti al programma di sistemazione ... . .... . .. . . ..
Il programma anzidetto sta entrando ora nella fase esecutiva (progetti di massima approvati per 6 corpi d'armata). Manca in esso uno stanziamento di fondi per i depositi munizioni di frontiera che rapprese ntano una necessità abbastanza urgente per le artiglierie da posizione. Occorrerà provvedervi, attuando opportune economie sulle altre voci di spesa e specialmente sulle som me previste per i depositi centrali.
B ) Direttive generali per il riordinamento delle dotazioni e dei depositi
1) Eliminare al più presto le munizioni radiate o eccedenti al fabbisogno per taluni calibri.
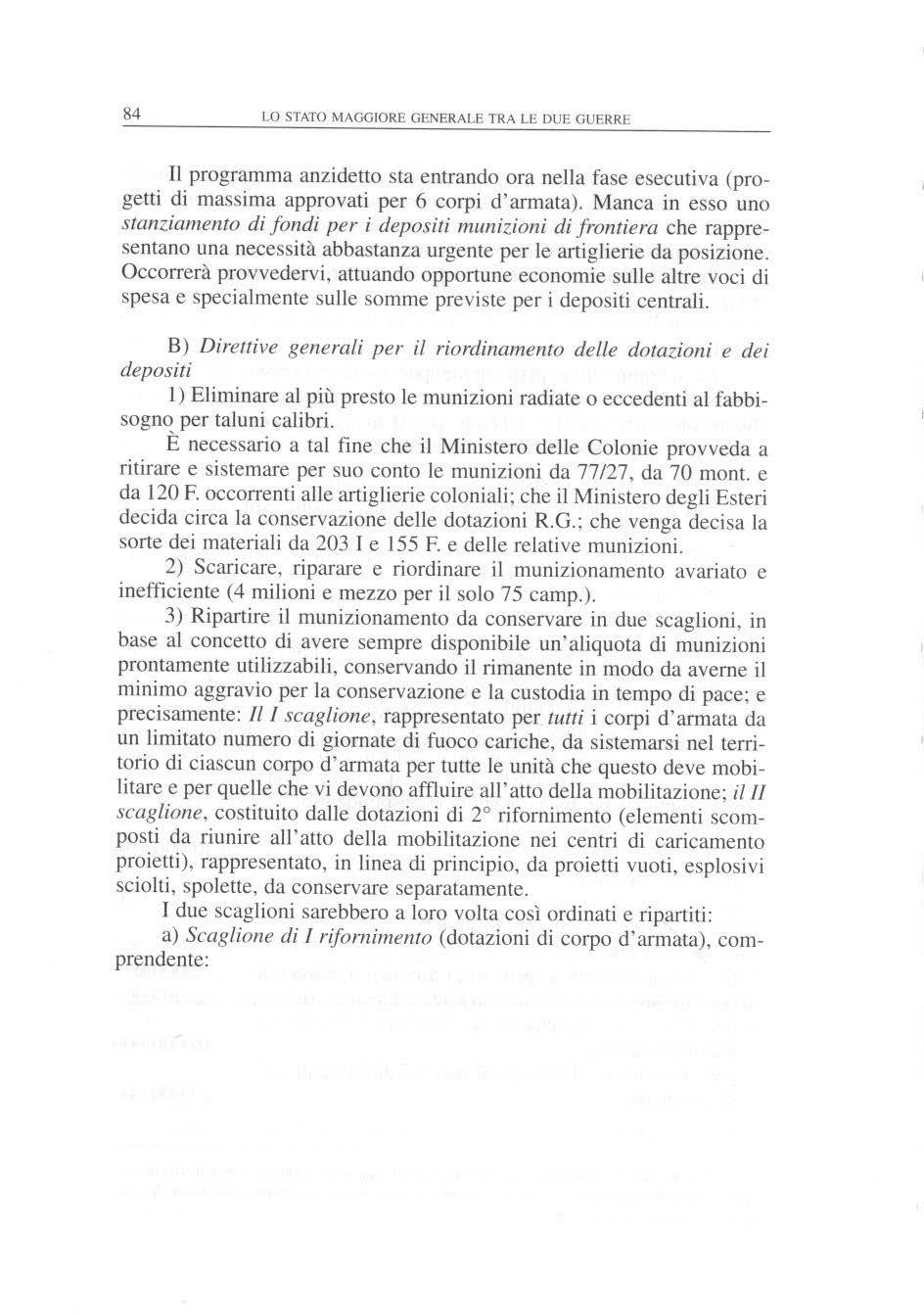
È necessario a tal fine che il Ministero delle Colonie provveda a ritirare e sistemare per s uo conto le munizioni da 77 /27, da 70 mont. e da 120 F. occorrenti alle artiglierie coloniali; che il Ministero degli Esteri decida circa la conservazione delle dotazioni R.G. ; che venga decisa la sorte dei materiali da 203 Te 155 F. e delle relative munizioni.
2) Scaricare, riparare e riordinare il munizionamento avariato e inefficiente (4 milioni e mezzo per il solo 75 camp.).
3) Riprutire il munizionamento da conservare in due scaglioni, in base al concetto di avere sempre disponibile un 'aliquota di munizioni prontam ente utilizzabili, conservando il rimanente in modo da averne il minimo aggravio per la conservazione e la custodia in tempo di pace; e precisamente: Il I scaglione, rappresentato per tutti i corpi d'armata da un limitato numero di giornate di fuoco cariche, da sistemarsi nel territorio di ciascun corpo d'armata per tutte le unità che ques to deve mobilitare e per quelle che vi devono affluire all'atto della mobilitazione; il II scaglione, costituito dalle dotazioni di 2° rifornimento (elementi scomposti da riunire all'atto della mobilitazione nei centri di caricamento proietti), rappresentato, in linea di principio, da proietti vuoti, esplosivi sciolti, spolette, da conservare separatamente .
T due scagl ioni sarebbero a loro volta così ordinati e riprutiti:
a) Scaglione di I rifornimento (dotazioni di corpo d'armata), comprendente:
Circa 4 giornate di fuoco per le unit à mobili di ognicorpo d 'armata
Deposit i reggimentali: (Circa una giornata e mezza di fuoco, proietti carichi con cariche di lancio). Dotazioni di batteria e di gruppo delle unità mobili del corpo d'armata4 •
Depositi avanzati di frontiera:
(Proietti carichi con cariche di lancio). 2 1/2 giornate di fuoco per le unit à di primo impiego (div isioni rinforzate).
-
6 giornate d i fuoco per le artiglierie da posiz ione di l 0 Tempo del corpo d'armata, 4 g. di f per 120 batterie di 2° Tempo e per quelle contraeree da posiz ione
Depositi di corpo d'armata: Per le batterie di 1° Tempo:
(Proietti carichi generalmente separati dagli esplosivi di lancio), circa 2 l/2 g. di fuoco per le rimanent i unità mobili del C.d' A. e per quelle di prima affluenza (C.d'A. di frontiera)5.
Depositi avanzati di frontiera. che potranno essere (in tutto o in parte) presso le stesse località d'imp iego delle batterie, oppure coincident i con quelli da stabi lire, un po' più indietro. per le unità mobili di primo impiego. Devono essere stabiliti , a cura dei comandi di C. d' A. in base al progetto di schieramento per la copertura.
Per le batterie di 2° Tempo:
Depositi arretrati di frontiera. da siste mare, su proposta dei C.d' A. dietro le posizioni arretrate di difesa (le 4 g. di fuoco ripartite fra le frontiere, in parli proporzionali all'armamento di 2 ° Tempo).
4 In casi favorevoli possono essere raggnippati opponunamente o aggregat i ai depositi di C.d'A. vicin iori.
5 Per la determinazione dei depositi corrisponden t i a ll e unità mobili di prima affluenza si è proceduto ad una ripanizione teorica delle truppe assegnate ad ogn i scacchiere, come se si dovesse provvedere alla sicurezza (misura prudenziale) su tutte le frontiere.

b) Dotazioni di 2 ° rifornimento: Sono poste in pace alla dipendenza del Ministero, ad eccezione dell'aliquota pertinente alle Isole. In teoria dovrebbero comprendere 8-1 O giornate di fuoco per tutte le artiglierie mobili e 6-8 per quelle da posizione effettivamente impiegabili dall'Esercito operante6.
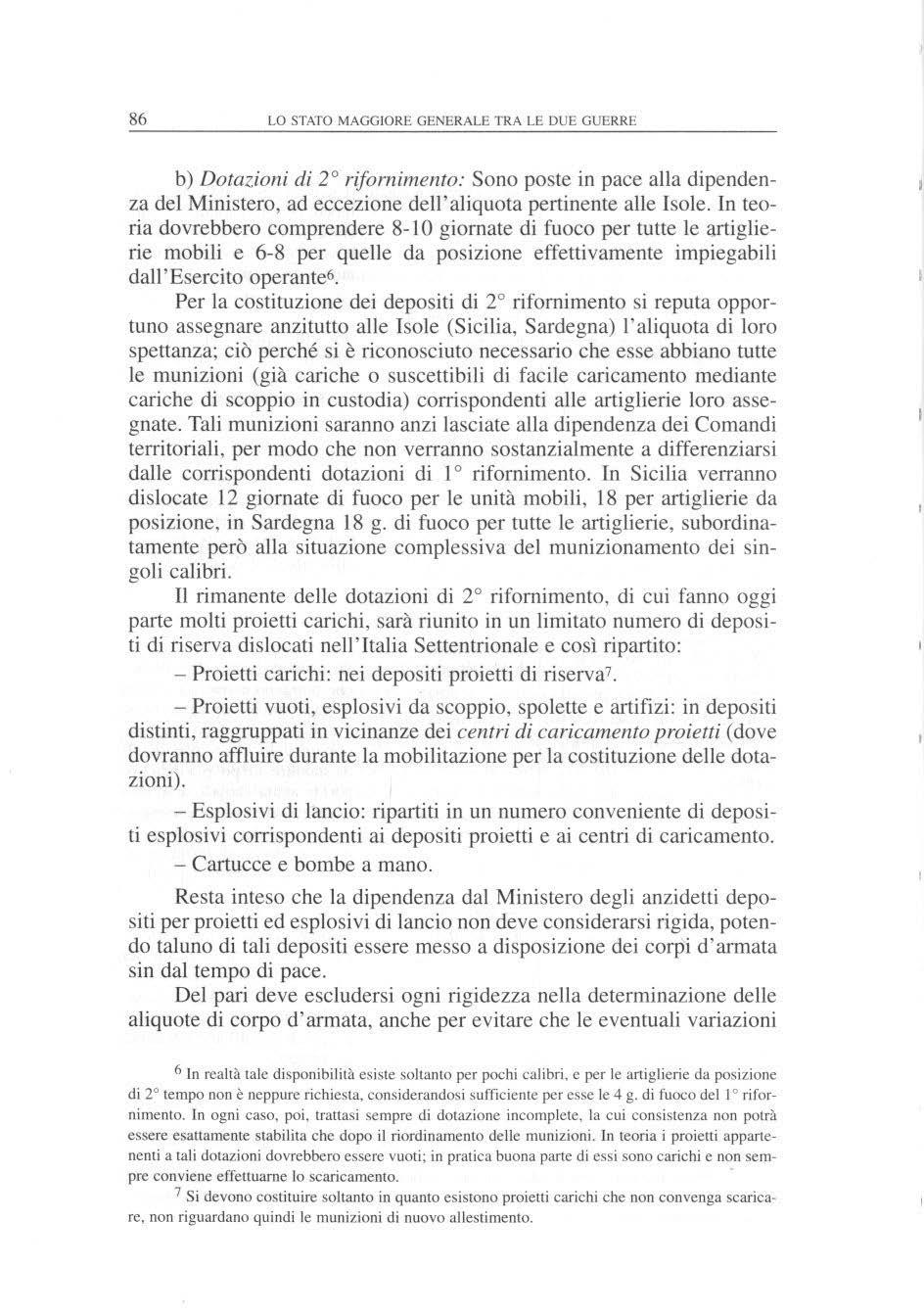
Per la costituzione dei depositi di 2 ° rifornimento si reputa opportuno assegnare anzitutto alle Isole (Sicilia, Sardegna) l'aliquota di loro spettanza; ciò perché si è riconosciuto necessario che esse abbiano tutte le munizioni (già cariche o suscettibili di facile caricamento mediante cariche di scoppio in custodia) corrispondenti alle artiglierie loro assegnate. Tali munizioni saranno anzi lasciate alla dipendenza dei Comandi territoriali, per modo che non verranno sostanzialmente a differenziarsi dalle corrispondenti dotazioni di l O rifornimento. In Sicilia verranno dislocate I 2 giornate di fuoco per le unità mobili, 18 per artiglierie da posizione, in Sardegna 18 g. di fuoco per tutte le artiglierie, subordinatamente però alla situazione complessiva del munizionamento dei singoli calibri.
Il rimanente delle dotazioni di 2 ° rifornimento, di cui fanno oggi parte molti proietti carichi, sarà riunito in un limitato numero di depositi di riserva dislocati nell'Italia Settentrionale e così ripartito:
- Proietti carichi: nei depositi proietti di riserva?.
- Proietti vuoti, esplosivi da scoppio, spolette e artifizi: in depositi distinti, raggruppati in vicinanze dei centri di caricamento proietti (dove dovranno affluire durante la mobilitazione per la costituzione delle dotazioni).
- Esplosivi di lancio: ripartiti in un numero conveniente di depositi esplosivi corrispondenti ai depositi proietti e ai centri di caricamento.
- Cartucce e bombe a mano.
Resta inteso che la dipe ndenza da l Ministero degli anzidetti depositi per proietti ed esplosivi di lancio non deve considerarsi rigida, potendo taluno di tali depositi essere messo a disposizione dei corpi d'armata sin dal tempo di pace.
Del pari deve escludersi ogni rigidezza nella determinazione delle aliq uote di corpo d'armata, anche per evitare che le eventuali variazioni
6 Jn realtà tale disponibi lità esiste sollanLo per pochi calibri. e per le artiglierie da posizione di 2° tempo non è neppure richiesta , considerandosi sufficiente per esse le 4 g. di fuoco del I O rifornimento. In ogni caso. poi, tranasi se mpre di dotazione incomplete, la cui consistenza non potrà essere esattamente stabilita che dopo il riordinamento delle munizioni. In teoria i proieni appartenenti a tali dotazioni dovrebbero essere vuoti; in pratica buona parte di essi sono carichi e non sempre conv iene effeuuame lo scaricamento.
7 S i devono costituire soltanto in quanto esistono proietti carichi che non convenga scaricare, non riguardano quindi le mu nizioni di nuovo allestimento.
nel numero e nell'armamento delle unità previste per qualche corpo d'armata obblighino a frequenti rivolgimenti nella sistemazione delle dotazioni relative, la cui determinazione per i singoli corpi d'armata sarà fatta dallo Stato Maggiore.
A complemento di quanto è detto nel promemoria riportato, di cui si accettano in massima le direttive proposte circa lo scaglionamento delle dotazioni, si osserva:
In sostanza la sistemazione del munizionamento richiede:
a) depositi per esplosivi di lancio
b) depositi per esplosivi di scoppio
c) depositi per proietti.
a) Per gli esplosivi di lancio il fabbisogno conseguente al riordinamento delle artiglierie mobili e da posizione risulterà sensibilmente ridotto non solo rispetto a quello precedentemente calcolato (27 .000 tonn.), ma ancora rispetto alle disponibilità attuali (24.500 tonn.). Si potrà quindi eliminare senz'altro molta parte degli esplosivi di minor gradimento (nitrocellulosa, polveri di P.B., ecc.), riducendo così anche il fabbisogno di depositi.
Molto probabilmente le 320 baracche che fra tre mesi saranno ultimate (capacità 12.800 tonn.) potranno, in unione con qualcuno dei depositi vecchi, non soltanto risolvere completamente il problema dei depositi per esplosivi di lancio, ma anche concorrere in piccola parte alla s istemazione degli esplosivi di scoppio.
b) Esplosivi di scoppio. Le disponibilità attuali di tali esplosivi (10.000 tonn.) risultano sensibilmente inferiori al presumibile fabbisogno (14.000 tonn. circa); esse saranno però gradualmente aumentate con gli esplosivi provenienti dallo scaricamento dei proietti radiati e con quelli di nuova produzione.
Di ciò si dovrà tener conto nell'allestimento dei nuovi depositi per tali esplosivi, cui spetta la precedenza per evidenti ragioni di pubblica incolumità.
c) Proietti. L'ordine di precedenza nella sistemazione delle varie aliquote specificate nel promemoria sopra riportato può così stabilirsi:

1) Dotazioni reggimentali
2) Dotazioni dei corpi di armata di frontiera
3) Dotazioni delle Isole
4) Dotazioni delle artiglierie da posizione
5) Dotazioni dei corpi d'armata non di frontiera
6) Dotazioni di 2° rifornimento e centri di caricamento proietti.
Circa la questione della spesa, si osserva che l'assegnazione degli 88 milioni, previsti dalla Commissione per l'attuazione di un piano ridotto di sistemazione, sulla base di un armamento sensibilmente supe-
riore a quello ora determinato, consentirà certamente di sistemare tulli gli esplosivi di scoppio e le dotazioni di 1° rifornimento (compresi i depositi di frontiera), oltre ad una parte di quelle di 2 ° rifornimento.
Il tempo assegnato all'esecuzione dell'anzidetto programma è stato già determinato in 3 anni. Perché tale limite non sia superato occorre l'armonico e attivo concorso di tutti gli organi direttivi ed esecutivi. E poiché il progetto e la costruzione dei depositi spettano agli organi centrali e territoriali del Genio, occorrerà che questi facciano del loro meglio perché l'attuazione del programma non soffra ritardi.
Circa la ripartizione delle attribuzioni relativa alla sistemazione dei depositi e delle dotazioni, si osserva che la parte diretti va spetta ali' ente cui compete in guerra l'alta direzione del servizio di artiglieria cioè all'Ufficio del Generale a disposizione per l'Artiglieria, sia perché tale attività organizzatrice costituisce in pace la miglior preparazione alla direzione dei rifornimenti in guerra, sia perché l'organizzazione dei depositi di pace costituirà nei primi mesi dopo la mobilitazione un fattore predominante per l'ordinamento del servizio di rifornimento.

Ciò non esclude l'ingerenza del Stato Maggiore nell'esame dei progetti di sistemazione compilati dall'Ufficio predetto, per controllare se essi corrispondono effettivamente ai concetti operativi e alle possibilità logistiche consentiti dai mezzi di trasporto disponibili.
Per agevolare l'opera del Generale a disposizione per l'Artiglieria viene posta a sua disposizione la ricordata Commissione permanente, la quale per essere costituita dai rappresentanti di tutti gli Enti che concorrono alla soluzione del problema, costituisce anche il migliore collegamento fra gli enti stessi.
A.U.S.S.M.E..fondo H- 10 « Verbali riunioni 1924-1943 », busra 11. 2,fascicolo 11. I.
Anche questo documento 11011 è un vero e proprio verbale 111a una rela~ione riassuntiva sulla riunione. compilala dall'Ufficio Operazioni dello Staro Maggiore del Regio Esercito. li docu111efl/o è annotato sia dal co/ormello Pariani. capo dell'Ufficio Operazioni, che da Badoglio.
« Prov, ·edimenti occorrenti al completamento e alla .~istema:.ione delle dotazioni di esplosil'i: esplosi, ·i di lancio (disponibilità, occorre11:.a e spesa. sistemazione) e esplosi Pi a scoppio».
Riunione del 20 agosto 1925 pre..,..,o il S.E. il Capo di Stato Maggiore Generale per la determina1,ione dei provvedimenti occorrenti per il completamento e la sistemazione delle dotazioni esplosivi.

Intervengono:
Il Generale di Divisione Torretta, Direttore Superiore delle Co<;truzioni di Artiglieria ( a l
Il Generale di Di, bione Cortese. Direttore Generale di Artiglieria
Il Generale di Brigata Amantea, Capo del Reparto Opera1,ioni
Il Generale di Brigata Santini. Capo del Reparto Ordin. e Mob.
Il Generale di Brigata Monte finale. addetto all'Ufficio del Generale a di..,posizione per l'Artiglieria
li Ten. Colonnello Maritano dell'Ufficio Servi1,i
Il Ten. Colonnello Mondino dell'Ufficio Ordinamento e Mobilitazione
Le questioni esaminate possono così riassumersi:
I) Esplo..,ivi di lancio:
a) Disponibilità
Esistenza complessiva: 18.400 T., cui possono aggiungersene altre 600 in allestimento per precedenti commesse. 'Totale 19.000 To1111.
Di tale disponibilità:
I0.200 Tonn. sono rappresentale da graniture regolamentari totalmente utilizzabili per l'armamento previsto (nel computo non entrano le artiglierie costiere. ancora da determinare).
2.500 Tonn. sono costituite da b,ùistiti regolamentari di utilizzazione certa, sebbene non precisata. Costituiscono nel loro complesso una riserva da conservare.
6.300 Tonn. sono costituite da nitrocellulose americane, utilizzabili con molte riserve e solo in caso di assoluta necessità (potranno forse destinarsi al caricamento di bombe a mano): sono soggette a deperimento relativamente rapido.
b) Occorrenza e spesa
Prescindendo dal fabbisogno delle artiglierie costiere, l'occorrenza complessiva degli esplosivi di lancio risulta di 13.800 Tonn., e poiché la disponibilità corrispondente è di 10.200 T. , ne risulta, per le graniture regolamentari, una deficienza complessiva di 3.600 T., la cui provvista importa una spesa di 80 milioni.
Volendo scalare tale spesa in base all'urgenza relativa della provvista: 20 milioni spetterebbero al completamento delle dotazioni delle unità di 1° tempo (deficienza 900 Tonn.), 60 per quelle di 2° tempo (2.700 T.).
c) Sistemazione
ln base a quanto sopra è esposto i quantitativi di esplosivi di lancio da sistemare possono così raggruppars i:
a) 10.200 Tonn. - aliquota delle dotazioni regolamentari, oggi disponibile.
b) 2.500 Tonn. - graniture regolamentari in più delle precedenti, utilizzabili ora o in avvenire (riserva).
c) 6.300 Tonn. - polveri americane di utilizzazione eventuale, da eliminare col tempo.
d) 3.600 Tonn. - aliquota delle dotazioni regolamentari da allestire ex novo.
Per la sistemazione dei gruppi a) e b) (totale 12.700 tonn.) risultano s ufficienti i nuovi depositi esplosivi da ultimare entro l 'an no.
Ad allestimento compiuto di tutte le baracche previste per tali nuovi depositi vi potrebbero trovare posto le 14.000 Tonn. circa dei gruppi a) ed). E poiché è probabile che quando saranno allestite le 3600 Tonn. del gruppo d), gli esplosivi del gruppo b) avranno in buona parte colmate le lacune (consumi annuali, distruzioni , incendi) del gruppo a), si può ritenere che nessuna nuova costruzione sia necessaria per la sistemazione dei quantitativi a), b), d).

Quanto alle nitrocellulose del gruppo c), la migliore soluzione sembra quella di lasciarla, fino a consumazione, nei vecchj depositi, evitando per quanto possibile, anche la spesa per spostamenti.
In conclusione gli esplosivi di lancio possono essere totalmente sistemati nei depositi esistenti o in costruzioni, e poiché si presume che queste ultime siano pronte entro l'anno, la sistemazione anzidetta dovrebbe essere compiuta entro la primavera del 1926.
2) Esplosivi di scoppio
Ne occorrono 12.700 Tonn. Ne esistono 9.600 Tonn. , cui vanno aggiunte altre 1.200 Tonn. in corso di allestimento per precedenti commes se.
La deficienza è quindi di 1.900 Tonn., il cui allestimento richiede una spesa di 12 milioni.
Degli esplosivi occorrenti una parte potrà essere conservata nei più adatti depositi oggi esistenti, per il rimanente occorre costruire nuovi depositi.
La Direzione Generale di Artig lieria deve far conoscere entro il 15 Ottobre p.v. il fabbisogno finanziario per la costruzione di detti nuovi depositi; terrà inoltre informato lo Stato Maggiore dei movimenti effettuati per la sistemazione definitiva degli esplosivi di lancio e di scoppio.
A.U.S.S.M.E..fondo H-10 «Verbali riunioni». busta 11. 2.fascicolo 11. I. li documento è una relazione riassunti va della riunione, compilata da/l'Ufficio Operazioni dello Stato Maggiore del Regio Esercito ed è siglato dal colo1111ello Paria11i, capo di quell'ufficio.
a) I partecipanti alla riunione erano 11mi ujfici<1li dell'Esercito e dirigevano enti del Ministero della Guerra (i generali Torre/la e Cortese) o dello Stato Mag giore del Regio Esercito (i generali Amantea, Santini e Monte.finale, il tenente colonnello Maritano e il tenente colom1ello Mondin o).


« Preparaz ion e della guerra contro la Jugoslavia ( Ipotesi Est): rapporti della Jugoslavia con gli Stati confinanti e questione interna del Montenegro, prepara zione dell'esercito jugoslavo, azione di un corpo di spedizione in Albania e schieramento delle nostre forz.e alla frontiera, organiz.-;,a-;,ione e poten-;,ialità dell'aviazione jugoslava, difesa di Fiume e compiti della Marina »
Verbale della riunione tenuta da S.E. il Capo di Stato Maggiore Generale il giorno 28 febbraio 1927.
Alle ore IO del giorno 28 febbraio 1927 nel sa lon e delle riunioni delle LL.EE. i Sottosegretari di Stato (Palazzo del ViminaJc), S.E. il Maresciallo B adoglio, Capo di S.M.G., ha convocato:
- S.E. il Capo di S.M. dell'Esercito 1a1.
- S.E. il Capo di S.M. della Marina.
- S.E. il Capo di S.M. dell'Aeronautica.
Erano anche presenti:
- TI Capo Ufficio Operazioni del Comando del Corpo di S.M.
- Il Capo Ufficio Operazioni dello S.M. della Marina.
- Il Capo dell'Ufficio del Capo di S.M.G.
- Il Capitano di S.M. della segreteria del Comando del Corpo di S.M.
Prende la parola
S.E. il Maresciallo Badoglio.
S.E. il Capo del Governo, eg li dice, mi ha ultimamente intratten uto s ulla s ituazion e jugoslava.
Risulta che il R eg no S. H .S. sta perfezionando, co n ritmo acceleralo, il suo armamento. Infatti il suo esercito ha già unificato l'armamento di tutta la fanteria. Quattro armate su cinque hanno unificato anche il calibro delle artiglierie leggere: tre con materiale francese, una con materiale ex austriaco.
Dopo il Lrattato di Tirana, poi, la Jugoslavia ha ancora aumentato la sua attività per quanto concerne la preparazione mi l itare, e il nostro addetto, Ten. Colonnello Visconti Prasca, ha ultimamente inviato in proposito un rapporto, del quale il Colonnello Be rti vi darà ora lettura.

Esiste effettivamente in Jugo s lavia, come mi ha fatto anche osservare S.E. il Capo del Governo in ba se ai documenti a Lui noti, una notevole ten s ione nervosa che s i traduce in preparativi molto manifes ti pe r una eventualità non lontana di guerra. Anche S.E. il Capo del Governo ritiene, come io ritengo, che tale nervosismo s ia originato da un se nso di paura: ma poiché ci sono noti i sen timenti di megalomania del popolo S.H.S. e l 'influe nza quasi egemo nica che l'elemento militare ha sulla politica jugoslava , potremmo in un giorno, anche non lontano, trovarci di fronte alla nece ssità di una guerra con tale popolo.
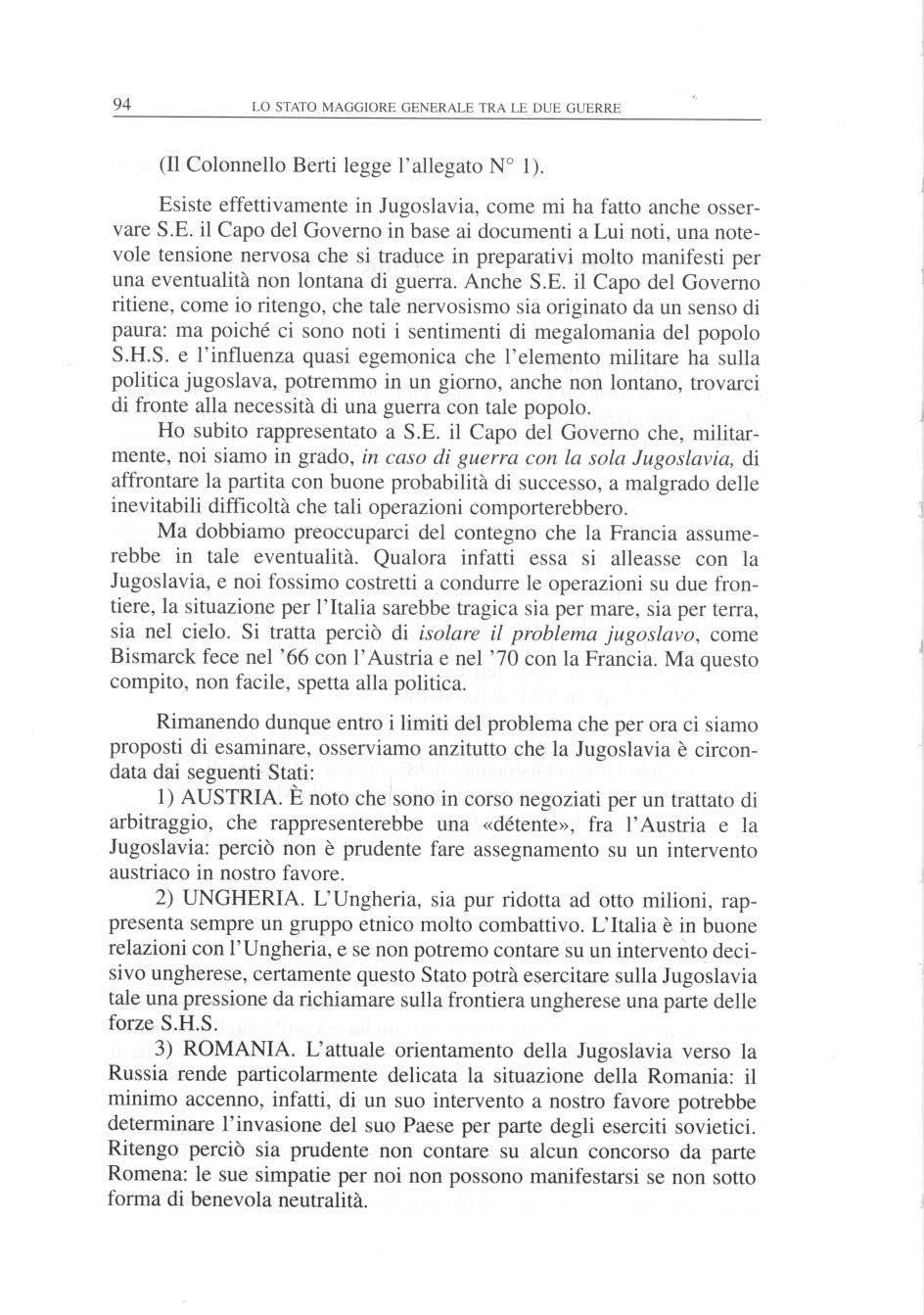
Ho subito rappre senta to a S.E. il Capo del Gov e rno che, militarmente, noi siamo in grado, in caso di guerra con la sola Ju gos lavia, di affrontare la partita con buone probabilità di s ucc esso, a malgrado delle in ev itabili difficoltà che tali operaz ioni comporterebbero.
Ma dobbiamo preoccuparci del contegno c he la Francia assumerebbe in tale eventualità. Qualora infatti essa s i alleasse con la Ju gos lavia, e noi fossimo costretti a condurre le operazioni s u due frontiere, la s ituazione per l'Italia sare bb e tragica s ia per mare, sia per terra, sia nel cie lo . Si tratta perciò di isolare il problema jugoslavo, come Bi s marck fece nel '66 con l'Austria e nel '7 0 con la Francia. Ma questo compito, non facile, spetta alla politica.
Rimanendo dunque entro i limiti d el problema che per ora ci s iamo proposti di esaminare, osserv iamo anzitutto che la Jugoslavia è circondata dai seguenti Stati:
1) AUSTRIA. È noto che sono in corso negoziati per un trattato di arbitraggio, che rappres enterebbe una «détente», fra l 'A ustria e la Jugo s lavia: perciò non è prudente fare assegnamento su un intervento austriaco in nostro favore.
2) UNG HERIA. L' Ungheria , sia pur ridotta ad otto milioni , rappresenta sempre un gruppo etnico molto combattivo. L'Italia è in buone relazioni con l ' Ungheria, e se non potremo contare su un intervento decisivo ungheres e, certamente questo Stato potrà esercitare sulla Jugoslavia tale una press ione da richiamare s ulla frontiera unghere se una parte delle forze S. H .S.
3) ROMANIA. L' attuale orientamento della Jugoslavia verso la Russia rende particolarmente delicata la situazione della Romania: il minimo accenno, infatti, di un suo intervento a nostro favore potrebbe determinare l'invasione del s uo Paese per parte degli eserciti sovietici. Ritengo perciò sia prudente non contare s u alcun concorso da parte Romena: le sue simpatie per noi non possono manifestarsi se non sotto forma di benevola neutralità.
4) BULGARIA. Ogni attività di S.E. il Capo d e l Governo è rivolta a stabilire ottime relazioni fra Bucarest e Sofia, allo sco po di dare alla Bulgaria maggiore libertà d'azione. E certamente essa con «comitagi», prima, e con truppe regolari, poi , entrerà nel conflitto contro la Jugoslavia, con la quaJe deve, e vuole, regolare la questione macedone.
5) GRECIA. Data la instabilità interna è difficile fare su di essa una previsione. Contro di noi è diffici le che si metta, data la vulnerabilità per mare. È prudente non tener conto di essa.
6) ALBAN IA. Questo Stato entrerà nel nostro giuoco, se noi lo appoggeremo. Qualora sia abbandona to a sé stesso, può darsi che al Governo di Ahmed Zogu ne succeda un altro a noi contrario. Quindi dobbiamo dargli armi (come facciamo) e materiali, in modo che l'Albania rappresenti per la Ju goslavia una reale minaccia e, per noi, una strada già organizzata per la penetrazione nei Balcani.

7) Vi è poi una Nazione che non esiste, come Stato, s ulla carta, ma che esiste dal punto di vista etnico: il Montenegro. È bene tenerlo prese nte , quantunque la nota volubilità dei suoi abitanti non ci permetta di considerarlo mai come un sicuro elemento a nostro favore.
Da questo breve e succinto esame possiamo dedurre che la Jugoslavia dev e nutrire serie preoccupazioni almeno su due frontiere oltre, ben s' intende la nostra: la Ungherese e la Bulgara, alle quali, se noi faremo qualche cosa, occorre aggiungere l'Albanese.
Pa ss iamo ora ad esaminare l'organiz zaz ione dell'esercito di pace S.H.S. Premetto che que sto esercito non ha corpi d'armata. Esso è ripartito in cinque armate che contano complessivamente 16 divisioni di fanteria , una divisione della Guardia e due divisioni di cavalleria;· il c he forma un totale di:
- 174 battaglioni di fanteria 1
- 50 s quadroni di cavalleria
- 244 batterie campai i leggere
- 20 batterie pesanti campali
- 20 batte,ie pesanti.
Il progetto di rnobilitazione jugoslavo, nelle sue grandi linee, è inspirato a concetti analoghi a quelli che presiedettero al progetto da noi in vigore prima dell'ultimo ordiname nto : ossia è basato sulla moltiplicazione delle grandi unità. In fatti la J ugoslavia ha me sso in preventivo la mobilitazione di 28 o 29 divisioni di fanteria. Ma, a parte le note deficienze di materiali, la Jugoslavia è povera di quadri; questi , come è noto,
sono già insufficienti ai bisogni dell'esercito sul piede di pace, tanto è vero che la Ju goslavia è costretta a ricorrere a ex ufficiali austriaci e ad ufficiali russi dell'esercito di Wrangel. Ora, siccome non è possibile costituire nuove grandi unità se mancano i quadri necessari, così ritengo che lo Stato S.H.S. mobiliterà un numero di divisioni corrispondenti a quello del tempo di pace e cioè 17 divisioni di fanteria e 2 di cavalleria.
Circa la radunata dell'Esercito S.H.S., il terreno ci dice che il grande movimento di afflusso deve avvenire secondo il solco Sava-Morava (percorso da ferrovia), solco che contorna tutta la parte montagnosa dello Stato, costituita dalla Croazia, dalla Bosnia, dalla Erzegovina e dalla vecchia Serbia. È vero che il Governo S.H.S. ba fatto non pochi lavori ferroviari attraverso la zona montana; ma occorre tener presente che tali linee , a scaitamento ridotto e tracciato tortuoso, non sono di grande rendimento.
Il Comando del Corpo di S.M. ha compilato uno studio per determinare la quantità di treni che dalla Jugoslavia possono giungere alla nostra frontiera ed è venuto nella conclusione che arriveranno al confine italo-S.H.S., al massimo, 80 treni al giorno.
L' I talia, favorita dai lavori fatti dal 1918 , ha migliorato la capacità di radunata del proprio esercito, tanto che sull'attestamento dell ' Isonzo possono giungere 150 treni al giorno.
E qui, tenendo presente:
a) che quasi certamente non tutte le forze jugoslave saranno contro di noi, ma una parte di esse dovrà essere inviata alle frontiere bulgara, ungherese e albanese;
b) che la nostra radunata si effettuerà più celermente di quella jugoslava, possiamo constatare come, sin dai primi giorni, noi avremo la superiorità numerica.
Questo ci induce a stabilire fin da ora quale deve essere, per parte nostra, il primo atto di ostilità: dobbiamo oltrepassare il confine e portare subito la guerra in territorio nemico: il che costituisce un primo notevole successo sia materiale che morale.
H o detto poc'anzi che dobbiamo adoperarci perché l'Albania costituisca reale minaccia per lo Stato S.H.S., e c iò perché una simile minaccia indurrà certamente Ja Bul garia a rompere ogni indugio e scendere in campo, costJingendo la Ju goslavia a trattenere parte delle sue forze alla frontiera bulgara.
S.E. il Capo di S.M. dell'esercito dovrà pertanto studiare la seguente questione:
azione di un corpo di sbarco procedente in Albania per attrarre da quella parte la maggiore quantità di forze jugoslave. Stabilire per la marcia verso est di questo corpo quale può essere la mig liore direttrice (probabilmente sarà la via R omana o via Egnazia).

Secondo punto di sbarco lungo la costa potrebbe essere Zara; ma questa città ha un retroterra così montagnoso che qualsiasi sbarco, per arrivare sul vivo, dovrebbe essere alimentalo da tante truppe che finiremmo per fare il giuoco del nemico, impiegando noi forze in numero superiore a quello che a lui occorrerebbe per resisterci. Perciò io escluderei uno sbarco in tale località. Ad ogni modo il Capo di S.M. dell'Esercito studi la questione.
Ciò premesso, conviene ora studiare su quale linea si deve effettuare lo schieramento delle forze al nostro confine terrestre.
Se noi potremo mobilitare subito tutte le 30 divisioni di 1° tempo , oltre i reggimenti bersaglieri, alpini e·· la cavalleria, la nostra frontiera da Fiume a M. Pec risulterà insufficiente alla schieramento (188 Km.). Può darsi però che il conflitto scoppi mentre tale numero di divisioni non sia ancora pronto: nella peggiore ipotesi noi possiamo fare assegnamento sulle 21 divisioni, che saranno pronte nell'entrante primavera.
Aggiungendo a queste i reggimenti bersaglieri, alpini e cavalleria possiamo ritenere di aver disponibile una forza complessiva di 24 divisioni, poiché in Albania invieremo le due divisioni di formazione speciale, che sono previste in più delle 21 ora ricordate. Anche in questo caso ritengo che da Pec a Fiume la frontiera sia difficilmente capace di uno schieramento ben articolato e tale da favorire una celere penetrazione nell'interno. Ciò perché la zona di facilitazione Porzen- Pomario è incastrata fra una zona montagnosa da Pec al Porzen e una zona di ostacolo dal Pomario al Trestenico.
È certo però che, nel caso della mobilitazione di 30 divisioni, la frontiera non è sufficiente allo schierame nto, e noi dovremo estenderla verso sud, comprendendovi Novi e Segna, origine di due itinerari che portano verso una direzione fra le più pericolose per gli jugoslavi. In questo caso sarà compito della R. Marina occupare Veglia e sbarrare il golfo del Quarnaro per assicurare il trasporto e lo sbarco delle truppe previste e i loro rifornimenti.

Quindi, riassumendo, il Capo di S.M. dell'Esercito deve effettuare:
- un primo studio: se occorre estendere lo schieramento fino a Novi e Segna, s upponendo di mobilitare le 21 divisioni e le altre truppe che saranno pronte in primavera;
- un seco ndo s tudio per lo schieramento delle 30 divisioni di 1° tempo.
S.E. il Capo di S.M. dell'Esercito fornirà questi dati a l Capo di S.M. della Marina, che completerà gl i st udi di s ua competenza.
Infine S.E. il Capo di S.M. dell'Esercito dovrà farmi compilare una tabella che faccia risaltare i dati di sbarco fra Zagabria e Lubiana delle unità jugoslave, basandosi s u di una durata di mobilitazione di cinque giorn i, e gli stessi dati per le no stre unità.
Circa l'aviazione jugoslava risulta che lo Stato S.H.S. possiede 380 apparecchi, di cui 80 non efficienti. Perciò la Jugoslavia può contare su 150 apparecchi in vo lo. Teniamo poi presenti le grandi difficoltà che questo Stato incontra per i rifornimenti.
Ho rappresentato a S.E. il Capo del Governo che l'Italia deve avere almeno 600 apparecchi per poter contare su 300 in volo.
Ho insistito su ciò per due ordini di idee:
I) Tale massa di apparecchi è la più efficace difesa antiaerea del territorio, difesa importantissima dato che nella zona di frontiera esistono molti manufatti idrici da difendere.
2) Tale massa di apparecchi è necessaria per bombardare e mettere fuori questione i centri ferroviari jugoslavi, ossia per arretrare le teste di sbarco delle Loro truppe e rendere così ancor più lenta la radunata nemica (in ispecie Zagabria, Carlovac e Ogulin e forse altri ancora verso l'interno).
A questi compiti deve concorrere tutta l 'aviaz ione: solo in un seco ndo tempo ali' Armata aerea non dipendente dall'Esercito e dalla Marina potranno essere assegnati compiti particolari , quali la distruzione degli stabilimenti principali interessanti la mobilitazione e specialmente quelli che riguardano l'industria bellica.
A tale scopo il Comando del Corpo di S.M. indicherà allo S.M. dell'Aeronautica quali obiettivi è necessario distruggere o neutralizzare.
Prego il Capo di S.M. dell'Aeronautica di mandarmi uno s pecchio s ull'attuale reale consistenza dell 'aviaz ione.
S.E. il Capo di S.M. della Marina domanda quali so no le direttive di S.E. il Capo di S.M.G. nei riguardi della città di Fiume dove es i ste un s ilurificio, che ha qualche interesse per la Marina.
S.E. il Capo di S.M.G. - Ritengo che ci s i debba fermamente proporre di proteggere subito la città di Fiume, s postando la copertura, fin dai primi giorni della mobilitazione, a sud-est.
Riassumendo , ora, quanto riguarda l'azione della Marina , occoITerà che lo S.M. della Marina studi:
I) L'operazione di protezione e di trasporto delle truppe in Albania .
2) L a protezione dello schieramento del nostro Esercito per la parte che sarà necessariamente prolungata verso Sud: l'occupazione dell'isola di Veglia effettuata, possibilmente, con truppe della Marina.
3) L a protezione dei traffici e tutte quelle altre questioni che, in seguito, indicherà il Capo di S.M. della Marina.
Poiché, secondo il R. Decreto relativo alle attribuzioni del Capo di S.M. Generale, debbo sottoporre i miei studi relativi al progetto in esame a S .E il Capo del Governo, dopo aver sentito le .propos te dei Capi di S.M. del R. Eserc i to, della R. Marina e della R. Aeronautica, prego le LL.EE. di farmi pervenire, al più presto, le proposte stesse.
La seduta è tolta alle ore 11,15.

L'a d detto milita re a Belgrado colo nn e ll o Visconti Prasca al Coman d o de l Corp o di Stato Maggiore
N. 6140 Prot. Belgrado, 17 febbraio 1927
OGGETTO: Istruzioni jugoslave per una eventuale mobilitazione.
A seguito del telegramma 6138 del 12 febbraio e.a. ho l'onore di comunicare quanto segue:
Le notizie contenute nel telegramma in parola ebbero successiva conferma da altre fonti, in genere bene informate.
Le dispo sizio ni per una eventuale mobilitazione debbonsi, naturalmente, considerare come una conseguenza dell'allarme suscitato in Jugoslavia dal patto di Tirana, nel quale questo Stato ravvisa una possibilità di conflitto con l'Italia. In primo tempo si è ritenuto qui che tale conflitto potesse essere anche immediato, poiché la clausola del mantenimento dello «s tatus quo » in Albania, era stata interpretata, seco ndo la psicologia balcanica, come una circostanza creata dal l'Italia per suscitare gli avvenimenti adatti ad un intervento in Albania.
Per quanto gli ambienti politici e militari ritengano attualmente che la eventualità di un conflitto possa, specialmente in causa della stagione invernale non essere immediato, tuttavia ne anunettono la possibilità a cominciare dalla prossima primavera, qualora abbiano a verificarsi in Albania le circostanze contemplate dal T rattato di Tirana. Tale convinzione, se è causa di allarmi nella minoranza benestante e nelle classi industriali commercianti che si dibattono in un 'ac uta crisi finanziaria, è invece accettata senza inquetitudine, e quasi con un certo compiacimento, dall'ambiente militare e naziona l ista, che non ha nulla da perdere, e in cui predomina lo spirito di avventura e il sentimento della propria superiorità combattiva.

Indice di tale stato d'animo è il rifiorire della propaganda, più o meno occulta, delle società dei «comitagi» e «cetnici» che rappresentano, oltre ad altri sentimenti e scopi, una specie di tradizione garibaldina serba.
Il nucleo centrale dell'associazione a Bel grado ha, in questi giorni, riunito, in privato, e con esclusione degli estranei, un gran numero di aderenti, per la festa annuale.
Vi sono intervenuti anche dei generali in servizio attivo.
Secondo notizie attendibili, vennero fatti dei discorsi allusivi alla possibilità di un conflitto con l'Italia per la «sacra difesa della Serbia meridionale (Macedonia) minacciata dalla invasione italiana in Albania».
La propaganda delle società dei «comitagi» ha anche lo scopo di raccogliere, sin d'ora, l'adesione di numerosi volontari che dovrebbero concorrere alla lotta contro i bulgarofili in Macedonia e alla copertura verso le frontiere italiana e ungherese.
Secondo le notizie contenute nel telegramma già citato, le istruzioni inviate ai comandi e reparti, oltre le misure per la copertura e la mobilitazione verso l' I talia, contengono misure analoghe verso la Bulgaria, la cui paitecipazione al conflitto verrebbe ritenuta come sicura, per quanto, forse , non immediata. Le misure di sicurezza e copertura verso la Bulgaria dovrebbero specialmente far fronte in primo tempo alla lotta contro i comitagi bulgari che si scatenerebbe subito in grande s tile e permettere l'immediato internamento dei nuclei di popolazione macedone s impatizzanti per la Bulgaria, iniziando tale internamento, in primo tempo con l'allontanamento degli uomini validi.
Misure di copertura e di sicurezza di minore entità verrebbero prese verso l'Ungheria e verso la Grecia.
Qualora l'Ungheria dovesse entrare in azione, oppure dovesse appoggiare , occultamente, l'insurrezione degli ungheresi che cos tituiscono la maggioranza della popolazione nella parte Nord della Voivodina, la difesa principale delle truppe regolari jugoslave dovrebbe avvenire sulla linea del canale di Re Pietro (Bezdan, Sember, StatiBecei). La difesa della parte Nord di tale linea verrebbe fatta da truppe leggere e da «comitagi» serbi , dei quali esistono già dei nuclei in Voivodina e specialmente a Subotica.
Vengono inoltre confermate le notizie, già trasmesse precedentemente, della grande intensità di lavoro che si svolge all'arsenale di Kragujevac per la riparazione delle artiglierie e la fabbricazione delle munizioni. Analoghe informazioni, di grande attività, sono giunte per i polverifici di Obilicevo e di Sai·ajevo.

L'addetto militare a Belgrado colonnello Vi sconti Prasca al Comando del Corpo di Stato Ma ggiore
N. 6138 P rot. Belgrado, 12 febbraio 1927
Notasi lavoro intens ivo doppio orario normale presso questo Stato Maggiore Esercito Belgrado et Comando Armata Skoplje stop Secondo notizie attendibili vengono emanati questi giorni istruzioni preve ntive eventuale mobilitazione tutti comandi grandi unità reparti distretti stop I struzioni riguardano ipotesi conflitto Jugoslavia It alia frontiera slovena e a lbanese con possibilità partecipaz ione B ulgar ia contro Jugoslavia stop. Ve nnero diramate norme sicurezza copertu ra confine ungherese e greco stop. Disposizioni mobilitazione riguarda no uomini primo bando et que l li fino 32 anni stop. Diramate istruzioni aumentare sorveglianza stranieri et disposizion i eventuale internamento nuclei uomini validi cittadini jugoslavi di sentimenti ostili J ugoslavia abitanti in zone prossime e di eventua l i operazioni.
A.U.S.S.M.E .fondo H-10 «Verbali riunio11i /924-1943 » busw 11. 2.fascicolo n. 2.
Il docu111en10 è 1111a copia dell'Uffil'io del capo di S1a10 Maggiore Genero/e, siglata da Mussoli11i il 7 marzo /927.
Ricordiamo che a/l'epoca S.H.S. era l'abbrevia;.ione del Regno serbo-aowo -si<>l'e110 (Jugoslavia), in /i11g11a origi11ale.
a) Nel documento 11011 ,·enJ?OIIO ripor/ali i 11omi dei ponecipomi 1110 solo i loro i11carichi. Essi era110:
Il capo di Sw10 Maggiore del Regio Esercito, ge11erale d'armata Francesco Giuseppe Ferrari, il capo di Swto Ma[lgiore della Regia Mari11a, vice a111111iraglio Alfredo Acto11, il capo di Staw Maggiore della Re[lio Aeronautica. ge11erale di brigata aerea Armando Anna11i, il capo Ufficio Operazioni del Comando del Corpo di Staw Maggiore. colon11ello Mario Berti, il capo U.fficio ,lei/·Ufficio del capo di Staio Maggiore Generale. co/01111ello Alber10 Ponza di S Martino. I capiw11i della segreteria del Comando del Co,po di Sta/O Maggiore era110 d11e, Guglie/1110 della Porta Rodiani Carrara e Osti Alberto, ma è s1aw impoJsibile idemificare chi dei due panecipò real· 111e111e alla ri1111ione. Nello Stato Maggiore della Marina non esis1ew1 l'Uffido Operazio11i, probabilme111e nel verbale ~i intende il capo del / 0 Reparto, capitano di vascello Sil,•io Sal:a (Ar1111.1ario Ufficiale della Regia Mari1111 • 1927. pag. Xl).

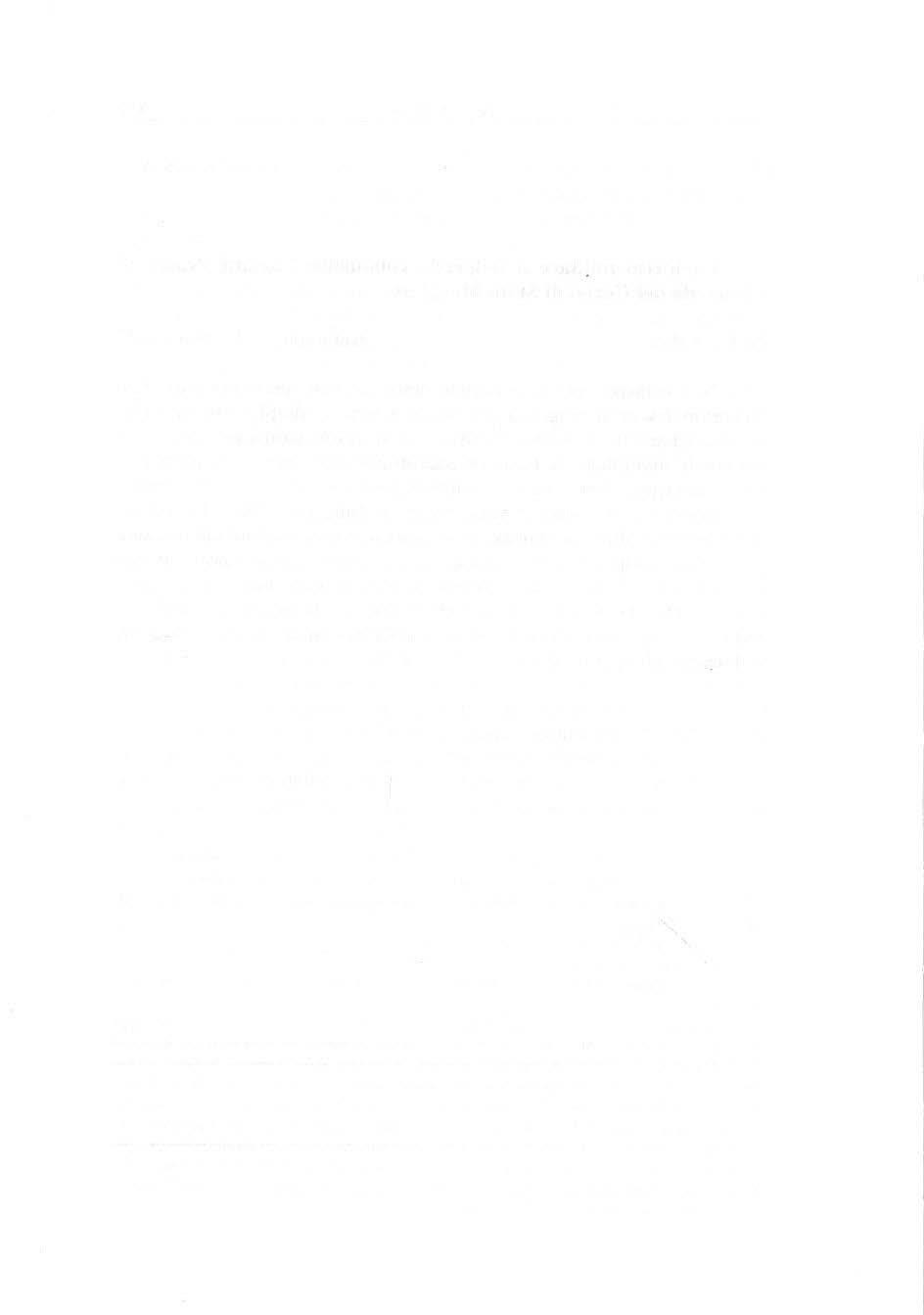
« Prepara z ione sistematica della guerra contro la Jugoslavia: aspetto politico e militare, piani di guerra, difesa di Zara e della costa adriatica, misure da studiare secondo le direttive del capo del Governo , premobilita zione, ripartizione delle for ze alle frontiere est ed ovest , tempi e modi della mobilita zione e radunata, piano offensivo di guerra »
Verbale della seduta del 18 luglio 1927 nell'ufficio del Capo di Stato Maggiore Generale.
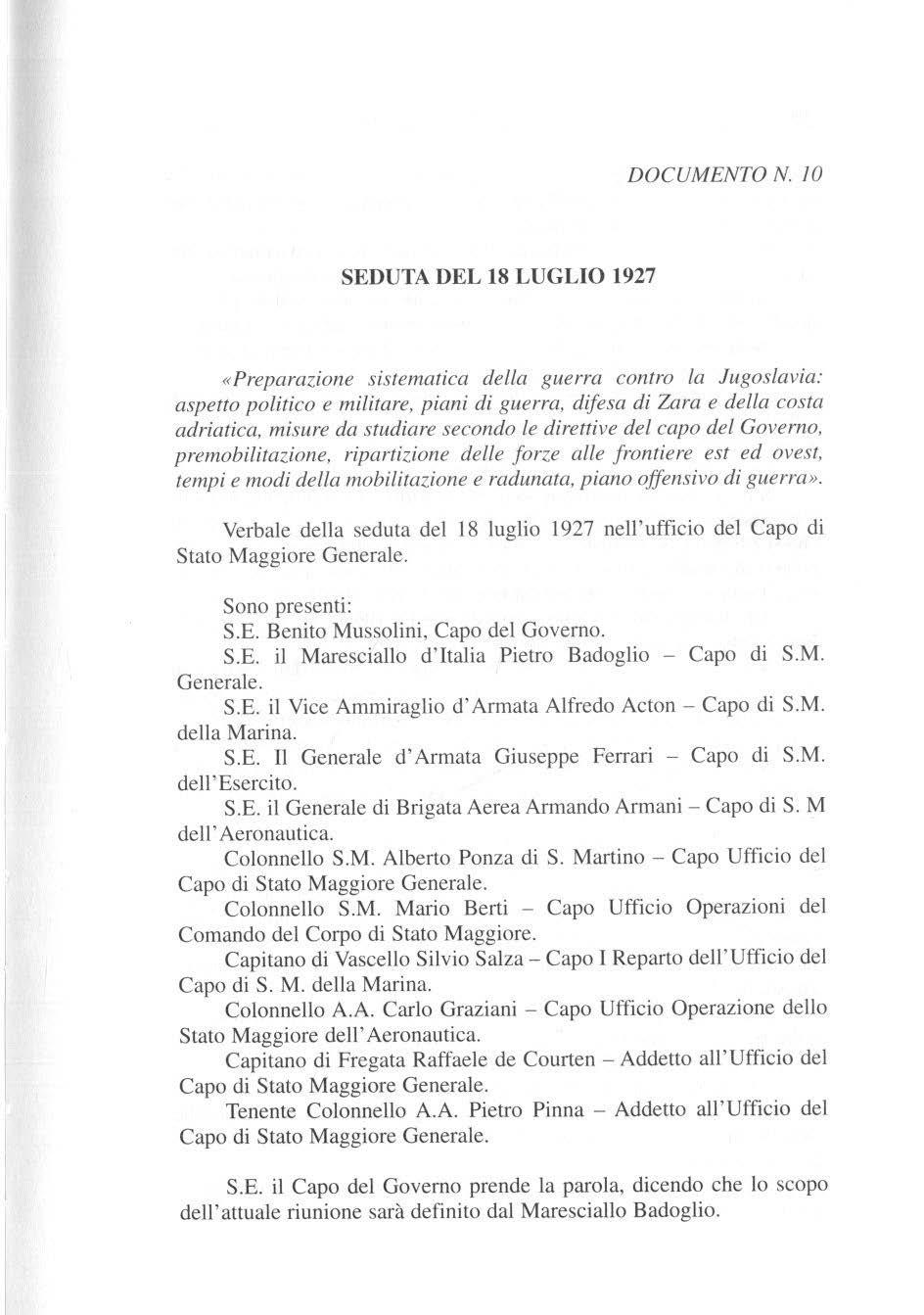
Sono presenti:
S.E. Benito Mussolini, Capo del Governo.
S.E. il Maresciallo d ' Italia Pietro Badoglio - Capo di S.M. Generale.
S.E. il Vice Ammiraglio d'Armata Alfredo Acton - Capo di S.M. della Marina.
S . E. 11 Generale d'Armata Giuseppe Ferrari - Capo di S.M. dell'Esercito.
S.E. il Generale di Brigata Aerea Armando Armani - Capo di S. M clell' Aeronautica.
Colonnello S.M. Alberto Ponza di S. Martino - Capo Ufficio del Capo di Stato Maggiore Generale.
Colonnello S .M. Mario Berti - Capo Ufficio Operazioni del Comando del Corpo di Stato Maggiore.
Capitano di Vascello Silvio Salza - Capo I Reparto dell ' Ufficio del Capo di S . M. della Marina.
Colonnello A.A. Carlo Graziani - Capo Ufficio Operazione dello Stato Maggiore dell'Aeronautica.
Capitano di Fregata Raffaele de Courten - Addetto all'Ufficio del Capo di Stato Maggiore Generale.
Tenente Colonnello A.A. Pi etro Pinn a - Addetto all'Ufficio del Capo di Stato Maggiore Generale.
S.E. il Capo del Governo prende la parola, dicendo che lo scopo dell'attuale riunione sarà defi nito dal Maresciallo Badoglio.
Per conto suo. Egli considera questa come la prima riunione per la preparaz.ione sistematica della guerra. Tale preparazione presenta due facce, una polilica e ww militare.
L'aspetto politico si riferisce alla sitmuione interna ed a quella estera. La prima è solida ed il Paese potrebbe resistere ad una guerra.
Quanto alla situazione estera, sono state mosse le pedine palesi e quelle non pale"i. che permettono di giuocare eventualmente la partita.
Militarmente, si tratfa di preparare e coordinare /'az.ione di tutfe le for ~e annate in l'ista di 1111 possibile conflitto.

Il 18 luglio segna l'inizio di questa preparazione sistematica alla guerra. La guerra può essere lonwna o forse 11011 lontana; ma certamente ci sarà.
Dà la parola al Maresciallo Badoglio.
S.E. il Maresciallo Badoglio inizia la lettura di un promemoria sul!' argomento ( 1·edi allegato), commentando in modo particolare i punti che ,i riferiscono alla necessità di piani di guerra definiti in tutti i particolari, allo studio della copertura, mobilitazione e radunata, ali' opportunità di una legislazione relativa al periodo di mobilitazione occulta.
S.E. il Capo del Governo domanda alle LL.EE. i Capi di S.M. delle ForLe Armate ,e essi abbiano osservazioni da fare.
S.E. l'Ammiraglio Acton accenna alla questione della difesa di Zara, facendo presente che la Marina può concorrere con lutti i mezzi navali alla difesa di Zara, ma che sarebbe opportuno fos..,cro precisati i compiti rispettivi dell'facrcito e della Marina in questa quc..,tione.
S.E. il Maresciallo Badoglio O',serva che finora sono in corso di esame e di studio direttive e non norme esecutive; che la questione di Zara, che investe problemi di carattl't'e politico e militare, sarà esaurientemente esaminata in sede di 111<11101.,-a, prima di prendere decisioni.
Militarmente 'Zara 11011 ha importan:a, come si è constatalo non ne aveva un progetto, relativo ad Antivari, esaminato dall'Ufficio del Capo di S.M. Generale. Altri progetti, come quello di una eventuale utiliuazione dello sbocco della Narenta per affrontare il ridotto di Sarjevo, saranno anch'essi esaminati nelle dic;cussioni relative alla futura manovra sui quadri.
S.E. il Capo del Governo precisa che il problema di Zara 11011 è militare, ma politico mornle; in ogni modo costituisce w1 dettaglio del complesso problema in corso di studio.
S.E. il Generale Ferrari fa presente l'opportunità che la difesa costiera del litorale adriatico de ll' I talia sia portata fin dall'inizio delle ostilità sulla costiera nemica mediante una serie di operazioni di occupa?ioni di isole.
S.E. il Capo del Governo riassume le considerazioni svolte, precisando che si tratta di studiare:
a) le misure di pre-mobilitazione (aspetto legislativo della questione - esame della legislazione tedesca del Kriegsgefahr, ecc.);
b) la ripartizione delle forze militari tra la fronte E. e quella W stabilendo l'aliquota delle forze che dovranno essere lasciate in osservazione verso ponente;
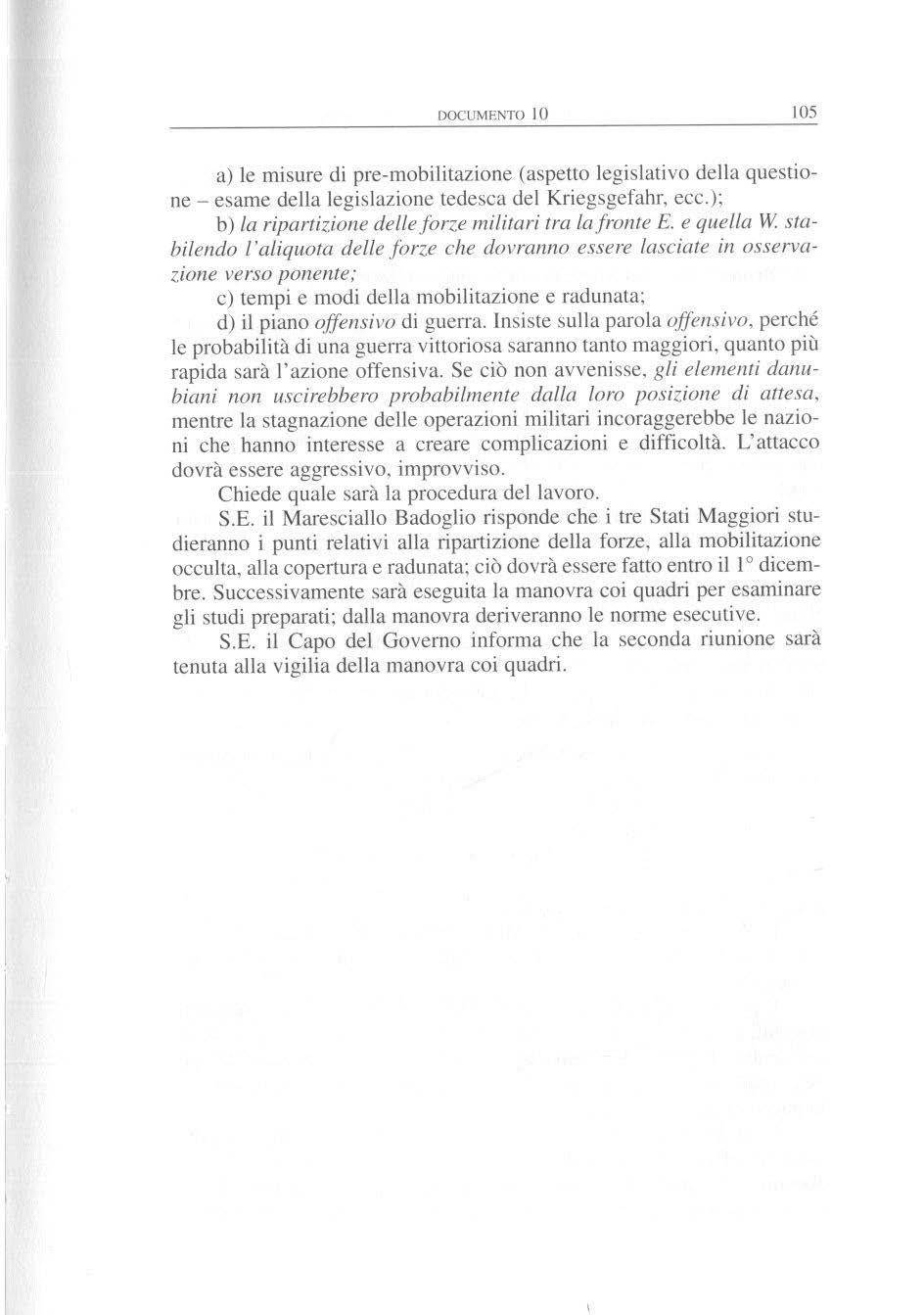
c) tempi e modi della mobilitazione e radunata;
d) il piano offensivo di guen-a. Insi ste sulla parola offensivo, perché le probabilità di una guerra vittoriosa saranno tanto maggiori, quanto più rapida sarà l 'azione offensiva. Se ciò non avvenisse, gli elemenri danubiani non uscirebbero probabilmente dalla loro posizione di attesa, mentre la stagnazione delle operazioni militari incoraggerebbe le nazioni che hanno interesse a creare complicazioni e difficoltà. L'attacco dovrà essere aggressivo, improvviso.
Chiede quale sarà la procedura del lavoro.
S.E. il Maresciallo Badoglio risponde che i tre Stati Maggiori studieranno i punti relativi alla ripartizione della forze, alla mobilitazione occulta, alla copertura e radunata; ciò dovrà essere fatto entro il l O dicembre. Successivamente sarà eseguita la manovra coi quadri per esaminare gli studi preparati; dalla manovra deriveranno le norme esecutive.
S.E. il Capo del Governo informa che la seconda riunione sarà tenuta alla vigilia della manovra coi quadri.
Allegato al verbale della seduta del 18 luglio 1927
Prom emori a d e l M a resciallo B adoglio re la ti vo ai piani di gu e rra
Roma, 18 luglio 1927
S.E. il Capo del Governo e Ministro delle Forze Armate mi ha affidato il compito dì determinare nelle sue linee generali e poi precisare neì particolari necessari i pìanì dì guerra corrispondenti alle ipotesi più probabili.
La manovra sulla carta che avrà inizio in dicembre, e che sarà seguita da nuove consimili negli anni venturi, ha appunto lo scopo di fosare i vari piani di guerra.
Non si tratta quindi di manovre fatte allo scopo normale di istruzione. Si tratta invece di ben stabilire tutte le modalità di esecuzione della copertura, della mobilitazione e della radunata, nonché di quelle operazioni iniziali che si possono prevede re nece ss arie sia in periodo di copertura sia a radunata pressoché ultimata per una migliore impostazione del piano generale di guerra.
A proposi to dei piani di guerra, molti scrittori militari ne hanno me ssa in dubbio l'utilità, giacché le incognite sono troppe e quasi sempre i fatti si svo lgo no in maniera non corrisponden te alle previsioni.

Jo non sono di questo parere.
Osservo anzitutto che nell'ultimo grande conflitto i faui hanno dato perfettamente ragione all'esistenza dei piani di guerra. In Francia il piano XV II fu internamente applicato.
In Germania il piano di W. Moltke ebbe esecuzione integrale non soltanto sino a radunata compiuta, ma anche nelle prime operazioni sino a Bruxelles.
È poi da notare che se vi sono delle incognite e delle conseguenti possibilità di variazioni, tre elementi rimangono fissi, o pressoché immutabili. 11 primo elemento è la copertura, che la ristrettezza di tempo nella quale deve essere posta in funzione esige che essa sia preordinata in pace nei suoi mi nim i partico lar i.
li secondo è la mobilitazione, che ha un ritmo così complesso che non può soffrire alterazioni durante la sua me ssa in moto. Tn terzo luogo, abbiamo i trasporti di radunata per i qua l i, se qualche variante dovrà essere apporta ta, questa dovrà essere bene studiata avanti, non essendo
possibile improvvisare cambiamenti duranle l'esecuzione di un movimento così poderoso.
Noi però non ci irrigideremo nella complicazione del piano di guerra. Cercheremo di dare alle nostre disposizioni la voluta elasticità, e poscia esamineremo un determinato numero di sotto ipotesi per studiarne le conseguenze e dedurre le necessarie varianti.
Noto che questa è la prima volta che siffatto studio riferentesi a tutte le forze armate si compie in Italia, e forse nel mondo.
Nei piani di guerra studiati in passato non era compresa l'aviazione come arma a sé, per motivo l'infanzia di detta arma.
I piani dell ' Esercito e della Marina erano st udiati separatamente, senza nessun legame fra di loro. Ne risultò quanto era inevitabile: uno slegamento fra le operazioni di terra e quelle di mare.
Basta leggere a questo proposito, per esserne edificati, tutte le discussioni e le conseguenti diatribe avvenute in Germania dove l'Esercito impostava il suo piano su un concetto estremamente offensivo, mentre la Marina adottava una linea della più prudente difensiva, e ciò nella più completa seg retezza , senza che uno sapesse quello che era nell'intenzione dell'altro.

Ora la vittoria si consegue con una intelligente somma di sforzi, non certo con la di s pers ione di energie.
È poi indi spensabi le che questi piani di guerra siano sv iluppati a fondo ossia siano preparati tutti i documenti di esecuzione occorrenti. E ciò perché qui non si tratta di studi teorici , ma bensì di stabilire delle provvidenze concrete.
Ricordo a questo proposito che il primo piano di guerra riguardante il so lo esercito venne stabilito in Italia dal Generale Cosenz nel 1885, e che dopo questo vennero concretati altri sei piani: uno da Cosenz, due da Saletta, tre da Pallio. Ma di tutti e sette questi piani, due soli, quello del 1904 del Saletta e quello del Pallio del 1908 erano realmente tradotti in documenti di esecuzione in tutti i suoi particolari. Gli altri erano piuttosto s tudi generici.
Co sì pure in Francia, seco ndo quanto riferisce il Marchand , dei diciassette piani che i france si adottarono dal 1880 al 1914, soltanto otto al massimo possono essere ritenuti come veri e concreti piani di guerra. Negli altri nebulose incertezze più o meno numerose.
Io voglio assicurare S.E. il Capo del Governo che noi ci mettiamo con tutto ardore per concretare nel miglior modo possibile i piani di guerra nostri.
E veniamo al caso concreto, col quale noi inizieremo lo studio del nostro primo piano di guerra.
L'ipotesi in questione è la guerra fra noi e la Jugoslavia.
Noi considereremo la Francia come non intervenente direttamente nel conflitto, ma il suo contegno a noi ostile ci obbligherà a prevedere, almeno in primo tempo, delle serie provviden7e verso la frontiera occidentale.
rn questa ipotesi noi studieremo a fondo anche l'azione dell' Albania. Terremo invece un calcolo molto prudente sull'intervento degli altri stati balcanici. Tutto sommato questo intervento potrà pareggiarsi tra i due contendenti, o forse essere anche a noi favorevole. Ripeto noi esamineremo ciò con largo margine prudenziale.
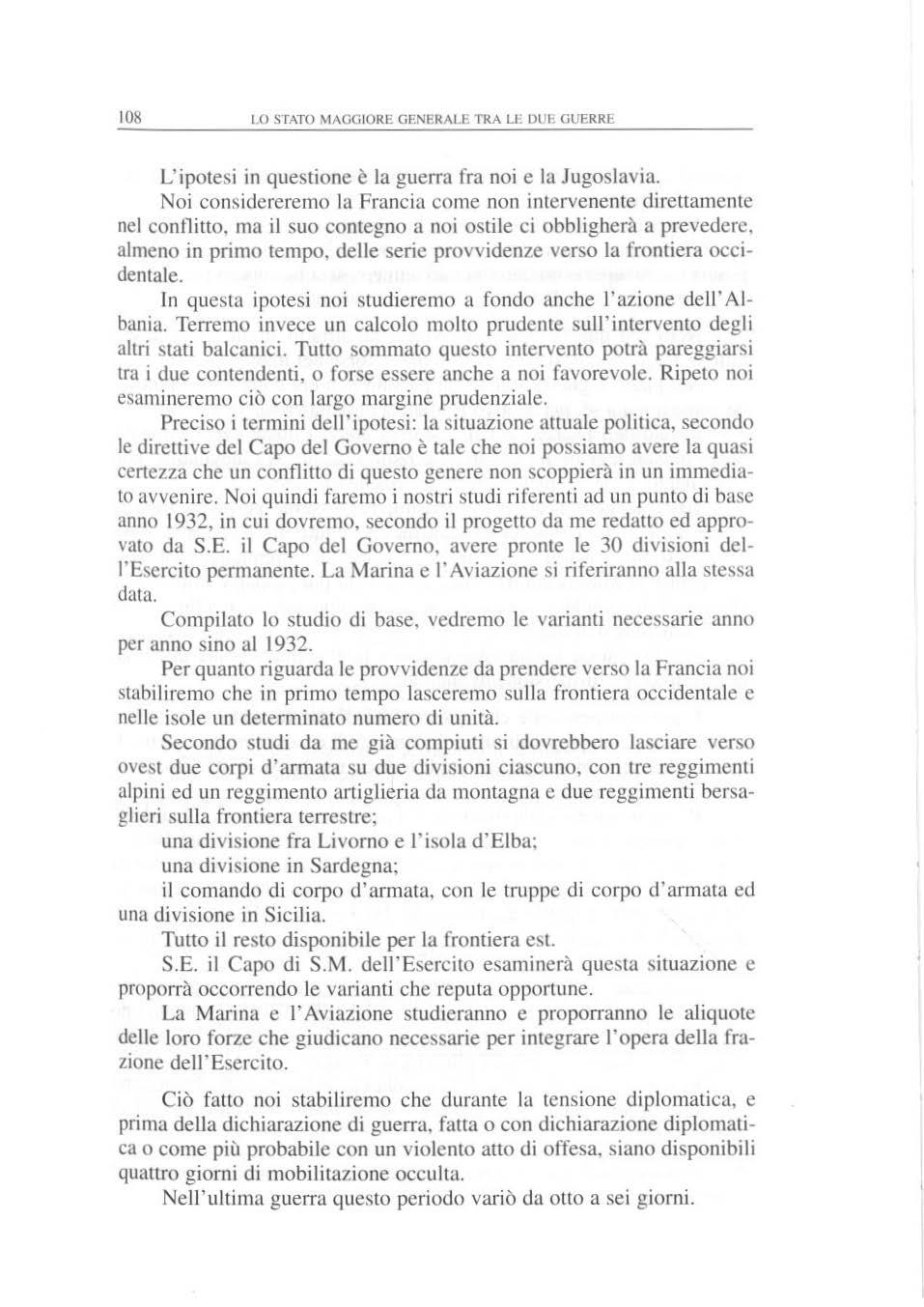
Preciso i termini dcli' ipotesi: la situazione attuale politica, secondo le direttive del Capo del Governo è tale che noi possiamo avere la quasi certeaa che un conflitto di questo genere non sco ppierà in un immediato avven ire. Noi quindi faremo i nostri studi riferenti ad un punto di base anno 1932, in cui dovremo, secondo il progetto da me redatlo ed approvato da S.E. il Capo del Governo, avere pronte le 30 divisioni dell'Esercito permanente. La Marina e l'Aviazione si riferiranno alla stessa data.
Compilato lo studio di base. vedremo le varianti necessarie anno per anno sino al 1932.
Per quanto riguarda le provviden.te da prendere verso la Francia noi stabiliremo che in primo tempo lasceremo sulla frontiera occidentale e nelle isole un determinato numero di unità.
Secondo studi da me già compiuti si dovrebbero lasciare verso ovest due corpi d'annata su due divisioni ciascuno, con tre reggimenti alpini ed un reggimento artiglieria da montagna e due reggimenti bersaglieri sulla frontiera terrestre;
una divisione fra Livorno e l'isola d'Elba;
una divic;ione in Sardegna;
il comando di corpo d'armata, con le truppe di corpo d'rumata ed una divisione in Sicilia.
Tutto il resto disponibile per la frontiera est.
S.E. il Capo di S.M. dell'faercito esaminerà questa situazione e proporrà occorrendo le varianti che reputa opportune.
La Marin a e l 'Av iazione studie ranno e proporranno le aliquote delle loro forze che giudicano necessarie per integrare l'opera della frazione dell'Esercito.
Ciò fatto noi stabilire mo che durante la tensione diplomatica, e prima della dichiarazione di guerra, fatta o con dichiarazione diplomatica o come più probabile con un vio lento atto di offesa. siano disponibili quattro giorni di mobilitazione occulta.
Nell'u ltima guerra questo periodo variò da otto a sei giorni.
Noi come limite prudenziale lo fisseremo in quattro; ma potremo anche studiare le provvidenze utili, se il tempo sarà maggiore.
Bisognerà ben precisare quanto noi dovremo fare in questi quattro giorni; ricordando che in siffatti periodi l'improvvisazione riesce in genere assai male.
Noi non abbiamo ancora un programma ben definito a questo riguardo. Dirò che solo la Germania, col suo stato di «pericolo minaccioso di guerra», aveva ben determinato le operazioni da compiersi da questa che chiamerò l'avanguardia della mobilitazione.
Dirò anzi di più che a questo riguardo mancano presso di noi anche le disposizioni legislative, e che sarà indispensabile che noi studiamo queste disposizioni per poi poterle sottoporre all'esame e all'approvazione del Capo del Governo.
Esaminata e concretata questa fase preliminare noi entreremo in pieno nella copertura, mobilitazione e radunata.
Per quanto si riferisce alla copertura, che deve essere integrata dal concorso di tutte le forze armate, io ho fatto preparare queste direttive che consegno ai Capi di Stato Maggiore(a l.
Per dunque meglio precisare, nelle prime sedute della manovra sulla carta si esamineranno i seguenti tre argomenti:
1) Ripartizione delle forze fra le due frontiere (terrestre, marittima, aerea) est ed ovest.
2) Definizione delle operazioni di mobilitazione occulta e delle conseguenti necessarie disposizioni legislative.
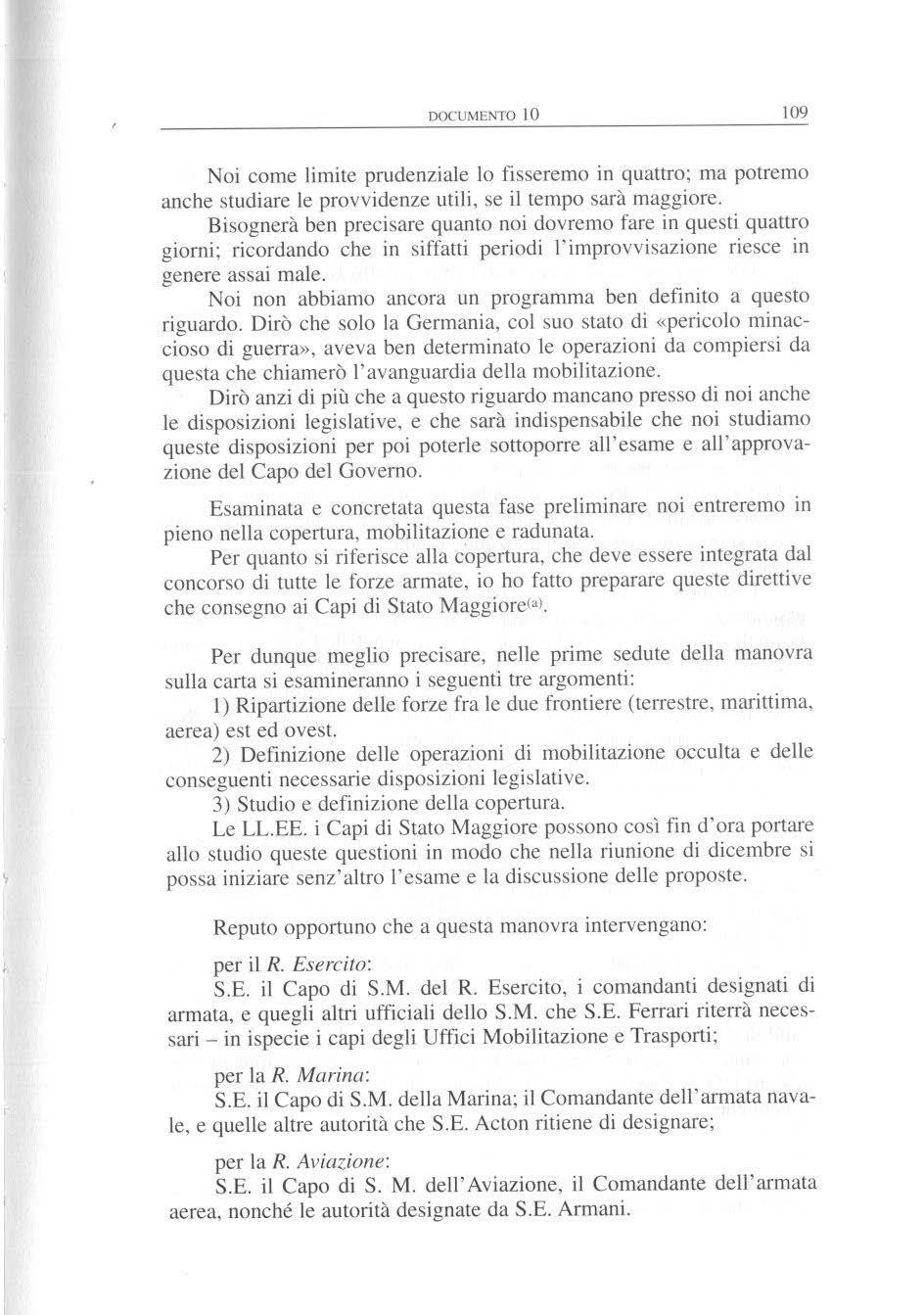
3) Studio e definizione della copertura.
Le LL.EE. i Capi di Stato Maggiore possono così fin d'ora portare allo studio queste questioni in modo che nella riunione di dicembre si possa iniziare senz'altro l'esame e la discussione delle proposte.
Reputo opportuno che a questa manovra intervengano:
per il R. Esercito:
S.E. il Capo di S.M. del R. Esercito, i comandanti designati di armata, e quegli altri ufficiali dello S.M. che S.E. Ferrari riterrà necessari - in ispecie i capi degli Uffici Mobilitazione e Trasporti;
per la R. Marina:
S.E. il Capo di S.M. della Marina; il Comandante dell'armata navale, e quelle altre auto1ità che S.E. Acton ritiene di designare;
per la R. Aviazione:
S.E. il Capo di S. M. dell'Aviazione, il Comandante dell'armata aerea, nonché le autorità designate da S.E. Armani.
Annesso all'allegato al verbale della seduta del 18 luglio 1927
Direttive per la copertura del Mares ciallo Badoglio ai Cap i di Stato Maggiore d elle FF. AA.
l 8 luglio 1927
La copertura ha lo scopo di proteggere la nostra mobilitazione e la successiva radunata da offese nemiche intese a disturbarle o comunque ritardarle, di impedire all'avversario di impadronirsi di sopresa di punti particolarmente importanti del nostro territorio in prossimità della frontiera terrestre e marittima, di creare (occorrendo, con piccole azioni offensive locali) le migliori condizioni di partenza all'attacco delle forze che si stanno raccog li endo nella zona di radunata e nelle basi navali ed aeree.
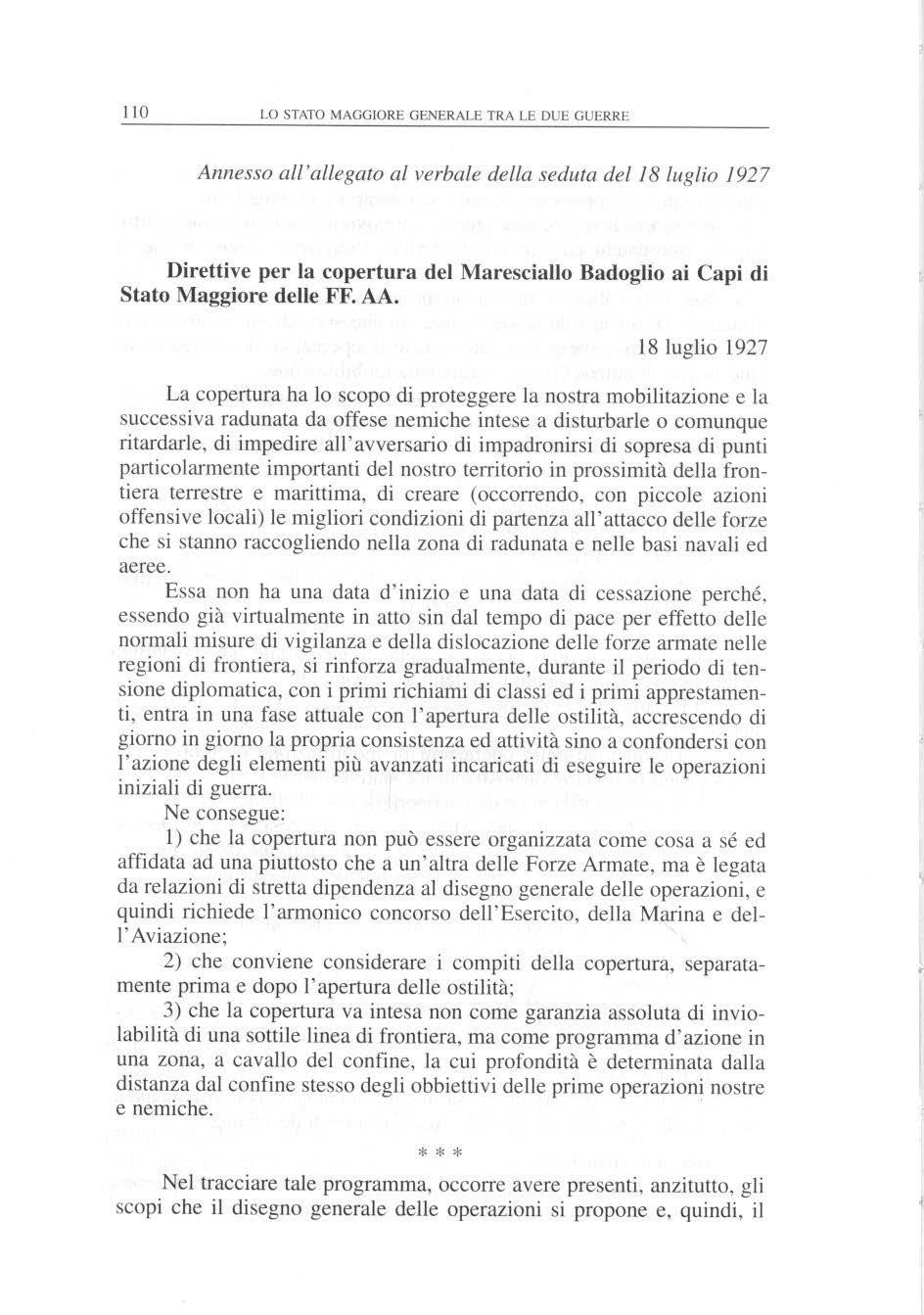
Essa non ha una data d'inizio e una data di cessazione perché, essendo già virtualmente in atto sin dal tempo di pace per effetto delle normali misure di vigilanza e della dislocazione delle forze armate nelle regioni di frontiera, si rinforza gradualmente, durante il periodo di tensione diplomatica, con i primi richiami di classi ed i primi apprestamenti, entra in una fase att u ale con l'apertura delle ostilità, accrescendo cli giorno in giorno la propria consistenza ed attività sino a confondersi con l'azione degli elementi più avanzati incaricati di eseguire le operazioni iniziali di guerra.
Ne consegue:
1) che la copertura non può essere organizzata come cosa a sé ed affidata ad una piuttosto che a un'altra delle Forze Armate, ma è legata da relazioni cli stretta dipendenza al disegno generale delle operazioni, e q ui ndi richiede l'armonico concorso dell'Esercito, de ll a Marina e del!' Aviazione;
2) che conviene considerare i comp iti della copertura, separatamente prima e dopo l 'apertura delle ostilità;
3) che la cope rt ura va intesa no n come garanzia assoluta di inviolabilità cli una sottil e linea di fro ntiera, ma come programma d 'azione in una zona, a cavallo del confine, la cui profondità è determinata dalla distanza dal confine stesso degli obbiettivi delle prime operazioni nostre e nemic he. * * *
Nel tracciare tale programma, occorre avere presenti , anzitutto, g li scopi che il disegno genera le delle operazioni si propone e, quindi, il
quadro generale della situazione che presumibilmente si presenterà atrinizio della guerra, ed i mezzi dei quali si dispone in quel periodo .
Ora è evidente c he in primissimo tempo le offese partenti da ciascu no dei due campi oppost i mireranno:
- a paralizzare le forze aeree dell'avversario, prevenendole nelle offese con attacchi tempestivi e violenti a ll e loro basi principa li ;
- a deprimere il morale della nazione avversaria, bombardando dal cielo centri popolosi di primaria importanza, anche molto addentrati nel suo territorio;
- a portare lo scompig li o nei cen tri di mobilita;,ione compresi e ntro il raggio di azione delle basi aeree o marittime:
- a interrompere, con ogni mezzo, le vie di comunicazione mediante le quali dovranno i richiamati affluire ai ce ntri sudde tti , e, più tardi, i reparti costituiti convergere nella zona di radunata;
-a menomare l'efficienza della fl otta navale avversaria, bombardandola ne lle sue basi co n gli aerei, o cercando di sorp rende rla con attacc hi del nav ig lio s ilur a nte;
- a conq ui stare punti di riconosciuta importanza militare, sia per facilitare le ulteriori operazioni da attuare con i l grosso dell'esercito, quando sarà pronto, sia per trarre il nemico in inganno circa la direzione prescelta per l'attacco strategi co;
- ad o tte nere successi m ora li co n la conquista di località che, pure essendo prive di qualsiasi valore militare, h a nn o, per motivi politici, storici od altri, un 'a lta importan za sent imentale agli occh i delle folle;
- ad effett uare incurs ioni ne l territori o di frontiera ten-es tre e marittima per provocare sollevazion i tra le popolazioni alloglotte e per organizzarle comunque ai danni dell'avversario.

Inoltre, se mpre durante il periodo di co pertura, ma a nc he fuori della zona definitiva al precedente comma 3):
- ognuno dei due contenden ti inte n sificherà i suoi traffici per via di terra e di mare allo scopo di accantonare la maggiore quantità possibile di qu ei materiali di g ue rra che il s uo territ o rio non produce e - appena dichiarate le ostilità - si adoprerà a disturbare i trasporti marittimi d e lJ'avversario;
- nell'interno di ciascuno dei due stati che si vanno armando l'un con tro l'a ltro, emissari del nemi co, agenti di te rzi Stati c he pur non avendo intenzioni di immediato intervento h anno ragione di sperare vantaggi dai danni dei contendenti, nemici inte rni di ogni specie e categoria, cerc heran no con tutti i mezzi di aggravare la c ri si in erente all'entrata in guerra e d anche alla se mplice probabilità de ll o scoppio di un conflitto.
Quanto ai mezzi disponibili è prudente considerare il caso più sfavorevole (scoppio di ostilità non preceduto da notevole periodo di mobililazione occulta) e quindi non fare assegnamento, in primo tempo, su forze molto superiori a quelle che costituiscono gli armamenti del tempo di pace.
Occorre inoltre tener presente che la differenza fra consistenza di pace e consistenza di guerra, ed il tempo necessario per passare dall'una all'altra, sono molto variabili in ciascuna delle tre forze armate: massimi per l'Esercito, sens ibilmente minori per la Marina, minimi (relativamente) per l'Aeronautica.
Ne consegue che la copertura, nella sua prima fase, dovrà fare il massimo assegnamento anzitutto s ull'Aeronautica e quindi sulla Marina.
Ma poiché non si può pensare a far agire tali forze fuori dell'elemento proprio di ciascuna per contrastare iniziative avversarie, ne consegue che l'assegnamento ora detto deve tradursi in iniziative nostre. ossia in atti offensivi che, per le accennate proprietà delle forze aeree e delle forze navali, possono, sin dai primi giorni, essere di entità assai più ragguardevole e di raggio assai più ampio che non quelle affidate alle forze ten-estri. * * *

La nostra frontiera orientale è costituita da una zona che si estende da M. Forno (Pec) a Otranto, passando per le isole di Lussino e per Ancona, si approfondisce sino alla linea (descritta dall'estremità dei raggi d'azione delle basi aeree nemiche ) approssimativamente individuata (nell'attuale situazione tecnica dell'aviazione avversaria) dalle seguenti località: Sondrio, Piacenza, Viterbo, Anzio, Cosenza, Crotone. Essa comprende, perciò, diversi elementi, per ciascuno dei quali si indicano, qui appresso, la forza armata alla quale spetta, nella copertura, il compito principale (sottolineato), e quelle che ad essa prestano concorso:
l) Confine da monte Forno (Pec) a Fiumc 1 e zona di radunata
Esercito ed Aviazione.
2) Confine da Fiume a Lus sino incluso: Marina, Esercito, Aviazione.
3) Mare da Lu ss ino ad Ancona2: Marina, Aviazione.
4) Specchio d'acqua prospicente la costa da Ancona ad Otranto: Marina, Aviazione.
5) Territorio del Regno non compreso nella zona di radunata terrestre: Comando generale della difesa territoriale 3 (aerea e costiera), Aviazione.
Olu·e frontiera, a guisa di posto avanzato ed isolato, abbiamo inoltre Zara, che, per ragioni morali, occorre difendere da colpi di mano, specialmente nel periodo iniziale; a ciò provvederà il presidio locale, sostenuto da mezzi navali.
In conseguenza, poi, dell'assegnamento che i nostri disegni di operazione fanno sul!' Albania, rientrano nei compiti della copertura le disposizioni da prendere per assicurare la rapida messa in efficienza delle forze armate di quello Stato, la cui azione deve precedere le nostre eventuali operazioni in quel teatro.
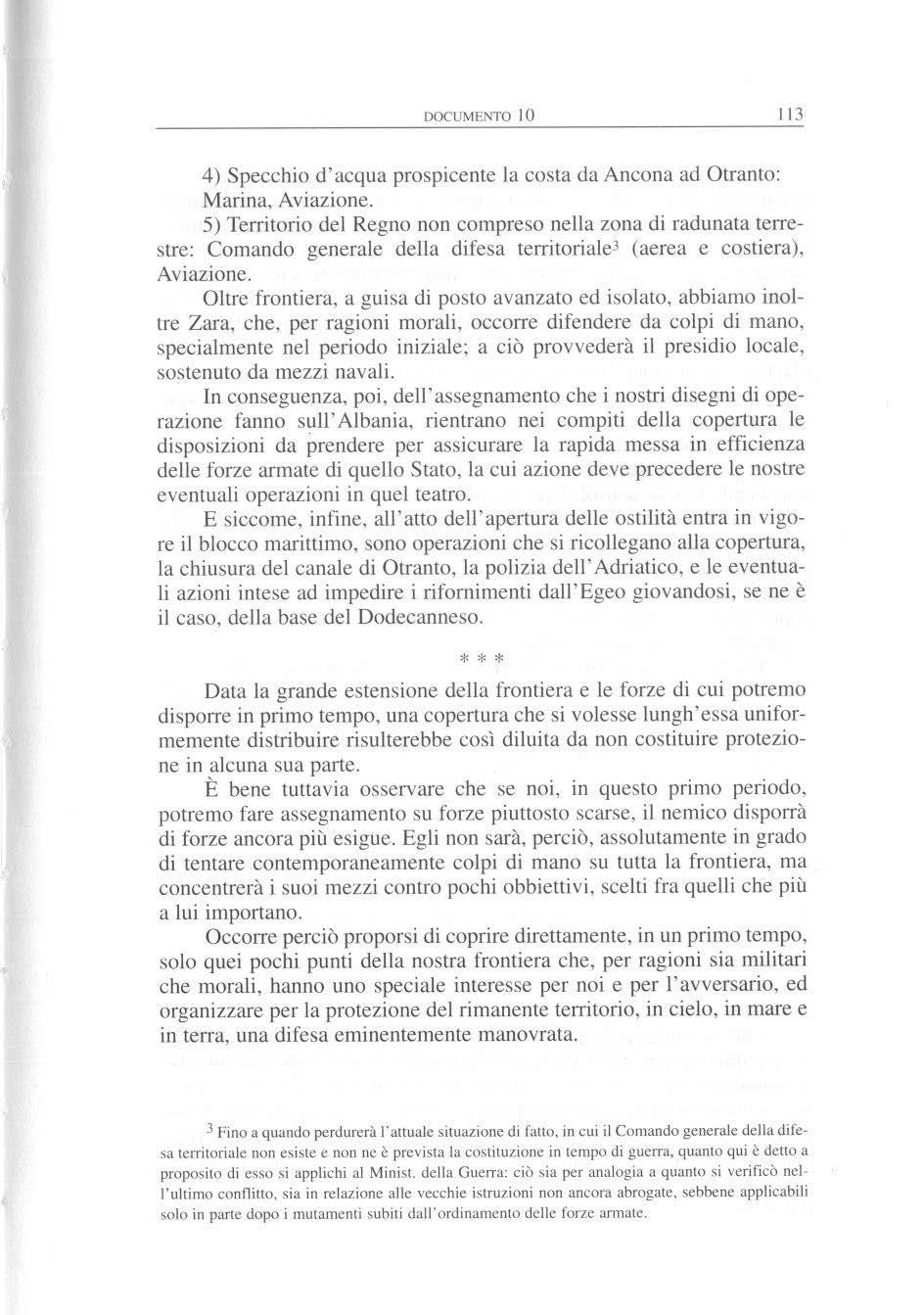
E siccome, infine, all'atto dell'apertura delle ostilità entra in vigore il blocco marittimo, sono operazioni che si ricollegano alla copertura, la chiusura del canale di Otranto, la polizia dell'Adriatico, e le eventuali azioni intese ad impedire i rifornimenti dall'Egeo giovandosi, se ne è il caso, della base del Dodecanneso.
Data la grande estensione della frontiera e le forze di cui potremo dispone in primo tempo, una copertura che si volesse lungh'essa uniformemente distribuire risulterebbe così diluita da non costituire protezione in alcuna sua parte.
È bene tuttavia osservare che se noi, in questo primo pe1iodo, potremo fare assegnamento su forze piuttosto scarse, il nemico disporrà di forze ancora più esigue. Egli non sarà, perciò, assolutamente in grado di tentare contemporaneamente colpi di mano su tutta la frontiera, ma concentrerà i suoi mezzi contro pochi obbiettivi, scelti fra quelli che più a lui importano.
Occorre perciò proporsi di coprire direttamente, in un primo tempo, solo quei pochi punti della nostra frontiera che, per ragioni sia militari che morali, hanno uno speciale interesse per noi e per l'avversario, ed organizzare per la protezione del rimanente territorio, in cielo, in mare e in terra, una difesa eminentemente manovrata.
3 Fino a quando perdurerà l'a1tualc situazione di fauo, in cui il Comando generale della difesa territoriale non esiste e non ne è prevista la costitul.ione in tempo di guerra, quanto qui è detto a proposito di e~so si applichi al Mini st. della Guerra: ciò ;ia per analogia a quanio si verificò nell'ultimo connitto, s ia in relazione alle vecchie istruzioni non ancora abrogate. sebbene applicabili solo in parte dopo i mutamenti sub iti dall'ordinamento delle forze armate.
Questa presuppone grande spirito aggressivo, non solo perché il suo giuoco è tutto basato sui contrattacchi, ma anche perché essa implica la necessità di conquistare, con un'offensiva di prima intenzione, taluni punti il cui possesso può facilitare la sua esecuzione o preparare la strada alla successiva avanzata delle forze mobilitate sugli obbiettivi nemici.
Poiché, tuttavia, errori nella presunzione delle intenzioni del nemico sono sempre possibili, è da aspettarsi che, puntando attraverso qualche tratto di confine da noi trascurato e quindi scarsamente presidiato o non presidiato affatto, incursioni avversarie, per terra o per mare, riescano a sboccare in nostro territorio. Questi successi locali del nemico non dovranno impressionarci se saremo in grado. con tempestivo contrauacco dei nuclei di manovra, di eliminare prontamente tali infiltrazioni, impedendo loro di consolidarsi stabilmente.
Tn ogni modo queste incursioni non potranno mai avere grande capacità di penetrazione, e perciò non dovranno distrarci dall'ordinata attuazione del piano che ci siamo proposto: anche se si consolideranno; l'esecuzione dello schieramento che man mano si sovrapporrà alla copertura rincalzando l'a1ione dei nuclei di manovra verrà, a suo tempo, a spazzarli via automaticamente.

Da quanto sopra risulta che, primo compito da proporre alla copertura, è quello di garantire sin dall'inizio la più assoluta inviolabilità delle teste di sbarco nella zona di radunata terrestre e delle basi navali ed aeree, ove concentrano i mezzi per attuare il disegno generale delle operazioni. * * *
Prescindendo dalla guerra aerea che, per la pronta disponibilità concessale, fin dall'inizio, della maggior parte dei suoi mezzi ha possibilità e necessità affatto particolari, è da osservare che quanto più esigue saranno le forze di cui si dispone in periodo di copertura tanto minore sarà il numero dei nuclei di manovra (non potendo ciascuno di essi scendere al disotto di certi limiti di consistenza) e, quindi, tanto più ampio il loro settore di azione, e, perciò, tanto maggiore la distanza a cui essi dovranno tenersi dal confine.
L'inconveniente di questa lontananza dovrà essere compensato da un'accurata sistemazione della vigilanza sulla linea di confine, perché nessuno sconfinamento nemico passi inosservato, e da un'organizzazione conveniente delle comunicazioni (co lle gamenti, strade, mezzi di trasporto) necessarie sia per trasmettere le segnalazioni degli organi di vigilanza, sia per diramare rapidamente gli ordini, sia per spostare celermente e far accorrere, a momento opportuno, il nucleo di manovra là dove occorre.
Col procedere della mobilitazione e della radunata, e con il conseguente sovrapporsi dello schieramento iniziale alla copertura, la trama costituita da questa viene ad essere naturalmente raffittita e rinforzata, e la protezione diretta del territorio, delle acque, e delle coste nazionali viene ad essere automaticamente assicurata, corrispondendo, con ciò, alle esigenze della fase operativa che richiede la più assoluta inviolabilità delle ragioni dalle quali trae alimento la resistenza delle forze combattenti.
Questa progressione nel rafforzamento dello schieramento è assai meno accentuata per le forze navali, per il fatto che queste sono in grado di disporre sin dal l'inizio di mezzi rilevanti: perciò su di esse farà assegnamento il Comando Supremo delle Forze Armate nel primo periodo di copertura, specialmente per condurre quelle operazioni offensive sulle isole e sulle coste, che non si possono affidare all'Esercito, più lento a mobilitarsi.
Evidentemente queste direttive generiche troveranno diversa applicazione nei vari tratti del teatro d'azione, a seconda che nelle forze operanti in ciascuno di essi avranno preponderanza i mezzi terrestri o i mezzi marittimi.
In ogni caso, però, il principio della manovra deve prevalere e quindi ogni cura deve essere posta nell'organizzare , sin dal tempo di pace la rapidità di azione (comunicazioni e trasporti), nel rafforzare i punti da coprire con occupazione diretta, nello stabilire gli obbiettivi dei nostri primi sconfinamenti , nell'individuare i punti più sensibili dell'avversario, in vista delle nostre prime azioni di disturbo.

Tali predisposizioni sono di competenza degli Stati Maggiori delle singole forze armate, ciascuno per il tratto di frontiera affidato al rispettivo Comando Supremo, come verrà appresso indicato.
* * *
Ben diversa è la situazione di fronte alle incursioni aeree.
È da presumersi, infatti, che primo atto di ostilità, contemporaneo alla dichiarazione di guerra (e forse anche in sostituzione di questo atto formale) sarà l'invasione del nostro cielo per parte della flotta aerea nemica che, a differenza delle forze terrestri e in maggior misura delle navali, disporrà ·fin da allora della maggior parte dei suoi mezzi.
Perciò la copertura deve anzitutto proporsi di impedire tale invasione, esercitando contro di essa una difesa eminentemente attiva; deve tendere, cioè, a stroncare l'attacco aereo nemico ali' atto stesso in cui sta per scattare dalle sue basi, ossia a prevenire l'avversario, bombardando i suoi campi quando ancora sta in essi raccolta e pronta a decollare, la sua flotta aerea.
Evidentemente il tempo, in simili operalioni, è fattore prevalente su di ogni altro, perché il ritardo di un 'ora so ltanto può mandarle quasi completamente a vuoto. Di qui la grande importanza della scelta del momento opportuno per sferrare l 'attacco aereo, e la necessi tà che essa sia riservata al Comando Supremo delle Forze Armate.
Siccome però la decisione occorrente per tradurre in atto tale scelta comporta anche una grande re sponsabilità politica, la decisione s tessa non può essere presa che dal Capo del Governo.
[... ] Fattore necessario di successo è l'intensità del bombardamento che deve essere tale da porre sicuramente fuori causa i campi e gli apparecchi. Di qui la necessità di agire a massa riunita, ossia di non disperdere l'azione su un numero eccessivo di cam pi contemporaneamente.

Siccome, peraltro, l'impiegare una quantità di esplosivo superiore a quella ri chiesta dal bersaglio rappresenterebbe uno spreco, e d'altra parte è da ritentersi che, quan do la nostra flotta aerea avrà raggiunto la consiste nz a prevista dall" ordinamento in corso di attuazione, disporremo di mezzi esuberanti in confronto a quelli necessari per la distruzione di un solo campo per volta, così occorre prevedere la possibilità di agire contemporaneamente contro tutti quei campi nemici nel cui raggio d'azione e ntrano porzio ni del nostro territorio (Zagabria, Mostar, Gijenovic, T raù e campi occasionali della zona di radunata).
In omaggio, tuttavia, a l principio fondamentale c he prescrive di non impiegare il bombard ame nto dal cie lo co ntro bersagli c he possono essere efficacemente battuti dal can none. sarà opportu no c he la M arina studi se e come potrebbe c;osti tuirsi ali' Aviazione, o quale concorso ad essa arrecare nell'azione co ntro i campi di Traù e di Gijenovic c he sorgono in prossimità della cos ta4
Non bi., ogna illudere che il successo delle azioni contro i campi di aviazione possa mai conferi re il dominio permanente del cie lo. La neutralizzazione dell'aviazione nemica sarà sempre temporan ea, perché la sua ricostru zio ne non richiede mezz i e tempo così rilevanti come quelli, ad ese mpio , occorre nti per la ricostruzione di una flotta navale.
Ottenut o pertanto tale successo (e ciò avverrà in pochissimi g iorn i, o non avverrà) bisogna sfruttarlo subi to e con la massima intensità, rivolge ndo tutti i mezzi di sponi bili contro altri bersagli, per approfittare delle co ndi zioni di tranquillità particolarmente favorevoli e di momenti critici dell'avversario che rendono il bombardamento re dditi zio al massimo grado.
4 Questo concorso riuscirebbe particolarmente utile. qualora un conlliuo ~orgesse mcntr.: la no,1ra Aeronautn: a non ha rngg1un10 il pre, 1sto ,viluppo. ln tal ca,o l'AvialJone dovrà neceS\anJmentc concentrare i suoi me11ì c o ntro uno solo (Zagabria) o .ti massimo due (Zagabria e Mo,iar) dei campi principali nemici. mentre da quelli di Traù e Gijenov1c l'avversario può sp ingere le MIC offc~c aeree fin su l versante 1irrenico dcll"lta lia peninsulare .
Tali bersagli sono i nodi ferroviari, i porti, le grandi stazioni di imbarco e di sbarco ed in genere i punti vitali delle linee, in zona di radunata, lungo le quali il movimento incomincierà a intensificarsi appunto allora, e, cioè, dopo i primi giorni, di sol ito assorbiti dalle operazioni preparatorie di mobilitazione.
Con questo non si esclude che fin dai primi giorni possa presentars i l'opportunità di eseguire azioni su più ampio raggio, miranti a paralizzare in altro modo la radunata nemica , a portare la distruzione nel cuore del paese avversario e a st ron care, con più vasti effetti materiali e morali, la sua volontà di resistenza. Ma tali azioni rientrano nel generale delle operazioni, e, più precisamente, nel progetto di impiego della massa aerea, che, posta alla diretta dipendenza del Comando Supremo delle F o rze Armate, è appunto uno dei mezzi principali dei quali questo dispone per intervenire nella lotta, imprimendole la direzione che corrisponde alla sua concezione strateg ica. Non è quindi il caso di parlarne in sede di direttive per la copertura.
È da prevedere ancora l'eventualità in cui la sorpresa, da parte nostra, dell'aviazione nemica nei suoi campi non sia possibile o non riesca, o sia prevenuta dall'avversario.
In tal caso interverrà l'azione della caccia che conviene impiegare a massa con criteri di manovra , in collaborazione con la difesa contraerea terrestre e navale alla quale spetta l 'avvista mento e la segnalazione delle in cu rs ioni e le conseguenti richieste di concorso dell'aviazione.
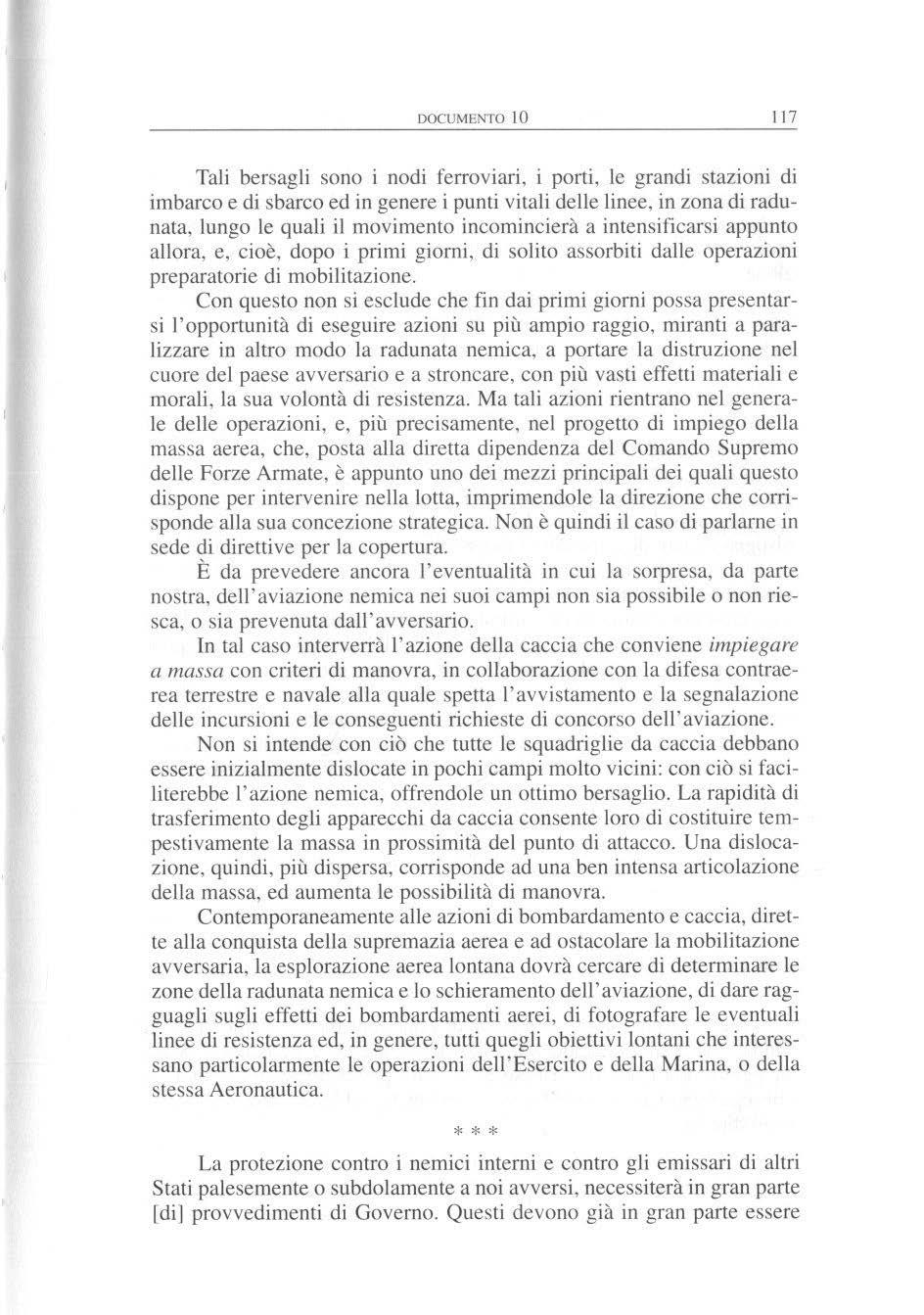
Non s i intende con ciò che tutte le squadriglie da caccia debbano essere ini zia lmente di s locate in pochi campi molto vicini: con ciò s i faciliterebbe l'azione nemica , offrendole un ottimo bersaglio. La rapidità di trasferimento degli apparecchi da caccia consente loro di costituire tempe s tivamente la massa in prossimità del punto di attacco. Una di s locazione, quindi, più di s persa, corrisponde ad una ben intensa articolazione della massa, ed aumenta le poss ibilità di manovra.
Contemporaneamente alle azioni di bombardamento e caccia, dirette alla conquista della supremazia aerea e ad ostacolare la mobilitazione avversaria, la esplorazione aerea lontana dovrà cercare di determinare le zone della radunata nemica e lo sc hieramento dell'aviazione, di dare ragguagli sugli effetti dei bombardam en ti aerei, di fotografare le eve ntuali linee di res istenza ed, in genere, tutti quegli obiettivi lontani che intere ssano particolarmente le operazioni dell 'Ese rcito e della Marina , o della stessa Aero nautica.
* * *
La protezione contro i nemici interni e contro gli emi ss ari di altri Stati palesemente o subdolamente a noi avversi, necessiterà in gran parte I di I provvedimenti di Governo. Ques ti devono già in gran parte essere
previsti dai progetti di mobilitazione compilati dai singoli Ministeri in base alle direttive della Commissione Suprema di Difesa, e saranno per il rimanente integrati dagli ordini che il Capo del Governo emanerà a momento opportuno in relazioni alle particolari contigenze della situazione.
Tali ordini comprenderanno anche la determinazione del momento preciso in cui l'autorità militare (Comando generale della difesa territoriale) dovrà assumere la situazione esecutoria anche dei provvedimenti predisposti dalle autorità civili.

La grande varietà di mezzi con i quali le ostilità interne si possono manifestare, implica una varietà altrettanto grande delle disposizioni dirette a contrastarle.
Non è pe11anto possibile stabilire fin d'ora criteri particolareggiati per l'attuazione di questo genere di difesa.
Si può soltanto dire in linea generale che anche in questo campo bisogna evitare di disperdere i mezzi di cui disponiamo su di un numero eccessivo di obiettivi e quindi occorre limitarsi a proteggere quei punti che veramente sono vitali.
Così non occorrerà disporre il servizio di vigilanza su tutte le linee della rete ferroviaria, ma soltanto su quelle di radunata e su poche altre che interessano particolarmente la mobilitazione generale.
Sulle une e sulle altre i punti da guardare dovranno essere scelti in base ad una giusta valutazione tecnica dell'importanza dei vari elementi ferroviari, evitando lo scaglionamento uniforme di guardie lungo i binari. Lo stesso dicasi per i depositi vari, le centrali elettriche, gli stabilimenti industriali, ecc. ecc.
Uguale criterio deve presiedere all'organizzazione del servizio di controspionaggio, che rappresenta la base della protezione interna, e che tutto avrà da guadagnare da un beninteso accentramento e da una giudiziosa quanto parca articolazione: economia di mezzi , uniformità di criteri di valutazione, serenità e fondamento di giudizi, falsi allarmi ridotti a l mfoimo, possibilità di agire a momento oppo11uno, prontamente e in direzione giusta.
La direzione delle operazioni di copertura da M. Forno (Pec) a Fiume spetta al Comando Supremo dell'Esercito, e pertanto lo Stato Maggiore dell'Esercito , in base al disegno per le prime operazioni , al conseguente piano di mobilitazione, radunata, schieramento, e alle presenti direttive:
1) comunicherà al Capo di Stato Maggiore Generale: a) quali sono i punti oltre confine che intende occupare in periodo di copertura;
b) quali sono gli obbiettivi oltre confine che interessa battere per intralciare la radunata terrestre nemica e per favorire, a suo tempo, la nostra prima avanzata;
2) prenderà accordi con lo Stato Maggiore della Marina per la saldatura della copertura terrestre con quella marittima lungo la linea costiera veneta, istriana e croata, e per il concorso di mezzi navali alle piccole operazioni offensive iniziali;
3) prenderà accordi con lo Stato Maggiore della Marina per la difesa di Zara, in base alle direttive superiori;
4) comunicherà allo Stato Maggiore dell'Aeronautica:
a) le zone più convenienti (per ragioni di sicurezza e di impiego) per l'impianto dei campi dell'aviazione ausiliaria;
b) i punti della nostra zona di radunata che più preme difendere da incursioni nemiche:
5) emanerà le diretlive per la copertura, da comunicare, prima, per l'approvazione, al Capo di Stato Maggiore Generale e, dopo, ai comandi di armata interessati, nonché agli enti delle altre Forze Armate destinati ad operare alla dipendenza de l Comando Supremo.
La direzione della copertura e protezione interna del territorio nazionale non compreso nella zona delle operazioni spetta al Comando della difesa territoriale. Gli studi inerenti a tale difesa sono, in tempo di pace, di competenza del Ministero della Guerra.
Perciò lo Stato Maggiore dell'Esercito:
1) sottoporrà al Capo di Stato Maggiore Generale gli elementi necessari per definire:
a) l'organizzazione e le modalità della difesa contraerea dei più importanti nostri centri industriali, commerciali e politici esposti a probabili offese avversarie, da attuarsi con i mezzi aerei territoriali in collaborazione con i mezzi a terra;
b) gli scopi, i limiti e le modalità del concorso dell'armata aerea alla difesa esercitata con l'aviazione territoriale e con mezzi a terra;
c) gli scopi, i limiti e le modalità del concorso dei mezzi navali alla difesa costiera, in ogni singolo tratto del litorale adriatico da Venezia ad Otranto.
2) previa definizione, per parte del Capo di S.M. Generale degli elementi di cui sopra e in base:

a) agli ordini emanati dal Capo del Governo pel tramite del Capo di Stato Maggiore Generale circa il concorso alla difesa interna delle autorità civili e delle organizzazioni ausiliarie;
b) alle necessità di particolari protezione per i rispettivi elementi segnalategli dagli Stati Maggiori della Marina e della Aeronautica; compilerà il progetto di copertura territoriale e protezione interna da comunicare, a suo tempo, al Comando della difesa territoriale, e, in stralcio, fin dal tempo di pace, a tutte le autorità civili e militari (di qualsiasi forza armata) interessate. * * *
Spetta anche allo Stato Maggiore dell'Esercito organizzare l'azione dell'esercito albanese su ed oltre la propria frontiera durante il periodo di copertura.
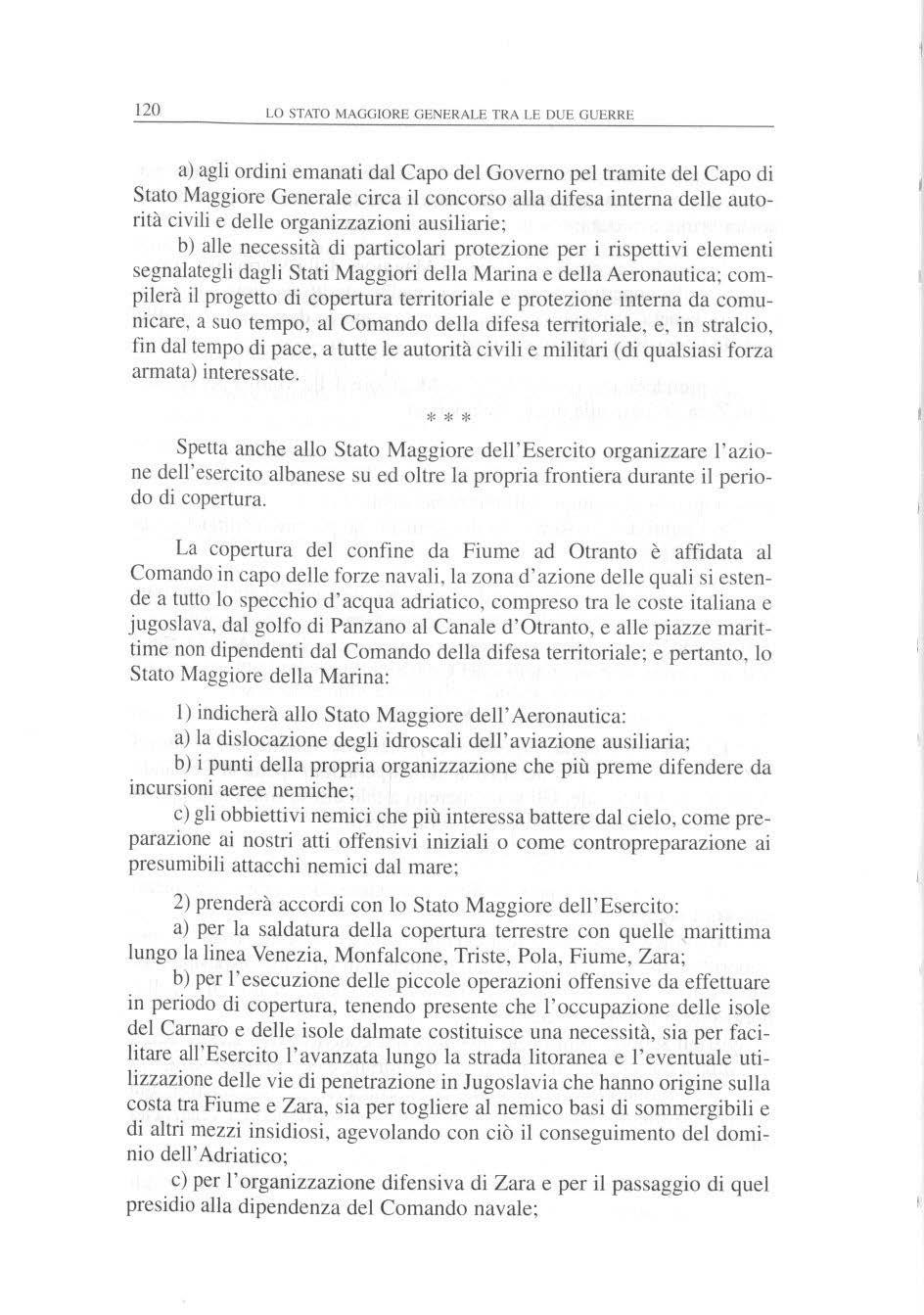
La copertura del confine da Fiume ad Otranto è affidata al Comando in capo delle forze navali , la zona d'azione delle quali si estende a tutto lo specchio d'acqua adriatico, compreso tra le coste italiana e jugoslava , dal golfo di Panzano al Canale d'Otranto, e alle piazze marittime non dipendenti dal Comando della difesa territoriale; e pertanto , lo Stato Maggiore della Marina:
I) indicherà allo Stato Maggiore dell ' Aeronautica:
a) la dislocazione degli idroscali dell'aviazione ausiliaria;
b) i punti della propria organizzazione che più preme difendere da incursioni aeree nemiche;
c) gli obbiettivi nemici che più interessa battere dal cielo, come preparazione ai nostri atti offensivi iniziali o come contropreparazione ai presumibili attacchi nemici dal mare;
2) prenderà accordi con lo Stato Maggiore del!' Esercito:
a) per la saldatura della cope1tura terrestre con quelle marittima lungo la linea Venezia. Monfalcone, Triste, Pola, Fiume, Zara;
b) per l'esecuzione delle piccole operazioni offensive da effettuare in periodo di copertura, tenendo presente che l'occupazione delle isole del Carnaro e delle isole dalmate costituisce una necessità, sia per facilitare all'Esercito l'avanzata lungo la strada litoranea e l'eventuale utilizzazione delle vie di penetrazione in Jugoslavia che hanno origine sulla costa tra Fiume e Zara, sia per togliere al nemico basi di sommergibili e di altri mezzi insidiosi , agevola ndo con ciò il conseguimento del dominio del!' Adriatico;
c) per l'organizzazione difensiva di Zara e per il passaggio di quel presidio alla dipendenza del Comando navale;
3) predisporrà le operazioni da eseguire all'atto dell'apertura delle ostilità, indipendentemente da quelle dirette contrn la flotta nemica, o intese a proteggere i nostri traffici, e cioè:
a) occupazione delle isole del Camara e della Dalmazia;
b) difesa di Zara;
c) eventuali azioni contro idroscali;
d) attuazione del blocco marittimo e repressione del contrabbando di guerra segnatamente nel Mediterraneo orientale;
e) chiusura del canale di Otranto e polizia dell'Adriatico;

I) rifornimenti delle forze albanesi;
4) prenderà accordi con lo Stato Maggiore del R. Esercito e, a suo tempo, con lo Stato Maggiore territoriale, per definire il concorso dei mezzi navali alla difesa costiera e alla difesa aerea del te1Titorio, [tenendo presente cheJ, nei riguardi della prima, spettano alla Marina i compiti di avviamento e di difesa mobile sul mare, e nei riguardi della seconda, il solo compito di avvistamento inteso a segnalare:
a) con la maggiore possibile precedenza di tempo, il comparire di incursioni aeree dirette al nostro territorio;
b) i successivi eventuali mutamenti di rotta delle incursioni stesse durante il loro percorso sul mare;
5) comunicherà al Capo di Stato Maggiore Generale quali sono i punti oltre confine che intende occupare (isole o altri punti di appoggio);
6) compilerà i progetti per la prevista riunione e dislocazione dei mezzi natanti occoITenti per effettuare i trasporti neces sa ri per piccole e per grandi operazioni da eseguire sia con mezzi propri che con quelli dell'Esercito;
7) analogamente a quanto è detto per lo Stato Maggiore dell'Esercito, compilerà le direttive per la copertura, e le comunicherà anche agli enti delle altre Forze Armate destinati ad operare alla dipendenza del Comando in capo delle forze navali.
* * *
Lo Stato Maggiore dell'Aeronautica:
I) in base ai dati comunicati dal R. Esercito circa lo schieramento delle forze terrestri e l'organizzazione della difesa territoriale, e ai dati dalla R. Marina circa la dislocazione delle proprie basi compilerà il proprio progetto di copertura difensiva;
2) in base:
- alle direttive di impiego più sopra esposte;
- allo studio delle organizzazioni nemiche:
a) aerea;
b) ferroviaria;
c) indu str iale , demografica, ecc.;
- alle even tuali richieste di concorso alle operazioni del R. E sercito e della R. Marina:
compilerà il proprio progetto offensivo in periodo di copertura;
3) sottoporrà, per il necessario coordinamento con l 'azione delle Forze Armate, tali progetti all'approvazione del Capo di Stato Maggiore Generale, e quindi compilerà le direttive di copertura che comunicherà, oltre che ai dipendenti comandi, anche ai Capi di Stato Maggiore del R. Esercito e delle R. Marina.

« Prepara zione della guerra contro La Jugoslavia (ipotesi Est): studi e piani relativi alla mobilita z ione (richiamo allogeni, situa zione dei reggimenti artiglieria e delle salmerie di fanteria , mobilitazione delle prime 30 divisioni, quadrupedi precettati, battaglioni ausiliari, mobilita zione oc culta, cartoline precetto, servi zi, dota zioni di mobilitazione) »
Manovra su ll a carta-Ipotesi Est (al
Verbale della seduta del 13 gennaio 1928 - VI. Nell'ufficio del Capo di Stato Maggiore Generale (Viminate)
Sono presenti le stess e persone che hanno pre s o parte alla seduta del 12 corrente <b>
La seduta si apre alle ore 9.
Il Colonnello Negri continua la lettura della memoria riassuntiva.
« Definizione delle operazioni di mobilitazione occulta».
A richiesta del Maresciallo Badoglio dà i seguenti schiarimenti circa il graduale sgombero di richiamati allogeni (pag. 115 della memoria - comma o): detti richiamati ammontano a circa 30.000 uomini per il Corpo d ' Armata di Trieste, 5.000 per l'Alto Adige, 1.000 per Zara. I centri di raccolta previsti sono rispettivamente Villa F ranca Veronese per il Corpo d'Armata di Verona; Trieste, P ola e Latisana per i Corpi d'Armata di Trieste e Udine; Zara per il territorio di Zara. Da questi centri i richiamati allogeni saranno avviati all'interno del territorio, nei distretti prestabiliti, dove essi saranno riuniti in battag li oni speciali, vestiti (se possibile), ma lasciati disarmati.
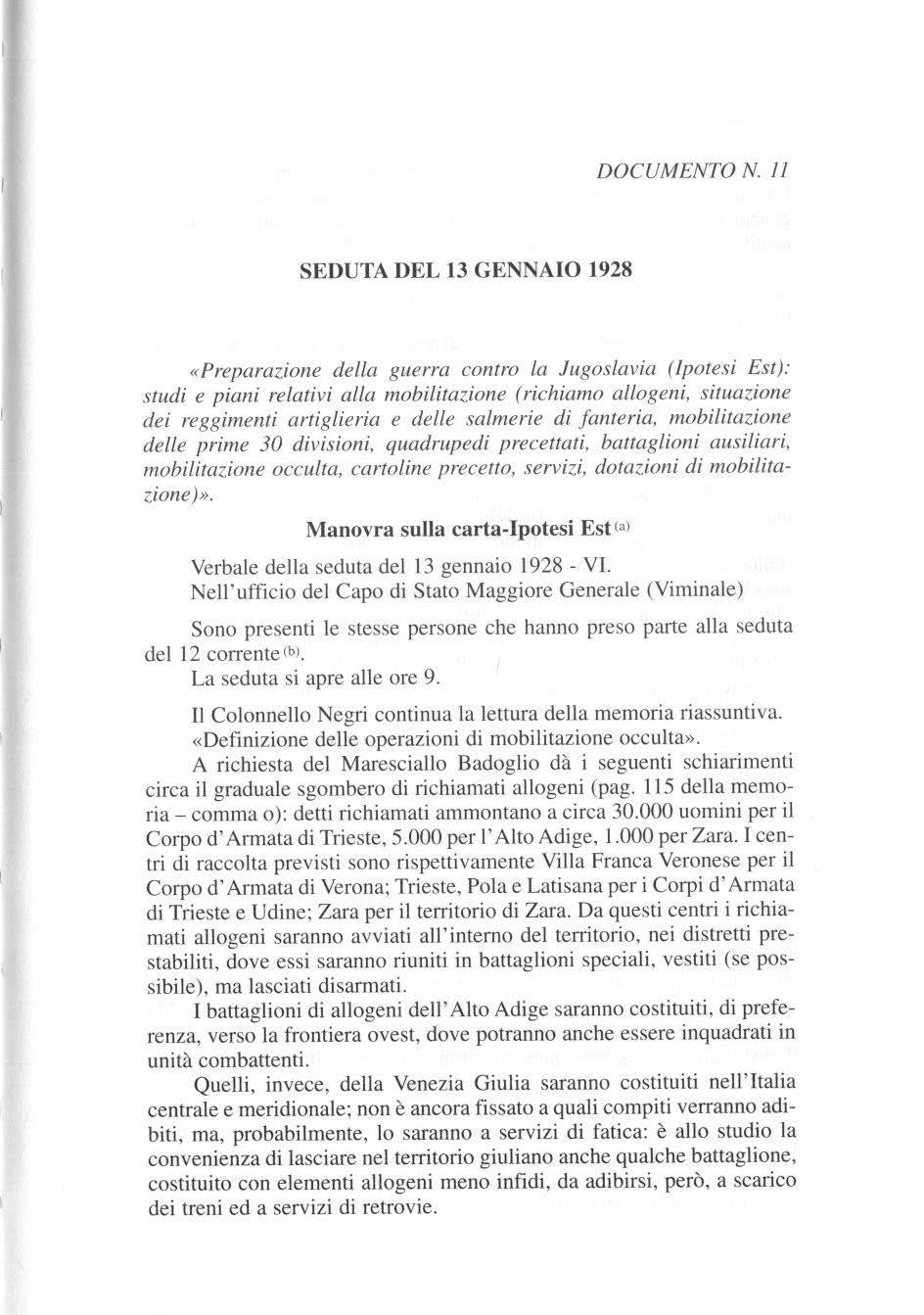
I battaglioni di allogeni dell'Alto Adige saranno costituiti, di preferenza, verso la frontiera ovest, dove potranno anche essere inquadrati in unità combattenti.
Quelli, invece, della Venezia Giulia saranno costituiti nell ' Italia centra le e meridionale; non è ancora fissato a quali compiti verranno adibiti, ma, probabilmente, lo saranno a servizi di fatica: è allo studio la convenienza di lasciare nel territorio giuliano anche qualche battaglione, costituito co n elementi allogeni meno infidi, da adibirsi, però, a scarico dei treni ed a serv izi di retrovie.
Sempre su richiesta del Maresciallo Badoglio, il Generale Graziosi fornisce i seguenti schiarimenti circa la situazione dei reggimenti di artiglieria (pag. 15 della memoria - comma p): le terze batterie saranno costituite con la classe che sarà chiamata nel 1929.
Circa le salmerie dei reggimenti di fanteria, informa che, quest'anno, si comincerà a costituire nuclei di 50 per reggimento per le divisioni rinforzate.
Quanto alle sezioni di accompagnamento di fanteria, rende noto che, per ora, ne esiste una per ogni divisione e che è prevista la loro scissione in tre sezioni all'atto della mobilitazione, in modo che ogni reggimento disponga della propria sezione.
S.E. Badoglio, richiamandosi allo svolgimento della mobilitazione tedesca ne 1914, chiede quante classi è necessario richiamare per assicurare la completa mobilitazione delle unità di primo impiego dell'Esercito italiano (pag. 16 della mcm01ia - comma q).
TI Colonnello Negri risponde che per la mobilitazione delle prime trenta divisioni - inquadrate nelle unità superiori - occorrono in media sei classi giovani e due anziane (6 classi per la fanteria, 4 per i bersaglieri e 7 per l'artiglieria): la mobilitazione delle successive dieci divisioni, per anivare al numero complessivo di 40, richiede il richiamo di altre due classi, perché il gettito della chiamata delle precedenti classi fornisce un contingente di oltre 1.000.000 di uomini, sufficienti alla costituzione di trenta divisioni, più un avanzo di 200.000 uomini circa, che saranno utilizzati per la costituzione delle unità di secondo tempo.
Circa il trasporto dei quadrupedi precettati (pag. 16 della memoria - comma r), S.E. Badoglio fa osservare come le difficoltà segnalate per eseguire il trasporto stesso confermano la necessità che ogni corpo d'armata sia in grado di trovare nel proprio territorio tutti gli elementi che gli occorrono per mobilitarsi.
Il Colonnello Vaccarisi informa che a tale concetto si ispirano appunto le disposizioni studiate, prescrivendo criteri di maggiore larghezza nella rivista quadrupedi testé ultimata e sfruttando, nella più larga misura possibile, i cavalli anche per il someggio, salvo poi, in secondo tempo, cioè a radunata compiuta, a sostituire i quadrupedi non perfettamente idonei con muli provenienti dall'Ttalia meridionale. Ma anc he tali provvedimenti non sono sufficienti: nel Corpo d'Armata di Trieste, ad esempio, secondo gli ultimi dati, è possibile fare assegnamento soltanto su 3.100 muli mentre ne occorrono circa l 1.500: quindi, tenuto conto di quelli già in distribuzione ai corpi, occorrono ancora circa 7 .000 muli che bisogna far giungere dalle Puglie. Così, nel Corpo d ' Armata di Verona, si presume una deficienza di 5.000 muli; deficienze alquanto minori sono da prevedersi anche nei Corpi d'Armata di Milano, di Alessandria e di Torino.

Circa l'impiego di battaglioni ausiliari ed altri elementi per lo svincolo dal territ01io delle unità dell'Esercito da mobilitarsi (pag. 17 della memoria - comma s), S.E. Badoglio domanda se è stato fatto un calcolo di ciò che occorre per poter eseguire tale svincolo in ogni corpo d'armata.
Il Generale Graziosi risponde che tale calcolo non è ancora stato fatto, ma si pensa di farlo prossimamente.
Circa la costituzione degli organi essenziali dei comandi territoriali con personale richiamato dal congedo (pag. 17 della memoriacomma t), sempre per svincolare i corrispondenti organi destinati a partire, il Generale Graziosi fa presente che sarebbe opportuno eseguire qualche esperimento pratico in proposito.
S.E. Badoglio osserva che non dovrebbe esservi preoccupazioni in proposito nel momento attuale, giacché per dieci anni abbiamo ancora molti ufficiali generali e superiori utilizzabili con sicurezza, per aver essi preso parte alla guerra.
Ma, col trascorrere degli anni, tale situazio ne favorevole andrà scomparendo e bisognerà stabilire richiami periodici degli ufficiali destinati ai comandi , anche per pochi giorni solta nto, allo scopo di tenerli in esercizio.
11 Colonnello Negri conferma che la si tuazione degli ufficiali non dà preoccupazione, poiché con gli ufficiali disponibili è possibile inquadrare anche 60 divisioni e le corrispondenti unità d'ordine superiore, e, nello stesso tempo, fare assegnamento su una riserva sufficiente a fronteggiare le perdite di un anno e mezzo di guerra: qualche deficienza , invece , si verifica nei corpi sanitario e veterinario.
A proposito dell'afferinazione che il periodo di forza minima dura praticamente - agli effetti della mobilitazione - 11 mesi dell'anno (pag. 19 della memoria - capoverso 4 °), il Colonnello Negri fa presente che, continuando, in pratica, a congedare la classe anziana a settembre, in effetti il periodo in cui l'Esercito ha la forza massima addestrata è di un solo mese; tale periodo si estenderebbe a due mesi, qualora le condizioni del bilancio pe1111ettessero di congedare la classe anziana in ottobre, facendole fare, così, tutti i 18 mesi previsti dalle norme di leggi vigenti.
11 Generale Graziosi richiama a questo proposito l'attenzione sul grave pericolo che minaccia l'efficienza dell 'Ese rcito, in seg uito al rapido accrescimento dei premilitari, che godono della particolare concessione di essere congedati con tre mesi di anticipo. Il numero di tali premilitari è passato rapidamente da 11.000 (1926) a 18.000 (1927), e si prevede che quest 'an no ammonterà a 50 - 60.000 uomini, di cui 40.000 nella sola Lombardia. L'esodo, in giugno, di una aliquota così considerevole di forza deve formare oggetto di seria considerazione.
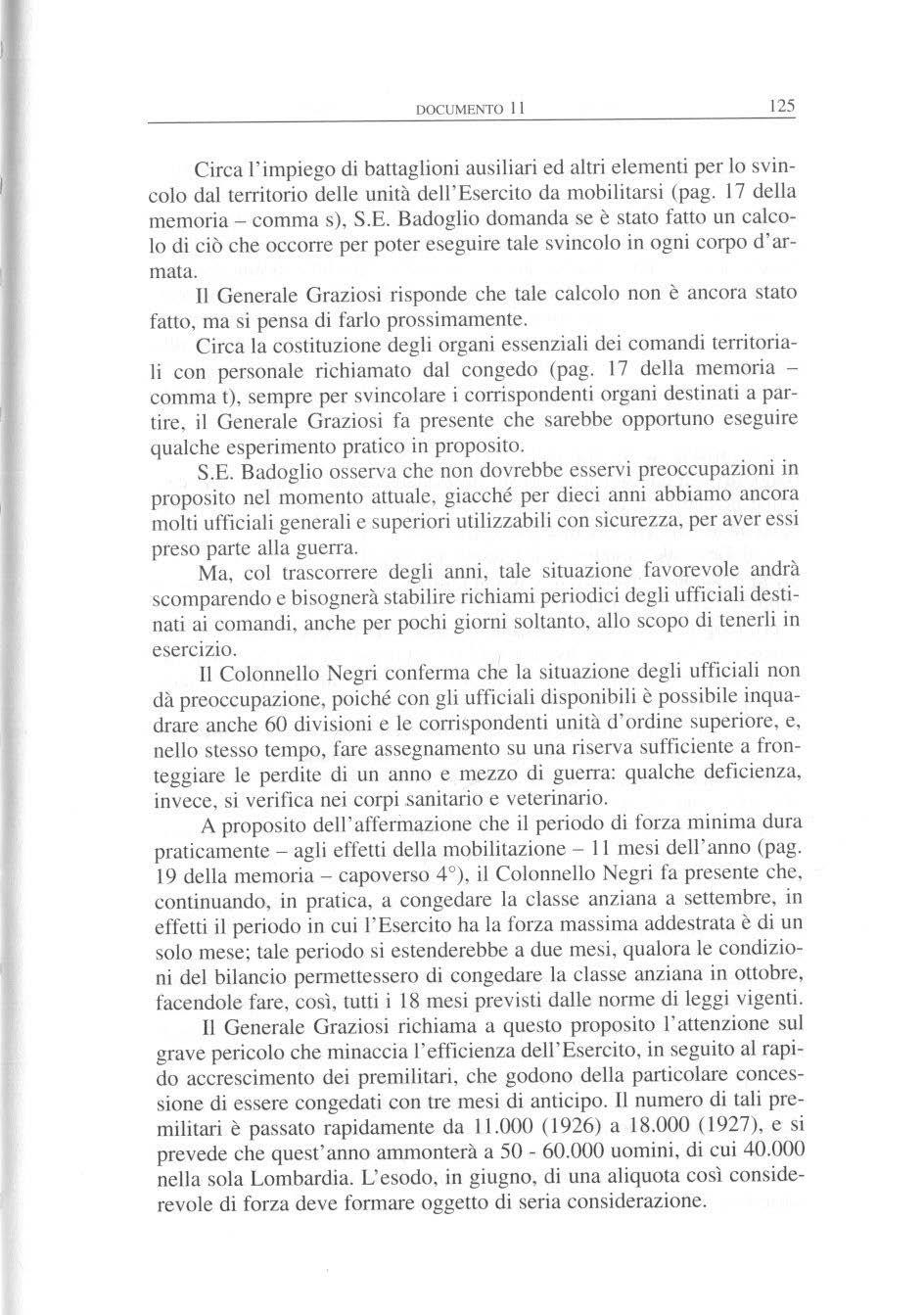
A proposito dei provvedimenti proposti per accelerare la mobilitazione nel caso in cui si possa disporre preventivamente di 4 giorni di mobilitazione occulta (pag. 22 della memoria - comma 4 ° e segg.), S.E. Badoglio osserva che lo scopo del presente studio è, appunto quel lo di concretare, con dati precisi, quale è la forza bilanciata da chiedere per avere la certezza che gli eleme nti di frontiera da rinforzare risultino realmente rinforzati , e quali sono i preparativi da attuare, sin dal tempo di pace, per assicurare l'ordinato svolgimento della mobilitazione occulta studiata. Infatti, forza bilanciata e preparativi si traducono in assegni di bilancio, a concretare i quali in cifre quanto più possibile esatte tende appunto il lavoro che si sta compiendo.

Ultimata la lettura della memoria del Colonnello Negri, S.E. Badoglio richiede schiarimenti sul funzionamento del sistema delle cartoline precetto nei riguardi di chiamate parziali di specialisti, appartenenti ad un numero di classi anche elevato.
Il Generale Graziosi e il Colonnello Negri forniscono tali chiarimenti e danno assicurazioni circa la praticità del sistema, accertato con apposite verifiche. Soggiungono che l'inconveniente più grave era, fino a ieri, rappresentato dalla possibile irreperibilità di alcuni precettati per omessa notificazione ai distretti dell'avvenuto cambio di domicilio; ma oggi anche tale inconveniente è eliminato , con l'imminente pubblicazione di provvedimenti legislativi, che dispongono penalità (multe fino a 5000 lire) a coloro che omettano di notificare le variazioni di residenza.
Il Colonnello Vaccarisi pone in rilievo l'importanza dei servizi per il funzionamento dell'Esercito e per la sua capacità a raggiungere gli obbiettivi che gli sono fissati; nota come l'organizzazione dei servizi abbia le maggiori ripercussioni sui provvedimenti finanziari del tempo di pace, a determinare i quali tendono, appunto, i presenti lavori.
Ricorda, inoltre, come l'apprestamento delle dotazioni di mobilitazioni richieda tempo notevole e presenti, nel caso particolare del nostro Paese, povero di materie prime e d'impianti industriali, serie difficoltà per la conseguente necessità di procedere a larghi acquisti ali' estero. Pone, infine, in rilievo il c riterio adottato di non accantonare nei magazzini tutto quello che costituisce dotazione di materiali dei reparti e servizi da mobilitare, ma, bensì, quei materiali c he non è possibile procurarsi in tempo utile all'atto della mobilitazione, col vantaggio di limitare le spese durante il tempo di pace, di allestire, a parità di spesa, materiali di uso esclusivamente militare per un maggiore numero di unità, di ridurre il fabbisogno di locali e di personale di custodia e di assicurare meglio la rotazione del materiale. Propone , per evitare dannose concorrenze nell'acquisto, all'atto del bisogno, dei materiali occorrenti alle varie Forze Armate, la creazione di un organo centrale integratore che,
in relazione al fabbisogno di ciascuna delle Forze Armate, provveda agli acquisti e conseguente riparti zione.
Ciò premesso, egli informa che la nostra situazione in fatto di dotazioni ci consentirà di mobilitare per la prossima primavera:
1 Comando Supremo;
4 Comandi di armata con relative truppe e servizi direttamente dipendenti, ma senza magazzini e depositi centrali;
2 divisioni di cavalleria;
12 reggimenti bersaglieri;
9 reggimenti di alpini
21 divisioni di fanteria, inquadrate in 8 corpi d'armata;
- le truppe occorrenti alla O.M.
La mobilitazione di tali elementi non esaurisce la disponibilità dei magazzini, ai quali si deve attingere per la mobilitazione di altre 9 divisioni, perché la disponibilità dei materiali interessanti i vari servizi non raggiunge un livello comune per tutti. Così per i materiali d'artiglieria ed armi portati li , disponiamo del fabbisogno anche per tutte le altre divisioni; per le unità sanitarie e da campo potremmo provvedere ad altre 4 divisioni, ecc.
Le recenti disposizioni date dallo Stato Maggiore consentono inoltre di mobilitare le previste 21 divisioni territoriali, senza bisogni di spostamenti, ove i centri di mobilitazione s iano messi in grado di accantonare le proprie dotazioni, per il che attualmente si verifica essenzialmente deficienza di locali.
Per completare le 31 divisioni, sarebbero necessari (escluso il servizio c himico) 993.000.000 di lire senza i magazzini e depositi centrali ed 1.917 .000.000 comp resi i magazzi ni e depositi centrali. Ove si consideri in più il servizio chimico (419 milioni) e in meno le assegnazioni di fondi straordinari, già concessi per acq ui sto dotazioni fino al 193 J (452 milioni), occorrono 960 milioni senza i magazzini e depositi centrali e 1.884.000.000 con i magazzini e depositi centrali.
S.E. Badoglio osserva che la diminuzione di assegni provocata dalla rivalutazione della lira, concor rendo con la minore assegnazione fatta per altri motivi, porta come co nseguenza la riduzione alla metà della cifra che era stata promessa.
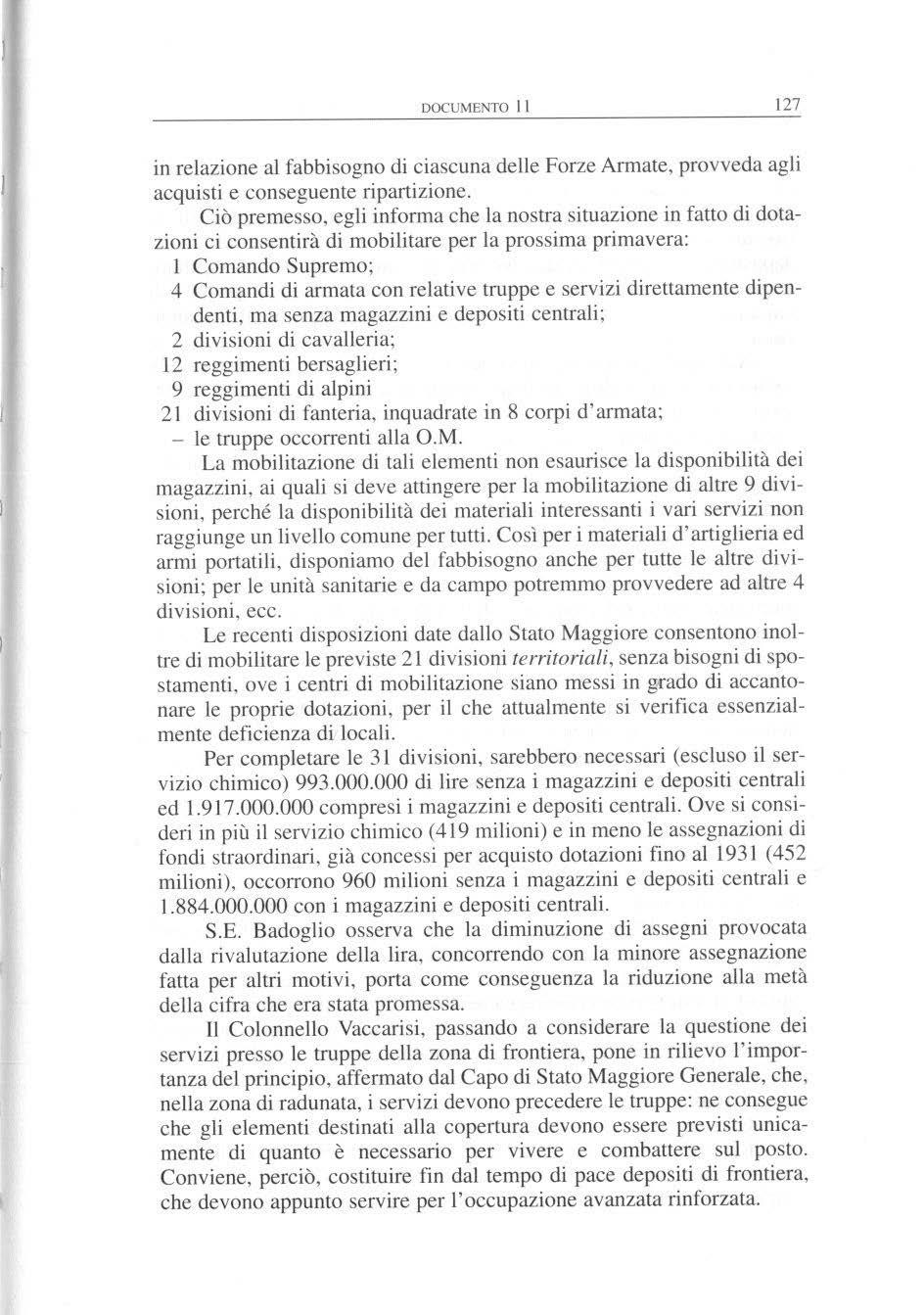
Il Colonnello Vaccarisi, passando a considerare la questione dei servizi presso le truppe della zona di frontiera, pone in rilievo l'importanza del principio, affermato dal Capo di Stato Maggiore Generale, che , nella zona di rad unata , i servizi devono precedere le truppe: ne consegue che gli elementi destinati alla copertura devono essere previsti unicamente di quanto è necessario per vivere e co mbatte r e sul posto.
Conviene, perciò, costitu ire fin dal tempo di pace depositi di frontiera, che devono appunto servire per l'occupazione avanzata rinforzata.
Per la frontiera Est i comandi di armata hanno già ricevuto le prime dirertive, che saranno completale prossimamente da quelle dei servizi. Studiate e concretate le località dove si devono impiantare i depositi di frontiera e la loro consistenza. si passerà alla costituzione effettiva dei depositi stessi, per evitare di doverli impiantare sotto rurgenza di imminente confliuo, distogliendo men,i di Lrasporto preziosi in periodo di mobilitazione occulta e svelando anzi tempo al nemico le nostre intcnLioni.
S.E. Badoglio insiste sul concetto che le truppe di copertura non hanno necessità di disporre della completa dotazione di mezzi di trasporto, che spetterà loro a mobilitazione ultimata, perché non vi sarà guerra di movimento se non a radunata compiuta: occorre che tutti coloro i quali hanno responsabilità di comando e di organiva1ione tengano ben presente questo, per fare argine a qualsiasi velleità di esagerazioni garibaldine. Ad esempio e conferma, cita alcuni dati di fatto delle prime operazioni francesi e tedesche sulla fronte occidentale nel 1914.
II Colonnello Vaccarisi accenna alle disposizioni prese per garantire la precetta.lione dei quadrupedi e dei meai di trasporto; espone il meccanismo di legislazione in materia e le modalità di attuazione. confermando che non occorre alcuna ulteriore disposizione legislativa. E ricorda la grave questione del trasporto dei muli, che devono affluire in numero di 15.000 dal!' ltalia meridionale a quella settentrionale (per il so lo Corpo d'Armata di Trieste, ne occorrono circa 7.000, in un periodo delicato per i trasporti di mobilitazione e di radunata). Può l'Ufficio Trasporti garantire tale afflusso? Occorrerebbe tale assicurazione perché, mancando questa, bisognerebbe studiare opportuni ripieghi.
Il Colonnello Scarelli osserva che trattandosi di ben 60 treni, la questione va esaminata a fondo.
li Colonnello Vaccarisi propone:
- portare le salmerie dei reggimenti di fanteria dei corpi d'armata dell'Italia del nord agli organici previsti dalle tabelle graduali numeriche ( 1926) sia per i 21 reggimenti con salmeria rinforzata, sia per i rimanenti reggimenti di fanteria con salmerie di addestramento.

- costituire fin d'ora la 3" batteria del gruppo someggiato dei reggimenti d'artiglieria da campagna delle se tte divisioni rinforzate.
- in conseguenza dell'onere finanziario che ne deriva, ridurre al minimo le salmerie di tutti gi altri reggimenti di fanteria dell'Italia continentale ed insulare, dove hanno la possibilità di prontamente completare i loro organici.
Oppure: Riprend ere in esame la prevista costituz.ione dei se r vizi di reggimento alpino, i quali, in consideraLione della loro funzione iniziale di truppe di copertura, non hanno bisogno di avere garantita un'autonomia
di due tappe; ciò che importerebbe un'economia di circa 500 muli per reggimento alpino.
S.E. Badoglio incarica S.E. Ferrari di eseguire gli studi necessari: osserva intanto, che la frontiera est presenta carattere ben diverso nei due tratti rispettivamente a nord e a sud di Piedicolle. Nel primo tratto si ha una catena montana vera e propria, la linea di displuvio della quale è seguita dal confine sul quale occorre tener fermo, poiché non abbiamo alcun interesse a passar oltre. Nel secondo tratto ci troveremmo in condizioni buone per raccoglierci prima di spiccare il salto oltre confine. Qui si attenderà, dunque, che la radunata sia ultimata, prima di iniziare le operazioni.
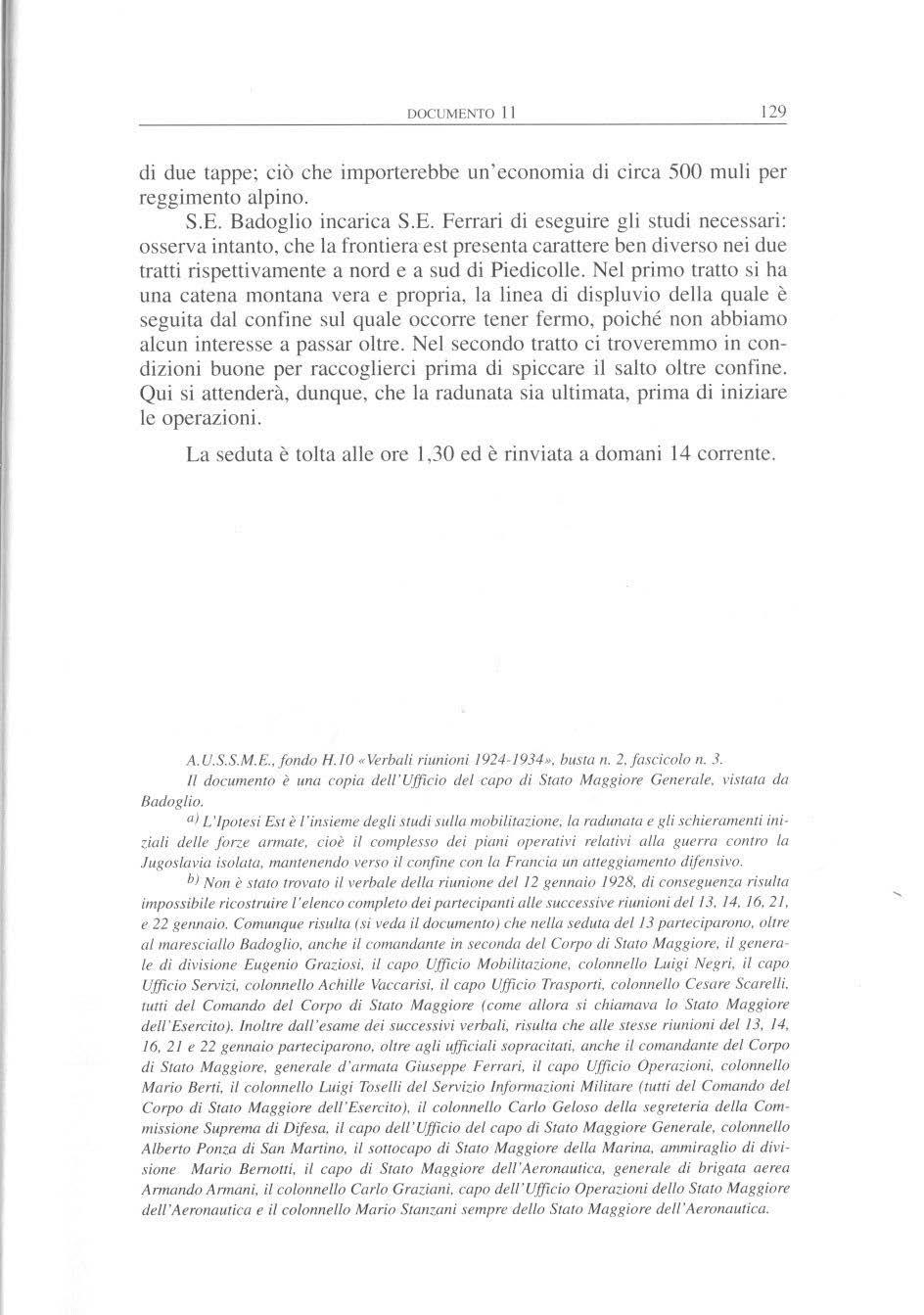
La seduta è tolta alle ore 1,30 ed è rinviata a domani 14 corrente.
A.U.S.S.M.E .fondo H./0 «Ve rbali riunioni 1924 - 1934». busw 11. 2.fascicolo 11. 3. li docume1110 è una copia del/· Ufficio del capo di Stato Maggiore Generale. visww da Badoglio.
"' L'Ipotesi E.1t è /"i11.1ie111e degli studi sulla mobilita:io11e. la radunata e gli schieramenti ini~ia li delle .fàr~e armate. cioè il complesso dei piani operatil'i relatfri lilla guerra con tro la Jugoslllvia isolata. momene11do verso il co11fi11e con la Francia 1111 lllleggill111ento difensivo.
b) Non è s tato trovato il 1•erbale della riunione del /2 gennaio /928 , di conseguenza risulta impossibile ricostruire l'elenco completo dei pllrtecipll11ti lllle successive riunioni del /3. 14. 16. 21, e 22 gennaio. Comunque risulta (si 1•edll il documento) che nello seduta del /3 parteripllmno. oltre ol maresciallo Badoglio. anche il rn11u111dan1e in seconda del Corpo di Staro Maggiore, il generale di di1•isio11e Euge11io Gra:iosi. il copo Ufficio Mobilita :io11e colo1111ello Luixi Negri. il capo Ufficio Servi:i, colon11el/o Achille Vaccarisi. il capo Ufficio Trasporti. colo11nello Cesare Score/li. tutti del Comando del Corpo di Srato Maggiore /come allora si chiamavll lo Swto Maggiore de/l'Esercito). Inoltre dall"esa111e dei successivi verbali, risulta che lllle stesse riunioni del 13. /4, /6, 21 e 22 gennaio parteciparono, oltre agli ufficiali sopracitati. llnche il co111a11da111e del Corpo di Stato Maggiore, generale d'armata Giuseppe Ferrari. il copo Ufficio Opera ~io11i. colo1111ello
Mario Berti, il colon11ello Luigi To.1elli del Servido /11Jor111a :io11 i Mi/iwre (tutti del Comando del Corpo di Stato Maggiore de/l ' Esercito), il colonnello Carlo Geloso della segreteria della Com· missione Suprema di Difesa, il capo de/l'Ufficio del capo di Sw10 Maggiore Generale, colo1111ello Alberto Ponza di San Martino, il souocapo di Stato Maggiore delle, Marina. ommiraglio di divisione Mario Bemolli, il capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica, ge11era/e di brigaw aerea Armando Armoni. il colonnello Carlo Graziani, capo dell 'U./Jicio Operazioni dello Stato Maggiore dell'Aeronoutica e il co/01111ello Mario Sta11:a11i sempre dello Stato Maggiore dell'Aero11aulica.

« Prepara zione della guerra contro la Jugoslavia (ipotesi Est): studi e piani relativi alla mobilita z ione (requisizione quadrupedi-automezzi e materiali vari, commissioni di in c etta, c ostituzione maga zz ini, viabilità e situaz ione idrica alla frontiera orientale, mobilita zione occulta) »
Manovre su lla carta-Ipotesi Est (•>
Verbale della seduta del 14 gennaio 1928 - VI - tenutasi nell'ufficio del Capo di Stato Maggiore Generale
Sono presenti i membri delle sedute precedenti, più il Colonnello Tose li i del Servizio Informazioni Militare del Comando del Corpo di Stato Maggiore (b> .

La seduta è aperta alle ore 9.
S.E. Badoglio premette che gli preme insistere sul seguente punto approvato dal Capo del Governo, ancora in un colloquio avvenuto ieri: quantunque l'impiego delle truppe sia di spettanza esclusiva dell'autorità militare, è necessario ribadire perché non si verifichino interferenze e non si producano correnti di faciloneria , che nessuna puntura di spillo è valida in tempo di guerra, e che, pertanto, l'Esercito non muoverà verso la battaglia se non avrà prima radunate e collegate Je proprie truppe. Da ciò si deduce, ancora una volta, che in zona di copertura è necessario disporre solamente di quel tanto di servizi che occorrono per vivere e combattere sul posto. Il nostro Paese, dopo una guerra come l'ultima da cui siamo usciti, non ha bisogno di successi reclamistici ottenuti con piccoli scontri, tipo Waissemburg.
Il Colonnello Vaccarisi continua l'argomento oggetto della seduta precedente, esaminand o in q uant o l a requisizione risponda attualmente ai suoi scopi. Malgrado la rivista del 1923-24, molti comuni non avevano compilato i prescritti documenti, alcuni l'improvvisarono per la circostanza e si verificò, in altri, che tali importanti pratiche erano affidate ad un semplice capo guard ia. Quasi ovunque i proprietari avevano o messo le segnalazioni di acquisto e di vendita, ecc. Questi inconvenienti furono segnalati al Ministero dell'Interno c hiedend o l'applicazione delle prescritte penalità.
Dal canto nostro si è venuti alle seguenti proposte conclusive:
- O la precettazione preventiva viene eseguita ogni due anni, e, allora, si può avere la sicurezza che la chiamata dei mezzi di trasporto risponda. al momento del bisogno. come la chiamata degli uomini.
- O, se qua nto sopra non è possibile per ragioni finan1iarie od altro, si faccia una volta tanto un esperimento di requisizione, almeno per una divisione (anche non dì fanteria) in periodo diverso da quello delle grandi esercìta1ìonì, visto che la legge ci dà questa facoltà per -,incerarsi dei risultati che si possono conseguire dalla requbìLìone stes-,a.
S.E. Badoglio osserva che tale provvedimento corrisponde a ciò che, in altri tempi, fu detta, per gli uomini, chiamata di controllo.
Prima, però, di proseguire su questo argomento intende aprire una parentesi. o-,servando che fra gli argomenti trattati nelle <,edute precedenti furono omessi due dì grande importan7a che converrà ricordare in segu ito. al momento di venire alla concl usion e:

- richiamo per istru.done delle classi in congedo:
- richiamo per istruLione degli ufficiali di complemento.
Circa i quadrupedi poi, dall'esposizione fatta dal Colonnello Yaccarisi, risultano concretate queste proposte:
- maggiore assegnazione di quadrupedi ai Corpi d'Armata di Trieste e di Udine. anche a detrimento di altri co rpi d. armata, né più e né meno di quanto si fa per gli uomini:
- minor e assegnazione di servizi ( ri spetto agli organici di guerra) alle truppe di copertura. perché (si ripete, im,istendo) queste sono destinate a combattere sul posto e non ad avanzare.
Occorrerà, poi, vedere se è possibile togliere qualche mulo ai gruppi someggiati dei reggimenti da campagna, a favore delle sa lmerie delle truppe di frontiera.
li Colonnello Vaccarisi, in seguito alla propria recente esperienza personale di comandante di reggimento d'artiglieria, crede di poter, lin d'ora, escludere tale possibilità, data l'infelicissima situazione. anche in fatto di quadrupedi. dei gruppi someggiati.
S.E. Badoglio prende atto.
Comunica, poi, che proporrà di sostituire una volta tanto, nel periodo delle esercitazioni estive, alle ordinarie manovre, un esperimento di mobilitazione comp leta di almeno una divisione. Sarà questa una delle proposte conclusive del presente studio.
Il Colonnello Yaccarisi, riferendosi alle difficoltà più sopra segnalate, per ottenere che i documenti base della precettazione siano tenuti a giorno, esprime il parere che sia da prendersi in considera1ione anche un altro provvedimento, e, cioè, limitare alle truppe di copenura e all'artiglieria da campagna l'assegnazione di quadrupedi precettati e fare assegnamento s ulla requisi zio ne per la provvista dei quadrupedi occorrenti
per tutte le altre unità. Ciò recherebbe anche un altro vantaggio, e, cioè, quello di permettere alle commissioni di requisizione, di assegnare ciascun quadrupede al servizio per il quale è realmente più adatto.
Passa ndo, quindi, alla precettazione di automezzi, egli osserva che per questa dovrebbero adottarsi temperamenti uguali a quelli proposti per la precettazione quadrupedi.
Gli automezzi esistenti in Italia sono poco numerosi: circa 30 mila autocarri, la maggior parte dei quali è residuata di gue1Ta con pochi anni di vita davanti a sé, in modo che non si può fare assegnamento se non sopra un terzo di essi, ossia circa 10 mila.
Anche qui, perciò, è necessario verificare ogni due anni le vere condizioni in cui ci troviamo; bisogna subito, però, soggiungere che la cosa si presenta meno ardua che non per i quadrupedi, poiché la spesa per queste riviste si aggira intorno alle 200 mila lire.

D'altronde, la situazione degli automezzi da precettare è meno difficile a determinarsi, in qualsiasi momento. con sicurezza, in quanto si può valersi dello schedario che sta compilando R.A.C.1. (R. Automobil Club Italiano) per disposizione governativa.
Ricorda che l'Esercito è anche incaricato di provvedere alla precettazione e requisizione degli automezzi occorrenti alla Marina o ali' Aeronautica.
S.E. Badoglio, preso atto che la requisizione è in grado di fornire circa JO mila autocarri e che un certo numero di automezzi sono fin d'ora in proprietà dell'Esercito, chiede quale sia la deficienza che si prevede in relazione al fabbisogno di gue1Ta.
li Colonnello Vaccarisi cita alcuni dati a memoria e quindi di valore soltanto approssimativo. Dice che il fabbisogno totale è su 20 mila mezzi, incluso, in questo numero, anche quelli specia li.
Di autocarri abbiamo un fabbisogno da 17 a 18 mila e possiamo coprirlo con la requisizione che ne dà circa 10 mila e con altri 8 mila che sono in possesso dell'Esercito. Da questi dati risulta che vi è solo deficienza di automezzi speciali.
TI Colo nn ello Berli fa rilevare la ripercussione che può avere, nel campo operativo, la deficienza degli automezzi e fa presente che, alla fine della guerra, la Francia aveva 95.000 autocarri di manovra; noi attualmente non ne abbiamo nessuno.
S.E. il Maresciallo Badoglio: noi ne avevamo 2.200 nel giugno del 1918 e la Francia, che ne aveva 22.000 nel parco di Versailles, voleva mettere le mani sui nostri 2 .200. Del resto non bisogna essere pessimistici e riflettere che, in questo campo, la Jugoslavia sta peggio di noi.
TI Colonnello Berti fa presente che occorrerebbero mezzi meccanici per il trasporto di almeno due divisioni.
li Colonnello Vaccarisi informa, che, per questo, si potrebbe fare assegnamento sulle auto-corriere, in numero di 3.200 (e precettate per un terzo) che andranno sempre aumentando, dato lo sviluppo crescente dei servizi postali e viaggiatori a mezzo di automobili. Ciò consente di considerare possibi l ità operative, senza manomettere disponibilità automobilistiche delle armate.
S.E. Badoglio domanda se nei 17 mila autocarri di cui sopra, sono compresi anche quelli che debbonsi assegnare alla fanteria per il trasporto degli zaini.
S.E. Fcrrari risponde che gli zaini sono aboliti; ma certamente occorrono mezzi per il trasporto di materiali a seguito delle truppe.
Il Colonnello Vaccarisi: effettivamente i 70 quadrupedi e le 8 carrette assegnate al battaglione non sono sufficienti: la soluzione del traspo110 di tutto il materiale non da combattimento dovrà trovarsi nella assegnazione di due autocarri leggeri per battaglione, ciò che imporla un aumento da 7 a 800 autocarri.
Il Colonnello Vaccarisi, accenna anche alla requisizione dei natanti, alla quale però provvederà la R. Marina, sia per conto suo, sia per conto dell'Esercito: da parte nostra, però, non ve n'è una grande nec essità, per la povertà della rete navigabile interna.
Altra questione: composizione, funzionamento e costituzione delle commissioni di incetta e requisizione di derrate e materiali vari.
In proposito, una commissione interministeriale sta s tudiando un apposito regolamento, previsto dall'art. 10 della legge sull'organizzazione della NaLione in guerra, del giugno 1925 <cl; il lavoro è a buon punto, ma le formalità sono lunghe: bisognerebbe sollecitarla perché le commissioni di incetta e requisizione dovrebbero entrare in funzione sin dal primo giorno di mobilitazione occulta.

li Co lonnello Gelo so informa che il lavoro conclusivo è stato sospeso, perché occorre risolvere, prima, alcune que stioni giuridiche in relazione alla questione delle esprop riazioni, che va regolata con disposizioni legislative attualmente in istudio presso il Ministero della Giustizia.
Il Colonnello Vaccari si: intanto i corpi d'armata potrebbero fare qualche cosa.
S.E. Badog li o : si può sollecitare il Mini stero della Giustizia, e, aspettando, diramare ai corpi d'armata una cìrcolare provvisoria.
Il Colonnello Geloso spera che per il mese di giugno il rego lamento sarà pronto.
IL Colonnello Vaccarisi: altra questione: costituzione dei magazzini di armata e dei depositi centrali.
Per i magazzini si è già abbozzato il quadro generale in base alla radunata di 3 armate; per i depositi centrali, data la minore urgenza, non si è ancora compilato lo studio, e, probabilmente, lo si co mpilerà entro l'anno.
La situazione, pertanto, è questa: ciascuna Direzione di servizi ha già in dotazione i materiali per far fronte alla forza prevista di ciascuna annata; si sa dove attingere per riempire ciascun magazzino futuro di armata; sono stabilite le località di resa e di presa; sono stati comunicati all'Ufficio Trasporti i dati relativi al movimento. Ciò che non s i conosce ancora sono le località precise dove so rgeranno i depositi ed i magazzini di cui trattasi, e, quindi, i movimenti dalle località di resa alle località sopradette. Per questo sono in corso ricogn izioni per parte dei Comandi designati di armata se vogliamo, però, entrare in un campo positivo è necessario che le proposte particolareggiate che saranno avanzate dai Comandi designati di armata siano tradotte in provvedimenti esecutivi (apprestamento di locali, raccordamenti ferroviari, per via ordinaria, ecc.).
S.E. Badoglio informa che al termine della manovra egli intende compilare due distinte relazioni: una sintetica ed un 'a ltra di proposte relative a maggiori assegnazioni. Per quest'ultima relazione gli Stati Maggiori lo aiuteranno, specificando tutte le ragioni per cui s i chiedono le varie maggiori assegnazioni.
S.E. Ferrari: per costituire i magazzini di armata dei quali ha parlato il Colonnello Vaccarisi , noi , attualmente, non abbiamo nemmeno un chiodo: que sto, a mio parere, è assai più interessante che non la questione topografica affidata, per studio, ai Comandi designati di armata.
Il Colonnello Vaccarisi: per la 0.M. tutto è pronto, ma non ancora riunito. Per ora si sta accantonando a Brindisi tutto quello che so pravanza alla mobilitazione di primo tempo.
Altra questione che acquista singo lare importanza nell'Ipotesi Est : strade ordinarie e servizio idrico.
Delle sette rotabili che attraversano il confine jugoslavo, alcune , come quelle di Piedicolle, del passo d' Idria e de l passo di Circhina, hanno caratteristiche tali che non sono sempre percorribili, nemmeno da autovetture leggere: non è, quindi , il caso di fare serio assegnamento su di esse per un pesante traffico autocarreggiato.
Occorre, perciò, provvedere con una certa urgenza al miglioramento di queste comunicazioni. (Alleg. n. 1) <d>.

S.E. Badoglio informa che si può fare assegnamento sul valido e volenteroso concorso del Mini ste ro dei LL.PP. , grazie all'efficace interessamento personale che il Mini stro Giuriati ha dimostrato, in ogni occasione, per le necessità della preparazione militare.
Osserva, poi , che, non meno della costruzione, interessa la manutenzione delle strade e, riferendosi all'espe ri enza da noi fatta nei primi mesi della nostra guerra, che portò all'ist itu zione dei «centurioni», domanda se è stata prevista anche la mobilitazione di un servizio di manutenzione stradale.
S.E. Ferrari dà assicurazioni in proposito.
Il Colonnello Vaccarisi insiste sulla cattiva condizione delle strade alla frontiera est.
Il Maresciallo Badoglio: certamente tali strade sono piuttosto infelici: non bisogna tuttavia dimenticare che nell'offensiva austriaca del 19 I7, esse hanno sopportato il movimento di Lutto qucll 'esercito che poi si è allargato nelle ottime strade della pianura friulana.
Il Colonnello Berti fa rilevare che la gravità della situazione stradale si delinea veramente oltre frontiera, e si accentua a misura che ci si allontana dalla medesima. E , difatti, le 12 strade che bene o male conducono al confine si riducono a 8 tra il confine e il meridiano di Lubiana, a 6 o 7 fra Lubiana e Zagabria, e a 3 oltre Zagabria.
S.E. Ferrari: appunto per questa considera7ionc è previsto un servizio stradale al seg uito dell'Esercito operante.
li Colonnello Vaccarisi. accennando alla recente istituLione dell'ALienda Autonoma Statale della Strada, propone che l'autorità militare sia in essa rappresentata con ufficiali di Stato Maggiore: per tal modo, i provvedimenti di interesse turistico. che ora si polariuano verso i grandi centri, verrebbero decentrati verso la frontiera a servizio anche delle esigenze militari.
L'autorità militare dovrebbe favorire la prospettata istitutione della milizia della c;trada, perché così noi potremmo concentrare nelle zone delle operazioni un cospicuo numero di mili ti pratici del servizio di disciplina stradale, assai utile al fine della organizzazione logi stica della rete stradale e del prevedibile intenso movimento che dovrà avvenire in quella di frontiera.

Servizio idrico: nella zona di frontiera est manca l'acqua per gli uomini e per i quadrupedi.
Impossibile, quindi, lungo taluni itinerari, rifornire grandi unità per l'intero perc orso. Se le cose continuano così, bisognerà rinunziare a talune operazioni. La stessa scarsezza di popolazione nella regione è probabilmente dovuta a tale mancanta di acqua. Si sono presi in esame i me ni (botti, bidoni, barili, autobotti. ghirbe. ecc.) coi quali si potrebbe eseguire rifornimento al seguito delle truppe; ma tale rifornimento sarà sempre di rendimento insufficiente. La vera soluzione del problema sta nell'e!,eguire la sistemazione del territorio. sin dal tempo di pace, in modo da aumentare le risorse idriche con condutture di adeguata portata. L'acqua, infalti, non manca in modo assoluto nella Venezia Giulia, ma è mal distribuita: nell 'Alta Valle del Timavo, ad esempio, e!.istono fonti so rgive, pozzi, torrenti che forniscono complessivame nte acqua s ufficiente per i bisogni di tutto l'Esercito. Occorre, quindi, distribuirla meglio. Perciò so no necessarie spese non indifferenti, alle quali l'autorità militare potrebbe concorrere.
TI Generale Graziosi, lo studio del rifornimento idrico sulla base di una distribuzione dell'acqua, in relazione ai bisogni dello schieramento, è già in corso ed è affidato al Colonnello del Genio Dall'Ora, il qua le, per aver prestato lungamente servizio nella Venezia Giulia, ed avere approfondito sul posto la questione in oggetto, è pa1ticolan11ente competente al riguardo.
Il Colonnello Vaccarisi ricorda che, durante la guerra, gli austriaci avevano già sistemata la regione, dal punto di vista idrico, con impianti notevoli; ma tutto fu distrutto ed il macchinario e le tubazioni asportati dagli abitanti, nel breve tempo intercorso tra la fuga austriaca e la nostra effettiva presa di possesso di tutta la regione.
Il Maresciallo Badoglio: la questione è della massima importanza. Non si possono impiegare molte divisioni se non si ha modo di fornir loro l'acqua necessaria. Ed allora non si può pensare ali' impiego di grandi masse, e tutto si riduce ad una campagna coloniale, ossia a nulla.
L'organizzazione idrica di questa zona è uno degli argomenti sui quali mi propongo di richiamare l'attenzione del Governo , per poter avere il concorso degli enti civili, poiché non è possibile pensare a risolverla coi soli mezzi del bilancio militare.
Il Colonnello Vaccarisi conclude: siamo ben lontani da un'adeguata preparazione: possiamo mobilitare 723.000 uomini (truppe e servizi): l'assegno per gli anni 1929-193 I è di 300 milioni, appena sufficienti a completare le 2 armate senza magazzini e senza depositi centrali.
Se la Jugoslavia lo sapesse, non accelererebbe il suo ritmo.
Il Maresciallo Badoglio: la Jugoslavia sta peggio di noi.
Domanda al Colonnello Vaccarisi: siamo in grado, oggi, di servire sul posto le truppe di copertura, durante i periodi di copertura?
Il Colonnello Vaccmisi: si, se costituiamo i depositi.
TI Mare sc iallo Badoglio: è stato fatto il conto della spesa occorrente per la costituzione di tali depositi?
li Colonnello Vaccarisi: si, ma i dati relativi dovranno essere ripresi in esame dopo la stabilizzazione della lira.
Il Maresciallo Badoglio: dovete dirmi: per mobilitare trenta divisioni, mi occorrono da oggi in poi, X milioni; per l'organizzazione dei servizi in zona di copertura, occorrono Y milioni; in totale, per iniziare le operazioni, occo1Tono milioni X+ Y.
Il Colonnello Vaccarisi: per questo occorre aspettare che i comandanti designati d'armata facciano conoscere quanti depositi occorrono e dove li vogliono.
Passa quindi a ll a lettura dello specchio «Operazioni riguardanti la mobilitazione dei servizi che si possono attuare in sede di mobilitazione occulta» (allegato n. 2)<el.

Il Maresciallo Badoglio fa arrecare alcune correzioni, che risultano dalle annotazioni poste all'allegato stesso.
Osserva, poi, che scopo dell'elenco di operazioni M.O. è quello di fornirgli dati per poter dire:
- in caso di conflitto occorrono tanti giorni per la mobilitazione, tanti giorni per la radunata, e, quindi, noi possiamo iniziare le operazioni tanti giorni dopo averne ricevuto l'ordine dal Capo del Governo, al quale, quest'ultimo dato darà norma per la condotta politica da tenere: specialmente, circa l'entità del vantaggio che si può conseguire, facendo durare un determinato numero di giorni il periodo di tensione diplomatica.
Come conclusione all'esposizione del Colonnello Vaccarisi, ritengo che provvedimenti d'ordine immediato, per far vivere e combattere le truppe in occupazione avanzata, siano: l) presentare una richiesta di fondi per impiantare i depositi in zona di frontiera; 2) risolvere la questione della precettazione dei quadrupedi; 3) preavvisare le varie autorità per anticipare le operazioni di loro spettanza.
Tutte queste previdenze, in unione a quelle che gli altri uffici dello Stato Maggiore proporranno, consentiranno di stabilire quanti giorni di M.0. occorrono per poter accelerare di un giorno o due le operazioni di mobilitazione.
La seduta è sospesa alle ore 11,30 ed è rimandata al giorno 16 corrente.
A.U.S.S.M.E Jo11do H-10 «Verbali riw1io11i /924-/943 », busra 11. 2.fascicolo n. 3.
Il docw11e1110 è 1111a copia dell'Ufficio del capo di Stmo Maggiore Ge11erale. 1-istata da Badoglio.

a) Cfr. la ri1111io11e del /3 - 1- 1928 (doc11111e1110 11. 11 ), 110/a (a).
b) Cfr. la riunione del /3 - / - /928 /c/ocumemo 11. 11 ), nota (b).
e) È la legge 11. 969 «Orga nh.za:ione della Nazio11e per la guerra». 8 giug110 1925 (G.U. 11. 144 del 23-6-1925).
dJ Nel fascicolo 11. 3 (H-10. busta 11. 2) l'allegaro i11 quesrio11e risulw ma11ca111e.
e) Nel fascicolo 11. 3 (H-10. busta 11. 2) l'al/egmo i11 q11esrio11e risulra ma11ca11te.
« Prepara zione della guerra contro la Jugoslavia (Ipotesi Est): studi e preparativi relativi alla mobilita zione (situazione ferroviaria alla frontiera orientale, criteri vigenti circa la compila z ione di progetti riguardanti i trasporti di mobilitazione e di radunara de/L'Esercito , influenza di un eventuale periodo di mobilita zione occulta sull'esecuzione dei trasporti di mobilitazione e radunata) »
Manovra su lla carta-Ipotesi Est <a>
Verbale della seduta del 16 Gennaio 1928 - VJ - nell'ufficio del Capo di Stato Maggiore Generale - (ViminaJe).
Sono presenti le stesse persone che hanno preso parte alla seduta del 14 gennaio (bJ ed inoltre:
S.E. l'Ammiraglio di Divisione Burzag li -Capo di Stato Maggiore della R. Marina
Generale Vacca Maggiolini - Generale addetto al Comando del Corpo di Stato Maggiore
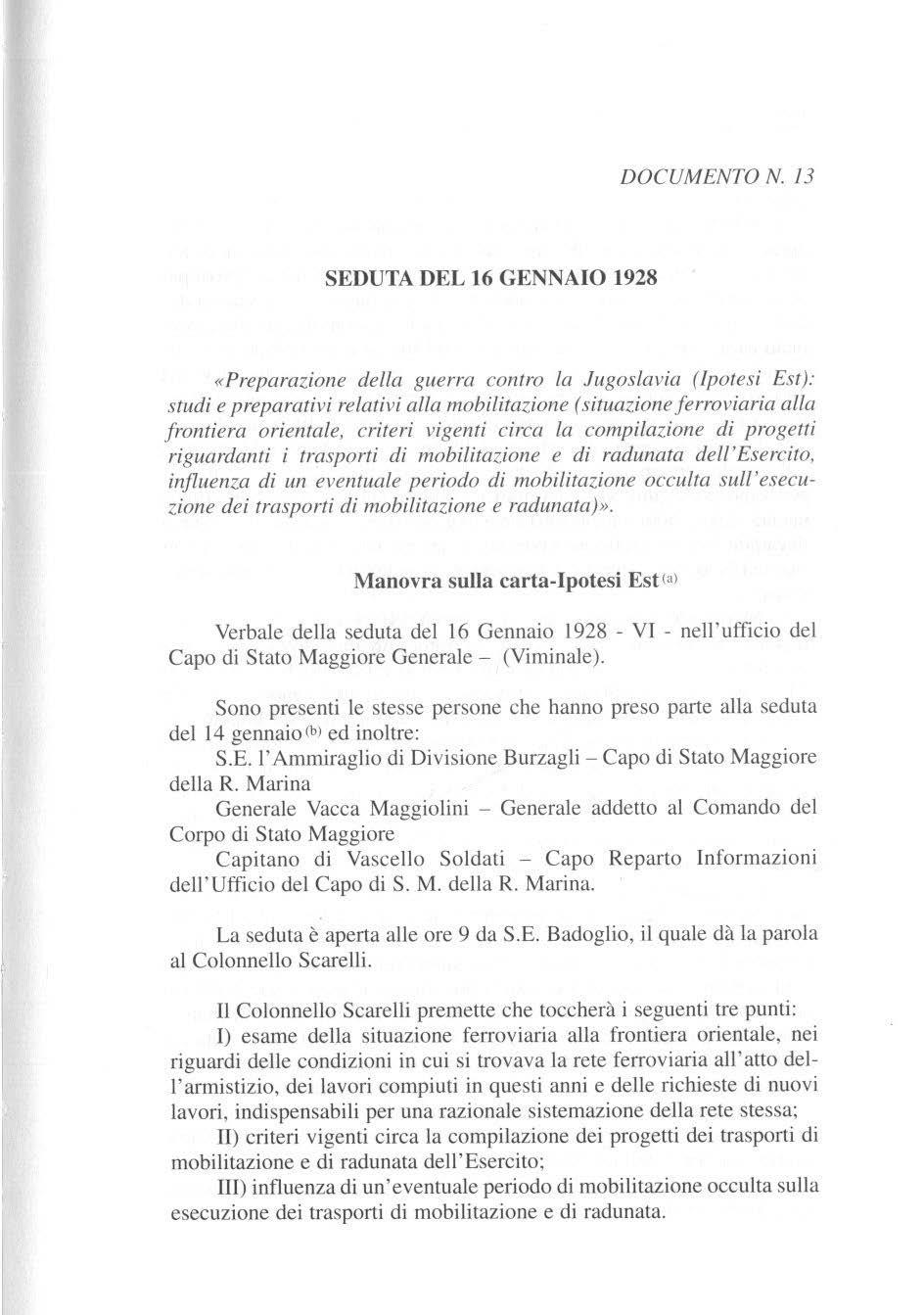
Capitano di Vascello Soldati - Capo Reparto In formazioni dell'Ufficio del Capo di S. M. della R. Marina.
La seduta è aperta alle ore 9 da S.E. Badoglio, i l quale dà la parola al Co lonnello Scarelli.
Il Colonnello Scarelli premette che toccherà i seguenti tre punti:
I ) esame della situazione ferroviaria alla frontiera orientale, nei riguardi delle condizioni in cui si trovava la rete ferroviaria all'atto del1' armistizio, dei lavori compiuti in questi anni e delle richieste di nuovi lavori, indispe nsab ili per una razionale sistemazione della rete stessa;
TI ) c rit eri vigenti circa la compi lazione dei progetti dei trasporti di mobilitazione e di radu nata dell'Esercito;
III ) influenza di un'eventuale periodo di mobilitazione occulta sulla esecuzione dei trasporti di mobilitazione e di radunata.
Alla fine della guerra l'Italia ereditò una situazione ferroviaria inorganica al massimo grado, anzi caotica in quanto che, l'impianto austriaco, nei riguardi sia delle sistemazioni preparate sin dal tempo di pace, come di quelle attuate a seconda dei bisogni manifestatisi via via durante la guerra (binari di ssem inati intorno alle stazioni in ogni direzione, piani caricatori costruiti con materiale facilmente deteriorabile, ecc.) rispondeva ad un orientamento generale ed a caratteristiche tecniche del tutto spec iali; mentre, d'altra parte, tra la rete austriaca e la rete italiana rimaneva interposta una zona neutra senza impianti militari stabili.
Di conseguenza, ad oriente della trasversale Verona-Monselice, (alla quale arrivano circa 140 treni al giorno) il numero dei treni che potevano proseguire verso la nuova frontiera andava man mano diminuendo fino a ridursi a circa 60 treni al giorno (meno della metà) oltre la linea dell'Isonzo. Di fronte a questa situazione, nel 1920, furono presi in esame i lavori occorrenti per migliorare il rendimento del sistema fe1Toviario.
Ne derivò un programma, compilato nel 1921, che prevedeva lavori per un ammontare di 45 milioni; il prograrruna fu concretato in dettaglio nel 1922: i primi stanziamenti di fondi si ebbero col bilancio 192324; i primi lavori ebbero effettivamente inizio nell'anno finanziario J924-25. Questo programma prevedeva il raddoppio della linea ferroviaria Montebelluna-Susegana, la s istemaz ione del nodo ferroviario di Gorizia e la s istemazio ne di ponti su l Tagli amento e sull'Isonzo, I ' estensione a varie linee del sistema di blocco, la costruzione di piani regolatori, ecc. Attualmente, questo programma è in via di esaurimento, e, teoricamente , i lavori dovrebbero finire col bilancio 1928 -29, mentre praticamente dureranno ancora un anno.
La s ituaz ione pertanto fra un anno e mezzo sarà quella che risulta dallo sc hizzo (allegato I) <cl; essa permetterà di fare arrivare all'Tsonzo 140 treni al giorno, ed anche più in là. Quando, poi, sarà ultimata la linea ferroviaria di Pojana, i 20 treni che si guadagneranno dovranno arrestarsi al Tagliamento, cosicché vi sa rà la possibilità di far giungere 160 treni solo fino a quel fiume, mentre rimane immutata la cifra dei 140 treni al giorno che giungono all'Isonzo. La ferrovia di Pojana , nel 1929, giungerà fino a Campo S. Piero, dove immettendosi nel tronco già esistente, Campo S. Piero - Castelfranco - Treviso, si congiungerà con la TrevisoMotta. Si avrà, con ciò, la stazione di Castelfranco comune a due itinerari. Ciò rappresenta, certo, un inconveniente, sia per il movimento ferroviario, sia per la vulnerabilità dall 'al to; ma questo inconveniente potrà essere eliminato quanto sarà costruito il tronco Campo S. Piero - Trevi so (si ricordi che, durante la guerra, a Padova confluivano ben tre itinerari)

La linea di Ostiglia - Pojana - Treviso avrà anche il tratto Treviso - Motta in comune con la Treviso - Portogruaro; in ogni caso, queste difficoltà potranno essere girate, istradando i treni su questa linea (che è a semplice binario) in un senso solo e valendosi, poi, per il viaggio di rilorno del materiale vuoto, delle linee e doppio binario, situate a nord ed a sud.
Tale risulterà la potenzialità massima del sistema ferroviario, alla frontiera orientale, nel 1929-30.
Si presenta, ora, il problema se converrà aumentare ancora la potenzialità di afflusso alla frontiera.
Dal punto di vista tecnico la risposta non può essere per ora che negativa, giacché le strozzature dei valichi appenninici non permettono neppure di alimentare 160 treni anzidetti, anche quando sia in funzione la nuova direttissima Bologna-Firenze (60 treni sulla direttis s ima, 30 fra la Porrettana e la Faentina, 20 sulla Pontremolese; ossia, in totale, I 10 treni). Però si deve tenere presente l ' influenza possibile della guerra aerea; l'inutilizzazione di un ponte potrebbe far perdere la possibilità di valerci. per un tempo più o meno lungo, di una delle arterie principali, capace ad esempio di 60 treni; evidentemente, disponendo di una maggiore potenzialità del sistema ferroviario, si potrebbe ovviare all'inconveniente della momentanea sospe nsione del movimento su di una linea. In altri termini, risulta evidente la necessi tà di avere, come ri se rva , un eccesso di disponibilità di potenzialità s u tutte le linee.
S. E. Badoglio rias s ume: sulla frontiera orientale si avranno disponibili complessivamente 6 bi nari, mentre la Francia, nel 1914 , disponeva di 10 linee a doppio binario, ossia di 20 binari .

Per quanto riguarda gli effetti di un'eventuale azione aerea, questo problema ci porterà, a suo tempo, ad affrontare il quesito della difesa antiaerea. Converrà, probabilmente, lasciar bombardare una città piuttosto che un ponte. Inoltre, occorrerà considerare sotto questo particolare punto di vista il problema della consistenza delle forze aeree all'inizio del conflitto e delle possibilità industriali di ricostituzione delle forze aeree, tenendo pre se nte che si deve tendere ad avere il mass imo rendimento dell'azione aerea nel periodo intercorrente fra la mobilitazione e la radunata , anche se a questo funzionamento intensivo debba succedere, per l'arma aerea, una fase di crisi.
S. E. Fe1Tari fa pres·ente che è già prevista la protezione dei ponti mediante speciali reti intese ad ottenere il prematuro scoppio delle bombe lanciate contro tali opere d'arte.
Il Colonnello Scarelli continua, facendo presente che l'aumento di potenzialità delle linee si può ottenere migliorando i servizi di blocco, in modo da portare a I 00 treni al giorno la capacità delle I inee a doppio binario (la potenzialità del tronco Monselice - Padova, ad esempio, è già portato a 80 treni al giorno). Fatto questo, e non sfruttando normalmen-
te la capacità massima così ottenuta, si avrebbe una disponibilità che pennetterebbe di parare agli inconvenienti della eventuale interruzione delle linee.
Un altro provvedimento potrebbe consistere nell'applicazione sulle linee a semplice binario del sistema di blocco e del traffico in tempo di guerra in un senso solo, facendo ritornare i treni vuoti sulle linee a doppio binario .
Riferendosi sempre alla minaccia dell'azione aerea, fa presente che la debolezza della nostra situazione ferroviaria alla frontiera orientale sta nella scarsità di ponti sui fiumi. Sull'Isonzo vi sono solo due ponti (Gorizia e Pieris): la progettata linea Trieste - Tarvis ci avrebbe dato a Sagrado un terzo ponte a doppio bina.rio; ma questa linea è stata rimandata ad epoca indeterminata. Sul Tagliamento vi sono pure due soli ponti, quello di Casarsa a doppio binario e quello di Latisana. La situazione qui si presenta più critica, perché il ponte di Latisana è a semplice binario e d'altra parte l'esecuzione del raddoppio del binario , nella posizione attuale, appare tecnicamente molto difficile (linea in curva, posizione del ponte rispetto all'abitato ed alla stazione, rampa di accesso al ponte così ripida che non può essere percorsa da treni molto pesanti, ecc.). È allo studio una soluzione radicale, ottenuta deviando la linea ferroviaria a nord di Latisana, e costruendo un nuovo ponte ed una nuova stazione; ma per questo occorrerebbe una somma di 30 - 35 milioni che non si sa dove trovare , sebbene l'Esercito sia pronto a concorrere con 5 milioni e mezzo.
Sul Piave vi sono tre ponti (Priula, Fagarè, a S. Donà di Piave) che sono in ordine.
I 5 milioni e mezzo per Latisana verrebbero presi dal fondo di 500 milioni, che è stato assegnato per lavori verso le frontiere settentrionale ed occidentale; siccome, però, il programma di lavori verso queste frontiere è stato calcolato con una certa larghezza, ne risulta la possibilità di farne avvantaggiare anche la frontiera orientale. Ed, infatti, su tale somma è prevista l'esecuzione dei seguenti lavori sulla frontiera est: ferrovia Prebacina - Aidussina, trasformandone l'armamento e rinforzando le opere d'arte, in modo che possa assorbire 20 treni militari a) giorno (sarà pronta entro il 1929): lavori anzidetti a Latisana , sistemazione del blocco sulla li11ea Vicenza-Susegana (6.000.000).
Si delinea, però, da parte del Ministero delle Finanze la tendenza a ridun-e il fondo di 500 milioni, in relazione alla rivalutazione della lira, in misura superiore alla rivalutazione stessa; sicché sembra che , nel 1928-29, le quote annuali dovrebbe essere ridotte sensibilmente.
S. E. Badoglio: occorre che lo stanziamento venga consolidato entro i limiti della rivalutazione della lira.
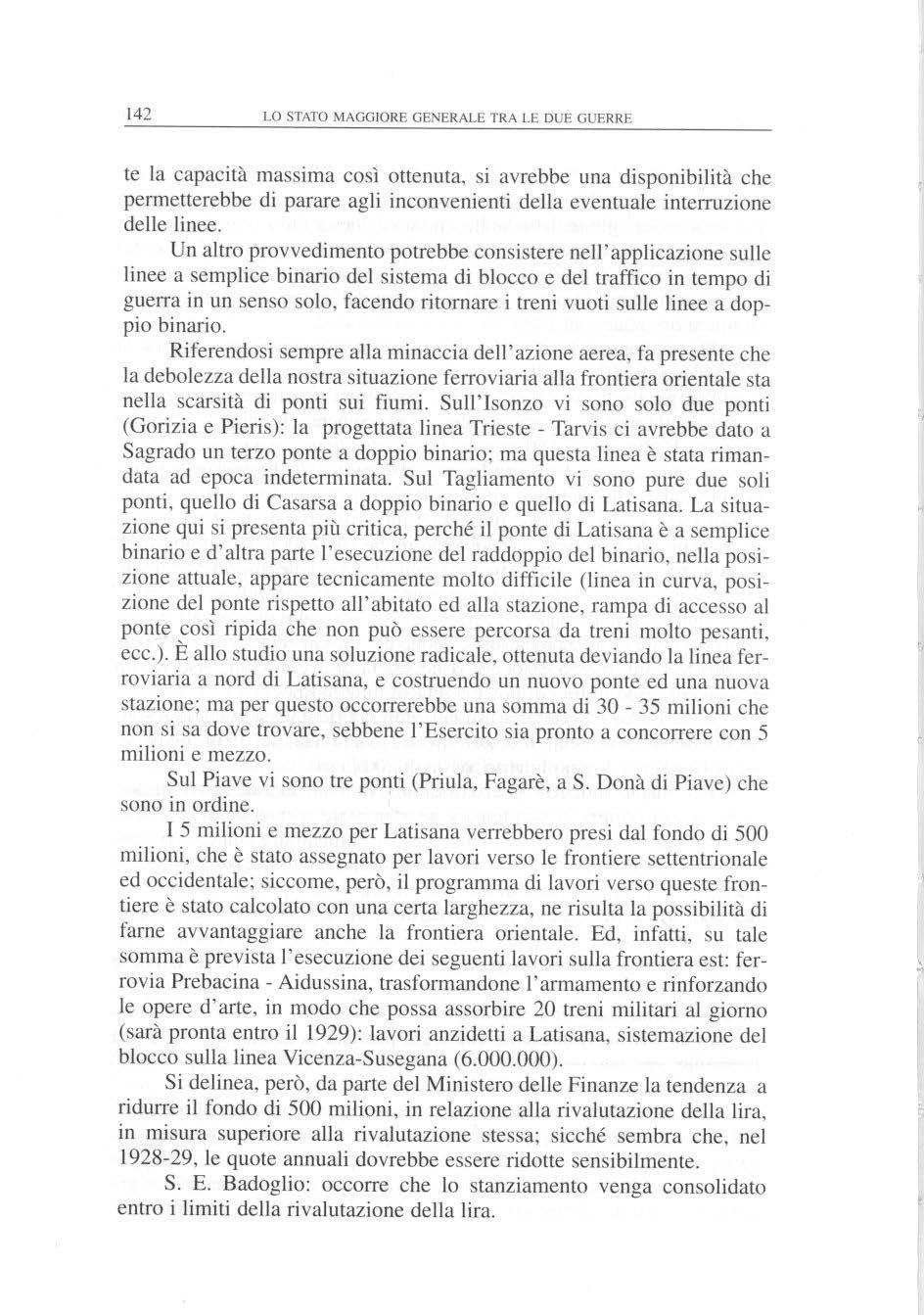
Il Colonnello Scarelli continua, facendo presenle che oltre i lavori compiuti dal Ministero delle Comunicazioni e quelli di miglioramento degli impianti fissi (i piani caricatori, ecc.) compiuti coi fondi straordinari del Ministero della Guerra, vi è terzo gruppo di lavori che deve essere fatto a cura del Ministro dei LL. PP. e comprende la costruzio ne delle nuove lin ee ferroviarie.

Per quanto riguarda queste ultime, dovrà essere completata la linea Legnago - Poj ana - Treviso: rimangono ancora da Lerrninare a questo scopo i tratti Ostiglia - L egnago e Campo S. Piero - Treviso, ma il Ministero dei LL. PP. ha dato garanzia che tali lavori saranno regolarmente proseguiti.
Merila considerazione la situazione in prossimità della frontiera, dove, nella zona fra Tarvis e Gorizia, non vi sono linee ferroviarie, con la consegue nza di una forte distanza fra le teste di sbarco e di un aggravio di traffico nel nodo di Gorizia, dove affluiscono 60 treni al giorno, ciò che costituisce un inconveniente, non tanto dal punto di vista tecnico quanto da quello della minaccia di offese aeree. Di sgraziatamente, come è già stato accennato, la costruzione della Tri este - Tarvis è stata rimandata ad epoca indeterminata: essa avrebbe dato anche il vantaggio d i poter giungere ad Idria, indipendentemente da Gorizia, attraverso i tronchi Creda - S. L ucia e S. Lucia - Idri a, c he erano richiesti anche dagli enti locali.
S. E. Badoglio osserva che, negli attuali studi di mobilitazione, non si deve tenere nessun conto della possibilità di costruz ione della Trieste - Tarvis e sue diramazioni.
TI Colonnello Scarelli mette in rili evo viceve r sa la necessità di richiedere altri due tronchi, che sarà possibile avere. U no di questi tronchi è quello di Aidussina - P ostumia, o meglio Aidussina - Pre stane: attualmente, dopo sistemata la P rebaci na - Aidussina, parte delle truppe dovrebbero affrontare la sa li ta degli altipiani di Ternova e compiere alcune faticose tappe per via ordinaria, per assumere lo schieramento sulla frontiera; il tronco in questione, in vece, darebbe la possibilità di scaricare truppe e materiali più avanti ed a quota più elevata. Il tronco è richiesto anche da interessi locali, che co nverrebb e pertanto appoggiare.
L'altro tronco, v ivamente desiderato pure dalle popolazioni locali, è quello di Erpelie-Sapiane. Per arrivare a Fiume , attualmente, bisogna passare da S. Pietro del Carso, nodo ferroviario in cui i lavori di ampliamento, per le condizioni locali e la natura del suolo, verrebbero a costare molto ( 1O milioni) e che sarebbe soggetto ad offese nemiche, anche di artiglierie, per la sua vicinanza alla frontiera. Essendo, ormai, tramontato il progetto della ferrovia diretta Trieste-Fiume, anche queste due città vedrebbero volentieri la costruzione di questo tronco Erpelie-Sepiane (33 km. circa), il cui costo ammonterà a circa 80-70 milioni; l'Esercito
potrebbe contribuire par7ialmente a questa spesa con g li ultimi avanzi del fo ndo di 500 milioni, dinanzi accennato.
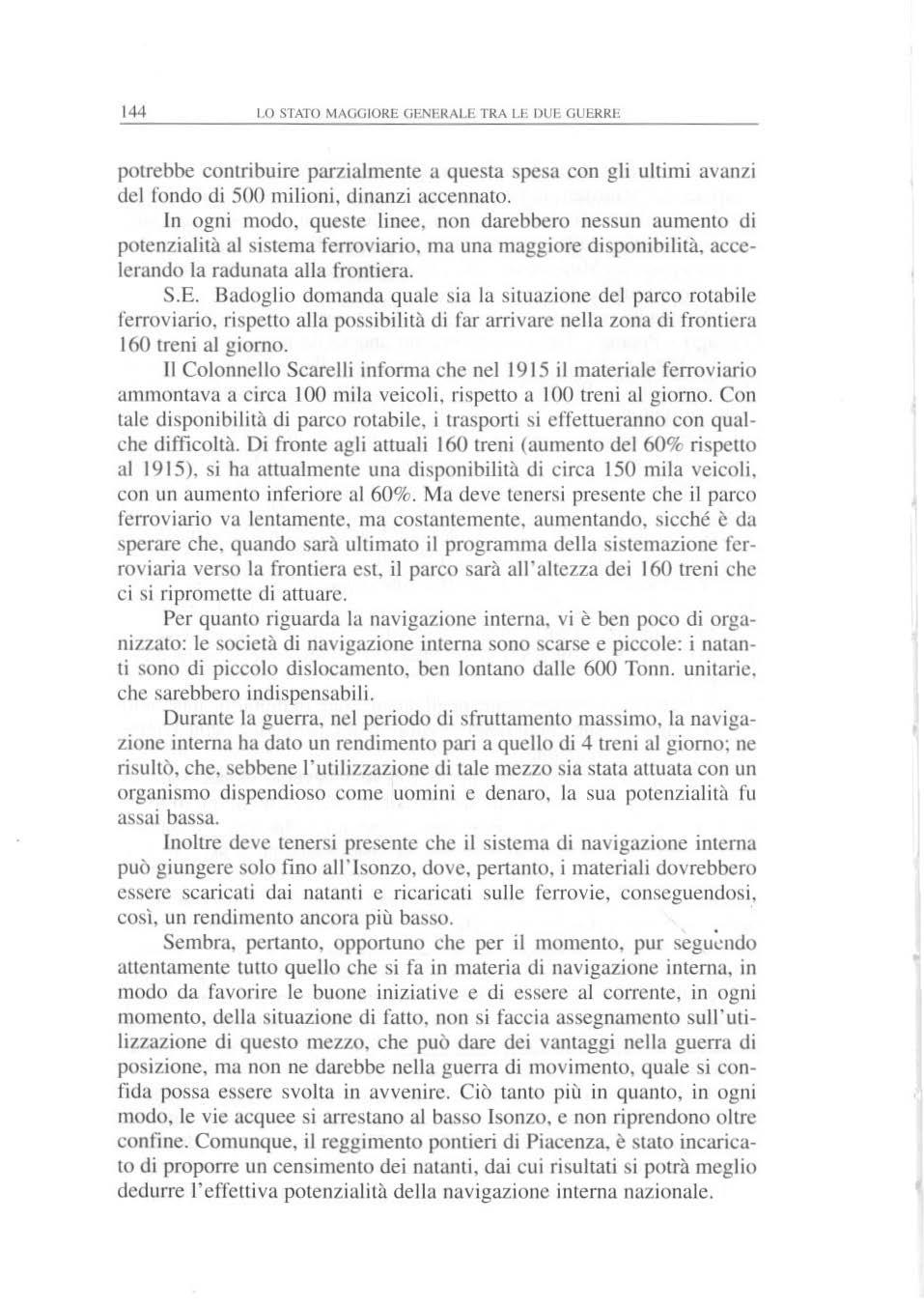
In ogni modo, queste linee, non darebbero nessun aumento di potenzialità al sistema ferroviario. ma una maggiore di sponibilità, accelerando la radunata alla frontiera.
S.E. Badoglio domanda quale sia la situaz ione del parco rotabile ferroviario. rispetto alla possibilità di far arrivare nella zona di frontiera 160 treni al giorno.
TI Colonnello Scarelli informa che nel 1915 il materiale ferroviario ammontava a circa 100 mila veicoli, rispetto a 100 treni al g iorno. Con tale disponibilità di parco rotabile. i trasporti si effettueranno con qualche difficoltà. Di fronte agli attuali J60 treni (aumento del 60% rispetto al 1915). si ha attualmente una disponibilità di circa 150 mila veicoli. co n un aumento inferiore al 60%. Ma deve tenersi presente che il parco ferroviario va lentamente, ma costantemente. aumentando, sicché è da sperare che. quando sarà ultimato il programma della sistemazione ferroviaria verso la frontiera est, il parco sarà ali" altezza dei 160 treni che ci si ripromette di attuare.
Per quanto riguarda la navigazione interna, vi è ben poco di organiznto: le società di navigazione interna sono scarse e piccole: i natanti sono di piccolo dislocamento, ben lontano dalle 600 Tonn. unitarie, che sarebbero indispensabili.
Durante la guerra, nel periodo di sfruttamento massimo, la navigazione interna ha dato un rendimento pari a quello di 4 treni al giorno; ne risultò, che. sebbene l'utilinazione di tale meno sia stata attuata con un organ ismo dispendioso come uomini e denaro, la s ua potenzialità fu assai bassa.
Inoltre deve tenersi presente che il sistema di navigazione interna può giungere solo fino ali' Isonzo, dove, pertanto, i materiai i dovrebbero essere scaricati dai natanti e ricaricati s ull e ferrovie, co nseg uend osi, così, un rendimento ancora più basso.
Sembra, pertanto. opportuno che pe r il momento, pur segu~ndo attentame nte tutto quello che si fa in materia di navigazione interna, in modo da favorire le buone ini ziative e di essere al corrente, in ogni momento. della situazione di fatto, non si faccia asseg namento sull'utili nazione di questo meao, che può dare dei van taggi nella guerra di posizione, ma non ne darebbe nella guerra di movimento, quale si confida po ssa essere svo lta in avvenire. Ciò tanto più in quanto, in ogni modo, le vie acquee si arrestano al basso Isonzo. e non riprendono oltre confine. Comunque, il reggimento pontieri di Piace nza, è sta to incaricato di proporre un ce nsimento dei natanti, dai cui risultati si potrà meglio dedurre l'effettiva poten zia lità della navigazion e interna nazionale.
IlPrima della guerra la preparazione dei trasporti di mobilitazione e radunata era ispirata ai seguenti criteri;
a) accentramento presso l'Ufficio Trasporti del Comando del Corpo di Stato Maggiore dei documenti relativi tanto ai trasporti di mobilitazione che a quelli di radunata;
b) compilazione completa presso l'Ufficio stesso dei documenti ferroviari per tutto J'Esercito.
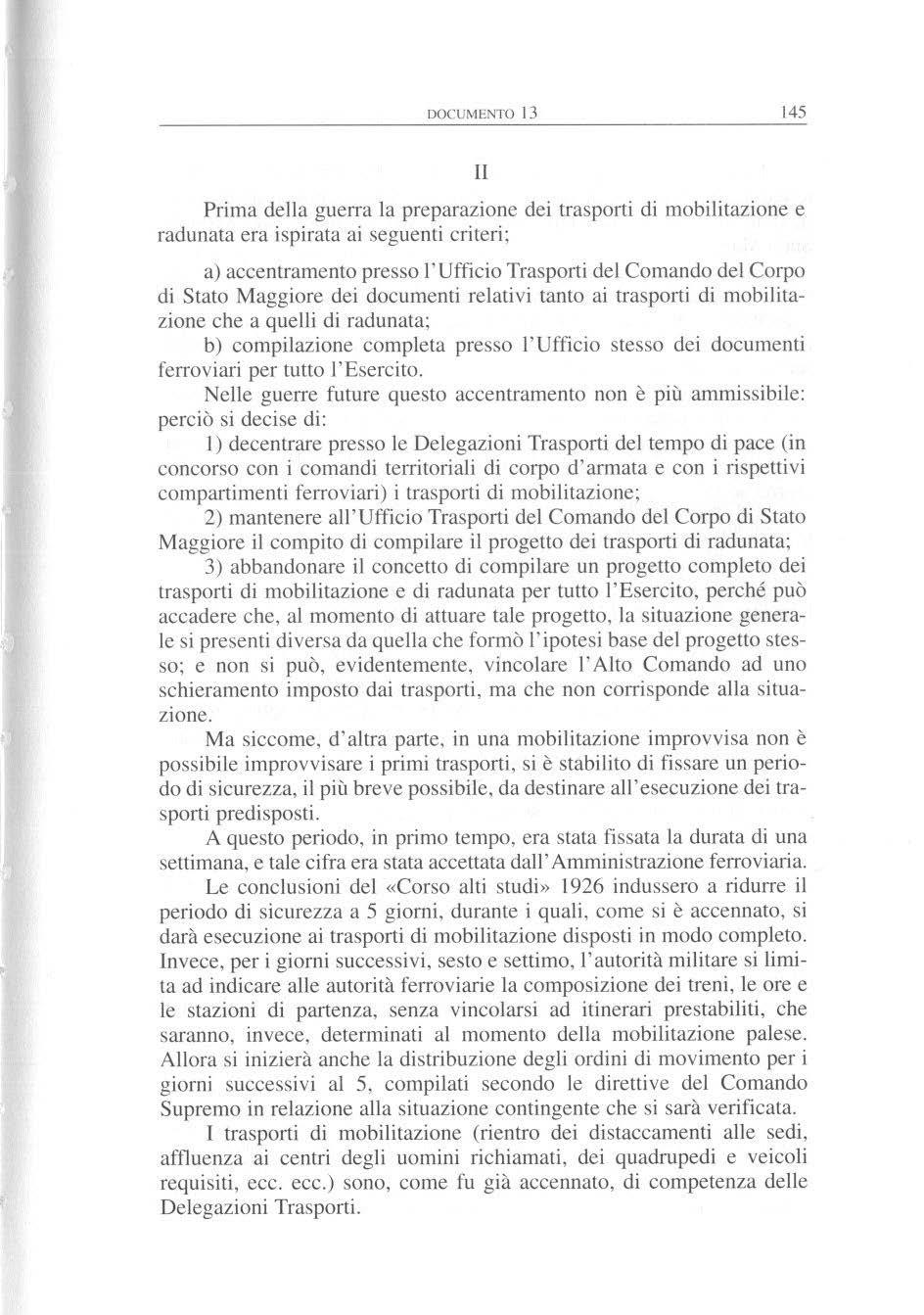
Nelle guerre future questo accentramento non è più ammissibile: perciò si decise di:
I) decentrare presso le Delegazioni Trasporti del tempo di pace (in concorso con i comandi teITitoriali di corpo d'armata e con i rispettivi compartimenti ferroviari) i trasporti di mobilitazione;
2) mantenere all'Ufficio Trasporti del Comando del Corpo di Stato Maggiore il compito di compilare il progetto dei trasporti di radunata;
3) abbandonare il concetto di compilare un progetto completo dei trasporti di mobilitazione e di radunata per tutto l'Esercito, perché può accadere che, al momento di attuare tale progetto, la situazione generale si presenti diversa da quella che formò l'ipotesi base del progetto stesso; e non si può, evidentemente, vincolare l'Alto Comando ad uno schieramento imposto dai trasporti, ma che non corrisponde alla situazio ne.
Ma siccome, d'altra parte, in una mobilitazion e improvvi sa non è possibile improvvisare i primi trasporti, si è stab ilito di fissare un periodo di sicurezza, il più breve possibile, da destinare all'esecuzione dei trasporti predisposti.
A questo periodo, in primo tempo, era stata fissata la durata di una settimana, e tale cifra era stata accettata dall'Amministrazione ferroviaria.
Le conclusioni del «Corso alti st udi » 1926 indussero a ridurre il periodo di s icurezza a 5 giorni, durante i quali, come si è accennato, si darà esecuzione ai trasporti di mobilitazione disposti in modo completo. Invece , per i giorni successivi, sesto e settimo, l'autorità militare si limita ad indicare alle autorità ferroviarie la composizione dei treni, le ore e le stazioni di partenza, se nza vincolarsi ad itinerari prestabiliti, che saranno, invece, determinati al momento della mobilitazione palese.
Allora si inizierà anche la distribuzione degli ordini di movimento per i giorni successivi al 5, compilati secondo le direttive del Comando Supremo in relazione alla situazione contingente che si sarà verificata.
I trasporti di mobilitazione (rientro dei distaccamenti alle sedi, affluenza ai centri degli uomini richiamati, dei quadrupedi e veicoli requisiti, ecc. ecc.) so no, come fu già accennato, di competenza delle Delegazioni Traspo rti.
I trasporti a lungo percorso, e quegli altri che, pur rivestendo carattere di trasporti di mobilitazione, interessano tuttavia più compartimenti, sono di spettanza dell'Ufficio Trasporti del Comando del Corpo di Stato Maggiore.
Ciascun gruppo di trasporti (uomini, quadrupedi, materiali, ecc.) è tenuto distinto dagli altri: ciò per conferire al sistema maggiore elasticità e garantire la segretezza dei movimenti, durante il periodo di mobilitazione occulta, nel senso che può essere attuato un gruppo di trasporti senza che siano eseguiti gli altri.
Le predisposizioni relative al periodo di sicurezza sono graficamente rappresentate nell'annesso documento alla lettera A), (alleg. 2)((1>, nel quale, però, non so no compresi i trasporti di artiglieria di campagna sul piede di gue1Ta, essendo tali unità pronte a partire dalle ore zero del giorno sesto1.

S.E. Badoglio osserva che la guerra ha allargato le idee in fatto di trasporti. TI sistema, in vigore fino al 1914, dell'orario militare era troppo rigido, e mal si adattava ali' indole del popolo italiano.
La maggior parte dei funzionari delle ferrovie trascuravano regolarmente di aITecare all'orario stesso le varianti numerose che venivano loro volta a volta comunicate.
Si è pensato perciò di adottare un siste ma più elastico, che si adattasse a qualunque s ituazione. Necessità, questa, impelle nte per noi, giacché il nostro problema politico non è così determinato da imporre in ogni caso una soluzione univoca; occo1Te perciò potere variare i provvedimenti che prenderemo, a seconda del caso contingente.
Intanto abbiamo visto che il sistema del periodo di s icurezza adottato ci dà modo di accelerare la mobilitazione palese, quando in precedenza disponiamo di un periodo di mobilitazione occulta.
Il Colonnello Negri ha detto, nella sed uta precedente, che se potessimo contare s u 13 giorni di tensione diplomatica, potremmo, in questo periodo, ultimare tutte le operazioni di mobilitazione. S.E. non sa se queste operazioni possono essere raggruppate in elementi unitari , costituenti una se rie la cui successione po ssa essere senza inconveni ent i variata, od interrotta e quindi ripresa. In ogni modo S.E. (insistendo su un concetto g ià ripetutamente espresso) conferma che ciò che a noi interessa è
1 Per quanto riguarda la riduzione del servizio per i l pubblico, essa non può essere amic ipala, perché occorre provvedere al trasporlo dei richiamati, il quale viene appunto compiuto coi treni adibiti al servizio pubb lico. A par1irc dal giorno 5 de l periodo di sicurezza, il servizio pubblico viene soppresso per quanto riguarda i treni accelerati ed omnibus, rimanendo attuato so lo quel lo a mezzo dei tren i direttissimi e di qualche treno delle altre categorie. Ai treni merci vengono poi aggiunte , nei limiti della disponibilità, vetlure per l'u lt eriore lrasporto dei richiamali.
il risultato finale, ossia il guadagno di tempo (nelle varie ipotesi di durata di mobilitazione occu lta), nella durata della mobilitazione completa. Il Colonnello Scarelli: un altro problema relativo alla radunata è quello dell'orario. Prima della guerra vi era un orruio militare che, come ha accennato S.E. Badoglio, non era mai al corrente. Dopo la guerra si è eseguito uno studio per la sua abolizione, sostituendolo con un «orario di servizio», il quale comprende, per ogni linea, tutti i treni facoltativi effettuabili in relazione alla potenzialità della linea stessa. In questo modo ogni linea ha il suo fascicolo orruio, in cui i treni facoltativi sono quelli che saranno utilizzati per l'esecuzione dei grandi trasporti militari. Gli orari di servizio sono ormai applicati in tutti i comp,utimenti ferroviari: entro l 'anno in corso saranno probabilmente estesi alle ferrovie nord Milano e Veneta. Si è evitato, così, il gravissimo inconveniente che, nel momento in cui i trasporti si sarebbero intensificati, entrasse in vigore un nuovo orario che nessuno (né personale di stazione, né personale viaggiante) conosceva.
Inoltre, l 'attuale orario può servire di base a tutti i lavori dell'Ufficio Trasporti , anche per l'avvenire , giacché è stata ammessa la possibilità, nelle varianti periodiche da apportare al servizio dei viaggiatori e merci, che la marcia di ogni treno facoltativo sia variata entro il limite massimo di circa mezz'ora (an ticipandone o ritardandone l'esecuzione di circa un quarto d'ora), cosicché si può dire che l'orario di servizio risponde a tutte le necessità militari.
Per quanto riguarda l'influenza di un periodo di mobilitazione occulta sui trasporti di radunata, sono stati compilati i tre grafici B), C) e D) dell'allegato 2.
Non è stato esaminato il caso corrispondente a quanto è avvenuto in realtà nel 1914- 15, poiché evidentemente un simile caso concede ogni possibilità.
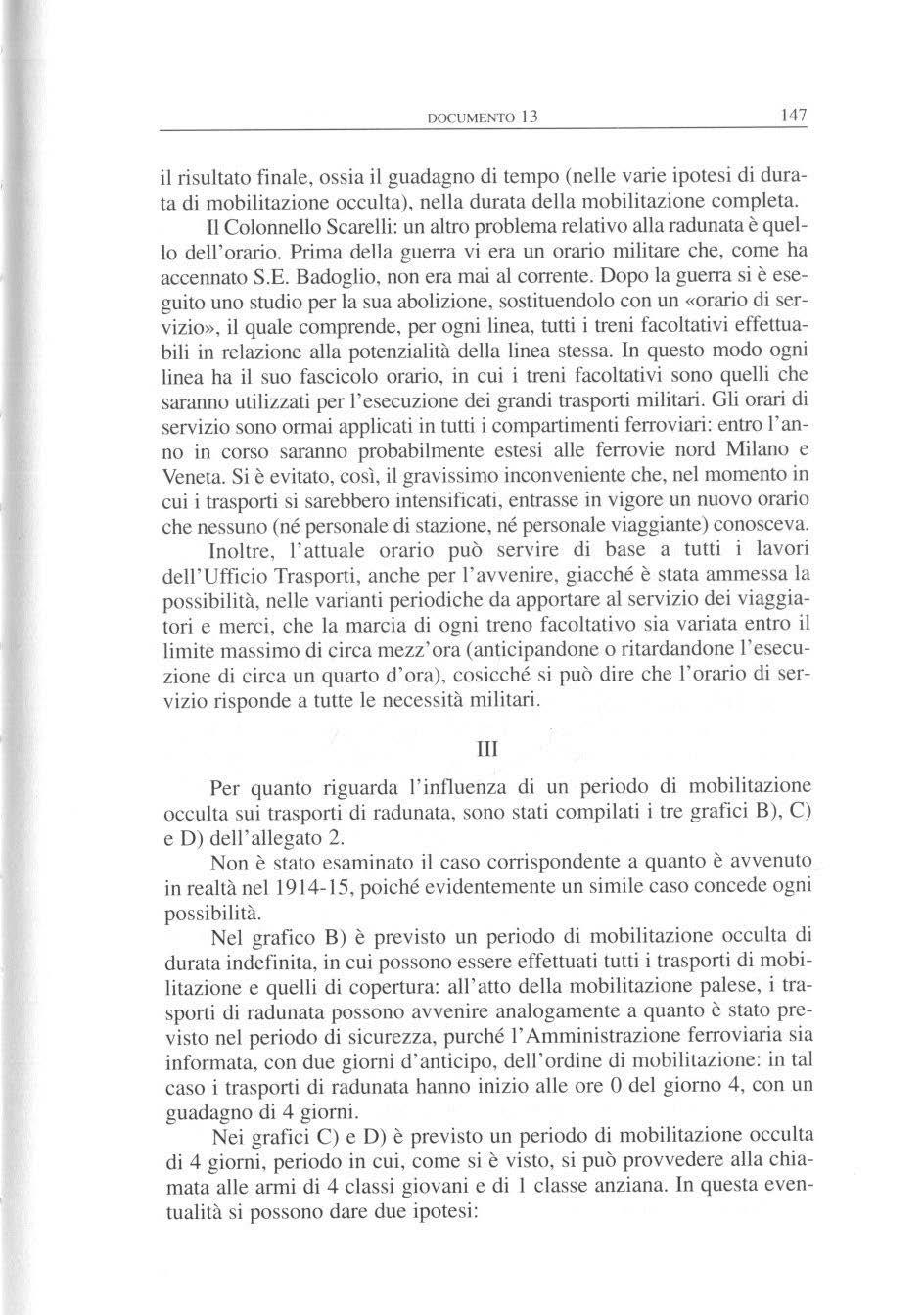
Nel grafico B) è previsto un periodo di mobilitazione occulta di durata indefinita, in cui possono essere effettuati tutti i trasporti di mobili tazione e quelli di copertura: all'atto della mobilitazione palese, i trasporti di radunata possono avvenire analogamente a quanto è stato previsto nel periodo di sicurezza, purché l'Amministrazione ferroviaria sia informata, con due giorni d'anticipo, dell'ordine di mobilitazione: in tal caso i trasporti di radunata hanno inizio alle ore O del giorno 4, con un guadagno di 4 giorni.
Nei grafici C) e O) è previsto un periodo di mobilitazione occulta di 4 giorni, periodo in cui, come si è visto, si può provvedere alla chiamata alle armi di 4 clas si giovani e di l classe anziana. In questa eventualità si possono dare due ipotesi:
A) - (grafico C) nei giorni 3 e 4 di mobilitazione occu lta sarà possibile eseguire tutte le operazioni corrispondenti ai giorni 1 e 2 del periodo di sic urezza: in aJtri termini, nel giorno 2 di mobilitazione occulta dobbiamo essere in grado di informare l' Amministra1ione ferroviaria che, alla sera del giorno 4, sarà proclamata la mobilitazione palese. Jn queste condizioni il giorno 3 del periodo di sicu rezza corrisponderà al g iorn o Odi effettiva mobilitazione palese, e pertanto il guadagno sarà di 3 giorni, ossia dei giorni O, I e 2 del periodo di sicurezza.
S.E. Badoglio osserva che, da quanto sopra, risulta confermato, nei riguardi dei trasporti, quello c he il Colonnello Negri aveva prospettato parlando della mobilitazione. E ciò, qualora al termine del seco ndo giorno di mobilitazione occulta sia possibile prevedere con certeaa che alla fine del quarto giorno di m obilitazione occulta sarà proclamata la mobilitazione palese (ossia sarà dichiarata la guerra) e, per conseguenza, entro il secondo giorno di mobilitazione occulta rautorità competente sarà in grado di dare al l'Ammini stra1ione ferroviaria il corrispondente preavviso, sarà possibile avere un guadagno di tre giorn i nella mobilitazione palese e conseguente radunata. Da quanto sopra si può dedurre che un periodo di mobilitazione occulta della durata sicura di quattro giorni, dopo i quali venga certamente dichiarata la guerra, è quello che ci dà il maggiore vantaggio assoluto e relativo: infatti. data la situaLione dello Stato S. H .S. nei riguardi dei movimenti di radunata, per la quale noi abbiamo lutto l 'interesse a guadagnare tempo rispetto al nemico, ogni prolungamento del periodo di mobilita1ione occulta oltre i quattro giorni si traduce in un vantaggio per il nemico senza un corrispondente maggiore vantaggio da parie nostra.
Il Colonnello Negri osserva che quando la forrn bilanciata sarà di 270.000 uomini, alcuni dati del programma potranno s ubire variazioni.
S.E. Badoglio: poniamo la questione nei suoi termini giusti. Voglio questi dati:
I) con riferimento alla forza bilanciata attuale, quanti g iorni di M.O. occorrono perché l'organismo ferroviario si metta in grado di rispondere alle esigenze dei trasporti di radunata?
2) quali provvedimenti di Governo sono necessari per passare dalla situazione attuale a quella rispondente ad una forza bilanciata di 270.000 uomini ?
li Colonnello Scarelli, riferend osi al caso del grafico C), mette in rilievo c he. nel secondo giorno di mobilitazione occulta, oltre a dare il preavviso ali' Amministrazione ferroviaria, occorre che r Ufficio Mobilitazione dia lo stesso preavviso alle autorità territoriali, prestabilendo esattamente le di s posizioni equivalenti, giacché tale preavviso corrisponde ad un ordine anticipato di mobilitazione palese.

li Colonnello Negri dà assicurazione che tutto è previsto in questo ordine di idee.
S.E. Badoglio mette in rilievo, ancora una vola, che indire la mobilitazione equivale al dichiarare la guerra e che lo studio in corso ha rivelato l'opportunità di non prolungare il periodo di mobilitazione occulta oltre un certo limite, per non dar tempo al nemico di compiere preparativi. Quando questo limite sarà esattamente definito, la persona che al momento del conflitto coprirà la carica di Capo di Stato Maggiore Generale si varrà di questo dato per ottenere dall'autorità politica che l'azione diplomatica venga convenientemente adeguata alle necessità militrui.
Naturalmente, in questo ordine di idee, data la complessività delle operazioni inerenti alla mobilitazione del R. Esercito, risulta evidente che le corrispondenti operazioni della R. Marina e della R. Aeronautica rimarranno ampiamente comprese nei limiti di tempo sopra calcolati.
Il Colonnello Scarelli: per l 'attuazione del caso corrispondente al grafico C) occorre tener conto di un ultimo elemento, e cioè della chiamata alle armi delle altre classi, oltre le 5 già richiamate durante il periodo di mobilitazione occulta. Si tratta di una massa di uomini, la quale può essere valutata a circa 300 mila persone, per il trasporto della quale il servizio ferroviario pubblico dei giorni 3 - 4 e 5 della mobilitazione palese, risulterebbe deficiente. A tale manchevolezza si può riparare ritardando la chiamata delle classi anziane, cosicché i movimenti per l 'afflusso dei richiamati continuerebbe r o nei giorni 6 e 7.

Se poi l'ordine di mobilitazione palese fosse emanato in modo improvvi so nei giorni 2 e 3 di mobilitazione occulta, non si verificherebbe nessun perturbamento nel passaggio dalla mobilitazione occulta a quella palese.
II grafico D) corrisponde al caso in cui, nel periodo di mobilitazione occulta, si eseguano soltanto i trasporti dei giorni l e 2 del periodo di s icurezza, ma non vi s iano elementi per poter dare il preavviso ali' Amministrazione fe r roviaria se non allo scadere del 4 giorno di mobilitazione occulta. In questo caso, evidentemente, tutto il guadagno si riduce alla soppressione del giorno O del periodo di sicurezza, ossia al risparmio di un giorno.
Data la situazione prospettata, non si vede come sia possibile ottenere un guadagno di due giorni: i soli casi possibili, nell'eventualità di periodo di mobilitazione occulta di quattro giorni, sembrano quelli che danno rispettivamente I o 3 giorni di guadagno.
Nel periodo di mobilitazione occulta possono essere presi anche altri provvedimenti di carattere tecnico; ad esempio: per la costituzione degli organi (delegazioni trasporti di nuova costituzione, comandi militari di stazione, ecc.) occorrenti per il funzionamento del servizio di
guerra ferroviario; per l'invio, in zona di radunata , della delegazione trasporti mobili, organo di nuova costituzione, destinato a tener conto degli effetti della guerra aerea, di linee ferroviarie o di ponti ecc., smaltendo, su altre linee, i treni imbottigliati sulla linea inutilizzata od arretrandone gli scarichi . Questo organismo dovrà funzionare in perfetto accordo con l'organo dei trasporti per via ordinaria, in modo che anche quest'ultimo possa intervenire per eliminare le conseguenze di un'interruzione ferroviaria.
Il Colonnello Vaccarisi fa presente che, in questo ordine di idee, bisogna prevedere la costituzione di una massa di manovra di autocarri, per la quale si dovrebbe provvedere gli autoveicoli stessi e si dovrebbero studiare le misure relative alle località di concentramento ed alla rapida dislocazione nei punti dove risulteranno necessari.
Il Colonnello Scarelli: un altro provvedimento di competenza dell'Ufficio Servizi dovrebbe essere quello di organizzare lo scarico dei treni, derrate , munizioni e materiali vari alle stazioni di testa , fin dai primi giorni della mobilitazione, per evitare che le stazioni stesse risultino congestionate e che, conseguentemente, le truppe in arrivo trovino piani caricatori ed impianti delle stazioni ingombri.
S.E. Badoglio domanda se esista un progetto dettagliato per la organizzazione del personale occorrente per tale servizio.
Il Colonnello Vaccarisi risponde che, per ora, non è stato provveduto alla preparazione del personale; si sono, viceversa, studiate le esigenze relative ad un rapido immagazzinamento dei materiali in arrivo, in modo da evitare che detti materiali rimangano ad ingombrare le stazioni per deficienza di locali.
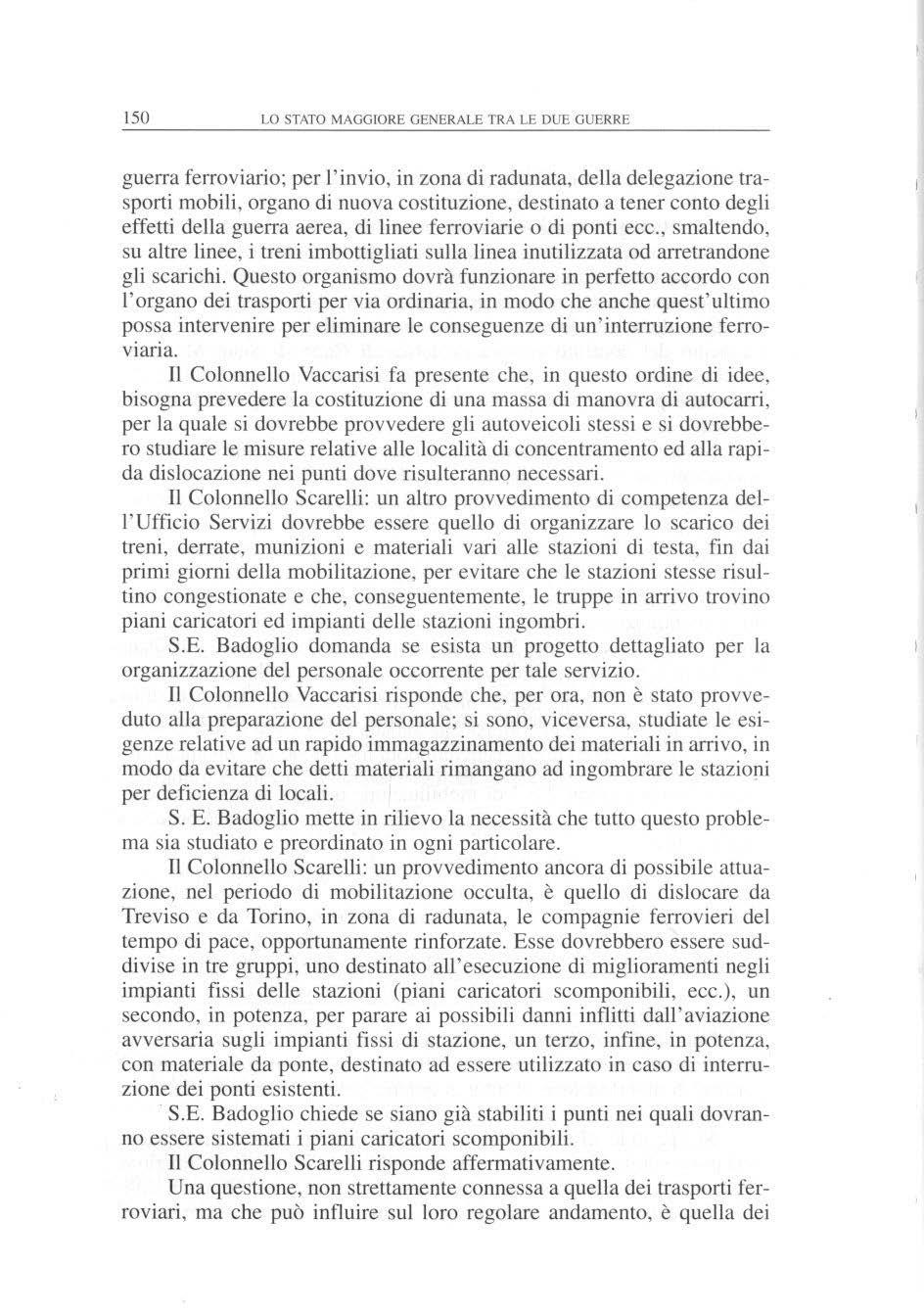
S. E. Badoglio mette in rilievo la necessità che tutto questo problema sia studiato e preordinato in ogni particolare.
TI Colonnello Scarelli: un provvedimento ancora di possibile attuazione, nel periodo di mobilitazione occ ulta, è quello di dislocare da Treviso e da Torino, in zo na di radunata, le compag ni e ferrovieri del tempo di pace, opportunamente rinforzate. Esse dovrebbero essere suddivise in tre gruppi, uno destinato all'esecuzione di miglioramenti negli impianti fissi delle stazioni (piani caricatori scomponibili, ecc .), un secondo, in potenza , per parare ai possibili danni inflitti dall'aviazione avversaria sugli impianti fissi di stazio ne, un terzo, infine, in potenza, con materiale da ponte, destinato ad essere utilizzato in caso di interruzio ne dei ponti esiste nti.
· S.E. Badogli o chiede se siano già stabiliti i punti nei quali dovranno essere sistemati i piani caricatori scomponibili.
TI Colonnello Scarelli risponde affermativamente.
Una questione, non strettame nte connessa a quella dei trasporti ferroviari , ma che può influire sul loro regolare andamento, è quella dei
depositi centrali. Qualche anno fa si manifestò la tendenza alla soppressione dei depositi centrali, tendenza alla quale l'Ufficio Trasporti reagì energicamente. Infatti il disordinato trasporto di materiale dai porti, o da altre zone del Paese, direttamente ai magazzini di armata, implica il pericolo di una grande confusione ferroviaria nella zona delle operazioni, con conseguenti complicazioni nello sfruttamento strategico-operativo delle lin~e. 1 depositi centrali costituiscono delle camere compensatrici, nelle queli si arresta il rifornimento saltuario e disordinato ed ha inizio il trasporto regolare e metodico verso gli organi operativi. Occorre, quindi, provvedere in tempo alla creazione dei depositi centrali, affinché al più presto questo sia un fatto compiuto.
li Colonnello Vaccari s i, richiesto da S.E. Badoglio se, alla fine della guerra, esistessero tali depositi centrali, risponde affermativamente, facendo però presente che la loro dislocazione di allora non sarebbe più rispondente alle necessità del futuro. Afferma, però, che tutto è predisposto per la costituzione di nuovi depositi centrali e pertanto le preoccupazioni dell'Ufficio Trasporti sembrano ingiustificate.

S. E. Badoglio richiede schiarimenti su tali predisposizioni.
li Colonnello Vaccarisi infonna che sono già state fissate le località in cui dovranno sorgere i depositi centrali (Padova, Treviso e Mestre; quest'ultima località è stata scelta in modo che, in caso di necessità, sia anche possibile utilizzare la via di mare per eseguire i trasporti verso Trieste).
Si faranno, prossimamente, ricognizioni di dettailio nelle città anzidette, per determinare i loca l i utilizzabili all'uopo. E stato stabilito che i depositi centrali del munizionamento saranno quelli che attualmente sono i depo siti di riserva dell'artiglieria, ecc .
In ogni modo fa presente che il problema dei depositi centrali può venire risolto in un secondo tempo, mentre il problema importante ed urgente è quello della costituzione dei magazzini avanzati.
Il Colonnello Scarelli osserva che l ' urgenza del problema dei depositi centrali sta nella necessità di predisporre convenientemente gli impianti fi ss i delle stazioni, alle quali dovrà far capo il traffico dei depositi centrali.
Circa i trasporti marittimi, per le sped izioni O.M. e V.A., nel periodo di mobilitazione occulta, sarà possibile provvedere aJ fermo dei piroscafi e alla loro attrezzature, in base agli studi che sono in corso con la R. Marina.
S.E. Badoglio fa presente che rimane ancora in sospeso il problema della protezione ferroviaria.
Il Colonnello Berti riferisce che i corpi d'armata sono stati incari cati di eseguire gli studi per calcolare le forze occorrenti; in base a tali studi, che si prevede saranno completati tra un paio di mesi, sarà possibi le
determinare le unità da adibire al servizio di protezione ferroviaria. Si tratterà, di mas sima, di battaglioni ausiliari costituiti con le tre classi più anziane.
Questo problema s i ricollega con quello della difesa costiera e con quello della protezione di centrali elettriche, dighe, bacini montani, depositi di carburanti, ecc.
La se duta è sos pesa alle ore 11.20 ed è ii mandata al giorno 17 corrente
A.U.S.S.M. E.,fondo H- 10 «Verbcdi ri1111io11i 1924 - /943». busw 11. 2.fmcico lo 11. 3. Il documento è probabilme111e w,a copia de/l'Ufficio del capo di Sia/o Mag!!iore Ge11erale.
a) Cfr. riunione del 13. /. /928 (documento 11 Il), nota (a).
b) Cfr. riunione del 13. I. /928 (documento 11 I I). 11010 (b).
e) Nel fascicolo n. 3 ( H -/0, busta 11. 2) /'allega10 in questione risulta 111a11ca111e.
dJ Ne/fascicolo 11. 3 ( H - 10. busta 11. 2) /'allega10 in questione risu/Ja mancante.

«Preparazione della guerra contro la Jugoslavia (Ipotesi Est): studi e piani relativi all'impiego dell'aviazione militare (preparazione raggiunta dall'Aeronautica, memoria sull'impiego dell'aviazione nell'Ipotesi Est, l'a viazione in Francia, Jugoslavia e Germania, programma di potenziamento dell'aviazione militare italiana fino al 1932, memoria sulla preparazione alla guerra dell'Aeronautica, suo impiego nei primi giorni di guerra, produzione di apparecchi in Jugoslavia, mobilitazione e servizio ch imico) ».
Manovra sulla carta Ipot esi Est(al
Verbale della seduta del 21 gennaio 1928 - VI - (nell'ufficio del Capo di Stato Maggiore Generale - Yiminale)
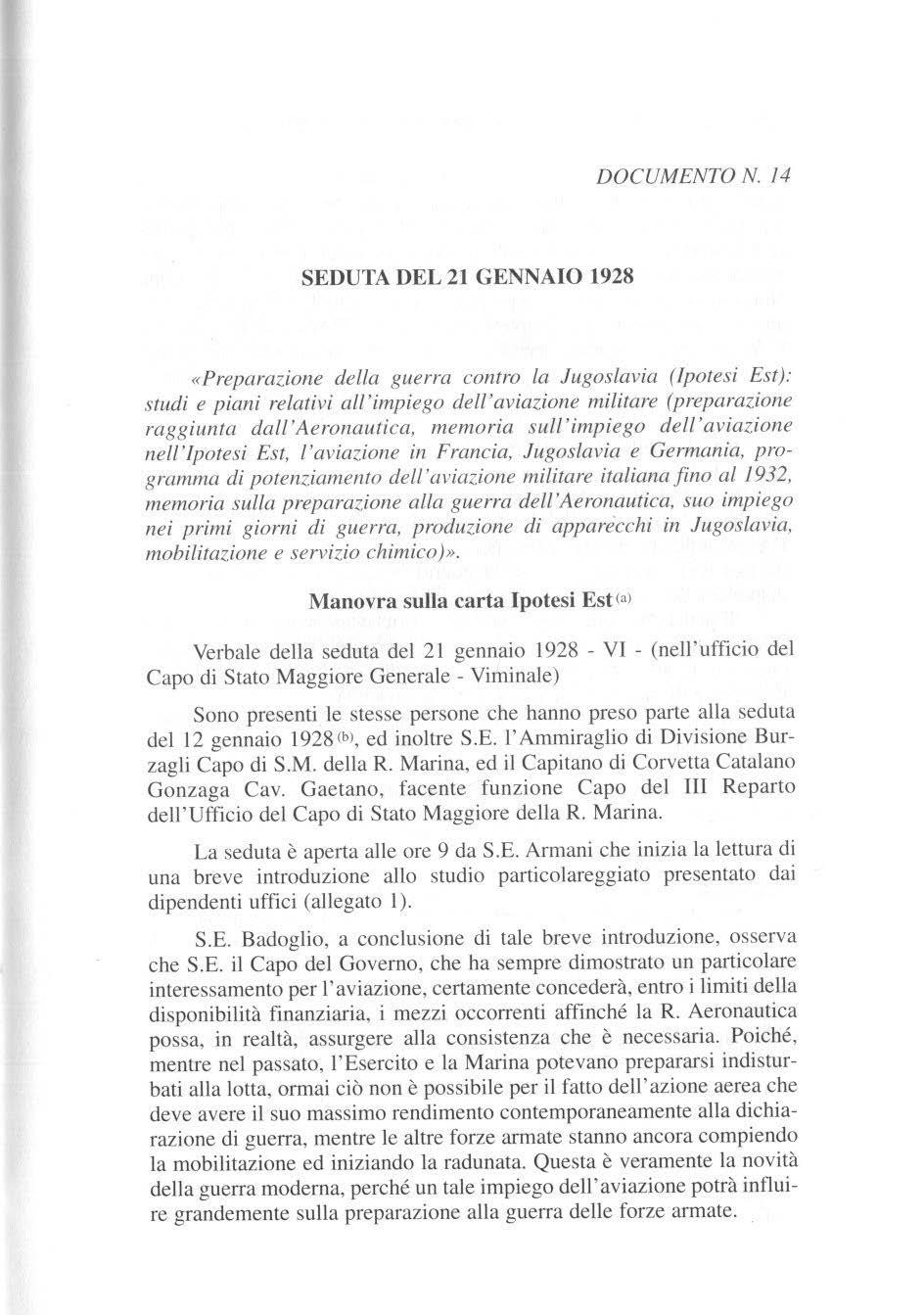
Sono presenti le stesse persone che hanno preso parle alla seduta del 12 gennaio 1928 <b>, ed inoltre S.E. l'Ammiraglio di Divisione Burzagli Capo di S.M. della R. Marina, ed il Capitano di Corvetta Catalano Gonzaga Cav. Gaetano , facente funzione Capo del III Reparto dell'Ufficio del Capo di Stato Maggiore della R. Marina.
La seduta è aperta alle ore 9 da S.E. Armani che inizia la lettura di una breve introduzione allo studio particolareggiato presentato dai dipendenti uffici (allegato 1).
S.E. Badoglio, a conclusione di tale breve introduzione, osserva che S.E. il Capo del Governo , c he ha semp re dimostrato un particolare interessamento per l'aviazione, certamente co ncederà, entro i limiti della disponibilità finanziar ia, i mezzi occorrenti affinché la R . Aeronautic a possa, in realtà, assurge re all a consistenza che è necessaria. Poiché, mentre nel passato, 1' Esercito e la M arina potevano prepararsi indisturbati all a lotta, ormai ciò non è possibile per il fatto dell 'az ione aerea che deve avere il s uo massimo re ndim ento contem poraneamente alla dichiarazione di guerra, mentre le altre forze armate stanno ancora compie nd o la mobilitazione ed iniziando la radunata. Qu esta è verame nte la novit~t della g uerra moderna, perché un tale impiego dell'aviazione potrà influire grande me nte sulla preparazione alla guerra delle forze armate .
Ma l'aviazione, nella sua organizzazione, non deve procedere a scatti che creano delle cuspidi , lasciando anche pericolose depressioni, ma costruire metodicamente, a strati paralleli, poiché non si può pensare a costituire una gran massa di apparecchi quando non vi sia in corrispondenza un'adeguata quantità di bombe, di mitragliatrici e di campi. Non si può pensare, perciò, al programma massimo di 170 squadriglie se ancora non abbiamo in completa efficienza le 73 squadriglie esistenti. L'Aeronautica procederà , pertanto, alla propria organizzazione procedendo a tappe successive e, perciò, in un primo tempo, dovrà pensare a completare le squadriglie esistenti e tutta l'organizzazione loro necessaria e, in un secondo tempo , al loro aumento fino a 170.
Jl Colonnello Graziani inizia la lettura della sua memoria - studio Ipotesi Est (allegato n. 2)<cJ.
S.E. Badoglio, riferendosi ai criteri d'impiego esposti nella memoria che si legge, osserva che la concezione attuale dell'impiego del1' Aeronautica (e cioè la sua immediata entrata in azione con bombardamento) non esisteva prima della guerra in quanto che ancora non si disponeva dei mezzi per poterla tradurre in atto.
Si pensi che come mezzo di offesa si usavano soltanto le ben note frecce e che nel 1914, a Bracciano, i nostri dirigibili facevano del le esercitazioni di lancio cli pallottole da 12-14 m/m che lasciavano cadere da una specie di sacca che pendeva sotto la navicella.
Nel 1914, concetto dominante d'impiego dell'aviazione, era quello della esplorazione, che pure ha reso importantissimi servizi: a tal proposito si ricordi che fu proprio l'aviazione a dare notizia al generale Joffre della infle ss ione della marcia della prima e della seconda armata tedesca che invece di proseguire verso ovest, avevano impiegato verso sud-est.
Il concetto dell'impiego dell'aviazione come oggi si concepisce si è delineato durante la guerra, sebbene non abbia potuto essere applicato.
II Colonnello Graziani continua la lettura della s ua memoria.
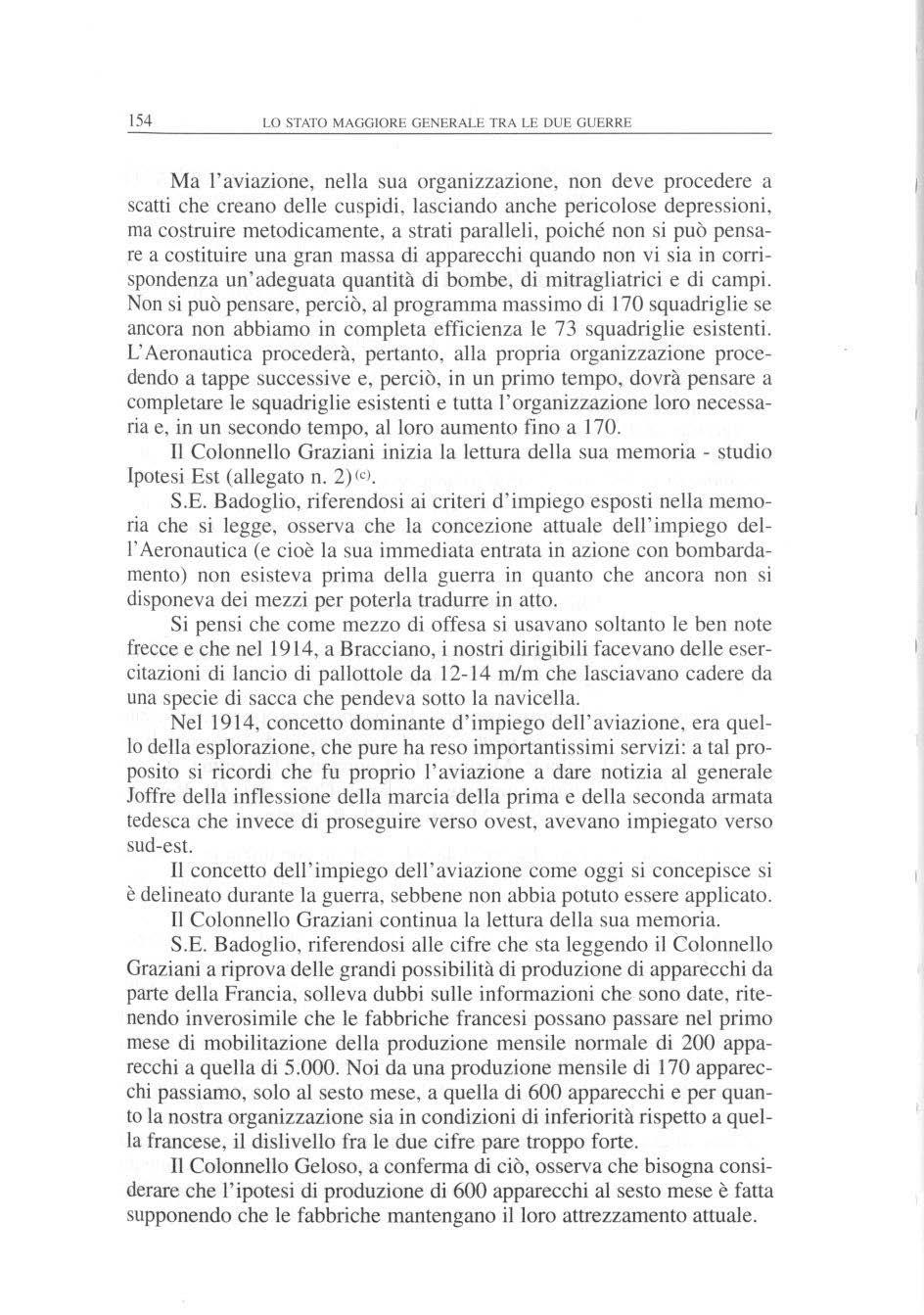
S.E. Badoglio , riferendosi alle cifre che sta leggendo il Colonnello Graziani a riprova delle grandi possibilità di produzione di apparecchi da parte della Francia, solleva dubbi sulle informazioni che sono date , ritenendo inverosimile che le fabbriche francesi possano passare nel primo mese di mobilitazione della produzione mensile normale di 200 apparecchi a quella di 5.000. Noi da una produzione mensile di 170 apparecchi passiamo, solo al sesto mese, a quella di 600 apparecchi e per quanto la nostra organizzazione sia in condizioni di inferiorità rispetto a quella francese, il dislivello fra le due cifre pare troppo forte.
Il Colonnello Geloso, a conferma di ciò, osserva che bisogna considerare che l'ipotesi di produzione di 600 apparecchi al sesto mese è fatta supponendo che le fabbriche mantengano il loro attrezzamento attuale.
S.E. Badoglio, ad ogni modo, ritiene che anche nell'aeronautica francese si proceda col sistema delle cuspidi piuttosto che col sìstema degli strati orizzontalì.
T1 Colonnello Geloso: non è infattì possibile, umanamente, i l passaggio di produzione da 200 a 5.000 apparecchi mensìli, nonostante il grande numero delle fabbriche francesi.
Ammiraglio Bernotti osserva che lo Statut Navaf prevede come necessari 5 mesi per avere i primi apparecchi ordinati all'atto della mobilitazione.
Il Colonnello Graziani continua la lettura della sua memoria, riferendo dei dati circa l'organizzazione dell'aeronautica tede sca e circa la possibìlità di trasformazion e degli apparecchi civili in militari, al momento del bisogno.
S.E. Badoglio osserva che l'aviazione tedesca, cacciata, dal trattato di Versaille s, fuori dalla porta è rientrata dalla finestra. Noi abbiamo detto che i nostri apparecchi commerciali non potranno immediatamente entrare in guerra e, quantunque la Germania abbia una organizzazione migliore della nostra, pure non è da credere che i s uoi apparecchi civili possano subito entrare in azione. In secondo tempo, certo, essa avrà una forte produzione di apparecchi, se s i tien presente l 'attrezzatura industriale avìatoria sia in patria che all'estero (paesi neutrali).
Il Colonnello Graziani continua la sua lettura riferendo dei dati circa l'organizzazione dell 'aero nautica nel Regno S.H.S.
S.E. Ferrari comunica che risulterebbe, da ultime informazioni , l'esistenza di circa 24 idroscali nel Regno S. H. S.
Il Colonnello di San Martino osserva che l 'i nformazione che porta questi dati non pare attendibi le, in quanto che una stessa località è elencata con due o tre nomi differenti.
S.E. Badoglio, come conclusione alla lettura dei dati sull'aeronautica jugoslava, fa notare che, per ora, si può ragguaglìare a 400 apparecchi la sua efficienza reale, non dovendos i tener conto di quelli residuati di guerra.

Il Colonnello Graziani continua la lettura e fornisce dei dati circa le caratteristiche degli apparecchi nostri e jugoslavi, quasi tutti , questi ultimi , di tipi francesi. S.E. Armani riferisce, al riguardo delle po ss ibilità di offesa dei nostri apparecchi, che noi ne abbiamo in costruzione da 2.000, 4.000 e 6.000 HP, con un'autonomia tale che potranno portare 2.000 kg. di bombe sopra quasi tutte le capitali europee.
Il Colonnello Graziani continua la lettura della sua memoria, e finisce col dire che, dovendo essere l'azione del!' Aeronautica violenta al massimo nei primi giorni del conflitto, occorrerà una gran massa di mezzi aerei e non già le sole 73 squadriglie che noi abbiamo oggi. Le 170 squadriglie che lo Stato Maggiore della R . Aeronautica ha richiesto
per il 1932, debbono rappresentare una cifra che si dovrà raggiungere, se si vorrà che l'arma aerea assolva con onore ai suoi gravi e delicati compiti e non tradisca la grande (ìducia e l'intensa aspettativa del Paese.
S.E. Badoglio raccomanda di completare l'esposizione con un programma finanziario che dovrà essere presentato al Capo del Governo. Raccomanda , a tal proposito, di non polarizzarsi semplicemente sulla costruzione degli apparecchi ma di tenere presente anche tutta r organizzazione necessaria al loro funzionamento di guerra (campi, armamento, ecc.). Ricorda, ad esempio, che il rendimento delle bombe dipende specialmente dal loro tipo e dalla loro perfezione: Ludendorff parla di bombe incendiarie a base di termite che avrebbero avuto una efficacia veramente terrificante e che non furono usate solo perché la Germania, già nella parabola discendente della guerra, non voleva aumentare le proprie responsabilità; noi, invece, avevamo ancora, all'armistizio, bombe incendiarie a base di zolfo, di pochissimo rendimento. Bisogna tenere in gran conto il fattore psicologico, e perciò pensare anche alla preparazione delle bombe a gas, in quanto che più gli effetti dei bombardamenti aerei sono terrificanti e più essi influiscono sul popolo. Rammenta ancora una volta come occoITa che l'organizzazione del l'Aeronautica proceda a strati paralleli e come sia da tener ben presente che l'azione aerea deve essere particolarmente intensa e violenta nei primi giorni per impedire, od almeno ostacolare fortemente, la mobilitazione e la radunata avversarie.
11 Colonnello Stanzani inizia la letlura della sua memoria sulla «p reparazione alla guerra della R. Aeronautica» (allegato 3)(d).
S.E. Badoglio, riferendosi al calcolo delle riserve necessarie in base ai consumi di guerra ed in base alle possibilità di produzione della nostra industria aeronautica, osserva che il calcolo teorico tien conto di un impiego dell'Aeronautica unifo1mcmente distribuito nel tempo, il che in realtà non è, poiché l'impiego più intenso, e perciò il massimo consumo, dovrà aversi nei primi giorni. Non vorrei che per voler mantenere costante il numero degli apparecchi in linea , si venisse nel concetto di risparmiarli nei primi giorni, oppure di tenere inoperosa una riserva eccessiva. l o preferisco che l'aviazione mi dia un grande risultato nei primi giorni, anche se tale risultato debba essere in seguito pagato con una fase di stasi più o meno lunga .
S.E. Armani mette in evidenza che per seguire tale principio, nella memoria presentata in ottobre, non aveva previsto alcun apparecchio di riserva.
TI Colonnello Stanzani continua la lettura della sua memoria, fornendo dati sull'organizzazione industriale jugoslava.
A tal proposito S.E. Badoglio osserva come, in fatto di produzione aeronautica, la Jugoslavia stia molto peggio di noi, non potendo riparare alle prime perdite di guerra.

S.E. Amrnni: ciò è vero, a meno che non venga rifornita dall'estero.
S.E. Badoglio fa osservare che i rifornimenti di materiale sono ammessi in tempo di pace, ma, in caso di guerra, costituiscono atto di ostilità, e quindi gli Stati neutrali andranno in ciò cauti, a scanso di complicazioni politiche.
TI Colonnello Stanzani continua la lettura della sua memoria e viene a trattare l'argomento delle riserve di materiale aeronautico.
S.E. Badoglio, a questo proposito, osserva che una grande riserva di apparecchi in tempo di pace è una palla di piombo che ci leghiamo al piede, in quanto gli apparecchi, che per la loro stessa natura sono soggetti a grande usura, potrebbero diventare inservibili senza essere stati usati; poi ciò impedisce di avere apparecchi ultimo modello. Bisogna piuttosto cercare di migliorare l'attrezzatura della noslra industria aeronautica in maniera che essa possa darci una maggiore produzione.
li Colonnello Stanzani continua la lettura della sua memoria, accennando alla mobilitazione su due fronti: est ed ovest.
S.E. Badoglio interrompe dicendo che non si può assolutamente pensare alla mobilitazione su due fronti poiché nelle nostre attuali condizioni tanto equivanebbe a volersi suicidare. Abbiamo già molto da fare per organizzarci verso est; verso ovest potremmo ancora far fronte, ma a denti stretti; a est e a ovest contemporaneamente non si può pensare se non come ad inutile sacrifizio.
L'Ammiraglio Bemotti fa notare che non può sapersi, all'inizio del conflitto, quello che potrà avvenire dopo, e che perciò la Marina prevede uno schieramento dell'aviazione ausiliaria anche ad ovest.
S.E. Badoglio fa notare, ancora una volta, che il presente studio, ispirandosi alla realtà della nostra attuale preparazione, ha, come presupposto di base, l'ipotesi che l'autorità politica responsabile abbia garantito che le complicazio1ù non avvengano nei primi giorni; se esse si verificassero in seguito sarà sempre possibile spostare le forze dalle basi orientali a quelle occidentali; ad ogni modo, il problema dello schieramento lo si studierà in tema di copertura.
Colonnello Stanzani continua la lettura della sua memoria trattando il problema dell'armamento degli apparecchi civili. Tali apparecchi potrebbero entrare so lo dopo circa un mese dalla mobilitazione.
S.E. Badoglio osserva che questo periodo gli sembra, in realtà, eccessivo tanto più che, per le modifiche occorrenti a trasformare gli apparecchi civi li in apparecchi militari, in Germania sono calcolate semplicemente 8 ore. Si può dunque ammettere che ci vog lia un periodo di due o tre giorni perché gli apparecchi siano pronti per l'impiego in guerra ma non un mese. Se la Germania, che ha solo aviazione commerciale, dovesse, per u n mese, non avere aviazione. non potrebbe fare la guerra.

S.E. Armani informa che esiste presso il Ministero dell'Aeronautica un apposito organo (Direzione del traffico aereo) incaricato di sorvegliare, a tali effetti, le ditte civili sovvenzionate. Sarebbe necessario che la sua azione fosse più oculata ed energica.
Il Colonnello Stanzani continua la lettura della sua memoria, rilevando come nelle linee civili italiane si usi ancora materiale tedesco.
S.E. Badoglio rileva che ciò è assai doloroso e che è necessario, se vogliamo essere una grande Nazione, avere una nostra industria aviatoria, capace di fornìre apparecchi commerciali e militari.
li Colonnello Stanzani continua la lettura della sua memoria.
S.E. Badoglio, a proposito del serv izio chimico, osserva che è tutto da costituire, perché con l'organizzazione attuale non è possibile andare avanti. Bisogna che lo S.M. dell'Esercito e lo S.M. dell'Aeronautica abbiano una propria rappresentanza nell'apposito organo unificato.
li Colonnello Stanzani continua la lettura della sua memoria, accennando ai campi di mobilitazione che ancora non sono preparati.
A tal proposito S.E. Badoglio osserva che ciò è molto grave, poiché senza campi non vi può essere aviazione.
li Colonnello Stanzani riprende la lettura e finisce leggendo i provvedime nti urgentemente necessari qualora dovesse determinarsi un preciso pericolo di guerra.

S.E. Badoglio osserva che gli studi da fare so no di tre specie:
1) studio delle operazioni da attuare nel periodo di mobilitazione occulta per essere pronti a dare il primo colpo all'inizio della mobilitazione palese;
2) studio per le provvidenze necessarie per i success ivi bisogni che si presentano durante la guerra;
3) studio su quanto è necessario impiantare sin d'ora per completare la nostra organizzazione attuale.
Il Colonnello Stanzani legge la conclusione della sua memoria.
La seduta è sospesa e rimandata a domani 22 corrente.
Pre messa letta da l Capo di Stato Maggiore de ll 'Aeronautica
Ge n era le Armani
Mi sia consentito anzitutto di giustificare le eventuali lacune che ancora oggi possano esistere nell'Aeronautica facendo la doverosa dichiarazione che l'Ufficio di Stato Maggiore della R. Aeronautica ha solo poco più di due anni di vita e che oltre alla crisi di assestamento, causata dall ' ordinamento approvato solo pochi mesi or sono, dura ancora la crisi di prima organizzazione. In ogni modo, prima ancora che fosse definito il nuovo ordinamento, ho fatto affrontare in pieno la questione delicata ed importante della mobilitazione e fin dall'inverno scorso so no stati emanati tutti i documenti relativi che, se anche non perfetti, rappresentano un primo importante passo.
E qui mi è gradito , Signor Maresciallo, ringraziare il Comando del Corpo di Stato Maggiore del R. Esercito per la cordiale collaborazione e l ' aiuto datoci in ogni occasione.
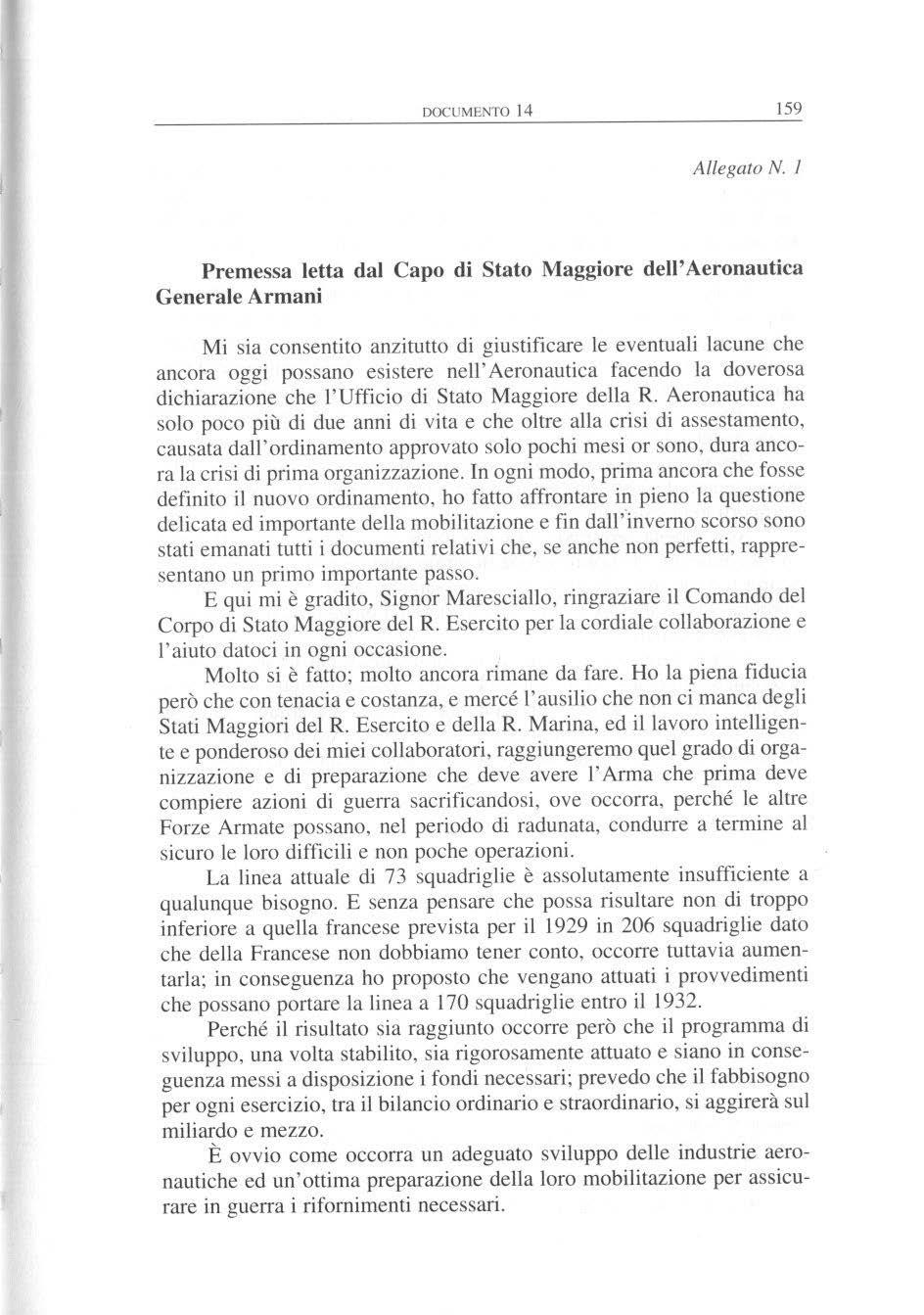
Molto si è fatto; molto ancora rimane da fare. Ho la piena fiducia però che con tenacia e costanza, e mercé l'ausilio che non ci manca degli Stati Maggiori del R. Esercito e della R. Marina , ed il lavoro intelligente e ponderoso dei miei collaboratori, raggiungeremo quel grado di organizzazione e di preparazione che deve avere l'Arma che prima deve compiere azioni di guerra sacrificandosi, ove occorra, perché le altre Forze Armate possano, nel periodo di radunata, condurre a termin e al sicuro le loro difficili e non poche operazioni.
La linea attuale di 73 squadriglie è assolutamente insufficiente a qualunque bisogno . E senza pensare che possa risultare non di troppo inferiore a quella francese prevista per il 1929 in 206 squadriglie dato che della Francese non dobbiamo tener conto , occorre tuttavia aumentarla; in conseguenza ho proposto che vengano attuati i provvedimenti che possano portare la linea a 170 squadr iglie entro il 1932.
Perché il risultato sia raggiunto occorre però che il programma di svilu ppo, una volta stabilito, sia rigorosamente attuato e siano in conseguenza messi a dispos izione i fondi necessari; prevedo che il fabbisogno per ogni esercizio, tra il bilancio ordinario e st raordinario, si aggirerà sul miliardo e mezzo.
È ovvio come occorra un adeguato sviluppo delle industrie aeronautiche ed un ' ottima preparazione della loro mobilitazione per assicurare in guerra i rifornimenti necessari.
Secondo le direttive da me impartite, tutte le squadriglie saranno sempre pronte a mobilitarsi entro cinque ore dall'ordine, cosicché, appena deciso, entro il primo giorno, i reparti prossimi alla frontiera potranno iniziare le operazioni di guerra; gli altri, con mezzi propri il movimento di radunata.
L'organizzazione dei servizi speciali per l'Aeronautica e che deve in pace di poco scostarsi da quella in guerra viene studiata in modo da assicurare fin dal primo giorno i rifornimenti necessari, riducendo così di minor momento alcune operazioni di radunata che potranno con rapidità essere compiute entro i primi quattro giorni, nei quali la capacità della rete ferroviaria non è ancora completamente assorbita dai trasporti di radunata del R. Esercito.
Per ragioni di economia e per esigenze di addestramento tutti i nuovi reparti da costituire saranno, per quanto è possibile, dislocati negli aeroporti già esistenti.
Non appena verranno concessi i fondi necessari sarà dato il mas simo incremento alla sistemazione di ottimi campi di mobilitazione; cioè a dire terTeni ampi di atterraggio ove saranno predisposti depositi per carburanti ed esplosivi e dove al momento del bisogno verranno montati hangars campali.
Così le forze aeree, limitate oggi a quelle di cui faranno cenno il Colonnello Graziani ed il Colonnello Stanzani, e nel numero maggiore che gradualmente ogni anno potremo raggiungere se saranno concessi i fondi necessari, risulteranno sempre pronte ad entrare immediatamente in azione, non appena sarà deciso dalle Superiori Autorità responsabili.
A. U.S.S.M.E.,Jo11do H-10 «Verbali riunioni /924-1943 », busta n. 2. fascicolo 11. 3. Il docume111<> è 11110 copia del/· Ufficio del rnpo di Stato Maggiore Generale ed è siglalo personalmente da Badoglio.
a) Cfr. la riunione del IJ. I. /928 (documento 11. Il). nota (a).
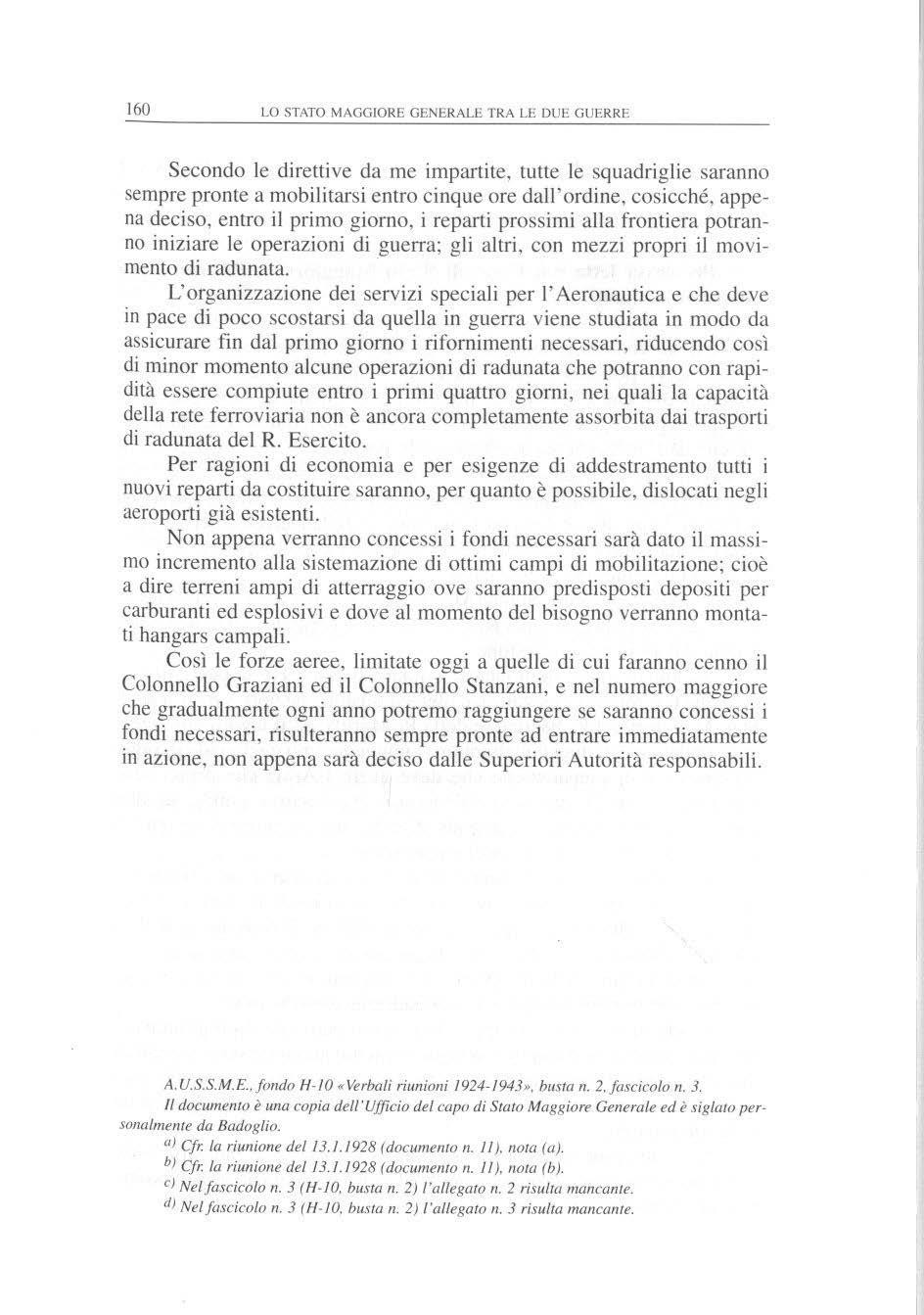
b! Cfr. la ri11nio11e del 13. I. I 928 ( docume1110 11. 11). 11010 ( b ).
e) Nel fascicolo 11. 3 (H- 10, busta 11. 2) l'allegato n. 2 risulta ma11cante.
dJ Nel fascicolo 11. 3 (fl - 10. hiwa 11. 2) l'allegato 11. 3 risulra ma11ca111e.
«Prepara zione della guerra contro la Jugoslavia (lpotesi Est): studi e piani relativi alla mobilitaz ione generale (produzione industriale a fini bellici, costituzione di organi di controllo per le derrate alimen1ari e la propaganda, mobilita zione dei vari ministeri , requisizione del naviglio mercantile , difesa antiaerea, produ zione aerei, rifornimento carbone), conclusioni di Badoglio sulla mobilita z ione occulta e s ul fabbisogno di fondi per la prepara zione della guerra» .
Manovra sulla carta-Ipotesi Est <aJ Verbale della seduta ciel 22 gennaio 1928 - VI (nell'ufficio ciel Capo di Stato Maggiore Generale - Viminate).
Sono presenti le stesse persone che hanno preso parte alla seduta del I 2 gen naio 1928 (bl, ed inoltre S.E. l'Ammirag lio di Divisione Bur zag li Capo di S.M. della R. Marina.
La seduta è aperta alle ore 9 da S.E. Badoglio che dà la parola al Colonnello Geloso, Capo dell'Ufficio Segreteria della Commissione Suprema di Difesa .
Il Colonnello Gelo so inizia la lettura di un promemoria circa un progetto generale di mobilitazione (vedi allegato l ed l bis) <c> . Nel commentare, durante la sua esposizione, la costituzione dell'Organo per le fabbricazioni di guerra, mette in rilievo la necessità che l'Esercito abbia pronti, fin dal tempo di pace, disegni, piani e ordini di lavoro per la costruzione di materiali ed artiglieria moderni da sostituire a quelli, molto antiquati, che costituiscono la totalità del nostro attuale armamento, e che sono conservati in servizio unicamente per motivi evidenti di opportunità finanziaria.
S.E. Badoglio informa, a questo proposito, che la infelice situazione delle nostre artiglierie è nota al Capo del Governo il quale, anzi , ebbe di recente a ricordargli come, alla Scuola di gue1Ta francese, sia stato affermato che l'Esercito italiano è buono , ma il suo armamento è costituito da reliquati di guerra. D 'altra parte S.E. Badoglio osserva che, al giorno d'oggi, tutte le nazioni sono, quale più quale meno, nelle stesse condizioni per quanto riguarda le caratteristiche ed i tipi dei cannoni in

servizio: in ogni modo egli ha diretto, già da molto tempo, una lettera al Capo del Governo con precise proposte su questo importante argomento. Ricorda che a metà novembre del 1917, dopo la crisi del ripiegamento, quando fu chiesto al Generale Dallolio di provvedere a 3.500 cannoni nuovi, questi rispose dichiarandosi pronto a fornirli, ma alla condizione che si dovesse semplicemente riprodurre i tipi di artiglierie già in servizio, non essendo possibile compilare i disegni ed eseguire le prove necessarie per l'adozione di nuove artiglierie.
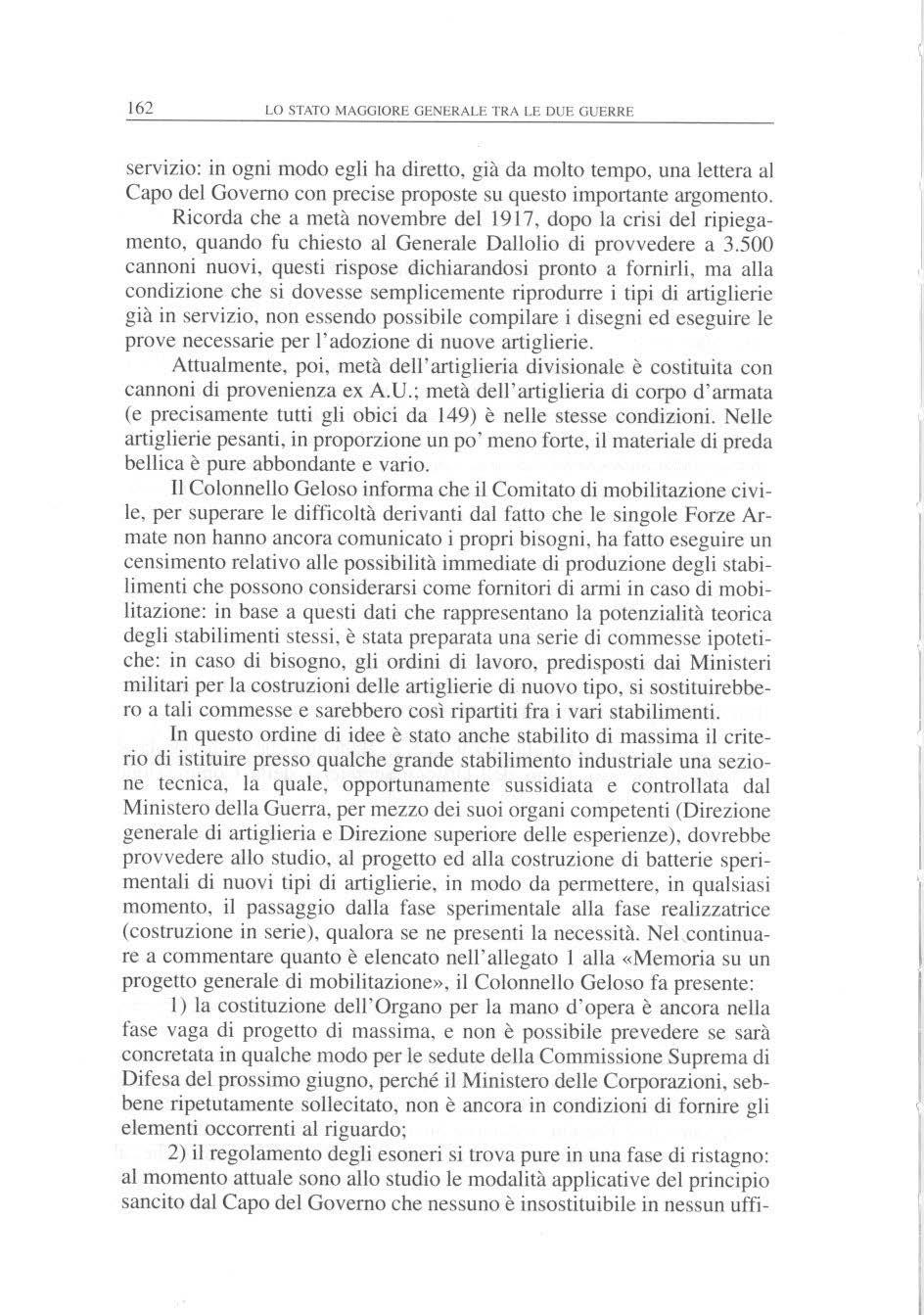
Attualmente, poi, metà dell'artiglieria divisionale è costituita con cannoni di provenienza ex A.U.; metà dell'artiglieria di corpo d'armata (e precisamente tutti gli obici da 149) è nelle stesse condizioni. Nelle artiglierie pesanti, in proporzione un po' meno forte, il materiale di preda bellica è pure abbondante e vario.
Il Colonnello Geloso informa che il Comitato di mobilitazione civile, per superare le difficoltà derivanti dal fatto che le singole Forze Armate non hanno ancora comunicato i propri bisogni, ha fatto eseguire un censimento relativo alle possibilità immediate di produzione degli stabilimenti che possono considerarsi come fornitori di armi in caso di mobilitazione: in base a questi dati che rappresentano la potenzialità teorica degli stabilimenti stessi, è stata preparata una serie di commesse ipotetiche: in caso di bisogno, gli ordini di lavoro, predisposti dai Ministeri militari per la costruzioni delle aniglierie di nuovo tipo, si sostituirebbero a tali commesse e sarebbero così ripartiti fra i vari stabilimenti.
In questo ordine di idee è stato anche stabilito di massima il criterio di istituire presso qualche grande stabilimento industriale una sezione tecnica, la quale, opportunamente sussidiata e controllata dal Ministero della Gueffa, per mezzo dei suoi organi competenti (Direzione generale di artiglieria e Direzione superiore delle esperienze), dovrebbe provvedere allo studio, al progetto ed alla costruzione di batterie sperimentali di nuovi tipi di artiglierie, in modo da permettere, in qualsia s i momento, il passaggio dalla fase sperimentale alla fase realizzatrice (costruzione in serie), qualora se ne presenti la necessità. Nel continuare a commentare quanto è elencato nell'allegato 1 alla «Memoria su un progetto generale di mobilitazione», il Colonnello Geloso fa presente:
I) la costituzione dell'Organo per la mano d'opera è ancora nella fase vaga di progetto di massima, e non è possibile prevedere se sarà concretata in qualche modo per le sedute della Commissione Suprema di Difesa del prossimo giugno, perché il Ministero delle Corporazioni, sebbene ripetutamente sollecitato, non è ancora in condizioni di fornire gli elementi occoffenti al riguardo;
2) il regolamento degli esoneri si trova pure in una fase di ristagno: al momento attuale sono allo studio le modalità applicative del principio sancito dal Capo del Governo che nessuno è insostituibile in nessun uffi-
cio, e che, pertanto, tutti coloro che hanno obblighi mjlitari debbono seguire le sorti della ,ispettiva classe di leva.
(S.E. Badoglio osserva a questo proposito cbe tale questione non può essere risolta se non dal tempo, che affievolirà talune impressioni lasciateci dall'ultima guerra: è palese infatti che organismi complessi e delicati , quali quelli industriali e di taluni servizi pubblici, non dovrebbero essere depauperati di parte del personale, proprio al momento in cui le loro funzioni si fanno più attive. Ora che siamo ancora sotto l' impressione diretta del fenomeno dell ' imboscamento possono prevalere ancora tendenze intese a livellare tutti i cittadini di fronte ai rischi della prima linea; ma, col trascorrere del tempo, prevarrà invece il criterio della logica utilizzazione dei valori individuali, nell ' interesse medesimo della collettività).
3) La costituzione dell'Organo per le derrate alimentari è a buon punto e, in ogni modo, anche allo stato attuale , le sue funzioni poss ono e s sere disimpegnate dalla Direzione di agricoltura;
4) l'Organo di propaganda all'estero ed all'interno e per l' assistenza civile non ha ancora nessun elemento embrionale di organizzazione;
5) la compilaz ione dei progetti di mobilitazione dei Ministeri, che nel caso in esame (studio della mobilitazione occulta) , ha importanza meno accentuata , procede con attività più o meno grande, a seconda dei Dicasteri: quelli delle Finanze , dell ' Istruzione pubblica e delle Comunicazioni hanno proceduto con alacrità nella compilazione di tali progetti e raggiunto già buoni risultati; qualche altro Ministero è più in arretrato; in ogni modo, tutte le Amministrazioni dimostrano di occuparsi con interessamento di questo argomento;
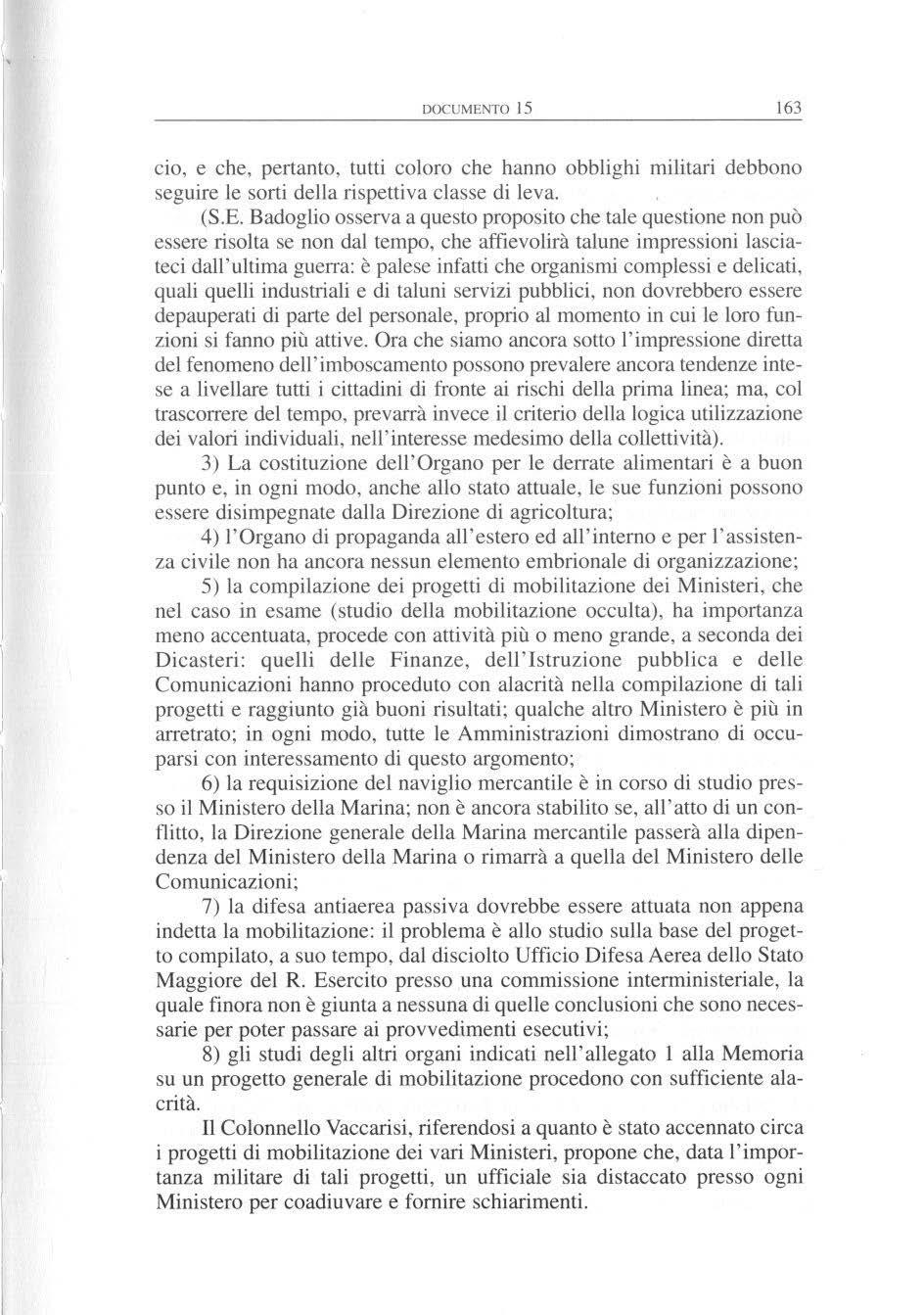
6) la requisizione del naviglio mercantile è in corso di studio presso il Ministero della Marina; non è ancora stabilito se, all ' atto di un conflitto, la Direzione generale della Marina mercantile passerà alla dipendenza del Ministero della Marina o rimarrà a quella del Ministero delle Comunicazioni;
7) la difesa antiaerea passiva dovrebbe e s sere attuata non appena indetta la mobilitazione: il problema è allo studio sulla base del progetto compilato, a suo tempo, dal disciolto Ufficio Difesa Aerea dello Stato Maggiore del R. Esercito presso una commissione interministeriale, la quale finora non è giunta a nessuna di quelle conclusioni che sono necessarie per poter passare ai provvedimenti esecutivi;
8) gli studi degli altri organi indicati nell'allegato 1 alla Memoria su un progetto generale di mobilitazione procedono con sufficiente alacrità.
Il Colonnello Vaccarisi, riferendosi a quanto è stato accennato circa i progetti di mobilitazione dei vari Ministeri, propone che, data l'importanza militare di tali progetti, un ufficiale sia distaccato presso ogni Ministero per coadiuvare e fornire schiarimenti.
S.E. Badoglio osserva che un rappresentante militare non sarebbe bene accetto e urterebbe molte suscettibilità. Già in passato la Segreteria della Commissione Suprema di Difesa, per aver voluto interferire troppo profondamente nelle attribuzioni dei singoli Ministeri civili, ha provocato una reazione dei Ministeri stessi.
L'Organo per il collegamento coi vari Dicasteri esiste già, ed è appunto la Segreteria della Commissione Suprema di Difesa.
Queste situazioni non debbono essere precipitate, ma convogliate senza urtare troppe suscettibilità.
Del resto il Capo del Governo ha già ordinato che per l'estate i progetti dei Ministeri civili siano pronti, e siccome è noto che egli non ha l'abitudine di lasciare che i suoi ordini cadano, così è da ritenere come certo che il lavoro sarà accelerato da parte di tutti i Dicasteri.
Il Colonnello Scarelli mette in rilievo la necessità che all'esame dei progetti di mobilitazione, compilati dai singoli Dicasteri, partecipino gli Organi competenti dei Ministeri militari (ad esempio l'Ufficio Trasporti del Comando del Corpo di Stato Maggiore per il Ministero delle Comunicazioni).
S.E. Badoglio osserva che a questa partecipazione s i è già provveduto appunto con l 'istituz ione della Segreteria della Commissione Suprema di Difesa, iJ cui capo, essendo un colonnello di Stato Maggiore , e quindi persona bene a conoscenza delle necessità militari e delle competenze tecniche dei vari uffici, si farà naturalmente parte diligente, ogni qualvolta nell 'esame dei progetti affioriranno questioni tecniche, per provocare il parere o l'intervento del! ' ufficio a cui spetta.
Il Colonnel1o Scarelli cita due particolari punti, che hanno importanza per il servizio ferroviario in caso di mobilitazione:
a) l'efficienza delle imprese private che hanno l'appaJto di determinati serv izi di stazione : tali imprese (se non so no presi provvedimenti in tempo di pace) all'atto della mobilitazione vengono a sfasciarsi per effetto della chiamata delle classi.
Il loro personale, almeno per un'aliquota, non dovrebbe essere sottoposto ad obblighi militari;
b) la riparazione dei veicoli e delle locomotive è attualmente affidata all'industria privata: se non si provvede tempestivamente al!' organizzazione del servizio delle riparazioni in tempo di guerra, il materiale ferroviario deperirà.
TI Colonnello Gelo so dà garanzia circa la partecipazione delle autorità militari alla revi sione dei progetti di mobilitazione dei vari Ministeri.
Continua poi la lettura, passando all'aJlegato 3 della «Memoria su un progetto generale di mobilitazione».
A proposito della produzione dei veivoli, e dell 'attuale impiego di apparecchi di costruzione estera su lle linee civili, fa presente che, apre-

scindere da tutte le altre considerazioni di caratlere militare e morale, l'impiego di apparecchi italiani su tali linee consentirebbe un aumento di produzione degli stabilimenti industriali aeronautici in tempo di pace e quindi un corrispondente aumento della loro capacità di produzione in tempo di guerra.
Il Colonnello Scarelli ritiene opportuno richiamare l'attenzione sul problema del rifornimento di carbone, che non ha visto trattato nella attuale esposizione. Le fe1rnvie dello Stato hanno attualmente una riserva di carbone corrispondente al consumo di 8-9 mesi.
Ma questa situazione ha carattere transitorio, in quanlo è basata sui rifornimenti tedeschi in conto riparazioni di guerra. Rallentandosi o cessando tali rifornimenti per effetto della guerra, le provviste di riserva diminuirebbero rapidamente, tanto più che è da prevedersi che ad esse attingeranno largamente i vari stabilimenti industriali chiamati a produrre per conto dello Stato. Infatti si è visto l'anno scorso, durante lo sciopero carboniero inglese, che se le ferrovie dello Stato non avessero potuto cedere agli stabilimenti privati parte del proprio combustibile, la maggior parte delle industrie sarebbe stata paralizzata. Chiede se la Commissione Suprema di Difesa ha provveduto in merito.

li Colonnello Geloso risponde che per ora nulla è stato definito. Termina poi la sua esposizione.
S.E. Badoglio: siamo giunti così alla fine della prima fase di questo studio, la quale doveva riguardare essenzialmente la mobilitazione occulta, e che, riallacciandosi direttamente, per forza di cose, alla mobilitazione palese, ha fatto sì che non potessimo astrarre completamente da quest'ultima.
Dico francamente che il problema della mobilitazione, anche per l'esperienza del passato, mi ha sempre profondamente preoccupato; e questo, non solo per le difficoltà tecniche che ogni soluzione compo1ta, ma anche per considerazioni di ordine psicologico; esiste infatti, in Italia, la naturale tendenza a non credere al pericolo se non quando esso \ è imminente, ossia quando è troppo tardi per provvedere; in tali circostanze il sacrificio di un capro espiatorio, se salva le apparenze, non evita il danno. Ed appunto tale preoccupazione mi indusse a prescrivere, fra l'altro, che presso la Scuola di guerra il corso di organica fosse diretto essenzialmente alla preparazione di buoni tecnici della mobilitazione. Sebbene gli spiriti non siano oggi molto cambiati, rispetto all'anteguerra, pure in questi ultimi tempi qualcosa si è fatto, come è dimostrato dal lavoro compiuto in materia di mobilitazione civile, argomento al quale, in altri tempi, non si pensava o quasi; ma occorre insistere senza stancarsi, secondo la massima evangelica: pulsate et aperietur vobis.
Veniamo, ora, ad alcune conclusioni circa l'argomento preciso del nostro studio: quello della mobilitazione occulta.
Questo periodo, c he occorrerà (come ho già accennato) designare con un nome o espressione più appropriata, si differenzia dalla mobilitazione palese per l'infl uen za che su di esso esercita ancora la politica, così prevalentemente che potrà anche capovolge re l'ordine dei pro, vedimcnti predbposti.
Occorre quindi che tali provvedimenti siano clastici, molteplici, attuabili in varie direzioni, in modo da permettere di corrispondere prontamente in qualsiasi momento alle esigenze dell'opportunità politica contingente.
Nella I a parte della relazione francese sulla Grande Guerra alcune pagine (79 e seguenti) sono tutte un grido angoscioso ed insistente del Generale Joffre, che incalza il Governo perché si decida a contrapporre i necessari provvedimenti a quelli che i Tede schi stavano prendendo, e che costituivano una vera e propria mobilitazione, eseguita sono la copert ura delle trattative diplomatiche.

Si può dire che, a partire dal 4 agosto. l'esercito germanico sarà tutto mobilitato senza che s ia stato diramato alcun ordine di mobilitazione.
Ogni 24 ore di ritardo da parte vostra, mi costringerà ad arretrare di 20 km. lo schieramento.
Se non vorremo trovarci noi pure in queste critiche condizioni all'inizio del connitto, occorre addivenire fin d'ora allo s tudi o delle provvidenze di mobilitazione occulte, classificandole per ordine di importan za, ma senza dar loro un ordine assoluto di esecuzione.
D 'altra parte questa materia non permette l'improvvisazione.
L'esposizione fatta dalle s ingol e Forze Annate consente di porre il problema della M.0. nei s uoi veri termini e di indicarne la so luzion e.
L'ideale al quale dobbiamo tendere consiste nel contemperare due opposte esigeni:e:
1) mettere l'Esercito in grado di aprire le ostilità il più prontamente possibile, ma sempre con una ma ssa raccolta e ben organizzata;
2) non com promettere o vincolare l'azione dell'autorità politi ca che, fino all'ultimo, deve essere libera di scegliere la direzione di imprimere, e di prolungare le trattative diplomatiche, o adottare al conflitto soluzioni pacilìche, o precipitare verso soluzioni violente.
Abbiamo visto che ciò si può ottenere predisponendo la mobilitaz ione di un numero di classi, che siamo riu sciti a determinare (ragguagliandolo ad una cifra piuttosto esigua), in un tempo assai breve che abbiamo pure determinato.
Abbiamo ancora visto che, fatto questo, po ss iamo rimanere in attesa degli eventi, perché con c iò avremo ottenuto di essere in grado di guadagnare tre giorni sulla radunata, ma non saremo trascinati a mobilitare a qualunque costo l'intero Esercito.
Abbiamo ancora constatato che la Marina e l'Aeronautica possono adagiare le loro operazioni su questo piano dell'Esercito, giacché le loro esigenze di mobilitazione sono ampiamente comprese nei limiti di tempo imposti da quello dell 'Eserci to.
Questo risultato è veramente notevole.
Raccomando ali' Esercito che, in materia di mobilitazione, s i trova di fronte al problema più complesso, la cui soluzione è determinante anche per le altre Forze Armate, di proseguire alacremente nel lavoro di preparazione della mobilitazione occulta, in modo da poterlo discriminare in tutti i particolari , con speciale riguardo alle reciproche relazioni fra ufficio ed ufficio.
La seconda parte di questo lavoro deve fornire a me, come Capo di Stato Maggiore Generale, gli elementi per rappresentare al Capo del Governo il reale fabbisogno di fondi occorrenti per accelerare la preparazione alla guerra. Disgraz iatamente, in questo campo, altro è il richiedere altro l 'ottenere. Ma , nell'ultimo colloquio avuto col Capo del Governo, questi mi ha assicurato che, consentendo ora la stabilizzazione della moneta di tracciare programmi finanziari pratici, anche a scadenza piuttosto lunga, egl i intende esaminare le spese militari in rapporto alle necessità che gli dovrò prospettare. Egli mi ha conseguentemente ordinato di compilare per lui due relazioni: una generale, relativa alla parte tecnica del problema, ed una relativa ai provvedimenti ritenuti necessari per perfezionare l'organizzazione del tempo di pace, in modo da consentire la sua rapida trasformazione nell'organizzazione del tempo di guerra.
Per poter compilare questa seconda relazione, ho bisogno che gli Stati Maggiori mi forniscano dati conqeti, tenendo presente che non si deve u scire dai limiti degli ordinamenti in vigore per esprimere nuovi desiderata di ampliamenti organici.
In relaz ione poi alla accelerata preparazione militare dello Stato S.H.S., vi so no provvedimenti urgenti , che s i impongono e che mi devono essere segnalati in ordine di importanza (ad esempio i depositi avanzati alla frontiera orientale, i campi di aviazione alla stessa frontiera, ecc.).

TI presentare queste necessità al Capo del Governo, mettendo in luce tutta la loro importanza, sa rà compito mio; ed ho fiducia di riuscire. Ma ho bisogno, ripeto, di dati precisi e ben documentati, per evitare che mi siano contrapposti altri dati.
Mi sembra inutile insistere s ulla nece ssità che questo lavoro sia condotto con sollecitudine.
A tempo opportuno, sarà affrontata la seconda parte di questo studio, relativa alla ripartizione delle forze ad alla copertura. Non posso precisare fin d'ora quando essa sarà svolta; posso dire soltanto che con-
cederà tutto il tempo po~sibile perché non voglio troppo aggravare il lavoro, già grande, degli Stati Maggiori.
Anche per la seconda parte cercheremo di arrivare a conclusioni ed a proposte concrete, rispondenti alle caratteristiche di qu es te nostre riunioni.
Ringrazio gli Stati Maggiori delle Forze Armate di avere aderito al mio appello di co llaborazione con tanta buona vo lontà. dimo strando con ciò di essere ben consapevo li che il problema è grave e che il Pa ese guarda a noi con comple ta fiducia.
La seduta è tolta alle ore 11 .
A. U.S.S.M.r.' .fondi H-1 0 «Verbali ri1111io11i /924-19-13». bmra 11. 2.fascicolo 11. J.
Il tlocumento i! una copia del/' Ufficio del capo di Stato Maggiore Generale ed è siglmo per · sonalmeme da Badoglio.

a/ Cfr. la rumio11e del IJ. I. /928 (docume1110 11. I I). 110/a (a).
bi Cfr. la riunume del 13.J. 1928 (docume1110 11. Il). 110w (b).
l'/ Ne/fascicolo J (H-10. bu.1w 11. 2) l'alleKlllO I e I bis risultano 111a11ca111i.
SEDUTA DEL 13 OTTOBRE 1928
«Difesa dell'Isola d'Elba: batterie d'artiglieria esistenti nell'isola, costitu-;.ione di un comando unico intetforze, creazione di depositi , organizzazione delle forze in congedo nell'isola, disposizioni finali di Badoglio agli Stati Maggiori delle Forze Armate per la difesa dell'Elba.
Preparazione della guerra contro la Jugoslavia (ipotesi Est): piano di guerra, la frontiera orientale e le linee di penetrazione adatte a una possibile offensiva ».
Verbale della Riunione del 13 ottobre 1928
La riunione ha luogo nel salone antistante all'ufficio di S.E. il Capo di Stato Maggiore Generale il 13 ottobre 1928, alle ore I 0,05.
Sono presenti:
S.E. il Maresciallo d'Italia Badoglio, Capo di S.M. Generale;
S.E. il Generale di C. d ' Arm. Gualtieri, Capo di S.M. dell'Esercito;
S.E. l'Ammiraglio Burzagli, Capo di S.M. della Marina;
Colonnello A.A. Stanzani, in rappresentanza del Capo di S.M. della R Aeronautica; Capitano di Fregata de Courten, dell'Ufficio di S.E. il Capo di S.M. Generale;
Tenente Colonnello A.A. Beltrami, dell'Ufficio di S.E. il Capo di S.M Generale.

S.E. il Maresciallo Badoglio dà il benvenuto a S.E. il Generale Gualtieri, nuovo Capo di Stato Maggiore dell'Esercito.
IVenendo ali' oggetto della riunione, ricorda come, durante le manovre navali del corrente anno, S.E. il Capo di S.M. della R. Marina abbia avuto occasione di mettere particolarmente in luce l'importanza dell'Isola d'Elba nella difesa del Tirreno. Si tratta ora appu nto di prendere in esame l'organizzazione difensiva dell'isola, attualmente in uno stato primitivo.
Occorre applicare, sia pure in proporzioni ridotte, al caso dell'Isola d'Elba quel medesimo concetto per cui, nell'attuale ordinamento del R. Esercito, sono stati costituiti i comandi militari della Sicilia e della Sardeg na. così da dare a dette isole possibilità di vita propria. nella prima fase della guerra, senza bisogno di trasporto di mezli dal continente.
L'importanza dell'Elba è grandissima: la perdita dell'isola importerebbe gravi complicazioni nella libertà di manovra strategica nel Tirreno.
Le condizioni attuali sono le seguenti:
I) esistono due batterie da 152 della R. Marina a Punta dei Riparti ed a Capo d'Enfola, le quali peraltro possono servire soltanto per tener lontani naviglio leggero e trasporti di truppe, ma la cui azione non è sorretta da nessuna sistemazione nell'interno dell'isola;
2) è in progetto una terza batteria da 152 della R. Marina a Capo d'Arco, con caratteristiche analoghe alle precedenti;
3) non vi è nessuna sistemazione di artiglierie terrestri.
Occorrono pertanto due ordini di provvedimenti: creare una organizzazione difensiva; rafforzare le difese fisse.
- Nel primo caso il R. Esercito deve studiare: la costituzione di un comando; la creazione di magazzini di armame nto e di equipaggiamento; l'organizzazione della forza in congedo esistente nell'isola, opportunamente censita, in relazione alla convenienza di raggrupparla attorno alle unità della guarnigione, oppure di creare nuove unità, o di appogg iarla alle formazioni di M.Y.S.N.; l'eventuale impiego di mitragliatrici che, se ben postate, sono particolarmente efficaci contro sbarchi; la viabilità dell'isola, di carallere fondamentale per l'attuazione di quella manovra su cui deve basarsi la reazione difensiva e per la cui sistemazione si potrebbe, ad esempio, provvedere con la temporanea dislocazione nell'isola di un battaglione zappatori e minatori; l'organizzazione di oppor tuni mezzi di sussistenza e di trasporto, ecc.
- (I rafforLamento delle difese fisse dev'essere studiato d'accordo fra R. Esercito e R. Marina.

La Marina ha giusta riluttanza a mettere gente a terra e conseguentemente l'Esercito dovrebbe prendere in consideraz ione la possibi lit à di utilinare all'uopo distaccamenti di reggimenti da costa o pesanti, oppure la costituzione di batterie occasionali. D'altra parte l'esame comparativo delle difese fisse della Maddalena e dell'Elba mostra che, a presci nd e re da qualunque consideraz ion e di caratte re asso luto, in linea re lativa vi è indubbiamente uno squi libri o a svantaggio dell'Elba. La Marina dovrà pertanto studiare se ed in che modo potrebbe eliminare tale sit uazio ne, aumentando i mezzi difensivi fissi dell'Elba.
Ri e piloga nd o:
1) Lo Stato Maggiore del R. Esercito studi l'organizzazione difensiva dell 'is ola.
2) Gli Stati Maggiori del R. Esercito e della R. Marina studino in accordo se l'attuale sistemazione delle batterie possa ritenersi sufficiente o se debba ed in qual modo essere completata.
3) Lo Stato Maggiore della R. Aeronautica studi il concorso che può essere dato dai mezzi aerei alla difesa dell'isola, in relazione ai mezzi già dislocati nella zona in base ai progetti di mobilitazione ed a quelli che potrebbero intervenire, valendosi dei punti di appoggio previst i.
Le LL.EE. i Capi di Stato Maggiore daranno carattere di urgenza allo studio della questione, lenendo presente che S.E. il Capo del Governo assegna all'argomento un'importanza di attualità, ed informeranno il Capo di Stato Maggiore Generale non appena avranno condotto a termine detto studio. Si potrà in tal modo addivenire, in apposita riunione, alle conclusioni da sottoporre a S.E. il Capo del Governo per le conseguenti decisioni.

Passando ad altro argomento, S.E. il Maresciallo Badoglio riepiloga lo stato cui è giunta la manovra coi quadri Ip otesi E s t.
Ri corda come S.E. il Capo del Governo abbia a suo tempo stabilito che il Capo di S.M. Generale studiasse anzitutto il problema della mobilitazione, radunata , schieramento, vale a dire il piano di guerra, verso la J ugoslavia iso lata, mantenendo verso le altre frontiere solo un apparecchio di sicurezza.
Questo problema ha naturalmente suggerito l'idea di esaminare quelle che sono le condizioni preliminari d el piano di guerra, ossia le prev idenze che possono essere prese nella fase di tensione dip lomatica, che si è convenuto di chiamare Periodo di sicurezza e che precede il giorno «zero» di convenzionale inizio della mobilitazione. Tali previdenze sono molte, ma, qualora siano attuate disordinatamente , possono riuscire non s olo meno efficaci, ma anc he in contrasto co n quelle che dovranno essere prese s uccessivamente.
Per questo le LL.EE. i Capi di Stato Maggiore delle Forze Armate furono incaricati di affrontare il problema con uno studio basato su dati positivi. Ne risultò un programma ben definito di operazioni, che avrebbero dovuto svolgersi regolarmente con ritmo metodico e preordinato; come tale esso è riuscito troppo rigido.
Tali operazioni debbono infatti essere studiate in modo da poter essere attuate oppure no, a seco nda delle esigenze della politica: non è possibile prefissarne un ordine di precedenza, bensì un semplice ordine
di preferenza, il quale all'atto pratico possa essere adattalo alle circostanze.
Pe rtanto: le LL.EE i Capi di S.M. preparino un promemoria da trasmettere al più presto aJ Capo di S.M. Generale, ne l quale siano elencati tulli quei provvedimenti che sono a lli a facilitare la mobilitazione generale, dand o loro un ordine di preferenza.

Una vo lta stabilito qu es to , si passerà aJlo stud io della seco nda fase della manovra, c he si riferisce alla mobilitazione e radunata: è intenzione del Capo di S.M. Generale che per la primavera del 1929 si sia giunti ad una conclusione sul piano di guerra Ipot esi Est.
Nell'intento di indiriaare il lavoro a tale scopo, S.E. il Capo di S.M. Generale prospetta i seg uenti punti:
- TI problema politico è impostato sulla ferma fiducia di isolare il probl ema S.H.S. così da ave re, in caso di guerra, a che fare con i soli jugoslavi. Conseguentemente il problema militare è quello di giungere al più presto a risultali positivi, tali da escl udere nei neutri ogni velleità di intervento. Quindi azione rapida, portata a fondo col massimo delle forze.
- Dall' esame della frontiera jugoslava risulta:
a) da Mont e Pec e Monte Blegos s i ha una zona tulla di alta montagna, in cui possono agire efficacemente le sole truppe alpine. All'estremo Nord, nella 1ona di Tarvisio, vi è qualche più larga possibilità d'azione, ma si tratta di zona eccentrica e che non può assorbire forza numero sa;
b) da M. Blegos a M . Nevoso si presenta la gra nde porta, che conduce a Lubiana , ma che tuttavia non permette neppure essa lo sviluppo dell'intero Esercito;
c) dal M. Nevoso al mare si stende un'altra zona durissima , per l 'ostaco lo di consecutive linee parallele e pel carattere boscoso. L'impegnarsi con molte forze su di un terreno del genere, non co n sentirebbe certo quella celerità di operazioni che si vuole ottenere.
Tutte le zone sopra considerate conducono poi su Lubiana, ove il nemico probabilmente attenderà con molte forze, costituite da buoni soldati cd appoggiate ad una salda linea dotata di buoni accessi dalrinterno del Paese, in condizioni cioè da poterci obbligare a quel rallentamento delle operazioni, che si vuole evitare.
La zona immediatamente a sud di Fiume, verso Novi e Segna, non pare adatta ad operazioni concorrenti, perché essen do vicina allo schieramento nemico, gli facilita l'utilizzazione delle riserve; lo S.M. della R. Marina ha già d'altra parte avuto occasione di rappresentare le difficoltà che s i oppongono alle relative operazioni di sbarco.
Occorre dunque cercare se più a sud si presentino linee di penetrazione convenienti. Si accenna alle tre seguenti:
1) una linea dalmata, che si presta così ad operazioni verso nord come, ma più difficilmente, verso l'interno della Jugoslavia;
2) la linea della Narenta, seguita nella campagna del 1877-78 dall'austriaco Filippovic per l'offensiva su Sarajevo. Per questa, oltre alla sensibilità militare dell'avversario a tale direzione, occorre anche avere presente la grande sensibilità politica, conseguente alla instabilità dell'Erzegovina nei riguardi del Regno S. H.S . Nei due casi suaccennati si tratterebbe sempre dell'effettuazione di sbarchi di viva forza, richiedenti un'azione preliminare della Marina, intesa a liberare il mare ed a costituire, con reparti appositi, teste di sbarco che successivamente costituirebbero punti di partenza per le operazioni dell'Esercito.

3) L'azione dell'Albania, molto temuta dalla Jugoslavia , verrebbe a colpirla nella Macedonia. l n merito a tale azione si deve avere presente come l'organizzazione delle forze militari albanesi vada migliorando continuamente. L'operazione potrebbe quindi ripromettere buoni risullati, benché sembri che gli jugoslavi considerino la possibilità, in caso di conflitto, di effettuare una immediata azione offensiva contro l'Albania per rimanere invece, a nord, in atteggiamento difensivo sopra una linea arretrata.
S.E. il Capo di Stato Maggiore dell'Esercito faccia subito mettere allo studio queste linee di operazione e prenda contatto con S.E. il Capo di S.M. della Marina per la indi spensabile cooperazione della Marina sulle tre linee.
Mi presenterà a suo tempo il risultato di questi studi che desidero siano condotti con carattere d'urgenza.
La seduta è tolta alle ore I 0,55.

« Difesa dell'isola d'Elba: comando unico della Marina con competenza inte,forze su tutta l'isola, organizzazione delle forze e dei mezz i (artiglieria, aviazione, armi, muni zioni, ecc.) e del terreno (lavori stradali).
Preparazione della guerra contro la Jugoslavia (ipotesi Est): studio sui provvedimenti attuabili in fase di sicure zza spe c ialmente per l'Aeronautica, esame del problema operativo, studio dello schieramento setlentrionale alla frontiera italo-jugoslava »
Verbale della Riunione del 20 dicembre 1928 - VI
La riunione ha luogo nel salone antistante all'ufficio di S.E. il Capo di Stato Maggiore Generale il 20 dicembre 1928 - VI, alle ore l O.
Sono presenti:
S.E. il Maresciallo d'Italia Badoglio, Capo di S.M. Generale;
S.E. il Generale di C.A. Gualtieri, Capo di S.M. dell'Esercito;
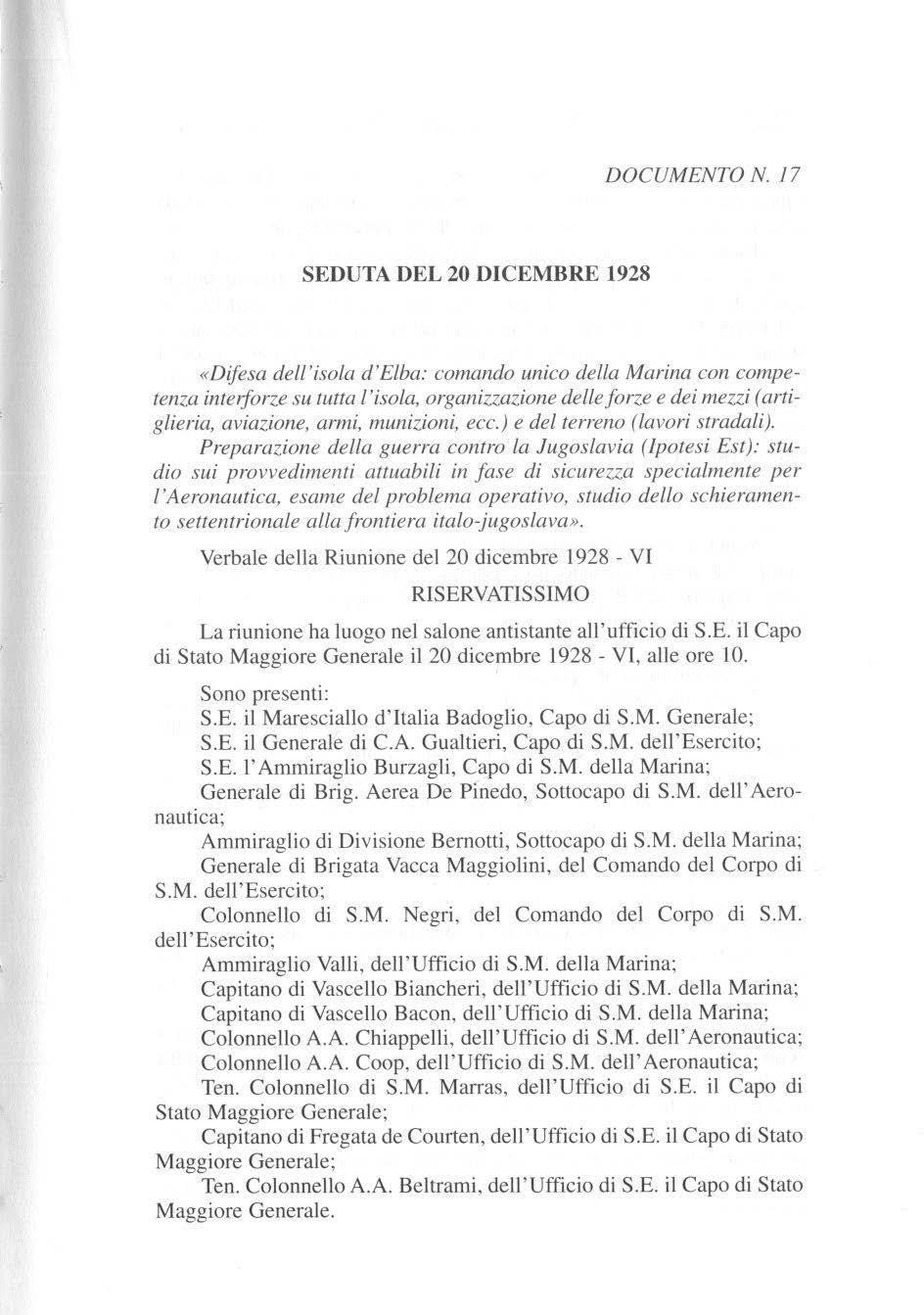
S.E. l'Ammiraglio Burzagli, Capo di S.M. della Marina;
Generale di Brig. Aerea De Pinedo, Sottocapo di S.M. dell'Aeronautica;
Ammiraglio di Divisione Bernotti, Sottocapo di S.M. della Marina;
Generale di Brigata Vacca Maggiolini, del Comando del Corpo di S.M. dell'Esercito;
Colonnello di S.M. Negri, del Comando del Corpo di S.M. dell'Esercito;
Ammiraglio Valli, dell'Ufficio di S.M. della Marina;
Capitano di Vascello Biancheri, dell'Ufficio di S.M. della Marina;
Capitano di Vascello Bacon, dell'Ufficio di S.M. della Marina;
Colonnello A.A. Chiappelli, dell'Ufficio di S.M. dell'Aeronautica;
Colonnello A.A. Coop, dell'Ufficio di S.M. dell'Aeronautica;
Ten. Colonnello di S.M. Marras, dell'Ufficio di S.E. il Capo di Stato Maggiore Generale;
Capitano di Fregata de Courten, dell'Ufficio di S.E. il Capo di Stato Maggiore Generale;
Ten. Colonnello A.A. Beltrami, dell'Ufficio di S.E. il Capo di Stato Maggiore Generale.
S.E. il Maresciallo Badoglio porge il suo sal uto al Generale De Pinedo , nuovo intervenuto a queste riunioni, il cui scopo è di conseguire la necessaria preparazione bellica delle tre Forze Armate.
Preci sa che, per disposizioni di S.E. il Capo del Governo, egli mantiene la carica di Capo di Stato Maggiore Generale , cumulandola con quella di Governatore della Tripol itania e Cirenaica. I lavori dell'Ufficio del Capo di Stato Maggiore Generale continueranno pertanto, qui a Roma, come se egli fosse presente. Attraverso l'Ufficio stesso il Maresciallo Badoglio si terrà al corrente delle questioni allo stud io ed i lavori verranno condotti regolarmente a termine, a mezzo di appositi sposta menti fra Roma e Tripoli del personale dell'Ufficio e, quando necessario, dello stesso Capo di Stato Maggiore Generale.
IVenendo al problema dell'Isola d'Elba, primo argomento della riunione, il Maresciallo Badoglio riassume i promemoria presentati dagli Stati Maggiori del R. Esercito e della R . Marina, relativamente ai tre punti fondamentali della questione:
1) Comando
2) Organizzazione delle forze
3) Organizzazione del terreno
In base a quanto esposto in detti promemoria ed ai chiarimenti richiesti al riguardo ai vari interven uti , determina:
1) Il Comando della difesa , poiché questa presenta interesse prevalentemente marittimo, sarà tenuto da un Ammiraglio che la R . Marina designerà allo scopo sin dal tempo di pace e che avrà attribuzioni ben definite nel campo dell'organizzazione della difesa.
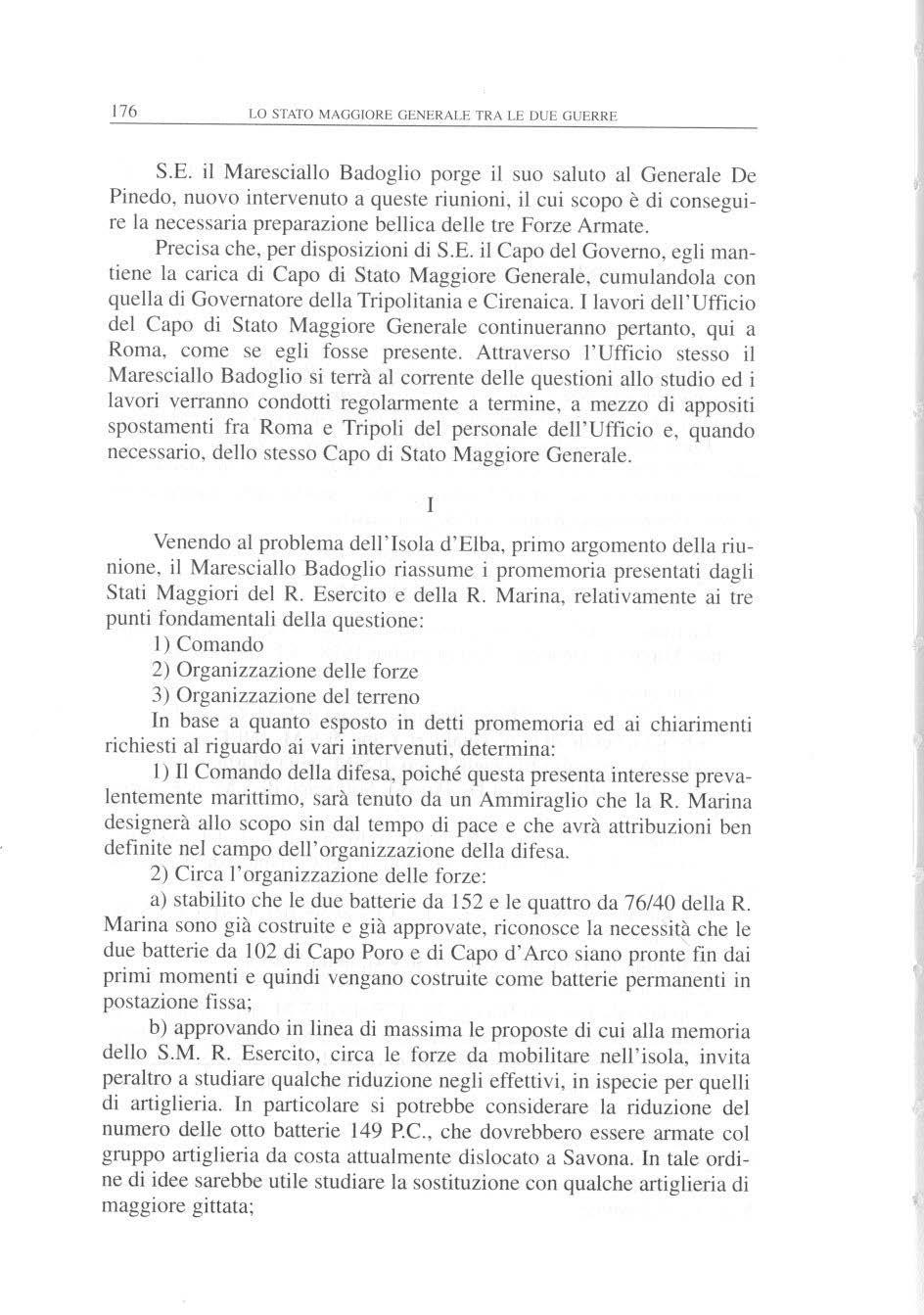
2) Circa l'organizzazione delle forze:
a) stabilito che le due batterie da 152 e le quattro da 76/40 della R. Marina sono già costruite e già approvate, riconosce la necessità che le due batterie da 102 di Capo Poro e di Capo d'Arco s iano pronte fin dai prim.i momenti e quindi vengano costruite come batterie permanenti in postazione fissa;
b) approvando in linea di massima le proposte di cui alla memoria dello S.M. R. Esercito, circa le forze da mobilitare nell 'iso la , invita peraltro a studiare qualche riduzione negli effettivi, in ispecie per quelli di artiglieria. In particolare si potrebbe considerare la riduzione del numero delle otto batterie 149 P.C. , che dovrebbero essere armate col gruppo artiglieria da costa attualmente dislocato a Savona. In tale ordine di idee s arebbe utile studiare la sostituzione con qualche artiglieria di maggiore gittata;
c) occorre accantonare nell'Isola gli autocarri necessari per lo s postamento delle artiglierie previste (v. alleg. 1) (a > , tenendo conto dei mezzi di proprietà requisibili s ul posto;
d) per l'accasermamento degli uomini e dei materiali, ci si avvalga in quanto possibile dei locali già disponibili;
e) non è il caso di accantonare nell'isola le 10 giornate di viveri di riserva, previste dallo S.M. dell'Esercito per l'intera popolazione. Se ne avrà un'importante riduzione di spesa. L ' Isola d'Elba dev'es sere posta, sin dal tempo di pace, in condizione cli completa autonomia per quanto riguarda l'armamento. Pel r esto vi sarà se mpre tempo di provvedere durante la fase di tensione diplomatica;
f) dovrà essere condotto a tenni ne lo studio delle mitragliatrici che potranno essere assegnate per l'impiego della difesa alle RR. Guardie di Finanza ed eventualmente a quei nuclei di Carabinieri Reali che risultassero convenientemente utilizzabili allo scopo. Tali armi dovranno essere date in consegna si n dal tempo di pace;
Per la R. Aeronautica il problema della difesa dell'Isola d'Elba rientra nel caso generale del suo concorso alla difesa costiera nell'Ipotesi Ovest. Tale particolare concorso sarà pertanto assicurato quando, nel quadro della sua preparazione d'insieme, la R. Areonautica avrà potuto organizzare l'adeguata s istemazione degli impianti nella zona toscana, necessari in tale caso di conflitto.
Interes sa che tali impianti siano posti in efficienza in corrispondenza coll'attuazione delle altre predisposizioni difensive;
h) per quanto riguarda magazzini, depositi munizioni e collegamenti, gli Stati Maggiori del R. Esercito e della R. Marina dovranno rivedere in accordo i rispettivi progetti, in modo da conseguire la maggiore possibile unificazione al riguardo, evitando doppioni.

3) Per l'organi zzaz ione del terreno, fra i lavori stradali considerati dal promemoria dello Stato Mag g iore del R. Esercito, occorre addivenire senz'altro alla costruzione della strada C. Marchetti - C. del Colle, la qual e dovrà avere la precedenza come più importante, e della strada C. Marchetti - S. Mamiliano. In secondo tempo s i potrà pensare al diretto allacciamento Portoferraio - Rio Marina, che si renderebbe necessar io nel caso la difesa fosse ridotta nella zona nord-orientale del1' isola. Occorre ad ogni modo addivenire allo studio del relativo progetto riprendendo in considerazione la possibilità di utilizzare la mano d'opera militare.
In base alle considerazioni sopra svolte ed agli oneri risultanti dalle relazioni dei singoli Stati Maggiori, il Capo di Stato Maggiore Generale sottoporrà al Capo del Governo la richiesta dei fondi necessari per l 'ap prestamento a difesa dell'isola.
Gli Stati Maggiori interessati si tengano pronti a tradurre in atto i provvedimenti deliberati , presentando al più presto i relativi progetti ai rispetti vi Ministeri.
Passando al problema generale dell ' Ipotesi Est, di cui alla precedente riunione 13 ottobre 1928 , il Capo di Stato Maggiore Generale invita gli Stati Maggiori delle Forze Armate ad accelerare lo studio dei provvedimenti attuabili in fase di sicurezza.
Rammenta che fra questi dovranno essere compresi essenzialmente quei provvedimenti di indole generale pei quali un anticipo, anche di pochi giorni po ss a conseguire importanti vantaggi, e che la loro attuazione o meno deve poter es sere completamente subordinata, in tale fas e, alle esigenze politiche.
Ricorda in particolare come per la R. Aeronautica la fase di sicurezza venga a corrispondere ad una vera e propria mobilitazione, in quanto i mezzi aerei devono entrare in azione per i primi ed in tutta la loro efficacia.
In base alle comunicazioni dei relativi Capi di S.M. , rimane convenuto che gli studi relativi a detta fas e dovranno essere presentati entro la prima metà di gennaio p.v.
Successivamente, si addiverrà all'e same del problema operativo, quale già delineato nella precedente seduta.
Criterio di base al riguardo quello che entro il 1929 dovrà ess ers i concretato il primo schieramento nell' Ip otesi Est. Questo potrà es s ere completato e modificato in seguito a s econda dei casi, ma la radunata di base rimarrà la stessa.
Negli studi al riguardo si dovrà tener conto:
a) che nello studio di eventuali operazioni moventi dal!' Albania , verso Scutari , oppure, come probabilmente preferibile, verso Uskub , le conclusioni cui si sarà addivenuti potranno servire per le predisposizioni nella zona di eventuale operazione;

b) non si deve tralasciare l'esame di eventuali operazioni in partenza dal Narenta. Sebbene queste, in linea di principio appaiano meno opportune, tale direzione potrebbe infatti imporsi come redditizia in particolari contingenze politiche;
c) che, qualunque sia la soluzione adottata, nel caso di sbarco si tratterà sempre di forze cui provvedere coi mezzi di un corpo d ' armata meridionale, verosimilmente con quello di Bari.
Data la posizione eccentrica nei confronti della zona di radunata settentrionale, l'eventuale intervento di tale corpo d'armata a nord si verificherebbe sempre in un secondo tempo.
Non è quindi indispensabile prestabilire la direzione delle eventuali operazioni di sbarco, né l'effettuazione o meno di queste, per risolvere il problema essenziale della radunata a nord, che sarà compatibile con qualunque delle suddette ipotesi.
Ciò posto si dovrà impostare lo studio dello schieramento settentrionale, il quale dovrà avere carattere nettamente offensivo verso est, con provvedimenti di sicurezza verso ovest. Tali provvedimenti dovranno essere studiati tenendo presente la necessità di disporre ad oriente di quante più forze è possibile, allo scopo di ricercarvi rapidamente risultati concreti.
Si abbia presente che per le operazioni in questione si deve contare di disporre:
- per il R. Esercito delle 30 divisioni di primo tempo, più le formazioni alpine, bersaglieri, ecc.
- per la R. Aeronautica delle 97 squadriglie del programma 1929.
Quando, secondo il concetto del Capo del Governo, si renderà possibile un concreto miglioramento nella situazione delle Forze Armate, attraverso ad uno sforzo finanziario, si terrà successivamente conto delle maggiori disponibilità di mezzi.
La seduta ha termine alle ore 11.
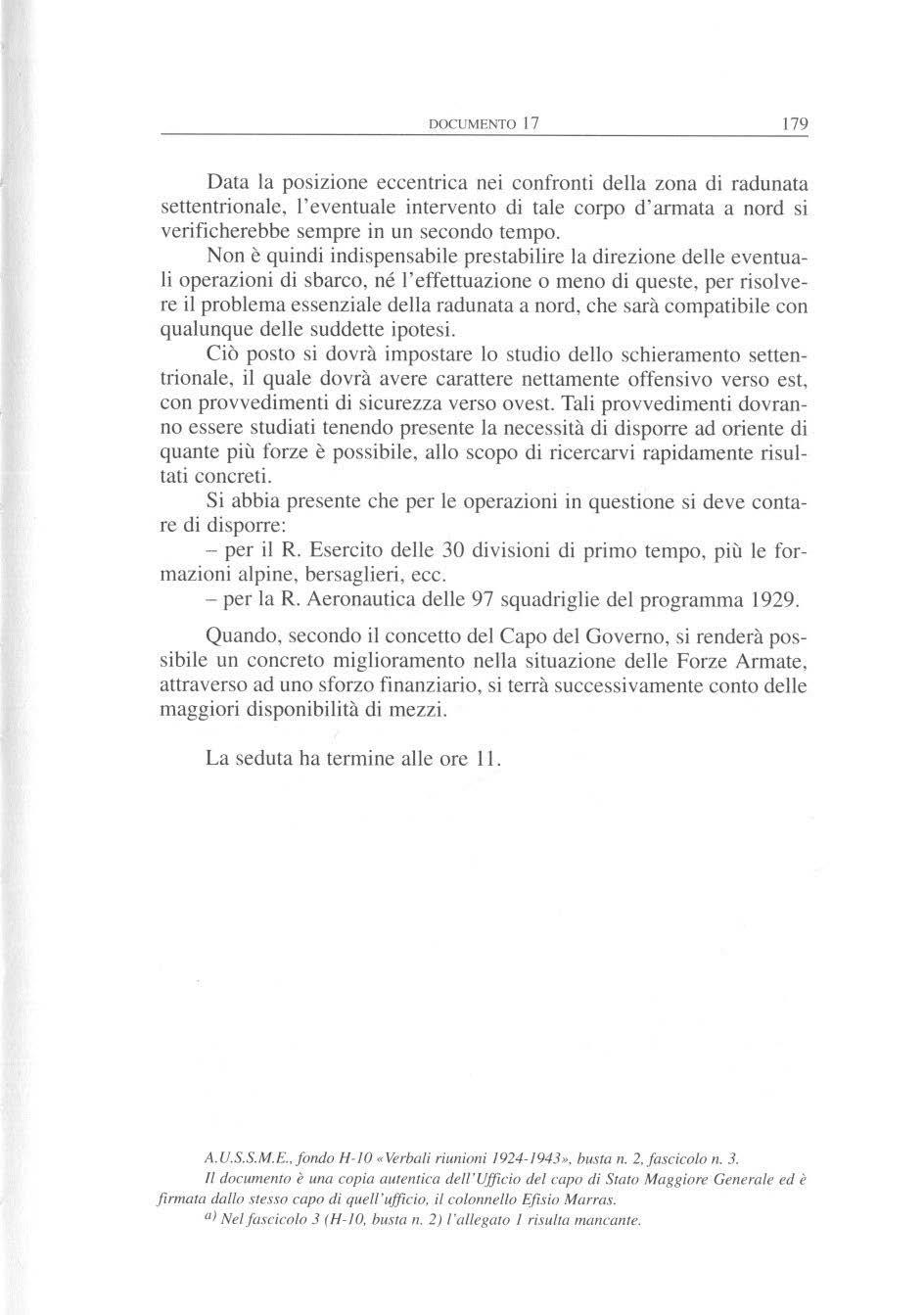

SEDUTA D EL 16 GENNAIO 1929
« Prepara z ione della guerra contro la Jugoslavia (Ipotesi Est): memoria sui provvedimenti da attuarsi durante il periodo di sicure zza (difesa contraerei e Mili z ia Volontaria di Sicure z.za Nazionale, vigilanza sulle ferrovie, depositi di frontiera e disloca zione de/L'artiglieria da posizione, trasporti di materiali, proietti e liquidi speciali, maschere antigas, poli zia militare n elle zone di frontiera), provvedimenti attuabili dalla Marina in fase di sicure zz a (sbarchi e relative truppe, trasporto truppe in Albania, Zara , spediz ioni oltremare) ».
Verbale della riunione del 16 gennaio 1929 - Anno VII
La riunione ha luogo nel salone antistante all'ufficio di S.E. il Capo di Stato Maggiore Generale il 16 gennaio 1929 alle ore 9,30.
Sono presenti:
S.E. il Maresciallo d'Italia Badoglio, Capo di Stato Maggiore Generale.
S.E. il Generale di C. d'Armata Gualtieri, Capo di S.M. dell'Esercito.
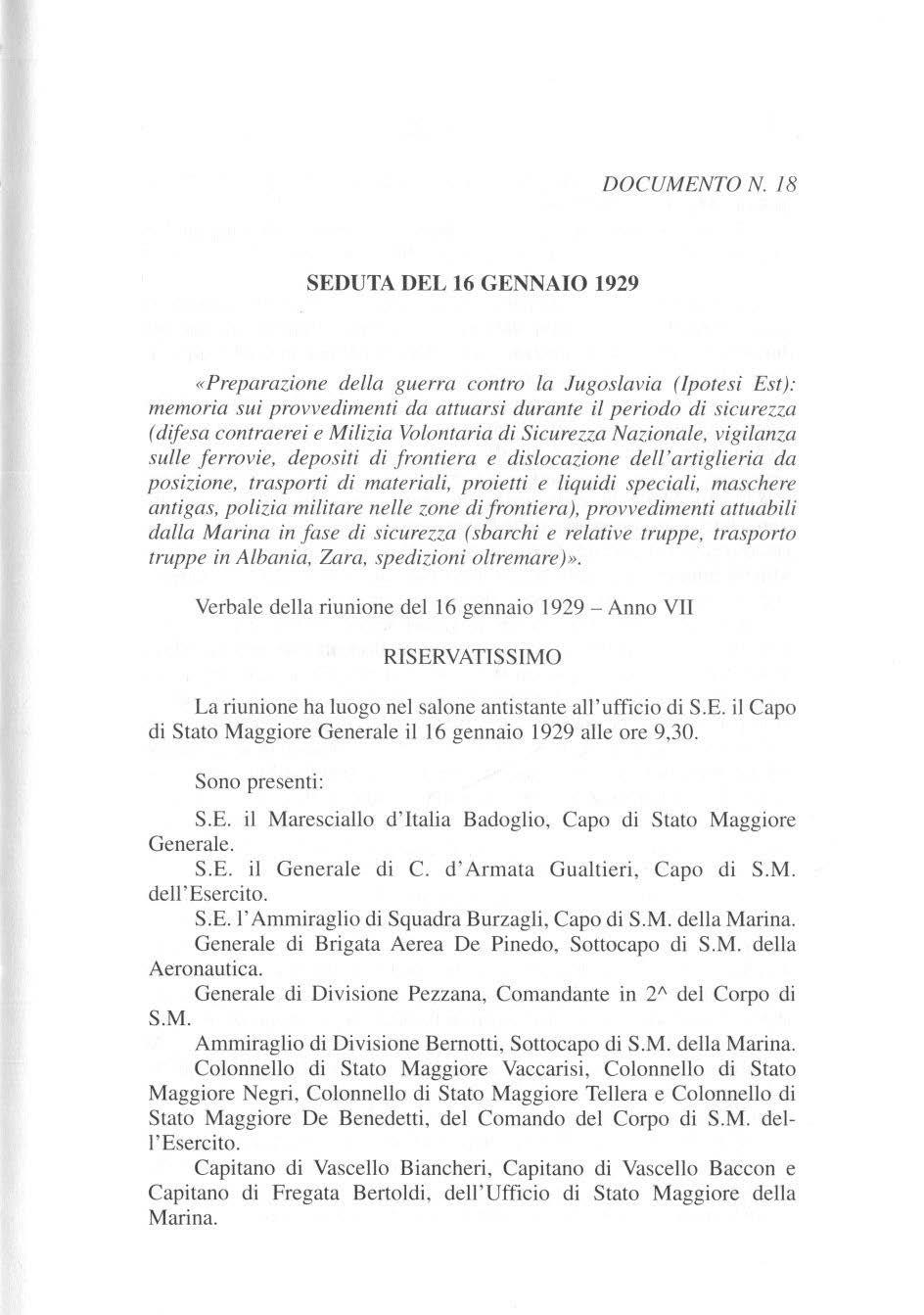
S.E. l'Ammiraglio di Squadra Burzagli, Capo di S.M. della Marina.
Generale di Brigata Aerea De Pinedo, Sottocapo di S.M. della Aero nautica.
Generale di Divisione Pezzana, Comandante in 2" del Corpo di S.M.
Ammiraglio di Divisione Bernotti, Sottocapo di S.M. della Marina.
Colonnello di Stato Maggiore Vaccarisi , Colonnello di Stato Maggiore Negri , Colonnello di Stato Maggiore Tellera e Colonnello di Stato Maggiore De Benedetti, del Comando del Corpo di S.M. del1'Esercito.
Capitano di Vascello Biancheri, Capitano di Vascello Baccon e Capitano di Fregata Bertoldi , dell'Ufficio di Stato Maggiore della Marina.
Colonnello A.A. Chiappelli e Colonnello A.A. Coop, dell'Ufficio di Stato Maggiore dell'Aeronautica.
Tenente Colonnello di S.M. Marras e Capitano di Fregata De Courten, dell'Ufficio di S.E. il Capo di S.M. Generale.
S.E. il Maresciallo Badoglio dà la parola al Colonnello Negri, il quale inizia la lettura della «Memo ria sui provvedimenti da attuarsi durante il periodo di sicurezza», compilata dal Comando del Corpo di Stato Maggiore del R. Esercito (v. allegato l) <a> .
Circa il comma 1 del paragrafo a) (Difesa C.A.T.) il Maresciallo Badoglio comunica di avere conferito in merito col Generale Nobili, comandante la difesa C.A.T., dal quale ha avuto informazione della situazion e attuale, con particolare riguardo al passaggio della difesa C.A.T. alla M.V.S .N. e annunzia che, dato che la M.V.S.N. è entrata ormai a far parte integrante delle Forze Armate sotto varie forme, ha proposto a S.E. il Capo del Governo che il Capo di Stato Maggiore della Milizia intervenga anch'esso, di massima, alle future riunioni. Questo argomento pertanto potrà essere ripreso in esame ulteriormente.
Circa il comma 2 del paragrafo a) (servizio di vigilanza sulle ferrovie), il Maresciallo Badoglio fa presente la necessità che lo Stato Maggiore dell'Esercito compili un apposito progetto per la fase transitoria del periodo di sicurezza, distinto dal progetto relativo allo stato di guerra, il personale da destinarvi, ecc. e prendendo gli opportuni accordi con il Comando G enerale dell'Arma dei CC.RR. in modo che al momento del bisogno non si debba fare altro che impartire l'ordine esecutivo, senza che l'attuazione importi alcun altro studio. Egli nota al riguardo che tutto questo studio deve avere carattere eminentemente pratico e perciò deve essere tradotto in norme, disposizioni concrete di possibile attuazione immediata.
Circa il comma 3 e 4 del paragrafo a) (depositi di frontiera e dislocazione artiglieria da posizione), il Maresciallo Badoglio osserva che anche su questi punti occorre che lo Stato Maggiore dell'Esercito proceda alla esecuzione di studi di carattere pratico, definendo per i depositi di frontiera per le truppe di copertura le località in cui dovranno essere sistemati ed i trasporli relativi, e per le batterie da posizione le postazioni, i progetti di trasporto del materiale e di afflusso del personale, ecc. Al riguardo comunica che tanto il problema dei C.D. e M.A. quanto quello dei gruppi di batterie da posizione hanno già formato oggetto di s tudi e di proposte da parte di S.E. il Sottosegretario d.i Stato alla Guerra.
Circa il comma 4 e 5 del paragrafo a) (stazioni sussidiruie di scarico ed organi per grandi trasporti militari), su richiesta del Maresciallo Badoglio, il Colonnello De Benedetti assicura che tutto è predisposto nel!' ordine pratico di idee richiesto dal Capo di Stato Maggiore Generale.

Circa il comma 6 del paragrafo a) (proietti e liquidi speciali e relativo caricamento), il Maresciallo Badoglio non ritiene sia conveniente accentrare le operazioni di caricamento nelle due sole località di Piacen za e di Casaralta; è nece ssario prevedere l'eventualità che si debbano impiegare i gas fin dall'inizio della guerra; pertanto le operazioni di caricamento dei proietti a liquidi speciali dovranno essere convenientemente decentrate. Definiti i centri di caricamento, bisognerà accantonarvi almeno due proietti scarichi. È una questione vilale e perciò occorre che siano presi gl i opportuni provvedimenti per assicurare che i centri di caricamento s iano in condizione di funzionare.
Circa il comma 7 del paragrafo a) (maschere antigas), il Maresciallo Badoglio osserva che la deliberazione del Ministero di tenere tutte le maschere anti -gas concentrate presso il laboratorio di Scanzano è stata imposta dalla delicatezza di questi mezzi, che richiedono particolare modalità di conservazione, ma implicherebbe al momento del bisogno, un assorbimento di tempo eccessivo per il montaggio e per l'invio ai vari centri. Domanda se sia stato fatto il computo della quantità giorna li era di maschere che potrà essere approntata e spedita.
11 Generale Pe zzana risponde comu ni cando che è in studio la sistemazione delle maschere in apposite casse di conservazione, le quali consent irebbero di distribuire le maschere stesse ai centri di mobilitazione fin dal tempo di pace. Informa che le maschere attualmente disponibili sono circa 650 mila, ma che il loro numero complessivo dovrà essere portato a un milione e mezzo.
11 Mare scia ll o Badoglio fa presente c he un problema sl imp ortante non può essere subordi nato al concentramento delle maschere in pochi centri di conservazione e che in specia l modo è necessario che le truppe di copertura abbiano a portata le maschere ad esse occorrenti così che il loro montaggio possa effettuarsi nella fase di sicurezza.
Ri ch iama vivamente l'attenzione di S.E. il Capo di S.M. dell'Esercito su questo vi tale problema, pregandolo di volerlo tenere al corrente degli ulteriori sv iluppi della questione per il tramite del Mini s tero della Guerra.
Il Colonnello Vaccarisi fa presente a questo proposito che, accantonando le maschere presso i cent ri di mobilitazione, s i avrebbe anche il vantaggio di acce le rare le operazion i di montaggio, valendosi all'uopo del personale che abbia g ià seguito gli appositi corsi.
Circa il paragrafo b) (entrata in azione della copertura), dietro richie s ta del Mare sc iallo Badog lio , i Colonnelli Negri e Tellera assicurano che tutto è già predisposto fin d'ora, salvo per alcuni particolari relativi all'impiego della M.Y.S.N. e della Guardia di Finanza, ma che anche per que sto sono già in corso gli studi presso i corpi d'armata.

S.E. Badoglio fa presente che, data la compartecipazione di elementi dipendenti da diverse autorità, è necessario che tulto sia accuratamente sLabilito, con s peciale riguardo ai Corpi d'Armata di Udine e Trie ste, in relazione alla particolare ipotesi di conflillo in corso di st udio. Desidera avere a suo tempo un cenno di assicurazione in merito.
Circa il comma 3) del paragrafo d) (Trasporto dei materiali ai centri di mobilitazione), il Colonnello Vaccarisi fa presente il grave problema della deficienza di locali, la quale impedisce di accantonare le dotazioni di mobilitazione presso i centri; inoltre molti locali risultano inadatti ad una buona conservazione dei materiali stessi. Il Maresciallo Badoglio osserva che questo problema ha già formato oggetto di apposito studio a parte del Ministero della Guerra e che esso è bene avviato: occo1Te però che i vari centri procedano a studi minuziosi ed in sp irati a concetti eminentemente pratici, per la migliore sistemazione di tali depositi.
Il Colonnello Vaccarisi prospetta la soluzione provvisoria di ricorrere all'affitto di locali, dato che, secondo ogni verosimiglianza, la sol uzione integrale del problema richiederà ancora parecchio tempo.
Circa il paragrafo a) (polizia militare nella zona di frontiera). il Maresciallo Badoglio osserva che non è possibile pensare né al concentramento né allo sgombero della popolazione allogena, trattandosi di parecchie centinaia di migliaia di persone, il cui movimento paralizzerebbe i trasporti di mobilitazione. 11 problema va quindi risolto con un duplice ordine di provvedimenti: internamento delle persone influenti , mediante ordine telegrafico , secondo liste preparate fin dal tempo di pace, e costituzione immediata dei battaglioni CC.RR. autonomi, destinati al servizio di polizia militare nella zona di frontiera. Per questi battaglioni prega lo Stato Maggiore dell'Esercito di prendere accordi col Comando Generale dell'Arma dei CC.RR. , in modo che la costituzione di essi possa avvenire nel tempo minimo e che i battaglioni stessi possano entrare immediatamente in azione, secondo una ripartizione di territorio e una distribuzione di nuclei prestabilita, tale da garantire che nelle regioni di frontiera venga mantenuto il massimo ordine.

Circa i rimanenti paragrafi, il Maresciallo Badoglio nulla ha da osservare, pur notando che alcuni dei provvedimenti contemplati si riferiscono ad uno stadio di periodo di sicurezza molto avanzato e che pertanto coincidono quasi con provvedimenti di mobilitazione.
TI Maresciallo Badoglio si compiace che siano stati compiuti gli studi relativi alla fase di sicurezza, i quali assumono particolare importanza per l'Esercito che ha indubbiamente la mobilitazione più laboriosa. Senza questo studio e senza le predisposizioni che ne derivano , il
periodo di sicurezza avrebbe certamente dato a luogo a disposizioni alquanto caotiche.
Lo studio ora compiuto deve essere approfondito nei particolari riguardi della ripercussione correlativa dei vari provvedimenti, in modo da mettere il Capo di S.M. Generale in grado di garantire al Capo del Governo che i provvedimenti della fase di sicurezza potranno in caso di necessità ricevere immediata attuazione, senza bisogno di ulteriori studi. Prende poi la parola il Capitano di Vascello Biancheri, il quale inizia la lettura del promemoria relativo ai provvedimenti attuabili dalla R. Marina in fase di sicurezza (allegato 2).

11 Maresciallo Badoglio ritiene opportuno di premettere alcune considerazioni di carattere generale sul problema degli sbarchi. Gli studi in merito del tempo di pace portano quasi sempre all'espressione di un numero così grande di desiderata da condurre alla conclusione che uno sbarco è possibile solo in località opportunamente organizzata per la difesa e per la esecuzione di operazioni di sbarco (banch ine , grue, pontoni. ecc.). Si deve tener presente, invece, che come l'esperienza dei Dardanelli insegna , le operazioni di sbarco sono attuabili anche in porti non organizzati e che d'altra parte, qualora le necessità militari impongano di effettuare sbarchi in grande sti le in una determinata zona, la quale offra una direttrice di operazione redditizia, dovranno essere prese tutte le previdenze per ridurre al minimo rischi e pericoli, ma dovrà pur essere prevista e messa a calcolo una certa percentuale di probabilità di perdite.
Riferendosi al comma c) (trasporto di truppe in Albania) del paragrafo «o biettivi principali>> pag. I, il Maresciallo Badoglio osserva che la frase «tras porto di truppe in Albania» dovrebbe essere integrata aggiungendo «od in altra località».
L'Ammi r aglio Bemotti osserva che secondo ogni verosimiglianza noi saremo certamente vincolati alla necessità di trasporti di truppe in Albania, indipendentemente dalle altre eventuali direttrici operative.
Il Maresciallo Badoglio fa presente che, nelle attuali condizioni del la rete stradale albanese, la possibilità di grandi operazioni in quella zona per truppe nazionali appare alquanto dubbia. Ma certamente, quando i lavori stra dali proposti in Albania saranno eseguiti, quella sarà di massima la zona più redditizia, perché nella condotta delle operazioni l'applicazione del << reattivo» appare tanto più efficace quanto più il suo punto di applicazione è lontano dalla fronte principale.
Per quanto riguarda la funzione di Zara nel quadro della condotta generale delle operazioni verso est, il Maresciallo Badoglio osserva che ogni decisione in merito risulta prematura, dipendendo essa dai risultati dello studio delle migliori linee di invasione del territorio nemico. P otrà anche darsi che a Zara venga assegnato un compito puramente difensi -
vo; in tal caso occorrerà semplicemente provvedere ad un adeguato rinforzo delle truppe di guarnigione, le quali già prossimamente saranno aumentate assegnandovi un reggimento di bersaglieri ed un gruppo di artiglieria.
È certo in ogni modo che le operazioni ed i provvedimenti destinati a completare la capacità difen siva di Zara potranno essere attuati anche nella fase di sicurezza, seco ndo progetti di dettaglio, che saranno stud iati a s uo tempo.
Circa i dati indicati nel paragrafo «spedizione 0.M. (A)» pag. 3, il Maresciallo Badoglio ne deduce che, supponendo una fase di sicurezza della durata di 4-5 giorni, entro tale periodo sarà possibile procedere, nei riguardi della spedizione 0.M., unicamente alla concentrazione parziale dei mezzi navali di trasporto. Questo elemento appare di particolare importanza per evitare che so rgano illusioni s ulla rapidità di esecuzione di operazioni di trasporto di truppe del tipo di quella 0.M.

Circa il paragrafo 7 (Reggimento S. Marco) ed in relazione ai dati numerici indicati nel comma «primo provvedimento», il Maresciallo Badoglio nota come il periodo di otto giorni necessario per mobilitare il Reggimento S. Marco su due battaglioni di 750 uomini non risulti sincrono con le altre operazioni e domanda in base a quali calcoli sia stato computato questo periodo di tempo.
Il Comandante Biancheri risponde che il periodo di otto giorni è richiesto dalla necessità di ricorrere ai complementi provenienti dall ' Italia meridionale e dalle isole, ma che, tenendo conto che due terzi dei richiamati del battaglione S. Marco appartengono all'Italia settentrionale qualora ci si accontentasse di mobilitare il reggimento S. Marco s u due battaglioni di 500 uomini ciascuno, si potrebbe addivenire alla mobilitazione stessa entro un periodo di circa 4 giorni.
Il Maresciallo Badoglio concorda e, riferendosi al comma «Terzo provvedimento» pag. 7, osserva che la proposta di mettere a disposizione il perso nale delle scuole di Pola è generosa, ma implicherebbe il consumo di un capitale preziosissimo, quale è quello costituito da questo personale.
Tale provvedimento quindi potrebbe essere adottato soltanto in casi di estrema necess ità. Lo studio della R. Marina porta alla conclusione che essa può fornire al massimo l.000 uomini, i quali probabilmente risulteranno largamente insufficienti. Ogni decisione definitiva deve essere rimandata alla fine degli altri stud i relativi all'Ipotesi Est. Sarà in ogni modo molto probabile la necessità di ricorrere a qualche reparto dell'Esercito, per esempio ad uno dei reggimenti di s tanza a Pola, ponendolo alle dipendenze della Marina per ricevere particolare addestramento alle operazioni di sbarco.
Naturalmente un simile provvedimento avrebbe ripercussione anche sui provvedimenti organici del tempo di pace.
La seduta è sospesa alle ore 11.00 e sarà ripresa alle ore 11.00 del 17 gennaio.

Promemoria <b) dello Stato Maggiore Regia Marina relativo ai provvedimenti attuabili in fase di sicurezza
Roma, 14 gennaio 1929 RlSERVATISSTMO
1) Obiettivi iniziali
L'ordine di preferenza dei provvedimenti deve stabilirsi in armonia con gli obiettivi iniziali della Marina per l'azione contro S.H.S. Dallo studio già fatto ri sulta che tali obiettivi possono genericamente definirsi nel modo seguente:
Obiettivi principali
Cooperazione diretta con l'Esercito consistente nelle operazioni per:
a) Appoggio all'ala destra dell'Esercito sul fronte principale e alla sua avanzata.
b) Tra sporto di truppe a Zara e concorso alle operazioni per consolidarne il possesso. Sgombero della popolazione civile di Zara.
c) Trasporto di truppe in Albania.
Avvertenza
L'appoggio di truppe all'Esercito, oltre che nel concorso navale, dovrà consistere nell'impiego di truppe di Marina (Reggimento S. Marco) di rapida mobilitazione con personale richiamato di Marina per le occupazioni di iso le richieste dalle operazioni delle specie a) e b).
Obiettivi secondari
a) Distruggere e paralizzare le unità navali S. H .S.
b) Tagliare le comunicazioni marittime del nemico (b locco nel Canale di Otranto e vigilanza estesa ad a ltre zone).
c) Protezione del nostro traffico.
2) Provvedimenti di massima urgenza
Dalla rassegna degli obiettivi iniziali risu lta che, oltre alla dis locazio ne delle forze navali e dell'aeronautica ausiliaria ne l modo previsto per il loro impi ego, mentre comincerà l 'appro ntamento dei servizi delle piazze marittime del litorale con la disponibilità di personale del tempo

di pace (assetto precauzionale), la R. Marina, iniziando la fase di sicurezza, dovrà attribuire la massima urgenza ai seguenti provvedimenti di essenziale importanza per l'apertura della ostilità.
1) Requisizione, concentramento e approntamento dei mezzi di trasporto per le spedizioni marittime.
2) Armamento e dislocazione di pontoni armati e di mezzi speciali di sbarco.
3) Mobilitazione con precetto personale del Reggimento San Marco.
4) Mobilitazione con precetto personale degli ufficiali e del personale del C.R.E.M. necessario per il servizio semaforico e delle comunicazioni e per la messa in efficienza del servizio a.a. e a.s . nel l'Alto Adriatico.
Sui provvedimenti anzidetti devono farsi le seguenti considerazioni:
3) Requisizione, concentramento e approntamento dei mezzi di trasporto. In relazione agli obiettivi iniziali si dovranno attuare i seguenti provvedimenti:
1) Requisizione dei piroscafi occorrenti per le spedizioni oltremare.
2) Invio dei piroscafi ai porti di concentramento per l'imbarco delle truppe.
3) Mobilitazione con precetto personale degli ufficiali e del personale di bassa forza occoITcnte per costituire le commissioni di requisizione e imbarco e per i comandi militari dei piroscafi.
l provvedimenti suddetti dovranno essere presi per ogni singola operazione da compiere; giovano al riguardo le seguenti considerazioni.
Non sono state ancora definite; quando perverranno i prospetti di imbarco si provvederà (d'accordo con l'Ufficio Trasporti dello Stato Maggiore R.E.) alla compilazione dei quadri di imbarco.

Per queste spedizioni di piccola entità, ma di immediata esecuzione, si potrà fare assegnamento sui piroscafi delle società S. Marco, Puglia, S.A.1.M., Istria, Trieste, ecc. che eserciscono le linee interne dell'Adriatico e che sono tutti prontamente reperibili e rapidamente concentrabili nelle località prestabilite. Tali piroscafi sono di limitata pescagione ed il personale ad essi preposto ha famigliarità con gli approdi della sponda orientale.
Sono in corso gli studi per valutare la capacità logistica del naviglio suddetto; dopo tali accertamenti, e in seguito agli accordi fra gli Stati
Maggiori dell 'Ese rcito e della Marina per la condotta delle operazioni, si potrà d efi nire quale affidamento si potrà fare che le spedizioni siano pronte in relazione alla durata della fase di s icure zza.
Spedi zione O.M. ( A) - Albania -
Secondo i pros petti ed i quadri di imbarco finora in vigore (da modificare in ba se alle nuov e indicaz ioni fornite dallo S.M.R.E. con foglio in data 11 gennaio) occorrono almeno 34 piroscafi (pe r 200.000 T S.L. ) Di questi, due devono esse re pronti alla caricazione al giorn o X+4, otto al giorno X+S, nove al giorno X+7, otto fra X+8 e X+9 e sette a l giorno X +9 , chiamando X il giorno in cui lo Stato Maggiore R. E. comunicherà di iniziare la requi sizione. Il quarto ed ultimo scag lione di truppe potrà essere pronto a partire , sa lvo imprev isti, il giorno X+ l 1.
È stato eseguito r ece ntemente un esperimento di prese ntazione dei piroscafi occorrenti alla s pedi zione in parola ; ne lla pro ss ima compilazione dei nuo vi quadri di imbarco si apporteranno alcune modifiche alla costituzione degli scag lioni in modo c he la pre cet ta z ione s ia resa più agevole.

Spedizione 0.M.(D ) - Dalmazia -
È ancora in fase molto embrionale. Lo Stato Maggiore della Marin a ha comunicato a quello dell ' E serc ito i dati per un apprezzamento so mmario sulla po ss ibilità e convenienza dell ' impresa.
In attesa del pro seg uimento degli s tudi sem bra di pote r rit e nere che, data l'ingente quantità di naviglio mercantile che sarebbe neces saria per tale impre sa, la mobilitazione non potrebbe essere occu lta, ossia esorbiterebbe dai limiti consentiti nella fase di sicurezza.
4) Pontoni armati
Ci occorrono pontoni armati per i seguenti compiti:
a) Appoggio all 'ala destra dell 'Esercito (operazione f.).
b) Contributo alla difesa di Zara.
I mezzi attualmente di s ponibili nell'Ad riati co consistono in due pontoni (Montello con 1 = 305 e Carso con 2 = 190) . Sono in corso di approntamento entro il 1929 due bettoline armate con 2 = 149 ex. a.u. e I = 76 a.a. ciascuna.
È stato deliberato di costruire due pontoni armati con 2 = 190 ed 1 = 76 a.a. ciascuno, ma non è ancora stabilito quando saranno approntati.
P er il sollecito armamento di questi pontoni lo Stato Maggiore della Marina terrà presente la necessità di destinare un nucleo di personale speciali sta fin dal tempo di pace.
Il Comando dell'Alto Adriatico e la Divi s ione Speciale provvederanno a dislocare preventivamente i pontoni predetti in modo che nella
fase di sicurezza, ammesso che abbi una durata di quattro giorni, possano trovarsi a posto.
5) Mezzi speciali di sbarco
La necessità di mezzi speciali di sbarco è richiesta in relazione ai seguenti obiettivi:
a) Occupazione di Veglia.
b) Contributo alla difesa di Zara, mediante la pronta occupazione dell'isola di Ugliano e l'esecuzione di uno sbarco tattico in modo da prendere di rovescio o di fianco le truppe nemiche intorno alla città. La Marina inizierà fra breve tempo esperimenti con una cisterna tipo «Adige», che è stata variata; quando le operazioni V e Z saranno definite si potrà stabilire il numero di mezzi speciali che saranno necessari e sarà proposta la loro costruzione.
6) Base passeggera
Lo studio del!' operazione V consentirà di stabilire se è necessario che la R. Marina appronti a questo scopo a Venezia una sezione di base passeggera, e se il suo approntamento presenti carattere di urgenza da essere incluso nella fase di copertura.
Lo Stato Maggiore della Marina ha studiato accuratamente il problema, per poter aderire efficacemente e largamente agli intendimenti espressi da S.E. il Capo di S.M. Generale. Si prospettano le possibilità della R. Marina, riservandosi di addivenire alle conclusioni quando le operazioni V e Z saranno definite. Si stima però opportuno di tener presente che le occorrenze segnalate dall'Ufficio Operazioni dello Stato Maggiore del R. Esercito, per l'occupazione di Veglia, Selve, Premuda, Ugliano e Rivazj, sommerebbero a un reggimento, due battaglioni, una batteria e servizi relativi. Tali occorrenze dovrebbero essere accresciute se ammessa la necessità di uno sbarco tattico nei dintorni di Zara, perché un nucleo di personale della R. Marina dovrebbe essere adibito al compito di occupazione di spiaggia.
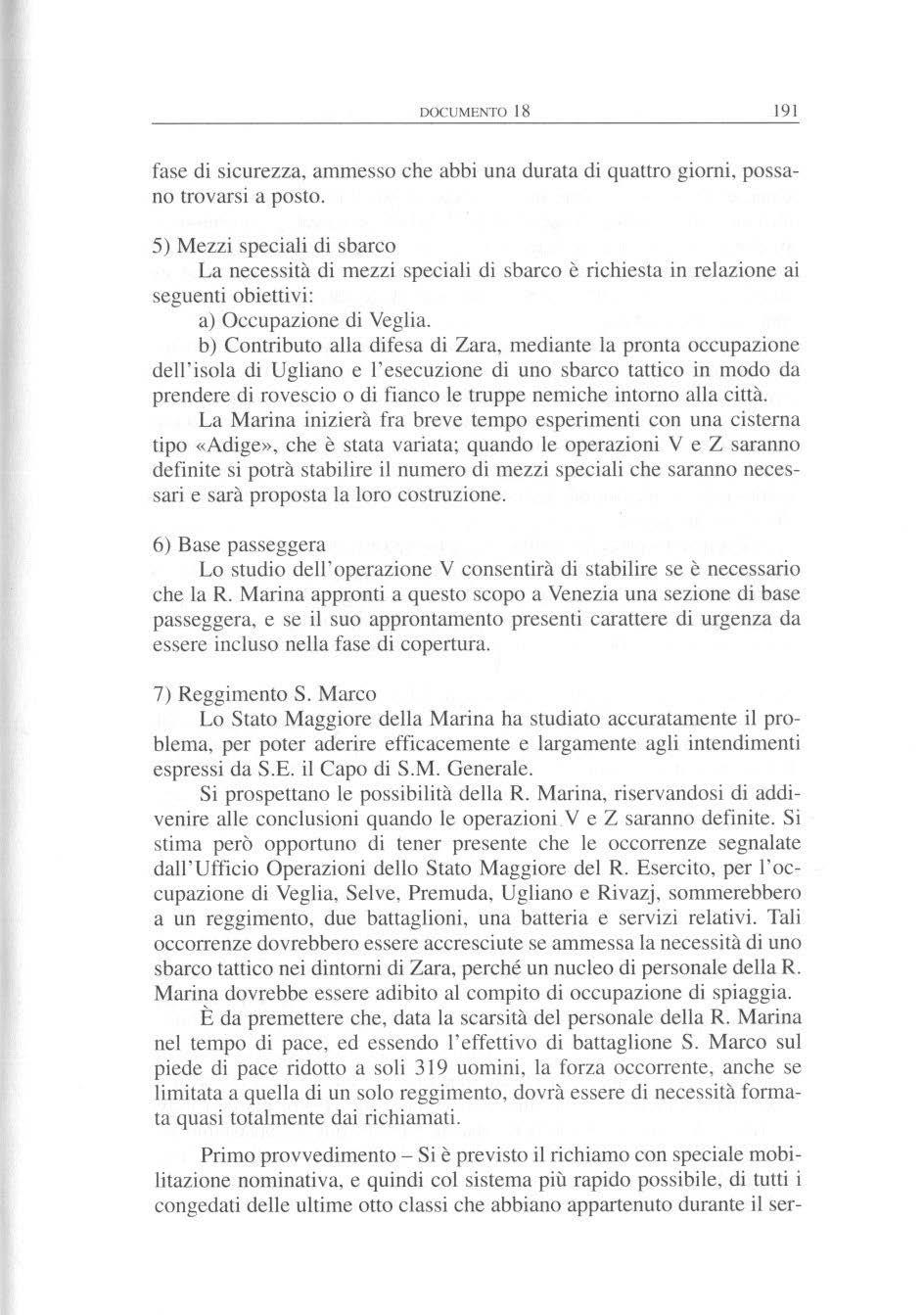
È da premettere che, data la scarsità del personale della R. Marina nel tempo di pace, ed essendo l'effettivo di battaglione S. Marco sul piede di pace ridotto a soli 319 uomini, la forza occorrente, anche se limitata a quella di un solo reggimento, dovrà essere di necessità formata quasi totalmente dai richiamati.
Primo provvedimento- Si è previsto il richiamo con speciale mobilitazione nominativa, e quindi col sistema più rapido possibile, di tutti i congedati delle ultime otto classi che abbiano appartenuto durante il ser-
vizio al Battaglione S. Marco di stanza a Pola ed al reparto distaccato in Cina, essendo ovviamente da escludere la possibilità di far contribuire altri elementi di categorie del C.R.E.M. Infatti per la categoria cannonieri, che più delle altre sarebbe adatta a fornire contingenti di fanteria, la disponibilità di ben otto classi di congedati viene assorbita dalle necessità di armamento delle riserve divisionali delle forze navali e per l'organizzazione costiera.
Per l'inquadramento del reggimento S. Marco sarà necessario altres ì una rapida affluenza di ufficiali del R. Esercito, secondo accordi già presi a suo tempo con il Ministero della Guerra.
Coi provvedimenti accennati potrà aversi pronto ' a Pola (entro otto giorni dalla data del richiamo) un contingente di richiamati che, inquadrati con gli elementi del serv izio attivo destinati sul posto, sono sufficienti a costituire due battaglioni di 750 uomini nonché una batteria da 76/17 s u due pezzi.
Da quanto precede ri s ulta che, a meno di cambiare l'attuale organizzazione, le pos s ibilità della R. Marina danno per il Reggimento S. Marco una disponibilità di personale di gran lunga inferiore alle occorrenze segnalate per le operazioni di esecuzione immediata; si prospettano perciò le soluzioni per accrescere il quantitativo anzidetto.
Secondo provvedimento - Qualora la M.V.S.N. secondo le proposte avanzate alla Commissione Suprema di Difesa sostituisce il personale della R. Marina impiegato per la difesa a.a. (ipotesi che per ora mi sembra assai lontana) si potrebbe disporre di circa altri 2.000 uomini (provenienti dalla categoria cannonieri) che potrebbero essere opportunamente inquadrati per operazioni terrestri, in aggiunta ai due battaglioni sopra indicati.

Devesi però rilevare che, dato il breve tempo a disposizione per la formazione di questi reparti, e trattandosi di elementi costituiti, nella quasi totalità , da richiamati dal congedo, e appartenenti anche a classi anziane, essi non avrebbero uno speciale addestramento quale sarebbe desiderabile per la loro particolare missione; si verificherebbe mancanza di affiatamento fra graduati ed uomini di truppa che non può certo stabilirsi nei primi giorni, assorbiti principalmente per le pratiche di inquadramento, vestizione, ecc.
Terzo provvedimento - Una soluzione che presenterebbe i requisiti di massima rapidità, e che fornirebbe un personale scelto, ma con grave sacrificio delle necessità della R. Marina, sarebbe quella consistente nell ' utilizzare il personale delle scuole di Pola. Tale provvedimento consentirebbe di avere immediatamente disponibile un contingente di circa 2.300 uomini già inquadrati da ufficiali e sottufficiali.
Indubbiamente questi giovani affiatati tra di loro, ben conosciuti dai loro ufficiali e dai loro graduati, affezio nati a questi, di sentimento e di morale alti ssimi, addestrati con esercizi pratici durante il corso (come sono addestrati per la gin nastica ed altri esercizi del genere), sarebbero molto atti allo scopo.
Si deve però tener presente:
1) che la possibilità di attuazione di questo provvedimento sarebbe limitata al periodo di marzo a ottobre, in cui si svolgono i corsi normali;
2) che il personale delle scuole rappresenta una percentuale preziosa di elementi da sfruttare al più presto per i servizi navali, sicché, non potendo escludere in modo assoluto complicazioni dal lalo ovest, con la conseguente necessità di dover mettere a l più presto in completa efficienza le forze navali, sare bbe molto dannoso di rinunziare s ulle navi, anche per breve tempo, all'impiego di questo personale che è prezioso per i servizi di bordo, per i quali è particolarmente preparato.
In base a quanto precede, anche ammesso di impiegare come truppe di Marina il personale delle scuole, sembra dubbia la possibilità che le truppe così formate possano assumersi da so le l'onere delle occupazioni in sulari, per le molteplicità degli obiettivi, e per la rapidità e sim ultaneità richiesta nel l'esecuzione.
Per provvedere alle necessità che sono state prospettate si possono riassumere nel modo seguente le previsioni nei riguardi de l richiamo di personale:
Ufficiali
a) In re lazione al graduale appro ntamento dei servizi delle piazze marittime e del litorale sarà provveduto dalla Direzione Generale del personale; a mezzo dei comand i di ascrizione dipartimentali, al richiamo nominativo di ufficiali.

b) Sarà richiesto al R. Esercito l 'avv iamento a Pola degli ufficiali di fante ri a occorrenti per l'inquadramento del re ggimento marina.
Militari del C.R.E.M.
A) Rich iamo, a mezzo di precetto personale, dei militari assegnati alle mobilitazioni specia li nominative:
a) serv izi o semaforico e comunicazio ni per tutto il
b)
B)
nomi nativo di sottufficiali con precetto personale . .
C)Richiamo con precetto personale dei militari assegnati alla mobilitazione numerica delle due ultime classi in congedo di tutti i compartimenti marittimi
A.U.S.S.M.E.. fondo H-10 « Verbali riunioni /924-/943 », busta n. 2,fascicolo n. 4. Il doc 11me1110 è una copia de/l'Ufficio del capo di Staro Maggiore Generale.
a ) L'allegato I risulta mancante ne/fascicolo 4 ( H - 10, busw 11. 2).
h ) Il promemoria è una copia, redarra da/l'Ufficio del capo di Swro Maggiore Generale. di un documento del capo di Staro Maggiore della Marina.

«Preparazione della guerra con 1ro la Jugoslavia (ipotesi Est): studi in corso sulla mobilitazione e fase di sicurezza dell'Aeronautica (richiamo per precetto, munizioni di caduta, mobilitazione di elementi dei servizi, requisizione di locali e terreni, scuole di pilotaggio, acquisti di materie prime per le scorte di materiali), finanziamenti per la costituzione di riserve di apparecchi».
Verbale della riunione del 17 gennaìo 1929 - Anno Vll
La riunione ha luogo nel salone antistante all'ufficio di S.E. il Capo di S.M. Generale il 17 gennaio 1929, alle ore 11.
Sono presenti le stesse autorità indicate nel verbale della riunione del 16 gennaio, colla sola differenza che è presente anche il Contrammiraglio Valli ed è assente il Capitano di Fregata Bertoldi <a>.
11 Generale De Pinedo premette che lo studio compilato dallo S.M. della R. Aeronautica è stato inspirato al crìterio di evitare provvedimenti vistosi, che possano essere considerati dalla nazìone avversaria come atti provocatori, e di non compromettere la possibilità dì arrivare eventualmente ad un pacifico componimento del contrasto. D'altra parte deve tenersi presente che gli studi ed i lavori in corso tendono ad ottenere che il passaggio della R. Aeronautica dal piede di pace a quello di guerra possa avvenire entro un termine brevìssìmo. Appunto in questo ordine di idee, la maggior parte delle squadriglie è stata concentrata nelle due zone dell'Italia settentrionale, le quali gravitano rispettivamente una verso la frontìera orientale e l'altra verso la frontiera occidentale. Nell'ipotesi di conflìtto in corso di studio, le forze dislocate ad est possono quindi considerarsì praticamente già pronte ad entrare in azione, mentre la mobilitazione consiste princìpalmente nel trasporto delle forze e dei servizi della zona occidentale sulla frontiera orientale.
Il Maresciallo Badoglio osserva che, verosìmìlmente, in una futura guerra, alle forze aeree spetterà il compito di iniziare le ostilità irrom-

pendo offensivamente nel cielo della nazione avversaria e rintuzzando le eventuali offese aeree nemiche; pertanto il concetto fondamentale, a cui si ispira la organizzazione della R. Aeronautica è sanissimo. Appunto per questo La fase di sicurezza deve considerarsi equivalente, per l'Aeronautica, ad una vera e propria mobilitazione, delle.forze pronte. La differenza fra fase di sicurezza e mobilitazione starà semplicemente in ciò: che durante la fase di sicurezza i provvedimenti previsti potranno opportunamente essere graduati in relazione alla situazione politica, mentre in caso di mobilitazione essi avranno applicazione integrale. Occorre quindi che il presente studio dell'Aeronautica, il quale aveva carattere alquanto prudenziale, venga completato elencando tutte le operazioni da attuare, in armonia ai concetti più sopra espressi.
Il Generale De Pinedo in questo ordine di idee aggiunge che, in caso di tensione diplomatica, gli apparecchi potranno essere trasferiti in poche ore dall ' una all'altra fronte, e che il trasporto dei servizi potrebbe essere certamente compiuto durante la fase di sicurezza, se fossero attuate quelle predisposizioni che difficoltà di bilancio hanno finora impedito di realizzare.
11 Maresciallo Badoglio ne deduce la necessità che, dovendosi fare sicuro affidamento sul funzionamento delle forze aeree fin dai primi momenti del conflitto, l'ordinamento della R. Aeronautica nei riguardi della consistenza di squadriglie sia adeguato alle possibilità del bilancio in modo che tale consistenza risulti commisurata allo sviluppo dell'organizzazione a terra e dei mezzi sussidiari.
Il Colonnello Coop inizia la lettura della memoria, compilata dallo S.M. della R. Aeronautica, relativa ai provvedimenti da attuare in fase di sicurezza (v. allegato 3).

Relativamente al comma 4 ° (richiamo per precetto personale), il Maresciallo Badoglio chiede se siano già approntate tutte le comunicazioni per i richiami con precetti personali.
Il Colonnello Coop risponde che i precetti personali sono preparati presso i Distretti Militari, salvo per pochi elementi specializzati per i quali sono ancora in corso gli studi presso i comandi di zona.
Circa il comma 5 ° (misure di sicurezza), il Maresciallo Badoglio richiama l'attenzione sull'assoluta necessità che tutti i provvedimenti di sicurezza siano predisposti in ogni particolare, prendendo all'uopo fin dal tempo di pace i necessari accordi col Comando dell'Arma dei CC.RR., in modo che questo possa essere esattamente orientato sull'entità dei servizi che gli saranno richiesti.
Circa il comma 8 ° (caricamento munizioni di caduta), su richiesta del Maresciallo Badoglio, il Colonnello Chiappelli informa che il munizionamento è attualmente ripartito fra i tre depositi di Villa Osti, Villa Trento e Porà, e che una parte dell'esplosivo occorrente è ancora in corso
di fabbricazione; la percentuale delle munizioni cariche è di circa 1/2, ma esse sono costituite in buona patte da residui di guerra su cui non si può fare grande assegnamento. Circa l'esplosivo, su 3.000 tonnellate di fabbisogno, 2.000 sono pronte e le altre 1.000 sono in corso di fabbricazione.
li Maresciallo Badoglio prega di tenerlo al corrente circa i progressi nella preparazione del munizionamento di caduta, rispetto al fabbisogno calcolato, e fa presente che, dato il tempo occorrente per le lunghe operazioni di caricamento, l'Aeronautica, la quale deve entrare in azione il primo momento, deve avere almeno una metà del munizionamento carico e pronto.
Circa il comma 9 ° (mobilitazione di elementi dei servizi), il Maresciallo Badoglio richiama l'attenzione sulla necessità di predisporre elenchi precisi dei servizi da mobilitare e dei mezzi occorrenti per il loro trasporto, in modo che la prevista mobi litazione possa effettivamente svolgersi secondo i progetti.
Il Colonnello Chiappelli informa che difettano gli automezzi occorrenti per il trasporto, ma che per essi si provvederà gradatamente nei successi vi esercizi finanziari.
Circa il comma I I O (requisizione di locali e terreni), il Maresciallo Badoglio osserva che anche su questo punto occorrerà compilare un progetto di dettaglio.
Circa il comma 12° (scuole di pilotaggio), il Colonnello Chi appelli informa che i progetti relativi sono già pronti.
Circa il comma 14° (acquisti di materie prime per le scorte di materiali), il Colonnello Chiappelli informa che i progetti sono pronti , ma dovranno essere riveduti in base alla riduzione del programma massimo di 170 squadriglie all'organico attuale di 97 squadriglie.
Il Generale De Pin edo dà assicurazione che per tutti i punti , che formano oggetto della memoria, lo Stato Maggiore della R. Aeronautica, provvederà alla compilazione di progetti completi di dettaglio.
Alla fine della lettura della memoria il Generale D e Pinedo osserva come l'Italia, con un bilancio di 700 milioni, preveda una forza in linea di 97 squadriglie, mentre la Francia, con un bilancio trip lo (di circa 2 miliardi), preveda una consistenza di 140 squadriglie. L'apparente contraddizione di questa cifra si spiega tenendo conto che, mentre la Francia è dotata dei necessari apparecchi di riserva, l'Italia ne è sprovvista. Questo problema riveste un ' importanza eccezionale, tenendo conto che in caso di guerra si prevede un consumo mensile di circa il 40% degli apparecchi in linea: è evidente la necessità di disporre di una riserva, la quale conse nta di mantenere in efficienza le squadriglie operanti finché l'industria nazionale non sia in grado di dare un gettito di nuovi apparecchi per lo meno equivalente al predetto 40%. D 'altra parte, non essen-

do mai stato assegnato nessun fondo straordinario per la costituzione del demanio Aeronautico, per il quale era prevista una spesa globale di circa 200 milioni, gli oneri relativi nella misura che anno per anno è stabilita in relazione alle disponibilità di fondi, gravano su lla parte ordinaria del bilancio.
Di massima si può affermare che l'attuale bilancio di 700 milioni è sufficiente per il solo esercizio delle 97 squadriglie esistenti e che, volendo addivenire alla costituzione di riserve di apparecchi, all'organizzazione degli impianti a terra, ecc. occorrerebbe una as.,egnazione straordinaria di circa un miliardo, da s uddividers i in tre anni. In seguilo sarebbe possibile col bilancio ordinario di 700 milioni tenere in efficien1a reale le 97 squadriglie previste.
li Maresciallo Badoglio comunica che prospetterà questa situazione al Capo del Governo, facendogli presente l'eventualità che, qualora non sia possibile provvedere alle spese straordinarie, occorra rivedere rorganico delle 97 squadriglie, riducendolo opportunamente.
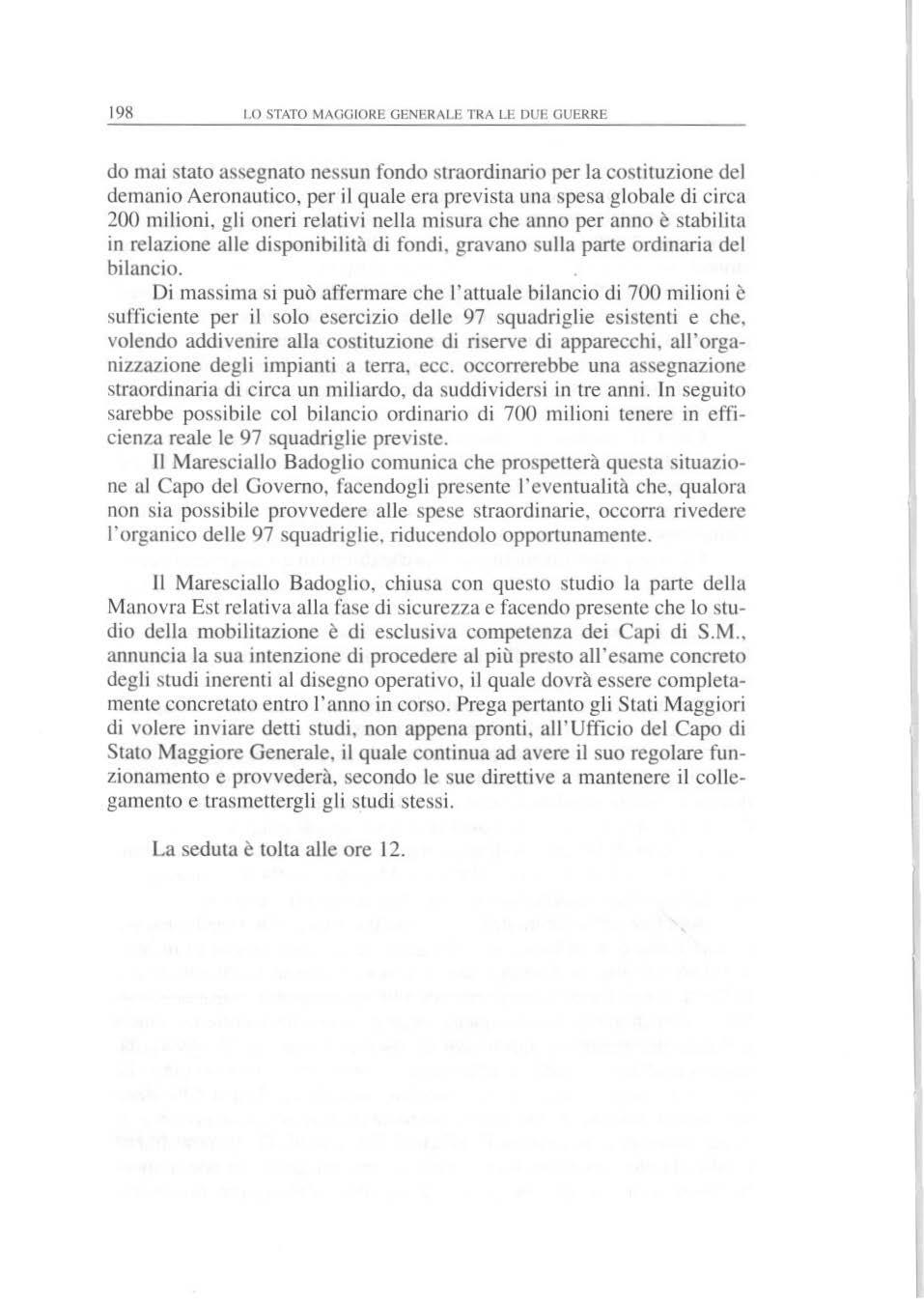
Il Maresciallo Badoglio, chiusa con questo studio la parte della Manovra Est relativa alla fase di sicurezza e facendo presente che lo studio della mobilitazione è di esclusiva competenza dei Capi di S.M., annuncia la sua intenzione di procedere al più presto all'esame concreto degli studi inerenti al disegno operativo, il quale dovrà essere completamente concretato entro l'anno in corso. Prega pertanto g li Stati Maggiori di volere inviare detti studi, non appena p ronti, all'Ufficio del Capo di Stato Maggiore Generale, il quale cont inua ad avere il suo regolare funzionamento e provvederà, secondo le sue direttive a mantenere il collegamento e u·asmettergli g li studi stessi.
La seduta è to lta alle ore 12.
Memoria (bl dell' Ufficio di Stato Ma ggiore R. Aeronautica - II
Re parto Addes tram ento e Mobilitazione a ll' Ufficio del capo di S tato Mag giore Generale
N. 500 13/5 P rot. Roma, 1O gennaio 1929
Mano vra coi quadri Ipotes i Es t.
ln relazione alle disposizioni date da S.E. il Capo d i S.M. Generale nelle riunioni del 13 ottobre e 21 dicembre u.s. si e lencano di seguito i provvedime nti da attuare nel periodo di sicurezza secondo un ordine di preferenza suscettibile di essere adattato alle circostanze:
1) inoltrare le richieste per un ' assegnazione strao rdinaria di fondi in base allo s tato di previsione delle spese precedentemente preparato ;
2
) far rientrare alla sede tutti i distaccamenti , so s pendere qual s iasi licenza, richiamare il personale già in licenza;
3) sospendere il congedamento dell'aliquota della clas se di imminente congedamento;
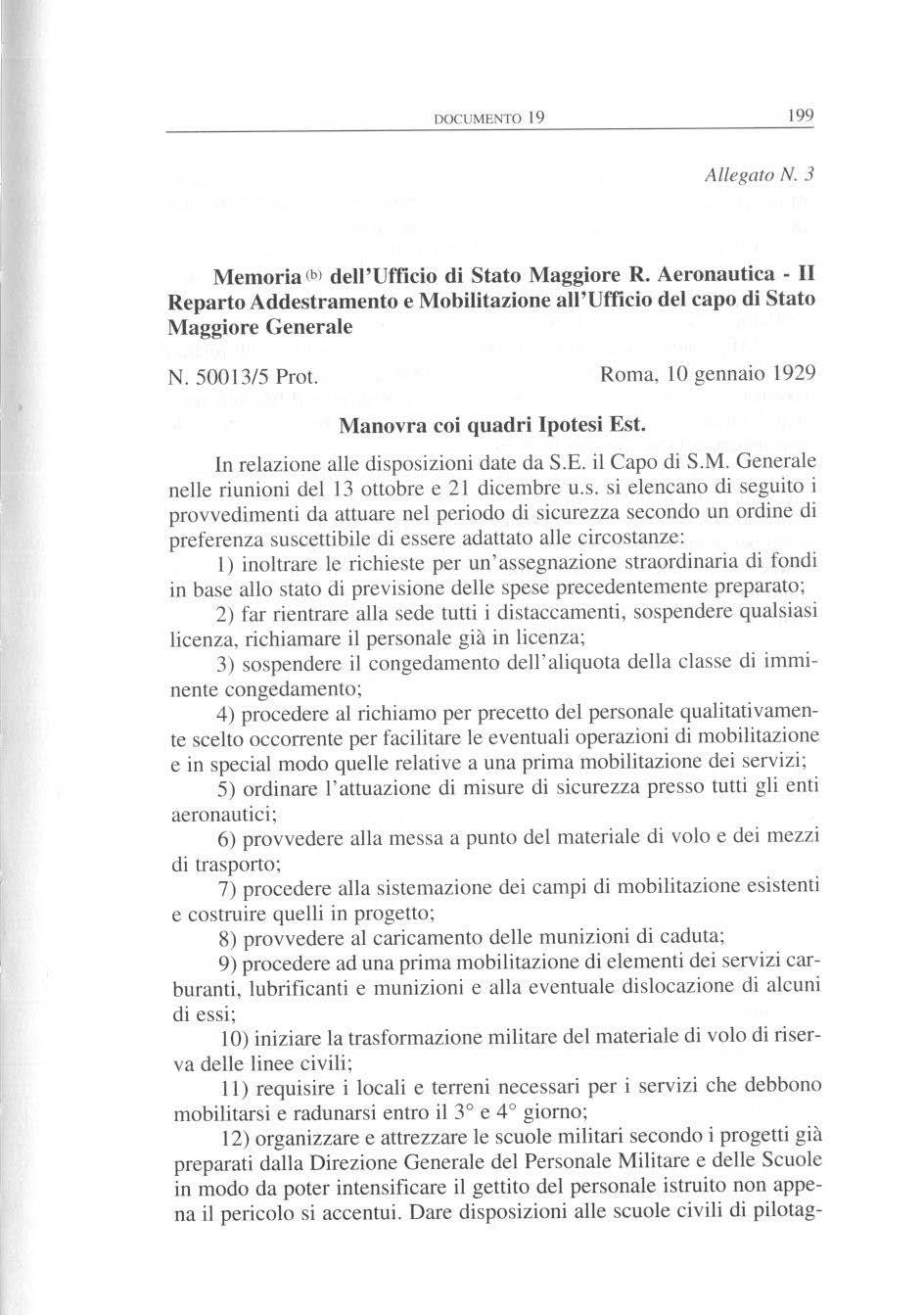
4) procedere al richiam o per precetto del personale qualitativamente scelto occorrente per facilitare le eventuali operazioni di mob ilitazione e in specia l modo que ll e relative a una prima mobi litazione dei servizi;
5) o rdinare l'attuazione di m is ure di sicurezza presso t utti gl i enti aeronautici;
6) provvedere alla me s sa a pun to del materia le di volo e dei mezz i di traspo rto;
7) procedere a ll a sistemazione de i campi d i mobilitazio ne esistenti e costruire q uelli in progetto;
8) provvedere al caricamento delle munizion i di caduta;
9) proceder e ad una prima mobi litaz ione di e leme nt i dei serv izi carburanti , lubrifica nti e munizioni e all a eventuale dislocazio ne di alcu n i d i essi;
10) i niziare la trasformazione m ili tare de l materiale di volo di riserva delle linee civili;
11) requisi re i locali e te rre n i necessari per i servizi che debbono mobilitars i e radunars i e ntro il 3° e 4 ° g io rn o;
12) or ga ni zzare e at trezzare le scuole mi litari secondo i progetti g ià pr eparat i da ll a D irezio ne Ge nera le de l Pe rsonale Mi li tar e e delle Scuole in modo d a p o te r in tensificare il getti to del pe rsonale istruit o non appen a il p erico lo si acce ntui . D are dispos iz io ni all e sc uo le civi li d i pil otag -
gio perché preparino i provvedimenti atti ad intensificare quando occorra la produzione dei piloti in base ai progetti precedentemente preparati per le singole scuole dalla predetta Direzione Generale;
13) preavvisare le ditte dei probabili ordinativi di materiali; prendere contatto con l '«Organo incaricato di provvedere alle fabbricazioni di guerra» per ricevere le direttive di competenza ai sensi della legge sul!' «Organizzazione della Nazione per la Guerra>>;
14) comunicare all' «Organo per le operazioni commerciali relative alla impo1tazione di materie prime» la nota degli acquisti necessari per costituire le scorte di materiali occoJTenti per assicurare il funzionamento e l'azione delle forze aeree nei primi 4 mesi di guerra, a conferma dei dati fomiti dal Comitato di Mobilitazione Civile;
15) predisporre la disponibilità delle materie prime e dei materiali che assicurino la possibilità di continuo incremento della produzione di materiale bellico necessario, prendendo gli opportuni accordi con I' «Organo per le operazioni commerciali relative alla importazione di materie prime» se si tratta di materie prime compresi i semilavorati, e con I' «Organo incaricato di provvedere alle fabbricazioni di guerra» se si tratta di materiali già lavorati.
A.U.S.S.M.E.,fondo H -10 «Verbali riu11io11i 1924-/943», busta 11. 2,Jascicolo 11. 4. li doc11me1110 è 1111a copia dell'Ufficio del capo di Stato Maggiore Ge11erale.
a) Cfr. il documento 11. 18.
bJ li documento è una cop ia, redatta dal/"UJ]icio del capo di Stato Maggiore Generale, di 1111 documento dello Stato Ma ggiore dell'Aeronautica.

« Preparazione della guerra contro la Jugoslavia e la Francia (ipotesi di guerra su due fronti): ripartizione delle forze, riserva, copertura alle frontiere, fortificazioni e forze mobili, hattaglioni mitragliatrici, capacità militari della Libia e delle altre colonie, impiego dell'aviazione, artiglierie».
Verbale della Riunione del 3 ottobre 1929 - VTT
SEGRETO
La riunione ha luogo nel salone antistante l'ufficio di S.E. il Capo di Stato Maggiore Generale il 3 ottobre 1929 alle ore 10.
Sono presenti:
S.E. il Maresciallo d'Italia Badoglio Capo di Stato Maggiore
Generale
S.E. il Generale Bonzani, Capo di S.M. dell'Esercito
Il Contrammiraglio Valli, Sottocapo di S.M. della Marina
li Generale di Brigata Aerea Valle, Sottocapo di S.M. dell'Aeronautica
Il Generale di Div. Pezzana, Comandante in 2a del Corpo di S.M.
Il Generale di Brigata Monti , Addetto al Comando del Corpo di S.M.
Il Colonnello di S.M. Vaccarisi, il Colonnello di S.M Guzzoni, il Colonnello di S.M. Negri e il Colonnello di S.M. Tellera, del Comando del Corpo di S .M.
Il Colonnello A.A. Faronato, dell'Ufficio di S.M. dell'Aeronautica

Il T. Colonnello di S.M. Palazzini, il T. Colonnello di S.M. Viale e il T. Colonnello di S.M. Angioj, del Comando del Corpo di S.M.
Il Capitano di Corv. Giorgis, dell'Ufficio di S.M. della Marina
Il T. Colonnello di S.M. Marras e il Cap. di Fregata de Courten, dell'Ufficio di S.E. il Capo di Stato Maggiore Generale
S.E. il Maresciallo Badoglio premette che la nuova ipotesi posta allo studio dei piani operativi deve condurre a determinare i progetti di
radunata e di schieramento in vista delle prime operazioni, dato che le operazioni successive dovranno prendere norma dalla situazione del momento.
Questa riunione è la prima che si indice dopo quelle, svoltesi nel!' autunno scorso, relative al periodo di sicurezza e dopo che il Capo del Governo notificò la situazione politica di base, prospettando l'ipotesi della guerra s u due fronti: ipotesi che è facile enunziare, ma che non riesce possibile determinare esattamente nei suoi contorni, data la difficoltà di immaginare, nel campo politico e nel campo militare , quello che potrebbe accadere per arrivare ad una situazione di questo genere. Gli Stati Maggiori sono st ati conseguentemente invitati ad effettuare lo st udio della ripartizione delle forze tra i due scacchieri e d e lle operazioni di copertura, radunata e schieramento per l'esecuzione delle prime operazioni, rimanendo inteso che le operazioni success ive dovranno prendere norma dalla situazione del momento.
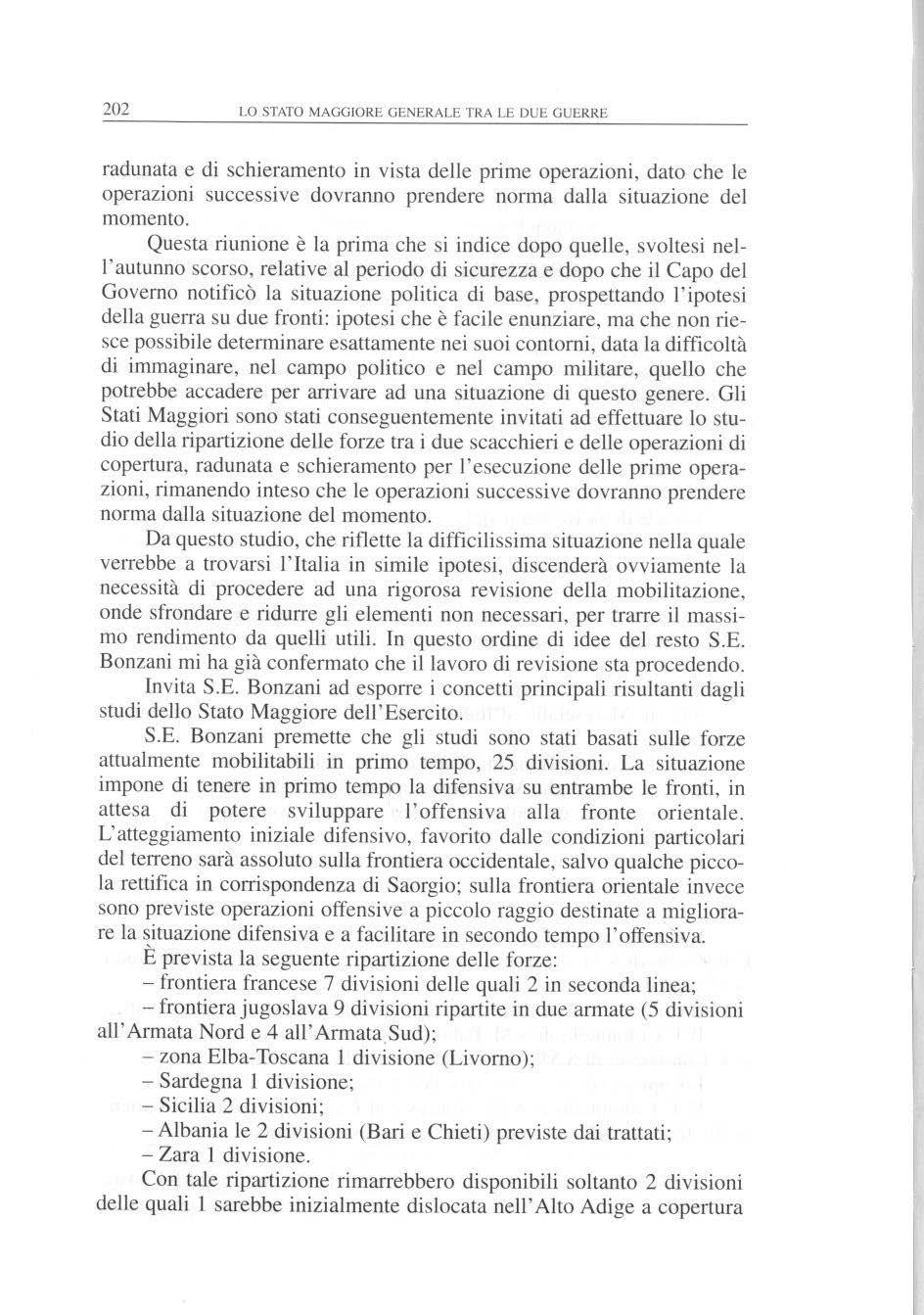
Da questo studio, che riflette la difficilissima s ituazione nella quale ve1Tebbe a trovarsi l'Italia in simi le ipotesi, discenderà ovviamente la necessità di procedere ad una rigorosa revisione della mobilitazione, onde sfrondare e ridurre gli elementi non necessari, per trarre il ma ssimo rendimento da quelli utili. Tn questo ordine di idee del resto S.E. Bonzani mi ha già confermato che il lavoro di revi s ione sta procedendo.
Invita S.E. Bonzani ad esporre i concetti principali risultanti dagli stu di dello Stato Maggiore dell'Esercito.
S.E. Bonzani premette che gli studi so no stati basati sulle forze attualmente mobilitabili in primo tempo, 25 divisioni. La situazione impone di tenere in primo tempo la difensiva su entrambe le fronti, in attesa di potere sviluppare l'offensiva alla fronte orientale. L'atteggiamento iniziale difen sivo, favorito dalle condizioni particolari del terreno sarà assoluto sulla frontiera occidentale, salvo qualche piccola rettifica in corrispondenza di Saorgio; s ulla frontiera orientale invece sono previs te operazioni offensive a piccolo raggio destinate a migliorare la s ituazione difensiva e a facilitare in secondo tempo l'offensiva.
È prevista la seguente ripartizione delle forze:
- frontiera francese 7 divisioni delle quali 2 in seconda linea;
- frontiera jugoslava 9 divisioni ripartite in due armate (5 divisio ni all'Armata Nord e 4 all'Armata .Sud);
- zona Elba-To scana l divi s ione (Livorno);
- Sardegna J divis ione;
- Sicilia 2 divisioni;
-Albania le 2 divisioni (Bari e Chieti) previste dai trattati;
- Zara l divisione.
Con tale ripartizione rimarrebbero disponibili soltanto 2 divisioni delle quali l sarebbe in izialmente dislocata nell'Alto Adige a copertura
della frontiera austriaca, e l'altra (Firenze) verrebbe dislocata nella Valle Padana u·a Brescia e Verona. Questa riserva, invero molto esigua, potrà essere aumentata entro il giugno 1930 di altre 4 divisioni.
In seguito a richiesta di S.E. Badoglio precisa che le due divisioni destinate all'Albania non hanno la formazione 0.M. ma avranno equipaggiamento da montagna e formazione adatta all'impiego in quegli speciali terreni. Comunque tale formazione rimarrebbe invariata anche se dette divisioni dovessero eventualmente operare s u altra fronte.
Parimenti s u richie sta di S.E. Badoglio informa che tutte le divisioni di confine sono rinforzate ad eccezione di quella di Gorizia; aggiunge però che le divisioni di Genova e di Cuneo sono state ridotte a 8 battaglioni (due reggimenti s u 3 e l su due) per potere portare a 8 battaglioni anche la divisione di Salerno di cui è in corso il trasferimento nella regione di Asti. Quanto ai battaglioni di camicie nere è da tenere presente che per il momento essi sono privi assolutamente di dotazioni di mobilitazione. A tali dotazioni non può provvedere l'Esercito per le difficoltà che incontra per la propria mobilitazione, né può per ora provvedere la Mili zia per mancanza di fondi.

S.E. Badoglio osserva che in sostanza la riserva sarà costituita dalle due divisioni di Bolzano e Firenze g ià accennate alle quali l'anno prossimo si aggiungeranno le altre 4 divisioni mobilitabili in primo tempo; ad esse potrebbero aggiungersi la divisione lasciata in Toscana, la quale essendo già a cavallo di una importantissima linea ferroviaria, potrebbe essere sollecitamente trasportata alla Valle Padana, e successivamente anche 1 divisione che in seco ndo tempo potrebbe essere tratta dalla Sicilia. Nel complesso la situazione non è certamente felice, ma s i può ritenere che essa permetta di ottenere una protezione sufficiente per consentire la mobilitazione delle altre divisioni. L'obiettivo al quale dobbiamo giungere è quello di potere mobilitare in primo tempo 40 divi sioni.
S.E. Bonzani osserva che in vista appunto della difficoltà che presenta la copertura di entrambe le frontiere con le sole divisioni attualmente mobilitabili ha fatto studiare la costituzione di 110 batte1ie da posizione, 7 battaglioni alpini, 69 compagnie mitragliatrici , unità tutte le quali, dislocate fin dal tempo di pace nelle zone di impiego , so no destinate a rinforzare la copertura in sostituzione in certo modo delle vecchie opere di sbarramento. Sono in corso gli s tudi per la detenninazione delle postazioni, la costruzione delle strade ecc., ma per l'attuazione di questi provvedimenti occorreranno fondi che per ora non sono ancora stati assegnati.
S.E. Badoglio, cogliendo l'occasione da questo accenno alle opere di fortificazione, ricorda che allorquando ebbe a prospettare al Capo del Governo nel 1925 la nece ss ità dell 'Esercito, distinse nettamente le spese concorrenti per l'apprestamento delle forze mobili da quelle necessarie per eventuali fortificazioni, dando l'assoluta precedenza ali' appresta-
mento del le forze mobili, anche nella considerazione che allora non erano ancora definiti i criteri circa l'organizzazione delle frontiere. Per quanto attualmente il problema di tale organizzazione sia più maturo e sia in Francia in via di soluzione e per quanto nella ipotesi di guerra che ora si studia debba apparire conveniente dare un certo sviluppo alle fortificazioni, pur tuttavia è ancora del parere che debba darsi la precedenza all'apprestamento delle forze mobili, senza impegnarsi nella costruzione di costose opere di fortificazione. L'impiego di batterie da posizione era stato studiato anche alcuni anni orsono ed erano disponibili i materiali occorrenti , ma non era stato ancora risolto il problema delle formazioni organiche corrispondenti.
S.E. Bonzani precisa che l'organizzazione difensiva in studio consisterà appunto nella co s truzione di strade e nella predisposizione di postazioni. Le batterie da posizione ve1Tanno costituite con i gruppi di artiglieria che si renderanno disponibili dopo la ce s sione alla M.V.S.N. delle batterie controaerei da posizione, e che saranno riunite in appos iti reggimenti. Le batterie e le unità mitragliatrici da posizione costituiranno un rinforzo di fuoco per le divisioni di copertura, alla cui dipendenza esse verranno a trovarsi.
I battaglioni alpini e i battaglioni mitragliatrici saranno formati con la forza esuberante dei battaglioni alpini.
S.E. Badoglio, riferendosi all'impiego dei battaglioni mitragliatrici, esprime i propri dubbi circa la convenienza della abolizione del battaglione mitragliatrici divisionale; il battaglione mitragliatrici di corpo d'armata, che si è voluto sostituire ai battaglioni divisionali, non può evidentemente rispondere, data l'estensione della fronte del corpo d'armata, a un impiego manovrato. Propone che lo S.M. dell'Esercito esamini la possibilità di rimettere allo studio la questione.
S.E. Bonzani fa osservare che nel complesso non si è avuta una diminuzione del numero delle mitragliatrici nella divisione, in quanto ad ogni compagnia mitragliatrici dei reggimenti di fanteria è stato assegnato un quarto plotone.
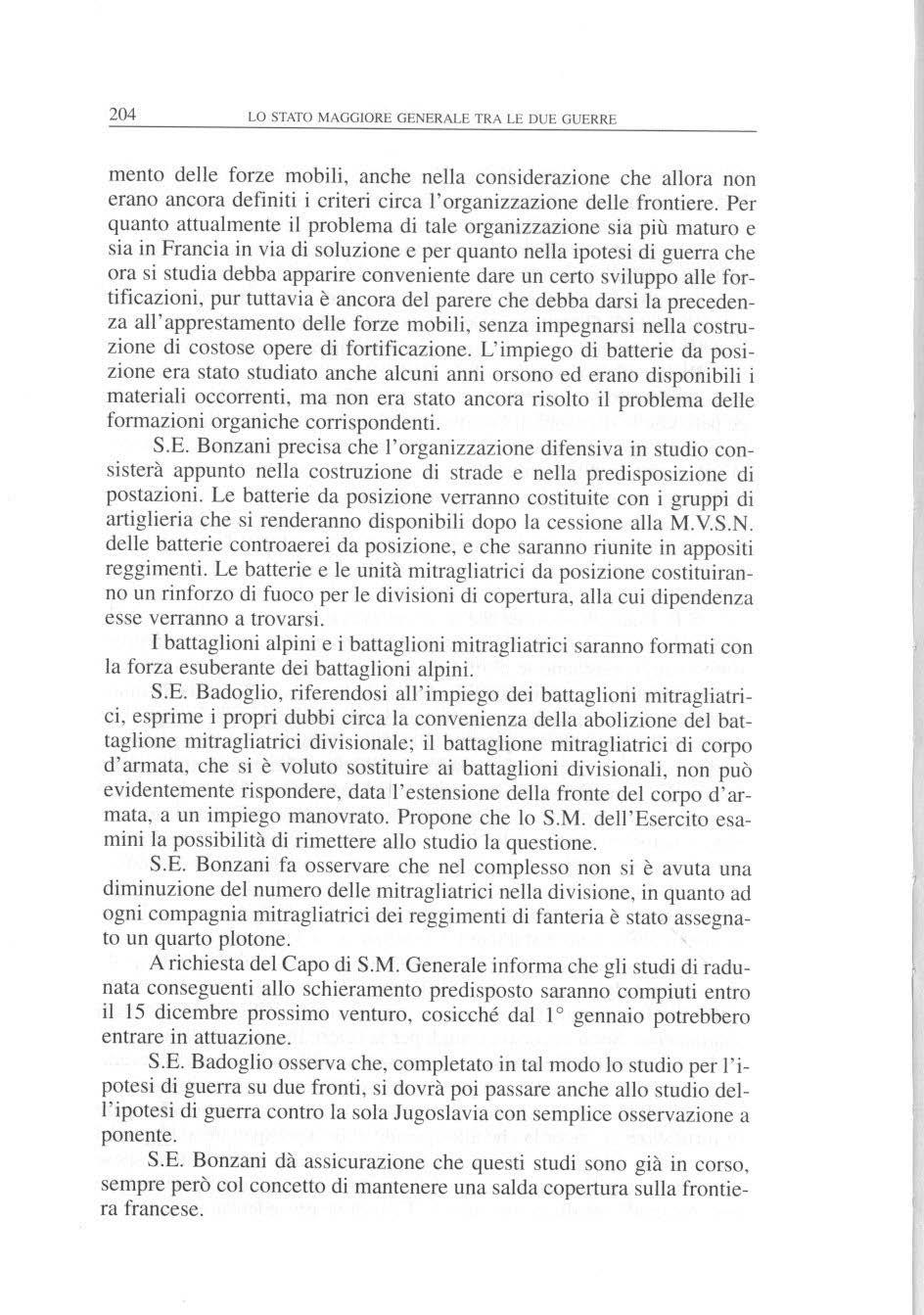
A richiesta del Capo di S.M. Generale informa che gli s tudi di radunata conseguenti allo schieramento predisposto saranno compiuti entro il 15 dicembre prossimo venturo, cosicché dal l O gennaio potrebbero entrare in attuazione.
S.E. Badoglio osserva che, completato in tal modo lo studio per l ' ipotesi di guerra su due fronti, si dovrà poi passare anche allo studio dell'ipotesi di guerra contro la sola Jugoslavia con semplice osservazione a ponente.
S.E. Bonzani dà assicurazione che questi studi sono già in corso , sempre però col concetto di mantenere una salda copertura sulla frontiera francese.
S.E. Badoglio ritiene opportuno di dare qualche comunicazione circa la capacità militare delle colonie libiche. Nella guerra mondiale esse rappresentarono una funzione negativa, assorbendo forze metropolitane. Entro giugno dell'anno venturo, sarà compiuta l 'occupazione delle due colonie, sino alle oasi di Cufra, Tummo, Ghat e Ghadames. Si entrerà così in una seconda fase nella quale le due colonie potranno militarmente bastare a sé stesse. Non è il caso di precorrere gli avvenimenti indicando quando le colonie stesse potranno diventare attive, ma può fin d'ora informare che sul Gebel tripolino sono stati prenotati 12.000 berberi, i quali potrebbero essere mobilitati in 24 ore. Questo provvedimento pare abbia destato qualche preoccupazione nei francesi, ma per il momento è certo che le forze libiche non sarebbero in grado di imprendere operazioni di qualche importanza oltre il confine né inviare forze alla madre patria.
S.E. Badoglio invita il Generale Valle ad esporre lo stato degli studi dell'Aeronautica in questa ipotesi di conflitto.
Il Generale Valle premette che gli studi sono stati basati sulle disponibilità attuali, le quali date le notevoli commesse in corso potranno aumentare entro il 30 giugno prossimo dal 20 al 25%. Queste maggiori disponibilità verranno impiegate per aumentare il numero degli apparecchi di ogni squadriglia, lasciando per ora invariato il numero delle squadriglie.
La dpa1tizione dell 'armata aerea, nei riguardi degli apparecchi eia caccia, è stata previs ta come segue: s u una disponibilità di 312 apparecchi da caccia terres tri, 160 saranno concentrati sulla fronte ovest per impedire incursioni aeree nemiche, 60 saranno dislocati s ulla fronte est ed il rimanente centinaio verrà adibito per la difesa del territorio, studiandone la dislocazione e l'impiego secondo il criterio di concentrare gli sforzi, e non di disseminarli.
S.E. Badoglio osserva che, date le direttive operative dell'Esercito, le quali prevedono atteggiamento difensivo ad ovest ed azione offensiva ad est, è lecito chiedersi se la ripartizione delle forze aeree eia caccia sia strettamente aderente alle esigenze dell'Esercito: prospetta quindi l'opportunità che il problema venga riesaminato in pieno accordo fra Esercito ed Aeronautica.
Il Generale Valle riferisce che, nei riguardi del bombardamento, è stato stabilito il criterio di massima di evitare lo sparpagliamento delle forze, dato che le azioni di bombardamento, per essere efficaci, devono essere svolte con l'impiego di forti masse e devono essere ripetute con continuità. In questo ordine di idee è stato stabilito di dislocare la massa di apparecchi da bombardamento terrestri (200 velivoli) in una zona centrale (Parma, Ferrara, Poggiorenatico, Borgo Panigale) e di predisporre un certo numero di campi di rifornimento rispettivamente sulle fronti est

ed ovest, in modo che gli apparecchi da bombardamento , trasferitisi in essi nel pomeriggio, possano, a seco nda della specialità, ripartirne per effettuare le loro azioni durante la notte ed all'alba, facendo poi ritorno ai campi di base della zona centrale.
Il Generale Valle fa presente che, non potendo nelle attuali condizio ni gli apparecchi da bombardamento oltrepassare le Alpi occidentali, nella preparazione di questi campi di rifornimento è s tata data la precedenza a quelli s ulla frontiera orientale, nonché a quelli della zona Toscana , dai quali sarà po ssibile svo lgere azioni metodiche di bombardamento contro le basi aeree nemiche esistenti in Corsica, come quelle da cui può provenire una diretta minaccia contro l'Italia centrale e contro la Capitale.
Per quanto riguarda il bombardamento marittimo, esso sarà scaglionato fra Stagnoni (3 squadriglie) , Elmas (3 squadrig lie) e Spezia (4 sq uadriglie): tale massa avrà il compito di operare, d'accordo con la Marin a, contro le linee di comunicazione tra la Francia e le Colonie e contro le basi navali avversarie, nonché di effettuare azioni di bombardamento contro la Corsica con un movimento di va e vieni fra EJmas e Spezia.
A richiesta di S.E. Badoglio precisa che i campi s ulla frontiera est sono già pronti o quasi e che quelli su lla frontiera ovest saranno completati entro il 1930: le basi dell 'idro-bombardamento saranno pronte nel 1931.
Accenna poscia alle condizioni di approntamento, in cui devono trovarsi tali campi fin dal tempo di pace nei riguardi dei materiali di rifornimento e del munizionamento di caduta. Prospetta le due possibili so luzioni: quella di predisporre ogni cosa fin dal tempo di pace e quella di provvedere in merito durante la fase di sicurezza, mettendo in evidenza che quest'ultima soluzione richiederà una cospicua quantità di traspo 11i , in una fase nella quale i trasporti stessi potranno interferire con quelli di radunata.
S.E. Badoglio nota che l'aviazione deve iniziare lo svolgimento della sua attività fin dai primi istanti di ostilità: d'altra parte le inevitabili esigenze della mobilitazione e radunata dell'Esercito importano già la quasi completa saturazione del servizio ferroviario. Occorre quindi che nei campi di frontiera siano concentrati i materiali di rifornimento e il munizionamento necessari , per assicurare almeno qualche giorno di attività delle forze aeree ad esse appoggiate. Il raggiungimento di questo obiettivo deve pa ssare in prima linea, ricorrendo se del caso ad economie in altri serviz i, pur di garantire la perfetta efficienza dei campi di frontiera.

Il Generale Valle informa che anche S.E. il Ministro Balbo è di questo preciso parere, compatibilmente con le disponibilità finanziarie.
S.E. Badoglio approva conseguentemente il concetto della massa da bombardamento dislocata in zona centrale con i campi di frontiera
approntati per il rifornimento, e condivide il criterio di graduare la loro preparazione nel seguente ordine: frontiera est, zona Toscana, frontiera ovest.
A richiesta del Generale Valle precisa che in tempo di guerra le direttive operative per l'impiego dell'armata aerea saranno impartite dal Comando Supremo, il quale evidentemente stabilirà gli obiettivi in relazione all'entità della massa aerea disponibile ed al le possibilità, commisurate anche alle richieste avanzate dalle forze armate.
I1 Generale Valle informa che per l'Albania è a buon punto la preparazione, giustificata dalle necessità dell'aeronautica civile, di una buona rete di campi, con centro Tirana e campi di fortuna in altre loca1ità (Goritza, Scutari, Elbassan). Per altro, dovendo la massa aerea destinata ali' A lbania venire tratta dalle nostre forze, già esigue, non risulta possibile per ora provvedere all'invio in Albania di un distaccamento di forze aeree.
È da ricordare anche che le riserve di materiale sono molto scarse o nulle. Esiste munizionamento di caduta per circa due mesi di attività, ma mancano le mitragliatrici, cartucce, ecc.
S.E. Badoglio osserva che la questione delle riserve di apparecchi ha, nelle attuali condizioni nostre, un ' importanza limitata, apparendo dubbio se convenga immobilizzare energie e mezzi finanziari in materiali di rapido deterioramento. Viceversa nota l'assoluta nece ss ità che le que s tioni delle mitragliatrici, del munizionamento di lancio , ecc. siano affrontate e risolte al più pres to.
Il Generale Valle comunica che nei riguardi della ricognizione sono previste 20 squadriglie per l ' Esercito e 13 per la Marina e sono già predisposti tutti i movimenti da eseguire in fase di sicurezza per l 'approntamento e la dislocazione di queste unità.
D à poi assicurazione a S.E. B adoglio che gli studi relativi a ll e predisposizioni ora accennate sono in corso e saranno certamente terminati per il 30 g iu g no 19 30, epoca nella quale l'efficienza dell'Aeronautica risulterà sensibilimente migliorata rispetto ad ora.
Su richiesta di S.E. il Capo di Stato Maggiore Generale S.E. Bonzani inform a:
- disponiamo attualme nte d i circa 5.400 mitragliatrici leggere; ne occorrerebbero altre 15.000 che dovrebbero essere di un unico tipo non ancora definito, ma che dovrà essere determinato entro il 20 novembre p.v.;
- disponiamo di 500 .000 .000 di cartucce delle quali circa metà residuate di guerra ma riordinate; altre 70 .000.000 devono essere fabbricate;
- non è stato ancora definito il tipo di bomba;
- si sta provvedendo gradatamente a sostituire nei reggimenti di artiglieria divisionali un gruppo di canno ni da 75/27 con un gruppo

someggiato da 75/13, impiegando i gruppi da 75/27 che si renderanno così disponibili, per costituirne artiglierie autoportate;
- s i sta rimettendo in efficienza il munizionamento di artiglieria; si ritiene che per il J 931 potrà aversi disponibile tutto il munizionamento di primo tempo, salvo qualche deficienza per i materiali da 100 e da 105;
- disponiamo di una piccola aliquota di proietti a gas, circa 1/2 giornata di fuoco in condizioni non buone di conservazione; occorrerebbero 20 milioni per poter approntare due giornate di fuoco;
- disponiamo di 600.000 maschere attualmente concentrate in un solo deposito, ma esse dovranno essere prossimamente ripat1ite fra i centri di mobilitazio ne.
S.E. Badoglio richiama l'attenzione di S.E. Bonzani s ulla opportunità di riprendere io esame la questione dell'equipaggiamento della fanteria, ritenendo che la abolizione dello zaino non sia scevra di inconvenienti. Richiama parimenti l'attenzione su lla necessità di commisurare i depositi di munizioni a gas alle possibilità di conservazione delle sostanze tossiche, che episodi recenti parrebbero mettere in dubbio, come pure sulla necessità di compiere con le truppe esperimenti di impiego di maschere per grandi spostamenti.
S.E. Bon zani informa che esperimenti d'impiego di maschere dovranno essere fatti prossimamente, dopo che le maschere stesse saranno distribuite ai centri di mobilitazione.
S.E. Badoglio coglie l'occasione da questa riunione per fare osservare che vari studi che sono stati fatti compiere in passato e che potranno esse re compiuti anche in avvenire circa patticolari operazioni non debbono essere interpretati co me rispondenti a una sua visione operativa sibbene come st udi diretti a esaminare le varie possibilità per trarne gl i elementi di decisione a tempo opportuno. Così ad es i vari studi compiuti circa operazioni offensive partenti da Novi-Segna o da Zara o dal!' Albania non infirmano la conclusione che trae fin d 'o ra che nel caso di offensiva con forze limitate sulla fronte jugoslava lo sforzo principale debba partire dalla base Mosic-Pomario.
Prima di chiudere la riunione S.E. il Capo di S.M. Generale ri chiama l'attenzione degli Stati Maggiori su due punti:
l) che gli venga no fatti pervenire periodicamente informazioni sostanzia li su llo stato di efficienza delle forze ai,nate;
2) che gli ve ngano fatte proposte relative ad eventuali esigenze di addestramento, soprattutto in vista di eventua li esercitazioni combinate.

« Preparazione della guerra contro la Jugoslavia e la Fran c ia ( Ipotesi di guerra su due fronti): impiego della Marina (ipotesi di a zione nemica, ipotesi di opera z ioni di nostra iniz iativa nel Tirreno, Adriatico, Egeo e Mar Rosso, organizzazione e disloca zione della flotta). Futuri studi affidati agli Stati Maggiori: opera zioni con la massa d elle for ze sulla frontiera est con leggera copertura a ovest e viceversa con la massa a Ovest e copertura a est».
Verbale della Riunione del 4 ottobre 1929 - VII
La riunione ha luogo nel salone antistante all'ufficio di S.E. il Capo di S.M. Generale il 4 ottobre 1929, alle ore 10.

Sono presenti le stesse autorità indicate nel verbale della riunione del 3 ottobre c.m. <aJ
S.E. il Capo di Stato Maggiore Generale invita l'Ammiraglio Valli ad esporre lo stato degli studi della Marina nella ipotesi di conflitto che viene ora esaminata.
L'Ammiraglio Valli espone i concetti fondamentali di azione delle forze navali, in base alle direttive ricevute dal Capo di S.M.G.
Tali concetti sono subordinati alla consistenza delle forze navali francesi - le quali sono dislocate nella loro quasi totalità nel Mediterraneo, pur supponendo che un nucleo di unità antiquate (la 2• squadra) sia tenuta in Atlantico - ed alle possibilità di azione del nemico. Queste possono essere sintetizzate affermando che il nemico svolgerà verosimilmente una energica offensiva sul mare coi seguenti obiettivi:
a) provocare azioni decisive tra le forze navali;
b) tagliare il traffico marittimo dell'Italia.
Nell'ordine di idee del comma a) sembra che la Francia, in relazione ai nostri trasporti in corso nel basso Adriatico ed alle condizioni di efficienza delle nostre forze navali (tabelle di pace ed effettivi ridotti), possa aprire le ostilità con un'incursione in forze nello Jonio e nel basso Adriatico, coprendo così anche l'invio di un nucleo navale in rinforzo
della Marina jugoslava, tanto più che questa operazione potrebbe costituire una protezione indiretta dei trasporti di truppe dall 'Africa del nord nella Metropoli.
Inoltre , specie se la situaz ione politica consentirà alla Francia una certa disponibilità di forze terrestri, si può pensare ad un suo tentativo di occupazione di una delle nostre maggiori isole, con lo scopo di provocare azioni navali, come di facilitare l'isolamento marittimo dell'Italia.
È altresì presumibile che la Francia inizi sin dal principio del conflitto le operazioni per l'attacco al traffico, mediante linee di crociera nel Mediterraneo occidentale ed impiego di so mmergibili nel Mediterraneo orientale.
Infine saranno probabili anche le seguenti azioni minori:
a) sbarco di cooperazione lattica con l'esercito nella zona di Taggia;
b) tentativo di occupazione dell'isola d'Elba;

c) azioni di sorp resa sull'estuario di Maddalena;
d) bombardamento navale dei cantieri liguri , in concorso ad azioni offensive aeree.
Quanto al teatro di guerra orientale è probabile che la Marina jugoslava, seb bene dotata di scarsi mezzi, agirà contro i trasporti di truppe dirette a Zara e in Albania.
In relazione a ciò, e considerando che il problema della protezione del traffico assumerà carattere di capitale importanza solo col prolungarsi delle ostilità, risulta evidente la necessità che la Marina , pur avendo una finalità difen siva, contrasti attivamente gli obiettivi dell 'avversario, traendo profitto di ogni favorevole occasione, e prenda l'iniziativa per quelle operazioni che offrono le possibilità di migliorare la nostra situazione marittima.
Le operazioni di nostra iniziativa saranno le seguenti:
- Mediterraneo occidentale:
1) azioni contro il trasporto delle truppe francesi allraverso il Mediterraneo occidentale, trasporto il quale potrebbe avere grande importanza rispetto ali' andamento generale della guerra: perciò la nostra Marina dovrà vigorosamente contrastarlo con sommergibili e con incursioni di naviglio di s uperficie; dola.
2) tentativo di rendere mal sicura la base di Biserta, imbottiglian -
- Adriatico:
3) appoggio all'ala destra dell ' Esercito sulla fronte giulia;
4) trasporto di truppe a Zara e concorso alle operazioni per consolidarne il possesso;
5) trasporto di truppe in Albania;
6) incursioni aeree e navali su Spalato, Metkovic e Cattaro per distruggervi le unità navali avversarie;
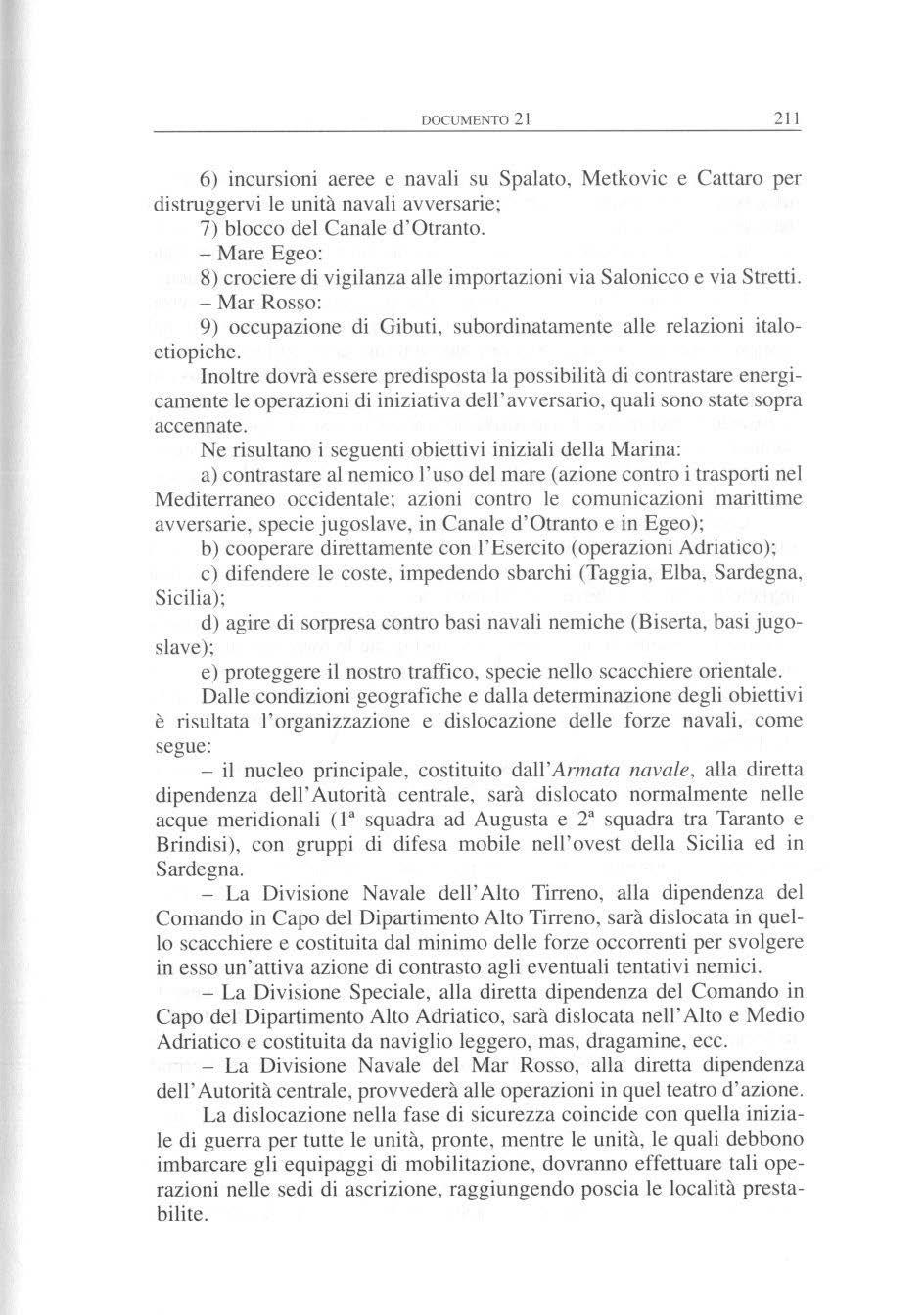
7) blocco del Canale d'Otranto.
-Mare Egeo:
8) crociere di vigilanza alle importazioni via Salonicco e via Stretti.
- Mar Rosso:
9) occupazione di Gibuti, subordinatamente alle relazioni italoetiopiche.
Inoltre dovrà essere predis po sta la possibilità di contrastare energicamente le operazioni di ini z iati va dell'avversario , quali sono state so pra accennate.
N e risultano i seguenti obiettivi iniziali della Marina:
a) contrastare al nemico l ' uso del mare (azione contro i trasporti nel Mediterraneo occidentale; azioni contro le comunicazioni marittime avversarie, specie jugoslave, in Canale d ' Otranto e in Egeo);
b) cooperare direttamente con l 'Esercito (o perazio ni Adriatico);
c) difendere le coste, impedendo sbarchi (Taggia, Elba. Sardegna, Sicilia);
d ) agire di sorpresa contro basi navali nemich e ( Biserta , basi jugos lav e);
e) proteggere il no stro traffico, specie nello scacchiere orientale. Dalle condizioni geografiche e dalla determinazione degli obiettivi è risultata l'organizzazione e dislocazione delle forze navali , co me segue:
- il nucleo principale, costituito dall 'Arma ta navale , alla diretta dipendenza dell'Autorità centrale, sarà di s locato normalmente nelle acque meridionali ( 1a squadra ad Augusta e 2a s quadra tra Taranto e Brindisi) , con gruppi di difesa mobile nell ' ove s t della Sicilia ed in Sardegna.
- La Divisione Navale dell'Alto Tirreno, alla dipendenza del Comando in Capo del Dipartimento Alto Tirreno, sarà dislocata in quello sc acchiere e costituita dal minimo delle forze occorrenti per svolgere in esso un'attiva azione di contrasto agli eventuali tentativi nemici.
- La Divisione Speciale, alla diretta dipendenza del Comando in Capo del Dipartimento Alto Adriatico. sa rà dislocata nell'Alto e Medio Adriatico e costituita da naviglio leggero, mas, dragamine , ecc.
- La Divisione Navale del Mar Rosso, alla diretta dipendenza dell ' Autorità centrale, provvederà alle operazioni in quel teatro d'azione.
La dislocazione nella fase di sicurezza coincide con quella iniziale di guerra per tutte le unità , pronte, mentre le unità , le quali debbono imbarcare gli equipaggi di mobilitazione, dovranno effettuare tali operazioni nelle s edi di ascrizione, raggiungendo poscia le località prestabilite.
Naturalmente questa dislocazione iniziale non deve ritenersi tassativa, potendo i comandi navali modificarla, a mobilitazione compiuta, in base alle contingenze.
S.E. il Maresciallo Badoglio, preso atto delle comunicazioni fatte dallo Stato Maggiore della Marina, desidera precisare i seguenti punti: L'attitudine difensiva, imposta dal1a presente ipotesi di guerra, deve essere interpretata con raziocinio; essa ha valore assoluto nel campo strategico, ma deve ricevere una interpretazione molto larga nel campo tattico, particolarmente nella guerra marittima. Non è esclusa la possibilità di ottenere qualche successo parziale anche con forze minori, ma evidentemente risultati positivi non potranno es sere conseguiti col semplice impiego di sommergibili e di siluranti; a tempo e luogo occorrerà impegnare anche naviglio leggero e maggiore, affrontando gli eventuali rischi.
La dislocazione proposta per le forze navali consente di attuare questo concetto, in misura tanto più larga quanto più si rafforzerà il nucleo efficiente della prima squadra con l'entrata in servizio delle unità leggere e sottili attualmente in costruzione.
In sostanza ritiene che ali' inizio delle operazioni potrà aprirsi per la Marina un periodo di operazioni attive nel quale le forze navali dovranno agire, mirando, non alla guerra di attrito per ottenere il pareggio delle forze , ma al conseguimento di obiettivi concreti, tenendo conto del fatto che la Francia non potrà fare a meno del le sue linee di comunicazione mediterranee.
Non ritiene probabile che la Francia voglia, ali' inizio delle ostilità , e seguire un'incursione in forze nel bacino ionico, per provocare la nostra flotta e per coprire l ' invio in Adriatico di un nucleo di forze navali: comunque, se le forze navali francesi tentassero ciò, pare dubbio se potrebbero raggiungere i loro obiettivi. Non sembra quindi che la nostra Marina debba, nella dislocazione iniziale delle proprie forze , preoccuparsi eccessivamente della eventualità sopraccennata. Appare invece assai probabile che le forze navali jugoslave, pur limitate, agiranno per ostacolare le operazioni di trasporto di nostre forze a Zara ed in Albania.
Per quanto riguarda la protezione del traffico , S.E. Badoglio esprime il parere che essa costituisca un problema di secondo tempo, in quanto le riserve della Nazione permettono certamente di vivere per qualche tempo ed esimono la Marina da preoccupazioni al riguardo nel primo periodo della guerra: questo deve essere invece sfruttato dalle no s tre forze nava li per ostaco lare le azioni di trasporto delle truppe nord-africane.
In sostanza la situazione delle forze navali italiane rispetto a quelle francesi verrebbe a presentare qualche analogia, sia nel rapporto di forze come negli obiettivi iniziali, con quella delle forze navali germaniche

rispetto a quelle inglesi al principio dell'ultima guerra: anche in questo caso infatti si può ritenere che una delle operazioni più redditizie della Marina germanica sarebbe stata l'azione contro il trasporto delle truppe inglesi attraverso la Manica. La Marina italiana si trova in condizioni similari nei riguardi del trasporto delle forze francesi del Nord Africa, forze le quali devono ritenersi indispensabili per la Francia. In questo stesso ordine di idee occorrerà che Marina ed Aeronautica st udino di comune accordo le operazioni da effettuare, in modo da ottenere il massimo rendimento della cooperazione delle Forze Annate. Per quanto riguarda l'operazione di Gibuti, fa presente che l'esiguità delle no stre forze nella Colonia Eritrea non ci permetterà di tentarla se non si abbiano garanzie sicure circa l'atteggiamento dell'Impero Etiopico. L'operazione di Gibuti pertanto dovrà essere studiata, senza peraltro farvi assegnamento.
S.E. Badoglio non ritiene probabile che l'avversario tenti grandi operazioni di sbarco al solo scopo di attirare la nostra flotta; è evidente infatti che in una operazione siffatta la copertura dei convogli delle truppe di sbarco e delle successive linee di rifornimento impone alla flotta attaccante vincoli così grandi da limitarne notevolmente la libertà di manovra.
S.E. Badoglio raccomanda infine che le operazioni di mobilitazione e di radunata delle forze navali vengano accelerate per quanto possibile, in particolar modo per le unità che dovrebbero agire in primissimo tempo.
S.E. il Capo di Stato Maggiore Generale, chiuso l'esame degli studi prospettati dagli Stati Maggiori , invita i Capi di Stato Maggiore a proseguire alacremente lo studio dei trasporti di radunata per l'E se rcito e delle disposizioni per lo schieramento iniziale delle altre Forze Armate , facendogli conoscere i tempi occorrenti per la mobilitazione e l'intera radunata, nella ipotesi che manchi completamente un periodo di sicurezza antecedente alla dichiarazione di guerra. Successivamente, sulla base degli s tudi già compiuti circa le operazioni attuabili in periodo di s icurezza, dovranno essere determinati e comunicati i dati di tempo corrispondenti alle ipotes i che si possa disporre in un periodo di sicurezza della durata di due , quattro e sei giorni.
Comunque, nel computo di questi dati di tempo, si tenga margine sufficiente per eventuali ritardi che l'intervento dell'Arma Aerea dove oggi far ritenere più probabili che in passato.
Gli studi ora fatti, in base all'ipotesi di guerra contemporanea su due fronti rappresentano, come ha avuto occasione di accennare più volte, una ipotesi estrema. Occorre prendere in considerazione anche altre ipotesi. Perciò gli Stati Maggiori, compiuti gli studi ora in corso, passeranno allo studio delle due seguenti ipotesi:

- operazioni con la massa delle forze sulla frontiera orientale con leggera copertura a occidente;
- operazioni con la massa delle forze sulla frontiera occidentale con leggera copertura ad oriente.
Questa ora indicata è la successione da dare agli studi. Non si vede per il momento la necessità dello studio delle operazionj sulla frontiera nord, il quale può perciò essere rimandato a tempi successivi.
S.E. il Capo di Stato Maggiore Generale informa che, sulla base di quanto gli Stati Maggiori hanno comunicato in queste riunioni, e di quanto egli stesso ha stabilito, riferirà a S.E. il Capo del Governo, dando assicurazione che-per il 1° luglio p. v. saranno completati gli studi e le predisposizioru per l ' attuazione della mobilitazione e della radunata nel!' ipotesi cli guerra su due fronti. Tali s tudi sono basati sulla disponibilità di forze indicata dai vari SS.MM. (per l'E sercito 29 divisioni) ; e saranno a mano a mano aggiornati e modificati in base al successivo incremento delle forze mobilitabili in primo tempo.
Annunzierà contemporaneamente al Capo del Governo che a seguito degli studi ora in corso gli Stati Maggiori compileranno gli studi relativi alle altre due ipotesi.
Prima di chiudere la riunione S.E. il Capo di Stato Maggiore Generale richiama l'attenzione sulla necessità che in merito alla materia trattata in queste riunioni alle quali ha partecipato un numero notevole di persone venga mantenuto il segreto più assoluto. Rinnova infine la preghiera agli Stati Maggiori di tenerlo a giorno, mediante periodiche informazioni succinte ma sostanziali, circa l'efficienza delle nostre Forze Armate e di quelle dei probabili avversari.
La seduta è chiusa alle ore 11 ,30.
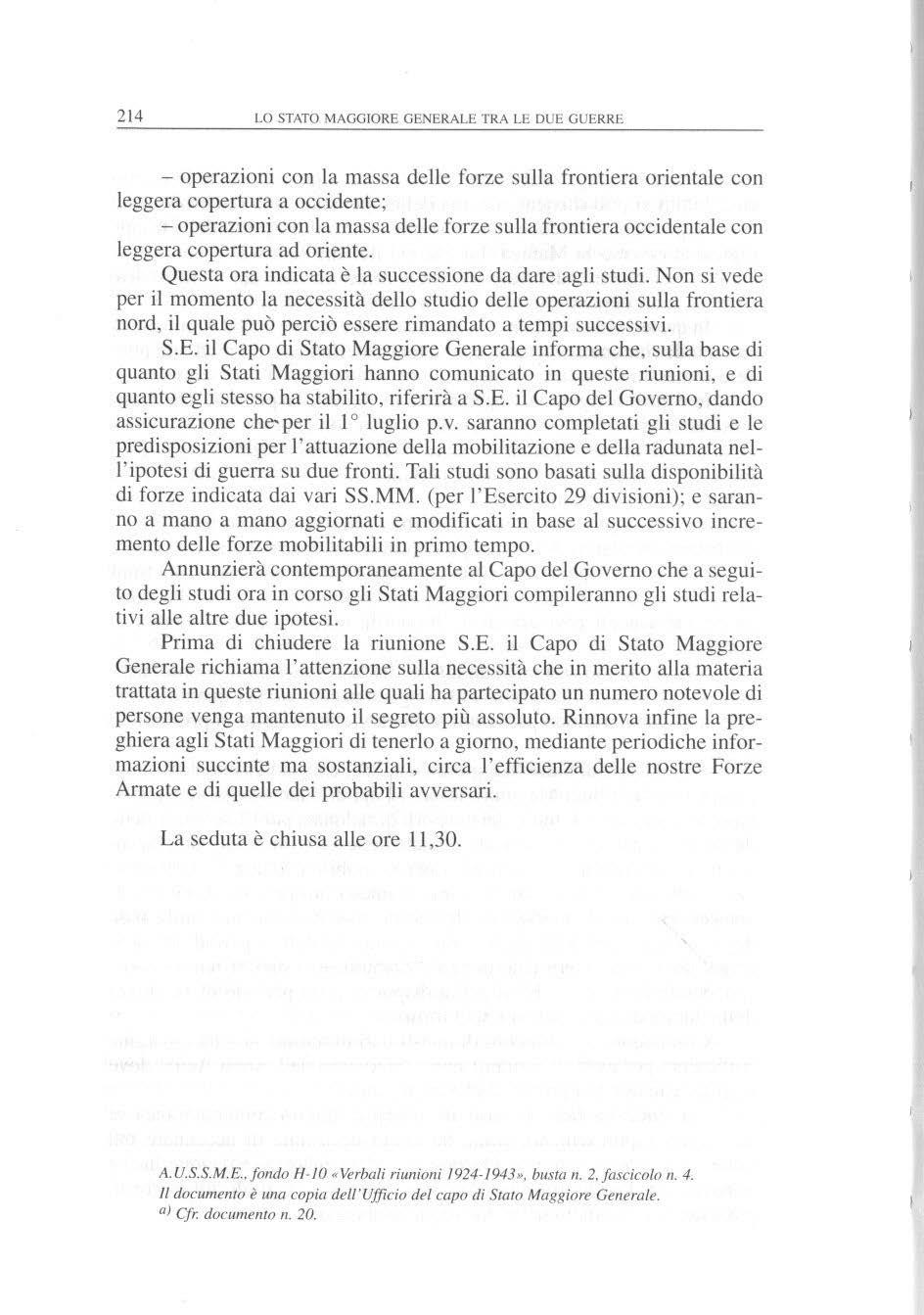
«Aeronautica: for za delle squadriglie, proporzione delle varie specialità, rela zioni di dipenden za dell'avia z ione dell ' Esercito e della Marina (portaerei) dall'Aeronautica, avia zione da cacc ia e armata aerea, avia z ione da ricogniz ione terrestre e marittima.
Fun zioni militari d ell e colonie (Libia) e delle isole d ell'Eg eo »
Verbale della Riunione dell ' 8 aprile 1930- VTTI
La riunione ha luogo nel salone antistante all'ufficio di S.E. il Capo di Stato Maggiore Generale 1'8 aprile 1930. alle ore 9,30.
Sono pres e nti:
S.E. il Maresciallo d'Italia Badoglio del Sabotino, Capo di Stato Maggiore Generale
S.E. il Generale di C.d' A. Bonzanì Alfredo, Capo di Stato Maggiore dell'Esercito
Il Contrammiraglio Valli Giulio, Sottocapo di S.M. della Marina
TI Generale di Brigata Aerea Valle Giuseppe, Capo dì S.M. dell'Aeronautica
11 Generale di Brigata Monti Edoardo, Addetto al Comando del Corpo di S.M.
Il Colonnello A.A. Martucci Mario, dell'Ufficio di S.M. della R. Aeronautica
Il Capitano di Corvetta Catalano Gonzaga Gaetano, dell'Ufficio di S.M. della R. Marina
11 T. Colonnello di S.M. Marras Efisio, il T. Colonnello A.A. Pinna Pietro e il Capitano di Fregata Mengoni Guido, dell'Ufficio del Capo di Stato Maggiore Generale

S.E. il Maresciallo Badoglio comunica quanto segue:
Sentiti i Capi di Stato Maggiore e preso in attento esame quanto essi hanno esposto nei promemoria comunicatimi e nella corrispondenza fra loro intercorsa, sono venuto alle seguenti conclusioni:
1) Come primo provvedimento ritengo indispensabile che le squadriglie di tutte le specialità di aviazione siano portate e mantenute al loro
completo organico e che ogni squadriglia disponga di una conveniente aliquota di apparecchi di riserva.
L'organico delle squadriglie delle varie specialità rimarrebbe determinato nel modo seguente:
Negli organici ora indicati non sono compresi gli apparecchi di riserva, il cui numero verrà determinato dall'Aeronautica, in accordo, per le aviazioni ausiliarie, anche con l'Esercito e con la Marina, in base all'effettivo delle squadriglie e al grado di usura cui sono esposte le singole specialità.
2) Tenuto conto delle richieste degli Stati Maggiori e ben considerate le necessità relative delle singole specialità, ritengo che la proporzione più conveniente fra di esse , riferita al numero delle squadriglie, sia la seguente:
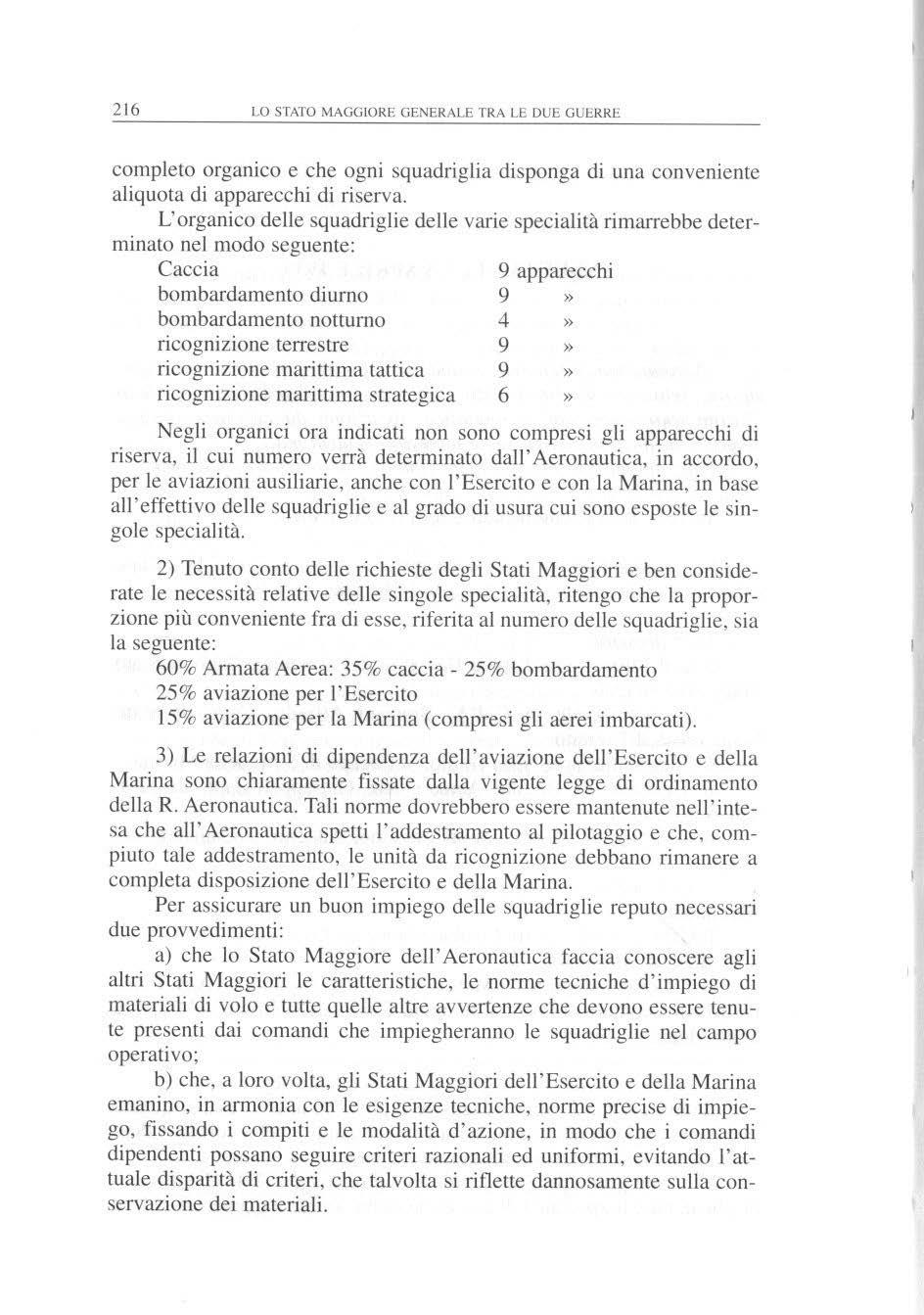
60% Armata Aerea: 35% caccia - 25% bombardamento
25% aviazione per l'Esercito
15% aviazione per la Marina (compresi gli aerei imbarcati).
3) Le relazioni di dipendenza dell'aviazione dell'Esercito e della Marina sono chiaramente fissate dalla vigente legge di ordinamento della R. Aeronautica. Tali norme dovrebbero essere mantenute nell'intesa che all'Aeronautica spetti l'addestramento al pilotaggio e che, compiuto tale addestramento, le unità da ricognizione debbano rimanere a completa disposizione dell'Esercito e della Marina.
Per assicurare un buon impiego delle squadriglie reputo necessari due provvedimenti:
a) che lo Stato Maggiore dell'Aeronautica faccia conoscere agi i altri Stati Maggiori le caratte ristiche, le norme tecniche d'impiego di materiali di volo e tutte quelle altre avvertenze che devono essere tenute presenti dai comandi che impiegheranno le squadriglie nel campo operativo;
b) che, a loro volta, gli Stati Maggiori dell'Esercito e della Marina emanino, in armonia con le esigenze tecniche, norme precise di impiego, fissando i compiti e le modalità d'azione, in modo che i comandi dipendenti possano seguire criteri razionali ed uniformi, evitando l'attuale disparità di criteri, che talvolta si riflette dannosamente sulla conservazione dei materiali.
Nell'ordine di idee ora esposto ritengo che debba essere mantenuta integra la competenza esclusiva del!' Aeronautica nella formazione dei piloti e che pertanto debba l'Aeronautica provvedere anche i piloti che, imbarcati su speciali apparecchi monoposti assegnati all'Esercito o alla Marina, dovessero avere particolari requisiti. L'Aeronautica, per sua parte, dovrà tenere conto di tali requisiti per regolare in corrispondenza l'addestramento di tali piloti.
4) È mio parere che sia da escludere il frazionamento della caccia e che essa debba perciò far parte totalmente dell'Armata Aerea. Sarà funzione del Comando Supremo delle Forze Armate determinare in quali casi la ricognizione debba essere protetta dalla caccia e coordinare, all'occorrenza, il bombardamento aereo con le azioni terrestri o marittime. Tale concezione risponde a una nece ssi tà di economia dei mezzi ed è stata già sancita dalla nostra esperienza dell'ultimo anno di guerra durante il quale la costituzione delle due masse da caccia e da bombardamento, sottratte alle rumate e tenute alla diretta dipendenza del Comando Supremo, consentì di trarre dalla nostra aviazione il massimo rendimento.

5) È mio avviso che, nella determinazione delle caratteristiche dei nuovi materiali da ricognizione, si debba provvedere al loro efficace armamento; ciò sia per considerazioni d'ordine materiale , inerenti alla difesa degli apparecchi, sia, e in maggior misura, per considerazioni d'ordine morale, le quali richiedono anche negli equipaggi da ricognizione un elevato spirito offensivo.
S.E. Bonzani fa presente che interessa allo Stato Maggiore dell 'Ese rcito conoscere s u quante ore di volo delle squadriglie da ricognizione potrà farsi assegnamento, in modo da poterne regolare convenientemente l ' impiego.
S.E. Valle comunica che in pratica, nei termini imposti dalle esigenze di conservazione del materiale di volo, non vi saranno limitazioni nell'impiego dei materiali stessi da parte dei comandi dell'Esercito e della Marina.
S.E. Bonzani fa presente che, a quanto gli risulta, l'Aeronautica studia materiali da caccia, che si potrebbero dire da difesa, atti cioè a combattere sul nostro cielo, escludendo i materiali da caccia da combattimento, quali si richiederebbero per proteggere la ricognizione o anche il bombardamento nel cielo avversruio. Appunto per tale considerazione egli aveva ritenuto di dover richiedere l'assegnazione di squadriglie da caccia all'aviazione per l'Esercito.
S.E. il Maresciallo Badoglio non ritiene che tali considerazioni possano infirmare il concentramento della caccia nell'Annata Aerea, imposto da un principio di economia e di manovra dei mezzi.
S.E. Valle informa che gli apparecchi da ricogni zione attualmente in istudio sono armati di quattro mitragliatrici, le quali riducono al minimo i settori indifesi aumentando così le possibilità di azione anche quando manchi la protezione della caccia.
L'Ammiraglio Valli esprime il parere che, comprendendo gli aerei imbarcati nella percentuale di squadJ·iglie che viene ora assegnata alla Marina , si venga a diminuire l'efficienza della ricognizione marittima, perché la costruzione delle nuove navi, le quali disporranno ciascuna di qualche aereo e più ancora l'eventuale costruzione di una nave portaaerei obbligherebbero a ridurre il numero delle sq uadriglie.
Domanda poi se la proporzione attuale tra squadriglie da ricognizione marittima tattica e sq uad1iglie da ricognizione marittima strategica dovrà rimanere invariata.
S.E. Valle comunica a questo riguardo che le squadriglie da ricognizione marittima lontana non dovrebbero essere destinate ad altri usi, quali ad esempio, il bombardamento o l'idro-siluramento, compiti che l 'Aeronautica ritiene debbano appartenere ali' Armata Aerea.
L'Ammiragli o Valli esprime le sue riserve al rig11ardo e per quanto riguarda g li aerei imbarcati prospetta la possibilità che la Marina provveda in avvenire direttamente a detti aerei, i quali devono considerarsi come facenti parte integrale dell'armamento delle navi.
S.E. Bonzani domanda se nel numero delle squadrig lie assegnate all'Esercito potranno comprendersi anche alcune squadriglie da ricognizione lontana.
S.E. il Maresciallo Badoglio dichiara di dover mantenere per la ricognizione marittima le conclusioni già espresse e fa osservare che, non includendo gli aerei imbarcati nell 'a liquota assegnata alla Marina, si sarebbe venuti ad alterare con danno dell'Esercito la proporzione studiata. È da tener presente infatti che l'Esercito ottiene solo 30 sq uadriglie sulle 45 richieste, mentre alla Marina vengono nel complesso assegnate 18 sq uadriglie sulle 20 richieste.
La ripartizione tra le squadriglie da ricognizione marittima tattica e quella da ricognizione marittima strategica potrà essere regolata con diretti accord i tra la Marina e l'Aeronautica. Analogamente per le squadriglie da ricognizione per l'E se rcito.
Chiude la discussione relativa all'ordinamento dell'Aeronautica facendo osservare che le conclusioni prospettate non possono naturalmente soddisfare tutte le esigenze delle tre Forze Armate; ciò non è conse ntito dalla Umitazione di mezzi disponibili, la quale ha impo sto di ridurre le varie richieste, armonizzandole in modo da poterne trarre il maggior rendimento complessivo.
Le conclusioni ora esposte saranno prospettate a S.E. il Capo del Governo, al quale spetta di prendere le decisioni al riguardo.

S.E. il Maresciallo Badoglio informa che il Capo di Stato Maggiore del! 'Ese rcito ha prospettato il problema della funzione militare delle Colonie e delle isole dell'Egeo.
Per le Co loni e S.E. il Maresciallo Badoglio si r i fer isce essenzialmente alle Colonie libiche e in particolare alla Tripolitania, la quale nella ipotesi principale di guerra assume maggiore importanza.
Al riguardo informa che le Colonie libiche sono attualmente in completa trasformazione di organizzazione.
In Tripolitania, occupato il Fezzan e proceduto al disarmo, si sta trasformando il Corpo di occupazione per metterlo in condizione di meglio assolvere i propri compiti, riducendo in pari tempo gli oneri finanziari. Col 30 giugno prossimo dovrebbero essere definite le tabelle organiche delle truppe della Tripolitania. Successivamente dovrà essere studiata l'utilizzazione della forza indigena in congedo. Un esperimento è già compiuto, con la chiamata di controllo di 1O nùla indigeni del Gebel e ha dato buoni risultati; non vi dovrebbero essere difficoltà d'inquadramento, dato che nella città di Tripoli si dispone di circa 300 ufficiali di complemento. Tutto lascia dunque sperare che la Tripolitania potrà bastare a se stessa, prescindendo dai materiali i quali non potranno essere precisati se non quando saranno completati gli studi in corso.
È da presumere che fra le due colonie libiche vi sarà una certa possibilità di compenso in quanto, probabilmente, esse non saranno attaccate contemporaneamente.
È bene intesto che questa possibilità di bastare a se stessa non deve interpretarsi in senso assoluto; essa si riferisce all'ipotesi che la Tripolitania debba resistere alle forze francesi dislocate in Tunisia e che nel caso in cui la Fran cia impieghi anche forze dell'Algeria e del Marocco, ciò che sarebbe facilitato dalle comun icazioni ferroviarie disponibili.
Rimane poi da considerare anche il problema della difesa del porto di Tripoli cont ro un eventuale colpo di mano, particolarmente per via di mare. Il Ministero della Marina ha già stud iato la difesa costiera di Tripoli. L'attuazione di tale progetto è subordinata alla disponibilità finanziarie; in ogni caso essa verrà ispirata alla massima economia, utilizzando, se po ssibi le , a nche il personale locale.
S.E. il Maresciallo Badoglio conclude dicendo che soltanto con l'esercizio 1931-32 potrà essere fissato l'ordinamento militare delle Colonie libiche e che pertanto si dovrà s up erare un periodo di crisi durante il quale le Colonie, se saranno attaccate, faranno del loro meglio per difendersi con mezzi propri , sempre pronte a sacrificare le propri e esigenze a quelle della madre Patria.
Per quanto riguarda le Colonie dell'Egeo il Capo di S.M. dell'E sercito propone il trasferimento a Lero dell'attuale battaglione dislocato a

Coo, nella considerazione che l'i so la di Lero assume maggiore importanza per la presenza di un punto di appoggio navale e di un idroscalo. li Governatore delle isole dell'Egeo si è opposto a tale trasferimento per ragioni di carattere polilico e finanziario.
S.E. il Maresciallo Badoglio informa che al riguardo conta di prendere contatto anche col Governatore delle isole dell'Egeo, riservando s i di trarre poscia le sue conclusioni e prospettarle a S.E. il Capo del Governo.
La seduta è chiusa alle ore I 0,30.

«Preparazione della guerra contro la Jugoslavia e la Francia (Ipotesi di guerra su due fronti): situazione dell'Esercito (forze mobilitabili, radunata generale, situazione delle armi e delle munizioni, impiego sostanze tossiche, situazione delle vie dì comunicazione, difesa della Sicilia, della Sardegna e dell'Elba, isole dell'Egeo e di Zara, battaglioni camicie nere).
Direttive di Badoglio per l'esecuzione degli studi relativi alla guerra contro la Jugoslavia (Ipotesi Est)».
Verbale della Riunione del 22 ottobre 1930 - Anno VIII
La riunione viene tenuta nel salone antistante all'ufficio di S.E. il Capo di Stato Maggiore Generale.
La seduta è aperta alle ore 9,30.
Sono presenti:
S.E. il Maresciallo d' Italia Badoglio del Sabotino, Capo di Stato Maggiore Generale
S.E. il Generale di C.d' A. Bonzani, Capo di Stato Maggiore del! 'Esercito
S.E. l'Ammiraglio Burzagli, Capo di S.M. della Ma1ina
S.E. il Generale A.A. Valle, Capo di S.M. dell'Aeronautica
Il Generale di Divisione Pezzana, Comand. in 2 ° Corpo S.M.
Il Contrammiraglio Valli, Sottoc. di S.M. Marina
Il Generale di Brigata Monti, Addetto al Com. C.S.M.
Il Colonnello A.A. Faronato, dell 'Ufficio di S.M. Aeronautica
Il T. Colonnello di S.M. Marras, il T . Colonnello A.A. Pinn a e il Capitano di Fregata Mengoni, dell'Ufficio di S .E . il Capo di S.M. Generale
S.E. Badoglio comunica che ha avuto incarico da S.E. il Capo del Governo:
1) di assicurarsi circa lo stato di approntamento degli studi e delle predisposiz io ni per l'ipotes i di guerra su due fronti;

2) dì dare le direttive per l'esecuzione degli studi relativi all'ipotesi di guerra contro la Jugoslavia con schieramento dì sicurezza verso la Francia.
In relazione al primo di tali due quesiti invita S.E. Bonzani a riferire per quanto riguarda l'Esercito.
S.E. Bonzani informa che al 30 giugno u.s. erano mobilitabili e radunabili a+ 8 divisioni, oltre un'altra divisione, di nuova formazione, mobilitabile in Sicilia, le divisioni di cavalleria e le brigate alpini.
Indica la ripartizione iniziale prevista per tali forze.
Annuncia che al l O luglio 1931 il numero di divisioni disponibili aumenterà di una e che quasi certamente sa rà possibile la costituzione di 110 batterie da posizione, 69 compagnie mitragliatrici alpine da posizione, 7 battaglioni alpini Valle, come pure si provvederà alle dotazioni corrispondenti alla nuova formazione assunta dai reggimenti bersaglieri e dai reggimenti di cavalleria, nonché alle compagnie armi pesanti divis ionali , da costituirsi ali' atto della mobilitazione. Non sarà possibile provvedere ai terzi battaglioni dei reggimenti bersaglieri ed alle quarte compagnie dei battaglioni alpini.
S.E. Badoglio prende atto con soddisfazione della ricostituzione dei reparti mitragliatrici divisionali, sulla cui necessità ebbe a richiamare l 'attenzione nelle riunioni dell'ottobre 1929, in rapporto alle esigenze di fuoco che presenta l'impiego della divisione.

S.E. Bonzani comunica i dati di tempo entro i quali so no previste la mobilitazione e la radunata delle grandi unità, indicando anche a quale data potrebbero essere iniziate operazioni a raggio limitato. Informa che è in istudio la chiamata contemporanea o con leggero ritardo rispetto alle classi di primo tempo, per le classi occorrenti alla mobilitazione delle unità di secondo tempo. Tale innovazione presenterebbe vantaggi di maggiore rapidità di mobilitazione, maggiore coesione e omogeneità delle grandi unità e migliore utilizzazione dei centri di mobilitazione in relazione alle risorse demografiche della propria zona.
Per quanto riguarda i trasporti di radunata, essi sono stati predisposti in modo da ridurre al minimo i percorsi e da riservare allo Stato Maggiore la maggiore possibile libertà di manovra.
A questo scopo i documenti per i movimenti oltre il 5 ° giorno vengono trattenuti presso l'Ufficio Trasporti, in modo da potervi introdurre tempestivamente le modificazioni che venissero a richiedersi al momento della radunata.
I dati di tempo indicati prescindono da eventuali interruzioni delle linee ferroviarie causate dal nemico. Sono però previste opportune misure (dislocazione compagnie ferrovieri, materiali ferroviari e da ponte presso i punti sensibili) in modo da poter ristabilire al più presto le comunicazioni.
La durata della radunata sarebbe naturalmente maggiore se essa dovesse gravitare sopra una parte, oppure se dovessero, in caso di radunata, eseguirsi spostamenti dall'una all'altra fronte.
S.E. il Capo di Stato Maggiore dell'Esercito fa presente al riguardo gli inconvenienti derivanti dall'attuale estensione della trazione elettrica in considerazione della minaccia cui sono esposte le centrali idroelettriche della zona di frontiera ed esprime il parere che tale sistema di trazione non debba ulteriormente estendersi nelle regioni di confine, particolarmente al confine orientale.
S.E. Badoglio concorda in tale apprezzamento ed informa che sosterrà tale punto di vista presso S.E. il Capo del Governo.
Prende atto dei dati relativi ai tempi di mobilitazione e di radunata e richiama l'attenzione sul la importanza che assume la predisposizione dei servizi nella zona di radunata, per evitare ritardi nell'inizio delle operazioni.
Domanda quale vantaggio si avrebbe nei tempi indicati quando si disponesse di un periodo di sicurezza.
S.E. Bonzani comunica che il vantaggio rifletterebbe soprattutto la mobilitazione e quindi l'efficienza dei reparti; sarebbe invece meno sensibile per la radunata, per la quale il periodo cli sicurezza può essere sfruttato soltanto per i due giorni di preavviso occorrenti per i movimenti. Nel complesso quindi il vantaggio massimo è di circa due giorni corrispondenti ad un periodo di sicurezza di 4 a 6 giorni. Se il periodo di sicurezza avesse durata inferiore ai 4 giorni, non si avrebbe vantaggio sensibile; d 'altra parte non potrebbe prolungarsi oltre un certo limite il periodo di sicurezza, senza mancare agli scopi intrinseci di occultamento di tale fase.
S.E. Bonzani dà informazioni generali sulla situazione delle dotazioni di mobilitazione e incarica il Generale Pezzana di esporre la situazione dei singoli servizi.
Il Generale Pezzana espone tale situazione, della quale ri s ulta che per tutti i servizi sono pronte le dotazioni per a + 9 divisioni e che per alcuni di essi sono anche pronte le dotazioni per altre divisioni. Vi sono però alcune deficienze quali risultano in appresso.
Il Generale Pezzana dà notizie circa:
- la situazione delle armi portatili, le quali bastano a provvedere per la esigenza y , salvo in parte per le pistole:
- la situazione delle mitragliatrici e le commesse in corso di mitragliatrici leggere, con le quali è previsto di provvedere entro il dicembre 1932 al fabbisogno per la esigenza y;
- la situazione delle artiglierie, le quali coprono numericamente il fabbisogno y, per quanto qualitativamente lascino a desiderare. Sono in corso provvedimenti per il materiale da 149/Skoda e per quello da 75/13;

- la si tua zione del munizionamento. compreso quello a liquidi speciali; le deficienze attualmente esistenti verranno colmate nella misura e con la rapidità che sarà concessa dalle disponibilità finanziarie;
- la situazione del servizio del genio, i cui materiali sono in parte in corso di trasformazione, mentre altri devono essere ancora definiti;
- la situazio ne del servizio trasporti, e in particolare quello degli automezzi, per i quali è coperto il fabbisogno + 1, ad eccezione di parte di automezzi speciali e delle dotazioni di riserva per i magazzini;
- la situazione del se r vizio chimico, per il quale saranno provvisti di maschere al l O luglio 193 1 gli elementi combattenti e le truppe da montagna, delle divisioni celeri, delle truppe di a + 4 divisioni e dell 'artiglieria e del genio non indivisionati.
S.E. Bonzani fa presente il grande vantaggio che si otterrebbe, per l'economia di forze che ne consegue, sbru,-ando con sostanze tossiche persistenti determinate zone di frontiera. Tale sbarramento potrebbe, all'occorrenza, essere fatto in nostro territorio anche in periodo di sicurezza. Ma per potervi fru·e assegnamento e adottare le predisposizioni occorrenti, sarebbe necessario ottenere fin d ' ora esplicita autorizzazione ed avere certezza che tale sbarramento chimico, il quale risponde in sostanza a es igenze difensive, non sarebbe impedito al momento del bisogno per considerazioni politiche. Gravissimo infatti sarebbe il danno qualora venisse a mancare improvvisamente - dopo avervi fatto assegnamento - tale mezzo d'azione.
S.E. Badoglio esprime il parere che di massima nessuna limitazione debba esservi in guerra nel! ' impiego dei mezzi, dato che sono in giuoco le sorti della Nazione. Comunque, trattandosi di questione che ha aspetti essenzialmente politici, riferirà al riguardo a S.E. il Capo del Governo.
A richiesta di S.E. Badoglio, S.E. Bonzani comunica che la data di approntamento completo delle munizioni dipenderà dai fondi che saranno disponibili e che il tipo di maschera adottato risponde bene alle esigenze di un efficace e pratico impiego.
Informa poi che i progetti di copertura so no stati compilati e che alcuni di essi sono in corso di revi s ione; analogamente per quelli di radunata, salvo per la 3a Armata, i cui studi dovrebbero essere presentati prossimamente.
Fa presente la assoluta necessità che la Marina assicuri le comunicazioni marittime. Recenti computi hanno stabilito che i rifornimenti annuali del Paese ammontano a una media di 23 milioni di tonnellate, dei quali non più di 16 potrebbero essere trasportati attraverso i valichi alpini, utilizzando al massimo le linee ferroviarie. Tali cifre lasciano vedere quale sarebbe la parte riservata al traffico marittimo, quando parte dei valichi alpini non potessero venire utilizzati.
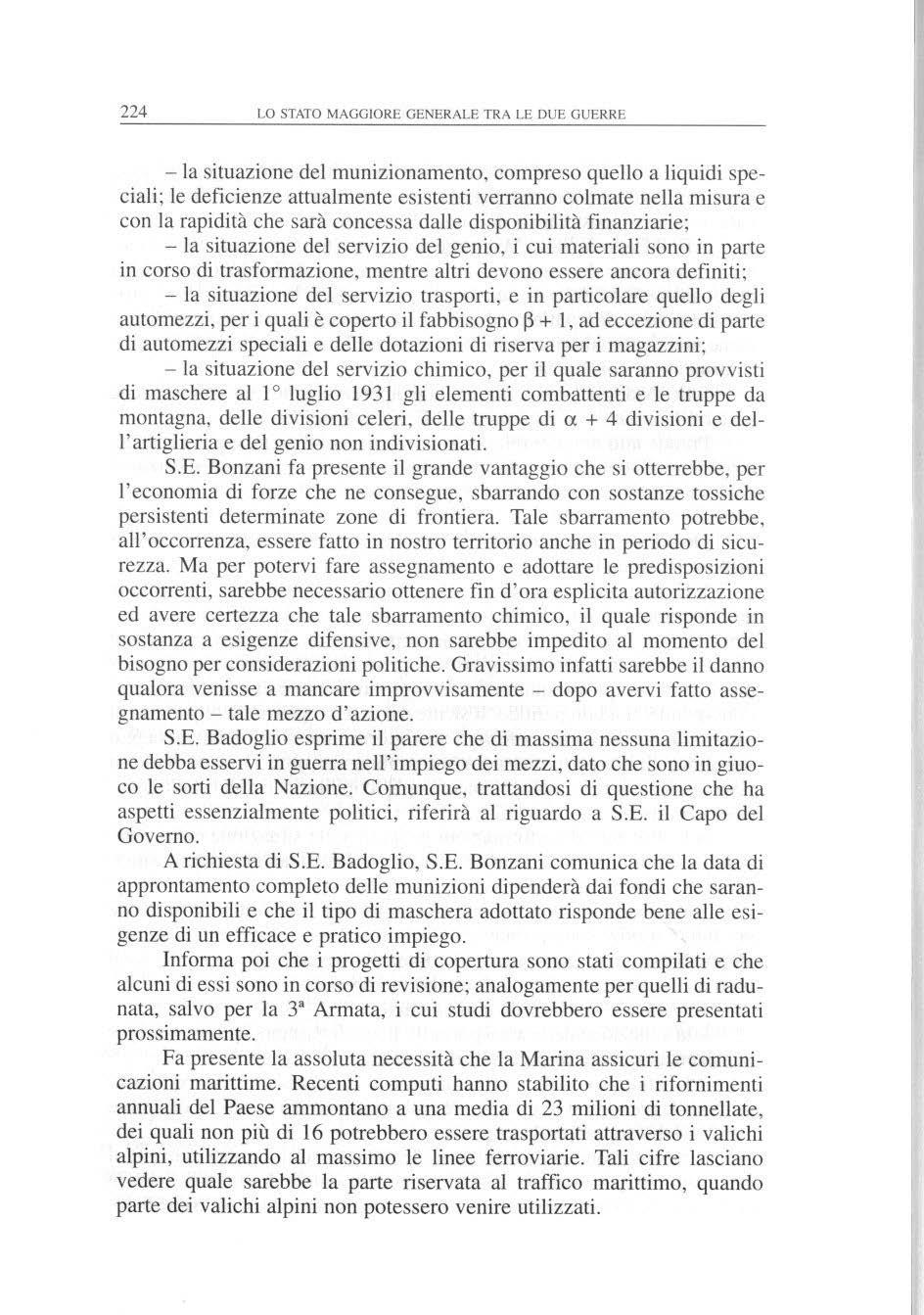
S.E. Badoglio chiede c he gli vengano comunicati al riguardo dati particolareggiati, per poter presentare la questione a S.E. il Capo del Governo e richiamare l'attenzione sulla necessità che, indipendentemente dal problema della protezione delle comunicazioni marittime, vengano predisposte e adottate fin dall'inizio della guerra le necessarie limitazioni dei consumi per la popolazione.
S.E. Bonzani riferisce circa la situazione ferroviaria, infonnando che i limitati assegni disponibili so no assolutamente inadeguati ai lavori che sarebbero necessari, tanto più che è venuto a mancare il concorso preannunciato dal Ministero delle Comunicazioni di 500 milioni da erogare in 10 anni.
Per quanto riguarda la rete strada le ordinaria sono previsti 140 milioni per lavori fino al 1936.
La situazio ne stradale delle regioni di frontiera si può ritenere discreta sulla frontiera orientale, buona in quella nord -occidentale, cattiva in quella sud-occidentale.
Per quanto riguarda quest'ultima richiama l'attenzione sulla necessità che venga costruito al più presto il tronco Borgomaro -MontaltoApricale, il quale, già compreso nei lavori da eseguire dall'Azienda Stradale, non è stato ancora iniziato.
S.E. il Maresciallo Badoglio informa che farà subito presente tale nece ssi tà a S.E. il Capo del Governo, proponendo che i fondi preventivati al riguardo dall 'Azienda Stradale vengano messi a disposizione dell'Esercito, il quale potrà così provvedere direttamente alla costruzione della strada.
S.E. Bonzani rife1isce sulla situazione dei lavori difensivi, informando che sono previsti al riguardo 258 milioni fino al 1936.
I lavori riceveranno impulso nella prossima stagione lavorati va, in base a progetti in corso di compilazione.
Per quanto riguarda le opere permanenti si attendono le proposte di apposita commissione.
S.E. Badoglio chiede info1mazioni su lle fortificazioni attualmente in costruzione per parte della Francia.
S.E. Bonzani dà notizie al ri guardo, richiamando l'attenzione su lla forte s pesa richiesta dalle costruzioni francesi (circa 10 milioni al chilometro).
S.E. Badoglio ritiene che per i tratti di vitale interesse e di non grande sviluppo, il cu i sbarramento avvantaggerebbe notevolmente la manovra delle forze mobili , occorrerà affrontarne le spese necessarie. Comunque, aderisce al concetto di S.E. Bonzani c he debba darsi l a precedenza allo sviluppo delle comunicazioni e fa osservare che converrà concentrare i fondi disponibili per la vori difensivi su determinati tratti anziché provvedere contemporaneamente su fronti più estese.
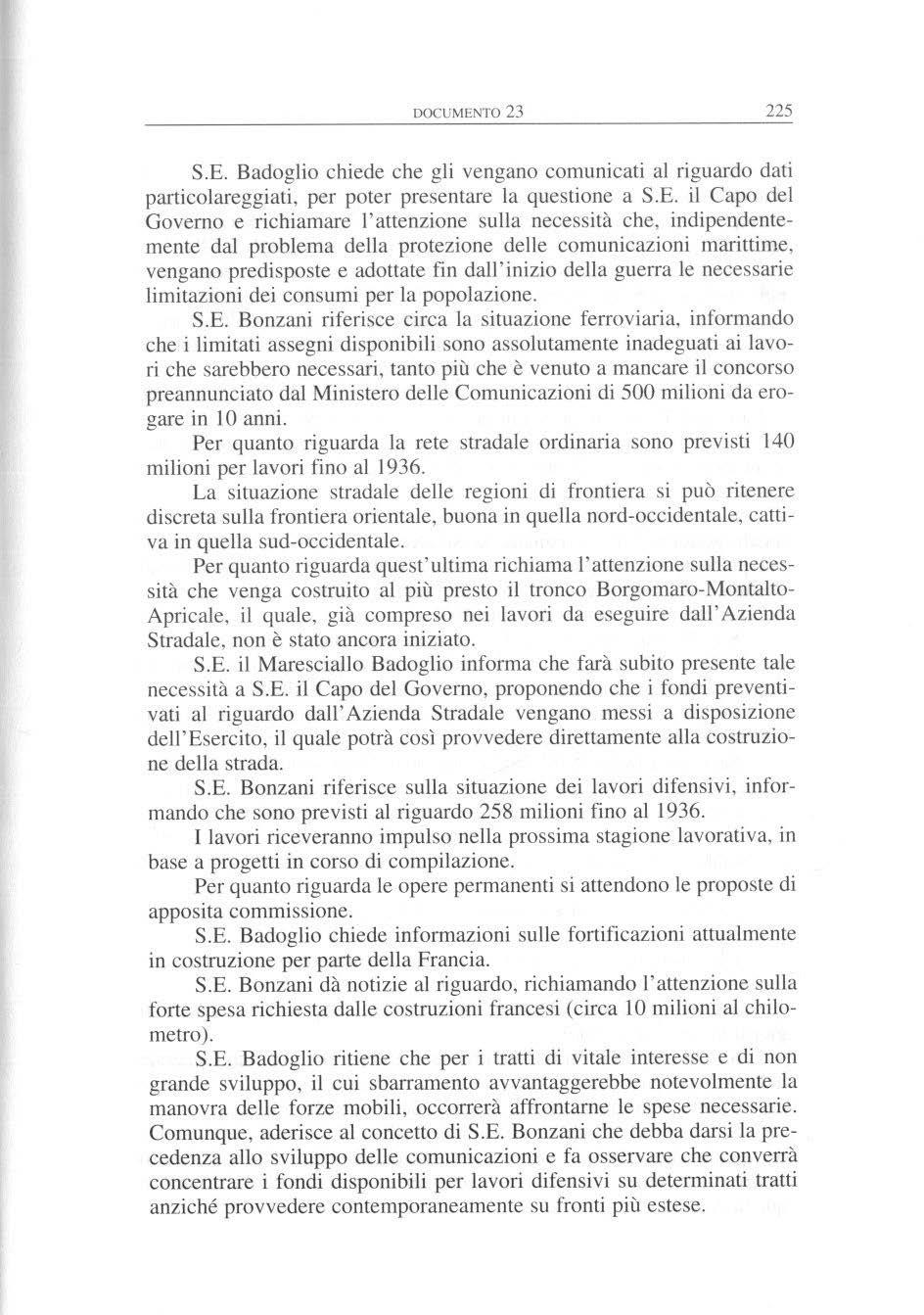
S.E. Bonzani riferisce circa la dis locazione della riserva del Comando Supremo e dà notizie circa gli studi e le predisposizioni adottati e i tempi di approntamento per la difesa della Sicilia e della Sardegna. Dà anche notizie circa il contributo dell'Esercito per la difesa dell'Elba.
S.E. Badoglio richiama l'attenzione sulla dislocazione delle forze nelle isole dell'Egeo e ricordando le difficoltà che si oppongono al trasferimento a Lero del battaglione attualmente dislocato a Coo, raccomanda che vengano studiate le modalità per trasportare sollecitamente, al momento del bisogno, detto battaglione da Coo a Lero.
S.E. Bonzani osserva che sarebbe conveniente dichiarare le isole italiane dell'Egeo <<zona di preminente interesse marittimo» e affidare perciò alla Marina l'incarico di organizzarne la difesa. Fa ancora presente la necessità che il battaglione di Coo venga sin d'ora trasportato a Lero.
L'Ammiraglio Valli informa al riguardo che, a parte i limitati mezzi locali, potrebbe farsi assegnamento su alcuno dei piroscafi italiani sempre presente nel Mediterraneo orientale, come pure s ulle unità navali destinate al Dodecaneso all'atto della mobilitazione, le quali comprendono anche alcuni incrociatori ausiliari.
S.E. Bonzani riferisce sulla situazione e sui provvedimenti in corso per la difesa di Zara e sulle modalità studiate per il suo rinforzo, in accordo con la R. Marina. Analoghe notizie dà per l'Albania.
Dà poscia infonnazioni su quanto gli risulta circa lo stato di efficienza dei battaglioni camice nere.
Secondo l'Indice di Mobilitazione dovrebbero mobilitarsi 58 battaglioni a piedi e altretta nti di complemento e 1O battaglioni ciclisti con altrettanti di complemento; complessivamente 136 battaglioni.
Per quanto riguarda il personale gli risulterebbero effettivamente mobilitabili 50 battaglioni a piedi e 9 ciclisti e questo ritiene che sia attualmente il massimo sforzo.
Non ha notizie circa la situazione delle dotazioni di mobilitazione per le quali si è riservato di provvedere il Capo del Governo.
Dà informazioni circa Io stato di addestramento constatato nei recenti campi divisionali.
Tutto il problema dei battaglioni CC.NN., come è noto, è in questi giorni in corso di esame.
S.E. Badoglio informa che chiederà notizie al Comando Generale della Milizia circa lo stato di efficienza dei battaglio ni CC.NN. e che parlerà della questione con S.E. i l Capo del Governo.
S.E. B onzani dà notizie circa gli accordi presi con la R. Aeronautica per quanto riguarda gli obiettivi interessanti l'Esercito e che potrebbero essere battuti dall'aviazione, particolarmente, nella zona di Lubi ana e in quella di Zara.
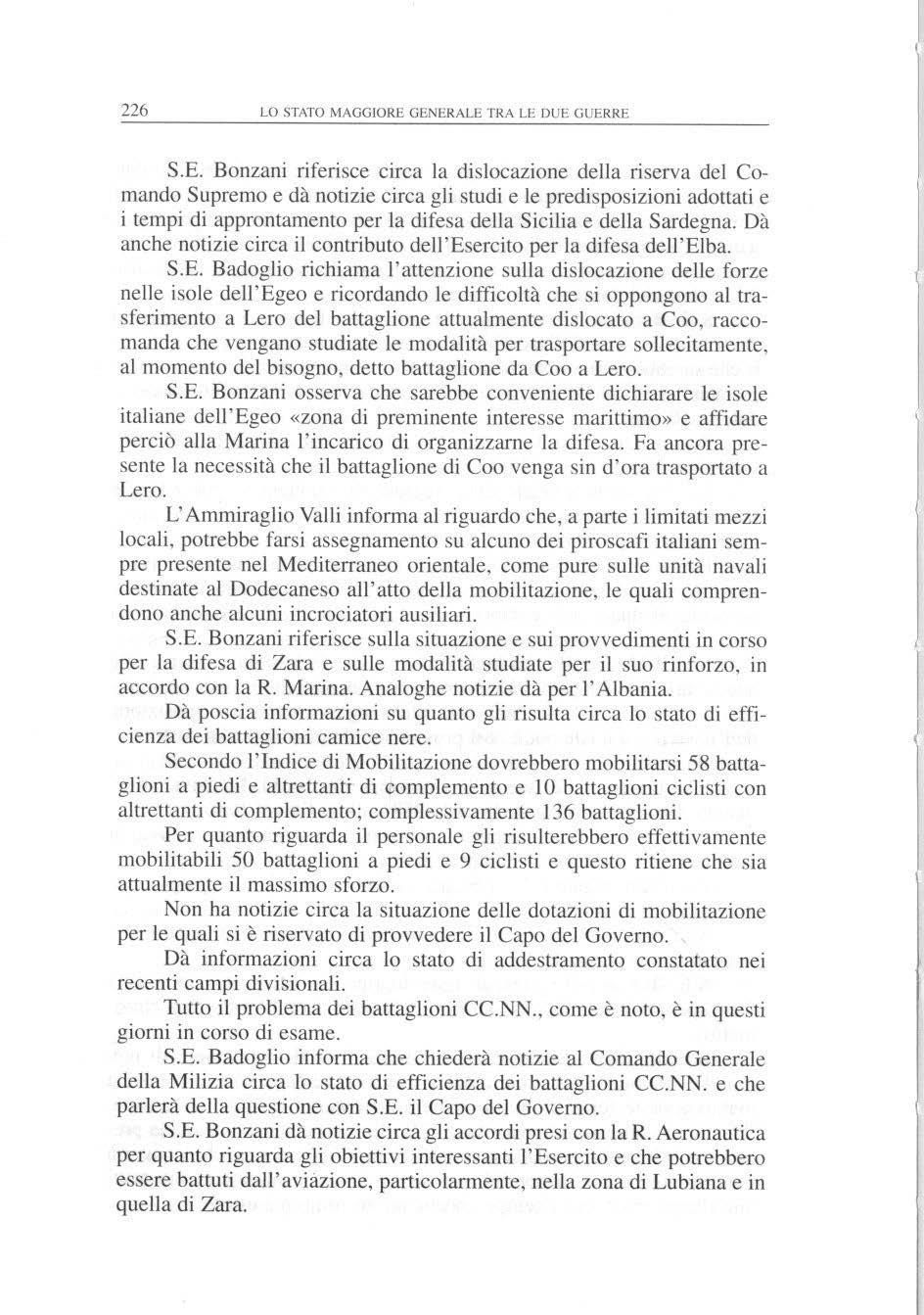
S.E. Badoglio ritiene che le ferrovie rappresentino obiettivo di vitale importanza.
Dà incarico allo Stato Maggiore dell'Esercito di compiere uno studio sulla radunata jugoslava allo scopo di determinare i punti più sensibili delle ferrovie, che potrebbero essere battuti dalla nostra aviazione.
In base a tali indicazioni eg li farà studiare il concorso della R. Aeronautica.
Annunzia anche che farà presente a S.E. il Capo del Governo la necessità che la mano d ' opera disoccupata venga di preferenza concentrata per l'esecuzione di opere mil itari.
La seduta è tolta alle ore 11,30.
A U.S S.M.E .fondo H - 10 «Verba li riunioni /924-1943 » busra n. 2.fascicolo n. 5.
Il documento è una copia dell'Ufficio del capo di Stato Maggiore Generale. Nel tes10 del verbale vengono utilizza te delle lettere dell'alfabeto greco: alfa, beta e gamma. Esse stanno a significare dei numeri in codice: alfa = 20, beta = 30 e gamma = 40. per indicare il numero delle divisioni mobilitabili.

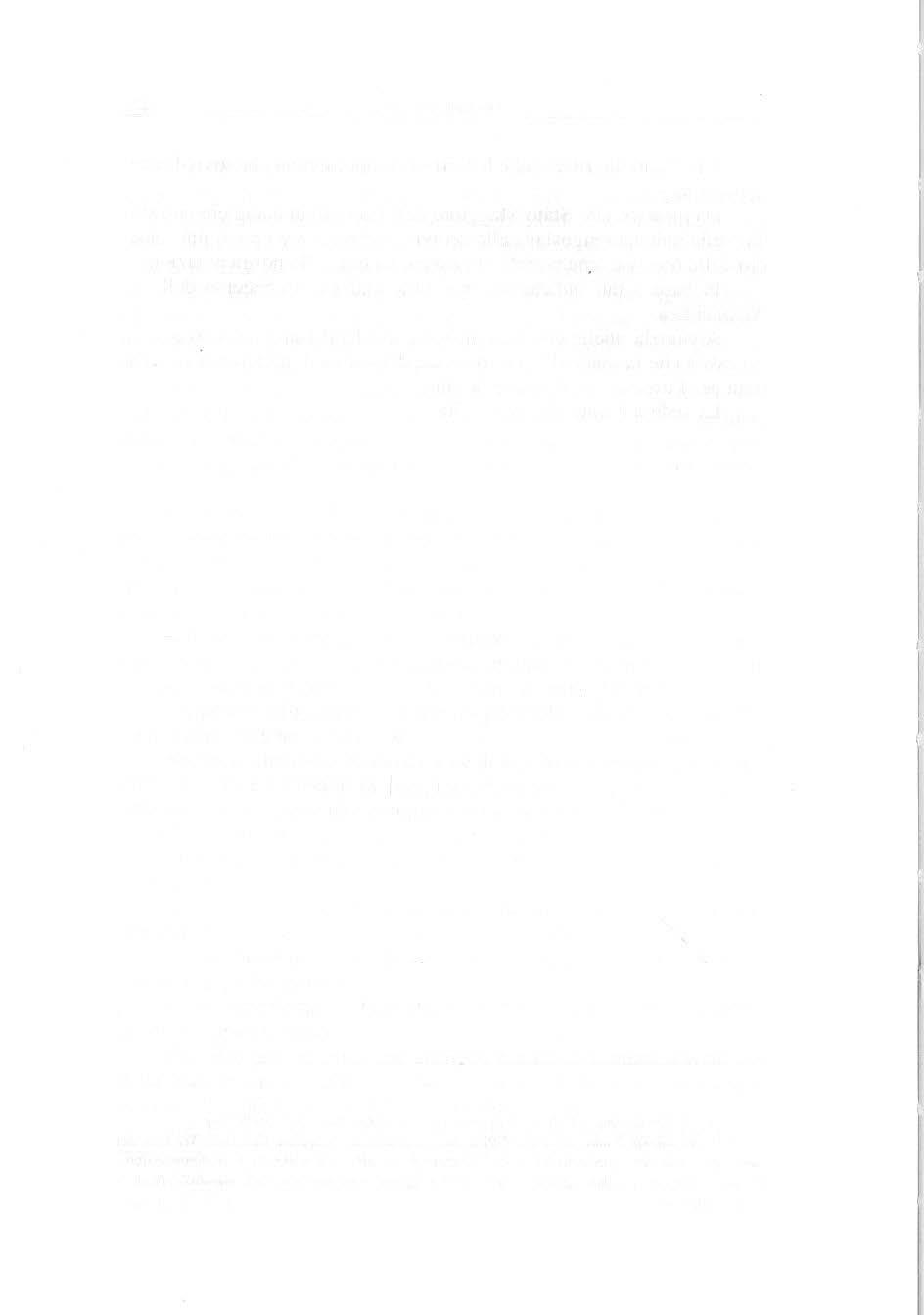
«Preparazione della guerra contro la Jugoslavia e la Francia ( !po resi di guerra su due fronti): situazione della Marina (basi navali e aeronavali, operazioni iniziali in concorso con l'armata aerea, operazioni navali nel Mediterraneo occidentale e a Largo del Maroc co, navi portaerei, trasporti di truppe in Libia), situa z ione dell'Aeronautica, (apparecchi efficienti per la ricognizione, la caccia e il bombardamento, riserve, munizioni, carburanti) e suo impiego (disturbo della radunatajugoslava, difesa di Zara e azioni alla frontiera ovest). Disposizioni di Badoglio agli Stati Maggiori sugli studi relativi all'lporesi Est.
Verbale della riunione del 23 ottobre 1930 - VIIl
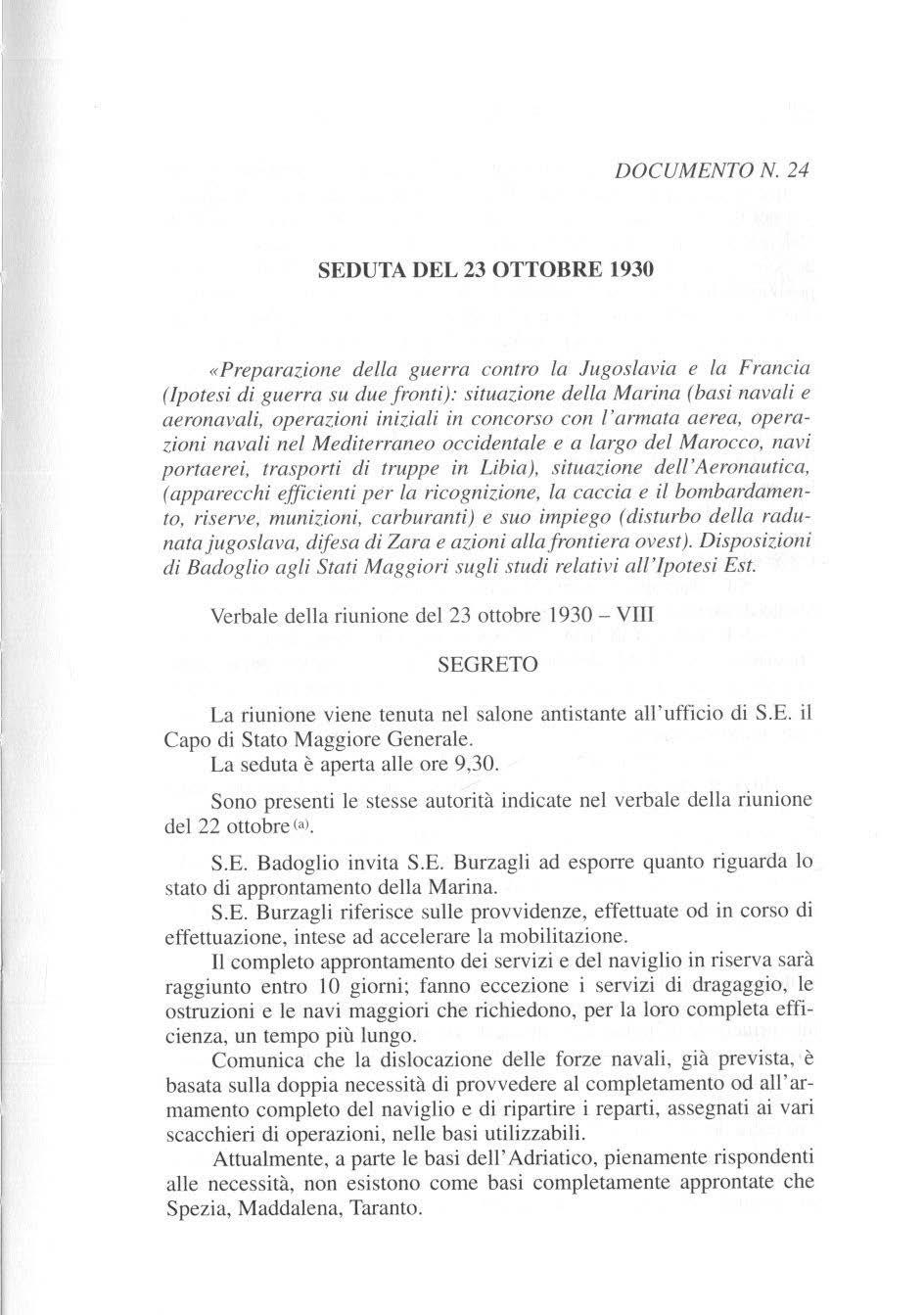
La riunione viene tenuta nel sa lone antistante all'ufficio di S.E. il Capo di Stato Maggiore Generale.
La seduta è aperta alle ore 9,30.
Sono presenti le s lesse autorità indicate nel verbale della riunione del 22 ottobre (a> .
S.E. Badoglio invita S.E. Burzagli ad esporre quanto riguarda lo stato di approntamento della Marina.
S.E. Burzagli riferisce sulle provvidenze, effettuate od in corso di effettuazione, intese ad accelerare la mobi li tazione.
Il completo approntamento dei servizi e del naviglio in riserva sarà raggiunto entro I O g iorni; fanno eccezione i servizi di dragaggio, le ostruzioni e le navi maggiori che richiedono, per la loro completa effic ienza, un tempo più lungo.
Comunica che la dislocazione delle forze navali, già prevista, è basata su lla doppia necessità di provvedere al completamento od all'armamento completo del naviglio e di ripartire i reparti, assegnati ai vari scacchieri di operazioni, nelle basi utilizzabili.
Attualmente, a parte le basi dell'Adriatico, pienamente rispondenti all e necessità, non esistono come basi completame nte approntate che Spezia, Maddalena, Taranto.
Maddalena è di limitata importanza data la sua vulnerabilità; restano quindi da utilizzarsi Cagliari, Trapani, Palermo come punti di appoggio per reparti navali diretti a ponente. Ma la loro non ancora raggiunta efficienza obbliga a mantenere ancora Augusta e Messina come basi principali, Taranto come base di raddobbo. Augusta non è situata nella posizione più felice, ma è lontana dagli attacchi aerei ed è al centro dei due bacini , Mediterraneo orientale e Mediterraneo centrale. Non è ancora efficiente ma si spera di provvedere al necessario entro due anni.
- Alla constatazione da parte di S.E. Badoglio che in definitiva lo schieramento per ora non subisce varianti, S.E. Burzagli fa osservare che ciò è dovuto allo stato attuale delle basi e che occorrerebbe fare sollecitare i lavori del Genio Civile a Trapani e Cagliari, perché soltanto dopo l'approntamento di questi due punti d'appoggio, potranno le forze navali assumere uno schieramento più occidentale.

- S.E. Badoglio assicura che farà presente ciò al Capo del Governo, il quale ha già espresso la necessità di uno spostamento delle forze navali più verso ponente.
- S.E. Burzagli fa rilevare anche la necessità di sollecitare l'impianto di una base aerea a Marsala.
- S.E. il Capo di S.M. dell'Aeronautica informa che è sembrato opportuno con i fondi disponibili provvedere al completamento della base di Elmas già esistente, la quale ha una dislocazione più occidentale; ma è già previsto che l'esercizio 1931-32 vengano iniziati i lavori per l'idroscalo di Stagnioni.
- S.E. Burzagli passa ad esporre le possibili operazioni ini ziali.
In Adriatico le operazioni principali sono i trasporti di truppe a Zara e in Albania, l 'occupazio ne di alcune isole ed il blocco del canale d'Otranto. Queste operazioni ricchiederebbero, qualora si verificassero scontri navali , il concorso dell'Armata Aerea; sorge quindi la necessità di costituire nel Basso Adriatico reparti di idroaviazione bombardiera e da caccia a disposizione per le operazioni ed i movimenti delle forze navali.
- S.E. Badoglio prega il Capo di S.M. dell ' Aeronautica di prendere nota di tale richiesta.
- S.E. Burzagli prosegue accennando che nell 'Al to Tirreno il compito principale delle forze ivi dislocate consisterà nella protezione della costa ligure e toscana quasi completamente indifesa dal mare.
Nel Mediterraneo occidentale graviterà l'attività della maggior parte dell 'A rmata per il controllo del traffico tra l'Africa e la Provenza.
Ciò potrà determinare azioni navali, anche di grande entità, che saranno ricercate dalle nostre forze. Sarà preziosa l'esplorazione aerea tattica e stra tegica e sarà pure di grande valore l'eventuale concorso offensivo aereo purché sia assicurata la tempestività.
Il controllo dei convogli oceanici tra il Marocco e la costa atlantica francese sarà effettuato dai pochi sommergibili di grande crociera.
Non sono considerate, nel primo periodo di ostilità, operazioni intese alla protezione del nostro traffico orientale né operazioni aggressive dell'avversario contro le nostre isole, sia per non sottrarre forze navali all'obiettivo principale, sia perché la zona di movimento delle nostre forze navali risulterebbe favorevole anche a questi eventi.
Lo studio delle operazioni navali, confortato dai risultati di recenti manovre con i quadri ed effettive, ha sempre meglio confermato l'utilità della nave portaerei.
- S.E. Badoglio dichiara di essere sempre più convinto della necess ità della nave portaerei. Coglie l'occasione per ringraziare S.E. Burzagli della copia d'info1mazioni che regolarmente gli invia e che gli hanno permesso di seg uire tutta l'evoluzione della Marina e le sue necessità.
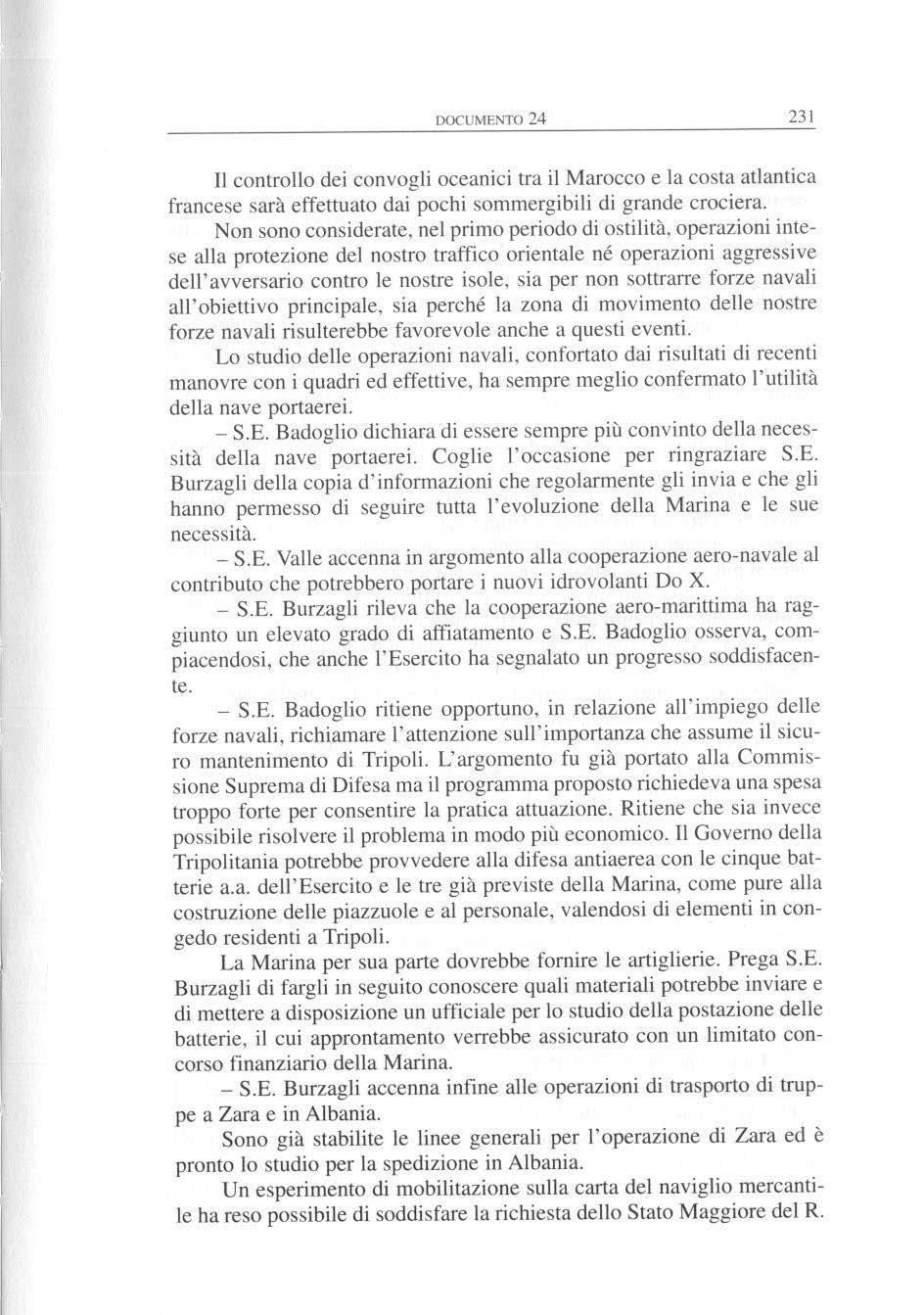
- S.E. Valle accenna in argomento alla cooperazione aero-navale al contributo che potrebbero portare i nuovi idro volant i Do X.
- S.E. Burzagli rileva che la cooperazione aero-marittima ha raggiunto un elevato grado di affiatamento e S.E. Badoglio osserva, compiacendosi, che anche l'Esercito ha segnalato un progresso soddisfacente.
- S.E. Badoglio ritiene opportuno, in relazione all'impiego delle forze navali, richiamare l'attenzione sull'importanza che assume il sicuro mantenimento di Tripoli. L'argomento fu già portato alla Commissione Suprema di Difesa ma il programma proposto richiedeva una spesa troppo forte per consentire la pratica attuazione. Ritiene che sia invece possibile risolvere il problema in modo più economico. Il Governo della Tripolitania potrebbe provvedere alla difesa antiaerea con le cinque batterie a.a. dell ' Esercito e le tre già previste della Marina, come pure alla costruzione delle piazzuole e al personale, valendosi di elementi in congedo residenti a Tripoli.
La Marina per sua parte dovrebbe fornire le artiglierie. Prega S.E. Burzagli di fargli in seguito conoscere quali materiali potrebbe inviare e di mettere a disposizione un ufficiale per lo studio della postazione delle batterie, il cui approntamento verrebbe assicurato con un limitato concorso finanziario della Marina.
- S.E. Burzagli accenna infine alle operazioni di trasporto di truppe a Zara e in Albania.
Sono già stabilite le linee generali per l'operazione di Zara ed è pronto lo studio per la spedizione in Albania.
Un esperimento di mobilitazione sulla carta del naviglio mercantile ha reso possibile di soddisfare la richiesta dello Stato Maggiore del R.
Esercito di anticipare alla sera del 6 ° giorno la partenza ciel 2 ° scaglione destinato in Albania, che era prevista per la sera dell ' 8 ° giorno.
Tale possibilità è però basata sulla presenza di piroscafi in disarmo a Trieste e Genova, esistenti attualmente solo per l'attuale stato del traffico marittimo. È necessario pertanto, nella previsione , ammettere un eventuale ritardo di uno e due giorni nella partenza di qualche convoglio.
-L ' Ammiraglio Valli fa rilevare come sarebbe anche possibile ricorrere al naviglio minore presente in abbondanza in Adriatico , ma in questo caso occorrerebbe alleggerire i convogli del materiale più pesante che dovrebbe essere inviato e mantenuto preventivamente sull'altra sponda.
- S.E. Bonzani confe1ma la necessità che l'operazione dell'Albania sia iniziata ed eseguita con la massima rapidità.
Aggiunge che il recente esperimento di trasferimento di uno stormo da S. Vito dei No1manni a Tirana deve essere rile vato con s oddisfazione , in quanto sarebbe della massima importanza , in cas o di guerra , dare al più presto ali' Albania un segno tangibile della nostra pres enza.
- S.E. Badoglio invita S.E. Valle a riferire per quanto riguarda lo stato di approntamento della R. Aeronautica.
- S.E. Valle comunica che l ' Aeronautica ha seguito i criteri direttivi nello scorso anno. Non si s ono in conseguenza create nuove squadriglie ma si è atteso al completamento degli effettivi delle s quadriglie esistenti e al rinnovamento del materiale.
Sono oggi disponibili 91 squadriglie cosi riprutite:
- 58 squadriglie dell'Armata Aerea;
- 20 squadriglie per il R. Esercito;
- 13 squadriglie per la R. Marina, oltre gli aerei imbarcati.
Qualitativamente si sono fatti grandi progressi.
La ricognizione terrestre è ormai tutta su apparecchi Ro e A/120 , mentre gli apparecchi A/300-6 sono stati passati alle scuole. Sono in corso le commesse per due squadriglie sperimentali di Ca/97 nelle quali si sono ottenuti notevoli miglioramenti nell'armamento, in base alle nuove necessità d'azione ed ai progre s si tecnici avvenuti.
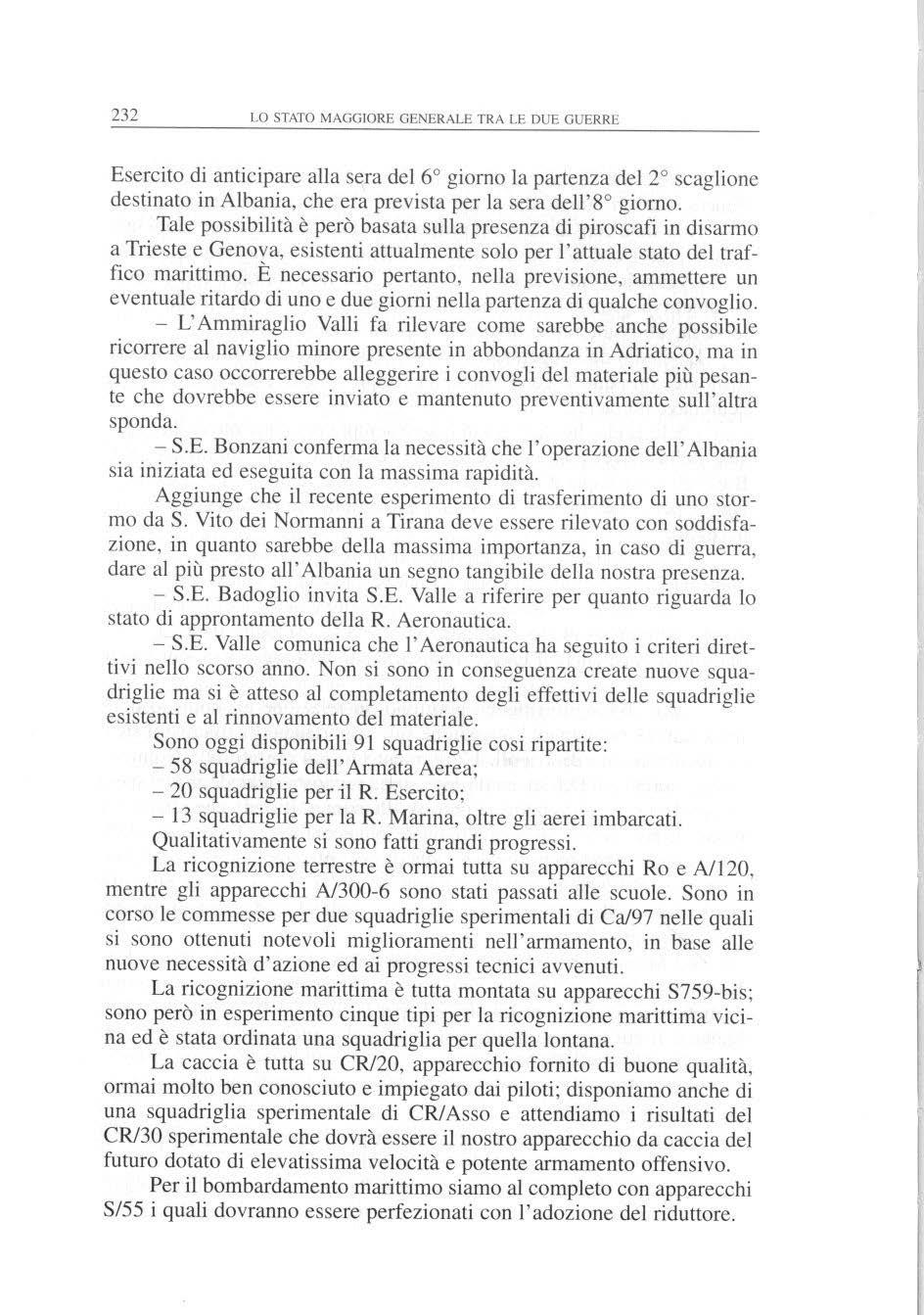
La ricognizione marittima è tutta montata su apparecchi S759-bis; sono però in esperimento cinque tipi per la ricognizione marittima vicina ed è stata ordinata una squadriglia per quella lontana.
La caccia è tutta su CR/20, apparecchio fornito di buone qualità, ormai molto ben conosciuto e impiegato dai piloti; disponiamo anche di una squadriglia sperimentale di CRI Asso e attendiamo i risultati del CR/30 sperimentale che dovrà essere il nostro appru·ecchio da caccia del futuro dotato di elevatissima velocità e potente armamento offensivo.
Per il bombardamento marittimo siamo al completo con apparecchi S/55 i quali dovranno essere perfezionati con l'adozione del riduttore.
Il bombardamento diurno si sta trasformando nel Br/3, che è un perfezionamento del Br/2 e intanto è allo studio il nuovo apparecchio S/70.
Il bombardamento notturno ha ancora gli apparecchi Ca/73 e Ca/74.
Entro l'inverno verrà definito un prototipo di grande autonomia, di cui esistono tre diversi campioni.
Quantitativamente, sebbene come è stato accennato non sia stato aumentato il numero delle squadriglie, si è pur compiuto un gran passo avanti col completamento degli effettivi dei reparti. Sono così disponibili attualmente 1.365 apparecchi invece degli 850 dello scorso anno; considerando la sola linea e le scuole il numero degli apparecchi è passato da 650 a 1.000.

L'aumento si è verificato soprattutto nella ricognizione terre stre, nella caccia e nel bombardamento marittimo, mentre le altre specialità sono rimaste stazionarie o hanno subito una lieve contrazione.
L'impiego degli apparecchi da turismo ha dato ottimi risultati per l'allenamento dei piloti di riserva.
Inoltre gli apparecchi da turismo impiegati nelle squadriglie hanno permesso e permetteranno notevoli economie nell'impiego degli apparecchi di linea. È perciò prevista l 'assegnazione di due o tre apparecchi da turismo ad ogni squadriglia per i normali voli di allenamento del personale.
S.E. Badoglio domanda se gli apparecchi da turismo possano avere un impiego bellico.
S.E. Valle risponde che tali apparecchi potrebbero avere efficace impiego per collegamento a tergo delle nostre linee.
Continuando nella sua esposizione, egli fa presente che la situazione ora prospettala potrebbe apparire soddisfacente, se non si dovesse lamentare l'assoluta mancanza di una riserva di apparecchi e di motori.
Non è da sperare che possa con gli attuali mezzi di bilancio costituirsi una riserva, perché, se è vero che nell'ultimo anno si è riusciti a migliorare la situazione numerica degli apparecchi, è da prevedere che in avvenfre tutti i fondi saranno assorbiti per il semp lice mantenimento in efficienza degli organici attuali, dato il maggior costo degli apparecchi. Si avrà così un miglioramento della qualità ma non un aumento del numero attuale delle sq uadriglie , esso è notoriamente insufficiente; basti semplicemente accennare al limitato numero di squadriglie da caccia di cui ora disponiamo, dislocate nel n. di 12 a protezione dell'intero fronte W. , 8 per l'intero Fronte E., 2 in Albania e 8 per la difesa delle coste e del territorio.
S.E. Badoglio informa che ha già parlato con S.E. il Capo del Governo circa la necessità di aumentare gli stazionamenti assegnati alla
R. Aeronautica. Ritornerà ancora su questo argomento nei prossimi colloqui, richiamando l'attenzione sull'importanza di questo problema.
S.E. Valle , riprendendo l'argomento della mancanza di riserve, fa notare che il fatto è molto grave perché la nostra industria soltanto al terzo mese potrà dare circa 200 apparecchi mensili e soltanto al sesto mese circa 600 apparecchi, corrispondenti al presunto consumo normale.
In tal modo, entro il primo mese di guerra saremo nettamente inferiori.
Date le attuali limitazioni finanziarie egli ritiene che la situazione potrebbe essere migliorata mediante l'adozione di programmi di costruzione poliennali, consolidando in corrispondenza l 'aliquota del bilancio destinata al materiale. Tale consolidamento dovrebbe essere fatto almeno per tre anni (con procedimento analogo a quello attualmente eseguito per le costruzioni navali). Dal consolidamento deriverebbe una continuità e una regolarità di commesse, le quali consentirebbero alle ditte di avviare una regolare produzione e rifornirsi di un ' adeguata sco rta di materie prime, avendo così a costituire indirettamente una certa riserva e facilitando il passaggio alle fabbricazioni di guerra.
S.E. Badoglio comunica che prende nota di questa proposta per segnalarla a S.E. il Capo del Governo.
S.E. Valle informa che l'Aeronautica deve ancora provvedere al rinnovamento delle stazioni radiotelegrafiche, per le quali già sono stati creati i prototipi e a quello delle mitragliatrici, per le quali occorre aumentare il calibro attuale.
Per quanto riguarda il munizionamento di caduta, se ne dispone attualmente per i bisogni di circa un mese; si conta di portare tale di s ponibilità a tre mesi entro il 1932 e di completare entro il 1931 il munizionamento a gas. È in corso di definizione un nuovo modello di bomba incendiaria, molto efficace.
Si sta provvedendo a completare il fabbisogno di autoveicoli e di imbarcazioni per le quali l'Aeronautica non può fare assegnamento sui mezzi di requisizione. La scorta prevista di benzina è di 15 mila tonnellate per 4 mesi. Per mancanza di depositi non è stato possibile di provvedere neanche in parte all ' accantonamento della suddetta scorta; si sono però obbligate le ditte a tenere sempre a disposizione una scorta fissa di circa 3.600 tonnellate.
Non esistono sc01te di lubrificanti, ma si sta dando incremento alla produzione dell ' olio di ricino.
S.E. Badoglio informa che al problema della produzione dell'olio di ricino , portato in discussione alla Commissione Suprema di Difesa, ha già dedicato la sua attenzione per il contributo che può portare la produzione delle Colonie libiche. Su questo argomento interesserà ancora il Ministero delle Colonie.
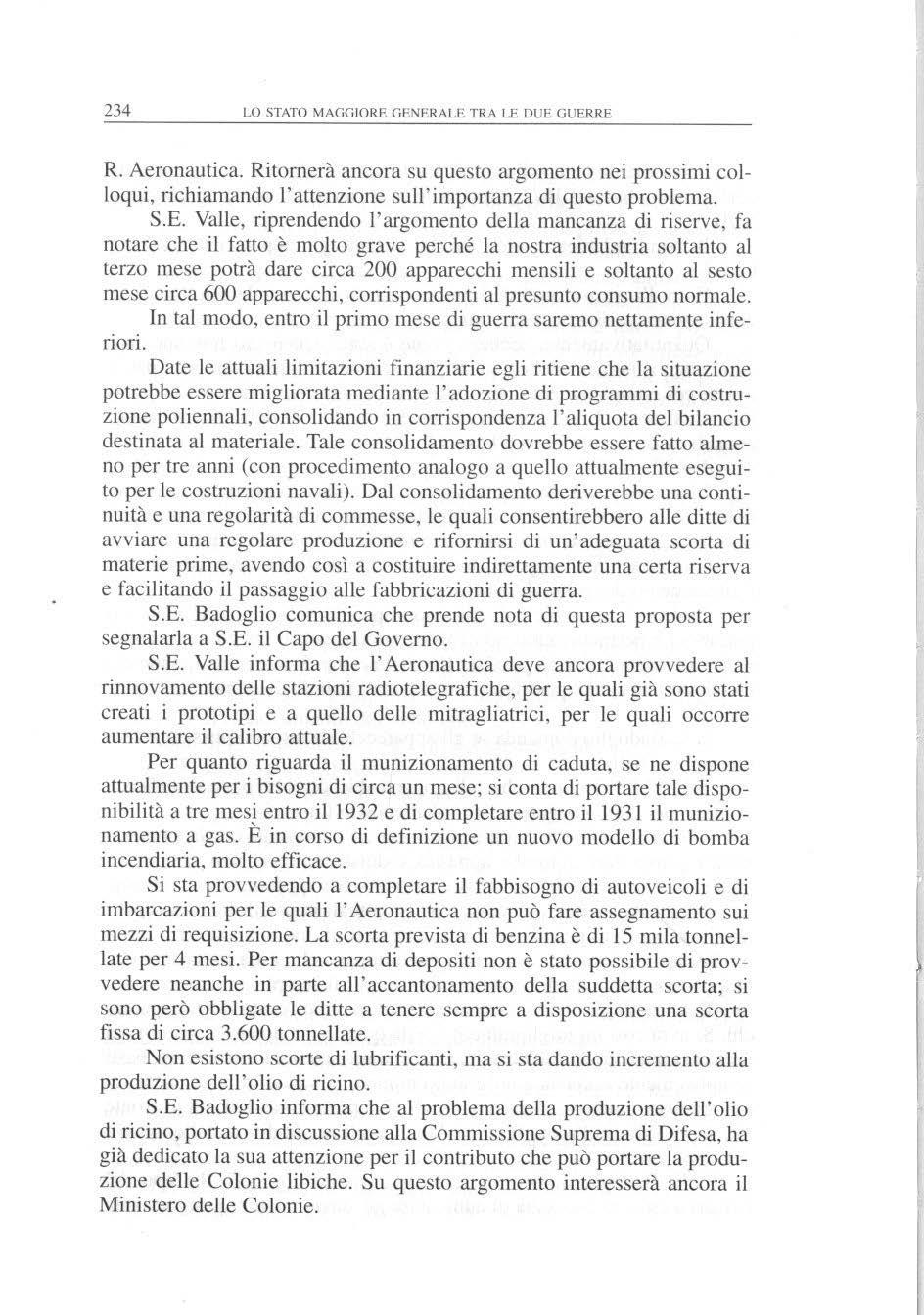
S.E. Bonzani fa osservare che l'adozione dell 'olio di ricino come lubrifiacante per gli automezzi dell'Esercito incontra difficoltà di ordine igienico nell'impiego di autocolonne di una certa entità.
L'Ammiraglio Valli comunica che anche maggiori sono le difficoltà per tale impiego nei locali chiusi degli apparati motori di bordo.
S.E. Valle passando all'argomento della preparazione dei campi informa che entro il 1931 saranno pronti trenta campi di mobilitazione, essendo stata dedicata per le spese occorrenti buona parte degli 80 milioni ultimamente concessi ali' Aeronautica. Tali campi saranno provvisti di depositi di benzina e di munizioni opportunamente costruirti e frazionati.
Accenna all'esperimento cli una squadriglia da trasporto di sei apparecchi, la quale nel recente viaggio in Albania poté trasportare il personale e i servizi per un intero storno di 50 apparecchi.
Per quanto riguarda lo schiera mento iniziale e i concetti di approntamento delle forze aeree conferma quanto è stato esposto nella memoria recentemente trasmessa a S.E. il Capo di Stato Maggiore Generale, aggiungendo che le prime operazioni potrebbero essere iniziate fin dalla 12a ora, che altre operazioni potrebbero compiersi dopo il secondo giorno e che al 5° giorno tutti i reparti e servizi saran no in efficienza, sempre, beninteso che sia perfezionato il previsto approntamento dei campi e delle scorte di mobilitazione.
S.E. Badoglio invita lo Stato Maggiore dell'Esercito a st udiare e a far conoscere quali s iano gli obiettivi sui quali si richiederebbe all'inizio della guerra il concorso dell'Armata Aerea, particolarmente per ritardare la mobilitazione e la radunata jugoslava e per contribuire alla difesa di Zara.
S.E. Bonzani fa osservare che in determinate circostanze potrebbe essere preferibile concentrare i mezzi aerei per un'azione alla fronte occidentale.
S.E. Badoglio comunica che la precedenza nello studio degli obiettivi sulla fronte orientale corrisponde alle recenti direttive di S.E. il Capo del Governo. Si tratta comunque di una semplice precedenza di studi, poiché rimane inteso che subito dopo dovrà essere compiuto analogo st udio anche la frontiera occidentale. Il concetto di base è quello che al momento del bisogno i mezzi aerei dei quali disponiamo non devono essere dispersi su molteplici obiettivi.

S.E. Valle riferendosi all'analoga questione posta da S.E. Bonzani circa l'impiego di sos tanze tossiche , fa rilevare come per la neutrali zzazione degli obiettivi dell'aviazione da bombardamento, sarebbe molto utile ricorrere fin dall'inizio della guerra a ll 'impiego della iprite.
S.E. Bonzani fa rilevare come l'efficacia dell'iprite debba considerarsi assai notevole nella zona di combattimento terrestre, dato il quantitativo di sostanze neutralizzanti che occorre impiegare per la bonifica
delle zone intossicate. Non altrettanto invece per i bombardamenti nelle retrovie , e particolarmente in prossimità dei grandi centri, data la maggiore facilità di disporre dei quantitativi occorrenti di sostanze neutralizzanti, e la conseguente possibilità di bonificare in tempo relativamente breve le zone intossicante. In conclusione, pertanto , ritiene che contro determinati obiettivi, in particolar modo i ponti , gli impianti ferroviari, nodi di comunicazione, sia più efficace il bombardamento con proietti esplosivi.
S.E. Badoglio conferma che per l'impiego di sostanze tossiche fin dall'inizio della guerra interpellerà S.E. il Capo del Governo, al quale spetta di prendere decisioni in argomento.
S.E. il Generale Valle chiude la sua esposizione informando che per quanto riguarda il bombordamento marittimo, l'Aviazione sarebbe in grado di portare la propria offesa su tutte le sponde del Mediterraneo e, risalendo il Rodano, fino a Lione.
S.E. Badoglio, chiuso con tale esposizione l 'es ame delle disposizioni prese per l'ipotesi di conflitto su due fronti, informa che riferirà al riguardo a S.E. il Capo del Governo e che si riserva, dopo tale colloquio, di comunicare alle LL.EE. i Capi di Stato Maggiore le decisioni sulle questioni che sono state poste nel corso di queste sedute.
Presi gli ordini di S.E. il Capo del Governo invita ora i Capi di Stato Maggiore a compiere gli studi relativi alla nuova ipotesi di guerra, la quale deve considerare l'azione con la massa delle forze contro la Jugoslavia, tenendo lo schieramento di sicurezza verso la Francia, in conformità delle direttive già date prima che gli studi venissero interrotti per prendere in esame l'ipotesi di conflitto su due fronti.
Prega le LL.EE. i Capi di Stato Maggiore di tenere l'Ufficio al corrente dello sviluppo di questi studi e preavvisa che conta di potere tenere alcune riunioni per l'esame di questi studi nel prossimo mese di febbraio

Prima dì chiudere la riunione egli rileva come la situazione generale europea non possa non preoccupare, ma che la nostra preparazione militare deve proseguire metodicamente e con continuità con que l ritmo che viene stabilito dal Capo del Governo, il quale solo è in condizione di regolarlo adeguatamente per la conoscenza generale delle possibilità della Nazione.
La situazione politica sulla quale si è basata lo studio di guerra su due fronti si può definire catastrofica, ma è da considerare che essa prospetta una sola faccia della situazione generale che vorrebbe a verificarsi, mentre è fuori di dubbio che non mancherebbero ai nostri due diretti avversari difficoltà anche notevoli di ordine vario.
Aggiunge che egli non ha mai mancato di far presente la situazione tragica in cui verrebbe a trovarsi l'Italia in caso di guerra sui due fronti , rilevando come occorrerebbe già un notevole sforzo per battere la sola Jugoslavia.
S.E. il Capo del Governo è perciò perfettamente a giorno della situazione; comunque ritornerà su ll'argomento, mettendo in luce anche gli elementi risultati da queste sedute, in modo che S.E. il Capo del Governo sia completamente illuminato.
Prima di chiudere la riunione S.E. il Capo di Stato Maggiore Generale rinnova la preghiera ai Capi di Stato Maggiore di tenerlo il più frequentemente informato su llo sta to di efficienza delle Forze Armate e s ugli studi ed esperimenti che si vanno compiendo rinno vando ancora a S.E. Burzagli il proprio ringranziamento per le notizie comunicategli, le quali gli hanno permesso di tenersi completamente al correnti della situazio ne della R. Marina.
La seduta è tolta alle ore 11, 15.


« Preparazione della guerra contro la Fran cia e la Jugoslavia ( Ipotesi di guerra su due fronti): Opera zione 1O , organi zza zione difensiva. Prepara z ione della guerra contro la Jugoslavia (Ipotesi Est): poten zialità dell'esercito jugoslavo e sua offensiva iniz iale, prepara zione del nostro Esercito e relativi piani di opera zioni ( offensive lungo la direttrice Postumia-Lubiana, dalla Dalmazia, dall'Albania, linea KninBihac, copertura alla frontiera Ovest), concorso dell'Aeronautica e della Marina (ipotesi di sbarco).
Questioni particolari riguardanti l'ordinamento dell'Esercito».
Verbale della riunione del 5 novemb re 1931-X

La riunione viene tenuta nel salone antistante all'ufficio di S.E. il Capo di Stato Maggiore Generale.
La seduta è aperta alle ore 9,30.
Sono presenti:
- S.E. il Maresciallo d'Italia Badoglio del Sabotino , Capo di Stato Maggiore Generale;
- S.E. il Generale d ' Armata Bonzani, Capo di Stato Maggiore dell ' Esercito;
- S.E. l'Ammiraglio di Squadra Ducci, Capo di Stato Maggiore della Marina;
- S.E. il Generale di Divisione Aerea Valle, Capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica.
Assiste il co lo nn ello d'artiglieria Marras dell'Ufficio di S.E. il Capo di Stato Magg iore Generale.
S.E. il Maresciallo d'Italia Badoglio, p1ima d'iniziare l'esame delle questioni poste all'ordine del giorno dell'attuale riunione, esprime alle LL.EE. i Capi di Stato Maggiore il suo ringraziamento per la col laborazione che ess i hanno prestato, mediante l'invio di notizie numerose ed esau ri enti sull'attività delle F orze Armate e sul loro stato di efficienza.
Esprime anche il suo vivo compiacimcnlo per il fervore di addestramento manifestato dalle tre Forze Armate ed aggiunge che sa rà sua c ura , a l momento opporluno, di interessarsi per l'esecuti o ne di esercitazioni di due o anche di tre Forze Armate in cooperazione.
S.E. Badoglio comunica che nel maggio scorso fu informato da S.E. il Ministro della Guerra, per ordine di S.E. il Capo del Governo, che negli ambienli militari francesi si sla affermando una larga corrente favorevole a una guerra preventiva contro l"ltalia, in contrasto con una cerla oppositione da parte degli ambienti politici.
I n seguito a tale comunicazione, S.E. Badoglio ebbe a prospettare a S.E. il Capo del Governo la nostra situazione dal punto di vista militare. come pure da quello economico e finanziario. in raffronto con la situazione dei probabili avversari. tenendo conto delle limitate possibililà militari e finanziarie dei nostri eventuali alleati e mettendo ancora una volta in evidenza la gravi là eccezionale della situazione nella quale l' It alia verrebbe a trovarsi.
S.E. Badoglio infonna poscia che in una recente conferenza avuta con S.E. il Capo del Governo ha nuovamente prospettato la situazione che verrebbe ad aversi nel caso di guerra s u due fronti, mettendo in evidenta gli inconvenienti derivanti dalla necessità di disperdere se tte divisioni su teatri secondari e in particolare le difficoltà che presenterebbe quella che per ragioni di segretezza rimane ora convenuto di indicare col nome di «Operazione l O» 1.
Al riguardo il Capo del Governo ha lasciato arbitro il Capo di Stato Maggiore Generale di rinunziare a tale oper azione semp re quando veni<,se assicurato nel settore relativo all'operazione stessa un certo grado di resistenza. Conseguentemente S.E. Badoglio ha comunicato a S.E. il Capo del Governo che le previdenze già attuate e quelle incorso assicurano una resbtenza di qualche durata e che pe11anto può rinunziarsi all'operazione in questione.

R imane dunque stabilito che nel caso di guerra s u due fronti non dovrà più essere eseguita « l'Operazione l O». TI più assoluto seg reto deve essere mantenuto su questa deliberatione, per la quale non occorre dare alle autorità dipendenti alcuna disposizione che implichi la conoscenza della deliberazione stessa.
S.E. il Capo di Stato Maggiore dell'Esercilo esaminerà i provvedimenti da prendere per migliorare ancora le conditioni di resis tenza nel se uore in questione.
I Tale denominazione "a riferi1a soliamo all"lpo1csi di guerra w due fronii e :,ervc per gli accenni che Ira le più elevale Au1ori1à mii ilari a cono,cenza di quc,1a deliberazione dovessero , cmre falli alla delibcra,ione Slessa. Nulla deve inv ece e~~ere variato nei riguardi delle au1ori1à dipcndenli a lla deno111i11a1ionc convenLionale attualmente in uso.
S.E. Bonzani informa che l'organizzazione difensiva in tale settore ha raggiunto un buon grado di efficienza sia per le opere costruite, sia per lo sviluppo delle comunicazioni, sia ancora per la costituzione speciale delle truppe che vi sono dislocate.

S.E. Badoglio passa poi all'esame dei piani operativi in corrispondenza dell'Ipotesi Est e premette che tale Ipotesi posta da S.E. il Capo del Governo non corrisponde alla situazione politica atluale, ma deve essere studiata ugualmente perché le situazioni politiche possono cambiare e rendere possibile ques ta eventualità che attualmente pare poco probabile.
Tale Ipotesi , nei termini stabiliti da S.E. il Capo del Governo, implica provvedimenti di semplice sicurezza sulla fronte ovest e azione con la massa delle forze su lla fronte est. È evidente che le modificazioni più importanti sono quelle che riguardano l'impiego dell'Esercito e dell'Aeronautica, perché la Maiina dovrà in questo caso provvedere essenzialmente ad assicurare il suo sopravvento su lle limitate forze della Marina jugoslava.
Invita S.E. Bonzani ad esporre quanto riguarda l'apprestamento dell'Esercito e i piani operativi dell'Ipotesi Est.
S.E. Bonzani comunica i seguenti dati:
Sono attualmente mobilitabili:
34 divisioni di I O battaglioni (dei quali uno mitraglieri ),
2 di visioni celeri,
3 brigate alpini, tutte inquadrate in 13 corpi di armata e un comando superiore della Sardegna, a loro volta inquadrati in quattro armate.
Sono anche mobilitabili le truppe speciali di copertura, costituite da 7 battaglioni alpini Valle, 69 compagnie mitragliatrici da posizione e I 1O batterie da posizione (queste ultime mobilitabili in due tempi). Oltre a queste i battaglioni territoriali mobili, i battaglioni territoriali, ecc.
Altre unità verrebbero mobilitate in secondo e in terzo tempo.
S.E. Bonzani indica poscia la situazione delle forze che, nel caso di operazioni su doppia fronte , sarebbero radunate sulle due frontiere entro il 5 °, entro il 10° ed entro il 15° giorno di mobilitazione.
Le forze mobi litabili dalla Jugoslavia vengono computate a 26 divisioni quaternarie (oltre la Guardia Reale), con reggimenti su 4 battaglioni.
S.E. Badoglio esprime il dubbio, pur tenendo conto dell 'a bbondante concorso francese e cecoslovacco, che le possibilità jugoslave siano alquanto sopravalutate.
S.E. Bonzani al riguardo fa presente che analoghi dubbi da lui concepiti inizialmente si sono dissipati sia tenendo conto dei numerosi invii di materiali che affluiscono alla Jugoslavia (soltanto nell'ultimo anno 2.000 vagoni di materiali; tra i materiali 250 bocche da fuoco Skoda
mod. 1929-30), sia tenendo conto del notevole contributo finanziario della Francia (di 6 miliardi di franchi non è stata data pubblica giustificazione).
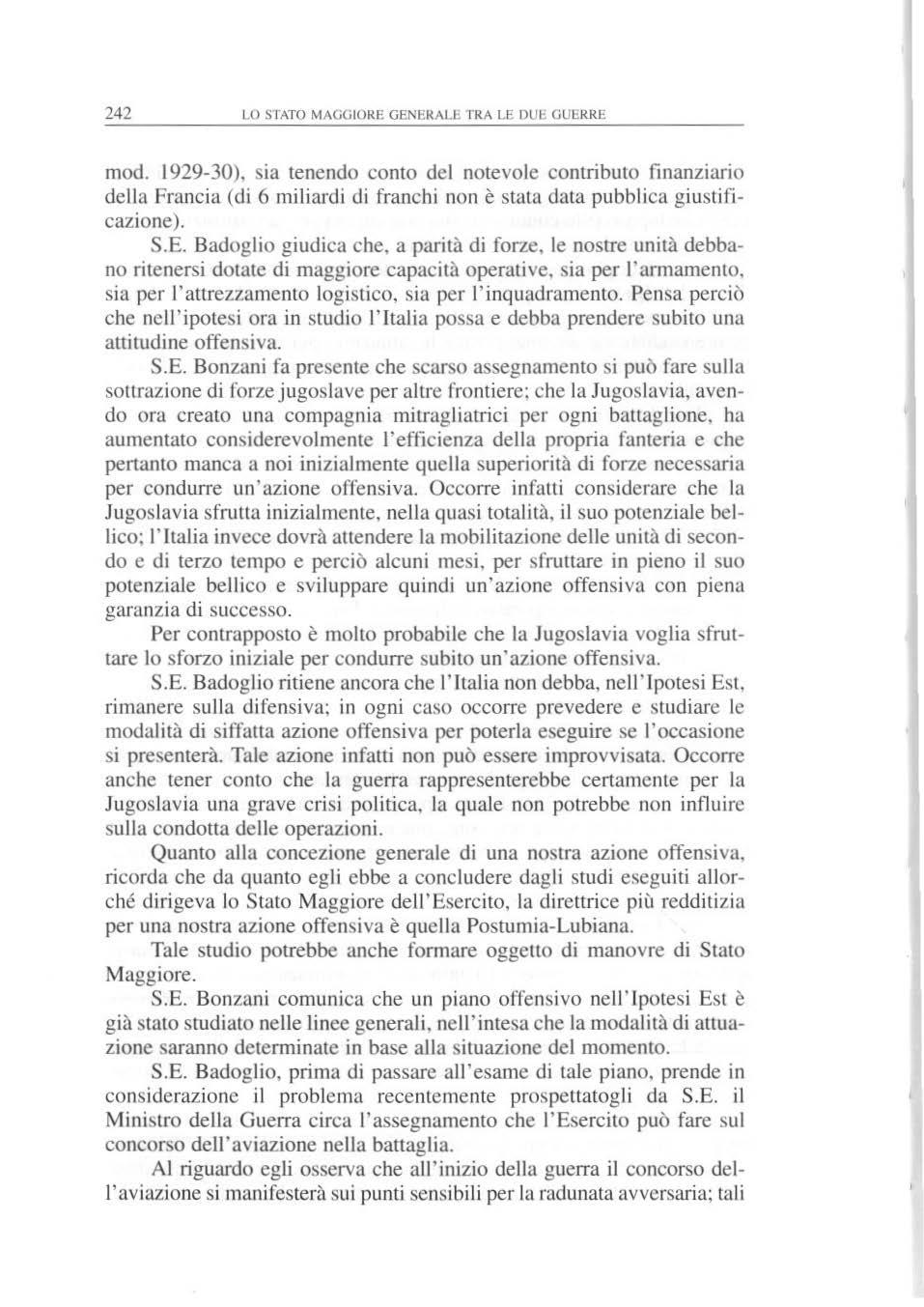
S.E. Badoglio giudica che, a parità di forLe, le nostre unità debbano ritenersi dotate di maggiore capacità operative, sia per l 'armamento, sia per l'at trezzamento logi stico, sia per l'inquadramento. Pensa perciò che ne ll'ipotesi ora in stud io l'Italia possa e debba prendere subito una attitudine offensiva.
S.E. Bonzani fa presente che scarso assegnamento si può fare sulla sottrazione di forze jugoslave per altre frontiere; c he la Jugo s lavia, avendo ora creato una compagnia mitragliatrici per ogni battaglione, ha aumentato considerevolmente l'efficienza della propria fanteria e che pertanto man ca a noi inizialmente quella supe riorità di for1e necessaria per condurre un'azione offensiva. Occorre infatti considerare che la Jugo s lavia sfrutta inizialmente, nella quasi totalità, il suo potenziale bellico; l' Italia inve ce dovrà attendere la mobilitazione delle unità di secondo e di terzo tempo e perc iò alcuni mesi, per sfru ttare in pieno il suo potenziale bellico e sviluppare quindi un'azione offensiva con piena garanzia di successo.
Per contrapposto è molto probabile c he la Jugo slavia voglia sfruttare lo sforzo iniziale per condurre subilo un'azione offensiva.
S.E. Badoglio ritiene ancora che l' It alia non debba , nell'Ipotesi Est, rimanere sulla difensiva; in ogni caso occorre prevedere e st udiare le modalità di siffatta azione offensiva per poterla eseguire se l'occasione si pre senterà. Tale azione infarti non può esse re i mprovvisata. Occorre anche tener conto che la guerra rappresenterebbe certamente per la Jugo s lavia una grave crisi politica, la quale non potrebbe non influire sulla condotta delle operazioni.
Quanto alla concezione generale di una nostra azione offensiva, ricorda che da quanto egli ebbe a conclude re dagli studi eseguiti allorché dirigeva lo Stato M aggiore dell'E se rcito, la direttrice più redditizia per una nostra aLione offensiva è quella Postumia- L ubiana.
Tale studio potrebbe anche fo rm are oggeuo di manovre di Stato Maggiore.
S.E. B onzani comunica che un piano offensivo nell ' ipote s i Est è già stato studiato nelle linee generali, nell'intesa che la modalità di attuazione saranno determinate in base alla s ituazione del momento.
S.E. B adoglio, prima di passare all'esame di tale piano, prende in considerazione il problema recentemente pro spe ttatogli da S.E. il Mini s tro della Guerra circa l'assegnamento che l 'Eserci to può fare sul concorso dell'aviazione nella battaglia.
Al riguardo egli osserva che all'inizio della guerra il concorso dell'aviazione si manifesterà s ui punti sensibili per la radunata avversaria; tali
punti devono essere concordati tra le due Forze Armate, limitandoli a quelli più indispensabili e di maggiore importanza, in modo da ottenere, con un'azione concentrata di mezzi aerei, la maggiore sicurezza di effetti.
Le LL.EE. Bonzani e Valle informano che tali accordi sono già stati presi, fissando un numero limitato di obiettivi classificati in ordine di importanza.
S .E. Badoglio prosegue affermando che l'intervento dell'aviazione nella battaglia sarà regolato dalla Direzione superiore delle operazioni; tale intervento sfugge evidentemente ad una regolamentazione o anche a preventive norme generiche, perché soltanto la situazione del momento potrà suggerire l 'e ntità e le modalità del concorso aereo. Una cosa è certa, che impegnandosi una grande battaglia, l'intervento dell'aviazione non potrà mancare.
Al riguardo ricorda che durante l'ultima guerra, ebbe personalmente a propugnare e a costituire, superando gravi difficoltà, due masse di aviazione da caccia e da bombardamento, le quali diedero nella battaglia s ul Piave i miglio1i risultati.
Il concorso dell'aviazione nella battaglia sarà assicurato dal Capo di S.M. Generale in diretto accordo con le forze armate interessate. Perché questo intervento possa esplicarsi efficacemente è necessario che l'Aeronautica consideri nel suo addestramento tale eventualità di concorso. Al riguardo ha già avuto assicurazione dall'Aeronautica circa l'adde stra mento al tiro di caduta e all'azione a bassa quota, cosicché questa Forza Armata sa rà certamente in condizione di intervenire utilmente nella battaglia.
S.E. Valle conferma facendo tuttavia presente che occorrerà prima disporre delle necessarie dotazioni di mobilitazione come anche di apparecchi rispondenti allo scopo.
S.E. Badoglio, passando all'esame del piano operativo nell' I potes i Est, domanda quale sia il numero di divisioni che in questa Ipote si verrebbe lasciato alla frontiera occidentale.
S.E. Bonzani informa che tali divisioni sarebbero in numero di 7.

S.E. Badoglio esprime il parere che le misure di protezione alla frontiera occidentale debbano essere ridotte al minimo, in corrispondenza dell'ipotesi politica posta da S.E. il Capo del Governo. Se vi fosse qualche dubbio sull'atteggiamento della Francia non saremmo più nell'ipotesi ora posta e quindi verrebbero adottate altre disposizioni. Ad ogni modo, è da tener presente che le comunicazioni longitudinali della Valle Padana consentirebbero in caso di bisogno uno spostamento abbastanza rapido di forze da una fronte all'altra.
S.E. Bonzani fa presente che la semplice forza di pace delle unità francesi metterebbe la nostra copertura alla frontiera occidentale in difficile situazione durante il periodo di forza minima. Per questa ragione
il numero delle unità dislocate alla frontiera occidentale non potrebbe essere ridotto al disotto di un certo numero, anche quando si vogliano prendere semplici misure di sicurezza, rinunziando ad avere una vera e propria copertura. Per quanto riguarda i movimenti tra le due fronti fa presente che per lo spostamento di 6 divi s ioni da una fronte all'altra occorrono 8 giorni.
S.E. Badoglio chiarisce nuovamente che S.E. il Capo del Governo , nel tracciare l'Ipotesi Est, ha affermato che tale ipotesi non risponde alla situazione attuale ma ad una eventualità che potrebbe in avvenire verificarsi; gli studi relativi debbono perciò prescindere dalle preoccupazioni attuali e considerare le disposizioni che dovrebbero essere prese qualora la nuova ipotesi venisse a verificarsi. È chiaro che se le condizioni relative a questa ipotesi non si verificassero, noi saremmo orientati con conveniente anticipo al riguardo e quindi liberi di adottare le disposizioni relative all'ipotesi di guerra su due fronti.
Per quanto riguarda il numero delJe unità da lasc iare alla fronte ovest nell'Ipotesi Est , occo1Te che un certo numero di esse, costituenti riserva, vengano considerate disponibili per l ' impiego sull'altra fronte e quindi tenute pronte a muovere non appena le eventuali incertezze iniziali venissero eliminate.
S.E. Bonzani conviene in queste considerazioni, facendo anche presente che alle disposizioni ora studiate è stato anche indotto dalla considerazione che non conviene s tudiare due diversi d i spositivi di copertura. D 'altra parte la rapidità dell 'a ttuale radun ata su due fronti è facilitata dal fatto stesso della ripartizione delle unità in due scacchieri; nel caso che la radunata dovesse compiersi su una so la fronte , essa richiederebbe certamente un tempo maggiore .

S.E. Bonzani passa poi ad esporre le linee fondamentali del piano di operazioni per un'azione offensiva nell'Ipotesi Est.
In tale Ipotesi s i ritiene che la Jugoslavia possa schierare in corris pondenza della nostra fronte 16 divisioni più l divisione di cavalleria, sulle 26 divisioni (oltre la Guardia reale) e 2 divisioni di cavalleria che essa può mobilitare. Si presume che la Jugoslavia assuma atteggiamento difensivo , disponendo in copertura alla nostra frontiera 3 divisioni fanteria e l divisione cavalleria oltre le fonnazioni speciali di confine, e sc hierando il grosso dell'esercito s ulla cosiddetta linea di Littaj (Grintovec - orlo occidentale della conca di Lubiana - Risnjak - golfo di Buccari).
Da parte nos tra verrebbero schierate alla fronte giu li a 19 divisioni fanteria, 2 brigate alpini e 2 divi s ioni celeri, oltre a tre divisioni tenute a disposizione del Comando Supremo. Delle rimanenti divisioni fanteria 7 verrebbero tenute alla frontiera francese, 1 in Sardegna, 1 in Sicilia, 1 divisione verrebbe inviata a Zara e 2 divisioni in Albania.
Tenuto conto della limitata superiorità iniziale delle nostre forze, i compiti verrebbero così limitati, in primo tempo:
a) immediata recisione del saliente castuano,
b) successiva recisione del saliente dell'alta Sava,
c) rovesciamento della copertura jugoslava e occupazione dell'orlo occidentale della conca di L ubiana,
d) occupazione della cosiddetta «linea viola» (Stegenek - StorzidKrainburg - M. Krim - M. Machovec - M. Boukar - Prezid - Suhi VrhBuccari).
In secondo tempo si procederebbe all'attacco della linea di Li ttaj in direzione di Zagabria.
Il secondo tempo potrebbe anche seguire immediatamente il primo , se la sicura neutralità assoluta della Francia, l'entrata in azione di altri Stati, la crisi interna della Jugoslavia creassero una situazione politicomilitare favorevole.
L'operazione a) verrebbe eseguita immediatamente; l 'operaz ion e b) verrebbe eseguita verso il 10° giorno di mobilitazione; il movimento generale potrebbe avere inizio verso il 13 ° giorno.
Le forze verrebbero ripartire in 3 armate:
2a Armata (7 divisioni fanteria, 2 brigate alpine, 2 divisioni celeri) a Nord;
3a Armata (6 divisioni fanteria) a Sud;
4a Armata (6 divisioni fanteria); inoltre 3 divisioni a disposizione del Comando Supremo.
Linea di contatto fra 2• e 3• Armata: strada Postumia-GrahovoLaschitz- Obergu (alla 2• Armata).
P er quanto riguarda le possibili operazioni offensive dalla Dalmazia e dall'Albania verso l'interno della Ju goslavia:
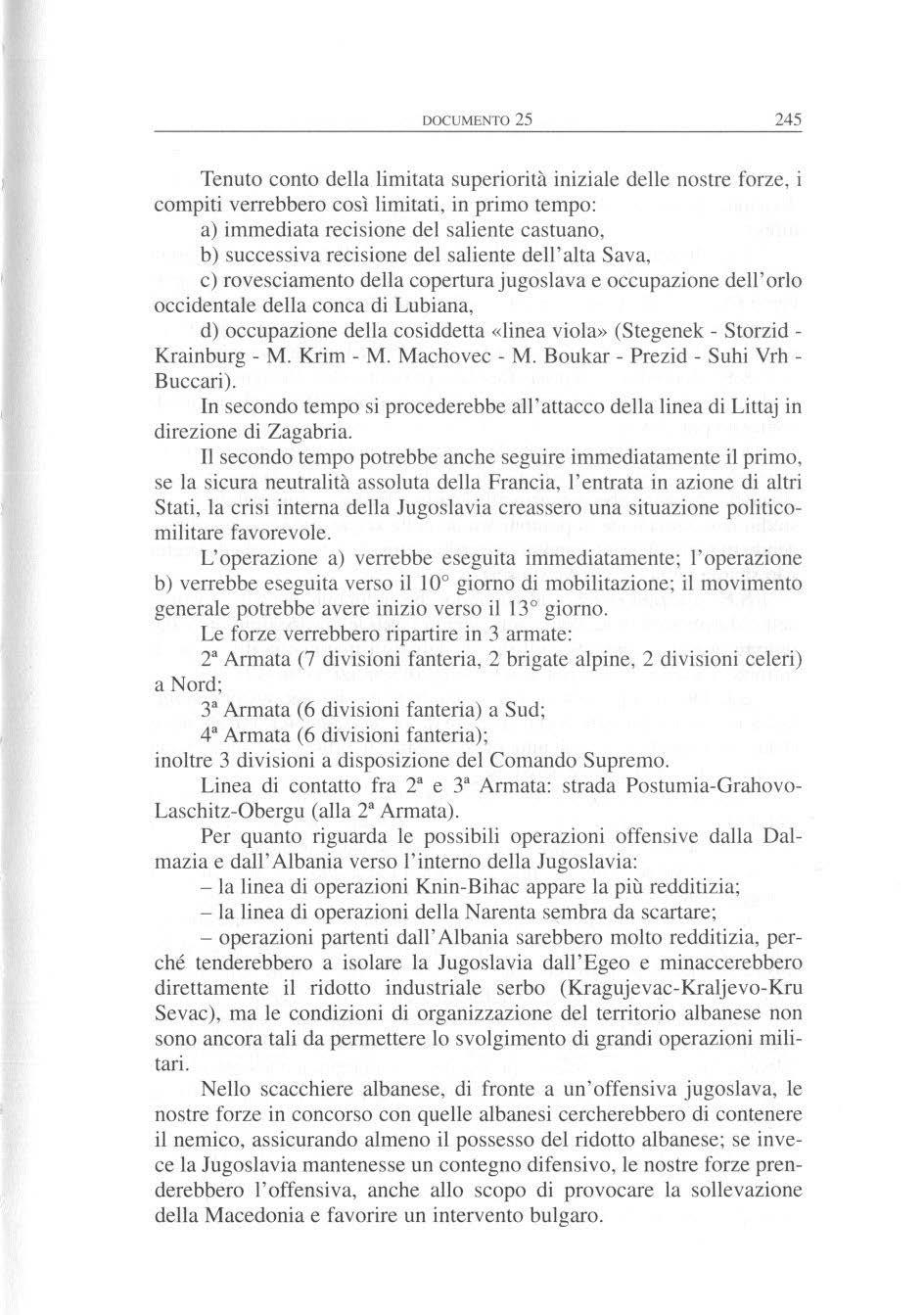
- la linea di operazioni Knin-Bihac appare la più redditizia;
- la linea di operazion i della Narenta sembra da scartare;
- operaz ioni partenti dall'Albania sarebbero molto redditizia, perché tenderebbero a isolare la Ju goslavia dall'Egeo e minaccerebbero direttamente il ridotto industriale serbo (Kragujevac-Kraljevo-Kru Sevac), ma le condizioni di organizzazione del territorio alba nese non sono ancora tali da permettere lo svolgimento di grandi operazioni militari.
Nello scacchie re albanese, di fronte a un'offensiva jugoslava, le nostre forze in concorso con quelle albanesi cercherebbero di contenere il nemico, assicurando almeno il possesso del ridotto albanese; se invece la Jugoslavia mantenesse un contegno difensivo , le nostre forze prenderebbero l 'offensiva, anche allo scopo di provocare la sollevazione della Macedonia e favorire un intervento bulgaro.
Nello scacchiere zaratino, il nostro presidio, rinforzato dalla 18" divisione, potrà, a seconda delle circostanze, estendere il raggio della difesa.
S.E. Bonzani informa che gli studi relativi all'Ipotesi Est vengono per ora limitati ai Comandi di armata, non ritenendosi opportuno aggravare i Comandi di corpo d'armata e gli organi djpendenti con nuovi studi in aggiunta a quelli in corso che rispondono a necessità più w-genti. In sostanza questi studi non hanno per il momento carattere esecutivo.
S.E. Badoglio conco rda , facendo presente che, in ogni caso gli studi ora compiuti rappresentano un utile orientamento per gli organi di comando più elevati.
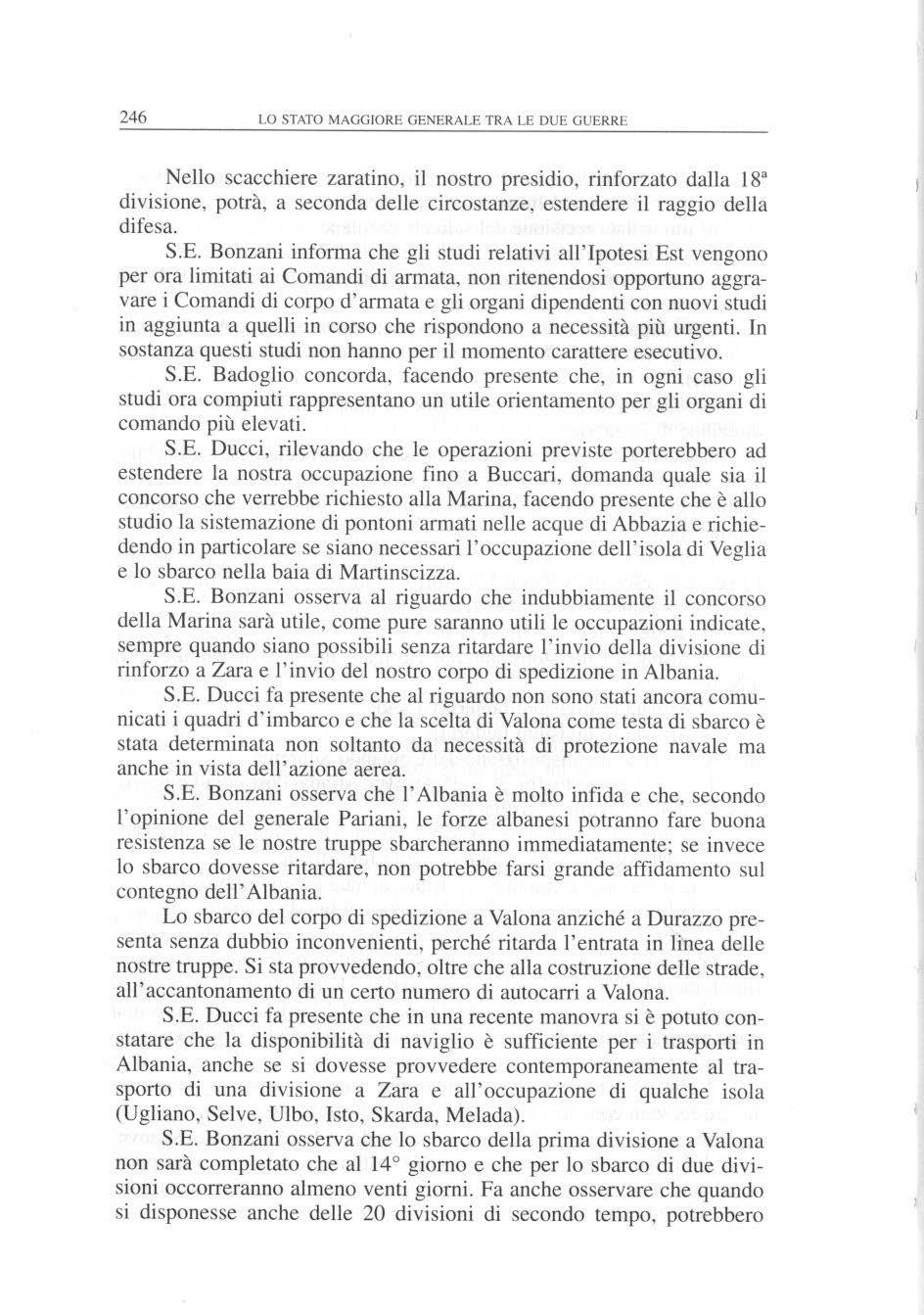
S.E. Ducci, rilevando che le operazioni previste porterebbero ad estendere la nostra occupazione fino a Buccari, domanda quale sia il concorso che verrebbe richiesto alla Marina, facendo presente che è allo studio la sistemazione di pontoni armati nelle acque di Abbazia e richiedendo in particolare se siano necessari l'occupazione de ll 'isola di Veglia e lo sbarco nella baia di Martinscizza.
S.E. Bonzani osserva al riguardo che indubbiamente il concorso della Marina s arà utile, come pure saranno utili le occupazioni indicate, sempre quando s iano pos s ibili senza ritardare l'invio della divisione di rinforzo a Zara e l'invio del nos tro corpo di spedizione in Albania.
S.E. Ducci fa presente che al riguardo non so no stati ancora comunicati i quadri d'imbarco e che la scelta di Valona come testa di s barco è s tata determinata non soltanto da necess ità di protezione navale ma anche in vista dell'azione aerea.
S.E. Bon zani osserva che l'Albania è molto infida e che, secondo l ' opinione del generale Pariani , le forze albanesi potranno fare buona resistenza se le nostre truppe sbarcheranno immediatamente; se invece lo sbarco dovesse ritardare, non potrebbe farsi grande affidamento s ul contegno dell ' Albania.
Lo s barco del corpo di s pedizione a Valona anziché a Dura zzo prese nta se nza dubbio incon venienti, perché ritarda l' e ntrata in linea delle nostre truppe. Si sta provvedendo, oltre che alla costruzione delle strade, all'accantonamento di un certo numero di autocarri a Valona.
S.E. Du cci fa presente che in una recente manovra si è potuto cons tatare che la disponibilità di nav iglio è sufficiente per i trasporti in Albania, anche se s i dovesse provvedere contemporaneamente al traspo rto di una divisione a Zara e all ' occupazione di qualche isola (Uglìano, Selve, Ulbo , Tsto , Skarda, Melada).
S.E. Bon zan i osserva che lo sbarco della prima divisione a Valona non sarà completato che al 14° giorno e che per lo sbarco dì due divisioni occorreranno almeno venti giorni. Fa anche osservare che quando s i disponesse anche delle 20 divisioni di secondo tempo, potrebbero
essere prese in considerazione operazioni per la direttrice Knin-Bihac. Escluderebbe inv ece la direttrice della Narenta.
S.E. il Capo di Stato Maggiore Generale prende atto degli studi fatti eseguire da S.E. il Capo di S.M. dell'Esercito per l'Ipotesi Est, nell'intesa che una parte delle divisioni inizialmente dislocate, secondo tali studi, alla frontiera occidentale verrà tenuta pronta a muovere per essere trasferita alla frontiera orientale, non appena la situazione politica inizia le appaia consolidata.

Ri mane altresì stabilito - anche per quanto riguarda il concorso delle altre Forze Armate - che nell'Ipotesi Est verranno attuate non soltanto le previste operazioni in Albania e di Zara e isole adiacenti, ma anche di altre isole nell'Alto Adriatico, secondo lquanto] potrà essere in seguito definito.
S.E. Badoglio passa poscia all'esame di alcune questioni particolari. Chiede a S.E. il Capo di S.M. dell'Esercito a qual punto sia la preparazione delle nuove Norme generali. Egli ritiene che il rifacimento delle attuali norme sia di grande importanza, perché esse sono ancora informate a concetti pre-bellici, non tenendo conto adeguato della potenza del fuoco e della necessità di risparmiare la fanteria mediante un ' adeguata preparazione di fuoco svolta dall'artiglieria. Le attuali norme, trascurando questa verità fondamentale messa in luce dalla guerra, hanno indubbiamente ingenerato un senso di smarrimento nei quadri, i quali d'altra parte sentono la necessità di avere un orientamento deciso mediante norme poco numerose ma chiare e precise.
S.E. Bonzani informa che tale rifacimento è già in corso.
S.E. Bad oglio prende atto con compiacimento di tale notizia e prega
S.E. il Capo di S.M. dell'Esercito di considerare, interessandone anche
S.E. il Ministro, l'opportunità di ribadire i l principio della inscindibilità della divisione, di cui la guerra ha ampiamente dimostrato la necessità. Ricorda al riguardo che la inscindibilità fu stabilita dietro sua insistenza nel 1918 e si dimostrò provvedimento molto utile. L'ordinamento del 1926, introducendo la divisione ternaria, vo leva ancor meg li o fissare questo principio, ma egli rileva come ancora lo spirito di brigata soverchi quello di divisione, il quale dovrebbe fondere insieme le varie anni.
È sua opinione che occorrerebbe, per facil itare lo sv iluppo di questo spirito divisionale, assegnare alle divisioni anziché un numero un nome, comu ne ai reparti delle varie armi che fanno parte delle divisioni stesse, e assegnare ai reparti medesimi le stesse mostrine distintive.
S.E. Bonzani riconosce in linea generale i l principio della inscindibilità della divisione; fa tuttavia osservare che le condizioni particolari del nostro schieramento nell' Ip otesi di guerra su due fronti non consentono in frequenti casi di rispettare questa inscindibilità.
D'altra parte la superiorità di artiglieria che occorre avere imporrà in molti casi di rinforzare le divisioni di prima schiera con le artiglierie delle divisioni di seconda schiera; e in altri casi anche nella difensiva non sarà possibile legare pennanentemente un elemento di grande resistenza come l 'artiglieria , con un elemento sottoposto a logoramento più rapido come la fanteria.
Al riguardo comunica che le esercitazioni completive recentemente compiute, alle quali hanno partecipato nel complesso circa la metà delle nostre unità d'artiglieria, hanno messo in evidenza il notevole perfezionamento e l ' uniformità di addestramento oggi raggiunti dalla nostra artiglieria. Tale uniformità di addestramento ci dà garanzia che l'assegnazione di unità d'artiglieria a grandi unità diverse da quelle organiche potrà compiersi senza inconv enienti.
S.E. Badoglio, pur riconoscendo tale situazione, 1itiene che essa non infirmi in alcun modo la necessità di disporre di divisioni complete e bene amalgamate; tali divisioni avranno un utile rendimento anche se dovessero venire scisse; e in ogni caso saranno di miglior rendimento quando esse dovranno essere nuovamente riunite.
S.E. Badoglio chiede poi notizie circa la s ituazione qualitativa delle no stre artiglierie.
S.E. Bonzani comunica che tale s ituazione può ritenersi soddisfacente, in quanto se la Francia e la Jugoslavia dispongono di bocche di fuoco di maggiore gittata, l'Italia dispone per contro di una maggiore proporzione di artigliere someggiate atte al traino in montagna , le quali consent iranno così di compensare con le più estese possibilità di sc hieramento il difetto di gittata.
Secondo quanto è già stato comunicato a S.E. il Capo di S.M. Generale, si provvederà alla sostituzione dell'obice da 75/13 con un altro obice già definito; si tende a diminuire nelle divisioni la proporzione delle unità di cannoni da 75/27 per farne reggimenti motorizzati d'artiglieria leggera, da impiegare come ri serva generale; l'obice da 100/17 verrà mantenuto, ma adottando nuovi proietti di maggiore gittata e di maggiore potenza; il cannone da 105 verrà mantenuto, con l'adozione di un nuovo proietto, il quale consentirà due km. di maggiore gittata; la sost ituzione dell'obice da 149/12 è d'importanza fondamentale; s i spera che entro l'anno esso verrà sostituito con materiale da 149/12 modello Skoda, che è in corso di riordinamento.

La sostit uzione del cannone da 149 richiederà ancora tempo per la definizione del primo esemplare.
Per i materiali e.a. autocampali sono in corso trattative con la Ditta Bofors per l 'ac quisto del materiale da 80; altre trattative so no in corso con la Ditta Vickers per un materiale da 75. È in corso una commessa di mitragliatrici e.a. da 20 mm. Solothurn atte anche al tiro contro carri e
munite di proietto scoppiante-tracciante. Tali mitragliatrici sono di notevole efficacia nel tiro e.a. fino alla quota di 2000 m., cosicché esse potranno riuscire di particolare utilità sulla frontiera occidentale, dati g li attuali limiti di quota pratici degli aerei avversari.
Tenuto conto di questa circostanza e del fatto che alla frontiera orientale le condizioni generali del terreno consentono una migliore copertura delle truppe, il numero delle nuove bocche da fuoco e.a. autocampali potrebbe essere abbastanza limitato, compensando il notevole costo di queste moderne bocche da fuoco.
Per la difesa e.a. delle retrovie verranno utilizzati su speciale affusto i cannoni da 77 come pure quelli da 76/40 già avuti e che ancora potranno essere ceduti dalla Marina.
La sit uazione del munizionamento è soddisfacente. Disponiamo delle giornate di fuoco previste, salvo per gli obici da 100, per i quali si ha una deficienza di l /4 e per i cannoni da 105 per i quali manca 1/ l O del munizionamento.
A richiesta di S.E. Badoglio, S.E. Bon zani informa che l'assegnazione di un secondo gruppo someggiato in sostituzione di un gruppo da 75 ippotrainato è stata effettuata per tutte le divisioni di frontiera e per quelle di Ancona, Bari e Chieti; la costituzione delle terze batterie nei reggimenti di frontiera viene effettuata so ltanto in alcune divisioni a causa della deficienza di forza bilanciata.
La seduta è chiusa alle ore 11,45, rinviando la riunione alle ore 16 del giorno 7 novembre p. v
A.U.S.S.M.E fondo H- 10 «Verbo/i riunioni 1924 - 1943», busta 11. 2.fascicolo 11. 6. Il documento è una copia dell'Ufficio del capo di Stato Maggiore Generale.

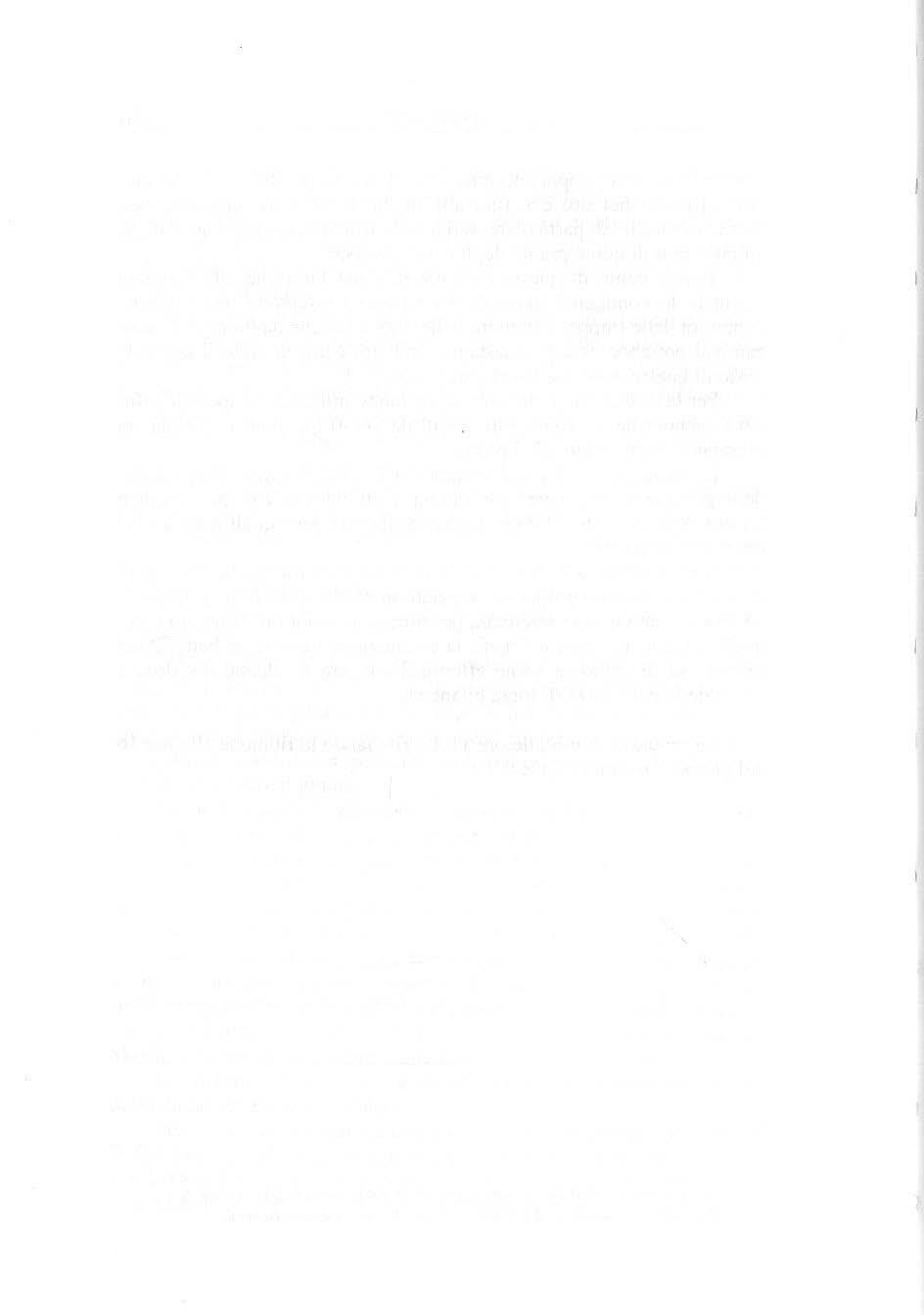
« Prepara z ione della guerra c ontro la Francia e la Jugoslavia (Ipotesi di guerra su due fronti) e contro la sola Jugoslavia (Ipotesi Est): fabbisogno di automez zi per le for ze armate, organizz a zione difensiva delle frontiere est ed ovest, organiz za zione difensiva e impiego dell'avia z ione in Albania, organizza zione difensiva di Zara, gu e rra chimic a ».
Verbale della riunione del 7 novembre 1931 - X
La riunione viene tenuta nel salone antistante all'ufficio di S.E. il Capo di Stato Maggiore Generale.
La seduta è aperta alle ore 16.
Sono presenti le stesse autorità indicate nel verbale della riunione del 5 novembre <a> .
S.E. Badoglio domanda a S.E. il Capo di Stato Maggiore dell'Esercito quale sia la situazione di mobilitazione rispetto agli automezzi.
S.E. Bonzani informa che il notevole incremento verificatosi nel numero degli autocarri ha consentito di coprire il totale fabbisogno di 40 .000 autocarri occo rrenti per 40 divisioni, dei quali 30.000 circa ( 18 .000 pesanti e 12.000 leggeri) dovrebbero essere forniti dalla requisizione.
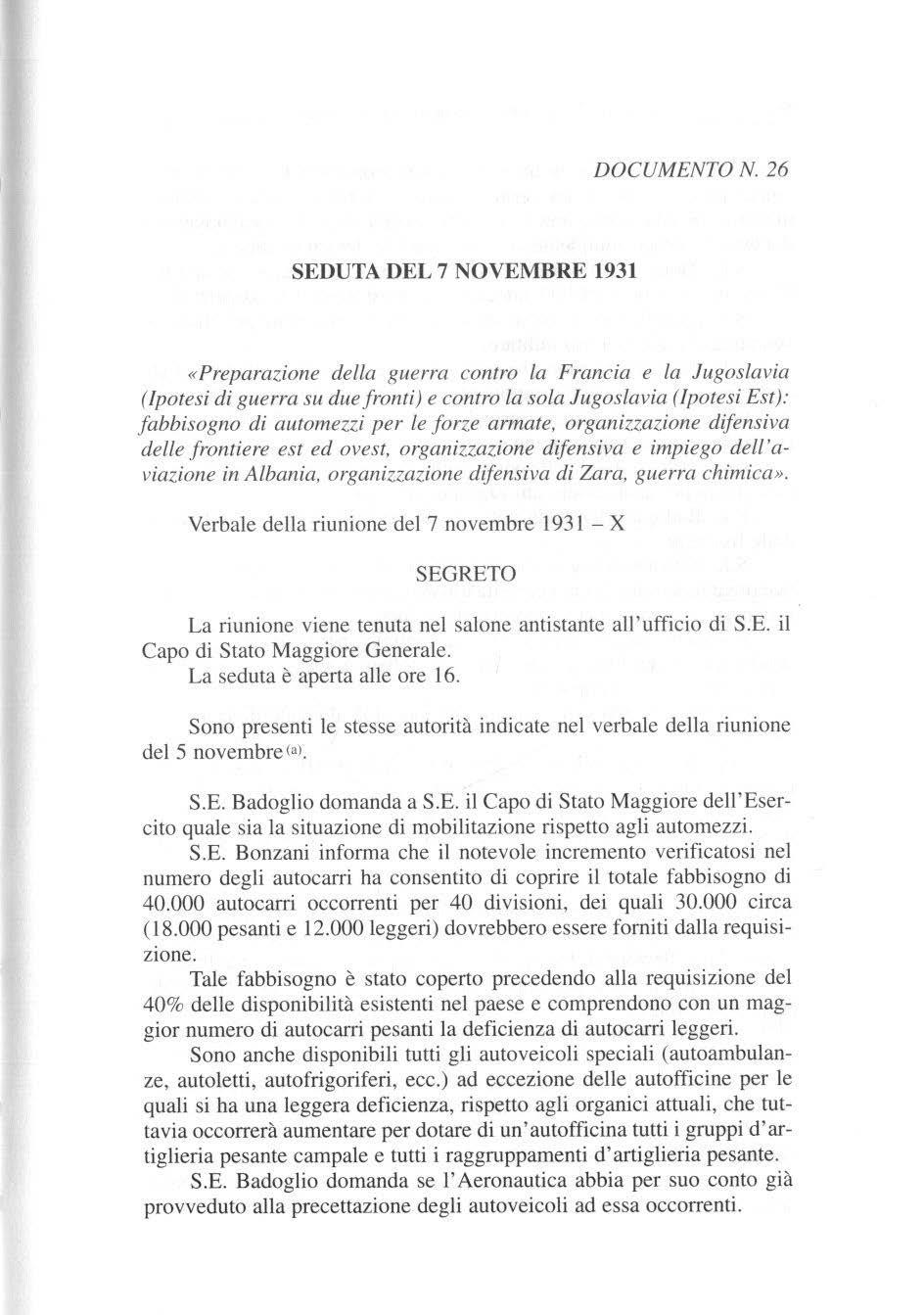
Tal e fabbisogno è stato coperto precedendo alla requisiz ione del 40% delle disponibilità es iste nti nel paese e comprendo no con un magg ior numero di autocarri pesanti la deficienza di autocarri leggeri.
So n o an c he disponibili tutti gli autoveicoli spec iali (autoambu lanze, autoletti, autofrigoriferi, ecc.) ad eccezione delle autofficine per le quali si ha una leggera deficienza, rispetto agli organici attuali, che tuttavia occorrerà aumentare per dotare di un'autofficina tutti i grup pi d'artiglieria pesante campale e tutti i raggruppamenti d 'arti g lieria pesante.
S.E. Badog li o d oma nd a se l'Aeronautica abbia per suo conto già provveduto alla precettazione degli autoveicoli ad essa occorre nti.
S.E. Valle informa che ad essa si sta provvedendo. Occorre tuttavia tenere presente che di un certo numero di autocarri sarà necessario disporre fin dalle prime ore; essi dovranno perciò essere accantonati fin dal tempo di pace completando con acquisti le dotazioni attuali.
S.E. Bonzani informa al riguardo che, per ragioni analoghe, l'Esercito tiene pronti 8.000 autocarri per le esigenze della copertura.
S.E. Badoglio domanda se sia stato istituito un premio per gli autoveicoli civili idonei a uso militare.
S.E. Bonzani informa che tale premio è previsto soltanto per gli autocarri a 6 ruote e per i trattori agricoli utilizzabili per le artiglierie. Aggiunge però che i trattori agricoli in pratica si sono dimostrati poco rispondenti, perché deteriorano eccessivamente le strade.
Comunque è stata predisposta anche la requisizione di trattori agricoli i quali potranno essere utilizzati per altri usi.
S.E. Badoglio domanda notizie circa la organizzazione difensiva delle frontiere.
S.E. Bonzani indica i concetti fondamentali che hanno presieduto a tale organizzazione, la cui necessità è stata imposta dalla situazione della guerra su due fronti, per economizzare le forze.
È stata esclusa un'organizzazione continua, per la quale - prescindendo dall'onere finanziario - mancherebbero i mezzi, per limitarla invece alle zone più importanti.
Questo concetto viene attuato con modalità alquanto diverse sulle due frontiere.
Sulla frontiera occidentale il possesso delle posizioni di confine ha importanza grandissima perché il terreno offre alla manovra scarso margine in profondità e perciò l'organizzazione in corso è quasi completamente concentrata su di esse , sulle quali si ha in animo di resistere ad oltranza.
Sulla frontiera orientale invece il possesso assoluto delle posizioni più vicine al confine ha minore importanza e perciò è stato possibile conferire all'organizzazione un carattere più elastico provvedendo, in corrispondenza delle zone di facilitazione, alla organizzazione di due linee:
- la prima linea per appoggiare la copertura ed eventualmente accettarvi battaglia;
- la seconda linea per originare le eventuali sacche e appoggiarvi la manovra.
La costituzione di bretelle fra le due linee completerà tale organizzazione la quale consentirà una difensiva spiccatamente manovrata.
Circa le zone da organizzare e il tipo di opere S.E. il Capo di S.M. Generale è già stato informato.
Tale organizzazione assume una configurazione speciale a seconda della confermazione delle singole zone; nelle zone ristrette (S . Anna,
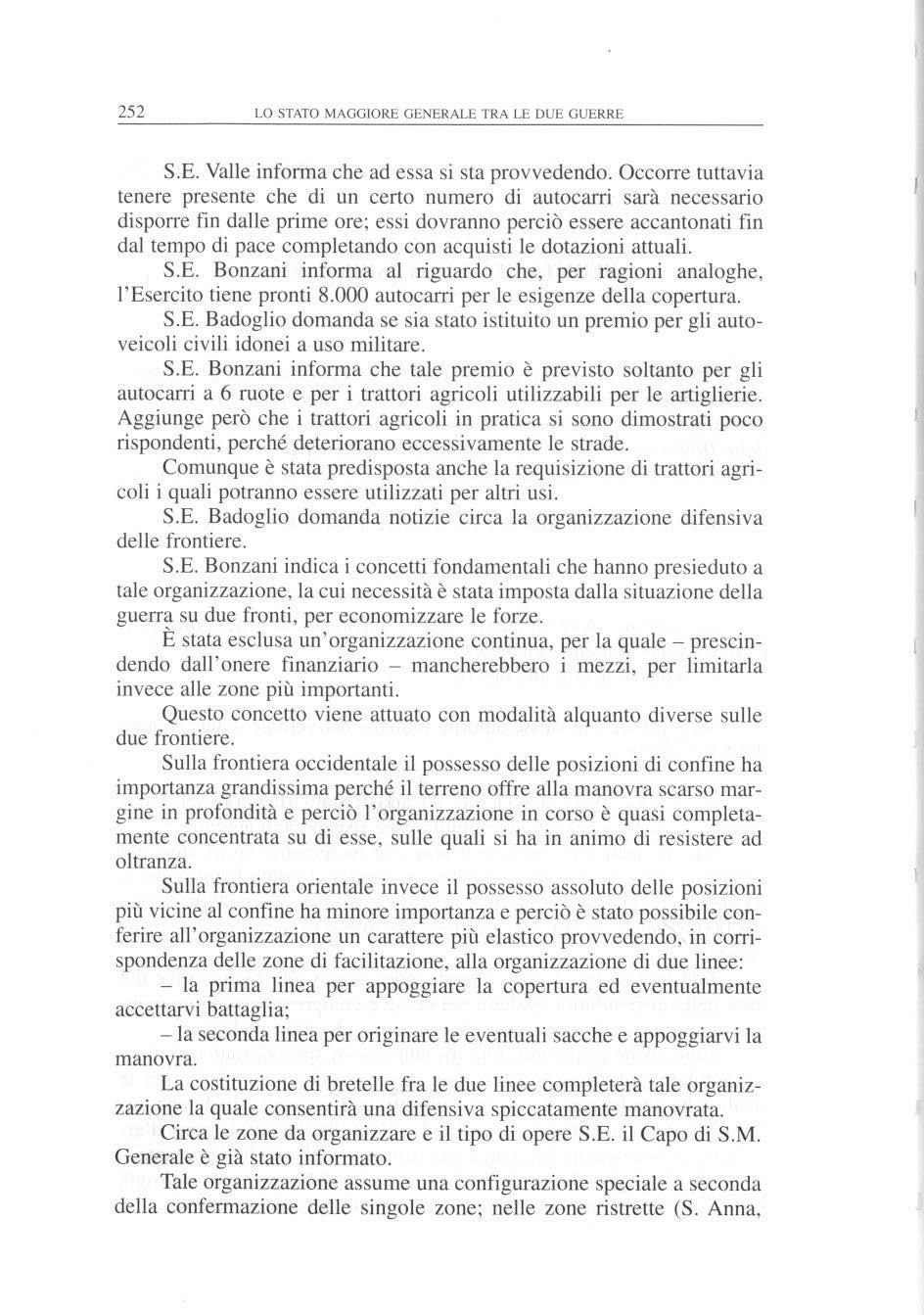
Coli al unga , strade del Nevoso) è organizzato un vero e proprio sbarramento; in altre zo ne, come al Monceni sio e a Cesana le organizzazioni si appoggiano agli ostacoli laterali; nelle zone aperte come ad esempio alla frontiera orientale, le organizzazioni presentano le ali ripiegate, a g ui sa di ridotta, per coprire le linee di facilitazione.
S.E. Badoglio chiede quale sia l'attuale stato di approntamento dei lavori.
S.E. Bon zani, procedendo ad un rapido esame dell'organizzazione delle singo le zone, infonna che i lavori compiuti sono relativamente limitati, anche perché nelle zone più elevate hanno dovuto essere interrotti, ma occorre tenere conto del tempo che è stato necessario per definire l'organizzazione ed avv iare il lavori superando anche le lentezze imposte da vincoli amministrativi.
Si può perciò ritenere - considerando tutte queste difficoltà - di essere all'incirca al 25-30% dell'approntamento complessivo (opere in costruzione, e progetti per quelle da costruirsi) come cifra di largo orientamento.
Comunque, entro l'anno 1932, se i fondi non verranno a mancare, la nostra organizzazione difensiva avrà raggiunto un buono stato di efficienza su entrambe le frontiere.

S.E. B onzani computa che con una spesa di 300 milioni possa provvedersi a tutta la organizzazione.
Tali lavori vengo no compiuti con mano d'opera civile. 1 reparti co nco rrono per loro parte alla sistemaz ion e, mediante costruzione di strade, predisposizione di postazioni, apertura di piste, ecc.
È anche da tenere presente che viene molto curata la conoscenza del terreno di frontiera e che, predisponendo l'affluenza dei richiamati alle unità dove hanno compiuto la ferma, s i potrà ottenere c he le unità di cope rtura utilizzino que sta conoscenza del terreno da prute del personale.
S.E. B adog li o domanda come si provvederà al presidio delle opere.
S.E. Bonzani comunica che si pensa di provvedervi mediante trasformazione di 1 o 2 compagnie dei battaglioni di copertura in altrettante compagnie mitragliatrici da posizione.
S.E. Bonzani informa poi che con criteri analoghi si sta provvedendo a ll'organiz zaz ione difensiva dell'Albania, la quale comprenderebbe:
- gli s barramenti della zona di Scutari e della zona dei La ghi collegati dagli sbarrame nti minori di Dibra;
un ridotto costituito dallo sbarram ento del M ari a Miloti e dallo sbarramento dello Skumbi a Elbassan, collegati dalla impervia muraglia di Kruja;
- una zona di manovra a S. Giorgio.
È a buon punto La predisposizione delle arterie stradali occorrenti alla manovra nella zona interna al ridotto.
Nessun lavoro stradale viene invece compiuto tra il confine e il ridotto, allo scopo di ostaco lare l'avanzala dei jugoslavi, i quali da loro parte stanno sviluppando continuamente oltre confine i lavori stradali.
Per quanto riguarda l'impiego delle nostre truppe, vi sono già accordi di massima col Generale Pariani; è così previsto che le nostre truppe debbano tenere lo sbarramento di Elbassan, lasciando alle forze albanesi il presidio di quelllo del Mati. Tali accordi di massima sono però subordinati alle necessità del momento.
Il Generale Pariani ha per sua parte fiducia nelle qualità del soldato albanese.

Comunque, occorre che le nostre truppe arrivino al più presto e S.E. Bonzani rappresenta perciò ancora la necessità che siano affrettati il trasporto e lo sbarco delle nostre unità.
S.E. Badoglio concorda pienamente circa ta le necessità , in vista della quale invita S.E. il Capo di S.M. della Marina a studiare le disposizioni per accelerare il trasporto e la messa a teITa delle nostre divisioni, usufruendo anche dei maggiori mezzi che risultano disponibili in s eguito alle nuove direttive impartite per «l 'Operazione l O».
S.E. Ducci ritiene che, grazie a questa maggiore disponibilità , possa aversi certamente un vantaggio; prevede tuttavia che le maggiori difficoltà si avranno per l'insufficienza delle banchine e segnala al riguardo il caso del porto di Brindi si, dove la costruzione già deliberata di un mercato ostaco lerà gravemente le operazioni di imbarco in corrispondenza della banchina normalmente utiJizzata.
S.E. Valle ricorda , per quanto riguarda la necessità del nostro pronto intervento in Albania, che l'esperimento compiuto lo scorso anno della mobilitazione e del trasferimento in volo di uno stormo Du razzo, ha dimostrato la possibilità per la nostra aviazione di intervenire nelle primissime ore e aggi un ge che tale esperimento produsse negli ambienti militari albanesi la migliore impressione.
Fa presente tuttavia S.E. Vall e che, allo stato attuale delle cose, la nostra aviazione potrebbe bensì intervenire subito, anche in forze notevoli, utilizzando i materiali meno recent i che avrebbero in Albania buono impiego, ma s i troverebbe nella imp oss ibilità di vivere e di operare se non si addivenisse a lla cost itu zio ne di depositi di be nzin a e di bombe.
S.E. B adoglio ricono sce tale necessità e informa che al riguardo interesserà direttamente S.E. il Capo di Governo. Prega S.E. Valle di fornire i dati occorrenti per formulare con maggiore precisione tale richiesta.
S.E. Bonzani, proseguendo la s ua esposizione circa lo stato attuale della organizzazione difensiva, informa che la cinta di sic urezza di Zara è quas i ultimata, salvo per il caposaldo di Bocagnazzo , e che le o pere da
costruirsi, per la maggior parte in roccia, danno affidamento di efficace resistenza, anche perché s i prevede di avere di fronte soltanto artiglierie da campagna sussid iat e da pochi pezzi da I 05 e da 150.
Le nostre artiglierie compre nd ono: 2 batterie da 75/906; l batteria da 100/17 e l batteria da 149/35, a11' azione delle qual i si aggiungerà, secondo le informazioni di S.E. Du cci, quella delle due batterie da 76 e dei 2 pontoni da 15 sistemati dalla Marina.
S.E. Badoglio domanda notizie circa la situazione attuale della organizzazione chimica.
S.E. Bon zani informa che per quanto riguarda i mezzi offensivi, il centro chimico unificato e i centri chimici sussidiari presso alcune università hanno diretto i loro studi verso la ricerca di nuovi aggress ivi, ma finora si hanno limitate speranze. data la difficoltà di ricercare un nuovo composto non soltanto efficace ma anche adatto a una riproduzione industriale. Per conseguenza occorre per ora fare affidamento sui tre tipi attuali: fosgene, iprite e arsine. Fa rilevare incidentalmente che i mezzi chimici offensivi vengono predisposti per il loro impiego come ritorsione, essendo convinto che l ' It alia non abbia alcuna convenienza a iniziare per prima la guerra chimica.
Circa le modalità d'impiego si incontrano difficoltà a definire i prodotti tossici per cannoni, a causa del!' alta velocità iniziale; proseguono gli studi e le esperienze.
È prevista una dotazione di due giornate di fuoco a liquidi speciali, delle quali una nei magazzini d'armata, 2/3 car ichi nei depositi centrali e 1/3 scarico presso gli stabilimenti territoriali.
S.E. Badoglio accenna all' impie go dell'iprite per lo sbarramento di alcune zone di frontiera, ricorda ndo che al riguardo egli ebbe a chiedere a S.E. il Capo del Governo l'autorizzazione a ricorrervi eventualmente anche fin dal periodo di sicurezza; e che a tale richiesta non è stata ancora data risposta esplicita.
Ril eva che da quanto è stato osse r vato in Libi a, e secondo quanto gli è stato riferito recentemente, sperimentato anche in Italia, l'iprite perderebbe rapidamente la s ua efficacia a contatto del terreno e per effetto del calore. Domand a perciò - prima di rinnovare la richiesta a S.E. il Capo del Governo - se si possa fare affidamento sull'efficacia degli sbarramenti ad iprite proposti.
S.E. Bon zani ritiene che co nvenga non rinunziare a questo mezzo, in quanto l'ipritazione potrà in alcune zone essere agevolmente ripetuta. I mezz i occorrenti potranno essere accantonati nella zona di frontiera nel 1932.
S.E. Badoglio comuruca che, così stando le cose scriverà al riguardo a S.E. il Capo del Governo.

S.E. Bonzani riprende la sua esposizione, comunicando che sono anche allo studio un nuovo tipo di lanciabombe del genere Livens e apparecchi di irrorazione più rapidi.
Si studiano altresì la produzione e l ' impiego dei nebbiogeni, per i quali si incontrano molte difficoltà, sia per superare la grande sensibil ità alle condizioni atmosferiche sia per determinare i procedimenti di impiego.
La provvista di sostanze tossiche è a buon punto; si dispone di 916 tonn. di iprite (ne mancano 184 per raggiungere il prescritto fabbisogno) di tutto il fabbisogno di fosgene, del 60% di arsine. Nessuna preoccupazione per la cloropicrina.
Per quanto riguarda i mezzi difensivi occorrebbero 1.600.000 maschere; ne abbiamo 600.000 , e presto altre 200.000. Disponiamo dei 30.000 indumenti antipritici previsti. Le divisioni di frontiera hanno già taJe dotazione a l completo.
Poco si è fatto per Ja protezione dei quadrupedi , ma il problema è meno preoccupante, perché essi hanno maggiore resistenza.
S.E. Badoglio chiede informazioni circa il funzionamento del Servizio unificato, nei riguardi della collaborazione della Marina e dell'Aeronautica.
S.E. Ducci ritiene che l'indirizzo dalo dall'attuale direttore al funzionamento del Servizio chimico ostacoli da una parte il collegamento con la Marina mentre dall'altra tenda ad invadere il campo di attribuzioni della Marina. È del parere che l'attività del Servizio chimico debba essere contenuta, in conformità del decreto istitutivo, al campo scientifico, lasciando alle singole Forze Armate lo studio delle applicazioni, le quali in molti casi assumono per ciascuna di esse aspetti particolari.

La Marina provvederebbe a mantene rsi a giorno di quanto realizza il Servizio chimico, mediante ufficiali propri distaccati presso il Servizio stesso.
S.E. Valle si associa a quanto ha esposto S.E. Ducci, rilevando che anche l'Aero nautica non può attualmente tenersi collegata e che il Servizio chimico no n ha dedicato attenzione alle sue particolari rich ieste, tra le qual i assai importante lo studio di mezzi chimici offensivi meglio adatti ad essere impiegati dagli aerei. Ad esempio sostanze atte a produrre nub i di gas più stabili de l fosgene e impiegabili, in co ndizioni di vento favorevoli, per distendere a distanza dalla costa nemica, per intossicare obiettivi costieri. Ritiene anche che il Servizio chimico debba interessarsi al mantenimento e allo sviluppo delle industrie chimiche, dalle quali soltanto possiamo attendere una produzione adeguata.
S.E. Badoglio, rilevando quanto è stato acce nnato circa il particolare indirizzo i mpresso dall'attuale direttore del Servizio chim ico, comunica che sull'argomento riferirà a S.E. il Ministro della Guerra.
In sostanza si tratta di contenere e indirizzare l'attività del Servizio chimico nei limiti stabiliti dal decreto istitutivo, lasciando alle singole forze armate di valersi dei risultati degli studi del Servizio stesso per le applicazioni particolari di ciascuna di esse. In questa intesa raccomanda alle Forze Armate di avere fiducia nell'opera di questo importante servizio e di valersene anche contribuendo con personale proprio a l suo funzionamento.
La seduta è chiusa alle ore 18 e rinviata alle ore 10 di Domenica 8 corrente.



«Preparazione della guerra contro la Francia e la Jugoslavia (Ipotesi di guerra su due fronti) e la sola Jugoslavia (Ipotesi Est): situazione e preparazione delle basi navali, difesa di Zara, Saseno, Valona e Durazza, situazione della nostra flotta nei confronti di quella francese, portaerei ed elicotteri, protezione chimica per la flotta».
Verbale della Riunion e dell' 8 novembre 193 1 - X
La riunione viene tenuta nel salone antistante all'ufficio di S.E. il Capo di Stato Maggiore Generale.
La seduta è aperta alle ore 10.
Sono presenti le stesse autorità indicate nel verbale della riunione del 5 e del 7 corrente <a> .
S.E. Badoglio prega S.E. il Capo di S.M. della Mru.ina di esporre quanto riguarda l'apprestamento delle basi navali.
S.E. Ducci premette che necessità politiche hanno obbligato in quest i ultimi anni a dare un g rande impulso alle nuove costruzioni navali riducendo al minimo le altre opere, particolarmente quelle relative alle basi. Comunque S.E. il Ministro della Marina ha cercato, nei limiti delle disponibilità, di aumentare lo stanziamento per le basi.
Passa poi ad esporre la situazione attuale delle singole basi.
La difesa a mare della Spezia è basata essenzialmente su lle due batterie da J52/50 del Tino e di P. Bianca, le quali lasciano un settore morto che potrebbe essere sfruttato per il bombardamento della piazza. Fu proposto di rimediarvi, mediante la costruzione di una nuova batteria o anche con lo spostamento di una delle batterie esisenti di obici. Finora tuttavia nulla è stato fatto, essendosi giudicato poco probabile un attacco con navi.
Rileva che in una delle batterie di obici del RE. si sarebbe accennato un difetto di solidità del parapetto nel cui spessore sono stati ricavati i depositi munizioni.
S.E. Badoglio osserva che sarà bene accertarsi della situazione per provocare i provvedimenti necessari.
S.E. Ducci prosegue comunicando che le difese subacquee le organizzazioni portuali sono in condizione soddisfacente.
Per quanto riguarda la difesa contraerei - la quale assume nel caso speciale massima importanza - la piazza dispone di 17 batterie e quindi è anche sotto questo aspetto in condizioni soddisfacenti, salvo per quanto riguarda la difesa contraerei a bassa quota. Mancano infatti le mitragliatrici da 13.2 già commesse.
È da rilevare però che la sola batteria e.a. sperimentale della Palmaria viene tenuta permanentemente armata e che col personale destinato normalmente ai servizi meno importanti, si potrebbero al massimo, in caso di mobilitazione, armare subito 5 batterie; occorrerebbero 3 giorni per annarne altre 5, mentre le rimanenti sarebbero armate con la mobilitazione generale entro il 14° giorno. D'altra parte, occorre anche tener conto del limitato addestramento del personale richiamato dal congedo.
Per rimediare a questa situazione, da una parte si procede ogni anno a parziali richiami, dall ' altra si cerca di accelerare la mobilitazione richiamando elementi locali, come già è stato fatto per la Sardegna e per l'Elba. Incidentalmente fa notare come per armare le batterie della Sardegna sia necessario, nonostante l'utilizzazione di tutti i richiamati dell'isola , inviarvi ali' atto della mobilitazione 3000 uomini.
Quanto all'impiego del fumo per la protezione della base, esso non è privo di inconvenienti , anche per la spesa che richiederebbe un uso molto esteso. Al riguardo si pensa di utilizzare anche gli opifici di Spezia dotati dj caldaie per produrre fumo di nafta. In massima si è di opinione che il fumo serva finché le batterie non siano tutte armate, cioè nei primi I 5 o 20 giorni.
Le condizionj del munizionamento sono buone; non tutto però si trova in prossimità delle batterie. Occorrerebbe perciò trasportarvelo al momento del bisogno.
Al riguardo rileva che l'Esercito mantiene a Spezia ingenti depositi munizioni, il cui movimento potrebbe intralci::u·e nei primi giorni di guerra il trasporto delle munizioni per le batterie e.a. della Marina.
1n particolare accenna al deposito di V. Durasca, per il quale occorrerebbe costruire un allacciamento diretto alla linea ferroviaria SpeziaParm a, in modo da evitare un lungo giro che intralcerebbe altri movimenti.
S.E. Bonzani osserva che nei primi giorni non vi sarà presumibilmente necessità di rico1Tere ai depositi di Spezia e aggiunge che quando saranno pronti i depositi di frontiera sarà forse possibile allegge1ire qualche deposito di Spezia.
S.E. Du cci aggiunge per quanto riguarda Spezia che, comunque, in caso di guerra le unità navali colà dislocate saranno ridotte al minimo

occorrente per la protezione della Liguria e che anche sul!' arsenale si fa poco assegnamento.
Passa poi all'esame della situazione del sistema Elba-Piombino. In questa zona sono già sistemate 2 batterie da 152/45 nell ' Elba e una a Piombino, oltre 4 batterie da 76 dell'Elba, con obiettivo anche e.a. Sono approvati i progetti per 2 batterie da 102/35 all'Elba.
La difesa e.a. è assicurata all'Elba dalle batterie da 76 ora dette; altre 3 batterie sono in costruzione nella zona di Piombino. Per quanto riguarda le munizioni si stanno ampliando le riservette delle batterie, in modo di avere sul posto anche il munizionamento di riserva. Sono in corso gli studi per la costruzione di 2 polveriere in comune col R.E. , per le quali recentemente il Capo di S.M. dell'Esercito ha ordinato di compilare i progetti di massima in accordo con la R.M.
Nella fortezza costiera di Messina, la Marina dispone di 2 batterie da 120/40 e di una batteria da 76. Le rimanenti batterie, armate con mortai da 280/9, sono annate dall'Esercito.
Ad Augusta si può dire che l 'organizzazione s ia appena iniziata. Le dighe sono in corso di costruzione e s u di esse non si può fare ancora assegnamento. Esiste una so la batteria da 152/50 a Capo S. Elia e una sezione di 2 pezzi da 152/50 a Siracusa con le armi s montate, ma su l posto; inoltre una batteria da 102/35 e 3 da 76, queste ultime con i pezzi smontat i; non esistono fotoelettriche né depositi munizioni e torpedini. È in corso lo stud io generale di tulle le necessità della R. Marina per ormeggi, rifornimenti e protezione di tutto l'ancoraggio , la quale è basata per ora sulle ostruzioni.
Al riguardo S.E. Ducci fa osservare come lo specc hio d'acqua richiesto per l'idroscalo venga a diminuire notevolmente lo spazio disponibile; questione analoga si presenta pe r Brindis i; prospetta quindi l'opportunità che l'aviazione organizzi altrove i suoi idro scali, specialmente quando si tratti dell'Annata Aerea.
S.E. Valle informa al riguardo che l'idroscalo di Augusta è organizzato essenzialmente come base di rifornimento, ma aggiunge che in caso di guerra gli apparecchi verranno molto probabilmente frazionati, per sottrarli alle eventuali azioni nemiche.

S.E. Ducci prosegue dando notizia dell'organizzazione di Trapani, rilevando anzitutto come il porto sia attualmente insufficiente e troppo ristretto per dare ricovero anche a forza leggera. Aggiunge che il Mini s tero dei LL.PP. ha recentemente informato che per Trapani, come per il porto di Cagliari, di cui esporrà tra breve la s ituazione, detto Ministero deve disinteressarsi, considerando che i lavori richiesti hanno carattere prevalentemente militare.
Trapani dispone attualmente di 3 batterie armate da 152/50 e di un'altra batteria da 120/50 con i pezzi smon tati; inoltre dispone di una
batteria da 102/35 e 5 batterie da 76 le quali hanno anche compito contraereo. La difesa e.a. dispone, oltre queste batterie, di un'altra batteria da I 02 e l da 76. Per completare la difesa e.a. ed a.s. devono essere costru ite altre 3 batterie.
È in studio l 'organizzazione del servizio fotoelettrico, depositi torpedini e siluri; è già pronto il deposito ostruzioni. Deve anche provvedersi al collegamento delle batterie coi comandi di gruppo e col comando difesa e.a.
La piazza de La Maddalena dispone di 2 batterie da 152/50 (a lle quali si aggiunge una batteria da 203/45 in costruzione avanzata, sull 'iso la di Spargi) e di un pontone con due cannoni da 381/40. La piazza dispone anche di 3 batterie da 152/40, 3 da 120, 1 da l 02 e 7 da 76, di cui 5 anche e.a., nonché di 1 batteria occasionale da 120/45; un'altra batteria occasionale è destinata a Golfo Aranci.
L'Esercito tiene armate una batteria da 305/ 17 e 3 batterie da 280; per la batteria da 305 si presenta la necessità di aumentare l'intervallo fra i pezzi, portando due dei pezzi stessi all'esterno dell'opera attuale.
La difesa e.a. è affidata a 14 batterie e a 14 fotoelettriche, tutte efficienti.
Sono anche pronti i depositi vari; cosicché nel complesso, le condizioni di approntamento della piazza devono considerarsi buone. È tuttavia da osservare che, a parte la minaccia aerea , la piazza trovasi entro il raggio d'azione di almeno 12 pezzi da 155 sistemati dai francesi nella zona di Bonifaci o-S. Manza.
S.E. Ducci richiama anche l 'attenzione sulla possibilità di uno sbarco nel golfo di Porto Torre s.
S.E. Bonzani ritiene al riguardo che con le disposizioni adottate dall'Esercito in Sardegna sia possibile difendersi contro uno sbarco a Porto Torres; mancano invece le forze per presidiare l ' Asinara.
S.E. Ducci esamina poscia la situazione di Cagliari, mettendo in rilievo come i lavori portuali colà progettati procedano molto lentamente. A Cagliari, come a Trapani, il Mini stero dei LL.PP. ritiene che debbano essere eseguiti a carico della Marina i lavori di interesse prevalentemente militare, e perciò, non so ltanto le costruzioni di depositi, ecc . direttamente interes santi la Marina, ma anche tutti i lavori destinati a rendere utilizzabile come porto il bacino di Bonaria.
Nel complesso, data la situazione attuale per i porti di Trapani e di Cagliari, la Marina non dispone né in Sicilia né in Sardegna dei punti di appoggio che le occorrerebbero per esercitare più validamente la sua azione nel Mediterraneo occidentale. Fa anche rilevare che recenti lavori deliberati a Palermo renderano difficile la manovra degli incrociatori da 10 mila in quel porto.
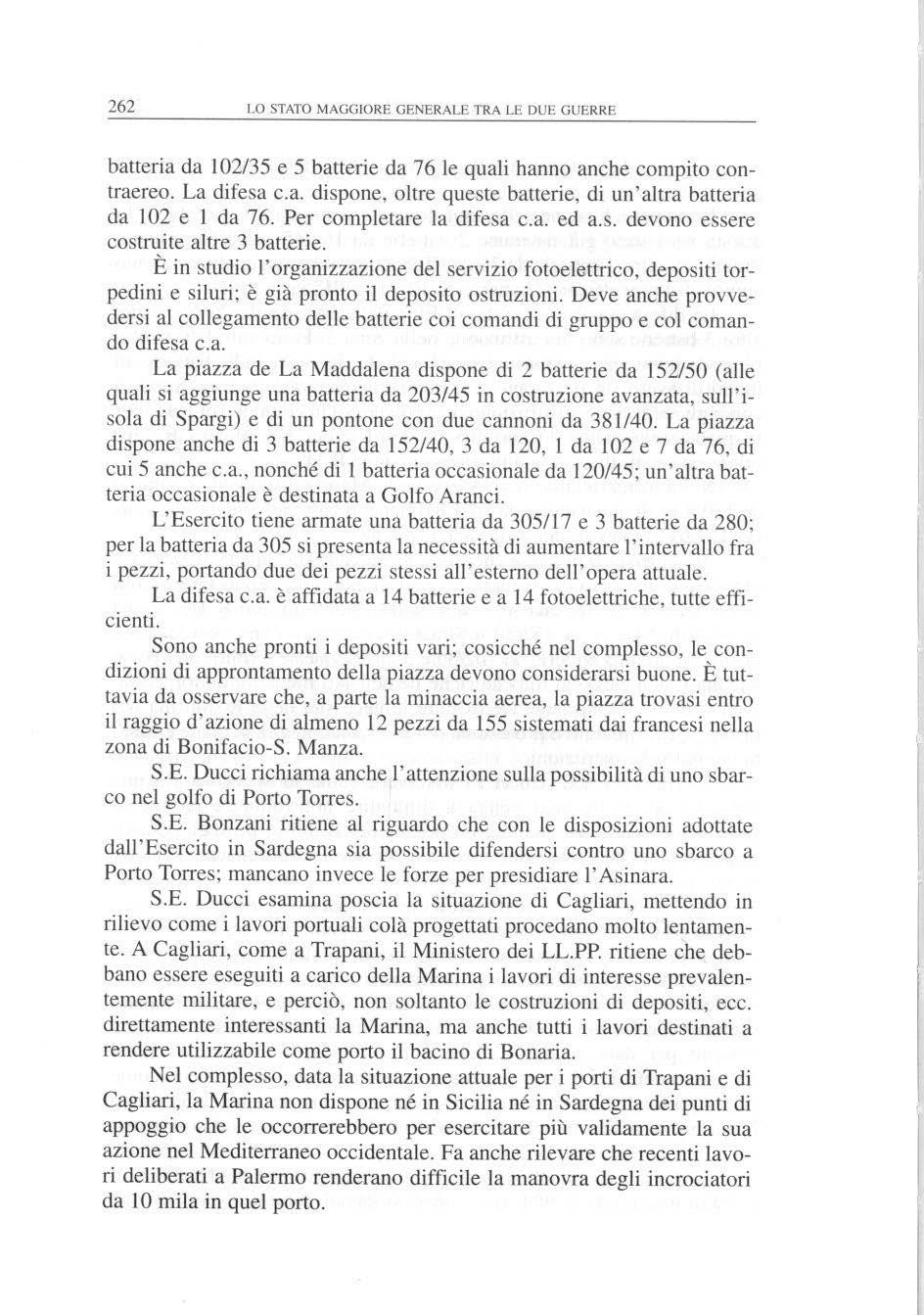
Allo stato attuale delle cose la Marina è perciò costretta ad utilizzare, per la sua manovra , essenzialmente la base di Augusta, dislocando alcune navi anche a Palermo e a Messina.
S.E. Badoglio, rilevando questa situazione, comunica che ne darà segnalazione al Capo del Governo , affinché venga accelerata la sis temazione di Trapani e di Cagliari, di quest'ultima in particolar modo.
S.E. Ducci informa che per la difesa di Cagliari sono già armate 3 batterie da 152/50, 2 da 102 di cui una occasionale, e 2 da 76, queste ultime 4 anche con compiti e.a. È in corso la costruzione di 3 batterie da 76 per la difesa dell'Idroscalo di Elmas e sono i corso di studi altre 2 batterie da 102 e.a.
Si deve ancora provvedere alla sistemazione delle fotoelettriche, come pure alla sistemazio ne dei collegamenti.
So no in corso di costruzione o in progetto i depositi vari.
Taranto dispone attualmente di una batteria e una sezione da 152/40, l batteria da 120/40 e 4 batterie da 76 di cui 3 con compito anche e.a.; è in costruzione l batteria da 152/45: le batterie di obici sono state disarmate. La difesa e.a. di s pone di 12 batterie, comprese 2 batterie nella zona di Grottaglie , contro le provenienze da Brindisi.
L'organizzazione di Brindi si, deve ritenersi soddisfacente, tenuto conto dei numerosi impianti fatti durante la guerra, così pure l 'orga ni zzazione di Venezia e di P ola.

È in corso di armamento l batteria di 4 pezzi da 156/47 nell'i sola di L ussino dove sono anche predisposte I batteria da 102 e 3 batterie da 66/47 da armare al momento opportuno. È da osservare che a Lussino potranno essere tenuti permanentemente in tempo di pace so ltanto una ventina di uomini mentre il rimanente dovrà essere inviato all'atto della mobilitazione.
S.E. Ducci fa osservare che questo problema della mobilitazione si presenta per tutte le piazze, in ciascuna delle quali trovasi pronta ad entrare in azione soltanto una batteria.
S.E. B adoglio domanda se, mediante precettazione di personale, possa assicurars i l'armamento delle batterie nel periodo di sicurezza.
S.E. Ducci informa che tale precettazione è prevista soltanto per le batterie e.a. e il personale semaforico. I treni armati sono 5 per la riviera ligure, uno per la costa toscana e 4 per l'Adriatico.
S.E. Ducci comunica poscia che a Zara sono previste 2 batterie da 76 e 2 pontoni da 149.
Quanto a Saseno essa è armata con 2 batterie da 152 e 3 batterie da 76 e a.
La Marina dispone anc he di 4 sezioni di basi passeggere di cui l per Valona e 1 per Durazzo, le quali verrebbero armate con 1 batteria da 120/45, 2 batterie da 76/40 e 1 sezione di mitragliere da 40/39 ciascuna.
Le basi passeggere verrebbero trasportate con i RR . Trasporti Cherso e Lussino.
S.E. Valle ritiene oppo rtun o richiamare l'attenzione su l fatto che recentemente sono stati iniziati lavori per la costruzione di 2 depositi della capacità complessiva di 45 mila tonnellate di benzina ciascuno a Civitavecchia e ad Ancona in località prossima alla costa e assi faci lmente reperibile.
S.E. D ucci informa che il caso analogo si è verificato a Savona e che per esso la Marina ebbe già ad esprimere la sua opposizione.
S.E. Badog lio concorda circa l'opportunità di evitare tali costruzioni, aggiungendo che per analogo deposito pure della capacità di 45.000 tonn. da costruire a Tripoli, ebbe ad imporre la scelta di località alquanto interna e la sistemazione in depositi interrati. Comunica che di questa questione avrà occasione di richiamare l 'attenzione nella prossima sessio ne della Commiss ione Suprema di Dife sa.
S.E. D ucci, chiudendo l'esposi1ione circa la situazione delle basi navali, fa rilevare come, in caso di operazioni verso ovest la Marina si vedrebbe costrella a dislocare le sue forze tra Augusta e Messina, facendo scarso assegnamento s u Cagliari e Trapani; che invece interessa siano messe al più presto in efficienza. Dà comunicazione di informazioni pervenute al riguardo dalla Presidenza del Consiglio al Ministero della Marina, secondo le quali i lavori del molo di ponente del porto di Cagliari non potrebbero essere ultimati che nella primavera del I 933; ne ssu na previ sio ne invece può farsi per il molo di le vante, dato che, come è già stato rilevato, il Ministero dei LL.PP. fa difficoltà ad eseguire i lavori inerenti a tale molo. Analogamente per i lavori di Trapani.
S.E. Badoglio, chiuso l'esame di tale situazione. formula il voto che le limitazioni nelle costruzioni navali, che le trattative internazionali lasciano sperare, possano consentire di accelerare e intensificare la sistemazione delle basi navali, le quali costituiscono un elemento essenziale per la manovra delle nostre forze.

P er sua p arte dichiara che si interesserà nu ovamente presso S.E. il Capo del Governo per l'acceleramento dei lavori portuali di Trapani e particolarmente di Cagliari.
S.E. Du cci espone poscia quale sa rebbe la dislocazione delle no s tre forze navali nell'Ipotesi Es t , la quale presenta poche varianti rispetto alla dislocazione prevista nell'Ipotesi Ovest.
S.E. Ducci espone particolareggiatamente questa dislocazione, la quale nelle sue linee sommarie contem pl a:
- il grosso delle forze (prim a e seconda squadra e in seguito la squadra di riserva) tra Augusta-Taranto-Brindisi (navi moderne ad Augusta, navi co razzate e naviglio ausiliario a Taranto, in crociatori e c.t.
antiquati a Brindisi, sommergibili g.c. a Napoli, rimanenti sommergibili in basi centrali rispetto agli scacchieri delle operazioni);
- la divisione speciale dell'Alto Adriatico ad Ancona con distaccamento a Pola;
- navi sotti l i a Spezia, in Sardegna ed a Trapani;
- una squadriglia c.l. a Leros.
È da notare che la squadra di riserva richiederebbe circa 15 giorni per la sua mobilitazione.
S.E. Badoglio domanda quali provvedimenti siano stati presi per accelerare la mobilitazione.
S.E. Ducci informa che sono stati migliorati gli apprestamenti di mobilitazione costituendo nuove sedi di concentramento dei richiamati e approntando nuovi magazzini per la vestizione; si calcola così che la gente richiamata possa essere vestita e inviata a destinazione entro il 10° giorno anziché entro il 15 ° . Si sta inoltre studiando la opportunità di poter destinare i richiamati dell'ultima classe inviati in congedo agli stessi bastimenti nei quali hanno prestato servizio. Tali navi, le quali sono attualmente pronte a muovere nei primissimi giorni, ma armando soltanto una parte delle artiglierie secondarie, potrebbero, completandosi con personale già pratico , acquistare prontamente la disponibilità tattica e strategica.
S.E. D ucci accenna all'esperimento di mobilitazione compiuto quest'anno con una squadriglia di caccia in disarmo, la quale è stata in grado di prendere il mare ed eseguire tiri entro il 10° giorno. Annunzia che l'esperimento ven-à esteso l'anno prossimo alla mobilitazione degli incrociatori Taranto, Bari ed Ancona, che passe ranno in ri se rva a fine d'anno. Aggiunge poi che le no s tre forze navali possono per il 70% circa considerarsi pronte ad entrare immediatamente in azione, con le limitazioni suaccennate per quanto riguarda l'armamento dell'artiglieria.
S.E. Ducci passa po scia ad esaminare l'attuale costituzione delle nostre forze navali, già comunicata a S.E. il Capo di S.M. Generale, e raffronta la nostra situazione in confronto di quella francese, che può riassumersi in:
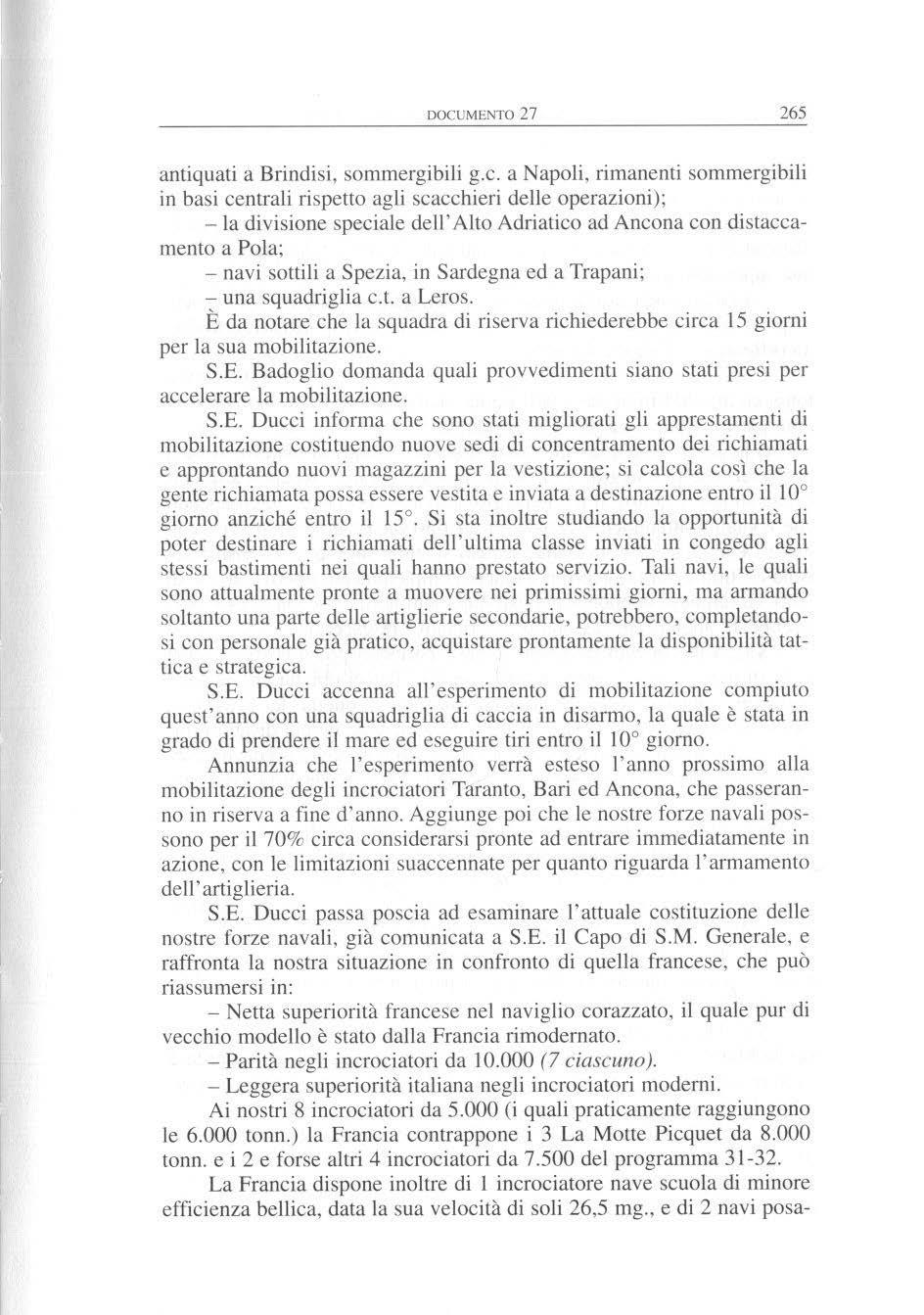
- Netta superiorità francese nel naviglio corazzato, il quale pur di vecchio modello è s tato dalla Francia rimodernato.
- Parità negli incrociatori da 10.000 (7 ciascuno).
- Leggera superiorità italiana negli incrociatori moderni.
Ai nostri 8 incrociatori da 5.000 (i quali praticamente raggiungono le 6.000 tono.) la Francia contrappone i 3 La M otte Pi cquet da 8.000 tonn. e i 2 e forse altri 4 in crociatori da 7 .500 del programma 31 - 32.
L a Francia dispone inoltre di 1 incrociatore nave scuola di minore efficienza bellica, data la sua velocità di soli 26,5 mg. , e di 2 navi posa -
mine tipo Pluton da 5-6.000 tonn. che hanno una velocità di 30 mg. ed un annamento metà di quello degli incrociatori.
- Sensibile superiorità francese nel naviglio sottile. La Francia dispone di circa 135 mila tonn. di materiale contro 90.000 italiane, con una superiorità globale di circa l/3.
- Marcata superiorità francese nel naviglio subacqueo. La Francia dispone anche di una nave portaerei e di una nave trasporto aerei moderna («Béarn» e «Com/te Teste»).
Complessivamente la flotta francese dispone di circa 628 mila tonn. contro 404 mila tono. dell'Italia; la superiorità francese è però in gran parte costituita da naviglio antiquato.
S.E. Ducci accenna alle nostre tendenze attuali in materia di navi portaerei, che la maggioranza ritiene indispensabili e accenna alla tendenza attuale a ridurre il tonnellaggio delle navi portaerei, aggiungendo che abbiamo attualmente in istudio un tipo da 12 mila tonnellate con motori Diesel elettrici mediante i quaU sarebbe soppressa la cosiddetta isola costituita dai fumaioli , per tenere completamente libero il ponte di volo. Di tali navi sarebbero previsti due esemplari; ciascuna di esse porterebbe 42 apparecchi (12 bomb.; 12 ricogn.; 18 caccia).
S.E. Valle fa rilevare come la nave portaerei possa costituire una palla di piombo per le forze navali; ma S.E. Ducci obietta che la nave portaerei, dotata di velocità alquanto inferiore a quella del grosso, si manterrà sempre fra le nostre basi e le forze navali, da cui disterà sempre qualche decina di miglia e quindi il grosso non dovrà preoccuparsene. A quella distanza essa potrà agevolmente agire con la gittata dei suoi aerei.
S.E. Ducci accenna anche ai progetti già compilati di navi corazzate. Un tipo da 29.000 tonn. porterebbe 8-381 e avrebbe tutto il ridotto salvaguardato dalla carena speciale; un tipo da 23.000 sarebbe armato con 8-305 e avrebbe la protezione soltanto fin agli impianti centrali sopra elevati compresi. Velocità 29-30 miglia in entrambi i casi.
Uno di questi progetti a motori Diesel avrebbe un ponte di volo di 80 m. a poppa; mentre sarebbe scarso per i comuni velivoli, potrebbe riuscire utile per elicotteri.
S.E. Ducci richiama l'attenzione sulla grande utilità che avrebbe per la Marina l'adozione di un elicottero, ricordando che al riguardo è stato presentato un progetto d'Ascanio, col quale sembrerebbe raggiungibile la quota di 2000 m. e una velocità di 80 km.
S.E. Valle informa che il tipo d'Ascanio sarebbe già oltrepassato dal tipo Scatizzi, ma aggiunge che per il momento si ha poca fiducia nel!'elicottero, particolarmente da parte dei piloti, ai quali rimruTebbe impedito l'uso del paracadute; aggiunge che gli esperimenti con l'elicottero
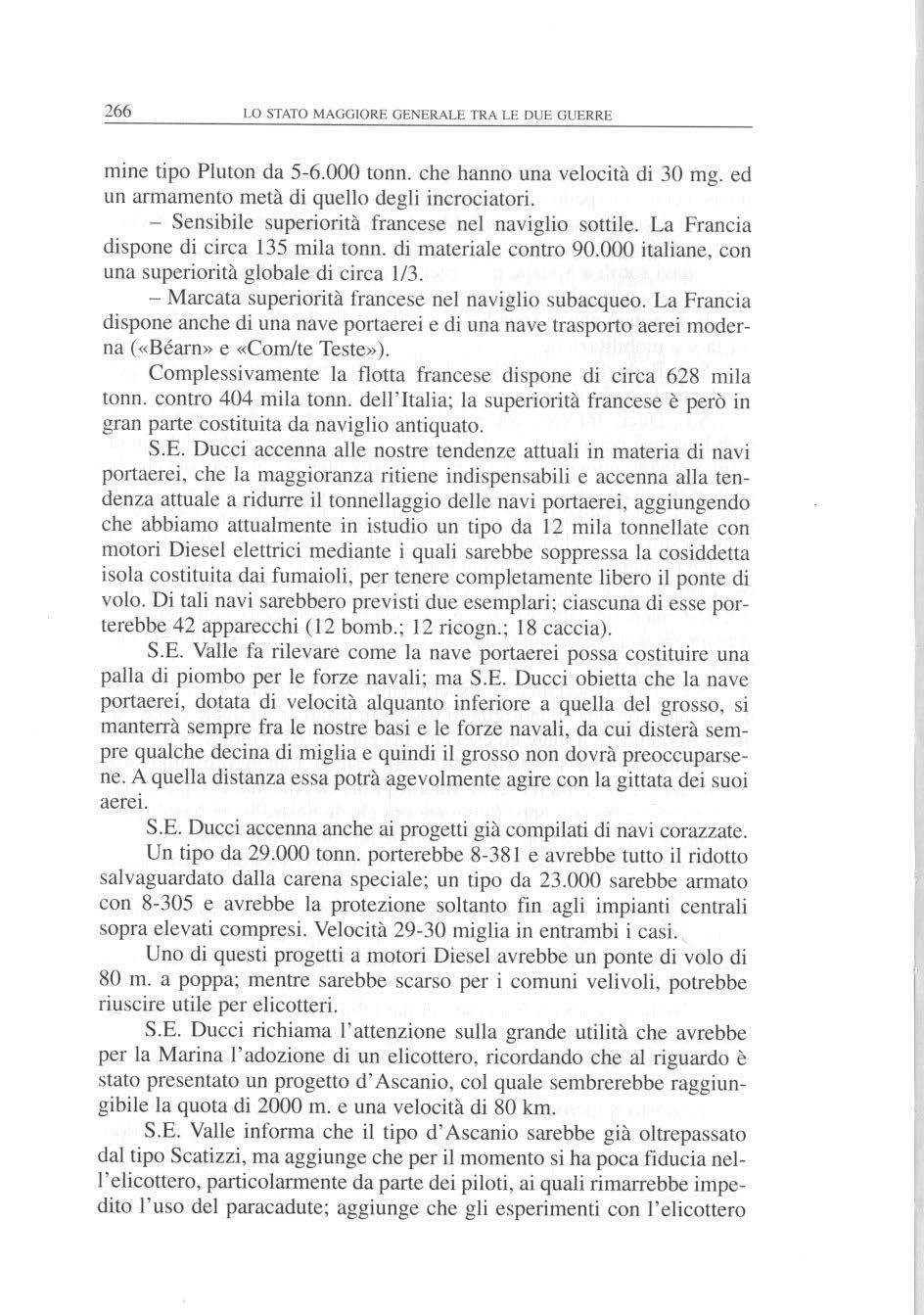
richiederebbero forti spese che l'Aeronautica non si trova in condizioni di affrontare.
S.E. Bonzani esprime il voto che nei riguardi della Marina venga studiato ed esperimentato un el icottero, anche nella speranza che per questo mezzo, come già per gli aeroplani, si possa conseguire rapidi progressi, utili all'assegnazione e all'impiego degli aerei s u navi senza bisogno di catapulte.
S.E. Badoglio domanda quale sia lo stato attuale della protezione chimica per le forze navali.
S.E. Ducci informa che è stata adottata una maschera speciale per la Marina; della quale sono stati provvisti 3.000 esemplari e altri 5.000 sono in commessa. Sono stati anche adottati filtri specia li da applicare ai locali chiusi, ove non sia possibile l'impiego della maschera (ospedali, radio, ecc.).
Nel comp lesso, tenuto anche conto del minor pericolo che presentano i gas nella guerra navale, l'apprestamento non si presenta difficile.
Su richiesta di S.E. Badoglio, S.E. Du cci dà anche informazioni sulle centrali di tiro, la cui sistemazione sarà completata nel 1932, e sulle centrali per il tiro con traerei, per le quali la Marina dispone dell'eccellente apparecchio Mini sini per le sistemazioni di bordo e degli apparecc hi W. Di ckers e Pittoni per le sistemazioni a terra.
La seduta è chiusa alle ore 12; verrà ripresa domani 9 novembre alle ore 9,30


SEDUTA D EL 9 N OVEMB R E 1931
«Stato di efficienza dell'aviazione e suo impiego nella guerra contro la Jugoslavia (Ipotesi Est): campi d'aviazione e depositi di carburante e munizioni, cooperazione tra Marina e Aeronautica, bombardieri, munizioni, situazione degli apparecchi p er il bombardamento, caccia e ricognizione, concorso dell'Esercito e della Marina nelle determinazioni delle caratteristiche degli apparecchi, proporzione numerica tra le aliquote dell'aviazione spettanti alla Marina e all'Esercito, aviazione francese e jugoslava».
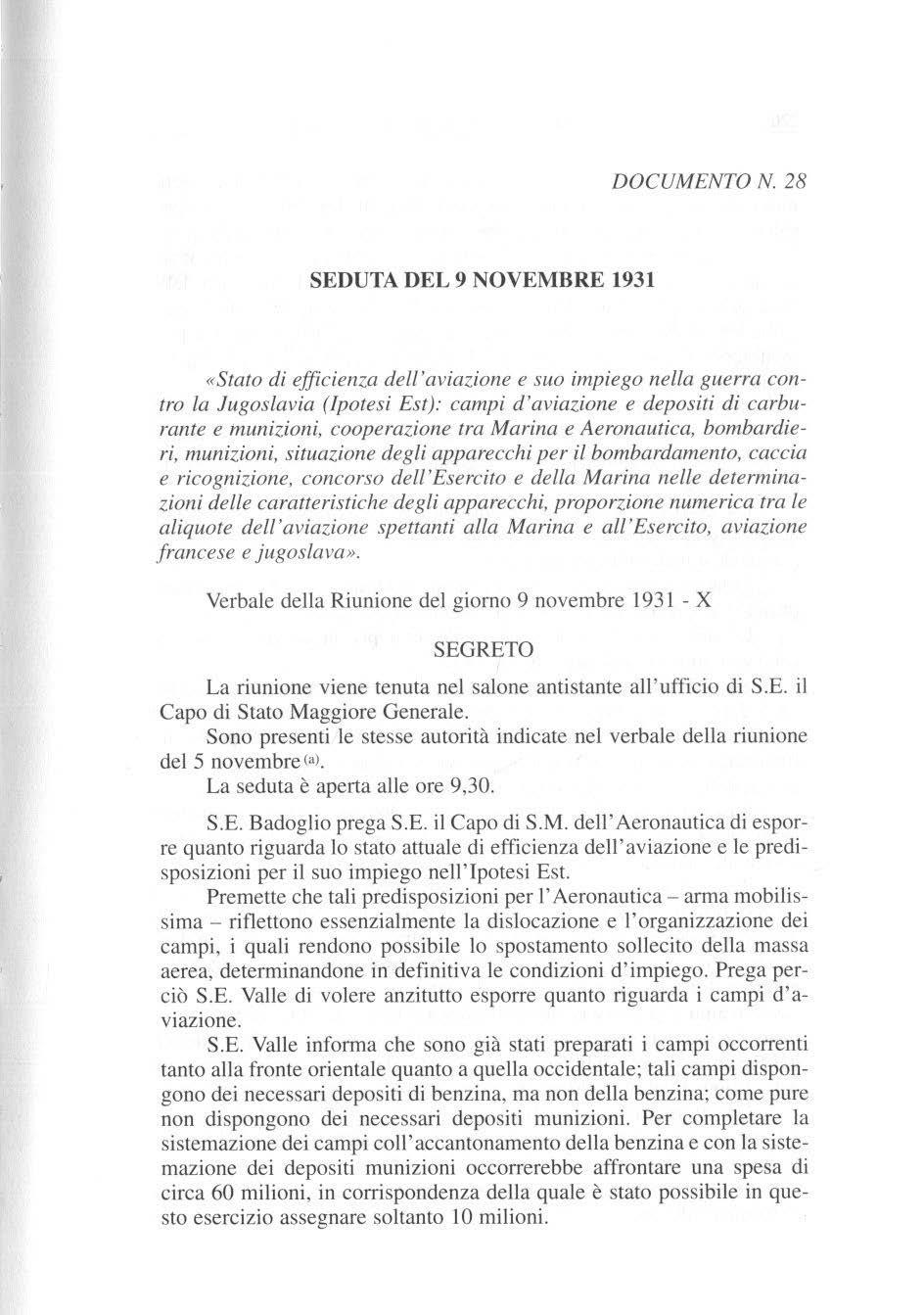
Verbale della Riunione del giorno 9 novembre 1931 -X
La riunione viene tenuta nel salone antistante all'ufficio di S.E. il Capo di Stato Maggiore Generale.
Sono presenti le stesse autorità indicate nel verbale della riunione del 5 novembre (a)
La seduta è aperta alle ore 9,30.
S.E. Badoglio prega S.E. il Capo di S.M. dell'Aeronautica di esporre quanto riguarda lo stato attuale di efficienza dell'aviazione e le predisposizioni per il suo impiego nell'Ipotesi E st.
Premette che tali predisposizionj per l'Aeronautica - arma mobilissima - riflettono essenzialmente la dislocazione e l'organizzazione dei campi, i qua l i rendono possibile lo spostamento sollecito della massa aerea, determinandone in definitiva le condizioni d'impiego. Prega perciò S.E. Valle di volere anzitutto esporre quanto riguarda i campi d'aviazione.
S.E. Valle informa che sono già stati preparati i campi occorrenti tanto alla fronte orientale quanto a quella occidentale; tal i campi dispongono dei necessari depositi di benzina, ma non della benzina; come pure non dispongono dei necessari depositi munizioni. Per completare la sistemazione dei campi coll'accantonamento della benzina e con la sistemazione dei depositi munizioni occorrerebbe affrontare una spesa di circa 60 milioni, in corrispondenza della quale è stato possibile in questo esercizio assegnare soltanto 10 milioni.
È da osservare che, a sistematione avvenuta della benzina e delle munizioni nei campi, occorrerebbe provvedere alla loro custodia con personale militare adeguato. specie per i campi situati in territorio allogeno.
Non addi, enendosi a tale sistemazione si avrebbe il grave inconveniente di dovere eseguire all'atto della mobilitazione il trasporto delle munizioni dagli attuali depositi centrali di Villa Osti, Riva di Trento. Collecchio e Bassano in Teverina ai campi di aviazione, il che non permetterebbe l'immediato impiego dell'arma, e incontrerebbe gravissime difficoltà nei trasporti.
Riguardo alla mobilitazione dei campi ricorda che nelle recenti manovre è stato sperimentato con ottimi risultati il nuovo sistema di mobilitazione mediante personale e materiali inviati dai campi base di circoscrizione.
L'esperimento è stato compiuto dal campo base di Parma, il quale ha provveduto ad armare i campi di Modena e di Sarzana, inviandovi personale e materiali con autocarri.
Emanato l'ordine alle ore 24 i campi di Modena e di Sarzana erano pronti rispettivamente alle ore 7 e alle ore 14 del giorno successivo .
Le dotationi degli autocarri occorrenti per la mobilitazione dei campi saranno completate entro il 1932.
S.E. Badoglio rileva come la mancanza della benzina e la mancanza di depositi munizioni presso i campi di frontiera ostacoli gravemente il sollecito intervento dell'aviazione; fa voto perciò che le disponibilità finanziarie consentano di porvi rimedio. Domanda quale s ia la consiste11Za delle dotazioni di esplosivi.
S.E. Valle comunica che l'Aeronautica dispone del munizionamento di caduta occorrente per circa un mese. in maniera da poter dare tempo alla industria di provvedere ai successivi rifornimenti.

Per quanto riguarda i campi di frontiera interessanti l'Esercito essi sono stati ultimati ed assegnati ai reparti d'aviazione per il R.E. secondo quanto l'Esercito stesso ha richiesto: è soltanto in discussione l'ubicazione di un campo nella zona di Monte Nevoso, per il quale si incontrano gravi difficoltà data la natura del terreno.
Quanto alla dislocazione dell'Armata Aerea nell' I potesi Est è previsto che i reparti vengano inizialmente dislocati nei campi del Veneto e del Friuli, lasciando soltanto tre squadriglie da caccia per la protezione della Lombardia e del Piemonte e due squadriglie da caccia per la protezione di Roma; 18 squadriglie da caccia proteggeranno la fronte orientale e 6 squadriglie la costiera adriatica; le 3 squadriglie da caccia marittima saranno dislocate a Pola-Varano e Brindisi.
Osserva al riguardo che i nostri apparecchi da caccia dispongono attualmente di apparati R.T. riceventi, i quali consenti ranno di dirigere in
volo le squadriglie e facilitare così la loro manovra per la protezione delle estese zone da salvaguardare.
S.E. Ducci fa rilevare che per quanto riguarda la caccia marittima l'Aeronautica ha infonnato che non saranno più in avvenire riprodotti apparecchi da caccia marittimi.
S.E. Valle conferma tali notizie, la specialità da caccia marittima sarà conservata fino a consumazione degli apparecchi attualmente esistenti, un'ottantina circa; ciò nella considerazione che la caccia marittima ha una inferiorità decisa rispetto alla caccia terrestre sia per la maggiore lentezza ascensionale, sia per le difficoltà di decollo. In avvenire perciò si conta di sostituire la caccia marittima con la caccia terrestre, anche nella considerazione che, data la sicurezza dei motori attuali, gli apparecchi terrestri possono spingersi anche al largo sul mare.
S.E. Ducci fa presente come sia necessario assicurare la protezione della caccia anche ad azioni che si svolgano sull'altra sponda dell'Adriatico. Con l'occasione rileva come lo S.M. della Marina ritenga che la ricognizione marittima lontana e anche vicina debba essere messa in condizione di poter offendere gli obiettivi, di estrema mobilità, eh' essa rileva nelle sue ricognizioni, come pure fa presente che le nostre eventuali azioni navali dirette a interrompere le comunicazioni mediteranee tra la Francia e il Nord-Africa, condurranno prevedibilmente a un incontro nella zona a nord delle Baleari, ossia in posizione tale da esporre le nostre forze navali anche alla offesa delle forze aeree francesi dislocate nelle vicine basi della Provenza. Anche sotto questo aspetto necessita alla Marina poter disporre del tempestivo concorso di apparecchi da caccia e chiede se gli apparecchi da caccia terrestri potranno disporre di sufficiente autonomia per esercitare tale azione partendo dalla Sardegna.
S.E. Valle comunica che per quanto riguarda la protezione delle formazioni aeree da bombardamento, essa sarà assicurata fin che possibile dalla caccia, ma rileva che le formazioni moderne da bombardamento devono essere in condizione di difendersi da sé, particolarmente le formazioni di idrobombardamento, le quali volando a bassa quota sono già sicure in tutto l'emisfero inferiore.
Quanto alla difesa aerea per azioni navali che si svolgessero molto a largo, quali quelle cui ha accennato S.E. il Capo di S.M. della Marina, essa non può essere assicurata che da apparecchi imbarcati sulle navi.
S.E. Ducci domanda che, addivenendosi alla situazione prospettata, le squadriglie da caccia marittima siano sostituite nelle località attualmente previste da altrettante squadriglie da caccia terrestre.

S.E. Valle concorda aggiungendo che le squadriglie da caccia terrestre si appoggeranno ai campi terrestri più vicino alle attuali sedi marittime.
S.E. Badoglio prende nota di questa dichiarazione del Capo di S.M. dell'Aeronautica, per la quale le basi marittime saranno in avvenire dife-
se da squadriglie da caccia terrestre al posto di s quadriglie da caccia marittima, quando queste siano esaurite.
S.E. Ducci comunica che una commissione sta studiando attualmente i profili per migliorare le qualità di penetrazione delle bombe d'aeroplano. Al riguardo informa che le attuali navi provviste d'una protezione orizzontale di 10-12 cm. in due strati risultano sufficientemente protette, in quanto assicurano l'esplo sio ne della bomba prima che essa sia penetrata nelle parti basse, le più sensibili della nave.
S.E. Valle informa che sono già pronti per essere sperimemati i prototipi di bombe antinavi con profilo conveniente e munite di spoletta ritardata, quaJi dovrebbero assicurare un'azione efficace anche cadendo in acqua a una certa distann da una nave.
Per il momento il problema dell'affondamento di navi dotate di forte protezione orizzontale non può considerarsi ancora risolto. Al riguardo sarebbe da esaminare se l' idrosiluramento non s ia preferibile ali' idro-bombardamento.
Per quanto riguarda i siste mi di lancio, premette che in previsione della conferenza del disarmo l ' Aeronautica ha dovuto dare speciale impul so alla costruzione di apparecchi. Ultimate le manovre, l'Aeronautica volge ora l'attenzione al perfezionamento dei vari materiali d'impiego (mun izionamento , armamento, mezzi di puntamento, apparati fotografici, protezione ecc.). A tali studi si attenderà specialmente questo inverno ed essi riceveranno applicazione nelle esercitazioni di stormo all'anno prossimo.
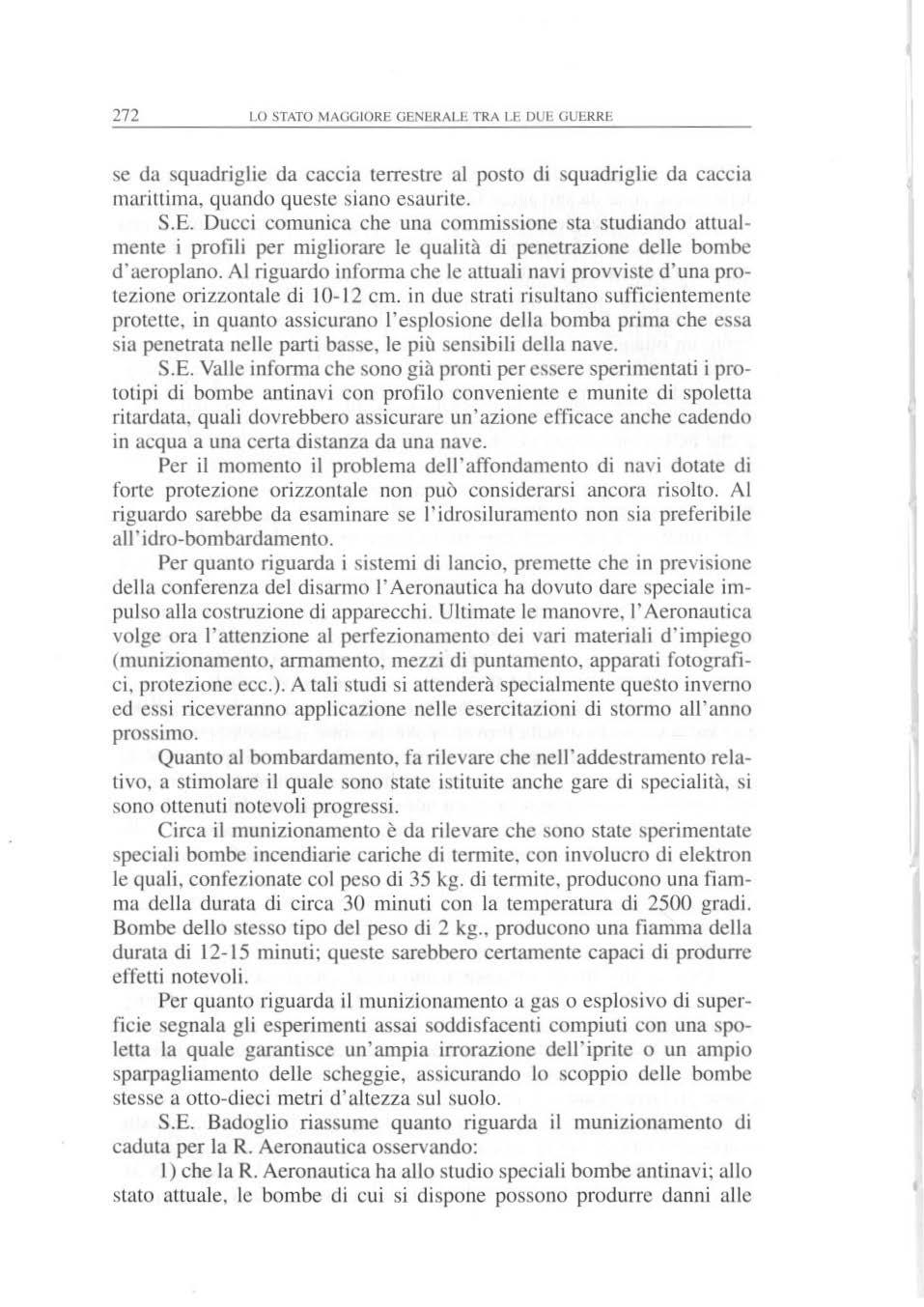
Quanto al bombardamento , fa rilevare che nell ' addestramento relativo, a stimolare il quale so no state istituite anche gare di s pecialità, s i so no ottenuti notevo li progressi.
Circa il munizionamento è da rilevare che so no state i-,perimen tate specia li bombe incendiarie cariche di termite, con involucro di elektron le quali, confezionate col peso di 35 kg. di termite , producono una fiamma della durata di circa 30 minuti con la temperatura di 2500 gradi. Bombe dello s tesso tipo del peso di 2 kg., producono una fiamma della durata di 12-15 minuti; queste sarebbero certamente capaci di produrre effetti notevoli.
Per quanto riguarda il munizionamento a gas o esplosivo di superficie segnala gli espe rimenti assai soddisfacenti compiuti co n una spoletta la quale garantisce un'ampia irrorazione dell'iprite o u n ampio s parpagliamento delle scheggie, assicurando lo scoppio delle bombe stesse a otto-dieci metri d'altezza sul suolo.
S.E. Badoglio riassume quanto riguarda il munizionamento di caduta per la R. Aeronautica osservando:
I ) che la R. AeronauLica ha allo s tudio speciali bombe antinavi; allo stato a ttu a le, le bo m be di cu i si dispone pos so no p rodurre dan ni alle
navi, ma non penetrare nelle strutture interne di navi robustamente protette, con doppio ponte dello spessore di 12 cm.;
2) che l'Aeronautica ha in studio il perfezionamento dei sistemi di lancio e sviluppa l'addestramento al tiro di caduta;
3) che il munizionamento già disponibile per il fabbisogno di un mese di guerra, rimane da risolvere il problema del dislocamento presso i campi di partenza.
S.E. Valle fa presente che oggi le navi protette da doppio ponte corazzato di 12 cm. di spessore non esistono che in misura assai scarsa.
S.E. Badoglio prega S.E. il Capo di S.M. della R.A. di dare notizie circa la situazione degli apparecchi, indicando anzitutto quale significato debba darsi ali' espressione «ap parecchi efficienti non bellici» che figura nelle situazioni periodiche del materiale ed è applicata ad una aliquota abbastanza notevole delle dotazioni.
S.E. Valle informa che tale denominazione introdotta nel passato è sta ta recentemente soppressa, in quanto essa non risponde alle vere condizioni degli apparecchi così classificati.
Attualmente le sq uadriglie danno come efficienti non bellici anche gli apparecchi momentaneamente non atti all'impiego per deficienze di carattere temporaneo, classificando come efficienti bellici soltanto gli apparecchi in condizione di prendere immediatamente il volo, con armamento e dotazioni al completo.
Tn avvenire verrà invece adottata la distinzion e tra apparecchi efficienti e apparecchi non efficienti, comprendendo in questi ultimi anche quelli non disponibili per una certa durata di tempo agli effetti dell'impiego bellico.

Pa ssando all'esame dei materiali infonna che sensibili progressi sono sta ti ottenuti dall'anno scorso.
Sono stati eliminati i vecchi apparecchi CR.l, S.16 tcr,A.300, 4 M 7.
Si è cercato di migliorare gli apparecchi esistenti e di definire i nuovi tipi.
P er la caccia è stato migliorato il CR.20, raggiungendo la velocità di 240 km. e un plafond di 7.200 rn.; possiamo così tenere la linea in confronto con l'estero per un paio d'anni.
È bensì vero che l ' In ghilterra dispone di apparecchi da caccia di grande velocità ascensionale (6.000 m. in 9 minuti) ma si tratta di apparecchi speciali adottati per la difesa di Londra, i quali d'altra parte dispongono di limitatissima autonomia.
Per conto nostro contiamo di poter iniziare nella primavera del 1932 gli esperimenti con un supercaccia, il quale avrà un plafond di 10.000 m., un a velocità ascensionale di 5.000 m. in 7 minuti, una velocità di 375 km/h alla quota di 5.000 m. e sarà armato con una mitragliatrice Vickcrs da 12.7 e due mitragliatrici da 7.7.
È stato omologato il nuovo motore A.30 da 800 HP della Fiat destinato al CR.30 (velocità 300 km/h, plafond 9.000 m.), del quale tipo si hanno già pronte le cellule per tre apparecchi.
Il bombardamento terrestre dispone del BR.3, derivato dal BR. l, il quale ha un ' autonomia di 6h.30 (650 km. di raggio utile, con carico di una tonnellata). Questo stesso apparecchio può anche essere impiegato per la ricognizione lontana con un raggio di J .000 km. Al riguardo è da rilevare la tenden1.a attuale alla riduzione del numero dei tipi, unificando bombardamento diurno e bombardamento notturno e ricognizione lontana.
[I bombardamento marittimo sarà quasi tutto provveduto nella primavera del 1933 di apparecchi S.55 tipo Atlantico (col riduttore) i quali hanno un raggio d'azione di 1.000 km. con carico di 600 kg.
La ricognizione terrestre disporrà dell'apparecchio Ro. J bis, derivato dal Ro.1 con l'applicazione del riduttore e già riprodotto in 9 esemplari. il quale disporrà della stes sa autonomia, ma avrà una ve locità superiore di 20 km. a quella attuale e potrà raggiungere la quota d i 6.500 m.
È in esperimento l'apparecchio da ricognizione Ro.30, triposto, munito di motore J upiter, il quale avrà la velocità massima di 238 km., una velocità di crociera di 21 O km. invece dei 160 attuali e sarà armato con tre mitragliatrici da 7 .7 e una mitragliatrice da 12.7, le quali assicurano un grande volume di fuoco. Di tale tipo si conta di poter disporre nel giugno prossimo di una squadriglia sperimentale di 7 apparecchi. È da rilevare incidentalmente che il nuovo apparecchio Ro.30 ve rrà a costare circa iI doppio del Ro. l.
La ricognizione lontana dispone dell'apparecchio A.120, il quale col motore A. 24 ha re centemente guadagnato la coppa Ribescu.
Per il bombardamento leggero disporremo dell'apparecchio Ca. I 02 del quale abbiamo già una squadriglia sperimentale. Esso è fornito di due motori Jupiter da 450 HP., anziché dei tre motori Linx del Ca.1 OI, può raggiungere i 5.000 m. di quota ed ha un raggio utile di 450 km. con carico di 700 kg. di bombe.
Quanto al bombardamento pe sante, ossia con carico di bombe superiore ai 2.000 kg., sono in esperimento l'apparecchio CC.20 e il BRG., il quale ultimo può portare due to1111. di bombe con 2.000 km. di autonomia e può raggiungere 5.000 m. di quota in un'ora.
Gli apparecchi attual i della ricognizione marittima S.59-bis sono senn dubbio i più efficienti. Sono in studio i nuovi tipi, tra i quali l'S.62 sembra abbia dato buoni requisiti. Non appena definito il nuovo tipo d'accordo con la Marina, l'Aeronautica provvederà a riportare al loro organico le squadriglie da ricognizione marittima, le quali non sono oggi tenute a numero nei loro apparecchi per non riprodurre un tipo già oltrepassato.
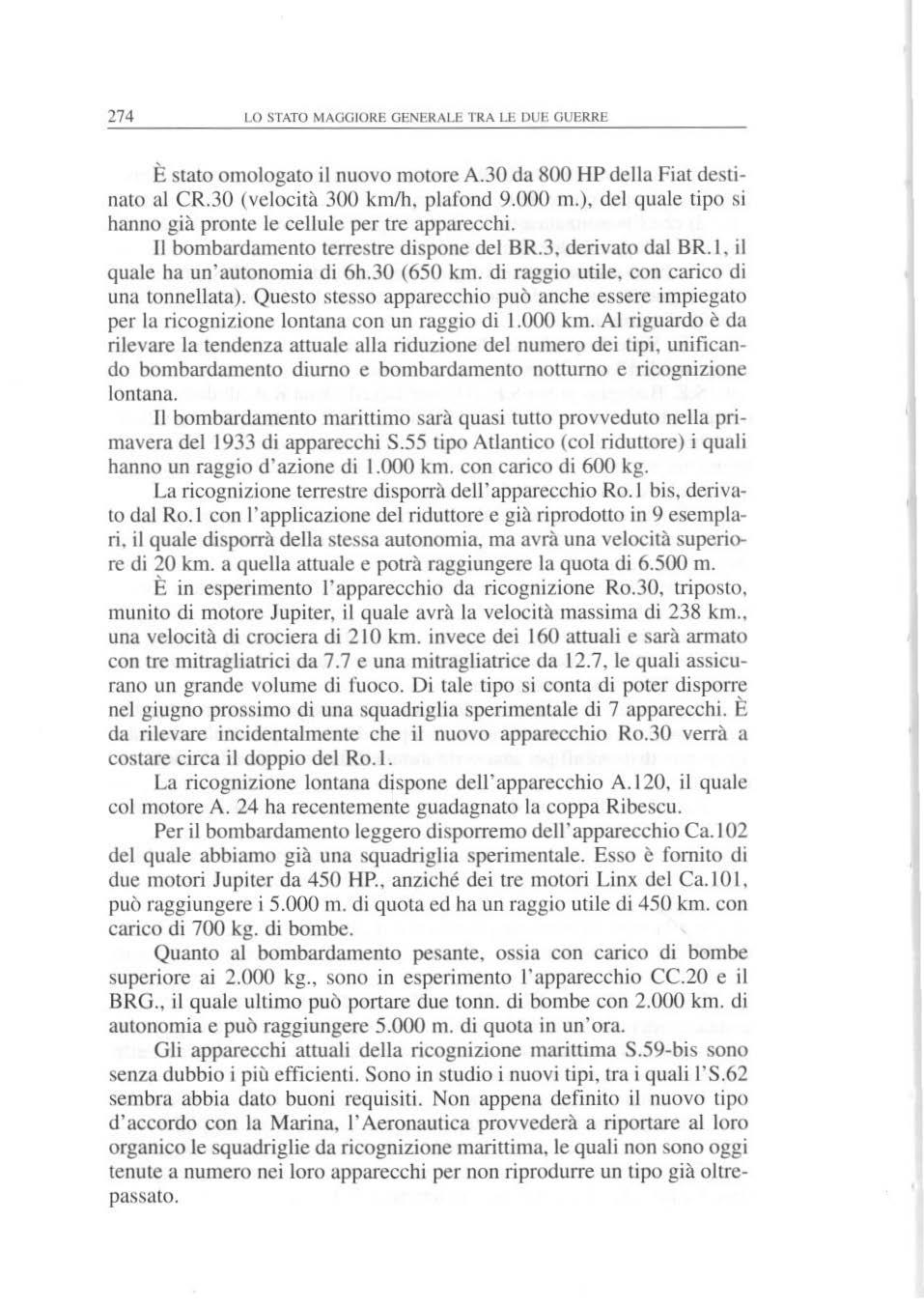
Per tali nuove costruzioni sono state già previste nel prossimo esercizio le somme necessarie.
Del tipo S.62 sono in studio due modelli: il modello S.62 con motore da 750 HP. adatto per ricognizione lontana e il modello S.62-ter con motore da 500 HP. con riduttore: entrambi non consentono il trasporto di siluri.
S.E. Ducci osserva come tale impossibilità di portare il siluro pregiudicherebbe notevolmente l 'efficienza della ricognizione lontana. Come già ha affermato, la Marina ritiene che gli aerei da ricognizione marittima debbano essere anche in condizione di offendere.
S.E. Valle tisponde che si sta al riguardo studiando il modo di armare gli apparecchi con un cannoncino da 20 mm.
S.E. Ducci obietta che tale armamento sarebbe del tutto inadeguato.
S.E. Valle ritiene che possa essere utile contro so mmergibili.
S.E. Bonzani fa osservare che anche l'armamento degli apparecchi da ricognizione terrestre appare deficiente; tali apparecchi sono assolutamente indifesi nel settore inferiore; d'altra parte occorre che gli apparecchi da ricognizione terrestri possano anch'essi svolgere un 'az ione di offesa a terra.
S.E. Valle informa al riguardo che gli apparecchi da ricognizione possono già oggi portare un carico di 250 kg. di bombe da 12 kg. e che possono quindi assolvere tali compiti eccezionali.
S.E. Badoglio osserva che in sostanza si tratta di conciliare nel modo migliore i requi s iti tattici con i requi s iti tecnici.
S.E. Bonzani aggiunge al riguardo come sarebbe opportuno che le caratteristiche degli apparecchi venissero definite da una commissione mista e che l'Esercito e la Marina fossero rappresentate nel Comitato tecnico dell'Aeronautica.
S.E. Valle comunica che nulla vede in contrario a che l 'Esercito e la Marina concorrano nella determinazione delle caratteristiche degli apparecchi, ma non ritiene che essi debbano essere rappresentati nel Comitato tecnico, le cui attribuzioni sono estranee ali' argomento, in quanto lo S.M. della R.A. definisce i requisiti dei prototipi, lasciando agli Enti tecnici di fare i calcoli relativi e provvedere poi ai concorsi per la presentazione dei prototipi, riserbandosi la sorveglianza nelle costruzioni e nei collaudi per la parte bellica.
S.E. Bonzani insiste sulla nece ssi tà che lo S.M. del R.E. concorra alla determinazione delle caratteristiche, facendo rilevare come ad esempio detto S.M. non sia stato affatto interpellato prima della determinazione del nuovo tipo Ro.30 e come l'aumento delle velocità di traslazione ora ricercate dall'Aeronautica non corrisponda alle necess ità della ricognizione terrestre.
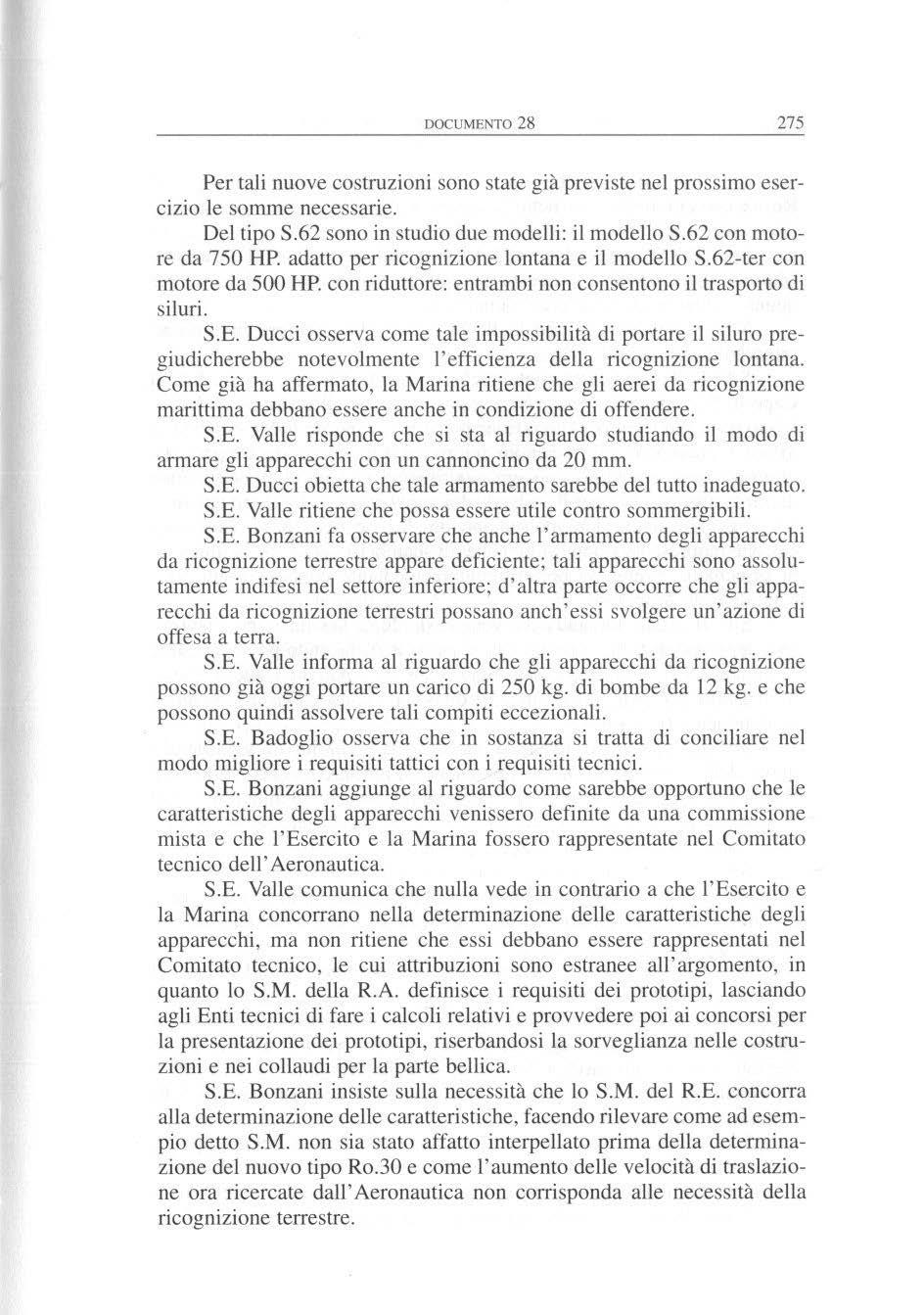
S.E. Valle dichiara che il Ro.30 avrà la stessa velocità minima del Ro. l e che c iò mentre permette la stessa facilità d'osservazione del tiro, può essere assai utile in particolari circostanze.
S.E. Ducci concorda con S.E. Bonzani per quan to riguarda la Marina , aggiungendo che questa deve avere ampia libertà di scelta per quanto ri guarda gli apparecchi delle navi.
S.E. Valle dichiara che la R. Marina è stata semp re invitata ad intervenire ai collaudi.
S.E. Badoglio tenuto conto anche di quanto ha ora esp re sso S.E. il Capo di S.M. della R.A. ravvisa l'opportunità che allorquando si definiscano gli apparecchi per l'aviazione per il R.E . e per la R.M. si debba in avvenire procedere a uno scambio di idee fra le tre Forze Armate per definire i requisiti attuabili, e che agli e s perimenti per l'ulteriore definizione di questi apparecchi e per il co llaudo dei nuovi apparecchi, siano chiamati ad intervenire anche i rappresentanti del R.E . e della R.M. Con l'occasione rappresenta l'opportunità che gli scambi di vedute per le questioni principali avvengano preferibilmente mediante contatti diretti fra i Capi di Stato Maggiore.
S.E. Bonzani domanda che venga esaminata la situazione quantitativa degli apparecchi da ricognizione per il R.E. facendo presente come a l riguardo S.E. il Mini stro della Guerra abbia richiamato l'atten zio ne di S.E. il Ministro dcli' Aeronautica, il quale, a quanto gli risulta, avrebbe recentemente risposto.
S.E. Badoglio ricorda che la proporzione numeric a tra le varie aliquote dell'aviazione fu da lui proposta nell'aprile dello scorso anno a S.E. il Capo del Governo il quale ebbe ad approvarla invitando le Forze Armate ad attenervisi, e invita S.E. il Capo di S.M. dcli' Aeronautica a voler fornire qualche indica z ione al riguardo.

S.E. Valle informa che al 20 ottobre le 20 squadriglie da ricognizione per il R .E. disponevano in totale di 193 apparecchi, con una forza variabile per ogni squadri g lia dai 9 ai 12 apparecchi, e sol tanto di una squadr ig li a di so li 8 apparecchi.
S.E. Bonzani osserva c he al l O luglio, ossia proprio all'inizio del periodo più inten so delle esercitazioni, le tre sq uadri g lie di Venaria Reale disponevano rispettivamente di 4, 4 e 6 apparecchi ossia complessivamente di so li 14 apparecchi, mentre dovevano provvedere alle esercitazioni di 6 divisioni, oltre c he delle artiglierie di corpo d'armata e di armata. Prende atto di questa nuova s itua z ione ora segna lata da S.E. il Capo di S.M. dell'Aeronautica.
S.E. Valle informa che la particolare siluazione del gruppo di Venaria Reale d eve attribuirsi al notevo le num e ro di incidenti di volo e di apparecchi messi fuori d'uso, in quel gruppo, ciò che ha determinato una critica s ituazione momentanea oggi superata.
S.E. Bonzani osserva che, pur prescindendo dalla situazione del gruppo di Venaria Re ale, le altre squadriglie gli risultavano avere una forza di 6-8 apparecchi.
S.E. Valle conferma l'esattezza delle proprie cifre e informa che 1' Aeronautica dispone già di altri apparecc hi da ricognizione in parte accantonati per le nuove 4 squadriglie per il R.E. che saranno costituite entro il giugno 1932.
Mette ancora in rilievo il forte logoramento di materiale da parte dell'aviazione per il R.E., informando che nell'esercizio 1930-31 sono stati messi fuori d'uso in tale specialità 55 apparecchi, oltre 47 apparecchi inviati alle ditte per la riparazione, con una perdita complessiva del 35% e un danno di 20 milioni, in corrispo nden za della perdita del 12% verificatasi negli apparecchi de l l'Armata Aerea. Tale elevata percentuale di perdite deve attribuirsi in parte anche all'uso dei ristretti campi di montagna, ai quali ricorre l'Esercito, e al frequente impiego di voli a bassa quota per il lancio di messaggi. A tali motivi debbono attribuirsi le forti perdite, che hanno richiesto un così cospicuo rifornimento per l'aviazione per il R. Esercito.

S.E. Bonzani ril eva che il logoramento del materiale imposto dal! ' uso di campi ristretti e da voli a bassa quota è inerente alle necessità stesse di impiego della specialità e che perciò esso si verificherà anche in guerra, in aggiunta alle maggiori perdite alle quali è esposta la ricognizione sul campo di battaglia. Osserva perciò che la riserva del 33% stabilita dalla Commissione Suprema di Difesa per l'aviazione da ricognizione debba cons iderarsi in sufficiente.
S.E. Valle fa osservare che ad eliminare discordanze sulla situazione degli apparecchi l'Esercito potrebbe essere periodicamente informato mediante appositi documenti, come già avviene per la Marina.
S.E. Badoglio concorda, aggiungendo c he rimane così stabilito che i comandanti delle squadriglie da ricognizione per l'Esercito debbano mandare men s ilmente ai comandanti di corpo d 'arma ta una situazione, da cui risultino il numero degli apparecchi in dotazione e la loro efficienza, come pure gli altri dati da concordare.
S.E. Valle passa poi ad esaminare la s ituazione dell'aviazione per la R. Marina, la quale si trova in notevole deficienza numerica di apparecchi rispetto ali' organico. Le sue squadriglie sono infatti attualmente in parte su 4-5 apparecchi e in parte su 6-7. Le ragioni di tale situazione so no già state esposte; l'Aeronautica attende per il completamento degli organici, che sia definito il nuovo tipo. Anche le perdite notevoli verificatesi hanno contribuito a determinare tale situazione, in quanto nell 'eserciz io 1930-31 l'aviazione per la Marina ha avuto 26 appa recchi messi fuori uso e 14 apparecchi inviati alle ditte per grandi riparazioni, ossia perdite percentuali di poco inferiori a quelle dell'Esercito.
S.E. Bonzani fa presente che l'aumento di velocità del nuovo tipo del Ro.30 renderà ancor più difficile l'atterraggio nei campi ristretti.
S.E. Valle informa al riguardo che al Ro.30 verranno applicati i freni, così che esso atterrerà entro gli stessi limiti di spazio del Ro. l.
S.E. Bonzani richiama l'attenzione sulla opportunità di seguire e incoraggiare gli studi e gli esperimenti per la realizzazione di un sistema pratico di elicottero, ricordando che S.E. Valle in una lettera in data 20 marzo u.s. diretta al Comando del Corpo di S.M dichiarava che l'elicottero D'Ascanio dava speranza di utile impiego pratico, civile e militare.
S.E. Valle dichiara che le limitazioni finanziarie impediscono all'Aeronautica di provvedere ai costosi esperimenti relativi all'elicottero. Al riguardo deve ricordare che recentemente l'Aeronautica ha dovuto assumersi d'improvviso l ' onere di 73 milioni per impegni presi dalle Provincie per i campi di fortuna in corso di allestimento. D'altra parte esprime l'avviso che l'elicottero rientri in certo modo nel campo dell'aerostatica e che pertanto alla sua realizzazione possa provvedere direttamente l ' Esercito.
S.E. Bonzani non crede che possa adottars i tale classificazione, che ritiene contraria a quanto è attualmente previs to dalla legge. A richiesta di S.E. Badoglio informa che, ove s i realizzasse un tipo pratico di elicottero, potrebbero esserne dotate 4 o 5 delle squadriglie esistenti.
S.E. Badoglio fa presente ancora una volta che la limitazione delle attuali disponibilità dell'Aeronautica induce a ridurre per quanto è possibile i nuovi oneri. Ritiene perciò di poter concludere, per quanto riguarda l'elicottero, esprimendo il desiderio che alla sua realizzazione l ' Aeronautica provveda non appena lo consentiranno le possibilità.
Aggiunge al riguardo essere del massimo interesse che l'Aeronautica possa ottenere un aumento di stanziamento, rilevando che l'aumento del costo degli apparecchi rende sempre più difficile ali' Aeronautica di aumentare le squadriglie e constatando come in sostanza, nonostante l ' aumento di fondi ottenuto dopo il 1925 l'Aeronautica abbia dovuto ridurre i programmi di sviluppo del numero delle unità , così come era stato previsto nel '25, per insufficienza assoluta di bilancio.
L' attuale situazione finanziruia generale rende per il momento impossibile l'aumento di fondi desiderato , ma S.E. il Capo del Governo , al quale S.E. Badoglio ha ripetutamente rappresentato la situazione del!' Aeronautica, ha dichiarato che si provvederà appena sarà pos s ibile , specialmente se accordi internazionali permetteranno di rallentare il ritmo delle costruzioni navali.
S.E. Badoglio, richiamandosi poi a quanto ha detto circa il costo degli apparecchi, esprime l'opinione che convenga rinunziare per l'avvenire ai grossissimi apparecchi, i quali hrumo un prezzo eccessivo e un

rendimento bellico non adeguato, per provvedersi invece di un maggior numero di apparecchi di minor tonnellaggio.
S.E. Valle si riserva di riferirne a S.E. il Ministro.
S.E. Ducci prospetta la situazione della ricognizione marittima lontana, facendo presente che la Marina dispone attualmente di una sola squadrigHa da ricognizione lontana, ora su 4 apparecchi, dislocata a Spezia. Con tale squadriglia sono stati compiuti esperimenti ben riusciti d'impiego idrosilurante.
Domanda quando la Marina potrà disporre delle altre squadriglie da ricognizione lontana previste.
S.E. Valle comunica che è prevista la costituzione di una squadriglia da ricognizione lontana a Elmas entro iI 1932 e delle due squadriglie di Stagnoni e di Lero entro il 1933: tutte però non siluranti.
S.E. Ducci insiste sulla necessità che la Marina possa provvedere alla ricognizione lontana, osservando che per l'assolvimento del s uo compito iniziale più importante nell' Ipotesi W., la Marina dovrà spingere le sue ricognizioni aeree fino sui porti occidentali del!' Algeria.
S.E. Valle informa che la Marina potrà contare entro il 1932 sulla nuova squadriglia da R. l di Elmas su apparecchio S. 62. Domanda se non convenga rinunziare a qualche squadriglia da ricognizione vicina per aumentare quelle da ricognizione lontana.
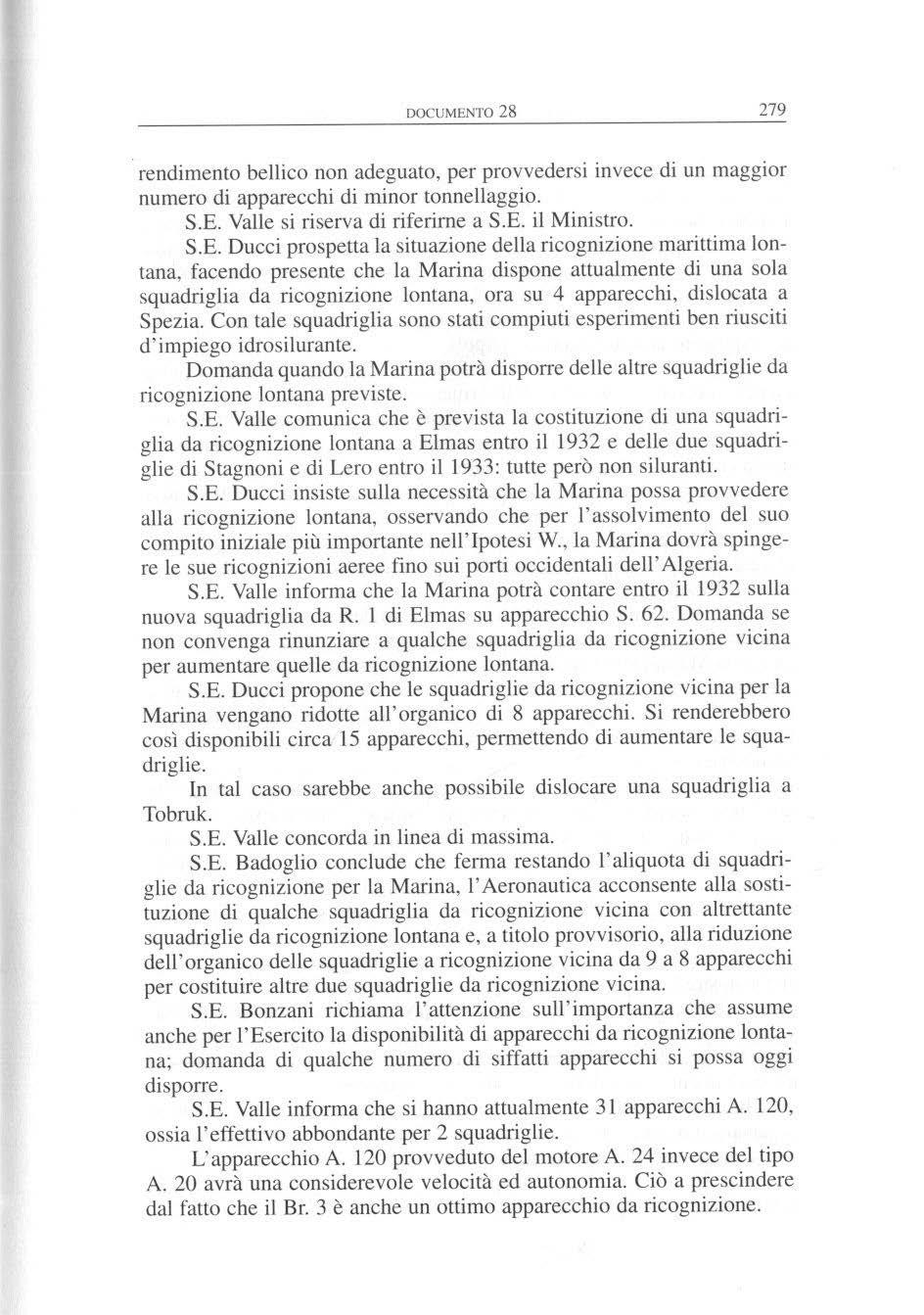
S.E. Ducci propone che le squadriglie da ricognizione vicina per la Marina vengano ridotte all'organico di 8 apparecchi. Si renderebbero così disponibili circa 15 apparecchi, permettendo di aumentare le squadriglie.
In tal caso sarebbe anche possibile dislocare una squadriglia a Tobruk.
S.E. Valle concorda in linea di massima.
S.E. Badoglio conclude che ferma restando l'aliquota di squadriglie da ricognizione per la Marina, l 'Aerona utica acconsente alla sostituzione di qualche squadriglia da ricognizione vicina con altrettante squadriglie da ricognizione lontana e, a titolo provvisorio, alla riduzione dell'organ ico delle sq u adriglie a ricognizione vicina da 9 a 8 apparecchi per costituire altre due squadriglie da ricognizione vicina.
S.E. Bonzani richiarna l'attenzione sull'importanza che assume anche per l'Esercito la disponibilità di apparecchi da ricognizione lontana; domanda di qualche numero di siffatti apparecchi si po ssa oggi disporre.
S.E. Valle informa che si hanno attualmente 31 apparecchi A. 120, ossia l'effettivo abbondante per 2 squadriglie.
L'a pparecchio A. 120 provveduto del motore A. 24 invece del tipo A. 20 avrà una considerevole ve locità ed autonomia. Ciò a prescindere dal fatto che il Br. 3 è anche un ottimo apparecchio da ricognizione.
S.E. Ducci fa presente che nella primavera o all'inizio dell'estate 1932 la Ma1ina vorrebbe riprodurre con una manovra fra Taranto e Tripoli la situazione che si avrebbe nella nostra azione contro i trasporti francesi del Nord-Africa. Le forze nazionali si appoggerebbero alla Sicilia occidentale, che rappresenterebbe la Sardegna. VetTebbero rispettate le distanze che si avrebbero nel caso reale e perciò sarebbe necessario che i nostri aerei da ricognizione lontana dislocati a Stagnoni potessero spingere la loro azione su T1ipoli.
S.E. Valle dichiara che per tali esercitazioni l 'Aero nautica potrà mettere a disposizione unità dell 'Arma ta Aerea.
S.E. Badoglio mette in rilievo l'importanza che assumono tali esercitazioni, le quali prendono in considerazione un problema essenziale per la condotta della guerra marittima.
Rimane stabilito che S.E. Ducci si rivolgerà a momento opportuno all'Aeronautica, la quale è pregata di dare il massimo appoggio.
S.E. Ducci fa presente che le manovre si svolgerebbero a fine maggio e ai primi di giugno e domanda se per tale epoca l'Aeronautica non abbia difficoltà.
S.E. Valle informa che converrebbe attendere il mese di settembre e poiché S.E. Ducci rileva che sarebbe troppo tardi , S.E. Valle comunica che la Marina potrà ad ogni modo fare assegnamento su di una squadriglia di S. 62. Pone tuttavia il quesito se, assicurato il collegamento ferroviario del Nord-Africa con i porti del l'Atlantico, debba ancora la Francia attribuire tanta importanza al trasporto delle truppe dai porti del Mediterraneo.
S.E. Badoglio ritiene che le comunicazioni ferroviarie, costituite da una linea a semp lice binario, non ancora unificata nello scartamento renderebbe molto lento lo spostamento delle truppe. È convinto perciò che, finché non interverranno altri fattori, la Francia annetterà grande importanza alle comunicazioni mediteITanee col Nord-Africa.
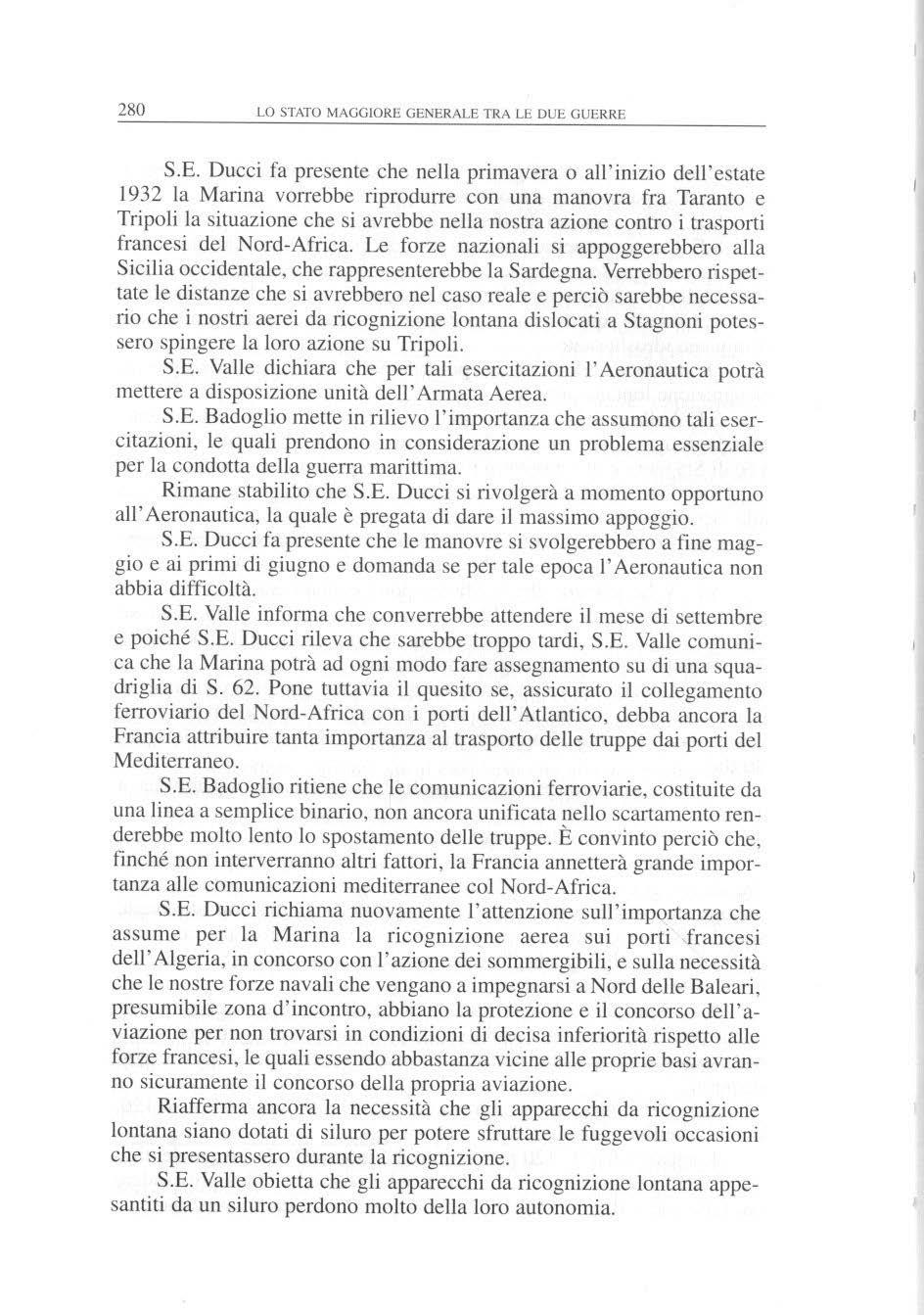
S.E. Ducci richiama nuovamente l'attenzione sull'importanza che assume per la Marina la ricognizione aerea sui porti francesi dell ' Algeria, in concorso con l'az ione dei sommergibili, e sulla necessità che le nostre forze navali che vengano a impegnarsi a Nord delle Baleari , presumibile zona d ' incontro , abbiano la protezione e il concorso dell'aviazione per non trovarsi in condizioni di decisa inferiorità rispetto alle forze francesi, le quali essendo abbastanza vicine alle proprie basi avranno sicuramente il concorso della propria aviazione.
Riafferma ancora la necessità che gli apparecchi da ricognizione lontana siano dotati di siluro per potere sfruttare le fuggevo li occasioni che si presentassero durante la ricognizione.
S.E. Valle obietta che gli apparecchi da ricognizione lontana appesantiti da un siluro perdono molto della loro autonomia.
D'altra parte ritiene che l'azione lenlata con un solo siluro dia poche garanzie di riuscita; l'azione contro un'unità navale deve a suo parere essere condotta da più apparecchi agenti da direzioni diverse e perciò non con apparecchi isolati ma con reparti di idrosiluranti.
L'Aeronautica conta di attrezzare tutti gli apparecchi da bombardamento marittimo per l' idrosiluramento, appoggiandosi alle sedi djpartimentali e valendosi anche dell'opera di siluristi della R. Marina.
L'Aeronautica potrebbe anche impegnarsi a tenere pronte in vista di determinate azioni e in determinate sedi unità da bombardamento per assicurare la cooperazione con la Marina.
S.E. Ducci fa osservare che per determinati compiti occorrerebbe alla Marina di poter fare assegnamento certo sul concorso di determinate aliquote di aviazione offensiva, mentre generalmente, negli accordi al riguardo, l'Aeronautica subordi na sempre il proprio concorso alle altre proprie eventuali necessità.
Per quanto riguarda il contrasto fra l'armamento offensivo e l'autonomia della ricognizione lontana, fa osservare che i due compiti di ricognizione e di siluramento non verrebbero sempre disimpegnati contemporaneamente.
Insiste perciò nel richiedere che gli apparecchi da ricognizione lontana e anche vicina per la Marina siano provveduti delle armi richieste dalle esigenze della guerra navale compatibilmente con le loro qualità di volo, in conformità del resto di quanto avviene per le altre Marine.
Richiama anche l'attenzione sulla necessità che gli apparecchi idrosiluranti si allenino nella cooperazione con le unità navali.
S.E. Badoglio, senza escludere l'eventuale impiego prospettato dalla Marina, esprime il parere che in linea di massima i requisiti di velocità e di autonomia che si richiedono alla ricognizione lontana non siano conciliabili con l'impiego idrosilurante. Ad ogni modo ritiene essenziale che la Marina possa fare assegnamento sul tempestivo concorso del1'aviaz ione offensiva (idrobombardamento e idrosiluramento).
Questo sarà compito precipuo della Direzione superiore delle operazioni, la quale darà a momento opportuno gli ordini per assicurare l'intervento di determinate aliquote dell'Armata Aerea, come pure, in vista delle necessità improvvise e fugaci che si manifestano nella guerra navale, potrà anche disporre, in date s ituazioni , che alcune unità da bombardamento marittimo siano tenute a disposizione per agire con le forze navali.

S.E. Valle fa presente, incidentalmente, che l'Aeronautica avrebbe necessità di trasferire a Durazzo , per via di mare, un centinaio di uomini entro le prime 24 ore; domanda se si possa fare allo scopo assegnamento su un cacciatorpediniere.
S.E. Ducci dichiara che non vi saranno difficoltà.
S.E. Badoglio comunica che sull'argomento degli obiettivi da battere con l'aviazione nei primj giorni per le necessità dell'Esercito e della Marina, non ritiene di tornare, risultando da precedenti dichiarazioni che i tre Stati Maggiori sono d'accordo.
S.E. Valle fa presente al riguardo che l'Aeronautica avrebbe da fare obiezioni per alcuni obiettivi designati dal Comando del Corpo d'Armata di Tri este per la recisione del saliente castuano.
S.E. Bonzani informa che gli accordi presi dru comandanti di Corpo d ' Armata hanno un semplice valore di orientamento per azioni eventuali.

S.E. Badoglio ritiene doversi stab ilire che abbiano valore esecutivo soltanto gli accordi diretti fra i tre Stati Maggiori, i quali hanno portato a definire in linea precisa gli obiettivi elencati in ordine d'importanza. Tali obiettivi definiti preventivamente hann o carattere strategico. L'accordo sugli obiettivi tattici dipenderà dalla situazione del momento.
S.E. Valle fornisce alcuni dati s ulla situazio ne delle aviazioru francese e jugoslava.
La Francia ha dichiarato a Ginevra di disporre di 3076 apparecchi di linea e in riserva di linea. Tali dati risulterebbero rispondenti al vero, ma oltre di essi occorre tenere conto di 2000-2500 apparecchi in magazzino, che vengono rinnovati meiliante le forniture alle aeronautiche satelliti.
La Jugos lavia dispone di 28 squadriglie efficienti, che verrebbero portate a 63 entro il 6 ° giorno di mobilitazione; dispone anche di un' attrezzatura di campi che è sta ta notevolmente sv iluppata in questi ultimi anni. In quanto agli stanziamenti, per quanto s i obietti che nei bilanci è difficile vedere chiaro: ma è da considerare che mentre l'Italia è ferma da 6 anni la Francia e la Jugoslavia aumentano continuamente gli stanziamenti per l'Aeronautica, e la percentuale di assegnazioni sul complesso dei bilanci militari.
La seduta è chiusa alle ore 12. Verrà ripresa il giorno 10 novembre alle ore 9,30.
«L'aviazione per l'Esercito e il problema della proporzione del numero delle squadriglie. Organizzazione militare delle Isole italiane dell'Egeo: unità di fanteria disponibili, situazione di Castelrosso, Lero, Rodi e Stampalia, relazione fra poteri militari e civili in caso di guerra. Organizzazione della difesa costiera di Tripoli e Tobruk».
Verbale della Riunione del giorno IO novembre 1931 - X
La riunione viene tenuta nel salone antistante all'ufficio di S.E. il Capo di Stato Maggiore Generale.
Sono presenti le stesse autorità indicate nel verbale della riunione del 5 novembre <a> .
La seduta è aperta alle ore 9,30.
S.E. Bonzani chiede che sia preso in esame anche per quanto riguarda l'aviazione per l ' Esercito il problema della proporzione del numero delle squadriglie, informando che sull'argomento S.E. il Ministro della Guerra aveva già interessato direttamente S.E. il Ministro dell 'Aero nautica, il quale ha risposto con una lettera della quale può oggi dare comunicazione.
S.E. il Ministro dell'Aeronautica fa conoscere che l'Aeronautica dispone oggi in totale di 95 squadriglie e che pertanto nella primavera prossima, con la costituzione delle 4 nuove squadriglie previste, l 'aviazione per l'Esercito disporrà di tutta l'aliquota di squadrigUe per essa stabilita. Per quanto riguarda il numero degli apparecchi informa che la s ituazione del materiale al 20 ottobre porta esistenti presso le 20 squadriglie per il R. Esercito un totale di 193 apparecchi, con una media quindi di circa 10 apparecchi per squadrig li a, tutti di tipo moderno. Ciò nonostante la forte percentuale di consumo dovuta alla intensa attività in terreno montano su campi di manovra occasionali e ristretti e a quote di lancio messaggi assai basse (dal 1° luglio a tutt'oggi 55 apparecchi resi inservibili e 47 inviati alle ditte per grandi riparazioni) con un onere comp lessivo di 20 milioni.

S.E. il Ministro dell'Aeronautica aggiunge che le scarse disponibilità di bilancio non consentono di provvedere all'attuale forza di apparecchi con un'adeguata quantità di personale; ha perciò determinato che in ogni squadriglia si debba avere un'aliquota di immediato impiego (linea: 7 apparecchi per l'aviazione per l'Esercito, come per il bombardamento) e un'altra di pronta riserva (riserva di Linea).
Sempre a cagione di tali limitazioni finanziarie l'Aeronautica deve rinunciare per il corrente esercizio ali' approntamento dei campi di Mondovì e di Novi Ligure , richiesti come urgenti dallo S.M. del R. Esercito, per i quali è prevista una spesa di 9 milioni.
In relazione a queste notizie S.E. Bonzani fa presente che dal supplemento riservatissimo al foglio d'ordini della R. Aeronautica in data 2 ottobre ri s ulta che l'Annata Aerea è attualmente costituita da 69 sq uadriglie, alle quali sono da aggiungere le squadriglie e le sezioni S.M. per un complesso equivalente a 7 squadriglie e quindi un totale di 76 squadriglie, in conispondenza delle quali l'Esercito dispone oggi di sole 20 squadriglie e la Marina di 15. L' Aeronautica conta dunque oggi un totale di 111 squadriglie anziché 95 e l'Esercito dovrebbe disporre , in corris pondenza delle 76 s quadriglie dell'Armata Aerea, almeno di 28 squadriglie anziché 20 attualmente esistenti. Con la costituzione delle 4 nuove squadriglie previste l'Esercito sarà quindi ancora al di sotto della aliquota spetta ntegl i.

S.E. Valle fa rilevare che le squadriglie e sezioni S.M. non devono essere considerate come nuovi reparti organici, ma semplicemente come un raggruppamento particolare di apparecchi adottato ai fini dell'addes tramento , il quale impone che nell'Armata Aerea i comandanti di reparto dispongano di un apparecchio proprio.
Nel fatti gli apparecchi delle unità S.M. rimangono in forza alle altre squadriglie.
Osserva poi che delle 69 s quadriglie indicate nel s upplemento al foglio d'ordini non devono essere considerate nei computi comparativi le 4 squadriglie del gruppo sperimentale detto d 'ass alto. Si tratta, come dice il nome, di un reparto costituito a semplice scopo sperimentale con materiale di tipo non recente per s tudiare le azioni a volo rasente. Non si potrebbe oggi dire se tale specialità sa rà o meno attuata definitivamente e in caso affermativo essa potrebbe servire non soltanto per l'Armata Aerea ma anche per l'Esercito.
S.E. Badoglio domanda se sia neces s ario mantenere costituite 4 squadriglie per Lali s tudi sperimentali.
S.E. Valle risponde affermativamente, per il fatto che occorre sperimentare l'impiego a massa di tale specialità. Proseg ue dicendo che neppure vanno incluse nel computo le 3 squadriglie dello stormo di Lero, le quali vanno computate nelle forze oltremare, assimilabili perciò alle
squadriglie coloniali, le quali non entrano nel computo dell'Aeronautica metropolitana.
L'Armata Aerea dispone quindi oggi soltanto di 60 squadriglie e precisamente:
27 squadriglie C.T.
3 » C.M.
22 » B.T.
8 » B.M.
alle quali devono aggiungersi 2 squadriglie sperimentali (Ca. 102 apparecchi da bombardamento a grande autonomia) che non debbono gravare sui percento, così come non gravano le 2 squadriglie sperimentali di apparecchi Ro 30 e Ca. 97 dell'aviazione per il R. Esercito.
S.E. Bonzani non ritiene che le squadriglie di Lero debbano essere escluse dal computo, in quanto la percentuale stabilita va applicata al totale delle squadriglie costituite col bilancio del Ministero Aeronautica. Le squadriglie coloniali non sono a carico di tale bilancio.

S.E. Duc ci concorda che S.E. Bonzani su questo punto di vista.
S.E. VaJJe fa notare che le squadriglie dislocate nell'Egeo verranno a trovarsi completamente distaccate dall'Armata Aerea perché a distanza superiore a una tappa di volo; di esse non si potrà disporre senza la benevola neutralità della Grecia.
Ripete che anche per l'Esercito verranno costituite, nel corrente eserci1.io. 2 squadriglie l>perimentali.
Quanto al computo del numero totale delle squadriglie aggiunge che esso deve essere fatto con un certo criterio di relatività: il totale assoluto arriverebbe infatti a 158 squadriglie comprendendovi anche 25 sq uadriglie da turismo e 20 squadriglie scuola, che evidentemente non possono venire messe a calcolo per stabilire l'aliquota delle varie specialità.
S.E. Bonzani fa rile vare che le due squadriglie spe rimentali alle quali S.E. Valle ha accennato rappresentano reparti « in fieri» e non reparti effettivamente esistenti come le squadriglie dell'Armata Aerea alle quali ha accennato. Anche prescindendo dai reparti S.M., si tratta di 69 squadriglie, delle quali 34 da bombardamento. Ricorda che per la specialità da bombardamento è stabilita l'aliquota del 25% uguale a quelle dell'aviazione per l'Esercito.
Avendo rilevato da un accenno di S.E. Valle che per la costituz ione delle 4 nuove sq uadriglie per l'Esercito si ricorrerà anche agli apparecchi A. 300-6, ra presente che secondo precedenti comunicazioni tali apparecchi dovrebbero venire ritirati.
S.E. Valle risponde che tale apparecchio deve considerarsi ancora buono, specialmente in zone non montuose. Esso viene infatti regolarmente impiegato nelle scuole. Gli A. 300-6 dovevano essere ritirati alle
scuole per essere sostituiti in linea con apparecchi migliori, ma i fortissimi consumi verificatisi nell'aviazione per l'Esercito obbligano a ricorrere all' A. 300-6 per la costituzione delle nuove squadriglie
S.E. Valle fa anche osservare che le squadriglie da bombardamento notturno sono nel fatto quasi inesistenti, date le deficienze del materiale. Ciò, nonostante le min01i perdite di questa specialità (appena il 12% in confronto del 33% circa dell'aviazione per il R.E. e di quella per la R.M.).
Conclude affermando che in sostanza l'Aeronautica ha osservato le percentuali stabi lite tra le varie special ità e aggiunge che, in considerazione dell'evoluzione rapida dei concetti d'impiego e dei tipi di apparecchi, l'Aeronautica non ritiene di potere rispettare in avvenire tali percentuali, ormai vecchie di oltre un anno, per le quali perciò si prospetta la necessità di una futura revisione.
S.E. Badoglio fa osservare che le percentuali in questione da lui attentamente studiate per conciliare nel modo migliore le esigenze discordanti delle tre Forze Armate, furono proposte e integralmente accettate da S.E. il Capo del Governo, il quale ordinò che esse avessero attuazione integrale. Non ritiene perciò di dover tornare ora sulla questione se non ne riceva espresso invito da S.E. il Capo del Governo.
Fa rilevare che in realtà l'Esercito, anche quando potrà disporre di 24 squadriglie, verrà a trovarsi in deficienza rispetto ai bisogni. Tenuto conto della limitazione dei mezzi, riliene ancora che il mantenere qualtro squadriglie per gli esperimenti d ' impiego a volo rasente possa essere eccessivo.
S.E. Badoglio perciò, sentite le spiegazioni fornite dalle LL.EE. i Capi di S.M., esprime il parere che gli esperimenti col gruppo sperimentale d'assalto siano portati a conclusione al più presto, in modo da includere quelle squadriglie in una delle aliquote previste per l'Aeronautica, e che debbano venire rispettate le proporzioni tra le varie aliquote approvate da S.E. il Capo del Governo.
S.E. Bonzani, riferendosi alla situazione numerica degli apparecchi, prende atto che al 20 ottobre 1' aviazione per il R.E. disponeva di 193 apparecchi, ma fa rilevare che - come ha già informato - al 1° luglio, ossia nel momento in cui si iniziavano le esercitazioni di campag na, le 3 squadriglie dislocate a Venaria Reale disponevano complessivamente soltanto di 14 apparecchi (4+4 +6) con i quali si dovette provvedere alle esercitazioni d i be n 6 di visio ni oltre le artiglierie di c.d'a. e di armata.
Le forti pe rd ite cui ha accennato S .E. Va ll e potranno in par te attribuirsi alle necessità dello speciale impiego de ll a ricognizione, in parte anche alle caratteristiche degli apparecchi o a difetto dei campi.
A tali inconve nie nti occorre ri mediare. Comunque tale forte pe rcentuale di perdite fa apparire necessario che l'av iazione per il R .E.

disponga in caso di mobilitazione di adeguate riserve. L'aliquota del 33% stabilita al riguardo dalla C.S.D. è certamente insufficiente.
S.E. Valle ritiene che il forte consumo debba piuttosto ascriversi a difettoso impiego da parte dei comandi del R.E.; frequente ad esempio il caso di missioni di volo protratte molto lungamente oltre il necessario, con forte logorio del materiale. Aggiunge che, per quanto riguarda il difetto dei campi, in molti casi si tratta di campi occasionali in zona montuosa impiegati dall'Esercito per le eserc itazioni estive, per i quali non si avrebbe alcuna convenienza ad eseguire costosi lavori di ampUamento. Tra questi camp i cita ad esemp io quelli di M Corvino Rovetla, di Aquino, di Pe scocosta nz o.

S.E. Bonzani, riferendosi a quanto è s tato accennato circa la deficienza di personale, che impedirebbe di tenere io linea tutti gl i apparecchi in organico alle squadriglie, fa osservare che, per quanto gli consta, non si verifica alcuna deficienza nella categoria dei piloti.
S.E. Valle osserva che le deficienze si verificano non nei piloti ma nel personale specializzato.
S.E. Bonzani aggiunge che è particolarmente sentita la deficienza di radiotelegrafisti; così ad esempio nelle squadriglie di Venaria Reale mancavano molti apparecchi radiotelegrafici e radiotelegrafisti a terra. Riferendosi poi alla sospesa costituzione dei campi di Navi e di Mondovì, domanda do ve potranno essere allogate le quattro nuov e squadriglie, facendo presente c he il campo di Venaria Real e è ormai saturo e agg iun gendo che per l'Esercito è di somma importanza potere compiere esercitazioni di ricognizione lontana.
S.E. Valle informa che le nuove squadrig lie potranno essere allogate a Elma s e a Noghera e fa notare che l'Aeronautica aveva un campo ad Alessandria (piazza d'armi) coi relativi impianti, ma ha dovuto rinunz iarvi per l'opposizione delrEsercito, che ha voluto la restituzione della piazza d'armi.
S.E. Badoglio riassume dicendo che in sostanza l 'Esercito chiede un aumento di campi permanenti alla frontiera occidenta le.
S.E. Valle fa o se r vare che in realtà i campi esistono, ma sono privi di hangars e di caserme. e c he in caso di necessità potrebbero essere sfruttati ug ualmente.
Così è anche per i campi di Navi e di Mondovì, esistenti già oggi come camp i. il cui so lo attrezzamento era previsto nel presente esercizio con una spesa di circa 9 milioni, dei quali l 'Aeronautica oggi non può invece più disporre.
S.E. Badoglio conclude comunicando che di questa situazione darà informazione a S.E. il Capo del Governo, rappresentando la necessità che l'Aeronautica sia messa in condizione di attuare le sistemazioni richieste dall'Esercito.
S.E. Badoglio passa poi all'esame della organizzazione militare delle isole italiane dell ' Egeo, comunicando che l'Esercito si propone di trasformare appena possibile il reggimento fanteria dislocato nell'Egeo, dotandolo di un maggior numero di mitragliatrici , analogamente a quanto è stato fatto per il reggimento bersaglieri di Zara.

S.E. Bonzani precisa che il battaglione dislocato a R odi manterrebbe una certa aliquota di elementi mobili , mentre il battaglione dislocato a Coo e destinato a Lero verrebbe trasformato in battaglione mitraglieri. Al riguardo aggiunge che, avendo la Marina a ssicurato il trasporto a momento opportuno del battaglione di Coo a Lero, si rinunziò nello scorso anno a dislocare fin dal tempo di pace quel reparto a Lero; ritiene invece necessario insistere su tale trasferimento , nella considerazione che il battaglione dovrà conoscere bene il terreno dell'isola in cui avrà impiego.
S.E. Ducci informa che per accordi intervenuti fra le LL.EE. i Ministri della Guerra e della Marina si rinunziò al trasferimento, ma annunzia che la Marina ritorna ora sull ' argomento chiedendo che almeno una compagnia con la sezione cannoni e con un ' aliquota di mitragliatrici pesanti vengano trasferite a Lero. Le rimanenti forze del battaglione potrebbero essere trasportate invece al momento del bisogno.
Fa presente che la Marina riterrebbe necessario che venis se dislocato un plotone a Castelrosso e un plotone a Stampalia per ostacolare l'occupazione nemica o quanto meno impedire che la popolazione la favorisca.
S.E. B onzani osserva che la forza del 9 ° Reggimento fanteria dislocato nell'Egeo è limitata e che perciò bisog na ridurre al minimo il numero delle località da presidiare; ricorda che al massimo il Reggimento potrà provvedere a 36 mitrag li atrici pesanti e a 6 leggere.
S.E. Valle fa presente che Castelrosso offre un ottimo s pecchio d ' acqua che la Francia potrebbe in caso di guerra utilizzare, avvicinando notevolmente la s ua offesa, che altrimenti dovrebbe partire da B eyruth. A conferma della importanza che la Francia attribuisce a Castelrosso, ricorda che nella convenzione del 1928 la Francia si decise ad accordare alle nostre lin ee commerc iali lo scalo a Tunisi, precedentemente sempre rifiutato, soltanto col corrispettivo di uno scalo a Castelrosso per la s ua linea aerea del Levante.
Ritien e perciò che il mantenimento della occupazione di Castelrosso debba almeno avere la precedenza su quella di Coo.
S.E. Badoglio ritiene c h e si debba evitare una dispersione di forze e fa osservare c he per presidiare Castelrosso occorrerebbe almeno una compagnia. Nella situaz io ne normale di forze dei presidi dell'Egeo ciò non sembra possibile. In avvenire potrà forse essere considerato un concorso dalle colon ie libi che.
In caso di guerra quindi dovranno rimanere presidiate soltanto Lero, Rodi e Stampalia. Soltanto se sarà possibile, in periodo di sicurezza rinforzare i presidi dell'Egeo, potrà essere mantenuta anche l'occupazione di Castelrosso.
S.E. Bonzani dichiara che, per quanto riguarda l'invio di complementi, l'Esercito non avrà difficoltà, sempre quando sia possibile trasportarli in periodo di sicurezza.
All'occorrenza potrebbero essere trasportati in abito civile, predisponendo magazzini a Rodi e a Lero.
S.E. Ducci informa che la Marina invierà a Lero, in caso di mobilitazione, circa 700 uomini con una quarantina di ufficiali e vi dislocherà 4 cacciatorpediniere; in primo luogo vi prenderanno appoggio anche altri 4 cacciatorpediniere destinati al Mar Rosso . Queste forze sottili potrebbero quindi provvedere alla scorta dei complementi. Quanto al rinforzo del presidio di Castelrosso, che si trova a sole 80 miglia da Rodi, potrebbe essere fatto trasportando le truppe con un cacciatorpediniere.
S.E. Valle dichiara che l'aviazione da Lero può già oggi battere da Beyrut al Sud sin al Mar Nero al Nord, con efficacissima azione di controllo su l traffico.
S.E. Badoglio esprime il parere che, fino a quando l 'Aeronautica non avrà altro sviluppo, le isole italiane dell'Egeo abbiano preminente interesse marittimo, in quanto esse se rviranno di base alle nos tre forze per la protezione del nostro traffico nel Mediterraneo orientale, s ia per le provenienze da Suez, in concorso con l'azione da Tobruk, sia per le provenienze dai Dardanelli.
Ritiene perciò che il comando militare delle iso le debba in guerra essere esercitato dalla Marina, e spera che questa provveda fino dal tempo di pace.
S.E. Ducci informa che per tale comando è già designato un ufficia le della riserva navale residente a Lero, il quale sarà prossimamente promosso ammirag li o.

S.E. Badoglio prosegue dichiarando che lo stom10 di cui è prevista la dislocazione a Lero è un elemento essenzialmente mobile e che la stessa mobilità dell 'arma aerea non consiglia di vincolare permanentemente lo stormo a una località.
S.E. Valle fa osservare che le isole dell'Egeo sono a distanza superiore a una tappa di volo dalle nostre basi e quindi la possibilità di ritirare le forze aeree dislocate nell'Egeo di penderà dalla benevola neutralità della Grecia.
S.E. Badoglio considera invece che in caso di neces s ità il movimento possa sempre essere fatto via Tobruk-Libia.
S.E. Valle non riti ene ciò possibile per la caccia.
S.E. Ducci domanda come saranno fissate in caso di guerra le relazioni fra il comandante militare e il governatore delle isole.
S.E. Badoglio ritiene che in caso di guerra il governatore civile potrebbe venire ritirato concentrando tutti i poteri nel comandante militare. Provvedimento analogo è del resto previsto per le isole maggiori , nelle quali, in caso di guerra, il comandante superiore dell'isola avrà i poteri attribuiti ali' autorità militare in zona di guerra.
Osserva anche che la situazione del governatore delle isole italiane dell'Egeo non è assimilabile a quella dei governatori delle colonie e già in tempo di pace assume una fisionomia distinta , anche per il fatto che dipende dal Ministero degli Esteri.
Comunque ritiene utile richiamare al riguardo l'attenzione di S.E. il Capo del Governo per gli eventuali provvedimenti legislativi.

S.E. Ducci ritiene opportuno aggiungere qualche notizia a quanto è già noto a S.E. il Capo di S.M. Generale circa l'organizzazione difensiva adottata dalla Marina, informando che è prevista anche l batteria da 76 a Parteni, la quale sarà allacciata con una strada a Santa Marina; I batteria da 76 è anche prevista per Stampalia.
S.E. Badoglio conclude dichiarando che rimane stabilito che le isole italiane dell'Egeo passano, in caso di guen·a, sotto la dipendenza del comando militare della Marina.
Le iso le di preminente interesse militare da difendere sono in ordine di importanza: Lero, Rodi , Stampalia e Caste lrn sso Saranno difese soltanto le prime tre, se si potrà disporre unicamente delle forze attualmente dislocate nell'Egeo; sarà difesa anche Castelrosso se sarà possibile inviare complementi.
S.E. Badoglio ravvisa anche l 'o pportunità che il 9° Reggimento fanteria s ia appena possib ile sosti tuito , per completare la divisione, di Bari , mettendo il presidio dell'Egeo alla dipendenza diretta del Ministero. Si rende tuttavia conto della impossibilità attuale di realizzare tale sostituzione, data la situazione del bilancio e si limita perciò a farvi cenno perché sia tenuta presente per situazione migliore.
Raccomanda altresì che venga s tudiata l ' utilizzazione dei nostri elementi in congedo re s identi nel Mediterraneo orientale, i quali potrebbero in parte affluire nelle nostre isole dell 'Egeo, usufruendo delle nostre linee di navigazione.
Con l'occasione dà notizia che è in studio un provvedimento per il quale i militari nazionali residenti in Libia verranno in caso di guerra richiamati in Colonia.
In Tripolitania poi, sistemata oramai la situazione interna, viene attualmente studiata la mobilitazione per la difesa della colonia contro minacce da ovest, difesa alla quale in seco ndo tempo potranno concorrere anche forze della Cirenaica.
S.E. Badoglio passa poi all'esame del problema relativo all'organizzazione costiera di Tripoli e di Tobruk.
Al riguardo informa che in passato venne studiato un progetto il quale avrebbe importato una spesa di 70 milioni, cifra proibitiva la quale impedì allora di dare ulteriore corso alla questione. Successivamente venne studiato un nuovo progetto, riducendo il preventivo di spese, ma anche per queste non poterono stanziarsi i fondi.
S.E. Badoglio stesso ebbe finalmente a fare una nuova proposta: la Marina avrebbe fornito il materiale d'artiglieria per le batterie costiere e la Colonia avrebbe provveduto alle costruzioni e al personale, usufruendo di militari in congedo residenti in Libia. Il preventivo di spesa ammontava per Tripoli a 7 milioni.
La riduzione subìta dai bilanci coloniali non permetterebbe oggi in alcun modo di provvedere anche alla spesa così ridotta.
Ma il problema non può più essere considerato d'interesse co loniale: esso non riguarda tanto la difesa delle due Colonie quanto la condotta generale della gue1Ta. Il possesso di Tripoli e di Tobruk infatti è indispensabile per mantenere un dominio relativo ne l Mediterraneo centrale e orientale e quindi per assicurare i nostri rifornimenti marittimi via Suez e Dardanelli. S.E. Badoglio si propone perciò di prospettare il problema a S.E. il Capo del Governo, il quale determinerà su quale bilancio debbano gravare le spese necessarie.
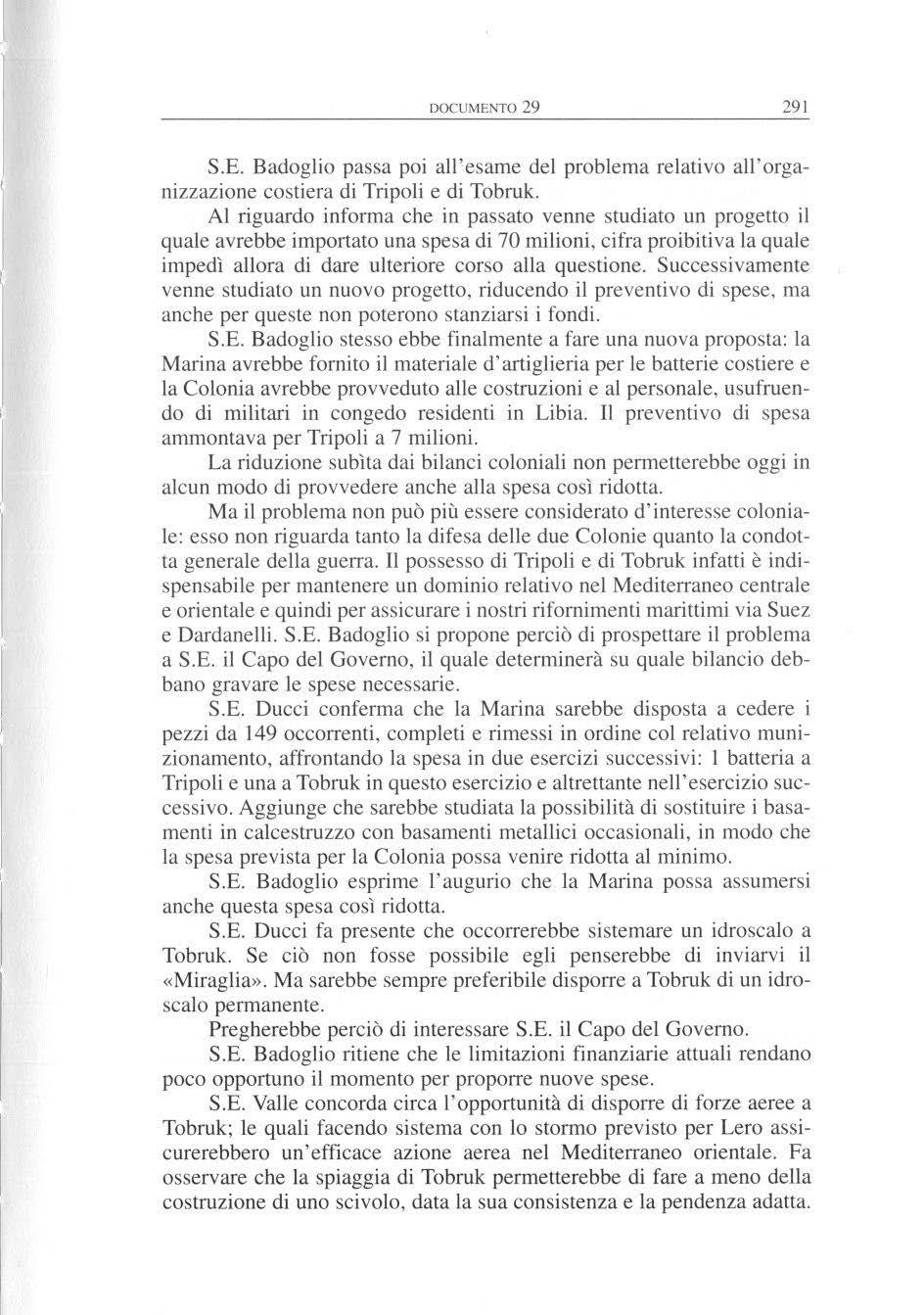
S.E. Du cci conferma che la Marina sarebbe disposta a cedere i pezzi da 149 occorrenti, comp leti e rimessi in ordine col relativo mlmizionamento, affrontando la spesa in due esercizi successivi: 1 batteria a Tripoli e una a Tobruk in questo esercizio e a ltrettante nell'esercizio successivo. Aggiunge che sarebbe studiata la possibilità di sostituire i basamenti in calcestruzzo con basamenti metallici occasionali, in modo che la spesa prevista per la Colonia possa venire ridotta al minimo.
S.E. Badog lio esprime l'augurio che la Marina possa assumersi anche questa spesa così ridotta.
S.E. Ducci fa presente che occorrerebbe sistemare un idroscalo a Tobruk. Se ciò non fosse possibile egli penserebbe di inviarvi il «Miragli a» . M a sarebbe sempre preferibile disporre a Tobruk di un idroscalo permanente.
Pregherebbe perciò di interessare S.E. il Capo del Governo.
S.E. Badoglio ritiene che le limit azioni finanziarie attuali rendano poco opportuno il momento per proporre nuove spese.
S.E. Valle concorda circa l'opportunità di disporre di forze aeree a Tobruk; le quali face ndo sistema con lo stormo previsto per Lero assicurerebbero un 'efficace azione aerea ne l M editerraneo orientale. Fa osservare che la spiaggia di Tobruk permetterebbe di fare a meno della costruzione di uno scivolo, data la sua consistenza e la pendenza adatta.
S.E. Badoglio conclude confermando che conviene s tudiare la so lu zio ne proposta dell'invio del Miraglia a Tobruk.
S.E . Ducci assicura che sarà fatto questo studio. E poiché era previsto che il Miraglia venfase inviato a Valona , in s ua sos tituzione verrà mandata in que sta ultima base una delle due bas i passeggere previst e La seduta è chiusa alle ore J 1.45.
A. U.S.S.M.E .fondo H- 10 «Verbali riunioni 1924-1943 » busra 11. 2. fascico lo 11. 6. Il documento è una copia de/l'Ufficio del capo di Staro Maggiore Genera le a) Cji: doc wnemo n 25.

«Opera z ioni in Eritrea: forze metropolitane di eventuale impiego, invio di unità dalla Libia e di ufficiali d'artiglieria e di stato maggiore, aliquota necessaria d'avia zione ».
L'anno millenovecentotrentaquattro (XII) addì sette del mese di maggio in Roma, a Palazzo Venezia , S.E. il Capo del Governo ha convocato le LL.EE. De Bono , Ministro delle Colonie ; Baistrocchi , Sottosegretario per la Guerra; Valle, Sottosegretario per l 'Ae ronautica; Badoglio, Capo di S.M. Generale; Bonzani, Capo di S.M. dell'Esercito , per esaminare le questioni relative alle operazioni in Eritrea.
È stato deciso che le forze metropolitane di eventuale impiego in Eritrea non debbono essere inferiori ad un corpo d ' armata su tre divisioni, truppe suppletive e servizi come da piano particolareggiato che sarà concretato dal Capo di Stato Maggiore dell'Esercito.
Resta affidato allo Stato Maggiore dell'Esercito lo studio dettagliato dei trasporti e l'organizzazione di tutti i servizi e l'eventuale anticipato dislocamento in Libia del predetto corpo d'armata metropolitano.
È stato deciso, per il prossimo mese di ottobre, l'invio in Eritrea:
- di due battaglioni eritrei tra quelli attualmente dislocati in Libia traendone uno dalla Cirenaica e l'altro dalla Tripolitania;
- degli ufficiali di artiglieria necessari per l ' inquadramento delle batterie da costituire col materiale già destinato in Eritrea;
- di un ufficiale di stato maggiore per occuparsi particolarmente dei servizi di intendenza.
Per quanto concerne l'aliquota di aviazione si decide che questa deve essere costituita da 75 a 100 apparecchi da bombardamento la cui ordinazione dovrà essere data in tempo uti le. Nel frattempo il Governo della Colonia deve provvedere alla sistemazione dei campi per il ricovero degli apparecchi nonché a tutto quanto occorre al rifornimento e alla manutenzione.
A.U.S.S.M.E..fondo H-10 « Verbali riunioni /924-/943» , busta 11. 2.fascicolo 11. 7.
Il documento è 1111 originale .m carta 1w11 intestata con le firme autografe tli tu/li i partecipami alla riunione (Mussolini, Badoglio, 8011:a11i. De 80110, Bais1roccl1i, Val/e), Non è 1111 verbale ma ww breve sintesi delle decisioni finali prese nella seduta del 7.5.1934.


«Prepara zione e apprestamenti difensivi in Eritrea ai confini con l'Etiopia»
Riunione presso il Capo del Governo con l'intervento del Capo di Stato Maggiore Generale Marescia llo d'Italia Badoglio, del Ministro delle Co lonie Generale De Bono, del Sottosegretario agli Esteri Suvich.
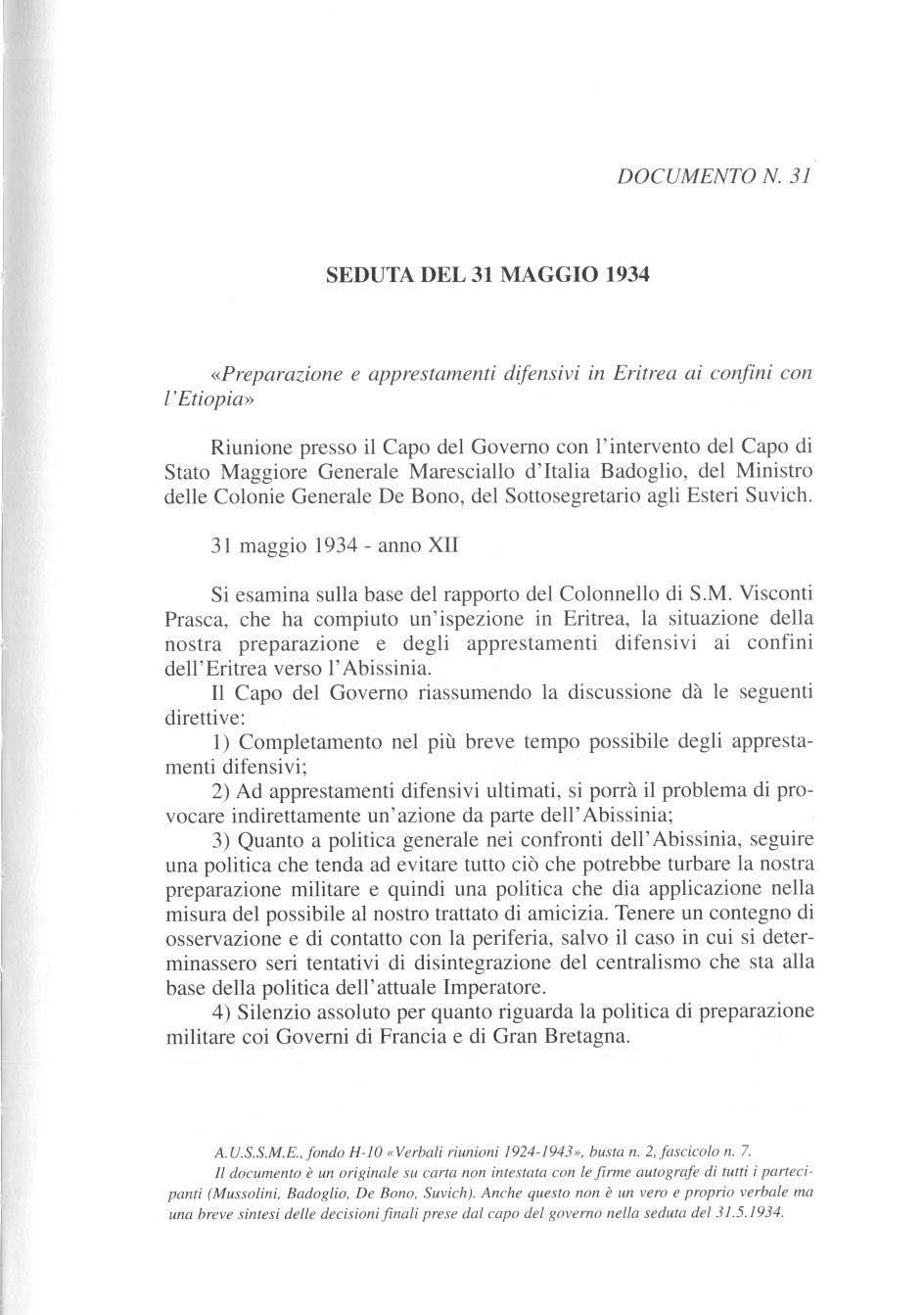
3 I maggio I 934 - anno XII
Si esamina sulla base del rapporto del Colonnello cli S.M. Visconti Pra sca, che ha compiuto un· is p ezione in Eritrea, la situazione della nostra preparazione e degli apprestamenti difensivi ai confini dell'Eritrea verso l'Abissinia.
11 Capo del Governo rias s umendo la discussione dà le seguenti direttive:
I) Completamento nel più breve tempo possibile degli apprestamenti difensivi ;
2) Ad apprestamenti difensivi ultimati , s i porrà il problema di provocare indirettamente un'azione da parte del!' Abissinia;
3) Quanto a politica generale nei confronti dell'Abissinia, seguire una politica che tenda ad evitare tutto ciò che potrebbe turbare la nostra preparazione militare e quindi una politica che dia applicazione nella misura del possibile al nostro trattato di amicizia. Tenere un contegno di osservazione e di contatto con la periferia, salvo il caso in cui si determinassero seri tentativi di disintegrazione del centralismo che sta alla base della politica dell'attuale Imperatore.
4) Silenzio assoluto per quanto riguarda la politica di preparazione militare coi Governi di Francia e di Gran Bretagna.
Il documento è w1 originale s11 carta 11011 intestata con le firme autografe di 1111ti i parteci · pomi (Mussolini. Badoglio, De 80110. Suvich). Anche questo 11011 è un vero e proprio verbale ma una breve sintesi delle decisioni finali prese dal capo del governo nella sedura del J 1.5.1934.

«Situazione in Africa orientale: possibile attacco abissino, truppe indigene di copertura, truppe del corpo di spedizione, rinforzi, orientamenti del capo del governo, situazione in Eritrea ( rete di viabilità, finanziamenti, invio di truppe, schieramento del Regio Corpo Truppe Coloniali e linea difensiva, servizio informazioni), impiego dell'Aeronautica e della Marina in Africa orientale»
Verbale della riunione a Palazzo Viminale.
27 luglio 1934-XII
Presenti:
S.E. Badoglio - S.E. De Bono - S.E. Baistrocchi - S.E. BonzaniS.E. Cavagnaii -Ammiraglio Vannutelli - S.E. Valle - Generale Pinna (a > .
OGGETTO: Eritrea.
S.E. Badoglio intende chiarire alcune questioni relative alla preparazione A.O. ed esprimere il suo punto di vista. Inn anzi tutto occorre mettere d'accordo due lettere del Mini ste ro delle Colonie, dell '8 luglio e del 23, in cui si parla della eventualità di un attacco abissino e poi si esclude un colpo di testa.

S.E. D e Bono in realtà si è avuta notizia che armali del Goggiam dovevano tenersi pronti a pa11ire per ignota destinazione. Forse le predisposizioni del Negus sono in relazione a dubbi sulla fedeltà dei capi, sembra quelli del Ti grè. Il Col. Ruggero esclude possibilità di colpi di testa. Bisogna però essere praparati.
S.E. Badoglio è, per modo di dire, preoccupato di tutte le voci che circolano in materia di operazion i in Africa orienta le. Anche i l comandante del «Turbine» ritornato da Massaua ha riferito che laggiù si parla ape11amente e da tutti cli guerra, ciò che messo in relazione coi nostri provvedimenti può dare motivi di allarme al Negus (ri volto a S.E. De Bono: occorre provvedere severamente) .
Considera l'azione del R. C.T.C. come azione di copertura finché non arrivino le truppe metropolitane, e su questo punto S.E. Badoglio pone due quesiti:
1) È sufficiente la forza del R.C.T.C. per costituire la copertura durante il periodo di tempo indicato dalla R. Marina occorrente per i trasporti di truppe dalla Madre Patria?
2) TI grado di fedeltà delle nostre truppe indigene è tale che la copertura possa essere affidata per tutto questo tempo alle sole truppe indigene?
Il nazionalismo abissino passa i confini: vedi il numero dei nostri fuorusciti ex militari; persino due radiotelegrafisti disertati.
Per questo scrisse a S.E. Bonzani se era possibile rinforzare la copertura di truppe indigene con nostre unità bianche da trasportare sollecitamente in Colonia.
Chiarisce che l'invio urgente di alcuni reparti di truppe bianche che precedono il grosso del corpo di s pedizione non può essere definito impiego a spizzico. Si tratta oltre che di un impiego di copertura, per completare le eventuali lacune, anche per consolidare la fedeltà delle truppe di colore. Quindi nella successione dei trasporti , dopo l ' invio dei complementi richiesti per l'inquadramento delle divisioni indigene , è necessario inviare quel quantitativo di truppe di fanteria che il comandante designato delle truppe ritiene necessario per rendere sia più efficiente la nostra copertura, sia più consistente la compagine delle truppe nere.
Fra le truppe suppletive italiane vi sono 3 battaglioni CC.NN. Si possono mobilitare subito. Poi un paio di reggimenti di fanteria, da mobilitare più rapidamente possibile e da far partire al più presto. Tutto o parte può essere tenuto all ' Asmara come riserva di truppe e come difesa di quel ridotto.
S.E Bonzani deve provvedere nella misura (numero di battaglioni) che sarà precisata da S.E. De Bono.
Si tratta di misura precauzionale indispensabile.
Quale è lo schieramento delle truppe del R. Corpo, in copertura? Non lo so. So solo la linea di difesa (non di copertura). In proposito scrissi al Ministro delle Colonie indicando quale linea di difesa per la nostra occupazione (Adì Ugri - Mai - Hainì - Coatit - Adi Caieh) coi posti avanzati di B arachit e di Adi Qualà; scrissi del collegamento con la baia di Zula, in modo da garantire Massaua; ed ho raccomandato di non estendere la linea di difesa verso ovest (Tucu l).
S.E. De Bono: Tucul è so lo necessario come osservazione.
S.E. Badoglio: alla osservazione provvederà l'Arma Area. Non conosce ancora lo schieramento: deve essere studiato il can1po trincerato di Adi Caieh e l'organizzazione di due o tre punti intermedi verso Zula.
Le disposizioni del Corpo di S.M. del R. Esercito prevedono l 'invio dei rinforzi in quest'ordine: I O complementi; 2 ° comando; 3° intendenza; 4 ° il resto. Quest'ordine di successione non tiene abbastanza conto della necessità di premunirci contro un colpo di sorpresa, e perciò,

nonostante le assicurazioni avute sulla situazione, penso che si debba tener pronto per l'invio immediato un nucleo di truppe.
S.E. De Bono concorda, se le truppe nere vedono giungere rinforzi non vi sarà da dubitare della loro fedeltà.
Ma occorre provvedere subito, essenzialmente con truppe di fanteria: chiederebbe tre reggimenti.
S.E. Bonzani: per mobilitare tre reggimenti del corpo di spedizione occorre il completamento nazionale: saranno pronti a partire dal giorno x + 7. Se si chiede maggiore urgenza si deve provvedere altrimenti, e con elementi alle armi (pronti x + 2 ed x + 3), o mobilitando reggimenti con completamento locale (pronti x + 4).
S.E. Badoglio: si può cominciare da un reggimento di CC.NN.
S.E. Bonzani : poi reggimenti di personale alle armi tratti dalle divisioni non interessate.
S.E. Badoglio: si potrebbe far partire prima di tutti i battaglioni dei complementi.
S.E. De Bono: basta che partano il giorno x + 7, come ha accennato S.E. Bonzani, parlando dei reggimenti di fanteria.
S.E. Bonzani pensava di farli partire anche dopo 48 ore prendendo una compagnia da ogni reggimento.
S.E. De Bono: non sarebbero organicamente solidi.
S.E. Bonzani osserva che sarebbero però costituiti tutti di pennanenti.
S.E. De Bono accetta i battaglioni CC:NN. se però ben comandati.
S.E. Bai strocchi: con il congedamento del 24 agosto avremo sotto le armi 25 mila uomini in meno dell'anno scorso.
Ben poca disponibilità, anzi, quasi nulla rimane nei reggimenti di fanteria, compresi quel l i di frontiera. Al massimo si potrebbe costituire un ploton e per reggimento di fanteria.
Si dichiara formalmente contrario alla costituzione di battaglioni formati di gente presa a spizzico. Abbiamo purtroppo già avuta una dolorosa esperienza in materia e sappiamo quanto valgono i reparti costituiti con quel sistema.
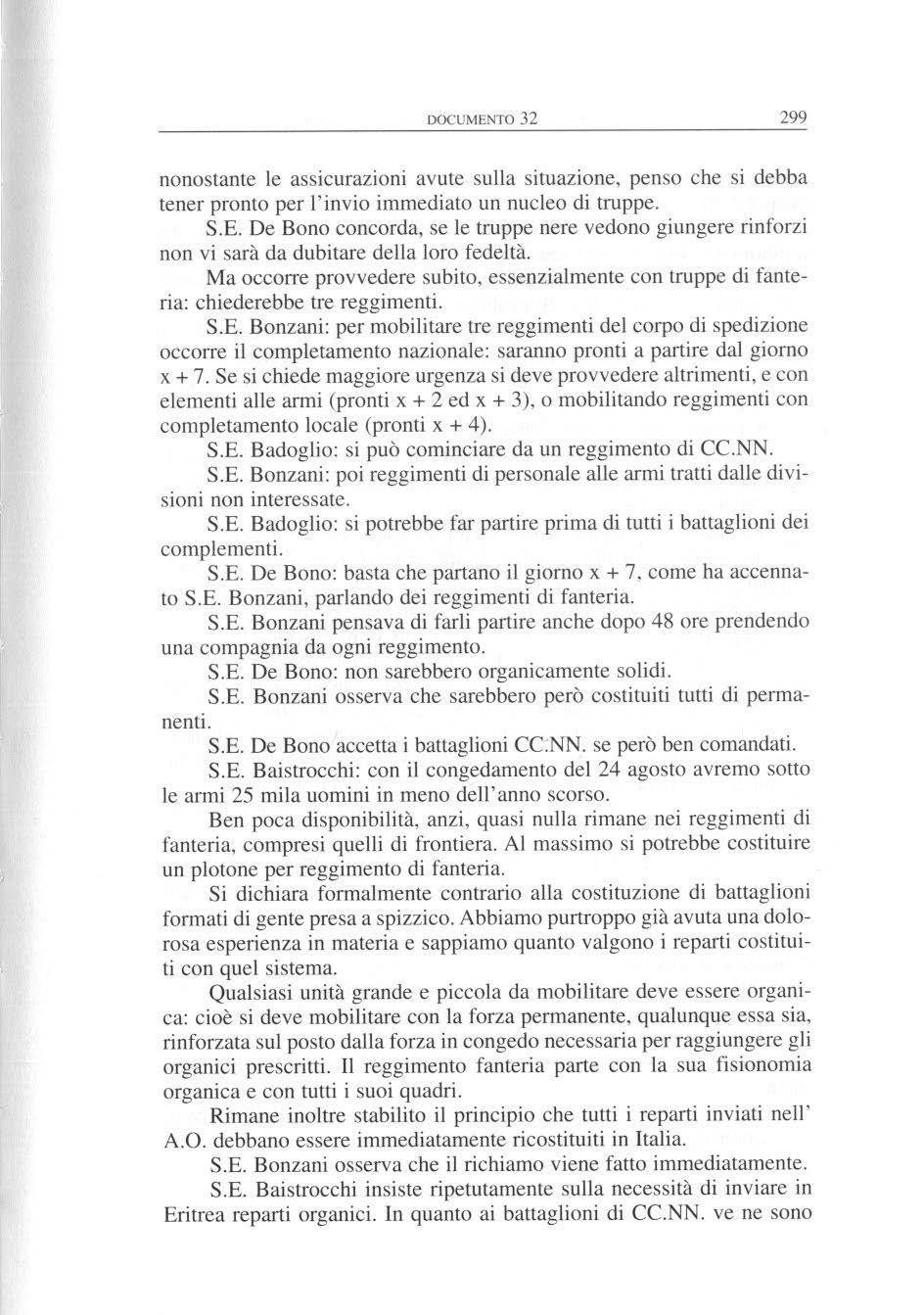
Qualsiasi unità grande e piccola da mobilitare deve essere organica: cioè si deve mobilitare con la forza permanente, qualunque essa sia, rinforzata s ul posto dalla forza in congedo necessaria per raggiungere gli organici prescritti. Il reggimento fanteria parte con la sua fisionomia organica e con tutti i s uoi quadri.
Rimane inoltre stabil ito il principio che tutti i reparti inviati nell '
A.O. debbano essere immediatamente ricostituiti in Italia.
S.E. Bonzani osserva che il richiamo viene fatto immediatamente.
S.E. Baistrocchi insiste ripetutamente sulla necessità di inviare in Eritrea reparti organici. ln quanto ai battaglioni di CC.NN. ve ne sono
degli ottimi. Si tratta di sceglierli. Ricorda che quello di Verona era in piena efficienza.
S.E. Bonzani: un reggimento di fanteria organico potrebbe partire il giorno x + 4 con completamento locale.
S.E. Badoglio riassumendo: su designazione di S.E. De Bono, comandante designato, S.E. Bonzani predisporrà tre reggimenti di fanteria (di cui uno può essere di CC.NN.) da far partire tra x + 4 ex+ 7. La Marina provvederà al trasporto , d'acco rdo con le S.M. del RE.
S.E. De Bono chiede sia fatto partire insieme il gruppo carri veloci.
S.E. Badoglio: sta bene.
S.E. Bonzani: nessuna difficoltà.
S.E. Badoglio considera la necessità di prendere provvedimenti al riguardo delle divulgazioni che si fanno senza riguardi anche per chi s i trova in alta posizione.

Comunica gli orientamenti ricevuti dal Capo del Governo:
1) preparare l'Eritrea (porti , strade,fortifica z ioni,forza in congedo) p e r metterla in grado di resistere effica cemente;
2) preparare, in paese, il corpo di spedizione, già definito;
3) preparare il trasporto (già vi provvede la R. Marina);
4) linea di condotta: restare sulle organizza zioni difensive e attendere l 'attacco nemico. Solo dopo respinto l 'attacco nemico il comandante potrà prendere quelle decisioni che la situaz ione consiglia.
S.E. De Bono: occorre prospettarsi anche l'eventualità che gli abissini non attacchino, ma s tiano a vedere la no s tra preparazione e facciano domandare dalle altre potenze che cosa intendiamo di fare. Noi non potremo lasciare per lungo tempo in Eritrea un grosso corpo di spedizione senza scopo.
L' eventualità è stata prospettata al Capo del Governo.
S.E. Badoglio: non possiamo fare troppe ipotesi e considerare tutti i casi.
S.E. De Bono: se si verifica quella situazione, ad un certo punto bisognerà provocarli.
S.E. B adogl io: si vedrà a suo tempo. Le condizioni dell'Abissinia non sono ancora molto mutate per quanto riguarda il sostentamento. Non può mancare la crisi logistica.
S.E. De Bono: vi sono soltanto s ei giornate di viveri in più di una volta.
S.E. Badoglio: il Capo del Governo valuta la gravità dell ' impresa:
a) quattro divisioni allontanate dalla madre patria;
b) s'intacca la riserva aurea di almeno un terzo;
c) si pregiudica la nostra situaz io ne in Europa con paralisi per un numero notevole di anni - non conviene quindi impegnarsi laggiù.
Bisogna illuminare anche tutti i nostri dipendenti: La nostra preparazione ha Lo scopo di mettere L'Eritrea in grado di parare i colpi di testa abissini: ci prepariamo in Italia soltanto per sostenere l'Eritrea.
l) non abbiamo intenzione di sollevare noi La questione abissina, perché ci polarizzerebbe per un certo numero di anni in un momento in cui la situazione in Europa è precaria;
2) il giuoco non vale La candela. Ha voluto.far queste dichiarazioni.fin dalla prima riunione.
S.E. Cavagnari. E nell'Oceano indiano?
S.E. Bon zani: c'è anche la Somalia.
S.E. B adoglio: vedremo poi. Ora trattiamo dell'Eritrea. Esiste un verbale per l 'invio di armi e di munizioni e per assegnazione di fondi. Per il programma stradale dovremmo essere a posto, perché gli stanziamenti già c'erano.
S.E. D e Bono: la costruzione della strada dell ' Haddas sulla quale insiste S.E. il Capo di S.M. dell'Esercito presenta difficoltà di costruzione. Potrebbe essere tracciata sulla cresta montana anziché seguire il percorso di fondo valle. H a fatto compiere delle ricognizioni aerea sulla zona. Si potrà anche adattare la mulattiera.
S.E. Badoglio conosce bene l'Haddas; la mulattiera deve essere riattata e serv ire, come dice S.E. Bonzani, per fanteria e salme1ie, raccorciando notevolmente il percorso pe r giungere dal mare alla lin ea fortificata.
Non dovrebbero esservi difficoltà finanziarie per questi lavori. Inizia l'argomento dei materiali fomiti dal R. Esercito.
S.E. Bai strocch i accenna all'assegnamento di 165 milioni per quei materiali.
H a chiesto a l Mini stero delle Finanze in qual modo quelle somme sarebbero disponibili, poiché si tratta di materiali in parte esistent i e in parte da ordinare. Non nasconde la sua preoccupazione in questa questione della disponibilità dei fondi, poiché in questo momento l'impegno di somme anche minime aumenta la crisi di bilancio che egli sta fronteggiando con le maggiori difficoltà. È evidente che non può intaccare il bilancio delle necessità europee.
S.E. D e Bono osserva che il Min istro delle Finanze assicurò categoricamente l 'assegnazio ne dei fondi in tre anni.
S.E. Bai strocchi: finora non ha avuto nulla, ma intanto bisogna far subito tutte le spese. Gli occorre la ga ra nzi a del rimborso tempestivo per l'equilibrio g ià detto del bilancio della Guerra.

S.E. B adog lio della questione finanziaria riferirà al Capo del Governo.
S.E. Cavagnari: anc he la Marina ha delle spese vive alle quali non può provvedere coi fondi del suo bilancio.
S.E. Badoglio dice che S.E. Bonzanì lo ha informato del continuo crescendo del numero dei complementi richiesti dal Ministero delle Colonie.

S.E. Bonzani dà le cifre del 1932, 33, 34 e infine le ultime. Osserva che il numero dei complementi incide s ui trasporti e anche sulla loro costituzione.
Una parte degli ufficiali deve essere richiamata; la stessa cosa dicesi per la truppa.
In sosta nza i complementi possono essere dati per ¼ dal servizio permanente e¾ dal congedo.
S.E. De Bono: gli basta di avere, entro x + 4, un quarto dei complementi.
S.E. Badoglio: concludendo, S.E. De Bono ritiene che l'ultima richiesta fatta rimanga come la definitiva. Sta bene, ¼e¾.
S.E. Bonzani: l'invio dei complementi deve precedere e seguire quello dei reggimenti di rinforzo ?
S.E. De Bono: precedere.
S.E. Bonzani: allora si possono prendere i reggimenti di fanteria organici a completamente regionale della G.U. , come disse S.E. Baist rocchi. E questi reggimenti saranno e lementi di orientamento per gli altri reparti delle divisioni.
Poi dà schiarimenti circa la formazione degli scaglioni: le unità del primo scaglione po ssono partire dai centri di mobilitazione il giorno x + 7.
S.E. Badoglio: allora resta inteso che, vista l'entità dei complementi, prima del trasporto dell' Intendenza è necessario inviare il rinforzo di truppe , che costituisce riserva nelle mani del comandante, e quindi:
1) - complementi;
2) - rinforzo (2 reggimenti di fant. e l CC.NN.);
3) - comando C.A., intendenza, materiali, ecc.;
4) - quadrupedi per il R.C.T.C.;
5) - tutto il resto.
S.E. B onzani fa presente le difficoltà di trasporto per i quadrupedi. Si tratta di 9 mila quadrupedi.
S.E. Badoglio esprime il desiderio di avere al più presto lo schieramento del R. C. T. C.
S.E. B onzani si associa. Des idera che sia definito almeno approssimativamente lo schieramento R.C. T.C..
Occorre anche sollecitare l 'organizzaz ione del servizio idrico.
S.E. D e B ono: per il servizio idrico si è provveduto a parte e anche insieme con il programma stradale.
S.E. Bonzani aggiunge che almeno un quarto dei complementi (cioè i permanenti) possono partire il giorno x + 3; dal giorno x + 7 si possono far partire i reggimenti di rinforzo.
P er la sua parte l'attuazione è possibile a partire dal 15 settembre.
S.E. De Bono: non ce ne sarà bisogno.
S.E. Badoglio dice che è stata stabi lita di comune accordo la linea difensiva.
S.E Bonzani osserva che non vi è completo accordo su tale questione.
S.E. Badoglio domanda a S.E De Bono se in Eritrea vi sia un buon ufficiale del genio.
S.E. De Bono fa il nome del Ten. colonnello Marseguerra.
S.E. Badoglio ripete che la linea difensiva è quella limitata a Adi Ugri - Mai Ainì - Adì Cajè, e a copertura della baia di Zula. Verso l ' ovest tenere una semplice osservazione.
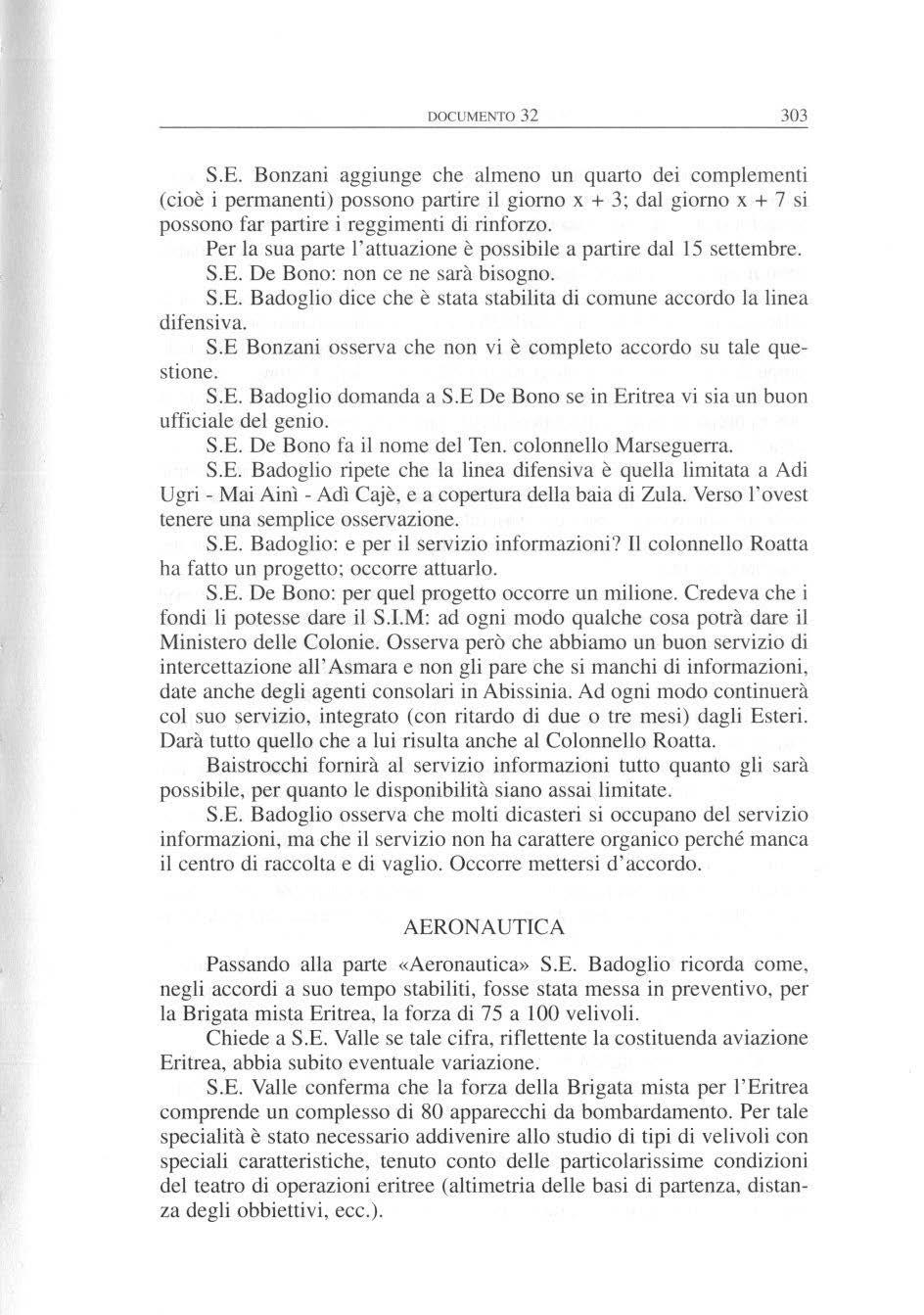
S.E. Badoglio: e per il servizio informazioni? TI colonnello Roatta ha fatto un progetto; occorre attuarlo.
S.E. De Bono: per quel progetto occorre un mi lione. Credeva che i fondi li potesse dare il S.I.M: ad ogni modo qualche cosa potrà dare il Ministero delle Colonie. Osserva però che abbiamo un buon servizio di intercettazione ali' Asmara e non gli pare che si manchi di informazioni , date anche degli agenti consolari in Abissinia. Ad ogni modo continuerà col s uo servizio, integrato (con ritardo di due o tre mesi) dagli Esteri. Darà tutto quello che a lui risulta anche al Colonnello Roatta.
Baistroccbj fornirà al servizio informazioni tutto quanto gli sarà possibile, per quanto le disponibilità siano assai limitate.
S.E. Badoglio osserva che molti dicasteri si occupano del servizio informazioni, ma che il servizio non ha carattere organico perché manca il centro di raccolta e di vaglio. Occorre mettersi d'accordo.
Pa ssando alla parte «Aeronautica» S.E. Badoglio ricorda come, negli accordi a suo tempo stabiliti, fosse stata messa in preventivo , per la Brigata mista Eritrea, la forza di 75 a 100 velivoli. Chiede a S.E. Valle se tale cifra, riflettente la costituenda aviazione Eritrea, abbia s ubi to eventuale variazione.
S.E. Valle conferma che la forza della Bri gata mista per l'Eritrea comprende un complesso di 80 apparecchi da bombardamento. Per tale specialità è stato necessario addivenire allo studio di tipi di ve li voli con speciali caratteristiche, tenuto conto delle particolarissime condizioni del teatro di operazioni eritree (altimetria delle basi di partenza, distanza degli obbiettivi, ecc.).
Le caratteristiche dei velivoli sono state ormai definite, ed esse sono tali da consentire il proficuo impiego del materiale anche per g li scacchieri europei. Si tratta infatti di velivoli capaci di portare 1000 chilogrammi dì carico offensivo a 1000 chilometri di raggio, e che consentono il giuoco tra autonomia e carico.
Ai primi di agosto dj quest'anno saranno stipulati i contratti con le ditte, per modo che nell ' agosto 1935 gli apparecchi saranno pronti a raggiungere in volo, in tre sole tappe, l'Eritrea, previa organizzazione delle tappe di Tripoli e Auenat da parte del Ministero delle Colonie.
Tali provvidenze si riferiscono naturalmente all'ipotesi in cui la nostra preparazione militare per l'Eritrea possa svolgersi secondo le previsioni normali.
Nella eventualità invece di un caso di necessità (derivante da una iniziativa abissina per l'ottobre 1934) sarà giocoforza provvedere con soluzione di assoluro ripiego , inviando cioè in Colonia materiale pre levato dai reparti metropolitani, con un ' aliquota di caccia e protezione del bombardamento.

Si tratta però di apparecchi già sfruttati, aventi caratteristiche non strettamente rispondenti alle esigenze di impiego in quella Colonia, e di limitata autonomia, specie in relazione alle distanze da coprire per il loro eventuale trasporto in volo dalla Madre Patria in Eritrea.
Sarebbe necessario a tale ultimo riguardo predisporre per l ' organizzazione di almeno 12 basi di tappa e di ottenere nel contempo il permesso di sorvolo da parte delle Francia, dell'Egitto e dell'Inghilterra.
Di fronte a tali difficoltà, non lievi, e che non assicurano che per altro l'integrale arrivo a destino del cont ingente, appare più conveniente il suo trasporto via mare. Sono in complesso 27 apparecchi da bombardamento più 9 apparecchi da caccia, da spedire tutti in cassoni (circa 90 colli delle dimensioni di metri 13 per m. 3, per m. 3). li materiale meno voluminoso (munizionamento, ricambi , scorte, ecc.) potrà trovare agevolmente posto fra i vari cassani. L' ingombro tota le risulterebbe comunque non inferiore a 20.000 mc.
Potrebbero affluire ad ottobre 18 apparecchi da bombardamento e , ove necessario , la squadriglia caccia pronta anch ' essa per quell'epoca.
Altri 9 velivoli da bombardamento potrebbe essere pronti a ll 'imbarco per il mese dì dicembre
Circa l'aviazione da ricognizione, si potrebbe sopprimere traendo i mezzi occorrenti dall'aviazione della Libia, e limitandosi ad impiegare quella già esistente in Eri t rea. Occorre in proposito riflettere che la ricognizione ad u na certa profondità potrà meglio e più agevolmente essere disimpegnata dag li apparecchi da bombardamento (maggiore autonomia , magg iore sicurezza). Va tenuto ben presente che, pel caso di estrema necessità ora considerato, la consistenza della nostra aviazione
metropolitana verrebbe depauperata di 3 squadriglie da bombardamento e l squadriglia da caccia. Le scorte varie occorrenti per le previste 90 azioni andrebbero poi prelevate dalla dotazioni di mobi li tazione, per un importo di 27 milioni di lire che il Ministero delle Colonie dovrà rifondere. Si tratta infatti di materiale che, per buona parte , dovrà essere approvvigionato, e per il rimanente reintegrato alle scorte di mobilitazione.
Ri ferendosi quindi alle modalità di invio in Eritrea del contingente aereo previsto per l'ipotesi in oggetto, S.E. il Generale Valle chiede di conoscere con che margine di tempo sarà preavvisato tale invio.
Se dovesse essere prescelta la s pedizione via aerea occorrerà predisporre per l'approntamento delle 12 basi previste pel transito. 11 che importerà un tempo non precisabile, per ora, ma certamente lungo.
Se la spedizione dovesse essere effettuata via mare allora sarà neces sario un preavviso di almeno un mese per poter preparare i cassoni occo rrenti , la cui spesa, abbastanza rilevante, dovrà essere rimborsata.
S.E. Badoglio: preso atto di quanto viene in argomento esposto, conviene che pel caso di estrema nece ss ità (iniziativa abissina per l'ottobre prossimo venturo) debba essere senz'altro adottata la spedizione via mare indubbiamente più sicura. Invita quindi S.E. il Mini st ro delle Colonie a tener conto della nece ssità di tempestivo preavviso espresso da S.E. il Generale Valle.
S.E. De Bono assicura che la s pedizione del material e sarà preavvisata col margine di tempo minimo richiesto (un mese).

S.E. Badoglio chiede a S.E. il Ministro delle Colonie quali provvidenze siano state adottate, o siano in corso, per assicurare la conveniente infrastruttura aeronautica alla quale è assolutamente vincolato l' impiego dei mezzi aerei.
S.E. De Bono conferma di aver predisposto per il montaggio di n° 4 hangars a copertura metallica tipo «Saporit i» ma che occorreranno 4 mesi di tempo, perché le aviorimesse siano pronte a ricevere gli apparecchi (3 per il montaggio più l per il trasporto in colonia).
S.E. Valle fa presente che le 4 autorimesse doppie tipo «Saporiti», rappresentano solo il minimo indispensabile per la necessità di ricovero del materiale.
Bisogna tenere infatti presente che di hangars in muratura ne esisto no solo: 1 ali' Asmara, I a Oturnlo, ed l ad Assab.
Ora, mentre la prima base ha i suoi inconveni enti in ragione della altimetria, le altre due non so no anch'esse le più idonee per la dislocazione dei reparti di volo, cioè, sia per la temperatura torrida cui sono soggette, sia per la loro eccentricità rispetto al teatro di operazioni.
Ragioni di opportunità e di consigliabile·previggenza suggeriscono quindi l'approvv igionamento di almeno altri due hangars doppi di tipo
«Saporiti», da montare in campi che saranno riLenuti più convenienti ai nostri fini operativi.
Altra necessità relativa alle basi è quella delle dimensioni del terreno di lancio. Tali dimensioni si possono in linea di massima fissare come appresso:
m. 1500 x m. 1000, per basi a 2000 m. di altitudine;
m. 1200 x m. 800, per basi interne ai 1000 m. di quota.
Infine, tenuto conto dalla delicatezza e dell'ingombro del materiale da trasportare, occorre assicurare un ottimo allacciamento stradale tra il porto di Massaua, ove saranno scaricati i cassoni velivoli, cd il campo di Otumlo, ove si procederà al monLaggio degli apparecchi. Per tale ultima occorrenza. la base di Otumlo dovrà essere anche provvista di un laboratorio adatto al rapido montaggio dei velivoli.
S.E. Badoglio: nel prendere atto di quanto viene in proposto notificato raccomanda la nece ss ità di un intimo collegamento fra i due Ministeri delle Colonie e dcli' Aeronautica, allo scopo di assicurare:
I) il ricovero degli apparecchi e del personale costituenti il contingente previsto per il caso di estrema necessità (iniziativa abissina nel1' ottobre 1934);

2) il ricovero delle forze costituenti il corpo di spediLione previsto pcl caso normale;
3) la conveniente attrezzatura dei campi, della indispensabile oflìcina, degli occorrenti laboratori di squadriglia, dei depositi carburanti, lubrificanti, munizioni.
Concludendo al riguardo:
S.E. De Bono prende impegno per assicurare:
a) le basi capaci di ricoverare tutti gli apparecchi, il personale, e il materiale vario;
b) la conveniente scorta di carburante, lubrificante e munizionamento;
c) l'impianto di un'officina centrale riparazione velivoli e motori, di laboratori di squadriglia presso i campi di manovra, e di un laboratorio montaggio apparecchi ad Otumlo;
d) la viabilità Massaua porto-Otumlo;
e) il collegamento fra i vari campi.
S.E. Badoglio rinnova la preghiera di essere man mano informato sullo sviluppo dei vari lavori. I n particolare. per quel che riguarda l ' attrezzatura dell'officina ce ntrale, segnala che potrebbe essere costituito in EriLrea un impianto analogo a quello esistente alla Mellaha, palesatosi rispondente a qualsiasi esigenza.
Passando alla questione del munizionamento si affaccia adesso il problema della scelta del tipo di bomba.
Premesso che trattasi essenzialmente di agire contro bersagli animati e di una certa densità, risulta preferibile la bomba di piccolo peso (2Kg. - 12 Kg.).
Nondimeno, qualche bomba di maggior peso (50 - 100 Kg.) potrebbe trovare conveniente impiego (effetti dilanianti dello scoppio; effetti morali).
Potrebbe altresì essere impiegata qualche bomba incendiaria di termite, a proposito della quale S.E. il Generale Valle fa presente che occorrerebbe provvedere in parte ali' approvvigionamento. In quanto alle bombe a gas, la questione esula dalla sua decisione e occorrerà sentire in proposito il pensiero di S.E. il Capo del Governo.
Comunque, esprime il parere che bisognerà andare assai cauti circa l'impiego delle bombe tossiche, sia perché potremmo s uscitare delle recriminazioni da parte di qualche altra potenza, sia ancora perché non si conosce fin qui a fondo il comportamento delle bombe a gas in ambiente del tipo eritreo, caratterizzati da elevate temperature a da terreni a fondo sovente sabbioso.
Per l 'az ione di mitragliamento accennata da S.E. il Generale Valle è dell'avviso che essa potrà, offrire rendimento, sop rattutto a coronamento dell'azione bombardiera.
In quanto al concetto d'impiego per le nostre forze aeree da offesa S.E. Badoglio precisa che: non conviene ammaestrare il nemico con bombardamenti prematuri e di relativo effetto, rivolti contro obiettivi di scarsa densità e importanza. Occorre invece reali zzare in pieno la sorpresa per far massa sull'avversario quando questo risulterà ammassato. Da quel momento non dovrà essere concessa alcuna tregua, e dovrà essere gettato sulla bilancia tutto il peso dell'offesa aerea, in modo da ottenere il massimo effetto.
Valle informa che, d'intesa con S.E. il Ministro delle Colonie, sara nno costituite basi di manovra in località oppo1tune.
Informa poi che saranno senz'altro inviati in Eritrea due ufficiali della R . Aeronautica (un navigante ed uno del Ruolo tecnico) per stabilire con precisione tutte quelle provvidenze rivolte ad assicurare la so luzio ne del problema fondamenta le delle basi.
Poiché gli argomenti trattati e le decisioni deliberate di comune intesa , durante la seduta, esauriscono i quesiti formulati da S.E. il Ministro delle Colonie col suo foglio 80798 del 18 corrente mese dirette a S.E. il Mini stro dell'Aeronautica , ritiene di avere implicitamente fornito tutti g li elementi dei quali era stato richiesto.
S.E. De Bono si associa a tale parere e ritiene risolto il questionario inoltrato col foglio sopra menzionato, demandando all'Ufficio Militare

del Ministero Colonie e allo Stato Maggiore della R. Aeronautica, d'accordo con l'Ufficio di Stato Maggiore della R. Marina, l'espletamento dei particolari di dettaglio riguardanti i trasporti per mare e la organizzazione delle basi.
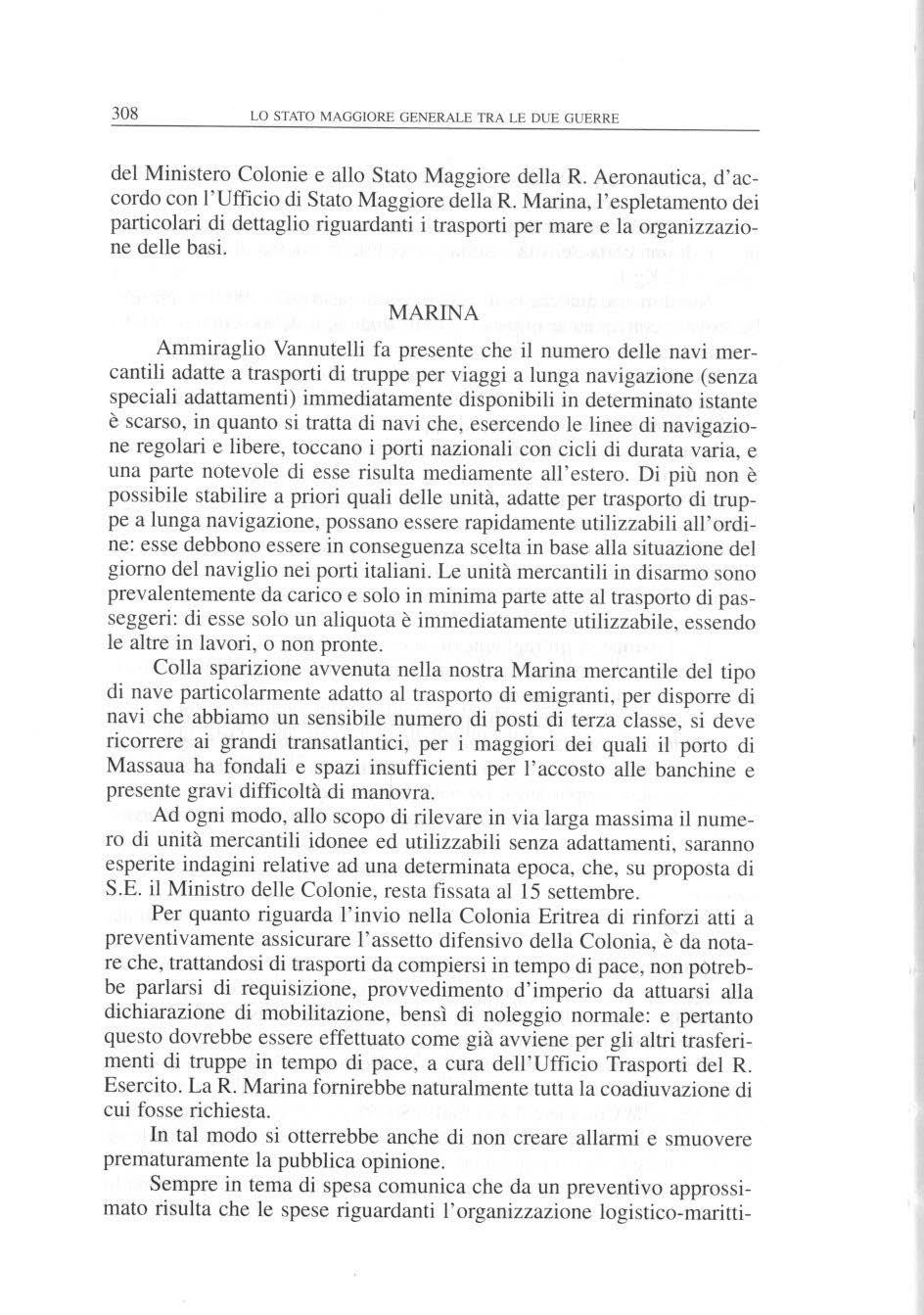
Ammiraglio Vannutelli fa presente che il numero delle navi mercantili adatte a trasporti di truppe per viaggi a lunga navigazione (senza speciali adattamenti) immediatamente disponibili in determinato istante è scarso, in quanto si tratta di navi che, esercendo le linee di navigazione regolari e libere , toccano i porti nazionali con cicli di durata varia, e una parte notevole di esse risulta mediamente all'estero. Di più non è possibile stabilire a priori quali delle unità, adatte per trasporto di truppe a lunga navigazione, possano essere rapidamente utilizzabili all'ordine: esse debbono essere in conseguenza scelta in base alla situazione del giorno del naviglio nei porti italiani. Le unità mercantili in disarmo sono prevalentemente da carico e solo in minima parte atte al trasporto di passeggeri: di esse solo un aliquota è immediatamente utilizzabile, essendo le altre in lavori, o non pronte.
Colla sparizione avvenuta nella nostra Marina mercantile del tipo di nave particolarmente adatto al trasporto di emigranti, per disporre di navi che abbiamo un sensibile numero di posti di terza classe, si deve ricorrere ai grandi transatlantici, per i maggiori dei quali il porto di Massaua ha fondali e spazi insufficienti per l'accosto alle banchine e presente gravi difficoltà di manovra.
Ad ogni modo, allo scopo di rilevare in via larga massima il numero di unità mercantili idonee ed utilizzabili senza adattamenti, saranno esperite indagini relative ad una determinata epoca, che, su proposta di S.E. il Ministro delle Colonie, resta fissata al 15 settembre.
Per quanto riguarda l'invio nella Colonia Eritrea di rinforzi atti a preventivamente assicurare l'assetto difensivo della Colonia, è da notare che, trattandosi di trasporti da compiersi in tempo di pace, non potrebbe par larsi di requisizione, provvedimento d'imperio da attuarsi alla dichiarazione di mobilitazione, bensì di noleggio normale: e pertanto questo dovrebbe essere effettuato come già avviene per gli altri trasferimenti di truppe in tempo di pace, a cura dell ' Ufficio Trasporti del R. Esercito. L a R. Marina fornirebbe naturalmente tutta la coadiuvazione di cui fosse richiesta.
In tal modo si otterrebbe anche di non creare allarmi e smuovere prematuramente la pubblica opinione.
Sempre in tema di spesa comunica che da un preventivo approssimato risulta che le spese riguardanti l'organizzazione logistico-maritti-
ma e militare della spedizione e quelle che la R. Marina dovrebbe sostenere per la esecuzione della spedizione stessa. limitatamente ai primi tre mesi, ammontano a 251 milioni circa, spese che non potrebbero essere sostenute dal suo bilancio ordinario. Esse non rappresentano prevalentemente il costo di materiali da cedere o da sostituire, ma riguardano specialmente spese vive per requisizioni, lavori di adattamento ai piroscafi, combustibili, viveri per le truppe imbarcate, ecc.
S.E. Badoglio osserva che a tali spese sarebbe eventualmente provveduto con una speciale assegnazione di bilancio per l'esecuzione della spedizione.
Ammiraglio Vannutelli infine fa presente che, dopo iniziate le ostilità, una tale spedizione ha due fasi oltremodo delicate per l'eventuale atteggiamento delle altre potenze, corrispondenti al passaggio dei trasporti nel Canale di Suez e al loro rifornimento, ed alla necessaria esecuzione della so rveglianza del contrabbando delle armi via mare a favore del nemico. In particolare, essendo l'Abissinia membro della Società delle Nazioni, la sol uzione 1isulterebbe particolarmente difficile qualora l'Italia assumesse la figura giuridica dell'aggressore. Vi è poi il Patto Kelloi che lega i firmatari a un contegno non aggressivo.
E perciò necessario per non far so rgere intralci che s i tradurrebbero in ritardi e in difficoltà logistiche e militari, che la condotta e le fasi siano sviluppate nel senso che la figura dell'aggressore s ia addossata al nemico.
S.E Badoglio osserva che tale questione esula da campo delle sue attribuzioni, ed invita l ' Ammiraglio Vannutelli a prospettarla per iscritto perché egli possa riferirne a S.E. il Capo del Governo.
S.E. Badoglio ringrazia i convenuti. Si augura che in caso di necessità la situazione debba essere affrontata con la massima preparazione. Raccomanda a tutti di tenerlo informato degli studi in corso e delle disposizioni prese.
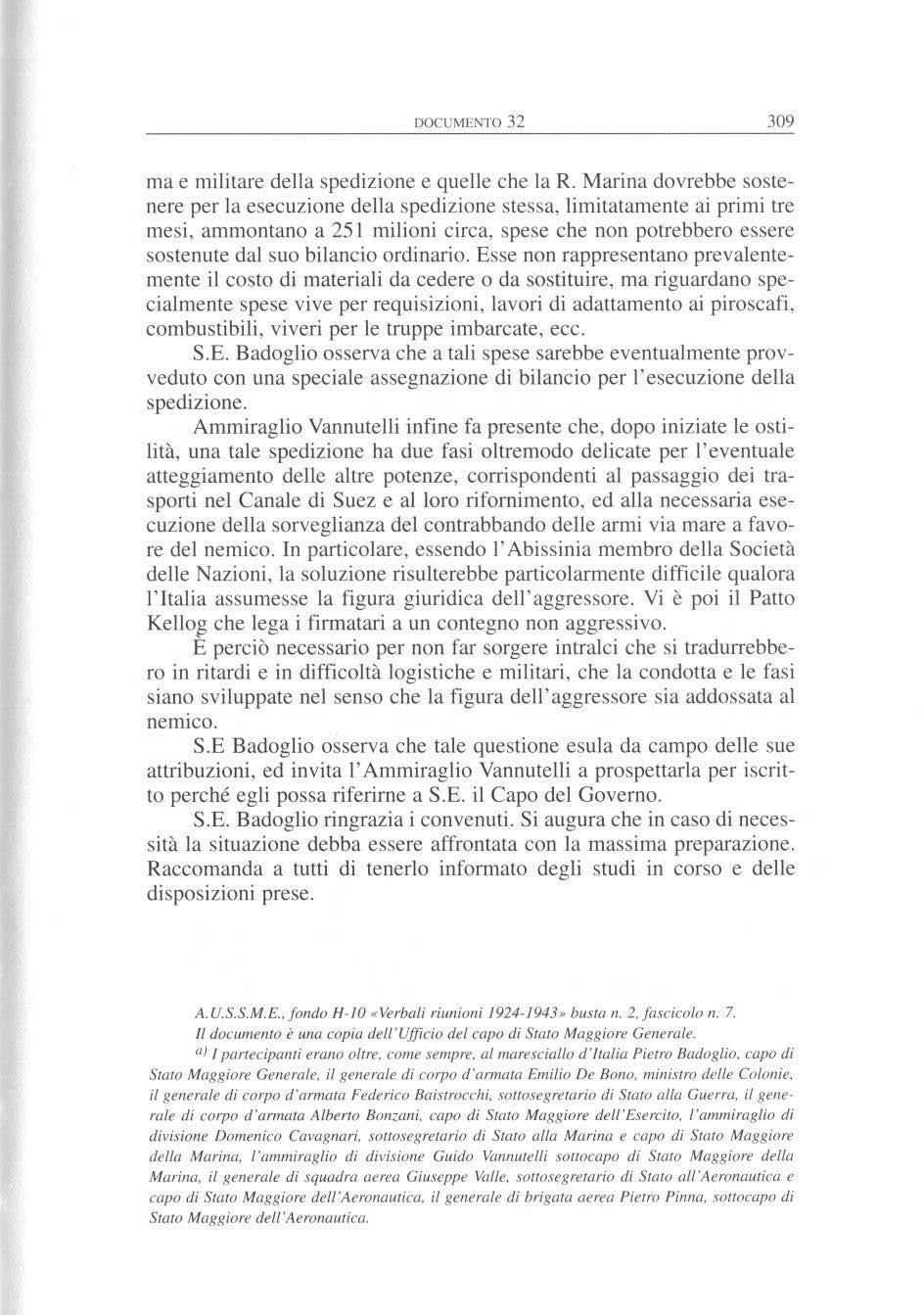
A.U.S.S.M.E.,fondo H - /0 « Verbali riunioni 1924 - 1943» busra 11. 2,fascicolo 11. 7. Il docume1110 è 11110 copia dell'Ufficio del capo di Sraro Maggiore Ge11erale.
aJ I parrecipallli era110 olrre, come sempre, al maresciallo d'Italia Pierro Badoglio , capo di Staro Maggiore Generale, il ge11erale di corpo d'armata Emilio De Bono, 111i11is1ro delle Colo11ie. il generale di corpo d'arma/a Federico Baistmrchi, soltosegretario di Stato alla Guerra. il generale di corpo d'armata Alberto Bo11,1111i. capo di Stato Maggiore de/l'Esercito. l'ammiraglio di divisio11e D0me11ico Cavagnari, souosegrerario di Swto alla Mari11a e capo di Stato Maggiore della Marina. l'ammiraglio di divisione Guido Va1111urelli so11ocapo di Staro Maggiore della Marina, il ge11erale di squadra aerea Giuseppe \!alle, so11osegre1ario di Staro all'Aero11autica e capo di Stato Maggiore del/'Aero11autica, il generale di brigata aerea Pierro Pinna. sollocapo di Stato Maggiore dell 'AeronaUlica.
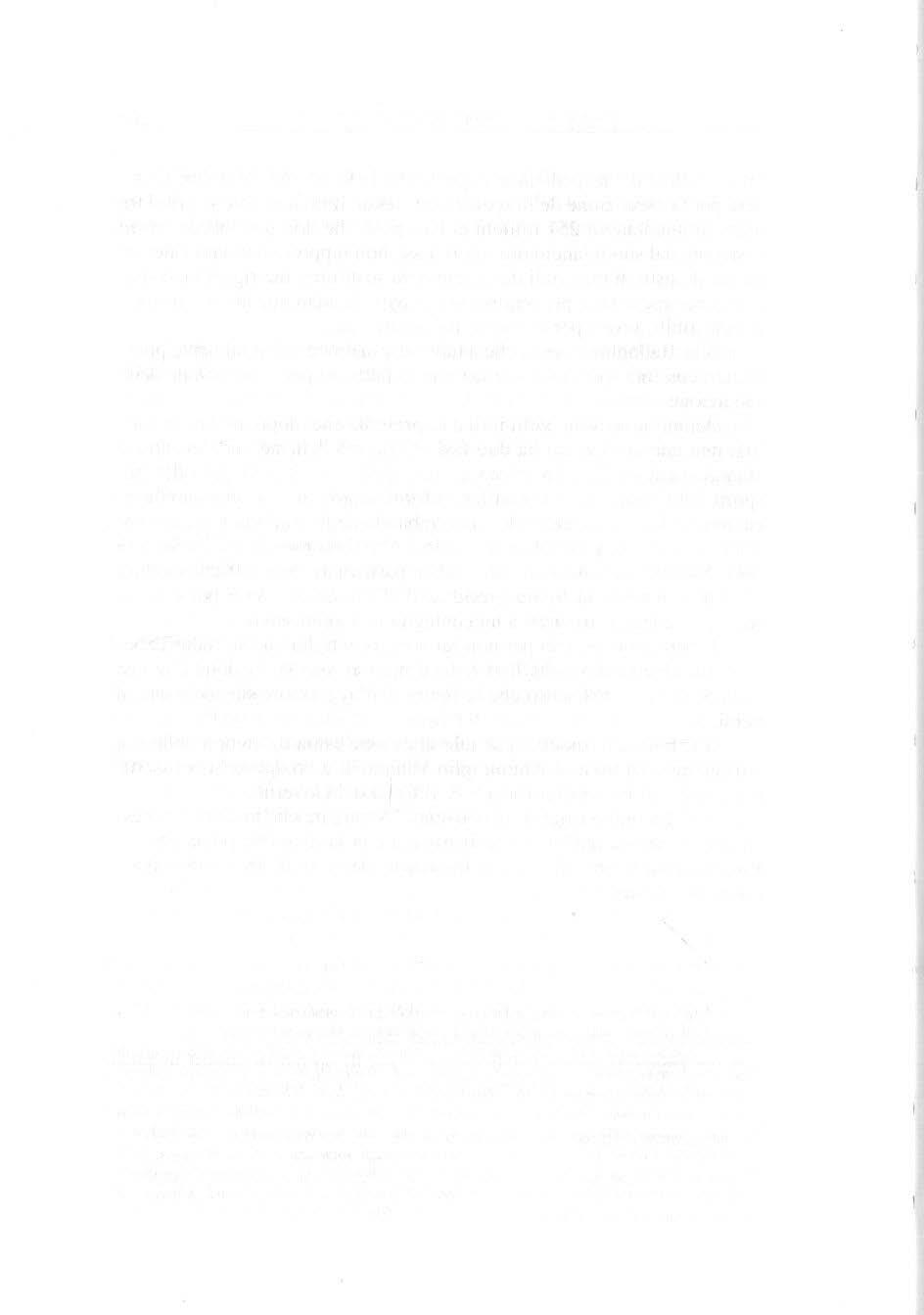
« Prepara zione della guerra contro la Germania con possibili a z ioni contro la Jugoslavia (Ipotesi Nord - Est): principali problemi relativi alla condotta delle operazioni, atteggiamento di alcuni Stati verso l'Italia in caso di conflitto, compiti dell'Aeronautica (a z ioni sulla Baviera), della Marina ( collaborazione con la flotta francese, a zioni in Adriatico) e de/l'Esercito (decisa offensiva a nord), accordi con l'Austria, direttive finali di Badoglio».
Riunione tenuta il 3 settembre 1934-XII presso S.E. Il Capo di Stato Maggiore Generale.
Presenti: S.E. Baistrocchi; S.E. Cavagnari; S.E. Vannutelli; S.E. Valle; Generale Pinna; Colonnello Visconti Prasca, segretario <al .

S.E. Badoglio - La situazione politica mondiale è molto incerta. Oggi il nostro orientamento è contro la Germania. Vi è possibilità di nuovi avvenimenti, tali da rendere indispensabile un nostro intervento in Austria: direttrice sud-nord.
Laterale a questa direttrice è degno di osservazione il contegno della Jugoslavia. Quale esso sarà nessuno può saperlo; dobbiamo però esserne sommamente preoccupati. Oggi la tendenza jugoslava è in favore dei tedeschi. Dopo aver smunto denaro alla Francia la Jugoslavia cerca altrove altri favori.
D obbiamo studiare misure che possono giungere fino alla mobilitazione contro la Jugoslavia.
Il Capo del Governo ha detto che non dobbiamo avere nessuna preoccupazione verso la Francia e l'Inghilterra.
Du e problemi quindi si impongono:
1) - Azione decisa verso nord; vigilanza verso est; forse azione verso est;
2) - Fortificazione, ma questo riguarda solo il Ministero della Guerra.
Il Comando del Corpo di Stato Maggiore ha g ià studiato un problema a sé stante senza coo rd inarl o con le altre Forze Armate.
Il Ministero della Gue1Ta darà comunicazioni di tale studio perché anche le altre Forze Armate ne abbiano conoscenza e vi si orientino.
Il problema è grave e pieno di incognite. Si conosce l'orientamento dei grandi Stati, non quello delle costellazioni minori. Di qui il carattere di assoluta gravità per noi, date le forze che potremmo trovarci schierate di fronte.
L'andamento delle nostre frontiere a T rappresenta una debolezza nonostante la possibilità di costituire una massa centrale di manovra. Quindi situazione sensibi lm ente grave per le forze terrestri ladd ove la Marina, se pure avrà specialissimi compiti per la protezione del mare , non avrà preoccupazioni in Mediterraneo.
S.E. Cavagnari - Nel seguito del connitto si, ma in principio no. Occorre stabilire quali potenze sono con noi contro il blocco tedesco.

S.E. Badoglio - Saranno certamente favorevoli Francia ed Inghilterra.
S.E. Cavagnari - Favorevoli assenti od operanti?
S.E. Badoglio - Operante la Francia, semplicemente favorevole l ' Inghilterra.
S.E. Cavagnari - Faccio un caso concreto: noi inseguiamo un piroscafo tedesco che viaggia con cannoni in istiva: i francesi e gli inglesi si comporteranno come neutrali o come avversari?
S.E. Badoglio - Il Capo del Governo ha detto che la Francia sarà con noi e l'Inghilterra non contro di noi. Le situazioni politiche non sono mai nettissime: la guerra le chiarisce. Non possiamo dire nulla circa un nuovo orientamento balcanico. Oggi sembra delinearsi una intesa jugoslava-bulgara. Nessuno sa quale potrà essere l 'atteggiamento polacco.
Di certo c'è questo che la questione austriaca è il perno della stessa esistenza di Hitler. Anche la nostra politica fa perno sulla questione austriaca. Dato il carattere tedesco la questione va inevitabilmente incontro ad una soluzione con le armi.
La Francia è sicuramente sulla nostra stessa linea.
L'faghilterra, pur essendo d'accordo con noi , avendo dichiarato necessaria la es iste nza dell'Austria, sta a vedere: come nel 1914.
Le predisposizioni della R. Marina devono ispirarsi a questo concetto: prima contro la marina tedesca , poi (pur mantenendosi sempre in potenza) contro la marina jugoslava.
Per quanto 1iguarda l'aviazione occorre studiare una dislocazione che permette azione a nord ed a est.
S.E. Valle - Verso nord poco possiamo fare, abbiamo soltanto il campo di Bolzano.
l campi più settentrionali sono a Verona , Casarsa e Udine: non ne abbiamo altri.
S.E. Badoglio - Bisognerà studiare i campi esistenti nella vallata dell'Inn.
S.E. Valle - Nella valle dell'lnn esiste una rete di campi di fortuna piccolissimi che non permettono il decollo di apparecchi pesanti. Un solo campo esiste a nord di Innsbruck.
S.E. Badoglio - Conosco il problema perché nel 1926 l ' ho posto a base di un corso di alti studi militari. Ma lo avevo già studiato all ' epoca dell'armistizio come comandante di un gruppo di annate operante verso la Baviera.
Il primo sbalzo da farsi è nella valle dell 'Inn. Con un secondo sbalzo dobbiamo raggiungere le Alpi bavaresi. Possiamo trovare dei campi?
S.E. Valle - Soltanto il campo di Linz, ma è troppo di punta. Tutti i campi sono come quelli di Plezzo: piccoli, soggetti a nebbia e vento.
S.E. Badoglio - L'Aeronautica deve studiare l'impiego delle masse aeree verso est e verso nord. La linea di operazione principale è Bolzano-Monaco. Bisogna decidere l'impiego di una forte aliquota verso nord e del resto verso est.
S.E. Valle - In periodo di predisposizioni possiamo fare qualche cosa in Austria? Si potrà mandare del personale nostro nei campi austriaci?
S.E. Badoglio - Vedremo in seguito; oggi esistono accordi politici, non ancora clausole militari.
Nel 1926 dicevamo che l'Austria sarebbe stata una avanguardia tedesca. Oggi le cose sono invertite: ma dobbiamo fame conto solo fino ad un certo punto.
Ne parlerò al Capo del Governo, ma occorrono cose concrete. Gli Stati Maggiori delle Forze Armate devono preparare gli studi relativi. Ammesso di poter fare affidamento sul contegno dell'Austria dove gradirebbe l'Esercito compiere la propria radunata? Dove dovrebbero fare una prima resistenza le forze armate austriache? Domande analoghe per l'aviazione.
S.E. Cavagnari - Dobbiamo esaminare anche le necessità della aviazione marittima.
S E. Valle - Per questo dovremo spostare tutta l'organizzazione verso est. Quale sarà l'atteggiamento dell'Albania.

S.E. Badoglio - Nemica: l'Albania è sempre stata un peso in pace e un nemico in guerra.
S.E Baistrocchi - Questo è sempre stato il mio parere.
S.E. Cavagnari - Noi abbiamo ancora batterie e personale a Durazzo: dobbiamo sgombrare? Il Ministero degli Esteri ha detto di si.
S.E. Baistrocchi - Siamo in vista d i accordi ulteriori.
S.E. Badoglio - Ad ogni modo domanderò a S.E. il Capo del Governo cosa dobbiamo fare nei riguardi del!' Albania.
S.E. Baistrocchi - Noi abbiamo ridotto gli organizzatori militari. Pare che l'Albania abbia domandato denari alla Jugoslavia ma non ne abbia ottenuti. Ora starebbe rivolgendosi ancora a noi. Ad ogni modo il programma delle riduzioni è in corso.
S.E. Badoglio - Veniamo alla Marina: si ripete la situazione del 15; ma abbiamo Istria e Pola al nostro attivo.
S.E. Cavagnari-La Francia impedirà l'uscita dei tedeschi dal Mare del Nord?
S.E. Badoglio - Per ora l'accordo che esiste è soltanto basato su dichiarazioni convergenti. Bisognerà arrivare poi a clausole più concrete. Oggi dobbiamo s tudiare nostre possibilità e nostre necessità: poi le adatteremo a quello degli altri.
Se noi avremo piena libertà ne l Mediterraneo, bene: ma bisogna prevedere, come dice S.E. Cavagnari una azione mondiale: azione diluita in s uperficie , ma importante se mpre .
S.E. Cavagnari - Bi sog nerà definire bene la linea politica della condotta di guerra.
S.E. Badoglio - Praticamente, guardare l'Adriatico, pronti potenzial mente per tutto il resto.
Per l 'Esercito compito concreto è: sorveglianza normale verso Svizzera e Francia: gravitare con tutte le forze verso nord e verso est dal Re sia al mare.

S.E. Bai st rocchi - so no già in corso movimenti a questo scopo. Ho studiato la cosa fin d,ù primo giorno in cui ho assunto la carica di Sottosegretario. C'è da fare moltissimo: devo cambiare anche l'orientamento s pirituale. Mi rendo perfettamente conto che occorre rapidità.
Stamane ho dato ordini per la eventuale mobilitazione di quelle stesse divisioni che già abbiamo spostato l'estate scorsa. In tre giorni possiamo riprendere la s ituazione di luglio.
Per una migliore sistemazione di forze nell'Alto Adige occorrono caserme: sto provvedendo.
S.E. Badoglio- Mi rendo conto delle difficoltà; fino ad oggi l'orientamento era contro ovest e contro est: oggi è contro est e contro nord.
La preoccupazione del Capo del Governo sta in questa frase <<fortificare la frontiera nord». Farò presente: dobbiamo sospendere su lla frontiera ovest? per quella est è già stato deciso; dati gli stanziamenti non si può fare tutto.
S.E. Baistrocch i - Bisogna lavorare a nord, proseguire i lavori a est.
S.E. Badoglio - Spostare truppe verso nord richiede tempo, non si può far molto.
S.E. Ba is trocchi - Nell'inverno qualche cosa si può fare: forse molto. Ad ogni modo rinforzeremo, per togliere la sen saz ione del vuoto prima della primavera prossima.
S.E. Badoglio - Va bene: avremo condizioni di copertura migliori: non dobbiamo nasconderci che l'Austria è per tre quarti nazista. Non sappiamo se le truppe austriache saranno in copertura per noi o per gli altri. La guerra può far rinascere il sentimento tedesco anche negli austriaci. Uguale preoccupazione del resto ha il Capo del Governo.
S.E. Valle - E l'Ungheria?
S.E. Baistrocchi - Roeder ha detto a S.E. Bonzani che l'Ungheria farà di tutto per evitare la guerra tra la Germania e l'Italia: ma in ogni caso sarà per l'Italia: essa è nettamente contro I' Anschluss.
S.E. Badoglio - Di positivo c'è solo questo: Francia e Italia unite contro lo stesso nemico: tutto il resto è incerto.
Gli Stati Maggiori delle Forze Armate pongano allo studio i problemi che gli riguardano , io cercherò di chiarire le idee politiche.
S.E. Valle - Uno schiarimento: nella Ipotesi Nord dobbiamo calcolare tutta la Germania contro di noi a una parte contro la Francia.
S.E. Badoglio - Prepararsi come se fossimo so li: però tener prese nte l ' intervento diretto della Francia.
Da un primo esame possiamo dire che gli obbiettivi italiani sono per la Germania meno importanti di quelli francesi. In linea generale possiamo pensare di avere di fronte metà delle forze tedesche.
S.E. Valle - Dobbiamo sa pere se dobbiamo essere pronti per il '35 sacrificando qualità e quantità, perché la nostra massa da bombardamento data dal '25-27.
S.E. Badoglio - Sarei favorevole alla preparazione metodica, qualità e quantità, ma su questo argomento dovrò interpellare il Capo del Governo.

S.E. Valle - Per il bombardamento notturno siamo in ritardo non possiamo essere pronti per la primavera prossima.
S.E. Cavagnari - La massa delle navi è in periodo di grandi riparazioni, fino a novembre. È necess ario attuare provvedimenti immediati?
S.E Badoglio - 11 Capo del Governo non ha accennato a questa urgenza, d ' altra parte ogni giorno che passa porta neve s ulle Alpi. Ma bisogna essere pronti. Una so la volta abbiamo potuto avere nove me s i per mobilitare.
S.E. Baistrocchi - TI Capo ha autorizzato tutti i congedamenti. l n relazione alla necessità della preparazione in Patria bisogna s ubordinare la preparazione in Eritrea: perciò aderirà a richieste di ufficiali per la Colonia facendovi concorrere per tre quarti ufficiali di complemento, specialmente per i servizi tecnici.
A.U.S.S.M.E.,fondo 1-4 «Caneggio Stato Maggiore Generale - Comando S11premo - Staio Maggiore Difesa 1924-/948 », b11sta 11. 68. fascicolo 11. 3.
li doc11111e11to 11011 è s11 carta intesrata ma molto probabilmente è ww copia dell'Ufficio del capo di Sraro Maggiore Generale.
a) I partecipami erano il generale di corpo d'armara Federico Baisrrocchi. souosegretario di Sraro allo G11erra. l'ammiraglio di dil'isione Domenico Cavag11ari, so11osegre1ario di Staro alla Marina e capo di Srato Maggiore della Marino, l'ammiraglio di divisione Guido Va1111111elli , so110capo di Stato Maggiore della Marina, il generale di sq11adra aerea Giuseppe Valle. so11osegretario di Stato all'Aeronawira e capo di Stato Maggiore dell'Aero11a11tica, il generale di brigala aerea Pietro Pinna. so/locapo di Srato Maggiore dell'Aeronawica e il co/01111ello Sebastiano Visco111i Prasco. capo dell'Ufficio del Capo di Stato Maggiore Generale.

«Smobilitazione dei reggimenti di artiglieria costiera e sostituzione con la Milizia da Costa: la Marina difronte alla riforma, mezz i e personale per la Mili z ia, relativo decreto di costituzione Difesa dell' Isola d'Elba: batterie della Marina, reggimento fanteria per l'isola, battaglione mitraglieri.
Preparazione della guerra contro la Germania con possibili azioni contro la Jugoslavia (Ipotesi Nord-Est): occupazione dell ' Albania e di alcune isole dell'Adriatico, offensiva generale a nord».
Verbale della riunione tenuta da S.E. il Capo di Stato Maggiore Generale il giorno 17 novembre 1934 - Anno Xlll
Alle ore 10 del giorno 17 novembre 1934-X lll nel salone antistante all'ufficio di S.E. il Capo di S.M. Generale (Palazzo Virnin ale) s i sono riuniti , presieduti da S.E. il Maresciallo Badoglio, Capo di Stato Maggiore Generale:
S.E. TI Sottosegretario di Stato per la Guerra - Baistrocc hi;
S.E. Il Sottosegretario di Stato per la Marina - Cavagnari;
S.E. Il Sottosegretario di Stato per l'Aeronautica - Valle;
S.E. Il Sottocapo di Stato Maggiore dell ' Esercito - Pariani;
S.E. 11 Sottocapo di Stato Maggiore della Marina - Vannutelli;
S.E. li Sottocapo di Stato Maggiore dell'Aeronautica - Pinna;
Il Luogotenente Generale M.V.S.N. Ispettore della D.I.C.A.TGenerale Guidotti;

Il Capo dell'Ufficio del Capo di S.M.G. - Segretario - Generale Visconti -Prasca;
TI Capo Ufficio Op erazioni del Comando del Corpo di Stato Maggiore <aJ .
Prende la parola S.E. il Maresciallo Badoglio dicendo che lo scopo della riunione è quello di trattare i seguenti due argomenti:
1) smobili tazio ne dei reggimenti artiglie1ia da costa e sostituzione con Mili zia da costa;
2) difesa dell'Isola d'Elba
Premette che ha desiderato la presenza delle LL.EE. il Sottosegretario di Stato dell'Aeronautica ed il Sottocapo di Stato Maggiore dell' Aereonautica anche se gli argomenti non riguardino direttamente l'impiego dell'Aviazione, perché reputa opportuno e necessario che ogni questione attinente alla difesa del territorio sia trattata alla presenza di tutti i rappresentanti delle Forze Armate.
1) - Smobilita z ione dei reggimenti d'artiglieria da costa e sostituz ione con Milizia da costa.
S.E. Badoglio dichiara che in linea di principio è favorevole alla sostituzione dei reggimenti di artiglieria da costa con elementi territoriali, sostituzione il cui studio è stato iniziato nel 1919.
Dopo aver quindi comunicato che il Sottosegretario di Stato alla Marina ha fatto presente la necessità di evitare soluzioni di continuità nella sostituzione suddetta, dà la parola al Sottosegretario di Stato per la Guerra.
S.E. Baistrocchi precisa che le apprensioni da parte della R. Marina sono dovute essenzialmente ad alcune difficoltà rappresentate dal comandante del 2 ° Reggimento artiglieria da costa (Venezia) circa la costituzione di nuovi gruppi , difficoltà che in effetti non esistono.
La trasformazione è affidata a due generali di artigli eria di alto valore (Ascoli e Guidotti) ed avviene in modo logico, graduale e regolare, e non deve portare a nessuna preoccupazione.
Per quanto riguarda il personale specializzato, Venezia è a posto, Spezia ne ha in esuberanza.
Non s i è ancora proceduto, è vero, alla chiamata delle truppe per l'istruzione, ma , in ogni modo, l'eventuale crisi si risolverà nel periodo invernale ed a primavera tutto sarà a posto.
Per intanto la mobilitazione delle batterie da costa rimarrà affidata all'Esercito fino a quando la trasformazione in atto non sarà completa.
La Marina, quindi, non deve avere preoccupazioni al riguardo, poiché riceverà un organo efficiente e perchè la Milizia costiera saprà a ss olvere ottimamente i suoi nuovi compiti.
In linea particolare aggiunge che mentre attualmente i reggimenti da costa dispongono solamente per 4-5 mesi all'anno del personale occorrente, la Milizia costiera potrà in ogni momento disporre degli elementi necessari per il pronto, immediato funzionamento delle batterie.
Afferma, infine, che l ' Esercito non può in questo momento pensare a sostituire taluni materiali con altri più moderni, poichè deve far fronte ad altre importanti esigenze.
Il Generale Guidotti assicura che l ' attuale situazione dei gruppi è migliore - come forza - di quella precedente. Benché non sia ancora emanato il decreto per la creazione della M. da C.O.S., la costituzione della mi l izia costiera è già a buon punto.

S.E. Baistrocchi assicura a sua volta che i mezzi per la difesa costiera non saranno lesionati e che la Milizia da costa sarà messa in misura di funzionare meglio di adesso.
TI Generale Guidoni informa che le domande per la M. da C.O.S. sono numerose tanto da dover sospendere gli arruolamenti.
H a dovuto mettere un freno agli arrulamenti per le spese che ne derivano e ciò è necessario finché non sia stato emanato il decreto che leggittima le spese.
Oggi Venezia ha 121 uomini di truppa in s.p.e. che rappresentano l'armamento di pronto impiego in caso di sorpresa.
Altri 400 uomini circa, nei quadri, sono stati scelti fra la popolazione rurale delle isole de l Cavallino, dei Sabbioni e presso Chioggia.
Si è quasi certi di completare il reclutamento lascia ndo Venezia e Mestre a dispozione della Milizia di difesa e.a.
Fra il personale reclutato vi sono elementi di primo ordine ex sottofficiali di Artiglieria da costa e di Marina, cannonieri e specia listi.
Me ss ina va più adagio. Di 118 elementi previsti ne ha solo 16 perchè vuole scegliere fra i migliori.
La Spezia che dovrebbe averne 47 ne ha invece 57.
La Maddalena dovrebbe averne I 03, ne ha 44; ma uno dei fo11i è ancora armato.
E pertanto, pur essendo agli inizi, la costituzione del nuove organo e bene avviata.
S.E.Badoglio osserva che se bbene si vada dicendo che la guerra può manifestarsi da un momento all'altro, vi sarà, tuttavia, un periodo di tensione diplomatica.
Bi sogna restituire il rispetto alla questione <<tempo>> e tener presente che le ostilità, anche se non vi sarà dichiarazione di guerra, non scoppieranno improvvisamente. Vi sarà un periodo intermedio tra la pace e la guerra e in questo periodo verranno iniziati i provvedim e nti del primo momento.
Le necessità più sensibi li saranno attuate subito.
S.E. Cavagnari precisa che non ha mai dubitato della efficienza della M. da C.0.S. Si è so lo preoccupato di una eventuale soluzione di continuità.
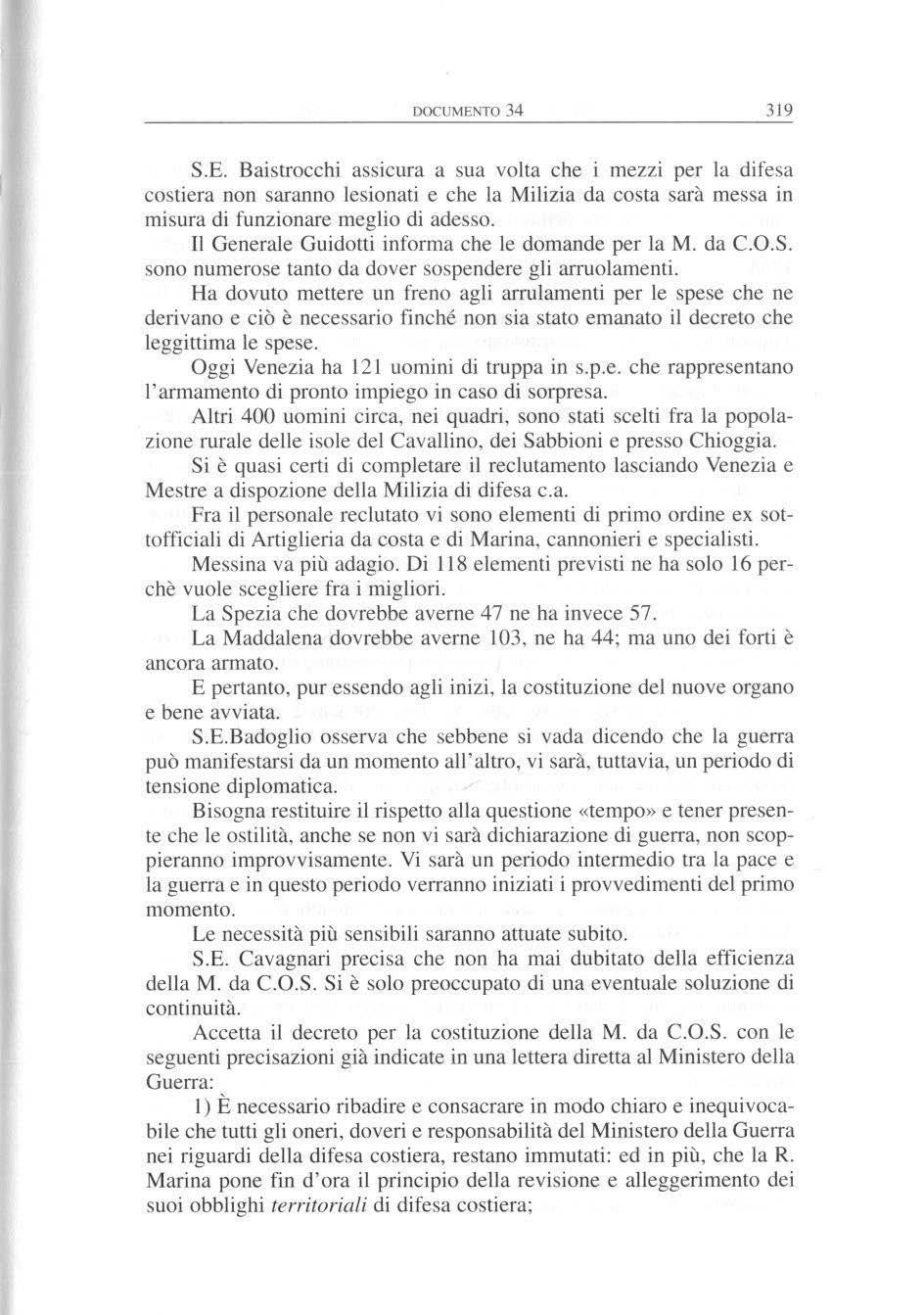
Accetta il decreto per la costitu zione della M. da C.O.S. con le seguenti precisazioni già indicate in una lettera diretta al Ministero della Guerra:
I) È necessario r ibadire e consacrare in modo chiaro e inequivocabile che tutti gli o ne ri , doveri e respon sa bilità del Ministero della Guerra nei riguardi della difesa costiera, restano immutati: ed in più , che la R. Marina pone fin d 'ora il principio della revisione e alleggerimento dei suoi obblighi territoriali di difesa costiera;
2) Poiché la responsabilità integrale della difesa delle Piazzeforti Marittime è della Regia Marina è necessario che fra R. Esercito e la R. Marina vengano trattate dettagliatamente le modalità di applicazione del decreto e alcune questioni già prospettate nella lettera dell' 11 luglio 1934:
a) Batterie e servizi delle Piazze che dovranno essere armate dalla Milizia e che dovranno essere in piena efficienza fin dall'assetto precauzionale: servizi, addestramento del personale, manutenzione delle opere in tempo di pace;
b) Mobilitazione delle opere e dei servizi di competenza del R. Esercito affinché sia raggiunto un rapido, sicuro ed efficiente annamento delle opere alla mobilitazione;
c) Rinnovamento delle opere antiquate;
d) Nei riguardi della costituzione della nuova Milizia la R. Marina ha fatto presenti due questioni sul pers onale che sarà reclutato e adibito al nuovo servizio, questioni che sarà necessario chiaramente definire:

1) possibiltà di reclutare tale personale nelle zone che interessano , senza che la cosa vada a scapito dei s ervizi della D.1.C.A.T., che in guerra dovranno avere un grandissimo sviluppo;
2) che il personale reclutato per la M. da C.O.S. sia atto al servizio cui deve essere assegnato e non prescelto fra mutilati, riformati e inabili ai servizi di guerra come ali' art. 12 del preposto decre to.
S.E. Bais trocchi os serva che la difesa costiera è essenzialmente basata s ui quadri e sug l i specialisti: il rimanente pers o nale ha limitata importanza: ha più che altro incarico di mano d ' opera. Non si permetterebbe mai di dare elementi ed organi deficienti alla Marina, che avrà un vantaggio nel ricevere quadri permanenti, ufficiali che non variano e personale che prende contatto con loro ogni domenica.
Per quanto riguarda la rinnovazione del materiale afferma che il prob lema non varia sia che lo abbia l ' Esercito o la M. da C.O.S. Abbiamo sempre avuto materiale scadente perché i cambiamenti sono fortemente onerosi. La Marina potrebbe aiutarci nel rinnovamento delle batterie da costa specialmente dandoci pezzi a lunga portata. Non abbiamo una bocca da fuoco nuova nè fond i per acquistarl a. Dobbi amo provvedere al problema urgente di armare la fanteria e l'esercito di campagna.
F a presente che ha deciso:
- di riarmare le batterie Chiodo e Montanari con i materiali già in armamento;
- di co nservare nella batteria Manin i pezzi ancora efficienti.
S.E. Badoglio ritiene che S.E. Cavagnari e Baistrocchi potranno mettersi d'accordo per far varare al più presto il decreto.
Chiude infine la discussione sull'argomento pregando S.E. Baistrocc hi di tenerlo al corrente .
2) - Difesa all'Isola d'Elba.
S.E. Badoglio prende la parola premettendo che nelle manovre del 1928 con S.E. Burzagli, Capo di Stato Maggiore della Marina, venne affrontato il problema dell'Isola d'Elba, che può costituire un obiettivo importante per il nemico, e che si aggiunge alla minaccia della Corsica.
L ' occupazione dell'Elba da parte del nemico comprometterebbe la nostra situazione marinara. Per questa ragione la Marina ha armato l'Isola di batterie e ha chiesto il mio intervento presso il Ministero della Guerra perché un reggimento di fanteria fosse in permanenza dislocato nell'Isola. Ma il Capo di S.M. dell'Esercito si preoccupa per la sollrazione di questo reggimento come di altri (distaccamento di Bari all'isola di Rodi).
Facendo astrazione dalla situazione politica contingente, considera l'ipotesi di una guerra con la Francia e ritiene che la maggiore probabilità di una colpo di mano sull'Elba s i può avere nei primi giorni delle ostilità, durante i quali è necessario far risiedere in permanenza nell'Isola almeno un battaglione.
S.E. Baistrocchi ha esaminato a fondo il problema. Noi disponiamo di poche divisioni permanenti.
Raffronta quindi l'efficienza di un battaglione mitraglieri bene inquadrato e con buoni organici, a quella di un reggimento empirico su due battaglioni, che per molti mesi dell'anno ha forza minima.
Il problema viene meglio risolto col battaglione mitraglieri, che è tra i reparti da tenere permanentemente in piena efficacia e di pronto impiego.
Ritene in tal modo conciliati gli interessi della difesa dell'Isola d'Elba e quelli della organicità della Divi sione Curtatone. Per l'Elba venne già fatto molto: batterie, strade impianti idrici.
All'atto della mobilitazione un reggimento T.M. su 3 battaglioni T.M. mobilitato in Toscana, andrà al più presto all'Elba.
S.E. Cavagnari dichiara che qualora il battaglione mitraglieri s ia tenuto costantamente in efficienza nulla ha da osservare.
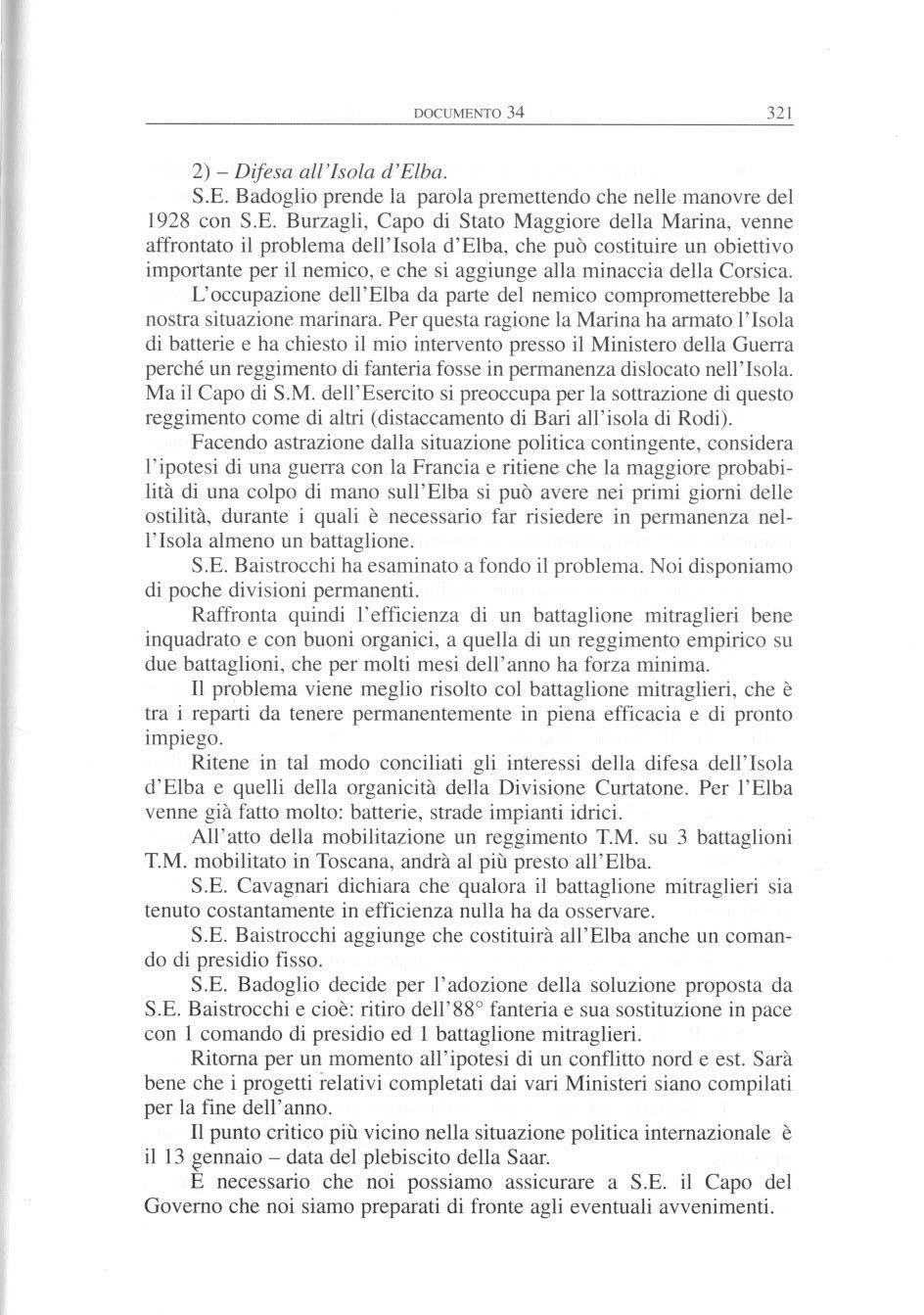
S.E. Baistrocc hi aggiunge che costituirà all'Elba anche un comando di presidio fisso.
S.E. Badoglio decide per l'adozione della soluzione proposta da S.E. Baistrocchi e cioè: ritiro dell'88 ° fanteria e sua sostituzione in pace con 1 comando di presidio ed l battaglione mitragLieri.
Ritorna p er un momento all'ipotesi di un conflitto nord e est. Sarà bene che i progetti relativi completati dai vari Ministeri siano compilati per la fine dell'anno.
Il punto critico più vicino nella situazione politica internazionale è il 13 ~ennaio - data del plebiscito della Saar.
E necessario che noi possiamo assicurare a S.E. il Capo del Governo che noi siamo preparati di fronte agli eventuali avvenimenti.
S.E. Cavagnari, per quanto si tratti di un argomento particolare riguardante 1' Adriatico, desidera affacciare la questione dell ' occupazione dell'Albania e delle Isole dell'Adriatico.
S.E. Badoglio apprezza al suo alto valore il problema adriatico per quanto si riferisce ali ' Albania e alle Isole. Ma occo1Te considerare il problema nel suo complesso e in tutta la sua gravità che può enunciarsi così:
a) Offensiva a nord;
b) Stato di difesa verso est.
Non è conveniente provocare con nessuna misura, anche conveniente in sé, una situazione decisiva verso est.
Verso est è opportuno provvedere che lo schieramento ci garantisca un da colpo d i testa jugoslavo, mentre l'organizzazione delle nostre forze ci deve garantire di puntare più a nord possibile.
Se la Jugoslavia si dichiarerà apertamente nemica, allora potremo vedere quali forze potremo distrarre verso s ud, ma non prima di quel momento e so ltanto quando il settore nord ci lascerà forze disponibili per iI settore est.
S.E. Cavagnari non intende riferirsi all'occupazione del territorio albanese, ma s oltanto di Yallona <bl.
S.E. Badoglio: l ' occupazione di una testa di ponte per lo scopo a cui si riferisce S.E. Cavagnari non può essere fatto se non col criterio di un grande raggio d'azione. Si ricordi che dall ' occupazione di Val lona con un reggimento bersaglieri siamo passati ad un corpo di spedizione di 3 divisioni con 100.000 uomini.
Per l'occupazione di Vallona sarà impegnato almeno un corpo d ' armata (Bari) e numerose bocche da fuoco.
L'incognita della nostra situazione a est è gravissima. Occorrerà dislocare almeno 10 delle nostre divisioni permanenti alla frontiera jugoslava. Vi è tuttavia da considerare che la potenzialità logistica verso nord non ci permette di incanalarvi molte forze. Dobbiamo essere sicuri del nostro fianco, e quindi non dobbiamo precipitare gl i avvenimenti verso est, e quindi riassumendo:

a) Dedicare la maggior parte delle forze verso nord;
b) Tenerci garantiti a est;
c) Non provocare a est.
S.E. Ba istrocchi e la questione di Zara?
S.E. Badoglio l'invio della divisione a Zara è stato sospeso.
S.E. Baistrocchi rinforzeremo quello che è già s ul posto.
S.E. Badoglio ad ogni modo debbono essere studiati anche i casi d'invio di truppe a Zara e in Albania. L'ordfoe esecutivo sarà dato se sarà possibile.
S.E. Pariani , riassumendo: l'Esercito può quindi contare per la nuova ipotesi anche sulle divisioni previste per l'Albania, sulla divisione
destinata a Zara e sulla divisione che era invece destinata a rimanere in Toscana.
S.E. Badoglio fa ancora presente che lo studio del progetto dell'Ipotesi Nord-Est dovrà essere completo per i primi di gennaio, in modo che lo sviluppo eventua le degli evvenimenti della Saar ci trovi pronti.
A.U.S S.M.E.,jàndo H - /0 « Verbali riunioni 1924 - 1943». busta n. 2.fascicolo n. 7.
Il documento è una cop ia dell'Ufficio del capo di Stato Maggiore Generale.

a} Il capo dell'Ufficio Operazioni del Comando del Corpo di Stato Maggiore (Stato Maggiore de/l'Esercito) era il colonnello Marco Galameri.
bJ Valona.

« Prepara zione della guerra contro la Germania , con possibili a zioni contro la Jugoslavia (ipotesi Nord-Est): situaz ione int erna zionale, studio del problema operativo, questioni relative all'Adria1i co (Albania e isole antis1an1i a Zara), opera zioni terrestri, accordi militari con la Francia »
Direttive date da S.E. Il Capo di S.M. Generale nella riunione del 17 novembre 1934, XlII, alla presenza delle LL.EE. i Sottosegretari di Stato e Sottocapi di S.M. delle Forze Armate per la parte operativa.
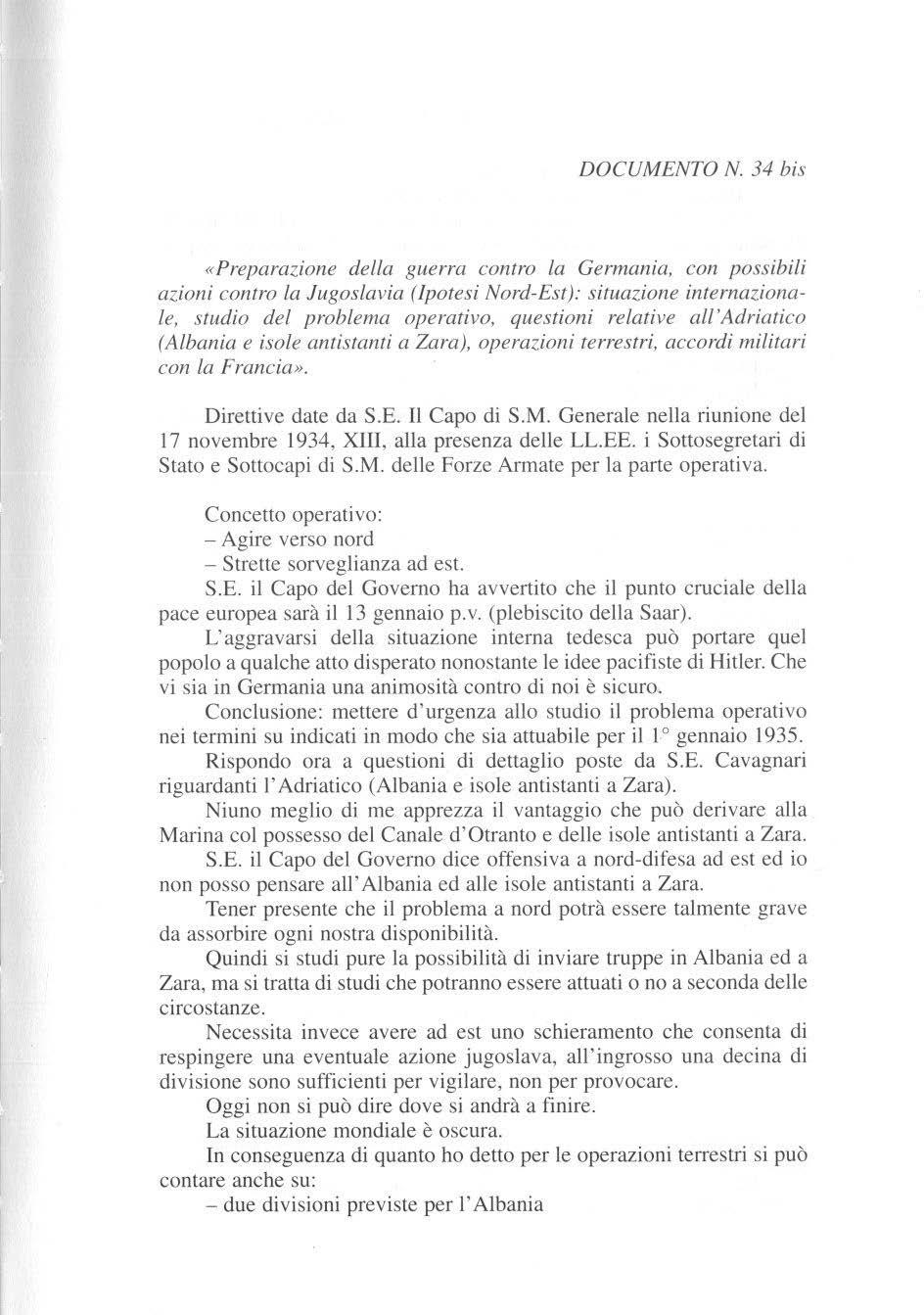
Concetto operativo:
- Agire verso nord
- Strette sorveglianza ad est.
S.E. il Capo del Governo ha avvertito che il punto cruciale della pace europea sarà il 13 gennaio p. v. (plebiscito della Saar).
L'aggravarsi della situazione interna tedesca può portare quel popolo a qualche atto disperato nonostante le idee pacifiste di Hitler. Che vi s ia in Germania una animosità contro di noi è sicuro.
Conclusione: mettere d ' urgenza allo studio il problema operativo nei termini su indicati in modo che sia attuabile per il l O gennaio 1935.
Rispondo ora a questioni di dettaglio poste da S.E. Cavagnari riguardanti l'Adriatico (Albania e isole antistanti a Zara).
Niuno meglio di me apprezza il vantaggio che può derivare alla Mruina col possesso del Canale d'Otranto e delle isole antistanti a Zara.
S.E. il Capo del Governo dice offensiva a nord-difesa ad est ed io non posso pensare ali' Albania cd alle isole antistanti a Zara.
Tener presente che il problema a nord potrà essere talmente grave da assorbire ogni nostra disponibilità.
Quindi si studi pure la possibilità di inviru·e truppe in Albania ed a Zara, ma si tratta di studi che potranno essere attuati o no a seconda delle circostanze.
Necessita invece avere ad est uno schieramento che consenta di respingere una eventuale azione jugoslava, all'ingrosso una decina di divisione sono sufficienti per vigilare, non per provocare.
Oggi non si può dire dove si andrà a finire.
La situazione mondiale è oscura.
In conseguenza di quanto ho detto per le operazioni terrestri si può contare anche su:
- due divisioni previste per l'Albania
- una divisione prevista per Zara
- una divisione (Curtatone e Montanara).
A titolo informativo aggiungo che ho parlato con S.E. il Capo del Governo per un accordo con la Francia, accordo che potrebbe essere portato a termine in questi giorni:
Ho proposto una convenzione militare su que s te basi:
- ciascuno opera nel suo territorio
- obiettivi definiti
Francia: Berlino
I talia: Monaco
- ogni esercito con il proprio comandante (niente comando unico)
- altre modalità che mi riservo comunicare poi.
A.U.S.S.M.E., fondo 1-4 «Carteggio Stato Maggiore Generale - Comando Supremo - Stato Maggiore Difesa 1924 - /948», busta 11. 68.fascicolo 11. 3.
Il documento non è su carta imesrara ma molto probabilmente è una cop ia dell'Ufficio del capo di Stato Maggiore Generale.

«Preparazione militare in Africa orientale: for ze da mobilitare, trasporto delle truppe via mare, vie di comunicazioni ( lavori stradali nelle colonie), servizi per le truppe operanti, munizioni per le forze aeree (bombe ad iprite), protezione delle retrovie, provvedimenti per la Somalia».
Verbale della riunione tenuta da S.E. li Capo di Stato Maggiore Generale - il giorno 14 gennaio 1935 - Anno XllI
Alle ore 1O del giorno 14 gennaio 1935 - Xlll - nel Salone antistante all'ufficio di S.E. Il Capo di S.M. Generale, a Palazzo Viminale, si sono riuniti, presieduti da S.E. il Maresciallo Badoglio, Capo di Stato Maggiore Generale:
S.E. il S.S. cli Stato alla Guerra - Generale Baistrocchi
S.E. il S.S di Stato per l'Aeronautica - Generale Valle
S.E. il S. Capo di Stato Maggiore dell'Esercito - Generale Pariani
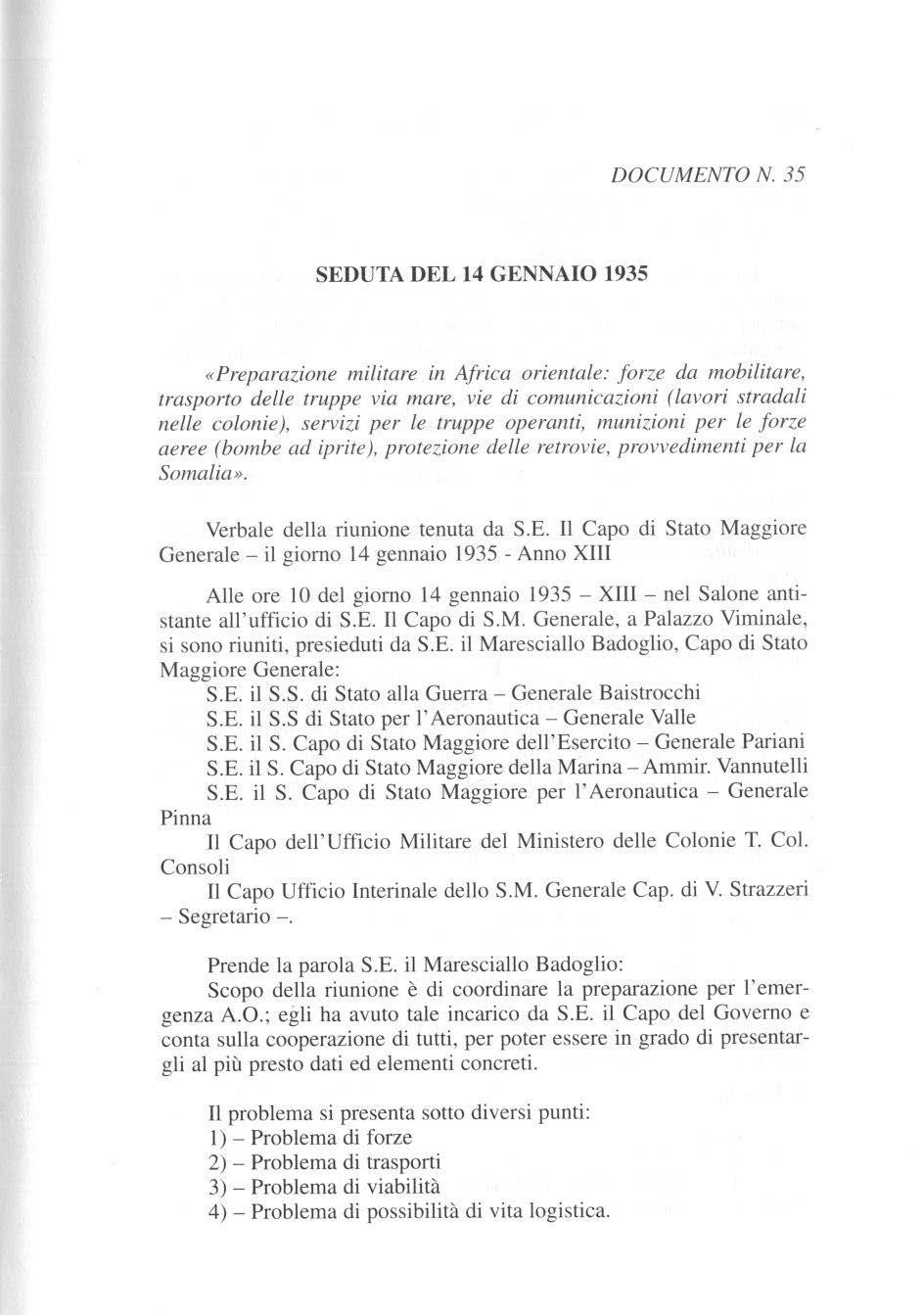
S.E. il S. Capo di Stato Maggiore della Marina - Ammir. Vannutelli
S.E. il S. Capo di Stato Maggiore per l 'Aero nautica - Generale
Pinna
Il Capo dell'Ufficio Militare del Mini stero delle Co lonie T. Col.
Consoli
Il Capo Ufficio Interinale dello S.M. Generale Cap. di V. Strazzeri - Segretario -.
Prende la parola S.E. il Maresciallo Badoglio:
Scopo della riunione è di coordinare la preparazione per l'emergenza A.O.; egli ha avuto tale incarico da S.E. il Capo de l Governo e conta sulla cooperaz ione di tutti, per poter essere in grado di presentarg li al più presto dati ed elementi concreti.
Il problema si presenta sotto div ersi punti:
1) - Problema di forze
2) - Problema di trasporti
3) - Problema di viabilità
4) - Problema di possibilità di vita logi stica.
Punto 1° - I/ problema esaminato sotto il primo punto di vista ,\i può scindere in due elementi d i studio:
A - Impiego del!' aviazione
8 - I mpiego delle truppe.
La questione dell'aviazione è felicemente impostata da uno studio comp il ato e presentato dallo Stato M agg iore de ll a R. Aeronautica, e si prospetta pertanto sotto un punto di vista meno allarmante di quanto si presentasse pochi giorni addietro: onde Egli ne trae occasione per esprimere a S.E. Valle la sua grande soddisfazione in proposito.
Si riferisce, per il problema di forze, al promemoria d istribu it o da S.E. il Capo del Governo: questo fissa alcuni punt i da tener presenti e per l'a viaz ione fissa dati concreti:
« Per una guerra rapida e definitiva, ma che sarà sempre dura, si devono predisporre grandi mezzi.
Accanto al 60 mila indigeni. si devono mandare almeno altrettanti metropolitani. Bisogna concentrare almeno 250 apparecchi in Eritrea e 50 in Soma li a.»
«Superiorità assoluta e.li artiglieria e di gas. Dovizia di munizioni. I 60 mila soldati della metropoli, meglio ancora se 100.000, devono essere pronti in Eritrea per l'ottobre 1935.»
L'idea di avere 250 apparecchi con tutto il carico ordinario e guerresco coinvolge il trasporto di molte migliaia di tonnellate di materiale.
S.E. Valle - nello studio sopraccennato ha stabilito che ferma restando l'attuazione dei campi su ll'altopiano per la ricognizione e la caccia, la massa da bombardamento sia tenuta in campi si tu ati presso la costa, in modo da poterne effettuare il rifornimento via mare, indip e nd e ntem ente da quello delle truppe.
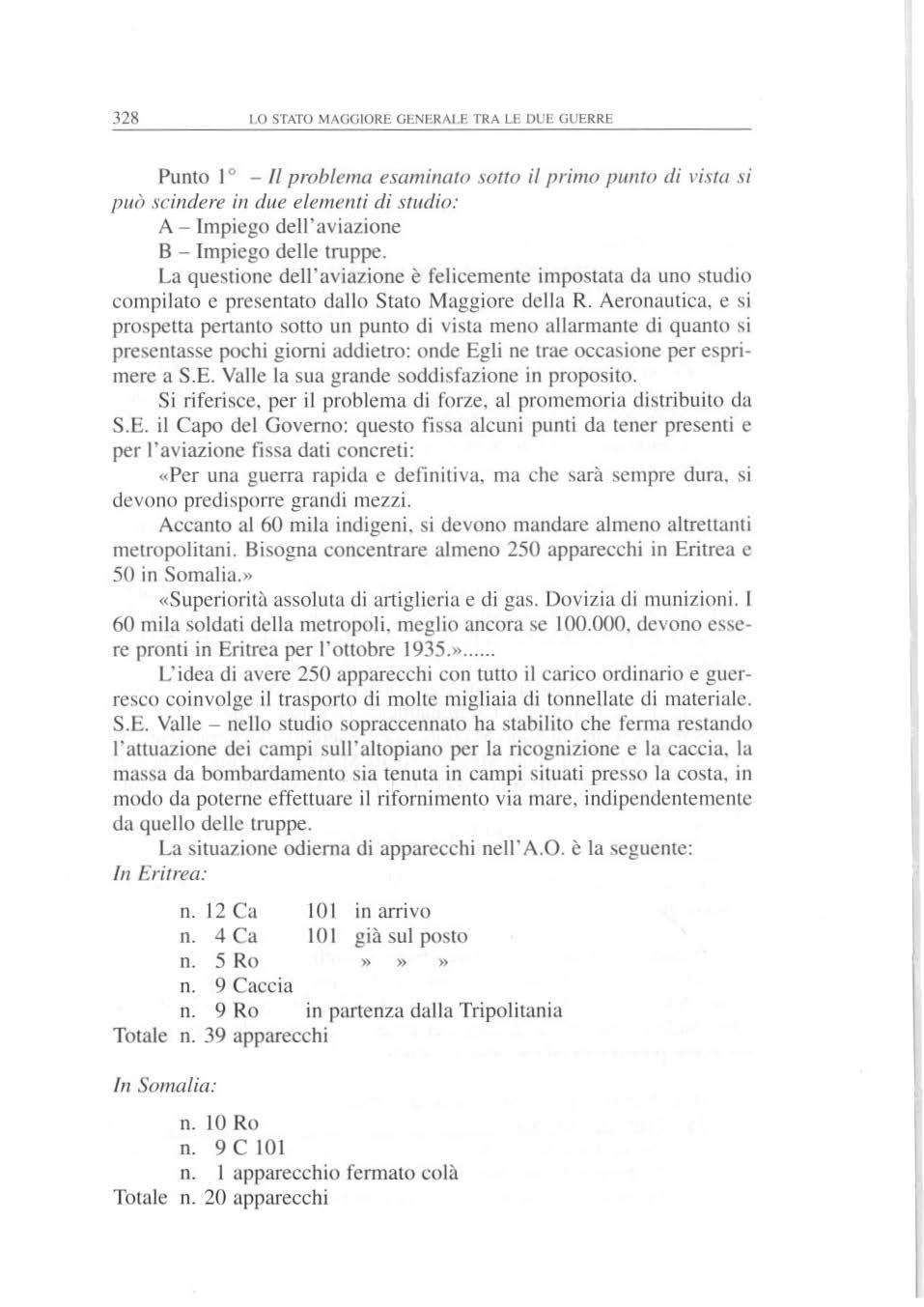
La si tua7ione odierna di apparecchi nell" A.0. è la seguente:
In Eritrea:
n. 12 Ca
n. 4 Ca
n. 5 Ro
n. 9 Caccia
I OI in arrivo
l OI già sul posto
n. 9 R o in partenza dalla Trip ol it ania
Totale n. 39 apparecc hi
In Som alia:
n. 10 Ro
n. 9 C 101
n. I apparecc hi o ferma to co là
Totale n . 20 apparecc hi
Occorre quindi, per raggiungere ìl contingente previsto, ìnvìare in Eritrea n. 210 apparecchi e in SomaJia n. 30 apparecchi.
S.E. Valle - propone di stabilire i seguenti campi costieri:
1) - Massaua - Otumlo
2) - Zula
3) - Marsa Fatma
La distribuzione degli apparecchi da bombardamento nei 3 campi sarà studiato dallo S.M. della R. Aeronautica.
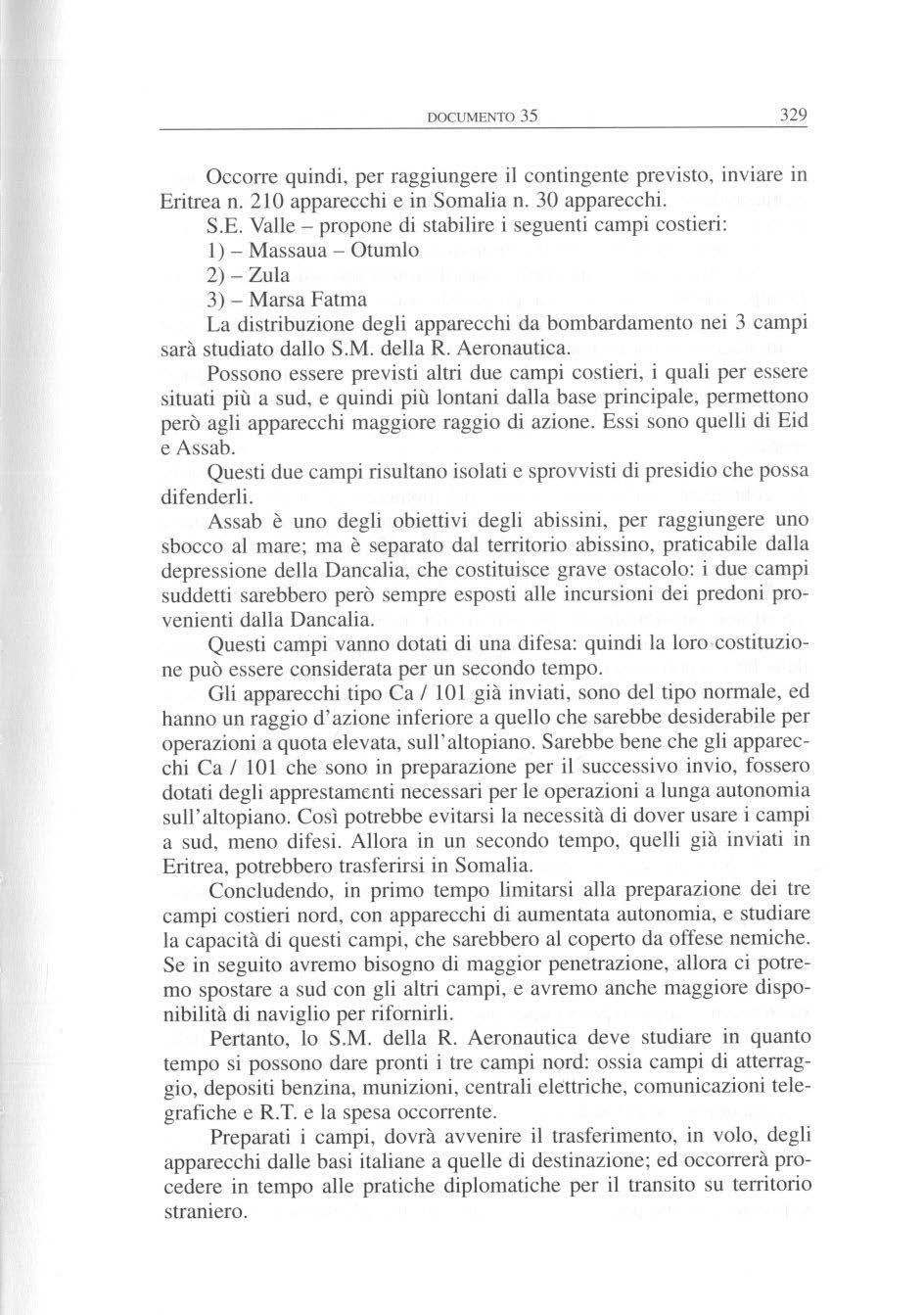
Possono essere previsti altri due campi costieri, i quali per essere situati più a sud, e quindi più lontani dalla base principale, permettono però agli apparecchi maggiore raggio di azione. Essi sono quelli di Eid e Assab.
Questi due campi risultano isolati e sprovvisti di presidio che possa difenderli.
Assab è uno degli obiettivi degli abissini, per raggìungere uno sbocco al mare; ma è separato dal territorio abissino, praticabile dalla depressione della Dancalia, che costituisce grave ostacolo: i due campi suddetti sarebbero però sempre esposti alle incur sio ni dei predoni provenienti dalla Dancalia.
Questì campi vanno dotati dì una difesa: quindi la loro costituzione può essere considerata per un secondo tempo.
Gli apparecchi tipo Ca/ 101 già inviati, sono del tipo normale, ed hanno un raggio d'azione inferiore a quello che sarebbe desiderabile per operazioni a quota elevata, sull'altopiano. Sarebbe bene che gli apparecchi Ca / 1O1 che sono in preparazione per il s uccessivo invio, fossero dotati degli apprestame:.nti necessa ri per le operazioni a lunga autonomia sull'altopiano. Così potrebbe evitarsi la neces sità di dover usare i campi a sud, meno difesi. Allora in un secondo tempo, quelli già inviati in Eritrea, potrebbero trasferirsi in Somalia.
Concludendo, in primo tempo limitarsi alla preparazione dei tre carnpì costieri nord, con apparecchi di aumentata autonomia, e studiare la capacità di questi campi, che sarebbero al coperto da offese nemiche. Se in seguito avremo bisogno di maggior penetrazione, allora ci potremo spostare a s ud con gli altri campi, e avremo anche maggiore disponibilità di naviglio per rifornirli.
Pertanto, lo S.M. della R. Aeronautica deve studiare in quanto tempo si pos sono dare pronti i tre campi nord: ossia campi di atterraggio, depositi benzina, munizioni, centrali elettriche, comunicazioni telegrafiche e R.T. e la spesa occorrente.
Preparati i campi, dovrà avvenire il trasferimento, in volo, degli apparecchi dalle basi italiane a quelle di destinazione; ed occorrerà procedere in tempo alle pratiche diplomatiche per il transito su territorio straniero.
S.E. Valle fa rilevare che, date le esigenze di manovra e di spazio richieste dai Ca/ I O1, ritiene sia difficile far bastare i tre campi costieri nord aJl'impiego di tutta la massa predisposta.
Prevede occorra anche il campo di Assab.
S.E. Badoglio - Non avendo specifica competenza in materia non fa opposizione a quanto sopra: prega S.E. VaJle di studiare di sal urare i 3 campi nord. In quanto al campo di Assab, se le esigenze di servizio e di impiego ne rendono necessaria la costituzione, avrà cura di interessare il Ministero delle Colonie affinché Assab s ia dotato di adeguata guarnigione difensiva. Qu esto perché il buon funzionamento ed il buon rendimento delle basi aeree presuppone una conveniente atmosfera di sicurezza.
S.E. VaJle - Espone alcune previsioni in merito alla preparazione del co ntingente aereo, dicendo che, dal momento dell ' ordine di esecuzio ne, occorrono due mesi in Italia per allestire il materiale (febbraio e marzo). A fine marzo possono partire i piroscafi. Per il lavoro delle basi si può cominciare subito con mano d'opera reperibile sul posto. Verso la metà di lu g lio le basi possono essere pronte a ricevere gli apparecchi, ma questi no n possono c be essere pronti tutti in settemb re , però da luglio possono cominciare ad affluire a stormi successivi. Per l 'attrezzatura delle basi occorrono circa 30 milioni di lire per ciascuna.
S.E. Badoglio - Conclude che la R. Aeronautica ha impostato bene il problema e può lavorare da sé.
Passa quindi al seco ndo punto del problema di forze. Quello del! ' impiego del personale del R .E S.E. il Capo del Governo ha indicato come forza del contingente quella di 60 mila indigeni e da 60 a 100 mila uomini metropolitani. Per i carri armati ha indicato il numero in 150 per l'Eritrea e in 50 per la Somalia.

In Somalia abbiamo già 30 carri, dei quali 20 arrivano in questi giorni. Il loro impiego ha grande efficacia ed è in accordo con la massima sanzio nata che noi dobbiamo procurarci, laggiù , grande s uperiorità di mezzi piuttosto che la s uperiorità numerica.
Lo Stato Maggiore del R.E. potrà dire quanti carri armati possono essere pronti per il trasporto in Eritrea e in Somalia. Per l 'imp iego in Eritrea non si nutrono preoccupazione, poiché i carri armati veloci hanno dimostrato la loro manovrabilità in terreni difficili, in occasione delle manovre nella zona tosco-emiliana. S.E. Baistrocchi dovrà stabilire quanti battaglioni di carri armati (su 45 unità ciascuno) occorre prelevare dalla dotazione del R.E.
S.E. Baistrocchi - Informa che la ditta Ansaldo ha già fatto riserve s ul tempo di consegna, ritarderà di qualche mese, ed a maggio incomincerà la dfatribuzione in ragione di 30 carri ogni IO giorni. Per ora di carri veloci ne esistono pochi: una compagnia pronta a Bologna (su 15 unità)
e tre gruppi in dotazione alle divisioni cele1i, di cui uno dislocato nella Saar. Questi tre gruppi fanno parte delle fo rm azioni organiche del R.E. È possibi le toglierli?
S.E. Badoglio - Riferisce come S.E. il Capo del Governo autorizzi ora a non fa re riserve mentali: il materiale che sarà mandato in Colonia verrà ricostituito per le dotazioni in Patria. Quindi dà incarico a S.E. Baistrocchi di riferire, per venerdì 18 corrente, sul numero di carri veloci che saranno di sponibili per il settemb re prossimo, insieme a l personale istruito occorrente al loro impiego, per essere inviati in Colonia. Essi saranno aggiunti alle truppe suppletive di corpo d'armata, e la Marina ne sarà informata per le disposizioni inerenti al trasporto.
Il problema delle truppe va risolto nei suoi due elementi costitutivi:
a) problema indigeno. Il Promemoria dell'Ufficio Militare del Ministero delle Colonie dice:
Nell'esercizio 1932 - 1933 furono istruiti 3.300 uomini del Chitet
» 1933 - 1934 furono istruiti 8.000 » » »
Nel corrente esercizio saranno istruiti I3.900 » » >>
Alla fine del prossimo giugno si disporrà quindi in totale di n. 25 mila uomini del Chitet, che, aggiunti ai 25 mila uomini della Milizia mobile, costituiranno una forza complessiva in congedo di 50 mila uomini da ridursi a circa 45 mila per l'applicazione di un coefficiente di riduzione del 10%. Tale forza è sufficiente per mobilitare il previsto Corpo d'Armata Indi geno.
Tale forza rappresenta però il numero dei «razionari» diversa da quello dei combattenti, che sono in numero minore.
Esistono ora in Colonia n 12.835 indigeni permanenti, sotto le armi, alcuni dei quali sono prelevati da l Chitet.
Quindi grosso modo si può dire che disponiamo di circa 50.000 combattenti, olt re alle bande. Provvediamo alla costituzione di un corpo d'armata indigeno su 27 battaglioni, della forza ciascuna di circa un migliaio di uomini.
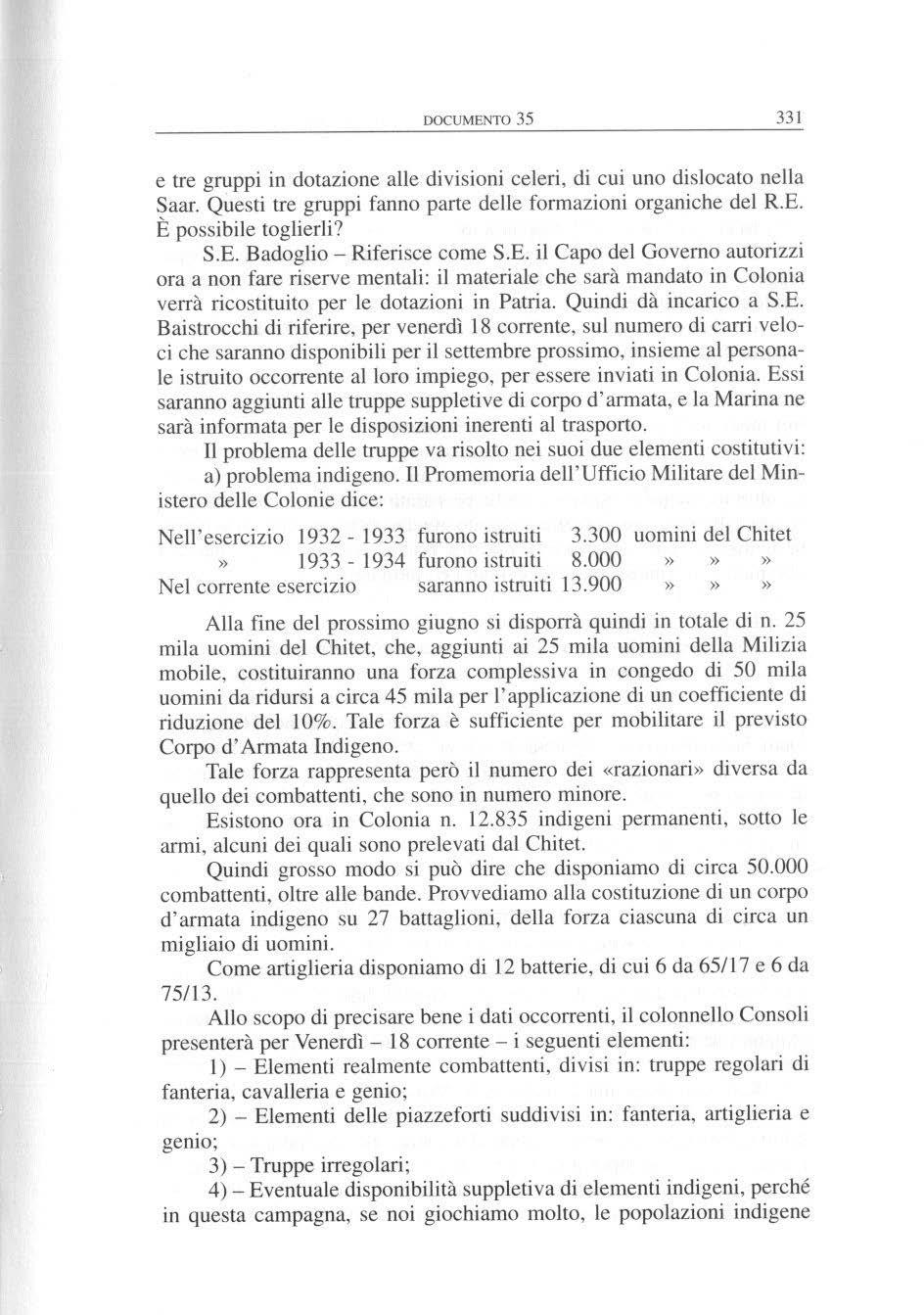
Come artiglieria disponiamo di 12 batterie, di cui 6 da 65/17 e 6 da 75/13.
Allo scopo di precisare bene i dati occorrenti, il colonnello Consoli presenterà per Venerdì - 18 corrente - i seguenti elementi:
1) - Elementi realmente combattenti, divisi in: truppe regolari di fanteria, cavalleria e genio;
2) - Elementi delle piazzeforti suddivisi in: fanteria, artiglieria e genio;
3) - Truppe irregolari;
4) - Eventuale di sponibilità s uppl etiva di elementi indigeni, perché in questa campagna, se noi giochiamo molto, le popolazioni indigene
giocano tutto, e quella terra deve dare per la sua difesa il mass imo numero di uomini possibili.
b) corpo d'armata Metropolitano.
Esso , salvo l'aumento del numero dei battaglioni di carri armati leggeri, rimane per ora stabilito nella forza delle tre divisioni previste, più le truppe suppletive.
Lo Stato Maggiore del R. Esercito dovrà spec ificare la forza dei reparti. divi s i in combattenti e servizi.
Secondo una statistica del Ministero delle Colonie, ri s ulta che gli ascari abissini da noi istruiti nel tempo in cui formavano i battaglioni eritrei misti, ammontano a 50 mila. Dobbiamo poi ammettere che le missio ni estere in Abissina servono alla istruzione di altre mas se, oltre a quelle delle guardie imperiali e dei nuclei armati permanenti: quindi un'altra massa quasi eguale a quella preparata da noi, se la trovano preparata daJle missioni suddette. Pertanto avremo di fronte un massa istruita, numericamente superiore alla no stra, poiché noi non raggiungiamo i 100 mila combattenti fra metropolitani ed indigeni.

Punto 2° - Problema dei trasporti:
Passeremo a s uo tempo alla R. Marina tutti gli elementi nuo vi risultanti, atti a modificare gli st udi già com piuti in merito ai trasporti. Nel lavoro fatto in questi giorni dalla R. Marina risulta che per il trasporto di parte di una divisione più i servizi d'armata occorrono 110 giorni, mediante requisizione limitata di mezzi , che non altera sensibilmente l'economia dell'andamento commerciale della Nazione. Evidentemente dovremo provocare da S.E. il Capo del Governo disposizioni su questo particolare, poiché, se ci impegnamo, tutto deve passare in seconda linea. Per il problema dei trasporti pOLremo affrontare un success ivo studio, basato sulla requisizione dei piroscafi necessari, senza riguardo alla economia del commercio. Tenteremo di diminuire questo inconveniente: ma, una volta che lo S.M. del R.E. darà le cifre concrete bisognerà affrontare il problema dei trasporti per vedere fino a che punto possiamo so ttrarre mezzi alla economia generale, allo scopo di rendere più sollecita l'esecuzione del piano. La nostra velocità deve essere in relazione alla velocità di mobilitazione del nemico. Anche esso ha bisogno di almeno due mesi: noi dobbiamo essere là prima che sia completata la loro radunata.
Risolto il problema di forza, la R. Marina dirà quanti mezzi occorrono per il trasporto: ma la soluzione del problema dei tra s porti non va limitata solta nto alla requisizione dei mezzi ed alla preparazione in Patria. Questa è sempre possibile: l'attrezzamento esiste ed è pronto a funzionare. È laggiù che l'attrezzamento delle basi non è pronto. La R. Marina informa che lo sbarco di truppe, limitato alla base di Massaua e
Daklyat, può avvenire in 7 giorni per ogni scaglione di 10 piroscafi contemporaneamente sotto scarico.
S.E. Vannutelli - osserva che tale preventivo è di larga massima, poiché bisogna tener conto anche dei materiali per la R. Marina, di quello dell'aviazione ecc.
S.E. Valle - precisa che l'aviazione fa capo soltanto a Zula, ed opera in modo autonomo.
S.E. Badoglio - prosegue precisando che il problema essenziale che viene posto alla Marina, prescindendo dalla questione finanziaria, è questo: la Marina veda se si può, ed in quanto tempo, attrezzare altri punti di sbarco. TI tempo disponibile va dal l O febbraio alla fine di settembre.
Occon-e presentare gli elementi per addivenire alla preparazione di altre basi, lavorando in collegamento con il Ministero delle Colonie. J 7 giorni previsti per ogni scaglione dovrebbero essere ridotti a metà, mediante lo sfr uttamento di un ' altra testa di sbarco - Zula per esempio ma senza interferire con l'attività della R. Aeronautica.
S.E. Vannute1lì - dice che il contingente di 60 mila uomini può essere sbarcato in 6-7 mesi , incominciando subito.
S.E. Badoglio - fa riflettere che non si può incominciare subito, perché su ll'altipiano non è possibile ora di ricoverare la truppa. Nella stagione delle piogge il soldato non vive sotto le tende. Il movimento delle truppe non può essere effettuato che dopo la stagione delle piogge. Occorre quindi ritardare l'inizio, e diminuire i tempi quando si è incominciato.
La R. Marina farà un completo promemoria su tutte le necessità compresa quella dell 'ac qua.

Punti 3 ° e 4 ° - Il Problema della viabilità e delle possibilità di vita.
L e strade:
S.E. Badoglio - espone come, secondo il programma dei lavori stradali del Ministero delle Colonie, avremo ai primi di ottobre:
- una strada a doppio transito Massaua - Saati - Ghinda - Nefasit Decameré - Mai Edagà. Da Decameré all'Asmara esiste già a semplice transito;
- una strada da Decameré, per Saganeiti, Adi Caieh, a Senafé a doppio transito;
- una strada da Decameré per Teramnì e Adi Ugri , ad Adì Qualà, parte a semplice e parte a doppio transito;
- una st rada di arroccamento da Adi Caieh, per Mai Hainì e Adi Ugri ad Arresa, parte a se mplice e parte a doppio transito;
- una strada da Massaua ai pozzi di Uaà;
- una mulattiera da Saberguma e Saati, Barresa, Saganeiti, ad
un'altra che dai pozzi di Uaà va ad Adi Caieh per la valle dell'Haddas e una terza che unisce Zula a Senafé per la vale del Comailé.
Da notare che la Nefasit-Decameré attraverso tre ponti che costituiscono punti critici.
Mentre prima si doveva fare la strada Massaua - Saati a quadruplice transito , e, la Saati - Barresa - Saganeiti, si addivenne in 2 ° tempo al concetto di fare la Massaua-Uaà , lasciando la prosecuzione per la valle dell'Haddas a semplice mulattiera.
Concludendo, al l O ottobre avremo una sola linea di comunicazione per autocarri, che congiunga Massaua con il centro logistico principale sull'altipiano. Ciò dà una certa preoccupazione.
Bisogna pertanto ricorrere alle cifre, ossia conoscere il tonnellaggio giornaliero che occorrerà trasportare a regime costante, ossia dopo il 1° sforzo iniziale di trasporto delle truppe sull'altipiano. Da Massaua a Decameré, per i primi mesi, si avrà un dato movimento; una volta concentrato il corpo di operazioni sull'altipiano, si verificheranno determinato necessità di rifornimenti: ne risulterà il numero di autocarri occorrenti, tenuto conto del s ussidio della ferrovia. Lo Stato Maggiore del R. Esercito deve fare questo computo.

Ma vi è un'altra questione molto più grave da esaminare: trasportate le truppe sul!' altopiano, si deve calcolare il fabbi sog no di acqua per la vita delle truppe. Bisogna tener conto che si tratta di 100 mila uomini, 20 mila quadrupedi, tanti motori terrestri e di aviazione, le necessità della panificazione, della lavanderie, degli ospedali. Quale è la disponibilità odierna di acqua?
Nessuno può dare ora questa rispos ta . Il calcolo sarà fatto dallo S.M. del R. Esercito con margini generosi. Il Ministero delle Colonie ha uno s chedario sui posti d'acqua, che però, com'è noto , non sono ad erogazione costante; dopo i primi sfruttamenti il rendimento scende anche ad un decimo.
Le soluzioni ideate per s opperire al fabbisogno d'acqua sono diverse: trasformazioni, ricerca di falde, impianti di pozzi. La ricerca sull'altopiano potrà dare una risposta positiva o negativa. La sola sorgente positiva oggi assodata è quella della pioggia. Quindi lavori di raccolta e immagazzinamento di quest 'ac qua.
Riman e così tracciato a grandi linee il quadro degli studi e lavori da compiere dei vari enti convocati. Compiuti ques ti con la maggiore sollecitudine si potrà presentare a S.E. il Capo del Governo uno specchio completo delle necessità, in modo che egli possa prendere le sue decisioni.
S.E. Valle - desidera sia definito bene il tipo di munizionamento che occon-e provvedere per le forze aeree, data la natura delle località ove si dovrà agire.
Dopo una esauriente discussione si stabilisce che dovranno essere provveduti i seguenti tipi di munizionamento:
- munizioni di scoppio • spezzoni da 2 Kg.
• bombe da l O Kg.
• qualche bomba d 50 Kg. per aumentare l'effetto morale.
- munizioni incendiarie: ammessa la loro efficacia in varie zone di operazione, ne deve essere provveduta una notevole scorta.
Si decide in favore dei mezzi per l'irrorazione con iprite, e si esclude l'efficacia delle bombe ad iprite.
Si raccomanda di dotare di maggiore sensibilità le spolette degli spezzoni da 2 Kg. , che in terreni molli danno una dannosa percentuale di scoppi mancati.
S.E. Pariani - si preoccupa della protezione de lle retrovie , per la quale verranno as sorbiti da JO a 20 mila uomini. Essi non risultano disponibili , data la limitazione delle forze del corpo d ' operazione.
S.E. Badoglio- ricorda che con i 6 battaglioni complementari si era previsto lo scaglionamento nei servizi di tappa. Sono 6 mila uomini, ed altri 4 mila si possono prelevare da bande e dal Chitet.
S.E. Pariani - fa rilevare che in Somalia esistono poche truppe e non si è pensato a rinforzarle.
S.E. Badoglio - informa dei provvedimenti presi per la Somalia da S.E. il Sottosegretario alle Colonie:

- Ordine di Mobilitazione del R. Corpo di Truppe Coloniali;
- Costituzione di una brigata mista su 8.000 uomini;
- Forza delle bande ........ . . ....... 4.000 uomini;
- Carri armati 20;
- Aliquota di aviazione.
Assodati questi elementi S.E. Badoglio pensa che è possibile prelevare 2 o 3 dei battaglioni eritrei esistenti in Libia. Sul posto possono essere sostituiti con battaglioni di camicie nere provenienti dall ' Italia, oppure con reparti libici di agevole arruolamento.
l n questo modo potranno essere inviati in Somalia altri 3 mila uomini, portando il contingente somalo a 15 mila uomini.
Contro la Somalia si prevede una forza nemica di 30 - 40 mila uomini, che operano in zone difficilissime. Fra esse si accentua un movimento di diserzione, e vi infieriscono le malattie.
L'episodio di Ual-Ual ha depresso il loro morale, mentre ha esaltato il nostro.
Le forze a noi opposte in Somalia dispongono di due linee di operazione: quella del Giuba , che è per loro molto eccentrica; e quella dello
Uebi Scebeli che è l'unica possibile, ma che, nel mentre li allontana dalle loro basi, avvicina noi alle nostre. S.E. Badoglio ritiene quindi sufficienti le predisposizioni prese.
S.E. il Capo del Governo ha sanlionato la necessità per noi di avere sugli abissini un assoluto predominio di mezzi meccanici.
L'aviazione ci conferisce predominio assoluto e magnifico.
Altra nostra superiorità schiacciante ci viene conferita dai carri armati veloci.
Disponiamo poi dei lanciafiamme, che le truppe nemiche non conoscono. Lo S.M. del R.E. studi anche questo provvedimento e quali unità attrezzare con i lanciafiamme.

Infine S.E. Badoglio accenna alla sua intenzione di provocare di S.E. il Capo del Governo una decisione circa il trattamento da infliggere ai prigionieri che non appartengono alla razza abissina.
S.E. il capo di Stato Maggiore Generale invita le autorità partecipanti alla riunione a voler presentare i loro studi, derivanti dalle decisioni prese durante la discu ss ione, entro il giorno di venerdì 18 corrente.
La seduta è tolta alle ore 12.
«Preparazione militare in Africa orientale: coordinamento per L'invio dei rifornimenti, rinforzi e mezzi in Eritrea, trasporti marittimi, questioni finanziarie, scorte, situazione in Somalia e possibile attacco etiopico, costituzione di un comando superiore sul posto ».
Verbale della riunione tenuta da S.E. il Capo di Stato Maggiore Generale il giorno 5 febbraio 1935 - Xlll
Alle ore 9,30 del giorno 5 febbraio 1935-Xlll nel salone antistante all'ufficio di S.E. il Capo di Stato Maggiore Generale a Palazzo Viminale, si sono riuniti, presieduti da S.E. il Maresciallo Badoglio, Capo di Stato Maggiore Generale:
S.E. Il Sottosegretario di Stato per le Colonie - On. Lessona;
S.E. Il Sottosegretario di Stato per la Guerra - Generale Baistrocchi;
S.E. TI Sottosegr. di Stato per la Marina - Ammiraglio Cavagnari;
S.E. Il Sottosegretario di Stato per l'Aeronautica - Genenùe Valle;
S.E. Il Sottocapo di S.M dell'Esercito - Generale Pariani;
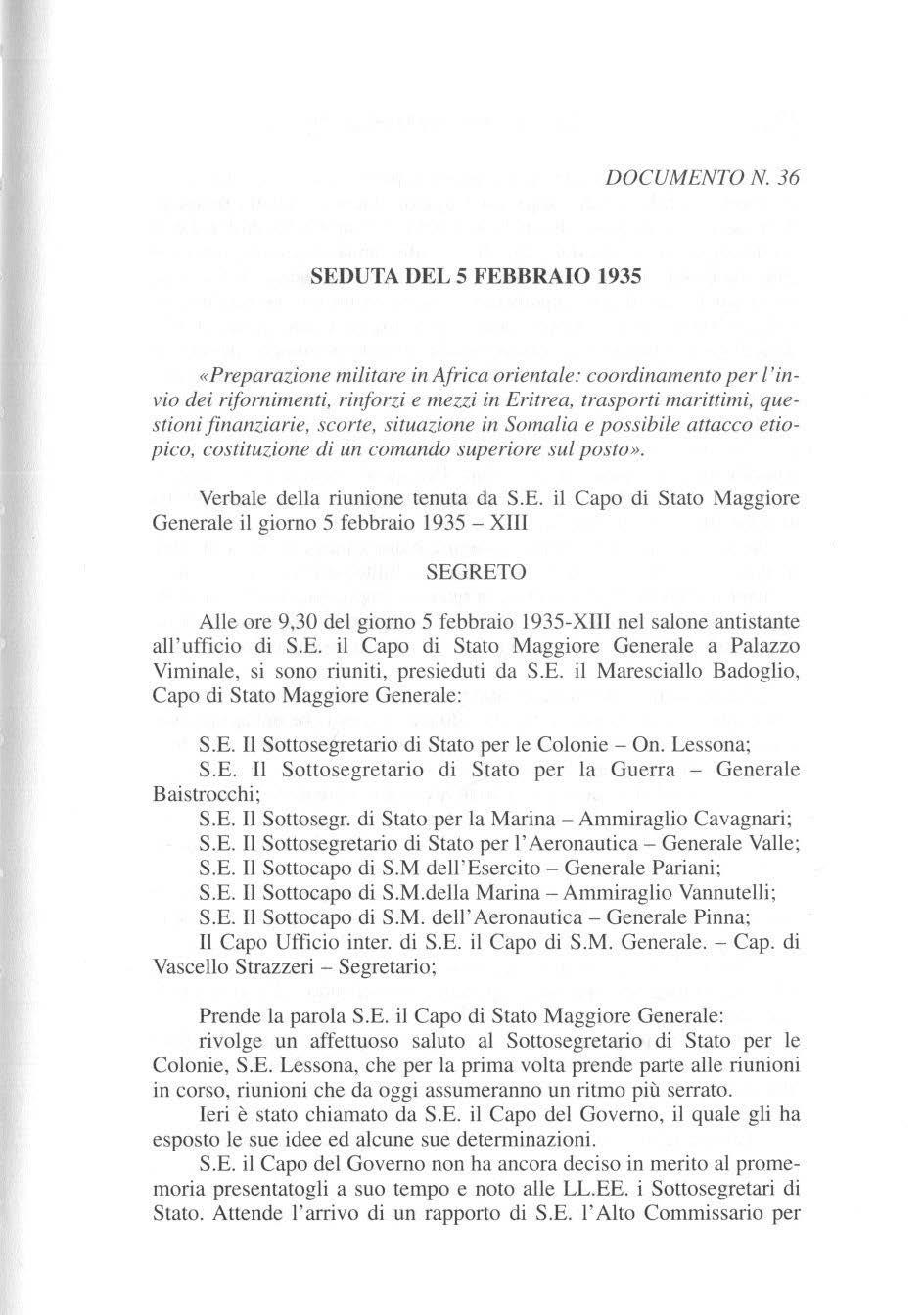
S.E. Il Sottocapo di S.M.della Marina -Ammiraglio Vannutelli;
S.E. 11 Sottocapo di S.M. dell'Aeronautica - Generale Pinna;
Il Capo Ufficio inter. di S.E. il Capo di S.M. Generale. - Cap. di Vascello Strazzeri - Segretario;
Prende la parola S.E. il Capo di Stato Maggiore Generale: rivolge un affettuoso saluto al Sottosegretario di Stato per le Colonie, S.E. Lessona, che per la prima volta prende parte alle riunioni in corso, riunioni che da oggi assumeranno un ritmo più serrato.
Ieri è stato chiamato da S.E. il Capo del Governo, il quale gli ha esposto le sue idee ed alcune sue determinazioni.
S.E. il Capo del Governo non ha ancora deciso in merito al promemoria presentatogli a suo tempo e noto alle LL.EE. i Sottosegretari di Stato . Attende l'arrivo di un rapporto di S.E. l 'Alto Commissario per
l'Afri ca O. Solo dopo aver visto questo rapporto ed averlo studiato c discusso con S.E. il Capo di Stato Maggiore Generale, po trà prend ere delle decisioni, in base a ll e quali si entrerà nel campo operativo. Però, fin d'ora, si preoccupa del fatto che la simultanea attività di numerosi enti, interessaci a provvedere all'invio di rin forzi e mezzi in Colonia, possa dar luo go ad uno s lega mento e quindi ad un minore rendim ento nella utilizzazione dei mezzi occorrenti. Ha quindi dato ordine a S.E. Badoglio di assume re la direzione di tale servizio per modo c he tutte le richieste che il Mini stero delle Colonie deve rivolgere ai Mini s teri , s iano indirizzate a Lui, che, dopo averle a rmonizzate, le passerà all'autorità competente.
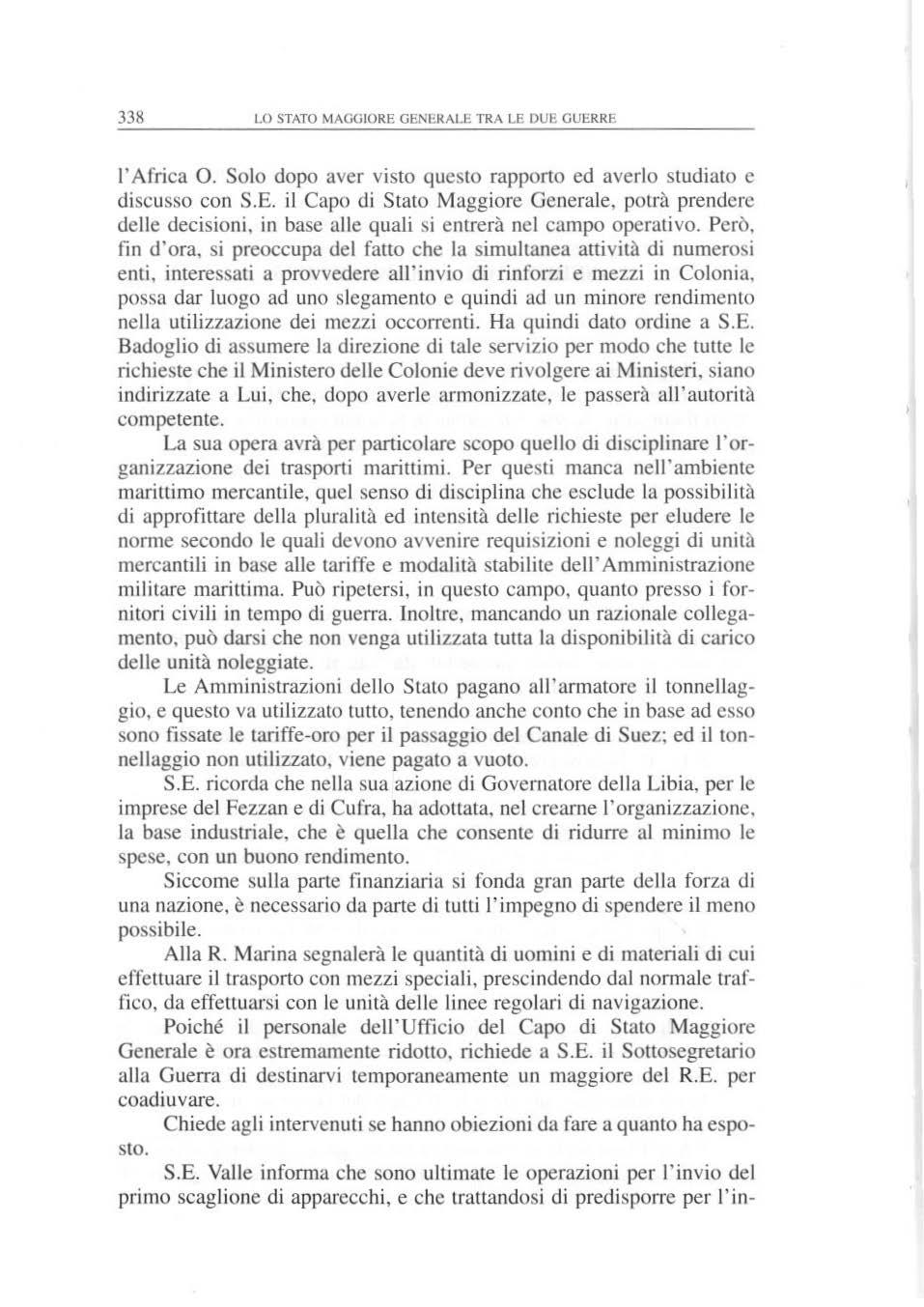
La sua ope r a avrà per particolare sco po quello di disciplinare l' organizzazio ne dei trasporti marittimi. Per que sti manca nell ' ambiente marittimo me rca ntile , quel se nso di disciplina che esc lude la possibilità di appro fittare della pluralità ed intensità delle richieste per e ludere le norme seco ndo le quali devono avv e nire requi s izio ni e noleggi di unità me rca ntili in base alle tariffe e modalità stabili te dell 'Ammini strazion e militare marittima. Pu ò ripete r s i, in questo campo, quant o presso i fornitori civ ili in tempo di g ue rra. In oltre, man ca nd o un razionale collegamento, può dars i che non ve nga ut iliaata tutta la disponibilità di carico delle unità noleggiate.
Le Amministrazioni de llo Stato pagano all ' armatore il to nnella ggio, e que sto va utilizzato tutto, tenendo anche con to che in base ad esso sono fissate le tariffe-oro per il p assaggio del Canale di Suez; ed il tonnellaggio non utilizzato, viene pagato a vuoto.
S.E. ri co rd a c he ne ll a s ua azione di Gov ernaLO re dell a Libia , per le imprese del Fezza n e di Cufra, ha adoltata, nel c rearne l'organizzazione, la base industriale, che è quella che consente di ridurre al minimo le spe se, con un buono rendimento.
Siccome s ulla parte finanziari a s i fonda gran parte della forza di un a nazione, è necessario da parte di tulti l'impeg no di spende re il meno po ss ibile.
Alla R. M arina seg nalerà le quantità di uo mini e di materiali di cui effe uuare il trasporto con mezzi special i, pre sc ind e ndo dal no rmale traffico , da effettuarsi con le unità delle linee rego lari di navi gaz ione
Poich é il personale dell'Ufficio del Capo di Stato Maggiore Generale è ora estremamente ridotto, ri c hiede a S.E. il Sottosegretario alla Guerra di destinarvi te mporan ea mente un maggiore del R.E . per coadiuvare.
Chiede ag li intervenuti se hanno obiezioni da fare a quanto ha esposto.
S.E. Vall e informa c he so no ultimate le o perazioni per l ' invio del primo scagl ione di apparecc hi, e che trattando s i di predisporre per l'in -
vio del secondo scaglione, avrebbe rivolto le necessarie richie ste di mezzi alla R. Marina. Seguirà ora la nuova procedura indicata da S.E. il Capo di S.M. Generale.
In questa occasione viene specificato che, per la completa utilizzazione del tonnellaggio noleggiato, sarà segnalato a tutti gli interessati la data di partenza delle navi e la disponibilità di tonnellaggio.
Si passa quindi a trattare la questione finanziaria.
S.E. Lessona informa come il Ministero d elle Finanze abbia dichiarato di essere disposto a far fronte a tutte le richieste inerenti alle attuali esigenze. Però le disponibilità di cassa fino a giugno sono molto esigue. In seguito ad una previsione sommaria del fabbisogno generale S.E. Les sona aveva chiesto, intanto, l 'accantamento della somma di 500 milioni; ma gli è stato risposto che tale somma per ora non è disponibile.
In base a ciò prospetta la necessità di addivenire ad una sistemazio ne transitoria:
Ridurre al minimo l'esborso immediato di questo primo periodo. Non si possono rimandare i pagamenti inerenti ad alcuni capitoli, e citando ad esempio, la nece ssi tà della R.Marina , sugger isce di effettuare le spese per il personale, le rate di noleggio , i consumi, i diritti di transito, ossia in linea generale, pagare le spese vive dei fornitori, rimandando o ratizzando ciò che costituisce il loro guadagno.
S.E. Cavagnari domanda se gli altri Ministeri hanno ottenuto assegnazioni straordinarie per questa esigenza.
S.E. Bai strocchj : l 'amm inistrazione della Guerra è in condizioni gravi. G li era s tata concessa una assegnazione globale di 172 milioni, da dividere in tre esercizi finanziari, ma non ha ancora ricevuto nulla.
Le assegnazioni del bilancio ordinario sono tutte assorbite, e le assegnazioni straordinarie, ridotte ora a soli 300 milioni , sono già tutte assegnate. Deve quindi ordinare a credito.
H a parlato della situazione attua le al Capo del Governo e della nece ss ità in cui potrebbe trovarsi, di sopprimere un corpo d'armata, diminuendo così la consistenza dell'Esercito. Egli ha incomindiato a separare le spese relative alla esigenza coloniale.
In tanto, in attesa di una decisione, cercherà di tirare avanti il più possibile. ·
S.E. Badoglio: poiché la questione finanziaria, date le circostanze, assume una specia le importanza, chiederà di essere ricevuto da S.E. il Capo del Governo.
Se dopo l'arrivo della relazione dell'Alto Commissario per l' A.O. l 'i nizio delle operazioni sarà deciso per il 1935, allora sarà necessario poter disporre dei fondi occorrenti.
S.E. Valle espone la situazione della sua aministrazione. Nel mentre la Ragioneria gli porta quotidianamente la situazio ne dei conti per la

parte normale, egli deve provvedere ad altre spese per cui non è possibile attendere il regolare perfezionamento dei contratti.
Egli ha già impegni superiori alle disponibilità di bilancio.
Anche l'Aeronautica deve quindi ordinare a credito. Le ditte potranno se del caso, maggiorare i prezzi aumentandoli degli interessi.
S.E. Cavagnari espone come la situazione dell 'Amministrazione militare marittima, in tema di di s ponibilità finanziarie sia altrettanto precaria.
Pochi mesi dopo l'inizio dell'ese rcizio del bilancio in corso già risultava che le disponibilità non erano sufficienti ed era prevedibile un deficit di circa 29 milioni.
La parte straordinaria del bilancio si conclude con la previ s ione di un deficit di 17 milioni.
Circa gli impegni da assumere ed alle spese da effettuare condivide l 'o pinione di S.E. Valle. Vi sono spese che debbono essere effettuate subito, ed impegni per i quali i pagamenti possono essere rinviati a giugno. J cantieri hanno offerto di assicurare lavori, spos tando i pagamenti a luglio.
Quindi non vi è speciale preoccupazione per l'ordinazione di materiali, mentre invece i pagamenti di ordine giornaliero debbono trovare immediato provvedimento. Vi è poi la questione delle scorte normali di dotazione, che possono essere intaccate solo se è possibile rimpiazzarle subito.
A suo parere, per quanto ha 1iflesso sulla R. Marina, le cifre occorrenti entro giugno non ri s ultano fot1i, rimanendo però se mpre nell'ambito dello scag lione di dieci piroscafi a reimpiego continuo. Si possono computare a 50 milioni circa.
S.E. Baistrocchi, circa alla questione delle sco rte , oggi asseconda ogni richiesta e continua ad inviare in Colonia ogni giorno del materiale. Però il Capo del Governo , nell'autorizzarlo a far ciò, gli ha ordinato di reintergrare al più presto le dotazioni, con un margine del 10 % in più. Egli esegue questo ordine nei limiti della po ssi bilità. Ma rimane viva la sua preoccupazione per l'integrità delle dotazioni normali in Patria.
Egli ha bisogno dell'assegnazione di 300 milioni per le spese ordinarie, e di 300 milioni per le spese s traordinarie.
S.E. Badoglio dichiara che l'argomento esula dalle sue possibilità di decisione. Pertanto chiederà udienza a S.E. il Capo del Governo per esporgli la situazione e per fargli presente come occorrono inderogabilmente assegnazioni di fondi per la reintegrazione delle scorte e per le spese vive che scaturiscono dalla preparazione coloniale attuamente in corso.
S.E. Les sona fa osservare che se si applica in modo razionale il procrastinarnento dei pagamenti per gli impegni che non comportino spese vive immediate, ne può risultare una disponibilità di cassa suffi-
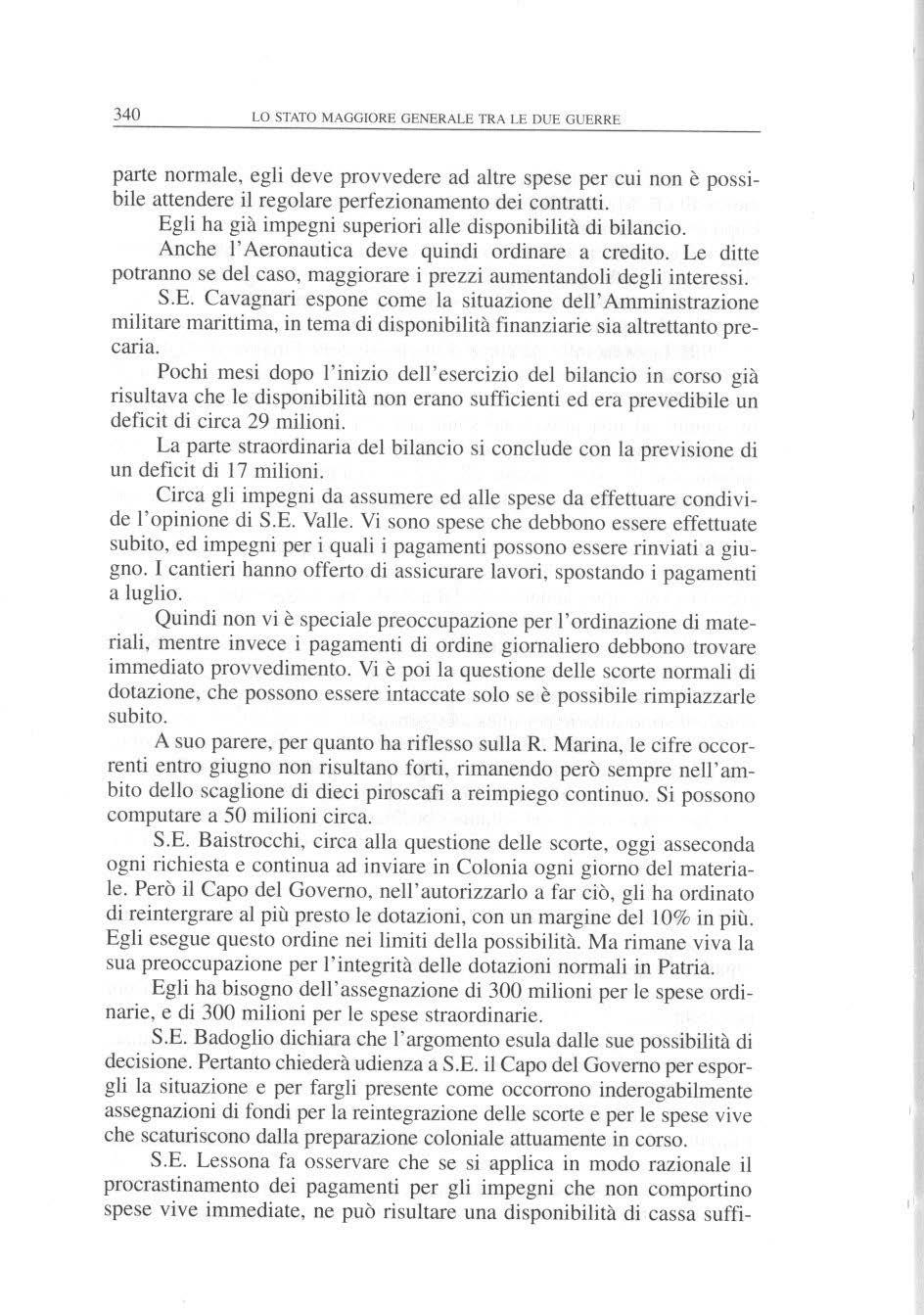
ciente per pagare le spese urgenti.
S.E. Valle dichiara di aver dovuto mettere uno stormo sul piede di guerra. Per affrontare le spese immediate ha stralciato le somme occorrenti dai capitoli che è possibile procrastinare.
S.E. Baistrocchi pensa che questa forma di dilazione può essere certo adottata, ma si tratta di questioni che debbono essere nettamente prospettate. Fino a ieri egli ha speso 131 milioni e ne ha avuto solo 55. Egli vede che i magazzini si vuotano. Se l'operazione si deve fare subito ci vuole subito il prestito. Se invece viene rimandata all'anno prossimo, allora si può rimediare con 1'organizzazione su accennata.
S.E. Badoglio prospetterà la cosa a S.E. il Capo del Governo che certo riunirà n1tti i Sottosegretari, il Ministro delle Finanze e il Ragioniere Capo dello Stato.
S.E. Valle ritornando sulla questione del reintegro delle scorte, espone come un aeroplano non si crea subito. Quelli inviati in Colonia potranno essere sostituiti nelle formazioni metropolitane nell'autunno 1936. Nei primi mesi del 1936 l'Armata Aerea attraverserà un periodo di sguarnimento. In tale periodo non dovrebbero verificarsi allarmi nè rendersi necessaria una mobilitazione.
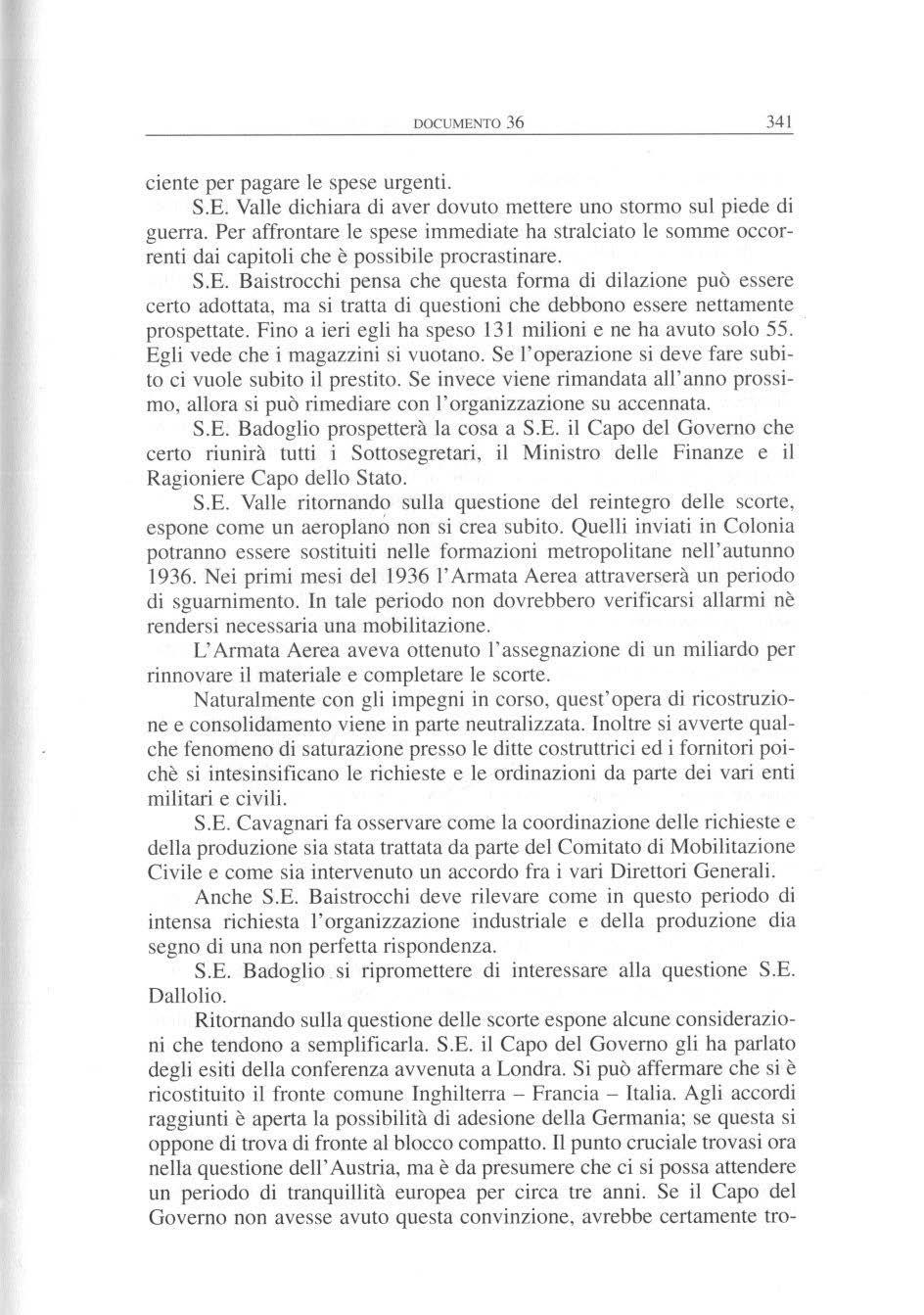
L'Armata Aerea aveva ottenuto l'assegnazione di un mmardo per rinnovare il materiale e completare le scorte.
Naturalmente con gli impegni in corso, quest'opera di ricostruzione e consolidamento viene in parte neutralizzata. Inoltre si avverte qualche fenomeno di saturazione presso le ditte costruttrici ed i fornitori poichè si intesinsificano le richieste e le ordinazioni da parte dei vari enti militari e civili.
S.E. Cavagnari fa osservare come la coordinazione delle richieste e della produzione sia stata trattata da parte del Comitato di Mobilitazione Civi le e come sia intervenuto un accordo fra i vari Direttori Generali.
Anche S.E. Baistrocchi deve rilevare come in questo periodo di intensa richiesta l'organizzazione industriale e della produzione dia segno di una non perfetta rispondenza.
S.E. Badoglio si ripromettere di interessare alla questione S.E. Dallolio.
Ritornando sulla questione delle scorte espone alcune considerazioni che tendono a semplificarla. S.E. il Capo del Governo gli ha parlato degli esiti della conferenza avvenuta a Londra. Si può affermare che si è ricostituito il fronte comune I nghilterra - Francia - Italia. Agli accordi raggiunti è aperta la possibilità di adesione della Germania; se questa si oppone di trova di fronte al blocco compatto. Il punto cruciale trovasi ora nella questione dell'Austria, ma è da presumere che ci si possa attendere un periodo di tranquillità europea per circa tre anni. Se il Capo del Governo non avesse avuto questa convinzione, avrebbe certamente tro-
vato la maniera di rimandare la soluzione del problema dell'Africa orientale. Se non ha agito in tale senso, vuol dire che è sicuro della tregua europea.
Pertanto se dobbiamo procedere a preparativi immediati bisogna dare a questi la precedenza in confronto alla questione della intangibilità e della ricostituzione delle scorte.
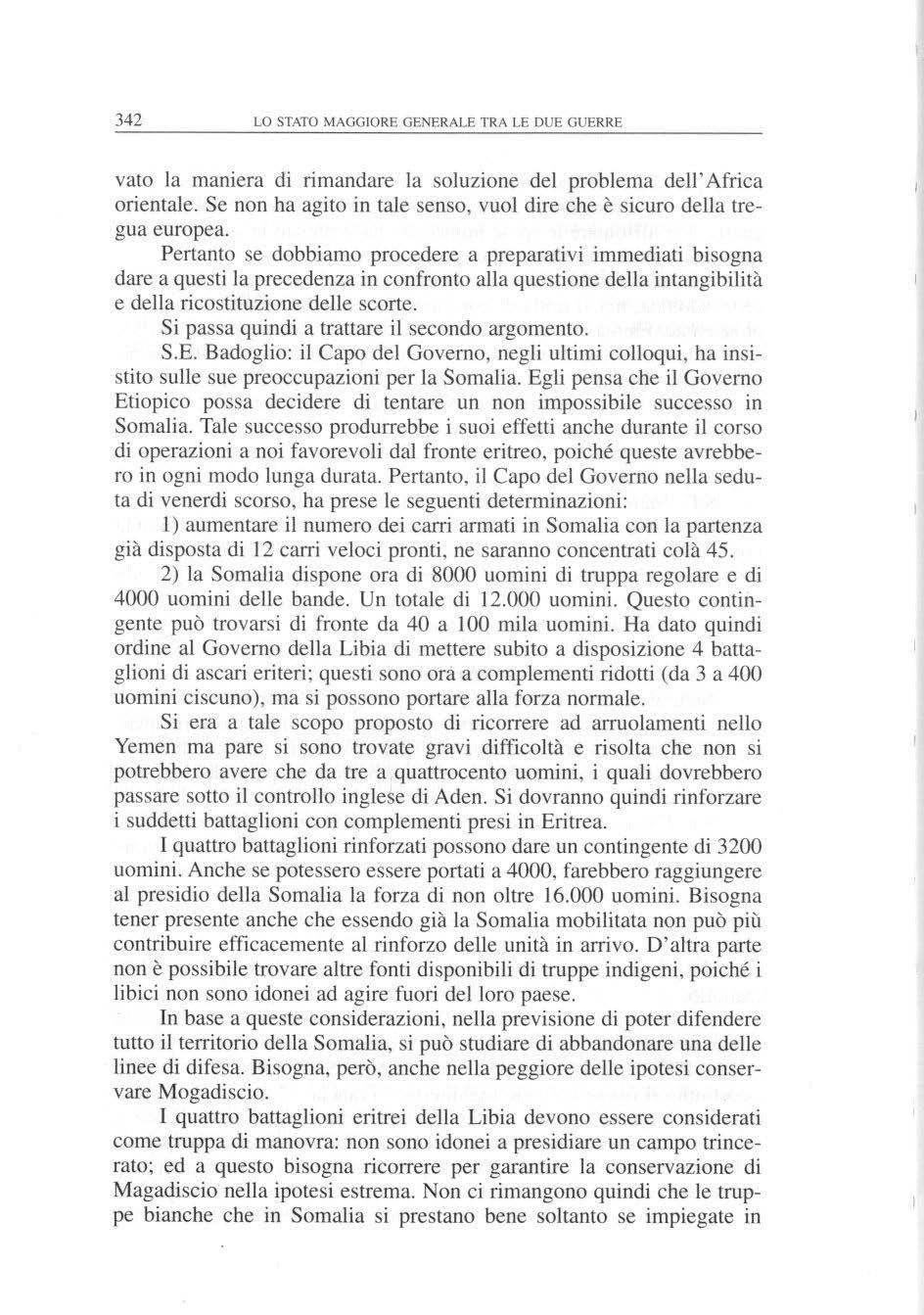
Si passa quindi a trattare il secondo argomento.
S.E. Badoglio: il Capo del Governo, negli ultimi colloqui, ha insistito sulle sue preoccupazioni per la Somalia. Egli pensa che il Governo Etiopico possa decidere di tentare un non impossibile successo in Somalia. Tale successo produrrebbe i suoi effetti anche durante il corso di operazioni a noi favorevoli dal fronte eritreo, poiché queste avrebbero in ogni modo lunga durata. Pertanto, il Capo del Governo nella seduta di venerdì scorso, ha prese le seguenti determinazioni:
l) aumentare il numero dei carri armati in Somalia con la partenza già disposta di 12 carri veloci pronti, ne saranno concentrati colà 45.
2) la Somalia dispone ora di 8000 uomini di truppa regolare e di 4000 uomini delle bande. Un totale di 12.000 uomini. Questo contingente può trovarsi di fronte da 40 a 100 mila uomini. Ha dato quindi ordine al Governo della Libia di mettere subito a disposizione 4 battaglioni di ascari eriteri; questi sono ora a complementi ridotti (da 3 a 400 uomini ciscuno), ma si possono portare alla forza normale.
Si era a tale scopo proposto di ricorrere ad arruolamenti nello Yemen ma pare si sono trovate gravi difficoltà e risolta che non si potrebbero avere che da tre a quattrocento uomini , i quali dovrebbero passare sotto il controllo inglese di Aden. Si dovranno quindi rinforzare i suddetti battaglioni con complementi presi in Eritrea.
I quattro battaglioni rinforzati possono dare un contingente di 3200 uomini. Anche se potessero essere portati a 4000, farebbero raggiungere al presidio della Somalia la forza di non oltre 16.000 uomini. Bisogna tener presente anche che essendo già la Somalia mobilitata non può più contribuire efficacemente al rinforzo delle unità in arrivo. D 'altra parte non è possibile trovare altre fonti disponibili di truppe indigeni, poiché i libici non sono idonei ad agire fuori del loro paese.
In base a queste considerazioni, nella previsione di poter difendere tutto il territorio della Somalia, si può studiare di abbandonare una delle linee di difesa. Bisog na , però, anche nella peggiore delle ipotesi conservare Mogadiscio.
I quattro battaglioni eritrei della Libia devono essere considerati come truppa di manovra: non sono idonei a presidiare un campo trincerato; ed a questo bisogna ricorrere per garantire la conservazione di Magadiscio nella ipotesi estrema. Non ci rimangono quindi che le truppe bianche che in Somalia si prestano bene soltanto se impiegate in
campo trincerato. Questo non è attualmente costituito: si sono solamente iniziati i lavori.
Occorrono almeno da sei a nove battaglioni di fanteria per presiedere il campo trincerato. Occorre quindi praticamente una divisione.
E qui si affaccia il problema delle forze.
Essendo necessario trasportare una divisione in Somalia, occorreche s ia perfettamente costituita ed a complementi completi.
Per completare una delle normali divisioni metropolitane del tempo di pace occorre raccogliere truppe da tutte le parti , e scombussolare tutto l'Esercito, la cui intelaiatura oggi ha la densità di una tela di ragno. Quindi si rende necessario procedere al completamento della divisione con chiamate precetto personale.

S.E. Lessona informa che S.E. il Capo del Governo prevedeva di dover mandare in Somalia dieci battaglioni di camicie nere
S.E. Baistrocchi espone come per la costituzione di ogni campo trincerato occorrano delle artiglierie, ed opina che le camicie nere non siano idonee a presidiare un campo trincerato.
D 'altra parte per costituire la divisione su accennata non occorre il richiamo di una classe, potendosi effettuare i richiami occorrenti per precetto personale.
S.E. Badoglio riassume decidendo che pro s petterà a\S.E. il Capo del Governo la opportunità di designare una divisione, portarla alla sua forza normale con richiami per precetto personale, e dotarla di una aliquota d'artiglieria di corpo d ' armata.
Viene quindi discusso un ultimo argomento:
Se si invia in Somalia una divisione completa diventa necessario prevedere laggiù un comando superiore. Occorre un comando di corpo d 'arma ta. Ed il comandante deve assumere il Governo della Somalia e la direzione delle operazioni militari.
Occorre quindi designare il comandante.
S.E. Baistrocchi prospetta l'opportunità di operare con criteri organici.
Se si stabilisce d 'inviare in Somalia una delle quattro divisioni già designate occoITe che questa abbia fin d'ora il suo comandante.
Egli ha in compilazione un elenco di nomi tra cui scegliere il comandante di corpo d'armata e i comandanti delle divisioni già designate; ciò nell'intesa che l'uomo idoneo và lasciato al suo posto, e quello non idoneo va sostituito subito.
S.E. Badoglio si riserva pertanto di proporre a S.E. il Capo del Governo i nomi, ed informarlo che il Ministero della Guerra stà provvedendo all'inquadramento delle divisioni designate e della quinta divisione in costituzione.
S.E. Lessona suggerisce l'opportunità che il comandante di corpo
d'armata da inviare in Somalia possegga i requisiti e le virtù civili occorrenti anche per espletare funzioni di Governo.
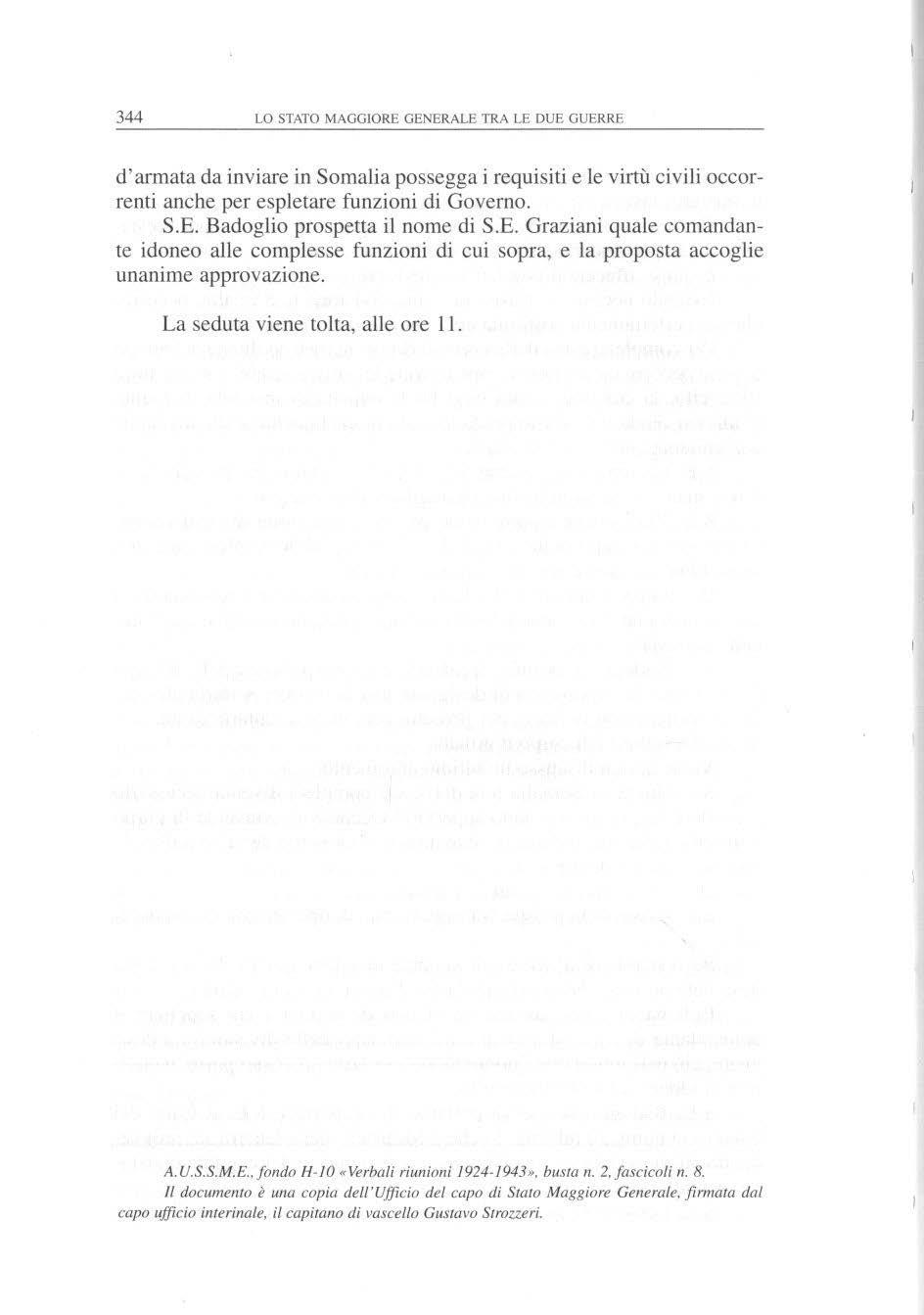
S.E. Badoglio prospetta il nome di S.E. Graziani quale comandante idoneo alle complesse funzioni di cui sopra, e la proposta accoglie unanime approvazione.
La seduta viene tolta, alle ore 11.
A. U.S.S.M.E .fondo H-10 «Verbali riunioni 1924-1943». busta 11. 2.fascicoli 11. 8. Il doc11menro è una copia dell'U.!Jìcio del capo di Sraro Maggiore Ge11erale. firma/a dal capo 11fficio inrerinale, il capira110 di vascello Gusiavo Srroz;,eri.
«Prepara zione militare in Africa orientale: relazione dell'alto commissario (generale De Bono); questioni relative alla Somalia: invio rinforz i ( Ja divisione metropolitana e battaglioni eritrei dalla Libia), forza presente, campo trincerato di Mogadiscio, trasporti marittimi di uomini e mezz i, in vio del generale Gra ziani ».
Verbale della Riunione tenuta da S.E. il Capo di Stato Maggiore Generale il giorno 8 febbraio 1935 - XlII
Alle ore 9,30 del giorno 8 febbraio 1935 - Xill, nel salone antistante all ' ufficio di S.E. il Capo di Stato Maggiore Generale, a Pala zzo Viminale, s i so no riuniti, presieduti da S.E. il Maresciallo Badoglio, Capo di Stato Maggiore Generale:
S.E. il Sottosegretario di Stato per la Guerra , Generale Baistrocchi
S.E. il Sottosegretario di Stato per la Marina, Ammiraglio Cavagnari
S.E. il Sottosegretario di Stato per l'Aeronautica, Generale Valle
S.E. il Sottocapo di S.M. dell'Esercito, Generale Pariani
S.E. il Sottocapo di S.M. della Marina, Ammiraglio Vannutelli
S.E. il Sottocapo di S.M. dell'Aeronautica, Generale Pinna
F.f. Capo Ufficio Militare Ministero Colonie, Maggiore Ferrara
il Capo Ufficio inter. di S.E. il Capo di S.M. Generale , Capitano di Vascello Strazzeri, Segretario
Prende la parola S.E. il Capo di Stato Maggiore Generale, informando di aver avuto copia della relazione che S.E. l'Alto Commissario per l' A.O. ha inviata al Capo del Governo. Dà lettura di tale documento. Rileva come esso non costituisca una messa a punto precisa dello stato di preparazione delle Colonie orientali né della loro possibilità difensiva ed offensiva. Contiene invece richieste specifiche di grandi unità di rinforzo.
In base a ciò, S.E. il Capo del Governo ha telegrafato per richiedere precisazioni ed anche S.E. Badoglio ha rivolto a S.E. De Bono , tele-

graficamente, tre domande, su punti sostanziali riflettenti la possibilità di vita e di azione in Colonia, delle truppe da inviare.
Anche di tale telegramma viene data lettura. Passa quindi a trattare in modo particolare del problema della Somalia. Ricorda ancora i provvedimenti disposti da S.E. il Capo del Governo.
In seguito all'invio in Somalia di una divisione metropolitana e dei 4 battaglioni eritrei della Libia, completati in Eritrea, la situazione colà sarà questa:
Presidio del campo trincerato di Mogadiscio
Truppa regolare mobile di colore
Bande
Carri armati veloci
Apparecchi (R. Aeronautica)
l divisione
12.000 uomini
4.000 uomini 45 50
Ha esaminato la situazione generale insieme al Generale Graziani ; è stata ammessa la possibilità di abbandonare, all'occorrenza, gran parte del terTitorio Somalo; e confermata l'assoluta necessità, della organizzazione del campo trincerato, che costituirà il solido appoggio necessar io alle truppe operanti in Somalia.
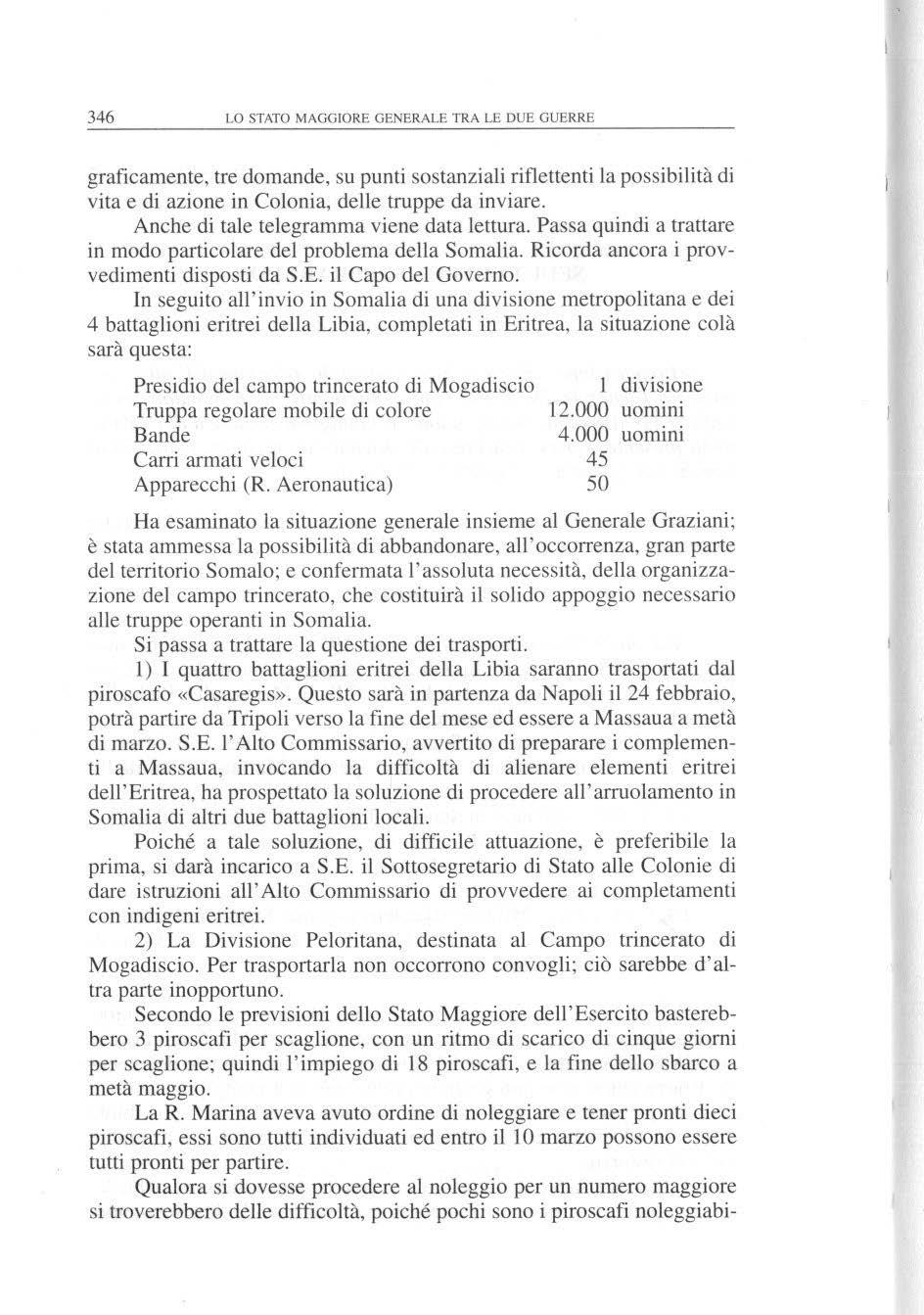
Si passa a trattare la questione dei trasporti.
l) I quattro battaglioni eritrei della Libia saranno trasportati dal piroscafo <<Casaregis». Questo sarà in partenza da Napoli il 24 febbraio, potrà partire da Tripoli verso la fine del mese ed essere a Mas sa ua a metà di marzo. S.E. l ' Alto Commissario, avvertito di preparare i complementi a Massaua, invocando la difficoltà di alienare elementi eritrei dell'Eritrea, ha prospettato la soluzione di procedere all'arruolamento in Somalia di altri due battaglioni locali.
Poiché a tale soluzione, di difficile attuazione, è preferibile la prima, si darà incarico a S.E. il Sottosegretario di Stato alle Colonie di dare istruzioni all'Alto Commissario di provvedere ai completamenti con indigeni eritrei.
2) La Divisione Peloritana, destinata al Campo trincerato di Mogadiscio. Per trasportarla non occorrono convogli; ciò sarebbe d 'altra parte inopportuno.
Secondo le previsioni dello Stato Maggiore dell'Esercito bas terebbero 3 piroscafi per scaglione, con un ritmo di scarico di cinque giorni per scaglione; quindi l ' impiego di 18 piroscafi, e la fine dello s barco a metà maggio.
La R. Marina aveva avuto ordine di noleggiare e tener pronti dieci piroscafi, essi sono tutti individuati ed entro i I I O marzo possono essere tutti pronti per partire.
Qualora si dovesse procedere al noleggio per un numero maggiore si troverebbero delle difficoltà, poiché pochi sono i piroscafi noleggiabi-
li che abbiano autonomia sufficiente per arrivare a Mogadiscio. Non s i potrebbe forse raggiungere che il numero di 15.
Si studia allora come possa essere risolto il problema.
La Divisione Pelo ritana data la sua speciale funzione di presidio al Campo trincerato, può ridurre il fabbisogno di quadrupedi ad 800, portando gli automezzi a 50.
T reparti ed il materiale sono pronti a partire a cominciare dal 14 febbrajo.
Confrontando le possibilità offerte dai piroscafi previsti, con le esigenze impo s te dalla forza dei reparti, dai quadrupedi e dal materiale, si vede come essi a prima vista non risultino sufficienti. Si esamina a tal uopo l'elenco dei piroscafi designati dalla R. Marina, ed alcuni si escludono dal viaggio a Mogadiscio per insufficiente autonomia.
Dato che l'ordine per ora è di noleggiare, e non di requisire i piroscafi, si esamina quale situazione si presenterebbe se fosse data l'autorizzazione di procedere a requisizione. Ed anche in questo caso la soluzione non si presenta molto facile, soprattutto come celerità di esecuzione dei trasporti, essendo i piroscafi da requisire attualmente in servizio sulle linee regolari, e dovendone attendere la disponibilità per procedere. Si esamina la possibilità di util izzare il piroscafo «Oceania», che potrebbe da solo trasportare fino a 5.000 uomini. P oiché con questo si potrebbe facilitare molto la so lu z ione del problema, si decide di ferma-· re senz'altro I' «Oceania» al suo ritorno in patria, per utilizzarlo.

Ammessa la disponibilità del!' «Oceania», che potrebbe esse r e pronto entro il 10 marzo, si vede come con il solo primo viaggio s i potrebbero inviare oltre 11.000 uomini: ma sorge allora la questione delle difficoltà di sbarco e di accasermamento. Però dato che non tutti i piroscafi hanno lo stesso ciclo-viaggio, ma che questo varia da un mese a 40 giorni, effettuando anche la partenza con tempora nea si avrebbe uno scagl ionam e nto automatico all'arrivo.
I n base a tutti questi elementi si giunge a fissare un primo stato di previsione.
Piros cafi: «Gange», Belvedere, Leonard o da Vinci, Sauro, Batti st i ~
Capacità-viaggio: uomini 6.000;
Capacità 2 viaggi: uomini 12.000;
trasportati entro 54 giorni dalla prima partenza.
Piroscafo: «Oceani a»;
Capacità-viaggio: uomini 5.000;
trasportati entro 15-20 giorni dalla partenza.
Total e 18.000 uomini circa entro la metà di aprile.
Rimane quindi stabilito che: Utilizzando subito il piroscafo «Oceania>>, che ha grande capacità, si può prevedere il trasporto della divisione ultimato per la fine di aprile.
Si osserva come il piroscafo <<Arabia» possa da solo trasportare molti quadrupedi, direttamente a Mogadiscio. I materiali pesanti possono essere mandati a mezzo piroscafi da merci, con ritmo più lento. L'imbarco nelle basi di partenza non presenta difficoltà.
Si prendono poi in esame le altre necessità concomitanti:
a) piroscafi necessari per la R. Aeronautica, oltre al California ed all'Aussa;
b) mezzi per il trasporto delle 2000 camicie nere.
S.E. Valle fa osservare che per mandare gli apparecchi in volo a Mas saua occorre svolgere subito l'azione diplomatica necessaria per poter addivenire all'assegnazione delle tappe in Egitto e nel Sudan.
A fine febbraio partono due piroscafi con a bordo i cassoni degli apparecchi. Vanno a Massaua ove i 30 apparecchi vengono montati e, quando pronti, pro seguono in volo per Mogadiscio.
Però prescindendo da questi piroscafi con a bordo i cass oni degli apparecchi, occorre per le tre basi aeree un bastimento per ciascuna, con 300 uomini e tante tonnellate di materiali. Ogni piroscafo fa la spola tra i porti italiani e la sua base fino a tutto ottobre, mentre il California e l' Aussa servono solo per Mogadiscio , ove tutto deve essere sbarcato entro giugno per ragioni di praticabilità della costa.
Circa il problema del trasporto delle CC.NN. per i lavori stradali dell'Eritrea, viene fatto presente che è già ipotecato il «Gange» che in un primo tempo va detratto dai piroscafi utilizzabili per la Divis ione Peloritana.
Si riaffaccia poi la questione del tonnellaggio occorrente per l'Eritrea; e S.E. Baistrocchi fa notare come, provveduto al trasporto delle truppe e loro materiali di dotazione, occorre poi pensare ai viveri , alle munizioni ed al rifornimento normale.
S.E. Badoglio richiama i presenti al punto di vista iniziale confrontandolo con lo sviluppo assunto oggi dalla questione.
Si sta esaminando ora il trasporto di reparti e mas se di materiali che costituiscono praticamente la metà delle grandi unità cui si 1ìferivano gli studi precedenti. Si era parlato allora di 90 piroscafi.
Di sponendo solo dei piroscafi attuali e limitandoci al sistema del noleggio, abbiamo visto come occorrano i mesi di marzo ed aprile per trasportare in Somalia una divisione; occorreranno i mesi di maggio e giugno per trasportare l'altra divisione in Eritrea. Se si vuole accelerare , allora occorre l'ordine di requisizione dei piroscafi: questo significa passare allo stato di guerra.

Si riapre pertanto la discussione sulla celerità e 'ìulle modalità dei trasporti.
Vengono affacciate le seguenti considerazioni:
a) Il piroscafo Gange è già impegnato per il trasporto delle CC.NN., la cui presenza è indispensabile in Eritrea per i lavori stradali:
b) Per la Somalia è necessario far precedere l'invio dei servizi, per rendere possibile l'arrivo e la vita delle truppe;
c) Nello stato di previsione. risultato in primo tempo per alcuni piroscafi, si prevede solo un ciclo viaggio;
d) Che quindi uno di essi può essere adibito esclusivamente al traspo rto materiali;
e) Che il materiale pesante non si scarica né presto né agevolmente; occorre quindi un piroscafo a parte;
f) Che si può ricorrere all'ausilio dei piroscafi di linea per il trasporto di truppe e di materiali; essi sono già stat i organizzati per questo e si sono già stabil ite le tariffe.
S.E. Badoglio, tendendo alla conclusione, afferma che. con i dovuti accorgimenti, con accordi fra R. Esercito e R. Marina , si può assicurare S.E. il Capo del Governo che entro il mese di aprile, il grosso della Divisione Peloritana è sul posto e che dopo questi due mesi si può ini7iare l'invio di una divisione in Eritrea, cd a metà di giugno tutto sarà effettuato.

Se S.E. il Capo del Governo decide di accelerare, allora s i rende necessaria la requisiLione.
S.E. Cavagnari prospetta la possibilità di prelevare dei piroscafi dalle lince regolari, senza una vera e propria requisizione. Però il vantaggio che si otterrebbe, nel tempo , non sarebbe molto sensibile, poiché bisogna attendere per ogni piros cafo il termine del v ia ggio in cui è impegnato.
S.E. Badoglio conclude la discussione sta bilendo i seguenti punti, c he egli presenterà a S.E. il Capo del Gov erno:
l) Il trasporto delle 2000 camicie nere per Massaua sarà fatto nel tempo richie sto. Partiranno il giorno 18 corrente.
2) li trasporto dei quattro battaglioni eritrei della Libia sarà effettuato, avvertendo però S.E. De Bono che è necessario preparare i loro co mplementi e tenerli pronti a Ma ssaua per 1·imbarco.
3) Che per il trasporto della divisione in Somalia, noleggiando anche il piroscafo «Oceania» ed utilizzando il carico dei postali, occorrono i me s i di marzo ed aprile e qualche giorno di maggio.
4) Che solo dopo avere effettuato il tras porto della divisione in Somalia, sarà possibile trasportare in 45 giorni la divi s ione in Eritrea, ultimando così il trasporto di questa divisione fra il 15 cd il 30 giugno.
5) Che la R. Marina si impegna a mettere a disposizione della R. Aeronautica oltre ai due piroscafi di cui dispone g ià , altri tre piroscafi idonei.
6) Se si vuole accelerare questi tempi , essenzialmente per quanto riguarda il trasporto della divisione in Eritrea, non essendo possibile ridurre i tempi per il trasporto della divisione in Somalia, per le condizio ni di sbarco, occorre che la R. Marina abbia l ' autorizzazione di procedere ad un più esteso noleggio di piro scafi, effettuato d'autorità , riducendo i servizi delle linee regolari e sovvenzionate, in tutte le direzioni , larvando così una vera requisizione di piroscafi.
7) Invitare il Ministero delle Comunicazioni a dare ordine che tutte le linee di navigazione, c he passano per il Mar Rosso , assumano carichi, e l'obbligo di scalo a Massaua, quando richiesto.
S.E. Valle chiede se il contingente aereo per la Somalia deve essere tutto raggruppato a Mogadiscio.
S.E. Baistrocchi fa rilevare come al punto a cui è giunto lo studio e la esecuzione iniziale dei provvedimenti per l'esigenza A.O. ritiene che debbano entrare ormai in esercizio le funzioni s pecifiche del Corp o di Stato Maggiore del R. Esercito.
S.E. Badoglio ris ponde delucidando ampiamente i seguenti due concetti :
a) Che è stato deciso l ' invio in Somalia di S.E. il Generale Graziani; in bas e alle sue future propo s te saranno prese le più opportune disposizioni;
b) Che il problema globale dell'Africa orienta le è tuttora nella sua fase di preparazione e che per ora possono funzionare gli enti del Ministero delle Colonie.

Ma non appena si entrerà in pieno nella parte esecutiva allora sarà lo Stato Maggiore del R. Esercito ad assumere la completa direzione.
La seduta viene tolta alle ore 11.15 .
1) U trasporto delle 2000 camicie nere per Massaua sarà fatto ne l tempo richiesto. Partiranno il giorno 18 corrente.
2) Il trasporto d e i 4 battaglioni eritrei della Libia sarà effettuato, avvertendo però S.E. De Bono che è necessario preparare i loro complementi e tenerli pronti a Massaua per l'imbarco.
3) Che per il trasporto della divi s ione in Somalia, noleggiando anche il piroscafo «Oceania» ed utilizzando il carico dei postali, occorrono i mesi di marzo ed aprile e qualche giorno di maggio.
4) Che solo dopo aver effettuato il trasporto della divisione in Somalia sarà possibile trasportare in 45 giorni la divisione in Eritrea, ultimando così il trasporto di qu esta divisione tra il 15 e il 30 giugno.
5) Che la R. Marina si impe gna a meltere a disposizione della R. Aeronautica, oltre ai due piroscafi di cui dispone già, altri tre piroscafi idonei.
6) Se si vuole accelerare questi tempi, essenzialmente per quanto riguarda il trasporto in Eritrea, non essendo possibile ridurre i tempi per il tra5porto della divisione in Somalia. per le condiz ioni di sbarco, occorre che la R. Marina abbia l'autoriZLazione di procedere ad un più esteso noleggio di piroscafi, e ffettuando d'autorità, riducendo i se rvizi delle linee regolari e sovvenzionate, in tutte le direzioni. larvando così una vera requisizione di piroscafi.
7) Invitare il Ministero delle Comunicazioni a dare ordine che tutte le linee di navigazione, che passano per il Mar Ro sso, assumano carichi, e l'obbligo di scalo a Mas5aua, quando richiesto.
Il documento è 1111a copia dell'Ufficio del capo di Swto Maggiore Generale. Oltre al 1•erbale ,lei/a riu11ione .1i pubblica110 di seguito a11che le cm1cl11sio11i. le q11ali , 11el fascicolo n. 8, si presema1•a110 u11i1e allo Jtesso i erbale


«Preparazione militare in Africa orientale: questioni relative alle basi di Napoli, Messina, Siracusa, Massaua e Mogadiscio (operazioni Logistiche per Le unirà indigene e metropolitane e loro direzione da parte dello Stato Maggiore dell'Esercito), procedura da seguire per le richieste e spedizioni. di materiali, munizioni, servizio cartografico e servizio informazioni, coordinamento generale, trasporti complementi del Regio Corpo Truppe Coloniali».
Conclusioni raggiunte ne lla riunion e tenuta da S.E. il Capo di Stato Maggiore Generale a Palazzo Viminale il 15 febbraio 1935 - XIII
Pre senti:
S.E. il Sottosegretario di Stato per le Colonie, Lessona
S.E. il Sottosegretario di Stato per la Guerra, Gen. Baistrocchi
S.E. il Sottocapo di S.M. dell'Esercito, Generale Pariani
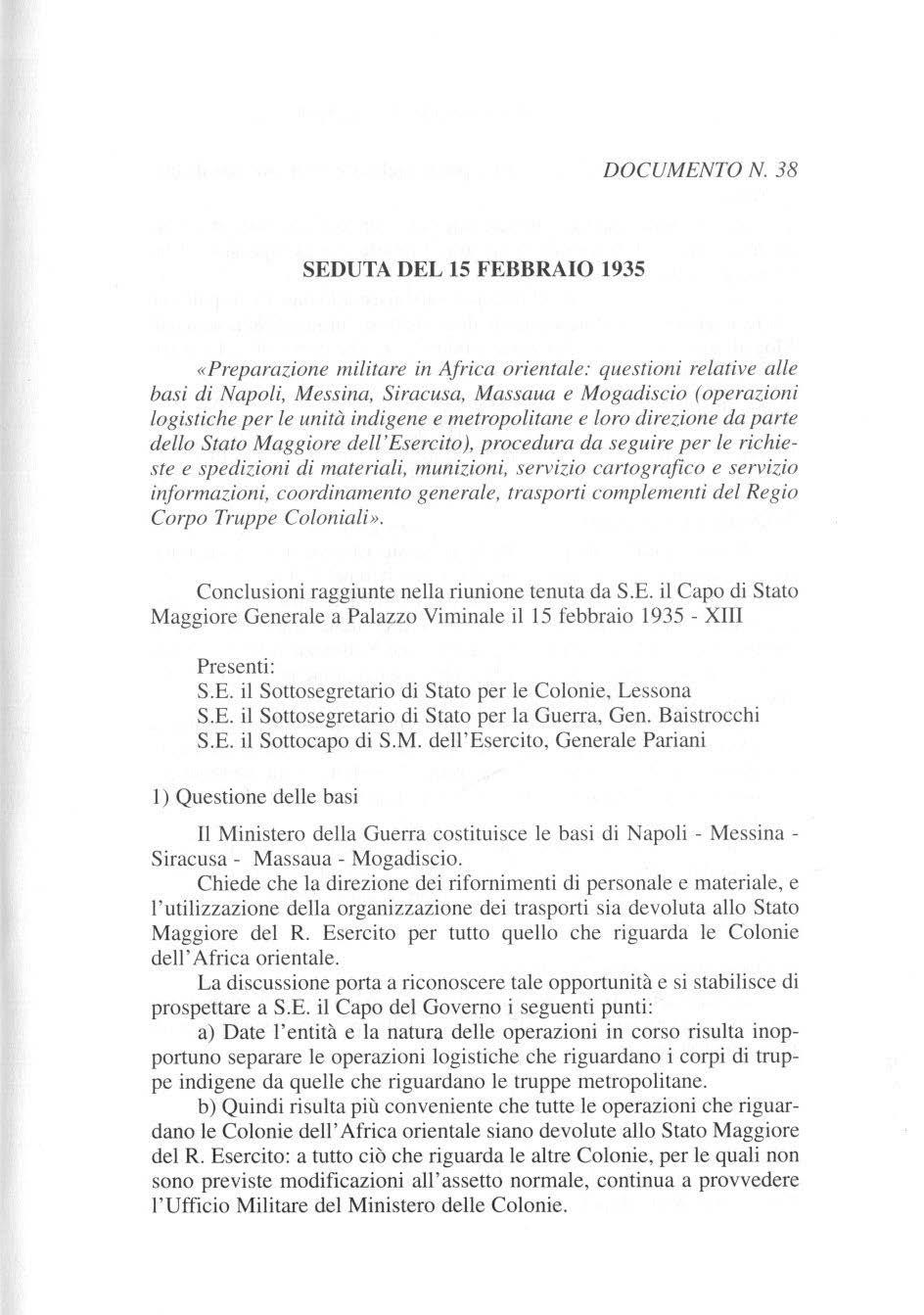
li Ministero della Guerra costituisce le basi di Napoli - MessinaSiracusa - Massaua - Mogadiscio.
Chiede che la direzione dei rifornim enti di personale e materiale, e l 'u tilizzazione della organizzazione dei trasporti sia devoluta allo Stato Maggiore del R. Esercito per tutto quello che riguarda le Colonie dell 'Afr ica orientale.
La discussione porta a riconoscere tale opportunità e si sta bilisce di prospettare a S.E. il Capo del Governo i seg uenti punti:
a) Date l'entità e la natura delle operazioni in corso risulta inopportuno separare le operazioni logi st iche che riguardano i corpi di truppe indigene da quelle che riguardano le truppe metropolitane.
b) Quindi risulta più conveniente che tutte le operaz ioni che riguardano le Colonie dell'Africa orientale siano devolute allo Stato M aggiore del R. Eserci to: a tutto ciò che riguarda le altre Colonie, per le quali non so no previste modificazioni all 'ass etto normale, continua a provvedere l'Ufficio Militare del Minis tero delle Colonie.
2) Questione procedura da seguire per le richieste e spedizione di materiali
a) Forniture materiali. Poiché tali richieste confluiscono, in ultima analisi, tutte al Ministero della Guerra, è inutile che esse passino attraverso altri enti.
b) Trasporti materiali. Il materiale affluisce aJJe basi metropolitane del R. Esercito: da queste viene spedito alle basi militari di Massaua e di Mogadiscio ove entra in funzione l'Intendenza che provvede alla distribuzione in sede.
Il Ministero della Guerra provvederà pertanto alla soddisfazione delle richieste e terrà al corrente in pari tempo S.E. il Capo di Stato Maggiore Generale ed il Ministero delle Colonie. Ciò vale anche per le date di partenza ed i nomi e la capacità dei piroscafi adibiti.

3) Questione munizioni
Resta stabilito che per tutte le richieste riferentisi al munizionamento, per quei tipi che non so no più in servizio nel R. Esercito ma so ltanto nelle Colonie, alle quali il Ministero della Guerra non può dare immediata evasione mediante le scorte metropolitane, s i provvederà con prelievi dalla Colonia libica che è ampiamente attrezzata, provvedendo in pari tempo a ripristinare con opportuna sollecitudine le dotazioni libiche con lo stesso tipo di materiale prelevato.
Lo stesso procedimento sarà seg uito per il materiale d 'artigl ieria richiesto per le batterie da 77/28. Il Ministero delle Colonie è incaricato di redigere un elenco di tutto il materiale d'artiglieria e munizionamento che forma le dotazioni della Libia e Io trasmette al Ministero della Guerra.
Similmente il Ministero delle Colonie darà istruzioni all'Alto Commissario del!' Africa orientale affinché tutte le comunicazioni riferentisi s pecialmente a richieste di materiali in genere s iano dirette al Ministero della Guerra.
4) Questione servizio cartografico
Per tale se rvizio si dà incarico al Mini s tero della Guerra di provvedere alla esecuzione ed alla anticipazione delle spese, redigendo apposita contabilità separata.
5) Questione servizio Informazioni
Si dà incarico al Ministero della Guerra di riferire sull'argomento a S.E. il Capo del Governo , allo scopo di ottenere la sanzione per l'ampliamento dello speciale ramo del Servizio Informazioni , già istituito per l'evenienza A.O., il quale dà già importanti risultati.
6) Questione coordinamento generale
Si constata come presso gli organi centrali, a Roma, il coordinamento per l'esigenza A.O. sia oggi perfetto ed encomiabile. Allo scopo di raggiungere lo stesso risultato nel campo d'azione dell'Alto Commissario per l' A.O. si provvederà ad invitare S.E. il Gen. De Bono a costituirsi uno stato maggiore regolare, affinché le varie attività, per quanto si riferisce al servizio logistico, assumano un ritmo organico.
7) Questione trasporto complementi R.C.T.C.

Si dà incarico a S.E. Lessona di informare S.E. l'Alto Commissario, che per la disponibilità attuale di mezzi di trasporto, potrà raggiungere la sede di Massaua, entro il 20 aprile, un'aliquota soltanto dei rinforzi richiesti, e predisposti , onde l'Alto Commissario faccia conoscere se è necessario che altri provvedimenti siano adottati allo scopo di far pervenire in colonia, per detta epoca, la totalità dei complementi stessi.
A.U.S S.M.E.,fondo H-/0 «Ve rbali riunioni 1924 - 1943», busta n. 2,fascicolo 11. 8. li documento è una copia dell'Ufficio del capo di Stato Maggiore Generale, ma 11011 è il verbale, bensì una sintesi con le conclusioni raggiunte alla riunione del J5.2.1935.
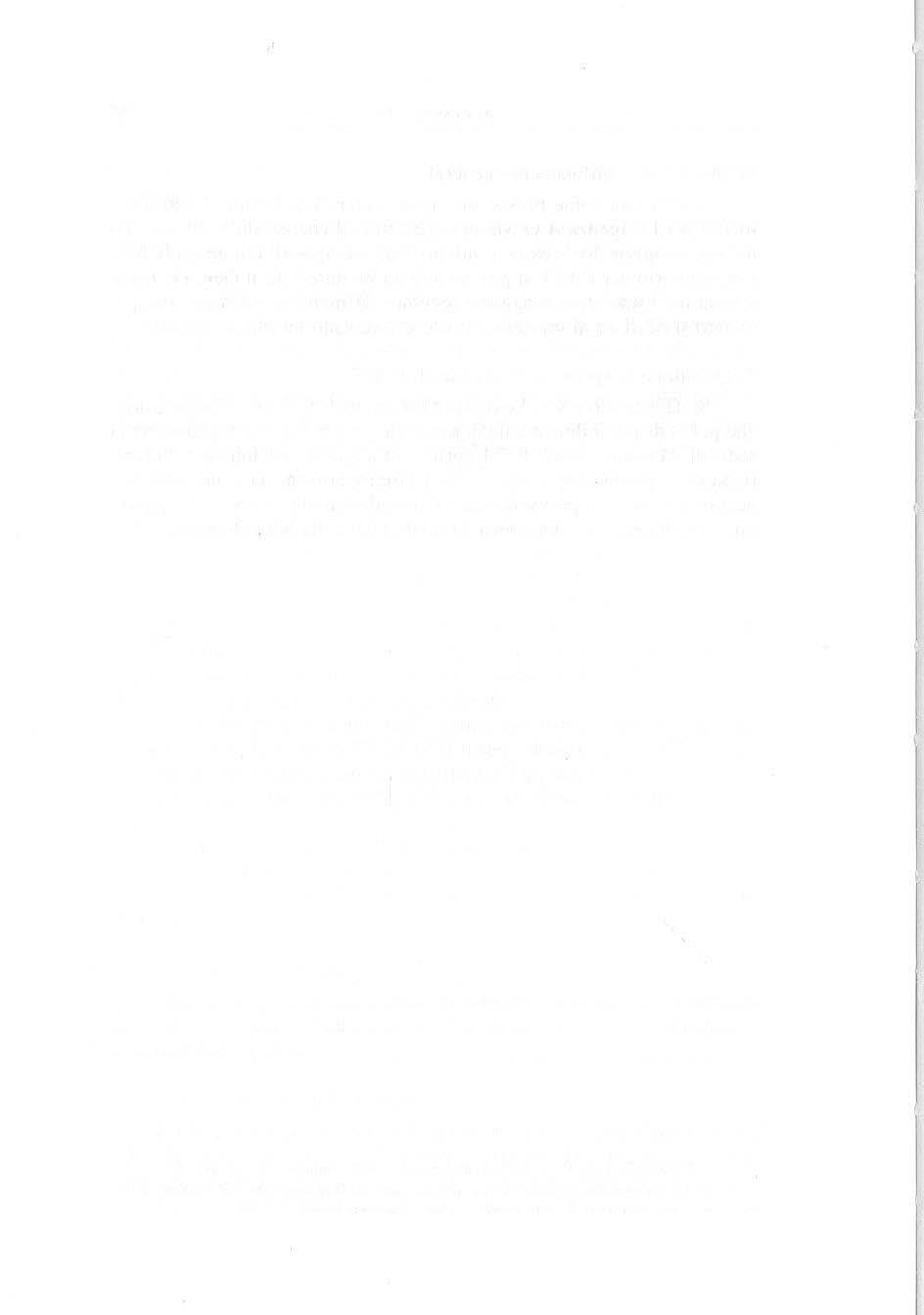
« Prepara zione militare in Africa orientale: riduzione quadrupedi per le truppe coloniali, baraccamenti per la Divisione Gaviniana e la Division e Sabauda, trasporti marittimi e requisizione dei piroscafi per le linee oceaniche, basi di sbarco di Massaua e Zula».
Conclusioni adottate nella seduta del 22 febbraio 1935 - Xlll
1° argomento
Interessare S.E. l'Alto Commissario per l' A.O. alla riduzione del numero dei quadrupedi richiesti per i complementi al R.C.T.C. , portando per ora tale numero da 7.000 a 4.000, ossia contemplando un fabbisogno di 2.000 quadrupedi per divisione.

2 ° argomento
Interessare S.E. l'Alto Commissario perché segnali qual è il numero di baracche pronte che gli occorre siano spedite per avere la sicurezza che tutti gli uomini ed i quadrupedi della Divisione «Gaviniana» e dei complementi per il R. Corpo troveranno ricovero per la stag ione delle piogge.
3 ° argomento
Se può costruire i baraccamenti s ufficienti al ricovero delle truppe della 3• Divisione («Sabauda»), in modo da rendere possibile l'inoltro di questa divisione a Massaua durante la stagione delle piogge.
4 ° argomento
Con la disponibilità attuale di mezzi per i trasporti marittimi, ricorrendo anche alla utilizzazione dei piroscafi di linea regolare del Lloyd
Triestino, non si può arrivare a mettere a terra a Massaua la Divisione «Gaviniana» ed i complementi, che per la fine di maggio.
5 ° argomento
Qualora S.E. il Capo del Governo ritenesse indispensabile che queste truppe fossero a posto per fine aprile, occorrerebbe la requisizione d 'imperio di grossi piroscafi delle linee oceaniche.
6° argomento
Occorre sollecitare S.E. l'Alto Commissario perché le basi di sbarco di Massaua e di Zula siano al più presto attrezzate in modo da permettere lo sbarco rapido delle tre dj visioni di rinforzo ( «Sabauda», «Gran Sasso» , <<Sila»).
A.U.S.S M.E., fondo D-1 «Carteggio sussidiario Africa orientale italian11 - Guerra italoetiopica», busta 11. i 3, fascicolo n. 3.
li documento è una copia dell'Ufficio del capo di Stato Maggiore Generale. ma non è verbale, bensì una sintesi con le conclusioni raggiunte alla riunione del 22.2.1935.

«Preparazione militare in Africa orientale: invio di forze in Eritrea, invio di operai e mano d'opera, trasporti marittimi di uomini e mezzi (organizzazione di un ufficio di sbarco a Massaua), invio delle Divisioni Gavinana, Sabauda, Gran Sasso, Sila, di alcune divisioni di camicie nere e organizzazione dei relativi alloggiamenti, invio di muli per le truppe coloniali e indigene».
Verbale sulla seduta dell'8 maggio 1935 - Xlll, presieduta da S.E.
il Capo di Stato Maggiore Generale
Autorità presenti:
S.E. il Capo di Stato Maggiore Generale
S.E. !'On. Lessona, Sottosegretario di Stato alle Colonie
S.E. il Generale Baistrocchi, Sottosegretario di Stato alla Guerra
S.E. l' AmmiragUo Cavagnari, Sottosegretario di Stato alla Marina
S.E. il Generale Valle, Sottosegretario di Stato per l'Aeronautica
S.E. l'On. Teruzzi, Capo di Stato Maggiore della M.V.S.N.
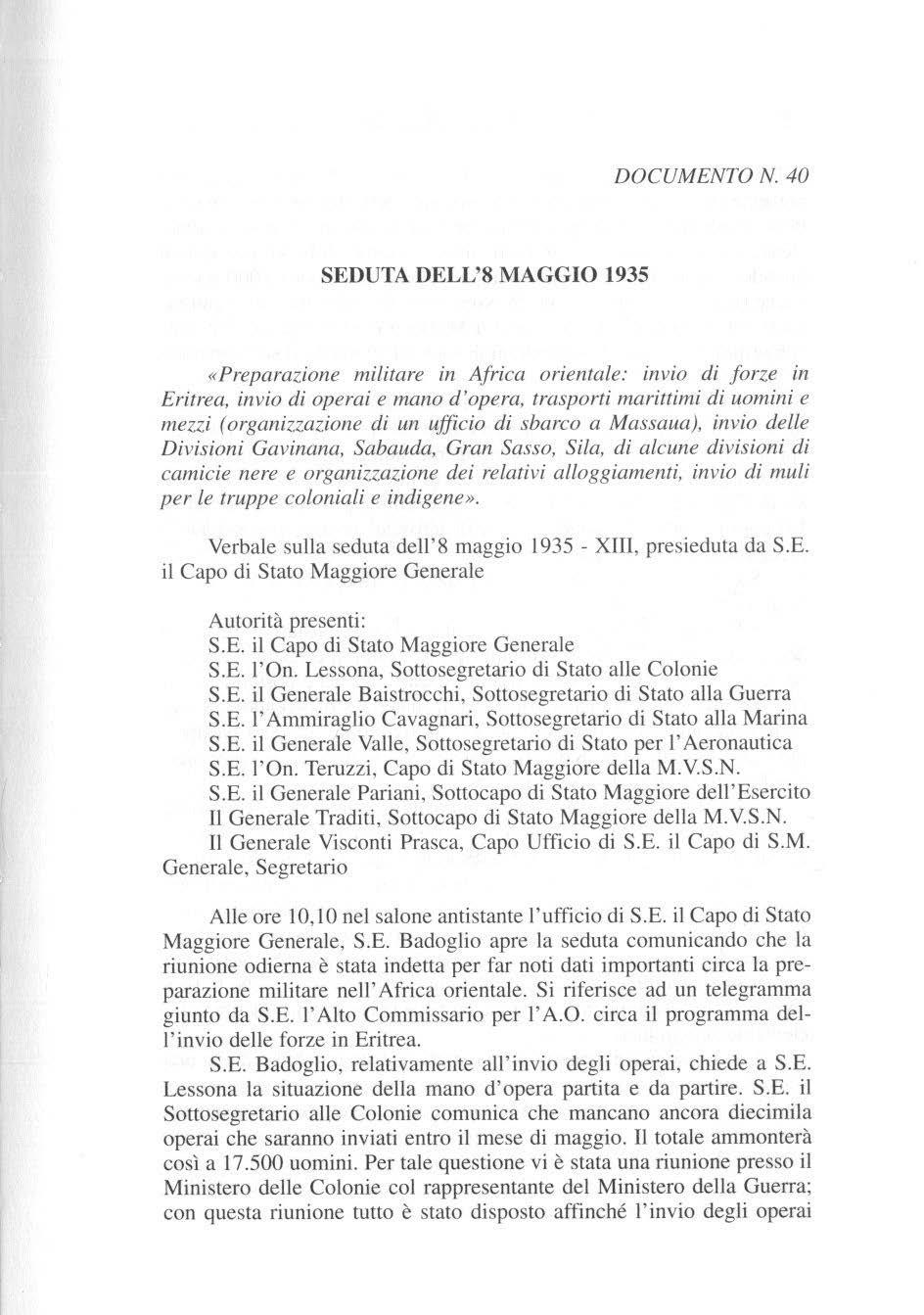
S.E. il Generale Pariani, Sottocapo di Stato Maggiore dell'Esercito
Il Generale Traditi, Sottocapo di Stato Maggiore della M.V.S.N.
11 Generale Visconti Prasca, Capo Ufficio di S.E. il Capo di S.M. Generale, Segretario
Alle ore 10, 10 nel salone antistante l'ufficio di S.E. il Capo di Stato Maggiore Generale, S.E. Badoglio apre la seduta comunicando che la riunione odierna è stata indetta per far noti dati importanti circa la preparazione militare nell'Africa orientale. Si riferisce ad un telegramma giunto da S.E. l'Alto Commissario per I' A.O. circa il programma dell'invio delle forze in Eritrea.
S.E. Badoglio, relativamente all'invio degli operai, chiede a S.E. Lessona la situazione della mano d'opera partita e da partire. S.E. il Sottosegretario alle Colonie comunica che mancano ancora diecimila operai che saranno inviati entro il mese di maggio. Il totale ammonterà così a 17.500 uomini. Per tale questione vi è stata una riunione presso il Ministero delle Colonie col rappresentante del Ministero della Guerra; con questa riunione tutto è stato disposto affinché l'invio degli operai
non intralci quello delle truppe. S.E. Badoglio prende occasione per far presente che è opportuno tenerlo al corrente anche di questioni che sembrano secondarie (invio operai) ma che incidono sul ritmo e sulla consistenza della preparazione militare nelle Colonie. S.E. chiede quindi quando sarà ultimato il trasporto della «Gavinana» e dei 10.000 operai. Viene risposto che tutto ciò potrà essere compiuto ai primi di giugno ma varie autorità fanno rilevare come a Massaua esista oggi una notevole congestione tanto che le operazioni di s barco e di deflusso saranno notevolmente ritardate.

S.E. Cavagnari fa rilevare come i piroscafi che affluiscono giornalmente a Massaua, che sono arrivati fino ad un massimo di diciotto, appartengono non soltanto al contingente noleggiato e requisito, ma anche, e principalmente , alle varie linee di navigazione che hanno deciso di fare scalo fisso a Massaua anche con i piroscafi destinati in Estremo Oriente. E poiché s i tratta di piroscafi postali, pretendono la precedenza alle operazioni di sbarco
S.E. Lessona informa che è stato dato incarico a S.E. l' A.C. di stabilire la precedenza dello scarico.
S.E. Badoglio rileva che lo scalo dei vari postali e privati a Massaua è stato chiesto da noi in un primo tempo a causa dell'urgente bisogno e osserva che, poiché molti piroscafi di linea e postali trasportano piccoli reparti o piccole quantità di materiale risolvendosi la loro collaborazione più in intralcio che in effettivo aiuto, qualora bastino i piroscafi requisiti, si potrebbe comunicare alla società di far sospendere alle loro unità gli scali a Massaua.
S.E. Cavagnari suggerisce di esaminare i compiti delle varie linee e operare quindi una discriminazione. A questo punto viene iniziata una discussione circa il miglior sistema da adottare per risolvere tale problema e viene presa in esame qual 'è l'autorità che si trova in condizioni migliori per poter regolare l'autorizzazione di scalo a Massaua ai piroscafi di linea ed in genere a quelli non noleggiati, quali so no gli uffici a ciò più idonei e qual è la loro migliore organizzazione. Si fa rilevare ancora che, mentre a Mogadiscio esiste un ufficio di sbarco che funziona con ottimo rendimento, a Massaua invece la cosa non è ancora sufficientemente regolata.
S.E. Lessona è del parere che i carichi vadano regolati qui e fa presente come I' A.C. non possegga oggi i mezzi per sollecitare l 'an damento delle operazioni portuali di Massaua, come i maggiori inconvenienti derivino appunto dalla pletora di piroscafi postali e privati, e come la capacità di assorbimento attuale dei porti sia tuttora insufficiente e cita il caso di Mogadiscio ove risulta che fino a giugno non sarà possibile mandare alcun nuovo piroscafo.
S.E. Badoglio ritiene sia necessario stabilire un accordo completo fra gli uffici esistenti nei porti d'imbarco e quelli esistenti nei porti di sbarco; che occorre quindi creare un'ufficio idoneo a Massaua, il quale si tenga in relazione con gli uffici di qui.
S.E. Pariani prospetta allora l 'opportunità di studiare un sistema di blocco che dovrebbe funzionare dalla Madrepatria.
S.E. Cavagnari pensa che le autorità locali debbono stabilire in base alla natura e all'entità del carico la possibilità di dare le autorizzazioni di partenza; quando una tale istituzione funzionasse egregiamente sul posto sareb be possibile stabilire da qui l'ordine e il ritmo delle partenze.
S.E. Badoglio conclude questo argomento incaricando S.E. Lessona di inviare un telegramma all' A.C. affinché provveda all'organizzazione di un completo ufficio di sbarco a Massaua. Dal collegamento di un tale ufficio con gli uffici imbarchi e dei nostri porti e da un più concreto accordo fra i Ministeri delle Colonie e Marina deriverà un funzionamento perfetto di tale essenziale servizio .
S.E. Badoglio, riprendendo la discussione generale su lla coordinazione dell'invio delle forze in Eritrea, assume come dato di fatto che entro giugno sia fissato l'invio degli operai e della «Gavinana » esclusa una aliquota quadrupedi. La di visione richiesta subito dopo la «Gavin iana» da S.E. De Bono è la «Saba uda» per la quale l ' A.C. informa che durante la stagione delle grandi piogge sarà riparata «alla meglio». S.E. pensa come occorrano informazioni esaurienti su di un argomento così importante poiché un contingente di truppe bianche male ricoverato in Colonia durante la stagione delle piogge, può giungere a perdere la disponibilità dell'80% dei quadrupedi e del 40% degli uomini. Ri tiene come sia molto importante poter provvedere a sufficiente ricovero per le divisioni che si inviano anche a costo di dover incominciare le operazioni un mese dopo. Poiché il SS. alle Colonie informa che per la Divisione «Sabauda» è previsto che le truppe siano in parte baraccate e in parte sotto tende e che l'invio delle baracche è risultato molto gravoso per il forte ingombro del materiale di esse, si propone di fornire le truppe di tende tipo «Roma ». D'altra parte, poiché quest 'u ltimo tipo di tende , sebbene si presti benissimo allo scopo, ri s ulta altrettanto ingombrante quanto le baracche e non se ne ha d 'altronde subito una disponibilità sufficiente, S.E. Badoglio propone d'interpellare in modo preciso S.E. I ' A.C. sulla possibilità di ricovero della «Sabauda», e sulla opportunità di intensificare l'apprestamento e l'invio dei materiali per le baracche. Poiché d'altra parte non risulta necessario che le truppe di tale divisione raggiungano subito l 'altipiano, si studia quale sede intermedia la divisione possa raggiungere per abbreviare il tempo di sgombro dal porto di Massaua e si stabilisce che la località di Ghinda pos sa rappresentare una soluzione convenknte. D'altra parte non è opportuno ritar-

dare l' invio della «Sabauda» sia perché oggi e per qualche tempo ancora l' A.C. non dispone in sede che di una divisione indigena e della «Gaviniana» incompleta, s ia perché il com uni cato dei giornal i di stamane si deve interpretare come una specie di dichiarazione di guerra che provocherà nel campo opposto provvedimenti ai quali bisogna essere in grado di far fronte. S.E. Badoglio conclude quest 'argomento affermando che la Divisione «Sabauda» debba essere in viata, in armonia con la richiesta dell' A.C. , prima della stagione delle piogge; che l 'A.C. si preoccupi in modo efficace per il suo ricovero e ne studi una conven iente sistemazione in modo da ridurre la lunghezza dei trasporti in sede. Dà pertanto incarico a S.E. Lessona d'informare l'A.C. per l 'A. O. di quanto sopra aggiungendo il suggerimento di fermare la divisione a Ghinda.
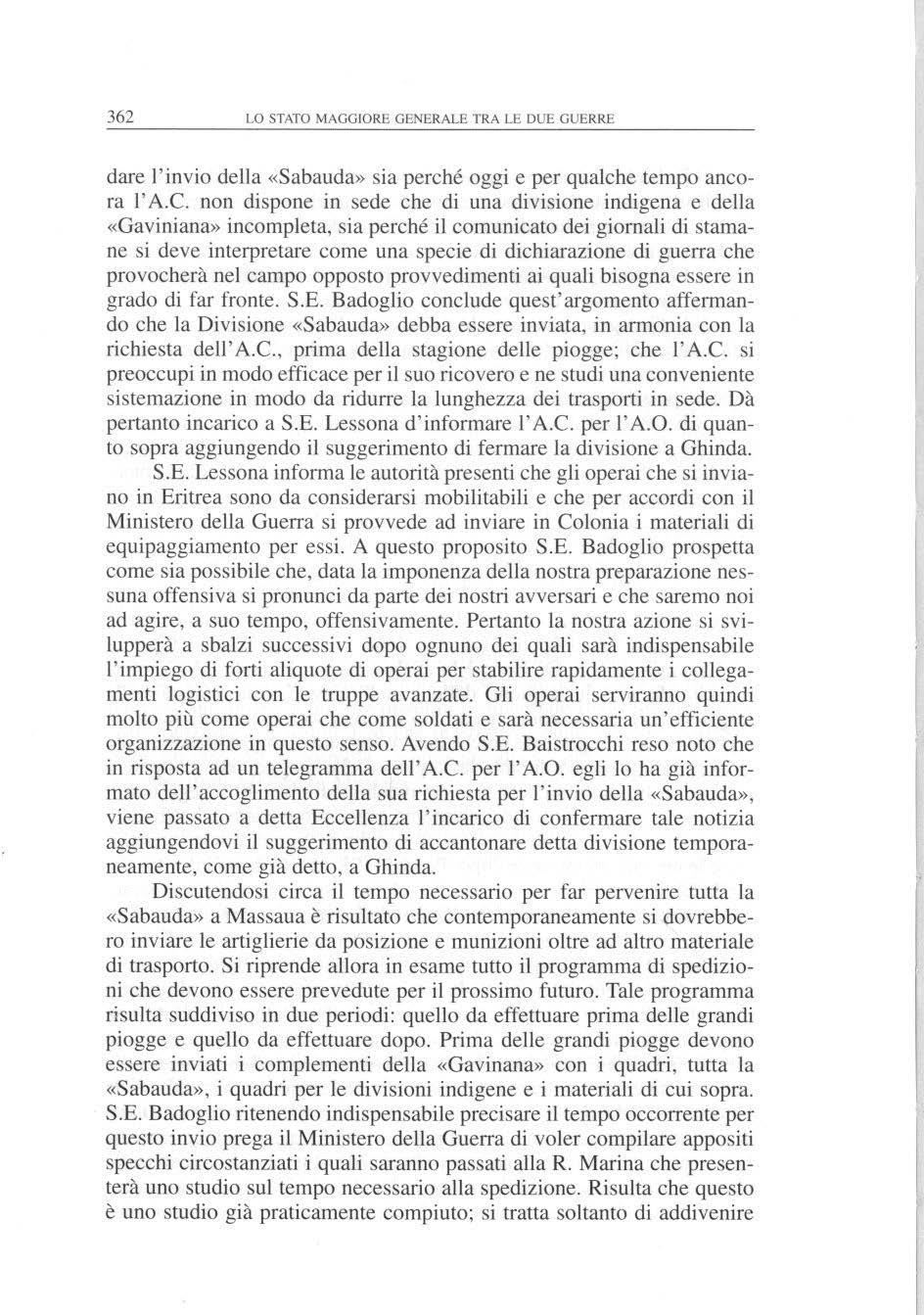
S.E. L essona informa le autorità presenti che gli operai che si inviano in Eritrea sono da considerars i mobilitabili e che per accordi con il Ministero della Guerra si provvede ad inviare in Colonia i materiali di equipaggiamento per essi A questo proposito S.E. Badoglio prospetta come sia possibile che, data la imponenza della nostra preparazione ness una offensiva si pronunci da parte dei nostri avversari e che saremo noi ad agire, a suo tempo, offensivamente. Pertanto la nostra azione si svilupperà a sbalzi successivi dopo og nun o dei quali sarà indispen sa bile l'impiego di forti aliquote di operai per s tabilire rapidamente i collegamenti logistici co n l e truppe avanzate. Gli operai serviranno quindi molto più come operai che come soldati e sarà necessaria un'efficiente organ izzazione in questo senso. Avendo S.E. B aistrocchi reso noto che in risposta ad un telegramma dell' A.C. per l' A.O. egli lo ha g ià informato dell'accoglimento della s ua ri chiesta per l 'i n vio della «Sabauda», viene passato a detta Eccellenza l'incarico di confermare tale notizia aggiungendovi il sugge rimento di accantonare detta divisione temporaneamente, come g ià detto, a Ghinda.
Di sc utendosi circa il tempo necessario per far pervenire tutta la «Sabauda» a Massaua è risultato che co ntemporaneamente s i dovrebbero inviare le artiglierie da posizione e munizioni oltre ad altro materiale di trasporto. Si riprende allora in esame tutto il programma di spedizioni che devono essere prevedute per il prossimo futuro. Tale programma risulta s uddi viso in due periodi: quello da effettuare prima delle grandi piogge e quello da effettuare dopo. Prim a delle gra ndi piogge devono essere inviati i complementi della «Ga vinana» con i quadri , tutta la «Sabauda», i quadri per le divisioni indigene e i materiali di cu i sopra. S.E. Badog lio ritenendo indi spensabile precisare il tempo occorrente per questo in vio prega il Ministero della Gu erra di voler compilare appositi specchi circostanziati i quali saran no passati alla R. M arina c he presenterà uno studio sul tempo necessario a lla spedizione. Ri s ulta c he questo è uno studio già praticamente compiuto; si tratta so ltanto di addivenire
alla conclusione. S.E. Badoglio fa osservare come, quando il Capo del Governo comunica le Sue decisioni, occorra garantirgliene la tempestiva esecuzione dopo averne studiate le modalità. E poiché egli è il responsabile della migliore esecuzione verso il Capo del Governo, desidera possedere tutti i dati del caso per apprezzare la possibilità di esecuzione di un determinato piano e dare il parere definitivo in merito. Si passa quindi allo stud io delle richieste dell 'A.C. per il periodo successivo alle grandi piogge:
- verso i primi di settembre occorre inviare i quadrupedi occorrenti per la «Gav inana » e «Sabauda» c he ammontano a circa 3000 muli. Occorrono poi i quadrupedi per le divisione indigene. Poiché risulta che larghe requisizioni ed acquisiti di quadrupedi avvengono anche in Colonia, tanto che in un primo tempo sembrava che per le divisioni indigene bastassero le risorse locali, si precisa l'opportunità che l'Intendenza in Colonia tenga gli organi centrali sempre al corrente sul censimento dei muli. Tuttavia si presume che debbano essere inviati in Colonia un totale di almeno 8000 muli.
P o i debbono essere inviati:
- Due divisioni di camicie nere
- L e divisioni «Gran Sasso» e «Sila»
- 3 divisioni CC.NN.
Per tutto questo s i dispone di tre mesi e mezzo poiché S.E. De Bono chiede di poter avere il corpo di spediz ione al completo entro il mese di dicembre.
Sono in tutto sette divisioni da trasportarsi in tre mesi e mezzo, ossia due al mese più 8000 muli più il materiale più quattro battaglioni di CC.NN., ecc .
Malgrado il discreto avviamento assunto dalla organizzazione di sbarco in Colonia, è questo programma eseguibile? S.E. Badoglio rivolge tale domanda particolarmente alla R. Marina. Poiché si tratta di pros pettare chiaramente a S.E. il Capo del Governo se ed in quanlo esista tale possibilità.

Dalla esposizione delle varie autorità risulta:
1) che ad una altrezzatura più che suffic iente delle basi di raccolta, imbarco e s pedizione in Patria non corrisponde analoga attrezzatura di sbarco e di assorbimento in Colonia;
2) che per ora l'utilizzazione dei mezzi marittimi è s tata limitata al noleggio di piroscafi di spo nibili: rimane il vasto campo delle requisizioni dei grandi piroscafi di linea;
3) che però tali piroscafi devono essere adattati poiché nelle condizioni di normale esercizio non s i prestano alla forma d'impiego per loro prevista.
S.E. Badoglio propone quindi che la R. Marina metta prontamente allo studio l'importante problema per quanto ha tratto coi mezzi e con l 'i mbarco e che l'A.C. sia invitato a riferire circa la possibilità di portare al più presto l'attrezzatura in sede ad una efficienza corrispondente sia aJle necessità prossime sia alla potenzialità dei mezzi esistenti in P atria. In base a questo si potrà stabilire un programma generale la cui attuazione sarà mantenuta se da ogni parte si adempiranno gli impegni presi.
S.E. Cavagnari fa osservare che sarà faci le e possibile adempiere alle promesse se i dati rimarranno invariati; se invece dovranno verificarsi delle cospicue aggiunte impreviste, ne risulterà un conseguente ritardo. Cita a questo proposito 1' inserimento dei 17 .000 operai, dei contingenti di autocarri, dei vagoni ferroviari ecc. che si è verificato recentemente.
S.E. Badoglio ritiene tale osservazione giusta: dà incarico a S.E. Cavagnari di fare eseguire lo studio relativo ai piroscafi occorrenti, al loro apprestamento, ai tragitti, e ai tempi di sbarco partendo dai dati di oggi. Se questi verranno variati il tempo risulterà aumentato in conseguenza. Certo è che quanto viene oggi richiesto dal!' A.C. non è eseguibile date le condizioni di Massaua e della Colonia non ostante che dal primo agosto si possa disporre del seno di Dakliat.
S.E. Baistrocchi osserva come sarebbe più conveniente basare lo studio di cui sopra non esclusivamente s ulle richie ste dell' A.C. ma in base ad un concetto che tenga conto delle possibilità operative riferite a piani di azioni determinati e limitati in precedenza. Ossia come sia meglio studiare l'invio dei mezzi che occorrono per effettuare i piani che s i vogliono mettere in atto. Pur avendo stabilito di mandare dieci divisioni ritiene sia preferibile operare con sei divisioni a dicembre che con dieci a febbraio.
S.E. Badoglio conviene che si potrebbe operare anche con cinque divisioni però fa osservare come la riunione di oggi non possa entrare in merito ai piani operativi sui quali egli si è già pronunciato.
La riunione odierna è stata convocata per esaminare le richieste di S.E. De B ono e la possibilità della loro esecuzione. L' A.C. precisa che le richieste debbono essere soddisfat te entro il mese di dicembre. S.E. Badoglio desidera poter dire al Capo del Governo se ciò sia possibile oppure no.
Dati gli impegni delle autorità presenti la riunione viene rinviata a domattina giovedì 9 maggio alle ore 9.
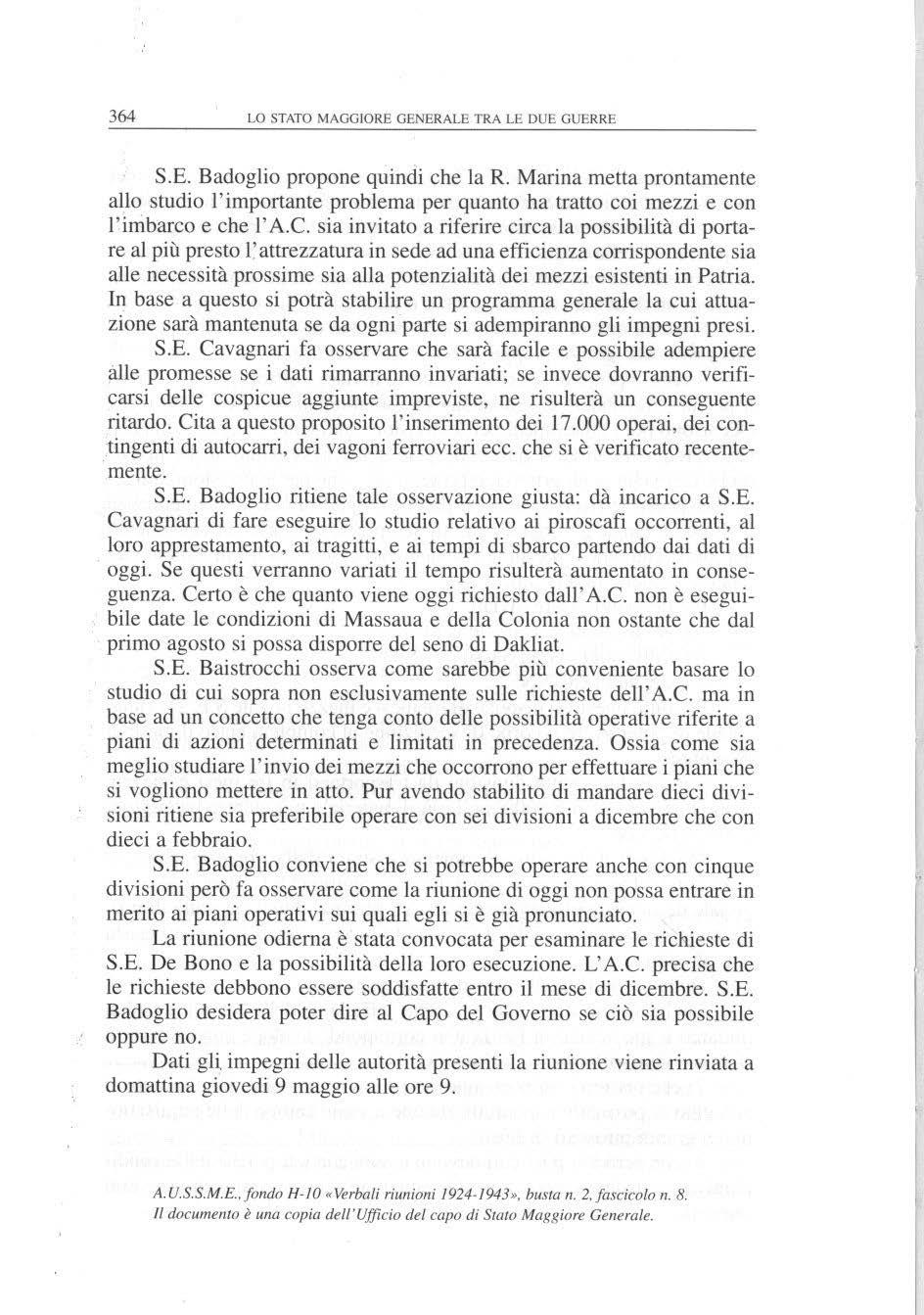
«Prepara zione militare in Africa orientale: situazione delle forze aeree in Eritrea, campi e aeroporti, impiego dell'iprite, difesa di Assab, viabilità e nuova rete stradale in costruzione in Eritrea, approvigionamenti d'acqua, questione relativa alla presentazione presso le nostre autorità di confine di nostri ex ascari etiopici, situazione militare della Somalia (Divisione Peloritana e campi trincerati di Giuba e UebiScebeli, situazione delle truppe indigene, base aerea di Belet-Uen , condizioni di sbarco a Mogadiscio, trasporto marittimo di truppe)».
Verbale sulla seduta del 9 maggio 1935 - XIII, presieduta da S.E. il Capo di Stato Maggiore Generale
Autorità presenti:
S.E. il Capo di Stato Maggiore Generale
S.E. l'On. Lesso na , Sottosegretario di Stato alle Colonie
S.E. il Generale Baistrocchi, Sottosegretario di Stato alla Guerra
S.E. il Generale Valle, Sottosegretario di Stato per l'Aeronautica
S.E. l'Ammiraglio Cavagnari, Sottosegretario di Stato alla Marina
S .E. l'On. Teruzzi, Capo di Stato Maggiore della M.V.S.N.
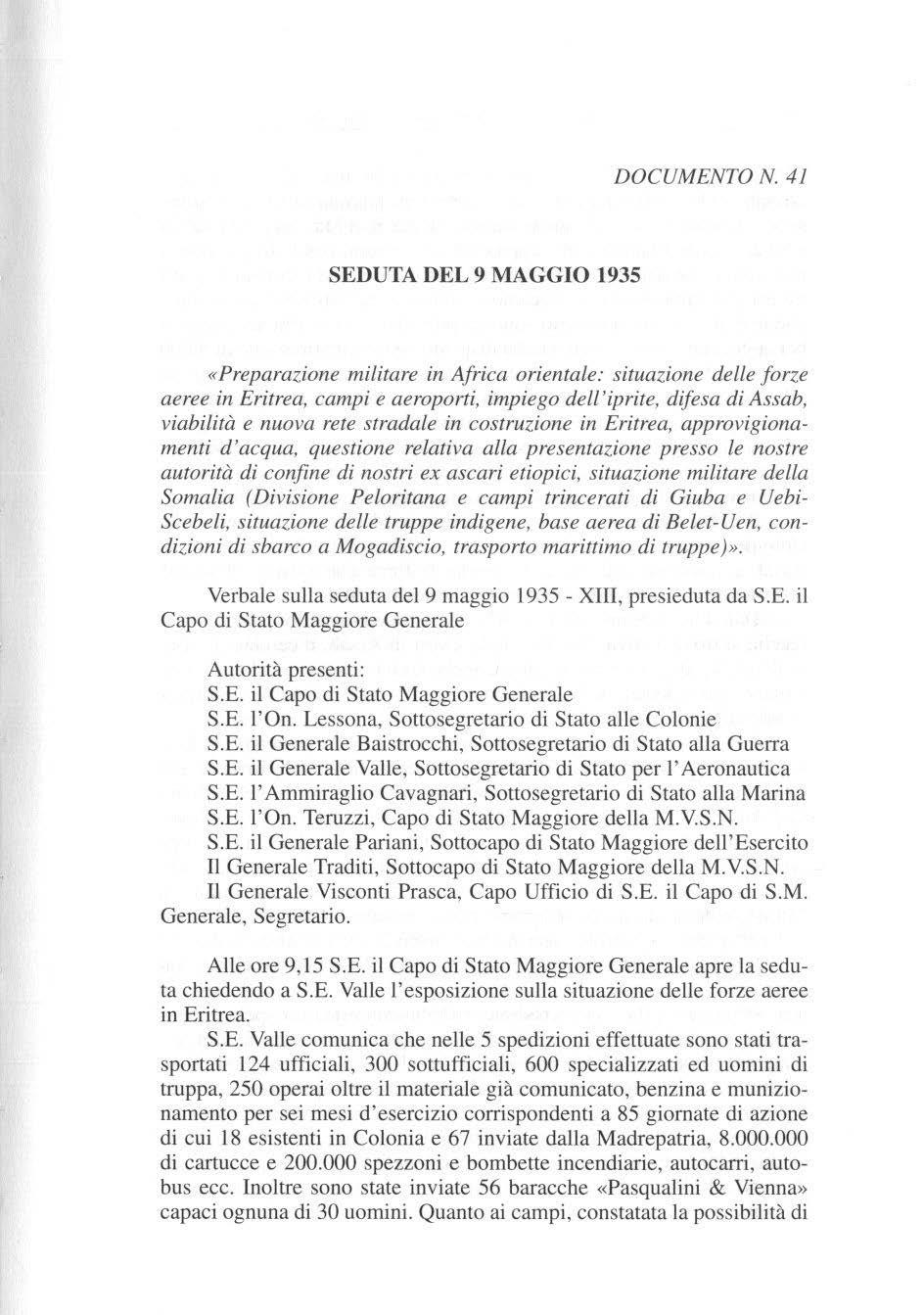
S .E. il Generale Pariani, Sottocapo di Stato Maggiore dell'Esercito
Il Generale Traditi, Sottocapo di Stato Maggiore della M.V.S.N.
Il Generale Visconti Prasca, Capo Ufficio di S.E. il Capo di S.M. Generale, Segretario.
Alle ore 9, 15 S.E. il Capo di Stato Maggiore Generale apre la sed uta chiede nd o a S.E. Valle l'esposizione sulla situazione delle forze aeree in Eritrea.
S.E. Valle comunica che nelle 5 spedizioni effettuate sono stati trasportati 124 ufficiali, 300 sottufficiali, 600 specializzati ed uomini di truppa, 250 ope rai oltre il materiale già comunicato, benzi na e munizionamento per sei mesi d'esercizio corrispondenti a 85 giornate di azione di cui 18 es istenti in Co lonia e 67 inviate dalla Madrepatria, 8.000.000 di cartucce e 200.000 spezzoni e bombette incendiarie, autocarri, autobus ecc. Inoltre sono state inviate 56 baracche «P asqualini & Vienna» capaci ognuna di 30 uomini. Quanto ai campi, constatata la possibilità di
vita su quelli della costa, l'Aeronautica si è limitata ad occuparne 3 (Assab, Zula e Massaua). Sui detti tre campi possono affluire e trovar sede 200 apparecchi da bombardamento di cui 50 a Massaua, 100 a Zula e 50 ad Assab. In quanto agli apparecchi cooperanti con le truppe questi potranno agire dagli aeroporti dell'altopiano. S.E. Valle comunica inoltre che per raggiungere il massimo rendimento nell'uso dell'iprite, dato che le bombe di piccolo peso sono da prevedersi poco efficaci co ntro il bersaglio che offrirà il nemico, ha disposto per la fabbricazione di 5.000 bombe da 500 kg. ognuna caricata ad iprite con spo letta a tempo regolabile da bordo che può consentire lo scoppio alla quota di metri 500 sul terreno producendo l'irrorazione di un cerchio avente diametro uguale alla quota di scoppio. I campi costieri saranno approntati per ottobre e i duecento apparecchi da bombardamento , di cui i primi potranno partire in agosto, saranno pure ultimati e pronti a muovere per fine ottobre.
S.E. Badoglio informa di avere scritto una lettera al Ministero delle Colonk in cui espone dei dubbi circa l 'efficienza sulla resistenza di Assab contro eventuali attacchi perché le forze che vi sono destinate sono scarse e non risiedono tutte normalmente in sede.
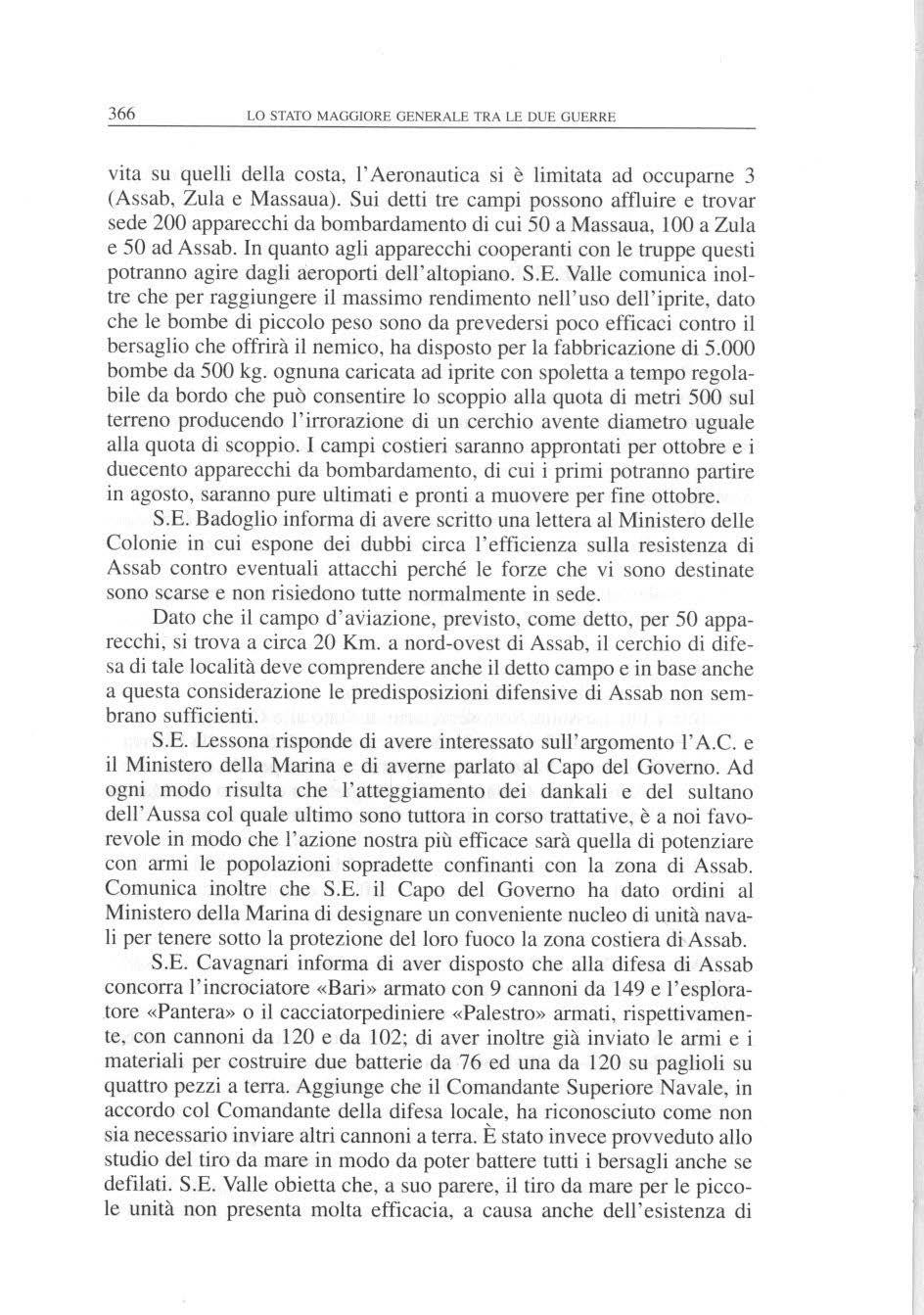
Dat o che il campo d'aviazione, previsto, come detto, per 50 apparecchi, si trova a circa 20 Km. a nord-ovest di Assab, il cerchio di difesa di tale località deve comprendere anche il detto campo e in base anche a questa considerazione le predisposizioni difensive di Assab non sembrano sufficienti.
S.E. Lesso na risponde di avere interessato sull'argomento I' A.C. e il Ministero della Marina e di averne parlato al Capo del Governo. Ad ogni modo risulta che l'atteggiamento dei dankali e del su ltano dell 'Aussa col quale ultimo sono tuttora in corso trattative, è a noi favorevole in modo che l 'azione nostra più efficace sarà quella di potenziare con armi le popolazioni sopradette confinanti con la zona di Assab. Comunica inoltre che S.E. il Capo del Governo ha dato ordini al Ministero della Marina di designare un conveniente nucleo di unità navali per tenere sotto la protezione del loro fuoco la zona costiera di Assab.
S.E. Cavagnari informa di aver disposto che alla difesa di Assab concorra l ' incrociatore «Bari » armato con 9 cannoni da J49 e l 'esploratore << Pantera» o il cacciatorpediniere «Palestro» armati, ri spettivamente, con cannoni da 120 e da 102; di aver inoltre già inviato le armi e i materiali per costruire due batterie da 76 ed una da 120 su paglioli su quattro pezzi a terra. Aggiunge che il Comandante Superiore Navale, in accordo col Comandante della difesa locale, ha riconosciuto come non sia necessario inviare altri cannoni a terra. È stato invece provveduto allo studio del tiro da mare in modo da poter battere tutti i bersagli anche se defilati. S.E. Valle obietta che, a suo parere, il tiro da mare per le piccole unità non presenta molta efficacia, a causa anche dell'esistenza di
numerose piccole dune che mascherano le zone da battere; segnala inoltre l'esistenza di un alto colle isolato sorgente presso il campo di aviazione di Assab, che potrebbe costituire ottima sede per la postazione di una batteria e come posto di osservazione S.E. Badoglio osserva che si può richiamare su ciò l'attenzione del!' A.C.
A questo punto S.E. Badoglio dichiara come ritenga necessario ricevere informazioni esaurienti sullo stato dei lavori stradali sotto forma di situazio ne mensile. Il forte nucleo di operai inviati dalla Madrepatria conferirà un ritmo accelerato ai lavori; tuttavia il tonnellaggio da trasportare sul!' altipiano sarà molto cospicuo e la strada per ora è una so la. S.E. Le ssona dà alcune notizie recenti, pure ammettendo che per ora non si è in possesso che di assicurazioni generiche e che è necessario provocare l'invio di regolari notizie periodiche. Le informazioni di S.E. Lessona, sono le seguenti: la seconda linea di comunicazione stradale Barresa-Saganeiti è stata iniziata dalla Ditta Puricelli che è da ritenere ditta seria che manterrà l'impegno preso per ottobre; il tratto Massaua-Saberguma è predisposto in modo che praticamente costituirà una duplice sede stradale che darà la possibilità di un quadruplice transito; reparti CC.NN. lavorano sul tronco Coatit-Adi Caieh. Il Capo del Governo ha accettato la proposta di unire Ghinda all'Asmara mediante una teleferica e sono stati dati gli ordini in conseguenza. S.E. Lcssona si propone di fare un sopraluogo personalmente entro il mese di maggio e di assumere così de visu le informazioni; del resto il Generale Pinna ritornerà in sede il 20 maggio e potrà già mettere al corrente s u quanto ha visto. S.E. Badoglio insiste suUa questione logistica che costituisce e costituirà la parte predominante di tutta la campagna e invita il generale Pariani a rifare il calcolo del tonnellaggio quotidiano occorrente su ll 'altipiano per i se rvizi del R. Esercito. A tale risultato sa rà poi da aggiungere il traffico occorrente agli altri enti e repatti.
S.E. Valle informa che durante la sua ispezione in Eritrea in un colloquio avuto con l'intendente, Gen. Dall ' Ora, ha sap uto come sul tratto Ghinda-N efasit non essendo possibile portare la strada a doppio transito occorra rassegnarsi ad applicare il s istema dei blocchi; dato però che il numero di autocarri necessario per il traffico giornaliero previsto nella fase di massima efficienza potrà raggiungere le 5.000 unità egli dubita che tale sistema possa dare un utile risultato. Quindi S.E. Badoglio ripete che occorre fare il calcolo del tonnellaggio da trasportare e degli autocarri necessari; bisogna però che l' A.C. garantisca la possibilità di transito di detti automezzi.
S.E. Badoglio accennando inoltre al problema dell'acqua e constatando come non s i sia in possesso che di assicurazioni generiche, sia per lui necessaria le recezione di specchi periodici che rendano conto del la situazione.
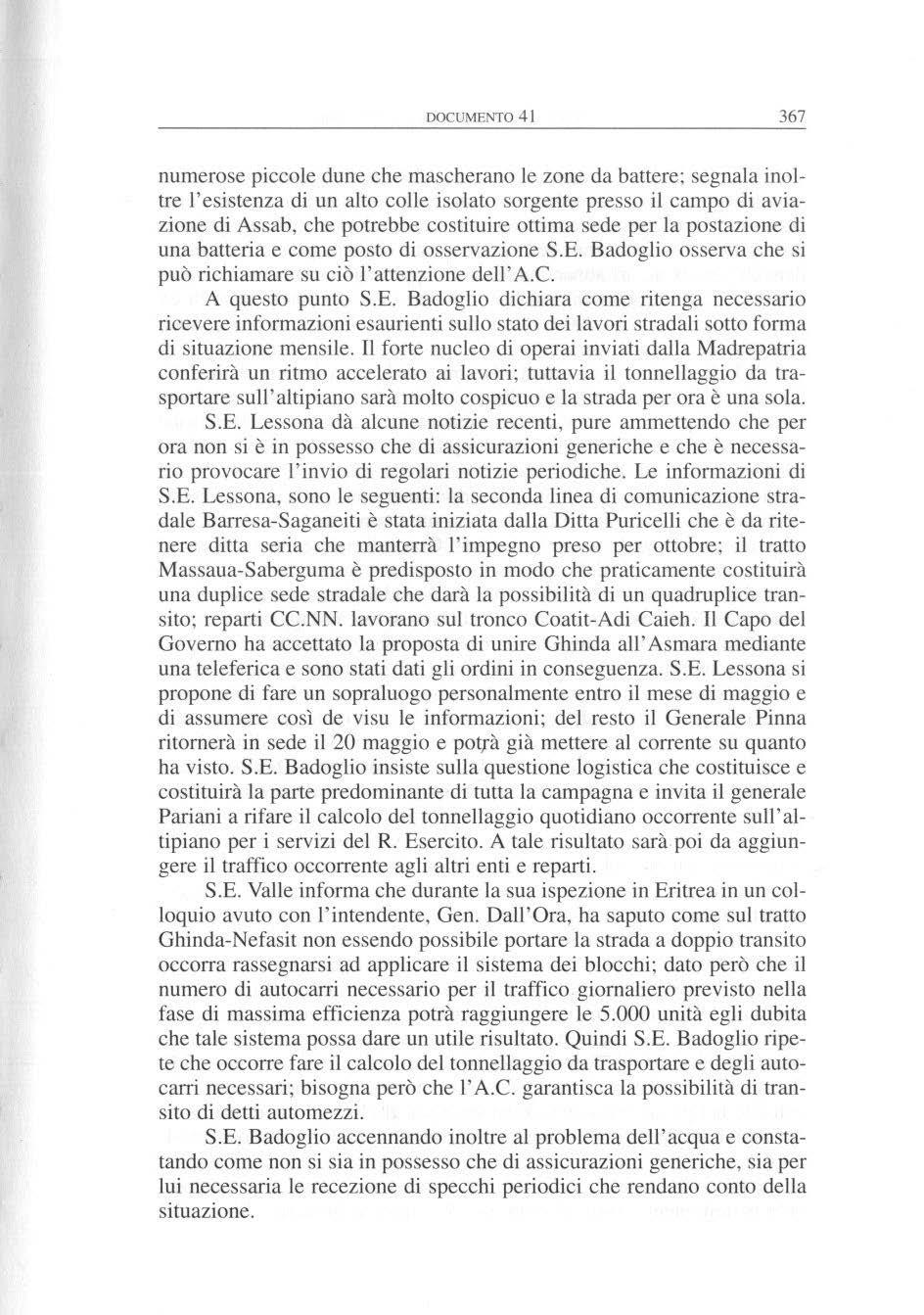
S.E. Badoglio esamina la questione relativa alle presentazioni pre sso le nostre autorità di confine di nostri ex ascari etiopici. Rileva come la quantità di tali uomini che tornano a noi dia un ' idea dell'impopolarità della guerra nei bassi strati della popolazione abissina poiché è da ricordare che gli ex ascari abbandonano alle rappresaglie del nemico le loro famiglie. S.E. Lessona informa che fino ad oggi il numero di detti ex ascari è salito a circa 4000 e che il movimento continua; la propaganda è proseguita attivamente.

S.E. Badoglio passa quindi ad e saminare la situazione militare della Somalia e rifacendosi ai precedenti ricorda che in seguito a proposta fatta al Capo del Governo fu inviata in Somalia la Divisione «Peloritana» per presidiare i due campi trincerati facenti capo alle due principali linee di penetrazione nemica ossia quelle del Giuba e del Uebi-Scebeli. Dopo l'invio di questa divisione sono pervenute success ive imponenti richieste di truppe e qui a suo tempo deve essere sorto un equivoco per il quale sembrò che S.E. Graziani , riferendosi a concetti offen s ivi accennatigli dal Capo del Governo , non avesse portato a fondo lo studio del suo compito principale rivolgendo la sua attenzione verso una forma di offensiva parziale. S.E. il Capo di Stato Maggiore General e ha meglio chiarito la funzione dei due scacchieri per compito dei quali non esistono più equivoci. In Somalia le truppe bianche non sono impiegabili in operazioni di campagna; bisogna perfezionare la preparazione delle truppe indigene che devono costituire i reparti mobili operanti mentre le truppe bianche devono essere riservate al presidio dei due campi trincerati. Mediante l'invio di quattro solidi battaglioni eritrei la situazione attuale del Corpo di truppe indigene in Somalia è la seguente: 4 battaglioni s omali costituiti, 4 battaglioni eritrei inviati , 2 battaglioni somali in costituzione e , secondo informazioni di S.E. Lessona , attualmente pronti. S.E. Badoglio accenna all'es istenza di un telegramma che riferisce l ' autorizzazione del Capo del Governo di giungere aLl'arruolamento di 50.000 uomini.
S.E. Lessona è in grado di fornire i seguenti chiarimenti; S.E Graziani dispone oggi di circa 30.000 uomini dei quali 18.000 indigeni e di tutte le armi necessarie , più 7.000 fucili di riserva. La cifra di 50.000 uomini è un limite a cui si tende arrivare esistendo la predetta s uperiore autorizzazione. Si è parlato di battaglioni autocruTati ma tale soluzione non è applicabile in Somalia poiché le strade non s i prestano. S.E. Badoglio s i richiama al s uo metodo, confortato da lunga pratica, che consiste nel procedere si s tematicamente per gradi. Egli ha ultimamente definito il problema della Somalia come un problema difensivo-controffensivo e ha confermate e precis ate le Sue direttive strategiche. Da quello che gli risulta lo sviluppo della preparazione studiato laggiù non coincide perfettamente , fino ad oggi, con le diretti ve impartite. Sono stati
dislocati i battaglioni metropolitani nelle quattro sedi di Mogadiscio, Merca, Brava e Chisimajo e ciò particolarmente per ragioni di disponibilità idrica: ma il problema era stato delineato in modo più semplice e si doveva procedere alla costituzione di due soli campi trincerati, uno a Mogadiscio e uno a Chisimajo. A tutt'oggi non si hanno notizie circa il grado di apprestamento di detti campi. Il secondo argomento da risolvere era quello relativo alle posizioni di arresto lungo le linee di prevedibile penetrazione nemica, posizioni la cui predisposizione è indispensabile data la rilevante sproporzione di forze. Anche su questo non abbiamo notizie e bisogna richiederle. Occo1Te obbligare la mente di chi è laggiù ad espletare i compiti principali prima di dedicarsi a studi che per il momento sono prematuri. A ltri problemi di primo piano erano quelli relativi allo sgombero delle popolazioni del bassopiano occidentale in Eritrea, allo sgombro del bestiame e alle predisposizioni per il loro vettovagliamento. Anche per tutto ciò non risulta che siano stati portati a compimento gli studi relativi, sebbene l'attuale presenza di S.E. Gabba dia assicurazione su questi ultimi argomenti.
S.E. Lessona prendendo la parola sull'argomento rifà la storia dello sviluppo degli avvenimenti: in seguito al primo ordine di costituire i due campi trincerati fu dalla Somalia inviata la controproposta di costituire quattro posti; in seguito a ciò furono confermate le istruzioni precedenti; però non è giunta a tutt'oggi nessuna risposta in merito. Tuttavia S.E. Graziani ha assicurato di non avere in alcun modo propositi offensivi e ha fatto conoscere che, nell'eventualità di dover arretrare le sue truppe a causa della pressione nemica, ha stabilito le due linee di arresto sullo Uebi-Scebeli prevedendo le seguenti quattro fasi: 1) ripiegamento da Ualual-Warder; 2) fermata su Mustahil; 3) ripiegamento a scaglioni su Belet-Uen;
4) fermata sulla linea villaggio Duca degli Abruzzi Afgoi.
S.E. Badoglio pure apprezzando il valore di queste notizie esplicative e costatando come siansi ricevute costanti assicurazioni circa l'esecuzione delle direttive emanate, afferma non essere possibile accontentarsi di questo; come occorra essere sempre in possesso di situazioni periodiche, come si sia sempre disposti a collaborare ed aiutare di tutto cuore inviando nella più grande misura quanto viene richiesto quando però se ne comprenda e se ne approvi la ragione d'impiego. Conclude dicendo che occorrono notizie costanti e aggiornate su :
a) sviluppo dell'organizzazione giornaliera delle forze indigene;
b) sviluppo dei lavori delle linee difensive;

c) tutte le altre not izie complementari.
S.E. Valle riferisce circa la proposta ricevuta di costituire una base aerea permanente a Belet-Ue n . Fa rilevare come la località sia troppo lontana dalla costa (circa 400 Km. da Mogadiscio) come occorrano 7 .000 tonnellate di materiale per costituire la base, come la situazione di
questo campo potrebbe risultare precaria perché si potrebbe presentare l'e vent ualità di doverla abbandonare. Pertanto ha ritenuto di non poter accedere a tal e proposta e di avere invece deciso la cosli tuzion e a Bclet Uen di un campo occasionale sim il e agli altri numerosi in corso di appron tamento. D' aJtra parte i I campo di Mogadiscio è già o rganizzato come lerreno: il materiale sarà tutto davanti a Mogadiscio per il 18 maggio. I colli sono stati confez ionati in modo da renderne agevole il maneggio e lo sbarco dall' «Aussa». Se lo sbarco avviene subito, il campo di Mogadiscio in settembre potrà ricevere 50 apparecchi da bombardamento ed entro iJ 15 ottob re sarà completo; si è anche provveduto ali' invio della benzina e dei materiali per i campi occasionali avanzati.
S.E. Cav agnari chiede notizie circa le attuali condizioni di sbarco a Mogadiscio e S.E. Lessona informa c he tutti i mezzi sono impegnati fino al 31 maggio. TI Generale Pariani prende la parola per riferire il risultato di un colloquio avuto con l'Ammiraglio Vannutelli circa la migliore organizzazione e il migliore impiego dei trasporti mariuimi. La questione è stata impostata sopra il segue nte criterio: che i trasporti debbono essere considerati divisi in tre gruppi; nel primo gruppo che va fino al prim o luglio l'utilizzazione dei mezzi marittimi è massima poiché vi è stato il trasporto della «Gav in ana», delle masse di operai e vi sarà quello della «Sabauda». Nel secondo periodo che compre nd e luglio e agosto, epoca delle grandi piogge, non è previsto che l'invio di piccole aliquote di materia le. Nel terzo periodo da sette mbre in poi l'attività dei trasporti marittimi riprenderà in pi eno per il completame nto del trasporto del Corpo di spedizione. In tal modo ne l secondo periodo numerosi piroscafi resterebbero privi d'impiego con gravissimo onere finanziario. Per ovviare a tale inconveniente si sono prese in esame numerose oluzi oni, tra le altre quella di intensificare il trasporto di baracche e mezzi di ricovero in modo da poter inviare duranle·i detti mesi contingenti di uomini da ricoverare a Massaua o nel bassopiano o ri entale ove le grandi piogge sono meno intense. S.E. Badoglio concorda nell'idea d'inviare contingenti di truppe in anticipo poi c hé così si rag g iunge l 'a ltro scopo di poter disporre in Eritrea di truppe sufficienti alla fine del periodo delle grand i piogge, fine che cos tituirà un momento piuttosto critico. Pertant o pensa sia opportuno avvisare S.E. De Bono che s i può intensificare l'invio di baracche per modo c he si p otrà anticipare al periodo delle piogge l'invio di due divisioni CC.NN. e c iò entro luglio ed agosto. Dà pertanto incarico a S.E. Bai strocc hi d'inviare apposito telegramma a li ' A.C. [n questo telegramma si dovrebbe far noto che, comp re ndend o la necessità di disporre s ubito dopo le piogge, sull'altipiano, di truppe sufficien ti, sarebbe possibile inviare tutta la Divisione «Sabauda» e due divisioni CC.NN. durante la s tagione delle pi ogge, qualora s i potesse risolvere soddisfacentemente il problema di baraccarle. Poi c hé è poss ibile l'invio de ll e

baracche dall'Italia, riferisca se può provvedere a montarle tempestivamente e in quale località 1itiene più opportuno. Ali' obiezione mossa da S.E. Baistrocchi che tale ordine d'idee risulterebbe noto a S.E. De Bono ma che se I' A.C. non dimostra desiderare in Colonia nuove truppe durante le piogge potranno esistere delle fondate ragioni, S.E. Badoglio risponde che la proposta concretata dal Generale Pariani e dall'Ammiraglio Vannutelli parte da due ordini d'idee ugualmente apprezzabili:
1) utilizzazione razionale e continua dei mezzi marittimi
2) non condensare i trasporti nei tre mesi e mezzo successivi alle grandi piogge.
Occorre quindi far comprendere a S.E. De Bono questo secondo ordine d'idee e, se non è possibile inviare in anticipo le truppe, dica se preferisce che siano utilizzati i due mesi delle piogge coll'intensificare la spedizione del materiale o se ammette che il terzo periodo si estenda a tutto gennaio 1936. Poiché S.E. Baistrocchi fa osservare come il materiale di cui sopra non possa essere pronto per il luglio-agosto, allora S.E. Badoglio ritorna alla soluzione che prevede l'anticipato invio di truppe con sistemazione delle medesime a Ghinda o in luogo analogamente acconcio. Occorre pertanto fare un lungo e chiaro telegramma esplicativo a S.E. De Bono esponendogli particolareggiatamente quanto sopra ed occorre uniformars i alle indicazioni che dalla prefata Eccellenza perverranno, qualora siano accettate.
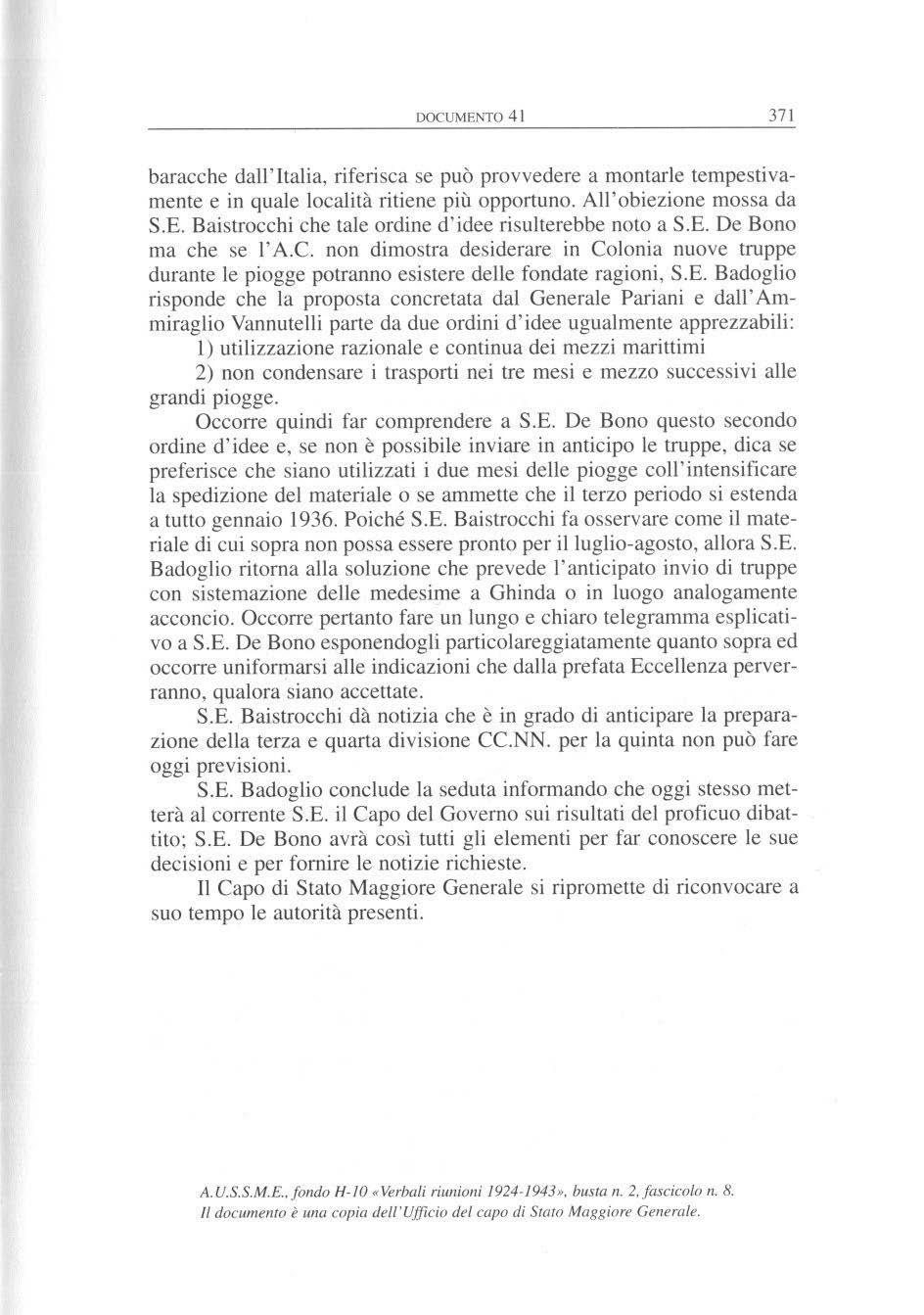
S.E. Baistrocchi dà notizia che è in grado di anticipare la preparazione della terza e quarta divisione CC.NN. per la quinta non può fare oggi previsioni.
S.E. Badoglio conclude la seduta informando che oggi stesso metterà al corrente S.E. il Capo del Governo sui risultati del proficuo dibattito; S.E. De Bono avrà così tutti gli elementi per far conoscere le sue decisioni e per fornire le notizie richieste.
Il Capo di Stato Maggiore Generale si ripromette di riconvocare a suo tempo le autorità presenti.

«Nuovo indirizzo dell 'ltalia in politica estera: rapporti con la Germania e la Francia, Ìnteressi italiani nel Mediterraneo e relative direttive strategiche. Assegnazioni massime di fondi straordinari alle forze armate sino al giugno 1938: situazione finanziaria dell'amministrazione dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, prospettata dai capi di Stato Maggiore, disposizioni finali di Badoglio».
Stralcio di verbale della seduta del 5 Novembre 1936
Alle ore 9 , 15 S.E. il Capo di Stato Maggiore Generale apre la seduta, dichiarando:
«Seguendo la nostra consuetudine del passato, dovrei far precedere l'esposizione delle vedute politiche del Capo del Governo, per dedurne i provvedimenti militari da adottare; ma quest'anno la situazione politica nostra è stata così chiarissimamente esposta da Capo del Governo in persona nel Suo discorso di Milano, che ogni mia parola sarebbe un pleonasmo. .
«C he cosa possiamo dedurre dalla esposizione fatta dal Capo del Governo?
«C'è una tendenza ad unire i nostri sforzi sull'asse Berlino-Roma e c'è una dichiarazione di pace per g li altri Stati.
«Il Capo del Governo inoltre mi ha separatamente detto che verso la Francia intende tenere un contegno benevolo, che però rende non operanti i noti accordi militari del t 935 perché manca il contendente dal1'al tra parte: la Germania.

«Ma un'altra cosa risulta ancora, ed in modo più evidente: è la dichiarazione del Capo del Governo che il Mediterraneo è per l ' Italia questione di vita.
«Perciò, per il momento, in attesa che la sit uazione politica venga a svilupparsi ulteriormente, o con l'adesione di altri paesi alla nostra linea politica, o con la differenziazione di altri Stati dalla nostra politica - ossia costituzione di blocchi -, dobbiamo esaminare il complesso problema sotto i tre punti di vista seguenti:
I) garanzia assoluta di vita dell'Italia nel Mediterraneo;
2) sicurezze delle nostre frontiere;
3) sicurezza del territorio nazionale.

«È evidente che, se la situazione politica avrà ulteriore sviluppi (o adesione di altri Stati alla nostra politica, o formazione di blocchi contrastanti), noi dovremo riunirci di nuovo per nuove decisioni.
«Per quanto riguarda le questioni relative ai tre punti di vista da me ora accennati, mi occorre fare subito riferimento ai verbali che il Capo del Governo ha fallo firmare alle LL.EE . i Sottosegretari di Stato delle tre Forze Armate nell'agosto u. s. I n tali ve rbali sono stabil ite le assegnazioni massime di fondi straordinari accordate, con l'impegno da parte di dette Eccellenze a non richiedere modificazioni sino al giugno 1938.
«Soggiungo che mi risulta che il Mini stro delle Finanze è molto preoccupato della situazione finanziaria del Paese e che il preventivo per l'anno venturo prevede 5 miliardi di passivo».
S.E. Cavagnari: «Se tali sono le premesse, non è il caso di prendere in esame un programma per la Marina. Mi è stata assegnata una cifra x, ed io ho sub ito dato disposizioni precise per l'attuazione del conseguente programma».
S.E. Badoglio: «Ma in qualsiasi bilancio, adottando sagge disposizioni si può sempre tirare fuori qualche cosa».
S.E. Pariani: « L'amministrazione della Guerra è in queste condizioni durante la campagna in A.O. si è aperto un capitolo 65 nel quale ognuno pescava, a il Ministero delle Finanze approvava. Dopo la marcia su Addis Abeba il Ministro delle Finanze ha chiuso il capitolo 65. Ma quello che da noi è stato inviato in A.O. era ve ro e proprio materiale di mobilitazione. Le commesse che s i sono date per integrare tali dotazioni hanno di già assorbito la assegnazioni del I 936-37, del 1937-38, e del 1938-39.
« L'ammini s trazione della Guerra ha già attualmente un debito di l .800 milioni. quindi non può manovrare fondi; se di manovra si vuol parlare, si deve intenderla come mirante a far sì che il debito di 1.800 milioni non aumenti ulteriormente.
« ln conclusione l 'amministrazione della Guerra può solo tirare avanti; ma nessun nuovo programma: al più può e deve cercare di ricuperare quanto più possibile dei l.800 milioni di passivo che oggi ha . Si vedrà di guadagnare sul bilancio ordinario, ma il campo è assai ristretto: si riduce a manovre nel ca mpo della forza bilanciata. Se si vuole un nuovo programma occorre la cifra tonda di 2.200 milioni».
S.E. Cavagnari: «Anche noi, per quanto s i riferisce alla gestione spese A.O., ci s iamo trovati nelle identiche condizioni: al termine della guerra è cessata la fonte delle assegnazioni straordinarie.
«Circa il bilancio ordinario è impossibile ricuperare nulla; anzi occorreranno ancora notevoli integrazioni, così che nelle pieghe del bilancio ordinario del la Marina non s i può pescare nulla».
S.E. Badoglio: «Tn sostanza per il Ministero della Guerra si tratta di 1.800 milioni che mancano rispetto agli impegni; occorrerebbero inoltre 2.200 milioni per sviluppare un nuovo programma»
S.E. Pariani: «Bene inte so in più dei 500 milioni avuti assegnati per il periodo triennale, i quali comprendono tutte le spese dell ' A.0. (esclusi i trasporti che gravano s ulla Marina), e la s istemazione difensiva della Patria.
«Noi calcolavamo di avere sull'aliquota dei 2.000 milioni per l ' A.O . un risparmio di 500 milioni da devolversi alla difesa della Madre Patria ; invece tutti i 5 miliardi e mezzo sono impegnati, e di più dobbiamo continuare a far fronte alle spese attuali dell' A.O. che sono 1ilevanti».
S.E. Badoglio: «Conchiudo: le assegnazioni state fatte alle tre Forze Armate di per se s tesse non erano sufficienti a coprire i fabbisogni già esistenti. A tali fabbisogni si sono aggiunte nuove neces s ità inderogabili.
«Come ho g ià accennato chiederà al Capo del Governo un colloquio perché non è possibile rimanere nell 'i ncertezza s u que s ti problemi che dobbiamo risolvere per assicurarci la vita nel Mediterraneo. La preparazione militare dev 'esse re in correlazione con la linea politica »
li verbale della seduta del 5.11.1936 è 1ra110 dall'opuscolo del generale Alberto Pariani. «Chiacchere e realtà», 27 gi ugno /949 (allega to n. /, pp. 23-25) e viene qui ripubblicato i111egralm e111e.


« Organi z zazione delle terre italiane d'oltremare (argomento i O dell'ordine del giorno per la XIV sessione della Commissione Suprema di Difesa): loro fun z ione militare nelle più probabili ipotesi di conflitto, l'Esercito e l ' organizz az ione delle colonie in caso di guerra, il teatro di opera zioni del Mediterraneo (importanza strategica del canal e di Sicilia, della Cirenaica e dell'Etiopia, delle isole italiane dell'Eg eo) , possibili operaz ioni in direzione est e sudest dalla Libia e a nord da/I 'Etiopia, la questione dei comandi per la dire z ione delle opera zioni ».

Verbale della seduta del 17 dicembre 1936 XV
Presieduta da S.E. il Capo di Stato Maggiore Generale
Autorità Presenti:
S.E. il Maresciallo d ' Italia Badoglio - Capo di Stato Maggiore Genera le
S.E il Generale d'Armata Aerea Valle - S. Segretario di Stato alla Aeronautica
S.E. l ' Ammir. d'Armata Cavagnari - S. Segretario di Stato alla Marina
S.E. il Gen. desig. d'Armata Pariani - S. Segretario di Stato alla Guerra
il Gen. di Brig. Aerea Santoro - Capo 1° Rep. Op. - Uff. S.M. R. Aeronautica
il Colon. di S.M. Gorlier - Capo Uff. Op. del Comando Corpo S.M. Min. Guerra
il Cap. freg. Del Cima - dell'Ufficio di S.M. della R. Marina.
Segretari:
Colonnello di S.M. Bollea
Colonnello A.A. Cassiani .:.... ln goni
Capitano di fregata Elena
Alle ore 9,30 S.E. il Capo di Stato Maggiore Generale 'apre la seduta dichiarando:
- H o pregato le LL.EE. di convenire a questa riunione per metterci d'accordo sull'argomento 10 ° dell'ordine del giorno per la XIV sessione della Commissione Suprema di Difesa: «l'organizzazione delle terre italiane d'oltremare», argomento del quale saranno relatori le LL.EE. i Ministri per le Colonie - Comunicazioni - Guerra - MarinaAeronautica - Finanze - nonché i Marescialli d'Italia Badoglio e Graziani, ed il Maresciallo dell'Aria Balbo.

- In questo momento riesce alquanto difficile stabi lire la funzione militare delle terre italiane d'o ltremare nelle più probabili ipotesi di conflitto perché una delle nostre Colonie, la più grande , è ancora in via di costituzione; non solo, ma, possiamo dire, per un paio d ' anni ed anche più assorbirà forze ed attività della Madre Patria, e non sarà in grado di dare nessun concorso in caso di conflitto altrove.
L a Libi a invece ha recentemente dato prova di quello che può fare: per la conquista dell'altra Colonia ha dato un'intera divisione più gruppi di sphais.
Il problema si presenta sotto aspetti diversi a seconda dei casi in cui si possono manifestarsi le ostilità, ed a secondo delle d iverse condizioni conseguenti in cui viene ad essere interessato il territorio della singola Colonia. Mi spiego: se , ad es. immaginiamo di trovarci in conflitto con Potenze confinanti con la L ibia, questa richiederà aiuti dalla Madre Patria tanto ad est quanto ad ovest. È quanto abbiamo dovuto fare durante il conflitto italo-etiopico.
Secondo me il venire oggi a precisare gli interventi delle nostre Colonie nel caso di avvenimenti europei è un po' prematuro. Oggi possiamo soltanto dire che per il prossimo avve nire , in caso di qualsiasi complicazione, una delle due nostre Colonie, l ' Impero , non solo non potrà intervenire, ma dovrà avere aiuti dalla Madre P atria; l'altra, la Libia , resta anch'essa subordinata alle attuali condizioni dell'A.0. perché ha in essa un ' intera sua divisione. E siccome tutta la L ibia ha scarsa potenzialità di reclutamento , possiamo formulare il principio che in genere contro forze nemiche gravitanti co ntro la Libia ad est o ad ovest, quest'ultima ha bisogno dell'intervento della Madre Patria.
- Questa è, secondo me, la visione generale del problema: s ulla visione particolare debbono riferire le LL.EE. P ariani, Cavagnrui, Valle.
- S.E. Graziani probabilmente non potrà intervenire alla sessione della Commis s ione Suprema di Difesa; S.E. Balbo vi interverrà, ma, d'altra parte, a tutti noi è nota la forza di cui la Libia può disporre.
Domando a ciascuno delle LL.EE. presenti se il quadro generico da me fatto rientra nelle loro vedute, o se hanno qualcosa di speciale da rappresentare.
S.E. Pari ani - Des idero premettere una questione di principio: l'Esercito è oggi esclu so da ogni organizzazione delle Colonie.
Nell'organizzazione attuale dell ' Impero l'Esercito si limita a fare stud i, ma non può poi intervenire in essa. Bisogna s tabilire che, in caso di guerra, le questioni debbono essere impostate e condotte dallo Stato Maggiore e non dal Ministero delle Colonie.
S.E. Badoglio - L'osservazione di S.E. Pariani è giusta: si dovrà portarla alla Commissione Suprema di Difesa. - 11 caso specifico della conquista dell'Etiopia in segna: nella guerra italo-etiopica si è innestato il pericolo di una maggiore estensione del conflitto che era puramente coloniale, e perciò si è dovuto intervenire per rinforzare la Li bia e l'Egeo.

S.E Pariani - Difatti l'Esercito ha ceduto unità, ma dal momento della loro cessione in poi non ha più potuto intervenire.
Nella nostra organizzazione mrntare dobbiamo tendere ad utilizzare le Colonie.
Se posiamo lo sg uardo s ul Mediterraneo , vediamo che i punti essenzia li del teatro sono il Canale di Sicilia, i Dardanelli ed il Canale di Suez: teatro marittimo, che influi sce però su quello terrestre.
Canale di Sicilia: abbiamo in corso la questione di Pantelleria, che dev 'essere esaminata non a sé, ma in relazione alla funzione del Canale di Sicilia.
D ardanelli e Suez - inte res sano il Dodecanneso, nel quale Marina ed Aviazione hanno i compiti essenziali, l'Esercito deve soltanto garantire la difesa del territorio del Po ssedimento italiano.
Cirenaica ed Etiopia - hanno funzioni la cui importanza appare evidente ai fini di:
esercitare il controllo del Canale di Suez, stabi lire una linea di collegamento tra Cirenaica ed Etiopia, donde: importanza di Tobruk, per un'eventuale azione verso est, importanza di tutto il co nfin e sud -orientale della Libi a, zona di partenza di un'eventuale nostra azione intesa a stabilire il collegamento territoriale della Lib ia con l'Etiopia.
L'Impero è in formazione; il Sudan anglo-egiziano per questioni di politica inglese non è mai stato unito all'Egitto con una comunicazione ferroviaria continua. Nel corso della tensione italo-inglese l ' Inghilterra ha sempre tenuto quale porto di rifornimento per il Sudan, Porto Sudan. L' In ghilterra può tenere nel Sudan anglo-egiziano soltanto poche forze, come è stato provato recentemente: durante la guerra italo-etiopica vi ha tenuto soltanto una divisione. Un'eventuale nostra azione dall'Etiopia verso il Sudan non offrirebbe grandi difficoltà , perché l 'Ing hilterra incontra nel Sudan maggiori difficoltà di noi.
S.E. Badoglio - Du rante la ca mpagna italo -etiopica ho fatto fare lo studio relativo: è risultato sufficiente l'impiego di un corpo d 'armata.
S.E. P ariani - Dalla zona Wadi Halfa si può tendere alla Cirenaica attraverso alla zona che corrisponde al vecchio Nilo. Nella zona deserti-
ca impraticabile che si stende tra l'antico corso del Nilo ed il corso attuale corre una serie di oasi che rende possibile una nostra azione che staccando l'Egitto dal Sudan, tenda a collegare le nostre due Colonie con un collegamento indipendente daJ mare.
Questo collegamento può essere realizzato per mezzo dell 'aviazione e di adatti mezzi meccanizzati.
Per quanto concerne il Canale di Sicili~, ossia un'azione verso la Tunisia, dobbiamo prendere in esame il rapporto delle forze.
S.E Badoglio - Rapporto di decisa inferiorità per noi , perché i Francesi si sono organizzati in modo da poter fare affluire forze in Tunisia dal Marocco e dall'Algeria.
S.E. Pariani - Dalla Libia noi non possiamo agire offensivamente ad est e ad ovest: dato che il lato occidentale è quale risulta da questo squilibrio di forze, lì abbiamo interesse a creare fortificazioni, invece che fortificare come s i è fatto ad est, a Tobruk. Perciò io vedrei un 'organizzazione difensiva ad occidente ed un'organizzazione offensiva ad oriente con lavori di fortificazione leggera a Tobruk per garantirci quella base dalla quale possiamo agire sia verso est, sia verso sud.
Per l'Etiopia non mi sembra possibile per ora pensare ad operazioni offensive che paitono dall ' Impero. ,
S.E. Badoglio - Conferma il mio pensiero che per l'Etiopia qualsiasi studio è per ora prematuro. Abbiamo laggiù più di 200.000 nazionali: ci vogliono anni prima che abbiamo una sistemazio ne interna che consenta di alleviare la nostra occupazione militare fatta con truppe della Madre patria.
Circa la questione relativa all'occidente della Libia, accennata da S.E. Pariani, l 'ho st udiata quando ero Governatore di quella Colonia. Mi so no risultati guai seri che ci ha confermato l'azione su Buchamez. Ora però abbiamo consolidato l'efficienza e l'organizzazione delle truppe arabe, con le quali potremo dare del filo da torcere; ma quella frontiera non offre nessuna difficoltà ad un'eventuale azione nemica: fortificato da noi in un certo punto, il nemico può facilmente passarla qualche chilometro più in là.
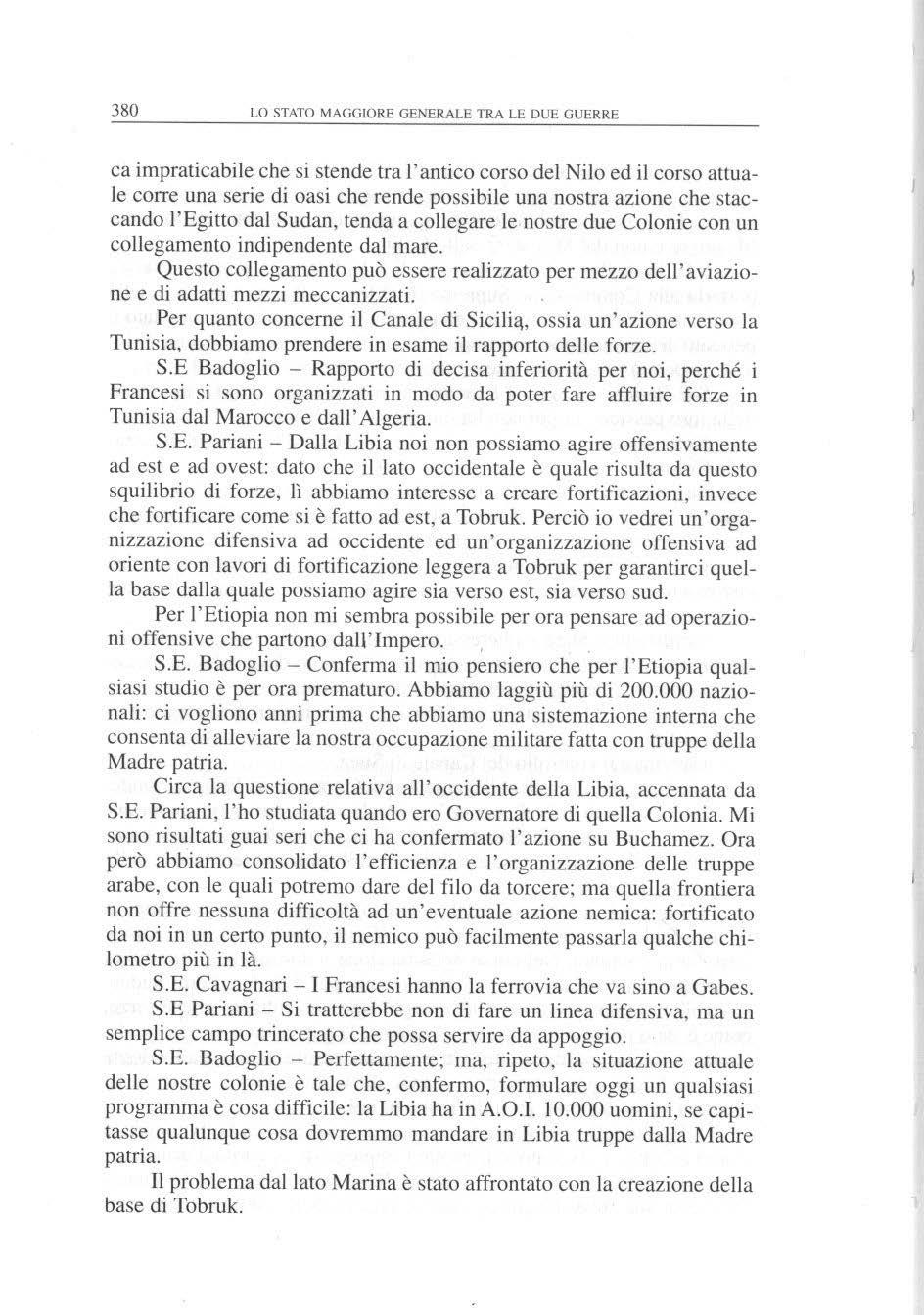
S.E. Cavagnari - 1 Francesi hanno la ferrovia che va s ino a Gabes.
S.E Pariani - Si tratterebbe non di fare un linea difensiva , ma un semplice campo trincerato che possa servire da appoggio.
S.E. Badoglio - Perfettamente ; ma, ripeto, la s ituazione attuale delle nostre colonie è tale che, confermo, formulare oggi un qualsiasi programma è cosa difficile: la Libia ha in A.O.I. 10.000 uomini, se capitasse qualunque cosa dovremmo mandare in Libia truppe dalla Madre patria.
11 problema dal lato Marina è s tato affrontato con la creazione della base di Tobruk.
S.E. Cavagnari -A questo proposito sorge la questione dei comandi, intesa nel senso di direzione delle operazioni. Già da tempo erano costituiti 3 Governatorati per le terre italiane d'oltremare. S.E. il Governatore dell ' Egeo poco fa assumendo il Governo ha comunicato di avere costituito un particolare Stato Maggiore (l'Ufficiale del R. Esercito, 1 della R. Marina, 1 della R . Aeronautica) che ha per capo di stato maggiore l'ufficiale della R. Marina perché la funzione principale in Egeo per ora l'ha la Marina. In avvenire sarà ancora così? o il Capo di Stato Maggiore dovrà essere un ufficiale di Aviazione?
È necessario addivenire ad una precisazione: a prescindere dagli apprestamenti permanenti (batterie, difese antiaeree, ecc.) in Egeo si avrà la dislocazione di forze mobili (divisioni navali, squadriglie di sommergibili, ecc.) che dovrebbero essere maneggiate da quel Governatore generale.
S.E. Balbo sostiene che il comando della base di Tobruk deve essere devoluto ad un ufficiale di Marina. lo rappresento che il campo trincerato è stato costruito per assicurare la possibilità di accentramento di forze del R. Esercito a quel confine, cioè come base per offensive verso oriente non per la difesa di Tobruk , e che, analogamente l'imponente organizzazione aeroportuale cui s i è addivenuti a Tobruk non ha per scopo la difesa di Tobruk, ma operazioni offensive.
S.E. Badoglio - Ritengo giustissima la sua osservazione. S.E. Valle ci dirà ora il suo pensiero che prevedo sarà simile a quello di S.E Cavagnari.
L'aumento delle forze aeree in Egeo ed a Tobruk deve sfugg ire alla competenza dei Governatori , ai quali spetta so ltanto il comando delle forze quando so no impiegate a scopi di dife sa; quando si va al di là i Governatori devono ricevere ordini da l centro.
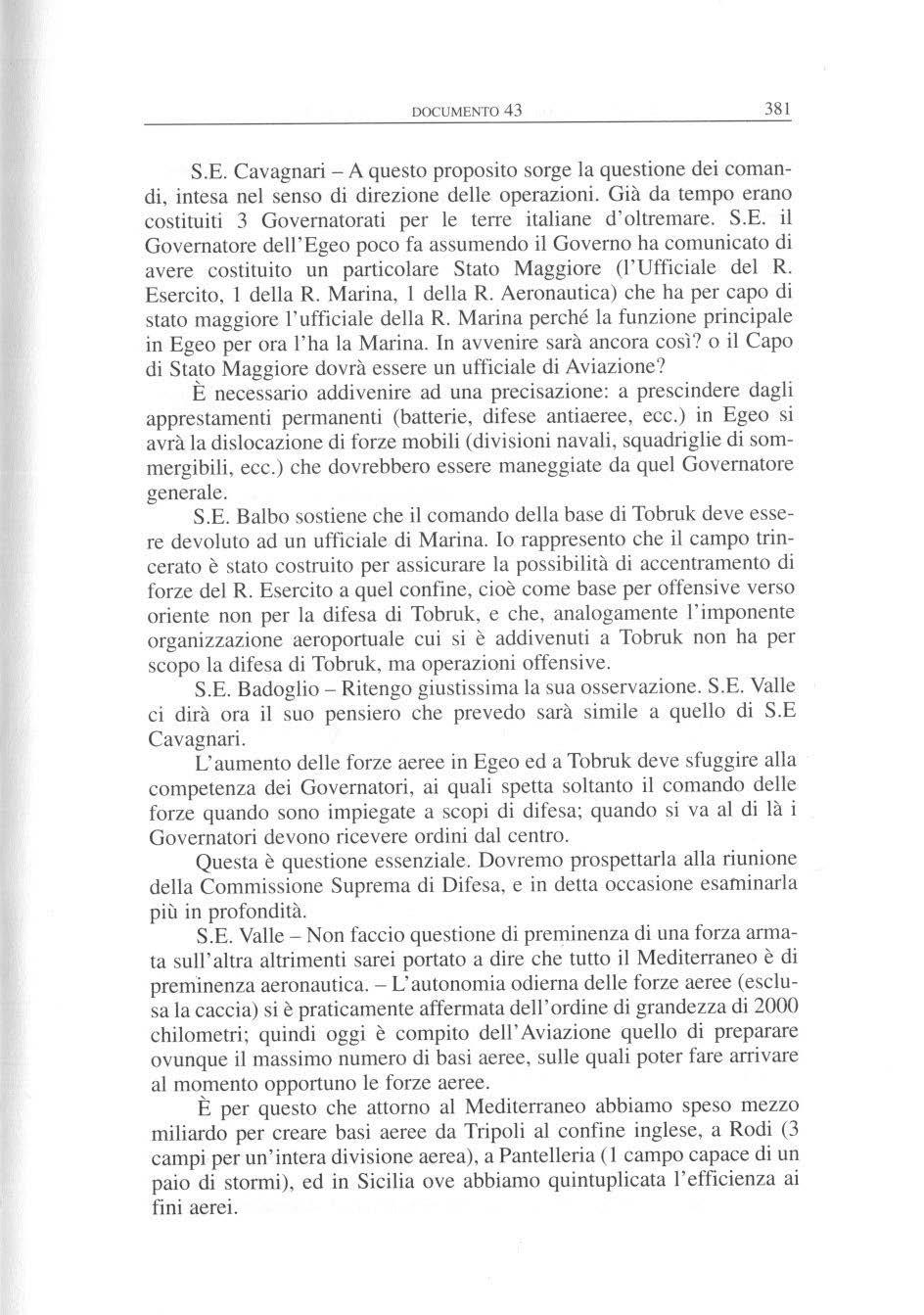
Questa è questione essenziale. Dovremo prospettarla alla riunione della Commi ss ione Suprema di Difesa, e in detta occasione esaminarla più in profondità.
S .E. Valle - Non faccio questione di preminenza di una forza armata sull'al tra alu-imenti sarei portato a dire che tutto il Mediterraneo è di preminenza aeronautica. - L'autonomia odierna delle forze aeree (esclusa la caccia) s i è praticamente affermata dell'ordine di grandezza di 2000 chilometri; quindi oggi è compito dell ' Aviazione quello di preparare ovunque il massimo numero di ba s i aeree , sulle quali poter fare arrivare al momento opportuno le forze aeree.
È per questo che attorno al Mediterraneo abbiamo speso mezzo miliardo per creare basi aeree da Tripoli al confine inglese, a R odi (3 campi per un'intera divisione aerea), a Pantelleria (1 campo capace di un paio di stormi), ed in Sicilia ove abbiamo quintuplicata l'efficienza ai fini aerei.
Questo grandioso programma sarà ultimato entro il 1937, e per il 1938 potremo avere il conseguente imponente schieramento di mezzi aerei.

«Organizzazione militare delle Isole italiane dell'Egeo: fabbisogno complessivo e spese necessarie alla difesa delle isole, piani di difesa studiate dalle tre forze armate, difese delle isole minori (Scorpanto, Srampalia, Coste/rosso, Coo), dipendenza in guerra delle forze militari dislocate nelle isole. Questioni relative al comando delle forze nella base di Tobruk. Difesa dell'isola di Pantelleria».
Roma, 30 gennaio 1937-XV
Verbale della seduta del 22 gennaio 1937-XV presieduta da S.E. il Capo di Stato Maggiore Generale.
Autorità presenti:
S.E. il Maresciallo Badoglio - Capo di Stato Maggiore Generale;
S.E. il Gen. d'Armata Valle - Sottosegretario di Stato ali' Aeronautica;
S.E. l' Ammiragl. d' Arm. Cavagnari - Sottosegretario di Stato alla Marina;
S.E. il Generale des. d' Arm. Pariani - Sottosegretario di Stato alla Guerra;

S.E. l' Ammfragl. di Squadra Pini - Sottocapo di S.M. della R. Marina;
S.E. il Generale di Squadra Pinna - Sottocapo di S.M. della R. Aeronautica;
il Gen. di Div. Ro si -Sottocapo di S.M. Intendente del R. Esercito;
il Colono. di S.M. Gorlier - Capo Uff. Op. del Comando del Corpo diS.M.;
il Cap. di fregata Del Cima - dell'Ufficio di S.M. della R. Marina
Segretari:
Generale di Brigata Bollea
Capitano di Vascello Elena
Colonnello A.A. Cassiani-lngoni
Alle ore 9,30 S.E. il Capo di Stato Maggiore Generale apre la seduta dichiarando:
«Questa mattina completeremo l ' esame della organizzazione militare delle iso le italiane dell'Egeo. All ' uopo farò dare s ucce ssive lettura di quanto è stato studiato, ed in parte già attuato, dalle tre Forze Armate, nonchè delle proposte pervenute dalla R. Marina , dalla R. Aeronautica e dal R. Esercito».
Gen. Bollea dà lettura delle organizzazioni difensive studiate dalla R. Marina (vedi allegato n ° I).
S.E. Pini - «Chiarisce che la batteria da 203 è ancora allo stato di progetto. Per essa si so no stud iate 2, anzi 3 postazioni in relazione a determinati settori di tiro che si ritiene di affidare a detti pezzi».
S.E. Badoglio - «In definitiva, questa batteria è già stata decisa? >>.
S.E. Pini - «Subordinatamente alla concessione dei relativi fondi».
S.E. Badoglio - <<In questa sede prescindo dalla assegnazione dei fondi neces sari, per i quali riferirò a S.E. il Capo del Governo. C'è una proposta d'ordine generale: trasportare a Rodi sin dal tempo di pace tutto ciò che non è deperibile, in modo da ridurre al minimo possibile i trasporti da effettuarsi poi al momento della guerra. Ritengo che a siffatta proposta ciascuna delle Forze Armate possa se nz'altro accedere. Si parla se mpre della guerra come di cosa che deve scoppiare improvvisa; ma io credo che si avrà pur sempre un periodo di tensione diplomatica che potrà essere sfrnttato ai fini militari.
Pur tuttavia è bene, ripeto, che si avvii si n da ora a Rodi quanto più si può.
Farò dare lettura dell'organizzazione s tudiata dalla R. Aeronautica per le isole italiane dell'Egeo».
Generale Bollea - Dà lettura della «organizzaz ione studiata dalla R. Aeronautica (vedi allegato n° 2)».
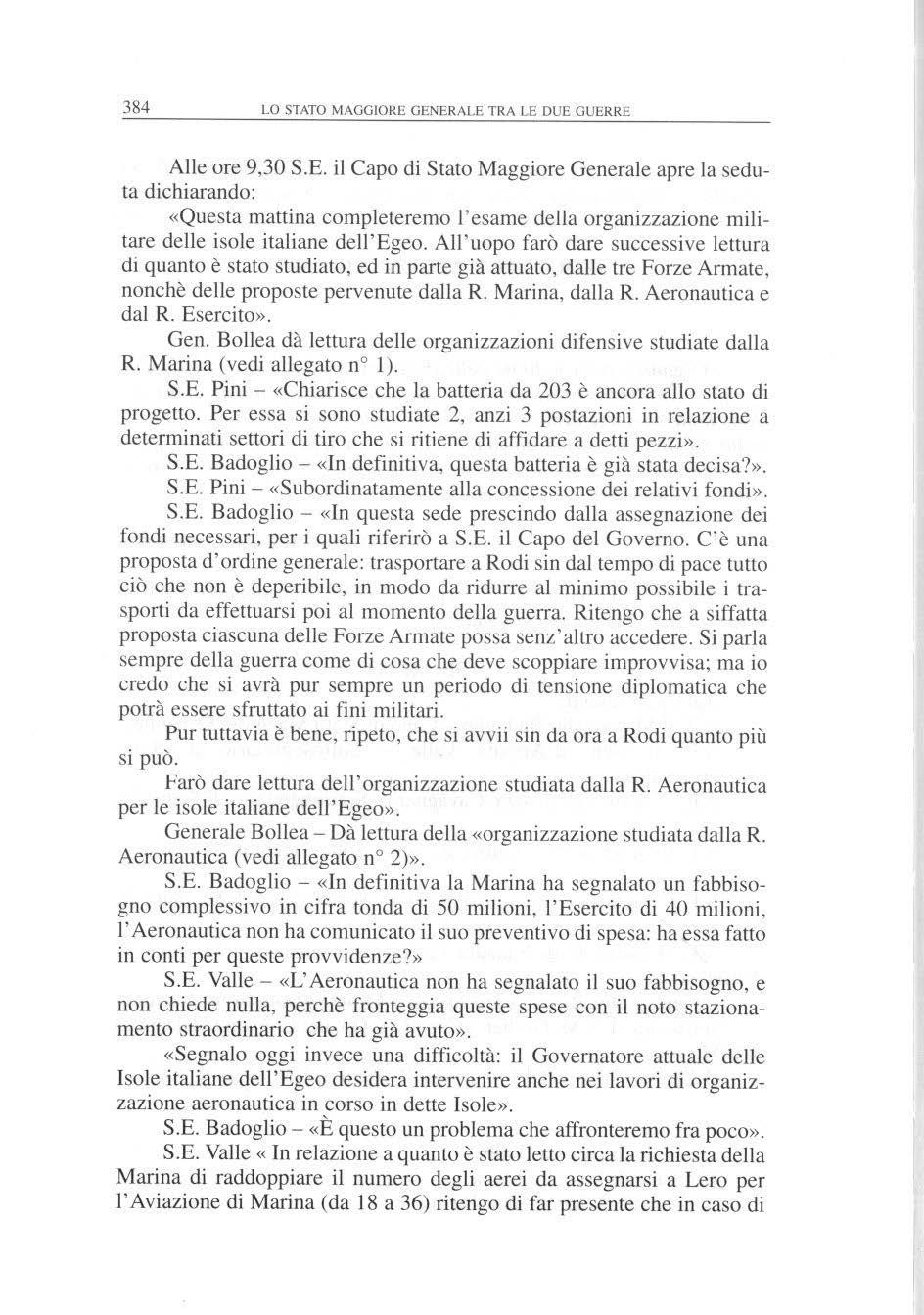
S.E. Badoglio - «In definitiva la Marina ha seg nalato un fabbisogno complessivo in cifra tonda di 50 milioni, l'Esercito di 40 milioni , l'Aeronautica non ha comunicato il s uo preventivo di spesa: ha essa fatto in conti per queste provvidenze? »
S .E. Valle - «L'Aeronautica non ha segnalato iI suo fabbisogno, e non chiede nulla , perchè fronteggia queste spese con il noto stazionamento strao rdin ario che ha già avuto».
«Segnalo oggi invece una difficoltà: il Governatore attuale delle Iso le italiane dell'Egeo desidera intervenire anche nei lavori di organizzazio ne aeronautica in corso in dette Isole».
S.E. Badoglio - «È questo un problema che affronte remo fra poco »
S.E. Valle« In relazione a quanto è stato letto circa la richiesta della Marina di raddoppiare il numero degli aerei da assegnarsi a Lero per l ' Aviazione di Marina (da 18 a 36) ritengo di far presente che in caso di
guerra i mezzi rinforzati che la Marina richiede non avrebbero modo di esplicare la loro attività a Portolago . Già s'incontrano difficoltà oggi. Bisogna che in quello specc hio d'acqua ri s ulti completamente sgombra la lin ea di partenza; perciò, prima di decidere l ' u1terio re aumento degli apparecchi, è indispensabile esaminare più profondamente il problema».
S.E. Badoglio - «È certo che per l ' Aeronautica è indispensabile avere lib e ra la linea dì partenza».
S.E. Valle - «È questa la ragione principale per la quale nella nuova organizzazione studiata s i è sostituito al bombardamento marittimo quello terrestre. Di quì la nuova attrezzatura di Rodi , per la quale P ortolago rimane a disposizione della Marina».
S.E. Badoglio - «Sta bene; allora, poichè è la Marina che ha il coma ndo a L ero, dovrà essa studiare la questione sul posto, in modo da decongestionare la rada cosicc hé questa possa fronteggiare le esigenze marittime e quelle aeronautiche. In base a quanto risulterà da questo studio i due Ministeri interessati definiranno direttamente fra loro la questione»
Gen. Bollea - <<Dà lettura delle «organizzazio ni difensive studiate dall'Esercito» (vedi allegato n° 3).

S.E. Badog li o - «Il R. Esercito ha provveduto per la mobil itazione di queste truppe?».
S.E. P ariani - «Ho provveduto quì in Patri a; in definitiva il presidio dì guerra studiato per l 'Egeo prevede 10.000 uomini, dei quali 4 mila già s ul posto sin dal tempo di pace, compresi in essa 600 uomini in congedo nelle iso le.
Resta perciò da provvedere al momento d ella mobilitazione al trasp orto dalla Madrepatria di 6.000 uomini; sì potrebbe invece portare sin da ora nelle isole tutto il materiale non deteriorabile; ma per fare questo s i dovrebbero avere pronti i magazzini relativi, per la costruzione dei quali occorrono fondi».
S.E. Cavagnari - «La Marina ha già sia a Lero, sia a Rod i, s ia a Tobruk il suo personale quasi al co mpleto » .
S.E. Badoglio - «Il Comando del Corpo di Stato Ma ggiore prospe tta l 'op portunità generica che sia vagliato il problema della difesa delle iso le italiane minori.
In particolare pe r d etto comando la difesa di Stampalia e di Scarpanto, se bene organizzata, potrebbe conco rre re a costituire una antemurale a protezione delle provenienze da Candia.
La Marina ritiene che l'Inghilterra potrebbe avere interesse ad occupare, ìn guerra, Stampalia per farne una base avanzata dalla quale agire contro Lero e co ntro Rodi , sebbene sia molto vicina (40 miglia); ma ritiene che non s ia il caso di rafforzarla con una vera organizzazione difens iva , per la quale ritiene s uffici e nti i mezzi che già vi ha dislocato:
una batteria da 76/40 antinavi, una da 76/17 da sbarco, 20 mitragliatrici da 6,5 ed una stazione fotoelettrica.
lo ritengo che per Stampalia questi mezzi siano sufficienti.
Circa Scarpanto secondo la Marina anche se caduta in mano al nemico, si può sempre passare attraverso gli sbocchi meridionali dell'Egeo.
lo non la presidierei per non disseminare i nostri mezzi.
Circa Castelrosso, la Marina ritiene che possa rappresentare un punto di appoggio avanzato per idrovolanti , ma non la giudica degna di sottrarre al le forze del Possedimento quanto sarebbe necessario per la sua difesa; l'Aeronautica non la prende in esame. Per me Castelrosso è eccentrica, è troppo sottoposta alla costa anatolica, e aggraverebbe il disseminamento delle nostre forze».
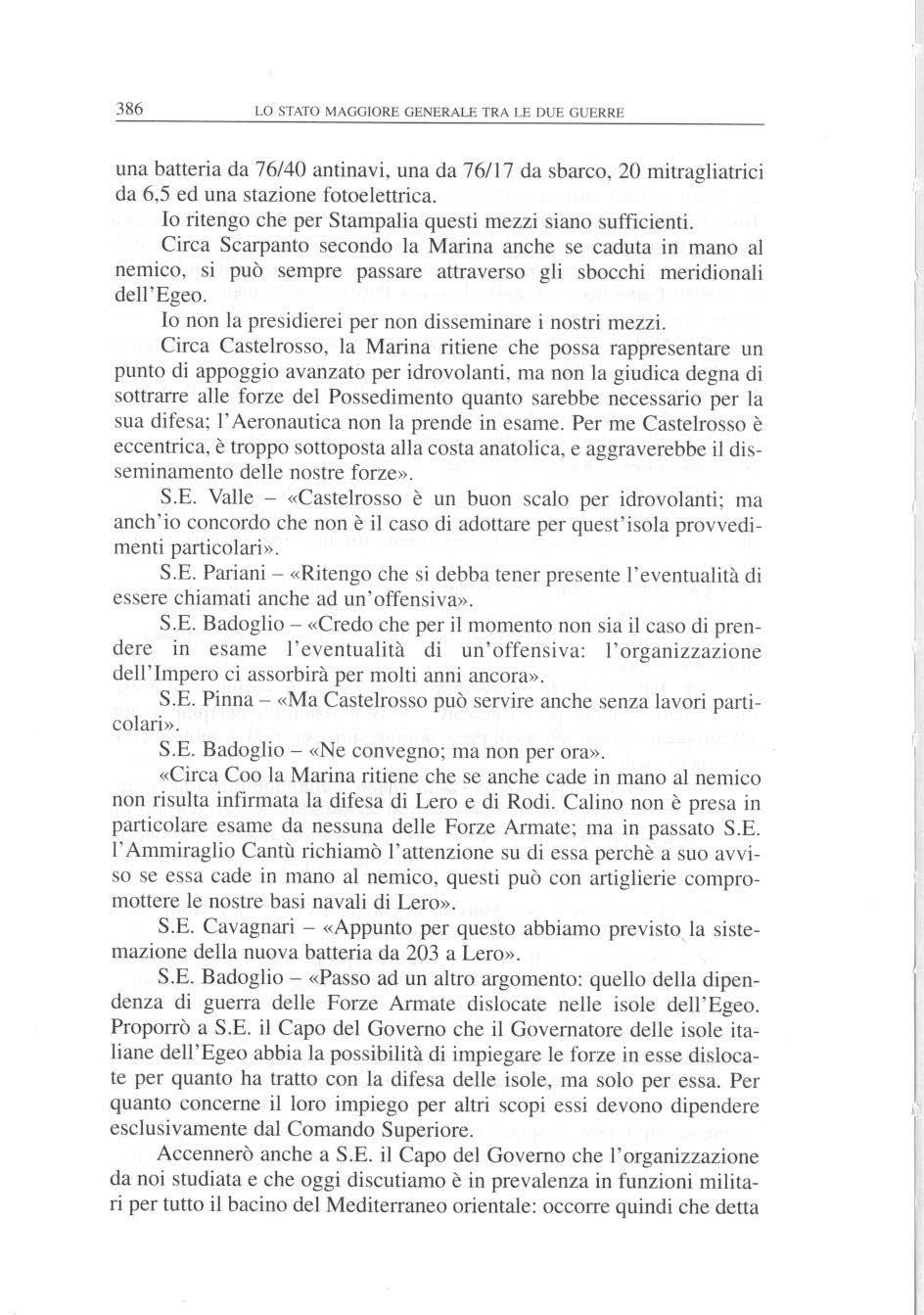
S.E. Valle - «Castelrosso è un buon scalo per idrovolanti; ma anch'io concordo che non è il caso di adottare per quest ' isola provvedimenti particolari».
S.E. Pariani - «Ritengo che si debba tener presente l 'eventualità di essere chiamati anche ad un'offensiva».
S.E. Badoglio - «Credo che per il momento non sia il caso di prendere in esame l'eventualità di un'offen siva: l'organizzazione dell'Impero ci assorbirà per molti anni ancora».
S.E. Pinna - «Ma Castelrosso può servire anche se nza lavori pai1icolaii».
S.E. Badoglio - «Ne convegno; ma non per ora». «Circa Coo la Marina ritiene che se anche cade in mano al nemico non risulta infirmata la difesa di Lero e di Rodi. Ca li no non è presa in particolare esame da nessuna delle Forze Armate; ma in passato S.E. l'Ammiraglio Cantù richiamò l'attenzione su di essa perchè a suo avviso se essa cade in mano al nemico , questi può con artiglierie compromottere le no stre basi navali di Lero».
S.E. Cavagnari - «Appunto per questo abbiamo previsto la s istemazione della nuova batteria da 203 a Lero>>.
S.E. Badoglio - « Passo ad un altro argomento: quello della dipendenza di guerra delle Forze Armale di s locate nelle iso le dell'Egeo.
Proporrò a S.E. il Capo del Governo che il Governatore delle isole italiane dell'Egeo abbia la possibilità di impiegare le forze in esse dislocate per quanto ha tratto con la difesa delle isole, ma solo per essa. Per quanto concerne il loro impiego per altri scopi essi devono dipendere esclusivamente dal Comando Superiore.
Accennerò anche a S.E. il Capo del Governo che l'organizzazione da noi studiata e che oggi discutiamo è in prevalenza in funzioni militari per tutto il bacino del Mediterraneo orientale: occorre quindi che detta
organizzazione possa svolgersi secondo le direttive che vengono date da Roma, al di fuori di qualsiasi ingerenza del Governatore».
S.E. Valle - «C'è già un precedente: l'organizzazione attuale delle forze aeree e navali in Libi a. La Libi a è in definitiva la base, dirò la pedana per agire offensivamente. Questo concetto è stato sancito con appos ita legge. Non c'è che estenderla a nche all'Egeo».
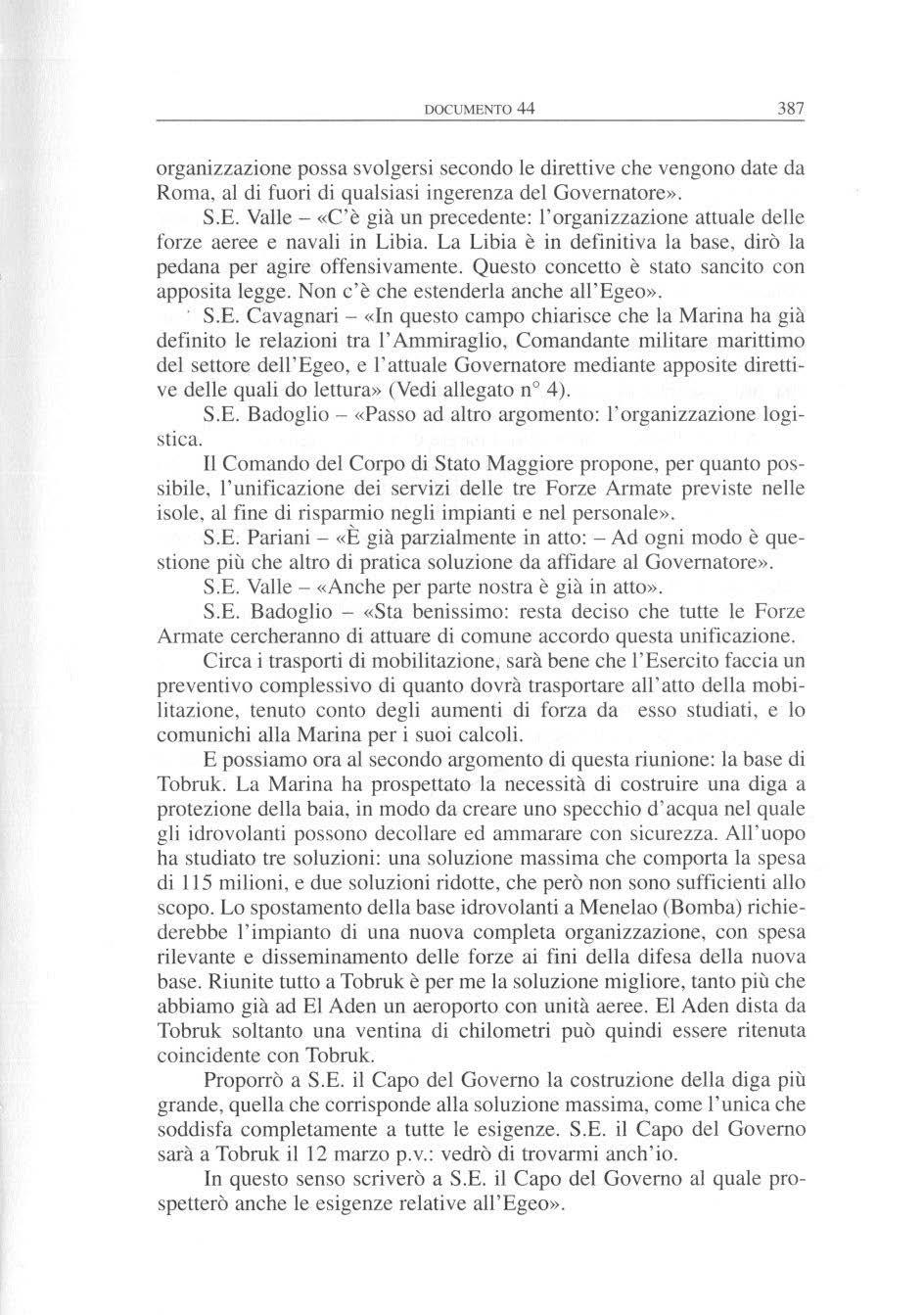
· S.E. Cavagnari - «In questo campo chiarisce che la Marina ha già definito le relazioni tra l'Ammiraglio, Comandante mi litare marittimo del settore del!' Egeo, e l'attuale Governatore mediante apposite direttive delle quali do lettura>> (Vedi allegato n° 4).
S.E. Badoglio - «Passo ad altro argomento: l'organizzazione logistica.
l1 Comando del Corpo di Stato Maggiore propone, per quanto possibile, l'unificazione dei servizi delle tre Forze Armate previste nelle isole, al fine di risparmio negli impianti e nel personale».
S.E. Pariani - <<È già parzialmente in atto: - Ad ogni modo è questione più che altro di pratica soluzione da affidare al Governatore».
S.E. Valle - «Anche per parte nostra è già in atto».
S.E. Badoglio - «Sta benissimo: resta deciso che tutte le Forze Armate cercheranno di attuare di comune accordo questa unificazione.
Circa i trasporti di mobilitazione, sarà bene che l ' Esercito faccia un preventivo complessivo di quanto dovrà trasportare all'atto della mobilitazione, tenuto conto degli aumenti di forza da esso studiati, e lo comunichi alla Marina per i suo i calcoli.
E possiamo ora al secondo argomento di questa riunione: la base di Tobruk. La Marina ha prospettato la necessità di costruire una diga a protezione della baia, in modo da creare uno specchio d ' acqua nel quale gli idrovolanti possono decollare ed ammarare con sicurezza. All'uopo ha studiato tre sol uzi oni: una soluzione massima che comporta la spesa di 115 milioni, e due so lu zio ni ridotte, che però non sono sufficienti allo scopo. Lo spostamento della base idrovolanti a Menelao ( Bomba) richiederebbe l'impianto di una nuova completa organizzazione, con spesa ril evante e disseminamento delle forze ai fini della difesa della nuova base. Riunite tutto a Tobruk è per me la soluz io ne mi g liore , tanto più che abbiamo già ad El Aden un aeroporto con unità aeree. El Aden dista da Tobruk soltanto una ventina di chilometri può quindi essere ritenuta coincidente con Tobruk.
Prop orrò a S.E. il Capo del Governo la costruzione della diga più grande, quella che corrisponde alla soluz ione massima, come l'unica che soddisfa completamen te a tutte le esigenze S.E. il Capo del Governo sarà a Tobruk il 12 marzo p.v.: vedrò di trovarm i anch'io.
In questo senso scriverò a S.E. il Capo del Governo al quale prospetterò anche le esigenze relative all'Egeo>>.
S.E. Pariani - «B isognerebbe risolvere la questione del comando delle forze a Tobruk».
S.E. Badoglio - «È questione di carattere interno che per ora, non ritengo indispensab il e affrontare».
S.E. Valle - «C'è invece la questione di Pantelleria che ritengo sia bene affontare oggi. L'Aeronautica sta di già attuando una sua organizzazione per la quale ha già sul posto; operai, materiali ecc. e che comporta una spesa che si aggirerà sui 60 milioni. La Marina ha previsto per Pantelleria un'organizzazione. Bisognerebbe che i lavori cLi questa ultima procedessero di pari passo con quelli dell'Aeronautica affinché venisse assicurata la difesa dell'isola».
S.E. Badoglio - «Sentiamo il parere di S.E. Cavagnari».
S.E. Cavagnar i - «Proprio ieri ho fatto vedere a S.E. il Capo del Governo gli studi fatti per la difesa antiaerea ed antisbarco di Pantelleria, e per la preparaz ione del porticciolo. S.E. il Capo del Governo, esaminato il completo programma di massima per il porticciolo (molo, scavo interno e svuotamento) ha approvato soltanto lo svuotamento (costo preventivato: 11 milioni).

Il programma per la difesa antiaerea ed antisbarco comprende 43 milioni per spese del genio militare (postazione delle batterie) più 84 mi lioni per acquisto dei matetiali di artiglieria e per la preparazione delle batterie: 3 di medio calibro, più 7 di piccolo calibro, più mitragliere; ossia un totale dai 100 ai 120 mi lioni.
S.E. il Capo del Governo ha autorizzato in massima questi lavori, ma ha ordinato che si esamini se è possibile diminuire la spesa per le artiglierie utilizzando materiali che già esistono».
S.E. Badoglio - «Sta bene: allora bisognerà ottenere i fondi necessari.
Otten u tili, mi si r iferirà, in modo che sia tenuto al corrente dello sv iluppo paralle lo delle due organizzazioni».
S.E. P aria n i - «Bisognerà vedere se per la difesa de ll 'isola occorrerà anche dis locarvi qualcosa dell'Esercito».
S .E . Cavagnari - «No n ritengo che si possa parlare di sbarchi veri e propr i su Pantelleria; al p iù di colpi di mano» .
S E. Badoglio - «Il Capo di Stato Maggiore dell ' Esercito studi la quest io ne e mi r i ferisca poi in me rito» .
La seduta è tolta alle ore 11.
Organizzazioni difensive studiate dalla R. Marina
Organizzazioni fisse:
a) a Lero, sbarramento di mine (ostruz ioni ); artiglierie antinavi, antiso mmergibili, antiaeree;
b) a Rodi , limiti apprestamenti antisbarchi e controaerei (ostruzioni, artiglierie antinavi, antisommergibili antiaeree);

c) a Stampalia, Castelrosso e Coo, qualche piccola difesa;
d) vigilanza semaforica delle acque di tutte le isole, effettuata da terra.
In particolare:
a Lero:
1 batteria su 3 pezzi da 203/55 co n X= 29.000 m. (in studio);
5 batterie m.c. ( 152/50 con X = 18.500; 152/40 con X= 16.000; 120/45 con X= 17.000; 102/35 con X = 12.000, che è anche contraerei con X = 7 .000);
16 batterie piccolo calibro antinavi e antisiluranti (76/50 e 76/40 con X = 9.000) delle quali 7 da 76/40 anche contraerei con X = 6.000.
7 s barramenti antinavi (di 30 anni ciascuno)
2 sbarramenti antisommergibili (60 armi ciascuno) (le 330 armi di cui sopra verranno aumentate a 600 e forse a 800)
ostruzione parasiluri per chiusura di Portolago
2 ostruzioni parasiluri per chiusura dei 2 ingres si E. ed
W. di Parteni
2 ostruzioni parasommergibili
2 compagnie del battaglione San Marco difesa contraerei completa (4 cann. 102/35 e 32 cann. 76/40 so praccennati)
47 mitragliatrici da 6 ,5
42 mitragliatrici da 13,2
6 mitragliatrici da 37 ,54
a Rodi:
comando DICAT in sede protetta, quasi ultimata rete semaforica, completa altre reti di trasmissioni (R.T., generale, servizi-telefoniche) quasi ultimate prevista la posa di altri tre cavi sotto marini depositi nafta, benzina acqua, carbone, viveri ecc . - tutto a posto collegamenti radio con Roma.
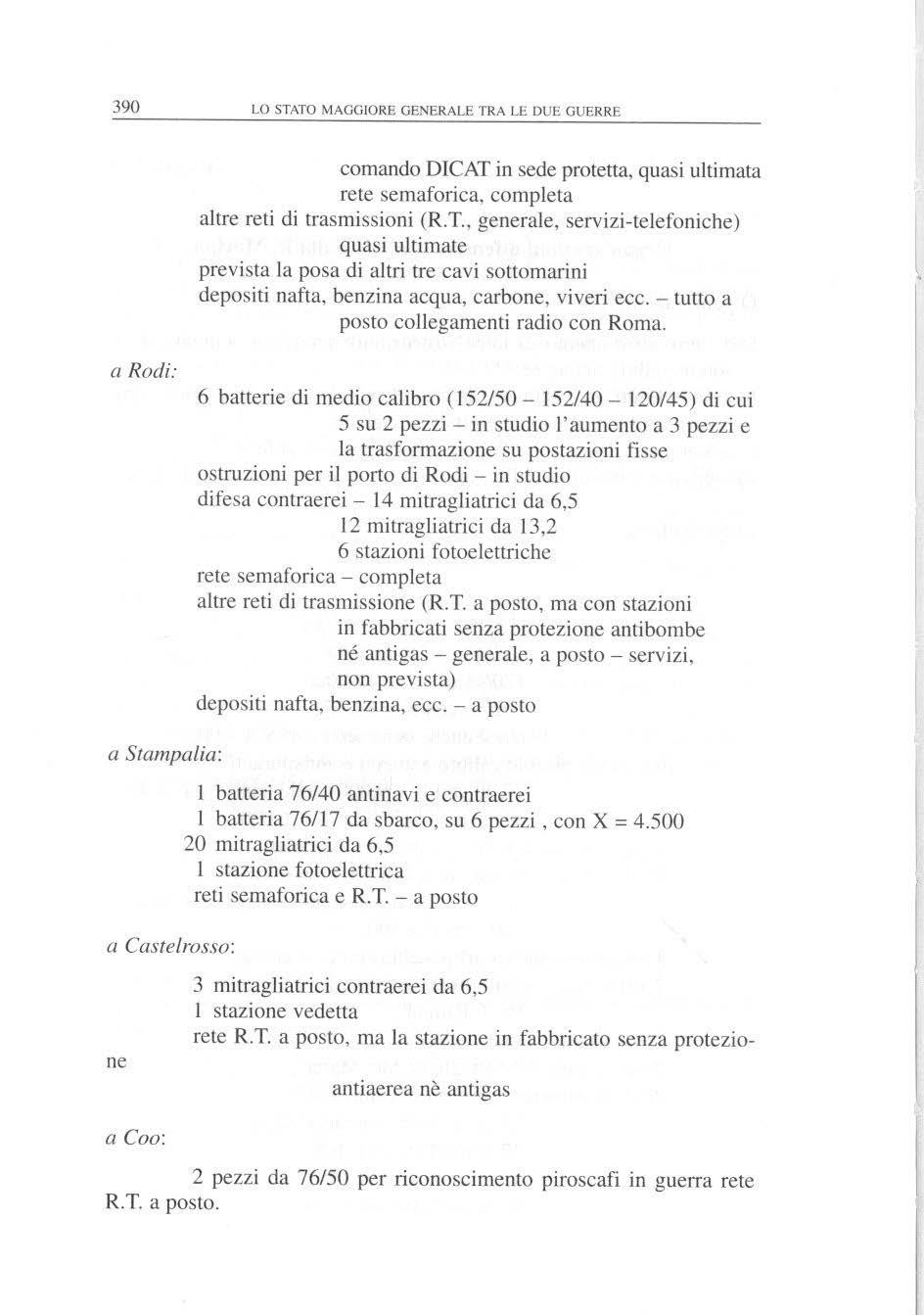
6 batterie di medio calibro ( 152/50 - 152/40 - 120/45) di cui
5 su 2 pezzi - in st udio l'aumento a 3 pezzi e la trasformazione su postazioni fisse ostruzioni per il porto di Rodi - in studio difesa contraerei - 14 mitragliatrici da 6,5 12 mitragliatrici da 13,2
6 stazio ni fotoelettriche rete semafor ica - completa altre reti di trasmissione (R.T. a posto, ma con stazioni in fabbricati senza protezione antibombe né antigas - generale, a posto - serviz i, non prevista) depositi nafta, benzina, ecc. -a posto
a Stampalia:
l batteria 76/40 antinavi e contraerei
l batteria 76/17 da sbarco, su 6 pezzi , con X = 4.500
20 mitragliatrici da 6,5
l stazio ne fotoelettrica reti se maforica e R.T. - a posto
a Castelrosso:
3 mitragliatrici contraerei da 6,5
1 stazione vedetta
rete R.T. a posto, ma la stazione in fabbricato senza protezione
antiaerea nè antiga<;
a Coo:
2 pezzi da 76/50 per riconoscimento piroscafi in guerra rete
R.T. a posto.
I n relazione alle nost re possibilità navali , offensive e difensive, ed alle limitate capacità degli ancoraggi del pos sed imento, sono da prevedere da parte nostra in guerra.
a) crociera di naviglio sottile contro il traffico nemico ;
b) attacchi di sorpresa e notturni di forze navali nemiche;
c) agguati offensivi di sommergibili nei passaggi obbligati e nelle zone prossime alle ba si nemiche;
d) colpi di mano su località vicine;
e) posa di mine nell ' Egeo;
t) protezione del no s tro traffico, in caso di conflitto limitato.
Di qui convenienza di dislocare in Egeo soltanto forze sottili e forze subacque: le forze sott ili annate con il 152 o almeno il 120.
P erciò:
a) avviarvi non appena possibile, 2 squadriglie di navi sottili, moderne e me gl io armate delle attuali (esploratore P re muda , vecchio tipo - 2 cc.tt. tipo «Crispi», non adatti a serv izi di squadra);
b) avviarvi non appena possibile, 9 sommergibili (ora ne abbiamo 4);
c) portare ad una squadriglia i 2 MAS che ora abbiamo per impiego contro sbarchi in mare buono;
d) aumento un altro turno di sommergibili, per agguati esclus ivamente difensivi;
e) comp letare l 'att rezzamento di Parteni , per decongestionare Portolago;
f) utilizz,are l'i so letta di Alinnia ad ancoraggio sicuro per stazio ne eventuale di attesa del nemico proveniente da ovest (p rov enienza più probabile;
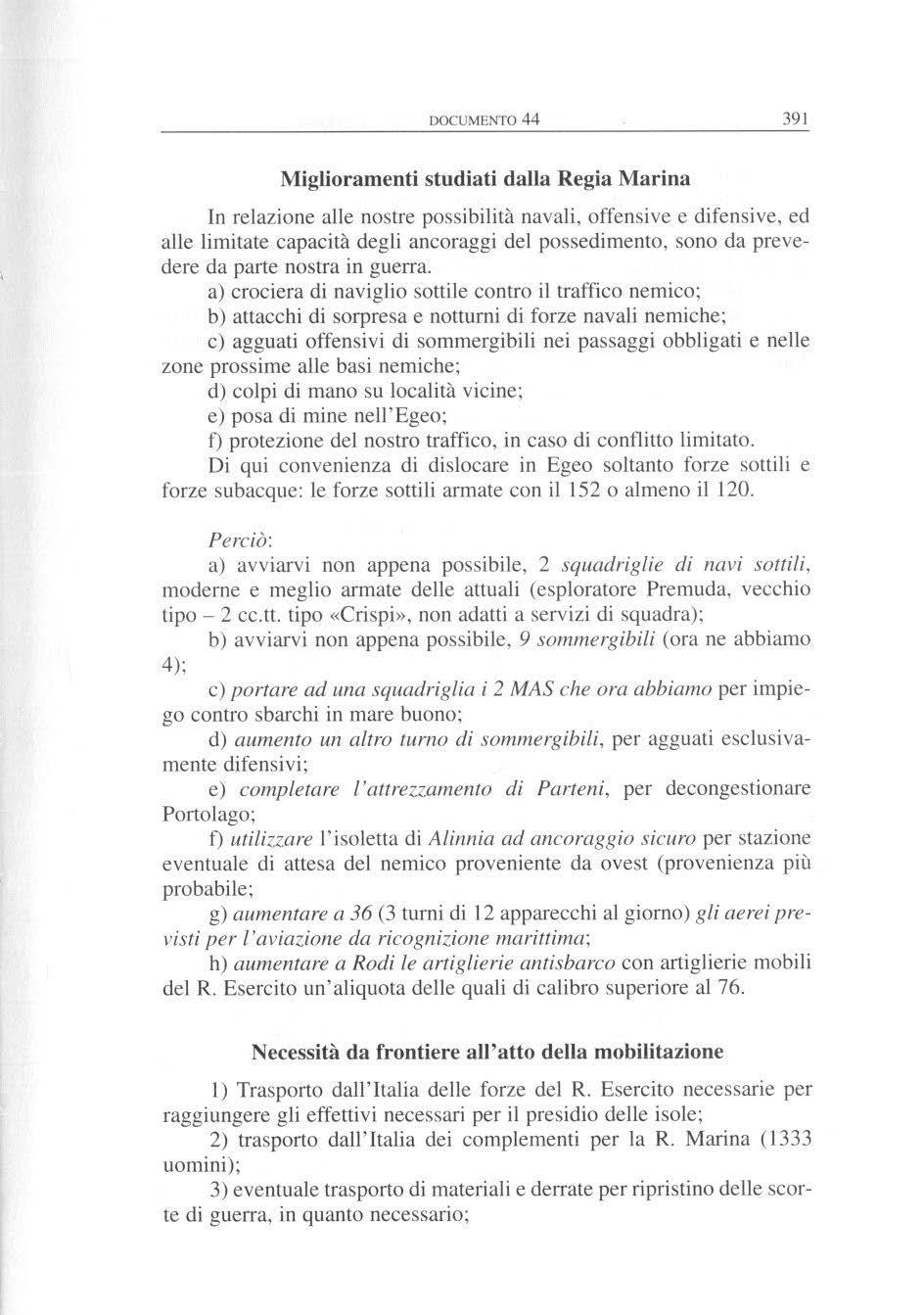
g) aumentare a 36 (3 turni di 12 apparecchi al giorno) g li aerei previst i per l'aviazione da ricognizione marittima;
h) aumentare a Rodi le artiglierie antisbarco con artiglierie mob ili del R. E sercito un ' aliquota de lle quali di calibro s uperiore a l 76.
1) Tra spo rto dall ' Italia delle forze del R. Eserci to nec essarie per raggiungere gli effettivi nece ssar i per il presidio delle isol e;
2) trasporto dall ' Italia dei complementi per la R. Marina (1333 uomini );
3) eventuale trasporto di materiali e derrate per ripri stin o delle sco rte di guerra, in quanto nece ssario ;
4) affluenza delle forze navali completamentari;

5) affluenza delle forze aeree complementari.
Ne consegue evidente l'opportunità di accantonare sin dal tempo di pace nelle isole:
- quanto può richiedere trasporto su piroscafi da carico, lenti;
- quanto è necessario per l ' immediato funzionamento dei servizi principali in tempo di guerra, e che è costituito da materiali non deperibili.
A causa delle deficienze aeronautiche già accennate per Lero, sistemare in detta isola soltanto:
- unità da ricognizione marittima su Cant. Z. 501.
- unità da caccia marittima su Ro 43 per la difesa
- organizzare la base al volo notturno
- fabbricare un terzo deposito munizio ni e carburanti per 25 azioni.
Sistemare invece a Rodi la vera base offensiva per forze aeree terrestri:
- l stormo da bombardamento terre st re (2 gruppi) su S. 81
-l squadriglia da caccia terrestre su Ro 41
- organizzazione aeroportuale corrispondente non solo a dette forze, ma anche a quelle maggiori che dalla madre Patria e dalla Libia, vi verranno avviate al momento del bisogno, perciò;
- attrezzamento del campo di Fileremo per lo storrno e la squadriglia di cui sopra;
- costruz ione di 2 aeroporti - campi di manovra a Cattavia e Gaddura, per appoggio alle forze aeree dell'isola nel caso di azioni offens ive nemiche contro l'aeroporto di Fileremo;
- costruzione di depositi munizioni e carburant i adeguati al le forze aeree permanenti delle isole, quelle di rinforzo sopra accennate.
Lero Lero
XCII gr. bomb mar. = S. 55-A. 20
sq. au t. C.M. = IO Cr. 20 bis
C.M. = 12 app. Ro 43
R .M. = 12 app. Cant. Z. SO i
sez. costiera= 6 Cani. Z. 501 aeroporto di Lero aeroporto di Lero
sq. aut. R.M. = 7 S. 78
dcpos. carburanti = Tonn. 300
depos. carburanti= Tonn. 1000 depos. munizio ni = Tonn. 250 depos. munizioni= Tonn . 200

Rodi Rodi
Com. Stormo auton. mist0 Egeo I stormo B.T. = 36 app. S. 81
I63A sq C.T. = 5 app. Cr. Asso I sq. C.T. = 12 app. Ro. 4 1
aeroporto d i Fi leremo aeroporto amp lialo di Fileremo
dcp. carbuaran ti = Tonn. 50 campo di manovra di Cattavia
dep. munizioni = To nn. 200
campo di manovra di Gaddura
dcp. carburanti = To nn. 2000
dep. mu nizioni= Tonn. 1500
Organizzazione difensiva studiata dal R. Esercito

1) Difesa costiera, per interdire o almeno contenere qualsiasi sbarco . Oggi già buona: a Rodi= 360 uomini (CC. RR. + R.G.F. + fanteria) con:
- 30 mitragliatrici;
- l batteria 75/906 da pos. (soli materiali);
- 20 unità di fuoco, a portata di impiego;
Lero = 110 uomini (CC.RR. + R.G.F. + ftr.) con:
- 14 mitragl. (alla baia di Portolago provvede la R. Marina)
- 20 unità di fuoco, a portata di impiego.
Bisogna migliorarla , s pecialmente a Lero con:
I) aumento delle mitr. in modo da costituire reparti mjtr. da posizione a rinforzo della difesa in corrispondenza delle zone di più facile sbarco;
2) distribuzione di 2 pl. lanciafiamme;
3) distribuzione di 2 pl. mortru da 81;
2) Unità mobili - bi sog na aumentarle al fine di avere maggiore disponibilità per il pronto intervento a rinforzo immediato della difesa costiera (azioni locali) o per azioni a mas sa contro sbarchi riusciti ad affermarsi.
In complesso, per le necessità della difesa costiera e della adeguata costituzione in unità mobili, tenute presenti le difficoltà di fare poi prontamente affluire, all'atto della mobilitazione, rinforz i dalla Madre Patria, si ravvia necessario l 'aumento del presidio di pace nella misura segue nte: FORZA
l btg. fuc. co n btr. accomp.
aliquota servizi
l comando di rgt. ftr
I btg. fuc. (destinato a Coo)
I p i. mortai da 81
I pi. lanciafiamme
I btr. da 75/27 (solo i materiali)
al iq uo ta de llo S M pre sso G ove rn o I uffi cio mil it are presso Govern o
1 co man do 9° rgt. fance ria I co mand o truppe Egeo (ge n. b ri gata )
2 bt g . fu c. co n bt r. accomp . 1 pi. morta i da 81
I sez. a uto blindo I gr. mi , to
I autosez io ne m is ta I btr. 7 5/906 da pos.materiali g ià i n pos to u ffici, de p ., l abora to ri ecc
1 btr 75/2 7 C. K ,, )) )>
1 btr. 20 >} )) ,.
1 gr. 7 5/27 (sol i mate ri al i) su 3 btr d i cui 1 pe r Le ro (ved i sopra)
3) difesa contraerea per protezione basi aeree , protezione centri vitali delle isole (alle basi navali provvede la R. Marina); Oggi le due isole hanno soltanto i materiali per la protezione delle città di Rodi (1 btr. da 75/27 C.K. - 1 btr. da 20 mm.).
Occorrono in più 21 sez. da 20 (7 per cias cuno dei 3 campi di aviazione di Fileremo, Cattavia, Gaddura).
4) Lavori difensivi - nulla con carattere di fortificazione permanente (onere rilevante).

E s istono di già elementi di fortificazione campale (postazioni per mitragliatrici, e batterie, reticolati).
Bisogna aggiungere mezzi di arresto (zone di sbarram e nto - iprite e mine a pressione) nelle zone di più facile sbarco.
5) Lavori stradali - Lero ha di già la strada dorsale da Baia Serocampo a Baia Parteni.
Rodi ha viabilità perimetrale e trasvers ale ottima.
Quindi niente lavori stradali: basta qualche miglioramento per facilitare il movimento degli automezzi nello spostamento dei nuclei di manovra.
6) Organizzazione logi s tica - oggi abbiamo:
- 20 unità di fuoco per armi portatili, -8 » » » per artig lierie, - viveri , ecc ....... per due mesi per il presidio di guerra.
Occorre:
a) qualche aumento di personale;
b) provvedere ai fabbricati per Comando truppe Egeo a Rodi , qualche caserma , qualche padiglione - magazzino;
c) accantonare munizioni e scorte per le unità di previsto aumento ;
d) prevedere che, affluendo all'atto della mobilitazione i rinforzi, affluiscano anche le relative aliquote di munizioni, viveri materiali;
7 ) In definitiva il presidio di guerra ritenuto necessario per le isole italiane dell'Egeo è il seguente:
Lero
- 1 rgt. ftr. (comando - 3 btg. - btr. accomp. - pl. mortai da 8 I - pi. lanciafiamme)
- 2 reparti mitr. da posizione costiera
- 1 batteria 75/27
- 2 sezione fotoelettricisti

- elemen ti di zappatori - artieri, telegrafisti, radio da trarsi dall'unità del genio di Rodi
- distaccamento di autosezione mista
-servizi.
Rodi
-l ufficio militare press o il Governo delle isole
- I comando truppe R. Èsercito (generale di brigata)
- I rgt. ftr. (comando - 3 btg. - btr. accomp. - pl. ruotai da 8 Ipi. lanciafiamme)
- 2 reparti mtr. da posizione costiera
- l gr. misto artigl. 1 btr. 75/27 da pos. costiera
1 btr. 75/27 C.K. contraerei
1 btr. 20 mm.
- 1 gruppo da 75/27 su 2 batterie
- 3 batterie da 20 mm. ( 2 J sezioni)
- 1 compagnia zappato ri - artieri
- 1 compagnia telegrafisti , con sez ione fototelegrafisti
- I sezione radiotelegrafisti
- 1 sezione fotoelettricisti
- 1 sezione autoblindo
- l autosez ione pesante
- e lemen ti di servizi.
1) Per la modifica dell'art. 3 del R.D. 30 agosto 1936 - XVII, la formula più idonea sembra la seguente:
<<Il Comandante M.M. delle Isole italiane dell'Egeo esercita il suo comando alla dipendenza gerarchia del Governatore Militare del Possedimento»
«La sua residenza è nell'isola di Lero. Esercita il comando sul!' isola, avendo alla sua dipendenza tutte le forze militari in essa dislocate per i compiti della difesa territoriale della isola stessa. Da lui dipendono, sia in pace che in guerra, i servizi della R. Marina dislocati in tutte le isole dell ' Egeo».
«Dipende direttamente dal Ministero della Marina per tutto quanto riguarda in pace le questioni di carattere tecnico e di allontanamento , ed in guerra per quanto riguarda l'appoggio che nelle isole debbono trovare le forze navali operanti nel Mediterraneo orientale».
2) Tutte le pratiche intere s santi la organizzazione difensiva marittima delle isole Egee saranno inviate per il tramite del Governo delle Isole italiane dell'Egeo - Ufficio Militare.


«Organizzazion e del comando delle Isole italiane dell ' Egeo: de c reto sulla nomina del nuovo governatore con tutti i poteri militari, ampliamento delle for ze aeree e coordinamento con le for ze della Marina e dell'Esercito presenti, responsabilità della difesa delle isole affidate al governatore , dipenden za delle for ze armate dell'Egeo dalle autorità centrali metropolitane per la preparazione e l ' impiego offensivo. Comando a Tobruk: coordinamento tra le tre for ze armate sotto la direzione di un comando unico dell'Esercito».
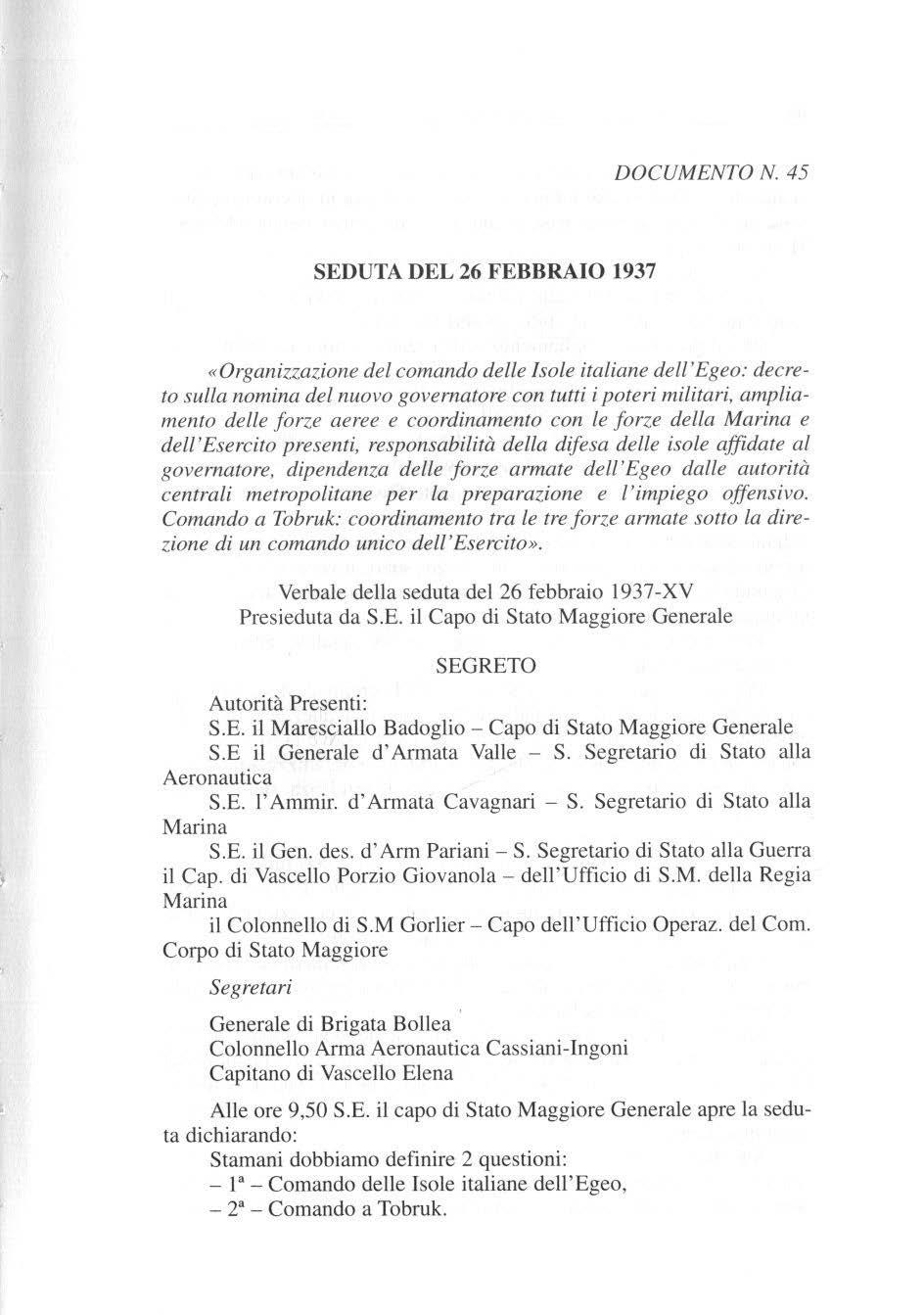
Verbale della seduta del 26 febbraio 1937-XV
Presieduta da S.E. il Capo di Stato Maggiore Generale
Autorità Presenti:
S.E. il Maresciallo Badoglio - Capo di Stato Maggiore Generale
S.E il Generale d'Armata Valle - S. Segretario di Stato alla Aeronautica
S.E. I' Ammir. d'Armata Cavagnari - S. Segretario di Stato alla Marina
S.E. il Gen. des. d'Ami Pariani - S. Segretario di Stato alla Guerra
il Cap. di Vascello Porzio Giovanola - dell'Ufficio di S.M. della Regia Marina
il Colonnello di S.M Gorlier - Capo dell'Ufficio Operaz. del Com.
Corpo di Stato Maggiore
Segretari
Generale di Brigata Bollea
Colonnello Arma Aeronautica Cassiani-Tngoni
Capitano di Vascello Elena
Alle ore 9,50 S.E. il capo di Stato Maggiore Generale apre la seduta dichiarando:
Stamani dobbiamo definire 2 questioni:
- 1• - Comando delle Isole italiane dell'Egeo,
- 2• - Comando a Tobruk.
l 3 • - Comando delle Isole italiane
-Anni or sono si convenne che la Marina era la Forza Armata che aveva in quelle isole interesse preminente; e perciò esse vennero costituite in «Comando Militare Marittimo dell ' Egeo».
Ora sono subentrati due nuovi ordini di fatti:
a) - il decreto con il quale si è nominato il nuovo Governatore, e gli sono stato accordati anche «tutti i poteri militari»;

b) - il grandioso ampliamento delle organizzazioni aeronautiche in quelle isole , e specialmente in quella di Rodi, per effetto del quale si rende inutile determinare se una delle tre Forze Armate debba avere la preminenza rispetto all'altra in quelle isole.
Quali sono le mansioni militari del Governatore? Già le abbiamo definite nelle loro linee generali nella no stra riunione del 22 gennaio u.s. nel corso della quale abbiamo chiaramente fissato che al Governatore delle I sole I taliche dell'Egeo spetta soltanto la difesa delle isole stesse, al quale scopo ha il comando di tutte le forze armate in esse stazionanti, fermo restando che quando dette forze so no invece chiamate dal Comando Supremo a missioni fuori Egeo esse acquistano piena e totale indipendenza dal Governatore.
P erciò oggi non ci resta da vedere se non qualche attributo dei comandi in sottordine.
Poiché abbiamo a Rodi un generale dell'Esercito, così sembra logico che in detta isola il comando militare spetti a quel generale, alle dipendenze del Governatore; e che invece a Lero, dove la Marina ha le sue basi ed ha contribuito alla maggior parte delle organizzazioni difensive, il comando spetti alla Marina , alla dipendenza dello stesso Governatore.
C'è qualche obiezione?
S.E. Pariani. - II Governatore, che ha i pieni poteri militari, ha un s uo stato maggiore misto, il cui capo è un ammiraglio. Perciò non vedo i motivi per i quali noi dovremmo qui scendere a precisazioni di dettaglio che mi sembrano di competenza del Governatore.
S.E. Badoglio. - Lo facciamo sotto il punto di vista di deduzione di buon senso: ci sembra naturale che a Rodi ed a Lero s ia così, e perciò noi proponiamo questa soluzione.
S.E. Cavagnari. -Confermo quanto ho già detto nella seduta del 22 gennaio u.s. e cioè che, se è vero che oggi il Capo di Stato Maggiore del Governatore è ufficiale di Marina, nulla toglie che in avvenire potrebbe ad es. essere ufficiale dell'Aeronautica: la situazione non verrebbe per nulla modificata.
S.E. Valle. - P er me la questione rimane quella di ordine generale che io ho decisamente posto nella riunione del 22 gennaio: l'Aeronautica deve essere lasciata libera di disporre delle proprie basi offensive in
Egeo e ovunque le ha create o le sta creando, così come meglio ritiene, in modo da poter spiccare il volo da esse a momento opportuno, dietro ordine del Comando Supremo, senza incontrare difficoltà di nessuna sorte, nemmeno nel campo organizzativo delle basi stesse.
S.E. Badoglio. - L'osservazione di S.E. Valle è di evidenza lapalissiana: corrisponde a quanto noi tutti riteniamo assolutamente indispensabile non solo per l'Aeronautica, ma anche per le altre Forze Armate. Riferirò queste nostre conclusioni a S.E. il Capo del Governo, ponendo bene in luce i seguenti punti fondamentali:
a) - il Comando Militare dell'Egeo resta quale è definito dall'ultimo decreto, nel se nso che a quel Governatore, come già ho scritto a S.E il Capo del Governo, spetta l ' impiego delle forze a1mate e dei mezzi dislocati in quelle isole soltanto nel campo della difesa delle isole stesse;
b) - il Governatore si crea il suo stato maggiore come meglio crede;
c) - il Governatore designa i comandanti delle isole. Questi, secondo noi, dovrebbero essere così designati: l ammiraglio, a comandante dell'isola di Lero ; 1 generale del R. Esercito, a comandante dell'isola di Rodi ;
d) - l'organizzazione delle basi e l'impiego offensivo delle forze annate in Egeo spettano alle Autorità centrali della Madrepatria ed al Comando Supremo, rispettivamente. - Le isole dell'Egeo rappresentano le basi di partenza delle forze marittime ed aeronautiche destinate ad agire offensivamente in Mediterraneo, ad ordine del Comando Supremo. Come tali esse debbono essere organizzate al di fuori di ogni ingerenza del Gov erna tore , a cura delle Autorità centrali della Madrepatria, sulla base degli studi da esse compiuti. - L'impiego a scopo offensivo delle forze armate sin da ora dislocate in Egeo , e di quelle che vi potranno in avvenire essere avviate è di competenza esclusiva de l Comando Supremo;
e) - anche alla preparazione dei mezzi ed all'addestramento delle forze armate in Egeo debbono presiedere soltanto le Autorità centrali, come quelle che, al momento voluto, presiederanno all'impiego di dette forze;
S.E. Cavagnari. - Nella riunione del 22 gennaio ho dato lettura di una lettera del Ministero della Marina al Governatore dell'Egeo intesa a definire le attribuzioni del Comandante Marittimo in Egeo. Ho ricevuto il foglio che presento , al quale non ha ancora risposto.
S.E. Badoglio dà lettura al foglio del Governatore; poi prosegue:
«Pregherò S.E. il Capo del Governo di intervenire in modo da troncare

ulteriori discussioni su questo argomento che deve risultare definito come qui abbiamo conchiuso, e come sopra ho esposto.
Passiamo al 2 ° argomento: i/ Comando di Tobruk.
La questione sta in questi termini: il Governatore della Libia desidererebbe che la Marina assumesse il comando della Piazza con tutto lo hinterland relativo, 50 Km. di fronte per 15-20 Km. di profondità. - La Marina, invece, vorrebbe ridurre questo hinterland a 5 Km . di profondità per lo sviluppo costiero.
Io sono d'avviso che la Marina deve essere lasciata sulle navi. Gli ufficiali di Marina, sia da noi, sia nella passata Grande guerra hanno confermata la loro piena capacità ed il valore nell 'im piego a terra; ma è meg li o che ciascuno sia impiegato in quello che è il suo normale campo di azione e di attribuzioni.
Perciò per risolvere questa questione, penso che si potrebbe adottare la soluzione seguente: visto che a Tobruk ci sarà un Comandante Supe ri ore dell'E sercito, che estenderà la sua azione di comando su tutto il campo trincerato, affidare a detto Coma nd ante Superiore la direzione di tutto, mettendogli a fianco un ufficiale di Marina come consulente per le ques ti oni marittime.
S.E. Cavagnari. - Propongo che s i adotti per Tobruk la stessa sol uzione che si adottata in Patri a per Trap ani, Pol a, Spezia, ecc. e che è collaudata dalla lun ga esperienza; e cioè, che nel settore militare marittimo di Tobruk l'organizzazione difensiva cost ie ra sia studiata ed attuata a cura della Marina, la quale prepone a quel settore un suo ufficiale come comandante. I mezzi mobili navali della Marina, al pari di quelli della Aeronautica, concorrono - come è previsto che concorreranno in P atria, per la difesa delle coste - al di fuori dei limiti del Settore M.M. ovu n que il Comandante Superiore del Campo trincerato di Tobruk lo ri chieda.
S.E. B adoglio. - Resta allora deciso che il Comandante Marittimo ed il Comandante Aeronautico hanno ciasc uno il comando delle forze e dei mezzi rispettivi nei 'limit i della propria gi uri sdizione; ma dipendono entrambi per l'impiego da un comandante unico, c he è il Comandante Superiore dell'Esercito, nel senso che tale Comandante Superiore ha giurisdizione di co mando per quanto s i riferi sce all'i mpi ego delle tre For.te Armate ai fini della difesa dell'intero territorio di Tobrnk.
S.E. Pariani. - Proporrei che si decidesse oggi se la preparazione territoriale e bellica delle colonie deve esse re studiato da noi, o se essa spetti ai governatori locali.
S.E. B adoglio. - L a decisione adottata dalla Commissione Suprema di Di fesa per l'Argomento I 0 ° della XI V sessione è redatta in termini precisi, sui quali non è più possibile nessuno equivoco: detta preparazione spetta a noi e non ai governato ri . -A tale deliberazione dobbiamo

quindi attenerci, e senz'altro affrontare e risolvere il relativo problema, bene inteso ciascuna delle Forze Armate per la parte di sua competenza. Per quanto riguarda la frontiera occidentale della Libia ritengo che sarebbe opportuno che l'Esercito inviasse sul posto ufficiali di stato maggiore per le relative ricognizioni.
La seduta è tolta alle ore l 0,50.
A. U.S.S.M.E .fondo H- 10 « Verbali riunioni 1924-/943» busta 11. 2,.fascicolo 11. 10. Il documento è una copia dell'Ufficio Operazioni del Comando del Corpo di Swto Maggiore. Il verbale era s t{lfo trasmesso all'Ufficio Operazioni dall'Ufficio del capo di Stato Maggiore Generale con il fn. 2999 di port. segreto in data 3.3. /937 (fascicolo n. IO. H - 10, busta ri. 2).


«Forteu a costiera di Messina-Reggio Calabria: armamento della piazzaforte, difesa dello stretto, passaggio del comando della forte zza costiera dall'Esercito alla Marina. Passaggio della Mili z ia da Costa alla Marina: atteggiamento della Marina di fronte alla riforma, questioni finanziarie. Ridu zione delle for ze addette alla difesa costiera: sostituzione della difesa delle coste a cordone con una difesa manovrata, impiego camicie nere. Protezione delle ferrovie , strade ordinarie, reti delle comunicazioni, impianti vari» .
Verbale della seduta del 31 marzo 1937-XV
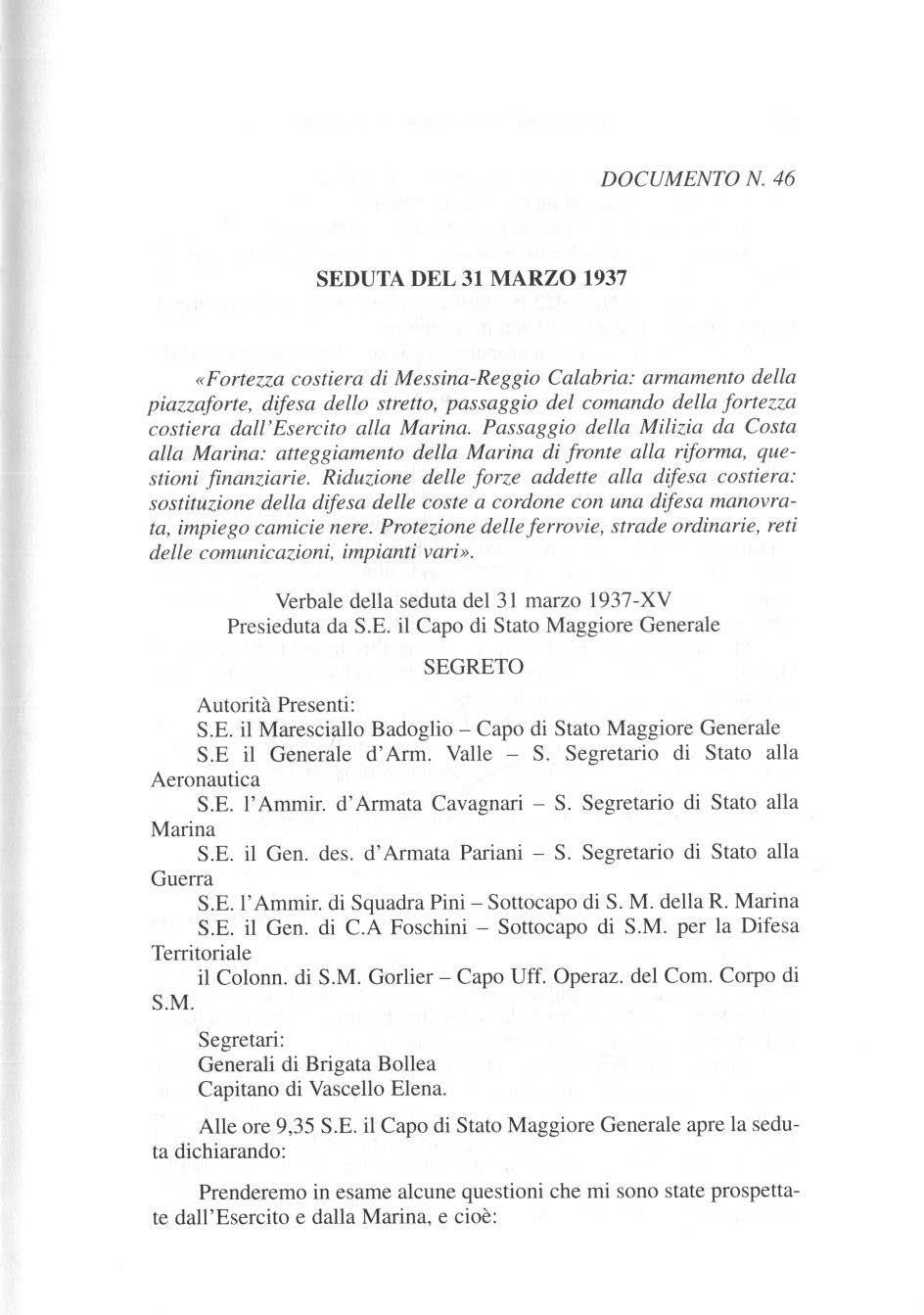
Presieduta da S.E. il Capo di Stato Maggiore Generale
Autorità Presenti:
S.E. il Mare sc iallo Badoglio - Capo di Stato Mag giore Generale
S.E il Generale d' Arm. Valle - S. Segretario di Stato alla Aeronautica
S.E. l' Ammir. d'Armata Cavagnari - S. Segretario di Stato alla Marina
S.E. il Gen. des. d'Armata Pariani - S. Segretario di Stato alla Guerra
S.E. l ' Ammir. di Squadra Pini- Sottocapo di S. M. della R. Marina
S.E. il Gen. di C.A Fo sc hini - Sottocapo di S.M. per la Difesa
Territoriale
S.M. il Colono. di S.M. Gorlier - Capo Uff. Operaz. del Com. Corpo di
Segretari:
Generali di Brigata Bollea
Capitano di Vascello Elena.
Alle ore 9,35 S.E. il Capo di Stato Maggiore Generale apre la seduta dichiarando:
Prenderemo in esame alcune questioni che mi sono state prospettate dall'Esercito e dalla Marina, e cioè:
1) fortezza costiera di Mes s ina -Reggio Calabria
2) passaggio della M.da Cos alla R. Marina
3) riduzione delle forze addette alla difesa delle coste
4) protezione delle ferrovie, strade, reti di comunicazione, ecc.
1• que stione - Nel 1922 la Marina cercò di avere la Piazzaforte di Messina-Reggio Calabria: l'Esercito s i oppose.
Nel 1934 fu l'Esercito a proporre di passare detta fortezza costiera alla Marina: la Marina non acconsentì ad accogliere la proposta.
Nel 1936 l'Amministrazione della Guerra è ritornata sull'argomento.
Venendo al fatto specifico, l'Esercito ritiene che l 'attuale difesa dello stre tto di Me ss ina basata s u vecchissime bocche da fuoco di ghisa - batterie di mortai da 280/9 - con celerità di tiro ridottissima scarsa gittata, munizionamento poco efficace, e conseguentemente problematico rendimento del tiro , cui si debbono aggiungere 4 batterie di cannoni da 105/28, 3 batterie di cann.da 75/27 mod. 906 , e 5 batterie della R. Marina (2 da 120 - I da 102 - 2 da 76/40 ed l da 76/40 con doppio compito), si possa considerare press'a poco nulla.
Ma la questione fondamentale sta in altri termini: lo stretto di Messina è zona che deve essere difesa efficacemente? oppure non merita nemmeno più un simulacro di difesa ?
Se effettivamente non sembra probabile che una vera forza navale nemica possa pensare di cacciarsi attraverso quello stretto, è tuttavia necessario che sia da noi fissato s e riteniamo di poter lasciar aperta, e cioè senza nessuna difesa, quella porta, dato che la velocità della corrente e al profondità dei fondali nello stretto non consentono un'efficace difesa subacquea.
Per me s i tratta di un punto sensibile, che non dobbiamo, né possiamo trascurare.
Prego S.E. il Capo di S.M. della Marina di dire il s uo punto di vista in merito.
S.E. Pini - Come V.E. ha accennato la fortezza costiera di Messina Reggio Calabria è stata palleggiata tra il Ministero della Guerra e quello della Marina: il Ministero della Guerra ha chiesto alla Marina di includerla nelle zone di preminente interesse marittimo.
La Maiina ha rappresentato che, secondo essa, lo stretto di Messina riveste importanza ai fini di garantire le comunicazioni tra l'isola ed il continente, ma che, per parte sua, non ritiene di poter aumentare i suoi oneri a terra: l'anno scorso, a mobilitazione avvenuta per la A.O.I., la Marina si trovò ad avere i 2/3 della sua forza impiegata a terra; solo 1/3 era a bordo.
Allo stato delle cose però, siccome è in discussione la questione del pas sagg io della M. da Cos alla Marina, la Marina ha rivolto la sua atten-

zione anche alla Sicilia, ed ha esaminato la convenienza di estendere anche alla M. da Cos della fortezza di Messina-Reggio Calabria il passaggio alla Marina. Il Comandante Ginocchietti , console generale della M. da Cos. che ha avuto modo di studiare sul posto la questione sotto il punto di vista marinaro, ritiene che converrebbe conservare gli attuali mortai da 280/9, perché bocche da fuoco con grande gittata non troverebbero utile impiego correndosi con esse il rischio di colpire la costa opposta.
Abbandonare completamente lo stretto non se mbra conveniente, perché , se Augusta non fosse guarnita con forze navali, l'eventuale nemico potrebbe accostarsi allo stretto per tentare di tagliare le comunicazioni dell'isola con il continente.
Perciò, sebbene la Marina ritenga di non poter crescere l'onere suo a terra, se si addiverrà al trapasso delle batterie servite dalla M. da Cos alla Marina, c'è da chiedersi se non converrà passare alla Marina anche le batterie della fortezza costiera di Messina-Reggio Calabria. La cosa sembra quasi inevitabile. - Naturalmente il passaggio della M. da Cos alla Marina avverrebbe soltanto per l'impiego.
S.E. Badoglio - Di fronte alle due tesi state esposte, ripresento il problema nelle sue linee maestre:

I) è o non è conveniente radiare la fortezza di Messina-Reggio Calabria?
2) se è conveniente tenerla , è l'attuale armamento suo sufficiente ai fini che ci ripromettiamo?
3) secondariamente: a chi deve essere data la fortezza? all'Esercito o alla Marina ?
Mi pare che S.E. Pini non esclude la necessità di difendere lo stretto, perché, se non saranno grandi forze navali nemiche quelle che potranno affacciarsi ad esso, forze leggere nemiche potrebbero però tentare un colpo in determinate condizioni, quando cioè la nostra flotta fosse impegnata altrove.
Prego ora S.E. Pari ani di esprimere il suo parere in merito.
S.E. Pariani - Per l'E se rcito la fortezza di Messina- Reggio Calabria presenta interesse soltanto nel caso di conflitto mediterraneo: in questo caso l'Esercito provvede lasciando l'intero XII Co rp o d ' Armata, con le sue 3 divisioni , nell 'is ola. Ben poco sarà quello che occorrerà mandare dal continente nella Sicilia, perché l 'isola è stata resa pre ssoc hé autonoma , e d'altra parte non è da prevedere che il nemico possa tenere con continuità lo stretto. - La difesa dello stretto non ha quindi importanza per l'Esercito, per il quale è invece importante la difesa costiera della Sicilia (punti di più probabile sbarco) e la difesa contraerea di MessinaReggio Calabria - Villa S. Giovanni ove fanno capo le comunicazioni fra isola e continente.
S.E. Badoglio - Dunque la difesa dello stretto è ritenuta necessaria dalla Marina, per l ' Esercito, che ha dato alle forze di terra dell'isola autonomia tale da non esigere più la continuità di uso de ll o stretto, lo stretto stesso non ha più l'importanza che riveste per la Marina.
Perciò, dato che la Marina ritiene che è necessaria la difesa dello stretto, delego lo Stato Maggiore della R. Marina a studiare se l ' attuale armamento è sufficiente, o se deve essere modificato od addirittura sostituito con altro nuovo.

S.E. Cavagnari- Preciso che lo stretto nOf! riveste preminente interesse marittimo. La Marina ritiene che l'interesse principale dello stretto consista nella necessità di mantenere le comunicazioni dell'isola con il continente, mentre l'Esercito ritiene che non sia necessario mantenere dette comu nicazioni con carattere di continuità.
Secondo me, a prescindere dai due diversi apprezzamenti , lo stretto deve essere difeso: se sopprimessimo le difese a terra, il compito della Marina diverrebbe più oneroso, perché essa dovrebbe devolvere alla difesa dello stretto parte delle sue forze mobili.
Se invece si apportano aglì attuali apprestamenti difensivi le migliorie tecniche studiate dal Comandante Ginocchietti per aumentare il rendimento del tiro delle attuali bocche da fuoco, si provvede alla difesa dello stretto senza imporre un nuovo onere alla Marina.
S.E. Valle - Sebbene non sia parte in cau s a, io , astraendo dalle cons iderazioni che sino ad ora sono state svolte, ritengo che la difesa dello stretto sia questione di interesse nazionale , perché l'eventuale attraversamento di esso da parte di mezzi navali nemici costituirebbe per il P ae s e uno smacco morale non ammissibile.
Per me la difesa dello stretto si impone tanto più in relazione all'attuale situazione internazionale.
S.E. Pini- L'importanza dello stretto di Messina deriva a noi anche per questioni di traffico: noi potremmo sbarrare il Canale di Sicilia al traffico mercantile, e prescrivere al traffico neutrale l'attraversamento dello stretto.
S.E. Badoglio - La discussione sinora fatta ci porta alle seguenti conclu sioni:
1) lo stretto di Messina deve essere difeso;
2) lo Stato Maggiore della R. Marina s tudierà se le difese attuali sono sufficienti, o se occorrono migliorie, e quali.
Dobbiamo ora esaminare a quale Autorità si deve affidare la difesa dello stretto, e così passiamo al 2 ° argomento.
La M. da Cos ha sostituito la sopp ressa artiglieria da costa dello Esercito in 12 batterie (7 a Venezia - 3 a lla Spezia - 2 alla Maddalena) ,
cui possiamo aggiungere le 8 di mortai da 280/9 della fortezza costiera Messina- Reggio Calabria. In totale trattasi quindi di 20 batterie.
I fondi per la M. da Cos sono annualmente assegnati all'Ispettorato
M.DICAT e M. da Cos. Essi, se del caso, sono integrati da ulteriori assegnazioni del Mini stero delle Finanze.
Dunque il passaggio della M. da Cos alla Marina non è questione di bilancio; è invece soltanto questione di impiego, e l'impiego della M. da Cos è essenzialmente competenza della Marina.
Prego La Marina di espOtTe le eventuali s ue obiezioni ad assumere in tutto le batterie servite dalla M. da Cos.
S.E. Pini -L' obiezione sta nel concetto, da me già accennato, dell'aumento di oneri a terra che conseguono alla Marina.
S.E. Badoglio - Osservo che le tre Pi azzeforti di Venezia, la Spezia, e la Maddalena dipendono di già totalmente dalla R: Marina.
S.E. Cavagnari - Preciso: la Marina italiana è l'unica, fra tutte le Marine, che ha sempre avuto parte preponderante nella difesa costiera, la quale assorbe all'incirca il 50 % della forza bilanciata della Marina.
Osservo che talune delle batterie M. da Cos sono ubicate in zone di popolazione rarefatta per le quali riesce difficile reclutare sul posto il personale indispensabi le perché le istruzioni settimanali riescano proficue, di modo che non è possibile assicurare a priori di avere dette batterie pronte ad entrare in azione al primo ce nn o. Questo particolarmente per la Maddalena.
S.E. Badoglio - Bi sogna distinguere nettamente la difesa delle coste dalla difesa delle Piazzeforti. - Sinora abbiamo discusso delle Piazzeforti: in questo campo sembra a me che, se la Marina ha tutti gli a ltri elementi delle singole Piazzeforti ai suoi ordini, è bene abbia anche le batterie servite dalla M. da Cos.
S.E. Pini - La questione deve però esse re esam in ata anche sotto il punto di vista finanziario. Le assegnazioni annuali previste per l a M. da Cos sembrano un po' esigue, soprattutto quelle relative a munizionamento di esercizio e manutenzione di fabbricati. Anche le dotazioni di materiali di mobilitazione non sembrano complete.
Perciò se la M. da Cos passa alla Marina, quest'ultima ne risentirà un onere finanziario.
S.E. Badog li o - La questione allora passa dal campo tecnico, nel quale mi sembra si sia raggiunta un'unità di ve du te, al campo finanziario. La Marina ritiene insufficiente la complessiva assegnazione annuale fissata per la M. da Cos di fronte alle esigenze dei materiali, dell'addestramento, delle esercitazioni, dei fabbricati.
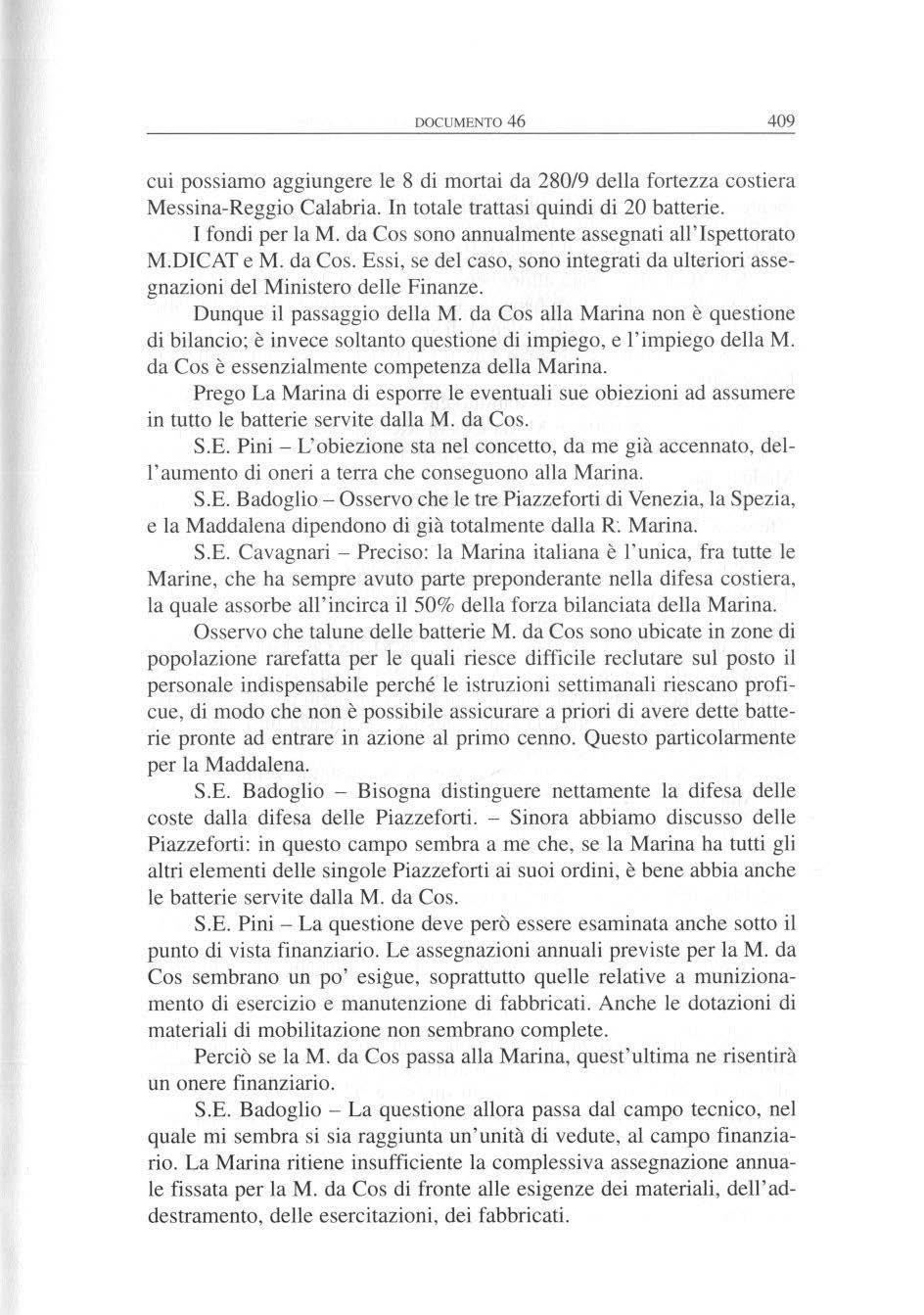
S.E. Pini - Preciso che il Ministero delle Finanze concorre annualmente con circa 3 milioni, ed il Ministero della Guerra con complessivi 3 milioni e 340.000 lire: un totale quindi di 6 milioni e mezzo; donde la necessità che si addivenga a precisazioni.
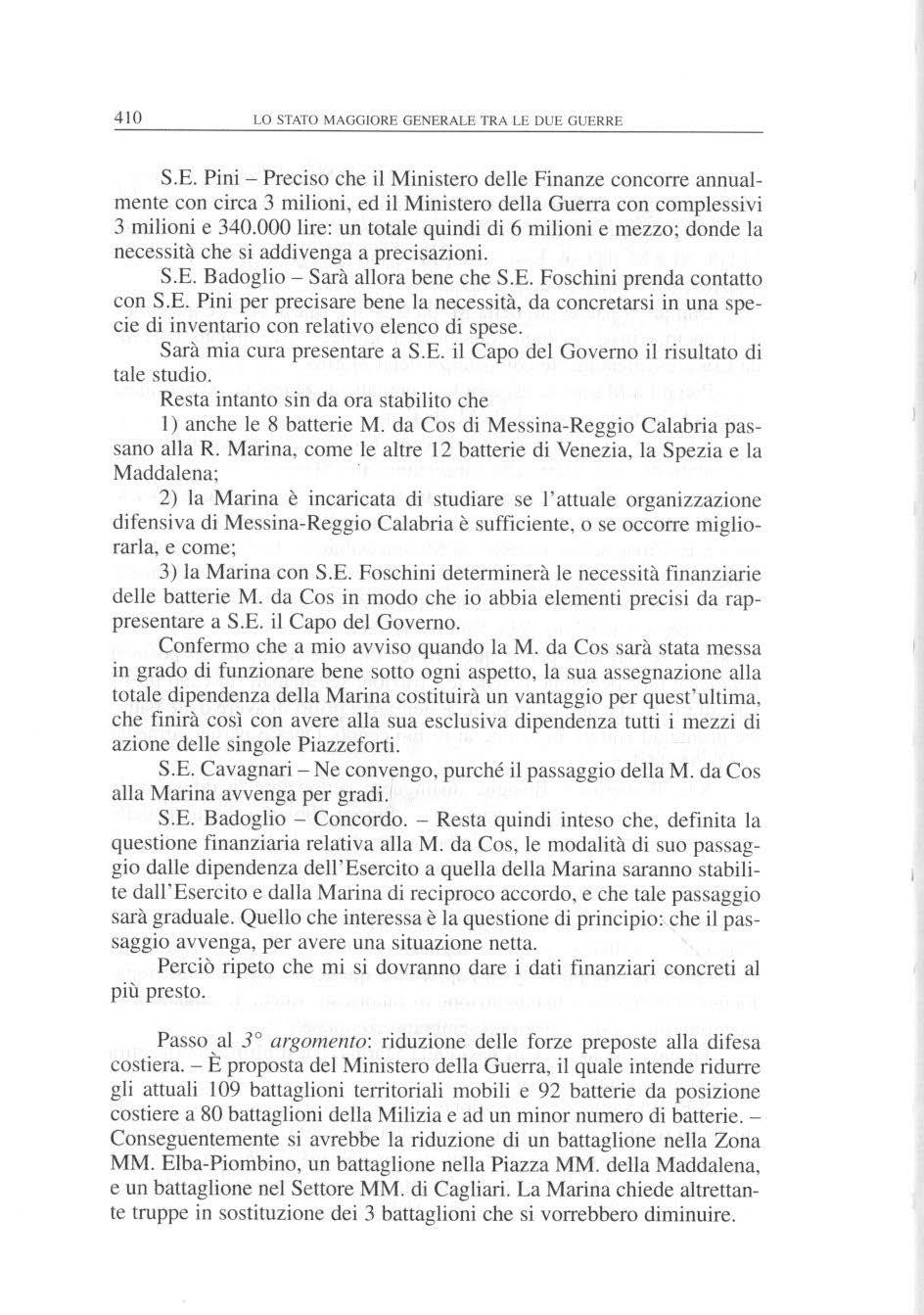
S.E. Badoglio - Sarà allora bene che S.E. Foschini prenda contatto con S.E. Pini per precisare bene la necessità, da concretarsi in una specie di inventario con relativo elenco di spese.
Sarà mia cura presentare a S.E. il Capo del Governo il risultato di tale studio.
Resta intanto sin da ora stabilito che
1) anche le 8 batterie M. da Cos di Messina-Reggio Calabria passano alla R. Marina, come le altre 12 batterie di Venezia, la Spezia e la Maddalena; ·
2) la Marina è incaricata di studiare se l'attuale organizzazione difensiva di Messina-Reggio Calabria è sufficiente, o se occorre migliorarla, e come;
3) la Marina con S.E. Foschini determinerà le necessità finanziarie delle batterie M. da Cos in modo che io abbia elementi precisi da rappresentare a S.E. il Capo del Governo.
Confermo che a mio avviso quando la M. da Cos sarà stata messa in grado di funzionare bene sotto ogni aspetto, la sua assegnazione alla totale dipendenza della Marina costituirà un vantaggio per quest'ultima , che finirà così con avere alla sua esclusiva dipendenza tutti i mezzi di azione delle singole Piazzeforti.
S.E. Cavagnari -Ne convengo , purché il passaggio della M. da Cos alla Marina avvenga per gradi.
S.E. Badoglio - Concordo. - Resta quindi inteso che, definita la questione finanziaria relativa alla M. da Cos, le modalità di suo passaggio dalle dipendenza dell'Esercito a quella della Marina saranno stabilite dall'Esercito e dalla Marina di reciproco accordo, e che tale passaggio sarà graduale. Quello che interessa è la questione di principio: che il passaggio avvenga, per avere una situazione netta.
Perciò ripeto che mi si dovranno dare i dati finanziari concreti al più presto.
Passo al 3° argomento: riduzione delle forze preposte alla difesa costiera. - È proposta del Ministero deJla Guerra, il quale intende ridurre gli attuali 109 battaglioni territoriali mobili e 92 batterie da posizione costiere a 80 battaglioni della Milizia e ad un minor numero di batterie.Conseguentemente si avrebbe la riduzione di un battaglione nella Zona MM. Elba-Piombino, un battaglione nella Piazza MM. della Maddalena, e un battaglione nel Settore MM. di Cagliari. La Marina chiede altrettante truppe in sostituzione dei 3 battaglioni che si vorrebbero diminuire.
L'Esercito osserva che con la nuova organizzazione:
l) si sostituisce alla vecchia difesa delle coste, a cordone e perciò di scarso valore, una difesa manovrata, qualitativamente più forte, perché i nuovi battaglioni di camicie nere costituiti con elementi tratti tutti dalla zona nella quale dovranno essere impiegati, saranno indubbiamente più prontamente disponibili dei battaglioni territoriali mobili (pronti solo dopo qualche giorno), più istruiti (possibilità di settimanali istruzioni), più affiatati, più pratici del terreno e più orientati sul loro impiego;
2) in caso di conflitto mediterraneo, gli interi corpi d'armata di Sicilia e di Sardegna restano in posto, ed in zona Elba-Piombino è previsto l'impiego di una grande unità in caso di minaccia.
Io aggiungo che, dato l'orientamento attuale della nostra politica è probabile che non solo i corpi d'armata della Sicilia e della Sardegna restino in posto , ma che vi rimanga anche buona parte delle altre Grandi Unità; perciò la difesa costiera verrebbe ad essere integrata tutta da Grandi Unità.
S.E. Foschini - Chiarisco che la Marina più che alla diminuzione specifica dei 3 battaglioni a Cagliari , La Maddalena, Elba-Piombino, ha fatto obiezioni alla questione generica della riduzione del numero complessivo dei battaglioni addetti alla difesa delle coste, riduzione dalla quale ritiene abbia a derivare un aumento degli oneri di sua competenza nel concorso alla difesa delle coste.
La Marina ha anche osservato che per i 3 battaglioni accennati, la questione è facilmente risolvibile: basta aumentare di poco gli organici degli altri battaglioni.
Per la questione generica assicuro che con la nuova organizzazione da noi studiata per la difesa delle coste, quest ' ultima viene migliorata. Avremo bensì un minore numero di battaglioni, ma la loro efficienza sarà sicuramente superiore per i motivi già detti da S.E. il Maresciallo Badoglio. Aggiungo che questi battaglioni di Milizia addetti alla difesa delle coste avranno una volta all'anno la loro scuola di tiro, saranno animati dallo spirito della M.V.S.N. che non è paragonabile a quello dei richiamati anziani in passato previsti per la difesa delle coste, avranno I compagnia mitragliatrici per ogni battaglione, e saranno dotati di mezzi di trasporto automobilistici per rapidamente accorre là ove è necessario.
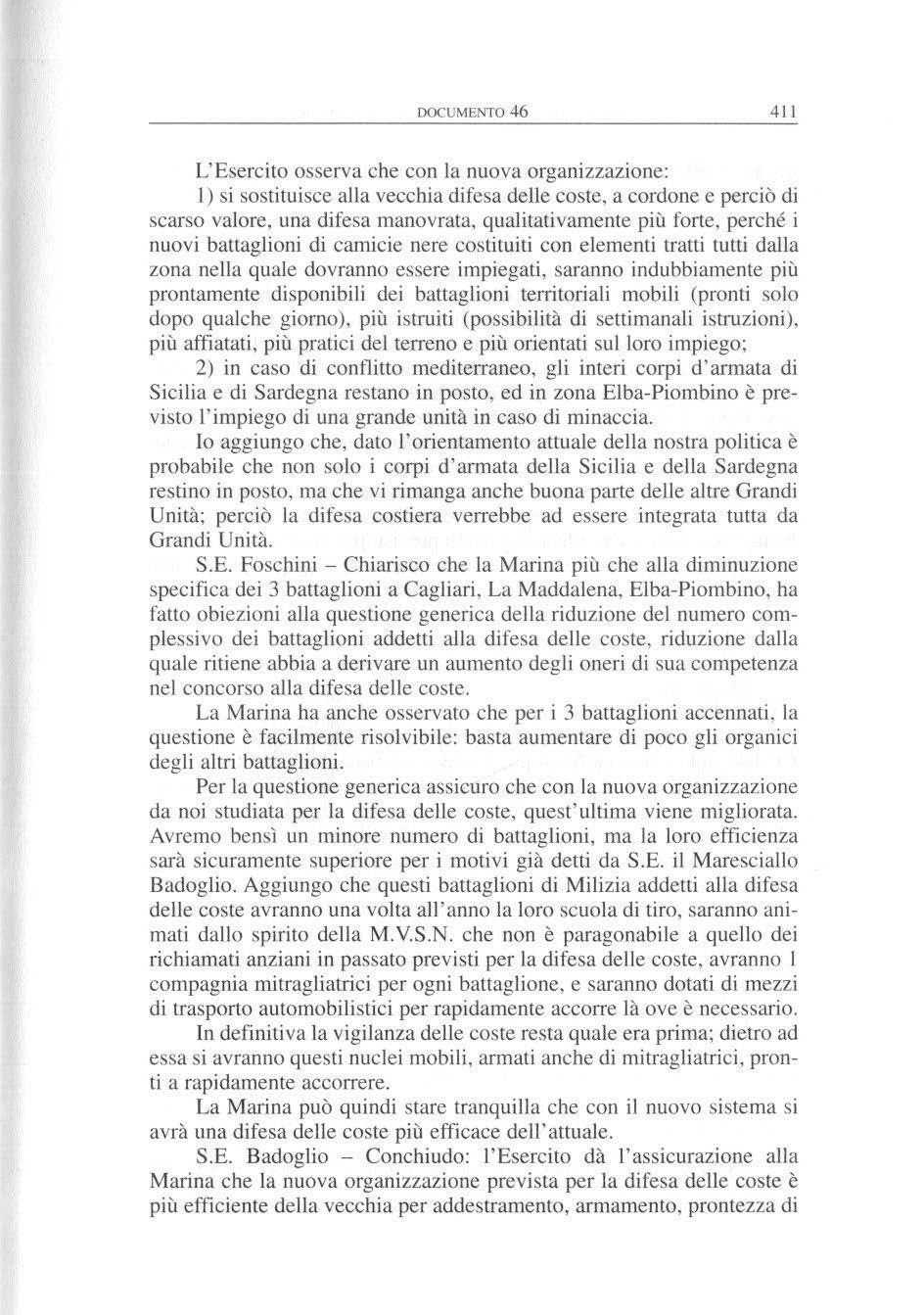
In definitiva la vigilanza delle coste resta quale era prima; dietro ad essa si avranno questi nuclei mobili, armati anche di mitragliatrici, pronti a rapidamente accorrere.
La Marina può quindi stare tranquilla che con il nuovo sistema s i avrà una difesa delle coste più efficace dell'attuale.
S.E. Badoglio - Conchiudo: l'Esercito dà l'assicurazione alla Marina che la nuova organizzazione prevista per la difesa delle coste è più efficiente della vecchia per addestramento, armamento, prontezza di
disponibilità in caso di bisogno, garantita mobilità, nonch é per il previsto impiego di Grandi Unità là ove è nece ssario.
S .E. Pariani - Confermo che è previsto, in caso di conflitto mediterraneo l ' impiego di buona parte delle Grandi Unità nei punti minacciati.
S.E. Badoglio - Pa sso al 4 ° a rgomento: protezione delle ferrovie, strad e ordinarie, reti delle comunicazioni, impianti vari.

Sino ad oggi è stato previs to di affidarla ad 89 battaglioni territoriali, non mo bili , con il concorso de ll e Mili zie speciali in quanto conse ntito dagli altri incarichi s pecifici ad esse affi dati .
Ogg i il Mini s tero della Gu erra ha progettato di va le rs i invece largamente di tutte le Milizie spec iali (fe rroviaria , stradale, portuari a, telegrafo nica) nonché di elementi spec iali zza ti g ià in posto (case llanti ferroviari, g uardafili, ecc.) e dello stesso personale operaio degli s tabiJime nti inscritto alla M .Y.S.N.; integrando detta difesa, ove ne cessar io, con 41 battaglioni di CC.NN., identi ci a quelli previsti per la difesa delle coste.
Prima di pronunciarmi in merito desidero che mi s i pros petti in uno s p ecc hio la di s locazione si no ad oggi prevista per i battag lioni territoriali , in confronto con quell a progettata per i nuo vi battaglioni di Mili zia
S.E. Foschini - Chiari sco che la protezione delle ferrovie, s trade , opere d 'arte, reti di comunicazione ecc. comprende 2 sottoserv i zi :
1) polizia,
2) difesa tattica.
Sino ad ora al serv iz io di poli zia era addetta una massa e norme di CC.RR.; alla difesa tattica s i provvedeva co n battaglioni te rritori ali .
Con la nuova organizzazione in luo go di vecchi CC.RR. appositamente richiamati si utili zzano le Milizie speciali; ed in luogo dei battaglioni territoriali si impiegano battaglioni di Milizia.
S.E. Badoglio - 11 nuovo criterio è giustissimo; la Mili zia ha e lementi s pecializzati proprio per questo servizio: p erc hé non utilizzarli ?
La campagna de ll ' A.O I. mi ha confermato quanto il rendimento dell 'e lemento uomo s ia oggi superiore a quello del pa ssa to.
Prego quindi di farmi avere, non app e na po ss ibile , lo specc hio cui ho già acce nnato.
La seduta è tolta alle ore 11.
A.U.S.S.M.E., fondo 1-4 «Ca rteggio Stato Maggiore Generale - Comando Supremo - Staio Maggiore Generale 1924-1948», busta 11. 73.fascico /o n. 3.
li docurne1110 è una copia dell 'Ufficio del capo di Stato Maggiore Ge11erale
«Organizzazione militare dell'isola di Pantelleria: intervento del Ministero dei Lavori Pubblici, R.D.L. del 6.5. /937 su Pantelleria base aerea, fondi necessari per l'organizzazione aeronautica e aeroportuale, compiti specifici delle tre forze armate nel/' Isola e direttive finali di Badoglio (responsabilità della difesa antisilurante alla Marina, difesa antisbarco e antiaerea all'Esercito, comando generale dell'isola all'Aeronautica, lavori stradali)».
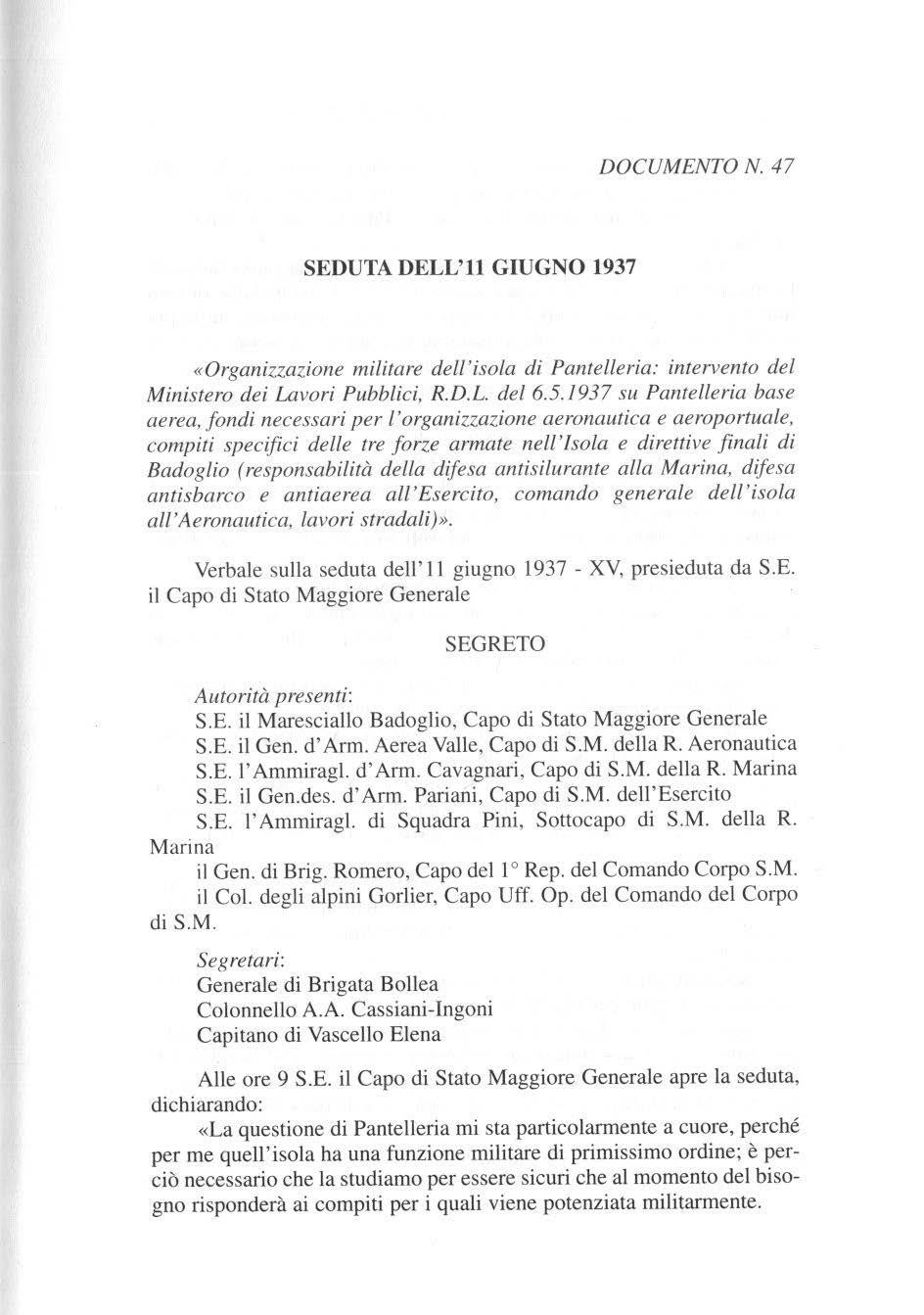
Verbale s ull a seduta dell' 11 gi ugno 1937 - XV, presieduta da S.E. il Capo di Stato Maggiore Generale
Autorità presenti :
S.E. il Maresciallo B adoglio, Capo di Stato Maggiore General e
S.E. il Gen. d' Arm. Aerea Valle, Capo di S.M. della R. Aero nautic a
S.E. I' Ammiragl. d' Arm. Cav ag nari, Capo di S.M. della R . Marina
S.E. il Ge n.d es. d'Arm. Pariani, Capo di S.M. d ell 'Eserci to
S.E. I ' Ammiragl. di Squadra Pini, Sottocapo di S.M. della R .
Marin a il Gen. di Brig. Romero, Capo del 1° Rep. del Comando Corpo S.M. il Co l. degli alpi ni Gorlier, C apo Uff. Op. d el Comando del Corpo di S.M.
Segretari:
Gen e rale di Brigata Bollea
Colonnello A.A. Cassiani-Ingoni
Capitano di Vascello Elena
Alle ore 9 S.E. il Capo di Stato Maggiore Generale apre la seduta, dichiarando:
«La questione di Pantelleria mi sta particolarmente a cuore, perché per me quell'isola ha una funzion e militare di primissimo ordine; è perciò nec essario che la s tudiamo per essere sicuri che al momento del bisogno risponderà ai compiti per i quali viene potenziata militarmente.
L'abbiamo già esaminata in un'altra nostra riunione , ma da quella discussione ad oggi sono intervenuti due nuovi elementi, e cioè:
- l'intervento del Ministero dei Lavori Pubblici nei lavori portuali dell'isola;
- il R.D.L. del 6 maggio 1937-XV, n. 775, che ha sanzionato che l'isola di Pantelleria è base aerea, ed ha affidato al comandante di essa tutti i poteri civili e militari e la tutela dell'ordine pubblico con le più ampie facoltà per porre l'isola in istato di difesa e di resistenza.

Nella precedente riunione nostra era risultato che l'Aeronautica aveva di già disponibili i 60 milioni necessari per l'organizzazione aeronautica del l'isola».
S.E. Valle - Oggi però i milioni sono saliti a 68.
S.E. Badoglio - Allora diciamo: i 68 milioni necessari per l'organizzazione aeroportuale completa per l stormo, s u due gruppi, di cui 1 da bombardamento e l da caccia; e cioè hangar sotterraneo a 2 piani, campo di decollo e di atterraggio, depositi vari in caverna, alloggi per ufficiali e truppa , ecc.
La R Marina aveva presentato due progetti: uno massimo, l ' altro minimo. Il Minimo, che aggirava attorno a 125 milioni , considerava la difesa antinavi dell'isola con batterie di m. e di p.c., più la difesa e.a. estesa al campo di aviazione, più lavori portuali.
A proposito di questi ultimi lavori non so se oggi rientrano ancora tutti nella competenza del Ministero della Marina.
S.E. Pini - Oggi, solo più parzialmente, perché subentrato il concorso da parte del Ministero dei LL.PP.
S.E. Badoglio - Poi, come ho accennato, la Marina aveva presentato anche un progetto massimo che considerava in più l'impianto di artiglierie di g.c., e perciò comportava una spesa aggirantesi sui 320 milioni.
Desidererei sapere:
a) quale dei due accennati programmi la Marina intende adottare;
b) su quali fondi il Ministero della Marina può contare, perché è inutile che l'Aeronautica stia spendendo 68 milioni se poi lasciamo l ' isola indifesa.
S.E. Cavagnari - La Marina non ha ricevuto nessuna assegnazione particolare di fondi per Pantelleria.
S.E. Badoglio - Pantelleria non ha , si può dire, profondità; un attacco nemico può essere tentato specialmente in giornate per le quali l'azione dell'aviazione sia limitata per effetto delle condizioni metereologiche; ed altra parte del potenziamento dell'isola da parte nostra si è parlato anche alla Camera Inglese.
Perciò, considerata l'importanza dell ' isola - anche come osservatorio - nel mezzo del Canale di Sicilia, è evidente che in caso di ostilità il nemico cercherà di impossessarsene, o quanto meno di neutralizzarla.
S.E. Valle - Appunto per questo l'Aeronautica sta predisponendo nell'isola il lancio degli apparecchi dalla caverna, a mezzo di catapulta.
S.E. Badoglio - Per me Pantelleria è un unico complesso, nel quale le tre Forze Armate debbono addivenire contemporaneamente alla rispettiva organizzazione militare, per agire poi in perfetta cooperazione: se l'organizzazione di una di esse è debole, la questione si fa grave. Ora, se la Marina non ha ancora ricevuto nessuna assegnazione particolare per Pantelleria, è necessario che la ottenga.
S.E. Pariani - Anche l 'Esercito non ha ricevuto nessuna assegnazione particolare per Pantelleria.
S.E. Badoglio - Ciò posto, per poter far dare alla R. Marina i fondi relativi, è necessario che venga fissata quale organizzazione marittima essa deve creare nell'isola.
S.E. Cavagnaii - 11 Capo del Governo ha escluso il programma massimo, perciò la Marina dovrebbe limitarsi alla difesa a.a. ed ai punti di possibile sbarco. Questi ultimi sono limitati alla zona di Pantelleria città, a Punta Scauri, ed a Punta Tracino, perché nel rimanente la costa dell'isola è diruta, e per di più in generaJe per buona parte all'anno si ve,ifica attorno all'isola un movimento d'acqua che impedisce l'accostarsi dei natanti.
Re sta la questione della difesa a.a.; ma al riguardo osservo che la R. Marina ha il compito di provvedere alla difesa a.a. delle sole sue basi navali, la difesa a.a. del resto del territorio è compito della DICAT. Perciò chiedo quale è il programma di difesa che la Marina deve attuare nel1' isola di Pantelleria.
S.E. Badoglio -È evidente la necessità che si organizzi la difesa a.a. dell'isola. Ad essa provvederà l'Esercito, e se non ci sono artiglierie né mitragliatrici e.a. disponibili, bisognerà produrlo od acquistarle. Per quanto riguarda la Marina resta allora inteso che S.E. Cavagnari mi presenterà il suo progetto sulla base della:
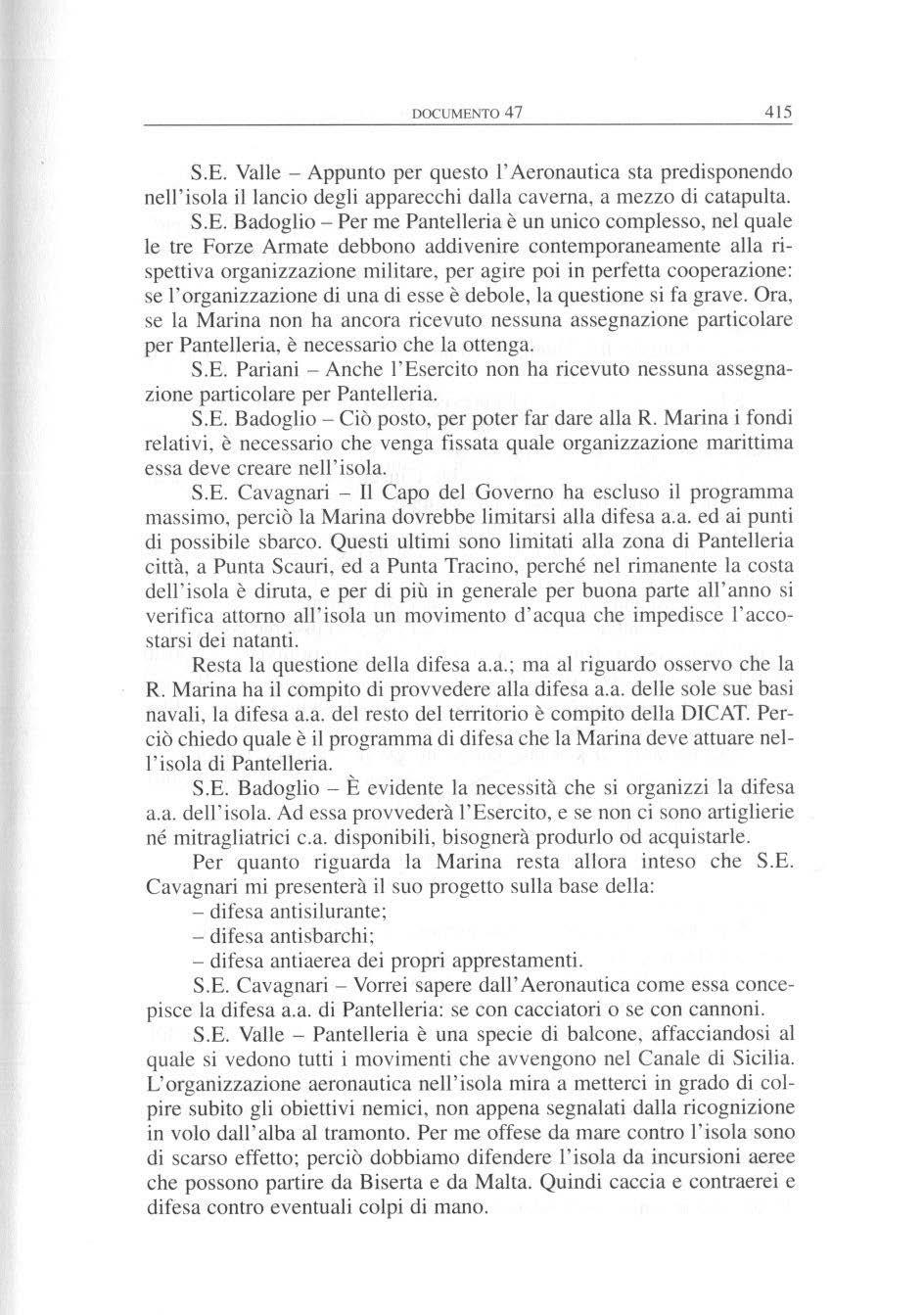
- difesa antisilurante;
- difesa antisbarchi;
- difesa antiaerea dei propri apprestamenti.
S.E. Cavagnari - Vorrei sapere dall'Aeronautica come essa concepisce la difesa a.a. di Pantelleria: se con cacciatori o se con cannoni.
S.E. Valle - Pantelleria è una specie di balcone, affacciandosi al quale si vedono tutti i movimenti che avvengono nel Canale di Sicilia. L'organizzazione aeronautica nell'isola mira a metterci in grado di colpire s ubito gli obiettivi nemici, non appena segnalati dalla ricognizione in volo dall'alba al tramonto. Per me offese da mare contro l'isola sono di scarso effetto; perciò dobbiamo difendere l'isola da incursioni aeree che possono partire da Biserta e da Malta. Quindi caccia e contraerei e difesa contro eventuali colpi di mano.
In tale quadro io vedo l 'organ izzazione difensiva dell'isola poggiante s u:
- una s trada di arroccamento, perimetrale, che permetta il rapido spos tamento di unità mobili autocarrate con mitragliatrici contro colpi di mano;
- nei punti più probabili di sbarco, piazzuole predisposte per le mitragliatrici ;
- una batteria di cannoni e.a. ed un certo numero di sez. mitr. per la difesa del campo di aviazione.
S.E. Pariani - L'Esercito ha previsto come unità mobile da dislocare nell'isola a momento opportuno un btg. dì ftr., più una cp. mtr. da inviare subito, più una btr. da pos. cast.

Circa la difesa e.a., per me una btr. è insufficiente; occorre almeno un paio dì batterie, meglio un intero gruppo.
S.E. Badoglio -Allora riepilogando:
- per quanto concerne l'Aeronautica nulla e' è da modificare al programma già in pieno sviluppo;
- la difesa antisilurante resta affidata alla Marina;
- la difesa antiaerea resta affidata all'Esercito insieme con la difesa dell'isola contro sbarchi. Perciò S.E. Pariani vorrà inviare s ul posto un ufficiale dell'Esercito con il compito di studiare in modo particolare la difesa e.a. e presentare poi il progetto completo della organizzazione di competenza dell'Esercito.
S.E. Pariani - Il progetto che io ho già presentato è completo in tutto, salvo la difesa e.a. che oggi si è decisa di affidare all'Esercito. In vierò al più presto l ' ufficiale a Pantelleria.
S.E. Valle - Se si dovranno acquistare armi e.a., propongo la mitragliera da 37 deJJa R. Marina che è la più adatta.
S.E. Badoglio - Confermo che alla Marina resta affidato il solo compito antisilurante.
S.E. Pini - Nel programma minimo già presentato, e perciò già noto, la Marina prevedeva l'impianto di:
- batteria di m.c. con compiti antinave;
- batterie dì p.c. con compito antisilurante ed antiaereo.
QuaJi di queste btr. dovranno restare nel nuovo progetto da compilare ?
S.E. Cavagnari - La Marina prevederà l'impiego e l'impianto delle batterie antìsiluranti adatte per noi; se esse avranno anche po ssi bilità di azioni antiaerea, tanto meglio; concorreranno alla difesa e.a. che sarà organizzata daJl' Esercito.
S.E. Badoglio - Concordo completamente; dico di più: io vedo a Pantelleria un unico comandante, il comandante dell'aviazione.
Egli avrà alle s ue dipendenze anche le altre forze, della Marina e dell'Esercito, che vi saranno dislocate.
Circa i lavori portuali osservo che essi non sono fatti per l' Aeronautica, ma per l 'iso la, e cioè per tutte le forze che in essa verranno dislocate. Per me quindi è indifferente che i fondi ad essi relativi siano dati all'una od all'altra Forza Armata; l'importante è che vengano dati.
S.E. Parianì - Chi provveded1 alla strada perimetrale?
S.E. Badoglio - Anche per essa mi occorrono dati precisi: quando S.E. il Capo del Governo riconosce che una spesa è necessaria, dà immancabilmente i fondi relativi.
S.E. Pariani - Allora definitivamente fissato che alla Marina ed all'Esercito, a Pantelleria, spetta so lo il compito di cooperazione con l'Aeronautica; e che siccome la Regia Marina non provvede più alla difesa e.a. del campo di aviazione, ad essa provvederà l'E serc ito.
S.E. Badoglio - Conchiudo: in base a quanto abbiamo discusso e convenuto, la Marina farà il suo progetto e l'Esercito farà il suo . Quando lì avrò ricevuto ci riuniremo di nuovo.
S.E. Valle - Proporrei che gli studi venissero fatti sul posto.
S.E. Badoglio - Non ho nulla in contrario per parte mia.
S.E. Valle - Per quanto concerne la strada perimetrale, riferisco che per guadagno di tempo ho fatto fare il relativo progetto dal personale addetto al l 'o rganizzazio ne aeronautica dell'isola e che è sul posto. Per la sua attuazione sì potrebbero utilizzare, al momento opportuno, i 2500 operai che stanno lavorando nell'isola.
S.E. Badoglio - Anche per questo non ho nulla in contrario per parte mia.
La se duta è tolta alle ore 9,45.
A. U.S.S.M.E fondo H-/0 « Verbali riunioni » husra 11. 2, fascicolo 11. IO. Il documento è una copia del/"Ufficio Operazioni del Conumdo del Corpo di Staro Maggiore. li verbale era stato Jrasmesso da/l'Ufficio del capo di Stato Maggiore Generale all'Ufficio Operazioni con/11. 1200 di prot. segreto, in data 20.6.1937 (fascicolo n. 10, H-/0, busta 11. 2).


«Situa z ione interna zionale e progetti operativi in corso di studio: piano AZ del Regio Esercito (conquista delle isole zaratine), piano AA. del Regio Esercito (Albania - padronan za del canale d'Otranto, possesso del bacino petrolifero del Devo/i), piano 10 (ipotesi di guerra contro Fran c ia e Jugoslavia) , piano 12 (ipotesi di guerra c ontro Francia e Inghilterra) e studi su operaz ioni contro la Grecia e in Africa settentrionale. Coopera z ione tra Aeronautica e Marina in guerra (coordinamento nell'Alto Tirreno, Mar Rosso e Adriatico, avia z ione di Marina e portaerei). Impianto per voli notturni nella baia di Porto/ago e difesa c ontraerei dei campi di avia zione di manovra dell'Egeo »
Verbale della seduta del 2 dicembre 1937-XYI
Presieduta da S.E. il Capo di Stato Maggiore Generale
Autorità presenti:
S.E. il Maresciallo Badoglio - Capo di S.M. Generale
S.E. il Gen. d' Arm. Aerea Valle - Capo di S.M. della R. Aeronautica
S.E. l' Amm. d' Arm. Cavagnari - Capo di S.M. della R. Marina
S.E. il Gen. d' Arm. Pariani - Capo di S.M. del R. Esercito
Gen. di Div. Bergia - Ufficio Sottocapo di S.M. per la Dif. Terr.

Ten. Col. di S.M. Piacentini - Uff. Segreteria Mil.-Minist. Guerra
Capitano di Freg. Varoli-Piazza - Capo Uff. Piani Op. S.M. R. Ma-
S.E. il Gen. di Squadra Aerea Pinna - Sottocapo di S.M. R. Aeronautica rina
Segretari:
Colonnello di S.M. Gandin
- Capitano di Vascello Elena
- Ten. Colonnello AA. r.n. Ravagli
Alle ore 9,30 S.E. il Capo di Stato Maggiore Generale apre la seduta iniziando la discussione dell'argomento primo da esaminare:
«In flu enza di alcuni sviluppi della situaL.io ne internazionale sui progetti operativi in co rso di studio». Si tr atta della proposta, fa tt a da S.E. Cavagnari - in co nside r azio ne delle attuali buo ne relazioni con la Ju goslavia e delle altre variazio ni subite dalla situazione internazio na le - di rin unziare alle operazioni previste nel!' Alto Adriatico ( Pi ano AZ del R. Esercito: co nqui sta iso le zara tin e) e nel B asso Adriatico ( Piano AA del R. Ese rc ito: Albania - padronanza Canal e Otranto - possesso bacino petrolifero del Devoli). Ciò anche nell'eventualità che la Ju gos lavia ritornasse a noi ostile cos icché fosse possibile alla R. Marina di co ncentrare la massa delle forze co ntro il nemico prin c ipal e: Inghilt c 1Ta.
S.E. Pariani - Noi non facciamo un piano tota litario , ma tre di versi piani co rri spondenti a varie ipotesi. li piano che riguarda la co nqui sta delle isole zaratine è il piano IO relativo ali' ipotesi di guerra cont ro Fran c ia e Ju gos lav ia alleate. Nel piano 12 ( ip otesi di guerra co ntro Fran c ia ed In gh ilte rra) vi si rinunzia, tra lland osi. s ulla fr ont iera jugoslava, di attuare una vigi lan za iniziale.
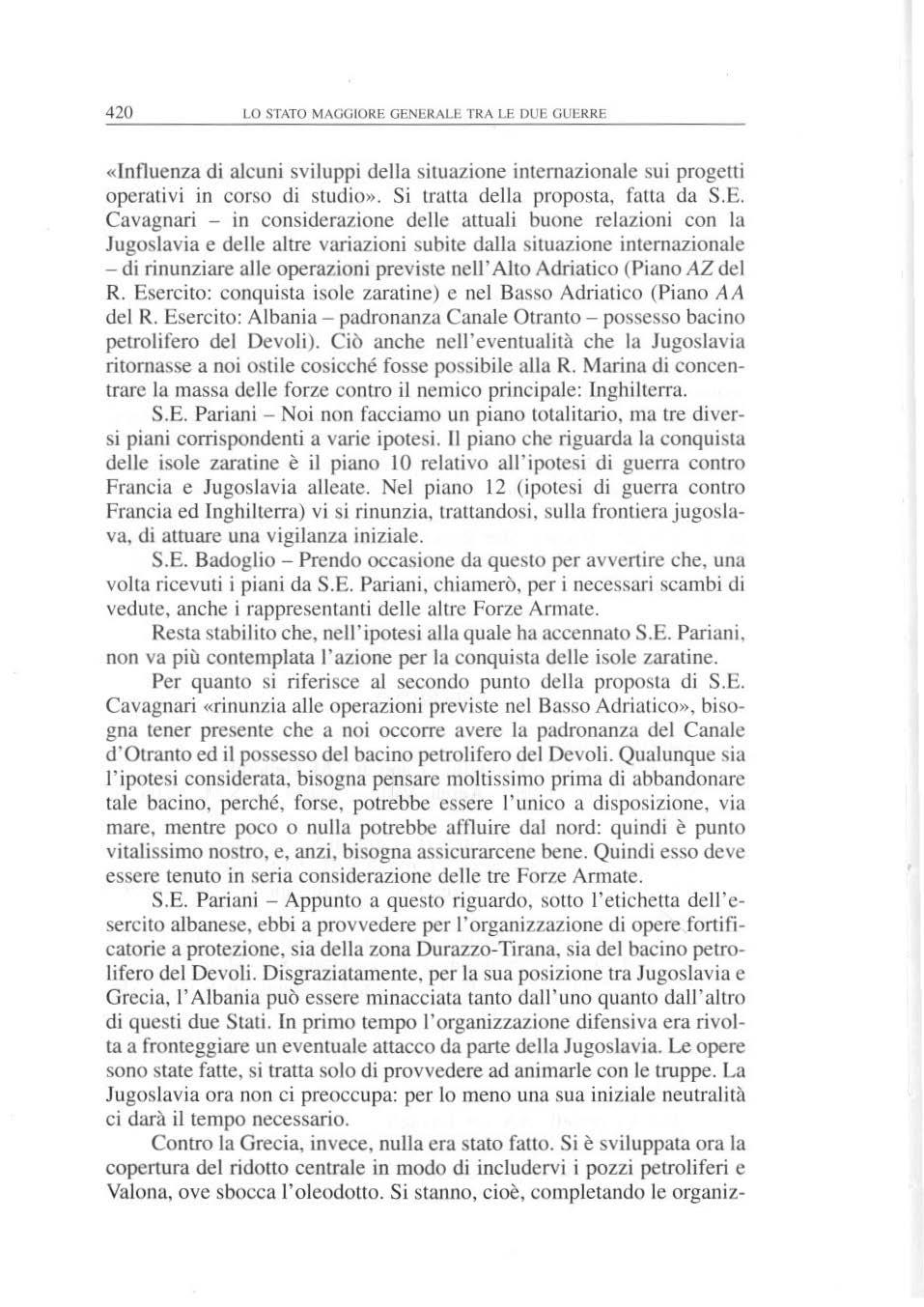
S.E. Badog li o - Prendo occasione da questo per avvertire che, u na volta ricevuti i piani da S.E. Pariani, ch iamerò, per i necessari scambi di vedu te, anche i rapprese ntan ti delle a ltre Forze Armate.
Resta stabilito c he, nell'ipotesi alla quale ha accen nato S.E. P ariani. non va più co nte mplata l' aL.io ne per la conqu i sta delle isole zarat in e.
Pe r quanto si riferisce al secondo punto della proposta di S.E. Cavagnari «rinu nz ia alle operazioni previste nel Basso Adriatico», bisogna tener presente che a noi occorre aver e la padronanza del Can ale d'Otr an to ed il possesso del bacino petrolifero del Devo li. Qualunque sia l'ipotesi co n s id e rata, bisogna pen sare moltissimo prima di abba ndonare tal e bacino, perc hé, forse, potrebbe esse re l'uni co a di spos iz ione , via mare, mentre poco o null a potrebbe affluire dal nord: quindi è punto vitalissimo nostro, e, anzi, bisogna assicu rarcene bene. Qu indi esso deve essere tenuto in seria considerazione delle tre Forze Armate.
S.E. P ariani - Appunto a qu esto ri guard o, sotto l'etichetta de ll 'ese rcito alban ese, ebb i a provvedere per l'organinazione di opere fortificatone a protez ione, s ia della zona Duraz zo- Tir a na, sia del bacino petrolifero de l Devoli. Di sgraz iatamente, per la s ua posizione tra Ju gos la via e Gre cia, l'Albani a può essere minacciata tanto da ll'uno quanto dall 'altro di questi due Stati. In primo tempo l 'o rganizzaz ione difensiva era rivolta a fronteggiare un even tu ale attacco da parte della Ju gos lavia. Le opere so no state fatte, s i tratta solo di prov vede re ad animarle co n le truppe. La Ju gos lavia ora non c i pre occ upa: per lo meno una s ua ini zia le neutralità c i darà il te mp o necessario.
Co ntro la Grecia, invece, nulla era stato fatto. Si è sv ilupp ata ora la copertu ra del ridotto centrale in modo di includervi i poz zi petroliferi e Valona , ove sbocca l'oleodotto. Si stanno, cioè, co mpletando le organiz -
zazioni per integrare la difesa della parte sostanziale dell'Albania, sia contro la Jugoslavia, sia contro la Grecia. Garantita la sorgente petrolifera ed il suo sbocco a Valona , entra ìn questìone la Marina per ì trasportì. Ma è anche da consìderare un eventuale attacco aereo contro ìl bacìno petrolìfero del Devoli , attacco facile e che potrebbe fruttare al nemìco grandì risultati. Bisogna, perciò , organizzare la difesa contraerei: cosa questa alla quale si so no opposte serie difficoltà di carattere politico, così che molto dovrà essere attuato solo al momento del bisogno.
S.E. Valle - Vi sono i campi di Coritza e di T irana, ma sono piccoli e difficili.
S.E. Pariani - L' Esercìto può provvedere alla dìfesa terrestre, ma , non potendo fare assegnamento sostanziale sulle forze albanesì, deve far fronte con traspo11ì. È fatta pure istruzio ne ad italiani s ul posto per l'impiego delle armi contraerei, ma si tratta di cosa aleatoria. Bisogna quindi seriamente pensare alla difesa contraerei, mentre la Marina deve dare la sicurezza dei trasporti, se vogliamo fare assegnamento , in caso di guerra, sui carburanti albanesi.
S.E. Cavagnari - 11 problema sì s ìntetizza in trasporti di truppe, di rifornimentì e dì nafta. La nafta, per ora, è poca (25-30.000 tonn. al mese: 4-5 carichì). È vero, però , che la produzione può essere intensificata.
S.E. Badoglio - Richiamo , sulla questione, l'attenzione di tutti. Il progetto AA. non sussiste più, in pieno, ma bisogna adattarlo alla nuova situazione e cioè: azione non più verso ìl confine jugoslavo, ma verso il confine greco.
S .E. Pariani - Contro la Grecia occorre molto meno.
S .E. Badoglio - Credo che, in caso di ~uerra, la Grecia cederà magari tutti i suoi porti, ma non si muove r à. E, però , da ricordare che scarso affidamento può essere fatto sull'esercito albanese.
S .E. Valle -Ai fini della difesa dal bombardamento aereo è da tener presente che gli obìettivi albanesi possono essere battutì in un 'ora e anche meno, partendo dal territorio greco: ed è noto come l'avìazione greca si possa considerare in mano agli inglesi.
S.E. B adoglio - Bisogna, dunque , studiare la difesa contraerei.
S.E. Valle- Sarà posto allo studio l'invio di un gruppo da caccia da interdizione come a P alma di Majorca.
S.E. Pariani - Ritornando alle linee generali dell'argomento in dìscuss ione, dalle modìficazìoni alla situazione internazionale deriva che i nostri probabili nemici so no Francia e Inghilterra. Dato questo , vediamo le rispettive possibilità cli azione.
Noi siamo a contatto con l a Francia, sia in Europa, sia in Tunisia e, con l'Inghilterra, in Egitto. La Francia sta facendo una triplice chiusura della frontiera delle Alpi e noi cerchiamo di elevare, dalla parte nostra,

una adeguata muraglia. Vi saranno dei tentativi di rottura, ma la soluzione dovremo cercarla altrove. Sulla frontiera alpina le truppe di copertura sono sufficienti: la lotta risolutiva si sposterà, quindi, con tutta probabilità, verso la frontiera egiziana o verso quella della Tunisia, dato che, verosimilmente, l' Inghilterra spingerà la Francia ad operare da quella parte per alleviare la nostra eventuale pressione sull'Egitto. Bisogna metterci in condizioni di operare decisamente verso l'Egitto, parando verso la Tunisia. In questa s ituazione: l'Esercito ha trasportato 4 divisioni in Libia e creato colà 2 divisioni coloniali; sta, inoltre, provvedendo alla costituzione di una massa di manovra spostabile, sia sul teatro operativo europeo, sia verso quello coloniale e, cioè, là dove sarà necessario per ottenere la decisione. Premesso questo quadro, occorre vedere se sia mo in grado di eseguire i trasporti neces sari per le operazioni.
S.E. Badoglio - È giusto quanto afferma S.E. Pariani. Ecco perché S.E. il Capo del Governo ha voluto in Libia un nocciolo di 6 divisioni pronte a parare eventuali offese da parte della Tunisia, visto che, in breve tempo, senza trasporti via mare, potrebbero affluire, da parte france se, 50.000 uomini.

S.E. Pariani - Sembra che tale forza sia ora salita a 142 battaglioni. Inoltre sono stati raccolti dalle autorità francesi numero sissi mi automezzi in Algeria.
S.E. Badoglio - Dato questo, dovremo, prima di tutto, metterci in condizioni di difenderci e vedere, poi, se e come sviluppare azioni offensive. Ho esaminato il problema con S.E. Balbo e con S.E. Pintor per l'organizzazione delle due frontiere e, in particolare, dei campi di arresto di Zuara e di Nalut. S.E. Pintor ha avuto incarico di risolvere il problema dell'acqua che è gravissimo non solo a Nalut, ma anche tra Nalut e Zuara. Ma vediamo la seconda parte di questo sviluppo strategico. S.E. Pariani si domanda se può essere risolto il problema del trasporto, dalle basi nostre alle basi libiche, del numero x di divisioni raccolte in riserva e se al trasporto medesimo può essere assicurata la necessaria protezione. Scarse sono le difese delle basi libiche: a Tripoli vi sono pochi pez1i da 149 della Marina. Però, naturalmente, le difficoltà non pos so no escludere il problema. Lo Stato Maggiore dell'Esercito concreti il piano in cifre e inizi i contatti con la Marina per lo studio dei trasporti dalla Madrepatria alla Libia. Ogni piano strategico può sedurre come ampiezza e caratteristiche, ma solo lo studio approfondito può dimostrarne la po ss ibilità di attuarlo.
S.E. Pariani - Per quanto si riferisce all'Egitto, questo può considerars i una preda relativamente facile: 10.000 inglesi e 22.000 egiziani. Se, però, la Marina trova difficoltà per i trasporti, allora bisogna, fin dal tempo di pace, destinare altri corpi d'armata in Libia, realizzando così la possibilità di marciare ver so Suez.
S.E. Badoglio - Dopo le dichiarazioni di S.E. Pariani non resta allo Stato Maggiore dell'Esercito che concrelare i piani, in stretta relazione con la Marina, per vedere in quanto si possono attuare.
S.E. Cavagnari - Non v'è dubbio che trasporti imponenti non possono essere presi in considerazione durante le ostilità: bisogna, quindi, effettuarli prima.
S.E. Badoglio - Credo anch'io. Prima, però, di dare una risposta definitiva in materia , bisogna compiere un accurato studio i cui risultati potrebbero modificare . le decisioni già adottate, non solo nei riguardi delle truppe e dei mezzi, ma anche dell'organizzazione delle frontiere, le quali sono s tate apprestate per parare eve ntuali colpi di mano e non contro uno sforzo continuo, come occorre ora. L'Aviazione, in questo problema, è quella che soffre meno. Essa ha già campi attrezzati in Libia e lavora a perfezionarli, mentre facile è trasvolare il Mediterraneo.

S.E. Valle - Ma anche l'Aeronautica, per i trasporti dei rifornimenti, è legata alla Marina. Tuttavia è da tener presente che abbiamo accentrato già in Libia munizioni e benzina per sei mesi. Se, però, si deve far fronte, tanto ad ovest quanto ad est, occorre l'invio di forze aeree doppie di quelle attuali.
S.E. Badoglio - Una volta esaminato il problema tra Marina ed E se rcito, ne sarà completato l'esame con l'Aeronautica.
S.E. Pariani - Uno dei principali problemi è quello dei carburanti. È in studio l'impianto di depositi di olii grezzi e di raffinerie in Libia. Poiché non vi sare bbe convenienza di creare s ufficienti depositi di benzina, date le necessita di rotazione per la conservazione, si costituirebbe, così, una specie di miniera artificiale di carburanti (oli i grezzi o gasolio), limitando l'accantonamento della benzina al quantitativo suffic iente per le prime necessità.
S.E. Valle - Abbiamo in Libia quasi 8.000 tonn. di carburante.
S.E. Cavagnari - Il punto di vista d e lla Marina in questo campo è che si tratta, in definitiva, di problema di depositi, di apprestamenti, di preparazione: non di problema di trasporti.
S.E. Badog lio - In conclusione, confermo la necessità di una st retta collaborazione tra i tre Stati Maggiori. Invito S.E. Pariani a concretare le proposte che saran no, poi, esaminate in accordo con la Marina e con l'Aeronautica.
S.E. Badoglio - Pa ssia mo ora alla discussione dell'argomento secondo: «Cooperazione tra Aeronautica e Marina in guerra, nel quadro dei progetti operativi in corso di studio». Questo seco ndo argomento entra un po' nel primo, ma in via generale. S.E. Cavagnari chiede: lo st udio in comune degli Stati Maggiori dell'Aeronautica e della Marina per l'impiego dei mezzi in guerra; il coordinamento, nei settori Alto Tirreno, Mar Ro sso e Adriatico, ove la Marina potrà dislocare forze es igu e; la
difesa aerea delle basi logistiche ed operative della Marina con creazione di aeroporti nelle loro vicinanze. S.E. Valle afferma che è previsto l'intervento dell'Aeronautica in concorso della Marina nella battaglia navale e che, di massima, è anche già stato provveduto alle altre necess ità prospettate dalla Marina.
Ora, una volta che l 'Esercito avrà perfezionato i s uoi studi con la Marina, nei riguardi del piano operativo attuale, Marina e Aeronautica, in stretto contatto, esamineranno il problema della rufesa delle basi e il concorso dell'Aeronautica alle azioni della Marina. Per quanto si riferisce alla difesa delle basi, ritengo problema pressoché in sol ubile quello della creazione di altri aeroporti: è, però, da considerare che le distanze degli attuali aeroporti dalle basi della Marina non sono tali da impedire il concorso dell'Aeronautica.
S.E. Valle - Si tratta di perfezionare gli accordi e i mezzi di collegamento.
S.E. Cavagnari - Ma bisogna tener presente che per la Marina si verificano particolari condizioni di sfavore, in quanto essa non è nelle stesse condizioni delle marine avversarie, essendo priva di una aviazione propria: dispone solta nto di 35 aerei imbarcati e di 98 apparecchi dell'aviazione ausiliaria. Le Maiine inglese e francese, che hanno una aviazione propria, possono , quindi, prendere l'iniziativa aerea prima che noi si possa efficacemente contrastarla.

S.E. Badoglio - Provvederà il Comandante unico delle tre Forze Armate a stabilire le operazioni da farsi. Non possiamo fare previsioni ora.
S.E. Cavagnari - Le Marine avversarie hanno una aviazione imponente che può loro concedere grandi possibilità.
S.E. Valle - Veramente s i tratta di 12 navi portaerei le quali sono una specie di tallone di Achille.
S.E. Badoglio - Bisogna, comunque, che gli Stati Maggiori ginnas tichino le loro intelligenze in stretto contatto fra di loro: lavoro utile anche se le soluzio ni escogitate non corrisponderanno alla realtà della guerra.
S.E. Valle - Ma come premessa di tali studi, occorre affermare la necessità di evitare che determinate aliquote da bombardamento vengano permanentemente decentrate per scopi particolari, rimanendo, così, bloccate e rendendo impossibile l 'efficace compimento di azioni di vitale importanza come, ad es., la neutralizzazione della Corsica.
S.E. Badoglio - È giusto. Bisogna fare la manovra dei mezzi come quella delle unità. Specialmente quando si tratta di agire con forze minori contro forze s uperiori, come è il caso nostro , non bisogna assolutamente bloccare forze per bisogni eventuali. Occorre, quindi, studiare tra Marina e Aviazione, il problema della cooperazione e le sue po ss ibili
soluzioni, ma non si può andare al di là dello studio. Sarà, poi, funzione del Comandante unico delle tre Forze Armate, decidere. Anche se avessimo una gran ricchezza di mezzi, non sare bbe impiego idoneo quello di bloccarne determinate aliquote per particolari compiti.
S.E. Pariani - Sono anch'io dell 'avv iso che occorre evitare il frazionamento. Occorre dire all'Aeronautica lo scopo da raggiungere. Fissato questo , l'Aeronautica agisce in piena libertà.

S.E. Badoglio - Sicuro.
S.E. Cavagnari - Ma si tratta, per noi, di rispondere alle iniziative avversarie.
S.E. Badogli o - Per concludere, la Marina esponga le sue previsioni e l 'Ae ron a utica risponda come potrà co ncorrere . Dato che siamo in condizioni di inferiorità numerica , e so lo num erica, bisogna co nservarci integra la manovra dei mezzi. Su questa base invito gli Stati Maggiori della Marin a e dell'Aeronautica a studiare il problema.
S.E. Badoglio -Argomento terzo: <<Impianto per vo li notturni nella baia di Portolago».
S.E. Valle - Riass um o la questione. L a Marin a ha ri ch iesto attività aerea diurna e nottu rn a. In tutti g li idroscali del Re g no è stata resa poss ibile tale attività mediante l'impi a nto di se ntieri luminosi. A Portolago sono state trovate difficoltà particolari e si è sen tita la necessità anche di un impianto di segnali lumino si sulle colline.
S.E. Cavagnari - Il comandante militare marittimo si è opposto a tali impianti data la vicinanza delle coste grec he e anatoliche eventualmente ostili, dalle quali, per la pre se nza delle luci , sareb be stato possibile bene individuare obiettivi.
S.E. Badoglio - Bisogna esaminare se il sentiero luminoso è s ufficiente, s pecie se può essere illuminato e spen to facilmente, in relazione alle necess ità. È noto quanto sia grande l'attività notturna dell'aviazione inglese. Non vedo, quindi, perché, di fronte a qualch e difficoltà di ordine tecnico, si debba rinun c iare al volo notturno . Prego riprendere in esame la questione e vedere se può farsi l'impianto di questo se ntiero luminoso: se è possibile, provvederò io a definire la questione con il Governatore delle Iso le italiane dell ' E geo.
S.E. Pinna - Per esperienza personal e posso assicurare che effettivamente la baia di Portolago s i pre s ta male per il volo notturno: la vicinanza delle colline richiede la necessi tà di segnalaz ion i luminose su di esse . Bisogna, inoltre, prevedere di accordarsi con la M a rina per togliere il sent iero lumino so quando formazioni navali devono entrare od usc ire. D 'a ltra parte non vi è altro posto adatto p er idrovolanti in E geo.
S.E. Cavagnari - La Marina ha chiesto il volo notturno , ma non il volo notturno degli idrovolanti. Si po sso no utili zzar e, per tale sco po , g li apparecchi terre s tri della base di Rodi.
S.E. Valle - Anche se il volo notturno può farsi con gli apparecchi terre s tri non mi se mbra si debba rinun z iare, a priori, alla possibilità di un impianto per voli notturni di idrovolanti a Portolago.
S.E. B adoglio - In co nclu sione, occorre studiare nuovamente il problema, in pieno accordo tra Marina e Aeronautica e poi, quando mi saranno comunicati i risultati di tali studi, risolverò io definitivamente il problema con S.E. De Vecchi .
S.E. Badoglio - Esaminiamo l'argomento quarto: «Difesa contraerei dei campi di aviazione di manovra dell'Egeo».
Ha sollevato la questione S.E. Pariani, il quale , in base a richiesta di S.E. De Vec c hi intesa a meglio organizzare la difesa contraerei dei campi di aviazione dell'Egeo , fa presente che non è ancora stat o definito se il finanziamento per l'a ttuazion e della difesa co ntraerei dei campi di aviazione compete ali ' Esercito o ali' Aeronautica.
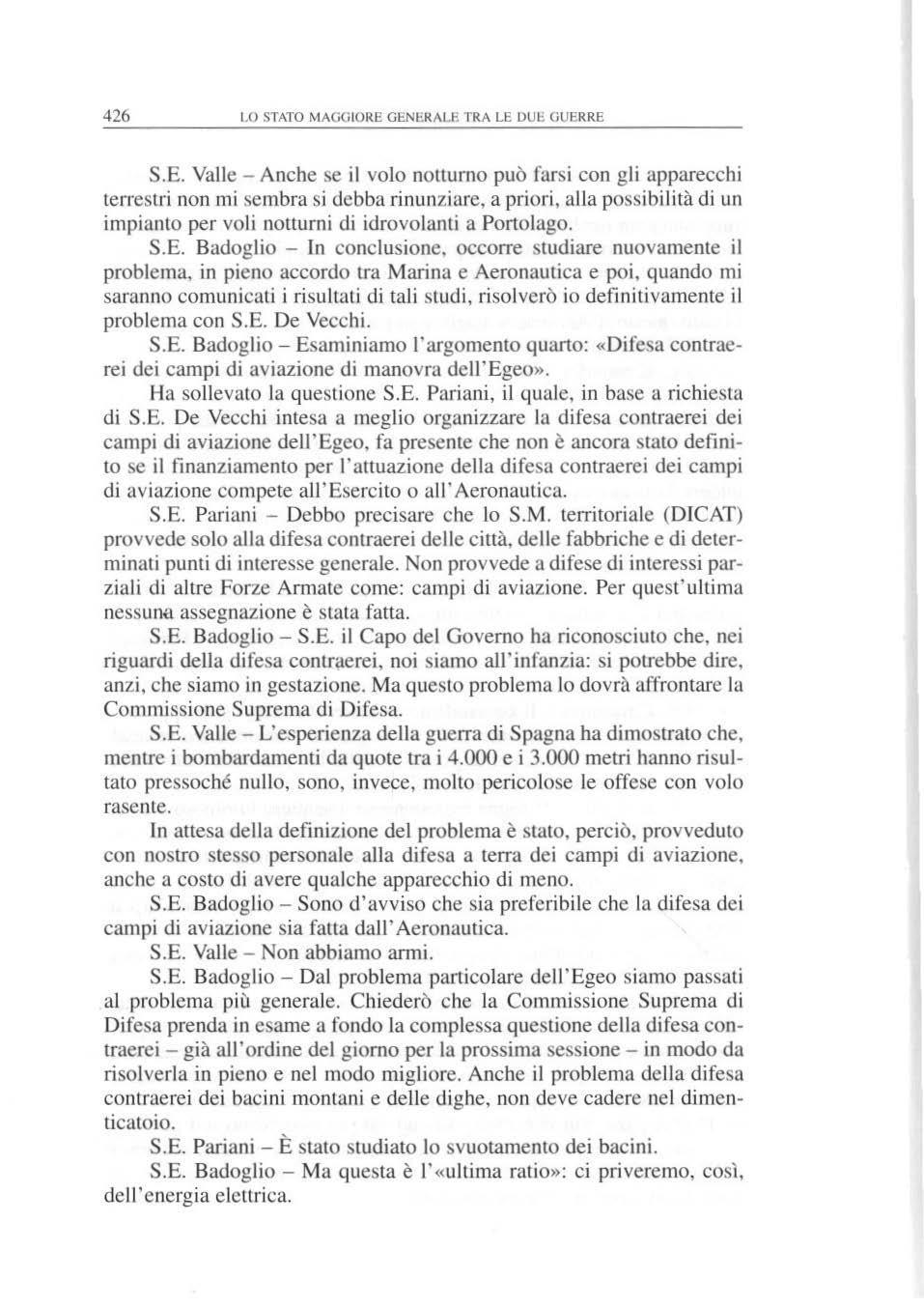
S.E. P ariani - Debbo precisare che lo S.M. territorial e (DICAT) provvede solo alla difesa contraerei delle città, delle fabbriche e di determinati punti di intere sse generale. Non provvede a d i fese di interessi parziali di altre Forze Annate come: campi di aviazione. Per quest'ultima nes s una assegnazione è stata fatta.
S.E. Badoglio - S.E. il Capo del Governo ha riconosciuto che, nei riguardi della d i fesa contraerei, noi s iamo all'infanzia: si potrebbe dire, anzi, che siamo in gestazione. Ma que s to problema lo dovrà affrontare la Commissione Suprema di Difesa.
S.E. Valle - L'es perienza della guerra di Spagna ha dimo s trato che, mentre i bombardamenti da quo te tra i 4.000 e i 3.000 metri hanno risultato pressoché nullo, sono, invece, molto pericolose le offese co n volo rasente.
In attesa della definizione del problema è s tato , perciò, provveduto con no s tro s te sso personale all a difesa a terra dei campi di aviazione, anche a costo di avere qualche apparecchio di meno.
S.E. Badoglio - Sono d'avviso che sia preferibile che la difesa dei campi di aviazione sia fatta dall ·Aeronautica.
S.E. Valle - Non abbiamo armi.
S.E. Badoglio - D al problema particolare dell'Egeo s iamo passali al problema più ge nerale. C hiederò che la Commissione Suprema di Difesa prenda in esame a fondo la complessa que s tione della difesa contraerei - g ià all'ordine del giorno per la prossima sess ione - in modo da risolverla in pieno e nel modo migliore. Anche il problema della dife sa contraerei dei bacini montani e delle dighe, non deve cadere nel dimenticatoio.
S.E. Pariani - È stato rudiato lo svuotamento dei bacini.
S.E. Badoglio - Ma que s ta è l' « ultima ratio »: ci priveremo, così, del!' energia elettrica.
S.E. Valle - Sarebbe già un successo per il nemico.
S .E. Badoglio - I n conclusione, bisogna che ci preoccupiamo seriamente del grave problema della difesa contraerei, sul quale non mancherò di richiamare l'attenzione di S.E. il Capo del Governo.
La sed uta è tolta alle ore 10,50.
A.U.S.S.M.E..fondo H - /0 « Verbali riunioni 1924-/943». busta n. 2.fascicolo 11. IO. Il documento è una copia dell'Ufficio Operazioni del Comando del Corpo di Stato Maggiore. Ques/0 verbale è stato già pubblicato dal generale Mario Montanari nella monografia « L'Esercito italiano alla vigilia della Seconda xuerra m.011diale», edito dall'UJ]icio Storico dello Stato Maggiore <le/l'Esercito nel 1982 (alle,tato I 3, pagg. 410-417).
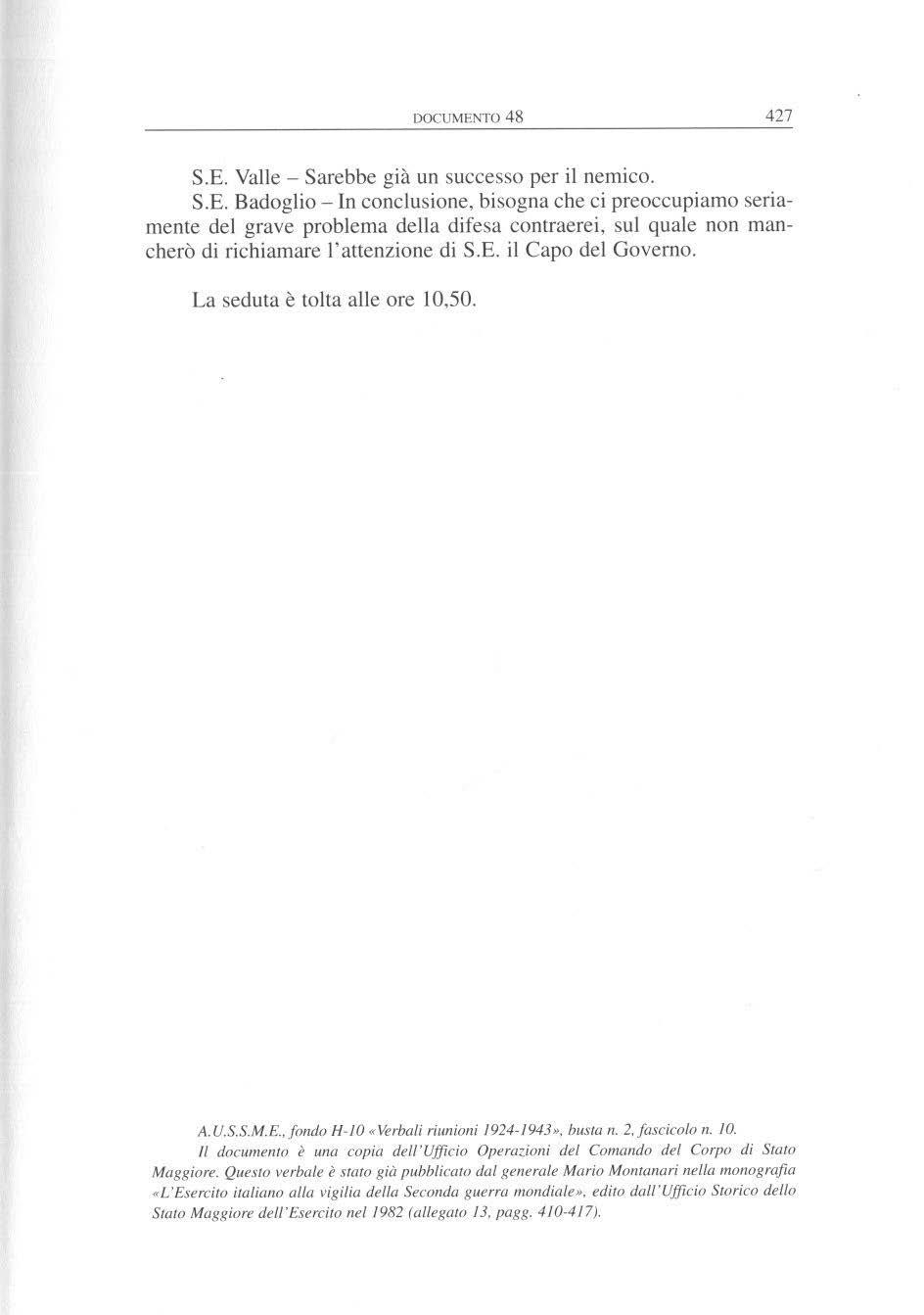



Capo di Stato Maggiore Generale dal 4 maggio 1925 al 4 dicembre 1940.
Nato a Grazzano Monfe nato il 28 settembre 1871 e morto a Grazzano Badoglio (Monferrato) il 1° novembre 1956.
Dal 1888 al 1890 fu allievo della R. Accademia militare di Torino e il 16 novembre 1890 fu nominato sottotenente dell'arma di arti glieria. Il 7 agosto 1892, nominato tenente, fu assegnato al 19° Reggimento artiglieria da campagna. Nel 1896-98 fu inviato in Eritrea, partecipando alle operazioni coloniali. Il 23 agosto 1902 assegnato alla 7a Brigata artiglieria da fortezza conseguì il diploma della Scuola di Guerra. Nel 1903 fu comandato a prestare servizio di stato maggiore presso la Divisione di Firenze e il 13 luglio dello stesso anno divenne capitano per promozione a sce lta nel 12° Reggimento artiglieria da campagna.
Nel 1905 venne comandato, sempre in servizio di stato maggiore, al XI Corpo d'Armata. Nel 191 l partì per Tripoli partecipando alla guerra italo -t urca. Nominato maggiore nel luglio 1912, venne assegnato al 3° Reggimento artiglieria da fortezza. Nel 1914 fu trasferito al Corpo di Stato Maggiore e destinato ali' Ufficio del comandante designato d'Armata di Genova. Il 25 febbraio 1915 fu promosso tenente colonnello , nel maggio dello stesso anno ebbe l'incarico di sottocapo di Stato Maggiore della 28 Armata e nel novembre l'incarico di capo di Stato Maggiore della 4a Divisione.
Nominato colonnello il 25 maggio 1916, divenne capo di Stato Maggiore del IV Corpo d'Armata. Promosso maggiore generale nell'agosto del 1916 fu nominato comandante della artiglieria della 2a Armata e in seguito comandante della Brigata fanteria «C uneo ». Nel marzo 1917 fu nominato capo di Stato Maggiore della zona di Gorizia e nel maggio comandante del TI Corpo d'Armata. Nell'agosto dello stesso anno, promosso tenente generale, ebbe l'incarico di comandante del XXVII
 1 Copia dello stato di servizio in Archi vio Ufficio Storico dello Stato Maggiore Esercito (da ade sso in poi A.U .S.S.M.E.), raccolta delle Biografie, bu s ta 83.
1 Copia dello stato di servizio in Archi vio Ufficio Storico dello Stato Maggiore Esercito (da ade sso in poi A.U .S.S.M.E.), raccolta delle Biografie, bu s ta 83.
Corpo d'Armata e il 9 novembre djve nne sottocapo de ll o Stato Maggiore dell'Esercito. Nel 1919, divenuto senatore del Reg no e generale dell'Esercito, ebbe l'incarico di commissario straordinar io militare nelle Venezia Giulia. Fu capo dello Stato Maggiore dell'Esercito dal novembre 1919 al febbraio 1921. Nel 1923 fu inviato a R io de Janeiro come ambasciatore straordinario.

Il 4 maggio 1925 ebbe l'incarico di capo di Stato Maggiore Generale e nel 1926 fu nominato maresciallo d' Italia. Dal 1928 al 1933 fu governatore unico della T ripolitania e Cirenaica. Nel 1935 divenne alto commissario per l'Africa orientale e dal maggio al giugno 1936 governatore generale dell'Etiopia col titolo di viceré. li 4 dicembre 1940 cessò dalla carica di capo di Stato Maggiore Generale.
Il 25 luglio 1943 divenne capo de l governo italiano e nel giugno 1944, dopo aver presieduto un secondo governo, diede le sue dimissioni. Nel 1947 fu collocato nella riserva.
Sottocapo di Stato Maggiore
Generale dal 4 maggio 1925 al 1° febbraio 1927.
Nato a Roma il 18 dicembre 1869 e morto a Firenze il 20 febbraio 1951.
Allievo dal I O nov embre 1883 del Collegio militare di Roma , il l 0 ottobre l 886 venne ammesso ai corsi della R. Accademia militare di Torino e il 7 marzo 1889 fu nominato sottotenente d'artiglieria. Il 1° agosto 1890, conseguita la promozione di tenente, fu assegnato prima al 13 ° Reggimento poi , 1'8 novembre 1894, venne trasferito al 28° Reggimento artiglieria da campagna. Nel 1895 fu assegnato prima alla 2a Bri gata e in seguito a lla 7a B1i gata artiglie1ia da fortezza, frequentando con successo il corso di stato maggiore della Scuola di Guerra di Torino.
Nel 1896-1898 fu inviato in Eritrea, partecipando alle operazioni coloniali. Nel 1900 fu destinato allo Stato Mag g iore della Divisio ne militare territoriale di Roma e il l O luglio dello stesso anno venne promosso capitano. Nel 1901 fu trasferito allo Stato Maggiore della Divisione militare territoriale di Livorno e nel 1903 fu assegnato al Comando del Corpo di Stato Maggiore a Roma .
Nel marzo 1910 fu promo sso maggiore e nominato comandante del 3° Battaglione del 2 ° Reggim e nto Granatieri. Partecipò nel 1911-12, in Libia , alla guerra italo -t urca , durante la quale fu nominato capo di Stato Maggiore della S3 Divis ione Speciale e promosso tenente colonnello. Rimpatriato per breve tempo, nel maggio 1913 fu di nuovo trasfe rito in Libia con l'incarico di capo dell'Ufficio politico-militare di Tripoli.
Rientrato definitivamente in Italia il 19 marzo 1915 fu nominato capo di Stato Maggiore del V Corpo d'Armata di Verona.
Nel maggio 1916 venne promo sso colonnello e divenne comandante della Brigata fanteria «Lam bro » e nell'ago sto seguente ottenne la promozione a maggiore generale. Nel maggio 1917 assunse il comando della 43a Divisione fanteria, nel settembre dello stesso anno fu comandante dell' VIII Corpo d 'Armata, nel novembre capo di Stato Maggiore
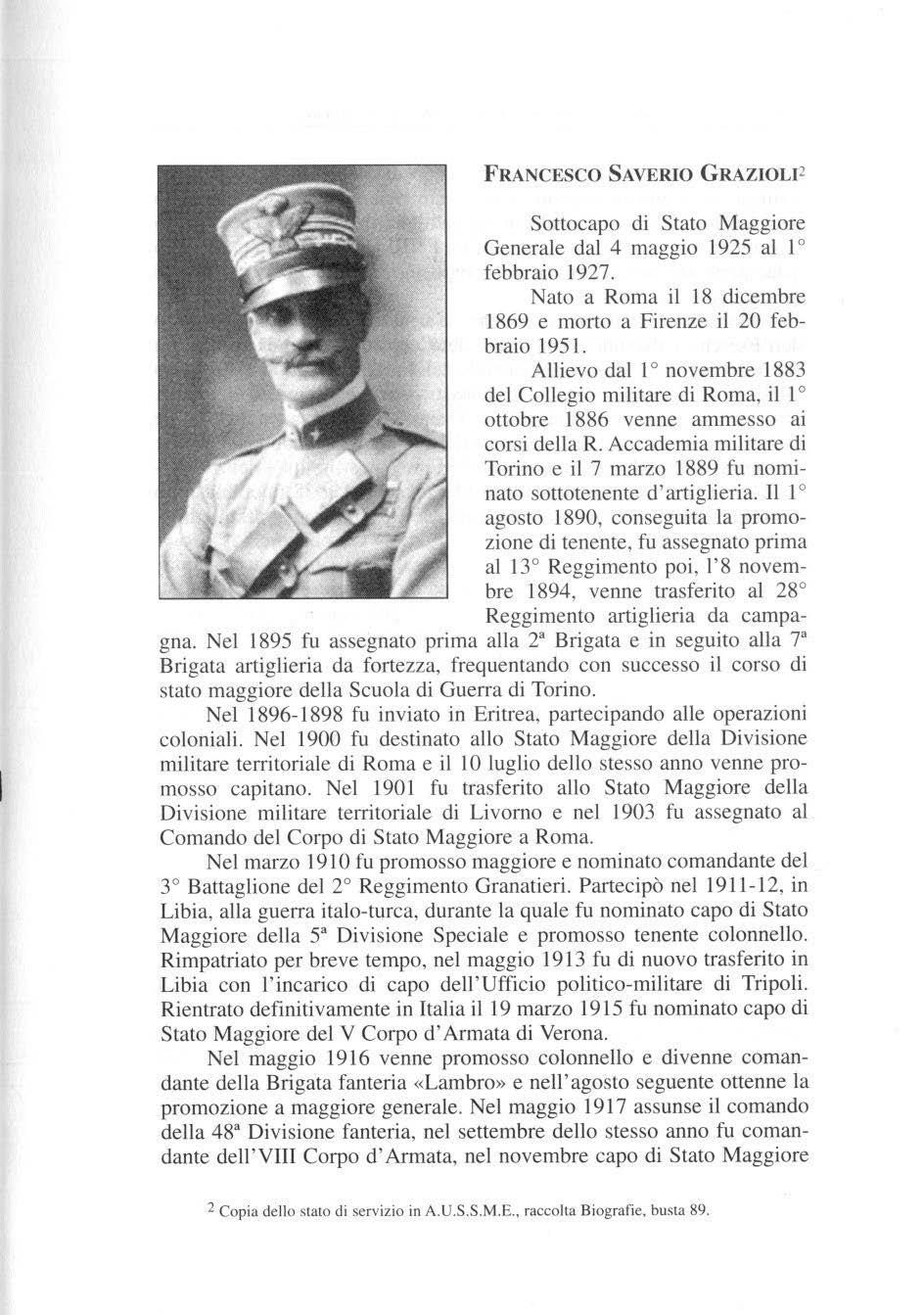 2 Copia dello s tato di servizio in A.U.S.S.M.E., raccolta Biografie, busta 89.
2 Copia dello s tato di servizio in A.U.S.S.M.E., raccolta Biografie, busta 89.
della 4a Armata e nel febbraio 1918 capo di Stato Maggiore della 5a Armata. Il 20 giugno fu promosso tenente generale e tenne il comando del Corpo d ' Armata d ' Assalto nella battaglia di Vittorio Veneto. Il I 6 novembre ebbe l'incarico di comandare l'Vill Corpo d'Armata ed entrò a far parte con le sue truppe del Corpo interalleato d'occupazione di Fiume come comandante.
Nominato generale di corpo d'armata, entrò nel Consiglio dell'Esercito e divenne comandante del Corpo d'Armata di Verona. Fu sottocapo di Stato Maggiore Generale del 4 maggio 1925 al l O febbraio 1927. Il 26 febbraio 1927 fu promosso generale designato d'armata. Nominato comandante designato d'Armata di Bologna, nel dicembre 1929 ricevette la nomina di senatore del Regno. Il 1° ottobre 1934 ebbe l'incarico di ispettore della preparazione pre e post-militare della nazione. Nel 1937 fu promosso generale d ' armata e nel 1938 fu collocato in congedo. Nel 1947 fu collocato in congedo assoluto per limiti di età.
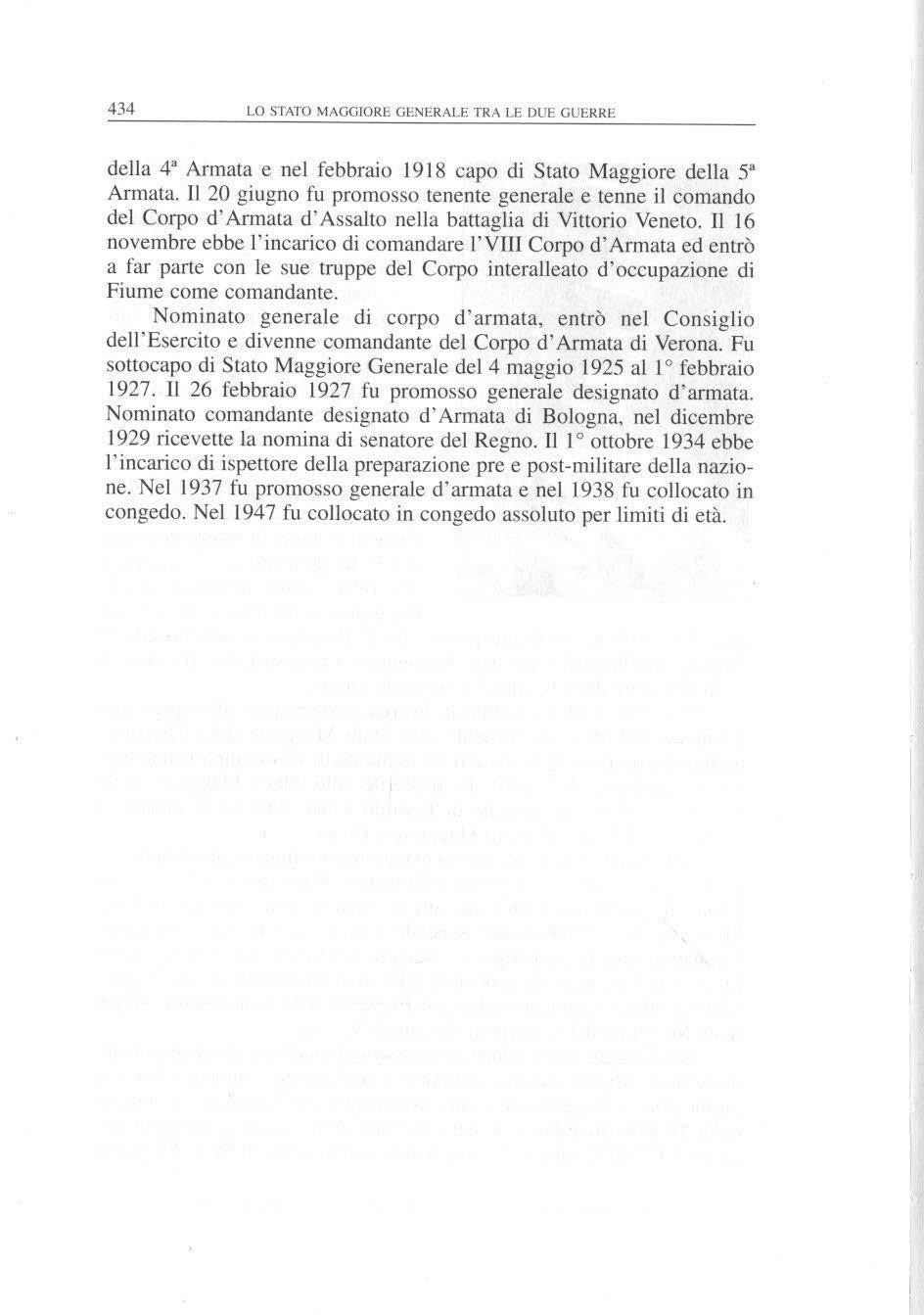
Capo dell'Ufficio del capo di Stato Maggiore Generale dal febbraio 1927 al settembre 1928.
Nato il 25 ottobre 1880 a Torino e morto sempre a Torino l' 11 aprile 1935.
Allievo nella R. Accademia militare di Torino nel 1898, il 26 agosto 1901 fu promosso sottotenente nell'arma d'artiglieria nella Scuola d'Applicazione d'Artiglieria e Genio. Nominato tenente nel 1903, fu assegnato al 5° Reggimento artiglieria da campagna. Nell'agosto 1912 fu promosso capitano e assegnato al 3 ° Reggimento artiglieria da campagna. Nel novembre dello stesso anno fu comandato presso il Comando del Corpo di Stato Maggiore. Nel 1913, in servizio di stato maggiore, venne inviato prima presso l'VIII Corpo d'Armata e poi nel 1914 presso iI I 9 ° Reggimento artiglieria da campagna. Nel J915 fu assegnato di nuovo al Comando del Corpo di Stato Maggiore. Nel maggio 1916 fu promosso maggiore e destinato al Ylll Corpo d ' Armata. Nell'ottobre dello stesso anno frequentò il corso pratico di stato maggiore in zona di guerra. Nel febbraio 1917 fu assegnato, quale sottocapo di Stato Maggiore , al XXIX Corpo d'Armata. Nel maggio dello stesso anno fu promosso tenente colonnello. Nel luglio 1917 fu assegnato, come capo di Stato Maggiore, alla 67° Divisione, nell 'otto bre, come sottocapo di Stato Maggiore , alla l • Armata e nel dicembre dello stesso anno al Consiglio Supremo Interalleato. Nel 1918 fece parte del Comando Supremo.
Nel 1919 fu trasferito, come capo dell'Ufficio Informazioni, presso 1'8° Armata. Dal 1920 al 1921 prestò servizio prima presso il Comando Generale delle Regie Truppe della Venezia Giulia e poi presso il Comando del Corpo d'Armata di Trieste e il Comando designato d ' Armata di Roma. Dal 1924 al 1925 fu trasferito presso il Mini stero della Guerra con incarico di capo sezione presso lo Stato Maggiore Centrale (Stato Maggiore dell ' Esercito). Nel 1925 venne promosso colonnello e nel 1926 ebbe l'incarico a direttore capo divisione sempre pres so lo Stato Maggiore del! 'Esercito. Nel 1927 fu nominato capo dell 'Ufficio del capo di Stato Maggiore Generale. Il 4 ottobre 1928 ebbe l'incarico di comandare il 7 ° Reggimento artiglieria pesante campale. Nel novembre 1930 venne destinato al Comando designato d'Armata di Napoli. Il 28 novembre 1932 fu promosso generale di brigata e fu nominato comandante l'Artiglieria del Corpo d'Armata di Trieste. Nel settembre 1934 fu nominato addetto all'Ispettorato di Artiglieria.
 3 Copia dello stato di se rvizio in A.U.S.S.M .E., raccolta delle Biografie, bus ta 93.
3 Copia dello stato di se rvizio in A.U.S.S.M .E., raccolta delle Biografie, bus ta 93.

Facente funzioni di capo dell'Ufficio del capo di Stato Maggiore Generale dall'ottobre 1928 e capo ufficio dall'ottobre 1930 al1' agosto 1933.
Nato a Cagliari i12 agosto 1889 e morto a Roma il 29 gennaio 1991.
Allievo nel 1906 alla R. Accademia militare di Torino, venne nominato sottotenente dell'arma d'artiglieria il 25 luglio 1909. Dop o aver frequentato la Scuola d' Applicazioni d'Artiglieria e Genio , fu promosso tenente il 13 luglio 19 l I e destinato al 19° Reggimento artiglieria da campagna. Dall ' aprile 191 2 al maggio 1915 partecipò alle operazioni in Egeo nella guerra italo-turca e 1'8 aprile 1915 fu promosso capitano.
Rientrato in patria fu assegnato al 37 ° Reg gi mento artiglieria da campagna al fronte. Terminato il corso pratico di stato maggiore, dal marzo 1916 all'aprile 1917 fu comandato in servizio di stato maggiore al XVI Corpo d'Armata in Albania. Assegnato alla Divisione di Stato Maggiore del Ministero della Guerra, nel febbraio 1918 venne nominato addetto alla segre teria della Commissione ministeriale d'inchiesta sui fatti di Caporetto.
Il 17 marzo 1918 fu promosso maggiore e confermato al Ministero della Guerra. Nel 1920 divenne segretario della Commissione parlamentare per l'ordinamento dell'Esercito e assegnato nel 1922 alla Divisione militare territoriale di Torino. Nel 1925 fu trasferito di nuovo al Ministero della Guerra. Il 31 marzo 1926 fu promosso tenente colonnello e nel maggio dello stesso anno fu destinato al 13 ° Reggim ento artiglieria pesante campale.
Dopo esser entrato a far parte definitivamente del Comando del Corpo di Stato Maggiore, il 15 giugno 1928 fu assegnato all'Ufficio del capo di Stato Maggiore Generale , ricoprendo contemporaneamente la cattedra di Arte militare terrestre e di Storia presso la R. Accademia navale di Livorno. Il 10 settembre 1931 fu nominato colonnello e il 7 settembre 1933 divenne comandante del 6° Reggimento artiglieria pe-
 4 Copia dello stalO di servizio in A.U.S.S.M.E., raccolta delle Biografie, busta 84.
4 Copia dello stalO di servizio in A.U.S.S.M.E., raccolta delle Biografie, busta 84.
sante campale. Nel 1935 fece parte della missione militare inviata ad assistere le manovre delle nuove unità corazzate tedesche.
Il 16 ottobre 1936 ebbe l'incarico di addetto militare a Ber Iino e fu poi accreditato anche presso le lega zioni italiane in Danimarca, Svezia, Lituania e Finlandia. Promos so il 9 sette mbre 1937 al grado di generale di brigata , ne l luglio 1939 fu inviato in Libia quale capo di Stato Maggiore della s• Armata. Nel novembre 1939 fu di nuovo nominato addetto militare a Berlino e il 12 ottobre 1940 fu promosso generale di divisione. Il 25 gennaio 1943 fu promosso generale di corpo d'armata. Inte rnato dai tedeschi dopo I' 8 settemb re 1943 e in seguito consegnato alle autorità della Repubbli ca Sociale Italiana, nel 1944 riuscì a fuggire. Nel maggio 1945 ebbe l ' incarico di co mandare il Comando militare territoriale di Milano. Dal 1° febbraio 1947 al 30 novembre 1950 fu capo dello Stato Maggiore dell'Esercito. Dal 1° dicembre 1950 al 15 aprile 1954 fu capo di Stato Maggiore della Difesa e nel giugno dello stesso mese fu collocato nella ri serva.

Capo dell'Ufficio del capo di Stato Maggiore Generale dall'ottobre 1933 al dicembre 1934.
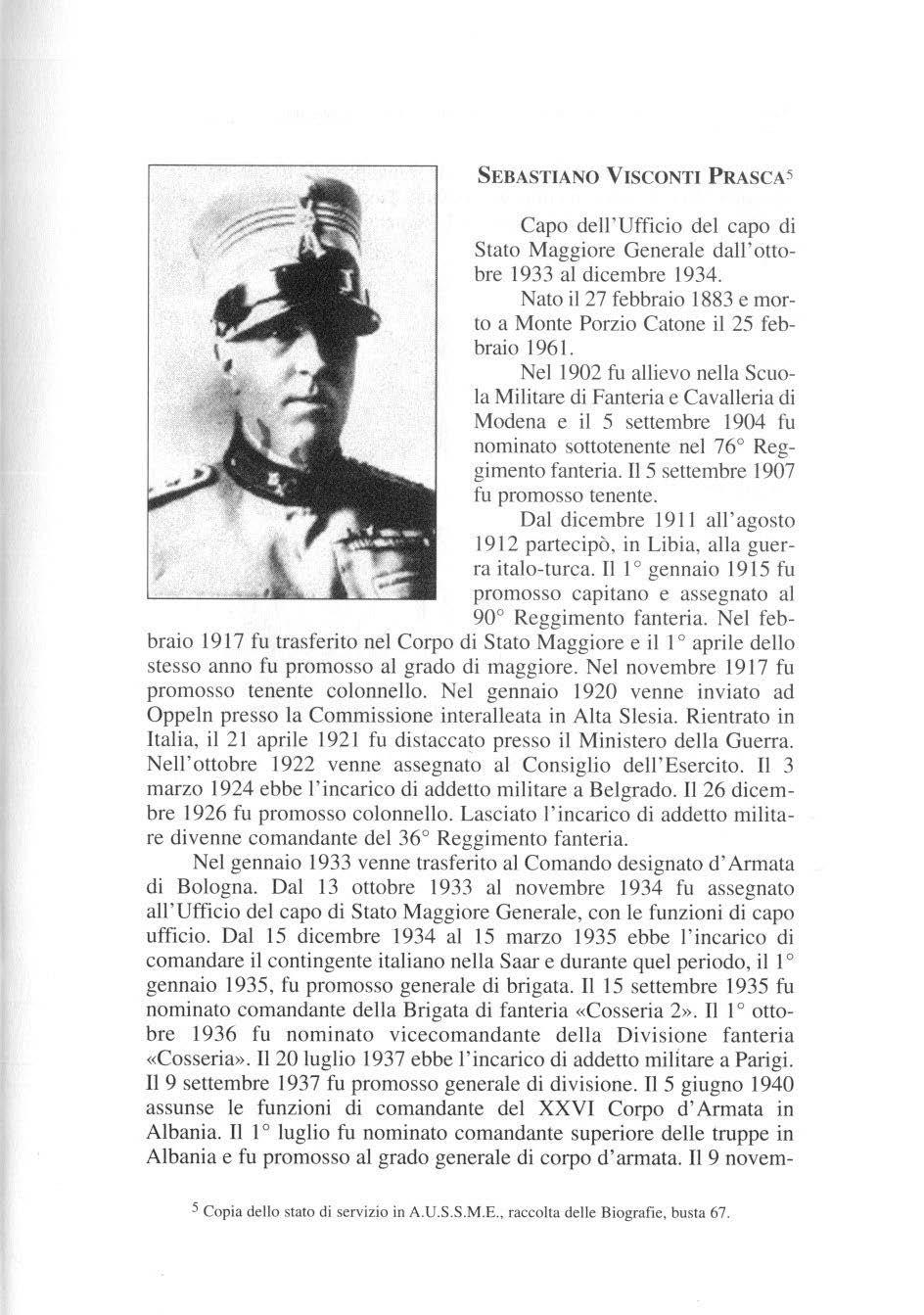
Nato il 27 febbraio 1883 e morto a Monte Porzio Catone il 25 febbraio 1961.
Nel 1902 fu allievo nella Scuola Militare di Fanteria e Cavalleria di Modena e il 5 settembre 1904 fu nominato sottotenente nel 76° Reggimento fanteria. II 5 settembre 1907 fu promosso tenente.
Dal dicembre 1911 al l 'agosto 1912 partecipò, in Libi a, alla guerJ ra italo-turca. Il I O gen naio 19 I 5 fu promosso capitano e assegnato al 90° R eggimento fanteria. Nel febbraio 1917 fu trasferito nel Corpo di Stato Maggiore e il I O aprile dello stesso anno fu promosso al grado di maggiore. Nel novembre 1917 fu promosso tenente colonnello. Nel gennaio I 920 venne inviato ad Oppeln presso la Commissione interalleata in Alta Slesia. Rientrato in Italia, il 21 aprile 1921 fu distaccato presso il Mini s tero della Guerra. Nell 'o ttobre 1922 venne assegnato al Consiglio dell 'Esercito Il 3 marzo 1924 ebbe l ' incarico di addetto militare a Belgrado. Il 26 dicembre 1926 fu promosso colonnello. Lasciato l 'incarico di addetto militare divenne comandante del 36 ° Reggimento fanteria.
Nel gennaio 1933 venne trasfe rito al Comando designato d ' Armata di Bologna. Dal 13 ottobre 1933 al novembre 1934 fu assegnato all'Ufficio del capo di Stato Maggiore Generale , con le funzioni di capo ufficio. Dal 15 dicembre I 934 al 15 marzo 1935 ebbe l ' incarico di comandare il contingente italiano nella Saar e durante quel periodo, il I 0 gennaio 1935, fu promosso generale di brigata. Il 15 se ttembre 1935 fu nominato comandante della Brigata di fanteria «Cosseria 2». Il I O ottobre 1936 fu nominato vicecomandante della D ivisione fanteria «Cosseria». Il 20 luglio 1937 ebbe l 'i ncarico di addetto militare a Parigi. 119 settembre 1937 fu promosso generale di divisione. I1 5 giugno 1940 assunse le funzioni di comandante del XXVI Corpo d'Armata in A lbania. Il 1° luglio fu nominato comandante superiore delle truppe in A lbania e fu promosso al grado generale di corpo d'armata. Il 9 novem-
5 Copia dello s tato di servizio in A.U.S.S.M.E., raccolta delle Biografie, busta 67.bre dello stesso anno ebbe l ' incarico di comandare l' 11• Armata e il 10 dicembre fu collocato in congedo assoluto. Dopo l ' armisti z io dell ' 8 s ettembre 1943 partecipò alla guerra di Liberazione come partigiano.

Capo dell'Ufficio del capo di Stato Maggiore Generale dal 5 settembre 1935 al l O ottobre 1937. Nato a Moncalieri il 29 agosto 1888 e morto a Torino il 21 agosto 1954.
Allievo nella R. Accademia militare di Torino nel I 903, il 7 settembre 1905 fu promos so sottotenente nell'arma d'artiglieria, nella Scuola di applicazioni d 'A rtiglieria e Genio. TI 25 agosto 1906 fu promos so tenente nel 1° Reggimento artiglieri a da fortezza. Nel 191 O fu trasferito presso il 6 ° Reggimento artiglieria da fortezza. Il l O gennaio 1915 fu promosso capitano. Nel maggio 1915 fu destinato in zona di guerra presso il 7 ° Reggimento artiglieria da fortezza. Il 9 febbraio 1917 fu trasferito nel Corpo di Stato Maggiore. Il 14 giugno 1917 fu promosso maggiore. Distaccato al Ministero della Guerra, effettuò varie missioni al fronte. Il 22 novembre 1917 fu promosso tenente colonnello. Nel 1919 ebbe l'incarico di capo sezione presso il Ministero della Guerra. Dal 3 gennaio 1920 al 20 marzo 1921 fu assegnato alla Commissione militare interalleata di controllo per la Repubblica austriaca. Dal 5 agosto 1921 al 15 marzo 1922 fu assegnato alla Commissione militare interalleata di controllo per la Repubblica d'Ungheria e rientrato in Italia fu di nuovo distaccato allo Stato Maggiore del R. Esercito. Nel giugno 1926 fu trasferito alla Scuola Centrale d'Artiglieria. Nell'agosto 1928 fu destinato al Comando Scuole Centrali Militari ed ebbe l'incarico di insegnante. Il 24 novembre 1930 fu promosso colonnello. Nel marzo 1933 fu distaccato presso il Comando designato d'Armata di Napoli. Nel gennaio 1934 fu distaccato presso la Scuola di Guerra e nel settembre dello stesso anno fu nominato comandante in seconda della stessa Scuola. Dal 5 settembre 1935 al l O ottobre 1937 fu assegnato all'Ufficio del capo di Stato Maggiore Generale, come capo ufficio e nell'ottobre 1935 accompagnò lo stesso Badoglio in missione
 6 Copia de llo stato di servizio in A.U.S.S.M.E., rac co lta delle Biografi e, busta 93.
6 Copia de llo stato di servizio in A.U.S.S.M.E., rac co lta delle Biografi e, busta 93.
in Eritrea. Il 1° gennaio 1937 fu promosso generale di brigata. Dopo l'incarico presso l'Ufficio del capo di Stato Maggiore Generale fu nominato comandante l'Artiglieria del Corpo d'Armata di Napoli e il 1° ottobre 1938 ebbe l'incruico di capo di Stato Maggiore del Comando designato della 4a Armata (Roma). Il 19 luglio 1939 fu promosso generale di divisione e nominato comandante della Divisione fanteria «Lupi di Toscana», in Albania. Dal 25 gennaio al 1O febbraio 1941 fu distaccato presso il Comando Superiore Forze Armate in Albania, per incarichi speciali, e in seguito fu trasferito presso il Ministero della Guerra. Dal 15 maggio 1941 fu collocato in congedo.

Capo dell'Ufficio del capo di Stato Maggiore G enerale dal 15 maggio 1938 al 10 giugno 1940.
Nato ad Avezzano il 13 maggio 1891 e morto il 24 settembre 1943, fucilato dai tedeschi, a Ccfalonia.

Allievo della Scuola Militare di Fanteria e Cavalleria di Modena, nel 1908 venne nominato sottotenente dell'arma di fante,ia. li 17 settembre 191 O fu assegnato al 92 ° R eggimento fanteria. DaJ 9 ottobre 1911 all' 8 ottobre 1912 partecipò alle operazioni del Corpo di spedizio ne italiano in Libia.
TI 21 settembre 1913 fu promo sso tenente e il 27 maggio 1914 fu destinato al 64 ° Reg g iment o fanteria. Nel g iu gno 1915 fu trasferito presso 1'82° Reggimento fanteria e il 9 settembre de!Jo stesso anno fu promosso capitano. Il 14 ottobre 1917 venne promosso maggiore. Nel I 918 fu assegnato al comando della 60• Div isio ne come ufficiale di stato maggiore. Nel gennaio 1920 fu assegnato allo Stato Maggiore del R. Esercito a Roma e nel febbraio dello stesso anno frequentò il corso di stato maggiore presso la Scuola di Guerra. Dal l O novembre 1921 al l O marzo 1923 ve nne comandato presso il Ministero delle Finanze. li 22 agosto 1926 venne di staccato presso il 51 ° Reggimento fanteria per il periodo di comando e il 4 novembre dello stesso anno fu promosso tenente colonnello. Nel novembre 1929 fu assegnato aJ Comando del Corpo di Stato Maggiore a Roma. Nel 1932 venne trasferito alla Scuola di Guerra dove ebbe l'incarico di insegnante. TI 28 marzo 1935 fu promo sso colonnello e il 1° luglio dello stesso anno fu nominato comandante del 40° Reggimento fanteria. Dal 15 maggio 1938 allo sco ppio della sec onda guen-a mondiale fu assegnato all'Ufficio del capo di Stato Maggiore Generale. MobiUtato l' 11 giugno 1940 con il Comando Supremo - Stato Maggiore Generale, i I 15 giugno dello stesso anno fu promosso generale di brigata e dal l O dicembre 1940 ebbe l ' incarico di capo del l O Reparto (Operazioni) del Comando Supremo. Il 12 ottobre 1942 fu promosso generale di divisione conser-
7 Profilo biografico tratto dallo stato di servizio in A.U.S.S.M.E raccolta de lle Biografie, busta 33.vando sempre il precedente incarico. Il 26 gennaio 1943 fu nominato capo dello Stato Maggiore italo-tedesco in Africa settentrionale (Tu ni sia). Dal 25 febbraio al 20 aprile 1943 riprese le funzioni di capo del 1° Reparto Operazioni del Comando Supremo. Il 19 giugno 1943 fu nominato comandante della Divisione fanteria «Acqui» nell 'isola di Cefalonia. Dopo l'armistizio dell'8 settembre 1943 si oppose con le armi all'ordine di resa intimatogli dai tedeschi e, dopo aspri combattimenti, fu fucilato da questi ultimi il 24 settembre 1943.
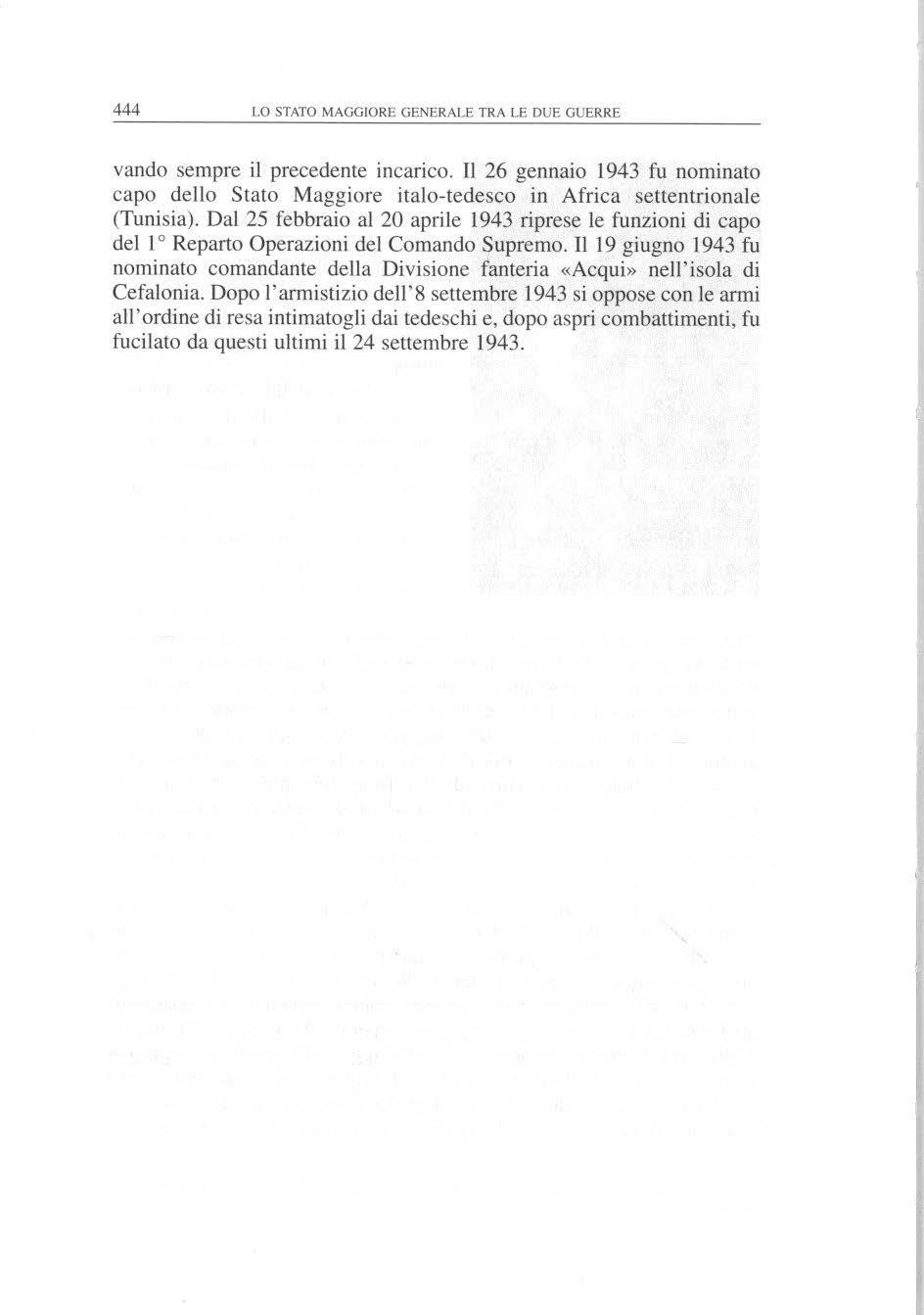
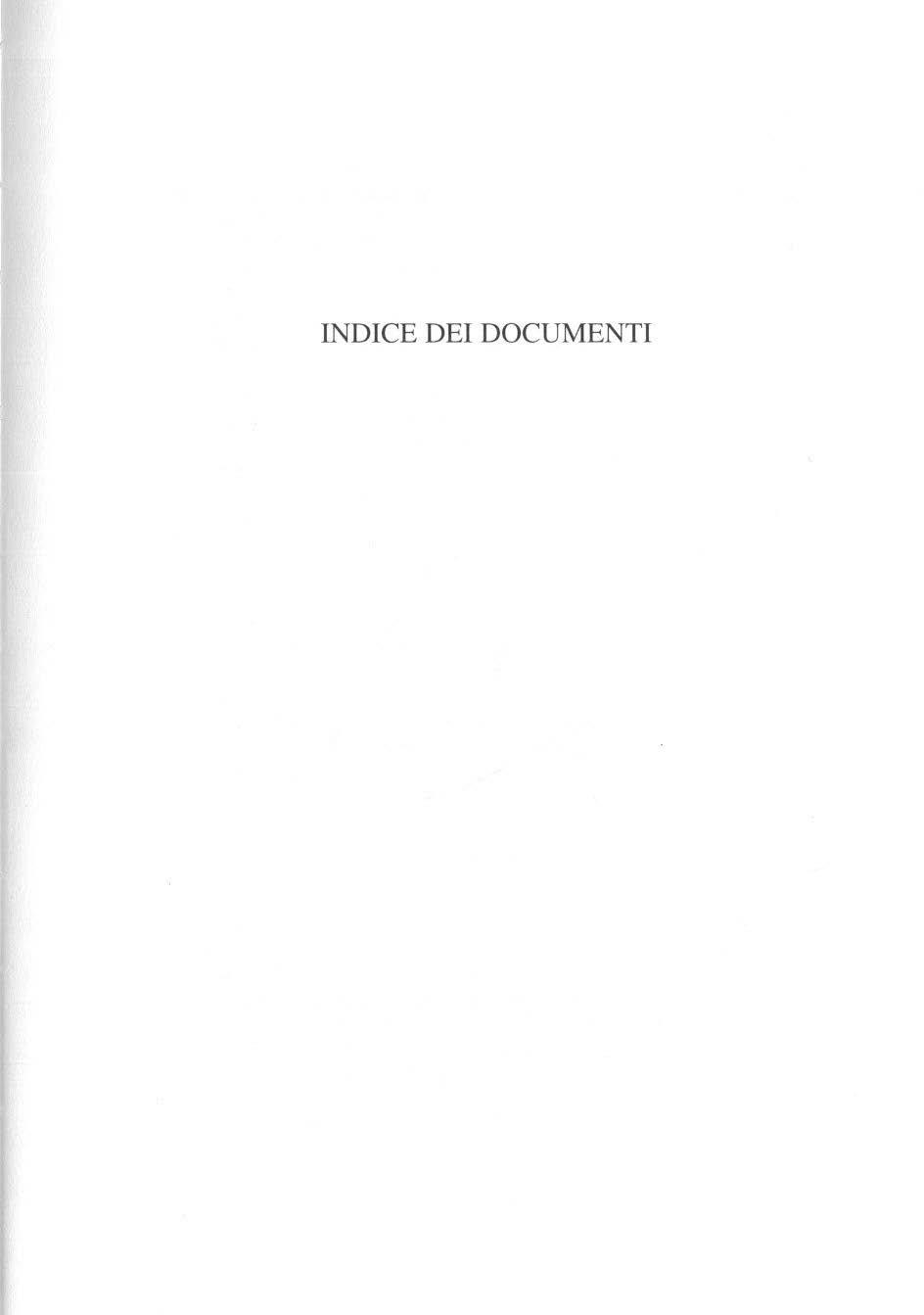

N. Principali argome n ti trattati nelle sedute Data Pagine
l Dotazioni per l'Esercito e relative disposi- 18.06.1925 59-60 zioni di Badoglio: riduzione delle spese per alcuni lavori di difesa alla frontiera e per la difesa costiera, revisione di tutto il bilancio straordinario , direttive relative ai lavori ferroviari per una veloce radunata dell'Esercito e alle costruzioni di armi, riduzione spese del genio e servizi, compilazione di un bilancio basato su un assegno non superiore ai trecento milioni per un periodo di dieci anni.
2 Considerazioni sulle possibilità finanzia- 03.07.1925 61 - 62 rie dello Stato e relativa organizzazione dell'Esercito: necessità primarie (mobilitazione di un esercito efficiente, funzionamento di rapidi trasporti di radunata, difesa dei confini) e armamento (impossibilità di costruzione di nuove am1i eccetto che per mitragliatrici leggere e artiglieria contraerea). Studio sulla frontiera settentrionale dell'Ufficio Operazioni (confine italo-austriaco) e disposizioni finali di Badoglio (ripartizione e radunata delle forze, preparazione di una manovra strategica in Alto Adige, lavori alla frontiera e studio sulla rete ferroviaria nord-orientale).
3 Alcune questioni relative al riordinamento 10.07.1925
63-66 dell'arma di artiglieria: obice da 149 mod. 14 di preda bellica, pezzi da 75 mod.911, da 65 montagna, da 77 P.B., da 75 A, obice da 100 , cannoni da 105, artiglieria pesante, gruppi autoportati del reggimento artiglieria a cavallo, munizioni, materiale contraereo, cannone da fanteria.
4 Ordinamento della difesa costiera: diverso 23.07.1925
67-69 interesse tra Esercito e Marina relativo

N. Principali argomenti trattati nelle sedute
alla protezione delle varie zo ne, dipendenza dei me zzi che intervengono nella difesa delle coste, repart i di artiglieria dell ' E serc ito per la Marina, unifi cazio ne dei procedim enti per le batterie da costa.
5 Rip artizione ge nerale e sistemazio ne dei 27.07. 1925 71-74 materiali e delle munizioni di artiglieria: programma per la definizione delle quantità di specie occorrenti all 'Ese rcito e de ll e dotazioni di mobilita z ione di artiglieria, programma di riord iname nto dei depositi per le muni zioni da conservare; situazio ne e spese per il rio rdiname nto delle artiglierie delle unità mobili, delle artiglierie da posizione delle frontiere terrestri, delle artig li eri e costiere, co ntraeree e coloniali.
6 Ordinamento della dife sa costiera: orga- O1.08. l 925 75- 79 nizzazione e dipendenza dei me zzi (dife se marittim e mobili e fisse, reparti di protezione, difesa contraerei, organi di avvistamento e co llegarnenro , batterie costiere fisse e mobili), ripruti zion e dei compiti e d ell e responsabilità tra Esercito e Marina, ordinamento complessivo della dife sa costiera, manovre costiere interforze, rifle ss io ni finali del so ttocapo di Stato Maggiore della Regia Marina sui compiti s pecifici della flotta.
7 Si ste mazione dei depositi di munizioni e di 05.08.1925 81-88 esplosivi: situazione attuale e progetti di sistemazione da attuare, direttive generali per il riordinamento delle dotazioni (dotaz ioni di primo rifornime nto per i corpi d ' armata comprendenti i depositi reggimentali e di frontiera , dotazio ni per le batterie di l O e 2 ° tempo, dotazioni di 2° rifor-
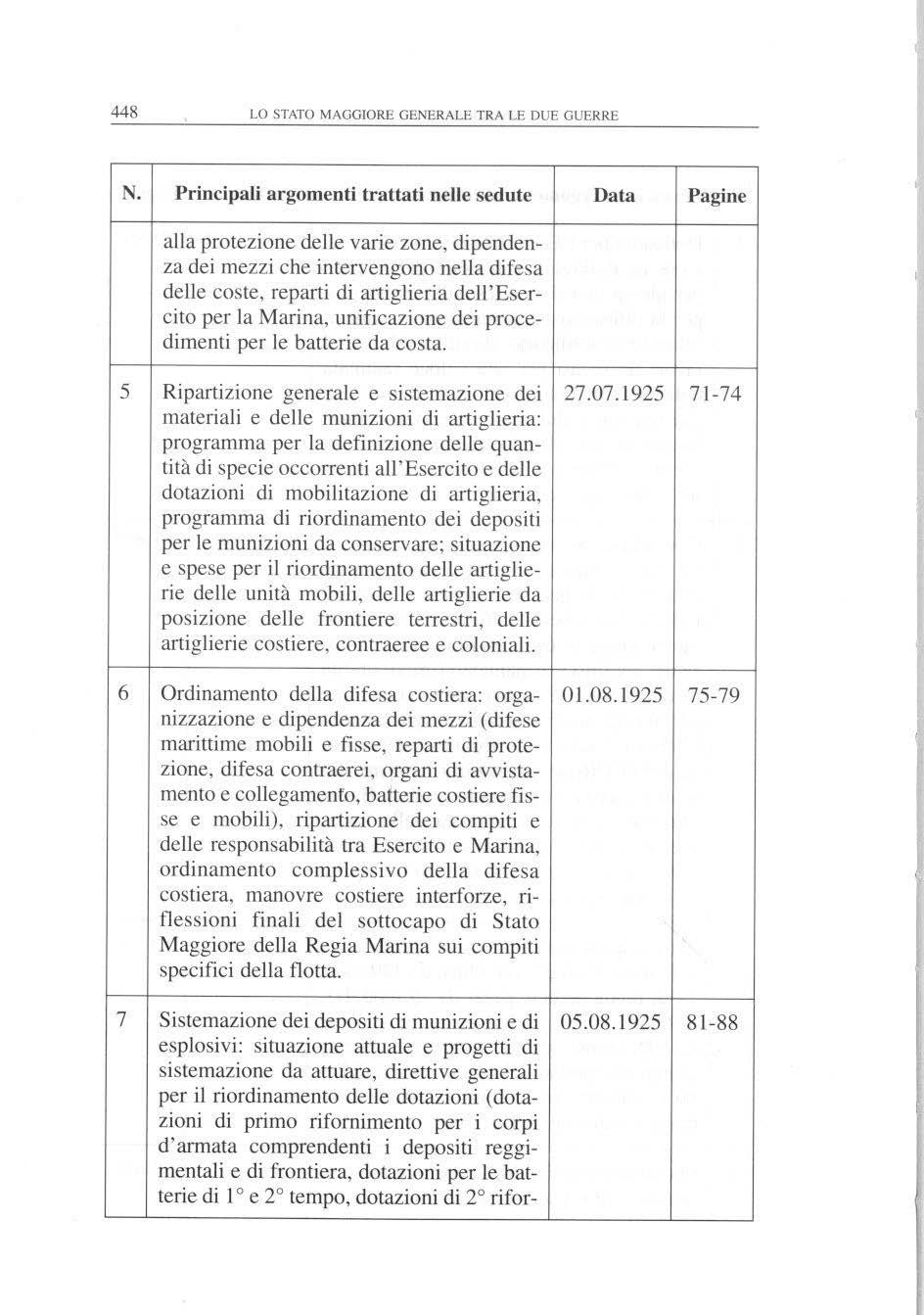
N. Principali argomenti trattati nelle sedute nimento) e dei depositi per esplosivi di lancio, di scoppio e per proietti.
8 Provvedimenti occorrenti al completa- 20.08.1925
89-91 mento e alla sistemazione delle dotazioni di esplosivi: esplosivi di lancio (disponibilità, occorrenza e spesa, sistemazione), esplosivi a scoppio.

9 Preparazione della guerra contro la Jugo- 28.02.1927
93slavia (Ipotesi Est): rapporti della Jugosla- 101 via con gli Stati confinanti e questione interna del Montenegro , preparazione del1'ese rcito jugoslavo, azione di un corpo di spedizione in Albania e schieramento delle nostre forze alla frontiera, organizzazione e potenzialità della aviazione jugoslava, difesa di Fiume e compiti della Marina.
10 Preparazione sistematica della guerra con- 18.07.1927
103tro la Jugoslavia: aspetto politico e milita- 122 re, piani di guerra, difesa di Zara e della costa adriatica, mis ure da studiare secondo le direttive del capo del governo, premobilitazione, ripartizione delle forze alle frontiere est ed ovest, tempi e modi della mobilitazione e radunata, piano offensivo di guerra.
11 Preparazione della guerra contro la 13.01.1928
Jugoslavia (Ip otesi Est): studi e piani relativi alla mobilitazione (richiamo allogeni, situazione dei reggimenti di artiglieria e delle sa lmerie di fanteria, mobilitazione delle prime 30 divisioni, quadrupedi precettati, battaglioni ausiliari, mobilitazione occulta, cartoline precetto, servizi, dotazioni di mobilitazione).
123129
12 Preparazione della guerra contro la J u- 14.01.1928
goslavia (Ipotesi Est): st udi e piani relativi alla mobilitazione (requisizione quadrupedi - automezzi e materiali vari , commissione di incetta , costituzione magazzini, viab ilità e situazio ne idrica alla frontiera orientale, mobilitazione occulta).
13 Preparazione della guerra contro la 16.01.1928
Jugoslavia (ipotesi Est): studi e preparativi relativi alla mobilitazione (situaz ione ferroviaria alla frontiera orientale, criteri vigenti circa la compilaz ione di progetti riguardanti i trasporti di mobilitazione~ di radunata dell'Esercito, influenza di un eventuale periodo di mobilitazione occul- · ta s ull'esecuzione dei trasporti di mobilitazione e di radunata).

14 Preparazione della guerra contro la 2 i.O 1.1928
J ugoslavia ( I potesi Est): studi e piani relativi all ' impiego dell'aviazione militare (p reparaz ione raggiunta dall'Aeronautica, memoria sull' impiego dell'aviazione nell ' Ipotesi Est, l'aviazione in Francia, Jugoslavia e Germania, programma di potenziamento dell'aviazione militare italiana fino al 1932, memo ri a s ulla preparazione alla guerra del!' Aeronautica , suo impiego nei primi giorni di guerra, produzione di apparecchi in Ju goslavia, mobilitazione e servizio chimico).
15 P reparazione de ll a guerra contro la 22.01.1928
Jugo slavia (Ipotesi Est): studi e piani relativi alla mobilitazione generale (produz ione industriale a fini bellici, costituzione organi di controllo per le derrate alimentari e la propaganda, mobilitazione dei vari
N. Principali argomenti trattati ne ll e sedute ministeri, requisizione di naviglio mercantile, difesa antiaerea, produzione aerei, rifornimenti carbone), conclusioni di Badoglio sulla mobilitazione occulta e sul fabbisogno di fondi per la preparazione della guerra.

16 Di fesa dell'Isola d'Elba: batterie d'arti- 13.10.1928 glieria esistenti nel!' isola, costituzione di un comando unico interforze, creazione di depositi, organizzazione delle forze in congedo nell'isola, disposizioni finali di Badoglio agli Stati Maggiori delle forze annate per la difesa dell'Elba. Preparazione della guerra contro la Jugoslavia (Ipotesi Est): piano di guerra, la frontiera orientale e le linee di penetrazione adatte ad una possibile offensiva.
17 Di fesa dell'Isola d'Elba: comando unico 20. I 2.1928 della Marina con competenza interforze su tutta l'isola, organizzazione delle forze, dei mezzi (artiglieria, aviazione, ar1ni, munizioni, ecc.) e del terreno (lavori stradali).
Preparazione della guerra contro la Jugos lavia (Ipote si Est): studio s ui provvedimenti attuabili in fase di sicurezza specialmente per l'Aeronautica, esame del problema operativo, studio dello schieramento settentrionale alla frontiera italo-jugo slava.
18 Preparazion e della guerra contro la Jugo- 16 .01.1929 slavia (Ipotesi Est): memoria sui provvedimenti da attuarsi durante il periodo di s icurezza (difesa contraerei e Milizia Volontaria di Sicurezza Nazionale , vigilanza sulle ferrovie, depositi di frontiera e dislocazione dell'artiglieria da po s izione , trasporto di materiali, proietti e liquidi specia li ,
maschere antigas, polizia militare nelle zone di frontiera), provvedimenti attuabili dalla Marina in fase di sicurezza (sbarchi e relative truppe, trasporto truppe in Albania, Zara, spedizioni oltremare).
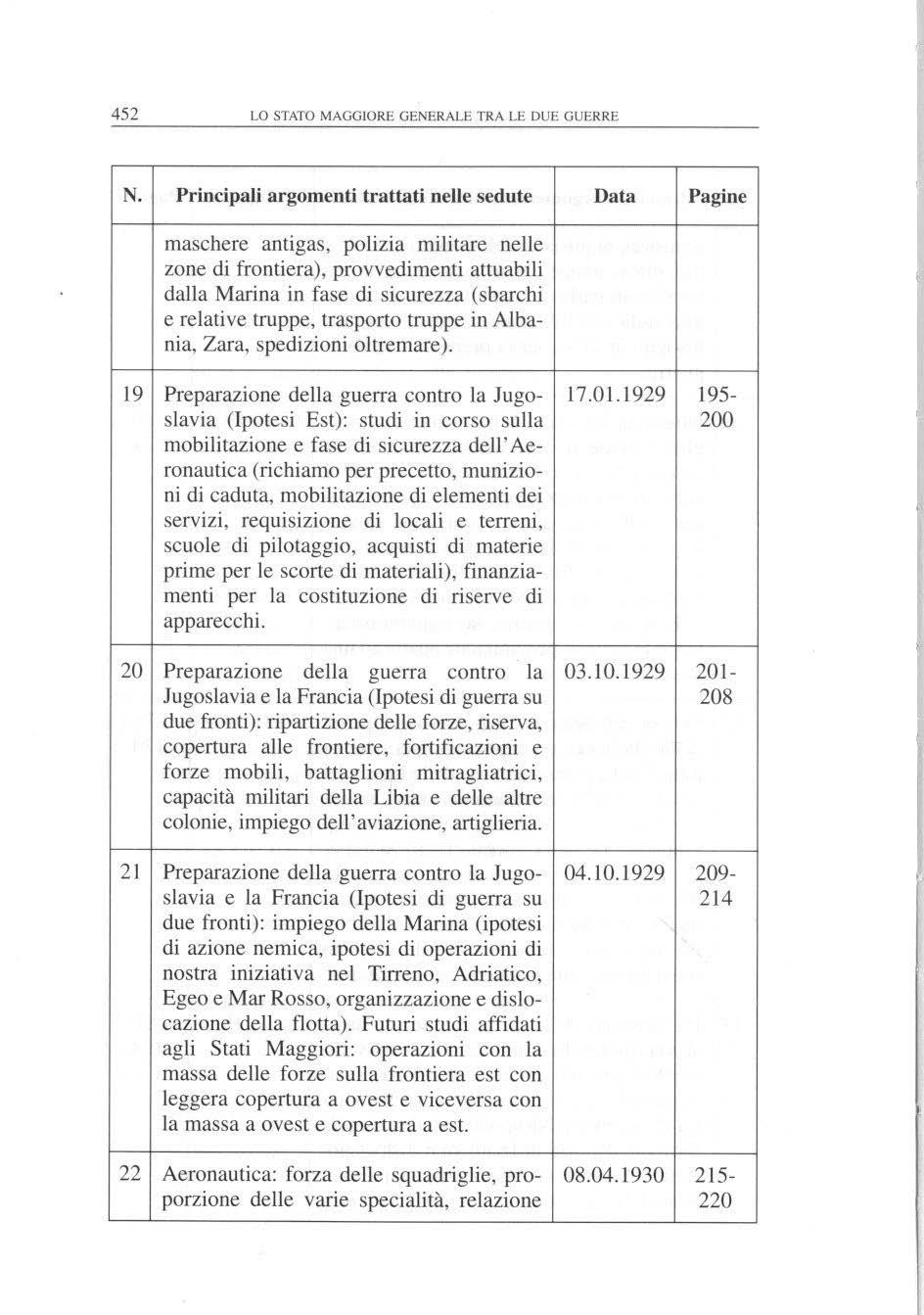
19 Preparazione della guerra contro la Jugo- 17 .O 1.1929 s lavia (Ipotesi Est): studi in corso sulla mobilitazione e fase di sicurezza dell ' Aeronautica (richiamo per precetto , munizioni di caduta, mobilitazione di elementi dei servizi, requisizione di locali e terreni, scuole di pilotaggio, acquisti di materie prime per le scorte di materiali), finanziamenti per la costituzione di riserve di apparecchi.
20 Preparazione della guerra contro la 03.10.1929 Jugoslavia e la Francia (Ipotesi cli guerra su due fronti): ripartizione delle forze , riserva, copertura alle frontiere, fortificazio ni e forze mobili, battaglioni mitragliatrici, capacità militari della Libia e delle altre colonie, impiego dell'aviazio ne, artiglieria.
21 Preparazione della guerra contro la Jugo- 04.10.1929 slavia e la Francia (Ip otesi di guerra su due fronti): impiego della Marina (ipotesi di azione nemica, ipotesi di operazioni di nostra i niz iativa nel Tirreno, Adriatico, Egeo e Mar Rosso, organizzazione e dislocazione della flotta). Futuri studi affidati agli Stati Maggiori: operazioni con la massa delle forze sulla fro nti era est co n leggera copertu ra a ovest e viceversa con la massa a ovest e copertura a est.
22 Aeronautica: forza delle squadiig li e, pro- 08.04.1930 porzione delle varie specialità, relazione
N. Principali argomenti trattati nelle sedute di dipendenza del!' aviazione dell'Esercito e della Marina (portaerei) dall' Aeronautica, aviazione da caccia e armata aerea, aviazione da ricognizione terrestre e marittima. Funzioni militari delle colonie (Libia) e delle isole dell'Egeo.

23 Preparazione della guerra contro la Jugo- 22.10.1930 slavia e la Francia (Ipotesi di guerra su due fronti): situazione dell'Esercito (forze mobiJitabili, radunata generale, situazione delle armi e delle munizioni, impiego sostanze tossiche, situazione delle vie di comunicazione, difesa della Sicilia, della Sardegna e dell'Elba, isole dell'Egeo e di Zara, battaglioni camicie nere). Direttive di Badoglio per l'esecuzione degli studi relativi alla guerra contro la Jugoslavia (Ipotesi Est).
24 Preparazion e della guerra contro la 23. l 0.1930 Jugoslavia e la Francia (Ipotesi di guerra su due fronti): situazione della Marina (basi navali e aeronavali, operazioni iniziali in concorso con l 'armata aerea, operazioni navali nel Mediterraneo occidentale e a largo del Marocco, navi portaerei, trasporti truppe in Libia) , situazione dell'Aeronautica (apparecchi efficienti per la ricognizione, la caccia e il bombardamento, riserve, munizioni, carburanti) e suo impiego (disturbo della radunata jugos lava, difesa di Zara e azioni alla frontiera ovest). Dispos izioni di Badoglio agli Stati Maggiori sugli studi relativi all'Ipotesi
25 Preparazione della guerra contro la 05.11.1931
Francia e la Jugo s lavia (Ipotesi di guerra
N. Principali argomenti trattati nelle sed ute
su due fronti): Operazione 1O, organizzazione difensiva. Preparazione della guerra contro la Jugoslavia (Ipotesi Est): potenzialità dell ' esercito jugos lavo e s ua offensiva iniziale, preparazione del nostro Esercito e relativi piani d' operazioni (offensive lungo la direttrice Postumia-Lubiana, dalla Dalmazia, dall'Albania , linea KninBihac , copertura alla frontiera ovest), concors o dell'Aeronautica e della Marina (ipotesi di sbarco). Questioni particolari riguardanti l'ordinamento dell'Esercito.

26 Preparazione del la guerra contro la 07. 11 . 193 1
Ju goslavia e la Francia (Ipotes i di guerra su due fronti) e contro la sola Jugoslavia
(Ipotesi Est): fabbi sogno di automezzi per le forze armate , organizzazione difen s iva delle frontiere est ed ovest, organizzazione difensiva e impiego dell'aviazione in Albania, organizzazione difensiva di Zara, guerra chimica.
27 Preparazione della guerra contro la 08.11.1931
Jugoslavia e la Francia (Ip otesi di guerra su due fronti) e la sola Jugoslavia (Ipotesi Est): situazione e preparazione delle basi navali , difesa di Zara, Saseno, Valona e Durazzo, situazione della nostra flotta nei co nfronti di quella francese, portaerei ed elicotteri, protezione chimica per la flotta.
28 Stato di efficienza dell ' aviazione e suo 09. l l. 1931
impiego nella guerra contro la Ju goslavia (Ip otesi Est): campi d'aviazione e depositi di carburante e munizioni, cooperazione tra Marina e Aeronautica , bombardieri, munizioni , situazione degli apparecchi per il bombardamento , caccia e ricognizione,
N. Principali argomenti trattati nelle sedute
concorso dell'Esercito e della Marina nelle determinazioni delle caratteristiche degli apparecchi, proporzione numerica tra le aliquote dell'aviazione spettanti alla Marina e all'Esercito, aviazione francese e jugoslava.

29 L'aviazione per l'Esercito e il problema 10.11.1931 della proporzione del numero delle squadriglie. Organizzazione militare delle I sole italiane dell'Egeo: unità di fanteria disponibili, situazione di Castelrosso, Lero, Rodi e Stampalia, relazione fra poteri militari e civili in caso di guerra. Organizzazione della difesa costiera di Trip oli e Tobruk.
30 Operazioni in Eritrea: forze metropolitane 07.05.1934 di eventuale impiego, invio di unità dalla Libia e di ufficiali d'artiglieria e di stato maggiore, aliquota necessaria d'aviazione.
31 Preparazione e apprestamenti difensivi in 31.05.1934 295 Eritrea ai confini con l'Etiopia.
32 Situazione in Africa orientale: possibile 27.07.1934 attacco abissino, truppe indigene di copertura, truppe del corpo di spedizione, rinforzi, orientamenti del capo del governo, situaz ion e in Eritrea (rete di viabilità, finanziamenti, invio di truppe, sc hieramento del Regio Corpo Truppe Coloniali e linea difensiva, servizio informazioni), impiego dell'Aeronautica e della Marina in Africa orientale.
33 Prepara zione della guerra cont ro la 03.09.1934
Germania con poss ibili azioni contro la J ugoslavia (Ipotesi Nord-Est): principali problemi relativi alla condotta dell e
297309 3 11 -
N. Prin c ip ali a rgom en ti tr atta ti nell e se dute
operazioni, atteggiamento di alcuni Stati verso l'Italia in caso di conflitto, compiti dell'Aeronautica (azioni sulla Baviera), della Marina (collaborazione con la flotta francese, azioni in Adriatico) e dell'Esercito (decisa offensiva a nord) , accordi con l'Austria, direttive finali di Badoglio.
34 Smobi l itazione dei reggime nti di artiglie - 17.11.1934 ria costiera e sostituzione con la Milizia da Costa: la Marina di fronte alla riforma, mezzi e personale per la Milizia, relativo decreto di costituzione. Difesa dell'Isola
d'Elba: batterie della Marina, reggimento fanteria per l'isola, battaglione mitraglieri. Preparazione della guerra contro la German ia con possibili azioni contro la Jugoslavia (Ipotesi Nord-Est): occupazione dell ' Albania e di alcune isole dell'Adriatico, offensiva generale a nord.
34 P reparazione della guerra contro la Ger I 7. 1 I .1934 bis mania, con possibili azioni contro la Jugoslavia (I potesi Nord- Est): situazione internazionale, studio del problema ope rativo, questioni relative ali' Adriatico (Albania e isole antistanti a Zara), operazioni terrestri, accordi m i li tari con la Francia.
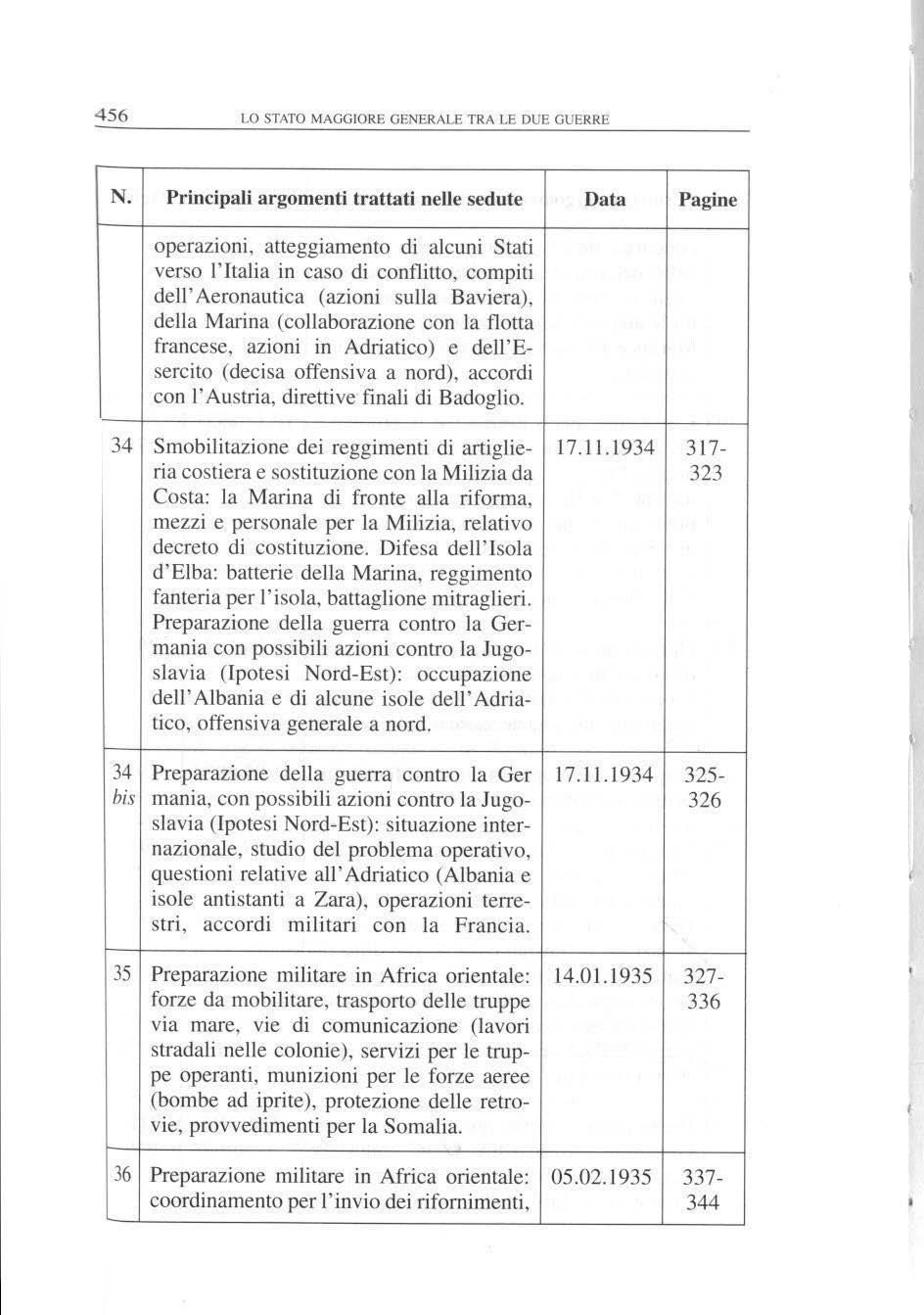
35 P reparazione militare in Africa orientale: 14.01.1935 forze da mobilitare, trasporto delle truppe via mare , vie di comunicazione (lavori stradali nelle colonie), servizi per le truppe operanti, mu ni zioni per le forze aeree (bo m be ad iprite), protezione delle retrovie, provvedimenti per la Somalia.
36 P reparazione militare in Africa orientale: 05.02.1935 coordinamento per l'inv io de i rifornimenti,
Principali argomenti trattati nelle sedute rinforzi e mezzi in Eritrea, trasporti marittimi, questioni finanziarie, scorte, situazione in Somalia e possibile attacco etiopico, costituzione di un comando superiore sul posto.

37 Preparazione militare in Africa orientale: 08.02.1935 relazione dell'alto commissario (generale De Bono) ; questioni relative alla Somalia: invio rinforzi (la divisione metropolitana e battaglioni eritrei daJla Libia) , forza presente, campo trincerato di Mogadiscio, trasporti marittimi di uomini e mezzi, invio del generale Graziani.
38 Preparazione militare in Africa orientale: 15.02.1935 questioni relative alle basi di Napoli, Messina, Siracusa, Massaua e Mogadiscio (operazioni logistiche per le unità indigene e metropolitane e loro direzioni da parte dello Stato Maggiore dell 'Esercito), procedura da seguire per le richieste e s pedizioni di materiali, munizioni, servizio cartografico e servizio informazioni, coordinamento generale, trasporti complementi del Regio Corpo Truppe Colon iali.
39 Preparaz ione militare in Africa orientale: 22.02.1935 riduzione quadrupedi per le truppe coloniali, baraccamenti per la Divisione Gaviniana e la Divisione Sabauda, trasporti marittimi e requisizione dei piroscafi per le linee oceaniche, basi di sbarco di Mas sa ua e Zula.
40 Preparazio..9e militare in Africa orientale: 08.05.1935 invio di forze in Eri trea, invio di ope rai e mano d'opera, trasporti marittimi di uomini e mezzi (organizzazione di un ufficio di
N. Principali argo menti trattati nell e s edute Data
sbarco a Massaua), invio delle Divisioni 08.05. I 935
Gaviniana, Sabauda, Gran Sasso, Sila, di alcune divisioni di cam icie nere e organizzazione dei relativi alloggiamenti, invio di muli per le truppe coloniali e indigene
4 I Preparazione militare in Africa orientale: 09.05.1935 sit uazion e delle forze aeree in Eritrea, cam pi e aeropo rti , impiego dell'iprite , difesa di Ass ab , v ia bi l ità e nuova rete stradale in costruz ion e in Eritrea, approvvigionamenti d'acqua, questione relativa alla presentazione presso le nostre autorità di confine di nostri ex ascari etiopici, situazione militare della Somalia (Divisione Peloritan a e campi trincerati di Giuba e Uebi-Scebeli, situazione delle truppe indige ne , base aerea di Belet Uen, condiz ioni di sbarco a Mogadi sc io, trasporto marittimo di truppe).
42 Nuovo indirizzo dell'Italia in politica este- 05.11.1936
ra: rapporti con la Germania e la Francia , interessi italiani nel Mediterraneo e relative direttive strategic he A sse gnazioni massime di fondi straordinari alle forze armate sino al giugno 1938: sit uazion e finanziaria dell'amministrazione dell'Ese rcito, della Marina e dell'Aeronautica prospettata dai capi di Stato Maggiore, disposizioni finali di Badoglio .
43 Organizzazione delle terre italiane d'oltre - 17.12.1936
mare (argomento 10 dell ' ordine del g iorn o per la XI V sessione della Commissione Suprema di Difesa): loro funzione militare nelle più probabili ipotesi di conflitto , l' Ese rcito e l'organizzazione delle colonie in caso di guerra, il teatro cli operazione

N. Principali argomenti trattati nelle sedut e del Mediterraneo (importanza strategica del canale di Sicilia, della Cirenaica e dell'Etiopia, delle Isole italiane dell'Egeo), possibili operazioni in direzione est e sudest dalla Libia e a nord dall'Etiopia, la questione dei comandi per la direzione delle operazioni.
Data
44 Organizzazione militare delle Isole italiane 22.01.1937
dell'Egeo: fabbisogno complessivo e spese necessarie alla difesa delle isole, piani di difesa studiate dalle tre forze armate, difese delle isole minori (Scarpanto, Stampalia, Castelrosso, Coo), dipendenza in guerra delle forze militari dislocate nelle isole. Questioni relative al comando delle forze nella base di Tobruk. Difesa dell' isola di Pantelleria.

45 Organizzazione del comando delle Isole 26.02.1937
italiane dell'Egeo: decreto sulla nomina del nuovo governatore con tutti i poteri militari, ampliamento delle forze aeree e coordinamento con le forze della Marina e dell'Esercito presenti, responsabilità della difesa delle isole affidate al governatore, dipendenza delle forze armate dell'Egeo dalle autorità centrali metropolitane per la preparazione e l'impiego offensivo. Comando a Tobruk: coordinamento tra le tre forze armate sotto la direzione di un comando unico dell'Esercito.
46 Fortezza costiera di Messina-Reggio Cala- 31.03.1937
bria: armamento della piazzaforte, difesa dello stretto, passaggio del comando della fortezza costiera dall 'Eserc ito alla Marina. Passaggio della Milizia da Costa alla Marina: atteggiamento della Marina di
N. Prin ci pa li argom enti t ra tta ti ne ll e sedu te fronte alla riforma, ques ti o ni finanziarie. Ridu zione delle forze ad dette a ll a difesa cos tiera: sostitu z io ne della difesa delle coste a co rdon e co n un a difesa manovrata, impiego camicie nere. Protezione delle ferrovie, strade ordinarie, reti delle com uni cazioni, impianti vari.
4 7 Organi zzazio ne militare dell'isola di P an- I 1.06.1937 telleria: intervento del Ministero dei La vori Pubbli ci, R.D.L. del 6.5.1937 s u Pantelleria ba se ae rea, fondi nec essari per I' organizzazione aeronautica e aeroportuale, com piti specifici delle tre forze armate nel! ' isola e direttive finali di Badoglio (res pon sab ilità della difesa antisilurante alla Marin a, difesa ant isbarco e antiae rea alJ'Eserc ito , comando ge nerale dell'isola aJl' Aeronautica, lavo ri strada li ).
48 Situazione internazionale e proge tti opera- 02 .1 2. 1937 tivi in corso di stu di o: piano AZ del Regio Eser ci to (co nqui sta delle isole zara tin e), piano AA. del Reg io Esercito ( Albaniapadronanza del cana le d'Otranto, posses so del bacino petrolifero del Devo li ), piano 10 ( ipo tesi di guerra contro Fra nci a e Jugo s lavi a), piano 12 (ipotes i di guerra co ntro Fr a nc ia e In g hilte rra) e stud i su operazioni con tro la Grecia e in Africa sette ntrionale. Cooperazione tra Aeronautica e Marina in g uerra (coo rdinam ento nell'Alto T irren o, Mar Ro sso e Adriat ico, av iazion e di M arina e portae rei). Impianto per voli notturni nella bai a di Portol ago e difesa contraerei dei campi cli aviazione cli manovra d ell 'Egeo.


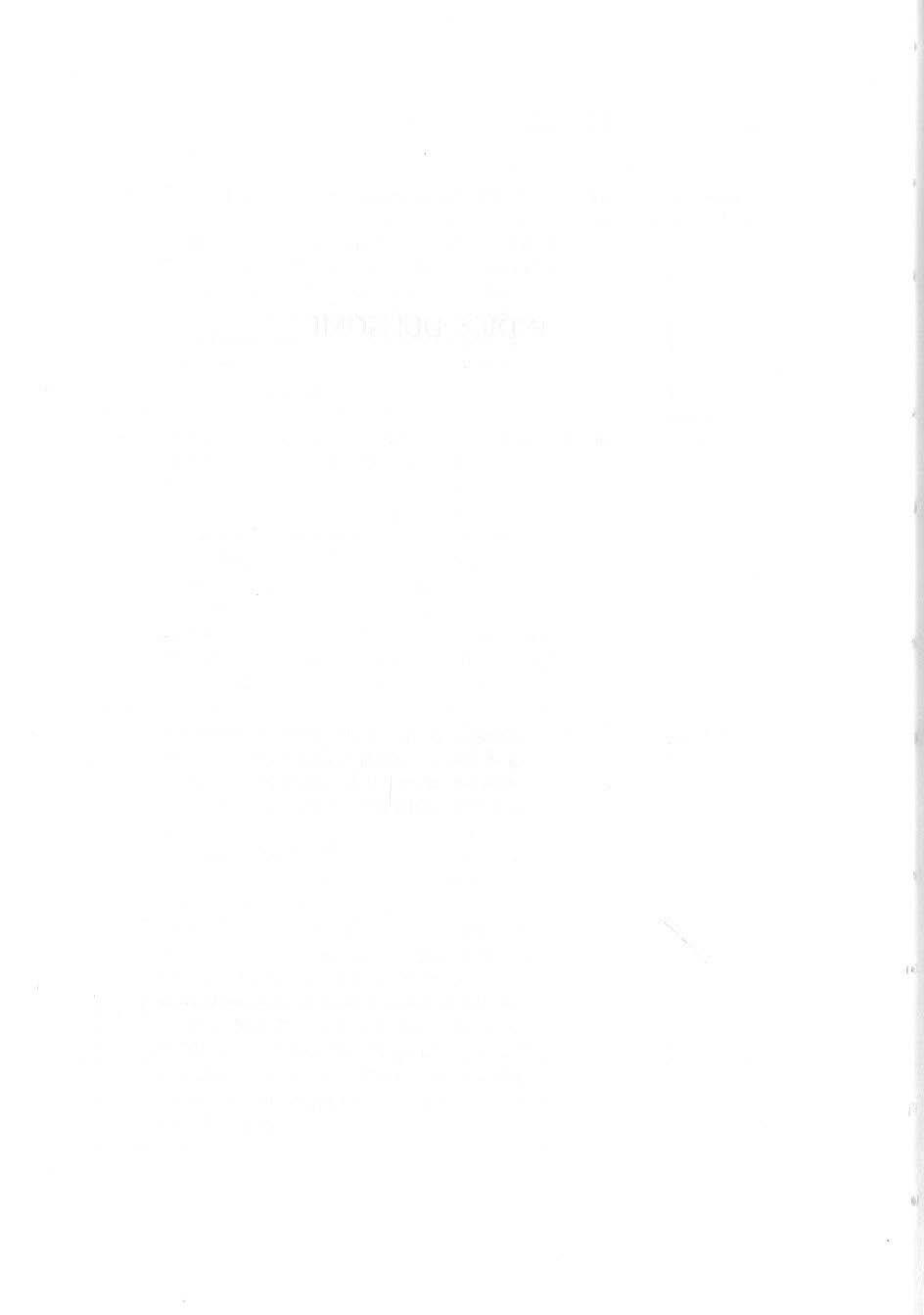
ACTON ALFREDO, vice ammirag li o, capo di Stato Maggiore della Mar in a (4. 12. 1919-6 2.1921 e 14.5.1925-2 1. 12. 1927), pp. 68, 79n., 93, 97, 98, LO In., 103, 104, 109.
ALBRICCI ALB ERICO, ten ~nte genera le. comandante del II Corpo d'Armata in Francia nel 19 I8, ministro della Guerra ( 24.6.191 9- 13.3.1920), p. 9.
AMANTEA L UIGI, general e di briga ta, capo del Reparto Operazioni dello Stato M agg iore de ll' Eserci to, pp. 59, 60n., 61, 62 n , 63, 6611 , 67, 69 n, 75, 81. 89, 91n.
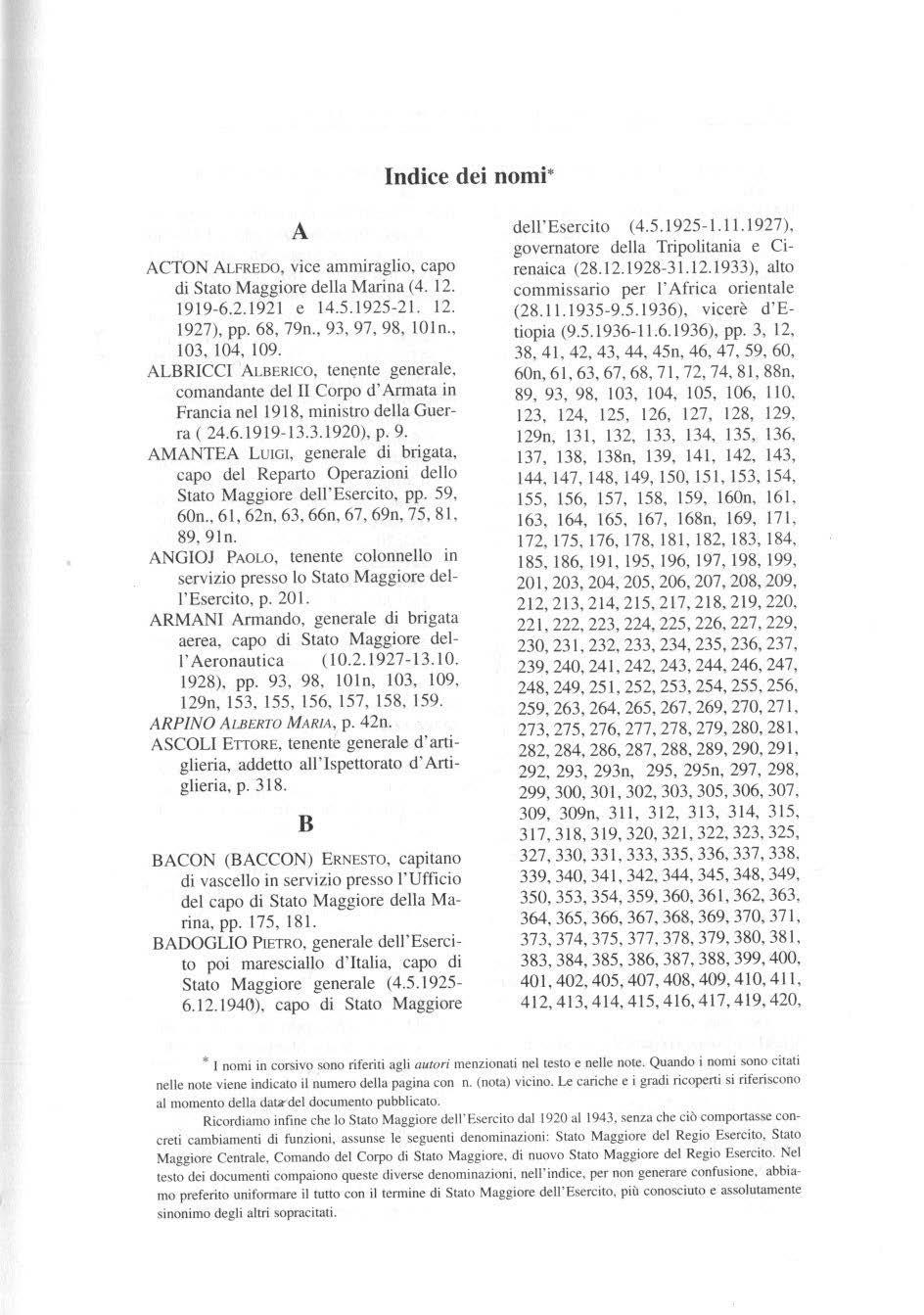
ANG IOJ PAOLO, te nente colo nn e llo in ser vizio presso lo Stato Maggiore dell' Ese rc it o, p. 201.
ARMANI Armando, genera le di brigata aerea , capo di Stato Maggiore del1'Aero nauti ca ( 10.2.1 927- I 3. I O. I 928), pp. 93. 98, 10 l 11 , I03, I09, 129n, 153, 155, 156, 157, 158, 159.
ARPINO AUJERTO MARIA , p. 42n.
ASCOLI ETIORE, tenente generale d'artig li eria, addetto all'Ispettorato d' Artiglieria, p. 318.
BACON ( BACCON ) ERNESTO, cap itan o di vasce ll o in servizio presso l'Ufficio del capo di Stato Maggiore d ella M arina , pp. 175, 18 1.
BADOGLIO PLETRO, generale dell'Esercito poi marescia ll o d ' Italia, capo di Stato Ma ggiore ge nerale (4.5 .19256.12.1940), capo di Stato Maggiore
dell'Esercito (4.5. l 92 5 -1.11.1927). governatore della Tripo li tania e Cirenaica (28.12.1928- 3 1.l2.1933), alto commissario per l'Africa orienta le (28. l l .1935-9 5.1936), vicerè d'Etiopia (9.5. 1936- 11.6 .1936), pp. 3, 12, 38,41,42,43,44,45n,46,47,59,60, 60n. 61, 63. 67 , 68, 71, 72, 74, 8 1, 88n, 89, 93, 98, 103, 104. 105, 106, 11 0, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 12911, 13 1, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138 , 138n, 139, 141, 142, 143, 144, 147,148,149, 150,151 , 153,154, 155, 156, 157, 158, 159, 16011 , 161, 163, 164, 165, 167, 168 n, 169, 171 , 172, 175, 176, 178. 181 , 182, 183 , 184, 185. 186, 191 , 195,196,197,198, 199, 201,203,204,205,206,207,208,209, 212,213,214,215,2 17,2 18, 219,220, 221,222,223,224,225,226,227,229 , 230,231,232,233,23 4 ,235,236,237, 239,240,24 1,242,243,244,246,247, 248,249,251,252,253,254,255,256, 259,263,264,265,267,269,270,27 1, 273,275,276,277,278,279,280,281, 282,284,286,287,288,289,290,291, 292, 293, 29311, 295, 295n , 297, 298, 299,300,301,302,303,3 05 ,306,307, 309, 309n , 3 11 , 312, 313, 314, 3 15. 3 17 ,3 18,319,320,321,322,323.325, 327,330,331,333,335,336,337,338, 339,340,341,342,344,345,348,349, 350,353,354,359,360,361,362,363 , 364.365,366,367.368,369,370, 371, 373,374,375,377,378,379,380 ,381. 383,384,385,386,387,388,399,400. 401,402,405,407,408,409,410,411, 412,4 13,414,415,4 16, 417,4 19,420,
• I no mi in corsivo sono riferiti agli amori menzionati nel testo e nelle note Quando i nomi so no citati nelle note vie ne indica to il nu mero della pagina co n n ( nota) vici no. Le cariche e i gradi ricoperti si riferi scono al mome nto della data-del documento pubblicato Ricordiamo in fine c he lo Stato Maggiore del I' F,scrci to dal 1920 al 1943, senza c he ciò comportasse concre ti cambiamenti d i fu nz io ni. assunse le seguent i denominazioni : Stato Maggiore del Regio Eserc ito, Stato Maggio re Centrale, Coma ndo del Corpo d i St.ato Maggiore. d i nuovo Stato Maggiore del Reg io Esercito. Ne l testo dei docu menti compaiono queste diverse denominazio ni, nell 'i ndice, per non generare confusione. abb iamo preferito u niformare il tutto co n il 1em1ine di Sta to Maggiore dell'Eserci to, più conosci uto e asso lutamente s inonimo de gli al tri sopracitati.
421, 422, 423, 424, 425, 426, 427. 431 -432, 441.
BAISTROCCHI FED ERI CO, generale di corpo d 'armata, poi generale designato d'armata, sottosegretario di Stato alla G uerra (22.7.1933-7.10.1936), capo di Stato Maggiore dell'Esercito (I.I 0.1934-7. 10.1936), pp. 293, 293n. 297,299,301,302,3 03, 309 n, 3 11 , 3l3, 3 14 , 315, 316n, 317, 318. 319, 320, 321, 322, 325, 327, 330, 331, 337. 338. 339, 340, 341, 343, 345, 348, 349, 350, 353. 359. 362, 364, 365, 370, 371.
BALBO ITALO , maresciallo dell'aria, ministro dell ' Aeronautica ( I 2.9.19296. 11. 1933), governatore della Libia ( 1934-1940), nel testo compare spesso con queste dizioni, pp. 206, 276, 278, 283, 284, 307, 378,381.402, 422.
BARBASE1TI CUR IO, colonnello, capo dell'Ufficio Ordinamento e Mobilitazione dello Stato Maggiore dell'Esercito, pp. 59, 60n, 63, 66. 67, 69n, 71, 74.
BELTRAM I MAR IO, tenente colonnello d'aeronautica in servizio presso l'Ufficio del capo di Stato Maggiore Ge nerale,pp. 169, 175 .
BENNI ANTONIO STEFANO, deputato , ministro delle Comu nicaz ioni (24. 1. 1935- 3 1. 10. I939) nel testo compare secondo questa diz ione, p.378.
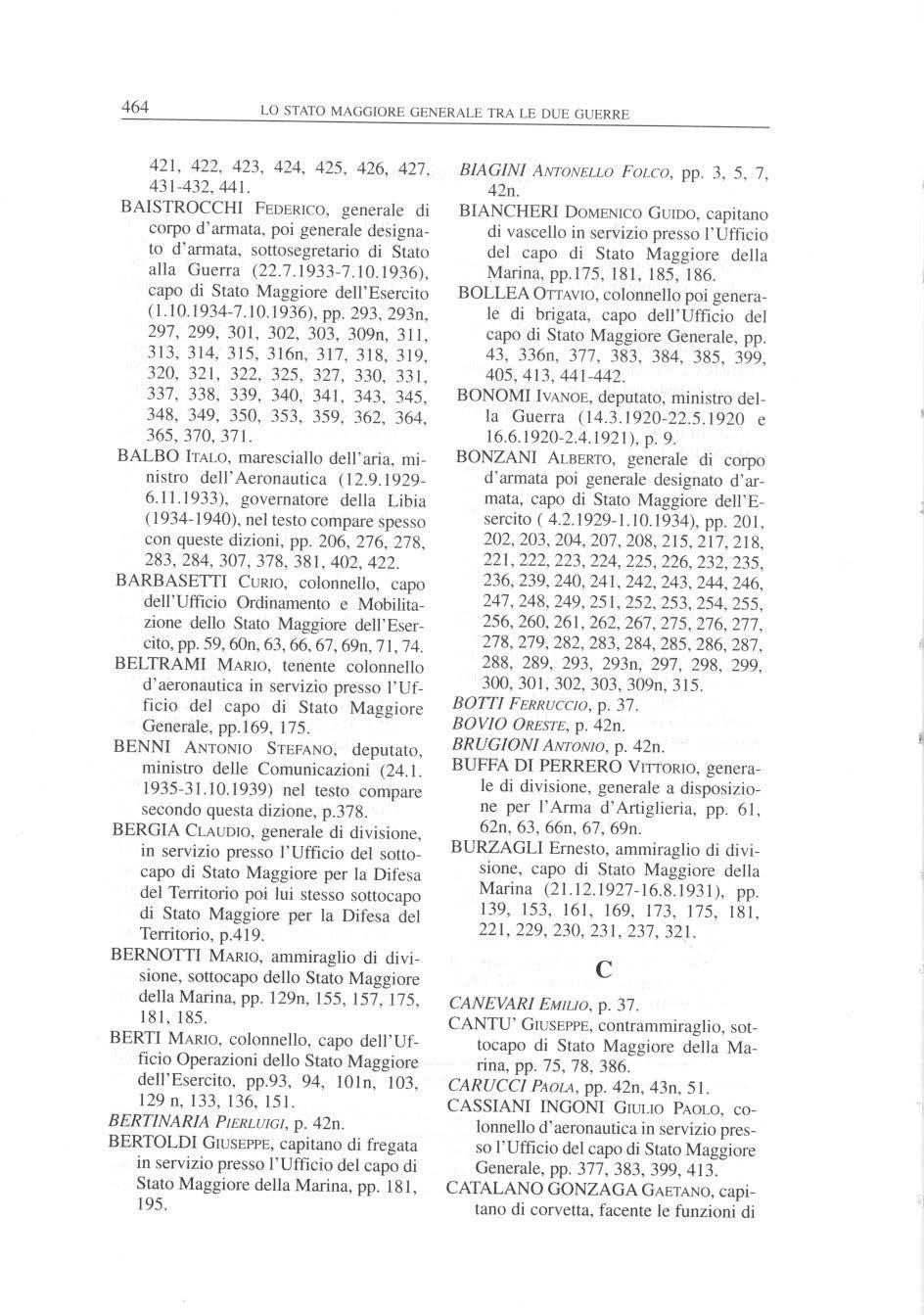
BERGIA CLA UDIO, genera le d i divisione, in serviz io presso l'Ufficio de l sottocapo di Stato Maggiore per la Difesa de l Territorio poi lui stesso sottocapo di Stato Maggiore per la D ifesa de l Territorio, p.4 I 9.
BERNOTII MARIO, ammiraglio d i divisione, sott ocapo de ll o Stato M aggiore de ll a Marin a, pp. 129n, 155 , 157, 175 , 181, 185.
BERTI MARIO, colonnello, capo dell'Ufficio Operazioni dello Stato Maggiore de ll 'Esercito, pp.93, 94, IO In , 103, 12911, 133, 136, 15 1.
BERTINARIA PtERWIGt, p. 42n.
BERTOLDI GIUSEPPE, cap itano di fregata in servizio presso l'Ufficio del capo di Stato Maggiore della Marina, pp. 181, 195.
BIAGINI ANTONEUO FOLCO, pp. 3, 5. 7, 42n.
BIANCHERI DOMENICO G UIDO, capitano di vascello in servizio presso l'Ufficio del capo d i Stato Maggiore della Marina, pp.175 , 18 1, 185, 186.
BOLLEA OTTAVIO, colonnello poi generale d i brigata, capo dell'Ufficio del capo di Stato Maggiore Generale, pp. 43, 336n, 377, 383, 384, 385, 399, 405,4 13, 441-442.
BONOMI IVANOE, deputato, ministro della Guerra (14.3. 1920-22.5.1920 e 16.6.1920-2.4. 1921), p. 9.
BONZANl ALBERTO, generale di corpo d'armata poi generale designato d'armata, capo di S tato Maggiore dell 'Escrcito ( 4.2.1929- 1.10.1934), pp. 201, 202,203,204,207,208,215,217,218. 221,222,223,224,225,226,232,235, 236,23 9,240,241. 242.243,244,246, 247,248,249,251,252,253,254,255, 256,260,261 ,262,267,275,276,277, 278.279,282,283,284,285.286,287, 288, 289, 293, 293n, 297, 298, 299, 300,30 1,302,303, 309n,315.
BOTTI FERRUCCIO, p. 37.
BOVIO ORESrE, p. 42n.
BRUGIONJ ANTONIO, p. 42n.
BUFFA DI PER RERO V1TTORIO, ge nerale d i divisione, generale a disposizione per l'Arma d'Artig li eria, pp. 61, 62n,63, 66n, 67,69n.
BURZAGLI Ernesto, amm iraglio di divis ione, capo di Sta to Maggiore de lla Ma ri na (2 1.1 2 .1 927- 16.8. I 931) , pp. 139 , 153, 161, 169, 173, 175, 18[, 22 1,229,230,231,237,321. e
CANEVARI EMtUO, p. 37.
CANTU' G IUSE PPE, contra mmirag li o, sottocapo di Stato Maggiore de ll a Marina, pp. 75, 78. 386.
CA R UCCI PAOLA, pp. 42n, 43n , 51.
CASSIANI INGONI G1u1.10 PAOLO, colonnello d'aeronautica in servizio presso l'Uffic io de l capo d i Stato Maggiore Ge neral e, pp. 377, 383,399,413.
CATALANO GONZAGA GAETANO, capita no di corvetta, facente le fu n zioni di
capo del Ili Reparto dell'Ufficio del capo di Stato Maggiore della Marina, pp. 153,2 15.
CAVAGNARI DOMENICO, ammiragli o di divisione, sottosegretario di Stato alla Marina (6. ! l.1933-8.12.1940), capo di Stato Maggiore della Marina ( 1.6. 1934-11.12.1940), pp. 297, 30 l. 309n, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317,318,319,320,321,322, 325,337. 339,340,341,345,349,359,360,361, 364.365,366,370,374.377,378,380, 381,383.385,386, 387,388,399,400, 401,402,405,406.408,409,4 10,413, 4 14 , 415,416,419 , 420,42 1,422,423. 424,425.
CAVALLERO Uoo, generale poi maresc iallo d ' Italia, sottosegreta rio di Stato alla Guerra (4.5 .1925-24. 11. 1928), capo di Stato Maggiore Generale (6.12.1940-1.11.1943).pp. 37. 46.
CESARI CESARE, p. 42n.
CEVA LUCIO, p. 37.
CHIAPPELLI L UI GI, colonnello d'aeronautica in servizio presso Stato Maggiore dell'Aeronautica, pp. 175, 182, 196, 197.
CONSOLI GI USEPPE, tenente colonnello poi co lonnello, capo dell'Ufficio militare del Ministero del le Colonie, pp. 327, 331.

COOP ERNESTO, co lonnello d'aeronautica in servizio presso lo Stato Maggiore dcli' Aeronautica, pp. 175, 182, 196.
CORTESE GIUSEPPE, generale di divisione , d irettore generale d'Artig li eria a l Min istero del la Guerra, pp. 71, 7411. 81, 89, 9111.
COSENZ ENR ICO, tenente generale, capo dello Stato Maggiore del!' Esercito ( l. 9.1882- 1.1 2.1893), p. 107.
DDALLOLIO ALFREDO, tenente generale, sottosegretario poi ministro per le ar mi e murnzi on i ( I 915-1918), generale di corpo d'armata e commissario ge nera le per le fabb ri caz ion i d i guerra ( I935 - I939), pp. I62, 34 1.
DALL'ORA F IDENZ IO, generale di division e, intendente generale pres so il
Comando Superiore in Africa Orientale, p. 367.
DALL'ORA GIUSEPPE, co lonnello de l genio, p. 137.
DE BENEDETTI GIOVAN ANTONIO, colonnello in se rvizio nello Stato Maggiore dell'Esercito, pp. I 8 I, I 82.
DE BONO EMILIO , gene rale di corpo d'armata poi generale designato d'armata in aspettativa, ministro delle Colonie ( 12.9.1929-17. 1.1 935), alto commissario per l'Africa Orientale ( 16 1. 1935- 12. 12.1935). nel testo compare anche secondo queste dizioni, pp.293, 293n. 295, 29511. 297. 298, 299, 301, 302, 303, 305, 306, 307, 308, 309n, 345, 346, 349, 350, 354, 355, 357, 358, 359, 36b, 361, 362, 363, 364. 366,367,370,371.
DE COURTEN RAFFAELE, capitano di fregata addetto all'Ufficio del capo di Stato Maggiore Generale, pp. 44n., 103, 169, 175 , 182 , 201.
DEL CIMA ADONE, capitano di fregata, in servizio presso l'Ufficio del capo di Stato Maggiore della Marina, pp. 377, 383.
DE PINEDO FRANCESCO, generale di brigata aerea, sottocapo di Stato Maggiore dell'Aeronaut ica, pp. I 75, 176, 181, 195, 196, 197.
DE VECCHI CESARE MARIA di va l Cismon, quadriunviro, ministro de l1'e ducazione nazionale (24.1.193515 .1 1.1 936), governa tore della Somalia , governatore del Dodecanneso da l 15.1 1. 1936, nel testo compare seco ndo questa ultima dizione, pp. 381, 384,386,387,400,425,426.
DELLA PO RTA R0DLANI CARRARA
GUGLIELMO, capita no, addetto alla segreteria dello Stato Maggiore dell'Esercito, nel testo compare secondo questa dizione, pp. 93, JO!n.
D' H AVET GI USEPPE, genera le di divisione, direttore superiore delle cos tru zioni del Ministero della Guerra, p. 8 1.
DJAZ ARMANDO, maresciallo d'Italia , capo di Stato Maggiore dell'Esercito (8. I I .19 17 -24 .11 .19 19), ministro della Guerra (3 I. I0.1922-30.4 I924 ), p. IO.
DI GIORGIO ANTONINO, generale di corpo d'armata, deputato, ministro della Guerra (30.4. 1924-4.4.1924), p.10.
DUCCI GINO, ammiraglio di squadra, capo di Stato Maggiore della Marina ( 16.8.1931-1.6.1934),pp. 239, 246, 254, 255, 256, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 271, 272. 275, 276, 279, 280, 285, 288, 289, 290, 291.
ELENA LEONARDO, capitano di fregata in servizio presso l'Ufficio del capo di Stato Maggiore Generale, pp. 377. 383,399,405,413,419.
FAWELLO EMIUO, p. 37.
FARONATO LUIGI, colonnello d'aeronautica in servizio presso lo Stato Maggiore dell'Aeronautica, pp. 20 I , 221.
FERRARA ARTURO, maggiore , facente le funzioni di capo dell'Ufficio militare del Ministero delle Colonie, p. 345.
FERRARA GIUSEPPE, genera le d'armata, capo di Stato Maggiore dell'Esercito (1.2.1927-15.2.1928), pp. 93, 97, 98, lOln, 103 , 104, 108, 109, 129, 129n, 134, 135, 136, 141, 155 .
FILIPPOVIC GruSEPPE (1819-1889), maresc iallo asburgico, comandante il corpo di spedizione austrungarico in Bosnia-Erzegovina nel 1877-78, p. 173.
FOSCH INI FRANCESCO, generale di corpo d'armata, sottocapo di Stato Maggiore per la Difesa territoriale, pp. 405,410, 411,412.
FRAITOL/LLO FERNANDO, p. 42n.
FRJCCHIONE GAETANO, tenente colonnello in servizio presso l 'Ufficio Ordinamento e Mobilitazione dela Stato Maggiore Esercito, p. 81.
GABBA MELCHIADE, generale di corpo d'armata, capo di stato maggiore del
Comando Superiore in Africa Orientale, p. 369.
GALAMERI MARCO , colonnello, capo dell 'Ufficio Operazione dello Stato Maggiore dell'Esercito, pp. 317. 323n.
GANDIN ANTONJO, colonnello, capo del! ' Ufficio del capo di Stato Maggiore Generale (15.5.1938-10.6.1940), pp . 43,419, 443-444.
GAZZERA PI ETRO, generale di divisione, ministro della Guerra ( 12 .9.192922.7. 1933), nel testo compare secondo questa dizione, pp. 240,242,247,256, 276, 283. 288.
GELJCH FERNANDO, p. 37.
GELOSO CARLO, colonnello in servizio presso la Segreteria generale della Commissione Suprema di Difesa, pp. 129n. 134, 154. 155, 161, 162, 164, 165.
GINOCCHTETII ANGELO, console genera le della Milizia da Costa, pp. 407, 408.
GIORDANO RUGG ERO, capitano di vascello, capo del 4°Reparto (difesa marittima e organizzazione) dell'Ufficio del capo di Stato Maggiore della Marina, p. 75.
GIORGIS GIORGIO, capitano di corvetta in servizio presso l'Ufficio de l capo di Stato Maggiore della Marina, p.201.
GIURATI G 10VANN1, deputato, ministro dei Lavori Pubblici (5.1. 1925-30.4. 1929) , nel testo compare anche con questa dizione, p. 135.

GORLIER MARJO, colonne ll o, capo dell'Ufficio Operazioni dello Stato Maggiore dell'Esercito , pp. 377, 383, 399, 405 , 4 13.
GRAZIANI CARLO, colonnello d'aeronautica, capo dell 'U fficio Operazioni dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, pp. 103, L29n , 154, 155, 160.
GRAZ IANI RODOLFO, generale di corpo d'armata, comandante del Corpo d 'armata di Udine, nel marzo 1935 nominato governatore della Somalia poi comandante del Corpo di spedizione contro l'Etiopia sempre in Somalia, in seguito maresciallo d'Italia, capo di Stato Maggiore dell'Esercito (3.1 I.
1939- J J- J J- J94 J), comandante superiore in Africa settentrionale (29.6.
1940- I l.11.1941 ), ministro delle Forze Armate della Repubblica Sociale Italiana , pp. 344, 345, 346, 350. 368, 369, 378.
GRAZIOLI FRANCESCO SAVERIO, generale di corpo d 'armata, sottocapo di Stato Maggiore Generale (4.5.1925 - 1.2. 1927 ) pp. 37, 59, 60n, 61. 62, 63, 66n, 67, 71, 75. 76,433-434.
GRAZIOSI EUGENIO, generale di divisione, comandante in seconda dello Stato Maggiore dell'Esercito. pp. 124, 125 , 126, 129n, 137.
GUALTIERI N1cOLA, generale di corpo d'annata, capo di Stato Maggiore dell'Esercito (27 .7 .1928-4.2.1929), pp. 169, 173, 175. 181, 183.
GUIDOTTI G1uuo, luogotenente generale della Milizia Volontaria di Sicurezza Nazionale, ispe ttore della Difesa Contraerea Territoriale, pp. 317,318,319.
GUZZONI ALFREDO, colonnello in servizio presso lo Stato Maggiore dell'Esercito. p. 20 I.
LESSONA ALESSANDRO, deputato, sottosegretario di Stato alle Colonie ( 12.9. 1929-11.6.1936), ministro delle Colonie ( I l.6.1936-20.11.1937), nel test0 compare anche con queste dizioni, pp. 335, 337, 339, 340, 343, 344, 346, 353, 355, 359, 360. 36 I , 362. 365, 366,367,368,370,378.
LODOLINI Euo, p. 42n.
LONGO LUIGI EMILIO, p. 37.
LUDENDORFF ERICII. generale tedesco, sottocapo dello Stato Maggiore germanico nel 1918, p. 156
MAGLIOCCO VIN CENZO, colonnello d'aeronautica in servizio presso l'Ufficio del capo di Stato Maggiore Generale, p. 44n.
MARCHAND. p. 107.
MARITANO MARIO, tenente colonnello in servizio presso l'Ufficio Servizi dello Stato Maggiore dell'Esercito, pp. 81, 89, 9111.
HITLER ADOLF, cancelliere del Reich, capo de ll o Stato tedesco, pp.312, 325.
HAILE' SELASSIE' T, imperatore (negusneghesti) dell'Etiopia, pp. 295, 297.
ILARI VIRGIUO, p. 37. .J
JOFFRE CESAR-JOSEPH-JACQ UES, maresciallo di Francia, capo di Stato Maggiore e generale in capo delle armate francesi del nord e del nordest ( 19141916~ pp. 154,166.
JVNG Gumo, deputato, ministro delle Finanze (20.7.1932-24.1.1935), nel testo compare con questa dizione, p. 301.
KELLOGG FRANK BtLLINGS, segretario di Stato americano (U.S.A.), p. 309.

MARRAS EF1s10, tenente colonnello, poi colonnello, facente funzioni (dall'ottobre 1930) poi capo dell'Ufficio del capo di Su1to Maggiore Generale (ottobre I930-agosto 1933), pp. 43, 175, 179n, 182,20 1,2 15,221,239, 437-438.
MARSEGUERRA GIOVANNI, tenente colonnello del genio in servizio nel Regio Corpo Truppe Coloniali. p. 303.
MARTUCCI MARIO, colonnello d'aeronautica in servizio presso lo Stato Maggiore dell'Aeronautica, p. 215.
MASSOBRIO Gt uuo, p. 38.
MENGONI GUIDO. capitano di fregata in servizio presso l'Ufficio del capo di Stat o Maggiore Generale, pp. 215, 221.
MOLTKE HELLEMUTH ( 1848- 1916), generale tedesco, capo dello Stato Maggiore dell'esercito germanico ( 19061916), p. 106.
MONDINO UMBERTO, tenente colonnello io servizio presso l'Ufficio Ordinamento e Mobilitazione dello Stato Maggiore dell'Esercito, pp. 89, 91 n.
MONTANARI MARIO, pp. 37, 45n, 427n.
MONTEF INALE TrTO, generale di brigata, capo del Reparto Operazioni dello Staro Maggiore dell'Esercito, pp. 63, 66n, 71, 74n , 75 , 81 , 89,9 1n.
MONTI EDOARDO, generale di brigata in servizio presso lo Stato Maggiore dell'Esercito , pp 201,215,221.
MUSSO CARLO , colonnello , capo dell ' Ufficio Difesa Aerea del lo Stato Maggiore dell'Esercito , pp. 61, 62n, 63. 66n, 67, 69n, 7 1, 74n, 75.
MUSSOLINI BENITO, capo del governo, nel testo compare spesso secondo questa dizione, pp. IO, 11 30, 31, 45n, 46, 93, 94, 95, 98. 101, 103, 104, 105. 106, 107, 108,109,131, 138, 153. 156, 162, 164 , 167,171.176, 179,203,214,218 , 220,223,224,225 , 226,227 , 230,234, 235 , 236,237,240, 241,243,244 , 254, 255 , 263,276,278 , 286,287,290,291.
293, 293n, 295, 300, 301. 307, 309, 311,312,314, 315, 32 1,325,326, 327, 328,330,33 1, 332,334, 336,337,339, 340,341,342,343,345,346,349,353, 357,363,364,366,367,368,371,373, 374,375,378,384,386,387,388 , 401 , 4[0,415,417,422,426,427.
PALAZZIN I ANTONIO, tenente colonnello in servizio presso lo Stato Maggiore dell'Esercito, p. 201.
PARIANI ALBERTO, colonnello e capo dell'Ufficio Operazioni dello Staro Maggiore dell'Eserc ito (1924- 1927). generale d i corpo d'armata e sottocapo dello Stato Maggiore dell'Eserc ito (I. I0.1934- 7. IO. 1936), generale designato d'armata, sottosegretario di Staro al la Guerra e capo dello Stato Maggiore dell'Esercito (7. I 0. 19363.12 I 939) , pp. I O, 12, 45, 45n, 59 , 60, 61, 62n, 63, 66, 6611,67, 69n, 71, 74, 74n, 75 81, 88n , 9 1, 246, 254, 317, 321 , 322, 325 , 327, 335 , 337, 345, 353, 359, 361, 365, 367, 370, 371, 374, 375, 375n, 377, 378, 379, 380, 383, 385, 386 , 387. 388, 399, 400, 402, 405, 407, 412, 4 13 , 415 , 416, 417, 419, 420, 42 1, 422, 423, 425 , 426.
PEZZA ALBERTO, capitano di fregata. capo della I 0 sezione (D i fesa litoranea e Relazioni con lo Stato Magg iore dell'Esercito) del 4 ° Reparto dell'Ufficio del capo di Staro Maggiore della Marina , p. 75.
NEGRI LuiGI, co lonnello, capo dell'Ufficio Mob il itazione dello Stato Maggiore dell'Esercito, pp. 123, 124, 125, 126, 129n, 146, 148, 149, 175, 181, 182, 183, 201.
NTCOLETTI ALTIMARI GUSTAVO, generale di divisione, genera le a disposizione per l 'A rm a del Gen io presso il Ministero della Guerra, pp. 61, 62n, 67 , 69n.
NOBILI GIORGIO, luogotenente ge nerale della Mil izia Volontaria di Sicurezza Naz ionale, ispettore generale della Difesa Contraerea Territoriale, pp. 44. 182.
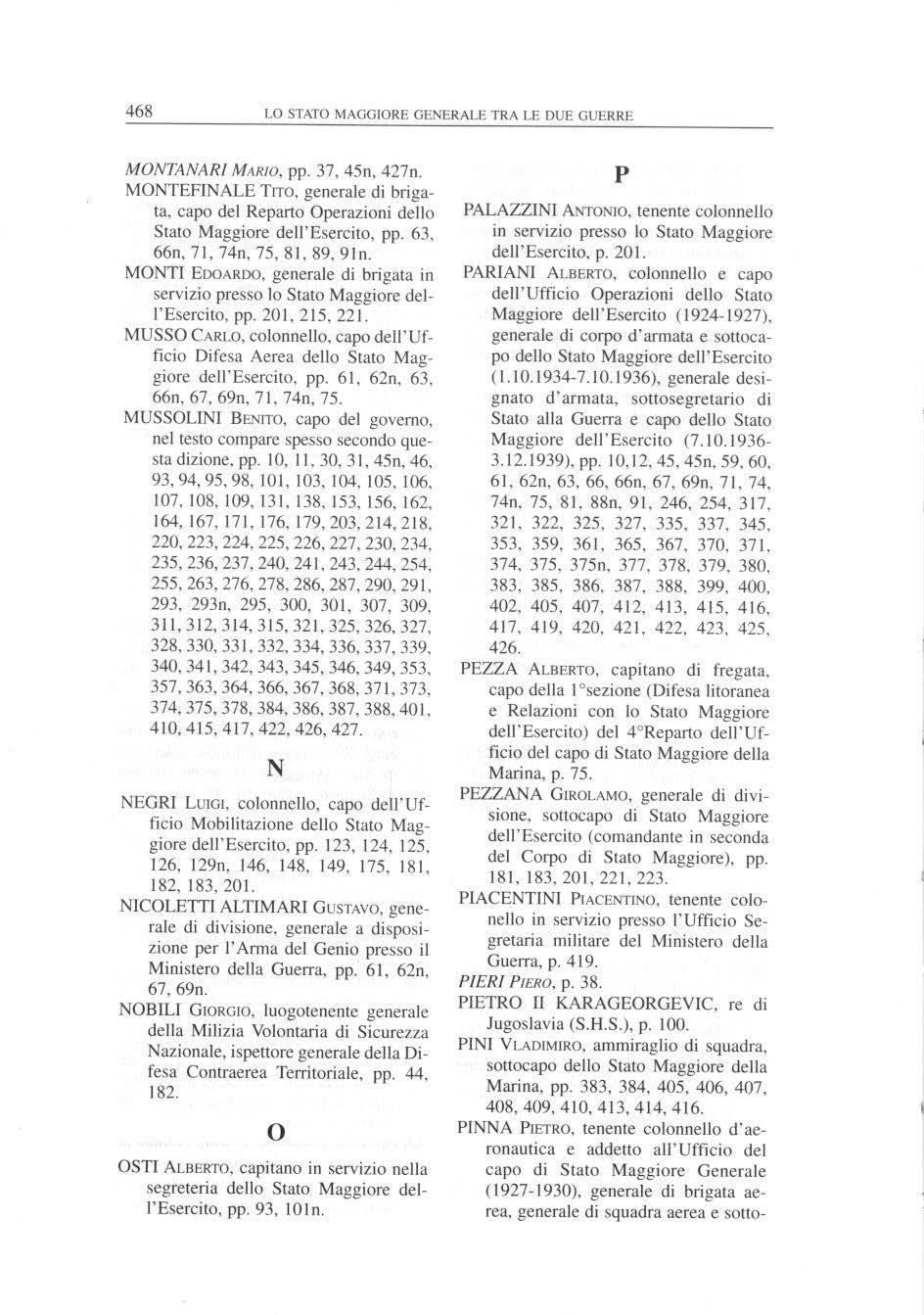
PEZZANA GIROLAMO, general e di divis ione , souocapo di Stato Maggiore dell'Esercito (comandante in seconda del Corpo d i Stato Maggiore), pp. 181,183 , 201,221,223
PIACEN TINI PIACENTINO, tenente colonello in servizio presso l'Ufficio Segretaria mi li ta re del Mi nistero della Gue n a, p. 419.
PIER! PtERO, p. 38.
PIETRO li KARAGEORGEVIC, re di Ju gos lavia (S .H.S .), p. I00.
PINI VLADIMIRO, ammiraglio di sq uadra, sottocapo de llo Stato Maggiore della Mar in a, pp. 383, 384, 405, 406, 407, 408,409,410,413,414,416.
OSTI ALBERTO, capitano in se r vizio nella segreter ia dello Stato Maggiore dell'Esercito, pp. 93, I O!n.
PINNA PIETRO, tenente colon nello d'aero n aut ica e addetto a ll 'Ufficio del capo di Stato Magg io re Generale ( 1927 - 1930), generale di brigata aerea, genera le d i squadra aerea e sotto -
capo dello Stato Maggiore del!' Aerona utica ( I934-1937), pp. I 03. 215,221 , 297, 309n, 311, 31611, 317. 318, 325 , 337, 345, 367 , 383, 386, 419 , 425.
PINTOR PIETRO, co lonn ello, capo del1 ' Uffìcio Addestramento dello StaLO Maggiore dell'Esercito, pp. 63, 66n , 75 , 422.
POLLIO ALB ER'l'O, tenente genera le , capo dello Stato Maggiore dell'Esercito ( 1.7. 1908- 1.7.1914), p. 107.
PONZA DI SAN MARTINO ALBERTO. colonnello, capo dell'Ufficio del capo di Stato Maggiore Generale (febbraio 1927-settembrel928), pp. 43, 93, 101n, 103, 12911, 155,435.
PORTA V1RGINIO , tenente co lonnello in servizio presso l'Ufficio del generale a disposizione pe r l'Arma del Genio del Ministero della Guerra, p. 75.

PORZIO GIOVANOLA Gumo , capitano di vas cello, capo dell'Uffic io Personale, Mobilitazione e Difesa cost iera dell'Ufficio del capo dello Sta to Maggiore della Marina, p. 399.
RUGGERO VnTOR IO, colonnello, addetto militare ital iano ad Addis Abeba, p. 297.
sSALETTA TANCREDI. tenente genera le, capo di Stato Maggiore dell'Esercito (1.6.1896-27.6 .1 908) , p. 107.
SALZA SI LVIO, cap it ano di vascello, capo del IO Reparto (Operazioni) dell'Ufficio del capo d i Stato Maggiore della Marina, pp. 93, JOln, 103.
SANTIN I RUGGERO, generale di brigata , capo del Reparto Ordinamennto e Mobilitazione dello Stato Maggiore dell'Esercito, pp. 95, 60n, 61, 62n, 63, 66n, 67, 69n, 7 1, 74n, 81, 89, 91n.
SANTORO GI USEPPE, generale di brigata aerea, capo del I 0 Reparto -Operazioni de ll o Stato Maggiore dc li ' Aeronautica, p. 377.
SAPORITI MA URIZIO, p. 42n.
SCARELLI C ESARE, colonnello, capo dell'Ufficio Trasponi dello Stato Maggiore dell'Ese rcito, pp. 128, 129n, 139, 141, 143 , 144, 147, 148, 149, 150, 164, 165.
RAVAGLJ P ERI CLE, tenente colonnello d'aeronautica in servizio presso l'Ufficio del capo di Stato Maggiore Generale, p. 419.
RJCCARDI ARTURO, capitano di vascello in servizio presso l'Ufficio del capo dello Stato Maggiore della Marina. p. 75.
ROATTA M AR IO, colonne ll o, capo del Servizio informazioni militari dello Stato Maggiore dell'Esercito ( 16.1.3 1.1 2. 1934), p. 303.
ROCHAT GIORGIO , p. 38.
RO EDER WILHELM , genera le magiaro, capo dello StaLO Maggiore ungherese, p. 3 15.
ROMERO FEDER ICO, generale di brigata, capo del --1 ° Reparto dello Stato Maggiore dell'Esercito, p. 413
ROSI Ezio, genera le di divisione, sottocapo di Stato Maggiore intendente dell'E se rc ito (20.10 .1936-31.11.1 937), p. 383.
S IRIANNI GI USEPPE, con trammiraglio, ministro della Marina (12.9.19296. 11. 1933), nel testo compare secondo questa dizione, pp. 259, 288.
SOLDATI ROBERTO, capi t ano di vascel lo, capo dell'Ufficio Informaz ioni dell ' Ufficio del capo di Stato Maggiore della Marina, p. 139.
STANZANI MARIO, colonnello d'aeronautica in se rv iz io presso lo Stato Maggiore del!' Aeronautica. pp. 129n , 156, 157, 158, 160, 169.
STEFANI FIUPPO, p. 38.
STRAZZERI GUSTAVO, capitano di vas ce ll o, capo in terinale dell'Ufficio de l capo di Stato Maggiore Generale, pp. 44 n.,327, 337, 344, 345
SUVlCH FULV IO, deputato, sottosegretario di Stato per g l i Affari Esteri (20.7 1932-1 1.6.1 936), pp. 295, 29511.
TELLERA GIUSEPPE, co lonn e ll o, capo dell'Ufficio Operazioni dello Stato
Maggiore dell"Esercito, pp. 181, 183. 201.
TERUZZI ATT ILIO , luogotenente generale, capo di Stato Maggiore della Milizia Volontaria di Sicurezza Nazionale. pp. 359, 365.
THAON DI REVEL PAOLO, senatore, ministro del le Finanze (24.1. 19356.2.1943), nel testo compare secondo questa dizione, p 374.
TORRETfA ALFREDO, generale di divisione, direttore superiore delle costrulioni di artiglieria del Ministero della Guerra, pp. 74, 81. 89, 91n.
TOSELLI L u 1G1. colonnello. capo del Servizio Informazioni dello Stato Maggiore tlell'Esercito, pp. 12911 , l 31.
TRADITI ALES SA 'IDRO. luogotentente generale. so11ocapo di Stato Maggiore della Milizia Volontaria di Sicurezza NaLionale, pp. 359, 365.
VACCA MAGGIOLINI ARTuRO, generale di brigata in servizio presso lo Stato Maggiore de ll 'Esercito. pp. 139, 175.
VACCARISI ACIIILLE, colonnello capo dell'Ufficio Servizi dello Srnto Maggiore dell'faercito, pp. 124, 126, 127.
128, 129n, 131, 132, 133, I 34, 135,
136. 137, 138. 150, 151, 163, 181 , 183, 184, 201.
VALLE GIUSEPPE, generale di brigata aerea e sottocapo di Stato Maggiore dell'Ae ronautica, generale di armata aerea. sottosegretario di Stato alt' Aeronautica (6.11.1933 - 31.1 O. 1939) e capo dello Stato Maggiore dell'Aeronautica (22.2.1930-6.11.1933 e 22.3.
1934- 10.11.1939), pp. 20 I, 205, 206, 207, 215, 217, 218, 221, 230, 231,
286, 287, 289, 291. 293. 293n, 297. 303, 305, 307, 309n,3 l I, 3 I 2, 3 13, 3 15, 3 1611, 3 17, 318, 325, 327, 328. 329, 330, 333. 334. 337, 338, 339, 34-0. 341, 345, 348. 350. 359. 365. 366, 367. 369, 377. 378, 381, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 399, 400, 401. 405. 408. 4 13, 414, 4 15, 416. 417. 419. 421. 423. 424. 425. 426. 427.
VALLI G1t 11.10. contrammiraglio, sottoca po di Staio Maggiore della Marina, pp. 175. 195. 201. 209,2 15,218.221, 226. 232. 235.
VANNUTELLI G u mo. ammiraglio d1 divisione, so11ocapo di Stato Maggiore della Marina, pp. 297, 308, 309 , 309n. 311. 315. 316n. 317,325,327, 333. 337. 345. 370. 371.
VALORI PIAZZA AsGLLO, capitano tli fregata, capo dell'Ufficio Piani Operazioni de ll o Stato Maggiorte della Marina. p. 419.
VIALE CARLO. tenente colonnello in ,ervizio presso lo Stato Maggiore dell'Esercito. p. 20 I.
VISCONT I PRASCA Sl·BASTIANO, co lonnello poi generale tli brigata. capo dell'Ufficio <.lei capo di Stato Maggio re Generale (ott.1933 -dicembrel 943). pp. 43, 93, 99, 101. 295, 311, 316n. 3 17,359. 365, 4 39-440.
VITTORIO EMANUELE m SAVOIA. re d' Italia. nel testo compare secondo questa di,ione. pp. 18. 24. 27. 28. 30. 32.
WRANGEL PETR NIKOI.AEVJC ( 18781928). generale controrivoluzionario russo, p. 96.
ZOGU Ahmed, presidente della Repubblica albanese poi re d'Albania (1.9.192812.4. 1939), con il nome di Zog I, p.95.