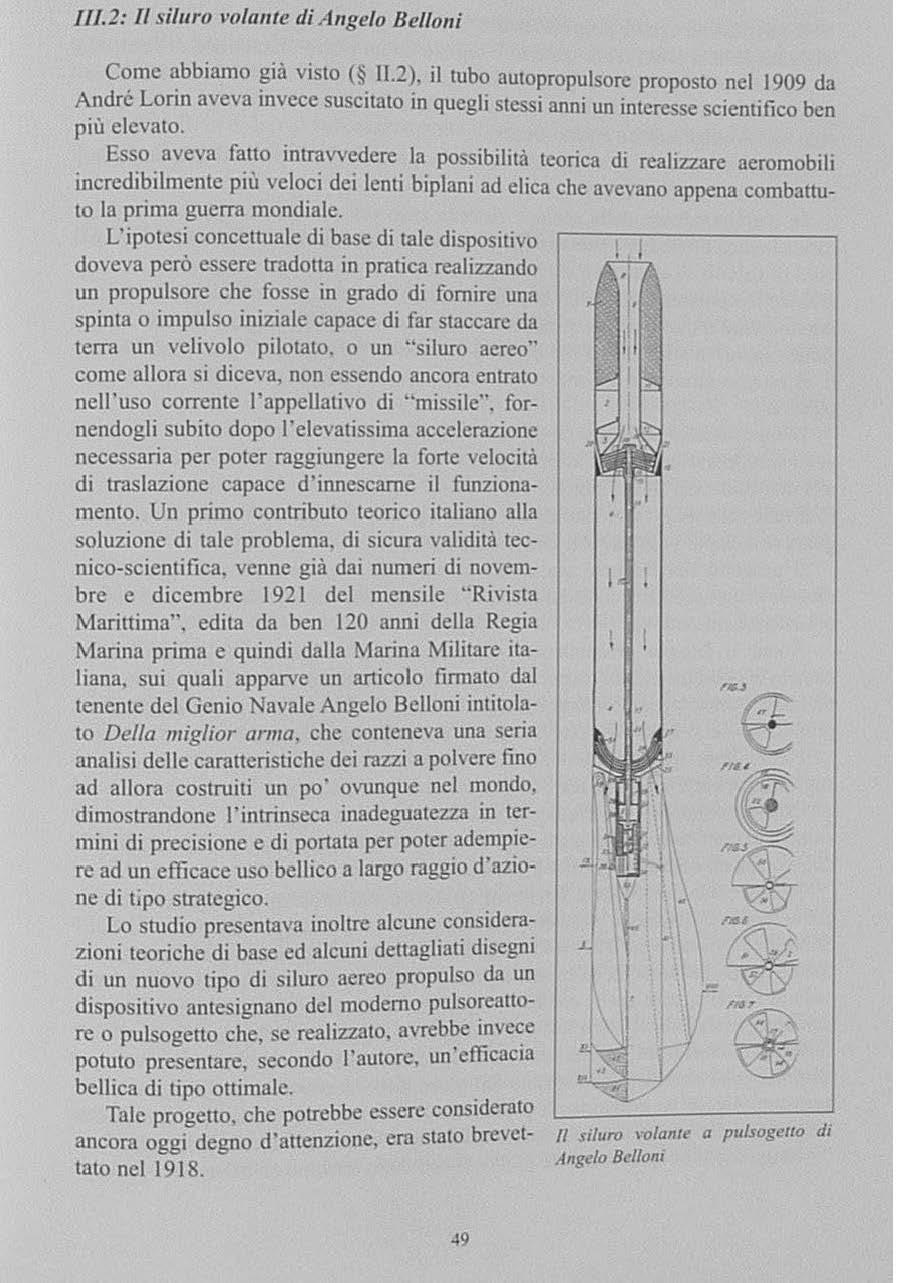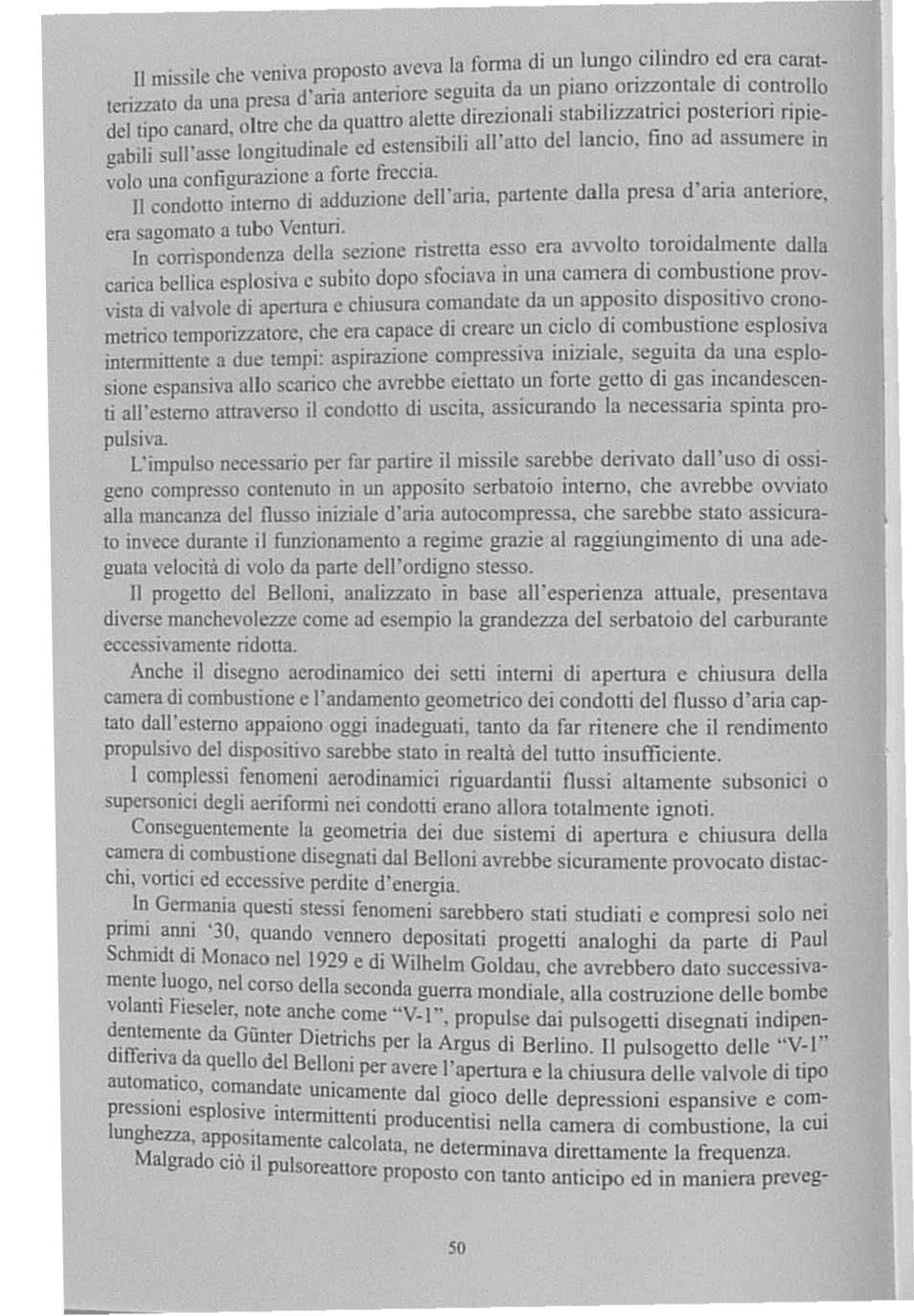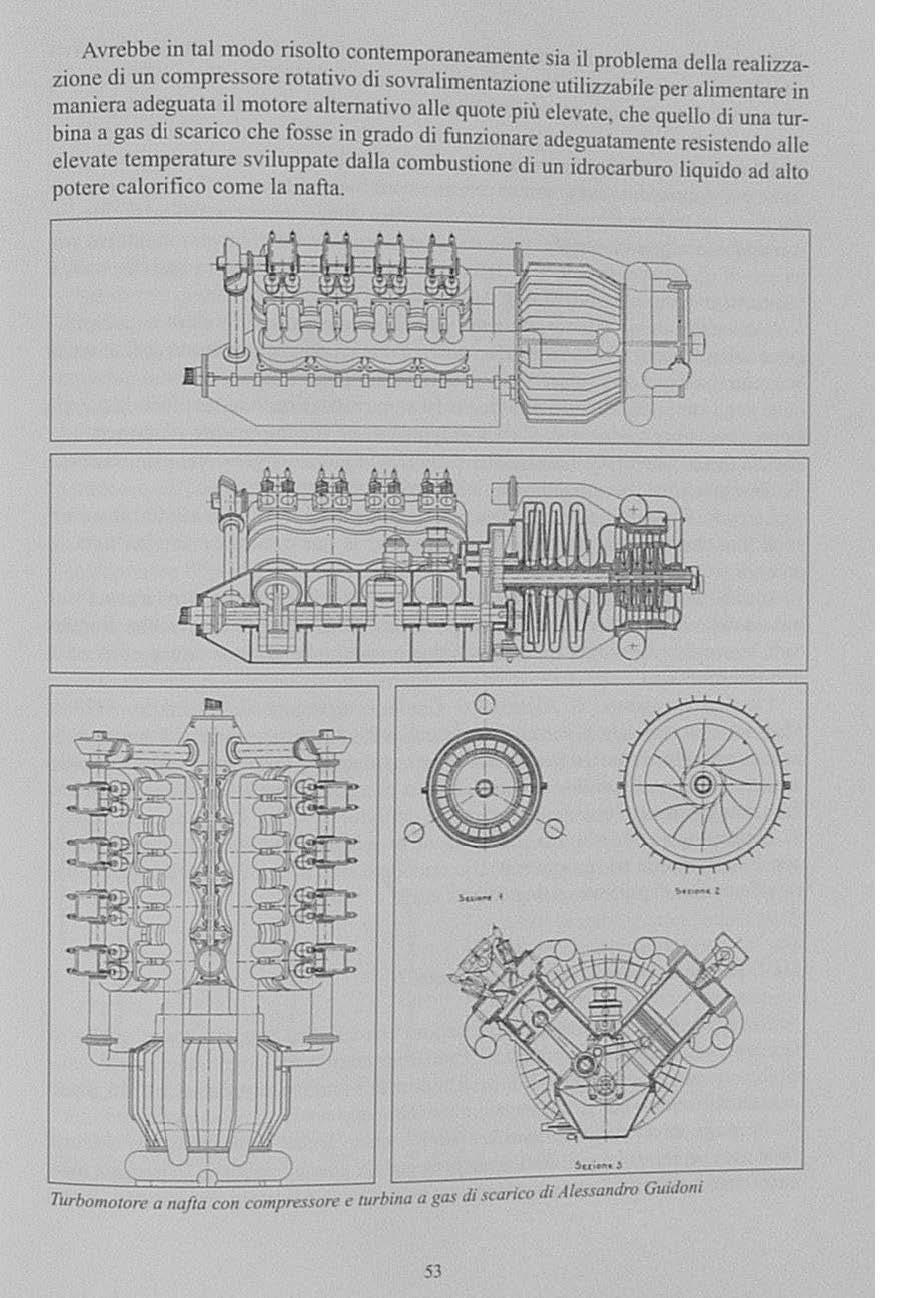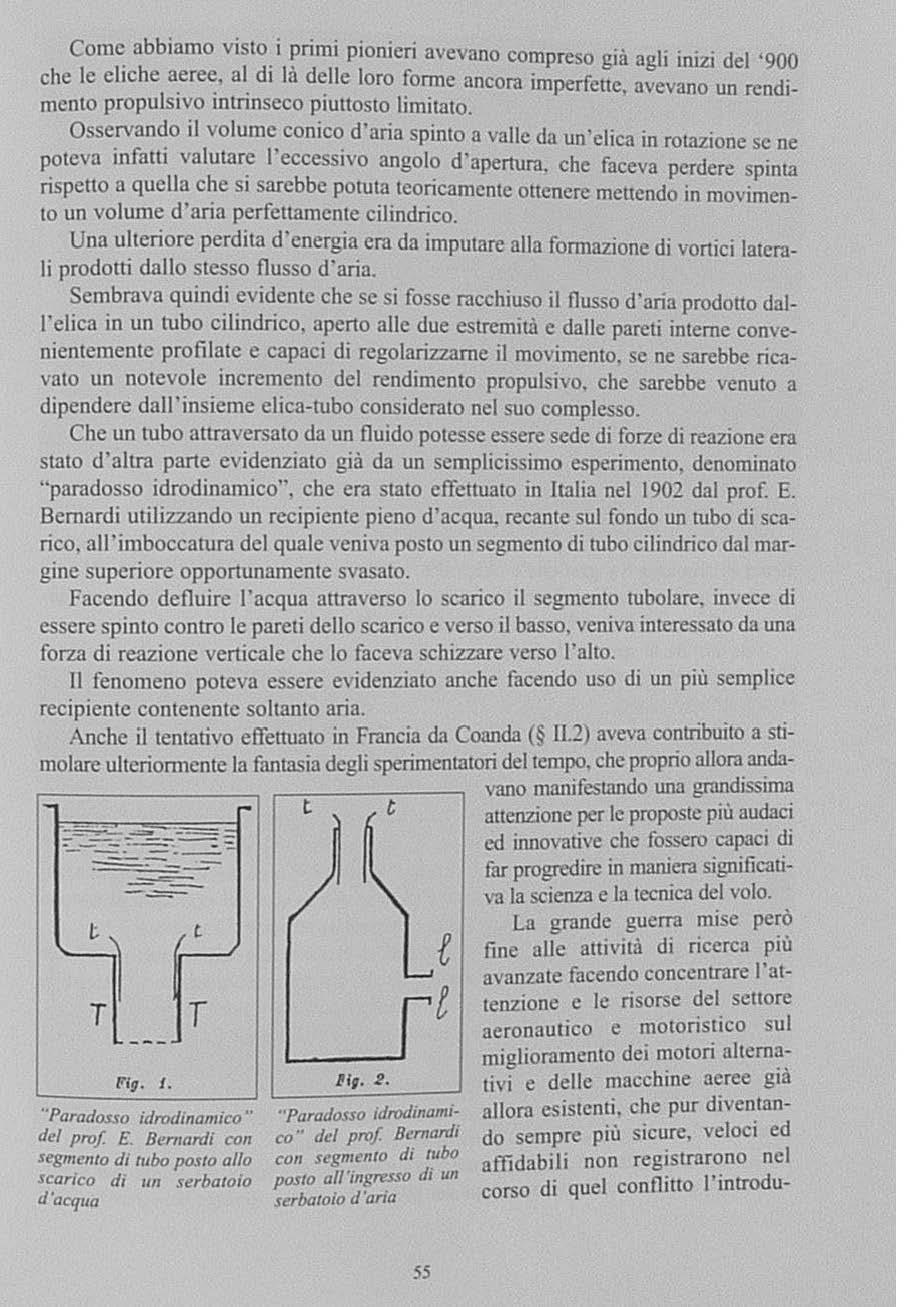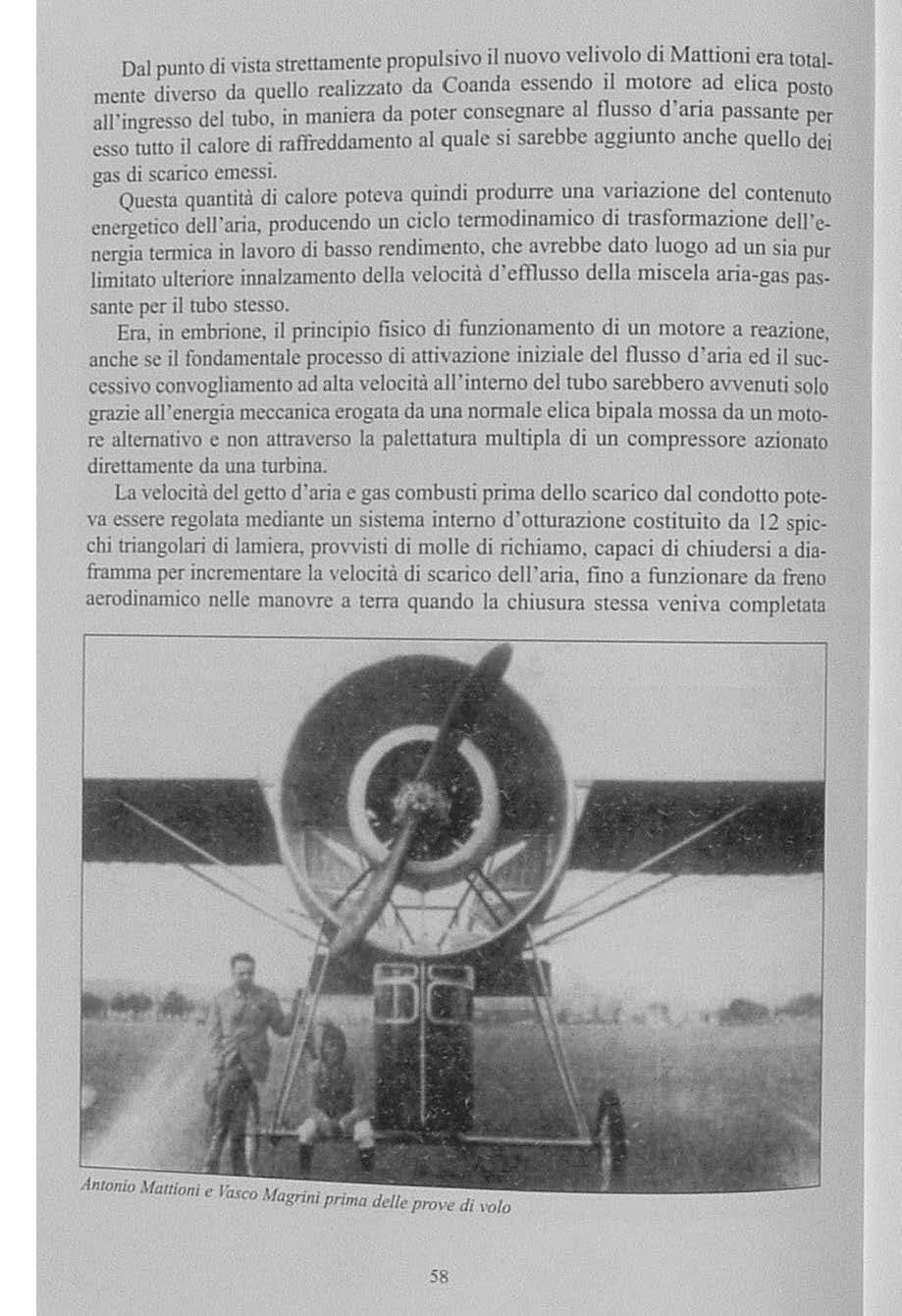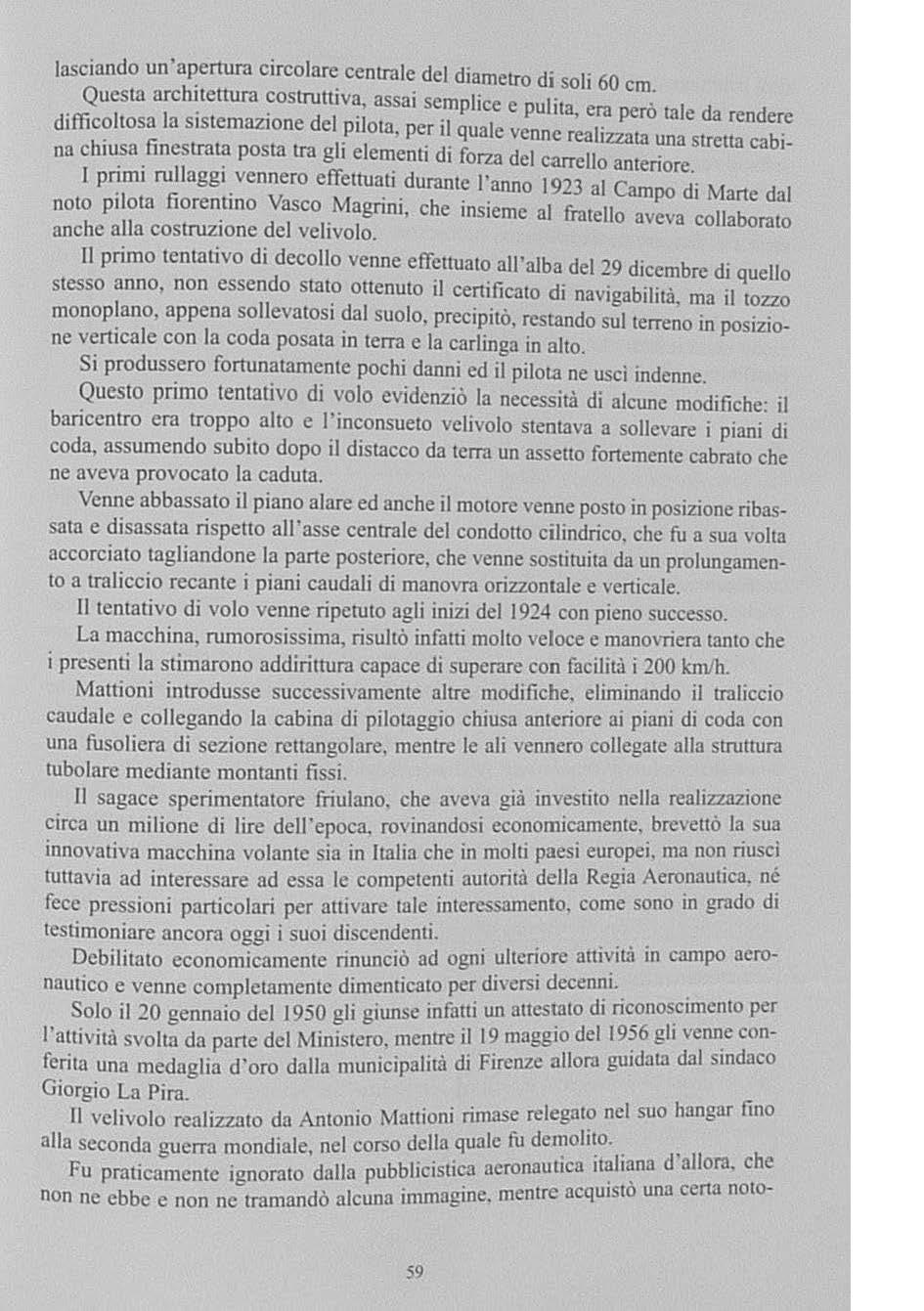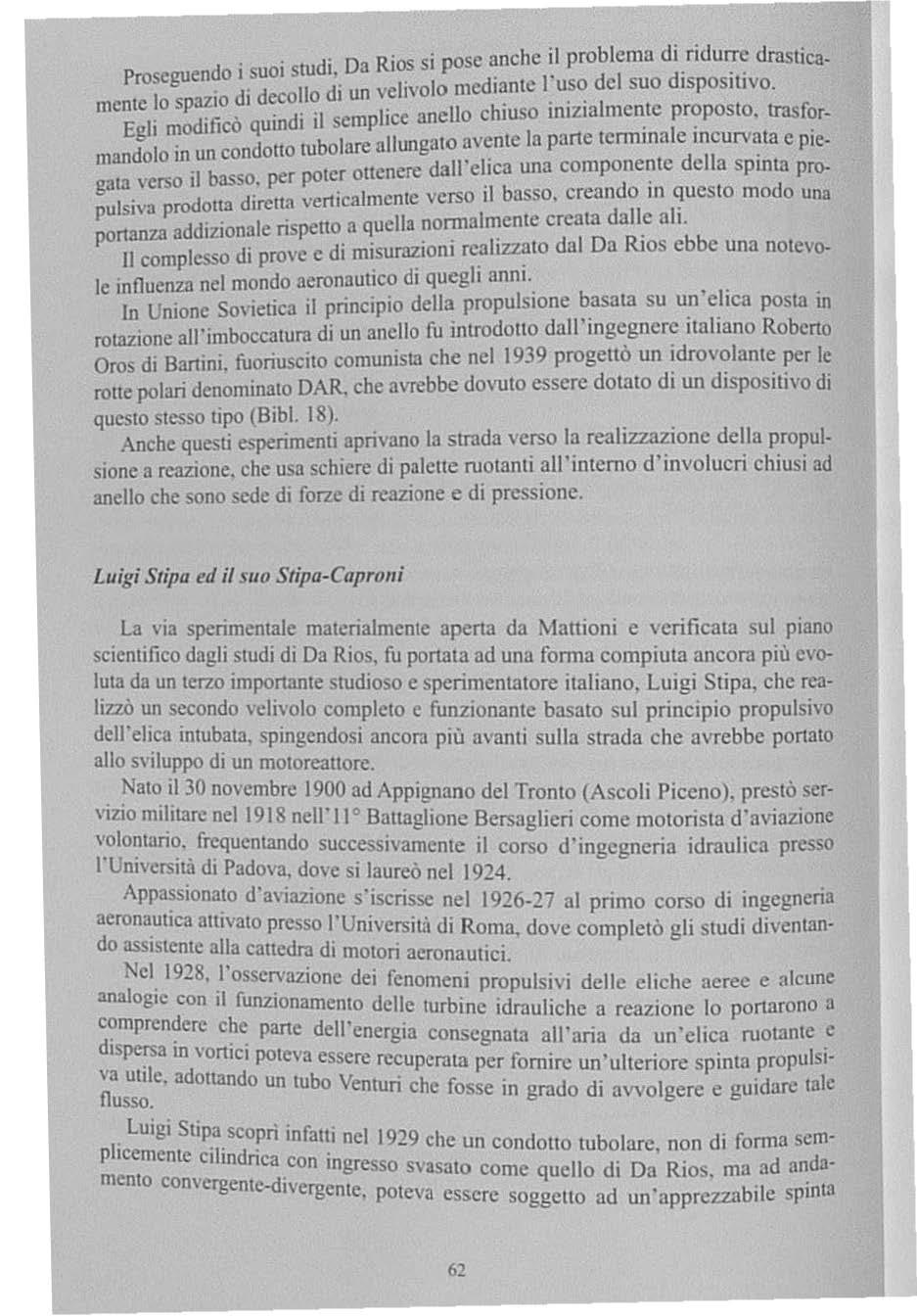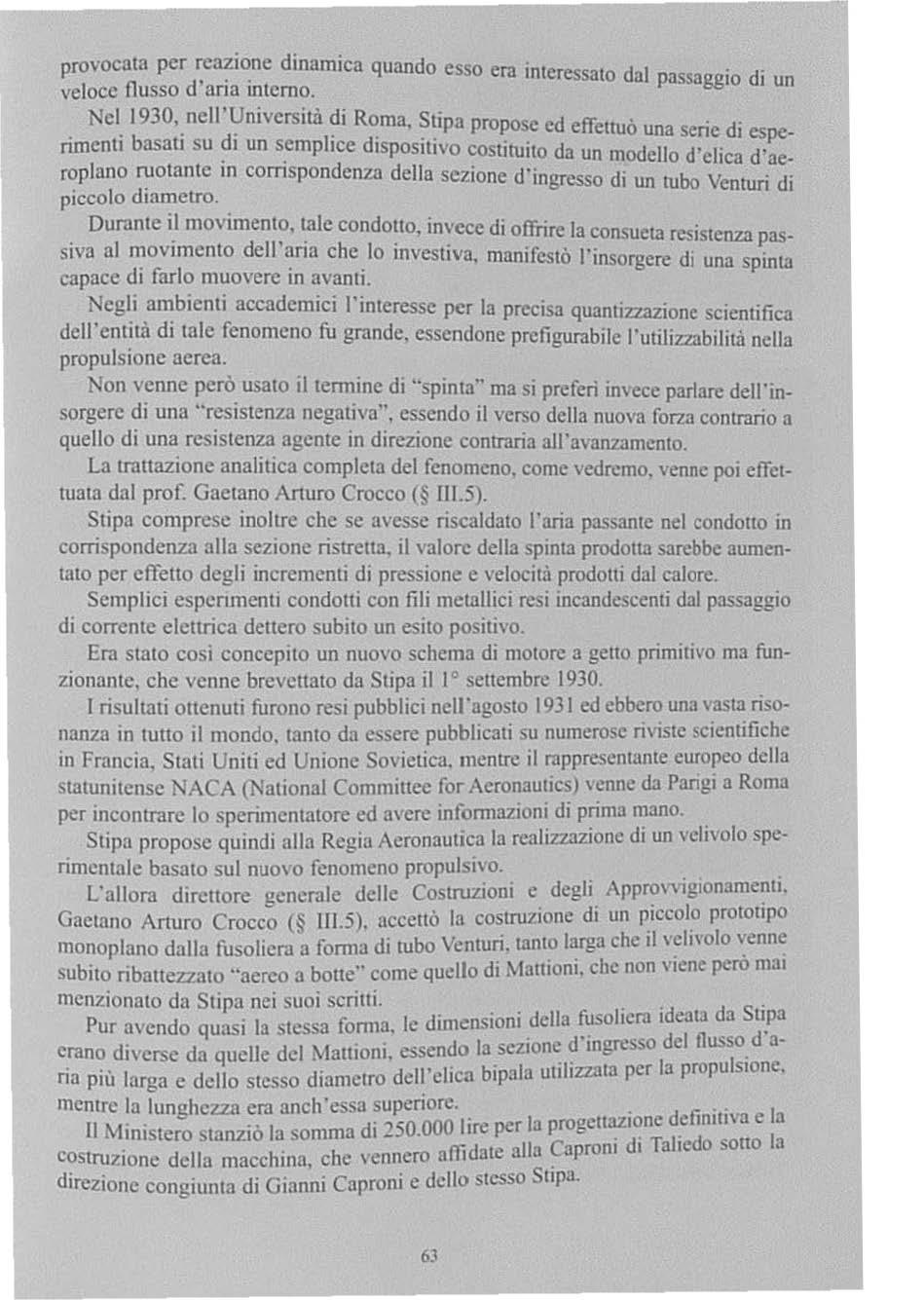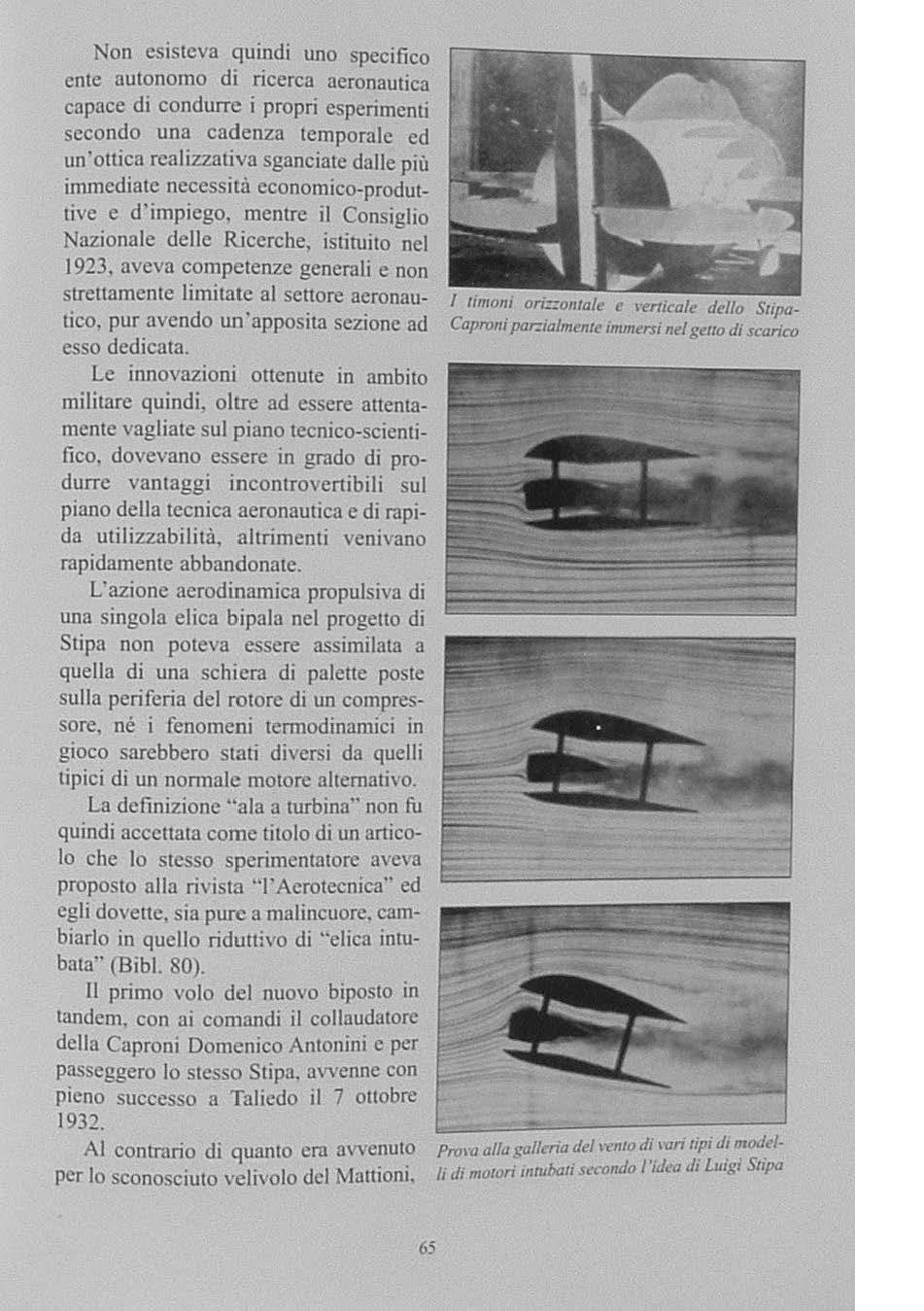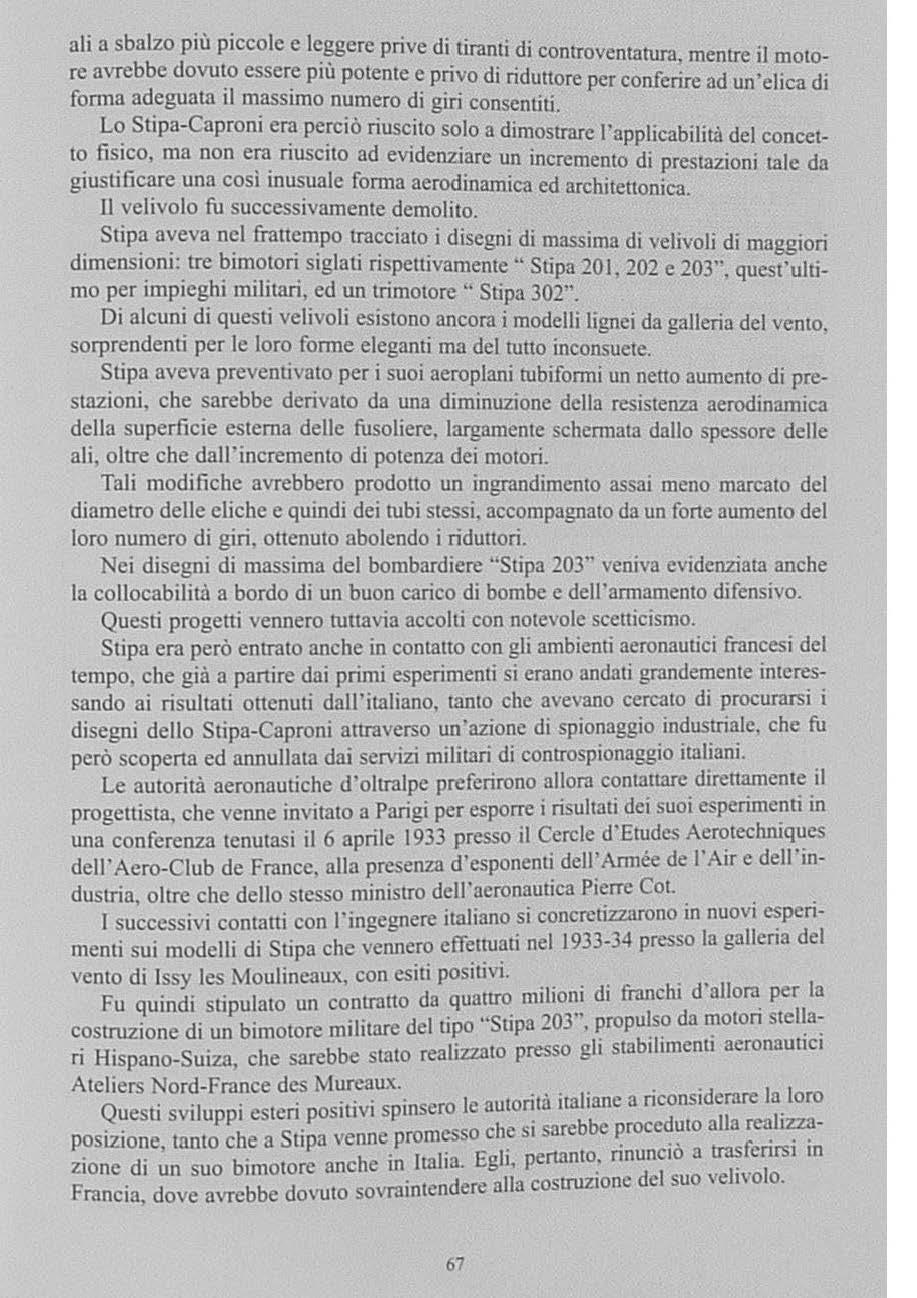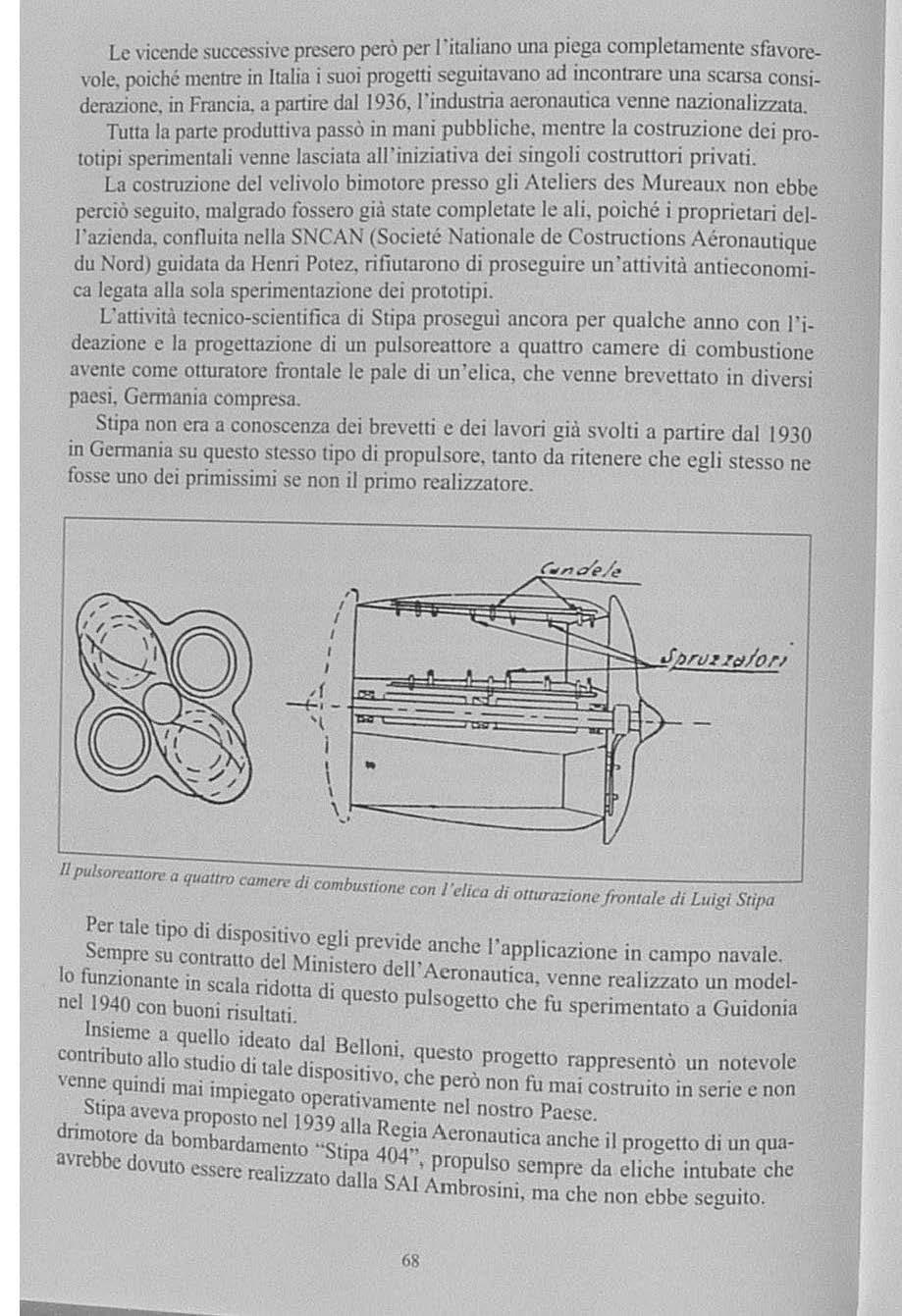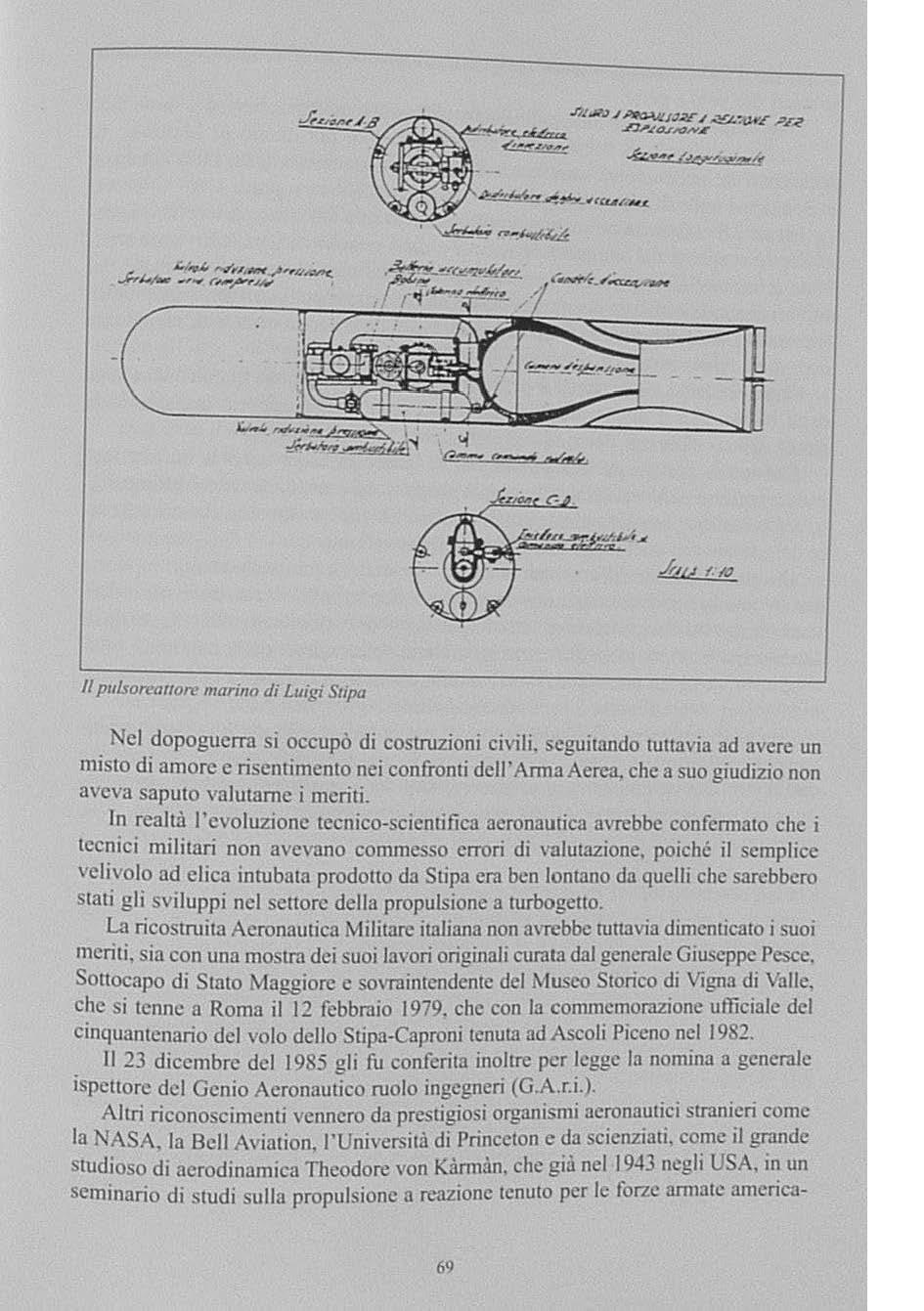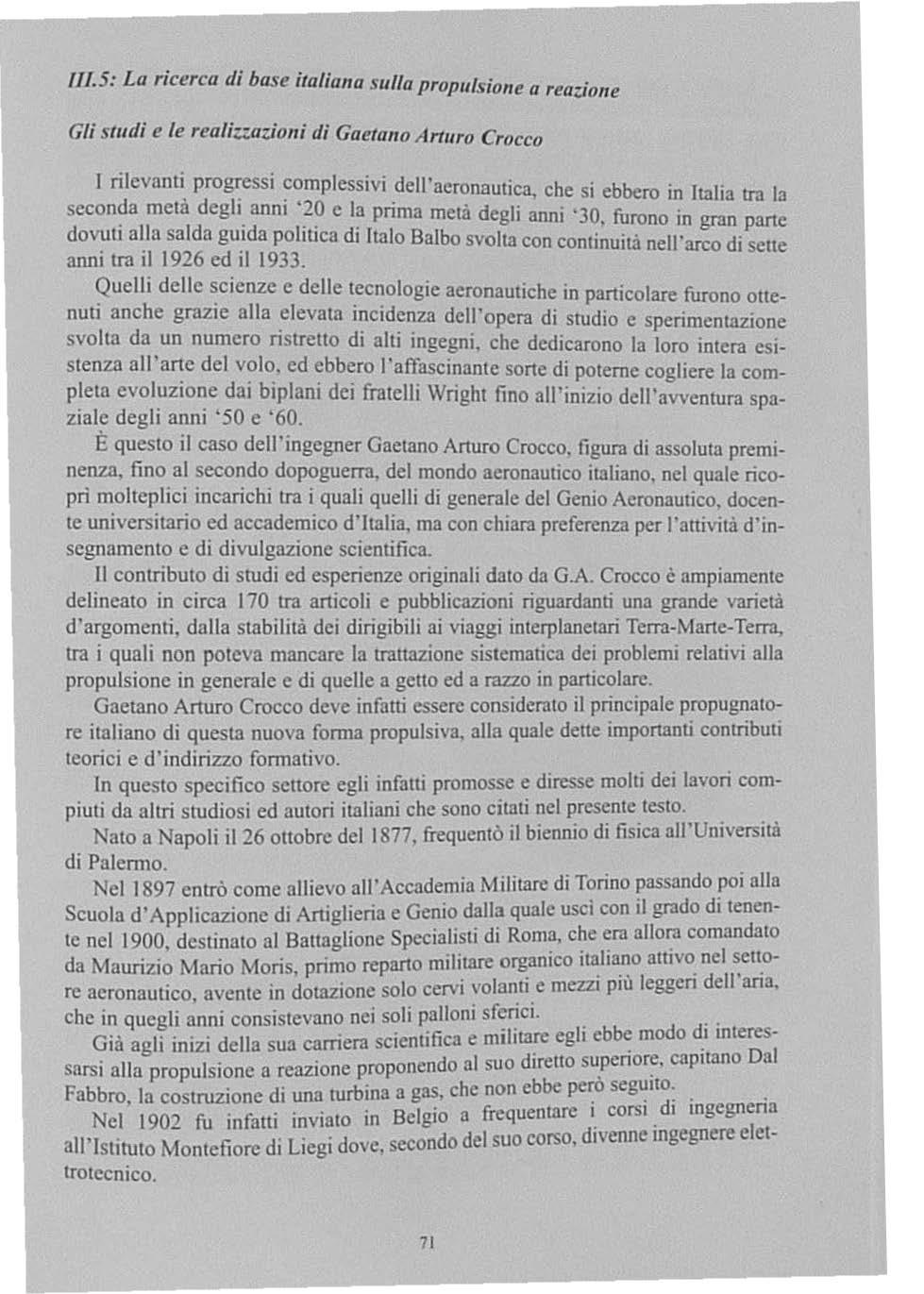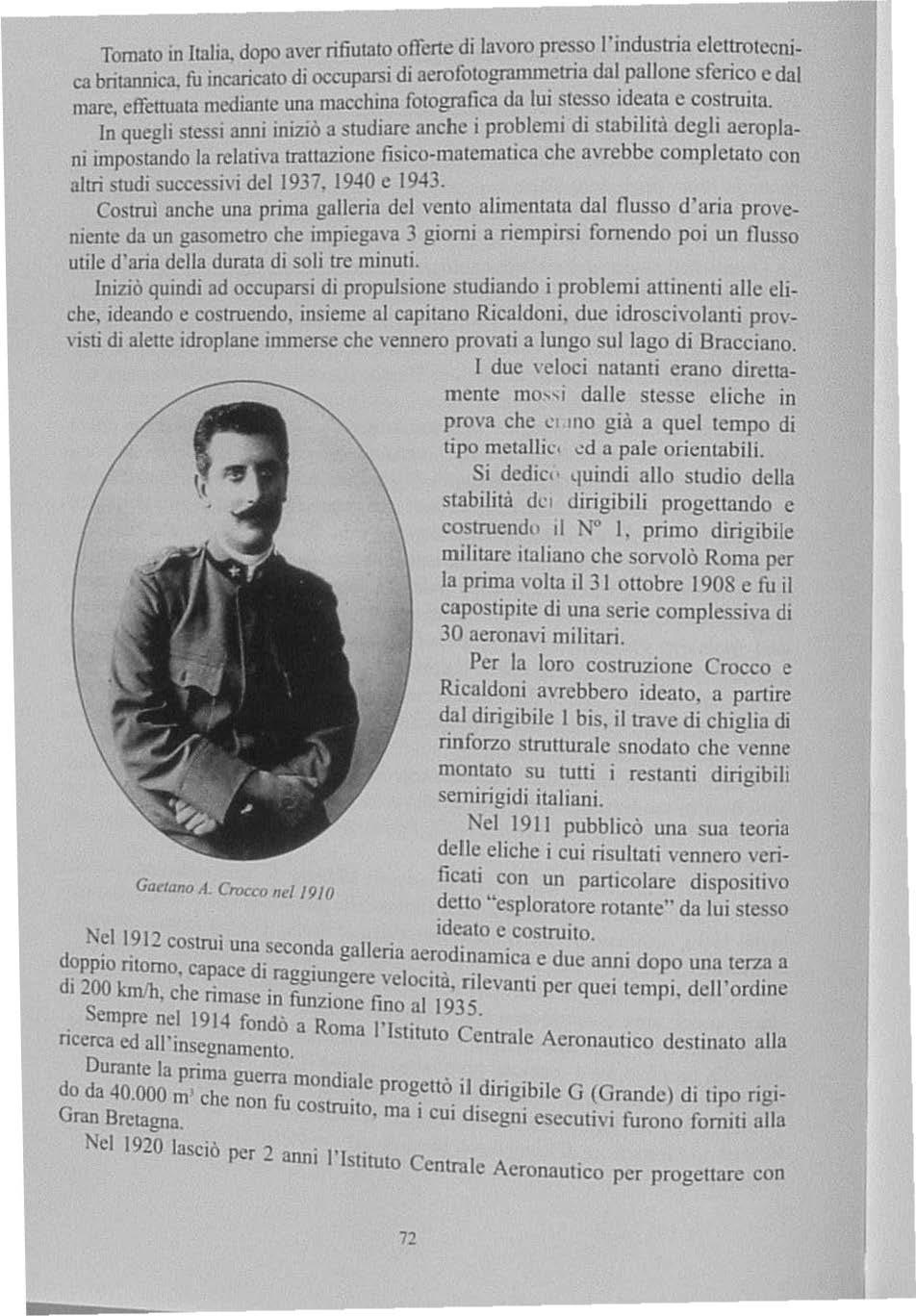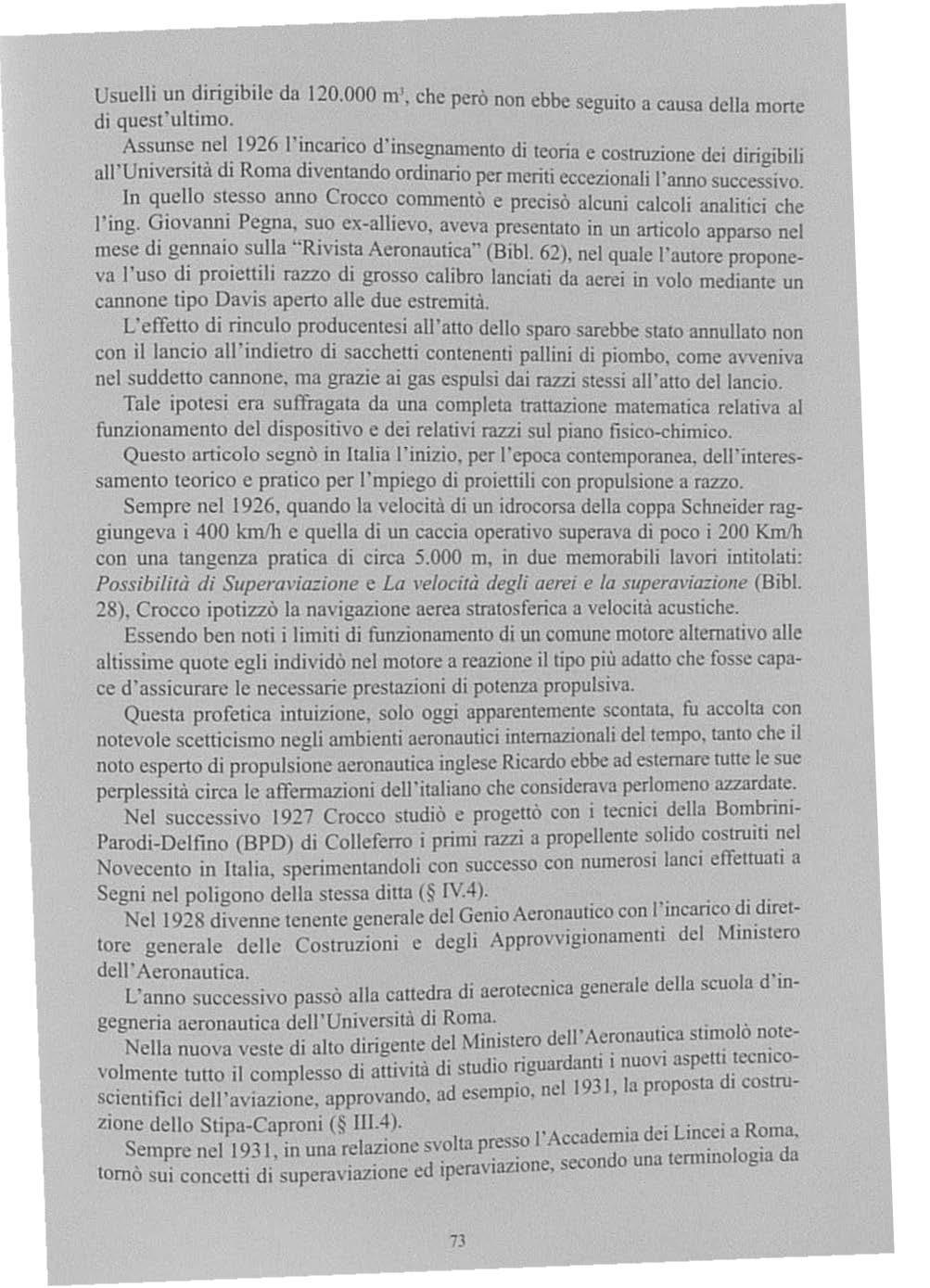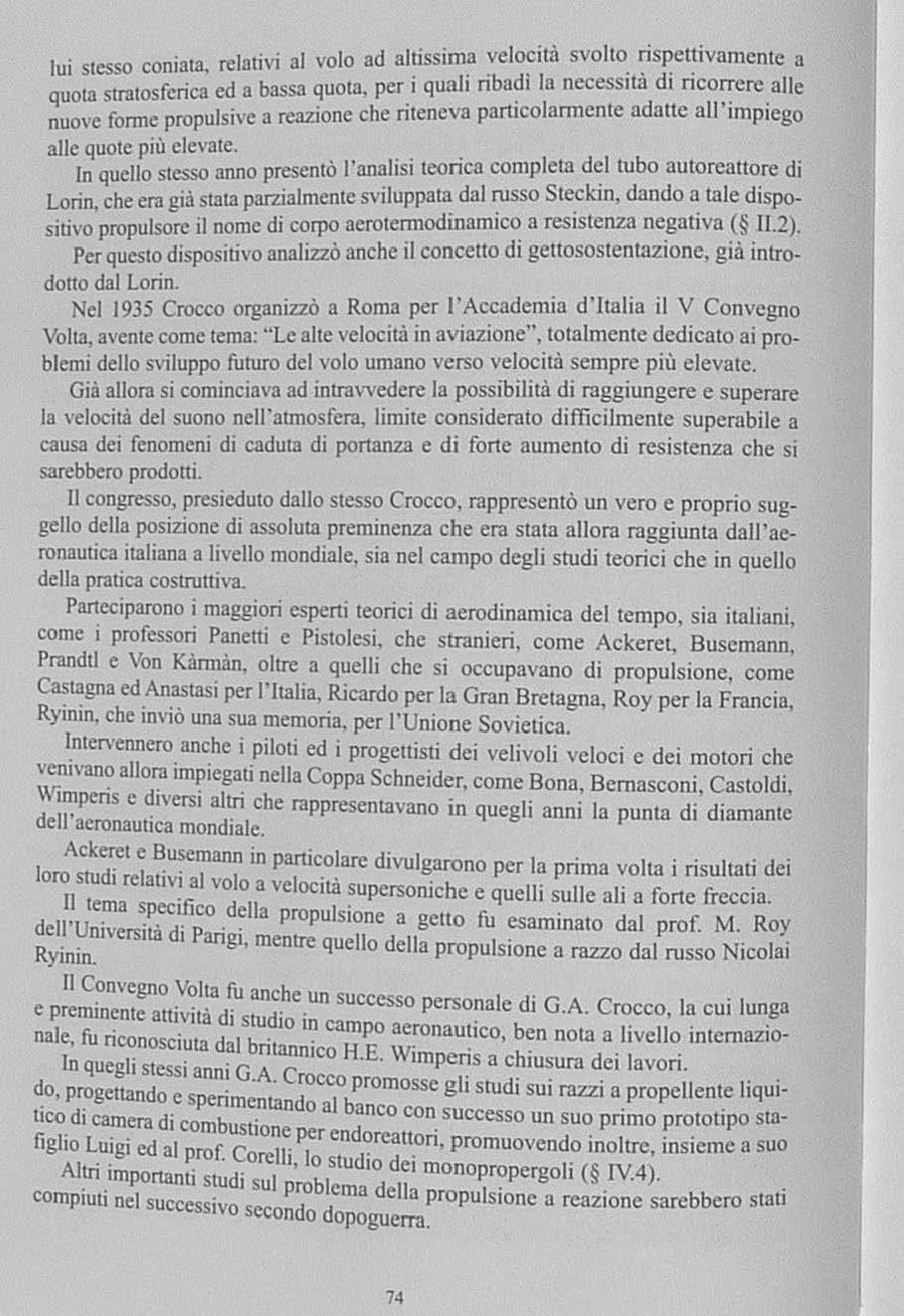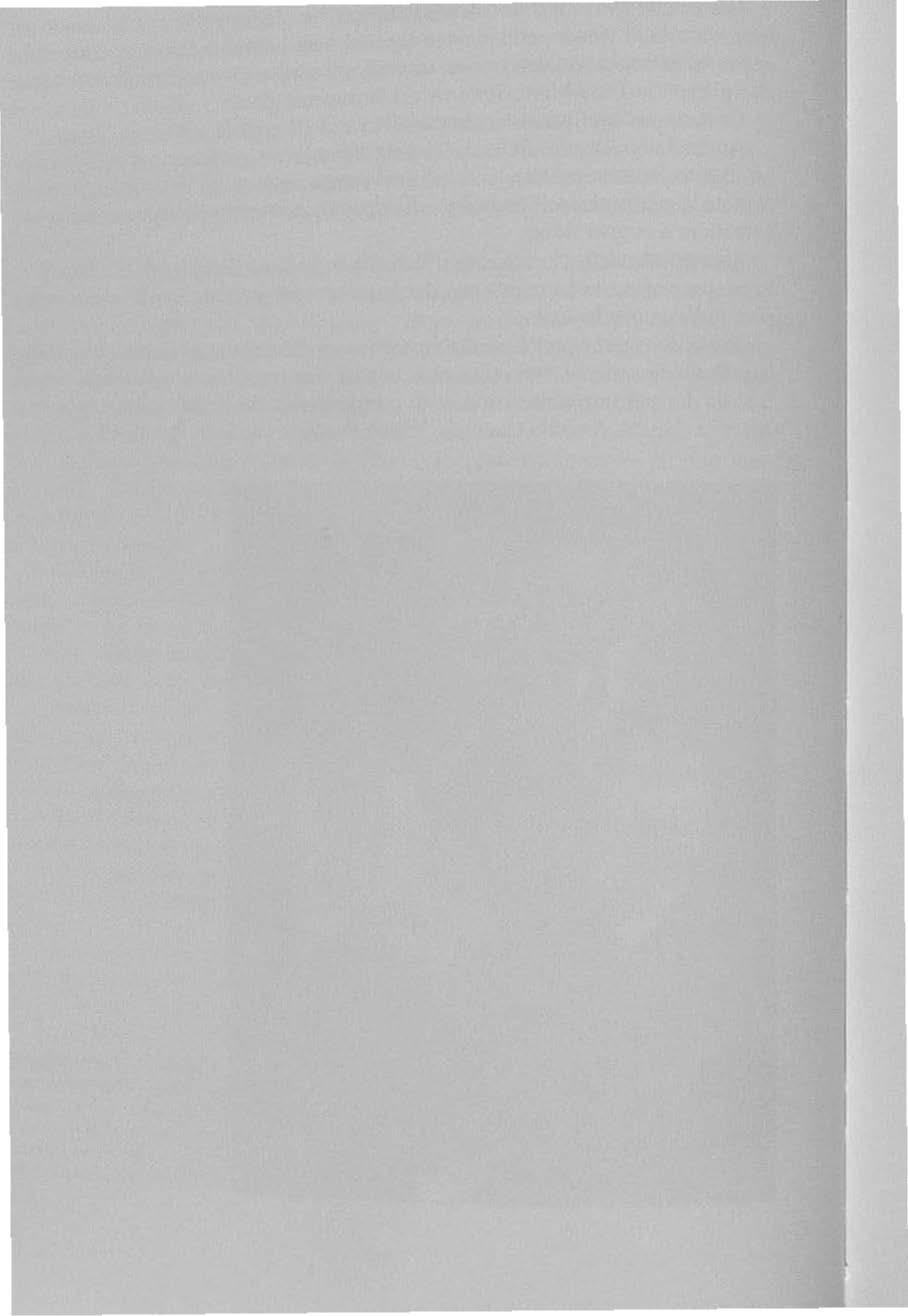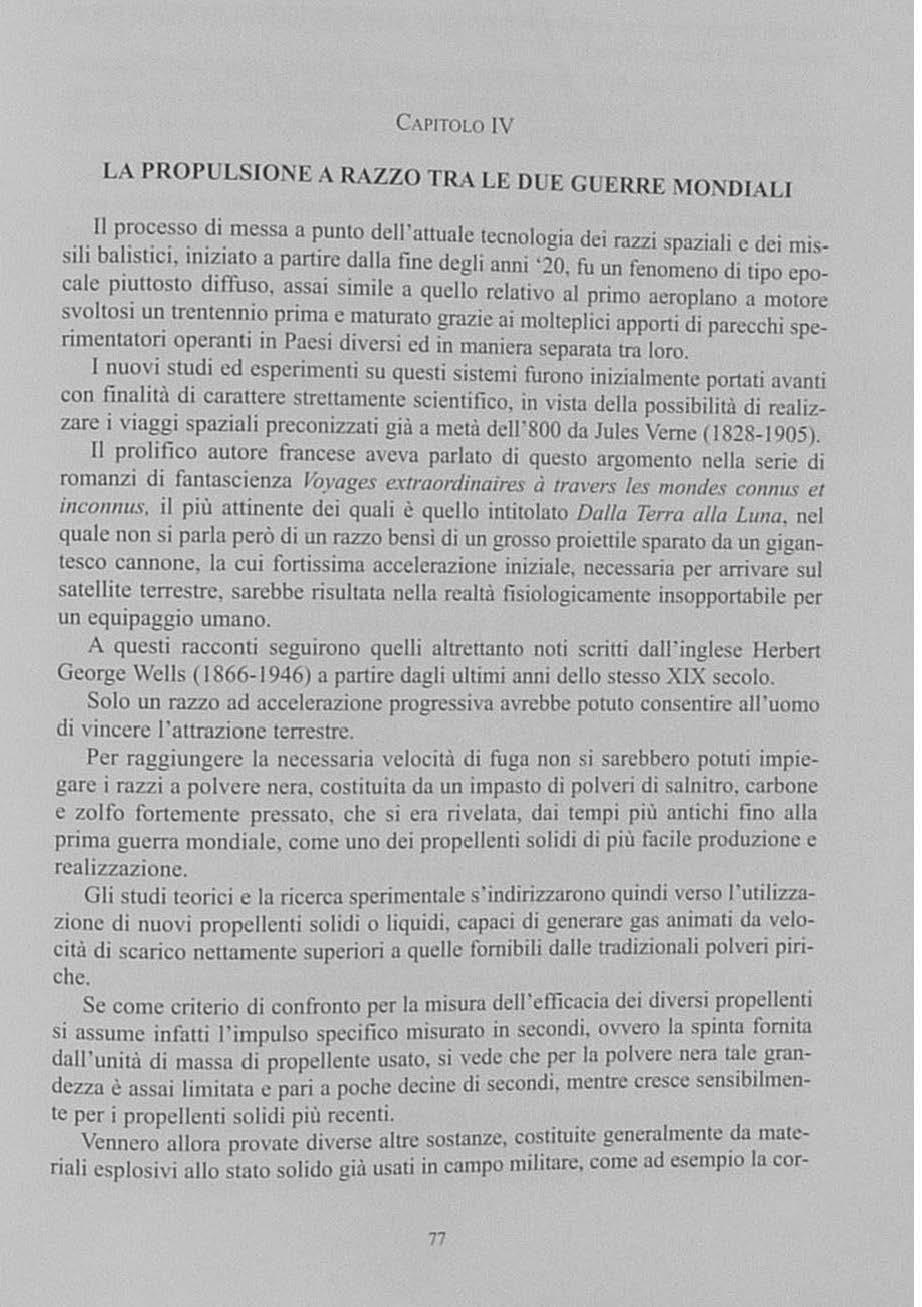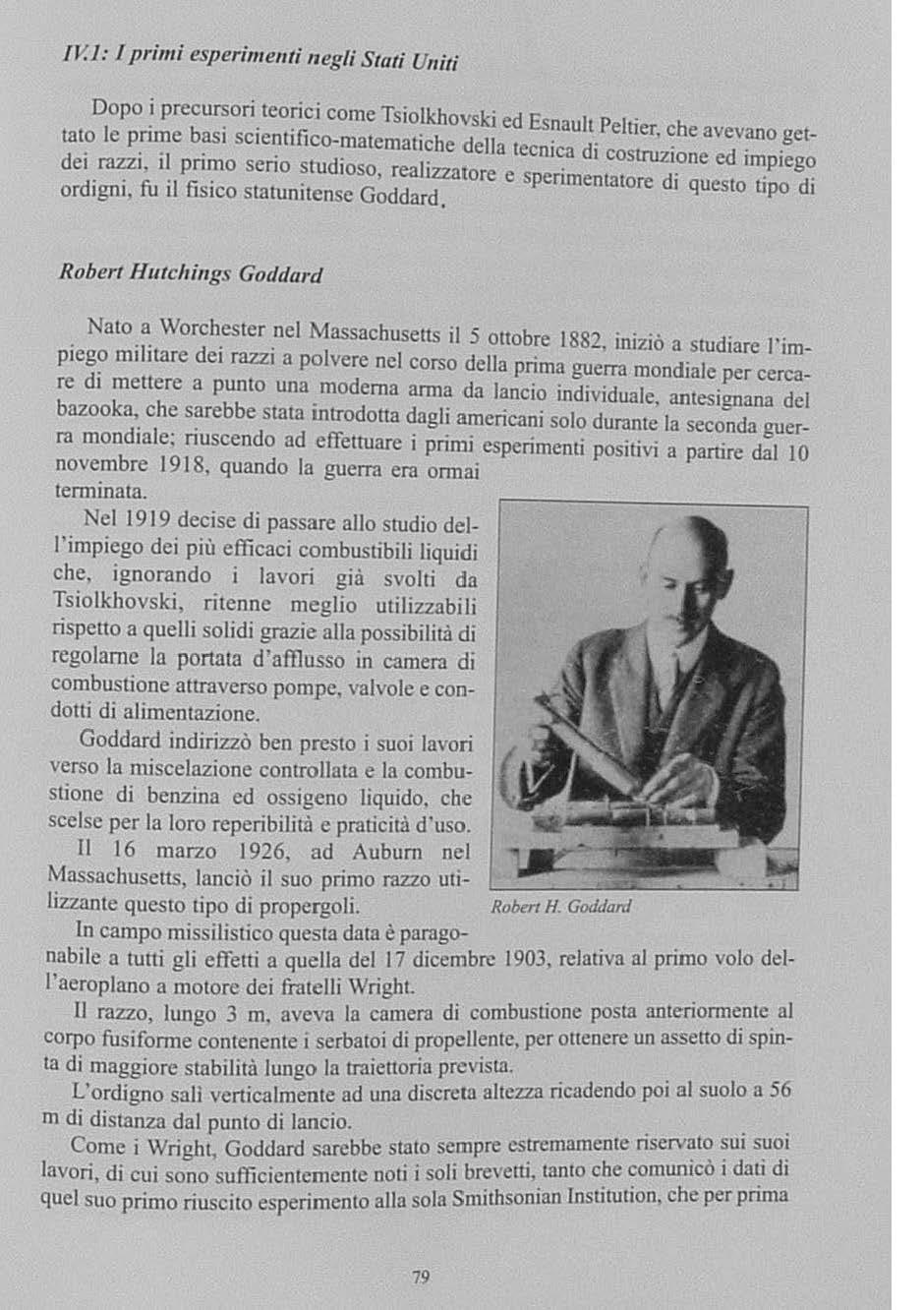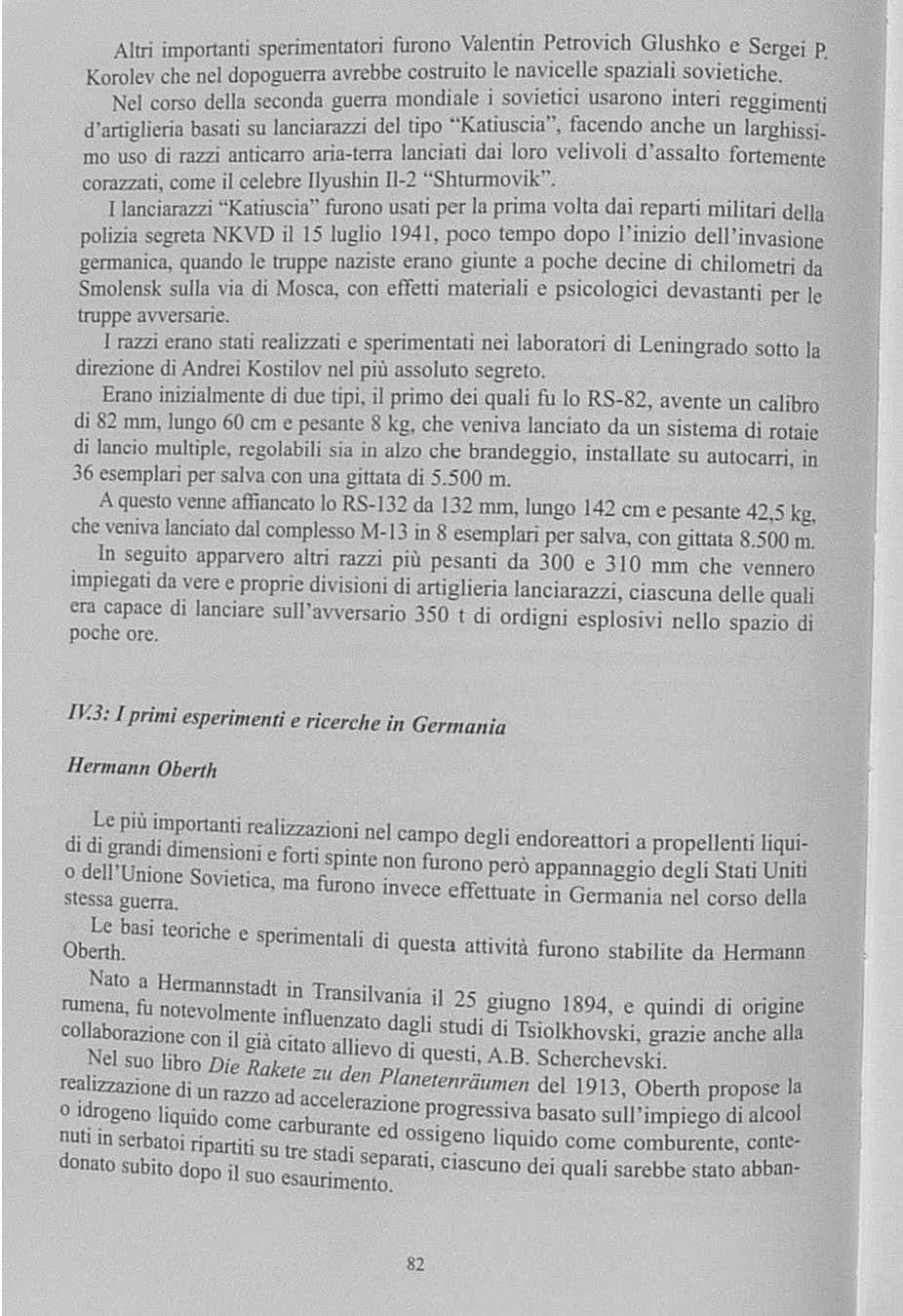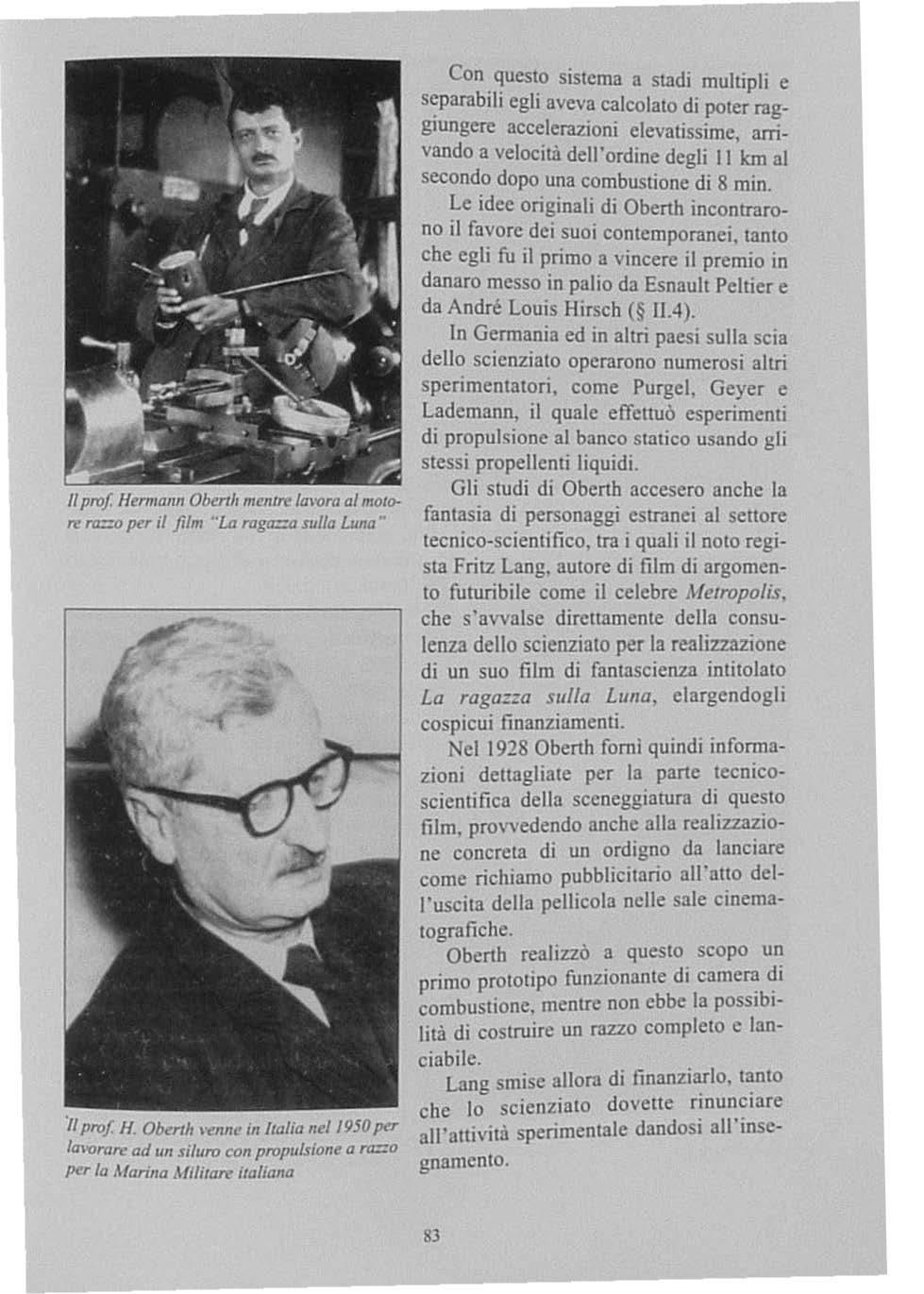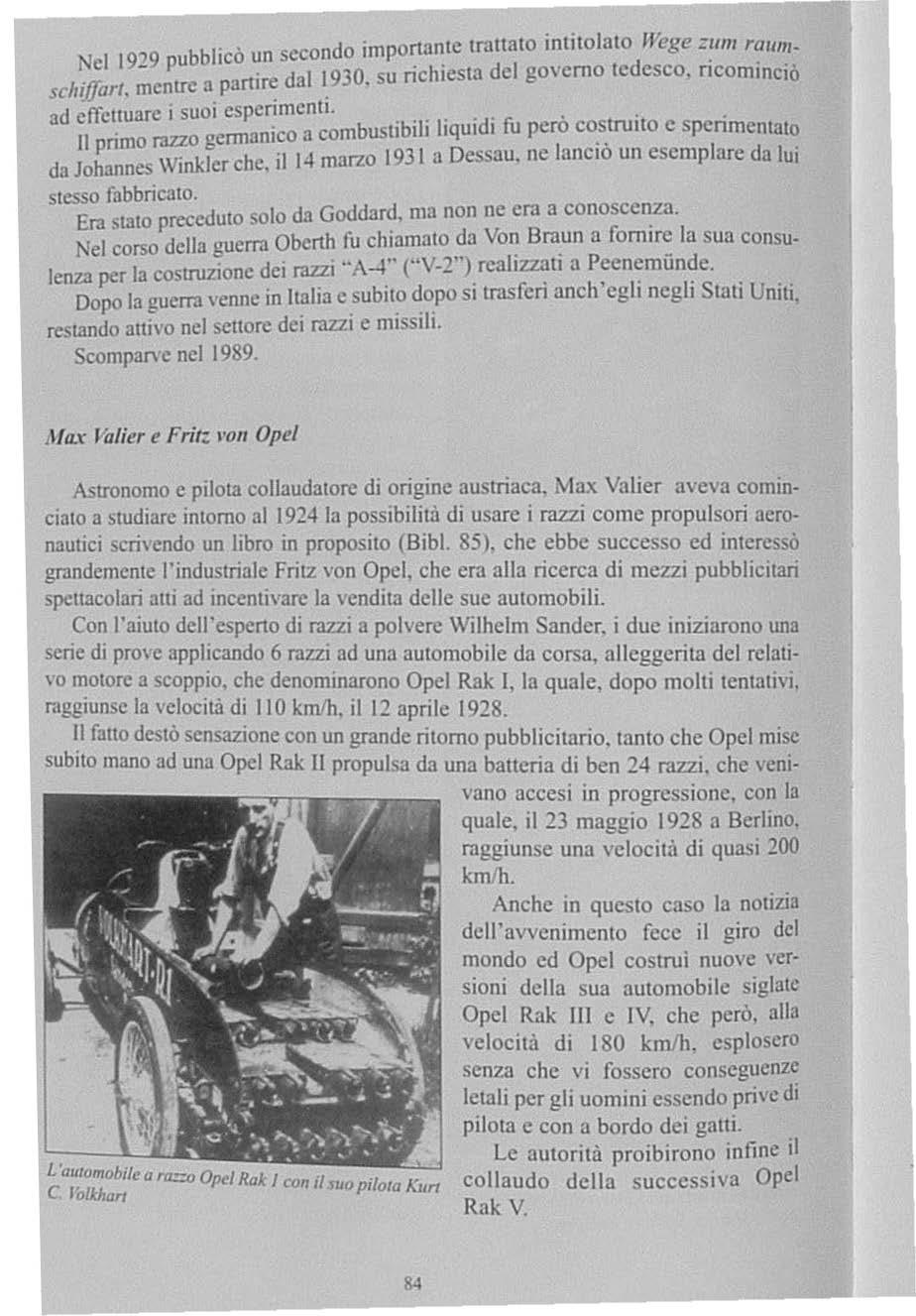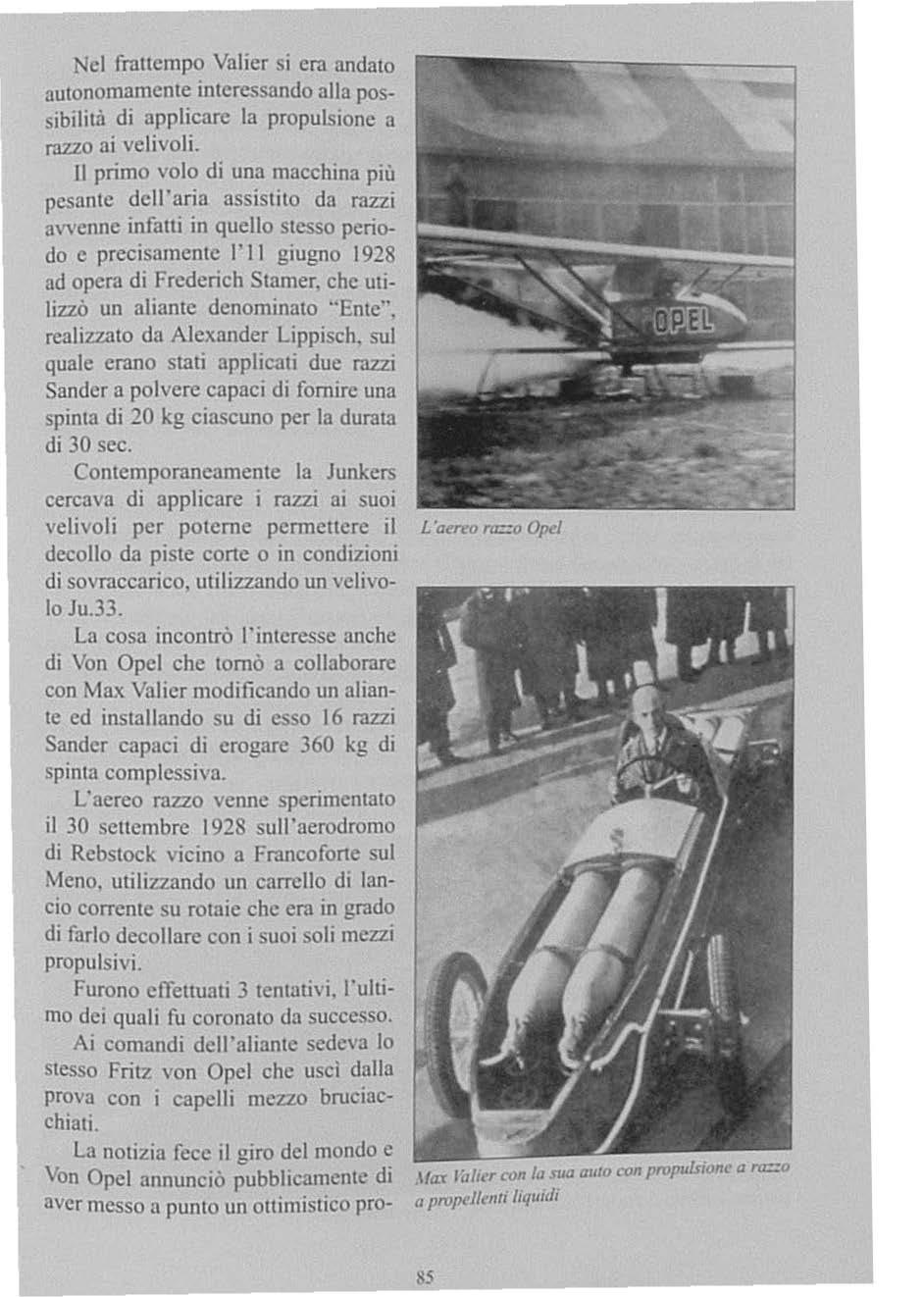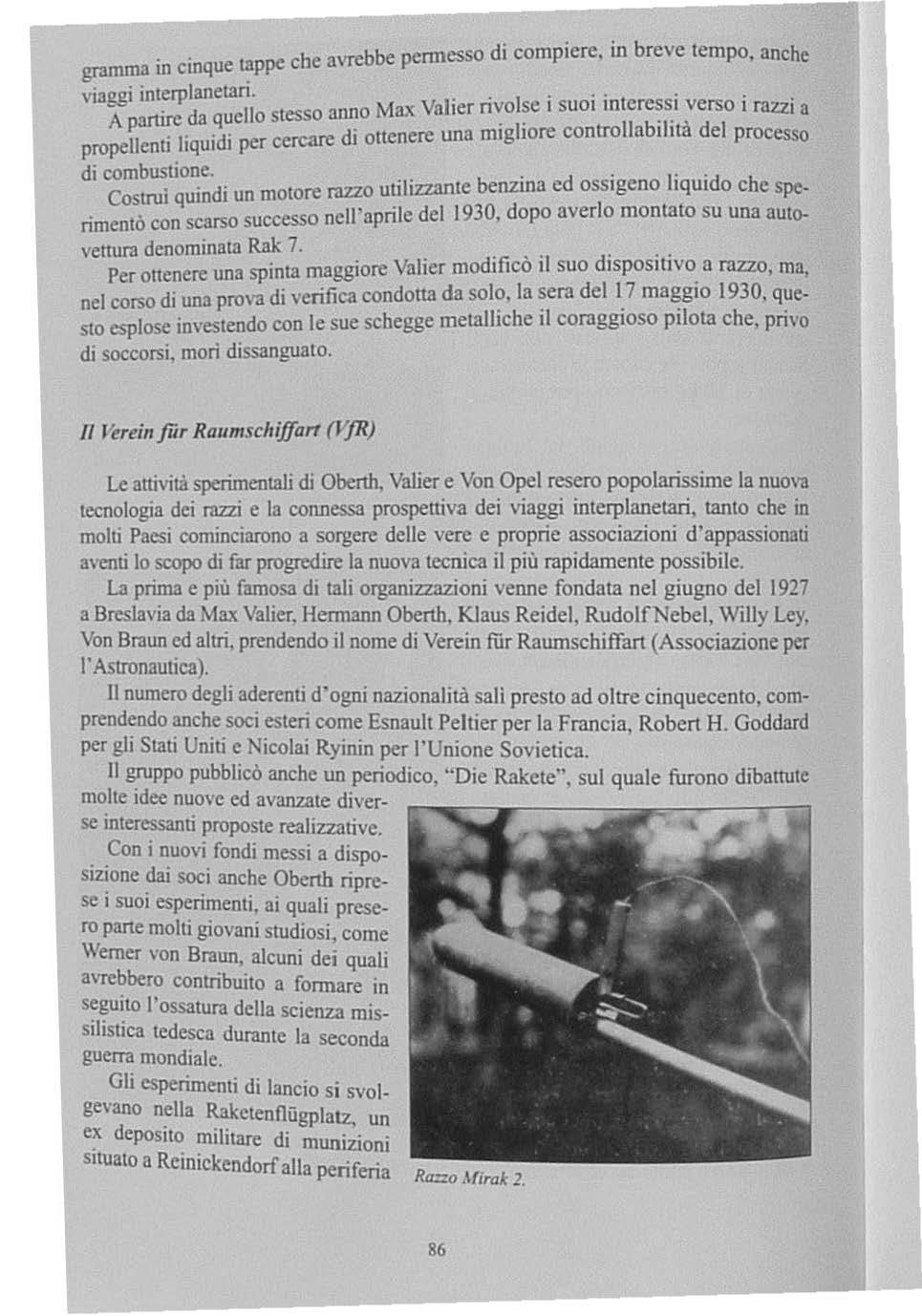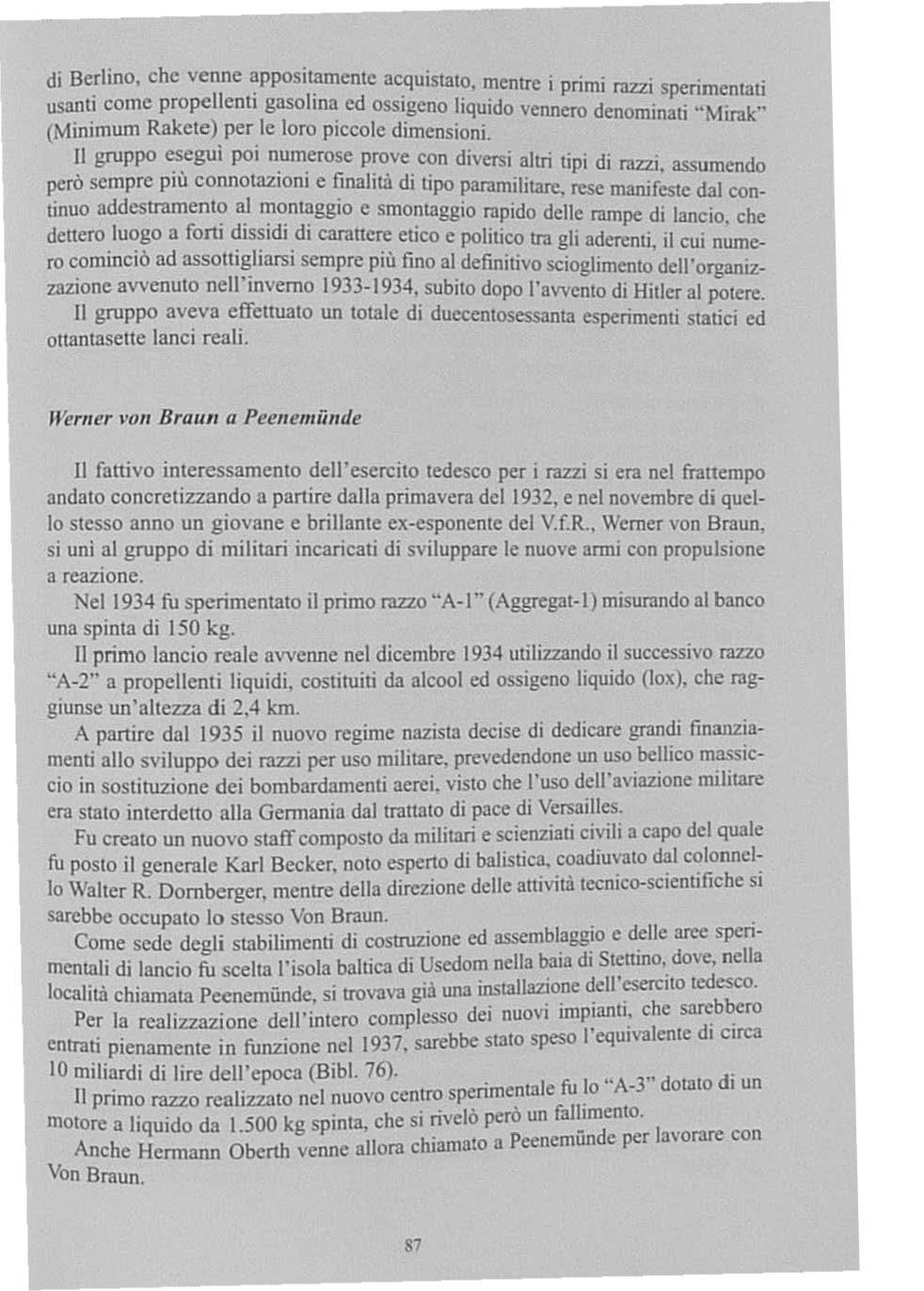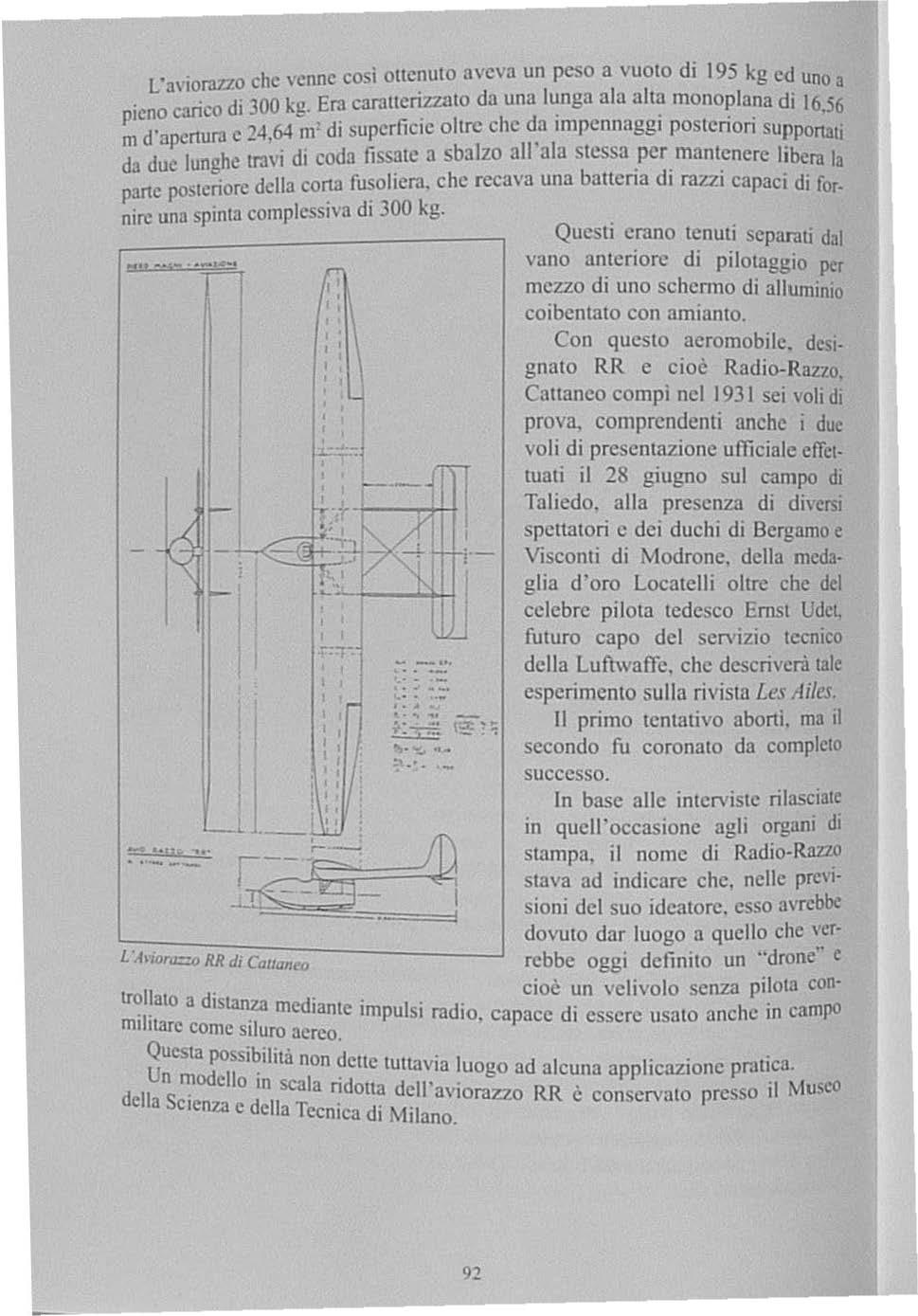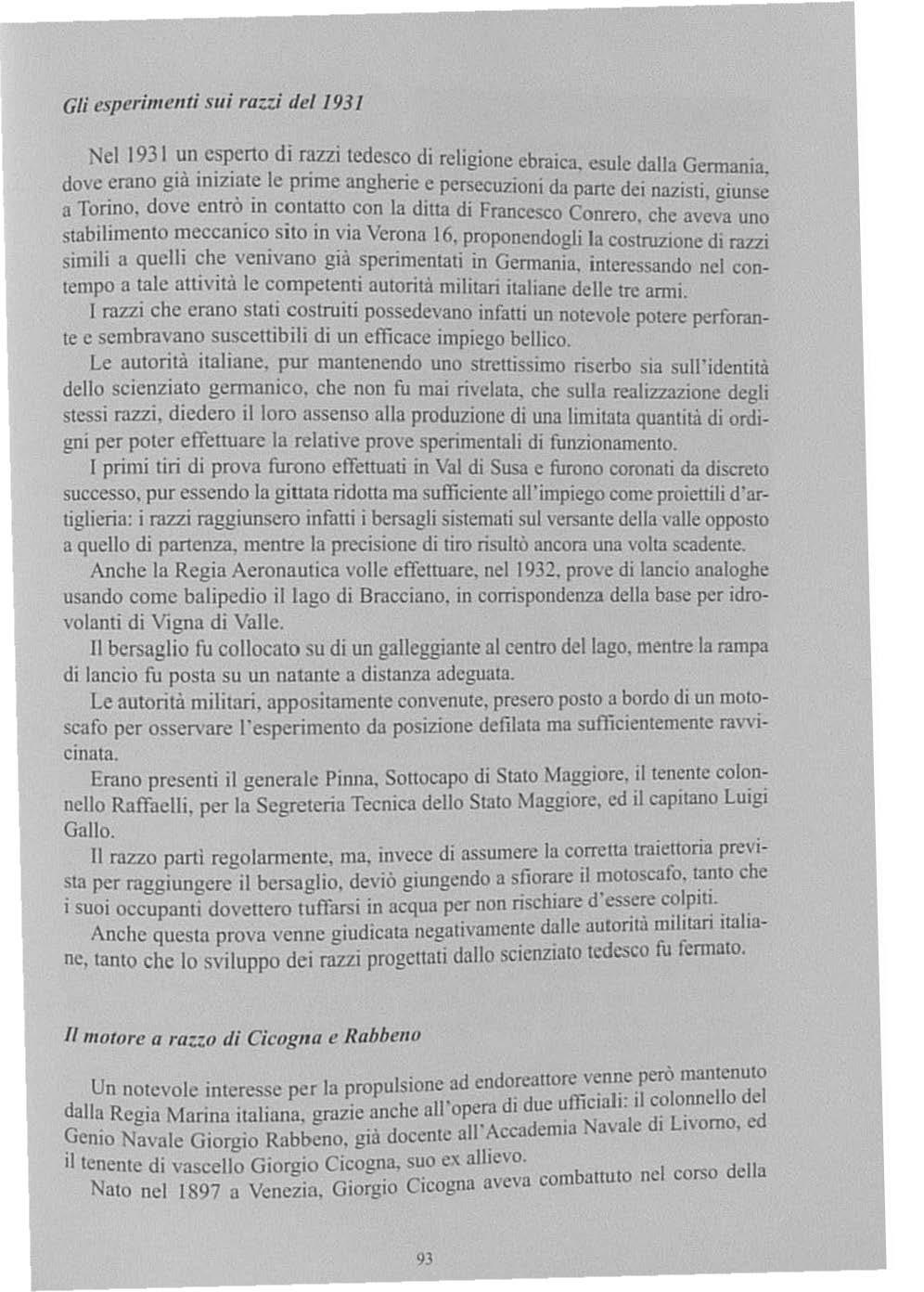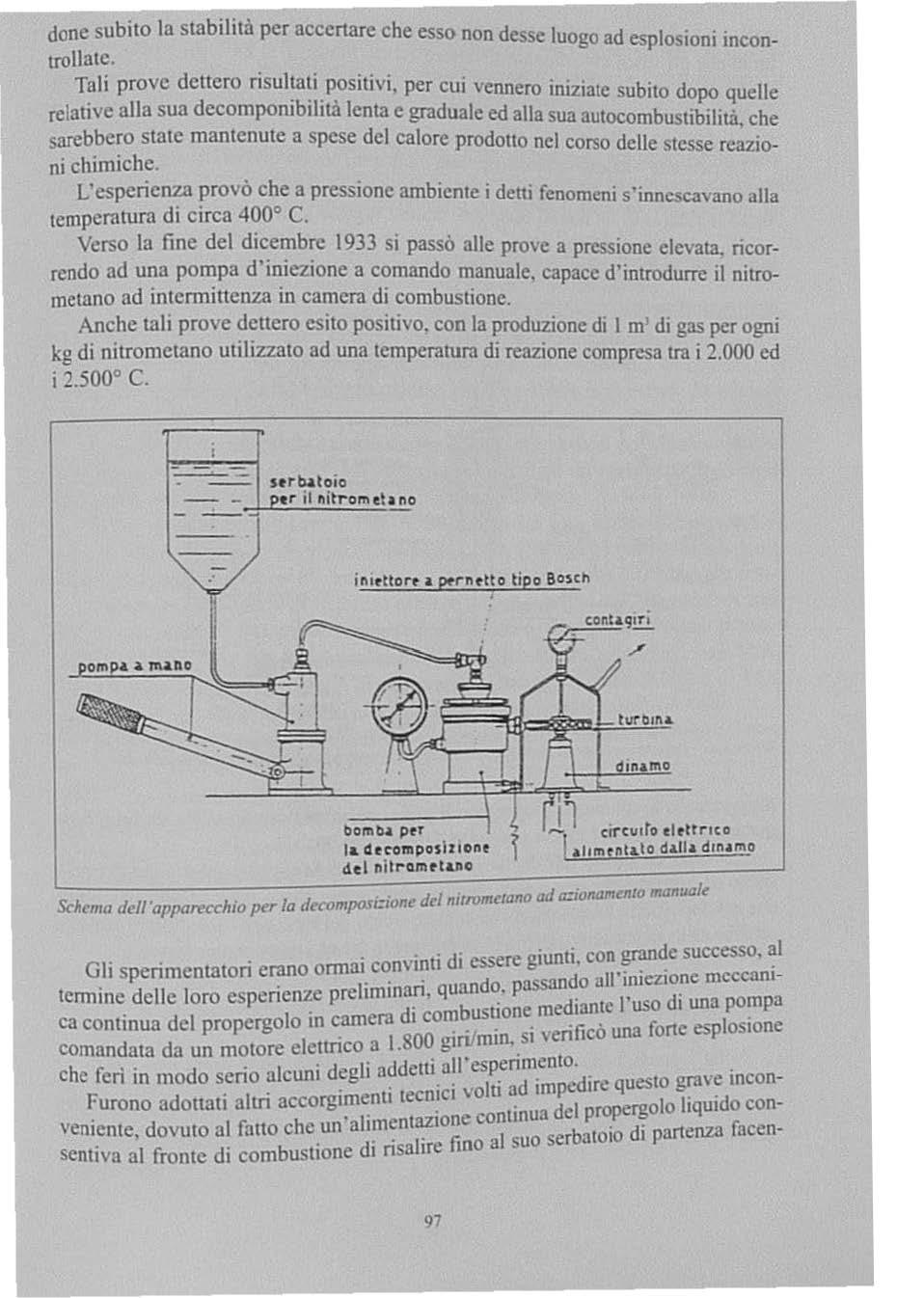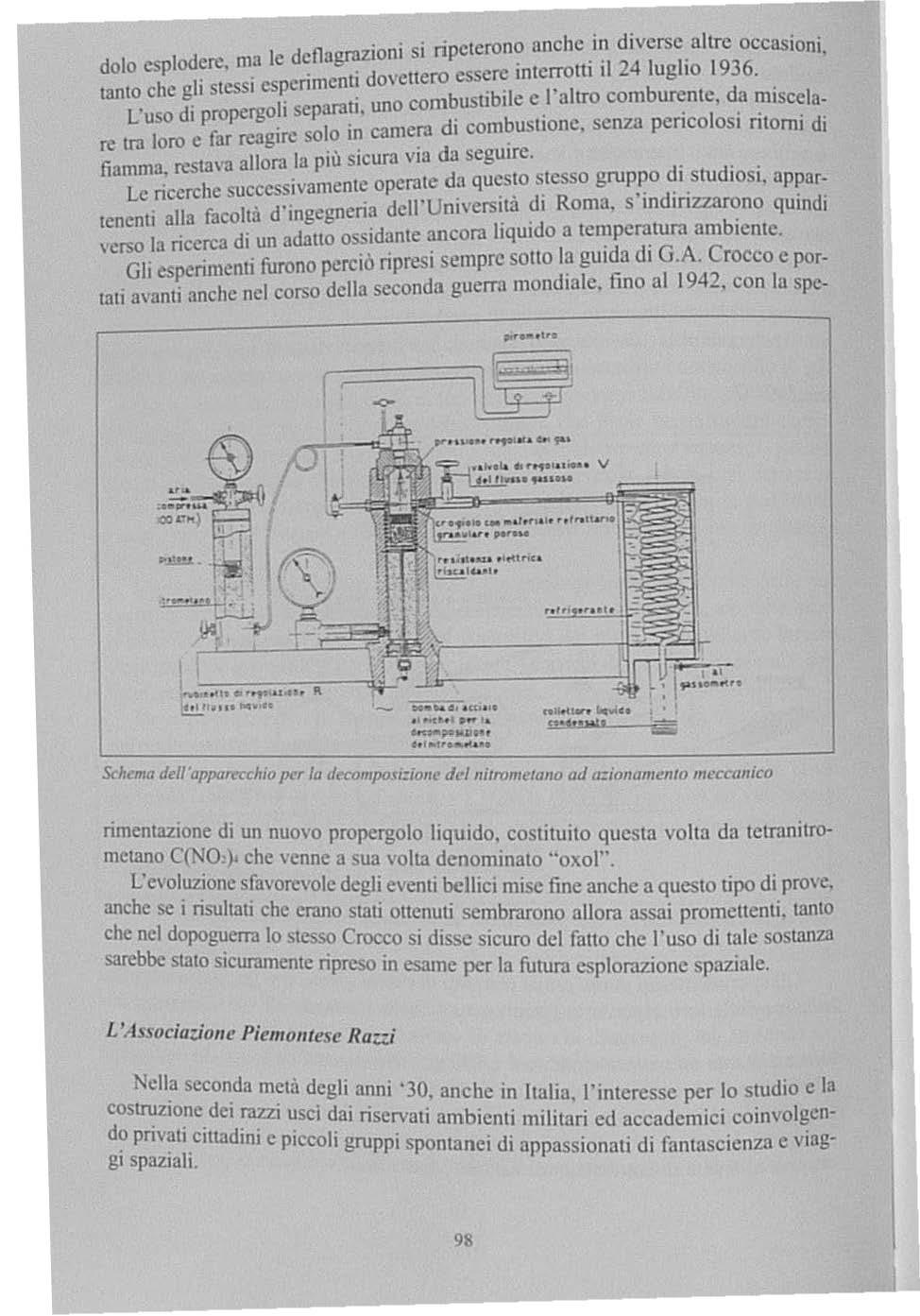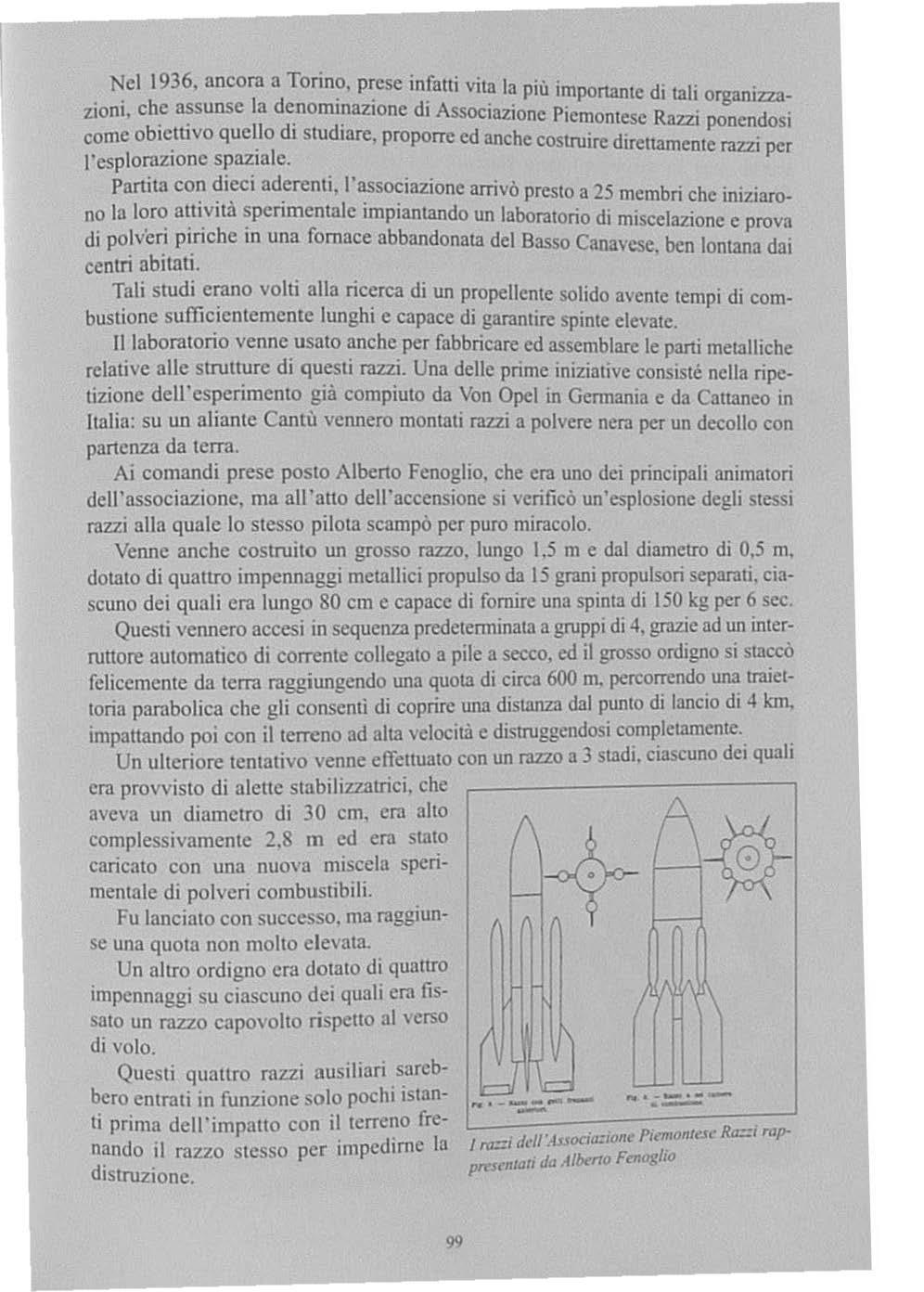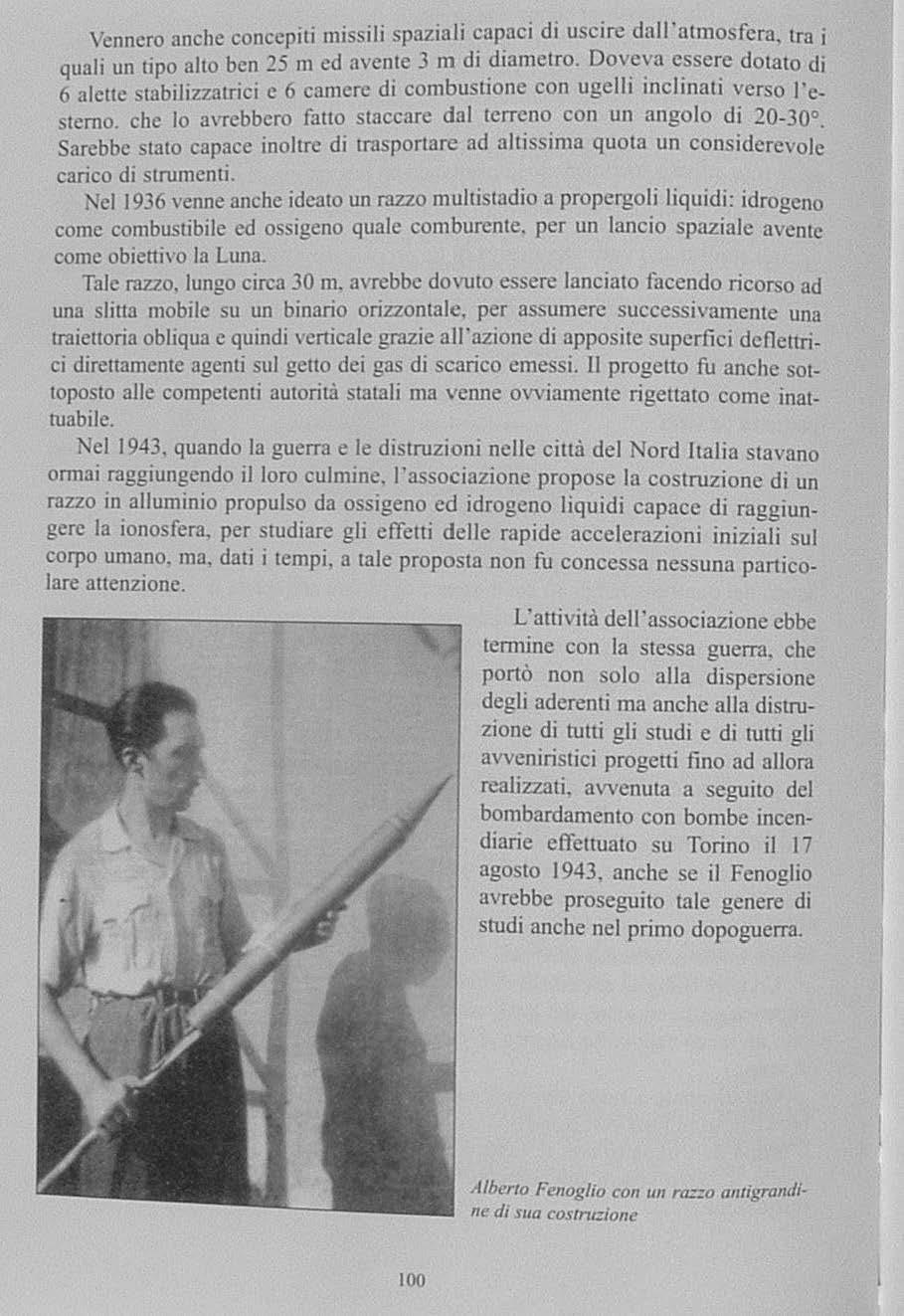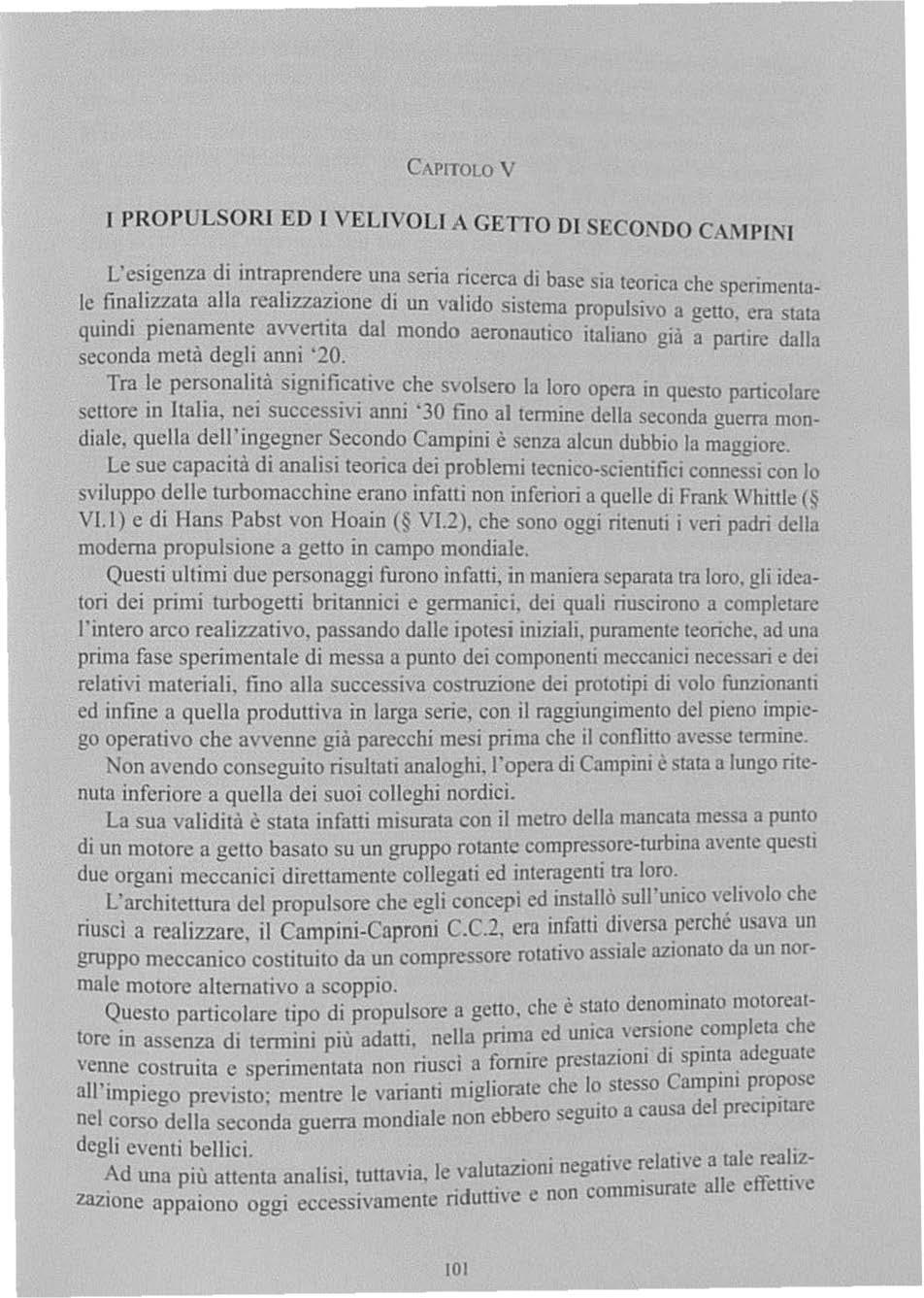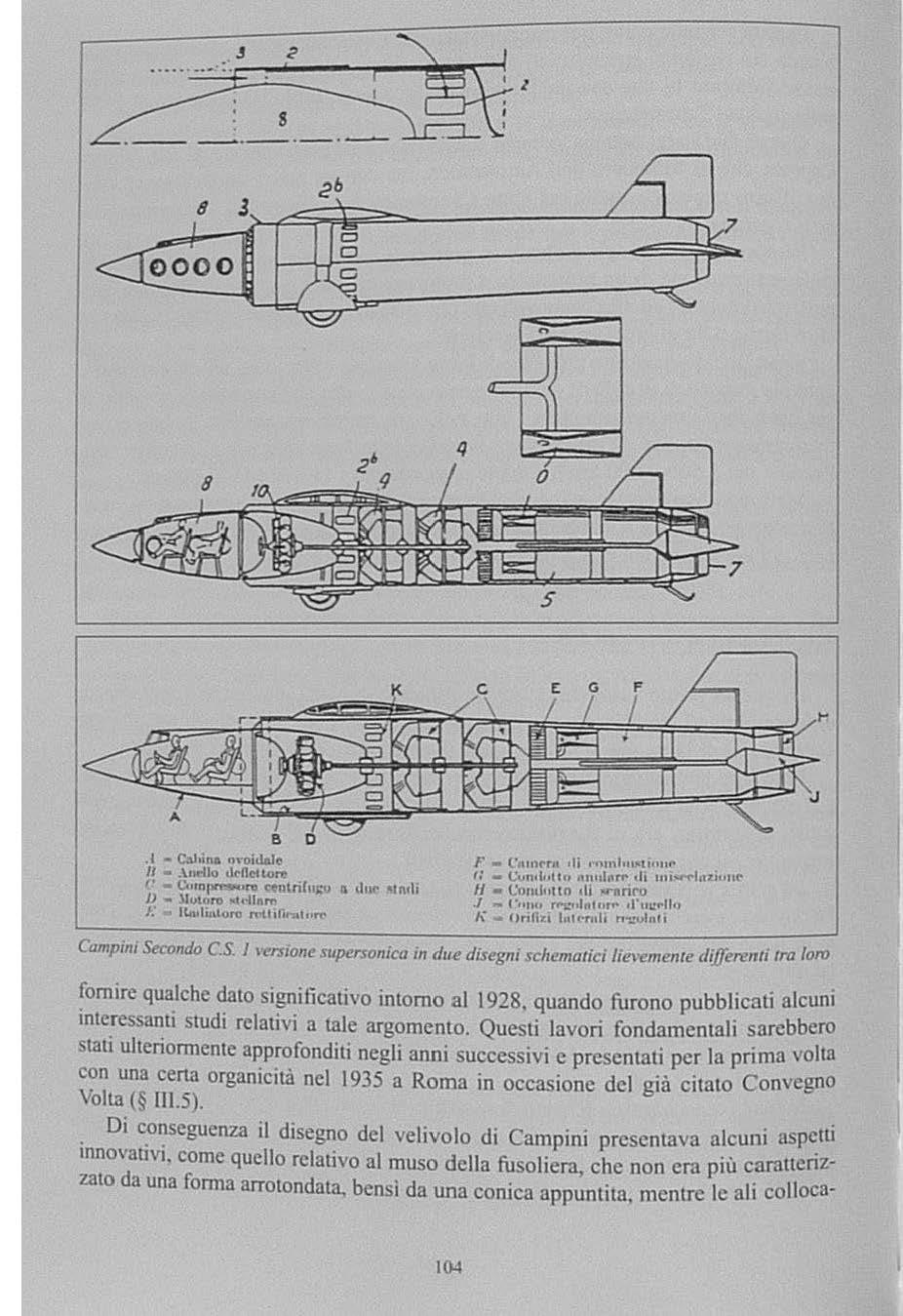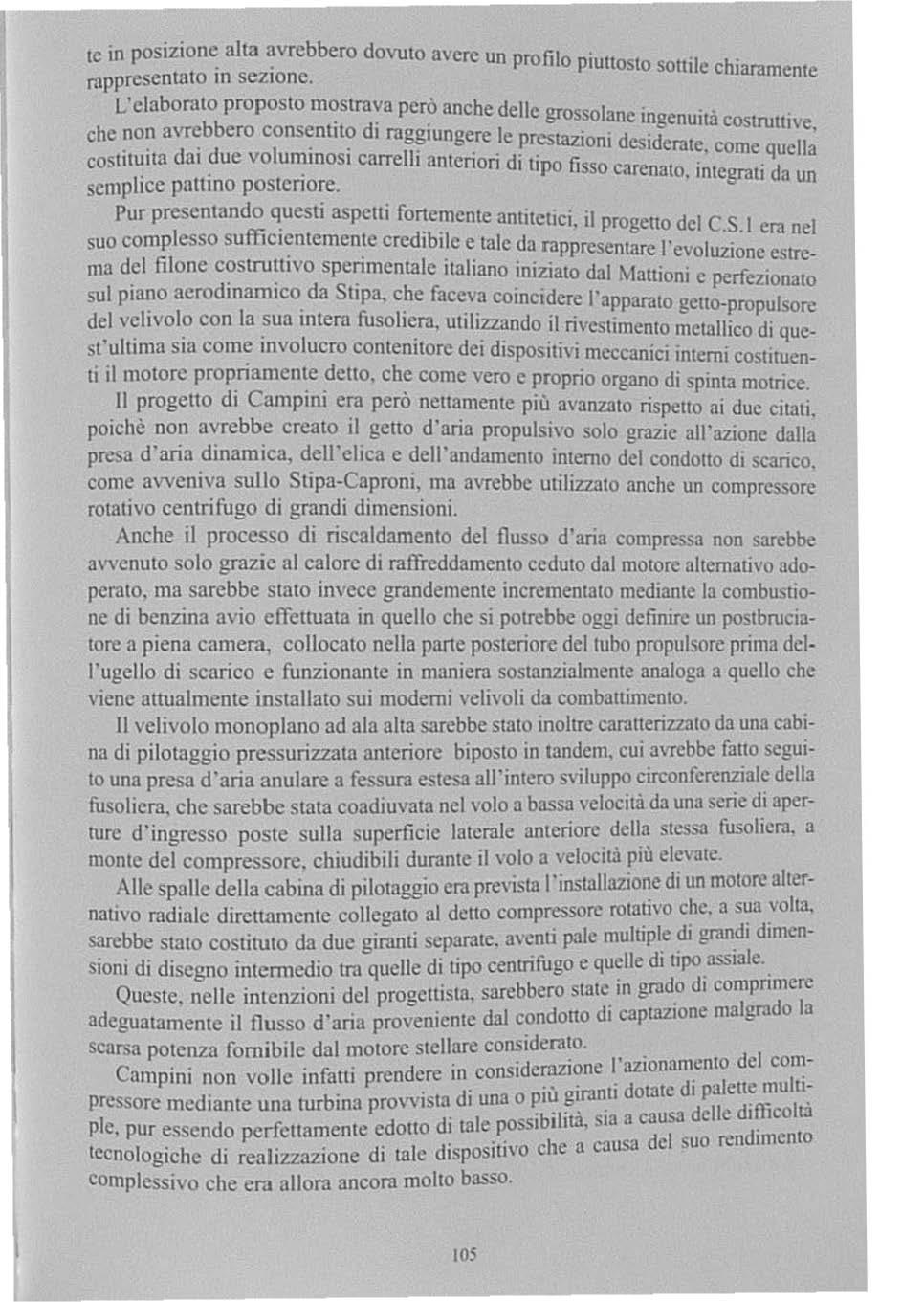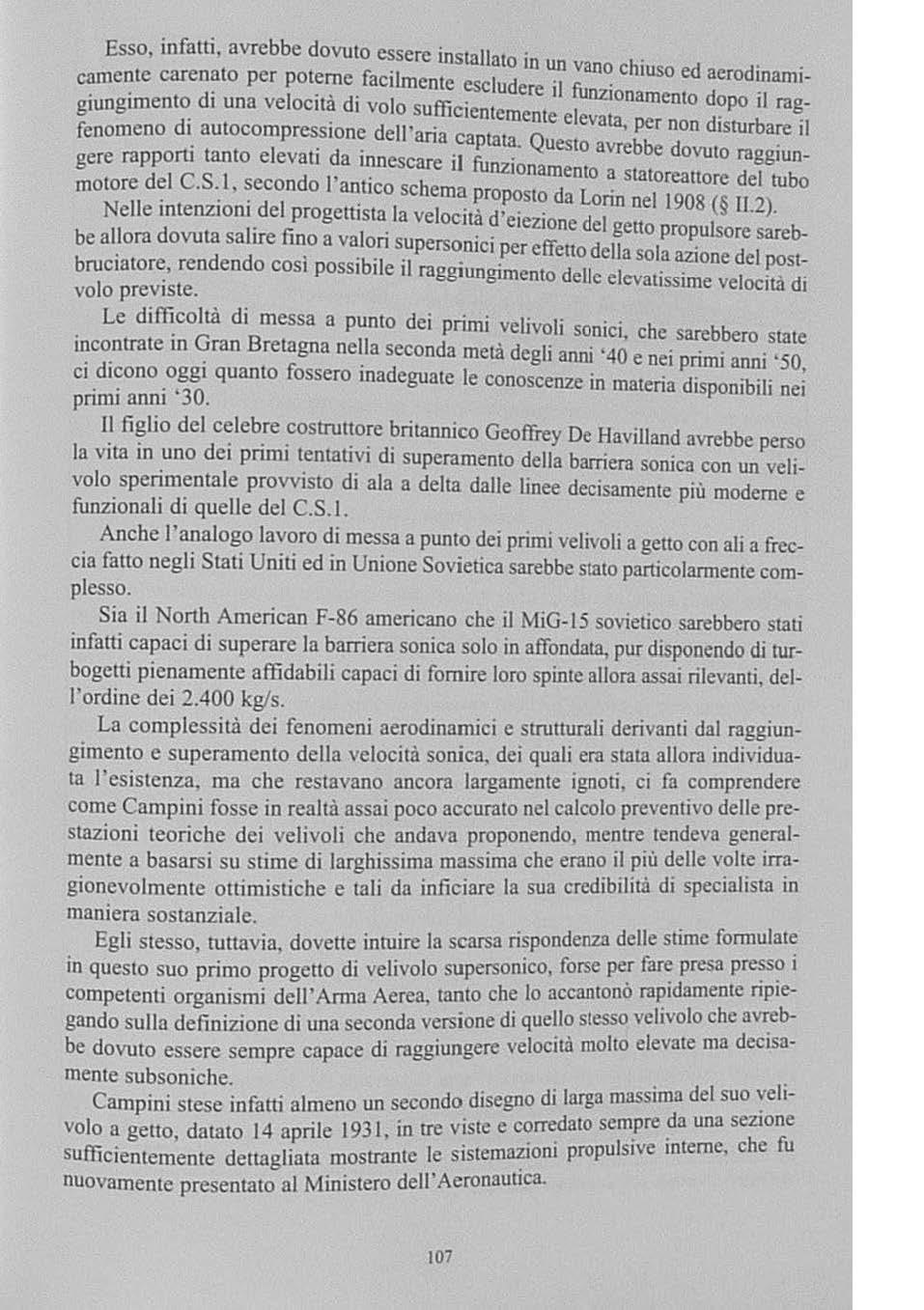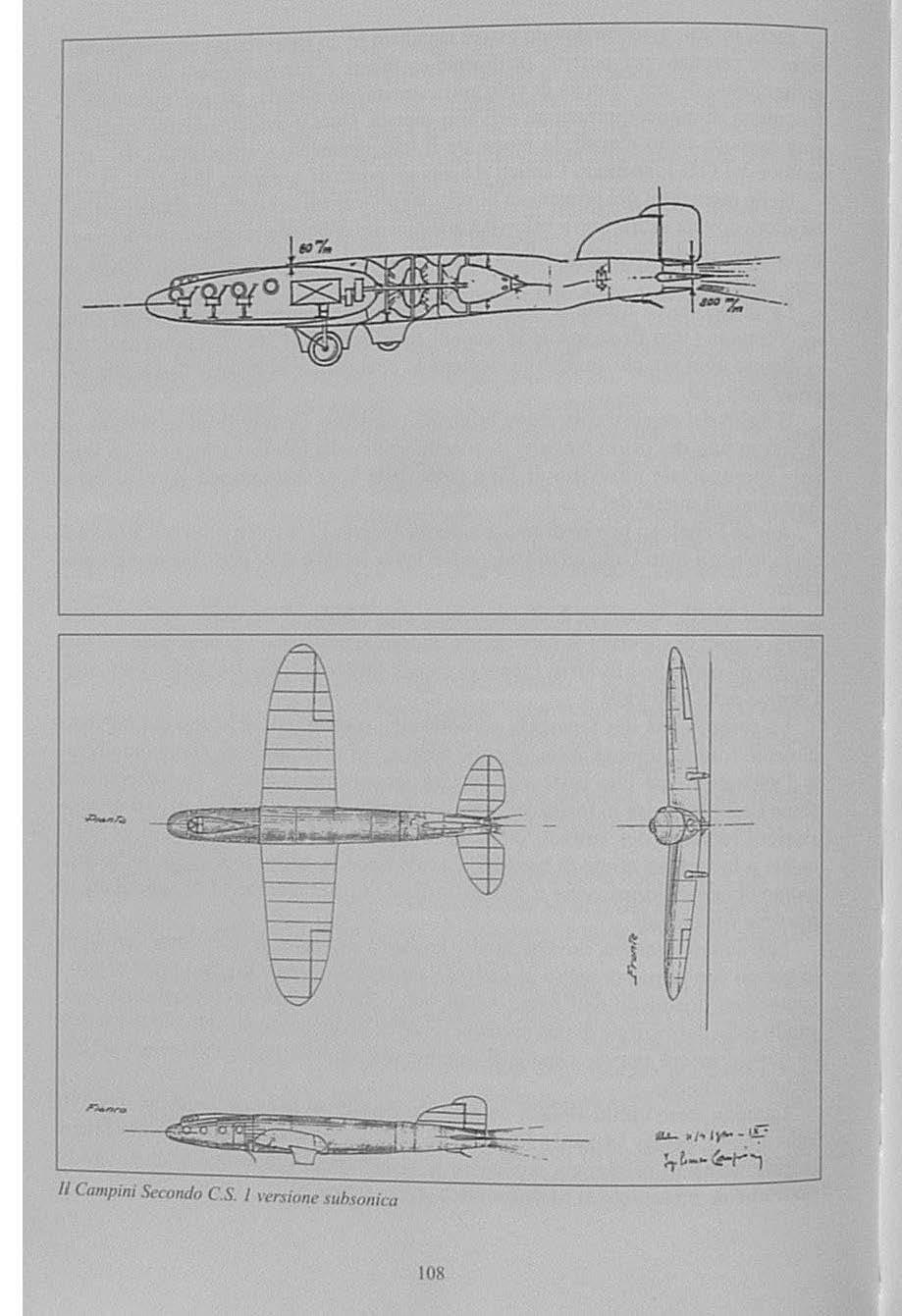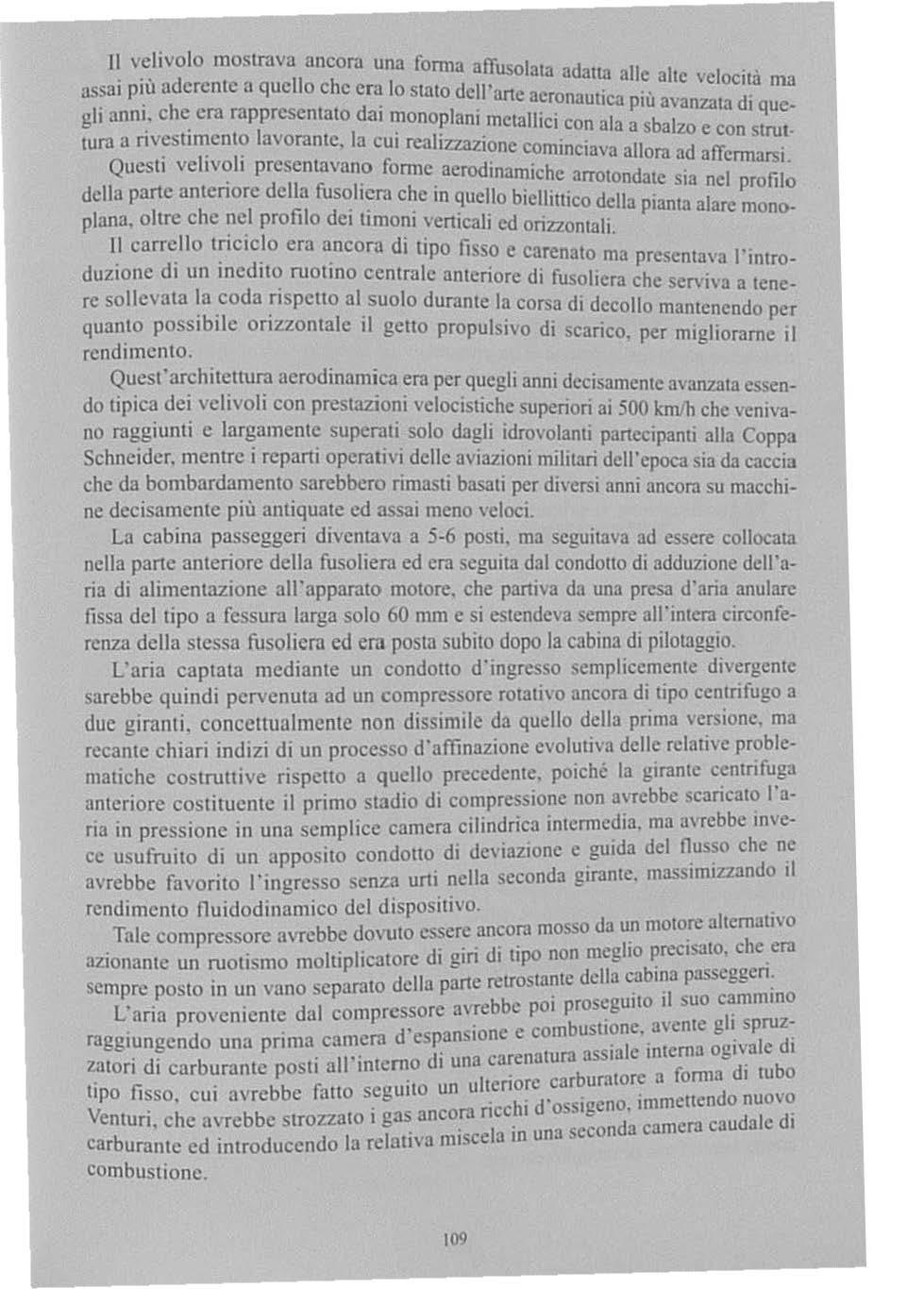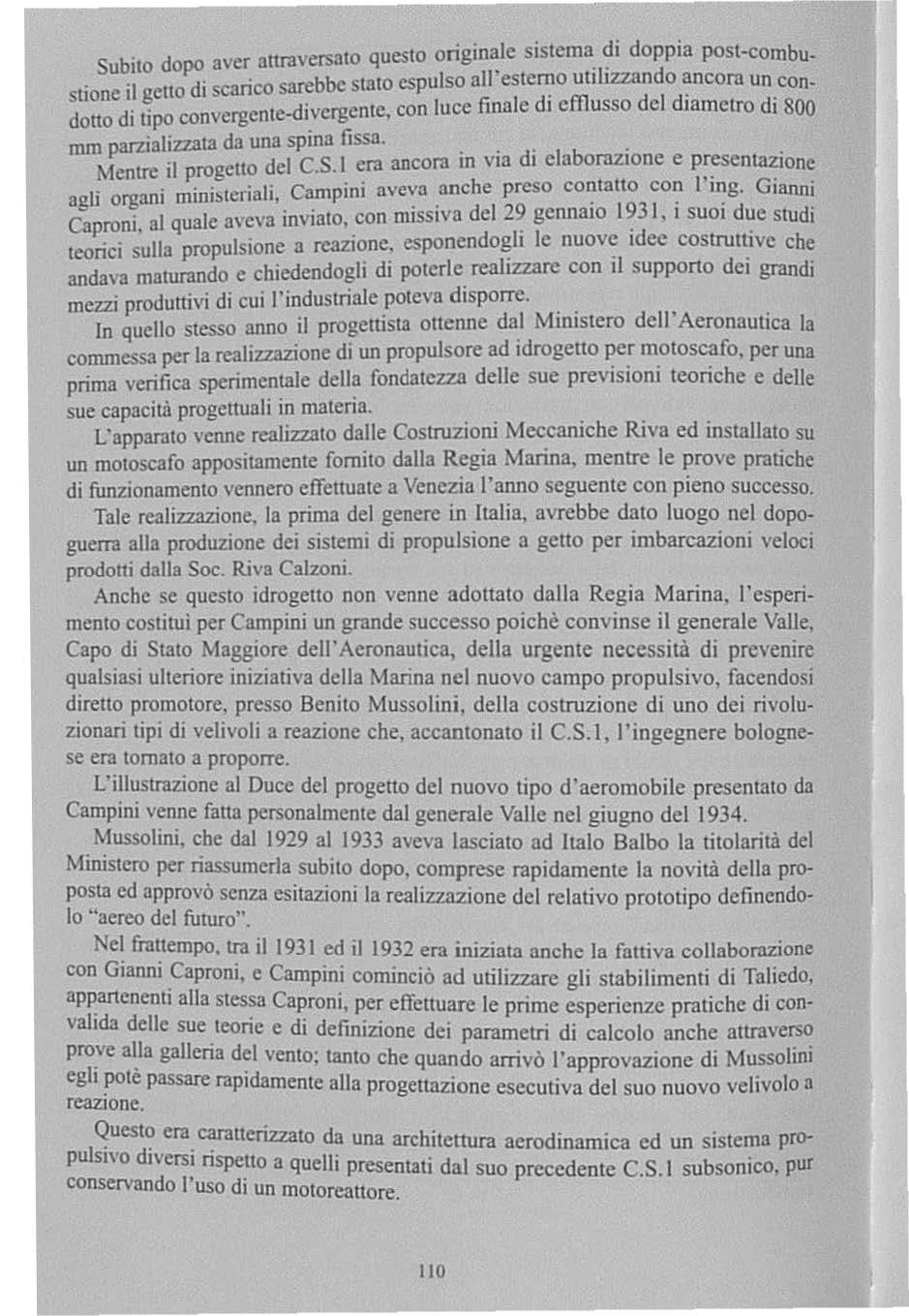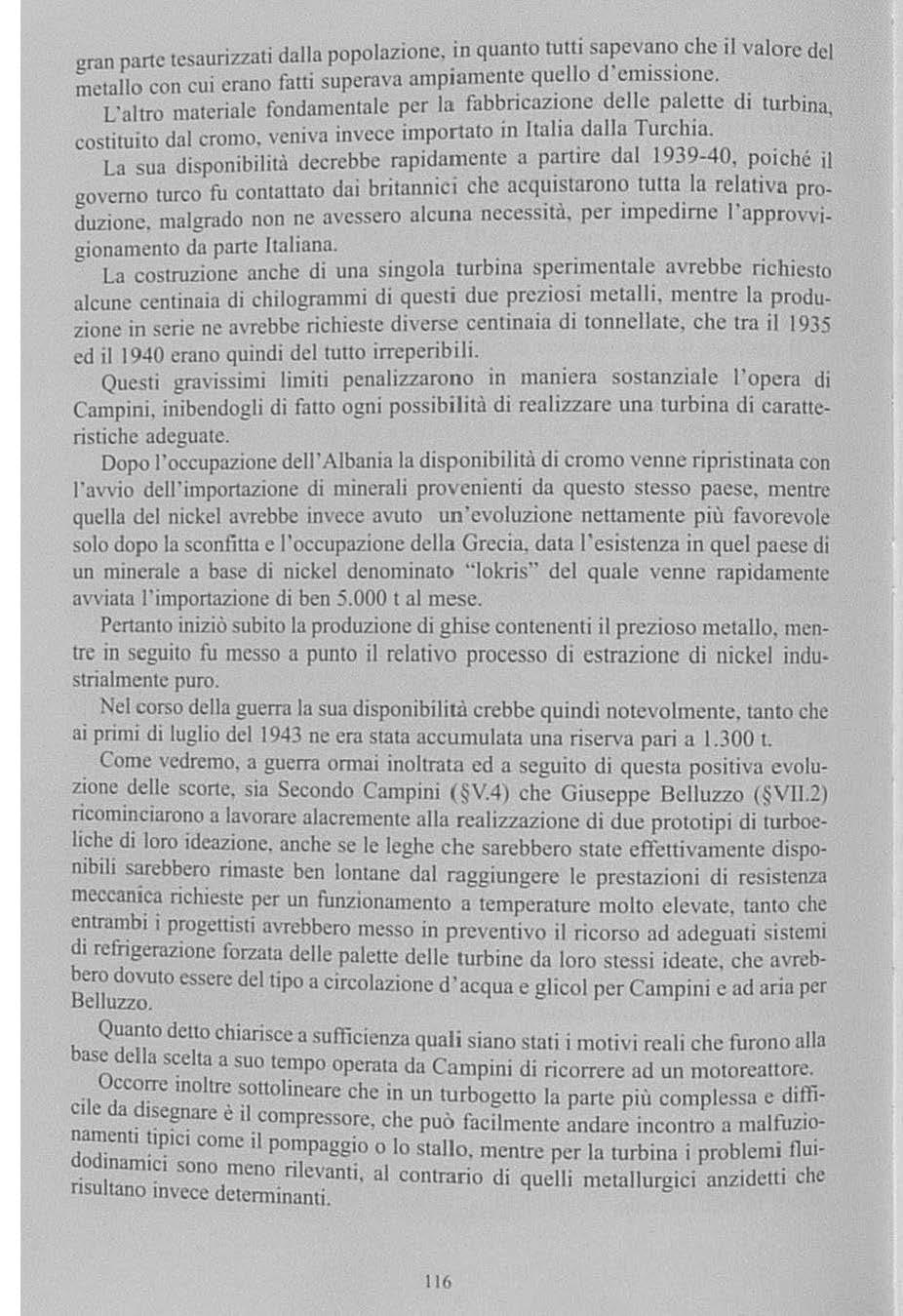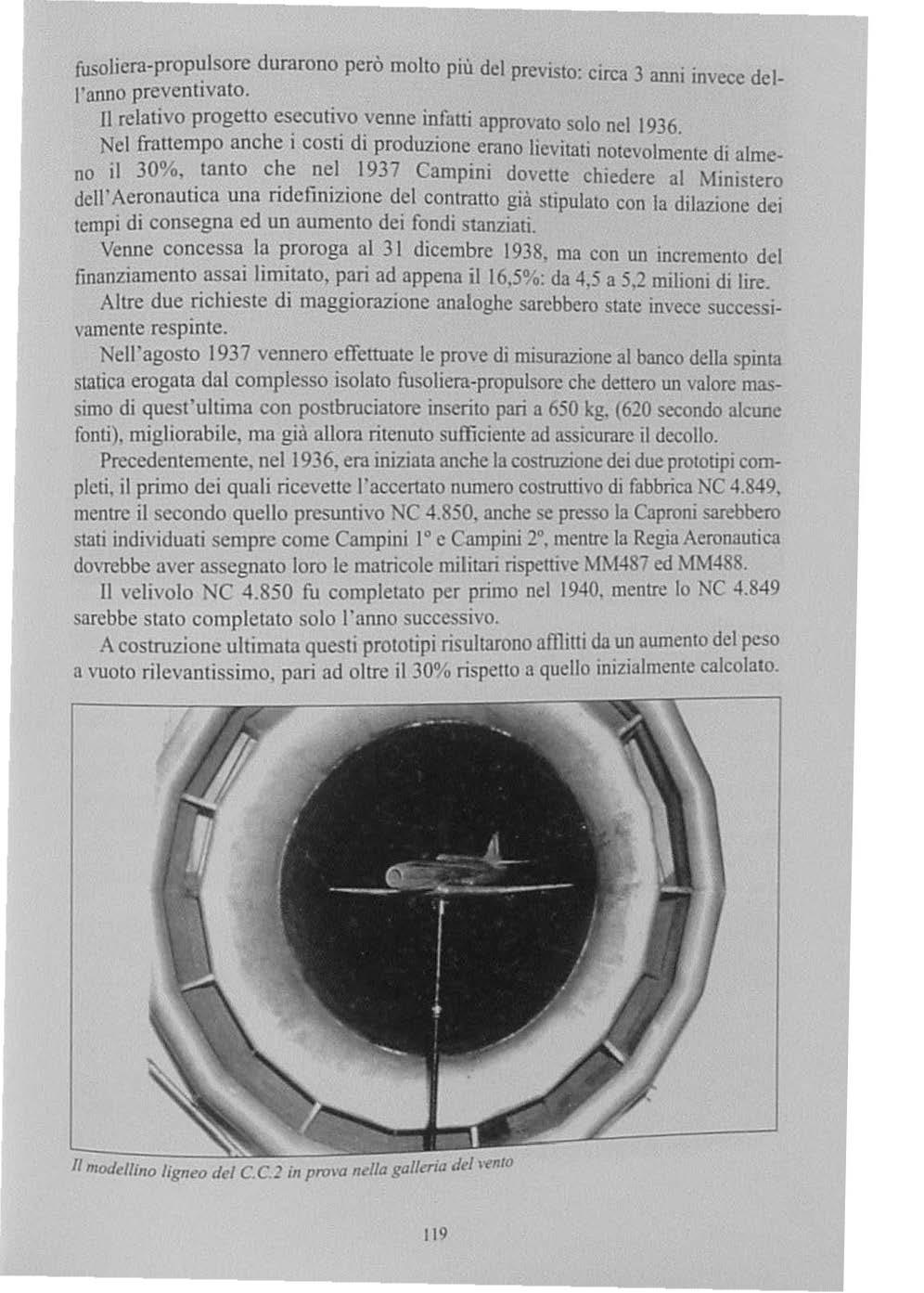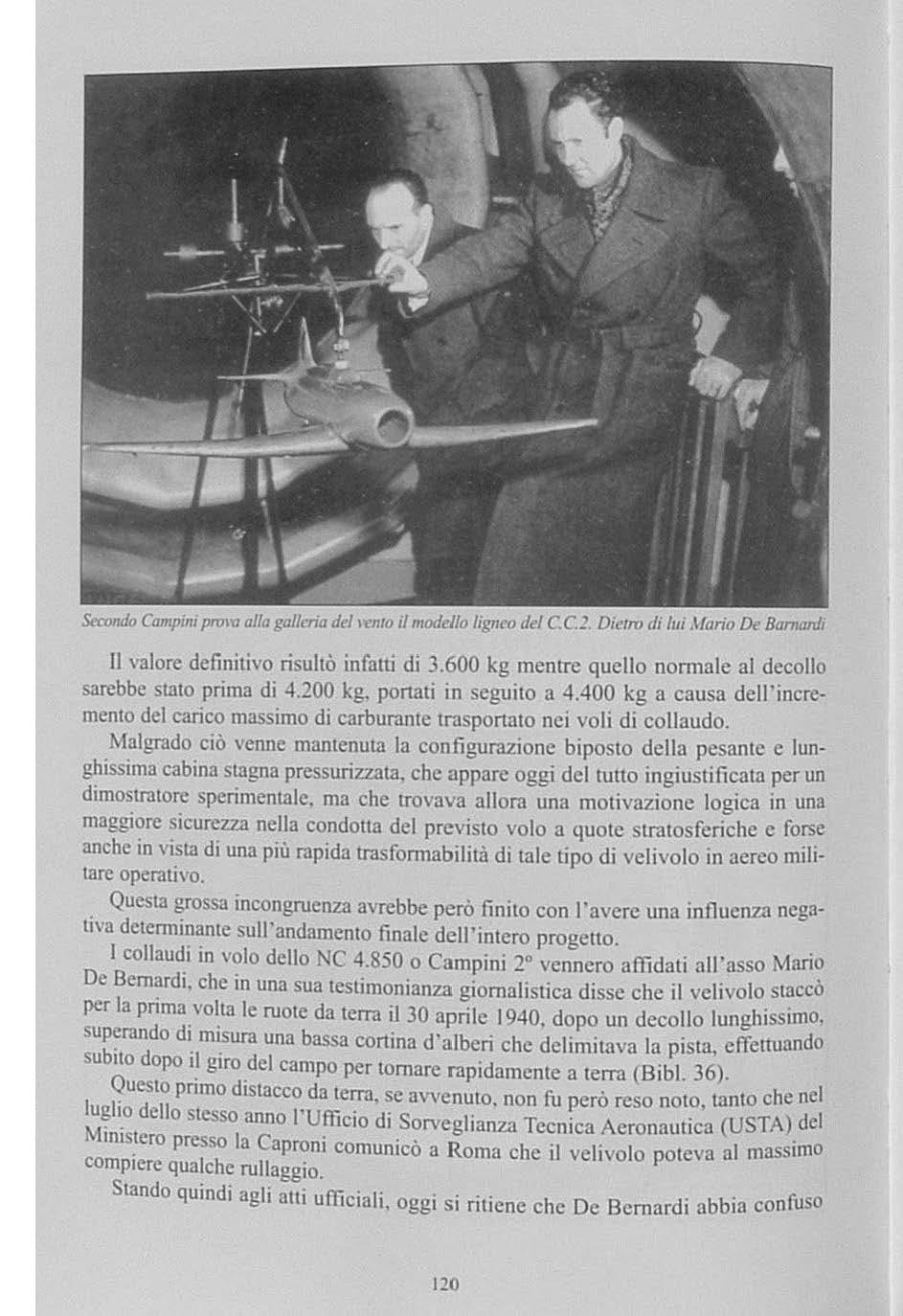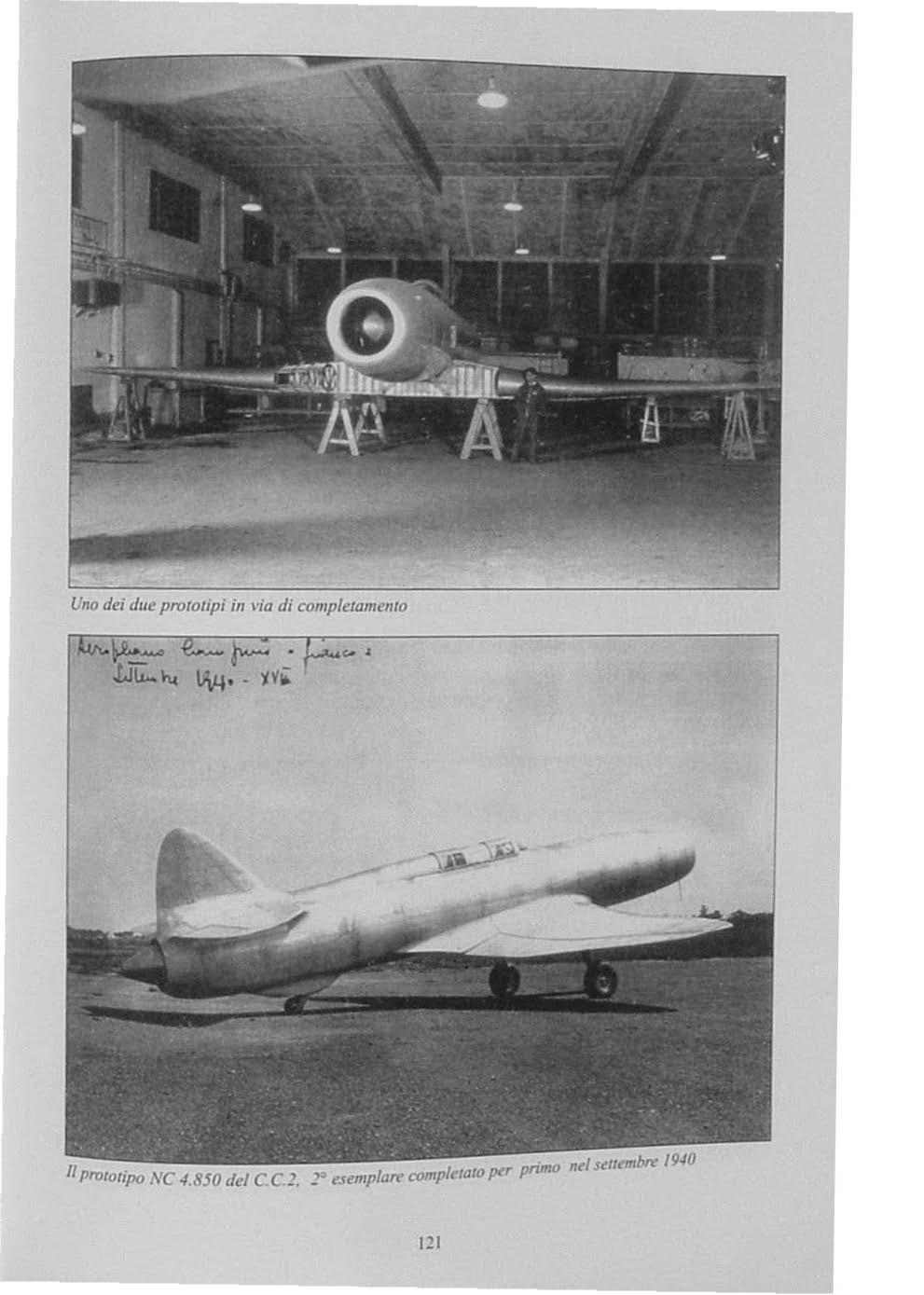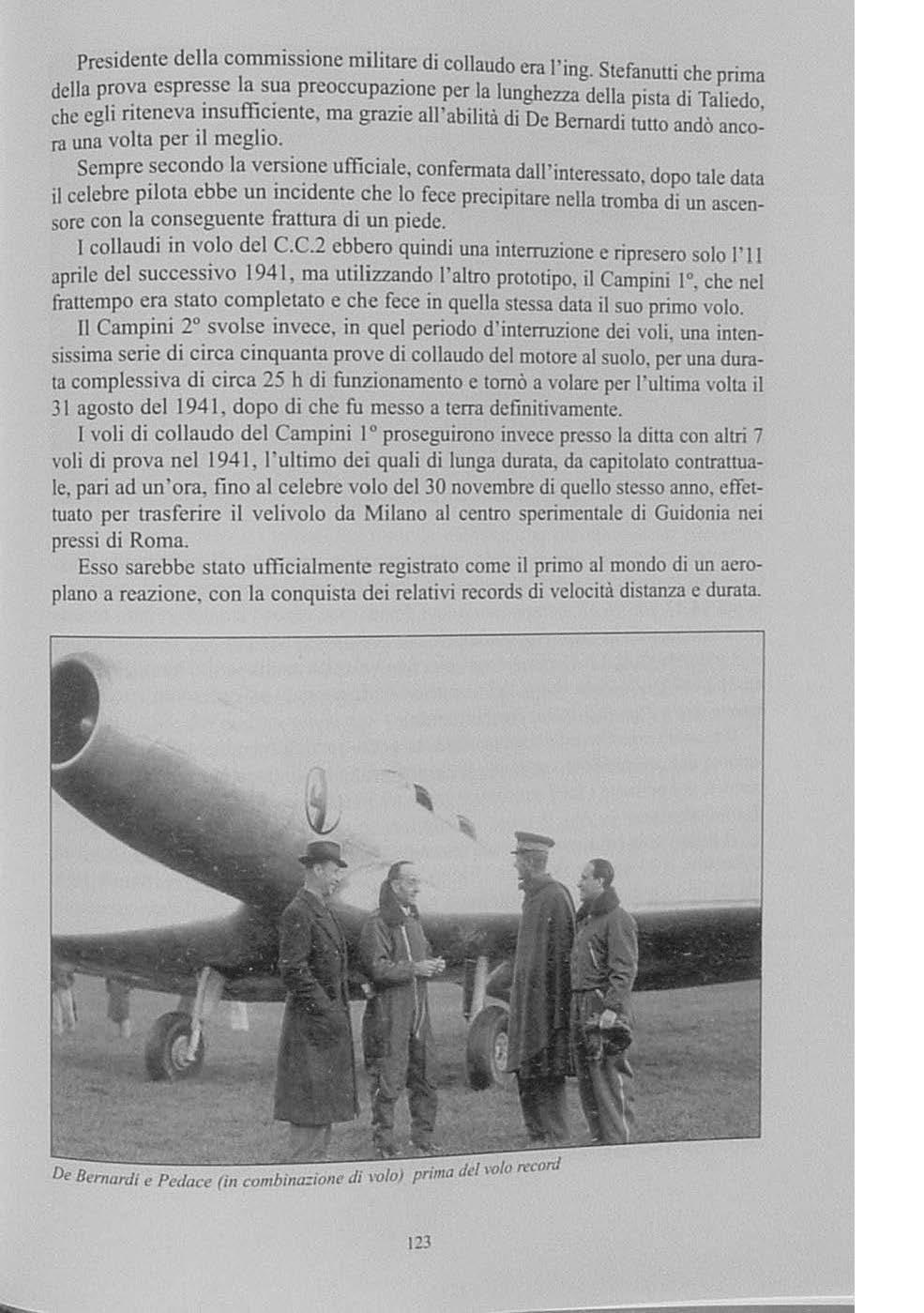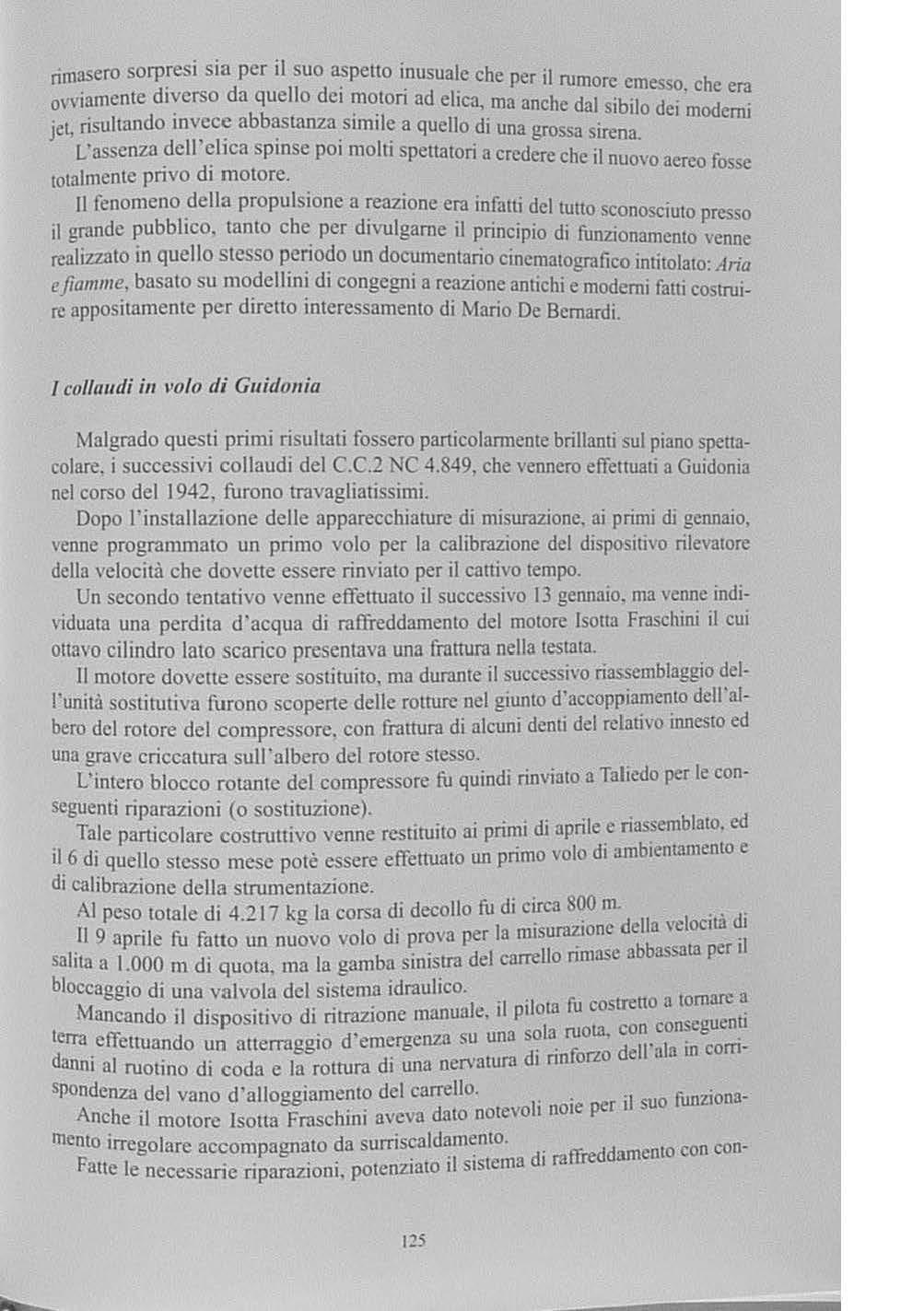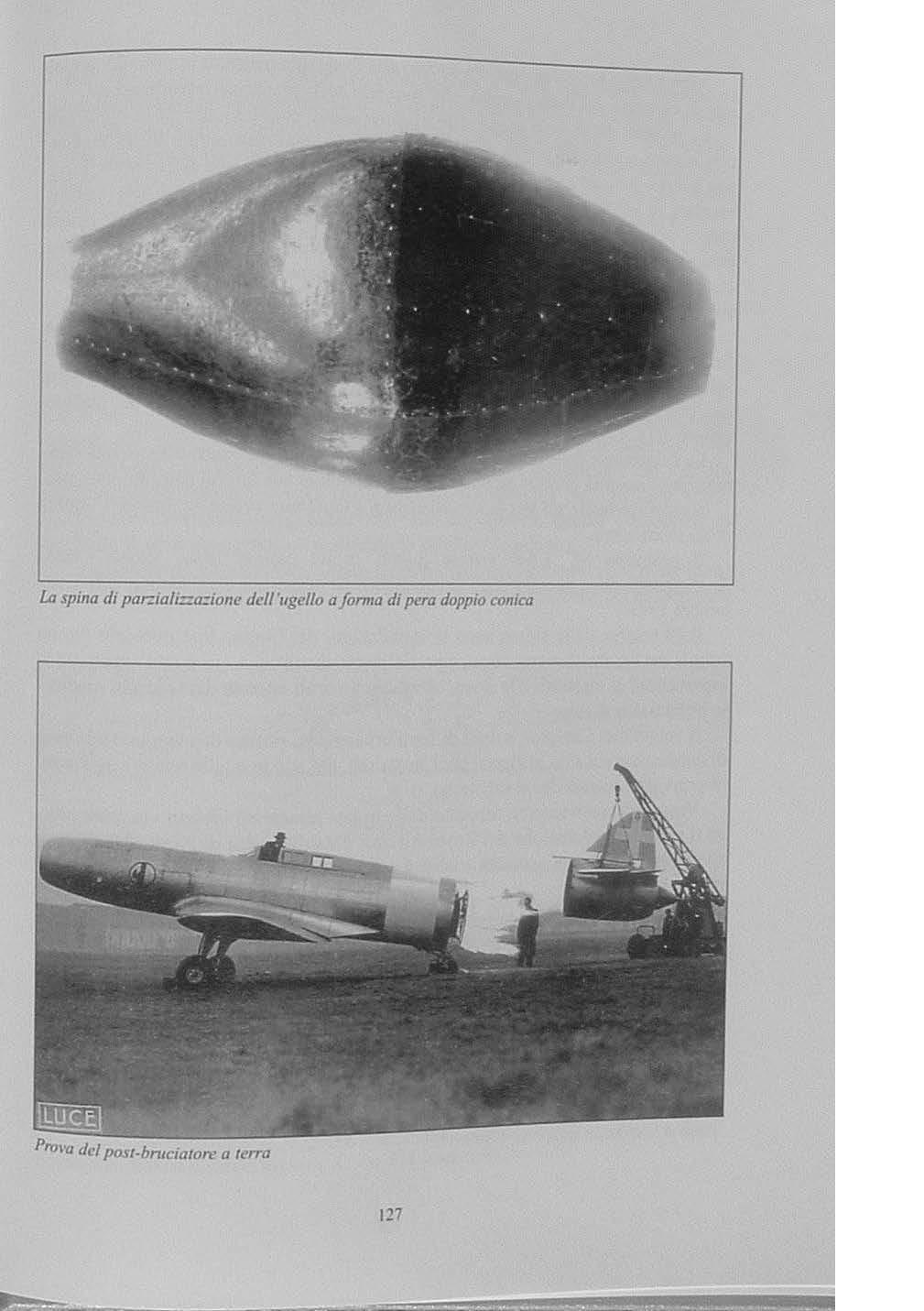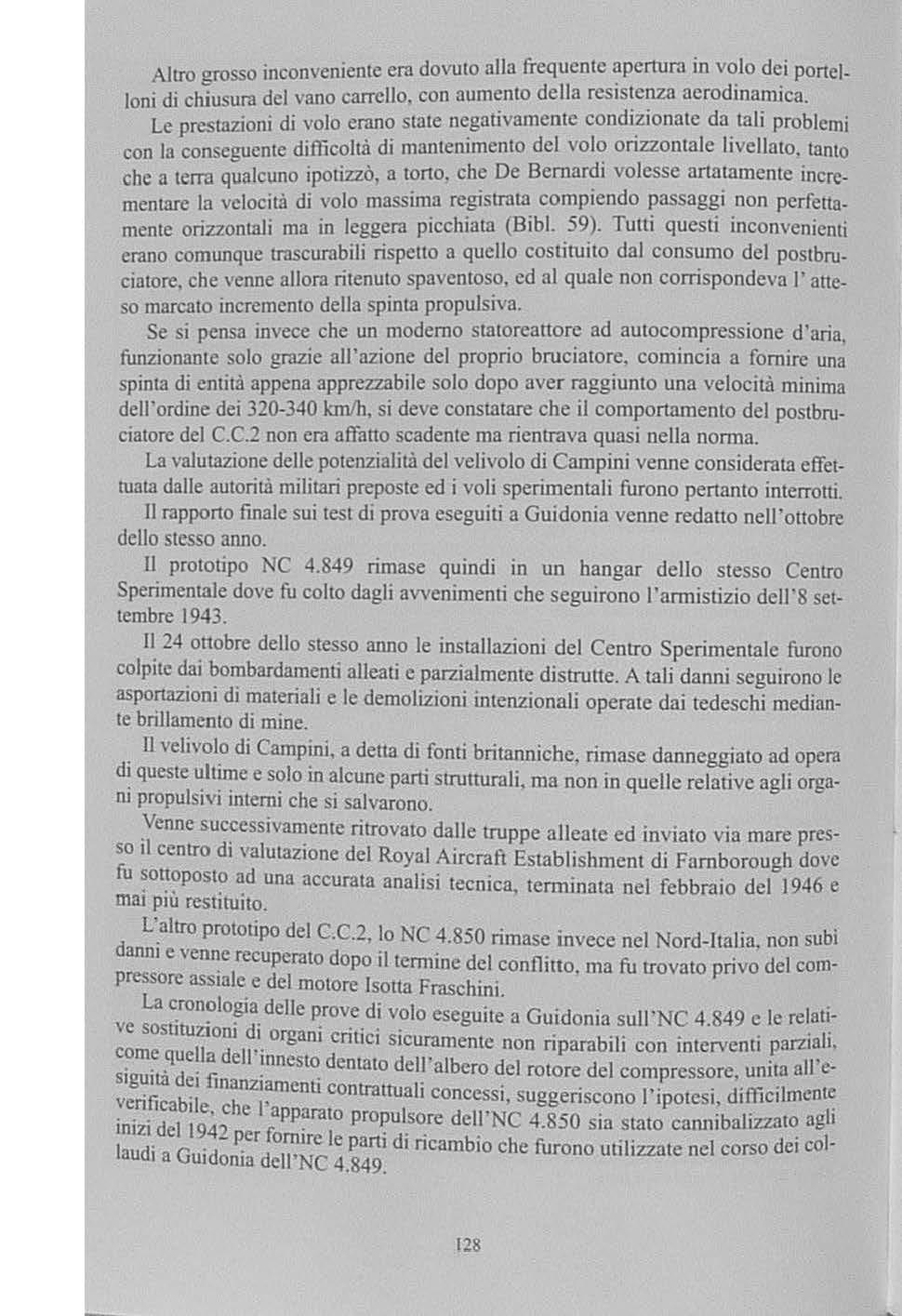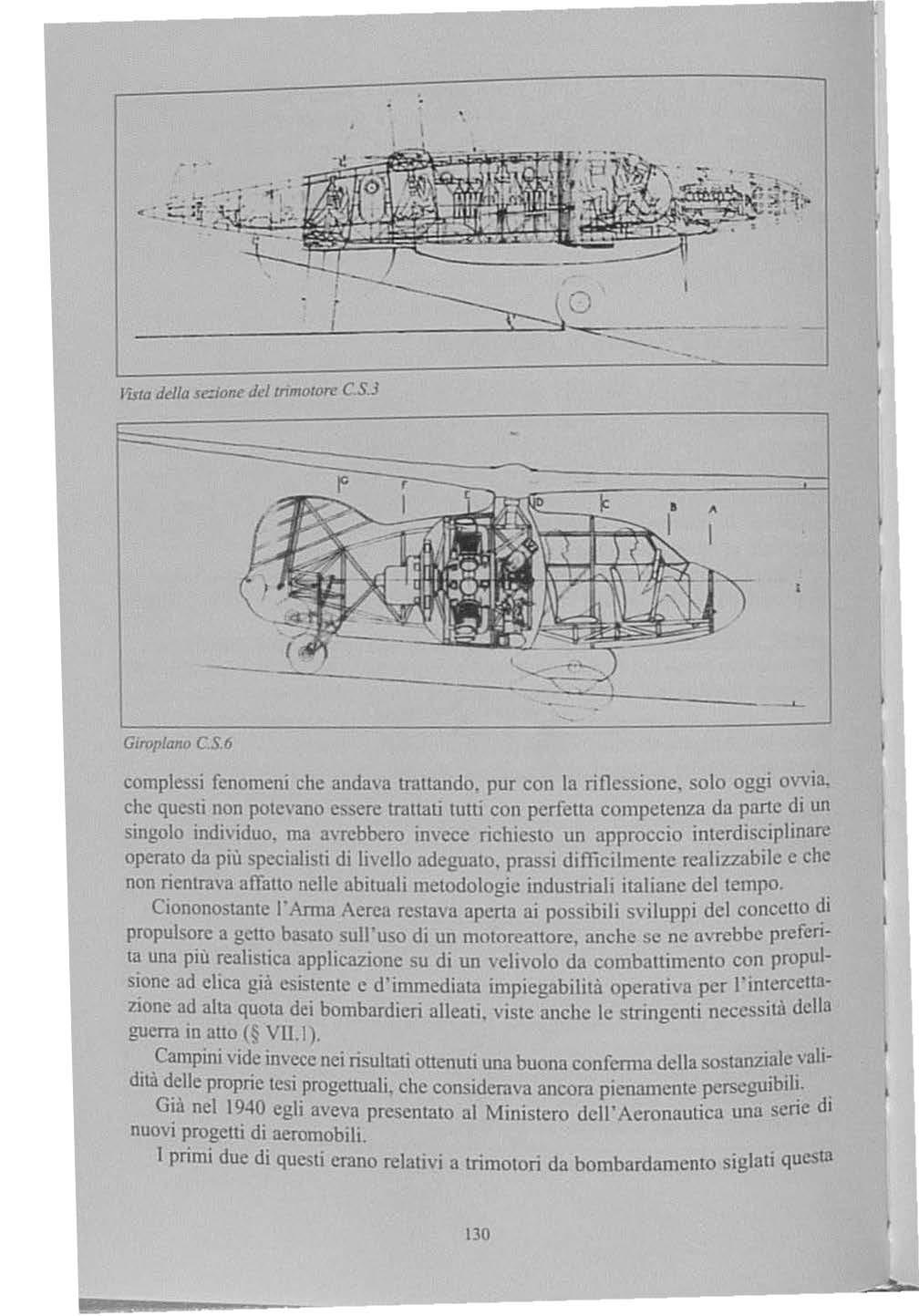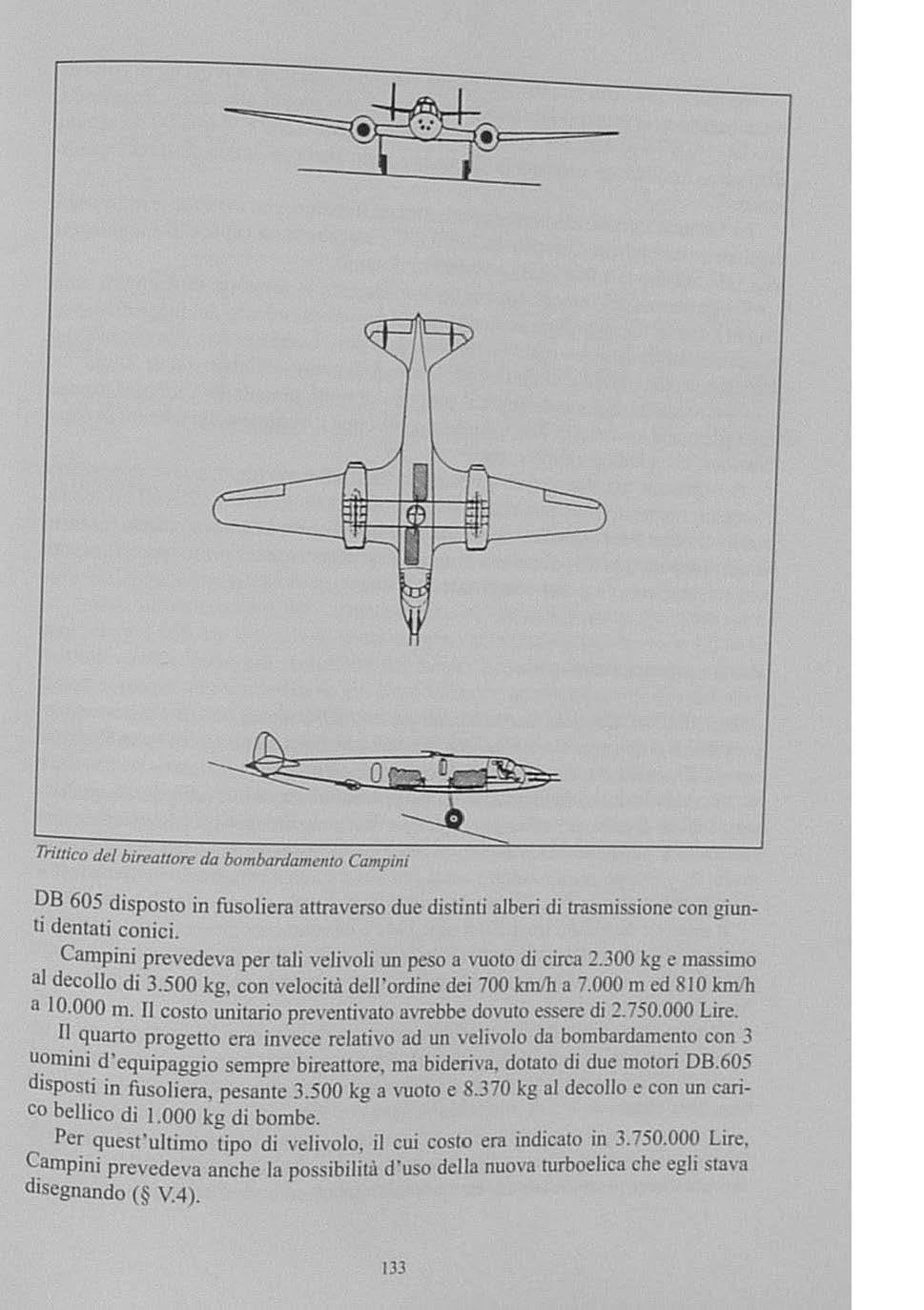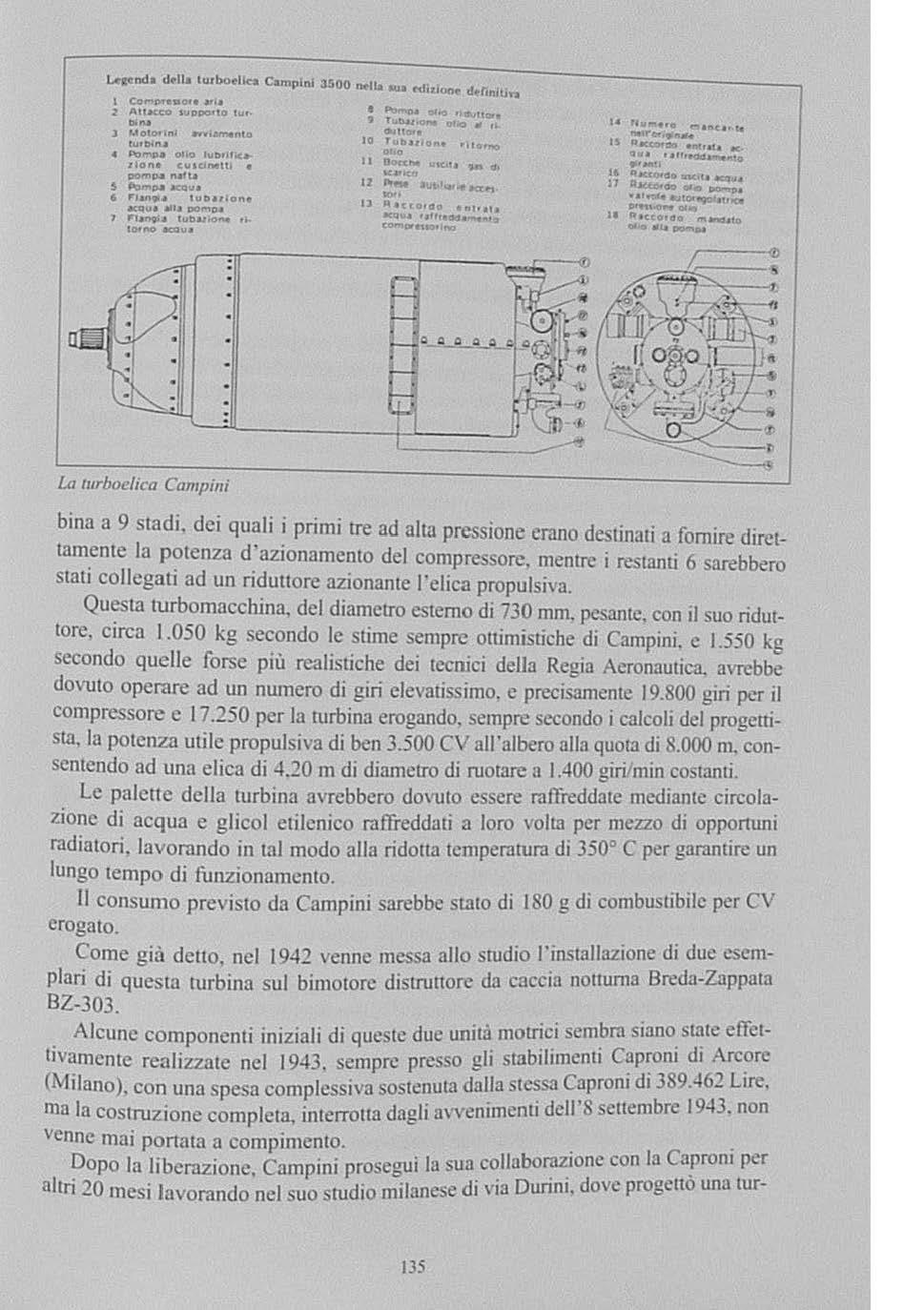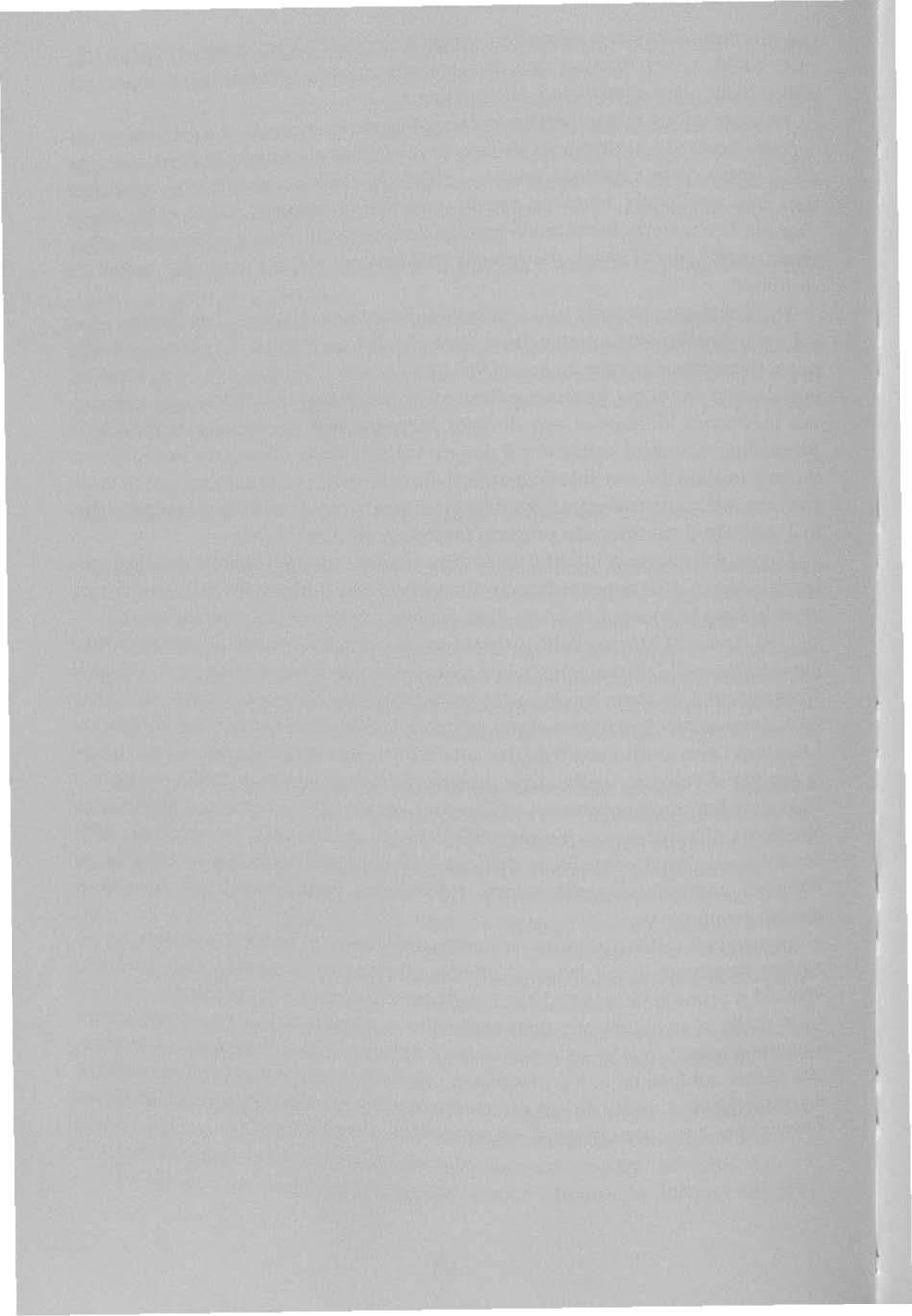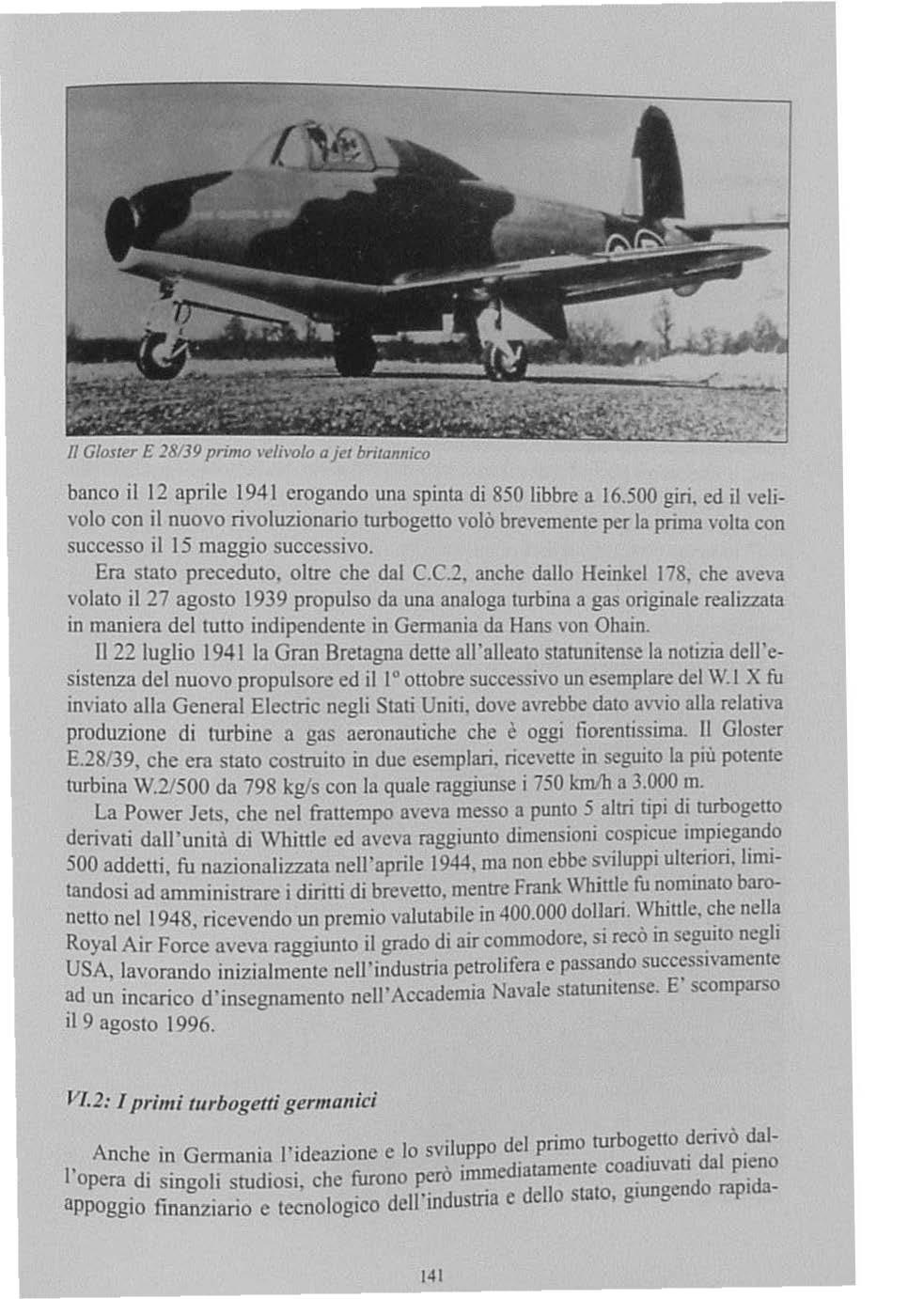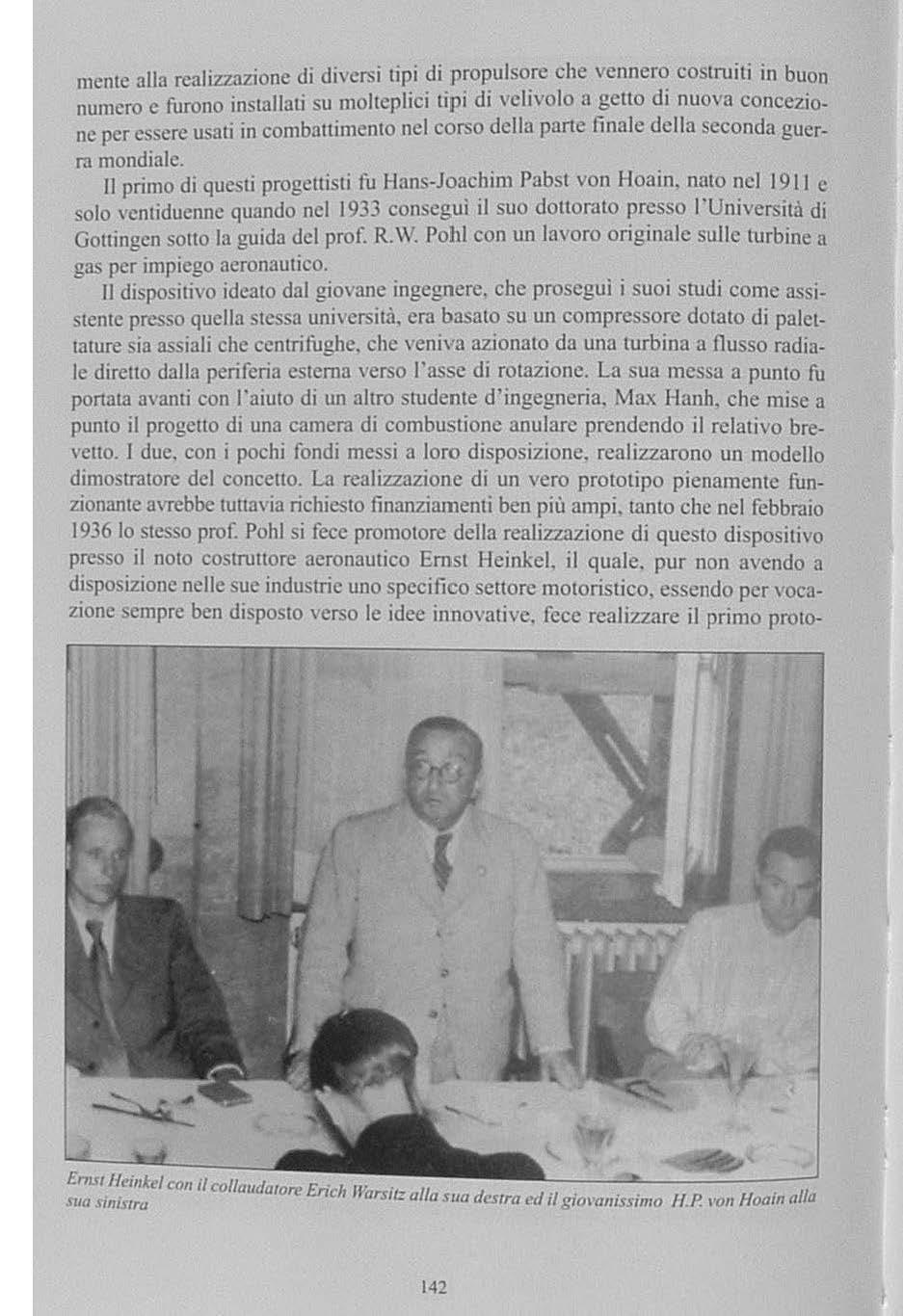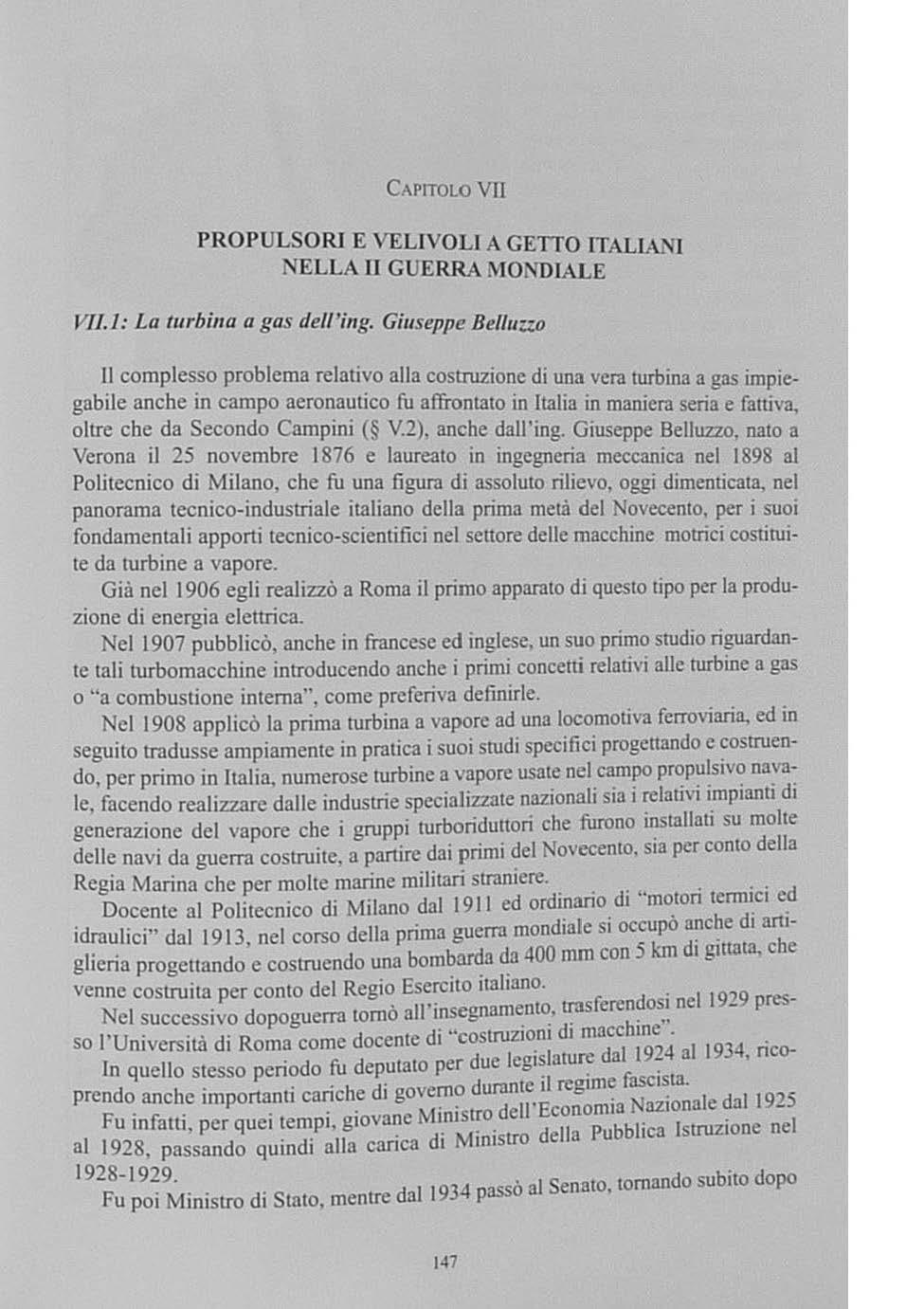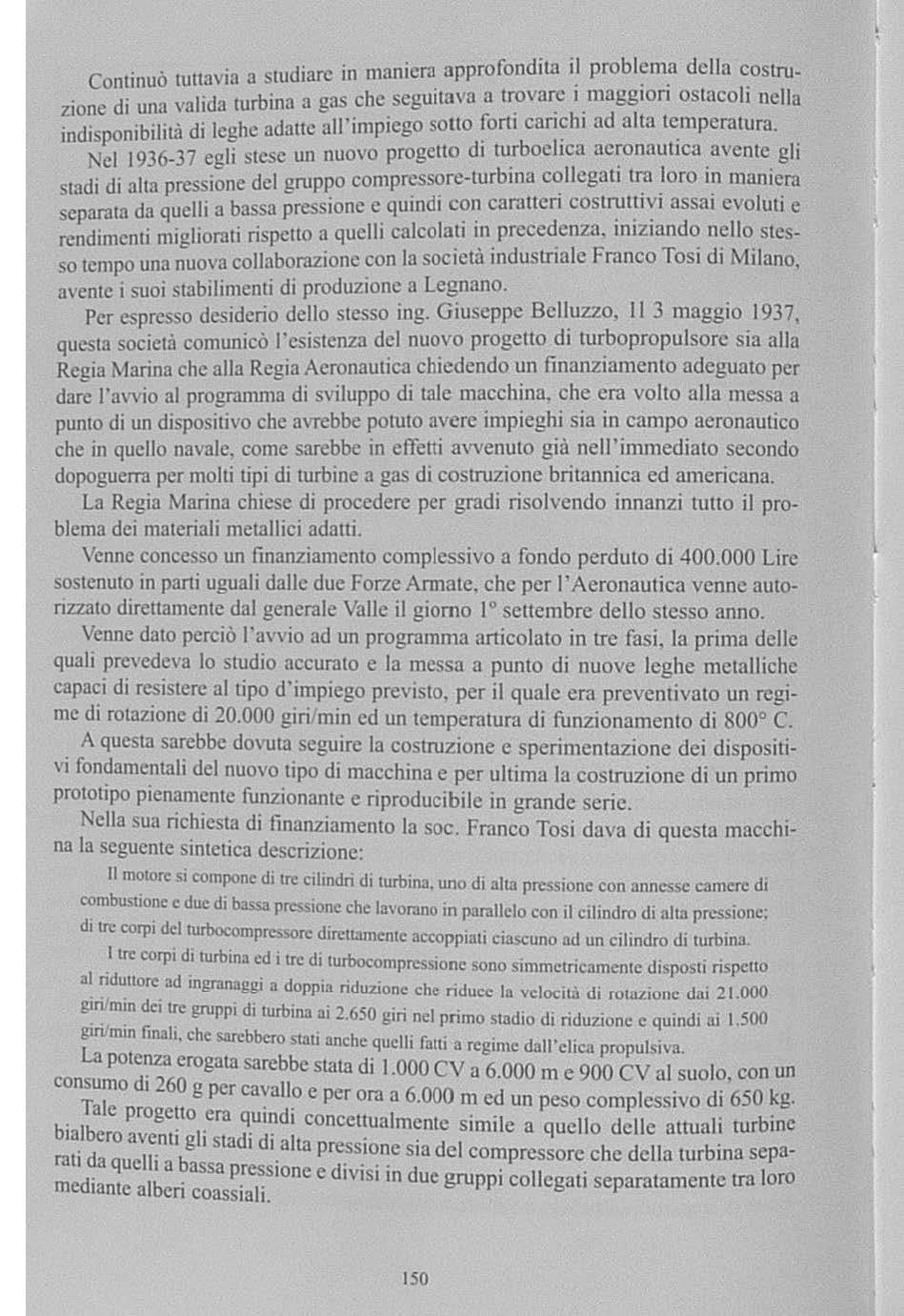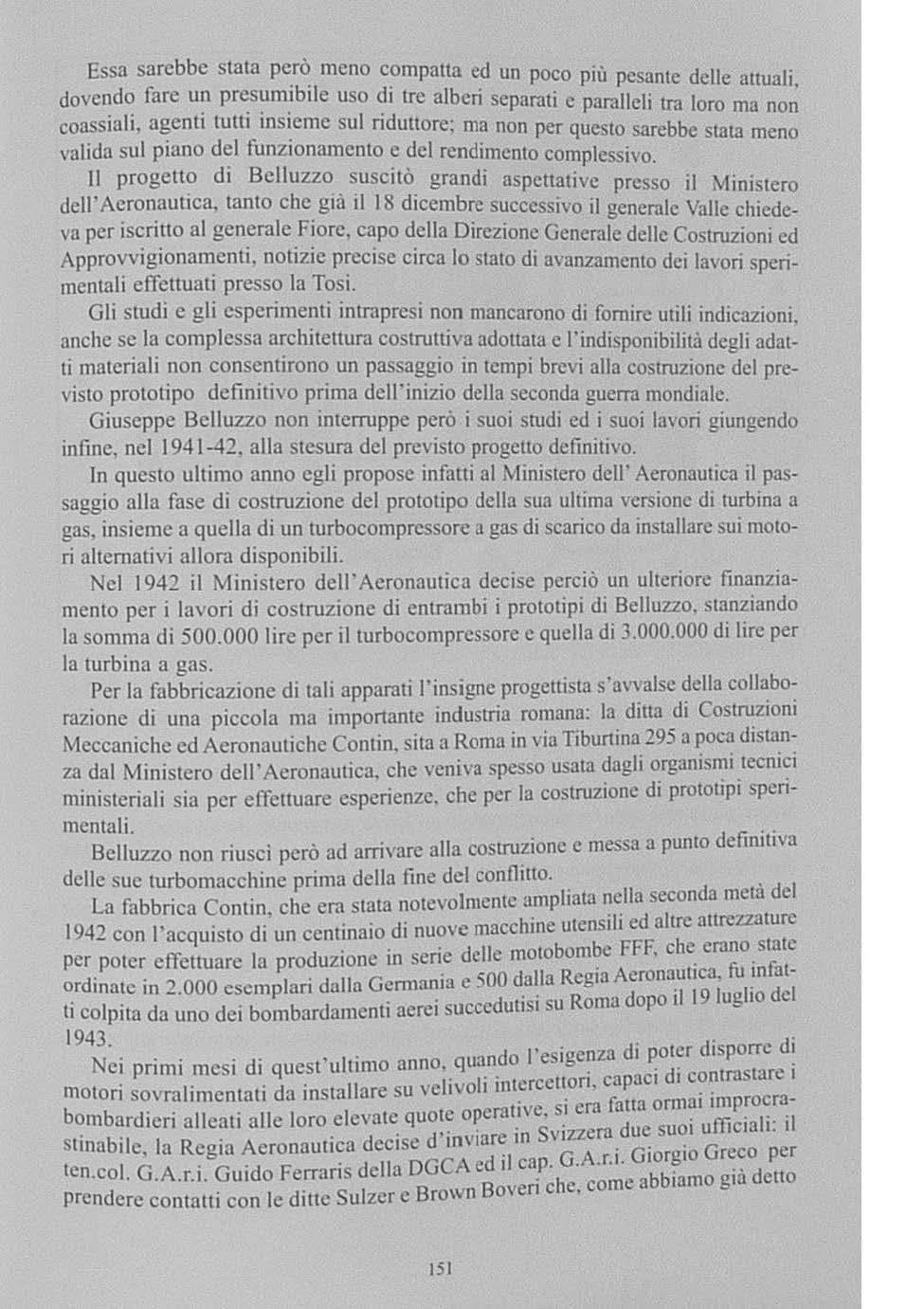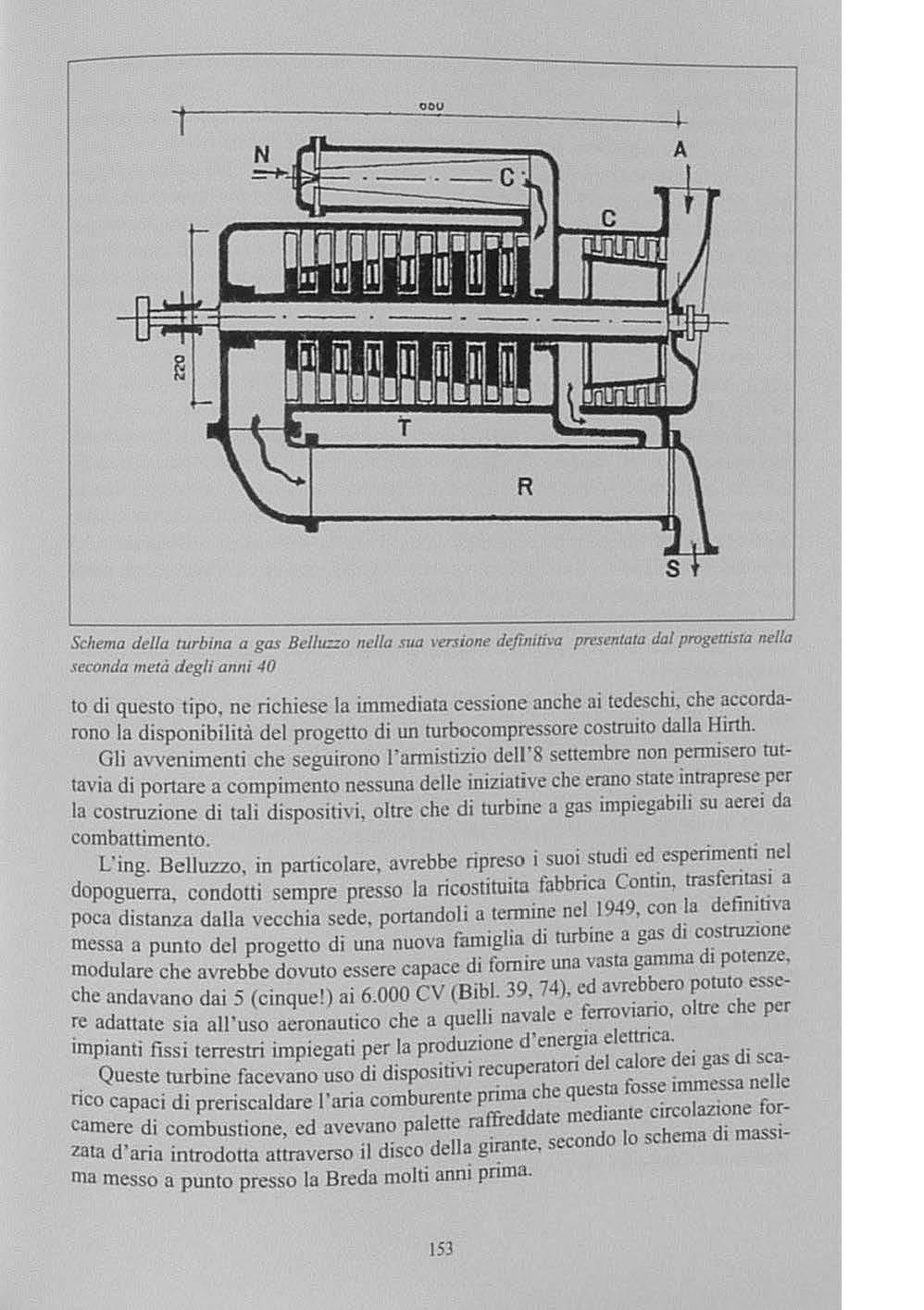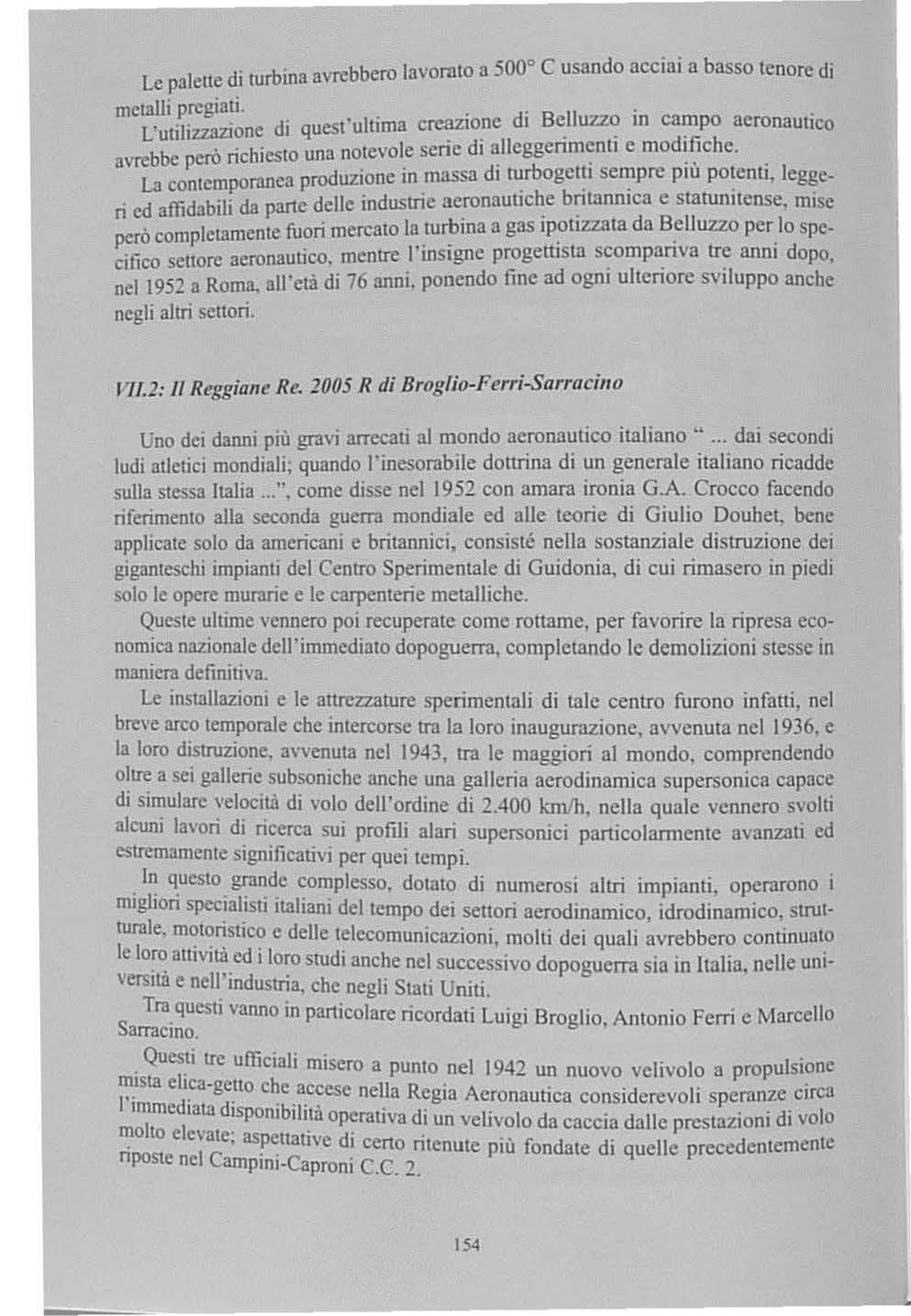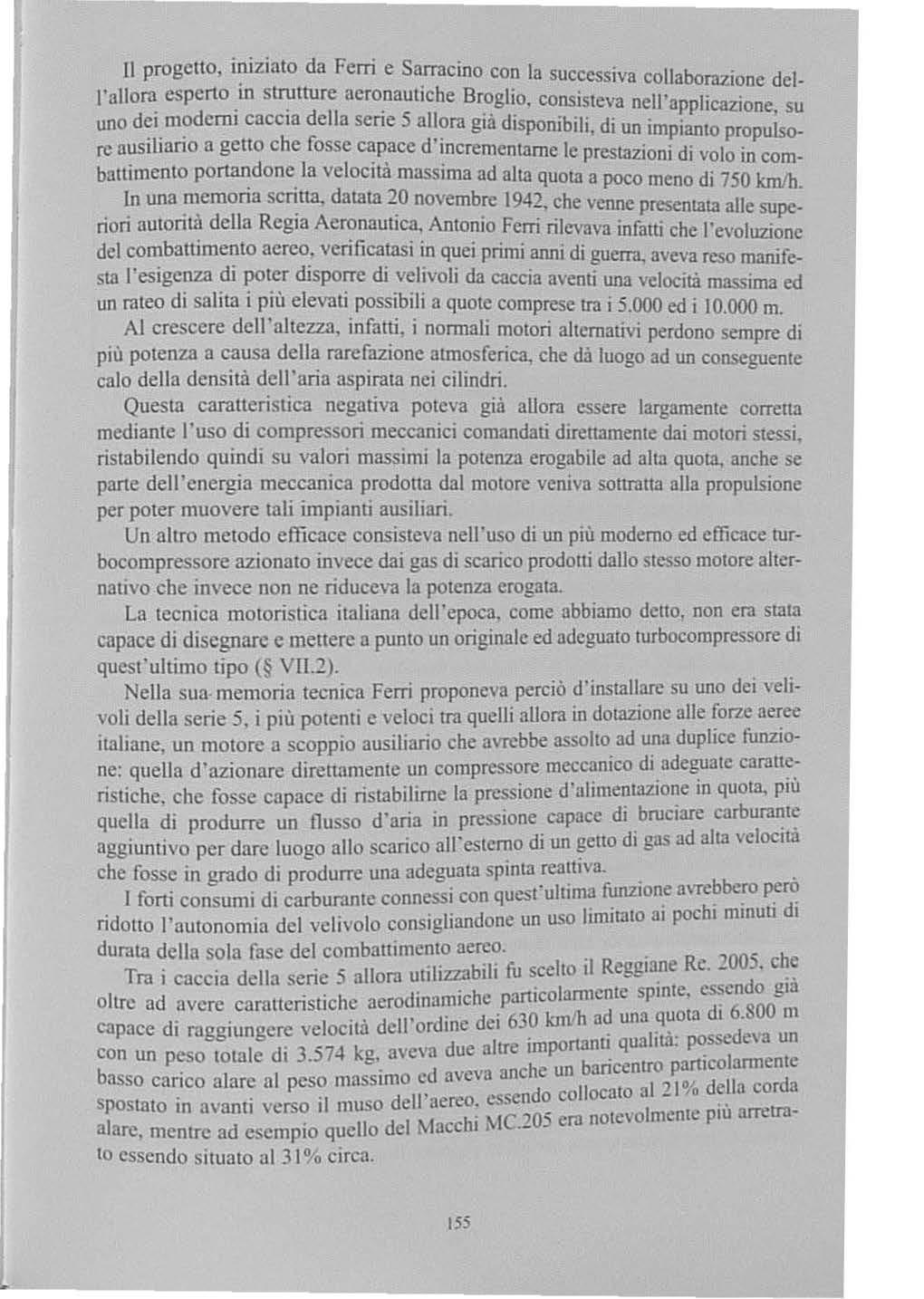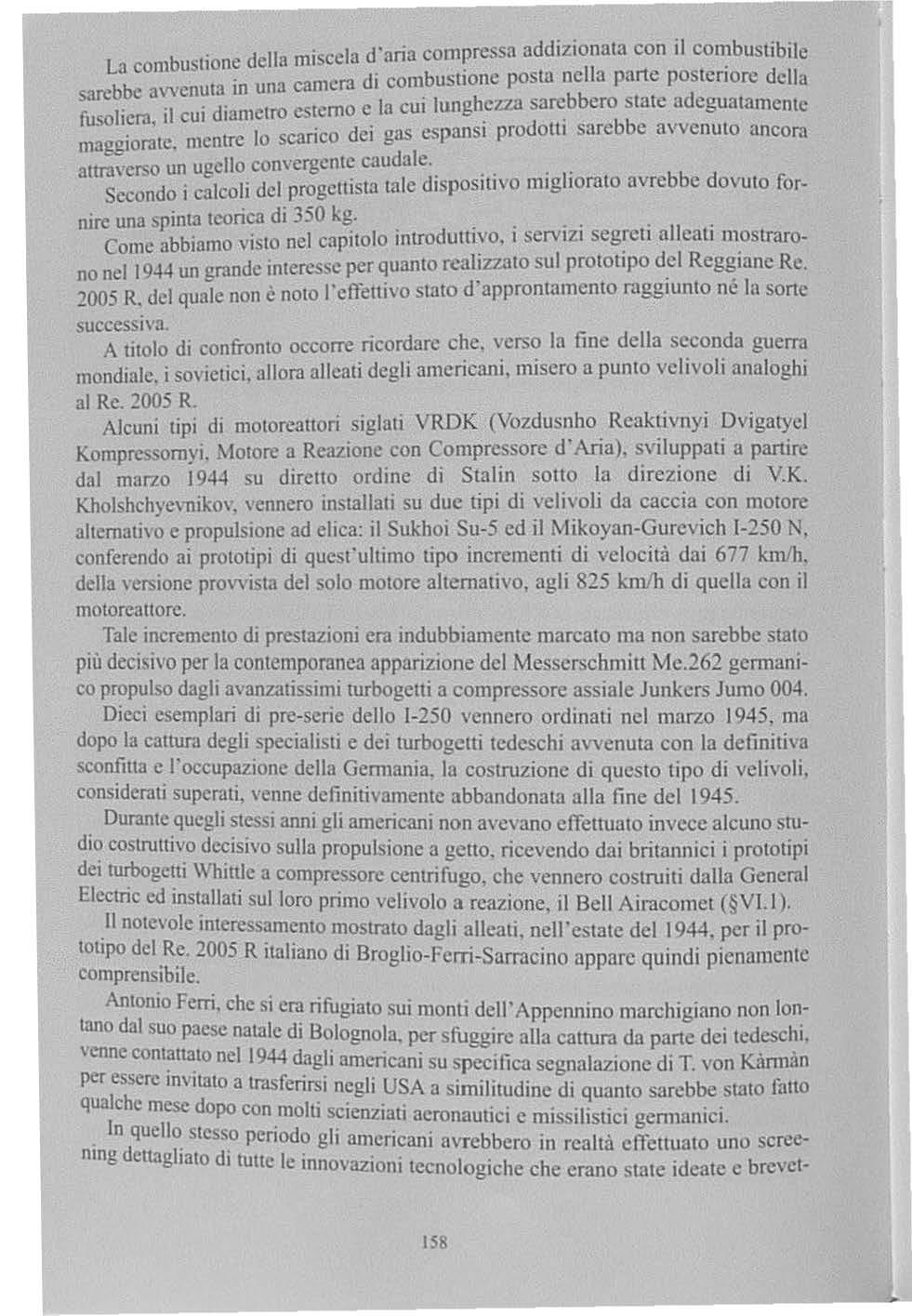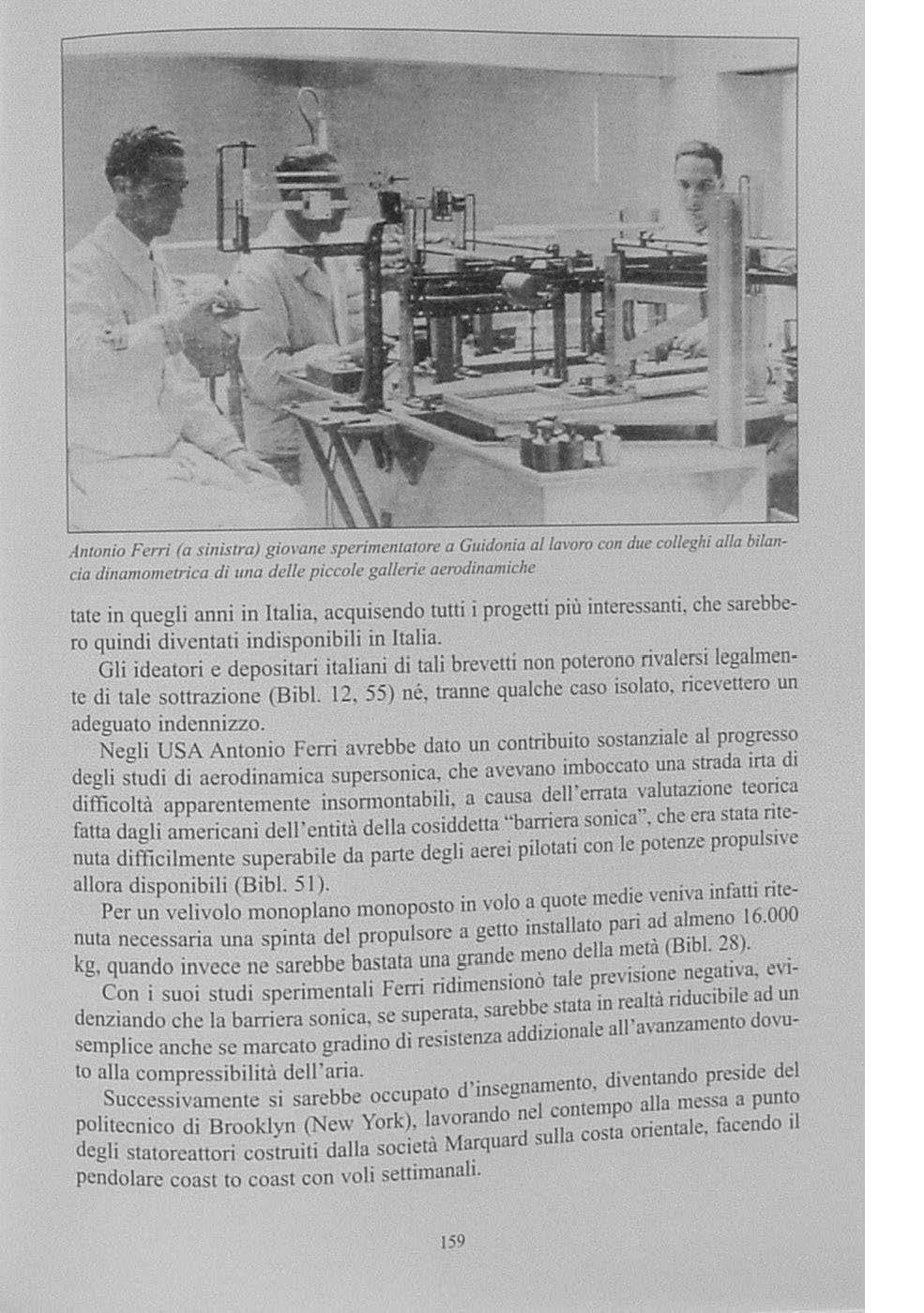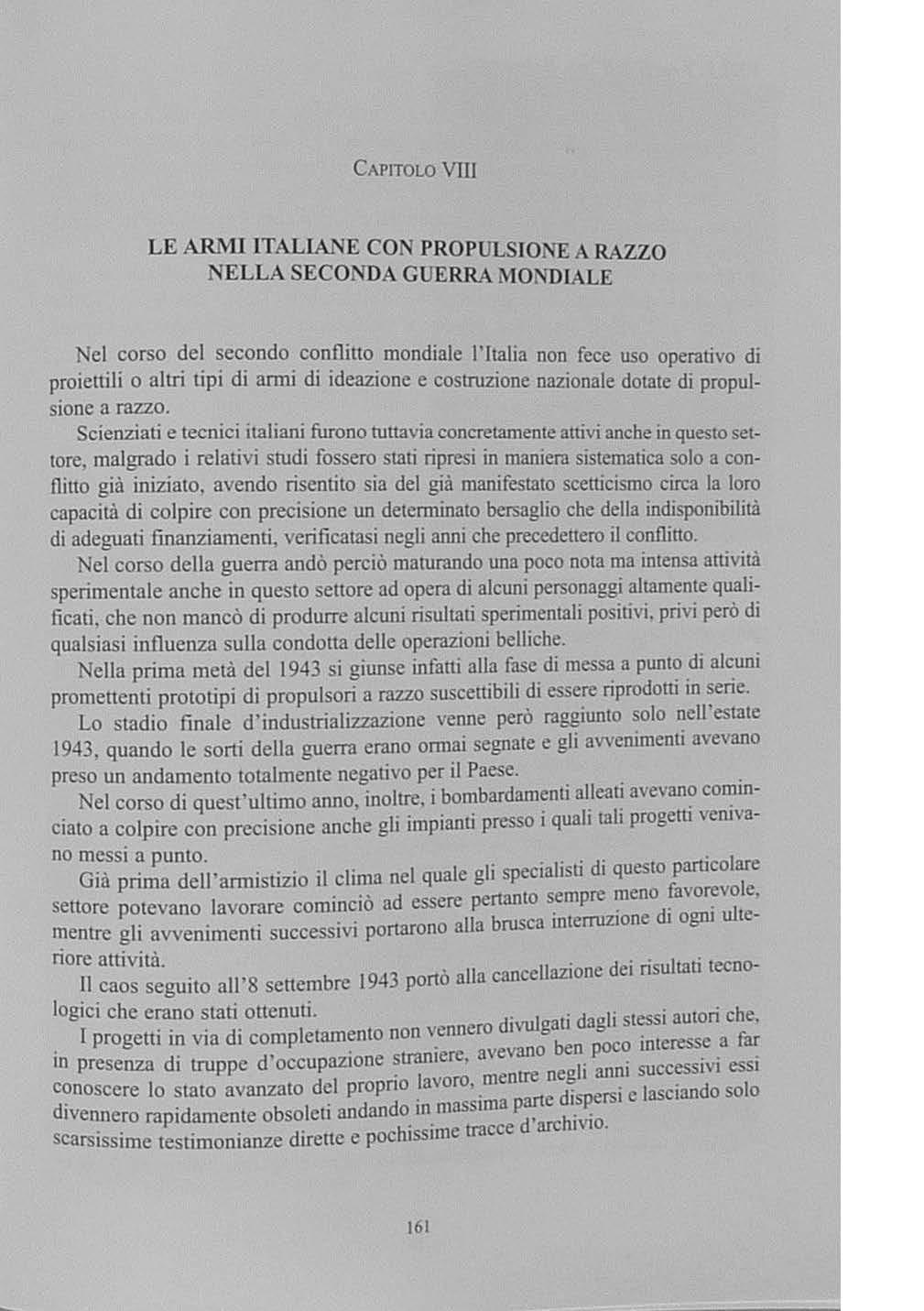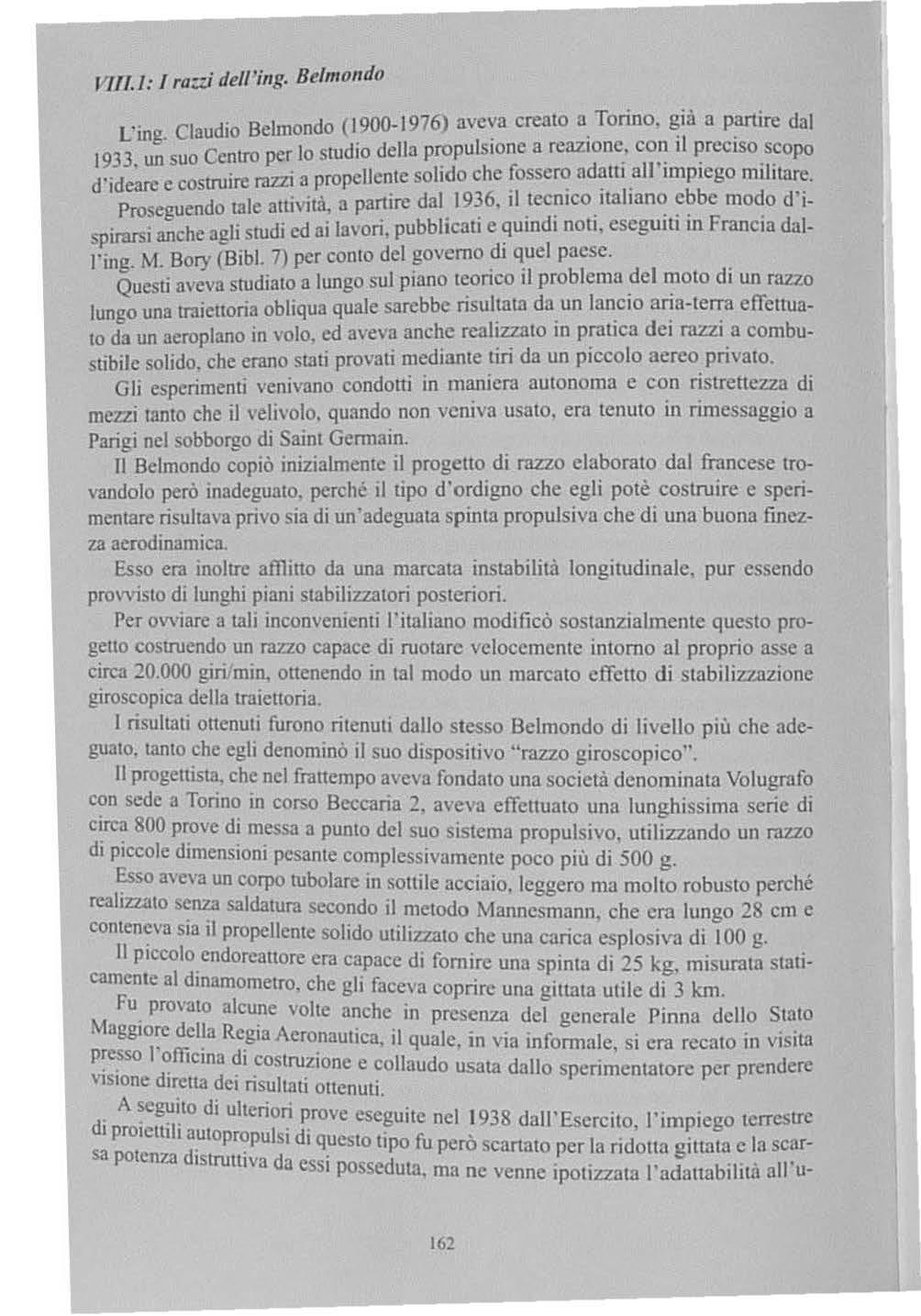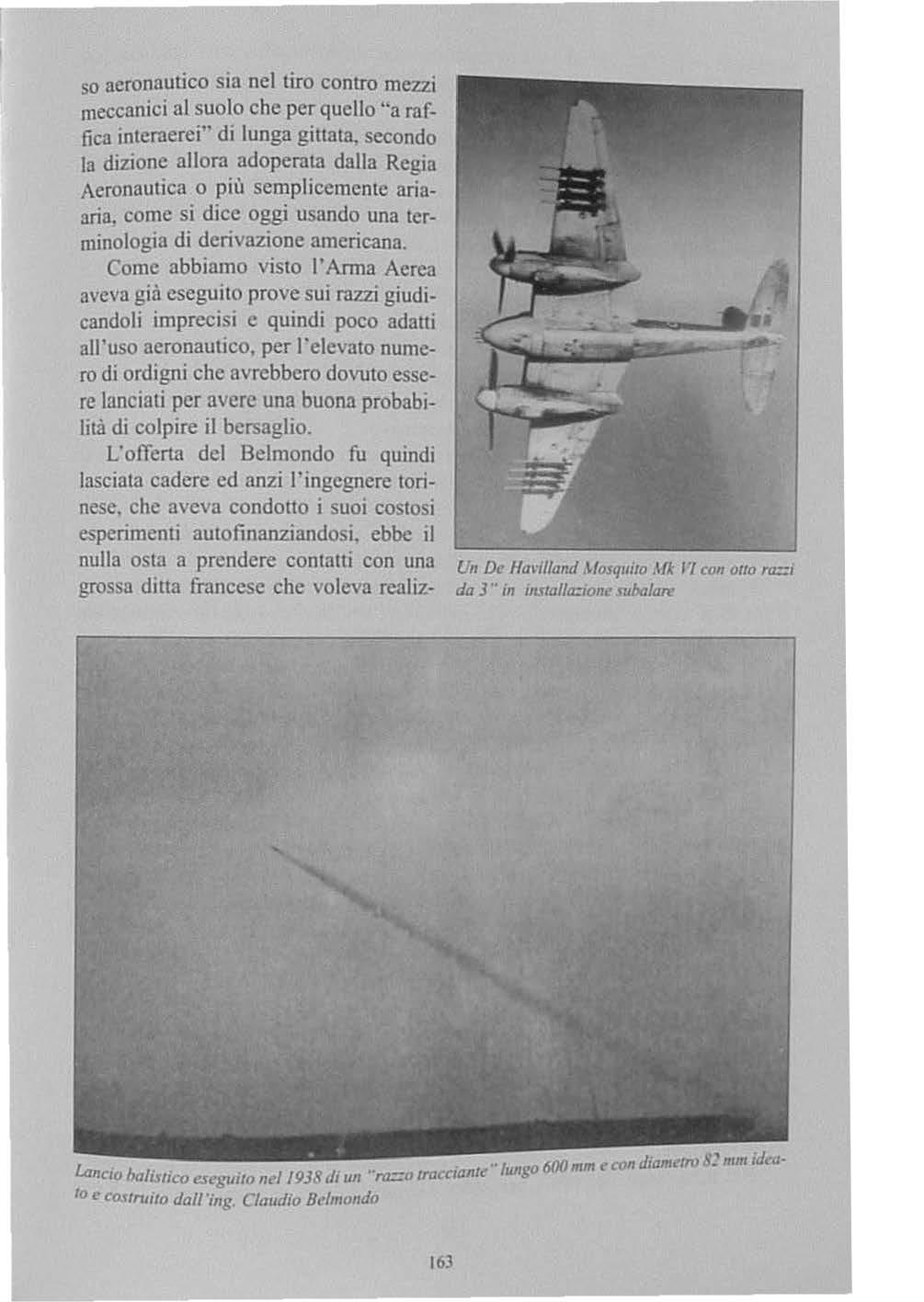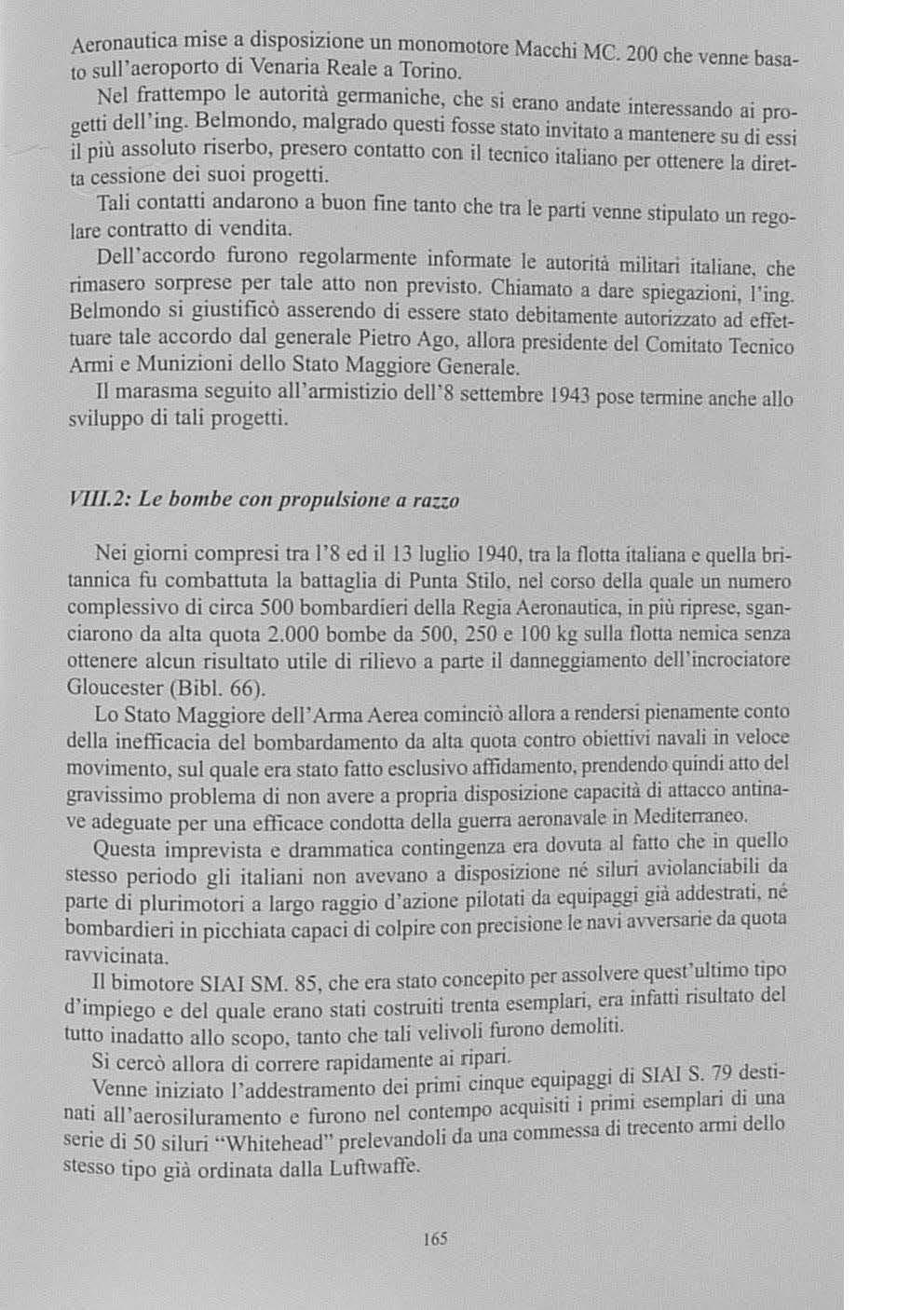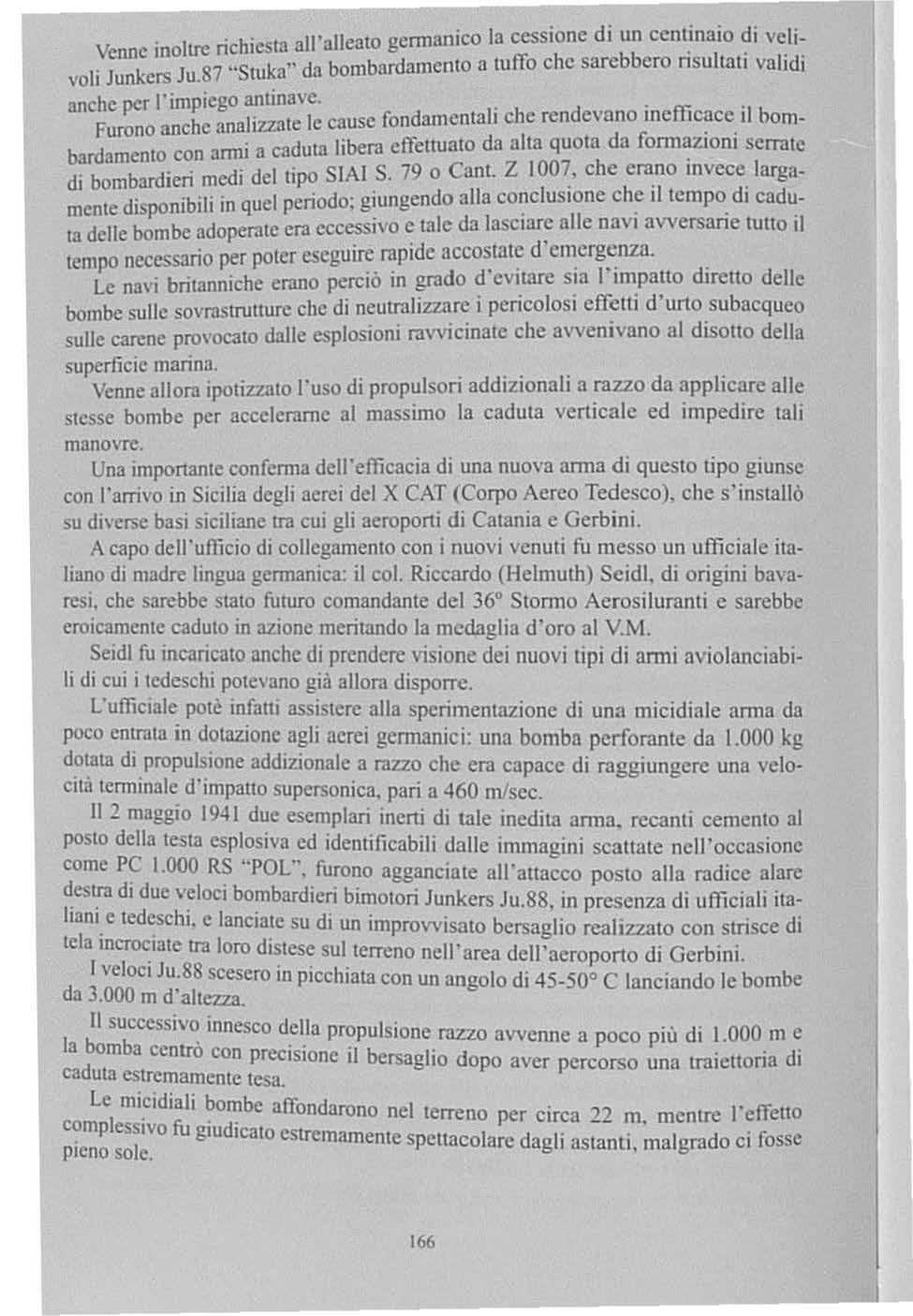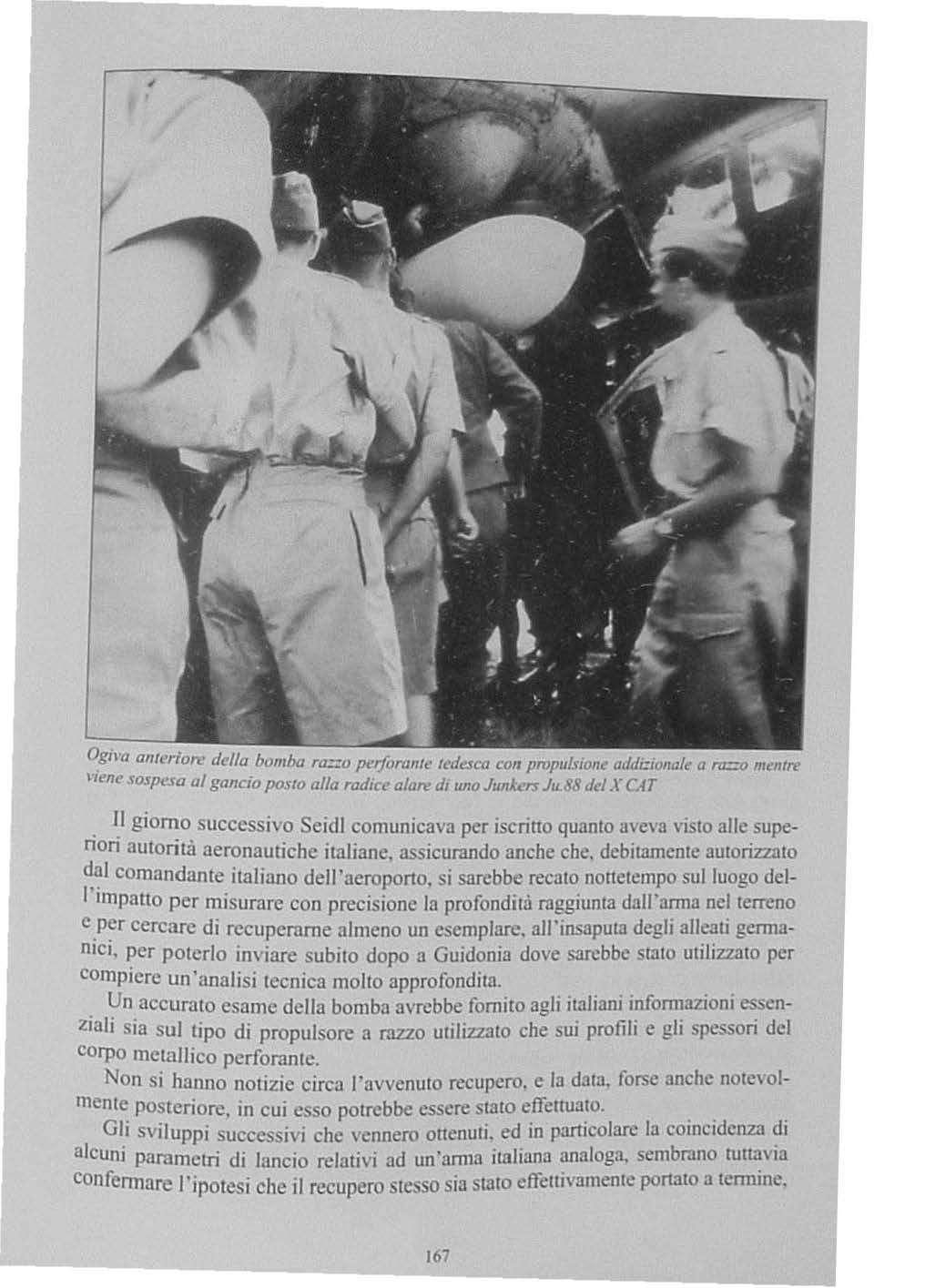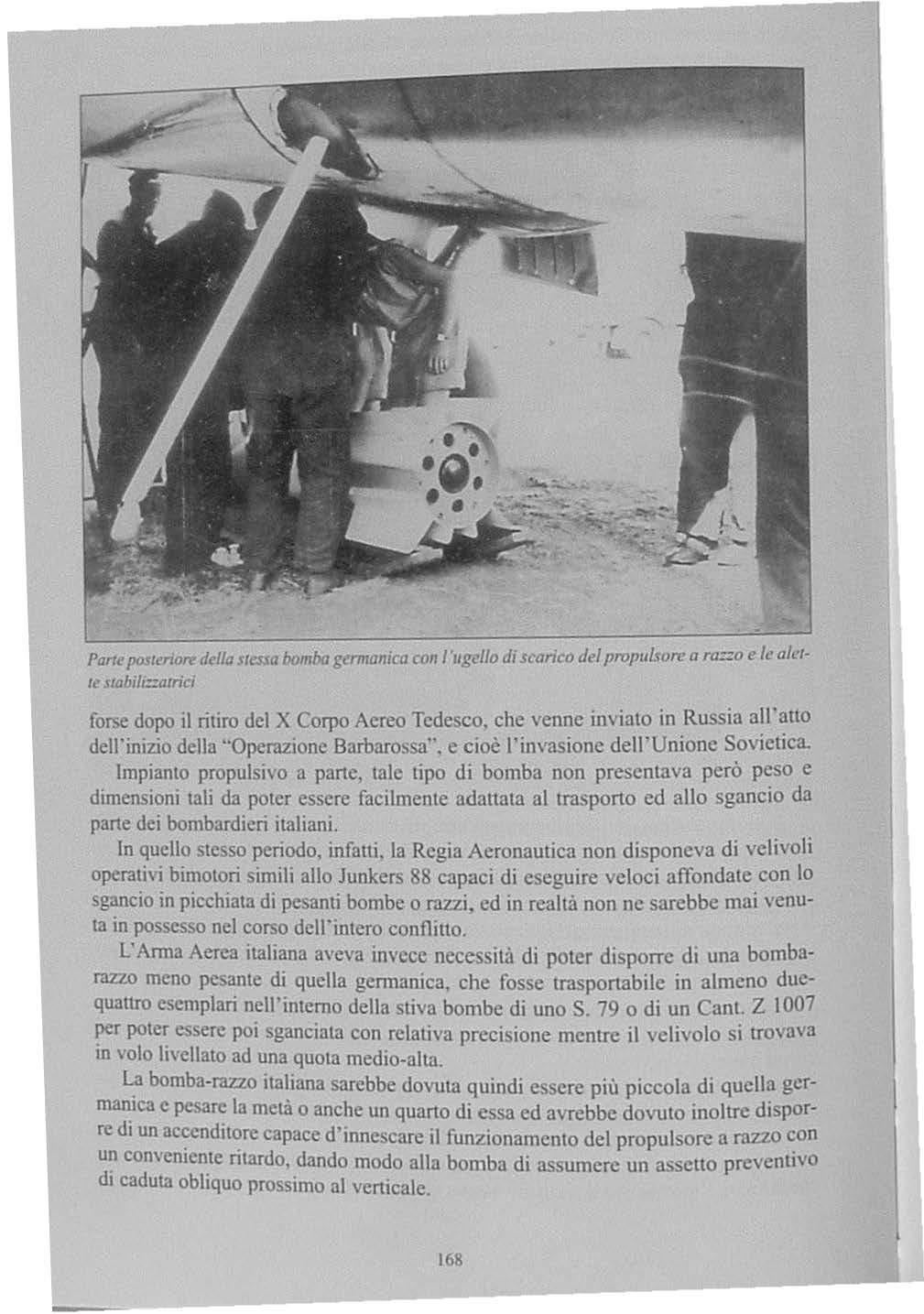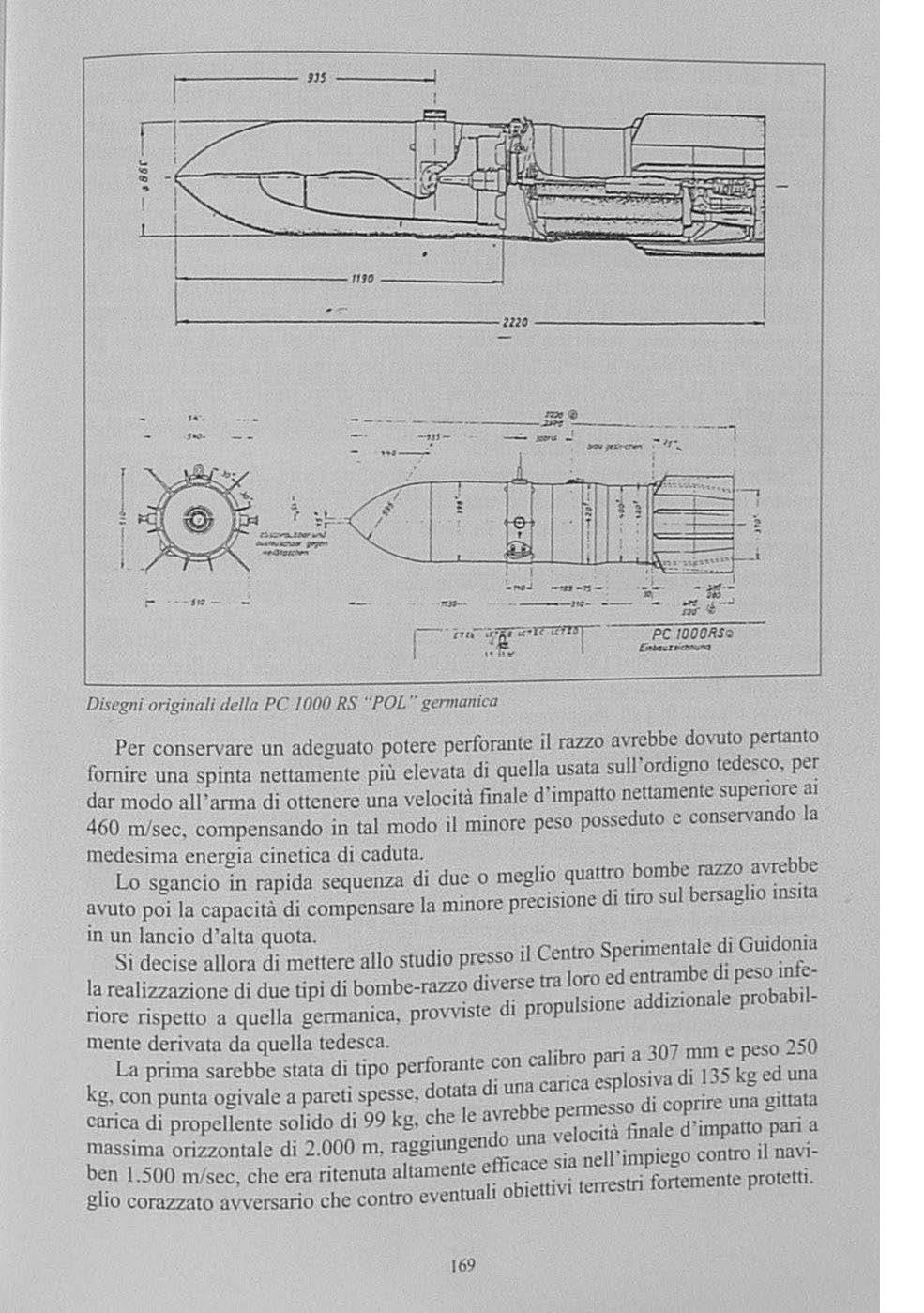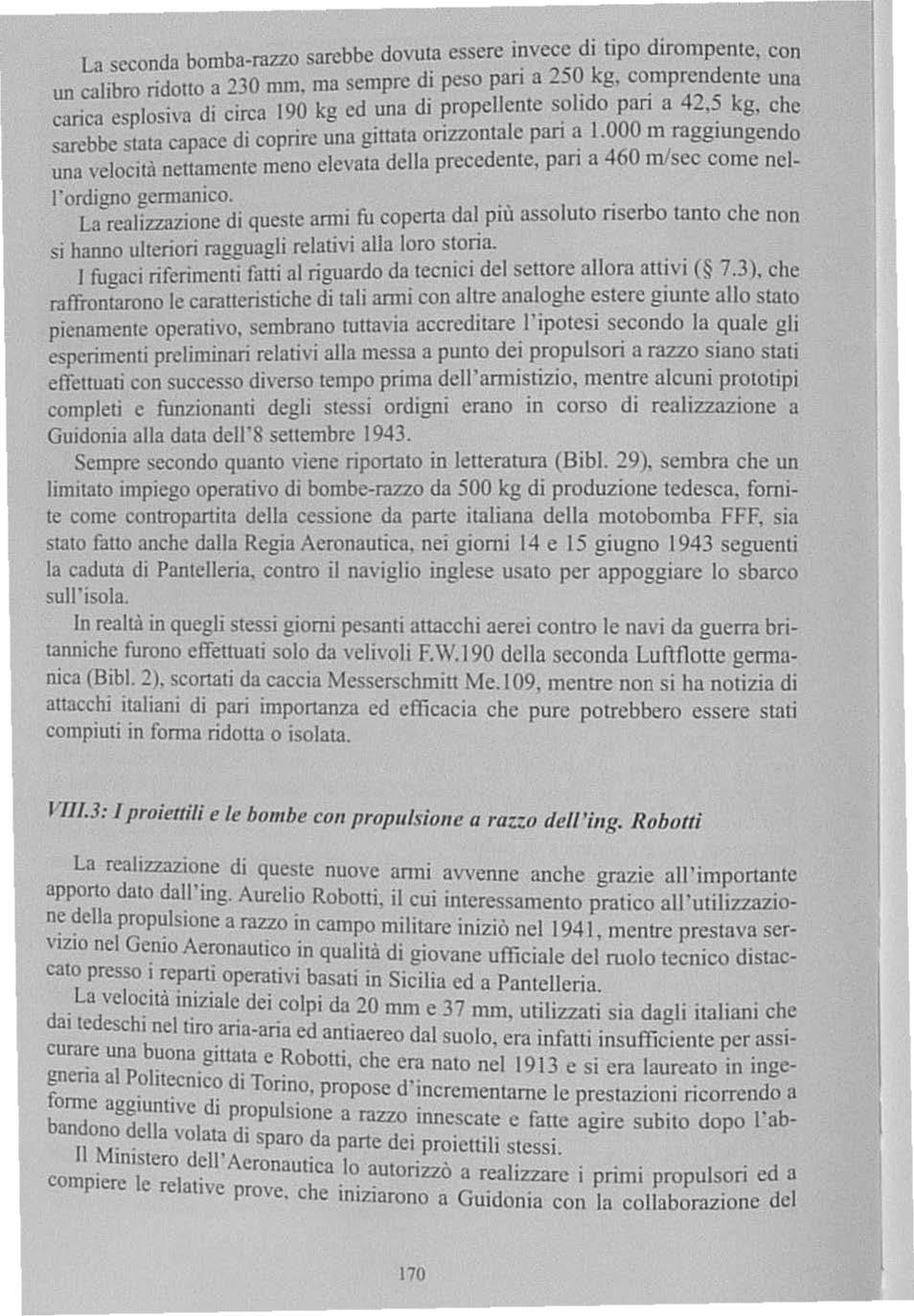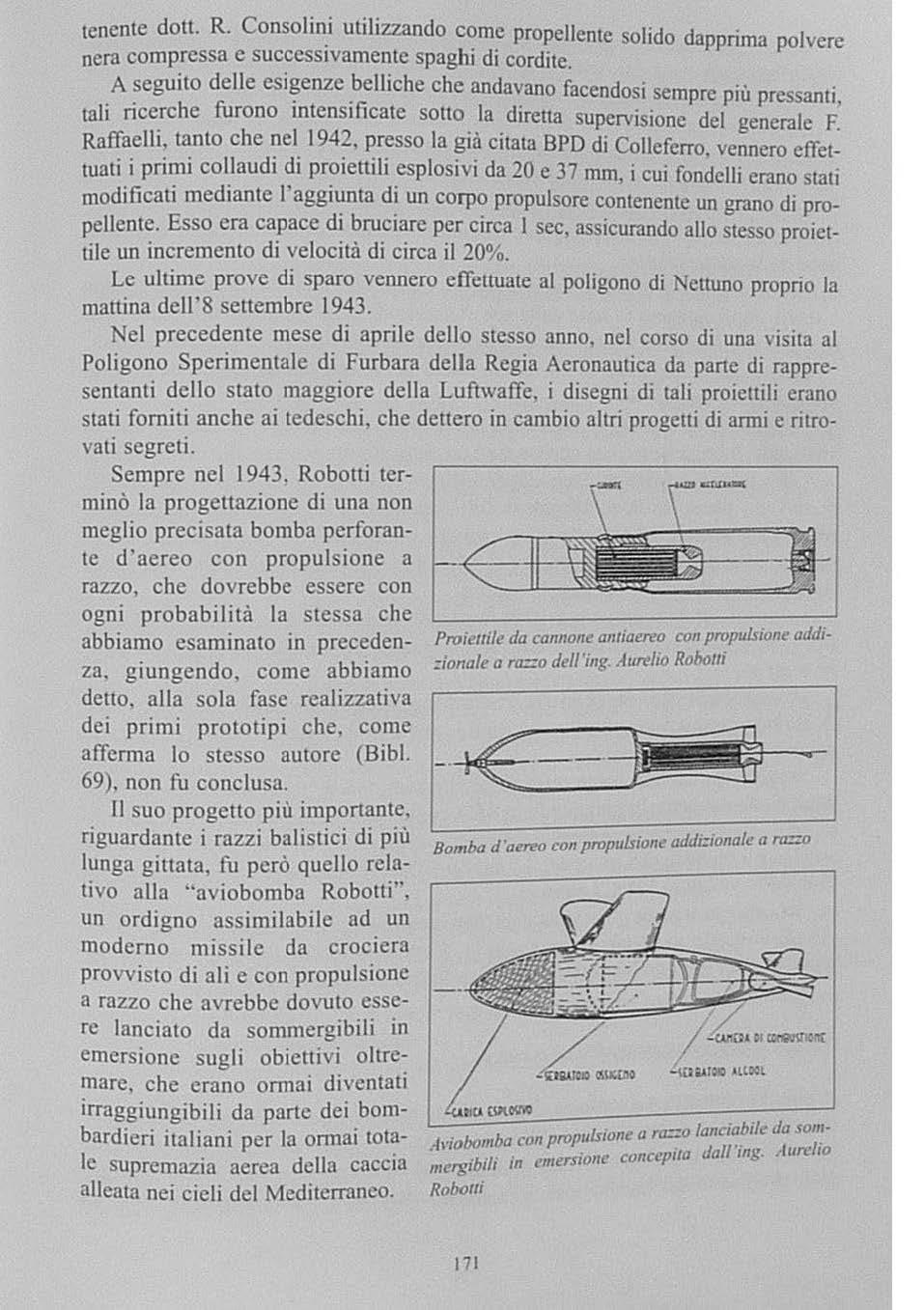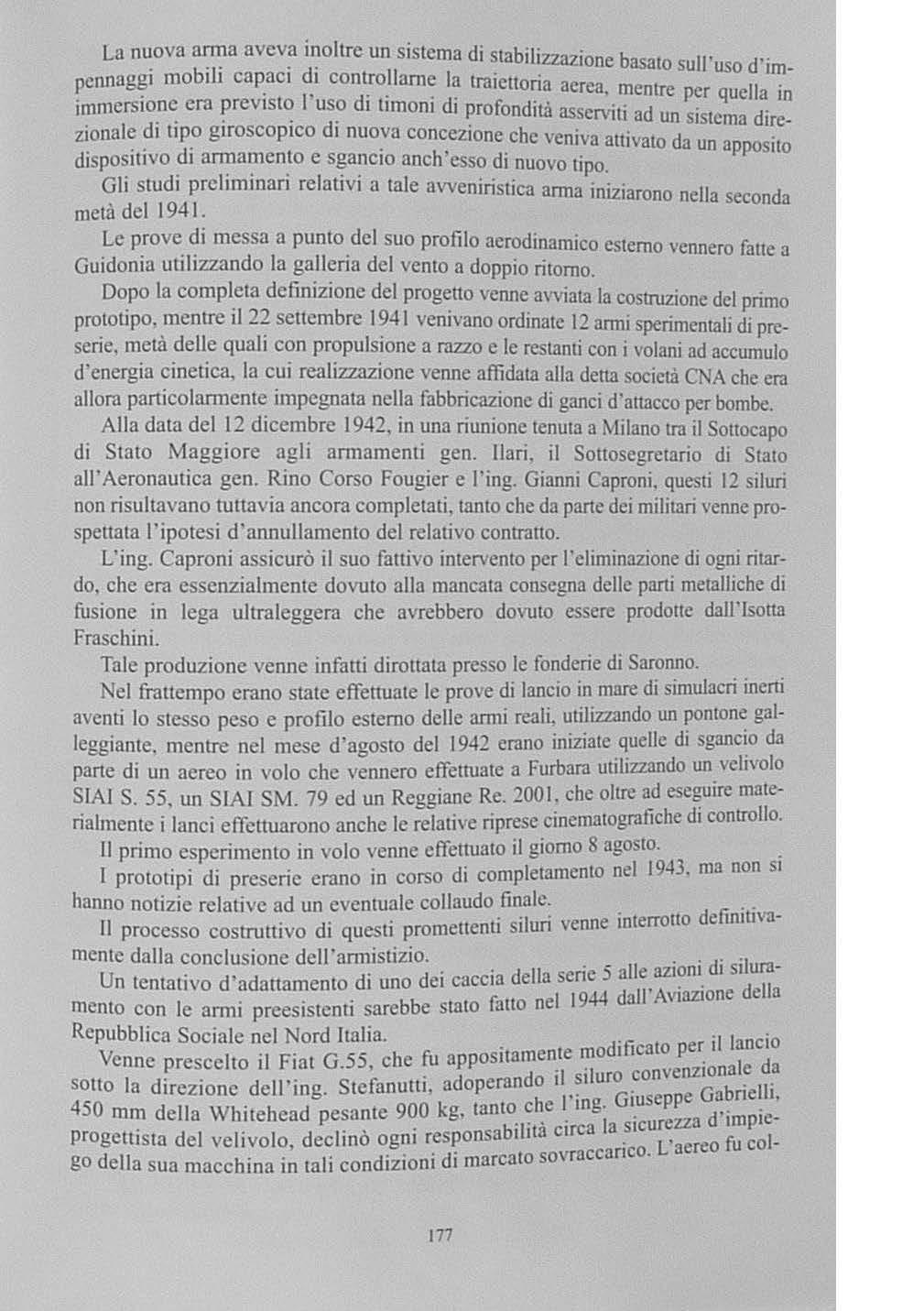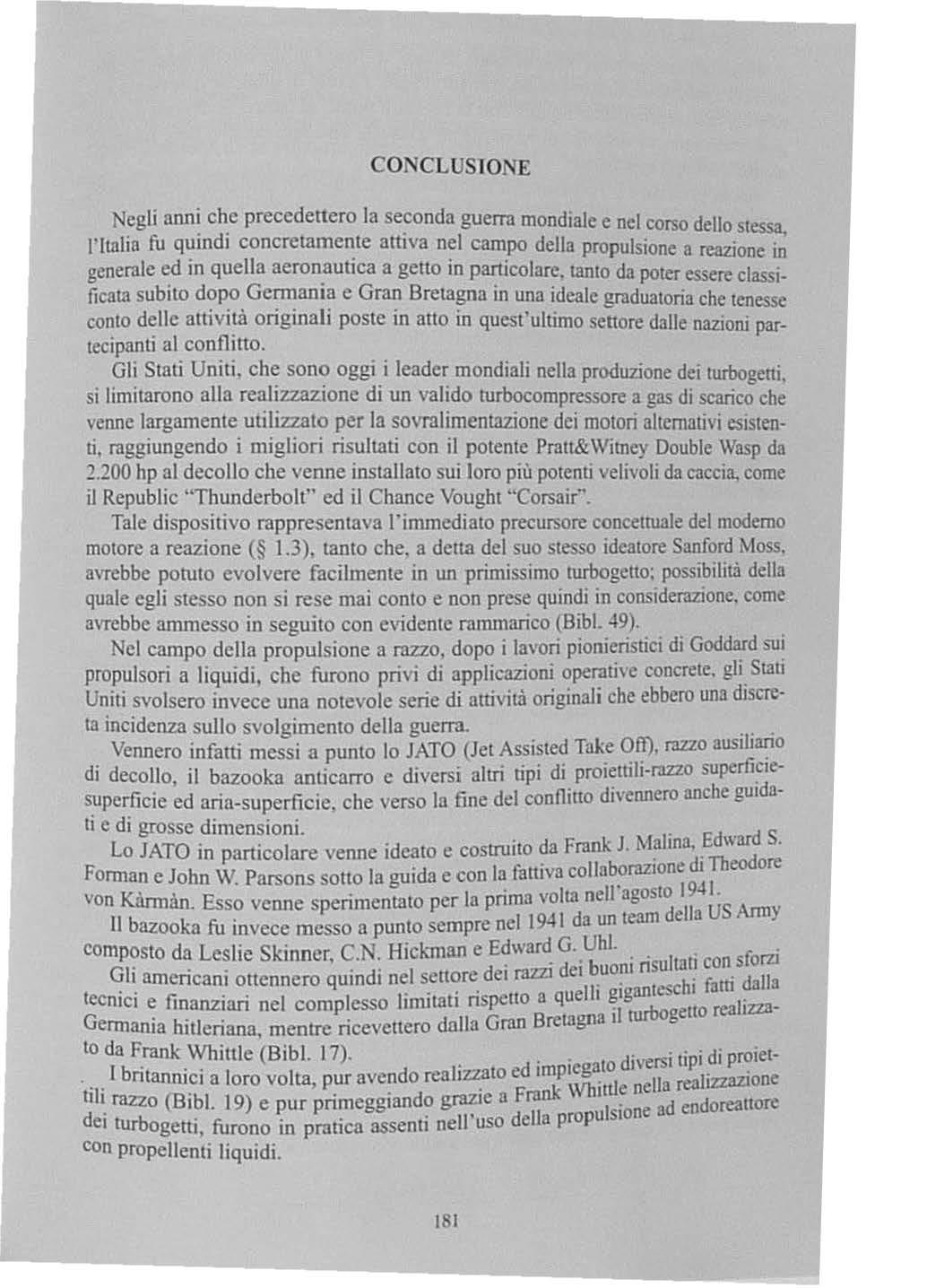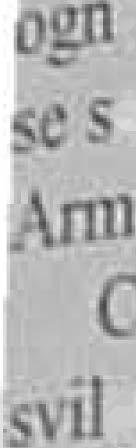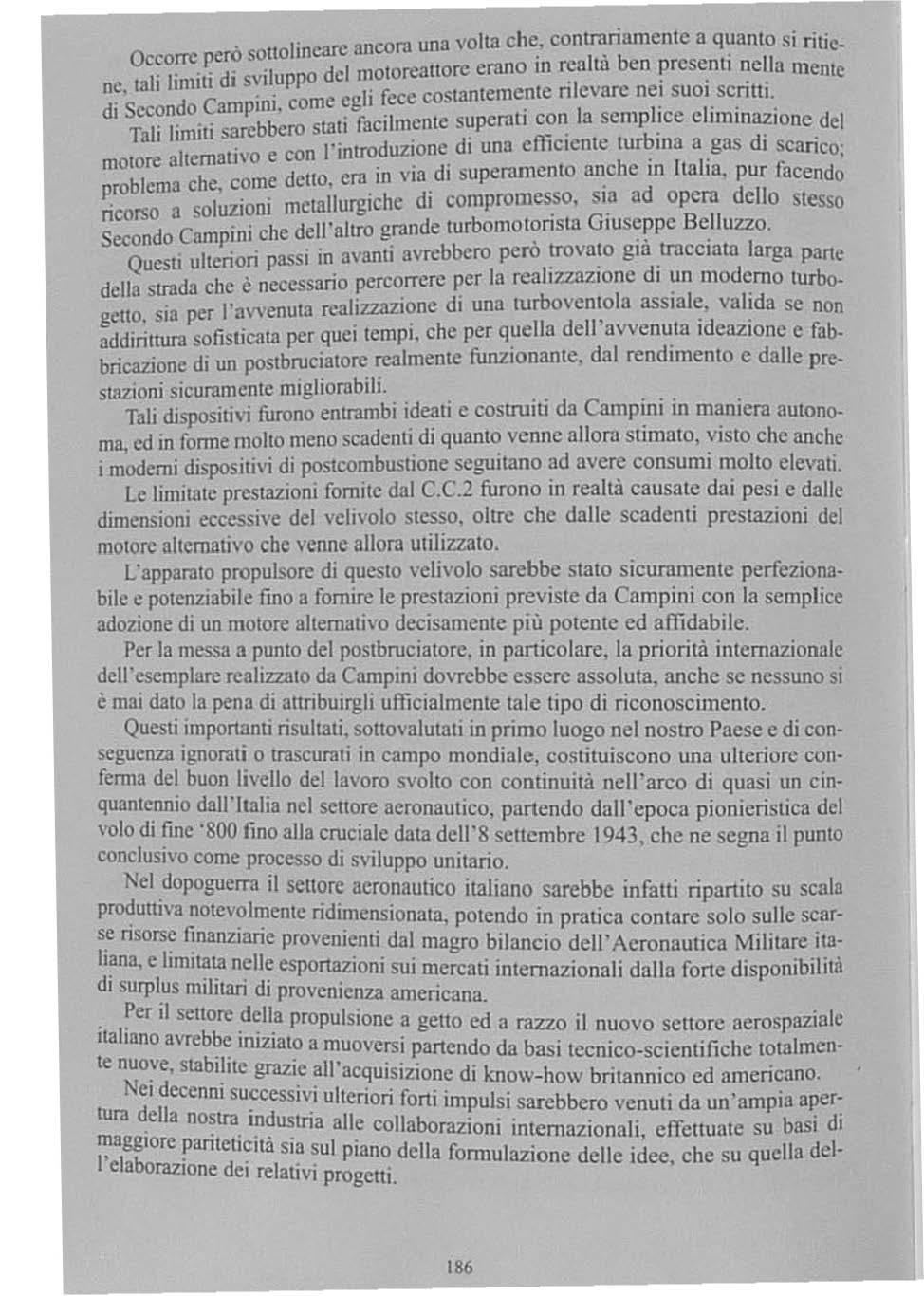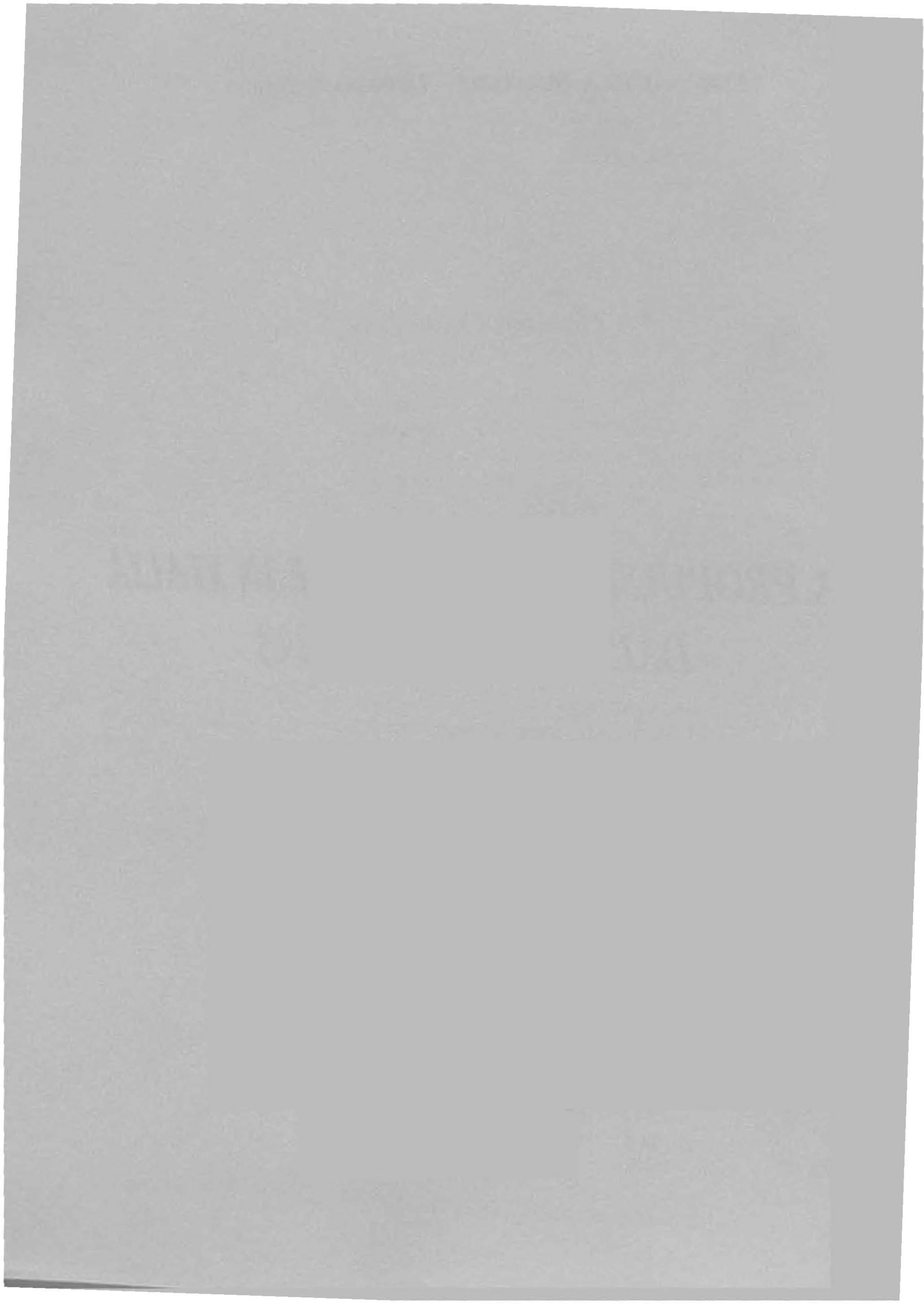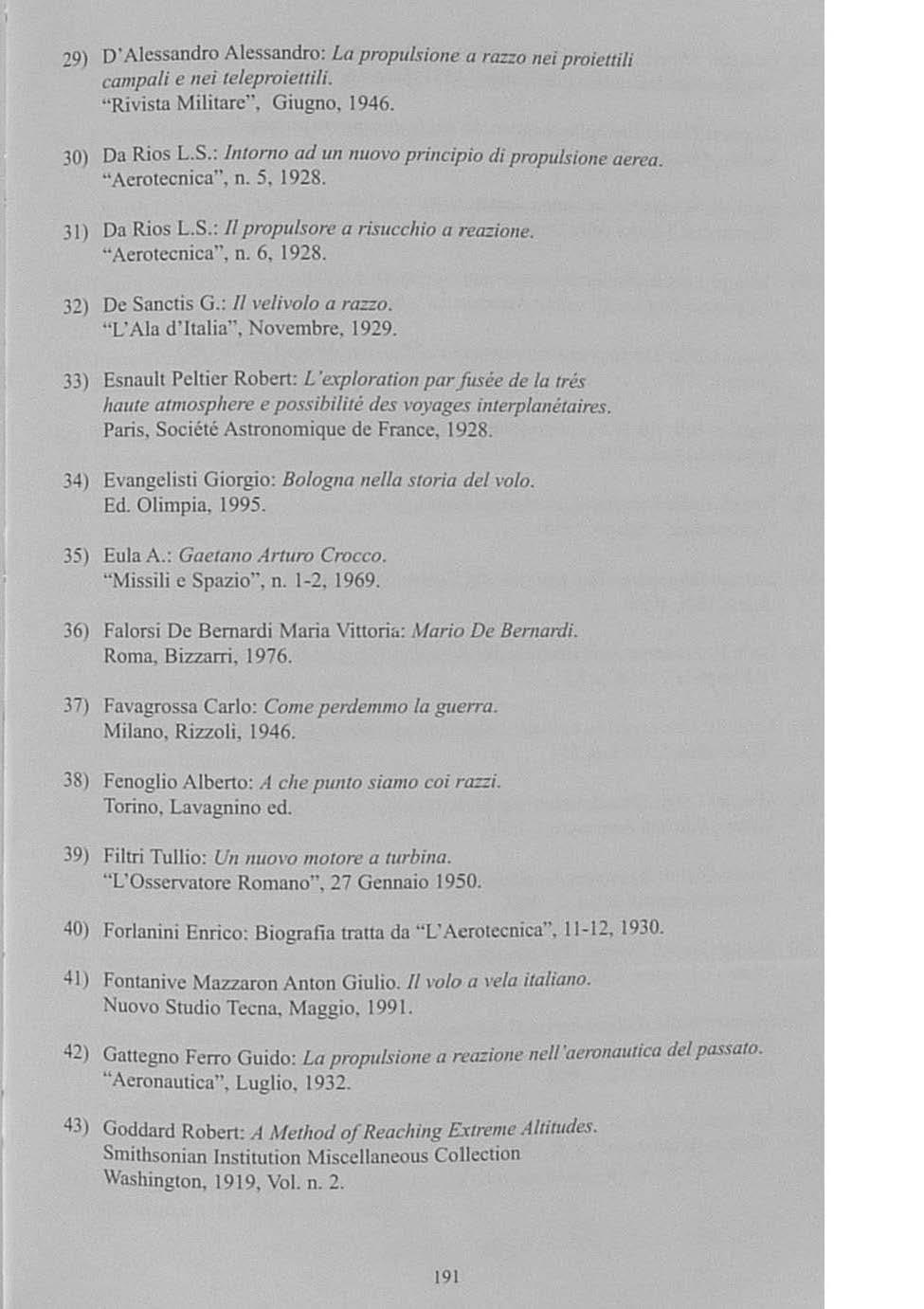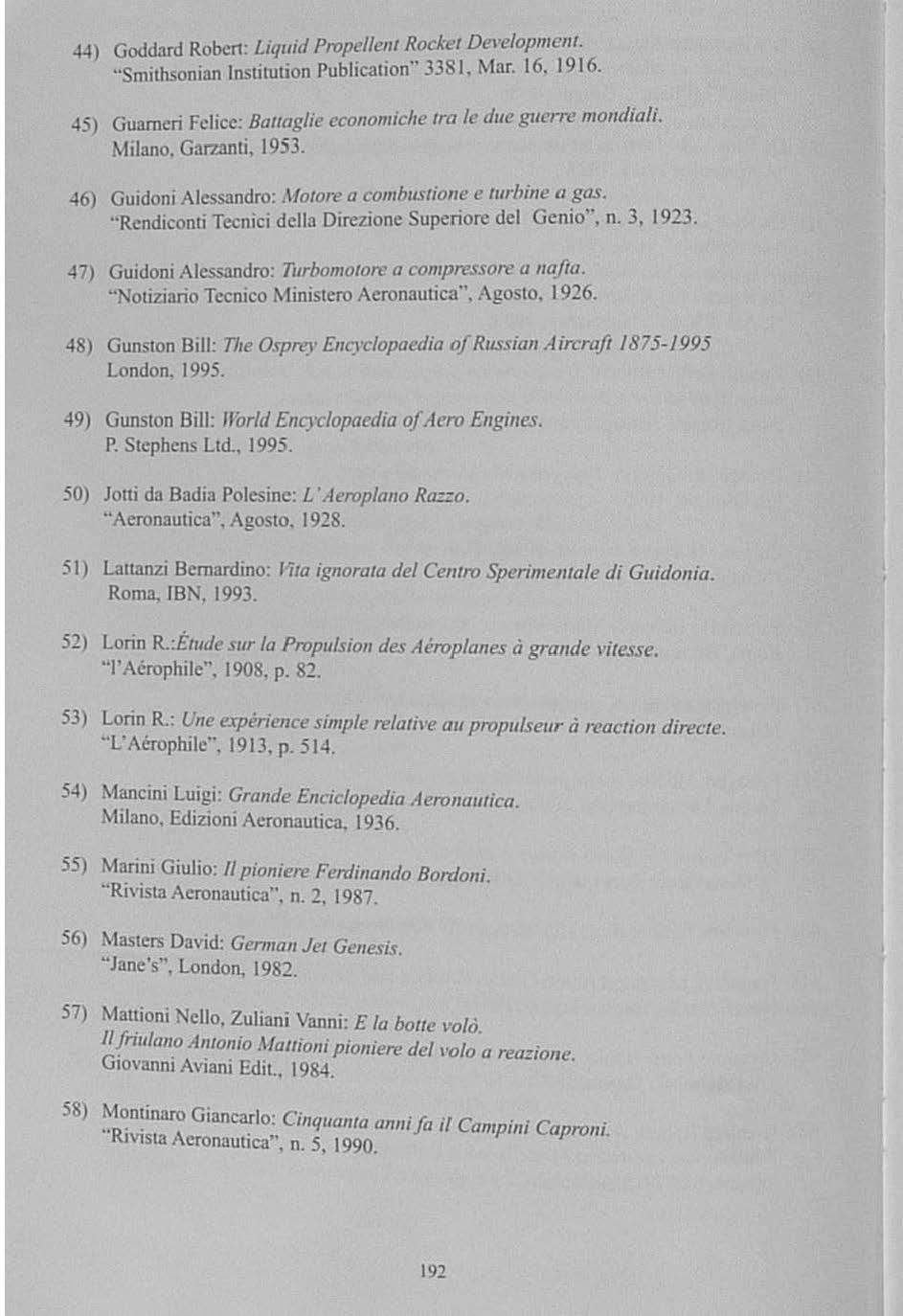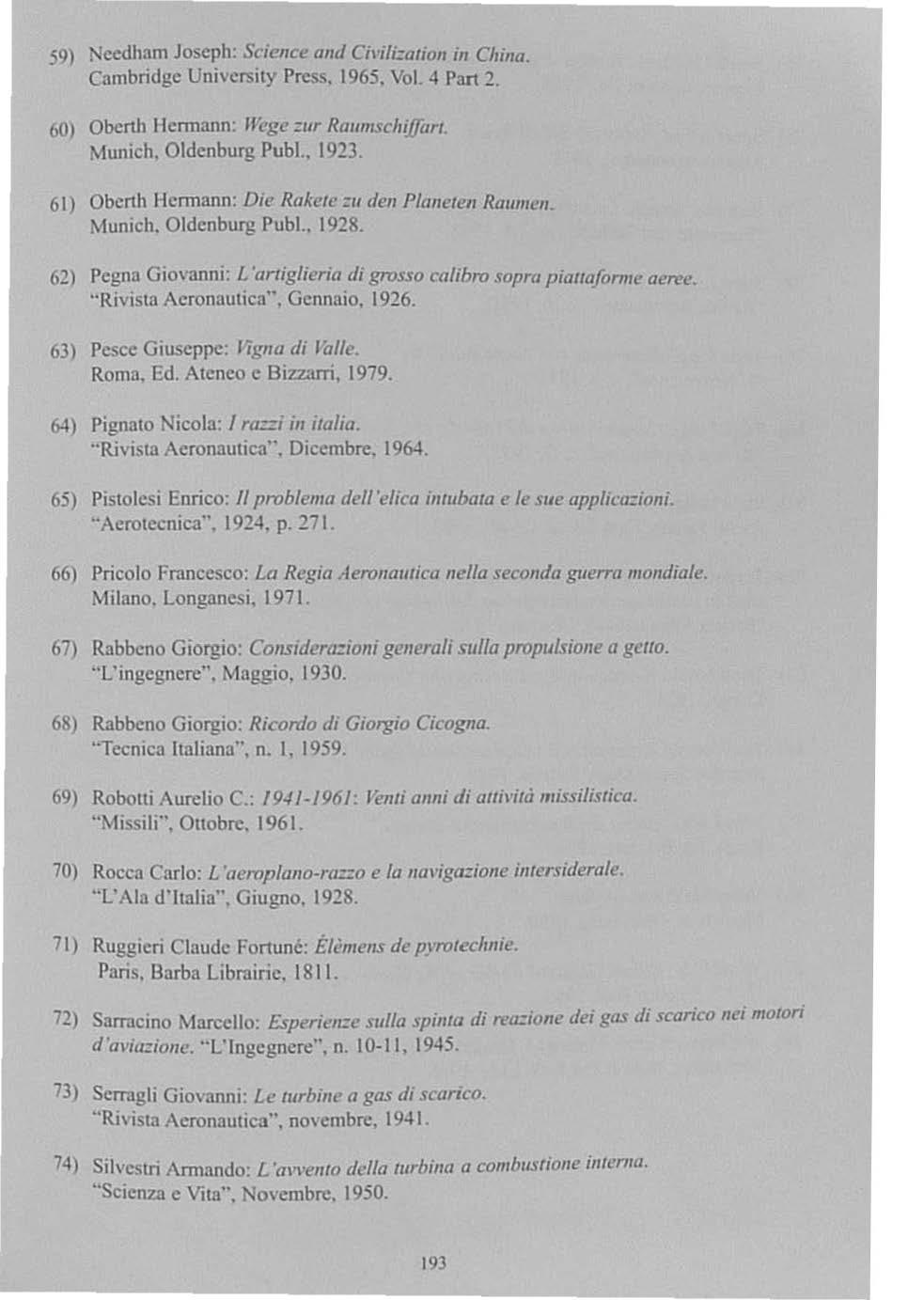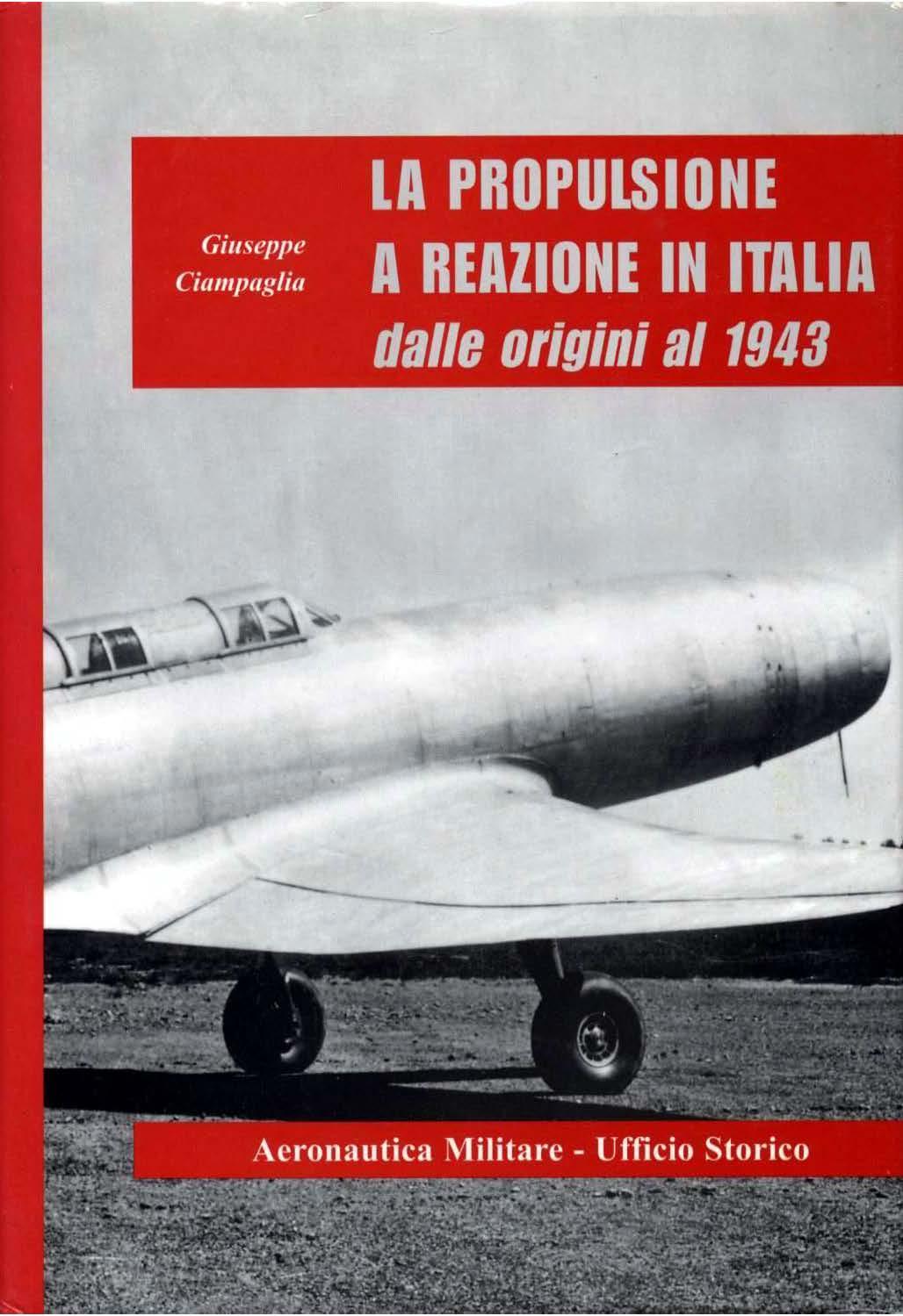



LA PROPULSIONE A REAZIONE IN ITALIA
DALLE ORIGINI AL 1943
MlliTARE - UFFICIO STORICO GIUSEPPE CIAMPAGLIA
.AERONAUTICA
ROMA 2002

PROrRIET,\ LETTERARI,\ T11111, d,rtlli rumutl
Iitt.J.tJ L, rirpoJ,,:J_. lnléh,- f>Jr:,,,l,1ncJ
O 8) SMA. Ulri,x,S1onco • Roma .100~
•
I I· Ln propulsione II getto
1.2· La propulsione a razzo
li. I. I precursori itoham
- Enrico Forlamm
11.2. I precurson stranien delln propulsione a getto
- Il tubo autoreattore di André Lonn
- Il motoreattore di lleruy Coandn
- Comprcsson rouun I e turbine (I gas d1 sc:irico - li turbocompressore per moton altemauvi
3· L'uso dei razzi a polvere ID epoca moderna
della miss11ist1ca spazmle contemporanlla

- Hcrmann Obcnh -
INDICE Introduzione . . ..••• . .•.•. .. •..••. 7 c ...r I. FORME DIVERSE DI PROPULSIONE A REAZIONE ................. . 11
· • • • • ••• , • • • • . • • • • . • • • • • . • • • • • • • • • • • 12 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 14 CAr 11; IPOTESI ED ESPERIMENTI TRA FINE '800 E PRIMI ·900 .. . . . . . . . . . . . . . 17
• , • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 17
• • • a • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 17 -
Canovetti 19
Cosimo
.•.•••.•..•. , .•• , 27
.. . • • ......... •• •.. . .... . ••.
. . ..•••• • •.. . ...•.• ..
••••.•.
11
precurson
. . •••••.... . - Konstantin Ts1olkho, ski ..•• • 27 30 32 39 39 44 44 - Robcn Esnault Peluer • . • . . . . . . • • • • • . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 CAr. lii • L-\ PROPULSIONE \ GETTO 11' IT•\LIA TRA LE DUE GUERRE \IONDI ·\LI •• •• • •• • •• • • •• • •• • • 47 lii I Il "ge1drovolantc" di don O1do Marchesi • • • • • • 47 lii 2: n siluro volante d1 Angelo Belloni . . . . • • • 49 11L3 n turbomotore a nafta con compressore d1 Alessandro Guidoni 51 lii 4. Ehche 1Dtubate od embrionali reatton? 54 - Antonio Mamom . . . . . . . . . . . • . . • . . . . . . • . 56 - Gh studi del prof Lu1g1 Sante Do Rio~ . . . • . . . . . . . . • • . . . . . . • . . . . 60 - Luigi Stipa cd 1I st10 Stipa-Caproni 62 lii .5 L(I ncerca d1 base itnlinna sulla propulsione a geuo . . . • • • • • • • . • . • 71 Gli studi e le reahuaziom d1 Gne1ano t\nuro Croceo . . . •• • • . . . . . • • 71 Cw lV: L·\ PROPULSIONE ·\ R. \ ZZO TR,\ LE DUE GUERRE MONDIALI • • • • • • • 77 I\ J · I pnmi espenmenu negli Stall Unili • • . . . • . • • • • . • . • • . . . • • . 79
Pmm esperimenti e ricerche
Umonc Sov1e11cu •.• • • . ....•.•.
fl.4 I
- Robcn Hutch1Dg:. Goddnrd rv 2:
m
JVJ· Pnm1 c:;penmenll e ricerche ID Gcnnunm
Valicr
. . • • . . . . . • . ..• • ••.•..•••.•••.•. - Il \ crem ffir Roumsch11Tar1 80 82 82 8-l 86 • \\'emer von Bmun a Pecncmunde . . . . . . . . . • . • . . . . . . • . • . . . . . . . . . 87 3
MnA
e Fnu , ·on Opcl
l\'.-1: Prime nccrche cd c:.pcrimenti in rialio
• I razzi dell3 BPD (Bombrini-Parodi-Dclfino)
• I raJZs di Euorc Canoni:o
. Gh c5pcrimenti sui r.lZZ1 del 1931
. li motore a razzo di Cicogna e Rabbcno
Gli esperimenti con il ni1romcUU10
L'A ·oc107.ione Pic:montese Razzi
\.I : li Campins Secondo C S. I ......
\ .,. L'aeroplano sn.•rimentalc Campini Caproni
- r-
• rt problema dello rurbma
I collaudi in \ olo d1 Guidonia
VJ: t progetti d1 b1re.11tori da combanimcnto
V.-1: li proge110 di turboelica .
La designazione

\'elivoli
VII.I: La rurbina a gas dell"ing. Beliuzzo
Il Reggiane Re.
VIII: LEAR.MI ITALIANE CON PROPULSIONE A RAZZO l'\ELLA Il GUERRA ~fONDIALE
Vlll.1: I razzi dell'mg. Bclmondo
Vtrt.2: Le bombe con propulsione a razzo
VTil.3: I proienili e le bombe con propulsione a razzo dclring. Roboui
Vlll.4: I silun con propulsione a razzo
• 11 siluro "Fantoni~ -1 siluri dell'ing. Bo~~~i
\'fil.5: Il siluro-l'B720 di Stefanmi.....•....•••.•............•••...
VJll. 6 : Il razzo a propellente solid~ ~~ll;i~~: ~-e·
88
. . • . . . • . . . . . . . . • • • • • . . • . 89
. • . . . . . . • • . • . . . . . • . . . . 91
• • · · · · · · • • • · · · · • • • • • · · · • · • · • · · · 93
. . . . . . . . . . . . • • • . . . . • . • . . . . . . . . 93
. . . • . • . . . . . . . . . . • . . . . • . . . 95
· · · • · · · · · · · · • • • • • • • ' · · · 98
•.•....•.........•..•... I 101 I PROPULSORI \ GETTO DI SECONDO C \MPIN •••••........•••••..
•
•
· · · · · · · · · · · · · · · · · • • • · · • · · · · · I o3
C.C.2 • • • • • • • • • • • • • • •• 111
114
· · ·· · • • · · · · · · · • • • • • • · · •
.......••. • • • • • • • • • • • • • • • • • - 125
...•............. • •. •. - 129
. ........................ • .. • • • • 134
Campini 136 C,u,. \'I: I PRJ\11 Tt;RBOGETTI ESTERI ........•.......•.................. 139 Vl.l: J primi turbogcttt britannici • • • • • • • 139 \'1.2: I pnm1 turbogcrn gennarnci . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141 \11.3: I primi veli\Oli a geno a confronto ....•.•.....••••........... 144 C,u,. \'Il: PROPlil.SORI
VELI\'OLI •.\ GETTO ITALIANI t-;ELLA Il GliERRA MO~Dl.\LE •.•....•..••.• 147
. .
\'.5:
dei progcni e dei
di Secondo
E
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . 147
2005 R
. . . . . • . . . . . . . . 154
. . . •• •• . . • . . • . • • .. •• . • 161
vn.2:
di Broglio-Fcrri-Sarrocino
~-
..••.•.........•.••••••.•....... 162
. • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . t 65
... 170
......•.................... 172
: ·:: · · • · · · · • · · · · • • · · · · · · · · · · · · · • • • • · · 17 ~
:
17:>
:::::: :: :!~ CONCLUSIONE ...•.•.• · · • • · · · · · · • · • · · · · .•.......•....... 181 BIBLIOGRAflA .......• · • · • • · · · · · · · · · · ..............•.... 187 4
:::::::::
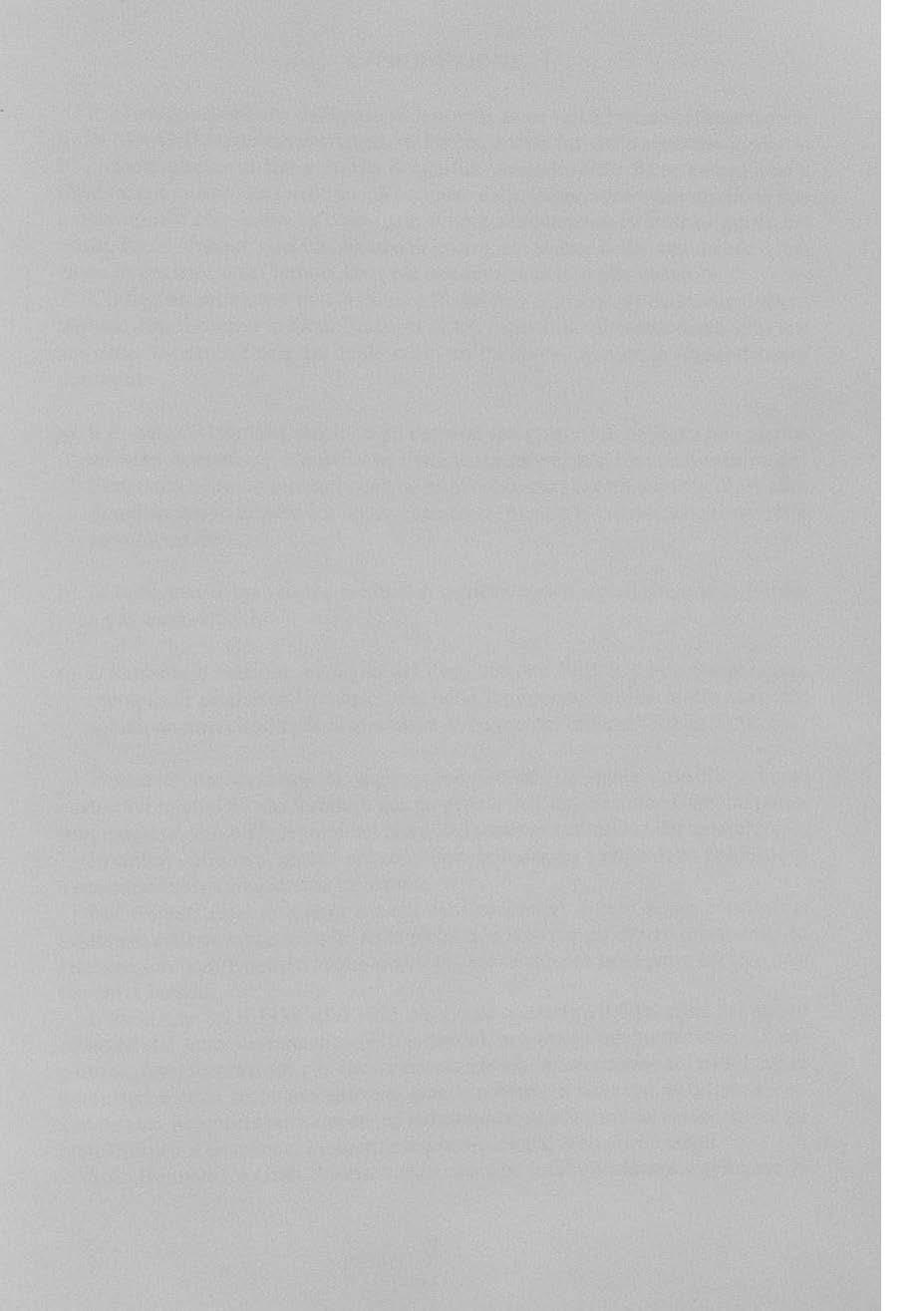
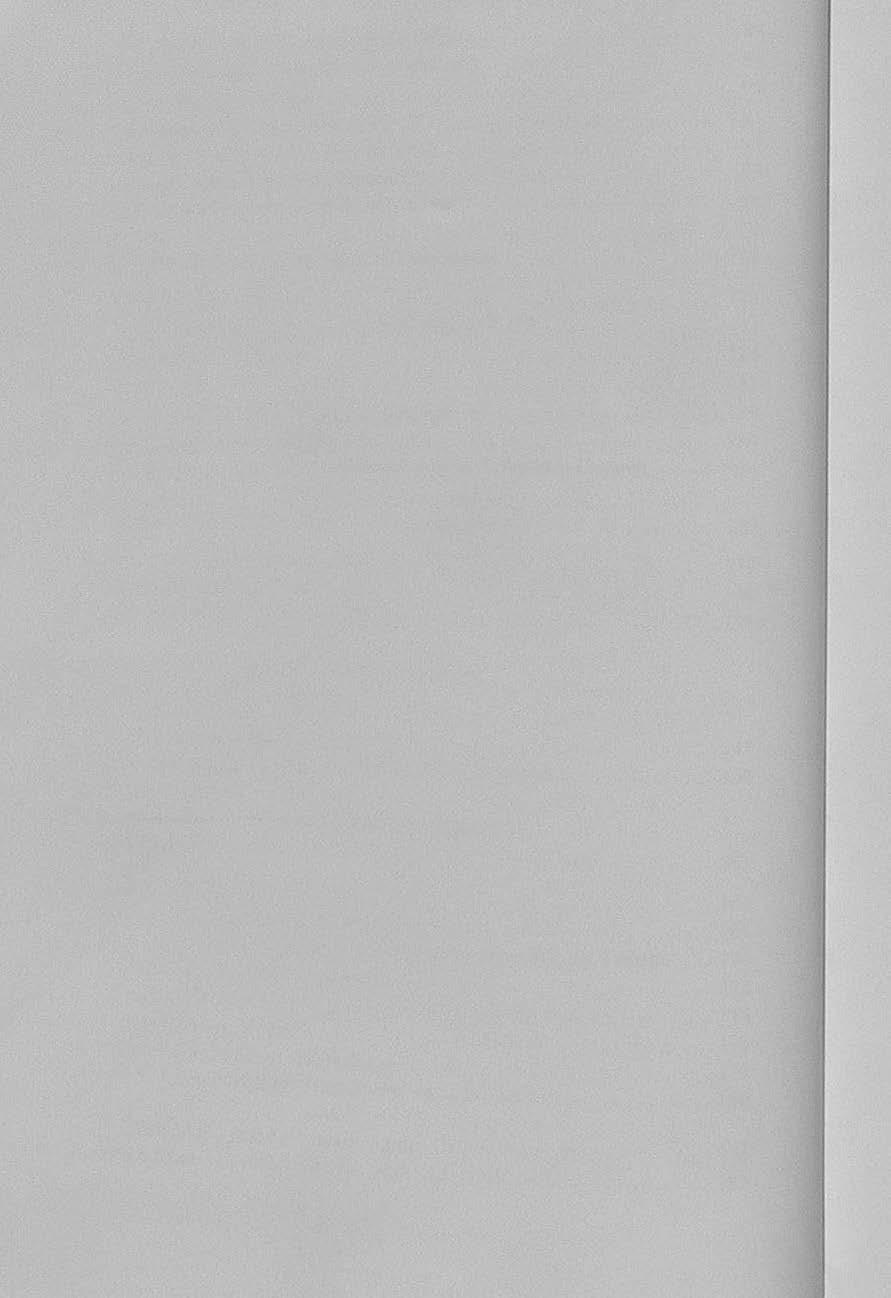
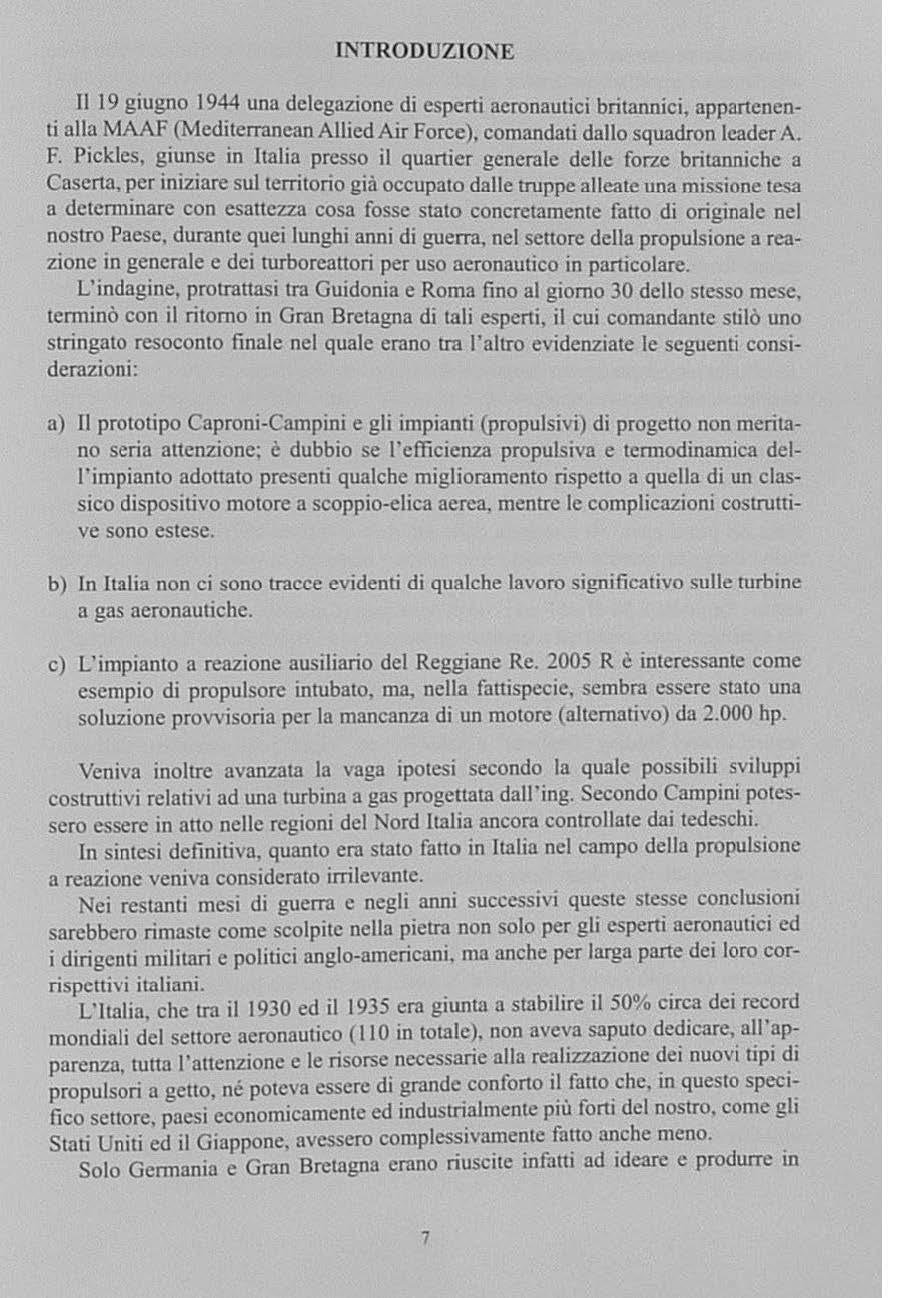
. Il 19 giugno 19~ una delega~ione di esperti aeronautici britannici, appartenenti alla MAAF (MedJterraneanAlltedAir Force), comandati dallo squadron leader A. F. Pickles, giunse in llalia presso il quanier generale delle forze britanniche a Casena, per iniziare sul territorio già occupalo dalle truppe alleate una missione tesa a detenninare con esattezza cosa fosse stato concretamente fatto di originale nel nostro Paese, durante quei lunghi anni di guerra, nel settore della propulsione a reazione m generale e dei rurboreanori per uso aeronautico in particolare.
L'indagine, protrattasi tra Guidonia e Roma fino al giorno 30 dello stesso mese. terminò con il ritorno in Gran Bretagna di tali esperti. il cui comandante stilo uno stringato resoconto finale nel quale erano tra l'allro evidenziate le seguenti considerazioni:
a) Il prototipo Caproni-Campini e gli impianti (propulsiYi) di progetto non meritano seria attenzione; è dubbio se l'efficienza propulsiva e termodinamica dell'impianto adottato presenti qualche miglioramento nspcno a quella di un classico dispositivo motore a scoppio-elica aerea. mentre le complicaziont cosu-uttive sono estese.
b) ln Italia non ci sono tracce evidenti di qualche lavoro significativo sulle turbine a gas aeronautiche.
e) L'impianto a reazione ausiliario del Reggiane Re. 2005 R è interessante come esempio di propulsore intubato. ma, nella fattispecie. sembra essere stato una soluzione provvisoria per la mancanza di un motore (aJtemarivo) da 2.000 hp.
Veniva inoltre avanzata la vaga tpotesi secondo la quale possibili sviluppi costruttivi relativi ad una turbina a gas progettata dall'ing. Secondo Campini potessero essere in ano nelle regioni del Nord ltabn ancora controllate dai tedeschi.
ln sintesi definitiva, quanto era stato fano m Italia nel campo della propulsione a reazione veniva considerato irrilevante.
Nei restanti mesi ili guerra e negli anni successivi queste stesse conclus1ont sarebbero rimaste come scolpite nella pie1.ra non solo per gli esperti aeronautici ed i dirigenti mrntari e politici anglo-americani. ma anche per larga parte dei loro corrispettivi i1aliani.
L'Italia. che tra il 1930 ed il 1935 era giunta a stabilire il 50% circa dei record mondiali del senore aeronautico ( 110 in totale). non aveva saputo dedicare, all'apparenza, tutta l'attenzione e le risorse necessarie alla realizzazione dei nuovi tipi di propulsori a getto. nl! poteva essere d1 grande conforto il fatto che. in questo spec1fico settore, paesi economicamente ed industrialmente più forti del nostro. come gh Stati Uniti ed il Giappone. avessero complessivamente fono anche meno.
Solo Germania e Gran Bretagna erano riuscite infatti ad ideare e produrre 10
INTROD UZI O IE
i
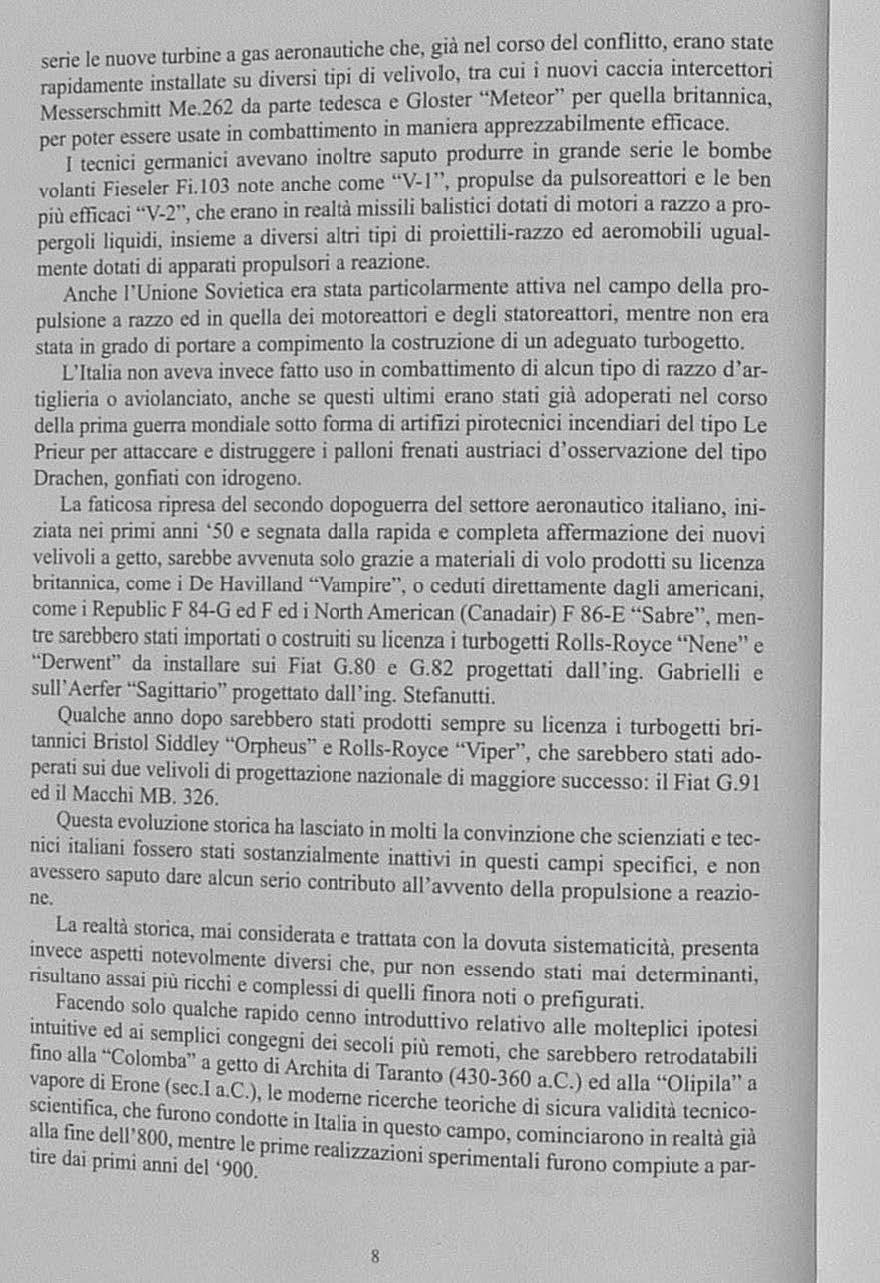
, --..1.· 0 gas aeronautiche cbe, già nel corso del conflitto. erano state sene le nuo, e Lw utOe . .
. ·d · tallate su diversi up1 d1 velivolo, tra cui , ouov1caccia mtercetton rapi amente 10s ti b · · M h Il i..1e ?62 da parte tedesca e Gloster "Metcor per que a ntann1ca, cssersc m1 1• •- • - 1 ffi • -e usate io combaltimento m maniera apprezzab1 mente e cace. per poter ess-., . d · I b I tecnici gennanic1avevano inoltre sapulo produrre in gran e sene .e ombe volanti Fieseler Fi.103 note anche come "V-1"', propulsc da pulsor~atton e le ben ù efficaci ..V-2'' che erano in realtà missili balis1ici dotati di moton a razzo a pro~rgoli liquidi. i~1eme a diversi alai tipi di proiettili-razzo ed aeromobili ugualmente dowti di apparati propulsori a reazione.
Anche l'Unione Sovietica era stata particolannente attiva nel campo della propulsione a razzo ed in quella dei motoreattori e degli statoreattori, menlre non era stata in grado di portare a compimeoto la costruzione di un adeguato turbogetto.
L'Italia non aveva invece fatto uso in combattimento dì alcun tipo di razzo d'artiglieria o aviolanciato, anche se questi ultimi erano stati già adoperati neJ corso della prima guerra mondiale sotto fonna di artifizi pirotecnici incendiari del tipo Le Prieur per anaccare e distruggere i palloni frenati austriaci d'osservazione del tipo Drachen, gonfiati con idrogeno.
La faùcosa ripresa del secondo dopoguerra del settore aeronautico italiano, iniziata ne, primi anni ·so e segnala dalla rapida e completa affermazione dei nuovi velivoli a geno, sarebbe avvenula solo grazie a materiali di volo prodotti su licenza bntannica, come i De Havilland "Vampire". o ceduci direuamente dagli americani. come I Repubhc F 84-G ed Fedi Nonh American (Canadair) F 86-E "Sabre", mentre sarebbero stnti imponau o costruiti su licenza i turbogetti Rolls-Royce "Nene" e "D~rweac" "da ~ta~I~ sui Fiat G.80 e G.82 progettati dall'ing. Gabrielli e sull Aerfer Saginano progettato dall 'iog. Stefanutti.
q~lche iUIJl~ dopo sarebbero stati prodonj sempre su licenza i turbogetti britanm~i ~nstol Siddley '.'Orpheus" e Rolls-Royce "Viper". che sarebbero stati adoperau sui due vehvoh d1 progettazione nazionale di maggiore successo· il Fiat G 9J ed ti Macchi MB. 326. · ·
Questa evoluzione Storica ha las · 1 · 1• 1 . . · • r . fi . eia O in mo ti a convm21one che scienziati e teemci Jta ian1 ossero stau sostanzialmente inattivi in questi campi specifici e non avessero saputo dare alcun seri .b ' ' ne. 0 contn uto aJI avvento della propulsione a reazio-
La realtà storica. mai considerala e . . . invece aspem notevolmente d. . htranata con la dovuta sistcmanc1tà, presenta risuhano assai più ricchi e 1vers1_c _e. PW: non essendo stati mai dclenninantì, Facendo solo qualche ~;:plessi di ~uelh ~ora nou_o prefigurati. intuitive ed ai semplic· 0 .cenno mtroduttivo relativo alle molteplici ipotesi 1congegni dei sec r ·· · fino alla ..Colomba" 8 getto di A h' d'0 1piu remou, che sarebbero retrodatabili va:"°'7 di Erone (sec.} a.C.), le m~:ta 1:oranto (43?-360 a.C.) ed alla "Olipila'' a sc1enufica, che furono condotte in I ~c_nccrcbe teonche dt sicura validita tecnicoalla ~e d~ll'800, mentre le prime r:,1 ; m~ue~co c8?1po, co_minciarono in realtà già lire dai pnm1 anni del '900. z:zaziom spenmen1ah furono compiule a par·
• • •
• . .
. .
8

Diverse altre iniziatjve furono panate avanti nei decenm successivi ed in panicolare nel corso della seconda guerra mondiale. anche se. nella maggior pane de, casi, non ebbero il tempo neccssano per essere messe definuivamentc a punto e non trovarono quindi una reale forma appljcauva.
Tuni I progetti in corso di sviluppo furono infatti totalmente cancellata dagli avvl!nimenti seguiti all'annìstizio dell'8 settembre 1943. tanto da essere rapidamente dimcnticau lasciando tra l'altro scarse tracce.
Per potere meglio comprl!ndere l'originalità e l'amponanza storica dei la\'ori sc1entific1 e tecnolog1c1 S\'Olti dagli italiana m questo specifico senorc, dovremo quindi descri\crc sinteticamente quanto da essa venne scopcno e realizzato tra la fine del XIX secolo e la fine della seconda guerra mondiale. dando nel contempo alcune sintetiche notazioni biografiche relati\'e a ciascun autore.
L'effcuiva ,alidità di tali contributi potrà inoltre essere giustamente apprezzata solo comparando per grandi lance il lavoro s\'olto dagli italiani con quanto venne fatto nello stesso periodo nel resto del mondo dai p1ù eminenti spi:cialisll strameri, limitando la relativa tranazaone ai soli perioda imzaali della propulsione aeronautica a gètto e della propulsione a razzo.


CAPITOLO I
FOR.\lE DIVERSE DI PROPLL IONE A REAZIONE
Le diverse fonne dì propulsione aerea s1 basano sulla nota legge fisica che vo sono il nome di Terzo Principio della Dinamica. detto anche d1 Azione e Reazione. che fu enunciato da sir Isaac Newton nel suo Philosopliiae 11atura/,s pnnc1p1a mothematica presentalo alla Reale Accademia d1 Londra il 28 aprile 1686 e pubblicato l'anno successivo.
Secondo tale principio. applicato al caso pan1colare del volo, un aeromobile ed un razzo possono muoversi rispettivamente nell'atmosfera e nello spazio se sono entrambi m grado d1 proiettare all'esterno, in d1reZ1one opposta a quello del movimento e con adeguata velocità, una detcnninata massa d1 aria e o gas combusti. La grandezza della spinta propulsiva prodotta nell'unità di tempo è, nella realtà applicativa concreta di un gas fuoriuscente da una camera chiusa attraverso un ugello di scanco. funzione della somma d1 due d1sunti prodon1 faru tra quallro diverse grandezze fisiche la massa d'aerifonne spostata moltiplicata per la ,elocità assoluta ad essa conferita, più la differenza di pressione esistente tra I gas in uscita e !"ambiente esterno moltiplicata per la sezione d'uscita del geno
In realtà rut11 1 propulson aeronautici fino ad oggi utihzzau operano sul princ1p10 dJ azione e reazione, sm se sono basau sulla rotazione d1 un'elica av" itamesi nclrana posta m movimento da un motore altematJ\O o da una rurbma. che sulla eiezione di un geno di gas d1 scarico effettuata attraverso un ugello.
Questa seconda fonna d1 propulsione puo essere moltre reahuata in moltephc1 fonne s1m1h tra loro quali quella del reanore puro. del pulsoreattore. della turboventola o dello statoreattore, tutte basate sull'uso d1 ana prelevata dall'esterno. oppure mediante quella del razzo. che è diversa dalla precedente poicht: tutta la matena elaborata viene trasportata nell'interno del razzo stesso senza alcuna ulteriore captazione dall'esterno
Altre forme propulsive a reazione sono state moltre solo proposte ed a volle anche sperimentate ma non attuate
A tale smteuca classificazione fa nscontro una nomenclatura, consolidata dall'uso, non propnamente adeguata
ln particolare per propulsori a gcllo Get) s1 dovrebbero mtenderc sia quelli basali su sistemi del tipo compressore-turbina. che I rozzi
Avendo tunn,ia a disposizione un nome d'uso stoncamente consolidato per questi ulum1 (rockets). che sono chiamali anche endoreanori, useremo correntemente il tennìne d1 getto Uet) esclusi,amcnte per i \an tipi d1 reatton a captazione d'ano esterna
11
J. I: l a propulsi01w a ge" o
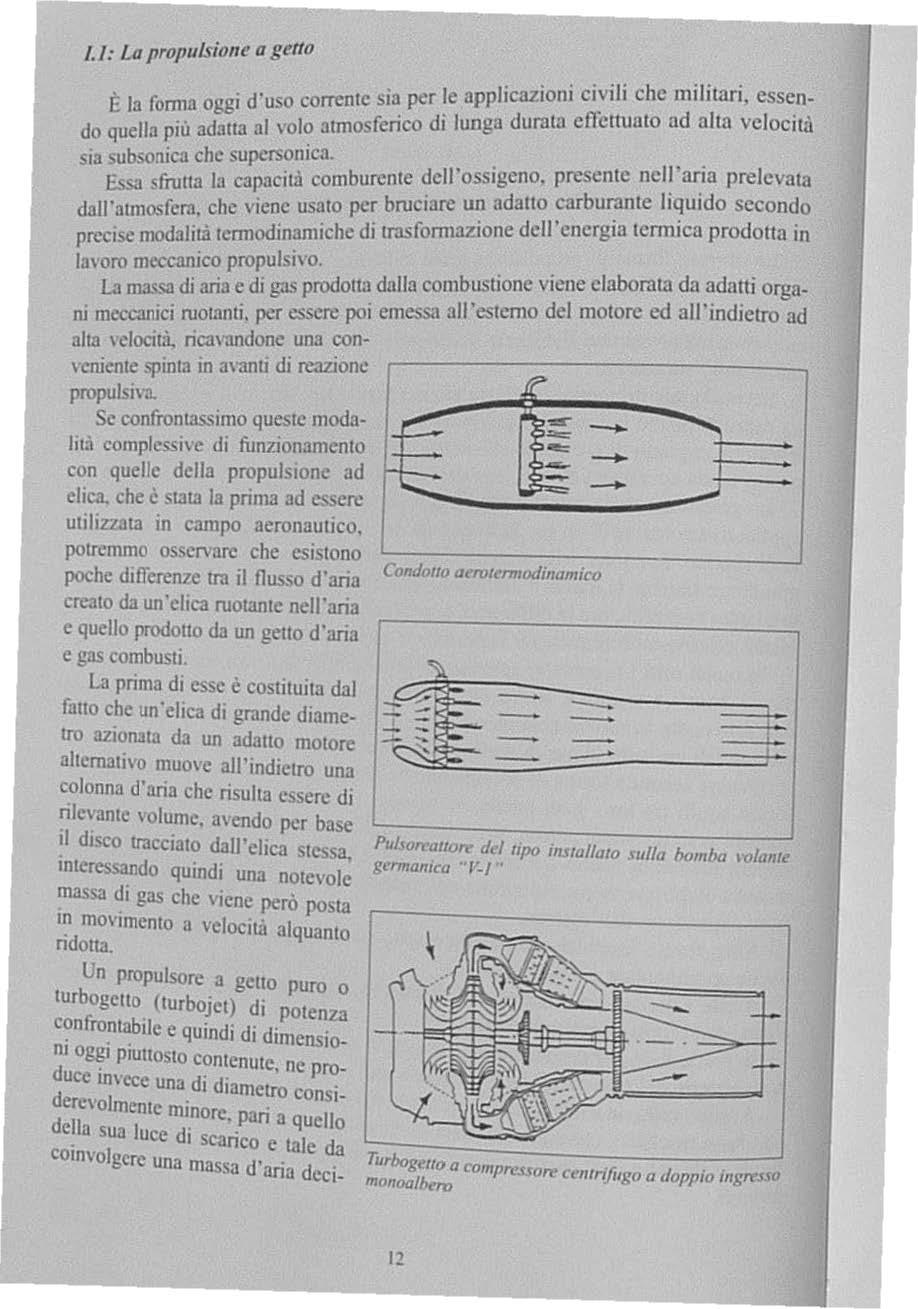
È la fonnn oggi d"uso corrente sia per le applicazioni c1, ili che militari, essendo quella più adana al ,olo atmosferico d1 lunga durata ctTertuato ad alta vclocnà ~ia ,ub:-onica chi: su['(!rso111ca !!.,sa ~frutta la capacita comburente dcfl'oss1geno. presente ncll ·ana prelevata dall'atmosfora. che nenc usato per bruciare un adatto carburante liquido secondo precise modahl.à termodinamiche di trasfonna71one dell'energia tcnnica prodotta in la,oro meccanico propuls1,·o.
La ma.~"1 di ari.i e di gas prodotta dalla comblliillonc viene claborot.a da adatti organi meccanici ruotanti. per e:·scn: poi emessa all'esterno del motore ed alr1nd1etro ad alto ,dootà. rica,'31ldone una con,-cnicnre ~inia in avan1i di reazione propul,l\a
Se confron1ass1mo queste modahta complessi\ e di funzionamento con quelle della propulsione ad elica. che è s1a1.1 la prima ad essere utilizzma in campo aeronautico. pom:mmo os,cnare che esistono
poche dilTerenze 1m il nu!>.,O d'aria Condouo U(,V/"71/0<lit1amir:o cre:110 da un'elica ruotante nell'aria e quello prodotto da un geuo d'aria e ga.~ combusti. /
La prima di css1: I! costituita dal , fi h
1:1:~1 e utn'edlica dr grande diame-
003 a a un adauo motore -
aJ1crnativo muo,c all'indietro una -c_olonna d'aria che risuha e:.serc di
~le~'ante ,olume. a\'endo per base l !1 di,co lr:Jccialo dall'elica stessa. Pul<orrallun.• dd llpo msrollaro s11/la bombo ,vl,1nt•• m1cres:.ando · d" g,·111,amc-a "T'..J • qum 1 una note\'ole massa ~1 gas che , iene però posta •~ mo\'lmen10 a vefocnà alquanto ndoua.
Un propulsore a gcuo puro o turbogetto_ {turbojet) di potenza c?nfron1ab1le e quindi di d' , .nr. 1mens10ogg1 p1u110:.10 contenute ne duce imcc1.: una d" d" . prodere, ohnen1c I iame~o consid Il minore. pan a quello e_ a sua luce di scarico è !aie d coinvolgere una massa d' - _a 77i~11r;bo:g::.:11;:o:-=a:--:,=.o-,,-=-= ---------_j . . ana dcci- monoalbero rpr. uore, ,·mrifi,go a doppio mgn•5w
-
=--:::::::::::-----===-=--
= ~i
-==
I
12
samente inferiore. che viene però posta m movimento con una velocità d·emusso nettamente più elevata.
Una seconda notevole differenza e data dal fauo che menlrc m un motore ad elica si misura la potenza propulsiva erogata. data da quella fornita dal motore che I'az10na. misurata all'albero. moltiplicata per il rendimento propulsivo dell'elica stessa, in un motore a getto si ,aiuta invece la sola spmta propulsiva.
Questa viene ottenuta come forza risultante di molteplici forze parziali e contrapposte che si producono nclJe , arie pani costitutwc di un turbogetto durante 11 suo funzionamento.
Sia le parti ruotami interne come il compressore e la turbina. che quelle fisse come l'involucro che le avvolge e le contiene con la relativa presa d"aria, l'ugello di
scarico e le camere di combustione. sono infam soggelle a spante che sono propulsive quando sono dirette nel verso dt volo o res1stent1 se dt.rette in senso contrario.
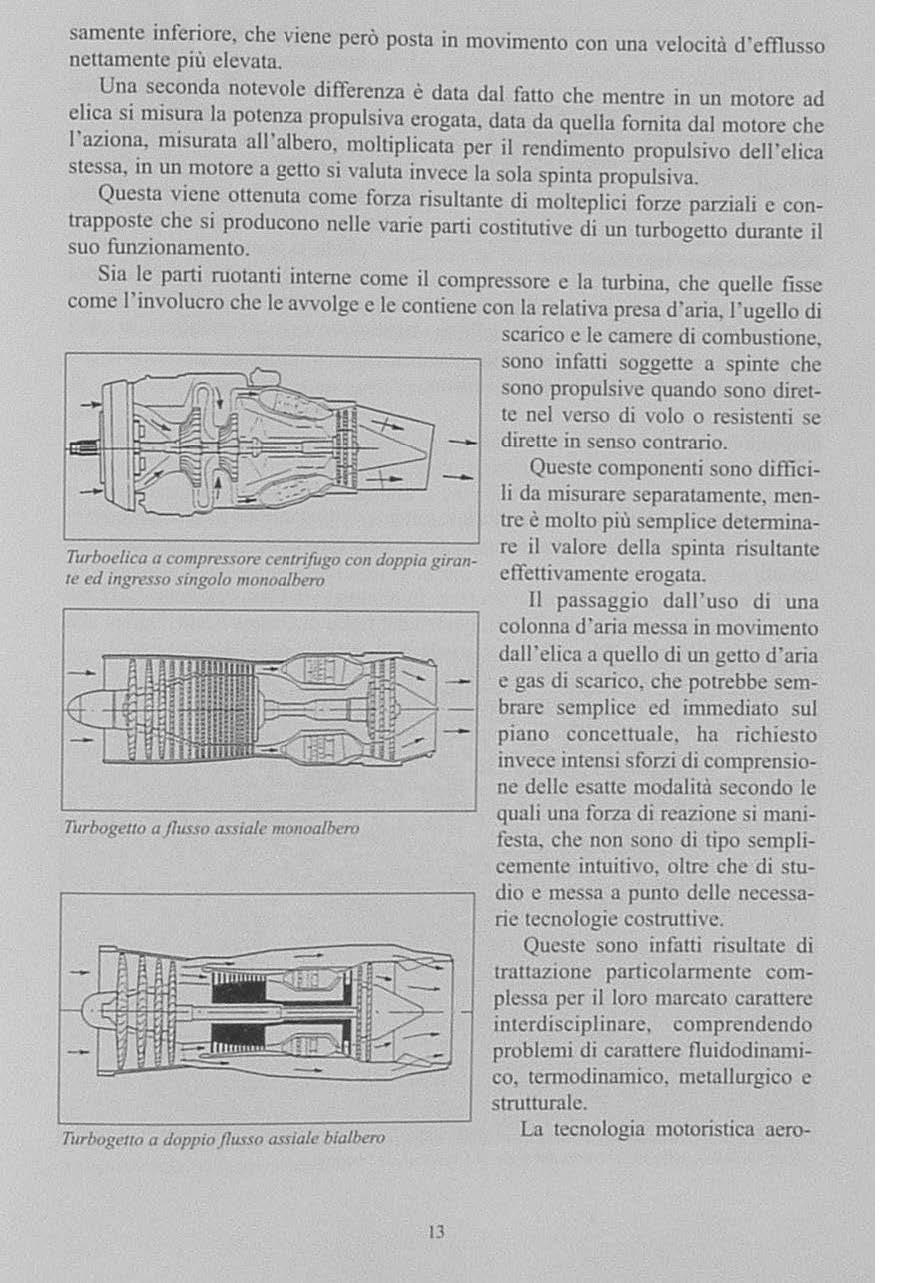
Turbocfit:a 11 i:omprcs.<ore Ctntrifugo co11 doppia giro11,., t•d Ìllgn.·uo Hngolo monoa/b(-ro
Qucs1e componenri sono difficili da misurare separatamente. menU'C è mollo più semplice dctcnninare il \alore della spinta risultante effetti\ amente erogara.
Turbogl!lto a flus.~o ru·11all' mo11oalb.-ro
Turbug,•110 a doppio jlm.m a.niah• biulbero
li passaggio dall'uso d, una colonna d ·ana messa m mo, imento dall'elica a quello di un getto d'aria e gas d1 scanco. che potrebbe sembrare semplice ed immediato sul piano concclluale. ha nchiesto m, ecc mtcns1 sforzi d, comprensione delle esatte modalità secondo le quali una forza d1 reazione s, manifesta. che non sono di tipo semphccmentè intuitivo, oltre che di studio e messa a punro delle necessarie tecnologie costrut11vc.
Queste sono mfatti nsullarc di 1rn11az1one particolarmente complessa per ti loro mnrca10 carattere mtcrd1sc1plinare, comprendendo problemi d1 carattere flu1dodinamico. 1ennotlinam1co. metallurgico e strutturale
La 1-:cnolog10 motoristtcu acro-
13
Ti,rll«lic:a a flusso =tale bio/Mro

nautica ha impiegato infatti più d1 quarant'anni per passare dalle prime ipotesi teoriche sulle turbomacchine. che "ennero fonnulatc dai primi studiosi di tali problemi, attivi già alla fine del XIX secolo. alla effettiva messa a punto dei primi propulsori a turbogetto realmente funzionanti.
Solo in questi ultimi decenni s1 è poi giunti a poter determinare a piacimenio sia la grandezza della massa d•ana e gas trattata che l'entità della sua "elocità d'eiezione. grazie all'uso delle moderne turboventole (rurbofan), le quah possono muovere masse d'aria molto grandi a ,·elocità d'effiusso nenamente più elevale di quelle fornibili da un'elica libera.
1.1: La propuMone a ra;.:,o
L'utilizzazione dell'altro fondamentale sistema d1 propulsione a reazione è mvece iniziata. oelle sue forme più semplici dì artifizio pirotecnico. in tempi assai p1u remoti.
Il primo impiego militare noto dei razzi fu effettuato m Cina nell'anno 1232 nel corso delrassedio portato dai Tartari. guidati dal figlio di Gengis Khan. Ogdaì. alla cinà di K'ai Fung Fu (Piang-King), capitale della regione dello Honang.
Du~ ddl'ucct'/Jo rrz::.o trauo dal testo di Gio,-a11ni do Fontana
14

I Cìoesì riuscirono inizialmente a respingere gh assedianti grazie al lancio di rudimentah bombe esplosive ed all'uso di "frecce di fuoco". ossia normaJi frecce propulse da piccoli razzi.
L'uso dei l'ID'.Zi giunse poi in Europa grazie agli indiani ed agh arabi
In Italia ì proieuìh-razzo vennero utiliuati dai genovesi nel corso della guerra contro I vcneziam del 1379 in occasione dell'assedio di Chioggia, durante il quale con ìl tiro dì questi ordigni da pane degli auaccantì venne danneggiata una torre e furono anche incendiati alcuni camminamenti proteui da te1101e d1 legno.
Il primo trattato europeo sui razzi, con la p1u antica rappresentazione grafica apparsa nel nostro continente di vari ordigni di questo upo e delle relative attrezzature di lancio. risale mvece al 1420 e compare nel manoscrino dell'ingegnere italiano Giovanni da Fontana conservato nella Staatsbibholhek di Monaco di Ba\lcra
In esso , iene ad esempio rappresentato un modello d1 razzo aJato avente la fom,a di un uccello. che emene un geno propulsivo caudale ed è inoltre dotato di baccheua stabilizzatrice postcnore.
Anche Leonardo da Vinci c1 dà la rapprl!Sentaz1one dì un razzo incredibilmente moderno. perché corredato di suibìlizznton postcnori con bordo d'attacco a freccia e dotato anteriormente d1 un cappuccio balistico ogi\ale rotante nspeno al corpo interno del razzo stesso grazie ad un sistema di sfere simile a quello degli attuali cuscinetti. che sarebbe stato posto in rotazione grazie alraz1one dell'ana su nenature elicoidali esterne presenti sul cappuccio stesso. in modo da ottenere un ulteriore effeno di stabilizzazione giroscopica
Il proi<'1ri/,...ra=o J, uvmarrfo da linc, 15

Nel 15-lO a \'enezia, fu stampato un altro interessante testo di antica arte pirotec~ica uali~a intitolato De la pirothecnia senno do Biringuccio Vannoccio.
Un altro importante teorico e sperimentatore del concetto di propulsione ottenu18 mediante la reaz.rone di un gcno di gas uscente da un recipiente chiuso fu Jacob Wrllcm Gravesande. docente :ùJ'univcrsità olandese cli leiden nel I720, il quale non disponendo di alcW10 macchina adatta al volo, u11lizzò 1ale fonna propulsh per muovere un carro a ruote producendo vapore all 'in temo di un recipiente sfenco meiallico fis:;a10 sul pianale ed eiettandolo ,·crso l'es1cmo mediante un condot1O tubolare opportunamenre confonnato.
Anche un contemporaneo italiano d, Newton, Giovanni Branca, architello dclJa Santa C.asa di Loreto. propose, nel libro le machine, 1•0/ume 11uol'o e di molto ani_/ìcio da fare_ t!_/feuì meraviglios~ del l~29. di utilizzare lo stesso vapore per far gira~ re la pale d1 una turbina ad :121one ncavando lavoro meccanico utilizzabile indus1rialmentc.
Un disposilivo funzionante secondo lo schema ideato dal Branca è conservato Londra presso il Bnrish \tuseum. a Que::.10 elenco potrebbe allungarsi ancora considerevolmente.
16

CAPITOLO 11
IPOTESI
ED ESPERIMENTI TRA
FINE ·800 E PRIMI '900
Fino dalle sue origini l'intero processo d1 sviluppo della propulsione a reaz10ne s1 è comunque avvalso esclusivamente delle idee innovative e delle proposte costruttive fonnulate da un numero assai ristretto d·individui, 1 quali operarono quasi sempre in maniera autonoma. elaborando idee e formulando proposte che dovenero scontrarsi spesso con il pervicace scenicismo e lo scarso suppono morale e materiale dei loro contemporanei.
Il.I: I precursori italia11i
In Jtalia i primi specialisti interessati alla propulsìone aeronautica a reazione cominciarono ad operare con un approccio di tipo scientifico. sistematico ed efficace, solo verso la fine del XIX secolo, quando. con la disponibilità dei primissinu motori a vapore. elettrici o a scoppio realmente funzionanti. fu possibile scegliere il tipo di apparato motore più semplice e leggero da installare sui soli mezzi aerei allora in uso: i palloni aerostatici. che presto cambiarono forma da sferica ad affusolata per diventare dirigibili.
Enrico Forla11i11i
l contributi teorici e le realizzazioni costruttive di questo insigne precursore delle scienze aeronautiche sono poco ricordau dalla pubblicistica contemporanea, non solo aJI'estero. per la scarsa diffusione della nostra lingua. ma anche in haha.
Nato a Milano il 13 onobre 1848. frequentò l'Accademia Militare di Torino lasciandola nel 1870 con il grado d1 tenente del Genio. .
Nel I 877, precedendo di quasi due decenru gli analoghi esperimenti effettuati negli Stau
Uniti da Samuel Pierpont Langley con I suoi modelli volanti denominali ..Aérodrome", egli riusci a far volare un modello di elicottero propulso da un motore a vapore che, n Milano.
17

d commissione di scienziati, si sollevò verticalmente a 13 m d'altezza. davano a una d 1. d' .. :\Ilo sperimentatori: \'Cnne assegnata una me ag 1a oro come tang1b1le ricono'-Cimento ufficiale.
- In st:guito, avendo conseguito I~ laure~ m mgegnena pr~s~o il Polite_cnico di Milano, lasciò il si:rvizìo m1hwre altl\O e divenne dappnma dmgente e qumdì proprie1ario dello fabbrica del gas d1 Forlj. . . .
Disponendo in tale sede d1 un'attrezzata officina m_e~camca ~ote dedicarsi con maggiore lena alla realizzazione prauca der suoi moltephc1 progetti aeronautici. tanto che nel 1885 cos1rui un modello di aereo monoplano dotato d1 ali arcuate con profi. lo mpianta di upo fulcifonni: di 2 m d'apertura. rinforzate da nervature in legno e conct:nunlmente simili a quelle disegnate da 0110 Lilienthal per i suoi libraton.
Esso pote, a essere lanciato in aria utilizzando un carrello a 4 ruote fissato alla fusoliera c posto m movimento su una rotaia d1 lanc10 costituita da due fili d'acciaio. opportunamente tesi e pnrnlle.h Ira loro.
L'impianto propulsi,,o del modello era costiruito da due razzi caricau con 200 g di polvere pirica. che erano stati solidamente fissati alla fusoliera del modello stesso.
La spinta propulsirn 011enuta, pan ad I kg. riuscì ad accelerare il piccolo veh\'Olo fino ad una \'elocita d1 12-15 m s facendogli compiere un volo libero dt circa 180 m.
l dicortuo (N I) I' 1· ,,___, . e auto razzo n.,3,. d· ~fNSUio11 • d. s 1"· 1 Enrico F. l < 1 torio della Sciim::a d I or amni co,, le altre s11c rea{i;;;:a=ioni allo e 1928 a Firenze 18
A seguito d! tali espe~m.enti Forlanini elaborò precise teorie sulla navign.zione aerea nelle reg1oru supenon dell'atmosfera, giungendo ad ipotizzare il volo nello spazio ~osm1co.~ed1~n_te razzi utilizzanti idrogeno come combusiibile liquido contenuto 10 appositi rec1p1enh a pareti doppie 1solan11, simili ai moderni vasi Dewar.
L'assoluta mancanza ~i uni~ motrici a combustione interna, capaci di far stacdal suolo una m~cch1~a pm pesante dell'aria, rese questi progetti del tutto furunb1h, tanto che negh anOJ successivi Forlanini volse I suoi interessi verso i mezzi più leggeri dell'~a realizzando i suoi beo noti dirigibili, seguitando però a manifestare un concreto mteresse per tale tipo di ricerche.
Forlanini scomparve a Milano il 9 ottobre 1930.
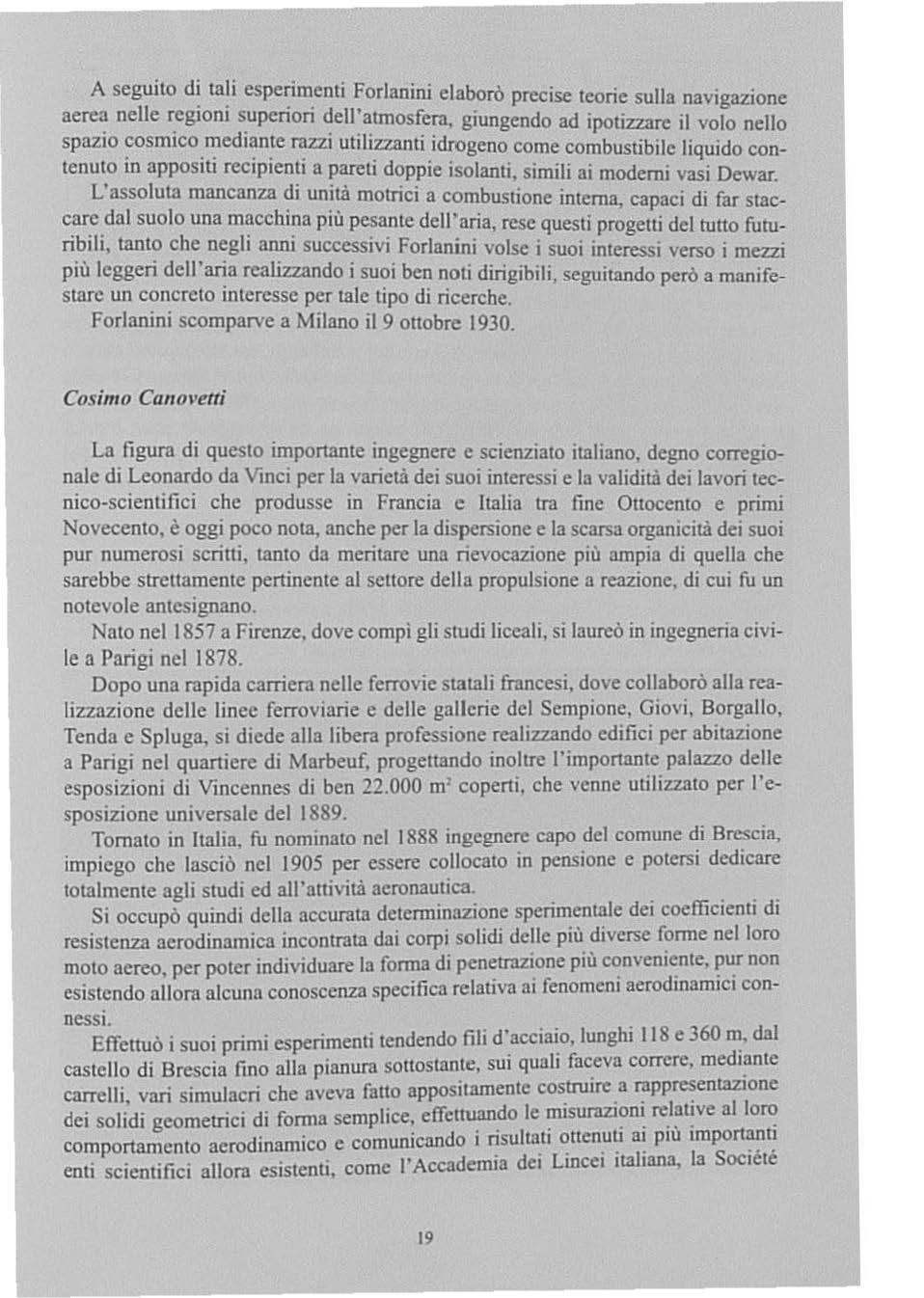
La figura di questo imponante mgegnere e scienziato italiano. degno corregionale di Leonardo da Vinci per la vanelà dei suoi mteress1 e la validilà dei lavori tecnico-scientifici che produsse in Francia e Italia tra fine Ouocento e primi Novecento, è oggi poco nota. anche per la dispersione e la scarsa orgamcnà dei suoi pur numerosi scritti, tanto da meritare una rievocazione p1u ampia d1 quella che sarebbe strettameme pertinente al settore della propulsione a reazione. di cui fu un notevole antesignano.
Nato nel 1857 a Firenze, dove compi gli studi liceali, si laureò in mgegnena civile a Parigi nel 1878.
Dopo una rapida carriera nelle ferrovie statali francesi, dove collaborò alla realizzazione delle linee ferroviarie e delle gallerie del Sempione, Giovi. Borgallo. Tenda e Spluga. si diede alla libera professione realizzando edifici per abitazione a Parigi nel quartiere di Marbeuf. progenando inoltre l'imponan1e palazzo delle esposizioni d1 Vincennes di ben 22.000 m coperti. che venne utilizzato per l'esposizione universale del 1889.
Tornato m Itaha. fu nominato nel 1888 ingegnere capo del comune di Brescia, impiego che lasciò nel 1905 per essere collocato in pensione e potersi dedicare totalmente agh studi ed all'amvilà aeronautica.
S1 occupò quindi dello accurata determmaziooe sperimentale dei coeffic1enu di resistenza aerodinamica incontrata dai corpi solidi delle più diverse forme nel loro moto aereo. per poter individuare la forma di penetraZ1one più conveniente, pur non esistendo allora alcuna conoscenza specifica relativa ai fenomeni aerodtnam1c1 connessi.
Effettuò I suoi primi esperimenll tendendo fili d'accia~o. lunghi 118 e 360 ~- dal castello di Brescia fino alla pianura sonostnnte, sui quah faceva correre. med1~nte carrelli vari simulacri che aveva fatto appositamente costruire a rappresentazione dei solidi geometrici di forma semplice, cffetruan~o le ~surazion~ re_lauve al lo~ comportamento aerodinamico e comunicando I ~sultau ottenuti a~ più 1mponan~ eou scientifici allora esistenù, come I'Accademta dei L10ce1 1tal1ana. la Soc,éte
Cosimo Ca11ovetti
19
d'E 'nt fmnc""e e la Smitbsonian lns1iru1ion s1arunitcnsc. ricevendo ncourageme e ""' • • numerosi attestati di riconoscimento e finanz1ament1 in danaro.
Ripetè tali esperimenti lra Bruna1e e Como usando un cavo ~es~ dt ben _700 m dì lunghez:za ed m Val •assina. ollenendo suss1d1 anche da banche 1tahane ed 11 premio Santoro dall'Accademia dei Lmce1. u suo in1ere~e per tu attivita aeronautiche. che erano allora considerate una semplice attiYità sponi,·a pri,a d1 seri contenu11 scientifici e~ in1ellet~alì. _era tuttavia iniziato già a partire dal 1883-1884. quando era ancora m Francia e I epopea del \'Olo con i palloni dirigibili era appena agli inizi
Cano\'ctti, che conseguì anche l'equirnlcntc dì una laurea in ingegneria aeronauuca d'alloro presso la Scuola Superiore d'Aerostatica di Parigi. e,à stato infatti attrano dallo studio dei problemi propulsn·1 connessi con l'uso delle nuove aeronavi. avendo assistito ai rela1ivi esperimenll condotti dai fratelli Gaston ed AJbert Tissandier.
Questt ave\'ano realizzato un dirigibile mosso da un·embrionale ehca bipala, disegnata da \~cror Tatìn. azionala dn un motore eleurico. che venne present.aio nel 1881 al Salon de l'Élecmcilé a Pang1 e \'Olò per la prima ,·olla il 3 ottobre 1883 ed in seguilo ncll 'cslDte dell'anno succes:,l\'O.
Egli st~e una relazione su tait espenmenu che presentò alla Società degli Ingegneri Civih francesi il l'ottobre 1884. nella quale, dopo aver calcolato il coefficiente dì resistenza aJra,·anz.amento di questa aeronave. ipotizzò anche le carat1cristiche di massima del tipo dì propulsore più adauo a muo"eme una di dimensioni nettamente maggiori. pari a I00.000 m .
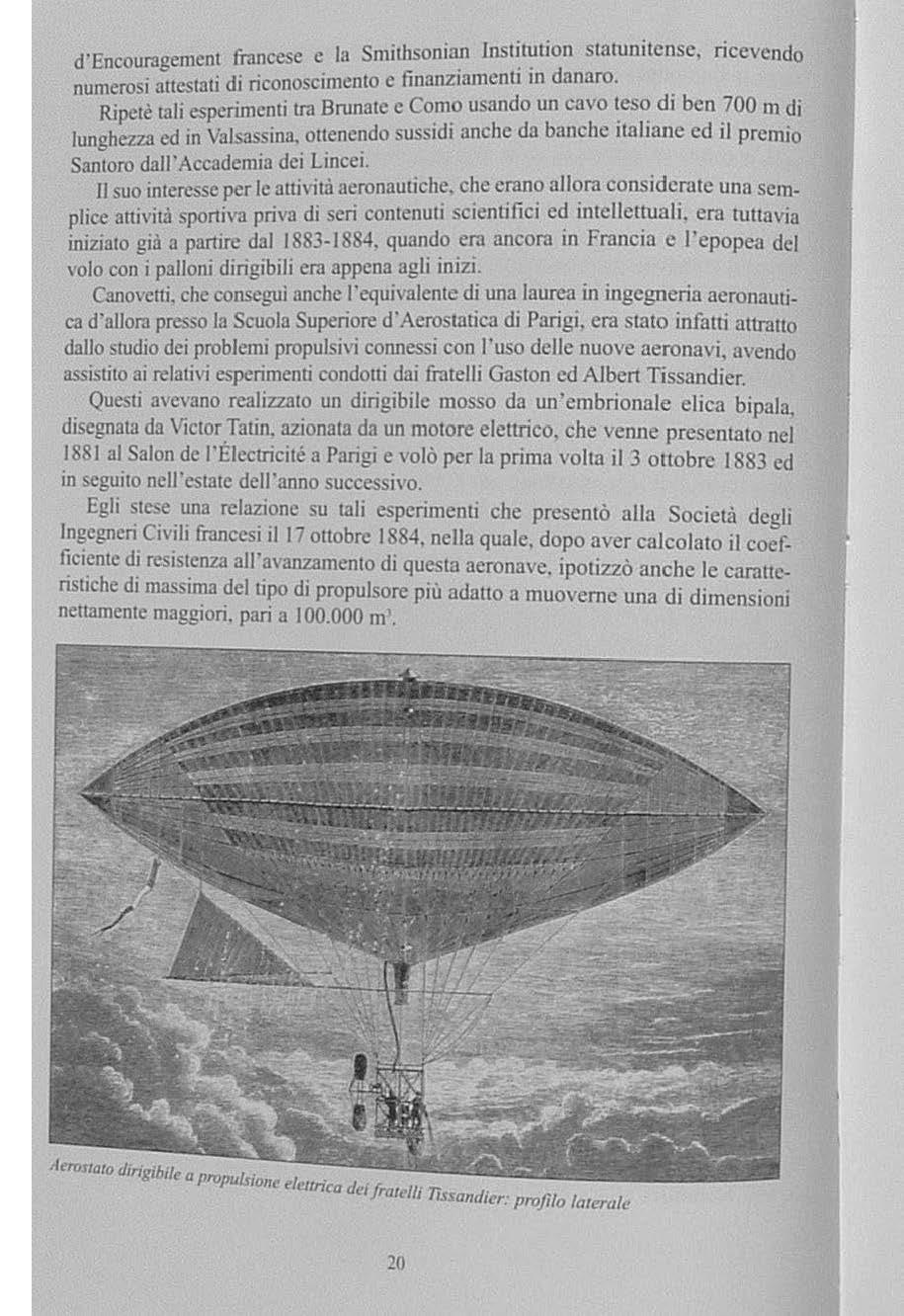
,lercmaro dingibile a PIVpu/..s,011., clm • d nca e1 fratl'II/ Trssandier: profilo laterale
20
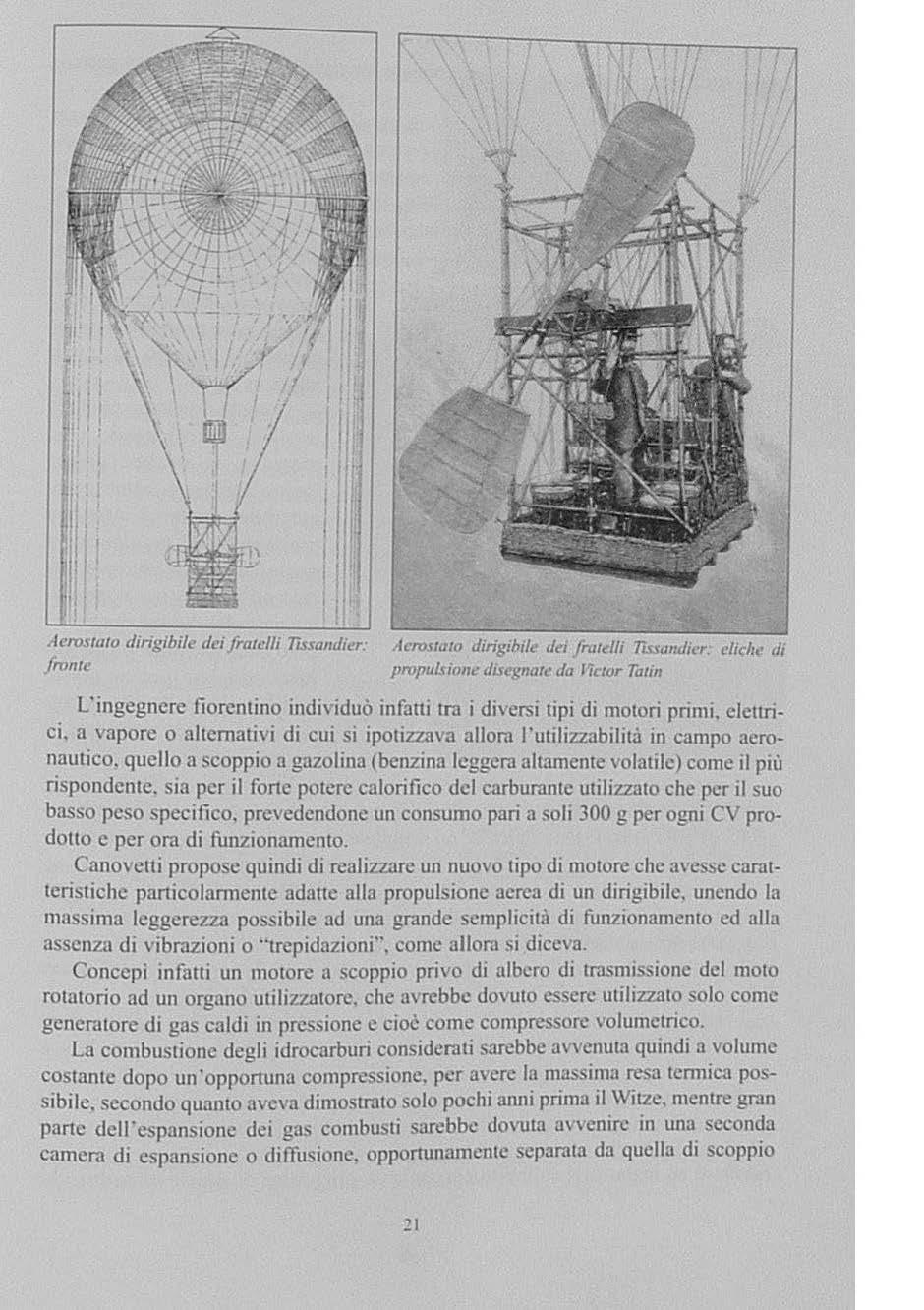
r -l krosruro dirigibile clei fratelli 1ìs.<a11dia. fronte , kro.111110 dirit.ihi/e de, jrutdli Tusmtdit•r: dic/1e di prof1ul1 in11e disel!natc: J11 Tictor Tatin
L'ingegnere fiorentino indh·iduò infani tra i di\'ers1 tipi di motori primi. cletuic1. a vapore o altcmati\ i di cui s1 ipotizza, a allora l'utilizzabilità m campo aeronautico. quello a scoppio a gazolina (benzina l~ggera altamenie \'Olat,le) come il più rispondente. sia per il fone potere calorifico di!! carburante utilizzato che per il suo basso peso spec1 fico, prc\'eckndone un consumo pari a soh 300 g per ogni CV prodolio e per ora di funzionamento.
Cano\'eni propose quindi d1 realizz.an: un nuovo tipo di motore che avesse cara11ens1iche panicolanncnte ada11e alla propulsione aerea d1 un dirigibile, unendo la massima leggerezza possibile ad una grande scmphc1t11 d1 funz1onamen10 ed nllu assenza d1 vibrazioni o ··1repidazioni",come allora s1 d1cern.
Conccp1 infatti un motore a scoppio pri\O dt albero di tra.mussionc del moto rotatorio ad un organo utilizzutore. che a,rebbe dovuto essere utilizzato solo come generatore d1 gas caldi in pressione e cioè come compressore \lolumetnco.
La combustione degh idrocarburi considerali sarebbe a,,·cnuta qumd1 a volume costante dopo un'opponuna compressione. per an!rc In massima resa tennica possibile, secondo quau10 o, C\'a dimostralo solo pochi anni prima il Witze, mentre gran parte delfcspans1onc dei gas combusti sarebbe! do\'Utn a, venire! 111 una seconda camera d1 espansione o diffusione. opponunami:n1e separata da quella di scoppio
.?I
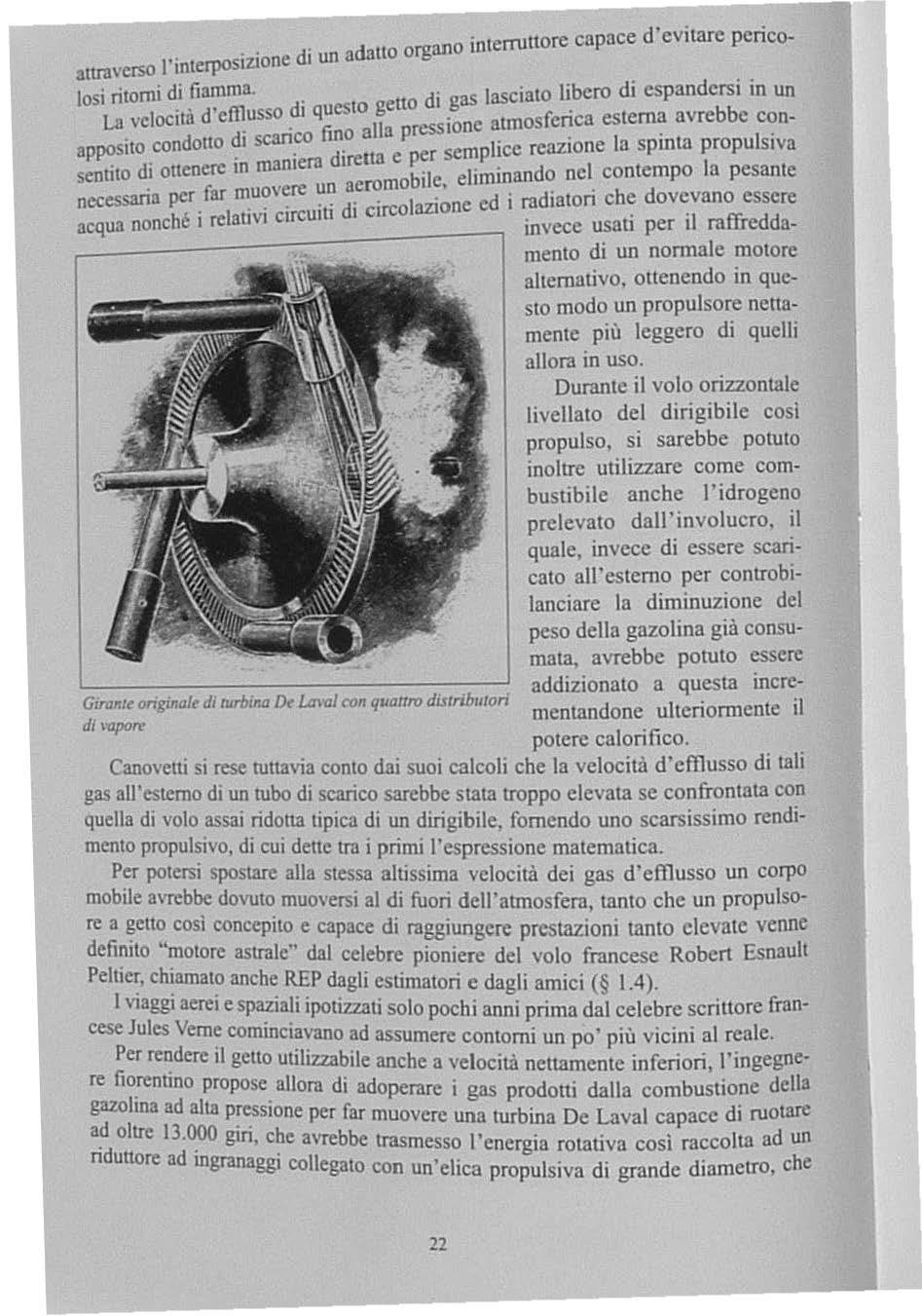
nterruttore capace d'evitare pericoatlJ'3\·erso l'interposizione di un adauo organo i
tosi ritorni d.i fiamma. d. gas lasciato libero di espandersi m un . d' ffi o d1 questo geuo I . bb
La veloc1tn e uss 1 •one aunosfenca esterna avre e cond co fino al o pressi . I apposito condotto I scan_ diretw e per semplice reazione la spmta propu s1va sennto di ottenere in mamera b·te eliminando nel contempo la pesante r. O\'ere un neromo i . d necessaria per 1ar mu. . .. d. . !azione ed i radiaton che ovevano essere acqua nonché i relnll\"l circuin 1 circo in\'ece usati per il raffreddamento di un normale motore alternativo, ottenendo in questo modo un propulsore nettamente più leggero di quelli allora m uso.
Durante il volo orizzontale livellato del dirigibile cosi propulso. si sarebbe potuto inoltre utilizzare come combustibile anche l'idrogeno prelevato dall'involucro. il quale. invece di essere scancato all'esterno per con1rob1lanciare In diminuzione del peso della gazohna già consumata. avrebbe potuto essere addizionato a questa increGrror.u orii,nale di nu-blna De La\al con quanro dùtrìlm1on mentandone ulteriormente il di \'Opol'I'! potere calon fico.
Canoveui si rese tuttavia conto daj suoi calcoli che la velocita d'efflusso dj tali gas all'esterno di un rubo d1 scanco sarebbe stata troppo elevata se confrontata con quella d1 volo assai ridona tipica d1 un dirigibile. fornendo uno scarsissimo rendimento propulsivo, di cui dette tra i primi l'espressione matematica.
Per potersi spostare alla stessa altissima velocità dei gas d'efflusso un corpo mobile a\'rebbc dovuto muoversi al di fuon dell'atmosfera, tanto che un propulsore a geuo cosl concepito e capace di raggiungere prestazioni uinto elevate venne definito ''motore astrale" dal celebre pioniere del volo francese Robert Esnault Pehier, chiamato anche REP dagli estimatori e dagli amici (§ 1.4)
I viaggi aerei e spaziali ipot1zza11 solo pochi anni prima dal celebre scrittore francese Jules Veme cominciavano ad assumere contorni un po· più vicim al reale.
Per rendere 11 getto utilizzabile anche a velocità nettamente infenori, l'ingegnere fforennno propose allora di adoperare I gas prodom dalla combusuone della gazohna ad alla pressione per far muovere una turbina De Lavai capace di ruotare a~ oltre 13-~ giri, che avrebbe trasmesso l'energia rotativa così raccolta ad un otlunore ad mgranagg1 collegato con un'elica propulsiva d1 grande diametro, che
22
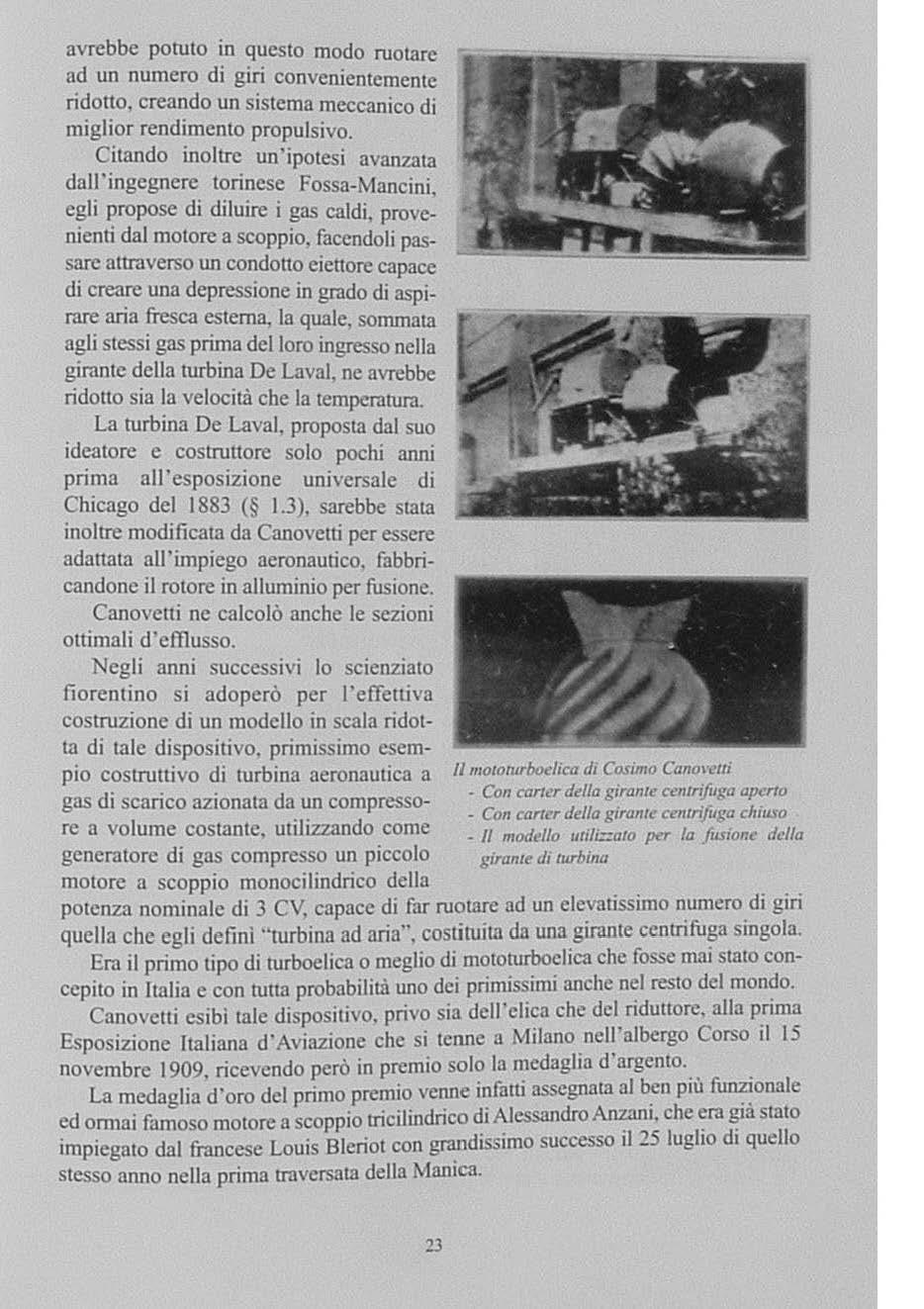
avrebbe potuto in questo modo ruotare ad un numero di giri convenientemente ridotto. creando un sistema meccanico di miglior rendimento propulsivo.
Citando inoltre un'ipotesi av807.ata dall'ingegnere torinese Fossa-Mancini e~li ~ropose di diluire i gas caldi, prove~ mentt dal motore a scoppio. facendoli pass~e attraverso un condotto eiettore capace dt creare una depressione in grado di aspirare aria fresca esterna, la quale, sommata agli stessi gas prima del loro ingresso nella girante della turbina De Lavai, ne avrebbe ridouo sia la velocità che la temperatura. La turbina De Lavai, proposta dal suo ideatore e costruttore solo pochi anni prima all'esposizione unjversalc di Chicago del 1883 (§ 1.3), sarebbe stata inoltre modHicata da Canovetti per essere adattata aLrimpiego aeronautico. fabbricandone il rotore in allumiruo per fusione. Canovcni ne calcolò anche le sezioni ottimali d·effiusso.
Negli anni successivi lo scienziato fiorentino si adoperò per l'efTeuiva costruzione di un modello in scala ridotta di tale dispositivo. primissimo esempio costruttivo di turbina aeronautica a Il moronubo.dica d1 Co.<imo Canon:11i
• Con can.•r dtlla girante c•·ntrifi,ga ap,:no
- Con cart<·r della giranti: centriJi1ga ch1u~o
- Il modello urili:=ato pt·r la fiuiont• della girante di turbina gas di scarico azionata da un compressore a volume costante. utilizzando come generatore di gas compresso un piccolo motore a scoppio monocilindrico della potenza nominale di 3 CV. capace d1 far ruotare ad un elevatissimo numcro di giri quella che eglì definì ··rurbinaad aria". costituita da uno girante centrifuga smgola. Era il primo tipo di turboelica o meg)jo di mototurboelica che fosse mai stato concepito in Italia e con runa probabilità uno dei primissimi anche nel resto del mondo. Canove11i esibì tale dispositi\'O, privo sia dell'elica che del riduttore. alla pnma Esposizione Italiana d'Aviazione che si tenne a Milano neU'albergo Corso il 15 novembre 1909. ricevendo però in premio solo la medaglia d'argento.
La medaglia d·oro del pnmo premio venne infnui assegnata al ben più funzionale ed ormai famoso motori! a scoppio tricilindrico dj Alessandro Anzani, che era già stato impiegato dal francese Louis Bleriot con gramdissimo successo il 25 luglio d1 quello stesso anno nella prima traversata della Monica.
23
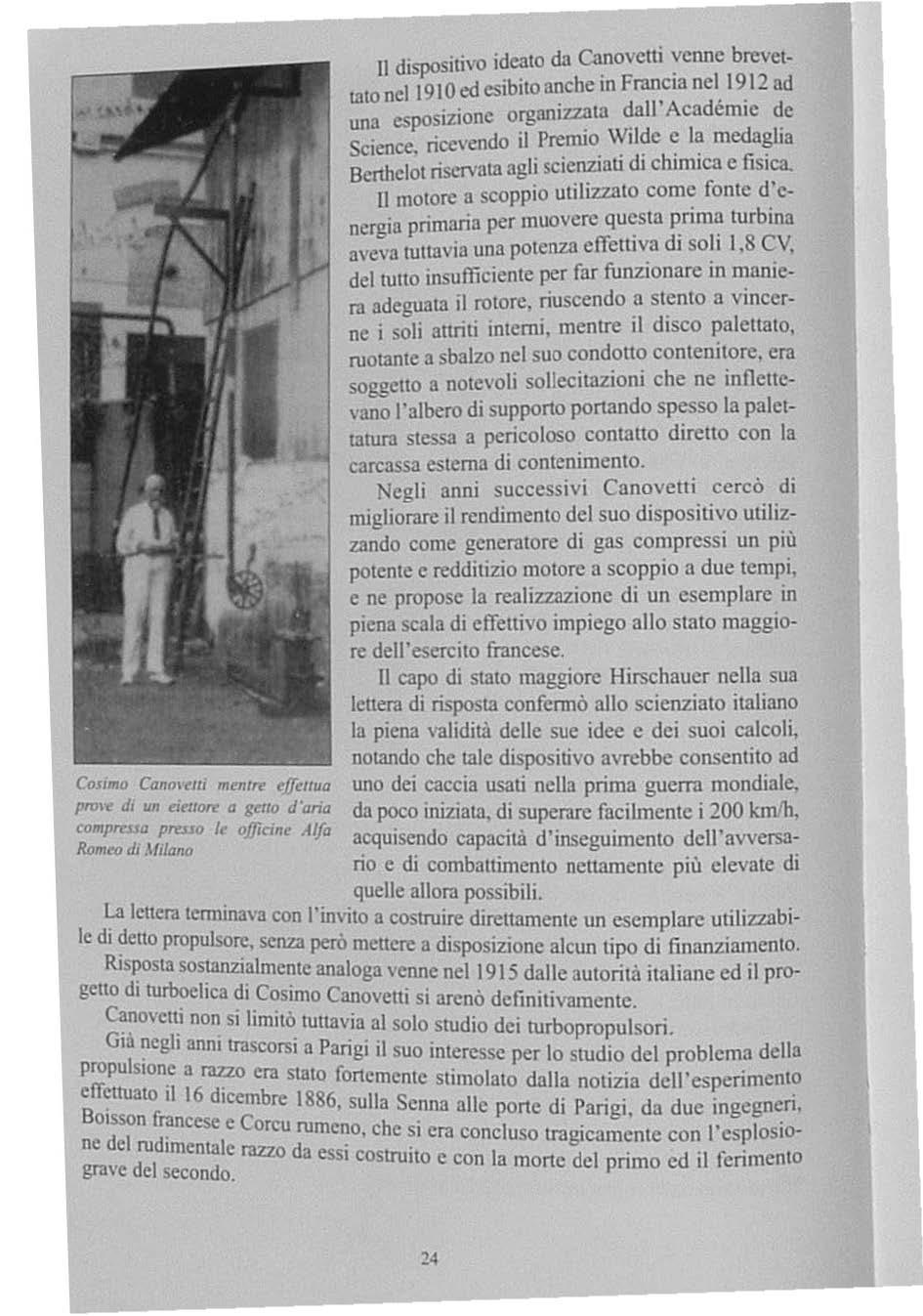
Cos11r.o Cono, ,•111 ntentre ,:ff,:1tua prow d, un cirtron• a ge110 d'aria compn:SJ,1 preSJo /,: ofjkin,: Alfa Romeo d, .\h/0110
0 i"deato da Cano\'etù venne brevet- 11 dlSJ)OSlll\ -, 11910 ed esibito anche in Francia nel 191 _ ad tatone · d ll'A d. . d . n. organia.ata a ca ernie e una espos1210 e • S . ·ce, endo il Premio Wilde e la medagha c1ence. n . . d. h. . fi . rth I •. .,,,"'ta agli sciellZlaU 1 c 1m1ca e 1s1ca Be e ot nsc, •.. , , n motore a scoppio uuhzzato come fonte d _ c. nna per muovere questa pnma turbina neriua pnm . . , a\'e~a tuttn\'la una potenza efTett1va di so! • 1.8 C\i. del tulio insufficiente per far funzionare m man1ed a"' 1-1rotore nuscendo a stento a \mcerra a egu "' · ne I soh annu interni. mentre 11 disco palettato. ruotante a sbalzo nel suo cond~ll~ contenllore. cra sogge1to a notevoli sollecitaz1001 che _ne mflette,·ano1·albero d1 supporto portando spesso la palettatura stessa a pencoloso contatto diretto con la carcassa esterna di contenimento. égh anni successh'1 Can~veui__cercò_ di m1ghorarc 11 rendimento del suo d1spos1u~o uuhzzando come gcneratore d1 gas compressi un p1u potente e reddiuzto motore a scoppio a due 1cmp1, e ne propose la realizzazione d1 un esemplare_ m piena scala d1 effetuvo 1mp1ego allo stato maggiore detrescrc110 francese.
11 capo d1 stato maggiore H1rschauer nella sua lettera di risposta coofennò allo scienziato italiano la piena validità delle sue idee e dei suoi calcoli, notando che tale dispositivo avrebbe consenuto ad uno dei caccia usati nella pnma guerra mondiale. da poco 1ruziata. dì superare facilmente i 200 km 1h. acquisendo capae1ta d'inseguimento dell'awersario e di combathmento nettamente p1u elevale di quelle allora poss1b1h.
La lettera tcnninava con l'in\'ito a costruire direttamente un esemplare utìbzzabile di deuo propulsore. senza però mettere a dispos1Z1one alcun tipo dì finanziamento. Risposta sostanzialmente analoga venne nel 1915 dalle autorità ilaIiane ed 1I progetto di turboelica d1 Cosimo Canovetti si arenò definiti\ amente.
Canovetti non s1 hmno 1uttavia al solo studio dei turbopropulson.
Gin ?egli anni trascor.;1 a Pang1 ìl suo interesse per lo studio del problema dello propulsione a razzo era stato fortemente s11molato dalla notizia dell'esperimento effettuato il 16 dicembre 1886, sulla Senna alle porte di Parigi. da due ingegneri. Boisson f1'.1ncese c Corcu rumeno. che si era concluso tragicamente con l'esplosione del rudimeniale razzo da essi costruito e con la morte del primo ed il ferimenio grave del secondo.

I due tecnici avevano sistemato su un natante una rudimentale.. d. b · d. d. manni.w I ronzo d1 30 cm 1 1ametro, nella quale avevano caricato 15 kg di una miscel b _ ib ·1 d. I . h . a com u stl I e 1 _ oro creazione c e, bruc1~do, avrebbe dovuto fornire un getto di scanco capace d1 far muover velocemente I imbarcazione stessa.
_L'esperimento: te~tato diverse volte in precedenza, era già sostanzialmente riuscito, _ma m que_ll ultima occasione lo scarso spessore della marmitta non era stato sufficiente a resistere alla sovrappressione interna di circa 20 atm, provoc.ata da una carica di combustibile più fone del consueto messa per fare bella figura con i finanziatori del progetto che erano presenti alJa prova.
Assistendo inoltre al primo collaudo del dirigibile coStruito dal conte Ferdinand von Zeppelin, che venne effettuato il 3 luglio 1900 sul lago di Costanza, Canovetti, unico latino invitato per l'occasione a rappresentare le Società degli Ingegneri Civili francesi ed italiani, aveva potuto vedere all'opera una delle grandi eliche usate per la propulsione, maturando la convinzione che tale dispositivo non potesse avere un elevato rendimento.
Che le eliche aeree usate dai costruttori d'aeroplano nei pnrnissimi anni del '900 avessero una efficenza propulsiva limitata era apparso subito chiaro ai primi studiosi di aerotecnica ed ai primi costruttori d'aeroplani.
Il fenomeno poteva essere infatti facilmente evidenziato in base a due osservazioni di carattere empirico: in un determinato intervallo di tempo nessun aereo riusciva a percorrere in volo una distanza renilinea pari al prodotto del numero dei giri fatti dall'elica stessa per il relativo passo; la velocità d'avanzamento del1'aereo era infatti sempre inferiore a quella dell'aria posta in movimento nella opposta direzione.
L'elica era soggetta cioè ad una specie di rinculo o regresso che. come allora creduto, le faceva perdere d'efficacia.
Altra perdita presa in esame era. come vedremo meglio parlando di eliche i.ntubate, quella causata dell'eccessivo angolo d'apenura del cono d'aria mobile che veniva proiettato a valle dell'elica stessa e dai relativi \'Onict.
In una dettagliata relazione su tali problemi. tenuta il 17 febbraio 191 I al Collegio degli Ingegneri di Milano e pubblicata nel dicembre cli quello stesso anno sulla rivista francese l'A.érophile. Canovetti formulò una delle pnme teone matematiche relativa all'esatto computo della forza trattiva di una elica. che venne m seguito universalmente accettata. . . . .
Poiché la creazione di tale forza era basata sul cosiddetto nnculo e c1oe sulla d!fferenza esistente lra la velocità d'avanzamento dell'aeromobile e quella confenta dall'elica all'aria, l'ingegnere l'italiano per primo fece presente che questa differenza lungi dall'essere una perdita. era alla base stessa del suo funzionamento'. ed ' · d. d. tto hbe avrebbe potuto essere prodotta anche attrnverso la creazione iremi unge _. · · · teta assenza dell 'wone meccamro d'ana effettuata con altri mezz1, e c10e m comp ca di un'elica ruotante. . . . . I' ffi II dei molti Fece infatti l'esempio di una m1traghatncc che nncula per e. e. 0 • 1 d . 1 d 1 d'aria a numeros1ss1m1 pro1cru 1 1 colpi sparati, assimilando le moleco e e geno
25

• 1 - · """ capaci· d·1·mprimere per reazione ad un corpo eiettore la neces- picco iss1ma mas.,.. sano velocità di t.mSlaziooe. . .. . ,
Negli anni precedenti la prima guerra mondiale. I_ mgegnere fiorcn~no s _era per.· andato interessando alli\'amente anche allo srudto del processo fisico d1 fonnacio d. 1s· h fì zione e mantenimento di un geno gassoso ad alto reo tm~nto ~,:opu 1~0. c e osse prodono per pressione da pane di un dispositi:o pnvo ~1 pani m movimento, progeuandone un modello funzionante che costrut presso I arsenale navale d1 Taranio nel 1912 in due esemplari.
Uno di tali dispositivi venne presentato alla Esposizione di Stona della Scienza di Frrenze. mentre l'altro \"enne utilizzato per prove pratiche di funzionamemo che vennero effemiate durante la prima guerra mondiale a Monza e Saronno.
Nel corso di tali prove Canoveni riusci a produrre un getto d'ana cilindrico lungo 19 m. che venne reso pienamente visibile mediante l'uso di segatura finissima. utilizzando pron-isoriamente aria prodotta con un compressore alternativo da 5 arm. misurandone la spin111 grazie a1 solle\'amento di un pendolo dinamometrico.
All'esperimento assistettero alcuni ufficiali dell'Esercito Italiano ma non furono stesi t relati\1verbali di prova.
L'esperimento venne ripetuto il IO giugno ed il'.! luglio 1931 con un apparato sostanzialmente sun.ile messo a punto m collaboraz1one con la Caproni, presso le o~cme di Milano di detta società, ma usando un compressore molto più potente az:iona10 da un motore da 150 bp.
_ I pos11iv1 risultati che vennero 011enuci non ebbero tuttavia alcun panicolare nscontro applicativo.
. Co~im_o Canovertt, pnm1ssimo precursore e decano degli aerodinamici e fluidod~nam~~1 1tal1am, rappresentò a lungo in congressi e convegm nazionali ed internazional_i il mondo pim~ierisùco aeronautico italiano del tempo, fallo di appassionali e prauc~tt sp~ovvist1 m genere di un'adeguata culrura, di cui costituiva quindi la pane nobile scientifica.
\'e/i o~cup~ ~noa tard? età a~che dt molti altn argomenti. arrivando persino a scri;:::al~i cn~ca dr aJcuru aspcu1 della teoria della relatività di Einstein.
G d gnuo dai francesi della Legion d'Onore. Scomparve il 29 febbraio 1932 a ar onc R1\'tcra.
26
//.2: I precursori s tranieri della propulsione a getto
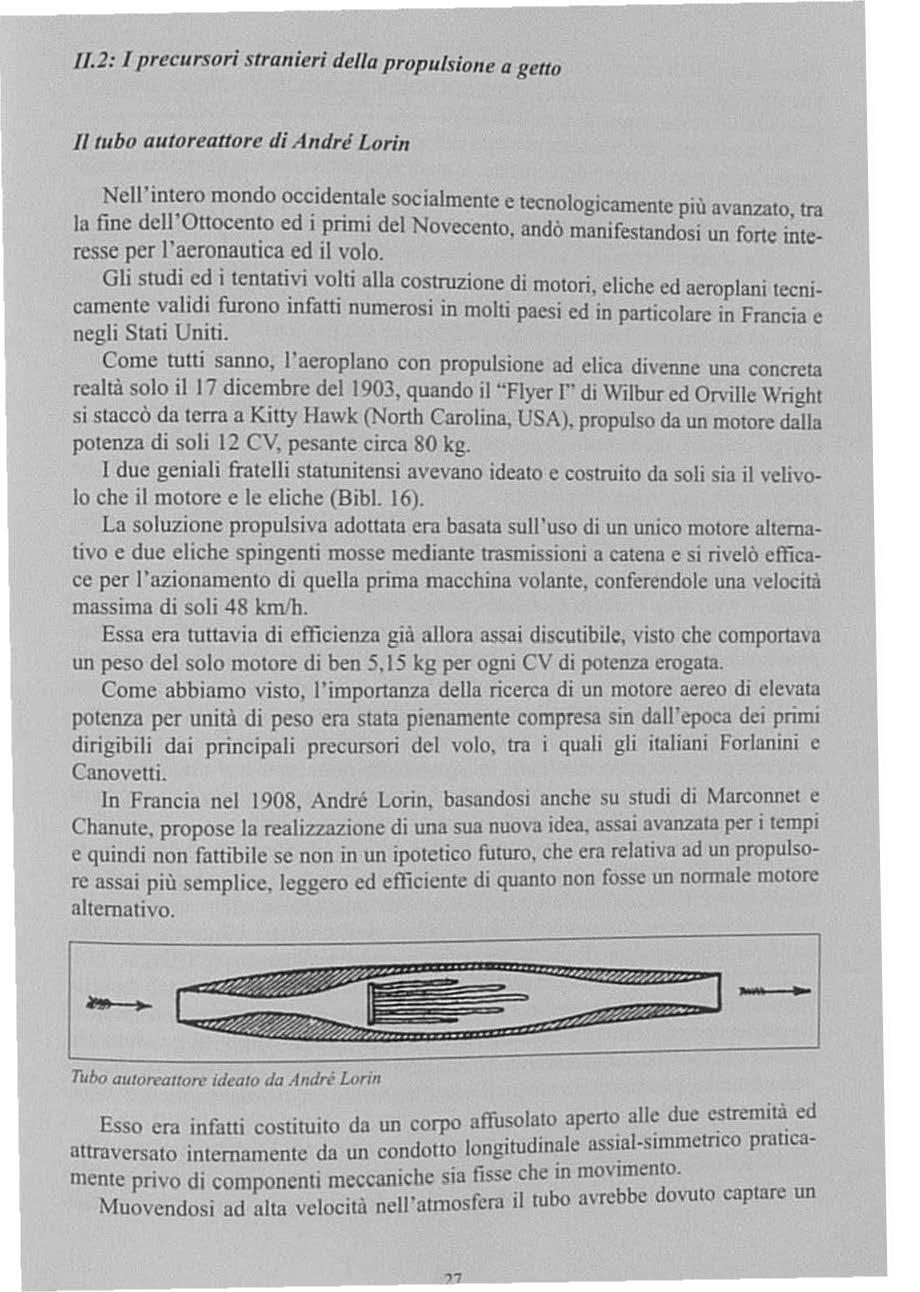
li tubo a111orea1tore di André lorill
Nell' intero mondo occidentale socialmente e tecnologicamente pm avanzai la fine dell'Ottocento ed I primi del Novecento. ando manifestandosi un forte 0 ~: resse per l'aeronautica ed il volo.
Gh studi e~ 1 tentaLi_vi vo_ltt alla costruzione d1 moLon. chcbe ed aeroplani tecnicamente valtd1 furono mfatt1 numerosi m molti paesi ed in particolare m Francia e negli Stati Untt1.
Come tutti sanno, l'aeroplano con propulsione ad ehca divenne una concreta realtà solo il 17 dicembre del 1903, quando il ..Flyer [" d1 Wilbur ed Orville Wnght si staccò da terra a Kitl)' Hawk (North Carolina, USA). propulso da un m01ore dalla potenza di soh 12 CV. pesante circa 80 kg.
I due geniali fratelli statunitensi avevano ideato e costruito da soli sia il \'Cli\'olo che il motore e le eliche (Bibl. 16).
La soluzione propulsiva adottata era basata sull'uso d1 un umco motore alternativo e due eliche spingenu mosse mediante trasnuss1om a catena e s1 nvelo efficace per l'azionamento di quella prima macchina volante, conferendole una \'elocità massima di soli 48 km/h
Essa era tuttavia di efficienza già allora assai discutibile, , ìsto che comporta,·n un peso del solo motore d1 ben 5.15 kg per ogni C\ di potenza erogata.
Come abbiamo visto. l'importanza della ricerca di un motore aereo d1 elevata potenza per unità di peso era stata pienamente compre5a sin datrepoca dei pnmi dirigibili dai principali precursori del volo. tra I quah gli 11alia01 Forlnnmi e Cano,·en1.
lo Francia nel 1908, André Lonn. basandosi anche su srud1 d1 Marconnet e Chanute, propose la reahzzaz1one d1 una sua nUO\ a idea. assai avanzata per I tempi e quindi non fattibile se non in un ipotetico futuro. che ero relall\a ad un propulsore assai più semplice, leggero ed efficiente d1 quanto non fosse un normale motore altcmat1vo.
Esso era infatti costiruno do un corpo affusolato apeno olle due escremlla ed · d. t · ·ial s1mmemco prauca- attraversato internamente da un condono longitu ma e ass. • mente pnvo di componenu meccaniche slll fisse che in movimento.
Muovendosi ad alta vclocita nell'atmosfera il rubo O\'rebbc dovuto ciiptnre un
Tubo a11ton·a1ton• idt·ato ,la Andr,' lonn
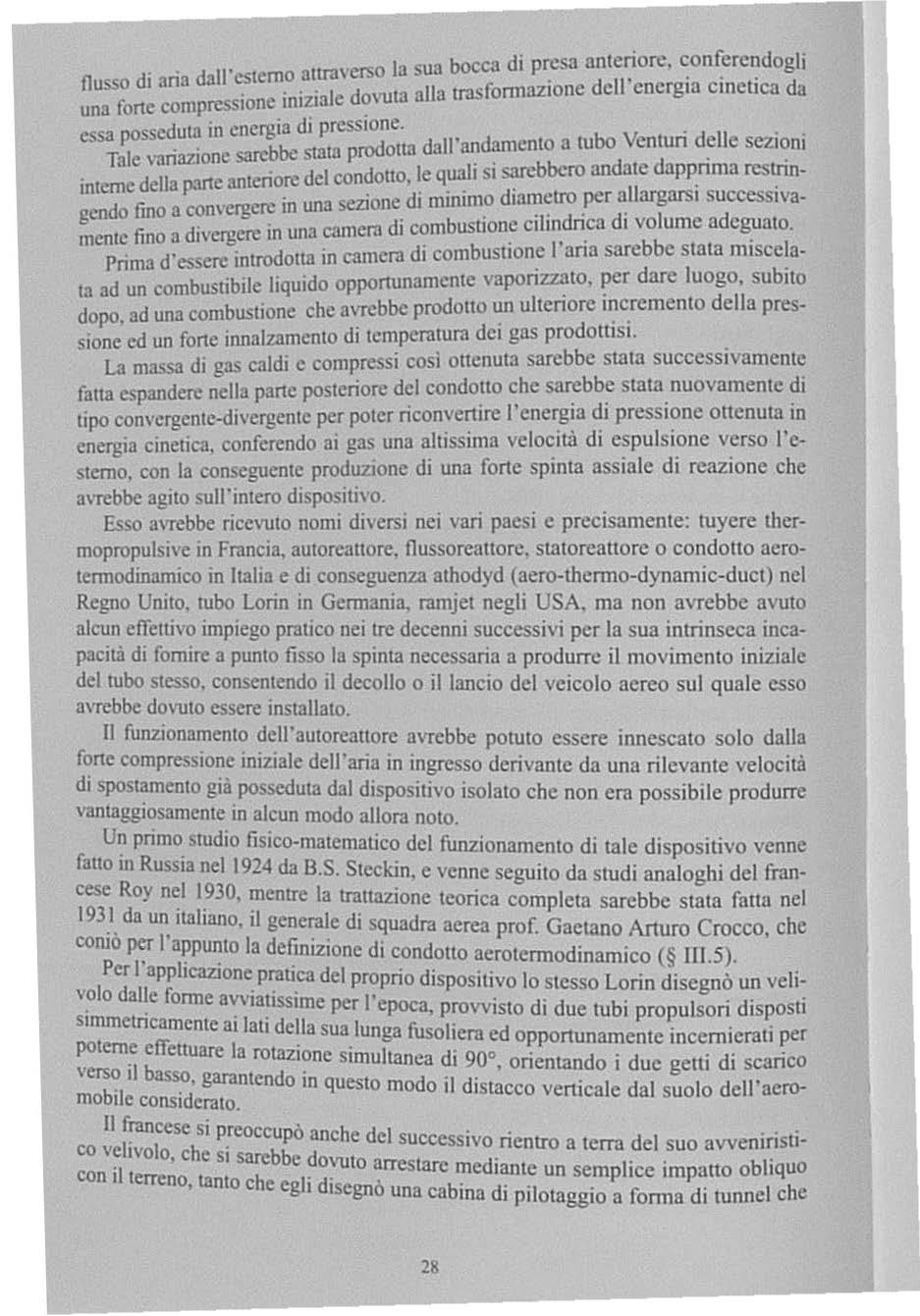
O la ·ua bocca di presa anteriore. conferendogli d. · d Il' ·temo att:ro\'ers flu,-~o 1:ma 3 es ... 1 d · uta alla traSfonnazione dell'energia cinetica da una forte compressione mma e o, •d ta in energia d1 pressione. . es 3 possc _u . . ·b....·· . t prodoua dall'andamento a tubo Ventun dellt! sezioni Tale \'anaz10ne sare ""' sta 3 . • d · . · d ICondotto le quali s1 sarebbao andate appnma restnn. tem • della 1>3rte antenore e • . . m e • • una ezione di mìrumo diametro Jll;!r allargarsi successtvagendo fino a con, ergere m . . • · · . I d , fi d. . n una crunero di combusuonc_' cilmdrica d1 , o urne a cgu _ nto. mente no a " ergere 1 , · d' trodot'"' 10 camera d1 combustione I ana sarebbe stata m1scela- Pnma es:-.erc: m "' d b -n-bile liquido opportunamente vaponzzato. per dare luogo. subito ma un com u:. • · d 11 dopo. ad una combustione che a,:rebbe prodono un ultenorc incremento e a pressmne ed un forte iMalzamento d1 temperatura dei gas prodotus1.
La massa di ga~ caldi e compressi cosi ottenuta sarebbe stata successi, amente fatta espandere nella pane posteriore del condotto che sa~ebbe stata_nuovamente d1 tipo conn:rgente-d1vergentc per poter ricon~·e~1re l'energ'.a dt press1?ne ottenuta.m energia cmenca, conferendo a1 gas una aluss1ma veloc1ta d1 cspuls1~nc verso I esterno. con la conseguente prodUZ1onc di una forte spinta assiale d1 reazione che a\'rebbe ae1to :-.utrintero disposi11,o.
Esso a~rebbe ricevuto nomi d1vers1 nei , ari paesi e precisamente: tuyere thermopropuls1ve m Francia. autoreattore, flussoreattorc. statoreattore o condotto acrotermodinamico in Italia e di conseguenza athodyd (aero-thermo-dynamìc-duct) nel Regno Unito, tubo Lorin in Germania. ramjet negli t;SA. ma non a,Tebbc avuto alcun cffctti\O 1mp1ego pratico nei tre decenni successivi per la sua intrinseca incapacilli di fornire a punto fisso la spinta necessaria a produrre il movimento iniziale del tubo stesso. consentendo il decollo o il lancio del veicolo aereo sul quale esso a,-rebbe dovuto essere installato.
fl funz1onnmento dcll'autoreauore anebbe potuto essere innescato solo dalla forte compressione iniziale dell'ana in 10g.resso derivante da una rilevante velocità di spo~t~men10 già posseduta dal dìsposuivo isolato che non era possibile produrre vantagg1osnmente IO alcun modo allora noto.
lin pnmo studio fisico-matematico del funzionamento d1 tale dispositivo venne fauo III Russia nel 1924 da B.S. Steckin. e venne seguito da studi analoghi del francese Ro) n~I 1_930, ?1entre la trattazione teorica completa sarebbe stata fana nel 193 I_ da un italiano. 11 generale di squadra aerea prof. Gaetano Anuro Croceo, che corno~ l'app~to la defimz1one d1 condotto aerotermodinarnico (§ IIJ.5).
Per I applicazione prauca del proprio dispositivo lo stesso Lorin disegnò un veli, ~lo dalle forme a\'\'iauss1me per l'epoca, provvisto d1 due tubi propulsori disposn sirnmetncamcntc ai 1311 della sua lunga fusoliera ed opportunamente incernierati per poterne effettuare la rotn"1one . lta d' 900 . . . . . - simu nca 1 , onentando I due geni d1 scanco 'crso 11 basso garantendo · d . . . b.1 . · IO questo mo o 11 distacco vemcale dal suolo dell'acromo I e cons1dcra1o.
Il francese si preoccupò h d 1 . .I. anc e e successivo nentro a terra del suo a,.,,·emnsnco ve ivolo, che s1 sarebbe d . . e .1 ovuto arrestare mediante un semplice impano obliquo on I terreno tanto che r d . . . · cg I tsegno una cabina <ti p1lotaggìo a fonna di tunnel che
28
!l. c-:-z-

Aeroplano a l't!a..-ione propoHo da , lndri.: lorin
a~·rebbe pennesso la completa estensione degh elastici ammortizzaton con i quali il pilota avrebbe dovuto essere assicurato al proprio seggiolino.
\;on é noto quale fosse il 11po d"imbonirura capace d'attutire il successivo urto di ritorno elastico del pilota sullo stesso seggiolino. ma tali curiose ingenuità non debbono trarre in mganno circa J"cffet11va v:ilidità propulsl\ a dell'au1orea11ore di Lorin. che schematizzava in fonna sostanzialmente corretta e tecnicamente realizzabile alcuni dei concctt1 fondamentab dei propulsori a reazione anuali.
André Lonn breve11ò la suo invenzione m Francia nel 1913. ma come :ibbiamo dello essa non ebbe alcuna applicazione pratica immediata.
Tale idea avrebbe però costiru1to la base concettuale di rutti gh S\ 1luppi apphcat1n successivi, ciascuno de, quali avn:bbe cercato in modo diverso di fornire la soluzione necessana all'ottenimento dell'innesco compressivo m1zialc.
Una pnma reahziazione costrutriva sarebbe stata introdotta dal francese Remi Leduc a panire dal 1930 con esperimenti di funzjonamento pratico effettuati nd 1935, seguiti dalla cosLruzione di un primo autoreattore funzionante nel 1940.
l'autoreattore cambiò fom1a rispetto al progcno ongmano di Lonn. finendo con l'essere costituto da ere sole parti fondamentali: un diffusore tronco conico divergente iniziale. seguito da uno camera di combustione cilindrica ed un ~ondotto di scarico finale ancora tronco conico semplicemente convergente Una gnghe metallica di separazione tra le pnme due pani avrebbe provveduto a stabilu..zare la pos1ZJone del fronte d1 combustione interno.
. La seconda guerra mondiale avrebbe interrotto tali esperimenti. che sarebbero npresi nel 1947 con la messo a punto del velivolo Leduc O IO propulso ancora da un dispositivo di questo stesso tipo
--·--
29
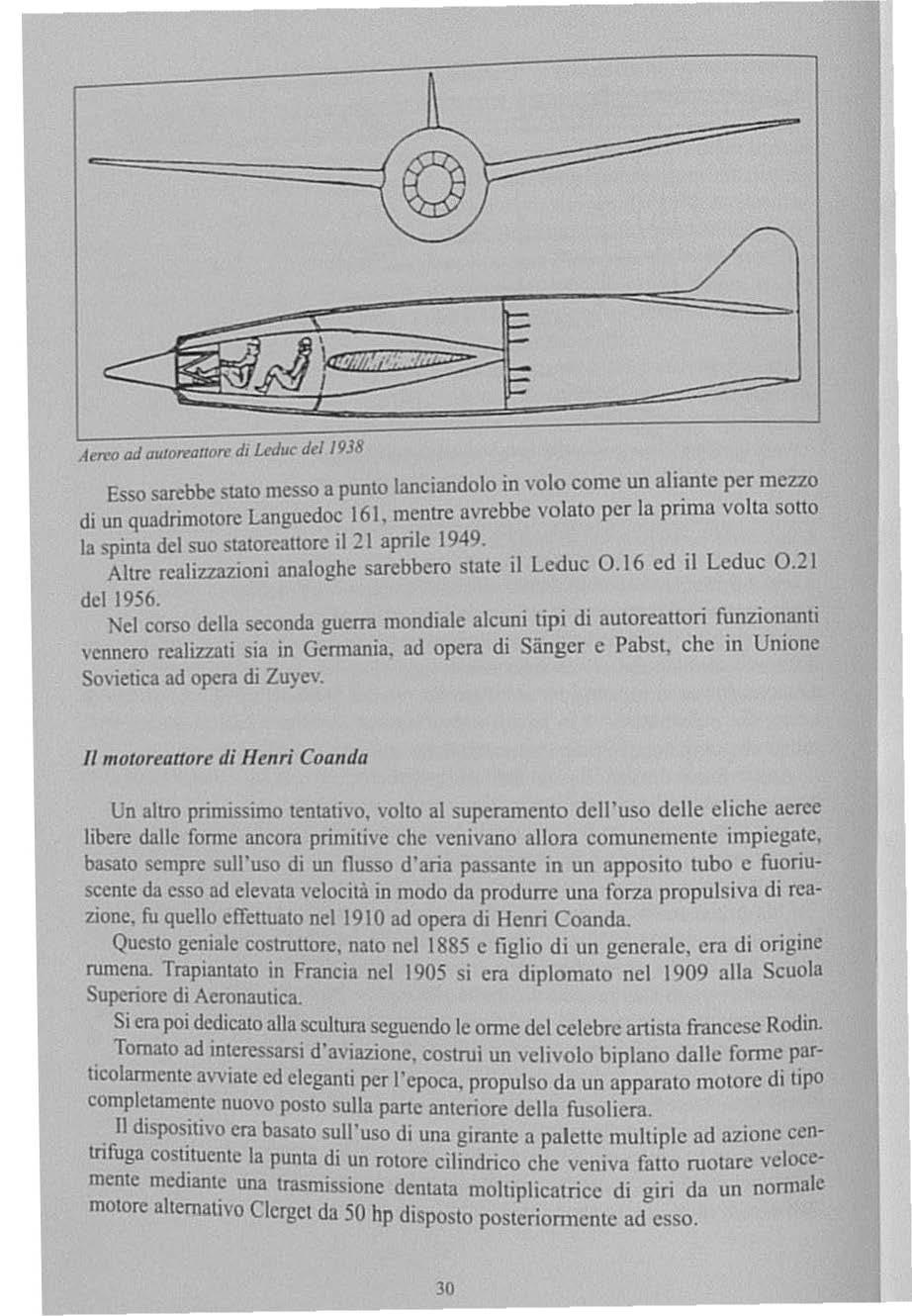
. ~em> ad autolt'Olltm· d1 Lctluc del 1938
Ess bbe 1.810 messo a punto lanciandolo in volo come un aliante per mezzo osare s · I cti un quadrimotore Languedoc 161. mentre avrebbe volato per la prona vo ta sotto la spinta del suo statoreattore il 21 aprile 1949 . . ., Altre realizzazioni analoghe sarebbero state ti Leduc 0.16 ed ti Leduc O.~ I del 1956. . . . ~el cor.;o della seconda guerra mondiale alcuni upt dt autoreatton fu11Z1onan11 \'Cnnero rcaltzzatì sia m Germania. ad opera di Sanger e Pabst. che m Unione So\'ielica ad opera cti Zuye\'
li motoreattore di fle11ri Coa11da
un altro primtss1mo tentatÌ\'O, volto al superamento dell'uso delle eltche aeree libere dalle forme ancora primiti\'e che venivano allora comunemente impiegate, basato sempre sull'uso di un flusso d'ana passante m un apposito tubo e fuoriuscente da t!sso ad ele,ata \'clocità tn modo da produrre una forza propulsiva di reazione. fu quello effettuato nel 1910 ad opera dt Henn Coanda. Questo geniale costruuore, nato nel 1885 e figlio dt un generale, era di ongme rumena Trapiantato in Francia nel 1905 s1 era diplomato nel 1909 alla Scuola Supenorc dt Aeronautica
Si era poi dedicalo alla scultura seguendo le orme del celebre anìsta francese Rodin. . Tornato ad interessarsi d'a,·iazione, costruì un vcli\'olo biplano dalle forme parucolarmente a\"\ 1a1e cd eleganu per l'epoca. propulso da un apparato motore di tipo completamente nuovo posto sulla pane antenore della fusoltera. n dtsposuh o era basato sull'uso d1 una girante a palette multiple nd azione ccntnfuga cosutuente la punta di un rotore cilindnco che veniva fatto ruotare vcloccmemc mediante una trasmissione dentata mohtpltcatrice di gtn dn un normale motore alternativo Clcrget da 50 hp disposto posteriormente ad esso.
30
La girante centrifuga cd il suo rotore di supporto ruotavano all'interno di una carcassa tubolare di forma tronco conica. aperta alle estremita ed avente la baseminore disposta anteriormente a formare il muso del velivolo, mentre la sua superficie laterale si prolungava posteriormente allare gandosi fino ad avvolgere con la base mag- .\foron-a11ore di Ffrnn Coanda giore la parte anteriore del motore Clerget. ;;
La bocca d'ingresso della carcassa !Tonco-conica, attraverso la quale l'ana entrava nel suo interno, aveva il suo bordo metallico circolare sagomato m sezione secondo la forma di un profilo alare di grosso spessore e fone curvatura.
La \'COB d'aria entrante nella carcassa era quindi risucchiata all'mtemo per effetto della depressione creata dalla rotazione dello girante centrifuga. Subito dopo l'ingresso, tale vena era obbligata a seguire la superficie d'intradosso del profilo alare, formato dal detto bordo metallico. piegandosi radialmente verso l'esterno quasi ad angolo reuo, percorrendo subito dopo il condotto anulare esistente tra l'involucro tronco conico esterno ed il rotore cilindnco mtemo mosso dal motore Clerget, che provvedeva a piegare nuovamente la , ena fluida stessa nponandola m direzione assiale per scaricarla successi, amente a valle del tronco d1 cono
In tal modo si ,·enl\a a creare una particolare forza di reazione propulsiva agente sulla pane anteriore della carcassa secondo un fenomeno aerodinamico che sarebbe stato definito ·•effetto Coanda.. ~egli anni ·70 si cercò di utilizzare questo particolare fenomeno su velivoli a decollo verticale do1a1i d1 un nuo, o upo d'ala avente profilo rnnabilc che era capace d1 assumere. m condlZloni d1 sollevamento dal suolo, una fone curvatura, che porta, a la parte 1erminalc dello stesso profilo a disporsi in posizione quasi ,·emcale, facendo giungere il suo bordo d'uscita a poca distanza dal suolo.
l\dollando tale conformaz1onè a fone curvatura. raia stessa era capace di deflettere il getto d'aria prodotto da un normale 1urboge110, posto antenormente ad essa ed avente asse d1 rotazione orizzontale, piegandolo ad angolo reno e convogliandolo verticalmente verso il suolo. La veloce circolazione d'aria generata dal motore a contano con il profilo alnre fonemente mcurvato avrebbe quindi generato una forza portante capace di far solle\'are 11 velivolo. inizialmente 1111mobile. direnamente verso l'alto.
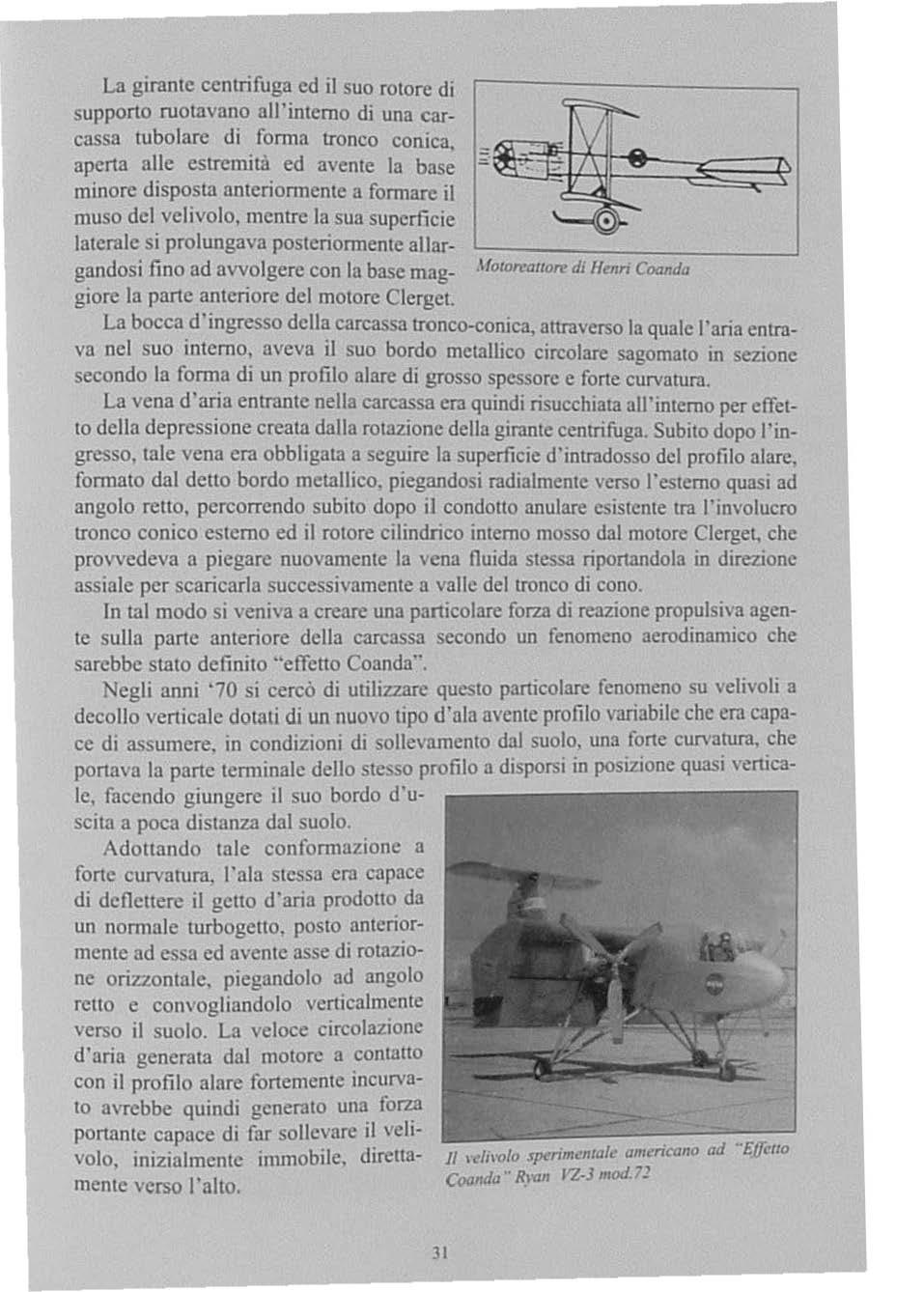
JI ,d,mlo .fp<nm.:nr.ilt· omuiruno oJ -EU.:110 Coando" Rmn 12-J mod 7!
31
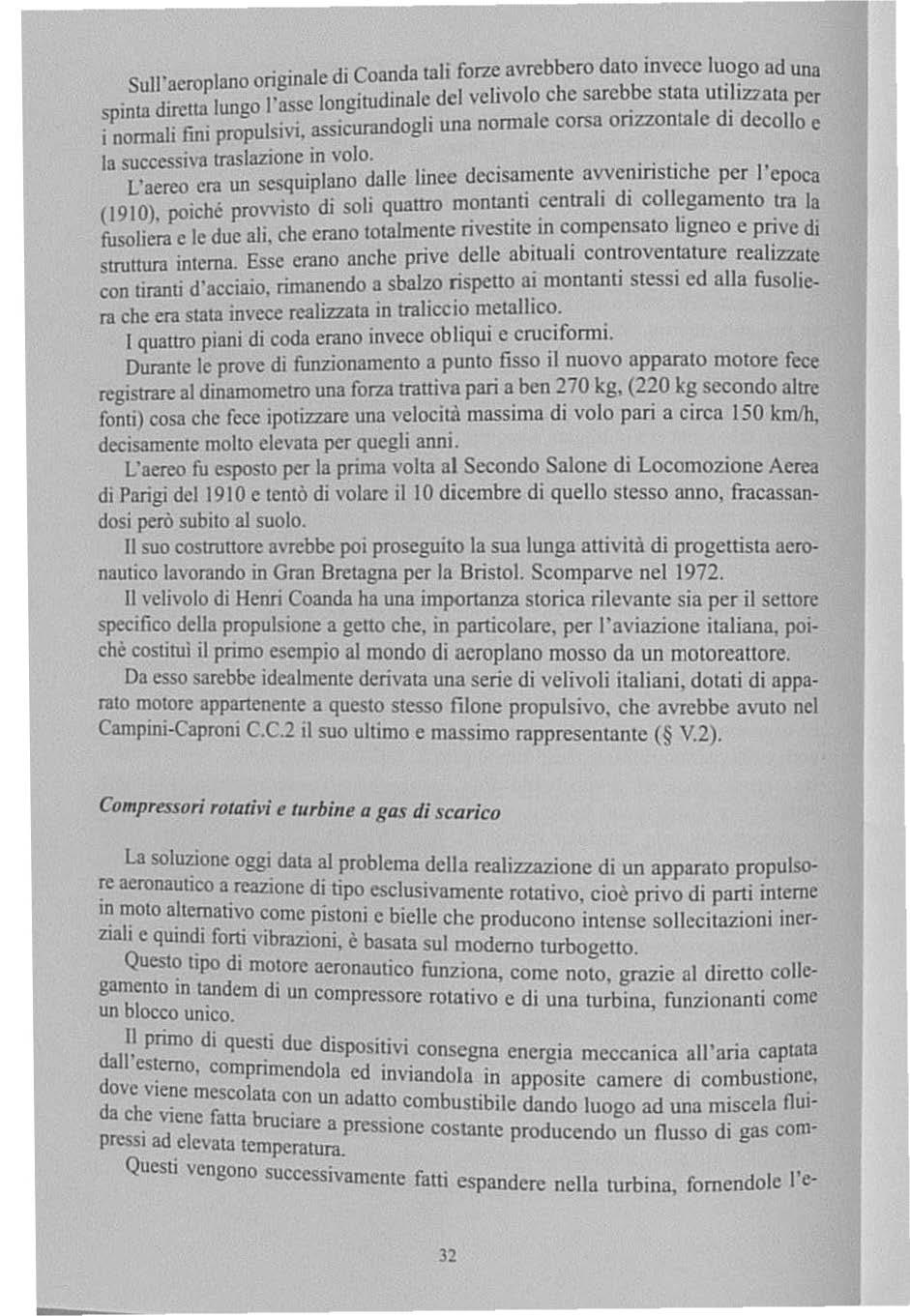
· · I di· Coanda mli forze avrebbero dato invece luogo ad una Sull'aeroplano ongma e . . .. . . 1 r e loneitudmale del velivolo che sarebbe sLata ut1hva1a per ~pinta dl,refitta ungo 1 05 ,,s assi;urandogli una nonnalc corsa orizzontale di decollo e 1 norma I m propu s1 . la successi, a traslazione in \'Olo. . . . . •
L. un sesquiplano dalle linee decisamente avvemnsuchc per I epoca aereo era . 1- d' li 910) · h · ro,'\isio di soli quattro montanll centra 1 1 co egamento 1ra la (I .po,cep . . . 1· · fu I. le due ali che erano 1otalmente nvesme m compensato igneo e pnve d1 so 1era e . . . . nu ·ntema. Esse erano anche prive delle ab1tuah controventaturc realizzate stru ra i . • . d Il fus . con tiranu d'acciruo. rimanendo a sbalzo nspetto a~ monr.anu stessi e a a altera che era stata in\'ece realizzata m traliccio metallico.
I quattro piani di coda erano invece obliqui e crucifonnt.
Durante le pro\'e di funzionamento a punto fisso 11 nuovo apparato motore fece registrare al dinamometro una forza tratti\'~ pari a_ ben ~70 kg. (2~0 k~ secondo allre fonti) cosa che fece ipotizzare una velocna massima d1 volo pan a circa 150 km/h, decisamente molto ele\'ata per quegli anni.
L'aereo fu esposto per la prima \'Olta al Secondo Salone di Locomozione Aerea di Parigi del 1910 e tentò di \'Olare il IOdicembre di quello stesso anno. fracassandosi però subito al suolo.
li suo costruttore avrebbe poi proseguito la sua lunga attività di progettista aeronau1ico lavorando in Gran Bretagna per la Bristol. Scomparve nel 1972.
11 velivolo di Henri Coanda ha una imp<>nanza s1orica rilevante sia per il seuore specifico della propulsione a getto che. in particolare. per l'aviazione italiana. poichè costituì il pnmo esempio al mondo di aeroplano mosso da un motoreauore.
Da esso sarebbe idealmente derivata una serie di velivoli italiani, dotati di appara10 motore appartenente a questo stesso filone propulsivo. che avrebbe avuto nel Campini-Caprom C.C.2 il suo ultimo e massimo rappresentante(§ V.2).
Compressori roratfri e t11rbi11e a gas di lcarico
Lo soluzione oggi data al problema della realizzazione d1 un apparato propulsore aeronauuco a reazione di tipo esclusi\'amente rotauvo. cioè privo di parti interne m moto altei:natwo come pis1oni e bielle che producono intense sollecitazioni inerzmh e qumd1 fort1 vibrazioni, è basata sul moderno turbogetto.
Quest t d' 0 •po I motore aeronautico funziona, come noto, grazie al diretto collegambeln1o m iandem di un compressore rotativo e di una rurbma funzionanu come un occo unico. '
Il primo d1 questi d d' · · · dati• . ue 1spost11V1 consegna energia meccanica all'aria captata esterno, compnmendol d · · d , · . · d . 8 e mv1an o.a tn apposite camere di combusuone, ove viene mescolata con d . . · d h . un a ano combusub1le dando luogo ad una miscelo fluia e e \.1cne fatta bruc -
P d I •are a pressione costante producendo un flusso di gas com· ressi a e e\ata temperatura.
Questi vengono success·ivamente fam espandere nella turbina, fornendole I e·
32

nergia meccanica che viene utilizzata per far girare lo sh.-sso compressore. mentre la restante parte viene trasfonnata in energia d',•cpnns·ion•·•ed es I · Il' ..,,, pu s1one a esterno dcel1 stessa gas sotto fonna d1 getto di scarico veloce usato""' I I · - .,-r a propu s1one a reazione.
Compressore tur_binn J>Olrebbero anche funzionare separatamente fornendo ug~lmente: con I ausilio d1 altri organi meccanici come ad esempio motori altcrnanv1 ~d eliche. una cena quantità d'energia utilizzabile per scopi propulsi, 1• ma con un efficienza alle alte velocità nettamente inferiore a quella fornita da un turbogeuo.
Questi due dispositivi non sono stati infatti ideati, sperimentati e costruiti contemporaneamente. ma_de~vano da meccanismi annloghi che furono sviluppati separatamente e vennero mlZlalmente usati solo per applicazioni non aeronautiche d1 tipo industriale.
li fortissimo incremento d'efficienza derivante dal loro diretto collegamento sarebbe infatti intervenuto solo qualche tempo dopo e sempre in applicazioni industriali a terrn.
Queste turbomacchine sono state denominate nd corso degli anni sia turbine a gas di scarico" che "turbine a combustione interna··.mentre vengono oggi definite semplicemente ··turbine a gas" quando sono utilizzate sia per impieghi industriali terrestri che nella propulsione navale. serton nei quali ono state precedute dalle turbine a \'apor d'acqua.
In una turbina a gas. la reazione chimica es0lern1ica fondamentale capace di produrre calore convenibile in energia meccanica, ed in panicolarc m spin1a propuls1,,u. si svolge nello stesso fluido primario utilizzato. a differenza di quanto a, viene nelle turbine a , apore che sono conccnualmcnte simili. ma utilizzano invece , apore acqueo in pressione prodotto in appositi generatori riscaldali da bruciatori esterni
Fin dagh inizi si capi che l'uso ot11mak di una turbina. che è per definizione un organo rotante ad un numero di giri molto elevato. avrebbe richiesto l'uso di un compressore anch'esso di tipo rotmivo. capace di girare ad aha \'elocità e d1 trattare volumi d'aria clc,·ati.
La già esistente compressione ba:,ata su pistoni in moto altemati,o scorrenti m camere chiuse come in un motore a scoppio d'automobile. che era capace d1 tranare masse d'aria ridonc conferendo loro un'alta prcs:.10ne finale. pur se adonata con successo. apparve fin <lugli inizi inadeguam _ Il pnmo esempio di compressore rotnti,o. ritenuto m grado d1 t.-ssere usabile m tandem con una turbina, fu il compressore Rutcau. . . .
Un secondo dispositi, 0 costituito da senari piani ruotanu mterogenu tra loro. che pure vc.:nne utilizzato. fu il compressore Rootcs. . . .
Tale dispositivo era però in grado di fomire solo prc:ss10~1 ridotte cd ebbe qu_m. · · ·· Iuse che anche 11 compressore rotau, o d1 applìcaz1om non dec1s1,·e. mentre s1 eone . . . avrebbe dornto essere costituito da girami multiple domt~ ~• palcnature_ penfenche che fossero in grado di comprimere l'uria secondo due d1stmtc_m~da_lt1a.. · I r. trifuga. che scaglia I nna radiulmentc
La prima agisce per effetto del a aorza cen ·
33

rispetto alrassc di rotazione del disposi11vo, facendo!? assum~re compressione gra. zie al semplice arresto contro una carcassa esterna d1 contenimento ed al suo successivo passaggio in un diffusore.
La seconda invece opera grazie a palettarurc muluple. che sono poste sia su giranti mobili con il rotore che su corone fissate sulla carcassa esterna di contenimento.
Tali palette sono capaci di coslringere l'aria a muoversi longitudinalmente, in direzione paralJela all'asse di rotazione della girante. lungo un percorso a zig-zag carauerizznto da una sezione di passaggio sempre più ristrella. ricavato tra il tamburo tronco conico fonnato dalle giranù di supporto delle schiere di palelh! in rotazione e la carcassa esterna.
11 compressore di tipo assiale presentò difficoluì rcalizzative iniziali maggiori di quello cenlrifugo.
Quesrultimo upo "enne introdotto per la prima volta in campo aeronautico da parte dei tedc·chi, a partire dagli ulumi anni della prima guerra mondiale.
Venne infa111 usato per sovralimentare i motori dei grossi bombardieri plurimotori che vennero 1mpiega11 per bombardare Londra. sui quali tale disposi1i,·o era comanda10 dire1mmen1e da un appos11O rno1ore alternativo ausihario..
In Italia il primo compressor~ cenlrifugo di so, ralirnentaz1onc
venne introdono dalla Fia1 negli \foto":• Fwt .IS6 con compnzsiore mt'ccanico O girante anni ·20 sui motori dei cc111nJ11ga \totoscafi ·\nt1 Sommergibili (MAS). (Bibl 9) per polcr Ollenere un'elevata potenza di spunto d_uran1e la corsa d1 a11.acco che veniva effettuata da questi erossi motoscafi siluranll sia co;1ro i ~mmergibili avversari in emersione che conlro le llllvi di super- ficie.
r, li primo compressore centnugo per uso aeronautico. convenientemente alleggerito med1an1e r d. · ~o. a una gtrantc in lega di alluminio ed un corpo in lega d1 magnesio. venne installato s I mo1ore Fiat A.S.6, che fu ap~- Votare lsoua F: , - l rasc,11111 111 Re ./0 r:011 compn.•sson· meccanico o gira111e C<'lllrifi1go
)4
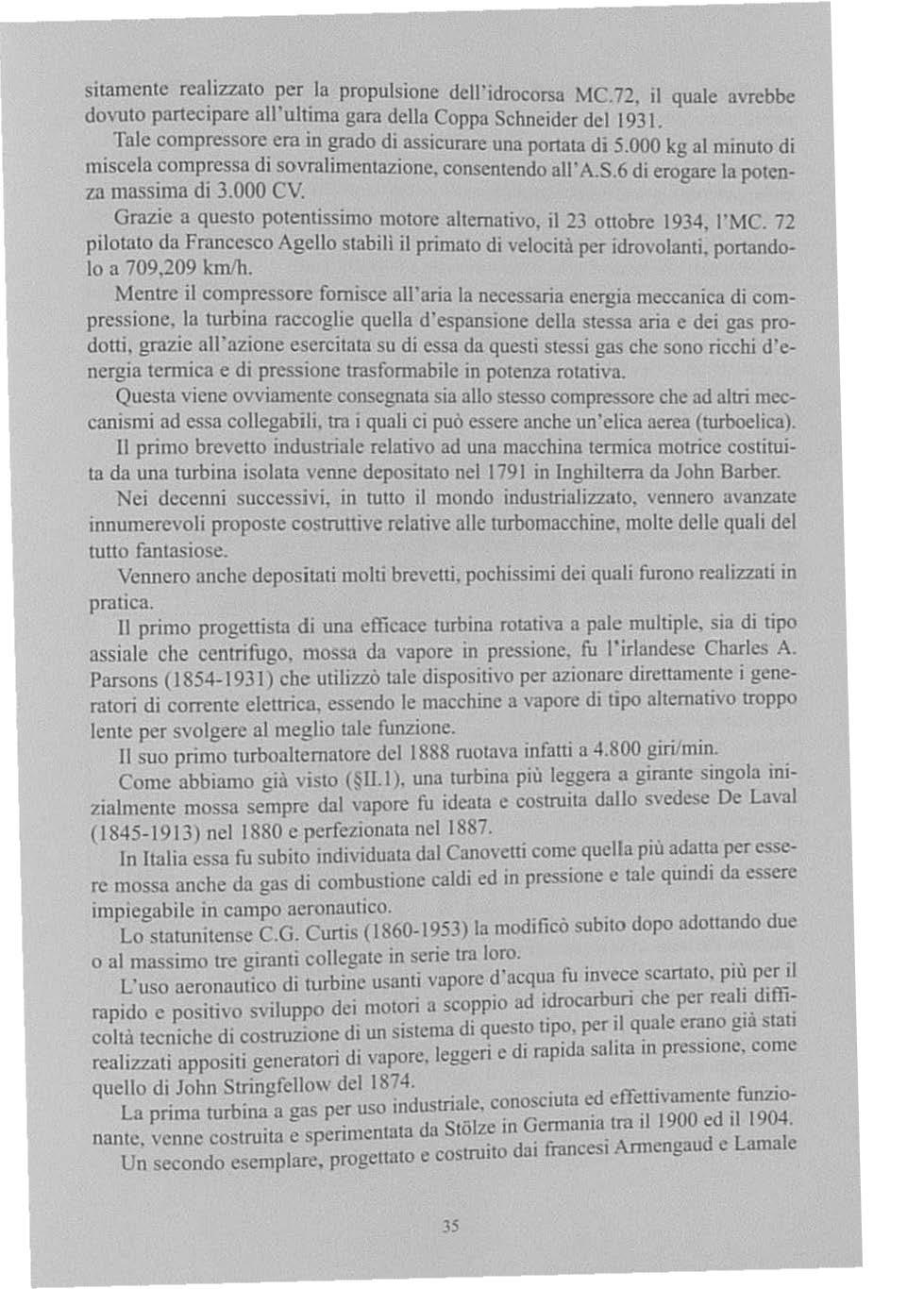
sitamente realizzato ~er _ la propulsione dctr idrocorsa \IC 72. 11 quale avrebbe dovuto partecipare ali u.Jllma gara delln Coppa Schneider del J931.
Tale compressore era in grado di assicurare una ponata d1 5.000 kg al minuto di miscela compressa d1 sovmlimeotazionc. consentendo atr :\.S.6 di erogare la potenza massima di 3.000 CV.
Grazie a questo potenttssimo motore altematÌ\'O, il 23 ottobre 193-t, l'MC. 72 pilotnto da Francesco Agcllo stabili il primato di velocità per idro\olanti. portandolo a 709,209 km h.
\lentrc il compressore fornisce all'aria la necessaria energia mi:ccanicu d1 compressione. In turbina raccoglie quella d"espans1one della stessa aria e dei gas prodotti. grazie alraz1one esercitata su di essa da quesu stessi gas che sono ricchi d'energia termica e di pressione trasfonnabilc m potenza rotali\ a.
Questa viene ovviamente consegnata sia allo stesso compressore che ad altri meccanrsmj ad essa collegabili. tra I quali c1 può essere anche un"clica aerea (turboelica).
li primo brevetto mdustnale relativo ad una macchina tenn1ca motnce costituita da una turbina isolata venne depos11a10 nel 1791 in Inghilterra da John Barber.
Nei decenni successi\ 1, in tutto 1I mondo industrializzato. vennero a\aniate mnumere, oh proposte costTUm,·e relative alle turbomacchine. molte delle quali del rutto fantas1ose.
Vennero anche depositati molti bre, etti. poch1ss1mi dei quali furono realizzati in pratica.
Il primo progettista di una efficace turbina rotalÌYa a pale multiple, sia d1 upo assiale che centrifugo. rnos ·u da vapore m pressione. fu l'irlandese Charles A Parsons ( 1854-1931) che uttli1.zò tale dispositivo per azionare d1ret1amen1e i generatori di corrente elcttric.i. essendo le macchine a , apore di upo altematn o troppo lente per svolgere al meglio tale funzione.
li suo primo turboalternatore del 1888 ruota,a mfat11 a 4.800 ~m mm ..
Come abbiamo grn \ 1:..10 ("11.1 ). una turbina più leggera a girante singola in1z1almente mossa se';nprc dal apore fu ideata e costruita dallo sved1..-se De La, al ( 1845-1913) nel 1880 e pcrfwonara nel 1887 ..
In Italia essa fu subilo mdi, iduata dal Cano, etti come quella pm adatta per e ·sere mossa anche dn gas di combustione caldi ed in pr1..>ssionc e tale quindi da .:ssere 1mp1egabile 1n campo aeronautico.
Lo statunitense C.G. Cunis ( 1860-1953) la modificò subilo dopo adottando due o al massimo tre giranti collegate in serie un loro. . _.
L"uso aeronauuco dì turbine usanti ,apon.: d"acqua fu invece sca.nato. p1u per 11 · . · ·o ad idrocarbun che per reali d1ffi- rap1do e positi, o S\ ,tuppo dei moton a scoppi colta tecniche di costruzione di un sistema di questo upo. per ti quale erano gta Slall I · · · ton· di vapore teegen e di mpida solna in pr1..-ss1one. come rea 1aa1t appos111 genero •quello di John Stringfollow del 18?4 . • ..-·u1a t!d effeui,11men1c.: funzioLa prima turbina a gas per uso industnalt:. conoG.c1 . ·1 1900 ..d il 190-l - • I dn Stòlze in errnama tra i '" . nantc. venne costruita e spenmcnta 8 • • en •aud e Lamale Ln secondo esemplari:. progcttnto e costruito dai france:.1 Arm g
35

nel I905. realizzm a gin il collegamento dire~to a~ un c~mpressore.rotati~o. Es~o \'enne concepito solo per usi industnah staztonan. quah la produzione d energia eleurìca.
Quest'ullimo tipo usava come combustibile_ olio d~ paraffina ed era ca~ace di s,·iluppare una potenza appena sufficiente ad az10uare ti compressore che gh forniva rarìa in pressione necessaria per il fun1jonamento. Esso era moltre m grado di rendere disponibile un :.-urplus minimo di energia meccamca per muovere altri orga01 meccanici utiliu.ntori solo sotto forma di ana compressa. l.itilìwl\-a una girante palenato tipo Curtis ruotante a 4.250 giri al minuto. nella quale il gas era immesso alla temperatura dt 560°C ed era capace di formrc circa ~.500 CV al compressore ad essa collegato che era del tipo Rateau. ma era carauerizzato da un consumo ele, atissimo. pan a ben 2.150 g di carburante per CV erogato e per ora di funzionamento. con un rendimento tcnnodinamico minimo non superiore al 3°o.
Nel 1906 lo Haltzwarth ideò a sua \'Olla una turbina che utilizzava un ciclo termodinamico diYerso dal precedente. detto a volume costante, nel quale mancava il compressore d'aria dt tipo rorati\'O mentre i gas in pressione capaci d'alimentarla venì\:ano prodolti attraverso un proct.-sso di combustione in camera chiusa utilizzante aria comburente unmessa a pressione atmosferica.
I gas vem\'anO ponati ad agire su un primo stadio di turbina cedendo poi iI calore residuo ad una caldaia che lo u111ìzzava per produrre vapore d'acqua capace di muo\'ere una seconda giranie
11 pnmo esemplare di questo dispositi\'O, capace d'erogare la potenza utile di circa 50 CV. \'enne fabbricato tra il 1906 ed il 1908 I dalla Kòning di I[annover. mentre • un secondo esemplare basato sem1 1 pre sullo stesso principio fu costnuto dalla Brown-Boveri svizzera nel 1909-1910
.. Quest'ultimo tipo raggiungc\'a gia una discreta efficten;a, tanto che era capace di erogare una potenza nommale complessiva di I.OO? rendendone disponibilt per I ut1ltzza1ore duecento ~egli . anni successi~•, altri csemplan vennero costruiu dalla Tyssen tra ti 1914 ed il 19n m tre I - ' en-
• n n.a 1 primo esemplare capace di Schema dl'l/a /urbina " <'sp/osioni: di Halt=wart/1
36
funzionare a regime con continuità ve fiaggio d'aria negli altiforni. nne costruito nel 1933 cd utilizzato per il sofln Italia. dopo il primo tentativo ct· T . propulsione dei dirigibili operato dal 1.~ll izzazione di una turbi_~ De Lavai nella realizzativi cd i primi esperimenti ap f 8 c!~lo Cost~O Cano~ell1, I primi seri srudi striale prima cd aeronautico in segui~o1c:1v1 correli su.~rbm~ a gas per uso mduVll. I) grande progenista di turbine a , rono ath dal) mg. Giuseppe Belluz.zo (§ vapore per uso oa\'ale.
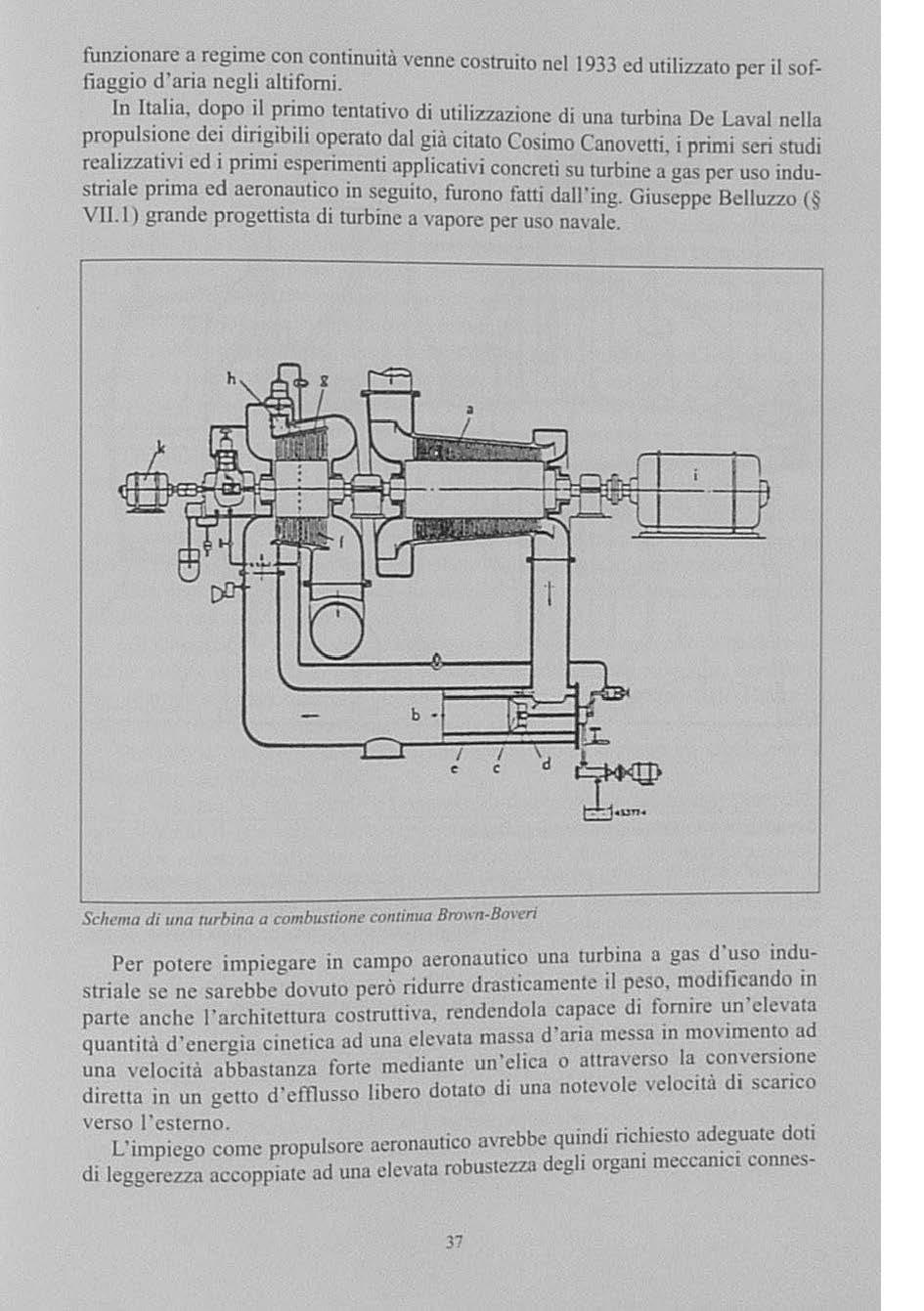
Per potere impiegare in campo aeronauuco uno turbino a gas d'uso industriale se ne sarebbe dovuto però ridurre drasticamente il peso, motlificando in parte anche l'architettura costrulli\'a, rendendola capace d1 fornire un 'cl ernia quantità d'energia emetica ad una elevata massa d'aria messa m movimento ad una velocita abbastanza forte mediante un'elica o allran:rso In conversione direua in un geuo d"effiusso libero dotato di una note, olc velocità di scarico verso rcstcrno.
L'impiego come propulsore aeronautico avrebbe quindi richiesto adeguate doti di leggerezza accoppiate ad una elevata robustezza degli orgoni meccanici connes-
Scl1t•ma di 11110 turbina a combrmionc co111in11a Bro,m-Bon:n
37
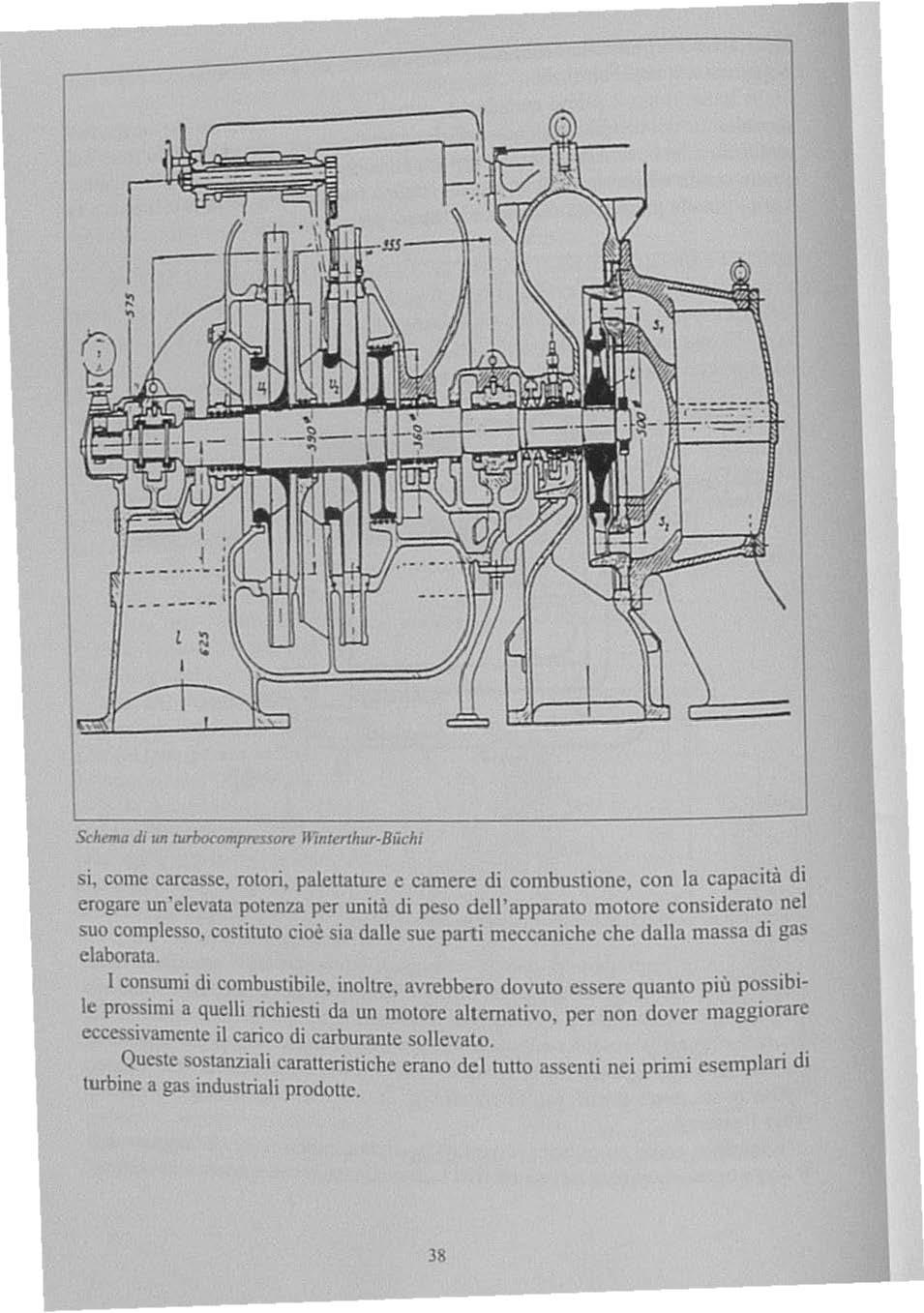
Schrma d, 11n turbocompn"5lo~ llintenhur-81ich1
si. come carcasse. rotori. palettature e camere d1 combustione. con la capacità di erogare un'ele,ata potenz_a per unità d1 peso dell'apparato motore considerato nel suo complesso, costituto cioè sia dalle sue pani meccaniche che dalla massa d1 gas elaborata.
l consumi di combustibile. inoltre. avrebbero dovuto essere quanto più possibile prossimi a quelli rich1cst1 da un motore altemati\'O, per non do\'cr maggiorare eccessi\'amente il canco di carburante sollevato.
_Queste sostanziali caratteristiche erano del tutto assenti nei primi cscmplan di tllrbme a gas industriali prodotte
38

li turbocompressore p er m oto ri alternati vi
Il primo uso aeronautico di ~n sistema turbina-compressore opportunamente collegati tra loro fu quello rclauvo alla compressione di sovralimcnta21ooe ad alta quota dell'aria usata da un nonnale motore alternativo.
Tale dispositivo, nella sua forma originale, era costnuito da una girante di rurb1na mossa dai gas di scarico di un normale motore a scoppio d'aeroplano. che era a sua volta in grado di azionare un compressore rotauvo centrifugo capace di comprimere l'aria comburente usata per alimen1are i carburnton dello stesso motore a scoppio, dovendone compensare la minore densità quando l'aria stessa veni"a captata dall'esterno a quote superiori ai 5.000-6.000 m.
Le palelle della turbina erano in questo caso relativamente poco sollcc1tate dal punto di vista termico, essendo la temperatura dei gas di scarico già scesa a poche centinaia di gradi per effetto della fase d'espansione da essi precedentemente subita all'interno dei cilindri del motore alternativo so,ralimentato.
Tale dispositivo fu idealo da Sanford A. Moss (1872-1949) intorno al 1910 e messo n punto presso la Generai Electric americana per la quale egh lavorava.
Fu quindi applicato ad un motore d'aeroplano "Liberty,.. da 400 hp. il cm funzionamento ad alta quota venne positivamente collaudato a 4300 m di quota sul monte Pike's Peak nel Colorado g1ò nel corso della prima guerrn mondiale.
Tale dispositivo non ebbe tuttm m ulterion sviluppi tanto che.. con la fine delle os1ilità. venne rapidamente accantonato.
Gli america01 lo a,Tebbero riesumato e sviluppato per impiegarlo in modo massiccio solo a partire dagli anni precedemi la seconda guerra mondiale. quando lo installarono sui motori Wright GR-1820-51 1mpiegau sul prototipo Y I 8-17 A della fortezza volante da bombardamento Boeing B- 17.
In Europa un primo dispositi\'O analogo fu messo a punto da Biich1 per la Brown-Boveri mtomo al 1920.
L'ideazione. la cos1TUZione e rimpiego di dispositi, i d1 ques10 tipo precedette quindi que!Ja di una vera turbina a gas aeronau1ica cli circa venticinque anni. ma _ non ebbe una eccessiva influenza sullo sviluppo di quest'uluma, che avrebbe nch1esto molu alm studi e sperimentazioni prima di poter essere realizzai.a
Questo lungo processo sarebbe infam ~arurato in Gran Bretagna e Germanm solo a partire dalla seconda metà degli anm ·30 (§V.I: V.1).
Jl. 3 : L'uso d ei ra-:.:J a pofrere in epoca moderna
li fi d azI·on•• reazione aveva già eia st..>coli tro\'ato la sua più antica pnnc1p10 s1co 1 . e e . dal 1 · ,.._clius·· tn""'O . . 1 . I --,..,0 nome denva10 auno ,u • ~· • fonna d apphcaz1one propu s1va ne '"'-' · . • 1 •·rak t ·· · · · · h' ato "rocket" m mg ese, e e 10
Questo tipo di proiettile a reazione e e 1am . . . . ·•fi • .. · francese nomi che. pochi sanno. dem:ano dm tedesco, ··racket"m russo, usce m · . . d r analoehi tenmm rifenti tennini italiani rocchetto e fuso. che traevano ongme ag 1al cilindro sul quale si avvolgeva un lilo !essile.
39

d · · 1 ni·c11·talinni del ·600-700 per indicare il razzo ' . . ccc usato m piro cc . . . \enJ\A mv . . --dato di· cappello conico anteriore d1 penetrazione. -1- d · pol"cre pinca co.... ci m neo a 1 1 •nte sulla cima di una lunga baccheua di supporto in che \'eruvo montato atcm mc . . fu . b"l· . -1I una sia pur appross1ma11,a nz1one sta 1 1zzalncc legno a, ente. durante • . anc10.
lungo la traiettoria pn:v1s1a. . . . la prima \'olla in lcueratura nel trattato stonco Belhconm1 Il termine appan e per . ., _ instnrm.:1110111111 /iber d1 Carlo Lodo,•1co _Muraton ( 167_-l 7.,0). . . .
Tra gli antichi pirotecnici italiani parn~olare successo ebbe la fam1g~10 Ruggen. d. · · b 1 ese I cui diversi mcmbn operarono a lungo m f<mneia aJla corte 1 oneme o ogn , . . . del R; Luigi X\" ed in Gran Bretagna. press~ q~ella cli ~10rg10 Il.
Nel 168'. con una batteria di qu~ti ord1gru collegati tra loro. Claudc Ruggen fece solle,are in aria un maiale. un cane ed una gallina che tornarono incolumi a terra grazie ad un primitivo paracadute. .. . .
Dopo l'uso come proiettili a·aniglieria che se ne era g1a fatto in Europa a partire dal 1300 es 1.2). quesu ordigni furono nuovamente adattati all'uso militare su ,.ista scala in Europa ira la fine del Settecento e gli inizi dell'Ottocento. tro,nndo largo uso m comban1mento.
Dopo averne subito l'impano distruttirn m India nel 1799. nel corso dell'assedio d1 Senngapatam. nell'impiego fallo conlTO di loro da parte dell'esercito del principe indiano d1 Mysore. guidato dal figlìo di quest'ultimo. Tippu Suhan (Tippoo Sahib). 1 britannici ne Ulilizzarono su larga scala alcuni tipi ideati da W11liam Cong1we (Bìbl. 17). aventi il corpo propulsore di cartone pressato rinforzato esternamente m rame e pron isto di una robusta testa conica di ferro contenente la carica esplosi\'a o una miscela incendiaria.
Questi razzi usa\'ano sempre una lunga asta posteriore stabilizzatrice ed 11 più leggero di essi pcsa\'a I'.! lb. a,·eva un diametro di 5 pollici e possede\ a una gittata di :?.OOO m.
Ve ne erano poi altri tipi di peso medio. rispettivamente da 24. 32 e 42 lb. con cariche esplosive che anda\'anO dalle 8-1 O fino alle 20 lb e giriate comprese tra i 2.000 ed i 2.800 m.
I upi più pesanti erano im·cce da 100 e 300 lb.
Ordigni "Con8fl:vc" del tipo medio da 32 lb vennero adoperali dalle navi britanniche sia contro 11 _pono francese di Boulogne nel 1805. nel quale si era andata rndunando la flotta d m\'as1one \'Oluta da Napoleone, bersagliata con il lancio di 2~0 ordigni, che nell'assedio di Copenaghen del 1807. che fu distrutta con il lancio dt 24.75~ ordigni incendiari di questo stesso tipo.
1 ~• inglesi '."rono usati anche contro i coloni ribelli americani.
Tra 11 f8"lQ cd 11 1840 -· · d. · t· d . - :.1 cerco I m1g 1orame le caratteris1iche balistiche portanone la gmata a 3 500 · . 1 1 1_ : ~- tncrcmemandone anche la precisione di tiro sul bersaglio. n ta 18 repani d anighen·a dota1· d. · · · · · · · · d , . . . . 1 t carri provv,su d1 8 tubi lanc10razz1 tramali 8 tre panghe d1 cavalli cia~c fì ·resta uno urono mtrodou1 dall'esercito piemontese dopo la uraz1onepost-napoleonica, intorno al 1830.
Se ne sl\Jd1arono le ca ·là 1 . . . . . . paci app 1cauve fino ad 1pouzzare la cosuruzione d1 vere
40
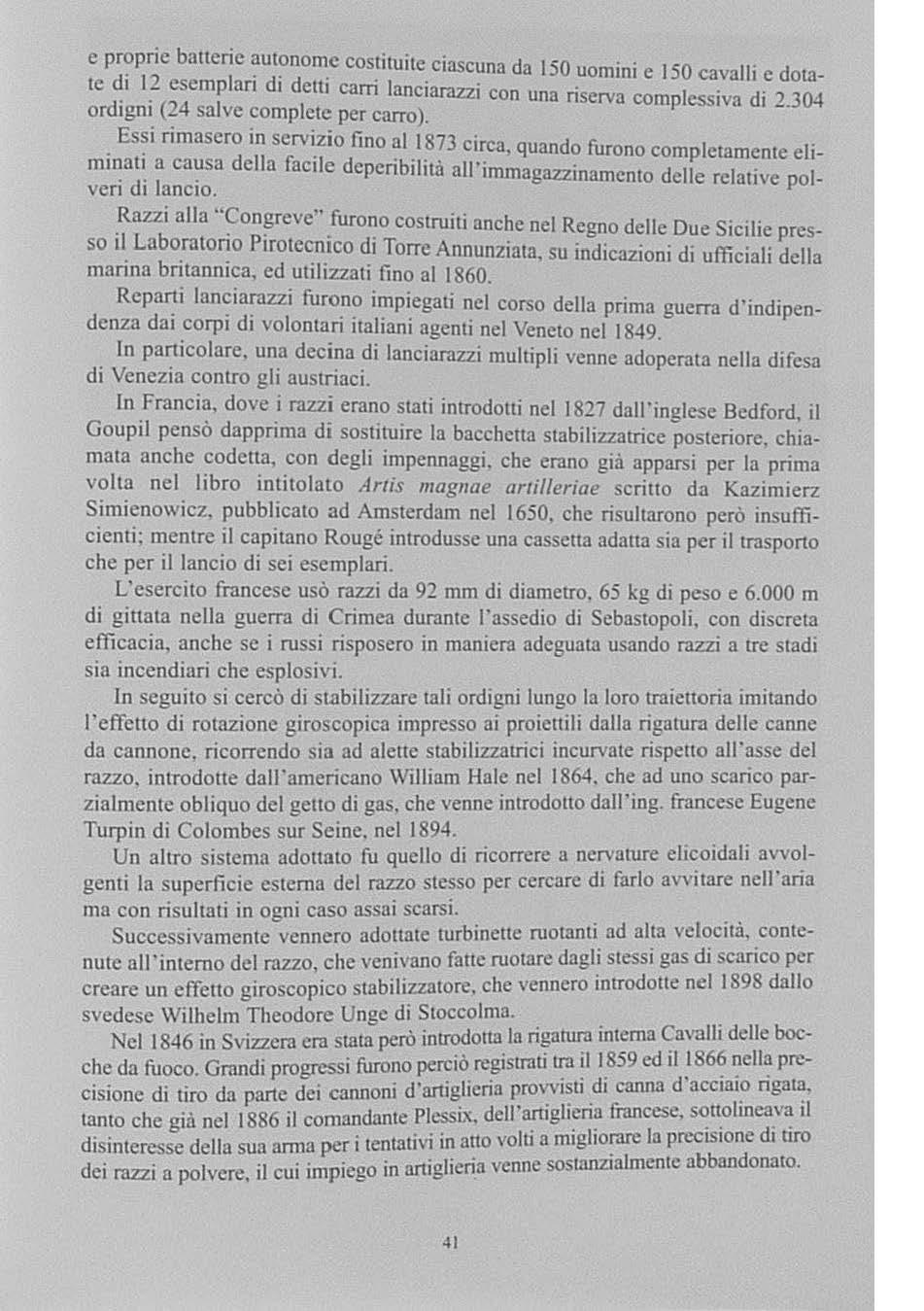
e proprie baneric autonome costituite ciascuna da 150 uoma· · I~o , 11 · d , d · I ' • I · · . . . . m e ., ca\ a i e otate 1 - esemp an d1 detti cam lanc1arazz1 con una riserv I · . d' .,3 n, rd. · ("4 1 a comp ess1\a 1 _ v-t o 1gru - sa ve complete per carro).
. Es~i rimasero in servi.zio fino al_I_873 circa, quando furono completamente elim1~at~ a ca~a della facile depenb1htà all'immagazzinamento delle relative pol- veri dt lancio.
_Ra1..zi alla "~on~eve··_furono costruiti anche nel Regno delle Due Sicilie presso 11 Laboratono P1rotecmco dt Torre Annunziata, su indicazioni di ufficiali della marina britannica, ed utilizzati fino al 1860.
Repa~i lan~iarazzi furo~? i~pi_egati nel corso della prima guerra d'indipendenza dai corpi di volontan 11aham agenti nel Veneto nel 1849.
In panicolare. una decina di lanciarazzi multipli venne adoperata nella difesa di Venezia contro gli austriaci.
In Francia, dove i razzi erano stati introdotti nel 1827 dall'inglese Bedford, il Goupil pensò dapprima di sostnuire la bacchcna stabilizzatrice posteriore. chiamata anche codetta, con degli impennaggi. che erano già apparsi per la pnma volta nel libro intitolato Artis magnae artilleriae scritto da Kazimierz Simienowicz. pubblicato ad Amsterdam nel 1650. che risultarono però insufficienti: menire il capitano Rougé introdusse una cassetta adaaa sia per il traspono che per il lancio di sei esemplari.
L'esercito fi-ancese usò razzi da 92 mm di diametro. 65 kg di peso e 6.000 m di gittata nella guerra di Crimea durante l'assedio di Sebastopoli, con discreta efficacia, anche se i russi risposero in maniera adeguata usando razzi a Lre stadi sia incendiari che esplosiva.
In seguito si cercò di stabilizza.re tali ordigni lungo la loro traienoria imitando l'effetto di rotazione giroscopica impresso ai proiemli dalla rigatura delle canne da cannone. ricorrendo sia ad alene stabilizzatrici incurvate rispeuo all'asse del razzo. introdotte dall'americano William Hale nel 1864. che ad uno scanco parzialmente obliquo del getto di gas. che venne introdouo dall'ing. francese Eugenc Turpin di Colombes sur Seine. nel I89-t
Un altro sistema adottnto fu quello di ricorrere a ncrvarure elicoidali anolgenti la superficie esterna del razzo stesso per cercare di farlo awitare nell'aria ma con risultati in ogni caso assai scarsi. . . . Successivamente vennero adottate 1urbinettc ruotanll ad alta veloclla, contenute ali' interno del razzo, che venivano fatte ruotare dagli stessi gas di scarico per creare un effetto giroscopico stabilizzatore. che vennero introdoth: nel 1898 dallo svedese Wilhelm Theodorc Unge di Stoccolma. . .
Nel 1846 in Svizzera era stata però introdotta la rigatura mtema Cavalli delle bocche da fuoco. Grandi progressi furono perciò registrati tra ~I 1.859 ed il _186~ nella precisione di uro da parte dei cannoni d'artiglieria provv1s11 dr canna d accw•~ ngat~. tanto che già nel 1886 il comandante Plessi.x, dell'arrigli~ri~ francese, s~~olmca_v~ il disinteresse della sua arma per i tentativi in ano 'olb a magho~ lo pn.,>e15ione di uro d · · I ·1 · ·mpi·cnoi·n aniglieria venne sosUU1Z1almcnte abbandonato. e1 razzi a po vere, 1 cui 1 é
-Il
I ra=.i J, llilliam Congm._.
Tali ordigni rimasero tutu1\·1a m uso oltre che nell'abituale settore degli spettacoli pirotecnici. anche per effettuare segnalazioni e nel lancio di sagole di soccorso in caso di naufragio di natanll specie in prossimità delle coste ed anche ad opera di battelli m mare. usando un tubo d1 lancio dotato dì uno schenno protettivo in lanuera assai simile ad un odierno bazooka.
Nel corso della prima guerra mondiale vennero usati I razzi ideati dal tenente delranazione navale francese Le Prieur per auaccare i palloni d'osservazione frenati gcnnanicì del tipo Drachen. fessurandolì ed incendiandoli.
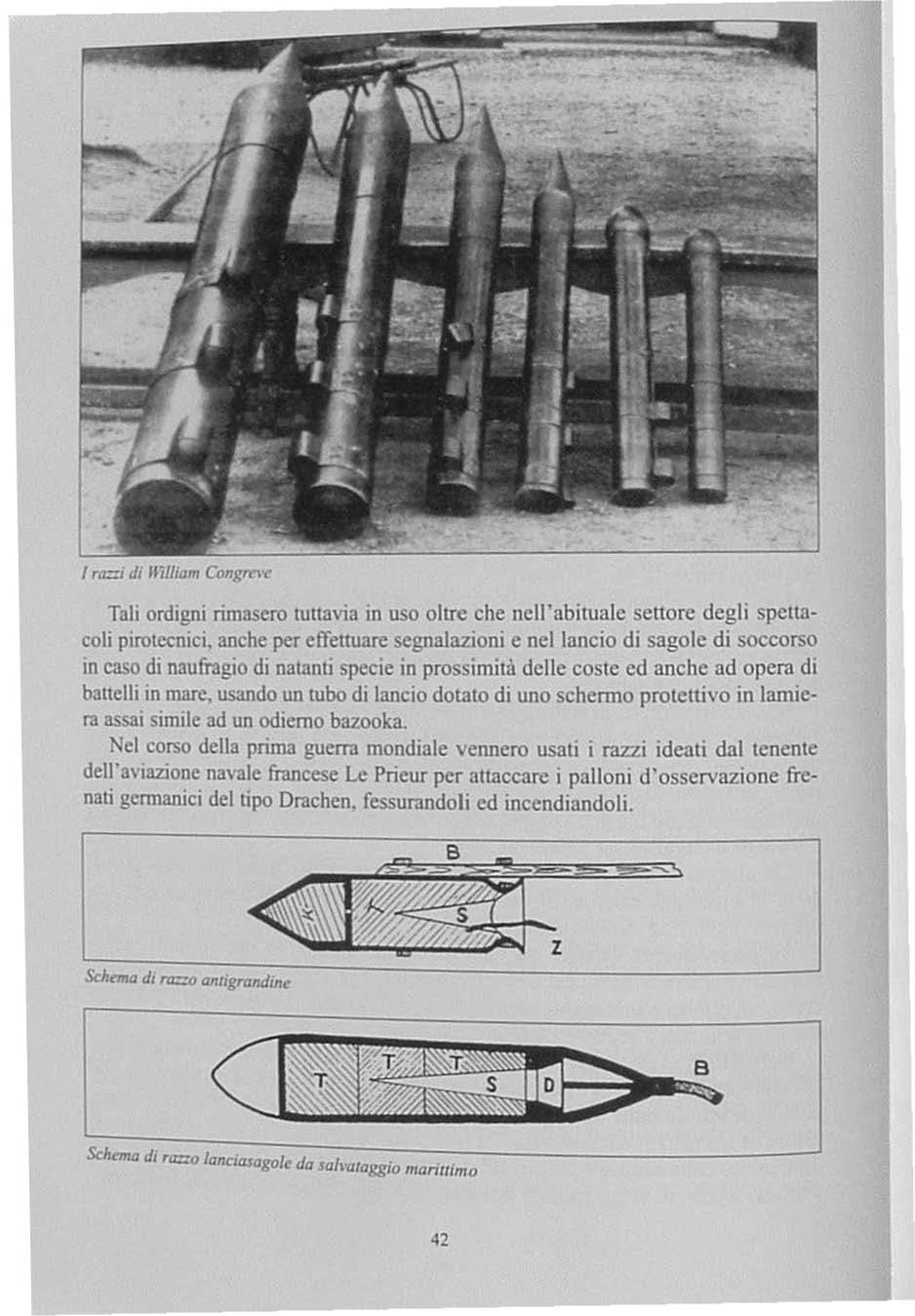
Schema d, rrz=o an11grondmt•
Schema d, ra=o lanc,asagolc da Jafra1aggio mani/imo
z
42
Caccia N,euport Bébé • con mstalla:,on,: per ,I lancio J, ouo m=, 1.,: Prieur
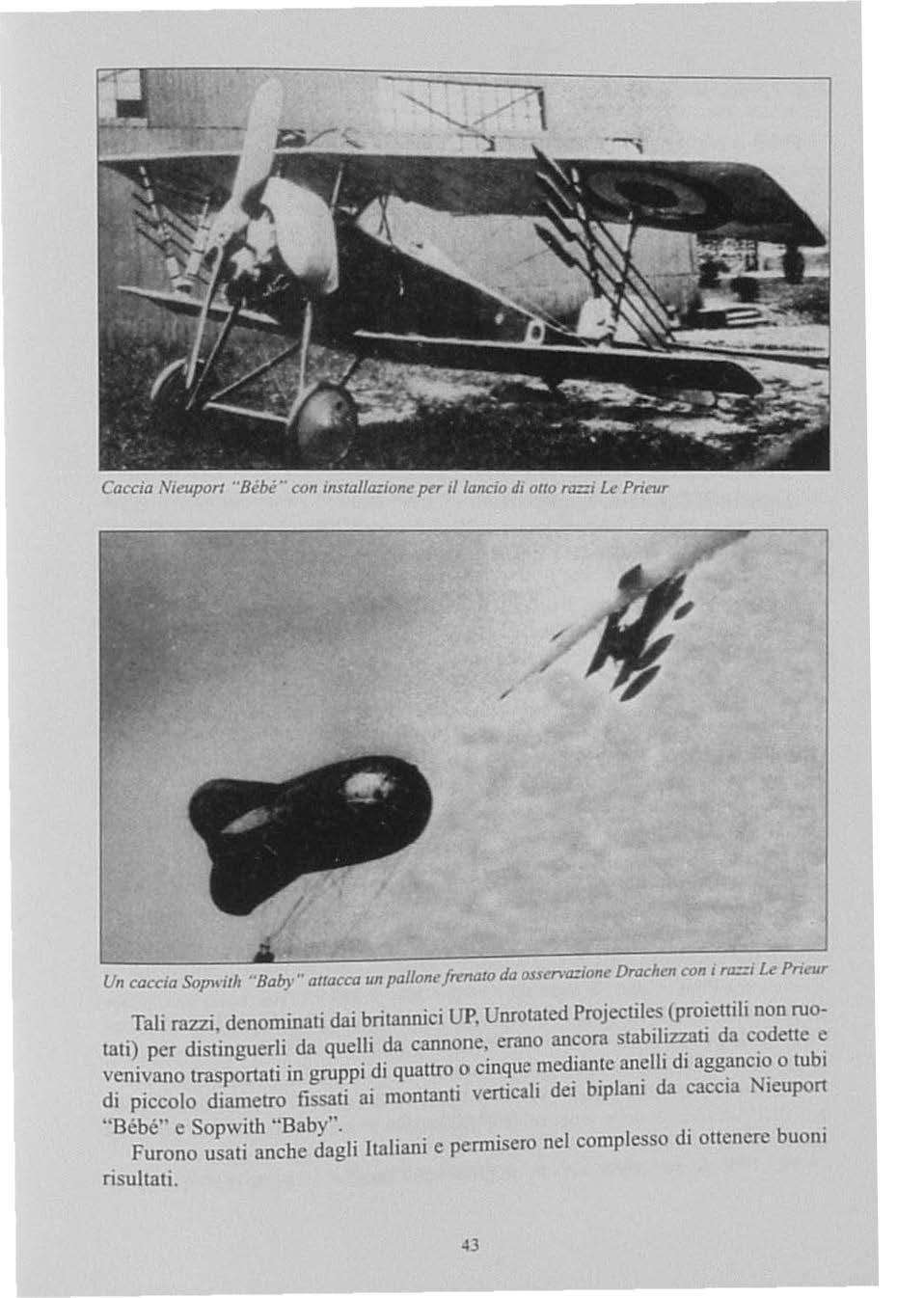
Un caccia Sopmth "Baby .. auacca un pa/lon•·Jrena10 da o.s.,awr::ione Drach,·n con i ra=1 le Priair
Tali razzi, denominati dai bri1annici UP. Unro1a1ed Projectiles (proienili non ruo1nri) per distinguerli da quelli da cannone. erano ancoro stabilizzao do codeue e venivano trasportati in gruppi di quallTO o cinque medinn1e anelli di aggancio o rubi di piccolo diametro fissati ai montanti vertic:ih dei biplani do caccia "11eupon "Bébé" e Sopwith ··Baby".
Furono usali anche dagli Jwliani e permisero nel complesso dJ ollenere buom risultali.
. . ..1. ( ca spo:.iole co 11tempora11 ea . . --011ier, dello ,mss , ,s , l/..f: f precursor, ,,, . 1 1 . t •resse per la propulsione a razzo \'enne riacgu •rra mond1a e in 1:
Dopo la pruno e . b dn ·a maturando nd pubblico per I pnm1 rac11 d passione e e an ' . . . ceso solo da a gran e . . . eiò con ricchezza d1 dctt.agh tecmco-sc1en11conti di fanroscienza. che _ipouaa, ano -
fici i futuri \'iaggi spaziali.' 1 d tersi muovere nello spazio e,tratcrrestre privo L'esigenza fondamenta~ po t ·r raeeiune.ere le elevatissime velocità di fuga d'o5sigeno. ~ommata ~Iq.ue a . 1 po; 1g~,~uà. riaccesero l'interesse degli studiosi i:cessane per, mcerc attrazione . d li n . d d 11 "e , ista già allora come l unica a alla a o scopo. er la propulsione a en orca o,, • . . . d . p . . • · ·fi · tematici furono etTe1tuatt m Russia a un eminente I pnmi studi sc1enu 1c1 s1s scienziato. Tsiolkhovsk1.
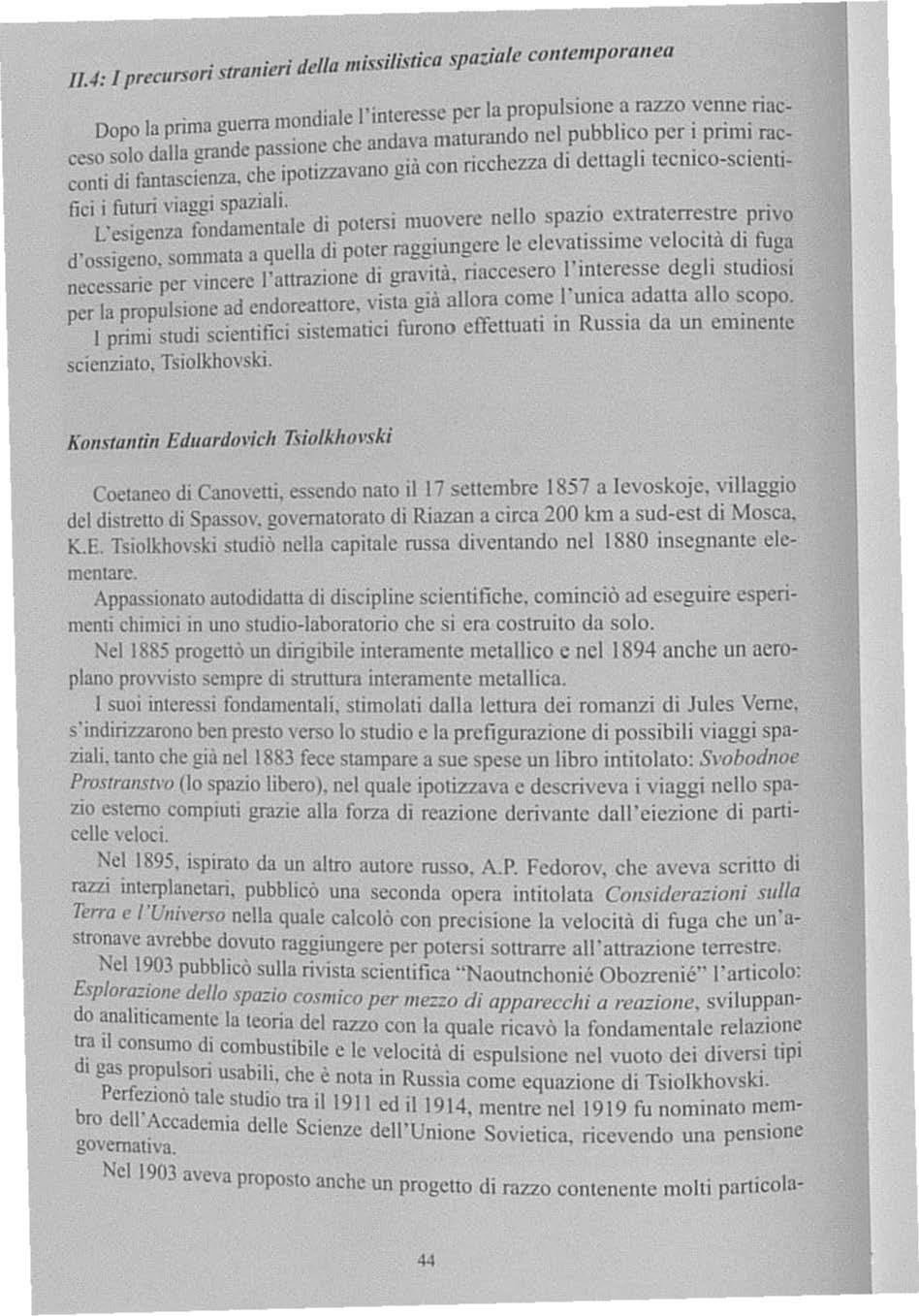
Coetaneo di Cano, em. essendo nato 11 17 settembre I 857 a lc\'oskoje, ~·illagg10 del distrello di Spnssov. governatorato di Riazan a circa 200 km a su~-cst d1 Mosca. K.E. Tsiolkhon;k1 studiò nella capitaJe russa d1vcn1ando nel 1880 insegnante elementare .
Appassionato autodidaua di discipline scicntiliche. cominciò ad eseguire esperimenti chmuct m uno s1udio-l0boratorio che s1 era costruito da solo.
Nel 1885 progettò un dirigibile interamente metallico e nel 1894 anche un aeroplano pronisto sempre d1 srruuura in1cramcnte metallica.
I suoi interessi fondamentali. stimolati dalla leuura dei romanzi di Jules Vcme, s'indirizzarono ben presto ,crso lo studio e la prefigurazione di possibili viaggi spaziali. 1an10 che gin nel 1883 fece stampare a sue spese un libro int1tolato: Svobodnoe Prostransrvo (lo spazio libero). nel quale ipotizza\'a e descri\'eva i viaggi nello spazio esterno compmu gra71e alla forza d1 reazione derivante dall'eiezione di particelle , eloc1
Nel 1895. ispiralo da un altro autore russo. A.P. Fedoro,. che ave\'a scnllo d1 razzi interplanetari. pubblicò una seconda opera intitolata Co11sidcra=1011i sulla Terra e /'L'11i1·erm nella quale calcolò con prec1s1one In velocità d1 fuga che un·astronave avrebbe dovuto r-.1ggiungcre per potersi sottrarre atrattraztone tcrre:.trc.
Nel 1903 pubblicò sulla rivista scientifica·· 'aoutnchonil! Obozrenié" rarticolo: Esplora=io11c dello spa::10 cosmico per me:=o di apparecchi a rea:.io11e, sviluppando analiticamente la teona del ra7.zo con la quale ncavò la fondamentale relazione tra 11 consumo di combustibile e le ,•elocità di espulsione nel vuoto dei diversi tipi di gas pro_pul~on usabili, che e nota m Russia come equazione di Tsiolkhovski.
Perf1.:10no tale studio tra il 1911 ed 11 191-t, mentre nel 19 I 9 fu nominato membro dell Accademia delle Scienze dell'Unione Sovietica. ricevendo una pensione govemauva.
Nel 1903 aveva proposi h · I 0 anc e un progetto d1 razzo contenente molti paruco n-
• • •
•
44
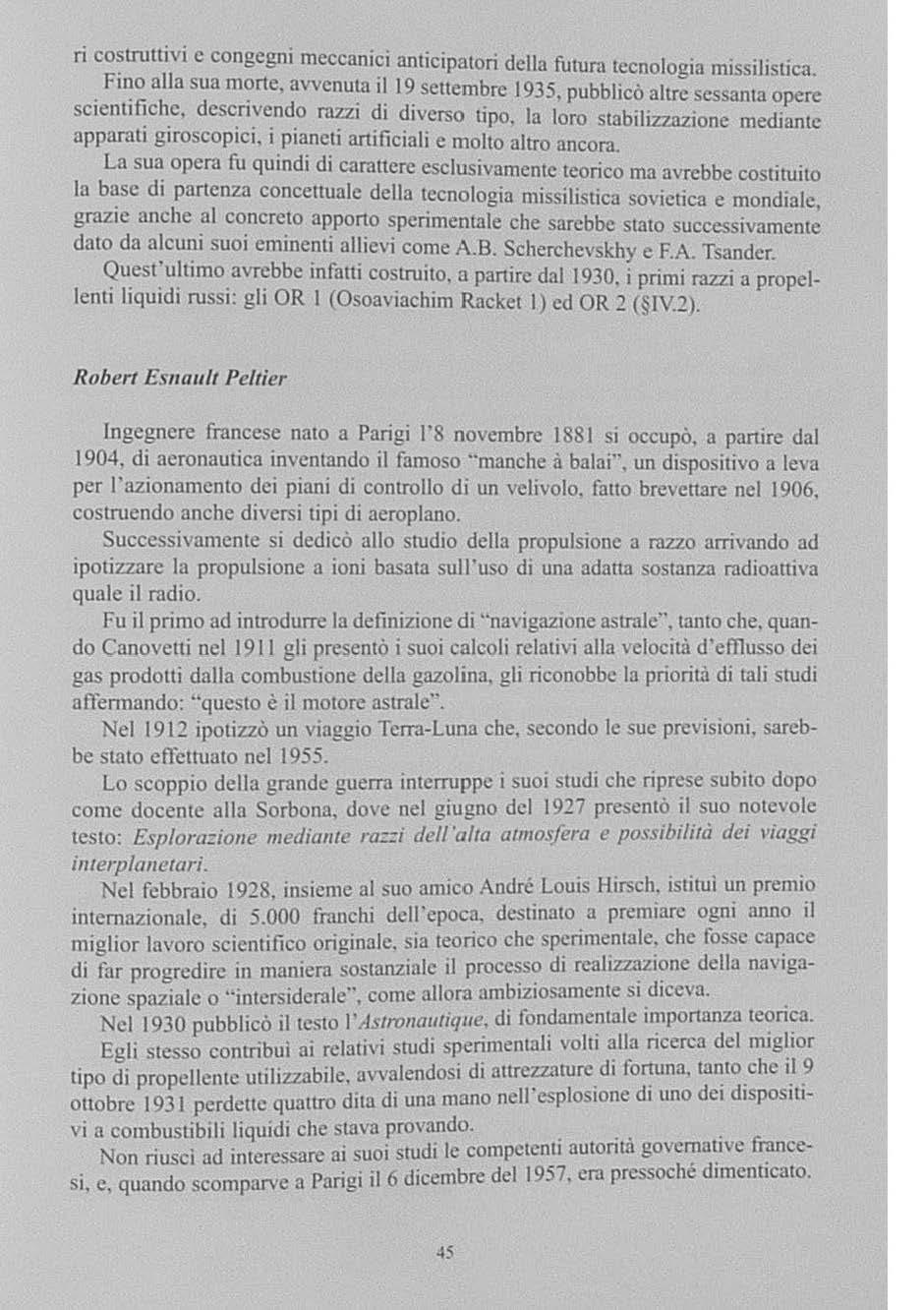
ricostruttivi e congegni meccanici anticipatori della futura t I · · ·1· · . ceno ogia miss, 1st1ca. F,~o alla sua m~rte. avvenu~ i~ l settembre 1935, pubblicò altre sessanta opere sc1enufichc, descnvendo razzi d1 diverso tipo la loro •t b·1· dt s a I JZZaZtone me ante apparati g1roscop1ci. 1pianeti artificiali e molto altro ancora.
La su~ oper.i fu quindi di carattere esclusivamente teorico ma avrebbe costituito la b~se d1 partenza concenuale della tecnologia missilistica sovietica e mondiale. grazie anche al concreto apporto sperimentale che sarebbe stato successivameme dato da alcuni suoi eminenti allievi come A.B. Scherchevskhy e F.A Tsandcr.
9u_esCuhimo avr7bbe infani costruito. a panire dal J930. i primi razzi a propellenu hqu1di russi: gh OR I (Osoaviach1m Racket I) cd OR 2 (§JV.2).
Robert Es110 11 /t Peitier
Ingegnere francese nato a Parigi 1'8 novembre 1881 si occupò. a pan1re dal 1904, di aeronautica mvcntando il famoso ..manche à balai". un dispositivo a lcva per l'azionamento dc, piani di controllo d1 un , ehvolo. fauo brevettare nel 1906, costruendo anche diversi upi di aeroplano.
Successivamente s1 dedico allo studio della propulsione a razzo arrivnndo ad ipotizzare la propulsione a ioni basata sull'uso di una adaua sostanza radioanl\'a quale il radio.
Fu il primo ad introdurre la definizione d1 --navigazione astrole... tanto che. quando Canoveni nel 1911 gli presentò i suoi calcoli relativi alla velocità d'effiusso dei gas prodotti dalla combustione della gazolina. gh riconobbe la pnoritil di tali studi anènnando: "questo è il motore astrale...
Nel 1912 ipotizzò un nngg10 Terra-Luna che, secondo le sue previsioni. sarebbe stato cffc1tunto nel 1955
Lo scoppio della gronde guerra interruppe I suoi studi che nprese subilo dopo come docente alla Sorbona. don: nel giugno del 1927 presentò il suo notevole testo: Esplora=iom· mediame ra==i dl!ll 'afta atmosjera e possibilità de, l'laggi i11terpla11etari.
Nel febbraio 1928, insieme al suo amico Andre Louis H1rsch. istituì un premio internazionale, di 5.000 franchi dell'epoca. destinato a prc:m1arc ogni anno il miglior lavoro scientifico originale. sia teorico che sperimentale. che: fosse capace di far progredire in maniera sos1aru:ialc il process~ di reahz:zazi~nc della na, igazione spaziale O "intersiderale", come allora amb121osamente s1 diceva. .
Nel 1930 pubblicò il testo l' -lstronaunque. di fon~ame~tnle importanza teon~a.
Egli stesso contribui 81 relati, ì studi spenmenmh volti ~Ila ncerca del m1g~1or tipo di propellente uliLizzabile. avvalendosi di aurezzature d1 fortuna. ta~lo_che 1_1 9 ottobre J931 perdetle qumtro dita di una mano nell ·esplosione d1 uno dei d1spos111v1 a combustibili Jiqu1d1 che stava provando. . . . .
Non riusci ad interessare ai suoi studi le compcien11 autont.n govc~o~1vc °'.1nccs1. c. quando scomparve a Parigi il 6 dicembre del 1957. era prcssoche d1mcn11cato.
45
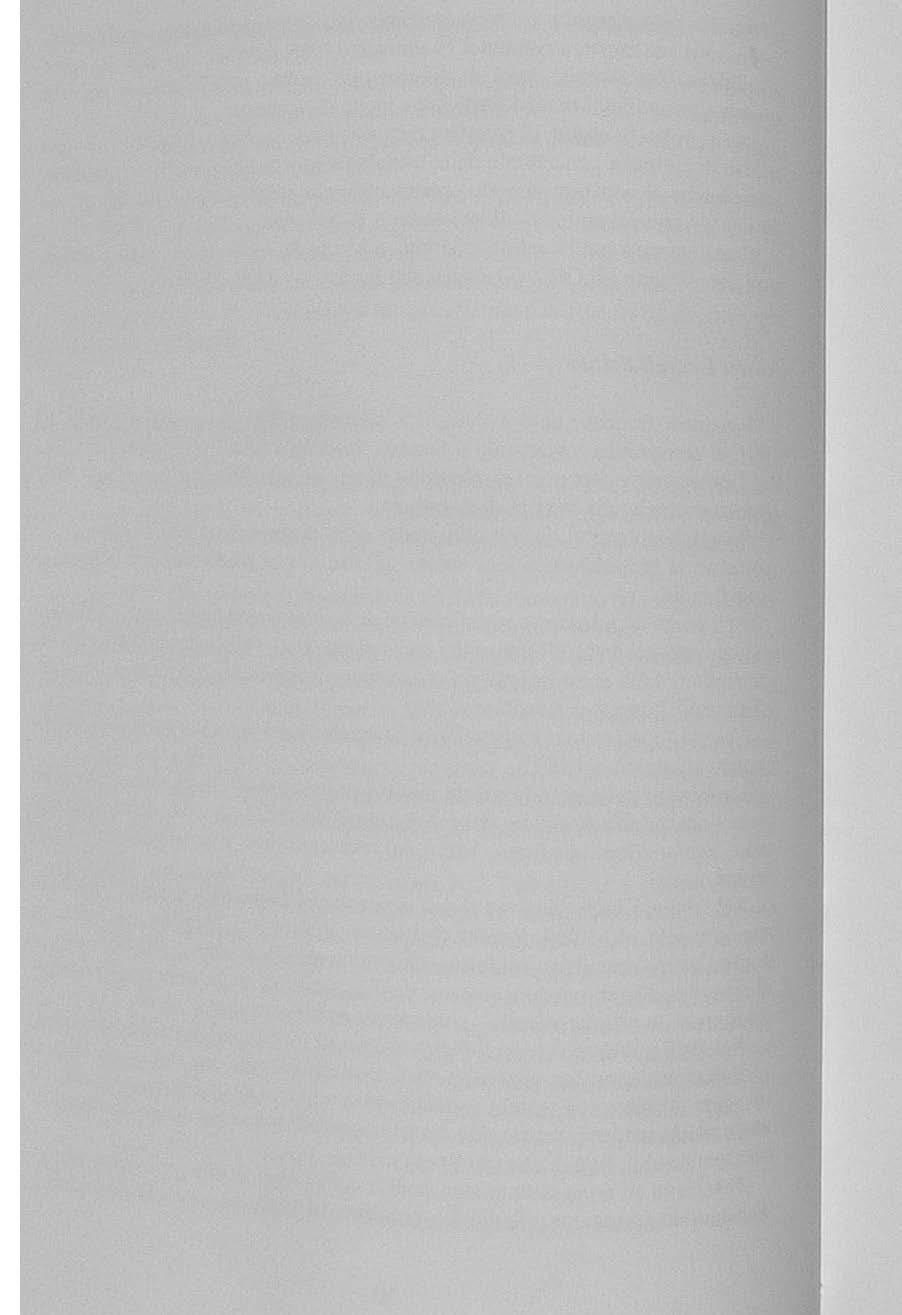
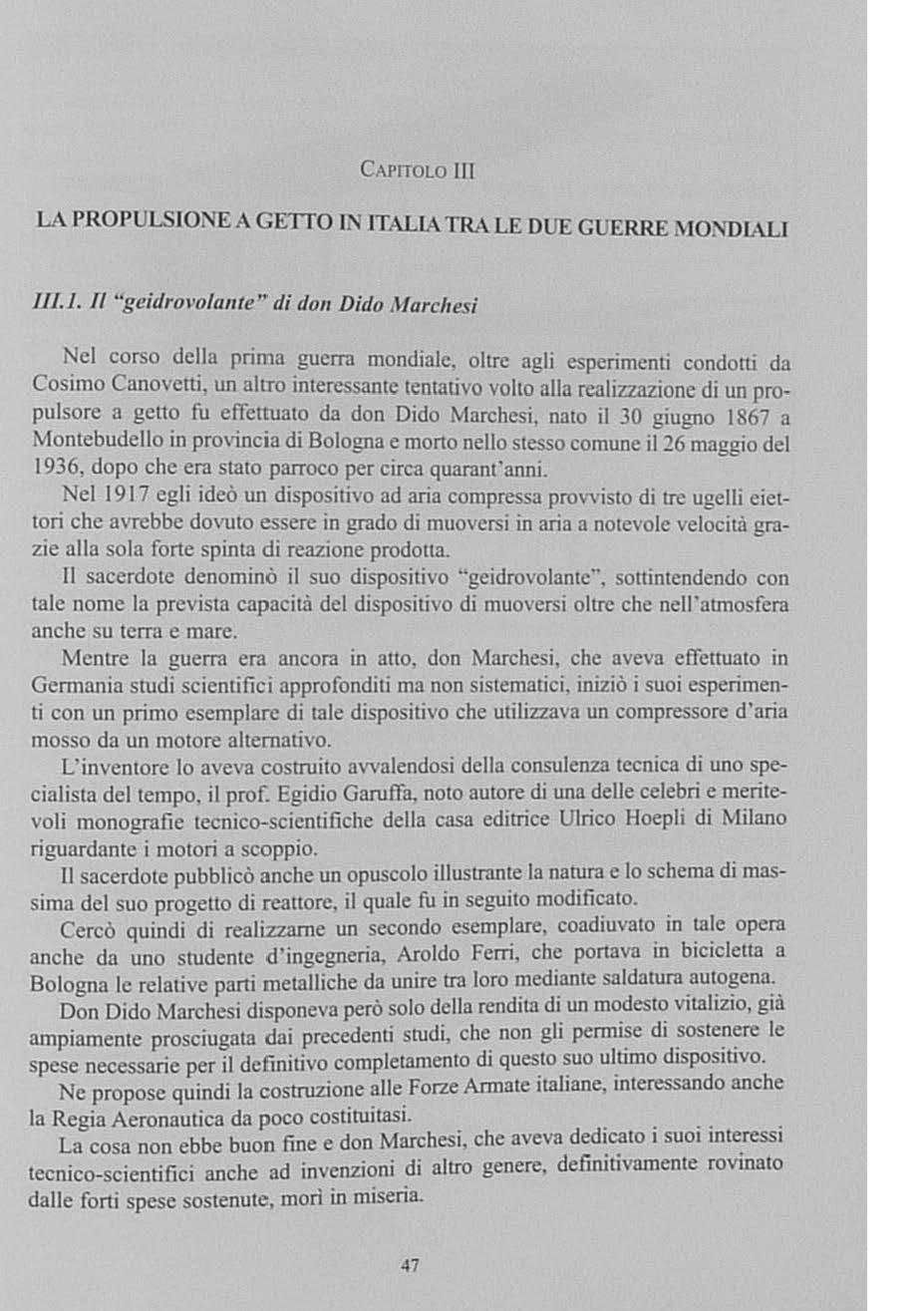 CAPITOLO Ul
CAPITOLO Ul
LA PROPULSIO, EA GETTO lì\ ITALlA TRALE DUE GUERRE \10.\'DIALJ
111 J. li " geidro l'o /a11te" di do11 Dido i \.farc/1esi
~el corso della pnma guerra mondiale. oltre agli espenmenu condotu da Cosimo Canovett1. un alrro m1eressan1e temaU\'O volto alla realizzazione dt un propulsore a get10 fu effettuato da don Dido Marchesi, nato il 30 giugno 1867 a Montebudello tn provincia di Bologna e morto nello stesso comune 11 26 maggio del 1936. dopo che era stato parroco per ctrca quarant'anni.
Nel 19 17 egli ideò un disposi11vo ad aria compressa prm,. isto dì tre ugelli eiet1ori che avrebbe dovuto essere in grado di muoversi in ana a no1evole velocità graZte alla sola fone spinta di reazione prodoua.
li sacerdote denominò il suo dispositi\'O -geidrovolamc", sollintendendo con tale nome la prevista capacità del dispositivo d1 muo\'ers1 oltre che nell'aunosfera anche su terra e mare.
Mentre la guerra era ancora in auo. don Marchesi, che aveva effettuato in Germania studi scientifici approfonditi ma non sistematici, 1ruziò i suoi esperimenti con un primo esemplare di 1ale disposiuvo che utilizzava un compressore d'aria mosso da un motore alternativo.
L' inventore lo aveva costruito avvalendosi della consulenza tecnica di uno specialista del tempo. il prof. Egidio Garuffa, noto aUlore di una delle celebri emeritevoli monografie tecnico-scientifiche della casa editrice Ulrico Hoeph di Milano riguardante i motori a scoppio.
Il sacerdote pubblicò anche un opuscolo illustrante la natura e lo schema di massima del suo progetto di rcauore, il quale fu in segu110 modificato
Cercò quindi di realizzarne un secondo esemplare, coadiuvato in tale opera anche da uno studente d'ingegneria, Aroldo Ferri, che portava in bicicletta a Bologna le relative parti metalliche da unire tra loro mediante saldatura autogena.
Don Dido Marchesi disponeva però solo della renditn di un modesto vitalizio, gin ampiamente prosciugata dai precedenti srudi, che_ non gli perm~e di ~oste~~re le spese necessarie per il definitivo completamento di ques_to ~uo ul_nmo dt5p0Sttivo.
Ne propose quindi la costruzione alle Forze Armate 1tahane. interessando anche la Regia Aeronautica da poco costituitasi. . . . . .
La cosa non ebbe buon fine e don Marchesi, che aveva dedicato I suoi mteress1 tecnico-scientifici anche ad invenzioni di altro genere, definitivamente rovinato dalle forti spese sostenute, mori in miseria.
47

JI ucolldo modello del ··Geidrorolanie" prog.:ttato da don Emilio ,\/arclwsi. frarello di don Dido Marchesi
Usuo progetto fu ripreso qualche anno dopo dal fratello. don Emilio. anch •egli parroco a Ponte San Pietro. sempre in provi111cia di Bologna. che lo sviluppò in fonne adaue al \'Olo aerodinamico sosLentato dotandolo di ala biplana.
Secondo le cronache di quegli anni questo nuovo ··geidrovolamc" fu sperimen1ato con discreto successo. ma non ebbe alcun segui10.
I modelli sperimentali a reazione dei due sacerdoti emiliani potrebbero essere annoverati più tra le cunosità di scarsa imponanza che tra le realizzazioni suscettibili di qualche pratico sviluppo.
Le idee innovative. anche quando sembrano apparentemenle sterili, possiedono tutta\'ia una fortissima \'alenz.a proposili\'a, poiché sono in grado di stimolare l'interesse e la famasia di ahri studiosi e sperimentatori che sono spesso capaci di trarre da un valido inizio, sia pure embrionale, una preziosa fonte d'ispirazione per sviluppi successivi di ben maggiore peso.
Ed è proprio questo il caso della realizzazione di don Dido Marchesi. che fece i~fatti da ~~imolo per i successivi lavori svolti nel campo della propulsione a rcaza~nc dall ingegnere bolognese Secondo Campini (§ V). che vide il "geidrovolante nel 1916 ad un'esposizione quando era appena dodicenne.
48
Jl[.2: lf silu ro vo lante d i A ngelo B e /Ion i
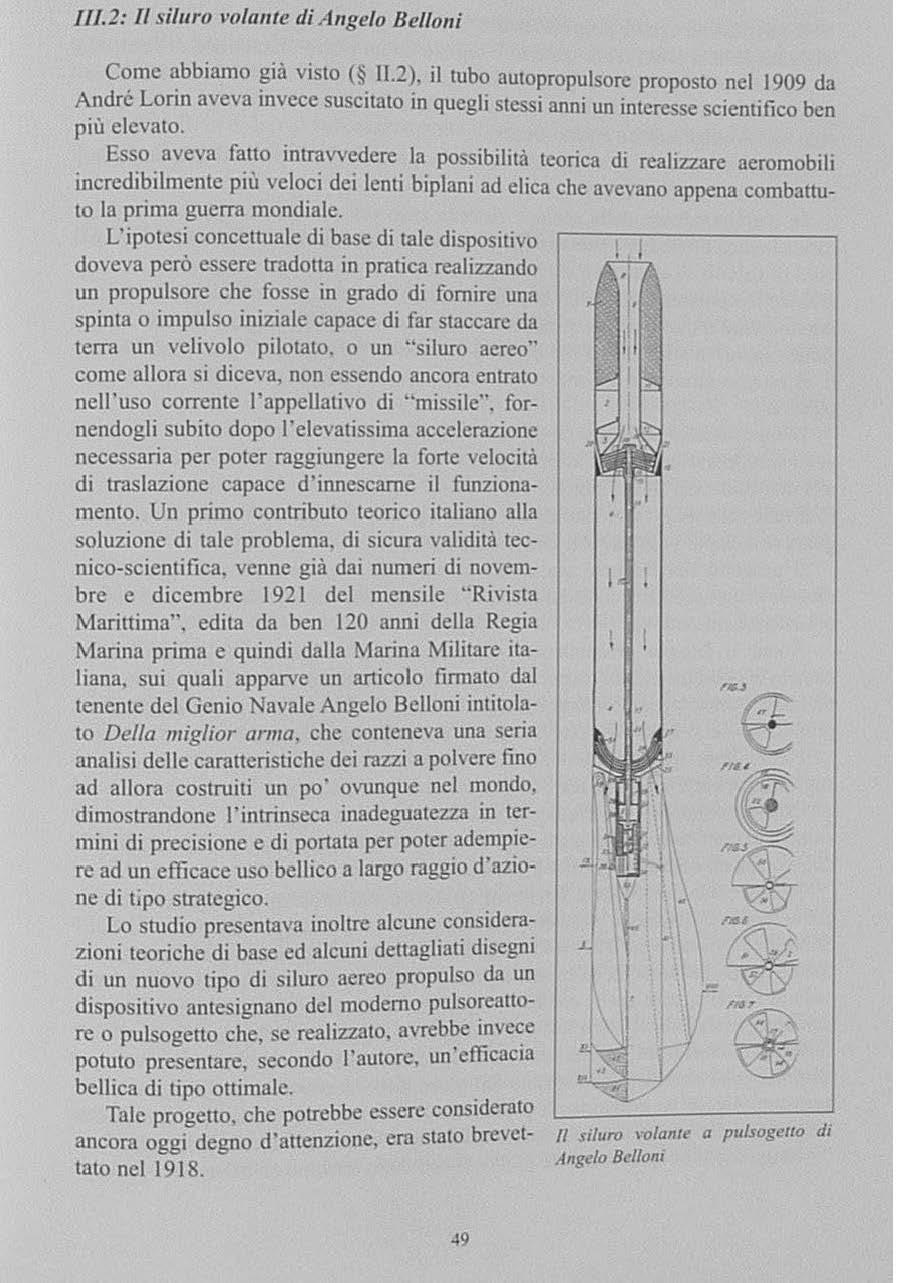
C~me abbiamo già visto(§ 11.2). il tubo au1opropulsorc proposto nd 1909 da Andre Lonn aveva mvcce suscnato m quegli stessi anni un imcrcsse scientifico ben più elevato.
Es~o aveva fatto intravvedere la possibilità !corica di rcahzzarc aeromobili incredibilmente più veloci dei lenii biplani ad elica che a\'evano appena combattuto In pnma guerra mondiale.
L'ipotesi concettuale di base di raie dispositivo doveva però essere tradotta in pratica realizzando un propulsore che fosse m grado d1 fornire una spinta o impulso iniziale capace di far staccare da terra un velivolo pilotalo. o un ..siluro aereo" come allora si diceva, non essendo ancora entrato nell'uso corrente rappellativo di "missile". fornendogli subito dopo l'elevatissima accelerazione necessaria per po1er raggiungere la forte velocità d1 traslazione capace d'innescarne il funzionamento. Un pnmo contributo teorico italiano alla soluz1one di tale problema. di sicura \'alidità tecnico-scienti fica. venne già dai numeri di novembre e dicembre l921 del mensile "Rivista Marittima", edita da ben 120 anni della Regia Marina prima e quindi dalla Manna Militare 1tahana. sui quah apparve un anicolo firmato dal tenente del Genio Navale Angelo Bclloni intitolato Della miglior on11a, che comcneva una seria analisi delle caratteristiche dei razzi a polvere lino ad allora costruiti un po· ovunque nel mondo. dimostrandone l'intnoseca inadeguatezza in termini di precisione e di portata per poter adempiere ad un efficace uso bellico a largo raggio d·azione di lrpo strategico.
Lo studio presentava inoltre alcune considerazioni teoriche di base ed alcuni dettagliati d,scgm di un nuovo npo da siluro aereo propulso da un dispositivo antesignano del moderno pulso~eauore o pulsogetto che. se realizzato. avreb~c anvc~e potuto presentare, secondo l'autore, un efficacia bellica di tipo ottimale. . Tale progeno. che potrebbe essere considerato ancora oggi degno d'attenzione. ero stato brevettato nel 1918.
Il siluro ,·o/ante a p11/sog~tto dì Angelo Bt'llom
49
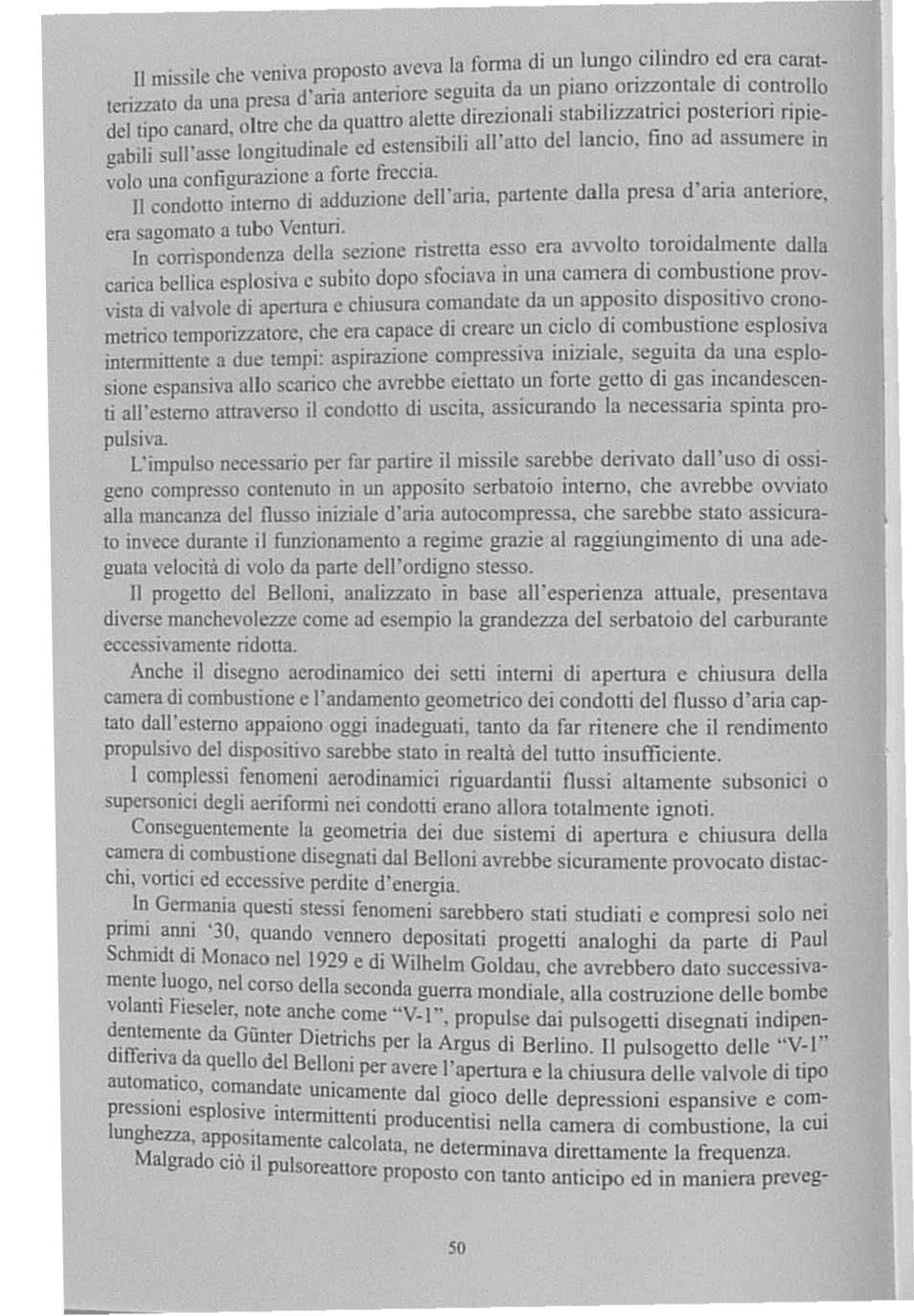
10 av •va la forma di un lungo cilindro ed era caral- 11 m•~~•le che, emva propos \; . I d. , . d' · anleriore segwta da un piano onzzonta e I controllo tenzzato da una prc:s,1 ana . . •i· · · · · · ·
I h da uauro aleue direz1onah stab1 1zza1nc1 postenon np1e- del 11po canard. o tre e e q • I I · fi d · . , . 1 · d. aie ed estensibili all allo dc anc10. no a assumerl! m gab1h sull as.e ongllu 10 \'Olo uno configurazione a fonc frecc10. • . . d · d,· addU7ione dell'aria. partente dalla presa d ana antenore. [I con otto m1emo era sagomato a tubo Venturi. . I - d nza della ,eziom: ristrella esso em an olto toro1dalmcntc dalla n comspon e • · b•11· . losi,a e subito dopo sfocm,a m una camera d1 combustione pro,·- canca 1: 1ca e~p · d' · · d. I ol • di· apenura e chiu~ura comandate da un apposito 1spos111vo crono, ·1s1a 1 , a , e. . . .
l · 0 temporizzatore. che era capace di creare un ciclo d1 combusuonc esplosiva me ne . . . ·a1 · d 1 mtcrmmcntc a due tempi: aspirazione compressi, a 101z1 e. seguita a una csp obione espansi\'a allo scarico che avrebbe eiettato un forte getto di gas _incandescenti all'esterno atlr:l,erso il condotto di uscita. assicurando la necessana spinta propulsi, a.
L'impulso necessario per far partire il mi ·sile sarebbe derivato dall'uso di ossigeno compresso contenuto in un apposito ·erbatoio interno. che avrebbe oniato alla mancanza del flusso iniziale d'aria au1ocompressa. che sarebbe stato assicurato imece durante il funzionamento a regime grazie al raggtungimento di una adeguata \'elocità di \'O)o da pane dell'ordigno stesso.
Il progcllo del Belloni, analizzato in base all'esperienza attuale. prescnta,a diverse manchc, otezzc come ad esempio la grandezza del serbatoio del carburante eccessi, ameme ridona.
Anche il disegno aerodinamico dei ,;etti interni di apertura e chiusura della camera di combusuone e randamemo geometrico dei condoni del flusso d'aria captato dall't:stemo appaiono oggi inadeguau. tanto da far ritenere che il rendimento propulsivo del dispositivo sarebbe stato in realtà del tullo insufficiente.
I complessi fenomeni aerodinamici riguardantii flussi altamente subsonici o supersonici degli aerifonni nei condotti erano allora totalmente ignoti.
Conse_guentemente la geometria dei due sistemi di apertura e chiusura della camera d1 combustione disegnati dal Bellom a\Tebbe sicuramente provocato distacchi. vort1c1 ed eccessive perdite d'energia.
. In Germania questi stessi fenomeni sarebbero stati studiati e compresi solo nei pnmi anm '30, quando vennero depositati progetti analoghi da parte dì Paul Schmidt di Monaco nel 1929 e di Wilhelm Goldau. che avrebbero dato successi\ amente_lu~go. nel corso della seconda guerra mondiale. alla costruzione delle bombe volanu F1eseler note anche come "V l" I da. · · · d' · - • propu se I pulsoge111 disegnali in 1pen:~;,1c?1ente da Gùnter Dietrichs per la Argus di Berlino. 11 pulsogeno delle ··v-r· 1 enva da quello del Belloni per avere l'apenura e la chiusura delle valvole di tipo automauco. coman~ate unicamente dal gioco delle depressioni espansive e comir~om esplosive mterm.inenti producentisi nella camera di combustione. la cui unM:~ap~suamente calcolata, ne determinava direttamente la frequenza. gra O ciò 11 pulsoreattore proposto con tanto anticipo ed in maniera preveg-
50

gente dal Bellonj, che in Italia non ebbe alcun segw·to pre ta · I 1 · · · · b ·1 • d · • . . • sen va tun1 g I e emenu cost1tul1v1 asi an e, m1ss1h a pulsogeuo ed avrebbe potuto h. • b . . cos nure una uona base d1 pancnza per lo studio teorico e sperimentale dei fenomen·1 f1 ·d d. · · d · bi · I · • . u1 o mam1c1 e e1pro emi tecno og1c1 e costrutuvi connessi.
Angelo BeUoni lasciò successivamente il servizio attivo nella R · " ·I · ·1 d d' · d. frc eg1a ,v anna con 1 gra o I capitano 1 "gata.
lll.3: Il turbom otore a 11afta co11 co mpressore di Alessandro Guidoni
A partire ~a•_ pri_mi del No~ecemo cd in panicolarc negli anni compresi tra le due guerre _m~nd1ah gh schem1 dt massima relativi ai più svariati tipi di turbomotori ed a quelli d1 altre ascruse macchine similari furono presentati a migliaia da moltissimi sconosciuti ideatori.
Questi progel1i erano. nella quasi totalità, del tuno fantasiosi ed inattuabili. mentre altri contravvcmvano in modo palese alle più elementari leggi della fisica in generale e della termodinamica in particolare, tanto da poter essere facilmente rigettati dagli organi tecnici delle Forze Armate alle quali venivano generalmente sottoposu, pur non essendo gli specialisti del tempo in possesso dì dettagliate conoscenze specifiche relative al senore delle turbomacchine ed a quello della propulsione a reazione.
Memorie tecniche inattendibili e progetti curiosi, spesso corredati da illustrazioni simpaticamente datate, sono ancora presenti negli archivi dello Stato italiano ed in quelli delle 11.re Forze Armate.
Emblematici tra questi studi furono quelli di Luigi Gussalli, tn\'eotore di un primo tipo di carro armato italiano a pattini mobili mai adottato, che ideò ed io parte realizzò dei curiosi apparau meccanici, uno dei quali era denominato "propulsore a doppia reazione", con il quale raggiunse una certa notorietà presso il grande pubblico italiano. mentre non fu preso in alcuna considerazione da parte dei maggiori ricercatori esteri del tempo come Esnault Peluer. Oberth. Le} cd alo, con i quali tentò invano di mettersi in contatto.
Tali progeni, pubblicati più volte a cura dello s~esso aut0re. denota\ a_no infat~ una sua evidente mancanza di conoscenza della fisica ed erano del tutto mattead1bili, tanto che, come ci fa sapere lo stesso Gussalli nei suoi scritti. qualcuno gli fec7 osservare che i dispositivi che andava proponendo avrebbero ~vuto .. capac11a di far sollevare io aria un missile quanta ne aHebbe avuta un singolo md1v1duo che avesse tirato verso l'alto i lacci delle proprie scarpe".
Non tutte te proposte avanzate in quegli anni erano pero ?i q_uesto stesso gene: re. Alcuni di questi progcrLi erano infatti fondali sul piano sc1enufico e p_ro1!1e_tt:nu su quello applicativo, tanto da essere accettati e pubblicati sulle magg,on nnste specializzate dell'epoca. il · · ·
Anche questi contributi di alto valore non dettero_vero luog~ 8 sv uppt prauci per cause contingenti, lasciando aperti seri interrogatt,'l su quah avrebbero potuto
SI
. · ..n·•tti\'i se ne sarebbero potuti trarre se I i • quah ,antaggt .. e . i.::.scrc I rdall\ 1::., I upp e fossero stati realinoii. . _ d Guidoni relativo ad un propulsore a motoÈ il caso del progeuo di :\kssan rol ate a quote superiori ai 5.000 m. che fu d. fi · , potenze e e, · turboelica. capace I orni~ in fonne as ai pro:,,sime a quelle definitive sulle pagipresentalo d~ suo autore ~ia li· R ·o .\eronautica dell'agosto 1926. nl! del "Nonz1ano _tecnico_ dc al IegS~ Torino laureato in ingegneria e nominato Al ndro Gu1dom nato ne ' . . . . 1· . essa · . ~t nel I9Q.l fu uno dei pnm1 p1001cn Ila mm 1cncn1e di "ascello della Regia ' anna . detraeronau11ca.
.
Pre e il bre, eno di pilota d.aeroplani n~mc~o 59 a Taliedo nd Iq 11. e subilo dopo quello d1 un•ciale di bordo di dirigibile. . .
Condus·e anche note\'oli esperienze d1 aerodinamica nel laboratorio da lui :,,lesso crealo presso l'arsenale della Spezio. progcnando aeroplani e dineibili e costruendo idro, olanti pienamente ctli~ienn come quello di grandi dimensioni proposto dal marchese Pa1cras Pescara che cm stato ::.pecificamente concepito per compiere mis::.ioni di ~1luramcn10, che collaudò per:-onalmente in , olo nel 1914 a Venezia conducendo anche i relativi esperimenti di lancio dell'am1a. uulinando un .simulacro del pe.,o d1 3ì5 kg.

Alessandro G,mlom
Impresa note,olisi.ima per quegli anni. . . ,.
Prese poi panc alla prima guerra mondiale al comando della squadngha d idro, olanti imbarcali sulla na, e "Elba'· della Regia Marina.
Nel 1920 fu nominato addetto aeronautico a Washington. dove lo aveva preceduto la sua fama di primo .spcnmenlatore del siluro aereo.
Nella capitale americana ebbe modo di conoscere il comandante del corpo aeronauuco dcll'cserci10 Billy ~titchell. facendolo panecipc delle nuove 1coric d"impiego dcll'anna aerea fonnulate dall'ualiano Giulio Oouhet.
All'atto della co:.tituzione della Regio Aeronautica come anna indipendente. nel 1923. optò per il passaggio nell'Anna Aerea e \'enne nominato direttore superiorc del Gemo e delle Costruzioni Aeronautiche. carica che detenne fino al 1925, dallo quale si dimise diH:oendo poi addetto aeronautico a Londra.
Tra le tame idee dabora1c da questa geniale pcrsonali1à ci fu anche quella per un nuo\'o tipo di turbopropulsore usante nalìa come nei motori dicscl, che hanno come no1o_un clern10 rendimento lennico. che auebbe consentito di superare in maniera relatJ\ameme semplice e brillante tutti i problemi. che risultavano allora di difficile soluzione. connessi con il suo funzionamento ad alta quota.
Il propulsore di Guidoni avrebbe dovuto consentire tale utilin.azione collegand? dircnamente tra loro sullo stesso asse d'azionamento un motore alwma1ivo a ciclo D1e d con un compressore rotatÌ\'O ed una turbino.
52
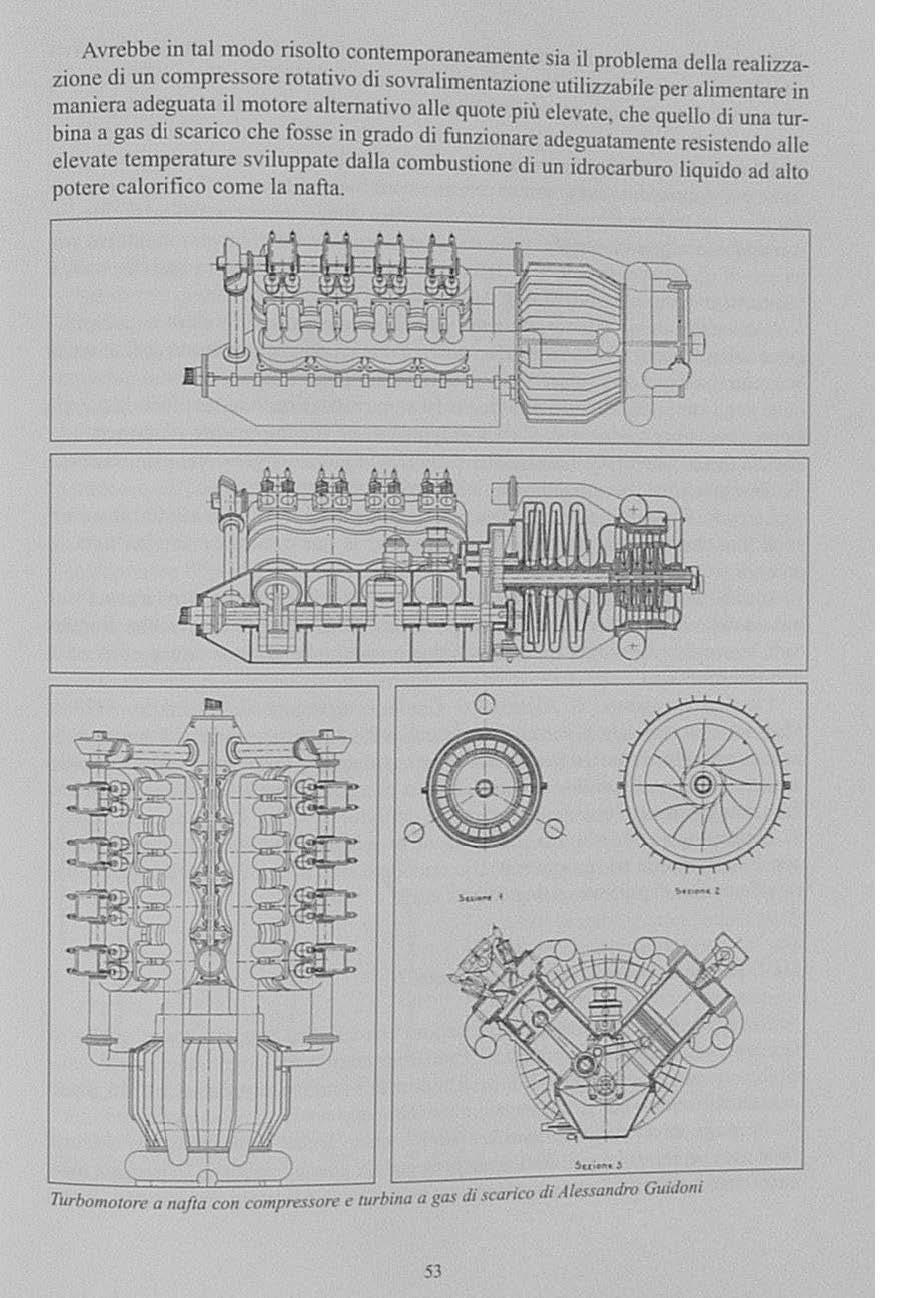
Avrebbe in tal modo risolto con1emporaneameme sia il problema della n:ahzzazione di un compressore rotativo di sovralimentazione utilizzabile per alimentare in maniera adeguata il motore alternativo alle quote più elevate. che quello di una turbina a gas di scarico che fosse in grado di funz1onare adeguatamente resistendo alle elevate temperature sviluppate dalla combustione di un idrocarburo liquido ad aho potere calori fico come la nafta.
_p e"' .. _ . L r I I J • J-..t= ' I '"'"'-= I - a_( tfi .,carico di Alessandro Guidoni Turbomotor,. a 1111~0 con ,·ompre_çsort' t' t11rb111a u g 53

- 1·c,, espansiva dei gas combus1i uscent.i dal motore alternativo L'energia meccan ... • fi I ·d bb ' - r.ari· · Lnle.,....J.lmente recuperata nella 1urbma no al a n otta pressio- sare e stata m1, 1 5'' d. funz. ne atmosferica esterna relativo aJla elevata quoto d1 volo 1 10namento del propulsore stesso. _ _ .
La miscela combus1ibile gassosa ana-nafta a~bbe subito_ una_pnma compressione per mezzo del compressore rou11ivo cenin~g? a g1ran~1, ~er ess~r~ poi immessa nel motore ahemati\'O che sarebbe stato d1 upo lineare a ad 8 c1hndri, il cui albero a gomiti sarebbe stato collegato a quello del compressore stesso per mezzo di un accoppiamento a ruote dentate in grado di collegare i due dispositivi facendoli ruo1are con numero di gin diversi.
L·uso dello stesso motore ahematho av,-ebbe consentilo di portare la compress1onc della miscela aria-nafta a valori elevaci, ottenendo una pressione di fine combus1ione di circa 60 aan, facendo avvenire subito dopo l'espansione dei gas combusu negli stessi cilindn. ma solo fino a IOaun. raccogliendo in 1al modo la porenza nccessana per azionare sia !"elica propulsiva che il compressore e penneuendo anche una considerevole d1mmUZ1one della temperatura dei gas combus1i nel corso di tale espansione parziale prima d'1mmetlerli m turbina.
La parte finaJe dell'espansione sarebbe poi con1inua1.a nella stessa turbina a ire suidi direttamente collegata con il compressore al quale avrebbe fomiro tutta la potenza residua da essa raccolta.
L'elica aerea di propulsione sarebbe stata quindi calettata direttamente sul mozzo delralbero del motore alternativo che insieme alla turbina avrebbe erogato tutta la necessaria potenza richiesta dai due organi comandati: la stessa elica ed il deuo compressore.
La fine prematura d1 Alessandro Guidoni. avvenuta il 27 aprile 1928 a Momeceho menrre stava personalmente collaudando un paracadute di nuova realizzazione, sul cu! funzionamento aveva espresso dubbi, mise fine a questo geniale progetto. allora sicuramente realizzabile, ma che non venne sviluppalo e costruito malgrado fosse stato quasi completamente defintto.
~uidoai si era infani preoccupato anche di calcolare ingombri, pesi e consumo specifico di_ q~~lo suo propulsore. che sarebbero stati inferiori a quelli degli apporau altemanv1 d1 potenza analoga allora usati.
lll.4: Eliche imubare o embrio11a/i reattori?
Sia il siluro aereo conce ·1 da B Il · . Guido 1• pi O e om che gh altri progetti come quello d1 ni, per epoca m cui furo fi uJ · ribili e di· n fu .1 . • .• no orm ah. presentavano comunque aspetti furuon Ci e nsolv1b1hta p 1•· d • . .concettuale che 5 11 er m ustna motonsuca italiana, sia sul piano
In . u que O strettamente tecnologico quegli stessi anni altri :n,, · • • assai meno ambizio • .. fi :;".'~nmentaton si _e~o andati invece ponendo obierov1 cata il funzionamen:: ~m . 0 :ilmente persegwb1h, volti a migliorare in maniero mare pnncipale organo propulsivo aeronautico già esistente: l'elica.
54
Come abbiamo visto_ i primì pionieri avevano compreso già agli inizi del '900 che le eliche aeree. al d1 là delle loro fonne ancora imperfeue, avevano un rendimento propulsivo inlrinseco piuttosto limitato.
Osservando il volume conico d'aria spinto a valle da un'elica in rotazione se ne poteva infatti valutar~ l'eccessivo angolo d'apertura. che faceva perdere spinta rispeno a queUa che s1sarebbe potuta teoricamente ottenere mettendo in movimento un volume d'aria perfettamente ciJindrico.
Una ulteriore perdita d'energia era da imputare alla fonnazione di vonic1 laterali prodotti dallo stesso flusso d'aria
Sembrava quindi evidente che se si fosse racchiuso il 0usso d'ana prodotto dall'elica io un tubo cilindrico, aperto alle due estremnà e dalle pareti interne convenientemente profilate e capaci di regolarizzarne il movimento. se ne sarebbe ricavato un notevole incremento del rendimento propulsivo, che sarebbe venuto a dipendere dall'insieme elica-tubo considerato nel suo complesso
Che un tubo attraversato eia un fluido potesse essere sede cli forze di reaZJooe era stato d'altra parte evidenziato già da un semplicissimo esperimento. denominato paradosso idrodinamico". che era stato effettuato in Italia nel I902 dal prof. E. Bernardi utilizzando un recipiente pieno d'acqua. recante sul fondo un tubo di scarico. all'imboccatura del quale veniva posto un segmento di tubo cilindrico dal margine superiore opportunamente svasato.
Facendo defluire l'acqua attraverso lo scarico il segmento tubolare. mvece di essere spinto contro le pareti dello scarico e verso il basso. veniva interessato da una forza di reazione verticale che lo faceva schizzare verso l'alto.
Il fenomeno poteva essere e, idenziato anche facendo uso di un più semphce recipieme contenente soltanto aria. . . .
Anche il tentativo effettuato in Francia da Coanda (§ U.2) aveva contnbu110 a Stlmolare ulteriormente la fantasia degli sperimentatori del tempo, che proprio allora_~da:::- 2=~-~- -
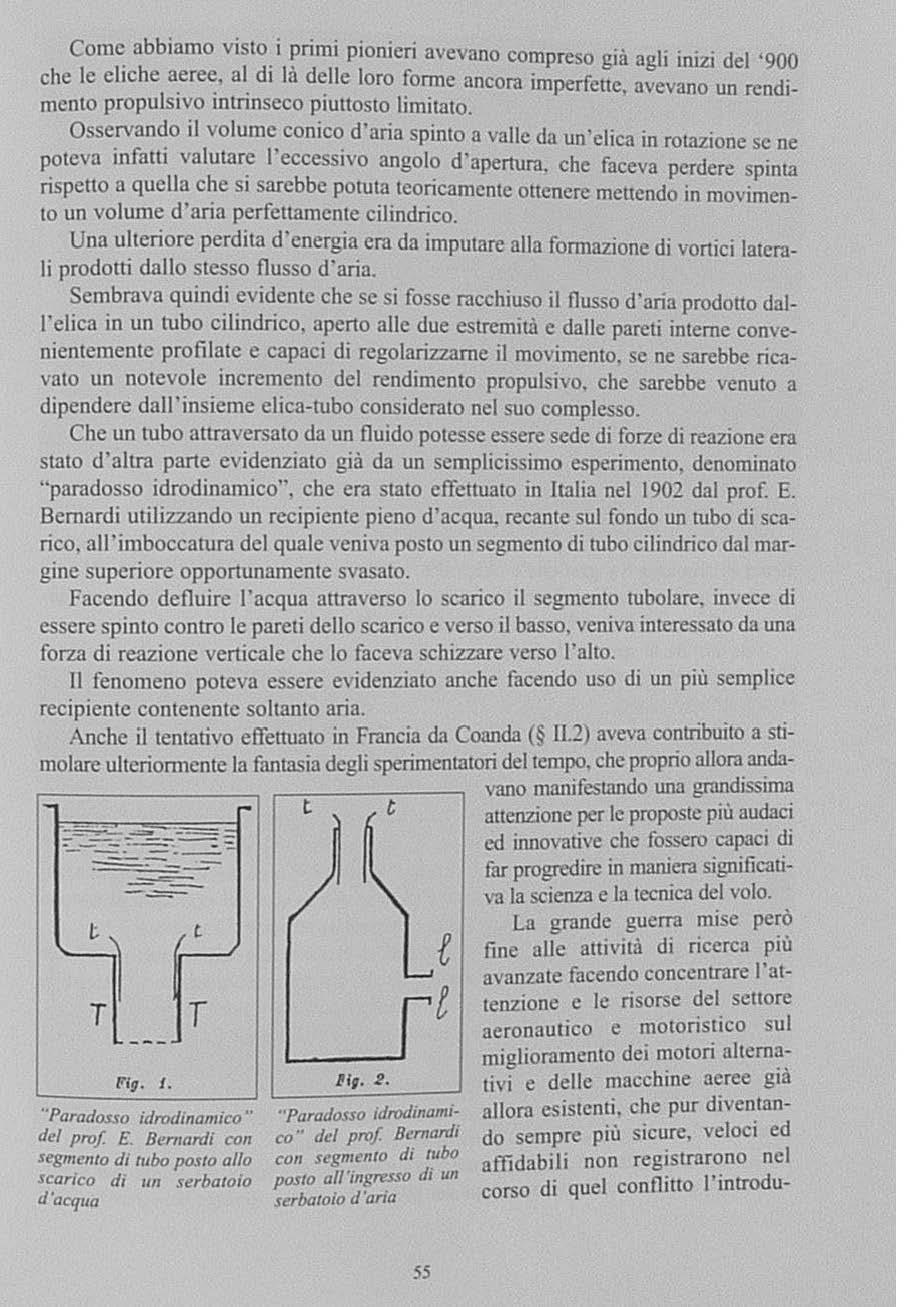
flg. I.
Paradosso idrodinamico de/ prof E Bl!nrordi con segmento di rubo posto allo scarico d1 1111 serbatoio d'acqua
vano manifestando una grandissima t t attenzione per le proposte più audaci ,r,. 2. l t
" Parado.tso idrodinamico.. del prof Bi!manii con se~m••nro d, t11bo posto a//'ingress-o ,li un serbatoio d'aria
cd innovative che Fossero capaci di far progredire in maniera significativa la scienza e la tecnica del volo.
La e:rande guerra mise però fine alle attività di ricerca piu avanzate facendo concentrare l'attenzione e le risorse del settore aeronautico e motonsuco sul miglioramento dei motori ahem~tivt e delle mocchine aeree già alloro esistenti, che pur diventando sempre più sicure, veloci ed affidabi &i non registrarono nel corso di quel conflitto l'introdu-
--=-=-T
55
• . . 1.. non nel settore degli annamcnll aerei. . d inno\ az1om paruco an ::... . . . . zione 1 _ . · , • i ·ntativi pratici ,ohi a m1ghorarc drasticamente ti rcn- Tcm11nota la guerra, sia t e I d' I
1•· d Il liche che gli studi 1conc1 su a In meto I propu sm npre- d1men10 propu SI\O e e e sero immediatamente vigore. . . . . 1·.· d ' 1· . · - • 1• e·~nmcnto prJllC0 1mphcante I ana 1s1 1 ta I aspetti fu Un pnmo 1mponan t: sr effettuato anche in ltaha da un pri\ :ito c111ad1110. Matt1om.

Antonio \Jattioni
N 10 a Ci, idale del Friuli il 20 giugno 1880. ~lattioni iniziò ad occuparsi fatthame~t; d'anaziooi: a pamre dal 1909. anno in cui si svolse il circuito aereo di \lonticluan. net pressi di Brescia. al quale assistette con grande mteress_e. . . ...
Successi\ameme lavorò con il conte Almerico da Schio. occupandosi d1 dmg1b1li e bre\c1tando per essi due congcgm di mano\ ra.
Spmto da un grande intere. ~e per i --più pesanti dell'aria". sì recò in lnghilterra per approfondire le sue conoscenze tecnico-scientifiche nel campo ideativo e costruttivo di questo nuovo tipo di aeromobili.
TomJto m Italia nl!I 1910 fini con lo stabilirsi a Firenze. dove s'occupò mizialmente d1 tecniche fotoeraficbc e chimiche. intraprendendo uccessi\ amente alcune floride atti, iùi in camp7, editoriale che lo panarono a fondare alcune riviste specializzate nel ·enore delle forniture per l'edilizia e l'arredamento.
Tale a11ività lo spinse ad effc1ruarc rrequemi viaggi dt srudio e di larnro in centro Europa. che gli permisero anche di approfondire le sue conoscenze 1coriche relati\e al settore aeronautico.
Agli inizi degli anni ·10. le buone disponibilità finanziarie dcri\ anri da queste a11h·ità gli consentirono di realizzare il sogno d1 costruire un nuovo tipo di \ eliYolo di propna originaria concezione.
11 proge110 era basato su di un condotto tubolare dt grande diametro. all'imboccanrra del quale era installato un motore stellare rotativo Gnòmc a 7 cilindri da 80 C\' nommah a I.I 50 giri. che era stato costruito nel 1916 ed usato in guerra. a2ionante un'~hca bipala di apertura d1 poco superiore a quella del condono stesso, la quale \'1..'Tl1va f~tta girare immediatamente prima della sezione d'ingresso.
Le d~e senuab monoplane di legno e bambu. rivestite in tela cerata. erano collocate m pos1Z1one media ed incenùerate direttamente alla strunura del condono a botte sulla quale ~o-fissati anche i relativi ca, i di controventatura usati per l'irrigidimento. ~fa1t 1oni ne propose inizialmeme la realizzazione ai fratelli Pomilio di Torino. i qualt decimarono l'offena.
Decisc allora di procedere in maniera autonoma. costruendone la struttura intera· mente hgnca auraverso l'ass bi · d' · · • · r. I . . · cm aggio I sezioni staccate reahzzate da diverse 1a egnamene fiorcnune situate nella zona di via Maragliano.
1 11 montaggio finah! venne effcnuato in un hangar al Campo di Mane del cap<>uogo toscano e completato nel corso del 1913.
56

/at,•rn/e del/u
lista
.ttntltura mtt"r11a dell'a.:n'O di Antamo .lfamom
57
I ì.vra a,m•nore della immura illf••rna clel/'a,·1w, di ,l11ronfo \ {allio,ri
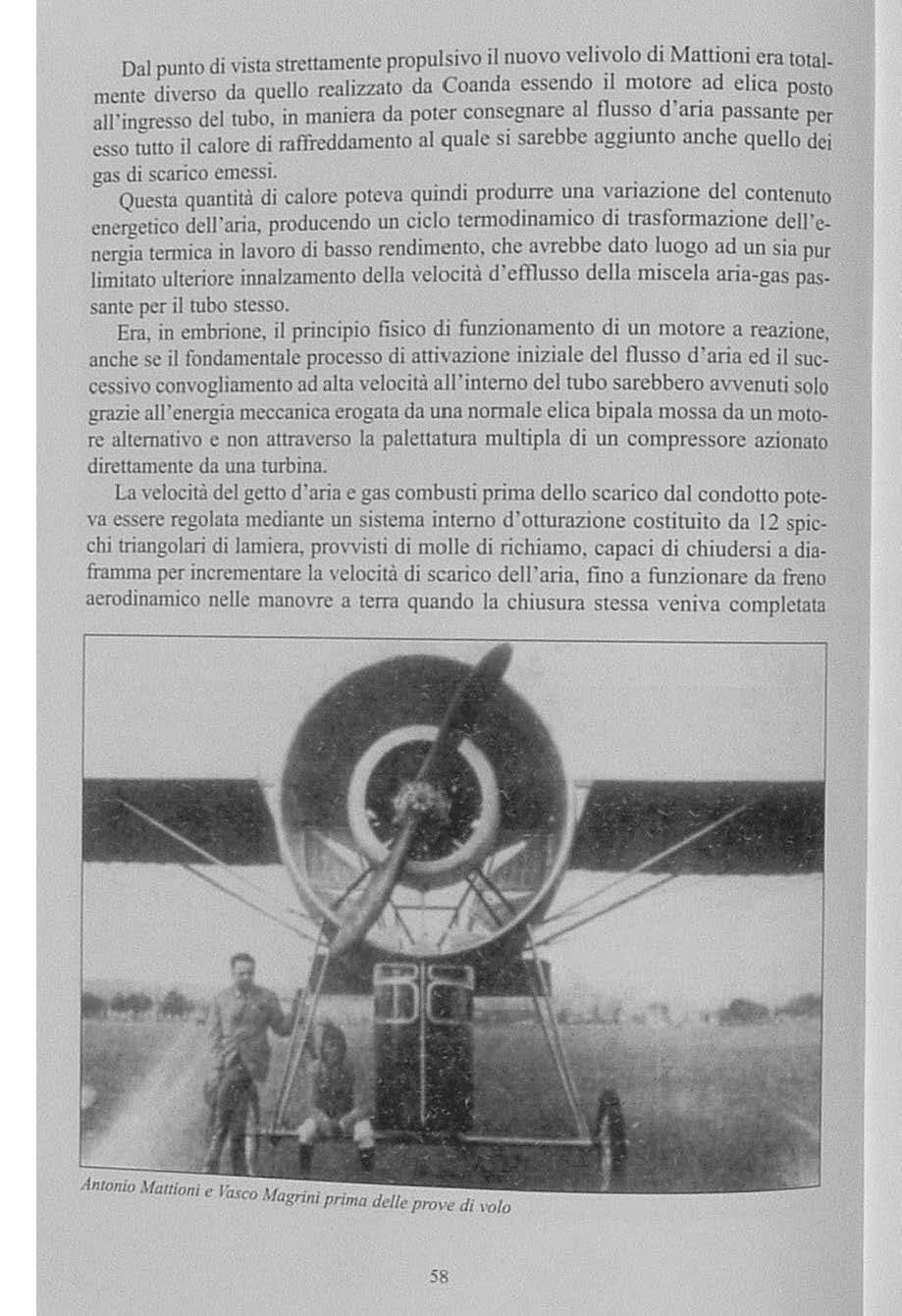
Dal unto di ùsta strettamente propulsivo il nuovo velivolo di MatLioni era totalmente :\'erso da quello realizzato da Coonda essendo il moto:e _ad elica posto all'ingresso del tubo. in maniera da poter cons~gnare ol nus_so d ana passante per esso tutto il calore di raffreddamento al quale s1 sarebbe aggiunto anche quello dei gru; di scarico emcssì. . . . _
Questa quantità di calore poteva qumd1 prod~rre ~na v?naz1one dc! contenuto energetico dell'aria. producendo un ciclo tennodmam1co d1 trasformazione dell'energia tennica in lavoro di basso rendimento, che avrebbe dato luogo ad un sia pur limitato ulteriore innalzamento della velocità d'effiusso della miscela aria-gas passante per il tubo stesso.
Era, in embrione, il principio fisico di funzionamento di un motore a reazione, anche se il fondamentale processo di aniuzione iniziale del flusso d'aria ed il successi\'o con\'ogliarnento ad alta velocità all'interno del rubo sarebbero avvenuti solo grazie all'energia meccanica erogata da una normale elica bipala mossa da un motore alternativo e non allra\'erso la palellatura multipla di un compressore azionato direuamcnte da una turbina.
La \'elocità del gello d'aria e gas combusti prima dello scarico dal condono poteva essere regolata mediante un sistema interno d·otturazione costituito da 12 spicchi triangolari di lamiera. provvisti di molle di richiamo. capaci di chiudersi a diaframma per incrementare la \'Clocità di scanco dell'aria, fino a funzionare da freno aerodinamico nelle manovre a terra quando la chiusura slessa veniva completata
.-lntomo .\fouiont e la.,co Il • 0 E:nm pnrrta dellt• pro\',1 di ,-o/o 58
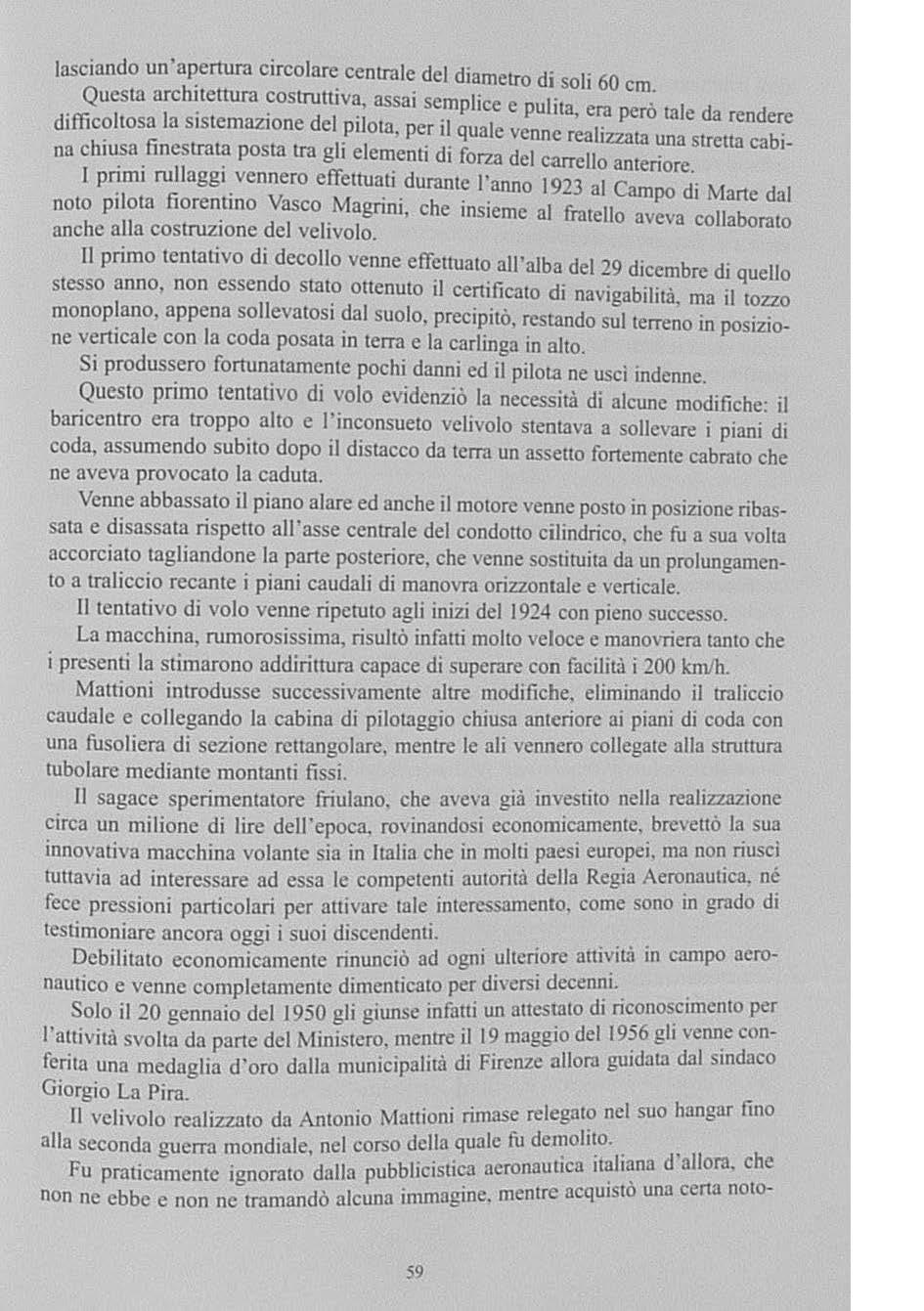
lasciando un•a~ertura circolar~ centrale del diametro di soli 60 cm.
. Questa architettura ~ostrutt1v~, assai semplice e pulita, era però iale da rendere difficoltosa la s1stem8Zlone del pilota, per il quale venne rea11·zza1a un t b . . a s retta ca 1na ch1u~a _finestra~ posta tra gh elementi di forza del carrello anteriore.
I p1?m1 rullaggi .vennero effettua.ti durante l'anno 1923 al Campo di Marte dal noto pilota fiorentino Vasco Magnni, che insieme al fratello aveva collaboraL anche alla costruzione del velivolo. 0
li primo tentativo di decollo venne effettuato all'alba del 29 dicembre di quello stesso anno. non essendo stato ottenuto il certifica10 di navigabilità, ma il cozzo monoplano. appena sollevatosi dal suolo, precipitò, restando sul terreno rn posizione verticale con la coda posata in terra e la carlinga 1n alto.
Si produssero fortunatamente pochi danni ed il pilota ne usci indenne.
Questo primo tentativo di volo evidenziò la necessità di alcune modifiche: il baricentro era troppo alto e l'inconsueto velivolo stentava a sollevare i piani d1 coda, assumendo subito dopo il distacco da 1erra un asseuo fortemente cabrato che ne aveva provoca10 la caduta.
Venne abbassato il piano alare ed anche il motore venne posto in posizione ribassata e disassata rispelto ali'asse centrale del condotto cilindrico. che fu a sua volta accorciato tagliandone la parte posteriore, che venne sosmuita da un prolungamento a traliccio recante i piani caudali di manovra orizzontale e verticale. li tentativo di volo venne ripetuto agb inizi del I924 con pieno successo.
La macchina, rumorosissima, risullò infaui molto veloce e manovriera lamo che i presenti la stimarono addiri1tura capace di superare con facilit:i i 200 km/h.
Mattionì introdusse successivamente nitre modifiche, eliminando il 1r.1hccio caudale e collegando la cabina di pilotaggio chiusa ameriore a, piani di coda con una fusoliera d1 sezione rettangolare, mentre le ah vennero collegale alla struttura tubolare mediante montanti fissi.
Il sagace sperimentatore friulano. che aveva già in, esti10 nella realizzazione circa un milione di lire dell'epoca, ro,inandosi economicamente._bre,e110 la su~ innovativa macchina volante sia in Italia che in molti paesi europei. ma non nusc1 tuttavia ad interessare ad essa le competenti au1oriuì della Regia Aeronautica. n~ fece pressioni particolari per auivare tale in1eressamento, come sono m grado di testimoniare ancora oggi i suoi discendenti. . . . .
Debilitato economicamente rinunciò ad ogni ultcnore an1vua m campo aeronautico e venne completamente dimenticalo per dh·ersi dccen~1- •
Solo il 20 gennaio del 1950 gli gmnse infntu un aues~ato di nconos_c,mcnto per l'auiviuì svolta da parte del Ministero. mentre il 19 maggio del 19?6 gh venne conti . . . 1. • d. F"rcnz" allora guidata dal sindaco ema una medaglia d'oro dalla mumc1pa 11a I i ..
Giorgio La Pira. fino
Il velivolo realizzato da An1onio Ma11ioni rimase relegai? nel suo hangar alla seconda guerra mondiale, nel corso della quale fu demoll~o. d' Il h bbl. · >ronaut1ca 1tahana a ora. e e Fu praticamente ignorato dalla pu 1c1s11ca ne . . . · ire acquisto una cena no10- non ne ebbe e non ne tramandò alcuna 1mmagme. men
59
. . t· -iudiosi di aerodina.mica teorica come primo valido esempio di nero solo presso g 1
• a licazionc pratica del principio dell'elica mtub~to. .ppln realtà l'aeroplano di Mauioni segnò l'cffetuvo tn1710 del proc~so 1Laltan~ di - d 1 1 della propulsione a gcuo. sul quale a\Tcbbe esercitato un pomo sviluppo e set ore ,. . _ marcato condizionamcn10 concettuale e d mdmzzo. . . L• h"t •twra costruiuva prescelta. basata su un condotto d1 grande diametro arc1c . "fi · · d. fungere sia da in,·olucro contenitore deglt orgam ss1e rotanti costituencapnce I l 1· t. 1·· pianto propulsore. che da fusoliera alla quale collegare e a 1 . In oob1.na di 1 1m . d 1 . . comando cd I piana di coda. sarebbe s1a1::i infatti npr-es~ ~g 1 spen~em~to~ 1taltani successivi, diventando un elemento ricorrente sui p1ù 1mportant1 vchvolt a reazione che \'ennero 1deau e cos1rui11 nel nostro Paese fino al 1crmine del secondo confliuo mondiale.
Gli s tudi del prof luigi
Sante Da Rios
fn quegli stessi anni. accanto a qucs1c aui, ità eminentemente pratiche, vennero s, ohe anche di, erse ncerchc teoriche e sperimentalt di laboratorio, miranti ad ollenere un neuo miglioramento del rendimento propulsh·o di un'elica.
Impanante fu il ccntattvo di farla ruotare in un anello tubolare di forma adeguata che fosse capace di a,·volgere e guidare m maniera regolare il flusso d'aria prodono.
Panìcolannente attÌ\'O fu. tra la fine della grande guerra cd il 1928, il prof L.S. Da Rios della Regia Scuola d'Ingegneria di Padova, il quale svolse delle accurate ricerche d1 base su questo fenomeno che gli penrnscro di arrivare all' importante conclusione secondo la quale un·elica ruotante all'imemo di un condotto c1lindrico ad anello chiuso avente una sezione d'ingresso ampiamente svasata avrebbe potuto mcremen1are il suo rendimento propulsivo fino a circa il 50%.
. ~I professore iniziò i suoi studi fissando un anello di qucSto stesso upo all'estremna de!lc pale di un\:hca prelevata da un triplano Caproni. il cui diametro di 3 m venne ndouo a soli 120 cm.
li nuo,·o disposi11vo venne posto in rotazione a 3.500 giri al minuto 011cncndo a

F.lica imubata del prof. Lwg, Sumt• o,, R1os Flg. 6.
Il
H
6(1 '. 1» H'

P?ri~à di spinta propulsiva una d~mtnuzionc dell'energia meccanica assorbita di circa il J5%.
Già _nel 1917, m piena guerra, lo studioso propose ad una ditta aeronautrca italiana di costnurc un velivolo utihzzantc un'elica di questo tipo. ma 11 consiglio di amministrazione d1 quest'ult1ma nliutò di prendere in esame tale proposta. asserendo che la ricerca sc1en111ica non era un'annità di competenza di una industria privatn.
Nel I 918 il fenomeno fu anche ponato a conoscenza del Elìca intubata del prof l11ig1 Sontt: Da Rios con andlo <' fllbo addi:io11a/e ricun·o comitato per le inven21om di Flf. 4. guerra di Milano. . . ,. .
Da Rtos proseguì i suoi espenment1 anche nell unmedmto dopoguerra, modificando il suo dispositivo mediante la separazione detranello dall'dica ed ìl suo fissaggio su una b!lancia dmamornetnca capace di misurare le forze tratt1ve sviluppantisi quando l'elica stessa veniva fatta ruotare all'imboccatura dell'anello.
li rendimento propulsivo crebbe ancora e risultò tanto più elevato quanto più ridotto era lo spazio tra la superficie interna delranello e la punta delle pale della stessa elica e quanto più elevato era il suo numero di giri.
ln particolare venne misurata la differenza di pressione tra la sezione a monte e quella a valle dell'anello mediante fon realizzati su dt esso e tubi dì collegamento ad un manometro ad aria libero.
Da Rios potè facilmente \·erificare che i \'alori di pressione che \'Cnivano misurati erano taJi da dar luogo ad una forza propulsiva supenore alla resistenza offenn all'aria in movimento dall'anello stesso.
Eglt vide in questo modo confennata I·1po1es1 iniziale dn lui stesso formulata secondo la quale l'incremento di spinta era do\'UIO. oltre che alla pura e semplice reazione. anche alla differenza di pressione che si \'eniva a creare nella corrente d'aria aspimta dall'elica tra una sezione posta a monte dell'anello ed una seconda posta invece sulla sezione d'uscito a valle dello stesso. tanto che definì tale dispositivo ·•propulsorn-veicolo o risucchio e a reazione".
Tali studi furono presentali atr -\ccademia dei Lincei in due diverse memorie nel 1926 e nel 1927.
Variando diametro e passo delle pale delle elJche adop~rate ed anche 11 profilo dell'anello. lo sperimentatore riusci ad onencri: incrementi di spinta che pote, ano arrivare a circa il 50°o.
Il. ... 'ti:: I • - - - - - • - ,- - - -, # - - -. -i ,. Il I " • , , I~-/ .· r ..,- --, _.. . . - ·--~ . JO----~• p
61
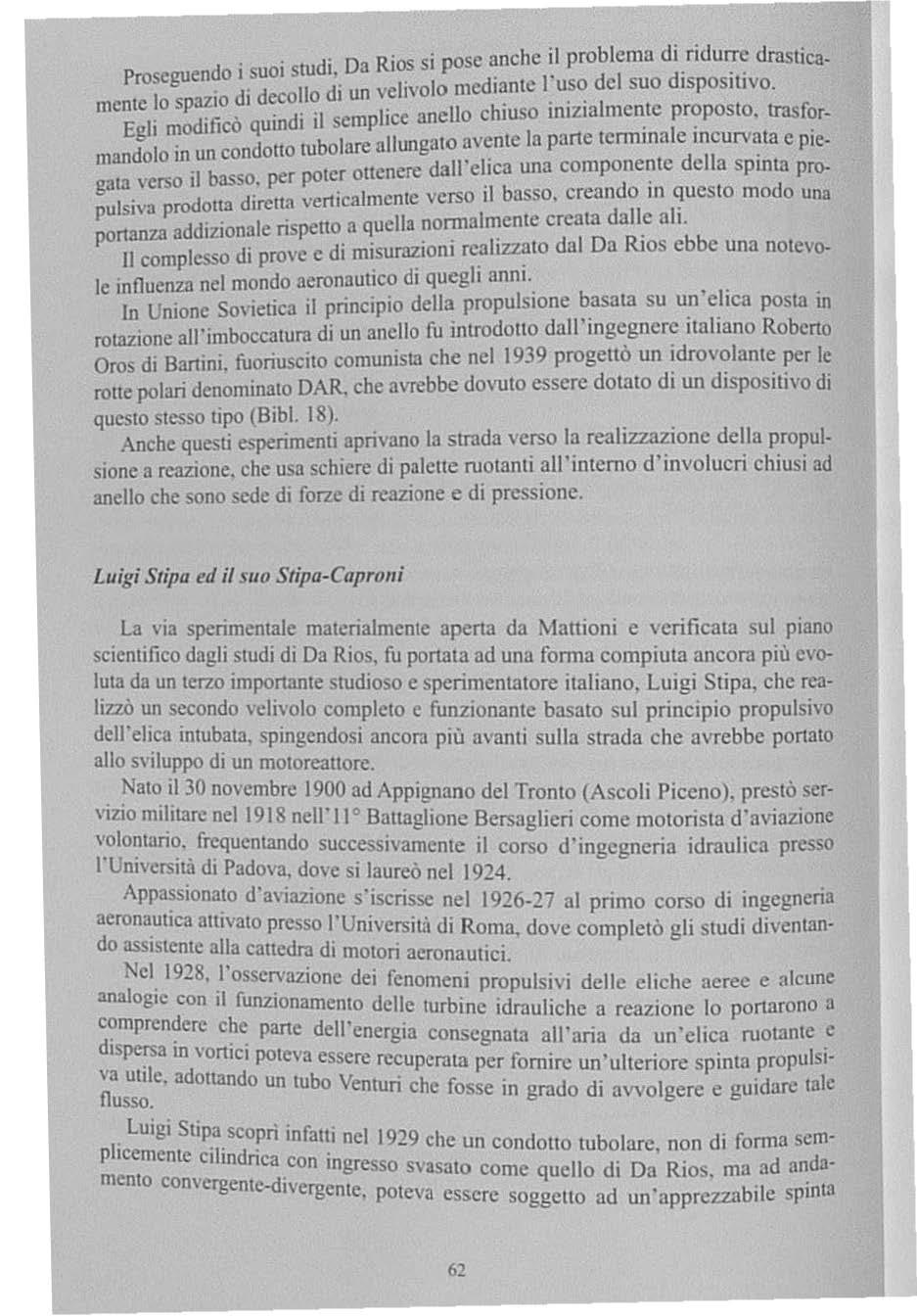
• d. D Rios si pose anche il problema di ridurre drastica. P •guendo I suoi stu t, 3 . . I d' · · rosc 11 d. velivolo mediante I uso de suo 1spos1uvo. •nt' lo spazio dt deco o I un 1 mc e ,-_ . . d.. 1 ·emplice anello chiuso tntZla mente proposto. trasfor- Eglt modifico qum i l . I . . . b lare allungato avente la parte tcnnma e incurvata e p1e- mandolo m un condotto tu o d Il . . .. t r ottenere dall'elica una componente e a sp1ma progala \'er.;o ti basso. per po e . d . d rod d. , 1 ·erticalmcnte ,·crso 11 basso. crean o m questo mo o una puls1va p otta ,rct a \ dall 1· , dd' . I n··peno a quella normalmente creata e a t. portanza a tz1ona e s . . . . I d. o,·e e di· misurazioni rcahzzato dal Da R10s ebbe una note,o- 11 comp esso I pr . le m0uenza nel mondo aeronauuco di quegli anm. . . . ln L . Soùetica il principio della propulsione basata su un ehca posta m monc •· . 1· R b · 11·· boccatura di un anello fu jntrodotto dall ingegnere Ila 1ano o erto rotazione a 1m . . Oro:. di Bamm. fuoriusctto comunista che nel 1939 progetto un ~dro, ~lant~ per I~ rone polari denominato DAR. che a\Tebbc do\'uto essere dotato d1 un dtspostll\'O d1 questo stesso tipo (BibL 18). . .
Anche questi esperimenti apri,ano la strada verso la realtzzaz1onc della propulsione a reazione. che usa schiere di polene ruotantt all'interno d'involucri chiusi ad anello che ~ono :-ede di forze d1 reazione e di pressione.
luigi Stipa t!d il mo Stipa- Caproni
La , ia sperimentale materialmente aperta da Maniont e , criticata sul piano scientifico dagli studi di Da R10s. fu portata ad una fonna compiuta ancorn più e\oluta da un terzo importante studio:.o e sperimentatore Italiano. Luigi Stipa. che r1.-aliuò un secondo ,eli,olo completo e funzionante basato sul pnnc1p10 propul,;i\'O dell'elica intubata. spingendosi ancora più a,anll sulla strada che aHebbc portato allo s, iluppo di un mo1oreanore.
\fato 11 30 nO\embre 1900 ad Appignano del Tronto (Ascoli Piceno). prestò ser,·1zio mìlitan.: nel 1918 nell' I I O Bauagltone Bersaglieri come mo1onsta d'aviazione volontario. frequentando successivamente il corso d'ingegneria idrauhca presso l'Uni\'ersi1à di PadO\ a, dove st laureò nel J924.Appa~siona!o d"a, iazionc s"iscrisse nel 1926-27 al primo corso di ingegneria aeronauuca alti\ ato pre~so l'Uni\'ersitit di Roma, dove completò gli studi diventando asstMentc alla cauedra di moton aeronauttc1. ~cl 1928. l'osservazione dei fenomeni propulsi\ i delle chche aeree e alcune analogie con il runz1onamen10 delle turbine 1drnulichc a reazione lo portarono a compren~ere che parte dell'energia consegnata all"ana da un'elica ruotante e dtspe~a m vonic, pote\'a essere recuperata per fornire un'ulteriore spinta propul5t,-a uulc. adottando un tubo \'entun che fosse m grado d1 avvolgere e guidare tale flusso.
Lu1g1 St · · r. · ip_a_scopn m,att1 nel 1929 che un condotto tubolare non di forma scmphcement• cii d · · • e m nca con mgrcsso s,asato come quello dì Da R1os. ma ad andamcnto con\'ergente-d\· , • 1 ergente, pote\'a essere soggetto ad un 'appre1.zab1le spinta
62
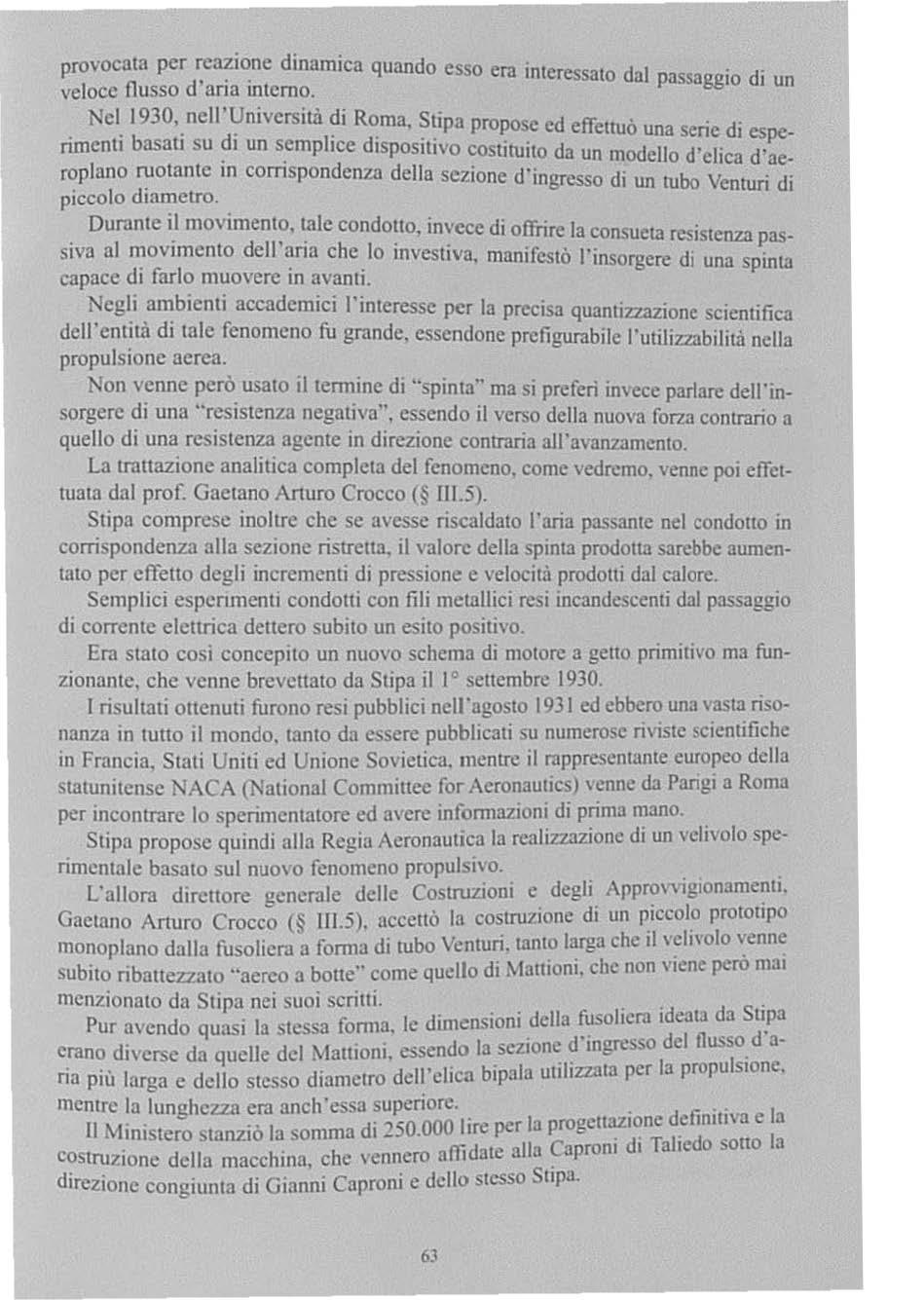
provocata per reazione dinamica quando esso era interessato d I · d. \'Clocc flusso d'aria interno. a passaggio I un
. cl I930, nell'Università di Roma. Stipa propose cd •ffettuo · · d" . · · d. . . . . e una sene I espe- nmcnll basati su . 1 un semplice d1spos111vo costiruilo da un modello d'elica d'aeroplano ~otantc 10 comspondenzn della sezione d'ingresso di un tubo Venturi di piccolo diametro.
_ Durante il mo\'iment?. tale condo~to. invece di offrire la consueta re:.istenza pass1Ya al movimento dcli ana che lo mvest1\'a. manifestò l'insorgere di una spinta capace di farlo muovere in a\anti.
Negli ambienti accademici l'interesse per la precisa quantizzazione scientifica dell'entità di tale fenomeno fu grande. essendone prelìgurabile l'utilizzabilità nella propulsione aerea.
'\'on venne però usato il termine d1 ··spinta"ma si preferì ifl\ecc parlare dell'insorgere di una ··resistenza negativa", essendo il verso della nuova for1a contrario a quello di una resistenza agente in direzione contraria all'a\anzamento.
La trattazione analitica completa del fenomeno. come ,edrcmo. \'enne poi effettuata dal prof. Gaetano Arturo Croceo(§ [11.5).
Stipa comprese inoltre che se avesse nscaldato l'aria p:issante nel condono in corrispondenza alla sez1on.:: ristretta. il \ alore della spinta prodotta sarebbe aumentato per effetto degli incrementi di pressione e \'eloc11à prodotti dal calore.
Semplici cspenmenu condotti con fili metallici resi mcandcscenti dal passaggio d1 corrente elettrica dettero subito un esito positi,o.
Era stato cosi concepito un nuo,·o schema di motore a geno primitirn ma funzionanti!. che venne brevettato da Stipa il I senembre 1930.
I risultati 011enuti furono resi pubblici nell'agosto 1931 ed eb~ro una vasta risonanza in tutto ti mondo. tanto da essere pubblicati su numero5e m 1:.te scientifiche m Francia, Stati unili ed Unione So\ietica. mentre il rappn!.Sentante europeo della statun11cnse .\CA (?\ational Committee for .-\eronauucs) ,enne da Pang1 a Roma per incontrare lo spenmcntatore cd a,·ere mfonnoz1oni di prima ~ano. .
S11pa propose quindi alla Rcgm .\cronautica la realinazione d1 un , cll\olo sperimentale basato sul nuo, o fenomeno propub1,o. . .
L'allora direttore ecnerale delle Costruziont e degli Appron igmnamenu. Gaetano Arturo Croce~ <* lfl.5). uccenò In cos1.n111one di un ~iccolo prototipo monoplano dalla fusoliera a forma d1 tubo Venturi. tanto larga che il v~hYolo :enne !>Ubito nbnttezzato "aereo a botte.. come quello di :i.taruoni. che non nene pero mai menzionato da Stipa nei suoi scriui. d s ·
I d. · · d"'lla fusoliera ideata a upa Pur avendo quasi la stessa forma. e 1mens1on1 " . .. . d. . do la . ·z1on•· d mere ·-,o del tlus:.o d a- erano 1vcrse da quelle dd \la111on1. essen :se V - • . . d 11. 1 b. la ut·,1·,.....ua per la propulsione. na p1u larga e dello stesso diametro e e 1ca ipa -mentre la lunghezza era anch·e·sa superiore. . d fi • I
Il Mm1stero !stanzio la somma di 250.000 lire per la progeuaz~~n; / t 11 '~; ,: costruzione della macch1110, che , ennero ani date alla Capront I a ,e O :.o direzione congiunta di Gianni Caproni e dello stesso Supa.
63
Lo Snpa Cuprom in costnc1011r

la ,1.11ema:1one d..t Dt• fla11/land "G1psy lii" da I :!O Cl· oli ',rwmo dello /woli,:ra 111bolCll'I• dello St1po-Copro111
L'inconsueto monoplano cra potenziato da un motore in linea De Ha,·illand •'Gipsy fll" da 120 CV. rnrrrcddato ad aria. già usato. che venne fornito direttamente dalla Forza Annata e fu montato su adatti supporti all"imerno della fusoliera al centro della parte converl?entc del tubo Venturi.
li ;alore d1 raffreddamento del motore e quello dei gas di scarico avrebbero così riscaldato il flusso d'a• ria mcrcmenlando la spinta propulsiva.
Il profilo della fusoliera era inoltre m grado d'assicurare una sufficiente portanza: la botte funziona, a c1oe come un'ala a forma d'anello. mentre In cabina d1 pilotaggio biposto era posta al disopra della fusoliera e, al contrano di quella del Mattionì, era accuratamente raccordala ad essa per ridurre al minimo la resistenza all'avanzamento.
I piani di controllo direzionale posteriori erano posti a sbalzo nella pane terminale della fusoliera e parzialmente immersi nd geno fuonusccnte da essa. realizzando in questo modo uno dei primi esempi di getto vettonntiz7.abilc. oggi tanto attuale, mai apparso su un vcli\'olo.
Snpa nbattezzò quella che era apparentemente solo un'elica intubato. ma che era in rcalta un reattore autoportante capace di realizzare un cmbnonolc ciclo tennodioam1co propulsivo: "ala a turbina"
Per meglio comprendere l"ultcnore evoluzione del progetto di Sllpa e quella di molti ahn progetti aeronau11ci successi\ 1· occorre ricordare che la ricerca tecnico-sc1enttfica italiana nel settore a_cronauuco era aHora concentrata nelle mani di pochi esperti d1 alto livello scicn· hlico. avcnu quasi sempre una duplice veste; accademica e militare.
Moltt docenti universìtan di discipline del volo erano infaui anche ufficiali dello Regrn A~ron~utica. ed I fondi di ricerca destinali aUc universita pro,·emvano spcs· so dai bilanci della stessa Anna Aerea. Lo stesso Stipa era allora tenente di com· plemcnto del Genio Aeronauuco.
Non es1sleva quindi uno specifico ente autonomo di ricerca aeronautica capace di condurre i propri esperimenù secondo una cadenza lemporale ed un·oltica realizzaliva sganciate dalle più immediate necessità economico-produtuve e d'impiego, mentre il Consiglio Nazionale delle Ricerche, istituito nel 1923, aveva competenze generali e non strenamente limitate al settore aeronautico. pur avendo un'apposita sezione ad esso dedicata.
Le innovazioni ottenute in ambito militare quindi, oltre ad essere attentamente vagliate sul piano tecnico-scientifico, dovevano essere in grado di produrre vantaggi incontro\ ertibili sul piano della tecnica aeronautica e di rapida utilizzabilità. altrimenti venivano rapidamente abbandonate.
L·azione aerodinamica propulsiva di una singola elica bipala nel progeno di Stipa non poteva essere assimilata a quella di una schiera di palette poste sulla peri feria del rotore di un compressore, né i fenomeni 1ennodinamic1 m gioco sarebbero stati diversi da quelli tipici di un nonnale motore alternativo.
La defini.zione "ala a turbina" non fu quindi accellata come titolo di un articolo che lo stesso sperimentatore aveva proposto alla ri,ista "l'Aerotecnica.. ed egli dovette, sia pure a malincuore. cambiarlo in quello ridutt1,·o di '"elica intubata" (Bibl. 80).
Il primo volo del nuovo biposto m tandem, con ai comandi il collaudatore della Caproni Domenico Antonini e per passeggero lo stesso Stipa. avvenne con pieno successo a Taliedo il 7 ottobre 1932.
Al contrario di quanto ero o\'venuto per lo sconosciuto \'eli\'olo del Mattiom.
I tmron, ori=o11talc e ,-ertic-ale dello S11paCapro11i par=ialmtnte imme1"1i nd gmo di st·arlco
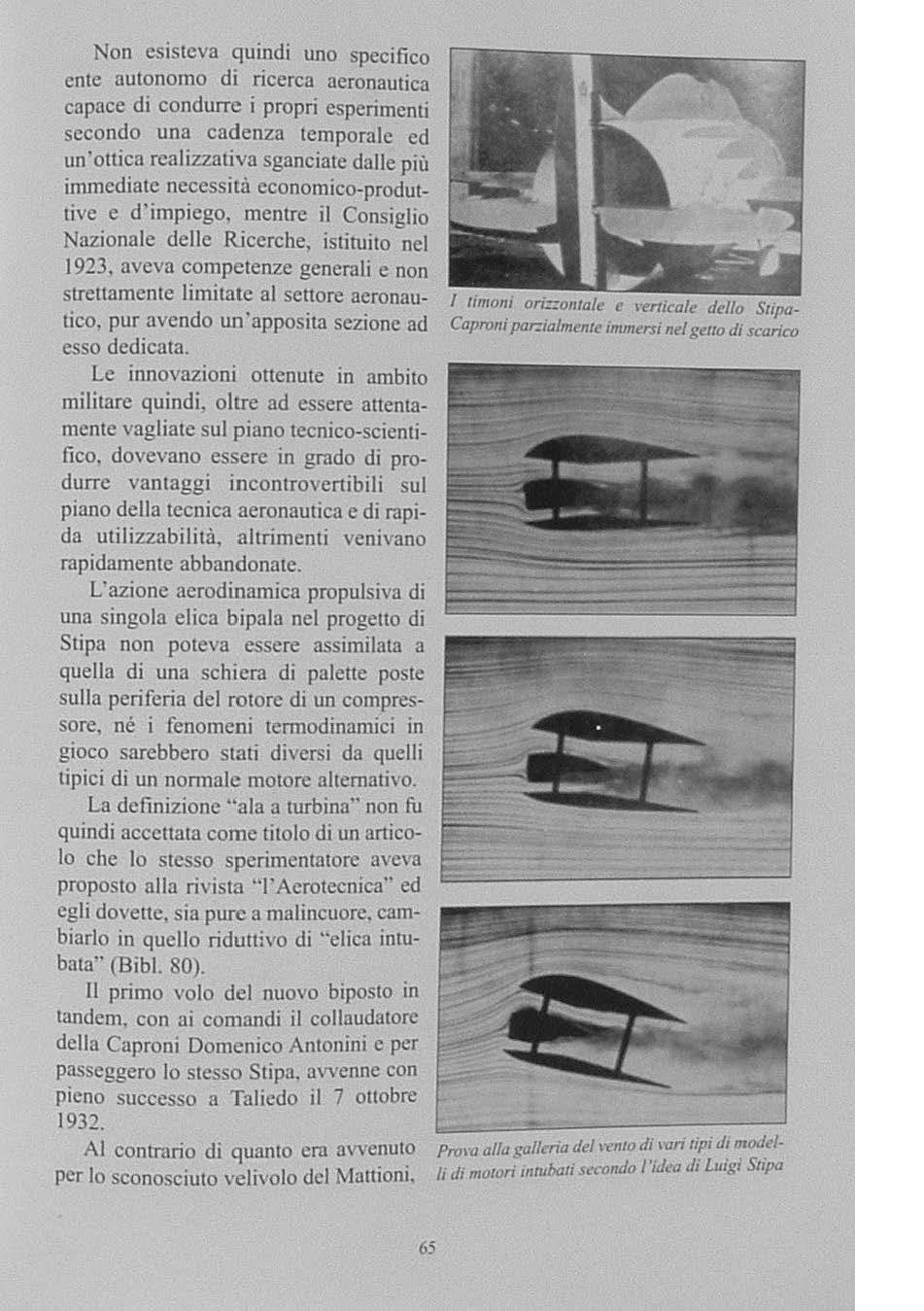
Pro,·a allu galleria Jet ,·.·nto di mn ti[" di modr!l/r di mowri mtul>ati so:rondo / '1J.:a J, L111g1 S11pa
Luigi S11pa ed 1/ co//audaton: della Caproni
Doml!mco Antonim !'rima del l'Olo d, collaudo dello Stipa-Copro11i

la notizia dell'avYenimenlo trovò vasta eco presso il pubblico. poiché la propaganda fascista la p_resemò co~e in_dice di modemi1à del regime e la divulgo altraverso fotografie e cinegiornali che fecero il giro del mondo. destando ovunque sensazione. Il singolare aeroplano, al quale fu assegnala la matricola militare MM 187. venne trnsferito successivamente presso il Centro Studi ed Espcrie111Ze della Regia Aeronautica di t-.fontecelio, l'atruale Guidonia. per il proseguimento det voli di collaudo.
L"inconsueta sagoma dello Stipa, Caproni. dì scarsissima presa sul piano
estetico e ritenuta non suscettibile di impieghi militari operativi, non raccolse tulla\'la grandi consensi, tanto che, come afferma lo stesso Stipa nei suoi scritu. tra gli stessi piloti collaudatori ci fu chi manifestò apenamente tali perplessità.
Le prove vennero regolarmente effettuale, ma dopo alcunj riusciti voli la macchina subi un incidente non grave, capponando in fase dì decollo e rimanendo danneggiata nella carenalUra superiore dei posti di pilotaggio.
Le sue prestazioni reali avevano evidenzialo notevoli capacità di dccolJo ed atterraggio corti. una grandissima stabilità di volo con una velocità minima di stallo mollo bassa, pari a 68 kmb. dovuta alla fusoliera tubolare che si comporta\'a come un'ala addizionale di 14 m· di superficie.
La \'elociui massima era invece risultata pari a soli 130 km/h. non superiore a quella degli aerei leggeri del tempo della stessa categoria. Discretamente elevata era invece risultata la quota d1 tangenza effettiva di 4.150 m, non superarn solo per la mancanza delrinalatore ad ossigeno, il che stava a dimostrare l'esistenza di una riserva di spima propulsiva anche a quella quota.
lo realtà l'enonne superficie delle ali e della panciuta fusoliera. cui si aggiungeva quella di ben 14 tiranti di controvematura_ ave, a frenato il velivolo in maniera marcata, me~tre la spinta del getto prodotto era risultata incapace di fornire miglion pr~staz1001 a causa del basso numero di giri fomiti all'elica dal motore.
Limnata _era ~che risultata l'entità del riscaldamento operato dal calore del motore e dei gas di scarico.
Malgrado · · · d Il · · · . 1vantaggi e a nuova formula a reazione fossero staù quanttfi~11 m un accresc1mc010 di sp· · I 130 · · • I ima pan a Vo, la macchma, per essere un poco p1u ve oce. avrebbe dovuto essere d"fi d . • · · d mo 11cata a ottando una fusoliera d1 diametro mfenore e
66
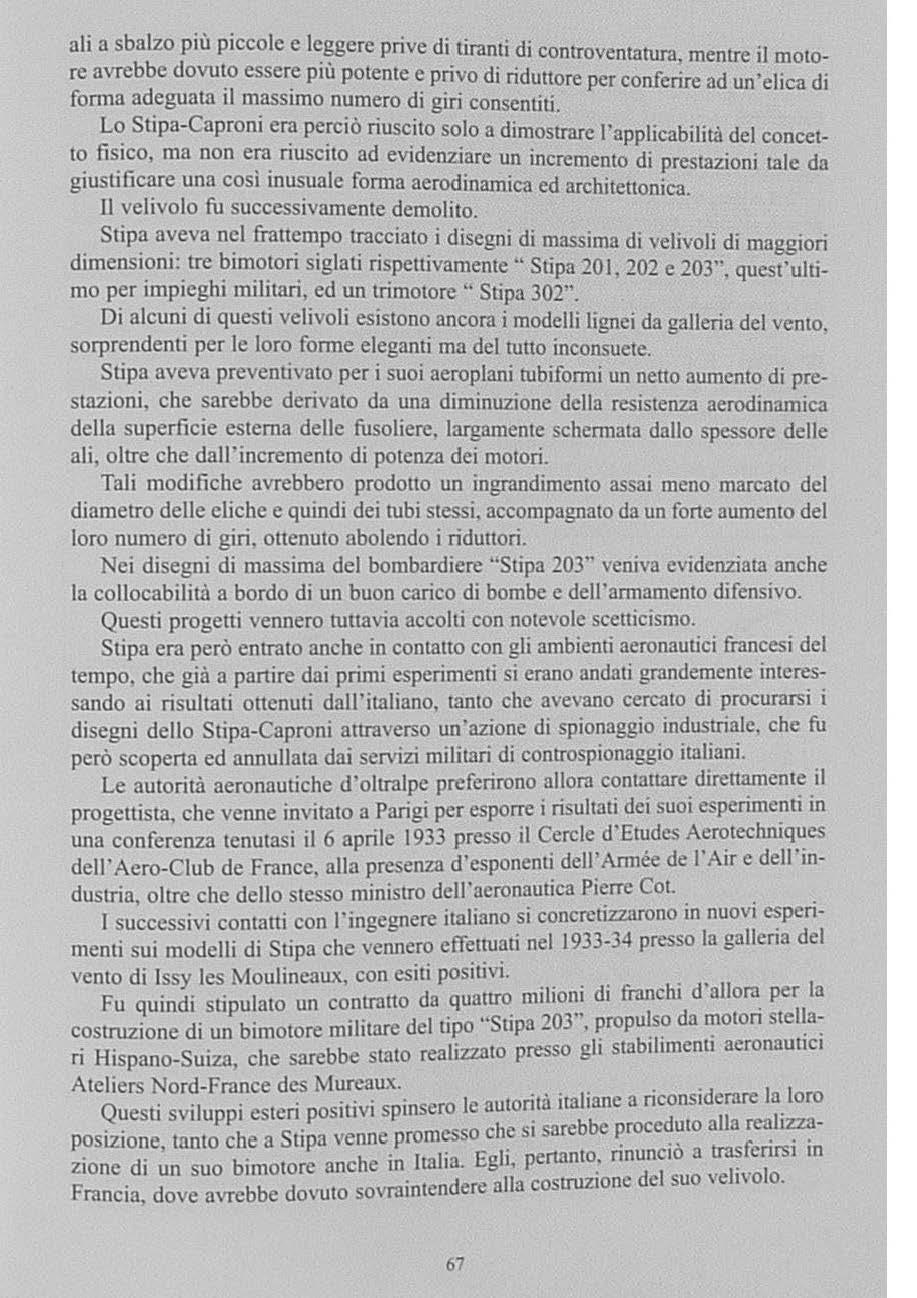
ali a sbalzo più piccole e leggere prive di tiranti di controventatura ·1 bb d .. . mentre I motore avre e ovu~o esser~ piu poteme e privo di riduttore per conferire ad un'elica di fonna adeguata ti massimo numero di giri consentiti.
L~ Stipa-Caproni e~ pe'.ciò riuscito solo a dimostrare l'applicabilità del concett~ fi~1co, ma non e~. nusc!lo ad evidenziare un incremento di prestazioni tale do g1ust1fi~re una cosi 1n~uale forma aerodinamica ed architettonica. li velivolo fu successivamente demolito.
. Stipa a~eva n71 fran~~po ':3<:ciato i disegni di massima di velivoli di maggion d1mens1~ru:_tre ?1m_o.1on. s1glau n~pettivameme" Stipa 201. 202 e 203··. quest'ultimo per 1mp1egh1 mthtan, ed un lnmotore .. Stipa 302".
Di alcun! di questi velivoli esistono ancora i modelli lignei da galleria del vemo. sorprendenu per le loro forme eleganti ma del ruuo inconsuete.
Stipa aveva prevenuvato per i suoi aeroplani tubiformi un netto aumento di prestazioni, che sarebbe derivato da una diminuzione della resistenza aerodinamjca della superficie esterna delle fusoliere. largamente schermata daJlo spessore delle ali, oltre che datrincremento di potenza dei motori.
Tali modifiche avrebbero prodotto un ingrandimento assai meno marcato del diametro delle eliche e quindi dei tubi stessi. accompagnato da un forte aumento del loro numero di giri. ottenuto abolendo i riduttori.
Nei disegm di massima del bombardiere "Stipa 203~ vemva evidenziata anche la collocabilìtà a bordo di un buon carico di bombe e dell'armamento difensivo.
Questi progetti vennero ruuavm accolti con notevole scenic1smo.
Stipa era però entrato anche in contatto con gh ambienti aeronautici francesi del tempo, che già a panire dai primi esperimenti si erano andati grandemente interessando ai risultati ottenuti dall'italiano, mn10 che ave,ano cercato di procurarsi i disegni dello Stipa-Caproni atrraverso un'azione di spionaggio industriale. che fu però scopena ed annullata dai servizi militari di controspionaggio italiani.
Le autorità aeronautiche d'oltralpe preferirono allora contattare d1renamenre il progettista. che venne invitato a Parigi per esporre I risultati dei suoi esperimenti IO una conferenza tenutasi il 6 aprile 1933 presso il Cercle d'Etudes Aerotechniques dell'Aero-Club de France. alla presenza d'esponenti dell'Année de l'Air e dell'industria olrre che dello stesso ministro dell'aeronautica Pierre Cot.
I su~cessivi contani con l'ingegnere italiano si concretizzarono in nuovi ~perimenti sui modelli di Stipa che vennero effettuati nel 1933-34 presso la galleria del vento di lssy Jes Moulineaux, con esiti positivi.
Fu quindi stipulato un contratto da quattro milioni di franchJ d'allora_per In costruzione di un bimotore militare del tipo "Stipa 203". propu~s~ da moton stel~a: ri Hispano-Suiza, che sarebbe stato realizzato presso glt stab1hmenu aeronaunc1
Atehers Nord-France des Murcaux. . . . . . 'd 1 L Questi sviluppi esteri positivi spinsero Je autonta italiane a nconst erare n _ oro . . S . C''"'O che 51 ""rebbe proceduto alla reaJ1zzn- pos1z.10ne. tanto che a upa \'enne prom - .,u • • 1· E 1· ertan10 nnunc10 a trasfenrs1 IO z1onc di un suo bimotore anche m lta aa. g 1• P · r 1 Francia, dove avrebbe dovuto so\'raintcnderc alla cosuuziooe del suo ve ivo o.
67
Le \iccnde successi,·epresero però pèr I"itnliano una piega compleiamcnte sfavorevole. poiché mentre m Italia i suoi progetti seguiiavano ad incontrare una scarsa considerozionc. in Fmncia. a partire dal 1936. l'industria aeronauuca venne nazionalizzata.
Tutta In parte produtuva passo in mani pubbliche. mentre la costruzione dei prototipi sperimentali venne lasciata aJl'iniziauva dei singoli costrullori privati.
La costruzione del velivolo bimotore presso gli Ateliers dcs Mureaux non ebbe perc10 seguito, malgrado fossero gi:i state complelah! le ali. poiché i proprietari dell'azienda. confluita nella SNCA1 (Societé · ationale de Costructions Aéronauuque du Nord) guidata da Henri Potez. rifiutarono di proseguire un 'attività an11economica legata aUa solo sperimentazione dei pro1011p1.
L'at1ivita tecnico-scientifica d1 S11pn prosegui ancora per qualche anno con l'ìde-azronc e la progettazione di un pulsoreanore a quallro camere di combustione avente come 011ura1ore frontale le pale di un'elica, che venne brevenato in diversi paesi. Germania compresa
Sopa non era a conoscenza dei breve11i e dei lavori già svolti a parure dal 1930 in Gennama su questo stesso 1ipo di propulsore, tanlo da ritenere che egli stesso ne fosse uno dei primissimi se non il pnmo realizzatore.
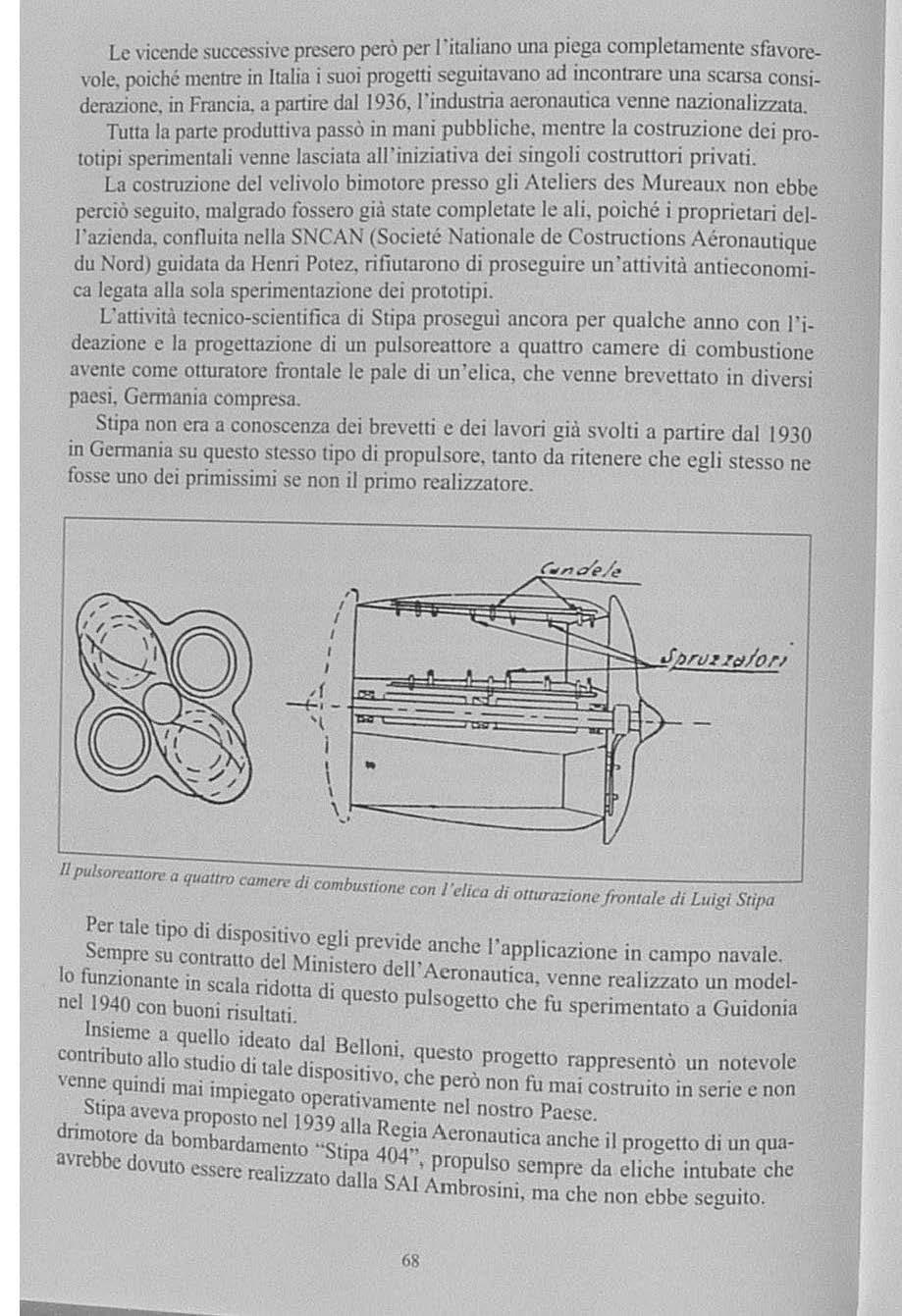
Il pul.1on,a11ar,• a q1101tro camcr,• di <:omb • ILHiont! con I cl,ca di 01111ra=io11,;:froma/e di Luigi Stipa
Per tale tipo di dispositivo egli r v.d . , . .
Sempre su comrauo del Minist!oe 1 anche I a_pphcaz1one in campo navale. lo funzionante in scala ridot d dcli Acronauuca. "enne realizzato un modelnel 19~0 con buoni risultatr.ta , questo pulsogetto che fu sperimentato a Guidonia
Insieme a quello ideato dal Bello . contributo allo studio di tale d' .. m. quest0. progetto rappresentò un notevole venne quindi mai rmp,cgaio 01spo:1.'1 \ 0 · che pero non fu mai costruito in sene e non
S1ipa aveva proposto nel 19j;ra1:Vame~te nel nostro Paese. dnmo1ore da bombardam "Sa a Regia Aeronautica anche il progeno d1 un quab emo ltpa 404'' I avre be dovuto essere reali'zza d 11 • propu so sempre da eliche intubate che IO a a SAI A b · · m rosin,, ma che non ebbe segui10.
/ 1 I I 'I ,( --+-•'l i I I\ t-.=------.....t__,,
68
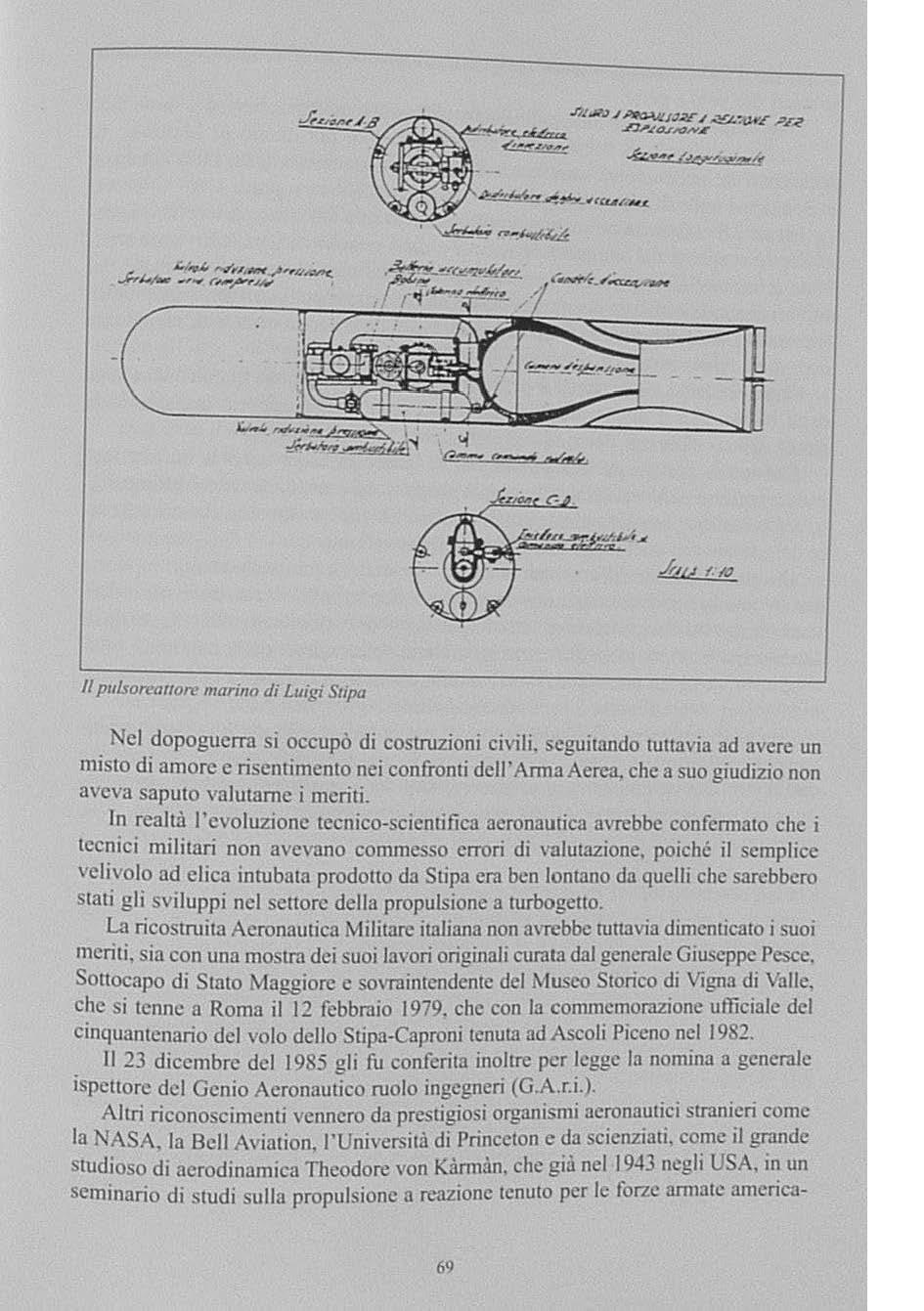
Il pulsoreauon marina di luigi Stipa
. Nel dopoguerra si occupò di costruzioni civili. seguitando tu11av1a ad avere un m1S10 di amore e risentimento nei confronti dcli'Anna Aerea. che a suo giudizio non aveva saputo valutarne i meriu.
In realtà l'evoluzione tecnico-scientifica aeronaurica avrebbe conferma10 che i tecnici mili1ari non avevano commesso errori d1 valu1azione. poiché il semplice velivolo ad elica intubala prodouo da Stipa era ben lontano da quelli che san:bbero s1a1, gli sviluppi nel senorc della propulsione a turbogetto.
La ricostruita Aeronautica Militare imliana non avrebbe ruttavia dimenticato I suoi meriti. sia con una mostra dei suoi la\'orì onginalr curata dal generale Giuseppe Pesce. Sonocapo di Stato Maggiore e sovraintendente del Musco S10rico di Vigna di Valle. che si tenne a Roma il 12 febbraio 1979. che con la cornmcmornzìonc ufficiale del cinquantenario del volo dello Stipa-Caproni tenuta ad Ascoli Piceno nel 1982.
Il 23 dicembre del J985 gli fu conferita inoltre per h!gge In nomma a generale ispettore del Genio Aeronautico ruolo ingegneri (G.A.r.i.).
Altri riconoscimenti vennero da prestigiosi organismi acronau1ici stranieri come la NASA. la Beli A\'iation. l'Università dì Princeton e da scienziati. come il gr,mde studioso dr aerodinamica Thcodore von Kànnàn. che già nel 19-B negli USA, m un semmano di studi sulla propulsione a reazione 1cnuto per le forze annmc amcnca-
69

1e 1-r:
• lnstitute ofTechnology. lo aveva definito uno dei primissimi ne presso I a 11orma pionieri del volo a getto. . . . ., Luigi S1ipa scomparYe ad Ascoh Piceno _1,1 9 gennaio 199_, h -1 . 1· ·olo di Stipa. come era g1a accaduto per quello d1 Matuoni, fu Anc e 1 ,e 1, . . . . · d' • 1· · b h. · dn' ·u· come un semplice tentaU\'O d1 uuhzzaz1one I un e 1ca mtu ata, are 1v1ato I p1 . e cioè come nulla di realmente attinente con l_a propulsione a getto. . . _
In realtà un motore a turbogetto non è cost1tu1to solo _dalle su_e parti _rotanti interconnesse costituite dal compressore rotante e dalla relauva turbina, cui vanno sommate le camere di combustione e l'eventuale postbruciatore. ma è fatto anche dal suo involucro contenitore che è esso stesso un organo propulsore avente un preciso andamento delle sue sezioni interne, mediante il quale risulta capace di creare una opportuna spinta in avanti.
Come abbiamo visto, questi aspeni furono attentamente presi in considerazione dagli italiani ed i risultati ottenuti costiruirono anch'essi un appono decisivo sulla strada della costruZione del moderno turbogeno.
Occorre in panicolare sonolineare che il lavoro di Stipa costituì un ulteriore influente passo nella na runa italiana alla propulsione a gel1o, che avrebbe seguitato a commettere il sostanziale errore di fondere insieme la carcassa esterna tubolare del motore con quella dell'intera fusoliera del velivolo.
Questa coincidenza d"in\'olucri metallici contenitori, pur consentendo in teoria una owia ed imponante riduzione di peso. avrebbe in realtà creato notevoli inconvenienti riguardanti l'intera architettura costruttiva dei velivoli considerati. sui quali sarebbe risultata particolarmente difficile sia la collocazione della cabina di pilotaggio che quella di un e\'entuale carico utile, finendo in definitiva con l'accrescere gli stessi valori di peso che s'intendevano ridurre.
Anche il ~ndimento fluidodinamico del motore a geno ne sarebbe stato negativ~en~e COO?IZIOOato a causa della maggiore lunghezza dei condolli di aspirazione de~I an~ e d1 _e1ez1one dei gas di scarico, rispetto a quelli realizzabili adottando un unna motnce separata disposta in un involucro apposito di minor volume.
70
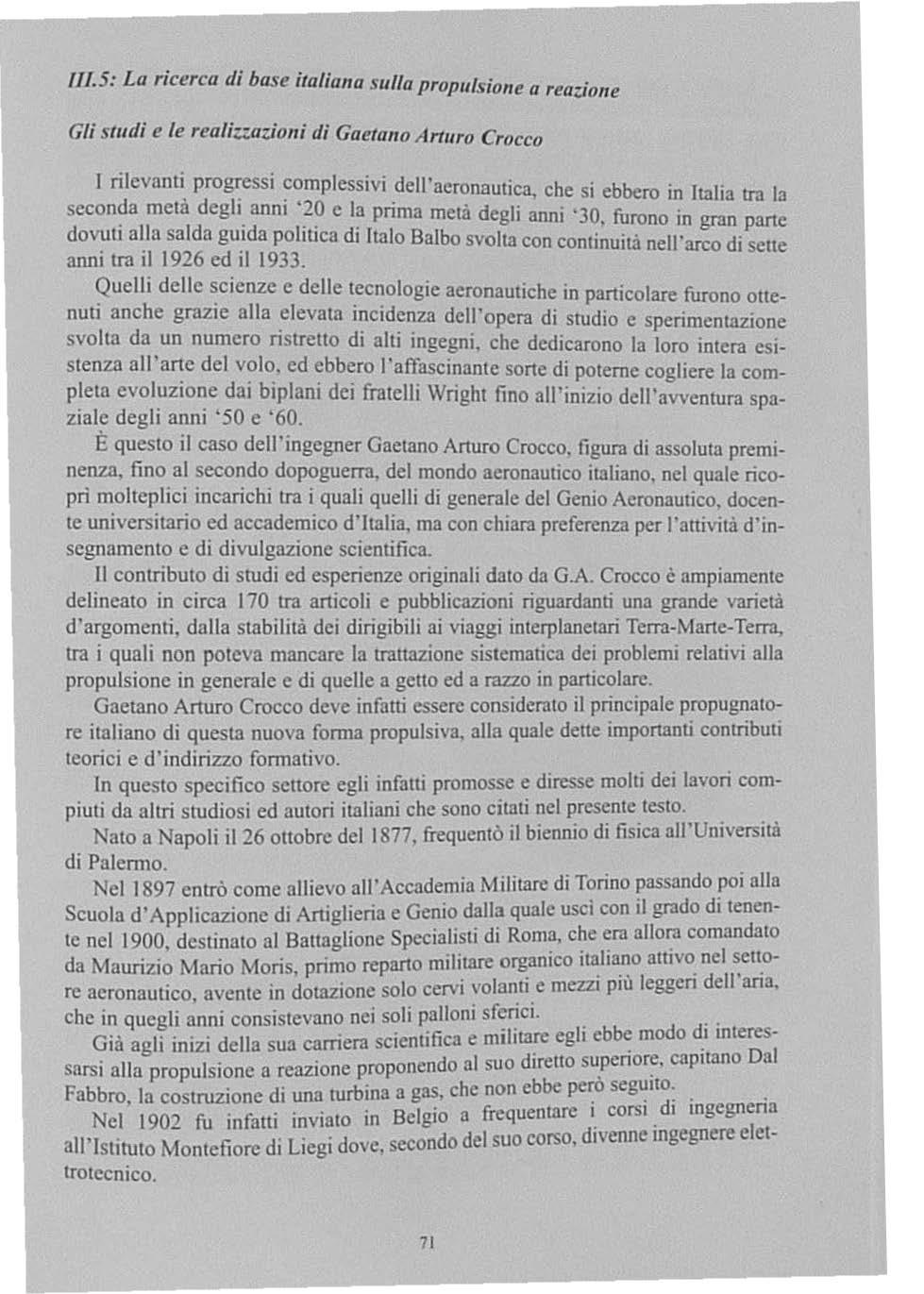
/11. 5 : La ricerca di base italiana s ulla propulsione a reazione
Gli s tudi e l e reali~a;Jo11i di
Gaetano Anuro Croceo
I rilc, anll_ progressi ~omplesm i dell'aeronautica, che si ebbero in Italia tra la seconda meta deglt an01 -~o e I? prima metà degh anni ·30, furono m gran pane do\'Ull alla salda guida poltuca d1 Italo Balbo svolta con continuita nell'arco d 11 anm tra il 1926 ed il 1933. 1 se e
Quelli delle ~cienze e delle tecnologie aeronauttche m particolare furono ottenun anche grazie alla elevata incidenza dell'opera di srudio e spenmentaztone svolta da un numero nstretto di alti mgegm. che dedicarono la foro intera esistenza all'a~e del volo. ed ebbero l'alTascmante sorte di poterne cogliere la completa evoluzione da, btplam de, fratelli Wngbt fino all'm1z10 dell'avventura spaziale degli anni ·so e ·60
È questo il caso dell'ingegner Gaetano Arturo Croceo. figura di assoluta prem1nerv.a. fino al secondo dopoguerra, del mondo aeronauuco naliano. nel quale ricopri moltepltc1 incarichi tra i quali quelli di generale del Gemo Aeronauttco. docente universitario ed accademico d'Italia, ma con chiara preferenza per !'atti,ità d'insegnamento e di divulgazione scientifica.
Il contributo di studi ed esperienze originali dato da G.A. Croceo è ampiamente delineato in circa 170 tra articoli e pubblicazioni riguardano una grande varietà d'argomenti, della stabilità dei dirigibili ai viaggi interplanetari Terra-Marte-Terra. tra i quali non poteva mancare la trattazione sistematica dei problemi relarin alla propulsione in generale e di quelle a getto ed a razzo in parucolare
Gaetano Arturo Croceo deve infatti essere considerato il principale propugnatore italiano di questa nuova forma propulsiva. alle quale dette importanti contributt teonc1 e d'indirizzo fonnali\'O.
ln questo specifico scnorc egh infotu promosse e diresse molli dei lavon compiuti da altri studiosi ed autori italiani che sono citati nel presente testo.
Nato a Napoli il 26 ottobre del 1877, frequentò il biennio di fisica all'Univers11à di Palenno
Nel I897 entrò come allievo ali'Accademia Milìtare di Torino passando poi alla Scuola d'Applicazione di Artiglieria e Genio dalla quale uscì con ìl grado d1 tenente nel 1900, destinato al Battaglione Specialisti di Roma. che era allora comandato da Maurizio Mario Moris. primo reparto militare organico 1taha_~o atuvo_ nel ~ett_ore aeronautico. avente in docazione solo cervi volanti e mezzi pm leggen dell ana. che m quegli anni consistevano nei soli palloni sf:ric1. _ . . .
G.. 1· · · · d Il carne"' ·c1·ent1·aca e m1htare egh ebbe modo d1 mteres- 1a ag I m1z1 e a sua ,.. :. . . . snrs1 alla propulsione a reazione proponendo al suo diretto su.penor~. capnano Dal Fabbro. la costruzione di una tUrbino a gas, che non ebbe pero seg~uo'. 0
Nel I902 fu infatti inviato in Belgio a frequentare 1 _ corsi di mgegnen all'Istttuto Montefiore d1 Liegi do\'e, secondo del suo corso. divenne mgegnere elet1.rotecnico.
71
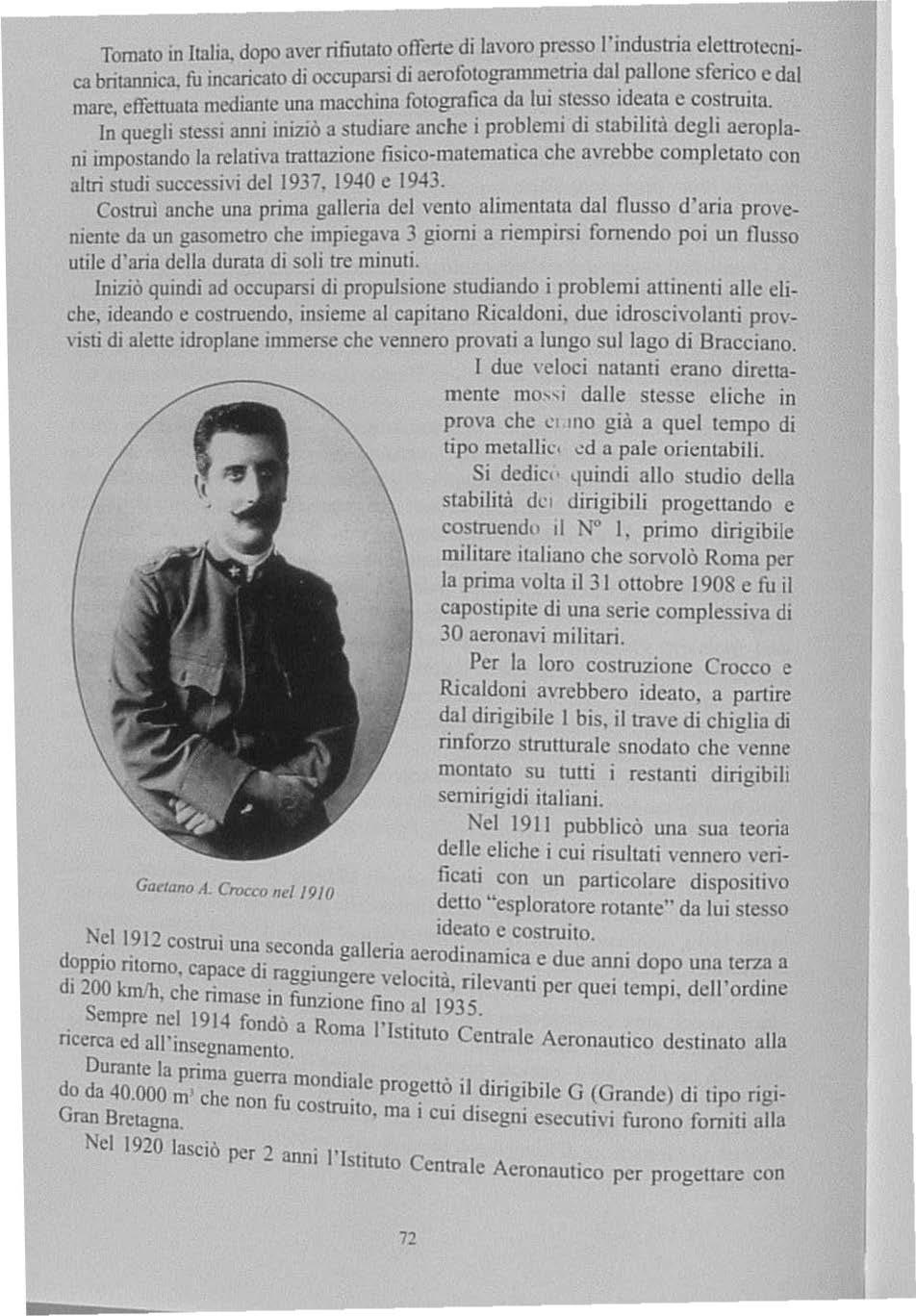
Tornato m Italia. dopo :m.:r rifiutato offone di la,oro presso l'industria clcrtrotccnica britannica. fu incaricato di occuparsi di aerofotogrammetria dal pallone sferico e dal mare. effettuata mediante una macchina fotografica dn lui stesso ideata e costruita.
In quegli stessi anni iniziò a studiare anche i problemi di stabilità degli aeroplani impostando la relativa a:anazionc fisico-matcmnuca che aHebbc completato con altri studi successi,i del 1937. I 940 e 1943.
Costruì anche una prima galleria del vento alimentata dal nusso d'aria prove. niente da un gasometro che impiega\'a 3 giorni a ricmpin;i fornendo poi un flusso utile d'aria della durata di soli tre minuti.
iniziò quindi ad occuparsi di propulsione studiando i problemi a1tinenti alle eliche, ideando e costruendo, insieme al capitano Ricaldoni. due idrosci"olanti prov. ,1sti di aletti! idroplane immerse che vennero pro,·ati a lungo sul lago di Bracciano.
I due ,·eloci natanti erano diretta• mente mo"' dalle stesse eliche in prova che · 1110 già a quel tempo di tipo metallil·• -:d a pale oricmabili.
Si dcdic, quindi allo studio della stabilità dl', dirigibili progettando e costruend11 il N° I. primo dirigibile militare italiano che sorvolò Roma per la prima volta il 31 ottobre 1908 e fu il capostipite di una serie complessiva di 30 aeronavi militari.
Per la loro costruzione Croceo e Rical_d~ni avrebbero ideato. a partire dal dmg1b1le I bis, il tra\'e di chiglia di rinforzo strutturale snodato che venne montato su tutti i restanti dirigibili semirigidi italiani.
'-lei 1911 pubblicò una sua teoria delle eliche i cui risultati vennero veri•
Gaetana ,1 Croceo nd 1910 ficati con un particolare dispositirn dello "esploratore rotante'' da lui stesso ~el 19I2 cos1rui una seconda alleria ide_ato e costruito. doppio ritorno. capace di ra iunge , acr~dinamica e due anni dopo una ter,a a d1 200 km1b, che rimase· ggfu . g re ,elocna. nle,ant1 per quei tempi. dell'ordine
S ID nz1one fino al 193 5 . empre nel 19 I 4 fondò a Roma l'I . . . ncerca ed all'insegnamento.
stlluto Centrale Acronauuco destinato alla
Durante la p · d da nma guerra mondiale prog 'li. I d' 0 40.000 m che non fu e O I mg1b1le G (Grande) di tipo rigi• Grnn Bretagna. cos1ru1to. ma I cui disegni esecutivi furono forniti alla
Nel 1920 lasciò per '> ann· 1.1 .1 Slltuto Centrai A . e eronauuco per progettare con
72
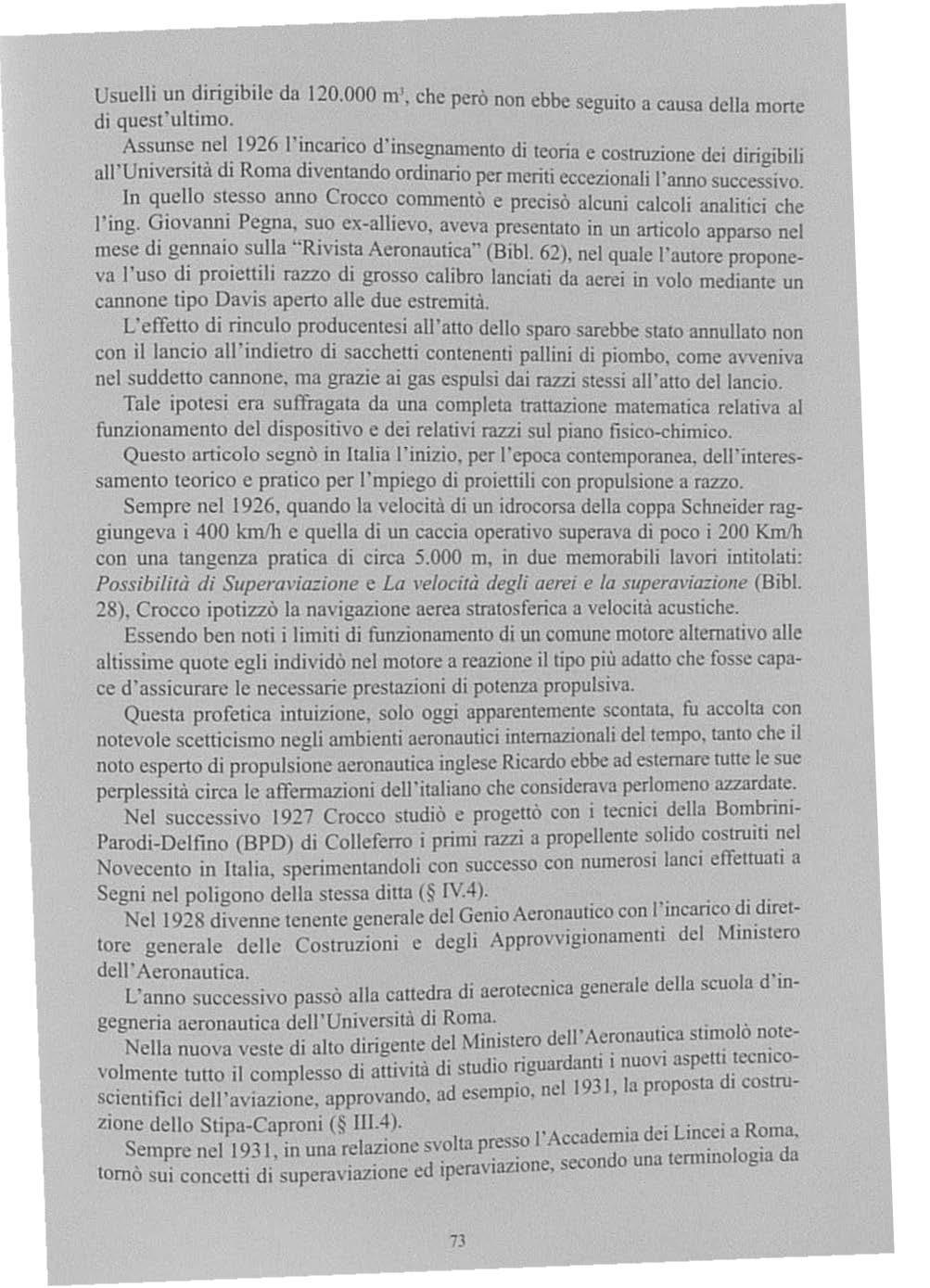
Usuclli ~n dirigibile da 120.000 m'. che però non ebbe seguito a causa della mone d1 quest ulumo.
Assunse nel 1926 l'incarico d·insegnamento di teoria e costruzione d · d' · ·b·1· • · · · d' R • . . e1 mg1 11 ali Univers1ta I orna diventando ordmano per meriti eccezionali l'anno successivo. In quello st_esso anno Croceo commentò e precisò alcuni calcoli analitici che l'ing. Giovann_i Pegna. s~o- ex-allievo. aveva presentato in un anicolo apparso nel mes~ d1 gc_nnat~ sulla '"R1v1s~ Aeronauti_ca" (Bibl. 62}. nel quale l'autore proponeva I uso d1 pro1ett1h razzo d1 grosso calibro lanciati da aerei in volo mi:diante un cannone tipo Oavis aperto alle due estremità.
L'effetto di rinculo producentesi all'ano dello sparo ·arebbe stato annullato non con il lancio all'indietro di sacchetti contenenti pallini di piombo. come avveniva nel suddetto cannone. ma grazie ai gas espulsi dai razzi stessi all'ano del lancio.
Tale ipotesi era suffragata da una completa trattazione matematica relativa al funzionamento del dispositivo e dei relati\"i razzi sul piano fisico-chimico.
Questo anicolo segnò in Italia l'inizio. per l'epoca contemporanea. dell'interessamento teorico e pratico per l'mpiego di proienili con propulsione a razzo.
Sempre nel 1926. quando la velocità di un idrocorsa della coppa Schncider raggiungeva i 400 km11 e quella di un caccia operati\'O supera\ a di poco i 200 Km/h con una tangenza pratica di circa 5.000 m, in due memorabili lavori intitolau: Possibilità di Supermùi=ione e La , ·elocità degli aerei e la s11pera1·iti=io11e (Bibl. 28}. Croceo ipotizzò la na, igazione aerea stratosferica a velocità acustiche.
Essendo ben noti i limiti di funzionamento di un comune motore ahcmati,o alle altissime quote egli individò nd motore a reazione il tipo più adano che fo·sc capace d·assicu.rarc le necessarie prestazioni di potenza propulsiva.
Questa profetica intuizione. solo oggi apparentemente scontata. fu accolta con notevole scetticismo negli ambienti aeronautici internazionali del tempo. tanto che il noto espeno di propulsi~ne aeronouùca inglese Ricardo ebbe ad esternare rune le sue perplessità circa le affermazioni deU·italiano che considera, a perlomc.:no azzardate.
Nel successivo 1927 Croceo studiò e progenò con i tecnici della Bombnm• Parodi-Delfino (BPD} di Colleferro i primi razzi a propellente solido cosl1lliti nel No\'ccento in Italia, sperimentandoli con successo con numerosi lanci effettuali a Segni nel poligono della stessa ditta(§ f\A}.
Nel 1928 divenne tenente generale del Genio Aeronauuco con Imcanco di diret• tore generale delle Costruzioni e degh Appronigionnmenu del Mm•5tero dell'Aeronautica. . 1 d 11 . I d.in L'anno successi,·o passò allo cattedra di aerotecnica gemmi e e 8 l>CUO a · gegneria aeronautica dell'Università di Roma. . . 1• t . . d 1, 1- · t ddl'Ac.:ronauuca sumo o no e- Nella nuova veste di alto dmgcnte e . m1s ero . . . . - d. d. · rdantt I nuo,·1 aspetti tecnico• volmente tuno il complesso d1 attinta I stu 10 ngua . . d , · ·I 1931 la proposta d1 costru· scientifici dell'a\'1azionc. approvando. a 1.-s1:mpio. m: · zione dello Stipa-Caproni(§ IIIA). . d · de·• Li·ncei a Roma. • lt pres ·o I .\cca ernia Sempre nel 1931. in una relazione sv_o a . s · . d una t•nninologin da • d 1..,. a, 1o.z1one ~econ o 1: tomo sui concettt d1 supera, 1az1one e r" · ·
7..l
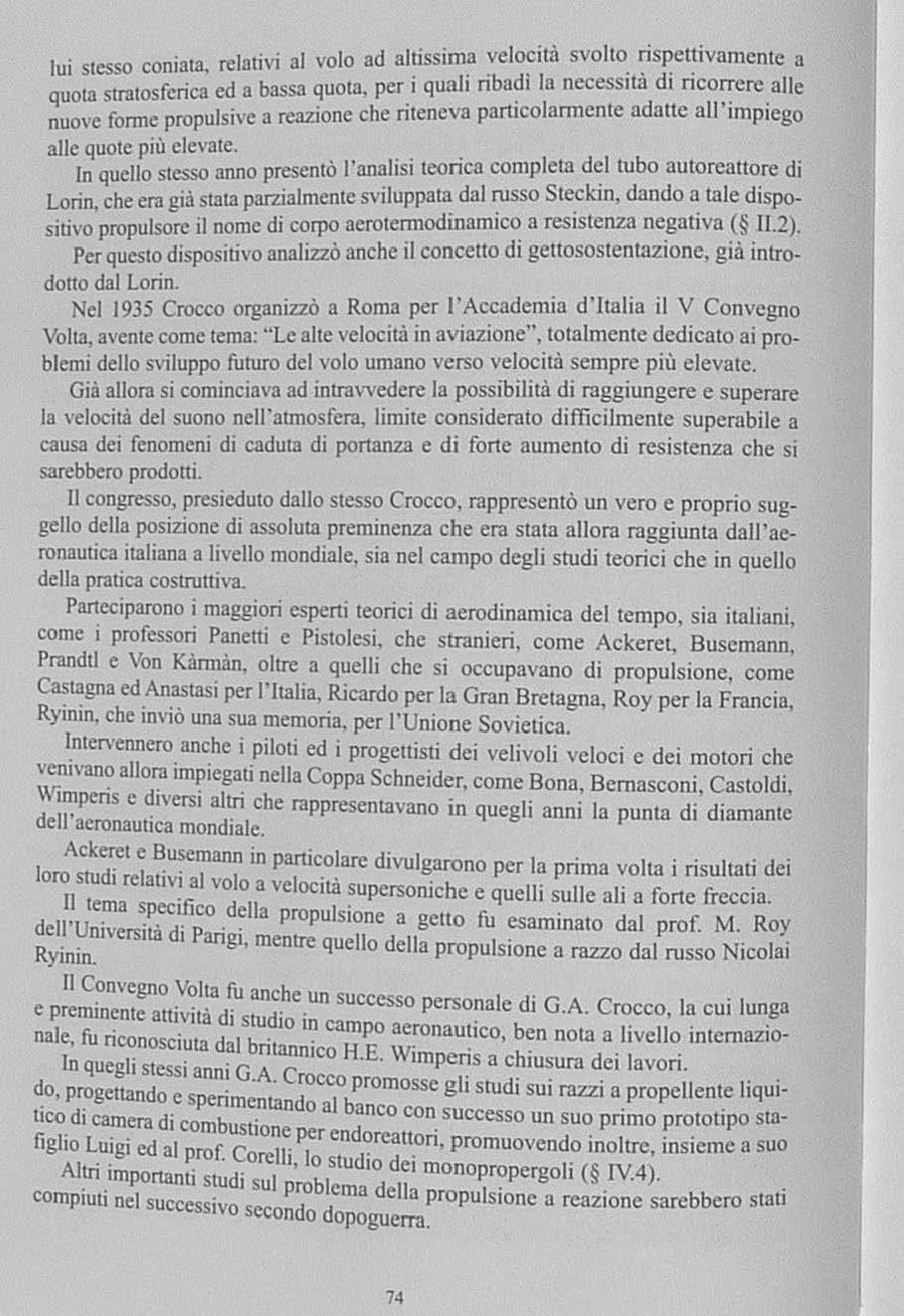
. . · , I volo ad altissima velocità svolto rispettivamente a lui stesso coni~ta. redlatlb\ 1 a quota per i quali ribadì la necessità di ricorrere alle ota strntosfenca e a assa ' . d 11 '. . qu 1 • . ·one che riteneva part1colannente a alle a unp1ego nuove fon11e propu s1, e a reazi alle quote più eJe,·ate. . esentò l'analisi teorica completa del t:ubo autoreattore d1
In quello stesso anno pr . .
• · • ta parzialmente sviluppata dal russo Steckin. dando a tale d1spo- Lonn, che era gm sta . . · · (§ II ") · · I ·1 nome di corpo acro1ermodmam1co a resistenza negativa ·. s1t1vo propu sore 1 • •••
Per questo dispositivo analizzò anche il concetto d1 gettosostenta.z1one, g,a mlrodotto dal Lorin. . • · ·1 V C
Nel 1935 Croceo organizzò a Roma per l'Accadenua d Italia 1 . on~egno Volta, avenae come tema: "Le alte velocità in aviazione",_t?talmente ~7d1ca10 a1 problemi dello sviluppo futuro del volo umano verso ,:e~o~~ta semp~e ptu elevate.
Già allora si cominciava ad intravvedere la poss1b1hta d1 raggiungere e superare la velocità del suono nelratmosfera. limite considerato difficilmente superabi le a causa dei fenomeni d1 caduta di portanza e di forte aumento di resistenza che si sarebbero prodoui.
li congresso, presieduto dallo stesso Croceo. rappresentò un vero e proprio suggello della posizione di assoluta preminenza che era stata allora raggiunta dall'aeronautica italiana a livello mondiale, sia nel campo degli st:udi teorici che in quello della pratica costruttiva.
Parteciparono I maggion esperti teorici di aerodinamica del tempo, sia italiani, come I professori Panetti e Pistolesi, che stranieri, come Ackeret, Buscmann. PrandU e Von Kànnàn, oltre a quelli che si occupavano di propu lsione, come Castagna ed AnastaSi per J' ltalta, R.icardo per la Gran Bretagna, Roy per la Francia. Ryinin, che Ìn\'iò una sua memoria, per l'Unione Sovietica.
Intervennero anche i piloti ed I progeuisti dei velivoli veloci e dei motori che venivano allora impiegati nella Coppa Schneider, come Bona. Bcrnasconi, Castoldi, Wimperis e diversi altri che rappresentavano in quegli anni la punta di diamante dell'aeronautica mondiale.
Ackei:et e ~~emano in panicolare divulgarono per la prima volta i risultati dei loro studi rela11': al volo a velocità supersonkhe e quelli sulle ali a forte freccia. e tema ~.ec 1 ~co _d~lla propulsione a getto fu esaminato dal prof. M. Roy d n~mversua di Pangi, mentre quello della propulsione a razzo dal russo Nicolai Ry10m.
Il C~nvegno Volta fu anche un successo personale di G.A. Croceo la cui lunga e prenunente · · · d. di · ' . anivua I stu o m campo aeronautico ben nota a livello internazionale, fu nconosci~ta dal britannico H.E. Wimperis a 'chiusura dei lavori. d In quegli stessi anni G.A. Croceo promosse gli st:udi sui razzi a propellente liquio. progettando e sperime ,...~d I b . . • d. . n...,, 0 a anco con successo un suo pnmo prototipo sta- uco I camera d1 comb f . figlio Lui i ed I us lOn~ per end~reatton. promuovendo inoltre, insieme a suo Al ..g a prof. ~orelh, lo studio dei monopropergoli (§ TV.4). tn 1mportanu studi sul p bi d 11 . . · com · · 1 . ro eme e a propulsione a reazione sarebbero stau p1uu ne successivo secondo dopoguerra.
74
Nel giugno 195 l avrebbe fondato l'Associazione Italiana Razzi (AIR) dando un forte contributo teorico e d'indirizzo ai primi studi italiani in campo spaziale, fornendo ad esempio una descrizione scientifica dettagliata e completa di un viaggio interplanetario Terra-Mane-Terra ancora largamente attuale.
Gaetano Arturo Croceo scomparve a Roma il 19 gennaio 1968.
Anche Lu1g1 Croceo, figlio di Gaetano Arturo. nato a Palermo nel 1909, avrebbe seguito le orme paterne lavorando nel campo della propulsione a reazione sia durante la guerra che nell'immediato dopoguerra. mettendo a punto la teoria del turboreattore a doppio flusso.
Successivamente si recò negli Stan Uniti dove fu docente all'Università di Princeton arrivando ad essere uno dei consulenti del progetto Apollo che avrebbe portato l'uomo sulla Luna.
Tra le due guerre mondaa\J altri importanti studi teorici e dt laboratorio dt carattere fluidodinamico e tennodinamico relativi alla propulsione a reazione furono fatti da docenti universitari italiani dt grande livello, tra I quali vanno annoverati Antonio Capetti, Arnaldo Castagna, Enrico PistolesL Modesto Panetti ed altri.

Gat'tano A. Cro<XO, alla Jint' Jt'l{li anni ·so. =nrrc mostra al giornalista CcstuP. Fakssì un model/mo d1 missilt· spa:iale concctrual,.,ertt< simile all'auualc Spaix S/rulllc
15
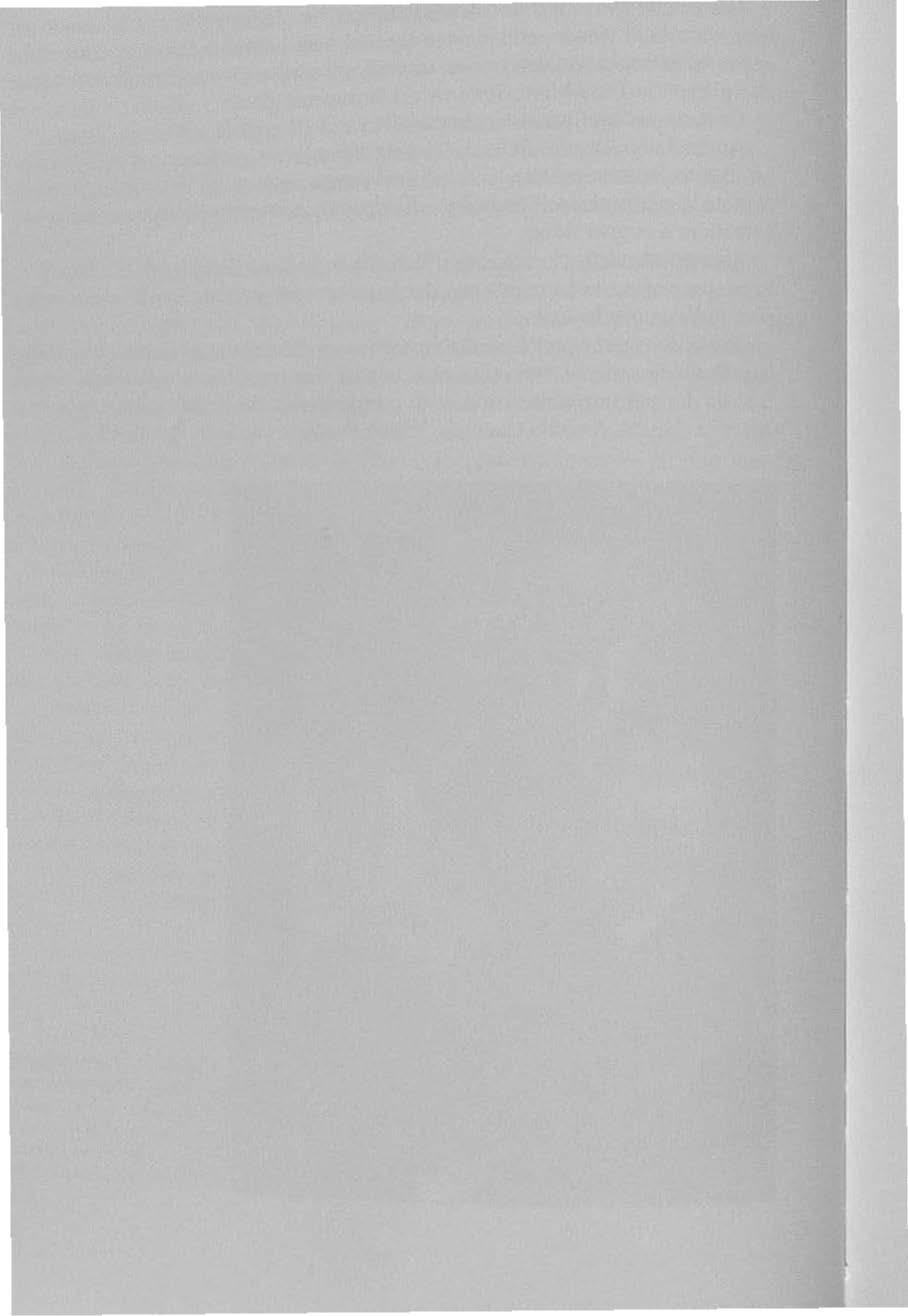
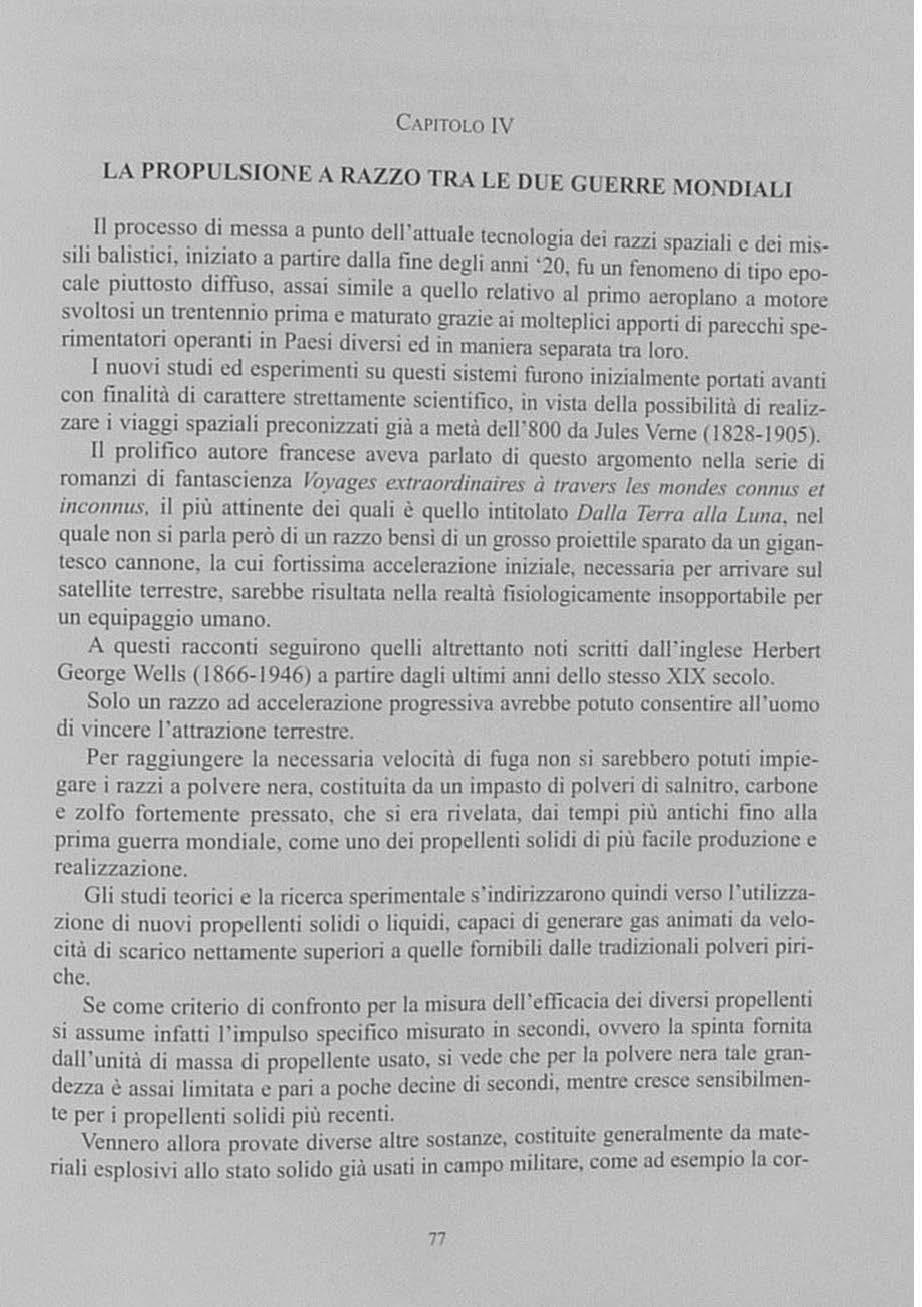
C.\PITOLO I V
LA PRO PULS IO NE A RAZZO TRA LE DUE GUE RRE MO l'\ DIALJ
. 11 processo di messa a punto dell'attuale tecnologin dei mzz, spaziali e dei missili bal1sl1c1. 101zrato a pani~e dalla fine degh anni ·20. fu un fenomeno di tipo epocale p1ullosto diffuso. assai s1mtlc a qul!llo rclau,·o al pnmo aeroplano a motore svohos1 un trentenmo pnma e maturato grazie a1 molteplici apponi di parecchi spcrimcntaton operanti m Paesi diversi t:d tn mantcm separata tra loro.
I nuo, i studi cd cspcnmenti su quesu s1stcm1 furono inizialmente portati avanti con finalità d1 camuere strettamente sc1en111ico. in, 1s1a della possibilità d1 realizzare i viaggi spaziali precomzza11 g1à a metà dcli '800 da Jules Vemt: ( 1828-1905).
Il prolifico autore francese aveva parlato d1 questo argomt:nto nella serie di romanzi di fantasc1cn1a 10\'ages errraorrimam:s a rrm·ers Ics momles cmmus er 111co1111w•• il più attinente dei quah è quello intitolato Dulia Terra alla Luna. nel quale non si parla però d1 un razzo bensì di un grosso proiettile sparato da un gigantesco cannone. la cui fortissima accelerazione m121ale. acccssana per arrivare sul satellite terrestre. sarebbe risultata nella realtà lìs1olog1camente msopponabile per un equipaggio umano.
A quesu racconti seguirono quelli altrenanto noti scritti daJrmglcsc llerben Gcorge Wells ( 1866-1946) a partire dagli ull1m1 anni dello stesso XIX secolo
Solo un razzo acJ accelerazione progrc ·s1,a a,Tl!bbc potuto consentire all'uomo d1, incerl.l l'attrazione terrestre
Per raggiungere la necessaria velocità di fuga non s1 sarebbero ~Olutl 1mp1egare I razzi a polvere nera. cosltluita dn un impasto d1 polveri d1 sulnttro. carbone e zolfo fortemente pressato, che s1 era n \'ela1a, dai tempi più amichi fino alla pnma guerra mondiak. come uno dei propellenti sohd1 d1 pm facile produzione e reahzzaz1onc.
Gli studi teorici e la ricerca sperimentale s'indinzzarono quindi verso l'utilizzazione di nuovi propellenti solidi o liquidi. capaci dì generare gas ammali da velocua di scarico nettamente supenon 8 quelle lòmibih dalle trad1z1onah polven pmche.
Se come criterio di confronto per la misura dell'efficacia dei d1vers1 propellenu · · · ·fi · t ·n · •condi· ovvero la spm1a fomua s1 assume mfott1 l'impulso spec1 1co misuro o I se • d 11 · Il t ·1 · ,·cdc che per In polvere nero 1.ale gmn- a 'uni1a d1 massa d1 prope ente usa o, s . I d · , d ·•condi mentre cresce sens1b1lmcn- dezza è assai hm1tma c pan a poc 1e cc1m: 1se • te per I propellenu solidi più rccenu. . , _. . • cm:ralmcnte da mateVennero allora pro, aie di, erse alire sostanze. cost1rut1c g . _ 1 ·· · . militare come ad esempio o cor- riah esplosn, allo stato solido g10 usau in c,impo •
77

· . . · te composizioni granulometriche e fonnature che si dite. adonando per essi s, ana rivelarono di buona efficacia . . . . I . "fì . . 11 - 1·d· erano ruttovia incapaci d1 fonure 1mpu s1 spcc1 1c1con-
Quesu prope enti so 1 1 . . 1- ·d· h
• 11· · ltanii· della combustione d1 propergoh 1qu1 1, c e possono frontab1h con que I nsu . . . . I d" .d . · d'i alcune cen1inrua d1 secondi per la m1sce a 11 rogeno raggmngere un massimo ed ossigeno liquidi. . . .
Anche la propulsione basata su gran_i di propellente solido fu qumd1 presto accantonata per l'ipo1izza10 impiego spaziale, mentre sarebbe stata mantenuta per I proiettili-razzo impiegai! nel s~.tto~ militare. che a, rebbero conoscmto un nuovo note\'olissimo s,iluppo poco p1u d1 un decennto dopo. quando_vennero largamente usati in comba11imen1o da sovietici, tedeschi. inglesi ed amencam nel corso della seconda guerra mondiale
L'attenzione degli sperimentatori civili interessati al settore dell'esplorazione dello spazio extraterrestre si spostò invece su alcuni combustibili l!quid~ faci lm~n: te reperibili. come ad esempio benzina o alcool. e su sostanZe oss1dantt. capaci d1 farli bruciare. come l'ossigeno sia liquido che gassoso compresso, la cui tecnica d'impiego venne inizialmente pro,ata e messa a punto negli anni ·20 e '30 sia negli Stati Uniti che in Germania. Unione Sovicùca ed Italia.
~-legli anni immediatamente successi, i i progressi furono decisivi anche per ques1'ultimo tipo di propulsione. che conobbe una evoluzione rapidissima nella Germania nazista. quando ne venne compresa l'elevata importanza anche per il raggiungimento di più immediate finalità di tipo militare.
L'uso dei propellenti liquidi, che richiede impianti ausiliari esterni al razzo di stoccaggio e caricamento e d1sposi1i,i interni ad esso nettamente più complessi di quelli dei razzi a propellenti solidi. giunse infatti ad uno stadio di avanzata maturazione durante la .econda guerra mondiale, quando venne realizzato il primo grande missile balistico gcnnanico "A-4" (Aggregat-4) noto anche come ··v-2·· (Venungstaffeln-2. arma della vendetta-2).
Dopo aver superato molte difficoltà costruttive ed effettuato numerosi lanci di prova completamente falliti. tale ordigno fu messo definitivamente a punto nel 1942, son~ la direzione di Wemer von Braun (§111.3), utilizzando processi fisicochuntci e ntrovati tecnologici che sono ancora oggi nm'altro che arretrati rispetto a quelli auualmeme tn uso. La tecnologia attuale deriva infatti largamente da quella allora realizzata.
Sol~ a. panire dalla seconda meui degli anni '50 i nuovi grandi missili. prodotti da Stau_ lJnttt ed Unione Sovietica come vettori balistici intercontinentali di ordigni ~uclea_n, sai:ebbero lo~ati anche all'impiego spaziale con il lancio dei primi sa1elhu arufic1~h e delle pnme sonde interplanetarie. I dln,1realta questa rapida evoluzione poté concretizzarsi solo grazie all'uso iniziae e e conoscenze tecnolog· h • . . . ic e maturate in Gennan1a durante la seconda guerra mondiale ed al diretto appono · 1 d. . . . m1zta e I numerosa specialisti tedeschi che operaro- no sia negh Sten Umt" I · U • . . . mental d 1 1 e te In_ ~IO~e Sov1et1ca. oltre che all'immediato uso spene i a cune cenuna1a d1 m1ss1li "V-2" di preda bellica.
78
n ~J: I primi esperimen ti negli Stati Uniti
Dopo! precu~ori_teo~ici come Tsio~kho\'ski ed Esnault Peltier, che avevano gettato le pnme basi sc1ennfico-matemattche della tecnica di costruzione ed impiego dei razzi. il primo serio studioso, realizzmore e sperimentatore di questo tipo di ordigni. fu il fisico statunitense Goddard,
Robert H111c/1i11gs Goddard
Nato a Worchester nel Massachusetts il 5 ottobre 1882, mizio a studiare l'impiego militare dei razzi a polvere nel corso della prima guerra mondiale per cercare di mettere a punto una moderna arma da lancio individuale. antesignana del bazooka, che sarebbe stata introdotta dagli americani solo durante la seconda guerra mondiale: riuscendo ad effettuare i pnmi esperimenu positivi a partire dal 10 novembre 1918, quando la guerra era onnai terminata.
Nel 1919 decise di passare allo studio del1'impiego dei più efficaci combustibili liquidi che. ignorando i lavori già svolti da Tsiolkhovski, ritenne meglio utilizzabili rispetto a quelli solidi grazie alla possibilità di regolarne la portata d'affiusso in camera di combustione attraverso pompe. valvole e condotti di alimentazione.
Goddard indirizzò ben presto i suoi lavori verso la miscelazione controllata e la combustione di benzina ed ossigeno liquido. che scelse per la loro reperibilità e praticità d'uso. Il 16 marzo 1926, ad Aubum nel Massachusetts, lanciò il suo primo razzo utilizzante questo tipo di propergoli.
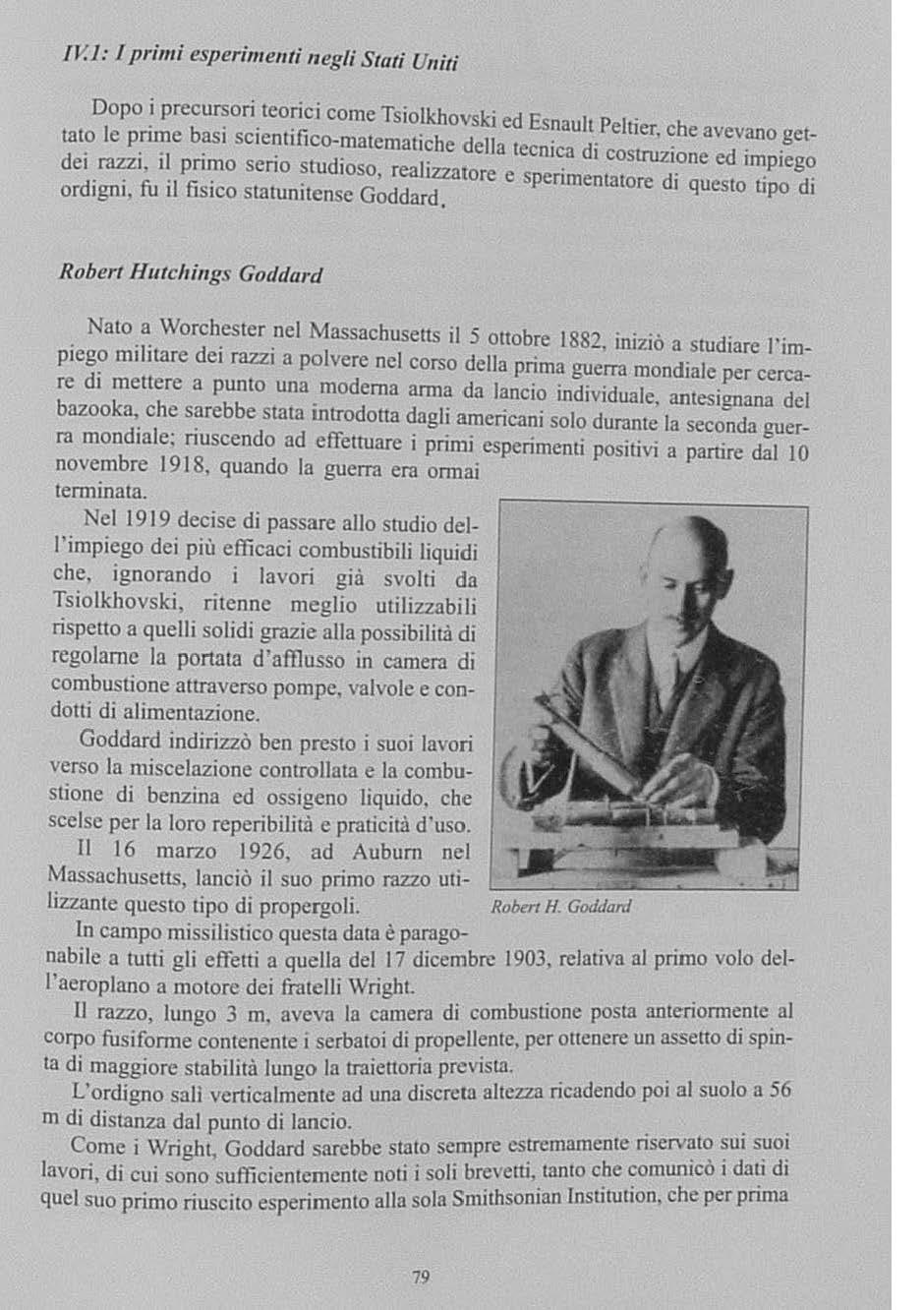
Robert H Goddarrl
In campo missilisuco questa data è parago- . . . 1 d I nabile a tutti gli effetti a quella del 17 dicembre 1903. relauva al pnmo ' 0 0 el'aeroplano a motore dei fratelli Wright. . b . ta anteriormente al Il razzo lungo 3 m aveva la camera di com usaone pos d. . , . . b . d. llente per ottenere un asseno i spm- corpo fus1fonne contenente I ser a101 1~rope . , ta di maggiore stabilità luogo la rraietton_a prevrs~. • dendo poi al suolo a 56 L'ordigno salì verticalmente ad una discreia a tezza nca m di distanza dal punto di lancio. , estremamente riservato sui suoi Come i Wright, Goddard sarebbe s~~o Sc_mpre_ rti tanto che comunicò i dati di lavori, di cui sono sufficient~mente 00111 si°l~bret~e ~30 lnstiturion. che per prima quel suo primo riuscito espenmento alla so 8 nu so 1
79

1 · f d. 0 •cessari nel 1917 e lo avrebbe finanziato lino al 1929. gh ave\'a e arguo tsareonbbtecstato infatti divulgato solo IO anni dopo. anche se il ccle- L'a,•\'cm1mento . . _, 1 , d 11·ALlnntico Charlcs Lindbergb ne venne quasi subilo a cono- bre tras,o :llore e h · ·b · I• t l da stimolare il miliardario Dame! Guggen e1m a contn u1re a ltnansccnzo. an o . I • 000 d Il . r ziamento dei la\'OrÌ di Goddard, tra il 1929 _ed 11 1_9-1 I, con .:>. . o an a~o. Nel 1929 riuscì a lanciare un rozzo di d11nens1om ra~gu~rdevoh, capace d1 tra.....re .....menti barometrici per il rilie,·o delle pressioni ad alta quota ed una spo,... !Su" · · d · h. a fotom-:ifica. tanto che i risulrati onenutJ commc1arono a mteressare macc m =··· . . · · · I · anche l'esercito degli SUJti Uniti. Goddard poti! perc10 proseguire I suoi anc1 usando laboratori e poligoni militari. dapprima a Fon Dc,·ens nel Massachussets ed in seguito, a panire dal 1930, nel ranch Mcscalero Rose~ell n_el Nu?vo ~es_sico. lontano da qualsiasi occhio indiscreto. dove costru1 e spenmemo quasi tutti I d1sposith·i necessari per il lancio ed il controllo dei missili, come i motori con le loro camere di combustione ed i relativi ugelli dt scarico, le pompe di alimentazione, i sistemi di stabilizzazione giroscopica del razzo lungo la traieuoria prevista e molto altro ancora.
Nel 1933 dovet1e tornare al suo incarico d'insegnante nell'Università Clark per mancanza di fondi, ma nel 1935 i suoi finanziatori gli rimisero a disposizione somme adeguate ed i suoi nuovi rozzi. che erano lungJù dai 3 ai 4.5 m. pesanti dai 30 ai 40 kg e stabilizzati mediante sistemi giroscopici. raggiunsero una velocità di I. I00 kmn e 2.500 m di quota dopo essere statt lanciati da una torre alta 18 m.
ln seguito alcum auton. come lo scienziato russo Leonid Sedov, affennarono che, a panire da questo anno, mentre I nazisti andavano completando la loro scalata al potere. Goddard entrò in corrispondenza con un altro importante scienziato, il tedesco di origine rumena Hermann Oberth (§ IY.3). fornendogli infonnazioni essenziali e dati su, progressi da lui ottenuti. anche se, come atrennano altre fonti di origine statunitense. questo tipo assai strello di collaborazione non è stato mai ufficialmente provato.
Lo scienziato scomparve il IOagosto 1946.
~el _corso della seconda guerra mondiale gli Stati Uniti non fecero un uso pratico sigmfica~i,·o ~ell~ tecnologie missilistiche che Goddard aveva saputo portare ad un allo stadio dt snlu~po. _mentre nel successivo dopoguerra avrebbero utilizzato largame~te le tccnolog1~ S\'lluppate in Germania dagli scienziati tedeschi guidati da Wemer ,on Braun. fatu appositamente emigrare in America.
IJ :2: Primi esperimenti e ricerche ;,, U11io11e Sovietica
IAI contrario di quanto viene normalmente ritenuto l'Unione Sovietica fu partico armente avanzata cli t d' d • ..,0 d d O O su •0 ella propulsione a razzo oià a partire dagh anni, prece en o la G~rm · · 1 . . cr a pu t d' . c.: ama 10 a cum setton fondamentali come quello della messa no c1 nuovi endon..'altori Il . 1· . . . tare r~lat· . . . . a prope em, 1qu1do-gassosi cd anche in quello md1c "o a, pro1ett1lt-razzo d' · 1- . . . . anig iena ed av1olancrnti a propellentè solido.
80

Gli studi di Tsiolkhovski dettero infatti luogo, nel 1924. alla fonnaz,one dei primi due istituti di stato dedicali a tale settore: il TsBIRP. Ufficio Centr.ile per lo Studio dei Probl:mì .dei Razzi. e lo OIMS, Società per lo Studio dei Viaggi lnterplanetan dell Unione, che nel 1927 organizzarono le pnme mostre divulgative sui \'iaggi spaziali.
Venne in tal modo a fonnarsi una seconda generazione di addeni e scienziau relat1vamen1c numerosa comprendente diversi esponenti di spicco. che durame 11 successivo periodo staliniano vennero fani confluire in due distin1e organìa..aziont principali: la prima. denominata Len-GIRD (Gruppa Isu1chenya Reaktinovo Ovishenya, Gruppo di Studio del Moto a Reazione), venne fondata a Leningrado nel 1929 da '-Jikolai Alexsevìtch Rymm e da Jako\ ls1dorovitch Perelman.
La seconda, siglata Mos-GIRD, venne invece creata a Mosca nell'aprile 1932 da I.P. Fortiko, con la collaborazione di Fridrikh Arturovich Tsander. Ryinin in particolare approfondì gli s1udi teonc, e scnsse anche una monumentale enciclopedia divulgativa intitolata Mc=hap/anetine ,·ooboshchenyia (Comunicaz1om mtcrplane1arie) m nove \'Olum1. comprendenie tutto l'insieme d1 conoscenze scientifiche allora possedu1e sui razzi e l'analisi delle pnncipah opere letterarie relative all'esploraz1one spaziale
Il ptù importante degli studiosi e sperimentatMi so\'ietici di propulsori a razzo fu lo stesso F.A. Tsandcr, che mise a punto nel 1929. medianle prove statiche. lo ORI (Opitnaya Raketa, motore a razzo) utilizzante gasolio ed ana compn.c.ssa e nel success1,·o 1933 lo OR-2. nel quale vennero tn\'ece usali gasolio ed ossigeno hqutdo.
Lo scienziato scomparve però nell'anno seguente
Ulf1~1ura=, "Katlll.\~IO" Rs-s:
Al · ortanti sperimentatori furono Valentm Petrovich Olushko e Sergei P. cn imp . Il . r . . Korole\' che nel dopoguerra avrebbe costruito le nav1~e. e spazia sov~et1ch~.
N I corso della seconda guerra mondiale I sov1e11c1 usarono mten reggimenti d'arti~lieria basati su lanciarazzi del tip~ ··~ati~cia", fa~cn~o ;111che un larghissimo uso di razz.i anticarro aria-terra lancmll dai loro vehvoh d assalto fortemente corazzati. come il celebre Tlyushin IJ-2 "Shrunnovik".
I lanciarazzi "Katiuscia" furono usati per la prima volta dai reparti militari dclJa polizia segreta NKVD il 15 luglio 1941. poco tempo dopo !"inizio dell'invasione germanica, quando le truppe naziste erano giunte a poche decine di chilometri da Smolensk suJla via di Mosca, con effeui materiali e psicologici devastanti per le truppe awersarie.
1 razzi erano stati realizzali e sperimentati nei laboratori di Leningrado sotto la direzione di Andrei Kostilov nel più assoluto segreto.
Erano inizialmente di due tipi. il primo dei quali fu lo RS-82, avente un calibro di 82 mm, luogo 60 cm e pesante 8 kg, che veniva lanciato da un sistema di rotaie di lancio multiple, regolabili sia 1J1 alzo che brandeggio, installale su autocarri. in 36 esemplari per salva con una gittata di 5.500 m.
A questo venne affiancato lo RS-132 da 132 mm, lungo 142 cm e pesante 42.5 kg, che veniva lancialo dal complesso M-13 in 8 esemplari per salva, con gittala 8.500 m.
In seguito apparvero altri razzi più pesanti da 300 e 31 O mm che vennero impiegati da ~•ere e_proprie divisioni di artiglieria lanciarazzi, ciascuna delle quali era capnce d1 lanciare sull"avversario 350 I di ordigni esplosivi nello spazio dì poche ore.
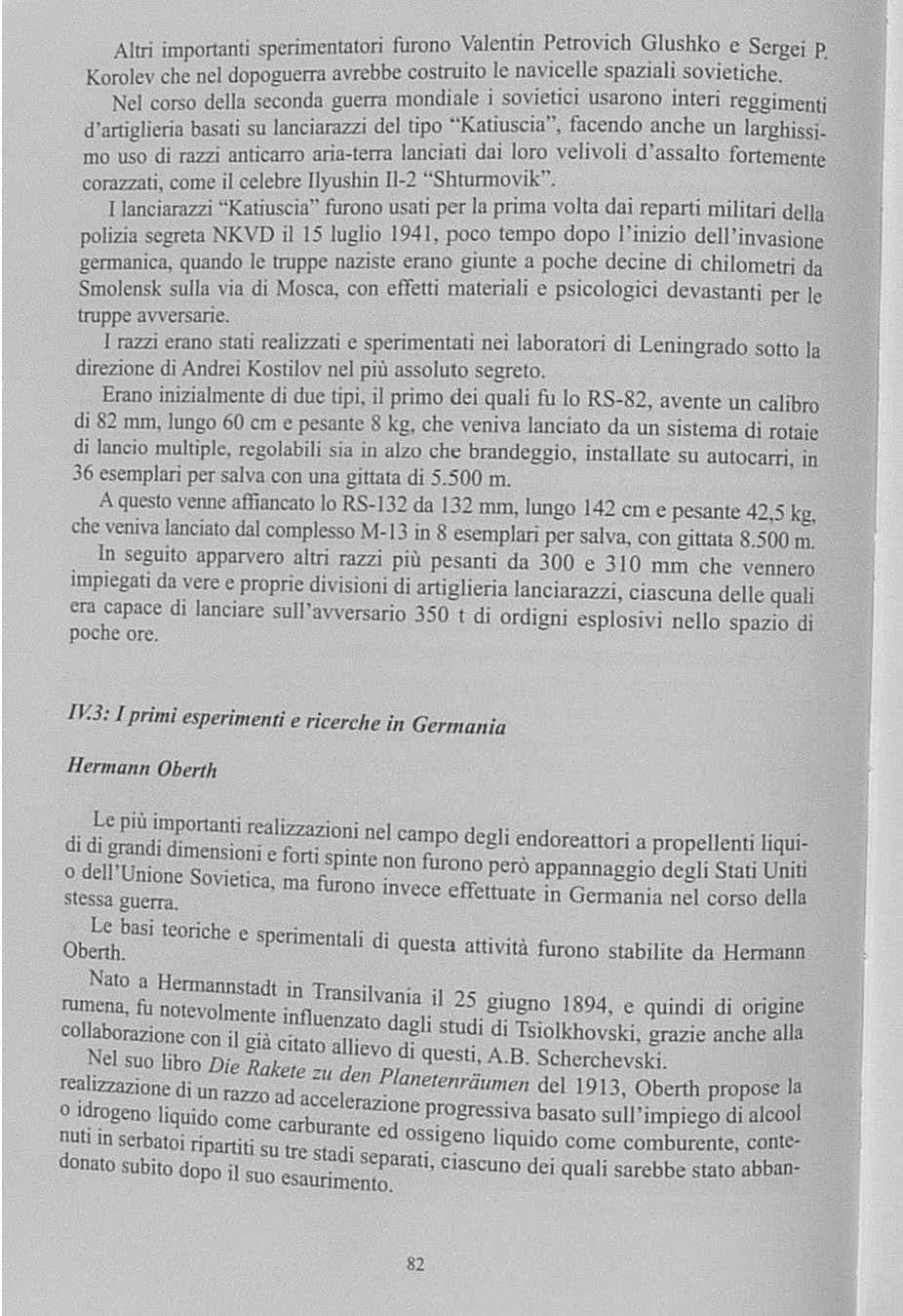
IE3: I primi esperimemi e ricerche in Germania
Berma1111 Oberth
d. d~e più im~ortan~ reali.zzaz.ioni nel campo degli endoreartori a propelJenri liqui0 1d 1 1gra 1,0 °~1 dtmsen~,o~i e foni spinte non furono però appannaggio degli Stati Uniu e nione ov1e11ca ma furo · fii . . I · no invece e ettuate m Gennan1a nel corso della s essa guerra.
Le basi teoriche e sperime tal· d. . .. Ob h n 1 1 questa att1v11a furono stabilite da Hermann en . Nato a Hermannstadt T ·1 . .. rumena fu note,roJ _in ransi vania 11 2:> giugno 1894. e quindi di origine • mente mfluenza10 da 1· d. • . collaborazione co .1 .. . . 1stu I d1 Ts1olkbovski, grazie anche alla Nel suo libro~! ~\citato allievo d1 questi, A.B. Schercbevski. realizzazione d. ,e a 'ete =11 den Planetenrii11me11 del 1913 Oberth propose la 1un razzo ad accele · • ' . o idrogeno liquido e b razione progressiva basato sull'impiego d1 alcool nuti in serbatoi npan°1.time car ~le ed ossigeno liquido come comburente, contesu tre stadi se · · donato subito dopoi-1 . parau, ciascuno dei quali sarebbe stato abbansuo esaunmento.
82
prof
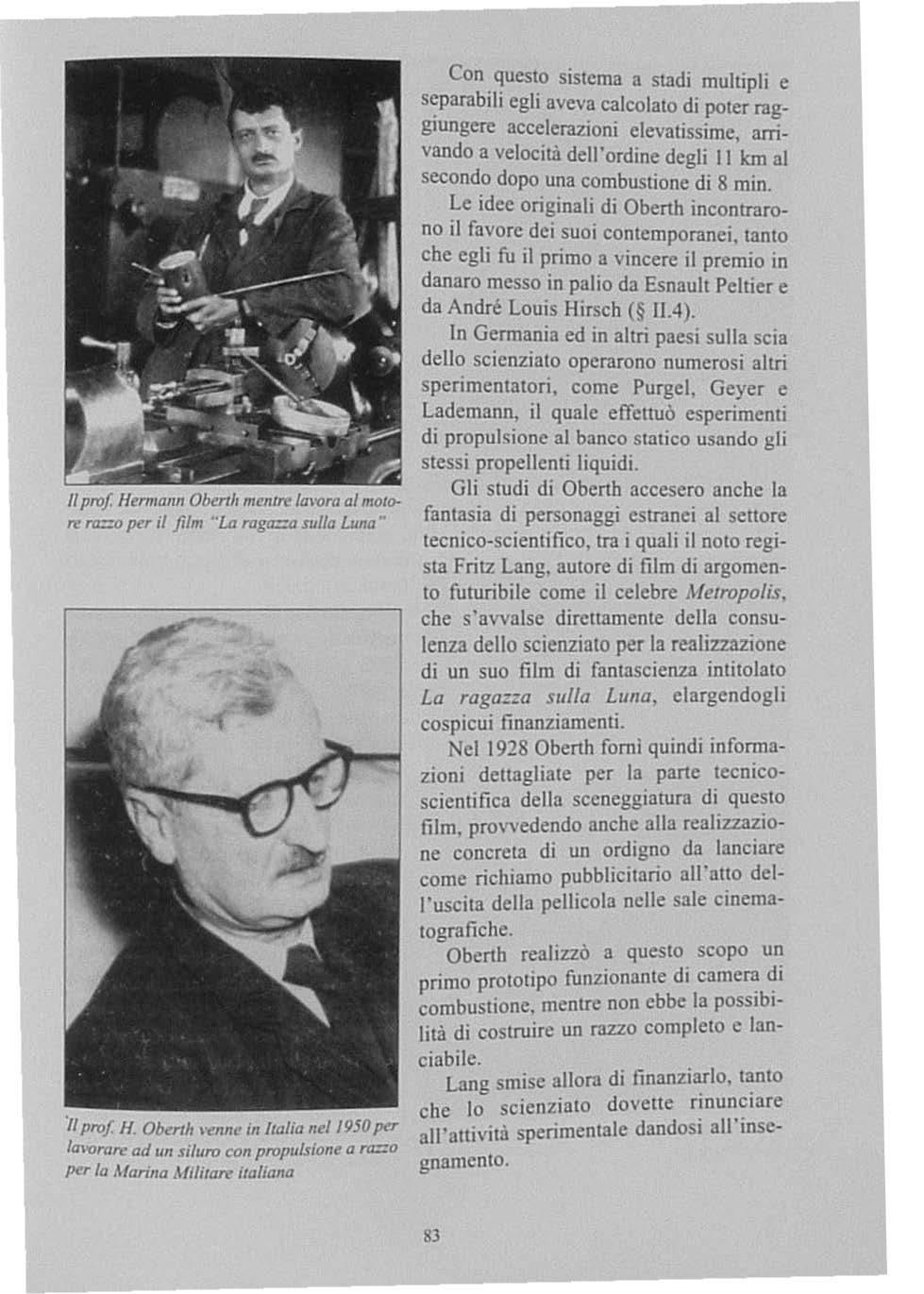
li prof. H Oberth ,·enne ,n Italia nel /950 per lm'Orure ad un sì/uro con propulsione a ra=::o per la
Con questo sistema a stadi multipli e s:parabili egh aveva calcolato d1 poter raggiungere accelerazioni elevatissime, anivando a velocità dell'ordine degli 11 km al secondo dopo una combustione d1 8 min.
Le idee originali di Obenh incontrarono 11 favore dei suoi contemporanei, tanto che egli fu 11 pnmo a vincere il premio m danaro messo m palio da Esnault Peltier e da André Loms Hirscb (§ Il.4).
In Germania ed m altn paesi sulla scia dello scienziato operarono numerosi altri spenmentaton, come Purgel. Geyer e Lademann. il quale effettuò esperimenti di propulsione al banco s1auco usando gli stessi propellenti liquidi
Gli studi d1 Obenb accesero anche lo fantasia d1 personaggi estranei al settore tecmco-scientifico, tra I quali il noto regista Fritz Lang. autore d1 film di argomento futuribile come 11 celebre .'.letropolts. che s'avvalse direttamente della consulenza dello scienziato per la realizzazione di un suo film di fantascienza intitolato la raga==a sulla Luna. elargendogli cospicui finanziamenti.
Nel 1928 Oberth forni quindi informazioni dettagliate per la parte tecnicoscient1fica della sceneggiatura di questo film. provvedendo anche alla realizzazione concreta d1 un ordigno da lanciare come richiamo pubblicuario all'allo dell'uscua della pellicola nelle sale cinematografiche.
Obertb realizzò a questo scopo un primo protoupo funzionante di camera di combusuone, mentre non ebbe la possibilità di costrujre un razzo completo e lanctabile.
Lang smise allora di finanz1~lo. tanto che lo scienziato doveue nnunc1are all'att1vt1a spenmentale dandosi all'insegnamento.
li
Hem1a1m Obenlr mentre lavora al moton: ra.=o per il film 'lo rag=a sulla luna"
Manna Militare italiana
83
9, 9
bblicò un secondo importante mutato intitolato rlcge :um ra 11111 • 1 - pu rtire dal I930. su richiesta del governo tedesco. ricominciò scMffarr. mentre 3pa . . ad cffe11uarc , suoi espenmcntt. . . . . . .
Il • 0 gennanico a combustibili hqu1d1 fu pero costrutto e spenmentato pnmo razz I · · I do Johannes \\'inkler che. il 14 marzo I 931 a Dessau. ne aneto un esemp are da lui stesso fabbricato.
Era stato preceduto solo da Goddard. ma non ne cr.1 a conosce~za.
Nel corso della guerra Oberth fu chiamalo da Von Braun a forni~ la sua consulenza per In costruzione dei razzi ··.\-t'· (''\.-2.. )_ rcaltzz~u a P~t!n~mun~e. . ..
Dopo la guerra venne in Italia e subilo dopo s1trasfcn anch eglt neglt Stati Umtt, re!\tando at1irn nd sellare dei razzi e missili.
Scomparve nel 1989.
.\fax I alier e Frir: ,·011 Opel
Astronomo e pilota collaudatore di origine austriaca. \,lax Valier ave, a cominciato a studiare intorno al 1924 la possibiliui di usare i razzi come propulsori aeronautici :.crfrendo un libro in proposito (Bibl. 85 ). che ebbe successo cd interessò grandemente l'industriale Fritz ,·on Opel. che era alla ricerca di mezzi pubblicitari speuacolari aui ad incenti,·are la , endita delle sue automobili.
Con l'aiuto dell'esperto di razzi a polvere \Vilhelm Sandcr. i due iniziarono una serie di pro,c applicando 6 raai ad una automobile da corsa, alleggerita del rclati\'O motore a scoppio, che denominarono Opel Rak I, la quale. dopo molti tentativi. mggiunse la velocità di 11 Okm1h. il 12 aprile 1928.
~I Fano de::.tò sensazione con un grande ritorno pubblicitario. tanto che Opel mise subito mano ad una Opcl Rak Il propulsa dn una batteria di ben 24 razzi. che \'Cni-
vano accesi in progressione. con la quale. il 23 maggio 1928 a Berlino. raggiunse una ,·clocità di quasi 200 km h.
Anche in questo caso la notizia dell'avvenimento fece il giro del mondo cd Opel costruì nuove versioni della sua automobile siglate Opcl Rak 111 e IV. che però. alla velocità di 180 km h. esplosero sen1..a che vi fossero conseguenze letali per gli uomini essendo pri"c di pilota e con a bordo dei gatti.
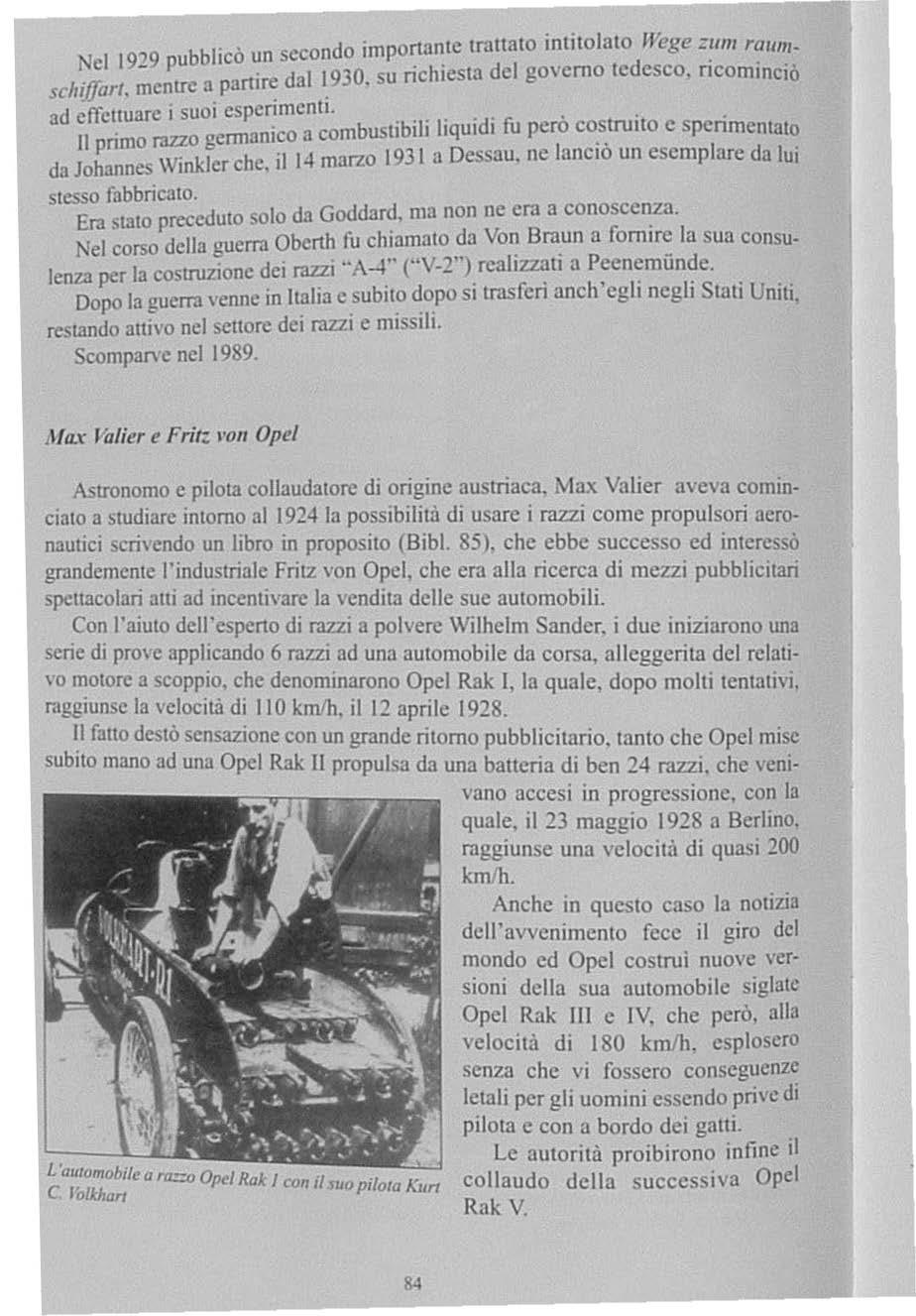
l 'automobì/,: a ro:::o O •/ R L / • C l'o/lJ1an 'pt a.. (Ofl ti JIIO pilota K1m
Le autorità proibirono infine il collaudo della successi"a Opel Rak V.
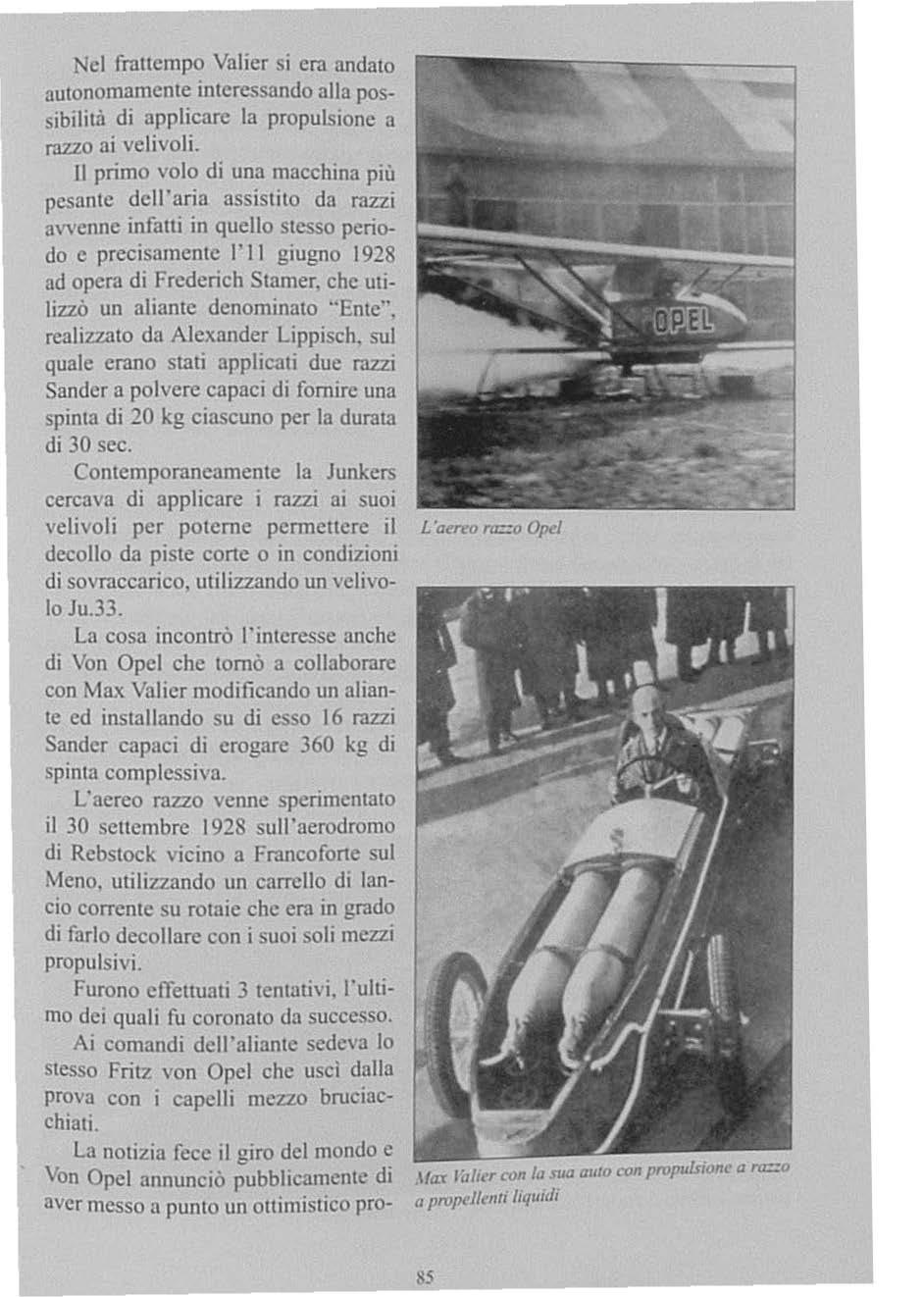
Nel frattempo Valier si era andato autonomamente interessando alla possibilità di applicare la propulsione a razzo ai velivoli.
li primo volo di una macchina più pesante dctraria assistilo da razzi avvenne infatti in quello stesso periodo e precisamente 1• 11 giugno 1928 ad opera di Frederich Stamer. che utilizzò un aliante denominato ..Ente··. realizzato da Alexander Lippisch. sul quale erano stati applicali due razzi Sander a polvere capaci di fomm: una spinta di 20 kg ciascuno per la durata di 30 sec.
Contemporaneamente la Junkers cercava di applicare i razzi a1 suoi velivoli per poterne pennettere 11 L 'ac:rro ra:::;:o Opd decollo da piste eone o m condizioni di sovraccarico. utilizzando un \·eli\'olo Ju.33.
La cosa incontrò !"interesse anche di Von Opel che tornò a collaborare con Max Valier modificando un aliante cd installando su di esso 16 razzi Sandcr capaci di erogan: 360 kg d1 spinta complessiva.
L'aereo razzo venne sperimentato il 30 settembre 1928 sull'aerodromo di Rebstock vicino a Francofone sul Meno. utilizzando un carrello di lancio corrente su rotaie che era in grado di farlo decollare con i suoi soli mezzi propulsivi.
Furono cITettuat1 3 tentativi. l'ultimo dei quali fu coronato da successo.
A1 comandi dell'aliante sede, a lo stesso Fritz ,·on Opel che uscì dalla prO\a con ì capelli mcuo bruciacchiati.
La notizia fece il giro del mondo e Von Opel annunciò pubblicamente di aver messo a punto un ottimistico pro\I/Z'C lii/i,'TCOII /a .wa auto ron propulsione a ro=o " prop, /lf11t1 i,q1111/1
S5
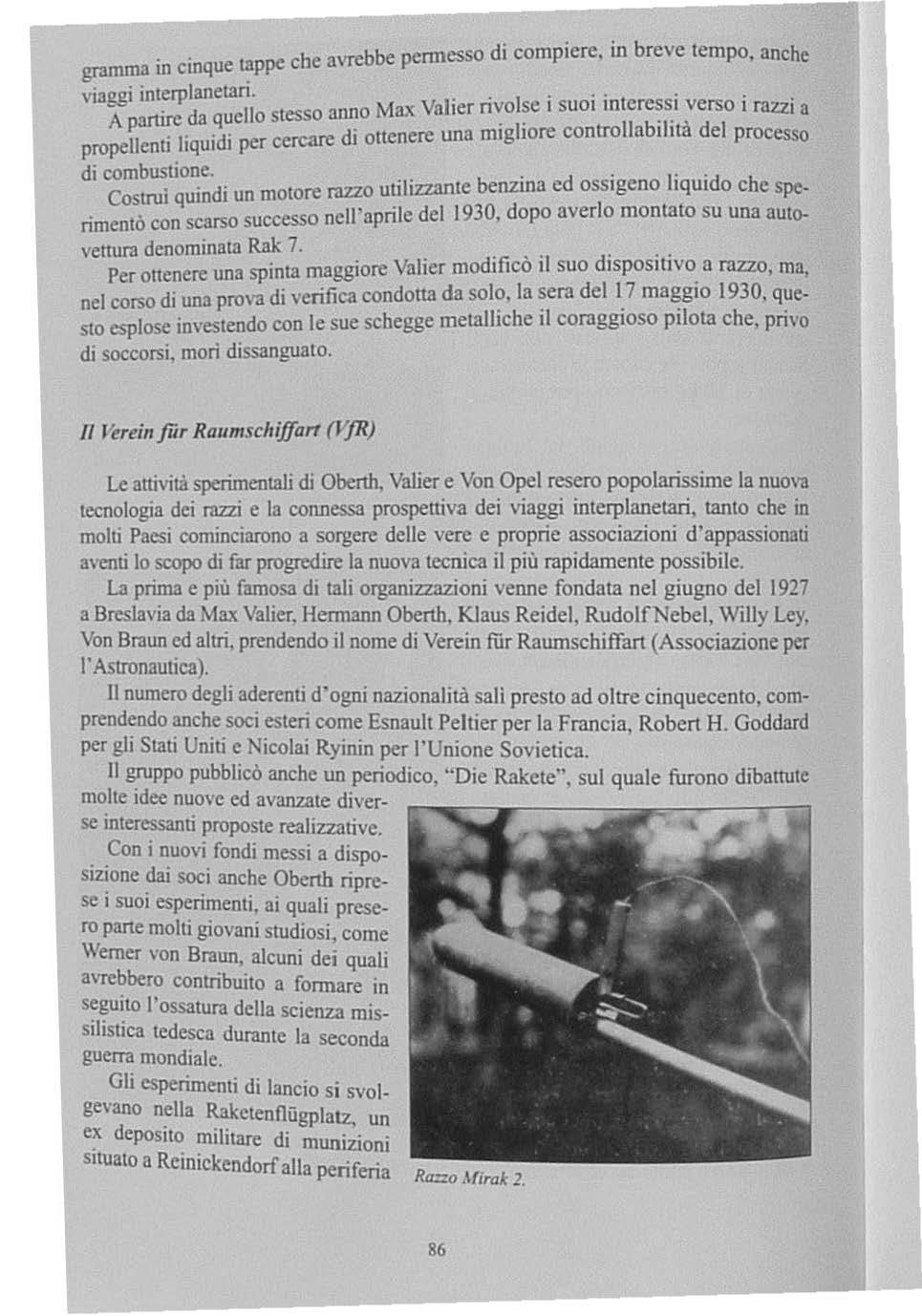
., che avrebbe permesso di compiere. in breve tempo, anche gramma tn cinque tappe viaggi interplanetan. . . . . . . .
• d Ilo stesso anno Max Valaer nvolse I su01 mteress, verso 1razz, 3
A parure a que · . . .. propellentJ liquidi per cercare dJ ottenere una m1ghore controllab1htà del processo di combustione . d · 1· ·d
Costruì quindi un motore razzo ulilizzanle benzina e ossigeno 1qu1 o che sperimentò con scarso successo nell'aprile del 1930. dopo averlo montato su una autovenurn denommam Rak 7. . . . . . .
Per ottenere una spinta maggiore Valier modifico 11suo d1spos111vo_ a razzo, ma, nel corso di una prova di verifica condona da solo. la sera del 17 maggio 1930. questo esplose investendo con le sue schegge meiaJliche il coraggioso pilota che, privo di soccorsi. mori dissanguato.
Il l 'erei11 fii r Raumscltijfarr {J 'jR)
Le attivi là sperimentali di Oberth. Valier e Von Opel resero popolarissime la nuo,a tecnologia dei mZZJ e la connessa prospetnva dei viaggi interplanetari, tanto che in molti Paesi cominciarono a sorge.re delle vere e proprie associazioni d'appassionati aventi lo scopo di far progredire la nuova tecnica il più rapidamente possibile.
La prima e più famosa d, tali organizzazioni venne fondata nel giugno del 1927 a Breslavia da Max Valier. Hermann Oberth. K.Jaus Reidel, RudolfNebel, \Villy Ley. Von Braun ed alni. prendendo il nome di Verein fiir Raumschiffart (Associazione per l'Astronautica}.
li numero degh aderenti d"ogm nazionalità salì presto ad oltre cinquecento. comprendendo anche soci esteri come Esnault Peluer per la Francia, Robert H. Goddard per gli Stau Uniti e Nicolai Ryinin per l'Unione Sovietica.
Il gruppo pubblicò anche un periodico, "D1e Rakete", sul quale furono dibanule molle idee nuove ed avanzate diverse interessanti proposte realizzatwe.
_ _Con i nuovi fondi messi a dispos1z1one dai soci anche Oberth riprese I suoi esperimenti. aì quali presero pane molti giovani studiosi, come Wemer von Braun. alcuni dei quali a\'rebbero contribwto a formare m seguito l'ossatura della scienza missilisuca tedesca durante la seconda guerra mondiale.
Gli esperimenti di lancio si svolgevano n~lla Rakctenfliigplatz. un ex deposito militare di munizioni snuato a Rcinickendorfalta periferia Ra=o .\firak z.
86
di Berlino. che venne appositamente acqu1S1ato mentre I pn·m· . . · Il · · . • 1 razz1 spenmentau usanti come propc enti gasolina ed ossigeno liquido vennero denominati "M ' rak" (Minimum Rakcte) per le loro piccole dimensioru. 1 1
Il gruppo eseguì poi numerose prove con d1vers1 altn tipi di d fi razzi. assumen o pero sempre p1u connotaz1om e maJ11à d1 upo paramilitare, rese manifeste dal conunuo addestramento al montaggio e smontaggio rapido delle rampe d 1an · h I " · d. ·d· d I c10. c e dettero uogo a ,oni 1ss1 1 1carattere etico e politico tra gh aderenu ,t cu _ · ·• d · 1· • • 1 nume ro <:°mmc10 a assotu~ iars1 sempre più fino al definitivo scioglimento dell'orgamzzaz1one avvenuto nell tn\'emo 1933-1934, subito dopo l'avvento di Hitler al potere. li gruppo aveva effettuato un totale di duecentosessanta esperimenti statici ed onantnserte lanci reali.
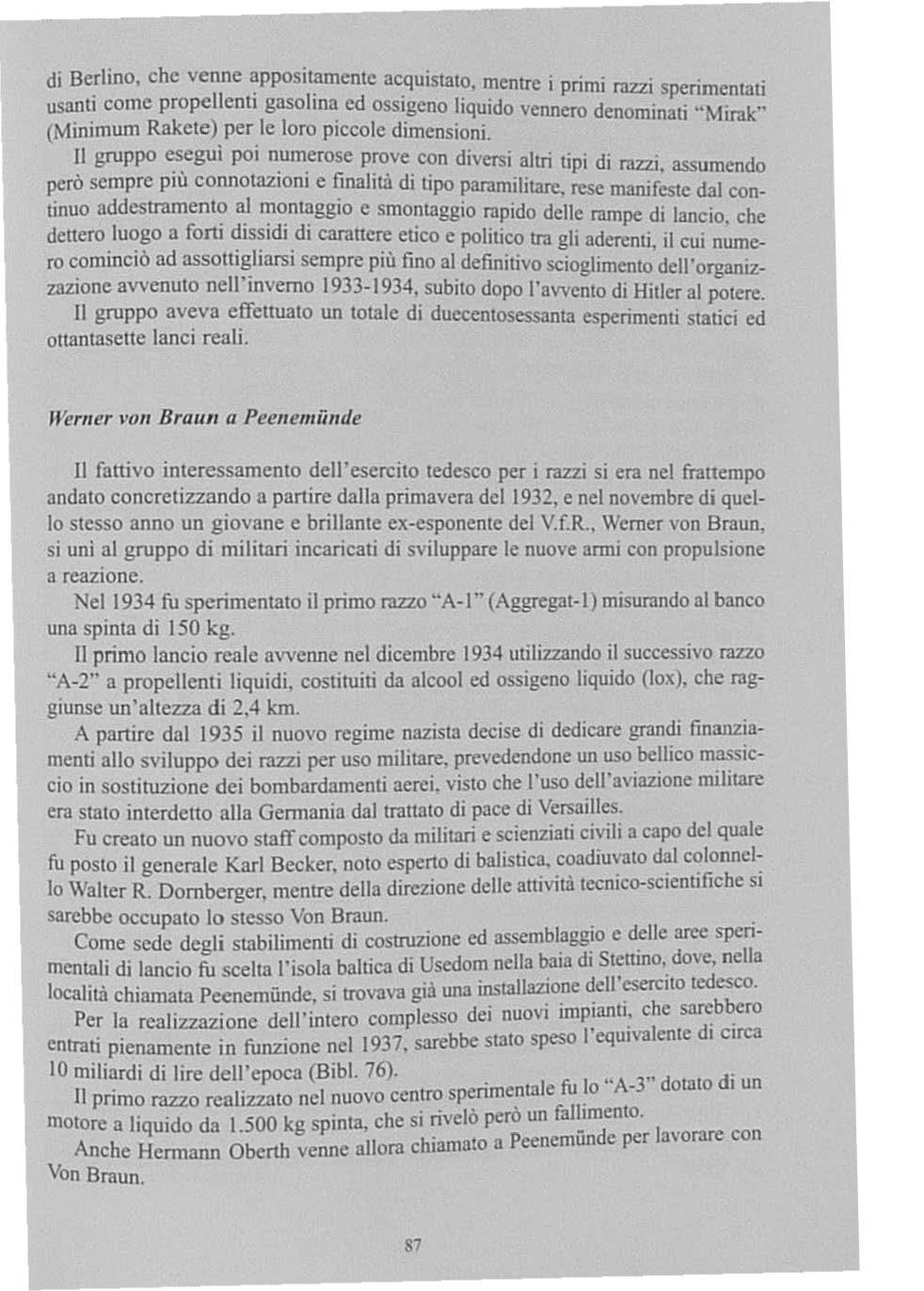
We rn er vo11 Bra 1111 a Pee11 e111 f111 de
li fattivo interessamento dell'esercito tedesco per I razzi si era nel frattempo andato concretizzando a partire dalla primavera del 1932, e nel novembre d1 quello stesso anno un gio\'ane e brillante ex-esponente del V.f.R., \\iemer von Braun, s1 unì al gruppo dì militari incanca11 di s, 1luppare le nuove anni con propulsione a reazione.
Nel 1934 fu sperimentato 11 pnmo razzo"A-1 ··(Aggregat-1) misurando al banco una spmta di 150 kg.
Il primo lancio reale avvenne nel dicembre I934 utili2zando 1I successivo razzo '"A-2" a propellen11 liquidi, cos11tu111 da alcool ed ossigeno liquido (lo:x). che raggmnse un'altezza di 2.4 km
A partire dal 1935 il nuovo regime nazista decise d1 dedicare grandi finan21amen1.J allo sviluppo dei razzi per uso m1hw.re. pre\'edendone un uso bellico mass1cc10 in sostituzione dei bombardamenti aerei. visto che l'uso dell'aviazione militare era stato interdeno alla Gennania dal trattato di pace d1 Versailles. Fu creato un nu0\'O staff composto da militari e scienziati civili a capo del quale fu posto il generale Karl Becker. noto esperto di balistica. coadiuvato dal colonne!: lo Walter R. Domberger. mentre della direzione delle amvità 1ecmco-sc1enufiche s1 sarebbe occupato lo stesso Von Braun. . . Come sede degli sutbilimenu d1 costruzione ed assemblaggio e delle aree spenmentali di lancio fu scelta l'isola baltica dt Usedom nella baia d1 Stemno. dove, nella località chiamata Peenemiinde, si trovava già una installazione dell'esercito tedesco. Per la realizzazione detrintero complesso dei nuovi imp1an11. che sarebbero entrati pienamente in funzione nel 1937. sarebbe staio speso l'equivalente di circa IO miliardi di hre dell'epoca (Bibl. 76). d d · I fu I "A 3" otalo I un Il pnmo razzo realizzato nel nuovo centro spenmema e Omotore a liquido da 1.500 kg spinta, che s1 rivelò però un faJ~mento. Anche Hennann Oberth venne allora chiamato a Peenemunde per lavorare con Von Braun.
87
Tak collaborazione non man~ò di dare
notevoli risultati pratici. sfoc1at1 srn ne~a cosuuzione di un tipo di propulso~~ razzo r,a 130 kg s per impieghi acronaut1c1. che u installato su un \'Clivolo Hemkel Hc 11 2 e sperimentato in volo nell'apnle 193~. nella ben più importante costruzione dei pnm1 missih balistici di grandi dimensioni ad alcool ed ossi1?.eno liquido .. A-t". che \·ennero sp~nmcn1at; con succes. o per la primo \'Olla il 3 onobre 19-12
Hitler rimase impressionato sia dalla nuova arma che dalla gio\'anissima età d1 von Braun. che a, e\ a allora 28 anm. tanto che diede 1•immediato ordine di costruzione m grandissima serie del nuovo missile del quale avrebbe \·olULo lanciare una micidiale salrn d1 5.000 esemplan su Londra nel più bre\'e tempo possibile
Gh s\'ilupp1 che seguirono furono notcvolissim1. tanto che tali armi. aventi circa 400 km d1 giunta ed annate con una testata espiosi\ a d1 1,000 kg, sarebbero state impiegale m gran numero come missili balistici nel corso della pane finale della seconda guerra mondiale
Nel 194-t sarebbero state infatti prodotte al ritmo d1 30 escmplan al giorno, fino ad un totale complessivo d1 circa 6.000 esemplan

Schema d1•/la " l '-2'' primo gra11d1• ra:=o balistico opaall\'o a propd/e1111 /iq11id1
ll '. .J: Prìme ricerche ed esperimenti in Italia
Alla fine degli anni venti la mania dei razzi aveva quindi creato proseliti un po: ovu~qu~ nel mondo tecnolog1camente s,·1luppato, tanto che spenmentaton 1solnt1 commc!arono ad operare anche in altn paesi
~ubi~o dopo commc1arono a costituirsi vere e propne assoc1az1om d, nppassio· nau s1m1li al V.f R.
L •\mencan Rocket Soc1ct)' guidata da Edward Pcndray si costituì il 21 mar70 del 1930.
----=:.o/.::1'/--_,.., -
88

A.oche in Italia l'attenzione per i razzi s1 riaccese a partire dal J976 · 11·· · · d - grazie a interessamento d1 esperti el settore aeronautico.
Come_ abbiamo visi?.(§ 1Jl:5) il p_roblema della propulsione a razzo fu toccato per la pnma vo~~ dall mg. G1~vanm_ Pegna nel gennaio 1926. con uno specifico anicolo sulla R1wsta Aero1101111ca (B1bL 62), e fu preso tn considerazione subito dopo. sul pia~o fisico-~atematico. anche _ dal P.rof. Gaetano A. Croceo. che. per conto_ dcli _lstnuto ~penmentale Aeronauuco. s1 preoccupò di far eseguire i primi espenmenll concr~n. avanzando anche. nel dicembre di quello stesso aMo. una richiesta di finanziamento alle autorità militari.
ln una riunione tenuta nel lugUo 1927 con esponenti dello Stato Maggiore Generale. presieduta dal gcn. Badoglio. alla quale panecipa\anO i generali Montefinalc e di San Martino per il Regio Esercito. l'ammiraglio De Counen per la Reg1a Marina ed i colonnelli Pmna e Magli della Regia Aeronau11ca, Croceo espose le sue idee circa il problema del tiro effettuato contro aerei nemici in volo offensrvo a quote stratosferiche. che avrebbe potuto essere risolto in maniera adeguata solo mediante !"impiego di proiettili esplosivi dotati di propulsione a razzo.
Sul piano teorico tale tipo di lancio ad aha quota non avrebbe infatti presentato limiti di velocità iniziale, mentre il lancio di proienih da cannone avrebbe incontrato seri problemi legati alle alte pressioni di scoppio che sarebbero state necessarie. le quali avrebbero richiesto l'uso di canne eccezionalmente robuste. mentre i relativi pezzi avrebbero dovuto essere dotati di un potente sistema d'assorbimento della forza dt rinculo. con un conseguente fortissimo aumento del peso e delle dimensioni dell'intera bocca da fuoco adoperata. mentre le più elevate quote stratosfcnche sarebbero rimaste semplicemente irraggiungibili.
Croceo chiese quindi un finanziamento adeguato per poter iniziare nuovi studi ed esperimenti nel campo della propulsione a razzo. finalizzati alla realizzazione d1 un 'arma contraerea di notevoli capacità. che egli definì "superan1g1ieria".
I rappresentanti dell'Esercito ricordarono ai partecipanti le esperienze del passa~~ attestanti la scarsa precisione di tiro tipica dei razzi. ma il prof. Croceo. che aveva g1a sperimentato con successo un dispositivo di autoguido giroscopico installato sulla bomba volante denommata ·1elebomba", realizzata e sperimemata con successo nel 1918 insieme a Guidoni (§lll.3), perorò con forza la causa della real~ione d_i un razzo antiaereo. puntualizzando che in tale stadio iniziale di studio e ~nml!ntazi~ne il nuovo ordigno sarebbe stato simile ad un bambino. che, prima d'imparare a dmgersi con precisione. a,Tebbe dovuto. per forza di cose, cominciare a camminare.
I ra:,zi della BPD (Bo m bri11i-Pa rodi- Delji110)
. . , r•sso dal gen. Montcfinale. la Malgrado 1I parere contrano coercntemcnlt:: esp t: • fi · 10 di 200 000 hrc. med1an- nun1one s1 chiuse con la conccss1onc d1 un monziamen · . h te il quale furono realizzate alcune delle prime apparecchiature usate e lurono anc e iniziati i primi esperimenti.
89

d 1 19..,7 ·ennero costruili i primi razzi a combustibile solido, suscetNell esLalc e - ' · · · · . d Il f .. . . ,.-. d'un·piego su ind1caz1om e progetu e o stesso pro . Gaetnno iibih cli diverse ,onne • . . · d e d. 0 figlio Luim allora laureando in rngegnena e el don. Marenco, Arturo rocco, i su ::,• . . . f: bb . d' .. d Il · ià BPD {Bombnru-Parod1-Dclfino). nota a nca I esplos1n e ad opero e a socie . . . km . d d' R od · h. · con siabilimentt sin a Colleferro. 50 circa a su I orna. pr ont c 1m1c1 . . . 1 razzJ. che usa"ano come propellen1e solido cord!te granulare pressata m bacb di. du» dt'versi 1ipi· a bacchena combus11b1le singola d1 90 g, con un e ette. erano ... · . .
. . tempo di combusuone P:1° quattro ?ec1m1 d1 secondo. I uno ed a fascio d1 tre bacchene combus1ibili riun11e insieme. I altro.
Essi erano sLati particolarmen1e srudiati per a\'ere una combust1one quan10 più possibile prolungala nel 1empo e di 1ipo.~nifonnc e regolare. dando luogo ad un picco di pressione all'accensione poco pm elevato del valore coslantc d1 I00 atm erogato a regime.
Si sperava in questo modo d1 hm1tare I ms1ab1hta d1Iez1onale m1z1ale provocata dalle eventuali irregolamà d1 combustione e di dis1acco dalla rampa di lancio.
Questi razzi. pur avendo la parte anteriore di forma ogivale, possedevano un·archi1e1tura aerodinamica poco adeguata alle velocità non molto elevate ma supersoniche che essi già allora potevano raggiungere, che risultarono essere pari a 400 m/sec.
Queste producevano infaui il fenomeno di compressibilità dell'aria i cui efTelli aerodinamici su di un corpo aerodinamico fusiforme. alquanto diverso da un proiettile d'artiglieria. erano allora comple1amente ignoti.
I nuovi razzi furono sperimentat1 nella primavera del 1928 presso il balipedio della dina, situato sempre nel Lazio presso il comune di Segni, ottenendo buoni risuhaà d1 funzionamento.
Se ne ipotizzava l'impiego come proiettili d'artiglieria, ma risultarono ancora una volta 1mprecis1 nel 1iro a causa della scarsa prevedibilità della loro traiettoria. malgrado fossero provvisti di ampie alette stabilizzatrici posteriori.
Gli sperimentatori cercarono di aumentare il tempo di durata del processo di combusuone isolando la superficie esterna dd grano combustibile con masrice di htargmo per limitare il fronte di fiamma alla sola superficie interna di esso. ma senza successo.
Questi s1~sì ~roblemi erano stati già incontrati da tutti gli altri sperimentat0ri di razzi non gui?all. che avevano sempre dovuto registrare una forte instabilità iniziale di tmienona ed una brevissima durata del processo di combustione.
. Malgrado il problema della stabilità direzionale venisse almeno in parte risollo ncorrend0 a rotaie o tubi di lancio ed inclinando alcune delle alette stabilizzatrici di un leggero angolo rispetto all'asse, consentendo in tal modo al rnzzo stesso di ruotare lungo 11 propri I · · · b. r . . asse ong1rudmale, ottenendo un conseguente efTcno d1 sta •· izzazione gi_roscoptca, la scarsa precisione di tiro riscontrata fu giudicata inndotm per eventuali applicaz· · ·1· · o I 19 . 1001 mi 1tan; tanto che le relative attività di ricerca cessaron ne 30 quando I finanz· · · . . . .
La BPD che iamenti, ormai_ esaun11, non furono nnnovau. . , • fu comunque la pnma m halia a realizzare su scala industnale iak
. .
. . •. . . . . . . . .
90
lipo dj endoreattori, è oggi un'azienda del gru F" campo della propulsione a razzo per impiegh;~ ~a~_panicolannent~ affermata nel i moton a razzo d'apogeo momati sui satelliu ,_. ~-el quale realJZZa tra l'ahro booster di lancio dei vcnori europei della serie Ari~ icia I geo5tanonan ed i grandi ane.

I moduni.ssimi gro11di boost,.,. laterol, dell'AriQ/1,' I' a pro~llt•tlfl solidi reali=ari m lta/10 dalla BPD
I razzi di Ettore Cattaneo
Nato a Melegnano il 6 dicembre 1898, medico e p1001ere del volo a vela. fu il pnmo privato cittadino italiano ad effettuare in maniera autonomo esperimenti sen sulla propulsione a razzo. costruendone alcuni prototipi a propellente solido in collaborazione con Baracchini ed i chim1c1 prof. Binach1 e prof. Molman
Questo tipo d'ordigno venne provato a Cascma Costa nei primi mesi del 1927 raggiungendo la quota di circa 1.000 m traSportando un bengala che, liberato ed innescato all'apice della traiettoria. illuminò l'intero campo di prova. Dopo gli esperimenti di propulsione effettuati in Gennania da Fritz \'On Opel. a_lcuni esemplan di tale npo dt razzo vennero montati su un aliante. che venne real~zzato dalla Piero Magni Aviazione di Taliedo, utilizzando l'ala di un precedente libratore G.P. l che ero stato costruito dalla stessa casa nel 1925 su progetto dell 'mg. Ugo Abate ed acquistato dallo stesso Cattaneo. che Io ave\'a già impiegato per compiere numerosi voli.
91
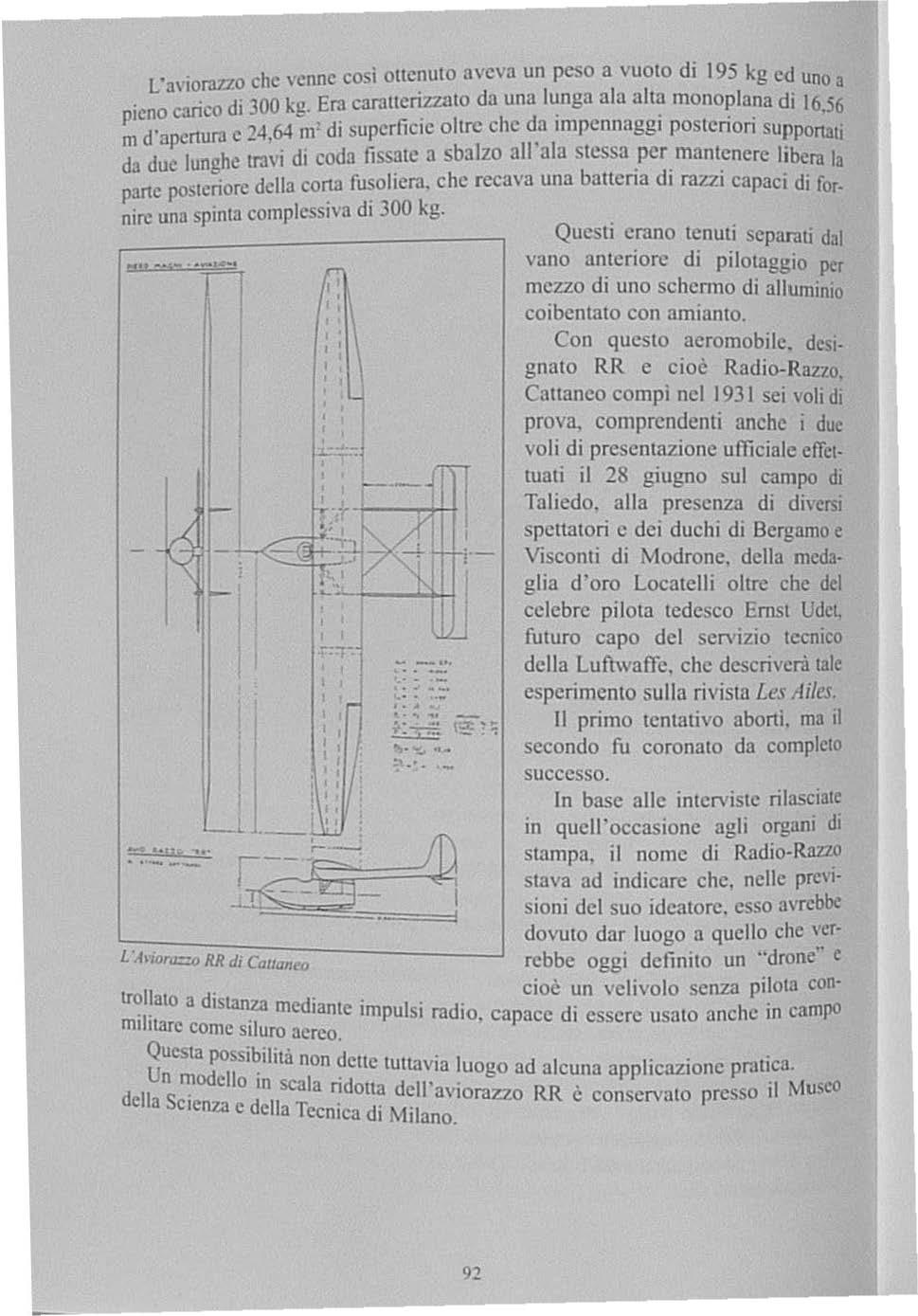
L"a, iora1..zo che venne così 01Lcnuto a\'cva un peso a \'UOto di 195 kg cd uno a ·, ,no carico dì 300 kl!. Era carnuerizzalo da una lunga ala alla monoplana di l6 , 6 p e w d . . ,., md'apertura e 24.~ rn· di superficie oltre che .a 1mpennagg1 posteriori suppona1t da due lunghe tt:i\ i d1 coda I.issate a sbalzo ali ala stessa per mantenere libera la parte posieriore della corta fusoliera. che recava una balleria di ra7.2i capaci di fornir.: una spinia complessi\'a di 300 kg.
Questi erano tenuti separati dal
vano a°:teriore di pilo1aggio per mezzo dt uno schcnno di alluminio coibentato con amtanro.
Con questo aeromobile. designato RR e cioè Radio-Razzo. Cattaneo compi nel 1931 sei voli di prova, comprendenti anche i due voli di presentazione ufficiale effc!. LUali il 28 giugno sul campo di Taliedo. alla presenza di di\'crs1 spettatori e dei duchi di Bergamo e Visconti di Modrone, della medaglia d'oro Locatelli oltre che del celebre pilota 1edcsco Ernst Udct, fu1uro capo del sen izio tecnico della Luftwaffe, che descriverà tale esperimento sulla rivista Les Ai/es. li primo tentativo aborti. ma il secondo fu coronato da complc10 successo.
Ln base alle intervis1e rilasciale in quel!·occasione agli organi di stampa, il nome di Radio-Razzo stava ad indicare che, nelle prevrsiooj del suo ideatore. esso avrcbbl! . . dovUlo dar luogo a quello che verL 4110= RR di Ca11an,"O rcbbe oggi dcfimto un ..drone" e trollato a distan d. . . cioè un velivolo senza pilota conmilitare come .za 1 mc tante impulsi radio. capace di essere usato anche in campo s1 uro al!reo.
Questa possibilita non d 1 • Un modello . 1 . e te lutlavta luogo ad alcuna applicazione pratica. m sca a ndona d 11· · della Sciell7..a e d 11 .,. . e a, rorazzo RR è conservato presso ti Museo e a ,ecntca di Milano.
.-. ••t]t- ••• .. ·-· -r-.iE~:%3.-' ....... S.• • • . . ........;.: ·, ::_ I~ : -:
92
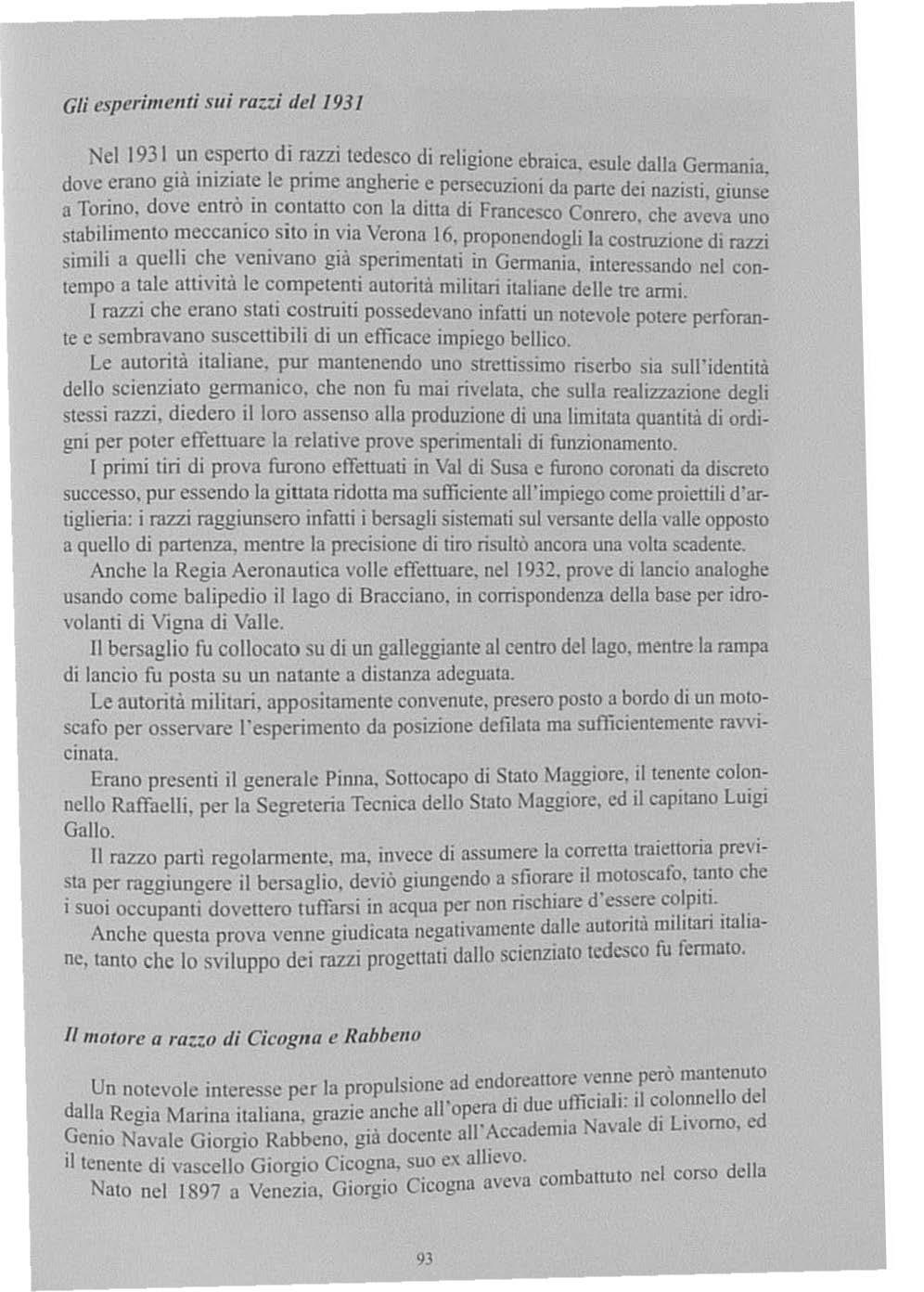
Gli esperimenti s ui ra:.:.i del I 93 I
"iel 1931 ~n esperto di razzi tedesco d1 religione ebraica, esule dalla Gennania. don: erano g1a m1z1~t~ le pnme anghene e persecuzioni da pane dei nazisti, giunse a Torino. dove entro m c~ntatlo con la ditta d1 Francesco Conrero. che a\c,a uno stabilimento meccanico suo m, ia Verona 16. proponendogli la costnmone di razzi simili a quelli che venivano gia sperimentati in Gennania. interessando nel contempo a tale attività le competenti autonta militan italiane delle tre anni
I razzi che erano stati costruiti possedernno infat11 un notevole potere perforante e sembra, ano su.scenibilt d1 un efficace impiego bclhco
Le autorità italiane. pur mantenendo uno strctuss1mo nscrbo sia sull'identità dello scienziato germanico. che non fu mai rivelata. che sulla realizzazione degli stessi razzi. diedero il loro assenso alla produzioni: di una limitata quantità di ordigni per poter elTenuare la relati\'e prove sperimentali di funzionamento.
r primi tiri d1 pro\'a furono cffeuuau m Val d1 Susa e furono coronati da discreto successo. pur essendo la giunta ridotta ma sufficiente all'impiego come proiettili d·artiglieria · t razzi raggmnscro infat11 i bersagli sistemati sul versante della , alle opposto a quello di panenza. mentre lo prec1s1one di tiro risultò ancora una \'Olta scadente.
Anche la Regia Aeronautica volle effettuare. nel 1932. prove dt lancio analoghe usando come balipt:d10 il lago d1 Bracciano. in corrispondenza della base per idro\'olanti di Vigna di Valle.
Il bersaglio ru collocato su dt un galleggiante al centro del lugo. mentre la rampa di lancio fu posta su un natante a distanza adeguata.
Le autontà militari. appositamente con\'enute, presero posto a bordo d1 un motoscafo per osservare !"esperimento da posizione defilata ma suflìcientemente ran-1• cmata.
Erano pn.:senu il generale Pinna. Sottocapo dt Stato \llaggtore. il tenente colonnello Raffaelli. per la Segreteria Tecnica dello Stato ~lagg1ore. cd 11 capttano Luigi Gallo.
11 razzo partì regolarmente, ma, invece di assumere la c~rreua tra~e~toria sta per raggmngere 11 bersaglto, dc\'lo giungendo a sfiorare ti r_noto~calo. l~nto i suoi occupanti dovettero tuffarsi in acqua per non nsch1are d L'SSCre colptt~ . . · d Ile autorità mihtan ttaha- Anchc questa prova venne giudicma negativamente a ne, tanto che lo sviluppo dei rat.zt progettati dallo :;cicnzrnto 11:dc:;co fu fonnalO.
fl motore a ra-::.:o di Cic:og11a e Rabb em1
I . d •ndoreattore wnne però mantenuto Un notevole interesse per la propu stone a e Ili 1 . I olonnello del dalla Regia Manna uahana. gmzic anche aJropera eh due u ~.c.,a 1 · 1 1 dc. L·,·omo ·•d Ir.\. dem1a ,..,.wa e 1 • • Genio Na, aie G1org10 Rabbeno, già docente a . cca ' il tenente d1 vascello G1om10 Ctcoena. suo ex alhcvo 1 della Nato nel 1897 a Vcnc;,a. G,o;g,o Cicogna a,e,a combattuto ne corso
93
111eni·111e di ,-asce/lo Giorgio Cicogna

prima guerra mondiale con il grado di guardiamarina. arrivando a comandare un MAS assegnato alla difesa navale del porto d1 Venezia, distinguendosi per le sue capacità tecnico-scientifiche: un nuovo tipo dì scandaglio acusuco da lui ideato venne infatti adouato dalla Regia Manna.
Dopo 16 anru dì scn. iz10 s1 congedò con il grado di lenente d1 vascello per dedicarsi sia alla anintà letteraria. per la quale era naturalmente portato come scrittore e poeta. che per dedicarsi allo studio della propulsione a razzo.
Agli inizi del 1931. dopo lunghi srudì dedicati all'argomento compiuu insieme a Giorgio Rabbeno. progettò e coslTUì un nuo,o upo di propulsore a propergoli liquidi utilizzante benzina come combustibile ed ossigeno liqwdo come comburente.
I primi esperimenti dettero risuhati incoraggianti, tanto da far ntenere a1 due sperimentaton. ed al già citato Francesco Conrero. che era stato cointeressato con la sua azienda a taJe realizzazione, di essere ormai giunti alla f-ase d1 messa a punto finale d1 un prototipo d1 propulsore a propellent1 liquidi suscettibile d"effenivo impiego.
Le pro"e di collaudo finale iniziarono nella pnma metà del 1932, ma s1 conclusero con una forte esplos1one avvenuta alle 11.35 antimeridiane del 3 agosto dello stesso anno nel già c11a10 stabilimento di Torino. nella quale persero la vita sia Giorgio Cicogna che Francesco Conrero con un h!cmco e due addetti, Guglielmo Bcgheuo e Serafino Brondo. mentre 6 altri. tra i quali lo stesso ing. Giorgio Rabbeno, allora direttore del Genio Navale a Tneste, rimasero seriamente fenu.
L'autodetonazione della mtscela di vapori di benzina ed ossigeno fu attribuita ad un fenomeno allora sconosciuto, consistente nell'innesco dcll'esplosiooc provocato da~l'ozono generato per scmtillamcnto da parte degli ìnterrutton dell'ìmpianio elettnco dello stabilimento.
Giorg10 Rabbeno, promosso generale l'anno successivo. sopraV\ ìsse alle ferite segunando ad occuparsi di snidi missilistici e di propulsione navale anche dopo la a guerra mondiale, ricordando con diversi anicoli (Bibl 68) il collega ed amico scomparso.
9-l
Gli cspenn_1c_n~1 fin ~u1 c~~siderati. condo111 come abbiamo visto tra la fine degli anm ·20 e gh tnlZ.I degli anni 30, pur interessando gh organismi militari italiani del tempo preposti allo studio ed alla realizzazione degh armamenti. non erano riusciti a dii:no~trare la convenienza dell'imp1cgo militare della propulsione a razzo. per la sua mtnnseca mancanza d1 prec1s1one che era eliminabile solo mediante l'adozione d1 un adatto sistema d1 guida radioelettrico allora difficilmente ipotizzabile.
La grande potenzialità bellica di un sistema propulsivo a reazione non era però sfuggita alle stesse autorita mihtan italiane. tanto che lo Stato Maggiore Generale decise d1 tornare a finnnz1are 1nuo, 1studi sugh endoreattori a propellente ltquido che Gaetano Arturo Croceo, abbandonali 1 l"3ZZl a combusùb1le solido. ave\'a deciso d1 intraprendere nel 1930 tn accordo con gli organismi preposti della Regia Aeronautica
Lo scienziato aveva infatti previsto un nuo, o tipo d'impiego della propulsione a reazione nella navigazione aerea alle alt1sstme quote stratoslèriche. avendone già dimostrato per via teorica la grande convenienza nspetto a quella ad elica(§ 111.5)
Egh aveva infatti ideato già nel 1928 un primo cndoreanore a liquidi basato sull'uso di benzina come combustibile e perossido d'azoto come comburente. per cercare d1 superare le notevoli difficoltà allora esistenti in Italia di produzione industriale. trasporto e maneggio dell'oss1geno liquido.
Un prototipo dimostratore della bontà di funzionamento del nuovo d1spos1ùvo, usante tali propergoli, venne costruito dalla dina OLME d1 Roma.
Esso consisteva in un una camera di combustione provvista d1 un sistema di al1meniazione collegato ai serbatoi conrenenti i propdlenh usali e dotata anche dei necessari manomelrl per il rilievo delle pressioni prodotte. _ li sistema era inoltre collegato ad un dinamometro misuratore della spmta ottenuta.

d b "IIOllt' n,•r pro"•·rgoli ltqu1d1 a ciclo
Camera I com 1 ~ r- r ng,:n.:ramo n-a/i=:ata da Ga.:tano A Croceo prY.sso /'Unin•rs11à di Roma
Questo embnonale endoreattore inlT'Oduceva per la prima volta al mondo. con un anticipo valutabile in almeno quattro anni rispetto a realizzazioni estere analoghe, un'importante particolarità tecnica, definita dallo stesso Croceo "idea madre", consistente nel fatto che una parte degli stessi gas propellenti, prima di bruciare, erano portnll a fonnare un velo gassoso isolante sulle pareti metalliche interne della camera d1 combustione usata. impedendo che I gas, prodoll1 alla altissima temperatura di 2.000-2.500 °C. potessero venire a contatto con esse, fondendole.
Gli
e.sp erim e nti con il 11irro m era11 0
. .
I
95

I d. ntbust·,one utilizzante tale dispositiYo, detto a ciclo rigenerativo r processo I co . . . • fu - - · no successo tanto che nel corso d1 un espenmcmo svollos1 verso nZtono con pie · . . . la fine del 1930. esso venne mantenuto per ben 10 mmuu. sviluppando una pressione conùnuatiYa di dicci atm. .
Le relatin? prove furono interrotte ~•erso la fine d1 quello s!~o ~no.per nprcnd I I933 con la sperimenrozione d1 un nuovo propellente ltqu1do: 11 mtrometano. ere ne fi 1- ·
Sono la direzione di Gaetano Arturo Croceo operavano suo 1g 10 mg. Luigi Croceo. assistente alla cattedra di motori per aeromobili ali 'Università di Roma. che progettò il relativo dìspositwo di combustione ed eiezione. ed il chimic~ prof Riccardo Cor-elli. anch"egli docente presso lo stesso ateneo, che s1 occupo della messa a punto del processo di fabbricazione di questa sostanza. della detenntnazione delle sue caratteristiche fisico-chimiche e del procedimento d'innesco e mantenimento del relati,o processo d1 combustione.
Quesu studi, del tullo origmalt. erano volli alla sperimentazione di un monopropergolo. cioè d1 un singolo composto chimico che tosse inizialmente capace di dissociarsi liberando I suoi costituenti, che avrebbero dato successivamente luogo ad una reazione ch1m1ca dt combustione esotermica tra di essi capace di produrre un fone s, iluppo d1 calore ed un rilevante volume di gas in pressione, i quaJ1. espulsi all'esterno afone velocità. a, rebbero fornito la spinia propulsiva richiesi.a.
L'uso di una singola sostanza liquida a temperatura ambiente invece delle due classiche abitualmente usate anche oggi, combustibile e comburente. avrebbe infatti pennesso di esemplificare i problemi costruttiYi dei razzi a propellente liquido dimezzandone in pratica le parti costitutive ed i necessari dispositivi meccanici: serbatoi, condoni valvole e pompe d'alimentazione.
Le ricerche chimiche di base ave\'ano pcnnesso d'individuare nel composto chi· mico nmometano la sos1anza adatta.
Allo stato puro essa aveva la consistenza d1 un liquido oleoso incolore. la cui molecola costitutiva, di formula chimica CH ,NO•. decomponendosi ad alta temperatura avrebbe fornito ben 3 molecole dt gas, secondo le reazioni chimiche:
CH,NO; - 111H:O ..._H.+ N_ + 55.7 kcal
CH,NO" - CO + 3!2Hi + l\. + 65,63 kcal
. ~ndo _l~ogo ad un \'Olume di I I00 I di gas prodotti per ogni kg di nitrome1ano hqu1do ut1ltzza10.
La ~ccessiva combustione d1 tali gas era in grado di produrre una quantità dJ calore d1 1.000 kcal per kg.
. l~ah caratteristiche erano part1colannentc indicate per fare del nitromc1ano un ,a 1 0 m~nopropellente, 1anto che il prof. Gaetano A.rturo Croceo sempre panicolarmente melme alla co · · d" · , . . mazione I nuovi nonu. secondo la moda dannunziana d 1mzio secolo. lo denominò "crgor·.
Le prove sperimentali di laboratorio iniziarono il 1° novembre 1933, verifican-
96
done subito la stabilità per accertare che esso non desse luogo ad esplosioni incontrollate
Tali prove dettero risultali positivi. per cui vennero iniziate subito dopo quelle relatin: alla sua decomponibilttà lenta e graduale ed alla sua autocombustibilit.à. che sarebbero state mantenute a spese del calore prodouo nel corso delle stesse rl!aZìo01 chimiche.
L'esperienza provò che a pressione ambiente i deni fenom1.'Tli s'innc~cavano alla tcmpernrura dt ctrca 400° C.
Verso la fine del dicembre 1933 s1 passò alte prove a pressione elevata ricorrendo ad una pompa d'iniezione a comando manuale. capace d'introdurre il nitrometano ad intenniltenza in camera di combusuone.
Anche tah prove dcnero esito positivo. con la produzione d1 I m di gas per ogni kg di nitrometano utilizzato ad una temperatura di reazione compresa tra i 2.000 cd i 2.500° C.
nr~to10
ptr il 11i~romd~
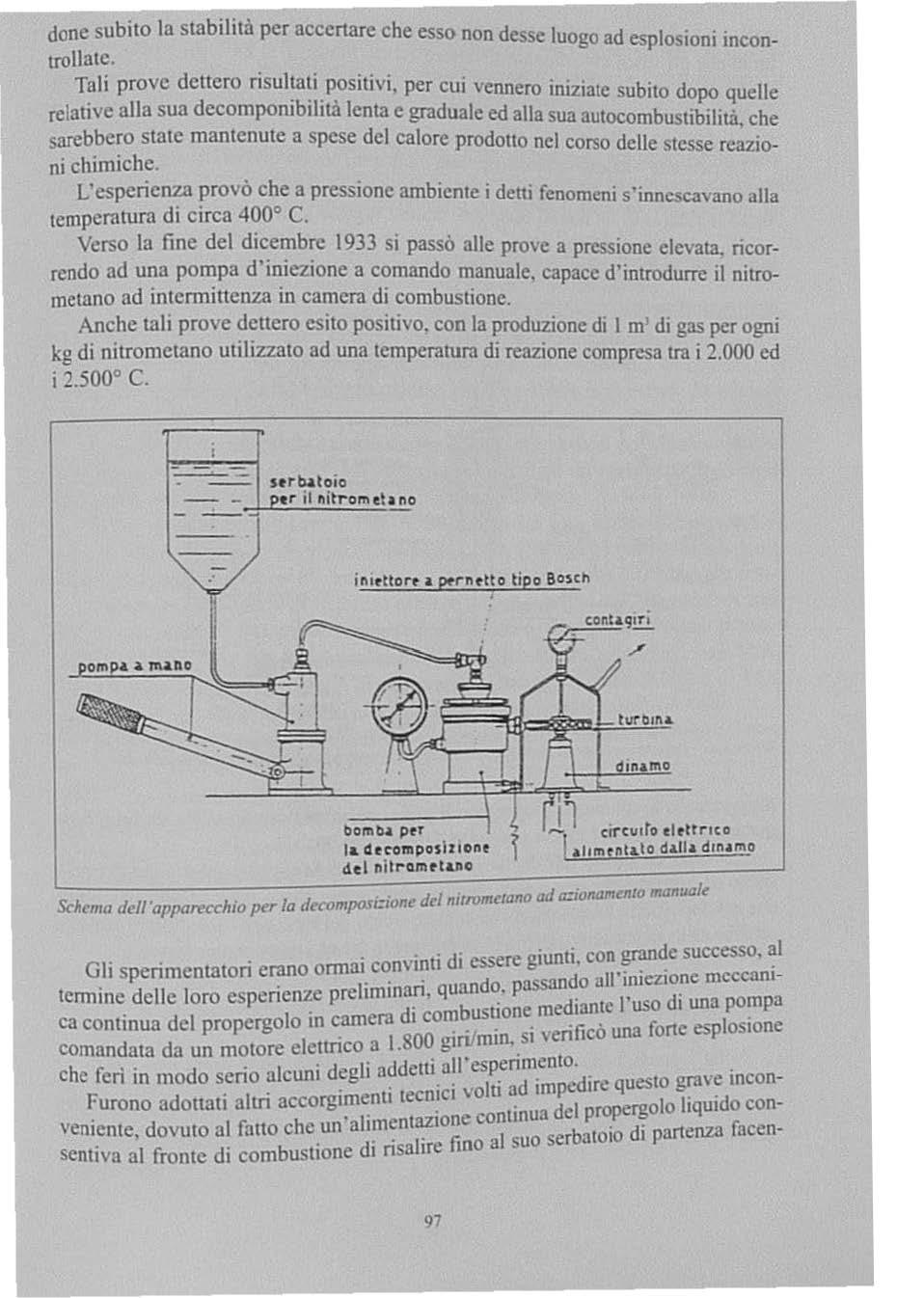
iMtttort ;a P!rn,tt o t ipo &os ch
bomiu ptr 1& deeomposh1one ciel nltro.mtt&no
J7
circuito t l ttfr 1co !;altmrnta.lo d~I& drn.amo . . d I erano ad a=wnam.nto manu.ile
Schema ddl 'apparecchio p,·r lo Ji:camposi:wm: " mtrom
. . d" 1·unt1· con grande successo. al . · connnu I essere g • Gh spenmematon erano onnat_ . . d assando all'iniezione meccanitermine delle loro esperienze preltmtnan. quabn o. p medi.ante l'uso di una pompa . d' com usnone · . ca continua del propergolo m camera 1 . . ,·en·ficòuna fonc esplosione I · I 800 gin mm. si comandata da un motore e cuneo a · . . . , . . d 1· dd ~n1 oll espenm1.:n10. . che ferì in modo seno alcuni cg 1 0 '-= • 1. d ·mp •dire questo e.rave incon. . . • t' tecnici \'O n a t t: w. "d Furono adouau altn accorg1mcn 1 • • a del propergolo hqu1 o con. , I" taZJOOt! conunu . r. _ veniente dovuto al fotto che un a Jmen fi I uo ~erbatoio di panenza ,ocen • · d · lire mo a 5 sennva al fronte di combustione I nsa
97
· 51· ripeterono anche m diverse nitre occas1oni. I d , , a le dcflograzioni · · · 1936 dolo esp o ere, m . d .•nero essere interrom 11 24 lugho . tanto che gli stessi espen~enll O\ e combustibile e l'altro comburente, da miscela-
L'uso d1 propergoh separaiti. uno era di combustione. senza pcricolos1 ritorni d1 re tra loro e far reagire so o m cam . Il la iù sicura via da seguire. fiamma. resta, a 3 ora P erat~ d" questo stesso gruppo d1 studiosi. appar- i •uccess1vamcnte op " "
Le nccrc ie s dcll'Lni\'ersita di Roma, s'indmzzarono quindi tenenti alla facoltà d'1clangegne~?dante ancora liquido a temperatura ambiente. • I ricerca d1 un a uo ossi . . n:rso. a . . r. •rciò ripresi sempre sono la guida dt G A. Croceo e por- Gh espcnmenn 1urono pc · fi I 19 '., I . I . d Ila s·condo guerra mondiale. mo a "1-, con n spc- u111 a,·anu anche ne corso e e
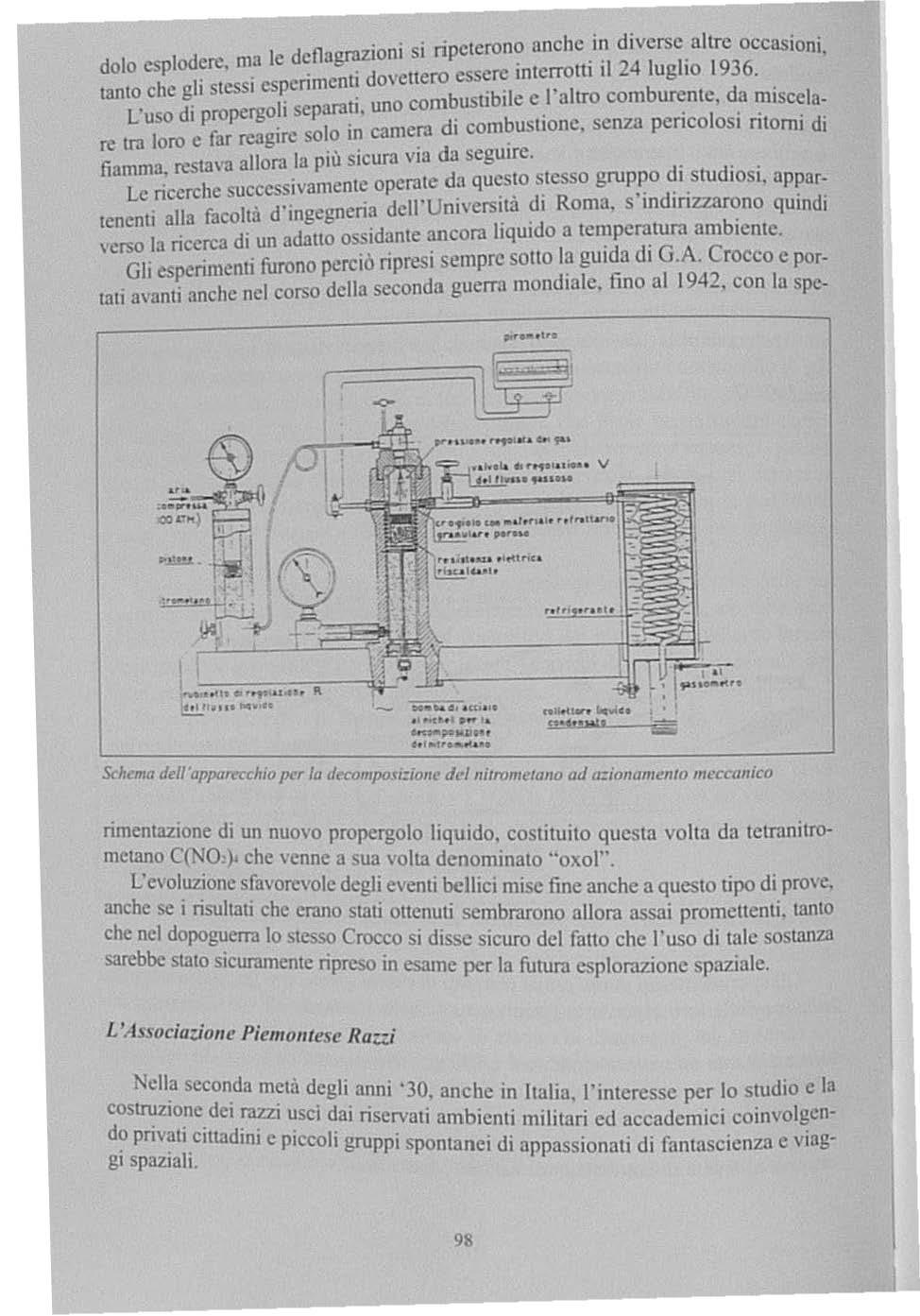
Mlllk.1 • ct, • it • •~f'• & •~po11ti";•r hl,_,,.,..tt.- 11., ;, r..,-,1.11 • V ue,-uu fii ri1.,., C..,,u1, ll!J•.!»11
Sehema dcli 'opparer:ch10 per la d<'compo<1:io11,• dt•I 11itrome10110 od a:.ìonameJl/o 111eccC1nico
rimentazione di un nuovo propergolo liquido. costituito questa \'Olta da tetranitrometano C(NO ), che venne a sua volta denominato ··oxol".
L'e, oluzione sfavorevole degli eventi bcllic1 mise fine anche a questo tipo di pro, e. anche se I ris-ultati che erano stati ottenuti sembrarono allora assai promettenu. wnto che nel dopoguerra lo stesso Croceo si disse sicuro del fano che l'uso d1 tale sostanza sarebbe stato sicuramente ripreso in esame per la futura esplorazione spa7iale.
L' h,ocia:ione Pie111011tese Ra:..:.i
Nella seconda meta degli anni '30, anche m Italia. l'mteressc per lo studio e la cosll'Uzionc dei razzi uscì dai nser\'ati amb1cnt1 militari cd accademici com,olgendo pri\ati cittadini e p1ccoh gruppi spontanei d1 appassionali dt famasc1enza e ,·iagg1 spaziali.
Nel 1936, ancora a Torino, pn:se infatti vita la più importante d. tal· · . · I d • . . . . 1 1orgamzza- z1om. che assunse a enommaz1one d1 Assoc1az1onc Picmontes, R · • d .· · · Il d" d" e azz, poncn osi come ob1ca1vo que. 0 I stu ,are. proporre ed anche costruire direttamente razzi er 1'esploraz1one spaziale. P
Partita co~ ~icci ad~renti, l'~so~iazione arrivò presto a 25 membri che iniziarono la l~ro at11_ntà ~penmentalc 1mp1antando un laboratorio di miscelazione e prova di polven pmche m una fornace abbandonata del Basso Canavese. ben lontana dai centri abitnti.
Tali studi erano volti alla ricerca di un propellente solido a\'cnte tempi di combustione sufficientemente lunghi e capace di garantire spinte ele\atc.
li laboratorio venne usato anche per fabbricare cd assemblare le pani metalliche relative alle strutture di questi razzi. Una delle pnme miziative consisté nella ripl!tizione dell'esperimento già compiuto da Von Opel in Germanrn e da Cattaneo m ltalin: su un aliante Cantù vennero montnt1 razzi a pol\ere nera per un decollo con partenza da terra.
Ai comandi prese posto Alberto Fcnoglio. che era uno dei principali animaton dell'associazioni!. ma ali'allo dcli'accensione si verificò un·esplosione degh stessi razzi alla quale lo stesso pilota scampò per puro miracolo.
Venne anche costruito un grosso razzo. lungo 1.5 m e dal diametro di 0,5 m. dotato di quattro impennaggi metallici propulso da 15 grani propulson separau. crnscuno dei quali era lungo 80 cm e capace di fornire una spinta di 150 kg per 6 sec
Questi vennero accesi in sequenza predeterminata a gruppi di 4. grazie ad un interruttore automatico di corrente collegato a pile a secco, ed il grosso ordigno si staccò felicemente da terra raggiungendo una quota di circa 600 m. percorrendo una traie1toria parabolica che gli consentì di coprire una distnnza dal punto di lancio d1 4 km. impattando poi con il terreno ad alta \elocità e d1struggcndos1 completamente_ .
Un ulteriore tentativo venne effettuato con un razzo a 3 stadi. ciascuno dei quah era pron isto dì alette stabili1.Zatrici. che ave\'a un diametro di 30 cm. cra alto complessi,amente 2.8 m ed era stato caricato con uno nuo\·a miscela sperimentale di polveri combustibili.
Fu lanciato con successo. ma raggiunse una quoto non molto de\ata.
Un altro ordigno era dotato d1 qunttro 1mpcnnagg1 su ciascuno dei quali cm fissato un razzo c.ipo, olto nspcno al \ crso di volo
Questi quattro rozzi ausiliari sarebbero entrati m funzione solo pochi istanti prima dell'impatto con il temmo frenando il razzo stesso per impedirne la distruzione.
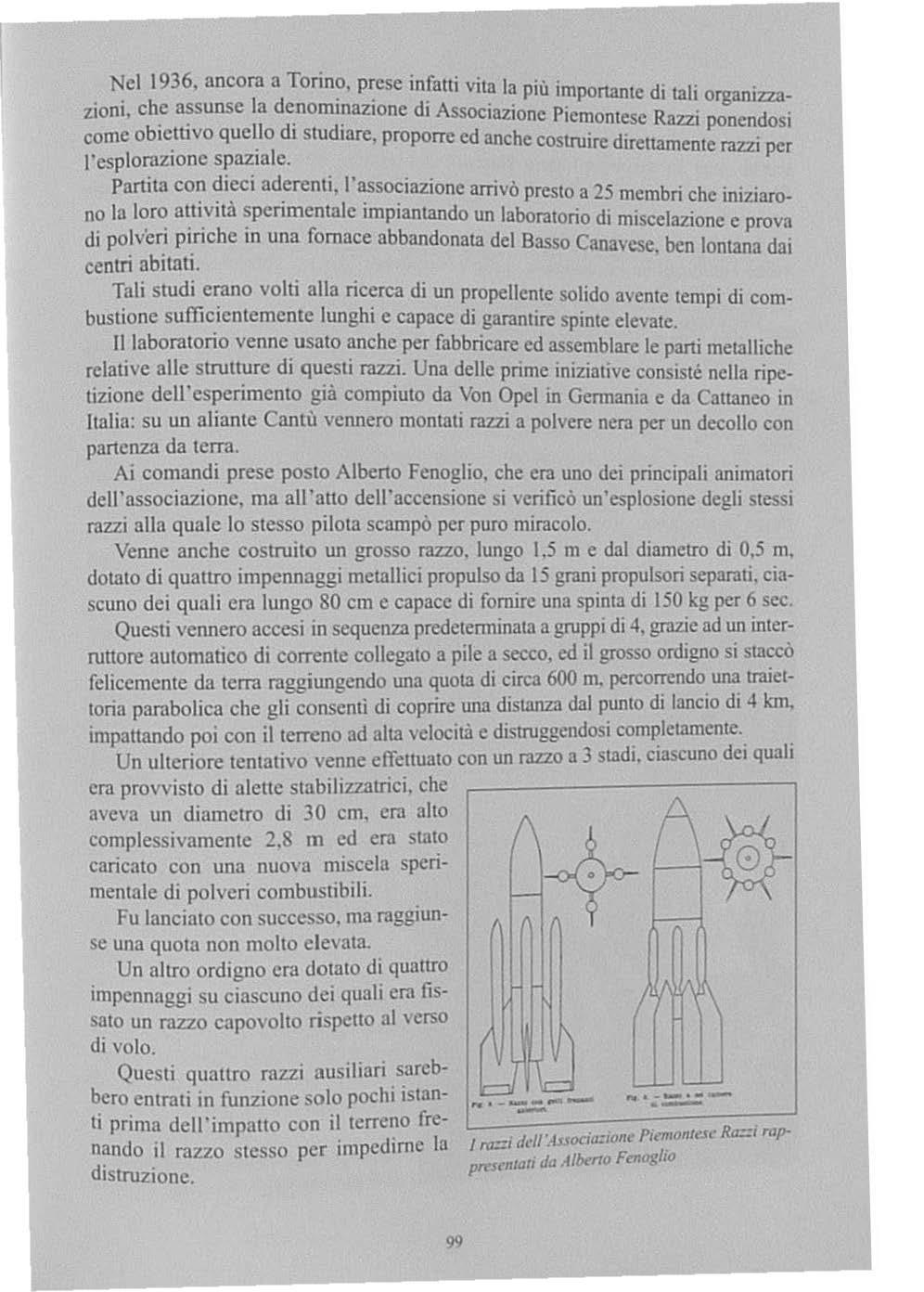
I ro=:1 d,•//'~uocia:1on1 P1t·111onl<'l<' Ra=, rop· pm, nla/1 da Alberro Fenor:ho
99
,.,. ....... . ...... --
Vennero anche concepiti missili spaziali capaci d1 uscire dall'atmosfera, tra i quali un upo alto ben 25 m ed avente 3 m di _diametro. Do,·:' a c_sscre dotato di 6 alette stabilizzatrici e 6 camere di combusuone con ugelli inclma11 verso l't:stemo. che lo aHebbcro fatto staccare dal terreno con un angolo di 20-30° _ Sarebbe stato capace inoltre di rrasponare ad altissima quota un considerevole carico di strumenti
~el 1936 \'enne anche ideato un razzo muhistadio a propergoli liquidi: idrogeno come combustibile ed ossigeno quale comburente. per un lancio spaziale avente come ob1et1i\'O la Luna.
Tale r.17.20. lungo circa 30 m. anebbc dovuto essere lanciato facendo ricorso ad una sliua mobile su un binario orizzontale, per assumere successivamente una traiettoria obhqua e quindi verticale grazie alJ'a21one di apposite superfici deflettrici direttamente agenti sul gello dei gas di scarico emessi. li progetto fu anche sottoposto aJle competenti autorità statali ma venne oniameme rigeltato come inatruabile.
Nel 1943, quando la guerra e le distruzioni nelle città del Nord Italia stavano ormai raggiungendo il loro culmme. l'associazione propose la costruzione di un razzo m alluminio propulso da ossigeno ed idrogeno liquidi capace di raggiungere la ionosfera, per studiare gli effetti delle rapide accelerazioni iniziali sul corpo umano. ma. dati i tempi, a tale proposta non fu concessa nessuna particolare auenzione.
L0 alli\ità dell'associazione ebbe termine con la stessa guerra, che portò non solo alla dispersione degli aderenti ma anche alla distruzione di tutti gli studi e di tutti gli avveniristici progetti fino ad allora realizzati, avvenuta a seguito del bombardamento con bombe incendiarie effelluato su Torino il 17 agosto 1943. anche se il Fenoglio aHebbe proseguito tale genere di studi anche nel primo dopoguerra.
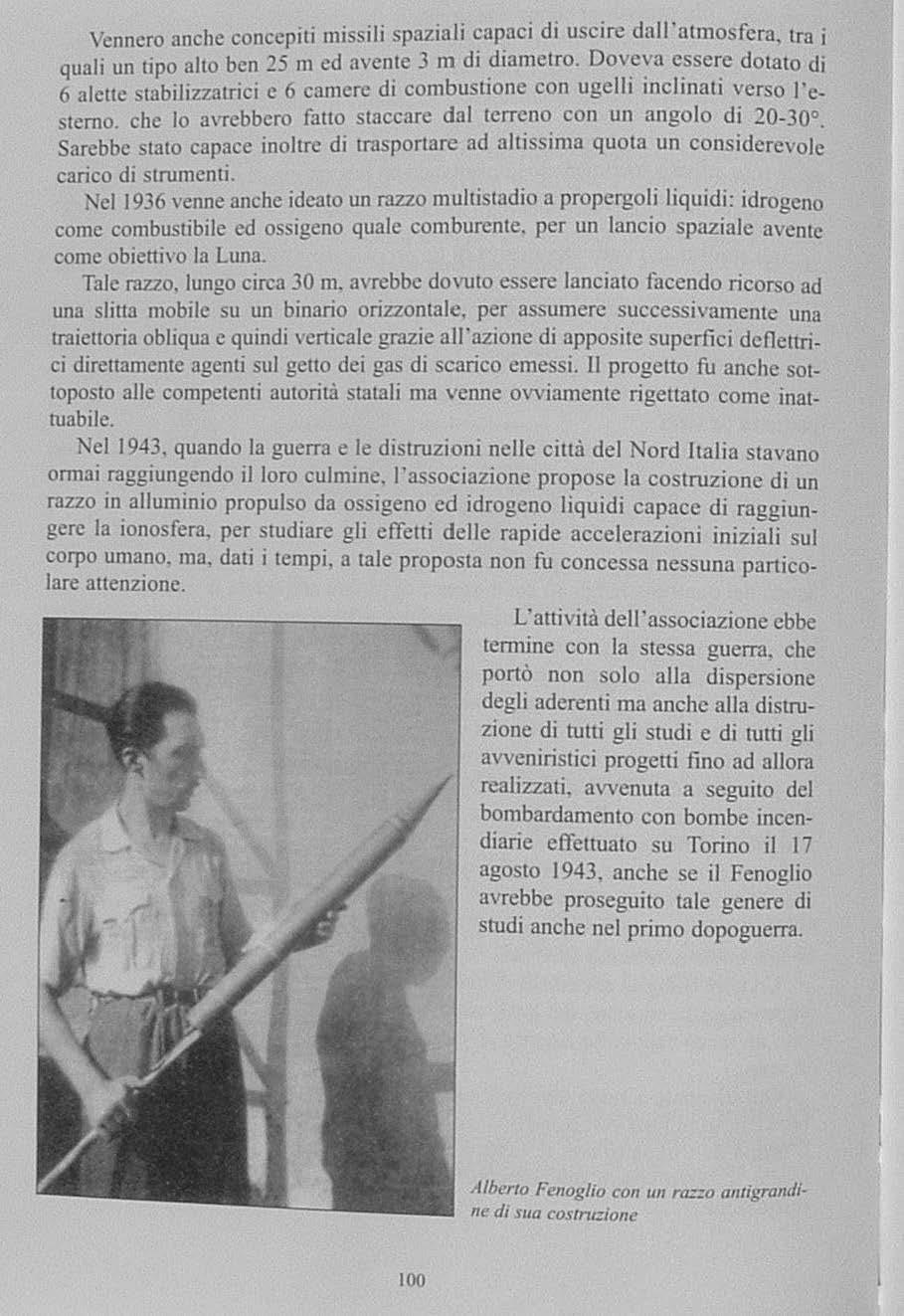
-liberto Fenoglio con 1111 ro:.:o m11t1,.,randi• nt d, ma coJtn,zione
100
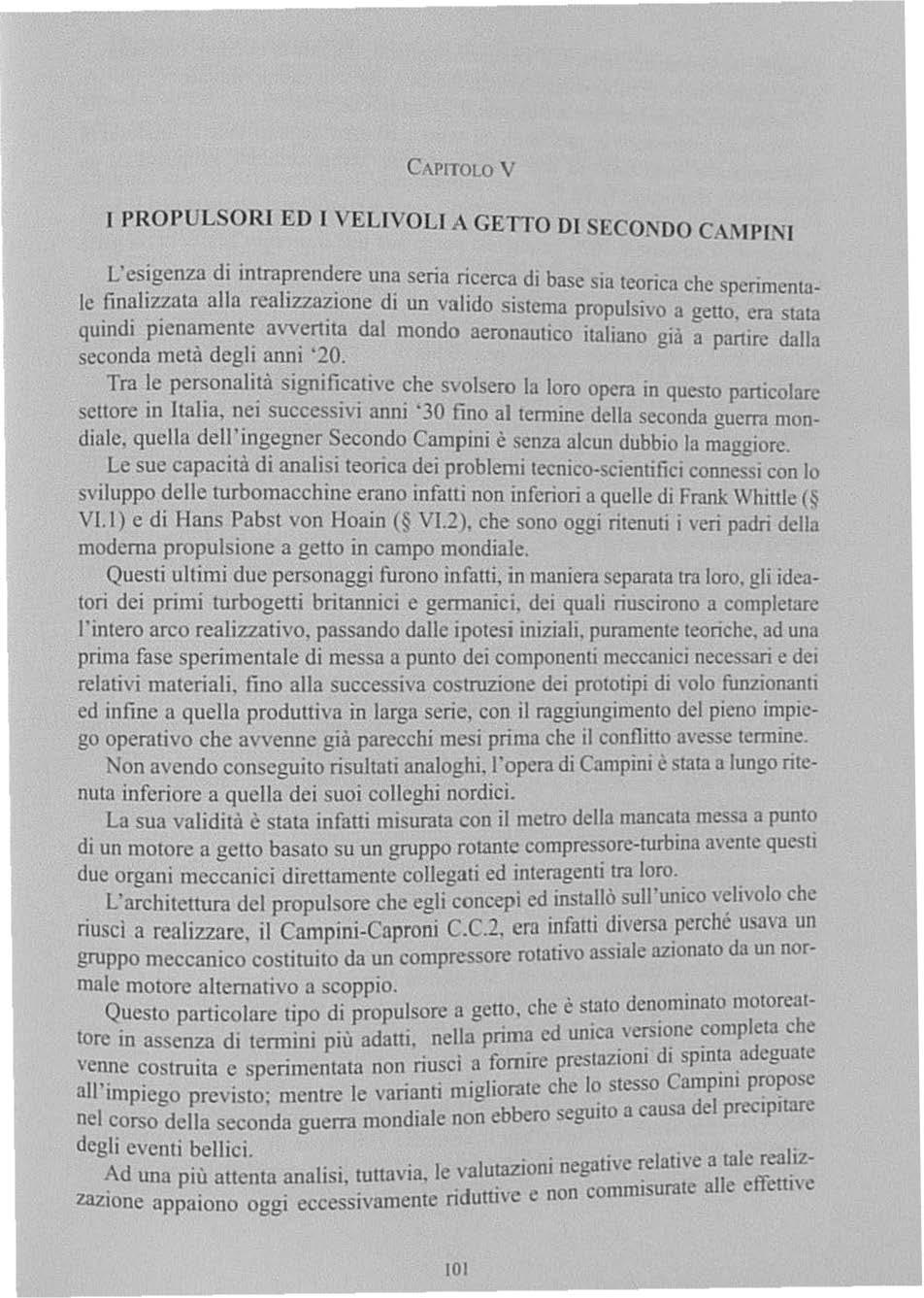
C\PITOLO V
I PROPliLSORl ED I VELI\OLT A GETTO DI ECOl\DO C.\\lPl,t
L'es!genza di mtra~rend~re una sena ncerca d1 base sia 1eonca che sperimentale ~nahuata alla rl!ahzzaz1one d1 un \alido sistema propulsivo a geno. era stata qumd1 p1ena_meme avvemta dal mondo aeronau11co uahano gia a panire dalla seconda meta degli anni ·20.
Tra ~e personalità significative che S\'Olsero la loro opera in questo panicolarc scnore m Italia, net succcss1v1 anni '30 fino al termine della seconda guerra mondiale. quella dell'ingegner Secondo Campmi è senza alcun dubbio la maggiore
Le sue capacità di analisi teonca dei problemi tecnico-sc1ent1fici cono;;,, con lo sviluppo delle turbomacchine erano infa111 non mfcnon a quelle d1 Frank Wh1nle (§ VI. I) e di Ilnns Pabst von Hoain (§ Vl.2). che sono oggi ntenu11 1\'en padri della moderna propulsione a getto in campo mondiah:
Questi ultimi due personaggi furono infatti. in maniera separata tra loro. gli ideatori dei primi turbogeni bmannici e germanici. dei quali nuscirono a comple1are l'intero arco realizzati\'O, passando dalle ipotesi m1ziah. puramente 1conchc. ad una pmna fase sperimentale di messa a punto dei componen1i mcccan1c1 necessan e de, relati\·i materiali. fino alla successtva costruzione dei pro1oup1 d1 \'Olo funz1onan11 ed infine a quella produtli\·a in larga serie. con il raggiungimento del pieno 1mp1cgo operativo che a\ \'enne già parecchi mesi prima che il conflillo J\'esse 1ermme on avendo conseguito risultati analog,ht. l'opera di Camp1m è stata a lungo ritenuta inferiore a quella dei suoi colleghi nordici.
La sua validità è stata infatti misurata con il me1ro della mancaia me ·sa a punto di un motore a getto basato su un gruppo rotante compressore-turbina avente questi due organi meccanici dirctlamente collegali ed interagenti tra loro. .
L'architenura del propulsore che egli concepì cd installò_sull'umco \'cl1\olo che riuscì a realizzare, il Cnmpini-Caproni C.C.2. era infa111 d1vma pcrchc usa\'n un gruppo meccanico costituito da un compre ·sorc rotati\'O assiale azionato da un normale motore altemauvo a scoppio.
Questo panicolarc tipo dì propulsore a geno. che è stato denominato motoreattore 10 assenza dt 1enmni piu adatti. nella pnma cd unica n!~ionc ~ompleta che . . . . • •tnzioru di spinta adce.uate venne costruita e spenmen1ata non nusc1 a tornire pn.-s ·Il•. . . . 1· t che lo stesso Campm1 propose a 1mp1ego pre\Ìsto· mentre le \ anann m1g. 1ora e · . bb . ·10 a causa del prec1p11are nel corso ddla seconda gucrra mondiale non e ero egu• degli eventi bellic1. . . li\'c relatiw a tale realtz\d una p1u attenta analisi, tutta\ 1a. le rnluiaziom nega t ali.. ,a:,n,\·e . ·d · . , non commisura e " 1.: 111. zaz1one appaiono oggi eccessivamente n um, e c.

. . • · t.fi h' dall'ingegnere italiano, il quale si occupò. con notevo- capac1ta 1ecmco-sc1en I c e • . . 1, h d. propulsione idrodinamica a getto m campo navo c. le successo. anc e • I 904
Secondo Campini nocque o Bologna il 28 agosto de I . . . .
I · .6 d · t =sars•· ai problemi del volo a 16 anni quando vide 11 modello di mli a mere., . . "gei~volante" realizzato da don Oido ~tarcbes1. semplicemente propulso da un getto di aria compre sa(§ JIJ.1 >: . . . . . .
F 10 · poi l'Università d1 Bologna laureandosi m mgegnena con 11 massimo requen • ·1 · ''"1 · d dei voti il 17 no,·embre 1928. ottenendo per la sua test I premio 1v. arcom a pane del Consiglio Nazionale delle Ricerche. . . . . .
Iniziò quindi I suoi rudi sistematici sulla pr~puls~one a re:izi~ne gin a p:in1re d~la fine degli anni ·20, mentre nel 1~30 s1 ~fen_ a .Milano, pnnc1pale ~•tta mdustnalc ualiana. dove avrebbe avuto m1ghon poss1b1hta d1 concreuzz.are I suoi progetll.
Qui fondò la sua società d'ingegneria denominata: Secondo Campini Milano VENAR (Velivoli E Natanti A Reazione). che deve essere considerata a tutti gli effetti la pnma al mondo, in ordine cronologico, ad avere come esclusiva finalità applicativa lo studio e lo realizzazione della propulsione a reazione in campo aeronautico e navale.
Un primo riscontro tangibile della validità delle sue idee, allora del tutto futuribili. si ebbe con lo pubbltcaz1one. negli ulumi 5 numeri dell'annata 1930 del mensile specializzato "Aeronautica", dt un suo elaborato teorico mtitolato: Co111rib1110 allo s11ttlio della propulsione a rea:ione. Motori a geuo ,on1im10 (Bibl. 10).
Questa complessa trattazione fisico-matematica analizzava iI funzionamento dei "sistemi o rifornimento iniziale". come Campioi classifica, a i razzi, ed indi, iduava. nei dice, punu conclusivi finali. quali fossero le loro caratteristiche dt funzionamento fondamentali. smtetizzabili nel modo seguente:
- nei propulsori a razzo I consumi variano inversamente alla velocità di eiezione del getto. che de,e qumdi essere molto elevata;
- nella fase di panenza, e cioè alJ·a\ ùamento ed al decollo d1 un ipotetico aeroplano propulso a razzo, il rendimento è molto basso. mentre nel contempo i consumi sono moho ele, ati. per cui sarebbe com eniente adottare un sistema di propulsione misto nel quale la spmla prodotta dal geuo interverrebbe solo dopo il distacco da terra e dopo l'avvenuta acquisizione di un'alta velocnà di traslazione:
· mentre nel funzionamento ad elevato regime i consumi del sistema motore altemativo-elica crescono con la velocità di traslazione e con la quota. qucl~1 del propulsore a ra.1.20 diminuiscono invece sensib1lmentc m funzione mversa del quadrato della \'elocìlà.. diventando panicolannente , antagg10s1 per ,aton eleva11ssim1 di quest'ultima. co;ampmi concludeva questo suo pnmo corposo saggio (ben trentadue pagine plesme fitte di calcoli e d1agramm1) nservandosi d1 pubblicarne uno seconda pane che avrebbe dovuto riguardare 1"sistemi a rifornimento continuo•· (di aria e carburan1e) e c10• i mot · • • e on acronau11c1 a getto, 11 cut uso sarebbe stato , antagg1oso anche per veloc1ta meno cle\atc di quelle richieste da un razzo.
102

Questa. sec~nd~ ?arte,.P~r ess.endo stata effettivamente redatta, non fu mar pubblicata sui p~n.0~1c1 specialtzzau ~ell:epoca, come sarebbe stato confennato dallo stesso Campmr m una sua pubbhcaz1one successiva (Bibl. 11) apparsa nel 1938 sulla rivista l'"Aerotecnic-a".
Questi due sa~i tuttavia ve.onero suc~essivamente presen1ati sia all'ing. Gianni Caproni che_ al Mmistero del! .Aeronautica, ma con un nuovo titolo leggennente modificato n spetto a quello gra noto: Cara11eris1iche e possibihrti della propulsione a reo=ione.
Sempre nel 1930, egli tradusse tn prauca le sue teorie maiematiche puntando sulla realizzazione di un propulsore a motoreattore per il miglior rendimento propulsivo al decollo ed alle basse velocità che esso avrebbe potuto fornire rispetto ad altre forme note di propulsione a reazione.
Stese quindi un primo progetto di larga massima relativo ad un nvolu210nario velivolo capace di decollare e volare senza elica grazie alla reazione di un getto di gas caldi inizialmente compressi, che. nelle sue intenZioni. avrebbe dovuto essere teoricamente capace di raggiungere velocità inimmaginabili per quei tempi. dèl1'ordine dei 1.500-2.000 kmba quote comprese tra i 15.000 ed 125.000 m.
Malgrado non venisse mai costruito, questo llpo di velivolo sarebbe stato siglato a posteriori C.C. I (Caproni Campini I). mentre a, rebbc dovuto essere denominato più correttamente C.S. I (Campini Secondo I),(§ V.5).
l :J: Il Campini Secondo C.S.I
Di questo primo a\'iogetto Campini presentò in realtà quelle che ~i pou-e~bcr~ definire almeno due distmte versioni, che erano in reaha poco più d1 due disegni complessivi di larga massima. corredali di una sintetica descrizione tecnica
Esse avevano in comune un apparato propulsore a getto della sie_ so up~. che. pur essendo solo schematicamente abbozzato in vista sezione n~• s~o• organi meccanici costitutivi, era di funzionamento delineabile ed approssnnatnamente comprensibile anche se solo sul piano qualitativo. . b
La pri~a versione proposta. sempre secondo le previsioni del progett1 5 la. a~·re. I . . • ersomche Essa venne bre, ena- bc dovuto essere capace di raggiungere ve ocua sup · . 8 la in Italia nel sencmbrc del 1930 e successi, amente ID Gennama. Gran retagna cd altri paesi. . . . . itarono delle 0 ,,vie perplessità ed Tali inusuali ed avvemnsllche pre5ta2rom ~use d Il R•gia Aeronautica che • Ci • · egli orgam tecmc1 e a e ' un p1u che g1ust1 1ca10 scetuc,smo n . d . nesa di più significuti\'1 la esaminarono ma non le dettero seguito. nmanen ° ID 8nscontri teorici e pratici. . . 1 b da Campini si avvaleva già. In realtà questo primo schema dr ~ 85511?8 e a ~~ 1~emazionali, tconc1 e di galin qualche misura, dei risultali dei pnmrssim_i 1 1 ID 'l'ebbe incontrato Yolando a lcria del vento, relativi ai fenomem che un ,e 1 ' 0 0 8 .\ 0 ed avevano cominciato a velocità soniche. che erano mizia1i già nei pnmi anm -
103
I - C3!1ìna •n-oìtlale
/I • .\rorllo tk-Oe110~
(' • C.unprr-,n, ctntru11~v n Jur ,1ntli
IJ ,iu,oro
J: IC.tuli,,toro '1"lhliri,t,,n-
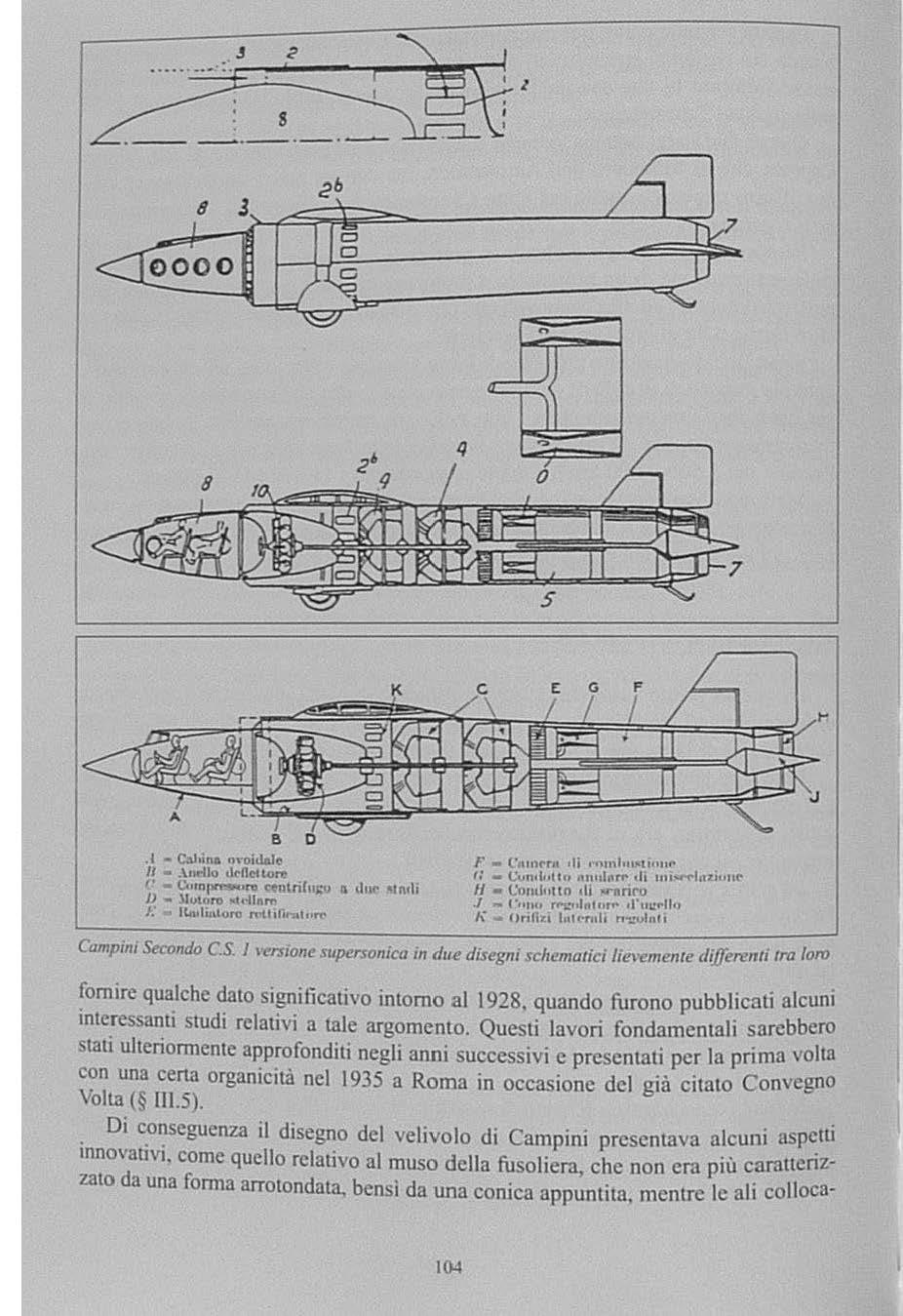
F - ,li , •Un1u, ,tiott'"
r: • Cun1l11th, m111h,"" di 1n1""1"ht-z1U11f"
Il • L'o111h111n rii ..,..nnro
J - I '0110 r~•lnth,,.. ,ruurll,, n· ()Mtir:1 11,tftf'Uli n-::olnh
Campin, Sttondo C S I , .:r.uonc supersonica in dtte disegni schematici liewmente differenti tra loro fornire qualche dato significativo imomo al 1928, quando furono pubblicali alcuni mteressanu studi relativi a taJe argomento. Questi lavori fondamentali sarebbero stau ulteriormente approfondili negli anni successivi e presentati per la prima volta con una cena organicità nel 1935 a Roma in occasione del già citato Convegno Volta(§ lll.5).
Di conseguenza il disegno del velivolo dt Campini presentava alcuni aspetti innovaliVJ, come quello relativo al muso della fusoliera, che non era più caratterizzato da una forma arrotondata., bensì da una conica appuntita, mentre le ali colloca-
~, • I ' • 8 : ' · -- - ---·-- · -
104
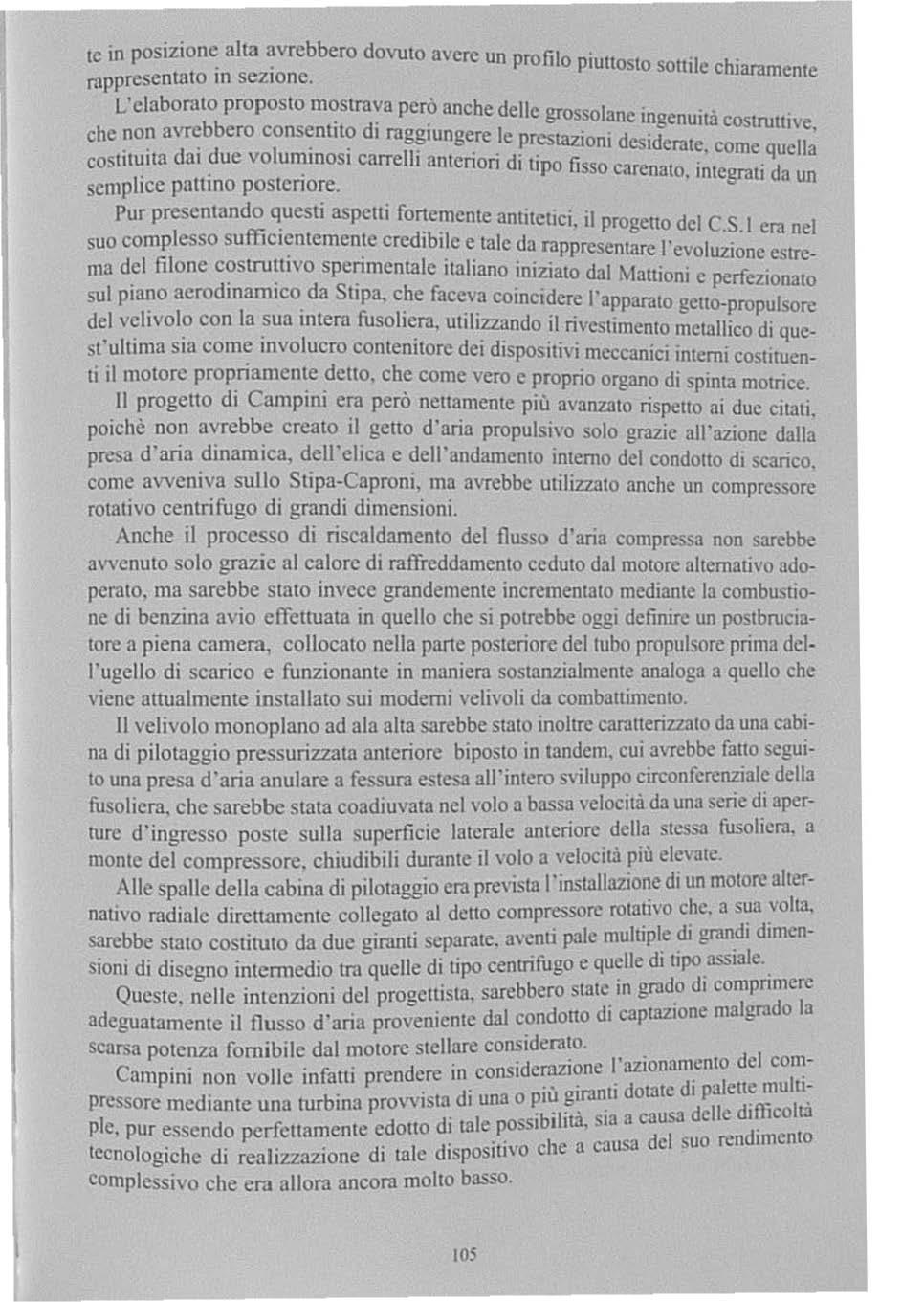
te in posizione alla avrebbero dovuto avere un profilo piuttosto . -1• • rappresentato m sezione. sotu e chiaramente
L'elaborato proposto mostrava però anche delle grossolan. · • . bb . . . e mgenuua costrutti\ e che non avrc ero consenuto d1 raggiungere le prestazioni d •. d · · · I • - • ~1 erate. come quella cos11tut1a dai due vo ummos1 carrelli antenon di tipo fisso carenai - d I . . . o. mtcg:rau a un semp ice pnumo postcnore. ..
Pur presentando q_uesti aspetti fortemente antncuci. il progetto del C.S. I era nel suo complesso sufficientemente credibile e tale da rappresentare 1·, 1 . · . . . . . evo uz1one estrema del filone costrutu,·o spenmentalc Italiano iniziato dal ~1attioni e ..r. • · d. · d S · pe,,cz1ona10 sul piano acro marmco a llpa, che faceq1 coincidere l'apparato g·tto- 1 . . . . _ e propu son: del veli\'olo con la sua intera fusoliera. u11hzzando il rh'es11mento metallico d" ._ · · · 1 . 1quc st'ult1ma sia come mvo ucro contennorc dei dispositiù meccanici interni costituenti il motore prop_namente _detto. eh~ come vero e proprio organo di spinta motrice. Il progetto d1 Campm1 era pero ncuamente piu avanzato rispetto ai due citati. poichè non avrebbe creato il getto d'aria propulsivo solo grazie all'azione dalla pre!>a d'aria dinamica, dell'ehca e dell'andamento interno del condono d1 :.carico. come avveniva sullo Stipa-Caproni. ma avrebbe utilizzato anche un compre ·ore rotativo centrifugo di grandi dimensioni.
Anche il processo di riscaldamento del flusso d'aria compre ,a non sarebbe avvenuto solo grazie al calore d1 raffreddamento ceduto dal motore alternalÌ\'o adoperato. ma sarebbe stato in\'ece grandemente incrementato mediante la combu~1ione di benzina 3\ io effettuata in quello che si potrebbe oggi definire un po,tbruciatore a piena camera, collocato nella parte posteriore del tubo propulsore prima dcli'ugello di scarico e funzionante in maniera sostanzialmente analoga a quello che viene attualmente installato sui moderni velivoli da combauimcnto
Il velivolo monoplano ad ala alta sarebbe staio inoltre cara11e.riua10 da una cabina di pilotaggio pressurizzata anteriore biposto in tandem. cui avrebbe fatto seguito una pre·a d'aria anulare a fessura estesa all'intero s\iluppo c1TConforenziale della fusoliera. che sarebbe stata coad1u\ ata nel volo a bas ·a\elocità da una serie di aperture d'ingresso poste sulla superficie laterale anteriore della ·te· a fusoliera, a monte del compre·sore. chiudibili durante il \·olo a velocità più ek\ ate .-\Ile spalle della cabma di pilotaggio era prensta 1·mstallaz1one d1 un moton: alternauvo radiale direttamente collegato al detto compressore rotaurn che. a suo \Olla. sarebbe stato costin110 da due giranti eparate. a\ enti pale multiple di grandi dimenioni di disegno intermedio Lra quelle di tipo cenLrtlùgo e qudle di tipoassiah: . Queste. nelle intenzioni del progettista. sarebbero state m grodo di comprimere adeguatamente il flusso d'aria proveniente dal condono di captazione mal!,rr:i<lo la carsa potenza fornibile dal motore stellare considerato. . . . . . -·d• ·one l'·t2ionomen10 del com- Campm1 non volle mfalll prendere m consi crazi • 1. . . . - · · nti dotate d1 palette mu 11pn.!ssore mediante una turbina prow1sta di una O P1~ g~ra d 11 d·t1· oltà 1 d I ...bilna. sia a cow,a e e i ic P e. pur essendo perfc11amente edotto I ta e po:,sl · d. lt a causa del ~uo ren imento tecnologiche di realizzazione d1 tale d1sposill\ 0 e e · complessi\'o che era allora ancora molto basso.
105

be d d. n·badire più volte egli considerò dannoso sovrapporre ai Come eb mo o 1 ' • , b. . h • bi mi· connessi con lo sviluppo d1 una adeguata tur ina aero- restaoll anc e I pro e · I h I . ad uno stadio di sviluppo embnona e, anc e se ne succes- naut1ca, che era ancora bb b · . b d 1 193, l'iog Giuseppe Belluzzo (§ vn.2) avre e pu bhcameote s1vo fob ra10 e - · . ffi · (B'b . d' · grado di costruirne una pienamente e 1c1ente I I. 5) con le assicurato I essere m . . . . . tecnologie ed i materiali allora disporubih m l~ha.
A 11 1· ria così compressa. addizionata a1 gas d1 scanco, avrebbe dovuto attra, a e a m.. dd ·1 I · d·atore rettt'ficatore che oltre a rau,e are I motore a temauvo con- versare un ra 1, • , • segnando altro calore al fluido gassoso, ne avrebbe regolanzzato 1 andamento dei fileui fluidi eliminando il moto elicoidale impresso loro d~lle p~le del compresson modo da renderli assiali e paralleli tra loro, per poterli poi immettere con per;;: minime d'energia nella corona anulare dei condoni cli miscelazione con il comb~tibile. che avrebbero dovuto avere un andamento a rubo Venturi convergentedin!rgente simile a quello dei nonnali carburatori d'automobile.
La successi,•a combustione a piena camera sarebbe avvenuta a valle di questi ultimi ed i gas caldi in pressione prodotti, espandendosi, avrebbero acquistato velocità confluendo subito dopo verso I·ugello di scarico, dove la loro velocità d'espulsione sarebbe stata ancora considerevolmente accresciuta grazie all'andamento convergente del condotto ed all'azione di otrurazione parziale dell'ugello di scarico realizzata mediante una spina mobile assiale, avente una forma doppio-conica a pera.
Con questa arch.itettura costruttiva, assolutamente originale ed inedita, Campini aveva previsto di risolvere in maniera ol(imale runi i problemi dei propulsori a getto già individuati per via teorica. evitandone i foni consumi e la bassa potenza erogata al decollo e durante il moto a bassa velocità. facendo funzionare in tale fase di volo il compressore come un'elica intubata a pale multiple ed a basso rapporto di compressione o tu.rboventola ed escludendo l'uso del postbruciatore.
Quest'ult1010 sarebbe stato invece inserito a partire da quote e velocità intennedie per potere accrescere subito dopo i valori di queste due stesse grandezze in maniera mollo rilevante.
Come abbiamo detto Campini doveva avere già una certa conoscenza dei fenomem d1 compressibilità dell'aria che si manifestano all'atto del raggiungimento e superamento del "muro del suono'·. con la fonnazione di onde d'urto sul muso del velivolo ed anche in corrispondenza delle prese d'aria.
In questa prima versione del suo C.S. I egli tenne infaui conto di tali fenomeni a.dot~do gH opp?nun! _accorgimenti necessari, il primo dei quali consisteva nelI adozione dr un d1spos11tvo per la variazione della geometria della presa d'aria anulare antenore, che ne avrebbe modificato la sezione longirudinale di c~ptazione ed efflusso fa~endola p~are da semplicemente divergente in volo subsonico a convetnte-d1vergen1e m_quello superso~ico.
n secondo accorgimento avrebbe invece permesso d'ovviare alla scarsa potenza trasmessa al compressore da pane del motore stellare disponibile, la cui potenza non avrebbe allora superato i 700-800 CV.
106
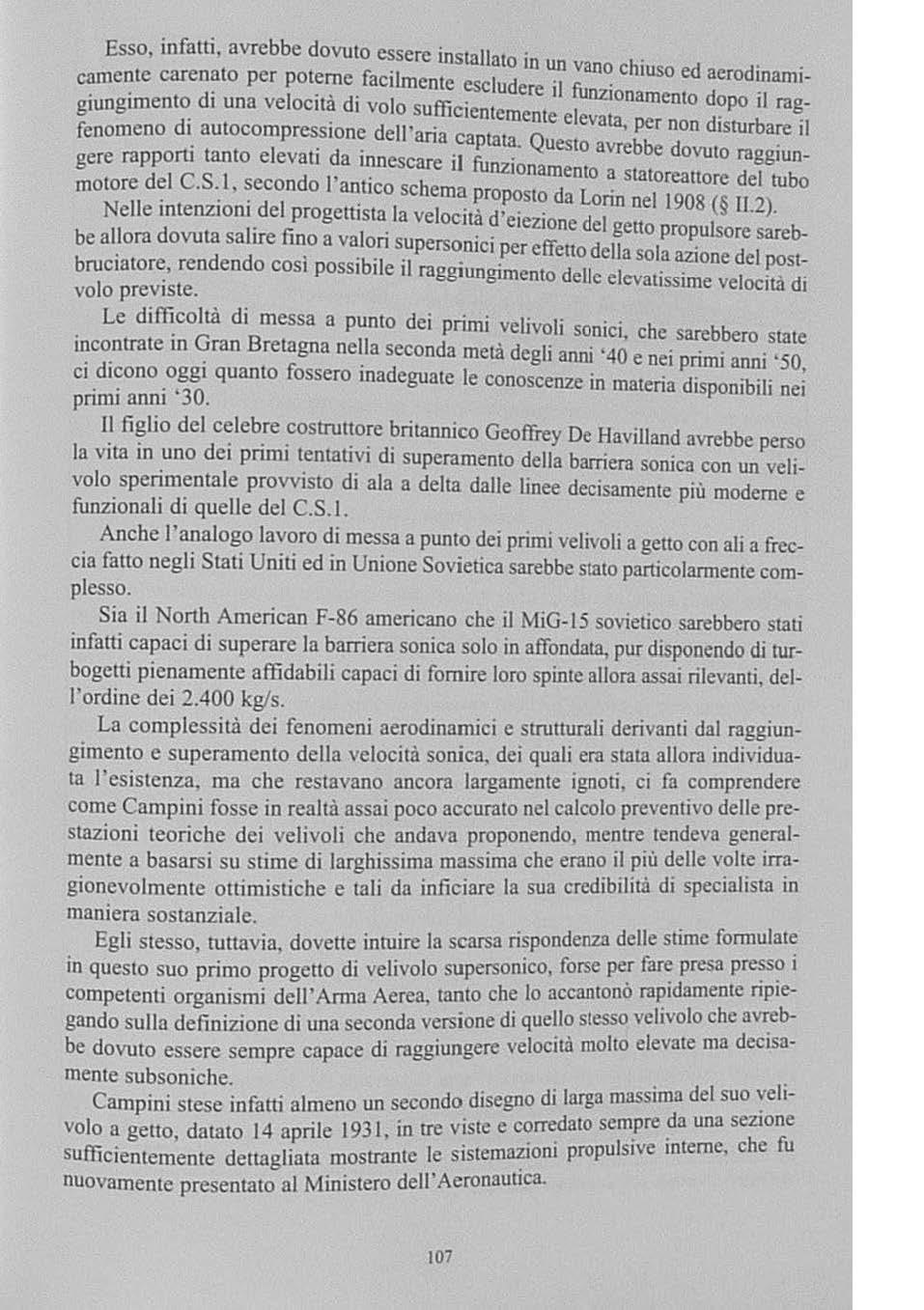
Esso, infatti, avrebbe dovuto essere installat · . camente carenato per poterne facilmente esclu~ 10 , ~an~ chiuso ed aerod~narnigiungimento di una velocità di volo sufficientemerct t I nz1onameoto dopo il rag. . en e e evata, per n d. rb 1 fenomeno dt autocompress1one dell'aria ca la Q on JStu are , . . P ta. uesto avrebbe dovut gere rapporu tanto elevatt da innescare il funziona O raggiund I e S I d , . mento a statoreanore del tubo motore e . . • secon o I antJco schema proposto da l ·
Nelle imenzioni del progettista la velocità d'eie.,.; donn, nel 1908 (§ 11.2). I d l. fi . ...one e getto propulsore sareb- be al ora avuta sa rre mo a valon supersonici per effetto d Il 1 . b · d d • . . . e a so a azione del post- ruc1atore, ren en o cosi poss1b1le 11 raggiungimento del! I • • volo previste. e e evaussune velocita di
Le difficoltà di messa a punto dei primi velivoli soni·c· h bbe · · o B 1 , c e sare ro state incontrate m ran retagna nella seconda metà degli· anru· ·40 · · · · . . . . e nei pruni anru '50, c1 dicono ogg, quanto fossero inadeguate le conoscenze in maten·a d. ibil' · · · · •30 1Spoo1 1ne, pnm1 anm .
Il figlio del celebre costruttore britannico Geoffrey De Havilland bb I · · d · • • . . avre e perso a vita m uno e1 pruni tentat1v1 di superamemo della barriera sonica con un velivolo sperimentale provvisto di ala a delta dalle linee decisamente più moderne e funzionali di quelle del C.S. I.
Anche l'analogo lavoro di messa a punto dei primi velivoli a getto con ali a freccia fatto negli Stati Uniti ed in Unione Sovietica sarebbe stato particolarmente complesso.
Sia il Nonh American F-86 americano che il MiG-15 sovietico sarebbero stati infatti capaci di superare la barriera sonica solo in affondata, pur disponendo di turbogetti pienamente affidabili capaci di fornire loro spinte allora assai rilevanti, dell'ordine dei 2.400 kg/s.
La complessità dei fenomeni aerodinamici e strutturali derivanti dal raggiungimento e superamento della velocità sonica. dei quali era stata allora individuata l'esistenza. ma che restavano ancora largamente ignoti, ci fa comprendere come Campini fosse io realtà assai poco accurato nel calcolo preventivo delle prestazioni teoriche dei velivoli che andava proponendo, mentre tendeva generalmente a basarsi su stime di larghissima massima che erano il più delle volte irragionevolmente ottimistiche e tali da inficiare la sua credibilità d1 specialista in maniera sostanziale.
Egli stesso, tuttavia. dovette intuire la scarsa rispondenza delle stime fonnulat: in questo suo primo progetto di velivolo supersonico, forse pe_r far: presa pre~s? 1 competenti organismi dell'Arma Aerea. tanto che lo accantono rapidamente np1egando sulla definizione di una seconda versione di quello stesso velivolo che avrebbe dovuto essere sempre capace di raggiungere velocità molto elevate ma decisamente subsoniche. . . 1 r
Campini stese infatti almeno un secondo disegno d1 larga massima de suo ve 1 • volo a getto, datato 14 aprile 1931. in tre viste e corredato sem_pre ~a una sezione ffi 1 · · 001· propulsive mteme. che fu su c1entemente dettagliata mostrante e s1stem~ nuovamente presentato al Ministero dell'Aeronauuca.
107
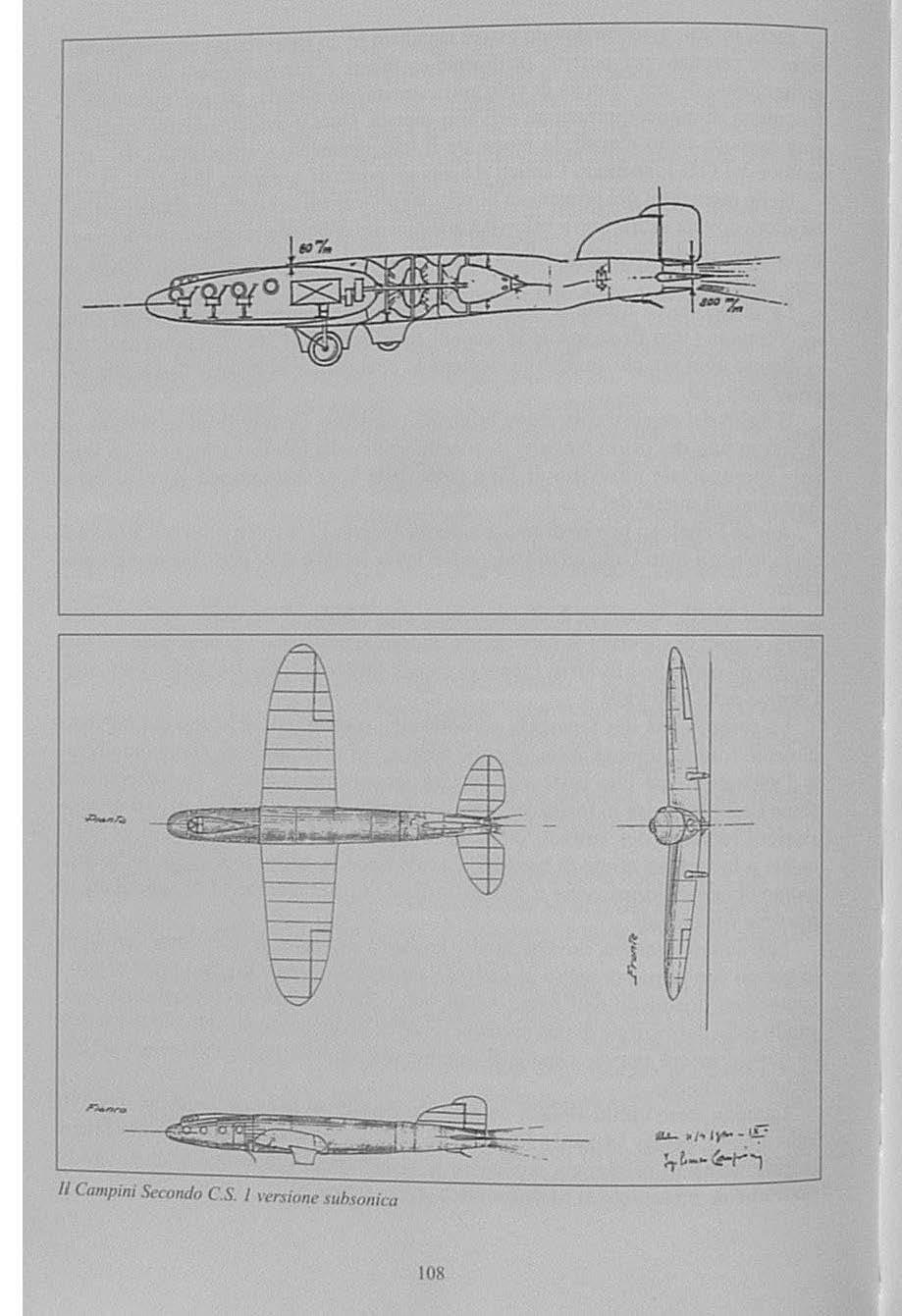
..,__ •J• lr'"° - •:i;: ;. i -~te-,-.-ì
108
/i Campin, Secondo es. / \t'f7.<IU/lt'
,11hso11ic11
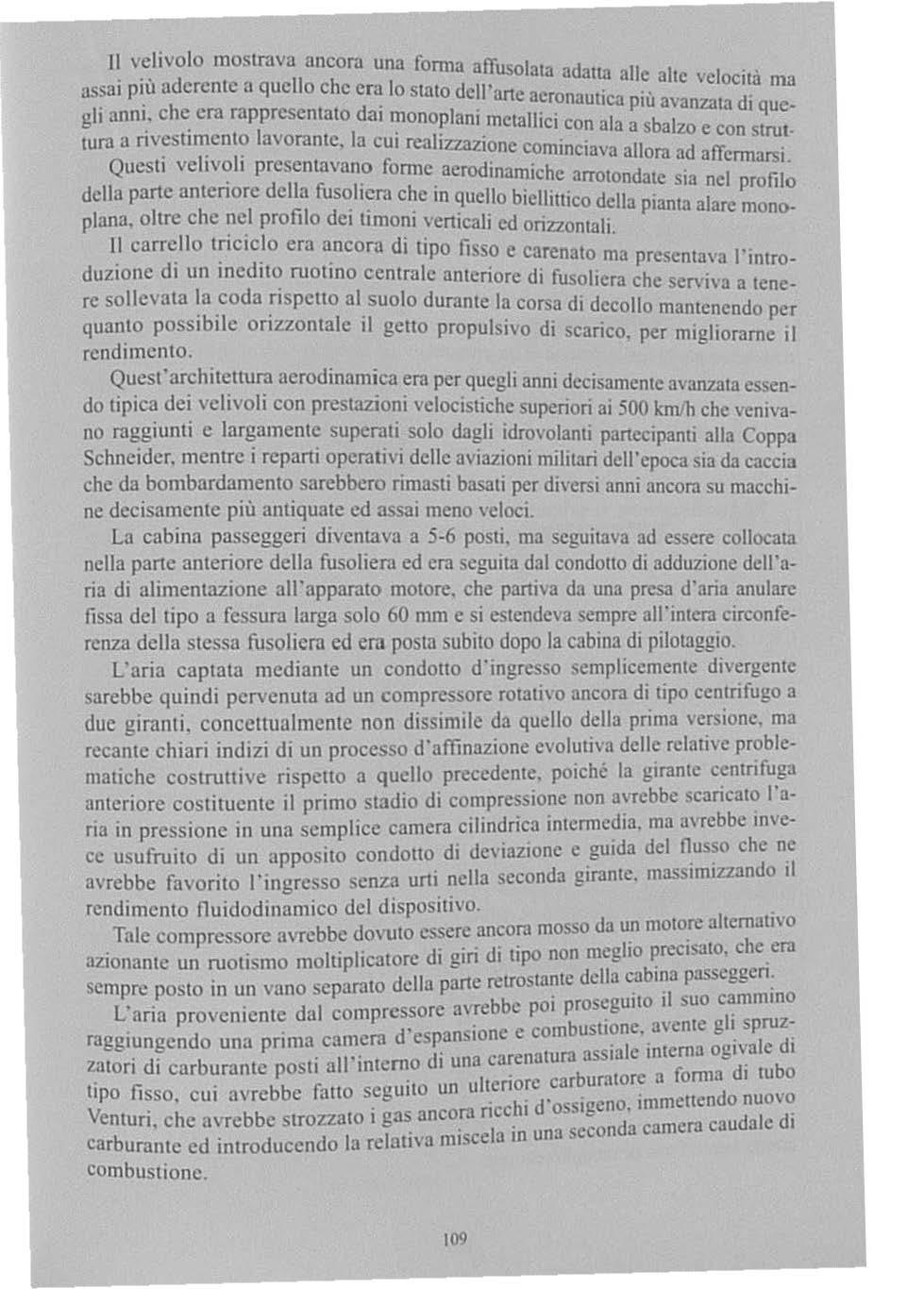
J1 velivolo roostn1va ancora una fonna affusolata d . 11 . .. d I a atta a e alte veloctta ma assai ptu a ercnte a quc lo che era lo stato dcll'ane acro,,a 1- . · h . . u tea ptu a, anzata dt que- gli anni. e e era rappresentato dat monoplani metallici co I b 1 · · I . n a a a s a zo e con struttura a nvcsttmcnto avorante. la cut realizzazione commc,·a ali d Ili · · 1· 1· ,a ora a a crmars1 Quesll ve 1vo I presentavano fonne. aerodinamiche arrot d 1 • . on ate sia ne profilo dello parte antenore della fusoliera che m quello biellt"tt,·co d Il I . . e a pianta a are monoplana. oltre che ?el profilo det limoni venicali cd onzzontali. li carrello trtc1clo era ancora dì tipo fisso e car"nato ma 1•. . . . . . " presenta, a mtroduztone dt un ined1t~ ruotino centrale anteriore di fusoliera che sen·iva a tenere sollevata ~a _coda :•spello al_suolo durante I~ corsa dt decollo mantenendo per quan_to poss1b1le orizzontale ti getto propulsivo dt scarico. per migltorame ti rend11nento.
Quest·architettura aerodinamica era per quegli annt decisamente avanzata essendo tipica dei ,·eli\'oli con prestazioni velocistichc superiori ai 500 km/h che vemvano raggiunti e largamente superati solo dagh idrovolanu panec1panu alla Coppa Schneider. mentre i repani operalin delle a, iaz,oni militari dell'epoca sia da caccia che da bombardamento sarebbero rimasti basati per diversi nnni ancoro su macchine decisamente più antiquate ed assai meno veloci.
La cabina passeggeri diventava a 5-6 posti. ma seguitava ad essere collocata nella pane anteriore della fusoliera ed era seguita dal condotto d1 adduzione dell'aria di alimentaz1one all'apparato motore. che pan1\.a da una presa d"ana anulare fissa del tipo a fessura larga solo 60 mm e si estendeva sempre alrintera circonfercnw della stessa fusoliera ed ero posta subito dopo la cabina di pilotaggio.
L"aria captata mediante un condono d'ingresso semplicemente divergente sarebbe quindi pervenuta ad un compressore rotall\'Oancora di tipo centrifugo a due giranti. concettualmente non dissimile da qudlo della pnma \'ersione. ma recante chiari indizi di un processo d"affinazione evolutiva delle rdarivc problematiche costruttive rispeuo a quello precedente. poiché la girante centnfu_ga anteriore costituente 11 primo stadio di compressione non avrebbe se.meato I ane in pressione in una semplice camera cilindrica intermedia. ma avrebbe invece usufrutto di un apposito condono dt deviazione e .guida del nus~o che ne avrebbe farnrito l'ingresso senza uni nella seconda girante. mas5 ,m,aamJo 11 rendimento nuidodinnmico del dispos11ivo. 1 • .. • osso da un motore a tcmauvo Tale compressore avrebbe dovuto c.:sseri.: an~o~ m . . azionante un ruo1tsmo moltiplicatore di gin d1 upo non meglto precisato. che era sempre posto in un vano separato della pane retrostante dello c_abma pnSSt:ggen. bb • 0 prosegutto ti suo cammmo L"aria proveniente dal comprc.:ssore aHe e P 1 . 1 . .. combustione avente g , spruz- ragg1ungendo una pnma camera d espansione e . · · . 1 d • 1 ra assiale interno ogl\ a e 1 201ori dt carburante posti all'intcmo dt una cn~eno u ,·orma dt tubo . • ult ·riore carburatore a tipo fisso, cu, avrebbe fatto seguito un i:: d" . ·mm••ttendo nuo\'O " . . ra nccht oss1e:eno. 1 ventun, che avrebbt: strozzato t ga~ anco_ . uno sc~onda camera caudale d1 carburante ed introducendo la relnttva miscela in • combustione.
109
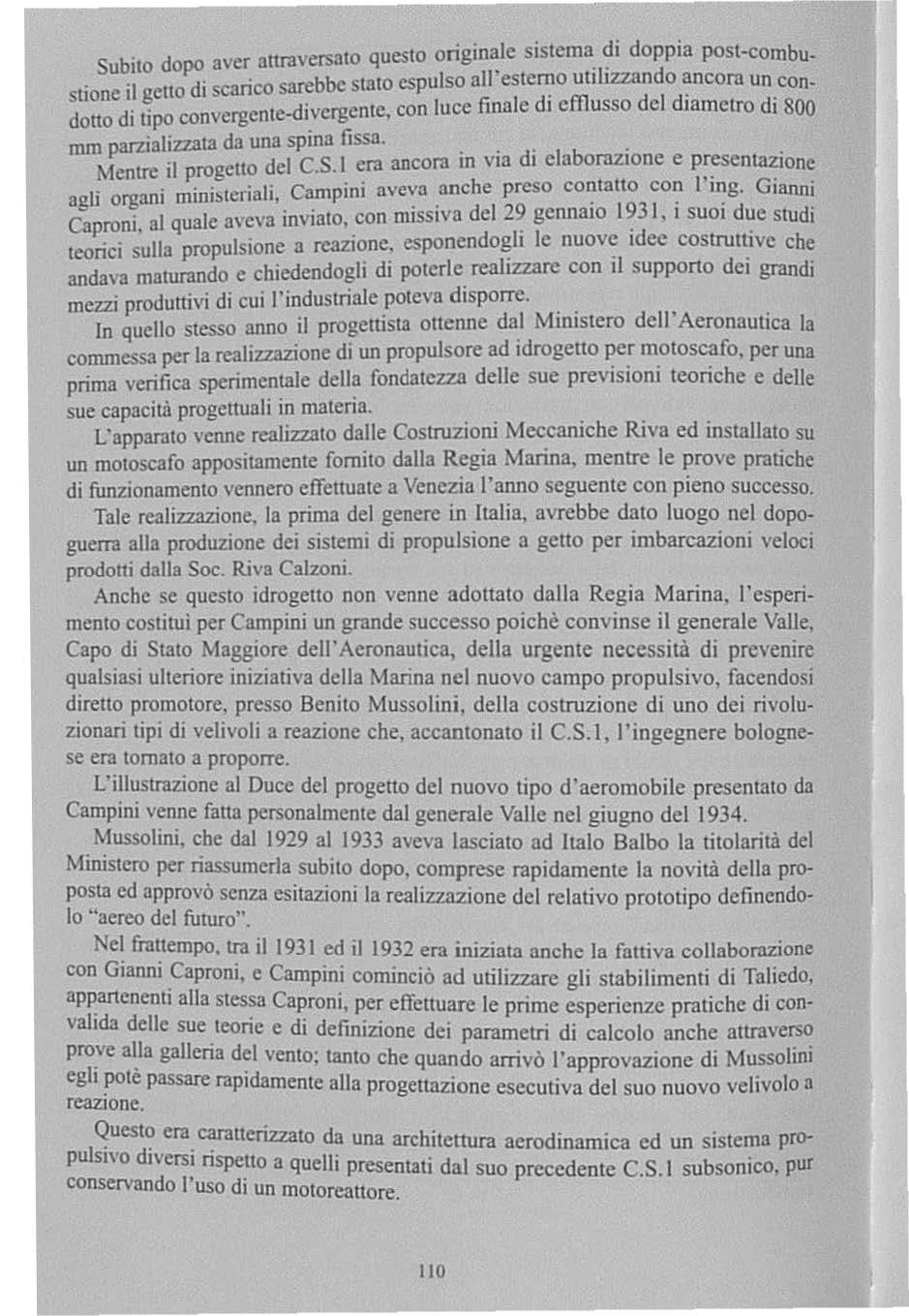
b. d ·er attra\'ersato questo originale sistema di doppia post-combu- Su 110 opo a\ · . . . .1 d. an·co :s·arebbc s11110 espulso ali esterno uuhzzando ancora un consnone I getto I se . m d Id" . d. · ergente dt'vergente con luce finale d1 e usso e 1amctro d1 800 dotto I upo conv - • mm parzializzata da una spinn fissa. . . . .
Mentre il progetto del CS. I era ancora m \'13 d1 elaborazione e p~~entaz.1one I. · mi'nh,teriah Campini aveva :mche preso contatto con I mg. Gianni ag 1 organi • · · , , · 1931 · · d · e · I quale ave\'a imiato. con m1ss1va del _9 gcrma10 . 1suoi ue studi aprom. a · 1 ·d · teorici sulla propulsione n reazione. esponendogli e nuo\'e I ee costnnt_1ve che anda,a maturando e chiedendogli di poterle reah.zzare con 1I supporto dei grandi mezzi produttivi d1 cui l'industriale pote\a disporre. . _ • _
In quello stesso anno il progetusta ottenne dal MIIllstero dell Aeronautica la commessa per la realizzazione d1 un propulsore ad idrogetto ~er motos~fo. per una prima \'erifica sperimentale della fondatezza delle sue pre\1s1on1 teonche e delle sue capacità progettuali in materia. . . _ _ _
L'apparato venne realizzato dalle Costruz1oru Meccaniche Riva ed mstallato su un motoscafo apposttamente fornito dalla Regia Marina. mentre le pro\'e pratiche di funzionamento \'ennero effettuate a Venezia l'anno seguente con pieno successo. Tale realizzazione. la prima del genere in ltalia, avrebbe dato luogo nel dopoguerra alla produzione dei sistemi d1 propulsione a getto per imbarcazioni veloci prodotti dalla Soc. R.l\'G Calzoni
Anche se questo idrogetto non venne adottato dalla Regia Marina. l'esperimento costituì per Campini un grande successo poichè COO\ inse il generale Valle. Capo d1 Stato Maggiore dell'Aeronautica, della urgente necessità di prevenire qualsiasi ulteriore m1ziat1\'a della Manna nel nuovo campo propulsivo, facendosi diretto promotore. presso Benito Mussolini, della costruzione di uno dei rivoluzionari tipi dì \'elìvoli a reazione che, accantonato il C.S. I. l'ingegnere bolognese era tornato a proporre.
L'illustrazione al Duce del progetto del nuovo tipo d·aeromobile presentato da Campini venne fatta personalmente dal generale Valle nel giugno del 1934.
Mussolini. che dal 1929 al 1933 aveva lasciato ad Italo Balbo la titolarità del Ministero per riassumerla subito dopo, comprese rapidamente la novità della proposta ed approvò senza esitazioni la realizzazione del relativo protoùpo definendolo "aereo del futuro".
Nel frattempo, tra il 193 l ed il 1932 era iniziata anche la fattiva collaborazione con Gianni Caproni, e Campmì cominciò ad utilizzare gli stabilimenti di Taliedo, ap~artcnenu alla stessa Caproni, per effettuare le prime esperienze pratiche di convalida delle sue teorie e di definizione dei paramctn di calcolo anche anraverso pro:e al_la galieno del vento; tanto che quando arrivò l'approvazione d1 Mussolini egh ~te passare rapidamente alla progettazione esecutiva del suo nuovo velivolo n reazione.
~uest~ era caraueri.zzato da una architettura aerodinamica ed un sistemo propulsivo divers! rispeuo a quelli presentati dal suo precedente C.S. l subsonico. pur conservando I uso di un motoreattore.

L 'aer op/011 0 sp erim e111a /e Campini Caproni C. C.2
Nella seconda metà del 1934 Campini pose quindi mano alla progetiazione esecutiva e costruzione del suo secondo aeroplano a geuo avente caratteristiche di volo assai meno spinte del C.S. I supersonico. e quindi assai più facilmenie perseguibili. ed anche di dimensioni nettamente inferiori a quelle del C.S. I subsonico.
L'impianto propulsivo era ancora basato su di un motore ahcrnauvo collegato ad un compressore rotativo, ma usava un motore in linea di minore sezione trasversale rispetto a quella dello stellare previsto per il C.S.I e quindi collocabile in una fusoliera di diametro nc1tamente inferiore. az1onan1c un compressore rotativo di tipo assiale. anch'esso di diametro esterno inferiore, ma di disegno e costruzione più complesse di quelle del tipo centrifugo del C.S. I, che non era più collocato posteriormente rispetto al motore a pistoni che lo azionava, ma anterionneme ad esso.
Il nuovo progetto fu caldeggiato presso Mussolini oltre che dal già citato Capo di Stato Maggiore della
Regia Aeronautica. anche dal grande Di.segno originale l'ENAR dd Campini Caproni e e 2 Disegno di progmo del CC.:! (parre anteriore)
l~.2:
.
lii
;

Di.t,,._'110 di progt uo del CC 2 parrt· po>terion:
pilota ed asso Mario De Bernardi, sempre molto ascohato dal Duce per la sua grande competenza sui temi aeronautici: 11 quale. lasciato il servizio attivo nella Regia Aeronauuca. era di\'entato dal 1930 pilota capo-collaudatore della stessa Caproni. li 5 febbraio 1934 la Regia Aeronautica stipulò quindi con la società intestata a Secondo Campim un regolare contrano per la costruzione di una fusoliera completa dei relati,i orgam propulsori interni, che sarebbe stata impiegata per la messa a punto e le pro\'e statiche di funzionamento a terra. oltre che di due prototipi compleu per I collaudi in volo.
L'impono di tale commessa fu stabilito m 4.5 milioni di lire e la data di consegna pm ista fu quella del 31 dicembre 1936.
Per la progettazione esecuti\'a iniziata in quello stesso 1934 e la costruzione della fusoliera di prova, Campini raggiunse un pieno accordo 1ecnico-commercìalc con l'ìng Gianni Caproni, tanto che, nel successivo 1935, la committente Secondo Campini Milano VENAR venne sostituita da una nuova società Campini-Caproni con sede a Taliedo.
Questo nuovo velivolo sarebbe stato classificato, anch'esso a posteriori, con la sigla C.C.2 (Carnpmi-Caprom 2). ma questa volta con ragione, visto che esso era stato ideato e disegnato da Carnpmi, ma progettalo nei dettagli e costruito da una società del gruppo Caproni per conto di una società che era stata intitolatn ad entrambi gli ingegneri.
Mal~do ciò tale designazione avrebbe dato successivamente luogo a molti problemi d1 corretta attribuzione cd identificazione (§V.5).
Il nuovo aeroplano aveva un·archtteuura totalmente inedita per quegli anm. carauen~t~ l'al~o da una notevole finezza aerodinamica che gli conferiva una grande vahd1La sul piano estetico.
I 12
La presa d'aria dinamica djveniava anteriore a piena apenura, mentre la lunga cabina di pilotaggio biposto pressurizzata veniva spostata dal muso al centro della lunga fusoliera ed annegata nel suo interno, lasciando emergere solo il lungo tettuccio esterno Palella del compmsore opportunamente raccordato all'ampio r-------;;;;;=------~ timone verticale posteriore.
Anche l'apparato propulsore presentava aspetti innovati\'i di grande modernità specie nel disegno del compressore anteriore che era di tipo assiale e costituito da un rotore recante tre distinie giranti, o stadi successivi dj compressione, che erano però carauenzzate da un numero ridouo di palette. soltanto 15 per ciascuna d1 esse, ma di grandi dimensioni come nelle attuali turboventole, ed a passo \'ariabile per eliminare eventuali problemi dt siallo alle velocità di flusso dell'aria relati\'e ai diversi regimi di rotazione.
Tali stadi rotorici erano infatti dotati di un a,•anzato sistema idraulico per la variazione dell'angolo d"incidenza delle paleue che sarebbe ricomparso in Italia solo negli anni ·60 sul turbogetto Generai Elcctric J-79 dell'F-104 '"Starfighter··.
Essi venivano posti in rotazione all'interno di tre stadi statonci cui faceva infine seguito il radiatore del motore alternati,·o funzionante anche da raddrizzatore del flusso stesso.
Girante .rperimentalt• p.-r pro,·<' d, ncsutt'tCO mt"C· canica

Tale compressore era infaui posto a monte e direttamente azionato da un 1 motore alternativo Isotta Fraschini Delta a 12 cilindri a ··v". il quale. nella sua versione più spinta L 121, era a sua volta dotato di un compressore di sovralimentazione e forniva. ma con molli problemi. 900 CV nominali. ', ,.,.,,,,/a,'Olf) t,-cno/ogìco d<'lfrporo • la gironi<' ..,n •-r- ·r ·e.e~ completa del compresson· dd Campim ._aprom -
I13

Il Ira I due apparati era effettualo tramite una trasmissione ad Il co egamento . . . h grado di incrementare notevolmente 11 numero dei gin dello mgranaeg1 c e era m l • - n·spellO a qudh del motore, ponandolo ad un va ore medio di stesso compressore circa 3 500 gin mm. . . . LI potenza effetti,a fomi1a al compre$sore da questo upo d1 motore ahemau\'o · lto piu· bassa di quella che sarebbe stata necessana, tanto che la restava tulta\'la mo . . . · ti aie dell'aria ottenibile all'uscila dell ultimo stadio del compressore pressione m · Il' d g3 b'-·· a,'tlto un \·alore estremamente hm1ta1O, _pan a incirca a 0-8-t0 stesso avrc = · mmHg. con un rapporto di compressione d1 poco supcnore ad I.
li problema della turbina
Come Campini a\'e\'a già ampiamente previsto, il compressore che a\'cva disegnato avrebbe potuto essere mosso anche da una più p~ten1e turbma capace di raccogliere direnameme parte dell'energia tennodmam1ca del flusso d1 gas caldi combusti uscenti da un processo preliminare di compress1one e combusuone.
Quesu pro,·oca, ano però un forte riscaldamento della palettatura. che se fosse s1ata realizzata con un comune acc1a1O al carbonio sarebbe stata rapidamente deteriorala da fenomeni di ossidazione e corrosmne.
Come abbiamo già deno {§U 2) 1aJe dispositivo cm noto in Jtalia fino dai tempi dt Cosimo Canovetti (Bibl. 14) e quindi pienamente realizzabile sul piano del disegno fiuoidodinam1eo, ma non pote\'a però essere fabbricato con i comum acciai inossidabili. contenenti percentuali ridoue di nickel e cromo, che sono resistenti alla corrosione ma non alle temperature di funzionamento superiori a1 500° C.
L·accia10 inossidabile allora fabbncato in Italia venne infatti utilizzato per realizzare l'involucro d1 rivestimento interno d1 fusoliera del C.C.2 m corrispondenza della camera di combustione. ma non poté essere usato per la coscruz1one delle paleue d1 una adatta turbina a causa della presenza del fenomeno dello scorrimento \'ISCOSO o ··creep".
Esso consiste nella continua deformazione del metallo sollo l'azione congiunta della forza centrifuga agente sulle palette in rotazione ad alto numero di giri e delle alte 1emperarure dei gas pro\'ementi dalle camere d1 combustione, che le avrebbe ponate ad allu~garsi progressivamente fino ad urtare contro la parete interna della carcassa metallica d1 contenimento.
Le palene a,~bbero perciò dO\'tltO essere costruite con adatte leghe speciali che oltre ad essere inossidabili avrebbero dovuto essere anche indefonnabili ed assai re.slSlenti_aUe sollec1tazioni: materiali che nella prima metà degli anni '30 erano ines1s1enh sia 10 Italia che alrestero.
ln quegh stessi anm, taLi leghe speciali, che in pratica avrebbero dovuto contenere e~clusivameote mckel e cromo, dovettero essere messe allo studio, fabbricale e spenmentate anche in Germania e Gran Bretagna.
114

Anche Frank Whinle ed Hans von Hoain incontrarono bi · al . . • · · b bb • pro em1 an ogb1 a quel- h di Campm1, c e avrc ero pero superato con relativa facili•:. • 11 di . · · · • 11· d 11 . .... grazie a a sponi- bilita dt quest1 stessi meta I e a e nlevami capacità delle ·,nd • 11 . . . . . ustne meta urg1che dei loro nspetl1v1 paesi.
Le scorte di nickel e cromo, nel corso della seconda guerra d. 1 lì ffi · · 1 mon 10 e, urono però appena su 1c1ent1anc te per la Gennania; il nickel veniva infatt' estratt I . . d' K I . kk" I I o so o dalle m~mere t o ~SJO_ t, ne la Penisola dei Pescatori della Lapponia norvegese. mentre 11 cromo veruva importato dalla Turchia (Bibl. 76).
Nel caso ?ritannico, i~ ~~colare, le ricerche di un adatta lega per palette di turbina ruotanti a 15.000 giri/mm ed a temperarure massime dell'ordine di 100° e furono effettuate dalla Mond Nickel Company su richiesta del governo britannico.
li risultato fu la produzione di una lega contenente circa 1'80% di nickel ed il 20% di cromo, denominata Nimonic 75 che venne realizzata nel 1940, mentre nel 1941 fu messa a punto anche la Nimonìc 80.
Esse vennero utilizzate su tutte le turbine a gas aeronautiche costruite in Gran Bretagna.
ln seguito un numero grandissimo di nuove leghe adane a questo tipo d'impiego. circa 400, sarebbe stato realizzato e messo a disposizione in tempi relativamente brevi anche dagli americani.
Nello specifico settore metallurgico delle leghe speciali tutti questi paesi erano assai più avanzati del nostro, che era rimasto al palo per oltre un quinquennio anche a causa dell'applicazione delle sanzioni che erano state decise nel 1935 dalla Società delle Nazioni al tempo della guerra d'Etiopia.
La produzione mondiale di nfokel in panicolare era allora controllata quasi al 100% dai paesi anglosassoni e dalla Francia essendo provemente in grande pane da giacimenti canadesi e della Nuova Caledonia.
L'embargo sui metalli strategici che ne derivò. rese quin~i d~cilm~nte reperibili per il nostro Paese i metalli pesanti usati nella costruz10ne dt t~rb~~e. .
Da noi inoltre il nickel con il rame e lo stagno. rientrava tra I piu costosi materiali p,regiati 0 tan10 che 0 negli anni immediatamente precedenti I'i?izio dell_a ' . I' lll- seconda guerra mondiale pur essendo orma, cadute le dette sanz,001, asso gliamento delle riserve ~uree derivante dalle guerre d'Etiopia e Spa~n.a ne • f1i • te commisuralo alle necessita del tmped1 un approvv1g1ona01ento e etllvamen
Paese (Bibl. 37). . • d. va infatù
A·ll'auo dello scoppio della seconda guerra mondiale I ltal~a _ispane_ d' di scone di nickel ammontanti a sole 250 t, sufficienti a copnre 11 fabbisogno 1 soli 20 giorni di nonnale produzione industriale già in_ atto. . e uito di un
U fi . . d' I00 tera rimasta bloccata m Norvegia a s g na om1tura m corso t . d rii I avesse dichiarato la diretto intervento ostruzionistico britanmco, malgra O a 18
sua non belligeranza. . . tanto che venne preven-
La situazione era rimasta qumd1 eStcema~ente gra~c,I a di nickel che erano · . d. · 2 500 t d1 monete in eg . t1vato 1I recupero forzoso I circa · • · che erano stati m allora in circolazione, i cosiddetti nichelini da 20 centesnru.
115
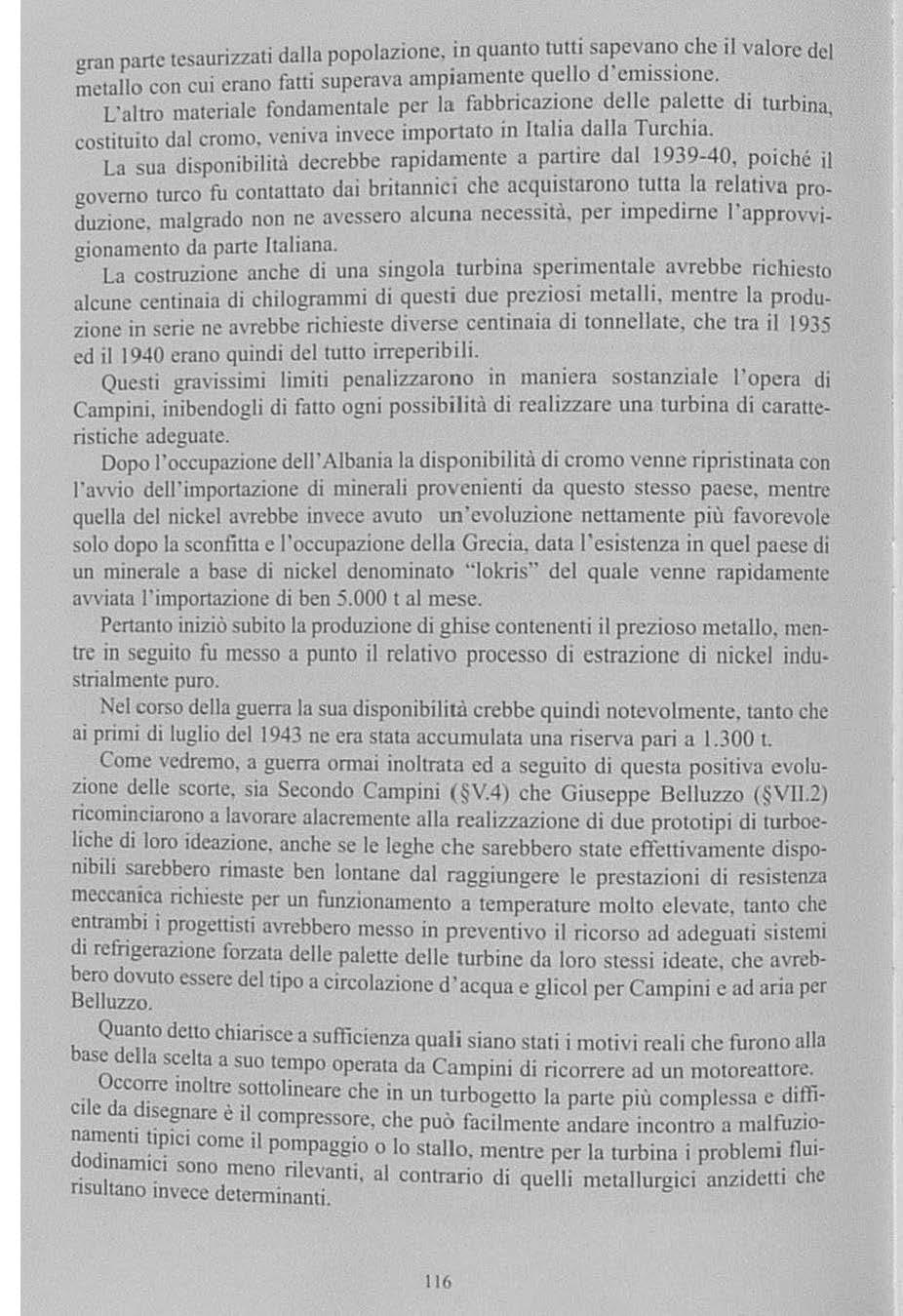
·. t. dalla popolazione. in quanto tutti sapc,ano che il \'Olore del eran parte te aunzza 1 , 11 d ". · · , y · f:alli supera\'a ampiamente quc o cm1ss1on1.:. metallo con cui erano • . . . .
L"alrro materiale fondamcn1ale per la fnbbncaz1~ne dellè pal~tlc d1 turbina, · · d I 010 , ,.,01\'a invece importato in li.alla dalla Turchia. cos111m10 a ero . . . .
La . d'sponibilità decrebbe rapidamente a pan1re dal 1939-40, po1che il ::.ua 1 - I I · , fu contat1nio dai britannic i che ncqu1s1arono tutla a re a11 va pro- governo rurco . • · d · 1duzionc. malgrado non ne a, essero alcuna necessita. per 1mpe ime approvvigionamento do pane Italiana. _ • • ,
La costruzione anche di una singola 1urbma spenmcntnlc a, rebbe nch1es10 alcune centinaia di chilogrammi di ques1i due preziosi metalli. mentre la produZJone in serie ne a, rcbbe richieste di\'erse centinaia di 1onnellate. che tra il 1935 cd il 19-10 erano quindi del rullo irreperibili.
Questi gra\'issimi limiti penalizza~o~o. in maniera sostnnzia!e !'?pera di Campini. inibendogli di fallo ogm poss1b1l1ta d1realizzare una turbina d1caratteristiche adeguate.
Dopo l'occupnzione dell'Albania la disponibilità di cromo \'Cnnc ripristinata con l'anio dell'importaz1one d1 minerali provenienti da questo stesso paese. mentre quella del nickel avrebbe tm cce avuto un ·C\'Oluzione nettamente più fa\'orevole solo dopo la sconfitta e l'occupazione della Grecia. data l'esistenza in quel paese di un minerale a base di nickel denominato "lokris" del quale venne rapidamente av, iata l'imponazione di ben 5.000 l al mese.
Pertanto iniziò subito la produzione d1 ghise contenenti il prezioso metallo. menu-e m seguito fu messo a pun10 il relativo processo d1 estrazione di nickel ìnùu• strialmen1c puro.
Nel corso della guerra la sua disponibilità crebbe quindi notevolmente, tanto che ai pnmi di luglio del 19-13 ne era stata accumulata una riserva pari a 1.300 1. Come vedremo. a guerra ormai inohra1a ed a seguito di questa positi\'a evoluzione delle scorte. sia Secondo Campini (§V.4) che Giuseppe Bclluzzo (~Vll.2) ricominciarono a lavorare alacremente alla realiuazione di due prototipi di turboeliche di loro ideazione. anche se le leghe che sarebbero state effettivamente disponibili sarebbero rimaste ben lontane dal raggiungere le prestazioni di resistenza meccanica richieste per un funzionwnento a 1empera1ure molto e leva1c, tanto che e~tra~bi i proge11isti a\Tebbero messo in preventivo il ricorso ad adeguati sistemi di refrigerazione forzato delle palelle delle 1urbinc da loro stessi ideate. che :n rcbbero dovuto essere del tipo a circolazione d·acqua e glicol per Campini e ad aria per Bclluzzo.
Quanto deno chiarisce a sufficienza quali siano stati i motivi reali che furono alla base ddla s:elt.a a suo tempo operata da Campim di ricorrere ad un mo1orca1tore.
. Occorre inoltre sottolim.-are che in un turbogcno la pane più complessa e difficile da ~•se~are è il compressore, che puo facilmente andare incontro a malfuziondamd_enu tipici come il pompaggio o lo stallo. mentre per la turbina i problemi Ouio mam1c1 sono meno n·1e,·an1· al · d. 11· · · ·d · I ' . . 1 . contrano I que I metallurg1c1 anzi c111 e ic risultano m\'ece deiennmanti.
116

Le capacità progettuali di Campini sono quindi rese cv·d · d I f: . 1 enu a ano che egh seppe disegnare un compressore assiale solisticato. essendo dotat d. 1, d • · b·t , • d· • . o I pa ette a incide~ vana,. I e dc. dq~m 11 as~1 valido sul piano fluidodinamico. pur essendo dotato d1 tre so I sta 1 1 pa euc d1 grande lunghezza e fone corda 1•.· d. d . . . per esigenza 1 crnrtare una gran. e mas;-1 d ana fornendo un rapporto di compressione poco ele,ato appena supenore a - solo a qu?te medie, mentre ad esempio il quasi coevo Junkers Jumo 004_ d~I Messers<:hmlll Mc.262 raggiunge\a un rappono pari a 3.7. ma con ben 8 stadi d1 compressione.
Que~ta scelta ~pparentementc ridutuva era in realtà determinata dal fatto che. per forza d1 cose. egli e~ dovuto ncorrerc ad una fonte d'energia meccanica primana d'azionamento assai meno potente di una turbina. adottando un classico motore alternativo da 900 CV che sarebbe stato incapace di fornire ad un compressore più spinto la potenza motrice necessaria
Campini dovette perciò ridurre il numero di giranti. limitando di conseguenza in maniera sostanziale sia il rapporto d1 compressione totale in uscita che il rendimen10 del postbruciatore posto a valle. a causa dell'eccesso di aria usata. tagliando cosi drasticamente già m partenza le prestazioni complesm e che a,Tebbe potuto ouenen: dal suo motoreattore. ma non rouimistica fiducia che messo egli a\Tebbe seguitato a nporrc.
La nuova disposizione del compressore a monte del motore alternativo sarebbi: stata mfatu panicolarmentc promettente. ,·isto che a\'rcbbe dovuto fa\'orire anche il ripristino della potenza in quota di que·t'ultimo. anche se m realtù. dopo alcune prove. l'Isotta Fraschini avrebbe seguitato a mantenere il suo compressore meccanico centrifugo posteriore di soualimentazione. li problema della mancanza di leghe resistenti alle alte temperature. mohre. non sarebbe slato completamente eliminato poichè sarebbe ricomparso nel postbruciatore. il cui rendimento dipende dalla temperatura massima d1 riscaldamento raggiunta nel suo interno dai gas Ji carico.
Anche questa dovette perciò essere limitata presumibilmente a non più d1 500 °C dosando r eccesso d•aria usata.
Pur presentando questi limiti congeniti di funzionamento In rivoluzionnna macchina ··senzaelica" di Campm1 \'Cnnc messa tn costruzione con note\'ole fiducia su quello che sarebbe stato il risultato finale complessi\'o. .
Le parti aerodinamica e strutturale del "elivolo \ennero definite con la consulenza degli ingegneri Verduzio e Pc!!Tla. ma runo il l\.'SlO fu essenzialmente opero deU_o st es-. 1 · rodìnnmtche pre\'alenu mqueso Cam.pini e malgrado alcune concl!Ssiom al e teone ae ' 11. • gl ore con profilo m pianta e imco. 1anni come l'ala a gabbiano mvcr..a d1 gro Ospess . bbe adottata per ridurre la resistenza indotta, che già alla fine degli anni ·1lo:~ ;:i irrimediabilmente datato esso avc\'a un C\'Ìdcnte ru.--petto innova~Yo nto O m eh, . . · d ......,., d'ana circolare antenore. c c nissuna e ben avviata fu oliera tubolare dotata I p,........ . . . . ·.,0 . . • ·,·cdesidei pnm1 anni ., • sarebbe ricomparsa solo sui jet amencam. so,·ieuci c s d . . an parametn d, L . . Il d 'I rminazione c1 nece e prove aerodmnm1che volle a n ce d 1 · 0 comple"O isolato progetto e la consl.!guencc Jefiniz1ooe e costruzione e pnm
117
la stro11ura posterioT'ì' del CC2 ron spina di par::lali=a::ion11 dell'ugello di scarico già montata

la strottura posteriore di fu.solit!TO del C. C 2
la robu.sta Stnlllura della cabina di pilot · b · agg,o ,posto pressun=ata
d'aria cirr:olaf'I! anteriore
J
P~a
118
Ogiva allleriorc
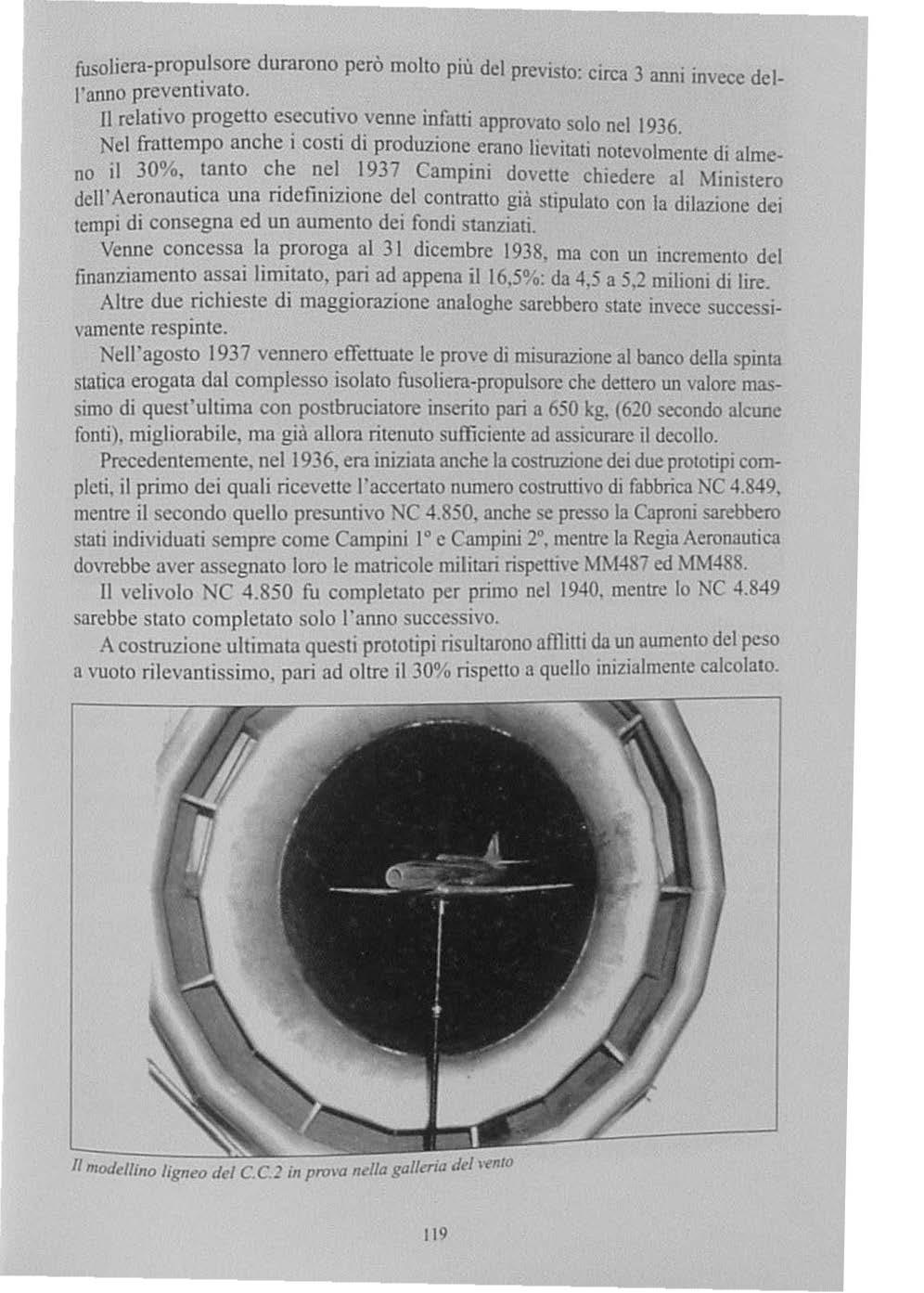
fusoliera-propulsore durarono però molto più del previsto: circa 3 anni invece dell'anno prevenltvato.
Il relativo progetto es_ecutivo venne infaui approvato solo nel 1936.
Nel fra!tempo anche I cosu dt produzione erano lievitati notevolmente di almeno il 30 "o, .tanto c~e n~I . 1937 Campim doveue chiedere al Ministero dell'Aeronautica una ndefimz1one del contrano già stipulato con la dilimone dei tempi di consegna ed un aumento dei fondi stanz1au.
Venne concessa la proroga al 31 dicembre 1938. ma con un incremento del finanziamento assai limitato, pan ad appena i.I 16.5°,o. da 4,5 a 5.:? m1hom di lire.
Altre due richieste di maggiorazione analoghe sarebbero state mYcce successi\'amente respinte.
Nell'agosto 1937 vennero effettuale le prove di misurazione al banco della spinta statica erogata dal complesso isolato fusoliera-propulsore chi! dettero un valore massimo di quest'ultima con postbruciatore inserito pari a 650 kg. (620 secondo alcune fonti). migliorabile. ma già allora ritenuto sufficiente ad assicurare Il decollo.
Precedentemente. nel 1936. era iniziata anche la costruzione dei due prototipi completi, il primo dei quali ricevette l'accertato numero costrulli\'o di fabbrica NC 4.849. mentre il secondo quello presunU\'O NC 4.850. anche se presso la Caproni sarebbero stati indiYiduau sempre come Campim 1° e Campini 2°. mentre la Regia Aeronautica do\'rcbbe aver assegnato loro le matricole militan rispelliYe \IM4S., ed M\1488. li velivolo "IJC 4 .850 fu completato per primo nel 1940. mentre lo 'JC 4.849 sarebbe staio completato solo l'anno successl\·o.
A costruzione ultimata ques11 pro1011pi risultarono affiilli da un aumento del peso a \'U0to rilevantissimo. pari ad oltre il 30°10 rispeno a quello inizialmente calcolato.
11 modi:llino ligneo dt'I CC.2 in prolYl nella galleria Jd , nro 119
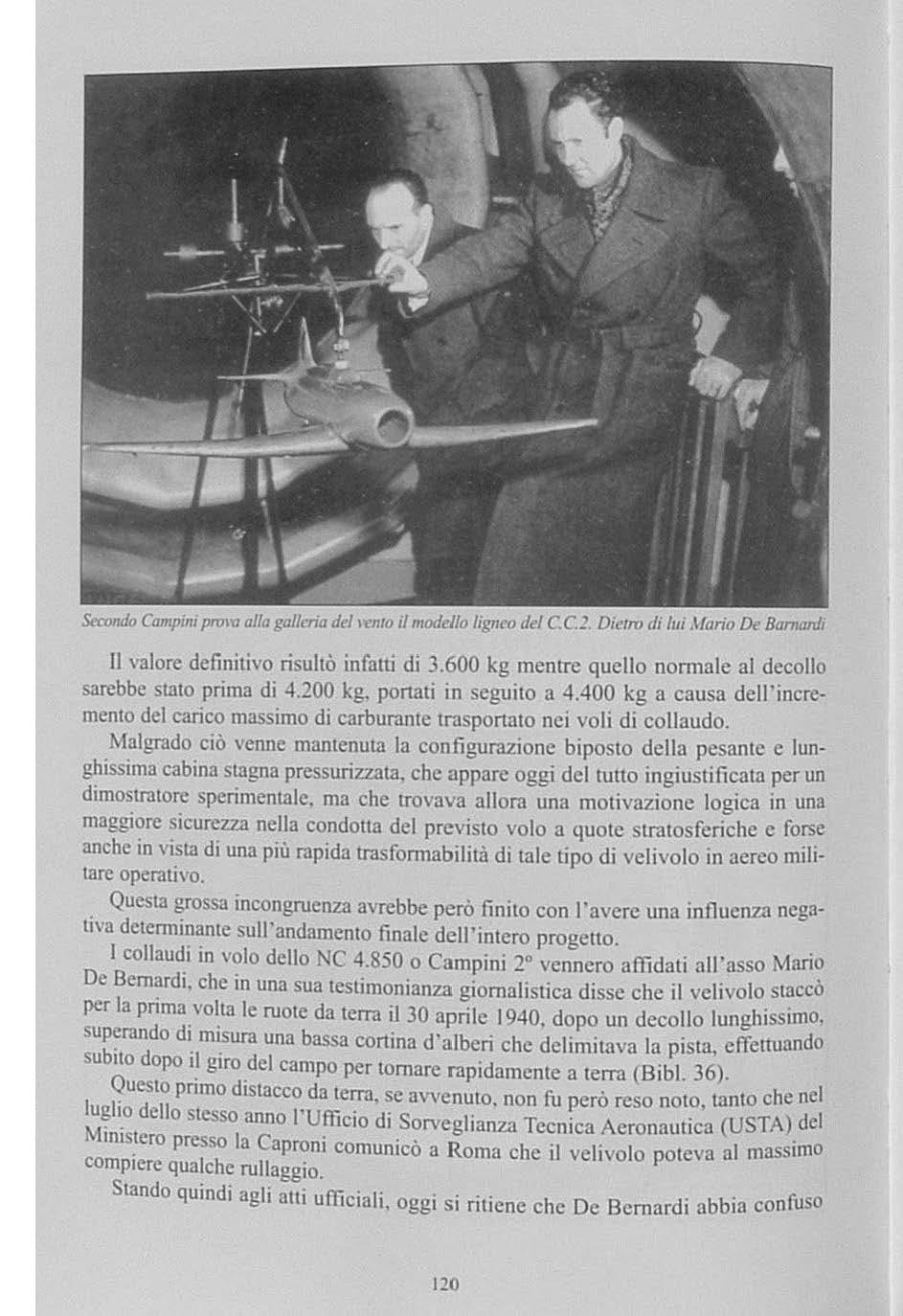
Campim pram al"1 ga//,:ria del mrta 1/
li \'alore definiuvo risultò infatti di 3.600 kg mentre quello normale al decollo sarebbe stato prima di 4.200 kg. ponati in seguilo a -t.400 kg a causa dell'incremento del carico massimo di carburante trasponato ne, voli di collaudo.
Malgrado ciò venne mantenuta la configurazione biposto della pesante e lunghissima cabina s1agna pressurizzata. che appare oggi del tutto ingiustificata per un dimostratore sperimentale. ma che tro\·ava allora una motivazione logica in una maggiore sicurezza nella condoua del previsto volo a quote stratosferiche e forse anche m nsta d1 una più rapida t:rasfonnabilità d1 tale tipo di velivolo in aereo militare operati\'o.
Questa grossa incongruenza avrebbe però finito con l'avere una influenza nega· ti\'a determinante sull·andamemo finale dell'intero progeno.
I collaudi in volo dello NC 4.850 o Campim 2° vennero affidati all'asso Mario De Bemardi. che in una sua testimonianza giornalistica disse che il veli\'olo staccò per la pnma volta le ruote da terra il 30 aprile 1940, dopo un decollo lunghissimo, sup~rando di. mi_sura una bassa canina d'alberi che delimitava la pista, effenuando subno dopo 11 giro del campo per tornare rapidamente a terra (Bibl. 36).
Questo primo distacco da terra. se a,·vcnuto. non fu però reso noto, tanto che nel lu~h_o dello stesso anno l'Ufficio di Sorveglianza Tecnica Aeronautica (USTA) del Ministero presso la Caproni comunicò a Roma che i.I velivolo poteva al massimo compiere qualche rullaggio.
Siando quindi agli atti ufficiali, oggi si ritiene che De Bemardi abbia confuso
Secondo
modello lig11ro del CC:! Dietro di lui Mano De Barnan/1
120
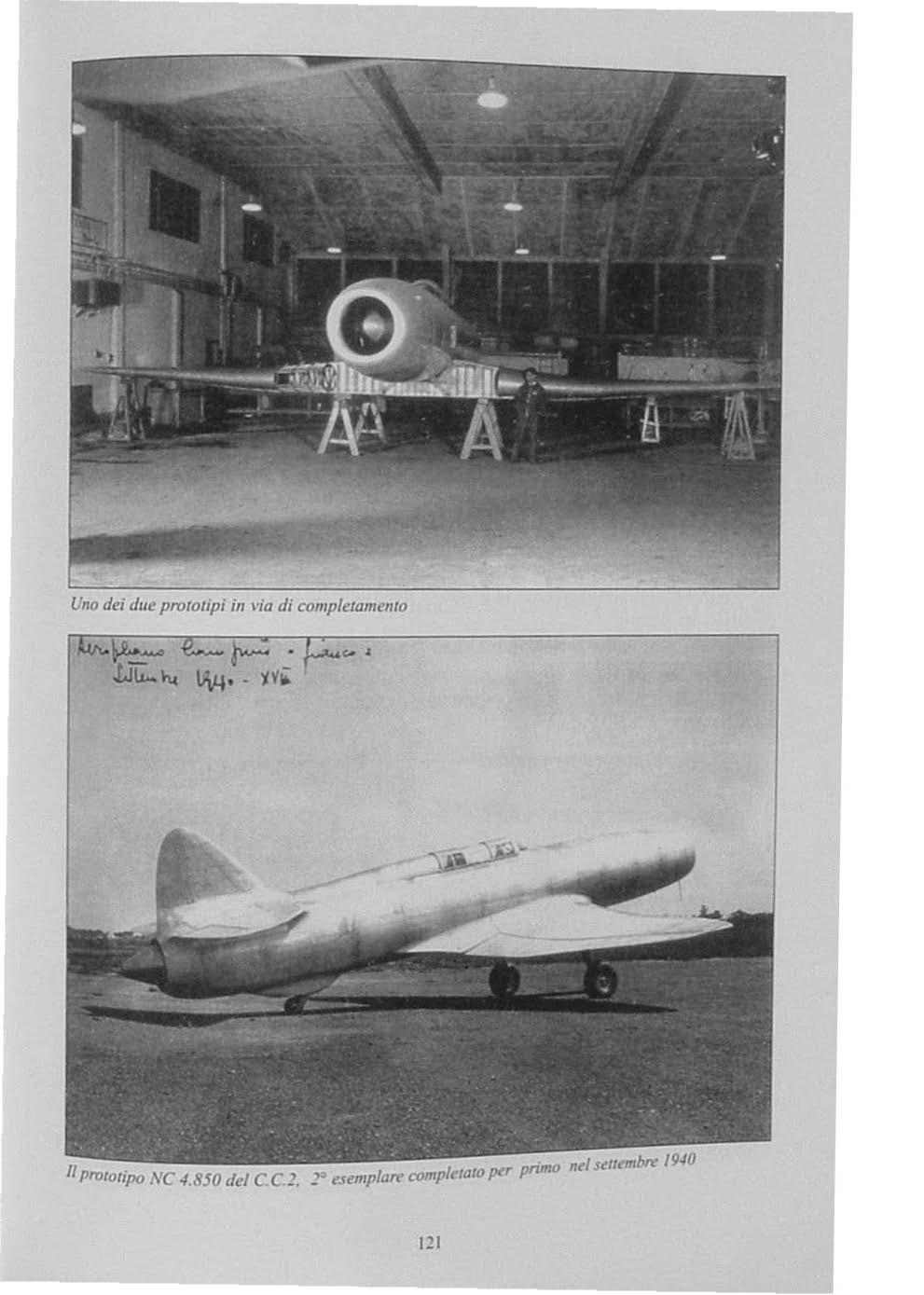
Uno dl!i d11e prototipi ,i, ,·ìa di camp/e1an11:m10
.....
Il prin•o nel stll,·mbn' /9.JO
121
Prototipo NC 4.850 del C Cl. e.semplafl' comph·tato pt:r

A/era 1ista dello \'C -1.850 le da1c. mentre nella realtà tale pnmo brevissimo balzo in volo. condolto secondo la migliore tradizione tipica dei collaudatori più abili. po1rebbe anche essere effe111vamcn1e av,enuto in maniera riservata con lo scopo di verificare se l'appesan1110 vch\'olo fosse efTeHivamente in grado di decollare da una normale striscia acroponuale del 1empo.
li primo vero \'Olo ufficiale di prO\'a avvenne invece il successivo 27 agosto alle 19.30 con una durata di IO mtn, incontrando una marcata tendenza a picchiare. mentre il primo \'Olo d1 collaudo contrattuale awenne il 16 settembre, con una durata di 5 mm.
Uno dlll due pro101ip1 completa, · · o l I en11c1ato con fa.vc,a b1a11ca e colllr'1sseg111 12.2
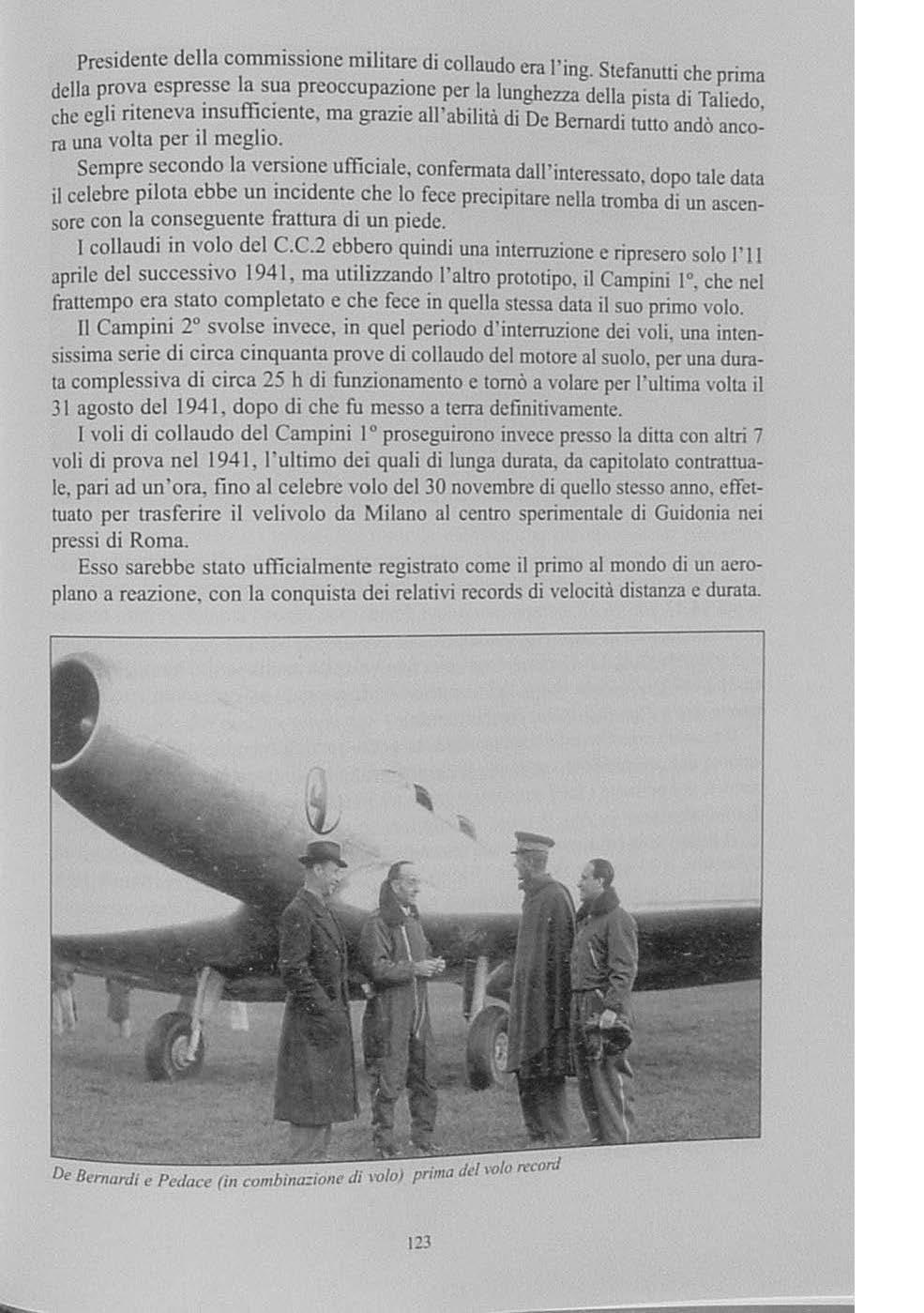
Presidente della commissione militare di collaudo era l'ing. Stefanuui che prima della prova espr~se la s~a preoccupazione per la lunghezza della pista di Taliedo che egli riteneva insufficiente. ma grazie all'abilità di De Bemardi tuuo andò onco~ ra una volta per il meglio.
Sempre ~econdo la ve~i~ne ufficiale, confermata dall'interessato, dopo tale data il celebre pilota ebbe un mc1dente che lo fece precipitare nella tromba di un ascensore con la conseguente frattura di un piede.
J collaudi in volo del C.C.2 ebbero quindi una interruzione e ripresero solo I' 11 aprile del successivo 1941, ma utilizzando l'altro prototipo. il Campm1 1°. che nel frattempo era stato completato e che fece in quella stessa data il suo primo \'Olo. li Campini 2° svolse invece, in quel periodo d'interruzione dei voli. una mtensissima serie di circa cinquanta prove di collaudo del motore al suolo. per una durata complessiva di circa 25 h di funzionamento e tornò a \'Olare per l'ultima \'Olta il 31 agosto del 1941, dopo di che fu messo a terra definitivamente.
I voli di collaudo del Campini IO proseguirono invece presso la ditta con al!n 7 voli di prova nel 1941. 1·ultimo dei quali di lunga durata, da capitolato contrauuale. pari ad un·ora. fino al celebre volo del 30 novembre di quello stesso anno. effettuato per trasferire il velivolo da Milano al centro sperimentale di Guidoma net pressi di Roma.
Esso sarebbe stato ufficialmente registrato come il primo al mondo d1 un aeroplano a reazione. con la conquista dei relativi records di velocità distanza e durata.
D d. I ) prima dt•f mio n-conl e Ben,arrJ, Pctfac< (in co111b111a=1om 1 ,-o 0 123

Il CC'! npn;_,o 1n mio
Venne cffonuato con a bordo come secondo membro d'equipaggio l'ing. Gio\'anni Pedace. capo dell'Associazione Pionien dell':\eronautica e s, svolse tm le ore l-tA7 e le 16.58. componando una de,1az1one verso Pisa per c\itare fom1aziom temporalesche sugh Appennini
La durata tu di :! b 11 min 24 sec. con una , elocilà medio molto bassa. di appena 217.1-H km h. tanto che moh1 ritennero che fosse stato efTettuato un atterraggio intermedio a Pisa che invece non avvenne.
Il reattore era stato infatti spinto dal solo geuo freddo derivante dell'azione delle \'entole del compressore senza che fosse stato fatto un sistematico uso del postbruciatore. per e, 1tarne i font consumi e garantire in tal modo la necessaria autonomia di trasfenmento.
li primo volo assoluto di un velivolo a getto era però già awenuto a Rostock in Germania il 27 agosto 1939 con I' Heinkel Ik 178 "V, .. dotato di un motore HeS 38 da 450 kg dt spinta. ma le autorità gennamche non ne a,·e,ano dato annuncio per ragioni di segretezza miliiare.
Esso non venne quindi comunicato alla Fcderaz1one Aeronautica Internazionale e per molli anni il Campini-Caproni nmase registrato a Pangi come ti pnmo vdivolo a getto al mondo ad avere dfcn,vamentc volato.
li manmo dopo il C.C.2 NC 4.849 venne , 1sìonato a Gu idonìa dal Duce ed in quello stesso giorno De Bcmardi venne telefomcamentc mvitato ad eseguire un volo dimostrativo su Roma sulla dìn.:ttrice di via dell'Impero abitualmente usata per le parate aeree militari.
Tah passaggi vennero annunciati dalla radio e furono regolarmente effettuai• a bassa quoui. tanto che la macchina fu vista d1s1m1amente da moltissimi romani che
124
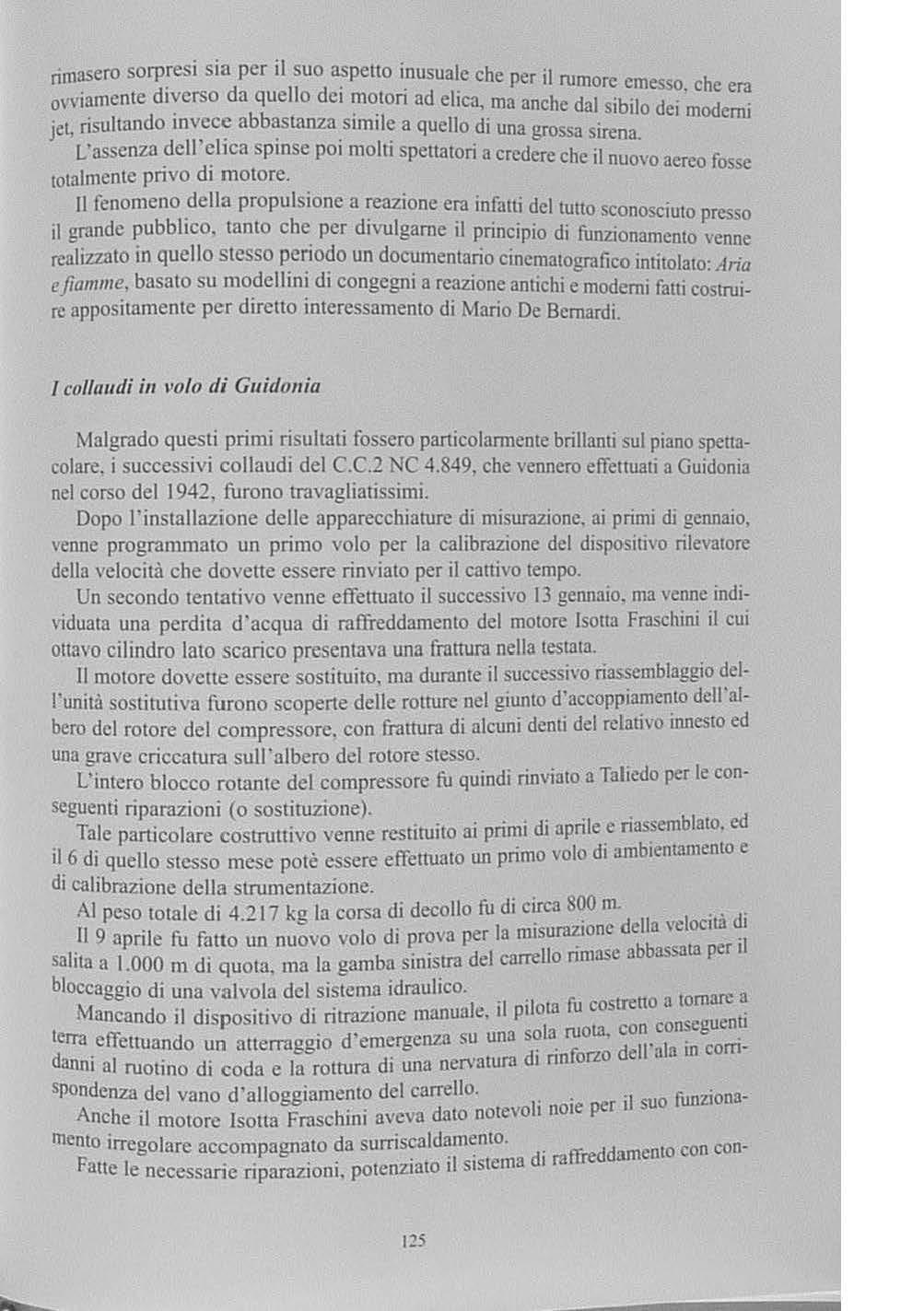
mnasero sorpresi sia per il suo aspetto inusuale che per il ru . d Il . . more t:messo che era on-iamente diverso a que o dei moton ad elica, mn anche dal 'b·I d ' . d . bb , . . s1 l o e1 moderni jeL, nsultan o mvecc a asumza s1m1le a quello di una grossa ·ire
L'assenza dell'elica spinse poi molti spettatori a credere che~I na. " . . 1 nuovo aereo ,osse totalmente pnvo d1 motore.
n fenomeno della propulsione a reazione era infatll del tutto scono c· t . . . . . . s m o presso 11 grande pubblico. tanto che_ per divulgarne 11 pnnc1p10 di funzionamento venne realizzato m quello stesso p_e~odo un documentano cinematografico inntolato: Aria e.fiamme, basato su mo_delh.n~ d1 congegni a reazione antichi e moderni ra111 costruire appositamente per diretto mteressamento di Mario De Bcmardt.
I collaudi in volo di Guido11ia
Malgrado questi primi risultati fossero particolanncnte brillanu sul piano spettacolare. i successivi collaud1 del C.C.2 NC -1.849, che \'Cnncro effettualt a Guidonia nel corso del 1942, furono travagliatiss1m1.
Dopo l'installazmone delle apparecchiature di misurazione, ai primi dì gcnn010, venne programmato un primo volo per la calibrazione del disposiIl\ o nlevatore della velocità che dovene essere rim iato per il canivo tempo.
Un secondo tentativo venne effettuato il successivo 13 gennaio. ma venne individuata una perdita d'acqua di raffreddamento del motore Isotta Fmscluru 11 cui ottavo cilindro lato scarico presentava una frattura nella testata.
Il motore dovelle essere sostituito, ma duran1e il successi\'O ri~semblaggio dell'unità sostitutiva furono scoperte delle rotture nel giunto d'accopp1amento dell'albero del rotore del compressore. con fraltllra di alcuni denu del relati\'O innesto ed una grave criccatura sull'albero del rotore stesso.
L'intero blocco rotante del compressore fu quindi rinviato a Tahedo per le conseguenti riparazioni (o sostituzione).
Tale particolare costruttivo venne restituito ai primi di aprile e riassemblato. cd il 6 di quello stesso mese potè essere effettuato un primo volo di ambientamento e di calibrazione della strumentazione.
Al peso totale di 4.217 kg la corsa di decollo fu di circa 800 m. .. d' I · · della vdoc1ta 1
Il 9 aprile fu fatto un nuovo volo di pro\'a per a misurazione 1 salita a 1.000 m di quota. ma la gamba sìnistrn del carrello rimase abbassnU1 per 1 bloccaggio di una valvola del sistema idraulico. a
Ma d ·1 d' . . d' . . anuale ·11 pilota fu costretto a tornare 1 ncan o 1 1spos1uvo I ntraz1one m , 1 ota con conscguenu ten-a effettuando un anerraggio d'emer11en1.a su uno so a ru · . 1 . · .'"' d' · fi dcli a a m com- danm al ruotino di coda e la rottura d1 una nervatura I nn orzo spondenza del vano d'alloggiamento del carrello. . . 1 • funziona-
Anche il motore Isotta Fraschini aveva dato note\'Oh nme per 1 :;uo memo irregolare accompagnato da surriscaldamento. . =--dd •nto con conF · ·1 · ma d1 ra,11" am1: auc le necessarie riparazioni, potenziato t S15te
1'.!5

ro ·eal banco e messi a punto tutti i dispositivi, venne compiuto un seconseguenu p , . . • · I ·.. I fu d , 1 ·1 10 giugno con misurazioni della velocità d1 vo o orizzonta e tle su due 0,001 b · · · passaggi lh ellati eseguili a mille metri di quota con po_st ruc1atore msento.
Il rilievo \'enne cffet1uato con il cineteodolne. ma nsultò alterato da una eccessiva deriva. La velocità medio misurata risultò pari a 292 km/h.
Vennero quindi eseguite pro\'e d1 consu~o a _terra che regJStrarono fabbi~~gno orario di circa J.500 Idi carburante per ora d1funzionamento del postbruciatore, pm che doppio rispetto a quello preventi,'ato in un massimo di 788 kglb ~r 750 kg di spinta, cui andavano aggiunll altri 300 kg1b consumau dal motore altematl\O Isotta Fraschm1.
JI carico di carburante massimo previsto venne quindi accresciuto di quasi 200 kg.
Un nuovo tenuitivo di volo eseguito il 12 giugno fu inizialmente frustrato dal portellone del , ano carrello destro che nmase apeno.
Risolto l81e problema e tornato in volo l'aereo si rifiutò di superare i 700 m di quota per perdna di potenza del motore alternativo, che presentava nuove perdite d1 liquido di raffreddamento con conseguenti surriscaldamenti.
li 23 luglio st ruppe la gamba del carrello destro in rullaggio con danni fortunatamente lie,i.
Dopo un altro tentattvo del 26 agosto. abortito per malfunzionamento del postbruciatore. il giorno successi\o rutto si svolse regolarmente e fu quindi effettuato un volo di collaudo completo con registrazione degli unici dati di volo ufficiali che sarebbero nmasti disponibili.
Al peso d1 4 409 kg alla quota di 4.050 m con 2.300 giri del motore ed 830 mmHg d1 pressione, la , clocllà senza bruciatore risultò pari a 316.5 km/h.
A 3.000 m di quota e con un numero d1 gm pan a I. 750 gin min con press1on..: interna di 804 mmllg ancora con getto freddo venne registrata invece una velocita di 325 kmb.
Sempre a quest'ultima quota con 2.020 gm mm. 834 mmHg di pressione e bruciatori pienamente inseriti. la velocnà crebbe a soli 359,5 km/h.
11 tempo di salita a 1.000 m con brucrnton inseriti risultò di 9 mm con velocita ascensionale di 1.80 m sec. mentre la salita a 4.000 metri senza bruciatori richiese invece ben 44 mm.
La velocità registrata era in realtà solo margmalmente mtèriore di circa l' 11.5 °o ns~tto a quella preven11,a1a teoncamente in 400 km/h alla stessa quota, mentre 11 v~~ivolo avre~be dovuto raggiungere gh 800 km'h a 8.000 m, quota mani festamcnlc 1rraggmng1b1le per eccc~s1vo peso e scarsità di potenza disponibile.
Le prestazi~m _ms~ffic1en11 del velivolo erano state influenzate negauvamente anche da alcum d1fot11 facilmente eliminabili con un più accurato disegno di progett~. ~ome quello pan1colarmeotc grave relauvo al posizionamento della spina di pamahu.azione dcU-ugdlo di scanco, la cui pos1Z1one non era prefissab1lc a 'alon costanu durante ti volo. ma soggetta invece a continue , ariaz1oni
Tale _ difetto d~vcne essere ehmmato in , ia breve dal costruttore tramne 11 prefissngg10 della spina st • · · • • · d. . essa m una pos121one costante ommalc con ovvie perdite 1 rendimento propulsivo.
126
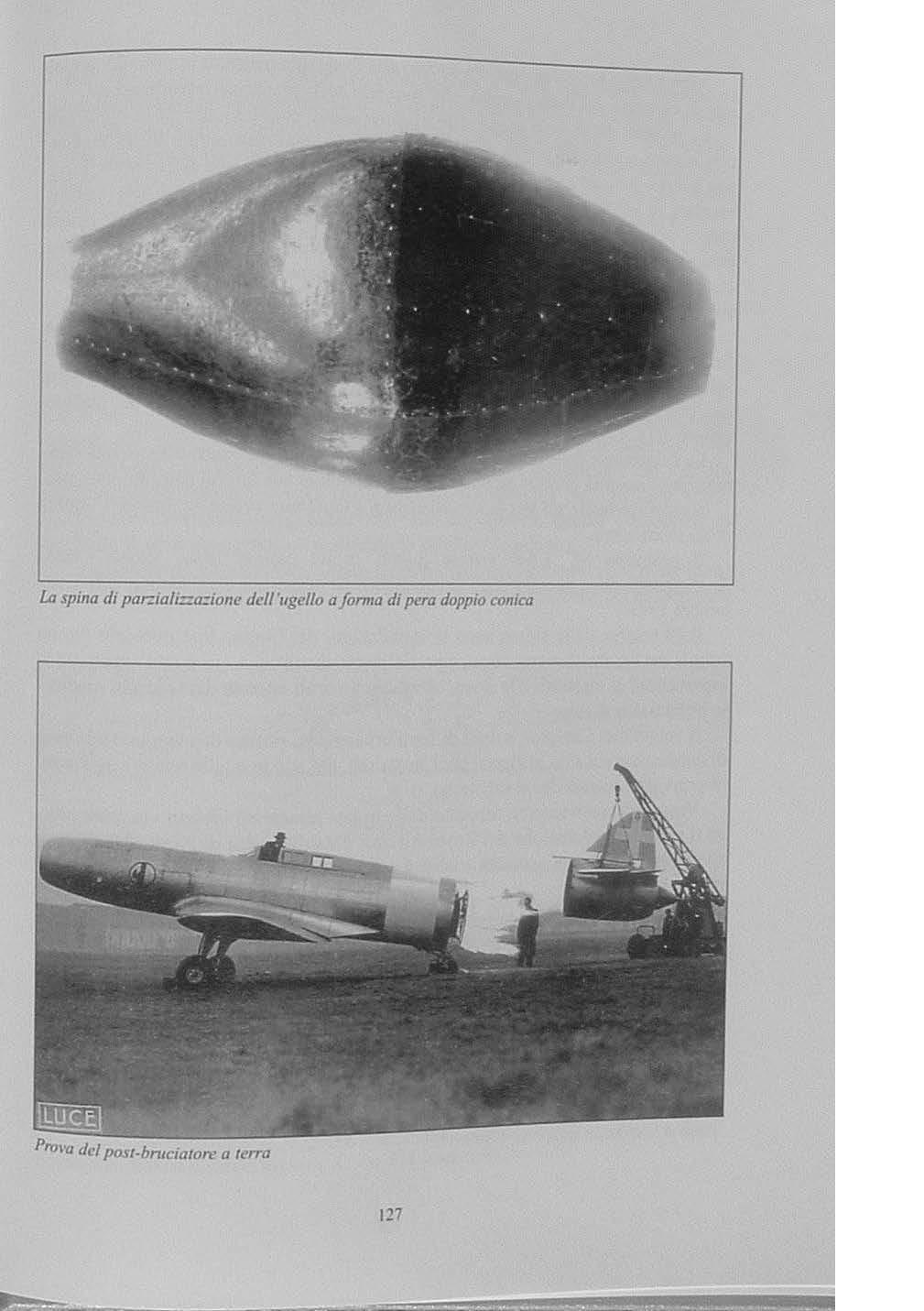
Pro\•a di!/ post-bnirioron· o terra
1A spina di par:iali=a=ione ddl '11gi•llo a /omio di pera doppio conica
127
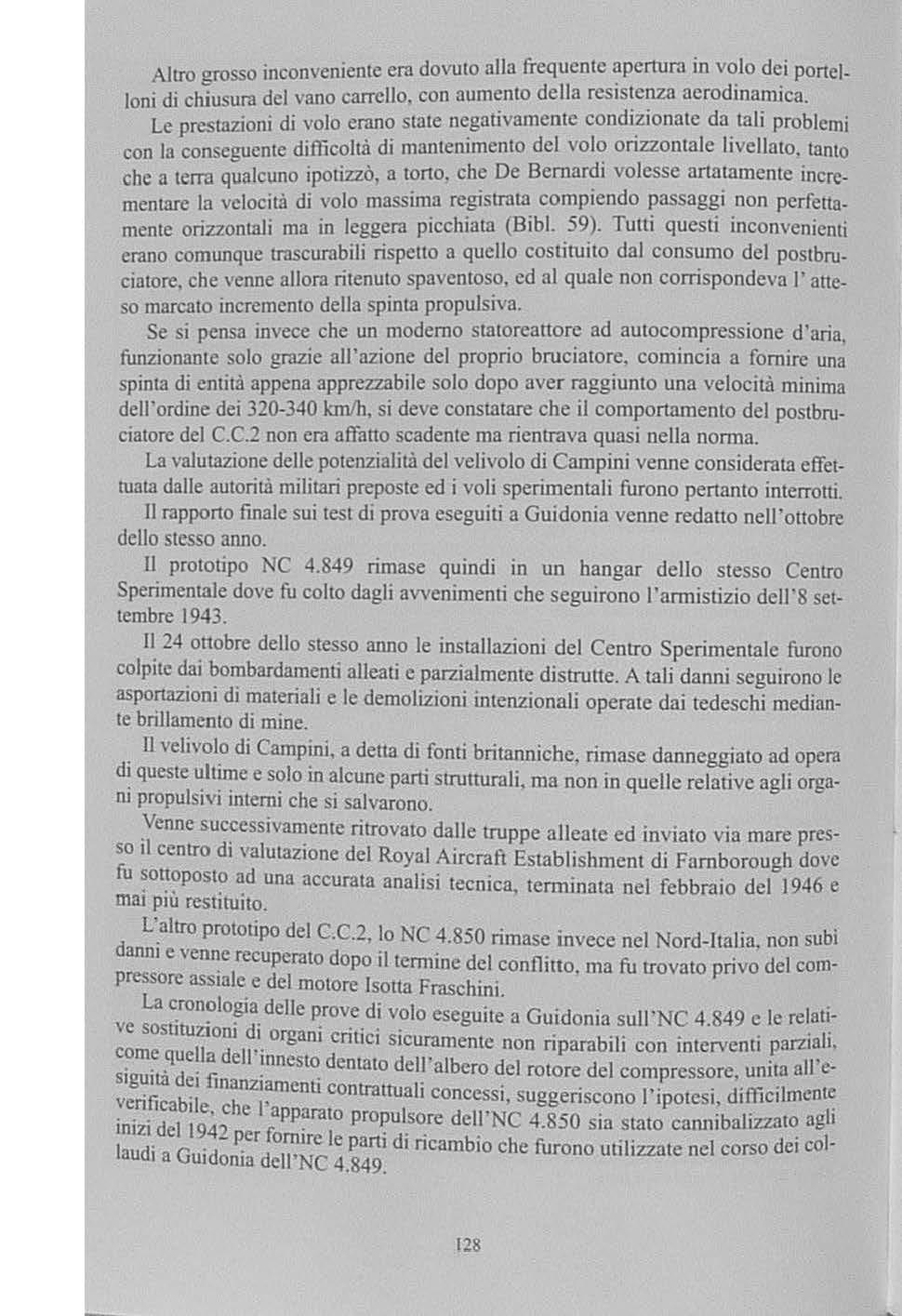
Al sso inconveniente era dovuto alla frequente aperrura in volo dei ponel- Lro ero d Il . d. . I · d' hi-: sura del vano carrello. con aumen10 e a res1s1enza aero mam1ca. om I e u d. · d 1·
Le presiazioni di volo erano sta1e o~gativamente c 1 on 1~1onate 1 a 1 _ ta 1 1 1 problemi con lo consegucnle difficoltà di man1enimen10 del vo onzzo111a e 1ve aio. tanto che a terra qualcuno ipotizzò, a torto. eh~ De Bemard1 volesse arta~amente incrementare In velocità di volo massima registrata compiendo passaggi non perfettamente orizzontali ma in leggera picchiata (Bibl. 59). Tuili questi inconvenienti erano comunque trnScumbili rispeno a quello costiruito dal cons~mo del postbrucia1ore. che venne allora ritenuto spaventoso, cd al quale non comspondeva I' atteso marcato incremento della spinta propulsiva.
Se si pensa mvece che un moderno sta1oreanore ad autocompressione d'aria. funzionante solo grazie all'azione del proprio bruciatore. comincia a fornire una spinta di emi1à appena apprezzabile solo dopo aver raggiunto una velocità minima dell'ordine dei 320-340 km/h, si deve consultare che il comportamento del postbruciatore del C.C.2 non era affatto scadente ma rientrava quasi nella nonna.
La valutaz.ione delle potenzialità del velivolo di Campini venne considerata effettuala dalle autorità militari preposte ed i voli sperimentali furono pertanto interrotti.
Il rapporto finale sui tesi d1 prova eseguiti a Guidonia venne redatto nell'ottobre deUo stesso anno.
li proto1ipo NC 4.849 rimase quindi in uo hangar dello stesso Centro Sperimentale dove fu coho dagli avvenimen1i che seguirono l'armistizio detrS set1embre 1943.
li 24 onobre dello stesso anno le installazioni del Centro Sperimentale furono colpile dai bombardamenti alJeaù e parzialmente distrutte. A tali danni seguirono le asportazioni d1 ma1eriali e le demolizioni intenzionali operate dai tedeschi medianle brillamento di mine.
Uvelivolo di Campmi, a detta di fomi britanniche, rimase danneggialo ad opera di ques1e ultime e solo in alcune parti strutturali, ma non in quelle relative agli organi propulsivi imemi che si salvarono.
Venne successivamente ritrovato dalle truppe alleate ed inviato via mare presso il centro di valutazione del Royal Aircrafi Establishment di Famborough dove fu sottoposto ad una accurata analisi tecnica, terminata nel febbraio del 1946 e mai più restituito.
L'_altro prototipo del C.C.2, lo NC 4.850 rimase invece nel Nord-Italia. non subi danm e venne recuperato dopo il termine del conflitto ma fu trovato privo del com· pressore assiale e del motore Isotta Fraschin1. '
La ~ron~lo~a delle prove di volo eseguite a Guidonia sull'NC 4.849 e le relati· ve sosutu21om d' - · · · · · 1· 1 organi cn11c1 s1curameme non riparabili con interventi parz10 1 , com~ _que~la dell'!nnesto demaio delralbero del rotore del compressore. uniia all'esig~lla dei finanziamenu contratruali concessi suggeriscono l'ipo1esi difficilmente ~'e_n~~abile. che l'apparato propulsore dell 'NC 4.850 sia stato cannibalizzato agh 1 1DIZ1_ el 1942 per fornire le pani di ricambio che furono utilizzate nel corso dei colaudi a Guidoma dell'NC 4.849_
128

Nel 1952 il C.C.2 NC 4.850 venne recuperato a Ponte San p1 · tro (B ) Mili. h e ergamo dalrArrnn.11ustraz1one tare c e ne era proprietana e destinato ali'~..; _ ·1 M S . d Il' · · · · -r-~-one perma nente presso i_ ~eo to~co ': Aeronautica Militare italiana che andava costituendosi, subendo d1vers1trasfenm~ntt an~he per panecipare a mostre e manifestazioni cclebrnuve. fino a_trovare _sistemaz~one nella sede definitiva prescelta per tale Museo presso la base 1drovolanu dt Vigna d1 Va!Je sul lago di Bracciano, dov·e tuttora esposto.
La fusoliera isolata di prova venne invece ceduta al Museo della Scienza e della Tecnica di Milano.
J;'.3: I progetti di bireatto ri da combani111 e11to
Le prove date dal Campint Caproni C.C.2 furono considerate scadenti dai competenti organi della Regia Aeronautica, che ne trassero un'impressione compless1vamente sfavorevole. che. come abbiamo visto, sarebbe stata confermata nel 19-M alla commissione alleata d'indagine proprio dall'allora comandante del Repano Sperimentale di Volo di Guidonia che le aveva condone, il col. ing. Pier Luigi Torre. mo1oris1.a di notevole competenza che, nel dopoguerra, presso I' Innocenti di Lambrate avrebbe progettato e realizzato la celebre "Lambretta'".
Campini veniva considerato infatti un buon teorico però sprovvisto d"1!Spenenzn pratica ed incline ad una visione approssimativa ed onimis1ica dei molteplici e
-====. ====~--7l , C S ' ,no/OCOmpn•JSOrÌ Hmo101'/ da bombardam,:1110 Campint ., con 129
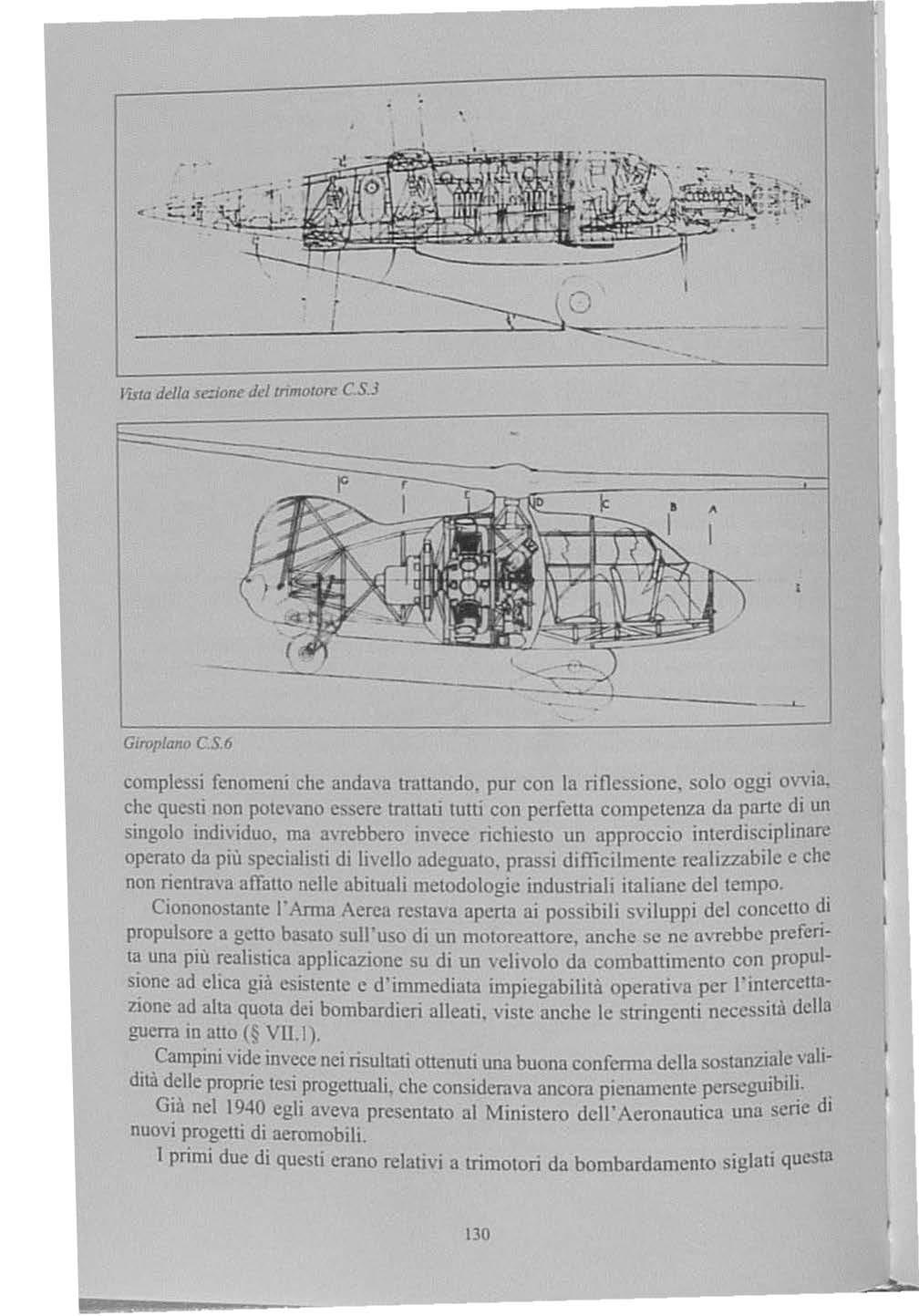
G1mplano CS.fJ
compbs1 fenomeni che anda,·a tmttando. pur con la riflessione. solo oggi ovvia. che questi non potevano essere trattati tutti con perfetta competenza da parte di un singolo indi,iduo. ma avrebbero invece richiesto un approccio interdisciplinare operato da più specialisti di li\'cllo adeguato. prassi difficilmente realiv.abilc e che non rientrava affatto nelle abituali metodologie industriali italiane del tempo. .
Ciononostante l'Arma Aerea resta, a aperta ai possibili sviluppi del concl!lto di propulsore a geuo basato sull'uso di un motoreattore, anche se ne nvrebbe preferita una più realistica applicazione su di un velivolo da combattimento con propulsione ad elica gin esistente e d'immediata impiegabilità operati,a per l'intercettazione ad alta quota dei bombardien allcau. viste anche le stringenti ncci.:ssitù della guerra mallo(§ VII.I).
Campini vide in\'ecc nei risultati ottenuti una buona confcm1a della sostunziale validità d~lle propnc tesi progettuali. che considerava ancora pienamente perseguibili
Gta nel 1940 egli aveva presentato al Ministero dell'Aeronautica una sene di nuovi progetti di aeromobili.
1 primi due di questi erano relativi a trimotori da bombardamento siglati questa
. -a- :i -.. ';;J . - : .f
Ju1a della i.::ione Jd tnmo1an: C S.J
130

volta con le sole sue iniziali: C.S.3 e C.S.4 che avrebbero d . 1 . · d" • 1 • . ' O\ u o essere propulsi ad ehca me iantc moton a temaon, accoppiati a grossi compr · • • . . . . . . csson roi.aun. az10- nan11 direttamente le ehche mo1nc1. ·
Questi impianti propulsivi avrebbero dovuto essere capaci di ri I b·t· I I•. · d. , 700 CV ,, sa I ire a poten.w comp essi, a i -· ,omna dai tre moton ahematì\'i anche alle lt . . d C a iss1mc tangenze operat1v~ pre-.1ste a ampini per tali macchine. che erano come al solito tanto elevate da nsu(tarc trreal~suche. essendo quella massima pari a 20.000 m. mentre quella d1 crociera opera11,ra avrebbe dovuto essere di ben 14.000 m.
Il terzo progeno C.S.5 era invece relativo ad un giroplano a reazione con rotore singolo che venne de~nito dai, suo progettista ..chco-tax.i", con turbocompressore avente una potenza dt 400 C\. carattenn.ato da un condotto di scarico del getto anraverso il mozzo dell'c::lica.
Campini chiese di esporre I dati relaiin a questi nuovi \'elivoli direttamente al generale Pricolo. allora Sottosegretario di Stato all'Aeronautica. tanto chi: venne convocato a Roma per il giorno 15 gennaio 1940.
I competenti organismi tecnici dcli'.-\nna Aerea rimasero però prudentemente in attesa dei risultati che sarebbero stati ottenuu con le prow dei due prototipi del C.C.2 in base al contratto già modificato del 1937.
Il 12 febbraio del 1942 Campini tornò a proporre alcuni suoi ulteriori progetti che erano invece relativi ad una famiglia di \'elivoli da comba111mento che a,rcbbero posto rimedio agli inconvenienti manifestati dal C.C.2.
Questi erano dipesi in primo luogo dalla eccess1\a lunghczza e pesantezza della fusoliera usata come involucro motore. cd in secondo luogo dalla scarsa affidabilità e dalla bassa potenza erogata dal motore alternativo Isotta Fraschini utilizzato.
Facendo un ulteriore passo O\'anti. forse risolutivo. Campmi decise che il gruppo compressore assiale-bmciatore a,Tcbbc dovuto essere disposto in un propno m,·olucro contenitore di volume interno con, cnientemcnte ridouo. ,·emendo cosi a costituire una vera e propria unità motrice a getto i:.olata che sarebbe stata collocabile a bordo nella posizione più vantaggiosa
Come fonte primaria d'energia meccanica per il suo azionamcnto_avreb~c dovuto fare ancora ricorso ad un motore altcma11vo che sarebbe ~Lato pero un pm potente e soprattutto affidabile Daimlcr-Benz 08.605 da 1.-175 CV al decollo e I.300 CV continui a 6.000 m. . • •
I · ·3 I · · b. · ·' ca~c1·a abbastUnza s1m1h tra loro, pnm1 progeu, erano re atl\·1 a 1rcatton uu · tranne che per la collocazione della cabina di p1lotagg10 e per quella delle anm di I . . 1 · · d I.,., mm •cannom ma che erano anc10 fisse. che comprende\ ano mnrag 1amc1 a -· 1.: • • • . . . e· · · li ·at, in pos1z1onc alare med1a- tut11 dotali di due unità motnc1 a ectto an1pm1 co oc 1.: . . h -11· d•II • s ·m·1ah come sul contemporaneo na sia nspeuo allo spc ·sore c e a apertura i: i: t; • caccia a getto Glostcr i\leteor britannico. 1 .'..1 d •I
Tali unita erano di lunghezza sut1icicntemente contenuta pi:_r a mancanz _i: b . • che nel l e , n?m,·a cons1- condo110 di collegamento tra compressore e ruciatorc. . · ·derc\'o)mcntc allungato dalla presenza della cabina di pilotagg~o bipo:,tdo. . . . . . ·bbao stai! mo:,~! a un umco I compresson assiali delle due umta motnci san::
131

.____________J * =-
132
Trm/cl dei bircauori d a caccw Campmi
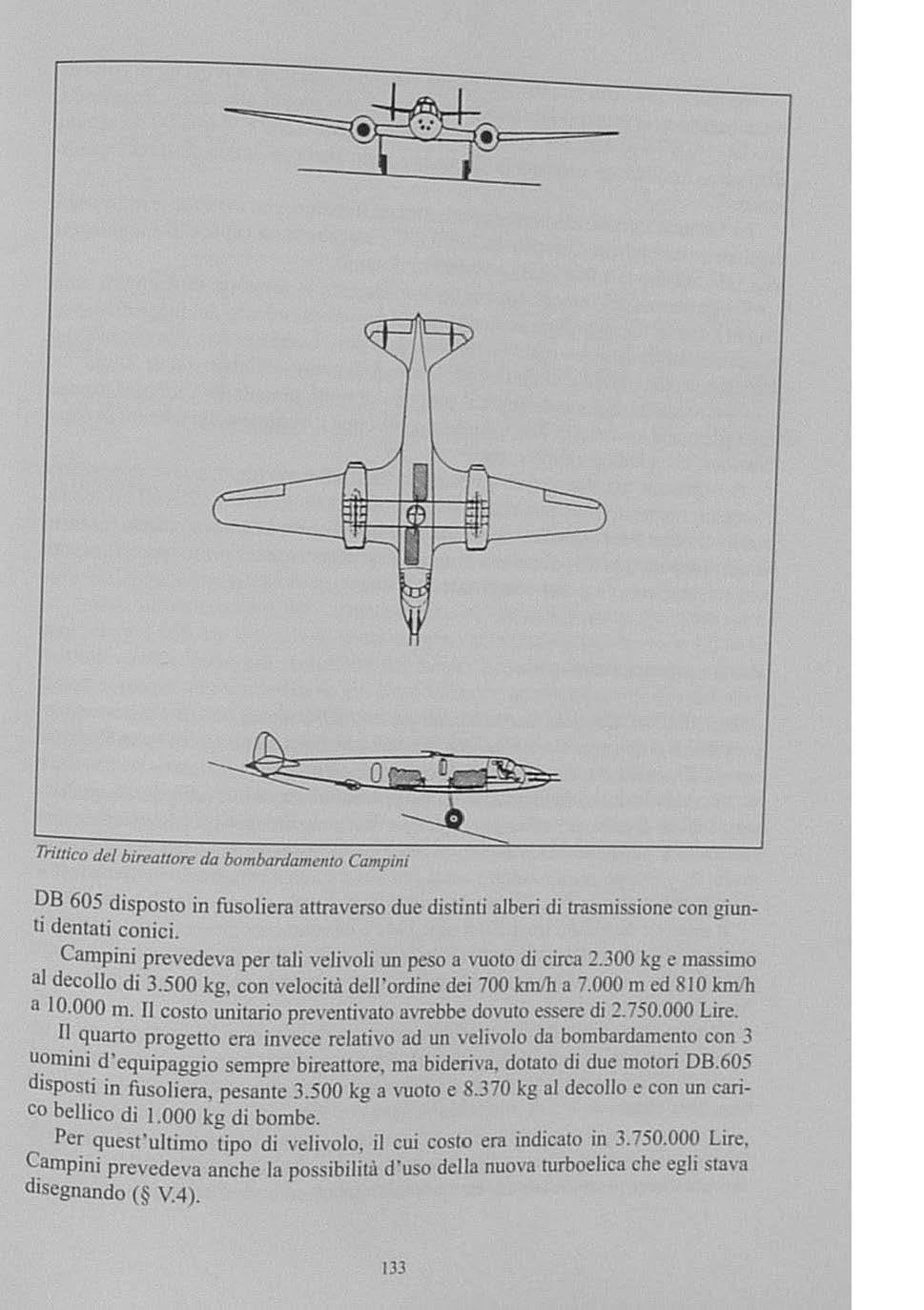
Tri11ico del b1rea11on: da bombarrlan11!1110 Campm, ~B 605 disposto in fusoliera attraverso due distinti alberi di trasmissione con giunu dentati conici.
Campini prevedeva per tali velivoli un peso a vuoto di circa 2.300 kg e massimo al decollo di 3.500 kg, con velocità dell'ordine dei 700 kmlJJ a 7.000 m ed 81 O km b 8 I0.000 m. II costo unitario pre\'enrivato avrebbe dovuto essere di 2.750.000 Lire.
Il quarto progetto era invece relativo ad un velivolo da bombardamento con 3 u?mini d'equipaggio sempre birca!lore, ma bideriva. dorato di due mo1on D8.605 disposti in fusoliera, pesante 3.500 kg a vuoto e 8.370 kg al decollo e con un carico bellico di J.000 kg di bombe.
Per quest'ullimo tipo di velivolo, il cui costo era indicato in 3.750.000 Lire, Campini prevedeva anche In possibilità d'uso della nuo\'a rurboelica che egli stava disegnando(§ V.-t).
133

N I O 19-13 egli propose due nuove , nrianti di questo suo progetto di bombar1 e marz · 1 · · R · dierc bimotore. la prima delle quali faceva uso d1 due mo~on a temal!VI egg1ane L 103 RC 50l a 18 cilindri a\\ invertita capace d'erogare _l.:>50 CV~ 6.00~ ~- sem~rc disposti in fusoliera ed azionanti le due unità a getto alan con lunghi alben d1 trasmissione.
La seconda \'ariante era invece relativa ad un bimotore che avrebbe dovuto usare le predelle turboeliche Campini da 3.500 C\ e sarebbe stato capace di raggiungere una ,·elocilà di ben 1.000 km 11 a I0.000 m d1 quota.
u Ministero delrAeronautica ,agliò attentamente le proposte di Campini, affidando l'analisi di rispondenza e fallibilità dei propulsori ad uno dei massimi esperti italiani di propulsione a reazione del tempo. il prof. Luigi Croceo. che era nel frattempo di,entato docente di motori per aeromobili presso l'Università di Roma.
Croceo analizzò accuratamente il progetto di unità propulsiva Campini trovandolo adeguato. avanzando solo qualche risen•a circa il volume della camera di combustione, che giudicò troppo cona.
li Ministero accolse quindi in maniera non sfa\'ore\'Ole i nuovi progelli di Campini. ritenendo però non necessaria la costruzione di nuovi velivoli ed ipotizzando invece l'impiegabilità delle nuove turboeliche sul nuovo caccia pesante Breda-Zappata BZ-303. di cui era in corso di realizzazione il primo prototipo. che non sarebbe stato però mai completalo.
I:./: Il progetto di w rboelica
Nel 19-12--43 Campini face,·a quindi grande affidamento sul suo più avanzato progetto di propulsore a reazione che avrebbe costituito l'epilogo d1 tuua l'intensa attività di ncerca che era andato svolgendo nell'arco d1 quasi 15 anni.
Esso era cos1iruito da un gruppo compressore-turbina multistadio di nuovo disegno: capace d1 azionare un'elica propuls1H1 mediante un apposito riduttore che. se realizzato e realmente funzionante, avrebbe potuto portare il nostro Paese ad uno stadio di sviluppo in tale settore assai prossimo a quelli raggiunti in Germania e Gran Bretagna.
I~ progello fu redatt~ tra il 19-t0 cd iJ 1941 e direttamente presentato al Ministero dcli Aeronau11~a nel ~1cembre 1941 dallo stesso Campini. che nell'occasione potè cs_porrc le sue idee direttamente al nuovo Souosegretario di St.ato ali'Aeronautica Rino Corso Foug1er.
L'anno successivo fu stanziata la somma necessaria per la costruzione di un pnmo esemplare, memre il 13 aprile 1943 il generale llari dava disposizione perché n7 \'Cntsse costruito anche un secondo esemplare per una somma complessiva di Lire 2.938.000.
11 ~uovo prop~lsorc, per In cui realizzazione fu costituito presso la Caproni di Arcor~ un appoSllo Centro Sperimentale diretto dallo stesso Campini, avrebbe dovuto •se · · e s re costnullo da un compressore assiale ad 8 stadi collegato ad una tur-
134
~oda d•lt. lu.tbot'Ba Ca.mplni 3500 nitU• IUt tdniOCM- IU'f,nH.n-a
I Cof'!'lo-,•a 0t e l'I • : Ali .eco :I. JDP0•10 h u ..... J '-' o l oun< ,.._..,...,,,.", a.
tJtl>òft,1
4 flo"N>• Ol !O l v b U l i(• , 1011• cv , d t111lh t Po'"P-a rutu
$ fltl,,,r, o,a MG \I • , ,., an.-..t t u t1•1lo l"I• «qu i Mli pO..,p,11
1 "1-'-"P" l u b a,,.n- ft I OtftO -.ca u ,11
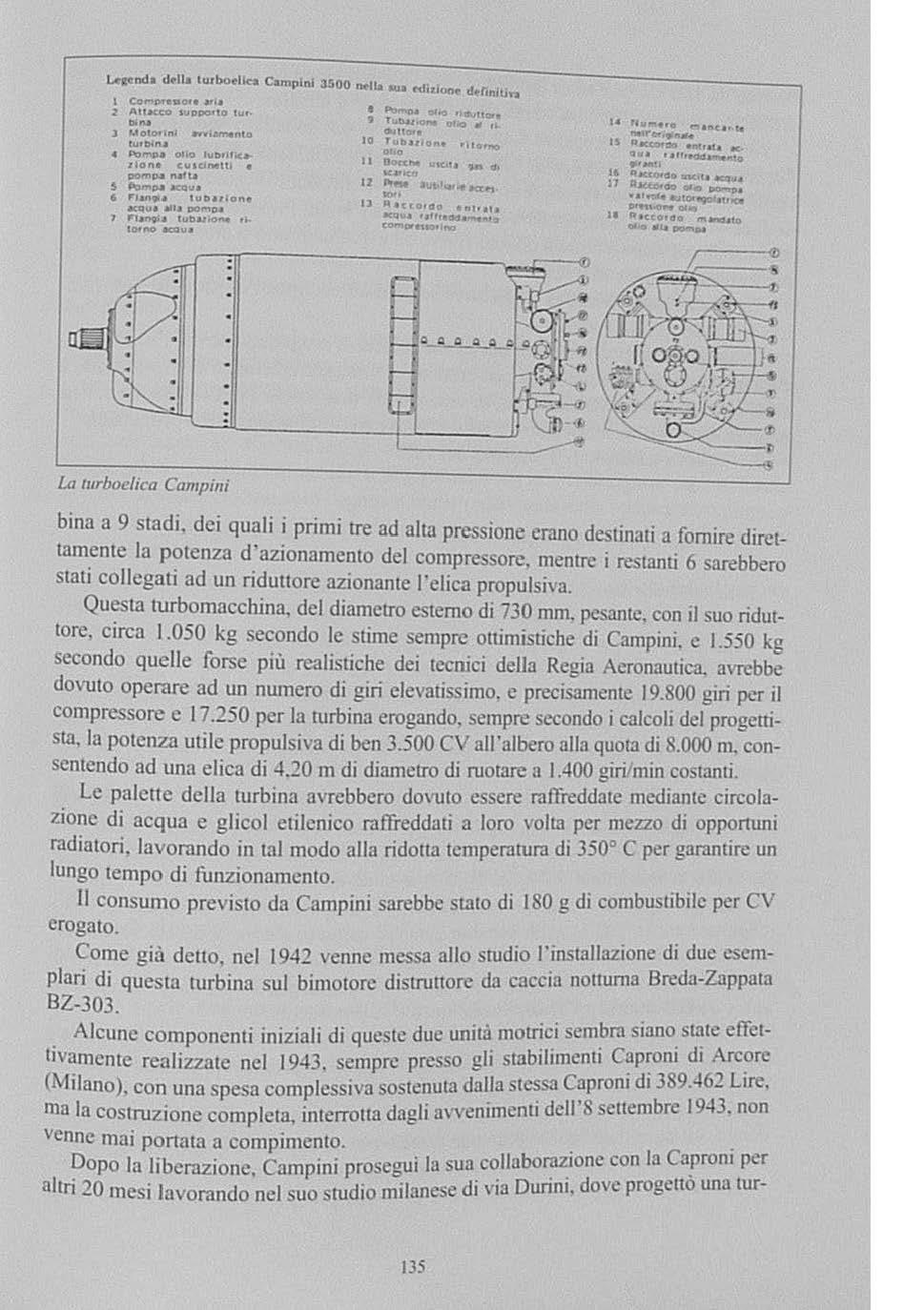
la turboelica Can,pmi
bina a 9 stadi. dei quali I primi tre ad alta pressione erano destìna1i a fornire direttamente la potenza d·azionamenio del compressore, mentre i restanti 6 sarebbero stati collegati ad un riduttore azionante relica propulsiva.
Questa turbomacchina, del diametro esterno di 730 mm. pesante, con il suo nduttore. circa I.050 kg secondo le stime sempre ouimisliche di Campim. e 1.550 kg secondo quelle forse più realistiche dei tecnici della Regia Aeronautica avrebbe dovuto operare ad un nwncro di giri elevatissimo. e precisamente 19.800 giri per 11 compressore e 17.250 per la turbina erogando. sempre secondo i calcoli del progeltista, la potenza utile propulsiva di ben 3.500 CV all'albero alla quota di 8.000 m. consentendo ad una elica di -t20 m di diametro di ruotare a I.400 girilmin cos1an1i
Le palcrte della turbina a\'rebbero do\'uto essere raffreddate mediante circolazione di acqua e glicol etilcnico raffreddaù a loro \'Olla per mezzo di opportuni radiatori. lavorando in tal modo alla ridotta tcmperarura di 350° C per garantire un lungo tempo di funzionamento.
Il consumo pre\'isto da Carnpini sarebbe stato di 180 g di combus1ib1lc per CV erogato.
Come già detto, nel t 942 venne messa allo srudio l'installazione di due esemplari di questa turbina sul bimotore distruttore do caccia notturna Breda-Zappata BZ-303.
Alcune componenti iniziali dì queste due un11à motrici sembra siano state eITe1ti\'amcn1e realizzate nel 1943. sempre presso gh s1nb1hmcnti Cap:oni di ~rcore (Milano). con una spesa complessiva sostenuta dalla st,essa Caproni di 389.46_ Lire, ma la costruzione completa, interroua dagli a\'venimenii dcll'8 settembre 19..JJ. non venne mai portata a compimento.
Dopo la liberazione. Carnpini prosegui la sua collaborazione con la Ca?rom pr.:r altri 20 mesi lavorando nel suo studio milanese di via Dunm. dove progetto una tur-
0 111 • ! O T•b
.-10"• •ÌtOf'PIO ....
1 b
'"''<=
»'Ctfl
o •
i
_. ''"'•O<ta..,.. .. 1
: =.,,:~of~~~'~:
,11
1
(K(hllJ 1.11(., ,a 'IJft e,,
J1 :::- 11Jlollìllii9
tJ Rt tr.o rd
n
,,i, ,ocq
COfflO,t\lOt f'rl
135

boelica da I00 cv per aerei leggeri, di cui_ fu iniziato anc!1e il processo di costruzione del protoùpo che non venne però 0101 po~to a temun~. . . .
Nel successivo dopoguerra Campini s:iolse 11 s~o _sodalizio mdustnale c_on I~ C · 0 un ceno tipo di collaboraz1one fiduc1ana, tanto che nel 1948 s1 reco aprom man n . d. b·1· • 1. S•ntJ· Uniti dove lavorò sia presso 11 noto costruttore 1 automo 11 ed aerei neg 1 "' F b. · h Il · Tucker, al quale Caproni sperava cli poter cedere l'fsotta. rase m1, e a a ~eahzzazione di una rurbina a gas a doppio flusso ed a quella d1 uno o due ehcotten sempre mossi da propulsori a turbina. . . . . . .
Tornò successivamente in ftalìa dove seguilo ad occuparsi d1progetn van relativi alla propulsione a reazione. . . . . . ..
L'ingegner Campini sciolse la sua ulnma soc1eta d1 progettazJone nel 1970 dosi a vita privata. conservando una certa amarezza. perfettamente comprensibile e condivisibile. per quella che riteneva essere stata una scarsa considerazione sia da parte italiana che internazionale dei suoi effettivi meriù di scienziato e progettista.
Scomparve a Milano il 7 febbraio del 1980.
1~5: la desig11a.Jone dei progetti e del velivo lo di Seco n do Cam p i11 i
Sulla corretta designazione del velivolo sperimentale realizzato da Campini presso la Caproni e dei diversi altri progetti da lui stesso redatti è stato scritto mollo.
Come abbiamo già detto. per i suoi progetti realizzati solo sulla carta nell'ambito della società Secondo Campini Milano VENAR o comunque in via del IUlto autonoma, che andavano dal semplice schizzo dimostrativo ad elaborati più complessi, lo stesso Campini usava la sigla C.S.. Campini Secondo, seguita da un numero progressivo. Questo per essere completamente riconoscibile rispetto ad altri costruttori aeronautici italiani.
Carnpini era infatti costretto ad usare anche la seconda lettera "S" relativa al nome. in aggiunta alla "C" del cognome, per evitare che i suoi progetti fossero confusi con quelh dell'ing. Colombo, per i quali il Ministero dell'Aeronautica aveva già in uso la sola lettera "C'' seguita anch'essa da un numero progressivo.
~on tale sigla ed il numero ordinativo I deve quindi essere designato il C.S. I (chiamato anche C.C. I) nelle sue due versioni cartacee sinora note. sia supersomc~. del _ru~o 1poteùca e futuribile, che subsonica, decisamente più concreta ma d1 dimens10_01 7peso eccessivi per la presumibile potenza che si sarebbe potuto insiallare e qumd1 altrenanto irrealizzabile quanto la precedente.
L'architetlura aerodinamica relativa alle due versioni era infatti solo abbozzata e del tutto in subordine rispetto allo schema d'apparato propulsore adottato, che era mvece sostanzialmente simile per le due versioni.
Ma se ~er i progetti puramente canacei la designazione C.S. può essere considerata ~ahda a runi gli effeui, per il velivolo realmente completato presso In Caproni essa non appare accettabile, né può essere considerata ufficiale.
Durante la loro costruzione, i due prototipi praticamente identici del jet di
136

campint furono costantemente denommat1 Campim 1° l'NC 4 g49 e • ·2, _ • • 1 • e amp1m . t'NC 4.8)0, senza ncevere una designazione uruvoca ufficiale · -1 . . . . . ne I progetusta dedico particolare attenzione a tale problema.
Nel dopoguerra tale imprecisa forma di designazione commciò O prese t · · _ h I . . . n arsi ma deguata, tanto c e a pnm~ JCt 1tal_1~0 fu inizialmente attnòuita la denominazione ~.C.2 intesa come ~apro01-Camp101 2 (Bibl. 7), che non era tra l'altro m perfetta linea c?n quella ~a usata 1~ passato con raltro prototipo sperimemale S11paCaprom. la cui stona burocraltco-amm1mstrat1va peraltro può essere ritenuta abbastanza simile, per il quale il cognome dell'ideatore precedeva sempre quello del costruiiore.
Negli anni successivi la cosa non mancò di suscitare qualche velata diatriba, coinvolgendo direnamente 1protagonisti. tanto che. il 4 gennaio 1965, in occasione della prima esposizione pennanente dell'NC 4.850 presso 1I Palazzo della Vela a Torino. mizialmente scelto per localizzare il nuovo Museo Storico dell'Aeronau11ca, con lettera indirizzata all'allora Capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica Mìli111rc Aldo Remondino. Campini chiese che il proprio velivolo fosse rides1gnato esclus1varmmte con I' iniziale del suo solo cognome. nulla osservando sulla numerazione progressiva, che, nelle sue inte021oni. avrebbe forse potuto seguitare ad avvalersi del numero 2. essendo il suo secondo progetto presentato ali' Arma Aerea.
Campini si riteneva infatti l'uruco vero ideatore ed anefice della macchina. Jh!r la quale aveva direuamente firmato il contrailo con 1I Ministero dell'Aeronautica. essendo stata la successi, a opera della Soc1euì Caproni solo di tipo esecuti\'O,
Nell'Archivio Storico dell'Acronauuca eststono due minute di nsposta di Aldo Remondino: nella prima, annullata e mai spedita, la richiesta di Secondo Campm1 veniva accolta di buon grado; nella seconda. datata 27 gennato 1965. che venne invece rcgolannente inoltrata al progeuista. il C.S M dell'Aeronauuca Militare italiana, dopo aver svolto una mdagine conosciti\'a circa la nomencla1ura a suo tempo in uso per il velivolo. nella quale decisiva fu la testìmomanz.a dell'mg. Gio\'annt Pedace, valido protagontsLB del volo record del C.C2 e persona noo direllameme mteressaLa alla questione, l\.>spmse tale richiesta confermando la correuezza della designazione onna1 com alidata dall'uso comprendente 1cognomi dt en~bi gh ingegneri cointestatari della socieui rcahzzatnce. senza specificare pero alcun numero progressivo. . . te in maniera completa. occor- Seguendo il criteno adottato dall ente commmen . ·o I essendo staio Il relauvo rerebbe far seguire a tali le11ere 1I numero progressi\ · _ d . . d 11 · 111 • costruttnce cons1 erata. velivolo 11 primo ed unico realizzato a a socie . d d - · , . · C C ? mhm en O ancoro In realtà s1 segu1ter.ì con ogm probab1hui a ~cnvere · _. .1 ogrcssivo 2 sta per non genc- Campm1-Caproni, ma facendo comparire 1 numero pr1 . 0 d,- conunuità per . d C S I che come cnten rare alcuna confusione con 1I prece ente · · · · ..cato dallo stesso -1 . · ·uì della numerazione ..., 1 completamento senza alcuna d1scontmu1 • . e · . 1 •denu che succcss1n. arnpm1 per rutti I suoi progem. sia an ecc
137
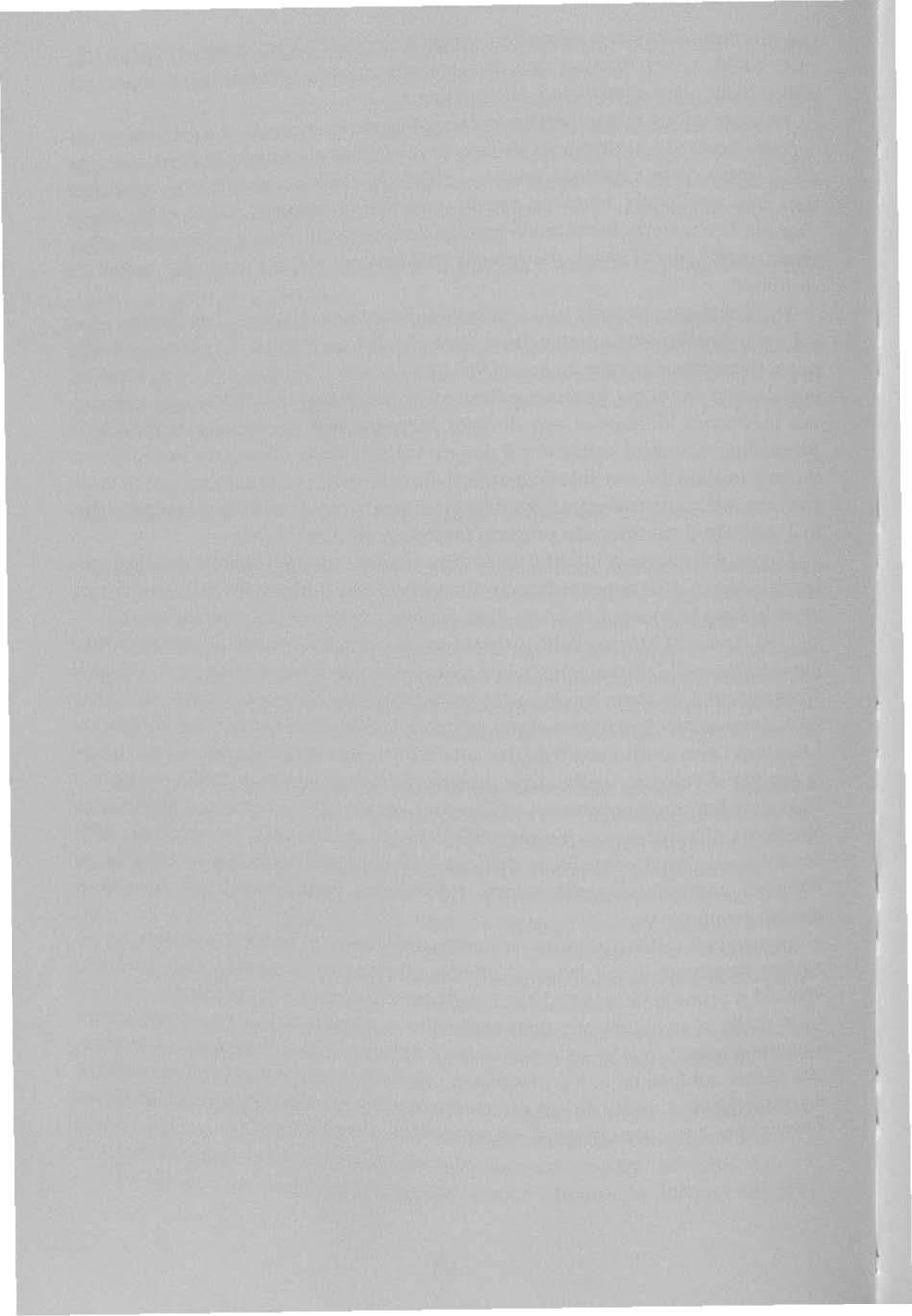

Cf\PITOLO VI
I PRlì\IT T URBO GETTI ESTE RJ
li comprensibile sentimento di rigetto per rutto quello che era stato ~-alinato e soprattullo reclam,z:zato durante ti regime fascista, che marurò in ltaha dopo fa sconfitta. ed il confronto con glt strabtlianu successi O11enu11 da tedeschi e britannici nel campo dei velivolt a reazione. ponò alla sostanztale cancellaztone del C.C.2 dal novero de, veri velivolt a geuo.
Quello che venne sottostimato in ltalta fu m segu11O ignorato o denigrato all'estero, do\'c la figura dt Campim è ovvtarnente nota, ma registrala come minore. mentre il C C.2 venne ed è tuttora considerato da molti autori come una curiosità marginale per dt più totalmente inefficiente. Questo marcato processo di delegmimazìone. mano da oltre mezzo sc:colo. de\e essere tuttavta considerato inaccettabile, essendo ti C.C 2. a tutti gh effetu. non un \'elivolo ad elica intubata ma a getto ed essendo per d, ptù tutt'altro che inefficiente. quanto sottopo1enziato.
Per collocare m maniera piu adeguata la reahzzazionc: d, Campini in campo mondiale possiamo quindt prO\'arc a formulare un confronto pieno t.rn le presiaz1O01 complessive del C C.2 con quelle delle pnm1ss1me realizzazioni sixnmentalt estere coeve, ritenendo tale paragone del tuuo lecito ed accenabtle
VI. I : I primi w rbogetti brit a1111 ici
Il pnmo turbogetto bntanmco funzionante fu ideato e costrutto da sir Frank Wh11tle. Nato a Covenll) in Gran Bretagna ti 1° giugno 1907. era ancora un g10,·nne cadetto all'Accademia Acronauuca di Cranwell. do\'e era entrato nel I923, quando concepì l'idea di una pnma fonna d 'ada11amento d1 una rurb1na a gas di scarico a LI· impiego aeronauuco che fosse valida cd effettivamente n.---alizzab1lc
Anche nt!lla , ersione aeronautica la grande potenza meccanica rotati\'a riclucsta dol compressore d'ana sarebbe stata quindi fornita da un'apposita turbina calettata dinmamcntc sull'albero del compressore stesso.
IJQ
Srr Frani. Wh,111.•
Il pnmo rurbogt'llfl sp,mn11:ntalc di Fronk ll'l1111h• WL (Tl'h111le Unii)

Il Po11.:r Ji:1s Il' J \'fornito anrli•• a,r:11 USA
Nel 1928 concretizzò tale idea descrÌ\ endo dettagliatamente il nuO\'O dispositivo nella sua tesi di laurea intitolata: The .future de,·elopmem in airc:raft design.
Brevettò il relativo progeuo nel 1930.
Negh anni successivi. malgrado fosse preso dai suoi compili di ufficiale pilota collaudatore nella R.AF. cerco di far accettare le sue idee daì competenti organi della Royal Air Force e del ministero dell'aria, che la considerarono inauuabile con I meui tecnologici allo-
1 ra disponibili.
Tale situazione di stallo cominciò ad e\'Ol\'erc positi,amentc solo a partire dal 1935. quando un gruppo pri, ato di estimatori del giovane tecnico trovò I finanziamenti necessan per fondare. nel mano 1936. una nuova società, la Powcr Jets Ltd., che affidò la stesura dei pnmi disegni esecutivi alla 8TH (British Thomson Houston).
Il nuovo motore era carattenZ7.ato da un compressore centrifugo a girante singola con doppia palettatura. azionato da una turbina monostadio e si rivelò di fabbricazione assai complessa. Part1colannente ardua fu, come abbiamo detto, la messa a punto di nuovi upi di leghe speciali in grado di sopportare le elevatissime temperature che si sarebbero manifestate nelle camere d1 combustione e sulla palettatura della turbina.
li primo motore denominato W~ (\Vhlllle Unìt) fu completato 11 12 aprile 1937 e provato con successo, ma la lunga sene di problemi da risolvere prot.raSse il completamento di uo primo prototipo capace di funzionare stabilmente a regime. il W. l X. fino al 14 dicembre 1940.
Nel frattempo lo scetticismo degli organi ufficiali era caduto, tanto che venne po5to il pnmo ordine per un propulsore impiegabile in volo designato W. l. mentre nel contempo la Gloster veniva incaricala di realizzare un nuovo tipo di veli\'olo basato sul nuovo propulsore: il Gloster E.28. 39. li W. I pesante 623 libbrt girò al
140
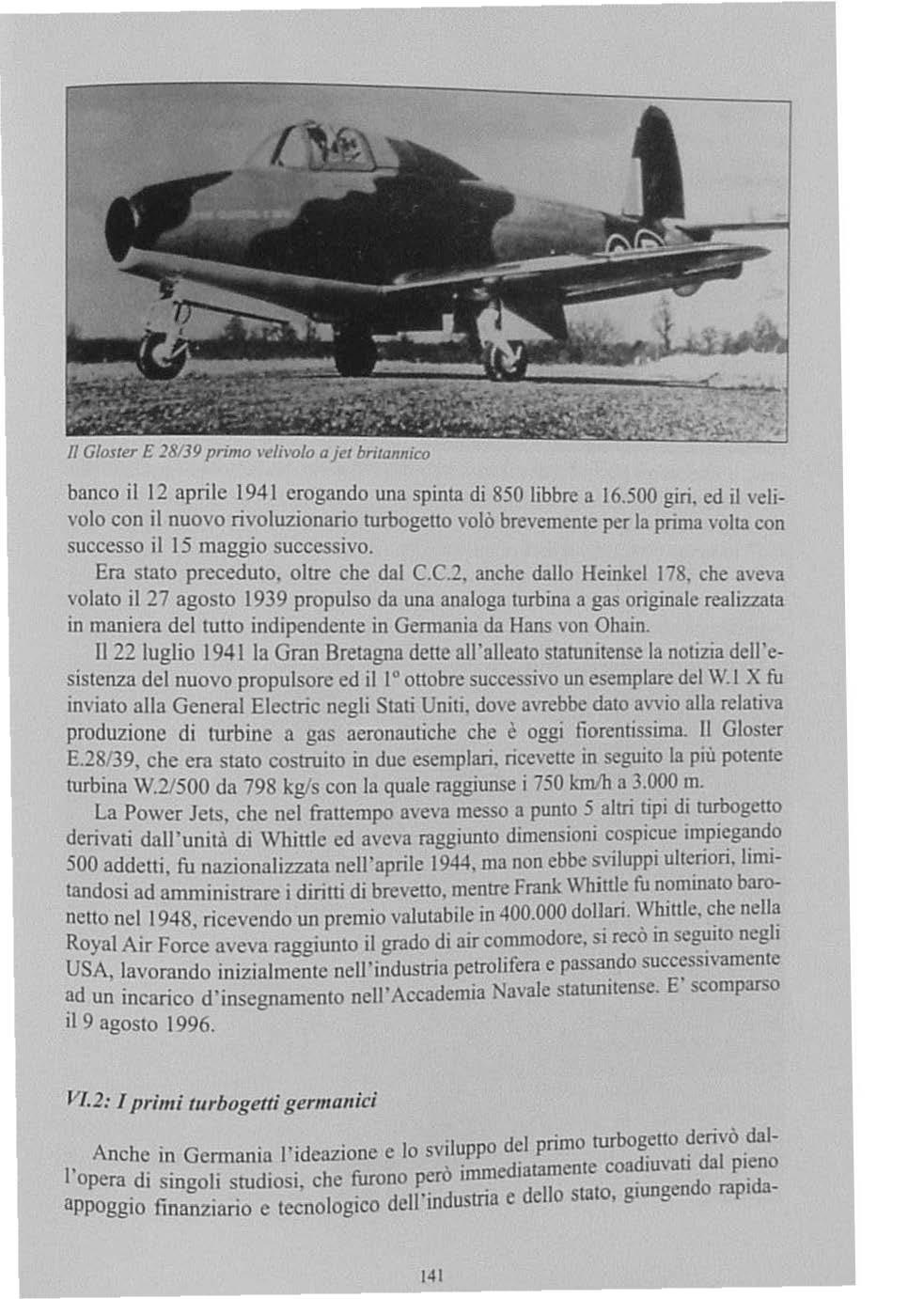
banco il 2 aprile 1_941 e~ogando una spinta di 850 libbre a 16.500 gin, ed 11 velivolo con 11 nuovo nvoluz1onano turbogeno volo brevemente per la pnma volta con successo il 15 maggio successivo.
Era stato preceduto. oltre che dal C.C 2. anche dallo Heinkel 178, che aveva volato il 27 agosto 1939 propulso da una analoga turbina a gas onginale realizzata m maniera del tutto indipendente in Gennama da Hans von Oham. 11 22 luglio 1941 la Gran Bretagna dene all'alleato staruni1ense la notlZla dell'esistenza del nuovo propulsore ed il IO onobre successivo un esemplare del W. l X fu tn\'iato alla Generai Electric negli Stati Umu. do\'e avrebbe dato an-io alla relauva produzione di turbine a gas aeronautiche che è oggi fiorentissima Il Gloster E.28 39. che era stato costruito in due esemplan. ncevette m segu110 la più potente !Urbina W.2/500 da 798 kg/s con la quale raggiunse 1 750 km/h a 3.000 m.
La Power Jets, che nel franempo a\'e\'a messo a punto 5 altn upi di turbogetto derivati dall'unità di \Vhìnle ed a\'cva raggmnto dimensioni cospicue impiegando 500 addetti, fu nazionalizzata nell'aprile 194-t. ma non ebbe sviluppi ulteriori, limitandosi ad amministrare I dinni di bre\'etto, mentre Frank Whinle fu nominato baronello nel 1948, ricevendo un premio valutabile in 400.000 doUan ~Vruttle. c_be nella Royal Air Force ave, a raggiunto il grado d1 air commodore. s1 reco mscguuo negh USA, lavorando inizialmente nell'industria petrolifera e passando successivamente ad un incanco d'insegnamento nell'Accademia Novale statunitense. E' scomparso il 9 agosto 1996.
VT. 2: I primi turbogetti germ anici
. . 1 d I nmo turbogetto derivò dal- Anche m Germanio l'1deaz1one e lo svi uppo e P . I. . . · diatamente coadmvau dal pieno opera d1 smgoh srud1osi che furono pero imme d da appoggio finanziario e tc~nologico dell'industria e dello stato, gmngen ° rapi •
141
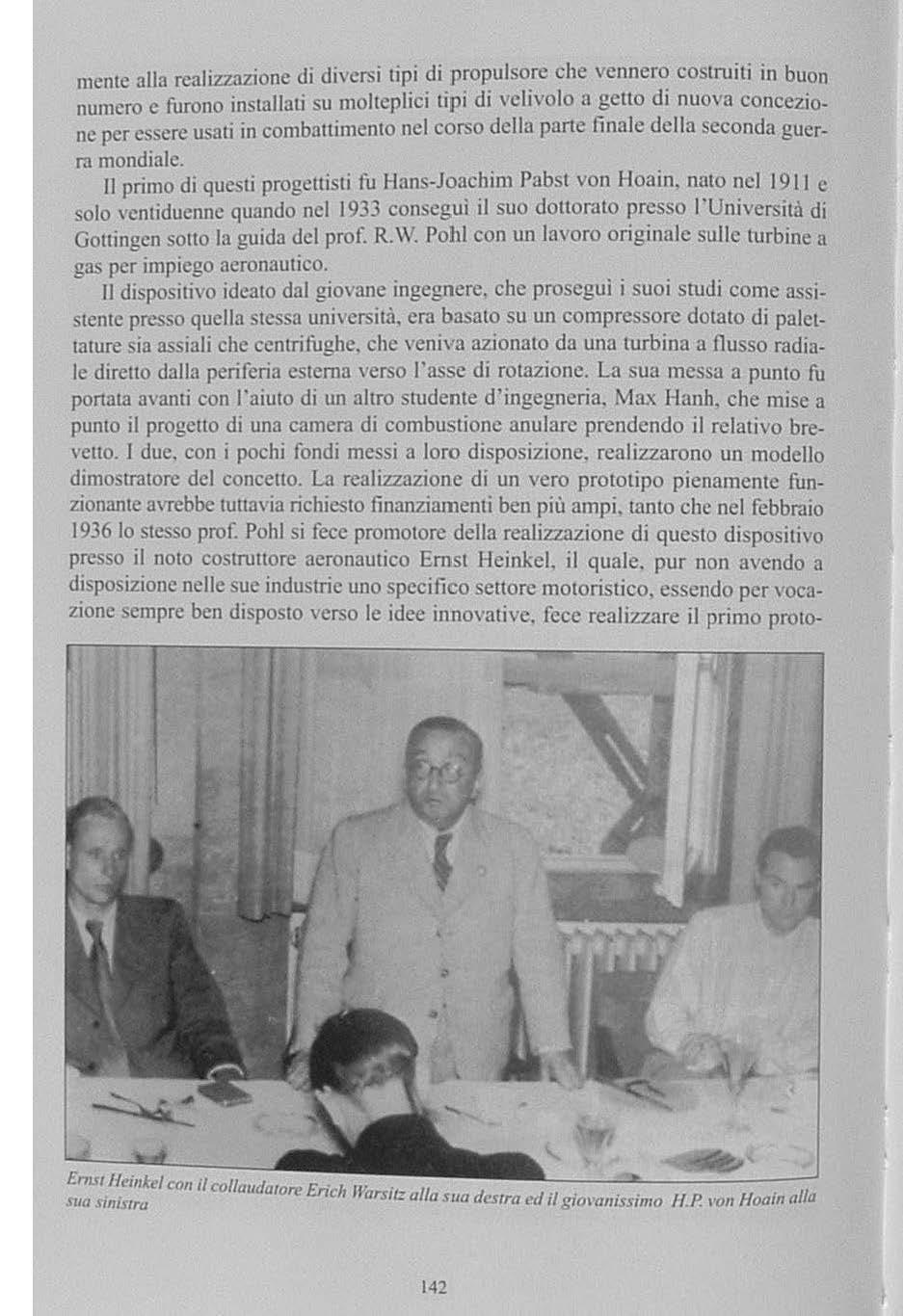
mente alla realizzazione d1 diversi tipi di propulsore che ,·ennero costruiti in buon numero e furono installau su molteplici up1 di velivolo a getto di nuo, a concezione per essere usati in combattimento nel corso della pane finale delta seconda guerra mondiale.
11 primo di questi proget1is11 fu Hans-Joachim Pabsl von Iloain. nato nel 191 l e solo ventiduenne quando nel 1933 consegui il suo dottorato presso l'Università di Gotlingen sono la guida del prof. R.\\. Pohl con un lavoro originale sulle turbine a gas per impiego aeronautico.
li disposi1iYo ideato dal gio,·ane ingegnere. che proseguì i suoi scudi come assistente presso quella stessa università, era basato su un compressore dotato di palc11a1ure sia assiali che centrifughe. che \'en1va azionalo da una turbina a flusso radiale diretto dalla perifena esterna verso l'asse di rotazione. La sua messa a punto fu ponata a,·ami con l'a1u10 d1 un altro studente d'ingegneria. Ma.,x Hanh. che mise a punto il progello d1 una camera di combustione anulare prendendo il relativo bre,·euo. I due. con I pochi fondi messi a loro disposizione. realizzarono un modeUo dimostratore del conceuo. La realizzazione dì un vero prototipo pienamente funzionante aHebbe 1u11a, ia nchiesto finanziamen11 ben più ampi. tanto che nel febbraio 1936 lo stesso prof. Pohl si fece promotore della realizzazione di questo dispositivo presso il noto cos1ru11ore aeronauuco Emst Heinkcl. il quale. pur non avendo a disposizione nelle sue industrie uno specifico settore motoristico. essendo per ,oca210ne sempre ben disposto "erso le idee mno\'ative. fece rcali7.zarc il primo proto-
tipo funzionant~ ~i tale turbina a gas presso lo stabilimento di Rostock Marianchc. a partire dal 15 aprile 1936.
Questa realizzazione fu portata avanti anche grazie alla collaborazione dcll'ing. \Vilhclm Gundennans ed il primo prototipo girò al banco nel marzo 1937 dando una spinta di 250. kg e . bruciando idrogeno per o,v,arc a, problemi di difficile miscelazione dell'ana con un carburant~ liquido. La nuo,·a turbina a gas fu ~1glata HcS (Heinkel Strahl, Getto Hemkel). La prima unità prevista per

Disl.'gno sc/1ema1ico dello HeinAel /lt•S.38
W 1/ein/;e/ 178 primo 1...!itr,/0 a Jt'I gennanico
il volo, capace di bruciare combustibile liquido. fu siglata HeS. 2. Essa fu completata nel 1938 ma non raggiunse le prestazioni sperate. fornendo solo 130 kg s. fu quindi necessario realizzare la HeS. 3 migliorata. la quale. nella \'Crsione ~e~.3B pesante 360 kg e capace di fornire una spmta statica di 500 kg ad I1.000 gin. volò in un pod applicato al prototipo Hcinkel I18 V'2 nel moggio 1939.
Nel frattempo lo stesso Heinkel aveva provveduto a far realizzare un 11uo,·ovelivolo sperimentale capace d'impiegare mie unità propulsiva. lo Heinkel He.178. che fu praticamente disegnato intorno allo stesso motore HeS 3B.
. Il nuovo velivolo era però caratterizzato da condotti di adduzione e di scarico piuttosto lunghi, che riducevano la spinla cffenivomenlc erogata a soli 450 kgts.

lifta anterion.• dello Jleinkel 178 gamanico
Il celebre collaudatore della Heinkel, Erich Wars1tz, compì i primi rullaggi ed un primo breve balzo con il nuovo velivolo il 24 agosto 1939 ed il primo vero volo. della durata di 6 min ad una quota di 500 m. il 27 successivo.
Era il primo volo al mondo d1 un aereo a getto.
Lo He. 178 effettuò m seguito pochi ahn voli essendo in realtà un velivolo poco riuscito. che aveva come il C.C2 probleTTIJ cli ritrazione del carrello e si rivelò pertanto incapace d1 superare 1600 km/h pur disponendo in seguito di unità propulsive migliorate come la HeS.6 pesante 420 kg e capace di fornire una spinta di 590 kgts.
Erano in pratica gh stessi problemi manifestati dal velivolo di Campini: i pnm1 jet sperimentali soffrivano tutti della mancanza di un'adeguata spinta propulsiva.
Nel corso della guerra Hans-Joach1m Pabst von Ohain continuò a sviluppare il suo turboreattore la,orando anche all'introduzione del compressore assiale.
Fu trasferito negh USA già nel 1945 attraverso l'operazione "Paperclip" mediante la quaJe numerosi scienziati e tecnici della Gennania nazista entrarono a fare stabilmente parte del mondo tecnico-scientifico ed industriale statunitense.
V/.3 : I primi aviogetti a co11fro1110
F_acendo un semplice ed immediato paragone tra queste primissime unità propulsive a getto britanniche e germaniche pienamente funzionanti ed effettivamente usate_ in volo ed il meno avanzato motoreanore italiano di Campini, occorre evidenziare che quest'ultimo, pur essendo privo di un elevato potenziale di sviluppo. era quello capace di fornire allora la spinta più alta ed era anche il primo ed unico ad essere dotato di un dispositivo assimilabile ad un post-bruciatore.
Confr~ntan_do ~ì tra loro i dati geometrici e di massa relativi ai primi velivoli a getto realizzati ne, tre Paesi europei, si vede che mentre i due velivoli a turbocompressore stranien appartenevano sostanzialmente alla slcssa classe di velivoli spen-
144

mentali, semplici, leggeri e di piccole dimensioni. il velivolo di Campini era invece del tutlo atipico. essendo caratterizzato da pesi eccessivi e dimensioni ridondanti. Malgrado ciò anche i due velivoli inglese e bri1annico risultarono inizialmente sottopotenziati, mentre il Gloster britannico po1è raggiungere velocità dell'ordine dei 750 km/h a 3.000 m. di poco superiori a quelle di un contemporaneo caccia con propulsore allemativo ad elica. solo quando venne correda10 con uni1à propulsive più avanzate e potenti.
Questo confron10 evidenzia quindi che il C.C.2. rimasto semplicemente allo stadio iniziale di primissimo proto1ipo mai modificato e migliorato, fu in reallà un velivolo nettamente migliore di quanto fu all'epoca frellolosamente stimato, dando ragione a Secondo Campini. il quale, nel corso della sua vi1a, sos1enne sempre con fo17.a l'intrinseca validità della sua maccbma.
Sembra verosimile che questa. già nel 1942, avrebbe potuto fare molto meglio in 1ennini di prestazioni di volo raggiungendo quo1e e \'elocità di \'Olo nettamente più elevate. se ne fosse staia realizzata una uhenore versione migliorata semplicemente equipaggiata con un più potemc cd affidabile motore alternativo Daimler Benz DB.60 I prima e DB.605 dopo, che erano allora disponibili. come lo stesso Carnpini avrebbe cercato di fare con i bimotori da combattimento che propose in seguito, ma senza alcun successo.
Dim e 11s io11i Pesi e Presta:io11i de lle versioni ini:iali dei p rim i 1•eliiioli a get10
Campini-Caproni
C.C.2 Lunghezza (m): 12.103 Apert. alare (m}: 14.63 Sup. alare (m1): 36.32 Peso a vuoto (kg): 3.400 t Pcso max (kg), 4.400 750 =Seinta max (kg/s}: Velocità max (km/h): 356 a quota (m): 3.000 1-15 Heinkel He.178 7.48 7.20 9,10 1.616 1.998 450 500 l.m. Gloster E.28/39 7.72 8,82 13,61 l.700 380

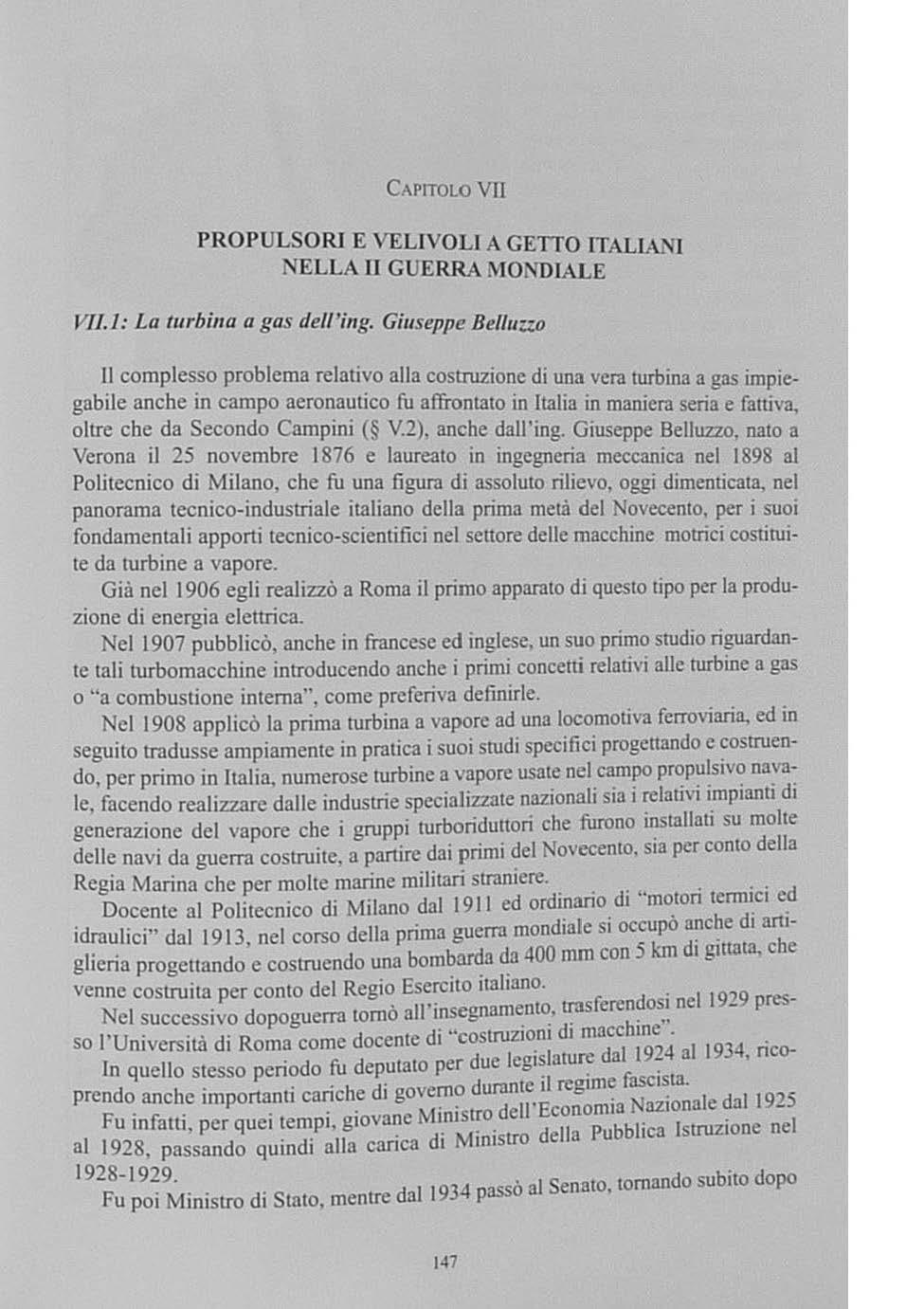
CAPITOLO vrr
PROPULSORJ E VEUVOL I A
GETTO ITALIANI
NELLA ll GUERRA MONDIALE
VIJ. I : La turbina a gas de ll ' ing. Giusepp e B el/11 ~0
l_l comples.so problema relau~o alla costruzione d1 una vera turbina a gas impiegabile anche m campo aeronauuco fu affrontalo in Italia m maniera sena e falli\'a oltre eh~ da Secondo Campim (§ V.2). anche dall'ing. Giuseppe Belluzzo, nato~ Verona 11 25 novembre 1876 e laurealo in ingegneria meccamca nel 1898 aJ Politecnico di Milano, che fu una figura di assoluto rilievo, oggi dimenùcata. nel panorama tecnico-industriale italiano della prima metà del Novecento, per i suoi fondamentali apporti tecnico-scientifici nel settore delle macchme motrici costin111e da turbine a vapore.
Già nel 1906 egli realizzò a Roma il primo apparato di questo 1ipo per la produzione di energia elettrica.
Nel 1907 pubblicò, anche in francese ed inglese. un suo pnmo srudio riguardante tali turbomacchine introducendo anche i primi conceni relatin alle turbine a gas o "a combustione interna", come preferi\'a definirle.
Nel 1908 applicò la prima 1urbina a vapore ad una locomotiva ferroviaria. ed in seguito tradusse ampiamente in pratica i suoi srudi specifici progettando e costruendo, per primo in ltalia. numerose turbine a vapore usate nel campo propulsivo na\'ale, facendo realizzare dalle industrie specializzate nazionali sia i relatr\; impianti di generazione del vapore cbe i gruppi rurboriduttori che furono installati su molte delle navi da guerra costruite, a parure dai primi del Novecento. sia per conto della Regia Marina che per molte marine militari stramere. . ..
Docente al Politecnico di Milano dal 1911 ed ordinario di "moton tenmc1 ed idraulici" dal 1913. nel corso della prima guerra mondiale si occupò ~c~e di amglieria progeuando e costruendo una bombarda da 400 mm con 5 km d1 gntata. che venne costruita per conto del Regio Eserci10 i1aliano. . Nel successivo dopoguerra tornò nll'insegnament~. ~feren~o~'. nel 1929 presso l'Università di Roma come docente di "costruziom di macchme · . ln quello stesso periodo fu deputato per due lcgi~lnture dal I9~4 al 193.J, neoprendo anche imponanti cariche di governo durante il regime fascisia. _ F · · · · · ~.1· · d !l'Economia l\az10nale dal 192:> u mfam. per quei tempi, g1ovanc 1v mistro e . . al 1928, passando quindi alla carica di Ministro della Pubbltca Istruzione nel 1928-1929. .
Fu poi Ministro di Stato. mentre dal 1934 passò al Senato. tornaodo subilo dopo
147
aeli studi ed alle realizzazioni d1
~rauere tecnico-scientifico per di\'ergenza di \'edute con il regime sulle soni dell'economia nazionale, per lo quale avrebbe \'Oluto una maggiore apertura verso I mercati intemnz1onah. mentre essa anda\'a in\'ece avviandosi ,·erso l'ou1archm
Nel sellore della propulsione navale raeeiunse sempre note\'Oli tragu;di. Memornbile fu m particolare il record mondiale di velocità dt -tO nodi conquistato dolresploratore russo Tashkent. costruito m Italia dai canucri
Odero-Temi-Orlando d1 Livorno e varato nel 1937. il quale era mosso do turbine a vapore e da caldaie Belluzzo.
Gia a partire dal 19n avern iniziato una lunga collaborazione con la Breda per la spenmentazione e costruzione d1 una turbina a combusuone del tipo ad azione funzionante grazie ali'azione dei gas dt scarico. prefiggendosi lo scopo di raggiungere per tale dispositi\'o costi di esercizio complesstvt confrontabili con quelli di un motore diesel, anche se con consumi effenivi d1 poco supenon.
La proficua attività sperimentale. condotta in collaborazione con !'mg. Arisì della Breda, compono la soluzione di numerosi problemi costruttivi, tra i quali quello fondamentale del raffreddamento della turbina ed in panicolare delle palette, che vennero realizzate in acciaio e di forma cava, unendo le relative

la pnma 111rbìna a gas da .fO Cl n ali:::ata da Bcllu=o a partirt; dal 192] pn•.uo la Brt!da
t
148
Primo schema di massima di 111rbina Belluz:o

P~/eue cave rotorica e statorica della rurbina Bel/reo con sistema di t'l!frigl!ra:.iortl! a circ:ola=ione d acqua
pani per saldatura, in modo da poterne effettuare il raffreddamento mediante circolazione d'acqua.
Dopo aver svolto con successo i relativi esperimenti utilizzando una rurbina dimostrativa da 40 CV, l'ing. Belluzzo effettuò i calcoli d1 massima per rurbine industriali, per la propulsione navale e per uso aeronautico, preventivando in quest'ultimo caso un peso dell'unità motrice di 0,600 kg/CV. con un consumo orario di combustibile pari a 0,325 kg/CVh ed una potenza erogata di 500 CV.
Nel l932 iniziò anche la progettazione di due turbine aeronautiche capaci di fornire rispettivamente 100 e 600 CV a 12.000 giri.
In particolare egli cercò di onimizzare le nuove macchine sotto il trinomio potenza-peso-consumo realizzando rendimenti più elevali di quelli prefigumbili in base alle caratteristiche degli acciai allora usati. cercando di far lavorare le palette di rurbina ad una temperarura dei gas io ingresso elevatissima, pari a ben 1200° C.
Modificò a tal fine il sistema di raffreddamento delle palette facendolo funzionare più semplicemente a circolazione d'aria, consentendogli di mantenere la temperatura del metallo a valori ridotti, pari a circa 500° C.
Questa soluzione avrebbe comportato l'uso di palette più pesanti di quelle prive di canali cli raffreddamento, ma avrebbe portato 11consumo di com~ustibile n valori molto bassi, dell'ordine dei 200 g per cavallo erogato/ora, conLro 1 1.000-1.200 g delle prime turbine a gas industriali già allora realizzate (§ 11.2), consentendo un forte risparmio sul peso di carburante trasportato. . . . ..
Questi lavori non dettero però esiti applicativi concreti e oegh s~ccesstvt il Belluzzo seguitò a dedicarsi sia alla politica che alla consue~a ~ttJVJta ~ 1 progettazione di impianti di turbine a vapore per applicazioni iodustnab e navali.
149
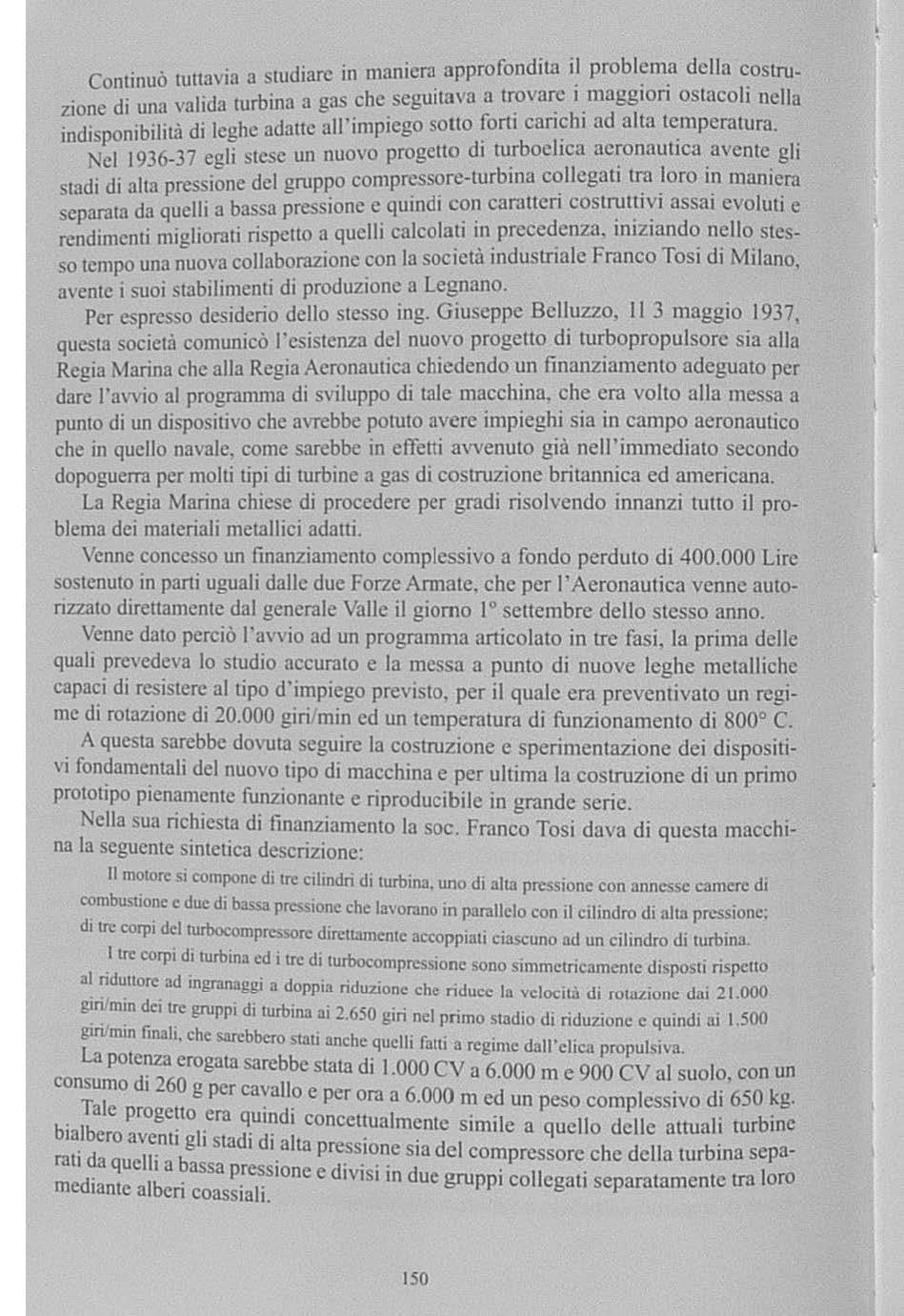
. . .· ·tudiare in maniera approfondita il problema della cosLru- Contmuo 1u11a, ta a s . . . . . d- . 1-d turbi·na a gas chi.! seguitava a trovare I magg1on ostacoli nella z1one • una , a t a .. h" d I - • ·b·i· · d. !·gli• adaue all"imp1ego sotto forti cane I a a ta temperatura. md1spom I Ila I e e,e1 )936-37 egli stese uu nuo\'O progetto dt tu_rboeltca ae~onaul1ca _avente_ gh d.· d" I ss·one del aruppo compressore-turbina collegatt tra loro m maniera S18 I I 3 la pre I , separata da quelli a bassa pressione e qumd1 e?~ carnttcdn cosL~t~•~1adssa1 c 1 , 1 •olut, e rendimenti migliorati rispe110 a quelh calcola~1 •_n_ prece _enza. tntztan n~ o_ stesso tempo una nuo\'a collaborazione con la societa industnalc Franco Tosi dt Milano, avente i suoi stabilimenti di produzione a Legnano.
Per espresso desiderio dello stesso ing. Giuseppe Bell_uzzo. 11 3 maggio_ I937, questa società comunicò l'esistenza del nuo_vo progetto d1 tu~bopropulson: sta alla Regia l\tarinn che alla Regia Aeronautica chtedendo ~n finanz1amcnto adeguato per dare J'a," io al programma di s,·iluppo di tale macchm~ che era volto alla messa a punto di un dispositi\'O che a\Tebbc potuto aYere impieghi sia in campo aeronautico che in quello navale. come sarebbe in e1Tet1i avvenuto già nell'immediato secondo dopoguerra per molti lipi di turbine a gas dt costruzione britannica ed americana.
La Regia Marina chiese di procedere per gradi risolvendo innanzi tutto il problema dei materiali metallici adani.
Venne concesso un finanziamento complessivo a fondo perduto di 400.000 Lire sostenuto in pani uguali dalle due forze Armate. che per l'Aeronautica venne autorizzato direttamente dal generale Valle il giorno 1° scuembre dello stesso anno.
Venne dato perciò l"a\'\ io ad un programma anicolato in tre fasi. la prima delle quali prcvcdcrn lo studio accurato e la messa a punto di nuove leghe metalliche capaci di resistere al tipo d·impiego previsto, per il quale era preventivato un n.!gimc di rotazione di 20.000 gin min ed un temperatura di funzionamento di 800° C.
A questa sarebbe do, uta seguire la costruzione e sperimentazione dei dispositi,i fondamentali del nuovo llpo di macchina e per ultima la costruzione di un primo prototipo pienamente funzionante e riproducibile in grande serie.
Nella sua richiesta di finanziamento la soc. Franco Tosi dava di questa macchina la seguente sime11ca descrizione:
Il motore s1 compone di tn: cilindri d1 turbina. uno d1 allll pressione con annesse camere d1 combustione e due di bJSsa prcs,1one che lovornno in parallelo con il cilindro di alta pr.:ssionc; di Ire corpi del turbocompre,,sorc din:11.amcntc accoppiati ciascuno ad un cilindro di turbina. 1 tre corpi di 1urtiina ed I Ile di 1uri>ocompres,1onc sono simmetricamente d1spos11 nsperto al nduuore ad mgr-JJlaggi a doppia riduzione che riduce lo 'l'cloc11.i di rouu.ionc da, 21.000 gin mm dei Ile gruppi d1 turbina · ., 6"0 · · I · · · · - 00 a1 - · ' gm n.: pnmo stadio dt ndu1.1onc e qumd1 at 1.5 gm m1n finali. che sareb'--o dnu , h Il fi · · . , ""r ,... anc e quc I a111 a regime dall'chca propulsiva. La pote~ erogata sarebbe stata di 1.000 CV a 6.000 me 900 CV al suolo. con un consumo di 260 g per cavallo e per ora a 6.000 m ed un peso complessivo di 650 kg. b" ~aie progc~to _era quindi conce11ualmen1e simile a quello delle attuali turbine 18 ero av~nu gh stadi di alta pressione sia del compressore che della turbina separau da qucllt a bassa pres · • d" · -. d. . stonc e l\'1S1 m due gruppi collegati separatamente tra loro me tante alben coassiali.
150
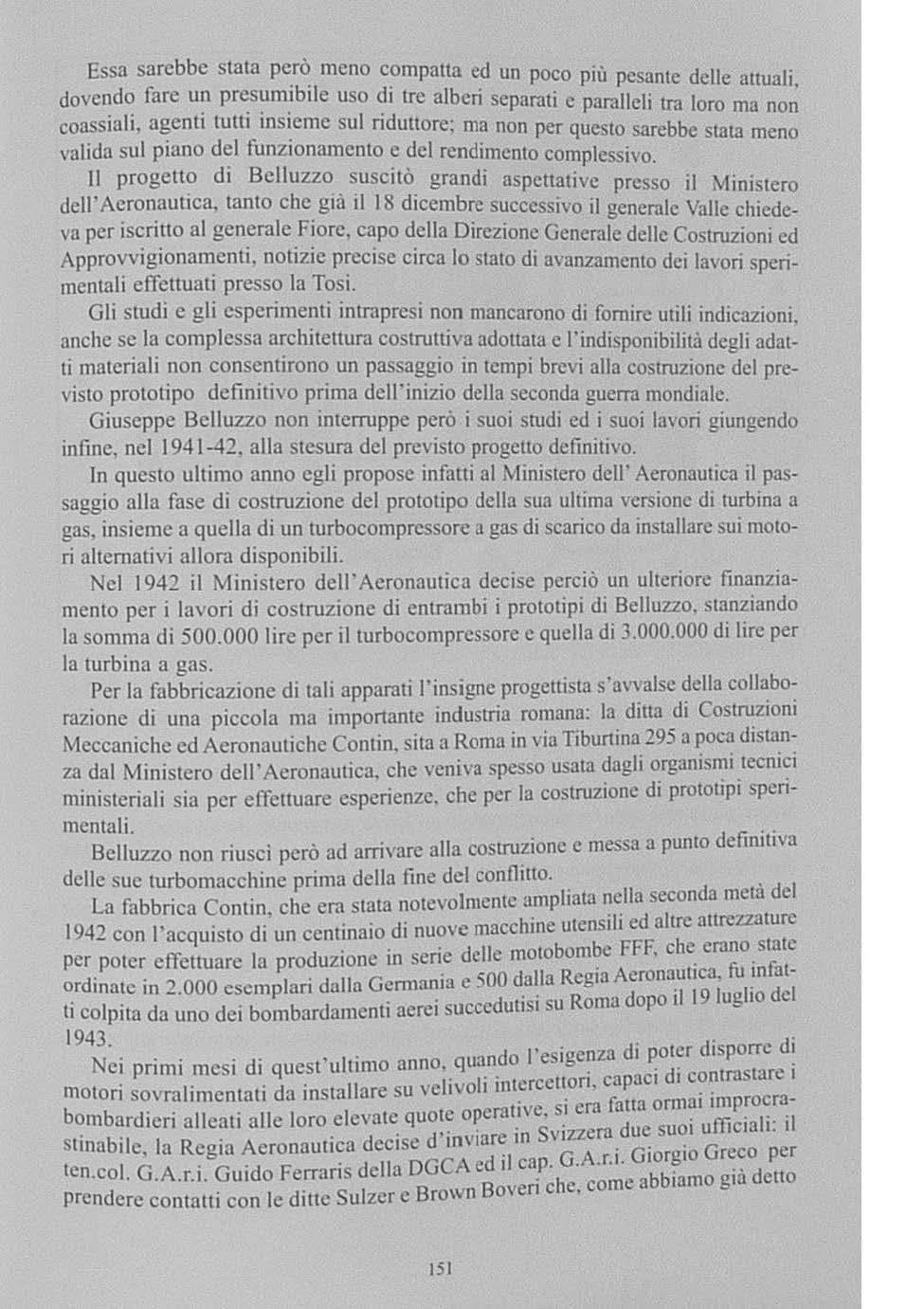
Essa sarebbe staia pc_r~ meno c~mpalta lld un poco più pcsan1e delle attuali, dove~d~ fare u~ p~um~b1le uso ~1 Ire alberi separati e paralleli ira loro ma non coassiali. agenti 1ull1 insieme sul riduttore; ma non per quesio sarebbe staia · d I t· · meno \'alida sul piano e unz1onamen10 e del rendimento complessivo.
li progetto di Belluzzo suscitò grandi aspclla1ive presso il :-Vlinisicro dell'Aeronau11ca. tanto che gtà 11 18 dicembre successivo il generale Valle chiedeva per iscrino al generale Fiore, capo della Direzione Generale delle Cosiruzioni cd ,-\pprowigionamenti. notizie precise circa lo stato di avanzamento dei lavon spcnmentalì effettuati presso la Tosi.
Gli studi e gli esperimenti intrapresi non mancarono d1 fornire u1ili ind1caz1oni. anche se la complessa architettura costruttjva adottata e l'indisponibilità degh adatti ma1eriali non consentirono un passaggio in tempi bre, i allo cos1ruzione del previsto prototipo definitivo prima dcll"inizio della seconda guerra mondiale.
Giuseppe Belluzzo non interruppe però i suoi srudi t:d i suoi lavori giungendo infine. nel 1941-[!. alla stesura del previsto progetto definitivo.
In questo ultimo anno egli propose infaui al Ministero dcli' Aeronauuca il passaggio alla fase di costruzione del prototipo della sua uhima "ersionc di 1urbina a gas. insieme a quella di un turbocompressore a gas di scarico da installare sui motori alternativi allora disponibili.
Nel 1942 il Ministero detrAeronauuca decise perciò un uhenorc finanziamento per i la\Ori di costruzione di entrambi i prototipi di Belluzzo. stanziando la somma di 500.000 lire per il turbocompressore e quella di 3.000.000 di lire per la 1urbina a gas.
Per la fabbricazione di tali apparati l'insigne progettis1a s·avi.alsc della collaborazione di una piccola ma importante industria romana: la dina di Costruzioni Meccamche cd Aeronautiche Contin. si1a a Roma in \ ia Tiburtina 295 a poca distanza dal Ministero dell'Aeronauuca. che \'Cnirn spesso usata dagli orgamsmi tecnici ministeriali sia per elTcttuare esperienze. che per la costruzione di pro1oup1 sperimentali. • •
Bellw.zo non riusci però ad arrivare alla cos1ruzione e messa a punto defirutiva delle sue turbomacchine prima della fine del conniuo. . La fabbrica Contin. che era s1ata note,·olmentc ampliata nella seconda mela del 1942 con l'acquisto di un centinaio di nuove macchine u1ensili ed altre aurcaaturc . . • d 11 1 bombe FFF che erano siate per poter effettuare la produzione m sene e e mo O • • . . . · 'i00 d Ila R'gta Aeronauuca. fu 111fat- ordmn1c m 2.000 esemplari dallo Germania e - a t: . . . . •d · ·s Roma dopo ti 19 lugho del li colpua da uno de, bombardamenu aerei succe uusi u 1943. . . . d 1• • enzn d1 poier disporre d, Nei primi mes i di quest'ultimo anno. quan ° esig . d. e n,,..star' 1 I 1· · , c •11on capaci I o ,.. t: motori SOHalimentati da ins1allare su ve 1vo I llllt:r e • .. , · ,, ·era faua ormai 1mprocra- bombardieri alleati alle loro elevate quo1e o.p1.rnt1,t:, 5.1 d . · mc1·~11• il . . . . . d' • · · 0 Sviz.zera ue suoi u 1 .. • st1nab1lc. la Rcgm Aeronauuca decise 111' tnr~ 1 G A • Giorgio Greco per ten col. G.A.r.i. Guido Ferraris della DGCA ed ti cap.h · .r.l.• abbiamo già detto . . 8 n Bon?n c e. comi: prendere con1a1u con le dme Sulzer e ro,,.
151

Turb«omprr<.1ore dt Jo1roltmen1a:ionl! a gas di scarico Bro11n-801eri sistema Bùclri rn 11.2). ave\'ano maturato una notc,·ole esperienza nel campo della costru~ione d1 turbine a gas per usi induslriah. avendone già costruito alcuni esemplari funzionan11.
La Brown-Boveri in panicolare ave\'a messo a punto un valido progeuo di turbocompressore a gas di scanco di tipo centrifugo su progetto dell'ing. Buchi. mentre la Sulzcr aveva realizzato un turbocompressore assiale per motori pesanti terrestn.
La Sulzer inoltre, già a panire dal 31 dicembre 1942, aveva proposto alla Regia Aeronnu11ca un nuovissimo progetto di un motore diesel a due tempi, di potenza compresa tra i 3.000 ed i 5.000 CV
La prcsen1a2.ìone di tale progeuo era avvenuta a Guidonia tramite un suo consulente tccnìco. l'lllg. Pio Franco Manmuzzt. che era cmadino italiano ma residente a Zungo.
I due ufficiali, appositamente incanca11, avrebbero dovuto cercare d'ouenere la cessione del progetto completo di un turbocompressore da installare sul nuovo motore Piaggio P.XV allora in fase di realtzzazionc.
La missione m Svizzera dei due ufficiali si svolse regolarmente nella prima d~cade _del luglio I943. Fu raggiunto un pieno accordo con la Sulzer per la costruzi~ne dt _un prototipo completo di tale dispositivo. anche se la società svizzera aveva gia marufestato l'mtenziooe d1 consegnarlo solo dopo la fine delle ostilità.
La Regrn Aeronautica, che aveva un disperato bisogno immediato di un appara-
152
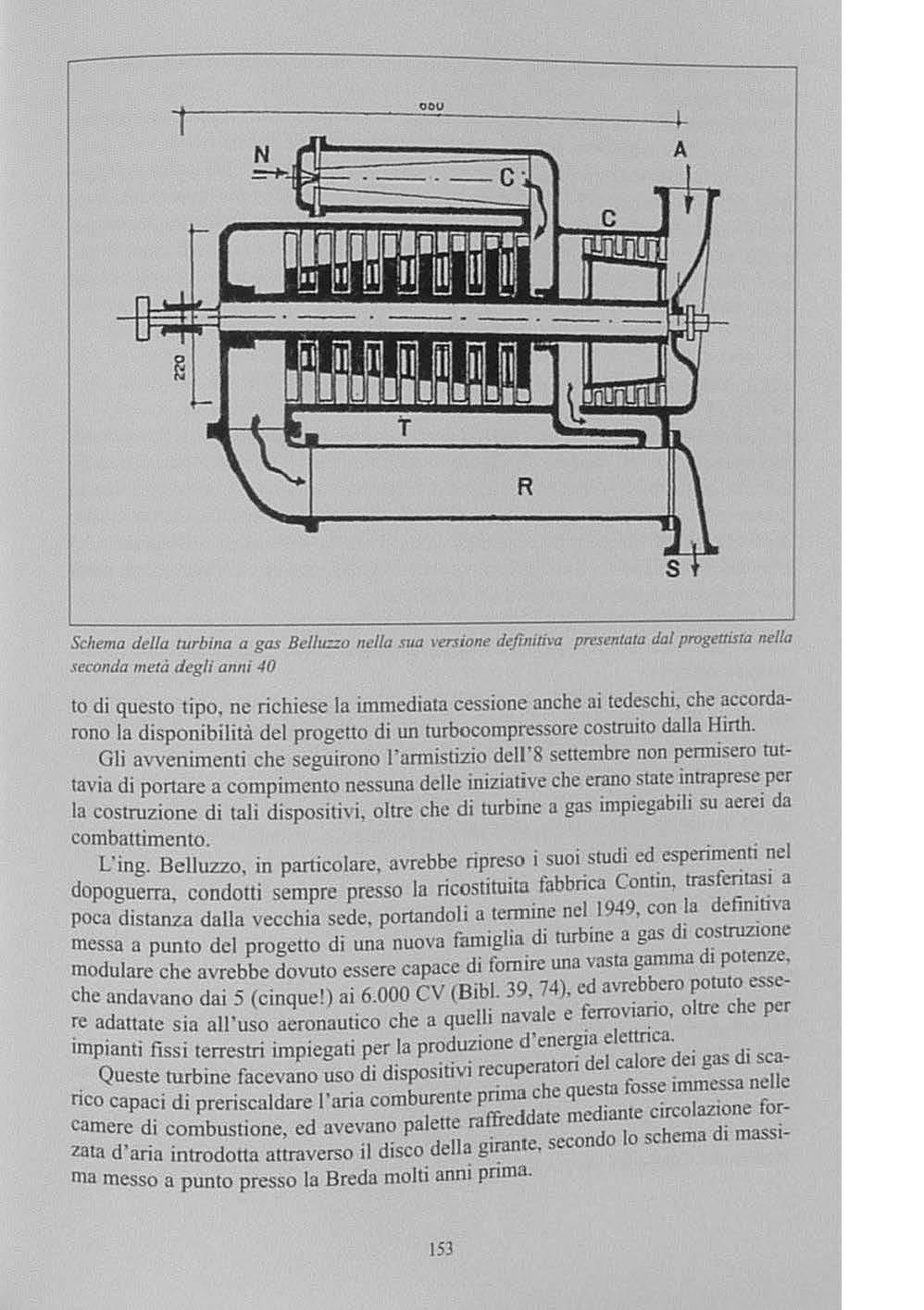
Schema della rvrbi11a a gas Belli=o 11,•l/a .rua ,·er:1ione defìnitil'O presl!ntara dal progetrura nl!lla Jeconda metà degli anni ./0
to di questo tipo, ne richiese la immediata cessione anche at tedeschi, che accordarono la disponibilità del progetto di un rurbocompressore costnnto dalla Hirth.
Gli awenimenti che seguirono rannistizio dell'S settembre non pennisero tuttavia di ponare a compimento nessuna delle iniziative che erano state intraprese per la costruzione di tali dispositivi, oltre che di turbine a gas impiegabili su aerei da combattimemo.
L'ing. Belluzzo, in panicolare, avrebbe ripreso i suoi studi ed esperimenll nel dopogue~ condotti sempre presso lo ricostituiw fabbrica Conun, trasfcntasi a poca distanza dalla vecchia sede, portando! i o tennine nel 1949, con la definitiva messa a punto del progetto di una nuova famiglia cli turbine a gas di cosuuzione modulare che avrebbe dovuto essere capace di fornire una vasta gamma dt potenze. che andavano dai 5 (cinque!) ai 6.000 CV (Bibl. 39, 74), ed avrebbero potuto esse~e adattate sia ali'uso aeronautico che a quelli navale e ferroviario, oltre che per impianti fissi terrestri impiegati per la produzione d'energia elettrica. . . . Queste turbine facevano uso cli dispositivi recuperatori del calore ~e1 gas d1 scanco capaci di preriscaldare l'aria comburente prima che quesui fosse immessa nelle camere di combustione, ed avevano palette raffreddate mediante circolazi~ne foruua d'aria introdotta auraverso il disco della girante, secondo lo schema di massima messo a punto presso la Breda molti anni prima.
oou
153
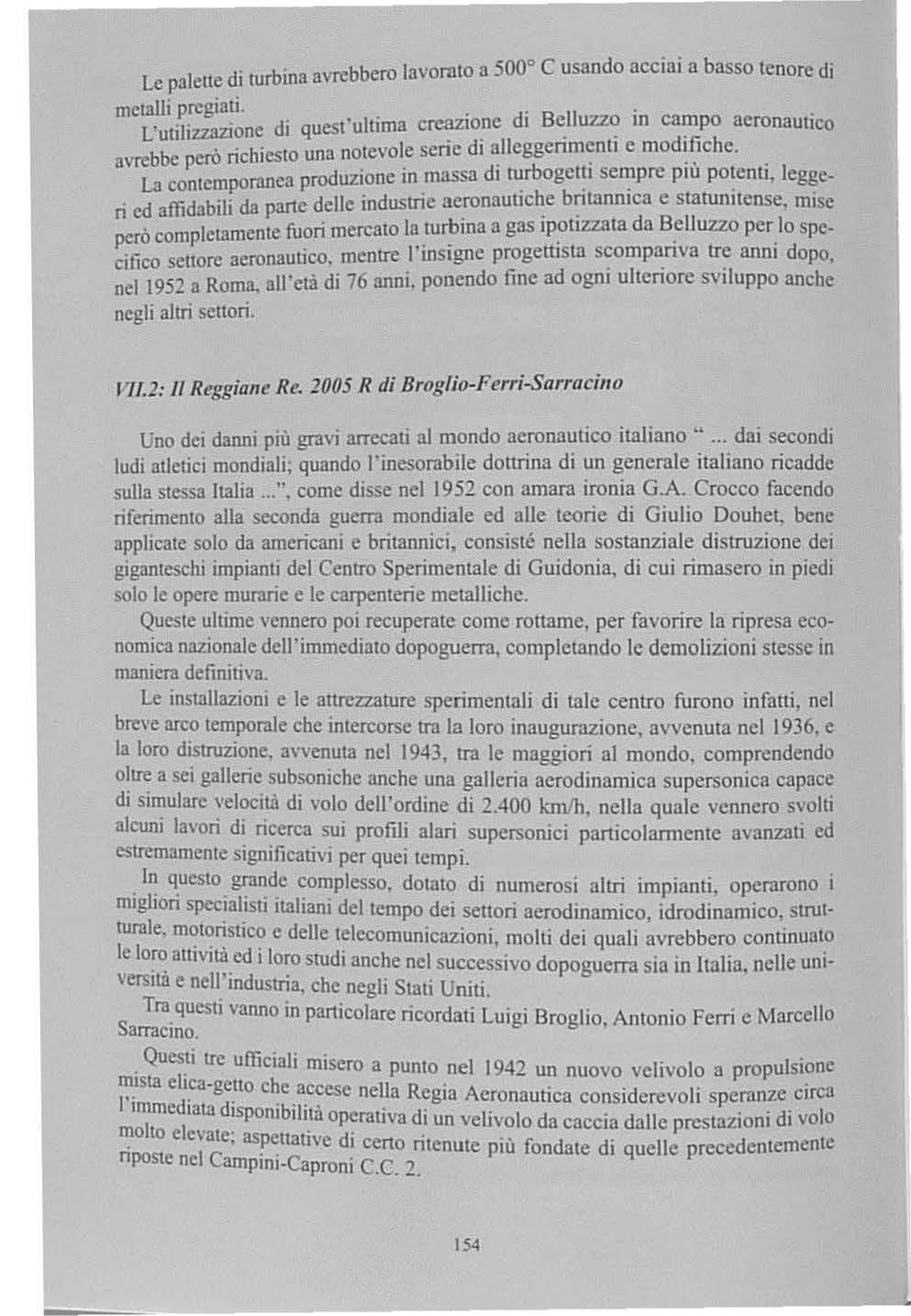
I d. b. 3 avr·bbero la\'ornto a 500° C usando accim a basso tenore di Le pa ene I tur m " mcmlii pregiati . Il ·
• .1. · di quest'ultima creazione d1 Be uzzo m campo aeronauuco L ull 1zzaz1one • · d'fi h b · · h'esto una notevole serie di alleggenmcntl e mo t te e. avreb e pero ne 1 . . . . . . , _ oranea produzione in .massa dt rurbogetu sempre p1u pot.enll, legge- 1.,U contcmp . b . . ed ffid b·1· da parte delle industrie aeronouuche ntanmca e statunitense. mise ri a O 11 · · d B Il I • letarnente fuori mercato la turbina a gas 1pot1zzala a e uzzo per o spe- pero comp •. . . • . . cifico senore aeronautico. mentre I ms1gne progettista scomp~nva tre anm dopo, nel 1952 a Roma. all'età di 76 anni. ponendo fine ad ogni ultenore sviluppo anche negli altn settori.
11/. 2: Il Reggia11e Re. 1005 R di Broglio-Ferri-Sarraci110
Uno dei danni più grav1 arrecat1 al mondo aeronautico italiano ·• ... dat secondi ludi atleuc1 mondiali, quando l'inesorabile dottrina d1 un generale italiano ricadde sulla stessa Italia .. ". come disse nel 1952 con amara ironia G.A. Croceo facendo riferimento alla seconda guerra mondiale ed alle teone di Giulio DouheL bene applicate solo da americani e bntannic1, consisté nella sostanziale distruzione dei gigantesclu 1mpianll del Centro Spenmentale dt Guidonia, di cui rimasero in piedi solo le opere murane e le carpentene metalliche
Queste ultime vennero poi recuperate come rottame, per favorire la npresa economica nazionale dell 'imrnediato dopoguerra., completando le demolizioni stesse m maniera defimuva.
Le ins1allaziom e le attrezzature sperimentali di tale centro furono infani, nel bre\'e arco temporale che intercorse tra la loro mauguraz1one. avvenuta nel 1936. e la loro distruzione. awenuta nel 1943. tra le maggion al mondo, comprendendo oltre a sei gallerie subsoniche anche una gallena aerodinamica supersomca capace dì simulare velocità d1 volo dell'ordine di 2400 km/h. nella quale vennero S\'ollt alcuni la\'ori di ricerca sui profili alan supersonici particolanneme a, anzati ed estremamente significativi per quei tempi.
. l~ questo grande complesso. dotato di numerosi altri impianti. operarono i miglion spccialisn 1tahan1 del tempo dei se11on aerodmam1co, idrodinamico. strut· turale, mot~risric? e delle telecomunicazioni, molti dei quali avrebbero cominuato I~ lor~ a111v1~_cd i loro studi anche nel successivo dopoguerra sta in Italia. nelle um\ er.;ita e nelI mdustna, che negli Stati Umu
Tra questi vanno m particolare ricordati Luigi Broglio, Antonio Ferri e Marcello Sarracmo.
Quesu tre ffi · 1· • . u cm I misero a punto nel 1942 un nuo,·o velivolo a propulsione ~. 1sta eh~a-geuo che accese nella Regia Aeronautica considerevoli speranze circa •mmediatn disponibilità operativa di un velivolo da caccia dalle prestazioni di \'olo molto elevate· aspettati d . .• , . • ve I ceno ntenute pm fondate di quelle precedentementi; nposte nel Campini-Caprom e.e. 2.
154
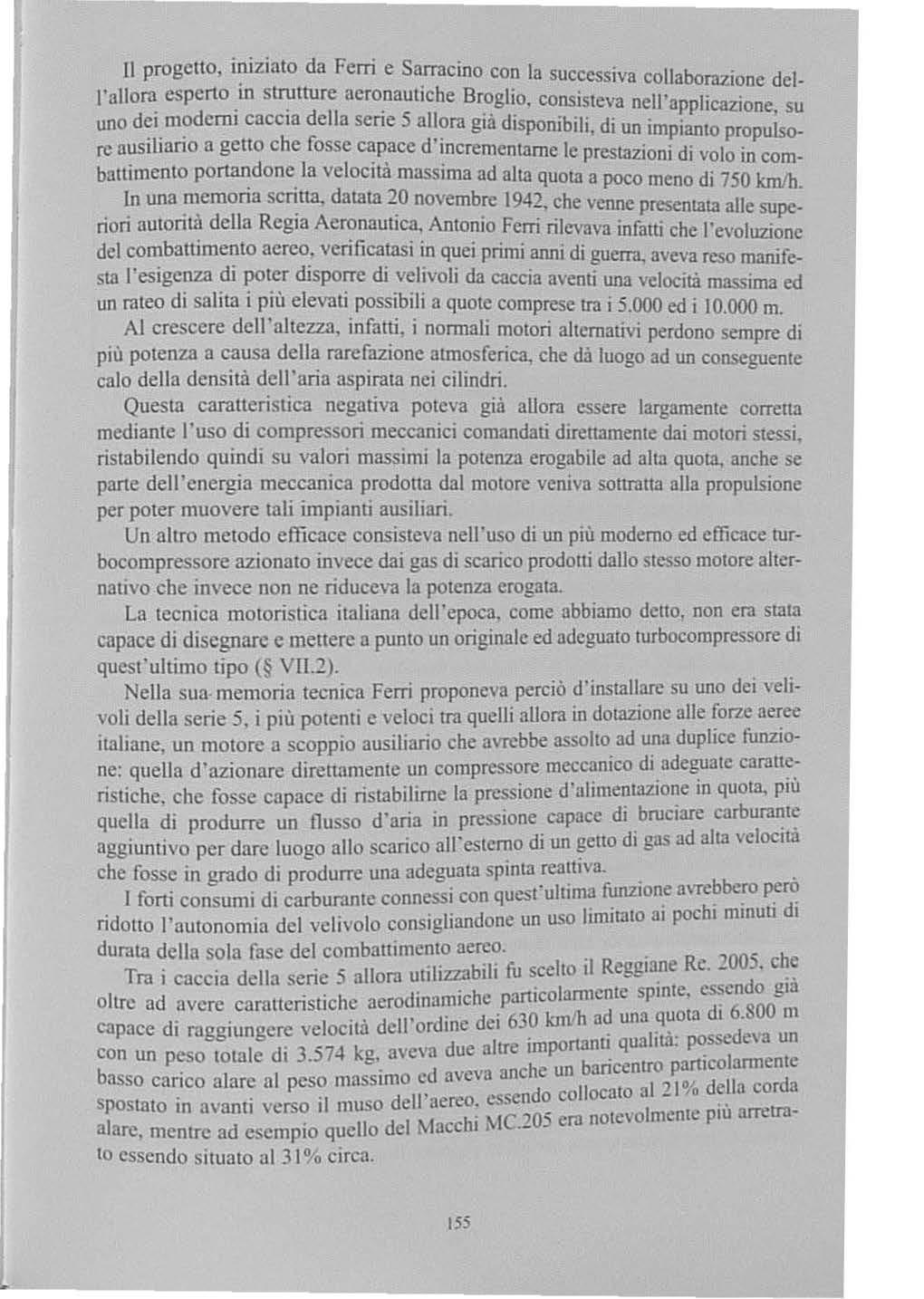
li progetto, iniziato da Ferri e Sarracino con la successiva collabo d I . . razione el'allora esperto tn strutture acronauuche Broglio, consisteva nell'applicaz· · d · · d Il · ione, su uno dei mo emi caccia e a sene 5 allora già disponibili, di un impianto pro uJs 'li tt h fì d' p o- re ous1 ano a ge o c e osse capace incrementarne le prestazioni dt volo in combauimen10 po~done_ la velocità massima ad alla quota a poco meno di 750 krruh. In una memona sc~tta. datata ~O novembre 1942, che venne presentata alle superiori autontà della Regm AeronauLJca, Antonio Ferri rilevava infatti che l'evoluzione del combattimento aereo. verificatasi in quei primi anni di guerra, aveva r~o manifesui l'esigenza di poter disporre di velivoli da caccia avenu una velocità massima ed un rateo di salita i più elevati possibili a quote comprese tra i 5.000 ed i 10.000 m.
Al crescere dell 'allezza. infatti. i normali motori ahernativi perdono sempre di ptù potenza a causa della rarefazione atmosferica. che dà luogo ad un conseguente calo della densità dell'aria aspirata nei cilindri.
Questa caratteristica negativa poteva già allora essere largamente corretta mediante l'uso di compressori meccanici comandatl direttamente dai mo1on stessi. ristabilendo quindt su valori mass1m1 la potenza erogabile ad alta quola, anche se pane dell'energia meccanica prodotta dal motore veniva sottratta alla propulsione per poter muovere tali impianu aus1hari
Un altro metodo efficace consisteva nell'uso di un più moderno ed efficace turbocompressore azionato invece dai gas di scanco prodolli dallo stesso motore alternativo che m,·ece non ne riduceva la potenza erogata.
La tecnica motoristica italiana dell'epoca. come abbiamo dello, non era stata capace di disegnare e mettere o punto un originale ed adeguato turbocompressore d1 quest'ultimo tipo(§ VCT.2). . .
Nella sua memona tecnica Ferri propone,a perciò d'installare su uno dei , eh\'Oli della serie 5, i più potenll e \'eloci tra quelli allora m do1a2ione alle ~017~ ae~ee 11ahane. un motore a scoppio ausiliario che avrebbe assolto ad una duplice funzione: quella d'azionare direnamente un compn.>ssore meccanico d1 ade~atc camtt~: ristiche. che fosse capace di ristabilirne la pressione d'alimen1az1one m quota, p,u quella di produrre un nusso d'aria m pressione capace di bruciare carbu~t: · · di d · ad alta \'cloc1ta aggmnli\'O per dare luogo allo scanco ali esterno un gc110 1gas che fosse in grado di produrre una adeguata spinta rcattna. . · · • ·1'uJ1i·ma funzione avrebbero pero I fom consumi dt carburante connessi con ques . . . . d . I mitato ui pochi minuti d1 ndotto l'autonomm del veh\'olo cons1gl1an one un uso 1 durata della so . la fase del.combattimento aereo. R , 00 - h· I b 1· sc ho il Rel!l!tane e - :>. e e Tra i caccia della sene 5 allora uu 1z:z.a I t ,u .. . · . . . h • art olonncnte spinte, essendo gia oltr..: ad avere caralleristiche aerodmam,c e P ,e d. 6 800-01 d 11 d. d · 630 km h ad uno quota 1 • capace d1 rugaiungerc , ·eloc1ta e or me et . . d o· I nanu quahta: possc e, a un con un peso totale d1 3.574 kg. ave,a due a Ire tmpo . • 1 e 1• , Ie un bancenLro pan1co ann n e basso canco alare al peso massimo ed ave, a anc 1 11 1., 1o, della corda . . d li' 'O essendo co ocato a, o spostato m a, anti , crso II muso e aen: · · 1 "nl, p,·u· ~.....,trah \.IC '0" era notevo m.. c ,~ alare, mentre ad esempio quello del Macc 1 · ·- • to essendo situato al 31 % circa.
155

-
Caproni-Reggiane Re, 2005 R
Il Reggiane Re ](}()5 R Ji Broglio-frrri-Sarracino co11 mo1ocomptl!ssorc ce11rnfugo
Anche se 11 progettista del bel ,·eli\·olodella Reggiane ing. Roberto Longlu ebbe 3 manifestare ad Antonio Fem tutte le sue perplessità in proposito per le negative \'ariazioni d'assetto che ne sarebbero potute denvare, il Re. 2005 venne ritenuto in grado d1 sopportare bene sia un incremento dei pesi di circa 51 O kg. derivante dal!'installazione del pre,·isto moto-compressore ausiliario corredato dei relativi condoni e del relati\'O bruciatore. che l'arretramento della posizione del nuovo baricentro verso la coda dovuto alla collocazione d1 mli carichi aggiuntivi dietro al posto d1 pilotaggio e nella parte tenninale d1 fusoliera.
L'unità propulsiva ausiliana avrebbe dovuto essere costituita da un motore Fiat A20 a 11 cilindri a "V" raffreddato a liquido. capace d1 erogare 370 CV, azionante due turbosoffianri centrifughe· una per la sovralimentazione del motore principale Daimler Benz DB.605 da 1.250 C\ continui. e !"altra per la creazione del getto propulsivo ausiliario.
Quest'ulumo sarebbe stato prodotto attraverso il passaggio dell'aria compressa. prevenu\'amente addi21onata al combustibile, in un diffusore che ne avrebbe ridotto la \'elocua pnma dell'mgresso in camera di combusuone.
I gas caldi cosi prodotti sarebbero quindi passati m un condotto di scarico per essere espulsi atrestemo attraverso un ugello a semplice convergenza capace d'incrementarne notevolmente la velocita d'uscita, con la conseguente produzione della massima spinta di reazione possibile.
Tuuo questo avrebbe reso disponibile una potenza propulsiva complessiva pienamente confrontabile con quella erogata da un singolo motore altema11vo di almeno 2.000 CV. che non era allora disponibile in Italia.
Unici inconvenienti prevmi erano quelli dovuti all'aumento di superficie bagnata ~all'ari~ den\'ante dall'allungamento della parte posteriore della fusoliera. ed all accrescimento della superficie dei radiatori utilizzati, che era dovuta aUa installazione di elementi aggiuntivi, relativi sia al motore Fiat che ad un refrigeratore 3usiltan~ 0 mtercooler che sarebbe stato utilizzato per raffreddare la miscela compressa di sovrahmentaz1one inviata al Daimler Benz DB. 605.
156

li Reggiane Re. 2005 R di Broglio-Fem-Sarracino con motocomprr.uon: assiale
Nei calcoli di progetto veniva preventivato un aumento della potcll2ll massima complessiva da 1.250 a 2.030 CV, con una veloc1tà massima di volo sicuramente non inferiore ai 700 km/h.
La spinta erogabile da parte del getto ausiliario era stimata in l'.!0 kg.
Alla realizzazione di alcuni dei dispositivi sopra elencati venne chiamata la dma Ansaldo di Genova., sotto la supervisione dell'ingegner Silla.
Venne quindi realizzato un protoupo di tale dispositivo che venne sottoposto a numerose prove di funzionamento, risolvendo rn particolare i problemi d"accensione della miscela compressa di aria e carburante
I positivi risultati di tali prove furono comumcaù ai superion orgam tecmci dello Regia Aeronautica nel luglio del 1943
Dalla documentazione esistente e da testimomanze di.rene nsulta che la costruzione dell'impianto propulsivo del prototipo del Re 2005 R fu cffetuvamente portata avanti, e venne inoltre iniziato iJ processo d1 modifica di un preesistente velivolo.
L'apparato propulsivo a reazione venne anche sottoposto a prove di fu~ionamemo a terra con misurazione stanca della spinta effemvameme erogata. che nsulto essere pari a 95- 100 kg, ma susceuìbilc di ulterion incremenn. . .
La pane posteriore del Re. 2005 do\'elle essere completamente nd1se~ata souo la direzione di Luigi Broglio per consentire l'alloggiamento d1 tutLJ I disposum connessi.
Le prestazioni previste ottenibili ad un peso totale d1 4.070 kg. comprendente quello dell' annameoto che ern stato ndotto ai soh 3 cannom Mauser da :!O mm. risultarono essere di 730 kmb a 7.800 metri mantenibih per I:! min.
Gli avvenimenti dell'8 senembre 1943 impedirono il pieno completan:ienio ~• tale progetto e l'inizio della suo ulteriore evoluzione. già previSta da Antonto Fem. consistente nell'uso di un compressore assiale posto dirennmente ~Ile spa!le del pilota, azionato directamcnte dol motore principale del \'ehvolo mediante un apposita trasmissione.
151
b
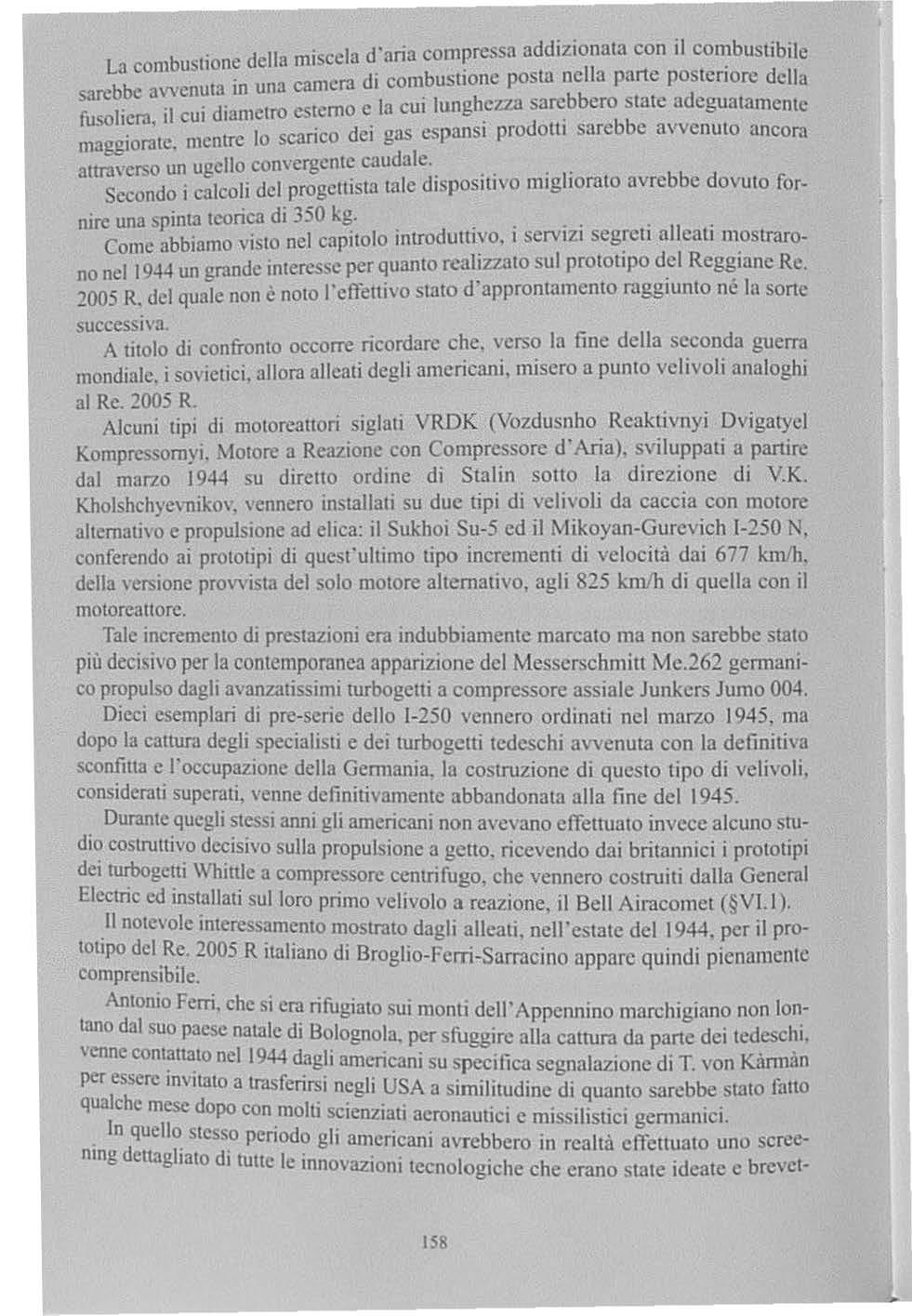
• d Ila mi\cela d"aria compressa addizionata con il combustibile
La com us11one e · . . · a camera di combusuone posta nella parte posteriore della sarebbe avvenu1a m un
· 1 d. ·iro •sterno e la cui lungheua sarebbero state adeguatamentl! fusoliera I cui 1amt: c. . . · • ' tre lo •carico dei gas l!spnns1 prodot11 sarebbe m venu10 ancora maggiorate. nn:n s altra\ cr.-o un ugello con,·crgl!nte caudale..
Sl!condo i calcoli del progl!ttis1a tale d1spos1tl\ o migliorato avrebbe dO\ uto fornire una ~pinta teorica di 350 kg. . . . . . .
Come abbiamo visto nel capitolo introdutu~·o, 1 sen:121 seg~ct1 alleati mos1rarol 1944 un erande mten:sse per quamo rt:ahzzato sul protoupo del Reggiane Re. oone _ .. 1 2005 R. del quale non e: noto !'effoni, o stato d"approntamcmo raggiunto ne a sorte successi,a
A tilOlo di confronto occorre ricordare che. vaso la fine della seconda guerra mondiale. i so\'ietici. allora alleati degli americani, misero a punto velivoli analoghi al Re. 2005 R.
Alcuni tipi di motoreattori siglati \'RDK (Vozdusnho Reaktivnyi Dvigatyel Komprl.'Ssornyi. \fotorc a Reazione con Compressore d"Aria). s, iluppati a partire dal mur,o J944 su dirello ordine di Stalin sotto la direzione di \'.K. Kholshchye\lliko,. , enncro mstallatt su due tipi di veli, oli da caccia con motore altemati,o e propulsione ad ehca: il Sukhoi Su-5 ed il Mikoyan-Gure,ich 1-250 N. conferendo ai prototipi di quest'ultimo lipo incrementi di n!locità dai 677 km h. della ,ers1one prov, ista del ~olo m01ore alternativo. agli 825 km/h di quel1~1 con il motoreattore.
Tale incremento di prestazioni era indubbiamente marcato ma non sarebbe stato più decisi,o per la contemporanl!a apparizione del Messerschmitt Mc.262 gcnnanico propulso dagli a,an?.atiss1mi turbogetti a compressore assiale Junkcrs Jumo 004.
Dieci esemplari di pre-seric dello I-250 vennero ordinati nel morzo 1945, mu dopo la cattura degli specialis11 e dei turbogetti tedeschi aVYenuta con la definiti, a sconfitta e l'occupazione della Germania. la costruz-iom: di questo tipo di vcli\'oli. considerali superati. venne definiti, amente abbandonata alla fine del 1945.
Durante quegli stessi anni gli americani non a,·c,ano cffettua10 invece alcuno studio coslruttivo decisivo sulla propulsione a getto. ricevendo dai britannici i protolipi dei turbogetti Whinle a compressore centrifugo, che vennero costruiti dalla Generai Electric ed installati sul loro primo velivolo a reazione, il Beli Airacomct (~VI. I).
_Il notevole interessamento mostrato dagli alleali, nell'estate del 194-t, per il protolipo del .R~ 2005 R italiano dì Broglio-I-erri-Sarracino appan.: quindi pienamcntt; comprens1b1le.
Amomo Ferri, che s1 era rifugiato sui monll dell'Appenmno marchigiano non lon~o ~I suo paese natale di Bolognola. per sfuggire alla cattura da parte dei 1edeschi. ,~n~e ~.o~tat~to nel 1944 d~gli amencani su specifica segnalazione di T. von Kànnàn per essere 1"' itato a tmsfenrs1 negli USA a similitudine di quanto sarebbe simo fatto qualche mese dopo con molti ··c1·enz·at·
1 1aeronau11c1 e m1ss1 1snc1 gennamct.
. In quello stesso periodo gli americani avrebbero in realtà effettuato uno screening dettagliato di tutt•' le ·
I
b mnovaz1on1 tecno og1che che erano siate ideate e revi:t-
· · · ·1· · · · ·
·'
158
· ·
·
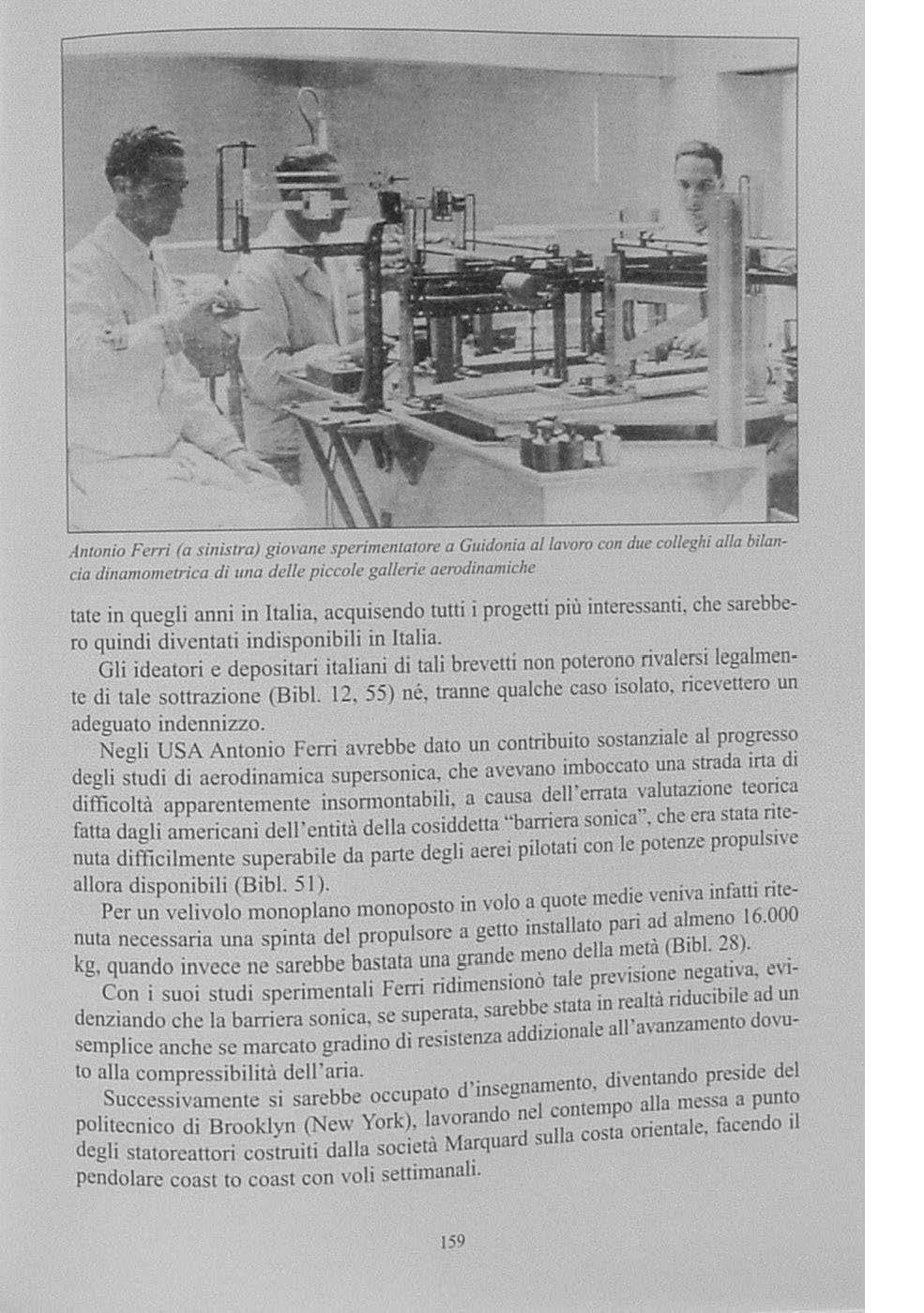
Antonio Ferri (a sinistra) giornnc sperimenratoff! a G11ido11io al lavoro con dut' colleghi allo bilonc1a dfllamomctrica di una delle piccole gal/crit' aerodinamiche tate in quegli anni in Italia. acquisendo tutti i progetti più inten."Ssanti. che sarebbero quindi diventati indisponibili in ltalia.
Gli ideatori e depositari italiani di tali breveui non poterono rivalersi legalmente di tale sottrazione (Bibl. 12. 55) né, tranne qualche caso isolato, ricevettero un adeguato indennizzo.
Negli USA Antonio Ferri avrebbe dato un contribuito sosianzialc al progresso degli studi di aerodinamica supersonica, che avevano imboccato uno strada irta di difficoltà apparentemente insonnomabili. a causa dell'emna valutazione teorica fatta dagli americani dcli 'entità della cosiddctln "barriera sonica·•. che era stata ritenuta dillicilmente superabile da parte degli aerei pilotati con le potenze propulsi,·e allora disponibili (Bibl. 51 ).
Per un velivolo monoplano monoposto in volo a quote medie veniva infani ritenuta necessaria una spinta del propulsore a getto installato pari ad almeno 16.000 kg, quando in\'cce ne sarebbe bastata una grande meno della metà (Bibl. 28). .
Con i suoi studi sperimentali Ferri ridimensionò tale pre, ìsìo~e negnt~va. e,,. denziando che la barriera sonica. se superara. sarebbe stata in renlta nduc1b1le ad un semplice anche se marcato gradino di resistenza addizionale all"a\'anzamcnro dovuto alla compressibilità dell'aria. ·
Successivamente si sarebbe occupato d'insegnamento. di,entando preside del politecnico di Brooklyn (New York). lavorando nel contempo alla mess~ 3 punto degli statoreanon costruiti dalla società Marquard sulla co 5t a orientale, tacc nd o 11 pendolare coost to coast con voli settimanali.
159

Ricopri inoltre la carica di direttore dei_ Laboi:3tori Aerospazi~li Guggenheirn e quella di presidente della Generai Apphed Sc1ence Laboratones a Westbury, Ne\\ York.
ln quegli s1essi anni, negli USA. lo statoreattore o ram-jet venne studiato anche presso lo Aeronautica! Laboratory della Comcll Universicy, diretto da Clifford Furnas, ad opera dj un altro italiano: l'ing. Giuseppe Foa. Antonio Fem, studioso di aerodinamica di eccezionale valore e di rinomanza mondiale. sc-0mparve premaruramente nel dicembre 1975.
La sua figura è praticamente sconosciuta in Italia presso il grande pubblico, mentre resta nota solo presso la ristretta cerchia degli speciaJis1i di tale seuore.
Occorre inoltre ricordare l'importante atrivì1à in campo missilistico e spaziale svolta da Luigi Broglio negli ultimi decenni. che esula dal periodo storico qui consideralo.
160
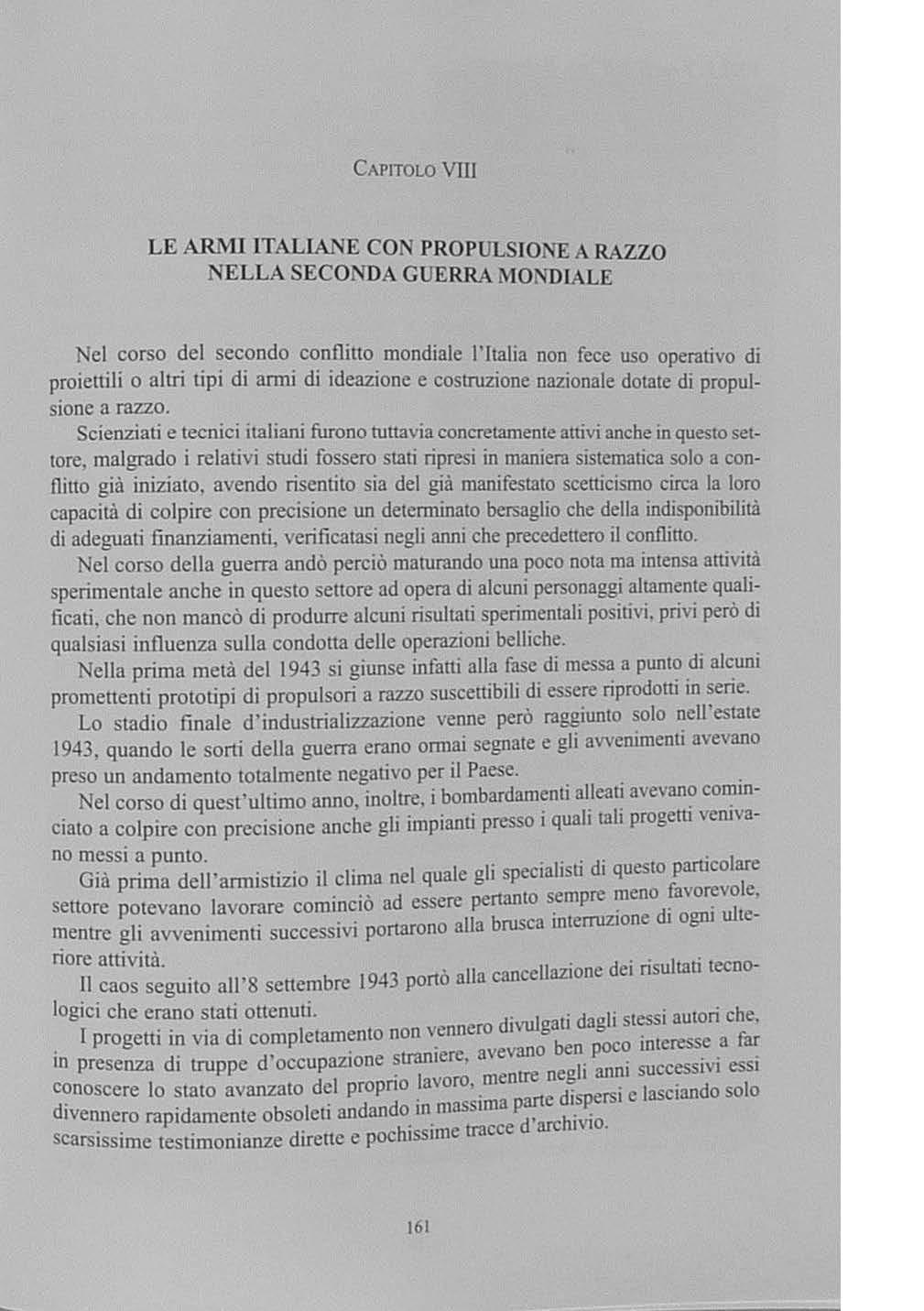
CAPITOLO V1I1
LE ARMI lTALl.ANE CO PROPULSIONE A RAZZO ELLA SECONDA GUERRA MO DlALE
~el_ ~orso ~e( ~ec~ndo_ c~n_fliuo_ mondiale l'haha non fece uso operativo d1 protetuh o altn up1 dt arrm di ideazione e costruzione nazionale dotate dì propulsione a razzo.
Scienziati e tecnici italiani furono tuttavia concretamenie attivi anche in questo settore, malgrado i relati'"i studi fossero stati ripresi in maniera sistematica solo a conflitto già iniziato, avendo risentito sia del gia manifestato scetticismo circa la loro capacità di colpire con precisione un detenntnato bersaglio che della rnctisponibilità di adeguati finanziamenti. verificatasi negli anni che precedettero il conflitto.
Nel corso della guerra andò perciò maturando una poco nota ma m1ensa attività sperimentale anche in questo settore ad opera dt alcuni personaggi altamente qualificati, che non mancò di produrre alcuni nsulta1i sperimentali posiuvi. privi però di qualsiasi influenza suUa condotta delle operaz.ioni belliche.
Nella prima metà del 1943 si giunse infàrti alla fase di messa a punto di alcuni promettenti prototipi di propulsori a razzo susceuibili di essere riprodotti m sene.
Lo stadio finale d'industrializzazione venne però raggiunto solo nell'estate 1943. quando le sorti della guerra erano ormru segnate e gli avverument1 nve\'anO preso un andamento totalmente negativo per il Paese.
Nel corso di quest'ultimo anno, inoltre. i bombardamenti alleati ave\•an~ cominciato a colpire con precisione anche gh impianti presso i quah 1ali progetu venivano messi a punto. . . . .
Già prima delrannistizio il clima nel quale gli spec1ahsu d1 questo parucolare settore potevano lavorare cominciò ad essere pertanto s_empre meno ~avorevole. mentre gli avvenimenti successivi portarono alla brusca interruzione di ogru ulteriore attività. . · I ·
9 3 • Il """CeUazione dei nsu tatt tecno- li caos seguito a11'8 settembre I 4 porto a a.....,. logici che erano stari ouenuti. . . d 1- tessi autori che. I progetti in via di completamento non vennero divulgali ag I s . far . . • avevano ben poco interesse a in presenza di truppe d'occupazione straniere. . . . . • 1 mentre negh anm success1v1 essi c?nosccre lo stato avanzato del propno .avoro. . arte di rsi e lasciando solo divennero rapidamente obsoleti andando tn massima P spe S • • h'ss1·me tracce d'archivio. cars1ss1me testimonianze dirette e poc 1 161
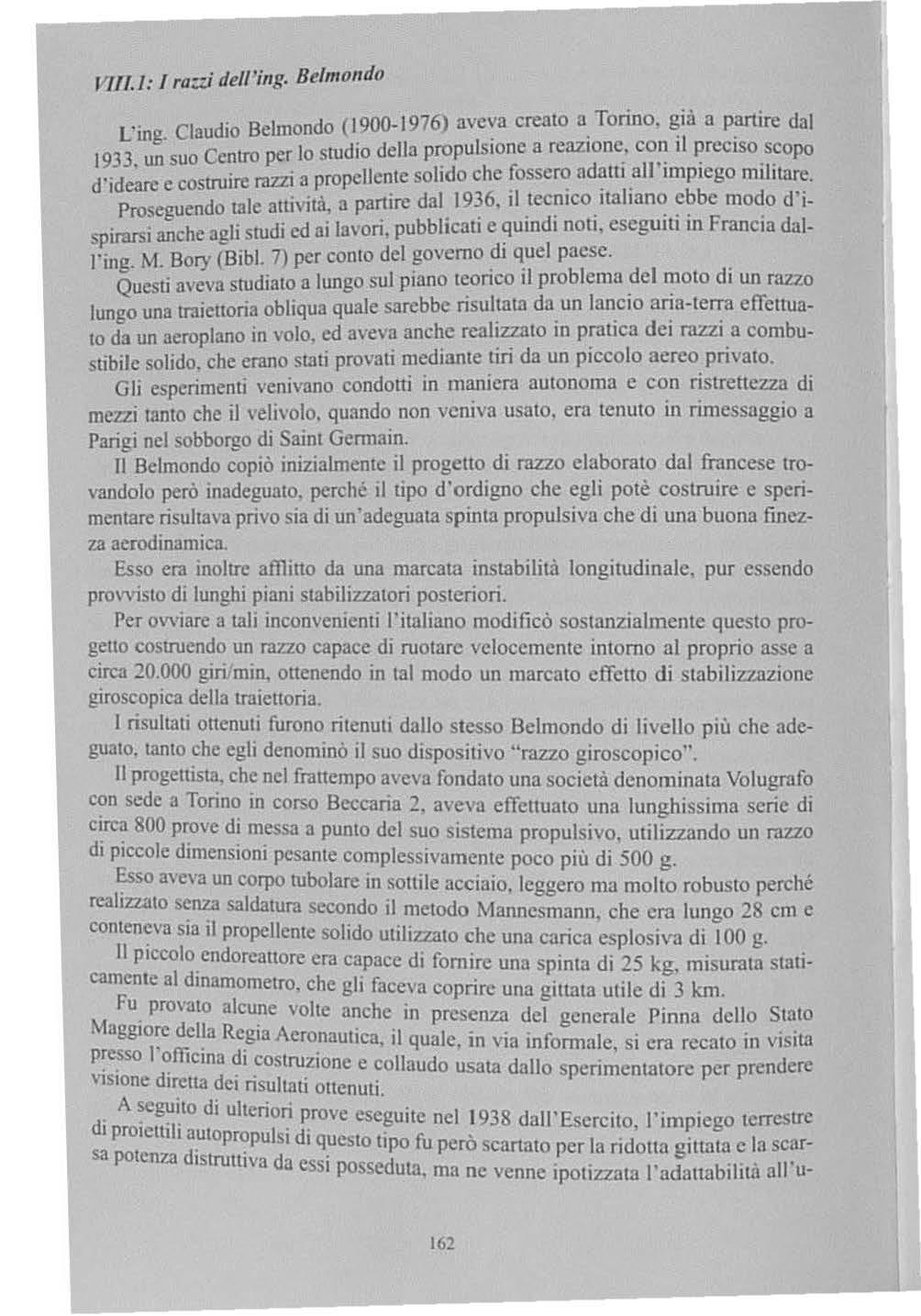
11 ff. l: I ra::.i dell 'ing. Be/m o n do
. Cl d' 8 !mondo ( t 900-1976) aveva creato a Torino. già a partire dal L tng au 10 e ·1 • 1933 un. suo Centro per lo srudio della propulsione a rcaztdonc. c 1 o 1 , ~reciso _s~opo d..d · ;,.,, razzi· a propellente solido che fossero a a1t1 a nnp1ego m1lttare. I eare e COSlnl u..
P . d tale atLi\ità. a partire dal 1936. il tecnico ttaltano ebbe modo d'iro~eguen o . .
F spirarsi anche agli studi ed ai Ja\On. pubbhcan e qumdt noli. esegu,u tn rancta dall'ing. M. Bory (Bibl. 7) per conto del governo ~i quel paese. .
Quesu aveva stucliato a lungo sul piano teonco il problema ~el ~010 dt un razzo lungo una traieuoria obliqua quale sarebbe nsul~ata da un lan_c10 a~a-terra elTeuua10 da un aeroplano in \'Olo. ed an!\ a anche realizzato m prauca dct razzi a combustibile solido. che erano stati provat1 mediante tiri da un piccolo aereo pnvato.
Gli esperimeoo Yenl\'ano condotti m maniera autonoma e con rìstrenezza dt mezzi tanto che il , ehvolo. quando non veniva usato. era tenuto m nmessagg10 a Pariei nel sobbomo di Saint Gennam.
JI Belmondo ;opiò mizialmen1e il progetto di razzo elaborato dal francese trovandolo però madegllllto. perché ti tipo d'ordigno che egli potè costruire e sperimentare risulta\ a pnvo sta di un·adeguata spinta propulsiva che d1 una buona finezza aerodinamica
Esso era inoltre affimo da una marcata instabilita longitudinale. pur essendo prov,..isto dt lunghi piani stabilizzatori poslerion.
Per ov\·1are a tah incoa,cn,enu l'italiano modificò sostanzialmente questo progetto costruendo un razzo capace di ruotare velocemente intorno al propno asse a circa 20.000 giri min. ottenendo in tal modo un marcato effcllo di stabiliu.az,one giroscopica della ttaieuoria.
I risultati onenu11 furono ritenuti dallo stesso Bclmondo di li\'ello più che adeguato. tanto che cgh denom100 il suo dispositivo ·•razzo giroscopico•·.
11 progenista. che nel frattempo a\ e, a fondato una società denominata Volugrafo con sede a Tonno in corso Beccaria 2. a\·e,a elTettuato una lunghissima serie d1 circ~ 800 prove di messa a punto del suo sistema propulsivo. utilizzando un razzo dt piccole d1mens1oni pesante compless1\'amente poco più di 500 g.
Esso a\ eva un corpo rubolare in sottile acc1a10. leggero ma molto robusto perché realizzato senza saldatura secondo il metodo Mannesmann. che era lungo 28 cm e contene\'a sia ti propellente solido uttliu.ato che una carica esplosiva di I00 g.
Il piccolo endoreattore era capace dt fornire una spmta di 25 kg. misurata slaticnmente al dmamometro, che gh faceva coprire una gittata utile di 3 km. Fu pro,-ato alcu~e volle anche m presenza del generale Pinna dello Stato ~aggio~ della Regia Aeronautica. il quale. in ,·ia informale si era recato in \ 1s11a presso I officina dt cosi · Il ' . _ . ruzione e co audo usata dallo spenmentatore per prendere VtSI0ne diretta dc, nsuhau onenut1 .
d. A se~tto dt ulterion pro\'e eseguite nel 1938 dall'E ercito. J'imptego terrestre 1pro1ctt1h autopropuls,· d , fu . · 1questo tipo pero scanato per la ridotta gittala e la scarsa potenz.a d1stru11iva da ess· . d . . . 1passe uta, ma ne venne ipotizzata l'adattabthla ali u-
• · ·
• •
. .
·
162
so aeronautico sia nel tiro contro mezzi meccanici al suolo che per quello ''a raffica interacrei" d1 lunga giuata, secondo la dizione allora adoperata dalla Regia Aeronautica o più semplicemente ariaaria. come si dice oggi usando una terminologia di derivazione americana.
Come abbiamo visto l'Anna Aerea aveva già eseguito prove sui razzi giudicandoli imprecisi e quindi poco adatti all'uso aeronautico, per l'elevato numero di ordigni che avrebbero dovuto essere lanciati per avere una buona probabilità di colpire il bersaglio.
L"ofTerta del Belmondo fu quindi lasciata cadere ed anzi l'ingegnere torinese. che aveva condono I suoi costosi esperimenti autofinanziandosi, ebbe 11 nulla osta a prendere comatti con una Un D<' Ha,·illand itosq11i10 .\fk l'I con 0110 ra=i grossa ditta francese che voleva realiz- da 3" in 111sralla=1011<' mbalan:
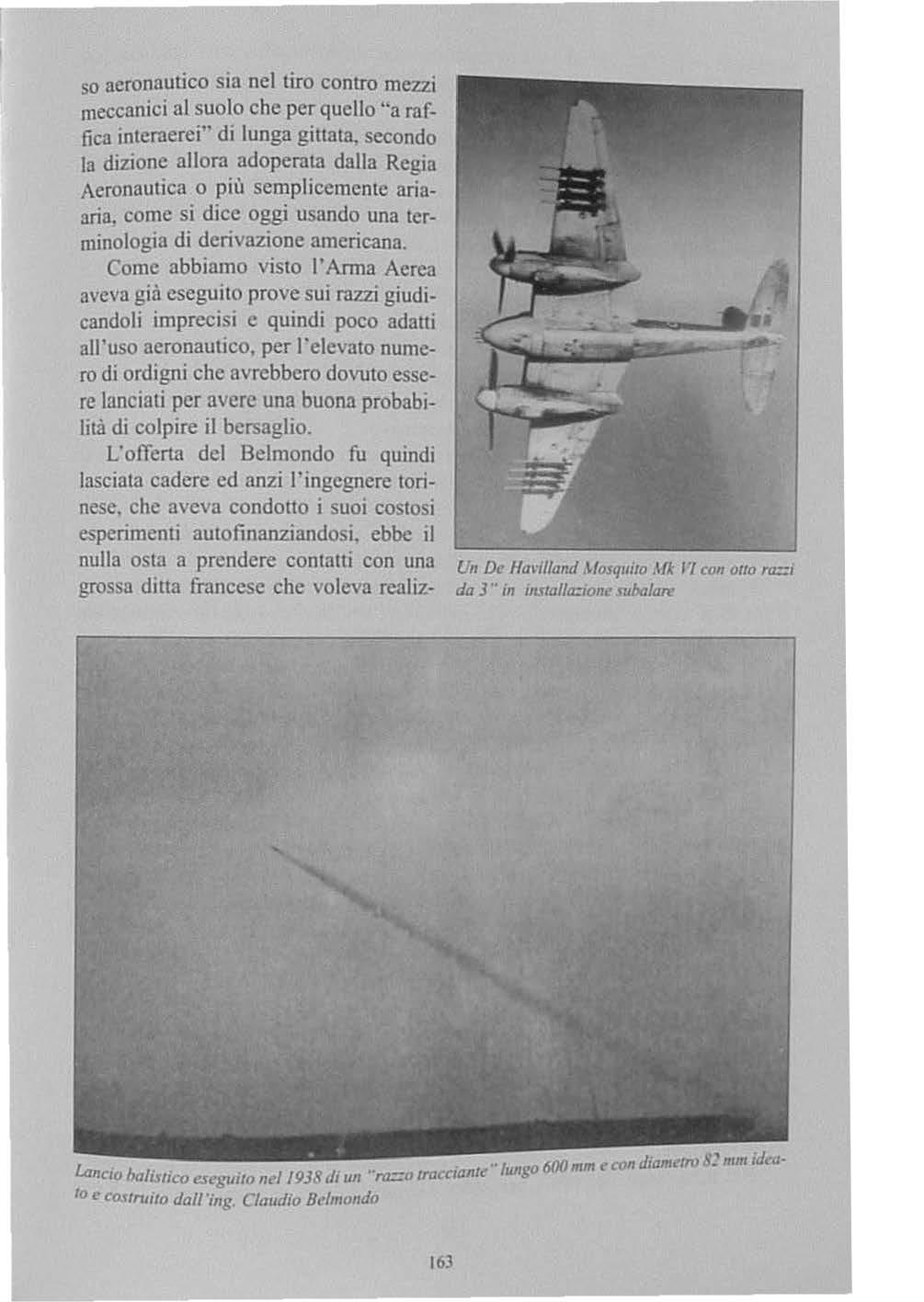
6()() "'"' ,. ron J1omttn> s: mm id,•<JLancio balimco ,'.Sc:g11110 11cf /938 di un ..ra:=o /r<Jcctant.! lungo 10 ,. co.,truuo da/1 ' ing. Claudio Bdmondo
163
••

- 1 aggiorata del razzo dell'italiano. capace di essere annazare un esemplare msca a m to con una testata esplosiva di I00 kg. . . . . . d I ·coppio della seconda guerra mondiale. gh 1tallam pote- Qualche tempo opo O s . . - · ·1· •. h• . · , a loro spese l'efficacia bellica dei pro1et11 1a razzo, c e venrono pero spenmentarc . . d I 194' d , b . · , la pnma volta in Russia nel luglio e -· ove, come a bmncro mcontrau pi;r . . - • · · ·1· d' · 1· . . (s IV,) \'eni\'ano largamente usau dat sov1et1c1 come pro1el11 1 art1g 1emol, 1st0 sd ·- ·.,,. mstallate su autocarri. dclii "Katiuscia". dei quali nel nO\'emna anc1au a ram,,- d I · · · · bre 19-12 fu anche catrurato almeno un esempla~c corredato . e1 re auv1 pr~1ett1ll. che n:nnc incorporato dall'ARMIR (Armata Italiana m Russia) ed usato p1u volte contro i soùetici anche nel corso della success1v~ b~uagha del Don. _ _
Anche 10 Mediterraneo e ~orci Africa gli Itaham dovettero subtre 1I lancio dei razzi fotto dai britannici che. verso la fine del 1942, inmarono ad impiegarne in combanimento con crescente successo un paio di tipi aria-superficie. particolarmente indicati per l'impiego an11carro ed antinave.
Tali proiettili-razzo veni\ ano trasportati. fissat1 a rotaie di lancio collocate in posizione subalare. dagli ..Humcane" e dai "Beaufighter" operanti in Nord Africa e nel \leditcrranco.
1J nostro grande transatlantico "Rex.. sarebbe stato affondato in Adriatico nel 1944 con il lancio di numerosi ordigni di questo stesso ùpo.
Il progetto di base d1 quesu particolari razzi era stato S\'iluppato in maniera autonoma dagh stessi britannici dopo che nel 19-11 i sovietici ave\'ano lasciato cadere l'offerta di fornirne dircuamente alcum toro esemplari aria-suolo già operati, 1, impiegati con grande successo contro le colonne corazzate germaniche.
La cessione di tale progetto sarebbe stata data come contropartita per la fornitura di uno squadron dJ caccia "Hurricane" (Bibl. 19) utilizzato dai russi per la protezione dei convogli d1 rifornimenti che venivano loro tn\ iati dagli alleati attraverso le rotte polari dell'Atlantico settentrionale. ma tale accordo non andò n buon fine.
La spiacevole presa di contatto degli italiani con questi nuovi ordigni dovette esercitare un notevole potere persuasivo sui responsabili della Regia Aeronautica circa la necessità d1 nconsiderare l'importanza bellica del razzo specie nel tiro anticarro, tanto che il Belmondo venne incaricato di fornire alcuni esemplari dei nuovi tipi di razzi che egli a,eva nel frattempo costruiti, per poter condurre le relative prove di lancio. Nel luglio 1942. sul poligono di Furbara, vennero quindi condoui alcuni tiri di pro\'a dall'aereo utilizzando razzi da 45 e 47 mm di diametro sistemati in collocazione subalare su un bimotore da bombardamento Fiat BR 20.
1risultati di queste prove vennero giudicati ancora una volta insufficienl1 per un efficace uro mirato aria-terra. ma migliorabili. tanto che il Belmondo do\'ctte ese~ire a~~une modifiche del suo progetto, intervenendo ancora una volta sul sistema di stah1hzzazione giroscopica del razzo stesso lungo la sua traiettoria. compiendo anche I necessan studi per la loro installazione su monomotori da caccia, che sarebb~ro st~u assai più adatti all'impiego anticarro a bassa quota di un pesante bombardiere bimotore.
Net pnmi mesi del 1943. per poter eseguire i lanci di prova reali. la Regia
164
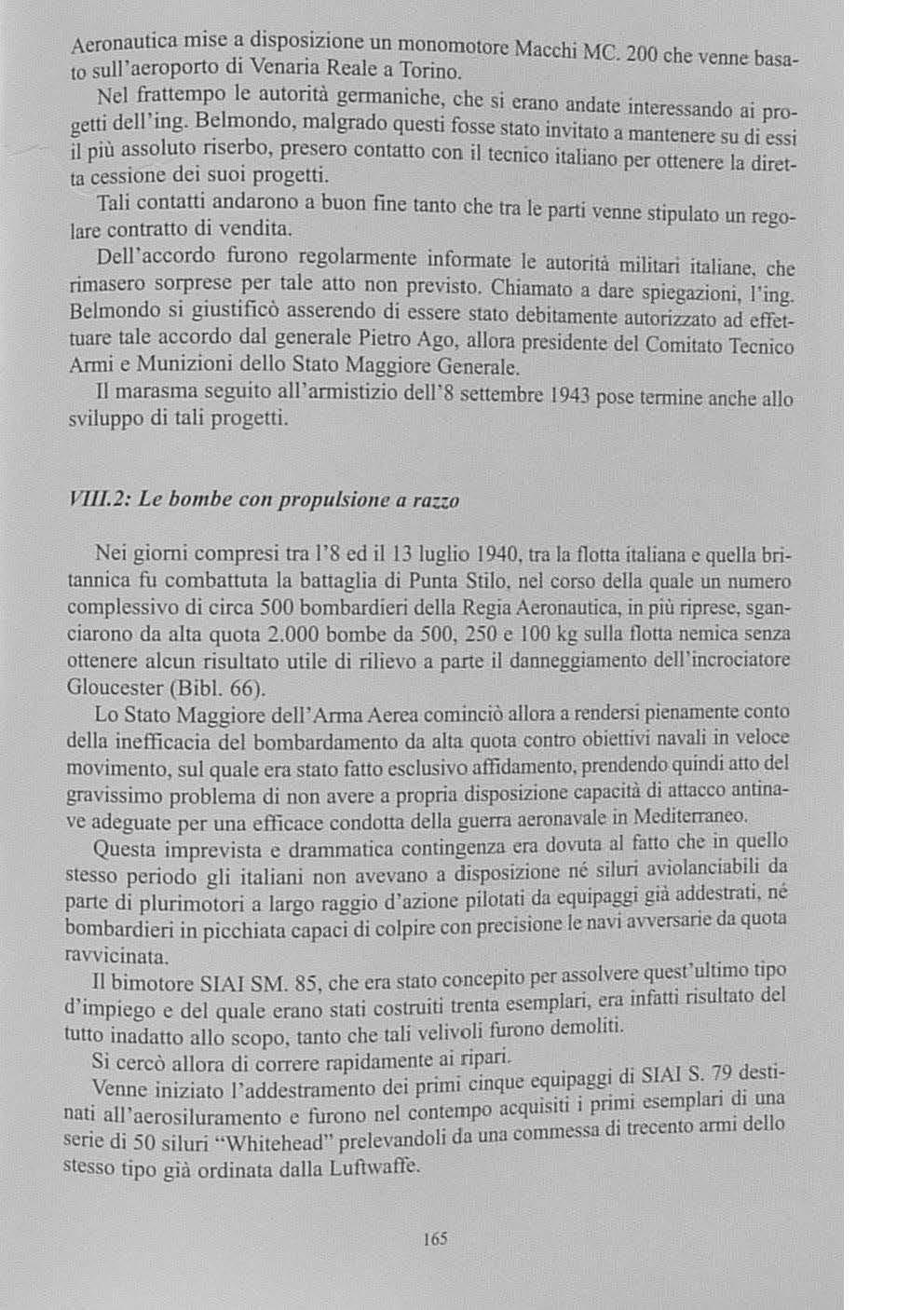
Aeronautica mise a disposizione un monomotore Macch· MC .,00 h 10 sull'aeroporto di Venaria Reale a Torino. 1 • - c e venne basaNel frattempo le autorità germaniche che si erano da • . . li'. B I d I ' an te interessando a1 pro- getti de mg e moo o, ma grado questi fosse stato invitai • •• I · b o a mantenere su d1 essi 11p1u asso uto nser o, presero contatto con il tecnico italiano t 1 • t.a cessione dei suoi progetti. per O tenere a d1ret-
Tali contatti andarono a buon line tanto che tra le parti v f 1 lare conirano di vendita. enne s ipu ato un rego-
Dell'accordo furono regolarmente informate le autorità militari · 1· h • I . ti.a 1ane, e e nmasero sorprese per ta e atto non prevtsto. Chiamato a dare spicon7· ,.. I d · . •fi • . c,-IOnl, mg. Be mon o s, g1Usu 1co asserendo dt essere stato debitamente autorizzato ad effettuare tale accordo dal generale Pietro Ago, allora presidente del Comitat -r, 0 M " . . d li O 1CCOJCO Amu e uruz1om e o Stato Maggiore Generale.
li marasma seguito all'annisti.zio delr8 settembre 1943 pose termine anche allo sviluppo di tali progetti.
Vlll.2: Le bombe cou propulsione a ra:...o
Nei giorni compresi tra 1'8 ed il 13 luglio 1940, tra la flotta italiana e quella britannica fu combattuta la battaglia di Punta Stilo. nel corso della quale un numero complessivo di circa 500 bombardieri della Regia Aeronautica, in più riprese, sganciarono da alta quota 2.000 bombe da 500. 250 e 100 kg sulla flona nemica senza ottenere alcun risultato utile di rilievo a parte il danneggiamento dell'incrociatore Glouccster (Bibl. 66).
Lo Stato Maggiore dell'Anna Aerea cominciò allora a rendersi pienamente conto della inefficacia del bombardamento da alla quota conrro obie111,1 navali in \'eloce movimento, sul quale er.i stato fatto esclusivo affidamento, prendendo quindi atto del graYissimo problema di non avere a propria disposizione capacità di attacco antinave adeguate per una efficace condona della guerra aerona\'ale m Mediterraneo. Questa imprevista e drammatica contingenza era dovuta al fono che in ~uello stesso periodo gli italiani non avevano a disposi:aone né sìlu~ a~1olancmb1~1 da parte di plurimotori a largo raggio d'azione pilotati da equipaggi già nd~estratt. ne bombardieri in picchiata capaci di colpire con precisione le nan avversane da quota ravvicinata
11 bimot~re SIAJ SM. 85, che era stato concepito per assolver~ qu~t'~timo upo d'impiego e del quale erano stati costruiti trenta esemplari. ~r:i mfntt, nsulmto del tutto inadatto allo scopo. tanto che Ulli velìvoli furono demohtr.
Si cercò allora di correre rapidamcntem ri~an. . . d. SIAJ S 79 dest"Venne iniziato l'addestrnmenio dei pnm1 cmque equipaggi 1 • • d' 1 · · · · · · esemplan I una nati all'aerosiluramento e furono nel contempo ncquisllt I pn~i . d li serie di 50 siluri "Whitehead" prelevandoli da una commessa di trecento arou e 0 stesso tipo già ordinata dalla Luftwaffe.
165
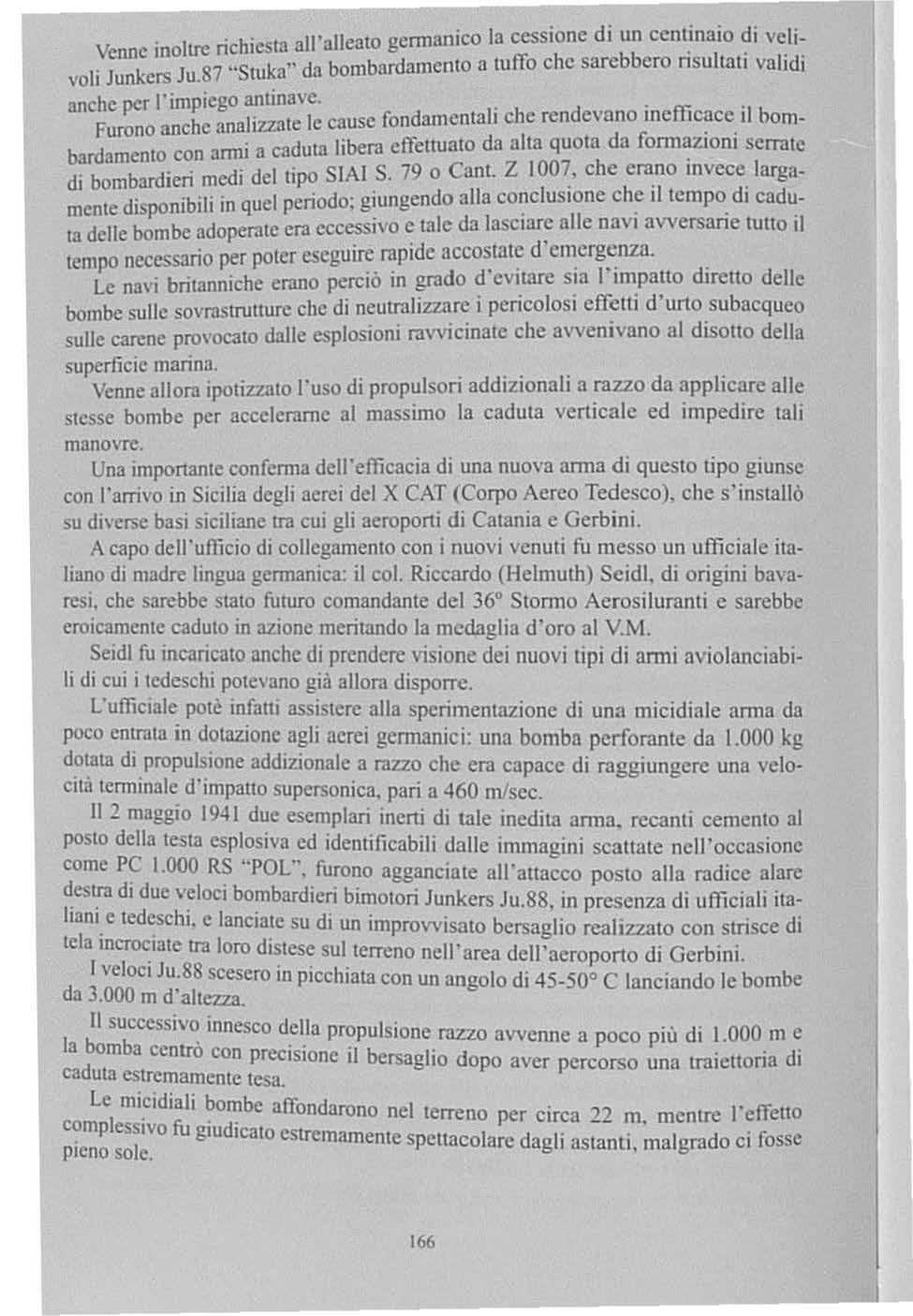
• 1 · h" ·t all'allealo gennanico la cessione di un centinaio di veli- Venne mo tre ne ics a . . . 1 g7 "SI ka" da bombardamento a tuffo che sarebbero nsullau validi voh Junkers u. u anche per l'impiego antina,·e. . . .
F h 8 11·,,..ate le cause fondamentali che rende,•ano mefficace il bomurono anc e an ,_,_ . . d mu 8 caduta libera cffetrua10 da alta quo1a da fonnaz1001 serra1e bar amento con a . d. b b d·en· medi del tipo SIAI S. 79 o Cant. Z 1007, che erano invece larga1 om ar 1 1 · h ·1 d" d. ponibili in quel periodo; giungendo alla eone us1one c e I tempo I cadumcnte 1s · li · · · ta delle bombe adoperate era eccessiYo e tale da lasciar~ a e on, 1avversane tutto 11 tempo necessario per poter eseguire rapide acco~Late d emcrg~nza. _
Le na, i britanniche erano perciò in grado d e\'ltare sia I impatto diretto delle bombe sulle sovrastrutture che di neutralizzare i pericolosi effetti d'urto subacqueo sulle carene pro, ocato dalle esplosioni ran 1cinate che avvenh ano al diso110 della superficie marina
Venne allora ipotizzato l'uso di propulsori addizionali a razzo da applicare alle stesse bombe per accelerarne al massimo la caduta verticale ed impedire tali manovre.
Una importante confenna dell'efficacia di una nuova arma di questo tipo giunse con ram,o in Sicilia degli aerei del X CAT (Corpo Aereo Tedesco). che s'installò su di\'cr..e basi siciliane tra cui gli aeroporti di Catania e Gerbini.
A capo dell'ufficio di collegamento con i nuovi venuli fu messo un ufficiale italiano di madre lingua germanica: il col. Riccardo (llelmuth) Seidl. di origini baYaresi. che sarebbe stato futuro comandante del 36° Stormo Aerosiluranti e sarebbe eroicamente caduto in a21one mentando la medaglia d'oro al V.M.
Seidl fu incaricato anche di prendere ,1stone dei nuovi tipi di armi a, iolanciabili di cui i tedeschi potevano già allora disporre.
L'ufficiale poté iofan1 assistere alla sperimentazione di una micidiale arma da poco entrata in dotazione agli aerei gcnnanici: una bomba perforante da 1.000 kg dotata d1 propulsione add12Jonale a razzo che era capace di raggiungere una velocua terminale d'impano supersonica. pari a 460 mtscc.
li 2 maggio 1941 due esemplari ineni di tale inedita arma. recanti cemento al posto della testa esplosiva cd identificabili dalle immagini scattate nell'occasione come PC 1.000 RS ..POL". furono agganciate all'anacco posto alla radice alare ~es~ d1 due veloci bombardien bimotori Junkers Ju.88. m presenza di ufficiali i1aham e tedeschi. e lanciate su di un improvvisato bersaglio realizzato con stnsce di tela incrociate tra loro distese sul terreno nell'area dell'aeroporto di Gerbini. 1veloci Ju.88 scesero in picchiata con un angolo d1 45-50° C lanciando le bombe da 3.000 m d'altezza.
11 successivo innesco della propulsione razzo avvenne a poco più di 1.000 m e la bomba centrò con pre · · ·1 b • . · cisione I ersagho dopo aver percorso una traiettona d1 caduta estremamente tesa.
Le micidiali bombe aflio d 1 • • . n nrono ne terreno per circa 22 m mentre I effetto complessivo fu giudicato estremamente spellacolare dagli astanti ~algrado ci fosse pieno sole •
166
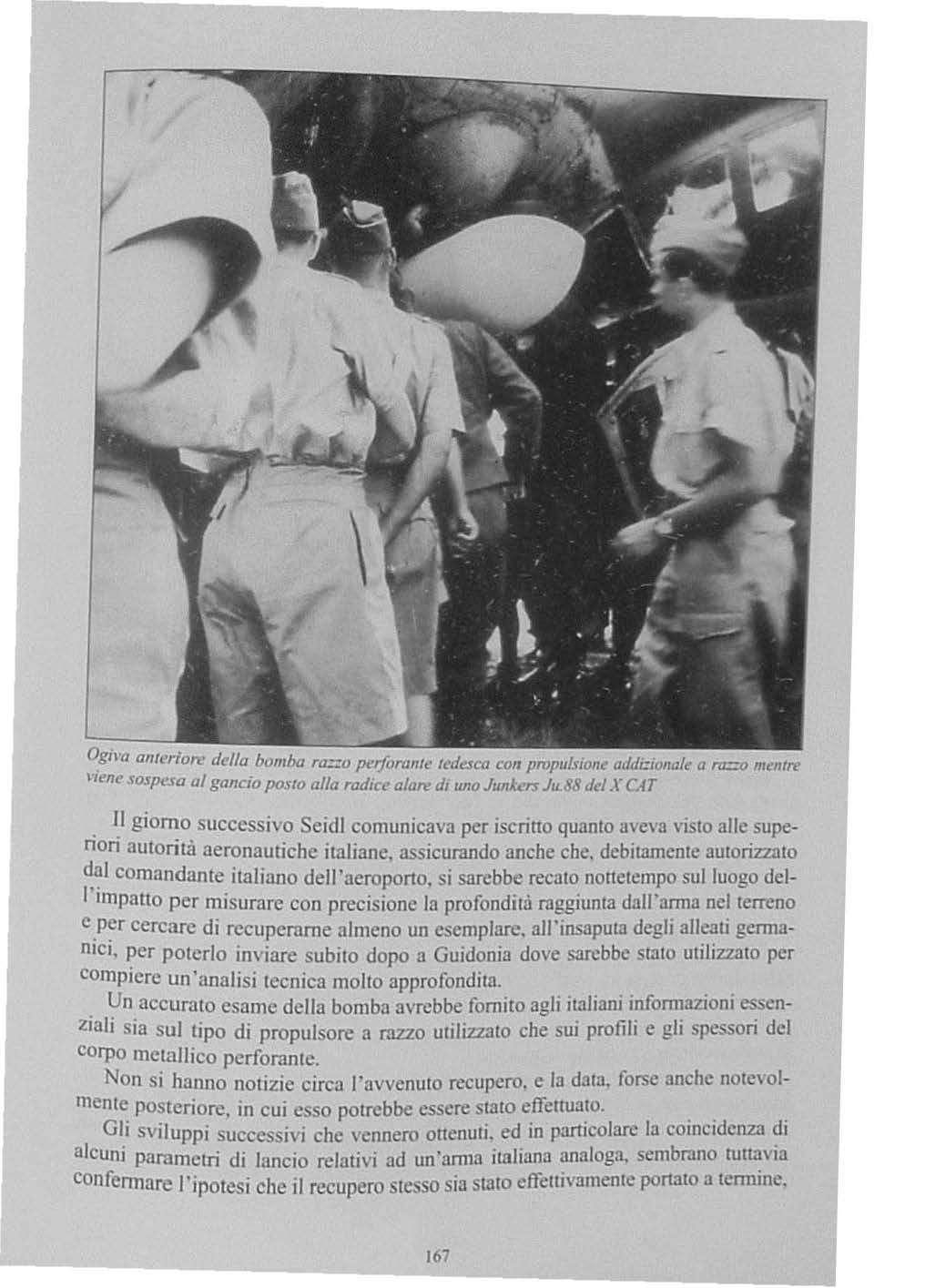
Ogfra a11ti.'riore d<!lla bomba ra.:::o perforalllt' ft•desca co11 propulsion,• 0Jdc1ona!t• a ra=o mmrre \'/l!flt' sospt'sa al gancio posto alla rodie,· alare di imo Junker$ Ju 88 dd X CAT
~I giorno success1\·o Seidl comunicava per iscritto quanto a\'e\'a visto alle supenon autorita aeronautiche italiane, assicurando anche che. debitamente autorizzato comandante italiano dell'aeroporto. si sarebbe recato nottetempo sul luogo delI impatto per misurare con precisione la profondità raggmnta dall'arma nel temmo c.p~r cercare di recuperarne almeno un esemplare. all'insaputa degli alleau germanici, per poterlo in, iare subi10 dopo a Guidonia do\'e sarebbe stato utilizzato per compiere un'analisi tecnica molto approfondita.
Un accurato esame della bomba a\'rebbe fornito aeli italiani informazioni essenziali sia sul tipo di propulsore a razzo uuhzzato eh; sui profili e gli spesson del corpo metallico perforanre.
Non si hanno nouzic circa l'avvenuto recupero. e la data. forse anche no1e\'olmente postenore, in cui esso potrebbe essere s1a10 effc1rua10.
Gh sviluppi successi\'! che nmnero onenull. ed in particolare la coincidenza di alcuni parametri di lancio relativi ad un 'amw italiana analoga. sembrano 1Utta,·1a confennare l'ipotesi che il recupero stesso sia stato effe111vnmen1e portato a tt:nnine.
167
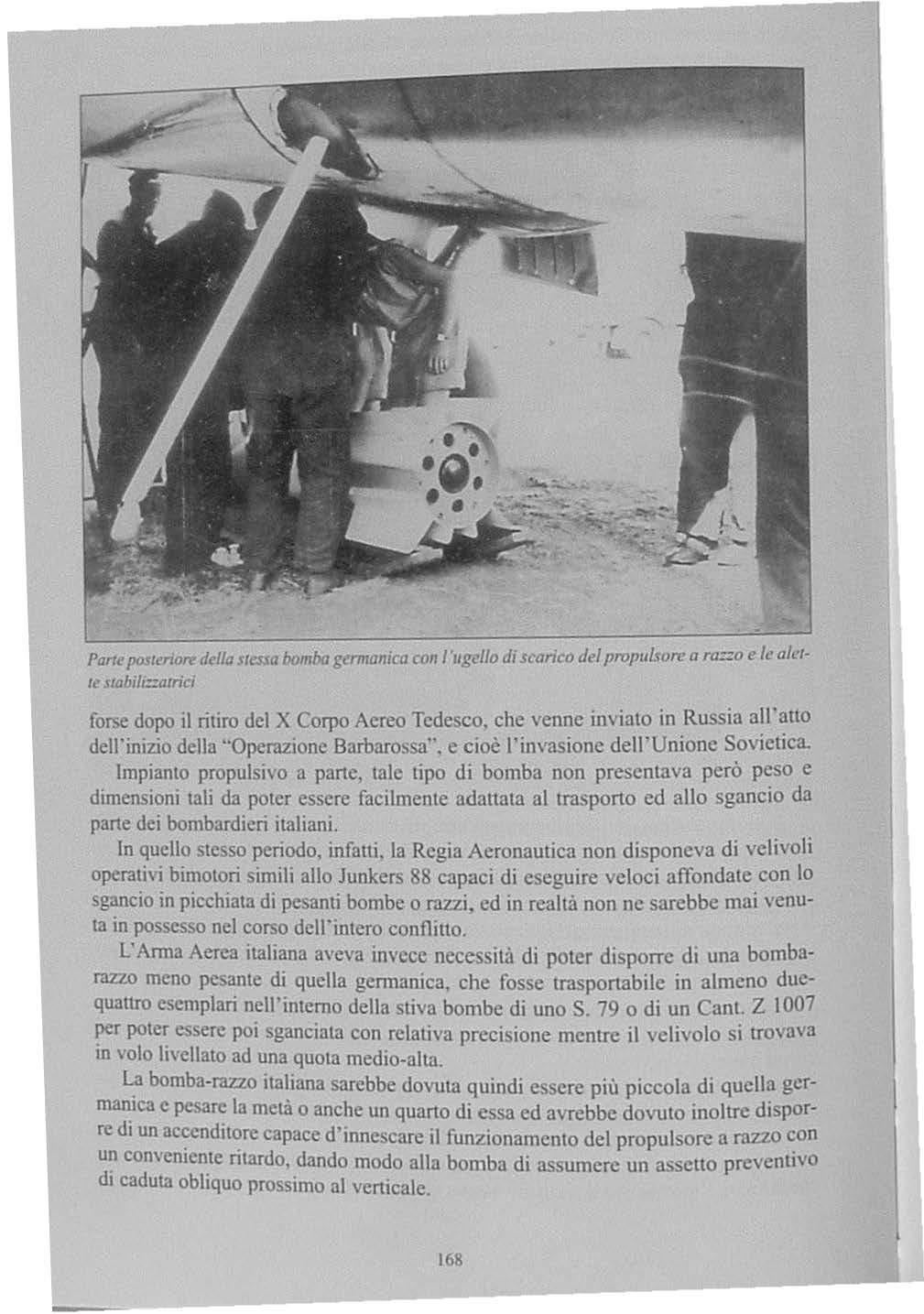
Parte po5teriof'l' dldla slessa bomba gtrmanica co11 / '11gdlo di scarico del propu/Jorc a ra=o eh• a/e1I<' Jtobili:=atrici
forse dopo il ritiro del X Corpo Aereo Tedesco. che venne inviato in Russia all'ano dell'inizio della ..Operazione Barbarossa". e cioè l'invasione dell'Unione Sovietica.
Impianto propulsi\'o a pane. tale tipo di bomba non presentava però peso e dimensioni tali da poter essere facilmente adallata al trasporto ed allo sgancio da pane dei bombardieri 11ahan1.
In quello ste:;so penodo, infani. la Regia Aeronautica non disponeva di velivoli operati\'i bimotori simili allo Junkers 88 capaci di eseguire veloci affondate con lo sgancio in picchiata di pesanti bombe o razzi. cd in realta non ne sarebbe mai \enuta in possesso nel corso dell'intero conflitto
L'Arma Aerea italiana aYeva mvcce necessità di poter disporre di una bombarauo meno pesante di quella germanica. che fosse trasportabile in almeno ducquauro esemplari nell'interno della stiva bombe di uno S. 79 o di un Cani Z I007 per poter essere poi sganciata con relativa precisione mentre il velivolo s1 trovava in volo livellato ad una quota medio-alta.
L_a bomba-razzo italiana sarebbe dovuta quindi essere più piccola dì quella germanica e pesare la metà o anche un quarto di essa ed avrebbe dovuto inoltre disporre di un accenditore capace d'innescare il fun;;,1onamento del propulsore a razzo con u~ conveniente ritardo, dando modo alla bomba di assumere un asscuo preventivo d1 caduta obliquo prossimo al venicale
168
PC IOOORSQ
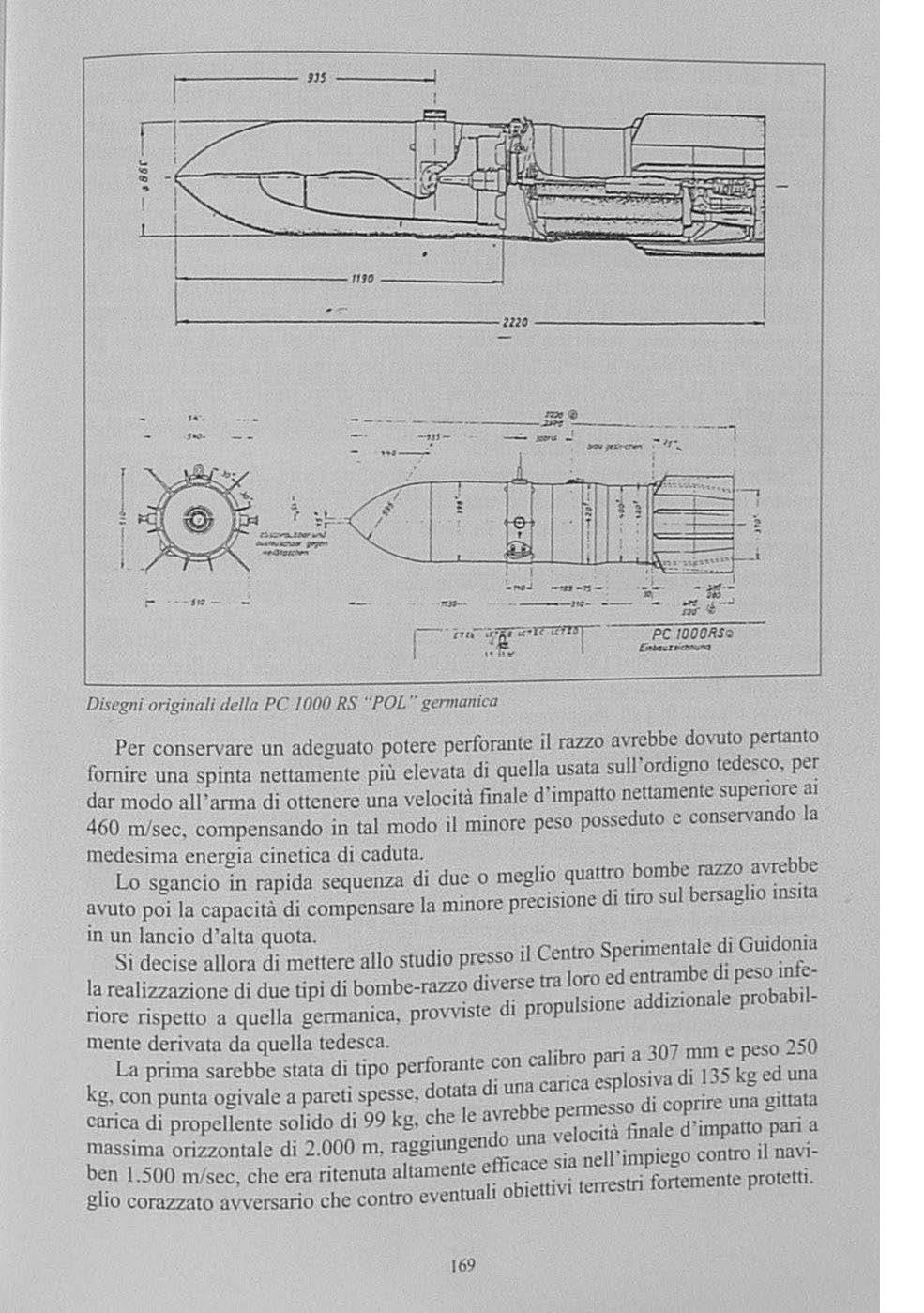
Disegni originali della PC 1000 RS "POL •· gem1anìca
P_er conservare un adeguato potere perforame il razzo avrebbe dovuto pertanto forrure una spinta nettamente più elevata di quella usata sull'ordigno tedesco, per dar modo all 'anna di ottenere una velocità finale d'impatto nettamente superiore ai 460 m/sec, compensando in tal modo il minore peso posseduto e conservando la medesima energia cinetica di cadura.
Lo sgancio in rapida sequenza di due o meglio quattro bombe razzo avrebbe ~vuto poi la capacità di compensare la minore precisione di tiro sul bersaglio insita m un lancio d'alta quota.
Si decise allora di mettere allo studio presso il Centro Sperimentale di Guidonia I~ realizzazione di due tipi di bombe-razzo diverse tra loro ed entrambe di peso intènore rispetto a quella germanica, provviste di propulsione addizionale probabilmente derivara da quella tedesca.
La prima sarebbe stata di tipo perforante con calibro pari a 307 mm e peso 150 kg,_con punta ogivale a pareti spesse, dotata di una carica esplosi~·a di 135 kg e~ una canea di propellente solido di 99 kg, che le avrebbe permesso d1 copnre una gmata massima orizzontale dì 2.000 m, raggiungendo una velocità finale d'impatt~ pan a ben 1.500 m/sec, che era ritenuta altamente efficace sia nell'impiego contro 11 08\'I· glio corazzato avversario che contro eventuali obietLin 1errestn fortemente protetti.
115 .. : . {--,..--:===-=.,,.,_--llfO----~ 1---------------iuo ---------~ .. ,...
r~..,-~
169
d b ba razzo sarebbe dO\'Uta e~ere invece di tipo dirompente. con Lal_:b,·econda torna .,3-0 mm ma sempre di peso pari a 250 kg. comprendente una un ca I ro n 01 o. · . . - I · ... di circa J 90 kg ed una di propellente solido pan a 42.5 kg, che canea esp 0s1\., . . 00 · sarebbe siata capace di coprire una g111a1a onzzontalc pan a I.O m raggiungendo una , elocità nettamente meno ele, ata della precedente, pan a 460 misec come ncl1•ordigno germanico __
La realizzazione di qu~1e anm fu coperta dal p1u assoluto nserbo tanto che non i hanno ulteriori ragguagli rdativi alla loro stona. _ _
I fugaci riferimenti fatti al riguardo da tecnici del settore allora ani, 1(§ 7.3). che raffrontarono le caratterisLiche di tali anni con altre analoghe estere giunte allo stato pienamente operati\'o, sembrano tuttana accreditare l'ipo1csi secondo la quale gli esperimenii preliminari rela1t\'i alla messa a punto dei propulson a razzo siano sta11 effe11uat1 con successo d1\'erso tempo prima dell'annisnz10, mentre alcuni protot1p1 compleu e funzionanti degh stessi ordigni erano in corso d1 rcalizzaz1one a Guido01a alla do1a dell°S settembre I943
Sempre secondo quan10 , iene riportato in letteratura {Bibl. 29). sembra che un limnato impiego operaLivo di bombe-ra;r_zo da 500 kg di produzione tedesca. forn ile come contropartita della cessione da parte naliana della motobomba FFF. sia staio fatto anche dalla Regm .\cronautica. nei giorni 14 e 15 giugno 1943 seguenti la caduta d1 Pamelleria. contro il naviglio inglese usato per appoggiare lo sbarco sutrisola
In reali.i in quegli stessi giorni pesanti anacch1 aerei contro le na, i da guerra bntannichc furono e!Tettua11 solo da velh·oli F.W.190 della seconda Luftflone germanica (Bibl 2). scortati da caccia Messerschmin Me I09. mentre non s1 ha notizia d1 attacchi italiani di pari importanza ed efficacia che pure potrebbero essere stati compiuti in fonna ridotta o isolata
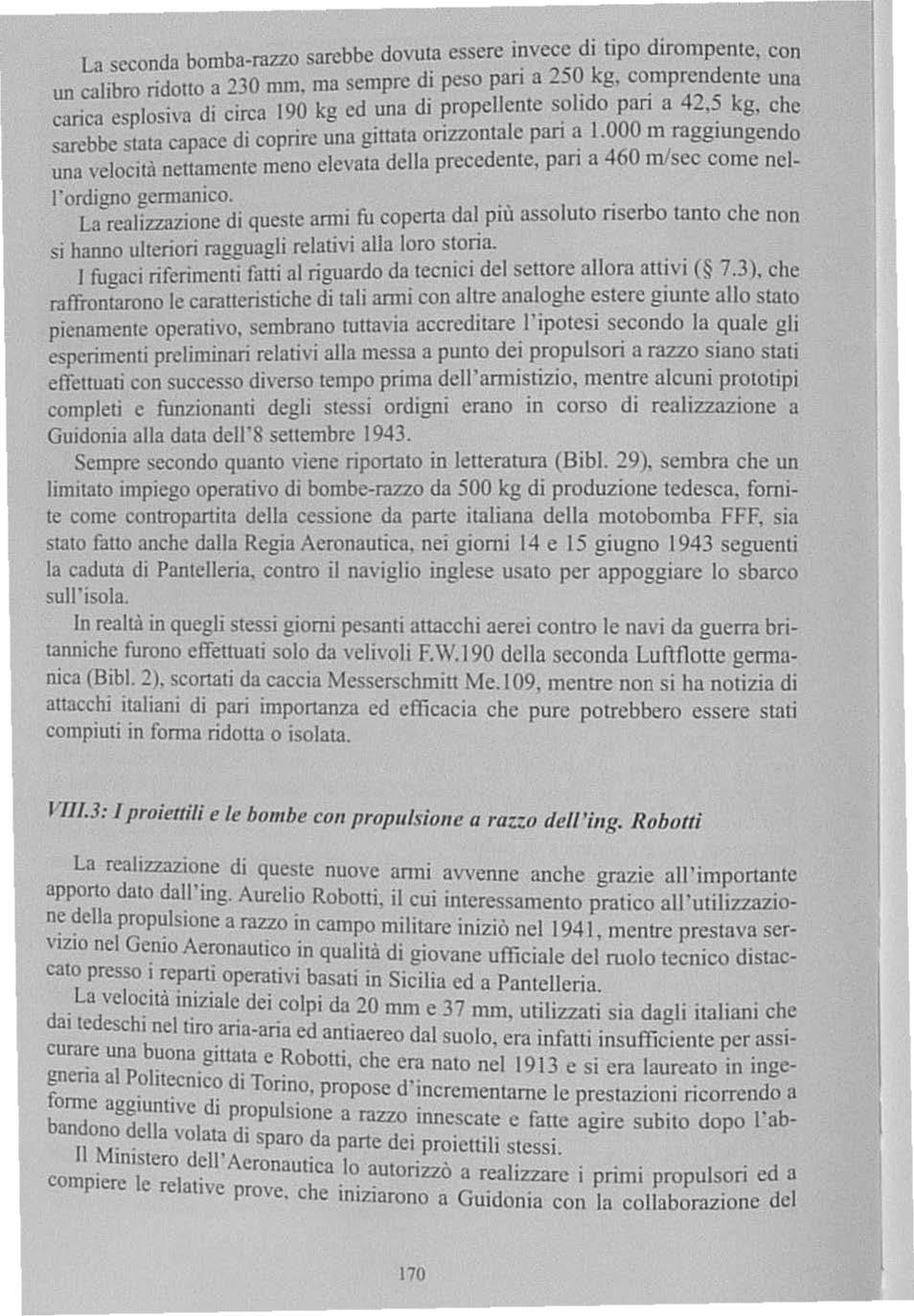
V fl/.3: I proiettili e le bo m be con p rop11Mo 11 e a r az:.o d ell ' ing. R ob o tti
La realizzazione d1 ques1c nuove anni avvenne anche grazie all'importanie apporto dato dall'ing. Aurelio Roboni, il cui mteressamen10 prauco all'u1ih1.zaz10n~ della propulsione a razzo m campo miluare iniziò nel 1941 mentre prestava scrvtzio nel Genio Aeronautico m qualità di gio\ ane ufficiale dcÌ ruolo tecnico disLaccato presso i ~part_i operatn i basau in S1c11ia cd a Pantcllena.
La veloc1ta m1z1ale dei colp' d '>O 37 . . . . . da. d . 1 a - mm e mm. ut1hzzau sia daglt ttaltam che 1h! esch1 nel uro aria-aria ed d 1 • . anuaereo a suolo. era mfatt1 msuffic1ente per ass1cura~e unia buona_gmata e Robott1, che era nato nel 19 I 3 e s1 era laureato m ingegncna a Polnecnico d1 Tonn d' fi . . . o. propose mcrememarne le presta,don1ricorrendo a onne agg1unt1ve d1 propulsione bando d 11 . 1 a razzo mnescate e fatte agire subilo dopo l'ab11 e a ' 0 3la di sparo da parte dei proictti11 stessi comp1erem1lseterol dell'Aeronautica lo autorizzò a realizzar~ I pnm1 propulsori ed a re at1ve prove h · ·. · . · e e mlZlarono a Gu1donta con la collaborazione del
170
tenente dott. R. Consolini utilizzando come propellente solido dapprima polvere nera compressa e successivamente spaghi di cordite.
A seguito delle esigenze belliche che andavano facendosi sempre più pressanti, tali ricerche furono intensi ficate sono la diretta super,.,isionc del generale F. Raffaelli, tanto che nel 1942. presso la già citata BPD di Colleferro. vennero effettuati i primi collaudi di proiettrn esplosivi da 20 e 37 mm, i cui fondelli erano stan moilificali mediante raggiunta di un corpo propulsore contenente un grano di propellente. Esso era capace di bruciare per circa I sec, assicurando allo stesso proiettile un incremento di velocità di circa il 20¾.
Le ultime prove di sparo vennero effettuate al poligono di Nettuno proprio la manina dell'8 settembre 1943.
Nel precedente mese di aprile dello stesso anno, nel corso di una , isna al Poligono Sperimentale di Furbara della Regia Aeronautica da pane di rappresentanti dello stato maggiore della Luftwaffe, i disegni di tali proietuli erano stati fomiti anche ai tedeschi, che dettero in cambio altri progeni di anru e ntrovati segreti.
Sempre nel 1943, Roboni terminò la progettazione di una non meglio precisata bomba perforante d'aereo con propulsione a razzo, che dovrebbe essere con ogni probabilità la stessa che abbiamo esaminato in precedenza. giungendo, come abbiamo detto, alla sola fase realizzativa dei primi prototipi che. come afferma lo stesso autore (Bibl. 69), non fu conclusa.
Il suo progetto più importante, riguardante i razzi balistici di più lunga gil!ata, fu però quello relativo aUa "aviobomba Robotti''. un ordigno assimilabile ad un moderno missile da crociera provvisto di ali e con propulsione a razzo che avrebbe dovuto essere lanciato da sommergibili in emersione sugli obiettivi ohremare, che erano onnai diventati irraggiungibili da parte dei bombardieri italiani per la onnai totale supremazia aerea della caccia alJcata nei cieli del Mediterraneo.
Pro1e11i/e da cannone an1iaerca con propulsione addi:ionale a ra=o dd/'i11g. ./~/io Rabolli
"'KE~_3EZ2ill
Bombo d ·aen.'O con prop11/sio11e addi::ionale a ra=o
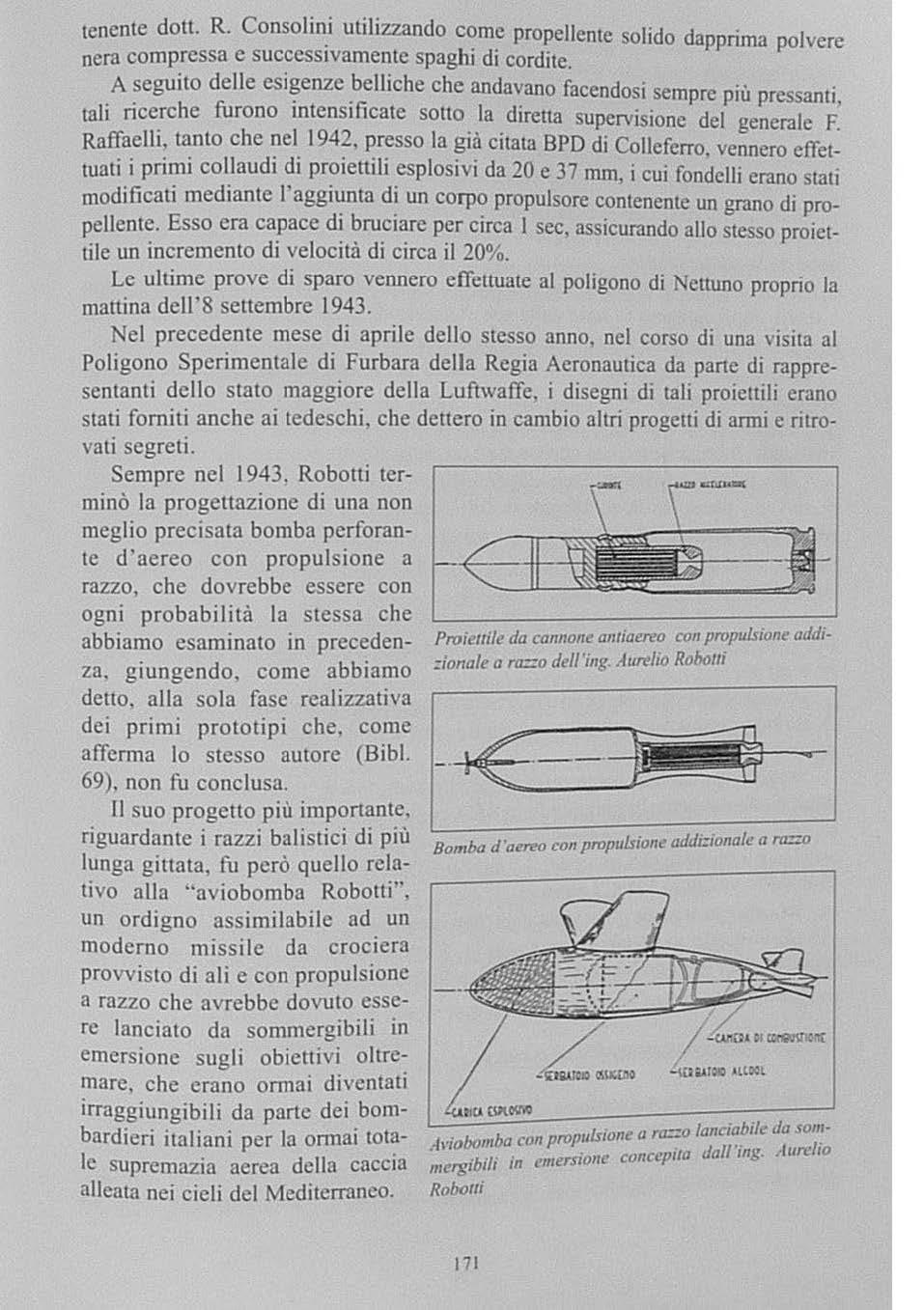
L(SPtOIMI
./ /.:'.(.u!OH, «,onn:ni: /_ - N•~•~• - 10;.,1:o •lt~l -1.laA.f:D ~-..,.
/sian. 0 ra=o lanciabile da som•h-iobomba con P'°P!' e , 10 Jo/1 'ing , l11rcfio ·b1·1,· in ,:merszoll<" co11np1 merg1 Rabolli
-
171

·d d I iutto originale ed in assoluto anticipo sui tempi, venne immeQuesta t ea, e · 1· · d Il R · • ta dal Souocapo di Stato Maggiore ag 1 annamenu e a egia d10tamente approva . . . . . . · raie Ilari che ordmo la sua uruned1ata reahzzaz1one. Aeronaunca gene . . . . .
Q d. provvis·to di ali dritte a sbalzo con diedro posmvo e con I solt ues10 or ,gno. . · ·caudaJ·, pri,·o quindi di timone verticale, doveva essere propulso da un 1mpenoagg1 , . d. 1 razzo usante come propelJeoti una solUZ1one acquosa al 75 I a cool ed motore a . • d. · 50 km f. · • gassoso che gli avrebbe assicurato una gmata teonca J circa , su - oss1gc.:no . . . . ficiente a poier dare al sommergibile lanciatore il tempo d1 1mmergers1 cd aUontanarsi dalla zona di lancio.
Questo missile da crociera avrebbe dovuto essere_realizzato _in fo_nna di_ p_rototipo e subito dopo costtutto in serie dalla soc. Ansaldo d1 Genova. 11 _cm amm1_n1slrato~e delegato ing. A. Rocca fu appositamente convocato a Roma per I necessan accordi.
Anche questo progetto, di cui era in corso la stesura dei disegni esecutivi, fu interrotto dall'annisriZJo.
Dopo tale data Roboni fu contattato dai tedeschi per proseguire i suoi lavori in Gennania. Il brillan1e 1ecnico oppose però un netto rifiu10 dandosi alla clandestinità.
Già a partire dall'arri,·o degli alleati a Roma egli poté riprendere la sua attività di servizio presso lo Stato Maggiore dell'Aeronautica che prosegui per qualche anno con la siesura del progetto di un cannone senza rinculo e la sua collaborazione alla redazione della parte tecnica del ''Bollettino Informazioni" edito dall'Arma Aerea sotto la direzione del geo. F. Santini.
Lasciò il servizio anivo nel I949 fondando una piccola socie1à, la "Te.Co." che sì sarebbe dovuta occupare dello studio e delle applicazioni della propulsione a razzo.
Di,·enneanche docenie presso la scuola d'ingegneria aeronautica del Politecnico di Torino proseguendo nello stesso tempo la sua attività pubblicistica specializzata nel campo dei razzi e missili.
P_rogenò quindi una lunga serie di razzi siglati con le proprie iniziali AR tra i quah part1colarm_eme impanante fu lo AR3. primo razzo completo ed effettivamenle fuI1ZJonante uuhzzante propellenti liquidi che sia stato mai costruito in Italia che v~nne sperimentato con successo il 9 maggio 1952 in un poligono di tiro situ;to a Pian della Mussa in Val di Lanzo.
T~le attivi~ s11;ebbe proseguita negli anni successivi fino alla realizzazione dello ARI:>. co~~no m collaborazione con la Whitehead-Motofides che venne sperimentato pru volte con buon successo sul poligono di Salto di Quirra.
VIIJ..J : I siluri con propulsion e a razzo
Conlrariamente a quanto s· ·t· 1. • . . . . 'li . 1 n iene, esigenza d1 poter disporre dt un s iluro spec1 1camente concept1o p I'· • . d. er impiego aeronautico, da usare in Mediterraneo nel corso t un eventuale co frt . . .. Stata ifì n I to contro la Gran Bretagna ed I suoi alleata era g1a man es1ata dal 1936 d J I S , . . ' . a co • erra, capo dell Ufficio aeros1luranl1 del
172

Ministero delJ 'Aeronautica, che aveva tempestivamente d . . 1 . . . provve uto ad aVVJare lo studio e a spenmentaz1one dt questo nuovo tipo di arm· h • · d d · • . J c e vcmvano allora costruite a ue lDlportantl dine specializzate: la Whitehead d" f' d Silurificio Italiano di Baia. 1 mmc e il I protolipi di bomba-siluro che vennero conseguentemente real' · d • ti "silurotti" per distinguerli dai più voluminosi e pesami siluri na=-u, eno1m•~:: O d. d' I, erano UDb'u
3.50 mm con un 1ametro 1515 mm ed erano dotati di una testa espi · d' T4 di soli I00 kg. osiva 1
Erano mossi da apparati propulsivi ad aria compressa o anidride carbonica ali stato liquido, e vennero sperimemati con lanci reali effettuati a Fiume con velivo~ SW S. 81 nel corso del 1937.
Tali prototipi vennero giudicati inadeguati ed inaccettabili, tanto che si nnunciò alla loro costruzione in serie.
Iniziato il conflitto, i primi reparti aerosiluranti affrettatameme predisposu dovettero perciò fare un necessario affidamento su alcuni tipi di siluri aerei non appositamente concepiti per gli aviolanci, bensì derivati da tipi leggeri già da tempo in uso nella Regia Marina, che li aveva originariamente destinati all'impiego da parte delle motosiluranti e dei ~V\S.
Essi avevano infatti un diametro inferiore a quello standard di 533 mm dei siluri pesanti in uso sui sommergibili e sui caccia10rpedioiere ed avevano ottime qualità d'impiego. tanto che. come abbiamo già visto, erano stati acquistati anche dall'allea10 gennanico in 300 esemplari. con la precisa clausola che in caso di necessuà questa stessa partita di armi avrebbe poruto essere direttamente acquisita dalla Regia Aeronautica, cosa che in effetti avvenne con rapidità dopo l'inizio del conflmo. In precedenza la Regia Aeronautica non aveva stanziato fondi per l'acquisto di tali costose armi. impiegabili esclusivamente per la lotta sul mare. ritenendo che )e relative somme avrebbero dovuto essere messe a carico del bilancio della Regia ~larina, (Bibl. 66), cosa che non fu mai accettata. . I siluri in questione erano designati con le sigle numeriche 450 170/~,46 per 11 tipo costruito dalla Whitehead di Fiwne e 450/170/5.25 per quell~ rea!•~to _d~I Silurificio Italiano di Baia. indicanti nell'ordine il diametro esterno IO mtlhmetn, • 1 peso della carica esplosiva trasportata e la lunghezza totale in _ me~. . .
Vennero felicemente adattati all'impiego aeronautico. grazie ali _uso di un pnmo leggero stabilizzatore aerodinamico costruito in legno e del co5lo di ben 1?-000 hre d'allora ad esemplare. Questo stabilizzatore veniva fissato alla coda dell anna per . . 1 ·oant. con un corretto angolo ottenere una traiettoria aerea di lancio rego are e tenni 1:: d'impatto con la superficie liquida. . r· esso dell'arQuesto efficace dispositivo vemva abbandonato subilo dopo mgr ma in acqua · b"d. . O d 860 k ma erano dotali enaam i i I due siluri pesavano rispettivamente 90 _ e . g affondare con un solo una testa esplosiva di 170 kg, io genere 11:s~ffic1ente i~er ode di quella un caccolpo a segno navi da guerra di stazza sensibilmente P gra I d" 'tà . 1 tivamente poco e evato I um c1atorpediniere (Bibl. I), il che spiega il numero re a
173
. . . . • h d alleate colate definitivamente a picco con il siluro da parte rn1htan bntanmc e e . . . d . I.• 1 - · r.onte dell'ele,ato numero d1 colpi messi a segno con gran e pcn- deg 1 11a 1aru. a 1r . . h fu · . • · ·1 · dell"alto numero d1 navi da guerra c e rono invece solo zia dai nostn pt 011 e pesantemente danneggiate. . . . .
Tali anni non potevano sopportare urti molto ,~1olent1 con la superfici~ manna. d , rt 10 sganciabili solo da quote relativamente modeste. teoricamente e t:rano pe an 30 -o d 1 · · non superiori ai 120 m. ma nella realttì pari i~ gene_re a -) m, e a ve oc11a_ ~assirne di \'Olo non superiori ai 300 km/h., alon che nsultavano appena accettabt11_ per gli S.79 che. pur potendo teoricamente volare a b:15sa q~ota a 380 km/h, raggiungevano a stento la velocità massima imposta per 11 lancio quando trasportavano a bordo un pesante siluro.
Queste caranerisliche penalizzanti sommate alla necessità di effettuare i relativi lanci da distanze molto rav\'icmate rispetto alle navi bersaglio, per poLCre limitare il tempo di corsa m acqua del siluro e massimizzare in tal modo la probabilità di colpire. comportavano perciò !"esposizione dei velivoli lanciatori ad un prolungato e letale fuoco di contraSto da parte dell'artiglieria navale awersaria, che in genere non veniva distraila dalla comtemporanca e massiccia apparizione di bombardieri calanti a tuffo sulle stesse navi da colpire. sec-0ndo l'efficace tecnica adoperata dagli americani nel Pacifico.
Venne quindi nuo\'amente manifestata l'impellente necessità di poter disporre di un nuovo tipo di siluro aereo che fosse in grado di sopportare le sollecitazioni denvanti dal lancio da una quota nettamente più elevata, quantificata in non meno d1 300 me con il veli,·olo in fase di leggera picchiata per poter assumere una maggiore velocità. che venne stabilita in non meno di 500 km/h. anche in vista della futura possibilità di ricevere in dotazione un adegualo sostituto del pur affidabile SM.79.
Tale proposta venne accolta nel co~o della 633 riunfone del Comitato Progeni della ~egia Aeronautica del 16 agosto 1941. durante la quale venne raccomandata la rapida costruzione di un·anna rispondente alle nuove specifiche deue.
Il siluro ·•Fa11to11i''

. Da_ P:"11e della Regia Marina era stato nel frattempo messo allo studio un nuovo llpo di silu~ navale dotato d1 un apparato propulsore semplice e leggero basato su un razzo u11hzzante come properg 1· · . . . . o I ossigeno gassoso m pressione contenuto in una apposi~ bombola ed una soluzione di acqua ed alcool.
Un arma subacquea dotata d. 1 • • . . 1 ta e tipo d1 motore, ideata e messa a punto dal maggiore del Gemo Naval F · dotate d. 1• antom, sarebbe stata assai meno delicata di quelle 1norma I propulson elettro · · · • • · . h· . . . mcccan1c1. perche sostanZ1almente pnva d1parti mecTcamc_ t: propulsive sia interne che esterne in movimento aie siluro avrebbe potut · d. . · veloc·,:. .. 0 qum I essere lanciato anche dall'aereo da quote e ha nettamente p1u elevate d" Il fi visti sarebbero • . 1 que e no ad allora utilizzate, anche se i pesi pre- nmast1 ancora alquanto elevati.
174

L'arma fu realizzata presso l'officina siluri di Pola e sotto O • di prove di coUaudo, ma non venne nè omologata nè c tru· P_ sta al relativo ciclo re parte alle operazioni belliche. os ua in tempo per prende-
I s ilu ri dell ' ing. B ord o ni
Un altro grave limite all'azione dei reparti aerosiluranù era costiruito. come abbiamo già deno, dalla rapida cd evidente obsolescenza del pur valido SIA! Marchetti S.79, che era stato l'aerosilurante standard italiano fin dagli inizi del conflitto.
La sua mancata sostituzione con il SW S.M. 84. rivelatosi eccessivamente pesante ed ancor meno adano allo scopo, ed il progressivo avvicinamento deUa minaccia aeronavale alleata alle acque prospicienù la Penisola, resero impellente la necessità di ricorrere alla ricen:a di un velivolo nettamente più L 'ing. F,:nlinando Bordoni veloce.
Si ipotizzò allora di poter adattare all"uso silurante uno dei caccia monomotori d'assalto dotati di motori in linea Daimler Benz DB.60 I, come il Re. 200 I. i cui primi esemplari erano allora in via di distribuzione ai reparti. che sarebbero risultati i più veloci tra quelli disponibili per l'attacco di superficie. grazie alla loro finezza aerodinamica ed alla buona potenza installata.
l già descritti siluri in normale dotazione agli SM.79 sarebbero però risultali d'ingombro eccessivo ed anche troppo pesanti per poter essere sollevali e trasportati in volo da queste agili macchine in condizioni sufficientemente sicure.
Venne quindi autorizzato lo studio di diversi nuovi ùpi di siluro, specificamente concepiti. tra i quali notevoli furono quelli che vennero progettati dagli ingegneri Ferdinando Bordoni e Piero Remor, con la collaborazione deU'ing. Carlo Giannini. . I primi due tecnici disegnarono e realizzarono due diversi tipi d·arma aviolan: Ctabile del tutto nuovi aventi le parti metalliche costruite in lega ultralegge~ di ~agnesio denominata elektron. mentre l'ing. Giannini fu coim·olto in tale reaJt~z~one nella sua qualità di direnore della CNA (Compagnia Nazionale Aeronautica) dt Roma, a suo tempo fondata datring. Borunartini ed aJlora appanenente al Gruppo Caproni, la quale a\'eva le sue officine di produzione ubicate presso l'acropono dell'Urbe a Roma li · • · . · essendo basato sull'acpnmo ltpo era a funzionamento totalmente meccanico . . cumulo di energia cinetica fatto da pane di due volani conte~uu nel stluro Slesso che erano collegati a due eliche marine propulsive con1roro1anu. . .
La messa in movimento rotatorio a 20.000 girifmin di tali vo(an1 veniva effettuata quando il siluro era ancora aggancialo in volo all'aereo lanciatore.
175

. d I onclo tipo di siluro era invece basato sulruso di un n funzionamento e sec
motore n razzo. . bacquee pur avendo dimensioni ridoue rispeuo a quelle Queste nuo\'e anm su · · 450 I - d ~\'endo un diameLro esterno sempre pan a mm mn con sU10dord al ora muso. e u d. -oo k d · · 1· 3 65 m ed un peso complessivo 1:, ·g, erano otate d1 unn lunghezza pan a so i ' d. Il . . li . d' I · ,0 neunmente più pesante e letale I que e 1mp1egatc 100 ad unn cnnco esp 0s1, allora. pari a beo 270 kg. . . .
Esse venivano quindi a possedere una potc~a d1~trultlva del l~tto c?nfro~tab1lc con quella dei siluri pesanti novali dell"epoca. 11 e~ peso tot.aie s1 aggirava mvecc sui 1.000-1.200 kg e che erano cnpaci di colare a picco, con un solo colpo a segno, anche un incrociatore pesante da l0.000 t. .
Le nuove armi. denominate sempre --silurouo'". ,·cnncro con~cpn~ per coprire la maggior parte della distanza dal bersaglio con u~a vel_oce tro1e~ona aerea, compiendo un volo di I.000 mdi lunghe~a in caso d1 lancio _aereo_ hvellato effettuato dalla massima quota ammissibile. o d1 l.500 m nel caso d1 lancio cabrato.
Si sarebbero poi infilate io acqua a 500 km/h. proseguendo la loro corsa per altri 700 metn fino al bersaglio, correndo in immersione a 40 nodi.
Per ottenere caraueristiche tanto spinte i progenisti ricorsero quindi anche ad un interessante apparato propulsi\'o a razzo che venne breve11a10 da Bordon e Remor il 7 giugno del 194 I.
Esso usava come propergoli ossigeno gassoso contenuto in una bombola sotlo pressione a 400 atm ed alcool di produzione corrente in soluzione acquosa. per limitare le temperature m camera di combusùooe a valori accettabili, con !"eventuale add1z1one di etere etilico.
Quesu erano in buona sostanza gli stessi propergoli usati dai tedeschi sulle loro ··v-2",pur non essendo i nostn esperti mai venuti a conoscenza diretta dell'esistenza dì queste micidiali anni e delle relati\·e tecnologie.
11 serbatoio in pressione dell'ossigeno comburente era contenuto all'interno di quello del combustibile liquido che fungeva anche da pane poppiera dell'anno stessa.
La pol\'erizzazione dell'alcool in soluzione acquosa e la sua miscelazione con l'os:.igeno av\'cnivaoo per effeno della fone pressione posseduta dalrossigeno stesso e grazie a ~ue tubi d'efflusso coocentnci tra loro. dei quali quello esterno sagom~to a semphce con\'ergeme era nservato all'oss1gcno e quello coassiale interno all alcoo~. che fuonuscendo veniva direttamente investito dal geno di gas. la mi_scela gassosa cosi onenuta vcni\'a quindi fana bruciare in un'apposita camera dt corubustmnc.
Quest0 semplice e geniale motore a razzo. che aveva come unico grosso inconvememe restr · I · · d" . . e~a penco 0s1là I trasporto dovuta alla presenza del serbatoio d"osSigeno 1~ pressione, era innescato da un'apposiw cartuccia d"accens1one ed ern in grado d erogare una spinta di 200 kg.
be Malgrado 10scarso rendimento propulsivo in acqua che ne sarebbe derivato, san:b.1 stato ~pace di funzionare per una durata massima di circa 30 sec, imprimendo 01 si urotto I elevata velocità di traslazione necessaria. che era valutata in circa 20 m1sec.
176
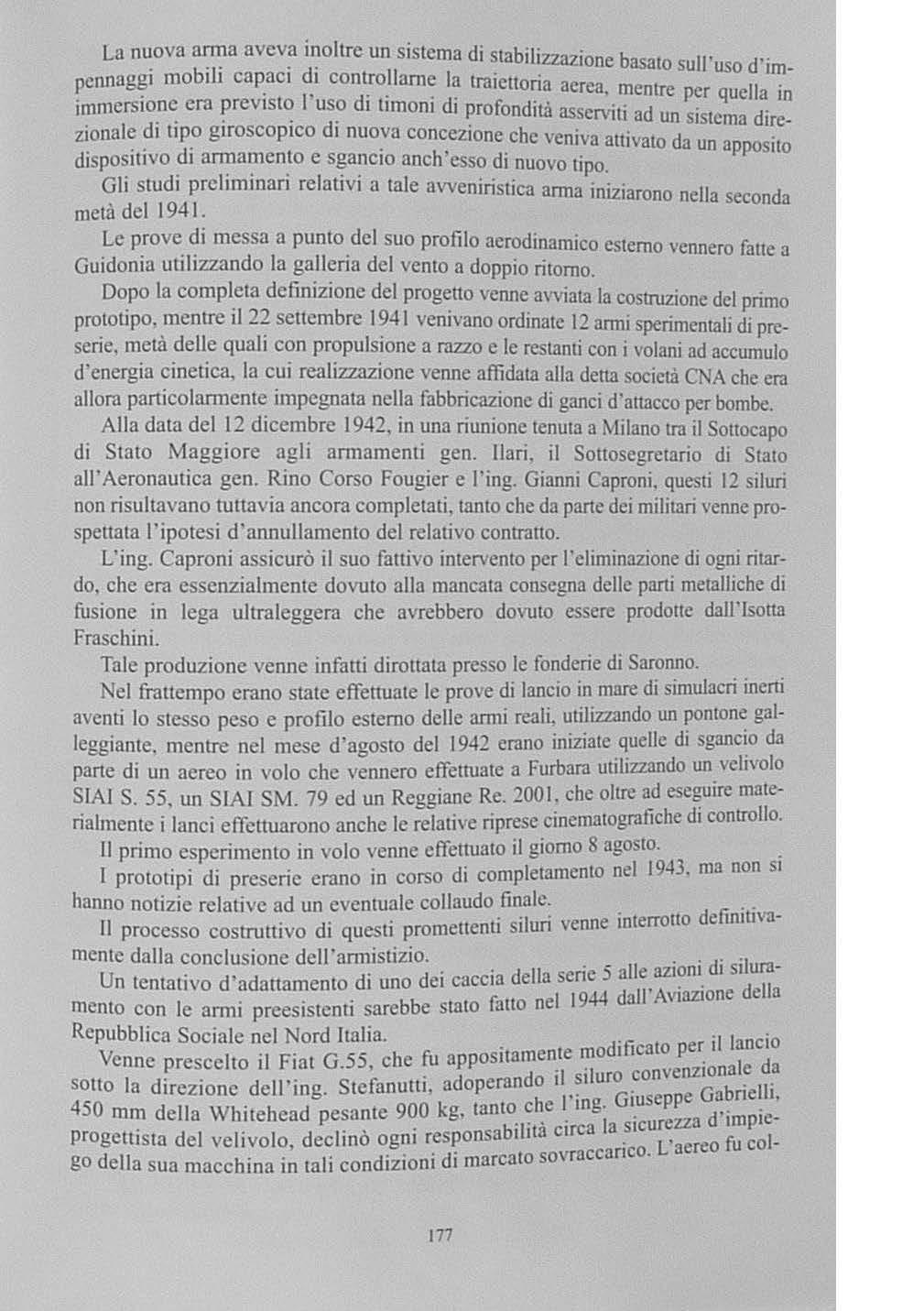
La nuova arma aveva inoltre un sistema d1 s1abiliZZa7ione basato Il' d'' · b·1· · d' su uso 1m- pennagg1 mo 11 capac, 1 controllarne la tra1ettona aerea mentre 11 · · 1· d.... • pcrqucam imrncrs1onc era previsto uso I timoni d1 profondità asservili ad un .·51 , d. · · · · d' lii cma tre- zionale dt 11po g1roscop1co I nuova concezione che ,·emva attivato da u · · d' • . n apposuo dispos111vo I armamento e sgancio anch esso di nuovo tipo.
Gli studi preliminari relativi a tale avveniristica anna iniztarono nella seconda metà del 1941 .
Le prove di messa a punto del suo profilo aerodinacruco esterno vennero faue 3 Guidonia utilizzando la galleria del vento a doppio ritorno.
Dopo la completa defmizione del progetto venne avviata la costruzione del pnmo prototipo. mentre il 22 settembre 1941 venivano ordinate 12 anm sperimentali di preserie, metà delle quali con propulsione a razzo e le restanti con I volani nd accumulo d'energia cinetica, la cui realizzazione venne affidata alla detta società CNA che era allora particolarmente impegnata nella fabbricazione di ganci d'a11ncco per bombe.
Alla data del 12 dicembre 1942, in una nunione tenuta a ~Iilano tra il Sottocapo di Stato Maggiore agli armamenti gen. llan. il Sottosegrecano d1 Stato all'Aeronautica gen. Rino Corso Fougier e l'ing. Gianni Caproni. questi 12 silun non risultavano tuttavia ancora completali, tanto che da pane dei militari venne prospellata l'ipotesi d'annullamento del relatÌ\'O contrauo.
L'ing. Caproni assicurò il suo fatùvo intervento per l'eliminazione di ogni ritardo, che era essenzialmente dovuto alla mancata consegna delle parti metalliche d, fusione in lega ultraleggera che avrebbero dovuto essere prodotte dall'lsona Fraschin1.
Tale produzione venne infatti dirottata presso le fonderie di Saro~o. . . .
Nel frattempo erano state effettuale le pro\'e di lancio in mnre di s1mulacn mcm aventi lo stesso peso e profilo esterno delle armi reali. utilizzando un ~nron~ galleggiante. mentre nel mese d·agosto del 1942 erano iniziale quelle di sgancio da pane di un aereo in volo che vennero effettuate a Furbara utilizzando un_vdi,olo SlAJ S. 55. un SIAI SM. 79 ed un Reggiane Re. :WO I. che oltre ad ese~ire marerialmeo1e i lanci effettuarono anche le relative nprese cinematografiche di controllo. 11 primo esperimento in \'Olo verme effettuato il giorno 8 ago5t0• l . . . . . d' letM"'ento nel 1943 ma oon s1 protoupt d1 presene erano m corso I comp · hanno notizie relative ad un eventuale collaudo finale. . d fi ... • • . ·1 enne interrotto e m1U\a- ll processo costruttivo d1 quesn promeuenlt SI un v mente dalla conclusione delrannistizio. . . 11 · 1 · d·• 5,·tura. . d . . d Ila sene :, a e az1on Un tentaLJvo d'adanamento d1 uno et caccia e _. . • d•lla I 19-44 dall',..vta.ztone i: mento con le armi preesistenti sarebbe stato fauo ne · Repubblica Sociale nel Nord Italia. d'fi 10 per il lancio V . . - "' si1amente mo , ica enne prescelto ti Ftat G..'.>5, che '.u appo . 1 .1 convenzionale da sotto la direzione dell 'ing. S1efanu1u, adoperando 1/' ur~·useppe Gabriel!J, 450 mm della Whitehead pesante 900 kg, tanto _ . mgj 1 curezza d'impteprogeltista del velivolo, declinò ogni responsabilita cll'Ca a ~ 1 0 L'aereo fu cold' to sovraccanc • go della sua macchina in tali condiz1ont t marca
177

_ d 1 ·ap Adriano \tantelh. ma l'applicazione non ebbe laudato con successo a e seguito. h • stato uno dei fondamentali artefici della creaL'ing. Ferdinando Bor<loni"-c e c.:rarazzo è scomparso nel 1987 atretà di 90 anni. zione del silurotto con_ prop~ s10ne 8 anch~ se poco noto. dell'Aeronautica italiana. Fu un piorucre gemale e 10st ~~~ Italia che neglt Stati Uniti il fondamentale N I 1930 a\'eva brcvenato st . h bb 1 e. . . . d 1 35 •0 colletti\'O deglt elicotten e e avre e trovato dtsposm,·o d1 regolazlione I esup msacchine prodotte in. molti paesi esteri. tra cui gli ·mpiego umversa e anc 1e un 1 . . . . h d a,·er fono ampio uso dt tale brevetto, compensarono stessi Stati Unttl. c e. opo · d' 50 000 d Il · . · I d la guerra con una somma forfettana t . o an. l'mgegnere ,~ ;°i";-t4o~oet pnmi anru del successivo dopoguerra. progettò. costruì
A partdi_rer la 1c.: nresso l'aeroporto dell'Urbe a Roma l'elicottero a rotori e collau o 1e ,ccmen e p · 1 t 1 ·'Lt'bellula" che non ebbe segutto ed e atrualmente conscr- coass1a I controro an 1 • ,·ato presso il Museo :\eronautico Caproni di Trento.
I 711.5: Il siluro-razzo di Stefa11i11i
Come abbiamo gtà ,1s10. la penuria di materiali metallici per uso industnale affi1sse cons1dere\'olrnente l'Italia nel corso dell'intero conflitto.
Venne fatta ince1ta d1 ogni genere d1 manufatti metallici esistenti in opera sul terniono nazionale, asportando e fondendo cancellate cli ferro e quant'altro potesse essere utile alla produzione bellica. senza poter risolvere integralmente questo gra,e problema. che m realtà avrebbe precluso già in partenza qualsiasi tentativo dì produzione in grandissima sene dt proiettih razzo da usare in massa nel tiro balistico a saturazione d'area. anche se essi fossero s1ati di comprovata efficacia bellica.
Il consueto spinto d'adauamento italiano non mancò di farsi valere anche in questo particolare sellore. grazie alla mgegnosa proposta di razzo riutilizzabile di Stefaninì. titolare d1 una fabbnca pirotecmca. il quale nel 1942 propose la costruzione di un ··siluro-razzo".come s1 continuava a chiamare in Italia, o di un missile balistico come s1 direbbe oggi. che avrebbe dovuto essere costituito da parti metalliche e meccamsmi inierni m massima parte recuperabili e riusabili.
Tale razzo lungo IO m e del diametro d1 1.5 m avrebbe dovuto avere capacità operative quasi analoghe a quelle della contemporanea "V-2" gcnnanica, essendo propulso da alcool ed ossigeno liquido con un car1co bellico pari ad I t d'esplosl\'O contenuto nell'ogiva.
Al di sono della testata esplos1\'a a,·rebbero dovuto essere collocati i congegni di radioguida.
Tutti i dis1><:>si11v1 meccanici interni e le pani metalliche pregiate relative all'imP1:11110_Proputs,vo avrebbero dovuto essere assemblate in tre distinte sezioni. costitutte nspeuivame_nte dai _serbatoi di propellente, posti sotto i congegni d1 guida. ~Ile ~rbme dt alimentazione ed infine dalla camera di combustione metallica riveSllta mtemamente m materiale refrattario. Trascorsi 85-90 secondi dal lancio ed
178

I~ ra=o stratosferico a compo11enti separabili e n11.Iabili di Stefa11ini rappresentato da ,Uberto Fenoglio 5 6 8
li ra:::w St.fanini con camera di combustione ameriore f g,!lli d, scarico laterali sperimentato con successo nel s.:condo dopogu•=
esaurita la fase iniziale di spinta, ciascuna di queste tre parti sarebbe stata separata da~le altre mediante l'uso di bulloni esplosivi. per essere quindi espulsa anravcrso ~scita ricavata nella parte inferiore dell'involucro esterno dello stesso missile. '"12•~do dall'ugello cui avrebbero fatto seguito i turbocompressori dj alimentazione cd infine i serbatoi. Queste diverse sezioni sarebbero poi scese a terra senza danni grazie ai loro para:~dute per potere essere recuperate e riutilizzate. . se L_ mvolucro esterno del missile. con i relativi impennaggi, avrebbe _m~ece ~i:o: .guuo la sua velocissima corsa lungo la traiettoria prevista insieme ai disposi un d1 ·d · gui a cd alla tesla di guerra, fino ad esplodere sul bersaglio. . Que5tO progetto. che sarebbe ancor oggi abbastanza costoso e complesso da realizzare· sembra che sia stato esaminato dalle autorità militari italiane dell'epoca. ma non ebbe · . OV\'1amcnte seguuo.
179

. d I Stefanini realizzò un razzo lungo 2 m e pesante a vuoto 7,5 l\el opoguerra o · b · Il • 1 • pellenti liquidi con camera di com usttone posta su a punta kg che uu izzava pro . . . . . . del missile stesso e doppi ugelli di scanco obli~u1 latera~1. . e rd ·gno furono effettuati due lanci coronati da successo, nel pnmo dei • I .1 . ·unse la quota di 1.700 m. mentre nel secondo quella di 2.500 m. qua 1 1 razzo raggi • · · d d 1·b [I razzo fu recuperato in entrambe le ~ccas1_0~1 grazie a un Pai:8C~ ute t erato al momento opporruno per mezzo di un d1spos1uvo ad autoscatto simile a quello di una macchina fotografica.
Vlll 6: Il ra:.:.o a propellen te solido del/ 'ing. De Luce
L'interesse della Regia Marina per la propulsione a reazione continuò anche dopo il fatale insuccesso di Cicogna e Rabbeno (§ Il.4).
In panicolare venne messo a punto un tipo di proiettile dotato di un sistema di propulsione a reazione basato sull'uso di un boccaglio De Lavai, che raggiunse un·accettabile funzionalità operativa ma del quale, a quanto sembra, non fu fatto un diffuso uso bellico, mentre nel 19-M presso un balipedio realizzato nello stabilimento della Regia Marina di Torre del Lago (Viareggio) venne sperimentato al banco un nuovo tipo di motore a razzo a propellente solido di grosse dimensioni realizzato su progetto dell"ing. De Luce.
A tali pro\'e assisté io rappresenLanZa della Regia Aeronautica l'ing. Bernardino Latumzi, che era allora uno degli esperti di aerodinamica del Centro Sperimentale di Guidonia (Bibl. 59).
Le relative prove dellero risultati promettenti, tanto che venne registrata al dinamometro una spinta statica dell'orcline di 6.000 kg.
questo endoreattore avrebbe dovuto essere impiegato per la propulsione balistica d1 un ordigno bellico di adeguate caratteristiche, ma lo studio e lo sviluppo del razzo e della relativa testata bellica cessarono del tutto con l'armistizio.
180
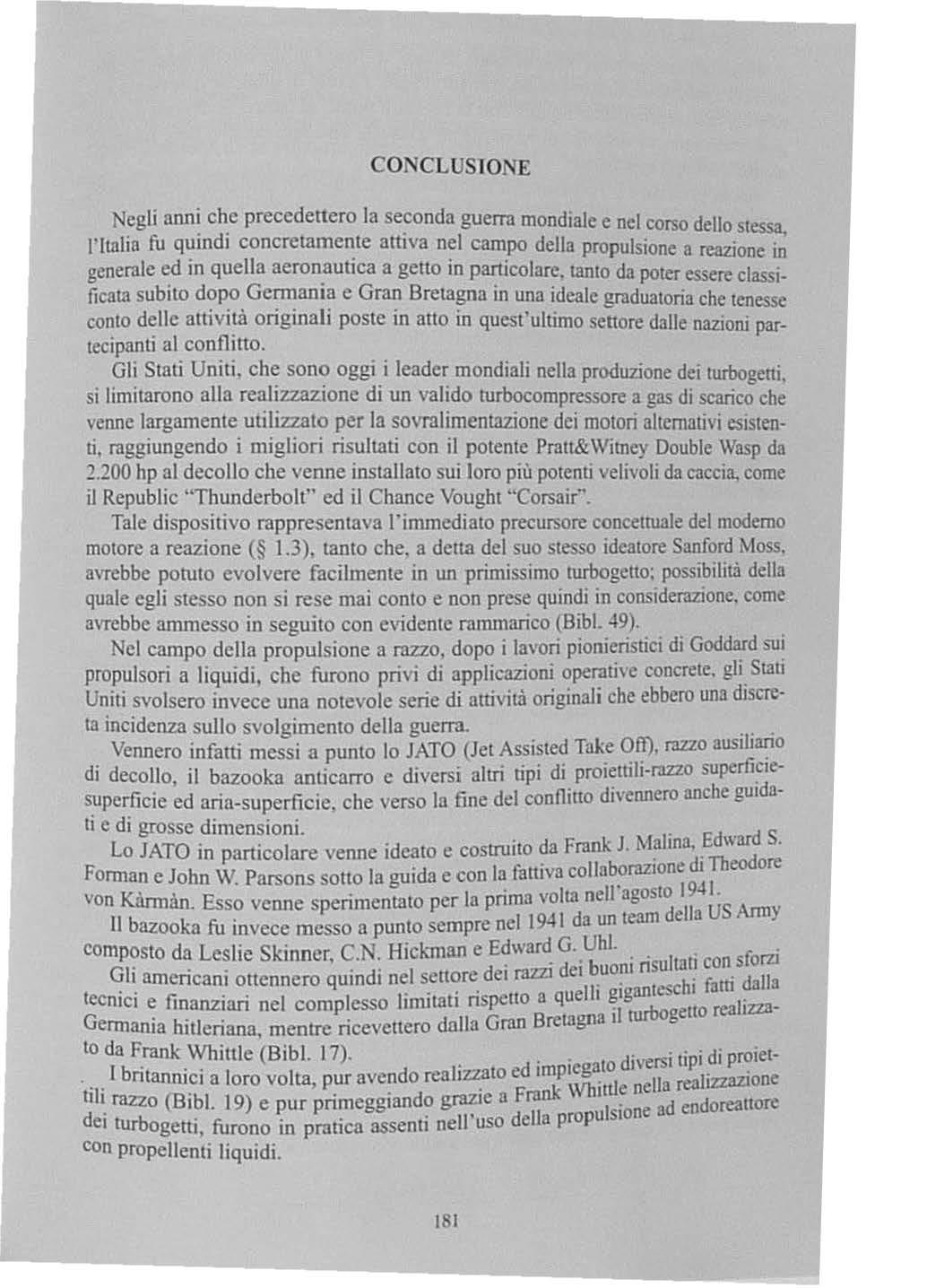
CO CLUSTONE
Negli anni c~e precedettero la se~onda guerra mondiale e nel corso dello stessa, l'Italia fu qu10d1 concretamente attiva nel campo della propulsione a reazione in generale ed in quella aeronautica a getto in panicolare. tanto da poter es.sere classificata subito dopo Germania e Gran Bretagna in una ideale graduatoria che tenesse conto delle auivilà originali poste in arto in quest'ulurno settore dalle nazioni partecipanti al conflitto.
Gh Stati Uniti. che sono oggi i leader mondiali nella produzione dei turbogeni. s1 limitarono alla realizzazione di un valido turbocompressore a gas di scarico che venne largamente utilizzato per la sovralimentazione dei moton alternativi esistenti, raggiungendo i migliori risultati con il potente Pratt&Witney Double Wasp da 2 200 hp al decollo che venne installato sui loro più potenu velivoli da caccia, come il Republic 'Thunderbolt" ed il Chance Vougbt "Corsair~.
Tale dispositivo rappresentava l'immediato precursore conceuuale del moderno motore a reazione (§ 1.3), tanto che. a deua del suo stesso ideatore Sanford Moss. avrebbe potuto evolvere facilmente in un primissimo turbogetto: possibihtà della quale egli stesso non si rese mai conto e non prese quindi in considerazione. come avrebbe ammesso in seguito con evidente rammanco (Bibl. 49).
Nel campo della propulsione a razzo. dopo i lavori pioniensric1 di Godlfa:rd sui propulsori a liquidi, che furono pri, i di applicazioni operati, e concrete. gh Stan Uniti svolsero invece una note,·ole serie di atti, ità originali che ebbero una discreta incidenza sullo svolgimento della guerra. . . .
Vennero infa11i messi a punto lo JATO (Jet Assisted Take 0ft), razzo ausil!ano di decollo, il bazooka anticarro e cliversì altri tipi d1 pro1et11h-razzo superhciesuperficic ed aria-superficie. che verso la fine dd cooflitto di"ennero anche guidali e di grosse dimensioni. . _ _ Edward s. Lo JATO m particolare venne ideato e costrullO da Frnnk J Malma, Forman e Jobn W Parsons sotto la guida e con la falliva collaborazione di Theodore von Kàrmàn. Esso venne sperimentato per la prima volta nelrago5 lo 1941 S Ann li bazooka fu invece messo a punto sempre nel 19.t I da un team della U } composto da Leslie Skinncr C.N. Hickman e Edward G. Uhl. . . - .r. • - ' - d b oni nsultall con :;,om Gh americani ottennero quindi nel settore det razzi ei u . . h r. tt,' dall3 I • • • • . quelli gigante:.c 1 ,a ecn1c1 e finanziari nel complesso limnat1 nspetto a 1turbo euo realizza· Germania hitleriana, mentre ricevettero dallo Gran Brewgna 1 g Lo da Frank Whittle (Bibl. 17). . . d. ·ersi tipi di pro1e1l britannici a loro volta pur avendo reaJjzzato ed impiegatoti 1 ' 11 _,A1 1•zzazione T ' · Frank Wbll e ne a r=-i 11 1razzo (Bibl. 19) e pur primeggiando grazie 8 1 - ne ad endoreauore dei turbogetti, furono in pratica assenti nell'uso della propu 510 con propellenti liquidi.
181

. 1- tienul·• daoli italiani a fronte di un livello assai ridouo I ·. llat ·=nmenia 1 o e-
• nsu 1 ~r 1 d. d. •d esperimcn1i s,olti. furono d1 qualche nhcvo nel seton tm.Scurab1 e I slu I e:: I b d. d" . man · 11 . i·qui·d,· con la messa a punto a anco t 1vcrs1 prototi- d razzi a prope enu 1 • . tore_ ei . 1• lcool ed ossigeno gassoso. che non dettero pero luogo ad pi di endoreauon usan I a lcuno s,·iluppo apphcauvo.
a . d 1 •riroenti effettuati nel campo dei pro1et11h-rnzzo furono
Ancheehstu 1egiespc
. - 1 d foss •ro stai, rage1un11 nsult.au accetta 11e susccu1 111 d 1mscnza esito. ma gm O i::
d 11
. · la marcata sfiducia 1mzialmente nposta a e automa m1btan pieeo opcran, o. per
· d"d. sulk loro prestazioni belliche in tennini d1 prec1s1onc e qum 1 1rappono tra cos1o ed efficacia. . · f: · I 1· Il Il compie so delle a11i,·i1à d1 studio e spenmentaz1onc. atte m ta ta su a propulsione a r.1zzo. sia del tipo a propellenll hqu1d1 che sohd1, ebbe due ccn':11 pnnc1~ ali di s\iluppo: Roma. grazie all'opera d1 Gaetano Arturo Cro~co e dcgh stud10s1 ~ella facoltà d"ingegneria dell'Uni, crsità. con la colla~oraz10ne ?ella 8P~ di Colleferro. e Tonno. do\'e. come abbiamo visto. agirono d1vers1 stud10s1 pm au sm in maniera coordinata tra loro che indipendente.
1 risultati onenuti nel settore della propulsione a getto furono invece assai più impananti. anche se nell'immediato "ennero considerati poco promettenti.
Le appltcuiom pratiche reah furono completamente nulle anche in quest"ultimo settore. ma solo a seguno della firma dell'armistizio e della sconfina finale.
Dec1s1va fu la scarsa entità dei finanziamenti che vennero accordati. sia dogli enti preposti dello Stato che da societa industriali e da singoli privali, che. effettuati nelrarco d1 una ventina d·anm. sono valutabili in prima approssimazione in non più dt una trentina di miliom di lire al valore del 1943.
Gli studi e le aninlà italiane nel settore della propulsione a reazione. pur essendo stati quindi d1 li\'ello apprezzabile. furono ininfluenti sia sulla condotta delle operazioni belliche del 1940-45. che sul rapido sviluppo dei moderni turboget11 e dei moderni missili che sarebbe avvenuto nei due dccennt successivi. r-;eJ nostro Paese. infaltl, non riusci a maturare un humus favorevole allo s, iluppo di tale fonna di propulsione basato su larghe disponibilità finanziane ed adcgunte_ capacità lecnologico-produuive. sebbene le personalità aventi potere decisionale m raie senore. politiche. militan e tecnico-scientifiche civili, fossero pienamen~e consape\'oli delle sue note, oli potenzialità applicati, e. _~ella s~con~ ~età degh anni '30 il nostro Paese s·impegnò a fondo nelle conquisie temtonah dt Etiopia ed .\lbania, oltre che nella guerra di Spagna, che furo· no condotte co~ dov1z1a di mezzi, assorbendo una larghissima fotta delle scarse nsorse economiche disponibili ed impegnando la quasi totalità delle capacità pro· dun1ve del complesso militare-industriale italiano.
. Tait impres:, pur terminando con altrettanti successi politico-militari. furono d~sastrose s~I piano economico perché prosciugarono le casse dello Stato (Bibl. 45) senza dar:e il desiderato accesso a risorse economiche e naturali decisi,·e. Q~esu apparenu succe·s1 deltero inoltre luogo ad un progressivo isolamento matenale e culturale del no t p . dall · • · · · · I dai . s ro aese a comuntta mtemaz1onale cd in paruco are paesi che erano semp · · · • • · · S · re s1a11 a noi trad121onalmen1e v1cm1. come Francia, tali
•
· · · ·
•
.. • ·
·b· · •·
- • • • • •
· · · ·
. .
b·1·
· .
182
Uniti e Gran Bretagna. nos~1 lHlelm:uau ~nua o 1ta1T~'Tlncra11 granoe guerra Durante e dopo_ la ~o~~u1sta dell Et!op1a. le grandi poterv.e occidentali. divenute: decisamente ost1lt. _101z1arono a tagltare I ponti con l'Italia, non tanto sul piano delle relazio_m formali, qua~t~ su quello sos~1ale dei trasferimenti di tecnologie ematerie pnme. oltre che d1_ risorse ~nanz1ane.
L'applicazione delle sanzioni, decise nel 1935 dalla Societa delle, ·azioni e mantenute fino alla fi~e della guerra d'Eti~pia pe'. i prodotti di piu largo consumo, ebbe conseguenze pratiche_ che op":rarono_ m_ ~amern strisciante fino allo scoppio della ~econda guerra mond1al~ p7r I m~1enal1 ~1- ~arattere eminentemente strategico.
La loro man~anz~ o_ltmitata d1~pomb1lna ebbe effetti deleteri sullo s\iluppo del euore acronouuco 11ahano perche vennero a cadere in un periodo critico di forti progressi tecnologici di cellule e motori. facendo accumulare al nostro Paese un rilllrdO evolutivo valutabile in non meno d1 5 anni. che. all'atto dello scoppio del conflitto nel 1939, si sarebbe rivelato incolmabile.
Basti pensare che la produzione del biplano da caccia CR.32 tennmò nella pnmavera del 1939 per poter dare inizio a quella del suo diretto denvato CR.42, poco meno obsoleto, quando lo Spitfire britannico era già in produzione fin dal marzo 19r
Le conseguenze pratiche dell'isolamento politìco-econom1co sub110 dall'Italia furono quindi molto pesanti sul piano tecnologico e scientifico, visto che Francia, Gran Bretagna e Stati Uniti, oltre ad essere paesi forti sul piano finanziario ed avanzati su quello tecnologico e scientifico, controlla\'anO anche le fonti mondiali d'approvvigionamento della maggior pane delle materie prime necessarie per lo s, iluppo dei diversi scnon industriali aventi nlcvanza bellica.
Sia le relazioni di carattere commerciale che l'abituale attenzione esercitata dalla società italiana del tempo verso modelli culturali d'importazione \Cnoero ~ -rei~ fatte convergere da parte del regime fascista verso la Germania. con nsulta11 hm1ta11 per la difficoltà d'accesso alle nuo\'e tecnologie che venivano allora messe a punto dai tedeschi.
Nella seconda metà degli anm ·30 lo s\"iluppo tecnico-scientifico della Germania aveva infatti assunto caratteri assai dinam1c1 in 1utù I campi ed m pa111colare anche in quello della propulsione a reazione sia a geno che a razzo. .
Tale p~occsso era stato però impostato e portato avanti soli~ la_ tutela deH:/:~ ngorosa nservatezza imposta dal regime nazista. data In volonta ?1Huler di P rare I vincoli militari imposti dal trattato di VcrsailJes. grazie ali uso della nuo, 3 n , I } di m"ZZI 1ecmc1 e finan,uu aerea e delle nuove armi segrete che con arg 1ezza eztan venivano studiate e fatte sviluppare. · 1 Gh apponi tedeschi di conoscenze a, anzatc oli'evoluzione 1ec_nologica 113 1 ~1n1a fur d' · • te nulh nel seuore dc a ono I conseguenza assai ridotti in generale e praucamcn propulsione a reazione. 1 · , fascista fu Sul pmno 1ecnico-produ11ivo la risposta che ,enne data da regim~ • 1,nali quella dell'autarchia consistent; nella sostituzione delle tecnologie e e111molcome div · · ' I •tro Paese o ne eco · entati 1rreperib.ilj con altri prodolli dirennmeote ne nos . 1 ul piano I · I · - - fu però efficaci so o s nsu ta11 pratici di questa nuova poltuca rono

183

. . h . · sero il Paese intorno alla classe dirigente fascista, nd1s11co pere e :.tnn
. . d I . . . propaga ·. . 1 •. mat•'riali ed econom1c1 e e1en. in pnmo luogo bb ffen1 psico og1c1, . . ma e . ero . . bblica venne ingeneralo un orgoglioso scn11mento di perche neH opinihone p_uia,·a a n·genare Oa non 1encrc mai conto di quanto veni- ffic1 •nza c e 10, 1 autosu. i: 11 • n•ntre veni\'a doto scarso peso al fatto che molti prodot11 \'a realizzato a estero., c . I d . 11· . . . • · i· ome ad esempio 1I cotone, a gomma e I meta I indu- industnah esscnzta I c . I . . 'b·1• 1 · k 1 0 lo stagno erano in realta de Lullo insosl1tu1 1 1, con O\'\'ie sinah come i mc e . d . . d I . • • 011·\·" sul li\'ello quoli1at1\·o delle pro uz1oni a a lo contenuto npercuss1on1 neg "'
tecnologico. . • · e · b ·
I . "d .,.1·autarchici che furono 10trodo1t1 erano mrani meno uoni o comunsuccc an... . h · • ·1
Ilo Pl·u· costosi dei prodoui d'importaz1onc, cosa c e unpoven I Paese e que mo 1 . . ·r. . ridusse in maniera sostanziale lo s,iluppo tecno og1co e sc1enl1 1co ane~o m mol. · , ree sia complementari che di direuo supporto a quella aeronauuca. uss1mc a . • h G ·d · d" ·
Basti pensare ai pro~le~i. n~cssi allo stud.10 an~ e a .u1 om~ 1 sost_1tuzi~ne dell"olio minerale con oho d1 ncmo per la lubnficaz1one dei mo1on a scoppio e I mlroduZ1one dell'alcool da addizionare alle scarsa e costosa benzina disponibile.
Nel senore metallurgico. già considerato parlando di leghe metalliche per la fabbricazione di turbine. si pensò di sostituire alcuni elementi metallici essenziali presentì negli acciai con il berillio. reperibile in Etiopia, al quale venivano auribuite proprietà miracolistiche.
Vennero importate migliaia cli tonnella1e di minerale usandolo come ZB\' Orra per le navi da carico che face\'ano la spola con 1·Africa Orientale. partendo piene dall'Italia e tornando scariche. \'isto che l'Impero era una scatola vuota nella quale c'era moltissimo da inviare e quasi nulla da importare. ma non se ne fece alcun uso industriale decisi\'o, tanto che la realizw.zione di leghe per impieghi ad alte temperarure e forti sollecitazioni necessarie per la costnJ7jone delle turbine, pur essendo s1.a1a presa in considerazione prima e durame la seconda guerra mondiale(§ \'.2), non dette risultali concretamente validi.
AJtro problema di drammatica rilevanza m campo aeronautico fu quello della messa a punto di carburami antidetonanti con numero d'ottani superiore a I00, che venne praticamente ignorato in Italia ed in\'ece efficacemente risolto da britannici ed ~ericani che si ritrovarono per questa sola, ia ad avere disponibili motori aeronauuci supercompressi più potenti di quelli precedentemente in uso di almeno il 20°'0. L'avvenuta soluzione del problema della detonazione nei motori altemati\i aeron~~~ci ~er valori del rapporto di compressione superiori a 7, insieme alla disponibili~ ~ei turbocompressori azionati dai gas di scarico, permise loro, già nei primi anni di guerra, di spremere, da motori altematiYi che erano almeno inizialmente, poco diversi dai nostri_, un numero di cavalli assai più elevat~.
La nostra aeronautica fu perciò messa subito di fronte al drammatico problema di una poten1:3 di~p_onibile per i propri velivoli sempre drammaticamente inferiore a qu:11° raggiungibile dalle controparti inglesi ed americane.
al~~ forte h.andicap fu quello della mancanza di adeguate risorse finanziane dedi:3bih allo sviluppo di idee e progetti di elevato contenuto tecnologico.
L Anna Aerea, che è sempre stata in Italia la fonte primaria di finanziamenti per
184 o

1 inizintiva d1 vilupp le mc in camp aeronautico n ma, di n or• ufficient, per fare pienamente fr nte an hc a1 oli com nali di Forza uwdello tal .
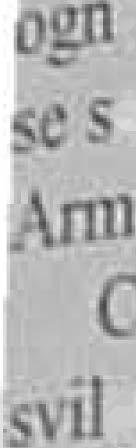
100 no 1an1 do cll pr , edere ai moli phc1 gra\<am1 conn .i con lo uppo nico mifi . di b . _ctto�e quasi da ol ; gllla pan1re. per fare UJ1 cmp del male ficallvo, �I finanz,amcmo d Ile maggiori pubblicaz �1 c1 . • del et �•e la pr• 11g10 rote m a".
Gh forti finanz,an hc furon mli dalla Regi auticap•rla mi: aa puntod1prototipi di non immediata util!zzabilJtàop rati\a,com•eranond mpio to 11pa-apro mp m. pur endo com cnl limitati in 1 rmmi monet . indi una \alenza le ni mitica rilc\ nte, um10d pot re id 'ficati\i lung1m1rami.
PerI re h I pr · ampirn I deve in ltrc ricord ec1 fu un forti:e borso finanziario in ita o I nutoanche dalla I" om
Purtra iffi ltà. venne to 3\'llnt1 con deci , ne il pro di viluppod Ua p 100 a getto ba i motori allori. che. pur a\·cn 10 le uc on_ini pio iche all'i; Lero ra del rumeno Hcnri oanda( ). ebbe in Itali ma ed · in i e mplcto ·v1lupp chiaramen1•d•lincabile. riccr a pc c 1az10n v nnep nato infatti aduno ·mdiodi im alt enim oncreti nsullati applicathi ia daparte che di ioni e .

L·u1ilizzaz1on d · di qu 1ipo bbc Latn 1u11·altro che · ·zzabilcpervelo ilàdi r et Oe 00km!h. nellequahl"elt rea cl · 1ca perd• mare I effic richi do ruso di moton a p, di potenza e tremnm n ta
Un "alido mot r a, o ,are un ffica impie o per\' I ita equo1 opt.:rati, eh bb aie crnciali nella e ndona dei omba111m ou aereid Ila ·ec mia m

Tali prc tazioni vcngon i. con un rendimentopro· imo3quellodi un e ahem · 1gl1or ùi quello fi m1b1I da un turboge110pur da part dalle modem turbo, n1ol · Ilmot oreno apa edi fornire I piùaltepoh!nzeprc,. pul·ivc n ari p r n11: ub oni be. perI h�ndi poienza lòmib un co e di un mo1 reahemall\ toricameme parla motore · infani am al oderog �:! 1• mc P lenze · ili. ine dei .000 hp lo ne, primi ��1 O. 1� rendo a o e . hitcll ruttin: e ·olograzieaJI u dt p turbo mpr i · ion -r 1. · .., l•· forti pini reJt· . aa I poi I run mad•guat• p rouen ,... " Uve nchie te 1 ·od •� Gli il liani eran p and qu·li che. n l luneoP n °· �al d li uh n a•rea. m,1 comunque d1 cntalo cl .amp . e o prop .• ·nod d1 I mpo qu_al rebbcrop tull Itali app�u:aun ndbn!Hpc pn ·ilupp pin eh ed'' mrbogeiu.

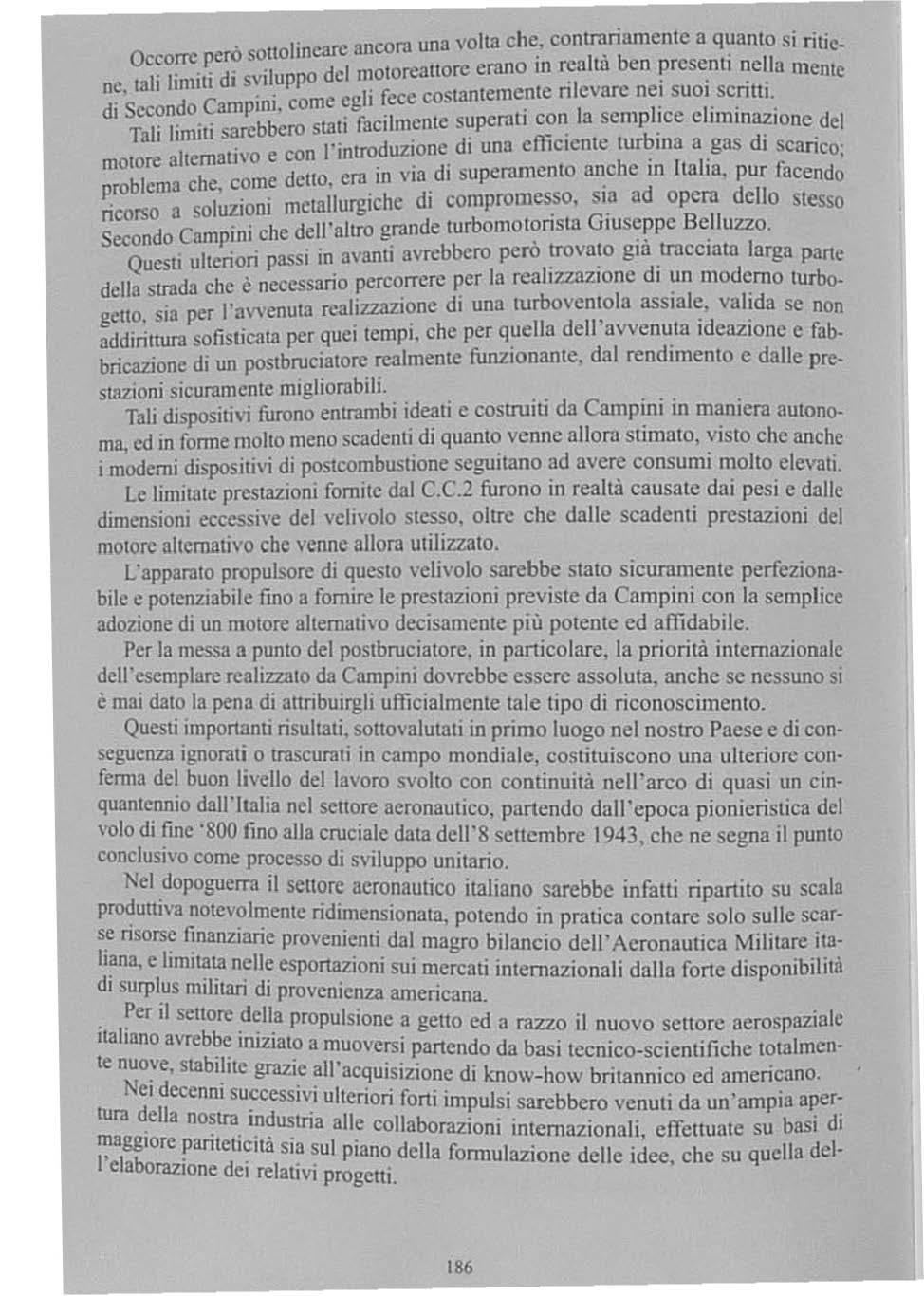
• . 1. ··"r'ancora una ,olla che. contrariamente a quanto si ritie- Occorre pero :.olio m.... e ' I . b . . . . . sv·lu del motoreattore erano an rea ta en presenti nella mente ne. tah hmtll da · 1 . ppo ·gli foce costantemente rilc,arc nei suoi scntti. d Sc·ondo Camp1m. come t: I 1· 1· .
1 1,; bb. stall facilmente superai i con a semp ice e 1minaz1one del Tah hmlll sare i.;ro . · b' · . . . on 1·mtroduzione d1 uno efficiente tur ma a gas d1 sconco: mo1ore allcmatl\O e c . . h . I 1· h dello ero in na d1 superamento nnc e m ta 1a. pur racendo problema c c. come . . . . . d . . . oluzt·ont mctallurg1che dt compromes:,o, sta a opera dello stesso ncorso a s · G· B 11 d e · ·che dell'altro grande turbomotonsta tuseppc e uzzo. Secon o amp1m . . . .
Q • 1 · pa5si m a, antl avrebbero pero tro, ato g1a tracctata larga pane ucsu u tenon 1. · d. d della strada che è necessario percorrere per la rea 1n.az1one I un mo cmo turbo• l'anenuta realizzazione di una turbO\c.!ntOla assiale. valtda se non getto. sin per . Il d 11· .d . addirittura sofisucat.a per quei tempi. che per q~e a e a, venuta I eaz1one e fabbricazione di un postbruciatore realmente funz1ooantc, dal read1mento e dalle presumoni sicuramente migliorabili. . . . . . . .
Talj ruspositwi furono entrambi ideati e costru1u da Camp~m in maniera autonoma. ed in forme molto meno scadenti di quanto venne allora sumato, visto che anche i moderni dispositivi di postcombusuooe segmtano ad avere consumj molto devau.
Le lim11ate pres1az1001 fomite dal C.C.2 furono in realtà causate dai pesi e dalle dimensioni eccess1\'e del , ·eli\'olo stesso. oltre che dalle scadenti prestazioni del mo1ore allcmam·o che venne allora utilizzato.
L'apparato propulsore di questo H!li\'olo sarebbe stato sicuramente perfezionabile e potenziabile fino a fornire le prestazioni previste da Campini con la semplice adozione di un motore altemau,o decisamente più potente ed affidabile.
Per la messa a punto del postbruciatore. in particolare. la priorità internazionale dell'esemplare realizzato da Campmi dovrebbe essere assoluta. anche se nessuno s1 è mai dato la pena di auribuirgli ufficialmente tale ttpo di riconoscimento.
Quesu importanti risultati. sotto\'alutati in primo luogo nel nostro Paese e di conseguenza ignorati o trascurati in campo mondiale. cosmuiscono una ulteriore confenna del buon lhello del lavoro svolto con continuità nell'arco di quasi un cinquantennio daJl'halia nel settore aeronautico, ponendo dall'epoca pionieris1ica del ,olo di fme '800 fino alla cruciale data dell'8 seltcmbre 1943. che ne segna il punto conclusi\'O come proce so di sviluppo unitario.
Nel dopoguerra il settore aeronautico italiano sarebbe infatti ripartito su scala produnJ\a ~otevolmente rid1mcns1ona1a, potendo in pratica contare solo sulle scars~ nsorse hnanziane provenienti dal magro bilancio dell':\cronautica \.filitare ilah~na, e hm1tata nell7esponazioni sui mercati internazionali dalla forte disponibilitò d1 surplus m1htan cli pro\'enienza americana.
. Per il seuore _deUa propuls1one a getto cd a razzo il nuovo senorc aerospaziale italiano avrebbe 1mz1a10 a muoversi partendo da basi tecnico-scientifiche 101almente nuove stabilite graz· Il' · · · . . · ie a acqu1s121one d1 know-ho,, britannico ed amencano. Nei decenni successivi ulteriori foni impulsi sarebbero venuti da un 'ampia apercura della nostra industna alle collaborazioni 1memazionali e!Tenuate su basi di maggiore p t · · ' r 1 b . an eticna sia sul piano della fonnulazionc delle idee, che su quella dele a orazione dei relauv1progen1.
186

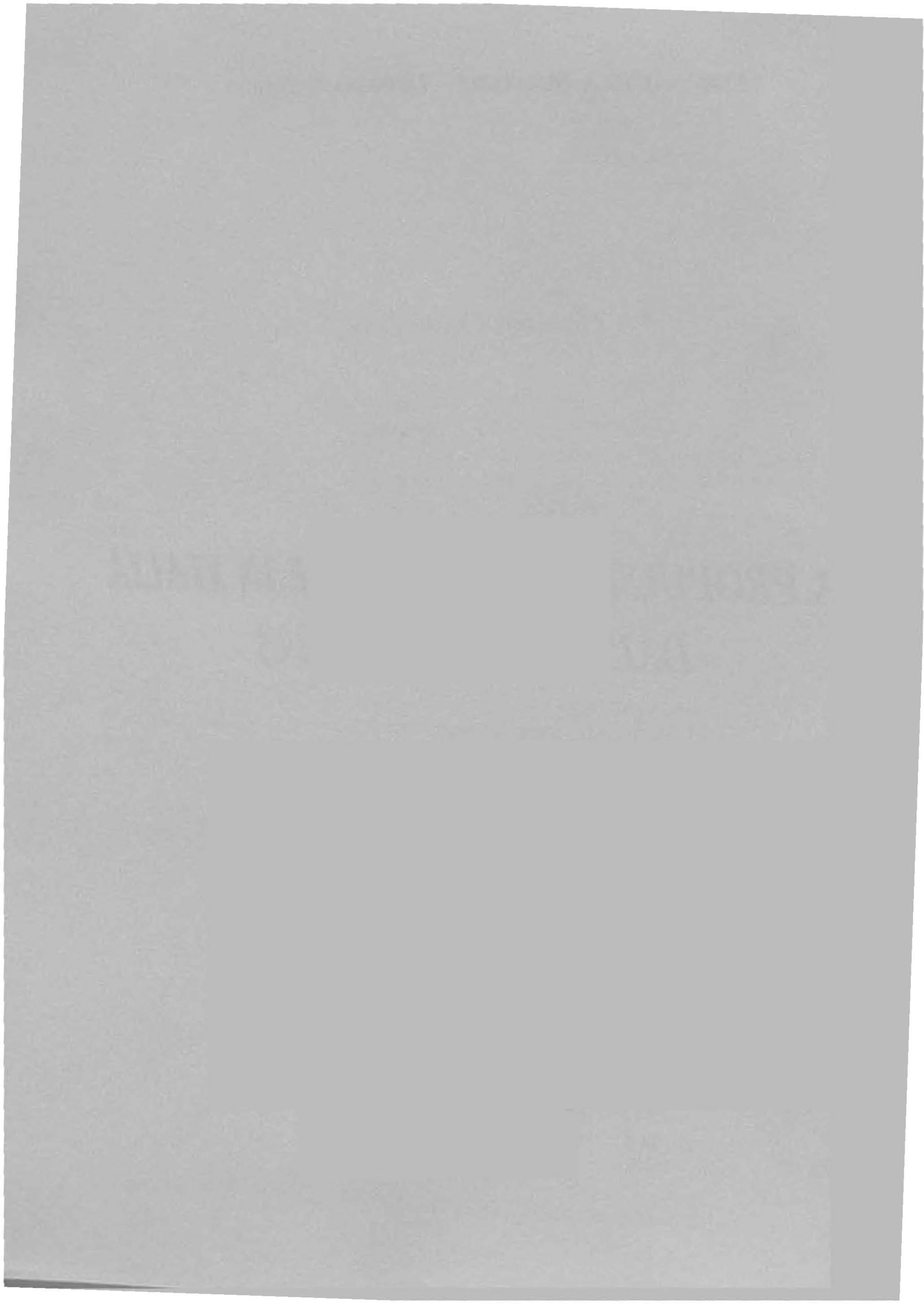

, ,1 · o· JI un1pipo Buscaglia e gli aerosiluranti Italiani. I) .\1chner 1v artU1 • e· -. \filano. Longanesi. 1969.
Nino: Lo Regia Aero11a111ica nella Il Guerra Alondiale. 1943. 11 :;:, Ufficio Storico Aeronautica Militare llaliana.) 995.
li Diego di Costabissara: Ricerca di 1111 propulsore aereo. "Rh1sta [taliann d'Aeronautica·•. Dicembre, 1916.
4) Belloni Angelo: Della migliore arma. "Ri\'ista Marittima". Ottobre-Novembre. 1921.
5) Belluzzo Giuseppe: Lo stato alluale del problema delle 111rbine a combustione interna. "L'Elettrotecnica". 15 Febbraio 1932.
6) Bemardi E.: u,, paradosso idrodinarmco.
Atti del R. Istituto Veneto. Pane Sl!COnda, 1903-1904. p. 1111.
71 Bignozzi, Catalanotto: Aerei d'Italia. Roma Edizioni Cielo, 1962.
8) Bol) M.: Essai sur la balistiqu'- de la fusée. \lemorial de !'artiglierie francaise. Paris. 1922. Tomo I. fase. 3 p. 638.
9) Bo~ Carlo Felice: / motori italiani per apparecchi d'alta velocità.
Ani del Convegno Volta. Roma, Reale Accademia d'llalia, 1935.
IO) Campini S d C . p econ o: onmbuto allo studio della propulsione a rea::ione . ..:;e Pnma; ~~lotori a geuo continuo. eronaultca •Agosto-Dicembre, 1930.
Il) Campini Scco d . S Il . ..1• \. • n o. " a teona del motopropulsore Campini. , cro1ecnica", n. I. 1938.
12) Campini Second . p. . . , . . "l'AI .. o. ,ospe111ve del/ av1a::1011e f11111ra. 0 , n. 2. 1948.
13, e ampm, Sccond . a· \filano ~ 1 d 0 • • iografia tratta da: Scie,dati e tecnologi co111empora11ei. • 1 " on adon. 1974.
BIBLIOGRAFIA
189

14) Cano,·cui Cosimo: Swdio di 1111 motore ad idrocarburo con appl,ca=ione della 111rbì11a "La1•a/". "Il Politecnico··. Luglio. 1905.
15) Canovclli Cosimo: S11/ propulsore a rt?a::ione direi/a e su/l'impiego dei ra==i. "L'Ala d'Italia". Settembre. 1931.
16) Ciampaglia Giuseppe:/ fratelli Tl'rig/11 e le loro macchine 1•ola111i. Roma, I.B.N.. 1993.
17) Ciampaglìa Gmseppe: E· scomparso Frank Whittle i11w111ore del motore a n:a::ione. ·•Ri\ista Aeronautica". n. 5, 1996.
18) Ciampagha Giuseppe: Roberto Bortini prog<!ltisto a Mosca. ·'RivistaAeronautica", n. 5, 1996.
19) Collier Webb Derek: Racket Allack. "Aeroplane Monthty•·. June-July. 1995.
20) Congrevc Wilham: A Tn:arise on 1/11: Generai Pri11ciples, Po1rers and Focility Applicotions of 1/1e Congf'l!l'e Racket systems. London, Longman, Recs. Orme, Brown & Grecn. 1841 .
21) Costanzi Giulio: Cì11quo11te11nio del/ 'a-via:ione italiana. I. 'apporto italiano alla tecnica aervnamica. "Rì\'1sta Aeronautica". 1959.
22) Corelli Riccardo \.1.: Note sulla dccomposdo11e isotem1ic:a del nitrometano i: .mo 111ili=a::io11e. ··LaChimica e l'Industria". 12. 1949.
23) Cremona Cesare: ll sorgere del/ 'industria per le attività spa:iali. "\1ìssili". 8, 1962.
24) Croceo Gaetano!\.: J.fi.ui/i Geodetici . ..Missili". 3, 1959.
25) Croceo Gaetano A.: Doli ·a111iaen:o alla base orbitale. '•Missili". 4, 1961.
26l ~~co Gaetano A.: La ricen:a aeronautica in Italia nel passato nel preseme e nelji1111ro. L ·\ero1ecmca". 1952. pp. 302-307.
27) :rocco Gaetano.-\.: Instniction und Researc:h i11 Jet Prop11/sio11. Joumal ofAmcncan Rockcl Society". March, 1950.
28) Croceo GacLano A. Opere Pubblicate a cura dcli'Accademia Nazionale dei Lincei, Roma. 1978.
190
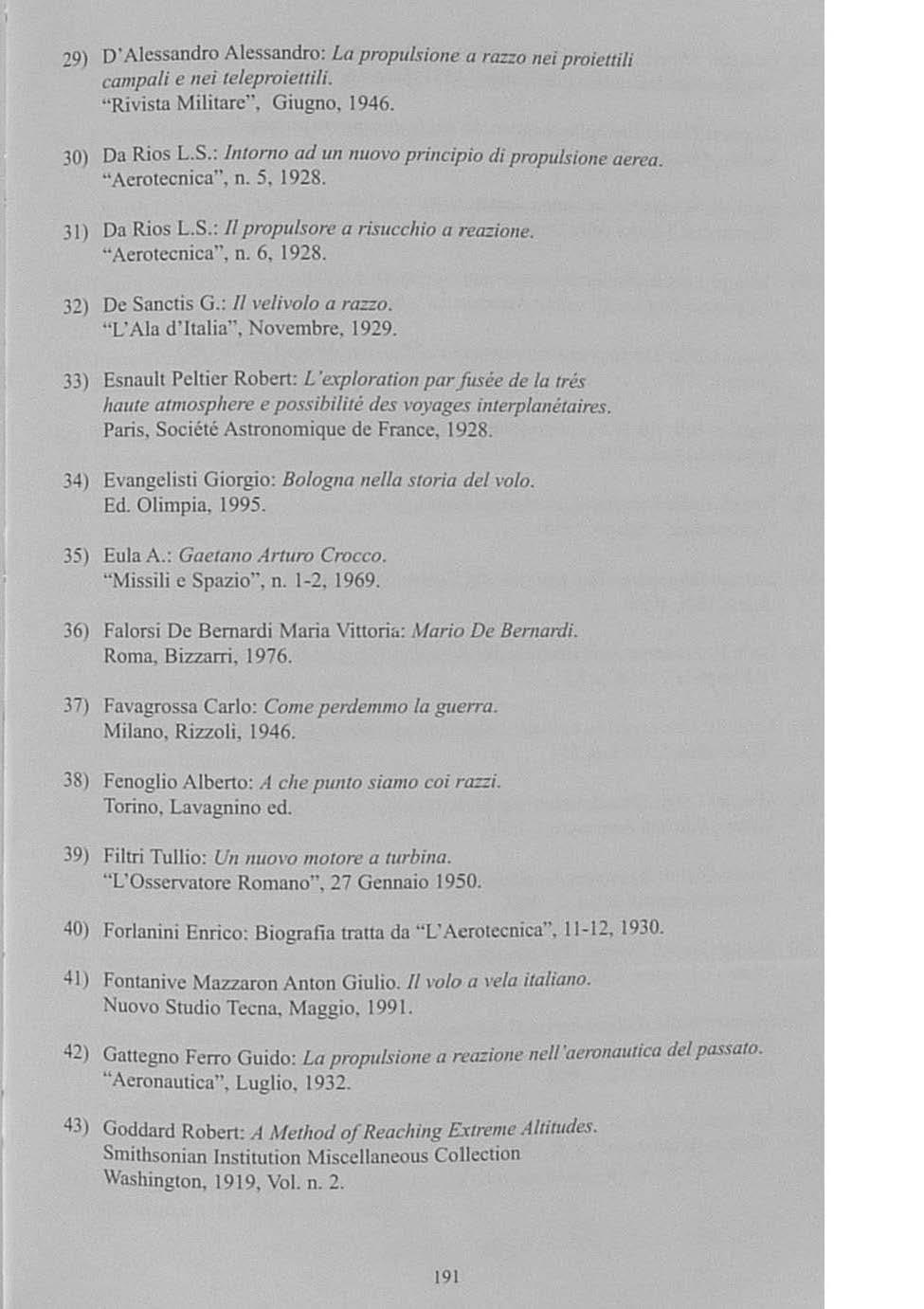
29) D'Alessandro Alessandro: La propulsione a ra::=o nei pro,eui/, campali e 11ei teleproieui/i. "Rivista Militare'', Giugno, 1946.
30) Da Rios L.S.: Intorno ad un nuovo principio d, propulsio11e aerea. "Aerotecnica". n. 5. 1928.
31) Da Rios L.S.: Il propulsore a risucchio a rea::ione. ··Aerotecnica", n. 6. 1928.
32) De Sanctis G.: li velfrolo a ra=o. "L'Ala d'Italia". ovcmbrc. 1929.
33) Esnault Pclticr Roben: L 'exploration par fi,sée d, la trés /,aute a1111ospherc t' possibilité des royage.t mterp/anétaires. Paris. Société Astronomique dc France. 1928.
34) Evangelisti Giorgio: Bolog110 nella stona ciel 1·0/0. Ed. Olimpia. 1995.
35) Eula A.: Gaeta110 Arturo Croceo. "Missili e Spazio". n. 1-2. 1969.
36) Falorsi Dc Bemard1 Maria \'iuori:.: \Iorio De Bemanli. Roma. Bizzarri. 1976.
37) Fnvagrossa Carlo: Comt: perdemmo la gue"a . Milano, Rtzzoh. 1946.
38) Fcnoglio Alberto: A che p1111lo siamo coi ra=i. Torino. Lavagnino cd.
39) Filtri Tullio: U11 111101·0 motore a 111rb111a. "L'Osservatore Romano", 27 Gennaio 1950.
40) Forlamm Enrico: Biografia traila da "l'Acrotecmca". 11-12.1930.
41) Fontnnh·c Mazzaron Anton Giulio li l'olo a nda italiano. Nuovo Studio Tecna. Maggio. 1991.
42) Gattegno Ferro Guido: La prop11/sio11e a n·a::io11e 11elf 'aero11a111ica cld passato . "Aeronautica". Luglio. 1932.
43) Goddard Robert: A Merhocl oj Reaching Extreme ,Uriwdes Smithsonian lnstituuon Miscellaneous Cotlection Waslung1on. 1919. Voi. n 2.
191
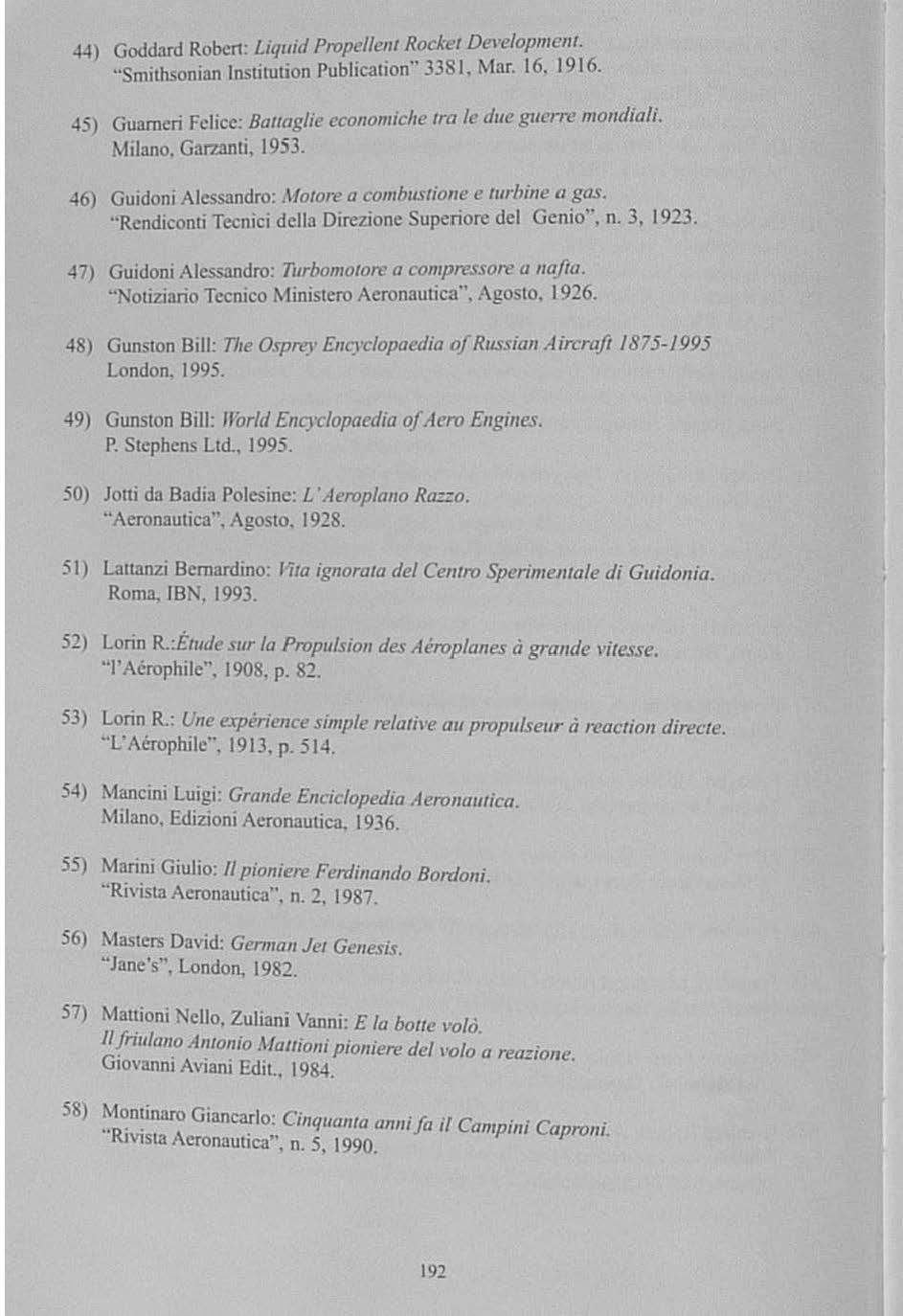
M) Goddard Robert: liq11id Propellem Rocker Developmellf. "Smilhsonian lnstitutfon Publication" 3381, Mar. 16. 19I6.
45) Guacneri Felice: Borraglie ecoflomiche tro le due guerre mo11dioli. Milano. Garzanti, 1953.
46) Guidoni Alessandro: ,\!lotore a combustione e t11rbi11e o gas. "'Rendìconti Tecnici della Direzione Superiore del Genio'·. n. 3. 1923.
47) Guidoni Alessnndro: Turbomotore a compressor11 a nafta. "Notiziario Tecnico Ministero Aeronautica"', Agosto, 1926.
48) Gunston Bill: Tlte Osprt!)' E11cyclopoedio ofR11ssia11 .-lircrafi 1875-1995 London. 1995.
49) Guns1on Bill: llòrld Encyclopaedia ofAero E11gù1e.s. P. Stc.:phcns LtcL. 1995.
50) Joni da Badia Polesine: l '.-leroplano Ra:::.o. "'Aeronautica". Agosto. 1928.
51) Latta.ozi Bernardino: l'ira ignorata del Cemro Sperime111ale di Guidonia. Roma. lBN, 1993.
52) lorin R.:Étude s11r la Propulsio11 de.s Aéruplanes à grande 1•iresse. "'l'Aérophilc", 1908. p. 8'.!.
53) Lorin R.: Une e.rpérience simple relatil'e au prop11/se11r à reoction directe. "'L"Aérophile... 1913, p. 514.
54) Mancini Luigi: Grande Enciclopedia Aero11amica. Milano, Edizioni Aeronautica. 1936.
55) Marini Giulio: li pioniere Ferrli11a11do Bordofli. -1uyistaAeronauijca", n. 2. 1987
56) Ma:stèrs David: Gemm.11 Jet Ge11esis. "Jnne's", London, 1982.
57) Mat~onì Nello. Zuliani Vanni: E la botte volò. li fn11la11_0 A~to11io Mo111011i pioniere del l'O/o o reazione. Giovanni AVJani Edit., 1984.
58) M~n~inaro Giancarlo: Ci11q11a11ta an11i fa ìf Campi11i Caproni. R1v1Sta Ac.:ronauùc.i", n. 5, 1990.
192
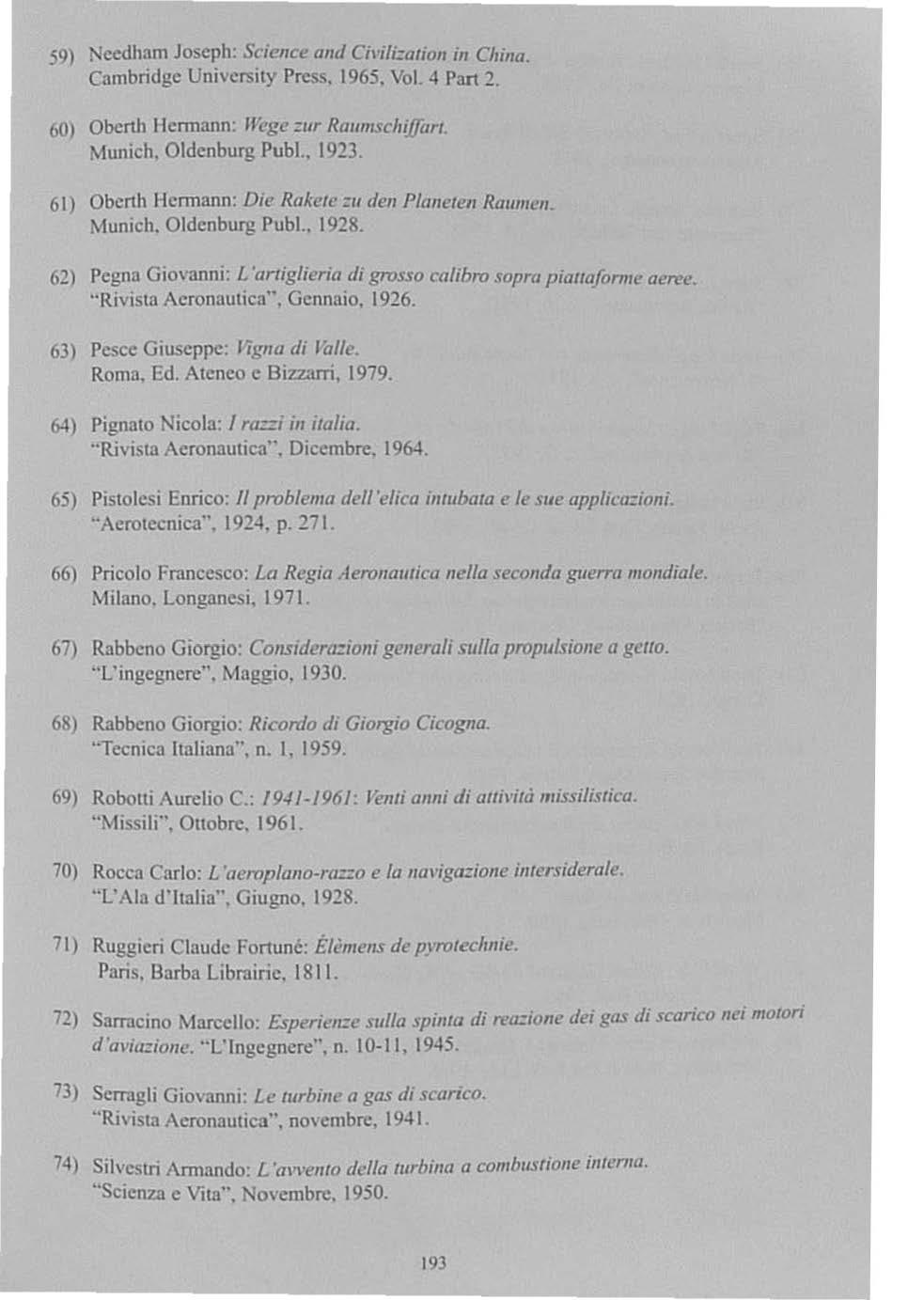
59) Necdham Joseph; Science and Civili=atio11 in China. Cambridge University Prcss. 1965, Voi. 4 Pan 2.
60) Oberth Ilennann: IJ'egc =11r Raumschiffart. Munich, Oldenburg Pubi.. 1921
61) Obcrth Hcnnann: Die Rakete =11 den Planete,1 Ra11111en. Mumch. Oldcnburg Pubi.. 1928.
62) Pegno Giovanni: l'artiglieria d, grosso calibro sopra piattafonm.: aeree. "Rivista Acronau1ica•·, Gennaio, 1926.
63) Pesce Giuseppe: Vigna di la/le:. Roma, Ed. Ateneo e Bizzarri, 1979.
6-1) Pignato Nicola: I rll==i in ,talia. "Rivis1a Aeronautica... Dicembre. 196-t
65) Pistolesi Enrico: Il problema cieli 'elica imubaJa e le s11e app/ica:umi ..Aerolccnica". 1924. p. ::!.71
66) Pricolo Francesco: la Regia -leronamica nella seconda gu.:"a 111011dia/e. Milano. Longanes1, 1971.
67) Rabbcno Giorgio: Comidera:,om generali sulla prop11/sio11e a getto. "L'ingegnere". Maggio. 1930.
68) Rabbeno Giorgio; Ricordo di Giorgio Cicogna. "Tecmca Italiano". n. I. 1959.
69) Robotu Aurelio C. 19./1-/96/ l'én11 anni di attil'ità missilistica. "Missili'', Ouobre. 1961.
70) Rocca Carlo: l 'aeroplano-r<E::o e la naviga=ione Ìllll!rsiderale ''L'Alo d'halio". Giugno. 1928.
71) Rugg1en Claudc Fortune: Élèmens de pl'rolechme. Pans. Barba Librainc. 1811.
72) Sarmcino Marcello: Espemm=c sulla spinta di rea::io11e dei gas di scarico nl!i motori d'avia=ione. ·•L'Ingegnere". n. 10-11, 1945.
73) St.."TTagh Giovanni' le turbim n gas di scarìco. "Riv1s1a Acronau1ica". no\'embrc. 19-41
74) Silvcsu, Armando: L ·av,·ento della turbina a comb11srio11e inrenw. "Scienza e Vi1a". ovembre. 1950.
193
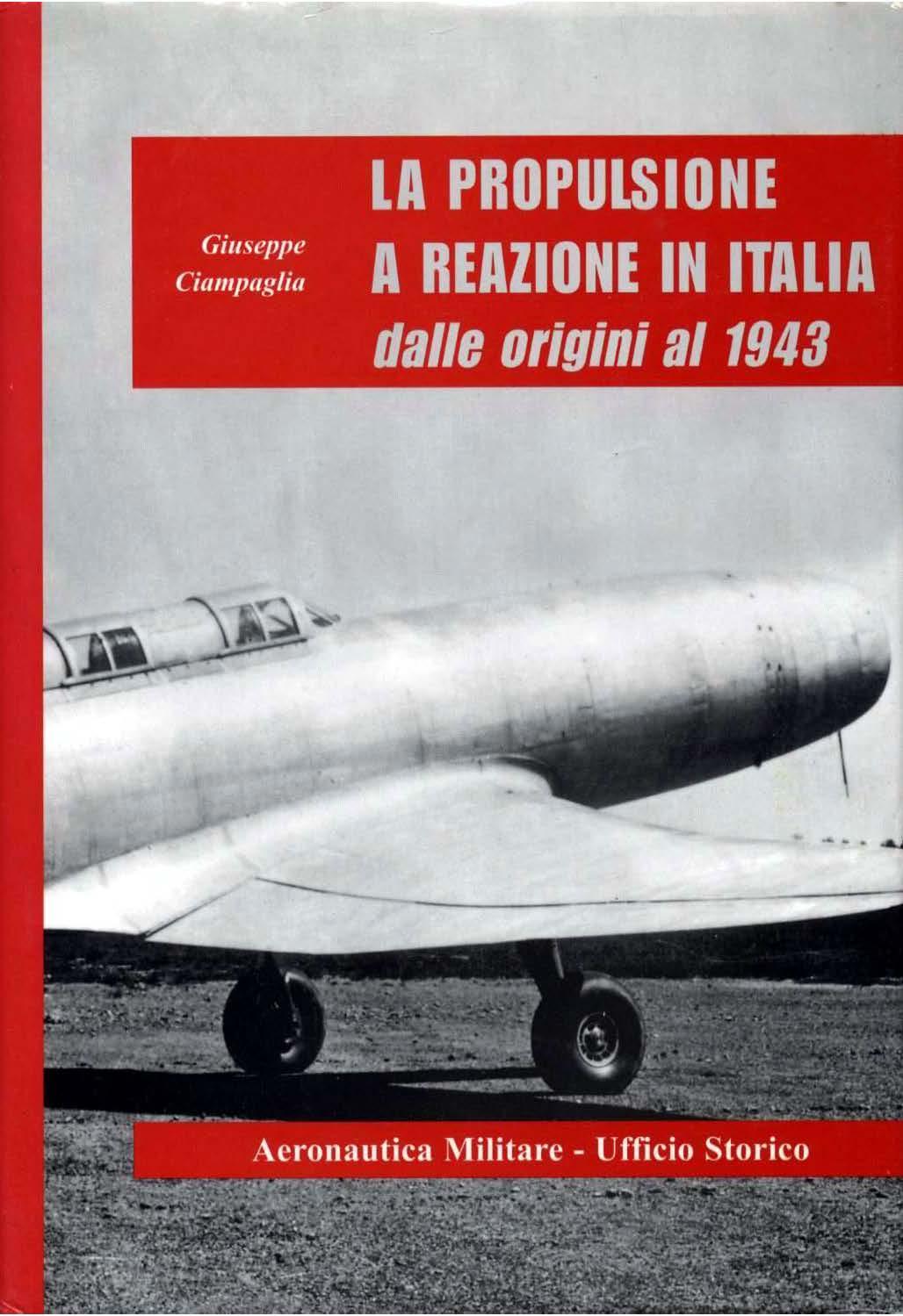






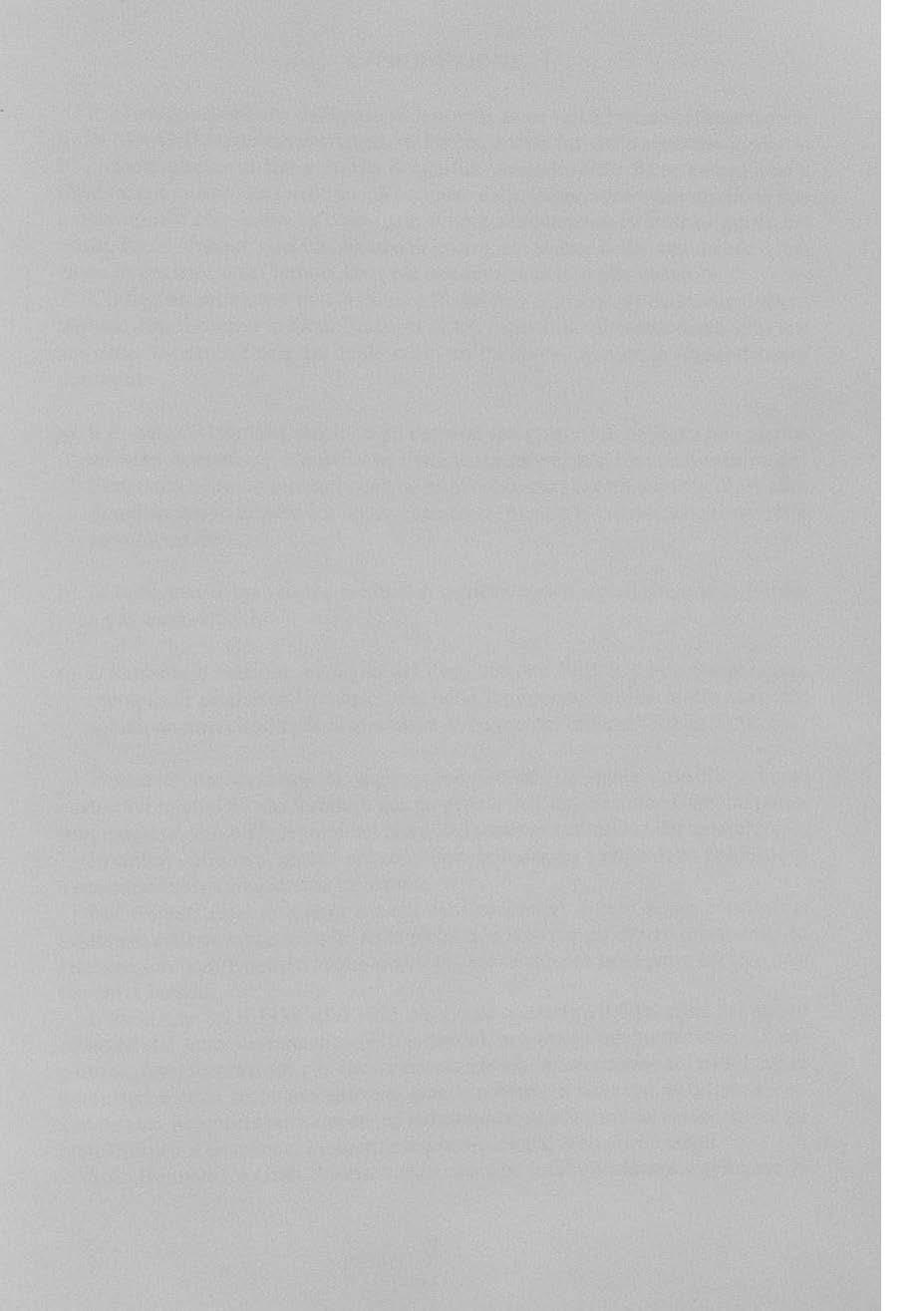
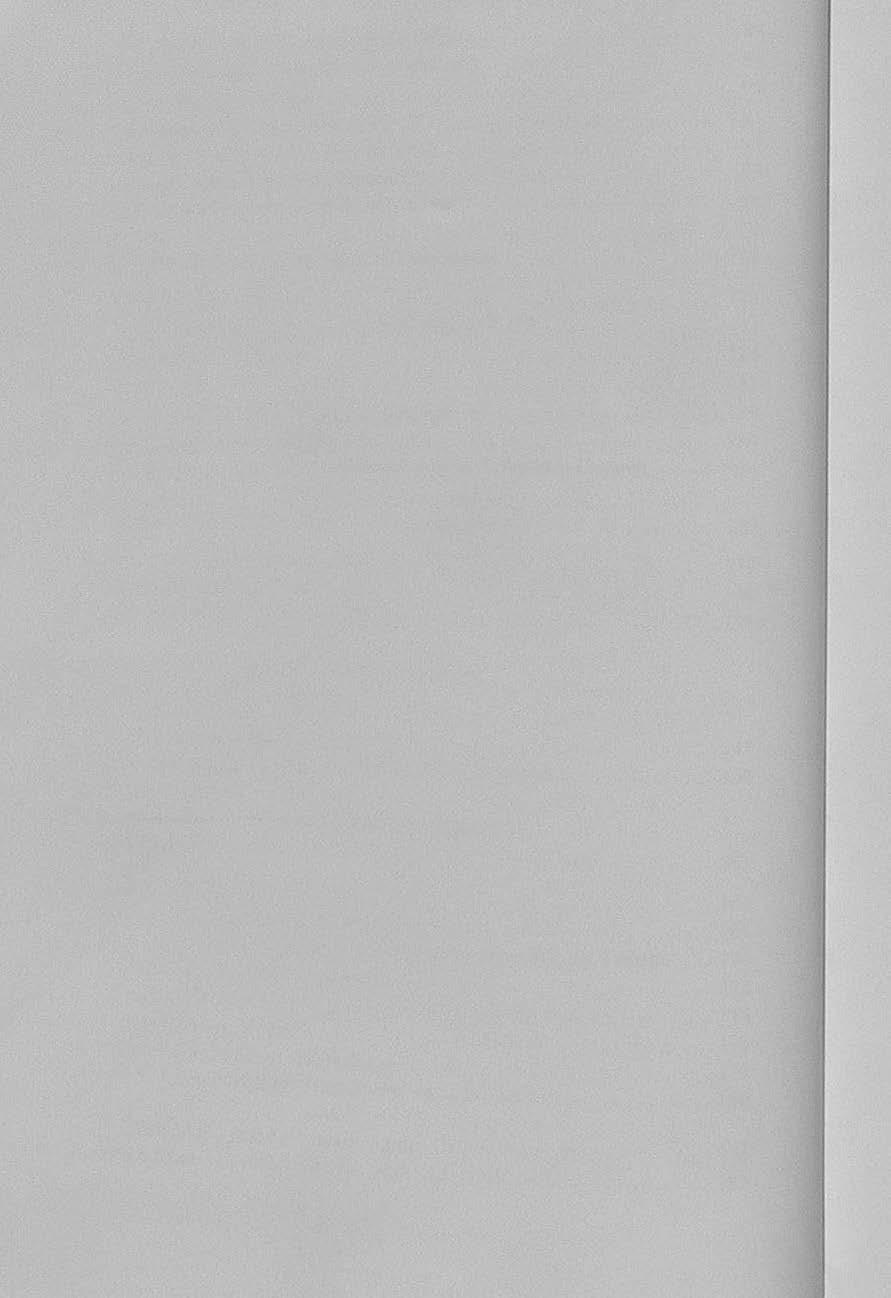
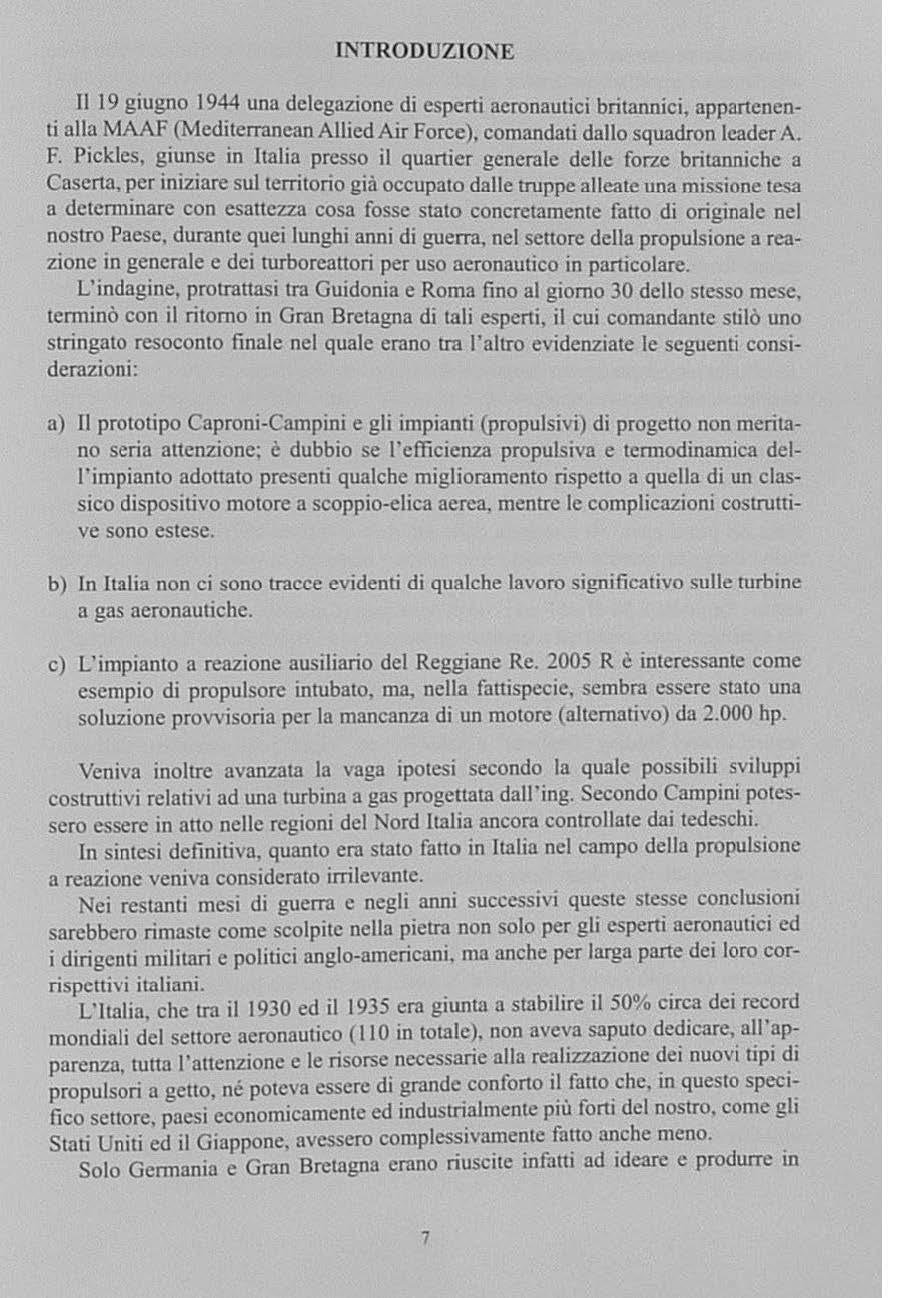
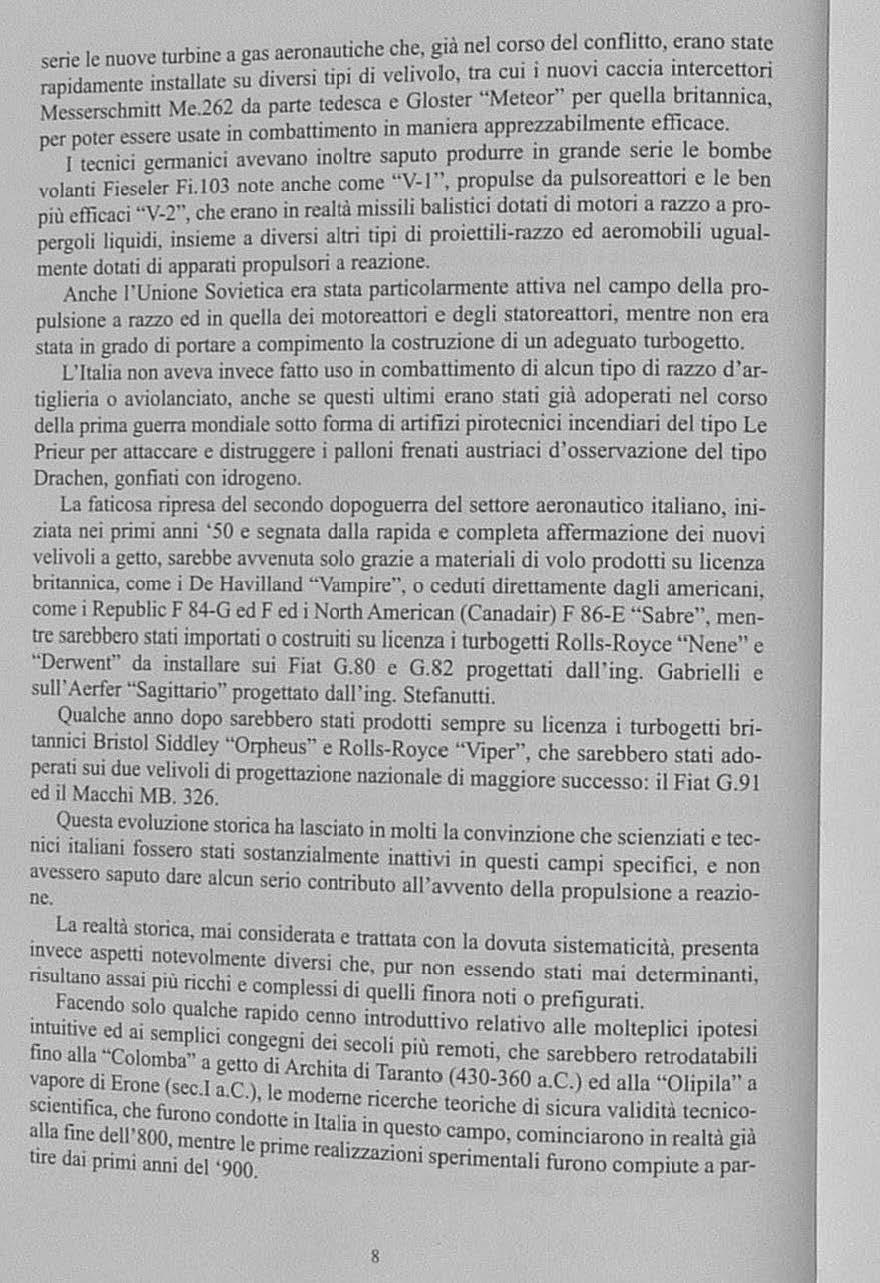




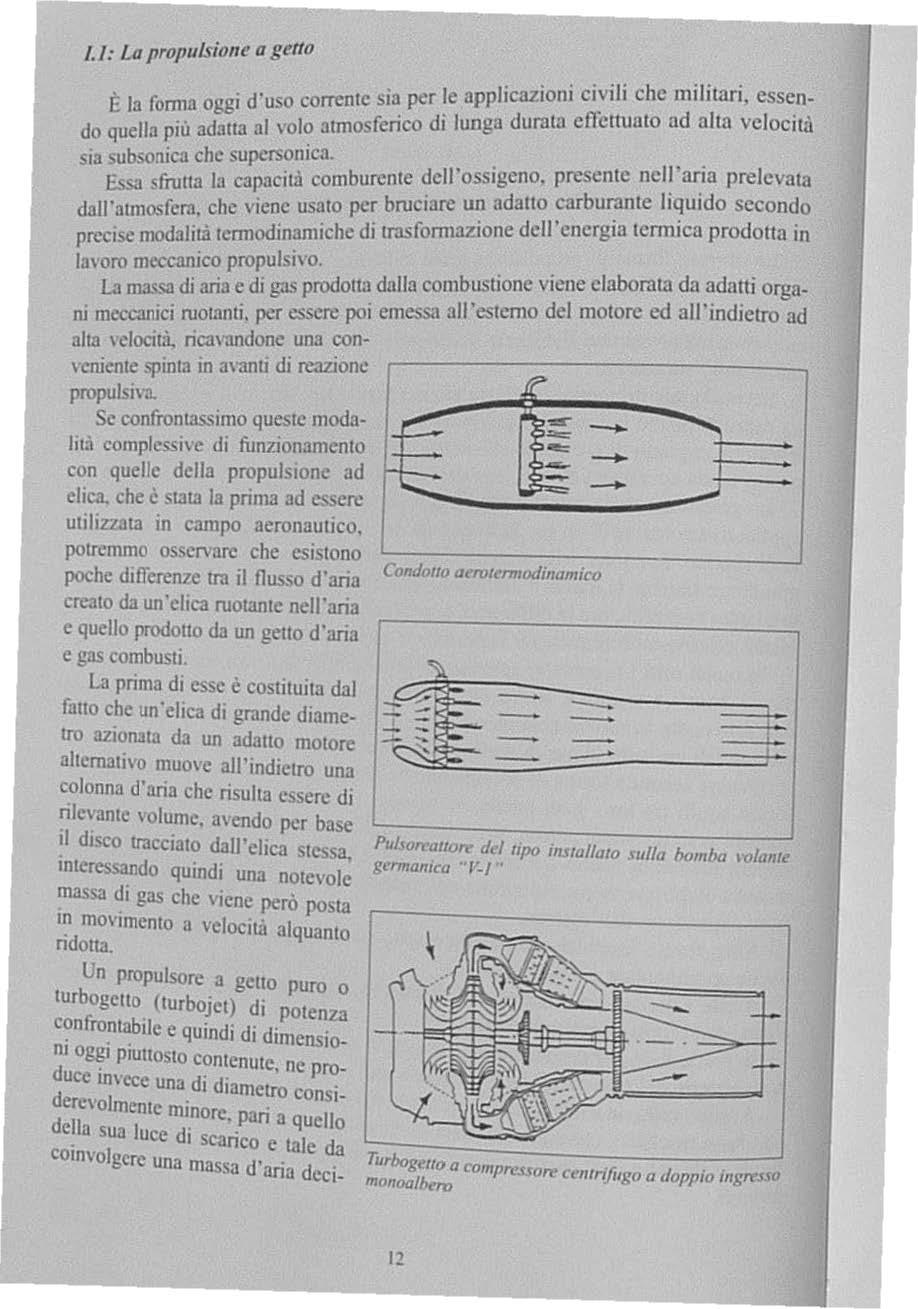
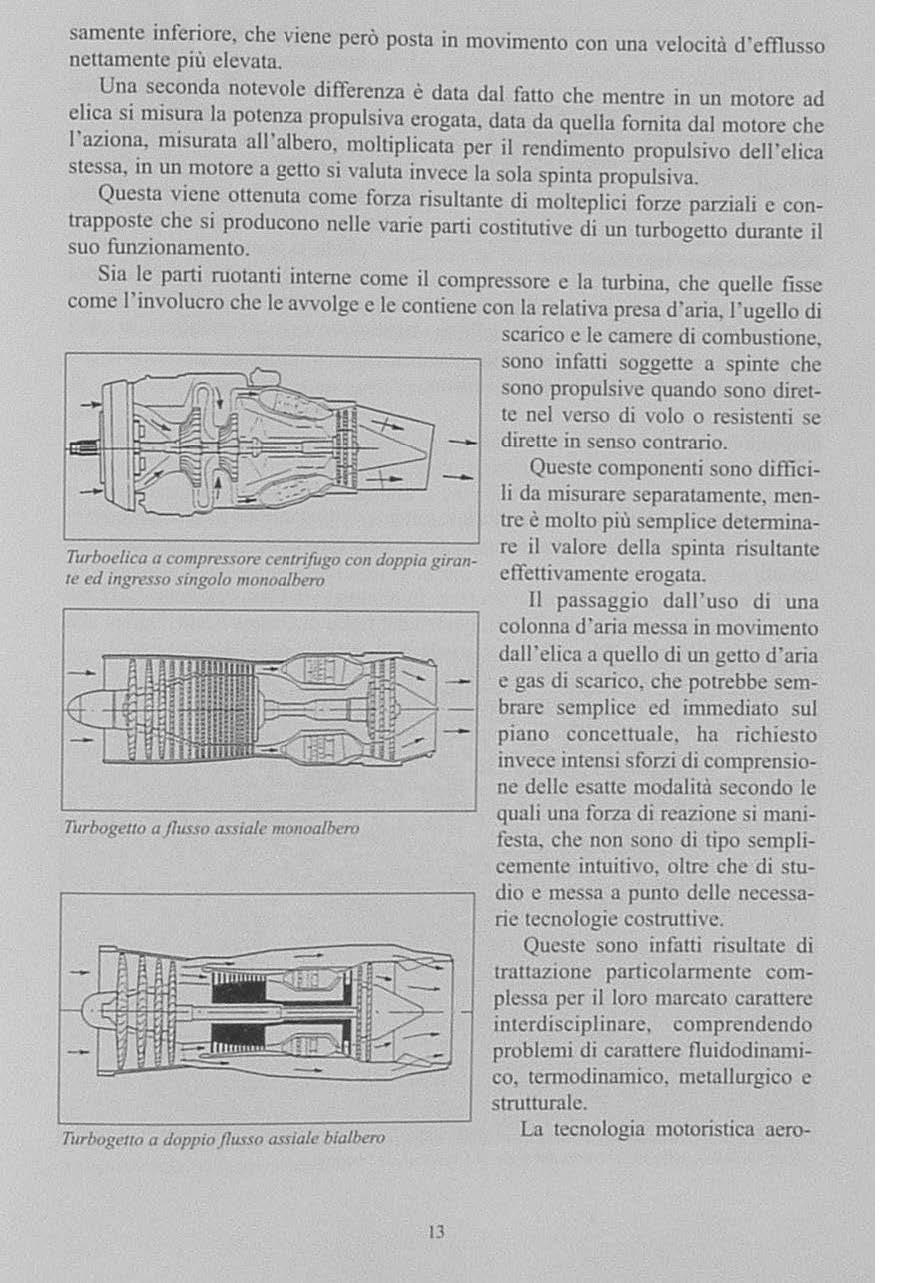





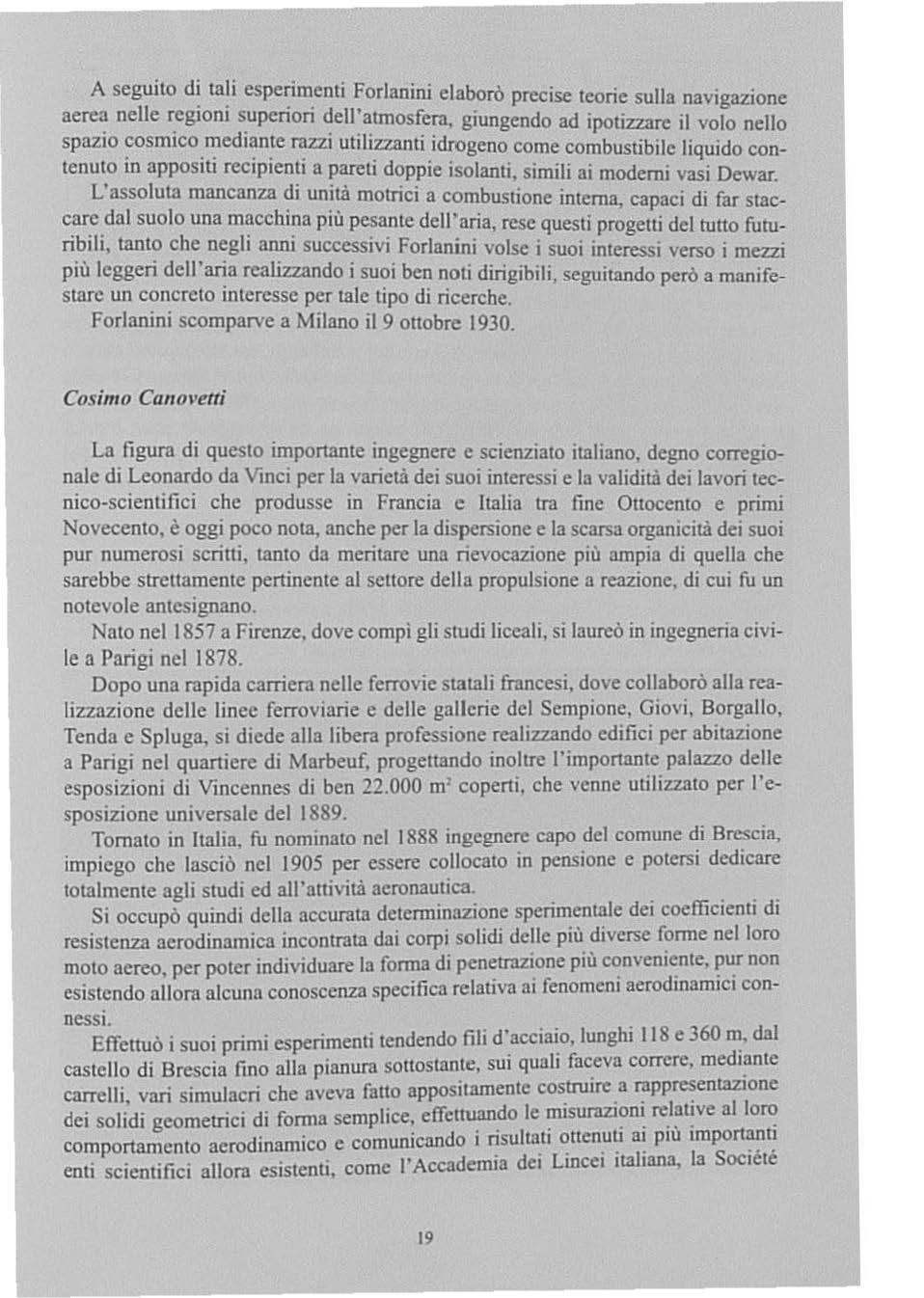
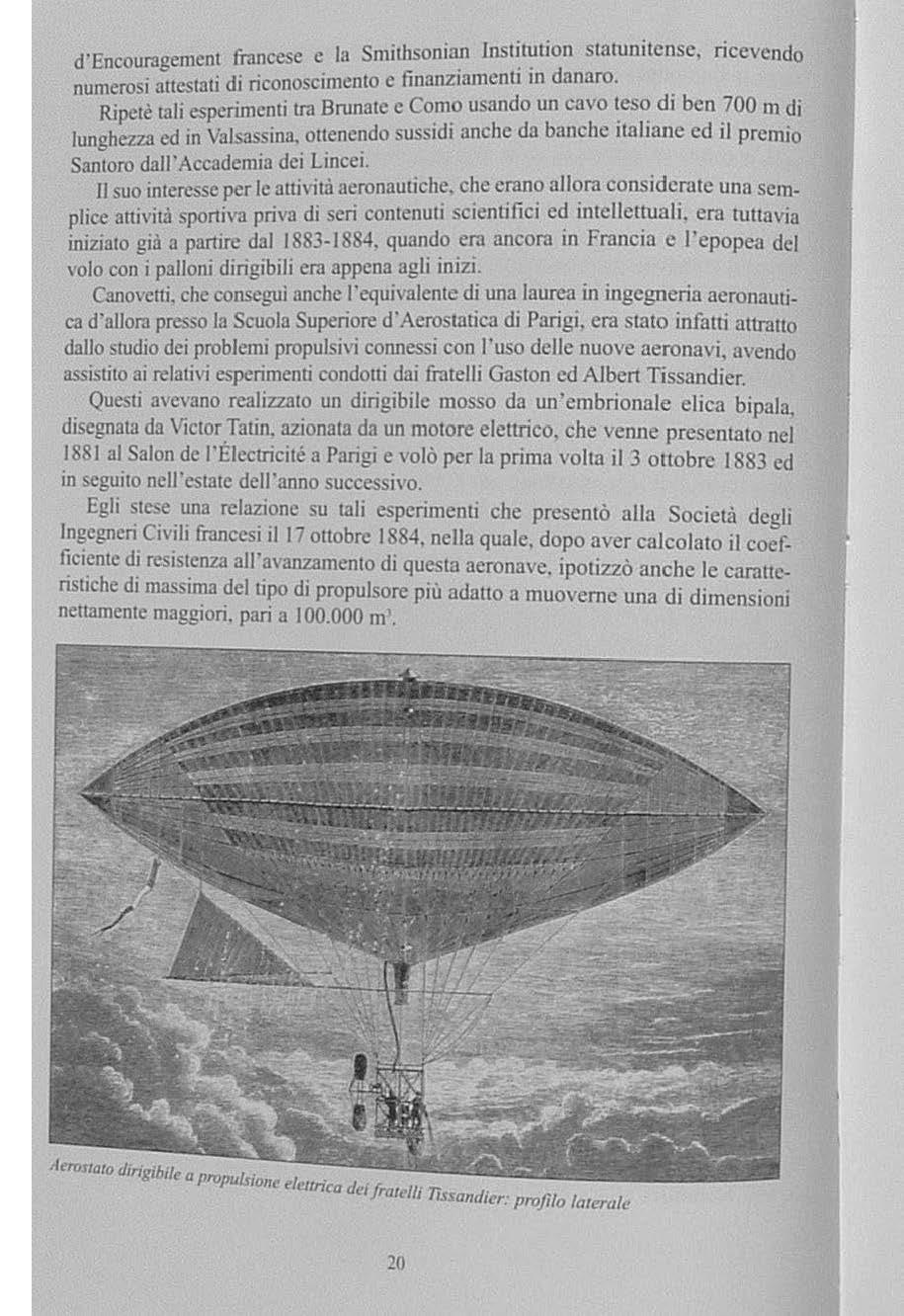
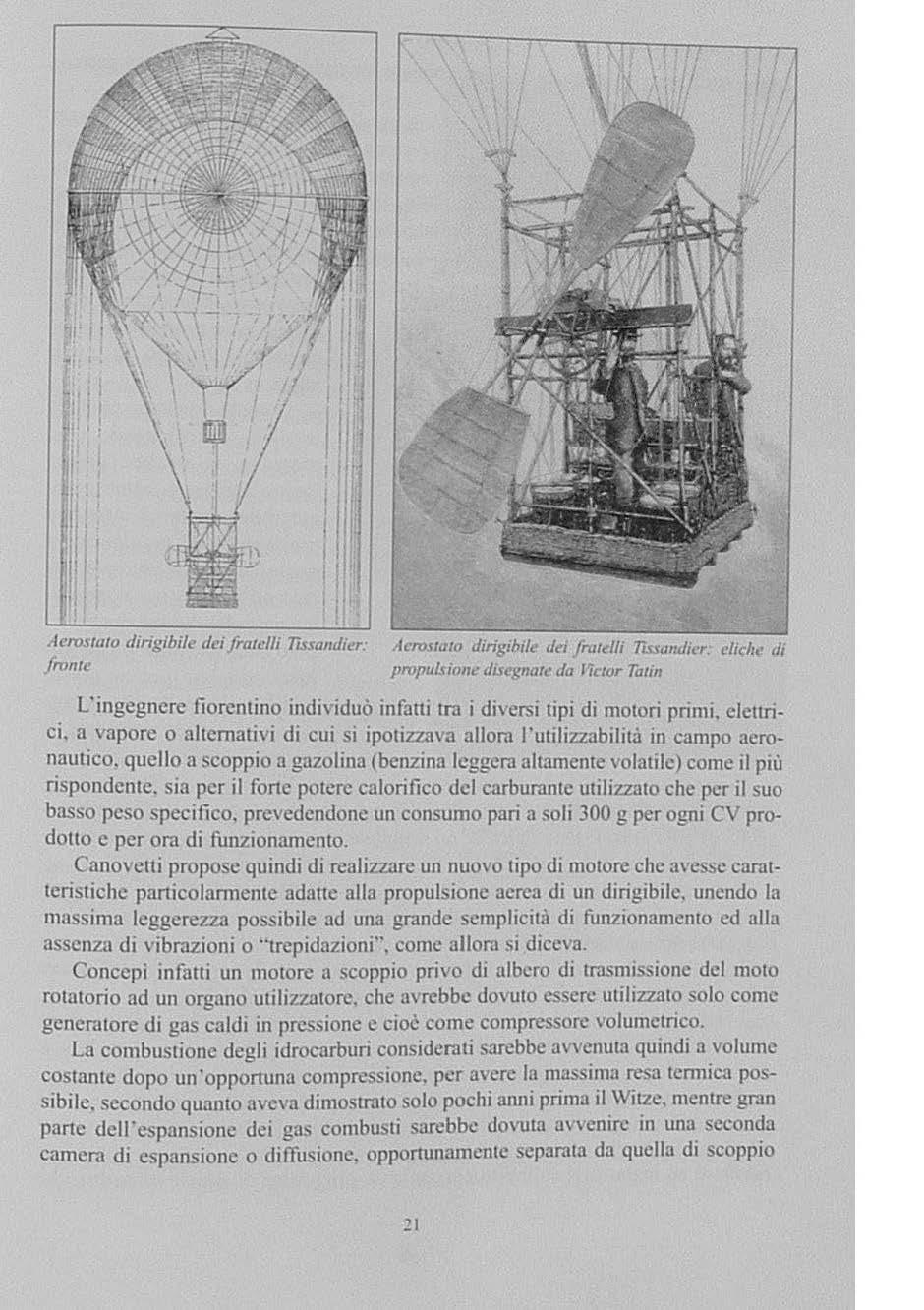
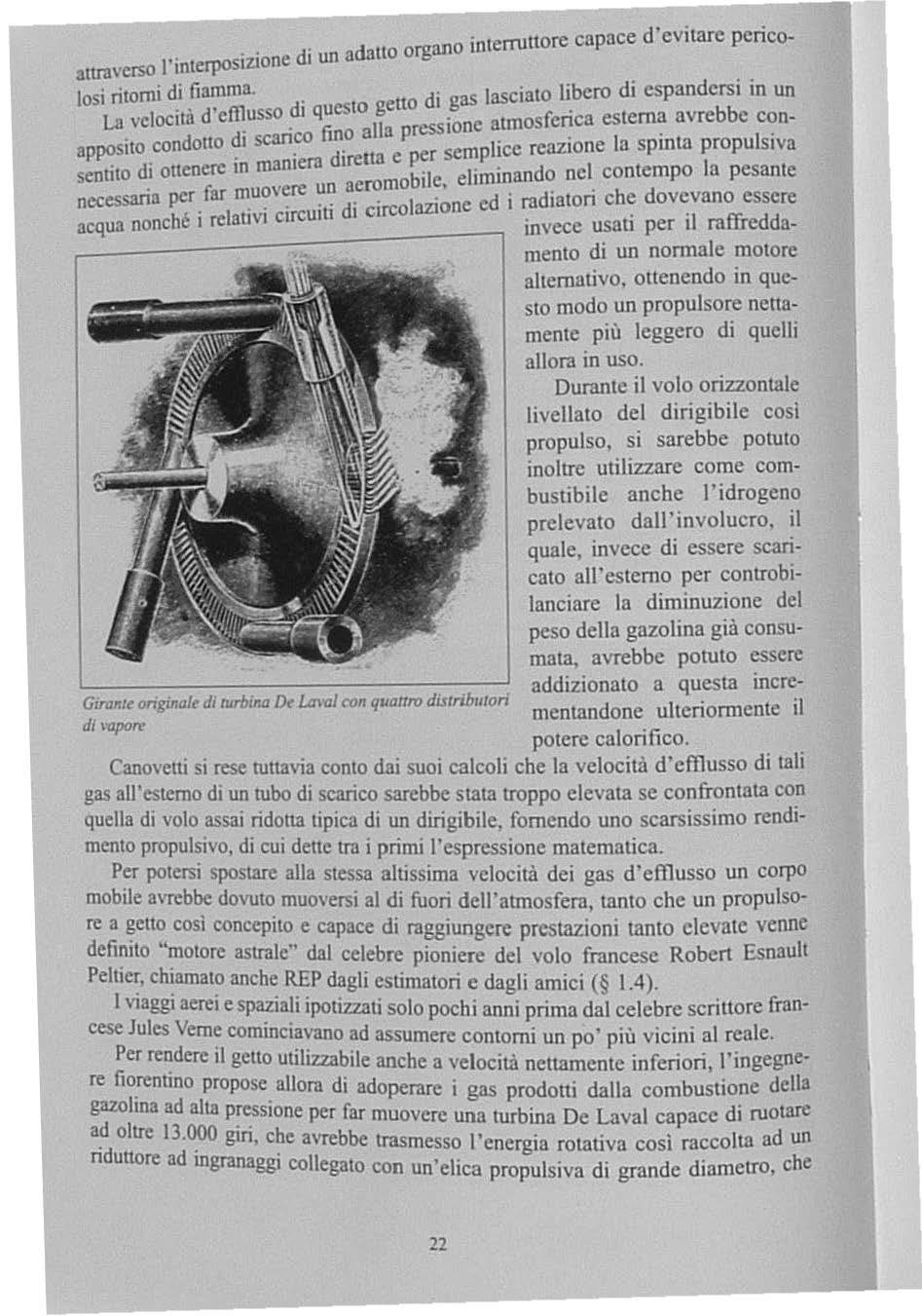
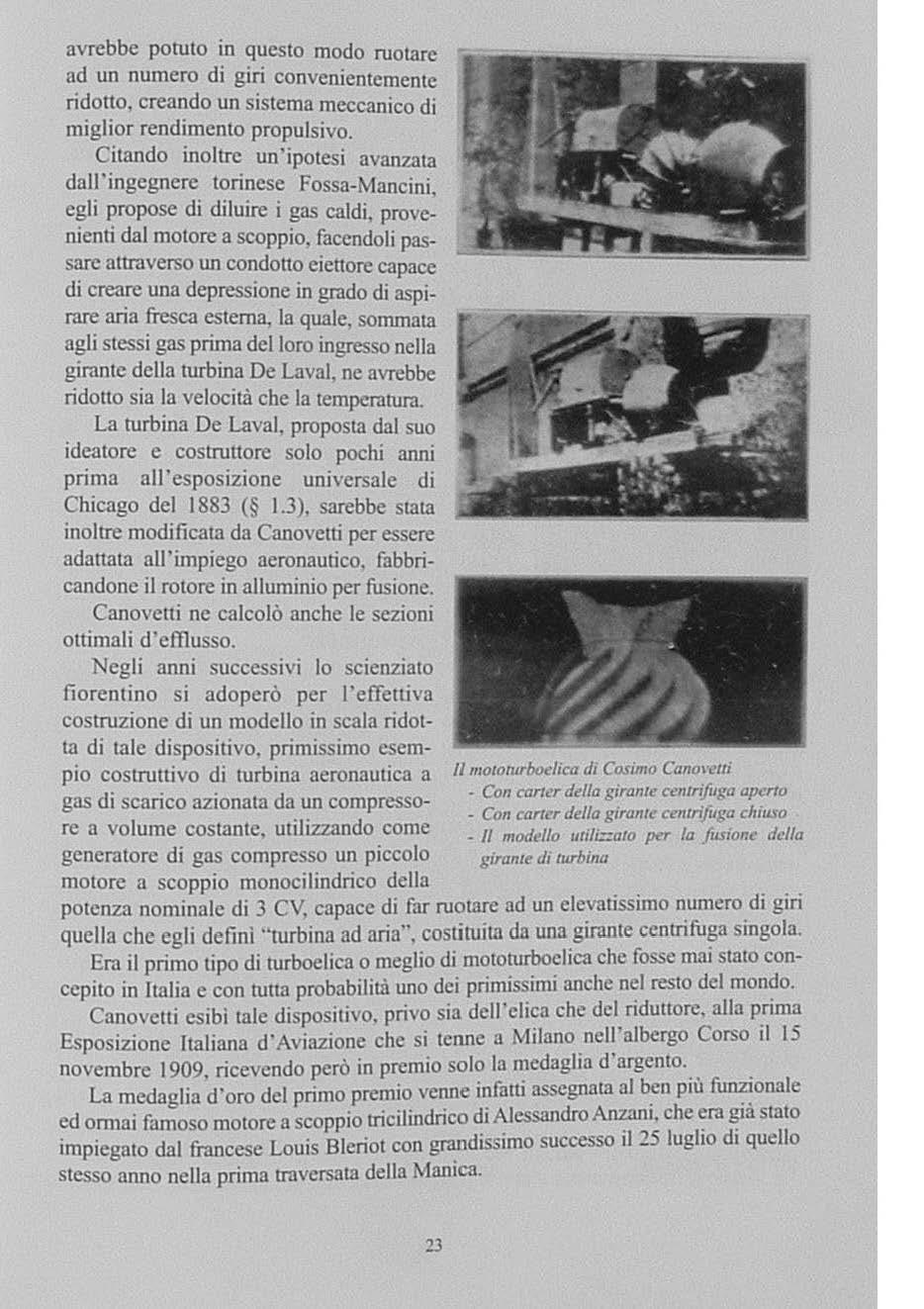
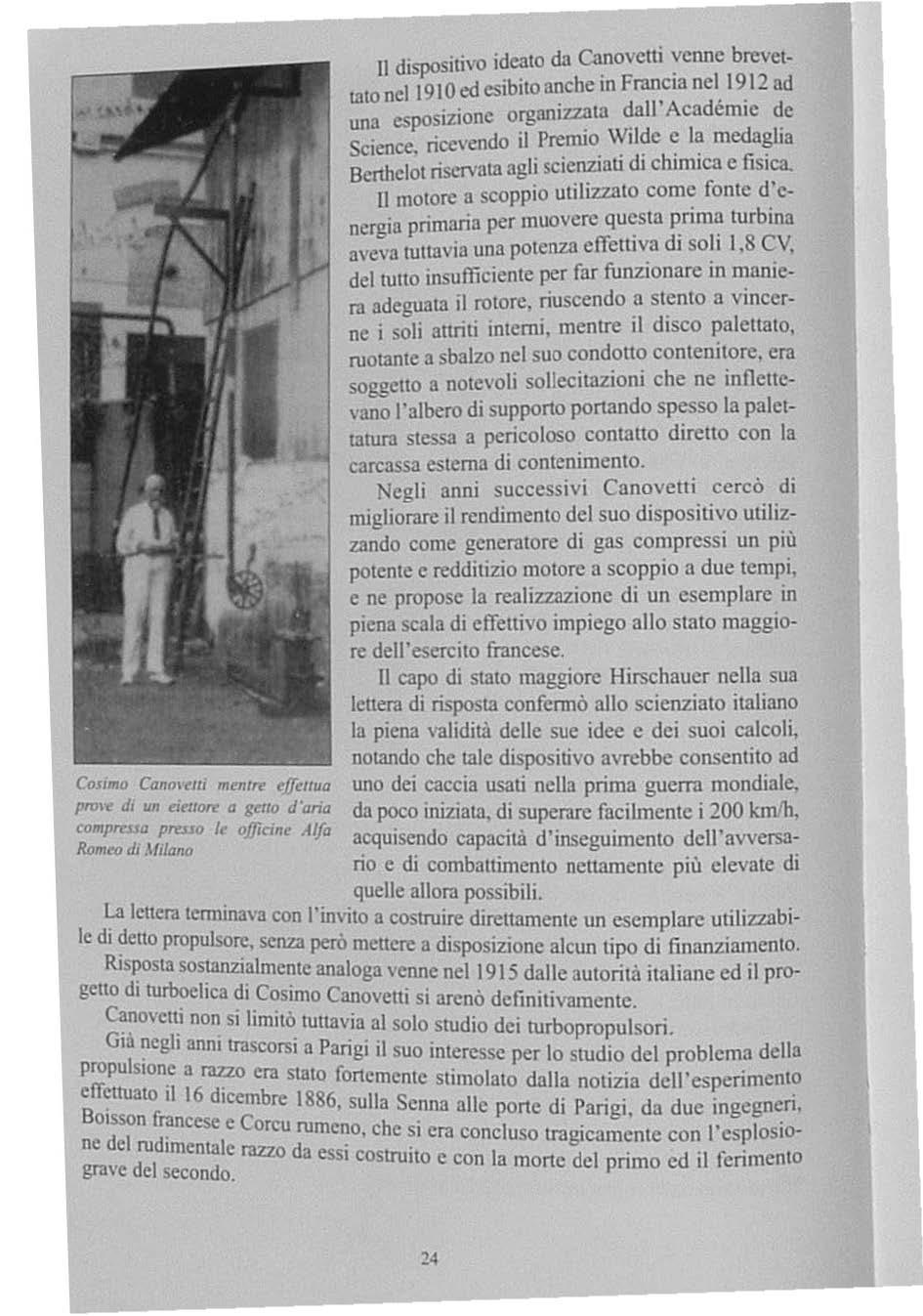


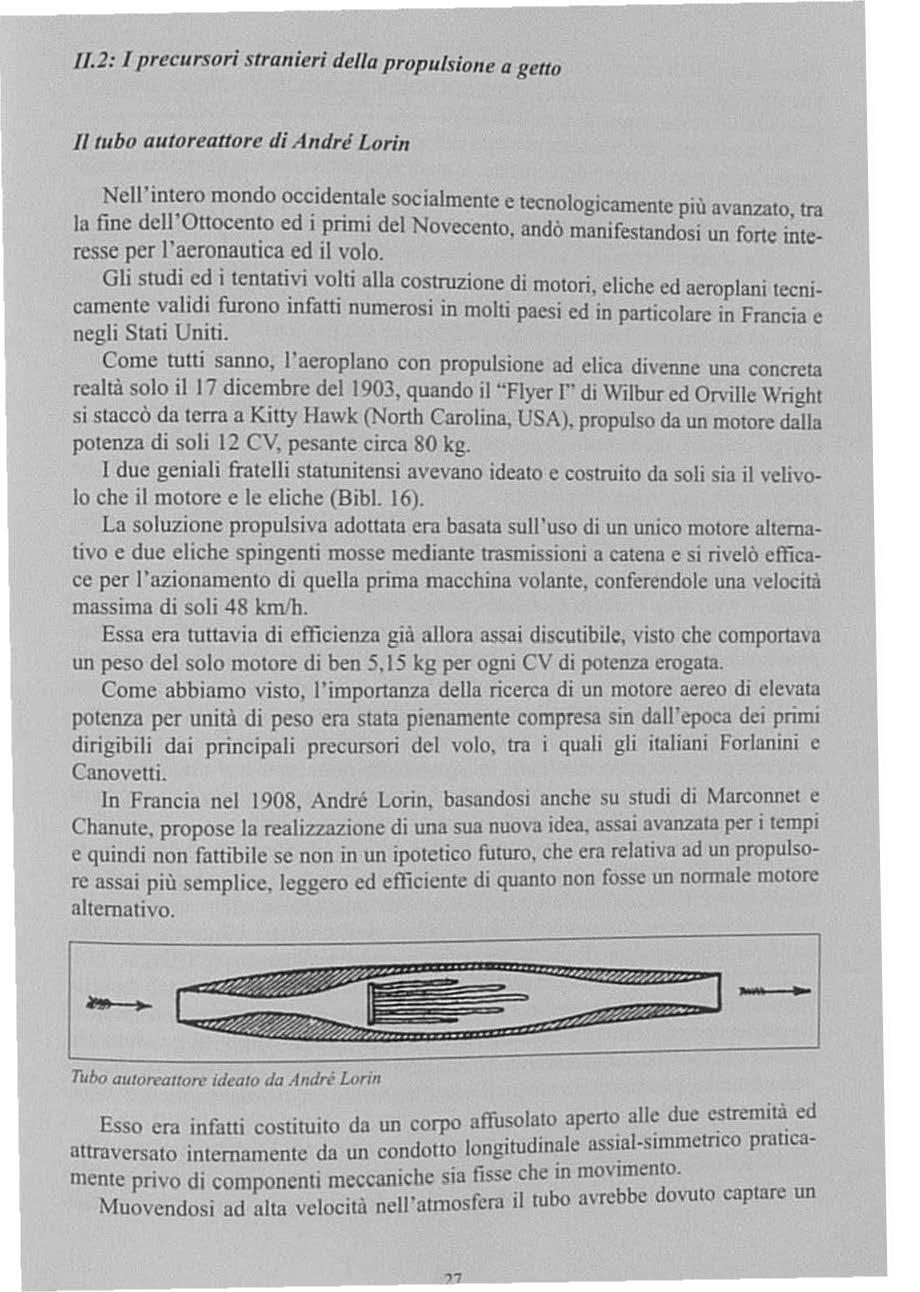
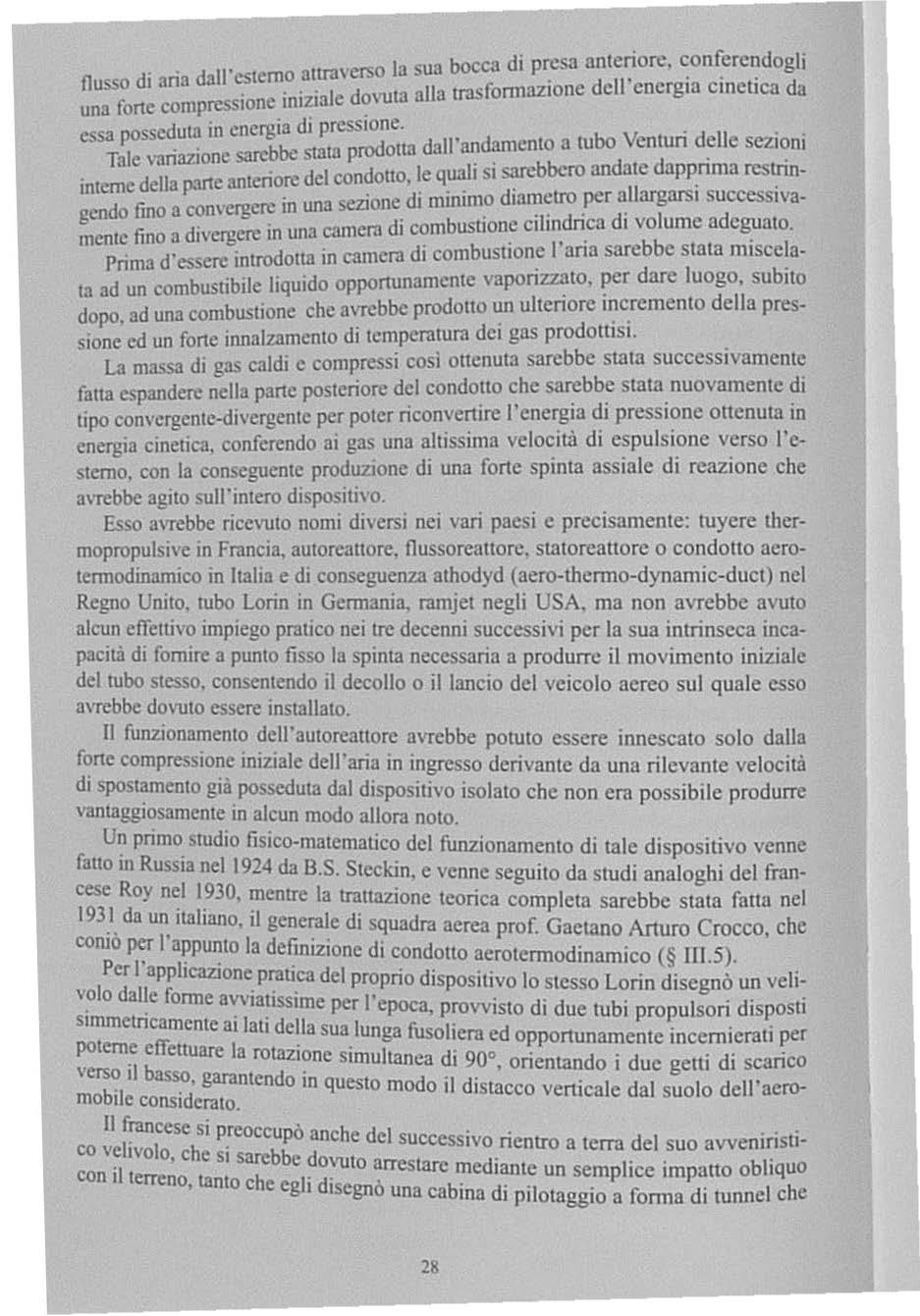

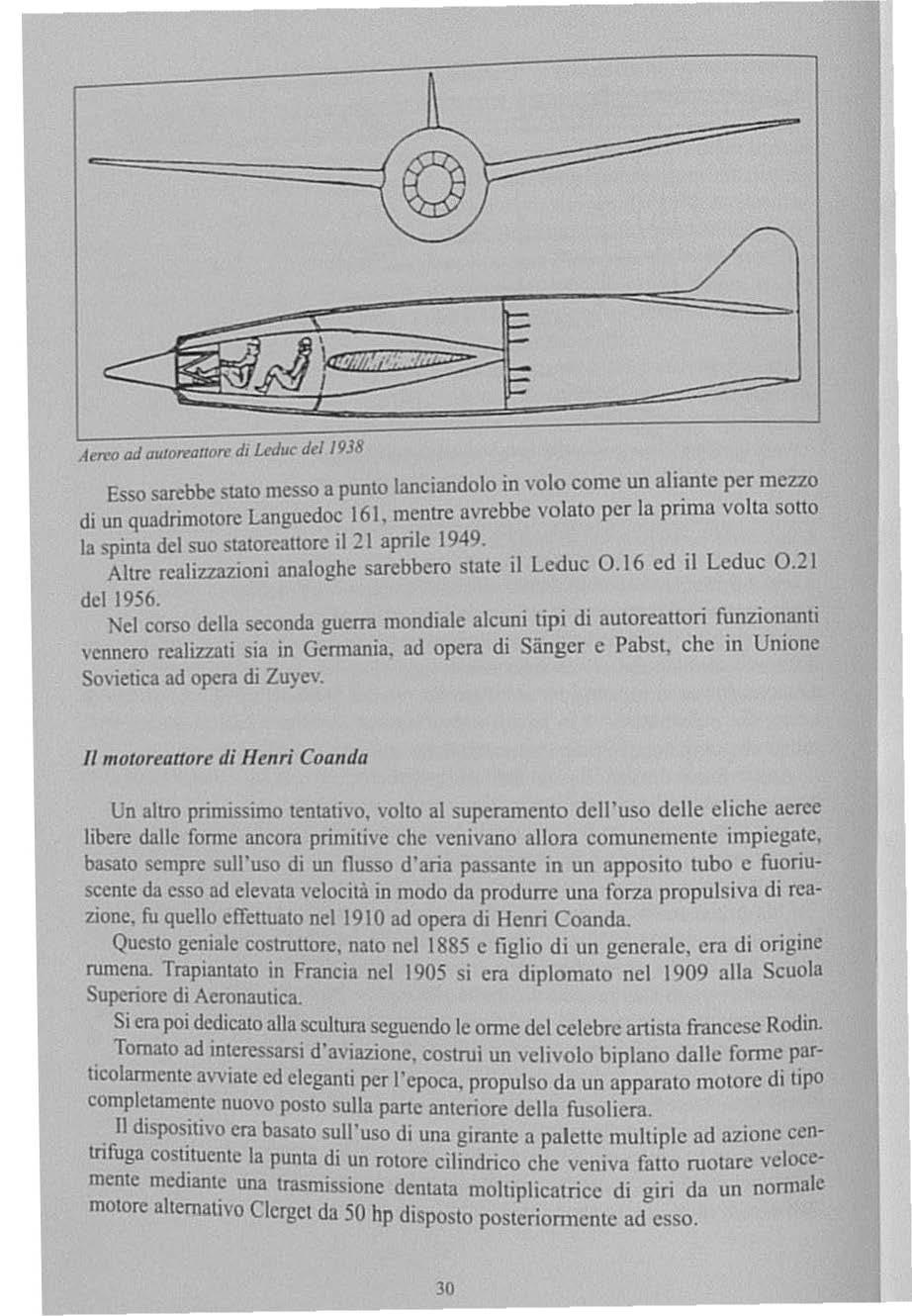
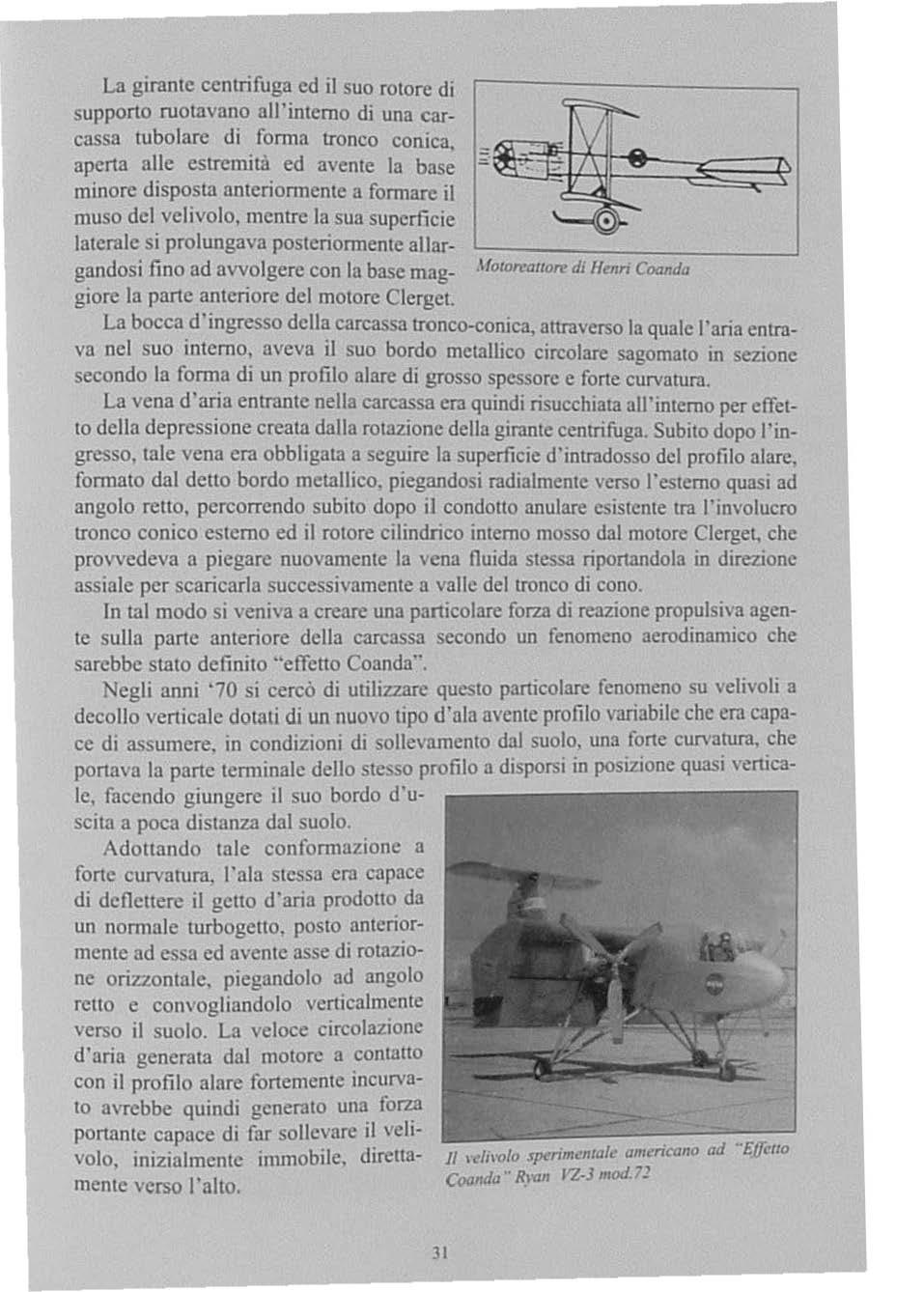
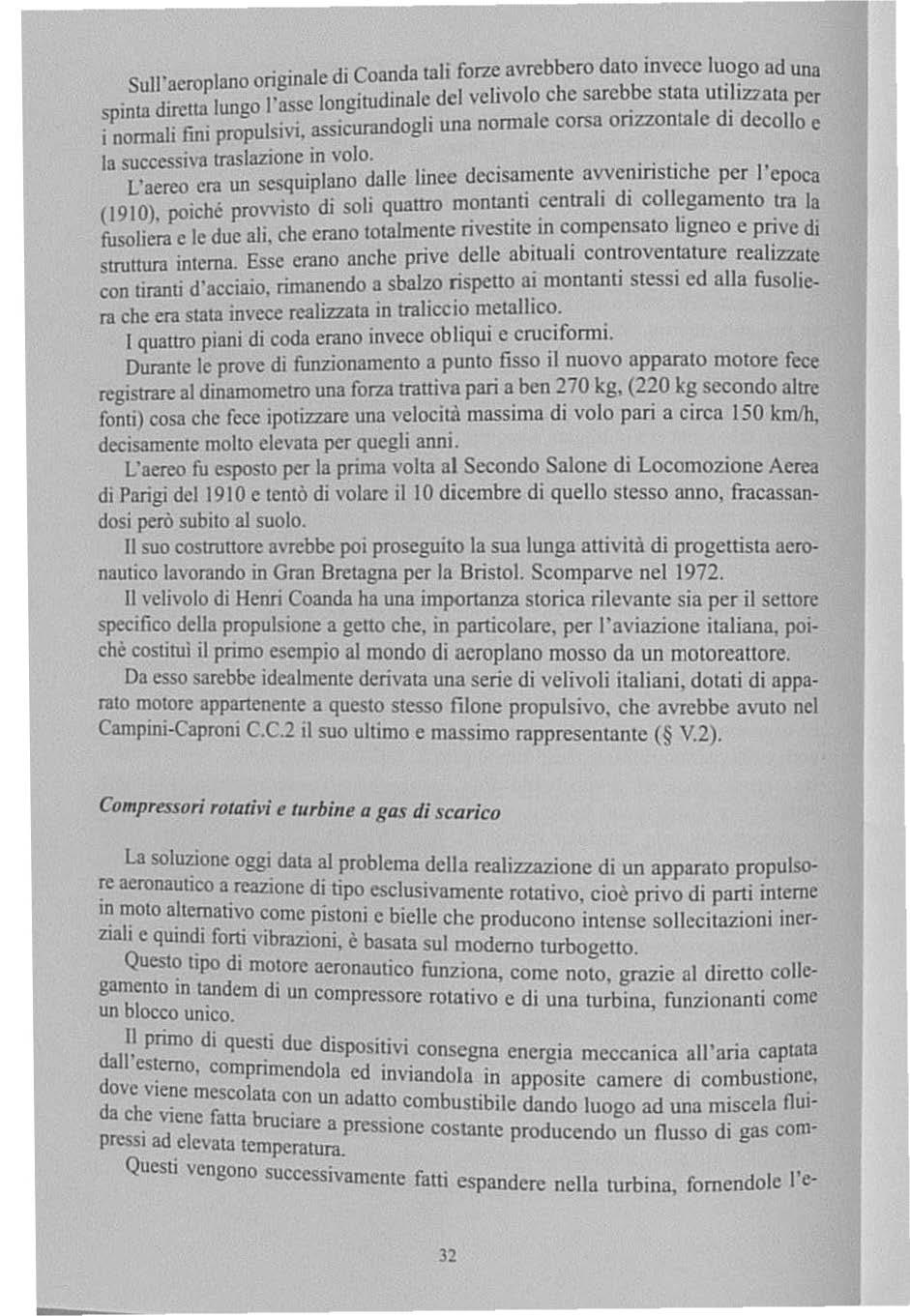


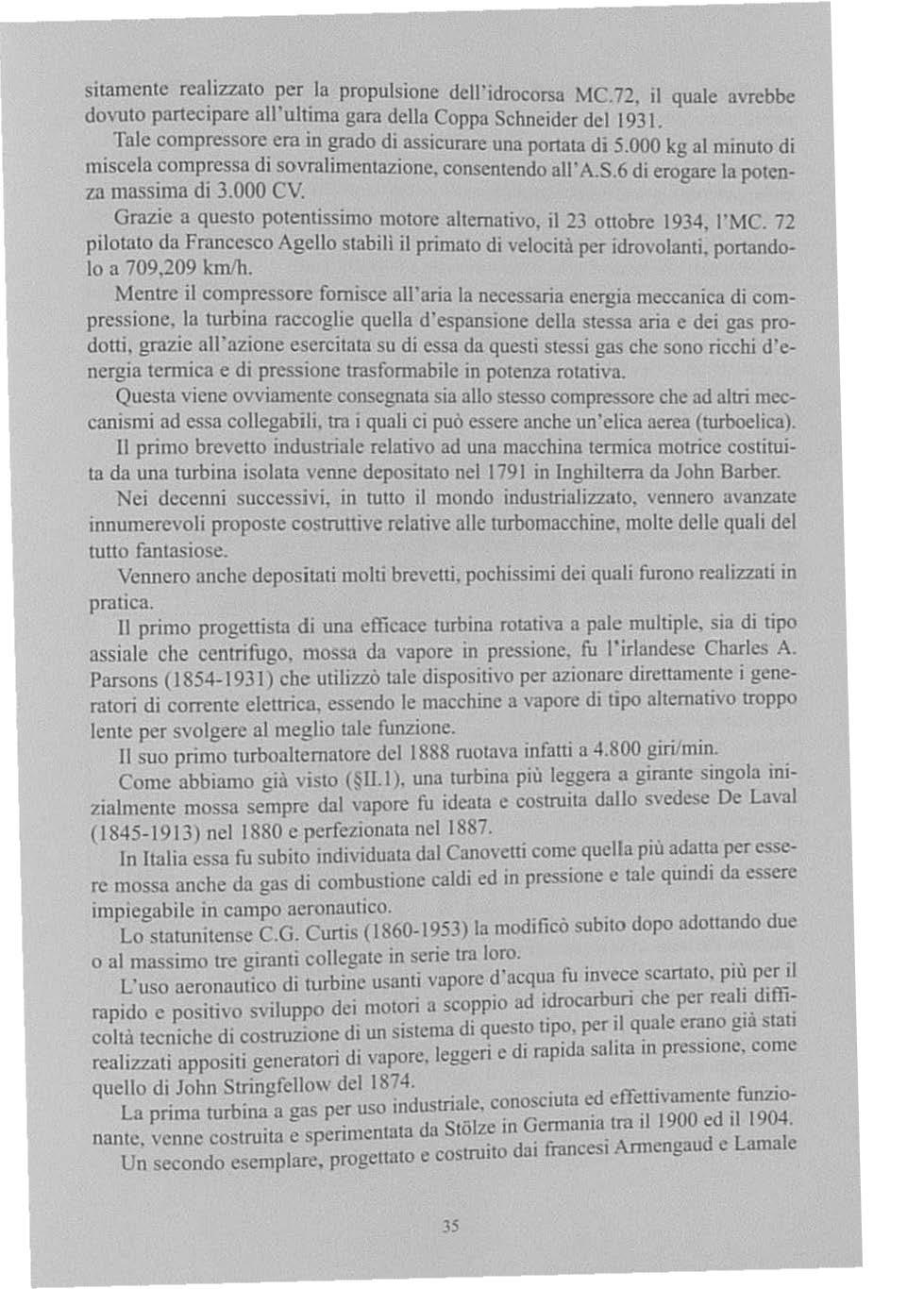

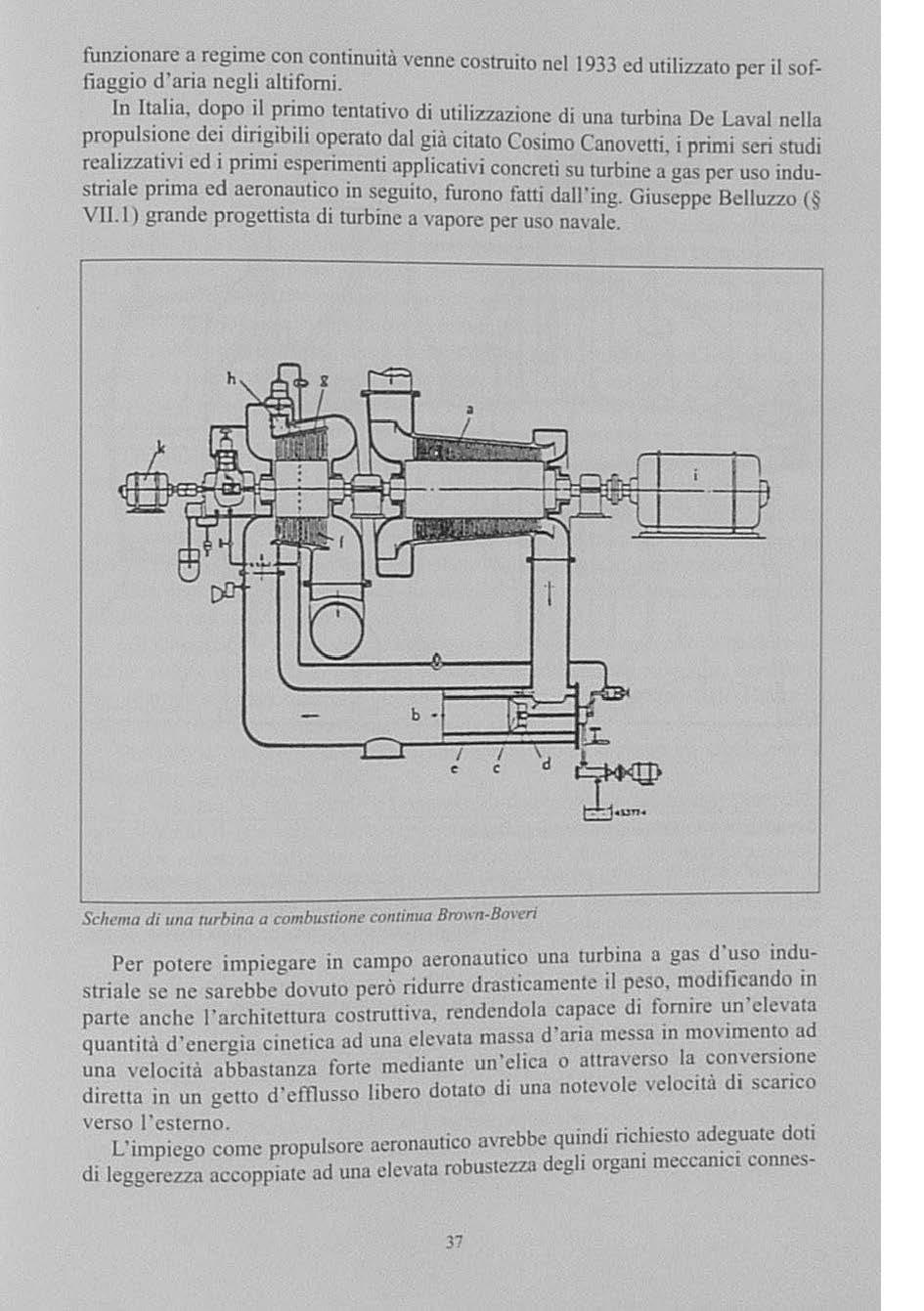
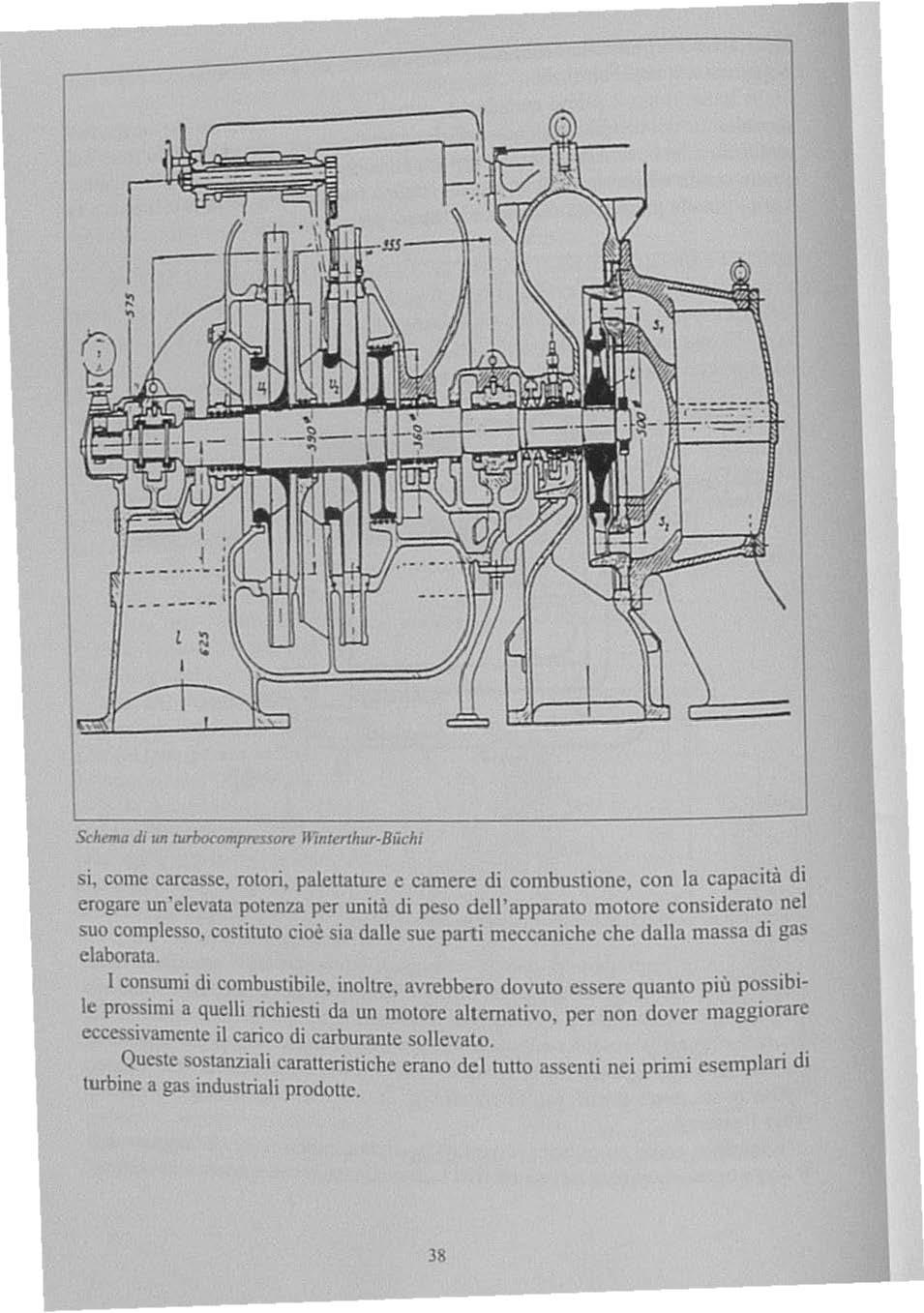


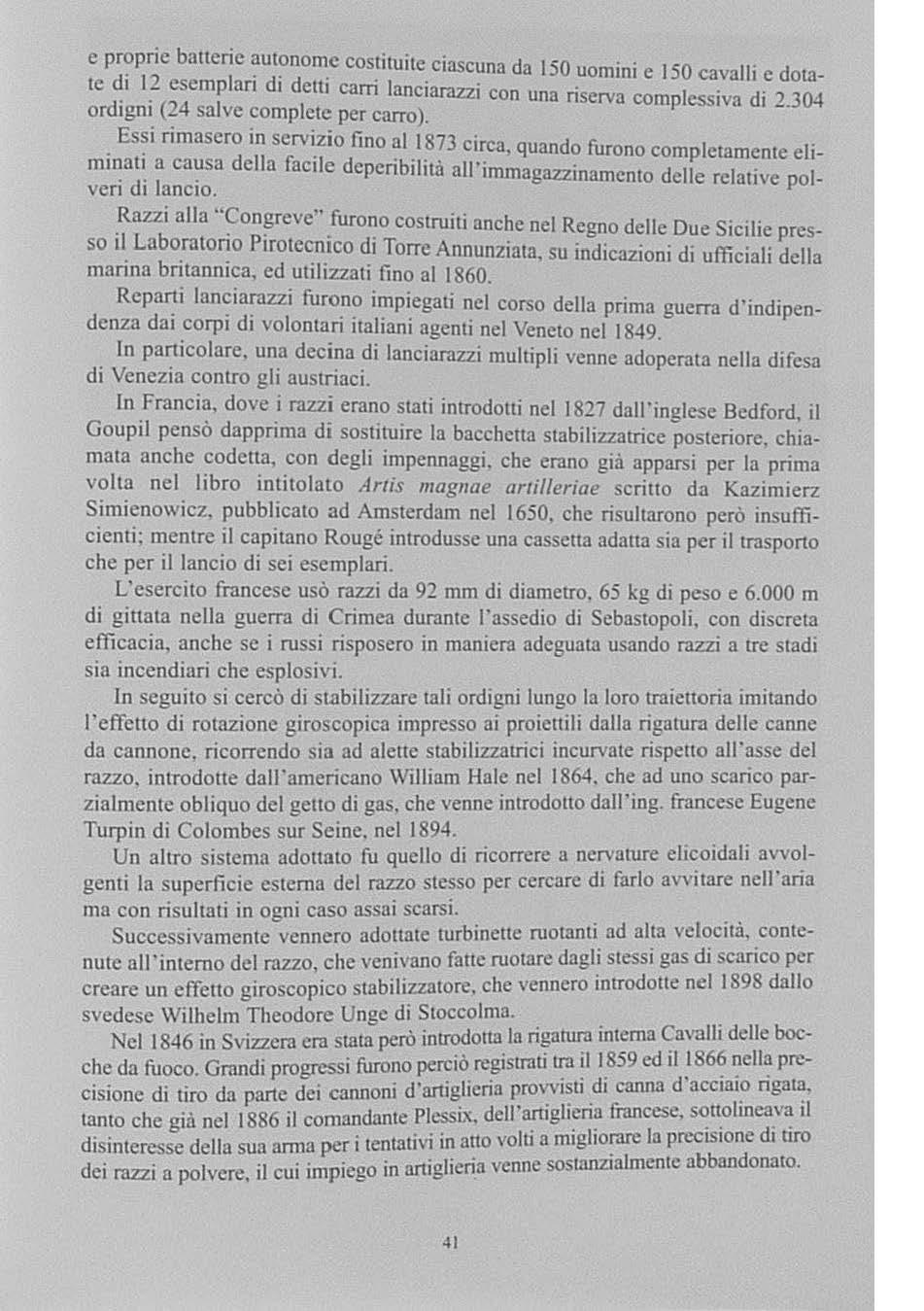
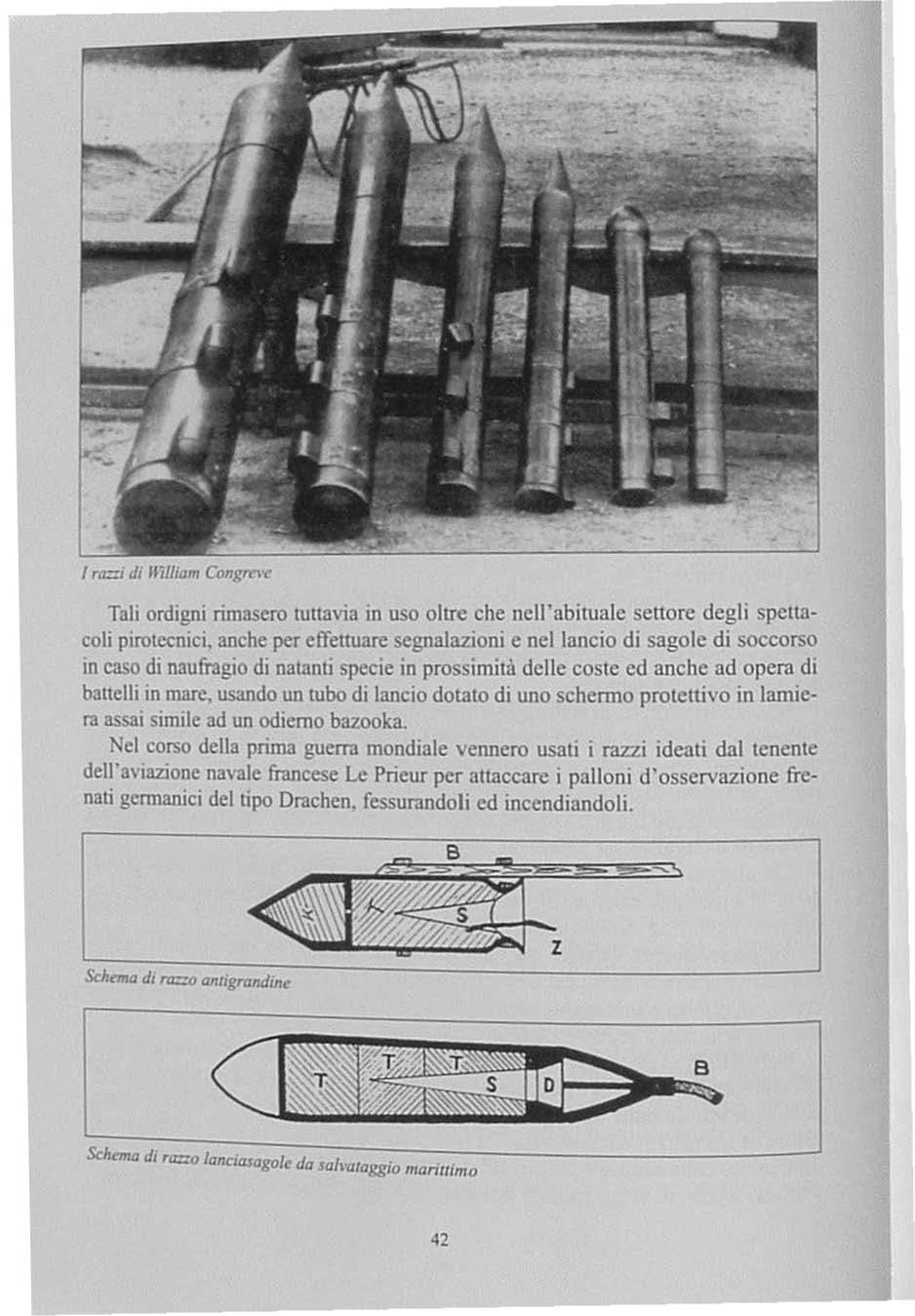
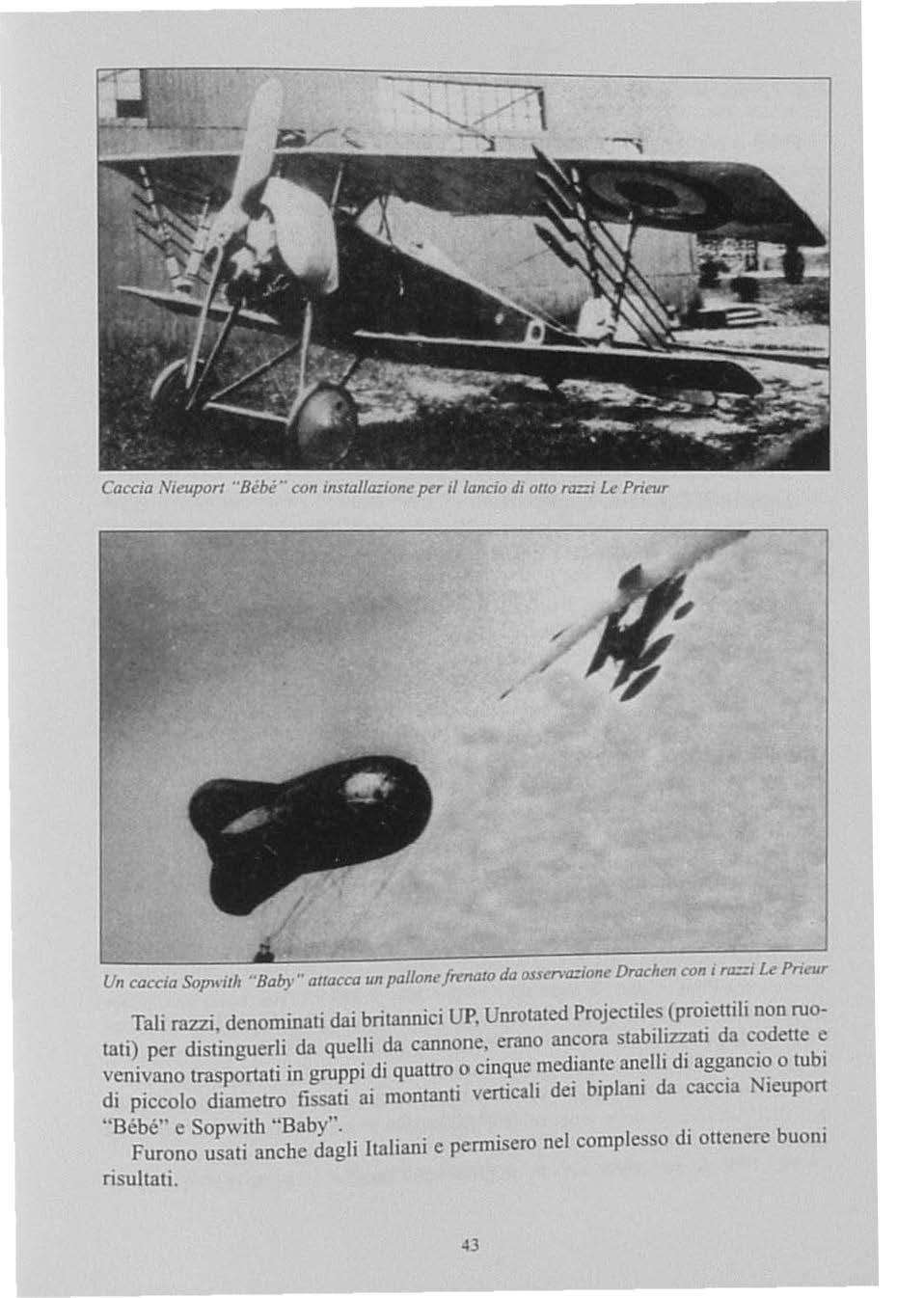
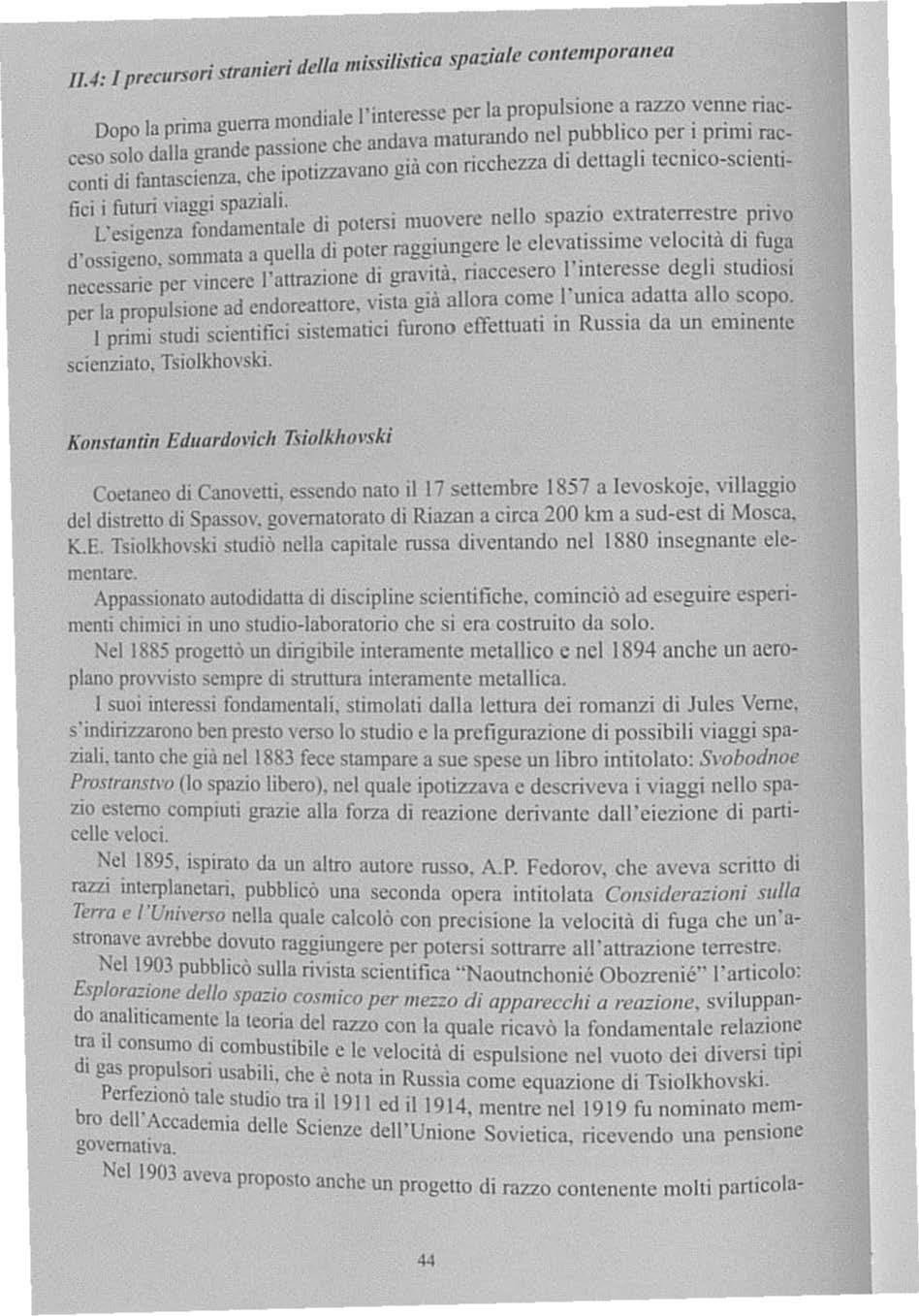
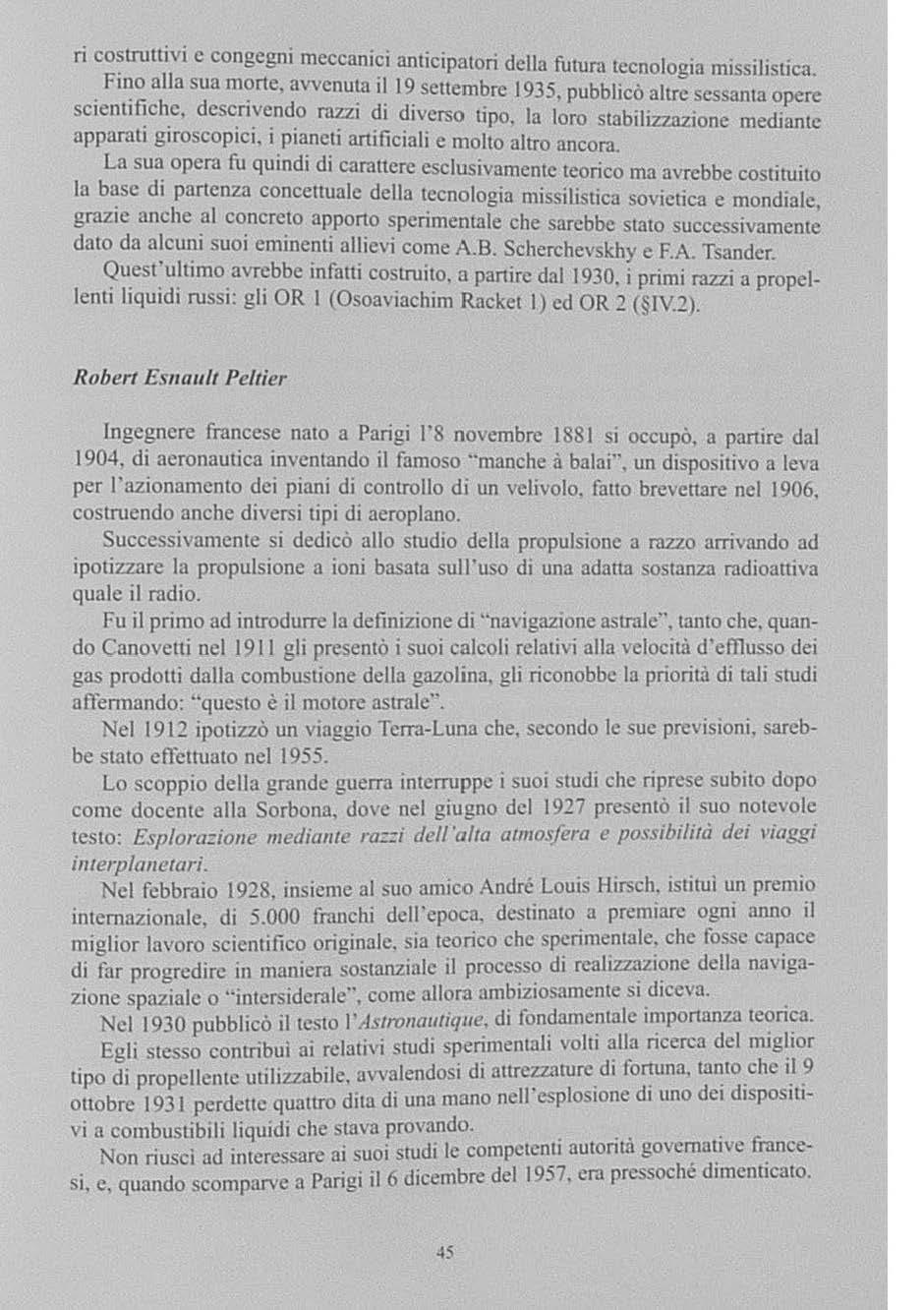
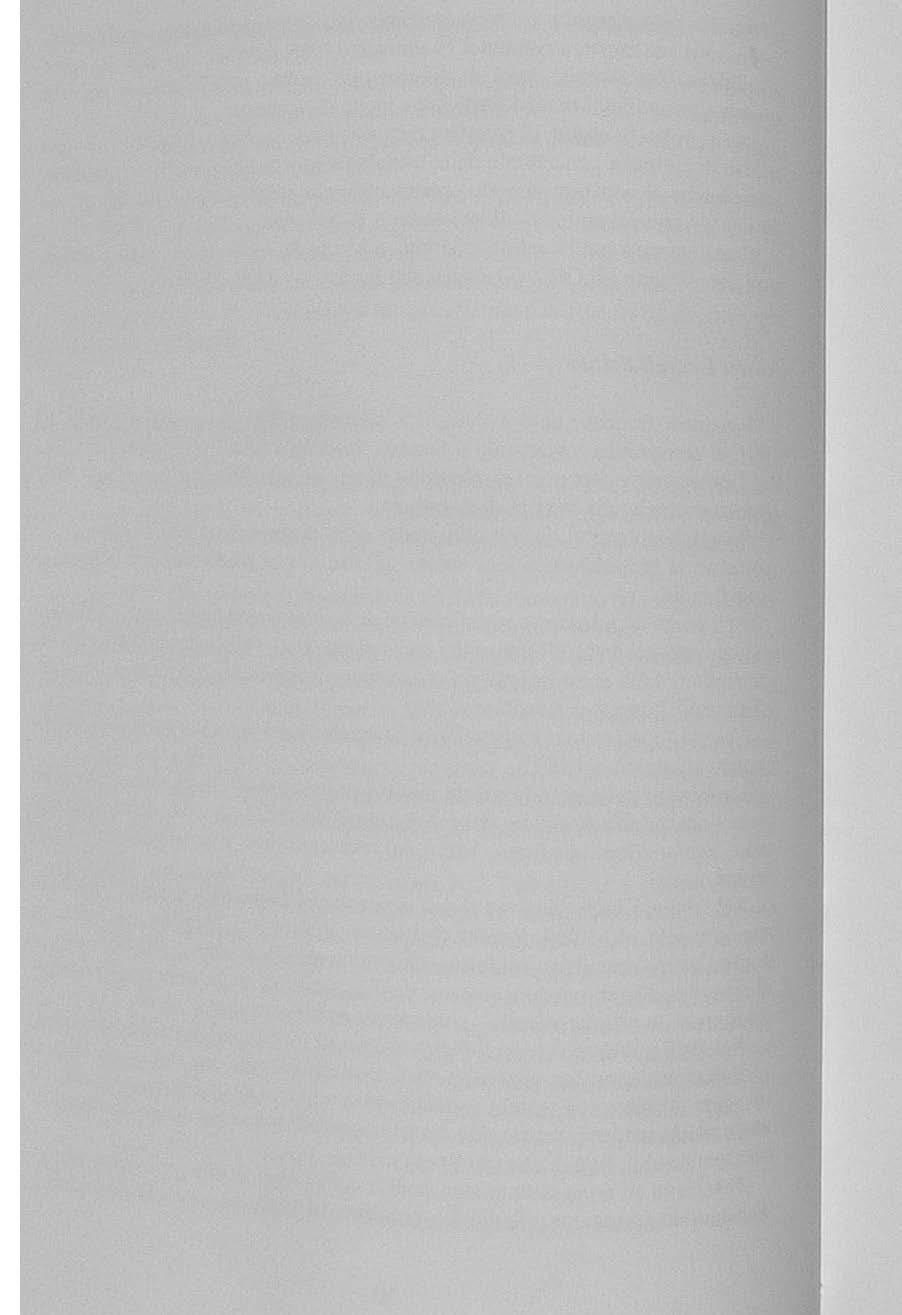
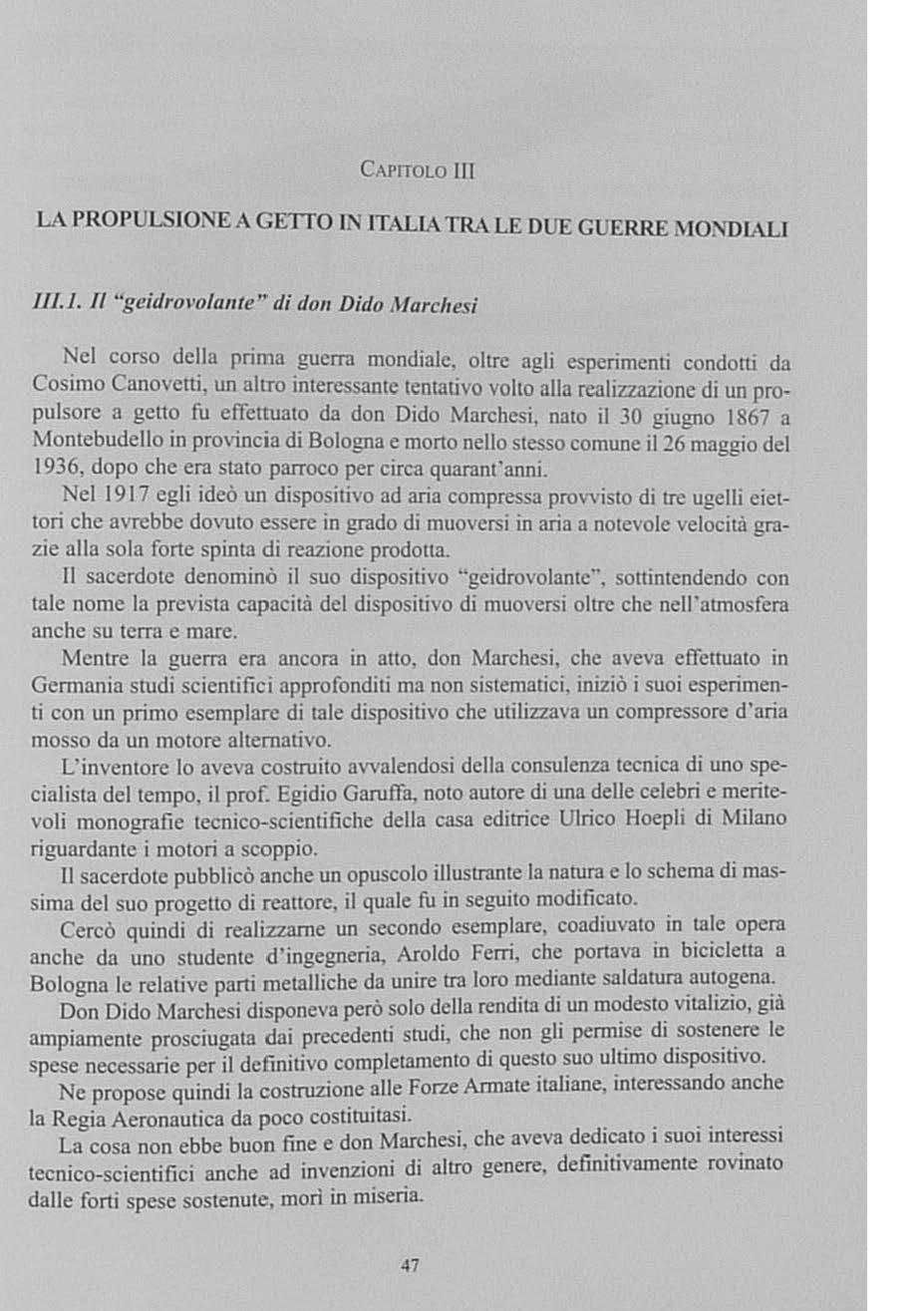 CAPITOLO Ul
CAPITOLO Ul