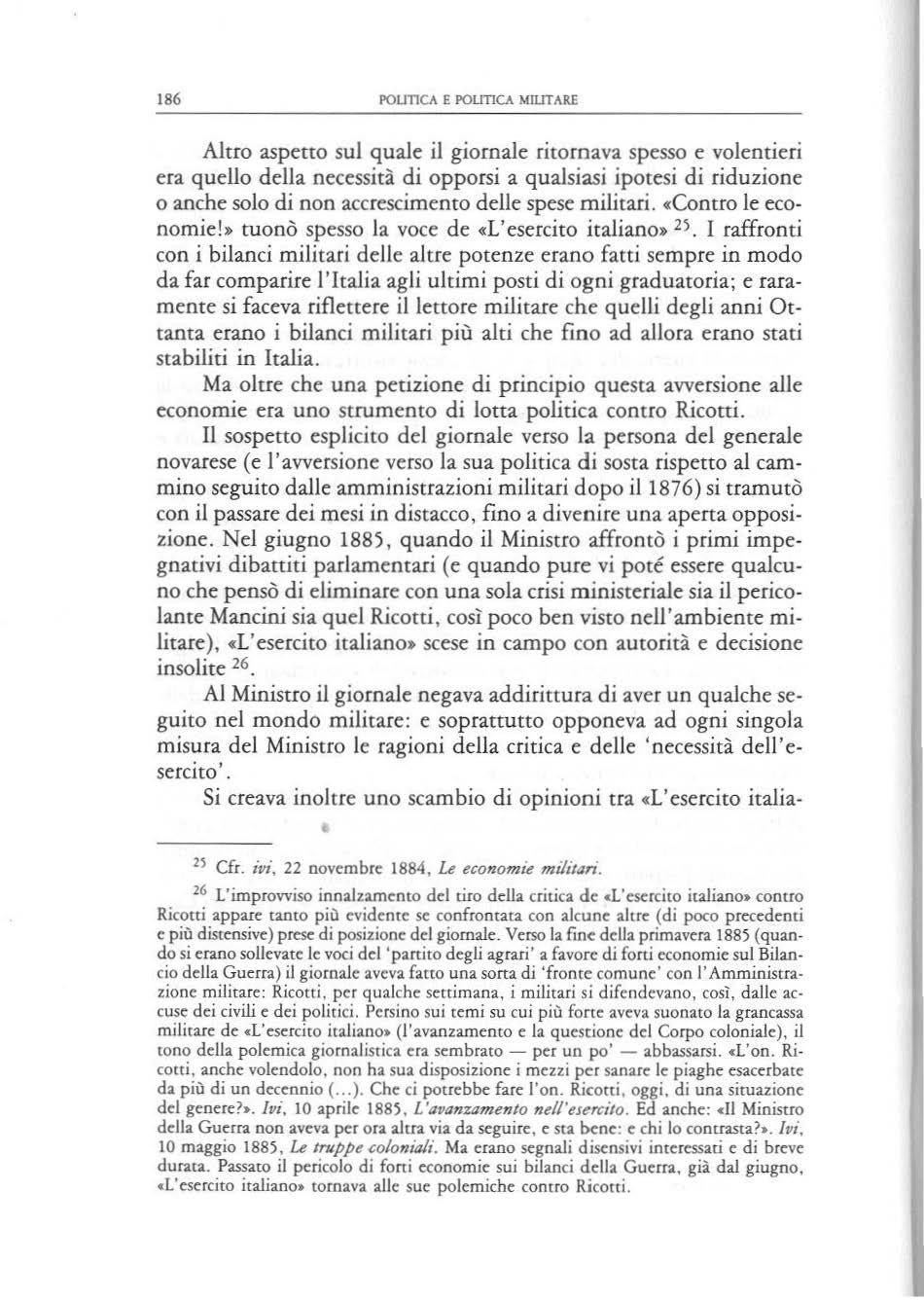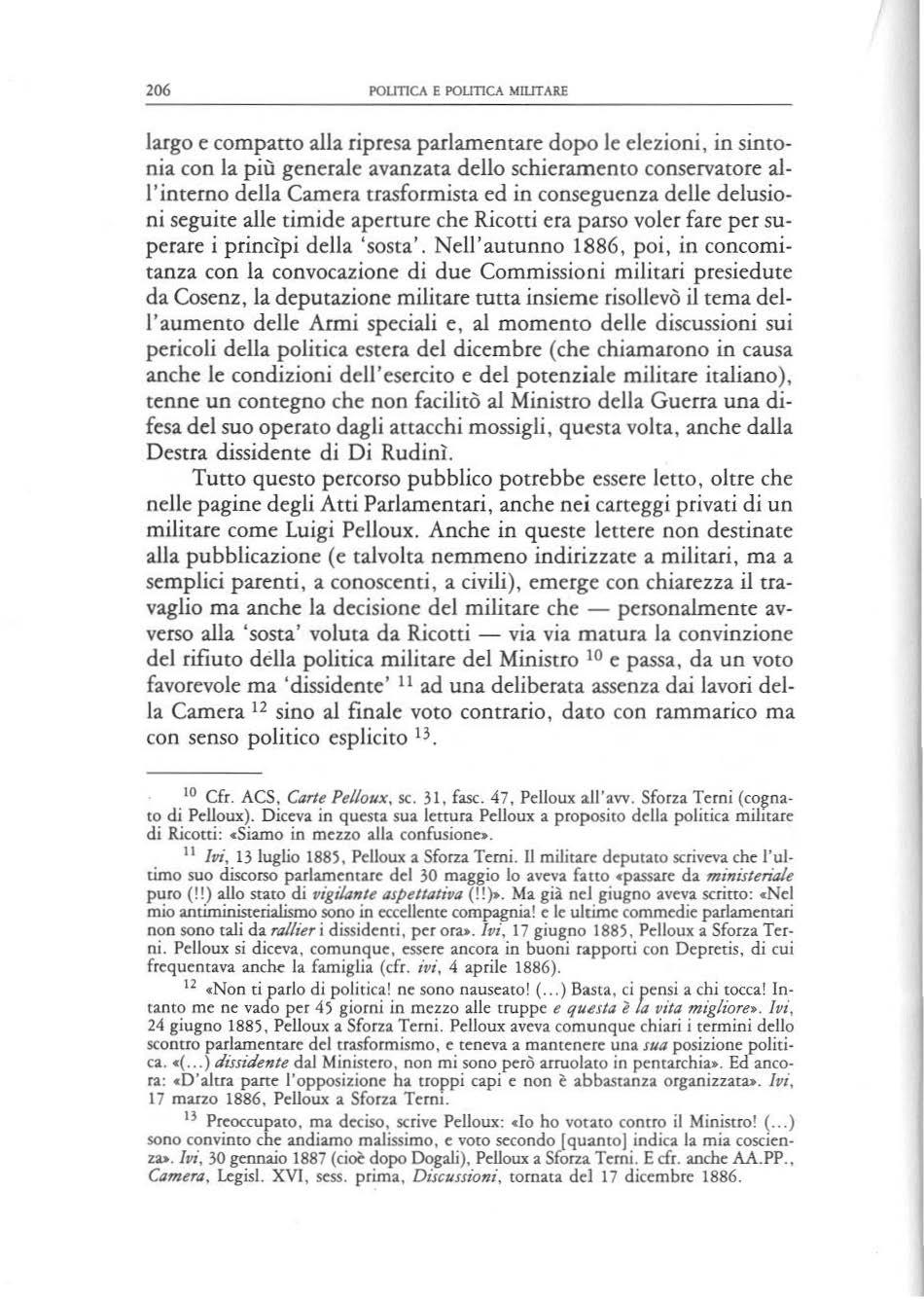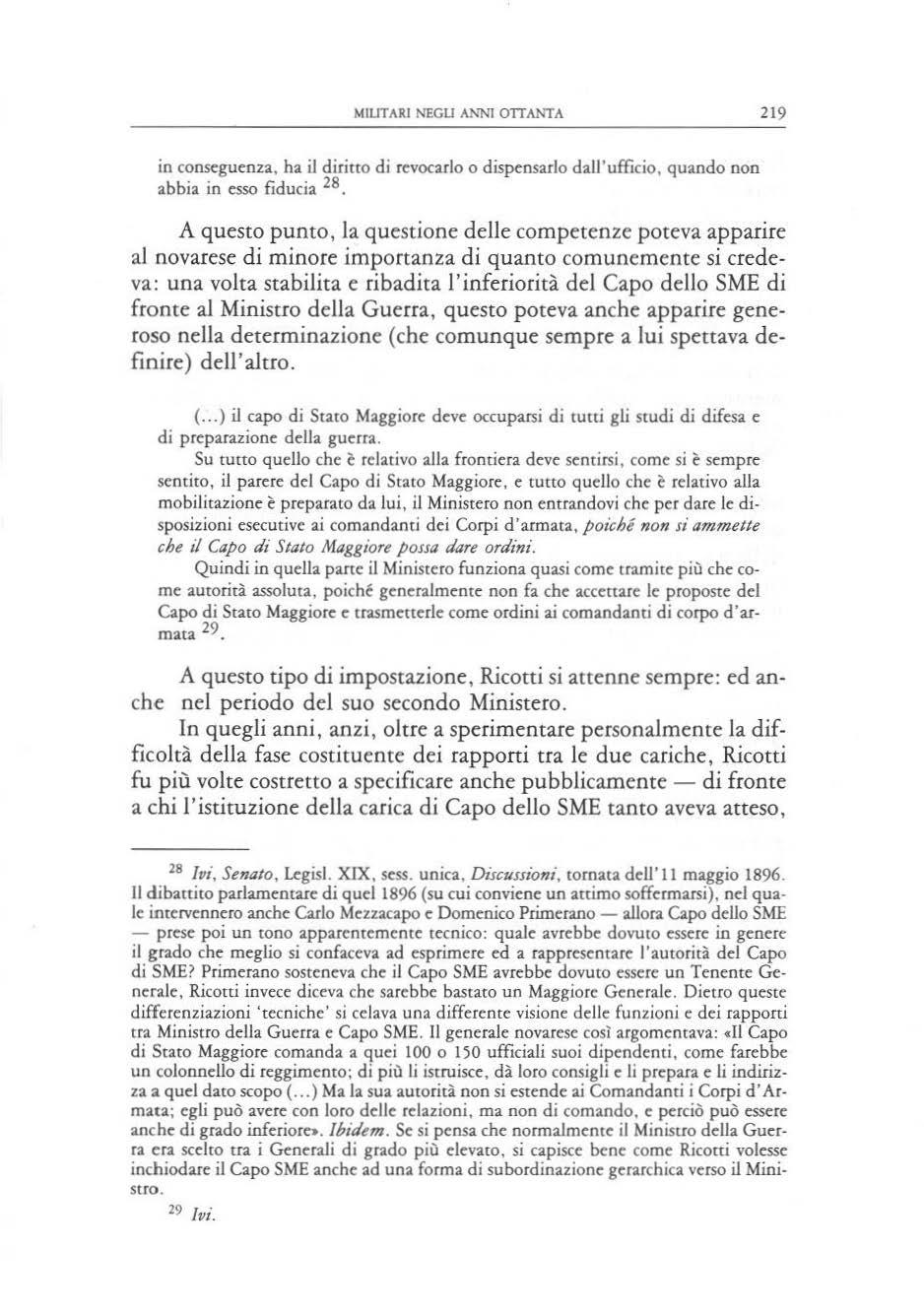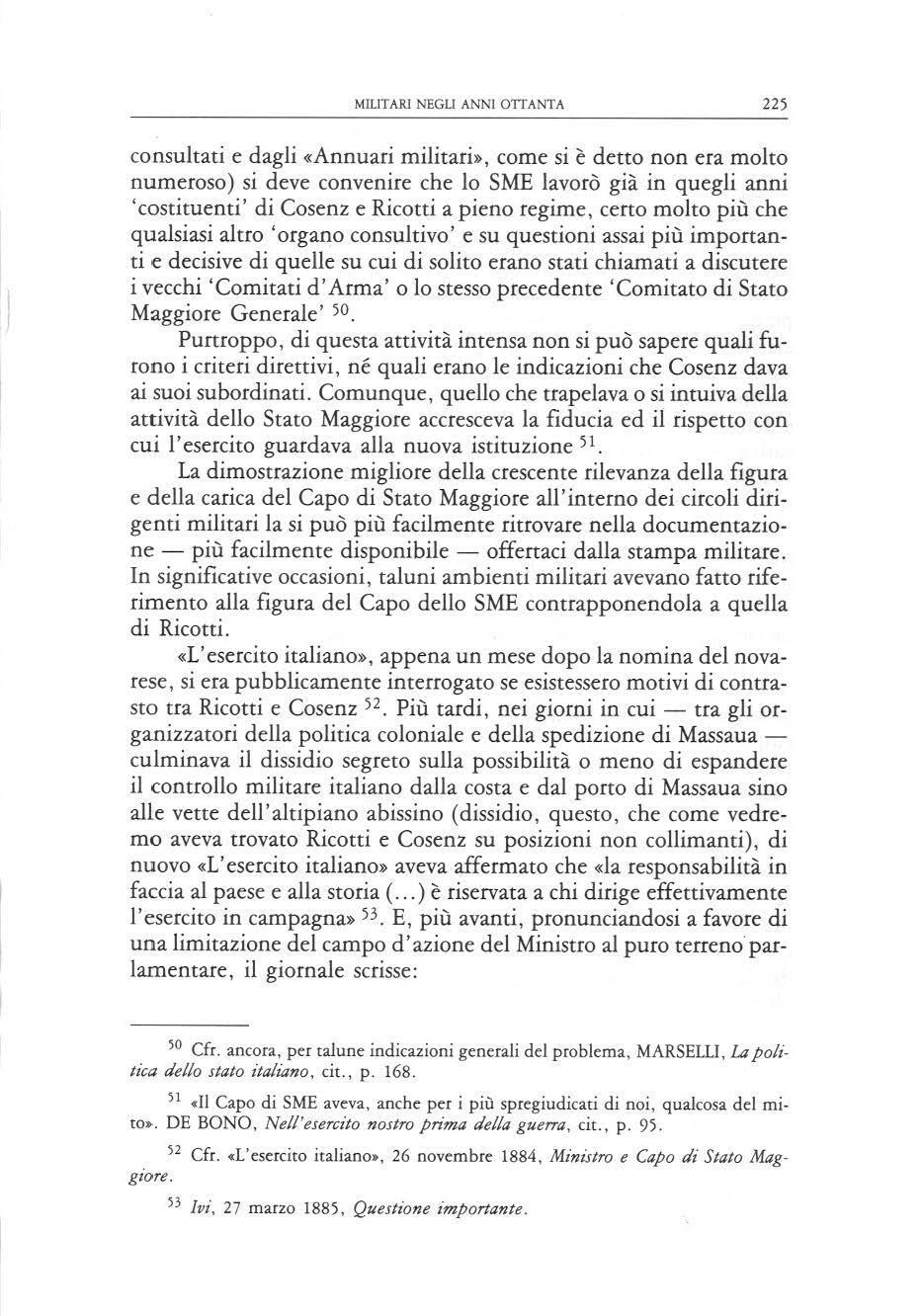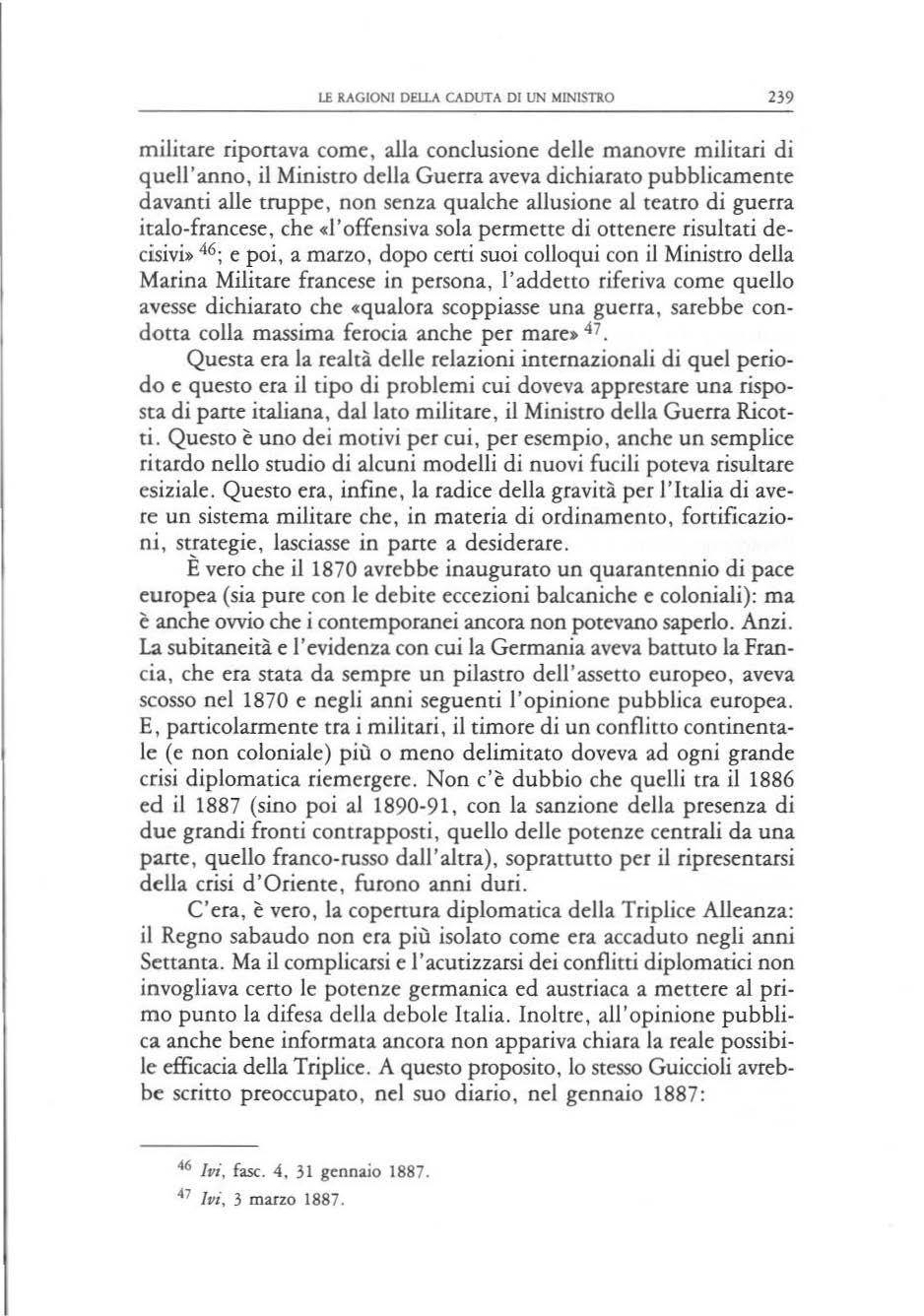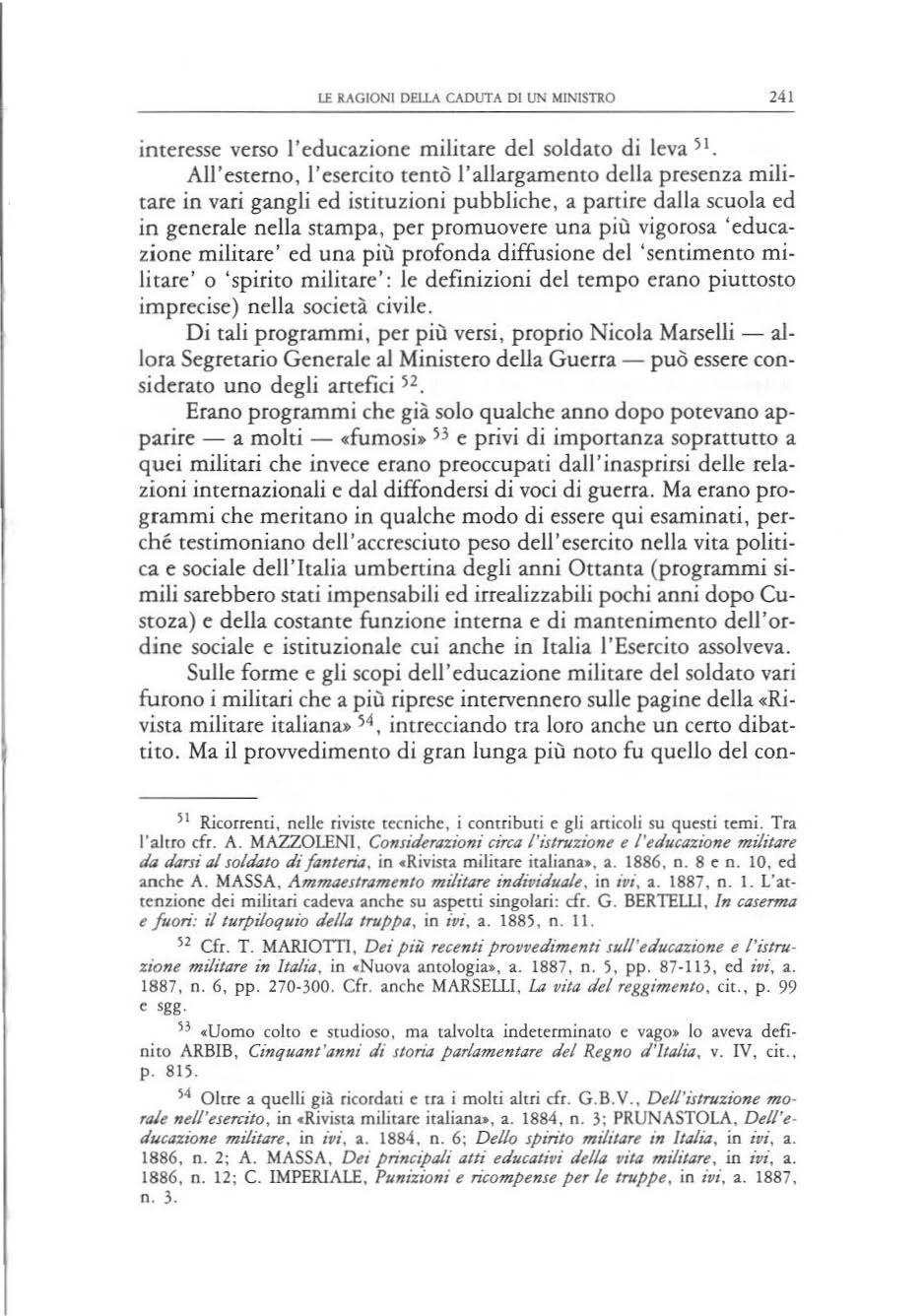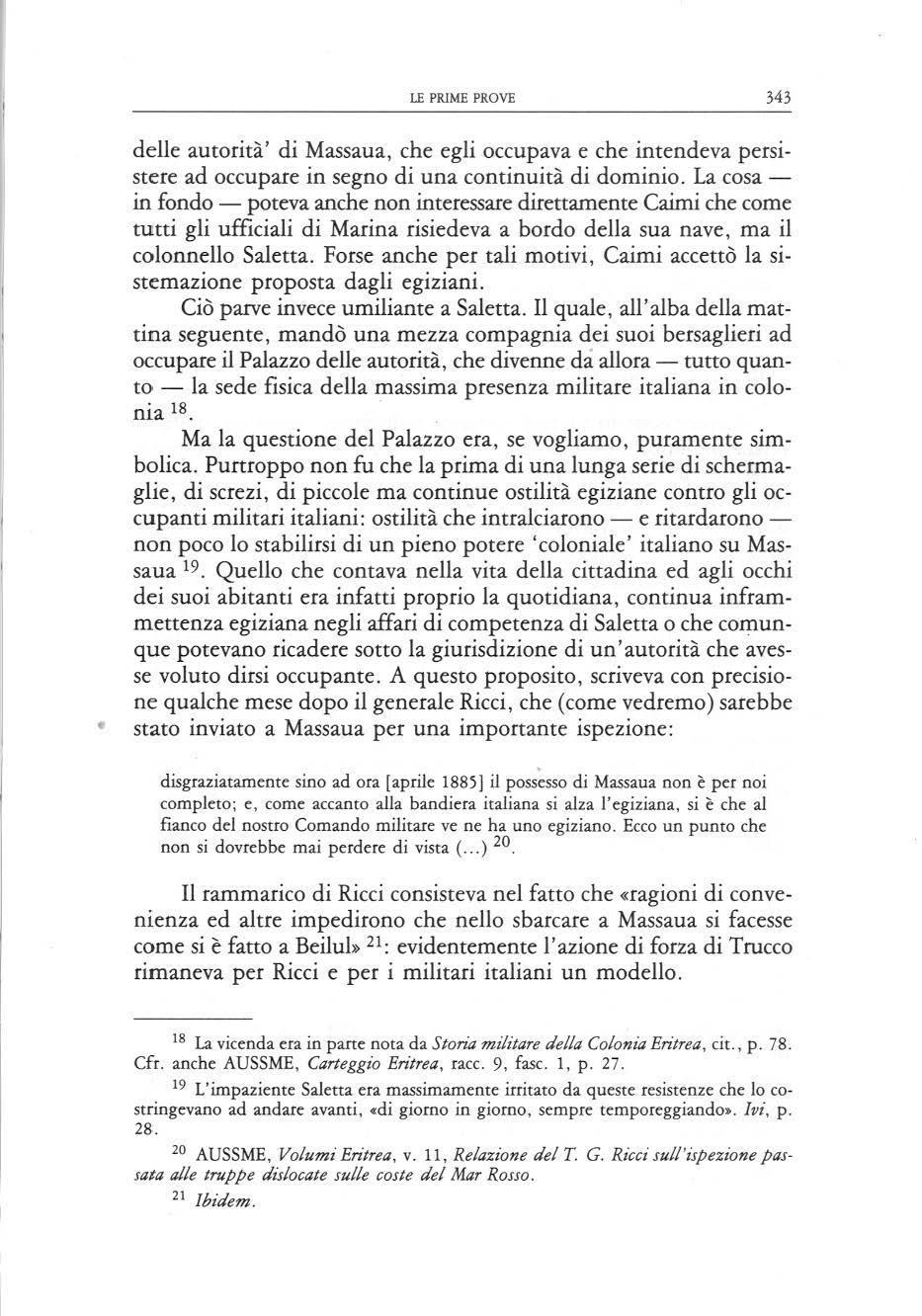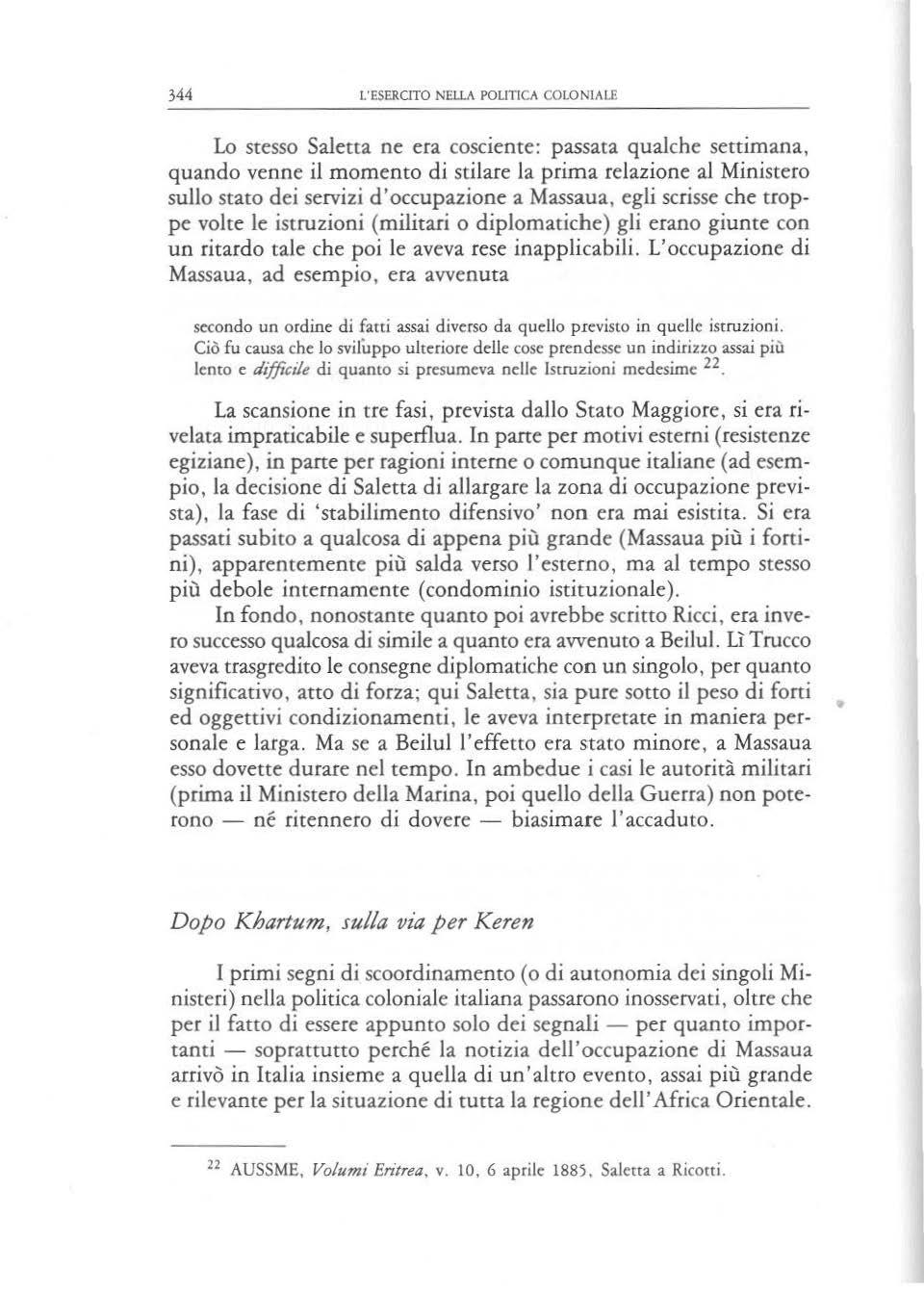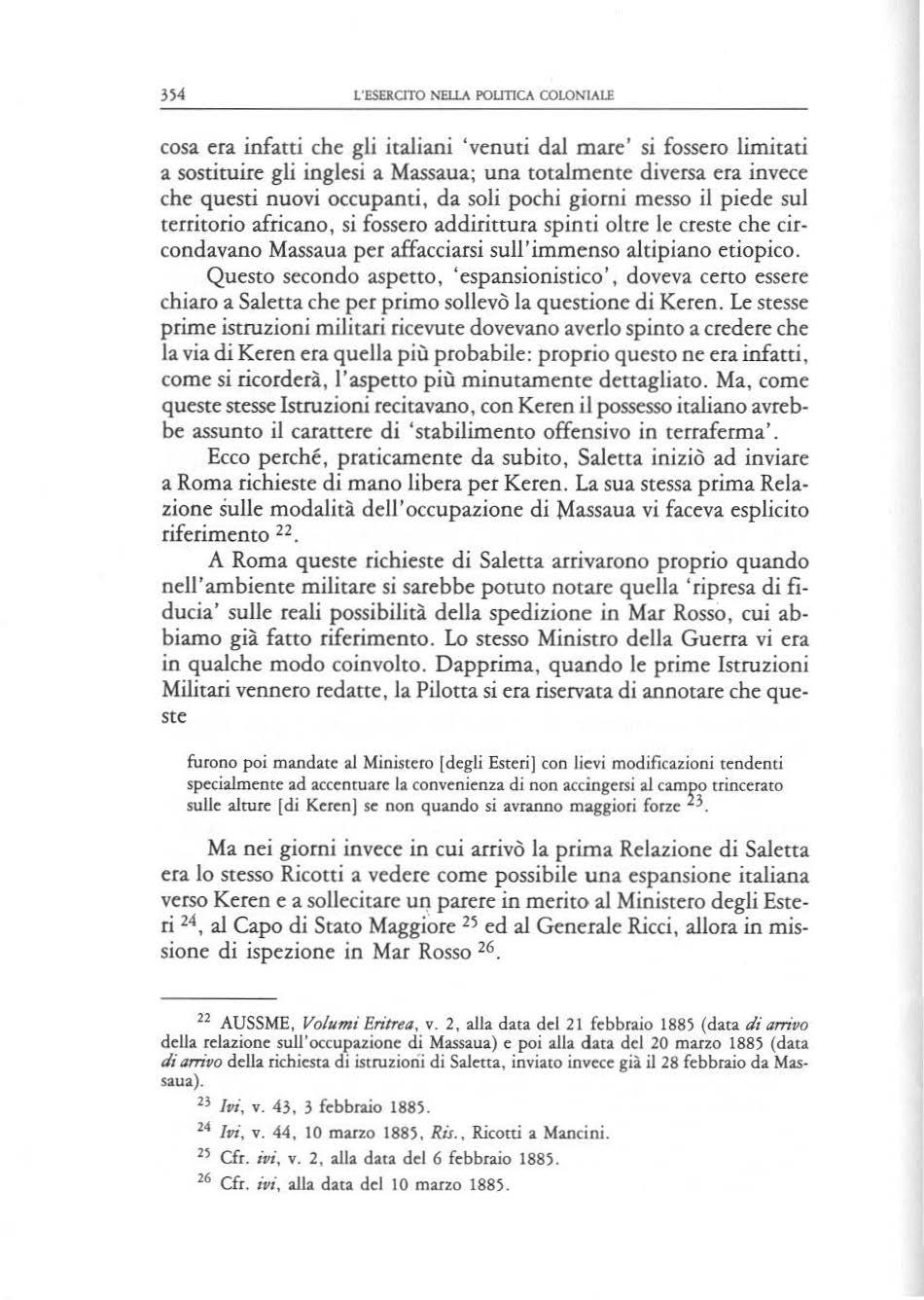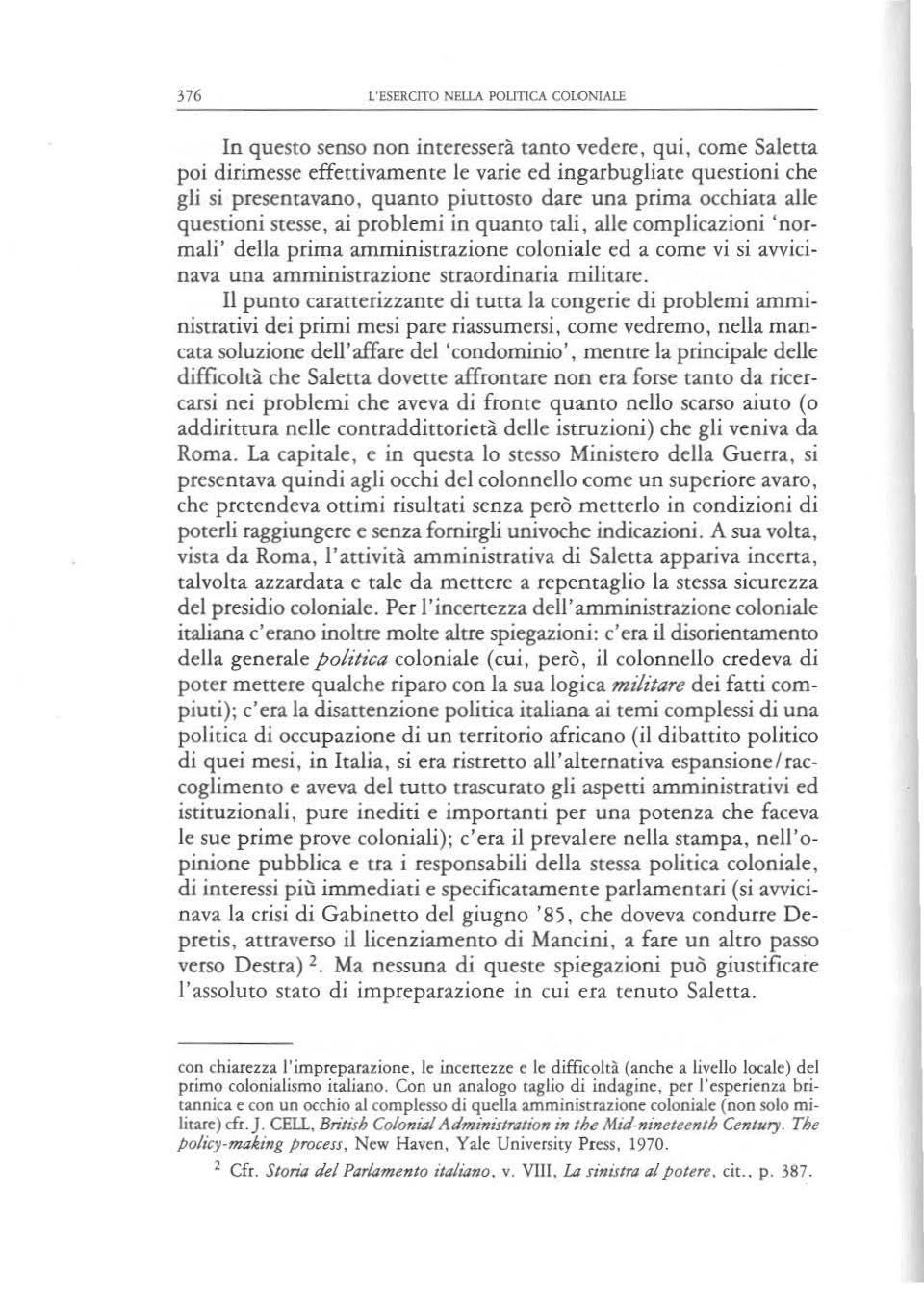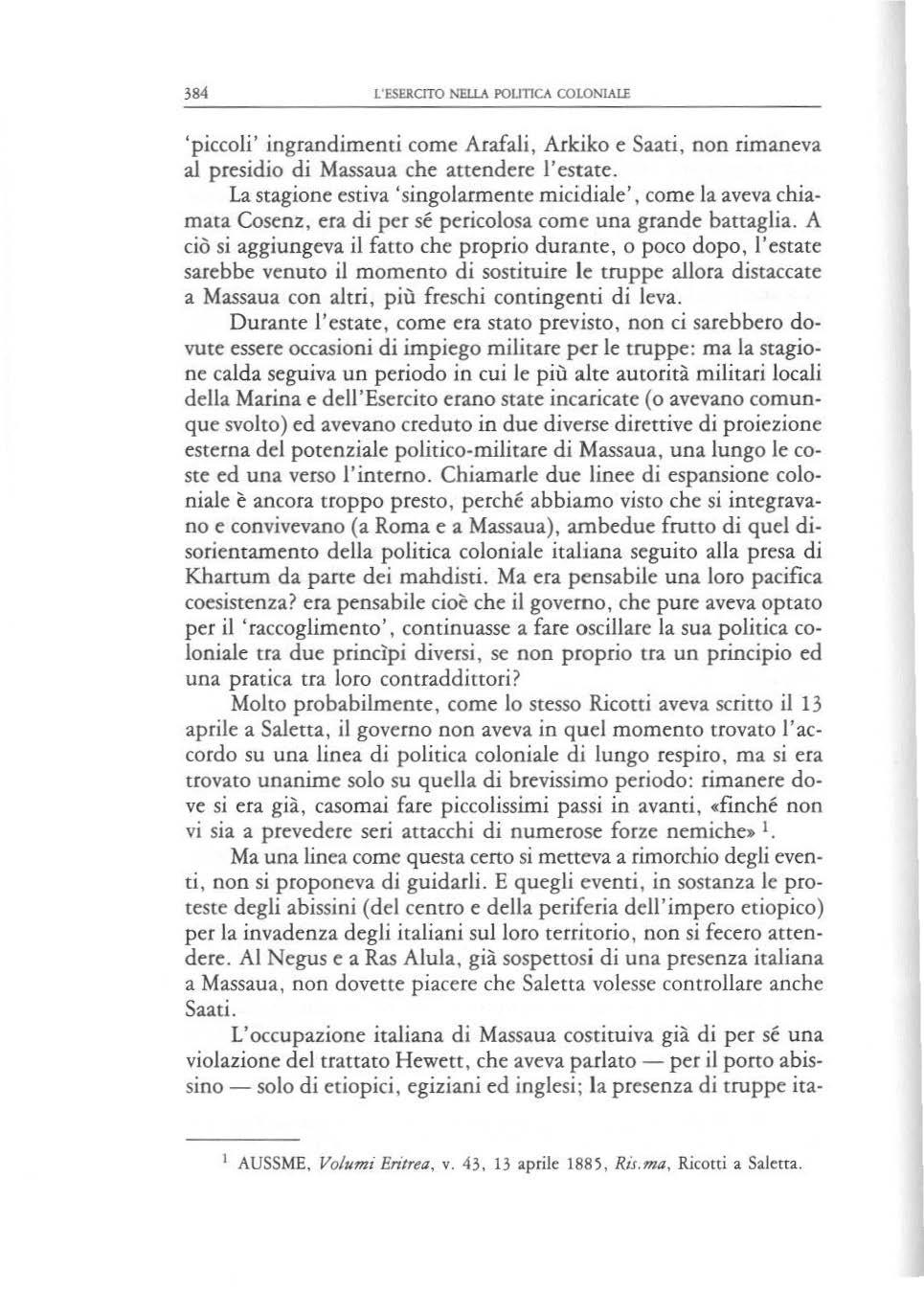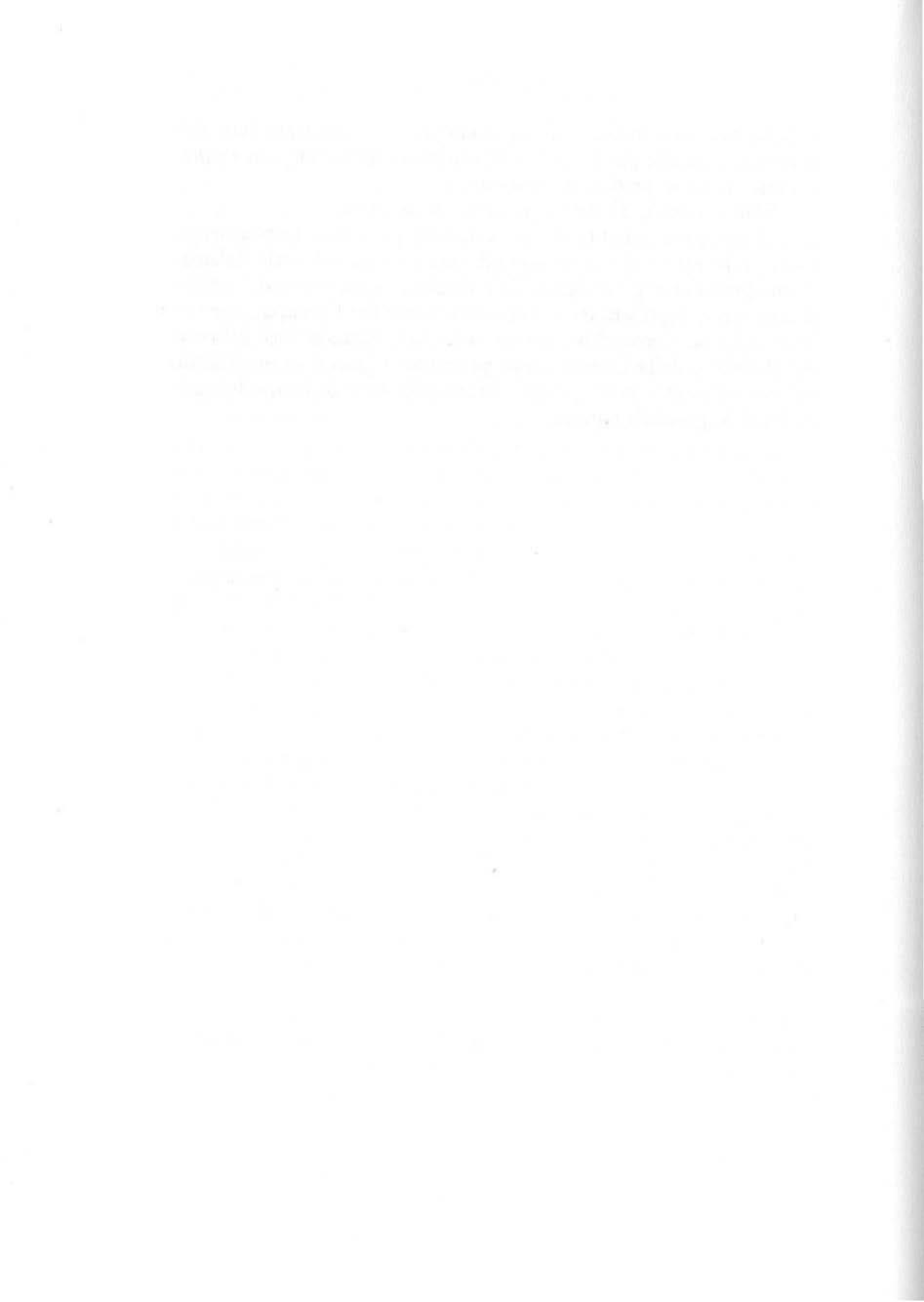STATO MAGG IORE D ELL'ESERCITO UFFICIO STORICO NICOLA LABANCA IL GENERALE CESARE RICOTI1 E LA POLITICA MILITARE ITALIANA DAL 1884 AL 188 7 ROMA 1986
PROPRlETÀ LETIERARIA

Tutti i diritti riservati. Vietara la riproduzione anche parziale senza autonzzaztone
© Ufficio Storico SME - Roma 1986.
Sti lgraJi co s.r.L •
1986
Roma
PRESENTAZIONE
Sulle vicende dell'Esercito Italiano sono ormai disponibtli varie opere generali che propongono più linee di interpretazione. Il rinnovamento storiografico, anche in questo campo, ha fotto in modo che venissero esaminate non più soltanto le battaglie e le guerre ma anche i lunghi periodi di pace, il ruolo delle forze armate nei contesti sociali e istituzionali, i rapporti tra esercito e politica.
L 'Ufficio Ston·co è stato da tempo partecipe a questo processo, con le sue pubblicazioni dz' volumi e di saggi.
La monografia preparata dal dottor Nicola Labanca, inserendosi in questo filone , per vari motivi presenta elementi di peculiare interesse e solleva questioni di grande momento, pur articolandosi su un nstretto arco cronologico.
Essa si fonda su un apporto documentan'o assai vasto, utilizzando fonti a stampa e d'archivio , amminùtrative e di personalità, civili e militari. In questo senso la monografia utilizza ampùtmente e valonzza zl maten'ale conservato presso l'Ufficio Stonco. Inoltre essa esamina a fondo un periodo della stona mzlitare italzana sinora alquanto trascurato. Nella crisi politica che segnò ti passaggz'o da Depretù a l'Esercito del tempo di Ricotti svolse di fotto un ruolo di rilievo. Nel volume sono quindi analzzzate z"n particolare le dinamzche della formazione di una politica militare da una duplice prospettiva: dall'interno della struttura dell'Esercito e dall'esterno verso l'Esercito. Al pn'mo scopo è funzionale l 'esame della stampa mzlitare, del ruolo dei mtlitan· deputati e dello Stato Maggt'ore, al secondo lo è la lettura della stampa politica, dei carteggi dei Minùtn· e degli atti parlamentan·.

Ma soprattutto - nell'esame attento e documentato degli 'aspetti mzlitan· della pn·ma spediZione coloniale italzana - ti volume spiega l'interagire e l'accavallarsi di diverse politiche anche sul momento operativo.
Sono temi, questi, che non si esaurùcono a Massaua o nel pen'odo qui accuratamente studzato dall'autore, ma che ricorrono nella stona della politzca mzlitare e della preparazione della guerra.
IL CAPO UFFICIO STORICO

INTRODUZIONE
Quasi non c'è saggio che, volendo ricostruire aspetti e momenti dell'evoluzione delle forze armate italiane dall'Unità alla Grande Guerra, non inizi ricordando le lacune della storiografia e la n ecessità di nuove ricerche.
In effetti il panorama delle conoscenze oggi disponibili sui vari aspetti del rappono tra esercito, stato e società in quel periodo non è tra i più incoraggianti. L'attenzione degli storici, appuntatasi sugli eventi bellici e su alcuni specifici momenti dell'evoluzione della poli tic a m ili tare del Regno d'Italia, non ci restituisce un quadro un iforme di informazioni in merito ad aspetti centrali ed imponanti di quelle vicende che videro protagoniste le forze armate nazionali 1 Mancano a tutt'oggi studi che ricostruiscano - in profondità e con continuità- l'intersecarsi dei motivi della politica estera con quelli della politica militare, l'intrecciarsi delle necessità della politica interna con le es igen ze 'tecniche' dello sviluppo degli ordinamenti militari, il ruolo svolto dalle istituzioni militari nella società italiana avanti la prima guerra mondiale.
Anche se recentemente, con l'affacciarsi di nuove leve di studiosi e con l'aprirsi di nuove prospettive di ric erca, qualcosa sta mutando nella storiografia militare italiana, la situazione concreta degli studi da cui il ri cercatore è costretto a prendere le mosse è in larga parte quella descritta.
In questo senso la conoscenza delle vicende della politica militare italiana degli anni Ottanta - al cu i studio sono in sostanza dedicate le pagine che seguono - non fa eccezione. Quegli storici che
1 Cfr. A MONTICONE, La ston'o grafia militare italiana e i suoz· problerm· (1866-1918}, in Atti del pn·mo convegno nazz'onale di stona militare , Roma, Officine Grafiche Spinosi, 1969 , p. 102 ; G. ROCHAT, G. MASSOBRJO, Breve storia deU 'esercito italiano da/1861 all943, Torino, Einaudi , 19 78. pp. 7-8 ; P. DEL NEGRO. Ufficiali di camera e ufficiali di complemento nell' esercito italiano della grande gue"a: la provenienza regionale, in Les fronts invisibles. Noum'r. Fournir. Soigner , a cura di G. Canini, Nancy, Presses Universitaires de Nancy , 1984. p. 263 Giorgio Rochat , anzi , ha scritto che cquesto settore degli srudi storici presenta limiti quaocitativi e qua1itativi tali, che si può discutere se esista davvero una storiografia militare italiana, intesa come branca autonoma delle scienze storiche•. G. ROCHAT, Forze Armate , in Il mondo contemporaneo , v. I, Storia d 'Italia , a cura di F. Levi , U . Levra , N . Tranfaglia , t. 2 , Firenze, La Nuova Italia , 1978, p. 501.

se ne sono interessati o che in qualche modo vi hanno fatto riferimento hanno conco rdemente messo l'accento sul fatto che quel decennio costituì uno dei periodi più felici per le forze armate italiane 2 Crescita delle spese militari , alleanza diplomatica con la massima potenza militare europea, aumento del ruolo delle forze arma-
2 La definizione è io CEVA, Le forze armate, Torino, UTET , 1981, p. 93. Cfr. anche ROCHAT, MASSOBRJO, Breve storia dell 'esercito italiano dal 1861 al 1943, ci t., p 115. Correttamente, più cauto è P. DEL NEGRO, La leva militare in Italia dall'unità alla grande guerra, in ID., Esercito , Stato, socie tà Saggi di storia militare , Bologna, uppelli, 1979, pp. 169-262 e ID., Ufficiali di carriera e ufficiali di complemento nell'esercito italiano della grande guerra , cit., p 266 e sgg. Anche V. GALLINARI, La politica militare della Sinistra Storica 1876-1887, in «Memorie storiche militari 1979•. Roma 1980, pp. 86-87 , aveva riproposto quelle vicende in chiave talvolta apologetica. Da questa interpretazione, sullo specifico punto, non molto si discosta F. MINNITI, Il ruolo dei militan· nella politica nazionale (1887-1914), in «Memorie storiche militari 1982•, Roma 198 3, adesso in ID. , Esercito e politica da Porta Pia alla Tnplice alleanu (1870-188 2), Roma , Bonacci , 1984 , p. 182. Recentemente, valutazioni eccessivamente ottimistic he sugli 'anni Ottanta' dell'esercito italiano si leggono anche in F MAZZONIS, L 'esercito italiano al tempo di Garibaldi, in Gan'baldi condouiero. Stona, teoria, p rassi, a cura di F. Mazzonis , Milano , Angeli , 1984, pp . 245 e sgg. Già più critico appare G.P . FRANZOSI, Garibaldi tra mito e stona nell'Italia umbertina e giolitttana , in Gan'baldi co ndottiero . Stona, teoria, prassi, cit., p. 525 e p. 530. Degli 'anni Ottanta' si sono occu pati da vicino, per quanto riguarda l ' esercito , anche M. MAZZETil , L'esercito italiano nella Triplice Alleanu, Napoli, ESI . 1974; F. VEN1URJNI, Militari e politici nell'Italia umbertina, io eScoria contemporanea., a. XIn (1982 ) n. 2, e F. MINNITI , JI secondo piano generale delle fortificazioni. Studio e progetto (1880 -1885), in cMemorie sto riche militari 1980•. Roma , 1981, e ID ., Politica militare e polihca estera nella Tnplice Alleanza. Dietro le trattah·ve del 1882, io cMemorie storiche militari 198h, Roma, 1982, (adesso raccolti in ID. , Esercito e politica da Porta Pia alla Tnplice Allean · za, cit.) . Accenni anche in]. GOOCH , L'Italia contro la Francia. l piani di guerra difensivi ed offensivi 1870-1914, in cMemorie st o riche militari 1979•. Roma , 1980 , e in M. MAZZETTI, I piani di guerra contro l'Austria dal 1866 alla p n'ma guerra mondiale, io cMemo rie stori che militari 1979», Roma, 1980. Per uno sguardo sintetico alle vicende militari internazionali del XIX secolo cfr. , tra l'altro , R A PRESTON, S.F. WISE , Storia sociale della guerra, (1956), Milano, Mondadori, 1973, pp . 243-315. Scarse le informazioni disponibili in italiano su lle vicende degli altri eserciti europei nello scorcio del secol o. Cfr. , per l'esercito germanico , ancora G. RJTTER , l militan· e la politica nella Germania moderna, v. I , Da Fedenco il Grande alla pn'ma guerra mondiale, (1951), Toòno , Einaudi, 1967, pp . 249-349 (im perniate sui contrasto Bismarck-Moltke ) e pp . 45 7-514 ( per il periodo successivo); e G.A. CRAIG. Il potere delle armi. Storia e politica dell'esercito pru.IIiano 1640-1945 , (1955), Bologna , Il Mulino , 1984 , pp . 243-330. Cfr. anche la recente rassegna bibliografica di S. SEGRE . Forze armate e societii nella Germania imperiale. 1870-1914, io cStoria contemporanea., a. XIV ( 1983 ), n. 3. Sull'esercito francese (insi eme al classico). MONTEILHET , Les insh'tutions militaires de la France 1814-1932 , Paris , Alcao, 1932) cfr . P . M. DE LA GORCE, Le armi e il potere. L 'esemlo francese da Serlan all'Algeria, (1963), Milano. 11 Saggiatore, 1967, pp. 15- 100. Sull'esercito russo cfr. S. ANDOLENKO, Storia dell 'esercito russo, ( 1967), Ftreoze, Sansoni, 1969. pp. 285-291. Alcune prim e informazioni sullo stato dei vari eserciti europei anche io RJTTER , I milùari e la polùica nella Germania moderna, v. I , Da Fedemo il Grande alla pn·ma guerra mondiale, cit., pp. 353 -45 4.
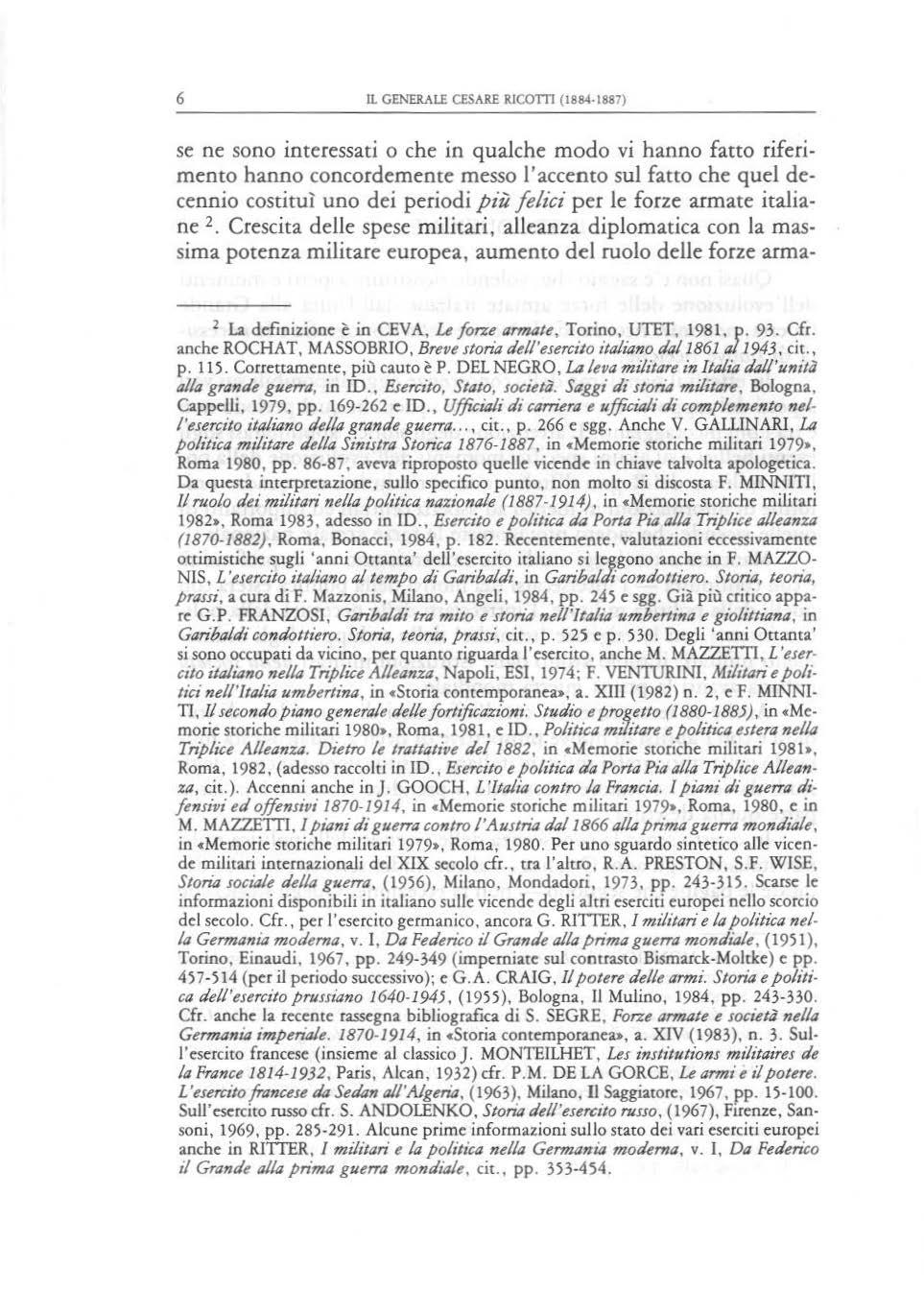
6 IL GENERALE
CESARE RI C01TI ( 1884·1887)
te nella tutela degli interessi nazionali, crescente professionalizzazione del 'quadro militare ', sempre maggiore possibilità di 'sganciare ' l'Esercito e la Marina dal mero compito di difesa dei confmi e delle coste e di 'proiettarli' verso più lontani ed impegnativi teatri di co mbattimento europei. E tutto questo avveniva dopo che per un decennio, gli anni Settanta, le forze armate italiane si erano prima dedicate ad una profonda opera di riforma interna (che le aveva messe, distanziate certo ma non più tanto lontane come per l'innanzi, sullo stesso piano delle più moderne istituzioni militari europee) e poi si erano sentite 'sacrificate' da una politica estera che pareva raccogliere più sconfitte che successi (Berlino 1878, Tunisi 1881) e che sembrava dover contribuire ad accrescere - piuttosto che ad alleggerire -l 'isolamento diplomatico dell'Italia dal concerto europeo delle potenze.
Negli anni Ottahta del XIX secolo, insomma, anche al di là della volontà dei singoli governanti italiani, si aprivano spazi oggettivi internazionali nuovi per le forze armate del Regno d'Italia.
A beo vedere, quindi, tornando allo stato della storiografia militare italiana, non sarebbero mancati davvero i soggetti per la ricerca stonca.
Ma, oltre a quelle lacune più generali di conoscenze cui sopra si è accennato, il panorama degli studi disponibili sulla storia militare italiana degli anni Ottanta evidenzia un carattere suo specifico (e negativo). Paradossalmente , paiono essere state scritte sulle vicende della politica militare di quel decennio più sintesi generali e riassuntive che attente e solide ricerche documentarie 3. E, sempre paradossalmente, talvolta talune odierne sintesi storiografiche paiono trarre -a proposito dello stato delle istituzioni militari nazionali - bilanci addirittUra più ottimistici 4 di quanto alcuni protagonisti di quelle stesse vicende storiche avessero mai potuto pensare di tracciare. Di fronte alla definizione degli anni Ottanta come 'anni felici', ricerche di archivio o pubblicazioni di memorie autobiografiche di
3 Questo aspetto, già segnalato da ROCHAT , MASSOBRlO , Breve storia dell'e· sercito it111illno dal 1861 a/1943, cit., p. IX, è stato richiamato da P. DEL NEGRO, Studi militari sul risorgimento e sull'Italia liberale, 1870-1914, ciel., p. 6, relazione preseotata al Convegno c Vent'anni di storiografia militare italiana», Lucca, 19 -21 onobre 1984 , organizzato dal Centro lnteruniversitario di Scudi e Ricerche Storico-militari.
4 Cfr. GALLINARl, La politica militare della Sinistra Storica, cit.; MINNITI, Il ruolo dei militan· nella politica nazionale {1887-1914), cit.; CEVA, Le forze armate, cit Analogo ragionamento per L'eserciJo e i suoi corpi. Sintui storica, Roma , 1971 (in testa al front.: Ufficio Storico Stato Maggiore dell'Esercito).

INiltOOUZIONE 7
importanti personaggi del mondo mi litare di quegli anni ci hanno invece fatto conoscere (e li citiamo a solo ti tolo d i esempio) i dub bi di Lu igi Pelloux sull'utilità di un'azione mi litare nella politica coloniale italiana l'insoddisfazione di Cesar,e Ricotti per le forme in cui si era sviluppato a livello di organica l'esercito e soprattutto per l'aumento di due nuovi corpi d'armata 6, le richieste di sempre nuovi stanziamenti finanziari che caratterizzò la lunga permanenza di Enrico Cosenz nella carica di Capo di Stato Maggiore dell'Esercito 7 , il malcontento di Giuseppe S. Pianell al momento in cui prese atto dei piani militari previsti per co ncretare la cooperazione militare ital ogermanica n eli ' ambito della Triplice Alleanza 8, le critiche di Agostino Ricci al generale indirizzo strategico italiano 9, le recriminazioni di Oreste Baratieri sul rapporto tra indirizzo diplomatico ed esigenze militari nella politi ca coloniale 10; e si potrebbe continuare.
Si potrebbe obiettare che quelli adesso ricordati erano solo dubbi personali partoriti da critici o m ere recriminazioni ex post di qualche vinto. Ma a fugare queste obiezioni sta il fatto inconfutabile che gli alci generali sopra menzionati erano pur sempre alcuni tra i veri e massimi protagonisti della politica militare di quegli anni e che anche altre fonti storiche degne di fede (come i diari privati di alcuni tra i più importanti e meglio informati uomini politici dell'Italia del tempo, quali Domenico Farini o Alessandro Guiccioli 11 ci restituiscono un'immagine della realtà delle condizioni in cui versava l' ese rcito italiano molto vicina alla sostanza dei dubbi e delle crit ich e di quei protagonisti sop ra ricordati ed assai meno rosea di quanto talune sintesi storiografiche odierne tendono a disegnare.
Quindi, per chiunque si fosse indirizzato a srudiare le caratteristiche della 'Italia militare' degli anni Ottanta, si trattava di assume-
5 Cfr LG PELLOUX, Quelques souvenirs de ma vie, a cura di G Manacorda , Roma, Istituto per la Storia del Risorgimento Italiano, 1967, p. 134.
6 Cfr. G. MANACORDA , Introduzione a PELLOUX , Quelques souvenirs de ma vie, cit . , p . XVI e sgg.
7 Cfr. ROCHAT, MA SSOBRIO , Breve storia dell'esercito italiano da/186 1 a/1943 cit., p. 111 e sgg
8 Cfr. VEN11JRIN1 , Mifitan· e politici nell'Italia umbertina , cit. , pp. 222-223 .

9 Cfr. ivi, p.
I O Cfr R. BATTAGUA, La pnmaguerra d 'Africa , Torino , Einaudi , 19 59, p. 6 39 e sgg.
11 Ci riferiamo a D. FARINI, Diano difine secolo , a cura di E. Morelli, Roma , Bardi , 1942 (ed . cons . 1961) . Il diario di A. Guiccioli fu pubblicato in varie riprese dalla e-Nuova antologi:b, ua il 19 32 ed il 1943 .
8 IL GENERALE CESARE RICOm ( 1884·188 7)
re come un dato di fatto quella situazione degli st udi e di sviluppare e di provare -senza mai cadere in tesi preconcette - quelle intuizioni , quegli stimoli , qu ei suggerimenti critici ed a u t o cri ti ci che gli stessi protagonisti avevano avan zato.
Per fare questo era utile non restringere la propria attenzione ad un so lo aspetto della comple ss ità della politica militare (le fortific azioni , l ' armam ento , i rapporti co l Parlamento , l 'o rganica) , via questa c he è stata più volte intrapresa dagli studiosi ma co n risultati a volte insoddisfacenti o semplicemente limitati Si do veva anzi provare a tenere quanto mai ap erto il diaframma della ri cerca, essere attenti ad ogni spostamento in tutti i possibili rami dell ' amministrazione militare , tentare di collegare cose tra loro distanti (come i cambiamenti di acce nto nella politi ca estera ed i mutam e nti dell 'organica militare , la realtà dell e guerre lontane e le innovazioni dei rego l amenti militari nazionali , il tono dei di sco rsi del Ministro della Guerra in Parlamento ed il dibattito mili tare più seg ret o ).

Ecco perch é ci è parso utile in questa nostra ricerca, ch e vuol e rimanere uno studio sulle form e e sulle motivazioni della politica militare i taliana negli anni Ottanta , restringere un poco l 'arco cron o logico ma nel conte mp o allargare nella maniera più co nsistente possibile il tipo di fonti documentarie prese in esam e. Non so l o do cumenti a stamp a o re soconti di atti parl amentari ma anche e soprattu tto materiale di archi vio, amm i nistrativo e politico, pubblico e privato, di politi ci e di mi l itari : p er così fondare su basi più cene un a valutazione più a pprofondita dello stato delle istituzioni militari italiane in quegli anni 12.
All'inizio di quel decennio un autorevole protagonista delle vicende militari nazionali , Nicola Marse lli , analizzando la condizion e delle relazioni internazi o nali europee del te mpo e riflettend o sul ru o lo e sull ' atteggiamento che l ' Itali a doveva assu m ere di fronte a quelle, . . scn veva a questo prop osuo:
12 Va ri po ssono essere approcci ad una storia delle istituzioni: uno di questi può quello che vi indtvidu i cii punto di inconrro e di sutu ra tra sto ria poli tica e storia sociale». Cfr. E. RAGI ONIERI, Politìca nella storia lia umia, Roma, Editori Riuniti, 1967 (l'espressio ne è nella Introduzione dj G . Turi all a nu ova edizione, del 1979, del volume di Ragionieri). Per a ltri aspetti cfr. S. CA SSESE , Aspetti della ston'a delle istituzioni, in Lo s11iluppo econ omico in Italia, a cura di G. Fuà, Milano, Angeli , 1969, p p. 169-202. Per un raglio più aggiornato cfr. A. CARACCIOLO , S. CASSESE , Ipotesi sul ruolo degli apparati burocratici nell'Italia liberale, in «Quaderni swrici•, a. VI {1971), n. 18 , pp. 601-608. Cfr. anche la rassegn a a cura di R ROMANEW, Stato, amm inistrazione, classi ding e nti nell'Italia liberale, in «Quaderni storici» , a. VIJI {1973), pp 603-642.
fNTRODUZIONE 9
Il lungo studio della storia ha ingenerato in me la convinzione che gli anta· gonismi nazionali simili a quelli ch e ogg i esistono non si risolvono che con la lotta armata( . .. ) . lo credo(. .. ) che sia indispensabile l' essere preparatissimi alla guerra , anzi a prendere alucsì l' iniziativa , se i maneggi e gli apparecclù delle potenze avverse acquistaSse ro un carattere minaccioso .
Non basta essere des ideros i di conquistare la pace: bisogna infondere nelle aluc potenze la convinzione che non si ha paura di affrontare la guerra , e si è risol u ti a prendere l' offensiva sul suolo nemico, quando la guer ra fosse divenuta inevitabile 13.
Già in queste poche frasi è p e rce pibile il mutamento di tono e di accento che era andato prevalendo in quegli anni nell ' ambiente militare italiano. Lo stesso Marselli , che pure qualche armo prima aveva scritto un opusco lo dal significativo titolo Raccogliam oci! 14 (e che solo qualche anno dopo , stilando una complicata graduatoria degli Stati europei e dei loro potenziali militari, sentenziava che l ' Italia dal 1861 aveva fatto taluni , ma non molti, passi in avanti) n, non a caso immetteva nel suo scritto del1882 qui ci tato un piglio ed una decisione nuova.
Il momento storico gli pareva ultimativo, la scelta politica militare da fare gli semb rava necessaria ed indifferibile. La gu e rra , a differenza che in altri passati momenti della vita dello stato unitario, poteva essere imminente; l ' Italia non doveva arrivarvi impreparata.
In questo , Marselli traduceva assai fedelmente le idee che nel 1882 si erano già diffuse o che andavano comunque prevalendo fra i militari italiani t 6
Proprio a cavallo tra gli anni Settanta e gli anni Ottanta , le riviste tecniche militari e le Commissioni segrete dei generali avevano discusso di come aumentare la forza della prima linea dell'esercito . Si trattava, come si diceva allora , di passare dall'esercito dei trecen-
13 N. MARSELLI , La politica dello stato italiano , Napoli , Morana , 1882 , p 388 c p . 390.

14 ID . , Raccogliamoci! , Roma, 1878.
15 ID ., La 111ta del reggimento. Osser11azioni e ricordi, Firenze, Barbera, 1889, o ra anche nella ristampa p r esso Roma (Gaeta, Stab. Graf. Milit . ), 1984 ( in testa al front. Ufficio Storico. Stato Maggiore Esercito), pp. 236-237 .
16 Su Nicola Marselli cfr tra gli altri P PIER! , Guemz e politica negli scrittori italiani, Milan o, Ricciardi , 1955 (noi citeremo dalla successiva edizione , Milano , Mondadori , 1975) , pp 209- 224 ; c V. GAWNARI , Nicola Marselli, in «Rivista militare., a. 1977, n. 5, adesso ripubblicato come Introduzione alla ristampa del volume citato del Marselli per cura dell'Ufficio Storico dello Stato Maggiore dell'Esercito. Cfr. an che DEL NEGRO, Esercito, Stato, società. Saggi dì storia milùare , cit., p. 192 , p. 206 e p. 216.
10 IL GENERALI!
CESARE RICOTI'l (1884-1887)
comila a quello dei 'quaruocentomila' 17 Dietro la schematicità del numero, si intende bene di quale entità era il progresso che si voleva far compiere alla maggiore delle forze armate nazionali. Quello che passò poi con il nome di 'ordinamento Ferrero' del 1882 non era alero che la sanzio ne politico-parlamentare di quel dibattito, che ancora non ci è del tutto noto 18 Lo stesso Emilio Ferrero ammise infatti che, se la creazione dei due nuovi Corpi d'Armata era apparsa com e la soluzione migliore dal punto di vista della 'potenza strategica', era pur sempre la questione di un ne cessario aumento della forza (numerica) dell'esercito quella da cui si erano prese le mosse 19. Anche le riunioni della Commissione Suprema per la Difesa dello Stato, che furono numerose ed importanti tra il1881 ed il1883 , pur frnalizzate alla compilazione di un piano nazionale delle fortificazioni permanenti , presumevano un aumento di forza dell'esercito. E non a caso si animavano in modo particolare quando, tralas ciando l'esame del sistema fortificato ri o, si passava a studiare la possibilità di fare dell'esercito , reso più forte e più numeroso , uno strumento offensivo 20.
Proprio sui temi della difensiva -offensiva, meglio che su altri, era percepibile un mutamento di tono tra i militari italiani degli anni Ottanta rispetto a quello del decennio precedente 21 • Seppure talvolta si faceva qualche confusione tra il principio dell'offensiva sul piano tattico con quello dell'offensiva sul piano strategico, tra lo spirito offensivo e la direttiva strateg i ca dell'offensiva 22 , è innegabile che lo spirito ed il carattere del dibattito militare fossero radicalmente mutati rispetto a quelli degli anni Settanta. Negli anni precedenti, le prese di posizione a favore di una 'offensiva strategica' erano espres -
17 Lo dichiarava lo stesso Marselli Cfr. ACS, Carte Pelloux, se. 26, fase. 25, 28 novembre 1879. Marselli a Pelloux.
18 Per l 'eserci to italiano , l'arco di anni fra 1878 e 1882 dovette esse re cruciale sot· to molti aspetti. Cfr., intanto, F. MlNNITI , Preparazione ed iniziatwa. JJ programma di Luigi Mezzacapo (1878-1881), in cMe morie storiche militari 1983•. Roma , 1984 e ID., Il secondo piano g enerale delle fortificazioni. Studio e progetto (1880-1885), cit., adesso ambedue raccolti in ID., Esercito e politica da Porta Pia alla Tnplice Alleanza, ci t.
!9 Cfr. anche F BAVA BECCARlS , Esercito italiano. Sue on'gini, suo succesri11o ampliamento , stato attuale, in Cinquant'anni di storia italiana, Roma, Lincei, 1911.
2° Cfr. MINNITI, Esercito e politica da Porta Pia alla Tn'p/ice Alleanza, cit., p. 107.
21 Su questo tema cfr. le acute osservazioni di DEL NEGRO , Esercito, Stato, società. Saggi di storia milùare, cit., pp 205-206 e p. 208.
22 Chiarificatore è MINNITI , Esercito e polih'ca da Porta Pia alla Tnplice Aileanza, cit., pp . 32-58.

INTRODUZIONE 11
sione solo di qualche isolato e ben informato ufficiale , che aveva studiato l'andamento della guerra franco-prussiana del1870 o che aveva avuto modo di conoscere le teorizzazioni ed i regolamenti militari prussiani . Negli anni Ottanta , invece , affermazioni perentorie come quella di Marselli poco prima citata si trovavano ormai in tutte le gazzette militari , le riviste tecniche vi facevano un ricorso diffusissimo , gli stess i Regolamenti ufficiali iniziavano a recepirne i principi essenziali, i piani di guerra preparati dallo Stato Maggiore concedevano uno spazio concreto (ben più dettagliato ed interessante che per l'innanzi) alla possibilità di operazioni offensive
È stato giustamente osservato che non çonviene oggi fare la storia delle forze armate procedendo , nell'analisi , per decenni 2 3
Eppure non si può fare a meno di notare che , per più di un verso , gli anni Ottanta furono per i militari italiani qualcosa di complessivamente diverso e non immediatamente rapportabile al decennio precedente.

Aumento di forza - organica e strategica -, offeosivismo sempre più pronunciato , non erano elementi isolati di un quadro che rimaneva, per il resto , statico . Le forze armate, l'esercito , si sentivano negli anni Ottanta depositarie di un ruolo e di una funzionenello stato, nella società, nel Paese - sempre più grandi ed importanti. Si esigevano aumenti notevolissimi nelle spese militari: e li si ottenevano 24 Di fronte ad una rinnovata effervescenza sociale delle larghe masse contadine ed artigiano-operaie, che si esprimeva in agitazioni urbane e rurali di intensità e qualità nuova , veniva maggiormente valo riz zata la funzione dell ' impiego delle truppe per il mantenimento dell ' ordine pubblico, della stabilità sociale ed istituzionale 25. Di fronte ad una classe dirigente nazionale che mostrava i suoi limiti di egemonia sui ceti subalterni , gli ambienti militari più sensibili teorizzavano ed avviavano ambiziosi programmi di «educazione nazionale militare», con cui poter diffondere tra le popolazioni al tempo stesso lo 'spirito militare ' ed il rispetto delle istituzioni monarchiche . Nel campo della cultura e dell'i struzione , si spingeva perché i convitti nazionali (statali) venissero militarizzati e - sia pure nell'ossequio della cultura umanistica- venisse introdotto lo studio
23 Cfr. DEL NEGRO , Studi militan' sul Risorgime nto e sull'Italia liberale, 18 70-1 914 , ci t ., p 9
24 Cfr. ROC HAT, MAS SOBRIO , Breve storia dell'esercito italiano dal 1861 al 1943. ci t. , pp . 111 ·115 . Cfr ivi, pp 14 - 15.
12 lL GENERALE CES ARE RI COTII (18:84-1 887)
di materie specificatamente militari nonché l'osservanza della più stretta disciplina militare. Attraverso la creazione di «Società di Tiro a Segno Nazionale» direttamente dipendenti dal Ministero della Guerra si compiva l'espropriazione della Sinistra democratica di una sua vecchia parola d'ordine e si cercava di raggiungere, organizzare e mobilitare fasce di popolazione e di giovani talvolta ancora lontani dai miti militari. Si diffondeva sempre di più un'interpretazione «militare» dell'utilità (non solo fisiologica ed individuale bensì anche sociale) della ginnastica e delle ideologie salutiste ed igieniste. Aumentava numericamente la pattuglia dei deputati militari io Parlamento , e cresceva in essa la percentuale dei più alci ufficiali. All'incirca a metà degli anni Ottanta - per un complesso di cause ed occasioni diverse- indossavano la divisa non solo il Ministro della Guerra e quello della Marina, ma anche il Ministro degli Esteri ed il Presidente della Camera; inoltre, altri importanti e noti militari erano insediaci in rilevanti posti d eU' amministrazione centrale dello Stato, in qualità di Segretari Generali, membri di Commissioni ti della Camera (ad esempio, la Commissione Generale del Bilancio) nonché - ovviamente - di Uffici parlamentari e Commissioni varie 26.

Questi aspetti, vari ed importanti per dimostrare l'accresciuto ruolo che l 'ese rcito veniva (e voleva venire) a giocare nella società e nella politi ca italiana degli anni Ottanta , erano poi amplificaci e dilatati nel dibattito militare, in quello ufficiale e in quello pubblicistico minore . Talune richieste stravaganti della pubbliciscica militare minore possono essere prese in considerazione in quanto testimonianza autentica, seppure esagerata, di un clima nuovo per i mi l itari italiani. Gli opuscoli di quegli anni esigevano , ad esempio, che Umberto I - prima ancora che sovrano del suo regno - dovesse dimostrare in ogni occasione possibile di essere il Capo dell'esercito: a partire dalle banconote, dove si voleva che non comparisse in abiti civili, bensì in marziale divisa 27. Il diritto per i militari a risolvere le loro questioni personali attraverso quel combattimento in sedicesimo che era il duello non doveva conoscere, per gli anonimi autori di altri fascicoletti, alcuna limitazione ; anzi, il ricorso al duello doveva essere imitato e diffuso anche presso le altre categorie professionali o so-
26 Alcuni dei temi cui si è accennato vengono sviluppati nelle pagine che seguono.
INTRODUZIONE 13
27 Cfr. Il morale dell'esercito e l'avanzamento degli ufficiali. Saggio cniico, Roma, Forzani, 1885.
ci alì, quale prova dì sentimento militare di tutta la nazione 28. Le stesse onoreficenze militari, allora proposte dagli organi militari ma formalmente concesse dalle supreme autorità politiche del Paese, dovevano essere svincolate- secondo altri opuscoli militari- dal controllo politico dell 'esecutivo ed accordate, per il solo tramite del Ministero della Guerra, dal monarca in persona 2 9. Si ripetevano , con autorità e frequenza nuove, le richieste di ' militarizzazione integrale' del Ministero de ll a Guerra 30 .
Tutto, insomma , nell'Italia degli anni Ottanta, doveva essere militare 31.
Ben poco rimaneva dell'afflato risorgimentale che molti pubblicisti, civil i e militari, avevano visto nelle vicende italiane del primo decennio uni tario 32; con il decisivo infoltirsi del Corpo Ufficiali negli anni Ottanta (dopo che durante il Ministero Ricotti degli anni Settanta esso aveva subito una drastica riduz ione) e con il compa-
28 La bibliografia sul duello, in quegli anni, è assai vasta. Cfr. tra l'altro, cL' esercito italiano•, 26 gennaio 1886, U duello e il codice penale militare.
29 Cfr., tra l'altro, zfli, 14 gennaio 1886, Le onorefoenze per l'Esercito.
30 La richiesta fu perentoriamente avanzata da L MEZZA CAPO, Armi e politica, Roma, Capaccini, 1881. Ma cfr. già l'intervento dello stesso C. Ricotti in AA.PP., Camera, Legisl. XII, scss. prima, Discuuiom·, tornata del 19 febbraio 1875.
3l Non molto venivano apprezzate le 'deviazioni' istituzionali dell'esercito dai suoi compiti più rigidamente militari. Se non veniva ben visto l'uso frequeote della truppa in ordine pubblico ed in genere in servizio di polizia e di vigilanza, sembra però che nemmeno l'aiuto portato dalle strUtture militari alle popolazoni in caso di calamità naturali incontrasse poi il gradimento degli ambienti miliwi. Cfr., in questo senso, cL' esercito italiano•, 7 onobre 1885 , Le riserve. Cfr. anche ACS, Carte Pelloux, se. 2, 6 settembre 1884, De Vecchi a Pelloux. In ogni caso, l'esercito teneva sempre moltissimo al suo caranere 'separato' ed alla sua autonomia. Nello stesso autunno 1884, ad esempio , quando il colera imperversava in Italia, il Ministero degli Interni chiese alla Guerra di sospendere c in modo assoluto• gli spostamenti militari dalle zone infette e da quelle adiacenti. Alla richiesta, invece, il Ministero della Guerra oppose il più secco rifiuto a far regolare da altri, da 'civili', i movimenti delle sue truppe. Cfr. ACS, Presidenza del Conszglio dei Ministn', b. 55, fase. 291, 4 onobre 1884, Morana a Depretis. Con ancora maggiore freddezza erano poi viste le proposte di impiego 'civile' dell'esercito per fini di pubblico interesse e utilità . Proposte che, pur ingenue o interessate , tendevano a valorizzare 'produrrivisticamente' l'enorme quantità di manodopera dei giovani coscritti. Tra queste proposte cfr. quella di F. VIGAN6 , Progetto di risanamento dell'agro romano coll'esercito, Milano , Zanoboni , 1885 Appena tollerate, infine, quelle iniziative 'civili' tendenti ad istruire le reclute su questioni non militari. Cfr., ad esempio, G. ZAMBRANO, Storia ed avvenire dell'istruzione agraria nell'esercito, Milano , Cogliati, 1901, che voleva negli anni Onanta «tener conferenze agrarie ai soldati che dal fucile debbono ritornare alla naùa vanga.. lvi, p. 16. Per alcune informazioni cfr. anche L ' esercito per il paese 1861 - 1975. Roma, USSME, 1977.
32 Cfr. PIERI , StÒria mi/ilare del Risorgimento. Guerre e insurrezioni, Torino , Einaudi, 1962 , p. 5 77.

14 IL GENERALE
CESARE RICOm ( 1884·1887)
rire di quegli aspetti della 'p resenza militare' di cui abbiamo parlato, si evidenziava un carattere nuovo del ruolo dei militari nella politica e nella società italiana. Questo era il corrispettivo 'interno' e meno appariscente di quel mutamento sostanziale ed evidente che Marselli aveva notato negli eserciti europei di quegli anni, e che le Commissioni di generali e gli Stati maggiori stavano preparando per l'esercito italiano 33.
Le questioni deU'aumento di forza dell'esercito e della diffusione delle teorie offensivistiche, nonché della loro adozione, diventavano così aspetti centrali della politica militare italiana degli anni
Ottanta: una politica militare che mirava più che nel passato a conquistare per l'Italia il ruolo di 'grande potenza', politica e militare, di livello europeo nonché ad imporre o comunque a far accettare questo nuovo ruolo italiano agli altri Stati del vecchio continente 34. Una politica militare che ebbe un costo finanziario notevole per lo Stato italiano 35, ed i cui esiti devono ancora essere analiticamente studiati e confrontati con quelli nel frattempo raggiunti dalle altre potenze europee. Appare chiaro però, sin da adesso e dagli studi oggi disponibi li, che al grande impegno finanziario ed al notevole carico di impegni politici e militari internazionali 36 che l'Italia ed il suo esercito andarono accumulando negli anni Ottanta non corrispose un · adeguato risultato, politico come diplomatico 37. Oltre a questo, alcune vecchie lacune nella composizion e organica dell'esercito, nel suo
33 Cfr., come è noto, MINNITI, Esercito e politica da Porta Pia alla Tnplice Al.feanza, cit., pp. 89 - 113.

'"34 La comparsa di questo tema nuovo e l'imponanza di questo snodo nella politica estera e militare italiana sono avvertite in tutte le grandi opere sulla storia d ' Italia. A livello di storia europea cfr. M. HOWARD, Le forze armate, in Stona del mondo moderno, v. XI, L'espansione coloniale e i problemi sociali 1870-1898, a cura di F.H. Hinsley (1967), Milano, Garzanti , 1970; eJ. GOOCH, Soldati e borghesi nell'Europa moderna, (1980), Bari , Laterza, 1982.
35 Cfr. L DE ROSA , lncùlenza delle spese militan· sullo sviluppo economico itaJ:ano, in Atti del pn'mo convegno nazionale di storia militare, cit., e A. PEDONE, Il bilancio dello Stato, in Lo sviluppo economico in ltalta , a cura di Giorgio Fuà, Milano, Angeli, 1969, v.II; ROCHAT, MASSOBRlO , Breve storia dell'esercito italiano dal 1861 al1943, cit., pp. 66-83.
36 Cfr. MAZZETTI , L 'esercito italiano nella Triplice A.lleanza, cit.; R. MORl, Cn'.spi e la Triplice. Gli accordi militan· itala -germanici, in «Rassegna storica toscana•, a. XV1 ( 1970), n. l; ID., Francesco Crispi e l'accessione italiana all'accordo austrorumeno, incClio•, a. V(1969), n. 2-3; BATTAGUA , La prima guerra d'Africa, cit.; A. DEL BOCA, Gli italiani in Africa onentale. Dall'unità alla marcia su Roma, Bari , Laterza , 1976
37 Cfr. F. CHABOD, Considerazioni sulla politica estera dell'Italia dal1870 al 1915, in Onentamenti per la stona d 'Italia nel Risorgimento, Bari, Laterza, 1952.
INTRODUZIONE 15
armamento, nella sua amministrazione - seppure più volte segnalate nei dibattiti pubblicistici e parlamentari- non venn ero colmate.
E dopo gli anni Ottanta, gli anni della espansione, arrivarono gli anni Novanta, gli anni 'della crisi' 38, gli anni delle forti economie sui bilanci militari, gli anni degli espedienti, dello spregiudicato u so del principio della 'forza massima e forza minima' , del rinsaldarsi delle ipotesi che miravano ad una sostanziale riduzione del quadro militare complessivo italiano. In questo senso uno studio della politica militare degli anni Ottanta non può essere condotto senza tener presente poi i suoi esiti nel decennio successivo, che non fecero che approfondire quella cau tosegregazione dalla vita del paese:., che era già stata notata. Un'autosegregazione con cui si nega una partecipazione 'alla pari' alla risoluzione dei problemi della Nazione, ed edifica un impenetrabile ridotto nel quale finisce per rinchiudersi e dal quale interviene negli affari del paese come fosse elemento ad esso estraneo• 39. Sino alla voragine vera e propria che i fatti del 1898 scavarono tra forze armate e società.
Comunque andarono po i le cose, gli anni Ottanta non furono proprio solo 'anni felici' per l'esercito italiano ma furono ceno quelli in cui la politica militare avrebbe potuto avvalersi di assai consistenti margini (politici e finanziari) per svilupp are quel nuovo programma- aumento della forza dell'esercito e diffusione dell' offensivismo -e per colmare alcune storiche lacune della sua composiztone orgamca.
Sugli artefici della politica militare di quegli anni, però, sui militari e sui polidci visti nei loro reciproci rapporti sul terreno della 'questione militare', non disponiamo oggi che di pochi studi. In un certo senso è anche oggetto di possibile discussione l'uso di queste stesse categorie interpretative ('militari e politici', ad esempio), per riferirsi ad un periodo storico in cui forse in Italia una separazione netta all'interno della classe dirigente tra politici e militari non era ancora
38 Cfr ROCHAT, MASSOBRIO, Breve Jtoria dell'eiercito italiano dal 1861 al 1943, cir., p 124 , e MANACORDA, Introduzion e, cit., p XXV1 e sgg.
39 Così scriveva F. Minniti nel 1973. Il passo, incisivo ed efficace, era stato apprez· zato da altri studiosi, che lo avevano più volte citato e segnalato. Punroppo , l'A. ha deciso di espungere quel passo dalla ristampa del saggio da cui era rrarto. Cfr. quindi MINNITI, EJercito e politica da Porta Pia alla Tnplice Alleanza, in cStoria contemporaoe:a, a IV (1973), o l , p. 34, ma non più ID. , E.rercùo e politica da Porta Pia alla Triplice Alleanza , ci t., p. 53.

16 n. GENERALE CESARE RJCOm (1884·1887)
così pronunciata 40 com e lo fu ceno in segui to. Come anche potrebbe esse re opinabile, ad esempio, la generica defmizione di 'militari ': proprio quando si vuole sotto lineare - all'interno del mondo militare -la presenza di una pluralità di liv elli strutturali ed un ' anicolazione (reale e funzionale) che contribuiscono a rendere co mposito e differenziato il giudizio storico.
Rimane comu nque indubbio il fatto che , se pure l 'uso di un a tale terminologia non può esse re accolta per int ero e con leggerezza, una differenziazione tra interessi più propriamente militari ed obiettivi pi ù gene ralmente politici era ovvia e presente (ed avvertita già) nell a classe dirigent e dell'Italia unitaria 4 1.

Recentemente è stato scritto a proposito di quel periodo , ormai pose-risorgimentale , che su politici e militari, pur non poi
40 Nonostante il titolo, non solleva tali problemi VENTURINI, Militari e politici nell'Italia umbertina, cit. Usa la categoria dì 'separazione' MINNJTI, e polili· ca da Porta Pia alla Triplice Alleanza. cit. Sullo 'stato monoclassc' cfr. E. ROTELLI , Le istituzioni politiche e amministrative, in Storia della società italiana, p. V, v. XIV. ·Il blocco di pot ere nell'Italia unita, Milano , Teti, 1980, pp. 357-385 Per un primo inquadramento sulle p roblematichc della storia dello Stato, delle istitu zioni e dell'amministrazione italiana (civile, ma anche militare), cfr. A. CARACCIOLO , Stato e società civile. Proble m i dell ' unificazione italiana, Torino, Einaudi, 1960; ID. , Lo stato italiano nelle dimensioni del suo tempo: alcuni appu n#, Mil ano, Giuffré , 1963; Stato e ammi· nistrazione, fase. spcc. dì •Quaderni storica, a. 1971 , n. 18; S. CASSESE, La formazione dello stato amministrativo, Milano, Giuffré, 1974; Gli apparati statali dall'unità al fascismo, a cura di I. Zanni Rosiel lo, Bologna, ll Mulino, 1976; ed ora L 'amministraz i o n e centrale , a cu ra di S. Casses e , Tori no , UTET, 1984.
41 La letteratura scie ntifica internazionale sulle forme e sul controllo dei rapporti tra politici e militari (soprattUtto per il periodo successivo alla fine del secondo conflitto mondiale, per i paesi cosidetti 'in via di sviluppo' c per i casi più drammatici di sostitu · z ione di un ' potere militare' al 'potere politico') è ormai vastissima. Per una impo ttan· te bibliografia (anche se ormai non più sufficientemente aggiornata) cfr. G. HARRIES]ENKJNS, C. L MOSKOS jnr {eds), Armed F<mes and Society, in cCu rrcnt Sociology., a. XXIX (198 1), n. 3. Sebbene non manca chi sostiene che il dibattito scientifico contemporaneo sui rapporti rea politici e militari sia iniziato m olto prima, è comu nque rico n osciuta g rande imponanza al volum e di S.P. HUNTINGTON, The Soldierand the State: The theory and poli#cs o/ civil-military relations, Cambridge ( Mass .), Harvard Universit y Press, 1957. Sottolineò l'imponanza del dato sociologico M. JANOWITZ, The ProfeSJional Soldier, New York, Free Press, 1960. L' analisi acce ntuò l'aspetto formalistico con D RAPOPORT. A comparathive theory of military and politica/ types, in S.P. HUNTINGTON (ed.), Changing patlerns of military politics, Ncw York, Free Press , 1962. Una successione di modelli diversi è stata identificata, era gli altri, anche da A PERLMUTTER, The military and politics in modem #mes, New Haven, Yal e U10ìversity Press, 1977. Ma questi so no so lo alcuni tra i più noti (e discussi) testi generali: contando anche gli studi specifici e i case-studies, le bibliografie aggiornate arrivano ad indicare diverse centinaia di titoli. In Italia- an che se qualcosa sra cambi ando negli ultimi anni- sono da ricordare gli studi pregevoli c pioneristici di G. PASQUINO, rea cui si ricorda Militarismo e professione militare , in cRasseg n a italiana di sociologiaJ, 1971, n. 4.
INTRODUZIONE 17
così lontani tra di loro «perch é provenie nti da una comune tradizione , agirono ben presto fauori che impedirono che questa integrazione si concretizzasse in una capacità di elaborazione alla pari degli obiettivi di politica militare, in una collaborazione , in una effettiva integrazione dei propri intenti . L"occhio militare ' e l " occhio politico ' mostrarono un se mpre più accenruato strabismo ... • 4 2 .
In tal senso va notato che, però, se il 'militare' attraversò il decennio degli anni Ottanta , conoscendo fasi diverse ma superandole, sostanzialmente senza fratture e mantenendo costante il proprio programma (sia pure nel variare delle cond izioni finanziarie e politicheinternazionali in cui veniva ad operare), il 'politico', la classe politica , conobbe proprio in quel periodo un mutamento profondo della sua storia interna 4 3. Se , infarti, l'indirizzo della politica militare di Ferrero , di Ricotti e di Benolé Viale (i tre ministri della Guerra di quel decennio) mutò ma all'interno di margini ben defmiti e costanti, la classe politica italiana avverti un ceno cam biamento nel suo passare dali' esperimento trasformista depretisiano alle prove dirigistiche ed autoritarie della 'dittarura crispina ' 44 • Dal punto di vista della storia politica (ma anche istituzionale) e parlamentare è infatti ceno che il 188 7 divide in due parti tra loro diverse l'intero decennio .
Il lasso di tempo da noi preso in esame in questo stud io, in particolare, appare comprensibile proprio solo a partire da questa constatazione. Mentre per i militari il periodo in cui Ricotti tornò a reggere il dicastero della Guerra fu solo una fase - anche se taluno la defmì una sosta - all ' interno di un percorso orm ai stabilmente defmito (que llo del conso lidamento dell'ordinamento su dodici corpi d'armata e della diffusione delle dottrine offensivistiche) , per i poli-
42 VENTURINI, Militan· e politici nell'Italia umbertina, cit., p . 233.
43 ar. E. RAGIONIERI, La storia politica e sociale, in Storia d 'Italia , v. IV, Dall'unità ad oggi, t. III , Torino, Einaudi, 1976 , p. 1744 c: sgg.
44 La bibliografia su Crispi c: sulla politica dei suoi governi è assai vasta, soprattutto se: confrontata con quella disponibile: sul trasformismo e sugli anni di Depre tis. Cfr., su Depretis, ancora G CAROCCI , Agostino Depretis e la politica interna da/1876 a/1887, Torino, Einaudi, 1956. Non più accettata è in genere l'opinione: di R. GREW, Il trasformismo: ultimo stadio del Risorgimento, in Il Risorgimento e l'Europa, a cura di U. Frosini, Catania , Bonanno, 1969, pp . 151-163 . Cfr. invece:, adesso , U. lEVRA, Sinistra stonca, in Il mondo contemporaneo. Storia d'Italia, a cu ra di F. Levi, U. Levra , N. Tranfaglia, Firenze, La Nu ova Italia, 1978, pp . 1258-1287. Su Crispi, tra i molti alui , gli atti dd XIX Convegno storico toscano su Crispi e il suo tempo, in cRassc:gna storica toscana., a. XVI ( 1970). n. l; F. FONZI, Crispi e lo 'stato di Milano ', Milano, Giuffré , 1965; G. MANACORDA, Crisi economica e lotta politica in Italia, 1892-1896, Torino , Einaudi, 1968.

18 IL GENERALE
CESARE R1COTn (1 884-1887)
t ici (e per l 'Italia intera) l'esperienza del sesto e settimo Ministero Depretis rappresentarono un difficile e confuso momento di passaggio dalla 'stagnazione' del trasformismo all"attivismo' e all'imperialismo crispini. Fu quello un periodo in cui si sfaldava un precedente sistema di potere parlamentare e politico ed in cui comparivano sulla scena forze - sociali e politiche - nuove, mentre altre più vecchie forze rideflllÌvano i loro obiettivi e i loro programmi; un periodo in cui si andavano preparando grandi cambiamenti, che proprio per questo ancora non acquistavano caratteri precisi e nuovi ma che pure urgevano e spingevano, sotto la crosta di un vecchio ordine parlamentare e politico. Un periodo politico, quello precedente il 1887, in cui è importante cogliere il comparire di nuovi accenti piuttosto che cercare già una loro completa evidenziazione.
Se questo è il senso politico generale dégli anni in cui Ricotti fu Ministro per la seconda volta, può anche essere non inutile interrogarsi sul perché si è sempre parlato così poco (nella storiografia più specifica) di questo periodo della storia dell ' Italia militare.
Nei manuali di storia militare, o nelle trattazioni comunque più generali e più organiche, in cui quasi sempre la storia d eli' esercito è fatta - per comodità o per co nvinzione - periodizzandola con il nome dei Ministri della Guerra, il secondo ministero Ricotti è sempre ingiustamente trascurato 4 5. Fiorenzo Bava Beccaris, in quel suo scritto del 1911 46 (in cui tanto però si deve alla mano rimasta anonima di A. Cavaciocchi) 47 aveva già dato l'esempio più ch iaro di come si possa addirittura tacere di questo periodo della storia italiana delle istituzioni e della politica militare. Quelle poche righe, che Bava Beccaris concesse al secondo ministero della Guerra di Cesare Ricotti ed agli anni 1884-1887 , ricordano so lo che in essi fu dato il via alla prima spedizione militare-coloniale italiana.
Un simile atteggiamento storiografico, in realtà, come vedremo, falsa completamente l'interpretazione e la comprensione storica.
45 Tra i più recenti cfr. ROCHAT, MASSOBRIO, Breve stona dell'esercito italiano da/1861 al 1943, cit., pp. 112-113 e p. 116; CEVA , Le forze armate italiane. cit., p. 94. Cfr. poi L 'esercito italiano dalz • tricolore a11 • centenano, Roma (Roma Tip Regionale}, 1961 (in testa aJ front. : Stato Maggiore dell'Esercito, Ufficio Storico), p. 191. Anche lo stesso A. TOSTI, Stona dell'esemio italiano. Milano , ISPI. 1942 , p. 89.

46 Cfr. BAV A BECCARIS. Esercito italiano. Sue ongini, suo successivo ampliam e nto , stato attuale, cit.
47 Cfr. A. CAVAClOCCH1, F SANTANGELO, hh"tuztonimilitariitaliane, To· rin o. Scuola di guerra, 1909. Quesco aspetto era già in parre notato da DEL NEGRO, Esercito, Stato, società. Saggi di storia mi/tiare, ci t .• p 247.
INTRODUZIONE 19
Ai tempi di Ricotti e di Cosenz, infatti, la spedizione di Massaua era vista, particolarmente fino alla giornata di Dogali, come un aspetto impegnativo e difficile ma comunque secondario nell'ambito della politica militare italiana. Solo l ' emergere delle prime difficoltà, insieme al clamore del dibattito politico che la politica coloniale del Governo sollevava, fece poi aumentare l'interesse e la preoccupazione dei militari .
L'origine storiografica di questa sorte di incomprensibile sil enzio (la constatazione delle lacune generali della storia militare italiana non può sempre spiegare tutto) è a nostro avviso da rintracciare in un curioso ma imponame libro che già stava in buona pane alla base del lavoro di Bava Beccaris e di Cavaciocchi, e a cui poi si è rifatto chiunque (in questi ultimi venti anni e più) abbia voluto in Italia scrivere la storia dell'esercito italiano. Ci riferiamo al volume di Carlo Corsi 4 8, vera miniera di informazioni sulle vicende dell'Italia militare dell'Ottocento.
Corsi in quel suo scritto riassumeva tutta la seconda esperienza ministeriale di Ricotti in poche righe.

Il successore di Ferrero era già nominato dall'opinione pubblica da qualche tempo( ) era Ricotti , rimasto sempre a capo dell 'opposizione militare di Desua( ) questo secondo Ministero Ricotti fu dunque necessariamente conservatore ( ... ) I suoi atti furono perciò, più che aluo, ritocchi, correzioni 49.
Queste affermazioni di Corsi spesso sono passate, senza nemmeno nessun adattamento , in molti dei manuali anche più recenti di storia militare italiana ; ma erano in realtà affermazioni da doversi prendere con le dovute caute le.
Per prima cosa andava tenuto presente che Corsi non aveva mai fatto mistero, nella sua opera di 'storico', di vedere con un certo occhio critico gli indirizzi e le realizzazioni della politica militare italiana successiva al1876 , contro la quale esplicitamente anche Ricotti aveva preso posizione 50. E già qui potrebbe stare una delle ragioni dell'indulgenza storiografìca di Corsi per l'operato del generale novarese. Ma ce ne sono altre, e più cogenti, che spiegano il silenzio di Corsi sul secondo Ministero Ricotti; silenzio che, come si è detto, in mancanza di studi che 'ritornassero alle fonti documentarie' di quel periodo , è passato poi nei manuali di storia militare.
4 8 Cfr. C. CORSI , Italia 1870- 1895, Torin o, Roux, 1896. 49 lvi, 279 e p. 282. )0 Cfr. ivi, pp. 162-163.
20 Il
GENERAlE CESARE RICOm ( 188<1·1887)
Le affermazioni di Corsi in quel suo volume non potevano avere il dovuto 'senso della prospettiva stOrica ' poiché esse erano state scritte ... in contemporanea agli eventi! Sebbene, infatti, il volume fosse stampato nel 1896, Corsi aveva scritto quelle sue note sull'Italia militare del suo tempo, proprio nel 1886, quando il Ministero Ricotti era iniziato da appena un anno e quando ancora non si conosceva quale sarebbe poi statO il suo vero epilogo. Quando Corsi scriveva su Ricotti, insomma , egli scriveva sul Ministro allora in carica e nella previsione di una prossima pubblicazione del suo studio: e non è da escludere che la sua penna, in molte altre occasioni graffiante ed acuta , non si fosse un po ' frenata ed arrestata di fronte all'analisi dell'operato di quello che rimaneva pur sempre allora un superiore gerarchico . Come però spiegava lo stesso Corsi io una sua pagina pubblicata in fondo al volume, egli era statO colto proprio nel 1886 da una grave malattia che lo aveva costretto a interrompere i suoi studi e quando li riprese , nel 1896 , egli aggiunse in fretta e furia una sorta di conclusione cronologica al volume , ma non cambiò una virgola a quantO aveva già scritto 5 1 .

Le pagine sul secondo Ministero Ricotti, seppur pubblicate nel1896, rimanevano quelle del 1886 e risultavano in un certo senso incompiute.
Per tutta questa somma di motivi , quindi , l' asprezz a e la varietà del dibattito militare che contraddistinse il secondo Ministero della Guerra del generale novarese sono rimaste per lungo tempo sottratte alla nostra: attuale conosc enza storica.
Compatibilità finanziarie , indirizzi contrastanti di politica militare, divario crescente con l ' evoluzione dell e forze armate delle altre potenze, ' soste ' programmate e realizzate con autoritarietà e forza: tuttO ciò non poteva forse essere chiaro a Corsi, che scriveva mentre questo accadeva . Ma tutte l e ricostruzioni storiche , che solo sulle pagine di Corsi si sono basate , hanno ignoratO questi as petti della realtà storica degli anni Ottanta.
Delle vicende militari italiane tra il 1884 e 188 7 , proprio come Corsi aveva scritto , rimaneva solo l'opera di ritocchi e correzioni. Spariva , veniva ignorato e censurato (proprio come Corsi ave va fatto) il vivace dibattito militare che attraversò e contraddistinse il secondo Ministero Ricotti.
Ma, così facendo, si perdeva un'occasione di analizzare le reali Cfr
INTRODUZI ONE 21
. ivi, p . 377 e sgg .
componenti e i complessi e contrastanti meccanismi di formazione della politica militare degli anni Ottanta nell'Italia liberale.
Erano quelli gli anni della 'espansione', del definitivo aJlargamento degli organici , delle assunzioni di nuovi impegni internazionali , del crescente peso su lle finanze dello Stato, dell'avvio di una politi ca militare coloniale che doveva poi risultare molto più impegnativa di quanto all'inizio poteva sembrare.
Concludendo si potrebbe anche dire che è ancora da scr iv ere un esauriente studio sulla politica militare italiana e sulle caratte ristiche del potenziale militare nazionale degli anni Ottanta nel loro complesso.
Nel frattempo, però, questa nostra ricerca sul 'secondo Ministero Ricotti' potrà almeno servirvi da preludio.
Per uno studio che trae origine da una tesi di laurea, se ppure a lungo corretta, ampl i ata, ri strutturata ed infine tutta 'riscritta', integrata da nuove e non second arie ricerche documentarie 52 , l'aver raggiunto quest o scopo sarebbe un risultato per noi già soddisfacente.
) 2 Dopo la sresura di questa nostra ricerca (durame il lento passaggio dal dattiloscritto alla stampa) sono apparsi due volumi che qui vanno ricordati , anche se per motivi diversi.
Il primo è il volume Vent'anni di storiografia mtlitare italiana, a cura di Giorgio Rochat, Milano, Angeli, 1985. Questa pubblicazi one raccoglie gli ani dell'omonimo Convegno, atri che noi abbiamo utilizzato citando dalla loro prima forma dattiloscritta.
Il secondo è una pubblicazione di L 11JCCARI, L'impresa di Mauaua cento anni dopo, Roma, USSME, 1985, cui si rimanda.

22 Il GEI'ERALf CESARE RJCOm ( 1884 -1887)
AVVERTENZA
In chiusura dd volume, piuttosto che il tradizionale lungo elenco della bibliografia consu ltata , si è scelto di inserire i nomi degli auton· nello stesso Indice dei nomi, in modo da rendere più agevole la consultazione dell'intero volume. N. Dd.R.

INTRODUZIONE 23

PARTE PRIMA
POLITICA E POLITICA MILITARE


CAPITOLO PRIMO
UN ESERCITO PER RICOm
Esercìto e polìtìca nel trasformismo
Talvolta la storia dei meccanismi di formazione della politica militare dell'Italia liberale è stata confinata in una mera ricostruzione del dibattito interno (dei militari, tra i militari) del tempo 1 Crediamo invece che fare solo questo non sia corretto. Almeno nel caso - qui preso in esame - del secondo Ministero della Guerra di Cesare Ricotti, una ricostruzione di quel tipo, 'tutta militare', lascerebbe ampie zone d'ombra.
Come vedremo, infatti, Ricotti salì e poi decadde da Ministro della Guerra per motivi puramente politici, parlamentari , di composizione governativa. Molta pane del suo operato alla Pilotta è comprensibile solo all'interno di una logica politica, contingente. Più di una volta l'opposizione che egli si trovò di fronte fu condotta- nel Parlamento ma talvolta (come pare di capire) anche nell'esercitooltre che su punt i e questioni specifiche e militari, anche e soprattutto per linee politiche generali.
Ricotti stesso, in quanto e nonostante fosse un militare, indulgeva ad ammettere più di altri che nella formulazione di una politica militare nazionale le sollecitazioni ed i suggerimenti della Camera potessero avere una parte importante (anche se, ovviamente, non d·ovevano arrivare a mettere in discussione il 'ridotto' militare in cui anche per il generale novarese doveva snodarsi il filo della formazione e della pratica, dello studio e dell'applicazione, della discussione
1 Aveva già rilevato questo aspeno ROCHAT, MASSO BRIO ,' Breve storia dell 'esercito italiano da/1861 a/1943, cic., p. 10. Sia pura proposito di un altro momento storico era stato sottolineato come« ( )i problemi dell'esercito sono suettamente connessi a quelli di tutta la politica( )». G. ROCHAT, L 'esercito italiano nell'estate 1914 , in •Nuova rivista storica , a. XLV (1961), n. 2, p. 308 .

e della correzione di quella stessa politica militare) 2 E forse anche da queste concezioni pubblicamente manifestate da Ricotti dovevano venire quei ceni segnal i di estraneità, di distacco, di insofferenza e di insoddisfazione che - co me vedremo - il mondo militare italiano più volte lan ciò in quegli anni contro il 's uo' Ministro e contro la sua gestione della Pilotta, considerata troppo legata ai cicli ed ai ritmi della politica parlamentare del rrasformismo.
Non è quindi possibile seguire gli sviluppi e la direzione di marcia della politica militare in Italia - anche per un arco crono logi co limitato quale quello da noi preso in esame -senza prima avere identificato con cenezza quali fossero gli sce nari, i margini, i protagonist i della politica interna più generale di quegli anni. Non si possono co mprendere i meccanismi e l'azione dei protagonisti e dei responsab ili della politica militare se non vengono confrontati con quelli della politica tout court. Storia delle istituzioni militari , storia della politica militare e sto ria politica devono nelle prime pagine di questo studio, per un attimo, marciare assieme.
Ciò , ovviamente, non significa tralasciare quelle che erano le 'costanti' del rapporto tra esercito e politica nell'Italia dall'unità alla grande guerra: semmai vuoi dire valorizzare il peso e l'influenza che quelle costanti ebbero nella specifica congiuntura presa in esame.
Viste nella lunga prospettiva , le determinanti della politica militare negli anni dì questa seconda permanenza di Cesare Ricotti al Ministero della Guerra erano le stesse che operarono nel più lungo arco cron ologico dell'Italia liberale.
Il legame st rettissimo tra istituzione militare e istituzione monarchica (e di larga subord in azione della prima alla seco nda) era un dato di fatto intangibile: il Re continuava a vedere le grandi decisioni della vita dell'esercito come cosa sua, o comunque come cosa di Corte e dei suoi consiglieri militari. Il rapporto sociale tra aristocrazia (nelle sue varie gradazioni) e borghesia, all'interno del Corpo Uf-
2 Su Ricotti e la Camera cfr. AA.PP., Camera, !Legisl. Xl, sess. seconda, Discussioni, tornata del4 gennaio 1872; ivi, Legisl. XIV, sess prima , Discussioni, tornata del 26 aprile 1882. Diverso il giudizio dì Ricotti sul Senato : cfr . iVi, Senato, Legisl. XVIII , sess . prima , Discussioni , tornata del 30 giugno 1893. Manca ancora, comunque, uno studio sulla 'percezione militare' dello spazio politico e istituzionale delle Camere nel processo di formazione della politica militare. Sulle d inamiche della formazione della politica militare neiJ'Italia liberale cfr. P. DEL NEGRO, Esercito, Stato e società nell'Ottocento e nel pn'mo Novecento : il caso italumo, in cThe Journal of ltalian History•. a . I (1978), pp. 315·328, adesso in ID., Esercito, Stato, società Saggi di stona mtfitare, cìt. , pp. 55·56 e p. 68

28 POLITI CA E POLITI CA MILITARE
ficiali seguiva linee già note, segnate tra il 1848 ed il 1861; l'incremento percentuale dei non-nobili nelle alte gerarchie e nel complesso del Corpo (già visibile in precedenza e in quegli anni esaltato dall' incremento numerico degli effettivi delle armi di Artiglieria e Genio) rimaneva bilanciato dal peso dell'ideologia monarchica e dalla fedeltà al Re. Potere civile e potere militare rimanevano quindi ancora assai distanti; ed il secondo, protetto al fondo da un uso forse non più tanto vistoso ma concreto e operante della prerogativa regia, godeva di una larga autonomia dal p otere politico (anche esecutivo, per non dire poi da quello parlamentare).
C'erano taluni simbol ici trait d'union tra militari e civili, ceni segnali di 'intervento' dei primi nell'ambito più naturale per i secondi. C'erano stati Primi Ministri militari, spesso in occasioni di crisi politiche difficili e quando si era voluto evidenziare quale fosse la soluzione regia; c'era una pattuglia di militari deputati al Parlamento; c'era stato più di un ambasciato re in uniforme militare, ed anche in sedi diplomatiche di prim'ordine (Londra, Parigi, Vienna); c'erano stati e continuavano ad esserci prefetti militari (per non parlare poi delle luogotenenze straordinarie, come quelle di Cadoma in Emilia Romagna); i Mi n istri di Guerra e Marina saranno sempre militari, tranne una so la fuggevole eccezione, in più di sessant'anni di vita unitaria. La presenza militare nelle istituzioni, poi, non finiva qui: scuo le-convitti , giornali e società che volevano essere popolari (quali le società per il tiro a segno) erano militari, e militari erano molti dei miti che costituivano il veicolo e lo scopo dell'istruzione pubblica elementare.

Tutto questo dilatava il peso del militare sul civile e allargava di fatto i confin i della politica militare, rendendovi sempre più difficile un intervento organico dei civili. Lo Stato dell'Italia liberale non era militare ma aveva molto del militare.
Il peso condizionante del Re e della Cone , in q u anto esponenti e rappresentanti massimi delle alte gerarchie militari, poteva però togliere spazio all'azione de l Ministro della Guerra. I decenni di pace dal 1870 al 1914 facilitarono la mancanza di una chiara soluzione del problema dell'alto comando dell'esercito in tempo di guerra: ed anche dopo il 1882 il Ministro tendeva a presentarsi come il comandante effettivo dell'esercito. A pane questo, e di ceno, egli cio rappresentava dinanzi a:l potere politico:. . Ma , come- al fondo - sembrava non stabilita la questione dell'alto comando, così anche la sua opera pol i tica presentava due aspetti divers i e disomogeQe i : «il min istro della guerra era quasi sempre contemporaneamente il portavoce
UN ESERCITO PER RICOlTI 29
dell'istituzione militare presso il sovrano e il governo ed il rappresentante del sovrano nel governo e presso l'istituzione militare» 3. Se questo era vero a livello di politica generale e a proposito delle scelte più impegnative , nell'ambito vasto della politica militare il Ministro della Guerra godeva pure di una certa indipendenza. Non è un caso, ad esempio , che negli anni da noi presi in esame , nono stante l'evidente rafforzamento del ruolo dell'esercito nei confronti della politica (rafforzamento che si farà poi anche più evidente nel periodo crispino), praticamente nessuna voce si alzò per chiedere la costituzione di un gabinetto militare del Re , salvo isolate eccezioni. Così, determinati per legge i confini del bilancio (che pure costitu ivano motivo di trattative e di contrattazioni tra governi e Corona) , senti to il parere delle Commissioni dei generali e - dopo ill882- interpellato il Capo dello SME (senza l'obbligo di accoglierne le eventuali proposte), ascoltati durante i dibattiti parlamentari i - di solito - pochi interventi di deputati civili intervenuti a discutere le leggi militari , al Ministro della Guerra rimaneva una certa autonomia di fatto politica e amministrativa.
Il grado di questa sua autonomia non era costante, né dipendeva sempre dalle scelte politiche individuali del generale nominato Ministro: la temperie politica del momento, i suoi personali rapporti con la Corona, la latitudine dei bilanci militari, la sua autorevolezza verso il mondo militare da una pane e verso il governo e il parlamento dall'altra, rendevano quel grado alquanto mutabile (s ia pure all ' interno delle linee di tendenza prima delineate) da Mini stro a Ministro, e non di rado da fase a fase durante una stessa gestione rninisceriale.
Vedremo ad esempio nelle pagine seguenti come il Ministro Cesare Ricotti resisté a forti pressioni militari e Reali per un ulteriore aumento delle già alce spese militari . Oltre alle convinzioni personali di Ricotti scava ali ' origine di questo il sostanziale allineamento delle posizioni del Ministro militare con quelle del Ministro delle Finanze e del presidente del Consiglio, nonché con l'opinione (largamente diffusa nelle Camere - bene documentata nei resoconti parlamentari- e nella stampa politica) che un aumento dei bilanci della Guerra avrebbe condotto ad un innalzamenco dd deficit pubbli co. Di fatti , e con minime concessioni, Ricotti riuscì a mantenere questa posizio-
3 Le citazioni sono rispettivamente da ROCHJ\T, MASSOBRIO, Breve storia del· l'esercito italiano dal I86Jal1943, cit., p. 43 , e da DEL NEGRO , Esercito, Stato, società. Saggi di stona militare, cìr .. p. 56 .
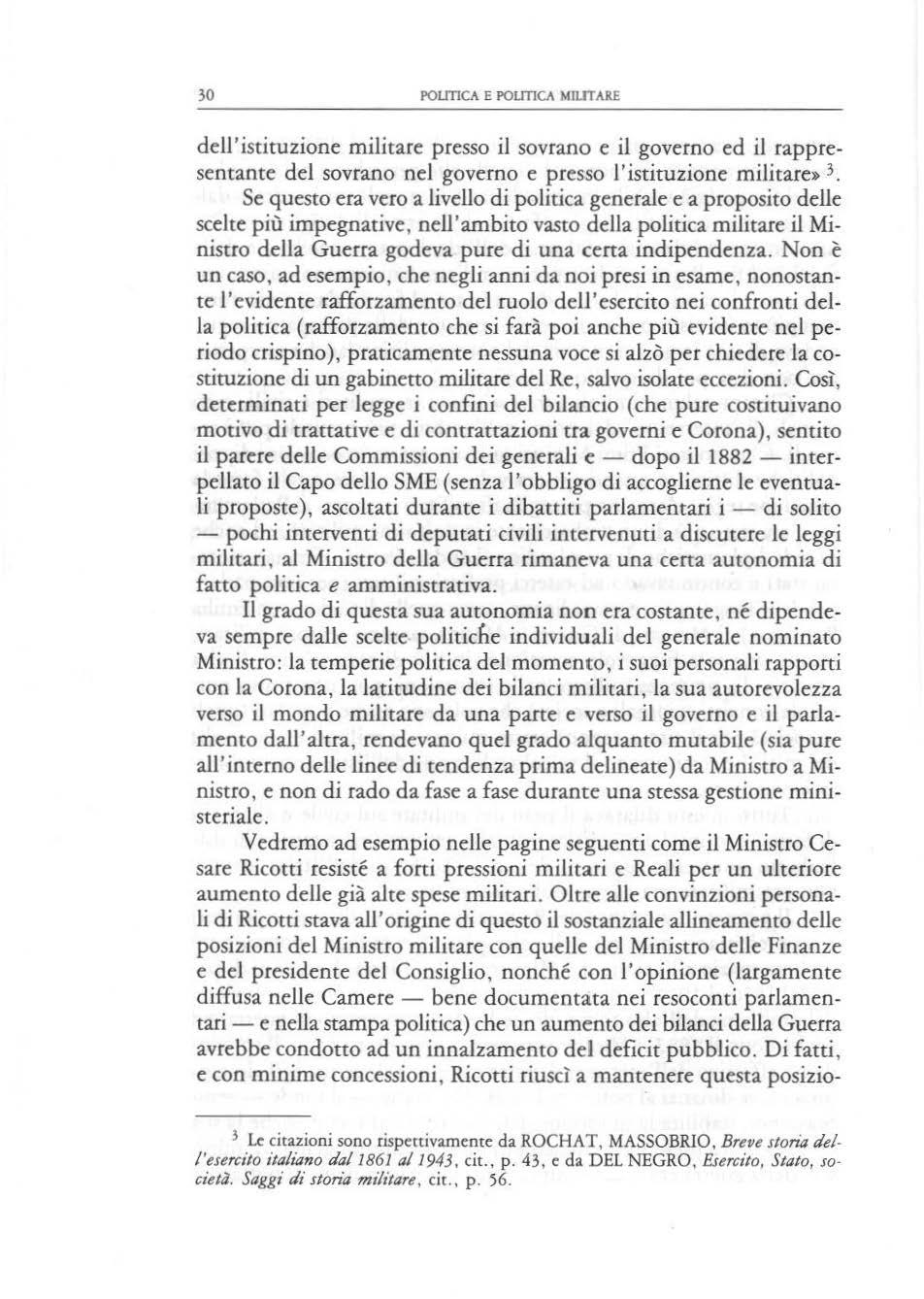
30 POLITICA E POLITICA MIUTA RE.
ne sino alla sua uscita dal governo che, quando avvenne, non si verificò per via di que sta politica di bilancio . Tali scelte di Ricotti (insieme ad alue, quali la nomina dì un Segretario Generale per il Ministero che fosse - oltre che ovviamente un militare - deputato al Parlamento e pubblicista) furono interpretate nei circoli militari e forse a Corte come indulgenze e cedimenti del generale ve rso la Camera, dell'esercito verso l a politica. Ma la questione era più complessa.
In quegli anni come si è già detto, l'esercito italiano stava cambiando, dopo il periodo di riforme e di ristrutturazione interna corrispondente grosso modo alla prima lunga permanenza di Ricotti alla Pilona. A livello europeo, passato il 1878, il lento ma deciso riemergere delle contraddizioni tra le potenze europee, il formarsi di un blocco politico-militare quale era la Triplice, lo scatenarsi dello scramble for Africa e delle tensioni interimperialistiche richiamavano i ricordi del1870 e tornavano a far parlare delle possibilità di guerra europea. In Itali a l ' obiettivo di un rafforzamento quantitacivo dell' esercito e la tendenza ad adottare strategie ( per quanto possibile) offensivistiche era ben simbolizzato dalla creazione di due nuovi corpi d'armata nel1882; una tale misura, assieme alla stipula della Triplice Alleanza, evidenziava a suffic i enza la vo l ontà della Corona , delle gerarchie militari e della classe dirigente di far contare maggiormente l ' Italia (ancora una volta, per quanto possibile) nell'arengo europeo. Si potrebbe così fare delle osservazioni.
A ben vedere l'aumento di forza bilanciata - prima ancora che a so ddisfare nuove aspettative di 'po tenza ' -sarebbe andato arimediare la cronica debolezza d e ll 'effettivo di pace delle co mpagnie , che raramente riu scivano a superare la forza di una settantina di unità. I soste nitori delle teorie offensivisciche, dal canto loro, non sempre ammettevano che il principale ostacolo ad una veloce e combattiva dislocazione delle truppe italiane sul campo di battaglia (padano o d'o ltralpe ) e ra da ricercarsi nel sistema di reclutam e nto nazionale. Veniva stimato che quel tipo di reclutamento, da solo, faceva ritardare il meccani smo della mobilitazione militare di una settimana. Che poi tale meccanismo fosse poco curato dal Ministero della Guerra e fosse intral ciato dall 'ins ufficienza della rete ferroviaria erano da considerarsi so l o aggravanti. Ma non sempre que ste osservazioni potevano essere basate su dati precisi, in quegli anni.
Quello che l'opinione pubblica e politica percepiva di quel cambiamento era la spinta interna all'esercito in direzione di un suo rafforzamento. Insieme all'emerge re dal dibatti to militare di tanti altri

UN ESERCITO PER RJCOTI1 31
temi , quelli della forza numerica dell'esercito e dell ' offensivismo davano il tono del periodo. Si parlava, così, forse ancora in maniera imprecisa o ingenua , di 'militarismo' . Una tale definizione si stava imponendo non solo in Italia ma in tutta Europa . In quegli anni Ottanta essa era suggerita e legittimata anc he dagli scontri politici e dai dibattiti tecnici che nelle varie nazioni si animavano intorno allo stato dei vari ordinamenti militari nazionali. Durante e verso la fine degl i anni Ottanta «non c' era praticamente nessun paese, in Europa , che non stesse operando , o almeno progettando, una riforma dell' ese rcito:..
Recentemente si è notato che molte possono essere le accezioni del termine 'militarismo': termine che, se non può essere acriticamente accettato, non può nemmeno essere facilmente scansato.
Pure i n Italia si andava sviluppando in merito una cena pubblicistica: diversa da quella successiva d eli' antimilitarismo socialista e rivoluzionario , essa testimoniava soprattutto le resistenze in campo borghese all'emergere di quei 'nuovi' obiettivi militari di cui si è parlato , al concedere un più ampio spaz io ai bilanci della Guerra e a tollerare la vecchia e tradizionale separazione tra esercito e paese che in quegli anni Ottanta andava consolidandosi.
Non è forse questa la sede per l 'analisi di tali tematiche (m ili tarismo, rapporti esercito-paese): eppure leggendo la stampa politica del tempo, i resoconti parlamentari, la stessa stampa militare si ha la percezione della loro consis tenza e la loro esistenza viene confermata anche da vicende isolate ma significative e che ebbero grande risonanza presso l'opinion e pubb lica del tempo. Il 'caso Misdea' rimane esemplare.
La vicenda di un povero militare esasperato dalla vita di caserma che risponde ad un ennesimo sopruso con la vendetta improvvisa e la strage fece scalpore ed è importante non solo per il nuovo impulso che i civili seppero trame allora per l'analisi dell'istituzione militare (sia pure con le tecniche e le scienze del tempo) , e non ceno per il pietismo che taluni organi di stampa seppero stendere sui temi della richiesta di grazia presentata in favore di Misdea ad Umberto l. Fu invece fatto notevole che l'opinione pubblica , la società civile e borghese sentì profondamente pe r una volta il distacco di valori , di p ratiche, di ordinamenti dalla società militare. Qualche anno più tardi le parole si fecero grosse, ma bene riassumono i tanti interventi proliferati intorno al caso Misdea: «La società militare vive in uno stato di vera anarchia morale ( ... ) La guerra, tra i popoli civili d'Europa, nel presente, non ha più alcuna

32 POUTICA E POUTICA MlUTARE
funzione da compiere» 4 L'accusa al militarismo (di essere incapace di comprendere gli orrori anche psicologici che aveva generato) non era però solo morale né poteva essere episodica , perché se nell'aprile del 1884 fu Misdea a sparare solo tra il 1884 ed il 1885 si ripeterono almeno altri tre casi simili, risollevando nell'opinione pubblica civile le stesse preoccupazioni e gli stessi sospetti intorno alle condizioni della 'società militare'.
Quella iniziale critica al militarismo era politica. Come è stato ben scritto, «attorno al caso Misdea tenzonano due concezioni riguardanti le nostre forze armate, quella rigida del 'giro di vite', e quella che si sforza di capire e ha intenzione di perdonare al fine di aprire, finalmente, le finestre delle caserme al vento delle riforme. Vince la prima delle due concezioni: e arbitro è re Umbeno», che riftuta di concedere la grazia a Misdea e lascia che il tribunale militare e poi il plotone di esecuzione seguano il loro corso. E non a caso vi è chi ha notato, analizzando le relazioni tra esercito e paese, come ai «!apponi stretti ed in larga misura reciprocamente fiduciosi nei primi decenni dopo l'unità» si sostituissero quelli «più diradati e sospettosi a partire dagli anni Ottanta>> (per arrivare poi a quelli <<ombrosi e antagonist ici» del periodo giolittiano).
Ma a pane l ' emozione suscitata, il caso Misdea non era la più adatta cartina di tornasole del militarismo e dell'ordinamento militare italiano. In questo senso, il reclutamento nazionale e il ruolo svolto contro il brigantaggio, la sollevazione di Palermo del 1866, le agitazioni contadine per il macinato, dicono molto di più . Di fronte a questi compiti di fondamentale imponanza, ma eccezionali, stava poi il consueto ricorso alla forza militare in occasione di assembramenti, agitazioni, tumulti. Quando , appunto con gli anni Ottanta , scesero in piazza le prime leghe operaie ed il Panico Operaio Italiano, insieme al bracciantato agricolo ed ai contadini della pianura padana, l'intervento d eli' esercito (spesso anche con re pani di cavalleria) si fece più frequente 5.
4 Sulle riforme militari in Europa du rante gli anni Ottanta cfr. GOOCH, Soldati e borghesi nell'Europa moderna, ci t., p. 193. Per alcuni penetranti accenni sul caso Misdea cfr. adesso L. NARBONE, Governo mrlitare e governo del sociale. Strategie e tattiche del disciplinamento nell'Italia liberale , in cAut aut», 1985, n. 205, p. 56. La citazione sull'anarchia morale della società militare è da G. FERRERO, Ilmilitarismo. Dieci co nferenze , Milano, Treves, 1898 , p. 136 e p. IX.
5 L' analisi del caso Misdea si trova in U. ALFASSIO GRIMALDI, Il re 'buono ', Milano, Feltrinelli, 1970, p. 226. Le citazioni sui rapporti tra esercito e paese sono ancora d:a DEL NEGRO , Esercito, Stato, società. Saggi di stona militare, cit., p. 173. Non

UN ESERCITO PER RICOTTI 33
Ceno non era questo il compito primario dell'esercito ed il militare spesso teneva a non essere solo 'carabiniere'. Ma l'ordine politico e sociale 'doveva' essere fatto rispettare, anche a costo (come si è visto per la questione reclutamento/mobilitazione) di pregiudicare l'efficienza bellica dello strumento militare. E pochi - borghesi o aristocratici, civili o militari - obiettavano.

Le onde, talvolta anche alte, del dibattito militare di quegli anni l asciavano sommersi questi scogli, queste costanti, della politica militare nazionale. Se anche è difficile, per una ricerca circoscritta e dall'arco cronologico limitato, che tali costanti risaltino quanto la loro importanza politica necessiterebbe, è bene averle sempre presenti, e tanto più nel quadro di un primo esame della compagine politica operante nel periodo storico su cui si apre il nostro studio.
Gli anni della seconda permanenza al Ministero della Guerra da parte del generale Cesare Ricotti dovevano essere anche gli ultimi del trasformismo. Sino all'avvento di Crispi, infatti, senza Depretis non si facevano governi duraturi, senza la sua capacità di trovare maggioranze parlamentari la Sinistra - che era giunta al potere solo nel 1876- non poteva spe rare di imporsi. Ma anche la Destra, che ormai da più anni aveva perso la guida del Paese (pur restando assai forte fuori del Parlamento, nella società, nei gangli decisivi del potere, nella burocrazia , nelle strutture portanti dello Stato), doveva venire a patti con l'uomo di Stradella e con il programma politico che rappresentava.
E l a storia delle vicende politiche italiane della prima metà degli anni '80 del XIX seco lo , che appunto è in buona sostanza la storia del trasformismo e delle sue crescenti opposizioni, fa comunque perno sulla figura di Agostino Depretis 6.
è vasta in Italia la letteratura storiografica sull'intervento militare per l'ordine pubblico. Oltre alle osservazioni di fondo presenti nelle storie 'generali', l'unico studio di ampio respiro rimane L VIOLANTE, La upres.sione del dissenso polilico nell'Italia liberale: stati d'asse'dio e giustizia militare, in cRivista di storia contemporanea», a. V (1976) n. 3. Di periodi importanti, ma specifici, si occupano con taglio diverso F. MOLFESE, Stona del bngantaggio dopo l'unità, Milano, Fcltrinelli, 1964; R. MARTUCCI, Emergenza e tutela dell'ordine pubblico nell'Italia liberale. Regime eccezionale e leggi per la repressione del reato di bngantaggio 1861-1865, Bologna, Il Mulino , 1980; A. BO LDETTI, La repressione in Italia: il caso del1894, in cRivista di storia contemporanea», a. VI (1977) n. 3; F. FIORENTINO , Ordine pubblico ne/1'/talt'a giolittiana, Roma , Carecas, 1978.
6 In reaJti non sono numerosi i buoni studi specifici su questo periodo, olue ovviamente le grandi opere di sroria generale. Tra le quali cfr. G. CANDELORO, Storia dell'Italia moderna, v. VI, Lo svtiuppo del capitalismo e del movimento operaio. 1871 -1896 , Milano, Feltrinelli, 1970, pp. 297-318 ed in parte pp. 183-296; G . CA-
34 POLITICA E POLITICA
M!UTA.RE
Sotto la guida di Depretis, l'Italia stava rafforzando la sua economia, il suo Stato, il suo prestigio internazionale 7•
Rimaneva ancora l'ultima delle grandi Potenze , ma il suo status andava oggettivamente crescendo, sebbene più per l'acuirsi dei contrasti internazionali che per veri e propri meriti nazionali. La firma del trattato della Triplice Alleanza, in questo senso, costituiva comunque un indubbio successo politico governativo 8.
Ali' interno , però la spinta riformatrice di Depretis , e della Sinistra, era praticamente esaurita 9 L' ultima riforma politica -lariforma elettorale del 1882 - si era risolta , se ppur tra apprensioni e timori, in una valorizzazione dell'esecutivo e a scapito dell 'autonomia del potere legislativo . In questo senso Depretis poté rafforzare ancora di più il suo ruolo di mediatore e di timoniere della politica nazionale. Con la riforma elettorale Depretis era riuscito a disgregare in maniera molto più radicale che per l'innanzi i vecchi 'partiti' e le tradizionali aggregaz ioni : e nel frattempo, co n quel centinaio di uomini nuovi che erano arrivati alla Camera, aveva allargato le possibilità di manovra parlamentare per il suo progetto politico lO.
Chiusa la fase dell e riforme politiche, Depretis pensava infatti che fosse necessario per l 'Ital ia un peri odo quanto mai lungo di riforme amministrative (ma qualche critico parlava di 'ordinaria amministrazione') attraverso cui poter consolidare le istituzioni delio Stato unitano.
Per tutto questo riteneva necessario comporre e dirigere Gover-
ROCCI, Storia d'Italia dall'unità ad oggi, Milano, Feluinelli, 1975, pp 57-88; RAGIONIERI, La stona politica e sociale, cit., pp. 1745-1758; R ROMANELLI, L'ltalta kberale, Bologna , Il Mulino , 1979, pp. 216-217 e pp. 251-284. Ancora stimolante l 'analisi proposta in P. FARNETI, Sistema polih co e società civile. Saggi di teoria e ricerca politica, Torino, Giappichelli, 1971. Ancora insost.ituibile CAROCCI , Agoshno Depretis e la politzca interna dal 1876 al1887, cit.
7 Cfr. V. CASTRONOVO , La storia economica, in Storia d'Italia, v. IV, Dall'unità ad oggi, t. l, Torino, Einaudi , 1975, pp. 92 99; P. CALANDRA, Storia del/ 'ammznistrazione pubblica zn Italta , Bologna, Il Mulin o, 1978, p. l 35 e sgg.; C. GHISAlBERTI, Stona costituzionale d'Italia 1849·1948, Bari , Laterza, 1974, pp . 155-200 ; F. CHABOD, Stona della polihca estera italiana dal1870 al1896 , vol. I , Le premesse, Bari , Laterza, 1951, pp. 292-293, pp. 540-542, p. 605 e sgg.; G. PERTICONE, La politica estera italiana da/1861 al1914, Torino, ERI, 1967, (2), pp. 42-63.
8 Cfr. ancora L. SALVATORELLI, La Tn"plt"ce Alleanza. Storia diplomah·ca, Milano , Ispi , 1939.
9 Cfr. CAROCCI, Agostino Depretis e la polittca interna da/1876 al1887, cit., p. 284 e p. 309 e sgg ..
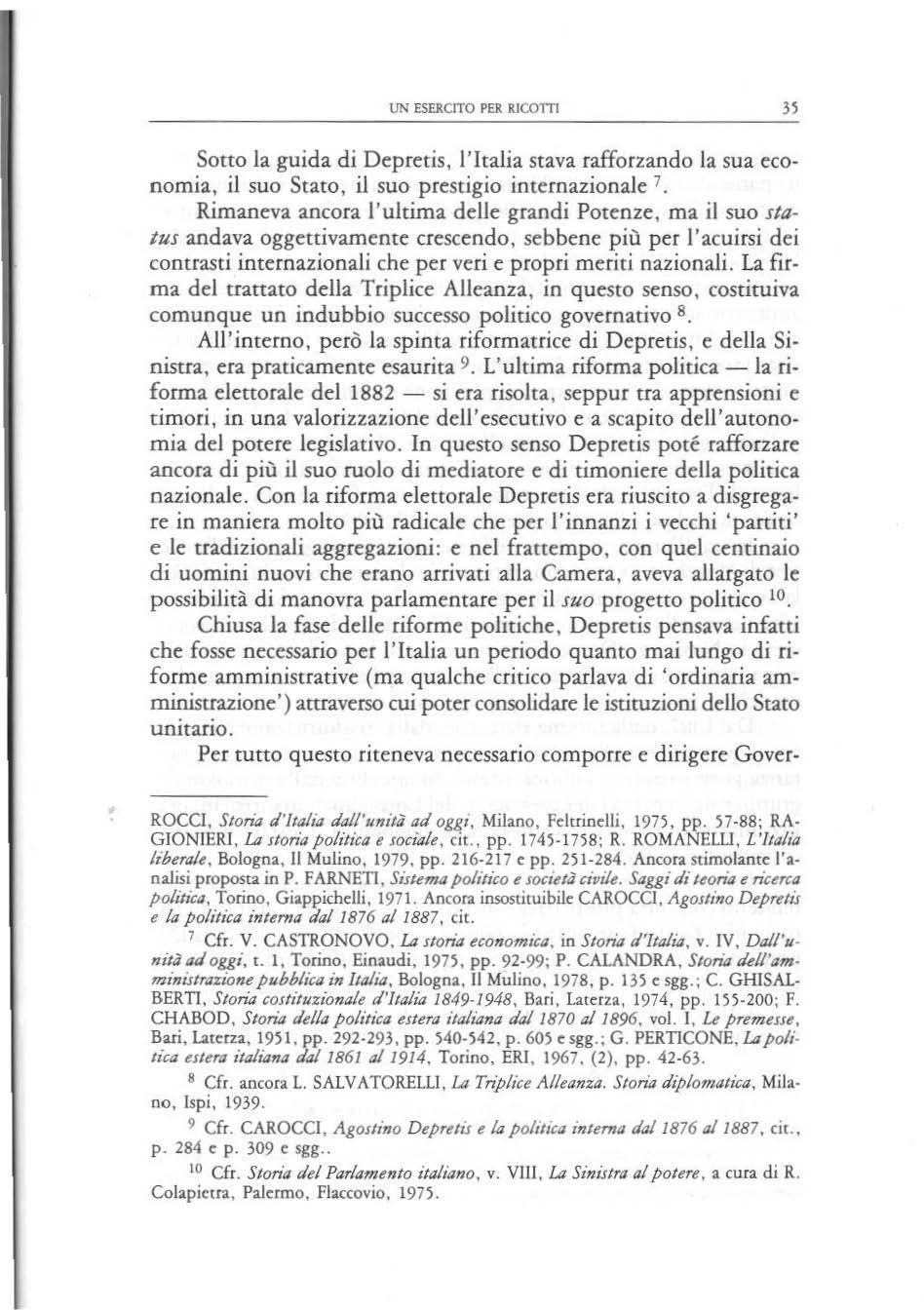
1
Cfr. Storia del Parlamento italiano, v. VIII , La Sinistra al potere , a cuia di R Colapi etra , Palerm o, Flaccovio, 197 5
UN ESERCITO PER RJCOTI1 35
°
ni che potessero mediare le opposte tenden.ze politiche parlamentari: panicolarmente con la Destra parlamentare eg li tentò sempre di essere conciliante, non dimentico che le forze della conservazione (e tra queste la monarchia) non attendevano altro che poter sostiruirlo. Pur mantenendo una qualche sua coerenza con il programma con cui era andato al governo nel 1876 (in un Governo di Sinistra integrale, con una piattaforma di riforme più amministrative che politiche, con un indirizzo economico più !iberista che 'interventista'), è stato giustamente detto che cDepretis cedette sempre a metà, ma cedette sempre» 11 E, mentre l'opposizione di Sinistra non riusciva ad accordarsi per sp ingere il presidente del Consiglio a fare una scelta politica e governativa di Sinistra 'integrale ', la Destra- sia pure non quella estrema e reazionaria - poté sempre usufruire della benevolenza di Depretis. Così facendo, le divisioni fra i panici andavano 'trasformandosi'. Panicolarmeote dopo il 1882 12
In quell'anno, assorbito nella maggioranza il gruppo della Destra di Minghetti (e reso così impossibile il tentativo di chi come Sella avrebbe voluto unire la maggior parte dell'opposizione conservatrice con quella certa opposizione di Sinistra moderata che si riconosceva in Nicotera), Depretis aveva costituito la più larga maggioranza parlamentare di cui avesse mai disposto ed aveva così bloccato l'evoluzione politica nazionale per vari anni a venire.
Dal1882, dalla riforma elettorale, dalla 'trasformazione' dei partiti- prima contrastanti - in 'g ruppi ' di un'unica grande maggioranza governativa, la poli tica interna fu assorbita dalle manovre dei gruppi e dai tentativi del presidente del Consiglio di mantenere, nell' equilibrio instabile della smisurata maggioranza , l'assetto della sua costruzio ne politi ca.
Inevitabilmente, la lotta politica diventava così una lotta tra contendenti con corta prospettiva, anche se i contrasti tra i gruppi parlamentari si facevano sempre più pericolosi per l'edificio voluto da Depretis dal momento che non appariva realizzabile alcuna radicale alternativa politica al progetto di Depretis e del trasformismo.
L'un ico fattore di movimento- e di pericolo per la costruzione depretisiana- appariva la Pentarchia, l'opposizione di Sinistra,
11 Cfr. CAROCCI, Agostino Depretis e la politica interna dal1876 al 1887, cit., p. 309.
12 Sul valore periodizzaote del 1882, cfr. CAROCCI , Storia d'Italia dall 'unità ad oggi, ci t , p. 59 e CANDELORO , Storia dell 'Italia moderna, v . VI, Lo sviluppo del capitalismo e del movimento operaio 1871 -1896. cit., p. 297

36 POUTICA E POLITICA MILITARE
ancora abbastanza forte da influenzare il presidente del Consiglio (che pure non avrebbe voluto forse una rottura del partito che lo aveva portato al governo) e da ridurre i margini della sua politica trasformista, tramite una vivace opposizione parlamentare ed una intensa attività di propaganda 13.
A dimostrazione di quel cambiamento di prospettive di Depretis e dei suoi Governi che tanto l'opposizione pentarchica criticava, stava il pressoché totale abbandono di quella politica sociale che era stata uno dei vessilli della prima Sinistra al potere: e se anche qualche realizzazione importante di quella politica venne, dopo il1882, essa fu l'effetto di meccanismi politici avviati col1876 piuttosto che di interessi e di scelte maturate negli anni del trasformismo compiut o.
Lo stesso atteggiamento governativo nei confronti delle agitazioni contadine e dei primi scioperi operai negli anni della crisi agraria rivelavano poi quella tendenza di Depretis ad abbandonare leprecedenti volontà riformatrici a favore di una politica di garanzia dell' ordine pubblico che si voleva sempre più rigida ed intransigente t4.
Questa politica conservatrice non riusciva però a nascondere gli insuccessi, le difficoltà, i segnali di continue crisi parlamentari cui andavano incontro i Governi del trasformismo: crisi governative che apparivano tanto più evide nti (e che spingevano il 'paese reale ' ad un sempre più marcato disinteresse e distacco dai modi e dai contenuti della politica) quanto più la società e l'economia italiana avanzavano- sia pur timidamente- in quella c:fase espansionistica del cicl o» che caratte rizz ò gli anni Ottanta 16.
Infatti, la coscienza di una aumentata vigoria economica della nazione , che al fondo pareva dovesse legittimare tante ambizioni da
l3 Cfr. G. BOCCACCINI, La Pentarchia e l'opposizione al Jrasformismo, Milano, Giuffré , 1971, p 97.
14 Cfr. CAROCCI, Agostino Depretis e la politica interna dal 1876 al 1887, cit., pp. 483 - 588; L. PRETI, Le lotte agrarie nella valle padana, Torino, Einaudi, 1955; La boje! ProceSio dei contadini mantovani alla Corte d 'ASiise di Venezia, a cura di R. Salvadori, Milano, ed. Avanti!, 1962.
15 Sulla 'crisi del parlamentarismo' la letteratura è assai vasta anche se ormai nel suo complesso non più recentissima. Tra gli altri, cfr. G. PERTICONE, Parlamentan·smo ed antiparlamentansmo nel posi-Risorgimento, in ID., Scn"tti dt stona e politica del pose-Risorgimento, Milano, Giuffré, 1969.
16 G. BARONE, Svzluppo capitalistico e politica finanziaria in Italia nel decennio 1880-1890, in cStudi storici•, a. XIV (1972) o. 3, p. 573. Per una visione d'a.sSieme cfr. G. MORI , Blocco di potere e lotta politica in Italia, in Storia della società italiana, parte V, v. XIV, Il blocco di potere nell 'ltalza unita, Milano, Teti, 1980, pp. 223-324.

UN ESERCJTO PER RICOTII 37
'grande potenza ', permetteva ai contemporanei di rendersi contosia pure ancora in forma imprec isa- «del salto produttivo e dei mutamenti qualitativi dell'economia italiana nel periodo 1881-1887• 17 : anni i quali appaiono così ancora più imponanti se si confrontano gli anni Ottanta con «la fase depressiva del se t tenni o successivo• 18, che impose alla classe politica italiana ed ai responsabili della politica economica e finanziaria varie e profonde riconsiderazioni. Si affacciava in Italia infatti, proprio nella prima metà degli armi Ottanta sia pure tra incenezze e difficoltà, l'ipotesi di un radicamento delle prospettive industrialiste.
Con una estensione più vasta che negli anni della Restaurazione e con una forza ed una possibilità di affermazione assai più grande che negli anni seguiti all'unità, durante gli anni Ottanta l'economia italiana si avviava infatti ad affrontare un altro tornante decisivo del suo lungo ed accidentato processo di industrializzazione 19. Varie erano le co nd izioni che sembravano rendere realizzabile quella prospettiva. L'indebolimento dell'agricoltura, sotto i colpi della crisi agraria 20; un rinnovato interesse della finanza internazionale per gli affari italiani 21 ; un'incisiva azione dello Stato fatta di alte spese pubbliche (per interessi militari, nel settore dei lavori pubblici, per la crescita dell'industria metalmeccanica e siderurgica) 22 E panicolare imponanza sembrava dovesse rivestire proprio questo ultimo fat-
17 BARONE, Sviluppo capitali.rtico e politica finanziana in llalta nel decennio 1880 -1890, ci t., p. 591. Sul ruolo dello Stato nell'afferma.zione in Italia di una prospettiva industrialista, cfr. F. BONEW, 11 capitali.rmo italiano . Linee generali di interpretazione, in StoritJ d'Italia. Annali l. Dal feudalesimo al capitali.rmo, Torino, Einaudi, 1978, pp. 1193-1254.
18 BARONE, Sviluppo capùali.rtico e politica in Italia nel decennia 1880-1890, cit., p. 581.

19 Cfr. G. MORI, Il processo di industnalizzazione in sé e l'ltalta, in La rivoluzione industriale tra il Settecento e l'Ottocento , a cura di L. Segreto, Milano , Mondadori, 1984, pp. 177-207.
20 Cfr. P D'ANGlO UNI, L 'Italia al termine della crisi agraritJ della fine del secolo XIX, in cNuova rivista storica•, a. Llll (1969). n. 1-2; e A. CARACCIOLO, L 'Inchiesta agraria )acini, Torino, Einaudi, 1958.
21 Cfr. per un quadro del problema A . CONFALONIERI, Banca e in Italia 1894-1906, Milano, Banca Commerciale Italiana, 1974-1976. Su un aspetto qualificante cfr. P. HERTNER, Il capitale straniero in ltalta dall'Unità alla prima guerra mondiale. Banche mi.rte e sviluppo economico italiano, Bologna, Il Mulino , 1984.
22 Larga è l'attenzione dedicata dalla storiografia a questo aspetto. Cfr. CASTRONOVO, La storitJ economica, cit., p. 90 e sgg.; F. BONEW, Lo sviluppo di una grande impresa in Italia. La Temi da/1884 al 1962, Torino, Einaudi, 1975 ; ID., Il capitali.rmo italzano. Linee generali di interpretazione, cit., p. 1218 e sgg
38 POUTIW\ E POUTIW\ MIUTARE
tore, che , se esponeva il Bilancio statale al ripresentarsi del defi cit prima tanto temuto, di fatto svo lgeva un'azione stimolante ed incentivante dell'economia: in qualche modo ancora prima della definitiva adozione delle misure protezionistiche 2 3.
Ceno, il presentarsi di questa prospettiva di progresso non significava assolutamente che essa fosse facile a percorrersi o che i fattori frenanti non fossero alla lunga più forti di quelli di movimento.
O che, addirittura, quegli stessi fattori che sembravano poter sorreggere quella prospettiva non si rivelassero poi gli stessi che la avrebbero fatta fallire: come poi accadde.
Gli anni Ottanta infatti, nonostante le condizioni prima elencate non fecero in realtà fare all ' economia italiana un c'salto ' strategico tale da ponare l ' industria al centro - come motore e guidadello sviluppo economico e sociale del Paese» 24.
Questo fu dovuto ad un comp lesso di ragioni. Come si è detto, proprio i fattori che quel salto strutturale avrebbero dovuto facilitare si rivelarono poi elementi massimamente frenanti.
La crisi agraria, che pure in quegli anni fu in Italia minore che altrove, non aveva liberato energie in termini di capitali e di forza lavoro , ma aveva solo acui to l e tendenze più immobilizzanti e retrive a scapito di quelle che avrebbero visto di buon occhio una modernizzazione dell'economia. Il nuovo peso della finanza , se ppure produsse qualche forma rinnovata di rappono tra banche e nascenti imprese, impoverì l'azione dello Stato e ridusse molte in iziative pubbliche (che avrebbero potuto avere conseguen ze dinamizzanti dell' economia) a puri e semplici riedizioni . in grande , di quegli affari e di quelle speculazioni finanziarie, cui i primi due decenni di vi ta unitaria avevano ormai abituato l ' opinione pubblica. E , soprattutto, il nuovo e più grande intervento dello Stato nell ' economianella forma di sempre maggiore co llo cazione di debito pubblico e di notevol e incremento della spesa statale- non promosse , se pure se lo era proposto, un generale ravvivamento dell 'economia. Anzi, furono creati, o rafforzati, solo alcuni circoscritti settori di intervento statale: settori che, se anche risultarono notevolmente irrobustiti nelle proprie strutture e nei propri strettissimi legami con lo Stato (come acc adde per la Navigazio ne Generale Ital iana ed in genere i gruppi cantieristici ed armatoriali, per la Terni ed alcuni casi di imprese me-
23 Cfr. BARONE, Sviluppo capitalistico e politica finanziari4 in Italia nel decennio 1880-1890, cit., p. 595.
24 MORI, Il processo d'industnaJizzazione in sé e l'Italia, cit.

UN ESERCITO PER RICOlTI 39
tallurgiche , per il settore assicurativo e bancario), non funzionarono per allora da moltiplicatori dello sviluppo. Ma non solo. Mancò soprattutto, come era accaduto in altre occasioni, la volontà politica di far compiere all'economia nazionale quel 'salto ' , di cui si temevano forse maggiormente i rischi connessi all'ordine pubblico e sociale di quanto se ne apprezzassero invece i vantaggi economici.
La decisione, nel 1885-87, di impedire che il Ministro delle Finanze Magliani, per frenare il crescente deficit, intraprendesse una via che conduceva all'aggravio delle imposte per i grandi proprietari fondiari (settentrionali come meridionali) , e poi la volontà di mettere al riparo di una fone protezione doganale le rendite di gran pane della proprietà terriera del Nord e del Sud indicano a sufficienza come i governi degli anni Ottanta non intendessero alienarsi gli appoggi delle componenti più retrive e conservatrici della classe dirigente nazionale e come, anzi, volessero a rutti i costi tenerle dentro il blocco di forze dominanti.
Non solo per motivi strutturali, quindi , bensì anche per specifiche volontà politiche l'economia italiana non doveva riuscire a decollare, negli anni ottanta.
Un analogo ragionamento può essere condotto per quanto riguarda la lotta politica nazionale di quegli stessi anni.
Non fu la composizione della Camera, ad esempio, fonemente e - secondo cena storiografia - negativamente segnata da quell' allargato suffragio del 1882, a rendere a Depretis necessaria la via del trasformismo e della confusione dei partiti. Più che il fatto oggettivo di un rinnovamento e di un'estensione a nuovi strati sociali della rappresentanza parlamentare, fu la volontà politica soggettiva di Depretis e di chi in lui si riconosceva a decidere di quel processo 25.
In parlamento, anzi, anche dopo il 1882 si sarebbero potute rintracciare le condizioni per una scelta di Sinistra integrale, che vedesse tornare unite la Sinistra delle riforme amministrative di Depretis e quella delle riforme politiche della Pentarchia: ma tra gli altri fu il Presidente del Consiglio a temere una simile scelta politica 26. Fu questo giudizio a spingere sempre più il Presidente del Consiglio sulla via d eli' alleanza politica trasformistica con i vari settori della destra che successivamente, per analoghi motivi, venivano avvicinandosi al-
25 Cfi. CAROCCI, Agostino Depretis e la politica interna dai 1876 a/1887, cir., p. 309.
26 Cfr. CARO CCI , Storia d'Italia dall'unità ad oggi, cir., pp. 60·61.

40 POUTICA E POUTICA MIUTARE
l'area ministeriale. D'altra pane questo autonomo processo politico, app unto , traeva gran parte della sua forza proprio dall'analogo processo sociale cui si è fatto pre cedentemente riferimento .
Dal canto suo, la Pentarchia non seppe opporre al progetto di Depretis una omogenea e credibile linea alternativa, soprattutto per via delle profonde divisioni al suo interno tra meridionali e settentrionali, tra sostenitori d eH' espansione e fautori di una sorta di 'sp lendido isolamento' italiano (che permettesse la cura dei molti problemi sociali interni), e - in ultima analisi - tra radicali e moderati 27.
Le occasioni di contatto e di unione tra Sinistra ministeriale trasformista di Depretis e settori moderati e conservatori, invece, non mancarono. Il defin itivo varo di una politica di rafforzamento della Marina Militare, il congelamento di una sia pur timida legislazione sociale, il mantenimento dell'ordine pubblico, la perequazione dell' imposta fondiaria ma anche, fin quando fu possibile, cuna corretta gestione del bilancio dello Stato, delle sue imposte e delle sue spese» 28 rappresentarono tutti momenti di compattamento della maggioranza e dell'ipotesi trasformista. Dal 1882 al 1884 al 188 6 e, in parte sino a Dogali , questa fu la tendenza che si impose.
Nel 1886, invero, qualcosa sembrò poter cambiare 29.
Nello sc hieramento parlamentare conservatore si andava facendo largo una corrente detta 'dissidente'. Quest'area politica appariva insoddisfatta dell'andamento della politica finanziaria del Governo, il quale non pareva riuscire ad arrestare l'aumento del deficit, e della sua politica estera, particolarmente delle forme che andava prendendo l'espansione colonial e italiana in Mar Rosso. Questo gruppo della Destra, ch e si nutrì anche del vario malcontento che la piatta ordinaria amministrazione dei Governi Depretis era andata facendo crescere, sembrò abbastanza forte nei primi mesi dell'anno (quando il Ministro delle Finanze fu duramente attaccato in Parlamento) e fu poi la forza politica che maggiormente si avvantaggiò delle elezioni del maggio 1886, che invece D epretis aveva indetto nella spe-
27 Cfr. BOCCACCINl , Ltz Pentarchia e l 'opposizione al trasformirmo. cit. , p . 17 3.

28 CAROCCI, Stona d'Italia dall 'unità ad oggi , cit., p. 62 .
29 Sul 1886 come momento del maggior successo elettorale ma anche come preludio della crisi politica del trasformismo , come segno di uno spostamento verso Desua dell ' opinione pubblica e come premessa dell'affe rmazione del blocco protezionista e 'c rispino ' , cfr tra gli alai an cora CAROCCI, Agostino Depreti.r e la politica interna dal 1876 al 1887, cit., p. 624.
UN ESERCITO PER RICOTfl 41
ranza di rafforzare il suo Governo 30.
Il crescere di una 'dissidenza' di Destra, anche se non ancora di una vera opposizione, all'interno del fronte ministeriale presentava per Deprecis una minaccia: quella del possibile congiungimento delle opposizioni di Destra e di Sinistra che preludesse ad una alternativa al trasformismo. Il fatto che, nel suo complesso, la Pentarchia fosse uscita ridimensionata da quelle stesse elezioni non poteva alleviare una tale minaccia, sia perché ciò che dello schieramento pentarchico era rimasto pareva intenzionato ad un incrudimento della sua opposizione, sia perché proprio all'interno di quello che una volta era la Pentarchia andavano emergendo forze ed uomini (come Crispi) che pur senza perdere la vigoria della forza di opposizione andavano impadronendosi di concetti, programmi e mete propri della dissidenza di Destra e dello schieramento conservatore. Di fronte .a questa duplice prospettiva di 'accerchiamento', la sone del uasformismo e la politica di Depreùs dovevano subire forzatamente qualche aggiustamento.
Poi venne Dogali, che accelerò tutti quesù processi politici e ponò Depretis a formare il Governo con Crispi agli interni ma con un programma decisamente conservatore e 'pa triotù co' .
Era divenuto , intanto, sempre più centrale, nel dibattito politico, il tema del crescente disavanzo finanziario 31 Vi era per questo più di un motivo reale. Il pareggio che la Destra storica aveva, con le sue 'economie sino all'osso', raggiunto nel 18 76 era andato disperdendosi col trascorrere degli anni Ottanta. In parte per quel complesso strutturale mutamento (che proprio in quegli anni si andava imponendo anche io Italia) delle funzioni dello Stato nell 'econo mia e nella società, in parte per la disattenta e superficiale gestione finanziaria di Agostino Magliani (che si era lasciato trascinare dal l a fase di espansione economica) il bilancio dello Stato vide sali re il deficit nel giro di due esercizi finanziari in maniera così rilevante da la-
30
Scarsi gli studi sul raggruppamento eterogeneo e transitorio, ma decisivo, della 'destra dissidente'. Cfr., per spunti autobiografici, G. GIOLITII, Memon'e della mia vita, (1922), Milano, Garzanti, 1967, p. 50 e Dalle carte di Giovanni Giolitti. Quarant 'anni di politica italiana , v. I, L 'Italia di fine secolo 1885-1900, a cura dì P D ' Angiolini, Milano , Feltrinelli, 1962 (specialmente la lettera 17 novembre 1886, Dì Rudinl a Giolitti, ivi, p. 3).
3J Per comprendere l'intricato viluppo di problemi che il deficit dei primi anni Ottanta portò con sé negli anni successivi e per coglierne gli metti legami con l'evoluzione della politica interna nazionale (con i suoi pesanti risvolti anche sulla politica militare e sui bilanci della Guerra) fondamentale rimane MANACORDA, Crisi economica e lotta politica in Italia 1892-1896, cit.

42 POUTICA E POLITICA MIUTARE
sciar credere che il disavanzo si fosse presentato anche negli anni precedenti e che fosse sino ad allora stato nascosto alla Camera ed al Paese con espedienti contabili 32.
Di fronte ad una progressiva crescita d e lle e ntrate tributarie , la finanza di Magliani e di Depretis aveva inaugurato una politica di progressivo e generale aumento delle spese . In alcuni settori specifici le spese statali avevano compiuto un vero e proprio balzo, che se mbrava legittimare le critiche di chi vedeva nelle spese pubbli che per questi settori le ragioni del deficit. Era il caso, sop rattutto , delle spese militari 33.
Attaccate dall'opposizione di Sinistra (contraria, in alcuni suoi settori, ad una politica militaristica), malviste dai gruppi più conservatori (e più legati al mantenimento del pareggio ed alla non ingerenza dello Stato nell'economia e nella società), criticate da tutti coloro che non approvavano che così ingenti stanziame nci non venissero poi valorizzati dalla politica est era e militare del Governo Depretis, apparsa a molti irresoluta ed oscillante , alla lunga (e specie con Crispi) le elevate spese militari avrebbero finito per diventare il punto di più acuta discordia tra ministeriali ed oppositori. Anche se sin o ad allora tutt i i settori della Camera, durante gli anni del prevalere dell'ipotesi trasformistica, avevano finito per app rovarle , per timore di essere visti come forze politiche non sensibi li ai temi 'nazionali' della difesa del Paese e della 'politica di potenza'. Anche qui , comunque , le elezioni dell886 co ntribuirono a chiarire le reciproche posizioni, facendo emergere opinioni differenziate (che però poi lo slancio patriottico seguito a Dogali, doveva coprire): se i governi riuscivano ad imporre la votazione degli ingenti stanziamenti militari, sempre più (nella politica o tra i cultori delle scienze economiche) si conve ni va che proprio quelle spese erano l'origine e la causa determinante del dissesto fmanziari o 34
Cfr. già le accese discussioni parlamentari del febbraio -marzo 1886. Cfr. AA.PP., Camera, Legisl. XV, sess. unica, Discussioni, tornate da122 febbraio al5 marzo 1886, in sede di esame dei progetti di legge sull'Assestamento dei bilanci per l'esercizio finanziario 1885-86.
33 Sul rapporto tsa disavanzo e spese militari in quel torno di anni cfr. MANACORDA, Crisi economica e lotta politica in Italia 1892-1896, cit., p 22. Pt ù in generale , sempre DE ROSA , Incidenza delle spese militari sullo s11iluppo economico italiano, cit.
34 Non fa eccezione a questo quadro (anzi ne è la conferma) la parabola delle posizioni assunte dall884 all886 dall 'auto revole quotidiano conserv atore lombardo cLa Perseveranza. sul tema delle spese militari e degli armam enti: parabola già ricordata da CAROCCI , Agostino Depretis e la politica interna da/18 76 a/1887 , cit., p. 403 e sgg.

UN ESERCITO PER RICOTTI 43
Nel frattempo, la nascita di una 'dissidenza' nello schieramento conservatore tanto corteggiato da Depretis, ed il mutamento di tono e di programma della opposizione di Sinistra andarono rendendo evidenti lo sfaldamento della maggioranza rninisteriale, 1' affermarsi di forze politiche nuove e la loro capacità di porsi come alternativa di Governo alla 'palude trasformista'.
Aiutò in parte Depretis il fatto che questi aspetti strutturali, almeno sino alle elezioni del 1886, erano rimasti solo coperti e tendenziali, di fronte alla perdurante capacità del presidente del Consiglio di imporsi (sia pure attraverso ricorrenti crisi governative da cui si usciva con la cooptazione di gruppi parlamentari nuovi all'interno della maggioranza ministeriale) 3:>.
Di tutti questi complessi mutamenti dell'economia, della politica e della società italiana degli anni Ottanta alle prese con il trasformismo depretisiano, può essere considerata massimamente esemplare la vicenda delle Convenzioni Ferroviarie, che proprio tra la fi. ne del 1884 e i primi mesi del 1885 arrivava a soluzione.
Era, quello ferroviario, davvero un «annoso problema» 36, una questione nazionale, che coinvolgeva politica ed economia, interessi produttivi e interessi speculativi, gtuppi sociali del Nord e del Sud e che risollevava le grandi questioni dello sviluppo nazionale.
Le sue origini andavano rintracciate nella condizione arretrata io cui ancora versava il trasporto su rotaia in Italia, mentre le altre potenze europee andavano velocemente moltiplicando i chilometri di strade ferrate ch e coprivano i loro Paesi. Già negli ultimi anni della Destra storica, tale problema aveva assunto le forme del dibattito tra sostenitori delle compagnie private e sostenitori delle compagnie pubbliche, in una situazione in cui ambienti economici legati proprio alle compagnie private volevano la statizzazione di alcune società ormai decotte. Con l'intervento della Sinistra storica, adesso al go-
35 Dal 1881 al 1886 i governi guidaci da Depretis avevano mutato il loro volto cambiando i responsabili degli Esteri, della Guwa, dei Lavori Pubblici , dell'Istruzione, dell' Agricoltura, della Marina e di Grazia e Giustizia. Praticamente solo Interni (Depretis) e Finanze (Magliani) erano rimasti immutati. Ogni sostituzione ministeriale aveva componato di fatto una crisi politica ed un ulteriore passo verso Destra . Cfr. A. MOSCATI , l Ministri del Regno d'Italia, v. IV, La Sinistra al potere, Napoli, Isr. St. Risorg. Comit. Napoli, 1964.
36 Cfr. F. IPPOUTO , Lo Stato e le jeTTOvie dall'unità alla caduta della Destra, io cCLio•, a. II (1966) n. 4, e ID., Lo Stato e le jeTTOvie dalla caduta della Destra alle convenzionio de//'85, in ivi, a. III (1967), n. 2; e S. FENOALTEA, Le ferrovie e lo sviluppo industriale italiano 1861 -1913, in Lo sviluppo econotnico italiano 1861-1940, a cura di G. Tooiolo, Bari , Laterza , 1973

44 POUTICA E POUTICA MIUTARE
verno, il problema ferroviario e le sue forme non avevano subìto alterazioni rilevanti, poiché Depretis già nel 1877 si era dichiarato favorevole all'esercizio privato, specie se la durata di tale esercizio fosse stata sufficientemente lunga (tre-quattro decenni in concessione).
Dopo questa presa di posizione di Depretis del1877, le cose andarono per le lunghe: lo studio del problema ferroviario fu affidato ad una Commissione parlamentare che, iniziando i suoi lavori nel1878, li terminò nel 1881. Ma anche nel 1881, ancora una volta, il maggiore interesse politico e parlamentare si era allontanato dalla questione ferroviaria: vi ritornò, per una serie di motivi, solo nel 1883. Da allora la determinazione dell'assetto proprietario delle ferrovie italiane divenne un problema politico scottante: le convenzioni ed il dibatti to sulla utilità di simili accordi tra lo Stato e compagnie private divenne un tema centrale della lotta politica 37. La Pentarchia, e particolarmente Baccarini, criticò la forma delle convenzioni con compagnie private (strettamente legate agli interessi frnanziari internazionali) poiché questo avrebbe potuto frenare (piuttosto che sviluppare, come ci sarebbe stato bisogno) l'ini ziativa industriale italiana per la produzione di material e rotabile e di locomotive. Ambienti m in isteriali e co n servato ri , invece, propendevano massicciamente per la soluzione delle grosse compagnie; dietro questi ambienti stavano i grossi interessi finanziari francesi, germanici (che poi giocarono una parte imprevista ma di un ceno rilievo nell'intera questione) e soprattutto nazionali.
I gruppi legati alla semp re più potente Banca Nazionale ne fecero, all a fi n e, uno dei più grossi e l ucrosi affa ri del decennio.
Ma a parte i risvolti econom ici e frnanziari, conviene a noi partire proprio dalle convenzioni ferrovia rie perché fu questa la congiuntura po litica e parlamentare in cui si affermò concretamente (e vinse) l'ipotesi di un ritorno di Cesare Ricotti alla Pilotta. Paradossalmente, il primo atto del suo triennio al Ministero del la Guerra fu politico (e so lo poi mili tare) .
Come si vedrà, il generale novarese aveva già da molto tempo acquistato una larga notorietà politica prima con la sua lunga permanenza al Ministero della Guerra coi governi della Destra e poi -
37 Cfr. CAROCCI, Agostino Depretis e la politica interna dal1876 al1887, cit., p. 364 e sgg. Era una lotta politica cui da qualche parte si voleva dare anche soluzioni extra-costituzionali. Nell'estate del 1884, ambienti diplomatici germanici ed austriaci 'consigliarono' ad Umberto I persino la formazione di un Ministero antiparlamentare.
Vi fa accenno Il Parlamento nella storia d'Italia . Antologia stonca della classe politzca, a cura di G. Carocci, Bari , Laterza, 1964 , p. 221.

UN ESERCITO PER RI COTT I 45
ma sempre in tema di politica militare- nei dibattiti parlamentari che lo avevano visto opposto ai vari Ministri della Guerra dei governi succedutisi dopo il 1876. Eppure, pur rivelatosi una personalità militare di primo piano, fu solo per la temperie politica suscitata dalle manovre per le Convenzioni che gli fu possibile ·tornare a reggere il Ministero della Guerra. .
Una volta divenuto un tema centrale di lotta politica, infatti la questione ferroviaria vide ogni gruppo parlamentare esprimere le sue proprie posizioni politiche.
Della Pentarchia si è già detto; di Depretis e dei suoi più stretti sostenitori anche. Quello che è invece assai interessante, ed ancora non molto studiato, è il comportamento del fronte conservatore 38. Naturalmente sostenitore delle compagnie private, escluso qualche isolato fautore del vecchio indirizzo statalistico selliano, il gruppo della Destra era allora diviso a proposito di Convenzioni ferroviarie da differenziazioni regionali e da interessi individuali o di gruppi più ristretti.
Tra questi vari gruppi, di consistenza parlamentare diversa, se ne distingueva uno che trovava il suo migliore organo di espressione nella «Opinione:., il giornale conservatore che era stato di Minghetti 39. Questo gruppo, che pure approvava il complesso del disegno governativo a favore dell'esercizio privato, sosteneva che per non impegnare troppo a fondo i bilanci dello Stato, le convenzioni avrebbero dovuto essere valide solo per dieci (o quindici) anni: dopo di che una apposita legge dello Stato avrebbe deciso se continuare nella forma delle convenzioni o se passare al riscatto integrale delle licenze di concessione. Al fondo di questa proposta, ch e per l'immediato non veniva a mutare i caratteri fondamentali della sc elta di Depretis a favore dell'esercizio privato, stava la vecchia preoccupazione della Destra per il mantenimento del pareggio , connessa ad una volontà di differenziarsi a tutti i costi dal progetto del Presidente del Consiglio e alla ricerca di pretesti tramite cui poter pesare sulla politica governativa.
A questa Qperazione, che in sostanza tendeva a ricattare Depre-
38 Scarsa in generale la bibliografia sui gruppi politici più conservatori, come anche si può ricavare da F. FONZI , La folla polilica, in Bibliografia dell 'età del Risorgimento, Firenze, Olshlci, 1972 , v. Il, pp. 554-555. Sulla questione specifica solo qualche cenno in CAROCO, Agostino D ep retis e la polilica interna da/1876 a/1887, cit., p. 35 7, poi ripreso da VENTURINI, Militari e politici n ell' Italia umbertina, ci r., p. 192.
39 Cfr. sempre CAROCCI , Agostino Depretis e la politica interna da/18 76 a/1887, cit., passim.

46 POUTICA E POUTICA MD.ITARE
cis e la maggioranza trasformista con la minac cia di una dissidenza conservatrice, Mingheni aveva dato il suo segreto ma imponante assenso 40 Si sarebbe potuto obiettare, e Depretis lo sapeva, che questo gruppo (imponante numericamente e po l iticamente) della Destra non aveva prospettive politiche assai lungimiranci, che la sua cooptazione nella maggioranza governativa (dal1882 e ancor più dal maggio 1883) era quasi completa, che, in fondo, la sua volontà di pressione politica poteva affermarsi solo entro margini piuttosto ristretti (in una alternativa Depretis/Baccarini i parlamentari conservatori non avrebbero mai votato, in opposizione al primo, un eventuale ordine del giorno del secondo) e che quindi prima o poi avrebbe dovuto rallier alla maggioranza . Ma, d'altra pane , la lotta politica del trasfor mismo era fatta anche di questi contrasti: ed il tema delle ferrovie era una questione politica troppo decisiva perché Depretis potesse fallire 4 1
Il peso di questo gruppo della Destra sulla congiuntura politica poteva essere quindi rilevante: un peso che, nella logica del trasformismo, andava premiato prima o poi anche a livello governativo.
Uno degli esponenti di questo gruppo di co nservatori parlamentari era il General e Cesare Ricotti Magnani . Infatti, per la deàsi one dimostrata nella sua opposizione già ai primi governi della Sinistra al potere e per l 'asprezza delle critiche poi da lui mosse ai successivi governi Depretis, Ricotti non era visto dagli ambienti e nelle cro nache parlamentari di quegli anni solo come un militare ma anche come un accorto esponente politico di rilievo della Destra 42 Già da tempo, di fronte all'indebolimento politico del vecchio Sella, acuti osservatori avevano riconosciuto che Ricotti , nell'ambito della Destra, cposs[edeva] tutte le qualità di un capo-partito• 4 3. Se pure queste potevano essere esagerazioni, rimaneva il fatto che l'operato par-
40 AGBO , Carte Minghetti, v. 157, 23 ortobre 1884 , Ricotti a Minghetù.
41 Da tempo Deprecis insisteva, nei confronti dell'opinione pubblica, attraverso il quotidiano cii popolo romano• sull'importanza politica e nazionale della questione ferroviaria. Quest'atteggiamento di Depretis non era solo esteriore. Intimamente, egli era preoccupato delJe conseguenze che un possibile mancato accordo circa le convenzioni avrebbe avuto per la stabilità politica e sui rapporti interni alla classe dirigente. Cfr . già CRCMI , Carte CotTenti, 11 maggio 1884, Deprecis a Correnti.

42 Tra gli altri cfr. E. ARBIB , Cinquant 'anni di storia parlamentare del Regno d 'Italia , v. IV , Undicuima, d odicesima e tredicesima legislatura dal 5 dicembre 1870 al 29 aprile 1880 , Roma , Tip . Camera dei Deputati, 1907, p. 8 33 .
43 A. GUICCIOU , Diano del 1881 , in cNuova antologia. , a . 1936, n. 12 , alla data del 22 dicembre.
UN ESEROTO PER RICOTil 4 7
lamentare di Ricotti appariva ai contemporanei incent rato m a assolutam ente non ridotto alle questioni più propriamente militari .
Come vedremo, per la logi ca interna all'andamento della politica militare italiana , il nome di Ricotti quale possibile Ministro della Guerra che potesse succedere al sem pre più incetto e malvisto Ferrero era già circo lato più volte. Già nel luglio 1884, il presidente del Consiglio gli aveva chiesto di accettare la carica mioisteriale: maRicotti, come vedremo, rifiutò adducendo motivazioni propriamente di politica militare 44.
Nell'autunno dello stesso anno, di nuovo e più insistentemente , Ricotti ricevette gl i inviti di Depretis ad entrare nel Consiglio dei Ministri. Erano qu e lli i mesi io cui le varie fazioni della maggioranza parlamenta re andavano confrontando le rispettive posizioni , p rim a della apenura dei lavori parlame ntari , proprio in merito alla questione delle convenzioni ferroviarie. Il problema d e lle ferrovie si andava se mpre più rivelando come il tema decisivo d eU a imminente sessione.
Ricotti , che pure nell 'accogliere le prime offene di Depretis aveva su bo rdinato il suo assenso alla accettazione da pane del Governo di alcune condizioni di carattere militare (di cui si riservava comunque di farne oggetto di successivi colloqui co l Re in persona), sem brò condurre tutta la sua personale trattativa con Depretis e con il suo emissario, il faccendie re Costantino Perazzi 45, ali ' insegna d eUe qu es tioni politiche riguardanti le convenzioni ferroviarie.
Nei suoi co ntatti con Perazzi e nella co rrispond enza che intrecciò con lui e con D epretis, Ri co tti parlò quas i se mpre e so lament e delle co nve nzioni 46 Egli dimo st rava di gradire le offene ministe-
44 Cfr. ID., Diario de/1884, in ivi, a. 193 7, n. 19. p. 301, alla data del3luglio.
45 Cfr. ivi, pp. 313-316. Guiccioli risulta bene informato delle trattative segrete ua Depretis, Perazzi e Ricotti, nonché degli inco n tri del generale co n il re. Pa rtico lare interessante è che , nonostante il quotidiano del presidente del Consiglio (c:Il popolo romano•) annunci solo in data 24 ottobre la successione di Ricotti a Perrero, Guiccioli dà per scontata la nomina del ge n erale novarese a Ministro già in data 11 Ottobre, dopo gli incontri con il re:. Cfr. ivi, p. 314 c: p. 316 alle rispettive date:.
46 U na parte assai interessante del carreggio tra Perazzi e Ricotti, con originali e minute, si uova in MCR , Carte Perazzi se. 904, fasce. 45 -47. Per gli accenni alle Convenzioni cfr. ivi, fase. 47, doc. 6, 12 ottobre 1884, Perazzi a Depretis (io cui vengono riass un ti) e più dettagliatamente ivi, fase 45, doc. 5 , 23 ottobre 1884 , Ric otti a Perazzi , e i11i, fase. 47, doc. 10, 4 novembre: 1884, Perazzi a Depretis. Su questa documentazione, cfr. E. MOREW, l fondi archivistici del museo centrale del Risorgimento. XXIX. Le carte di Costantino Perazzi, in cRassegoa storica del Risorgimenro,., a. UV ( 1967), pp. 641-645. Ricotti era conv intissimo dell'importanza del suo in gresso nel Ministero ai fmi della risoluz ion e della questione dell e Convenzioni. •Accettando il portafoglio della Gu erra ho messo per condizione che il contratto per la convenzio ne ferroviaria sia ridotto

48 POLmCA E POLmCA MILlTARE
riali di D epret is , ma esigeva che il governo accettasse il punto di vista dell'cOpinione• cui abbiamo sopra accennato (sì all'esercizio privato ma possibilità di riscatto entro un quindicennio).

Questo atteggiamento era destinato a pesare su Depretis, che vedeva come decisiva la presenza della Destra di Minghetti nella maggio ranza governativa e che aveva già detto di veder «dipende[ re] ( ... ) dali' approvazione della legge [delle convenzioni] la conso lida zio ne o lo sfacelo del Ministero• 4 7. E che , preoccupato , scriveva: «Le conseguenze di una nuova crisi io non le posso misurare:. 4 8.
D i fro nte ad un Depretis così intimorito per un eventuale insuccesso della legge sulle convenzioni ferroviarie, le in sisten ze di Ricotti e soci per una 'convenzione a termine' dovevano avere il loro effetto.
Da parte sua Ricotti pareva compreso e convinto, per i motivi che abbiamo visto, di riuscire a poter condizionare il programma di Deprecis circa le convenzioni ferroviarie. Durante le trattative, in ogni sua co muni caz ion e con l'intermediario Perazzi, egli vol eva essere info rmato su ll 'atteggiamento di Depretis al riguardo.
Ne parlava con tutti, lo scriveva persin o a militari che, come Marselli, potevano anche disinteressarsi di tali questioni: in una importante lettera a quello che sarà poi il suo Segretario Generale, egli spiegava la sua accettazione del posto di Ministro della Guerra con l 'intento di rafforzare il ministero Depretis e con il proposito di condizionarlo proprio alla criduzion e a quindici anni della durata delle Co nvenzi oni ferroviarie:., anche se per il momento «non se ne dovreb be ancora parlare:. 49.
Anche osservatori bene informati sottolineavano la valenza politica dell'ingresso di Ricotti nel governo Depretis. Guicci oli, nel suo diar io, scriveva cl giornali moderati di tutte le gradazioni esultano. Vado al Ministero dei Lavori Pubb lici dal Segretario general e Correale ( .. )Mi dice: 'Con la nomina di Ricotti siamo sicuri di vedere
a 15 anni, ma di questa condizione sarebbe bene di non parlare per ora.. AGBO, Carte Minghetti, v. 157, 23 ottobre 1884, Ricotti a Minghetti.
47 Già cosi scriveva il Presidente del Consiglio, quando ancora si trattava di nominare solo La Commissione parlamentare. CR CMl, Carte Co"en ti, 11 maggio 1884, Depretis a Correnti.
48 Ibidem. Ma sui timori di Depretis per la solidità deUa maggioranza governativa, cfr. anche ivi, 15 dicembre 1884; ivi, 20 marzo 1885; ivi, 3 febbraio 1886; ivi, 8 marzo 1886; ivi, 20 aprile 1886; sempre Oeprecis a Correnti.
49 Lettere inedite dall'archivio del generale Marselli, a cura di N. Giacchi, Roma, Min. Marina , 1946, p. 31.
UN ESERCITO PER RICOTI"I 49
votate le Convenzioni Ferroviarie':. 50_ Ed infatti fu proprio così.
Le convenzioni ferroviarie vennero approvate nella primavera 1885. Uno dei più grossi 'affari' della fine del XIX seco lo italiano aveva ricevuto la ratifica parlamentare, il Governo' Depretis ne era uscito rafforzato, l'asse politico della maggioranza si era spostato ancora di più verso Destra.
Era però riuscito Ricotti a condizionare Depretis a proposito della durata delle Convenzioni? Solo a metà. Gli accordi stipulati con le Compagnie private parlarono infatti di una possibilità di riscatto allo scadere dei venti o dei quarant'anni 5 1 E, detto qui per inciso, le vicende della sua nomina a Ministro avrebbero potuto ins egnare qualcosa a Ricotti e moderare le sue pretese di influire sul corso della politica - interna e militare - di quegli anni.
Il fatto era che (anche a prescindere dall a inconsueta situazione di un militare che poneva condi zioni di politica economica alla sua accettazione del posto di Ministero della Guerra) rimaneva comunque ancora Depretis a tenere in pugno le redini del trasform ismo.
Qualche tempo più tardi, ripensando a quegli eventi, alle crisi ministeriali della maggioranza trasformista ed alla capacità del Presidente del Consiglio di venirne a capo, Guiccioli infatti scriveva: Quanto alla posizione del Depretis, essa diventa sempre più curiosa. Deprecis è una specie di istiruzione: egli funziona come un sovrano costiruzionale. Quando una proposta qualsiasi è ponata da un Ministro innanzi alla Camera, o è accolla, e allora tanto meglio, ne viene gloria aJ Gabinetto ed al suo Presidente; o non passa, e allora va a fondo il Minisuo che l'ha presentata, o alla peggio si determina una crisi, dalla quale riesce fuori un'altra nuova combinazione Depretis 52
)O GUICCIOLI, Diario de/1884, cit., p. 317, alla data del28 ottobre.
H Cfr. anche CASTRONOVO, La storia economica, cit Per alcune reazioni politiche alla nomina di Ricotti, cfr. cii Diritto• , 27 ottobre 1884; cii Caffè•, 27 ottobre 1884; cFaofullu, 28 ottobre 1884; cla Perseveranza., 28 ottobre 1884 (alcuni esemplari dei quali si trovano conservati anche in ACS, Carte Pelloux, se. 29). Vale la pena ricordare che la manovra di Depretis sulle convenzioni ferroviarie non aveva solo una valenza politica ma anche sociale. Come ben scrive G. Carocci, cle Convenzioni ferroviarie, discusse e approvate dal Parlamento tra la fine del 1884 e i primi mesi del 1885 , diedero rutta la misura della posizione preminente che: l'alta finanza aveva acquistato presso il Governo e presso la maggioranza del Parlamento, e si posero quasi come l ' avvenimento conclusivo del trasforrnismo e della politica seguita da Depretis fin dal 1876:.. CAROCCI, Agostino Depretis e /apolitica interna da/1876 a/1887, cit., p. 354. Ricotti, quindi, si trovava in mezzo a rutto questo .
)2 A. GUICCIOLI, Diario de/1886, in cNuova antologia., a. 1937, n. 23, p. 321, alla data del 30 novembre Ministero della Guerra, o- come si diceva allora- Pilotta.

50 POLITICA E POLITICA MILITARE
Anche nel momento cruciale delle discussioni sulle convenzioni ferroviarie, Depretis era riuscito nel suo gioco di manovre parlamentari. In più, adesso, c'era il generale Cesare Ricotti Magnani al Ministero della Guerra.
Cesare Rz'cotti, un militare particolare
Cesare Ricotti, che divenne così per la seconda volta Ministero della Guerra in quell'ottobre del 1884, era già una delle personalità più imponanti del dibattito e del mondo militare del tempo e dell'Italia liberale. La sua figura, diversamente apprezzata 1 ma ancora in larga parte da studiare, si intrecciò di fatto con la preparazione, la nascita, la riforma, la gestione e lo sviluppo dell'esercito italiano dali 'Unità praticamente sino alla fine del secolo.

Percorsi con rapidità tutti i gradini della scala gerarchica, il novarese fu promosso generale già a trentotto anni 2 • Occupò per più volte le più alte cariche (politiche o amministrative) militari , panecipò a decisive Commissioni militari pubbliche o segrete, fu per ventiquattro anni deputato al Parlamento (dove svolse, a differenza di molti altri suoi colleghi ' deputati in divisa ', un'attività politica continua ed intensa), e poi senatore per vencisette, fu Ministro della Guerra- in tre riprese- con cinque diversi Governi, fu incaricato persino (nel 1896, sia pure in un contesto partico lare) di formare un governo. Anche so lo questi schematici dati sono sufficienti a delinare un personaggio d'eccezione nella vita militare e politica d eli' Italia umtarta.
Per questi motivi, e per il rispetto che già aveva sapu to ispirare intorno a lui nel mondo politico e militare, al momento stesso della sua nomina a Ministro della Guerra si capì che con Ricotti non si sarebbe ripetuta la sceneggiata dei Ministri 'comandati', degli alti mi-
Sul perché. impropriamente ma per lungo tempo, il Ministero della Guerra fosse identificato con il Palazzo romano della Pilotta, cfr. adesso P. FERRARA , Il Ministero della Guerra, in Roma Capitale. l Ministeri di Roma Capitale. L 'imedi4mento degli uf.foi e la costruzione delle nuove sedi, Venezia, Marsilio, 1985, pp. 136-146 (catalogo dell'omonima mostra documentaria).
1 Cfr. MOSCATI, I Ministri del Regno d'Itali4, v. III, Da Mentana alla caduta della Destra, Napoli, 1960 , pp. 259-268 ; e P. PIERI , Le forze armale nell'età della Destra, Milano , Giuffré, 1962 , p. 82 e sgg.
2 Cfr. A USSME, Biografie, racc. 57. fase. 31.
UN ESERCITO PER RICOTII 51
litari che occupavano lo scranno ministeriale solo per il buon volere della Corona e non per mettere in discussione la precedente politica 3.
Di quali fossero però gli orientamenti di politica militare del novarese parleremo in altra parte: è adesso utile illustrare qualche precedente della sua vita politica e militare, per chiarire alcuni aspetti del suo carattere, del suo atteggiamento politico e delle sue convinzioni militari. Non una biografia, comunque, che pure sarebbe inte ressante, ma per la quale in ogni caso paiono a tutt'oggi mancare le necessarie fonti documentarie 4.
Cesare Francesco Ricotti Magoani era nato a Borgo Lavezzano in prossimità di Novara il 30 gennaio 1822. Suo padre era l'avvocato Giuseppe Ricotti, facoltoso ma non nobile, che fu poi per lunghi anni sindaco del capo lu ogo piemontese 5.
Il giovane Ricotti, entrato prestissimo nella Regia Accademia di Torino vi uscì nel1841, ma per farvi ritorno assai presto: questa vo lta non più da alunno ma da insegnante. Cominciava così la car riera del novarese, che rimase all'Accademia dal1844 al1848. Nella guerra del1848 ebbe modo di farsi notare per alcune belle prove d'iniziativa 6. Ma le sue qualità più apprezzate parevano allora la conoscenza della teoria dell'arte militare e soprattutto della pratica dei complessi meccanismi dell'amministrazione militare. Dopo la guerra del '48 Cesare Ricotti scrisse un libro cd' ordine di S.A.R. il Duca di Genova» sull'artiglieria da campagna 7, e dal 1851 al1853 insegnò- appunto Arte militare - alla Scuola Complementare d'Artiglieria e
3 Cfr. cii popolo romano:., 20 ottobre 1884, Il Mini.rtro della Guerra
4 Non è stato possibile rintracciare nessuna copiosa serie documentaria di carte private del generale . Le stesse note biografiche che seguono devono molto della loro disorganicità, tra l' altro, al fano di essere fondate su una paziente e lunga ma disomogenea raccolta di documenti autografi di Cesare Ricotti , compiuta nell'arco di vari mesi, tra diversi Archivi italiani . Allo stesso Archivio di Stato di Novara (città nei cui pressi il generale era nato e in cui la famiglia Ricotti era import.ante e rispettata) non si uovano oggi che du e -tre documenti di nessun valore storico per la ricostruzione della lunga vita pubblica del generale.
5 Cfr. Dizionano del Risorgimento nazionale . Dalle ongini a Roma capitale . Fatti e person e, v . IV , Le p ersone , Milano, VaUardi , 1937, ad vocem , p. 74 .

6 Cfr. MONTÙ, Storia dell 'arttglieria italiana, p. ll, Da/1815 al1914, v. III, Roma, Arti Graf. Santa Barbara, 1937 (edito a cura della cRivista di Artiglieria e Genio:.), p 965.
7 Si tratta va di N ozio ni sull'artiglieria da campagna compilate al camp o d 'istruzione del 1849 d ' ordine di S.A.R. il duca di Genova dal capitano d'Artiglien'a Cesare Rico tti, Torino, 1849.
52 POLITICA E POLITICA M!UTAR.E
Genio. Non per questo, però, tralasciò di panecipare alle imprese militari piemontesi del tempo: fu in Crimea con il Corpo di spedizione di La Marmora e vi ottenne «la promozion e a maggiore per meriti di guerra ed il riconoscimento del valore, della perizia ed ardire addimostrati» 8 .
Il novarese continuò poi ad alternare incarichi amministrativi e comandi di reparti operativi. Una volta tornato in Piemonte , venne impiegato (per le qualità in precedenza dimostrate) dapprima presso la Direzione del Materiale di Artiglieria e poi come Direttore di quella Scuola complementare di Artiglieria e Genio dove aveva già insegnato. Ma non perse occasione di farsi notare, all 'ap prossimarsi dlella guerra del 1859. In quell'occasione fu anzi nominato Capo di Stato Maggiore dell'Artiglieria dell'Armata e poi Capo di Stato Magg iore della Terza Divisione dell'Armata 9 .
Dal '59 al '61 fu so lo un ascendere di cariche, spesso grazie al favore personale allora dimostratogli dallo stesso La Marmora. In quegli anni Ricotti fu cosi successivamente Capo di Stato Maggiore del Primo Gran Comando Militare, Capo di Stato Maggiore dell'Arma di Artiglieria , Comandante della prestigiosa Brigata Aosta. Sul fmire della guerra fu nominato 'Co mandante militare della città, Fortezza e Provincia di Napoli' e poi fu inserito in quella delicata Commissione incaricata di determinare la posizione degli Ufficiali provenienti dall'Es ercito regolare del cessato Regno delle due Sicilie Alla fine della guerra, le già spiccate conoscenze amministrative del novarese gli fruttarono la cari ca di Direttore General e delle Armi Speciali al Min iste ro della Guerra, carica dalla quale poté osservare e dirigere il complesso riarmo dell'esercito italiano seguito alle vicende del '60 -'61 ed in preparazione della guerra del '66.
Era nel frattempo stato promosso già Maggior Generale, a soli trentottanni. Nella guerra del '66 tenne un comando d ivisionale e si fece notare per alc u ne sue azioni militari ed in generale per l' efficienza e la capacità con cui tenne il comando della truppa 10 .
Ma la traiettoria di Ricott i non si riduceva a questo suo alternare periodi di studi e di amministrazione militare con periodi di comando di repano: in tutti questi anni, in pane per le sue capacità, in pane per una certa ambizione che veniva da altri ri conosciuta ed
9 Cfr. anche P. PIERJ , Storia 1nilitare del Risorgimento. Gue"e e insu"eziom·, cit., p. 747.
1° Cfr. ibidem.

UN ESERCITO PER RlCOTII
8 MONTU , Storia dell'artiglieria italiana , p. 11 , Dal lBIJ a/1 914, cit., p. 759.
incoraggiata 11 , il novarese andava sviluppando un suo proprio con. cetto di come avrebbero dovuto essere costituite le istituzioni militari del Regno unitario. Solo altri e beo più approfonditi studi potranno dirci quanto le idee di Ricotti (quali quelle che qui vogliamo rico rdare sulla condotta strategica degli eserciti, sulla loro costituzione organica, sul rapporto tra politici e militari, o tra politica finanziaria e politica militare , sul Parlamento , etc.) fossero anche quelle dei militari italiani della sua generazione: ceno è che nel novarese esse erano ben solide e radicare 12.
Da vero e proprio 'generale (anche se giovane) delle guerre d'indipendenza', egli era assai convinto che le battaglie si vincessero con l'uno di grandi e forti masse di soldati. Sia pure senza la fissità ed il ricorrere delle rigide formule matematiche jominiane 13, è provato che Ricotti anche molti anni dopo la fine di quelle guerre continuava ad essere convinto dell'importanza in guerra come in pace dei 'grossi battaglioni' 14 e delle foni compagnie 15. Questo però non lo escludeva dal recepire i suggerimenti d eli' esperienza ptussiana, che proprio in quegli anni si andavano diffondendo tra i militari italiani. Anzi, in questo senso, la stessa sua forte amicizia con Govone - che in Germania aveva avuto modo di operare - gli fu di grande utilità 16. Negli anni precedenti il 1870 studiò infatti le teorie e i regolamenti germanici dell'ordine sparso 17 e contribì alla loro progressiva adozione in Italia.
11 Cfr. M CASEm, Le carte di Alfonso Ferrera della Marmora. Spunti per una biografuz e un epistolano, Vercelli, SETE, 1979, p 424, dove si ripona la lencra del 30 sencmbre 1861, G. Dabormida a Lamarmora.
12 !11i, p. 696, e la lettera 12 luglio 1861 , A. Petitti Baglioni di Rorero a Lamarmora.
13 ar. PIER!, Stona mzlitare del Risorgimento. Guerre e insurrezioni, cit., p. 143 e sgg.
14 Cfr. FARINI, D1ario di fine secolo, cit., pp. 76-77 , alla data del 20 aprile 1892.

15 Il numerismo di Ricotti (e di Pelloux), che pure assai bene rappresentava le aspirazioni ad un esercito 'grosso ' ed ad una 'politica di potenza' italiana e che ceno era la tesi più diffusa tra gli ufficiali del Regio Esercito del tempo. non poteva però impedire che altre concezioni si facessero strada. Negli anni seguenti ad esempio, quando ai fallimenti di Ricotti a fare dawero grosse le compagnie si sommarono gli effetti delle restrizioni di bilancio apponace da Pelloux , ci fu chi sostenne con forza anche la superiorità delle compagnie 'piccole'. Tra gli altri , cfr. C. AIRAGHI, La forza delle compagnie, Roma, «.a rivista di Fanteria. Editrice, 1895, p. 7. Sulla tendenza europea ai 'g rossi' eserciti nel XIX secolo , cfr. HOWARD, La guerra e le armi nella storia d'Europa , ci t., p l 13.
16 Cfr. MNR . TO , Carte Go11one, cartt. 5, 7 ed 8.
17 Cfr i11i, can. 7, fase. 6, doc. 19. 7 dicembre 1867, Ricotti a Govone; e ivi, can. 7, fase. 6, doc. 20, 21 gennaio 1868, Ricotti a Govone.
54 POLITICA E POUTICA MIUTARE
Ciò che lo colpiva maggiormente nel sistema p russi ano (ed era cosa che cosùtuiva proprio una delle più gravi lacune dell'ordinamento italiano) era però l'imponente numero della truppa mobilitabile e quel perfetto cooperare ed integrarsi di eserciti di prima, di seconda e di terza linea. Nella costituzione di imponenti ed organizzate riserve e nella 'militarizzazione' della società 18, egli vedeva quindi il modo di costituire più forti e più numerosi battaglioni, che fossero pronti a schierarsi ed a scontrarsi in battaglia in un formidabile 'u rto' con la potenza avversaria.
Quanto questa conoscenza e questa interpretazione del modello prussiano fossero diffusi in Italia è cosa ancora da stabilire 19. Comunque, che Ricotti la sostenesse con vigore divenne chiaro già nel 1867 quando l 'allora Minisuo della Guerra Cugia, riunendo una Commissione segreta di generali per discutere le vie da seguire per intraprendere la necessaria ristrutturazione dell'esercito, ch iamò a parteci parvi anche il giovane novarese 20. In quelle sedute, decisamente ma senza intransigenza , Ricotti propose l'adozione del sistema prussiano , adattato alle condizioni italiane e comunque conformato in modo da avere 21 , al più presto, disponibile un imponente strumento militare nazionale. Il fatto che Ricotti nel 1867 difendesse il sistema prussiano con tanta autorità e calore, e di fronte a generali più anziani e più noti di lui, acquista un valore ancora più grande ove si pensi che in quelle assise non poche erano ancora le 'lance spezzate' in favo re di una 'riforma' militare che non portasse alla costituzione di un 'esercito-numero' bensì a quella di un piccolo ma efficiente 'esercito -qualità ' 22 Non si trattava, in quelle riunioni della primavera 1867, di una discussione astratta su due modelli di organica militare (il prussiano o il f rancese), ma- al fondo- di un aspro dibattito interno al mond o militare su quale dovesse essere il nuovo principio ispiratore dell'esercito del Regno dopo la non bella pagina del 1866 e di Custoza: se quello di salvaguardare l'onore delle armi,
18 Cfr. AUSSME. Studi t ecnici, racc. 2, alla data del 18 gennaio 1867.
19 Cfr. PIER!, Le jot:le firmate nell'età della Destra , ci t., pp. 6-9.

2° Fu Ricotti il primo ad intervenire e fu intorno al progetto di ordinamento militare presentaw dal novarese che , per scelta e per caso, si sviluppò la discussione. Cfr. A USSME , Studi tecnici, racc . 2 , alla data del17 gennaio 1867. La Commissio ne si riunì daJJ'8 gennaio al 27 marzo 1867.
21 Cfr. ivi, alla data dell'8 gennaio 1867 , nonostante quanto si legge in ivi, alla data del 17 gennaio 1867.
22 Cfr. ad esempio, gli incervenù di Govone (ivi, alla data del 9 gennaio 1867) e dello stesso Nino Bixio (ivi, alle date del 10 e dell' 11 gennaio 1867).
UN ESERCITO PER RJCOIT! ))
fa cendo leva solo su una ritrovata efficienza d e llo strument o militare (e d allora poteva forse bastare l'esercito piccolo , di ' qualità') , o se invece e ra nec essario far ricorso alla forza d e lla nazione, inquadrandola ed inserendola nelle file ampliate di un nuovo ordinamento militare (ed allora , in tal senso , si capisce come il termine 'Nazione armata' potesse a questo riguardo essere usato anche da generali come Ricotti) .
Già nel 186 7, inso mma , il novarese aveva le id ee chiare su come - se fosse dipeso da lui - avrebbe dovuto essere ordinato l'esercito 23.
Punroppo , per una serie di motivi , la spinta riformatrice in seno all'esercito regio dovette allentars i dopo il 1867 . Il progetto di legge di riordiname nto dell'esercito avanzato da Cugia in quello stesso anno , e che pure solo in pane recepiva le conclusioni del dibattito della Commiss ione dei Generali del1867 , fu fatto arenare ; e a nulla valse che i successivi Ministri de ll a Guerra , Thaon di Revel e Benolè Viale, l o riprese ntassero con poche modifiche all'attenzione del legislativo 24 .
In sintonia coi tempi , probabilmente, lo stesso Ricotti attenuò dopo il 1867 l'enfasi con cui aveva sino ad allora sostenuto la necessità di una riforma dell'esercito. Sebbene privatamente e ne lla corrispondenza con i suoi più intimi ami ci continuava a professare le sue idee e a dare mostra di svilupparle ed aggiornarle, pubblicamente non prendeva posizioni di spicco o di ro ttur a. Per questi motivi , al la vigilia della presa di Roma e della sua nomina a Ministro , veniva considerato come un militare intelligente ma «c almo» 2 5 .
E pare ch e fu proprio qu es ta impressione di militare ' amministratore ' e ' quieto' che facilitò la sua ascesa al Ministero nel 1870 , in momenti n on facili per l'organi zzazion e militare e per l'Italia .
Del suo primo lungo ministero della Guerra ( 1870-1876 ) è st a-
23 Cfr. il progeno di Ricotti in i11i, alla data dell'S gennaio 1867, nonché la sua seconda versione in i11i, alla data del 14 ge nn aio 1867. Cfr. poi con il progetto di legge Cugia che dai lavori della Commissione prese le mosse (i11i, alla data del25 marzo 1867) e con i progetti di legge di Revel (AA.P P. Cam era , Legisl. IX , sess. prima , Documen#, n. 48} e di Benol é Viale (AA.P P. , Camera, Legisl. X. sess. prima , Documenti, n. 286}: e poi sino alle leggi J9luglio 1871 e 30 settembre 1873, che furono la base della 'riforma Ricotti'.
24
Cfr. PIERl, Le forze armate nell'età della Destra, cit., p. 83 e sgg.
25 E. SARTORIS, Il generale Cesare Ricotti Magnani ed il suo tempo, Novara , 1965. p. 62, cita una le nera di Lamarmora a Lanza, del 7 settembre 1870, in cui si sarebbe detto di Ri cotti: cEgli ha molte qualità e quel che più conta è calmo• .

56 POliTICA E
POUTI CA MIUTARE
to così spesso scritto - anche se ancora in modo !ungi dall'essere soddisfacente - che ci esimiamo da farvi un ulteriore richiamo 26 Sottolin eeremo solo alcuni aspetti, rilevanti per la storia dell'esercito italiano e per la storia personale del generale novarese. Non interessa qui fare una valutazione qualitativa del lavoro di Ricotti: se cioè egli fece quanto era in potere fare da pane della giovane 'potenza' italiana 27 o se invece - come a lungo gli rimp roverarono i suoi critici- egli costituì solo un esercito nuovo ma «scheletrico:. 28, per via della volontà di non eccedere nelle spese militari e della oggettiva ristrettezza dei bilanci della guerra. Sottolineeremo invece i l fatto che Ricotti realizzò in quegl i anni qualcosa di assai vicino a quello che dal 1867 si era ripromesso: riformò il meccanismo di leva, ampliò il contingente, iniziò a prevedere legislativamente ed a organizzare praticamente un esercito di seconda e di terza linea. E già nel fare questo (in una situazione internazionale non facile per l'Ital ia, ma in un ambiente politico interno assai favorevole pe r il generale novarese e per la sua azione riformatrice) Ricotti e gli u ltimi governi della D estra storica costruirono per l'Italia uno strumento militare che ne legittimava le ambizioni, quelle allora correnti come quelle successive, da ' grande potenza europea ' 29.
Q u el binomio di prob l emi che era stato per i governanti italiani 'eserci to e finanze ' 30, poteva dirsi avviato a so l uzione dopo il governo della Destra: anche se il raggiunto pareggio finanziario doveva poi crollare per un a logica interna a quella stessa soluzione, di fronte ad un crescente int erventismo statale nell'economia e nella società ma soprattutto di fronte proprio al crescere di quelle spese militari che il 'nuovo esercito' di Ricotti avrebbe fulÌto per esigere.
Questo , tra l'altro , co nduce al cuore di un altro grande aspetto che può dirsi permanente nell'opera e nel pensiero di Ricotti: la sua
26 Cfr. PIER! , Le forze armate nell'età della Destra, cit.; V. GALLINARI, Le n ·fo rme mtlitari di Cesare Ricotti, in cMemorie storiche militari 197 8 •, Roma, 1979 .
27 Cfr. in ques to senso GALLINARI , Le n/orme militan· di Cesare Ricotti, cit., p. 32.

28 Cfr. F. DE CHAURAND DE SAINT EUSTACHE , Come l'esercito italiano entrò in gue"a, Milano , Mondadori , 1929 , p . 20.
29 Cfr. ROCHAT , MASSOBRI O, Breve st oria dell'esercito italiano dal 1861 al 1943, cit., pp. 108-109.
3° Cfr. CHABOD Stona d ella politica estera italiana dal 1870 al 1896, ci t., p. 563 e sgg.; PIER! , Le forze armate n ell'età della Destra , cit., pp. 71-72 (che ne nota il legame già dal1864 ); ROCHAT , MASSOBRIO , Breve storia d ell'eurcito italiano dal 1861 al 1943, cir. , p. 84.
UN ESERCITO PER R1COffi ) 7
concezione del rapporto tra bisogni militari e disponibilità finanziane.
Quando disporremo di smdi accurati e puntuali su ll 'ideologia dei militari, si potrà forse stabilire in che modo le idee di Ricotti stesse ro in rapporto con le 'idee diffuse' tra i militari del suo tempo. E si potrà definire co n precisione quanto esse fossero rappresentative di quelle, o quanto invece risentissero del fatto di essere le idee di un Ministro, di un amministratore, di un parlamentare.
Fatto sta che, di fronte a tanti esempi di richieste militari esagerate e generalizzate (tipico il caso delle Commissioni di generali che chiedevano la fortificazione integrale del Regno senza stab ilire alcun ordine politico, o politico-militare, di priorità e senza tener che uno scarso conto della si tuazione delle casse dello Stato) 31, Ricotti sottolineava sempre il tema della necessaria 'armonia' tra Tesoro e Guerra. Questo ceno non gli facilitava il consenso nel mondo militare del tempo 32, ma nemmeno tra gli storici dell'oggi, che talvolta lo hanno visto con malanimo, come una sorta di «bastian contraire, sempre pronto a presentarsi come l'unico militare capace di ve nire incontro alle esigenze del potere politico, e mosso da una volontà di rivalsa in cui l'ambizione personale si mesco lava alla fede di parte:. H. lo realtà Ricotti aveva visto di persona i risultati delle immediate ed improvvise restrizioni finanziarie dei bilanci militari dopo il 1866, e l' effetto che esse avevano avuto sulle proposte anche innovatrici dell'ambiente mili tare: e voleva evitare che ciò si ripetesse.
Si potrebbe dire che quello che lui temeva non erano tanto le restrizioni dei Bilanci in sé quanto il loro essere non contrattate dai politici coll'ambiente militare (ed anzi a quello imposte) e la loro possibile radicalità e subitaneità. Non a caso egli fu tra i sostenitori,
32 Le idee 'politiche' di Ricotù sulla necessaria 'armonia ' tra Guerra e Finanze erano spesso viste: negli ambienti militari (degli anni '70 e degli anni '80) come meri cedimenti del generale novarese alle lusinghe ed alle compatibilità parlamentari. A questo si aggiungeva, a screditare l'immagine di Ricotti nei confronti di taluni ambienti militari , la serie: di conuadditoric: prese di posizione (o di riserve mentali) cui il generale novarese era obbligato dalla sua ferma vo!oocàpolitica di contrastare e di condizionare lo svolgimento della politica militare dei governi della Sinistra A questo proposito, in una sua personale rubri ca , l ' allora co lonnell o L.G. Pc:lloux aveva annotato polemicamente e scrupolosamente decine e decine di quelle 'contraddizioni' di Ricotti. Cfr. ACS , Carte Pelloux, se. 21, fase. lla In realtà , non andrebbe confusa la sostanza 'politica ' del suo pensiero , con le ' necessità' tattiche delle banaglie parlamentari di Cesare Ricotti.
33 VENTURJNI , Militan" e politici nell 'Italia umbertina, cit. , p. 176.

POUTICA E POUTICA MllJTARE
3I Cfr. MINNITI , Esercito e politica da Porta Pia alla Triplice Alleanza , cit. , pp . 104-105.
in tempi anche precoci, delle ipotesi di consolidamento dei bilanci 34.
Dove stesse poi quella ' armonia' tra Tesoro e Guerra, anche a sfogliare pazi e ntemente le numerosissime pagine degli Atti Parlamentari che racco lgono i suoi interventi, non appare poi in realtà ben chiaro. Forse stava in quel dover essere un qualcosa di molto accono, di assai bilanciato: una questione insomma di misura e di metodo, piuttosto che di merito. Ma ceno questo non bastava. Probabilmente, dietro questa proclamata necessità di una armonia tra bilancio dello Stato e bilanci militari (cui pure Ricotti credeva fonemente), si celano due elementi egualmente imponanti per capire la sua personalità: il suo forte senso di appanenenza alla pane Destra del Parlamento e la sua grande fiducia in se stesso e nelle sue capacità amministrative e di mediazione.
Ricotti, ad esempio, da Destra, non vide mai dì buon occhio quella serie ripetuta distanziamenti 'straordinari' con cui la Sinistra sbilancia va la regolare e lenta crescita delle spese militari e con cui sostenne a lungo la sua politica militare 35. Secondo il novarese , lo Stato italiano o poteva o non poteva concedere; di fronte all ' armonia dei Bilanci ordinari, non potevano esistere situazioni intermedie. Ma soprattutto Cesare Ricotti non apprezzava la figura e l'opera di quei militari (anche del massimo grado) che gl i apparivano troppo condiscendenti con la politica della Sinistra. Piemontese e monarchico leale, per lui la Sinistra (anche storica) era ancora troppo vicina a quegli ex-mazziniani o a quei gruppi di cs obillatori :. che tra gli anni '60 e '70 avevano più volte tentato di minare l'unità politica e la fedeltà dinastica del Corpo Ufficiali dell 'Ese rcito, con le loro manovre e con i loro 'circoli Barsami' 36. Nel 1876, nonostante glielo avessero proposto, non volle rimanere alla Pilotta un giorno di più , quando il Ministero passò alla Sinistra; e fu sempre in Par lamento il più autorevole (anche se non sempre il più onodosso) ponavoce militare della Destra.
Si pensi all'accanita guerra che egli mosse a Luigi Mezzacapo 37,
34 Cfr AA.PP., Camera, Legisl. XV , sess. unica , Discussioni, tornata del 9 giugno 1885. Ma accenni in questo senso si trovano anche in alcune sue prese di posizione degli anni 1870-76.
3) Cfr., tra le alue varie occasioni, ivi, 31 maggio 1885.

36 Cfr. MNR.TO, Carte Govone, cart. 8, b. 5 , doc 55, 25 marzo 1870, Ricotti a Govone, e ivi, cart. 8, b. 5, doc. 56, 26 marzo 1870, Ricotti a Govone.
n Cfr. tra l'altro AA.PP . , Camera, Legisl. Xlll, sess. seco nda , Discussioni , tornata del l febbbraio 1877.
UN ESERCITO PER RICOm 59
o alle durissime obiezioni che mosse a Perrero quando questi volle i due nuovi corpi d'armata 38 , o a Pelloux Ministro della Guerra del primo governo Giolitti 39. Il suo impegno politico e pubblico fu, tra i militari del suo tempo, forse senza eguali. Fu , col passare degli anni, selliano, minghettiano, dirudiniano: ma fu sempre conservatore. Numerose ed esplicite le sue prese di posizio ne contro le agitazioni popolari e contadine 4o come contro - volta a volta - i radicali, i pentarchici, i Sinistri.
Persino del Parlamento, per il quale disse sempre di avere grande rispetto anche in tema di politica militare 4 1 (e nel quale appunto egli combatté alcune delle sue battaglie politiche più difficili, come quella contro i due corpi d'armata nel 1882 o per la riduzione dell'esercito nell896, battaglie che nel chiuso dei corridoi del Ministero della Guerra avrebbe certo perso ma che nel pubblico dibattito della Camera egli cercò di far prevalere politicamente), anche del Parlamento- dicevamo- egli ebbe un concetto tutto conservatore, come di una riunione di ottimaci 42 che fosse chiamata a decidere delle sorti della nazion e e che in quanto tale 'doveva' essere sensibile alle richieste di ordine e di stanziamento dei militari . Verso un tale parlamento (che pure già negli ultimi anni della Destra sto rica non aveva poi tanta rispondenza con quello reale ), eg li poteva nutrire deferenza e rispetto; ed in questo poteva anche tollerare la presenza di un dibattito pubblico tra diverse linee di politica militare. Ma non verso quello, che già la riforma del 1882 e della Sinistra aveva crea-
3S Cfr. tra l'altro AA.PP., Camera, Legisl. XIV , sess. prima, Discussioni, tornata del l O maggio 1882. Ricotti fu già in predicato di Ministro nel 1881, quando il re affidò a Sella l'incarico di risolvere- da Destra - la crisi governativa della Sinistra storica, dopo gli esperimenti di Cairoli e Depretis. Cfr. FARINI , Diario difine secolo, cir., p. 1:>19. alla data del 19 maggio 1881.
39 Cfr . tra l'altro AA.PP., Senato, Legisl. XVlll, sess. prima , Discu.uioni, tornata del 29 giugno 1893.
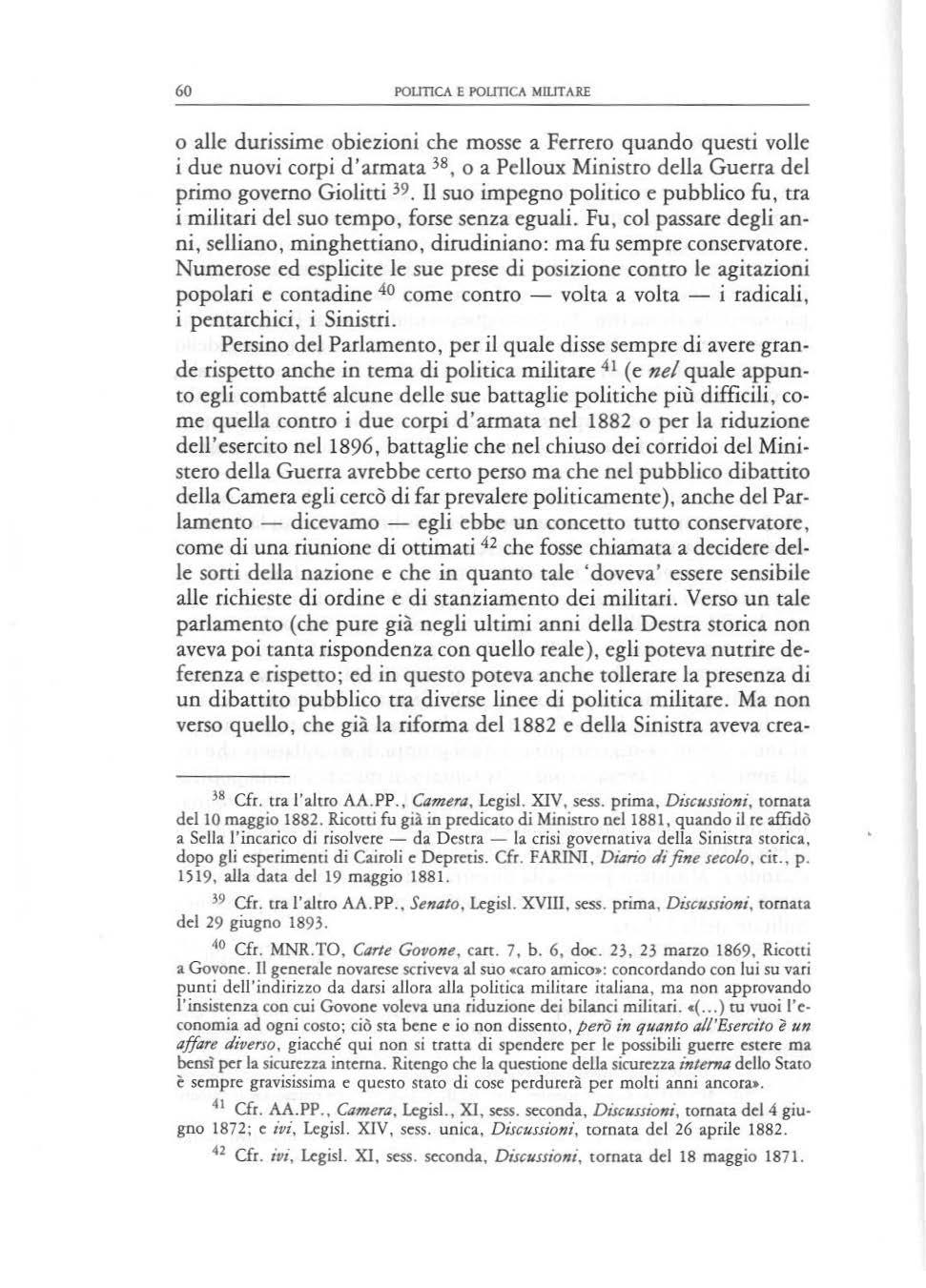
40 Cfr. MNR.TO, Carte Govone, can. 7, b. 6, doc . 23, 23 marzo 1869, Ricotti a Govone. Il generale novarese scriveva al suo ccaro amico•: co ncordando con lui su vari punti dell'indirizzo da darsi allora alla politica militare italiana, ma non approvando l'insistenza con cui Govone voleva una riduzione dei bilanci militari. c( ... ) tu vuoi l 'economia ad ogni costo; ciò sta bene e io non dissento, però in quanto aii'Esercùo è un affore di11erso, giacché qui non si tratta di spendere per le possibili guerre estere ma bensì per la sicurezza interna. Ritengo che la questione della sicurezza interna dello Stato è sempre gravisissima e questo stato di cose perdurerà per molti anni ancora..
41 Cfr. AA.PP., Camera, Legisl., XI, sess. seconda, Discussioni, tornata del4 giugno 1872; e i11i, Legisl. XIV, sess. unica, Discussioni, tornata del 26 aprile 1882.
42 Cfr. ivi, Legisl. XI, sess. seconda, Discussioni, tornata del 18 maggio 1871.
60 POUTICA E POUTICA MIUTARE
to, dove addirittura gli operai salivano le scale di Montecitorio 4 3 Oltre a questi aspetti naturalmente conservatori del suo pensiero, e che avevano un riflesso diretto sulla sua concezione della politica militare, c'era nell'uomo Ricotti - come abbiamo detto- una forte carica di ambizione e di fede in sé, che si sposava con un fortissimo senso dell'autorità e della scala gerarchica militare, specie quando di quella scala egli si trovava ad occupare il più alto gradino 44 Un'ambizione e un autoritarismo che dovevano sembrare tanto più spiccati e dannosi per quegli altri militari che non condividevano le sue idee e la sua condotta nel rapporto tra politici e militari. In conclusione, era quella di Ricotti una figura complessa, con le sue idee e i suoi programmi. Un personaggio che proprio per i suoi concetti si trovò frequentemente isolato nel più generale dibattito militare, soprattutto quando non li celò più dietro quell'apparente calma che aveva ingannato persino La Marmora tra il1867 ed il1870 e quando - raggiunta la piena maturità - se ne rese continuo ed altiloquente assertore. Cosa che ne fece , proprio a partire dagli anni Ottanta un personaggio 'sco modo ' : un militare, di cui nessuno dubitava la fede nazionale, illealismo monarchico e l 'as pirazione a fare sempre più 'numeroso' e più forte l'esercito (e con esso la 'potenza' italiana), ma di cui si temeva l'autonomia di giudizio e la personale determinazione.
Le idee ed zl programma di Ricotti
Ricotti era entrato nel quinto Ministero Depretis essenzialmente per le sue opinioni politiche in materia di Convenzioni ferroviarie
43 Cfr. Storia del Parlamento italiano, v. VIII, La siniJtra al potere, cit., p. 347. Non e ra comunq ue il solo militare rimasto a credere ed a volere una società ed una politica che stavano tramontando. A proposito di quegli stessi anni, G. Manacorda ha evidenziato quanto le idee e le concezion i di politica interna ed estera di un generale come Luig i Pelloux fossero ormai in cont.rasto ed in ritardo sui tempi . cLo stato che Pelloux vuo le conservare, come l'optimum raggiunto una volta per sempre, è la monarchia costituz ionale prodotta dal Risorgimento ( ). Nella politi ca internaziona le la sua visione non va oltre il quadro classico dell'equilibrio delle potenze io Europa. Il colonialismo era insomma un elemento che esorbitava da una formazione ideologica che risal iva al 1870. Così come ne esorbitava il socialismo•. G. MANACORDA, Introduzione, a PELLOUX, Quelques souvenirs de ma vie, cit., pp. LV-LVI
44 Cfr. tra l'altro AA.PP Camera , Legisl. XI, sess. seconda, DiJcussioni, tornata del 18 maggio 1871. Accenni anche in VENTIJRINl, Militan' e politiet' nell'Italia umbertina, cit., p 210.

UN ESEROTO PER RlCOTn 61
(cioè per il suo riuscire a rappresentare un più vasto gruppo parlamentare) e per la sua disponibilità ad accettare una stabilizzazione dei bilanci militari. Ma quale sarebbe stata la sua politica militare?
D ep retis , come ·era consuetudine sua e dei presidenti del Consiglio dell'Italia liberale, una vo lta fissatone i termini finanziari e generali, ne lasciò al generale novarese la piena autonomia di impostazione 1
Nelle aattative che Ricotti aveva avuto nell'autunno- tramite Perazzi- con Depretis, non si era parlato quasi mai di politica militare e di bisogni dell'esercito. Qualcosa di più, forse, era sta to detto nel luglio, quando Ricotti comun qu e aveva rifiutato la proposta venutagli, questa vo lta tramite Biancheri, sempre da Depretis.
Nell'estate il novarese aveva rigettato l'offerta del presidente del consiglio perché ccolla somma stanziata nel bilancio non crede[va] assolutamente possibtle mantenere l'esercito nell'assetto definito dalle ultime leggi:. 2 • Che cosa significava questo? Era il consueto ' lamento' dei militari che volevano un aumento dei bilanci della Camera? Probabilmente non ci fu allora né la possibilità né l 'interesse ad approfondire la questione dal momento che comun qu e il novarese pareva deciso a non accettare l'offerta di Depretis. Ma riflettere su questa affermazione di Ricotti (con quei bilanci non si può mantenere quelfesercito con 12 corpi d'armata) ci permette di arrivare a considerazioni imp ortanti per l 'analisi del pensiero e dell'azione del novarese.
1 Esemplare come, più tardi, il quotidiano del presidente del Consiglio si disimeressò della querelle sona in Parlamento tra Ricotti e Pelloux su quale tipo di spesa militare (ordinaria o straordinaria) convenisse elevare. La questione, come vedremo, nascondeva un contrasto tra due diverse impostazioni di politica militare e di rappotto tra politici e militari. Dal canto suo , invece, il quotidiano politico di Depretis commentava: cOra che più convenga l'uno o l'altro metodo è una questione tecnica. U paese si accontenta di pagare e non può giudicare della ripartizione•. -cii popolo romano», l giugno 1885, GueTTa e Finanze.
2 A . GUICCIOU, Dian"o de/1884, cit., p. 301, alla data del 3 luglio 1884. Ricotti avrebbe voluto anche effettuare una 'epurazione' del massimo verrice militare, forse (nelle sue intenzioni) analoga ed opposta a quella che nel 1876 era stata condotta dal generale Luigi Mezzacapo, Ministro della Guerra del primo governo della Sinistra storica. Se quella di Mezzacapo si era appuntata contro alti militari piemontesi e 'di Destra', l'epurazione voluta da Ricotti avrebbe dovuto colpire anche generali 'meridionali' e 'di sinistra'. cNegli alti gradi si imporrebbero misure che adottate da lui, Ricorri , potrebbero parere suggerite da rancori personali Crede Ricotti, per esempio, che Ferrero, i due Mezzacapo, lo stesso Cosenz dovrebbero essere allontanati dal servizio attivo». Ibidem. Io realtà, il generale novarese - una volta oominaco Ministro- dovette recedere anche da tali sue intenzioni. Ma queste rimangono ugualmente indicative del carattere, delle idee e del fervore polemico del personaggio.

62 POLITICA E POUTJCA M.IUTARE
Ricotti, poi, come si è visto, fece nel luglio un grande discorso parlamentare di opposizione a Ferrero, discorso che fece notizia nel mondo militare 3. In questi ambienti, però, si notò che il novarese, nel denunciare la politica ministeriale, aveva calcato la mano in quel suo discorso alla Camera più sul tema tecnico dell'avanzamento degli ufficiali che su quello 'politico' dei due Corpi d'Armata in più, che pure tanto efficacemente e veementemente aveva criticato nel 1882 4
Stava questo a signifi care forse che l'implacabile critico dell'ordinamento del 1882 finiva per andare soprassedendo alle sue note obiezioni?
Comunque , e nonostante questi segnali , Ri cotti era rimasto la principale figura dell'opposizione militare , che aveva dimostrato di avere proprie idee e propri programmi. Avrebbe quindi il generale novarese, una volta nominato Ministro, stravolto l'ordinamento militare sancito dalla Sinistra e dalle riforme del 1882 , che egli aveva vivacemente criticato?
Nell'opinione pubblica e negli ambienti militari , simili timori furono presenti e operanti , al momento della nomina di Ricotti a
In realtà , come oggi appare ovvio , simili timori erano infondati . Ricotti in nessun caso avrebbe potuto decidere da solo , dal momento che tra i soggetti deliberanti della politica militare italiana molto prima del Ministro della Guerra c'erano il Sovrano e le più alte gerarchie militari, strette intorno al Re , da un vincolo di comune rispetto dell'istituzione dinastica 6 . E né Umbeno I né i più alti ge nerali avrebbero certo permesso , se pure Ri cotti vi si fosse indirizza to , uno stravolgime nto dell'ordinamento del 1882. Inoltre , in quegli anni , la recente stipulazione del trattato della Triplice Alleanza , con quel suo esplicito richiamo all'importanza ed a lla salvaguardia del prin cipio monarchico e p er quel ruolo decisivo che il 'partito di Corte' aveva giocato per arrivare alla sua firma, ave-
3 Cfr. AA PP. , Cam era, XV , sess. u n ica , Discu ssioni, to rna t a d el l luglio 1884.
4 Lo notava anch e, in m od o inte ressat o, un collabo rato re (mi li ta re) d e cii popolo ro mano•, 4 luglio 1884, A n cora d elle i d ee d el gen e rale Ricolli
5 Cfr. c: II Diritto•. 27 onob re 1884. U o ri t aglio si trova anche in ACS, Carte Pelloux, se. 29. Per g li ambienti mil itari, cfr. cL' esercit o italiano•, 2 1 ottobre 1884. Le dimissio n i d el Min istro d ella Gue" a.
6 Cfr. DEL NEGRO , Esercito, Stato, societ à. S aggi d i st oria militare, cir., p . 28 , pp. e p . 25 3.

UN ESEROTO PER RICOTTI 63
va aumentato di fatto il peso specifico delle decisioni sovrane e l'interesse del Re nel campo della politica militare 7•
La prima partita, quindi , sulla politica militare del secondo Ministero Ricotti, andava giocata tra il Re ed il nuovo ministro.
Così fu, infatti. Inoltre dal tenore degli incontri che, verso la metà d'ottobre, Ricotti ebbe con il Re appare più chiaro che cosa il generale avesse voluto significare nell ' estate 1884 con quel suo accenno all'incompatibilità del bilancio militMe e dell'ordinamento dell' ese rcito.
Il generale, che Perazzi e Depretis andavano convincendo ad accettare la carica di Ministro, parlò a lungo con Umberto I della politica militare che egli avrebbe voluto realizzare 8 .
Il resoconto seppur breve e schematico di questo incontro che si trova nelle pagine del diario di Guiccioli è della massima importanza: «Ricotti - riferisce Guiccioli - sostenne la necessità di rafforzare le compagnie mettendone tre per battaglione• 9 .
Questo avrebbe significato , dal momento che ogni battaglione contava allora quattro compagnie , ridurre di un quarto rutto l'ordinamento militare nazionale. Tutta l'organizzazione dell'esercito avrebbe dovuto essere così rivista: mobilitazione, armamento, dislocazione territoriale avrebbero dovuto essere globalmente ripensati. Il contingente di leva , che non sarebbe stato diminuito, avrebbe rafforzato le compagnie esistenti lO.
Con questo suo proposito, esposto intenzionalmente nel suo co lloquio con Umberto I , capo dello Stato e dell'Esercito, Ricotti confermava di essere rimasto intimamente se m p re convinto delle ragioni della sua opposizione all'ordinamento Ferrero.
In questo suo rivoluzionario progetto , il novarese evidenziava il fondo delle sue convinzioni politiche e militari. Anche se a prima vista poteva sembrare il contrario, il generale che proponeva l'abolì-
7 Cfr. ROCHAT, MASSOBRI O, Breve storia dell 'e.rercito italiano da/1861 a/1943, cit., p. 108 E già SALVATOREW, La Tnplice Alleanza. Storia diplomatica, cit., p. 12.

8 Tracce di questa opera di convinzione sono da una parte (quella pubblica) una serie di articoli elogiativi d elle idee e della persona di Ricorci apparsi nell'estate 1884 sul quotidiano del presidente del Consiglio, e dall'altra {privau) quel fino carteggio che Costantino Perazzi scambiò con Ricotti, e di cui rimane traccia in MCR, Carte Perazzi, se. 904.
9 GUICCIOLI , Diano de/1884, cit., p . 317, alla data del 29 otto bre 1884 (ma l'i nconuo era del 10 ottobre ).
10 Ibidem
POLITICA E POLITICA MIUTARE
zio ne di una compagnia su quattro era il solito Ricotti 'numerista' 11 , che poneva come massimo scopo della politica militare italiana l'aumento di forza reale dell'esercito (specie ora che la riforma dell'ordiname nto Ferrera aveva ridotto il tetto massimo della forza di pace delle compagnie, da 100 a 90 uomini) e che continuava a credere che l'allargamento dei quadri dell'organico- conseguente all'aumento dei due Corpi d'Armata- non aveva rappresentato (nonostante l'apparenza di un aumento di potenza strategica) che un indebo lim ento sostanziale dell'esercito 12 , adesso costretto a curare la sua allargata intelaiatura di quadri piuttosto che la forza numerica delle sue compagnie.
Il progetto di Ricotti se realizzato, avrebbe mutato dalle fondamenta la struttura dell'esercito italiano.
In generale non è un punto di poco conto , questo del Ricotti che anche nel 1884 come nel 1877 13, nel 1882 14 e poi nel 1889 15, nel 1892-93 I6 e poi ancora nel 1896 17, credeva nella necessità di dover ridurre l'ordinamento dell'esercito. Un punto che, se in altre trattazioni è stato messo un po' in ombra 18, conviene a noi - nell' ottica di u n più attento studio della personalità del novarese e della politica militare del suo secondo Ministero della Guerra - assolutamente sottolineare.
Ricotti , in questo senso, in quanto militare, rimase sempre l'uomo della riduzione d eli' intelaiatura dei quadri e dell'aumento degli organici. Era un convinto ' numerista ', colla sua fede nei grossi bat-
11 Per il significato originario del termine cfr. C. CORSI, 1848-1869. Venticinque anni in Italia, Firenze, Favero, 1870, p. 16.
12 Di parere sembrava fossero anche gli ambienti di Corte, che pure avevano salutato con soddisfazione il nuovo e più largo ordinamento Ferrero. Cfr. Il generale Osio, Milano, Hoepli, 1911, p. 334, alla data del 27 marzo 1882.
13 Segnaliamo queste date perché significative e ne indichiamo alcune tracce documentarie solo nelle affermazioni pubbliche fatte dal generale. Ricerche più specifiche porrebbero meglio sottolineare questo dato di continuità. Cfr. AA.PP., Camera, Legisl . XIII, sess . seconda, Discussioni, tornata del 2 febbraio 1877.
14 Cfr. ivi, Legisl. XIV, sess. prima, Discussioni, tornata del IO maggio 1882.
15 Cfr. ivi, Legisl. XVI, sess. terza, Discussioni, tornata del 23 febbraio 1889.
16 Cfr. AA.PP., Camera, Legis l. XVIll, sess. prima, Discussioni, tornara del 29 giugno 1893.
17 Cfr., tra l'altro, AA.PP., Camera, Legisl. XIX, sess. prima, Discussioni, tornata del 22 maggio 1896. Sulle vicende del 1896 cfr. PELLOUX, Quelques souvenirs de ma vie, eit., p. 168.
!8 Cfr. ivi, ed anche VEN11JRINI, Mtlitan· e politici nell'Italia umbertina, ci t., pp. 229-230 .

UN ESERCITO PER RJCOTTI 65
taglioni , appena scalfita dal riconoscimento dell ' utilità (ma non certo della necessità) dell'ordine sparso. Eppure c'era qualcosa che lo differenziava dagli alui numeristi come Pelloux. Questi ultimi credevano che l'aumento numerico delle maggiori unità avrebbe prima o poi ponato all' irrobustimento delle compagnie e del ' numero' dell' esercito: ed in questo senso salutavano con soddisfazione la riforma Ferrero. Per Ricotti invece, scettico sulla forza finanziaria dello stato unitario e dubbioso della possibilità di ' riempire' davvero quei più larghi quadri , la riforma militare che contava, nel suo pensiero , era solo quella che lui stesso aveva realizzato negli anni Settanta mutando il rapporto ua esercito e società, con la nuova legge di leva, con l ' inuoduzione dell ' istituzione della Milizia di seconda e di terza linea, con l'aumento della forza di guerra delle compagnie di Fanteria da 150 a 200 uomini (e con quel complesso di misure che poi avrebbe portato inevitabilmente Mezzacapo a far passare da sette a dieci i Corpi d'Armata dell ' esercito ) .
L'ordinamento di Ferrero, con quei suoi due Corpi d'Armata in più gli appariva davvero come qualcosa di estrinseco, che aumentava il carico finanziario per il Paese, riduceva l ' efficienza dell' esercito permanente in tempo di pace come in tempo di guerra , creava ingiustificate ed a suo dire inopponune fantasie di ' politica di potenza' italiana.
A questa sua opinione dissenziente egli rimase quindi sempre intimamente convinto e la professò spesso pubblicamente. Nel1884 , come abbiamo visto. Nel 1889, contro le ' megalomanie' crispine. Nel 1892-93, quando - al Senato e nelle commissioni militariin forma più chiara ed estesa , ripropose il suo progetto, volto non a diminuire il numero delle grandi unità ma quello delle piccole: ancora una volta con la soppressione di una compagnia per battaglione. Nel1896 infine quando, per una serie di combinazioni politiche in cui forse egli non sperava più , tornò alla massima ribalta della politica del paese, con l'incarico di formare il governo. In carico che decise di passare a Di Rudinì ma grazie al quale tenne per sé il Ministero della Guerra, per poter realizzare il suo vecchio programma. E proprio nel 1896 il novarese provò concretamente ad attuarlo proponendolo alle Camere in forma di disegno di legge: ma, come si sa , le condizioni non c'erano allora , come forse non ci dovevano mai essere state. E da allora, Ricotti cadde nell ' oblio, politico e militare. Comunque nel1884 il generale tutte queste cose non le immaginava nemmeno. Pensava solo a cercare, una volta chiamato al Ministero, di praticare quello che era il suo programma e di affermare

66 POUTICA E POUTICA
MDlTARE
quello che doveva sempre rimanere il suo punto di vista. E le affermazioni fatte a Biancheri e a Depretis nel luglio si spiegavano con quelle fatte a Umberto I nell'ottobre.
Rimaneva comunque il fatto che, quello di ridurre di un quarto la consistenza dell'esercito era davvero un progetto rivoluzionario. Dal punto di vista militare, ovviamente; ma anche da quello politico o diplomatico. Un qualcosa che mal si conciliava con le volontà diffuse e generalizzate negli anni Ottanta (tra politici come tra militari) di condurre una 'po litica di grande potenza'.
Fu per questo insieme di motivi che, tornando alla nostra narrazione delle vicende dell'autunno 1884, di fronte alla chiara enunciazione fattagli dal generale novarese, Umberto I disse no.
Continua infatti ad annotare Guiccioli nel suo diario: seccamente, «il Re non approvò questo disegno soste nendo che non conveniva portare cambiamenti importanti all'organizzazione dell'Esercito» 19.
Ricotti certo avrebbe potuto aspettarsi una simile risposta, ma forse non credeva che sarebbe stata così secca e recisa. Egli pensava di poter pesare maggiormente suJ corso della politica militare italiana.
In fondo, pare egli abbia pensato, non era stato lui a voler fare il Ministro della Guerra: egli era stato interpellato e chiamato da Depretis per ben due volte (prima nell'estate e poi nell'autunno); e quindi non poteva escludere che il suo programma fosse apprezzato o che comunque ci fossero spazi politici per una sua attUazione. Inoltre non temeva uno scontro con il Re, con Umberto I. In anni passati, nel suo lungo Ministero del '70-'76, si era trovato più di una volta a sostener opinioni eterodosse o comunque malviste da Vittorio Emanuele II e da una buona pane dei circoli monarchici e militari. Eppure era poi riuscito, sia pur con gradualità e con qualche limitazione, ad attuare il suo programma 20.
Fu così che, deluso e scoraggiato dopo la discussione con il Re, «Ricotti tornò quindi a Milano dal Perazzi, deciso a rifiutare l' incarico:» 21.
t9 GUICCIOU , Diano del 1884, cit. , p. 317, alla data del 29 ottobre.
20 Già al momemo della sua nomina nel 1870, c'erano state resistenze da parte della Corona: ma in quella occasione il generale novarese aveva dalla sua tutto il governo della Destra. «Spiacque a Vittorio Emanuele la scelta [di Ricotti al Ministero della Guerra] e con tanta vivacità se ne dolse con Lanza; ma il re, secondo l'usato suo, finì col rabbonirsi•. E. ARBIB, Cinquant 'anni di storia parlam entare del Regno d'Italia, vol. IV , Undicesima, dodicesima e tredicesima legislatura dal 5 dicembre 1870 al 29 aprile 1880, cir., p. 23
21 Ancora GUICCIOLI, Dian'o del1884, cit., p. 318, alla data del 29 ottobre.

UN ESERCITO PER RICOTTI 67
Come doveva succedere più tardi in tema di convenzioni ferroviarie, già sul terreno delle linee di politica militare il generale novarese iniziava ad accorgersi che difficilmente avrebbe potuto incidere e pesare sull 'atteggiamento del governo, nella misura in cui aveva credut o o sperato di potere.
Mancano purtroppo i documenti necessari per seguire ulteriormente nei dettagli la vicenda: mancano soprattutto le cane del generale Ricotti 22.
Perché , alla fine, Ricotti abbia accettato l'incarico ministeriale nonostante che il Re in persona gli avesse impedito di attuare quel suo programma militare (cui forse teneva più di tutto) lo abbiamo già visto. Sentiva pesare su di lui la responsabilità di un accordo politico tra Sinistra e Destra su uno dei punti più caldi della politica (e degli affari) del suo tempo.
Contò poi anche sull'animo di Ricotti, probabilmente, quella ambizione personale che altri ha già rilevato , quel ceno sentimento di fiducia in sé e quel sentirsi importante (come nel caso della clauso la per le convenzioni ferroviarie) anche quando in realtà non lo era. Contò forse anche quella chiara soddisfazione che gli ambienti della Destra mostravano per la figura di Ricotti e per un suo ingresso nel Ministero Depretis. E in questo senso vi era più d'un po litico che, al momento della nomina del Generale a Ministro , vide in lui l ' unica grande figura della D estra che potesse prima o poi sostituire lo stesso Depretis. «Il Ricotti non entra nel Ministero semp licem ente come 'tecnico', ma soprattutto come uomo politico( .. ) Tutti hanno la certezza che con la scelta di Ricotti si è designato il nuovo Presidente del Consiglio dopo 23. E questo doveva certo piacere al novarese.
Fu in questo scenario che Ricotti , designato politicamente a Ministro (nonostante che l 'opposizione del Re gli avesse già bloccato qualsiasi progetto di riordinamento dell'esercito), accettò l'incarico. Era in sé, già, un segno della potenza del trasformi smo.
Il novarese diveniva Mini stro della Guerra , però , senza aver la possibilità di svolgere la 'sua' politica militare.
E quindi , quale politica militare avrebbe seguito?
Per dare una risposta a questo interrogativo, ci soccorre un documento eccezionalmente chiaro.

22 Infruttuosi i nostri tentativi, a Roma, come a Novara, come nei luoghi dj resi · denza di alcuni dei discendenti in linea dire tta di C. Ricotti.
2 3 GUICCIOU , Diario dei 1884, cit., p 316, alla data del 26 otto bre
68 POUTICA E POUTICA MIUTARE
In una lettera (di appena una settimana successiva al contrastato incontro tra il Generale ed il Re) di Ricotti al futuro suo Segretario Generale, il novarese chiarificava perfettamente l'indirizzo da seguue.
Quanro alle questioni militari, vorrei che la nostra amministrazione breve o lunga che possa risultare assuma un carattere spiccato di quiete legislativa ( ... ) limiteremo la nostra attività ad alluare il meno possibile quanto fu stabilito con le nuo11e leggi militari 1101a1e in ultimi anni, al ritocco di molte disposizioni regolamentari, al riordinamento degli lsciruri e scuole militari ed al miglior funzionamento delle due Milizie (Milizia mobile e territoriale) 24
Davvero programma più chiaro di questo non ci si sarebbe potuto aspettare. Chi scriveva a Marselli, in questa lettera , era il parlamentare della Destra che si era opposto ai governi della Sinistra ed alla ' loro' politica militare, a Perrero ed al suo ordinamento del1882, era il militare dissenziente di fronte all'orientamento prevalente, era il generale che in tutte le occasioni aveva tentato di ostacolare il prog ramma di militari come Luigi Mezzacapo e che adesso - seb bene non com piutamente - aveva la possibilità di bloccarlo per qualche tempo
Egli si rendeva conto dell' callarme generale che io entri nel Ministero per sconvolgere tutto quanto fu fatto di nuovo nell'esercito in questi ultimi anni» 26 e ordinava a Marselli che cnon sarebbe male che l'opinione pubblica, panicolarmente quella militare, fosse subito tranquillizzata mediante un articoletto spiegativo» 27
Il novarese non avrebbe quindi 'sconvolto' l'esercito (come pure aveva chiesto al Re di poter fare): ma certO non avrebbe rinunciato a modificarlo nei punti in cui gli pareva necessario. Il principale di questi punti era- cont inuava ad essere -la forza delle compagnie di Fanteria, il 'numero' dell'esercito.
Oltre e prima che ad altri aspetti secondari di politica militare, che pure il generale aveva richiamato nella sua lettera a Marselli, la massima preoccupazione di Ricotti andò negli anni del suo secondo Ministero proprio al numero, alla quantità.
A chi lo rimproverava che quello era un tema da poco (quando
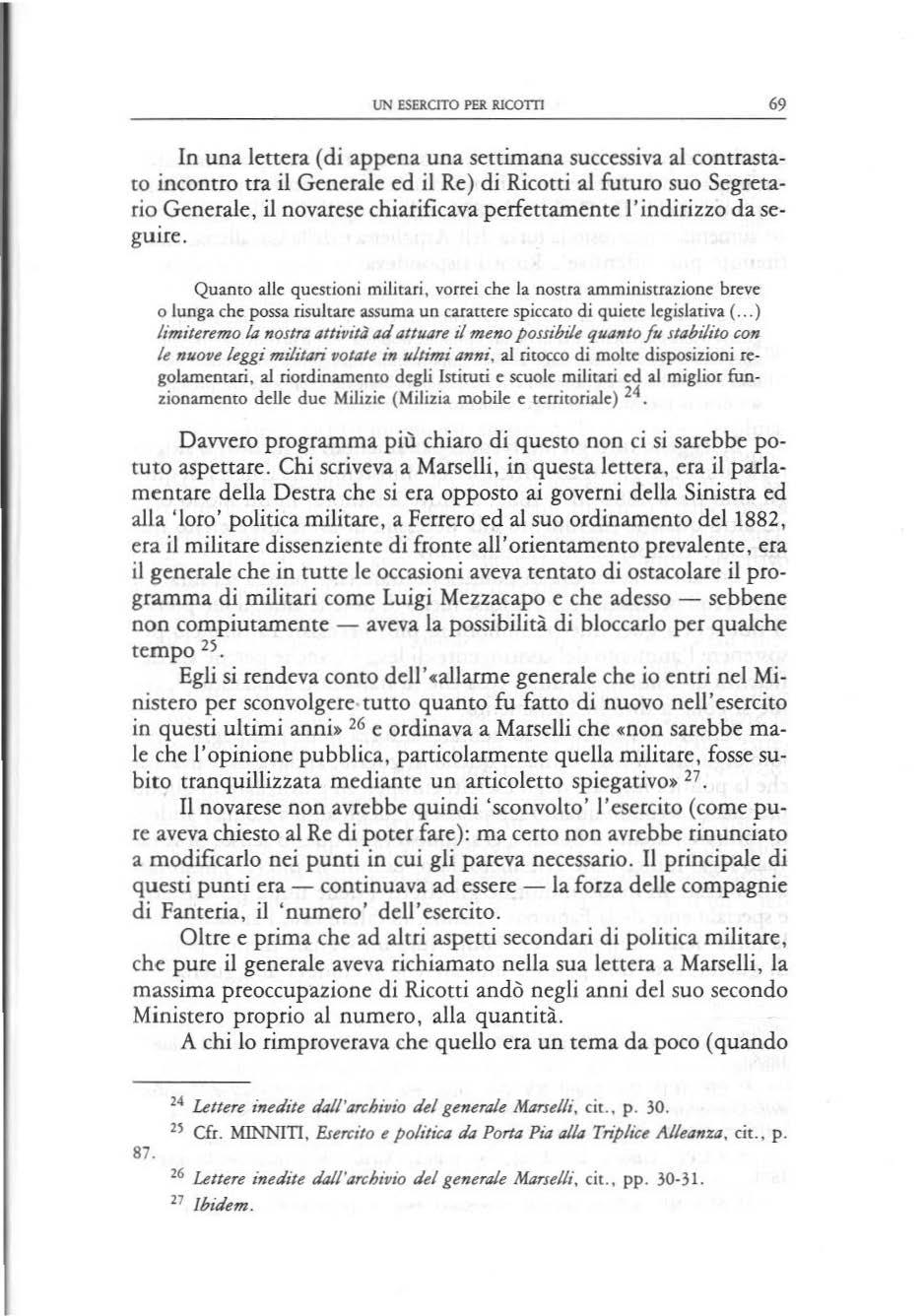
UN ESERcrTO PER RICOlTI 69
87.
24 Lettere inedite dall'arçhivio del generale Marselli, cit., p. 30. 25 Cfr. MINNITI , Eserçito e politica da Porta Pia alla Triplice Alleanza, cit., p. 26 Lettere inedite dall'archivio del generale Marselli, cit., pp. 30-31. 27 Ibidem.
gli alleati diplomatici stranieri e l'opinione pubblica e politica italiana, impazienti, chiedevano piuttosto un esercito sempre più offensivo) come a chi (De Zerbi nel 1886, ad esempio) lo voleva spingere ad aumentare piuttosto la forza dell'Artiglieria e della Cavalleria, Armi ritenute più 'offensive', Ricotti rispondeva:
Se fosse esano il di lei apprezzamento, darei subito la preferenza all'Artiglieria o alla Cavalleria; ma io ho un'opinione opposta. Io ho la convinzione che saremmo meglio ricercati dagli amici o imporremmo maggiormente ai nosui nemici avendo buone e grosse fanterie ( ) e sono obbligato a replicare che preferisco dare la precedenza al miglioramento della Fanteria( ... ) 28.
Si leggano tutti gli intervenuti parlamentari di Ricotti, si sfoglino le annate degli organi ufficiosi del Ministero della Guerra di quegli anni ua il 1884 ed il 1887: si troverà sempre, in un modo o in un altro qualche riferimento alla necessità di avere un esercito numeroso e compagnie di Fanteria fotti.
Era anche la misura di politica militare che, olue a sembrare a Ricotti così necessaria, costava forse meno di tutte le altre: il suo prezzo si riduceva a quei due-tre milioni in più, necessari in bilancio per sostenere l'aumento del contingente di leva 29, anche perché «la deficienza di uomini, è l'unica cosa che in Italia non abbiamo• 30, come si ebbe a dire in Parlamento.
Sempre nel senso di aumentare la foria delle compagnie, nel loro organico di pace come in quello di guerra, andava in realtà anche la politica militare degli eserciti europei. In panicolare in quello prussiano, secondo quanto segnalava in quegli anni a Roma l'addetto militare italiano a Berlino, ci si muoveva in questo senso. Si votavano leggi militari che avrebbero dato «uomini in più ( ... ) destinati a rinforzare in modo uniforme gli effettivi delle unità già esistenti e specialmente della Fanteria. 31 Anzi, in taluni casi, l'aumento della forza delle compagnie era addirittura un segnale di una politica di guerra, o di una politica militare che preludeva alla guerra.
28 AA.PP., Camera, Legisl. XVI, sess. prima, Discussioni, tornata del 2 luglio 1886.
29 Cfr. ACD, Dd/, Legisl. XV , sess. unica , reg. 388, n. 182, Verbale della seduta della Commissione, 12 dicembre 1884; e AA.PP., Camera, Legisl. XV, sess. unica, Discussio ni, tornau del 9 giugno 1885.

30 AA.PP., Camera, Legisl. Xl, sess. prima, Discussioni, tornata del 18 maggio 1871.
31 AUSSME, Addetti rmlitan·. Germania, racc. 3, 14 dicembre 1886, Ris.
70 POUTICA E POUTICA
MIUTAR.E
Da alcune parole invece del discorso del Maresciallo Moltke, sembra si debba ritenere probabile un'altra soluzione, cioè che gli aumenti degli effettivi di pace sia limitato alle unità di truppa, specialmente di Fanteria, dei corpi d' Armata di frontiera, le quali assumerebbero in tal caso sin dal tempo di pace una forza che poco si discosterebbe da quella di guerra. E se così fosse la cosa prenderebbe un altro aspetto, non sarebbe più una disposizione semplicemente organica ma eserciterebbe la sua influenza nell'inizio delle operazioni militari, siano queste offensive o difensive 32 .
Ricotti, ovviamente, era a conoscenza di queste decisioni straniere, e se ne fece scudo più volte contro le opposizioni degli 'offensivisti' italiani.
Che quindi Ricotti intendesse andare nella direzione di colmare una tale grave lacuna non poteva, di per sé, scontentare nessuno.
Ciò che infastidiva, negli ambienti militari, era il fatto che Ricotti (nonostante disponesse oggettivamente di larghi bilanci per la Guerra) 33 affermava che tutto - nella politica e nell'amministrazione militari di quegli anni - andasse posposto a quest'obiettivo del rafforzamento delle compagnie di Fanteria.
A chi chiedeva di aumentare Artiglieria e Cavalleria, a chi proponeva di riformare l'Amministrazione militare centrale, a chi chiedeva di dirottare fondi verso la Marina Militare, a chi esigeva un maggior 'offensivismo', a chi voleva un armamento più efficiente e moderno: a tutti Ricotti rispondeva che si doveva invece aumentare la forza della Fanteria. Il suo 'numerismo', verbalmente, diveniva estremo. Di fronte al problema delle compagnie, diceva Ricotti, tutto doveva conoscere una 'sosta'.
A leggere i suoi interventi, alla Camera come nelle interviste rilasciate ad autorevoli giornali conservatori, dava l'idea di un Ministro militare tutto dedito al rafforzamento reale, numerico, dell'esercito. Questo, in ambienti politici sempre più sensibili ai miti del-
32 Ibidem.
33 Statisticamente, il peso relativo del bilancio della Guerra sul totale del bilancio dello Stato fu negli anni del secondo Ministero Ricotti tra i più alti dell'intero cinquantennio dell'Italia liberale. Esclusi ovviamente gli anni di guerra (1861 -1866, ed anche il1896) il rapporto spese Guerra/ spese Stato fu più alto che sotto Ricotti solo negli anni 1882-1883 - per gli effetti della costituzione dei due nuovi Corpi d'Armata-, nel 1889-1890- per via delle eccezionali spese militari crispine -, nell898 e negli ultimi anni del decennio giolittiano, per il riarmo pre-bellico. In termini assoluti, invece, il bilancio della Guerra degli anni 1884-1887 passò da 253 a 269 milioni, superando e di parecchio la quota di 256 milioni dell883 (che pure, come si è visto, aveva costituito uno sforzo non indifferente per le Casse dello Stato). Per i dati, cfr. BAVA BECCARIS, Esercito italiano. Sue origini, suo successivo ampliamento, stato attuale, cit., p. 95.

UN ESERCITO PER
RlCOTIJ
71
la 'potenza' italiana, non doveva dispiacere. Come non dovevano dispiacere i costanti appelli di Ricotti per concentrare le forze frnanziarie della Nazione e dell'Esercito per l'essenziale dei bisogni militari (secondo il suo punto di vista, la forza ed il numero della Fanteria) piuttosto che per l'utile ma in fondo superfluo (tutto il resto).
Una volta stabilito il livello dei bilanci militari , ad una larga fascia della classe politica non doveva risultare sgradevole quel programma di forza e di 'potenza' tutto sommato a buon mercato (tutto fatto, cioè, di numero di soldati). Soprattutto se messo a confronto col programma di quei militari che ancora, invece, continuavano a chiedere quel miliardo di spese straordinarie cui aveva più volte fatto cenno Luigi Mezzacapo 34.
In fondo, l'opinione diffusa non era quella (anche se sempre meno condivisa da taluni avveniti settori militari) secondo cui le guerre si vincevano con l'uno di grandi masse La stessa lezione del 1870 era stata per lo più così interpretata, tra civili e politiCl.

Così, ua i politici, Ricotti con quel suo insistere sull'aumento della Fanteria doveva apparire ceno un mili tare ' integrale ' e moderno.
Ma di quale entità era l'aumento delle forze che Ricotti si proponeva? era questo il metro con cui si poteva giudicare la sua iniziativa (e con cui infatti la giudicavano i militari).
In Germania, come vedremo, la politica di aumentare la forza delle compagnie di Fanteria era una delle tante misure adottate per rendere sempre più pronto ad un immediato uso bellico lo strumento militare: a Berlino, mentre le compagnie passavano da 200 a 225 uomini anche in tempo di pace, si aumentava l'Artiglieria da campagna, si sveltiva la mobilitazione, si decentravano responsabilità ed incarichi dal Ministero della Guerra ai Comandanti di Corpo d'Armata , si aumentavano le spese militari ricorrendo ai bilanci cçmsolidati, e così via 36
L'Italia , invece, era ben l ungi dallo standard prussiano. Le compagnie di Fanteria italiane dovevano avere in tempo di pace, dopo
72 POUTICA E POUTICA
MILITARE
34 Cfr. L MEZZACAPO, Armi e politica, cit.
3) Cfr. CHABOD, Stona della politica estera italtana dal 1870 a/1896, cìt., p. 149.
36 Cfr. AUSSME, Addetti militari. Germania, racc. 3, 26 settembre 1886. Ris.
il 1882, hl consistenza di 90 uomini: ma questo formalmente 37. Sia pur non considerando la normale quota di ammalaci, dispensati, etc., una parte considerevole di quel già magro organico era quotidianamente distratta per i tradizionali compiti di ordine pubblico, sorveglianza, guardie e altro. In un intervento parlamentare, si fece notare che la compagnia di Fanteria si trovava, nel periodo di sua forza massima, ad avere presenti alle istruzioni non più di 45-50 uomini 38. E nessuno poté smentire quella cifra, segno questo che non doveva essere molto lontana dal vero. Tenuto presente questo grave dato, se si calcola che sul piede di guerra la compagnia avrebbe dovuto raggiungere l'effettivo di 225 uomini, si capisce bene come questa politica di bassi effettivi intaccasse fortemente e alla radice la qualità dell'esercito italiano, io pace come in guerra.

Ecco che allora, se si fosse voluto davvero 'sanare' una volta per tutte la questione della Fanteria, si sarebbe dovuto compiere nell'Italia di quegli anni un gigantesco sforzo di militarizzazione della società e imprimere alla politica militare una radicale correzione di rotta. Forza del contingente, tasso di militarizzazione, rapporto tra il gettito della leva e quello dell'ordinanza, entità delle spese militari: tutto avrebbe dovuto fare un eccezionale passo io avanti.
Si pensi a quelle compagnie (reali) di 50 uomini, a quelle (previste nell882) di 90, per non parlare poi a quelle richieste dai Regolamenti per il tempo di guerra: e ci si renderà facilmente conto dello sforzo che avrebbe necessitato passare dalle prime alle seconde (e alle terze) .
Era l'Italia del trasformismo pronta a tutto questo?
Ma era poi davvero questo l'obiettivo di Ricotti?
In realtà lo stesso Ministro della Guerra non pretendeva assolutamente di arrivare a tanto. Per la sua dichiarata volontà di non im-
37 In quegli anni (ma anche più tardi) la Pilotta non riusciva a mettere insieme nemmeno in occasione delle Grandi Manovre - e cioè in uno dei momenti di massima os t entazione della potenza militare nazionale (verso l'opinione pubblica come verso gli Stati esteri)- che deboli compagnie che non superavano le 70-72 unità. Cfr. MINNI· TI, Esercito e politica da Porta Pia alla Tnplice Alleanza, ci t .• p. 148. Ma il numero poteva forse anche essere più basso, se si pensa che dieci anni più tardi ancora si faceva conto in Parlamento su compagnie di Fanteria di non più di 73 unità. Cfr. AA.PP. Senato, Legisl. XIX, sess. prima, Discussioni , tornata dellO giugno 1896, intervento di D Primerano. Eugenio De Rossi, infine, annotava che negli anni Ottanta, in media, su 256 unità a ruolo non più di 67 soldati si presentavano al rancio. Cfr. E. DE ROSSI, La vita di un ufficiale italiano sino alla gue"a , Milano, Mondadori, 19 28 (2), p . 41.
38 Cfr. l'intervento del deputato Borrelli in AA.PP., Camera, Legisl. XV, sess. unica, Discussiom·, tornata del 9 giugno 1885.
UN ESERCITO PER RICOlTI 73
pegnare il governo in altre spese militari, Ricotti aveva calco lato e deciso che l'aumento della forza delle compagnie si sarebbe dovuto effettuare assai gradatamente, anno per anno, poco per volta. Di fronte all'enfasi verbale dei suoi discorsi (in cui denunciava il peri co lo delle esili compagnie) stava il ben più misero obiettivo di aumentarle di circa 10-12 unità 39.
Ma che cosa rappresentavano dieci uomini in più quando le compagnie dell'esercito italiano, si trovavano in tempo di pace a circa solo un quarto del loro organico di guerra?
Al massimo si potevano annullare gli effetti delle disposizioni emanate da Ferrero nel 1882 (e che appunto, per permettere finanziariamente la formazione dei quadri per due nuovi corpi d'armata, avevan o previsto la diminuzione della forza delle compagnie di pace da 100 a 90 u omi ni) . Ma certo non erano state quelle disposizioni da sole, come pure invece Ricotti talvolta sosteneva, a fare dell'esercito italiano uno strumento militare dall'imponente facciata ma dalle deboli fondamenta organiche. Tutta l'operazione sulle compagnie di Fan te ria - su cui , si badi bene, si affermava che faceva fulcro l'indirizzo ministeriale di Ricotti - rivelava così una chiara manovra trasformistica. Per l'ennes ima volta, 'con poco sforzo e poca spesa', l'Italia voleva fare la grande potenza
Una tale operazione, a ben vedere, ebbe un notevole successo tra i politici e nell'opinione pubblica, che per qualche tempo si poterono lagnare della riluttanza di Ricotti a promuovere nuove spese militari ma che quasi mai (tranne forse i seguaci di Crispi) arrivarono a m ettere in d iscussione il programma militare circa le compagnie di Fanteria. Caso mai, tra i politici, maggior fortuna ebbero- come vedremo - i temi dell'ammodernamento e del rafforzamento delle Armi speciali .

Tra i militari , invece, il successo fu presto assai minore. Non si tratta qui di anticipare quello che è poi l'oggetto di tutte le pagine che seguono: ma almeno due elementi vanno sottolineati.
Primo: taluni ambienti militari erano irri tati dall'insistenza co n cui Ricotti affermava che il suo indirizzo circa la Fanteria risultava riparatorio verso i 'guasti' provocati dalle amministrazioni militari succ edutesi dopo il 1876 e particolarmente da quella di Emilio Ferrero (e di Luigi Pelloux). In sis tenza spiega bile inv ero secondo una logica politica e parlamentare (Ricotti parlamentare, e poi Ministro ,
39 Cfr. già cL ' esercito italiano•, 27 ottobre 1884 , Il programma del nuovo Mini· stro, e cL'Italia 20 ottobre 1884, La situazione militare.
74 POUTICA E POLI11CA
MILITJ\llE
'de ll a Destra' che si oppone a Ferrero Ministro della Guerra in goverru io cui la forza 'de lla Sinistra' era ancora notevole: ma con classificazioni, queste, schematiche e tutte unilaterali), logica però che poco poteva interessare o risultare gradita ai militari (non pochi dei quali, inoltre, continuavano a nutrire fiducia e rispetto nelle idee di Luigi Mezzacapo, in buona parte riprese dall'amministraz ione Ferrero).

Secondo: io generale l'opinione pubblica militare, ed io specie gli ambienti più vicini allo Stato Maggiore, erano coscienti dei reali progressi organici, ordinativi e tecnici che gli altri eserciti europei andavano realizzando in quegli anni 40: e poco doveva soddisfarli quello scarso interesse (o quella scarsa determinazione) al riguardo che le idee di Ricotti sulla Fanteria parevano loro rivelare.
È vero che Ricotti, con quel suo programma militare (che presupponeva il mantenimento di quel livello di spese militari), metteva di fatto l 'esercito al riparo dalle critiche politiche inevitabili in caso di nuove richieste di bilanci. E questo, io un momento in cui il deficit statale avanzava, non era cosa da poco. Ma era ceno un qualcosa che non poteva soddisfare le varie richieste del mondo militare negli anni della sua 'espans ione' .
ll motivo , quasi un refrain, della 'sosta' 41 ricottiana nasceva rutto da qui. Il ritornello sulla 'tirc hiooeria' 4 2 del Ministro vi si accom-
40 Già cfr. ACD, Dd/, Legisl. X:V, sess. unica, reg. 388, n. 182, Verbale di seduta della Commissione, 12 dicembre 1884.
41 Il concetto di 'sosta' implicava che Ricotti e il suo Min istero avrebbero rappresentato una soluzione di continuità nella via dello sviluppo e dell'allargamento degli organici dell'esercito L'uso di questo concetto divenne generale a partire dalla campagna politica che l'opposizione parlamentare e la dissidenza militare lanciarono per l'aumento delle Armi di Artiglieria e Cavalleria. Con un giro di parole, L. G. Pdloux definì il secondo Ministero Ricotti come cun primo passo di fermata dal 18 76•. AA.PP., Camera, Legisl. X:V, sess. unica, DiscUJsioni, tornata del3l maggio 1885. Ma l'uso di questa definizione dell'intera politica di Ricotti passò molto presto dal campo della politica militare anche a quello della politica coloniale. Velocemente, negli ambienti militari , si diffuse la convinzione che il Ministro della Guerra, prima ancora degli altri Ministri, intendesse imporre da subito un «periodo di sosta. alla appena avviata espans ione coloniale italiana. Cfr. «L'esercito italiano•, 29 marzo 1885, Oggi e domani.
42 Questo concetto , a differenza di quello della 'sosta', aveva una sua vita già più lunga. Si riallacciava alle contestazioni che da Sinisua erano state mosse tra il 1870 ed il 1876 al generale novarese, quando egli fu accusato di aver allargato i quadri dell'esercito con le leggi 1873 e 1875, pur non disponendo del necessario sostegno finanziario. Questa definizione era ampiamente diffusa anche tra i politici ed in genere i non -militari (cfr. ad esempio G. CHIESI, G. NORSA, Otto mesi d'Africa, Milano , Aliprandi, 1888, p. 26) e memorabile per lungo tempo (anche dopo quarant'anni lo ricordava G. ANGHERA, L 'azion e militare nella nostra politica coloniale, io cRi vista militare•, a. un (1908), o. 6).
UN ESEROTO PER RICOrri 75
pagnava. Non era solo una scelta di politica finanziaria che vi stava alla base, bensì anche - come si è visto- una opzione di politica parlamentare e di politica militare: Ricotti (se pure non gradiva che lo si dicesse esplicitamente) concepiva molto della sua linea di politica militare come antitesi di quella di Perrero e di Mezza capo . Come aveva detto il novarese nella sua lettera a Marselli , si trattava i nfatti di 'a ttuare il meno possibile quanto fu stabilito con le nuove leggi militari votate in questi ultimi anni'.
Quanto questo fosse adeguato ai 'bisogni dell'esercito ' era iovece un ' altra cosa e oggi lo si potrebbe dedurre facendo un confronto tra le condizioni concrete dell'esercito nel 1884 con quelle dell887 Si noterebbe così che molte delle più criticate lacune della sua composizione organica persistevano sostanzialmente immutate anche dopo la gestione Ricotti.
La stessa forza delle compagnie, la situazione delle fonificazioni , lo stato della difesa costiera, la percentuale di Cavalleria e di Artiglieria nei vari corpi d'armata, la questione delle carriere degli ufficiali, l'ordine assai accentrato dell'amministrazione militare: tutte le carenze che si sarepbero potute notare nell'esercito che usciva dall'amministrazione Perrero , si sarebbero ritrovat e pressoché immutate in quello che accoglieva nell ' aprile del1887 il nuovo Ministro della Guerra Benolè Viale.

Rispetto alle questioni centrali dello sviluppo di una forza armata, il periodo in cui il dicastero della Guerra fu retto dal novarese avrebbe com e congelato la situazione italiana rispett o a quelle- negli stessi anni ben più dinamiche, aggressive ed offensive - degli altri eserciti europei.
La pane centrale degli anni Ottanta, gli ' anni felici ' dell ' esercito italiano, trascorrevano quindi, nonostante quell'insistere di Ricotti su lla questione delle compagnie di Fanteria , senza alcuna miglioria sostanziale nell ' organico militare . I bilanci m ilitari rimanevano intoccati, certo, e quindi assai alti: ma il loro uso rimaneva quello dell' ordinaria amministrazione. Ciò pote va forse dare alle strutture territoriali e locali dell'esercito la sensazione dell'abbondanza e della potenza , ma erano sensazioni che sem pre più avrebbero contrastato con la situazione reale delle finanze dello Stato, quale essa si andava presentando ai responsabili dell'azi one governativa. Lo spettro della crisi e della restrizion e dei bilanci del dopo-Custoza era ormai lontano nel tempo: ma ciò avrebbe impedito che si foss e potuto ripresentare?
Al bivio tra protagonismo e subordinazione, tra coscienza della
76 POUTICA E POUTICA MlllTAll
necessi tà di profonde riforme e ristrettezza dei margini politici, istituzionali e finanziari per affrontarle, tra affermazione di una propria linea di politica militare (spesso anche contrastante con quella prevalente, da Mezzacapo a Perrero a Pelloux) e accettazione di un insieme di misure intimamente però disapprovate , Ricotti finiva poi per cedere. Come se dovesse essere il motto del rrasformismo, quello che è stato detto per Agostino Depretis -e cioè che politicamente ccedette sempre per metà, ma cedette sempre• 43- potrebbe militarmente adattarsi anche per Cesare Ricotti. Di fronte alla sensazione di dover imprimere una svolta decisa, anche se brusca, al corso della politica militare nazionale (e già nei primi colloqui con il Re , dell'ottobre 1884, esemplare era stato il tema della riduzione dell' intelaiatura dei quadri), il generale novarese finiva per non dare battaglia e per ripiegare su una sona di mistura trasformistica di mezze mtsure.
Ricotti stesso, che forse aveva pensato di poter pesare sull'indirizzo del governo, finiva per subire il peso vischioso del trasformismo.
In questo senso, tra ide e di Ricotti e programma del Ministro e problemi militari d eli' esercito italiano degli anni Ottanta, si instaurava così un rappono non chiaro e diretto: un rappono che impone di tener sempre discinti i vari livelli.

Anche se, col passare dei mesi, i problemi avrebbero avuto maggior peso specifico delle idee e dei programmi .
Solo in questo senso è vero quanto è stato ripetuto, e cioè che il secondo Ministe ro Ricotti fu fatto di ritocchi e di piccole correzioni.
Era infatti pensabile per i militari che, con uno dei bilanci della Guerra in assoluto tra i più alti della storia d eli 'I talia liberale, fosse possibile fare solo 'r it occhi'? In quegli anni l 'opposizione politica , e la dissidenza militare, non avrebbero tardato a ritenere di no.
Polz#ci oppost"ton· e milt"tari dissidenti
La manovra parlamentare di Depretis che aveva portato Ricotti al Ministero della Guerra poteva però dirsi, sul momento, riuscita a tutto favore del presidente del Consiglio.
43 CAROCCI, Agostino Depretis e la polihca inJema dal 1876 al 1887, àt., p. 309.
UN ESERCITO PER RICOTn 77
Come si è visto, sul terreno della politica generale e nel breve periodo, l'ingresso del novarese nel ministero aveva significato un rafforzamento della maggioranza trasformista ed aveva permesso che il dibattito sulle convenzioni ferroviarie si concludesse secondo la volontà del presidente del Consiglio. Inoltre, le condizioni sulla durata degli accordi per le convenzioni ferroviarie che Ricotti aveva creduto di poter imporre a Depretis al momento del suo ingresso alla Pilotta erano state assai presto superare dal dibattito parlamentare ed avevano ridotto di molto quel peso contrattuale che il Generale si era forse illuso di poter avere nel Consiglio dei ministri. Analogamente, la convinzione, diffusa in vari settori conservatori del trasformismo, che la personalità di Ricotti potesse essere tale da emarginare e sostituire lo stesso Depretis nella guida della maggioranza ministeriale si sarebbe presto rivelato come un puro sogno irrealizzabile.
Nei mesi immediatamente successivi la nomina di Ricotti a Ministro della Guerra, quindi, la posizione di Depretis poteva dirsi rafforzata e più sicura che in molte altre passate occasioni 1 . A ciò doveva poi contribuire, sempre nei primissimi mesi del188), quell 'impressione di forza e di 'potenza' nazionale che la spedizione di Massaua e l'avvio di una politica coloniale, sia pure ancora timida e limitata, poteva dare 2
Ma col passare del tempo, il sostegno che Ricotti aveva di fatto dato all'ipotesi trasformista doveva invece tramutarsi in un elemento di debolezza per Depretis, proprio a causa degli indirizzi che il novarese andava prospettando per la politica militare nazionale. Sotto la pesante critica delle opposizioni, che erano rimaste per un attimo disorientate al momento della sua nomina. la politica militare di Ricotti doveva alla lunga finire per scontentare quegli stessi settori conservatori della maggioranza trasformista che invece il suo ingresso nel Ministero era parso dover mantenere stabilmente sotto la direzione di Depretis. Ma non solo. Con lo scivolare dei mesi, che vedevano rimanere la politica militare italiana inchiodata sul principio della 'sosta' (mentre la situazione internazionale si andava complicando e la conduzione della politica coloniale italiana andava mostrando
1 Cfr. CAROCCI, Agostino Depretis e la politica interna da/1876 a/1887, cit., pp. 357-358, e Storia del Parlamento italiano, v. VIII, La sinistra al potere, cit., pp. 352 ·353.
2 Cfr. CAROCCI, Agostino Depretis e la politica interna dal1876 a/1887, cit., p. 594. Così scriveva D. Farini, dopo la notizia della nomina di Ricorti aJla Guerra: cO io mj inganno, o Depretis è più che mai sicuro al potere•. MCR, Carte Camerani, se. 935, fase. 15, doc. 11, Farini a Camerani.

78 POUTICA E POUTICA MIUTARE
tutte le sue incertezze e tutti i suoi limiti ), generale doveva divenire il malcontento e l'insoddisfazione nei confronti della gestione di Ricottt.
Ma quanto, di questo crescente disfavore parlamentare e politico nei confronti del MiniStero della Guerra , era addebitabile alla sola volontà di Ricotti e quanto invece doveva ricondursi ai limiti della più generale impostazione moderata voluta da Depretis per i suoi governi? La 'sosta ' era desid erata solo da Ricotti, che per tanto tempo si era battuto contro la politica militare seguita dalla maggioranza dei governi della Sinistra, o anche e soprattutto da Magliani e Depretis, ambedue preoccupati dalle richieste finanziarie dei militari ' alla Mezzacapo'?
Lo spazio politico in cui avrebbe, secondo Depretis, dovuto muove rsi il nuovo Ministro della Guerra era quello più generale che egli vedeva necessario imporre ai lavori di tutta la legislatura.
Altro che riforme politiche!( ... ) il compito della XV legislatura è essenzialmente amministrativo-sociale. Noi spe riamo che il Parlamento faccia il suo dovere 3 .
Così la voce ufficiosa della presidenza del Consiglio, nei giorni in cui si andava preparando la nomina di Ricotti aveva messo l' accento sulla maggiore utilità anche per la politica militare italiana di non dedicarsi a riforme impegnative, politicamente e finanziariamente.

Il lettore sa che noi non fummo soverchiamcme entusiasti di parecchie delle riforme, le quali l'oo. Ferrero introdusse nell'ordinamento dell'esercito, imperciocché credevamo e continuiamo a credere che allo stesso risultato si poteva arrivare più so lle ci tamente e più economicamente tessendo altre vie e seguendo altri sistemi 4 •
Solo qualche giorno prima che il generale novarese ricevesse ufficialmente la nomina a Ministro , il quotidiano di Deprecis specllicava chiaramente che «ora il popolo italiano di riforme p olitiche ne ha le tasche piene( ... )» 5. E poi, al momento d e lla nomina , infine, tornava di nuovo sul tema per cui nella politica militare fosse giunto il momento di «string ere un po' i freni» 6 . E se anche si ribadiva che
3 Cfr. cii popolo roman o•, 27 agosto 1884, La questione del giorno.
4 lvi, 4 settembre 1884 , Le forze militan· italiane.
) lvi, 5 ottobre 1884, L 'Oppoiizione.
6 lvi, 20 ottobre 1884, Il Ministro della Guerra
UN ESERCITO PER RICOTTI 79
solamente il Ministro della Guerra «è considerato responsabile di tutto ciò che avviene nell' ese rcito •. la situa.zione politica e finanziaria imponeva a tutti «un po' di sacrificio personale!:. 7•
Il nuovo Ministro della Guerra ceno dovette comprendere e condividere l 'ammo nimento se, quando annunciò il suo programma, parlò proprio della necessità di cun periodo eli attività amministrativa, tutta indirizzata a consolidare e a migliorare l 'attuale ordinamento dell'esercito e l'assetto definitivo della difesa dello Stato• 8 .
D'altra parte in quel periodo, nei diba tti ti di politica militare , non era in vista nessuna riforma politica di una cena entità , se si escludeva il progetto di legge che Ferrero e Pelloux avevano presentato tra la primavera e l 'estate 1884 per un aumento dei quadri della Artiglieria e della Cavalleria (di cui proprio il duro discorso di Ricotti del luglio aveva contribuito a bloccare l'approvazione parlamentare) 9 .

Era così che la predilezione che Ricotti aveva sempre dimostrato per la necessità di un aumento della forza della Fanteria si adattava magniftcamente l 'indirizzo voluto da Depretis.
Aumento della forza delle compagnie di Fanteria , stabilizzazione dei bilanci militari, co ntrarietà all'aumento dei quadri di Cavalleria e Artiglieria: questo, in sostanza, era il perimetro politico in cui doveva aggirarsi il dibattito sui bisogni dell 'es ercito e sulla politica militare di quegli anni. E in generale, quelli, furono anni nei quali Ricotti difese sempre strenuamente l'idea secondo cui per l'esercito era sufficiente una rigorosa attività amministrativa , mentre l'opposizione parlamentare chiese invece (e con sempre maggiore insistenza) precise riforme militari , che la maggioranza trasformista giudicava 'politiche'.
E più la situazione politica internazionale si andava face ndo difficile e più la politica coloniale ita liana andava rivelando i suoi modesti obiettivi, più la critica dell'ordinamento militare e della gestione di Ricotti dovevano dare forza all'opposizione antitrasformista 10 Sin dall'inizio del suo dicastero, quindi, Ricotti , in sintonia con i desideri di Depretis, si presentò come il Ministro dell'ordinaria amministrazione. Sulla cltalia militare• egli faceva scrivere che il nuovo
80 POUTICA E POUTJCA MIUTARE
7 Ibidem.
cL'Opinione•, 26 onob re 1884, Il programma del generale Ricotti
Cfr. VENTURINI, Miltiari e politici nell'ltalitJ umbertintJ , cit., p. 193.
Cfr
ivi, p . 216.
8
9
1°
.
Ministro si sarebbe interessato del «compimento e perfezionamento d eli' esercito» e del fatto che «non erano grandi cose le risorse del paese:. 11. Le primissime circolari che egli volle emanare ebbero un carattere eminentemente amministrativo, come quelle volte ad alleviare talune macchinose procedure del carteggio d'ufficio 12 o tese a scoraggiare una vecchia piaga dell'amministrazione militare, le «raccomandazioni fatte per via indiretta a favore dei dipendenti dell' Amministrazione della Guerra» 13. Deciso a proseguire per questa strada e forse presago delle opposizioni che da più parti un tale indirizzo avrebbe potuto sollevare, Ricotti- nella sua prima comparsa nelle aule parlamentari in qualità di Ministro - pose poi l'accento sull' importanza di lasciare al Ministro della Guerra ed alla sua volontà la più larga libertà d'azione, perché egli potesse 'svolgere il suo programma' 14
A segnalarsi sfavorevolmente, specie nel mondo militare, furono poi altri provvedimenti ministeriali che, se anche toccavano questioni reali dell'amministrazione della Guerra o problemi importanti di politica militare, vennero considerati come meri palliativi.
Una delle caratteristiche della struttura amministrativa militare del tempo era il suo rigido eccessivo e talvolta superfluo accentramento , per cui la struttura centrale - il Ministero della Guerraveniva sovraccaricato di funzioni e responsabilità. La cosa era stata già da tempo segnalata lS ed andava anche in contrasto con quanto si stava allora facendo nelle amministrazioni militari delle altre potenze europee del tempo 16. Quando Ricotti manifestò la sua intenzione di procedere ad un decentramento delle competenze del Ministero, sperava forse di raccogliere il favore più ampio del mondo militare. Ma questo favore venne presto meno quando si capì che, se anche l'intenzione ministeriale era lodevole perché andava nella giusta direzione (cioè «accrescere l'autorità dei Comandanti di Corpo d' Ar-
1 1 «L' Italia militare•, 17 dicembre 1884, Le forz e vive dell'esercit o, e ivi, 12 novembre 1884 , Ragioniamo ancora.
12 Cfr. «Giornale militare ufficiale• , 18 dicembre 1884, atto n 208
13 Cfr «L' eserci to italiano,. , 29 novembre 1884 , Le raccomandaz ioni
14 Cfr. AA.PP. , Senato, Legisl. XV , sess. unica , Discussioni, tornata del 27 novembre 1884.
l ) Tra gli altri cfr. MARSEW, La politica dello stato italiano , cic., pp. 166- 169.
!6 Cfr. AUSSME , Addetti militan . Germania , racc. 2 , l dicembre 1884 , Ri.r. , ed anche ivi, 3 febbraio 1886.

UN ESER CITO PER RICOTTI 8J
mata> 17 e c lasciare a ciascuno libertà di azione piuttosto ampia» 18, la concretezza delle funzioni che venivano decentrate era talmente ridotta da rendere vano il bel proposito enunciato. Non a caso, un profondo conoscitore del mondo militare ed uomo di Corte di Umberto I aveva già scritto nel suo diario a questo proposito: «Ricotti e decentramento mi paiono due termini che si elidono• 19.
Analoga attesa e analogo sfavore avrebbero poi incontrato altre misure, come quelle per perfezionare il reclu tamento delle truppe alpine 2o o per il richiamo per un breve periodo di istruzione militare degli iscritti alla seconda categoria 21 Misure che , per la forma in cui erano state decise o per la lim itata ampiezza in cui erano state condotte, furono ogge tto di pubblica critica 22
Ma , seppure mal predisponevano l ' ambiente militare , non erano queste misure amministrative tutto sommato di secondaria importanza a destare una opposizione politica e militare alla gestione Ricotti.
A livello politico, grande e durevole impressione aveva avuto il fatto che, correttamente , taluni organi di stampa avessero messo la nomina di Ricotti in relazione alla questione delle convenzioni ferroviarie 23. Inoltre , il rinnovato interesse con cui Depretis andava sistematicamente spostando a Destra l'asse della maggioranza doveva sollecitare e rinvigorire l'opposizione di chi - come i pentarchicivedeva nella presenza di Ricotti nel Governo il segno più chiaro della sua emarginazione politica 24 . Non era infatti un mistero che proprio la Pentarchia avrebbe visto con favore , al momento della sostituzione di Ferrero , la nomina a Ministro dell'ex-Segretario Generale Luigi Pelloux .
Per tutti questi motivi , l'opposizione a Ricotti da pane della Pentarchia e dei suoi rappresentanti parlamentari era destinata a crescere .
Questa tendenza politica era inoltre avvalorata dalle forme in cui prese le mosse la prima sped izion e coloniale italiana, quella per Massaua . Se anche, in genere , il responsabile dell'indirizzo in ce rto
l7 cGiornale militare ufficiale• , 28 maggi o 1885, atto n. 71.
l8 lvi, 14 aprile 1885, ano n. 47.
l9 Il generale Osio, cit . , p . 373, alla data dd 10 dicembre 1884.
20 cGiornale militare ufficiale•, 5 dicembre 1884, att o n 223
21 Cfr. «L 'esercito italiano•, 15 marzo 1885, Il richiamo.
22 Cfr ivi, 21 marzo 1885 , L 'ordinamento dell 'esercito e la dzfesa dello Stato.
23 Cfr. ACS, Carte Pelloux, se. 29.
24 Cfr BOCCACCINI, La Pen tarchi4 e l'opposizione altrasformismo, cit., p. 97.

82 POUTICA E POUTICA MIUTARE
e timido di questa politica coloniale era visto - a ragione - nel Ministro degli Esteri Mancini, contro il quale infatti si indirizzavano la maggior pane delle critiche e del malcontento 25, anche Ricotti doveva prima o po1 nceverne una s ua pane .
Così la stessa politica coloniale, che sembrava poter prefigurare la nuova dimensione 'offens iva ' dell ' esercito italiano in quegli anni Ottanta 26, doveva nel corso del semestre gennaio-giugno 1885 indebolire la posizione di Ricotti.
La crescente insoddisfazione del mondo militare per i principi della 'sosta' e l 'o pposizione sempre più acuta di tal uni settori politici per la gestione della spedizione di Massaua dovevano così portare il Ministro della Guerra ad accettare il dato di fatto per cui ogni suo intervento parlamentare avrebbe suscitato discussioni e resiste nze politiche.
Ma una volta indicatone i motivi di fondo , di questa insoddisfazione e di questa opposizione è ora opportuno ripercorrere le varie tappe successive, nello scorrere dei mesi del seco ndo ministero Ricotu.
Le occasioni in cui la Camera si limitava a non fare opposizione ai progetti di Ricotti erano davvero poche e riguardavano, in quei primi mesi del 1885 , disegni di legge davvero secondari. Era il caso della proposta di mettere sotto controllo statale - in qualche forma - la Croce Rossa it aliana 27, o della necessità di ripianare il deficit della Cassa Militare 28. Eppure anche in quei cas i taluni esponenti di Sinisua, come Crispi 29, o di Destra, come Saracco 30 e Branca 31, si alzarono per protestare le loro riserve o l e loro preoccupazioni. In un ceno senso, Ricotti riuscì poi a sfruttare la situazione di
25 Cfr. C. ZAGHI, P.S. Mancini e ti problema del Medìte"aneo, Roma, Casini, 1955, e C. GIGUO, L'impresa dì Massaua, Roma , Ed . IStituto Italiano p er l 'Afri ca, 1955.
26 Cfr. DEl NEGRO, Eserçìto, Stato, società. Saggi dì storia militare, ci t., p. 260.
27 Cfr. AA.PP., Camera, Legisl. XV, sess. unica, Discussioni, tornata del 14 maggio 1885.
28 Cfr. ivi, tornata del l giugno 1885 Qualche obiezione (da pane di esponenti della Destra contrari alla dilatazione delle spese statali in genere) era stata invece sollevata in sede di Commissione esamina t ri ce. Cfs. ACD , Dd/, Legisl. XV, sess. uni ca, reg. 401, n. 272, Verbale di seduta della Commissione, IO aprile 1885.
29 Cfr. AA PP ., Camera , Legisl. XV, sess. unica , Discussioni, tornata del28 maggio 1885.
30 Cfr. AA PP., Senato, Legisl. XV, sess. unica , Discussioni, tornata del 22 giugno 1885.
H Cfr. ancora ACD, Dd/, Legisl. XV, sess. unica , reg . 401, n. 272, cit.

UN ESERCITO PER RICOITI 8 3
crisi governativa in cui versava il Gabinetto nel giugno 1885 (quando Mancini fu costretto a lasciare la Consulta). Proprio in quei giorni veniva infatti messa in discussione la annuale legge sulla leva, che però quella volta non era del tutto 'ord inaria '. Attraverso quella legge, infatti , Ricotti, fedele ai suoi assunti ' numeristi', volle differenziarsi ulteriormente dall'amministrazione Ferrero e dall'indirizzo delle amministrazioni militari del dopo-1876, aumentando il contingente di leva e soprattutto quella pane che sarebbe stata congedata dopo soli due anni di prestato servizio 32 . Ricotti, (che sapeva che il principio dei congedi anticipati avrebbe suscitato discussioni nell'ambiente militare e tra i deputati militari, tra cui non mancavano invece i sostenitori del prin cipio della categoria unica) 33 pose la legge all'attenzione della Camera proprio durante la crisi governativa: ed il Parlamento fu invitato ad approvarla come fatto di ordinaria amministrazione. Cosa che infatti avvenne.
Nonostante simili artifizi regolamentari Ricotti non poté evitare, già a pochi mesi dalla sua nomina , il dibattito e la critica parlamentare. Se sino allo ra, come si è visto, le obiezioni erano state mosse al Ministro della Guerra in Aula da deputati 'civili' e soprattutto di Sinistra, pentarchici , nella sia pur veloce ma importante discussione sul la legge della leva Ricotti si trovò di fronte un certo dissenso della stessa deputazione militare. Questo dissenso, allora, non si tradusse in opposizione, per il delicato momento di trapasso governativo cui si è accennato Eppure il segnale c' era stato. In sede di Commissione parlamentare, deputati militari come Sera.fini, Taverna e Giudici avevano rivolto una interrogazione scritta al Ministro perché «indicasse i fondi sui quali provvedere al maggior aumento del contingente:. 34; poi, in aula, persino Taverna, relatore sulla legge, colonnello della riserva e aiutante di campo del Re dal 1882 , si era lamentato che il regolamento di leva in Italia concedesse «troppa libertà al Ministro della Guerra» 35.
La legge, nonostante questo, fu approvata e il dissenso dei de-
32 Sulle questioni dei congedi anticipati, cfr. DEL NEGRO, Esercito, Stato, società Saggi di storia milìtare , cit. , p. 208, e VENTIJRINI , Militan· e politici n ell'Italia umbertina, cit .• p. 178 e sgg.

33 Cfr. la voce (panicolare ) di Riccio in AA.PP., Came ra , Legisl. XV , sess. unica , Discussioni, tornata del 19 giugno · 1885.
34 ACD, Dd/, Legisl. XV , sess. unica , reg 403, n. 303, Verbale di uduta della Commissione, 2 maggio 1885.
AA.PP., Camera, Legisl. XV, sess. unica, Discussioni, tornata del 19 giugno 1885
84 POLITICA E POLITICA MI LITARE
putati militari fu appena notato dalla stamp a 36; eppure era un disse nso che doveva prefigurare, in piccolo, un ' opposizione futura. Ma, nonostante i primi timori della stampa militare, le prime sfavorevoli reazioni della stampa d'opposizione, e queste prime vicend e parlamentari, il periodo che andò dall'ottobre 1884 al giugno 1885 fu ceno quello in cui la posizione politica di Ricotti era ancora più che sufficientemente sicura. Il suo ingresso nel Ministero aveva avuto quella imponanza politica nei rapponi tra Depretis e la Des tra che abbiamo visto, il varo delle convenzioni ferroviarie era ancora vicino nel temp o, la polemica della Pentarchia pareva ancora tutta rivolta contro Mancini, e così il Ministro della Guerra poteva ritenersi ancora uno dei pilastri nel Governo.
Oltre e prima di questi motivi generalmente politici, però , c 'era un'altra ragione , più propriamente di politica mt/itare, che garantiva allora la permanenza di Ricotti alla Pilotta.
Erano quelli i mesi in cui, infatti , arrivava alla sua con clusione parlamentare il lungo iter politico (e militare ) del progetto di legge che stanziava un'ingentissima somma di bilancio a favore del sistema fonificatorio permanente. Come si sa 37, dal 1881 al 1883 si era riunita la Commissione per l a Difesa dello Stato e aveva stilato uno schema delle fonificazioni da costrUirsi o da rinforzare Dopo una complessa trattativa politica , che aveva visto protagonist i Ferrera e Depretis 38, fu stabilito l 'ammontare ftnanziario che lo Stato poteva mettere a disposizione per la realizzazione della pane centrale di quello schema. Quando Ricotti fu nominato Ministro , il progeto di legge aveva quasi terminato il suo esame alle Commissioni di Camera e Senato e attendeva di essere discusso in Aula. L'entità dello stan ziamento straordinario era assolutamente imponente: si sarebbe trattato di ben 217 milioni , quasi quanto l ' esercito italiano aveva asso rbito in spese straordinarie in tutto il ventennio precedente , dal1861 al1879 (escluse le spese per la guerra del 1866) 39. In un progetto di legge così im-
36 Cfr. ad esempio, l'atteggiame nto de «<l popol o romano• e de «L'O pinione• . L' attenzione politica della stampa andava, ovviame nte. alla crisi di gove rno. L' organo dd presidente del Consiglio, anzi, tendeva a difendere Ricotti dagli attacchi mossigli dalla co nservatrice cl.a Perseveranzv {attacchi , questi, però, ponati sul terreno della poLitica co loniale e con lo scopo di una riduzione delle spese militari).
37 Cfr. MINNITI, E.!ercilo e politica da Porta Pia alla Triplice Alleanza, cit., pp. 89-113.

38 Cfr. VENTURINI , Militari e politici nell' Italia umbertina, ci t.. p . 195.
39 Alcune tabelle (riprese dal saggio citato di A. Pedone) sull'entità delle spese militari sono ora anche in CEVA, Le forze armate , ci t ., pp 103-105
UN ESEilCITO
PE!l RICOlTI
portante, la cui preparazio n e aveva impegnato rilevanti energie militari e politiche, il cambio della guardia alla Pilotta doveva avere ripercussioni secondarie.
Eppure anche in quella occasione Ricotti giocò un ruolo autonomo.
Le sue particolari concezioni del rapporto tra bilanci militari e disponibilità finanziarie , insieme ad al cune decisive pressioni di Magliani, avevano - come si è visto - condotto Ricotti a ritenere di poter gestire le necessità dell 'ese rcito se nza dover chiedere aumenti nelle spese militari. Anzi , per quanto riguardava il progetto di legge sulle fortificazioni, fu possibile fare di più. Dal momento che Magliani voleva conte n ere al massimo il deficit statale che invece proprio in quegli anni andava ripresentandosi 40 e poiché Ricotti non aveva mai ritenuto che il sist ema fonificatorio di una nazione dovesse avere un costo che immobilizzasse troppa parte delle sue risorse 41 , fu di fatto concordato di diminuire l ' incidenza economi ca della legge per ciascuno dei primi esercizi finanziari. Ricotti annunciò così che essa avrebbe richiesto per ciascuno dei primi due anni non più 45 milioni ma solo 30 4 2 .
Anche in questa decisione le opinioni di Ricotti si erano perfettamente sposate con le preoccupazioni di Magliani. In realtà, già da tempo era stato notato che cRicotti, come generale , subordina troppo il problema militare a quello finan ziario:. 4 3 : proprio quando se mpre più i militari sostenevano invece che «ora è divenuto urgente il dare alla questione militare rispetto a quella finanziaria un rilievo maggiore:. 44. Inoltre , anche questa posizione , assunta dal neoMinistro sul progetto di legge per le fortificazioni, avvalorava nel mondo militare italiano l'idea che si andasse verso una 'sosta'. Eppure non era forse nemmeno questo il dato rilevante- come inve ce e ra parso all 'interno del mondo militare - come non lo erano gli storni tra i capito li della legge (soprattutto aumento degli stanziamenti per
4° Cfr. BARONE, Sviluppo capitalistico e politica fina nzian'a nel decennio 1880-1890, ci t., p. 190 .
41 Cfr già AA.PP., Camera, Legisl. Xl, scss. t erza, D itcussioni, tornata del15 marzo 1874. Cfr. anche CORSI, Italia 1870 -1895 cit., p. 157.
42 Cfr. MINNITI , Esercito e politica da Porta Pia alla Tnplice Alleanza, ci t., p. 108.
43 GUICCIOU, Dian'o del 1884, cir., p. 301, alla data dal l luglio.
44 MARSELLI, La politica dello stato italiano, cir. . p. 319.

86 POUTICA E POUTICA MlUTARE
le difese costiere) 45, storni che rivelavano la vecchia preoccupazione di Ricotti per uno sbarco francese sulle coste tirrenich e.
Il dato più interessante , ancora una volta, e ceno quello che spiega meglio le ragioni del successo ' politico ' di Ricotti vanno ricercate nell'oggettivo intreccio dei rapponi tra politici e militari che la vicenda delle foni spese per le fonificazioni sollevava (e della delicata ma cruciale posizione che in quel rappono il generale novarese si trovava ad occupare).
Sulle fonificazioni , Ricotti contava su un 'g io co incrociato'. Ricotti infatti , da una pane si presentava al mondo militare come il garante dell'approvazione della legge , che per la sua entità finanziaria era dj ponata eccezionale e che era (tanto per capire) anche più alta dj ognuna delle leggi per spese stra ordina rie militari che poi Crispi farà votare qualche anno dopo . E, d'altra parte , si presentava al mondo politico ed agli ambienti governativi come quel mili-" tare che assicurava che, dopo quella legge, non ci sarebbero state per un pezzo altre richieste di spese militari.
In tal modo, da nessuna delle due pani , almeno fino all ' approvazione della legge , nessuno avrebbe potuto attaccare fino in fondo l'amministrazione del generale novarese. E, infatti, così fu. Eppure nemmeno questo doveva bastare per smorzare le riserve e le critiche alla sua amministrazione: critiche che, semp re più spesso, tendevano a contrapporre Ricotti a Ferrero , esaltando il secondo e censurando il primo, nonché a evidenziare una crecente ostilità verso la 'sosta'.
Già nel maggio 1885, sulla legge di bilancio (in pratica la prima grande occasione dj dibattito parlamentare su lla politica militare dj Ricotti ed a proposito di quello che era il primo bilancio della Guerra di cui il novarese poteva dirsi in pane responsabile, essendo stato presentato alla Camera alla fine del novembre 1884) , il Ministroforse già meno protetto da quella duplice ed incrociata difesa cui abbiamo ora accennato- subì un fone attacco 46. Se, nella discussione parlamentare sulle fortificazioni erano ancora stati gli interventi 'politici' - come queJli della Pentarchia - ad essere i più critici, nella discussione della legge di bilancio furono le voci dei deputati militari a farsi sentire: e non tutte furono favorevoli.
45 Cfr. invece VENTURINI, MzJitari e politici n ell'Italia umberJina, cit., pp 195-196 e 203.
46 Cfr. AA.PP. , Camera, Legisl. XV, sess. unica , Di.Jcussio n i, tornata del 28 maggio 1885.

UN ESEROTO PER RJCOm 87
Comunque , già prima della deputazione 'in divisa ' tutta l' opposizione politica di Sinistra attaccò la gestione Ricotti.
Il Ministro fu accusato (talvo lta anche a sproposito) di esse re il generatore di tutti gli squilibri esistenti nell'esercito , e particolarmente tra Fanteria e Armi speciali 47 I pentarchici parlarono di (e contro) tutto : dalle classi di punizione agli abusi di autorità, dalla ferma di Cavalleria al ritardo nella costituzione della Milizia Territoriale 4s. Si ascoltarono anche voci che chiedevano un aumento dei bilanci militari 49. Intervenne persino una personalità del livello di Baccarini , criticando l'ottimismo del Ministro e affermando tra l'altro che «Se si fosse in pericolo, [avrebbe] votato un eventuale bilancio Crispi» 50. Quando , dopo la discuss ione generale , si passò ad esaminare i singo li articoli del bilancio (o ltre ai vari interventi critici che si susseguirono da Sinistra e da Destra) 5I, parlarono i deputaci militari: Pozzolini, Baracieri e Pelloux. Tutti e tre fecero al Ministro appunti di carattere generale e specifico: e comunque contro il principio della 's osta' H.

Ma non erano stati i so l i. Anche durante la discussione generale, lo stesso relatore sulla legge , il militare- moderato e ministeriale- Gandolfi, si era direttamente e pubblicamente lamentato di Ricotti , dei suo i prindpi e del suo bilancio. L'indirizzo della 'sos ta ', aveva detto, poteva forse dare «il numero» dell'esercito: «ma la qualità? ma la forza morale?» B.
A questo Ricotti rispose con un dettagliato disco rso parlamentare , in cui ribadì tutti i suoi princìpi: difese la sua passata amministrazion e del1870-76 dagli attacchi che vi erano stati ri volti, affermò di non voler effettuare una deviazione dal programma militare di Ferrero (e in questo e ra scarsamente credib il e, come anche quando disse più tardi di essere uno dei più accesi sostenitori della 'offensiva'), ripeté il suo scarso favore per le fortifi ca.zioni permanenti, dichiarò che non c'era al cuna necessità di nuove sp ese militari 54
47 Cfr. l 'in terv ento di Pais in ibidem.
48 Cfr. l'intervento di Giovagooli in ivi, tornata del 31 maggio l88S.
49 Cfr. l 'inte rvento di Baccarini in ivi, tornata de U'8 maggio 1885.
Ibidem.
51 Cfr. ibidem .
52 Cfr. ivi, tornata del 28 maggio e del l giugno 1885.
53 Cfr. ivi, tornata del 9 giugno 1885.
Ibidem.
88 POUTICA E POUTICA MI UTARE
Ma le critiche, rivoltegli dall'opposizione politica e da qu ella parte della deputazione militare che cominciava a manifestare la sua d issidenza, dovettero avere il loro peso se, al momento della votazione, un terzo della Camera negò la sua fiducia a Ricotti 55. D'altira parte il momento politico per l'intero governo era difficile e si era a ridosso della crisi del giugno 56. Non a caso lo stesso Ricotti per ben tre volte , nel suo intervento, aveva fatto appello ad un voto ministeriale, di fiducia.
Il primo grande appuntamento parlamentare di Ricotti, quindi, non si era risolto in quell'intervento frantumatore delle opposizioni che Depretis forse si era augurato nell'autunno 1884. L'indirizzo politico del Ministro della Guerra, anzi, pareva già aver vivacizzato le opposizioni pentarchiche (ma anche certi malumori moderati). Ricotti non era nemmeno riuscito completamente a far accettare gli obiettivi del Ministro e del governo all'interno dello stesso esercito, come le critiche di taluni organi di stampa militare e di parte della deputazione militare stavano ad indi care. Non era un bilancio granché positivo.
Il bilancio si faceva ancor meno positivo se si metteva in conto l'aperta e pubblica polemica che militari di alto grado e di indubbia fama (co me Agostino Ricci) avrebbero in quei giorni condotto contro la politica del Ministro 57 . Di queste polemiche, la più efficace e la più perentoria fu quella di Carlo Mezzacapo. Il noto generale aveva rotto addirittura la consueta pratica invalsa al Senato di approvare quasi senza discussione i bilanci militari ed aveva usato la Camera Alta per sferrare un duro e frontale attacco al progetto della 'sosta' di Ricotti 58 .
Mezzacapo attaccò il Ministro su tutto il fronte della sua politica. Troppo bassa la percentuale di Armi speciali rispetto alla Fanteria, insufficiente la Milizia Mobile , mancante di solidità la Milizia Territoriale, bisognosa di un riordinamento l'Artiglieria, non svalutabile il ruolo delle piazzeforti e delle fortificazioni, carente il Bilancio della Guerra, specie quello per le spese straordinarie. Tutto, secondo Mezzacapo , avrebbe dovuto fare a meno di una 'sos ta'.
Ma se Carlo Mezzacapo, al Senato, era solo (ness un altro sena-
Cfr. ivi, tornata del 13 giugno 1885 .
Cfr. Stona del Parlamento italiano, v. VIli , La sin istra al potere, cit., p. 378.

57 Cfr. ultra , p. 150.
58 Cfr. g ià VENTURINI, Militan· e politici nell'Italia umbertina , cit., p. 209.
UN ESERCITO PER RICOITI 89
tore lo segui nella sua critica a Ricotti ed anzi la votazione senatoriale si risolse in una delle migliori per il Ministro della Guerra) 59 , egli non era solo ua i militari , tra i quali il suo discorso ebbe largo eco e riscosse significative approvazioni. Ed anche facendo astrazione dal successo della sua impostazione nel più vasto Corpo ufficiali, rimaneva il fatto che un militare del calibro di Mezzacapo aveva già deciso a poco più di un semestre dalla nomina del Ministro di dare forma pubblica (ed altisonante) alle sue critiche alla gestione Ricotti. Le voci 6o, pure diffuse, che Mezzacapo sarebbe stato l' eventuale candidato della Pentarchia alla carica di Ministro della Guerra qualora Depretis avesse deciso di sbarazzarsi - oltre che di Mancini - anche di Ricotti , non diminuivano ma anzi appesantivano il bilancio politico di quelle tornate parlamentari (e in generale del primo periodo ministeriale) del generale novarese.
In realtà, però, agli occhi dei militari , un altro grosso merito (oltre ad aver garantito la conversione in legge del progetto per le fortificazioni) Ricotti lo aveva.
Il Ministro della Guerra , infatti, con la sua autorità , aveva contribuito a che venissero rintuzzate le proposte di radicale economia sui bilanci militari che dalla parte più conservatrice della Camera erano state avanzate nei mesi precedenti. Anche se forse in questo caso, a differenza che per le fortificazioni, il merito era più della congiuntura politica che del generale e del suo pro gramma .
Aveva aperto le ostilità in questo senso già nel settembre 1884 un articolo di Ruggero Bonghi sulla «Nuova antologia» . Valutato l'equilibrio europeo come ormai stabile e duraturo , l ' ideologo della Desua antitrasformista aveva chiesto a Deprecis che si facessero economie sui bilanci della Guerra (soprattutto , ma anche della Marina) per un ammontare di 100 milioni .

La cifra, evidentemente , era simbolica ed esagerata: ma comunque indicativa della tendenza politica che si voleva affermare . La rispo ndenza parlamentare e della scampa più conservatrice non era stata irri levant e : più di un deputato di Destra e vari organi di stampa , tra cui la autorevole «la Perseveranza» di Milano , organo degli agrari lombardi , si erano dimostrati interessati alle idee di Bonghi 6 1 •
59 C fr. A A.P P., Sen ato, Legis l. X V, sess. u n ica, Discussioni , tornata d el 25 g iug n o 188 5.
60 Su cui cfr . U. P ESCI, 11 generale Carlo Mezzacapo e il suo tempo. Da appunti autobiografici e da lettere e documenti inediti, Bo log na, Zanichelli, 1905, p 170.
61 Cfr. CAROCC I, Agostin o Depretù e la pol ittca i n terna dal 1876 a/ 1887, cit., p. 405.
90 PO UTI CA E POUTICA MILITARE
Il progetto (che a veva fatto gridare gli orgari Ì d ì st ampa militare aJl ' attentato politico contro la sicurezza dello Stato) 6 2 era destinato poi ad aumentare la sua pericolosità per i militari quando esso, nei mesi successivi, fu rilancìato da quel vasto ed schieramento parlamentare che fu detto 'panico degli agrari' 3 I rappresentanti dei proprietari terrieri erano in quei mesi mobilitati per sollecitare un intervento pubblico che alleviasse i clarini inferti dalla prima diffusione in Italia della crisi agraria europea. In o ltre, le ri ch ies t e degli agrari erano un po ' il corrispettivo di quelle de i gruppi finanziari ed industriali (che stavano in quei mesi ottenendo le co nvenzioni ferroviarie ) e dei circoli mili tari (c he , come si è visto , si erario avvantaggi aci dello starizÌamento per le fortificazioni ).
Per un complesso di motivi (in realtà so starizialmente l' eterogenità sociale e regionale del ' partito degli agrari ' ) e per il fatto che Depretis trovò il modo di soddisfarne le richie ste in altro modo , l'idea di decurtare le spese militari dovette cadere 64. Eppure in quel volgere di mesi ch e e ra andat o dal settembre 1884 alla primavera del 1885 , lo spettro della riduzione aveva aleggiato sui bìlari ci militari .
In un ceno senso , Depre ci s aveva vià dato una prima risposta a Bonghi ed alla Destra agraria con la stessa nomina di Ri cotti. Così infatti scriveva l'organo di stampa vicino alla presid e nza del Consig lio: eRadicali economie nel Bilaricio italiario sono impossibili ( ) rutto questo va fatto con ordine e gradualmente , se nza precipitare e senza forzare». E proprio senza precipitare e sen z a forzare Ricotti stava in quei mesi imponendo al mondo militare una stabilizzazione dei Bilanci.
Raccomandi l'on. Bonghi no n un parziale disarmo- continuava il cP opolo romano•- che sarebbe un suicidio mat eriale e morale deU'Italia, ma bensì molto più o p po nun ameme una severa amministrazione, che resechi dal Bilancio deiJa Gue rra ogni spesa non strenamente n ecessaria alla vitalità del graduale sviluppo dei n ostri o rd inamenti mili t ari ed il Paese , o m olta pane di esso, sarà con lui 65 •
Fu così che, sopra t tutto per l'avversione di Depretis a concedere
62 C f r. d' eserci to itali wo•. 7 o tto bre 1885 , Sve n triamo l'esercito.
63 C fr. CARO C CI , Storia d'Italia dall'unità ad oggi, ci t ., p. 65 e sgg
64 Su gli inte ressi degli agrari pe r eco n omie sul bilancio della Guerra, cfr. cenni in VENTIJRINI, Militari e politici nell'Italia umbertina, ci t., p. 200. Ma già Carlo Corsi aveva posto - in via generale - il p rob le ma dell e economie nello Stato postUnitario come un'alternativa tra 'toccare la rendita' e 'tagliare i bilanci militari'. Cfr. C. CORSI , 1844-1869. Ve n ticinque an ni in Italia, cit., p. 301.
65 cii p o polo romano•, 22 nove m b re 1884, Le spese militan·.

UN ESERCITO PER RICOm 9 1
troppo alla pane più retriva delle classi dominanti del tempo, la manovra degli 'agrari' si sc iolse come neve al so l e: e forse diversamente non poteva essere nell'Italia che anzi- di fronte alle prime incertezze della politica coloniale - chiedeva sempre più una politica estera ardita ed una 'politica di potenza' e di presenza europea.
Ma anche qui, una volta esauritasi la minaccia deg li agrari , e cioè intorno al giugno 188), Ricotti si trovava al governo sempre più isolato.
Intanto , l'estate 188) passò per Ricotti politicamente quieta , a pane alcune campagne di stampa della Pentarchia che rivelarono all 'opinione pubblica italiana la difficilissima situazione sanitaria del presidio militare di Massaua, prima colonia italiana 66
Nell'autunno, poi, dopo un trimestre di inten·m, di Depretis , Di Robilant accettò finalmente la carica di Ministro degli Esteri, contribuendo a sanzionare una ulteriore svolta a Destra del governo Depretis 67.
La riapertura dei lavori parlamentari dell'ottobre-novembre 188) fu disattenta e stanca, come in genere furono le discussioni di quel periodo sino al maggio 1886, quando si svo lse ro le elezioni politiche anticipate 68. A livello politico, nella Camera prevaleva il malcontento della maggioranza ministeriale , accentuato dal rafforzarsi della opposizione Pentarchica e da una certa dissidenza 'tecnica ' (ed ancora non politica) di alcuni gruppi di Destra , riuniti intorno a Di Rudinì. Queste condizioni parlamentari, e la reale mancanza di grossi disegni di legge da discutere, rendevano il dibattito politico sfùacciato e stagnante. Continuava in superficie la predominanza di Depretis e del uasformismo , ma in profondità si stavano mettendo - nel malcontento generalizzato - le basi per una crisi della maggioranza.
66 Cfr. le reazioni ministeriaLi in ivi, 22 giugno 1885, La politica colo niale e la crisi; ivi, 18 luglio 1885, La guerraall'on. Ricotti; ivi, 19luglio 1885, La nostra situazione a Massaua; ivi, 20 luglio 1885, Massaua e le colpe del governo; ivi, 2 agosto 1885, La stampa e Massaua. Per i risvolti militari cfr. cL' esercito italiano•, 19luglio 1885, L 'Italia in Africa; ivi, 31 luglio 1885. Le provvidenze amministrative per le truppe in Africa. Difendeva l'operato di Ricotti cL' Italia militare.-., 28 giugno 1885, Da Massaua; ivi, 19 luglio 1885, Cose d 'Africa. Purtroppo si trattava di polemiche g io rnalistiche, in coincidenza ma del tutto ignare di quanto in quei giorni si agitava in co lonia (ad esempio tra Saletta e Noce): polemiche che quindi non andavano al fondo del problema della prima politica coloniale italiana.
67 Cfr. CAROCCI, Agostino Depretis e la polihca interna dal 1876 al1887, cit., p. 61 0. Cfr. anche E. DEL VECCHIO, Di Robilante la criri nei rapporti man.ttimi italofrancesi, Milano , Giuffré, 1970.
6S Cfr. Storia del Parlamento italiano, v. VIII, La sinistra al potere, cir., p. 416.

92 POUTICA E POUTJCA MIUTAJtE
In questo processo più generale,la discussione parlamentare sulla politica militare di Ricotti rispecchiava perfettamente le caratteristiche del dibattito politico più generale.
Come al solito Depretis aveva raccomandato, in apertura della sessione parlamentare all'inizio dell'aumnno, di occuparsi solo di question i amministrative.
Il programma più pratico per il nosrro paese è quello di concentrare rune le cure a riordinare su basi razionali i grandi servizi pubblici ( ... ) Governo e Parlamento dovrebbero, rafforzati dall'opinione pubblica, occuparsi meno di politica per dedicare il prossimo periodo di lavoro alle cose amministrative ed economiche 69.
Ed ancora
No n mancheranno alla Camera, forse, scaramucce ( )Ma saranno, lo ripetiamo, scaramucce. Una vera e propria lotta non vi troverebbe il terreno propizio 70 •
Come per l 'anno precedente, anche nel 1885 il programma di Ricotti collimava con i desideri di Depretis.
In una serie di articoli co mparsi su un autorevole organo di stampa di Destra , Ricotti aveva illu strato le linee di quello che avrebbe dovuto essere quel suo secondo anno di Ministero della Guerra. Nessun imponame progetto di legge, niente grandi riforme, nessun invito ad un dibattito strategico. Solo misure da ordinaria amministrazione , magari anche importanti ma piccole e delimitate: proseguimento dei lavori di fortificazione, misure anti-sbarco all'Isola d'Elba ed all'Argentario, ulteriore rinvio dell'aumento per le Armi di Cavalleria ed Artiglieria, ennesimo scoraggiamento per la costituzione di società private o pubbliche di Tiro a Segno Nazionale 7 1
Cosa non usuale per un Ministro della Guerra, però, l'interesse maggiore di Ric otti pareva essere non di ordine militare bensì politico. Così scriveva esplicitamente infatti l'organo ufficioso del Ministe ro della Guerra:

Noi [Ricotti] teniamo alla conservazione dell'anuale maggioranza perché il suo sfasciamemo ed il trionfo di un'opposizione, così scissa ed inorganica come l'attuale , darebbe all'Italia una politica più debole senza darle una finanza più
69 cll popolo romano•. 6 ottobre 1885, La vera politica.
70 lvi, 20 novembre 1885, Alla vigilia.
7 1 Cfr. cL' Italia militare• , 12 novembre 1885 , Il programma militare.
UN ESERCITO PER RICOm 93
fone. Tale ci pare divenut2 la siruazione nostra , dopo l'agitazione della crisi agraria e la perequaziooe fondiaria 72 •
Con questo spirito, e nonostante le continue critiche de «L' esercito ital iano» (che pure in qualche modo sembrava risentire di un generale affievo limento e immiserimento del dibattito p olitico), la stampa ufficiosa militare abbandonava la discussione dei grandi temi della politica militare e tornava a disquisire sui temi più astratti dei cgiudizi esteri su l nostro esercito» 73 o su questioni minori, come l 'appono dei militari alla lotta contro il colera, che allora imperversava in mezza Italia 74, o sui temi più ideologici e meno immediati della Milizia Territoriale e del Ti ro a Segno Nazionale 75. Anche l'iniziativa politica ministeriale di Ricotti segn ava il passo.
72 Ibidem. Per un commento critico, cfr. cL' esercito italiano», 24 novembre 1885, Il programma militare. Vo"ei ma non posso.
73 Cfr. cL'Italia militare•, 23 settembre 1885, Giudizi esteri sul nostro esercito.
74 Cfr. ifli, 7 ottobre 1885 , A proposito di certe notizie.
75 Cfr. ivi, 7 ottobre 1885, Milizia terrilon"ale e Tiro a segno nazionale. La questione del Tiro a segno Nazionale, della sua nascit2 e del suo sviluppo, della sua importanza nell'evoluzione della politica militare italiana come delle polemiche che intorno ad esso si svilupparono anche negli anni del secondo Ministero della Guerra di Cesare Ricotti, è cosa assai complessa e che meriterebbe di per sé uno studio specifico. lo quegli anni, in particolare, il dibattito tra politici e milita.ri sul Tiro a segno si andava iocenuando sulla necessità o meno per il Ministero deiJa Guerra e per l'esercito permanente di sostenere le neocoscitute 'società' di Tiro a segno (secondo quanto prevedeva la legge del1882 ), società che- diffuse e sorte un po' io tutto il Regno- avrebbero dovuto rinnovare il mito della 'Nazione armata' sia pur all'interno di rigidi condizionamenti statali e centralistici. La stampa militare d'informazione era a quel proposito divisa: cL' esercito italiano» era caldamente favorevole allo sviluppo delle 'società', cL'Italia militare» ricordava che comunque l'esercito permanente rimaneva il fulcro della di· fesa nazionale e che non conve niva sperperare fondi per quelle associazioni, spesso animate da ex -garibaldini , da crispini e da ' democratici'. NeiJa sostanza- anche se, come: si è detto, la materia richiederebbe specifici studi - negli anni del secondo Ministero Ricotti si assisté a questo proposito ad un'ennesima operazione: di segno uasformistico: da una pane si fece in modo di editare il dettagliato manuale di Compendio di istruzioni militari per le società di Tiro a segno nazionale, Roma, Voghera, 1885, dall'altra si fece: di tutto per deprimere le varie energie locali , scoraggiando la costitu zione di nuove società e lesinando fondi c: armi per quelle già costituite. La letteratura pubblicistica sul rema è assai vasta: per uo primo orientamento cfr. O. BRENTARI , Un grido di dolore per il Tiro a segno nazionale, 1885; C. FISOGNI,ll Tiro a segno nazionale in Italia: cenni statistici e stonco-cniici, Brescia, 1887. Interessanti spunti d ' analjsi storica per avvicinare: temi sirnilari sono oggi contenuti nella raccolta di saggi di imposrazionc: sociologica e politologica curata da L.A ZURCHER, G. HARRIES-JENKINS (Ed.), Supplementary Mililary Forces: Reserves, Militias, Auxilianes, Bevc:rly Hills (Calif.), Sage, 1978.

94 POLITlCA E POLITlCA MILITAllE
Era quello , in effe tti , forse uno dei moment i p i ù grigi del trasformismo 76 .
In maniera distratta la Camera votava, senza nemmeno un solo intervento in sede di disc ussione generale, il progetto di legge sul «Computo del tempo trascorso in servizio dei presidi del Mar Rosso». Eppure la legge, anche se apparentemente tecni ca ed amministrativa , avrebbe potuto essere un ' occasione importante per fare il punto sulla politica militare coloniale italiana 77 . Qualche giorno dopo, in tema di c Modi.ficazioni di stipendi e assegni , per ufficiali , impiegati , militari di truppa e quadrupedi •, la discussion e parlamentare sembrava animarsi , per gli interventi di militari come Pe lloux o Ungaro. Ma poi tutto si risolse in un contrasto di opinioni personali su aspetti laterali e di scarsa importanza 78 Dal punto di vista militare , analogo discorso può essere fatto per la discussione sulla legge che prevedeva la «Estensione a tutto il Regno della legge 19 ottobre 1859 sulle servitù militari»: discu ssione che (se dal punto di vista politico era assai importante per gli innumerevoli interessi so ciali che una legge sulle servitù militari sempre solleva ) 79 non vide alcun impegno dei deputati militari o comunque di deputa t i con in te ress i militari .
In questo periodo le assisi parlamentari erano poco adatte ad una discussione sulla politica militare del general e novarese.
Inoltre, proprio a livello parlamentare , Ricot t i pareva di nuovo avvantaggiarsi di quella sorta di 'tregua' che la Camera gli aveva già concesso qualche mese prima (subito dopo la sua nomina) , in sintonia con il più generale allentamento della tensione e del dibattito politico. Esemplare il caso delle discussioni finanziarie del febbraiomarzo 1886 .
Certo, anche nel1 886 , Ri cotti e le spese militari erano nel mirino degli oppositori: tra cui si possono ricordare Gi olitti co me Pleba-
76 Cfr. CAROCCI , Agoitin o Depretù e la politica in terna da/1876 a/1887, cit., p. 623.

77 Cfr. AA. PP. , Camera, Leg isl. X V, sess. unica , Discussioni, to rnat a del 7 aprile 1886. Anche questa volt a Ricotti s i trovò di fronte le critic h e più acute n o n in Aul a ma in sed e di Comm iss ione esamin atrice. Cfr. ACD , Dd/, Lcg isl. XV , sess. unica , reg 4 1 2, n 397, Ve rbale di seduta della Comm ission e, 11 febbraio 1886.
78 Cfr. AA. PP ., Camera, Legisl. XV, sess. unica, Dùcussioni, tornata del9 aprile 1886.
79 AA. P P., Camera, Legisl. XV , sess. unica, Discussioni, tornata del 7 aprile 1886 e sgg. Sulla vicenda politica delle servitù militari cfr. G. OUVA , Esemio e territorio legislazion e sulle servitù militari 1859-1932 , in cRivista di scoria con te m po ranea», a. X ( 198 1), n. 2
UN ESERCITO PER RIC01TI 9)
no, Sonnino come Bacca rini, Di Rudinì <:ome Bovio so. Ma quello che ancora veniva criticato non era tanto la spesa militare in sé (il 'militarismo', di cui comunque si iniziava a parlare) bensì la disaccona politica finanzi aria di Magliani. Non si accusava tanto Ricotti, quanto il Ministro delle Finanze. Non si criticava il fatto di destinare imponenti risorse all ' esercito, bensì la politica di Magliani che- dopo aver promesso alle Camere che quelle risorse finanziarie c'eranotornava a dire che invece non erano disponibili. Esemplare il discorso del deputato Parenzo , da questo punto di vista: in Italia si è voluto fare la grande politica senza avere la grande finanza , eg li disse: quindi o politica o finanza, o Depretis o Magliani 81 Il che non toglieva che, potendo, si sarebbe gradita invece sia una finanza robusta, sia soprattutto la politica estera ardita e la 'politica di potenza'. Ancora più esplicito fu il democratico Seismit Doda che, pur schierandosi contro la finanza di Magliani e contro il governo di Depretis, affermò che «la Camera accetta le spese militari» 82
Ecco perché se in quelle arroventate sedute Magliani fu costretto a replicare più volte , a spiegare e a difendersi, Ricotti nemmeno prese la parola. E quando anche il Ministro della Guerra prese la sua dose di critiche (né nuove né più pungenti di quelle prima ricordate) fu addirittura Depretis che lo difese . A chi accusava le spese militari quali una delle cause del deficit il presidente del Consiglio rispose che, con la crescita della nazione , una crescita delle spese militari era ovvia ed indispensabile. E a quei pochi che avevano chiamato in causa la persona di Ricotti , Depretis , rivolto ai 'politici' ed alla Camera, disse: «Ricotti? Ma se è sempre stato il vostro beniamino! Siete voi che me lo avete indicato ... » 83 Ricotti, insomma pur bersagliato dalla polemica di vari ambi enti politici e militari, polemica che proprio in quei mesi era destinata a crescere, passava così quasi indenne dalle discussioni finanziarie della Camera, la quale non processava il suo Governo per la 'politica di potenza' e di alte spese militari bensì per il loro fallimento. La verità sulle spese militari, involontariamente, era invece uscita dalle parole del deputato Vacchelli, che però nessuno aveva ripreso. Si faceva il processo al deficit ed alla politica finanziaria di
80 Cfr. AA.PP. , Camera, Legisl. XV, sess. uruca, Di.rcumoni, tornate dal 22 febbraio al 5 marzo 1886.

8! Cfr. ivz·, tornata del 2 marzo 1886.
82 lvi, tornata del l marzo 1886. lvi, tornata del 5 marzo 1886.
96 POUTICA E POUTICA MIUTA RE
Magliani che lo aveva creato? Ma, rispondeva ingenuamente il ministeriale Vacchelli, «tutte le spese in più si riducono a quelle militari ( ... ). Questa è la colpa del Ministero, se colpa è. Per me non è colpa; e credo di aver concordi tutti i patrioti, da Minghetti a Crispi» 84. Nessuno allora, invece, voleva accorgersi che le 'spese in più', erano quelle militari. Qualche anno più tardi, chiusasi l'esperienza del trasformismo, una simile 'distrazione' dell'intera classe politica e parlamentare italiana sarebbe stata impensabile.
Per intanto, significativamente, proprio quando sul versante politico sembravano accettate spese m i litari e 'sosta' di Ricotti, il Ministro della Guerra doveva incassare un altro, durissimo attacco politico su quello militare. Il generale Mezzacapo, dall'Aula del Senato dove era venuto in discussione il progetto di legge di Ricotti su avanzamento e reclutamento degli ufficiali, era tornato proprio in quei giorni a sparare bordate contro la Pilotta 85.
Il tema era troppo tecnico, l'oratore ormai troppo chiacchierato come candidato anti-Ricotti e la sua efficacia politica fu quasi nulla. Ma vasta fu la risonanza all'interno del mondo militare .
Se anche i deputati militari tradizionalmente più critici verso la gestione Ricotti non erano intervenuti nelle discussioni finanziarie alla Camera , doveva essere un segnale significativo il fatto che praticamente nessuno degli altri deputati 'in divisa' (nemmeno quelli reputati più affidabili e 'ministeriali') aveva speso una parola per sostenere l'operato del Ministro.
Se anche per allora, come si è visto, Ricotti aveva usufruito di una sotta di tregua politica da parte d eli' opposizione (in occasione delle discussioni finanziarie), era un dato di fatto che il deficit cresceva e che le spese militari rimanevano sino ad allora le più alte della storia dell'Italia postunitaria. Questo da pane politica non avrebbe potuto essere ignorato ancora a lungo; sarebbe venuto il momento in cui il Ministro della Guerra sarebbe stato chiamato a dover rispondere di fronte ai politici e alla classe politica di come queste spese venivano effettuate e con quali risultati.

Allora, l'avere alle spalle un ambiente militare scontento- come si sarebbe potuto dedurre da quel diffidente silenzio dei deputa-
84 Cfr. ivi, tornata del 25 febbraio 1886.
85 Cfr. AA.PP., Senato, Legisl. XV, sess. unica, Discussioni, tornata del 3 aprile 1886. A proposito di alcune risonanze e riprese del forte discorso di Carlo Mezzacapo, cfr. cl'esercno italiano:., 4 febbraio 1886 , La legge di avanzamento in Senato; ivi, 13 aprile 1886 La legge sull'avanzamento in Senato e fuori; ivi, 23 aprile 1886, Di alcuni provvedimenti per risolvere la questione dell 'avanzamen to.
UN ESERCITO PER RICOTTI 97
ti militari - avrebbe potuto riservare al Generale novarese brutte sorprese.
Ma, in quei primi mesi del 1886, forse si pensava ancora poco all'importanza di un simile rendiconto. La classe politica e l'opinione pubb l ica, stancata dagli inutili e vuoti dibattiti parlamentari, attendeva solo la fine della legislatura.
D'al tra pane, si andavano ponendo due elementi nuovi nel dibattito politico generale: la consapevolezza delle dimensioni che andava prendendo il deficit statale e il rafforzamento di un'opposizione di Destra in seno allo stesso trasformismo. Proprio nelle discussioni che avevano accompagnato l'esame dello schema di assestamento del bilancio dello Stato per l'esercizio finanziario 1885-86, svoltesi tra il febbraio ed il marzo del 1886 , si era assistito ad un vistoso indebolimento della maggioranza trasformista ed a un notevole rafforzamento delle opposizioni di Sinistra (Pentarchica) e soprattutto di Destra (dissidente). Lo stesso assestamento era staco approvato nella votazione nominativa con soli 14 voci di scarto 86.
Si preparava, così, la crisi del trasformismo di Deprecis. Si arrivò però alle el ezioni del maggio 1886, in un momento di stallo e di distacco dalla politica 87. Cosa avrebbe guadagnato il trasformismo di Deprecis da quella scadenza elettorale?
Era quella una domanda la cui risposta avrebbe potuto essere importante anche per i margini della politica militare di Ricotti.
86 Cfr. ancora Storia del Parlamento italiano, v. VIII, La Jinistra al potere, cit., p. 417.
87 Cfr. AA.PP., Camera, Legisl. XV, sess. unica, DircuJJÌoni, tornata del 5 marzo 1886.

98 POLITICA E POLITICA MI LITARE
CAPITOLO SECONDO
I PROBLEMI MILITARI
Ali' interno di una certa tradizione di studi di storia militare, la parte centrale di qualsiasi ricerca finiva non di rado per incentrarsi sull'esame di quello che veniva definito 'il problema militare'.
Un'epoca storica, un torno di anni, la vita di un comandante, un dibattito politico, una generazione di ufficiali: tutto ciò era visto alle prese con un suo problema militare. Per non parlare poi di quelle ricostruzioni della storia militare fatte attraverso il susseguirsi di famose battaglie viste come (e ridotte a) m ere manifestazioni dell'apparire di un sempre nuovo 'problema militare', dall'arco lungo alla mitragliatrice, all'arma totale.
Talvolta una simile impostazione può essere forzata dalla limitazione dello spazio editoriale e tipografico a propria disposizione, o consigliata da un intento esemplificativo , piuttosto che scientifico e analitico. Più spesso essa appare solo come un retaggio della storia insegnata negli Istituti d'istruzione militare, un qualcosa di più vicino ai forzatamente sintetici capitoli dei manuali o delle 'sinossi' di storia militare delle Accademie piuttosto che a vere ricerche storiegrafiche, documentate ed esaurienti.
Troppo spesso, la storia ideale dei 'problemi militari' ha trascurato la storia concreta e materiale , isolando eventi e vicende che invece possono essere comprese solo se illuminate in uno sfondo più vasto, non solo nel quadro della storia politica 1 ma nello scenario più largo della storia delle strutture degli Stati e delle società.
1 Secondo quanto proponeva il titolo di H. DELBRUECK , Geschichte der Kn'eg · skunst, Berlin, 1899-1920 (adesso disponibile in una traduzione inglese ID., History of the Art of War within the Framework of Politica/ History, Westport , Cono., London , UK, Greenwood Press , 1975-1982). Ridimensiona l'apporto mecodologico di Delbrueck RITfER, I militan· e la politica nella Germania moderna. Da Feden'co il Grande alla prima gue"a mondiale, ci t., definendolo «Storico e pubblicistll'» (p. 479 , nostra sottolineatura) e rimproverando alla sua opera di essersi in sostanza «limitata unilateralmente alla tecnica mili tare:., massime neUa nota contrapposizione logoramemo/aonien-

Una tale esigenza, solo in anni non lontani compiutamente sentita, trova punroppo nelle pagine che seguono solo qualche indiretta e lontana eco. Si è cercato soltanto, per adesso, di esaminare alcuni problemi dell'ordinamento militare italiano alla metà degli anni Ottanta non solo dall'interno delle richieste delle Commissioni dei generali e non solo seguendo l'evoluzione delle proposte suggerite dalla pubblicistica militare; ma- per quanto era possibile ad una ricerca come la nostra (ritagliata in un ristretto arco cronologico)si è cercato di notare come sulla percezione, sull'esame e sulla soluzione di quei 'problemi' da parte dell'esercito influissero motivi ed elementi non solo militari, bensì anche e più esplicitamente politici, sociali, istituzionali ed anche talvolta riconducibili al solo 'spirito di corpo'. Si è tentato quindi la via della ricostruzione non del solo 'pensiero militare' (che, così astrattamente inteso, è ancora da dimostrare se effettivamente esisté) ma dell'interagire dei diversi soggetti più o meno attivi della politica militare del tempo.
Ma quale tempo? Nel concreto caso da noi esaminato, la tradizionale autonomia conquistata dalle gerarchie militari italiane ali' interno della classe dirigente si combinava con l'atmosfera parlamentare contingente del trasformismo. Ne sortiva così un rapporto tra esercito e politica non limpido, fatto di manovre e di collimanze, di patteggiamenti e di concessioni - in tema di sistema fortificatorio, di orientamento strategico, di rapporti tra le due maggiori forze armate.
Su taluni di questi problemi si era sviluppato, tra il 1870 ed il 1876 ed anche dopo, un interessante dibattito pubblico tra militari come tra militari e civili: esemplare il caso delle fortificazioni, nei primi anni '70. Un dibattito ampio e vivace, non sempre informato e concreto, ma assai importante anche per il solo fatto di essere pubblico. Sarebbe però vano cercare, negli anni della seconda permanenza di Cesare Ricotti alla Pilotta, qualcosa di simile su quei temi. Il dibattito militare era tornato a correre su binari in un certo senso più burocratici e 'interni'. Si incontrava ancora, talvolta, vivacità e contrasto di opinioni: ma i 'problemi militari' sia pur secondo logi-
tamento e di non aver preso «maggiormente in considerazione il rapporto tra politica e condotta dell'esercito• (p. 44). Per un elogio dell'opera di Delbrueck e del suo ruolo nello sviluppo e nell'arricchimento della storiografia militare cfr. invece P. PIER!, Il legame fra guerra e politica dal Clausewitz a noi, in Relazioni, v. I, Metodologia. Problemi generali. Scienze ausiliarie dei/a storia, a cura della Giunta Centrale per gli Studi storici, Firenze, Sansoni, 1955 (in testa al front.: Comitato internazionale di Scienze storiche. X Congresso internazionale di Scienze storiche), pp. 309-318.

100 POLITICA E POUTICA MILITARE
che spesso trasformiste dovevano tornare ad essere affare dei soli militari.
Dzfese, fortificazioni e cinte
Nella questione delle fortificazioni Ricotti incappò quasi subito, poco dopo nominato Ministro. Non era stato il novarese a sollevare la questione: si trattava di far approvare al Parlamento un progetto di legge per il finanziamento di grandi lavori di fortificazione nazionale, già presentato da Ferrere 2 . Ma anche in quella occasione Ricotti trovò il modo di far passare alcuni suoi personali concetti.
Sul problema strategico e militare di quante fortificazioni costruire, di dove situarle e di come utilizzar! e c'era sempre stato in Italia un vivo dibattito. In questo confrontarsi di opinioni, Ricotti si era sempre attenuto ad alcune sue idee fisse. Egli avrebbe voluto - in contrasto con l'altra (prevalente) tendenza militare - poche grandi fortificazioni, dal momento che queste gli apparivano troppo onerose per le casse dello Stato, pericolose per l'uso controffensivo che ne avrebbe potuto fare l'avversario (una volta che se ne fosse impadronito) e dannose per quella sorta di sfiducia che a parer suo infondeva nei comandanti militari e nella truppa l'avere nelle prossimità del cruento campo di battaglia una sicura e comoda piazzaforte presso cui ricoverarsi 3.
Forse, di tutti questi aspetti, quello economico era l'elemento determinante 4.
Nel 1880 egli aveva di nuovo chiarito, durante le r1unioni della Commissione suprema per la difesa dello Stato, il suo concetto. Di fronte a tanti generali che auspicavano comunque la presenza di un
2 Cfr. di nuovo MINN1TI, Esercito e politica da Porta Pia alla Tdplice Alleanza, cit., p. 104 e sgg.

3 Cfr. AUSSME, Ordinamento e mobilitazione, racc. 68, fase. 2, alla data del 25 novembre 1880, p. 6. Il dibattico pubblico, tra i militari, dovette cedere il passo alle riunoni della Commissione dei generali. Scarse conseguenze concrete dovevano avere , verso la metà degli anni Ottanta, interventi talvolta critici come quelli di A. ARALDI, Gli errod commessi in Italia nella difesa dello Stato: appunti, Roma, 1884 o di G.B. BRUZZO, La difesa dello Stato: poche osservazioni, Roma, 1884 o ID. , Altre osserva· zioni sulla dzfesa dello Stato, Roma, 1884.
4 Cfr. ivi, fase. 5, alla data del4 febbraio 1882, p. 14. Ricotti vi sosteneva ua l'altro che non era possibile .:preservare in modo assoluto una piazza dal bombardamento senza darle uno sviluppo sproporzionato ai danni che da un bombardamento possono derivare•.
I PROBLEMJ MILITARI 101
alto numero di grosse piazzeforti, da erigere o da riadattare, il novarese aveva provocatoriamente sostenuto essere sufficiente un'unica base la quale possa opportunamente funzionare ad un tempo come base principale tanto nell'ipotesi di guerra coll'Austria, quanto in quella con la Francia, senza escludere anche il caso di una violazione della neutralità svizzera 5.
Così facendo, «senza incorre re nell'inconveniente di moltiplicare le piazze da guerra:. 6, si sarebbe potuto alleggerire il carico di spese immobilizzato nelle opere di difesa pe rmanente, indirizzarne una parte verso l 'approntamento di qualche fortificazione imp rovvisata, e sop rattUtto dirottarne il grosso verso l'esercito mobile, verso la Fanteria.
Negli anni Ottanta un sim i le modo di vedere, se pure p oteva sembrare 'attuale' quando sotto li n eava l'esigenza di spend ere mo l to per l'esercito mobile (e qui la vocazione 'numerista' del novarese lo soccorreva assai bene) era de l tutto inadeguato rispetto ai p rogressi raggiunti nell'arte fortificatoria da parte delle altre forze armate europee 7 ed appariva al mondo militare italiano un concetto attardato e conservatore.
Q u ando Ricotti fu nominato Ministro, ci fu nell'ambiente militare qualche segno di apprensione. Proprio i n quei mesi infatti sarebbe stato appunto discusso in Aula il progetto di legge che recepiva Je con clusioni delle riunioni in tema di fortificazione della Commiss i one per la Difesa dello Stato (in cui il novarese era stato p i ù volte messo in minoranza dai suoi colleghi generali) s. Avrebbe i l nuovo Ministro sovvertito quel disegno di legge?
A Ricotti in realtà non restava altro che tradurre in legge il progetto. E sul momento si limitò di effettuare comunque alcuni storni

5 Ancora da ivi, fase. 2, alta data del 25 novembre 1880, p. 6.
6 Ibidem.
7 Alcune brevi note su questo complesso tema , in A. FARA, L'archtiettura e la cultura militare dell'Ottocento nella Roma Capitale d'Italia, in A. FARA, C. ZANELLA, La città dei militan·. Roma Capitale nell'Archivio dell'ISCA G. Roma, Kappa, 1984, pp. 7-9.
8 Cfr. gli stessi verbali della Commissione per la Difesa dello Stato sin qui utilizzati, in varie occasioni. Non è un caso se Ricorri fu messo in minoranza, o votò da solo, per un numero maggiore di volte quando- dal 24 settembre al 13 dicembre 1882la Commissione esaminò il possibile quadro strategico di opera.zione all'interno del territorio della penisola, dove l'uso delle fortificazioni permanenti sarebbe stato determinante. Cfr . i11i, racc . 4, fase. 6, alle date del 25 settembre, del 4 dicembre e del 13 dicembre 1882. Appena pochi mesi prima era stato firmato il trattato della Triplice Alleanza
102 POUTICA E POUTICA MIUTARE
ua i vari capitoli, spostando fondi finanziari dalla difesa interna verso la difesa delle coste 9.
Un tale comportamento di Ricotti non dovette però rassicurare del tutto quegli ambienti e quei militari che invece annettevano una grande importanza alla presenza di un artico.lato sistema fortificatorio, anche perché- durante l'esame in Aula del progetto di legge - il Ministro non perse l'occasione di ribadire pubblicamente le proprie idee sull'argomento.
Valorizzazione delle forze vive dell'organismo militare, rafforzamento delle compagnie, ruolo insoscituibile della Fanteria (del fattore uomo, cioè) nella probabilità di una grande battaglia nella pianura al di qua delle Alpi. Una riaffermazione, insomma, del concetto (che per Ricotti era un programma) del tutto-esercito, dell'esercito mobile, d eli' esercito unico pilastro per la difesa del Paese: da cui scarso ruolo per le fortificazioni, alla Marina la difesa delle acque territoriali e all'esercito persino il controllo dei punti-chiave del litorale 10_
Ma queste tesi non erano le uniche presenti nel dibattito militare in tema di fortificazioni. Ché anzi altre vi si contrapponevano, sostenute da militari più convinti delle teorie germaniche dell'offensiva e preoccupati dell'importanza del fattore tecnico (armamenti, Armi speciali) piuttosto che della sola forza del 'numero'. E proprio in quei giorni, l'ambiente militare doveva presentarsi niente affatto allineato sulle posizioni del Ministro.
Lo stesso progetto di legge che Ricotti fece approvare, frutto delle riunioni della Commissione per la Difesa dello Stato, prevedeva un numero assai alto di fortificazioni da costruire: ceno un numero più consistente di quanto avesse voluto Ricotti, che durante i lavori della Commissione aveva avanzato opinioni eterodosse da quelle poi risultate definitive 11.
Inoltre, qualche mese prima della discussione parlamentare, lo stesso Cosenz, Capo dello stato maggiore, invece di favorire la tendenza ministeriale al disimpegno dal tema delle difese fisse, aveva
9 Come già ricordavamo , cfr. VENTURINI, Militan· e politici nell 'Italia umbertina, cit., p . 195 .

1° Cfr. AA.PP. , Camera , Legisl. XV, sess. unica, Discussioni, tornata del 28 maggio 1885.
11 Cfr. anche il solo AUSSME , Ordinamento e mobilitazione , racc , 298 , fase. l, dove è conse. rvato il testo del Piano generale delle fortificazioni per la Difesa dello Stato nella versione in cui fu presentato alla Commisione esaminatrice della Camera nel maggio 1884, in vista dell'approvazione del relativo progetto di legge.
l PROBLEMI MILITARI 103
scritto a Ricotti, chiedendo una maggiore attenzione e varie migliorie tecniche per le fortificazioni militari (per esempio, incremento delle razioni viveri che avrebbero dovuto, in caso di conflitto, servire all'alimentazione delle truppe e che secondo lo SME erano invece del tutto insufficienti, quando non addirittura mancanti, etc.) 12
Infine , proprio in quei giorni, il deputato militare Pozzolini, addetto allo SME, aveva pubblicamente sostenuto nel dibattito parlamentare che le fortificazioni erano strumenti essenziali e irrinunciabili di qualsiasi strategia militare: la quale avrebbe dovuto prevedere, oltre alle battaglie e alle vitto rie , anche i possibili «momenti difficili:• - e quindi la necessità di ricove ri per le truppe 13.
Ma il dato più interessante della vicenda non pare tanto questo -sia pur talvolta dimenticato 14 - contrasto di opinioni all'interno dei militari, quanto il fatto che trasformisticamente proprio uno dei militari che più era stato contrario alle fortificazioni fu poi il Ministro che ne avviò un importante programma di costruzione. In questo senso, le affermazioni fatte in Parlamento da Ricotti parevano più tese a depistare l'opposizione politica al progetto (e alle spese militari di cui quelle fortificazioni necessitavano) che a proclamare un indirizzo di politica e stra tegia militare.
Vi furono, è vero, militari che negli anni successivi accusarono il Ministro di aver ritarda to, frenato o bloccato il programma di fortificazione nazionale 15. E non è improbabile (anche se non si è reperito ancora una sufficiente documentazione al riguardo) che qui e là Ricotti abbia lesinato fondi per costruire forti e piazzeforti. Certo, comunque, è il sostanziale fatto per cui, proseguendo quel gioco delle parti e quel 'rimescolarnento delle cane' che è già stato notato 16, gli ultimi anni del trasformismo videro i militari impegnati in un notevole sforzo edificatorio proprio quando il Ministro della Guerra in car ica vi si professava pubblicamente contrario. Quanto questo doveva creare disorientamento nei rapporti tra
12 Cfr. AUSSME, Ordinamento e mobilitazione, racc. 123, n. l, 2 febbraio 1885, Ris., Cosenz a Ricotti, Mem ona .
13 Cfr. AA.PP., Camera, Legisl. XV, sess. unica , Discussioni, rornata dd l giugno 1885.
14 Cfr. MINNITI, Esercito e politica da Porta Pia alla Triplice Alleanza , ci r. , p 107.

15 Ma non era la prima volta: cfr. F. CERROTI, Le fortificazio ni di Roma e il si· stema di direzione dei lavon· pubblici militan·, Roma, Bodoniana, 1882.
16 Cfr. DEL NEGRO , Esercito, Stato, società. Saggi di stona militare, ci t., p 256.
104 POUT!CA E POUT!CA MIUTAR.E
politic i e militari, ed anc h e all'interno del dibattito militare, è cosa che va da sé .
. Una analoga serie di compromessi e patteggiamenti tra teoria e prassi, tra convinzioni personali e ambito d eli' amministrazione militare, tra riserve mentali e realtà dello sviluppo dell'esercito e del potenziale militare (che coinvo lgono quindi la figura di Ricotti molto oltre quella immagine di 'M inistro anti-Fe rrero' o 'anti-Sinistra ' o 'anti- Mezzacap o' che egli voleva accreditare e che talvolta è stata ripresa) la si può ved ere ope rante anche nella questione- più delimitata ma meno conosciuta - delle fortificazioni della Capitale. Che l a costru zione di un grande campo trincerato intorno a Roma fu una de ll e più importanti real izzazioni della politica militare della Sinistra appena giunta al potere è cosa sufficientemente nota 17. È anche noto come questa sce lta , costosa ed impegnativa , fu l 'ul tima propaggine di quel complesso movimento europeo che portò l'architettura e le scienze militari a fortificare le capitali degli Stati nazionali 18. Ed anche qui è stato ricordato, infine, l 'attegg i amento di netta critica espresso a questo proposito, già nel 1877, da Ricotti nel quadro allora della sua vigorosa campagna contro Mezzacapo, Ministro della Guerra del primo governo della Sinistra storica.
Comunque fosse, il campo trincerat o e la l inea dei forti poteva dirsi largamente completata nel 1884, quando il gene rale novarese assunse per la seconda volta il Ministero della Guerra 19. A questo punto era presumibile che il nuovo Ministro avrebbe defmitivamente bloccato i lavori. Ma non fu esattamente così.
La documentazione non è, in questo caso, così prec isa com e vorremmo; la stessa datazione degli eventi non è, nelle fonti rintracci ate, semp re accettabile. La questione, insomma, necessita di nuovi e più approfonditi studi.
Ma rimane - ed è notevole comunque - il fatto ch e proprio negli anni del secondo Ministero Ricotti furono avviati gli studi (ed effettUati certi primi lavori) per la costruzio n e di una cinta muraria 20
17 Cfr. MINNITI , Esercito e politica da Porta Pia alla Tnplice Alleanza, cit., p. 48 e 51. All'origine, rimane sempre il giudizio di CORSI. Italia 1870- 1895 , cit., p. 162 e sgg

ts Cfr. le ricerche di Fara
l 9 Cfr. AUSSME , Ordinamen to e mobilitazione, racc. 273. Ad un primo esame anch e taluni documenti conservaci presso l ' Archivio ISCAG , armadio A , racc. 39, Fortificazioni dì Roma , forniscon o varie conferme in tal senso Ma le cane ISCAG attendono da tempo un qualche ordinam e nto
2° Cfr. AUSSME, Ordinamento e mobilitazione , racc. 273, in cui è reperibile una lunga memoria (con allegati) su l forti di Roma , databile al 19 11 circa.
l PRO BLEMI MIUTARJ 105
che in parte collegasse i forti già eretti ed in parte anche se ne discostasse, ampliando così il diametro della piazza della Capitale. Studi e lavori, quindi, che non solo non limitavano lo spazio spettantenella strategia italiana del tempo - alle fortificazioni ed alla difesa, ma anzi lo rilanciavano in un punto delicato ed importante quale era la sicurezza della capitale del Regno. Cosa questa, come ben si vede, assai diversa da quelle verbalmente proclamate da Ricotti.
Un ennesimo segno, si porrebbe dire, del trasformismo dei tempi.
La costruzione di una tale cinta, in realtà, contrastava abbastanza apertamente con l'impostazione che la Sinistra (e da pane militare, il Ministro Mezzacapo e l'ingegnere militare colonnello Bruzzo) aveva dato all'ipotesi della difesa della Capitale. Nel 1877 si era infatti pensato, con la linea dei forti, di difendere Roma da colpi di mani improvvisi da parte dell'avversario, da sbarchi subitanei la cui entità si presumeva non superasse quella di una divisione o di una divisione rinforzata 21 ; nel 1885-1886, invece, il silenzioso avvio della costruzione di una nuova e più larga cinta muraria intorno a Roma appariva comprensibile solo nel senso di una difesa prolungata della capitale da attacchi di forze avversarie di entità superiore, sino e oltre quella di un corpo d'armata.
La costruzione di questa cinta, inoltre (se anche vi si era fatto qualche accenno in proposito, nel corso delle riunioni della Commissione per la Difesa dello Stato), pare essere stata avviata del tutto al di fuori di un adeguato controllo parlamentare 22. Quasi nulli, ad esempio, furono gli accenni fatti dai militari a questi lavori nella discussione parlamentare del progetto di legge sulle servitù militari 23, che pure vide mobilitata gran parte dell'aristocrazia romana e dei possessori di terreni confinanti con la capitale, in difesa dei propri interessi intaccati dalle necessità militari 24.
Varie possono essere le spiegazioni di una simile mossa. Si potrebbe pensare così ad una sona di 'inerzia' dell'istituzione militare (dopo il campo trincerato, anche la cinta muraria) se la correzione del punto strategico di fondo non fosse stata di così rilevante entità.
21 Cfr. ivi.
22 Cfr. ivi.
23 Forse solo vaghi ed imprecisi accenni del relatore Taverna. Cfr. AA.PP., Camera , Legisl. XV, sess. unica, Discussioni, tornata dell ' 8 aprile 1886.
24 Cfr. i documenti (tra cui una lettera di protesta fumata dai più noti nomi dell'aristocrazia capitolina , Tanlongo in testa) conservati in ACD , Ddl, Legisl. XV , sess. unica , reg. 413, n. 408 , Allegati a Verbale di seduta della Commissione.

106 POUTICA E POUTJCA MILITARE
Si potrebbe anche ipotizzare una sona di 'rivincita' politica di Ricotti, del Ministro 'della Destra' sui Ministri (come Mezzacapo) 'della Sinistra', se non fosse che una tale spiegazione dice troppo e troppo poco. Certo è che Ricotti- più di altri militari- temeva in quegli anni l'eventualità di consistenti sbarchi militari francesi sul litorale tirrenico 2 5. Un'eventualità forse possibile: ma che appariva ad altri (ad esempio, lo stesso von Moltke, da Berlino) cenamente esagerata 26_
Sia pure nel necessario richiamo alla necessità di nuove ed approfondite ricerche su questo aspetto (ceno non fondamentale, ma pure significativo), pare probabile che varie potrebbero quindi essere le spiegazioni di questo passo dell'amministrazione Ricotti. Un passo silenzioso ma non senza conseguenze, se (come sembra di capire dai documenti) questa nuova cinta muraria intorno a Roma impegnò le finanze statali ed il genio militare di Roma sino a tutto il decennio giolittiaoo 27.
Fatto sta che, anche in questa occasione come in altre, Ricotti per qualche vario motivo (fosse esso politico o parlamentare o militare o personale), acconsentiva trasformisticameme a transigere su alcuoi aspetti centrali del suo pensiero. La politica militare italiana, sotto Ricotti ma quasi nonostante Ricotti, seguiva autonomamente il suo corso.
Tra difensiva ed offensiva: la prima Triplice e l'Italia militare
Tutti i manuali di storia militare convengono sul fatto che con la stipulazione nel maggio 1882 della Triplice Alleanza tra Germania, Austria-Ungheria ed Italia si aprì per la politica estera e per la politica militare italiana un orizzonte nuovo 1
25 Cfr. AUSSME, Ordinamento e mobilitazione, racc. 68, fase. 2, 25 novembre 1880, p. 7.
26 Cfr. MINN1TI, Esercito e politica da Porta Pia alla Tnplt'ce Alleanza, cit., p. 222. D'altra parte, secondo gli studiosi di sroria militare marittima, il problema della difesa delle coste e delle misure antisbarco era gravissimo. Cfr. M. GABRIELE , G. FRJZ, La flotta come strumento di politica neipnmi decenni dello stato unitario italiano, Roma, 1973, passim

27 Cfr. ancora , AUSSME , Ordinamento e mobilitazione, racc. 11.
1 Cfr. BAVA BECCARIS, Esercito italiano. sue ong,im: suo successivo ampliamento , stato attuale, cit.; MAZZETII, L'esercito italiano nella Tnplice Alleanza, cit., p. 28; L'esercito italiano dal l • tncolore alz• centenano, cit., p. 189 (il volume è poi :stato ristampatO col tirolo L 'esercito e i suoi corpi. Sintesi ston'ca, cir.).
I PROBLEMI MlLJTARI 107
Per la politica estera italiana la Triplice costituì un elemento di forza e di prestigio (sia pure con le limitazioni che un'alleanza dinastica e difensiva portava con sé, e con le frequenti oscillazioni e i vari 'giri di valzer' che la difesa di quegli interessi e di quelle ambizioni italiane non coperti dal trattato imponeva alla diplomazia di Roma) 2 . E su questo aspetto sono disponibili dei buoni studi, ancorché non numerosi.
Sull'influenza- diretta o indiretta- della Triplice sulla po litica militare italiana, invece, gli studi documentati e rigorosi sono assai pochi 3. La particolare d ifficoltà del tema. connessa alla necess i tà qi affrontarlo con una buona conoscenza delle vicende degli altri eserciti della Alleanza, ha sinora sostanzialmente inibito l e ricerche. A questo si deve poi aggiungere che quella influenza non deve essere ricercata in ogni, od in ogni importante, atto della politica militare dei diversi Paesi, dal momento che (fatta ovvia esclusione per le trattative che precedevano la firma dei rinnovi dell'alleanza e delle convenzioni militari ad essi allegate) la collabo razione diretta tra i vari eserciti «rimase sempre di superficie, mirlata dall'avversione degli austriaci e dalla scarsissima fiducia dei tedeschi verso l'alleato latino, e dalla riluttanza di tutte le parti ad un avvicinamento effettivo» 4 .
Almeno su un punto, però, è possibile e necessario dire qualcosa, nell'economia più generale di questa ricerca: su come, cioè, la dimensione internazionale della questione militare fosse percepita dall'esercito negli anni del secondo Ministero Ricotti, dai responsabili della politica m ilitare come dalla più vasta opinione pubb lica militare. Una tale prospettiva, naturalmente, sottolineerà i legami e le intersezioni tra motivi di politica militare ed elementi di politica interna.
2 Cfr. SALVATORELLI, La Triplice Alleanza 1877 -1912. Storia diplomatica, cit., p. 14, che parla anzi di una asserita del trattato:. (in realtà più ricercata da parte italiana che reale). Noto il duro giudizio di G. SALVEMINI, La politica estera dell'Italia 1871-1914 , Firenze, Barbera , 1944 , p. 58: cl'Italia si allea con gli Imperi centrali perché ha paura di averli nemici( ). Più che un trattatO di alleanza, è un trattato di vassallaggio•. Cfr. poi C. MORANDI , La politica estera dell 'Italia. Da Porta Pia all'età giolittiana, a cura di F. Manzotti , Firenze , Le Monnier, 1968; come anche A. TORRE , La politica estera dell'Italia dal1870 al1896, Bologna, 1959 Cfr. infine La politica estera dell'Italia negli atti, documenti e discussioni parlamentari dal 1861 al 1914, v. Il, t . 2 , 1883-1887, a cura di G. Penicone.

3 La ricerca di MAZZETII, L 'esercito italiano nella Triplice Alleanza, cit.• è stata giudicata da ROCHAT, MASSOBRIO , Breve storia dell'esercito italiano da/1861 a/1943 , cit., p. 121, «una cronaca minuta , ma priva di inquadramento critico•.
4 lvi, p. 121 , n. 2.
108 POLITICA E POLITICA MILITARE
Non tanto quindi l'esame di come la politica di un Ministro della guerra potesse influire sulla politica estera nazionale (o viceversa) ma semplicemente una lettura del complesso di piani e di aspirazioni, di idee e di miti che una prospettiva militare europea quale quella della Triplice poteva sollevare tra i militari italiani di quegli anni.
In questo senso, preliminarmente, va tenuto presente di che tipo di alleanza, di quale Triplice, si trattava allora. E proprio in questo senso, la scelta di limitare l'attenzione al solo periodo 1884-1887 (oltre che ovvia per un lavoro che si concentra sul secondo Ministero Ricotti) appare utile ed adeguata.
La Triplice, la 'prima nata infatti come patto difensivo e destinata a mantenere lo status quo europeo (al lora essa veniva chiamata, dagli Stati membri, 'Lega per la pace') 6, aveva avuto al suo inizio un valore solo relativo nel pensiero del suo massimo anefice, il cancelliere germanico Bismarck. La Triplice era infatti solo un coro llario , seppur imporrante, di quel suo piano di stabilizzazione euro pea che più naturalmente si sarebbe dovuto basare sul Dreikaiserbund, sulla lega dei Tre Imperatori di Germania, di Russia e d'Austria-Ungheria.
Il maggior punto di frizione diplomatica internazionale (nonostante il congresso di Berlino del 1878) a quel tempo era ancora la penisola balcanica, dove si presumeva si sarebbero prima o poi scontrati i conflittuali interessi di Austria e di Russia. Fu così che proprio in tema di interessi balcanici dovevano alla fine rivelare la loro intima contraddizione la Triplice A ll eanza e la Lega dei Tre Imperatori (conducendo, tra l'altro, quest'ultima alla sua pratica dissoluzione).
La Lega si basava sulla cooperazione austro-russa ; l' Alleanza era pensata in vista di una guerra austro-russa. La Lega era direna contro la Gran Bretagna: il suo scopo era quello di chiudere, con un. azione diplomatica conco rde , gli stretti agli inglesi; ne i termini della Triplice era spiegato che essa non era diretta contro l'Inghilterra e sia l'Austria-Ungheria sia l'Italia speravano in un suo evenruale aiuto 1 .
) Cfr. già L. SAlVATOREW, Dalla pn·ma alla uconda Tnplice, in «Rassegna di politica internazionale., a. 1936 , pp. 576-622, e ID. , La seconda Tnplice, in ivi, a. 1936 , pp. 800-820 (poi rielaborare in SALVATOREW, La Tnplice Alleanza 1877 - 1912. Stona diplomatica, cit. ). Più acute le note di CHABOD , Considerazioni sulla politica estera dell'Italia da/18 70 al1915. cit.
6 Cfr. A.).P. TAYLOR. L 'Europa delle grandi potenze. Da Metlernich a Lenin, (1954), Bari , Laterza , 1961, p . 389.
7 Ibidem.

l PROBLEMI MIUTARI 109
E non a caso, al momento del primo rinnovo della Triplice e sempre in tema di questioni balcaniche l'Italia propose e l'Austria accettò il noto trattato particolare che venne ad integrare quello dell' Alleanza. Rimaneva comunque il fatto che
la Triplice Alleanza sembrava un qualcosa di formidabile e complesso; ma la sua ponata effettiva era assai modeSta. In apparenza essa univa in un unico blocco l'Europa Centrale( ) ma in parole povere Bismarck accenava di difendere l ' Italia per tentare di placare il malcontento dell 'Austria-Ungheria nei con· fronti della Lega dei Tre Imperatori ( )
Inoltre egli sapeva che( ... ) ciò che essi [gli italiani] realmente desideravano era di essere riconosciuti come Grande Potenza, non di essere difesi dalla Francia 8
Tale vario insieme di questioni portò, proprio intorno al 1884, ad una ridefinizione dell'importanza della Triplice : ed ecco perché da questa data si può parlare di una seconda fase della 'prima Triplice'.
Il 1884 fu infatti un anno difficile per Bismark e ceno l'anno più difficile per la prima Triplice.
Scadendo infatti nel marzo la Lega dei Tre Imperatori (e già in questo l'Italia non poté non sentirsi esclusa ed isolata anche dalle sue recenti alleate), il Bundfu rinnovato, ma senza alcuna modifica al trattato originario, come fatto di pura amministrazione. Ciò rappresentò uno smacco diplomatico per Bismarck , che tanto aveva puntato su un asse preferenziale Berlino-Pietroburgo. Inoltre nel settembre 1884 fallirono a Skiernowice i tentativi del cancelliere tedesco di costituire in sostituzione del Bundun'alleanza co ntinentale anti-inglese che vedesse unite alle Potenze dell'Europa centrale anche la Francia repubblicana. Ma come i dissidi austro-russi avevano reso impossibile una valorizzazione del Bund, quelli franco-germanici impedirono il formarsi di una Lega continentale.
Alla fme del1884, quindi, Bismarck poteva contare solo sulla Triplice Alleanza per i suoi disegni di egemonia in Europa 9.
D 'altra pane all'incirca con il 1884 le cose stavano cambiando anche in Italia.
A Roma, già tra il1882 ed il1884, forti erano state le tendenze a non considerare esaurito lo spazio diplomatico italiano nella partecipazione alla Alleanza ma a considerare questa solo come un ele-
8 lvi, p. 386.
9 Cfr. R. ALBRECHT-CARRÉ, Storia diplomatica d'Europa 1815-1968. (1973). Bari , Laterza, 1968, p. 220.

110 POUTICA E POUTICA MIUTARE
mento, anche se il più importante, di una più vasta politica internazionale. A sostegno di queste tendenze, che non erano malviste dal presidente del Consiglio, stava il fatto che specifici interessi italiani (Mediterraneo, Balcani) erano rimasti estranei al testo ed allo spirito della Triplice de11882. A non voler restringere l'azione diplomatica italiana negli angusti margini dell'alleanza dinastica e conservatrice della Triplice doveva orientarsi persino il Ministro degli Esteri, Pasquale Stanislao Mancini, autorevole esponente della Sinistra, che pure aveva firmato il trattato costituente della Triplice. La debolezza politica, militare e diplomatica della prima fase della prima Triplice (e l'assai lacunosa 'copertura' diplomatica che essa forniva all'Italia)
è, infine, ben rappresentata dal fatto che fino a tutto il 1884 l' Austria considerò il fronte italiano come il più probabile scacchiere di guerra, posponendovi persino il suo fronte con la Russia lO_ Intorno al 1884, invece, mentre lo scenario internazionale mutava in senso avverso a Bismarck, in Italia l'asse politico della maggioranza parlamentare di Depretis si spostava sempre più verso Destra li , i tentativi di arricchire la politica estera italiana con temi non coperti dalla Triplice stavano sostanzialmente fallendo (è il caso, per esempio, della così detta 'politica mediterranea' di Mancini) 12 , lo stesso responsabile della Consulta veniva poi sostituito 13. La spedìzione di Massaua, pur realizzata grazie ad una sostanziale concordanza di interessi britannici e italiani, non aveva avuto gli effetti più larghi che forse Mancini aveva sperato e non aveva portato ad un ralliement anglo-italiano. Inftne lo stesso riemergere dei conflitti di interesse sui Balcani (che aveva già fatto fallire la rivalutazione del Bund) doV·eva costringere la politica estera italiana a riflettere sulla fragilità di una qualunque sua eventuale iniziativa autonoma: la crisi balcanica,
1° Cfr. SALVATORELU, La Tnplice Alleanza 1877-1912. Storia dzplomatica, cit., p. 78 e sgg.; e MAZZETII, L'esercito italiano nella Triplice Alleanza, cir p. 46.

11 Cfr. CAROCCI, Agostino Depretis e la politica interna dal1876 a/1887 , cit., p. 309.
12 Qualche accenno, ma insoddisfacenre, in C. ZAGHI , P.S. Mancini e il probletna del Mediterraneo 1884 -1885, cit Per l'origine , lontana, del componamento di Mancini (e delle varie tendenze della Sinistra del tempo), cfr. F. D'AMOJA, La sinistra e i problemi di politica estera, in «Rassegna storica toscana», a. XI (1965), n. l, pp. 39-76
13 Cfr. CHABOD, Storia della politù:a estera italiana dal1870 al1896, cit., pp. 687-702. Il passaggio delle consegne da Mancini a Robilam, mentre, coincise a livello politico e commerciale con un deterioramento dei rapporti italo-francesi. Cfr. E. DEL VECCHIO, Il fallimento delle trattative manttime tra Italia e Francia nel1886, in c StOria e politica», a. VIII (1969), n. 4, poi rifuso in ID. , Di Robilante la cn'si nei rapporti manitimi italo-francesi, cit.
l PROBLEMI MIUTARI 111
che sarebbe poi esplosa nel 1885-86, vide infatti quasi assenti le autorità diplomatiche italiane, emarginate come annullate di fronte allo scontro dei due colossi russo e austriaco 14.
In Italia, insomma, con l'acutizzarsi delle tensioni internazionali (in specie dopo il 1884) la Triplice Alleanza diveniva l'unica ancora diplomatica.
È per questo che è legittimo parlare, come avevamo fatto, di una seconda fase della 'prima Triplice': seconda fase che, cronologicamente viene a corrispondere per inte ro con il periodo di permanenza al Ministero della Guerra di Cesare Ricotti.
Vi fu, vi doveva essere, un adeguamento della politica militare o dell'orientamento strategico dell'esercito italiano, che pure da tempo aveva già trovato - come si è detto - la sua 'direzione precisa', alla mutata situazione diplomatica?
Pare questo, nella sostanza , il problema da porsi.
In questa sede non vale tanto tenta re un'esegesi diplomatica del testo del trattato per dedurne quanto le preoccupazioni e gli interessi militari delle varie potenze fossero alla base (e rimanessero poi operanti negli anni) della prima Triplice. Il preambolo al trattato proclamava la sua «natura essenzialmente conservatrice e difensiva» e, come è noto, sottolineava la necessità di «rafforzare il principio monarchico» e di «mantenere intatto l'ordine sociale e politico dei rispettivi stati» 15. Il trattato , più specificatamente, assicurava il casus foederis all'Italia ed alla Germania in caso di attacco francese, nonché ad uno qualsiasi dei contraenti, se impegnato in una guerra «con una o più grandi potenze non firmatarie del presente trattato»; impegnava poi alla benevola neutralità le potenze firmatarie se una di queste, anche se solo minacciata da un'altra grande potenza, «SÌ vedesse costretta a farle guerra». A questa serie di condizioni politiche e diplomatiche - tutte di spiccato carattere antifrancese - facev:1 seguito, a livello militare, solo un vago accenno (e con i verbi coniugati al futuro) ad una «eventuale cooperazione» tra i vari eserciti: ma niente più 16. Al momento della firma del trattato, infatti, le preoc-
14 Cfr. A . TAMBORRA, La crisi balcanica del 1885-1886 e l'italia, in «Rassegna storica del Risorgimento:., a. XLV (1968), n. 3.

15 Il testo del trattato della Triplice Alleanza è stato pubblicatO più volte, tra cui notO è G. CAPRIN, I trattati segreti della Tnplice Alleanza, Bologna, 1921. Noi citiamo dalla versione integrale pubblicata da G. PERTICONE , La politica estera italiana dal 1861 a/191 4, Torino, ERI, 1961 , p. 196.
16 lvi, p. 197.
112 POUTICA E POUTICA MIUTARE
cupazioni di Bismarck erano di ordine diplomatico più che militare, e da parte austriaca c 'era- nei confronti dell'Italia- quell'atteggiamento bellicoso cui si è già fatto riferimento.
Da parte italiana il discorso era diverso.
Se è vero che ciò che i circoli diplomatici e reali volevano era di vedere considerato il regno umbertino una grande potenza europea, è pur vero che l'ipotesi di una cooperazione militare italogermanica avrebbe potuto rappresentare una prima concretizzazione di quella 'potenza'. Questo obiettivo, però, pareva maggiormente sentito negli ambienti militari (e pure non in tutti) 17 piuttosto che da quelli diplomatici o politici, tra i quali anzi le manovre per la immediata definizione di una possibile cooperazione militare italogermanica furono lasciati cadere già alla vigilia del 1882 18.
Da parte germanica Bismarck come von Moltke, i politici come i militari- anche se per motivi diversi-, non parvero curarsi negli anni tra il 1882 ed il 1887 di mettere le basi per il raggiungimento di un accordo così impegnativo. A Berlino non si nutriva una grande fiducia nella solidità e nell'efficienza dell 'eserci to italiano. Inoltre un apporto militare da Roma, nel caso di una guerra contro la Francia, rischiava di porre ai tedeschi più problemi di quanti gli italiani avrebbero potuto risolvere con una loro spedizione sul Reno (ammesso e non concesso che fossero riusciti ad impegnare vittoriosamente, sulle Alpi o in Provenza, un consistente numero di unità francesi) 19 .
Nonostante che al momento della firma della Triplice l'esercito fosse stato (insieme all'ordinamento istituzionale monarchico) l 'unico concreto pegno diplomatico italian o 20, sferzanti furono per lungo tempo i giudizi germanici sulle forze armate del regno umbertino. E questo sebbene l'esercito (grazie alla sua larga ristrutturazione con le riforme Ricotti del '70-'76 ed all'incremento dell'intelaiatura del l 'ordinamento Perrero) fosse in fondo il principale elemento che legittimava e sosteneva l'aspirazione politica italiana al rango di 'grande potenza' europea 21.
17 Cfr., ad esempio , il ruolo diretto (ed indiretto, attraverso diplomaùci come Blanc) di un militare come Annibale Ferrero, quale ci è stato ricostruito da MINNITI , Eserczio e politica da Porta Pia alla Tnplice Alleanza , cit.
18 Non è senza significato che la manovra di Ferrero-Blanc sia poi, in fondo, fallita.
19 Lo stesso MAZZETII, L 'esercito italiano nella Tnplice Alleanza, ci t. , p. 35.
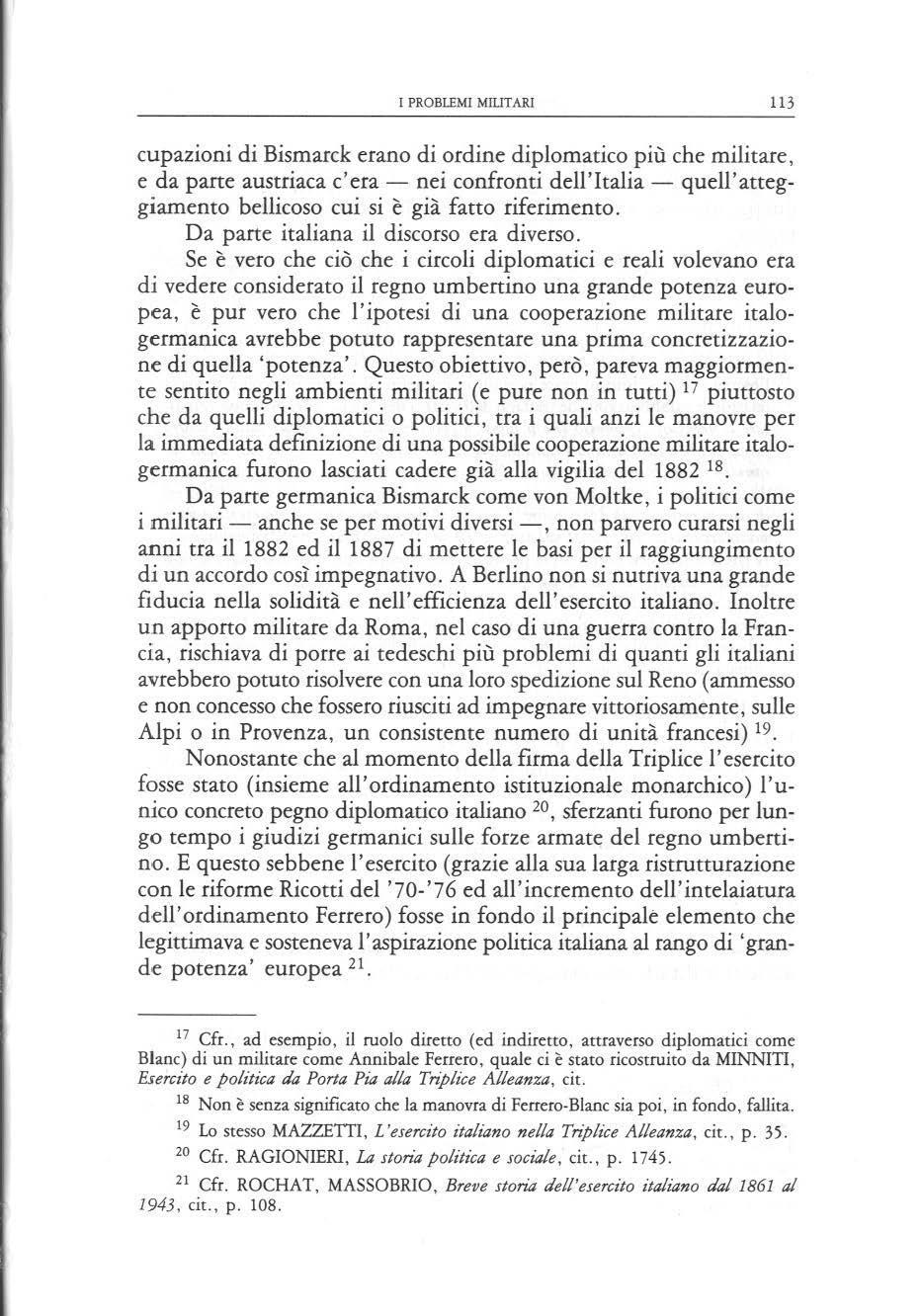
2° Cfr. RAGIONIERI, La stona politica e socÙJie, cit., p. 1745 .
21 Cfr. ROCHAT, MASSOBRIO, Breve stona dell'esercito italiano dal 1861 al 1943 , cit. , p. 108 .
I PROBLEMI MILITARI 113
Ciò che panicolarmente non piaceva, e non interessava, dell'esercito italiano ai militari germanici - da tempo propensi ad una guerra offensiva ad ovest e ad est- era il generale orientamento strategtco.
Nel 1882 cosi riassumeva il pensiero degli stati maggiori tedeschi l'addetto militare italiano a Berlino:
E del resto , soggiunge a mo' di chiusa [l'alto ufficiale germanico interpella· to dall'addetto italiano J quello che colpisce, astrazion fatta dall'ordinamento dell'esercito, è lo spirito militare portato unicamente alla difensiva come si rivela da tutte le pubblicazioni che trattano della difesa dell'Italia. Come vedremo mpettare il nemico? Ammesso che il nemico sbocchi dalle Alpi quale sarà la nostra ponzione? In caso di una prima battaglia perduta dove ripiegheremo, quali saranno i nostri punti d 'appoggio? Questi e simiglianti sono i quesiti che gli studiosi militari si propongono costantemente in Italia, né mai, mai fanno l'ipotesi dì una guerra al di là del confine. Che ci può importare a noi di un esercito buono solamente a combattere nel proprio paese? Il proclamare che l'Italia non aspira che a difendersi potrà essere politicamente opportuno ; ma militarmente non bisogna lasciarsi travolgere da questo concetto.
L'esercito tedesco, invero, ha carattere eminentemente offensivo, e nessuno dubita io Europa che, in caso di guerra, non istaremo ad aspettare l'avversario sul nostro territorio. In nessuna delle nostre pubblicazioni militari troverete formulata una simile ipotesi 22 •
Il primo appunto, insomma che dalla Germania giungeva all'Italia era proprio un appunto strategico.
In Italia, un simile appunto veniva a trovare orecchie sensibili.
È già noto come qui, forse sin dal 1870, ma certo dal 1878, si confrontassero a proposito dell'orientamento strategico diverse tendenze militari. Quello che emerge con chiarezza è che una di queste tendenze, che voleva fare della 'offensiva' e dello 'offensivismo' il principio ispiratore dell'organica e della strategia italiana 23, poté dopo il 1882 oggettivamente avvantaggiarsi di quegli sferzanti giudizi che da Berlino fioccavano - talvolta nel segreto dei rapporti degli addetti militari, talvolta apertamente dalle pagine dei giornali mili-
22 AUSSME, Addetti mzlitan Germania , racc. 2, fase. 2 , 14 febbraio 1882. Ora anche in MINNITI, Esercito e politica da Porta Pia alla Tnplz"ce Alleanza cit., p. 149.
l3 Cfr. ivi, pp. 47-58; e DEL NEGRO , Esercito, Stato, società. Saggi di stona militare, ci t. , p. 206. U tema , se esaminato specificatameme e dettagliatamente , non sarebbe di poco conto. Proprio in quegli anni fu pubblicato lo schematico articoletto di L. CADORNA, Delle forme di combattimento della fantena, in cRi vista militare italiana:o, a. 1885, n. 12: articoletto che, integrato da altre riflessioni pubblicate nel 1887, fu ua l'aluo alla base del noto L. CADORNA, Attacco frontale e ammaestramento tattico , Roma, 1915 .
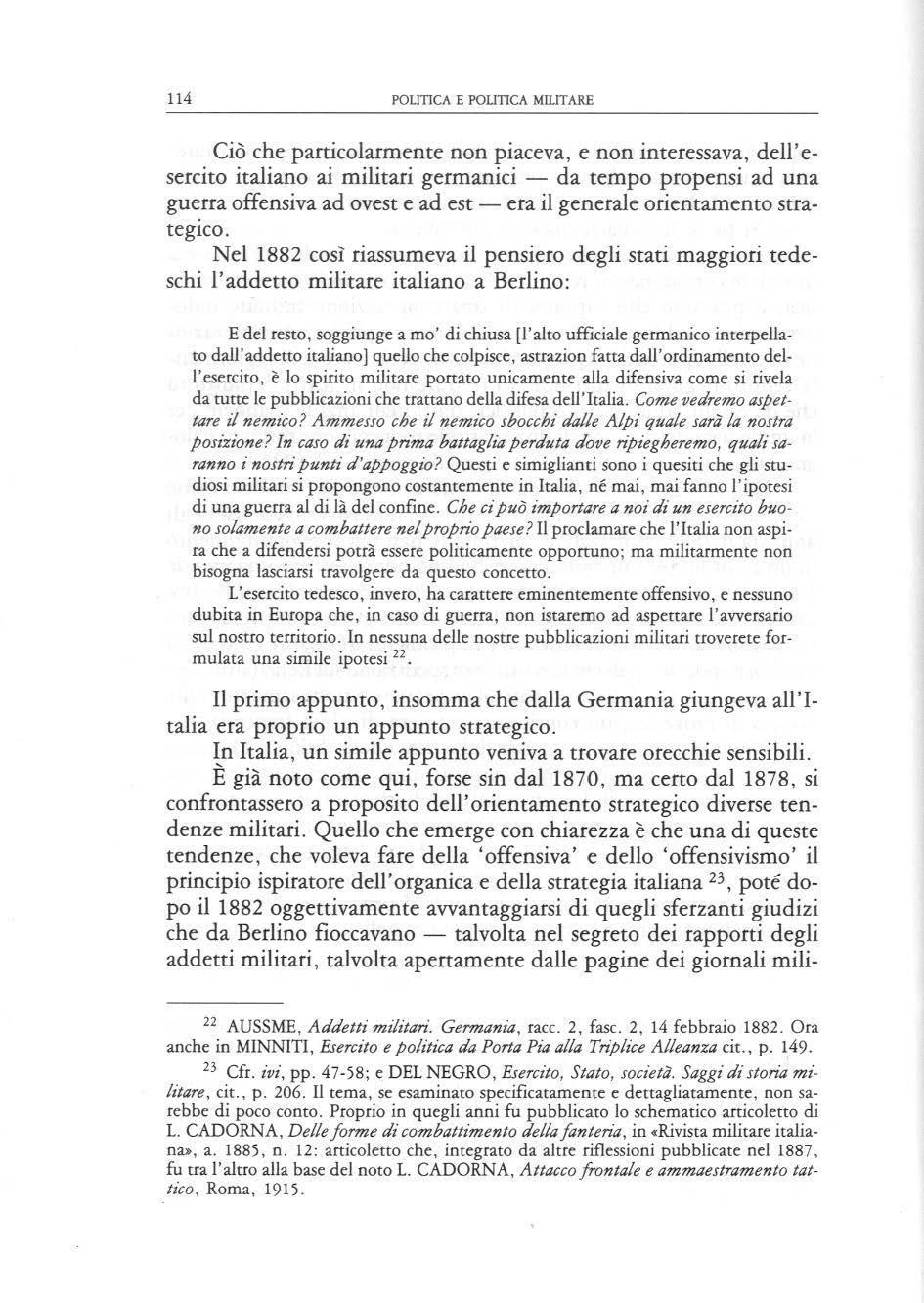
114 POUTICA E POUTICA
MUJTARE
tari esteri e italiani - all'indirizzo di Roma.
Ad alue ricerche spetterà far luce in modo esaust ivo su queste vicende e sulla diffusione anche in Italia delle 'teorie dell'offensiva', sulle loro eventuali unilateralità o schematicità, sulla loro progressiva adozione nella pianificazione ufficiale degli Stati Maggiori. Nel fratte mpo , con l 'occhio rivolto agli anni del secondo Ministero Ricotti, qualcosa può essere detta.
Ad esempio, dopo pochi mesi dalla nomina Ministeriale del novarese, il giornale cL' esercito italiano» - che più di una volta ebbe ad esprime rsi in favore di un 'offensi vismo' militare- e ra felice di riponare alcune osservazioni critiche tedesche a proposito del nuovo Ministro della Guerra italiano. Il cDeutsche Heeres Zeitung», scriveva cL' esercito italiano », si era interrogato sul significato che Ricotti voleva dare al suo Mini stero di 'sosta'. Si trattava forse per l'Italia , notava con apprensione il giornale germanico, di passare su quel campo strategico così caro ai militari tedeschi da una fase che veniva definita di 'offensiva possibile' emersa nel corso della permanenza ministeriale di Perrero ad un'altra fase, definibile come quella della 'difensiva assoluta'? Una tale eventualità, sosteneva il giornale tedesco e ribadiva cL' esercito italiano», sareb be sta ta assai negativa per le relazioni politiche e militari fra i due Stati 24. I sostenitori dell'offensiva dicevano anche, polemicamente, che
un esercito composto ed ordinato in guisa da rispondere a turri i bisogni dell'offesa, sarà sempre più capace e più arto alla difesa, e tutte le preparazioni per l'offensiva faciliteranno sempre egualmente la difensiva. Ma in ragione inversa, quesco non si verificherà mai n .
Un esercito offensivo , si diceva inoltre, avrebbe liberato l'Italia militare da quello che era in quegli anni - come vedremo - uno
24 Cfr. «L'esercito italiano•. 15 giugno 1885, Le controversie militan· itf1iiane giudicate (1//'estero.
Cfr. AUSSME, Ordinamento e mobilitazione, racc. 300. memoria anonima databi le in torno al 1882. Colpisce, comun que, in questa ed in altre prese di posizione di quegli anni a favore dell'offensiva, il totale silenzio e la generale sottovalurazione del tema invero cruciale della mobilitazione. In una fase storica in cui, pure, la tendenza era ad allargare quanto mai gli organici degli eserciti, gli 'offensivisti' italiani parevano ridurre il grande rema della iniziativa suaregica ad una sorta di 'corsa ad arrivare primi' sul campo di battaglia, ma - pare- senza comprendere l'importanza dello strumento della mobilitazione militare (e la necessità di curarla) per sfrutta re tutte le energie del Paese. Ne sortiva quindi un offensivismo debole e velleitario, tutto militare e assai poco 'nazionale'. Sul nesso ua mobilitazione e offcnsivismo in Europa, cfr, HOWARD, La guerra e le armi nella stona d'Europa, cit., pp. 184-221.

l PROBLEMI MIUTARI 115
dei suoi più foni timori strategici: l'eventualità cioè che uno sbarco improvviso di un consistente nerbo di forze nemiche si impadronisse della Capitale, tagliasse le linee di comunicazione lungo la penisola e creasse teste di ponte sufficientemente resistenti da mettere lepremesse di un'invasione via mare.
La configurazione speciale de l Paese e l'estensi one delle sue lunghe coste renderà però sempre difficile , quasi impossibile l ' assicurarlo solo difensivamente. L'accrescimento del numero [della forza dell'esercito] può migliorare quello stato cos1 poco come l ' aumento delle fortificazioni. Non es iste altro rimedio che l'offensiva, per occupare nel suo proprio terreno la più gran parte delle forze [del nemico], impedendo per quel modo per sé stesso quasi sicuro ogni sbarco 26 .
Anche il fatto di entrare a far parte di un'alleanza, non doveva - secondo gli offensivisti - rassicurare i militari italiani e farli desistere dal definire un assetto militare caratterizzato da una strategia offensiva: dal momento che, solo in questa visione, gli alleati mil itari «in caso di guerra occuperebbero ed attirerebbero a sé le forze principali del nemico, facilitando così l'offensiva dell'esercito italiano» 27.
offensivisti, infine, parlavano direttamente ai governi dell' Italia umbertina, oltre che alle alte gerarchie militari.
Un esercito solamente difens ivo non sarà mai né temuto, né molto ricercato e , appoggiato sopra quello, il Governo non può avere un'influenza poli tica importante, non è capace d i consegu ire pe r forza la sua opinione , non può farsi giustizi a da sé stesso , non può dichiarare una gueCia, non può chiedere conto di un'offesa, non può vendicarla. Perciò l ' influenza politica di una Nazione, come la sicurezza e l'integrità del Paese , dipende specialmente dal valore militare del suo esercito , e questo valore non dipende dal suo numero ma dalla sua capacità offensiva 28 •
26 AUSSME, Ordinamento e mobtlitazto n e, racc . 300. 27 lvi 28 lvi. I sostenitori it aliani dell'offensiva cadevano spesso, nell ' esame della dottrina militare prussiana (da cui dicevano di prendere le mosse ), io una sorta di acri t ica accettazione . Se ancora rimane da studiare come e quanto quella dot trin a fosse veramente conosciuta in Italia , l ' aspetto della vuota apologia e del retorico culto della personalità appare evidente in certi ritratti italiani di militari prussiani. lo uno di questi bozzetti, Moltke veniva di pinto come colui che «apparve sulla scena della storia inaspettato e forte, come uragano che tutto abbatte, schianta ·e trascina in brev'ora:o , secondo la descrizione di S. ZANEW , Uomini digue"a dei tempi nostn· , v. I, Moltke Saggio stanco , Torino, Voghera, 1895 , p . 3. ln questa visione ideologica , però , grande importanza concreta aveva la riproposta dell'istituzione di uno Stato Maggiore come corpo militare del tutto separato, come in Prussia cdipendente solo dal Re e dal Comandante Supremo:o, non «punzecchiato, tormentato , avversato dallo spettro della responsabilità parlamentare , e vocata dal Ministro della Guerra.. lvi, p. 14 3 e p. 146.

116 POUTICA E POUT ICA MIUTARE
Gli
Questo tipo di argomentazioni, a volte più velate, a volte più implicite, comparivano assai spesso nel dibattito militare italiano, sulla stampa come in Parlamento.
«L'esercito italiano», appena un mese dopo la nomina di Ricotti, ricordava seccamente (al momento della riapertura del Parlamento, chiamato a votare importanti disegni di legge militari) che «l'accusa di oltralpe è quella che il nostro esercito non ha sufficiente carattere offensivo» 29.
Più tardi, sostenne che uno spirito militare gagliardamente offensivo faceva parte del complesso di misure di cui l'ordinamento Ferrero era stata solo una delle espressioni: e che quindi qualsiasi 'sosta' sulla via del completamento di quell'ordinamento ne avrebbe tradito l'impostazione e, compromettendo il passaggio all'offensiva, sarebbe stato fatto politico assai grave 30. Poi fu la volta d eli' accusa di «depauperare l'esercito di tutti gli elementi più necessari per una valida e pronta mobilitazione delle forze del Paese», una volta che si fos.se abbandonato il principio dell'offensiva 31 .
Infine , in un momento di particolare ostilità verso l 'indirizzo che la gestione di Ricotti andava prendendo, «L'esercito italiano» sbottò addirittura in una sorta di deprecatio temporum secondo cui, pur di avere un 'esercito offensivo' sarebbe stato meglio aver conservato il vecchio, piccolo, esercito lamarmoriano piuttosto che aver costruito la 'Nazione armata' di Ricotti e Marsell i, con le sue Milizie, se questa era incapace di superare la 'difensiva strategica' Nel settembre 1886 , infatti (e ci oè quando stavano per iniziare nel segreto delle cancellerie le trattative tra Roma , Berlino e Vienna per il rinnovo della Triplice), sotto il titolo significativo de «l veri prussiani», sentenziava così «L'esercito italiano»:
Noi non remiamo di essere smentiti nell'affermare che il piccolo esercito piemontese di venticinque anni fa, coi suoi speciali ordinamenti e colle sue cosiddene pedanterie, era assai più vicino all'Esercito Prussiano di quello che lo siamo noi oggi ( ) 32
A parte manifestazioni più confuse come quest'ultima, le richieste de «L'esercito italiano» per un ordin amento offensivo dell'esercì-
29 Cfr. «L'esercito italiano», 18 novembre 1884, L'apertura del parlamento e le leggi militari.
30 Cfr. ivi, 11 marzo 1885, L'ordinamento dell'esercito.
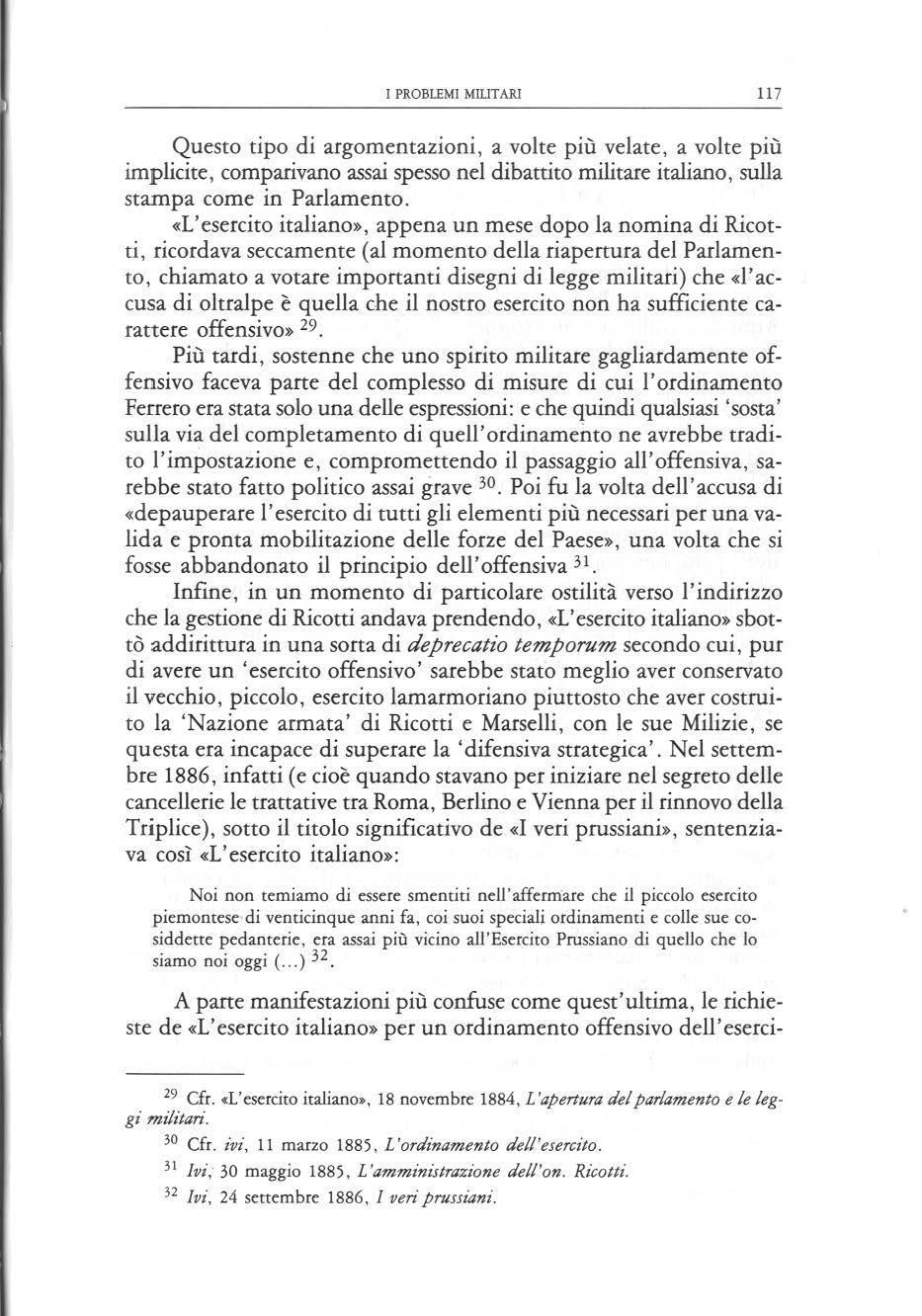
3! lvi, 30 maggio 1885, L'amminùtrazione dell'on. Ricotti.
32 lvi, 24 senembre 1886, lven· prussiani.
l PROBLEMI MILITARI 117
todi Ricotti erano pur sempre all'ordine del giorno; ed è solo per brevità che qui oon se ne riportano altre, simili a quelle ricordate. Oltre che stampa militare, anche in Parlamento Ricotti doveva difendere il suo operato da chi lo accusava di ritardare o di impedire l'adozione di una strategia offensiva per l'esercito italiano. Nelle aule della Camera e del Senato tali critiche prendevano solitamente lo spunto dalla rivendicazione di un aumento organico delle Armi di Cavalleria e di Aniglieria 33. Questo aumento, annunciato da un disegno di legge dell'amministrazione Perrero- disegno poi ritirato da Ricotti - aveva acquistato (come vedremo meglio in seguito) il valore di vessillo polemico antiministeriale e di emblema per la tendenza 'offensivistica': con più Aniglieria e più Cavalleria, si diceva infatti, si verrà incontro alle richieste degli alleati militari di oltralpe e si renderà di fatto 'più offensivo' l'ordinamento strategico dell'intero esercito 34.
Uno schieramento così ampio di prese di posizione per 'l' offensiva', però, non poteva reggersi solo su convinzioni di natura teoricomilitare. L'aggancio della diffusione delle teorie offensivistiche con la politica interna (e ovviamente con la politica militare) appare chiaro negli anni tra il 1884 ed il 1887 proprio a panire dali' opposizione al Ministro Ricotti: e all'interno di questa si fa particolarmente evidente negli ultimi mesi di quel Ministero, sui temi dell'aumento dell' Artiglieria e della Cavalleria.
D'altra pane, queste teorie militari avevano (a conferma dellegame tra politica interna e politica militare) una diffusione ed una ricaduta in ambienti non solo militari ma anche politici. Ad esempio, il mito dell'offensiva poteva permanere- anche se mutato di segno - nel passaggio da ambienti militari conservatori e triplicisti ad alcuni ambienti politici e 'democratici' della Sinistra pentarchica. In questo senso, ad esempio, si era espresso il deputato della Sinistra pentarchica Pais, nel giugno 1886 durame una seduta della Commissione parlamentare chiamata a discutere un progetto di legge di Ricotti. Sostenendo la necessità di aumentare Cavalleria ed Artiglieria, egli «appoggiò il suo assunto con la che devesi provvedere non soltanto alla difesa ma all'offesa, riflettendo che dalla costituzione dell'esercito emergerebbe la possibilità di trarci dal-

118 POUTICA E POUTICII MILITAR.Ii
33 Cfr., ad esempio, l'imervemo di Oreste Baratieri, in AA.PP., Camera , Legisl. XVI, sess. prima, tornata del l 5 dicembre 1886.
34 Cfr., tra gli altri, cL' esercito italiano», 28 ottobre 1886 , La Cava/lena e l'am · ministrazio ne Perrero.
l'impaccio politico della scelta delle alleanze» 35. L'affermazione, a ben vedere, era di un'importanza notevolissima. E non deve stupire, se confrontata con quella di Baccarini che si opponeva al Ricotti difensivista perché incapace di assicurare la Nazione portando la guerra 'fuori casa'.
Non ci interessa qui sottolineare il carattere 'inquinante' del trasformismo rispetto a quelle che erano state le tradizionali posizioni politiche - ed anche di politica militare - dei vari gruppi parlamentari (in questo caso della Sinisua pentarchica); né ci soffermeremo sul fatto che fu questo clima a permettere l'affermarsi di Crispi come 'uomo nuovo'.
Si può però evidenziare come questo tipo di 'sconfinamenti' politici delle teorie offensivistiche confermano che il dibattito a più voci su offensiva e difensiva non fu tanto una disinteressata ripetizione di critiche straniere all'ordinamento dell'esercito italiano, quanto una battaglia politica e delle idee tutta italiana, interna al mondo militare 36, ma con una rilevanza più ampia e tutta politica. Una rilevanza, nell'Italia di quegli anni, che andava tutta in una direzione opposta a quella in cui voleva però muoversi Ricotti.
Certo non era questo il dibattito capace di 'mettere in crisi 1' e-
3S ACD, Dd/, Legisl. XVI. sess. prima, reg. 426, o. 32 , Verbale di seduta della Commissio ne , 19 giugno 1886. U na tale impostazione non era solo politica , né solo dei politici (ed in special modo di taluni settori pemarchici e crispini), ma anche militare. Qualche tempo dopo, Pe lloux dichiarò pubblicamente in Parlamento che- in quanto militare - avrebbe preferito che l'Italia disponesse di una (autosufficiente) «autonoma forza bellica» piuttosto che essere cosuetta a dover dipendere dalla potenze alleate. Cfr. AA.PP., Camera, Legisl. XVI, sess. prima, tornata del 15 dicembre 1886. Ed, ancora, era stato proprio un militare , ed un militare come Oreste Baratieri, ad affermare che la miglio r strategia per l'Italia sarebbe stata quella di poter essere «indipendenti dall'estero:o.lvi, Legisl. XV , sess. unica , Discussioni, tornata del12 giugno 1885. Con la solita acutezza, già qualche anno prima , Nicola Marselli (sia pur all'interno di una valutazione fonememe negativa dell'attività dei governi della Sinistra sino al 1882) aveva previsto la possibilità di tre diverse impostazioni strategiche per il problema militare italiano. «Dei ere programmi ragionevoli: raccoglimento assoluto, isolamento ed armamento estremi, armonia tra le finanze, le armi e le alleanze , si è trovato modo di non eseguirne alcuno:.. MARSEU.I, La politica dello Stato italiano, cic., p. 319. Se di 'raccoglimento assoluto' (forzato dopo il 1866, ma virtualmente già superato con la riforma Ricotti del 1873-75) nessuno ormai parlava più, e se Ricotti aveva sempre professato di voler costruire la potenza italiana sulla base di una 'armonia tra finanze ed esercito' , è indubbio che - negli anni Ottanta - più di un settore po l itico -militare si fece abbacinare dal miraggio di un 'armamento estremo', considerato forse il simbolo migliore e la scorciatoia più breve per una 'vera ' politica di potenza iraliana .
36 Cfr. ancora DEL NEGRO, Esercito , Stato , società. Saggi di storia militare, cit., pp. 20) -206.

l PROBLEMI MiliTARI 11 9
sercito' 37, ceno non solo per questo la gestione di Riconi poteva es. . sere messa m cnst o sostttutta.
A prese di posizione così decise da parte dello schieramento dei sostenitori 'dell'offensiva', non si deve credere inoltre che Ricotti opponesse solo le sue vecchie e solide convinzioni 'difensive'. In sintonia col dilagare del trasformismo politico, la sua posizione si faceva più articolata ma anche più contraddittoria.
Anche nel recente passato, peraltro, il novarese non aveva esitato nel ribadire quelle sue convinzioni. Queste, come si è deno, si basavano su una valutazione negativa del meccanismo e della velocità della mobilitazione italiana, e per converso su un accentuato timore che le truppe francesi - più consistenti numericamente, avvantaggiate da una più veloce mobilitazione e da un potente sostegno della Marina Militare - potessero far pressione e battere in breccia la difesa italiana su due distinti ma crucial i settori. Sulle coste del litorale tirrenico (in particolare toscano), Ricotti temeva l'eventualità di uno sbarco in forze che potesse anche tagliare in due le comunicazioni politiche e militari del Regno Sulla cerchia alpina, egli vedeva l'imminente pericolo per le truppe i taliane- più deboli non so lo numericamente ma anche in opere di fortificazione e in artiglieria da montagna- di essere costrette a cedere il controllo delle cime e di non riuscire ad impedire l'avanzata francese. Su quest'ultimo punto egli pareva assai convinto: «qualsiasi resistenza nell'interno della barriera alpina» era da lui vista solo «come un semplice preludio alle grandi manovre in pianura» 38.
Era questa svalutazione delle più recenti acquisi zioni strategiche su un possibile ruolo nuovo della difesa alpina e della guerra in montagna 39 che, insieme alla più volte riaffermata fiducia nella ca-
37 Per il caso più chiaro di crisi militare e di contrap.Posizione netta tra esercito e paese cfr. ROCHAT, MASSOBRIO , Breve storia dell 'esemto italiano da/1861 al1943, cit., p. 122 e pp. 124-141. Cfr. anche U. LEVRA, Il colpo di stato della borghesia. La cnsipolitica difine secolo in Italia 1896-1900 , Milano , Feltrinelli, 1975.
38 Cfr. AUSSME, Ordinamento e mobilitazione, racc. 68, fase. IV, p. 5, alla data dell'8 novembre 1881.
39 Per i progressi della guerra in momagna, cfr. ivi, fase. I. Da più tempo sostene vano queste teorie 'offensivistiche' delia guerra in montagna pubblicisti e militari come G. PERRUCCHETTI, La difesa dello Stato. Consideraz ioni, Torino , Roux, 1884 o V E. DABORMIDA , La dife sa della nostra frontiera occidentale in relazione agli o rdinamenti militan· o dierni , Torino , Loescher, 1878 . Ma an che anni prima , pubblicamente , tesi analoghe erano state divulgate. Cfr. A. RICCI, La difesa interna della valle del Po, Torino, Loescher , 187 3 , a p. 15 7 , il quale sosteneva che • le guerre oggidì devono avere il carattere dell ' offesa anche nelle difese». Su questi temi, cfr. oggi le brevi osservazioni di G. OLIVA , Sto na d egli alpini, Milano, Ri.zzoli , 1985, pp. 39-44.

120 PO UTICA E POUTICA MIUTARE
pacità dell'esercito italiano di saper recuperare in una battaglia campale nella pianura padana gli eventuali insuccessi precedenti, faceva di Ricotti un convinto assertore della 'difensiva' 40. O di quella sua rielaborazione che passava sotto il nome di difensiva-controffensiva. (E infatti dicevano i suoi critici che la «controffensiva non è altro che la difensiva cambiata di nome») 4 1
Contro questa per lui ormai assodata convinzione, niente potevano i dibattiti militari cui abbiamo accennato. Per Ricotti, almeno da quanto sembra di poter dire da alcuni suoi interventi pubblici, 'offensiva' e 'difensiva' non erano più che mere questioni nominalistiche. L'esercito italiano poteva schierarsi, combattere e solo in un certo modo: di più non si poteva chiedere.
Quindi, se da taluni dei suoi oppositori si voleva 'l'offensiva', egli - nel quadro della politica trasformista di quegli anni - non esitava a dichiararsi entusiasta dell'offensiva 4 2: purché fosse l ' offensiva come la intendeva lui. Ecco allora che in Parlamento Ricotti si professava offensivista prussianofilo accanito 4 3 Ecco che la voce ufficiosa del Ministero della Guerra propone le coordinate di un 'caso possibile' in cui l'esercito italiano combatte 'offensivamente' (ma sempre nella pianura padana) 44 Ecco che la «Rivista militare italiana» pubblica articoli ispirati alla difesa delle «teorie offensivistiche» (ma svuo tate della loro capacità di critica dell'ordinamento militare esistente) 4 5
Ai militari italiani più esperti (o alle cancellerie o agli Stati Maggiori stranieri) questi richiami 'offensivistici' del Ministro della Guerra Ricotti non apparivano che per quello che erano: un trasformistico gioco di parole, che copriva una realtà dello schieramento strategico dell'esercito che rimaneva quella di sempre. E quindi la loro critica
40 Già Io ricordava MINNITI , Esercito e politica da Porta Pia alla Tnplice Alleanza, .cit., p. 103.
41 Ad esempio AFJ, La difesa di uno stato come la intendiamo noi, in <Rivista militare italiana», a. 1886, n. 7 , p. 22.
4 2 Cfr. ad esempio, AA PP ., Camera , Legisl. XV, sess. unica , Discussioni, tornata del9 giugno 1885 Ma gli interventi parlamentari di Ricotti sono pieni di simili affermazioni, cui corrispondevano evidentemente altrettante riserve mentali.
4 3 Cfr., tra le varie affermazioni in questo senso , quelle in AA.PP. , Camera , LegisL XVI, sess. unica , Discussioni , tornata del 16 dicembre 1886; o in ivi, Legisl. XV, sess unica, Discussioni, tornata del 9 giugno 1885.

44 Cfr. «L ' Italia militare•, 2 gennaio 1886, Un caso possibile.
45 Cfr. ivi, 10 gennaio 1886, Difesa dello Stato; e J.bidem , Pace universale e perpetua.
l PROBLEMI MIUTARJ 121
non poteva che essere rinfocolata da queste prese di posizione del novarese.
Per buona pane del mondo politico, per la Camera (che in così larga pane le elezioni del 1882 avevano rinnovato), per la pubblica opinione, invece, la professione verbale da parte dello stesso Ministro della Guerra di teorie militari così ardite e gagliarde dava l' impressione che - se lo strumento militare nazionale poteva praticare le teorie offensivistiche che il Ministro mostrava di condividereallora si potesse davvero 'osare', che davvero fosse il momento di condurre una 'po liti ca di potenza'.
Ci si trovava, insomma, di fronte ad uno strano gioco delle parti, ad una confusione delle lingue e degli schieramenti, ad un ennesimo «rimescolamento delle cane» 46 . L'irri tazione o lo stupore (per un vasto settore del mondo militare che ormai si vedeva avviato verso la 'politica di potenza') di fronte alle contraddittorie e trasformistiche prese di posizione di Ricotti sull'offensiva non poteva che essere profonda.

D'altra parte simili dibattiti militari (come questi su offensiva e difensiva) non erano riducibili solo alla loro mera espressione pubblicistica: non erano un fatto di sola stampa militare. Essi avevano invece ben solidi radici in alcuni grandi problemi che la strategia e l 'ordinamento dell'esercito italiano dovevano affrontare proprio negli anni di Ricotti. Uno di questi era il pieno uso del potenziale militare italiano.
Il militare ed il diplomatico italiano non avevano, negli anni della prima Triplice e soprattutto in quelli del secondo Ministero Ricotti, gli stessi problemi e le stesse priorità.
Dal punto di vista diplomatico, due erano le tendenze che si intrecciavano o si giustapponevano. Da una pane problema principale di quegli anni era rafforzare la politica estera nazionale, sfruttando dove era possibile il dato nuovo dell'esistenza della Triplice che però solo dopo il 1884-85 pareva dare sufficienti garanzie. Dall' altra pane non si tralasciava di cogliere tutte quelle possibilità diplomatiche, anche al di fuori o contro la Triplice , che fossero risultate utili agli interessi nazionali (ed in questo senso, il benestare britannico ali' avvio di una politica coloniale in Mar Rosso e poi gli accordi navali italo-inglesi del 1887 dovevano rimanere di questa tendenza i risultati migliori) 47.
122 POUTICA E POUTICA MILITARE
46 Cfr. DAL NEGRO, Esercito, Stato, società. Saggi di storia militare, ci t., p. 256.
4 ì Cfr. C. GIGLIO , L 'impresa di Mauaua, ci t., e B. MAUNVERNI , Il primo accordo per il Mediterraneo (jebbran·o -marzo 1887), Milano , Marzorati , 1967.
Dal punto di vista militare dell'esercito , invece, problema principale era valorizzare tutte le potenzialità che la Triplice poteva offrire all'Italia, facendosi accettare come alleati a pieni diritti e- salvando ed innalzando l ' onore delle armi nazionali - potendo impiegare tutta la propria forza. Pur non volendo prendere in esame la possibilità di uno scontro con la confinante Austria (che pure in qualche modo era temuto e preparato anche da parte italiana) 48 il problema strategico italiano di quegli anni presentava sostanzialmente due schematiche possibilità 49 : il caso di una guerra contro la Francia in cui l'Italia sarebbe rimasta isolata ed il caso di una guerra , sempre contro la ' sorella latina' , in cui l'Italia avrebbe potuto servirsi (o far pane) di una più potente alleanza (con la Germania di Bismarck e di von Moltke innanzitutto, e caso mai anche con l'Austria).
Nel caso di una guerra dell'Italia isolata contro la Francia sembrava che non vi sarebbero state molte chances per l'esercito italiano. Era quindi assolutamente prioritario valorizzare al massimo la Triplice nonché l'alleanza con la massima potenza militare del tempo che ne conseguiva.
Eppure anche nel caso di una guerra in cui l'Italia non sarebbe rimasta sola contro la Fran cia , vari erano i problemi militari ancora t utti da sciogliere. Principale tra tutti quello di una coop erazione italore desca.
Come è noto, non era quella la prima volta che si prendevano in considerazione in Italia simili ipotesi di cooperazione 50. Essa, nei var i momenti , era stata immaginata poter prendere diverse forme concre te.
Un'ipotesi era quella del fronteggiamento al co nfine alpino che ve deva l'esercito italiano tutto proteso ad un attacc o che impegnasse ril e vanti forze militari dell ' avversario francese , permettendo così all' alleato germanico di sfondare da nord la difesa fran cese . Un ' altra , più complessa , prevedeva un congiungimento delle forze tedesche e di quelle italiane di fronte al Giura o intorno a Lione, in suolo nemico, come fase fmale di un accerchiamento offensivo a tenaglia: ma
48 Cfr. AUSSME, Ordina m e nto e m obil i/azio n e, racc. 1 1 , Stu dio circa la dtf ensiva e l'offensiva Nord-Esi. Scarsa l'attenzione su quest o d a parte di GOOCH, L 'l/alia contro la Fran cia l piani di guerra dtfennvi e offemivi 1870·1914, cit., p. 162
49 Cfr. ROCHA T, MASSOBRIO, Breve storia dell'esercito italiano dal 1861 al 1943, cit., p p 107-108: e MAZZETTI, L'esercito iJaliano nella Tnplice Alleanza, cit., p. 32 e pp. 37- 38
5° Cfr. ivi, p. 33.

l PROBLEMI MlUTi\RI 123
questo congiungimento poteva a sua volta avvenire (a seconda di come si intendesse in questa ipotesi il valore dell'apporto militare italiano) prima o dopo di una più decisiva battaglia che - sul fronte settentrionale - avesse già sostanzialmente deciso le sorti della guerra. Una terza ipotesi (che fu quella a prendere corpo più tardi) infine, vedeva nella difficoltà per l'Italia di assumere immediatamente l' offensiva contro la Francia la principale ragione per cui - insieme all'impegno assunto di occupare quante più forze francesi fosse stato possibile al confine franco-italiano o nelle sue prossimità -1' esercito italiano doveva far giungere al fianco delle truppe germaniche sul campo di battaglia franco-tedesco un significativo numero di proprie grandi unità militari. Era insomma, quest'ultima, l'ipotesi della spedizione di un'Armata italiana sul Reno.
Furono delineate poi, in quegli anni, anche altre ipotesi minori (come quella di un aggiramento offensivo del confine francese da parre di un forte Corpo di spedizione italiano che, trasportato via mare, potesse invadere la Francia meridionale, decongestionare il confine franco-italiano e permettervi una più agile vittoria italiana) ma che ebbero scarsa fonuna per gli ovvi motivi di sopravvalutazione della forza italiana 5l che essi presentavano
Le varie ipotesi, intorno al 1884 , erano già state quasi tutte affacciate ed in vari momenti sottoposte a critica, germanica o italiana.

La prima ipotesi si sarebbe potuta dire per gli italiani la più 'difensiva' ma anche la meno produttiva, politicamente e militarmente.
La seconda, più ardita, si prestava però come abbiamo visto a due diverse interpretazioni: una propriamente offensiva ed una più esattamente controffensiva, a seconda che il congiungimento delle forze militari italiane e germaniche si fosse effettuato prima o dopo una più grande battaglia campale. In ogni caso lo scenario previsto per le forze armate italiane da questa - come dalla precedenteipotesi pareva dover essere limitato alla conduzione di una sorta di offensiva di alleggerimento sul fronte sud del conflitto, mentre le sorti della guerra si sarebbero risolte sul fronte nord.
La terza ipotesi pareva contemperare i due elementi (difensiva o controffensiva al fronte italiano, offensiva congiunta sul fronte del Reno) ma era anche la più complessa: comportava una unità d'in-
124 POLITICA E POLITICA MILITARE
5!
Cfr. ivi, pp. 35-37 e p. 43.
tent i tra le due Poten ze alleate, pareva porle militarmente sullo stesso piano, rendeva le forze italiane necessarie e risolutive per la vittoria nello stesso modo di quelle germaniche, sanzionava più perfettamente di tutte le altre ipotesi il riconoscimento (da parte della Germania e della Triplice) del salto di qualità che i militari italiani volevano far compiere alloro esercito. Nel comp lesso, era quest'ultima l'ipotesi che maggiormente corrispondeva ai desideri ed alle ambizioni 'offensivistiche' italiane.
Poco prima che Ricotti tornasse alla Pilotta, nel 188 3, il Capo di Stato Maggiore italiano aveva proposto all'alleato tedesco che venisse congiuntamente pianificata quest'ultima delle tre ipotesi ricordate: ma aveva ricevuto da Berlino solo un secco diniego 52 . La negativa risposta tedesca alla mossa italiana pare che indusse poi Cosenz a far marcia indietro e a proporre ali' alleato tedesco che venisse presa in considerazione almeno l'ipotesi di un'offensiva di alleggerimento sul fronte franco-italiano. Ma questo oltre a risultare meno gradito e meno soddisfacente per le ambizioni dei militari italiani, non ne risolveva ceno t u tti i problemi.
Gli ambienti militari direttivi italiani sentivano come fortemente !imitatrici le ipotesi d eli' offensiva di alleggerimento.
L'ordinamento dell'esercito italiano , ormai strutturato su dodici corpi d'armata, poteva esprimere in caso di guerra perlomeno quattro potenti Armate; di questa una poteva essere stazionata nel Centro Italia, volta a difendere la penisola e a garantirne l'ordine pubblico e sociale. Un'altra poteva essere impegnata nel fronteggiamento, più o meno offensivo, ai confi ni con la Francia. Un'altra, più consistente, avrebbe atteso nella pianura padana l'evolversi degli avvenimenti, pronta a entrare in combattimento per battere il nemico ove fosse sboccato a valle, od a seguire (cosa più improbabile) le punte avanzanti delle forze di montagna italiane.
E la quarta Armata? sostenevano i militari. Poteva l' Italia pensare di lasciare inoccupate un numero cosÌ rilevante di grandi unità?
D'altra parte l'evoluzion e del sistema fortificato rio francese era andata cosÌ avanti - soprattutto dopo il 1884 - che con poche truppe Parigi poteva tenere impegnate e 'bloccate' un numero non trascurabile di unità italiane , nonché impedir loro eventuali sconfrnamenti offensivi 53.

52 Cfr. zfli, p. 36.
H Cfr. S. RAU , L 'etal miiitaire des pnncipales puissances etrangeres au pn.ntemps de 1886, Paris, Berger-Levraul t, 1886.
l PROBLEMI MlUTARI 125
In questo senso, sul tema della guerra in montagna, l'Italia un ceno passo avanti lo aveva già fatto. Luigi Mezzacapo, come è noto 54, volle definire questo mutamento di impostazione strategica in un settore rilevante della dottrina italiana (guerra di montagna non poteva che voler dire guerra con la Francia) con la seguente formula: passaggio dalla resistenza manovrata - ostacolamento in quota dell' invasione avversaria cui si sarebbe fatta seguire una più decisiva battaglia in pianura con manovra di truppe per linee interne- alla 'resistenza ad oltranza'.
Dal canto suo, invece, il critico ma acuto Pianell preferiva parlare di un più contenuto passaggio «da una debole difesa ad una forte difesa» ss.
Seppur così ridimensionato, un mutamento teorico nella dottrina italiana della guerra di montagna c'era stato. A sostenerlo, stavano un complesso di misure organiche, quali il rafforzamento delle truppe alpine , l'edificazione di nuove e più robuste fortificazioni in quota. Forse difettava un po' l'artiglieria da montagna 56, ma nel complesso l 'irrobustibimenco della difesa italiana alle Alpi era cosa fatta al momento in cui Ricotti salì al Ministero, o quasi ultimata.
Tutta la questione strategica italiana, schematizzando, si riduceva negli anni della prima Triplice a questo: volontà di raggiungere decisivi risultati 'per l'onore nazionale', impossibilità di pervenirvi con queila situazione delle forze contrapposte, intenzione di coinvolgere allean ze e definire cooperazion i militari (essenzialmente italotedesche), frustrazione e stallo per i reiterati rifiuti germanici anche solo a discutere di cooperazione, volontà - comunque - di non mettere in discussione l'ordinamento militare nazionale su dodici corpi d'armata che quella impasse aveva creato.
Punroppo è difficile oggi procedere più avanti nell'analisi storica: i documenti originali del tempo non sono facilmente reperibili e gli archivi dello Stato Maggiore non sempre sono sufficienti a chiarire questo punto fondamentale 57.
L'impression e che comunqu e si ha è che, anche prescindendo
54 Cfr. MINNITI, Esemto e politi&a da Porta Pia alla Tnplice AUeanza, cit., p. 100.
H AUSSME, Ordinamento e mobilitazione, racc. 68, fase. lll , p. 72, alla data del 18 luglio 1881.

56 Cfr. MARTEL. Military ltaly, Loodon, 1884.
57 Su problemi formidabili, quali quelli appena ricordati, la documentazione necessaria per swdi definitivi è maggiore di quella disponibile presso l'Archivio dell'Ufficio Storico dello SME.
126 POUTICA E
POUTICA M1UTARE
dalla volontà di Ricotti per una 'sosta' più o meno lunga nel cammino intrapreso dall'esercito italiano (aumento di forza, diffusione delle teorie offensivistiche), da quello stato della questione strategica derivasse in quegli anni per gli ambienti militari italiani una diffusa sensazione di stallo.
L'esercito italiano degli anni tra il 1884 ed il 1887 appariva infatti come un esercito grosso (con i suoi dodici corpi d'armata) e forte (rispetto a quello di quindici o anche dieci anni prima), che strategicamente però poggiava molto più su miti ed illusioni o comunque solo su aspirazioni (di cooperazione militare triplicista) che su certezze. Si poteva pensare alla spedizione sul Reno, ma di fatto niente era certo. Si poteva anche presumere che all'occorrenza l'esercito italiano avrebbe espresso un massimo di offensivismo (difesa avanzata sulle Alpi, cinque o anche sei corpi d'armata in Germania), ma di fatto la dislocazione strategica e la mobilitazione delle forze rimanevano inchiodate a quella difensiva-controffensiva nella pianura padana che ricordava molto le 'vecchie' guerre risorgimentali. Ci si poteva illudere di possedere uno strumento militare potente ed ambito, ma rimaneva il fatto che ancora nessuno si era fatto avanti per chiederne (od anche solo per accettarne) la collabo ra.zione.
Un'euforia di potenza inebriava settori politici e militari 58 : ma
ss «In questi ultimi tempi, in Italia, tutto è divenuto più grande-.: così, ironicamente, bollava questa 'euforia di potenza' F.S. MERLINO , L'Italia qual è {1890), a cu ra di N. Tranfaglia, Milano, Feltrinelli, 1974, p. 42. Il tema cui qui si accenna è assai vasto e obbligherebbe ad uno studio profondo, basato sulla lettura 'trasversale' della stampa e della pubblicistica politica e militare. Ma che ci si trovi di fronte, negli anni Ottanta del XIX secolo, ad un clima militare diverso da quello dei decenni precedenti (un clima in cui le temaciche della 'politica di potenza' e della 'esibizione della forza' scavano prevalendo anche in Italia) era cosa nota già da tempo Tra gli altri, F. Chabod aveva sottolineato il mutamento di prospettiva internazionale che in pochi anni si era realizzato per l'Italia (la quale nell870 cera perfettamente isolata..) e che dava ad alcuni ambienti nazionali la sensazione di poter e dover far giocare aJI'Italia un ruolo di 'grande potenza'. Notevole impottanza in questo aveva avuto la congiuntura economica di quegli anni, durante i quali gli stessi colpi che la crisi agraria andava infliggendo a rurte le economie europee si fecero sentire in Italia duramente ma in forma relativamente meno radicale che altrove, per un complesso di motivi non ultimo dei quali la stessa arretratezza del tessuto produttivo nazionale. Cfr. BARONE. Sviluppo capitalistico e poli#ca finanziaria in Italia nel decennio 1880 -1890, cit., e P. D' ANGIOUNI, L 'Italia al termine della eroi agrana della fine del secolo XIX, ci t.. Un ruolo non faciLmente sopravvalutabile, poi, ebbe la firma della Triplice che, seppure «fu forse più utile all'interno che all'estero:. (come disse Robilant), impresse comunque calla nostra politica este ra - secondo la definizione di Nigra - una direzione precisa che prima non aveva e( ) generò in Italia un sentimento di sicurezza che ci è stato di grande sollievo•. Le citazioni in CHABOD , Considerazioni sulla politica estera dell'Italia da/1870 al 1915, cit., p. 31 e p. 37. Da qui, le aspirazioni e le velleità per una 'politica di potenza'. diffuse in diplomazia, come era i militari o nella pubblica opinione.

l PROBLEMI MIUTARI 127
chi pensava agli impegni, ai carichi, ai gravami che questa prospettiva comportava? C'erano militari che non si sentivano di garantire nemmeno la difesa nazionale, e tanti parlavano con facilità della massima offensiva ...
È in questa atmosfera italiana e con queste caratteristiche che rinacque e si sviluppò il mz'to offensivista (il piano strategico-militare era altra cosa) dell'invio di truppe italiane sul Reno. Come si era detto, è da molto tempo che vi si era fatto cenno. Già nel 1882, nei giorni in cui si andava fumando il trattato della Triplice, il giornale espressione dell ' allora Ministro degli Esteri affermava che, volendo, si sarebbe potuto mandare anche 300.000 soldati cald i là della frontiera» 59. Il numero era esagerato, ma la sostanza era chiara già allora. Poi era venuto il rifiuto di Berlino, nel 1883: e molte fantasie erano sbollite. Ma nonostante tutto, progressivamente ed insistentemente , del Reno si tornava a parlare in Italia.
L'ipotesi di un invio di truppe, sul fronte re nano di una possibile guerra antifrancese, era divenuta di ampio dominio pubblico in Italia, dal1884 al1887. Forse, prima in Italia che in Germania, prima in pubblico che nel segreto delle stanze degli Stati Maggiori , prima ua i politici che tra i militari. Comunque fosse, di un invio di truppe tutti parlavano, tutti vi alludevano, tutti utilizzavano questa argomentazione per avvalorare le proprie tesi o per negare quelle altrui. Piuttosto che su lla stampa tecnica o nella stampa d'informazione militare, questo è visibile in Parlamento .
Nel maggio 1885, già nel primo grande dibattito parlamentare sulle linee della politica militare di Ricotti, fu Giovagnoli a farvi esplicito riferimento 60, dopo che Pozzolini e Pelloux vi avevano alluso in forma più velata 6I. E Giovagnoli ne parlò lib e ram ente, estesamente, quasi fosse cosa già decisa e pianificata (ed abbiamo visto come invece ancora non lo era). In sede di discussione di bilancio della Guerra, fu addirittura Baccarini a farvi un riferimento abbastanza chiaro, quando- tra l'altro- sosten ne il gran principio 'democratico' per cui la guerra offensiva era più favorevole agli interessi nazionali poiché non ponava ' la guerra in casa' 62.
Cfr. MINNITI, Esercito e politica da Porta Pia alla Tnplice Alleanza, cit., p. 138.

60 Cfr. AA PP., Camera , Legisl. XV , sess. unica , Discu.r.rioni, tornata del28 maggio 1885.
61 Cfr. ibidem
62 Cfr. ivi, tornata del 9 giugno 1885.
128 POUTICA E POUTICA M[UTA RE
L'on. Cavalletto , poi, quando nel febbraio 1886 si scagliò veementemente contro la «politi ca gretta di raccoglimento infecondo» 63 che a suo parere l'opposizione andava predicando, era proprio all'ipotesi di una più attiva presenza italiana nella Triplice ed al miraggio di una cooperazione militare itala-germanica che pensava. E proprio da questo tema l'on. La Pona, presidente d e lla commissione parlamentare che aveva esaminato il disegno di legge allora in discussione, panì per poi allargare il suo discorso; non era più il tempoa suo parere - in cui l ' Italia poteva accontentarsi di una ' politica casalinga' : il Regno di Umberto I doveva scegliere ormai ua l'essere una 'g rande potenza eu ropea ' o il rimanere una 'potenza di second'ordi ne ' 64_ E a questo indirizzo si accodava l 'on. Cavalloni, destinato a diventare poi maggiormente noto, che a sua volta si esprimeva contro «la politica dei piccoli borghesi» che lesin avano le spese dello Stato quando era in gioco l'onore della naz ione 65 .

Ma l'ipotesi di un invio di truppe italiane in Germania diventò inftne ancora di più un tema di comune e diffusa lo tta politica, quando p iù tardi (co me vedremo) il dibattito parlamentare e la critica politica e militare alla gestione Ricotti finì per incentrarsi sulla questione dell'aumento dell'organico della Cavalleria e dell' Aniglieria. A quel punto aumentare o non aumentare i quadri delle due Armi speciali sembrava dover significare permettere o non permettere che l'Italia avesse la forza militare sufficiente e necessaria per una spedizione su un prevedibile fronte europeo-settentrionale. L'o n. De Zerbi, addirittura, argomentò pubblicamente il suo favore per l 'aumento dell' organico delle due Armi con alcune sue di sse rtazion i geografiche sul «te rreno fra Woerth, Wissenburg, Rosbache, ecc.•, che a suo parere prima o poi avrebbe dovuto avere l 'onore di essere calpestato dagli sti vali di qualche Grande Un ità ital iana, inviatavi a collaborare co n l'esercito di Moltke 66. E come se ciò non fosse parso già abbastanza sufficiente, aggiungeva:
Ora è qui il nodo della questione. Io non posso parlar chiaro, ma la Camera intenderà più assai di quel che io non elica. Per noi, maggioranza della Commissione, l 'aumento della Cavalleria e dell'Artiglieria da campagna, è una questio1. . ( ) (8 li 67 ne po mca . . . ene.1
6 3 lvi, tornata del 25 febbraio 1886.
64 lvi, tornata del 27 febbraio 1886.
6) lvi, tornata del 4 marzo 1885.
66 lvi, Legisl. XVI, sess. prima, tornata del 2 luglio 1886.
67 Ibidem.
l PROBLEMI MILITARJ 129
A tutto questo la stampa militare ufficiosa rispondeva con un imbarazzato silenzio 68 che, se oggi appare pienamente comprensibile (altro che spedizione al Reno! i militari italiani avevano fatto fatica sino ad allora anche solo a far gradire a Berlino l'ipotesi della offensiva di alleggerimento al confine francese), ai politici ed agli oppositori del tempo doveva sembrare quanto mai sospetta e confermarli nell'impressione secondo cui Ricotti stava imponendo a tutto l'esercito italiano una lunga 'sosta'. E questo proprio quando si presentava, forse per la prima volta nella storia dell'Italia unita, l'occasione di abbandonare per semp re la 'politica casalinga'.
Eppure, se c'era una persona, un militare, che più di altri si mostrava alieno dal lasciarsi coinvolgere da simili correnti d'opinione pubblica- che parevano far coincidere la 'potenza' di uno Stato e le capacità offensive di un esercito con la possibilità di poter inviare forti contingenti militari al di fuori del territorio nazionale e lontano dai confini conquistati (in qualche modo) con le guerre risorgimentaliquesto era proprio il Ministro della Guerra, on. Cesare Ricotti.
Già a suo tempo, nelle riunioni della Commissione per la difesa dello Stato, il generale novarese aveva ripetuto questa sua vecchia convinzione. La superiorità numerica e qualitativa delle forze armate francesi, connessa ai difetti ed alla lentezza della mobilitazione italiana 69, avrebbero secondo Ricotti costretto da subito l'esercito nazionale a tentare di difendere l 'agibilità ed il possesso dell'arco alpino: ma questo senza grandi speranze di successo. La valle padana rimaneva secondo Cesare Ricotti il più probabile teatro di guerra per l'esercito italiano: ed anche il più favorevole, «avuto riguardo ai favori che può trovare l'esercito nel paese proprio a paragone dell'in7°.
68 Pur tenendo in conto quella sona di crisi cui, come si vedrà, cL' Italia militare• andava incontro io quegli anni, quasi nessun articolo pubblicato prese in esame- più o meno esplicitamente - una simile prospettiva negli anni del secondo Ministero Ricotti. Coltre di silenzio imposta dal 'difensivista' Ricotti? Solo una specifica ricerca sulla stampa militare (sulle sue caratteristiche in Italia, sui suoi collaboratori, sulla sua ideologia) potrebbe dirlo. Certo, l'impressione offerta a questo riguardo dalla stampa ufficiosa era di eccessivo riserbo. Un riserbo, poi , a doppio taglio perché la mancanza di notizie o di indicazioni ufficiali lasciava spazio al diffondersi - come si è visto - di miti e di fantasie , non sempre strumentali ma il più delle volte ingiusrificate.
69 eTerne il Ricotti i battaglioni deboli io tempo di pace, per cagione di un improvviso assalto o d'una tarda mobilitazione?•. D. FARINI, Diario di fine secolo, ci t., pp. 76-77, alla data del 20 aprile 1892.
70 AUSSME, Ordinamento e mobilitazione racc. 69, fase. H, p. 31, alla data del 27 novembre 1880.

130 POU11CA E POUTICA
MILITA.R.E
La difesa, la 'difensiva strategica', rimaneva infatti l'orizzonte militare in cui Ricotti continuava a muoversi. Per questo motivo, il tanto parlare che negli anni Ottanta si faceva a proposito della 'potenza' militare italiana, della 'pol itica di potenza ' ormai spettante all'Italia, della possibilità di una guerra offensiva , doveva in genere risultargli come fastidioso e pericoloso. In quelle stesse riunioni cui si è fatto prima riferimento , Ricotti era parso molto convinto della debolezza del sistema militare (artche solo difensivo) italiano. Egli prospettò -praticamente unico tra i generali presenti- l 'ipotes i per cui, in una guerra con la Francia, l 'Italia sarebbe stata cos tretta da subito a cedere tatticamente pane del territorio alla potenza avversaria. E questo territorio, questo spazio lasciato ali' avversario per guadagnare tempo per la mobilitazione delle proprie forze da impiegare in pianura , non poteva che essere il Piemonte.«( ... ) Noi potremmo forse essere costretti ad abbandonare il Piemonte» 7 1 aveva detto Ricotti provocando una levata di scudi tra i militari presenti . E mentre questi non giudicavano nemmeno pensabile lasciare al nemico quello che era la culla dei Savoia, il pur novare se Ricotti invece tornava provocatoriamente sul tema e spiegava che «per quanto anche a lui dispiaccia di abbandonare il Piemonte , egli preferirebbe ridursi in Alessandria , piuttosto che impegnare l 'i ntero esercito durante la crisi della mobilitazione » 72 intorno e davanti Torino . Ad Alessandria, in vece, sarebbero poi potuti giungere m eglio e più presto i rinforzi dalla pianura, dove comunque sarebbe sta ta impostata una manovra per linee interne.
A tale visione Ricotti era particolarmente legato. A chi parlava di fortificare il Ticino, per imbastirvi una resistenza attiva, egli ob iettava che «no n potrebbe ammettere come cosa molto probabile che il nostro ese rcito , dopo aver tocca to una rotta in Piemonte sia in grado di riprendere l 'offen siva, prima che il nemico sia entrato in Lombardia:. 73. E, allo stesso proposito, affermava addirittu ra che c:la probabilità di un ritorno offensivo dopo una serie di rovesci gli pare[ va] tanto lontana da non doversi prendere per base della sistemazione difensiva dello Stato» 74.
E dal momento che, dal 1881 (quando Ri cotti aveva fatto que-
7 1 fili, fase. III, p. 26, aJia dala del 13 luglio 1881.
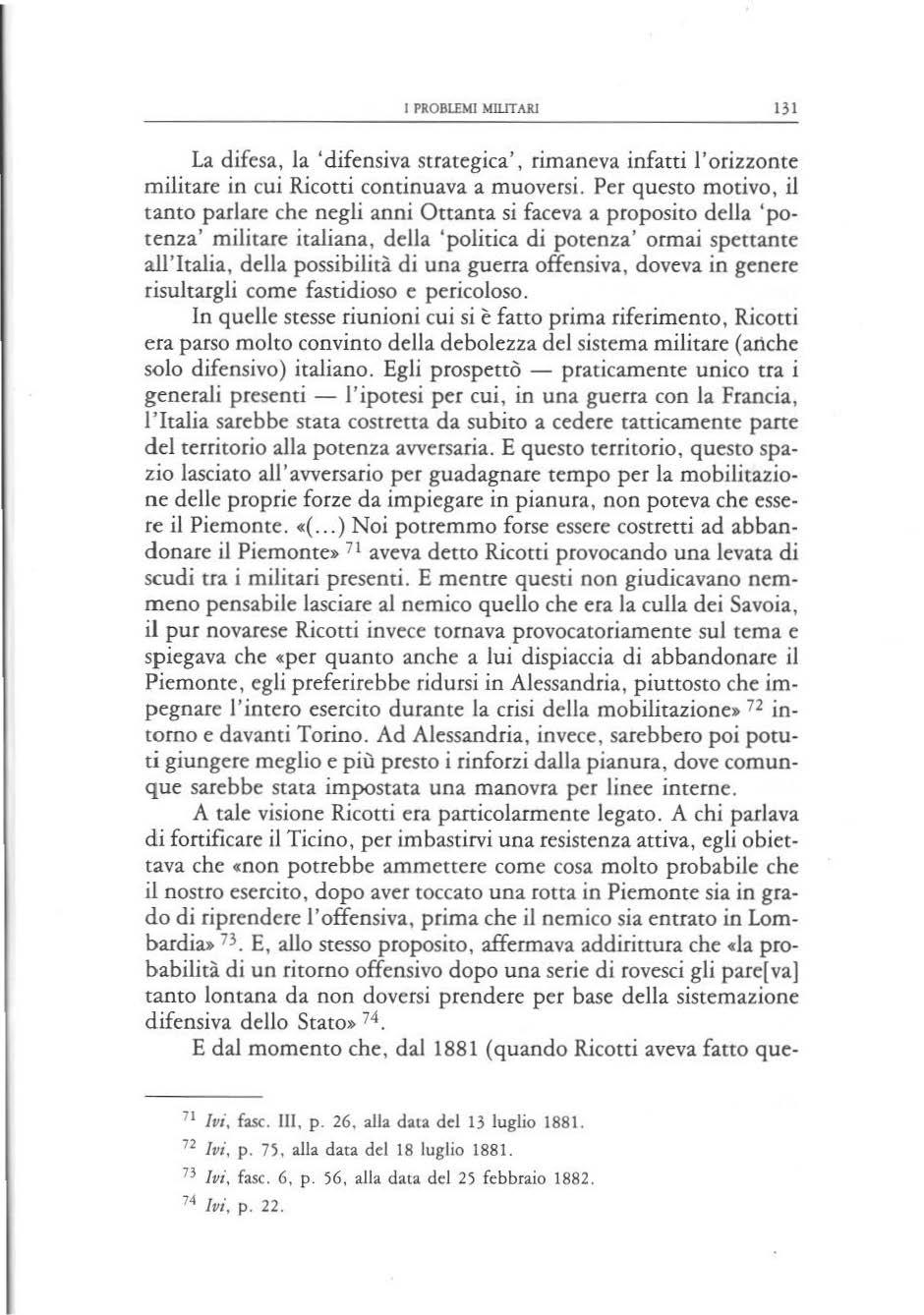
72 lvi, p 75, alla data del 18 luglio 1881.
73 lvi, fase . 6 , p. 56, alla dala del 25 febbraio 1882.
74 lvi, p. 22.
l PROBLEMI MILITARJ 131
ste affermazioni) al1884 (quando egli tornò a reggere la Pilotta) non vi erano state variazioni apprezzabili a favore dell'Italia per quanto riguardasse il teatro di guerra italo-francese (e casomai c'era stato il varo dell'ordinamento di Ferrero che, con quel suo diminuire le forze delle compagnie di Fanteria, era apparso al generale novarese una vera e propria diminuizione di forza dell'esercito), il suo atteggiamento mentale e la sua visione militare della difensiva come elemento centrale della prospettiva strategica italiana non doveva subire mutamenti sostanziali. Doveva anzi aumentare il timore che uno sbarco di forze francesi lungo il litorale tirrenico potesse tagliare in due le linee di comunicazione militari italiane.
È vero, però, che con la firma del trattato della Triplice Alleanza, dal punto di vista militare, l'Italia aveva in buona parte attenuato i timori di trovarsi costretta a dover battersi da sola contro la Francia. Ed è anche vero che, in linea generale, lo stesso Ricotti nelle riunioni della Commissione per la difesa dello Stato (pur negando nella forma radicale che è vista, ogni validità pratica alle teorie offensivistiche) aveva una volta accennato ad un difficile ma possibile ritorno offensivo dell'esercito italiano «essenzialmente nella previsione di qualche alleanza» 75 Si era quindi attenuato, dopo il1882, il pessimismo di Ricotti? Non doveva essere così.
Cesare Ricotti non sottovalutava le potenzialità nuove offerte all'Italia dalla Triplice: ma (cosciente dello sfavore che la politica militare italiana continuava a destare nei circoli politici e militari di Berlino e di Vienna) certo non era portato a sopravvalutarle. Inoltre, e soprattutto, le sue convinzioni sulla necessità di una difensiva strategica non erano basate tanto su valutazioni politiche o diplomatiche, quanto sulla coscienza e sull'analisi mzlitare delle debolezze e delle lacune dell'esercito.
Come nel 1881, anche negli anni del suo secondo Ministero la mobilitazione militare italiana rimaneva più lenta di quella francese, la forza numerica d eli' esercito inferiore, la capacità difensiva delle coste della Penisola ancora spesso inesistente. Nonostante laTriplice, perciò, la costituzione militare nazionale doveva continuare a sembrare a lui debole in vari dei punti decisivi.
E questo Ricotti lo fece capire anche negli anni del suo secondo periodo di direzione alla Pilotta. Nel gennaio 1886, quando (dopo più di un anno di permanenza al Ministero) egli aveva avuto modo

132 POliTICA E POLI
TICA MILITARE
l) lvi, fase. Il, p. 6, alla data del 25 novembre 1880.
di vagliare ancora meglio lo stato di salute dell 'organismo militare italiano, egli faceva scrivere sull'organo ufficioso del Ministero della Guerra un articolo assai importante, in cui si prevedevano le coordinate militari di «un caso possibile» di guerra con la Francia 76 _
L'ani colo sembrava ricalcato sulle posizioni che Ricotti aveva già espresso, nel 1881, nel chiuso delle stanze della Commissione per la dilesa dello Stato. Niente pareva mutato nelle posizioni del generale novarese in quei cinque anni, nonostante l'avvenuta firma della Triplice.
La valle del Po rimweva il teatro di guerra privilegiato: lì si sarebbe svolta la mwovra per linee interne nel caso possibile, in cui a ppunto l'esercito italiano avesse dovuto subire un primo scacco. Accentuata risultava la sottolineatura del pericolo che sarebbe potuto venire dal mare: la Fran cia, immobilizzate rilevanti forze italiane alla frontiera, avrebbe potuto con un grosso sbarco su lle coste del Tirreno centrale tagliare addirittura in due la penisola. E, forse solo a quel punto, l'e serc it o francese sarebbe riuscito a superare la dilesa alpina e padana dell'esercito italiano , tro vandosi questo o rmai «col morale rottO».
Con l 'autorità della voce ministeriale, anche nel 1886 non poteva quindi esserci, secondo Ricotti, una prospettiva militare realisticamente 'offensiva' per l'esercito italiwo.
Va da sé cp.e una simile presa di posizione- la quale, pubblica ta dal giornale del Mini ste ro della Guerra , poteva far pensare che tutta la pianificazione militare ital iana fosse ispirata a quei principi difensivistici- suscitò l e immediate reazioni dei fautori dell" offensiva' 77_ Il giornale mili tare «L'ese rcito italian o» repli cò duramente.

L' «Italia militare», a sua volta, colse poi l'occasione di ribadire il suo concetto (rispond endo, oltre che alla replica dc cL' esercito italiano», anche ad un altro artico lo 'offensivista' comparso su lla «Rivista militare italiana» ben sei mesi prima): la presa di posizione dell ' organo ufficioso acquistava così un valore perentorio 78 Tra l'altro (la replica era infatti assai argomentata) l' «<talia militare» tornava a ripetere i vecchi assunti di Ricotti: reale pericolo di uno sbarco avversar io, concreta possibilità di un'invasione del Piemonte (anche se non
76 Cfr. cl'ltalia militare», 2 gennaio 1886, Un caiO possibile.
• Cfr. la prima risposta dell'organo ufficiale in ivi, 6 gennaio 1886, Contraddizrom.
78 Più disteso, ivi, 6 gennaio 1886, La difesa di uno Stato come la intendono alcunz.
l PROBL.EM1 MIUTi\R.I 133
subito , all'inizio delle ostilità), profonda contrarietà agli eccessi nel sistema di fonificazione permanente. Ma - soprattutto - l'attacco ministeri al e era portato alla possibilità di applicare uno schema 'offensivista' (che gli altri due organi di stampa militare, invece, dichiaravano di considerare uno degli insegnamenti migliori della guerra del 1870), alla strategia militare italiana. Scriveva la voce ufficiosa del Ministero della Guerra, contro l'impostazione de «L'esercito ita• liano» e della «Rivista militare italiana»: «Voi applicate ad una guerra eventuale tra l 'Italia e la Francia [lo schema del]la sesta delle guerre combattute fra la Francia e la Germania, che non ci si attaglia in nessuna guisa» 79
Con una esplicitazione così decisa della linea di Ricotti la polemica giornalistica non poteva che dirsi conclusa.

Queste prese di posizione degli organi ministeriali celavano un mutamento della strategia italiana? Davvero Ricotti era l' anti-Ferrero, come dicevano i tedeschi? Davvero alla «offensiva possibile» era subentrata la «Stretta difensiva»?
Non crediamo che le cose siano andate così, anche se in realtà mancano tutti i documenti per poterlo affermare con cenezza. Due sono gli elementi che (leggendo le più varie testimonianze su quel periodo) emergono con maggior evidenza.
Polemiche come queste erano più un indice di incertezze e divergenze reali (tra i militari, nella impostazione di un indirizzo strategico italiano) che un segno dell'alternarsi di 'partiti' o di principi direttivi (difensivisti od offensivisti, difensiva od offensiva) alla guida della politica militare vera e propria. Una politica che, nel frattempo, invece seguiva il suo corso: un corso che sempre più, comunque, doveva allontanare l'esercito italiano dalle teorie 'alla Ricotti'.
Apparenti contraddizioni come quelle cui si poté assistere negli anni del secondo Ministero Ricotti (prese di posizione ufficiali per la 'difensiva' e aspirazioni 'offensivistiche') trovavano la loro spiegazione nel trasformismo imperante in quegli anni a livello politico, ma di cui anche a livello militare abbiamo già messo in evidenza varie manifestazioni. Un trasformismo che copriva quel nodo di incertezza e di stallo strategico (tra difensiva, offensiva di alleggerimento e operazioni sul Reno) cui si è accennato e che poi non era in potere di Cesare Ricotti - presentatosi sin dali' ottobre 1884, per il pesante intervento personale di Umbeno I, come un Ministro 'dimezzato'
134 POUTICA E POUTI CA MILITARE
79 lvi.
e comunque 'a sovranità limitata' -sciogliere, se non con radicali riforme militari.
Questa sona di trasformismo, o eclettismo, o indecisione, era notata anche all'estero. Sia l'alleato germanico, sia l'avversario francese, sia il più distaccato osservatore britannico controllavano attraverso attaché ed Intel/igence l'evoluzione militare italiana. Il loro 'giudizio estero', quando veniva rivelato dalla stampa militare nazionale, appariva talvolta segnato da dubbi profondi sulla qualùà dei comandanti e in genere dell'esercito italiano. Trapelava , stranamente, una certa sottovalutazione delle più recenti correzioni 'offensivistiche' apponate nel tradizionale orientamento strategico dalle forze armate del Regno sabaudo; ma quasi mai quei giudizi sopravvalutavano le oggettive difficoltà cui l'esercito italiano andava o sarebbe andato incontro. Il ruolo dell'Italia nella Triplice Alleanza veniva analizzato e ne usciva il più delle volte drasticamente ridimensionato.
Spesso quei giudizi esteri conducevano la loro attenzione sul tema dei rapporti tra esercito e marina. Se era vero che i dodici corpi d'armata erano stati un pegno decisivo offerto da parte di Roma al momento della stipula della Triplice Alleanza , di fatto anche l'apporto della marina militare italiana in eventuale confronto marittimo contro la flotta fran cese (immobilizzandone buona parte, impedendo un suo concentramento nei mari del nord ed il possibile conseguente blocco delle coste tedesche) poteva essere di un qualche interesse per la Germania. Ma cosa faceva- o poteva fare - l'Italia per venirle incontro?
L'importanza di questo tipo di valutazioni critiche, come abbiamo visto e come vedremo , era sentita anche in Italia. La coscienza dell'impotenza italiana ad una vera offensiva (verso Nizza, sulle Alpi , sul Giura svizzero , o sul Reno) e la mancanza di difese sufficienti sul lungo litorale tirrenico faceva temere le alte gerarchie italiane. Nel caso dì un conflitto contro la Francia, da soli o aiutati dall'alleato germanico, dove avrebbe dovuto essere atteso il primo colpo avversario? Dal mare o da terra? Le due forze armate nazionali tendevano il più delle volte a dare allo stesso interrogativo risposte divergenti, e rimaneva il fatto che la domanda rivelava l'insicurezza di fondo del sistema militare italiano.
In quegli anni si diceva che ogni nazione aveva un 'proprio' naturale sistema militare (o strategia): ovviamente si trattava solo di semplificazioni pubblicistiche o di definizioni ideologizzanti che sottolineavano, nazione per na.zione, solo alcuni dei componenti dell'intero sistema. Eppure erano definizioni acute. La Germania, prima

l PROBlEMI MILITARI 135
e dopo i11870, aveva basato- si diceva -la sua preparazione militare su 'truppe e ferrovie'. La Francia, invece, fondava il suo sistema militare su 'truppe, fortificazioni e ferrovie'. E l'Italia? si chiedevano gli osservatori esteri. Parafrasando, si sarebbe dovuto dire che il Regno sabaudo poteva contare solo su un po' di truppe e su qualche fortezza (se l'affermazione non risultasse troppo forte e riduttiva).

Negli anni di Ricotti, anzi, piuttosto che su fortificazioni a difesa o su un miglioramento dei meccanismi di mobilitazione (uno degli effetti, tra l'altro , di un potenziamento della rete ferroviaria), l'esercito aveva continuato ad affidare le sue fortune ancora una volta sul 'n umero' , sia pure non senza contraddizioni.
Poteva un grosso esercito (ma come armato? quanto efficiente? come comandato?) sostenere le ambizioni di taluni settori militari? Certo non era Ricotti, ma v'e ra più d'uno che credeva possibilecon quello strumento militare - un'offensiva sulle Alpi per contenere ed immobilizzare truppe francesi ed una spedizione offensiva sul Reno. Ma quanto si poteva credere possibile per l'Italia - nelle menti di questi militari- quel tipo di guerra su due fronti che era invece stato sempre massimamente temuto da Stati ben più potenti militarmente e ricchi economicamente, quali la Franc ia , l'Austria e la stessa Germania?
Questi erano solo alcuni degli aspetti che osservatori militari stranieri notavano, stupiti, nel divario tra la realtà del potenziale bellico italiano e le ambizioni di taluni settori militari nazionali. Ricorrevano infatti anche altri spunti di riflessione, di ordine assai vario. Quali sarebbero state le conseguenze sul morale militare italiano nd caso di un eventuale- e possibile- primo insuccesso campale? Od anche: nel caso di una penetrazione di forze militari italiane attraverso la Svizzera (allo scopo di incontrarsi alle falde del Giura con truppe tedesche, per dirigere un'offensiva congiunta verso Lione) sarebbero esse state preparate a combattere - e a difendersi da - la guerra partigiana che probabilmente le milizie svizzere avrebbero praticato?
Altre annotazioni, invece , potrebbero farsi a partire dallo stesso esame della pubblicistica militare italiana (e delle sue lacune). L' assoluta mancanza di una previsione degli sbocchi di un possibile dopoguerra, il disinteresse verso le forme di finanziamento della guerra (che, se lunga , avrebbe potuto rovinare le casse dello Stato), l'assenza di studi sulle possibilità di mobilitazione totale di tutte le forze vive della Nazione, anche nel caso di un breve ma colossale conflitto (attraverso il meccanismo delle Milizie di seconda e terza linea, il coinvolgimento delle società paramilitari, lo stimolo alla forma-
136 POLITICA E POLITICA MILITARE
zione di una leva volontaria) confermavano i limiti evidenti della capacità prefigurativa e della professionalità militare.
In generale, però, si doveva ammettere che gli appunti mossi dagli osservatori d'oltralpe sollevavano temi più latamente politicomilitari. Ad esempio, se povere erano giudicate le basi oggettive dell' offensivismo militare italiano, non si poteva trascurare che tali orientamenti tecnico-militari rispondevano anche a determinati piani politici. Non era un mistero per nessuno che, prima la firma della Triplice, poi l'obiettivo della spedizione al Reno, erano stati funzionali ad un disegno politico e diplomatico teso a portare l'Italia al tavolo di possibili conferenze di pace post-belliche con qualche carta da giocare. La Triplice, l'offensiva, il Reno, insomma, erano anche e soprattutto obiettivi politici. Compito delle più alte gerarchie militari avrebbe dovuto essere quello di denunciare l'inadeguatezza dello strumento militare nazionale a raggiungere quegli obiettivi politici. Ciò non fu fatto.
È così che, in tutto questo, quello che colpisce è il progressivo rafforzarsi delle posizioni 'offensivistiche' 80 e il permanere di quella sona di 'euforia di potenza' 81.

Gli impazienti, ed anche nell'esercito italiano e tra i pubblicisti militari ve ne erano, continuavano a premere. E a criticare l'amministrazione Ricotti che secondo loro, con la sua 'sosta', non voleva porre riparo alle stonure e alle lacune d eli' ordinamento dell' esercito.
Confini e coste, Esercito e Marina
Ancora molto resta da fare in Italia per una storia delle istituzioni militari in senso- si direbbe oggi - 'interforze', una storia che permetta di ricostruire unitariamente e parallelamente l'evolu-
80 Talvolta funzionali alle tendenze offensivistiche erano anche gli scudi di geografia militare. Tra questi cfr. G. PERRUCCHETTI, Esame del teatro di gue"a italoaustriaco, Torino, 1878 ; ID., Teatro di gue"a italo -franco, dal T icino al Rodano: studio di geografia militare, Torino , 1883; ID. , Teatro di gue"a italo-svizzero: studio di geografia mzlitare, Torino, 1883. Sulla geografia militare cfr. intanto, M. QUAINI , La lezione della geografia mzlitare , in cHerodote. Italia», a. l (1975) n. O, pp. 95-116. 81 Per gli eventi successivi , e panicolarmente per la Convenzione militare italogermanica del 1888 , oltre alle opere già citate, cfr. R. MORI , Crispi e la Tnj;lice. Gli accordi mzlitari italogermanici, in cRassegna storica toscana•, a. XVI (1970), n . l; e M. MAZZETTI , L 'Italia e le convenzioni m:litari segrete della Triplice Alleanza, in cStorìa contem poranea» , a. I ( 1970) , n. 2.
l PROBLEMI MILI TARJ 137
zione delle forze armate nazionali, cogliendone i momenti di unità come quelli di contrasto 1
Che i rapporti tra Esercito e Marina negli anni '80 ed in specie in quelli del secondo Ministero Ricotti fossero decisivi per l'Italia di quegli anni era questione già nota 2 Quello che qui si pretende di fare non è certo scrivere un paragrafo di una tale storia, ma più semplicemente tentare di descrivere come, dall'interno dell'esercito del periodo di Ricotti, fosse percepito il rapporto più generale con l'altra forza armata e come fosse visto il vigoroso sviluppo che proprio in quegli anni la Marina militare nazionale andava conoscendo.
Da subito, va rilevata l'importanza (oltre che per la storia militare, per la storia d'Italia più generale) del rafforzamento degli interessi marittimi e delle attività economiche armatoriali e cantieristiche nazionali cui si assisté negli anni Ottanta 3.
Confrontarsi, infatti, in quegli anni sul ruolo e sul futuro marittimo dell'Italia era una questione di grande momento, che coinvolgeva una valutazione dello stato dei rapporti tra le potenze marittime del Mediterraneo ed una previsione del ruolo commerciale ed economico, ma anche politico e militare, che l'Italia avrebbe potuto o saputo giocarvi.
In un probabile ruolo 'mediterraneo' dell'Italia grande spazio aveva quindi la definizione del futuro della Marina Militare. Non va infatti sottovalutato il fatto che proprio la Marina Militare poteva divenire una dei principali destinatari possibili della produzione cantieristica nazionale, soprattutto se l'Armata fosse andata indirizzandosi (come pareva) verso la costruzione di grandi corazzate. Come non va dimenticato che era sempre la Marina Militare - sia pure col concorso non trascurabile dell'esercito - che proprio in quegli anni era la più interessata al nascere di uno stabilimento industriale imponente e destinato a lunga vita come quello delle Acciaierie di Terni 4.
Se pure non si può e non si deve ridurre il forte dibattito navali-
1 Cfr. ancora DEL NEGRO , Studi militan· sul Risorgimento e sull'Italia liberale, 1870- 1914, cit.
2 Cfr. VENTURINI , Militari e politici nell'Italia umbertina, cit., p 230.

3 Manca uno studio specifico. Per alcuni risvolti più immediatamente politici di questa complessa vicenda, si veda ancora R. MORI, La politica estera di Francesco cn·spi, cit ..
4 Cfr. BONEW, Lo sviluppo di una grande impresa in Italia. La Temi dal1884 aii962, cit .. Una breve nota su questo volume in ROCHAT , MASSOBRIO, Breve stona dell 'esercito italt'ano dal 1861 a/ 1943, cit., p. 123, n. 14.
138 POLITICA E POUTICA MlLITARE
stico (mercantile-commerciale e militare) degli anni Ottanta in Italia al più circoscritto argomento del futuro e degli indirizzi da darsi alla Marina Militare, non deve essere trascurato il dato di fattopresente ai politici ed agli industriali del tempo - che senza una Marina Militare fone non ci sarebbe stato alcun futuro navale e mediterraneo italiano. Anzi, proprio quel puntare su una accelerata evoluzione dello strumento militare navale piuttosto che sul più naturale ma più lento sviluppo dell'industria e dei commerci poteva apparire, agli occhi dei contemporanei, la 'scorciatoia' per arrivare prima del dovuto all'ambìto status di grande potenza , anche marittima s.
D'altra pane, la situazione militare e politica nel Mediterraneo non invogliava ceno alle più rosee speranze per il regno umbenino.
L'Inghilterra, colla spedizione egiziana del 1882 e con la riedizione - nel pono di Alessandria - della intimidatrice politica delle cannoniere, aveva sanzionato il suo interesse alla piena agibilità mediterranea per i suoi commerci ed aveva ribadito la decisione di mantenere sotto il suo controllo e sotto la sua egemonia la parte orientale del Mediterraneo stesso. La Francia, che nel 1881 aveva occupato la Tunisia e che non nascondeva le sue mire·sul Marocco (controllato il quale avrebbe avuto mano libera in tutto il Mediterraneo occidentale), non trascurava occasione per manifestare la forza della sua Marina Militare e per scoraggiare gli interessi navali italiani 6.
Di fronte a queste potenze l'Italia si trovava in condizioni di palese inferiorità, quando anche avesse voluto affermare il suo 'diritto' all' imperium mans obtinendo colla sola forza del suo strumento militare ed allo scopo di difendere i propri interessi transmarini 7 Ma prima ancora che di assicurare i propri commerci mediterranei l'Italia del tempo appariva incapace di garantire lo stesso territorio nazionale da ipotetici attacchi, sbarchi e colpi di mano anfibi avver-
5 Cfr. G. BARONE, Lo Stato e la Man·na mercantzle in Italia 1881-1894, in «Studi storici•, a. XV (1974), n. 3, pp. 624-6)9.

6 Cfr. M. GABRIELE , Le convenzioni navali della Tn'plice, Roma, Tip. Regionale, 1969, pp. 19-27 e p 38.
7 Cfr. M. GABRIELE, G. FRIZ , La flotta come strumento dì politica nei pn.mi decenni dello stato unitan·o italiano, Roma, 1973 (in testa ai front.: Ufficio Storico delI-a Marina Militare); e M. GABRIELE, G. FRIZ, La politica navale italiana dal1885 al 1915, Roma (Gaeta, Stab Graf. Milit.) , 1982 (in resta ai front.: Uffi cio Storico della Marina Militare).
l PROBLEMI MILITARI 139
sari 8.
La stessa stipulazione della Triplice Alleanza non aveva granché assicurato una più facile difesa della penisola dalla parte di mare. L'alleata Austria guardava con un certo sospetto al mantenimento da parte italiana di una flotta militare persino nel solo Adriatico ed in più occasioni manifestò la sua riluttanza a voler collaborare militarmente con la Marina italiana in quelle acque, sulle cui rive balcaniche l'Italia pareva nutrire qualche ambizione commerciale e politica 9.
Sia prima sia dopo il 1882 comunque, il pericolo maggiore veniva ali 'Italia marittima da parte della Francia.
In Italia, negli ambienti della Marina, si andava radicando a questo riguardo la lezione strategica della blue water school che predicava la necessità d i imporre la propria egemonia militare allargo delle coste e delle acque nazionali, lanciando la flotta militare nazionale contro quella avversaria alla ricerca offensivistica della battaglia risolutiva ed annientatrice IO_ E, per inciso, si potrebbe anche dire che, proprio su questa piattaforma offensivistica, la Marina Militare andava trovando una sua nuova e più compatta unità 11 , dopo il periodo di profonde divisioni interne che l'avevano caratterizzata'negli anni immediatamente successivi al 1861 quando era stata formata sostanzialmente dalla giustapposizione dei due tronconi ex-piemontese ed ex-borbonico delle cessate Marine degli Stati preunitari e negli anni '70, quando era stata bloccata dalle controversie tra Acton, Brin e Saint-Bon.
Se pure sono ancora necessarie più specifiche e più approfondite ricerche non pare che si possa affermare che negli anni del secondo Ministero Ricotti i lineamenti di questo complesso mutamento del ruolo della marina militare italiana fossero percepiti con chiarez-
8 Cfr. ivi, p. l. Scrivono gli autori, proprio in apertUra del volume, che c:il principale problema militare del paese, durante gli anni della Triplice, fu quello della difesa delle coste. U no scenario allarmante si presentò per decenni a coloro che dovevano provvedere a tenere lontano la minaccia nemica, che veniva valutata come reale e concreta e condizionò in buona parte la politica estera e la politica militare italiana». Assai vasta è la letteratura pubblicistica di quegli anni: una sua u tilità ha lo scritto (non imparziale) di F. MARIANI , La difesa della corte: sunti bibliografici, Roma, Voghera, 1887 (già apparso sulla «Rivista di Artiglieria e Genio »)
.
9 Cfr. anche M. GABRIELE, Aspetti del problema adnatico con particolare n/erimento al pn'mo rinnovo della Triplice, in .:Memorie storiche militari 1979», Roma, 1980.
1° Cfr. GABRIELE, Le convenzioni navali della Tnplice, cit., pp. 21-23.
11 Cfr. GABRIELE, La flotta com.e strumento di politica nei primi decenni dello stato unitan'o italzano, cit., passim.

140 POUTICA E POU'fiCA MILITARE
za- e, quindi, tanto meno apprezzati- negli ambienti militari dell'esercito. La marina militare (n ella pubblicistica, nella stampa militare d'informazione, negli ambienti e nei progetti del Ministero della Guerra o dello Stato Maggiore dell'Esercito) era ancora vista come la 'sorella minore' dell'esercito, talvolta come il suo 'braccio' marino, spesso secondo una interpretazione che si sarebbe potuto dire ancora tutta 'piemontese'. Della marina militare, frequentemente, gli alti comandanti dell'esercito vedevano solo la costante inferiorità di f ronte al potente nemico francese piuttosto che il suo recente rafforzamento e rinnovamento strutturale.
Tra le varie autorità militari che avevano contribu ito al formarsi di un simile indirizzo strategico per l'esercito, Cesare Ricotti era forse quello che più chiaramente di altri poteva impersonare queste concezioni. Ciò che, tra l'altro , rimaneva massimamente estraneo dal1' orizzonte concettuale del generale novarese era che la Marina italiana potesse giocare un ruolo 'offensivo' contro gli avversari marittimi dell'Italia: una tale 'pretesa' della Marina contrastava con l'indirizzo strategico più generalmente 'difensivistico' del generale, con la sua valutazione del potenziale militare naval e italiano e soprattutto con quelli che dovevano essere invece i compiti e gli indirizzi dell'Esercito.

Confermando sue precedenti prese di posizione, Ricotti nel corso delle riunioni della Commissione Suprema per la Difesa dello Stato aveva affermato che
considerando la nostra grande inferiorità di mezzi finanziari rispetto alla Francia , non è probabile che per molti anni ancora la nostra Marina possa essere messa in grado di dar battaglia con probabilità di successo alla Marina francese 12 Quindi, per il novarese, era meglio lasciar perdere le applicazioni delle teorie offensivistiche alla guerra i tal iana per mare:
Fino a tanto che la nostra flotta non è distrutta, egli [Ricotti) non crede pos· sibile che il nemico tenti operazioni di sbarco.
E perciò egli ritiene che il vero compito della Man'na dovrebbe essere quello di evitare i combattimenti e di costituire una continua minaccia.
Questo sarà compito meno brillante ma certo assai più proficuo per la difesa del Paese 13 .
12 AUSSME , Ordiname nto e m obilitazione, racc. 69, fase. 3, p. 9 1, alla data del 20 luglio 1881.
13 lvi, p. 15, alla data dell'll luglio 1881.
l PRO BLEMI MlllTARI 141
Detto per inciso, una simile, schietta affermazione non poteva non attirarsi le ire dei rappresentanti ufficiali della Marina, presenti a quelle stesse sedute. Tra loro, fu l'Ammiraglio Pacoret di Saint Bon a replicare sdegnato: cUna simile condotta ripugnerebbe ai sentimenti della Marina. 14 .
Ma l'impostazione data ai lavori di quella Commissione non esigeva che i presenti dovessero schierarsi in un verso o nell 'a ltro sulla complessa questione del rapporto strategico tra Esercito e Marina: così il tema, seppur poi risollevato anche polemicamente da Ricotti e da altri , non fu sviluppato quanto forse invece avrebbe meritato.
Nel suo periodo di permanenza alla Pilotta tra ill884 ed ill887 il probl ema strategico dei rapponi tra Esercito e Marina non poteva non emergere. Come si è detto, furono quelli gli anni in cui la marina militare italiana conobbe alcune decisive modificazioni , nella sua costituzione materiale (navi, arsenali, rapporti con l'industria) come nella sua dottrina strategica.
L'avvento di Ricotti , di cui negli ambienti dell'esercito erano note le predisposizioui poco benevole nei confron ti della Marina, avrebbe potuto anche essere interpretata come un segnale di riaffermazione della 'supremazia' delle forze armate di terra rispetto a quelle di mare. Si assisté invece, nel corso di quegli anni, ad una ennesima operazione di sapore trasformista. Come vedremo il timore e la sfiducia degli ambienti direttivi dell'esercito nei confronti dell'efficienza difensiva del litorale nazionale da pane della Marina non scemarono , né fecero posto ad una ri considerazion e generale - militare e strategica- sui rapporti tra esercito e marina (a favore della quale pure si erano manifestati nel dibattito militare suggerimenti e spinte). Su questi rapporti, anzi, fu dispiegata una generica e trasformistica coltre di 'buoni rapporti' formali ed este riori, che indussero in errore anche attenti conoscito ri del mondo militare.
La più chiara manife stazione della sfiducia dell'esercito nei confronti della marina si può ritrovare nell'attività di pianificazione e di addestramento di quadri che lo Stato Maggiore andava svolgendo. Piuttosto che nelle annuali e teatrali grandi Manovre , organizzate e gestite direttamente dal Ministero della guerra 15 , il timore di un insuccesso marittimo della Marina italiana e di uno sbarco di forze francesi era in quegli anni evidente nell'indirizzo delle più rise r-
14 lvi, p. 16.
t5 Cfr. AUSSME, Ordinamento e mobilitazione, racc. 78, volume Segreteria. Uf ficio Istruzioni e manovre.

142 POLITICA E POLITICA MIUTA RE
vate e circoscritte - ma più interessanti - manovre ed esercitazioni dirette dallo Stato Maggiore 16.
Nella loro duplice possibile forma, quella di esame pratico per il 'corso di esperimento per ufficiali del Corpo di Stato Maggiore' (co rso che andava superato per essere ammessi al Corpo) e quella più tecnica di 'manovre coi quadri per ufficiali di Stato Maggiore', le manovre organiz.zate da Coseoz rendono assai bene l'idea delle 'preoccupazioni più ricorrenti', delle 'idee diffuse' negli ambienti dello Stato Maggiore di quegli anni.
Dovunque esse s1 svolgessero, negli anni del secondo Ministero Ricotti (ma, come si è visto, anche prima), il tema ricorrente era costituito dal timore di uno sbarco francese in qualche località del litorale tirrenico e la conseguente necessità per l'esercito italiano di fronteggiar e una parte delle forze avversarie nel mezzo del territorio nazionale, spesso nel cuore della penisola, e forse anche di resistere per qualche giorno in situazione di inferiorità di forze (con assedi o combattimenti d'arresto e d'incontro campali) nell'attesa dell'arrivo dei rinforzi. Tutte cose che presupponevano una sconfitta in mare aperto della Marina militare nazionale, o un'elusione dei suoi controlli del litorale da parte di forze avversarie.

Già nel1880, sulla linea Gubbio-Nocera, fu saggiata la capacità di resistenza italiana in una zona semi-montuosa, di fronte ad ipotetiche forze avversarie provenienti da sud 17 Nel giugno 1881, mediante l'uso di ferrovie, fu la volta della possibilità di arrestare tra Napoli e Gaeta un attacco avversario sempre da sud, mediante truppe trasportatevi dalla Toscana a Roma e da qui a Napoli 18 Nel marzo 1882 lo Stato Maggiore ideò una esercitazione combinata, con la previsione di due sbarchi avversari successivi, uno nei pressi di Orbetello ed un altro ben più temi bile tra Roma e Civitavecchia 19. In questo caso, il tema prevedeva addirittura che, invece di marciare direttamente sulla capitale, le truppe avversarie si impadronissero del Monte Amiata, tagliando in due la difesa nazionale italiana e interrompendo ogni linea di comunicazione.
16 Raramente la stampa d ' informazione militare (che invece dava grande spazio alle grandi manovre ed alla conduzione dei 'campi estivi') accennava allo svolgimento di queste più limitate esercitazioni, che spesso rimanevano quindi ignorate dalla stampa politica e dai dibattiti parlamentari.
17 Cfr. AUSSME, Campi e manovre, racc. 2, fase. b (i fascicoli non sono numerati).
18 Cfr. ivt', fase. a.
l 9 Cfr. ivi, fase . c.
l PROBLEMI MILITARI 143
Già allora però si potevano notare segni di doppiezza tra le idee (o la pianificazione) dei militari d eU 'Esercito e le loro pubbliche prese di posizione. In quei giorni il capo di Stato Maggiore Enrico Cosenz aveva scritto una lettera al Ministro della Guerra Ferrero in cui esponeva le su e perplessità e i suoi timori sulle falle dell'azione difensiva della Marina e in cui indicava come più temi bile ipotesi bellica quella che prevedesse al suo interno uno sbarco - non puramente diversivo - «il quale si propon esse come obiettivo immediato la Capitale d'Italia» , e che egli riteneva allora avrebbe potuto essere tentato da eventuali forze attaccanti francesi tra Monte Argentario e Terracina 20 Eppure era lo stesso Cosenz che, so lo qualche mese più tardi nel rispondere ai quesiti della Commissione Parlamentare che vagliava la richiesta della Commissione Suprema per Ja Difesa dello Stato di spese militari straordinarie, indicava invece nel tratto di costa tra Fiumicino e Civitavecchia quello più favorevole al nemico 2 1. Poi, nel marzo 1883, sotto la direzione di Ricci- comandante in seconda lo SME - fu esperimenta ta la difesa del tratto di strada che da Livorno e Viareggio cond uce a Firenze, con l'obiettivo della salvaguardia della ferrovia strategica Firenze-Pistoia 22 . Sempre sotto la direzione di Ricci, nel1883 erano state con dotte manovre combinate tra Esercito e Marina in prossimi tà di Napoli 2 3. In questa occasione, scopo della Marina era stato deciso dovesse essere quello di mantenere la sua libertà d'azione, di attaccare i grossi convogli militari avversari al momento dello sbarco, ma di evitare ad ogni costo qualunque combatti mento che non avesse lo scopo di ritardare o impedire gli sbarchi nemici (e cioè di evitare quelle battaglie di altura, cui pareva invece indirizzarsi la strategia offensivistica della Marina).
Tra il 1883 ed il1884, sotto indicazione dello Stato Maggiore , era la Divisione militare di stanza a Palerm o che - con una manovra coi quadri - si voleva supporre sottopoSta al pericolo di uno sbarco avversario a Porto Empedocle: sbarco che nella manovra, nonostante ogni sfo rzo delle truppe a difesa, riusciva perfettamente 24. Sempre nel 1883 si era tentato, in una previsione di uno sbarco a Civitavecchia, di arrestare nella zona tra Roma e Bracciano l'avanzata delle

2°
Cfr. ivi, fase. d, 4 febbraio 1882, Cosenz a Ferrero (estratto).
21 Cfr. ibidem.
22 Cfr. ivi, fase. d.
23 Cfr. ivi, racc. 3. fase. a.
24 Cfr. ivi, fase. b.
144 POUTICA E POUTICA MIUTARE
forze provenienti dal mare. Ma con il risultato sconsolante che, come emerge dalla «Relazione complessiva» stesa a chiusura della manovra, non si poteva nemmeno essere sicuri di riuscire a compiere nella zona di Orte il concentramento delle truppe italiane a difesa, dal momento che azioni avversarie avrebbero potuto costringere ad effettuarlo in posizione ancora più arretrata 25. Nel novembre 1884 la 'Manovra coi quadri eseguita dagli ufficiali del Corpo di Stato Maggiore' (cui parteciparono, tanto per dare l'idea della qualità e dell'attendibili t à di t ali manovre, ufficiali dell'importanza e del futuro come Ricci e Viganò alla Direzione, Orero, Goiran e Caneva per il 'Partito Nord', e Dal Verme, Radicati, Nava e di Robilant, per il 'Partito Sud') ebbe addirittura il compito di saggiare la possibilità di formare, radunare ed inviare - in tutta fretta e con urgenza - un consistente distaccamento di forze da Roma verso i colli Albani, perché affrontasse un imprevisto sbarco di forze avversarie, facendo in modo di prevedere l'impossibilità (da parte dei centri militari della Capitale) di sostenerlo e supportarlo adeguatamente 26. Nella palese gravità del tema si può 'leggere' tutto il timore e tutte le preoccupazioni degli ambienti dello Stato Maggiore.
Quando Ricotti salì di nuovo alla Pilotta, quindi, l'orientamento preval ente e consolidato nell'Esercito ricordava già molto da vicino quelle che erano le convinzioni personali del Ministro.
Negli anni del secondo Ministero Ricotti, infatti, i timori dello Stato Maggiore (e del Ministero) non sembravano essere scemati. Anzi, le manovre indicavano una tendenza a ipotizzare quan t o mai possibile uno sbarco avversario in prossimità di Roma. Nell'aprile 1885, nello stagno di Maccarese, nella bassa valle del Tevere, sotto la direzione di Pozzolini venne eseguita una manovra coi quadri tendente a saggiare i più minuti particolari logistici e tattici di una difesa ravvicinata della capitale 2 7. Nell'aprile del 1886 si ipotizzava già occupata dai francesi Frosinone e si manovrava per attendere ed arginare un secondo sbarco presso Civitavecchia 28. Nello stesso anno, a marzo, era stato Orero a dirigere un corso di esperimento per gli ufficiali di Stato Maggiore, in cui si ipotizzava che i francesi avanzasse-

l PROBLEMI MILITARJ 145
25 Cfr. ivi, fase. c. 26 Cfr. ivi, racc. 4, fase. a. 27 Cfr. ivi, racc. 5 , fase. a. 28 Cfr. ivi, fase . b. 29 Cfr. ivi, racc. 6, fase. a.
ro da Civitavecchia verso Roma mentre le forze italiane tentavano il blocco della Val di Nava 29.
Nel 1887, nel maggio, si ricostruì lo scenario militare di un tentativo di liberare La Spezia, bloccata da pane di mare ma anche assediata da pane di terra da foni truppe nemiche 30 . Nel marzo , si era immaginato in un 'corso di esperimento per ufficiali di Stato Maggiore' che gli sbarchi francesi - convergenti su Genzano - fossero più d'uno e rutti imponenti 3 1
E si potrebbe cont inuare, se già questa elencazione non rende sse abbastanza chiaramente quale fosse lo stato d'animo dello Stato Maggiore e dell'esercito rispetto al tema della minaccia francese per via di mare. Può essere significativo notare che nessuna di queste manovre o corsi di esperimento o esercitazionj (che e rano poi le esercitazioni degli anni Ottanta, degli anni considerati 'felici ' per l ' esercito italiano) prevedesse l 'ipo tesi di un fronteggiamento armato ai confini e alle frontiere , e che tutte profilavano invece la minaccia di una 'guerra in casa'. Alla preparazione ed all'esperimento di una grande battaglia in pianura, allo sboccare delle valli alpine, erano dedicate le sole (ed annuali) Grandi Manovre, di cui però come si vedrà veniva criticato l 'eccessivo formalismo.
Il ricorrente, ossessivo timore di un colpo di mano francese nella attività dello Stato Maggiore chiarisce poi ed integra in manier a decisiva il dibattito tecnico che sulle rivist e militari del tempo si andava evidenziando a proposito d eli' assetto da darsi alle fortificazioni per la difesa dello Stato 32 Mentre nel dibattito pubblico venivano sotto lineati e discussi i temi della difesa alpina ed interna, nella concreta attività dello Stato Maggiore era la minaccia di uno sbarco francese a monopolizzare l'attenzione.
A questo proposi to, ne ll 'organizzazio ne e nel pensiero degli Stati Maggiori, pareva quasi non avere rile vanza una riflessione sull'entità delle forze che la flotta francese avrebbe potuto sbarcare sui litorali italiani. La previsione più ricorrente ipoti zzava una forza di sbarco

29 Cfr. ivi, racc. 6, fase. a.
30 Cfr. ivi, racc. 5, fase. c.
3l Cfr. ivi, racc. 6, fase. a.
32 Senza dimensioni paragonabili a quelle raggiunte nella prima metà degli anni Senanta, il dibattito pubblico militare sull'assetto e sull'uso del sistema fonificatorio nazionale continuò anche negli anni Ottanta. In realtà, però (a differenza di quanto in pane accadde durante il primo Ministero della Guerra di Cesare Ricotti) negli anni Ottanta tutti i giochi per le fonificazioni erano già stati farti nelle riunioni segrete della Commissione per la difesa dello Stato.
146 POUTICA E POUTICA
MWTARE
nemica che poteva giungere sino ad un corpo d'armata: ma sarebbero bastate forze anche minori (o sbarchi più numerosi) per mettere in crisi tutto il meccanismo di mobilitazione italiana, tagliare i collegamenti tra la Capitale e la pianura padana, causare direttamente o indirettamente il collasso delle forze dislocate nel più tradizionale campo di battaglia per le armi italiane dal Risorgimento in poi.
Tutto ciò poteva avvenire sostanz ialmente per l'in capacità di difesa del litorale e delle acque territoriali della Marina.
Questo permette di inquadrare anche la dibattuta questione della difesa dei litorali e di cogliere l 'aspetto determinante della percezione militare di un problema strategico che aveva interessato - per motivi vari e diversi - anche ambienti politici ed economici nazionali.

L'interesse militare che proprio nella prima parte degli anni Ottanta, e particolarmente negli anni del Ministero Ricotti, si andava appuntando sul tema della difesa costiera pareva ridursi (nonostante le ripetute affermazioni verbali o pubbliche sulla necessità di una più fitta serie di fortificazioni fisse) in sostanza alla intima convi nzione , secondo i militari della forza armata di terra, della necessità di una funzione di supplenza da pane dell'esercito nei confronti della manna.
Un tale orientamento strategico, diffuso negli ambienti dell 'esercito, avrebbe potuto proporsi due (diversi) scopi politici: o rafforzare militarmente (e sostenere finanziariamente) quei compiti di supplenza dell'esercito, ovvero- in senso opposto- dirottare grandi fondi dalle casse statali verso la politica cantieristica della marina militare (che, con la cos truzione delle grandi navi progettate , pensava a suo modo di assi curare la difesa del litorale e soprattutto di poter prospettare una vittoria italiana in una eventuale grande battaglia marittima). Ma si esigeva una chiara presa di posizione: la via prescelta (da Ricotti , da Brio , da Depretis) fu invece ancora una volta quella delle mezze misure.
La legge sulla difesa costiera che il Minist ero della Marina fu spinto a preparare e a far votare al Parlamento nel 1886 non rimediava che so lo parzialmente al problema della difesa dei litorali né, soprattutto , esprimeva una chiara opzione politico-militare tra quelle due possibili 33 .
H Cfr. AA.PP., Camera, Legisl. XVI, sess. unica, Discussioni , cornata del 17 dicembre 1886.
l PROBL.EMI M!UTARI 147
Ed è già noto che nell'inverno 1886, dopo la votazione di quella legge, una Commissione Militare presieduta da Volpe giudicava ancora solo secondario l'apporto della Marina rispetto a quello dell'Esercito in tema di difesa delle coste 34 .
Il fatto era che, come si è detto, la Marina andava orientandosi sempre più verso le dottrine strategiche offensivistiche e verso l' ipotesi di una grande battaglia risolutiva. Ma se gli ammiragli mostravano di contare sulla forza dei 'molti Duili lanciati nel mare' 35, i generali continuavano a temere il confronto diretto marittimo tra le forti (ma poche) navi italiane con la molto più numerosa e complessivamente più forte Marina Militare francese ed a paventare cosa sarebbe successo se ad una sconfitta in mare aperto della flotta italiana fosse seguita la completa indifendibilità delle coste della penisola. Se questi erano i grossi problemi di fondo, bisogna ammettere che il dibattito pubblico e pubblicistico sul tema della difesa delle coste affrontò invece raramente in maniera esplicita la questione cruciale del reciproco ruolo strategico di Esercito e Marina e si ridusse spesso a diatriba tecnica quando anche non acquistò un tono ed un sapore regionalistico 36: notabili di ogni provincia vedevano con piacere la possibilità di controllare qualche fetta di quel grande programma di lavori pubblici che la difesa delle coste poteva richiedere. Difendere e fortificare il litorale ligure o quello toscano, quello laziale o quello meridionale, spesso diveniva inoltre- negli scritti di pubblicisti militari minori - l'occasione di fare sfoggio di personali teorie militari o di particolari punti di vista su questa o quella arma (cannone, obice, mitragliatrice) che meglio avrebbe potuto difendere questo o quel tratto di coste. Nella babele delle opinioni si rischiava così di perdere di vista il punto centrale.
34 Cfr. GABRIELE, Le convenzioni navali della Tnp!ice, cit., p. 29, che ricorda inoltre il contemporaneo fallimento delle manovre navali italiane di quegli anni (cfr. ivi , pp. 16-17 e p . 45 ).

35 Cfr. E. FERRANTE, Il potere man"ttimo. Evoluzione ideologica in Italia 1861-1939, suppl. a.:Rivìsta marittima», a 1982, n. 10; ed anche ID. , Benedetto Bn'n e la questione man"ttima italiana (1866-1898}, suppl. a cRivìsta marittima», a. 1983, n. 11 , p. 75.
36 Anche reali problemi militari e strategici, come quello del rappono (o della scelta) tra i poni e gli arsenali dì Taranto o Napoli venivano a colorarsi di poco chiare lotte dì interessi locali. Per alcune prime ( apologetiche) informazioni, cfr. A. PANARA , La Man'na Militare pioniera dello sviluppo socio economico di Taranto, in «Economia e storia., a. l (1980), n 3, pp. 358-369. Sterminata è la letteratura pubblìcistica sui temi della difesa costiera ravvicinata: ma appunto talvolta solo tecnica, ta l'altra inficiata dalle pecche di cui sopra, tal'altra ancora solo superficiale e disinformata .
148 POUTICA E POLITICA MILITARE
Altrettanto esemplificativa del trasformismo dei tempi, e solo in parte già nota 37 , fu l'idea di Ricotti di devolvere qualche milione del bilancio della Guerra a favore di quello della Marina quale proclamato segno di comprensione e di collaborazione delle due forze armate per il bene della 'potenza italiana'. Il Ministro affermò di voler seguire questo indirizzo già poco dopo la sua nomina nell'autunno 1884 e poi , con maggiore concretezza, dopo le elezioni del maggio 1886.
L'affermazione , in apparenza, poteva accontentare un po' chiunque: gli ambienti della Marina come quelli dello Stato Maggiore dell'Esercito, come l'opinione pubblica.
In realtà doveva scontentare tutti: la Marina , che con qualche milione in più non risolveva ceno tutti i suoi problemi strategici e cantieristici; lo Stato Maggiore , cui poteva sembrare che venissero sottovalutate le esigenze dell'esercito; la stessa opinione pubblica che, pur prevalentemente coinvolta dal risorgere di temi e miti navalistici, era però sempre più insospettita dalle accuse circa l' impreparazione ed il mancato 'svolgimento' del!' ordinamento d eli' esercito che l'opposizione politica andava spargendo. In o ltre l'ambiente politico, ma anche quello militare, era disorientato dalla proposta di Ricotti, in cui molti ancora vedevano (e con ragione, se si pensa alle affermazioni del novarese prima ricordate) il generale che non si era mai mostrato tenero nei confronti della Armata.
Ma, soprattutto, l'entità del trasferimento di fondi dalla Guerra alla Marina se pur significativo come segnale di una politica, in realtà non aiutava di per sé in nessun modo decisivo la Marina Militare ad uscire dalla sua situazione di 'minorità' nei confronti dell'esercito. Il tutto, insomma, finiva per apparire un'ennesima battuta del solito copione trasformista.
L'occasione per simili riflessioni fu data al mondo militare (e politico) da alcune secche affermazioni parlamentari del Tenente Generale Ricci , nell'estate del1885, in sede di discussione del Bilancio della Marina. Invece di pochi milioni che non possono servire a tutto, disse Ricci , sarebbe forse meglio fare un'unica, grossa assegnazione di fondi per risolvere qualcuno dei problemi più ingenti dell'ordinamento della Marina. E parlò in questo senso dell'arsenale di La Spezia che a suo parere sarebbe stato possibile costruire e difen-

l PROBLEMI MILITARI 149
37
Cfr. VENTIJRINI, Militari e politici nell'Italia umbertina, cic ., p. 202.
dere definitivamente con una trentina di milioni 38.
Nel 1861 -a soli ventinove anni - insegnante di 'arte della guerra' all'allora principe ereditario Umberto di Savoia e poi professore alla Scuola Superiore di Guerra, dal 1882 Comandante in seconda del Corpo di Stato Maggiore, dal1884 promosso Tenente Generale, Ricci era allora un ufficiale molto ascoltato nell'ambiente militare. Schierato a Destra, Ricci anticipò così nel giugno 1885 alcuni dei temi della critica ami-Ricotti che furono sollevati poi anche da Carl o Mezzacapo: quelli del rapporto tra Esercito e Marina.
Egli non aveva mai fatto mistero del suo interesse per il fronte marino: e costante era stato il suo sollecitamento perché fossero presto completati i lavori di fortificazione del porto di La Spezia, perno della difesa navale italiana 39. Nel giugno 1885 Ricci andò però oltre la questione (cruciale ma delimitata) di La Spezia: sostenne pubbl icamente che la Marina era «i l punto debole» del l 'organismo militare italiano e che perciò, se necessario , sarebbe stato utile beneficiarla di parte delle ingenti spese straordinarie da poco approvate dalla Camera a favore dell'Esercito e delle fortificazioni terrestri. Aggiunse infine che queste fortissime spese per l 'es ercito erano in parte conseguenza della decisione presa nel1882 di creare due nuovi corpi d'armata.
La rigidità e la forza delle affermazioni di Ricci erano quelle di una critica militare 'integrale': non c' era spazio nelle sue parole per alcuna mediazione politica , per alcuna comprensione delle esigenze parlamentari causate dalla rinascita di temi navalistici, né egli pareva disponibile ad accettare alcuna gradualità nella soluzione dei probl emi delle forze armate di mare . La Marina era carente? alla Marina si dovevano quindi concedere tutti i fondi necessari . Questo era lo schematico ragionamento del generale.
D'altra parte la sua critica non poteva esser lasciata cadere nel nulla , per quanto riguardava gli ambienti militari dell'esercito. Anche perché , pur nella sua esteriore schematicità, il pensiero di Ricci era penetrante. Quello che Ricci sollecitava, in sostanza, era l' apertura di un grande dibattito (militare) sul rapporto tra Esercito e Marina, sperando forse che l'ambi ente (politico) parlamentare avesse po-
39 Già nel 1872, A. Ricci definiva La Spezia cunico e veramente monumentale no· stro stabi limento marittimo •. A. RICCI, La piazza di Stradella nella difesa della frontiera n ord-ovest dell'Italia , Torino, Loescher , 1872.

150 POUTICA E POUTICA MIUTARE
3S Cfr. AA. PP ., Camera, Legisl. XV, sess. unica, Discuuioni, tornata del 13 giugno 1885.
tuto concedere i fondi necessari.
Per prima cosa, dovette pensare a questo proposito Ricotti, la critica di Ricci non poteva essere stata solo una iniziativa personale: il comandante in seconda del C.S.M. non parla a solo titolo proprio. Inoltre, Ricci- e lo si è visto - parlava a ragion veduta: egli conosceva molto bene i termini della questione e non si sperdeva, come faceva tanta parte del dibattito sulla difesa delle cos te , negli aspetti minori 40 . Infine - poté notare il Ministro - vi era un che di capzioso, di esagerato nella sua affermazione per cui i fondi mancanti alla Marina erano quelli che l 'Esercito aveva preso per il suo ordinamento militare al momento de l passaggio da dieci a dodici corpi d'armata. Da una parte Ricci, così dicendo, addossava alla Sinistra la responsabi lità di quella 'distrazione' di fondi e delle deficienze della Marina; dall'altra pareva voler parlare direttamente allo stesso Ricotti, di cui egli conosceva le intime convinzioni a proposito del rapporto tra Esercito e Marina e dell'ordinamento militare del 1882.

Insomma, da qualunque parte la si riguardasse, la critica di Ricci era pesante e complessa .
La stessa ufficiosa «Ital ia militare» dovette aprirsi ad un (piccolo) pubblico dibattito, in cui trovarono espressione varie tendenz e militari. Fu così chiaro al pubblico (militare e politico) che nell' ese rcito c'era chi considerava necessario l'adozione del principio dell' offens iva in terra (e quindi in primù, per l'Italia, alle frontiere e in montagna) come in mare (da cui l'utilità di avere grosse e forti navi offensive per una grande e decisiva battaglia marina) 4 1 , c'era chi considerava offensiva una forza marittima solo quando fosse stata in grado di gettare, con uno sbarco sulle spiagge nemiche, grandi unità di fanteria cui sarebbe spettato l'onore di essere le forze decisive della guerra (e così sarebbe venuta meno l'urgenza da Ricci avanzata di so ttrarre fondi di Bilancio dall'esercito per passarli alla Marina) 42; c'era chi rifiutava la scelta tra «ese rcito, flotta e fortificazioni» e richiedeva più
40 Impo_naote la_ su_a al in del Corpo di Stato MaggiOre .. La posiZione dr RtccJ, come vedremo, ed m parucolare sul terreno della politica coloruale , non era esente da contraddizioni; ma il richiamo allo 'spazio mediterraneo' dell ' Italia era in lui costante. Piuttosto che ad andare in Mrica, egli pareva in t enzionato a che non si lasciasse cformare intorno a no i , nel Mediterraneo e nell'Adriatico , un vero anello di ferro che ci soffocherà e che dovremo spezzare colla forza, un giorno in cui ci sentiremo portati ad espanderci:. . ]/ generale Osio , cit. , p. 374, alla data del 29 dicembre 1884.
41 Cfr cL' Italia m ilitare• , 19 giugno 188) , Un discorso opportuno.
42 Cfr. ivi, La questione militare.
l PR O BLfMI MILITARI 151
moderatamente, «misura>> ed equilibrio nelle preferenze (ed un ordine politico e finanziario di priorità n eli' attuazione) 43. Ma fu un dibattito presto soffocato e chiuso d'autorità.
Le parole di Ricci avevano suscitato, pur partendo da un solo problema, troppe questioni insieme; nessuna autorità e nessun ambiente militare (o politico) poteva nel giugno 1885 accettare che tutto l'ordinamento militare italiano fosse di nuovo messo in discussione. L'equilibrio e l'assetto delle forze armate creato nel 1871-76 e corretto nel 1882 poteva essere forse ritoccato ma non ancora una volta sconvolto.
Il deputato militare provò ancora a risollevare, in un secondo momento, le sue critiche alla gestione Ricotti in un discorso ai suoi elettori nell'agosto, ma l'eco politica fu già minore 44.
Nell'autunno, infine, Ricci fu allontanato dal prestigioso incarico di comandante in seconda del Corpo di Stato Maggiore (e di vice di Enrico Cosenz) e destinato al più tranquillo Comando della divisione militare di Cuneo.
Significativamente, già nel luglio l'ufficiosa «Italia militare» aveva ammonito l'esercito contro le «discussioni tumultuose e tumultuarie, per non citare quelle delle quali l'agge ttivo di rivoluzionarie avrebbe espresso molto tenuamente la natura» 45. E qualche giorno prima si era rammaricata contro quei militari che svelassero «dispareri che non dovrebbero trapelare , perché l'idea che dovrebbe trionfare è quella di coloro che ne avranno la responsabilità» 46.
Le grandi questioni erano così di nuovo archiviate.
Ma il dibattito militare su tali grandi questioni non poteva essere archiviato con una misura repressiva e con pochi articoli giornalistici. Il tema, di ampio respiro, venne così ripreso dagli organi di informazione politica e dalla stampa 'di partito' 4 7 . Ma così facendo si perse la sua concretezza e la sua incisività, tanto più che nell' ambiente militare dopo le misure prese a carico di Agostino Ricci parve tornare a prevalere il silenzio.
A contribuire poi, tra il1885 ed il1886, a frenare un libero confronto di opinioni tra i militari sul reciproco rapporto tra Esercito e

4 3 Cfr. ivi, 19 giugno e 21 giugno 1885, Esercito, flotta o fortificazioni?.
44 Cfr. ivz', 19 agosto 1885, Un discorso del generale Ricci agli elettori di Belluno, e cfr. «L'esercito italiano», 27 agosto 1885. Un discorso del generale Ricci.
45 Cfr. «L'Italia militare:., 3 luglio 1885, A parlamento chiuso.
46 Cfr. ivi, 21 giugno 1885, Unum focere et alterum non omittere.
47 Cfr. già ivi, 21 giugno 1885 , Le idee del generale Ricci ed il 'Diritto'.
152 POLITICA E POLITICA MIUT ARE
Marina nella strategia nazionale, doveva aggiungersi anche l'esperienza coloniale di Massaua. Proprio quando , come è stato notato, l'esercito italiano passava da potenzialmente offensivo a concretamente offensivo - sia pure su un teatro d'operazioni particolare quale quello africano e coloniale - e quando la Marina veniva ad operare come diretto supporto di quell 'offensivismo 48 (tra l'altro in condizioni del tutto nuove e difficili) gli spazi per il dibattito militare dovevano invece restrmgersL
Anche se l'opinione pubblica non ne sarebbe stata informata, proprio in quei mesi e sul terreno della politica coloniale non avrebbero comunque tardato ad entrare in conflitto opposte visioni strategiche tra ambienti della forza armata di terra e ambienti di quella di mare. Ma rimaneva il pesante dato di fatto che quello non era il momento per i militari italiani di un dibattito pubblico in tema di rapporto tra Esercito e Marina.
Tra il 1885 ed il 1886 ci furono poi altri episodici segnali di ripresa di interesse del dibattito militare sui rapporti tra Esercito e Marina: tra questi segnali si può ricordare la pubblicazione di due articoli - interessanti e divergenti- sulla «Italia militare» e sulla «Rivista militare italiana» 49

Ma non c'erano elementi nuovi: si trattava nel primo caso di una ci proposizione di vecchi temi che Ricotti aveva già affrontato nel segreto delle riunioni della Commissione Suprema per la Difesa dello Stato , nel secondo di una più estesa articolazione delle teorie offensivistiche militari applicate sia alle forze di terra che a quelle di mare. Non si trattava più ormai di un dibattito, bensì di voci isolate. Una conferma comunque che il problema era sentito come importante ed urgente e che persistevano anche all'interno dello stesso eserci t o impostazioni assai diverse.
L'Esercito andò consolidando il suo ordinamento, sviluppando il suo offensivismo e rafforzando le ipotesi di un suo impiego in teatri di guerra non ital iani. La Marina incrementò la sua flotta e vide aumentare gli sranziamenti finanziari messi a sua disposizione con un ritmo di crescita superiore a quelli decisi per l'Esercito (anche se questi, ovviamente, rimanevano di gran lunga i più consistenti in termini quantitativi). Se anche nella realtà e nel pur ristretto dibat-
48 Cfr. anche GABR1ELE , FRlZ, La poHtica navale :italiana da/1885 al 1915 , cit. , p. 53 e sgg.
49 Ci riferiamo ai già ricordati «L'Italia militare» , 2 gennaio 1886, Un caso possibile e A.F.J., La dzfesa di uno stato come la intendiamo noi , cit. .
l PROBLEMI MIUTARI 153
tito degli anni del secondo Ministero Ricotti c'erano già tutti i segnali di una divaricazione delle opzioni tra le due forze armate nazionali, essa sarebbe divenuta evidente solo più tardi 50.
Per l'intanto, negli anni tra i11884 ed ill887, una volta frenato il dibattito ma non ceno attenuati i problemi che lo avevano originato, c'era solo posto per qualche ennesima operazione di ripiego, per qualche altro espediente trasformistico.
A questo si può ridurre il significato del progetto di legge presentato congiuntamente dai Ministri Ricotti e Brio per un assegno militare di 15 milioni a favore di ciascuna delle due forze armate. Se qualche militare dissenziente poteva gridare allo scandalo e indirizzare i suoi strati sui «fratelli siamesi• Ministri alla Guerra ed alla Marina 5l, in realtà con quel disegno di legge (di cui acutamente Ricci, in Commissione Parlamentare, indicò il «carattere eminentemente politico») 52 Ricotti tendeva a conquistarsi a poco prezzo la fama di militare dell'Esercito sensibile alle necessità della Marina.
Ma , nonostante questo bel gesto, poco doveva cambiare nella sostanza dei rapporti strategico-militari delle due forze armate in quegli anni. Il trasformismo di Depretis e di Ricotti non mutava la precedente situazione.
)O Cfr. già VENTURINI , Militan· e politici nell'Italia umbertina. cit., p 231.
)J Quando Pelloux scrisse quel breve articoletto (di cui F. Venrurini ha rimracciato il manoscritto originale tra le ca ne del generale , conservate presso l' ACS) ce no voleva colpire le persone ed il prog e tto poliùco di Ricotti e di Brio, piuttosto che una presunta 'a rmonia ' tra esercito e marina che- come si è visto e come si vedrà - non esisteva più di tanto. Cfr. ivi, pp 201-202.
) 2 AA.PP., Camera, Legisl. XVI, sess. unica, Discussioni, tornata del 17 dicembre 1886.

1)4 POUTICA E POUTICA MlliTARE
CAPITOLO TERZO
MILITARI NEGLI ANNI OTTANTA
Chi erano i militari italiani del primo decennio della Triplice Alleanza? Era tutto il mondo militare 'appiattito' sulla politica del Ministro? Quali erano gli 'ambienti militari' tra cui si muoveva Ricotti?
Sono, questi, interrogativi assai complessi cui ceno qui non si pretende di dare più che qualche primissima e parziale risposta. Ma appare ugualmente necessario stendere alcune note su taluni , specifici, ambienti militari che furono assai attivi nel periodo centrale degli anni Ottanta: in quegli anni cioè del secondo Ministero Ricotti di cui sino ad ora abbiamo prima disegnato le coordinate politiche generali e poi ricordato i più complessi problemi militari di fondo.
Recentemente, è stata notata «la presenza di un'opinione pubblica più complessa e meno identificabile [con quella] dei 'generali'» 1 E soprattutto è stato ricordato come il mondo militare degli anni Ottanta (di cui i Ministri della Guerra e la loro politica costituivano una delle pani in gioco) era impegnato in un dibattito ideale e politico in cui si confrontavano opinioni diverse e non sempre omogenee. Il tono generale , comunque , andava mutando rispetto a quello del decennio precedente. Anche sui periodici non militari le opinioni dei collaboratori in divisa si richiamavano sempre meno alle teorie 'alla Marselli' sulla funzione nazionale e 'democratica' dell'esercito e sembravano riallacciarsi sempre più ai perentori inviti all'azione ed ai moniti offensivistici 'alla Baratieri' 2
Non si tratta però. di inventarsì un 'idealtipo' di militare di quel decennio bensì, più concretamente e partendo da questi assunti, di capire come questi vari ambienti militari accolsero la nomina del nuovo Ministro, come reagirono alla politica della 'sosta' di Ricotti e come 1 VENTURINI, Militari e politici nell' Italia umbertina , cit. , p. 232. 2 DEL NEGRO, Esercito, Stato ,
 società. Sagg i di storia mtlitare, cir. pp. 205-206 .
società. Sagg i di storia mtlitare, cir. pp. 205-206 .
operarono e che influenze ebbero (se di influenzare erario capaci) sulla po liti ca militare.
Come si vedrà, le reazioni furono articolate, e assai spesso anicolate per 'amb i ente', per settore, per ognuno dei vari livelli della complessa macchina d eli' amministrazione militare. E si noterà come in ognuno di questi ambienti, col passare dei mesi e degli arini, sempre più si evidenziarono settor i vivaci ed importanti che non esitavano a prendere una dura posizione contro vari aspetti della politica militare del Ministro . Strati del Corpo Ufficiali acc usavario il Ministro di non provvedere adeguatamente all ' avarizare delle loro carriere; collaboratori di riviste tecniche militari ed addirittura o rgarii d' informazione militari in quanto tali si schieravano co ntro Ricotti e criticavario aspramente i suoi provvedimenti; dai l oro scranni parlamentari i pochi ma ascoltati deputaci militari (pur politicamente divisi tra D estra, ministeriali trasformisti e Sinistra) abbaridonavano le loro distinzioni politiche e compat ti mettevano sotto stato di accusa la politica militare del Mini st ro ; lo Stato Maggiore continuava, nel segreto dei suoi uffici una ' preparazione della guerra ' non semp re del tutto collimante con gli interessi e le preoccupazioni del Ministro; e nelle più imponariti questioni lo stesso Cosenz ve n iva addiri ttura chiamato a prendere posizione contro la politica del Mini st ro della Guerra. E, come se tutto questo non bastasse (ma in questo nostro lavoro se ne parlerà in altra p a rte) da Massaua i Comandariti militari locali disapp licavano volontariamente le direttive ministeriali, per realizzare -nel margine del co nsentito- una 'loro', più audace , politica coloniale.
Ceno , una ri costruzione della politi ca militare di Ricotti non può ridursi a questi dissensi e a queste prot es te di taluni settori del mondo militare. Ma è altrettanto ceno che non sareb be comprensibile senza farvi un adeguato riguard o.

Allora , negli ari n i del secondo Ministero Ricotti , l ' esercito n o n era in crisi , né appariva diviso di fronte alla pubblica opinione o a l potere politico. Era un orgariismo forte, comp l esso, dinamico, potente, in uno Stato che , amm inistrat ivamente, diveniva sempre più grande ed in una nazione che sempre più si riteneva ponata a svolgere una 'politica di potenza'. I bilanci militari della Guerra di quegli anni Ottanta , ed in particolare di quel seco nd o Ministero Ricotti , stavano lì a dimostra rl o.
Come si vedrà, ognuno d i questi ambi ent i militari si agitava e protestava perché all'esercito italiario ed alle sue necessità fosse data se mpre più considerazione. E , paradossalmente, l'unico che pareva
156 POUTICA E POUTICA MIUTAR.E
accontentarsi deJla condizione in cui l'Esercito si trovava nei confronti dello Stato (in quanto a bilanci, potere, prestigio, influenza) era lo stesso Ricotti.
Spiegava bene questa situazione un giornale militare dell' epoca, quando affermava che sembrava di vivere in un «mondo aJla rovescia» 3, nel quale i militari chiedevano - in varie occasioni non scoraggiati, in questo, da vari settori del mondo politico - ed il Mimstro negava.
Paradossi a parte, era questa - in fondo - una delle caratteristiche degli anni Ottanta, in cui i militari, l'esercito, tutto l'esercito (e non solo i Ministri della Guerra e la loro politica) vivevano una fase di 'espansione', di maggiore favore, di aumentata coscienza del proprio peso contrattuale in una società, in uno Stato ed in una Europa che parevano sempre più incamminati sulla via della 'politica di potenza' 4
Tutto questo movimento, tutte queste dinamiche strutturali, si agitavano però (tranne eccezioni importanti ma rare) dentro la società militare, all'interno del fortilizio dell'Esercito, tra militari. Ecco perché questo confronto di posizioni e di idee, anche se toccava questioni ed evidenziava meccanismi di radicale importanza per una struttura militare (un'importanza che andava oltre i pochismi del Ministero Ricotti), poteva dare ai contemporanei l'impressione e la sensazione di una vitalità dell'organismo militare . Anche se poi, alla lunga, avrebbero potuto metterlo in crisi.
Il Corpo Ufficiali e le polemiche sull'avanzamento delle camàe
«Un pronunciamento» 1 : con questa pesante definizione è stato ricordato, da chi vi aveva assistito, il dibattito pubblico dei militari italiani alla metà degli anni Ottanta sulle questioni dell'avanzamento del Corpo Ufficiali.
In effetti, a prendere visione della moltitudine di scritti, di anicoli, di opuscoletti ftrmati od anonimi che riportavano, amplificavano ed infiammavano le discussioni tra ufficiali e che passavano di ca-
3 «L'esercito italiano• , 24 agosto 1886, Una salubre reazione.
4 Per una prospettiva europea cfr. HOWARD, Le forze armate, cit., p. 2)).
1 G. BORELLI, La crisi morale nell'esercito, v. I, On'gini e sintomi, Roma, Off. Poligr. !tal., 1908, p. 92 .

M!UTARI NEGU ANNI OTTANTA 157
serma in caserma, di lettore in lettore, davvero si deve concludere che quel dibattito ebbe proporzioni ed incisività particolari e specifiche. Ben diverse, soprattutto, da quel 'normale' battibecco su questa o quella misura ministeriale che pare essere il tono fisiologico con cui i militari accoglievano i regolamenti e le leggi (quando c'erano) sul delicato tema dell'avanzamento delle carriere 2
Che fosse sempre esistita, e che abbia continuato ad esistere, una pubblicistica critica e polemica sui temi deJJ'avanzamento è cosa facilmente documentabile. Chiunque consulti repenori bibliografici generali sulle pubblicazioni del primo quararttennio di vita nazionale unitaria se ne può agevolmente accenare 3. Ma non sempre (come invece si potrebbe credere) il tono e la sostanza di questa pubblicistica era la stessa.
Chi, infatti, abbia preso a sfogliare uno per uno quegli opuscoli si accorge subito che a seconda degli anni di pubblicazione (e quindi a seconda degli stadi di aggravamento dell'intricata questione dell'avanzamento e delle carriere) i libelli militari sull'avanzamento non sono tutti fra loro uguali.

Quelli pubblicati durante gli anni Sessanta - la generalizzazione è forse un po' ardita e qualche studio successivo la potrebbe meglio precisare (ma serve per spiegarsi)- paiono abbinare l'attesa della soluzione del problema della velocità delle carriere ali' ipotesi di un allargamento dei quadri organici dell'esercito.
Col passare degli anni cambiano sensibilmente il tono e la sostanza delle affermazioni. Di fronte ad una chiara permanenza degli
2 Sulla storia dei vari Corpi Ufficiali degli eserciti del secolo XIX, sulla loro composizione sociale , sul loro tasso di professionalizzazione , sulle loro caratteristiche interne e sul loro rappono con i centri politici, è disponibile una interessante letteratura . Tralasciando qui gli studi più specifici e ricordando solo le opere più generali (anche se talvolta pionieristiche e in talune parti superate dalla ricerca più aggiornata), cfr. a questo proposito il vecchio A. VAGTS, A Hùtory ofMtlitarism, New York, Norton , 1937; il classico K. DEMETER, Das Deutsche 0/fmerkorps in Gesellshaft und Staat, 1640-1945, Frankfurt a.M., Bernard und Graefe, 1962 (disponibile anche in edizione statunitense);). BUSQUETS, El Militar de Camra en Espana, Barcelona, Ariel, 1967; il dettagliato B.J. BOND , The Victonan Army and the Staf!College 1854- 1914 , London, Methuen, 1972; il recente W. SERNAM, Les officiers français dans la Nation, 1848- 1914, Paris , Aubiec, 1982. Una attenzione specifica, e talvolta più analitica , è stata inoltre ponata a livello internazionale sui Corpi Ufficiali delle varie Marine militari. Ciascuno di questi studi concede la dovuta attenzione ai meccanismi del reclutamento ed alle polemiche che frequentemente ricorrevano tra i militari del tempo a proposito degli incagli dell'avanzamento. Ancora niente di comparabile, per estensione e dettagliatezza, in Italia, è disponibile sulla storia del Corpo Ufficiale nazionale.
3 Cfr. il classico A. PAGUAINI, Catalogo generale della libreria italiana dall'anno 1849 a tutto i/1899, Milano, Ti p. Libraria Italiana, 1925.
158 POLITICA E POLITICA MILITARE
aspetti generali del problema (insoddisfazione degli ufficiali di talune o di tutte le Armi, lentezza in questo o in quel grado deJla scala gerarchica), cambia radicalmente l'atteggiamento della pubblicistica m ili t are rispetto alla questione dell'avanzamento.

Gli opuscoli editi negli anni Settanta, in un periodo di grandi riforme organiche (che non avevano di molto aumentato l' intelaiatura dei quadri ma che anzi avevano in un certo senso rappresentato la continuazione e la fine dell'opera di ridimensionamento numerico di quell'organico militare che la guerra del 1886 aveva notevolmente ampliato), paiono piuttosto invocare i favori ministeriali ora per questa ora per quell'altra Arma.
Quelli pubblicati negli anni Novanta paiono invece più rassegnati di fronte all'immodificabilità di un sistema di reclutamento e di avanzamento che ormai sembrava rimasto immutato da oltre trent ' anni (dalla formazione del Regno d'Italia e del suo esercito nazionale) e tentano di analizzare, con un tono di sopportazione solo a tratti interrotto da qualche acuta invettiva , la nuova graduatoria degli avvantaggiati e degli sfavoriti 4.
E negli anni Ottanta? E durante gli 'anni felici'?
Sorprendentemente, il numero dei titoli si moltiplica rispetto a quello degli altri decenni. Le pubblicazioni si susseguono senza sosta, gli opuscoletti - destinati certamente ad animare le discussioni di caserma - si rispondono tra di loro, e una sort a di dialogo (spesso tra autori anonimi) si accende sul tema dell'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito. Il linguaggio , in altri anni tecnico e distaccato, si fa adesso acceso; le accuse e le difese si alternano a seconda degli interessi volta a volta toccati dalle varie e contrastanti circolari ministeriali o dai diversi progetti di legge. Le pubblicazioni e le proteste seguono più o meno il ritmo dell ' iniziativa politica e parlamentare. Assai spesso l'interesse e lo studio dei meccanismi amministrativi trascendono - negli opuscoli degli anni Ottanta - nella critica e nella polemica, coinvolgendo nelle accuse di responsabilità il potere politico e i Ministri militari (aspetto questo che non sempre si ritrova nelle pubblicazioni di altri periodi ) . Leggendo tra le righe, pare chiaro che si spera che anche forze o ambienti politici si rendano sostenitori ora di questa ora di quella migliorìa amministrativa. Le più roventi accuse vengono così lanciate ai sistemi realizzati dai Ministri d e lla Guerra in carica, nonché ai loro lodati (o deprecati) predecessori.
MIIJTARI NEGU ANNI OTIANTA 159
4 Cfr. G . STI CCA, Gli scrùtori mzfitari italian i , To rin o, C asso ne , 19 12, passim .
Più di un indizio ci fa credere che queste pubbliche prese di posizione di militari degli anni Ottata riflettessero, interpretassero e moltiplicassero gli umori della più vasta schiera degli ufficiali italiani 5. Che questa, od alcuni suoi consistenti settori (regionali , di grado, di impiego, d'arma di provenienza, d'età, di esperienza civile o politica), si esprimesse con accenti di critica nei confronti del più generale sistema istituzionale e politico è a nostro avviso un elemento della vita nazionale che troppo spesso è stato dimenticato o sottovalutatO 6 . Non andrebbe trascurato il fatto che, in uno Stato di recente formazione come era allora l'Italia, peraltro diretto da una ristrettissima élite, centinaia o migliaia di individui incaricati oggettivamente di una funzione di conservazione sociale 7 accusassero i superiori e i regolamenti da loro redatti di trascurare i de st ini e le fortune dei subordi nati. E non si dovrebbe minimizzare quella realtà per cui, in un Paese dove l'analfabetismo era la regola, i militari prendevano la penna per criticare (spesso veementemente) l'amministrazione di cui facevano pane.
Si potrebbe parlare, in casi simili, di 'richieste immotivate' o
) Si tratta di una ricerca rutta da fare , quella sul Corpo Ufficiali italiano. Unica imporrante eccezione è lo studio di DEL NEGRO, Ufficiali di carriera e ufficiali di com· plemento nell'esercito italiano della grande gue"a: la provenienza regionale, ci t.. In questo senso, sùmolanti ma puuoppo insufficienti sono le note sulla 'vira nell'esercito e nella marina', desumibili dalla poca memorialistica degli ufficiali italiani (tra cui cfr. F MACOLA, Come si vive nell'esercito e nella Man na, Genova, Tip dei Tribunali , 1884; DE ROSSI , La vita di un ufficiale italiano sino alla gue"a, cit.; E. DE BONO , Nell'esercito nostro pn·ma della gue"a, Milano, Mondadori, 1931) o da alcune prime ricostruzioni storiche (cfr. CEVA, Le forze armate, cit.). Per alcune osservazioni cfr. M BRIGNOU , Reclutamento e formazione professionale degli ufficiali dalla restaurazione all'unità nazionale, in 1861-1887. Atti del L Congresso di storia del Risorgimento, Roma, 1982. Sullo spazio per le critiche ai sistemi di avanzamento diffuse negli anni Ottanta, dr. intanto DE ROSSI, La vita di un ufficiale in Italia sino alla gue"a, cit., p. 17 e p. 70; DE CHAURAND DE SAINT EUSTACHE, Come l'eJercito italiano entrò in gue"a, p. 136; DE BONO, Nell'esercito nostro prima della gue"a, cit., p. 31. In generale, però , scarsa è l'attenzione della storiografia al problema della formazione e delle caratteristiche sociali della burocrazia statale. Solo qualche punto di contarto tra il problema delle carriere militari e quello delle carriere nell ' amministrazione civile (su un aspetto del quale cfr. R. UGOUNI, Per una storia dell'Amministrazione ce ntrale. Il Ministero della Pubblica Istruzione, 1859-1881. Roma, Ed Ateneo & Bizzarri , 1979. pp 75 -88)
6 Negli stessi bozzetti lenerari sulla 'vita militare' che si trovano talvolta nelle più rece nti sintesi, il tema dell'avanzamento e delle carriere è singolarmeoce trascurato. Tra gli alui, cfr. CEVA , Le forze armate. ci t., p . 64 e sgg. Alcuni dati si possono ricavare ancora da F. L. ROGIER, La R. Accademia militare di Ton'no , Torino, Bona, 1916.
7 Cfr. ROCHAT, MASSOBRIO , Breve storia dell'esercito italiano dal 1861 a/1943, cit., p. 37 e sgg.

160 POUTICA E POUTICA MIUTARE
orporative' s. Ma affermazioni impegnative e 'onnicomprensive' come queste dovrebbero essere adeguatamente supportate, con attente e puntuali ricerche sullo stato della pubblica amministrazione e dei pubblici dipendenti nell'Italia post-unitaria, quali purtroppo la storiografia italiana oggi ancora non dispone 9 O con studi sulle caratteristiche interne del Corpo Ufficiali, quali solo molto recentemente si è iniziato a fare 10
Per adesso, semmai con studi limitati ma solidi nella documentazione, si dovrebbe invece tentare di definire il campo di ricerca e provare a fornire qualche elemento di periodizzazione e di modellizzazione.
Comunque, per chi da un'analisi delle statistiche ufficiali e dalla pubblicistica maggiore e minore sui temi dell'avanzamento voglia provare a suggerire alcune riflessioni sul tema della storia del Corpo Ufficiali, la meta non sembra facilmente raggiungibile. Come è stato notato, «la storia dell'esercito italiano quale istituzione politica e sociale presenta, come sottolineano gli studi più recenti, ampie lacune» 11
In questo senso, le tematiche dell'avanzamento- che proprio negli anni di Ricotti assunsero un così particolare interesse - erano e sono incomprensibili se separate da quelle, più rilevanti e più 'politiche', del reclutamento degli ufficiali. Purtroppo, su questo tema le conoscenz e oggi in nostro possesso sono assai poche, a differenza di quanto accade in altre nazioni 12
Il reclutamento degli ufficiali negli anni Ottanta era, intanto, largo e prestigioso. Anche se, come vedremo, in qualche significativo caso Ricotti diminuiva il numero degli iscritti in alcuni Istituti di istruzione militare, nel complesso aumentarono le occasioni messe a disposizione di quei giovani che vo levano intrapr endere la carriera
8 Cfr., tra gli altri , VENTURINI, Militan· e politici nell'Italia umbertina, cit., p. 190

9 Per lo stato delle conoscenze sulla storia dell'amministrazione in Italia cfr. adesso L 'amministrazione centrale, a cura di S. Cassese, Torino, UTET , 1984, e particolarmente la firta bibliografia ragionata di F. VENTURINI, Gli scn#i di stona dell'amministrazione , in L'amministrazione centrale, cit. , pp. 473 -492.
10 Il riferimento d'obbligo è aJ sagg io di DEL NEGRO, Ufficiali di camera e ufficiali di complemento nell'esercito italiano della grande guerra: la provenienza regionale , ci t.
1 1 lvi, p. 263.
12 Io questo senso, le pagine che seguono vogliono essere solo una parte di una ricerca più ampia e sistematica, ancora in corso.
MIIJTARJ NEGU ANNI OTTANTA 161
delle armi 13. La politica del reclutamento, anche in questo senso, rispondeva a quella l ogica che è stata già notata di «rigida dipendenza ( ... ) dalla dinamica delle spese militari» l4.
Ma non era il reclutamento delle nuove leve di ufficiali che impensieriva i militari del tempo, bensì le modalità concrete di regolare l 'avanzamento di tutti quelli che già facevano pane del Corpo Ufficiali.
Negli anni Ottanta questo Corpo Ufficiali era numeroso, in valori relativi ed assoluti 15.
Gli ufficiali costituivano quasi il15% cii tutti gli impiegati dello Stato, contro il 10,05 del 1859 -se si fossero sommati i pubblici dipendenti dei Regni preunitari e si fossero confrontati con la somma aritmetica dei diversi Corpi Ufficiali dei vari eserciti 16 - e qualcosa in più di quel14,25 del1891, quando iniziavano a farsi sentire da una pane i co lpi della crisi dei bilan ci militari e dali' altra il crescente aumento delle dimensioni e delle funzioni statali, aspetto questo destinato ad un progresso inarrestabile 17. Si potrebbe quasi dire, insomma, anche se ulteriori ricerche sono sempre necessarie, che proprio negli anni Ottanta gli ufficiali toccavano il tetto della 'militarizzazione' del pubblico impiego (esclusi ovviamente i periodi di guerra e di mobilitazione precedenti e successivi) dell'Italia liberale 18.
Non a caso, i più alti responsabili della politica militare del tempo consideravano «titanica» 19 l'estensione raggiunta in quegli anni dalla amministra.zione militare.
n Cfr. la relazione di F. TORRE, Della leva sui giovani nati nell'anno 1863 e delle vicende dell 'esercito da/l luglio 1884 al 30 giugno 1885. Relazione a S.E. il Ministro della Gue"a, Roma, Tip. Cecchini , 1885 (e seguenti).
14 DEL NEGRO, Uffici'aH di cam'era e ufficùzli di complemento nell'esercito italiano della grande gue"a: la provenienza regionale , cit. , p. 275.

Fonte principale sono i dati dell'Annuario militare del Regno d 'Italia.... Roma , Voghera , che dà le cifre effettive dei militari a ruolo , spesso diverse e superiori anche a quelle previste dalla stesse leggi organiche. Per un primo inquadramento si tenga presente che, io valori assoluti, gli ufficiali dell 'ese rcito erano 14.528 nel 1866, 15. 72 6 nel 1867 , 10.651 nel187 3, già 11.269 oel1874 , 12 .193 nell882, sino a raggiungere il numero di 14 .528 nel 1890.
16 Cfr. R. BENINI, La burocrazia di Stato in italia da/1859 al1891, in «La riforma a. II (1895), v. IV, no 4-5.
17 lvi.
18 Sono, queste , ricerche che meriterebbero dì essere approfondite.
19 ACS, Carte Pelloux, se. 2. 11 febbraio 188 7, Guaita a Pelloux. cL' amminisuazione della Guerra ai tempi nostri è qualche cosa di titanico, di mostruoso , di ìnfmiro•.
162 POUTICA E POLITICA MIUTARE
La questione degli avanzamenti, comunque, di per sé difficile ed ingarbugliata, stava in quegli anni assai a cuore agli ufficiali. Già alla fine degli anni Settanta, c'era chi scriveva a Luigi Pelloux che quello dell'avanzamento era «Stato per molto tempo il tema di tutti i discorsi» 20: proprio quando, invece, «non si riusciva a far leggere una sola linea di argomento militare a nessun ufficiale! al di là dei fatti vari nelJe gazzette cittadine nessuno arrivava!» 21 Se la massa della ufficialità dell'esercito italiano poteva talvolta sembrare disinteressata dei grossi temi politici od anche delle più urgenti questioni militari d'interesse strategico, o tattico, o tecnico, quando si parlava di avanzamento tutti avevano qualcosa da dire, tutti si lamentavano e quesuonavano.
L' eccitazione- si scriveva ancora , in quegli anni, a Pelloux - era fatta ancora più viva per via di quegli anicoli pubblicati sui giornali; articoli ispirati al desiderio di mettere in vista le gravi differenze di carriera esistenti fra le varie Armi e che perciò avevano il grave inconveniente di destare nei crocchi di ufficiali continue discussioni non sempre tenute nei limiti della desiderata moderazione: era divenuto questo l'uniCo discorso , in modo da raggiungere le proporzioni di una vera calamità( ... ) 22.
Questa situazione era dovuta ad un complesso di motivi: ed affrontarla anche solo per capire le origini e le dinamiche della protesta dei militari negli anni del secondo Ministero Ricotti ci obbliga ad un lungo excursus. ·
L'avanzamento, come il reclutamento, era regolato ancora dalla legge votata dal Parlamento subalpino del 185 3-54 2 3 Essa aveva recepito l'insegnamento francese e, dal punto di vista del reclutamento, lasciava un terzo dei posti disponibili per la nomina di nuovi ufficiali a quei sottufficiali che avessero superato i necessari esami. Per questo e per altri suoi aspetti, la legge era vista nel mondo militare come assai 'liberale' 24 A ciò concorreva il fatto che -sul piano regolamentare dell'avanzamento - la legge lasciava formalmen-
20 lvi, se. 29 , fase. 53, 30 dicembre 1879, More!Ji a Pelloux.
21 lvi, 23 dicembre (1879), Bose!li a Pelloux.
22 Ibidem.
23 Cfr. AA.PP., Senato, Legisl. IV, sess. terza , Documenti, p. 825, poi legge 13 novembre 1853, n. 1625; nonché AA.PP. , Senato, Legisl. V, sess. prima , Documenti, p. 427, poi legge 29 gennaio 1854, n. 1656.
24 Cfr. F. SANTANGELO , Reclutamento e avanzamento degli ufficiali negli eserciti italiano , france.re , tedesco, ed austrungarico. Studio, Torino, Tip. Oliviero , 1909.

MIUTARI NEGU ANNI OTTANTA 163
te grande spazio alla 'scelta' rispetto alla 'anzianità' all'interno del meccanismo delle carriere. Un terzo dei capitani, la metà dei maggiori e tutti gli ufficiali da tenente colonnello in avanti potevano infatti essere nominati tali per i propri meriti militari. Inoltre, le permanenze minime nei vari gradi erano molto basse, quali si confacevano ad un esercito piccolo come quello piemontese (dal punto di vista degli ufficiali, cinque volte più piccolo dell'esercito italiano del 1866) ed alla mobilità sociale che esso pareva garantire 25.
Ma la legge venne, in più delle occasioni, ed in varie sue parti, disapplicata 2 6: sia dal punto di vista del reclutamento sia da quello dell'avanzamento. Basti pensare che, una volta approvata la legge, furono emanate dallo stesso Ministro La Marmora che l'aveva proposta e dal suo successore Durando - nel giro di un solo armo e mezzo - precise e profonde correzioni derogatrici 2 7.
Questo, soprattutto dalla parte dell'avanzamento, fu solo l'inizio della norma.
Una serie slegata, varia, disomogenea e non programmata di misure -spesso non lungimiranti ma dettate solo dall'urgenza di risolvere problemi occasionali e di alleviare situazioni contingentifu il modo con cui i Ministri della Guerra affrontarono sul livello amministrativo il mutamento strutturale dell'esercito, prima e dopo le riforme Ricotti del '70-'76 .
Da una parte stava infatti un Corpo Ufficiali che, oltre a crescere nelle proporzioni che si è detto, mutava nella sua composizione interna: meno sottotenenti, molti tenenti e capitani in più (in valore relativo, oltre che in valore assoluto). Poi, a livello di Arma, ed in senso proporzionale, si assisteva ad un altro ·cambiamento di grande rilevanza: dopo la Fanteria , l'Arma che veniva ad essere la più consistente numericamente diveniva sempre più f Artiglieria, degli ingegneri e dei 'borghesi', a scapito della vecchia Cavalleria, dei nobili
25 Cfr. DEL NEGRO, Esercito, Stato, società. Saggi di storia mi/tiare, cit., pp. 62-63.

26 Già nel 1870, acutamente , Carlo Corsi collegava a questo proposito nell'ambiente militare le aspiruioni (in tema di organica) oumeristiche e le preferenze (in tema di avanzamento) per il principio di anzianità, rispetto a quello della scelta codificata nelle leggi del1853. Cfr. C. CORSI, 1844-1869. Venticinque anni in Italia , Firenze , Favero, 1870, p. 19.
27 Cfr. , per questo, negli Atti Parlamentari, le discussioni che accompagnarono appunto il varo della legge 13 novembre 1853 , n. 1625 , e poi le leggi di modifica del 29 gennaio 1854, n. 1656, e 4 aprile 1855, n. 725 (andrebbe a firma di La Marmora) nonché quella del 30 marzo 1856, n. 1540 (Durando)
164 POUTICA E POUTICA MlUTARE
e dei 'benestanti'. Infine, facendo una comparazione trasversale tra gradi ed Armi, la pane più consistente in assoluto della Ufficialità ital iana continuava - ovviamente - ad essere costituita dai capitani di Fanteria (ed il loro numero cresceva in valore assoluto) ma in valore relativo la loro pe rcentuale sul t otale degli Ufficiali scendeva alquanto 28.
Dall'altra pane, invece, stava una fitta ma contradditoria serie di regolamenti e di circolari ministeriali che avvantaggiavano ora questa ora quell'altra Arma, rendendo più veloce ora questo ora quel grado. Commentava amaramente Marselli che in Italia «si va soggetti, in questo, a veri stringimenti e ri lasciamenti di freni, secondo ch e urge spazzar gli ingomb ri o dar tregua agli an imi ( )» 2 9. In genere si trattò di misure extra-parlamentari, dal momento che per ben quattro legislature (dalla undicesima alla quindicesima) i politici non furono chiamati a discutere alcun progetto di legge in tema di reclutamento e avanzamento m ilitare . Tutto veniva deciso nel chiuso delle stanze del Ministero, nonostante che la stampa militare proclamasse sempre più la necessità di dare una soluzione duratura al problema delle carrie re 30.
Infine, dopo il 1867 e più ancora dopo il 1873, un fattore di rigidità era venuto a complicare questo pur fluttuante sistema delle carriere degli ufficiali: si trattava dei vantaggi e delle precedenze nell'avanzamento che venivano concessi agli ufficiali di Stato Maggiore (per agevo lare la loro veloce ascesa della scala gerarchica e per ricompensarli degli anni trascorsi negli Istituti militari di istruzione superiore, cioè nella Scuola di Guerra) 31 Nel comp lesso e profondo mutamento strutturale dell'esercito italiano che più sopra abbiamo appena delineato, gli ufficiali di Stato Maggiore non a caso eranoin ogni grado - gli unici ufficiali ad aver garantito meglio degli altri le loro posizioni, aumentando in maniera significativa la fila del Corpo, in valore relativo come assoluto, con la conseguente diminuì-
28 Se nel 1866 gli ufficiali di Fanteria erano 9.379 (nel 1867 già 10.288), quelli di Cavalleria 1.122 e quelli di Artiglieria 1.034- dopo lo sfoltimento degli anni 1873 -74 - (che aveva portato gli ufficiali di Fanteria a 6.372, quelli di Cavalleria a 799 e quelli di Artiglieria a 1.016), nel 1890 essi erano rispettivamente 7.547. 917 e 1.717.
29 MARSELLI, La vita del reggimento, cir. , pp. 326-327.

30 Cfr. tra gli altri, «L'esercito italiano•, 19 dicembre 1884 , L 'abolizione degli esami per le promozt'oni ad anzianità; ivi, 10 aprile 1885, L 'avanzamento nell'esercito; ivi, 14 maggio 1886 , La questt'one dà quadri; e molti altri.
3I Cfr. C. RINAUDO , La Scuola di Guerra da/1867 al 1911, Torino , Tip. OlivierQ , 1911 (in testa al front.: Scuola di Guerra)
MIUTARI NEGU ANNI OTTANTA 165
zione delle soste nei vari gradi e con il risultato di avere carriere più rapide ed interessanti.
Questo ultimo elemento - tra tutti quelli ricordati - risultava il meno gradito agli ufficiali delle altre Armi, i quali vedevano invece allungare la permanenza necessaria in ogni grado per poter essere ammessi alle commissioni di avanzamento.
La cosa, inoltre, era aggravata dal fatto che il principio della 'scelta' era stato largamente disapplicato, nonostante esso fosse ancora - fo rmalment e - il principio ispiratore della unica legge allora in vigore a proposito di avanzamento delle carriere degli ufficiali. In questo senso aveva influito una certa 'inerzia burocratica ' della macchina militare ed un timore che la 'scelta', in un ambiente ancora largamente segnato - all'interno del Corpo Ufficiali - dalla presenza di gruppi regionali e da forme estese di clientele e di camarille, potesse risultare un mezzo per ricreare vecchi favoritismi all'interno del Corpo piuttosto che essere uno strumento moderno per 'scegliere' una élite direttiva militare 32 Il principio moderno e 'prussiano' della scelta segnava quindi in Italia il passo. La 'anzianità' era quella che in fondo - sempre esclusi gli ufficial i di Stato Maggiore - regolava le carriere militari in Italia .
Ma questo era possibile e semplice con un Corpo Ufficiali esiguo (quale era stato a suo tempo quello dell'esercito piemontese) e silenzioso (come in ultima analisi era quello italiano persino degli anni Settanta, ancora disorientato dalla 'grande nov i tà' delle riforme militari di Ricotti e tutto sommato ancora diviso ed intimidito dalla forte opera di restringimento degli effettivi del Corpo, che proprio nel 1873 avevano subito una riduzione di un terzo rispetto a solo sei anni prima).
Il Corpo Ufficiali italiano degli anni Ottanta, invece, come abbiamo visto e come vedremo, non era né esiguo né disposto a tollerare pazientemente qualche ritardo delle carriere.
Oltre a questo, in realtà, non va sottovalutata la reale e comprensibile delusione per la oggettiva lentezza delle carriere che la confusa se rie di misure ministeriali sull'avanzamento aveva creato. E ciò nonostante che, a parole, la questione delle carriere e dell'avanza-

166 POU11CA E POU11CA MIUTARE
32 Sul processo di fo rmazio n e di un ' dite militare cfr M HOW ARD , La g u e"a e le armi nella storia d 'Eu ropa , ( 1976), Bari , Laterz a, 1978, p 264. Cfr. anche B.H
LIDDELL HART Le fo rze armate e l'arte d ella gue"a : gli eserciti, in Storia del m ondo m oderno , v X , Il cu lmin e d ella potenza europ ea {1830-1870), a cura diJ.P Tuer Bury , ( 1967) Milano , Garzanti , 197 0 pp. 386-389.
mento degli ufficiali fosse considerata della massima importanza. Da essa- è sempre Marselli a sostenerlo- «dipende, oltre alla saldezza e alla sanità dei quadri, tutto l'indirizzo direttivo dell'esercitO» 33.
La questione si presentava quindi, all'apertura degli anni Ottanta e poi al secondo Ministero Ricotti, come assai ingarbugliata. C'era, nel fondo, la necessità di misure profonde e radicali.
Il principio della 'scelta' era stato largamente disatteso. Parallelamente, era rimastO irrisolto uno dei più rilevanti problemi per la cui soluzione quel principio era stato adottato nel1853 dal legislatore e dai militari piemontesi: il problema dell'età media dei più alti quadri dell'esercito. Aveva infatti detto il generale Durando, al tempo relatore al Parlamento per il disegno di legge del1853 sull'avanzamento ed il reclutamento del Corpo Ufficiali:

Che cosa vogliamo stabilire con questa legge? noi vogliamo particolarmente fare in modo di avere capi giovani, energici, per il tempo di pace, che servano poi per il tempo di guerra( ... )
L'avanzamento a scelta serve a dare ai giovani d'ingegno e di operosità la facilità di pervenire ai gradi superiori nell'età della forza e del vigore 34 •
Inoltre, il principio della scelta, in un'età che vedeva crescere una nuova fisionomia ed un nuovo ruolo per gli Stati Maggiori, implicava la necessità di buoni studi militari. Attraverso gli studi, si pensava, doveva nascere una figura professionale di ufficiale più ampia e più aperta che nel passato.
A che tendono gli studi? Anzitutto, senza dubbio, a formare ufficiali forniti di un'al tra cui tura generale professionale ( ) Ma gli studi della Scuola di Guerra hanno anche un altro intento. Quando la società militare viveva separata dalla società civile, e quasi in lotta con essa, forse poco importava conoscere l ' organismo e l'ambiente sociale. Ma ora rutto è mutato. Fortunatamente l'esercito non è più lo strumemo d'un capriccio o d'un interesse puramente dinastico , ma è il palladio dell'indipendenza e della libertà dei popoli; l'esercito non è più reclutato dalla ciurmaglia e dagli inftmi strati sociali, ma da tutta la Nazione valida; gli ufficiali devono quindi conoscere la società civile, palpitare con essa , sentirne i bisogni e le tendenze. Inoltre destinati alle Ambasciate, chiamati a legiferare in Parlamento , inviati al governo di provincie e di colonie , nominati membri di congressi internazionali, non possono gli ufficiali, che aspirano ad alti gradi della milizia, rinchiudersi nel campo esclusivamente militare. Se vogliono adempiere a tali uffici con cognizione di causa, devono allargare il loro orizzonte intellettuale , elevare
MILITARI NEGU ANNI OTTANTA 167
33 MARSELLI, La vita del reggimento, cit., p. 327. 34 Ci t. in RfNAUDO, La Scuola di Guerra
1867 al 1911, ci t., p. 31.
dal
lo spirito scientifico, conoscere la via percorsa dalla società per giungere alle presenti condizioni, aver chiara idea degli ordinamenti po litici ed amminisuativi del loro Paese e dei maggiori Stati d'Europa, sapere quali siano le relazioni internazionali, determinate da convenzioni e consuetudini, avere idea del mondo economico-sociale presente, conoscere una delle principali lingue moderne, s! per g li usi della vita come per istrumento scientifico n.
Di fronte ad un problema così precisamente e calorosamente sentito, stava però la realtà della Scuola di Guerra , i cui metodi e le cui materie di insegnamento erano spesso criticate (dai militari , ancor prima che dai civili).
Inoltre il problema della costituzione di una élite militare, di uno Stato Maggiore , aveva trovato nell ' Europa del tempo varie soluzioni: da quella del Corpo di Stato Maggiore , in cui gli uffic iali sceglievano di entrare ed all'interno del quale facevano la loro carriera, a quello del Servizio di Stato Maggiore , che non era un Corpo irrigidito e codificato ma semplicemente una 'funzione ', un incarico , cui gli ufficiali reputati più adatti venivano t e mporaneamente assegnati dai loro comandanti 36 . E in Italia pareva proprio che la direzione scelta delle più alte gerarchie militari fosse quella di avere un Corpo chiuso , sia all 'entra ta sia all'uscita 37.
Stretta da tutti questi lati e da questi problemi oggettivi (aumento del Corpo Ufficiali, mutamenti delle tradizionali proporzioni interne al Corpo tra gradi e tra Armi , disapplicazione del principio della scelta , ' invecchiamento ' dell e più alte gerarchie, carenze nel sistema di alta istruzione militare , impostazione rigida e chiusa del problema dello Stato Maggiore) la questione dell'avanzamento attendeva, come si è detto , una qualche radicale e complessiva soluzione legislativa .
Mancando que sta, il malumore degli ufficiali per tutto ciò ( ma in panicolare per la lentezza delle carriere che da ciò derivava) andava aumentando .
A fronte di un a carriera ' normale ' che a vre bb e potuto ponare
3) lvi, pp. 11-12.

>6 Per lo Stato Maggiore come servizio frequenti furono le prese di posizione, in quegli anni , de cL' esercito italiano•. A questa richiesta si aggiungeva spesso quella insistente di una maggiore aperrura del reclutamento del Corpo Ufficiali (attraverso il canale del 'complemento') ai sottufficiali ed ai gradu ati di truppa. Cfr. ivi, 18 marzo 1885, Ufficiali di complemento; ivi, 29 marzo 1885, Gli ufficiali di complemento; ed ancora ivi, 14 luglio 1885, ed ivi, 18 ottobre 1885, e così via.
37 Cfr. SANTANGELO, Reclutamento ed avanzamento degli ufficiali, cit., p. 104 e sgg.
168 POLITICA E POLmCA MILITARE
da capitano a colonnello in sette-d ieci anni (come prevedevano regolamenti e disegni di legge ), gli ufficiali di Stato Maggiore- che pure erano i più favoriti - impiegavano nella realtà degli anni Ottanta in media quindici anni, quelli di Cavalleria diciannove, quelli di Artiglieria ventuno, quelli di Fanteria ventidue e quelli del Genio ben vemisei 38 Con questa realtà, qualsiasi regolamento perdeva legittimità e qualsiasi soluzione sembrava divenire impossibile.
Già qualche anno prima era stato supposto che , al fatto complesso rappresentato dalle «sfavorevoli condizioni d eli' avanzamento ord i nario:. 39, forse cnon si può rimediare completamente , perché ripete la sua origine dal modo eccezionale con cui si è formato l ' esercito italiano:.. Però , si aggiungeva, «è possibile attenuarne consid erevo lmente gli effetti coll'applicare su larga scala l 'avanzamento a scelta» 40.
Particolarmente dopo il1882, ma in parte anche prima, infatti , non si poteva sperare in un ulteriore decisivo allargamento dei quadri dell'esercito che p e rmettesse di per sé più ve loci carri e re . Anzi, la stessa 'infomata' di tenenti e sottotenenti che aveva accompagnato l 'aumento di due Corpi d'Armata non aveva fano che causare un ulteriore rallentamento delle carriere di rutti gli ufficiali 41 . Qualcuno poteva sperare che un mezzo per renderle più veloci fosse costituito dall'impiego (di personale militare in servizio permanente effettivo) presso le Mili zie di seco nda e di terza linea, ma queste erano invece destinate a formarsi so lo in tempo di guerra ed erano solo assai superficialm ente preparate in tempo di pace 42 • La protesta degli ufficiali si indirizzava allora contro le cspe requazioni:. 43 tra le varie Armi nell ' avanzamento . Dietro i vantaggi conseguiti per la frequenza di Istituti militari d'istruz ion e, si intravedeva lo spettro odioso del favoritismo, piuttosto che la comp lessa
38 Sono dati ricavati da AA.PP., Camera, Legisl. XVI , sess. terza, Documenti, n. 72.

39 L 'avanzam ento nell'esercito ed il Corpo di Stato Maggiore, Firenze, Barbera, 1876. p. 48.
40 lvi, p 49.
41 Or. DE BONO , Nell 'esercito nostro prima della guerra , cic., p . 130.
42 Cfr. G. DELEUSE , L 'avanzamento nell'esercito ed i quadn' della Milizia mobil e. Co nsiderazioni di G.D Roma , Voghera, 1877.
4 3 Al conceto di ' sperequazione ' faceva suppono quello di ' diritti acquisiti' (cioè , sostanzialmente, di 'anzianità'): diritti , però, cche militarmente sarebbe assurdo di consentire•, diceva una pubblicazione ufficiosa degli anni del ministero della Guerra di Ferrero. Alcune questioni militan·, Roma, Capaccini, 1882, p . 70.
MIUTAJU NEGU ANNl OTIANTA 169
situazione che abbiamo sinora delineato.
Di questa protesta, il bersaglio preferito e più frequente era quindi il Corpo di Stato Maggiore ed i suoi ufficiali. Praticamente tutti gli opuscoli che animarono il dibattito degli anni Ottanta e la stragrande maggioranza degli articoli della stampa militare che in quegli anni furono pubblicati se la prendevano con gli ufficiali di Stato Maggiore. «L'emblema dell'aquila che essi appariva il più delle volte, secondo quanto diceva un opuscolo di quegli anni, piuttosto che cun glorioso simbolo di meritate promozioni•, quas i cuna lucida mostra d'un animale rapace• 44
La realtà dell'avanzamento era- come si è visto- ben più complessa, ma gli ufficiali erano resi più suscettibili e preoccupati dal fatto che né i Ministri della Guerra si impegnavano politicamente io Parlamento per risolvere l'an n oso prob lema con le necessarie misure di legge, né i giornali ministeriali (né la voce ufficiosa del Ministero della Guerra, né le riviste tecniche che di esso erano espressione) parevano darsi grande pensiero di tale questione 4 5.
Di fronte a tali inadempienze ministeriali, la protesta contro le lente carri ere diveniva sempre più evidente.
A tale comportamento dei Ministri della Guerra non sembrò agli ufficiali fare eccezione, nella sostanza, lo stesso Ricotti (che pure, prima di essere nominato Ministro, aveva sferrato alla passata amministrazione Ferrero un potente attacco proprio sui temi delle carriere e del malessere diffuso tra gli ufficiali) 46.
Il General e novarese, dopo pochi mesi dal suo insed iamento, infatti, aveva emanato alcuni p rovvedimenti ministeriali con cui aveva sperato di risolvere la questione dell'avanzamento e tentato di presentarsi come 'paladino' delle richieste degli ufficiali 4 7 .
44 AvanZtZmento nel R. Esercùo innanzi al Senato , Roma , Prasca , 1886 , p. 15 .
4
5 Non furono avanzati disegni di legge in proposito dalla undicesima alla quindicesima legislatura (cioè dal 187 3 al 1884). Se si dà una scorsa agli indici delle annate della «Rivista militare italiana•, ad esempio, si nota che ogni anno fu pubblicam qualcosa in tema di avanzamento (a conferma dell'esistenza di un prob lema irriso lco) ma si nota anche che questa attenzione della principale rivista tecnica ufficiosa non andava al di là di un solo articolo (e solo talvolta, nei momenti di maggior crisi delle carriere , ve ne troviamo al massim o un paio ) all'anno. Questo, ovviamente , non poteva non contrastare con l'attenzione praticamente settimanale che, invece , organi di scampa militari più spigliati come «L ' esercito italiano• dedicavano ai temi dell ' avanzamento , delle carriere e delle promozioni .
46 Cfr. AA.PP ., Cam era , Legisl. XV , sess. unica , Discu moni, cornata del l lug lio 1884
47 Cfr. cGiornale m i litare ufficiale• , 29 marzo 1885 , ano n . 40, Regio Decreto .

170 POU11CA E PO U11CA MIUTARE
Ma quei provvedimenti , in realtà , non andavan o alla radice del problema. Il suo decreto-legge recepiva parre delle proteste degli uffi c iali, come quando limitava l ' accesso degli ufficiali agli istituti militari d'istruzione superiore (e così facendo restringeva, sul lungo periodo, il numero degli Ufficiali di Stato Maggiore che potevano uscirne) e limitava ulteriormente il principio della 'scelta' nelle loro promozioni. Ma il tutto in forme ed in misure del tutto inadeguate alla realtà del problema. Chi infatti provò a calcolare l ' effetto delle disposizioni Ricotti sulle carriere degli ufficiali , si a cc orse che queste sarebbero state sveltite solo di qualche mese: cosa che era ben lontana dal ritardo di anni che , come abbiamo visto , esse stavano accumulando 4s.

Si sentiva, è vero , al fondo del provvedim ento Ricotti, un qualcosa di nuovo: ma era ancora troppo poco per pote rne capire l'estensione. Solo quando , più tardi, il Ministro ebbe presentato un suo progetto di legge sul tema dell'ordinamento e dell'avanzamento degli ufficiali dell'esercito si poté intendere la sostanziale diversità dell ' impos t azione del n o varese rispetto a quella dei Ministri che lo avevano preceduto. Ma qu el di segno di legge , com e vedremo , non ebbe al cuna fortuna parlamentare . La protest a degli uffi ciali venne così maggiormente alimentata e si indirizzò tu tt a co ntro il seco ndo Mini stero Ricotti.
L'azione del Ministro , che aveva voluto essere t empe stiva ma che risultò solo inadeguata, non poté smorzare le criti che contro quelli che sino ad allora erano stati i bersagli della pubblica protesta degli ufficiali: criterio della 'scelta' e privilegi del Corpo di Stato Maggiore .
Si assisté anzi , negli anni in cui Ricotti fu Mini stro , ad un ceno i nc rudimento ed ' involgarimento ' della protesta dei militari. Se prima la questione dell ' avanzamento era stata solleva t a - negli opusco li pubblicati qui e l à in tutta Italia- con garbo , con varietà d ' argo menti e con una certa diplomazia , negli anni d e l secondo Ministero Ricotti la polemica si fece aperta e sfrontata. Molti , a distanza di tempo , si ricordavano di co me in quegli anni , p ersino lo ' scarpone' 49 , il povero ufficiale di Fanteria, avesse osato alzare la testa per dife ndere la sua carriera .
48 Cfr. cl ' ese rcito italiano•, l m aggio 1885, Appunti ai R. D. 29 marzo 1885.
49 La pubblicazione cui ci si rife riva è Grido di dolore d ella Fan teria. Petizione ai signon· mem b n · del Parlamento, So nd rio, Quad rio, 1884. L'autore, anonimo, si autodefmiva un ' povero scarpone' di Fame ri a.
MILITARJ NEGU ANNI OITANTA 171
Contro lo Stato Maggiore i toni si facevano grossi: «occo rre tagliare le teste dell'idra., diceva un opuscolo 5° . A molti ufficiali, il C.S.M. sembrava addirittura cuna potente organiz zaz ione oligarchica che si è imposta e dispone dell'esercito come di un pod ere da sfruttare a proprio vantaggio» 5 1 . Chi voleva esporre «in modo vergine, diretto» il pensiero degli uffi ci ali di Fanteria e dei reggimenti si esprimeva così. Ma non solo. Anche da chi scriveva a nome degli ufficiali delle vecchie Armi speciali (Artig lieria e Genio ), gli ufficiali dello Stato Maggiore erano visti co me cun piccolo nucleo, rip e tiamo , imbevuto di dottrine sovversive, di pomposa eloquenza, di e rrati princìpi , e sop rattutto di ben poca modestia. 52.
A questo mal conte nto , si tentò sul l e prime (da parte del Ministero della Guerra ) di opporre una pubblicazione ufficiosa che provasse a placare gli animi. Ne uscì fuori un opuscolo che, però, quasi moltiplicava le ragioni degli insoddisfatti. «Si potrà solo calmare, ma non troncare , il malcontento [in parte esagerato] che serpeggia nellefùe dell 'esercito:. 53, ammetteva infatti l'anonimo autore filo-ministeriale.
Il giornale cl ' esercito italiano:. svolgeva nel frattempo un ruolo fondamentale nel rivelare e nel diffondere tra gli ufficiali le magagne dell'avanzamento 54 Il periodico militare , che già durante il p re-
50 l vi, p. 45.
51 lvi, p. 10.
52 Le Armi speciali e l'avanzamen t o, Milano , Galli , 1884, p. 21. Per 'A rmi speciali' si intendevano al temp o Artiglìeria e Cavalleria, come di 'Arm i dotte' si parlava per Artiglieria e Genio . Erano comunque termini non sempre esplicitati e destinati a modificarsi col tempo.

53 Gli ufficiali, Torino, Stab. Arristico- Lerterario, 1885, p. 84.
54 Impossibile elencare qui, per il loro numero, gli arricoli dedicati al tema delle carriere. Da notare , semmai, il fatto che il giornale- strumentalmente- si opponeva al principio della scelta ed al sistema degli esami in nome di quella che veniva considerata una cdifesa dei veterani dell'indipendenza.. Ricorrenti erano infatti le critiche a quei progetti ministeriali che prevedevano l ' avanzamento degli ufficiali inferiori regolato da prove o da esami: esami che avreb bero poruto sottoporre una 'vecchia giberna ' al giudizio di qualche giovane ufficiale uscito dalla Scuola di Guerra. Mancano i da ti statistici pe r affermare se una simile operazione ideologica avesse una sua base co ncreta (cioè se i più colpiti dal la le n tezza delle carriere degli anni Ottanta furono proprio - come pure è probabile - g li ex-sott ufficiali entrati nel Corpo grazie alle promozioni d egli anni delle guerre dell'indipendenza) . È ceno che queste proteste de cL' ese rcito intendevan o 'sac ralizzare', attraverso il richiamo agl i anni ed agli uomini dell ' indipendenza , più concrete pretese burocratiche . Cfr., tra i molti altn, «L'esercito 29 gennaio 1886, L 'esercito dell'indipendenza e dell'unità nazionale . In senso analogo , qualche anno prima, era stato scritto che «Se nulla muta all'attUale sistema d'avanzamento, il grado di capitano è quello cui f atalmente sono destinati ad arresrarsi la magg ior pane dei sortorenenti del 1860 , tutti quelli del 1861 e forse anche quelli di parecchi anni successivi L 'avanzamento nell'esercito e il Corpo di Stato Maggiore, cir., p. 148.
172 POUTICA E POUTICA MlUTARE
cedente Ministero Perrero era ritornato più volte sul tema delle carriere, condusse durante e contro l'amministrazione Ricotti una campagna continua e radicale sulla questione delle carriere.
Se Ricotti voleva limitare l'applicazione del principio della 'scelta•, «L'esercito italiano» ne era invece uno dei più implacabili avversari. 'Tutta anzianità', sosteneva il giornale militare, e gli ufficiali di Fanteria avrebbero visto immediatamente sanate le loro 'tristi condizioni' 55 . Conseguentemente, massima era la opposizione all'introduzione dei limiti d'età nelle carriere, che avrebbe di fatto costretto molti ufficiali a terminare la loro carriera senza quel raggiungimento degli alti gradi che molti speravano.
Dei fascicoletti militari più esasperati - come quelli che abbiamo ricordato - talvolta «L'esercito italiano» non accettava il tono «iracondo» dell'esposizione 56, ma ricordava che quel tono non era altro che «una prova di più del malessere dei nostri quadri» 57. Della condizione degli ufficiali di Fanteria si arrivava a dire che essa legittimava «una fuga dal reggimento» 58 e un abbandono in massa della carriera militare.
Dei decreti di Ricotti del marzo 188 5, il giornale esplicitamente affermava che «anche questo è un tentativo sbagliato e che vede la questione con un occhio solo» 59: non sembrava inoltre, a «L'esercito italiano», che davvero il Ministro avesse voluto deviare dalla strada «perniciosa» 6o che sino ad allora era stata seguita con «l' accarezzare nelle carriere e nelle competenze il Corpo di Stato Maggiore a danno solamente delle due Armi di Fanteria e Cavalleria» 61 In altra occasione, ma sullo stesso argomento, il giornale sentenziava: «È un brutto principio» 62.

Qualche mese più tardi, quando anche nei successivi «Bollettini Ufficiali» delle promozioni il giornale militare non vide quei miglioramenti che esso si aspettava, il giudizio su Ricotti e sulla sua gestione dell'avanzamento non poté migliorare: «Le cose adunque vanno
55 Cfr. ad esempio, ivi, 25 ottobre 1885, Il morale dell 'esercito.
56 lvi, 21 dicembre 1884, La petizione di un povero scarpone.
57 Ibidem.
58 lvi , 16 gennaio 1885, Sulle attuali condizioni degli ufficiali di Fanteria.
59 lvi , 24 aprile 1885, Appunti ai R D. 29 marzo 1885.
60 Ibidem.
6 1 Ibidem.
62 lvi, 6 maggio 1885, La questione dell'avanzamento.
MIUTARI NEGU ANNI OTTANTA 173
•
ancora come per il passato» 63 . E deprecò di nuovo i «quindici anni di sviamenti, di tentativi e di controsensi» cui a suo parere andava ridotta la gestione ministeriale (di tutti i Ministri della Guerra) della questione dell'avanzamento 64 .
Lo stesso progetto di legge - che Ricotti poi presentò alle Commissioni parlamentari sul tema dell'avanzamento - fu accolto sulle pagine de «L'esercito italiano• dapprima con un laconico «Non esprimiamo giudizi» che già indicava l'opposizione del giornale, e poi da un'articolata analisi che coglieva nella proposta Ricotti soprattutto il suo essere «assai al di sotto» 66 dei problemi reali delle carriere degli ufficiali. L'opuscolo che il Ministero aveva fatto stampare per tentare di placare le proteSte degli ufficiali, infine , era parso a «L ' esercito italiano» addirittura «Oltraggiante per i veterani dell' indipendenza. 67 , che in buona pane erano - nell'analisi del giornale militare - i veri sfavoriti dalla lentezza delle carriere.
E se in tal una occasione «L'esercito italiano» era parso inclinare verso un sia pur sfiduciato sostegno al disegno di. legge di Ricotti (era pur sempre il primo intervento legislativo dopo tanti anni di disinteresse politico) , alla lunga i motivi di dissenso dovevano prevalere su quelli di consenso 6 8.

In realtà, poi, nonostante le frequenti analisi degli avanzamenti ora in questa ora in quell ' altra Arma, «L'esercito italiano» non era in grado di proporre una precisa soluzione: il toccasana continuava ad essere veduto ancora nell'abbandono del principio della 'scelta ' Più tardi ( mentre il giornale con più impegno era andato portando avanti la sua opposizione generale alla Amministrazione Ricotti e quando il contrasto tra Ministero ed opposizione militare si era andato appuntando sui temi dell'aumento organ ico delle Armi di Cavalleria e di Fanteria), «L'esercito italiano» cominciò a dire che con una crescita degli organici delle due Armi anche lo stato delle carriere avrebbe potuto essere migliorato. Ecco allora che la questione dell'avanzamento tornava ad essere una questione politica nel senso più pieno del termine. Per rendere più veloci le carriere, allora, e
63 l vi , 16 o tt o bre 1885 , Le recenti promozion i.
64 l vi, 2) otto bre 1885 , 11 m orale d ell'esercito .
6 > lvi, 8 d ice mbre 1885 , Pro m ozion i.
66 lvi, 16 dicembre 1885 , La nu ova legge sull'ava,tzam en to.
67 lvi, 28 gennaio 1886, Il nu o vo opuscol o sull 'avan z amento.
6S lvi, 4 febbraio 1886, La leg ge sull'avanzam ent o in S enato.
• 174 POUTICA E POUTICA MJUTA&.E
con più forza che nel passato , si chiedeva cun rimaneggiamento dei quadri:., al limite csia pure di carattere transitorio:. 69 .
«Questo è il punto capitale della questione :. 70 : aumentare i quadri, e dopo quelli di Cavalleria e di Artiglieria, anche quelli di Fanteria. E poi anche quelli del Genio, che altrim enti rischiavano di rimanere tagliati fuori da questa euforia di aumenti organici 71
Nel frattempo, cL' esercito non era rimasto solo nel controbattere vivacemente la politica del Ministero Ri cotti sul tema dell' avanzamento: numerosi erano i fascicoli e g li opuscoli che continuavano ad essere pubbli cat i.
Sulla stessa linea degli opuscoli più provocatori e degli articoli de cL' esercito italiano:. più intransige nti , si muoveva poi una interessante serie di figure di pubblicisti ' minori ', di 'mi litari di provincia' che, non di rado a proprie spese, scrivevano e facevano pubblicare le loro rimostranze e proteste per la lentezza delle carriere . Molti potrebbero essere gli esempi. Tra questi, a Verona, un tale Luigi Castellani inveiva contro i privilegi dello Stato Maggiore ed esigeva a gran voce l'abbandono de l principio della 'scelta ' n. Ed a Firenze, un cen o Ulisse Fi um i (che aveva fondato pers in o un ' Comitato elettorale e di Mutuo Soccorso fra i Veterani e Reduci dell ' esercito italiano che in età immatura od a incompleto servizio furono d ' autorità collocati a Riforma o a Ritiro con il minim o della Pensione ', co mitato che -a suo dire e nel solo capoluogo toscano - contava già 15 7 'commilitoni' ) predicava anch'egli co ntro i vantaggi degli ufficiali di St ato Maggiore 73.
D ' altronde , lo Stato Maggiore e il principio della scelta erano se mpre «fonte continua di disgusti e di malumori nelle fùe dell'esercito» 74, come dicevano altri opuscoli anonimi.
La giustizia è base dell 'o rdine -stabiliva uno ru questi - ed giustizia che reclamano tanto gli 'scarponi' quanto gli ufficiali di Artiglieria e Genio 75.
69 lvi, 23 aprile 1886, Di alcuni provvedimenti per n'so/vere la questione dell'avanzame nto.

70 l vi, 14 maggio 1886 , La questio n e dei quadn'.
71 lvi , 16 novembre 1886, Pensate anche al Genio (e poi ancora, ivi, 18 , 23 e 25 novembre 1886).
72 Cfr. L CASTELLANI , Sull'avanzamento militare. Appunti di un ex-uffo;iale, Ve rona, T ip. Nuova Arena, 1885.
73 Cfr. U. FIUM I , Ziba/done storico, critico, mi/ilare. Memoriale agli onorevoli rappresentanh· della Nazione indirizzato da U.F., Firenze, Tip Galletù, 1886.
74 Le condizioni degli ufficiali d'arn'g,lieria e genio, Torino, Casanova, 1886, p. 5.
7) lvi, p. 20.
MIUTARI NEGU ANNI 01TANTA 175
Un altro risollevava la richiesta che si abolisse lo StatO Maggiore in quanto Corpo chiuso e che lo si riformasse solo come ' Servizio ' accessibile a tutti gli ufficiali 76 .
In realtà, tra deprecazioni anonime e polemiche giornalistiche , gli anni stavano passando.
In anni successivi , si disse che la situazione delle carriere, oltre ad avere quelle cause lontane di cui abbiamo parlato, era stata aggravata «in gran parte dagli atti governativi del 1885 , i quali dal loro carattere precario e dall ' idea di quelli scessi dai quali emanarono, dovevano essere completati e corretti con altre disposizioni contenute nella legge sull'avanzamento che naufragò ( ... )» 77 . Ma la legge Ricotti avrebbe potuto risultare migliore dei decreti Ricotti?

In realtà, come cL' esercito italiano:. aveva già notatO e come fu possibile capire dalla lettura del testo completo del disegno di legge che Ricotti presentò alle Camere, nemmeno con la conversione di quel progetto io legge la materia dell'avanzamento degli ufficiali avrebbe potuto dirsi definitivamente risolta. Come già i decreti -legge del marzo 1885, il disegno di legge di Ricotti del1886 puntava a riorganizzare principalmente (ed in senso resuittivo e punitivo, un po' come il dibattito pubblicistico militare richi edeva) l ' avanzamento del Corpo di Stato Maggiore, ma non ambiva a sanare la complessa materia degli avanzamenti delle varie Armi , né riusciva quindi a realizzare la tanto sospirata 'perequazione' delle carrier e .
L'intervento del generale no varese anche in quesro delicato settore, come in altri della più gen e rale politica militare , si era limitato ad un'operazione dal segno ambiguo e limitato. Il grande problema delle carriere veniva così ridotto alla necessità di impedire veloci carriere degli ufficiali dello Stato Maggiore: ma in qu es to modo , se pure si fosse riuscito a placare gli animi del dibattito militare (ed abbiamo visto che, purtroppo per Ricotti, nemmeno questo sarebbe stato possibile) certo non si sarebbe riusciti a impostare una soluzione effi cace e duratura del problema.
Non a caso , la questione si trascinò , n e lla sua sostanza senza apprezzabili miglioramenti, anche per gli anni a venir e , sino (ed oltre) la legge del1896 ch e fu pensata proprio per mettere più ordine nella complessa materia ( ma che , dal punto di vista dell ' avanzamento non fece altro che dare forma di legge ad alcune realtà ormai inval se nel-
176 POLITICA E POLITICA MlLITARE
76
77
Cfr Il morale dell'esercito e l'avanzam en to degli u fficiali. Studio cniico, cit.
Qu estione late nte , Ro ma , Vog h e ra, 1889, p. 52.
la pratica degli avanzamenti e rinviare ancora una volta la soluzione del problema) 78.
Eppure, se anche la sostanza del problema militare non subì negli anni Ottanta radicali miglioramenti ed innovazioni, a livello politico e parlamentare si deve proprio al secondo Ministero Ricotti una sorta di 'aggiustamento' e di 'correzione' del punto di vista da cui il legislatore e la politica militare italiana dovevano guardare alla questione dell'avanzamento . Sino ad allora l'ottica con cui i Ministri della Guerra avevano guardato all'avanzamento era quello della necessità di una riaffermazione formale dei princìpi sostanziali della vecchia legge subalpina del 1853 (principio della 'scelta') anche a costo poi di una loro disapplicazione 79. Dagli anni del secondo Ministero Ricotti in poi, la Guerra accettò invece l'idea che per riformare o per rendere comunque più fluide le carriere degli ufficiali (o per non intralciare quelli che sempre più si dicevano loro diritti acquisiti) si doveva abbracciare il principio opposto della anzianità, coniugato con una scelta - o selezione - limitata ai soli ufficiali di C.S.M ..
La differenza era notevole.
La legittimazione del principio dell'anzianità, quale si ricavava dal progetto di legge 1886 (che era un po' il frutto e la 'risposta' politica all'estensione ed all'asprezza delle polemiche della base militare sul tema dell'avanzamento, durante il secondo Ministero Ricotti) bene si confaceva ad un organismo come quello del Corpo Ufficiali degli anni Ottanta poderosamente ingrandirosi grazie ai forti bilanci militari ed ormai caratterizzato da un forte peso contrattuale: un organismo che, in un certo senso, appariva ormai irriformabile (come invece una rigida e motivata applicazione della scelta avrebbe forse permesso) agli stessi Ministri della Guerra.
Ma anche a livello politico, in Parlamento, il progetto di legge Ricotti non fu indenne da critiche e da opposizioni, militari e politiche. Esso prevedeva cose ben diverse dal progetto Ferrero, del 1883 80_ Eppure erano cose che ancora non bastavano: allungamento
78 Sulla legge del 1896 , dal punto di vista del reclutamento , cfr. DEL NEGRO , Ufficiali di camera e ufficiali di complemento nell'esercito italiano della grande guerra: la provenienza regionale, cit., p. 272.

79 Cfr., come ultimo esempio di questo indirizzo, il progetto di legge sull'avanzamento presentato da l'allora Ministro della Guerra Emilio Perrero (nella Relazione al progetto si sente forte l'influenza e lo stile di Luigi Pelloux) in AA.PP., Senato, Legisl. XV, sess. unica , Documenti, n. 42.
8° Cfr. ibidem.
MiliTARI NEGU ANNI OTTANTA 177
della permanenza minima prevista per i gradi inferiori (cioè accettazione dello stato di cose) e accorciamento di quello previsto per i gradi superiori; diminuzione dello spazio alle promozioni a scelta (solo un sesto del totale, e applicabile solo per quegli ufficiali che sì trovassero iscritti nel primo quinto del quadro dì avanzamento della loro Arma) e per il resto tutta anzianità 81.
Non compariva, nel progetto Ricotti a differenza di quello Ferrere, la facoltà concessa al Governo di chiedere e ottenere dall'amministrazione militare il trasferimento di un ceno numero di Ufficiali per esigenze superiori, politiche o del Paese.
Una serie così grande di cambiamenti (accompagnata da una analoga serie di correzioni per quanto riguardava la parte del reclutamento) non sfuggì a chi aveva sempre creduto negli ordinamenti del 1853 ed aveva ritenuto imprenscindibile per un organismo militare che l'avanzamento ai più alti gradi fosse regolato dalla scelta.
Al momento della discussione al Senato. il Generale Mezzacapo protestò contro chi, secondo lui, voleva stravolgere lo spirito della legge del 185 3 ed attentare alla libertà dì scelta e di azione per il Corpo di Stato Maggiore 82.
Ma fu il solo ad opporsi: e il disegno fu approvato. Poi vennero le elezioni del 1886 e la legge dovette essere ripresentata da capo a tutte e due le Camere. Il testo del disegno, lievemente modificato, arrivò così alla Commissione Parlamentare della Camera, per il consueto esame preventivo prima della discussione in Aula. Ed anche in Commissione il progetto di Ricotti trovò forti opposizioni. Pais accusò il Ministro di <<avere troppa fretta» nel voler vedere approvate quelle importanti norme; Levi ripeté la «necessità di discuterle a lungo>>; Zanolini affermò di avere, sul tema dell'avanzamento, «concetti molto diversi da quelli del MiniStro» 83. Infine, il 27 gennaio 1887, la Commissione decise di non approvare quel testo del disegno di legge e di subordinarne l'esame a quando il Ministro avesse presentato un più generale progetto di legge sulle pensioni civili e militari. Era un modo di dire che la legge andava tutta riscritta.
81 Cfr. ivi, n. 243.
82 AA.PP., Senato, Legisl. XV, sess. unica, Discussioni, rornata del 3 aprile 1886.
83 ACD, Dd/, Legisl. XVI, sess. prima , reg. 430 , n. 100. Per Pais, cfr. ivi, Verbale di seduta della Commissione , 7 dicembre 1886. Per Levi, cfr. ivi, 21 gennaio 1887. Per la decisione finale della Commissione, cfr. ivi, lettera del l febbraio 1887, Inviti (presid. della Commissione) a Ricotti. Ma cfr. anche ivi, 8 febbraio 1887 , Ricotti a Inviti, dove il Minimo si dimostra fortemente contrario e cont r ariare dalle risoluzioni della Commissione.

178 POLITICA E POLITICA MJUTARE
Ma era troppo tardi. Già da due giorni la colonna del col. De Cristoforis era stata annientata dagli abissini di Ras Alula rra le sabbie di Dogali: e a Ricotti, anche sul tema dell'avanzamento, non sarebbe stata concessa per lungo tempo una riprova.
Se il generale novarese non poté quindi concretare il suo piano circa le carriere degli ufficiali, va però ricordato che tutti i Ministri che lo seguirono - senza alcuna eccezione - quando furono chiamati a proporre disegni di legge sul tema dell'avanzamento e del reclutamento, si rifecero sempre al disegno di legge Ricotti del 1886 84 . Questo stava a significare che dalla metà degli anni Ottanta in poi si era rinunciato per lungo tempo a regolare le carriere secondo la scelta: e che questa strada, tentata per ultimo dal Ministero Ferrero, era stata definitivamente sbarrata dalla protesta del Corpo Ufficiali proprio durante il secondo Ministero Ricotti.
Certo: dire questo non significa dire che tutti i giochi erano fatti. Si trattava di stabilire, anche una volta abbandonato il principio della scelta per quello dell'anzianità, in quale misura concreta, in quale proporzione la stessa anzianità avrebbe regolato le carriere degli ufficiali. E per questo si dovette attendere il1896: ma un grande passo a livello politico era stato ormai già fatto.
84 Cfr. AA.PP .• Camera, Legisl. XVI, sess. seconda, Documenti, n . 21 (presentato da l'allora Ministro della Guerra Berrolé Viale); poi ivi, sess. terza, Documenti, o. 72 (ancora Berrolé Viale); ivi, Legisl. XVII , sess. unica , Documenti, n. 306 (Pelloux); ivi,l.egisl. XVIII, sess. prima, Documenti, n. 2 (ancora Pelloux) ; ivi, n. 17 1 (di nuovo Pelloux) ; ivi, sess. seconda, Documenti, n. 3 (Mocenni). Questo progetto di legge, cipresentato da Mocenni nel 1895. fu ripreso con modificazioni da Ricotti che riuscì ad ottenerne finalmeme la co nversione in legge (appunto , la legge 2 luglio 1896. n. 254). La legge del 1896 era quindi molto attesa. Del clima in cu i essa venne a situarsi è esemplificativo il noto opuscolo A . ... Z ... , Verità ingrate sull'on'entamento militare italiano Roma, Tip. Casa Editrice Italiana, 1895, che ha avuto tanta (trop pa ) fortuna sroriografica. Vi fanno riferimento, ua gli altri, VENTURINI, Militari e politici nell' Italia umbertina, cit., p. 208, e MAZZONIS, L'Esercito italiano al tempo di Gan'baldi, c ir .,passim. In realtà , le affermazioni dell'opuscolo sono incomprensibili senza una attenta ' lettura' dell ' agitazione degli ufficiali dell'esercito negli anni Ottanta. Comunque, il problema dell'avanzamen to era destinato a perpetuarsi anche dopo il 1896. Tra gli altri , cfr. U PRlGHT Saggio critico sui principi che regolan o le carriere mtlitan·, in militare italiana», a. 1904, o. 5 (che, con tabelle e grafici, critica il principio di anzianità considerato ancora il responsabile dell ' arresto di tante carriere al g rado di capitano).
Cfr. anche la lunga memoria dattiloscri tta in MCR, Carte Perazzi, se. 894, fase. 10, doc. 8, Osservazioni alla legge sull'avanzamento fatte da S.E. il generale Ricotti e riepilogate dal gen. Bava Beccans.

MILITARI NEGU ANNI OTTANTA 179
La stampa d'informazione militare
Il Corpo Ufficiali dell'esercito, se era attraversato da un così profondo malcontento per le questioni dell 'avanzamento, questioni per le quali veniva chiamata in causa direttamente la politica del Ministro della Guerra, che cosa pensava degli altri aspetti maggiori della politica militare di Ricotti? Quali erano le 'idee diffuse' tra i militari italiani verso la metà degli anni Ottanta?
Sono queste domande cui non è facile -e per molti ve rsi non è oggi possibile - dare una risposta esatta ed esauriente.
Alcune prime indicazioni possono, però, essere dedotte da una attenta lettura della stampa militare del tempo. Non ci riferiamo solo alla stampa più tecnica e specializzata, come quella delle riviste tecniche o d'Arma (come la «Rivista militare italiana», la «Rivista di Artiglieria e Genio», etc.) 1 Stampa, questa, che- si può dire con buona approssimazione- non veniva letta dalla globalità del Corpo Ufficiali, non pretendeva di ' rispecchiarne' gli orientamenti (bensì, casomai, di suscitarli o di omogeneizzarli), non ne appagava sempre le curiosità e gli interessi 2 In questo caso, per provare a rilevare quali fossero alcuni elementi della ideologia , delle 'idee diffuse', tra le fila del Corpo Ufficiali del tempo, è più utile rifarsi invece a quella che si potrebbe definire come 's tampa d'informazione militare'.
Si trattava di giornali, quotidiani o più s p esso trisettimanali, di formato, composizione e tecniche tipografiche assolutamente identiche a quelli della più generale stampa quotidiana politica o d'informazione: la loro unica caratteristica era di trattare solo argomenti militari. La cosa dà bene l'idea del posto che i militari occupavano al lora all'interno della classe dirigente nazionale e, dal punto di vista della storia del giornalismo, ha una sua impanante specificità,
1 La stessa c:Rivista militare quando nacque, nel 1856, fece fatica a trovare anche solo cento abbonati (sino a che La Marmora non li trovò nelle strutture del Ministero della Guerra subalpino). Cfr. PESCI, Il generale Carlo Mezzacapo e ti suo tempo , cit., pp. 51-52 ; e [L. CISOTIIJ, Cinquantesimo anniversan'o della Rivista Militre italiana. Sguardo stonco retrospettivo e ncordi di L. C , Roma, Voghera, 1906.
2 Per un primo, ma ancora non completo , elenco , cfr. l cento anni della Rivista Militare [a cura di P.G. Franzosi) , Roma , (Roma, Tip . Regionale ). 197 6 . Per cL' esercito italiano• cfr. ivi, p. 51. Un primo uso organico della stampa d ' informazione militate , ma limitato ad un tema specifi co, è quello di L. STRIK LIEVERS , La stampa militare di fronte alla crisi dei Fasci, in I [11Ici stctliani, v. II, La crisi italiana di fine secolo, Bari, De Donato, 1976 , pp . 20 9 -224 .

180 POUTICA E POUTICA MILITARE
che però non è stata messa ancora nel dovuto risalto 3. Erano, probabilmente, l'unica categoria professionale che vantava una stampa propria: non c'era una stampa dalla periodicità così frequente per avvocati o ingegneri. Intorno alla categoria dei militari (che, nell'Italia del tempo costituivano una quota non indifferente del totale degli alfabetizzati) era sorta nel primo quarantennio di vita nazionale unitaria una serie numerosa, varia ed interessante (anche se non sempre, per vari motivi, finanziariamente fonunata) di iniziative giornalistiche e pubblicistiche 4 .
Al tempo del secondo Ministero Ricotti, inoltre, una attenta lettura della stampa d ' informazione militare è necessaria anche perché -oltre a restituirei un interessante 'spaccato' dell'ambiente militare del tempo - proprio questo tipo di stampa svolse un ruolo centrale nell'evoluzione della politica ministeriale, riflettendo ed alimentando, all'interno del Corpo Ufficiali, quel ceno distacco (se non quella vera e propria opposizione) nei confronti della gestione del novarese che siamo già andati notando. Alla stampa militare del tempo, quindi, si attaglia bene la figura di protagonista consapevole del dibattito militare dell'Italia del trasformisrno e della 'po l itica di potenza'.
Tralasciando di prendere in considerazione esplicita la rilevante massa di pubblicazioni minori - periodiche o meno - che in quel periodo veniva diffusa 5, la nostra attenzione può rivolgersi ai due principali organi di informazione militare del tempo, «Italia militare» e «L'esercito italiano». Se anche una cena differenziazione, o conflittualità, tra le due testate si dovette presentare più volte, fu ceno negli anni del secondo Ministero Ricotti che la divaricazione di prospettive e di interessi dei due giornali divenne più chiara e percepìbile.
«L'Italia militare» era considerata la voce ufficiosa del Ministero
3 Scarsi cenni, ad esempio, in V. CASTRONOVO, Giornali e comnti d'opinione pubblica in lJalia dopo l'unità {1861-1887), Torino, Coop. Libr. Torin., 1962, o in ID., La stampa italiana dall'unità al fascismo, Bari,Laterza, 1970. Su un versante internazionale, invece, avevano sotto lioearo l'interesse di questo tipo di stampa taluni ua i saggi raccolti io M. JANOWITZ,]. VAN DOORN, On Mzlitary Ideology, Ro([erdam, Rotterdam University Press, 1971.

4 Tra cui, anche se per anni uo poco più cardi, cfr. Annuario della stampa italiana, a cura di H. Berger, Milano, 1895. pp. 693-856; ed ancora meglio cfr. Annuario dell.a stampa italiana, a cura di H. Berger, Milano, 1897, p. 779.
5 A proposito di cui si rimanda , ancora una volta, a PAGLIAINI, Catalogo gene·rale della libreria italiana ... , ci r.
MILITARI NEGU ANNI OTIANTA 181
della Guerra. Quando altri Ministeri - o Ministri - si servivano di quotidiani politici per far meglio conoscere le proprie il Ministro della Guerra aveva un proprio istituzionale organo di stampa. Stampato presso una tipografia di fiducia del Ministero, amministrato dal Ministero stesso, esso per lunghi anni raccolse e chiarì le posizioni dei Ministri in divisa 6. Da quella sede - militarevenivano così le risposte dei Ministri della Guerra a quegli ambienti od a quei giornali - politici - che fossero intervenuti nelle discussioni di politica militare.
«L'esercito italiano», invece, pare conducesse una vita- politica e finanziaria - più autonoma 7. È probabile che «L'esercito italiano:., che tanta fortuna di pubblico doveva avere proprio negli anni Ottanta, fosse in origine quel giornale creato a Roma per sostenere una linea di politica militare favorevole a Luigi Mezzacapo ed al generale Nunziante, durante i primi anni della Sinistra al potere s. È comunque cerro che, negli anni del secondo Ministero Ricotti, fu il giornale militare più letto e diffuso 9. Al punto che, quandonel maggio 188 7- !'«Italia militare:. cessò le pubblicazioni, pochi nell'ambiente militare ne sentirono la mancanza. «L ' esercito italiano» visse negli anni centrali di quel decennio un periodo di forte espansione, che lo portò per più di un anno ad uscire addirittura in forma di quotidiano , senza per questo perdere le caratteristiche di vivacità, di critica e di acutezza che lo avevano sino ad allora contraddistinto. Intorno all'ambiente del giornale (oltre al tradizionale servizio di assistenza legale per i militari di Roma) lO si andava radunando un insieme di iniziative editoriali che poi, negli anni Novanta, dovevano
6 Cfr. O. MAJOLO MOLINARI, La stampa pen'o dica romana dell'ottocento, Roma, lst. di studi romani, 1963, v. l , pp. 513-514.

7 lvi, pp 366-367.
8 Cfr. CORSI , Italia 1870-1895. cic., p. 163.
9 V. CASTRONOVO, Per la storia della stampa italiana (1870-1890), in «Nuova rivista sto rica. , a. XLIII (1963), nn. 1-2, dà la cifra di quattromila leuori. Se anche la cifra non fosse sottostimata, si pensi che il Corpo Ufficiali coorava al tempo poco più di quattordicimila unità . Nel novembre 1885, «L'esercito italiano• riuscì anche a trasformarsi da trisettimanale in quotidiano, seppure poi per un solo anno. Dopo Dogali , per una settimana , il giornale fu quotidiano. Nei mesi successivi, infrne, in coincidenza con la spedizione 'di rivincita' del gen. Di San Marzano 'contro l'Abissinia' cL'esercito italiano• pubblicò un sup plemento.
10 Un servizio di non trascurabile utilità per i militari della capitale. Varie, poi, le rubriche ospitate dal giornale. Tra queste: 'Guida del militare io Roma', 'Piccola cronaca militare', 'Aste e appalti', 'Piccola posta', 'Tribuna militare', etc ... Non mancavano i raccomi d ' appendice.
182 POUTICA E POUTICA MWTARE
sfociare nella fondazione della Casa Editrice Italiana. Questa casa editrice si specializzò, ovviamente , in pubblicazioni militari e, con i suoi libelli e le sue edizioni, contribuì notevolmente ad intaccare quella sorta di monopolio editoriale che per i militari degli anni Sessanta ed Ottanta avevano rappresentato le più ufficiose (e ministeriali) case editrici come la Voghera , o la Tipografia eredi Botta, o talvolta la Loescher di Torino 11.
Quanto in questo tentativo editoriale poi influiss e ro scelte politiche o di ambienti politici non si può, allo statO attuale delle conoscenze, dire; come non si conosce a sufficienza quanto questO processo di apertura del mondo editoriale militare italiano (che ebbe effetti diversi, di rinnovamento del dibattitO militare come anche di una su a setto rializz azione e specializzazione, ma comunque effetti profondi e duraturi) fosse collegabile con le manovre editoriali e finanziarie di Oblieght, che proprio negli anni Ottanta andava allargando la sua influenza sul mondo della stampa italiana 12 .

In ogni caso , negli anni Ottanta e specificatamente negli anni del secondo Ministero Ricotti, «L'ese rcitO italiano• ebbe tra i militari un' imp ortanza ed un ruolo difficilmente sottovalutabile.
Molte delle sue fortune , va riconosciutO , furono legate alla campagna continua, martellante , insistente sulle questioni dell'avanzamento 13 . Non c'era settimana in cui il giornale non rinsaldasse Io spi ri to di Corpo e denunciasse il malcontento degli ufficiali, pubblicando analisi particolareggiate della situazione de ll e ca rriere ora di questa ora di quell'altra Arma dell'esercitO. Ampio spazio avevano poi i confronti con la situazione militare esistente in al tri Paesi europei o le proposte di soluzione e di sveltimento delle carriere per questo o quel gra d o. Costante era la de pl orazione per lo stato io cui versavano le carriere degli ufficiali inferio ri della Fanteria , tra le cui fila - evidentemente- «L'esercito italiano• trovava il maggior numero dei suoi lettori . E, quando la protesta per la lentezza delle carriere e per la fluttuante politica ministeriale di favori per le varie Armi raggiunse la forma pubblica di opuscoli e di libretti, il giornale di De Luigi poté a ragione - orgog lio samente - «rivendicare l'iniziativa di questo poderoso movimento della pubblica opinione» 14 Me-
11 Per un 'analisi di tali questioni, poco offre- purtroppo - STICC A, Gli scritlon· militan· italiani, cir.
12 Cfr. CAS1RONOVO , Per la storia d ella stampa italiana (1870-1890), cit. , p . 139.
l3 Cfr. infra p. 15 7.
14 Cfr. cL ' esercito italiano• , 28 dicembre 1884, La questione dell'avanzamento
MILITARJ NEGU ANJ\'1 OTIM'TA 18 3
glio di altri, infatti, quel giornale aveva avuto il merito di fare (di una questione che poteva essere solo amministrativa o corporativa) anche un problema politi co.
In questo senso, ma non solo, «L'esercito italiano:. affermava che:
La stamp a fa l'ufficìo suo e prende la mano al Governo quando questo sì mostra contìn uamen te irresoluto e inceno e ti tuba di fronte alla più piccola responsabilità 15.
Il giornale, infatti, pareva aver idee assai chiare. In un'altra occasione esso scrisse che stampa militare deve essere lo specchio fedele delle condizioni morali dell' esercito• 16: e qualora il dibattito militare sui vari aspetti d eU' amministrazione della Guerra avesse fatto emergere tra i militari che vi partecipavano differenze anche notevoli sul piano ideologico, il giornale non avrebbe accettato chiusure e repressioni ministeriali. cLa disciplina non ci ha a che vedere con le questioni di principio:., concludeva cL' esercito italiano• 17. Questa cosciente e riaffermata volontà di spazi di discussione mil itare, che trascendeva ovviamente la singola questione dell'avanzamento e che si allargava agli aspetti più vari e complessi di una politica militare, avanzata da un giornale militare, non deve sorprendere e può avere almeno due spiegazioni, una politica ed una 'sociale'.
La prima, ovvia, è che esistesse al tempo del secondo Ministero Ricotti un dibattito od un confronto sulla politica militare che era assai più consistente e più meditato di quanto sinora si sia potuto pensare. Un confronto che era molto più che una 'coda' dei dibattiti precedenti tra Luigi Mezzacapo e Ferrero t8 e che aveva molto in comune con un grande tema di quegli anni che era la diffusione delle teorie offensivistiche e ' militaristiche '.
La seconda spiegazione, non contrastante con la prima, è che l 'Esercito, il Corpo Ufficiali, 'i militari' - sempre più coscienti del loro ruolo nella società e nella politica dell'Italia degli anni Ottanta - cercassero oggettivamente spazi di elaborazione e di espressione più ampi e più 'liberi' di quelli che il Ministero della Guerra, con la sua sonnacchiosa «<talia militare» o con le sue rare ma controllatissime pubblicazioni , poteva offrire. In questo senso- scriveva cL' e-
15 lvi , 6 gennaio 1885, L'Italia e la paura
16 lvi, 9 giugno 1885, La . disciplina e la stampa militare.
17 Ibidem.
18 Cfr. MINNITI, Esercito e politica da Porta Pia alla Triplice Alleanza , cir., p. 87.

184 POUTICA E POLITICA MWTARE
sercito italiano» a proposito di alcuni rimproveri impartitigli dall ' organo ufficioso del Ministero- dl segreto militare ha grande importanza in tempo di gueTTa»: ma solo in quello, ché in tempo di pace l'esercito cresce e si rafforza anche nel dibattito tra le tendenze» 19
Ilgiornale, inoltre , pubblicava spesso articoli eterodossi, provocatori della discussione . Di fronte alla nota preferenza di Ricotti verso le foni compagnie di Fanteria e verso i 'gross i battaglioni', cl' ese rc ito italiarw» scriveva che non si potevano spiegare le sconfitte italiane nella guerra del 1866 - a cui spesso ricorreva il Ministro della Guerra per dimostrare la fondatezza delle sue asserz i on i - con la mancanza di quei grossi battaglioni. cl ' esercito non ha vinto a Custoza perché nessuno ha saputo guidarlo» , questa era la lapidaria e polemica definizione del giornale 20.
Più tardi, dopo la trasformazione del giornale da tr isettimanale a quotidiano, e dopo l 'oggettivo arricchimento delle sue pagine con la comparsa di nuove rubriche e dal percepibile nuovo apporto di altri contributi e di altri collaboratori, il direttore De Luigi scriveva con soddisfazione : «È la prima volta che si costruisce in Italia un centro di discussione militare» 21 , e questo, come disse qualche tempo dopo, in un momento in cu i la discussio ne sulla politica militare governativa stava attraversando cun momento di viva concitazione» 22 .
Con questo spirito di discussione e di critica, rutti gli aspe tti della politica militare di Ricotti vennero sollevati ed analizzati nelle pagine de «L'esercito italiano». Il tono di critica e di polemica antiministeriale fu praticamente costante .
Già al momento della nomina di Ricotti il giornale espresse i diffu si timo ri che la politica del nuovo Ministro della Guerra avrebbe potuto sconvolgere l 'assetto raggiunto dall'esercito dopo l'amministrazione Ferrero , con l a quale cL' esercito italiano » si era mosso in più di un'occasione in modo simpa tetico 23. La difesa dei dodici Corpi d'Armata e anzi la necess i tà di completare que ll 'ordinamento con un adeguato aumento della unità di Cavalleria e di Artiglieria divenne così un'altra delle bandiere del giornale 24.
l9 cL' esercito italiano:., 29 agosto 1885, l segre# militari.
20 lvi, 4 novembre 1885, Ballaglioni grossi e battaglioni piccoli.
21 lvi, 10 dicembre 1885, Ai nostri lettori.
22 lvi, 6 novembre 1886, Le discussioni militan·.

23 lvi, 3 giugno 1885, L 'indirizzo dell'amministrazione della guerra.
24 Già a metà novembre .t'esercito italiano• ammetteva di aver «accolto con qualche riserva:. la nomina di Ricotti. lvi, 18 novembre 1884, L'apertura del Parlamento e le leggi militan·.
MIUTARI N'EGU ANNI OTIANTA 185
Altro aspetto sul quale il giornale ritornava spesso e volentieri era quello della necessità di opporsi a qualsiasi ipotesi di riduzione o anche solo di non accrescimento delle spese militari. c:Contro le economie!» tuonò spesso la voce de c:L' esercito italiano» 25. I raffronti con i bilanci militari delle altre potenze erano fatti sempre in modo da far comparire l'Italia agli ultimi posti di ogni graduatoria; e raramente si faceva riflettere il lettore militare che quelli degli anni Ottanta erano i bilanci militari più alti che fino ad allora erano stati stabiliti in Italia.
Ma olue che una petizione di principio questa avversione alle economie era uno strumento di lotta politica contro Ricotti.
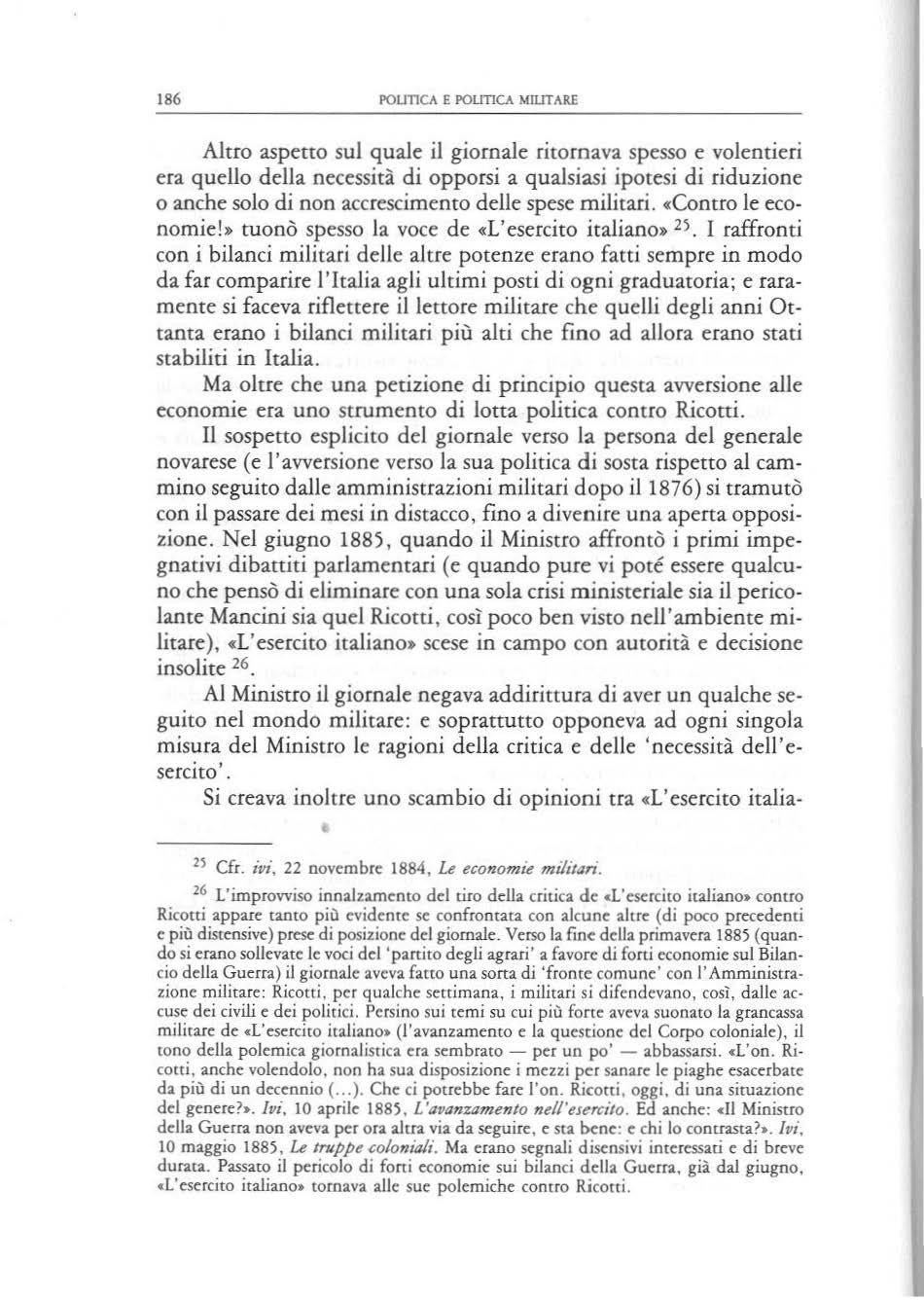
li sospetto esplicito del giornale verso la persona del generale novarese (e l'avversione verso la sua politica di sosta rispetto al cammino seguito dalle amminisuazioni militari dopo il1876) si uamutò con il passare dei mesi in distacco, fino a divenire una aperta opposizione. Nel giugno 1885, quando il Ministro affrontò i primi impegnativi dibattiti parlamentari (e quando pure vi poté essere qualcuno che pensò di eliminare con una sola crisi ministeriale sia il pericolante Mancini sia quel Ricotti, così poco ben visto nell'ambiente militare), c:L'esercito italiano• scese in campo con autorità e decisione insolite 26.
Al Ministro il giornale negava addirittura di aver un qualche seguito nel mondo militare: e soprattutto opponeva ad ogni singola misura del Ministro le ragioni della critica e delle 'necess ità dell'esercito'.
Si creava inoltre uno scambio di opinioni tra c:L' esercito italia-
2) Cfr. ivi, 22 novembre 1884, Le economie militan·
26 L'improvviso innalzamento del tiro della critica de cL' esercito italiano• contro Ricotti appare tanto più evidente se confrontata con alcune altre (di poco precedenti c più distensive) prese di posizione del giornale. Verso la ftnc della primavera 1885 (quan· do si erano sollevate le voci del 'partito degli agrari ' a favore di forti economie sul Bilancio d ella Guerra) il giornale aveva fatto una sona di 'fronte comune' con l'Amministra· zionc militare: Ricotti , per qualche settimana, i militari si difendevano, così, dalle ac· cuse dei civili e dei politici Persino sui temi su cui più forte aveva suonato la grancassa militare de cL' esercito italiano• (l'avanzamento e la questione del Corpo coloniale), il tono della polemica giornalistica e ra sembrato- per un po' -abbassarsi. «L'on. Rj cotti, anche volendolo, non ha sua disposizione i mezzi per sanare le piaghe esacerbate da più di un decennio( ). Che ci potrebbe fare l'on. Riconi , oggi, di una situazione del gene re?•. lvi, 10 aprile 1885, L'avanzamento nell'esercito. Ed anche: cll Ministro della Guerra non aveva per ora altra via da seguire, e sta bene: e chi lo contrasta?•. lvi, lO maggio 1885 , Le truppe coloniali. Ma erano segnali disensivi interessati e di breve durata. Passaro il pericolo di foni economie suj bilanci della Guerra, già dal giugno, cL'ese rcito italiano• tornava alle sue polemiche contro Ricotti.
186 POUTICA E POUTICA MIUTARE
no• e quei deputati che in Parlamento si opponevano, in forme diverse , alla gestione Ricotti: i secondi risollevavano nelle aule parlamentari le critiche che il giornale aveva avanzato nel corso dei mesi, il primo dava ampio risalto ai discorsi parlamentari di quei deputati.
Ad esempio, l'ampia critica che Carlo Mezzacapo aveva fatto nel giugno 1885 in Senato alla politica militare del novarese era qualificata da cl' esercitO italiano » come l'espressione delle cidee e aspirazi oni predominanti nelle più alte sfere del nostro Esercito» 27 . Analogamente, del discorso di Cosenz - sempre di quei giorni- si facevano rilevare quei passaggi in cui il Capo di Stato Maggiore , pur accettando l'obiettivo propostO da Ricotti d eli' aumento della forza de ll e compagnie , aveva detto che quesro «non doveva pregiudicare» il rimanente del programma militare di completamento d eli' assetto del 1882 28

Altri provvedimenti di politica militare, come quello del concorso indetto da Ricotti per il 'miglior libro di lettura per il so ldato ', che non parevano a cl ' eserc it o italiano» corrispondere alla necessità avv ertita come più urgente di completare l'ordinamentO militare ed in nalzarne l 'efficacia, venivano senza mezzi ter mini qualificati come clenocini» 2 9.
Quando poi era possibil e mettere l'amministrazione Ricotti in contrasto con se stessa, il giornale di De Luigi pareva ben lieto di far lo
Ad esempio, nel gi.ugno 1886, dopo che le e lezioni avevano rafforzatO la parte più conservatrice dell'assemblea parlamentare, Ricotti ed il suo Segretario Generale Marselli commentarono con accenti diversi le conseguenze che questo poteva avere sulla politica militare del Governo. Il Ministro , più cautamente , disse so l o che ciò avrebbe fatto approvare con maggiore velocità alcuni p roge tti di legge che da te mp o aveva p resentato all'attenzione delle Came re 30_ Marselli, in maniera più decisa , affermò invece che si stavano ponendo le condi zioni politiche per andare oltre quella 'sosta' che sinora era stata im posta alla politica militare italiana3 1 Il fatto che poi l'organo ufficioso de'l Ministero della Guerra avesse pubblicato solo il
27 lvi, 27 giugno La qu estione militare in Senato.
28 Ibidem.
29 lvi, 8 gennaio l /libro di lettura pel soldato italiano.
30 Cfr. cL'Italia 16 giugno 1886.
3l Cfr. cL'eserciw l giugno 1885 , L 'indirizzo dell'amministrazione militare.
MIUTAJll NEGU ANNI 01TANTA 187
testo del discorso del Ministro , senza fare cenno a quello del Segretario Generale 32 , parve a c:L' esercito italiano» un segnale da indicare e da criticare pubblicamente 33.
Qualche settimana più tardi, di nuovo, il giornale tornava a lamentarsi delle condizioni militari dell'esercito ed il fatto che esse fossero 'cattive' veniva definito come «Un pensiero , e ci duole il dirlo , ormai entrato nella coscienza del paese» 34 . La volontà espressa da Ricotti di continuare tutto sommato nella sua attività di ordinaria amministrazione e di non impegnarsi a superare la ' sosta ' era per c:L' esercito italiano• la ragione per cui io Italia c:si arres ta[ va] insomma ogni manifestazione di quell ' attività militare di cui gli Stati esteri ci danno imitabile esempio » 35.
Un elemento importante e ricorrente caratterizzava questa opera di continua critica della gestione Ricotti che si levava dalle pagine de «L'esercito italiano ». Nelle pagine del giornale di De Luigi si parlava spesso della 'insofferenza' con cui l'Esercito guardava alla politica militare che il Governo e le Camere gli volevano imporre. Ricotti , più di una volta esplicitamente , era criticato da c: L' esercito italiano » non in quanto militare che aveva delle idee divergenti da quelle della redazione del giornale bensì in quanto autorità politica , e non militare , in quanto deputato e non soldato , estraneo all ' Esercito. La differenza era notevole.

Già al momento della candidatura di Ricotti , il giornale si era lamentato che alla nomina del nuovo Ministro si fosse giunti solo dopo una «discussione quasi esclusivamente politica» 36 , interessata a consolidare la compagine governativa ma non a 'rispondere alle necessità dell'esercito ' . E lo stesso giorno , mostrando questa volta «compiacenza» 37 per la scelta di Marselli a Segretario G e nerale , si riportavano del militare napoletano alcuni brani di un suo vecchio discorso in cui egli si era manifestato contrario alle «influenze parlamentari sull'esercito» 38
Già nel marzo 1885, esplicitamente, «L ' esercito italiano» affer-
32 Cfr. ivi , 3 g i ugno 1885, Il programma mil itare.
33 ar. ivi, 9 gi ugno 1886, Ragioniam o pure.
34 lvi, 2 1 ag osto 1886, Le nostre co ndizio ni m ilitari.
35 l vi, 27 agosto 1886, Uh'li co nfro nti.
36 lvi, 28 n ovembre 1884, La nu ova amm inistrazione della Gue" a.
37 l vi, 11 nove m b re 1884, Il Segretario G en erale d ella G u e"a .
38 Ib idem .
188 POUTICA E POUTICA MWTARE
mava che Ricotti non doveva seguire la sua «fluttuante inclinazione personale>> 39 bensì quello che il corpo dell'esercito gli dettava. Più tardi, quando la Camera fu chiamata a discutere di alcuni aspetti centrali della sua politica militare, il giornale scriveva:

noi non vediamo la via attraverso la quale §li attuali dibattiti parlamentan· possano arrivare a qualche risultato pratico 4 .
In maniera ancora più chiara, nel giugno, «L'esercito italiano» dichiarava che «Ricotti non è altro che una pura e semplice competenzaparlamentare» 4l e che per questo motivo si era caduti «di nuovo in pieno opportunismo militare» 42.
Questa insofferenza verso il Parlamento e la politica, per «L'esercito italiano» era l a causa di mo l ti dei mali dell'organismo mi l itare. Nell'ambito della stampa militare, il giornale criticava il componamento dei redattori militari della «Italia mil itare» e ne spiegava il motivo con analoghe considerazioni:
bastò che l'onorevole Ricotti entrasse nel Ministero, perché diventassero muti come pesci. Ciò che vuoi dire? Vuoi dire che la politica eseràta la sua tirannia( ) 43.
Io generale, «L'esercito italiano» era contrario a che un alternarsi di Ministri al la Pilotta, quale lo svolgimento dell'attività parlamentare poteva comportare, si risolvesse in mutevoli influenze politiche «che lascia[ vano] l'Esercito in balìa del primo occupante» 44 .
E ancora più tardi, nei giorni concitati seguiti al diffondersi delle notizie di D ogali, il giornale tornava ad inveire contro Ricotti e «contro la politica» 45.
È insomma nel ripetuto accento ami-parlamentare che sta una delle particolarità con cui «L'esercito italiano» accoglieva e giudicava le mosse di Ricotti. In questo senso, come di corpo che si chiude al
39 lvi, 11 marzo 1885, L'ordinamento dell'esercito.
40 lvt·, 8 maggio 1885, La politica coloniale dal punto di vista militare.
41 lvi, 3 giugno 1885, L 'indinzzo dell'amministrazione della Guerra.
42 Ibidem.
43 lvi, 21 ottobre 1885 , L 'Esercito quottdiano. Timon· e speranze dell'Italia Mzlitare.
44 lvi, 2 settembre 1886, L 'indiffirentismo militare.
45 lvi, 25 febbraio 1887, I danni militari della cnsi
MlliTARI NEGU ANNI OTTANTA 189
suo interno secondo quanto è stato notato 46, acquistano un altro e più caratterizzante valore le affermazioni più tipicamente 'militaristiche' del giornale.
«Risvegliare dal torpore il sentimento militare del Paese dopo un ventennio di vera decadenza» 4 7 diveniva così uno degli scopi del giornale, casomai auspicando, o non temendo, «un momento di serio pericolo» 48 che, csolo», avreb be potuto destare quello spirito militare che pareva essersi sopito.
Ma non solo. Contro chi andava sottolineando un po' troppo insistentemente che- nell'ordinamento politico ma anche in quello militare - «il re regna ma non governa» 49, il giornale militare riaffermava invece che la prerogativa della Corona nelle cose militari doveva essere piena e totale. Il Ministro della Guerra poteva amministrare: ma chi, in ultimo , doveva decidere per l'esercito era il Re. Solo a quest 'u ltimo gli ufficiali si inchinavano , senza discutere.
Ecco allora che, riassumendo, l'orizzonte istituzionale in cui voleva muoversi in quegli anni cl ' esercito italiano» era assai ristretto: contro il Ministro , lontani dalla politica, ossequienti al Re ed al massimo (come vedremo) al Capo di Stato Maggiore. La chiusura in se stesso dell'esercito e del Corpo Ufficiali non avrebbe potuto essere meglio definita. Il tutto veniva fatto non per un esercito dal quieto vivere, in un Paese in cu i occorreva anzi in ogni modo risvegliare il 'sentimento militare ', bensì per un esercito efficiente, forte, 'offensivo ' 5°. ·
46 Cfr. MINNITI, Erercito e politica da Porta Pia alla Tn'plice Alleanza, cit., p. 34.
47 Cfr. «L'esercito italiano• , 18 gennaio 1885, Le nostre imprudenze.
48 Come già aveva fatto notare CHABOD, Storia della politica estera italiana, ci t., p. 68 e p. 155.

4 9 Lo aveva sostenuto cii popolo romano•. quotidiano del presidente del Consiglio. Cfr. la fone risposta de cL' esercito italiano•. 19 marzo 1886, Le prerogative della Corona nelle cose mzlitan· (e poi ancora, con lo stesso titolo, in data 23 marzo 1886).
Il giornale non era nuovo a queste riaffermazioni dell'esistenza di un rappono diretto e privilegiato ua Esercito e Re. Anche nelle piccole cose. Quando Ricotti, con una delle sue prime misure amministrative successive alla sua nomina, aveva ordinato che (in assenza del Re) la residenza romana dei regnanti fosse vigilata non più dalla Guardia d'o· nore ma da un semp li ce ed ordinario picchetto di fanter ia, il giornale militare aveva gridato addirittura alla cdemolizione morale• di quel rapporto. Cfr. ivi, 18 novembre 1884, La Reggia militare.
50 Offensiva, anche in Africa. Cfr. ivi, 19 marzo 1886, La missione italiana in Afri· ca. Simili toni 'militaristici' de cL'eserci to italiano• non p ossono non sollevare- sia pure, qui, per inciso -la questione del militarismo italiano. Questione che pure abbisog nerebbe di uno srudio a pane e non di una breve nota: e comunque di uno srudio che non si esaurisca nel solo esame della stampa militare Per intanto, si può ricordare
190 POUTICA E POUTICA MILITARE
Se infatti le polemiche sull'avanzamento erano quelle che garantivano al giornale una grande diffusione, le critiche mosse da «L'esercito italiano» alla politica di Ricotti in tema di espansione coloniale erano quelle che lo facevano apparire più radicale.
Al giornale, la politica coloniale militare realizzata ed impersonata da Ricotti appariva costituzionalmente viziata da una deficienza di ardire e di 'offensivismo'. E contro la 'parodia coloniale' del novarese «L'esercito italiano» doveva combattere alcune delle sue più efficaci campagne giornalistiche 51.
Tr a l'altro, su questo terreno, il giornale appariva assai bene aggiornato, come se qualcuno- dall'interno dell'apparato dirigente militare o dalla stessa Massaua - gli passasse continuamente molte e attendibili informazioni.
Già nei primissimi giorni di gennaio, quando ancora tra Stato Maggiore dell'Esercito e Ministero della Guerra si andavano scambiando le prime disposizioni, il giornale militare scriveva:
Chi avrebbe mai potuto credere che la presa di possesso della baia di Assab avrebbe dovutO rimanere allo stato di una semplice parodia coloniale? 52 .
Era lì, nel Mar Rosso, che si doveva guardare per una possibile espansione coloniale italiana, e non sulle coste della Libia o addirittura nel Congo, come pure in quei giorni si poteva credere. E , qualche giorno dopo, insisteva: «Assab non poteva finire, !asciateci dire la brutta parola , in una semplice buffonata» 53
Queste parole aspre (contro la politica 'coloniale' seguita al1882) servivano a «L'esercito italiano» non ceno per una polemica retrospettiva, ma per incitare in quei giorni il governo ed il Ministro della Guerra ad una intraprendente azione coloniale. Da allora, infatti, il giornale si manifestò sempre insoddisfatto del carattere moderato che, a suo parere, la prima spedizione coloniale andava prendendo.

Più tardi scrisse: «Se qualche cosa si deve fare, tanto vale farla subi-
come qualche anno più tardi Guglielmo Ferrero avrebbe notatO che in Italia (anche perché .:le nostre uadizioni di vittoria [militare] sono troppo povere:.) «il militarismo, oltre quella degli interessi particolari che dipendono da lui , ha oggi base puramente politica nella monarchia:.. G. FERRERO, Il mtlitan!mo. Dieci conferenze, Milano, Treves , 1898. Ma lo stesso 'antimilitarismo borghese' di Ferrero , pensato e scritto prima della drammatica crisi del maggio 1898, andrebbe analizzato.
5Ì Cfr. già ivi, 6 gennaio 1885 , L'Italia della paura.
52 Ibidem.
53 lvi, 19 gennaio 1885, La nota giusta.
MILITARI NEGli ANNI OTIANTA 191
tO» 54 E questo pare essere stato il criterio alla luce del quale il giornale valutò la politica coloniale di Ricotti.

Incurante delle possibili congiunture diplomatiche , disattento alle necessità finanziarie di una politica coloniale audace, disinteressato se a decidere dell'orientamento della politica coloniale fossein ogni singola e diversa situazione - il Presidente del Consiglio, il Ministro degli Esteri o quello della Guerra , «L'esercito italiano» dimostrò sempre di volere una politica coloniale 'offensiva', caratterizzata da audaci avventure militari e da spericolate espansioni verso l'interno africano 55. E, se così non si faceva, la colpa era sempre 'della politica', o di Ricotti.
Il punto di maggior dissenso con la politica coloniale governativa stava, non a caso, in una questione tecnicamente mtlitare.
«L'esercito italiano» si era fatto sostenitore della costituzione di un 'corpo militare coloniale' specifico e speciale, composto da militari volontari e con soldo maggiore del normale 56 Con questo strumento militare, modella to su quello di altre nazioni colonialiste, si sarebbe potuto raggiungere il massimo di capacità offensiva. In verità, l'organo militare non si era dato poi molta pena di spiegare come e perché un simile Corpo Coloniale sarebbe stat o migliore di un Corpo di spedizione, come quello che stava andando a Massaua, formato da truppa di leva: ai collaboratori del giornale questo appariva come un dato di fatto facilmente comprensibile a tutti i militari, come un qualcosa di evidente.
Da questo punto di vista non poteva non sembrare irrazionale -od almeno ispirato da una volontà coloniale troppo 'pacifica 'il sistema voluto da Ricotti, consistente nell ' invio di tre successivi contingenti militari che solo sul posto avrebbero formato il necessario Corpo di Spedizione militare in Mrica. Contro un tale «regime di pillole coloniali a quindici giorni o ad un mese di distanza l' uno dall' altra» 57 , che pareva scelto apposta per non far sentire ali' esercito la grande novità ed il nuovo impegno che una politica di espansione co l oniale componava, «L ' esercito italiano» scese in campo più volte. «Per il momento bisogna convenire che s ' incomincia abbastanza ma-
H lvi , 8 marzo 188 5 , Le n ostre truppe a Massaua
Cfr. ivi, 15 aprile 1885, La d elusio n e di Massaua.
Cfr. g ià i vi, 31 genn aio 188 5 , I distaccamenti colo niali 57 I b i d em .
192 PO LIT I CA E POLmCA MJUT ARE
le» 58 , fu il suo commento sulle prime misure militari della storia coloniale italiana.
Anche più tardi, quando parve proprio che la meteora coloniale italiana dovesse arenarsi intorno al solo porto sabbioso di Massaua e qu ando andarono chiudendosi le strade che per qualche sett imana erano parse dover portare i soldati italiani sull'altipiano abissino, la ricetta de «L'esercito italiano» rimaneva esclusivamente militare.
Per noi non vi è che un sistema da seguire. Largo impiego delle truppe ordinarie quando si tratti, sia pure in Africa, di importanti e continuate fazioni di guerra co n obiettivi ce rti e precisi e di non troppo lunga durata . Cost ituzione di distaccamenti delle varie Armi, con arruolamento di volontari della durata di almeno cinque anni , co me si reclu tano tanti altri Corpi speciali, se si trana di semplice servizio di presidio 59.
Sempre in materia coloniale, «L'esercito italiano» dava più di una volta dimostrazione di essere ben informato. Propri o quando, come vedremo, a Massaua infuriava una polemica tra i Comandanti locali dell'Esercito e della Marina , che il governo ed i Ministri interessati volevano mantenere rigorosamente segreta, il giornale militare interveniva pubblicamente nella questione, affermando che il Comando Supremo spettava ai militari dell'Esercito, che il nuovo Comandante (ed infatti di H a un mese Saletta , allora Comandante delle truppe del Regio Esercito, venne sostituitO) avrebbe dovuto essere un ufficiale del più alto grado, e che non si dovevano prendere nemmeno in considerazione ipotesi- che pure in quei giorni erano ventilate - di nominare per la prima colonia italiana un Comandante civile e politico 60.
Poi , col passare dei mesi , l a polemica tra l'organo militare e il Ministero della Guerra andò attenuandosi, in sinronia con il più generale disinteresse che andava prevalendo in Italia a proposito delle questioni coloniali: ma senza che questo avesse intaccato la convinzione di fondo del giornale rispetto alla questione del Corpo Coloniale.
Solo alla fine del 1886 si fecero evidenti alcuni accenti più moderati. Si richiese allora, solamente, una «organizzazione stabile e permanente» dei presidi d' Mrica e, pur continuando a crit icare il Ministero per «aver abbandonatO gl i studi per la costituzione di un nu-

Ibidem
)9 lvi, IO magg io 1885 , Le truppe coloniali. 60 Cfr. ivi, 15 agosto 1885 , U comando a Massaua.
MllJTARINEGLI ANNI OTTANTA 193
eleo di truppe coloniali» 6 1 e per aver continuato in quel suo sistema di continui cambi di guarnigioni di leva tra Italia e Mrica, si scrisse:
L'armale organizzazio ne non poteva avere che un carattere provvisorio equeSto carattere transitorio è già durato troppo a lungo . Comunque lo si voglia costituito , sia con truppe di leva, sia con volontari a lunga ferma, è ora che i nostri presidi africani assumano una forma definitiva( ... ) 6 2 .
A questa constatazione, più possibilista e aperta, si aggiungeva però che
[questo) lo vuole il beninteso interesse della nostra politica coloniale, lo vuole anche più l'organismo dell'esercito, n el quale le spedizioni a[gcan e hanno prodotto dei piccoli buchi che bisogna assolutamente tappare 3 .
Quali fossero questi 'buchi' il giornale non specificava: ma quell'articolo, ad un mese esatto dalla giornata di Dogali, acquistava di per sé una valenza ammonitrice.
A questa insistente critica delle forme militari dell'espansione coloniale italiana si accompagnava poi una serie, lunga ed interessante, di corrispondenze «da Massaua» che il giornale ospitava periodicamente. Si trattava per lo più di lettere di militari di stanza in Mrica che cl' esercito italiano» pubblicava per denunciare i ritardi , le lacune o le inefficienze della sistemazione militare e politica della prima colonia italiana 64. Spesso, quelle stesse lettere o corrispondenze venivano poi ripubblicate da altri giornali politici e costituivano altrettante armi di critica della politica coloniale 'moderata' del governo e di Ricotti. E a chi , come la ministeriale «Italia militare» , criticava questo comportamento de «L'esercito italiano:., il giornale replicava seccamente che non avrebbe affatto interrotto quel suo servizio di corrispondenza così singolare e provocatorio e che «Bisogna dunque che ci abituiamo anche a questo genere di letteratura africana»
La distanza tra cl' esercito italiano» e la politica di Ricotti, quindi, su rutti gli aspetti, non poteva essere più grande. La cosa che col-
6 t lvi, 28 dicembre 1886 , Presidi d ' Africa
62 Ibidem.
63 Ibidem.
64 Già con il 14 febbraio 1885 si aprì una nuova rubrica, intitolata ' La spedizione d' Assab' (poi, ovviamente, corretta in 'La spedizione di Massaua '). In quesra rubrica venivano riportare notizie varie, militari e politiche .
6) cl'esercito italiano,., 8 marzo 1885 , Le lettere dall 'Africa.

194 POUTICII E POUTICA MllJTARE
pisce maggiormente è che il giornale militare continuava a parlare «in nome dell'esercito», senza che il Ministero volesse o potesse porre qualcosa di equivalente, senza che il Ministero riuscisse a sconfessarlo o a 'smascherarlo' 66
Ad un'eventuale, ma necessaria, opera di contrasto delle opinioni antiministeriali de «L'esercito italiano» non valeva certo la povera «Italia militare» 67.
Essa era entrata ormai in uno stadio che si sarebbe potuto dire 'p re-agonico'. Per vari motivi, che sono in buona parte ancora da esplorare, già al momento della nomina di Ricotti essa non veniva più stampata sotto la diretta cura del Ministero della Guerra mapur restandone la voce ufficiosa - era tornata al suo vecchio proprietario (tale Bini). Ad un certo disinteresse per l' «<talia militare», forse, dovette contribuire anche il fatto che Ricotti - considerato importante esponente politico, oltre e prima che essere militare e Ministro della Guerra - preferiva annunciare i suoi programmi di politica militare dalle colonne dei più autorevoli quotidiani politici della Destra, piuttosto che da quelle dello scarsamente letto organo militare ufficioso 68.
Questo non significa però che il Ministero non fosse sensibile alla perdita di tono e di importanza di quello che era stato per tanti anni il suo giornale. Anzi, la presenza- al Segretariato Generale - di Marselli (che pensava che alle critiche delle opposizioni si dovesse rispondere anche in materia militare secondo il principio «parola contro parola, stampa contro stampa») 69 deve indurre a pensare che si fosse in qualche modo tentato di evitare la crisi dell'organo ministeriale. Oltre alla ventilata creazione al Ministero di un apposito Ufficio Stampa 70 (che avrebbe potutO prendere il posto dell' «Italia militare») di cui però in fondo non si fece nulla, varie furono le misure presse da Ricotti e tese a scoraggiare nel mondo militare la lettura del concorrenziale «L'esercito italiano».
66 Anche a distanza di anni, i militari si ricordavano de cL' esercito italiano• come di un giornale cd' opposizione•. DE ROSSI , La vita di un ufficiale italiano sino alla guerra, cit., p. 95.
6? Cfr. I cento anni della Rivista militare, cit., p. 50.
6S Ciò contribuiva a diffondere l'immagine di un Ministro ' politico ' oltre che militare. La frequenza con cui il novarese era definito dalla stampa 'l' on. Ricotti ' (piuttosto che 'il generale Ricotti ') ne era un altro, se pur secondario, segno.
69 MARSELLI, La vita del reggimento, cit., p. 183.
7° Cfr. cL' esercito italiano», 31 luglio 1885.

MJUTARI NEGU ANNI OTTANTA 195
Tra queste misure la più imporrante fu quella di regalare agli abbonati all' «Italia militare• le copie del «Bollettino Ufficiale» del Ministero della Guerra con le liste di promozione degli ufficiali 71 Proprio in quegli anni così surriscaldati dal punto di vista dell' avanzamento, una tale misura avrebbe dovuto invogliare gli ufficiali a leggere e abbonarsi all' «Italia militare». Invece la manovra, contro cu i a voce molto alta protestò cL' esercito italiano», pare non ebbe avuto alcun successo apprezzabile.
Altri interventi a favore deJI '«I talia militare» erano costituiti dalle misure disciplinari che il Ministero , qui non interessa se a ragione o a rono, infliggeva ai collaboratori de cL' esercito italiano» 72. Ma né queste, né il «Bollettino Ufficiale», né i disegni di Quinto Cenni frequentemente ospitati sulla «<talia militare», né il suo carattere tipografico più grande e più leggibile dovettero riuscire ad invogliare gli ufficiali a leggere la voce ufficiosa del loro Ministero. E questo, in un ceno senso, si rispecchiava nel menabò stesso del giornale che si impoveriva di anicoli e di commenti, che aumentava lo spazio concesso alla pubblicità 73 o alle notizie minime ed ininfluenti e chea sfavo re degli articoli sulle questioni militari italiane - allargava lo spazio dedicato ad un 'pas tone ' editoriale di notizie, copiate da giornali militari stranieri, dedicate alla situazione degli eserciti europei.
Nonostante queste iniziative ministeriali, l' «<talia militare» non riusciva a 'rispondere' ed a ribattere a tutte le varie critiche che il giornale concorrente (ma allora si diceva <<confratello») avanzava alla po litica di Ricotti .
Comunque, sia pure nel suo oggettivo minore interesse, qualcosa vale la pena essere ri co rdata di questo giornale ministeriale. I collaboratori (e forse i lettori) delh:Italia militare» apparivano militari più ' respon sab ili ' e meno burocratici, più sensibili al va-
71 Cfr. ivi, 29 novembre 1885, La concorrenza ufficiale all'Esercito Italiano.
72 Uno dei quali fu il ten. col. Biancardi, collaboratore appunto de cL' esercito italiano•, trasferito da Roma (dove era addetto al Comitato d'Artiglieria e Genio) ad Ancona. Probabilmente per via di un articolo pubblicato su cL'ese rciro italiano •, e ripubblicaro in varie forme da altri organi poliùci tra cui cLa Tribuna. o cLa Nazione». Cfr. ivi, 11 marzo 1887.
13 Ha comunque la sua imponanza, ad esempio , a dimostrazione dell'inserimento di rutto rispetto de cl' esercito italiano• nei circuiti poliùci na zionali , il fatto che la potente ed influente Banca Generale, pubblicizzasse nell'ambiente militare le sue molteplici attività dalle pagine di questo giornale e non da quelle della pur ufficiosa e ministeri aie c: ltalia militare•. Cfr .. ad esempio, ivi, 11 febb1aio 1885.

196 POUTICA E POUTJCA MIUTARE
lore 'nazionale' delle strutture militari dello Stato unitario, più compresi delle eredità risorgimentali di quelli de <<L'esercito italiano>>. Tanto per iniziare, deploravano anch'essi alcune forme di decadenza dello spirito militare del Risorgimento, ma non per fare un lamento militarista. In Italia 'non vi è possibilità di militarismo', sostenevano 74; in Italia 'esercito e popolo' sono uniti (dalle riforme Ricotti in poi) da un vincolo democratico e moderno, ripetendo così alla lettera certe affermazioni di Marselli di qualche anno prima. E poi, il militarismo è di per sé antipopolare: e questo in Italia, dove <<tutto il favore del popolo va all'esercito» 75, ciò non era - secondo il giornale - possibile. Infine, diceva l' «Italia militare» il militarismo non è di per sé un fattore di potenza di uno Stato, ché non vi è «potenza dì Stato» se non vi è «potenza del Paese» e questa è formata da un insieme di fattori ben più complesso del solo fattore militare 76. E in un'altra occasione, tornando sullo stesso argomento, l' «Italia militare» affermava l'esistenza (e la necessità) di una diversità tra «spirito militare» e «spirito nazionale», nonché la incontrastabile superiorità del secondo sul primo 77 .
A cosa si riduceva quindi, secondo la voce ufficiosa del Ministero della Guerra, il «mìlitarismo»? Alla necessità della preparazione della guerra, al rafforzamento degli arsenali, ad un qualcosa chese esisteva - aveva dimensione europea e non nazionale 78 In questo senso gli eserciti, oltre e prima che dare la misura della potenza di uno Stato, avevano piuttosto «in tempo di pace una funzione preventiva» 79, dissuasiva verso l'esterno ma anche e soprattutto verso l'interno. Proprio a questo proposito - negli stessi giorni in cui in Belgio una forte repressione manu mziitari aveva stroncato gli scioperi e le agitazioni operaie di Charleroi -l' «Italia militare» ricordava come a livello sociale l'esercito fosse un efficace «preservativo» 80 dell'ordine pubblico. O, analogamente, quando si emanarono le nuove norme riguardanti la Milizia Mobile e Territoriale, l'organo ufficioso del Ministero della Guerra ricordava che queste milizie poteva-
74 Cfr. «L'Iralia milirare», 15 febbraio 1885, Mziitarismo.

n Ibidem. Eran o, in fondo, le concezioni più volre proclamare da Ricorri.
76 Ibidem.
77 Cfr. ivi, 31 gennaio 1886, Lo spirito nazionale e lo spirito militare.
78 lvi, 3 marzo 1886, Il militan'smo
ì9 Cfr. ibidem
80 lvi, 9 aprile 1886, L 'esercito e gli interessi sociali.
MILITARI NEGU ANNI OTTANTA 197
no utilmente surrogare i reggimenti di Reali Carabinieri e cooperare con i prefetti, i sindaci e i Distretti militari nel mantenimento dell' ordine pubblico 81.
Ma il punto esplicito che differenziava l' «<talia militare» da «L'esercito italiano» era soprattutto l'attenzione e la reverenza nei confronti dell'azione politica del Parlamento, anche in tema di politica militare. Ciò che il giornale di De Luigi combatteva (l'azione delJa politica per l'esercito) era invece sollecitato dall'cltalia militare».
A pochi mesi dalla nomina di Ricotti, la voce ufficiosa del Ministero criticò apenamente la cDeutsche He e res Zeitung:. (e cL' esercito italiano» che di quella si era fatto cassa di risonanza) 82. Da pane germanica era stato emesso un pesante giudizio su ll 'invadenza del Parlamento italiano nelle questioni dell'esercito 83. Contro le critiche d'oltralpe, e contro i ripetitori 'militaristi' italiani, l' «<talia militare» affermava invece solennemente che l 'opinione pubblica «in Italia vuoi controllare, per mezzo dei suoi rappresentanti , tutto ciò che si riferisce alJ' esercito:. perché questo «è un paese liberale, non come la Germania:. 84.
Analogamente , quando cL' esercito italiano:. si fece quotidiano , e l' cltalia militare:. criticò questa iniziativa (il quotidiano è un mezzo di informazione politica, si sosteneva, che mal si adatta alla necessaria ponderazione con cui vanno meditate le complesse misure dell'amministrazione militare ), la voce ufficiosa del Ministero si spinse in una lunga tirata polemica «contro -lo spagnolismo» 85, cioè contro quel sistema ch e a suo parere poteva far intravedere la possi-
81 Cfr. ivi, 26 gennaio 1887, La Milizia Comunale.
82 Cfr. cl' esercito italiano•. 22 novembre 1884, L'Esercito in Parlamento, e larisposta de • L'Italia militare», 7 gennaio 1885, Esercito e parlamento.
83 c( ) Le decisioni venivano prese quasi sempre fuori del Parlamento». Così anche A. CAPONE. Destra e sinistra da Cavour a Crispi, Torino, UTET , 198 1, p. 371.

84 cL'Italia militare», 7 gennaio 1885, Esercito e parLamento. Questa riaffermata fiducia nel Parlamento da parte dell'organo ufficioso non può essere sottovalutata. Anche perché quel tipo di affermazione non era per niente scontata, tra i militari. Il geo. Antonio Brignone aveva sostenuto in un suo lungo scritto (composto, come egli tenne a precisare, dopo il 1878 e pubblicato dalla 'ufficiosa' tipografia Voghera) che - al fo ndo- una delle più urgenti misure da adonare per risolvere le crisi politiche di quegli anni era proprio il restringimento radicale dello spazio l egislativo e politico del parlamento. Cioè un salto all'indietro, al tempo d ella Restaurazione, prima del1848. Cfr. A. BRIGNONE Piano graduale di riforma nei due poteri legislativo ed esecutivo a soluzione della questione sociale in Italia, Roma, Voghera, 1880.
8 ) lvi, 18 ottobre 1885, Stampa militare; ed anche ivi, 18 novembre 1885. La stampa dell'esercito.
198 POUTICA E POUTICA M1UTARE
bilità di una influenza dell'esercito e dei militari sulla naturale evoluzione della politica nazionale.
Inoltre, il concetto di 'stampa militare' che l'organo del Ministero voleva accreditare era ben diverso da quello de «L'esercito italiano:..
Della mobilitazione militare e delle sue caratte ristiche , in Italia e all'estero nonché della difesa dello Stato, era fatto cdivieto di fare oggetto di pubblica discussione:.. Ogni tanto , si riportava la voceanche per smentirla - di una possibile cci rcolare durissima:. tesa alla «destituzione di quegli impiegati che scrivono sui giornali di cose che riguardano l'amministrazione:. 86. In ogni caso gli argomenti più scottanti erano lasciati sotto silenzio, o trattati con molti distinguo ed omissis.
Con un occhio evidentemente rivolto alle pagine de «L'esercito italiano», l' «Italia militare» scriveva poi che erano quanto mai da abolire dalla stampa militare le cminuziosità» dell'analisi, le «critiche personali e spietate», nonché le «lettere private di militari appanenenti a corpi di truppa che si trovano fuori paese:. (elegante eufemismo, questo, per indicare il Corpo di occupazione colonial e di Massaua) 87. Oltre che per il loro catt ivo effetto all'interno del mondo militare, questo tipo di pubblicazioni erano pericolose- secondo l' cltalia militare» - per i possibili effetti esterni e sociali.

Con tanta gente che oggidl sa leggere, ma non ha discernimento per giudicare ciò che legge, queste pubblicazioni sono un veleno per il buon senso e per i buoni sentimenti della popolazione. ( )qui non si tratta di panito, non si trana di mio e tuo, ma del bene della patria 88.
Questo perché , tutto sommato, ancora una volta , il migliore ufficio dell 'es ercito era (i n quei tempi di pace) il mantenimento di «ordine e tranquillità» 89, la trasformazione (che si attuava nel periodo della leva) del giovane da cittadino a soldato, il «crogiuolo» delle varie regioni italiane.
Oltre a queste affermazioni di carattere generale, comunque indicative di una tendenza e di un concetto, rimaneva poco spazio nel!' «Italia militare:. di quegli anni per chiarire e spiegare i termini
86 Cfr . ivi, 28 agosto 1885, Smentita.
87 lvi, 30 aprile 1886, La stampa nelle cose militan
88 Ibidem.
89 Cfr. ancora ivi, 9 aprile 1886, L 'esercito e gli interessi sociali.
MIUTARII'.'EGU ANNI OTIANTA 199
specifici della politica militare del Ministro. E quando vi si faceva accenno, era spesso per ribattere alle accuse de «L'esercito italiano». La voce ufficiosa del Ministero sminuiva così la necessità di uno sviluppo del Tiro a Segno Nazionale, o l'urgenza dei miglioramenti sul terreno delle Milizie di seconda e di terza linea 90; e si diffondeva, caso mai, su questioni e provvedimenti di scarsa consistenza politica e finanziaria, come i programmi ideologici di Marselli per una «educazione militare nazionale» 9 1 Talvolta venivano illustrate anche questioni di grande momento per la difesa nazionale, come l'organizzazione dei reggimenti di Alpini 92 o come il rappono che doveva regnare tra Esercito e Marina 93; ma tali illustrazioni si riducevano ad articoletti troppo brevi per poter essere pari alla grande rilevanza dei terni affrontati, e spesso scritti con una intonazione troppo fedelmente ufficiosa per poter essere qualcosa di più che secchi comunicati. In questo senso, l' «<talia militare» si confondeva troppo con la «compatta falange dei giornali rninisteriali» 94 , con l'insieme della stampa politica contro cui lanciava i suoi strali «L'esercitO italiano».
Sta forse anche in questo suo non riuscire a dare molte più informazioni - anche sullo specifico terreno della politica militaredi un qualsiasi quotidiano governativo, che può essere rintracciata una delle cause della probabile diminuzione dei lettori dell' «<talia militare».
Fu così che, a solo un mese dalla nomina del successore di Ricotti, quel Bertolè Viale il cui nominativo era stato già fatto da «L'esercito italiano» 95 nel corso della lunga crisi ministeriale seguita ai giorni di Dogali (e che invece era stato accolto molto più freddamente dali' «<talia militare») 96, il giornale che era stato sempre consideratO la voce ufficiosa del Ministero chiuse i battenti.
La motivazione addotta sulle sue stesse pagine (il decesso del vecchio proprietario, Bini, aveva colto l'erede ancora nella sua minorità e quindi nella impossibilità di rilevare direttamente ed immediatamente la testata) era risibile e confusa 97.
9° Cfr. ivi, 7 ottobre 1885, Mzlizia tem.torUile e tiro a .regno nazionale.
9 ! Cfr. ivi, 28 marzo 1886 , Sul concorso per un libro di lettura pel .roldato italiano.

92 Cfr. ivi, 5 aprile 1885 , Alpini.
9 3 Cfr. ivi, 7 febbraio 1886 , La dife.ra delle coste .
94 «l'esercito italiano», 16 gennaio 1886, Molti nemici, molto on ore.
95 lvi, 17 febbraio 1887, La crisi ministerUile ed zl portafoglio della Guerra.
96 Cfr. «L'Italia militare», 7 aprile 1887. Fiducia
97 Cfr. ivi, 14 maggio 1887, Ai nostri associati.
200 POLITI CA E POLITICA MILITARE
Ma vi doveva essere qualcosa di simbolico , di rivelatOre , nella fine del giornale che, solo, si era dato da fare per difendere la politica della 'sosta' di Ricotti daJle invettive criti che ' militaristiche' e dagli attacchi de «L'esercito italiano», che adesso rimaneva l'unico giornale di informazione militare in Italia.
Ai 'responsabili' d eli' «<talia militare» si sarebbero sostituiti in tutto e per tutto i 'c ritici' de «L'esercito italimo:..
È indubbio che in quella differenziazione di metOdo e di merito (che sul campo della politica militare i due giornali per il Corpo Ufficiali dovevmo esprimere) c'e ra in qualche modo un 'gioco delle parti': tra il giornale di o pposizione , che si dimostrava esigente ed intransigente, e la voce mini steriale, più accomodante e conciliatrice. Come è anche probabile che, soprattutto negli anicoli dell' «<talia militare», c'era in qualche modo un riflesso di quel tentativo di conciliare gli opposti, così tipico della politica trasformistica di Depretis, ed in fondo anche di Ricotti.
Ma era comunque un gioco delle pani che, come si è visto e come vedremo meglio dalla analisi dei passi successivi dell ' amministrazione Ricotti, doveva co nosce re una parte vittorio sa ed una parte vinta e superata. E questo - su quel terreno della pol itica militare che g ià nel non l ontano passato aveva conosciuto dibattiti politici assai aspri - non doveva essere senza importanza.
In conclusione, non si può negare che la stampa militare aveva g i ocato nel più general e dibattito sulla poli tica militare nazionale di quegli mni, un suo ruolo decisivo e prefiguratore.
Mtlt'tari deputati o deputati militari
L'esistenza , nel primo cinquantennio di vita po l itica unitaria , di una cospicua ed interessan te pattuglia parlam entare di deputati militari era tema già noto agli studiosi. Se ne era segnalato il ruolo nella definizione della politica militare nazionale 1 , se ne ermo rico rdati i principali e più vivaci componenti , se ne era tentato un primo approssimativo el e n co 2
1 Cfr DEL NEGRO, Esercito, Stato, ;oàetà. Saggi di Jtoria militare, cir., pp 56 -5 9.
2 Cfr. V. GALLINARI , l militan· n el Parlamento italiano {1861 - 1922), in cRivista militare•, a. 1977, n. 2.

MIUTARI N'ECU ANNI OTTANTA 201
Meno noto è il fatto che la deputazione militare tra il 1884 ed il1887 recitò una parte centrale nel progressivo indebolimento politico dell'ipotesi della 'sosta' voluta da Ricotti. Pur all'interno della generale evoluzione politica e parlamentare degli ultimi anni del trasformismo, il componamento dei deputati militari mantiene infatti un interesse specifico e una periodizzazione sua propria.

Chi erano questi militari deputati negli anni Ottanta 3?
Vi erano i casi personali più diversi.
Vi era chi come Cesare Ricotti faceva parte della Camera sin dal 1870 o chi come Torre sin dal1861 e chi invece (come Adami, Mirri e Siacci) vi erano appena entrati con quelle elezioni del maggio 1886. Vi era il caso di chi era stato eletto deputato a soli trentacinque anni, come Marazzi, e di chi invece quando era già Tenente Generale ed andava per la sessantina, come Rolandi. Vi erano militari che andavano a sedersi a Destra, chi nel 'centro-sinist.ra', chi si definiva «di sinisua monarchica.» 4. In genere, si trattava però di militari che erano già stati 'provati' per periodi più o meno lunghi nelle amministrazioni militari centrali 5 dove avevano avuto modo di farsi una pro-
3 Ricerche su un più ampio arco cronologico potrebbero meglio dedicarsi ad una analisi della composizione della pattuglia dei militari deputati, alla Camera come al Senato, e sopratruno ad uno studio del loro rappono con l ' istituzione militare e con la politica militare. Un notevole numero di militari, infatti , aveva anche raggiunto il laticlavio, costituendo uno dei più evidenti trait d'union tra Ancien regime e Italia liberale. Anche se il peso politico e conservatore della presenza di Generali al Senato non può essere sottovalutato (specie all'interno di quelle 'infomate' che dovevano costituire io Italia uno dei metodi per regolare i capponi rra Camera alta e Camera bassa), il 'significato ' di quei militari deputati era più sociale e istituzionale che parlamentare. Spesso assenti dalle sedute, raramente impegnati in prima persona nel dibattito politico, ai militari al Senato spettava (o finiva per spenare) di essere più un pendant della Corona che un'espressione o una rappresentanza - sia pur mediata e particolare- dell'esercito. Prevalentemente la nostra attenzione ricadrà invece sui militari alla Camera , sul loro ruolo, sul loro rappono con la politica del Mini stro della Guerra
4 Cfr. poi i repertori parlamentari , tra cui ad esempio T. SARTI, Il Parlamento subalpino e nazionale. Profili e cenni biografici dt. tutti i deputati e senaton· eletti e creati da/1848 a/1890, Terni , Tip. Ed. dell ' Industria , 1890 , ed anche cfr. A MALA·
TESTA, deputa/t·, senaton· da/ 1848 al 1922, Milano , lst. Edir. Ital., s.a.
5 Un elemento di differenza tra i militari deputati p iemontesi delle prime legislature con quelli dei tardi anni Settanta o degli anni Ottanta (ed una conferma che in questo periodo si stesse consumando nell ' ambiente m ilitare il passaggio da 'quadro nazionale' e risorgimentale a ' quadro burocratico': su cui cfr. DEL NEGRO , Ufficiali di carriera e ufficiali di complemento n ell ' esercito italiano della grande guerra: la provem'enza regionale , cit. , p. 265 e sgg.) sta nel fatto che quasi tuni i deputati in divisa di quegli anni venivano eletti ad una cena età, già in possesso di un certo grado e so · pratrurro già noti per il servizio prestato a Roma presso il Ministero della Guerra , presso lo Stato Maggiore o presso i vari Comitati d'Arma .
202 POLITICA E PO LITICA MILITARE
pria competenza specifica o avevano potuto entrare in contatto con esponenti del mondo politico. Difficile quindi fare una media delle varie situazioni politiche ed elettorali che li avevano portati in Parlamento. Ma l'impressione è che essi fossero stati presentati quasi dovunque in 'collegi sicuri', dove non andavano incontro ad opposizioni o a ballottaggi, spesso in località vicine a quelle natali doveoltre al prestigio acquistato, in provincia, per l'essere una alta carica dello Stato- il militare avrebbe potuto far valere i non infrequenti nobili natali e con questi agevolare la sua elezione.
Ma questo ci direbbe ancora poco della attività dei mil itari deputati. Che peraltro non si riduceva a quella meramente politica delle discussioni in Aula.
Militari in quanto tali, più che per il loro essere deputati, erano infatti presenti in tutte le Commissioni e in tutti gli Uffici che affiancavano e preparavano il lavoro delle Camere, spesso svolgendo un ruolo silenzioso, amministrativo , di controllo, ma non per questo meno importante. C'erano militari (spesso uno per organismo) nella Commissione Permanente per le Elezioni, in quella per le Petizioni , tra i Commissari per la sorveglianza su ll'Amministrazione del Debito Pubblico. C'era un militare nella Commissione Permanente per l'esame dei Decreti e Mandati registrati con riserva dalla Corte dei Conti, e ovviamente c'erano militari in Commissioni come quelle per il monumento a Vittorio Emanuele II o per il m o numento a Quintino Sella. I Commissari per la Sorveglianza sull'Amministrazione della Cassa Militare, poi, erano tutti e due militari, per poter controllare direttamente e senza ingerenze politiche o civili le pensioni militari ed altre cose. Soprattutto, c'erano militari nella Commissione Generale del Bilancio la cui funzione, importan tissima, ancora rimane da studiare.
Oltre a questo, ovviamente, c'erano deputati 'in divisa' nelle Commissioni Parlamentari che erano chiamate ad esaminare ed a relazionare alla Camera sui vari progetti di legge. E non di rado i Ministri anche non militari , come quelli dell'Interno o degli Esteri, affidavano ad un militare o ad un ex-militare l'importante compito di relazionare sui bilanci d'esercizio annuali.
Anche se in fondo non molto numerosi , questi deputati militari avevano insomma il loro da fare .
Sulla loro partecipazione ai lavori della Camera, il discorso potrebbe invece essere un po' diverso. Non di rado assenti, anche giustificati, i militari che poi prendevano la parola in Aula non erano poi molti, in quegli anni Ottanta. Non è improbabile che (una volta

MIUTARI NEGU ANNI OTTANTA 203
trascorso il periodo degli anni Sessanta e Settanta, in cui la deputazione militare sembrava contare militari più giovani, di grado inferiore e tutto sommato politicamente più vivaci) anche la deputazione militare sia andata intristendosi ed omologandosi.
Negli anni del secondo Ministero Ricotti però, oltre a questo, il silenzio di alcuni militari deputati equivaleva ad un tacito dissenso dalla linea di 'sosta' del Ministro. In questo periodo, quasi la metà degli interventi 'militari' in Aula fu pronunciato da quattro soli deputati in divisa (Pelloux, Pozzolini , Taverna, Gandolfi), dei quali perlomeno due erano da tempo iptimamente contrari alla politica di Ricotti ed un altro vi era in varie parti dissenziente . E questo dato già rende l'idea del ruolo della deputazione militare.
Oltre ai mili t ari in servizio permanente effettivo, c'era poi alla Camera la pletora (in quegli anni Ottanta) degli ufficiali della riserva e soprattutto di quelli della Milizia Territoriale 6 . Erano questi, per la maggior parte, o reduci delle campagne dell'indipendenza, (e tra questi non pochi ex-garibaldini o ex-volontari) o no bilotti di provincia, o ex -m ilitari che avevano lasciato a metà la loro carriera sotto le armi per più lucrose professioni private, i quali tra il 1882 ed il 1883 (anni in cui fu definito il quadro degli Ufficiali della Milizia Territoriale) furono immessi honoris causa nelle liste degli annuari militari in qualità appunto di ufficiali delle milizie di seconda e di terza linea. Ma in verità, di militare tali deputati non avevano niente altro: non era infrequente il caso - specie tra i deputati dell'opposizione di Sinistra - in cui qualche pentarchico, particolarmente sensibile ai temi militari e riguardato dai suoi compagni di partito come un 'tecnico' ed un esperto, si fregiasse pubblicamente della sua carica di tenente colonnello di Milizia Territoriale.
Ai militari deputati n e l loro complesso, comunque, era concessa una grande importanza dalla stampa politica 7 : i loro discorsi erano considerati come quelli di vere e proprie autorità in materia, e non

6 Scarsissime le conoscenze, purtroppo, sul funzionamento (o sul non-funzionamento e sul non -ap prontamento) delle Milizie di riserva avanti il primo conflitto mondiale Su quella che a quei te mp i era così poco preparata da sembrare «una cosa un rantinello ridicola> (come la definì DE BONO, Nell'esercito nostro pn·ma della guerra, cit. , p. 46) cfr. ancora BAVA BECCARIS , Esercito italiano. Sue origini, suo successivo ampliamento, stato attuale , cit. Eppure l'organizzazione e la prepara zione della Milizia Mobile e della Miliz ia Territoriale furono sempre al centro dei dibattiti e degli scontri tra sostenitori numeristi della 'nazione armata' e 'offeosivisti'.
7 Si veda, a solo t irolo d'esempio , lo spazio concesso agli interventi dei militari deputati nei resoconti parlamentari dai quotidiani politici o indipendenti.
204 POLITICA E POLITICA MILITARE
di rado le opinioni di qualcuno di questi militari deputati influenzarono le posizioni dei gruppi parlamentari. Se si accendeva il confronto sulle politiche ed i concetti del Ministro della Guerra, era quando parlava un militare deputatO che tutta l'Assemblea ascoltava con attenzione, cercando di capire dal variare dei suoi accenti e delle sue sotto l ineature le oscillazioni ed i progressi della politica militare nazi onale. Questo, d'altra pane , aveva anche i suoi risvolti negativi in occasione dell'esame dei progetti di legge 'tecnici' militari: occasioni in cui la maggior parte dei deputati 'civili' usciva dall'Aula orimaneva silenziosa e distratta, mentre pochi militari si dilungavano a disquisire ed a cavillare 8 . In quel caso la discussione rimaneva tra militari (Ministro della Guerra e militari deputati) e gli altri deputat i , al massimo, si facevano sentire solo perché fosse chiusa la seduta. Negli anni del secondo Ministero Ricotti l'influenza della deputazione militare era però moltip licata dal suo non infrequente farsi portavoce delle tendenze militari più radicali ed esigenti, quali certi organi di stampa militari riportavano 9 Nonché dal loro ribadire t esi militari che erano (o che si riteneva fossero) esp ressione degli ambienti dello StatO Maggiore dell'Esercito . Il f requente richiamo alla necessità di una 'po t enza ital i ana', la costante ammonizione a 'completare' l'ordinamento deJI'Esercito ed a aumentare gli organici delle Armi dì Cavalleria e di Fanteria, le ripetute sottolineature dell'importanza di tenere pronti i meccanismi della mobilitazione, di prevedere i materiali per quella necessari e di approntare la quantità d i quadrupedi sufficienti (nonché la disponibilità delle ferrovie e de l materiale rotabile) venivano tutti interpretati dall'opinione pubblica come segnali di particolari inadempienze del Ministro della Guerra. Che in alcuni casi erano anche real i. Ma oltre a questo corredo di motivi politici cui i deputati militari spesso facevano ricorso , quello che colpisce n eli' esame del loro comportamento durante q u esto Ministero è la progressione del malcontento verso la gestione Ri co tt i ed il suo supe rare- tra i depu t ati militari come e prima che tra gli altri - le divisioni di tendenza politica o di gruppo d'opinione.
Già presente , come si è visro, al tempo delle prime discussioni del maggio -giugno 1885 e sensibilizzatosi durante q u elle che p rece_dettero il maggio 1886, il dissenso della de p utazione mi l itare si fece

8 Cfr. l ' episodio na rra to da ARBIB , Cinquant 'anni di stona parlamen tare del Reg n o d 'ltalza, v IV, Undicesima, dodicesima, e tredicesima legislatura da/5 dicembre 1870 al29 apnJe 1880 , cit. , p. 831 , spesso f acilmen t e generalizzabile.
9 Cfr. infra , p 180.
MIUTARJ NEGU ANNI OTTANTA 205
largo e compatto alla ripresa parlamentare dopo le elezioni, in sintonia co n la più generale avanzata dello schieramento conservatore all' interno della Camera trasformista ed in conseguenza delle delusioni seguite alle timid e aperture che Ricotti era parso voler fare per superare i princìpi della 'sosta'. Nell'autunno 1886, poi, in concomitanza con la convocazione di due Commissioni militari presiedute da Cosenz, la deputazione militare tutta insiem e risollevò il tema dell'aumento delle Armi speciali e, al momento delle discussioni sui pericoli della politica este ra del dicembre (che chiamarono in causa anche le condizioni dell'esercito e del potenziale militare italiano) , tenne un contegno che non facilitò al Ministro della Guerra una difesa del suo operato dagli attacchi mossigli, questa vol ta , anche dalla Destra dissidente di Di Rudinì.
Tutto questo percorso pubblico potrebbe essere letto , oltre che nelle pagine degli Atti Parlamentari, anche nei carteggi privati di un militare come Luigi Pe lloux. Anche in queste lettere non destinate alla pubblicazione (e talvolta nemmeno indirizzate a militari, ma a se mplici parenti, a conoscenti, a civili ), em erge con chiarezza il travaglio ma anche la decisione del militare che - personalmente avverso alla 'sos ta ' vo lu ta da Ri co tti -via via matura la convinzione del rifiuto d èlla politica militare del Ministro lO e passa, da un voto favo revole ma 'dissidente' 11 ad una deliberata assenza dai lavori della Camera 12 sino al finale voto contrario, dato con rammarico ma con senso politico esplicito 13.
1° Cfr. ACS, Carte Pelloux, se. 31, fase. 47, Pelloux all'avv. Sforza Terni to di Pelloux). Di ceva in questa sua lettura Pelloux a proposit o della politica militare di Ricotti: cSiamo in mezzo alla confusione...
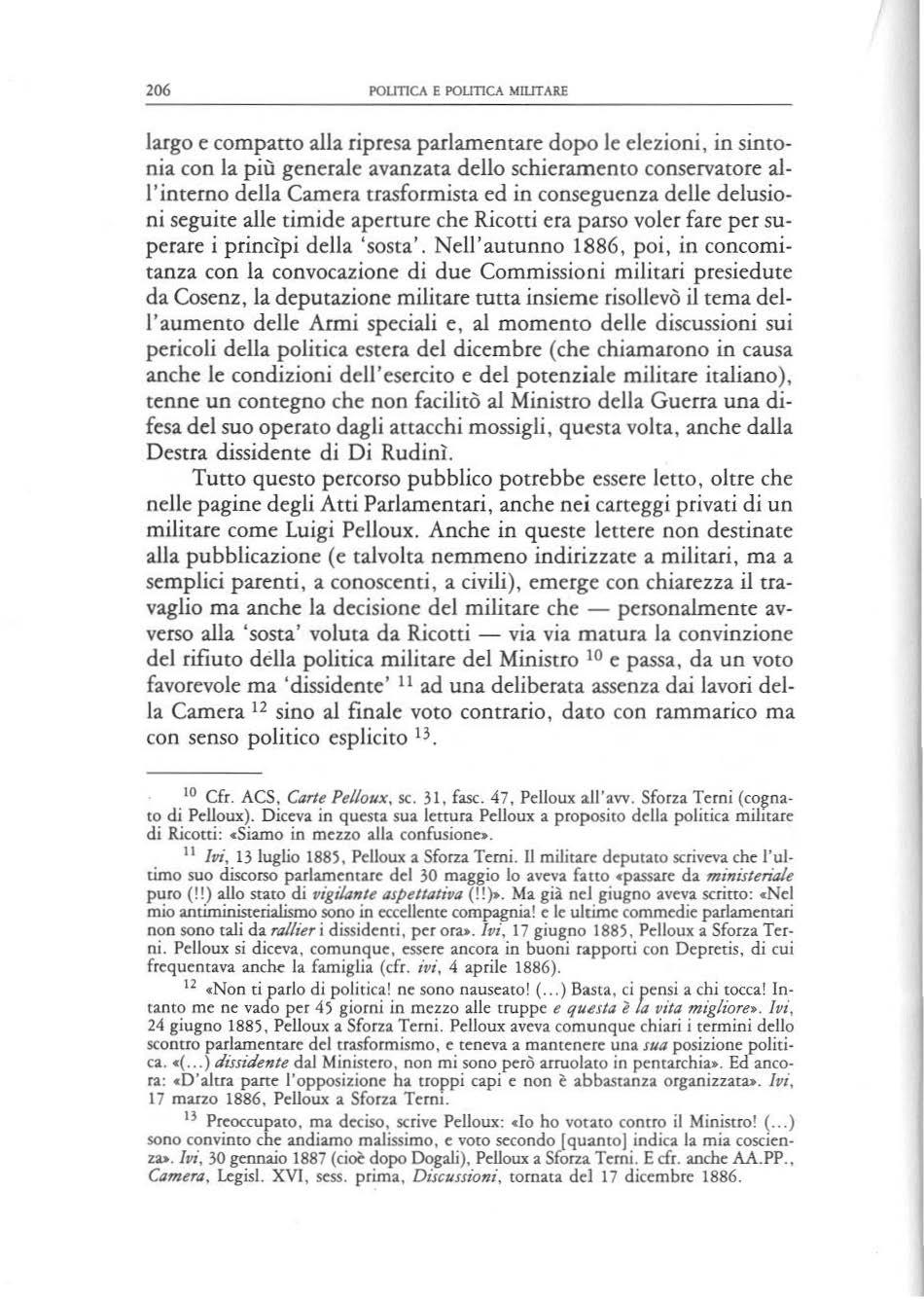
11 lvi, 13 luglio 188), PeUoux a Sforza Temi. li militare deputato scriveva che l'ultimo suo discorso parlamentare del 30 maggio lo aveva fatto cpassare da ministeriale puro(!!) allo stato di vigilante aspettah'va (!!) Ma già nel giugno aveva scritto: cNel mio antiministerialismo sono in ecceUente compagnia! e le ultime commedie parlamentari non sono tali da rallier i dissidenti, per ora... lvi, 17 giugno 1885, Pelloux a Sforza Terni. Pelloux si diceva, comunque, essere ancora in buoni rapporti con Depretis, di cui frequentava anche la famiglia (cfr. ivi, 4 aprile 1886).
12 cNo n ti parlo di politi ca! ne so n o nauseato! ( ... )Basta, ci pensi a chi tocca! Intanto me ne vado per 45 giorni in mezzo alle truppe e questa è la vita migliore-.. lvi , 24 giugno 1885 , Pelloux a Sforza Terni. Pelloux aveva comunque chiari i termini dello scontro parlamentare del rrasformismo, e teneva a mantenere una sua posizione politica. c( ) dissidente dal Min istero, non mi sono però arruolato in pentarchia•. Ed ancora: cD'alua pane l'opposizione ha troppi capi e non è abbastanza organizzata... lvi, 17 marzo 1886, P elloux a Sforza Terni.
n Preoccupato, ma deciso, scrive Pelloux: cio ho votato contro il Ministro! ( ... ) sono convinto che andiamo malissimo, e voto secondo [quanto) indica la mia coscienza:>. lvi, 30 gennaio 1887 (cioè dopo Dogali), Pelloux a Sforza Terni. E cfr. anche AA.PP., Camera, L:gisl. XVI, sess. prima, Discuuioni, tornata del 17 dicembre 1886
206 POliTICA E POUTICA MIUTARE
Di fronte a fenomeni individuali, come questo di Pelloux , ma poi generalizzatisi tra i deputati militari, Ricotti - specie nel suo ultimo e più difficile periodo di permanenza alla Pilotta - non seppe che far ricorso alla maniera dura ed all ' autoritarismo repressivo. Il caso del capitano Turi è sufficientemente esemp l ificativo 14 soprattutto per l a decisione e l'intransigenza con cui il Ministro si mosse. Per altri aspetti, invece, i motivi e gli scopi (se pure ve ne furono) dello scontro tra il Ministro della Guerra ed il giovane deputato militare rimangono ancora poco chiari.

Il giovane ufficiale della Marina aveva più volte tentato di essere eletto in Parlamento; ma il collegio prescelto- quello di Pozzuoli e Napoli - si era sempre dimostrato avverso. Nel maggio 1886 (forse con l'appoggio determinante di qualche potente interesse navalistico) Turi era riuscito finalmente a passare il vaglio dell' elettorato, andando a sedersi nei banchi della Sinistra assai moderata e vicina a Nicotera. Il carattere energico (in Aula si era subito fatto notare come «parlatore facile» e per la sua «figura piuttosto sottile, con una barbetta nera e due occhi neri assai vivaci») 1 5 e le sue idee lo spinsero a presentare, appena eletto, una interpellanza al Ministro della Guerra circa le prospettive e lo stato dei lavori per la fonmcazione dJi La Spezia. In realtà, così fa cendo, Turi avrebbe dovuto rendersi conto di stare per cacciarsi in un ginepraio. Non era usual e che un ufficiale della Marina pensasse di criticare pubblicamente la condotta del Ministro della Guerra dai banchi del parlamento. Inoltre la questione della difesa di La Spezia era una di quelle intorno a cui più facile era perdere il filo conduttore degli interessi militari, politici, economtct.
La Spezia era- in quegli anni- molte cose allo stesso tempo: il più grande arsenale marittimo nazionale, la migliore postazione a difesa per l a flotta italiana che avrebbe operato nel Tirreno, uno snodo ferroviario cruciale (sulla linea litoranea Lucca-Genova e in quella, che si stava incrementando, verso Parma e l'interno). A La Spezia erano quindi compresenti interessi dell'Esercito e della Marina. Non ancora rinforzata la posizione naturale della Maddalena, lontana la decisione di declassare dal punto di vista marittimo-militare il porto di Napoli a tutto vantaggio di Taranto, ancora da stendere i piani per Brindisi e per le altre postazioni dell'Adriatico , il pono ligure 14 Cenni
MILITARI NEGU ANN I OTTANTA 20 7
già in VEN1URINI , Militari e politici nell'Italia umbertina, ci t., p. 211.
!5 SARTI, 11 Parlamento subalpino e nazionale, cit., ad vocem , p . 937.
rivestiva un ruolo vitale e strategico per l ' ordinamento militare italiano. Dal 1870 e poi dal 1876 , rilevanti erano stati gl i investimenti per La Spezia, anche se non sempre il criterio che li aveva guidati era stato unico.
Fu così in questo intrico di interessi che Turi andò a cacciarsi. Il suo punto di panenza e lo scopo erano erano forse complessi (nella sua interpeUanza egli criticava Ricotti sia dal punto di vista finanziario che da quello tecnico-militare, sul tema della diga sottomarina a difesa dell'arsenale ) ma fatto sta che non fece nemmeno in tempo ad esplicitarli.
Infatti, per quanto lo riguardava, il Ministro della Guerra non aveva accettato nel giugno 188) le critiche di Ricci ali' ordinamento generale della difesa nazionale ; e nell'estate-autunno 1886 dimostrò in più occasioni di non essere disposto ad accogliere alcuna proposta di rimaneggiamento delle decisioni prese dalle Commission i dei generali nel 1881-83. Anche se Turi - in fondo - aveva criticato il Ministro solo su un punto specifico, Ricotti volle dare in questo un segno di fermezza . Non rifiutò di discutere l ' interpellanza di Turi , ma lo costrinse all a discussione solo dopo qual che mese , nell ' ottobre , quando il giovane deputato era del tutto impreparato, senza i suoi appunti sull'argom e nto, senza aver avuto il tempo di sollevare una più vasta attenzione parlamentare sul tema. Il tutto si risolse così in pochi minuti, tra un Ricotti documentato e puntiglioso ed il giovane militare deputato, imbarazzato e non convincente. Già Turi poteva dirsi sconfitto: ma il suo carattere (e forse qualche pressione da pane del suo elettorato cantieristico napoletano) lo spinse a tornare sull'argomento, repli cando in altra giornata in Parlamento e scrivendo lettere alla stampa. In tali occasioni , ribadendo le sue convinzioni, egli lanciava contro il Ministro della Gu e rra - per usare le parole del giornale ufficioso della Pilotta - «la più terribile delle accuse , quella di sciupare i milioni della Nazion e e di dare alla Camera cifre inesatte» 16.

In verità, la questione di La Spezia era così intricata, ed un suo libero esame avrebbe forse fatto tornare a galla affari poco chiari, che le cifre 'esatte' forse non le conosceva nemmeno il Ministro. Ricotti avrebbe potuto lasciar perdere la questione , probabilmente destinata a sbollirsi da sola.
Invece il mom e nto politico era delicato per la Pil o tta ed il Mini-
208 POUTICll E POUTICll MIUTARE
16
cltalia m ili tare•, 29 ottob re: 1886, Un fa tto spiacevole
stro stesso si vedeva in quelle settimane sottoposto a troppi esami incrociati (commissioni militari, stampa politica, dibattiti parlamentari, deputazione militare) e per una volta volle strafare, dal momento che l'oppositore - il povero Turi - appariva solo e senza un apprezzabile seguito politico. Il generale novarese chiese ed ottenne dal Ministro della Marina la sconfessione di Turi e la sua messa agli arresti militari. Non si poteva accusare impunemente e con leggerezza il Ministro della Guerra.
La mossa, però, da politica si fece istituzionale. La deputazione militare vedeva attaccata la sua autonomia e la sua immunità parlamentare. Era poi anche un segnale al la dissidenza ed alla stampa militare.
La stampa quotidiana riportò in modo distratto la notizia della sorte di Turi, spesso plaudendo all'energia del Ministro della Guerra che faceva rispettare la disciplina e la subordinazione gerarchica all' interno del mondo militare. La politica di potenza, sembrava di capire, non doveva tollerare tarli critici; la relativa libertà d' espressione dei militari deputati, conosciuta nel decennio successivo all'unità ed anche durante gli anni delle riforme Ricotti, sembrava ormai cosa lontana e non più necessaria né utile.

Attaccandosi a taluni cav illi , «L'Opinione» scriveva che «fuori della Camera non c'è più il deputato militare, non c'è che l'ufficiale». Non mancò chi dichiarava che ormai erano «essenzialmente incompatibili le qual it à di deputato e di militare in servizio attivo»; ci fu anche chi, deplorando l'insubordinazione gerarchica di un giovane ufficiale di fronte ad un Ministro militare ed evocando fantasmi di spaccatura dell'esercito, disse che se la critica di Turi fosse stata tollerata «ma via, non dovrebbe farci invidia la Spagna! ... » 17. «L'esercito italiano» che, pur geloso della propria autonomia, aveva sempre condannato l'influenza della politica nell'esercito (e quindi tentato di contenere l'esistenza stessa di una deputazione militare parlamentare) tornò sul tema della «essenziale distinzione tra ciò che si dice dentro e ciò che si dice fuori del Parlamento» 18.
Nessuno risollevò i temi concreti, di finanza e di strategia militare, toccati da Turi. Troppo pochi si soffermarono in maniera approfondita (come pure si sarebbe potuto e dovuto fare) sui problemi costituzionali della presenza dei militari alla Camera e al Senato: do-
17 Sono posizioni riportate in ibrdem. Il riferimento andava alle asp re lotte civili ed al fazionalismo dei militari spagnoli del tempo.
18 Ibidem .
MIUTARI NEGU ANNI OTIANTA 209
vunque si sentiva parlare solo di disciplina e di gerarchia da far rispettare. Chi, nella stampa militare, provò a difendere l 'utili tà di una presenza di militari deputati, lo fece con motivazioni deboli e vaghe («i deputati militari devono esserci: ma nei debiti modi») 19.
La lezione del 'caso Turi' (che per l'esiguità del suo protagonista si chiuse velocemente ed ebbe minore risonanza di quello, di due anni più tardi ma iscrivibile nello stesso ordine di idee e di cose, del generale Mattei) sembrava essere quella per cui la libertà d'espressione dei militari deputati non doveva toccare la gestione dei bilanci militari.
La questione era così finita nel si lenzio e nel disinteresse politico generale: che avesse più o meno ragione nel merito militare della questione di La Spezia, Turi si era imbattuto in una questione politica più grande di lui. E aveva avuto il tono di credere di senti rsi al sicuro dietro la sua immunità parlamentare.
Depretis, dal suo punto di vista (che poteva essere più quello politico della tenuta del governo e della maggioranza che quello istituzionale della garanzia delle immunità parlamentari di un giovane militare), poteva ritenersi soddisfatto.
Si è cercato bensì in questi ultimi giorni di creare un caso Turi - scrisse il giornale ufficioso della Presidenza del Consiglio - e di farne argomento di campagna contro il Ministero. Fu un tentativo sbagJ.iato che cadde nel vuoto . L'immensa maggioranza nel Paese o non si commosse punto al preteso attentato del potere esecutivo contro le franch ig ie del deputato, o diede ragione ai provvedimenti del Governo 20.
Se così, dal lato politico immediato, il caso poteva considerarsi chiuso, non con altrettanta facilità potevano dimenticare il fatto gli ambienti militari. Dal punto di vista delle istituzioni militari si era toccato un tasto importante.
Che Ricotti fosse un Ministro ed un militare quanto mai autoritario e rigido era noto 21 : ma non si pensava che sarebbe arrivato a questo punto.
Lo stesso generale novarese, anzi, era sembrato in più di un'occasione sensibile e disponibile alle prerogative della Camera e del potere politico nei confronti dell'Esercito. Proprio in uno dei suoi pri-
19 lvi, 31 ottobre 1886, Deputato e militare
20 c:Il popolo romano», 4 novembre 1886, Governo e maggioranza.
21 Cfr. VENTURINI, Mtlttan· e politici nell'Italia umbertina , cit., p. 210.

210 POUTICA E POUTICA MiliTARE
missimi discorsi di fronte alla Camera, nel 1871, si era reso conto d eU' esistenza di «una questione di principio molto delicata, cioè fino a qual punto si estenda fuori della Camera la qualità di deputato per un militare» 22 • E , inoltre, forse molti ricordavano un altro discorso parlamentare di Ricotti - questa volta non più Ministro come nel 1871 ma semplice deputato d'opposizione- in cui il novarese aveva fatto un grande elogio, per alcuni versi anche inaspettato e sospetto, dell'istituzione parlamentare. Contro chi voleva affrettare la chiusura di una discussione in tema di politica militare, Ricotti aveva allora detto:
Io invece desidero che si discuta , perché credo che la Camera sia competentissima a discuterla, più competente fone dei generali che sono interessati, non per interesse personale, ma per interessi nobilissimi.
Invece la Camera sente le ragioni pro e contro , e tutti i deputati sono io caso di poter decidere. Dirò anzi che la decisione è forse più giusta di quella fatta da uomini semplicemente tecnici che hanno già prevenzioni, idee preconcette e non ascoltano le buone ragioni ( )
Invece qui la maggior patt.e dei deputati è indifferente all'una piuttosto che all'altra delle due soluzioni che si agitano, ed ascoltando le ragioni dei tecnici, possono giudicare veramente bene purché non vi entri lo spirito di partito.
Quindi bisogna aver pazienza -e malgrado i suoi inconvenienti - bisogna adattarsi al gran principio costituzionale che anche le questioni relative 1;li ordinamenti e spese militari debbono essere discusse e risolte dal Parlamento ( ... ) .
Nonostante le evidenti contraddizioni (come si poteva fare politica senza un qualche spirito di partito?) era comunque un elemento non trascurabile che un militare esponesse pubblicamente una tale fede nel sistema parlamentare, e con tanta veemenza.
Ma non poté beneficiare di tanta costituzionalità.
Contro di lui operò, insieme ed oltre le personali concezioni di Ricotti, anche quel mutamento di atmosfera che vedeva nel militare deputato non più tanto un rappresentante della nazione (od anche dell'esercito, come pure si sarebbe potuto pensare), bensì soprattutto un sottoposto gerarchico del Ministro della Guerra 24. Questo, per la deputazione militare, era un po' l'inizio della fine.
Militari deputaci dopo Turi, e dopo Mattei nel 1889, ce ne fu-
22 AA PP Camera, Legisl. XI , sess. prima , Discussioni, tornata del 18 maggio 1871.
23 lvi, Legisl. XIV , sess. unica , Discussioni , tornata del 26 aprile 1882.
24 Cfr. DEL NEGRO, Ufficiali di camera e ufficiali di complemento nell'esercito italiano della grande guerra: la provemenza regionale. cir. , p 266.

MILITARI NEGLI ANNI OlTANTA 211
rono ancora. E tra loro si trovarono anche personaggi di grande interesse e di indubbia autonomia intellettuale e politica.
Ma qualcosa , anche in quesro , dopo quel secondo Ministero Ricotti, piantato com'era a metà degli anni Ottanta (quasi a metà strada tra la proclamazione dello Stato unitario e l'intervento italiano nella prima guerra mondiale, come è stato già notato) 2 5 qualcosa stava cambiando.
Lo Stato Maggiore dell'Esercito: la preparazione della guerra
A conclusione di questO nostro breve tentativo di tratteggiare alcuni tra i soggetti più importanti del dibattito e della politica militare italiana degli anni del secondo Ministero Ricotti, dopo aver esaminato le caratteristiche e l'operare del Corpo Ufficiali, della stampa d'informazione militare, della deputazione militare nel Parlamento, non può mancare almeno qualche cenno allo Stato Maggiore dell'Esercito.
La decisione del 1882 di dare vita alla carica di Capo di Stato Maggiore è generalmente considerata uno degli eventi più signific ativi e carichi di conseguenze per la sroria dell'Amministrazione e della politica militare l.
Purtroppo , su quesro tema disponiamo o di conoscenze troppo specificamente amministrative 2 o, ancora, di intuizioni e di ipotesi piuttosto generali 3 La constatazione, pure non da tu tti condivisa, che solo col 1907 i rapporti tra Ministro della Guerra e Capo di StatO Maggiore si sarebbero modificati irreversibilmente a vantaggio del
2' Cfr. MINNITI, Esercito e politica da Porta Pia alla Triplice Alleanza, ci t., p. 181.

1 Cfr. ROCHAT , MASSOBRIO, Breve storia dell'esercito italiano dall861 al1943, cit., pp. 114-115. Valutazioni diverse in MINNITI, Esercito e politica da Porta Pia alla Triplice Alleanza, cit., pp. 191-192.
2 Cfr. C. MAZZACCARA, L'evoluzione del Corpo di Stato Maggiore nei Regni di Sardegna e d'Italia. Parte prima. 1796- 1881, in «Memorie storiche militari. 1980•, Roma, 1981; e adesso cfr. F. FRATTOLILLO, Elenco generale cronologico delle leggi, regolamenti, decreti, disposizioni, e circolari relative allo Stato Maggiore Generale ed allo Stato Maggiore dell'Esercito, in «Memorie storiche militari 1982:., Roma, 1983, pp . 472-513; e poi in «Memorie sto riche mili ta ri 1983:., Roma, 1984, pp. 605 -667.
3 Cfr. anche BATTISTELLI, Esercito e società borghese, cit.
212 POLITICA E POLITICA MILITARE
secondo 4, ha forse frenato gli studiosi dall'esaminare con più attenzione questo aspettO per quanto riguarda il periodo precedente quella data. D'altra pane, le competenze delle due cariche non si svilupparono dal 1882 al1907 ed oltre secondo una linea retta, fosse essa ascendente o discendente, né si mossero di moro uniforme. Ché anzi, alla storia dei rapporti fra le due cariche militari, si addice forse maggiormente l'immagine di una battaglia tutta fatta di avanzate e di arretramenti (a seconda che la congiuntura politica, militare 5 o personale permettesse l'allargamento o il restringimento delle competenze e dell'influenza del Capo di Stato Ma gg iore dell'Esercito).
Quindi, per questo primo periodo della storia dei rapponi tra Ministro e Capo SME (e ancora di più per il ristretto lasso di tempo, che pure vide fenomeni interessanti, da noi preso in esame) la ricostruzione non si può fare panendo dai regolamenti o dalle leggi, che ci dicono assai poco di utile, ma solo utilizzando e collazionando i più vari documenti che ci possano restituire l'atmosfera militare generale in cui quelle due cariche militari venivano ad operare ed a re. . . ctprocamente tnterague.
Quando nel1884 Ricotti sali al Ministero della Guerra, la carica di Capo dello Stato Maggiore dell'Eserci t o era stata istituita da appena due anni. Si trattava ancora di una fase che potremmo dire costituente. Eppure, un po' per la grande attesa che aveva preceduto e preparato l 'istituzione di questa carica 6, un po' per le caratteristiche individuali di chi l'aveva per primo occupata 7 , il primo Capo
4 Cfr. ROCHAT, MASSOBRIO, Breve storia dell'esercito italiano da/1861 a/1943 , ci t., p. 115 e p. 155. È già ricorsa e ricorrerà la dizione 'Capo di Stato Maggiore dell'Esercito', Capo dello SME e Capo di Stato Maggiore. Si pensi ch e , negli anni di cui questo·volume si occupa, la carica era stata istituita solo dal 1882. Per una spiegazione dell'uso dei termini (e sul perché il Comandante in seconda del Corpo di Staro Maggiore - o CSM -fosse di fatto il Comandante in seconda dello SME) si possono confrontare gli Annuari militari o, adesso più comodamente, FRA TTOLILLO, Elenco generale cronologico delle leggi, regolamentt; decreti, disposizioni e circo/an· relattv e allo Stato Maggiore Generale ed allo Stato Maggiore dell'Esercito, ci c., p. 606.
Da notare, ad esempio, l'accelerazione subita durante il periodo crispino dal processo di autonomizzazione del Capo SME nei co nfronti della carica del Minimo della Guerra. Cfr R. MORI, La politica estera di Francesco Crispi (1887·1891), Roma, Ediz. di storia e letteratura, 19 74 , p. 250.

6 Cfr. MINNITI , Esercito e politica da Porta Pia alla Triplice Alleanza , cit. , pp. 66 -67.
7 Cfr. l capi di Stato Maggiore dell'Esercito. Ennco Cosenz, s.I., s.d. (ma 1935 ); F. GUARDIONE, Il generale Ennco Cosenz. Rzcordo, Palermo , Reber, 1900. Cfr. anche, per il valore che può avere , G. SALADINO , Enn co Cosenz come mtlitare, uomo politico, patriota, pensatore, lungo manoscritto inedito , datato 1925 , conservato in AUSSME , Studi parttcolari, racc. 272, fase. 5.
MiliTARI NECU AI,1NI OTIANTA 213
dello SME aveva già avuto modo di farsi riconoscere in quei soli due anni come un esponente importante all'interno dell'establishment della Pilotta 8 Le sue competenze tendevano già allora a superare quelle semplicemente consultive che in precedenza erano state riservate al Comandante del Comitato di Stato Maggiore Generale o ai Presidenti dei vari Comitati d'Arma 9
Molti erano i motivi d una simile tendenza. Tra l'altro, fatto non principale ma certo importante, ciò che pareva differenziare principalmente la nuova carica da qualsiasi precedente era - aspetto questo talvolta trascurato - la razionale organizzazione dell'Ufficio: un'organizzazione che si veniva inoltre avvalendo di ufficiali giovani ma già distintisi per i loro meriti (e che erano destinati col passare del tempo ad occupare ruoli di rilievo nell'Amministrazione e nella politica militare) e della incessant e attività autonoma del suo Capo. Su alcuni aspetti di quella organizzazione converrà qui, per un attimo, soffermarsi.
Sotto forma di memoriali, di appunti, di schemi o di note un continuo flusso di informazioni, di consigli e di piani pare sia passato dagli uffici dello Stato Maggiore al Gabinetto ed alla persona del Ministro 10. Secondo una logica insistente, molti degli aspetti del1'organismo militare vennero studiati, analizzati e criticati nelle loro (presupposte o reali) mancanze in studi che il Capo dello SME assegnava ai suoi ufficiali e che poi passavano sul tavolo del Ministro. In un certo senso, Cosenz lentamente e silenziosamente si conq uis tò di fatto un diritto di competenza (o perlomeno di ispezione) molto prima che questo fosse sancito dal Regolamemo o dalla legge: regolamento che pure rimaneva assai largo nella definizione che assegnava al Capo dello SME la competenza di «tutti» quegli studi che fossero necessari per una onnicomprensiva «preparazione della guerra» 11 .
Altrettanta larghezza si trovava nei primi 'ordini del giorno' che Cosenz impartì agli ufficiali del suo Ufficio.
Gli uffici l, 2 e 3 del Primo Reparto si occupano di quanto riguarda la preparazione della guerra offensiva e difensiva nello scacchiere a ciascuno d'essi rispettivamente assegnato ( )
8 Cfr. MINNITI, Esercito e politica da Porta Pia alla Triplice Alleanza cit., p. 87.

9 Cfr. MARSELLI, La politica dello Stato italiano, cit., pp. 166- 169.
10 Qualcosa rimane in AUSSME, Carteggio corrispondenza del Corpo di Stato Maggiore, racc. vari.
11 Cfr. AUSSME, Studi particolari, racc. 300 , fase. l , Regi.Jtro degli ordini del giorno del Sig . Capo di SME.
214 POLITICA E POLITICA MILITARE
Detti studi abbracciano per conseguenza tutto ciò che riguarda la potenza militare di detti Stati confinanti con lo scacchiere assegnato ed anche di guelli aventi coi medesimi stretta attinenza per ragione geografica o politica 12
Questo tipo eli organizzazione 13, varata nel 1882, era quella che Ricotti trovò funzionante al momento della sua nomina a Ministro e che fu riformata (seppure solo in qualche parte secondaria) per la prima volta solo nel 1887 14. Sia pur numericamente ancora ristretto, il pool di ufficiali che lavorava con Cosenz e che rappresentava lo SME al momento del secondo Ministero Ricotti era poi formato da personalità di rilievo 15
A questa organizzazione, diretta con il piglio attivistico che abbiamo detto, il Ministro della Guerra poteva 'opporre' la vecchia Divisione di Stato Maggiore del Ministero della Guerra , nonché il proprio Gabinetto personale e l 'Ufficio del Segretariato Generale 16. Il

12 lvi, ordine del giorno n. 3. alla data del 9 novembre 1882.
13 L'ufficio del Comando del Corpo di Stato Maggiore era struttUrato in due Riparti; il Primo Riparto era diviso per scacchieri geografico-militari, il Secondo per materie e campi di interesse strategico . Il Primo Riparto, infatti, comprendeva l'Ufficio l (destinato a raccogliere informazioni sullo scacchiere militare composto da AustriaUngheria, Germania e Russia), l' Ufficio 2 (Francia , Svizzera, Belgio, Inghilterra), l'Ufficio 3 (Stati del Mediterraneo) cui più tardi fu aggiunto un Ufficio 4 per i problemi del personale. Il secondo Riparto presiedeva ai lavori.deii'Ufficio A (che si occupava specialmente dell 'Intendenza di Guecra), dell'Ufficio B (Fecrovie) e dell'Ufficio C.
L'Ufficio del Capo dello Stato Maggiore dell'Esercito, con un suo specifico Segretario, si sarebbe occupato- a discrezione del Capo- di tutto quanto apparisse di particolare ed importante interesse, ma specificatamente delle materie riguardanti la Scuola di Guerra, il personale del Corpo di Stato Maggiore, le Piazze di Guerra, la situazione dell 'ar mamento, le questioni organiche dell'esercito intero, la mobilitazione e la radunata , le relazioni tra Esercito e Marina nella difesa dello Stato ed ogni questione che per le sue caratteristiche potesse interessare più di un Ufficio (i cosiddetti 'lavori complessivi').
14 Cfr. AUSSME, Studiparticolan·, racc. 300, fase. l, alla data del 31 maggio 1887.
15 Oltre al Comandante in seconda del Corpo di Stato Maggiore (che fu per qualche tempo A. Ricci), furono alle dirette dipendenze di Cosenz ufficiali del calibroe del futuro- di C. Corsi, V. Dabormida, S. Sismondo , G. Viganò, G. Gazzera, A. Pollio, C. Corticelli, G. Zavattari , G. Di Lenna, G. Goiran, C. Caneva, M. Girola, G. Dogliotti, O. Bararieri, E. Sapio, A. Leitenitz, P. Frugoni, G. Arimondi, G. Bollati, S. Mocenni. G. Ferraris, B. Orero, L. Dal Verme, G. Po zzolini, F. Clavarino, U. Brusati, L. Majnoni d'lntignano. Anche se l'elenco può apparire lungo, risulta evidente il ruolo svolto dallo SME nel forgiare un nucleo del gruppo dirigente militare, protagonista delle guerre coloniali e dell 'amministrazione militare sino alla guerra mondiale.
16 In un momento di acuto sco n tro col Ministro della Guerra, ancora dieci anni più tardi , così parlava D. Primerano: cC' è soverchio accentramento alla sede dei Ministeri [a sfavore delle sedi tecniche, quale lo SME voleva definirsi ] . Difatti, per non parlare che del solo Ministero della Guerra, vediamo che là c'è una Divisione di Stato Maggio re , cioè un duplicato del Corpo di Stato Maggiore , più piccolo sì, ma che sta a con-
MIUTAR1 NEGLI ANNI OITANTA
215
resto dell'organizzazione ministeriale aveva compiti di regola m eramente amministrativi. Gli stessi Comitati d'Arma, che già nel passato erano stati spesso trascurati dai Ministri (forse con l'unica eccezione del Comitato di Artiglieria, assai attivo per le questioni tecniche di armamento) 17, perdevano sempre p.iù il carattere che pure una volta avevano avuto di consulenti strategici, man mano che le loro fila si infoltivano di vecchi generali nominati per motivi e frnalità onorifiche piuttosto che strettamente operative. Alla divisione dello Stato Maggiore del Ministero della Guerra , anche in quegli anni 18, furono addetti ufficiali capaci e destinati a felice carriera , che parteciparono della formazione dei più delicati aspetti della politica militare e della pianifi cazione strategica 19. Non di rado essi svolgevano personalmente anche una funzione divulgativa e pubblicistica sulla stampa militare ufficiosa 20.
Ovviamente , non era quest i one di mera organizzazione amministrativa o di qualità del personale militare; la questione del rapporto tra Stato Maggiore e Ministero era in quegli anni una questione politica , di potere ali' interno della struttura militare, di politica militare. Il ruolo del Ministro della Guerra rimaneva, in quegli anni e ancora per un ceno periodo, «predominante, perché egli assommava il potere politico e il comando effettivo d eli' esercico, sia pure con il limite del costante interessamento del Re, della necessità di un certo consenso da parte dei maggiori comandanti, e della responsabilità collegiale del Governo nelle maggiori decisioni politiche» 21

Ma nel frattempo il Capo di Stato Maggiore aveva svilu ppat o un insieme di conoscenze e di competenze che dovevano risultare di importanza fondamentale per lo stesso Ministro: il secondo, in più di un'occasione , era costretco a servirsi del primo 22 . Inoltre il Capo
tatto immediato del Min istro. e del quale egli si serve di preferenza. c che anzi molte volte fa da ufficio di revisione del grande Stato Maggiore ( ). Per rutto ciò il Capo di Stato Maggiore è poco consultato( ... )». AA.PP., Senato, Legisl. XIX, sess. prima , Discussioni, tornata dell'li giugno 1896.
17 Cfr. MONTO, Stona dell'artigltena ttaliana , p. Il, Dal 1815 a/1914, v. 3, cit. , passim.
18 Tra l'altro , cfr. Annuano militare 1885, Roma, Voghera , 1885.
l9 Spesso i loro nomi ri co rrono nei carteggi conservati presso l' AUSSME.
20 Cfr. le annate de l 'c Italia militare •, ad esempio
21 ROCHAT , MASSOBRIO , Breve storia dell 'eiercito italiano da/1861 a/1943, cir., p 114.
22 Esemplare il caso della spedizione di Massaua quand o, al momento della preparazione della spedizione, fu lo Stato Maggiore di Cosenz a contribuire in maniera decisiva a delineare il piano operativo.
216 POLmCA E POUTICA MIUTARE
dello SME, specie nel periodo di Cosenz, aveva dalla sua una permanenza in carica che non seguiva l'alternarsi politico dei Ministri (e che gli permetteva di poter parlare 'a nome dell'esercito').
Comunque, fino a quando le competenze reciproche non furono precisate, l'andamento dei rapporti tra Capo di Stato Maggiore dell'Esercito e Ministro della Guerra fu sempre alterno. Il tutto veniva condito, nelle occasioni migliori, da un certo diplomatismo dei rapporti 23, che permetteva a ciascuno dei due di sorvolare sulle diversità delle opinioni, particolarmente quando si trattava di temi che non impegnavano la politica immediata del Ministro e del Ministero 24 Questo , almeno, pare essere stata la regola dei rapporti che, tra il 1884 ed il 1887, si erano stabiliti tra Cosenz e Ricotti.
Le due personalità, com e si sa, erano quanto mai diverse, dal punto di vista personale, politico, militare. E i momenti di attrito non dovettero mancare. Il contrasto di fondo fra le due personalità poteva emergere anche a partire dalla definizione delle reciproche competenze.
Da parre sua, Ricotti aveva già maturato alcune sue profonde convinzioni su quale dovesse essere il ruolo del Capo di Stato Maggiore nei confronti del Ministro della Guerra . Ed erano convinzioni cui restò fedele per tutta la vita.
N el 1871, quando appena nominato Ministro aveva dovuto resistere alle accuse di La Marmora, aveva ribadito più volte con forza - tra l'altro - di essere «Ministro della Guerra, la di cui autorità, per diritto di carica, è nell'esercito superiore a qualsiasi generale!» 25. Nel 1882 , il Ministro Perrero voleva difendere dall'opposizione di Ricotti un provvedimento , affermando che esso era stato consigliato dal Comitato d'Arma competente: anche in quell'occasione il gene-

23 Appena nominato Ricotti accettò i piani di mobilitazione militare quali Cosenz glieli espose, pur non approvandoli in pieno. In una sua lettera (conservata in MCR, Carte Cosenz , b 326, fase 18, doc. ), Ricotti a Cosenz) , il novarese dichiarò esplici t ameme di soprassede re ad alcune sue precedenti osservazioni critiche. Su un tema nodale come la dislocazione iniziale dei Corpi d ·Armata nelle due ipotesi di radunata NordEst e Nord-Ovest, il Ministro appena nominato finiva per acconsentire al Capo di Stato Maggiore.
24 Ricotti aveva molto forte la concezione per cui, comunque, una grande libertà d'azione sarebbe stata (ed avrebbe dovuto essere) lasciata alla responsabilità del Comandante Sup remo in guerra . Cfr. AUSSME, Ordinamento e mobilitazione, racc. 68 , fase. IV , 8 novembre 1882. Ed an che pubblicamente in AA.PP., Camera, Legisl. XVI, sess. prima, Discussioni, tornata del 16 dicembre 1886. In quest'ottica , è probabile che Ricotti abbia accettatO anche misure e preparativi che pure non condivideva sino in fondo. lvi, Legisl. Xl , sess. prima, Discussioni , tornata del 18 maggio 1871.
M[LJTARJ NEGU ANNI OTTANTA 217
rale novarese dimostrò di avere le proprie intime convinzioni su quali fossero, all'interno dell ' amministrazione militare, gli organi d eliberativi e politicamente responsabili e quali fossero invece quelli solo consultivi ed accessori. Ricotti rispose infatti a Perrero affermando di non potere accogliere la giustificazione addotta dal Ministro e di non potere «accettare quella teoria, perché avrebbe per naturale conseguenza di dover cambiare la nostra costituzione politica; bisognerebbe allora che i corpi consultivi diventassero deliberativi, mentre invece è zi Ministero solo che è responsabtle innanzi al Parlamento>> 26 .
Nel 1896, durante i pochi mesi della sua terza presenza al Ministero della Guerra, Ricotti dovette ancora tornare pubblicamente e dettagliatamente al suo pensiero. Ironicamente, rispondendo a quei deputati che «parlarono del Capo di Stato Maggiore

lo considerano come fosse il comandante dell'esercito», Ricotti
affermò:
È un equivoco: il Capo di Stato Maggiore non è il Capo dell'esercito, è in sotto rdine al co mandante dell'esercito. Chi comanda l'esercito è il Re per il mezzo del Ministro della Guerra, al quale solo spetta la responsabilità. È strano come si sia formata l'idea che il Capo di Stato Maggiore sia responsa · bile della vittoria e della sconfitta, che egli debba fa r e rutto , scegliere i generali, ordinare l'esercito. Invece niente di rutto questo: se è consultat o, dà il suo avviso, ma non spetta a lui la responsabilità. Si è fatta una confusio ne strana 27
E già qualche giorno prima, sempre sullo stesso tema, Ricotti aveva spiegato con ancora maggiore larghezza di concetti il suo penstero.
( ) il capo di Stato Maggiore non è il Comandante dell'esercito.
Io cap isco che, sotto molti punti di vista, sarebbe desiderabile che vi fosse il comandante responsabile dell'esercito anche in tempo di pace , ma nei Governi costituzionali ciò non è possibile .
Tutti i loro sistemi hanno i loro vantaggi e i loro inconvenienti.
Il sis tema parlamentare, fra mol ti vantagg i, ha l'inconveniente di non poter affidare la responsab ilità che ai Ministri. Quindi bisogna che il Capo di Stato Maggiore dipenda, sotto il punto di vista costituzionale, dal Ministro , il quale
218 POLITICA E POLITICA MILITARE
[e]
26 lvi, Legisl. XlV, sess. unica, Discussioni, tornata del 26 aprile 1882. 27 lvi, Legisl. XIX, sess. unica, Discussioni, tornaita del 27 maggio 1896.
in conseguenz a, ha il dìritto di revocarlo o dispensarlo dall'ufficio, quando non abbia in esso fiducia 28.
A questo punto, la que st ione delle competenze pote va apparire ai novarese di minore importanza di quanto comunemente si credeva: una volta stabilita e ribadita l'inferiorità del Capo dello SME di fronte al Ministro della Guerra, questo poteva anche apparire generoso nella determin az ione (che comunque sempre a lui spettava definire) dell'altro.
( ... )il capo di StalO Maggiore deve occuparsi di tutti gli studi di difesa e di preparazione della guerra.
Su rutto quello che è relativo alla f ro n tiera deve sentirsi, come si è semp re sentito, il parere del Capo di Stato Maggiore, e tutto quello che è relativo alla mobilitazione è preparato da lui, il Ministero non entrandovi che per dare le dj. sposi zi oni esecutive ai comandami dei Corpi d'armata, poiché non si ammette che ti Capo di Stato Maggiore possa dare ordini.
Quindi in quella pane il Ministero funziona quasi come trami re più che come autorità assoluta, poiché generalmente non fa che accettare le proposte del Capo di Stato Maggiore e uasmenerle come ordini ai comandami di corpo d'armata 29
A questo tipo di impostazio ne , Ricotti si attenne se mpre: ed anch e nel periodo del suo secondo Ministero.
In quegli anni , anzi, oltre a sperimentare personalmente la difficoltà della fase costituente dei rapporti tra le due ca riche, Ricotti fu più volte costretto a spec ifi care anche pubblicamente - di fronte a chi l'istituzione della carica di Capo dello SME tanto aveva atteso,
28 lvi, Senato, Legisl. XIX , sess. unica, Discussioni, wrnata deiJ' 11 maggio 1896. Il dibattito parlamentare di quel 1896 (su cui conviene un animo soffermarsi), nel quale intervenne ro anche Carlo Mezzacapo e Domenico Primerano - allora Capo deiJo SME - prese poi un tono appareotemente tecnico: quale avrebbe dovuto essere in genere il grado ch e meglio si confaceva ad esprimere cd a rappresentare l'autorità del Capo di SME? Prìrnerano sosteneva che il Capo SME avrebbe dovuto essere un Tenente Generale, Ricotti in vece diceva che sarebbe bastato un Maggiore Generale. Dietro queste differenz iazioni 'tecniche' si celava una differente visione delle funzioni e dei rapporti tra Ministro della Guerra e Capo SME. Il gene rale novarese cosl argomentava: cii Capo di Stato Maggiore comanda a quei 100 o 150 ufficiali suoi dipendenti, come farebbe un colonne ll o di reggimento; di più li istruisce, d à loro consig li e li prepara e li indirizza a quel dato scopo( ) Ma la sua auwrità non si estende ai Comandanti i Corpi d' Armata; egli può avere con loro delle relazioni, ma non di comando, e perciò può essere anche di grado inferiore•. Ibidem. Se si pensa che normalmente il Ministro della Guerra era scelw ua i Generali di grado più elevalO, si capisce bene come Ricorri volesse inchiodare il Capo SME anche ad una forma di subordinazione gerarchica verso il Ministro.
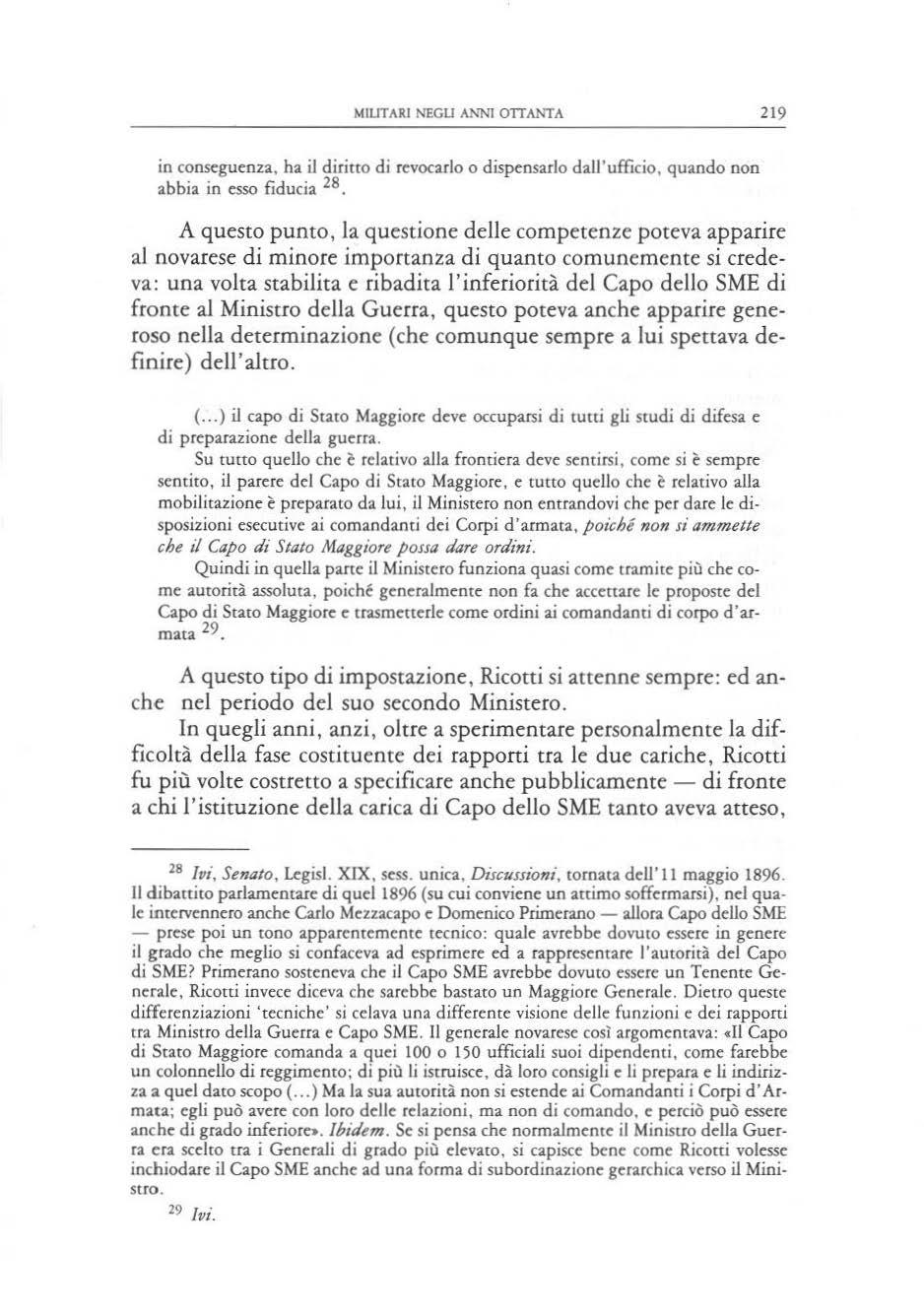
MlUTARJ NEGU Am-.'1 OTIM'TA 219
29 lvi.
favorito, incoraggiato - quali a suo avviso dovessero essere le competenze reciproche .
Già si è visto come una parte dell'ambiente militare non fosse aliena dal dare maggior vigore alle proprie critiche della politica militare ministeriale chiamando in causa e mostrandosi sicura dell'appoggio di Cosenz 30.
Questo tipo di comportamento della 'dissidenza militare', oltre a costituire un evidente motivo di impaccio per la attuazione della politica militare decisa dal Ministro, non poteva andare assolutamente a genio al Generale novarese. Per lui, il Capo dello SME era e doveva rimanere una carica consultiva, e subordinata, del Ministro della Guerra.
Il contrasto delle opinioni, così, era destinato prima o poi a manifestarsi chiaramente, anche perché i fautori d eli' importanza della carica del Capo di Stato Maggiore non volevano che -a pochi anni dalla sua istituzione - le sue competenze ed il suo prestigio venissero duramente mortificati dalla volontà di Ricotti. Il momento in cui il contrasto fu più chiaro e rivelatore fu in una discussione parlamentare dell'inverno 1886, una delle ultime cui Ricotti partecipò come Ministro della Guerra.

Si trattava allora di approvare un provvedimento minore del suo Ministero, ma che l'opposizione politica e militare in Parlamento vedeva con grande disappunto 31 L'ambiente parlamentare era già stato surriscaldato da un forte discorso di opposizione del pentarca Pais - che aveva accusato Ricotti di numerose e gravi inadempienze 32 -e da una dichiarazione pubblica di un militare del calibro di Luigi Pelloux , che aveva affermato che per la prima volta avrebbe dato un voto contrario alla politica del Ministro della Guerra 33. A riprova dell'acceso clima politico, i verbali di quelle sedute parlamentari sono costellati di frequenti annotazioni come «Molti deputati occupano l'emiciclo», «Interruzioni», «Rumori», «Conversazioni animate» 34 _
30 Cfr. ancora «L'esercito italiano», 13 giugno 1885, Un prudente consiglio.
31 Cfr. ACD, Ddt, Legisl. XV, sess. unica, reg. 412, n. 398 , Verbale di seduta della Commissione; e ivi, Legisl. XVI , sess . prima, reg. 430, n. 99 . Verbale di seduta delta Commissione.
32 Cfr. AA.PP. , Camera , Legisl. XVI, sess. prima, Discussioni , tornata del 17 dicembre 1886
33 Cfr. ibidem.
34 l vi, tornata del 18 dicembre 1886.
220 POU T ICA E POUTJCA MiliTARE
In quella animata temperie, il generale Pozzolini- addetto al CSM - introdusse il tema dei rapporti tra Capo dello SME e Ministro, proponendo che essi fossero regolati per legge .
Secondo Pozzolini, l'autorità del Capo di Stato Maggiore («autorità che deve essere in relazione all'enorme responsabilità che gravita su di lui in tempo di guerra») doveva essere commisurata alla vastità del compito assegnatogli (infatti preparazione alla guerra deve essere intesa assai largamente• e «condiz ione essenziale della preparazione alla guerra è questa: che chi ha coordi nato gli elementi di questo esercito, che ha preparato questo strumento, sia quello stesso che lo deve poi adoperare»). Lo scopo ultimo, e dichiarato dallo stesso Pozzolini , era qu esto: «indurre il Ministro della Guerra a rinunziare ad un pane dell e sue facolth 35.
Un tal punto di vista era assolutamente in contrasto con le idee ed il programma di Ricotti. Inoltre il discorso di Pozzolioi rientrava, in quei giorni, io quella corrente di opinioni che tendeva a far apparire come contrastanti gli indirizzi del Ministro con quelli del Capo di SME. D'altra parte, il novarese non poteva sottovalutare chequesta volta- a ricordargli le competenze ed il diritto di ingerenza e di critica del Capo di Stato Maggiore era un alto e noto ufficiale che proprio a fianco di Cosenz lavorava da tempo. Si poteva quindi presumere che Pozzolini non parlasse solo rcr
La risposta di Ricotti a Poz zol ini dovette così seguire due binari: doveva controbattere teoricamente le posizioni espresse da Pozzolini e, soprattutto, doveva mandare un segnale implicito ma sufficiente mente chiaro a Cosenz, perché non alzasse troppo la testa.
Per la prima di questa doppia sua esigenza, Ricotti fece ricorso a tutte le argomentazioni che prima abbiamo ricordato , e che facevano pane dei suoi più intimi convincimenti. Ribadì così che «il so lo responsabile davanti al Parlamento ed al Paese per la preparazione alla guerra è il Ministro • e che , se anche il responsabile dei ri su ltati e della condotta della guerra poteva essere co nsiderato il comandante in capo, in un ceno senso persino in qu esto campo responsabilità ricade in pane sul Ministro, so l perché ne ha proposto la nomina. 36.
Per lan ciare un segnale a Cosenz, invece, Ricotti fu assai più breve e seccamente disse:

MIUTARINEGLIANNIOTTANTA 221
35 Ibidem. 36 Ibidem.
Per tali considerazioni la coesistenza del Capo di Stato Maggiore e del Ministro della Guerra è soltanto possibile in quanto regni fra loro il più completo accordo.
Se questo accordo non esistesse, appunto per la responsabilità che grave ed intera pesa sul Ministro della Guerra, il Capo di Stato Maggiore dovrebbe cedere, cessare, se occorre, a meno che non si ritiri il Ministro.
La mia conclusione è pertanto questa 37
Ma se anche il Ministro della Guerra in carica poteva affermare in modo così perentorio i prÒpri pareri sulla questione delle competenze formali del Capo dello SME, questo non significava che - lentamente ma irresistibilmente - il prestigio reale e l'ingerenza concreta del Capo di Stato Maggiore non fosse già andata crescendo, nell'opinione della stampa e dell'ambiente militare e nella realtà dell' amministrazione de ll 'esercito.

Punroppo, per ricostruire quello che fu in realtà l'operato dello Stato Maggiore nel!' ambito del!' amministrazione e della pianificazione militare di quei suoi primj annj di esistenza, manca la documentazione necessaria. Abbiamo alcune carte che alludono o comunque fanno capire l'estensione degli interessi e della pianificazione direttamente condotti dagli Uffici dello Stato Maggiore in quegli anni 38, ma non è disponibile assolutamente la completezza della serie. Sulla questione appunto - che potrebbe essere decisiva - se lo Stato Maggiore avesse intrapreso quegli studi e quella pianificazione per ordine del Ministero della Guerra o per propria iniziativa auto n oma, non si può il più delle volte dare una risposta sufficientemente documentata.
L'impressione generale che si ricava è però che, nella maggior parte dei casi, l'Ufficio dello Stato Maggiore negli anni di Cosenz e di Ricotti abbia lavorato autonomamente, secondo ordini di interesse e di priorità personalmente decisi dal suo Capo 39. In qualche occasione impanante, io realtà, fu lo stesso Ministro- o il suo Segretariato Generale - a commissionare allo Stato Maggiore taluni studi o la compilazione di memorie. In altri casi era il Ministro che
37 Ibidem.
3S ln questo senso grande interesse hanno le raccolte dell' AUSSME, Scacchiere occidentale; Scacchiere orientale; Studi tecnici; Ordinamento e mobilùaztone; Studipar· ticolari. Minore importanza hanno, nonostante la loro determinazione , le serie Carteg· gio corrispondenza del Corpo di Stato Maggiore , nonché le poche e disordinate, Mobilitazione.
39 Qualcosa degli appunti personali di Enrico Cosenz riassume in AUSSME , Carteggio vano, racc. 115 , 116 , 117, 118.
222 POUTJCA E
POUTJCA MILITME
si rivolgeva direttamente al Capo dello StatO Maggiore dell'Esercito, per esporgli i suoi intendimenti ci rca alcuni aspetti della sua politica militare: ma spesso tali esposizioni arrivarono solo dopo la stessa emanazio ne delle direttive ministeriali 4o.
Anche senza voler arrivare a conclusioni affrettate, la stessa scarsa documentazione disponibile testimonia chiaramente la grande estensione dell'opera di ricognizione dell'esistente e di pianificazione del necessario che lo Stato Maggiore di Cosenz andava svolgendo in quegli anni, contribuendo a fare dello SME e del suo archivio di studi e di piani un crocevia obbligato della politica militare nazionale e della preparazione della guerra.
Le opere di fonifica.zione dei confini terrestri venivano rip etutamente studiate .
Lo stato delle piazzeforti del Paese, il loro approvvigionamento, la loro capacità di durata, il loro grado di maggiore o minore affidabilità erano fatte oggetto di grande attenzione: specialmente allora, quando il costoso 'secondo piano generale delle fonificazioni ' imponeva ai Ministri della Guerra di rendere como sul come erano spesi i denari dello Stato 41.
Veniva continuamente (anche troppo frequentemente) corretta la 'cana logistica' della nazione, che avrebbe permesso - nel caso di un conflitto - al Comandante in Capo di sapere come e da dove sareb bero potuti giungere rirlforzi, truppe, viveri, comunicazioni, etc. 42
Un interesse panicolare veniva dedicato alla conoscenza del materiale e del tracciato ferroviario disponibili: e più di una volta si stendevano Promemoria in cui lo Stato Maggiore , e per esso gli ufficiali responsabili, si dichiaravano insoddisfatti di questa o quella situazione 4 3
Una 'Commissione di viabilità' venne cos tituita per essere aggiornata della situazione nazionale sul delicatO argomento 44 .
Tutto questo comp lesso di informazioni, infine , serviva poi per
40 U na tale impressione si ricava anche dai pochi documenti disponibili in AUS · SME , Carteggio corrisp ondenza del Corpo di Stato Maggiore, nei racc. 30, 31, e 37.
41 Cfr. AUSSME, Ordinamento e mobilitazione, racc. 123, n. 10, 2 febbraio 1885, Rù., Cosenz a Ri cotti.

42 Cfr. AUSSME , Carteggio com!pondenza del Corpo di Stato Maggiore, racc. 61, 17 dicembre 1886, Ris., Cosenz a1 C. te in seconda del CSM.
43 Cfr. ivi, racc, 59, aprile 1885.
44 Cfr. ivi, racc. 37, 30 novembre 1884, Pozzolini a Cosenz
MIUTARI NEGLI ANNI OTTANTA 223
comporre e correggere le Istruzioni e i Quadri di Mobilitazione, dei quali Cosenz andò sempre orgogl ioso (come quando, molti anni più tardi, avrebbe affermato che «p rima che venisse creato l'Ufficio del Capo di Stato Maggiore, vi era il nome e non la cosa; vi era un a Radunat a a stampa che non era che una fantasmagoria, nulla essendo preparato e studiato ( ... )») 45.
Oltre a questa fase di ricogni zione, c'era poi l'attività p i ù propriamente di studio e di p ianificazione.
Fondamentale, in questo senso, era il continuo fl usso di informazioni che dali' estero veniva aruaverso gl i Addett i Militari italiani allo Stato Maggiore , con cui di regola essi comunicavan o 46 .

D ove non c'erano ambasciate né Addetti Militari, ma dove lo Stato Maggiore presumeva si potesse indirizza re in un t empo più o me n o vicino l a politica e l'azione militare ital iana, ven ivano stretti accordi di periodica informazione con civili di solito bene informati sull'atti vità po litica e militare de llo Stato in cui risiedevano. Come succedeva per la Libia, dove un agente della Società di Navigazione Generale Italiana a Tripoli restò in contatto episto l are con lo Stato Maggiore dal 1884 al 1892 47.
Lo Stato Maggiore poteva poi ordinare agli Ufficiali suoi dipendenti di compiere ricognizioni segrete in territori di Stati confinanti, per carpire le informazioni militari che po t evano sembrare necessarie, o per saggiare inosservati le caratteristiche de ll a difesa avversaria 4 8.
Della vera e propria opera di pianificaz i one strategica, p oi, è dispon ib il e oggi lo «Studio circa la difensiva e l'offensiva N ord-Est» (un piano di guerra contro l'Austria in cui veniva sottolineata la possibilità di un'azione offensiva dell'Italia isolata contro la confinante Austria e che rimarrà in vigore 49 - nelle sue linee essenziali - per molto tempo) e poche altre cane.
Consi derato il ristretto arco cronologico da noi preso in esame, per quest a rassegna dell'attività militare dello Stato Maggiore, ed il personale che vi appare impiegato (che, a giudicare dai documenti
La lerrera è citata n ello stu dio manoscrirro, inedito, di G. Saladino su Enrico Cosenz.
46 Cfr le serie ivi, Addeth. militan·.
47 Cfr. i11i, Libia, racc. 11, fase. l.
48 Cfr. tra le molte altre ivi, Scacchiere orientale, racc. 29, fase. 12, luglio 1886, Radicati a Cosenz.
49 l11i, Ordinamento e mobtiitazione, racc. Il.
224 POUTICA E POUTICA MfUTARE
consultati e dagli «Annuari militari», come si è detto non era molto numeroso) si deve convenire che lo SME lavorò già in quegli anni 'costituenti' di Cosenz e Ricotti a pieno regime, ceno molto più che qualsiasi altro 'organo consultivo' e su questioni assai più importanti e dec isive di quelle su cui di solito erano stati chiamati a discutere i vecchi 'Comitati d'Arma' o lo stesso precedente 'Comitato di Stato Maggiore Generale' 50
Purtroppo, di questa attività intensa non si può sapere quali furono i criteri direttivi, né quali erano le indicazioni che Cosenz dava ai suoi subordinati. Comunque, quello che trapelava o si intuiva della attività dello Stato Maggiore accresceva la fiducia ed il rispetto con cui l'esercito guardava alla nuova istituzione 51.
La dimostrazione migliore della crescente rilevanza della figura e della carica del Capo di Stato Maggiore all'interno dei circoli dirigenti militari la si può più facilmente ritrovare nella documentazione - più facilmente disponibile - offertaci dalla stampa militare. In significative occasioni, taluni ambienti militari avevano fatto riferimento alla figura del Capo dello SME contrapponendola a quella di Ricotti.
«L'esercito italiano», appena un mese dopo la nomina del novarese, si era pubblicamente interrogato se esistessero motivi di contrasto tra Ricotti e Cosenz 52 . Più tardi, nei giorni in cui - t ra gli organizzatori della politica coloniale e della spedizione di Massauaculminava il dissidio segreto sulla possibilità o meno di espandere il controllo militare italiano dalla costa e dal porto di Massaua sino alle vette dell'altipiano abissino (dissidio, questo, che come vedremo aveva trovato Ricotti e Cosenz su posizioni non collimanti), di nuovo «L'esercito italiano» aveva affermato che «la responsabilità in faccia al paese e alla storia ( ... ) è riservat a a chi dirige effettivamente l'esercito in campagna» 53. E, più avanti, pronunciandosi a favore di una limitazione del campo d'azione del Ministro al puro terreno ·parlamentare, il giornale scrisse:
5° Cfr. ancora, per talune indicazioni generali del problema, MARSELLI, La poft'tica dello stato ùaliano, ci t., p. 168.
51 «li Capo di SME aveva, anche per i più spregiudicati di noi, qualcosa del mito•. DE BONO, Nell'esercito nostro prima della guerra , cit., p. 95.
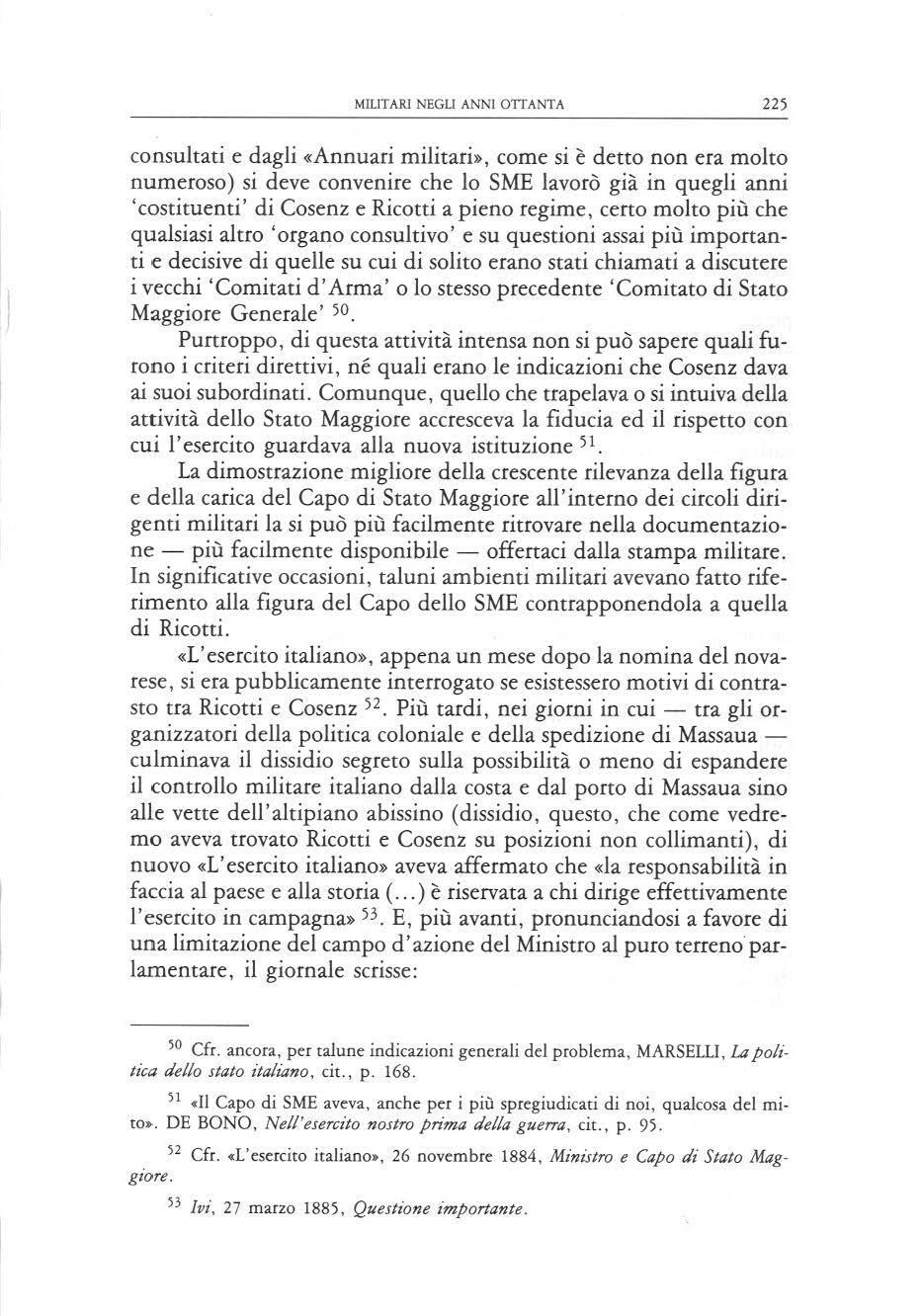
52 Cfr. «L'esercito italiano», 26 novembre 1884, Ministro e Capo di Stato Maggiore.
53 lvi, 27 marzo 1885, Questione importante.
MILITARI NEGU ANNI 01TANTA 225
Noi saremo per quei Ministri della Guerra che, in omaggio ai superiori interessi, generosamente si spoglieranno di tutte le attribuzioni non strettamente collegate al loro ufficio di amministratori 54.
Nel giugno 1885, infine, quando Ricotti dovette affrontare impegnativi e caldi dibattiti parlamentari, il giornale militare pr opose di interpellare pubblicamente il Capo dello Stato Maggiore, per sapere se davvero egli approvasse la 'sosta' di Ricotti 55. Una tale iniziativa de «L'esercito italiano», pur in sé irrealizzabile (avrebbe esposto l 'esercito ad una crisi istituzionale di proporzioni allora difficilmente immaginabili) e che sopravvalutava la portata del contrasto e della divergenza di opinioni tra il Cosenz e Ricotti, era però indicativa della considerazione e del prestigio che già a soli tre anni dalla sua istituzione il Capo di Stato Maggiore aveva guadagnato in certi settori del mondo militare.

Segno che i tempi stavano cambiando, «L'esercito italiano» chiamò più tardi in causa il Capo dello SME anche in questioni di organico dell'esercito, quando- come vedremo - si trattò di discutere se aumentare o meno i quadri di Artiglieria e Cavalleria 56; ed infine (in occasione del contrasto parlamentare dell'inverno 1886, che si è visto) il giornale diede ampia risonanza al discorso parlamentare di Pozzolini , piuttosto che alla replica di Ricotti, discorso che - a giudizio dell'organo militare di stampa - confermava l'opinione per cui, se il Parlamento ed il Ministro avessero rinunciato a qualche competenza in materia di politica militare, non ci sarebbe certo stata una vacanza di potere poiché «ci sarebbero stati già i Corpi a ciò destinati» 57.
A questo tipo di argomentazioni (che spesso erano riprese da quotidiani e da ambienti politici avversi al Ministro Ricotti) in verità, la voce ufficiosa del Ministero della Guerra, «Italia militare» 58, ma anche le riviste tecniche militari, non riuscivano ad obiettare alcunché di coerente: anzi parevano saper opporre alle affermazioni de «L' esercito italiano» solo un imbarazzato silenzio che non faceva altro che contribuire a diffondere le idee di chi vedeva in Cosenz una
54 Ibidem.
55 lvi, 13 giugno 1885, Un prudente consiglio.
56 lvi, 14 ottobre 1886, Le Commissioni per l'Artiglieria e per la Cava/lena.
57 lvi, 23 dicembre 1886, Le attribuzioni del Capo di Stato Maggiore.
58 Essa poteva al massimo ripetere pedissequamente Le dichiarazioni del Ministro della Gue"a, in cL'ltalia militare•, 19 dicembre 1886.
226 POUTICA E
POUTICA MiliTARE
sona di controalrare, insoddisfatto ma per allora silenzioso, di Ricotti e della sua politica di 'sosta'.
Tutto questo, se non direttamente, certo almeno indirettamente doveva contribuire ad erodere le radici del consenso alla politica del Ministro nella base dell'organismo militare e tra le fila del Corpo Ufficiali.

MILITARI NEGU ANNI OTTANTA 227

CAPITOLO QUARTO
LE RAGIONI DELLA CADUTA DI UN MINISTRO
Voci di gueTTa europea e calma ùaliana
A livello diplomatico, il 1886 si era aperto per l'Italia in una situazione di difficoltà 1 e si doveva chiudere con un momento di incertezza 2 . Dall'inizio dell'anno sino all'aprile (quando la fase più acuta della crisi balcanica provocata dal conflitto serbo-bulgaro si poté considerare conclusa) la 'potenza' italiana dovette esperimentare quanto fossero ristretti i suoi spazi di manovra 3. Nella seconda parte dell'anno l'Italia cominciava prima a pensare e poi a fare i primi passi per il rinnovo della Triplice, in un contesto internazionale però assai diverso da quello in cui, nel1882, il primo trattato era stato firmato. Da parte sua la Germania faceva in modo da approfondire i contrasti con Parigi, che ancora risentiva dei fermenti boulangisti, dichiarando pubblicamente di voler aumentare le sue spese militari e gridando al pericolo francese. Inoltre, Bismarck metteva le basi segrete di un rinnovato accordo tra Berlino e Pietrogrado, che poi avrebbe portato alla firma del trattato di controassicurazione 4 In questo quadro, per Berlino (ma poi anche per tutti i contraenti) la Triplice Alleanza veniva ad acuire il suo carattere antifrancese.
La consapevolezza di assistere ad una fase di correzione degli equi-
1 Cfr. TAMBORRA, La crisi balcanica del 1885 - 1886 e l ' Italia , cit.
2 Cfr. SALVATORELU, La Tnplice Alleanza 1877- 1912. Stona diplomatica, cit., pp. 102-103. Niente infatti poteva al momento garantire che la mossa di Robilant, per un rinnovo della Triplice in un senso più favorevole all'Italia, avrebbe poi poruto realmente andare in porto.
3 Cfr. di nuovo TAMBORRA, La cnsi balcanica de/1885-1886 e l'ltalza , cit.; cfr. anche , specificatamente , A.F.M BIAGINI , Momenti di stona balcanica (1878 - 1914). Aspetti militan·, Roma (Roma, Arte della Stampa), 1981 (in testa al front : Staco Maggiore dell'Esercito. Ufficio Storico), pp. 89-104.
4 Cfr. TAYLOR, L'Europa delle grandi potenze. Da Mettemich a Lenin , cit. , p. 442 .

libri diplomatici europei, in un momento in cui non mancavano le minacciose voci di guerra , tra l'altro rinfocolate da contrasti diplomatici ancora non sopiti (come quelli dell'area balcanica), dava all'Italia la misura della necessità di dover pur giocare un qualche ruolo per non venire 'schiacciati' dalla politica bismarckiana. La fortunata manovra diplomatica di Robilant doveva poi riuscire a far ottenere a Roma qualche risultato (ma in fondo solo in termini di mantenimento dello status quo e di riconoscimenti di qualche pretesa italiana) 5 ma all'inizio e durante la sua complessa conduzione da parte della Consulta niente era garantito. Ed anzi, lo scarso e laterale ruolo giocato solo qualche mese prima dall'Italia nella questione balcanica poteva e doveva indurre alle più pessimistiche previsioni. Per l'Italia la situazione non sembrava più rosea dal punto di vista della politica interna. Le elezioni volute da Depretis per fermare la crescente opposizione alla sua politica avevano invece rafforzato la d issidenza di Destra 6 e, se avevano indebo lito la Pentarchia, non ne avevano tacitato la veemente opposizione né erano riusciti a decapitarne il movimento po lit ico 7. Inoltre, la maggioranza parlamentare si dimostrava sempre più insofferente e la Camera, per l'ingresso di nuovi deputati, sempre più ingovernabile 8. Il progetto di una politica nazionale improntata all'ordinaria amministrazione ed alla pratica delle 'riforme amministrative' non trovava l'accoglienza dell' opinione pubblica che denunciava le debolezze e le incenezze della proclamata 'potenza' italiana .
Dal lato finanziario, infine, la situazione era incamminata verso l'approfondimento del deficit pubblico: la politica di Magliani era sempre più criticata 9.
Nel complesso, in quelli che sarebbero stati i suoi ultimi mesi, il trasformismo depretisiano sembrava ormai incapace di aggregare e cooptare nuovi gruppi politici e sociali nella gestione del potere lO
5 Cfr. B. MALINVERNI, Il primo accordo per ti Mediterraneo (febbraio-marzo 1887), Milano, Marzorati, 1967.
6 Cfr. Storia del Parlamento italiano, v. IX , Tra Cnspi e Gtolitti, a cura di R. Colapietra, Palermo, Flaccovio , 1976, pp. 8- 9.
7 Cfr. BOCCACCINI, La Pentarchia e l'opposizione al trasformùmo, ci t. , p. 161.
8 Cfr. CAROCCI, Agostino D epretù e /apolitica interna da/1876 aii887, cit., p. 82.
9 Cfr. BARONE, Sviluppo capitalistico e politica finanzianti in Italia nel decennio 1880- 1890, cit., p. 595.
1° Cfr. CAROCCI, Storia d 'Italia dall'unità ad oggi, cit., pp. 63 -64.

230 POLITICA E POLITICA MILITARE
e di a correggere vecchie lacune o a riparare a nuovi problemi.
E in questo quadro più generale che veniva ad operare il Ministro della Guerra, con la sua po li tica militare che un tempo aveva avuto l'avallo del presidente del Consiglio e del Ministro delle Finanze.
Come abbiamo visto, forti erano le spinte interne al mondo militare che esigevano ormai che si md asse oltre la 'sosta': ma fare questo avrebbe voluto dire superare proprio quegli steccati politici e finmziari che Ricotti aveva scelto ed accettato al momento della sua nomina. In questo quadro si mdava così erodendo la fiducia parlamentare (e ministeriale) nel Ministro della Guerra. Qumdo poi- inaspettata , non voluta ma temuta - arrivò la notizia dello smacco coloniale di Dogali, c'erano già tutte le basi per una caduta rovinosa del Ministro della Guerra.
11 problema di Ricotti era tutto qui. Nel frattempo la 'sosta' di Ricotti doveva farsi sentire non solo nelle questioni di organica o di strategia, ma mche in quelle tecnico -mili tari che pure avevmo la loro decisiva importanza 11 .
Particolare rilievo avevano avuto , ad esempio , negli anni Ottarita i miglioramenti tecnici conosciuti dalle artiglierie , con i progressi raggiunti nella fabbricazione ( e nella dottrina d ' impiego ) di o bici e cannoni 12 • Ma la vera rivoluzione tecnica che in Europa , proprio negli anni del secondo Ministero Ricotti, si stava impostando era quella dell'artiglieria 'portatile' , cioè dei fucili.
Negli anni Ottanta gli studi e le invenzioni in questo settore si erano concentrati sulla possibilità dì avere un ' arma capace di aumentare il volume di fuo co in rapida successione mediante un meccanismo di ripetizione del caricamento , da cu i il n ome . Il fucile a ripetizione venne studiato e poi adottato in Germania nel 1884 , in Frmcia nel 1885 , in Austria nel 1886 13 Proprio in quegli anni stavano avanzmdo inoltre gli studi nel campo delle polveri da sparo , studi che sarebbero sfociati qualche mno dopo ne ll'adozione da pane di tutti gli eserciti europei della cosiddetta 'polv e re infume' , causando una vera e propria rivoluzione tattica l4.
1 1 Sul ruolo co n d izio nante e de cis ivo dei progress i tec nici io Eu ro pa nel penultimo d ecennio del seco lo XIX , cfr . HAll G ARTEN , Storia della corsa agli armame n ti, ci t ., pp . 4 7-52 .

12 Cfr. MONTÙ , Storia dell'artiglieria italiana , p. Il , Da/IBIJ a/1914, v. 3, cir., p. 2073 e sgg
13 Cfr UDDELL HART , Le forze armate e l'arte della guerra: gli eserciti, cit., p. 378.
14 Cfr. i vi , p 379 e sgg.
LE RAGIONI DEllA CAOtrrA DI UN MINISTitO 231
In Italia per il fucile a ripetizione già da qualche tempo si era cercato di seguire gli studi stranieri e si erano incoraggiati gli esperìmenti dei tecnici e degli specialisti, come il Vitale o il Bertoldo. La cosa era di importanza capitale perché il rischio di un ritardo o di una cattiva degli studi era poi quello di isolare l' esercito italiano dal progresso che stava coinvolgendo gli altri eserciti europei, rischio che l'esplosione di un confl itto europeo avrebbe moltiplicato. Preoccupazioni di questo tipo erano diffusissime tra i militari italiani, che sottolineavano come un combattimento con fucili a ripetizione sarebbe stato diversissimo da quelli delle passate guerre d'indipendenza:
( ... )questo dell' Aniglieria sul campo di battaglia per noi italiani è d'importanza capitale. Venti anni di pace hanno messo in condizione tale l'esercite italiano che , come quello di Spagna o di G recia ... , sono [sic] i soli i quali non abbiano ancora subito gli effetti del fuoco rapido, menrre gli altri ed anche il Turco, lo esperimentarono tutti. Per me questo è un pensiero. Un maggiore, un colonnello, si vedrà in pochi minuti sparire, cadere 113, 112 della forza, della sua compagnia, crederà in una sconfitta e non so se riuscirà a mantenere bene il resro, e sarà Io stesso ufficiale che nel '66 avrà condotto benissimo il suo plotone e la sua compagnia nel folto della mischia l).

Da Roma si chiedevano quindi informazioni agli addetti militari italiani alle ambasciate all'estero, ma la loro opera era piena di difficoltà, «poiché ogni paese procurò di tener celati gli studi che faceva» I6 .
Già l'amministrazione Ferrero si era interessata alla questione.
Si sapeva che p resso ogni esercite erano in esame due sistemi - racconta uno dei responsabili italiani di quegli studi - cioè quello di una arma a ripetizione e quella di un caricatore da aggiungersi al fucile. Per l'arma a ripetizione si studiavano poi dappertutto le due questioni della trasformazione delle armi esistenti e dell'adozione di un'arma nuova di piccolo calibro .
Gli studi presso di noi erano proseguiti con lo stesso indirizzo ( ) l 7
Lo scopo era
di tenersi a giorno di ogni studio o progetto fatto all'estero, di esaminare e provare ogni sistema proposte che presentasse qualche pregio, dz teners-i pronti per
232 POLITICA E POLITICA MILITARE
se. l, 16 ( . .. ) 1885,
n ACS , Carte Pelloux,
Bigotti a Pelloux. !6 lvi, se. 4, 9 agosto 1886, Pozza a Pelloux. 17 Ibidem.
adottare quel sistema d'arme a ripetizione che poteva essere giudicato il più conveniente al momento in cui il Ministero avesse creduto di addivenire ad una parziale o totale trasformazione dell'armamento.
Non dirò che la Commissione abbia fatto molto , ma delle prove e degli studi se ne sono fatti ed i tipi d'arme più stimati si acquistavano ( ) Il guaio è che da noi si esigeva forse troppo ( ... ) l8.

Questo tipo di istruzioni 'troppo' esigenti avrebbero potuto essere corrette quando, nell'ottobre 1884, Ricotti fu nominato Ministro della Guerra : all'estero si erano già fatti i primi passi nella direzione delle armi a ripetizione ed in Italia la stampa militare cominciava a porre il problema dei fucili su basi più realistiche.
Invece, forse per non impegnare i bilanci della Guerra, lo studio italiano sui fucili non fu sollecitato né in coraggiato: a piani esigenti, la correzione di fatto proposta da Ricotti per un lungo primo tempo fu l'inerzia.
( )si raliemarono gli studi perché pareva esagerato il pagare un migliaio di lire per qualche modello di fucile estero;( ... ) venuto Ricotti, si pose ogni cosa a dormire. Dopo qualche tempo si diede di nuovo l'incarico alla Commissione di studiare; ma doveva essere uno srudio teorico, senza fare esperienza, cioè essenzialmente senza fare spese. lo credo che la Commissione avrà fano nulla, tanto più il Geo. Galieani [posto da Ricotti a capo di quella Commissione) si vantava, qualche tempo prima, di aver seppellito la questione delle armi a ripetizione bocciando tutti i sistemi s u cui la Commissione decideva. Forse, quando avrà saputo che Ricotti non era più tanto contrario agli studi, avrà cambiato parere, ma è certo che sino adesso abbiamo fatto poco e nulla. Invece la questione è già riso Ira presso le altre Potenze l 9.
La responsabilità che Ricotti si era assunto nel ritardare gli studi sull'ar ma a ripetizione italiana era assai grande. Anche su ll 'onda dei segnali di inasprimento del clima diplomatico europeo, più di un settore dell'ambiente militare dovette rimanere scontento di tale comportamento del Ministro; la stampa d'irtformazione militare sollevò a più riprese l'argomento 20. Fu così che, all'incirca nel 1886, Ricotti imp resse (sia pure con i limiti che abbiamo visto) un qual certo nuovo impulso agli studi della Commissione per i fucili. Ma gli studi tardavano a concretizzarsi nell'adozione di questa o quell'arma.
18 Ibidem.
19 Ibidem. Per gli aspetti tecnici cfr. A. BERTOCCI, L. SALVALATICI, Armamento individuale deU'esercito piemontese e italiano 1814-1914. Firenze, 1978.
2° Cfr. tra l'altro cL' esercito italiano•, 7 agosto 1886 , Le armi a ripetizione, ed anche ivi, 12 agosto 1886 , Ancora del fucile a n'petizione.
LE
RAGIONI DEllA CADUTA DI UN MINISTRO 233
Ma sempre più preoccupanti erano le notizie che nel frattempo stavano arrivando dagli addetti militari.
L'addetto militare a Vienna aveva segnalato già nello scorcio nel 1885 un «periodo di maggiore attività» 21 e poi l'avvio di un «largo esperimento» 22 di armi a ripetizione presso l 'esercito asburgico. Faceva notare anche, con rammarico, che da tempo egli aveva contattato personalmente l'inventore Mannlicher - la cui arma a ripetizione venne adottata in Austria- e che con questo aveva concordato l'acquisto di quattro modelli del suo fucile: modelli che avrebbero potuto essere di grand e utilità agli studi in Italia. Mannlicher, dopo aver inviato il primo dei quattro modelli, aveva atteso il compenso pattuito: ma questo, responsabile il Ministero della Guerra, non venne mai, cosicché l'inventore tedesco - forse sentendosi truffato - non inviò gli altri fucili richiesti e la Commissione italiana non poté effettuare gli studi necessari 23. L'addetto militare a Parigi scriveva poi che in Francia gli studi erano molto avanzati, anche se parevano rallentati da un dibattito sono n eU' esercito tra Artiglieria e Fanteria, con un «antagonismo tra l'Arma incaricata di confezi onare le armi e le munizioni e quella che deve servirsene• 24 Seppure in queste forme singolari, il dibattito francese ricalcava quello europeo con la sua divisione tra i sostenitori di armi a rip etizione ottenute trasformando i vecchi fucili e i fautori della costruzione di una intera nuova serie di armi a ripetizione, con calibro minore di quelli allora in dotazione.
Ma le notizie più impressionanti arrivavano dalla Germania, dove sin dal 1882 erano in corso gli esperimenti per armi a ripetizione e dove già col1885 si era avviata a pieno regime la produzione di una nuova serie di fucili nelle fabbriche militari (a Spandau, a Danzica, ad Erfun). A Berlino si pensava di non riadattare vecchi fucili ma di costruirne nu ovi con il sistema cMauser trasformato• e si era deciso di armare con i nuovi fucili non solo la prima linea dell'esercito permanente, ma in prospettiva anche la seconda e la terza linea 25.
21 AUSSME, Addetti militan·. Austria, racc. 4, 20 novembre 1885. Anche se talvolta impreciso (e comunque limitato alle sole sedi di Vi enna e Berlino tra 1882 e 1915 ), cfr. un elenco degli addetti militari italiani compilato da S. LOI, L 'iTTede ntismo all'inizio del secolo in alti di archivi ufficiali e privati, in cMemorie storiche militari 1979,., Roma, 1980, p. 335.
22 lvi, 2 febbraio 1886.
23 lvi, 26 novembre 1886.
24 AUSSME, Addelli mililan·. Francia, racc. 4, fase. 2, 7 febbraio 1885.
25 Cfr. AUSSME, Addetti mililan·. Germania, racc. 4, fase. 3a, 10 febbraio 1886.

234 POUllCA E POUllCA M1UTARE
Di mese in mese , dal febbraio all'aprile 26 all'agosto del 1886 , l ' addetto militare a Berlino precisò i contorni dell ' operazione tedesca: a metà dell'estate l'addetto scrisse (dopo aver avuto notizia che una notevole quantità di nuovi fucili era già stata approntata) che Germania si trova ora ad avere un vantaggio sulla Francia in questa quistione e credo che penserà a conservarlo:. 2 7. In settembre si venne a sapere che i corpi d'armata tedeschi schierati alla frontiera francese erano già stati tutti riforniti delle nuove armi e che «sembra si abbia l ' intenzione di spingere la fabbricazione , in modo di avere per la primavera ventura la po ss ibilità di armare di fucili a ripetizione tutto l ' esercito di prima linea:. 28. La scadenza indicata non era posta a caso. Per il deteriorarsi della situazione diplomati ca, molti a Berlino e nelle capitali europee erano convinti della «necessità di trovarsi pronti ad ogni eventualità fino dalla primavera del corrente anno» - come sc riveva l'addetto militare nel gennaio del 1887 , aggiungendo con preoccupazione che a Berlino si parlava in quelle settimane senza remore di cuna guerra se n ò n pro babile almeno poss ibile nella prossima primavera:. 29

Alla luce di queste notizie , e di altre analoghe che giungevano da Vienna 30 e da Pietro burgo 3 1 , ancora più grave appare la responsabilità di Ricotti nel n o n aver voluto o sapu to capire l ' impon.anza della posta in gioco con la questione dei fucili a ripeti z ione . Proprio quando , per l'immediata adozione dei fucili a ripetizion e, si era schierato un ampio ventaglio di forze. Non solo organi di stampa militari , che pure spesso tornavano in quei mesi sull'argomento , ma anche impon.anti quotidiani politici si interessavan o di fu cili 32 .
Fu così che in fo ndo la stess a decisione del Ministro (del gen-
26 lvi, 24 a p rile 1886.
27 lvi, 11 agosto 1886.
28 lvi, 22 sett em b re 1886.
29 l vi, fase . 3b , 16 gennaio 1887.
3° Cfr. AU SSME , A d detti m ilitan· Austria , racc. 5, fase. l, l agosto 1886 ; ed ivi, 19 novem b re 1886.
3! Cfr. AUSSME, Addetti mili111n·. Russia, racc. 2, (30 ottobre) 11 novemb re 1886, ed ivi, (13 aprile) 25 aprile 1886.
32 Cfr. u a gli altri le collezioni de cil popolo romano• tra luglio, agosto e settembre 1886, quando le richieste politiche per un nuovo e più moderno armamento della Fanteria si congiunse ro e si sovrapposero con quelle militari (della Marina) in favore d elle corazzate e conuo le torpedinie re e con quelle diplomatiche per il rinnovo della Triplice. G rande interesse p er i temi oavaJistici e della Marina Militare mostravano anche organi di stam p a conservatori come cL'Opinion e• o cLa Perseveranza..
LE RAGIONI DELLA
235
CADUTA DI UN MINISTRO
naio 1887} di adottare in Italia un modello trasformato del vecchio Wetterly, denominato 'Wetterly-Vitali modello 1870-87', apparve tardiva ed approssimata 33.
Il nuovo modello non era certo l' optimum: la discontinuità degli studi italiani poi non fece la fortuna del Wetterly- Vitali. Solo quattro anni dopo, il Ministro della Guerra allora in carica decise infatti di sostituire il modello 1870-87 con un nuovo 'mode llo 1891', che accompagnò poi sostanzialmente la Fanteria italiana sino alla seconda guerra mondiale 34.
Alla decisione 'i o extremis' del novarese (la ci rcolare di adozione del mod. 1870-8 7 comparve sul «Giornale Militare Ufficiale» solo due giorni prima del massacro di Do gali) non doveva inoltre essere estranea la volontà di Ricotti di attenu are quel certo malcontento, che come si è visto si era nel frattempo andato diffondendo nelle file dell'esercito.
Qualche giorno prima, il bene informato Guiccioli aveva scritto nel suo diario
( ) incontro il generale Bertolè, anche lui Jcontenlo per il modo come procedono le cose Egli prevede la guerra a primavera. e dice ch e il Ministro Ricolli negli ultimi due anni ha fatto poco, e che ora deve r iparare in fretta e alla meglio 35.
Benolè Viale non era una personalità quals iasi: già Ministro della Guerra e autorevole esponente del 'partito di Corte' fu proprio il militare poi chiamato a sostituire il novarese alla Pilotta. Se esplicita era l a critica di Bertolè (forse anche della Corona?) verso Ricotti, anche lo stesso suo insistere su un pericolo di guerra non può dirsi strano o eccemnco.
Durante il periodo della permanenza mini steriale di Ricotti si erano infatti sempre più rinnovate le voci della possibilità di conflitti armati che avrebbero co involto tutte o in parte le potenze europee. 111885, segnato dal riemergere del conflitto austro -russo , sfociò poi nella guerra serbo-bulgara che, risollevando la complicata que-

33 Cfr. C"Giornale militare ufficiale• , 23 gennaio 1887, ano n. 20.
34 Il modello 70-87 cnon poteva considerarsi che come una soluzione transitoria del problema integrale della ripetizione•. Lo ricorda lo stesso MONTO , Storia dell 'artiglieria italwna, p. Il , Dal 181.5 al 1914, v. 3, cit., p . 2099.
236 POUTICA E POUTICA
MILITARE
3) A. GUICCIOU , Diano del 1887, in cNuova amologia. , a. L938 , n. 22 , p 398. alla data dell'8 gennaio.
stione balcanica, preoccupò tutte le Cancellerie d'Europa 36.
Il 1886 fu poi tutto percorso da voci di pericoli e di apprestamenti militari di guerra. N el febbraio l'addetto militare italiano a Berlino scriveva che la Germania si stava preparando per una guerra ad est, contro la Russia: le forze alla frontiera russo -germanica erano st ate aumentate, negli ambienti militari tedeschi si andava ripetendo che - per rendere più immediata possibile l'entrata in combattimento di truppe germaniche - si sarebbero resi contemporanei il completamento e la radunata generale, mentre lo stesso movimento ferroviario delle truppe sarebbe stato fatto iniziare prima di quanto si era in altre occasioni stabilito 37. Ad aprile, le voci di guerra si appuntavano più ad occi dente , verso un conflitto con la Franc ia 38. A gennaio del 1887, come abbiamo visto, si riteneva «possibile» una guerra addirittura in primavera 39. Nel marzo lo stesso addetto comunicava che a Berlino non si sarebbe atteso, in caso di guerra, nemmeno il completamento della mobilitazione ma che le prime unità militari disponibili sarebbe ro entrate subito in combattimento 40_ Nello stesso periodo analoghe e preoccupanti notizie provenivano a Roma dalle altre capitali europee. Nel maggio 1886 l'addetto militare italiano a Pietroburgo segnalava un articolo (comparso sulla stampa russa e manifestamente ispirato dagli ambienti dello Stato Maggiore) che con minacciosa precisione indicava quale sarebbe stato lo schieramento delle forze russe nel caso ritenuto probabile di un conflitto con Austria e Germania: l'articolo, segno evidente di una lunga preparazione militare segreta, appariva volutamente assai dettagliato, con l'entità delle forze avversarie e la velocità delle m o-
36 Cfr. ALBRECHT -CARRÉ, Storia diplomatica d 'Europa 1815 - 1968 , cir., p. 221. Sull'atteggiamento delle autorità militari italiane cfr., in generale, A. BIAGINI, I militari e la politica italiana nei Balcani (1875-1912) , in L'Esercito italiano dall'unità alla grande guerra { 1861 -1918), Roma (Roma, Ti p . Regionale), 1980 (in testa al front.: Stato Maggiore dell'Esercito. Ufficio Storico), pp. 395 -428.

37 Cfr. AUSSME , Addetti militan·. Germania, racc. 4, fase 3a, 8 febbraio 1886.
38 Cfr. ivi , 27 marzo 1887.
39 lvi , fase. 3b, 17 gennaio 1887. Le voci di guerra rivelavano timori tra i politici come ua i militari. Qualcosa di simile era già accaduto nel 1870-71. E vero clne, ad esempio, con quelle date si apriva un periodo di pace concinentale europea (fattas eccezione per i Balcani): c:Eppure ( ... )l'Europa era convinta di trovarsi di france all' inizio di una lunga serie di guerre che sarebbe terminata solo con lo stabilirsi di un nuovo equilibrio». V. GALUNARI, l pn.mi quindici anni, in L 'esercito italiano dall ' u· nità alla grande guerra ( 1861-1918), cit., p. 73.
40 lvi , 17 marzo 1887.
LE RAGIONI DELLA CAD UTA DI UN MIN ISTR O 237
bilitazioni dei diversi Paesi 41 A Parigi, nel novembre, l'addetto militare notava una preoccupante diffusione di teorie guerresche e di apprestamenti militari:

Nei circoli militari , specialmente tra i giovani, si crede in una prossima guerra. Per che cosa? contro chi? Non lo sanno neppure loro. Ma si credono pronti e se lo vanno dicendo 42.
A Vienna, analogamente, l'addetto militare faceva notare che
sembra ceno che si siano fatti contrani per provviste considerevoli di oggeni di vestiario e di equipaggiamenti , che si siano adottate disposizioni per affrettare l ' istruzione della Landsturm, e che si sia anticipata (dal l aprile al 20 febbraio) la chiamata sotto le armi delle reclute assegnate alla riserva di completamento 4 3.
Con lo stesso tenore, l'addetto italiano da Berlino comunicava che, in seguito a colloqui avuti, aveva avuto la cenezza che
qualora (la Russia] fosse attaccata dalla Germania o dall'Austria [lo zar) è ben deciso a non fumare la pace che a Berlino o a Vienna ; che in caso di rovesci , egli si ritirerebbe anche fmo in Asia ma continuerebbe la guerra a qualunque costo , fino al momento in cui , rfrendendo il vantaggi o, potrebbe dettare le condizioni di una pace durevole 4 .
Più inquietanti- e direttamente coinvolgenti l'Italia- erano le informazioni provenienti da Parigi. Nella Repubblica, il cu i clima politico era riscaldato dalle sonite di Boulanger, parevano continuare gli apprestamenti militari. Nel gennaio 1886 l'addetto .militare italiano aveva reso note talune disposizioni del Ministero della Guerra francese, dal cui esame egli era convinto si potesse
dedurre chiaramente l ' intenzione di svincolare da ogni ritard o taluni nuclei di forze per modo di lanciarli immediatamente sui rispettivi obiettivi al primo cenno di mobilitazione 45.
Sempre più minacciosi i messaggi che da Parigi giunsero a Roma nei mesi successivi: a gennaio del 1887, ad esempio, l'addetto 41
238 PO UTICA E POUTICA MIUTARE
AUSSME
militan·.
, racc . 2 , (28 a prile )
42 AUSSME , Addeth' militan·. Francia , racc. 4 , 23 n o vembre
. 5 , fase . 2 ,
5 AUSSME,
militari Francia , racc . 4, fase . 3. 27
Cfr.
, Addetti
Russia
10 maggio 1886.
1886 43 AUSSME , Addetti militari. Austria , racc
18 g e nnaio 1887 . 44 lvi , 5 marzo 188 7. 4
Adde tti
gennaio 1886.
militare riportava come , alla conclusione delle manovre militari di quell ' anno , il Ministro della Guerra aveva dichiarato pubblicamente davanti alle truppe , non senza qualche allusione al teatro di guerra italo-francese, che «l ' offensiva sola permette di ottenere risultati decisivi» 46; e poi, a marzo, dopo certi suoi colloqui con il Ministro della Marina Militare francese in persona, l'addetto riferiva come quello avesse dichiarato che «qualora scoppiasse una guerra , sarebbe cond o tta colla massima ferocia anche per mare • 47.
Questa era la realtà delle rela.zioni internazionali di quel periodo e questo era il tipo di problemi cui doveva apprestare una risposta di parte italiana , dal lato militare , il Ministro della Guerra Ricotti . Questo è uno dei m o tivi per cui, per esempio , an che un semplice ritardo nello srudio di alcuni modelli di nuovi fucili poteva risultare esiziale. Questo era, infine, la radice della gravità per l'Italia di avere un sistema militare che, in materia di ordinamento, fortificazioni , strategie, lasciasse in parte a desiderare.
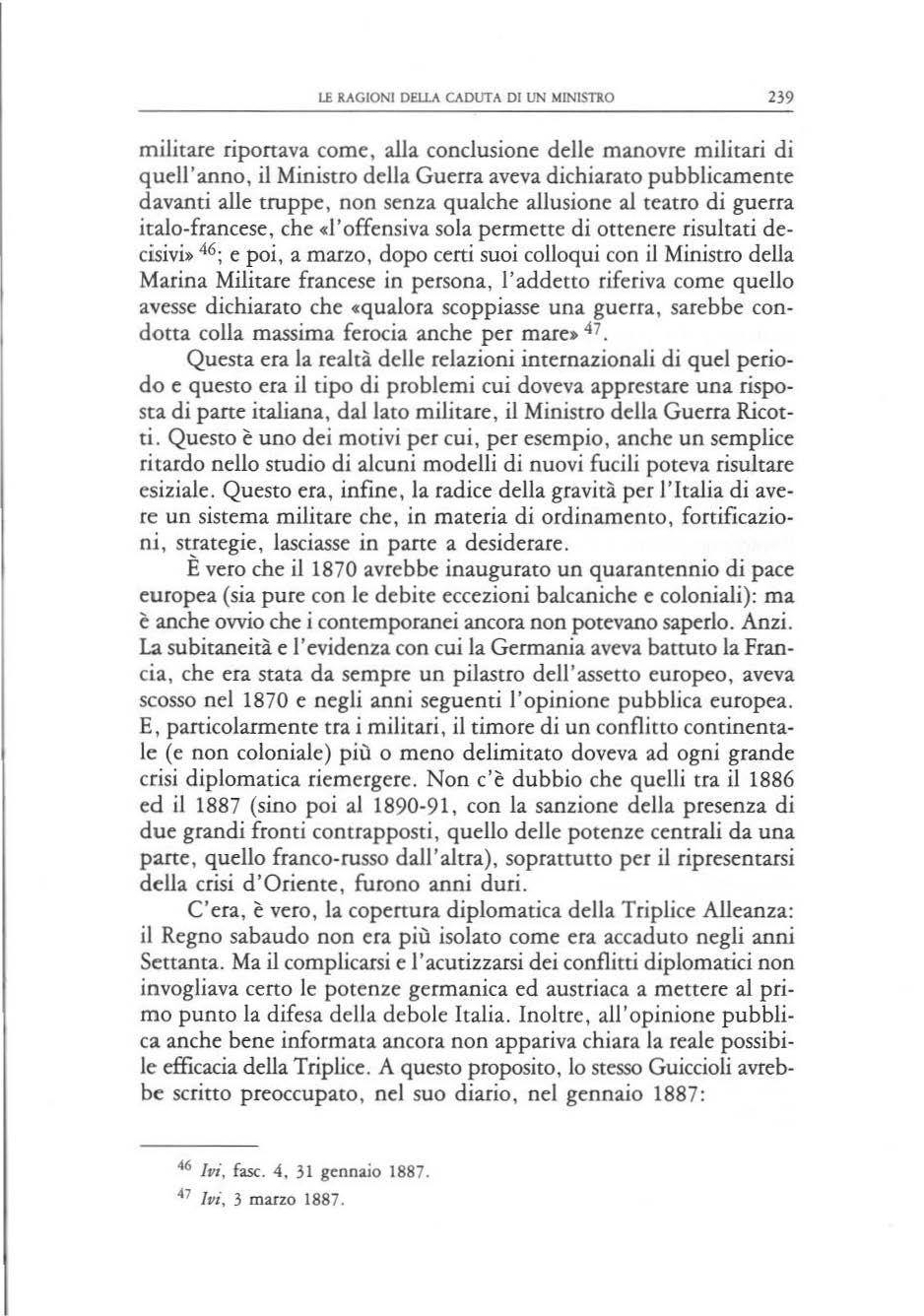
È vero che il 18 70 avrebbe inaugurato un quarantennio di pace europea (sia pure con le debite eccezioni balcaniche e coloniali): ma è anche ovvio che i conte mporanei ancora non potevano saperlo. Anzi . La subitaneità e l ' evidenza con cui la Germania aveva batruto la Franc ia , che era stata da sempre un pilastro dell ' assetto e uropeo , aveva sc osso nel 1870 e negli anni seguenti l'opinion e pubblica europea. E, particolarmente tra i militari, il timore di un conflitto continentale (e non coloniale) più o meno delimitato doveva ad ogni grande crisi diplomatica riemergere. Non c'è dubbio che quelli tra il 1886 ed il 1887 (sino poi al 18 90-91, con la sanzione della presenza di due grandi fronti contrapposti , quello delle potenz e centrali da una parte , quello franco-russ o dall ' altra ), soprattutto p e r il ripresentarsi della crisi d ' Oriente , fur o no anni duri.
C'era , è vero , la copertura diplomati ca della Tripli ce Alleanza: il Re gno sabaudo non era più isolato come era acc adut o negli anni Settanta. Ma il complicarsi e l'acutizzarsi dei conflitti diplomatici non invogliava certo le potenze germanica ed austriaca a mettere al primo punto la difesa della d e bole Italia. Inoltre, all'opinione pubblica anche bene informata an cora non appariva chiara la reale possibile efficacia della Triplice . A questo proposito , lo stesso Guiccioli avrebbe scritto preoccupato , nel suo diario , nel gennai o 188 7 :
LE RAGIONI OEU.A CADl!TA 01 UN MINISTRO 239
46 lvi , fase. 4, 31 gennaio 1887. 47 l vi , 3 marzo 1887.
Le relazioni tra la Germania e l'Austria rimangono piene di incognite. Se la lotta di influenze tra l'Austria e la Russia in Oriente non interessa la Germania, e se un evemuale conflitto tra questa e la Francia non dovesse interessare l'Austria, qual ' è dunque la questione che le interessa entrambe e in ragione della quale fu fatta l'alleanza? 48.
Anche senza risalire direttamente ai trattati ed alle alleanze l'opinione pubblica e la classe politica erano seriamente preoccupate dal progresso tecnico degli armamenti europei come dal deteriorarsi della situazione internazionale 49, di cui le voci di guerra non erano che l'estrema espressione. Di fronte a queste 'voci di guerra', se anche per motivi finanziari non si fosse potuto armare tutto l'esercito con i nuovi fucili, se anche- come diceva Ricotti- l'armamento promiscuo di reparti militari poteva far più danno di un vecchio ma omogeneo equipaggiamento, qualcosa andava pur fatto, sosteneva l'opinione pubblica e una parte importante dei militari. E non è improbabile che anche in questo senso si fosse espresso il Capo di Stato Maggiore dell'Esercito.
Ecco perché i ritardi del Ministro della Guerra circa gli studi e l'adozione di fucili a ripetizione dovevano apparire in giustificati all' opinione pubblica e ai politici 50.
D i fronte a questi ritardi tecnico-militari, soprattutto, dovevano risultare ai contemporanei tanto più incomprensibili e negat ivi gli interessamenti di Ricotti in un'altra direzione, più 'pacifica' (e meno impegnativa finanziariamente) cui pure Ministro e Segretario Generale avevano dimostrato di tenere particolarmente: quella per una 'educazione militare nazionale'.
Sotto questa definizione si volevano allora ricondurre vari provvedimenti che erano tesi ad aumentare e val orizzare il ruolo dell'esercito nella società civile. Per questo scopo le forze armate avevano due mezzi, interni ed esterni.
AH' interno dell'esercito furono quelli gli anni di un rinnovato
48 GUICCIOU, Diario del 1887, cit., p. 398, alla data del 14 gennaio.

49 Cfr. gli allarmati anicoli ne cii popolo romano», 24 dicembre 1886, Le voci di guemz, ed ivi, 31 dicembre 1886, C'è la guerra in vista?. Ma cfr. anche «L'Opinione», 19 novembre 1886 , La mobtfitazione delle truppe russe. Ad un simile proposito, assai efficacemente scrive Eric Hobsbawm: «L'assenza di guecra può combinarsi col timore permanente di essa•. E.). HOBSBAWM, Il trionfo della borghesia 1848-1875, (1975), Bari, Laterza, 1976, p . 100.
Cfr. ad esempio ivi, 9 agosto 1886, La guerra in tempo dz. pace.
240 POLITICA E POLITICA MIUTARE
ime resse verso l'educazione militare del soldato di leva 5I.
All'esterno, l 'esercito tentò l'allargamento della presenza militare in vari gangli ed istituzio ni pubbliche, a partire dalla scuola ed in gene rale nella stampa, per promuovere una più vigorosa 'educazione militare' ed una più profonda diffusione del 'sentimento militare' o 'spirito militare': le definizioni del tempo erano piuttosto imp recise) nella società civi le.
Di tali programmi , per più versi, proprio Nicola Marselli - allora Segretario Generale al Ministero della Guerra - può essere considerato uno degli artefici 52.
Erano programmi che già so lo qualche anno dopo potevano apparire -a molti - «fumosi:. 53 e privi di importanza soprattUtto a quei militari che invece erano preoccupati dali' inasprirsi delle relazioni internazionali e dal diffondersi di voci di guerra. Ma erano prog rammi che meritano in qualche modo di essere qui esaminati, perché testimoniano dell'accresciuto peso d eli' esercito nella vita politica e sociale dell'Italia umbertina degli anni Ottanta (programmi simili sarebbero stati impensabili ed irrealizzabili pochi anni dopo Custaza) e della costante funzione interna e di mantenimento dell'ordine sociale e istituzionale cui anche in Italia l ' Esercito assolveva. Sulle forme e gli scopi d eli' educazione militare del soldato vari furono i militari che a più riprese intervennero sulle pagine della «Rivista mi litare italiana. 54 , intrecciando tra loro anche un ceno dibattito. Ma il provvedimento di gran lunga più noto fu quello del con-
51 Ricorrenti, neUc riviste tecniche, i contributi e gli articoli su questi temi. Tra l'alcro cfr. A. MAZZOLENI , Comiderazioni circa l'islrUzione e l'educazione militare da darsi al soldato di fanteria, in c.Rivisca militare italiana., a. 1886, n. 8 e n IO, ed anche A. MASSA , Ammaestramento militare individuale, in ivi, a. 1887, n. l. L'attenzione dei militari cadeva anche su aspetti singolari: cfr. G BERTELLI , In caserma e fuon·: il turpiloquio della truppa, in ivi, a. 1885 , n 11.
52 Cfr. T. MARIOTTI , Dei più recenti provvedimenti sull'edu cazione e l'islrUzio ne militare in Italia , in cNuova antologia., a. 188 7, n. 5, pp. 87-113, ed ivi, a. 1887, n. 6, pp. 270-300. Cfr. anche MARSELLI, La vita del reggimento, cit., p. 99 e sgg.
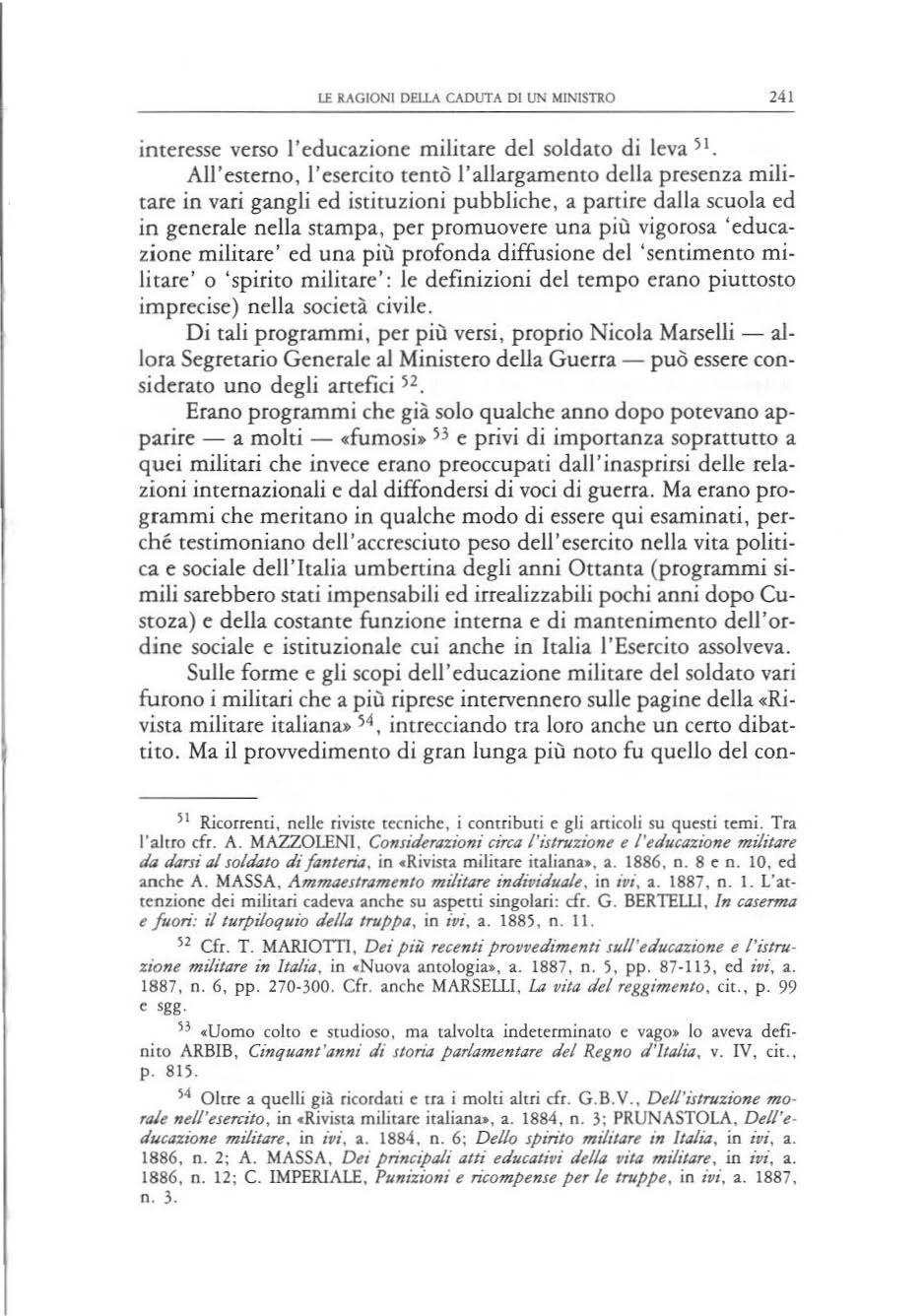
B «Uomo colto e studioso, ma talvolta indeterminato e vago• lo aveva definito ARBIB, Cinquant 'anni di storia parlamentare del Regno d'Italia, v. IV, cit., p. 815.
54 Olrre a quelli già ri cordati e tra i molti altri cfr. G.B.V., Dell'istruzione m orale nell'esercito, in c.Ri vista militare italiana. , a 1884, n 3; PRUNASTOLA, Dell'educazione militare, in ivi, a. 1884, n. 6; Dello spirito militare in Italia, in ivi, a 1886, n. 2; A. MASSA , Det principali atti educativi della vita militare, in ivi, a 1886, n. 12; C. IMPERIALE , Punizioni e n compense per le lrUppe, in ivi, a. 1887, n. 3.
LE RAGIONI
241
DEllA CADliTA DI UN MJNISTRO
corso per il miglior 'libro del soldato' 55. Questo libro avrebbe dovuto rappresentare aJ giovane militare gli scopi morali e civili del suo obbligo di leva e contribuire (nell ' Italia di quegli anni, sempre più percorsa da movimenti contadini e operai) a diffondere nella truppa sentimenti di ordine e disciplina, non alieni da una cena comprensione per il credo religioso 56 Anche non volendo ironizzare sul fatto che una grande pane dei soldati del tempo erano ancora analfabeti (nonostante lo sforzo - dove ancora funzionavano- delle vecchie scuole reggimentali) 57 e che quindi il! libro del soldato non avrebbe potuto essere efficace e raggiungere il suo bersaglio senza la mediazione -sociale e culturale - del sottufficiale o dell'ufficiale di compagnia che quel libro avrebbero letto al soldato, non deve sfuggire l'importanza e la intelligente tempestività della scelta politica ministeriale nell'Italia degli anni della crisi agraria. Il provvedimento, inoltre , si inseriva in una serie di altre misure (incoraggiamento delle 'conferenze reggimentali', spinta per la stesura di storie di corpo, etc.) ss che tutte tendevano a rinforzare le basi per una ' letteratura militare ' di cui nel Paese gli organi di informazione militare dicevano di «sentire la mancanza» 59 . Altri provvedimenti ancora nel
55 Cfr. «Giornale militare l dicembre 1885, atto n. 191.

56 Cfr. anche E. FANCHIOTII , Illzbro di lettura pel soldato italiano, in «Rivista militare italiana», a. 1886 , n. 2.
57 Accenna al rapporto rra scuole reggimentali e corpo elettorale (e cioè alla loro valenza poliùca) P. VILLANI, Gruppi sociali e classe dirigente all'indomani dell ' unità , in Storia d'Italia, Annale l , Dal feudalesimo al capitalismo, Torino , Einaudi , 1978 , pp. 881-980.
58 Cfr. MARIOm, Deipiù recenti provvedimenti sull'educazione e istruzione militare in Italia , cit. In si n to nia coi t empi, già si era mosso in questo senso Telesforo Sarù, componendo dell'esercito italiano («l'unica radiosa poesia patriottica non contaminata ancora dal soffio delle passioni partigiane», egli diceva) c:una storia popolare da servire di sana lettura e d 'o pportUno ammaestramento alle generazioni venute tardi e ai cittadini che sono dalla patria chiamati a prestare servizio in quei corpi ( ... ) Taie istoria ci infiammerebbe tutti.-. T. SARTI , Storia dell 'eserc-ito italiano dalla costituzione dei suoi van· corpi ad oggi narrata su documenti , Roma , Paolini , 1884, v. I , p. 4 e p .
7 . Anche così era intesa la storia militare , a quel tempo.
59 C'era anche chi metteva in guardia dal pericolo di un 'o ndata di vuota retorica: «Il nostro ambiente poliùco-militare è poco adatto a far fiorire una letteratura robusta e non manierata•. «L'esercito italiano• , 8 gennaio 1886 , l/libro di lettura pel soldato italiano. Sotto la retorica, talvolta , negli opuscoli diretti ai coscritù , si celeva un programma politico di fondo, conservatore. Considerando «il soldatO come un bambino• , l'oscuro tenente A. Caldemaro sentenziava che ogni giovane cdeve apprendere ad essere forre e guerriero col catechismo militare , come apprende ad essere laborioso ed onesto col catechismo cristiano:.. Le messe ai batt aglioni dopo Dogali e i tricolori nelle chiese del1887 non erano naù per incanto. A. CALDEMARO , il catechismo militare , ossia la morale e il diritto spiegati al popolo e al soldato , Alba, Marengo , 1880 , p 9 e p. 6.
242 POUTICA E POUTICA MiliTARE
senso della «educazione militare nazionale• furono quelli della fondazione del giornale c:La caserma. (diretto esplicitamente ai soldati ed ai sottufficiali) e della militarizzazione di alcuni collegi (o convitti nazionali) 60.
Purtroppo, il difetto princ ipal e di molte di queste iniziative per la 'educazione militare nazionale' fu quello di non riuscire a suscitare per la loro realizzazione energie sufficienti (energie intellettuali e politiche - soprattutto - che non fossero già militari): la maggior diffusione del sentimento militare rimase così in larga parte so lo un programma ideale ed una petizione di princìpi e quantO della maggior diffusione dello spiritO militare nel Paese si realizzò, lo si dovette forse ad altre concomitanti cause (operazioni co l oniali, mito di Dogali, aggravarsi della crisi internazionale, atteggiamento della stampa, etc.) piuttosto che ai programmi ministeriali. Sebbene una tale questione sia ancora in buona parte da studiare, si potrebbe dire che se scopo di Ricotti e di Marselli era stato quello di attivizzare il Corpo Ufficiali nel suo complesso il risultato dovette essere ceno assai inferiore alle l oro aspettative. Così, almeno, pare si possa desumere da un primo esame della scarsa produzione ufficiale delle riviste militari. Analogamente si potrebbe dire delle pubblicazioni varie che su questi argomenti furono edite in quegli anni in forma diversa (opuscoli, articoli per periodici e quotidiani, etc.): da cui anzi pare di evincere un qualche interesse per i temi della 'educazione militare nazionale' più da parte di civi li che da parte di militari in servizio.
Poche quindi furono le e nergie cercate in questo senso al di fuori del mondo militare 6 1 Per questo motivo , in ultima analisi, il concorso per il libro del soldato trovò l'esito misero che ebbe.
Analoga considerazione si potrebbe fare per c:La caserma. la quale non pare abbia annoverato, tra i suoi collaboratori , civili di vaglia che soli, forse, avrebbero potuto impedire da una pane quella cena sua decadenza nel gergo, appunto, 'di caserma' e dall'altra invece quel suo essere ancora impregnata di una certa aria pedagogico-
60 Diamo di tali quesùoni solo un breve esame, a proposito di quello che è inquadrabile nell'ortica delle vicende politiche del secondo Ministero della Guerra di Cesare Ricorù. Ovvi amente, sia pur uartandosi di due iniziaùve sostanzialmente aborùte , la loro rilevanza nell'ottica di uno srudio dell'ideologia militare porrebbe essere assai più vasta.
6J A parte le vicende del co ncorso per il libro del soldato è sufficiente sfogliare le pagine delle collezioni di cla caserma. per rendersene como. A partire dal tono e dagli argomcnù degli articoli

LE RAGIONI DELLA CADUTA DI UN MINISTRO 243
paternalistica pre-smilesiana. Così «La caserma», se da una parte poteva riuscire poco gradita agli ufficiali o a quei sottufficiali che non si accontentassero della banalizzazione e della volgarizzazione propagandistica dei problemi della politica militare, dall'altra riusciva noiosa per gli stessi soldati di leva. Con il risultato che nessuno la leggeva e nessuno ne parlava (risultato questo che pare confermato anche dalla precoce scomparsa della testata) 62.
Se talvolta le energie civili non si sentivano 'cercate' come nel caso de «La caserma», in altre occasioni esse si potevano ritenere addirittura combattute dai programmi della 'educazione militare nazionale'. Era questo il caso della militarizzazione dei convitti nazionali. Non considerando qui la questione dal punto di vista dei suoi risultati nel reclutamento di nuovi ufficiali (che, a quanto pare, non furono cattivi, ma comunque assolutamente trascurati dalla polemica del tempo) 63, deve essere ricordato come invece le iniziative di Ricotti per la militarizzazione di quei tre o quattro convitti statali in tutta Italia sollevò discussioni a non finire sulla stampa 64 e perfino in Parlamento. Al fondo di queste discussioni stava la protesta di pedagogh i e di insegnanti contro quella che era vista come una invadenza dei princìpi e della disciplina militare nelle scuole 65. È vero che in parte di queste reazioni si poteva leggere il risentimento di taluni interessi corporativi colpiti, o talune poco edificanti proteste degli insegnanti clericali che vedevano con timore la possibilità di un intervento statale (attraverso l'esercito) in quel settore scolastico che era ancora in gran parte sotto il loro controllo 66. Ma è evidente a chiunque legga quegli interventi pubblicistici o parlamentari come in tutti si ritrovasse al fondo la stessa protesta contro l' invadenza dei metodi 'militari' rispetto a quelli - modernamente e 'positivamente' - civili. E da qui le varie campagne contro il rigorismo della disciplina militare e iJ settorialismo militare della formazione culturale degli ufficiali, rispetto ai grandi valori degli insegnamenti
62 La rivista durò solo dal 1886 al 1888 e editò nel complesso solo un centinaio d i numeri, tutti di piccolo formato e composti con co rpo tipografico assai grosso.
63 Cfr. DEL NEGRO, Ufficiali di camàa e ufficiali di complemento nell'esercito italiano della grande guerra: la provenienza regionale, ci t . , p. 275.
64 Cfr. tra l'altro E PELUCClANTE, L 'edu cazione militare nei convitti naziona · li, in «Nuova antologia•, a. 1886 , o. 18 , pp. 214 - 250.

6S Cfr. AA. PP., Camera, Legisl. XV, sess. unica, Discussioni, tornata del 10 g i ugno 1885, con interventi di Coppioo, Bovio, Dotto de' Dauli, Costancini, Luchini
66 Cfr. ivi.
244 POLITICA E POLITICA MILITARE
umanistici, campagne che in non poche occasioni parevano mettere in difficoltà il mondo militare o i suoi rappresentanti 67.
Se si considera quindi il sostanziale fallimento dei programmi per la «educazione militare nazionale», non si possono non comprendere i sentimenti e le proteste di quegli ambienti militari che parevano assai più preoccupati della crisi internazionale e dei progressi degli armame n ti europei che dell'urgenza di educare moralmente il soldato .
Ricompariva, anche sotto ques t a forma, il già noto contrasto tra 'numeristi' e fautori dell'esercito 'offensivo' 68. Non che le due cose e i due programmi venissero messi appositamente in alternativa, ché anzi- quando si trattava poi di difendere l'Esercito dalle polemiche dei 'civili', come accadde per la questione dei 'convitti nazionali' - t u tti i militari facevano fronte compatto 69. Ma era un dato di fatto che queste due d i verse tendenze militari rivelavano chiaramente due diversi ordini di idee e di priorità ali' interno dello stesso mondo militare.
Ricotti, in quella sua 'sosta' militare che era anche stabilizzazione finanziaria, ovviamente, era più incline a favori re i vaghi programmi per la 'educazione militare nazionale' piuttosto che i cosrosi ed impegnativi programmi di riarmo che i sostenitOri dei 'fucili a ripetizione subito' parevano suggerirgli. Certo non avrebbe raggiunto lo stesso risultato, né se lo proponeva. Il fatto era che ai suoi occhi e con quei bilanci una cosa si poteva fare ed un'altra no: che era proprio quello che i suoi oppositori gli contestavano.
Poi, come si è visto, durame il 1886, il Ministro dovette forzatame n te permettere un più concreto e proficuo studio per i fucili a ripetizione. Ma a quel punto il provvedimento non appariva come una sua decisione bensì come una conquista di chi per tanto tempo lo aveva ad alta voce richiestO: ed invece di andare nella colonna dei guadagni della sua gestione, la questione dei fucili doveva iscriversi
67 Cfr. «L'esercito italiano», 27 agostO 1886, Utili confronti.

68 Cfr. ivi, 19 settembre 1886, Pensiamo all'esercito. La stampa militare affermava che si stava profilando per l'Italia , il cui esercito era considerato «poco offensivo•, il «pericolo di non essere conside rati dagli alleati». Alcuni articoli apparsi su questo giornale potrebbero far pensare ad un tentativo , da parte di determinati ambienti rmlitan·, di influenzare l'orientamento politico e diplomatico italiano proprio in quelle se tti mane in cui si andavano ponendo alla Consulta le basi per il rinnovo della Triplice. Cfr. anche ivi, 25 settembre 1886, La politica estera dell'Italia; ivi, 9 novembre 1886, Il nuovo indirizzo militare , ed ivi, 8 dicembre 1886, Le alleanze dell'Italia.
69 Cfr. «L'Italia militare :. , 24 novembre 1886, Convitti nazionali e militari: dati.
LE RAGIONI DEllA CADUTA DI UN MINISTRO 245
in quella delle perdite .
Anche se forse non era in realtà esattamente così , questo era il modo con cui tale decisione venne allora accolta dal mondo militare. Politici e mtlitari contro Ricotti
È necessario adesso riprendere il fi l o della narrazione , da noi interrotto con le elezioni del 1886.
Da quella tornata elettorale era uscita una Camera più conservatrice e più sensibile ai miti della politica di ' potenza' della preparazione militare nazionale. L'incremento della presenza di deputati meridionali e il rafforzamento della Destra dissidente rendevano poi sempre meno ampi i margini di manovra per il trasformismo depretisiano. Inoltre , varie grosse questioni (diplomatiche , politiche, finanziarie) potevano sempre meno essere dilazionate ed il loro necessario esame non avrebbe mancato di dividere o indebolire la maggioranza ministeriale . li programma di Ricotti , sempre più schiacciato sulle compatibilità politiche e finanziarie del trasformismo, do. . veva pnma o po1 nsenurne.
Sul momento , però , Ricotti parve poter avvalersi di questa nuova situazione politica. Come vedremo, ci fu anche chi parlò di fine della 'sosta'; questo atteggiamento, quasi un accenno di 'nuovo corso', del Ministro della Guerra è desumibile anche da certi segnali lanciati dalla stampa militare. La questione su cui apparve più evidente questo apparente ripensamento di Ricotti era quella della costituzione organica dell ' Esercito e della necessità di aumento delle Armi di Cavalleria e di Artiglieria .
Tale questione delle Armi speciali aveva finito per divenire forse la discriminante tra i sostenitori del Ministro ed i suoi oppositori , politici e militari 1 . C'erano state, come abbiamo visto, discussioni anche sulla questione finanziaria e sul fatto che Ricotti era assolutamente restio (ed impossibilitato) ad aumentare i bilanci militari. Ma queste (un po' anche perché ripetevano l'ormai logoro copione dell' opposizione di Sinistra che chiedeva maggiori stanziamenti finanziari di quelli concessi dal Governo) non sembravano avere la forza critica che inve ce avev a quella delle Armi sp e ciali.

246 POUTICA E POUTICA
Mll.lTAltE
1 Cfr. a ncora VENTURlNI , Politici e mi/illiri nell'Italia umbertina , cit., pp. 213-214.
In realtà, anche l'aumento di Cavalleria e Artiglieria era cosa vecchia. La sua origine oggettiva stava nel fatto che le riforme organiche degli anni Settanta, non avevano avuto i margini finanziari sufficienti per potere aumentare gli organici di Cavalleria e di Artiglieria in maniera proporzionale agli aumenti che invece aveva subìto, nella sua forza di pace e di guerra, la Fanteria 2 . Negli anni successivi non era stato possibile (né si era voluto) fare molto di meglio. Nonostante le raccomandazioni di militari come Luigi Mezzacapo 3, anche al momento del varo del nuovo ordinamento Ferrero, le due Armi speciali non furono granché beneficiate 4 Nel giugno 1884, però, sempre sotto l'Amministrazione Ferrero fu avanzato un progetto di legge che - riprendendo le proposte più volte riaffermate in varie occasioni negli ambienti militarisi riproponeva di aumentare alquanto gli organici delle due Armi 5. Questo progetto di legge però suscitò in ambienti politici e militari vari risentimenti. Ricotti criticò pubblicamente il Ministro della Guerra e affermò che lo avrebbe ritirato preferendo a quello altri provvedimenti in favore della Fanteria. Nasceva così, come si è visto, il tema della 'sosta'. Soprattutto per il ritiro del progetto di legge sulle Armi speciali, poi, si diffuse rapidamente la formula di Ricotti come 'anti-Ferrero', come Ministro contrario all'indirizzo della politica militare dal 1876 6_
Un tale giudizio evidentemente è lungi dal poter essere oggi accolto senza qualche precauzione. Non è infatti accettabile la visione di chi ha voluto vedere con la nomina di Ric ott i un ribaltamento della politica militare 'della Sinistra' che, in queste forme assolute, era lungi dall'esistere 7. Per dirla con una battuta, il trasformismo ci fu per
2 Cfr. ROCHAT, MASSOBRIO, Breve storia dell 'esercito italiano dai 1861 a/1943 , cit .• p. 89.
3 Cfr. MINNITI, Esercito e politica da Porta Pia alla Tnplice Alleanza , cit., pp. 85-86.
4 Cfr. GALUNARI, La politica militare della Sinistra stanca 1876-1877, cit., pp. 79-80.

5 Cfr. AA.PP., Camera , Legisl. XV, sess. unica, Documenti, n. 181.
6 Già Carlo Corsi, dopo un esame dei risultati dell'amministrazione Ferrero, ricordava come «Ricotti [fosse) rimasto sempre a capo dell'opposizione militare». CORSI , Italia 1870 -1895, cit., p. 279.
7 Cfr. GALUNARI, La politt'ca mtfitare della Sinistra storica 1876 - 1877 , cit .. Già ROCHAT , MASSOBRIO , Breve storia dell 'esercito italiano da/1861 a/1943, cit. , p. 73, avevano notato come (per l'Italia liberale e a proposito dell'atteggiamento politico di fronte alle spese militari) le espressioni 'Destra' e 'Sinistra' non siano da intendersi in forma univoca e schematica.
LE RAGIONI DEU.A CADUTA
247
DI UN MINISTRO
Ricotti come c'era stato per Ferrera . Solo che ìl trasforrllismo politico degli anni di Ricotti aveva margini finanziari più stretti di quelli che i suoi predecessori avevano conosciuto. La questione dell'aumento dell'Artiglieria e Cavalleria si incagliò, negli anni del secondo Ministero Ricotti, oltre che nelle visioni personali del Ministro, proprio in quei margini . Anche chi ha stu<:liato più da vicino la politica militare dell'amministrazione Ferrera ha notato la mediazione ed i patteggiamenti, tra militari e tra politici e militari, che pure in quegli anni sì verificarono 8 Come !ungi dall'essere omogeneo ed intransigente era lo stesso 'programma' di Luigi Mezzacapo 9.
La questione, per essere compresa nella sua importanza di quegli anni piuttosto che tra i soli militari, andrebbe inquadrata nel più vasto scenario dei rapporti tra militari e politici.
Infatti il tema dell'aumento delle Armi di Cavalleria e di Artiglieria dopo la nomina ministeriale di Ricotti, aveva avuto una singolare fortuna nel mondo politico 10.
Questa richiesta militare, originariamente, aveva la sua ragìon d'essere nella volontà di meglio proporzionare la forza delle Armi speciali a quella della Fanteria italiana secondo i modelli ed i rapporti più generalmente accettati allora in Europa 11 . E, come si è visto, era una richiesta che non aveva già allora meno di dieci anni di vtta.
Negli anni del secondo Ministero Ricotti essa acquistò però altre - e non sempre congrue - valenze.
La prima, meno elegante, era quella per cui in allargamento dei quadri avrebbe aiutato gli ufficiali di quelle due Armi a percorrere carriere più veloci 12.
La seconda, era quella che un aumento di quelle due Armi, peraltro da effettuarsi in proporzioni non sempre univocamente e chiaramente stabilite, avrebbe consentito all'esercito italiano di assumere un atteggiamento, uno spirito ed una strategia 'offensiva' 13.
La terza, più cruda ma forse più di tutte le altre reale, era che
8 Cfr. VENTURINI, Politici e mzfùan· nell'Italia umbertina, cit. , pp. 195 - 196

9 Per la definizione di 'programma' (in realtà un po' ambiziosa e benevola) cfr. MINNITI , Esercito e polùica da Porta Pia alla Tnplice Alleanza , cir. , pp. 71-72 .
1° Cfr. già VENTURINI , Politici e mzlitari n ell'Italia umbertina , cit. , p. 213.
11 Cfr. HOWARD, Le forz e arma te , cit ., p. 263 .
12 Cfr. tra gli altri opuscoli Le armi speciali e l'avanzamento , Milano, Galli, 1884 .
13 Esemplare, in questo senso, «L'esercito italiano», 7 senemb re 1886, Le zdee positive dell 'Esercito Italian o .
248 POUTICA E POUTI CA MIUTARE
obbligare politicamente il Ministro ad aumentare quelle due Armi per cui egli non vedeva necessità immediata di aumento di sona avrebbe significato di fatto indebolirlo radicalmente, n ell'ambiente politico come in quello militare.
Di queste valenze la prima era quella più sentita in taluni ambienti militari, la seconda era quella destinata ad avere più fortuna nel dibattito pubblicistico, la terza quella più concreta e quella che alla fme, tra i politici, avrebbe giocato il ruolo più importante.
In un tale contesto, in cui tutti- tranne il Ministro- per un motivo o per un altro parevano avere un interesse a chieder che le Armi di Cavalleria ed Artiglieria fossero aumentate , il tema era destinato a diffondersi sempre più nell'ambiente e nella stampa militare. Sempre più Ricotti, invece, pareva irrigidirsi facendone quasi una questione di partito preso, anche al di là dei ragionevoli motivi di politica militare (o fmanziaria).
È difficile rendere conto quante volte, ad esempio, un organo di stampa come «L'esercito italiano» fosse ritornato sull'argomento tra il novembre 1884 e il maggio 1886, auspicando l'au mento di Artiglieria e Cavalleria. E quante volte, dal canto suo, l' ufficiosa «L'Italia militare» vi abbia risposto sostenendo che un tale aumento era superfluo.

Qualcosa parve cambiare, forse , dopo le elezioni del maggio 1886, quando - come si è detto- ci fu anche chi parlò di nuova volontà del Ministro di andare oltre la 'sosta'. In effetti un attento esame della stampa militare ufficiosa ci restituisce l'immagine di un Ministro più dinamico, come se per la politica militare si fosse aperta co l maggio 1886 una fase di movimento.
Poco più di due settimane dopo le elezioni, l' «<talia militare» tornava a parlare dell'ordinamento militare de Il ' esercito 14 . L'argomento, che adesso era risollevato dalla discussione in sede di Commissione di un progetto di legge ministeriale 15, era fmora rimasto vessillo dell'opposizione, con i suoi progetti di aumentare Cavalleria e Artiglieria.
Già a febbraio una commissione parlamentare si era riunita, nell' ipotesi che il progetto andasse in votazione nel corso di quella legi'slarura , che poco dopo invece fu chiusa dalle elezioni. In quella sede i dissensi e le repliche si erano appuntati sul tema dell ' istituzione
14 Cfr. cL'halia militare:., 13 e 18 giugno 1886, La nostra artiglieria da montagna. IS Cfr. AA . PP ., Camera. Legis l. XV , sess. unica , D ocumenti , n. 398.
LE RAGI0/'.1 OELJ.A CADUTA DI UN MINISTRO 249
di una Scuola di applicazione per la fanteria (cosa che avrebbe allungato di altri due anni il tirocinio per gli ufficiali di quest'arma già allora duramente colpiti dalle norme per l'avanzamento) piuttosto che affrontare aspetti organici generali.
In giugno, il giornale ufficioso della Pilotta, pur non accedendo ai temi dell'aumento vero e proprio, parve disponibile a talune soluzioni intermedie: come quella dello sdoppiamento di taluni reggimenti esistenti (per l'artiglieria da montagna, per esempio) 16, cosa che avrebbe raddoppiato la richiesta di quadri Ufficiali pur senza un immediato incremento del numero delle bocche da fuoco. Altro fatto nuovo, la Pilotta si dichiarava disponibile a prendere in esame la possibilità (sia pure limitata e scaglionata) di un aumento degli organici di Cavalleria.
Insomma, vi era una serie di segnali nuovi.
Ricotti non gradiva però che altri si appropriassero dell'iniziativa ministeriale, affinché non apparisse che il Ministro fosse stato spinto da altri che non dalla propria autonoma iniziativa su questa nuova via. La cosa apparve evidente, durante l'estate, quando il quotidiano «<l Diritto», organo della Sinistra, tornò ad insistere per l'aumento di Artiglieria e Cavalleria 17. A quel punto la disponibilità dell'organo militare ufficioso parve di colpo diminuire prima respingendo taluni attacchi polemici del «Diritto» sui temi dell'aumento delle Armi tecniche, poi tornando a far rivalutare (da un anonimo autore) il ruolo della fanteria e della fanteria speciale (alpini, bersaglieri) rispetto a quello delle Armi dotte e 'nobili' 18.
Nonostante queste battagliette politiche, tipiche del clima ç della lotta parlamentare del trasformismo, ai primi di novembre, l'organo ufficioso della Pilotta parlò dell'imminenza di una modifica dell'ordinamento della cavalleria 19: pur annunciando che la realizzazione della modifica sarebbe potuta avvenire in un futuro non vicinoe cioè dopo il termine della trasformazione dei fucili, del completamento dei lavori per le fortificazioni e dell'aumento della forza delle compagnie - questo era un segnale politico di un certo rilievo.

In ogni caso era legittimo pensare ad un Ministero più attivo,
16 Cfr. cL' Italìa militare», 14 luglio 1886, Ventiquattro battene, ventiquattro reggimenti
17 Ce ne informa ivt·, 20 agosto 1886, La questione della mobilitazione, ed ivi, 3 settembre 1886 , Gli attacchi del «Dinlto•
18 Cfr. ivi, lO settembre 1886 , Il nostro o rdinamento mi/tiare nell' offensiva.
19 Cfr. ivi, 5 novembre 1886, Provvedimenti per l'esercito.
250 POUTICA E POUTICA MiliTARE
seppure sempre attentissimo a che niente gli sfuggisse di mano, a che le richieste dell'opposizione politica e di certi ambienti militari non avessero il sop ravven to. Questo pareva confermato dallo stesso Marselli, Segretario Generale de l Ministero, che come si è visto già nel giugno aveva dichiarato che era ora di andare oltre la csos ta>.
Il mondo militare dovette certo vedere con favore questa correzione di rotta del Ministero che, una volta acceduto ai temi dell'aumento per la Cavalleria, avrebbe forse potuto davvero proseguire 'oltre la sosta'.
In realtà, accorri osservatori politici avevano già messo in dubbio la reale vo l ontà del Ministro di proseguire su questa 'nuova' strada. Ad esempio: nel discorso di Marselli non figurava alcuna precisa previsione di spese, di costi, di bilanci 20. E - si obiettava a Destra e a Sinistra- come si sarebbe riusciti a riformare senza spendere?
Il problema dell'aumento di Artiglieria e Cavalleria, da prettamente militare che era (e nonostante le apparenti nuove concessioni del Ministro della Guerra a quello che era stata da tempo una richiesta di settori militari più sensibili ai temi dell'offensiva), tornava così direttamente nel campo del dibattito politico e parlamentare.
La logica delle successive mosse, su questo tema, doveva quindi tornare ad essere p rettamente politica. La Sinistra ed in genere l' opposizione politica, di fatto raffreddata nei suoi accenni distensivicome vedremo- dall'andamento del dibattito parlamentare sul problema della leva, tornò ad i rri gidirsi ed ad accusare il Ministto. Il Ministro, come si è visto, restrinse immediatamente la sua disponibilità ad un aume nto degli organici delle due Armi. Ai militari , all'esercito, alla stampa d'informazione militare non rimase così che protestare contro quel «mondo alla rovescia» 21 in cui Ricotti Ministro della Guerra non voleva spese per l'esercito. E non mancò , tra i militari , chi calcò i toni della propaganda sulla necessità di un aumento di Artiglieria e Cavalleria , al punto di augurare alla nazione - come si è visto - persino «un momento di serio pericolo». Partì così una campagna della stampa militare contro il Ministero, accusato di lasciare impreparata la nazione sulla «frontiera minacciata> 22 e deteriorate le condizioni militari («un pensiero ormai entrato, e ci duole dirlo , nella coscienza del paese» si scriveva in quelle settima-
2° Cfr. cL' esercito militare», 10 giugno 1886, Il programma militare.
21 Cfr ivi, 24 agosto 1886 , Una salubre reazione
22 lvi, 25 agosto 1886, La discussione si allarga.

LE RAGIONI DEIJ.A
251
CADl!TA DI UN MINISTRO
ne) 2 3 . A Ricotti fu addebitato addirittura il fatto di non essere considerati come credibili interlocutori militari degli alleati d'oltralpe 24 Ancora una volta, pur partendo solo da Artiglieria e Cavalleria, si era tornati a parlare di politica estera e di offensiva/ difensiva.
Ricotti ceno non dovette veder di buon occhio questa ennesima campagna politica che, dal suo punto di vista, tendeva a dividere il mondo militare ed a mettere in evidenza una larga ed influente fascia di dissidenza militare all'interno dello stesso Esercito.
Inoltre, a livello politico, le concessioni, sia pure parziali, che il Ministro aveva fatto intravedere dopo il maggio rischiavano di nuovo di prendergli la mano e di tornare a fare della politica militare di Ricotti un peso ed un bersaglio delle opposizioni per il Governo Depreus.
Ma quello che preoccupava soprattutto Ricotti era il fatto che quelle concessioni, invece di creare intorno alla figura del Ministro della Guerra il favore e l'appoggio del mondo militare, rischiavano di ricreare le precedenti situazioni di distanza e di sfiducia che da vari ambienti militari erano venuti nei mesi passati a Ricotti.
Ricotti, conscio di questo, varò una misura che nelle sue intenzioni avrebbe dovuto ricompattare il più largo sostegno dell'ambiente militare alla politica del Ministro: convocò pubblicamente per l'autunno tre importanti Commissioni militari in cui spazio preponderante sarebbe stato lasciato agli ambienti dello Stato Maggiore.
La prima fu riunita a settembre per riesaminare la questione dell 'affardellamento di guerra del soldato di fanteria e furono chiamati a farne parte militari conosciuti (e non sempre allineati sulle posizioni ministeriali) come Pelloux.
Ma, soprattutto, nell'ottobre furono riunite per vagliare i contestati ordinamenti della Cavalleria e dell'Artiglieria due commissioni presiedute dallo stesso Cosenz nella sua qualità di Capo dello SME e composte da militari di altissimo grado e notorietà 25.
Era questa una decisione notevolissima, che in quanto tale venne accolta con «fiducia» anche da chi era stato più diffidente nei confronti del Ministro. Lo stesso «Esercito italiano» adesso parlava di «nuova era di liete speranze e di operoso e concorde lavoro» 26 e soddi-
23 lvi, 21 agos t o 1886, Le nostre condizioni militari.
24 Cfr. ivi, 19 settembre 1886, Pensiamo all'esercito.
25 Cfr. cl' ese rci to italiano:., 5 ottobre, 1886, Buoni sintomi.
26 lvi , 7 ottobre 1886, La nuova situazione militare.

252 POUTICA E POUTJCA MiliTARE
sfatto esultava: cL' accordo con cui si chiede che si provveda al completamento del nostro ordinamento militare prende la proporzione di un vero plebiscito:. 27
In specifico, per quanto riguardava la questione dell'aumento di Cavalleria e Artiglieria, lo scopo di Ricotti era chiaro: di questioni militari, dovevano essere i militari a discutere. E, inoltre, pensava Ricotti , il fronte militare apparirà- così- compatto e leale nei confronti del Ministero della Guerra , approvandone la politica.
Era comun qu e una svolta importante, di cui fu notato anche il «carattere un po' rivoluzionario:. 28, sia sotto il punto di vista politico-congiunturale (si accoglievano temi dall'opposizione) sia sotto quello amminisuativo-rnilitare (si riconosceva pubblicamente , a quattro anni dal 1882, i l peso della nuova carica di Capo dello SME, affidandogli incarichi - presidenza di Commissioni - che sino allora erano stati appannaggio dei comandanti di alcune strutture amministrative interne al Ministero della Guerra , come erano i Comitati delle varie armi , o di specifici Generali di particolare fiducia del Ministero).

Il mandato di queste Commissioni non era certo esteso: studiare e proporre , velocemente ed economicamente. E non mancò chi contro questa limitatezza propose di rimettere l'incarico ricevuto. Nonostante queste eStremizzazioni , va osservato che , con le nomine delle Commissioni, Ricotti - volendo riconfermare pubblicamente di essere il massimo rappresentante del mondo militare e volendo accreditare l'immagine di un ambiente militare compatto e leale verso il Ministro (e quindi disponibile ad aumentare solo parzialmente le Armi speciali, etc.) - fornì politicamente il destro anche a specu l azioni ed esagerazioni come quelle del «Diritto» che fece diffondere una voce secondo cui la Pilotta voleva addirittura aumentare il bilancio militare tramite economie su quelli di altri ministeri, per esempio dei Lavori Pubblici 29; autorevoli organi di stampa conservatrice ripresero l'indiscrezione 30 poi rivelatasi scarsamente fondata. Ma questi erano tentativi politici d'interferenza nelle dinamiche militari.
Quello che contava (anche e soprattutto oltre le intenzioni di Ricotti ) era l 'oggettivo spostamento di peso specifico che si era avu-
LE RAGIONI DEllA CADUTA DI UN MINIS TRO 253
29 Cfr. ivi, S otto bre 1886 30 Cfr . ivi, 19 ottob re
6,
e
en ti.
27 l vi, lO ottobre 1886, Ade/ante Pedro ! 28 lvi , 14 ottobre 1886 , Le Co mm issioni per l 'A rtiglieria e la Cavalleria.
188
Finanza
armam
to, con la convocazione delle Commissioni presiedute da Cosenz, tra le massime cariche militari. Era uno spostamento certo né irreversibile né consolidato, ché anzi era affattO iniziale e congiunturale. Ma era comunque un segnale importante.
Tanto più che le Commissioni presiedute da Cosenz finirono per riconoscere la perfetta legittimità delle richieste militari di un aumento largo e completo delle Armi di Cavalleria e di Artiglieria di cui si arrivava ad auspicare , oltre che un ampliamento, anche un riordinamento.
Seppure con il peso non vincolante del parere consultivo, lo StatO Maggiore aveva direttamente e pubblicamente criticato la politica di Ricotti e assunto su di sé quella che sino ad ora era solo un tema di contrasto politico.

In maniera evidente, a livello politico-sostanziale come a livello istituzionale-militare, Ricotti aveva completamente fallito nei suoi scopi: la convocazione delle Commissioni si era risolta in un boomerang contro il Minisuo della Guerra.
In un certo senso, Ricotti si era spinto molto al di là di quanto avesse fatto negli anni precedenti l'Amministrazione Ferrero. Quest'ultima aveva infatti chiamato a partecipare Cosenz ai lavori della Commissione per la Difesa dello Stato; ma aveva comunque lasciato la Presidenza delle sedute (e la responsabilità finale di stilarne i riassunti da comunicare al Ministro) al generale Luigi Mezzacapo, che di per sé non aveva particolari cariche militari esclusa quella di comandante di corpo d'armata 3 1 Ricotti, invece, aveva chiamato Cosenz in quanto Capo di SME a presiedere riunioni di importanti e noti militari per discutere - sia pure ancora solo consultivamente -di questioni quanto mai scottanti e d'attualità politica e militare. Cosenz da parte sua (e, per lui, il mondo militare) non era stato da meno, assumendo- con l'avallo della Commissione- allo Stato Maggiore la liceità di riconoscere la legittimità di una richiesta militare che sino ad allora era stata sollecitata a livello politico solo da ambienti dell'opposizione, menue lo stesso Mirllstro della Guerra non ne aveva considerato né necessaria né urgente l'attuazione.
La questione, poi, oltre ad essere notevole sotto il punto di vista istituzionale, doveva esserlo anche sotto quello più politico della permanenza di Ricotti al Ministero.
La posizione di Ricotti, infatti , riusciva profondamente indebo-
2)4 POUTICA E
POUTICA Mll.ITARE
3! Cfr. AUSSME, Ordinamento e mobilitazione, racc. 68.
lita dal risu ltato di queste Commissioni militari: in particolare egli aveva completamente fallito nel suo tentativo di apparire appoggiato dal mondo militare. La più alta autorità 'tecnica' si era schierata con tro la politica del Ministro della Guerra (e del Governo). Il mondo militare voleva asserire - attraverso i deliberata delle Commissioni - la sua indipendenza dalla politica e dal Parlamento. Ovviamente, quello di Cosen z e delle Commissioni da lui presiedu te non componava di per sé alcuna 'sfiducia' militare verso il Ministro della Guerra, né poteva pretendere di avere alcuna conseguenza concretamente politica (il loro rimaneva pur se mpre un compito 'consultivo') o istituzionale (il Ministro della Guerra rimaneva sempre il Capo dell 'Esercito). L'insuccesso era più personale, di Ricotti, che (ancora) del Ministro della Guerra. Inoltre la cosa avrebbe anche potuto avere poche conseguenze, o comunque conseguenze rimarginabili col temp o.
Ma dalla riunione di quelle Commissioni (nell'ottobre) al fatto di Dogali ed alla crisi politica che ne conseguì dovevano passare solo poco più di due mesi. Alla drammatica scadenza di fine gennaio 1887, quindi, Ricotti non poté non arrivare sotto il peso della 'sfiducia' militare che i risultati delle Commissioni di Cosenz avevano significato per lui .

Un altro motivo di indebolimento era cost ituito per Ricotti , paradossalmente , alla lunga distanza, proprio dall'intangibilità delle spese militari. Quell'intangibilità che il Ministro della Guerra aveva garantito all'Esercito- come si è visto- in più occasioni (dal grosso stanz iamento di spese straordinarie per le fonificazioni al complesso delle spese militari ordinarie, contro le proposte di economie avanzate da taluni settori politici) finiva infatti per essere funzionante nei due sensi: impossibilità di ridurre le spese ma anche incapacità a farle aumentare. Dopo le elezioni del1886, in uno scenario politico segnato da una avanzata delle forze conservatrici (sensibili ai temi delJ"onore' e della 'potenza' nazionale e preoccupate del deteriorarsi della sit uazione internazionale), quella intangibilità sembrava a taluni- incuranti delle dimensioni del deficit pubblico- un tetto troppo basso che andava invece al più presto superato.
In realtà, sulla questione frnanziaria e sull'analisi dei bilanci mil itari (anche solo degli anni di Ricotti) andrebbero dette mol te più cose di quanto qui si possa in realtà dire. Molti sono infatti gli ostacoli. Da una parte, lo stUdio delle spese militari in sé e nella l oro influenza sui vari aspetti del complesso rappono tra Stato ed economia male si presta a ricerche limitate a brevi archi cronologi ci . I
LE RAGIONI DELLA CADUTA DI UN MINISTRO 255
lodevoli ma pochi saggi che su questo t ema sono stati scritti hanno non a caso privilegiato l'esame dei trend di lungo periodo 32 . Dall' altra, la complicazione dei bilanci militari non poteva che scoraggiare la ricerca. È in fondo per questi motivi che, con rammarico, non possiamo aggiungere qui che poche altre note su questi importanti temi.
Eppure, come già abbiamo avuto modo di segnalare, la questione d eli ' altezza dei bilanci militari rimane centrale per definire lo spa z io politico che le forze armate avevano conquistato ed il ruolo strategico di cui esse erano state investite nell'Italia liberale e specialmente negli anni del trasformismo.
La politica finanziaria ed in genere l'indirizzo economico del governo parevano avere come obiettivo la conduzione di una 'politica di potenza' piuttosto che l'alleviare le pesanti difficoltà economiche del Paese 33.
La produzione agricola nazionale , che già aveva decelerato negli ultimi anni Settanta il suo ritmo di crescita, aveva incontrato varie difficoltà al primo aprirsi del decennio successivo: dopo il 1881 le ricadute della crisi agraria europea si fecero sentire, contraendo decisamente i livelli produttivi . All'incirca con il 1886, poi, la situazione finiva per peggiorare ancora. Per sostenere la produzione, proprietari terrieri, imprenditori capitalisti, affittuari, settentrionali e meridionali, avanzavano ognuno le proprie richieste. Pur senza condurre riforme agrarie o apportare sostanziali mutamenti negli assetti proprietari e pur senza porsi come obiettivo il riequilibrio del dualismo dell'economia italiana tra nord e sud, una via praticabile per il governo sarebbe stata quella di diminuire le imposte agricole e avviare una larga serie di lavori pubblici. Fare questo avrebbe significato un grosso impegno per la finanza, comportando anche un probabile dirottamento di risorse. Per una politica di questo tipo, infine, l'agitazione
32 Cfr. ancora DE ROSA, Incidenza delle spese mditan· sullo sviluppo economico italiano, cit., e ROCHAT, MASSO BRIO , Breve stona dell'esercito italiano, cit., p. 66 e sgg.
33 Epicarmo Corbino già aveva sottolineato questo dato, anche nei suoi aspetti minori. «Certo le condizioni economiche del paese alla fine del decennio non erano liete. Erano diminuiti i consumi di prima nece ssità, e molto di più quelli volutruari; non progrediva ma accennava ad arrestarsi la massa delle comunicazioni postali e telegrafiche, e persino i prodotti del lotto dimostravano, con la sensibile loro diminuizione, di sottostare alla legge di restrizione, che dominava tutto il movimento economico italiano . Un sordo malessere regnava dappertutto. Vi erano inso mma tutti i sintomi di una crisi generale ( )• E. CORBINO, Annali dell'economia italiana, vo l. III , 1881-1890, Città di Castello, Tip. Leonardo , 1933, pp. 28 -29.

POLITICA E POLITICA MILITARE
del 'panito agrario' faceva intuire che si sarebbe trovata una conveniente maggioranza parlamentare.
Si sarebbero dovute toccare, però, le cosiddette 'spese intangibili', io sostanza il debito pubblico (gelosamente sorvegliato dai potenti interessi finanziari) e le spese militari. Fu scritto più tardi che «interessi, debito vitalizio e spese militari assorb i vano il 67, l% della spesa e che l' 11,3 era richiesto dalle spese di riscossione delle imposte, e( ... ) per i servizi civtli restava appena il 21,6% della spesa, cifra veramente irrisoria io un paese come il nostro in cui di fatto tutta l'impalcatura statale era tenuta essenzialmente su per amministrare i debiti e per mantenere le forze armate» 34. I dati di Corbino siriferivano, è vero, all'intero decennio, ma un eventuale aggiustamento percentuale ai soli anni sino al 1887 non inficerebbe la sostanza di queste sue affermazioni.

Perciò, per non toccare l'intangibile, Depretis e Magliani ripiegarono- per alleviare il malessere agrario- prima su misure qualificanti ma a lunga scadenza (la perequazione fondiaria) e poi , nell'ottavo governo Depretis succeduto alla crisi di Dogali e sboccatO nell'assunzione del potere da parte di Crispi, sull'adozione di misure protezionistiche.
Il blocco di forze, politiche e sociali, che intorno al protezionismo aveva finito per formarsi, nasceva quindi dopo e grazie all'iotangibilità delle spese militari. Le quali, anzi, sotto Crispi, furono potentemente incrementate. Se il 24 giugno 1887 fu votata l'adozione della nuova tariffa daziaria, il 30 dello stesso mese venivano elargiti alle forze armate 20 milioni per l'impresa colon iale , nonostante che (allo stesso scopo) un'altra concessione fosse stata votata solo qualche mese prima, a ridosso di Dogali.
Una tale politica , voluta da Magliani e sancita di fatto da Depretis, costituisce uno degli elementi più consistenti- anche se talvolta sottovalutati - di continuità tra trasformismo e crispismo.
Ricotti in tutto questo stava come il militare che garantiva la politica dei grossi bilanci. Certo, nell'ambiente militare erano presenti settori che erano allora insoddisfatti anche del livello già raggiunto dalle spese militari: ma le loro richieste di aumenti non sarebbero state facilmente accolte. In compenso, però, Ricotti poteva avere grossi bilanci e soprattutto una loro gestione autonoma dal controllo politico. Nonostante le professioni di fiducia e di rispetto dell'istituto par-
LE RAGIONI DELLA CADUTA DI UN MINISTRO 257
34 lvi, p. 382.
lamentare (professioni che comunque di rado erano esplicitate dai Ministri militari), uno degli ani più significativi compiuti da Ricotti nel campo delle spese militari fu la risoluta e ostinata opposizione a creare capitoli di spesa separati per gli stanziamenti riguardanti la spedizione coloniale 35 . Una tale politica di completo distacco dalle richieste di controllo politico e parlamentare ha prodotto risultati così durevoli che ancora oggi chi voglia anche approssimativamente conoscere il costo finanziario della spedizione di Massaua (qualora non si accontenti di poche cifre palesemente sottostimate offerte qua e là dagli atti parlamentari) non dispone di alcun resoconto o valutazione statistica attendibile. Per il resto, allo stato attuale delle conoscenze, non molto di più si potrebbe dire delle alte spese militari di quel tempo. Forse qualcosa di più si saprà quando si sarà riusciti a disaggregare i dati dei bilanci militari dell'Italia liberale e a leggerli in serie storica, quando si stabilirà quanto costarono all'Esercito gli aggiornamenti e gli esperimenti indotti dal progresso tecnico di quel tempo (in quegli anni la mitragliatrice, i nuovi cannoni, la polvere senzafumo, le mongolfiere, etc.) e quando si sarà gettata maggior luce sull'intreccio tra interessi militari ed interessi privati in alcuni specifici casi di ammodernamento tecnico (esemplare, per più versi, il 'rin novo ' delle artiglierie a cavallo del secolo).
Per intanto, il dato che in questo senso va sottolineato a proposito degli anni del secondo Ministero Ricotti è la politica di alte spese militari globalmente intese, se nza che sia rintracciabile un particolare fattore od elemento (tecnico, strategico, militare) che di per sé faceva gonfiare i bilanci. Non fu da sola la spedizione di Massaua a spiegare l'altezza delle spese per l'esercito, come non lo fu né la decisione (ribadita dal Re) di non toccare l'ordinamento su dodici corpi d'armata né tantomeno la volontà di stare dietro al progresso tecnico degli armamenti (esemplare il caso dello studio per i fucili): furono tutte queste cose insieme, fu la politica di avere al tempo stesso un grosso esercito e grosse ambizioni, fu l'indirizzo di conservare le spese militari lontane dal controllo politico.
Nella situazione finanziaria del tempo , però, con la crisi agraria che non risparmiava le campagne italiane, quella politica di alte spese doveva condurre prima o poi al deficit. La coperta della finanza pubblica era troppo corta per bastare sia ad interventi in favore del-

258 POU11CA E POUTICA MWTARE
35 Cfr. AA.PP , Camera , Legisl. XV , sess. unica , Ditcuuioni, tornata del12 giugno 1885 , e poi ancora ivi, Legisl. XVI, sess. prima, Ditcu.rsioni. tornata dell6 dicembre 1886.
l'economia agricola sia a lasciare imoccato l " intangibile'.
Invece, tal uni settori dell'opinione pubblica e della classe politica sembravano (soprattutto dopo le elezioni del maggio 1886) non curanti dello stretto legame tra deficit delle finanze e spese intangibili. Magliani veniva così accusato di incapacità gestionale e contabile, Ricotti della 'sosta' e di mancata sollecitudine per le 'esigenze dell'esercito'. Lo sbocco di queste campagne politiche e di stampa (evidenziate anche in Parlamento dai discorsi di Di Rudinì e di Crispi nel dicembre 1886) non poteva che essere un ' altra impennata delle spese militari e la sostituzione di Ricotti Un altro passo , cioè , oltre il confine del trasformismo , verso il decennio crispino.

Questa situazione di indebolimento politico ed istituzionale del Ministro della Guerra fu inoltre accentuata da come erano passati per Ricotti quegli ultimi mesi di attività politica e parlamentare seguiti alle elezioni del maggio 1886.
Dentro il Parlamento , era quasi parso non avere alcuna influenza quel complesso di se gnali ( nel senso di un superamento della 'sosta ' ) che Ricotti aveva mandato invece al mondo militare. A livello politico , infatti , il Ministro della Guerra continuò a t rovarsi di fronte una dura opposizione : un'opposizione anche più forre adesso che , dop o le elezioni e con il rafforzamento della Destra di ss idente , un altro gruppo parlamentare oltre la Pemarchia pareva a ver puntato i cannoni della sua critica sulla persona e sul programma del Ministro della Guerra.
Questo tipo nuovo di opposizione (Pentarchia e Destra dissidente ), ancora più compatta di quella dei mesi precedenti , si era resa visibile persino nella disc uss ione di taluni , min o ri , pro getti di legge militari.
A proposito di al cune modifiche alla le gg e d e l 1885 sulle spese straordinarie , già in Commissione forti eran o sta te le ri serve : Zanolini aveva giudicato cnon acc ettabile:. la proposta del Ministro - un passaggio di 18 milioni (mi) dal Bilancio della Guerra a quello della Marina (probabilmente a proposito delle fortificazioni della Maddalena)- e Maldini, presidente, aveva espresso ceni suoi dubbi e ritenuto di esigere che cla difesa debba avere un ' uni ca direzione» 36 . Ancora più contrastato fu l ' iter parlamentare di un progetto di legge circa gli ' assegni ' agli ufficiali. Il progetto , tramite cui si aumentavano gli stipendi militari , era di dubbia interpretazione e so36 ACD , Dd/, Legisl. XVI, sess. p rima, reg 426, n 31, Verbale della sedu ta della Commission e, ! 9 gi u gno 1886
LE RAGIONI OEU.A CADLTTA DI UN MINISTitO 25 9
prattutto non c'era nessuna giustificazione per l'urgenza chiesta da Ricotti nella sua discussione. Tutta la questione rischiava di assumere la veste di una operazione politica di tipo corporativo. Decise furono le opposizioni anche sulla legge per un nuovo Ordinamento dell'Esercito che, dopo due lunghe serie·di sedute della Commissione referente, fu portato alla Camera nello stesso giorno delle votazioni sul Bilancio della Guerra. Diversi furono i punti di frizione tra maggioranza ed opposizione. Pais accusò il Ministro di lacune nel meccanismo di mobilitazione e definì «spese di lusso» molti dei provvedimenti (istituzione di una Scuola d'Applicazione per la Fanteria, lievi aumenti di organico, tra cui l 'inserim ento nelle tabelle del grado di Maggior Generale per il Comandante delle truppe «per l'Africa>>), proposti da Ricotti 37 Tra i deputati in divisa, Pelloux illustrò tecnicamente quale sconvolgimento avrebbe potuto portare l'apertura di una nuova Scuola nel complesso degli istituti militari, per via di insegnamenti che andavano spostati da istituto a istituto, per non essere duplicati o per non mancare del tutto nel cum·culum dei nuovi ufficiali. Va infine ricordato come, essendo questa scuola prevista a Caserta «per ragioni distributive», non mancarono nel dibattito parlamentare toni regionalistici e preoccupazioni campanilistiche (tra deputati meridonali e deputati settentrionali e piemontesi), che divisero la maggioranza governativa.
In quell'occasione, in cui per l'ennesima volta si dissolsero i confini tra Destra e Sinistra, emblematico del clima di esaurimento del trasformismo e di formazione d'i un nuovo blocco di forze politiche fu un inaspettato discorso parlamentare di Francesco Crispi. L'uomo politico, il 'pentarca', che forse più di altri aveva criticato la conduzione della politica coloniale e in genere la gestione della politica militare di Ricotti, si schierava adesso a favore di una completa 'autonomia' dei militari dal sistema politico.
Come stupito dell'opposizione che si andava facendo al Ministero della guerra - e un po' volendo bilanciare politicamente (da sinistra) talune bordate di critica che Di Rudinì aveva sparato (da Destra) solo tre giorni addietro ali' indirizzo del generale novareseil pentarca Crispi veniva infatti in soccorso del 'destro' Ricotti.
«È questione di concetto», disse; in tema di politica militare sono «i poteri dell'esecutivo» che devono sempre prevalere in Parlamento, anche a costo di servirsi di decreti reali (e, quindi, anche contro

260 POLITICA E POLITICA MILITARE
37
AA.PP. , Camera, Legisl. XVI , sess. prima, Discussìonì, rornata deli7 dicem· bre 1886.
il Parlamento). Quando si tratta di ordinamento delle forze armate, poi, qualsiasi remora sulle spese deve essere dimenticata. Dopo questo autorevole parere politico e costituzionale - che ce rto non poteva essere dispiaciuto ai militari e che dimostrava come il trasformismo avesse ormai rese superate le vecchie distinzioni tra 'Destra' e 'Sinistra', rendendo possibile anche ad un ex- 'sinistro' di aspirare a dirigere coalizioni che prima si sarebbero definite 'di Destra' e che comunque si fondavano su un programma conservatore - il dibattito parlamentare sull'Ordinamento dell'Esercito si era però arenato, essendo giunto a toccare questioni di orientamento politico generale , che però ancora non erano compiutamente maturate. Da pane della deputazione militare, comunque, Pozzolini e Gandolfi risollevarono con vivacità i remi del rapporto tra Ministro e Capo dello SME 38 C'erano fors e le cond izioni per una grande battaglia politica ma, ad una settimana dal Natale, la Camera svogliata premette continuamente per la chiusura, riuscendo ad ottenerla (su un tema così importante) dopo solo una seduta di dibattito.
Un altro progetto , presentato di conserva tra Ricotti e Brin (che comportava 2) ml. di spese extra-bilancio equamente divise tra esercito e marina) passò alla Camera senza difficoltà solo dopo che Ricci ne ebbe ricordato il «carattere essenzialmente politico » 39 e Pl ebano avesse ammesso quanto «non [fosse] momento di opposizio ni».
Riassumendo, risultato di questa tornata di discussioni rimaneva però il fatto che Ricotti non era minimament e riuscito a placare le opposizioni specifiche, né tantomeno a sedare gli umori di buona parte della deputazione militare: e che, inoltre, per motivi politici generali, anche la Destra dissidente, resa più forte dalle elezioni del maggio e da un'atmosfera preoccupata per i recenti sommovimenti nell'arengo europeo, aveva aperto le ostilità contro il Ministro della Guerra.
In questo senso, oltre ai dibattiti ricordati, le opposizioni più grosse Ricotti se le era viste crescere davanti in due occasioni particolari: durame la discu ssione della legge di leva, nel giu gno, e durante l'esame dello stato di previsione delle spese per il Ministero della Guerra, nel dicembre.
In ognuno dei due casi, l'opposizione aveva sollevato la questione delle Armi di Cavalleria e di Artiglieria.

lE
RAGIONI DELLA CADlJTA DI UN MINISTRO 261
3S l vi , tornata del 18 di ce mbre 1886 39 l vi , tornata del 17 di cembre 1886.
Nel caso della legge di leva, ciò che aveva suscitato le rimostranze del Parlamento era la riaffermata volontà di Ricotti di procedere nel suo concetto di creare grossi contingenti attraverso un più radicale uso dei congedi anticipati 40 . Concetto questo che si era già manifestato nella legge di leva dell'anno precedlente (ma per cui il Ministro aveva fatto in modo di evitare una discussione parlamentare) e che contrastava con la linea che era stata intrapresa dalle precedenti amministrazioni della Guerra (non tanto quella di Ferrero che, come si sa, aveva fatto anch'essa un ricorso - seppure più limitatoai congedi anticipati, quanto piuttosto quella, lontana, di Luigi Mezzacapo) 4 1 . Ma dai congedi anticipati il contenzioso venne esteso dai militari deputati alla questione degli aumenti per le Armi speciali, dando l'impressione di volere fare della stessa legge annuale per la leva- contro Ricotti- un vero e proprio caso politico, dopo le elezioni del maggio 1886.
Infatti, durante il primo esame in sede di Commissione Parlamentare (ancora nella XV legislatura, prima delle elezioni del maggio) la resistenza ai progetti di leva di Ricotti era parsa presente, ma leggera e quasi solo verbale. C'era chi aveva riaffermato la sua preferenza per la categoria unica, chi aveva sottoposto al Ministro qualche quesito, chi pure aveva fatto riferimento alla questione delle Armi speciali ma senza vigorìa e senza particolari o nuovi accenti 42 . Finita la legislatura, invece, e riunita la Commissione ad elezioni effettuate, sulla questione della leva «Si entra( va] a gonfie vele nella discussione sull'aumento delle Armi a cav allo» 43. I deputati (avuto forse sentore, dagli accenni della stampa militare ufficiosa, della probabile volontà del Ministro di aprirsi ad un 'corso nuovo') tentarono di forzargli la mano . Le critiche a Ricotti fioccarono così da tutti i membri della Commissione. Siacci, parlando di leva e di congedi antièipati, si oppose al «modo di applicarla»·proposto dal Ministro. Levi criticò che «per risparmiare alcuni milioni si ponesse a repentaglio
40 Sull'imponanza dei congedi anticipati, prima che fosse introdotto il sistema della forza massima e della forza minima , cfr. VENTURINI, Militan· e poli#ci nell'Italia umbertina, cit., p. 178 . Sulle conseguenze dei congedi anticipati nei confronti della durata della leva, cfr. DEL NEGRO, Esercito, Stato e società. Saggi di storia militare, cit., p. 208.

41 Cfr. ivì, p 206.
42 Cfr. ACD, Dd/, Legisl. XV, sess. unica, reg. 412, n. 396, Verbale della seduta della Commissione, 2) marzo 1886.
43 lvi. Legisl. XVI, sess. prima, reg . 426, n. 32, Verbale della seduta della Commissione, 19 giugno 1886
262 POLITICA E POUTICA MIUTARE
la sicurezza del Paese:., come a parer suo sarebbe stato qualora Ricotti non avesse voluto aumentare Artiglieria e Cavalleria. Fu presentato così un ordine del giorno alla Commissione sulla «opportunità e convenienza assoluta di stabilire il voluto equilibrio tra la forza delle varie armi:., ordine del giorno che tra l'altro impegnava il Ministro a presentare un progetto di legge che permettesse entro il maggio 1887 cl 'aumento proporzionale:. di Cavalleria e Artiglieria. Dopo altré perentorie accuse di altri membri, Ricotti in persona intervenne in Comm issione, obiettando che cle finanze non presentano margine per tutto:. ma non riuscendo a contrastare o a smussare l 'atteggiamento antiministeriale . Sia pur modificato , l'ordine del giorno raggiungeva così la Camera , dove da subito si accese una violenta diatriba tra il Ministro e la deputazione militare 4 4.
Tra gli altri intervenne Pelloux, con un discorso ampio e radicalmente criti co: tutto, dalla questione offensiva/ difensiva a quella dei militar i in Parlamento , dallo stato della amministrazione militare alla prospettiva della 'nazione armata ', dalla forza delle compagnie alla conduzione della politica coloniale (da cui pubblicamente dissentiva), pareva costituire oggetto di accusa contro Ricotti. Altri ancora presero la parola, come Pozzolini, che criticò non solo il Ricotti politico , bensì anche il «Ricotti ammini stratore:.. E poi De Zerbi, che assicurò la sua cfone opposizione:. ai concetti del Ministro della Guerra, e Branca, che dai banchi della Destra, ritornò sug li aspetti finanziari della questione delle spese militari. Insomma , anche una semplice le gge di leva di Ricotti riusciva a suscitare un vespaio di opposizioni e di criti che nei confronti del Ministro della Guerra.
Ma in fondo quella sulla leva era pur sempre una 'legge tecnica' e la accesa discussione parlamentare, seppure ebbe una certa risonanza nell'ambiente militare, non influì poi molto sulla votazione in se stessa , in cui il governo mantenne assai bene la sua maggioranza.
Assai diverse le cose furono invece nel dicembre, in occasione della discussione sui bilanci militari.
Ricotti fu attaccato da ogni pane politica e su ogni punto del suo p rogramma , praticamente da tutta la deputazione militare: non solo dai militari, quanto anche dai politici. L'accesa discussione sulla leva del luglio, le campagne di stampa dell'estate sui pericoli della

LE RA GIONI DELLA CADUTA DI UN MINISTRO 263
44 Cfr. AA.PP ., Came ra , Legisl. XVI , sess. p rim a , Discustio n i, 2 lugl io 1886.
difesa nazionale 45, le risoluzioni delle Commissioni militari presiedute da Cosenz avevano tutte lasciato il loro segno. In forma chiara, adesso, non era più solo l'opposizione pentarchica a criticarlo, bensì anche la potente Destra dissidente: Ricotti vedeva così rivoltarglisi contro anche la stessa parte politica che, in fondo, l'aveva portato al Governo.
La seduta fu aperta dallo stesso Di Rudinì che, con un poderoso discorso di intonazione bellicista sulle carenze della mobilitazione dell'esercito e sui pericoli per l'incolumità del Paese, aprì le ostilità contro quel Ministro della cui nomina, solo due anni prima, si era pure dimostrato «contentissimo». Timori di guerra e apprensioni per «la vittoria» che - con quell'organico e con quel morale dell'esercito italiano - avrebbe potuto anche non venire furono i due cardini del suo discorso. Aumentare l'organico dove era necessario, spendere dove e se era urgente, senza riguardi per le finanze statali: questa era l'obiezione della Destra alla gestione Ricotti.
Dopo Di Rudinì e qualche altro deputato 'civile', come Arbib, Cavalletto o Albini, che pure non lesinarono critiche 46, fu la volta dei deputati militari. I quali, senza riguardo del lato della Camera in cui sedevano, criticarono frontalmente la politica militare di Ricotti.
Il ministeriale Corvetto (poi Segretario Generale con il successore di Ricotti, Bertolè Viale) prese spunto da questioni minori, Chiala ammonì circa la triste situazione dei sottufficiali, il conservatore Taverna obiettò sul sistema di spese per i presidi africani.
Tra Turi e Ricotti si alzarono di nuovo le voci a proposito della diga di La Spezia e del sistema difensivo italiano 47
Il dissidente Pelloux tornò sulla questione delle Armi speciali, ma al centro del suo discorso, sull'esempio di Di Rudinì, furono la asserita preoccupazione per «gli avvenimenti politici europei ultimi, i quali hanno creato una situazione molto pericolosa, molto oscura» e la necessità di meglio provvedere all'approntamento delle forze armate dal momento che «tutte le operazioni relative alla mobilitazio-
45 Cfr. cltalia militare•, l agosto 1886, Esperimenti di mobilitazione parziale; ivi, l) agostO 1886 , Notizie sulle condizioni dell'esercito itafiano; ivi, 20 agosto 1886, La questione della mobzfitazione; ivi, 3 settembre 1886, Gli attacchi del 'Diritto ' Cfr. an· che «L'esercito italiano•, 21 agosto 1886 , Le nostre condizioni mtfitan·.
46 Cfr. AA.PP., Camera, Legisl. XVI, sess. prima, Discussioni, tornate del 14 e 15 dicembre 1886.
47 Cfr. ivi, tornata del l) dicembre 1886.

264 POUTICA E POLITICA MlLIT ARE
ne devono essere considerate come urgentissime». Ricotti , di fatto , veniva così denunciato all'opinione pubblica come il responsabile di eventuali lacune in tale senso . Baratieri, dal canto suo, da 'uomo di sinistra monarchica', pur volendo apparire come il difenso re dell'esercito da tante e così aspre accuse (lo stato di salute dell'organismo militare, ribatteva orgogliosamente, «è migliore di quanto spesso si pensi»), in realtà infilava nel suo discorso tante e tali critiche alla gestione Ricotti da fornire all'opposizione politica una infinità di temi antiministeriali. La condizione degli ufficiali, la disciplina, la Milizia Territoriale, il Tiro a segno, il rapporto tra esercito e nazione: tutto sembrava a Baratieri essersi peggio rato negli ultimi anni, gli anni di Ricotti. E, per ftnire, l'esortazione «Completate gli ordinamenti: non risparmiate né cure né spese per l'esercito!» e la citazione, invero signiftcativa, di un discorso di Boulanger.
Perfino il deputato e generale Morra di Lavriano - di solito assente dai lavori della Camera o comunque silenzioso ascoltatorecon l'autorevolez za dell'uomo di Cone di Re Umbeno, ebbe in quella occasione qualcosa a che ridire sulla gestione di Ricotti. E le sue preoccupazioni, sul morale dell'esercito e degli ufficiali e sulle condizioni dlella mobilitazione, apparvero in linea con quelle degli altri oratori e di fatto rappresentarono come un segnale che forse, anche «in alto» (come si soleva allora dire) , la politica di contenimento e di 'sosta' di Ricotti era ormai vista con assai scarso favore 4.8.
La levata di scudi era st ata quindi imponente. E, fatto significativo, nessun militare deputato si sentì in dovere o nelle condizioni di poter difendere il Ministro della Guerra da così varie parti attaccato. Lo scendere in campo contro Ricotti (ancora prima che quello della solita Pentarchia) della Destra dissidente e la omogeneità con cui la deputazione militare si era espressa contro il Ministro erano stati i fatti rilevanti delle discussioni del dicembre 1886.

Rico tt i, nella sua replica, tentò verbalmente di sminuire la portata degli attacchi a lui diretti, sostenendo che in quella tornata «non vi [erano] state opposizioni, ma amici con suggerimenti e cortesi domande». Ma poco egli poteva fare per non dare all'opinione pubblica , politica e militare, l'immagine del Ministro della Guerra screditato ed accusato dai suoi stessi più naturali sostenitori.
Purtroppo per il generale novarese non ci fu tempo, dopo quel-
LE RAG IO NI DEI.LA CADUTA DI UN MJNISTRO 265
48
Cfr. ivi, tornata del 16 dicembre 1886.
le discuss ioni, per poter tentare in extrem ù di smussare le critiche o di alleviare le opposizioni, se anche questo egli fosse stato in potere di fare.
Poco oltre un mese più tardi, infatti , De Cristoforis guidava la sua colonna di giovani soldati italiani proprio incontro a Ras A lula .
Ricotti tentò , proprio in quelli che sarebbero stati gli ultimi giorni del suo Ministero, di venire incontro alle richieste ed alle opposizioni che dal mondo militare erano venute alla sua gestione militare. Ma furono, queste sue ultime misure, espedienti tardivi ed insufficienti a garantirgli un più esteso consenso politico e militare.
Nelle primissime settimane dell ' anno 188 7 egli emanò importanti provvedimenti come quelli sull'organizzazione della Milizia Mobile 49 o sull'adozione del modello trasformato 1870-87 di fucile a ripetizione 50 Fece addirittura pubblicare, sul quotidiano ufficioso della presidenza del Consiglio (per dare loro maggiore autorità), alcune 'indiscrezioni' che , precisamente e dettagliatamente, esponevano quali erano i criteri di un prossimo provvedimento ministeriale per l ' aumento delle Armi di Aniglieria e Cavalle ria 51. Dopo tante resistenze , politiche e militari, quindi, per evitare di essere travolto da quel mare di critiche che la sua intransigenza sul tema aveva creato nell'ambiente militare (ma anche, come si era visto dalle discussioni parlamentari del dicembre, in quello politico), Ricotti accedeva all ' aumento delle Armi speciali. Sarebbe cambiata la politica militare del Ministro? Era terminata la 'sosta'? Ci sarebbe stato un ' nu ovo corso' per l'esercito e per i militari italiani , con una maggiore armonia tra Ministro e ambiente militare?
Come si è detto, non c'era ormai più tempo p.er rispondere a queste domande. Quando le indiscrezioni circa gli aumenti su lle Armi special i furono rivelate , mancavano soli quattro giorni all 'e pisodio di Dogali. A cui quindi Ricotti arrivò co n tutta la montagna di critiche che la sua gestione aveva accumulato , e senza avere avuto il tempo di ovviarvi (anche solo in pane , con misure trasformiste e dell'ultima ora).
Rimane quindi l'impressione che ormai, già con il dicembre, la figura politica di Ricotti era definitivamente ridimensionata tra i politici come tra i militari.
49 Cfr. cG iornale militare ufficiale•. 10 gennaio 1887 , atro n. 9 .

Cfr. ivi, 23 gennaio 1887, atto n. 30.
Cfr. cii popolo romano•, 23 gennaio 1887, L'aumento d elle armi a cavallo
266 POUTICA E- POUTICA MIUTAR.E
Vari erano i segnali chiari in questo senso. Già da tempo erano state diffuse voci di contrasti tra Ricotti e Magliani 52 e voci di dissidio tra il generale ed il potente Morana 53, Segretario Generale agli Interni. Nel gennaio 1887 da più parti veniva poi notato il silenzio parlamentare di militari ed uomini di Corte del calibro di Bertolè Vi ale, silenzio che veniva interpretato come un dissenso. Sul versante politico, inoltre, lo stesso organo di Depretis- nel momento in cui pubblicava l'indiscrezione sul disegno di Ricotti di aumentare Cavalleria ed Artiglieria- si mostrava insoddisfatto. «Temiamo assai -scriveva il giornale a proposito, dei ventilati provvedimenti di Ricotti- che essi non abbiano a soddisfare interamente l'opinione pubblica la quale attendeva che l'onorevole Ricotti prendesse opportunità dall'aumento delle due Armi per dare ad esse un ordinamento rispondente ai bisogni della mobilitazione meglio che non faccia l'attuale [ordinamento del 1882], che può essere stato adottato come ripiego temporaneo consigliato dalla fmanza ma che i suoi stessi autori [Ferrero e Pelloux] non possono mai aver ritenuto come ordinamento definitivo» 54 Erano, sul giornale del presidente del Consiglio, le stesse parole dell'opposizione politica e militare alla gestione di Ricotti.

Il generale novarese , chiamato alla Pilotta per motivi politici , sostenuto al Ministero- di fronte alla crescente insoddisfazione militare - dal Governo e dalla maggioranza, veniva adesso scaricato da quelli stessi che erano stati i suoi interessati sostenitori politici. Ricotti, invece di contribuire al rafforzamento defmitivo della maggioranza trasformista, aveva con la sua politica scontentato tutti (oppositori, certo , ma anche ministeriali; politici, in gran parte, ma anche militari) ed aveva permesso, sui temi della 'questione militare' un rafforzamento ed un compattamento delle opposizioni antitrasformistiche di Destra e di Sinistra.
Invece di essere uno strumento ed un ausilio per Depretis , Ricotti fmiva per essere una delle più immediate cause di crisi governat iva. E in quei giorni di inizio-metà gennaio 1887 ancora non si pensava a quello che, nelle sabbie infuoca te intorno a Dogali , avrebbe finito per accadere.
Le vicende parlamentari e politiche che seguirono la notizia del-
52 Cfr. «L' ese rci to itali an o », 26 agosto 1886.
53 Cfr. zvi , 13 settembre 1886 .
54 «<l pop olo roman o.", 2 3 gennai o 1887 , cit.
LE RAGIONI DELLA
267
CADUTA DI UN MINISTRO
l'eccidio di Dogali sono ormai sufficientemente note, e noi ci asterremo dal farvi richiamo. Il ruolo di Ricotti in queste vicende fu di fatto secondario ed ininfluente: da subito il Ministro della Guerra
- come e più del Ministro degli Esteri (che in quei mesi continuava a trattare con le Potenze straniere il rinnovo della Triplice Alleanza)
- figurava su l banco degli accusati.
Se già la sua azione amm inistrativa era stata conten u ta nei mesi precedenti, que lla delle settimane seguite a Dogali e precedenti la nomina di Bertolè Viale alla Guerra fu di assoluta stasi. Peraltro, il nome del successore di Ricotti e il gradimento della Corona ad una tale nomina erano già stati resi noti ed accolti dali' opinione pubblica e militare. Il generale novarese dovette certo sentirsi sotto 'amministrazione controllata'.

La sua posizione politica, inoltre, aveva dei risvol ti personali che non possono essere trascurati.
Accusato da ultimo del fallimento di una causa (quella coloniale) in cui non aveva creduto e di cui aveva sempre tentato di limitare le ricadute politiche e militari, Ricotti si trovava in una strana e difficile posizione. Ed il suo carattere animoso ed irritabile non dovevano aiutarlo a districarsi nella sua situazione.
Poli ticamente, una volta chiamato dalla Camera a rispondere delle sue responsabilità politiche nell'affare coloniale (e in specie nel drammatico ed evidente disastro militare di D ogali) il Ministro dapprima si attenne alla cautela, alla disciplina e al riserbo militare: ma proprio per questo non parve credibil e.
Per conto mio- disse Ricotti- la pane del telegramma [che il Coman· dante de ll e truppe Genè inviò a Roma per annunciare l'ecci d io d i Do gal i] che si riferisce al fatto d'armi del 26 , è tale da far sorgere, dirò quasi, dei dubbi; tanto più che lo stesso redattore, il generale Genè dice che si riserva di mandare ulteriori particolari. Ora da questa parte appunto del telegramma, molti oratori trassero argomento per condannare il ministro della Guerra per attribuirgli cioè delle negligenze , delle colpe le quali furono poi causa della sventura che in que· sto momento deplo r iamo ( ). A mio modo di pensare però , il dare giudizio così severo del Ministro della Guerra e, più panicolarmente, dei Comandanti delle truppe in Africa, in base alle semplici informazioni di un semplice telegramma non completo, il quale lascia ancora qualche dubbio, come purtroppo succede il più delle volte con i telegrammi, mi pare un poco prematuro. Quindi io pre· gherei vivamente la Camera a non voler emettere nessun giudizio sulla condotta dei nostri ufficiali e sulla condotta delle nostre truppe in Mrica (No! no!Interruziom) Voci a sinistra. Chi ha parlato della condotta delle truppe?
(Agitazione)
Ricotti, Ministro della Guerra. Molti ne hanno parlato, anzi ne hanno fatto
268 POLITICA E POLITICA MILITARE
la questione principale; ad ogni modo, di esatto non si può dire nulla , prima che vengano completate le comunicazioni ufficiali 55.
Ma il suo carattere battagliero lo portò poi a protestare: non gli pareva giusto rimanere l 'unico imputato, o capro espiatorio, di uno scacco subìto da quella politica coloniale che Ricotti non aveva certo incoraggiato.
Io vado però più in là ancora; e dico che se il Ministro della Guerra risultasse, da un'inchiesta e da investigazioni fatte con documenti alla mano, causa, se pur lontana, della sventura accaduta, non si tratterebbe soltanto delle sue dimissioni, ma di ben altro.
Io accetto la responsabilità , ma dico che per poter dare un giudizio sicuro bisogna sapere se la disgrazia avvenuta ai nostri soldati in Africa , sia stata cagionata da qualche cosa sulla quale poteva influire il Ministro della Guerra( ) Se tutto ciò fosse provato, io npeto che non basterebbe la semplice dimissione del Ministro della Guerra 56.
Se pure era comprensibile (ma poco politico) questo atteggiamento risentito del Ministro, una qualsiasi chiamata di correo verso i politici del Governo o verso i militari distaccati in colonia (o addirittura verso «l'alto»?) sarebbe stata impossibile, a meno di non voler rinverdire i tristi fantasmi del 1866 e delle polemiche di La Marmora con Cialdini.

Di fatto, la posizione e la persona di Ricotti erano ormai troppo screditate.
No n furono facili per lui, così, i quasi tre mesi che separarono quei dibattiti parlamentari del gennaio 1887 da quei primi giorni di aprile in cui Deprecis formò il nuovo Governo con Crispi e Bertolè Viale. In quei giorni persino un suo aspro avversario quale Pelloux commiserava la sorte del Ministro:
Il punto saliente della seduta d ' oggi è stata l'accoglienza ... terribile persino villana, che è stata fatta al Ministro della Guerra, al quale non si è letteralmente lasciato dire le quattro parole necessarie per presentare un disegno di legge qualunque.
Non hanno voluto sentirlo! La sinistra ha urlato in modo indicibile, il centro e la destra se non hanno partecipato al clamore, hanno partecipato alla disapprovazione co l più glaciale silenzio , e senza reagire contro l 'offesa. Non vogliono più !asciarlo parlare! Durante il baccano io pensavo alla triste figura che il Mi -
LE RAGIONI DELLA CAD UTA DJ UN MINI STRO
269
55 AA.PP., Camera, Legisl. XVI, sess . prima, Discussioni , tornata del4 febbraio 188 7 . 56 Ibidem.
nistro della Guerra, Capo dell 'Esercito faceva di fronte a parecchie centinaia di ufficialì che si trovavano nelle t ribune ! Una cosa grave, veramente. Uno scoppio! 57
Quello che co lpi va il militare Pelloux era la critica impi et osa da parte del parlamento alla perso na del Ministro della Guerra ; c'era un po ' il rammarico di vedere l ' esercito attaccato dalla politica. E dire che tutto ciò saliva alla mente di un militare che pure non aveva esitato a fare ed a panecipare ad una campagna politica contro Ricotti: questo a dimostrazione che i capponi tra esercito e politica , tra società militare e società civile, erano ben più stretti e complessi di quanto talvo l ta si fosse o si sia ponati a credere.

Ma, al fondo , dato saliente delle settimane politiche successive a Dogali non era la so ne di un Ministro o l'evoluzione della sola politica militare; era lo scenario politico cui il uasformismo aveva abituato l'Italia del tempo che si stava irremediabilmente incrinando. Se le ragioni di un simile mutamento della prospettiva politica si erano già fatte evidenti nei me si prece denti , decisiva fu l 'atmosfera ' patriottica' che si coagu lò intorno al mito di Dogali.
Nel voto per quei cinqu e milioni di spese straordinarie a favore dei presidi d' Mrica, Destra e Sinistra si erano completamente confuse (con l 'un ica vera eccezione degli irriducibili anticolonialisti dell 'Estrema): ma il segno di questa operazione non era dato più dalla ripresa di un trasformismo alla Depretis , bensì dall'imponente schieramento co nservatore che po co prima aveva votato l 'o rdine del giorno di sfiducia al governo presentato- non a caso, da Des tra- da Di Rudinì . Crispi- che pure avrebbe fatto pane, in quanto esponente della sini stra antitrasformista, del governo che da quelle votazioni sarebbe riuscito - era alla testa di questo schieramento che si sarebbe posto .
In un tale mutamento di scenario p oliti co, dietro il disp iegars i di questo diverso orientamento generale, era però sempre il contenuto della politica quello che imponava: ed era un contenuto non nuovo, ma rinnovato nella forma e presentato, nell ' asprezza dell'ora seguita a Dogali, come obbligato. Non era il cooptamento della sinistra pentarchica che segnava il nuovo governo Depretis-CrispiBenolè Viale, uscito dalla lun ga crisi parlamentare del gennaio-aprile 1887, ma quel contenu to della politica , quel programma di governo: che preludeva e che preparava quello cri spin o .
270 POUTICA E POUTICA MlliTARE
57
ACS , Carte Pelloux, se. 31, LO marzo 1887 , Pelloux a Sforza Terni.
Più autoritarismo nell'immagine del governo, maggior autonomia dell'esecutivo dal legislativo, sottolineatura dei temi della 'potenza' i t aliana e dell"onore nazionale': intorno a questi elementi, a questi cardini doveva girare e svilupparsi la politica economica, sociale, istituzionale, militare e coloniale del 'decennio crispino'. Non erano però elementi nuovi: li abbiamo in parte già visti operare nella politica trasformista, sia pure in forme ed in tempi diversi.

Nello stesso circoscritto campo della politica militare, in più di un'occasione la continuità, una certa continuità, prevaleva sulla rottura. Alte spese, grosse ambizioni, offensivismo esibito e manifestato: quello che Ricotti aveva tollerato, o che non era stato capace di fermare, veniva ripreso da Crispi e dalla sua politica. Non era un caso se, solo poche settimane dopo la caduta di Ricotti, il governo e il nuovo Ministro della Guerra presentavano alla Camera un disegno di legge sull'aumento di Artiglieria e Cavalleria i cui relatori furono - per i due diversi rami del parlamento - Luigi Pelloux e Carlo Mezzacapo.
In questa linea a suo modo continua che unisce trasformismo e crispismo, le strutture di fondo dell'uno e quelle dell'altro (piuttosto che i vari Ministri), la caduta di Ricotti con Dogali è chiarificatrice. Il generale della vecchia Destra non condivideva niente, si starebbe per dire, con Crispi: se non una cena concezione dell"onore nazionale' e della necessità di una 'potenza' italiana. La sua caduta equivalse così alla sua sconfitta. Il generale novarese poteva in un ceno senso sentirsi sconfitto- nel campo della politica militare- perché proprio alcuni degli elementi che egli meno aveva approvato nel corso delle cose e nell'evoluzione della politica militare italiana (bellicismo di fondo, ruolo del Capo dello SME, spinta colonialista, impennata delle spese straordinarie) furono quelli intorno a cui Crispi fece ruotare una pane della.-oua politica interna e estera e su cui si basò il suo mito di uomo 'forte'.
Questo non significa dire che Crispi recepì in pieno le richieste che i militari avevano maturato sotto la coltre della 'sosta' di Ricotti, o che, Crispi consule, non si verificassero contrasti e conflitti che forti tra politici e militari. Ma è certo che - sotto Crispi - il già largo spazio occupato dai militari ali' interno della politica del trasformismo venne esaltato e ampliato.
LE RAGIONI DELLA CADUTA DI UN MINISTRO 27 1

L'ESERCITO NELLA POLITICA COLONIALE

PARTE SECONDA

CAPITOLO PRIMO
ALLE ORIGINI DELLA SPEDIZIONE PER MASSAUA
Verso una politica coloniale italiana
È stato acutamente scritto che talvolta l'imperialismo (o, nell'Italia degli anni Ottanta del secolo XIX, l' espansionismo coloniale) fu il mezzo con cui una nazione «poteva sentirsi una Grande Potenza, senza affrontare gli sfo rzi e le spese che generalmente questo im1
Perché questo potesse compiutamente realizzarsi erano però necessarie molte condizioni: fondatezza delle aspirazioni (i n questo caso, a 'grande potenza'), saldezza della guida politica nel perseguirle, beneplacito internazionale , coordinamento ed efficienza degli strumenti istituzionali - politici, diplomatici, militari - attivati. Poche di queste condizio ni erano presenti in Italia quando - a metà circa degli anni Ottanta - si cominciò a pensare più concretamente ad una presa di possesso diretta di territori non nazionali e non europei 2 .
1 TAYLOR. L'Europa delle grandi potenze. Da Mettemich a Lenin, cit., p. 382. Per una prima sintesi delle vicende del colonialismo italiano cfr. G. ROCHAT, Il colo· nialismo italiano. Torino, Loescher, 1973 .
2 Cfr. ivi, pp. 20-21; BATTAGLIA, Lapn'mague"a d'Africa, cit., p. 159; DEL BOCA, Gli italiani in Africa orientale. Dall'unità alla marda su Roma, cit., p. 3. Sostanzialmente, eludono la riflessione su tale cruciale problema C. GIGLIO, L 'impresa di MaJiaua 1884-1885, Roma, Ediz. Istituro Italiano per l'Africa. 1955; C. ZAGHI, Le ongini della colo nia En.trea, Bologna, Cappelli, 1934, e, al fondo, fa ugualmente lo stesso R. ClASCA, Storia coloniale dell'italia contemporanea, Milano , Hoc: p li, 1938. Per un quadro europeo cfr. SJ. WOOLF , La trasformazione del mondo europeo 1880-1910, in cQuaderni storici•, a. VII (1972). n. 2, e V. CASTRONOVO, Congiuntura economica e politica colonialista, in ivi. Per un primo inquadramento sui problemi principali della 'storiografia coloniale' italiana cfr. R. CIASCA, La politica coloniale dell'itgfia, in Questioni di storia del Risorgimento e dell'unità d 'italia , a cu ra di E. Rota , Milano, Marzorati , 1951; e R. RAINERO, Colonialismo e imperialismo italiano n ella storiografo italiana del secondo dopogue"a, in L 'Italia unita. Problemi ed interpretazioni storiografiche, a cura di R. Rainero, Milano, Marzorati, 1981. Due importanti ed

Comunque, anche un'ipotetica presenza di quelle condizioni non garantiva che, prima o poi, 'gli sforzi e le spese' - evitati al momento della nascita della politica colonia le - non avrebbero potuto divenire necessari o obbligatori in una seconda fase.
Nell' It al ia unita, pe r il g rave fa rdello d i p roblem i interni (e per il fatto che a lungo la politica estera aveva avuto come principale scopo quello di prevenire ch e fosse risollevata la 'questio n e roma n a') 3, concrete aspi raz i oni diplomatiche ad una seria espansione coloniale erano nate tardi 4.
Sp esso vi supplivano, creando miti e fa n tasie (come quello dell' Africa com e 'Venere nera' che a tt endeva impaziente un am p lesso italiano), l'interesse e l'iniziativa privata. Pio n ie ri e ' precurso ri' il col onialismo i t aliano, infat ti, n e e bbe . Ma erano spesso missi onari, viaggiatori ed avventurieri che - si a pure sotto l'occhio vigile e benevolo dell o Stato- si muovevano pe r proprio conto, con personal i mete di affari o di gloria 5.
Le cose potevano cambiare solo quan do, insieme a questi p e rson aggi isolati, si fossero mossi interessi economici so stanziali, o a lm eno intraprendenti . Ed all ora, co m e nel caso della mi ssio n e di Sap e t o
aggiornate rassegne dal taglio problematico sono quelle di G.P. CALCHI NOVATI, Co · lonialismo: la questione, in Il mondo contemporaneo. Politica internazionale , a cura di L. Bonanate, Firenze, La Nuova ltalia, 1978; c A.M. GENTILI, Colonialismo: recenti sviluppi del dibattito, sempre in ivi. Assai utile aoche A. BOZZO, Colonialismo, in Il mondo contemporaneo. Gli strumenti della ricerca. Percorsi di lettura, v. I, Firenze, La Nuova Italia, 1981. Recentemente, ha destato in teresse l'antologia di L GOGLIA, F. GRASSI, Il colonialismo italiano da Adua all'impero, Bari, Late rza, 198 1.
3 Cfr. CHABOD, Storia della politica estera italiana dal1870 a/1896, ci t., p. 2 15; PERTICONE , La politica estera italiana dal1861 al1914, cir., p. 27.

4 GIGLIO, L 'impresa di Massaua. 1884 -1885, cit. , a p. 12, dice che «come detto , i Governi ital iani - dal 1861 al 1882 - non ebbe ro nessu n p rog ramma o indirizzo a -coloniali, un po' per paura e incapacità:>. Cfr. anche Il colonialismo nella stona d'Italta 1882 1949, a cura di G Bosco Naitza, Firenze, La Nuova Italia, 1975. Per una veloce sintesi cfr. J.L. MIEGE, L 'imperialismo coloniale italiano. Dal1870 ai giorni nostri, (1968), Milano, Rizzoli, 1976.
5 Cfr. F. SURDICH, Breve profilo di storia delle esplorazioni, Genova, Bozzi, 1974; ID. , Momenti e problemi di storia delle esplorazioni, Genova, Bozzi, 1976; ed anche ID., Esplorazioni geografiche e svduppo del colomalismo nell 'età della rivoluzione industnale, Firenze, La Nuova Italia, 2 voli. 1979-1980. Su aspetti più specifici cfr. poi M. CARAZZI, La Società Geografica Italtana e l'esplorazione coloniale tn Africa, Firenze, La Nuova Italia, 1972; A. MILANINI KEMENY , La Società d'Esplorazione Commerczale in Africa e la politica colomale, Firenze, La Nuova Italia, 1973 . Cfr. anche S. SACCONE , L BROCCOLI, G. MAURIZI, Aspetti politici ed economici nell'esplora · zione italiana deii 'Afnca (1864-1900), Bologna, Patron, 1976. Pe r un aspetto specifico cfr. L. FABBRI , La Società Geografica Italiana e l 'esplorazione deii'Etiopza, in cBollettino del Museo del Risorgimento di Bologna• , a. X (1965), pp. 27-38.
276 l'ESERCITO NEllA POLITICA COLONIALE
del1869, che viaggiava per interesse dell'armatore genovese Rubartino 6, si poteva anche mobilitare in prima persona lo Stato, inviando una nave militare e il futuro ammiraglio Guglielmo Acton 7. Ma nel primo ventennio di vita unitaria questi furono solo casi sporadiCl.
Gli interessi privati ce no si avvalsero anche dell'operato delle 'società geografiche', primo vero esempio di permanenti centri di propaganda coloniale. Ma queste, sia pure importanti ed in vari modi collegate al potere politico, non riuscivano ancora a prendere l ' estensione auspicata dai loro organizzatori 8 . Inoltre, fatto talvolta trascurato, molti dei loro membri risentivano ancora di una cena impostazione 'umaniscica' del pensiero geografico nazionale, impostazione per più versi 'pac ifica' , tollerante e quasi rousseauiana nei confronti dei 'popoli incivili' 9. Da questi si differenziavano, comunque, oltre ai veri e propri uomini d'azione, i geografi colonial isti , i - non molti ma battaglieri - sostenitori della ' geografia esploratri ce'.
Tutto ciò , insomma, confermava l'assenza di una vera presenza dello Stato o del Governo in quanto tali. Man cava una politica coloniale.
Strutturalmente, le cose cominciarono a cambiare forse dopo il 1878 quando, al Congresso di Berlino , l 'Italia fu all'inizio accolta da tutto il 'co ncerto europeo ' come 'grande potenza' 10. Non che questo segnasse un radicale mutamento nell 'imp ressione che Roma dava alle Cancellerie europee. Bismarck, pensando ai vari Stati regionali preunitari della peniso la , aveva detto in quel periodo a proposito dell'Italia che «dalla somma di tanti piccoli Stati non poteva uscire, ovviamente, che un grande Stato» 11 Ma Berlino nel1878 (sia
6 Cfr. BATIAGLIA, Lapn mague"a d'Afnca, cit., pp. 77 -87; DEL BOCA , Gli ilaliani in Africa on'entale Dall'unità alla marcia su Roma, cir., pp. 36-40.

7 Cfr G. FIORAVANZO , G VITI, L'opera della Man na, Roma , 1954 (che è il volume II della se rie storico-militare de L 'Italia in Africa).
8 Cfr CAR AZZI , La Società Geografica Italiana e l 'esplorazione coloniale in Afn'ca, cit., p. 40 e p. 52.
9 Cfr. L LUZZANA CARACI, La geograjza italiana tra '800 e '900 (dall'Unità a Olinto Mann ellt), Genova, Ti p Esse bi, 1983 (in testa al fronc.: Università di Genova. Facoltà di Magistero Pubblicazioni deii'Isciruto di Scienze Geog rafiche), p. 13 e sgg.
1° Cfr. PERTICONE , La politica estera italiana dal 1861 al 1914, cit., p. 12; AlBRECHT- CARRÉ, Storia diplomattca d 'Europa 1815-1968, cit., p. 194 e sgg. Cfr anche l'acuta si nte si di E. COLLOTII , Congresso di Berlino, in TI mondo contemporaneo. Politica tntemazionale, a cura di L. Bonanate , Firenze, La Nuova Italia, 1979, pp. 65 -76.
11 PERTICONE , La poltltca estera italiana rla/1861 al 1914 , cit., p. 16.
AllE ORIGINI DEI.I.A SPEDIZIONE PER MASSA UA 277
pure senza considerare i reali esiti di quella che fu la presenza diplomatica italiana a quella assise) indicava un ceno mutamento di rotta: cosa che non doveva essere senza conseguenze anche per la politica di 'espansione coloniale'.
Proprio l'anno seguente, in coincidenza con lo scadere del trattato firmato un decennio prima da Sapeto per Rubattino (trattato con cui l'armatore genovese acquistava la baia di Assab ), si assisté ad un primo importante atto politico in quella direzione. Tra la fine del 1879 ed il maggio 1880 i contratti che rinnovavano la proprie tà privata di Assab e di una più larga parte del territorio che vi si affacciava venivano controfirmati, «in assenza di autorità consolari», da un militare della Marina italiana, il De Amezaga 12 .
Rubattino, però, intendeva disfarsi quasi da subito di questa sua 'proprietà', e iniziò le pratiche per vendere al Governo i suoi diritti sulla zona. E così, dopo una complessa vertenza diplomatica con l'Egitto, appianata dali' intervento favorevole all'Italia della Gran Bretagna , il Governo italiano prendeva possesso il 10 marzo 1882 della baia di Assab 13
Sia pure certo non all'interno di un vero piano complessivo coloniale, l'Italia aveva adesso la sua prima colonia. L'intervento politico e statale lo aveva sancito.
È ovvio, però, che gli interessi della politica estera italiana continuavano ad essere ben altri. Le preoccupazioni continentali non potevano non essere prioritarie, proprio quando tra le varie Potenze europee tornavano a manifestarsi i vecchi contrasti, appena sopiti e solo in parte riorientati dal Congresso di Berlino. La Germania continuava, nei confronti di Vienna, ora ad esagerare ora a minimizzare il fantasma del pericolo russo, per poter controllare meglio sia le aspirazioni dell'Impero Austroungarico sia quelle degli Zar , tra loro sempre più spesso contraddittorie 14. L'Inghilterra si poneva in frontale
12 Lo ricordava BATTAGLIA , La prima gue"a d'Afnca , cit. , p. 141.
13 Tutti concordano sul valore del passaggio del 1882. Cfr. tra gli altri, GIGLIO, L 'impresa di Massaua 1884 -1885, cit., p. 13 e sgg. Cfr. anche L'Italia in Africa, serie storica, La politica coloniale dell'Italia negli atti, documenti e discussioni parlamentari, a cura di G. Perticone e G. Gugliella, Roma , 1965 (opera del Comitato per la documentazione dell'opera dell'Italia io Mrica, presso il Mininstero degli Mfari Esteri) e soprattutto L 'Afnca italiana al Parlamento nazionale 1882 - 1905, a cura di B. Pellegrini, Roma, 1907 (opera per incarico della Direzione Centrale degli Affari Coloniali del Ministero degli Affari Esteri).
14 Cfr. TAYLOR, L'Europa delle grandi potenze. Da Mettemich a Lenin, cit., p. 364 e sgg.

278 L'ESERCITO NELLA POUTICA COLONIALE
contrasto con la Francia a proposito del Mediterraneo e del protettorato sull'Egitto 15.
In tutto questo (e con pesanti interferenze di personaggi e motivi di politica interna negli ambiti della politica estera) 16, l'Italia cercava di consolidare il suo nuovo prestigio di ' grande potenza' continentale. La stipulazione del trattato della Triplice Alleanza, prima di tutto, rispondeva a queste es igenze
Ciò avveniva anche a scapito di - o comunque non favorendo -altri importanti e vitali interessi italiani. Era il caso del Mediterraneo.
È difficile infatti parlare di politica mediterranea , nell'Italia di quegli anni. Eppure i l problema esisteva: e toccava l ' autonomia , il non-accerchiamento, lo sviluppo futuro degli interessi commerciali, marittimi e strategici della nazi one I7. Qualche pubbli cista, da tempo, se ne era accorto e aveva predi cato il destino sui mari della 'terza Italia' 18 . Ma gli interessi economici che avrebbero dovuto sostenere una tale politica solo allora si stavano rafforzando e concentrando 19; e gli spazi diplomatici non erano tra i più ampi, proprio quandonelle vertenze che si erano seguite a propo sito di Marocco ed Egitto - era stato pesantemente riaffermato il potere marittimo mediterraneo della Gran Bretagna , disposta tutt'al più a tollerare una cena prevalenza francese ne l Mediterraneo occidentale.
In tali frangenti, in aggiunta a queste difficoltà st rutturali , il dato politi co che si era evidenziato da parte italiana era stato quello dell'incertezza e della co ntraddittorietà.
Quando l'Inghilterra nel 1882 aveva chiesto aJl'ltalia di intervenire assieme ad essa per poter istituire un protettorato sulle province egiziane (cosa che poi Londra fece comun que da sola), la politica estera di Roma fu per lo meno oscillante. «<n un primo tempo Mancini cerca di entrare nell'in tesa occidentale e, addirittura di so-
15 Cfr. ALBRECHT-CARRÉ, Storia diplomatica d'Europa 1815-1968, cit., p. 211 e sgg '

l6 Come ha sottolineato MINNITI , Esercito e politica da Porta Pia alla Tnplice Alleanza, cit., pp. 114-144.
11 Cenni , talvolta apologetici, in ZAGHI, P.S. Mancini e il problema del Mediterraneo 1884- 1885, cit
18 Cfr. CHABOD, Storia della politica estera italiana dal 1870 al1896, cit., p. 302.
l9 Cfr. ad esempio U. SPA DONl , linee di navigazione e costruzioni navali alla vigilia dell 'Inchiesta parlamentare sulla Manna mercantile italiana (1881·1882), in «Nuova rivista a. LVII (1973), n 3-4 , p. 313.
All.E ORIGINI DELlA SPEDIZIONE PER MASSAUA 279
stituire la Francia e di fare un accordo a due con la Gran Bretagna; poi punta risolutamente sul concerto europeo, un principio politico col quale egli pensa di non staccarsi dagli Impe ri centrali e, nel contempo, di tenersi legato alla Gran Bretagna. Ma quando questa la invita a cooperare in Egitto, rifiuta» 20. In tale altalena di posizioni diplomatiche , il dato notevole non pare tanto il perché di quell'ultimo, importante rifiuto , bensì la costatazione della assoluta mancanza di un piano 'mediterraneo' di pane italiana. In questo senso acquista maggior valore il fatto che una parte di queste oscillazioni fosse da ricondurre anche all'incerta posizione politico-parlamentare dello stesso Mini stro degli Esteri, sempre costretto a 'mediare' tra spinte politiche interne diverse e -come è stato notato a propos ito delle trattative che avevano condotto alla firma della Triplice Alleanzaampiamente contrastanti.
Analogo comportamento si evidenziò poi all'ennesima manifestazione della cosiddetta 'questione marocchina' tra Francia e Spagna, nella primavera-estate del 1884 21 . Mancini assunse anche in questa occasione un atteggiamento non univoco e chiaro e solo quando la venenza pareva assestarsi da sola avanzò, difensivamente, il principio del mantenimento assoluto dello status quo nel Mediterraneo quale chiave principale della difesa degli interessi italiani nell'area. Ma era davvero troppo poco per poter parlare di un 'piano' italiano per il Mediterraneo.
Semmai, il dato interessante che era riemerso in quelle settimane del1884 era l'inesistente protezione offerta dalla Triplice Alleanza - firmata solo due anni prima - nei confronti degli interessi (anche solo difensivi) dell'Italia nel Mediterraneo. In tutta la questione 'marocchina', infatti, Germania ed Austria si disinteressarono completamente della minaccia che un'estensione della presenza francese sulle coste meridionali del Mediterraneo occidentale avrebbe potuto significare per l 'Italia marittima, per i suoi interessi commerciali e per la sua libertà d'azione strategica . Come se questo non bastasse, a ciò si doveva aggiungere anche una cena incoerenza degli stessi ambienti diplomatici italiani. Mancini, proprio quando predicava ed 'esigeva' il mantenimento dello status quo, dava disposizioni perché si studiasse un piano militare italiano di occupazione delle

280 L'ESERCITO NELLA POLITICA COLONIALE
20 G. TALAMO, li mancato intervento italiano in Egitto, in storica del Risorgimento» , a. XLV (1958), o. 3, p. 448.
2 1 Cfr. P. BALDOCCI, Mancini e la questione marocchina, in «Rivis ta di studi politici internazionali•, a XXIII (1956), n. 2 , p. 235 ·236.
coste tripolitane , nel caso la Francia avesse dato vita a ulteriori forme di pressione armata sul Regno Marocchino 22
L'oscillazione diplomatica del Governo e lo stato di impotenza dell'intera politica nazionale avevano nel frattempo raggiunto e colpito l'opinione pubblica e parlamentare. Soprattutto i settori più conservatori della politica italiana mettevano sotto accusa l'operato del Ministro Manc.ni, peraltro uno dei più importanti esponenti della Sinistra storica e della maggioranza trasformista di Depretis. Da parte sua, l'anziano p residente del Consiglio non poteva non essere in qualche modo sensibile a queste proteste conservatrici, proprio quando egli andava continuamente spostando l'asse del suo Gabinetto verso Destra, rimuovendo e sostituendo Ministri 23. Il Ministro degli Esteri , quindi, si sentì 'mancare la terra sotto i piedi'.
A quel punto per Mancini, trovare un qualche successo io poliùca estera poteva significare allungare e legittimare la sua stessa presenza alla Consulta, prima ancora che comportare qualche decisivo miglioramento della situazione diplomatica dell'Italia.
Se davvero fossero costate , come avevamo de t to, ' poco sforzo e poca spesa', le imprese coloniali avrebbero potuto salvare Mancini.
La cosa non appariva in quei giorni senza fondamento.
Proprio in quella estate dell884, che era venuta dopo la brutta prova diplomatica italiana sulla questione marocchina , si era andato riaccendendo in Italia il dibattito politico sui temi coloniali. L' organo di stampa più autorevole dell'opposi zione conservatrice titolava significatamente «La Germania colonizza. E l'Italia?». La passata politica dei Governi Depretis a tale riguardo veniva icastivamente stigmatizzata, quando si scriveva che «Assab non è una colonia, è una parodia coloniale». «L'opinione» concludeva ammonendo «ma non sarà troppo tardi se si indugia troppo?» 24. Attraverso queste campagne di stampa, la D estra cercava di influenzare la successiva condotta italiana alla Conferenza di Berlino nella quale, nell'inverno 1884-85, le grandi potenze si sarebbero riunite per dirimere alcune
22 Questa prospettiva si affacciò in due diverse occasioni: nella primavera 1884 e poi nell'aurunno di quell'anno (cfr. ZAGHI, P.S. Mancini e ti problema de/ Mediterraneo 1884- 1885, cit. , p. 74, che pubblica in appendice anche una lettera di Mancini a Ricotti in data 21 novembre 1884, ivi, alle pp 151-152).

23 Cfr. CAROCCJ, Agostino Depretis e fa politica interna da/ 1876 a/ 1887, cit., p. 309.
24 «L ' Opinione:., 22 settembre 1884 , La Germania colonizza, e l'Italia?.
ALLE
ORIGINI DEllA SPEDIZIONE PER MASSA UA 281
importanti conuoversie coloniali 2 5. Se l'opposizione scalpitava, la maggioranza parlamentare sembrava invece lontan a dal pensare a ipotetiche imprese coloniali italiane.
Significativamente, il quotidiano portavoce degli ambienti più legati alla presidenza del Consiglio invitava i 'colonial isti' a tener presente che «le colo nie devono nascere laddove ci [fossero stati] davvero interessi nazionali , e non con atti di puro imperio politi co». E , dal momento che i più antichi e più consolidati insediamenti di Italiani all'estero erano localizzati in America Latina, era lì che doveva andare l'attenzione nazionale. In altre parole: niente colonie 26 . Riassumendo, l'incerte zza della politica estera di Man ci ni , la mancanza di una copertura diplomatica da pane della Triplice Alleanza, la sostanziale assenza di grossi interessi economici privati nazionali, il disinteresse se non la vera e propria ostilità della Presidenza del Consiglio: erano questi tutti fattori che inducevano a pensare che ancora per un lungo tempo non ci sarebbero state le cond izi oni per una politica col oniale italiana.
Invece, ed in gran segreto, tra l'estate e l'autunno-inverno 1884, Mancini preparò la spedizione di Massaua e con essa diede avvio all' espansione italiana in Mrica.
Le modalità con cui ciò fu fatto sono già in pane note 27: è comunque questo un aspe tto che non riguarda specificatamente questo studio, incentrato sulla conduzione politico-milita re della prima colonia italiana.
Ceno, di quelJa fase preparatoria qualcosa si riflesse ne lJ a vera e propria con duzion e della co lo nia: e gli stu di già disponibili sull'espansione coloniale italiana lo hanno più volte messo in luce.
La stessa scelta del luogo per la prima vera colonia italiana, sem-
25 L'importanza di quelle assisi era presemira anche dai contemporanei. Cfr. E. CATELLANI, Le colonie e la Conferenza di Berlino, Torino, 1885. Recentemente, sulla conferenza di Berlino, cfr. T. FILESI, L ' Italia e la Conferenza di Berlino 1882-1885, Roma, Ediz. Istituto !taio-africano, 1985.
26 cll popolo 6 agosco 1884, Le nostre colonie.
27 La bibliografia fondamentale sulla spedizione si riduce a: BATTAGUA , La prima gue"a d'Africa, cit. ; DEl BOCA, Gli italiani in Africa onentale. Dall'unità alla marcia su Roma, cir.; GIGLIO, L 'impresa di MaiSaua. 1884-1885, cir.; oltre al vecchio ma ancora utile L. CHIALA, La spedizione di Massaua. Na"azione documentata, To rino, Roux, 1888. Inoltre cfr. Storia militare della Colonia Eritrea, Roma, Tip. Regionale, 1935-1936 (io testa al front.: Ministero della Guerra. Ufficio Storico); Italia in Africa, serie storica, v. l. Etiopia e Mar Rosso (1857 - 1885), a cura di C. Giglio, Roma, 1958-1960; A. GIANNI, Italia e lnghdte"a alle porte del Sudan: la spedizione di Massaua {1885), Pisa, Nistri Lischi, 1940.

282 L'ESE.ROTO NEil.A POLITICA COLONIALE
brava eccentrica rispetto ai tradizionali obiettivi (Mediterraneo) come alle mete che avvenimenti più recenti avevano sembrato valorizzare (Tripolitania) 28 .
Continuò a mancare un vero e proprio piano di politica coloniale, la guida politica dell'impresa si rivelò poi superficiale quando non (e fu nella maggior parte dei casi) contraddittOria ed oscillante , il favore internazionale (con cui pure fu obiettivamente vista all'inizio questa prima spedizione coloniale italiana) parve poi dissolversi in momenti decisivi e drammatici. Dopo qualche tempo , e per noi significherà alla fine di questo studio , la politi ca col o niale italiana richiese molti più sforzi e molte più spese di quanto in un primo momento s1 era pensat o .
Ma, se questi erano aspetti che sarebbero diventati evidenti solo dopo qualche tempo , il dato che invece colpì immediatamente gli osservatori politici e l'opinione pubblica era il gran segreto in cui fu avvolta tutta la fase della preparazione della spedizione per il Mar Rosso.

Le stesse ' società geografiche ', che pure avrebbero potuto forse preparare una migliore campagna propagandistica per l'avvio di una politica coloniale italiana, non furono sufficie ntemente mobilitate. Tutto fu preparato tra poche persone: diplomatici , politici , militari. Tra i pochi segnali, per cui l'opinione pubbli ca poteva capire che qualcosa di impanante si stava preparando , i più autorevoli giungevano attraverso gli articoli del «Diritto», quotidiano considerato la voce ufficiosa della Consulta. Il l o gennaio 1885 , a conferma che la posizione attendista di Depreris era ormai stata gi à battuta nel segreto delle trattative politiche , il giornale scrive va che cobbligo dell'Italia è di stare bene attenta. Il 1885 deciderà delle so rti come grande potenza>. cL' anno nuovo comincia in mezz o alla fr e n es ia , ad un vero steeple -chase di acquisti coloniali in tutte le parti del m o ndo. L' aurora del 1885 illumina uno spettacolo non mai vedu to, quello delle bandiere di quasi tutti gli Stati europei piantate qua e là su litorali e sopra isole quasi dimenti cate». Ed a togliere qualsiasi dubbio si annunciava che «sorge adunque l'anno dell'ardim e nto » 29
28 cQuando venne la n otizia, d ell'occupu ion e di Massaua la cosa sembrava così stra n a che noi non volevamo crede rl a.. M,. CAMPER1 0, Da Assab a Dogali. Gue" e abissin e, Mil ano, D umolard , 1887, p. )7. E in sost anz a la p rima obiezione che g ià allora fu m ossa alla 'politica coloniale' dì Man cini. A livell o p ub b lìcistìco cfr. ULE MA (G iulio d ì Cast el nu ovo), Massaua o Tnpoli?, Roma, Stab. T ip og r . ! tal., 188).
29 L' artico lo de eli D iritto• sì trova ci tato in BATTAG LIA , La pn·ma g u e"a d'A· fnca, cìt. , p . 11 0 .
AllE ORJGINI OEll.A SPEDIZJONE PER MASSAUA 283
_
Si era in quei gi orni a sole due settimane dalla partenza da Napoli, il14 gennaio 1885, del primo convoglio militare per il lontano Mar Rosso. Il Governo motivò quella partenza di militari italiani con la volontà di punire gli autori del massacro di una spediz ione esploratrice italiana, quella di Bianchi, trucidata nell 'autunno 1884 in Mrica orientale; ma purtroppo non era la prima ad incontrare questa tragica ftne, e non sarebbe poi stata l'ulùma. Sino a quando gli fu possibile, il Governo indicò all'opinione pubblica il po rto di Assab quale meta del convoglio militare: così facendo si voleva accreditare l' ipotesi rassicurante di un 'rinforzo' di un possedimento gi à italiano, e non prospettare la più impegnativa meta di una conq u ista coloniale. Anche perché in questa seconda ipotesi, di fatto, viste le modalità con cui lo Stato italiano aveva ottenuto Assab (venalmente, da Rubattino), sarebbe stata la prima volta che la 'Terza Roma' si sarebbe incamminata sulla via del!' espansione co loniale.
Solo tre settimane dopo la partenza, in Italia si saprà che il battag lione di so lda ti italiani era sbarcato a Massaua (o Massawa, o Massua, o Massaoua, come indecisi riportano i giornali) il 5 febbraio 1885.
L'op inione pubblica, quindi, non sapeva molto. Il problema era sapere se il Governo conosceva più cose.
Un partecipe osservato re di quegli avvenimenti scrisse:
Il governo italiano incominciò allora a chiudersi nel più assoluto silenzio, così ha negato schiarimenti sulla sua politica assai più che qualunque ministro degli esteri avrebbero fatto in qualunque altro lib ero paese del mondo, e sono per dire anche non libero. Noi siamo stati tenuti, ed il paese con noi, soverchiameote al buio. Il Ministro quando ha discorso non ha mai esposto con una parola semplice, chiara, esatta. il concetto suo; e talora, pure di dire, ha divagato tanto e così lungamente che ha lasciato al Paese, ai deputati , una maggiore voglia , una maggiore stizza , direi , di non potere, attraverso discorsi così lunghi , giungere ad afferrare un'idea che pareva doveva essere rivelata da quelli. Questa condotta lasciò nel paese il sospetto che quello che non si diceva non si potesse per nessuna maniera dire , e provocò negli animi alternativamente illusioni ed accasciamenti 30
In conclusione: nei primi giorni della spedizione per il Mar Rosso,
30 A. BRUNIALTI , L'Italia e la questione coloniale. SJudi e proposte, Milano, Brignola , 1885, p. 321. Dei nomi di luogo e di persona è stata adottata la grafia del tempo, anche quando distorcente e talvolta errata. Lo si è fatto per non creare ambiguità tra testi con rraslirterazioae corretta e citazioni dal materiale documentario coevo con grafia errata. Più consistente era la questione rerminologica Etiopia / Abissinia. Quando non palesemente errato e talvolta pur coscienti della possibile imprecisione si è teso a considerare i due termini come simili. Si è cercato invece di non usare il termine Eritrea.

284 L' ESERCITO NEU..A POUTICA
COLO NIALE
aspetti segreti e aspetti pubbli ci, questioni di politi ca interna equestioni di politica estera , parevano far temere che il primo tentativo coloniale italiano stesse nascendo sotto cattivi auspici.
Per capire come mai si andò ugualmente a Massaua rimane ancora da guardare in due direzioni: gettando uno sguardo più lontano alle politiche coloniali delle altre potenze europee ed alle condizioni dell'area geografica in cui si voleva iniziata l'es pansione italiana , e gettandone un altro , più ravvicinato , all'ambiente ' colonialista ' nazionale , alle modalità diplomatiche con cui fu permesso all'Italia di Mancini ed a quel complesso di uomini e di s trutture militari di approdare sulle cost e del Mar Rosso
Il colonialismo delle potenze europee
N el penultimo decennio del secolo XIX il col o nialismo era già di venuto un sistema mondiale , con le sue leggi , le sue teorie , i suoi protagonisti 1 Era l ' inizi o d e lla spartizione del mondo in sfere di dominio politico e mili t are: ma l e grandi potenze europee arrivavano già preparate a quest ' appuntamento. I meccanismi diplomatici, politici , militari, ideologici che l'esperienza coloniale mise in moto erano già oleati quando, come è stato detto, «gli anni '80 videro l' esplosione della febbre coloniale in tutta Europa» 2
Silenziosamente, ma concretamente, da almeno un decennio si e ra iniziato a gettare le fondamenta di questo nuovo assetto delle relazioni internazionali a live ll o mondiale. Oltre l ' Inghilterra , che av e va solo da consolidare un impero già vasti ssim o e da 'completarlo ' in alcune zone cruciali , già altre potenze ave vano iniziato ad attivare quelle forze che avrebbero permesso la conquista ed il mantenimento di vasti imperi coloniali 3 .
Gli avvenimenti sarebbero da allora andati succedendosi senza tregua e, considerati sulla lunga durata dello sviluppo del mondo,
1 Sottolinea qu esto aspetto RAG IO NIERI , La storia politica e sociale, cit., p . 1747.
2 ROCHAT , U colon ialismo italiano , cir. , p . 2 1. Cfr. anche W . L. LA N GER, L'Europa in pace 1871-1890 , Fite nz e, Vallecchi , 19 55 ; e , p er talune linee di te n d en za, ID ., La diplom azia d ell'imperialismo 1890- 1902, Milano, ISPI, 1942 .
3 Cf r. F.H. HINSLEY , Introduzio n e, a S t oria del mondo moderno, v. Xl , L'espansion e colo niale e i problemi sociali 1870- 1898 , p . 44 .

AllE ORJGINI DEllA SPEDIZI ONE PER MASSAUA 28 5
avrebbero avuto effetti sconvolgenti 4 li continente africano, se nel 1870 vedeva solo un decimo del suo territorio in mano agli europei, nel1914 era completamente occupato e dominato dai bianchi, con la sola eccezione sporadica della Liberia e dell'Etiopia 5.
E proprio su questo continente dovettero concentrarsi negli anni Ottanta le mire colonialiste delle potenze europee 6.
L'Inghilterra, che già nel 1867 aveva tentato di aggredire l'Etiopia, ma con scarsi risultati militari e politici, pareva fortemente interessata al controllo della zona del Canale di Suez ed in generale a quell'area, cosl strategicamente situata sulla rotta per l'India. Nel 1879 assunse, insieme alla Francia, un controllo congiunto sulle Casse del Tesoro del governo egiziano. Quando il movimento nazionalista di 'Arabi Pacha si ribellò a questa situazione di sudditanza, Londra non esitò ad inviare le sue cannoniere nel porto di Alessandria e a bombardarlo; ingaggiò poi battaglia con l'esercito di 'Arabi, lo sconfisse e diede inizio all'occupazione integralmente britannica dell'Egitto. Dopo qualche periodo di relativa calma, però un altro gravissimo problema veniva ad affliggere il dominio britannico nella zona: la rivolta religiosa e nazionalistica del Mahdi La ribellione popolare era partita dal Sudan, che dal1822 era considerato una delle provincie dell'Egitto, ma i suo i riflessi si sentirono in tutta l'area musulmana. La Gran Bretagna, sin dal momento deLla sua occupazione dell'Egitto, venne coinvolta quindi neJl'affare sudanese. Londra tentò di soffocare la rivolta, uno dei cui primi obiettivi era di riscattare l' au-
4 Stupisce in questo senso il giudizio di F. BRAUDEl, Il mondo attuale, Torino, Einaudi, 1966 (ed. coos. 1977), v. l, pp. 167-169. Circa l'Etiopia, cfr. anche ivi, p. 152 e sgg.
5 Cfr. W. MARKOV , Sommario di storia coloniale, Roma, Editori riuniti, 1961 (ma ed. coos. 1975), p. 39.
6 Per questi temi cfr. anche D.H. FIEWHOUSE, Politica ed economia del colonialismo 1870-1945, BaJi, Laterza, 1980; R. LURAGHJ, Ascesa e tramonto del colonialismo, Torino, UTET, 1964; C. GIGLIO, Il mondo africano, in Stona politù:a universale, Novara, De Agostini, 1971, v. VIII, pp. 161-446; R. RAlNERO, Storia dei'Afni:a dall'epoca coloniale ad oggi, Torino, ERI, 1966. Per un aggiornato e critico inquadramento cfr. G. CAROCCI, L'età dell'imperialismo, Bologna, Il Mulino , 1979. Assai datati, ma ancora difficilmente sostituibili da analoghe ricerche in lingua italiana, sono gli studi suJ colonialismo delle varie potenze europee Tra gli altri cfr. G MONDAINI , Storia colonide dell'epoca contemporanea, v. I, La colonizzazione inglese, Firenze, 1916;
C. GIGLIO, La politica afncana dell'lnghi/temz ne/secolo XIX, Padova, Cedam, 1950;
P. GIORDANI, L'impenizlismo coloniale tedesco. Come nacque e come finisce, Milano, 1915;
C. DI MARZIO , Ongini e sviluppo della colonizzazione belga, Napoli, 1938;
R. RAINERO, L 'espansionismo colonide francese dalle ongini alla pn·ma guerra mondiale, in cTerzo programma•, a. III (1962), pp. 16-61.

286 L'ESERCITO NEllA
POUTICA COLONIAU
tonomia del Sudan dal Cairo. La lotta ebbe fasi alterne. Ma nel novembre 1883 le truppe anglo-egiziane sub irono ad el-Obeid una disfatta militare pesantissima: il governo del Cairo fu costretto addirittura alle dimissioni. Il nuovo governo, formatosi 1'8 gennaio 1884 dovette inserire, di fronte all'estendersi del moto mahdista, come punto fondamentale del suo programma, il ritiro dell'Egitto dal Sudan.
Dal canto suo la Francia, in questo incoraggiata dall'opinione pubblica interna e dalla Germania, si era posta con l 'inizio degli anni Ottanta più decisamente sulla via dell' espansio ne coloniale. Da decenni presente in Algeria, e dopo l'alterna parentesi egiziana, si installò nel 1881 in Tunisia , nel 1883 aggredì il Madagas car e nel 1884 prese la Guinea.

La Germania, oltre ai suoi interessi nel Pacifico meridi onale, andava nel frattempo concretizzando i suoi precedenti sforzi diplomatici in direzione africana, dichiarando nel 1884 un suo protettorato su Togo, Camerun ed Mrica sud-occidentale.
Il Belgio, infine, che già dal1876 aveva fondato la 'Association lnternationale Africaine', istituì nel 1885 un proprio 'Stato libero del Congo'.
Questa breve analisi delle principali linee d'espansione europea in Mrica (e che quindi non tiene conto dei molteplici altri interessi che portavano nel frattempo l'Inghilterra in Afghanistan, la Francia in Cocincina e nel Tonchino, etc.) non fmisce casualmente con la questione del Congo 'belga'. Fu infatti proprio per dirimere alcune questioni diplomatiche in merito a tale occupazione che fu convocata a Berlino nell'inverno 1884-85 un'importante Conferenza delle grandi potenze coloniali (cui abbiamo già fatto riferimento in precedenza a proposi to delle aspettative che essa creò nell'opinione pubblica conservatrice italiana).
Dopo una prima fase di espansione coloniale, che aveva visto gli europe i occupare zone del territorio africano con atti unilaterali e con procedure assai diversificate da caso a caso (al punto da creare motivi di attrito tra le varie Potenze, come successe appunto per il Congo) , parve infatti necessario accordarsi in modo che gli aspetti diplomatici formali non costituissero più un intralcio a quella espansione. Fu così che, esaurito l' affaire Belgio-Congo, i rappre sentanti diplomatici europei trovarono opportuno stabilire una volta per tutte le modalità - diplomatiche e politiche - con cui una potenza europea poteva stabilire il proprio dominio , o protettorato , od occupazione , su un territorio ' non-civilizzato '.
AllE ORIGINI DELLA SPEDIZIONE PER MASSAUA 287
L'Atto generale finale della Conferenza comprendeva sei dichiarazioni. Una di queste determinava che
La Potenza che d'ora innanzi prenderà possesso di un territorio sulle coste del continente africano, o che , non avendone avuto fino a quel momento, verrebbe ad acquistarne, o ugualmente , la Potenza che vi assumerà un protettorato, accompagnerà l'atto rispettivo con una notifica, indirizzata alle altre Potenze firmatarie del presente Atto, a fine di metterle in grado di far valere , se vi ha luogo, i loro reclami 7
Con il principio della 'notifica', si doveva quindi legittimare e dare nuovo impulso allo scramble for Africa: la spartizione dell'Africa fra le potenze europee aveva finalmente trovato la sua legge.
Anche l'Italia, che partecipò alla conferenza, sarebbe divenuta una 'potenza coloniale'? Anche se così' doveva alla fine essere, di lì a qualche mese, pochi lo avrebbero potuto credere a livello internazionale.
Si era saputo, per esempio, che Roma aveva fatto fatica persino per essere presente alla conferenza.
L'Italia faticava ad essere considerata a tutti gli effetti una 'grande potenza' , anche dai suoi alleati. Fu proprio la Germania infatti a commettere, nei confronti della 'terza potenza' della Triplice un grave sgarbo diplomatico. Bismarck infatti non invitò alle prime alcun rappresentante italiano.
Questo significava considerare il Regno di Umberto I alla stregua di una qualsiasi potenza minore, come la Spagna, la Grecia o la Bulgaria.
Fu solo in un secondo momento che Mancini riuscì a far correggere questa umiliante decisione di Bismarck , «vedendo che l ' Italia non era chiamata a intervenire nella Conferenza preliminare per la questione dell'Africa occidentale- come scrisse poi lo stesso Mancini in un suo appunto per Depretis, non rimanendo alle Potenze posteriormente invitate che accettare passivamente, oppure respingere con proprio danno, le prese deliberazioni» 8. Ma anche una volta ammessa a tutte le riunioni della Conferenza di Berlino, quella di Bismarck non sarebbe stata l ' ultima delle umiliazioni che l'Italia avrebbe dovuto tollerare sulla via del suo colonialismo.
7 Il passo citato in Somalia , v. I, Dalle on'gini al 1914, Roma, Tip. Regionale , 1938 (in testa al front.: Ministero della Guerra. Ufficio Storico), p. 47.
8 ACS, Carte Depretis , serie quarta , se. 7bis, fase. 73 , 18 ottobre 1884, Mancini a Depretis. In generale, cfr. P. MAYER, La politica coloniale di Bismarck alla luce dell'impen'alismo, in «Storia contemporanea» , a. V (1970), pp. 307-320.

288 L'ESERCITO NELlA POLITICA COLONIALE
Anche per quel minuscolo possesso coloniale che sarebbe stato Massaua, l'Italia fu costretta a lunghe e defatiganti trattative diplomatiche con l'Inghilterra, prima che questa concedesse il suo benestare ad una limitata e circoscritta installazione di truppe italiane sulle coste del Mar Rosso.
La decisione di Mancini di consultare Londra non era casuale. Prima di tutto l'Inghilterra era la massima potenza imperiale del mondo e controllava tra l'altro il Mediterraneo orientale e il Canale di Suez; inoltre essa era la potenza maggiormente insediata nella zona dell'Africa orientale; infine quei porti sul Mar Rosso che Mancini avrebbe voluto far occupare dai soldati italiani erano proprio alcuni di quei territori che, l'Egitto- e con esso l'Inghilterra- deteneva, ma che entro breve tempo avrebbe dovuto abbandonare (secondo il programma del nuovo governo cairota e secondo quanto Londra stava autonomamente trattando con il Negus abissino, come poi vedremo meglio).
D'altra parte la Triplice Alleanza non prevedeva nel suo primo trattato alcuna forma di 'copertura' per gli interessi o per le ambizioni italiane nel Mediterraneo e tantomeno in Africa. Mancini, che quel trattato aveva firmato, lo sapeva bene. Qualche tempo più tardi, quando le realizzazioni della politica coloniale italiana ebbero bisogno di propri miti, si accettò l' interpretazione per cui era stata addirittura l'Inghilterra ad avere chiesto l'intervento, militare e coloniale, dell'Italia nel Mar Rosso 9. Queste ricostruzioni, ingigantendo alcune voci diffuse ad arte dalla Consulta nelle prime settimane della spedizione di Massaua, sono del rutto prive di fondamento. Certo vi fu un interesse inglese a che l'Italia andasse in quelle zone, tra Assab e Massaua; ma vi fu al solo scopo che non vi si istallassero invece altri e ben più potenti Stati europei 10. Era questo, infatti, l'aspetto più preoccupante del 'piano' di Mancini per il Mar Rosso: anche solo una superficiale conoscenza dei luoghi e dei piani coloniali delle varie potenze avrebbe dovuto far risultare infatti che proprio su quell'area tra 'Eritrea', Etiopia e Suclan che vide le prime prove e che conobbe le prime aspirazioni coloniali dell'Italia, si stavano addensando le mire più varie.
9 Avvalorava questa ipotesi (peraltro fatta diffondere anche in contemporanea agli eventi) già CHIALA, La spedizione dt Massaua. Narrazione documentata, cit., p. 126 e sgg.
10 Esplicativa la canina geografica inserita in GIANNI, Italia e Inghilterra alle porte del Sudan: la spedizione di Massaua {1885), cit., tra p. 48 e p. 49. Ma cfr. anche DEL BOCA. Gli italiani in Africa orientale. Dall'unità alla marcia su Roma, ci t., p. 177.

ALLE O RIGINI O EU.A S PED IZI ONE PER MA SSAU A 289
La Francia, che proprio in quei mesi rivitalizzava i porti di Obok e Tagiura, aspirava ad incunearsi dal Mar Rosso verso l'interno. La Germania avrebbe visto con interesse la costituzione di un tutto continuo, sotto il suo dominio, tra i suoi possedimenti africani subequatoriali e i ricchi altipiani etiopici e sudanesi. Il Belgio, tramite il suo 'Stato libero del Congo', avrebbe potuto ottenere, attraverso una sua ingerenza anche in questa zona, una egemonia continentale centroafricana temibile. La stessa Etiopia, tra l'altro, avrebbe potuto inserirsi proficuamente nel vuoto di potere lasciato dal ritiro apglo-egiziano dal momento che, conquistata Cassala e liberato il territorio dalle minacciose scorribande mahdiste, avrebbe liberamente potuto aprire e chiudere le pone commerciali del ricco Sudan.
In un ceno senso, era solo l'imperversare della rivolta mahdista - religiosa e sociale insieme - a frenare in quei mesi tra il 1884 ed i11885 le ambizioni delle varie potenze interessate ad un contro llo di quelle aree. Le grandi potenze europee, oltre che a causa delle proprie reciproche contraddizioni diplomatiche, dovevano fermare i loro disegni (e le loro diplomazie, e i loro eserci ti) di fronte ad una rivolta popolare musulmana, capeggiata da un leader misterioso e poco conosciuto l l.

L'Europa coloniale attendeva che la situazione si fosse almeno in pane chiarita, per poter poi decidere sul da farsi.
Chi non voleva attendere (quando mai si sarebbe ripresentata una situazione simile?) né poteva aspettare (quanto tempo gli avrebbe ancora concesso in Parlamento l'opposizione conservatrice?) era invece Mancini.
La politica interna, la stessa permanenza di Mancini alla Consulta avevano bisogno di un 'successo' in politica estera: qualcuno parlò anche, eccedendo, di 'diversivo estero' rispetto alla più grave questione del dibattito parlamentare di quei giorni (le convenzioni ferroviarie) 12 . Di fatto, la panicolare congiuntura diplomatica e il momento di stallo imposto dalla rivolta mahdista alle mire delle altre potenze fecero forse intravedere a Mancini la possibilità di un successo 'senza sforzo e senza spesa'.
11 Qualche informazione in C. ROSSE1TI , Storia diplomah'ca deU' EJiopia durante il regno di Menelik Il, Torino , Nazionale , 1919; od an che io M. PIGU, L 'Etiopia moderna colle sue relazioni internazionali 1889-1931 , Padova, CEDAM, 19 31.
12 La voce circolava già allora anche ua i militari. Cfr. l'opuscolo del generale A BRIGNONE, La voce dell'ultima ora sulle convenzionife-rroviarie in discussione innanzi alla Camera dei DeputaH, Roma, Tip. della Pace, 1885, p. 23.
290 L' ESERCITO NEI.l.A POliTICA COLON IALE
Ma tu tto rimaneva nelle mani di Londra: se questa, nelle trattative dell'autunno-inverno 1884 avesse rifiutato l'accordo, il piano di Mancini sarebbe certo naufragato nel nulla. Perciò, pur di riuscire , egli avanzò richieste assai contenute. Egli fece chiedere dall'ambasciatore italiano a Londra se il Governo britannico avesse visto «senza gelosia una modesta estensione del nostro possedimento [di Assab] ( ... ) e fosse stabilita, se non mercè annessioni territoriali, almeno io altre forme da determinarsi, l'autorità italiana» 13
In sostanza Roma chiedeva a Londra l'autorizzazione a partire, e non voleva per allora definire le modalità precise (diplomatiche e politiche) della sua futura presenza in Mar Rosso. La cosa poteva essere io parte giustificata dal fatto che mal si conveniva ad una potenza minore dettare regole ad una potenza imperiale come quella inghese: ma piuttosto che eliminare il problema (quale era lo scopo reale della prima spedizione coloniale italiana: annessione? occupazione? protettorato? semplice influenza?), lo rimandava.
Come vedremo, proprio questo aspetto istituzionale (ma in realtà politico) fu uno dei massimi crucci degli amministratori coloniali locali e dell'intera diplomazia italiana del primo periodo della presenza a Massaua 14 .
L'acco rdo infatti tra Italia ed Inghilterra, cui si addivenne nel dicembre, si basava su un equivoco di fondo,
perché l'Inghilterra pensava ad un 'occupazione italiana temporanea delle coste del Mar Rosso( ) mentre l'Italia( ) pensava ad una conquista definitiva15.
Mancini sottovalutava l'aspetto istituzionale, accontentandosi solo del successo politico personale che la accordata benevolenza inglese alla spedizione italiana significava per lui Invece, andando a fondo oell' esame di quell'aspetto, Mancini avrebbe previsto con chiarezza tutti i primi pericoli cui sarebbe andato incontro nei mesi successivi la spedizione italiana. E avrebbe capito meglio perché l'Inghilterra si mostrava così disponibile nei confronti dell'Italia, che di fatto faceva pane di un'alleanza (la Triplice ) i .cui interessi erano divergenti da quelli inglesi.
Londra, infatti, manteneva e perfezionava i suoi piani di espan-
n Citato in GIGLIO , L'impresa di Massaua 1884-1885, cit., p. 27.
14 Qualche accenno superficiale e troppo indulgente in E. DE LEONE, L'occupazione diMassaua e ii condominio itala-egizio, in «Rassegna italiana>, a. 1954 , pp. 359-367.
GIGLIO, L'impresa di Massaua. 1884-1885, cit., p. 29.

ALLE ORIGINI DELLA SPEDIZIONE
291
PER MASSAUA
sione e di controllo in quell'area dell ' Mrica orientale.
L'Inghilterra dopo lo smacco di el-Obeid si era mossa su due piani (diplomatico e militare).
A livello diplomatico aveva inviato una missione al Negus. In quei giorni il problema principale era garantire l'indenne ritiro delle forze anglo-egiziane dal Sudan scosso dalla rivolta mahdista. L'Ammiraglio Hewett, a capo della missione, riuscì ad ottenere che il Negus si facesse garante di quel ritiro , da svolgersi attraverso il territorio abissino; in cambio il Negus avrebbe avuto la concessione del paese dei Bogos, una fertile regione dominante le coste del Mar Rosso, e la cointeressenza economica ed il condominio istituzionale (anglo-egizio-abissino) a Massaua, che era il principale sbocco al mare dell'intera regione. Il trattato Hewett, che per l'Inghilterra rivestiva una garanzia ed una importanza solo temporanea e transitoria (legata al momento del ritiro delle truppe) insieme alla conferma del suo prestigio , ebbe invece a costituire un elemento 'istituzionale' con cui tutte le potenze che fossero intervenute nella zona avrebbero dovuto fare i conti. Tra loro, per prima, proprio quella italiana. Con i suoi confini così mal stabiliti (tra area di influenza abissina e territorio anglo-egiziano , che appunto si apprestava a divenire italiano) il uattato Hewett non doveva tardare a divenire il ' pomo della discordia' tra Italia ed Etiopia 16 o, il che era lo stesso, se pure talvolta i Comandanti militari italiani non se ne avvidero, tra Corpo di spedizione italiano ed esercito abissino .
Al livello militare , inoltre, l'Inghilterra si era premunita occupando Suakim, il miglior pono naturale del Mar Rosso, e inviando a garanzia dello sgombero di Khanoum (dove arrivarono ad essere presenti 6.000 soldati britannici su SS.OOO abitanti ) il generale Gordon con un nerbo di truppe. Qui, paradossalmente , il piano inglese cominciò ad incontrare i primi intoppi. Se Gordon era incaricato di presiedere al solo sgombero della guarnigione, poi non volle estranearsi dai tentacoli della complessa situazione civile e religiosa della zona (ed in sostanza dalla rivolta mahdista). A quel punto, mentre Cassala, stava per essere sgomberata sotto l 'egida abissina, Khanoum mahdista teneva in scacco Go rd on e la sua potente guarnigione. Seppure con riluttanza , Londra fu costretta ad organizzare un'altra spe-
16 La defini zio n e è in G IANNI, Italia e Ing h ilt erra alle porte d el Sudan : la sped i · zion e di Massaua (1885), cit., pp 97-9 8 Ma cfr. an che GIGU O, L 'im p resa di Massaua 1884-1 885 , cit. , pp 158 ·1 59.

29 2 L' ESERCITO NEI..LA
POUTJ CA COLONIALE
dizione: questa, comandata dal gen. Wolseley, partì da Suakim per aiutare Gordon.
Lo scopo ultimo di queste manovre era quello, come abbiamo d!etto, di non perdere tutte le chanches britanniche nell'area. Lond!ra, molto probabilmente, considerava lo smacco di el-Obeid solo momentaneo e pensava di poter riprendersi tutto il Sudan, anche se a costo di una momentanea 'ritirata strategica' 17 (magari anche da sola, senza l'impaccio egiziano).
Ed è in sostanza a questo punto che arrivava Mancini con le sue proposte.
In realtà, rispetto a quella che era stata la sua stessa linea di condotta seguita in politica estera sino ad allora, la decisione di Mancini di inviare truppe nazionali in fondo al Mar Rosso costituiva una svolta, decisiva e impegnativa. Non tanto perché, come talvolta si è stati propensi a sottolineare, egli si era dichiarato sfavorevole ad espansioni coloniali o perché aveva sempre detto di preferire la via pacifica dell'espansione dei commerci e dei contatti economici rispetto a quella militare delle occupazioni e dei protettorati. Quanto perché sino ad allora aveva sempre ripetuto che una delle massime preoccupazioni italiane doveva essere quella di garantirne gli interessi mediterranei: e davvero, anche ai suoi contemporanei, appariva difficile comprendere come quella occupazione di Massaua avrebbe potuto dare all'Italia le chiavi del Mediterraneo.
Egli voleva far credere che dall'assenso britannico sarebbe potuto nascere tutto un nuovo clima di rapporti tra Roma e Londra, che avrebbe permesso forse di non restringere la politica estera italiana dentro i confmi angusti della Triplice: e forse, in questo, Mancini sperava davvero, ingenuamente. Ma così facendo, egli sottovalutava quelle forze interne ed esterne che invece puntavano sulla Triplice: la quale sola, allora, sembrava poter garantire i ben più importanti interessi continentali deU 'Italia. Inoltre Mancini sopravvalutava in questo quadro la volontà e la disponibilità inglese 18.
Londra accettava la situazione del Mediterraneo quale allora si era venuta a creare: con una predominanza francese ad ovest ed inglese nel centro e ad est. E non voleva sconvolgerla, solo per permettere all'Italia di stabilirsi in Tripolitania (da più parti considerata,
17 Una prima ricostruzione è in GIANNI, Italia e Inghilte"a alle porte del Sudan: la spedizione di Massaua {1885}, cic., p. 67 e sgg.
18 Ingiustificate le deduzioni di ZAGHI, P.S. Mancini e il problema del Mediterraneo 1884-1885 , cit., p. 111.

AllE ORIG!Nl DELLA SPEDIZIONE PER MASSA UA 293
allora, la vera chiave del Mediterraneo, per Roma), dal momento che non credeva che l ' Italia potesse essere un valido baluardo antifrancese.
Di questo (ammesso che i 'piani' o le idee di Mancini avessero potuto andare così lontano, sino a p refigurare una alterazione dello status mediterraneo) se ne sarebbe accorto qualche an no dopo il successivo Ministro degli Este ri italiano, Di Robilant, che vide comenei mesi che precedettero il primo rinnovo della Triplice -l 'Inghilterra accettava di fo rmare assieme all 'Italia un 'intesa mediterranea' al solo scopo però della conserv:uione dello status quo e non della sua alterazione (come un'eventuale egemonia, formale od informale, italiana sulla Tripolitania avrebbe di fatto significato).
Ecco perché, per allora, l'Italia otteneva illasciapassare inglese per Massa u a: ma niente di p i ù.
Nel fra tt em po andava ad insediarsi in una regione surriscaldata dai mah(iisti, ambita da più potenze, al l 'interno di un piano ing lese di cui Mancini non aveva colto con esattezza gli scopi immediati e remou.
Colom'alismo italt'ano e A/n'ca on·entale
Tu tto questo non era noto all' opinione pubb lica. Ma anche solo la scelta di Massaua, a prescindere dagli scopi segreti cui essa pareva subordina ta nella mente d i Mancini, non poté non disorientare buona parte dello stesso ambiente colonialista italiano.

Esso era ben l ungi dall'esse re compatto e, all'incirca in quella fine del 1884, poteva essere diviso in più 'correnti', ognuna delle qu ali propugnava un proprio indirizzo d'espansione:
la prima - forse la più numerosa, rappresentata dal Brunialri e dal Camperio in prima flla- era favorevole all'acquisto della Libia (allora si diceva della Tripolitania) sia in sé e p e r sé, sia come eventuale punto di partenza che, attraverso il Sudan, ci portasse al Mar Rosso; una seconda - assai ristretta, rappresentata dal giornalista Bianco Bianchi, ma alla quale , in un certo senso, aderivano Cristoforo Negri e il capitano Cecchi - sosteneva che di fronte alle difficoltà diplomatiche di un 'imp resa libica e alla scarsa importanza di Assab e in genere delle coste del Mar Rosso, convenisse occupare i territori da Capo Guardafui a Mozambico o quelli attorno alla foce del Congo; la terza - assai numerosa anche essa e che in un ceno senso annoverava lo stesso Camperio oltre al gruppo di coloro che avevano già operato in Africa Orientale (Branchi, De Amezaga, Cecchi, Martini, Antonelli) - propendeva verso l'Africa Orientale, sia pure in maniera non
294 L' ESERCITO
NEllA POUTICA COLON1ALE
concorde: chi preferiva il nord (Camperio) e chi il sud (Aotonelli) dell'Abissinia, chi Zeila scanando l 'Abiss inia (S. Martini) e chi (Cecchi) guardava tanto al Mar Rosso quanto all'Oceano Indiano, chi infine preferiva il Harar (senatore Vitelleschi, al Senato, 21 marzo 1885 ) 1
Persino secondo quelle correnti colonialiste che guardavano al Mar Rosso (e non erano ceno le più importanti) Massaua in quanto tale non figurava tra gli obiettivi possibili.
Per di più, proprio in quegli anni, pareva che lo stesso possedimento dì Assab andasse incontro a diverse difficoltà. Il porto si insabbiava (e Mancini presentava progetti di legge per migliorarlo) 2 e le stesse carovane locali semb ravano allontanarsene, ora per le scorribande mahdiste, ora per le migliori condizioni che venivano loro offerte dai porti francesi di Obok e Tagiura 3.
Lo scopo economico, inoltre, sembrava difficilmente invocabile per Massaua: una località che, come fu ammesso qualche anno dopo, presentava «per noi il grave in conven iente di trovarsi in un mare chiuso, di cui gli sbocchi sono in mano ad altre potenze» 4.
A questa serie di svantaggi, infine, si aggiungeva l'elemento climatico particolarmente sfavorevole, a proposito del quale c'era chi scriveva che «Massaua è veramente una fornace, e giustamente i geografi affermano che è uno dei punti più caldi del globo» 5.
Solo qualche tempo dopo la 'conquista', si iniziò ad intravedere la misera realtà del primo possedimento coloniale italiano.
Chi va a Massaua si prepari a trovar fresco l'ardente soffio del deserto, grata l'insipida e qualche volta anche fracida [sic] acqua , soffice e delizioso il nudo terreno, ed a farsi amico con sorci, serpentelli, scorpioni, tarantole, mosche e zanzare a miriadi 6.
1 G. GIGLIO , La politica africana di Agostino Depretis, in «Annali pavesi del Risorgimento•, a. IV (1965), p. 23.

2 Si tratta del progetto di legge n. 242, presentato alla Camera il 28 giugno 1884.
3 Qualche traccia di questo già nella pubblicazione riservata Obok e Tagiura, (in testa al front.: Comando del Corpo di Stato MagS"iore. I repano. III Ufficio), del cap. N. D 'Avanzo , significativamente datata 2 febbra10 1884. Una copia in AUSSME, Volumz' Eritrea , v. 55.
4 M. CAMPERJO, Da Assab a Dogali. Guerre abissine, cit. p. 56. Per orientarsi nella vasta produzione pubblicistica 'colonialista', utile si rivela M. MOZZATI , L'afn'canismo italiano dal '400 ai giorni nostri, v. I, La produzione bibliografica, t. 2 , (1886-1957) Dal Catalogo Unico per le biblioteche italiane, Pavia, (Milano, ltalcanografica), 1979 (in testa al front.: Istituto di storia ed Istituzioni dei paesi afroasiatici dell'Università di Pavia).
· 5 L. NEGRJ, Massaua e dintorni. Dogalz: Saati, Ai/et. Da Cheren agli Abab e il deserto. Descn'zioni, viaggi e notz'zie agn'cole , Valenza, Tip. Farina, 1887, p. 8. 6 lvi, p. 7.
AllE ORJG!Nl DEllA SPEDIZIONE PER
MASSAUA
295
Il tutto si rifletteva, e pesava, non tanto su quegli Italiani (pochi) che deliberatamente avevano deciso di lasciare la penisola per tentare la fortuna (commerciale, esploratrice o chissà quale altra) in territorio coloniale e africano, quanto su quelli che- obbligatoriamente - erano stati costretti a recarsi 'in colonia'. Tra questi, i primi funzionari pubblici e soprattutto i militari: tra i quali, ufficiali o giovani di leva che fossero, cominciava a girare la diceria per cui «chiedere di andare volontariamente in Africa equivaleva alla confessione di essere assillato dai creditori o di avere qualche rotella del cervello fuori posto» 7.
Sinteticamente, poi, è stato scritto:
alla soglia del 1885, appena una decina di italiani vegetavano miseramente sulla costa eri crea, imprecando quotidianamente alla vita miserabile e sordida che conducevano e aU'avverso destino che li aveva portati laggiù 8_
Sia che fossero una decina, sia che fossero un po' di più, isolati sulla povera e torrida costa o alloggiati comodamente presso le corti dei sovrani locali sugli altopiani, gli italiani che già prima della presa di Massaua si trovavano in Abissinia contavano assai poco. Qualcuno aveva finito di fare l'avventuroso esploratore ed aveva trovato una qualche fruttuosa sistemazione; qualcun'altro viveva del commercio d'armi; altri - più dotati o fortunati - si erano fatti apprezzare dai capitribù o dai ras delle varie aree dell'Impero etiopico per le proprie capacità artigianali o professionali di architetti, medici, falegnami. Quando hanno potuto, essi hanno lasciato una non copiosa ma interessante memorialistica: le loro descrizioni di paesaggi e di personaggi abissini hanno spesso costituito l'unica fonte d'informazione per gli storici dell'espansionismo italiano. L'essers i sparsi questi 'precursori' un po' in tutta l'area abissina (dallo Scioa al Tigrè, dai Galla all'Harrar al massauino) ha poi facilitato agli studiosi italiani la conoscenza di varie e diverse vicende. Quello che però questa letteratura memorialistica non può fare è aiutarci a disegnare un quadro sufficientemente preciso del delicato momento di trapasso attraversato dall'Impero etiopico nei vent'anni tra il suicidio di Teodoro II e l'ascesa al trono di Negus Neghesti di Menelik. A seguire, in sostanza, gli anni difficili e contrastati del regno di Giovanni IV non
7 A SAPELL!, Memon'e d 'Africa. 1883-1906, Bologna, Zanichelli, 19 35, p. 4.
8 ZAGHI, P.S. Mancini, l 'Africa e iJ problema del Mediterraneo. 1884-1885, cir. , p. 43.

296 L' ESERCITO NELLA
POUTICA COLONIALE
ci aiuta poi nemmeno tanto la stessa letteratura pubblicistica delle società co loniali e degli ambienti espansionistici ad esse co llegati: una letteratura più informata e 'sc ientifica ' di quella degli esplo ratori ma certo ancora lontana dali' essere riuscita a identificare al suo tempo le profonde linee di tendenza che attraversavano e ri compo nevano in quegli anni l'Impero del Re dei Re. Una letteratura, infine, quella delle società coloniali, che non sempre era conosciu ta dalla classe politica (dai diplomatici , dai militari, etc.) e che quindi più di una volta non era riuscita ad influire direttamente sulla determinazione degli scopi e dei mezzi della politica coloniale nazionale 9 . Come se non bastasse, sia la pubblicistica delle società coloniali - tanto più quan to sopraffatta dalla vuota propaganda- sia la memorialistica dei primi italiani in Abissinia soffrono di un grave difetto: quello di esagerare il peso, l'influenza o la presenza italiana al momento delle grandi scelte politiche nella regione. In questo modo, la storia dei popoli e dei regnanti abissini viene espunta e falsata , o perlomeno rimane incompresa. Analogamente, di riflesso, la storia della politica e dell'espans ione coloniale italiana è stata troppo spesso ricostruita dall'interno tramite l'alternarsi di Ministri, di ambasciatori , di comandami militari; mentre il peso dell'aggressione coloniale è stato talvolta sopravvalu tato nell'analisi della politica degli stati aggrediti.

Il difetto ricordato di quella lette ratura è tanto più grave quando si esaminano i primi passi dell'espansione coloniale italiana. È già stato più volte ricordato quanto scarsa fosse la conoscenza della storia, della cultura, della società e delle guerre dell' Mrica orientale, a metà degli anni Ottanta del secolo scorso tra i politici , i diplomatici e i militari italiani. In questo senso, anzi, la paura del misterioso e de ll 'ignoto - che è stata notata nell'opera e nell'attività dei primissimi esploratori europei in terra africana- doveva in qualche modo farsi sentire anche tra i primi colonialisti italiani sbarcati a Massaua all'inizio del 1885. Ma, sop rattu tto, la mancanza di informazioni generava - oltre che il timore - l'incertezza e l 'oscillazione politica, la sottovalutazione militare dell'avversario, l'immoti vata sicurezza.
Fino a che punto g li organizzatori della spedizione pe r Massaua conoscevano il confuso agitarsi delle rivalità regionali e dei conflitti personali tra i regnanti dell'area coperta dali ' Imp ero abissino? Sia
AllE O RIG INI DEllA S PEDIZIONE PER MASSAUA 297
9 Cfr. CARAZZI , La Società Geografica Italiana e l 'esplorazione coloniale in Africa , c it.. passim.
pur con i loro limitatissimi obiettivi iniziali (Massaua e la costa), si rend evano essi conto di essere solo gli ennesimi aspiranti a tentare di trar vantaggio dalla crisi politica dell'Impero abissino? Prevedevano essi che, una volta sbarcati sulla costa dell' Mrica orientale, difficilmente avrebbero trovato le popolazioni locali pronte ad una cooperazione più o meno servile con I' occupante e che prima o poi dall'Etiopia o dalla 'Eritrea' per motivi diversi sarebbe spirato il vento fone della resistenza anticoloniale?
Alcuni dati essenziali vanno ricordati 10 La spedizione inglese del 1868, se anche aveva alla fine fatto crollare la resistenza etiopica, non era stata che una delle pressioni che l'Impero di Teodoro II aveva dovuto sopportare. La Turchia dalla costa del Mar Rosso non aveva mai fatto mistero di voler espandersi verso l 'interno. L'Egitto, dal nord, con il suo controllo più o meno saldo del Sudan , costituiva una minaccia difficilmente trascurabile per un Impero fondato di fatto su una federazione di tribù e di regni su basi multirazziali e pluriconfessionali, un impero che la continua spinta autoritaria e centralizzatrice di Teodoro teneva assieme. Quando poi nel1866 alcune località della costa passarono dalla Turchia all'Egitto, i confini dell'Impero di Teodoro furono di fatto messi a nuova prova: dal Cairo la spinta espansionistica dei successori di Mohammed Ali tornava a farsi sentire.

L'uno militare della potenza inglese con il numeroso e valoroso ma meno organizzato e peggio armato esercito abissino non fece che rivelare alcune delle vecchie crepe del sistema etiopico. Ciò permise l'accentuarsi di una relativa e conflittuale autonomia delle regioni più periferiche e più lontane da quello che era sempre stato il centro dell'Impero: l'altopiano etiopico.
10 Tra le varie bibliografie introduttìve, cfr. A. HIDARU , D. ROHMATO , A Short Guide to the Study ofEthiopia. A generai Bibliography, Westport, Conn , London, UK, Greenwood Press , 1976, e C F. BROWN. Ethiopian Perspectives. A Bibliographical Guide to the History ofEthiopia, Westport, Conn .• London, UK, 1978. Cfr. anche H.G. MARCUS, The Modero History ofEthiopta and the Horn ofAfrica. A Select and Annotated Bibliography, Stanford , Hoover Press, 1972. Due classiche , anche se ormai datate , storie generali sono R. GREENFIELD, Ethiopia: A New Polittcal History, New York , Praeger, 1965, e E.S. PANKHURST , Ethiopza: A Cultura/ History, Essex, Lalibela, 1965. Fondamentali , per queste nostre successive pagine, tutta una serie di riferimenti e di notizie tratte dalla bibli ografia qui ed altrove citata, nonché da taluni report dell' lntelligence dell'esercito inglese del tempo, che seguiva con attenzione e con preoccupazione gli eventi nell ' area tra Etiopia e Sudan. Affrettato e superficiale appare L 'ltalza in Africa , serie scientifico -culturale, Studi t'taliani di .etnologia e f olk/ore dell 'Africa orientale. Enirea, Etiopia, Somalza, Roma, 1st. Poligr. dello Stato, 1973, (testo di E. Pavante)
298 L' ESEROTO NELLA POUTICA COLON IALE
Regioni come lo Scioa e il Tigrè finirono per assurgere a nuova importanza al punto che il nuovo imperatore fu nel 1872 il tigrino Giovanni IV. L'oggettivo spostamento geografico del baricentro del potere imperiale, se lo rendeva più sensibile agli e venti ed alla sorte delle regioni settentrionali di quanto lo fosse stato sinora nella sua stor ia millenaria, non significava però una soluzione di continuità nella volontà di tenere unite le varie regioni etiopiche; sottolineò anzi gli elementi nazionalistici e religiosi per i successori dell'Impero aksumita. Ad una importante differenziazione, invece , si assisté nel concetto e nella pratica del potere al tentativo di forte centralizzazione di Teodoro II successe l'orientamento di Giovanni IV verso qualcosa di più simile ad una federazione di poteri statali diversi, ognuno responsabile per la sua regione. Oltre che un'inclinazione personale dell'imperatore, questO era un dato di fatto, dal momento che al sud, tra i Galla, a nordest, nello Scioa , ed anche a nord, tra alcune tribù minori dell'area tigrina , andavano montando sentimenti di insofferenza verso il controllo superiore imperiale. Il simbolo di questa tendenza centripeta e disgregatrice del vecchio assetto imperiale è la nota e contrastata ascesa di Menelik II da suddito imperiale a Re dello Scioa e , infine nel 1889 , a Imperatore d'Etiopia. A fronte di questo fondamentale processo di autonornizzazione e decomposizione dell ' Impero etiopico, molte erano le sfide esterne che Giovanni IV dovette affrontare. Dapprima, dal 1872 al 1876, furono gli egiziani a tentare di impadronirsi dei territori settentrionali dell'Impero dalle coste del Mar Rosso al Paese dei Bogos verso il Sudan. Poi, nel1881, proveniente dal Sudan fu la mahdiyyah, il movimento popolare nazionalistico e musulmano , ad infiltrarsi all'interno delle regioni settentrionali , facendo leva su an ti che rivalità tr.ibali e sociali tra copti e isl amic.i. Quasi contemporaneamente (nel 1882 , le navi britanniche avevano bombardato il porto d ' Alessandria d 'Egitto) la potenza politica e militare inglese tornava nella zona , favorendo la lotta antimahdista nel Sudan ma anche risollevando e alimentando l e vecc hie tendenze espansionistiche egiziane verso l'Etiopia. Le im prese di Gordon verso Khartum e della Gordon reliefexpedition di Wolseley mostravano questo duplice segno. Erano gli anni dello scramble for Africa.
Queste ed altre varie minacce finirono per minare defmitivamente il potere di Giovanni IV , imperatore di un Impero sempre più loose , ma non impedirono ch e l ' Eti o pia nel comp l esso resistesse vittoriosamente alla spartizione tra l e potenze europee ch e invece stava trionfando in tutto il resto dell ' Mrica. Specialmente al nord, la risposta

AllE ORIGIJ\1 DEllA SPED IZI ONE PER MASSA UA 299
abissina a quelle minacce, oltre che politica e diplomatica , non poteva che essere militare . In questo senso, la vicenda di Ras Alula è esemplare.
Di umili origini, Alula si era distinto come comandante militare nella battaglia di Gura, quando l'esercito abissino fermò l'avanzata egiziana dalla costa. Il 'leone di Gura' da quel momento diventò uno dei notabili più importami dell'Impero di Giovanni IV e uno dei più fedeli all'Imperatore. Governatore dell'Hamasen, turkbasha (titolo onorifico militare), Governatore del Tigrè, Comandante di Massaua, ' nemico dello Scioa', Alula svolse dopo il 1876 le più importanti funzioni nella regione settentrionale dell'Impero. Isolò e sconfisse il potente Wolda Michael, da tempo aiutato dagli egiziani allo scopo di indebolire l'autorità abissina sui confini del nord; pose le premesse militari di un effettivo dominio imperiale sulla regione dei Bogos, annientandovi la presenza militare egiziana e allargando l'egemonia etiopica in quelle zone con la sottomissione di varie tribù minori; condusse una lotta senza tregua alla penetrazione della mahdiyyah nelle regioni del nord. Fu l'uomo forte di Giovanni IV nel Tigrè , fino a quando ci fu una forza dell'imperatore; e quando le trame di Menelik furono sul punto di riportare il successo definitivo, Alula non esitò a porsi in contrasto con quegli atti del Negus che gli sembrassero ispirati da eccessiva diplomazia e condiscendenza verso i fattori di disgregazione dell'Impero.

Fu un forte comandante militare, ma la sua azione non fu mai solo guerresca: contro il mahdismo, ad esempio, seppe usare i legami religiosi come quelli sociali, per rinsaldare l'unità etiopica. Seppe trattare complesse questioni diplomatiche, prima con gli egiziani, poi con gli inglesi , poi con gli italiani: sempre con l'obiettivo di garantire l'unità dell'impero. Un ' unità imperiale che talvolta andava costruita anche con la forza.
Se altre regioni etiopiche potevano dirsi più compatte etnicamente, politicamente e religiosamente, il nord del Tigrè poteva sembrare invece un complesso mosaico tribale e sociale. Mensa, Bogos, Habbab , Assaorta: questi erano solo alcuni dei maggiori ceppi tribali, ognuno con le proprie divisioni e suddivisioni interne. Rivalità religiose, contrasti per l'acqua e per il bestiame, rancori atavici: vari erano gli aspetti che rendevano spesso fluido e conflittuale l'orizzonte tigrino, specie in quegli anni di crisi dell'impero etiopico, di influenze mahdiste , di interferenze colonialiste. Talvolta, infine , queste tribù mal tolleravano il peso dell"unità etiopica' che nei loro confronti significava soprattutto periodici e pesanti tributi in merci ed in uo -
300 L'ESE RO TO NELLA PO LITICA CO LONIALE
PER MASSAUA 301 mini (per l ' esercito imperiale); e fu così che queste tribù minori del nord del Tigrè - verso la costa, verso Massaua - spesso esposte al pericolo di raid e di razzie da parte abissina come da parte di altre tribù minori ma avverse, furono particolarmente sensibili per esempio alle offerte e alle lusinghe delle forze d'occupazione coloniale europea.
Quanto fosse instabile il sistema politico intertribale del nord abissino, ad esempio, è chiaro da un primo esame delle vicende della tribù degli Habbab. Nel breve arco di anni tra il 1884 ed il 1887, infatti, lo stesso ceppo etnico oscillò tra diverse e contrastanti collocazioni (perché alleanze sarebbe termine troppo impegnativo) politiche. Tra le più consistenti numericamente e po l iticamente, la tribù musulmana degli Habbab aveva sempre tenuto ad una certa autonomia . Nel luglio del 1884 , invece , nell'ambito della dura pressione esercitata da Alula contro i mahdisti e contro gli ultimi declinanti capisaldi della presenza egiziana nella zona, il capo degli Habbab , Hamid (o Ahmed, come si diceva in Italia) , era stato costretto a contrarre un accordo con il rappresentant e tigrino di Giovanni IV. Ahmed venne così nominato kantibai e ricevette periodicamente del denaro da Alula, ma la sua tribù fu costretta a pagare un altretanto periodico tributo In questo senso, nei primi del1885 , quando il ras aveva lanciato un ' altra offensiva antimahdista, Ahmed nonostante persistesse nella sua fede musulmana, veniva considerato l ' uomo di Alula nel nord del Tigrè e nel retroterra massauino Ma il peso del tributo dovette apparire eccessivo. Già nel giugno egli aveva stretto contatti con l'occupante italiano, nonostante questi avesse molti motivi di contrasto con Alula e con Giovanni IV, a partire dalla questione di Saati . E fu proprio nei giorni in cui le prime truppe irregolari al soldo italiano giunsero a Saa t i, che Ahmed fu autorizzato da Saletta a rifornirsi di vitto e foraggio a Massaua . Un tale avvicinamento degli Habbab a Saletta non piacque a Ras Alula, che scrisse indignato al Comandante italiano per quello che poteva apparirgli un tradimento di Ahmed, ma non fu utile più di tanto agli italiani. Essi continuarono a subire qualche razzia da parte dei gruppi di Habbab che non avevano bene accolto la mossa di Ahmed. Inoltre, alcune tribù tradizionalmente avverse agli H abbab (come i Mensa o i Bani Amer, da lungo tempo favorevoli agli egiziani), nella loro globalità o in loro consistenti sezioni, accentuarono la loro precedente ostilità antiitaliana. La 'questione indigena' o quella della sicurezza intorno a Massaua non erano state risolte.
Nell'ottobre 1885 (dopo la battaglia di Kufit, in cui Alula ave-

ALlE
ORIGINI DELLA SPED IZIONE
va sbaragliato la mahdiyyah di Osman Digma) , kantibai Ahmed chiese ed otte nne di entrare a Massaua con imponente corteo di uo mini, cavalli e cammelli per discutere con Saletta della stipula di un accordo. Gli Habbab e Ahmed non avevano panecipato alla battaglia di Kufit ma fu detto che egli si presentò a Massaua sotto cons iglio di autorevoli mahdisti , in modo da instaurare un contatto diretto con gli italiani. La cosa fece andare su tutte le furie Alula che, riferendo a Giovanni IV la notizia dell'incontro Sale tta-Ahmed, riuscì a peggiorare - se possibile dopo la presa italiana di Saati - il giudizio dell'imperatore etiopico circa l' occupazione di Massaua. In realtà , l' accordo non fu stipulato che assai più tardi, nell'estate del1887, e quindi la mossa di Saletta non apportò altro risultato immediato che l' inasprimento dei rapporti italo-etiopici.
Inoltre, sorpresa destò la decisione del comandante italiano (che pure parlò di 'successo diplomatico', di richiesta di protezione da parte di Ahmed , di riconoscimento della potenza italiana) e sorpresa destarono soprattutto le voci secondo cui il trattato sarebbe stato stipulato a condizioni particolarmente onerose per la pane italiana: concessione ad Ahmed di cannoni da montagna, di ingenti quantitativi di armi individuali, di vitto, nonché di impegno a difendere ' comunque' gli Habbab da 'qualsiasi' attacco ed a inviare 1000 soldati italiani nella zona abitata dalla tribù. Se anche queste voci erano forse esagerate, in ogni caso bene illustravano le velleità di Sal e tta e latotale incomprensione delle dinamiche profonde della crisi dell ' impero etiopico. Non era ceno con un patto con una tribù minore e di frontiera che Massaua poteva di rsi sicura.
Saletta aveva scambiato quelli che erano ordinari mutamenti di fronte nelle relazioni interuibali alla frontiera di un grande Imp ero come quello etiopico per segni di riconoscenza degli 'indigeni' nei confronti della ' potenza' italiana. Sarebbe quindi errato dire che una politica indigena nacque per il co lonialismo italiano solo con Baldissera: già Saletta , nei primi mesi di occupazione , ci aveva provato. Ma il suo orizzonte , a riprova dei limiti e delle velleità del colonialismo italiano ma anche della generale ignoranza della situazione politica e sociale locale (etiopica), non andava al di là di qualche decina di chilometri da Massaua. Mentre un grande e plurisecolare impero si stava sfaldando e trasformando - per spinte interne ed esterne -l ' occhio italiano non andava al di là delle scaramucce e dei voltafac cia di poche tribù della più vicina frontiera ; mentre tra Giovanni IV, Alula e Menelik si stava sviluppando un decisivo braccio di ferro (fu poi nel 1887 che il re dello Scioa , impadronendosi dello Harrar ,

302 L' ESERCITO NEUA POUTI CA COLONIALE
pose le premesse decisive al titolo imperiale) l'occupante militare italiano guardava unicamente ad Ahmed e alle sue tribù di qualche centinaia di individui e tramite mosse malaccorte complicava le ben più decisive relazioni italo-eciopiche. Ci sarebbe da chiedersi, addirittura, se in quei giorni Saletta e i suoi avessero davvero chiara la differenza abissale d'importanza e di potere che separava un semplice capotribù dal Governatore del Tigrè, uomo di fiducia dell'Imperatore. In fondo, solo un paio d'anno più tardi, il maggiore Pianoinviato segreto del Ministero della Guerra nel Tigrè e prigioniero di Alula- faceva confusione nell'analisi d eU' esercito del ras tra alti e bassi ufficiali, come tra tenenti e generali ....
A discolpa di Saletta, in un certo senso, sta l'amara annotazione che non fu solo lui a non aver chiari i termini fondamentali del problema etiopico. Qualche mese più tardi, quando il colonnello fu sostituito dal generale Genè si assisté, senza che l'amicizia con Ahmed fosse ufficialmente rinnegata, ad un tentativo di distensione nei rapporti italo-etiopici, che contemplava anche il transito da Massaua verso le terre del Ras di un ingente quantitativo di armi. Forse quelle stesse armi, però, con cui egli condusse due pesanti raid contro gli Habbab nel febbraio e nell'agosto 1886. Ma prima ancora di questa dimostrazione di astuzia da pane di Alula e di insipienza da pane di Genè, la 'politica indigena' italiana non aveva mancato di essere contraddittoria. Nelle Istruzioni fornite dal Ministro degli Esteri Robilam al generale Pozzolini per una missione diplomatica da svolgersi alla corte del Negus durante la quale si sarebbe cercato di appianare i vari dissensi sorti tra l'occupante italiano e l'Impero etiopico (missione che peraltro, come vedremo, non si svolse mai) i paragrafi al riguardo delle tribù vicine a Massaua reclamavano già per gli italiani la mano libera sul territorio degli Habbab, come se fosse ormai cosa loro ...
Nel frattempo , le relazioni tra il presidio italiano ed il Ras (ed il Negus) erano- come si vedrà più avanti- peggiorate: e proprio da lì si parti, dopo il raid di Alula nell'agosto 1886, per il provocatorio rinforzo italiano di Ua-à, seguito dall'ultimatum di Alula, e così via per quel pendìo che doveva condurre a Dogali.
Dopo quella drammatica giornata , in verità, un po' per il blocco del commercio e delle relazioni che Alula strinse intorno a Massaua ed un po' per il blocco marittimo che Saletta (nominato di nuovo comandante italiano nell'aprile 1887) fece attuare al suo ritorno in colonia, si assisté ad un avvicinamento di alcune tribù abissine all' occupante italiano. Gli Habbab di nuovo, ma poi anche gli Assaorta,

AllE ORIGINI DE!l.A S PEDIZIONE PER MASSAUA 303
le bande di Debbeb, etc. chiesero protezione a $aletta. Ma era solo una conseguenza tattica del timore di rapp r·esaglie d a parte di Alula a spingerle verso gli italiani: non ceno la presenza di un'organica politica indigena. E - soprattutto - Dogal i aveva già mietuto le sue vittime: ciò che quella politica indigena avrebbe dovuto evitare era già accaduto.

In questo senso, per la mancanza (a giudicare dai loro atti) tra i protagonisti italiani di un concetto chiaro della crisi etiopica, è anche legittimo osservare i due anni della spedizione di Massaua principalmente dall'interno. Le mosse del conte Antonelli allo Scioa ancora non avevano l'importanza che ebbero in seguito, come nel1889 ed in genere nei primi anni del decennio crispino: ed anche quelle mosse non poche volte apparvero effettuate sull'onda e a rimorchio delle trasformazion i ali' interno dell'impero etiopico, piuttosto che secondo un organico e personale calcolo. Forse, Menelik sapeva della non perfetta conoscenza dell'amarico da parte del conte Antonelli anche prima di Uccialli [ ... ].
Sono questi, riassumendo, i motivi pe r cui la letteratura pubblicistica delle società coloniali e la memorialistica degli esploratori non ci aiuta poi molto a capire la crisi dell'impero etiopico. Le mosse italiane, in quei primi due anni di espansione coloniale intorno a Massaua, raramente illuminate o guidate dalla conoscenza dei motivi e delle forme della crisi etiopica, furono essenzialmente mosse mil itari. A loro deve andare la nostra attenzione.
Mi/t'fan· italt'ani e colonialismo
Quanto abbiamo sinora detto può essere servito a richiamare gli element i essenziali dello scenario diplomat ico-internazionale, italiano ed africano, in cui nacque la prima spedizione coloniale italiana. Con alle spalle un tale scenario, alla fine di dicembre 1884, Mancini poteva comunicare al Ministro della Guerra che era necessario preparare una spedizione militare verso il Mar Rosso con destinazione da precisarsi 1 .
1 Lo si ricava da AUSSME, Volumi En.trea , v 43, 5 gennaio 1885 , Ricotti a Mancini. Le cospicue serie documentarie V olumi Eritrea e Carteggi En.trea si trovavano, al momcmo in cui sono state condotte queste ricerche (inverno-primavera 1983 ), largamente inesploratc . La documentazione storica conservata presso I'AUSSME è imeres -
304 L' ESERCITO NEllA POLITICA COLONIALE
Non era la prima vol ta che le autorità militari si vedevano sollecitate alla preparazione di una spedizione extra-metropolitana e coloniale: ma fu la prima a vedervi seguire dei fatti concreti. Sarebbe interessante qui, a mo' di prologo di uno studio sulla prima vera spedizione coloniale-militare, poter disegnare un affresco della penetrazione nel corpo militare di quelle idee colonialistiche, che erano andate imponendosi tra gli anni Settanta e g li anni Ottanta del XIX secolo io 'Vari settori della società italiana 2 • Si potrebbero ricordare i piani per altre ' spedizioni' , ideate e preparate ma non condotte, gli studi che vi erano stati dedicati , gli uomini che li avevano redatti, le strutture militari che a tale scopo erano state
sante. Su come si viene a formare un archivio coloniale cfr., per un caso specifico, A. SOZZO, Archivi e decolonizzazione: zl caso algerino, in Il mondo contemporaneo, v. X, Gli strumenti della ricerca. Que1tioni di metodo, a cura di G. de Luna, P. Ortoleva , M. Revelli, N. Tranfaglia , Firenze , La Nuova Italia , 1983 (utili, in questo se nso, le pp. 1072-1076 sul rapporto tra amminisua zioni politiche c militari co loniali, producenti l 'archivio).
2 In genere con rilunanza e ci rcospezione (anche per via delle non poche pagine oscure) la ' sroriografia militare ' italiana si è avvicinata allo srudio delle caranerisriche e dell ' azione dell 'esercito nazionale in terreno coloniale. Le guerre di aggressione, le occupazioni militari, le operazioni di poliz ia coloniale, le ripercussioni di runo questo sulla amministrazione in loco e sulla più generale politica militare hanno visto un'attenzione differenziata da parte degli storici militari, a secondo dei periodi storici e dei teatri in cui esse furono con dotte. Sulla 'prima guerra d'Africa', come è stato detto, è disponibile una letteratura vasta (cfr. G. ROCHAT, Studi sulle guerre coloniali, relazione presentata al Convegno eVenti anni di storiografi a militare e jtaliana. , datt. , p. l) ma oramai - rrannc rare occasioni - invecc hiata ed insufficienre. In ogni caso , per la prima guerra d'Africa come per le alue imprese coloniali mjlirari, la sto riografia militare si è pressoché limitata a fornire ricosuuzioni nel migliore dei casi dei soli eventi bellici ( le guerre, appunto) trascurando di analizzare il co mplesso intreccio di relazi oni tra politici e militari, tra Esercito, Stato e società, tra militari europei e popolazioni africane che quelle imprese erano destinate a sollevare. Tra i capostipiti di questa sto riografia militare sta, a suo modo, P. VALLE, La gue"a in Africa; ordinamento igienico con nozioni geografiche, Roma , 188). Tra i prosecurori rimane F. DE CHAURAND DE SAINT EUSTACHE, Le lotte per l'espansione coloniale nel XIX secolo , Roma, Voghera, 1887. Più tardi, anche grazie alle numerose 'sinossi' che gli Istituti d'istruzione militare erano andati accumulando , co minciarono ad essere editati i vari manuali di 'storia militare coloniale', tra cui si ricordano qui R. CORSEW , La gue"a in colonia, Roma , 1914; A. GAIBI, Manuale di storia politico-mtlitare delle colonie italiane, Roma, 1928; A. CABlATI.
E. GRASSELLI , Le gue"e colo niali dell 'Italia, Milano , 1935; V. GIGUO, A. RAVENNI, Le gue"e coloniali d'Italia , Milano , Vallardi , 1935; G VITAU , Le gue"e italiane in Africa , Milano , Sonzogno , 1936; G. PESENTI , Le gue"e coloniali, Bologna, Zanicbelli , 194 7. Come si vede, quindi , in questa sto ri og rafia, per i militari in co lonia esistevano sempre e solo le guerre. Una uattazione più interessante, non italiana ma francese , è quella di A. MARTEL , Les guerres colonia/es, in Histoire mondiale des gue"es, Paris, 1965.

AlLE ORIGINI OEUA SPEO IZJO!I.'E PER MASSAUA 305
mobilitate 3 Si sarebbe così potuto conoscere più ravvicinatamente quanti di questi progetti militari di spedizioni (e d'espansione) coloniali furono originati per autonoma decisione militare e quanti invece erano stati commissionati ai militari dai politici.
Purtroppo questo significherebbe fare un altro studio, la cui docume ntazione- comunque- non è oggi facilmente rintracciabile. Per adesso, possiamo far seguire solo alcune note.
Che, isolatamente e personalmente, molti alti ufficiali avessero fatto parte delle 'società geografiche' è cosa già nota 4, anche se in buona parte ancora da ri costruire nei suoi panicolari.
Mentre molti altri 'co lonialisti ' ancora speravano che un avvio coloniale in Italia potesse avvenire grazie all'operato di interessi privati (ad esempio con la costituzione in terra africana, o comunque straniera, di fattorie, officine, etc. che poi potessero legittimare una richiesta di intervento e di protezione statale italiano) 5, i militari inseriti nelle società geografiche in genere avevano ben presente che un'espansione coloniale italiana si sarebbe potuta fare solo grazie all'intervento attivo delle strutture (politiche , diplomatiche, militari) dello Stato, e non aspettando un naturale svilupp o e radicamento delle ideologie coloniali nel tessuto economico e sociale della nazione. Tra questi militari, ad ese mpio , il colonnello Giuseppe Pozzolini pareva avere già le idee molto chiare : scrivendo nel 1878 ad un sostenitore di quelle teorie (che si auguravano che singoli cittadini o società commerciali andassero in territorio africano a costruire fattorie agricolo-coloniali italiane), Pozzolini ebbe a dire:
Ma dubito assai che, con i criteri di diritto internazionale che han vigore rra noi, tali fattorie possano reggere con forruna alle molteplici difficoltà che le
3 È questo un tema su cui pensiamo di ritornare con successive ricerche, già in parte avviate ali' interno di un programma di ricerca presentato alla Fondazione Luigi Einaudi di Torino.
4 Cfr. CARAZZl, La Società Geografica Italiana e l'esplorazione coloniale in Africa, cit., e MILANINI KEMENY , La Società d'Esplorazione Commerciale in Africa e la politica coloniale, cit. Per alcuni aspetti dì un ' imponamc esperienza individuale cfr. anche O. BARATIERI, Carteggio 1887-1901, a cura di B. Rizzi , Trento, Ed. Mutilati cd Invalidi, 1936 Alcrettanto individuale (anche se pre cede nte negli anni) fu l'esperi enza di R. Cadorna , su cui cfr. ora a cura di M. BRIGNOU, Il 'Diano d 'Algeria ' di Raffaele Cadoma (magg to-agost o 18.50), in cRassegna stori ca del Risorgimento:., a. LVI (1969). pp. 386-420
Sono ideologie che opereranno anche in seguito sia pur i n un altro contesto. Cfr. R. RAINERO, l primi tentati11i di colonizzazzone agricola e di popolam ento dell 'Eritrea , Milano , Marzorati, 1960.

306 L'ESERCITO NELLA
POUTIC/1 COLONIALE
minacciano( ) Ecco perché io penso che il Governo, il solo Governo italiano, può tentare questa impresa con probabilità di successo 6.
E, chiarendo megl io il suo pensiero, lo stesso Pozzolini aveva scritto che
come mezzo d'espansione alla nostra nazionalità, veggo un sol rimedio, credo necessario un provvedirnemo: che il Governo arditamente pianti la nostra bandiera in un dato luogo e la protegga , attiri intorno ad essa il torrente dell'emigrazione, il quale va oggi confuso e disperso con innumerevoli sofferenze degli individui, con poco o nessun profitto per la nazione 7.
Questa posizione, che giustamente intuiva come niente si sarebbe potuto fare senza un'azione politica e statale diretta, doveva essere ceno general izzata tra quei militari.
Ovviamente non si può dimenticare che, per valutazioni personali o politiche, una larga schiera di mil itari (ed anche era i più noci ed imponanci) fosse invece avversa a spedizioni coloniali. L'esercito italiano, già troppo distratto dalla continua pratica del mantenimento dell'ordine pubblico, rischiava a l oro avviso di esse re caricato pe r via di probab i li spedizioni coloniali di pesi eccessivi e che non gli competevano 8 Varie sono le testimonianze che lo confermano. Sono già note le dichiarazioni in questo senso di Luigi G. Pelloux 9. Può essere qui utile anche ricordare la posizione del generale Clemente Cone. Scrivendo a Domenico Farini nel gennaio 1885, Corte disapprovava radicalmente quello che egli definiva il «delirio coloniale» dell'Italia in quei giorni. In maniera co l orita, esprimeva il suo crammarico di vedere il nostro povero paese, che al solo pensiero di possedere un pezzo di terra in partibus infidelt'um, è diventato come un bambi n o alla vista di un primo giocattolo, o come un frate che vede per la
6 La lettera dell' 11 dicembre 1878, Pozzolini a Camperio, è cit. in R. RAINERO, Carlo Guarmani e la questione di AJsab, in cMiscellanea storica ligure•, a. VII ( 1975 ), n.l ,p.194.

7 Anche la lettera del 7 dicembre 1878, Pozzolini a Camperio, è cit. in ibz'dem.
8 I vari manuali italiani di arte della guerra tardarono ad includere quello coloniale tra i vari settori di possibili operazioni miLitari per l' esercito nazionale. Il modello teorico rimaneva quello ben sintetizzato dall'oscuro tenente di Fanteria C. F. MIAGUA nel suo Sull'ordinamento delle forze militan· del Regno d'Italia: pensien', Ancona, Cive!Ji, 1868, e ricordato da DEL NEGRO, De Amicis Versus Tarchetti. Letteratura e militari al tramonto del Risorgimento, adesso in ID., Esercito, Stato, società. Saggi dt. storia militare, cit., p. 161, p. 148 e p. 165.
9 Cfr. PELLOUX , Quelques souvenirs de ma vie , cit., p. 134 e sgg.
AllE ORIGINI DELLA SPEDIZIOJ\'E PER MASSAUA
307
prima volta una donna nuda». La sua maggiore preoccupazione, infine, andava alle forze armate.
E come si concilia l'organizzazione eminentemente difensiva del nostro Eser. cito con queste velleità di lontane spedizioni? Non ci condurrà questo alla necessità dell'istituzione di un esercitO coloniale con uomini assoldati o surrogati?
10
Per Corte, insomma, e molto probabilmente per la maggior parte del Corpo Ufficiali, anche una piccola spedizione militare coloniale come quella che in definitiva si stava preparando per Massaua poteva preludere all'incrinatura del modello strategico ed m:ganico, politico e militare, di 'esercito nazionale italiano' come lo avevano costituito le riforme Ricotti del 1870-76 (delle quali proprio Corte era stato uno degli artefici).
Tra queste due posizioni 'estreme', quella favorevole di Pozzolini (ma si sarebbe potuto citare Oreste Bara tie ri 11 , o altri ancora)
10 La lettera di Clemente Corte a Domenico Farini è ci t. in ZAGHJ , P.S. Mancini e il problema del Mediteffaneo 1884-1885, cit., p. 186. Analogamente contrario pare essere stato Carlo Mezzacapo. Quando nel marzo 1885 seppe di una morìa di quadrupedi a Massaua, egli ebbe a dire: «Speriamo che la cosa si arresti là! Ma purtroppo quella del Mar Rosso è una questione che si farà grossa, indipendentemente dalla nostra volontà! Ed allora le perdite saranno d'altra natura( )». A proposito poi delle mire italiane di invasione dell'interno abissino, egli ammorù contro simili c irrealiscici «voli napoleonici:o. PESCI, Il generale Carlo Mezzacapo e il suo tempo , eit., p 267. Con un'implicita polemica verso le forme (politiche e militari) prese dal nascente colonialismo italiano, C. CORTE scrisse poi Le conquiste degli inglesi nelle Indie, Torino, Roux, 1886
11 Pare indubbio che vi furono manovre e pressioni politiche per imporre al Ministero della Guerra la nomina di O. Baratieri a capo del Corpo di Spedizione coloniale. Direttamente od indirettamente , giornali pentarchici sostennero questa ipotesi (anche Clemente Corte , nella lettera prima ricordata, vi faceva riferimento). Nelle carte di P.S. Mancini si conserva un biglietto manoscritto di Cesare Ricotti che «SÌ duole:o con il Minisuo della Consulta per il fano di non potere «accettare» la proposta di nomina di Baratieri a Capo della spedizione (proposta che, quindi , qualcuno doveva aver fatto). Cfr. MCR, Carte Mancini , racc , 655 , fase. 12, doc. 6 , Ricotti a Mancini. La cosa ebbe un seguito. Lo stesso Baratieri, nel 1887, durame le prime fasi della preparazione della spedizione ' di rivincita' dopo Dogali , scrisse a Crispi autoproponendosi direttamenteda militare a poli t ico- quale il più esperto militare italiano in tema di guerre co loniali «Onorevole Presidente del Consiglio - iniziava la sua lettera Baratieri, nessuno più di me ha esultato alla notizia del tuo viaggio in Germania perché sono sicuro che tu hai acquistato all'ltalia la posizio n e che le compete. Orgoglioso di aver cominciatO , te precursore, la mia carriera delle armi e di essere semp re stato tuo amico ed ammiratO· re, ora in questo frangente ricordati la promessa fattami di ;parlare al Ministro della Guerra per la mia destinazione alla spedizione in Africa. Io sono stato tra i primi a viaggiare in Africa , io mi sono sempre occupato di studi africani, io dovevo per ben due volte essere destinato in Africa , io sento in me la forza di rendere colà buon servizio. Se vi mandano alcuni battaglioni di bersaglieri, io potrei esserne il Comandante Perdona se incoraggiato dalla tua benevolenza ho osato intrattenerti di cose mie personali e credimi sempre tuo devotissimo , amico O. Baratieri:o. ACS, Presidenza del Consiglio dei Mi-

308 L'ESERCITO NELLA PO UTI CA COLONIALE
e quella estremamente dura e n egativa di Cort e - probabilmente assai diffusa- c'era evidentemente all'interno del mondo militare un largo ventaglio di punti di vista intermedi.
Ma, in ultima analisi, queste opinioni personali e individuali, contavano poco (se non come testimonianza di un ambiente politico professionale affatto diviso su i vantaggi di una politica coloniale, per l'I calia e per l ' esercito). Ciò che realmente contava erano i veri piani militari: senza di questi le opinioni dei singoli ufficiali erano destinate a rimanere pure posizioni di principio.
Quello che contava era lo studio che gli organismi militari centrali erano incaricati di compiere ed, eventualmente, le strutture che venivano attivate per aggiornare e completare quegli eventuali piani (di spedizioni militari coloniali) che quegli studi avrebbe ro potuto produrre. Qui, come avevamo annunciato, ancora carenti sono le conoscenze della storiografia per dare una risposta sufficientemente preCISa.
Si può dire comunque che a questo proposito un punto di svolta dovette essere (proprio coi primi anni Ottanta) l' introduzione nell'ordinamento militare italiano della carica di Capo di Stato Maggiore dell ' Esercito. La razionale organ izzazio ne dello Stato Maggiore per teatri possibili di guerra , finalizzata alla raccolta di informazioni e di dati di interesse militare , permise forse per la prima volta che fosse dedicato alla pianificazione della guerra un personale militare tutto so mmato stabile (o perlomeno poco soggetto a spostamenti) e agevolò la crescita di veri e propri quadri specializzati 12 .

Qualcosa di simile era ovviamente stato fatto anche prima, dall' allora ufficio del Comandante del Corpo di Stato Maggiore, o da quello del Presidente del Comitato di Stato Maggiore Generale. Ma il mutare dei loro responsabili , lo scarso personale disponibile, l ' as-
nislri, b. 67, fase. 302, 5 ottobre 1887, Baraùeri a Crispi. In questo senso, tra Crispi e Baratieri, possono essere invocati anche taluni legami di tipo massonico. Non a caso, qualche anno più tardi, si scriveva che «la Massoneria si diffuse nell'esercito specialmente attraverso l' Eritrea, per impulso del Baratieri». DE CHAURAND DE SAINT EUSTACHE , Come l'esercito italùm o e ntrò in guerra, cit., p. 164.
Il rutto a confer ma che, all'inte rno dell ' esercito , oltre ai cont rari od ai disinteressati (che forse furono per lungo tempo la maggioranza) c'erano anche i ferventi sostenitori delle spedizion i militari coloniali. Talvolta , anche , per ragioni e con scopi non proprio nobilissimi.
12 Già nei primi ordini di servizio, fumati da Cosenz , per il nuovo Stato Maggiore del dopo - 1882, era previsto uno spa zio (seppur limitato} per lo studio delle questioni africane e coloniali. Cfr. AUSSME, Studi particolari, racc. 300, fase. l, Registro degli ordini del giorno del Signor Capo dello SME, alla data del 9 novembre 1882.
AU..E ORJGINI OEu.A SPEOIZIOI\'E PER MASSA UA 309
soluta pred om inanza (anc he in questo ) d e ll 'U ffi cio d i Gabinetto del Ministro della Gu e rra o della Divisione di Stato Mag gi o re del Ministe ro 13 impedivano dal punto di vista amministra ti vo una sufficiente accumulazione dell e conoscenze. Oltre a talj asp ett i istituzionali era comunque, prima degli anni Ottanta, un problema politico di fondo quello che fren ava e non incitava le strutture militari a dedicare ai fronti coloniali (ch e pure altre potenz e e urop ee avevano già aperto) strutture e perso nale permanente 14 L' Itali a po l i ti ca non si interessava delle col o ni e, negli anni Se ttanta 15. Come i nvece abb iam o visto , negli anni Ottanta la cosa era destinata a mutare.
Unica p os iti va eccezione in questo quadro di disinteresse dell 'establishm e nt mil i tare pre -1882 poteva ess ere cos tituita dalla Biblioteca del Corp o di Stato Maggiore , ch e regolarmente imroitava molti volumi -e tra i migliori - sulle esp e ri e nze politiche e coloniali delle altre potenze europee 16 . Ma il fatto ch e , al momento della sp edizione di Massau a, pochi fossero i milit a ri al co rrente delle più elem e ntari noti zie sul co ntinente african o dal punt o di vista geografico, politico , econ o mi co e militare lascerebb e purtro ppo intendere che quei volumi e rano forse d estinati- p e rlom eno sino al 1884a giacere polverosi su gli scaffali.
In questa man canz a d i una struttura stabile ris ie de quindi la diffe renza di talune iniziative , sia pure impegnative ed inte ressanti (quali
13 Cfr. anco ra MARSEUI , La politica d ello stato italiano, cit., p. 168. Lo ste sso Marselli dove tte trasformare le sue id ee in me rit o all a convenie n za pe r l 'Ita li a d i u na sped izio n e co loniale. Ne l1 882, infatti, vi si era mosuato asso lutamente contrario, olue che d al p unto di vista tecnico-militare anche dal punto di vista politico -ideolog ico, o dei prinàpi cl principi che hanno presieduto alla costruzione del nuovo Stato h aliano, i nostri bene intesi interessi, e la triste esperienza che f anno gli stati conquistato r i ci debbono consigliare a non ambire alcuna occupazione territoriale, sulla costa dell'Afri· ca o io Albania. Una Ipedizr'one di Albania o a Tripoli sarebbero [sic] state la peggior Iciagura dell'Italia, se anche fossero riuscite bene nel principio. Il nosuo ideale deve essere affa tto civile( )•. Nel 1884-85, invece, lo stesso Marselli (che nel1882 pare così appassionatamente anticoloniale) avrebbe preparato, a u torizzato ed avallata la sp ed izio n e di Massaua. La 'politica di pot enza' it aliana marciava a passo spedi t o, in quegl i an ni . Su N. Marse ll i, ma con u n al tro taglio im erp re tativo, cfr. S. LAN ARO , Nazr'o n e e lavo ro. Sagg io sulla cultura borghese in Italia 1870·1925, Venez ia , Marsili o, 1979.

14 Per un a veloce ma acu ta sintesi cfr. R.E. ROBINSON, J. GAllAGHER , La spartizione dell'A frica, in Storia del mondo m ode rno vol. XI, L 'espansione colo n iale e i problemi Iociali {1870-1898), cit., pp. 745 -804.
15 Cf r. il citato passo di GIGUO, L'impreia di Mtmaua 1884- 1885, cit., p. 12.
16 Cfr. Catalogo delle opere e carte esistenti nella Biblioteca del Corpo di Stato Maggiore, Roma, Voghera, 1883 (i n testa al front.: Ministero della Guerra. Corpo di Stato Maggiore), poi periodicamente aggiornato. Cfr. anche Catalogo della B zblr'oteca [del] Ministero della Gue"a, Ro ma, Fo rzani, 1884; ma era un'altra biblioteca
310 L'ESERCITO NELLA POLITICA COLONIALE
ad esempio quella di Agostino Ricci nel 1864 o quella di Oreste Baratieri nel1875), dalle altre successive al 1882, tra cui gli studi della primavera-estate 1884 e poi la preparazione vera e propria della 'spedizione di Massaua', momenti questi da cui - anche formalmente - 'nacque' per i militari italiani un fronte coloniale.
Tra il giugno e il luglio 1864, in un momento di tensione internazionale e di apprensione italiana per la politica dei Paesi rivieraschi del Mediterraneo meridionale (Tuni sia, Tripolitania), l'allora maggiore Ricci, insieme ai capitani Bettolo e Milo, aveva svolto per incarico dell'Ufficio Militare del Corpo di Stato Maggiore una importante missione sulle coste tunisine. A mezzo tra la ricognizione e la manovra navale, l'operazione, che impegnò due compagnie di Fan teria, una di Bersaglieri, una batteria di Artiglieria ed una compagnia del Genio, comportò alcuni studi preparativi di una cena entità 17 .
Nel1875 Oreste Baratieri, svolse poi un'analoga ma più segreta missione sulle coste e in suo lo tunisino insieme al marchese Orazio Antinori 18 .
Queste 'sped izioni ' rivestivano però un interesse proprio nella loro episodicità (come a suo tempo lo avevano avuto per le Marine degli stati p re-unitari quelle del 1825 o del 1853) 19, o al massimo ebbero un'importanza più che altro personale, nella vita privata di quei militari che le condussero a termine (che non a caso diventarono tra i primi 'quad ri ' militari coloniali ital iani , per le conoscenze accumulate, per le specifiche tendenze personali, per il loro credere nella possibilità di espansioni militari coloniali). Ma una volta terminate, poco · rimaneva di queste espenenze.

Questa situazione doveva cambiare, come abbiamo detto, dopo il 1882, con la creazione di un vero Stato Maggiore.
Nei suoi uffici si cominciavano a conservare (frutto ad esempio di una attenzione continuata e di un razionale processo di accumulazione delle informazioni), tra l'altro, una copia del rapporto al Ministro della Marina su una ricognizione sui poni cirenaici condotta
17 Cfr. AUSSME, Libia, cart. 6, fase. l, Relazione, (datata settembre 1864).
18 Lo ricorda, anche se solo incidemalmeme, DEL BOCA, Gli Italiani in Afn.ca orientale. Dall'unità alla marcia su Roma, cit., p. 62.
l9 Cfr. ASMM, Titolan·o n. I, catt. 23 , fase. 4, Spedizione della Marina Sarda a Tnpoli; ivi, cart 33, fase. l, Studi sulla spedizione napoletana a Tn"polz", Cfr. anche ivi, can. 74, fase. l, Missione in Afnca
ALLE ORIGINI DELLA
IZIONE
311
SPED
PER MASSAUA
nel luglio 1883 20, le 'Note sulla Tripolitania' redatte dal capitano Mirabello sempre nel 1883 21 ed altro ancora.
Ma il vero cambiamento, perlomeno secondo i documenti esaminati , pare essere databile proprio alla primavera-estate del 1884.
Fu infatti in questo periodo che il ruolo del nuovo Stato Maggiore- in relazione ad un'impresa coloniale- parve venire valorizzato dalla congiuntura politica e diplomatica 22 . È importante accennarvi (aprendo un inciso, seppur breve) anche perché - come vedremo- l'attività della primavera-estate '84 non fu senza influenze per la stessa spedizione di Massaua del 1885. In coincidenza con i timori diplomatici per un accerchiamento f rancese dell'Italia (quando Parigi , oltre a tenere saldamente Algeri e Tunisi, sembrava ciproporre le sue vecchie mire su Rabat), il Ministro degli Esteri Mancini aveva segnalato al Ministero della Guerra la possibilità di dover procedere - per rappresaglia o per sicurezza - ali' occupazione della costa tripolitana. La Pilotta , dal canto suo, aveva passato la cosa allo Stato Maggiore. Qui si trovava in qualità di Capo dello SME in seconda Agostino Ricci, di cui già abbiamo ricordato la missione del 1864.
Ricci si dovette dedicare con interesse alla questione e stese un piano di massima per le operazioni, denominato 'Promemoria sugli studi ed altri provvedimenti preventivi da farsi per preparare la spedizione di Tripoli' 23. A questa attività, che verosimilmente vide impegnato lui ed altri ufficiali (tra questi l 'allora colonnello Tancredi Saletta) 24 daUa primavera sino a luglio , poi non corrispose niente di fattivo perché, come abbiamo visto, la vertenza marocchina andò scemando d'importanza per Parigi e quindi anche per Roma 25.
L'ipotesi di una spedizione tripolitana , che da parte italiana avrebbe dovuto essere sufficientemente forte da ridurre all ' impotenza in pochi giorni (e prima che una qualsiasi altra potenza- cioè la Fran cia - avesse il tempo di intervenire, ché altrimenti sarebbe stata la guerra frontale) le almeno 10.000 unità turche di stanza a
2° Cfr. AUSSME, Libia, cart. 6. fase. 2, Rapport o del C. te Avvùo 'Rapido' al Ministro della Man·na, (datato 9 luglio 1883).
21 Cfr. AUSSME, Libia , cart. 8, fase. 3.
22 Cfr. BALDOCCJ, Mancini e la questione marocchina, cit., p. 245.
H Cfr AUSSME, Libia, cart. 6, fase. 5.
24 Ne fa riferimento lo stesso Saletta in AUSSME, Volumi En.trea, v. 11 , 16 feb · braio 1885 , Saletta a Ricci.
2
5 Cfr. BALDOCCI, Man cini e la questione marocchina, ci t. , p. 242 c sgg.

3 12 l'ESERCITO NELLA
POUTICA COLONIALE
Tripoli, sembrò tornare di attualità nel novembre 1884, in contemporanea con l'aprirsi della Conferenza coloniale di Berlino. Mancini scrisse infatt i , in data 21 di quel mese, a Ricotti perché- sulla base degli studi già effettuati - «la comp ilazione del programma e le corrispondenti predisposizioni si trovino compiute entro il più breve termine possibile» e perché esse fossero «curate per modo che continuino costante mente a trovarsi suscettibili di immediata attuazione, quali che siano, nel regno , i mutamenti e le dislocazioni delle nostre forze:. 26 .
La cosa pareva di una gravità senza confronti, se si pensa che lo stesso Mancini prevedeva nella sua missiva che - per questa nuova spedizione tripolina - sarebbero state necessarie truppe per non meno di un corpo d'armata 2 7 D'altra parte, molto tende a far credere che quella di Man cini fosse una sortita anche per saggiare il grado di 'malleabilit à' e di disponibilità del neonominato Ministro della Guerra a ipotesi belliche ed espansionistiche. Dagli Esteri, infatti, si era pure scritto che si trattava di «contingenza non imminente» per una spedizione che «forse possa anche non avverarsi mai:. ; e si concludeva la lettera con una sibillina allusione a non meglio precisata c al tra futura esigenza:. 28.
Cesare Ricotti - è questo forse il primo documento che possediamo con cui il novarese entri a pieno diritto nella storia della politica coloniale italiana - non si scompose. Politicamente lontano dagli entus iasmi politici (anche interessati) di un Mancini per le spedizioni coloniali, militarmente attento agli interessi 'nazionali' dell'esercito che lui stesso aveva plasmato, Ricotti fece attendere Mancini per oltre due settimane prima di inviargli una lunga ma anodina e grigia risposta. Al documento della Consulta ch e poteva sembrare quasi il preparativo di uno stato di guerra il novarese rispose , con significativo ritardo , quasi con una circo lare amministrativa: in cui si auspicava «un pieno e perfetto accordo tra codesto Ministero [gli Esteri] e quelli della Guerra, della Marina e del Tesoro», si ricordava come per ipotesi ardimentose e tali da «compromettere» l'onore nazionale «occorre indubbiamente poter disporre di adeguati mezzi finanziari» e si ammoniva il collega diplomatico su una prevedibile

26 Cfr ZAGHI , P.S. Man c-ini e la question e del Med iteffan eo 1884·1885, cit., pp . 151-152.
27 Cfr. ibidem
28 Cfr . ivi, p. 152 .
AU.E ORIGINI DE.I.l.A SPEDIZIO !'.'E PER MASSA UA 313
incapacità della Marina a spostare l'ingente corpo di truppe che sarebbe stato all ' uopo mobilitato 29.
In una parola, Ricotti si era da subito mostrato scettico, se non contrario, ad un'ipotesi tripolina o che comunque co involgesse forze militari di rzfevante entità (grandi unità , divisioni, corpi d'armata, etc.). E non va dimenticato che Ricotti era stato chiamato a reggere il Dicastero da solo poco più di un mese quando ricevette la missiva di Mancini e che poteva quindi senùrsi meno politicamente sicuro del suo scranno ministeriale rispetto al responsabile della Consulta , il quale invece permaneva nel suo ormai da quasi tre anni 30.
Eppure qualcosa - tra i militari - doveva cominciare a trapelare dei piani tripolini di Mancini, o delle sue trattative londinesi. Negli ambienti dello Stato Maggiore, infaui, il rinnovarsi dell' ipotesi tripolitana pare essere stata accolta con maggiore interesse ché in quelli ministeriali. Ricci si rimise all ' opera ed aggiornò il piano da lui stesso steso qualche mese prima 3 1 Dopo un a serie di scambi di opinioni tra il Capo dello Stato Maggiore e il Comandante in seconda 32 , Cosenz chiese al Ministro della Guerra di determinare addirittura già il Comandante del Corpo Militare italiano per la Tripolitania (prima ancora che questo fosse stato effettivamente formato) e propose a Ricotti di nominare da subito Ric ci 33. All'incirca negli stessi giorni il Capo dello SME si era informato presso il Ministero per conoscere il probabile ammontare finanziario che sarebbe stato messo a disposizione per la preparazione del Corpo stesso 34
Se agli inizi di dicembre Ricotti aveva risposto in maniera sostanzialmente negativa a Mancini, alla fine del mese aveva cambiato
29 Cfr. ivi, pp . 152-153. Ma anche ivi, pp. 55-56 e p. 75.
30 Questo comportamento di Ricorri dovrebbe , come poi vedremo, togliere qualsiasi fondamento alle interpretazioni secondo cui il novarese fu chiamato alla Pilotta proprio io previsione (e per preparare) una spedizione coloniale di notevole entità. Lo soste nne implicitamente per primo UN EX-DIPLOMATICO, La politica coloniale dell'Italia, in •Nuova antologia., a . 1884, n. 22, pp. 316-329; lo ri pre se BATIAGLIA, La prima guerra d 'Africa, cit. , pp. 166·167. Recentemente, lo ripete acriticamente, in pratica, STEFANI , La storia della dottrina e degli ordinamenti dell'esercito italian o, v . I , Dall'esercito piemontese all'eurcito di Vitton'o Veneto, ci t., pp. 326-3 27.
3! Cfr. AUSSME, Libia, cart. 6, fase. 5.
32 Cfr. AUSSME, Libia, catt. 6, fase. 6, 3 dicembre 1884, Ris.ma, Cosenza Ri cci; e ivi, 6 dicembre 1884, Rù.ma Pers., Ri cci a Cosenz.
33 AUSSME , Libia, eatt. 6, fase. 7, Il dicembre 1884, Rii.ma, Cosenza Ricci.
34 Cfr. AUSSME, Libia, can. 6, fase. 8, 20 dicembre 1884, Ris.ma Pers., Ricotti a Cosenz, dove vi si fa riferimento.

314 L'ESEJlCJTO NELLA
POUTICA COLONIALE
(o era stato spinto a cambiare) op inione . Stretto dagli Esteri (i cui programmi coloniali proprio in quel ristretto t orno di tempo si stavano forse decisamente affermando) , dallo Stato Maggiore (pronto a uadurre in pianificazione le tendenze del momento) e forse anche da altri e superiori consigli , Ricotti attenuò molto nella risposta a Cosenz la sua precedente (e come vedremo , personale e naturale) avversione per le imprese coloniali.
Anche qui, comunque, significativamente, Ricotti fece attendere il suo corrispondente e solo il 20 dicembre rispose a Cosenz 35: ma il tenore della risposta alla missiva del Capo dello SME era già diverso da quello della sua replica al Mini stro della Consulta.
La lettera è inoltre significativa del momento e della perso nalità del novarese. Ricotti ha già capito che la Tripolitania era un bluff politi co di Mancini, ma che qualcosa alla Consulta si stava preparando ugualmente. È, a tutto questo, ancora personalmente contrar io perché vede in una spedizione co loniale impegnato l ' onore e l ' interesse militare in una prospettiva che gli appare poco chiara ; molto probabilmente non ha nemmeno una grande stima personale di Mancini. Ma non può rifiutarsi di obbedire quando l'ordin e è supe riore (dalla Corte o dalla presidenza del Consiglio) e quando per mezzo di quella spedizione potrebbe essere ribadito il ruolo di 'g rande potenza ' dell ' Italia (purché con poco sforzo e poca spesa).

Ecco perché Ricotti finì per accettare la proposta di Cosenz su «l'opportunità di affidare al Tenente Generale Ricci il Comando di un Corpo di operazioni da destinarsi eventualmente ad una spedizione marittima nella Tripolitanilb , approvò gli srudi già fatti e diede m andato di proseguirli 36 . Dava l'impressione di essere già in qualche modo al corrente dei nuovi indirizzi de1la Consulta: non più verso la Tripolitania, ma verso il Mar Rosso: per la destinazione effettiva del Corp o il novarese sc ri veva infatti a Cosenz che essa «non deve considerarsi un impegno assoluto da mantenersi in qualsiasi eventualità, . Infine affe rmava di essere sens i bile a ll e ipotesi che Mancini andava diffondendo su un ' «eventuale cooperazione dell'Italia con l'Inghilterra nell'Egitto,.
C'è in queste parole di Ricotti dello sco rcio del 1884 la co nferma che, anche se di T rip o litania non si parlerà più concretamente per un po' di tempo , Mancini stava vincendo o già aveva vinto . L' I-
AllE OR IGINl DEllA SPED IZIONE PER MA SSAUA 315
3 ) Cfr AUSSME , Libia, can. 6, fase. 8, Ri.s.ma Pers., 20 dicembre 1884 , Ricotti a Cosenz 36 lvi
tali a iniziava a lavorare per avere una sua ' vera ' colonia.
Tornando al punto da cui eravamo partiti - e cioè al dato nuovo rappresentato per le strutture militari anche in relazione a pianificazioni di imprese coloniali dalla presenza di uno Stato Maggiore (e il poco conosciuto prologo alla spedizione di Massaua rappresentato dall'ipotesi di una 'spedizione a Tripoli' lo conferma) - rimane da dire che, definitivamente con lo scorrere degli anni Ottanta, cambiavano i tempi anche nell'ambiente miLitare. Anche dopo Massaua, ritrosie e remore come quelle di Cone e di Ricotti verso le imprese coloniali rimasero largamente presenti tra i militari (lo furono persino nei giorni di Adua). Ma, fatto nuovo , altre concezioni iniziarono a radicarsi nella 'società militare'.
Giovani ufficiali vedevano ormai nei territori africani i suoli dove le armi italiane avrebbero potuto trovare quella fortuna che l' immobile e 'pacifica' situazione europea sembrava loro negare.
È per questi motivi che gli archivi dello Stato Maggiore ospitavano sempre più studi (commissionati o autonomamente redatti da singoli ufficiali) sulle possibilità di un'espansione coloniale italiana.
In uno di questi studi, con sentimenti del tutto opposti al rammarico del vecchio Coree per il ' delirio coloniale ' italiano , il giovane capitano Carini scriveva, in quello stesso 1885:

Le preoccupazi o ni d ' ordine interno e di politica continentale non possono assorbire tutta la nostra ene rgia.
Ed ancora, riducendo tutta la complessa questione del ruolo mediterraneo dell'Italia alla presa militare della costa tripolina, proclamava che
Roma era o nnipo t e nte quand o g li assalti di Canag in e - la nu o va Tunisi - misero a repe nrag l io la su a esistenza , e richiamar on o al Medi terraneo [e Mediterraneo , p er Carini , sig nifi cav a Libia]la sua a t ti vità ( ... ).
Chi ha fed e n ei d est ini d ' Italia non può peraltro d ubita re ch e il suo presente disinteresse dalle questi o ni mediterranee non sarà dura turo e che l'opera del Governo e l' ini ziativ a d e i privati vorranno e presto ri co nquistare l'influenza perduca 37.
La conoscenza delle modalità di penetrazione delle ideologie colonialiste nel mondo militare avrebbe certo bisogno di altri studi: ma
3 16 L'ESERCITO
NEllA POUTICA COLONIALE
37 Cfr.
AUS SME , Libill, cart. 6, fase. 10, Stu dio su lla Tn politanill del cap. Carin i, manoscri tto.
quanto abbiamo qui ricordato può essere intanto sufficiente per dare conto del mutare - con gli anni- dell'ambiente e delle strutture militari.
Come avrebbero potuto operare queste nuove strutture e quegli uomini messi a diretto confronto con le difficoltà di preparazione e di gestione di un'impresa co loniale era cosa che non si sarebbe potuto determinare con esattezza prima della spedizione di Massaua. Quanto , inoltre , sull'azione militare potessero pesare quegli elementi obiettivamente sfavorevoli che abbiamo prima ricordato (carattere improvvisato dell 'obiettivo colo niale del Mar Rosso , decisione tutta dip l omatica di indirizzare la spedizione in un'area geografica ambita da più potenze e scossa da profonde agitazioni popolari, delinearsi -poi confermato dagli avvenimenti successivi - di contrasti politici tra la Consulta e la Pilotta , mancanza di una ravvicinata azione sintetizzante e mediatrice della Presidenza del Consiglio) era un'altra grande incognita che sovrastò di fatto l 'intera preparazione della ffilSSlOne.
Solo la pratica conduzione della prima spedizione colonial e (che è l 'argomento delle nostre prossime pagine) si incaricò di darvi una nsposta.

Ma qualche indizio in merito poteva trarsi, già in quello scorcio di 1884, da un evento che, pur cronologicamente precedente la vera e propria occupazione di Massaua, può però con profitto esserne letto come un'anticipazione: si tratta dell'occupazion e di Beilul.
Quando Mancini aveva iniziato le sue trattative dell'autunno 1884 con Londra, che poi avrebbero dovuto condurre all'assenso britannico circa lo sbarco di truppe italiane a Massaua, il primo obiettivo dello statista italian o era stato proprio Beilul 38 _ Anche a Beilul , come in tutta quella zona che da Khanoum andava al mare, erano infatt i stanziate truppe inglesi ed egiziane che avrebbero dovuto essere in quei mesi ritirate. Beilul era poi la località sugge rita dal Primo Ministro egiziano Nubar Pacha al comm. De Martino, Regio incaricato d'Affari al Cairo, per un'eventuale nuova presenza italiana nel Mar Rosso (oltre ad Assab) 39. E Beilul fu la lo calità che il Regio Incaricato segnalò a Mancini, il quale poi - aggiungendovi Massaua - pose il tutto all'attenzione diplomatica inglese.
Non a caso l 'assenso di Londra per una presenza italiana a Bei-
AU..E ORIGINI DELLA SPEDIZIONE PER MASSAUA 31 7
38 Cfr. GIGUO , L 'impresa di Massaua 1884-1885, cit., p. 18 e sgg. 39 Cfr. ivi, p. 26 .
lui fu quasi immediato 4 0: per Massaua invece si continuò a trattare. Però a Mancini il villaggio dì Beilul senza Massaua non serviva; comunque, fece mettere in stato d'allena la marina militare perché si tenesse pronta all'eventualità di un'occupazione militare di quella prima località. Il Ministro degli Esteri, in un suo messaggio al collega della Marina, sottolineava specificatamente che l'occupazione militare italiana di Beilul che si andava preparando non doveva in alcun modo poter essere vista come una definitiva presa di possesso italiana 41 . I motivi per questo erano sostanzialmente due. Da una pane Mancini non intravedeva ancora, a quella data, la conclusione delle ben più imporranti trattative per Massaua; e dal momento che la presa di Beilul poteva esse re fatta anche subito (l'assenso inglese c'era) si trattava di non pregiudicare, e di non rivelare alle altre Potenze , l 'inte ra manovra italiana. Dall 'altra Mancini sapeva bene che, pur di riuscire, aveva inizi ato le trattative londinesi proprio con l' assunto diplomatico di non soJievare la questione istituzionale: questo ceno aveva ben disposto le autorità inglesi (e forse la Consulta sperava che la Conferenza di Berlino avrebbe poi potuto fare qualcosa per passare dall'occupazione al protettorato) ma aveva vinco lato di fatto tutta la successiva azione italiana, politica e militare.
Così sc riveva Mancini a Brin:
in segujto a trattaùve confidenziali, già da qualche tempo intavolate con l'Egitto [sic!), è stato convenuto con quel governo che esso abbandonerà quanto prima la costa di Beilul e che questa passerebbe sotto la giurisdizione italiana. Per raggiungere questo scopo, non sembra necessario procedere ad una occupazione permanente, la quale oltre ad esigere spese non lievi. susciterebbe intempestivamente la questione della sovranità su quel territorio. Basterà invece limitarsi al semplice innalzamenco della banruera italiana nel paese , o tutt'al più ricorrere ad uno sbarco dj un drappello di marinru , i quali dovrebbero essere ritirati dopo giorno dj effettiva permanenza salvo a farvi periodicamente ritorno 4 .
La direttiva diplomatica era sufficientemente chiara: quanto essa fosse approp riata ali' inizio di una 'coraggiosa' politica coloniale era un'altra questione. Come era pure un altro problema l'interrogativo se le autorità egiziane o inglesi dì Beilul fossero state esattament e avvisate della manovra italiana e se si sarebbero rivelate disponibili ad assecondarla
4° Cfr ivi, p. 28 e p. 40.

41 Cfr. ivi, p. 29.
42 Una copia anche in AUSSME, Volumi Eritrea, v. 45. 22 novembre 1884, Mancini a Brin .
318 L' ESERCITO NELLA POUTICA COLONlAL.E
La parola, comunque da quel momento passava ai militari. In questo caso alla Marina.
La Regia Marina non disponeva allora di un proprio specifico Stato Maggiore (elemento di differenza questo - e abbiamo visto di quale importanza- con l'E serc ito) . Comunque il proprio Ufficio Operazioni indicò nella 'Agostino Barbariga', che in breve tempo salpava da un porto italiario , la nave da guerra adatta per la missione. Era il17 dicembre 1884. Il 30 succesivo il Barbariga, quando aricoca è in acque mediterrariee, va in avarìa.
Il 4 gennaio la Marina decide di sostituirlo con il 'Castelfidardo ' che parte da Messina il 10: ma ar1che questa nave fa appena in tempo ad arrivare a Suez che va in avarìa. FortUnatamente - nel quadro della più complessa manovra per l 'occupazione di Massaua, che in quei giorni passava dalla fase ideativa a quella operativaera già partito da Brindisi il 'Messaggero', che viene indicata adesso come la nave per Beilul. Ma persino questo ' legno' incontra difficoltà nella navigazione, e si guasta. Nel frattempo era stata riparata finalmente la 'Castelfidardo': e con la 'Castelfidardo' l 'o perazione, rimasta interrotta da tanti incidenti, riparte. È allora solo con il 25 gennaio, infine, quasi due mesi dopo che il Ministero degli Esteri aveva diramato la direttiva dip lomatica di occuparla , che su Beilul sventola il tricolore. Ceno, l 'azio ne della macchina militare no n era stata te 43.
Purtroppo c'era anche dell'altro: e riguardava gli individui.
Al momento dello sbarco italiano erario sorte infatti alcune impreviste difficoltà. G li tirano per le lunghe la quest ione , non vogliono il tricolore, accamparlo scuse per non ' avere istruzioni in proposito'. Si proflla addirittura un'inadempienza della massima autorità della zona, il colonnello inglese Chermside , che non avrebbe dato disposizioni al riguardo 44
La situazione era obiettivamente delicata.
Il capitano di vascello Trucco, comandante della Corazzata 'Castelfidardo', però, non ha dubbi: dopo aver atteso per un paio di giorni che il nodo si sc iolg a, fa catturare i militari e le autorità egiziane, le prende con la forza e le fa imbarcare su un vapore
43 Qualche cenno in GIGUO, L ' impresa di Massaua 1884-1885 , cit., p. 64. Per una esame diretto cfr. MCR , Carte Mancini, se. 653, fase. 6, doc. 3, 26 giugno 1885, Mal vano a Mancini.
44 Cfr. DEL BOCA , Gli italiani in Africa onentale. Dall'unità alla marcia su Roma , cit., p 185.

AllE ORIGINI DEllA SPEDIZIONE PER MA SS AUA 319
(che le condurrà poi a Massaua). È così con una azione di forza che Beilul è interamente italiana, a partire dal 27 gennaio.
La cosa era di una gravità non trascurabile.
Proprio quando la Consulta aveva impiantato tutta la sua manovra diplomatica intorno al principio di non sollevare la questione istituzionale della sovranità territoriale, l'azione militare quella questione poneva in primo piano.

La reazione del rappresentante inglese Chermside, della diplomazia egiziana e di quella turca furono immediate. E niente affatto formali 45.
In realtà tutto questo , per fortuna di Mancini, venne a confondersi nella più generale operazione per Massaua, con la quale - come abbiamo visto - quella di Beilul si era più di una volta incrociata. Il capitano di vascello Trucco non venne perseguito, né il Ministero della Marina - a quanto ci consti - redarguito dai responsabili della Consulta. Della piccola, ma significativa questione di Beilui tutti si dimenticarono 46 . Per tutti il 'colonialismo italiano' inizia solo con l ' occupazione di Massaua.
È chiaro che non si potrebbe a rigore confrontare una missione di fatto consumatasi in pochi giorni, come quella dell'occupazione di Beilul , con l'intero arco dei tre anni (perlomeno) che portarono gli italiani da Roma a Massaua (e poi a Dogali). Né sono nemmeno lontanamente paragonabili gli effetti diplomatici, politici, militari della spedizione di Massaua nel suo complesso con la piccola operazione per Beilul. Anzi a ben vedere l ' occupazione di Beilul potrebbe essere vista come un episodio dell ' intera :spedizione di Massaua. Eppure, per uno studio sulla azione militare nella prima spedizione coloniale italiana, la pur circoscritta vicenda di Beilul assume perlomeno in alcuni suoi caratteri un valore emblematico.
C'è l'opera to diplomatico , apparentemente chiaro e sicuro (ma in realtà ben lungi dall ' essere riuscito ad appianare tutti i possibili contrasti internazionali e locali che un'azione coloniale può originare). C'è l'azione militare, di per sé non indenne da qualche pur vistosa pecca organizzativa. C'è soprattutto la insospettata decisione dimostrata dai più giovani Comandanti militari locali e il loro ricorrere alla forza delle armi anche quando non previsto dalle istruzioni diplomatiche e politiche ricevute.
3 20 L' ESERCITO NEllA POLITICA COLON IALE
45 Cfr. GIGLIO , L'impresa d i Massaua 1884 -1885 , cit. , p. 6 2. 46 Cfr. ZAGHI , P.S. Mancin i e il p ro blema d el Mediterraneo 1884 -1 8 85, ci t. , p. 9 2 e p. 103
Rispetto alla più complessa spedizione per Massaua mancaè vero - quel contrasto tra autorità diplomatiche e militari, quel dibattitO all'interno dello stesso ambiente militare, quel suo fronteggiare avversari ben più pericolosi di quella quarantina di militari egiziani imbarcati d'autorità da Trucco, quel suo tragico epilogo, che solo una più lunga e importante spedizione militare poteva originare e che sono i caratteri più conosciuti della prima impresa coloniale italiana.
Ma c'è, se non altro, in quella azione di forza di Trucco, un primo suggerimento alla luce di cui capire poi l'atteggiamento delle autorità militari a Massaua.
La spedizione mtlitare verso zl Mar Rosso: Comando e truppe
L'ideazione di una spedizione militare italiana a Massaua era quindi tutta diplomatica, se non proprio politico-personale di ManCUli.
Come abbiamo visto, però, l'obiettivo del Mar Rosso spostava alquanto il possibile teatro di operazioni militari coloniali da quel più consueto scenario mediterraneo in cui gli ambienti militari erano stati sino ad allora propensi a credere che prima o poi si sarebbe indirizzata la politica italiana 1
I militari, sia esercito, sia marina, avevano sino ad allora, caso mai, pensato ad una eventuale spedizione italiana principalmente in direzione della Libia, specialmente dopo che la Francia si era impadronita di Tunisi. Questo, come abbiamo visto, avrebbe richiesto un ingente sforzo militare (per l'esercito si era parlato dell'impiego di almeno un corpo d'armata) ma che in qualche modo av,rebbe potuto essere bilanciato dalla relativa vicinanza delle coste tripolitane con quelle italiane. Messina, Brindisi e soprattutto Napoli (i porti e gli arsenali che avrebbero soste nuto il peso logistico della spedizione) non sono poi lontanissimi da Tripoli o da Bengasi.
Con Massaua era invece tutta un'altra cosa.
1 MARSElll, La politica dello stato italiano, ci t. ,p. 343. Di scarso aiuto per la comprensione delle dinamiche interne agli ambienti militari sono, per quel periodo, L 'Italia in Africa, serie storico -militare, v. I, L'opera dell'esercito, t. l, Ordinamento e reclutamento, Roma, !st. Poligr. dello Stato , 1960 , e idem , t. 2, Avvenimenti mtlitan· e impiego. parte prima, Afnca onentale {1868-1934), Roma , lst. Poligr. dello Stato , 1962 (in ambedue il testo è di M.A. Vitale).

ALLE ORIGINI DElLA SPEDIZIONE
321
PER MASSAUA
Le linee di comunicazione si sarebbero allungate perlomeno di sei volte, i mari erano più pericolosi e lontani, e soggetti alla giurisdizione di più autorità statali. La stessa possibilità di comunicazioni rapide e sicure si allontanava , dal momento che non c'era telegrafo in quelle zone: l'ultima stazione telegrafica era Suakim, a più di duecento chilometri a nord di Massaua.
Il tutto , apparentemente, poteva essere compensato solo dal fatto che per tenere Massaua ci sarebbe voluto un numero molto inferiore di soldati che per occupare la costa tripolina; ma , nell ' obie ttivo di una occupazione prolungata , quelle truppe sarebbero state soggette a cambi o a spostamenti. C'era poi nei dintorni di Massaua (anche a non voler tener conto della risposta dell'Impero etiopic o) un vivace fermento mahdista: e se, in un caso malaugurato, il presidio nuovamente costituito sul Mar Rosso avesse avuto bisogno di rinforzi? Se l'originario scopo di 'innalzare la bandiera ' si fosse tramutato- ed era proprio Mancini a spingere in questa direzione , auspicando il più stretto rappono con l ' Inghilterra (che si trovava nell'estate-autunno 1884, come abbiamo visto, in difficoltà militari nel Sudan e quindi forse bisognosa di aiuti)- in un ben più co mplesso obiettivo di cooperazione militare tra ingenti corpi di truppe? O se, infine , si fosse ordinato alle truppe italiane a Massaua di spingersi offensivamente verso l 'interno, come si sarebbe potuto provvedere con velocità a tanta distanza dalla madrepatria?
Vi è già chi ha ironizzato su lle scarse conoscenze geografiche di Mancini (ma non solo) al riguardo di quella stessa regione africana in cui egli spediva forze italiane 2 . Importa qui sottolineare come tutto ciò avveniva ad immediato detrimento (e rivelando quindi un certo disinteresse verso le modalità concrete) dell'azione militare 3 . Questo doveva avere il suo peso.
Se questa responsabilità di Mancini era chiara (ed è da tempo nota) non va dimenticato che i militari non seppero tenere un atteggiamento sufficientemente univoco e saldo, anche su questioni di grande importanza tecn ico-operativa . La questione del Comando (ma, prima di questa, la stessa questione della forza e degli obiettivi della spedizione per Massaua) riflette questi successivi aggiustamenti o acco modamenti delle autorità militari: le quali si trovavano spesso in difficoltà di fronte alle cangianti poli tiche di Mancini , ma mai volle-

322 l 'ESERCITO NEUA POLITI CA CO LONIALE
2 Cfr. BATIAGLIA , La pn'ma gue"a d 'Africa, cic, p. 185.
3 Già qualche acce nno al risentimento dei militari in AUSSME , Volumi Eritrea, v. 43, 5 gennaio 1885 , Ricotti a Man ci ni.
ro assum e rsi l'onere e il rischio di bloccarle. Nella fiducia, forse, che dalle trattative della Consulta e dalla forza militare della spedizione potesse e dovesse farsi più grande la 'potenza' italiana. Intanto, come abbiamo visto, l'ambiente milit.are centrale era stato in qualche modo avvertito che qualcosa stava per accadere. Già il 20 dicembre, Ricotti doveva averlo intuito 4.
Il 31 Mancini infme scrisse ufficialmente al Ministro della Guerra 5. Erano per il momento destituiti d'interesse i preparativi per la Tripolitania né si sarebbe fatto niente per il lontano Congo 6. La spedizione ci sarebbe stata , ma verso altri lidi
Il tutto rimaneva però ancora abbastanza co nfuso agli occhi delle autorità militari, le quali ancora a fine dicembre (e Ricotti ne aveva riferito a Cosenz) potevano pensare di dover preparare un «corpo di spedizione isolato, destinato a concorrere con le sole sue forze alle operazioni che in quel tempo stesso si compirebbero nell'Alto Egitto» da parte degli Inglesi 7 . Cosa che si precisava , poi, nei primissimi giorni di gennaio come cu na probabile spedizione all 'interno dell' Mrica p er la costa orientale» s. Se anche, infine , Massaua emerse come la meta della spedizione militare , riman ev a l ' incognita di una
4 Cfr. AUSSME , Libia, can. 6, fase. 8, 20 dicembre 1884, Ris.ma Pen. , Ricoui a Cosenz.
5 Cfr. AUSSME, Volumi Eritrea, v. 2, alla dara del 31 dicembre 1884, e ivi, v. 43, 5 gennaio 1885, Ricotti a Mancini .
6 In effetti, in questo senso, era stata preparata una nave da guerra all'ancora del porro di Genova. Vi si doveva imbarcare, tra gli altri , per contro di Mancini e del Ministero degli Affari Esteri, il cap. Cecchi, che fu poi in vece dirottato in tempo verso il Mar Rosso. La notizia dei preparativi della Marina era già trapelata in quei giorni. Cfr. MCR , Carte Mancini , se. 651, f. 10, doc. 13. Già lo ricordava CHIALA, La spedizione di Massaua. Narrazione documentata , ci r., il quale accennava a probabili dissapori tra Guerra ed Esteri. Ricordava infatti Chiala come cll Diritto• , giornale di Mancini , avesse amm onito già con il 1• gennaio 1885 che cl' ese rcito deve quandochessia essere pronto ad enuare in 15 giorni in ordine di battaglia, a prestare in qualunque momento uno o due corpi da sbarco, per qualunque destinazione vicina o lontana ( )•. lvi, p 152 Lo stesso Chiala già avanzava alcuni suoi dubbi circa il carattere esauriente dell e informazioni presentate dalla Consulta (e dalla Pilotta) al Governo il quale, se si riunì prima della fine del 1884 per autorizzare i preparativi (come si è visto, già assai avaruati) , per una spedizione nel Mar Rosso, so lo più tardi poté votare sulla specifica destinazione di Assab-Massaua. Cfr. ibidem, e cfr. anche AUSSME, Volumi En.trea, v. 44, 8 gennaio 1885 , Ris.ma, Brina Caimi. Come al solito, e sempre sorp re ndemememe , bene informaro si rivelava cL' ese rcito italiano•. che già in data 24 dicembre 1884 pubblicava un articolo su AJsab e la politica "colonia/e.
7 Cfr. G IGLIO, L'impresa di Massaua1884-1885. cit., p. 47.
8 Cfr. AUSSME, Volumi En'trea, v. 43, 5 gennai o 1885 , Ricotti a Mancini.

AllE ORJG!NI
DEllA SPEDIZIONE PER MASSAUA 323
qualche operazione «a qualche giornata dalla costa» verso l'interno 9 .
Chi ricevette la missiva dì Mancini (con cui la direttiva diplomatica si fece precisa e definitiva) fu Marselli, il segretario generale del Ministero della Guerra il quale contattò immediatamente Ricotti, che si trovava allora lontano dalla capitale, a Modena.
Marselli nel suo avviso al Ministro faceva riferimento ad altre precedenti disposizioni e riferiva di abboccamenti già personalmente avuti con il comandante in seconda dello Stato Maggiore.
Sì è stabilito perciò col Generale Ricci - egli scriveva - che preparerebbe disposizioni per mobilitare un alrro battaglione ed altri 4 pezzi. Se V.E. domenica approva e Minimo degli Esteri accetta si darebbe esecuzione , se no nulla è compromesso IO
Ma, significativamente, a commento di queste misure che evidenziavano chiaramente l'intenzione di allestire un piccolo corpo di spedizione militare, Marselli si premurava di aggiungere che «ad ogni modo una spedizione interna sarebbe difficilissima per non dire inattuabile» 11 .
Nel frattempo era stato sollecitato lo stesso Agostino Ricci, Comandante in seconda del CSM, affinché lo Stato Maggiore preparasse una relazione tecnico-militare: di fronte ad alcune sue obiezioni tese forse a conoscere meglio gli scopi della missione per poter poi stendere un vero e proprio piano operativo, Marselli disse invece che si sarebbe accontentato anche solo di <<una risposta d'ufficio» che si potesse inviare alla Consulta: in mancanza di ulteriori e decisive precisazioni ed informazioni, Marselli consigliò infatti Ricci almeno di «prepararla come può» 12 . Il gioco degli aggiustamenti successivi andava ad iniziare.
La ' Memoria' dello stato maggiore, firmata Cosenz, fu così indicativa della cauta disponibilità con cui gli ambienti militari dello SME guardavano a questa spedizione, che però semp re più sembrava allontanarsi dalla 'grande' prospettiva di cooperazione italobritannica lasciata all'inizio trapelare dalla Consulta. Anzi adesso, quando tutto si riduceva a proporzioni limitate (due battaglioni, o
9 Vi insistono BATIAGLIA, La pn·ma guerra d 'Africa, cit., p. 188, e DEL BOCA , Gli italiani in Africa onentale. Dall'unità alla marcia su Roma, cir., pp. 174-175.

10 AUSSME, Volumi En'trea, v. 43, 2 gennaio 1885 , Marselli a Ricotti.
12 lvi, v. 43 , 2 gennaio 1885, Marselli a Ricotti.
324 L'ESERCITO NELLA POLITIC A COLONIALE
1 1 Ibidem.
tre come volevano Marselli e Ricci), lo stato maggiore poco apprezzava quegli accenni di Mancini circa possibili operazioni verso l'interno , di cui ancora non si conosceva il nemico, la durata e i possibili alleati. Queste spedizioni, o 'puntate', all'interno potevano nascondersi - agli occhi dello Stato Maggiore - anche n eU' affermata volontà di Mancini di 'punire' i responsabili del!' eccidio della missione Bianchi . Ma come trovarli in un territorio sconosciuto ed ostile? Come distinguerli da innocui 'indigeni' ?
Cosenz scrisse così che «mancavano assolutamente i dati per apprezzare l 'entità della spedizione» l3: e ricordava al proposito le diffiwltà e gli insuccessi incontrati in quella regione dalla ben più forte ed organizzata spedizione militare inglese del 1867. E soprattutto, dichiarava di «ritenere cosa affatto azzardata il dare inizio ad un'opera di repressione» verso l'interno. Sottolineando le differenze che intercorrevano dal punto militare tra le varie ipotesi affacciatesi (a seconda che si volesse solo rinforzare il presidio di Assab, andare alla ricerca dei colpevoli di un eccidio o indirizzarsi con decisione addirittura verso l'interno), Cosenz chiedeva alla Consulta che si prendesse un più sicuro partito.
Mancini, invece, rispondendo ad una missiva di Ricotti che portava con sé in allegato la memoria preparata da Cosenz, pareva accettare l'ordinamento militare della spedizione comunque suggerita dallo SME ma non era disposto a cedere su l tema degli obiettivi (che continuavano a rimanere imprecisati io più parti) né a volerli chiarire. Questo era il senso della sua affermazione con cui diceva di continuare ad «essere non contrario a qualsiasi severa e legittima opera di repressione» ! 4 . La questione rimaneva perciò impregiudicata.
Nel frattempo, come diceva Mançini nella stessa lettera, era «urgente e necessario andare» 15. E da parte militare non si poté né si volle ritardare i preparativi. Si andava io Mar Rosso.
Questo stato di fretta e di imprecisione, però, non poteva non influenzare le operazioni militari di allestimento della spedizione, anche in alcuni suoi aspetti importanti. Massaua dovette così fare i conti, tra l'altro, anche con i non lineari rapporti tra esercito e marina, tali perlomeno dai giorni di Custoza e di Lissa , se non da prima ancora.

13 AUSSME , Volumi Eritrea , v. 2 , alla data del 4 gennaio 1885.
14
AllE ORIGINI DELLA SPEDIZIONE PER MASSAUA 325
Ibidem. IS AUSSME , Volumi Eritrea , v . 43 , 6 gennaio 1885, Ris.ma, Mancini a Ricotti.
Sino a quando si era parlato di una grande spedizione (per l ' interno dell'Etiopia o addirittura su per il N ilo) era chiaro che il grosso della responsabilità e dell'onere militare sarebbero ricaduti sulla maggiore delle due forze armate, cioè sull'Esercito. Ma quando l'obiettivo pareva rimpicciolirsi, e lo scopo diplomatico divenire raggiungibile anche con un limitato sforzo militare, come a Beilul, poté sembrare anche alla Marina di aver qualche cosa da dire in propositO. La cosa non era poi senza motivazione: in fondo , reparti della Marina erano già stati incaricati di occupare Debeken ed altri stavano occupandosi (anche se con le difficoltà che abbiamo visco) dell'affare Beilul 16 . E, se davvero si pensava di andare a Massaua solo per rimanere poi sulla costa, non dovevano sembrare fuori luogo azioni prevalentemente dirette e condotte solo dalla Marina 17.
In verità (e gli ambi enti direttivi dell'esercitO, lo sapevano bene), perlomeno all'inizio dell'operazione che avrebbe dovuto condurre gli italiani a Massaua, si era parlatO di ben più ardite mete militari. Se anche qualche incomprensione tra esercito e marina era da addebitarsi a Mancini e alla sua incerta e contraddittOria azione diplomatica , non si può non sottolineare come queste stesse incomprensioni si nutrivano di più antiche rivalità militari 18.
Fu così che, ai primi di gennaio, Brio Ministro della Marina scriveva chiaramente al Contrammiraglio Caimi che
il Governo ha deciso di riunire nel Mar Rosso una forza navale sufficiente per poter fornire un battaglione di almeno 500 marinai, olue gli ufficiali, onde essere eventualmente in grado di miJitarmente occupare la piazza di Massaua 19_
E, specificava Brio sempre nello stesso dispaccio , solo dopo l' occupazione da parte della marina sarebbero giunti a Massaua truppe dell'esercito per sostituirle, provenienti da Assab o dall'Italia.
Questa ipotesi d'azione dovette pure per più tempo avere una sua veridicità, dal momento che per più di una settimana i messaggi del Ministero della Guerra recavano come destinazione del corpo di
16 Cfr. GIGLIO, L'impresa di Massaua 1884-1885, cit., p. 61 e sgg. Cfr. anche AUSSME, Volumi En'trea, v. 45, 19 novembre 1884, Mancini a Brio (copia).

17 AUSSME, Volumi Enirea, v. 44, 12 gennaio 1885, Confle, Mancini a Brio.
18 I contrasti ua i milita.ri italiani in loco non dovevano tardare a divenire evidenti anche ai civili (ua cui la rappresentanza consolare italiana a Massaua). Cfr. GIGUO, L'impresa di Massaua 1884 - 1885, cit., p. 88, n. 3.
l9 AUSSME, Volumi Enirea, v. 44, 8 gennaio 1885, Brin a Caimi.
326 l'ESERCITO
NElLA POUTJCA COLONJAI.E
spedizione Assab 20 (e non Massaua la cui occupazione poteva sembrare quindi commissionata alla Marina) e che lo stesso Saletta, a giudicare da p iù di una ricostruzione storica 21 e dalle sue stesse 'Memorie' 22 , seppe di dover occupare Massaua solo quando fu a poca distanza dal porto abissino. Se anche rimane da chiarire come mai la marina sapesse 'più' di quello che sapeva l'esercito, le ambizioni di primato della forza di mare dovettero però cedere il passo al peso della forza dell'esercito. Ma il contrasto ua le due forze armate, se anche non inficiò sul momento l'occupazione di Massaua , ebbe invece più di una conseguenza su aspetti anche imporranti della preparazione della spedizione.
Tra questi aspetti, uno dei più decisivi era indubbiamente quello del Comando.
In uno scenario politico, diplomatico e militare così difficil e e incerto era chiaro che molto del futuro coloniale italiano in Mar Rosso sarebbe dipeso anche dalla personalità stessa di chi avrebbe avuto sul luogo la massima responsabilità militare.
Molti fu rono i nomi avanzati, spesso apparentemente in modo unilaterale da ognuna delle Forze Armare , per questa carica: riprova e indice , questo, di quella cena concorrenzialità di cui si è detto. Né, pare di capire, Mancini aveva la forza o l'interesse di imporre una sua nomina politica, attendendo invece che lo stesso ambiente militare trovasse la sua unità intorno ad un nome.
Ecco perché nel corso della stessa preparazione della missione, si parlò a proposito del Comando della piazza di Massaua indifferentemente del Generale Ricci, del colonnello Leitenitz o del capitano di corvetta Lo Preve 23.
A due-tre settimane dallo sbarco nel porto abissino, insomma, non era ancora chiaro chi avrebbe avuto il Comando del presidio di Assab e chi di quello di Massaua, chi delle truppe marine e chi quelle terrestri, e se sarebbero dovuto esserci poi dei cambi di mano, dopo la presa di possesso vera e propria e dopo la definitiva sistemazio-
2° Cfr. ivi, 8 gennaio 1885, Ricotti a Brin.
21 Cfr., ua gli altri , BATIAGLIA, Laprimague"a d 'Afnca , cit., p. 182. Ma anche AUSSME, Carteggio En'trea, racc. 44, 9 aprile 1896 , Ru ma Pers., Sal erta a Ricotti Torneremo poi a spiegare l 'inte resse di questa lenera.
22 Cfr. AUSSME , Carteggio En'trea , racc. 9. fase . l, p . 31.
23 Cfr. GIGLIO, L 'impresa di Massaua 1884-1885, cit., p. 64. Cfr. anche AUSSME, Volumi En'trea, v. 45, 13 gennaio 1885, Ru., Mancini , a Ricorri (che fa seguito a 30 gennaio 1885 , Ricotti a Mancini).

AllE ORIGINI DELLA SPEDIZIONE PER MASSAUA 327
ne dell e truppe a terra. Il fatto , di per sé grave sotto il profilo dei rapporti personali che potevano instaurarsi tra gli alti ufficiali incaricati (il Contrammiraglio Caimi e il colonnello Saletta, pur destinati alla stessa mission e militare , non tardarono a sentirsi ognuno il superiore ge rarchic o dell ' altro e a crede re di avere due scopi diversi), influiva anche sulla delicata questione delle 'Istruzioni militari'.
Queste, in una situazione così mutevole, erano decisive: ma , come è noto , furono in casi ìmportanti consegnate o fatte recapitare troppo tardi 24. Scriveva poi di sé in alcune sue 'me morie ' il colonnello Saletta:
libero dal legame di qualsiasi istruzione, mi trovavo costretto ad agire secondo il mio cri cerio 25.
Una tale condizione non poteva non rischiare di esporre le forze militari del Mar Rosso ad iniziative - da pane dei Comandantipersonali e contrastanti.
Se , riassumendo, non poche erano le difficoltà cui la preparazione militare della spedizione coloniale e ra esposta dalla contraddittoria poli tica di Mancini , non si può dime nticare che anche l' ambiente militare appariva talvolta diviso da intéressi diversi ed attrave rsato da un dib attito non trascurabi le.
L'as petto del dibatùto e del confronto di opinioni diverse diventò più chiaro nel prosieguo dell'operazione: ma certo era stato presente anche nei primissimi giorni.
Un punto su cui ci fu discussione, per esempio , era quello della composizione organica dei re parti da inviare in Mar Rosso.
Dal momento che, come ab biam o visto, si andava semp re più riducendo l'ipotesi di ardite collaborazioni militari anglo-italiane, l'entità complessiva del corpo di spedizione avrebbe finito per non superare due , o per sicurezza tre, battaglioni più i relativi servizi. Cioè
24 D isse qualche anno più tardi $aletta, in un a comunicazione riservata, che il te · sto completo delle istruzioni gli pervenne solo il 24 febbraio da Assab (si uanava del dispaccio datato, e partito , il 3 febbraio) e il 26 da Roma (dispaccio 1 1 febbraio). Onestamente , però, aggiungeva che «Cotesti intendimenti [delle istruzioni) già mi erano in parte palesati dai telegrammi ricevuti ancece dememente•. AUSSME, Carteggio Eritrea, racc. 44, fase. l , 9 aprile 1896, Ris.ma Pers., Saletta a Ricotti. A distanza di un decennio, e solo qualche sett imana dopo Adua, le difficoltà e i contrasti di dieci anni prima a Massaua dovevano ancora essere ricordati dai protagonisti. Cfr. anch e BATIAGUA , Laprimague"a d'Afoca, cit., p p. 181-182.
25 Di nuovo AUSSME, Carteggio Er-itrea, racc. 9, fase. l, p. 31.

328 l'ESERCITO NELLA POUTICA COLO NIALE
non più di tremila uomini in tutto 26.
Le modalità per radunare un tale quantit ativo (sia pur ridotto) di uomini erano però varie.
Si poteva destinare più semplicemente a tale scopo un numero corrispondente di unità: si sarebbe così mantenuta l'omogeneità e dei reparti. E poi non si poteva escludere l'eventualità di qualche vera e propria azione armata. In questo caso il preservare l'unità dei reparti avrebbe potuto anche facilitare il mantenimento di quelle tradizioni dei singoli reggimenti che proprio in quegli anni si volevano valorizzare: era questo un elemento so lo formale e certo assai secondario, ma che pure sembrava attirare l'interesse degli organizzatori militari del periodo.
Oppure si potevano comporre quelle unità solo a livello ammin istrati vo, tramite l'unione di piccole unità prelevate in più zone. In tal modo la scelta degli elementi militari avrebbe potuto essere più accurata e sarebbe rimasta alla totale discrezionalità dell'amministrazione centrale della Guerra. Il corpo militare che si sarebbe così formato avrebbe però presentato il difetto di una più evidente disomogeneità , perlomeno iniziale.
Queste erano le due più co nsistenti ipotesi 27 .
Ce ne erano anche altre, più improbabili, ma che erano certo presenti anche in quei giorni (u na di queste era queiJa adombrata, dal suo punto di vista con apprensione, dal generale Corte nel brano prima ricordato) e che qualche tempo dopo furono sollevate con una certa enfasi da parte della stampa politica e militare.
Di queste una era que iJa della costituzione di un Corpo specificatamente Coloniale, su l modeiJo francese, con truppe a lunga ferma ed ad alto soldo. Questo tipo di organizzazione militare si sarebbe caratterizzato per l'estrema qualificazione e per un particolare addestramento delle sue truppe e dei suoi ufficiali 28.
L'altra, infine, era quella di una ' leva politica' di volontari coloniali, civili ed in uniforme, formata attingendo a quegli individui
26 Per la pane tecnica , cfr. AUSSME, Volumi Enirea, v. 4. Indicativa la presenza , tra le cane dello Stato Maggiore del tempo, di una traduzione italiana manoscritta di un arricolo che il geo. britannico Wolseley scrisse per il cSoldier's Book for Field Servi· ce•, intitolata Sulla costituzione dei piccoli corpi di spedizione e sul modo di com batte· re contro nazioni selvagge, adesso in AUSSME, Carteggio Entrea, rac. 160, fase. l.

27 Erano ben chiarite già in cL' ese rcito italiano•. 31 gennaio 1885, I distaccamen· ti coloniali.
28 Ibidem. Conuaria apparve cL'h.alia militare•, l febbraio 1885, L 'esercito ... coloniale.
AllE ORJGII'\1 DELU SPEDIZlONE PER MASSAUA 329
ed a quegli strati sociali che una propaganda colonialista avrebbe potuto galvanizzare (magari sfruttando il richiamo ad un passato garibaldino ed alla partecipazione popolare alle guerre per l'indipendenza nazionale) 29.
Per ognuna di queste ipotesi, il dibattito militare venne segnalando vantaggi e difetti.
Per quanto riguardava l'ultima (la 'leva garibaldina') è chiaro che si trattasse di uno strumento difficilmente realizzabile, e comunque importante solo come indice di un permanere in certi ambienti politici di vecchi miti giustapposti a nuove (ed anche radicalmente contrastanti) esigenze. Era più uno strumento di lotta politica che un mezzo militare.
Già l'ipotesi del Corpo Coloniale militare riscuoteva più adesioni. Il giornale «L'esercito italiano» propose a chiare lettere la creazione di un tale Corpo militare di volontari, con ferma di cinque anni ed adeguati compensi 3°. Ma ormai, per il segreto con cui era stata avvolta l 'attività di preparazione , la spedizione di Massaua era già partita, e le scelte erano già state fatte: in colonia si era andati con le normali truppe di leva. Per questo motivo, le voci dissenzienti che volevano il Corpo Coloniale acquistavano solo il valore di critica, di richiesta di qualcosa 'di più'. Ebbero perciò buon gioco gli ambienti militari ministeriali a riaffermàre il valore delle scelte organiche già fatte e provando a tacitare le voci interne allo stesso mondo militare. «Aspettiamo adunque di conoscere bene le cose, prima di dare giudizi prematuri ed ingiusti», scriveva la voce ufficiosa del Ministero della Guerra 3 1 «Non è ancora provato che le truppe di leva offrono prestazioni militari-coloniali inferiori a quelle dei volontari» 32 La base di questo ragionamento stava nella precisa volontà di Ricotti (come anche aveva già detto Corte) di non dare origine ad un 'altro' esercito, ad un Corpo staccato dall'organismo militare nazionale, che avrebbe potuto anche essere sottoposto- per la sua specificità 'coloniale' -a forme di subordinazioni amministrative, gerarchiche e politiche da parte di altri Ministeri , quello degli Esteri
29 Ne dà notizia R. RAINERO, L 'anticolonialismo italiano da Assab ad Adua (1869 - 1896), Milano , Ediz. Comunità , 1971 , p. 196.

30 Cfr. gli anicoli citati, ed ancora «l'esercito italiano• , 8 febbraio 1885. Le truppe coloniali; ivi, 19 febbraio 188 5 , Le spedizioni in Africa; ivi, 4 marzo 1885, Assegno indennità alle truppe in Africa; e così via.
3l «L'Italia militare•, 3 maggio 1885, I doni per i nostri soldati d 'Africa.
32 lvi, 27 marzo 1885, Truppe coloniali.
330 L' ESERCITO NELLA POUTIC/1 COLONlALE
ad esempio, cosa che pure accadeva in altri Stati europei del tempo. L'esercito-nazione, la ' n azione armata' era unica e tale doveva rimanere, alle dipendenze esclusive e totali del Ministero della Guerra 33. E poi c'era il pericolo di dividere ulteriormente il Corpo Ufficiali, che come abbiamo visto era proprio in quegli anni attraversato da un già aspro dibattito sull'avanzamento e su asserit i privilegi concessi a questa o a quell'Arma, a questo o a quel gruppo; e non sembrava opportuno introdurre - in questo ambiente surriscaldato- un'ulteriore 'cors ia p referenziale' per gli ufficiali coloniali che, alimentando forse nuove polemiche, avrebbe potuto dividere il Corpo in 'combattenti' e in 'sedentari' 34_
Se la base del ragionamento era questa, infine, va ricordato che tutte queste discussioni avvenivano in uno scenario generale che vedeva il Ministero della Guerra, e Ricotti prima di altri, voler attribuire tutto sommato una scarsa imponanza alla spedizione di Massaua. Non si voleva, alla Pilotta, essere trascinati in una spirale di spese e di impegno solo per quel piccolo contingente di tre reggimenti. I problemi dell'esercito, e della nazione, continuavano a dover rimanere altri.
Scriveva a questo proposito la voce ufficiale del Ministero della Guerra:
Tutti i nosui guai sono conseguenza diretta o indiretta del 1866 35.
E, in un'altra occasione, continuava pessimisticamente:
Molto più che di colonie, abbiamo bisogno di rialzare il nostro prestigio militare. Non ci mancherebbe altro che un nosuo insuccesso contro i Negri! 36_
Da qui anche quel certo tono infastidito delle repliche ministeriali a «L'esercito italiano», che invece - a somiglianza di certi settori dell'opposizione politica, crispina in panicolare- parevano annettere una grande importanza al futuro della spedizione e del colonialismo italiano 37.
33 Cfr. ivi, 7 febbraio 1885, R. BIANCIARDI, Esercito coloniale?.

34 Questi termini erano chiaramente adoperati già in ivi, 27 marzo 1885, Truppe coloniali.
35 lvi, 22 marzo 1885, Disciplina mzlitare.
36 lvi, 29 marzo 1885, Preoccupazione.
37 Le consonanze, in tema coloniale, tra i militari de «L ' esercitO italiano• e i politici dell'opposizione pentarchica dovrebbero costituire oggetto di uno studio separato.
AllE ORIGIN I DEU.A SPEDIZIONE PER MASSAUA 331
Scanata quindi (e da subito) da parte degli organi militari centrali, l'ipotesi del Corpo coloniale, rimaneva da scegliere tra leprime due modalità: grandi unità omogenee o grandi unità 'eterogenee'.
E proprio su questo aspetto risultarono alla lunga decisivi lo scenario generale qui sopra ricordato ed il complesso di idee affermatosi tra i massimi responsabili della preparazione del Corpo di spedizione, che portavano a non voler caricare di importanza una missione militare dall'esiguo peso organico, dallo scopo ancora impreciso (Assab o Massaua, costa o interno dell'Africa) e che già a quel momento aveva sollevato dissidi non trascurabili (concorrenzialità ua esercito e marina).
L'adozione di unità organiche omogenee (battaglioni già formati) avrebbe potuto sguarnire località dal punto di vista del mantenimento dell'ordine pubblico- che proprio in quei mesi e in quegli anni si faceva più insicuro tra scioperi urbani e sommosse rurali 38 - e dal punto di vista di un ordinato svolgimento dei meccanismi di mobilitazione, cui in quel periodo si voleva mostrare una più ravvicinata attenzione (sarà proprio del 1885 la preparazione, e del 1886 l'emanazione, del primo 'Bollettino di mobilitazione' diviso in due parti, la prima di pubblica diffusione all'interno del mondo militare, la seconda preparata ma da mantenere segreta sino ali' eventuale decisione di passare dal piede di pace a quello di guerra) 39. Quindi, tra una più alta qualità delle truppe 'coloniali' di Saletta ed una 'sicurezza' in patria, Ricotti non aveva dubbi: optava per la seconda e quindi per la formazione delle grandi unità da impiegarsi in colonia tramite compag n ie disseminate un po' in tutta Italia 40.
3S Oltre ai vari studi sul rema già citati in precedenza, rendono bene l'idea dell ' estensione nuova dell'agitazione operaia e contadina di quegli anni anche raccolte cronachistiche e cronologiche come L 'Italia nez· cento anni del secolo 'XIX, v. V, Milano, Vallardi, 1942. Cfr. ad esempio, per il1884, alle date del 29 gennaio (Livorno), 5 maggio (Roma), 22 giugno (Rovigo), 28 giugno (Anguillara), 8luglio (Bergamo). Per ill885, a quelle del 5 marzo (Mantova), 5 agosto (Roma), 6 settembre (Parma) , 19 (Brescia). Per ill886 , inftne, 12 gennaio (Napoli), 15 febbraio (Roma), l marzo (Ancona, Venezia, Bologna, Foggia), 15 aprile (Roma), 30 luglio (Firenze) , e così via. E queste sono le date soltanto delle agitazioni maggiori, in ognuoa delle quali è facilmente presumibile un qualche intervento delle truppe in funzione di ordine pubblico.
39 Cfr «Giornale militare ufficiale:. , 10 febbraio 1886 , acro n. 22.
40 Un'altra , sia pura laterale, spiegazione per questa scelta è da ricercarsi nella preoccupazione delle conseguenze (dannose per l ' ordine pubblico) che un'eventuale disfatta militare del Corpo di Sped izione avrebbe portatO con sé se il contingente fosse stato prelevato tutto da una sola Provincia o regione d'Italia. Lo spettro di un insuccesso ' contro i Negri' aleggiava sulla preparazione della spedizione per Massaua. Scriveva chia-

332 L' ES ERCITO NE llA PO
COLO N'IALE
UTICA
Questo tipo di pro bi ematica (quale scelta organica effettuare per i reparti), più freddamente tecnico-militare, potrebbe a prima vista apparire meno importante di altre più evidenti questioni, come la ricordata leggerezza di Mancini nel far cambiare alla spedizione obiettivi e co nsistenza , o come lo stato di difficoltà e di incertezza in cui questa contraddittoria politica diplomatica costringeva gli ambienti militari- ad esempio- al momento della definizione del quadro del Comando militare locale.
Eppure essa non va trascurata, dal momento che ci riporta al cuore del nostro problema , e cioè l'atteggiamento dei militari nei confronti della prima spedizione coloniale.
È infatti a questo punto indubitabile che, dopo aver visto balenare ipotesi ben più impegnative come quella della spedizione tripolina o della immediata cooperazione militare italo-britannica su per il N ilo (da Alessandria a Khartum), gli ambienti direttivi militar.i non si potevano comunque mostrare entusiasti per la 'piccola' spedizione di Massaua. Lo Stato Maggiore declinava così, da una parte , qualsiasi responsabilità, accusando (e a ragione) di non possedere dati sufficienti; il Mini stro posponeva, dall' altra, la qualità del piccolo Corpo di spedizione coloniale al mantenimento di una ordinata strut-
ramente la sezione amministrativa del Ministero della Guerra: •Nell'ipotesi sfavorevole che le truppe di spedizione dovessero sottostare a notevoli perdite, queste si troverebbero equamente (sic) ripartite sopra un maggior numero delle provincie del Regno:.. AUSSME, Volumi Eritrea, v. 4, 6 gennaio 1885. Ma l'interesse per la localizzazione e la distribuzio ne delle perdite doveva durare a lungo. Nei giorni successivi a Dogali, il Ministro della Guerra , ancora il novarese Ricotti, fece compiere tal une ricerche perché si iden· tificassero gli evenruali caduti nativi della provincia di Novara, onde poter loro dedicare qualche lapide, qualche monumento o qualche cippo commemorativo. Anche per conuobilanciare - in quello che era in fondo il suo circondario elertorale - la cattiva impressione che l'eccidio africano avrebbe poruto creare nei confronti dd generale. Ma, nonostante queste ricerche, soldati novaresi a Dogali non ce ne erano stati. Con un cert<> disappunto e- se vogliamo- cinicamente, scriveva così Ricotti a Perazzi: cDei nativi della provincia di Novara nessuno trovavasi al fatto d ' arme di Dogali. È una fatalità, ma non vi ha rimedio». MCR, Carte Perazzi, s<:. 904, fase. 45, doc 14, 5 aprile 1887, Ricotti a Pe razz i. Secondo alcuni calcoli successivi (che però non è possibile verificare) i Corpi d'Armata che maggiormente contribuirono alla composizione di repani inviati in Mar Rosso furono il X, l' Xl ed il XII, rutti con sede nell'Italia meridionale. Sempre dagli stessi calcoli, e ceno computaci in difetto, pare che dalla prima spedizio ne di truppe del 17 gennaio al 12 marzo 1887 (successivo a Dogali, quando tornò a Massaua Saletta, con il compi m di sostituire Gené, chiudere la fase della 'spedizione di Massaua ' e preparare la fase della rivin cita) si alternarono a Massaua - nelle file del solo eserciro -non meno di 10.550 giovani, tra drappelli, compagnie organiche e reggimenti. Una cifra non indifferente , e che spiega - a livello popolare - la durezza del contributo e l'incidenza dell ' esperienza coloniale e africana dei coscrini . Per le cifre, cfr. AUSSME, Carteggio En'trea, racc. 39.

All.E ORlGIN J DEllA SPEDIZIONE PER MASSAUA 333
turazione del generale quadro militare nazionale di pace. Questa Massaua semb rava insomma creare più problemi che aprire vie all'onore delle armi nazionali: nell'incertezza degli scopi, in quei primi giorni de l gennaio 188 5, di ceno per i militari restava so lo il fatto di per sé non entusiasmante che si andava in Mar Rosso per alzare la bandiera. Tutto il resto sarebbe stato deciso dai diplomatici, dai politici .
Non si intravedevano allora i perico li cui sare b be andato incontro il presid io di Massaua, anche perché non si conosceva a fondo né la zona né la forza dell'Impero etiopico né l'intensità del ferm e nto de ll a rivolta mahdista. Né si coglieva appieno il peso di quel ficcarsi nelle maglie complicate ed insicure del Trattato Hewett.
Questo intersecarsi di più minacce (all ora ignorate) avrebbe invece gravato, in generale , sull'intera politica coloniale italiana successiva: e soprattutto ed in primo l uogo sulle autorità militari locali cui la sicurezza di quel p iccolo presidio era dem andata.
Quello che , come dicevamo , all'inizio non si intravedeva - né Io sospettava il pur cauto Ricotti- sarebbe presto venuto alla luce. Era passato poco tempo dall'occupazione di Massaua che già la voce ufficiosa del Ministero della Guerra sentenziava, a proposito del grave insuccesso inglese di Khartum:
Fortuna te le nazioni che come la Francia o I'InghiJterra hanno una lunga e gloriosa tradizione militare! Esse possono far pace dopo una sconfitta, magari se avuta dai Cinesi o dai Negri. Noi, nati ieri , e con Lissa e Custoza sulle nostre prime due pagin e, non potremmo, in simile caso, fare altrettanto, senza suicidarci 41 .
E non era la prima volta che il tema del pericolo e del timore di uno smacco coloniale si era presentato su quelle pagine. L'ammonizione della Pilotta era anche diretta contro i responsabili diplomatici e po litici della spedizione su Massaua: si era fatto tutto il possibile per scongiurare anche solo l'eventualità di esporre le armi nazionali ad un insuccesso? Quella 'piccola' spedizione, apparentemente nata davvero 'senza sforzo e senza spese' (rispetto alle altre più gravi ipotesi a volta a volta affacciatesi), avrebbe impegnato la struttura mi litare più di quanto all'inizio si fosse pensato. Cominciava a circolare, così, tra i militari italiani , quell 'augurio che invece doveva essere un triste presagio: ' Non ci mancherebbe altro che un nostro insuccesso contro i Negri!' . Ma questo , in quei primi mesi, non sarebbe avvenuto.

334 L'ESERCITO NELLA POUTICA COLONIALE
41 cL ' Italia militare•, lO aprile 1885, L 'esempio degli altri.
CAPITOLO SECONDO
LE PRIME PROVE
Istruzioni e realtà: l'occupazione di Massaua
Oltre ai timori militari per un insuccesso africano vi era un altro elemento, assolutamente decisivo, nelle vicende di quei giorni: laperlomeno apparente , a giudicare dai documenti - assenza di un momento di sintesi della politica coloniale italiana a livello di presidenza del Consiglio dei Ministri.
Le ricerche che, anche dal punto di vista della storia diplomatica, hanno ricostruito i precedenti e le primissime mosse del colonialismo italiano , hanno già ricordato questa assenza: nella preparazione come nella prima conduzione politica o nell 'o rdinaria amministrazione del presidio di Massaua erano rilevanti (e co me tali sono stat i conservati) i dispacci di Mancini o di Ricotti ma praticamente mai quelli di Depretis 1 La presidenza del Consiglio pare abbia fatto invece sentire la sua voce, attraverso i deliberata del Consiglio dei Ministri, solo nei momenti più drammatici, o in quelli che apparissero tali. A fine dicembre '84, al momento del definitivo assenso britannico; a febbraio 1885, quando si trattava di riorientare l'intera politica italiana per Massaua; ad aprile, per la decisione di aprire una sosta (non solo estiva) nell'attività di irraggiamento e di proiezione esterna delle forze militari stanziate a Massaua; a settembre, quando si procedette al varo di una politica coloniale più cauta ed alla sostituzione dell'allora comandante del presidio, Saletta, con un militare più tranquillo. Queste furono, nel1885, le occas ioni in cui tis riunì il Consiglio dei Ministri 2 con all'ordine del giorno la politica coloniale (ed in cui riuscì ad imporre una certa cautela e a far vale-
1 Per runi cfr. BATIAGUA , La pn·ma guerra d'Africa, cit., p . 172.
2 Secondo quanto risulta anche da AUSSME, Volumi Eritrea, v. 2, alle date Citate.

re quella sua certa riluttanza al colonialismo) 3.
Ma tra una riunione del Consiglio ed un'altra, l'attività dei Ministri sembrava svolgersi quasi autonomamente e senza controllo, talvolta anche secondo logiche- e verso mete- tra loro contraddittorie.
Il problema dovette in qualche modo essere presente a Depretis stesso, o perlomeno doveva riconfermarlo nella sua convinzione per cui la Presidenza del Consiglio- in forma di Ministero, di Segreteria di Stato od altra - necessitava in Italia di più solide basi istituzionali. Non a caso egli - che già aveva provato a far passare nel governo ed alla Camera queste sue idee nell876, nell881 e nel1884 - avrebbe tentato ancora, proprio nei mesi della spedizione di Massaua, di realizzare un più centralizzato controllo sull'attività dei vari Dicasteri 4 .
Se questo fosse stato possibile già nel 188 5, forse alcune delle più evidenti contraddizioni della politica coloniale italiana (tra indirizzo diplomatico ed indirizzo militare , per esempio) avrebbero potuto essere evitate. Si potrebbe dire che ciò sarebbe stato solo una 'razionalizzazione' amministrativa, che pure non avrebbe eliminato i contrasti politici di fondo: ma sembra che la prima spediz ion e coloniale italiana avesse avuto bisogno anche di questo. Nel frattempo (in mancanza di quelle riforme amministrative o di una più decisiva volontà politica di Depretis di intervenire personalmente nella conduzione dell'impresa di Massaua) il filo della politica coloniale italiana doveva continuare a dipanarsi immutato.
Era così questo lo scenario politico-istituzionale che si lasci ava alle spalle la missione per il Mar Rosso, quando essa partì da Napoli il 14 gennaio 1885, con destinazione ufficiale Assab.
Le vicend e del viaggio (dall'Italia a Suez prima, e a Suakim poi)
3 Uno studio puntuale sul ruolo della politica coloniale nel pensiero e nell'azione di Depretis è ancora da venire, nonostante le pagine di GIGLIO, La politica africana di Agostino Depretis, cir. A suo tempo Giampiero Carocci aveva scritto che cper il Depretis le spese militari erano spese improduttive , che minacciavano la faticosa integrità del bilancio e solleticavano pericolosi amor propri c: interessi sez ionati:. all'interno della classe dirigente. E che il colonialismo (in Italia cnon ( ) tant o determinato da un cccesso di produzione o dalla necessità di trovare nuovi mercati, quanto, all'opposto, dalla miseria») fu c imposto al rilu ttante Dcpretis:.. CAROCCI, Agostino Depretù e la politica interna da/1876 al1887, cit., p. 399 e p. )93. Cfr. anche G. TALAMO, La formazion e politica di Agostino Depretis, Milano, Giuffré, 1970.
4 Cfr. E. ROTELLI, La prmdenza del Consiglio dei Ministn·. Il problema del coordinamento dell'amministrazione centrale in Italia 1848-1948, Milano, Giuffré, 1972, p. 99 c: sgg , e p 131; CALANDRA , Storia dell'amministrazione pubblica in Italia, cit., p. 14) e sgg.; ed anch e GHISALBERTI, Stona costituzionale d 'Italia 1849 - 1948, cit., p. 169.

336 L' ESERCITO NEllA
POUTICA COLONIALE
sono già sufficientemente note per dovervi fare ancora dettagliati riferimenti 5. Al momento della partenza forse solo Caimi 6, il Contrammiraglio che avrebbe dovuto prendere il Comando nella zona , sapeva che lo scopo vero non era Assab bensì Massaua. In ogni caso egli, conformemente alle disposizioni ricevute, fece sostare il convoglio nel porto 'inglese' di Suakim, dove poté ricevere le ultime istruzioni. Queste parlavano di Massaua, e Saletta poté presto prendere co noscenza dei reali scopi della missione cui era destinato. Quali Istruzioni politiche e diplomatiche, in verità, il colonnello ebbe modo di consultare - e quali invece gli giunsero più tardi - è ancora cosa non perfettamente sicura. Ceno non poté prendere visione del testo integrale del messaggio ministeriale e più probabilmente, essendo Suakim allora una stazione telegrafica, l'ultima prima di inoltrarsi nel tratto più meridionale del Mar Rosso, si può ritenere che Saletta ne conobbe la versione ridotta , riassunta a mezzo telegram ma 7• Per quanto riguarda invece le istruzioni militari (seppure anche in questo caso non si può essere del tutto ceni sulla base di quali documenti il colonnello realizz ò la sua occupazione di Massaua) si può ragionevolmente pensare che la sostanza di queste gli fosse già chiara a seguito dei ripetuti contatti avuti prima della partenza con il Ministro della Guerra e con lo Stato Maggiore 8 . Quest'ultimo, solo in data 3 febbraio, aveva steso le ultime e definitive ' Istruzioni Militari per il Comandante Superiore a Massaua'
9. Se anche Saletta non le avesse effettivamente le tte a Suakim o poco dopo, è ceno che eg li ne conosceva già il senso.
Le Istruzioni Militari risentivano ancora d eli' incertezza di fon-
Cfr. Storia militare della Colonia Eritrea, cit., p. 77 e sgg.
6 Nonostante l'ordine ufficiale risulta essere stato spedito il 2 febbraio (dr. AUSSME, Volumi Eritrea, v. 2, alla data del 2 febbraio 1885). come si è visto, già dall'S gennaio Caimi (o comunque chi, della Marina militare, fosse stato destinato a tenere il Comando delle forze navali del Mar Rosso) sapeva da comunicazioni riservate del Ministero della Marina che la meta della spedizione era Massaua e non Assab (cfr. ivi, v. 44, 8 gennaio 1885, R.ù.m, Brina Caimi).
7 Questa pare anche l'opinione di GIGUO, L'impresa di MtJJsaua 1884-1885, cit., p. 71.

8 Quelli del gennaio 1885. ma anche quelli della primavera 1884. Anche se questi. tesi alla pianificazione di una spedizione per T ripoli, dovevano prevedere l'impiego (al contrario della spedizione per Massaua) di un cpiù consistente nerbo di truppe•. AUSSME, Volumi En'trea, v. U, 16 febbraio 1885, Saletta a Ricci, allegato a 9 marzo 1885, Cosenz a Ricotti.
9 Cfr. ivi, v. 2, alla data del 3 febbraio 1885; e ivi, v. 43, 3 febbraio 1885, Cosenz a Ricotti (in risposta a 30 gennaio, Ricorri a Cosenz).
LE PRJME PROVE 337
do sui reali scopi della missione, ed infatti prospettavano beo tre possibili operazioni completamente divergenti tra di loro. Ma dalla loro lettura traspare, sia pure ancora non esplicitamente definito, un elemento nuovo. Lo Stato Maggiore, i militari, infatti, sospettosi nei rapponi con i diplomatici fino a quando di spedizioni coloniali si era solo parlato (per T ripoli, per l'Alto N ilo), dovettero poi sentirsi in un ceno senso rassicurati quando la spedizione per Assab -Massaua fu realmente preparata e avviata. In quei giorni, appena precedenti (e sempre più in quelli seguenti) la partenza da Napoli del contingente, si dovette diffondere negli ambienti militari dirigenti un clima nuovo e più gagliardamente fiducioso: alla fine, questa spedizione coloniale si faceva!

Sta qui la ragione per cui superate le prime diffidenze e le iniziali cautele, le Istruzioni Militari (sia pure ancora solo implicitamente) -ed in seguito lo stesso Capo dello Stato Maggiore dell'Esercito in persona - si mostrarono più sensibili a prospettive espansioniste anche ardite ed avanzate: nell'ottica di una espansione coloniale italiana che dalle coste del Mar Rosso avrebbe dovuto spingersi al più presto all'interno dell' Mrica. Ecco perché le Istruzioni Militari si dimostravano in parte inadatte per eccesso alla reale composizione del Corpo per Massaua (che rimaneva pur sempre un piccolo contingente di solo tre battaglioni, peraltro inviati in tre successive riprese) 10 In esse si giungeva a prospettare anche ipotesi politico-militari che per lungo tempo dovevano rimanere impraticabili per le forze italiane in Mar Rosso (e la cui realizzazione completa poté infatti effettuarsi, all'interno di condizioni completamente mutate, in una situazione più favorevole all'Italia, solo molto tempo dopo) 11.
Comunque fosse stato, le Istruzioni del febbraio prevedevano tre discinte fasi della presenza militare italiana nella zona. Una prima, detta di 'stabilimento difensivo', che doveva limitarsi alla conquista di Massaua; una seconda detta di 'stabilimento offensivo in terraferma', che implicava uno sbilanciamento della presenza militare verso il retroterra di Massaua, con la costruzione di una 'testa di ponte' (di dimensione non ancora precisata, ma forse comprendente anche i primi lembi dell'altopiano che sovrastava il pono e che in qualche modo sembrava necessario poter controllare per garantire la sicurezza militare e le vie di rifornimento idrico della cittadina);
81-84.
338 L'ESERCITO NElL\ POUTICA COLONI.Au:
10 Per le fasi d e U' invio di uomini e materiali , cfr. Storia militare della Colonia Eritrea , ci t. , pp.
11 Cfr. BATTAGUA , La prima gue"a d'Africa cit., p . 39 e sgg.
ed una terza eufemisticamente detta di ' ricognizione topograficamilitare' di cui ancora non venivano stabiliti gli obiettivi, ma che rivelava la nuova disponibilità dello Stato Maggiore a quelle che Mancini aveva chiamato 'puntate verso l'interno dell'Africa'.
Anche solo con una prima occhiata ad una cartina geografica (e Saletta ricordava polemicamente che la prima che poté vedere gli fu fornita, durante il suo viaggio nel Mar Rosso , solo nelle immediate prossimità di Massaua) si possono fare alcune considerazioni.
La prima fase, apparentemente, non avrebbe costituito alcuna difficoltà per gli italiani, se l e autorità egiziane si fossero arrese o consegnate a quelle occupanti: in tal caso le autorità militari italiane (e specificatamente quelle navali, dal momento che il baricentro del presidio sarebbe stato così concenuato sull'isolotto di Massaua, sulla tozza penisola di Gherar e sull'iso l otto di Taulud) avrebbero dovuto mantenere il possesso del solo porto.
La seconda, qualora dall a prima vi si fosse voluto passare (ma le stesse Istruzioni specificavano che ciò era «su bordinato al parere de l Ministero:.) , non avrebbe esposto il contingente a pericoli di sorta qualora , olue alla collaboraz ione delle autorità egiziane , gli italiani avessero potuto avvalersi di una benevole accoglienza di quelle tribù che abitavano nel territorio appunto tra Massaua , Saati ed Ailet (ed in tal caso il baricentro del presidio non avrebbe potuto essere, come anche la sua denominazione ufficiale diceva, altro che terrestre). Ma questo era più facile sperarlo che ottenerlo. In questa seconda ipotesi, comunque, il dispiegamento del potenziale militare italiano su una più vasta area avrebbe ponato con sé la necessità di rinforzi e difficilmente non avrebbe potuto preludere ad ulteriori avanzamenti in territorio africano.
La terza fase, infine, era quella più dichiaratamente offensiva ed anche a prima vista mal si conciliava con la limitata forza del concingente di Saletta. Ma ch e la presenza di questa terza ipotesi nel dispaccio di Istruzioni non fosse puramente simbolica lo dimostra il fatto che proprio questa terza fase era quella in realtà più dettagliatamente specificata. Si prevedevano così diverse linee di operazione. Una, in direzione sud-ovest, mirava invece verso il Sudan, secondo la direttiva (Keren-) Cassala-Khanum e ipotizzava quindi una spedizione militare italiana verso la guarnigione inglese, in difficoltà appunto nella capitale sudanese in mano ai mahdisti. Un'altra, in direzione nord-nord-ovest, avrebbe ponato i militari italiani a Suakim, o per rilevare la cittadina una vo lta che la guarnigione britannica si fosse ritirata o per aggiungere le truppe italiane a quelle inglesi

LE PRIME PROVE 339
nella difficile opera di repressione del moto mahdista. Tra queste ipotesi, le Istruzioni precisavano che la più probabile sarebbe stata quella di raggiungere Cassala attraverso tre 'balzi', da Massaua a Senait, da lì a Keren, e da Keren finalmente a Cassala 12 .
Non si può quindi negare che queste istruzioni, di cui Saletta (quand'anche non avesse potuto conoscere la lettera) certo interpretava lo spirito, concedesse ro non poco alle suggestioni di Mancini per una 'pun tata ' militare italiana verso l'interno (o, come egli diceva , 'a duecento chilometri dalla costa': seppure ce ne sarebbero voluti almeno 300 per arrivare a Cassala) 13. Come d'altra pane è difficile credere che l'ipotesi della 'ricognizione topografico-militare', pur nell'ince nezza del suo reale scopo (contro l'Etiopia? contro i mahdisti? a puro sostegno dell'Inghilterra? da soli?), avrebbe potuto attuarsi con il 'piccolo' contingente di Saletta.
Il quadro del Comando militare, intanto, andò delineandosi. Secondo disposizioni ricevute da Roma, infatti, il Contrammiraglio Caimi, che si fregiava del massimo grado tra i militari presenti, aveva il Comando della Spedizione. Il colonnello Saletta, invece, già al comando del rinforzo di truppe 'destinate ad Assab', era incaricato di occupare Massaua e di detenervi il solo Comando Superiore delle Truppe colà distaccate, nonché il Comando della Piazza e dei suoi dintorni quale suprema autorità civile e militare 14 .
Il fatto che Saletta, e non Caimi con i suoi marinai, fosse incaricato di occupare Massaua era già un mutamento dell'originario pia-
12 Cfr. AUSSME, Volumi Eritrea, v. 43, 3 febbraio 1885, Cosenz a Ricotti. Ad indicazione eli quanco lo Stato Maggiore tenesse a questo piano e di quanto esso volesse essere dettagliato e operativo, sta il fatto che Cosenz non vi lesinava nemmeno le note tecniche e pratiche. Tra l'aluo, il Capo deUo SME meticolosamente indicava l 'utilità che una ferrovia 'sistema Lattigue' (con piccoli carri, su monorotaia, a trazione animale) avrebbe potuto rivestire nel trattO Massaua-Senait (cioè nel primo uarro di scalata verso l'altipiano abissino).
13 Già BAITAGUA , Lapn'maguerra d'Africa , cit., pp. 190-192, lo aveva intuito.
14 li problema, che appare chiaro anche ad una prima lettura delle dimostrazioni date alle autorità in loco, viene stranamente taciuto in varie ricostruzioni. Cfr. Italia in Africa, Il governo dei tem'tori d'oltremare, Roma, 1970. In questo volume, opera del noro 'Comitato', o con superficialità, o per ignoranza, o per volontaria apologia , è costruita infatti a questo (limitato ma significativo) proposito la tab. IV, Cronologia della Colonia En'trea , in cui non si fa cenno del contrasto Caimi-Salerra del 1885. ma si designa il solo colonnello co m e cii comandante supremo delle truppe italiane in AfriCb dal 5 febbraio 1885 al 13 novembre 1885: cosa che non è vera. Punroppo non pare possa trattarsi eli una svista tipografica: anche nel testo il contrasto tra le amministrazioni militari della Guerra e della Marina è taciuto. Cfr. rispenivamente, ivi, p. 417 e pp. 6-7 (nonché p. 213).

340 l'ESERCITO NEllA POUTICA COLONIAlE
no (e comportava una oggettiva rival utazione delle truppe dell'Esercito e dei loro compiti, rispetto a quelle della Marina Militare). Ma ciò che alla lunga sarebbe stato causa di maggiori contraddizioni era p roprio quell'evidente sovrapporsi di cariche impropriamente definite - Comando della spedizione, delle truppe, della piazza- che avrebbe poi creato non poche difficoltà allo svolgimento anche della normal e amministrazione della prima colonia politico-militare italiwa. Che Caimi poi mantenesse formalmente il Comando della Spedi zione anch e quando il bari centro della colonia accennava ad allontanarsi irreversibilmente dal mare era cosa difficile da sostenere, anche dal solo punto di vista militare .
Ma a Roma non si prestò molta attenzione a questo aspetto, che poteva apparire solo tecnico-militare, di fronte al cumulo di problemi po l itici e diplomatici che la conduzione dell'occupazione coloni ale andava via via sollevando.
Fu quindi con quel tipo di istruzioni militari, e con quella struttura di Comando , che Massaua fu occupata dagli italiani.
Sal etta, quando la sera del S febbraio si avvicinò alla costa di Massaua, si trovava in una situazione obiettivamente non facile e che in qualche modo rifletteva le velleitarie ambizioni e i limiti del nascente colonialismo italiano.
Comandava un piccolo contingente militare , aveva da poco visto una approssimativa carta geografica del punto che andava ad occupare, conosceva solo le linee generali delle Istruzioni politiche e milit ari assegnatagli (le quali, peraltro, quand'anche avesse potuto leggerle per intero, gli avrebbero detto molto più su quello che allora non poteva fare - la 'ricognizione topografica' verso Cassalapiuttosto che su quello che avrebbe dovuto fare- impadronirsi di Massaua - ). Poteva forse, al massimo, sperare nel col. Che rmside e - per lui -n eli' aiuto della potenza britannica: ma anche questo non semp re sarebbe poi stato possibile durante e dopo la presa di Massaua.
All'interno di questa occupazione l'elemento decisivo non fu tanto , come talvolta è stato fatto notare 15, il presentarsi di alcune impreparazioni tecniche - peraltro comprensibili alla luce delle complesse vicende che avevano mutato l'originaria destinazione del Corpo guidato da Saletta - quanto il carattere stesso che il colonnello italiano volle dare al presidio di Massaua.
l5 Cfr. BATIAGLTA , La prima guerra d 'Africa , ciL, pp. 180 -1 83 , e D EL BO CA , Gli italiani in Africa orientale. Dalf'uniki alla marcia su Roma , ci t ., p 18 7

LE PRIME PROVE 34 1
Egli, infatti , non si limitò all'occupazione di quel ristretto lembo di terra e di sabbia su cui sorgeva Massaua (cosa che avrebbe legittimato la definizione di 'stabiliment o difensivo') ma fece occupare anche i due fortini, este rni alla cittadina, di Otumlo e di M'Kullo (Monkullo) . L'op erazio ne (a proposito della quale lo stesso Saletta disse che egli l'aveva ponata a termine «sebbene l 'occupazione potesse allora sembrare imprudente») 16 dava al presidio di Massaua una caratteristica di maggiore sicurezza da eventuali scorribande di tribù locali (e forse rivelava quell'intimo timore di un insuccesso 'contro i negri ' che già abbiamo visto presente tra i militari italiani). Ma evidenziava anche una tendenziale predisposizione militare di Salett a a proiettare la forza italiana al di là di Massaua, verso le alture, verso quella che era stata chiamata 'fase di stabilimento offensivo in terrafe rm a'.
L'importanza di questo dispiegamento di forze voluto da Saletta assunse poi una maggiore importanza, alla l uce delle diverse difficoltà che la presenza italiana dovette da subito affrontare a Massaua.
Prima di tutto la resistenza passiva, se non il vero e proprio ostruzionismo , delle autorità egiziane. Come sappiamo, Mancini aveva ottenuto da Londra l'assenso ad una presa italiana di Massaua ma non un'autorizzazione a sostituire completamente i rappresentanti (militari e politici) del Cairo: era questo, come si ricorderà, il prezzo della questione istituzionale e del cosiddetto 'condominio'. Non sappiamo quanto le autorità militari italiane (centrali e locali, cioè a Massaua) fossero a giorno di questa situazione 1 7, ma conosciamo perfettamente l 'i nsofferenza- partico l armente di Saletta - per questo aspetto che in realtà dimezzava il potere co l oniale italiano in loco.
Un esem pio significativo di tutto ciò era stato dato sin dal giorno successivo l'occupazione. Caimi, in quanto Comandante del Corpo, aveva o rdinato al rappresentante a Massaua del governo egiziano che fosse concessa una adeguata ospitalità al Comando delle forze terrestri italiane. Il governatore egiziano , invece, volle concedere p er il Comando militare italiano una sola delle tante stanze del ' Palazzo
t6 AUSSME, Carteggio En"trea , racc 9, fase. l, p. 25.
17 Certo talvolta la disinformazione dei politici non aiutava più distesi rapporti con i militari Mancini arrivò a proporre a Ricotti che , per una cprima fase•, Salerta in quanto Comandante della Piazza di Massaua fosse e rimanesse subordinato all'autorità politica e militare britannica del col. Chermside ! Proprio quando invece $aletta, auto· nomamente, stava facendo avanzare la linea di difesa.

342 L'ESERCITO NElLA POLITICA COlONIALE
delle autorità' di Massaua, che egli occupava e che intendeva persistere ad occupare in segno di una continuità di dominio. La cosain fondo - poteva anche non interessare direttamente Caimi che come tllltti gli ufficiali di Marina risiedeva a bordo della sua nave, ma il colonnello Saletta. Forse anche per tali motivi, Caimi accettò la sistemazione proposta dagli egiziani.
Ciò parve invece umiliante a Saletta. Il quale, all'alba della mattina seguente, mandò una mezza compagnia dei suoi bersaglieri ad occupare il Palazzo delle autorità, che divenne da allora - tutto quanto - la sede fisica della massima presenza militare italiana in colonia 18.
Ma la questione del Palazzo era, se vogliamo, puramente simbolica. Purtroppo non fu che la prima di una lunga serie di schermaglie, di screzi, di piccole ma continue ostilità egiziane contro gli occupanti militari italiani: ostilità che intralciarono- e ritardarononon poco lo stabilirsi di un pieno potere 'coloniale' italiano su Massaua 19. Quello che contava nella vita della cittadina ed agli occhi dei suoi abitanti era infatti proprio la quotidiana, continua inframmettenza egiziana negli affari di competenza di Saletta o che comunque potevano ricadere sotto la giurisdizione di un 'autorità che avesse voluto dirsi occupante. A questo proposito, scriveva con precisione qualche mese dopo il generale Ricci, che (come vedremo) sarebbe stato inviato a Massaua per una importante ispezione:
disgraziatamente sino ad ora [aprile 1885] il possesso di Massaua non è per noi completo; e, come accanto al la bandiera italiana si alza l'egiziana, si è che al fianco del nostro Comando militare ve ne ha uno egiziano. Ecco un punto che non si dovrebbe mai perdere di vista ( ... ) 20
Il rammarico di Ricci consisteva nel fatto che «ragioni di convenienza ed altre i mpedirono che nello sbarcare a Massaua si facesse come si è fatto a Beilul» 21 : evidentemente l'azione di forza di Ttucco rimaneva per Ricci e per i militari italiani un modello.
18 La vicenda era in parte nota da Storia militare della Colonia Eritrea, cit , p. 78. Cfr. anche AUSSME, Carteggio En'trea, racc. 9, fase. l , p. 27.
!9 L'impaziente Saletta era massimamente irritato da queste resistenze che lo costringevano ad andare avanti, cdi giorno in giorno , sempre temporeggiando:.. lvi, p. 28.
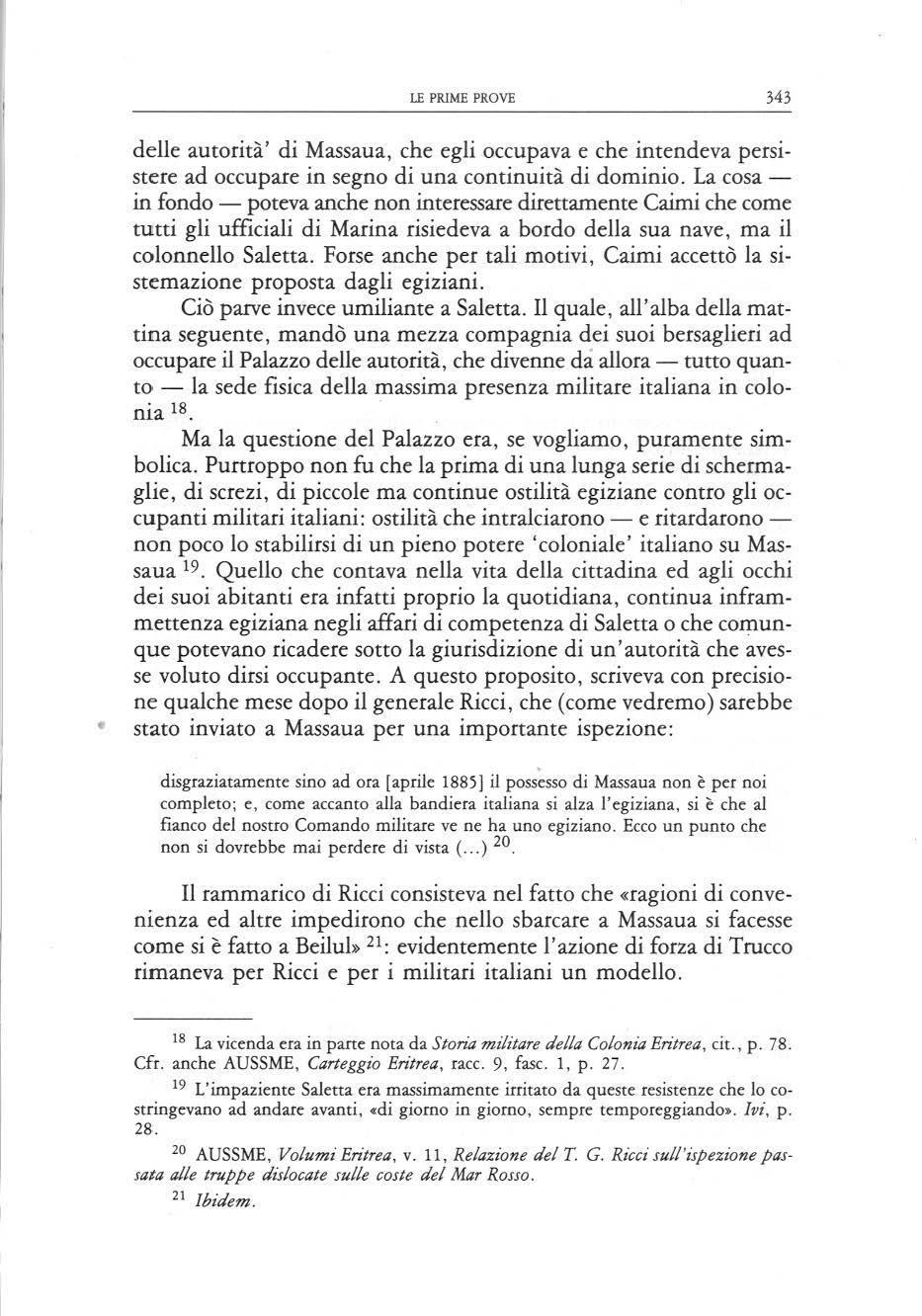
20 AUSSME. Volumi Eritrea, v. 11, Relazione del T G. Ricci sull'ispezione passata alle truppe dislocate sulle coste del Mar Rosso.
21 Ibidem.
LE PRIME PROVE 343
Lo stesso Saletta ne era cosciente: passata qualche settimana, quando venne il momento di stilare la prima relazione al Ministero sullo stato dei servizi d'occupazione a Massaua , egli scrisse che troppe volte le istruzioni (militari o diplomatiche) gli erano giunte con un ritardo tale che poi le aveva rese inapplicabili. L'occupazione di Massaua, ad esempio, era avvenuta
secondo un ordine di fatti assai diverso da quello ptevisto in quelle istruzioni. Ciò fu causa che lo sviluppo ulteriore delle cose prendesse un indiiizzo assai più lemo e difficile di quamo si presumeva nelle Istruzioni medesime 22 .
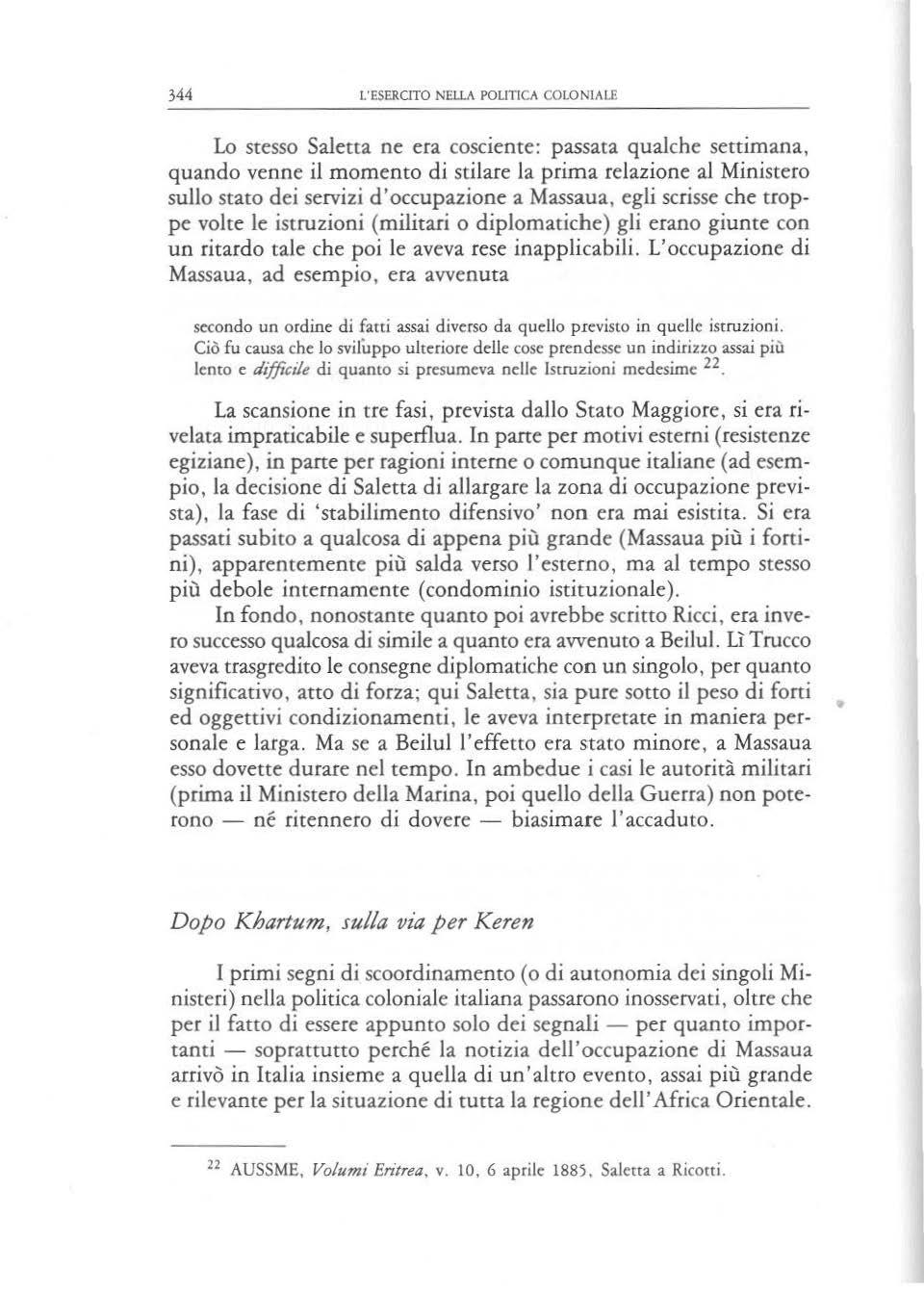
La scansi o ne in tre fasi, prevista dallo Stato Maggiore, si era rivelata impraticabile e superflua. In parte per motivi esterni (resistenze egiziane), in parte per ragioni interne o comunque italiane (ad esempio, la decisione di Saletta di allargare la zona di occupazione prevista), la fase di 'stabilimento difensivo' non era mai esistita. Si era passati subito a qualcosa di appena più grande ( Massaua più i fortini) , apparentemente più salda verso l'esterno, ma al tempo stesso più debole internamente (condominio istituzionale).
In fondo , nonostante quanto poi avrebbe scritto Ricci , era invero successo qualcosa di simile a quanto era avvenuto a Beilul. Lì Trucco aveva trasgredito le consegne diplomatiche con un singolo, per quanto significativo, atto di forza; qui Saletta, sia pure sotto il peso di forti ed oggettivi co ndizionamenti , le aveva interpretate in maniera personale e larga. Ma se a Beilul l'effetto era stato minore, a Massaua esso dovette durare nel tempo. In ambedue i cas i le autorità militari (prima il Ministero della Marina, poi quello della Guerra) non poterono - né ritennero di dovere - biasimare l'accaduto.
Dopo Khartum, sulla via per Keren
I primi segni di scoo rdinamento (o di autonomia dei singoli Ministeri) nella politica coloniale italiana passarono inosservati, oltre che per il fatto di essere appunto solo dei segnali - per quanto importanti - soprattutto perché la notizia dell'occupazione di Massaua arrivò in Italia insieme a quella di un'altro evento, assai più grande e rilevante per la situazione di tutta la regione dell' Mrica Orientale.
344 L'ESERCITO NELI.A
POUTICA CO LONIALE
22
AUSSME, Volumi Eritrea , v IO, 6 aprile 1885 , Sal erra a Ricotti
E quindi anche per il nascente colonialismo italiano.
Il S febbraio il telegrafo annunciava, infatti, insieme al colpo di mano italiano a Massaua , che il 26 gennaio Khartum era caduta in mano alla ribellione m ah dista 1
La seconda spedizione inglese di soccorso, quella di Wo lseley, era infatti arrivata troppo tardi: la guarnigione inglese, si era dovuta arrendere e la testa del Gen. Gordon era stata issata su una picca dai nazionalisti musulmani su danesi 2 .
La politica britannica nella zona si trovava così ad un bivio.
O insistere militarmeme, ad un anno dallo smacco di el-Obeid, o ritirarsi prudenremenre, per evitare che scorresse altro sangue inglese. Di fatto, la politi ca di Hewett era fallita ed il moto mahdista - era presumibile - avrebbe attinto nuove forze dalla caduta di Kharturn. Per un pezzo, quindi, il Sudan sarebbe sfuggito dalle mani di Londra.
La reazione britannica, se confrontata ali' entità della sconfitta, fu sufficientemente veloce. Considerando che anche in un'altra lontana parte del globo il grande impero inglese stava sc ric chio landonell'Afghanistan, ai confini co ll 'India , la Russia sembrava fare preparativi di guerra - il governo di Londra decideva il 26 aprile di ritirare le truppe dal Sud an e di inviarle in Asia 3. Nel frattempo, in Italia la caduta di Khartum fu semiracome una doccia fredda: tutti avevano capito che la spedizione di Massaua si era potuta effettuare solo per via della alta protezione della maggiore potenza imperiale e coloniale del mondo. Ma, ora che questa si trovava in così grande difficoltà , che cosa sarebbe potuto accadere a Massaua? Mancini, che non aveva mai rinunciato all'ipotesi di ingrandire Massaua 4 , temeva di veder fallire in un attimo tutto il suo piano.
1 Per le reazioni politiche italiane, cfr, tra l'aluo, a Desua, cl'Opinione•, 6 febbraio 1885, Senza esagerare; e ivi, 10 febbraio 1885, Guardiamoci dalle esagerazioni; per la maggioranza depretisiana , cii popolo romano», 7 febbraio 1885. Inghzlterra e Italia; ivi, Massaua nei suoi rapporti con Assab e Zeifa (dove, nonostante il titolo, si propone di occupare Keren); ivi, 12 febbraio 1885, Italia e Turchia; ivi, 17 febbraio 1885, Dopo le truppe. Cfr. anche CHIALA, La spedizione di Massaua. Narrazione documentata, cit., p. 189 e sgg.
2 Sul mahdismo cfr. A. SANT ALENA, L 'insurrezione nel Sudan, Trento, Turazzi, 1885. Qualche accenno interessante in XXX, Il movimento ùlamico e l'Italia, in cNuova antologia., a. 1906, pp. 325-333.

3 Per taluni commenti militari italiani cfr. cL'esercito italiano•, 29 aprile 1885.
4 Solo in questo senso, e cioè come aspirazioni ma mai come piani reali e concreti, appaiono comprensibili i risultati di quegli srudi. Cfr. invece GJGUO, La politica africana di Agostino DepretiJ, cit., p. 30, e ZAGHl , P.S. Mancini e il problema del Mediterraneo 1884-1885, cit., p. 111.
LE PRIME PROVE 345
Da una pane, è vero, ci si poteva illudere che si riaprisse quel capitolo -su cui il Ministro aveva puntato tanto - di una possibile cooperazione militare anglo-italiana. Secondo Mancini ce n'erano tutte le condizioni: gli inglesi erano già vicini a Khanum, gli italiani erano a Massaua- da dove, secondo la Consulta, con una rapida 'puntata' si sarebbero potuti spostare dovunque fosse stato necessarioed altri ancora potevano arrivare. Bastava solo che Londra avesse accettato l'offerta italiana , e quello che non si era potuto realizzare 'per la via del Nilo' si sarebbe potuto fare a Khartum.
Dall'altra , però, si profilava la concreta possi bilità che Londra decidesse di gettare la spugna e di abbandonare - anche provvisoriamente - l' Mrica orientale: cosa che poi puntualmente avvenne.
li Ministro degli Esteri, e con l ui una buona parte di coloro che erano al corrente degli eventi o che come Ricotti avevano forse iniziato ad entusiasmarsi per la prospettiva coloniale solo dopo aver visto le prime concrete mosse ed i primi risultati (e tra questi proprio la notizia dell 'avvenuta occupazione di Massaua) , non poteva rassegnarsi a che tutto fosse destinato a finire proprio quando appena si era llliZtato.
Era anzi , si credette per qualche tempo in Italia dopo quel 5 febbraio 1885 , il momento migliore per valorizzare la propria presenza in Mrica orientale: aiutando gli ing lesi o facendo da soli.
In realtà, come apparve più chiaramente quando Londra ebbe annu n ciato il suo ritiro, quello da febbraio ad apr i le fu uno dei momenti più difficili e convulsi dell'intera storia della spedizione di Massaua. Venuta a mancare la figura (e la potenza) della grande protettrice britannica , la politica coloniale di Roma avrebbe avuto bisogno di una grande saldezza di principi ispiratori ed avrebbe dovuto mirare per un verso a conso lidare i1 proprio- per quanto limitatodominio, o- nell'altro verso- avrebbe dovuto rinunziare a tutto: ma fare ciò avrebbe anche significato perdere l'onore - non ancora conquistato ma assaporato - di ' grande potenza ' coloniale.
La mancanza di lungimiranza e di serena obiettività di larga pane della classe dirigente (molte delle successive mosse di Mancini, ad esempio, furono di nuovo ispirate al principio della ricerca del successo personale che, solo, gli avrebbe garantito la permanenza al governo) fu all'origine, invece , di più d ' uno tra gli eventi che seguirono.
Da pane sua Mancini provò di nuovo ad impegnare il governo inglese sul terreno di una cooperazione militare: perlomeno in maniera sostanziale (se non formale, come aveva richiesto i1 Consiglio

346 L'ESERCITO
NEllA POUTICA COLONIAL.E
dei Mini st ri ch e 1'8 f e bbrario si e ra riuni to sotto la presiden za d e ll o stesso Re Umb e no I) 5
I tenta ti vi in questo se nso d ella Cons u lta fu ron o vari e si rip e terono a d ondate suc cess ive , tra il fe bbraio ed i pri mi di m agg io di qu e l 18 85 . Sul tavo lo di Gr anv i lle, pri ma Min istro d eg li Esteri e po i Prernier , arri varono i n quel p e riod o i vari pian i itali ani. Le trattative per ciascuno di essi ebbero du ra t a di ve rsa: qualcun a impegnò le risp ett ive Cancellerie per qual che se ttimana , qual ch e altra durò lo spa zi o di un mat tino . Ma tutte ebbero esito sfa vo revole.
Dapprima , a metà del me se di fe bbraio, Manc ini cerc ò a Lond ra conse nsi p er una spedizi o ne cong iunt a pe r Cassala. Ma i nu tilmente 6.
Poi , tra ill2 e illS m arzo, la Consulta tentò di p roporre a G ranville - sempre p e r Cassala - un 'azione militare italiana «per co m o proprio », cui si sarebbe da to il via purch é Londra avesse espresso un
5 Sul ruolo della Corona e dei circoli monarchici nella preparazione c nella conduzione della politica coloniale sarebbe necessario uno spa zio ben maggiore di una breve nota. Da tempo era stata sottolineata l ' im p ortanza di studi (ma anche la difficoltà nel d ocu mentarli) sul peso della Corona ne!Ja politica nazionale. Cfr. RAGI ONIERI , La ston a politica e socrale, ci t., pp. 1675- 168 5 . Ed anche sul te rre n o sp ecifico della ricost ruzi o n e de ll a po lit ica co loniale , vari sono stat i i suggerimenti alla ricer ca. Cfr. BATTAGU A, La prima guerra d 'Afn'ca , ci t ., p. 190 e pp. 192-193; DEL BOCA, Gli italiani in Ajma on'entale. Dall'unità alla marcia su Roma , cit ., p 184 Quello che ci ha impedito di sviluppare quamo av rebbe me r itato questo pumo è la difficoltà di reperire fonti documentarie adeguate e p recise. Qualche cenno però merita di essere fatto , rimandando il resto a future ricerche. G ià era stata indicata la permanenza della grande politica mil itar e nell ' ambito di una p rerogativa regia. Recememenrc cfr. DEL NEGRO , Esercito, Stato e soct'etli. Saggi di ston a militare , ci t. , p. 56. Per quanto rigu arda la sp edizione di Massa u a e il su o o rientam ento do p o la caduta di Khartou m - la cui n otizia gi u nse in Italia i l 5 febbraio 1885 - può essere rico rdato che ancora pn'ma d ella seduta de l Consiglio dei Ministri d e!J '8 febbraio (in cui U m beno l chiese una più vigorosa espansion e coloniale verso l'intern o dell ' Africa) ed in singolare sintonia con quella mossa del Re, già il 6 febbraio il Ministro della Guerra aveva so!Jecitato a Cosenz taluni s tudi nel senso appumo di una maggiore espansione. Cfr . AUSSME , Volumi Enirea , v. 2 , alla data del6 febbraio 1885. E come il Re sembrava dunque disinteressarsi del fatto co nc reto , politico e diplomatico, p er cui appena usciti da Massaua si sareb b e e n trati in territori o ab issino , così lo stesso Rz'cotti dimostrava di no n ca p ire e di non conoscere le condizioni d ettate dal tratta to H ew ett. Cfr. AUSS ME, Carteggio En'trea, racc. 121, fase. 11, 3 se ttem bre 1885 , Ricotti a Marselli E questo nonostante che da tempo la Consulta si fosse preoccupata di illustrar e alla Pilotta quelle condizioni (cfr tra l'altro AUSS ME , Volu mi Enlrea , v 2, alla data del 5 aprile 1885 , o AUSSME , Carteggio Eritrea, ra cc 121 , fase 6, aprile 1885 , Mancini a Rico ni ). Anche a presc indere da giudizi sull a realizzabilità o su!Ja opponunità delle mosse del Re o degli studi d e i militari , quella t empestività e quella sintonia tra U m beno l e il suo Ministro della Guerra conferman o co me, nei momenti cn'tr'ci, e b en dentro gli anni dell'Italia liberale, rimanesse operante una prerogativa reg ia ed una consonanza di intent i tra Corona e ese rci t o.
6 Cfr. GIG LI O , L'imp resa di Massaua 1884-1885, ci t., p. 119 e sgg.

LE PRIME PROVE 34 7
qualche parere positivo. Il tutto con analoghi e deludenti risultati 7
Qualche giorno dopo, il 23 marzo, Mancini, dal momento che nel loro piano complessivo di ritiro gli inglesi avrebbero abbandonato anche Zeila e Harrar, propose a Londra di permettere alle truppe italiane di avvicendarsi con quelle britanniche in quei ricchi territori a metà strada tra Massaua e l'Etiopia. La trattativa per tale ipotesi si trascinò per più di un mese e mezzo, accendendo nel responsabile degli Esteri una grande speranza di riportare un successo politico che sarebbe stato incommensurabilmente più grande di quello di Massaua s. Lo stesso ambiente militare fu più volte sollecitato a fornire al riguardo piani e previsioni 9. Ma poi tutto si rivelò una sona di b/uffinglese (il 5 maggio Granville propose addirittura a Roma di accordarsi per Zeila con la Turchia, cioè con la potenza maggiormente danneggiata e più indignata per la presa italiana di Massaua!). Ma già a metà aprile, poco prima della pubblica dichiarazione inglese di abbandono del Sudan, si era capito che non ci sarebbe stato nulla da fare.
Acutamente, da Londra, l'ambasciatore italiano Costantino Nigra aveva scritto allo stesso Mancini che «essa [ringhilterra] si rifiuta assolutamente a qualsiasi accordo e qualsiasi impegno dopo Khanum e all'occorrenza vuole poter lavarsene le mani» 10 E, quando tutta la convulsa opera di Mancini ebbe incontrato la fine che si era meritata, Nigra sentenziò in un suo rapporto al Ministro che «era da prevedersi che noi non avremmo ottenuto nulla di chiaro» 11.
Per quanto riguarda il versante italiano dell'azione di Mancini, è interessante sottolineare come questi credesse possibile spostare a suo piacimento il possibile teatro di operazioni militari del Corpo d'occupazione di Massaua, all'interno di una vastissima area geografica che andava dalle coste del Mar Rosso all'Eritrea, dal Sudan allo Scioa e all'Harrar.
Ma durante ed a causa di questi successivi fallimenti diplomatici, la posizione personale del Ministro degli Esteri si andava rapidamente indebolendo. Appena passate le nuvole della caduta di Khartum, e scioltosi come neve al sole il primo tentativo (tra quelli qui
7 Cfr. ivi, p. 133 e sgg.
8 Cfr. ivi, p. 133.
9 Cfr. AUSSME, Volumi En'trea, v. 2 , alle date del 12, dell3 e del21 marzo 1885.
1° Cfr. GIGUO, L'impresa di Massaua 1884-1885, cit., p. 151.
11 lvi, p. !)).

348 L' ESERCITO NELLA POUT!Ci\ COLONIALE
ricordati) per Cassala, il 'Popolo Romano' organo di stampa fedelissimo a Depretis già scriveva:
La verità è che, co me più volte annunciammo, per ora non si tratta di altre spedizioni, ritenendosi che con questo ultimo invio possa essere sufficiente la forza necessaria a garan tire i poni occupati e guarnire i punti della costa( ... ) . Ed è app unto per constatare il fabbisogno richiesto dalla situazione, che il Ministero invia un Generale dello Stato Maggiore (si trattava, co me detto e come vedremo meglio, d i Agostino Ricci, comandante in seconda del CSM) il quale dopo aver ispezionato i luoghi potrà dire se occorra per avventura di meglio rafforzare i presidi: ma fino a che il Generale Ricci non avrà compiuta la sua missione il parlare di nuove spedizioni equival e a tirare a ind ovinare 12
Si rifletta sul fatto che Ricci non tornò (e non sarebbe potuto tornare) prima del9 aprile; che una qualsiasi spedizione militare avrebbe necessitato del tempo (almeno qualche settimana) per essere allestita; che a partire dalla fine di aprile (ed al massimo dalla metà di maggio) la zona intorno a Massaua diventava inagibile per il fortissimo calore tropicale. Si rifletta su tutto questo e si capirà che Depretis, convincendo Ricotti ad inviare Ricci in ispezione, aveva già implicitamente sconfessato tutto quell'agitarsi di Mancini e tutti i suoi ' piani', come aveva già pra t icamente deciso che sino al prossimo autunno non ci sarebbe stato nessun allargamento del presidio di Massaua.
Questa interpretazione trova ancor maggior fondamento se si presta fede ali' indiscrezione raccolta in quei giorni dall' ambasciatore inglese a Roma Lumley, uomo di solito molto bene informato ed autorità diplomatica romana tra le più importanti, secondo cui già dal 24 febbraio - e cioè dal giorno successivo alla pubblicazione sul «Popolo romano» dell'ammonimento sopra ricordato - «Si era formata una combinazione per ottenere da Depretis le dimissioni di Mancini, con la promessa di votare lo schema di legge sulle concessioni ferroviarie senza ulteriore opposizione» 13, schema di legge cheè bene averlo presente - costituiva an cora in quei giorni il maggior cruccio politico-parlamentare del presidente del Consiglio.
La sorte di Mancini. insomma, era segnata. E di fatti egli fu costretto a lasciare il Ministero a giugno, quando però già a fine maggio era stato pesantemente battuto in Parlamento. Mancini fu una vittima di quello stesso meccanismo che proprio egli - talvolta da
cii popolo romano:., 23 febbraio 1885, Fem'ere e colonie

LE PRIME PROVE 349
!3
12
Cit. in GIGUO, L'impresa di Massaua 1884-1885, cit., p. 128.
solo - aveva messo in moto. Gettatosi con foga sulla via di un'espansione italiana, era rimasto invischiato nei suoi stessi tentativi e aveva voluto legare la sua sorte a troppi e troppo rapidi successi coloniali. Se era stato ' l'uomo giusto al posto giusto' (sia pure con tutti i limiti pesantissimi che abbiamo visto) per Massaua, era diventato l'uomo 'sbagliato ' dopo la caduta di Khartum. I suoi 'piani', già sufficientemente noti e qui solo ricordati , non misuravano solo le velleità e i sogni dell'uomo politico (o di una parte della classe dirigente cui apparteneva) ma anche la reale debolezza del primo esperimento coloniale italiano e della sua preparazione diplomatica .
D'altra parte i fantastici 'piani' diplomatici di Mancini non erano stati gli unici ad essere avanzati da parte italiana in quel lasso di tempo che seguì alla caduta di Khartum.

Più costantemente, e più silenziosamente, anche gli ambienti militari già in quei primi giorni di presenza a Massaua organicamente andavano esprimendo una 'loro' linea di espansione .
Ma qui il discorso deve essere diverso.
Se i piani di Mancini si basavano solo su ipotetiche ed improbabili alleanze internazionali (e rispondevano più, come si è visto, ad esigenze politico personali che a specifici interessi del presidio di Massaua) l'interesse verso la regione di Keren che in più occasioni fu manifestato da autorevoli esponenti del mondo militare (Cosenz, Ricotti, Saletta) aveva due caratteristiche: partire da alcune 'necessità tecniche' del presidio appena conquistato, contare solo sulle proprie forze (e cioè sulla forza del contingente militare italiano). Se la prima di queste due caratteristiche, ambedue assenti dai 'p iani ' di Mancini, stava ad indicare quanto Massaua - da sola - fosse tutt'altro che autosufficiente, la seconda doveva rivelarsi indiscutibilmente un limite, e di fondo. Come si poteva credere- cosa che pure semb ra avessero fatto Cosenz (con più convinzione) e Ricotti - che la ' potenza' italiana avrebbe potuto affermarsi grazie alla sola forza militare?
Avevamo già accennato, durante l'esposizione dei preparativi per Massaua, ad una sorta di 'delusione' militare per il carattere 'minore' che la spedizione era andata assumendo, a confronto di altre più impegnative ipotesi affacciatesi in precedenza. Ma abbiamo anche ricorda to come , dopo la partenza del primo contingente per il Mar Rosso e poi più chiaramente dopo la notizia della avvequta occupazione di Massaua , si era potuto notare n ello stesso ambiente una certa 'ripresa di interesse' per gli sviluppi militari della prima impresa coloniale.
350 L'ESERCITO NEllA POUTICA COLONIALE
Questo secondo atteggiamento era significativamente dimostrato proprio dalla diffusione dei programmi (e dalla rilevanza annessavi dai militari) per una eventuale occupazione militare del fresco e ricco altipiano sovrastante la conca di Massaua che, dal nome della tribù che vi si era installata, prendeva il nome di 'paese dei Bogos' 14 .
Le carte indicavano che il centro maggiore di tale regione era costituito da Keren sulla via per Cassala, ed era bagnato dalle acque della Anse ba.
Keren era già nota ai dirigenti italiani militari: il suo nome (seppur ancora nell'incerta grafia di 'Kehren') era comparso in uno studio di Cosenz inviato da Ricotti a Man cini quando quest'ultimo pensava ancora possibile, appena dopo la caduta di Khartum, un 'azione militare combinata anglo-italiana 15. E già allora, in un altro contesto, Cosenz aveva dimostrato di apprezzare positivamente la via che peJr Keren menava fino a Khartum.
A questo proposito, sia pur aprendo una sorta di digressione, vale la pena accennare un attimo a quello studio di Cosenz 16. Lo studio era stato commissionato dal Ministro degli Esteri con la proposta di prendere in esame, due ipotesi: un'azione militare italiana che, partendo da Suakim, si fosse spinta nell'interno «fino a due o tre giornate di marcia», oppure una spedizione che (da Suakim o da Massaua o da tutt'e due le località) si fosse offensivamente indirizzata ve rso la capitale del Sudan.
La 'memoria' del Capo di Stato Maggiore, in realtà , guardava con un certo scetticismo alle ipotesi proposte da Mancini (e che infatti non furono prese, come si è detto, in grande considerazione a Londra). È oggi interessante, semmai, leggerla soprattutto perché disegna abbastanza fedelmente le preoccupazioni degli ambienti militari italiani.
Cosenz pareva temere in primo luo go la scarsissima conoscenza del teatro di operazioni: scrisse infatti che
i dati che si hanno sulle condizioni del Sudan e sugli avvenimenti che in esso :si svolgono da due anni [la rivolta rnahdista] sono così scarsi ed incompleti, che
14 Cfr. ERliCH, Ethiopia an d Eritrea During the Scramble for Africa: A Politica/ Biography of Ras Alula, 1875-1897, cit., p. 213.
15 Ci riferiamo di nuovo a AUSSME, Volumi Eritrea, v. 2, alla data del6 febbraio 188:5. Cfr. anche MCR, Carte Mancini, se. 709, fase. l, doc. 8, 28 febbraio 1885, Ceechi a Mancini; ed ivi, doc. 9, 18 marzo 1885, Cecchi a Mancini.
16 Cfr. il testo pubblicato in ZAGHI, P.S. Mancini e zJ problema del Mediterraneo 1884-1885, cit., pp. 175-178.

LE PRJME PROVE 351
lo studio relativo ad una nostra possibile azione in quel paese , sul quale non si era portata finora una attenzione, non può fare a meno di riuscire in molta parte deficiente .
Temeva inoltre il clima africano, e soprattutto la sua stagione estiva «singolarmente micidiale», e si chiedeva quali mezzi potesse mai l' I talia fornire alle sue truppe per ovviarvi, se anche il presidio (britannico) l asciat o a Suakim, «nonostante la larghezza con la quale gli inglesi sogliono provvedere alle loro truppe, ebbe durante la stagione estiva una proporzione di ammalati tale da corrispondere agli effetti di una forte epidemia» 18.
Il Capo di Stato Maggiore pareva infine temere la specifica natura dell'avversario, nella prospettiva - per l'Italia nuova- di una guerra coloniale . Nel caso in esame si trattava delle bande mahdiste comandate da Osman Digma, che appunto erano attive anche intorno a Suakim; ma in generale le riflessioni di Cosenz dovevano risultare applicabili a grande parte delle guerre coloniali: guerre che non si risolvevano con battaglie in campo aperto «contro forze regolari», ma che assumevano il carattere dì «guerre insurrezionali» (e qui vi è chi ha voluto vedere, nelle parole del Capo di Stato Maggiore una sorta di ricordi autobiografici del Cosenz garibaldino).
Queste forze non cost ituiscono g ià un corpo regolarmente costituito e permanentemente riunito. Con Osman Digma sta soltanto un piccolo nucleo di forze, che formano , per così dire, gli avamposti dell'insurrezione di fronte a Suakim. Ma non appena le t ruppe [britanniche) che muovono per attaccarlo escono dalla piazza e si dirigono verso le mooragne da esso occupate, le tribù vicine accorrono alla chiama ta e vengono a schierarsi attorno a quel nucleo, per disperdersi di bel nuovo dopo il co mbattimento, tenendosi però sempre pronte ad accorrere ad una nuova chiamata 19.
Nonostante questi timori militari e t ornando al nostro esame degli interessi e dei piani per Keren, va però notatO che vi era una sostanziale diversità tra il ruolo che si annetteva al controllo italiano di quella località nel primo studio di Cosenz (dove Keren aveva solo un'importanza di punto tattico intermedio lungo una via di comunicazione che portava all'obiettivo strategico) e il ruo l o invece che esso pareva avere assunto durante il mese successivo alla presa di Mas-
17 lvi, p. 175.
18 l vi, p. 176 l9 lvi, p. 175 e p. 176. Su questi passi aveva già posto attenzione BATIAGLIA , La prima guerra d'Africa, cit., pp. 191 -1 92 .

352 l'ESERC ITO NEllA POLITICA COLONIALE
saua (cioè di vera e propria specifica importanza, per la sua collocazione geografica). L'utilità militare del possesso italiano del paese dei Bogos e dell'altipiano era evidente: Massaua sarebbe stata completamente sicura, questa volta non solo dalla parte di mare (settore di . interesse della Marina) ma anche da quella di terra; oltre, ovviamente, al fatto - secondario ma non trascurabile- che le truppe avrebbero potuto usufruire di una migliore e più fresca sistemazione, in cui riprendersi - a turni - dali' insopportabile caldo della conca di Massaua.
La preoccupazione dei militari per l'ingrediente stagione estiva africana, sia detto per inciso, non deve infatti essere sottovalutata nell' analisi dei possibili moventi di un indirizzo strategico come quello che si andava affermando e che pareva puntare direttamente sull'altipiano. Oltre alle parole di Cosenz sopra riportate va notato che addirittura il primo dei punti del 'Progetto di Istruzioni', che il Ministero della Guerra aveva steso per il Generale Ricci e per la sua ispezione sui presidi del Mar Rosso, diceva appunto che
è probabile che la prova maggiore per la quale dovranno passare le nostre truppe in Mar Rosso sia quella della entrante stagione estiva, che potrebbe avere una dannosa influenza sulle loro condizioni sanitarie 20 ed il secondo richiedeva a Ricci la determinazione di «un sito, più arieggiato» 21 di Massaua, dove poter far ricoverare le truppe. Il paese dei Bogos con Keren era indubbiamente il più vicino ed il più invitante.
Se questo era vero, non sappiamo però quanto i militari italiani si rendessero conto del fatto che uno stabilimento degli italiani a Keren avrebbe avuto un indubbio carattere spiccatamente offensivo e- particolarmente in quei primi giorni di presenza militare sul Mar Rosso - avrebbe potuto assumere un aspetto di grande minacciosità per tutte le popolazioni della zona e per lo stesso Impero etiopico. Una
20 AUSSME, Volumi Eritrea, v. 11, 20 febbraio 1885, Ris. ma Pers., Ricotti a Ricci
21 Ibidem. Le aspirazioni ad un 'paese dei Bogos italiano' erano poi destinate ad avere una buona stampa. Dopo Dogali, nell'attesa della spedizione 'di rivincita', il tema fu risollevato in vari interventi. Ci fu così chi sostenne - di nuovo - che era ciodimostrabile:ol'acclimatamento degli Europei in uno dei climi più caldi del mondo• (cioè Massaua), a meno che non si fosse occuparo anche- per l'appunto- l'altopiano dei Bogos. Cfr. G. FARALLI, Le mzlizie coloniali. Osservazioni, Firenze, Tip. Cooperativa, 1887 (il parere di Faralli si voleva 'scientifico': egli era il direttore della rivista «<drologia e climatologia medica.).

LE PRIME PROVE 353
cosa era infatti che gli italiani 'venuti dal mare' si fossero limitati a sostituire gli inglesi a Massaua; una totalmente diversa era invece che questi nuovi occupanti, da soli pochi giorni messo il piede sul territorio africano, si fossero addirittura spinti oltre le creste che circondavano Massaua per affacciarsi sull'immenso altipiano etiopico.
Questo secondo aspetto, 'espansionistico' , doveva ceno essere chiaro a Saletta che per primo sollevò la questione di Keren. Le stesse prime istruzioni militari ricevute dovevano averlo spinto a credere che la via di Keren era quella più probabile: proprio questo ne era infatti , come si ricorderà , l'aspetto più minutamente dettagliato. Ma, come queste stesse Istruzioni recitavano, con Keren il possesso italiano avrebbe assu nto il carattere di 'stab ilimento offensivo in terraferma '
Ecco perché, praticamente da subito, Saletta iniziò ad inviare a Roma richieste di mano libera per Keren. La sua stessa prima Relazione sulle modalità dell'occupazione di Massaua vi faceva esplicito riferimento 22
A Roma queste richieste di Saletta arrivarono proprio quando nell'ambiente militare si sare bbe potuto notare quella 'ripresa di fiducia' sulle reali possibilità della spedizione in Mar Rosso, cui abbiamo già fatto riferimento. Lo stesso Ministro della Guerra vi era in qualche modo coinvolto. Dapprima , quando le prime Istruzioni Militari vennero redatte, la Pilotta si era riservata di annotare che queste
furono poi mandate al Ministero [degli Esteri] con lievi modificazioni tendenti specialmente ad accentuare la convenienza di non accingersi al camfo uincerato sulle alture [di Keren J se non quando si avranno maggiori forze 3.
Ma nei giorni invece in cui arrivò la prima Relazione di Saletta era lo stesso Ricotti a vedere come possibile una espansione italiana verso Keren e a sollecitare u n parere in merito al Ministero degli Esteri 24, al Capo di Stato Maggiore 2 5 ed al Generale Ricci, allora in mission e di ispezione i n Mar Rosso 26.
22 AUSSME, Volumi Eritrea, v. 2, alla data del 21 febbraio 1885 (data di amvo della relazione sull'occupazione di Massaua) e poi alla data del 20 marzo 1885 (data di arrivo della richiesta di istruzioni di Salerta , inviato invece già il 28 febbraio da Massaua).
2 3 lvi, v. 43, 3 febbraio 1885 .
24 lvi, v. 44 , 10 marzo 1885 , Ris. , Ricotti a Mancini.
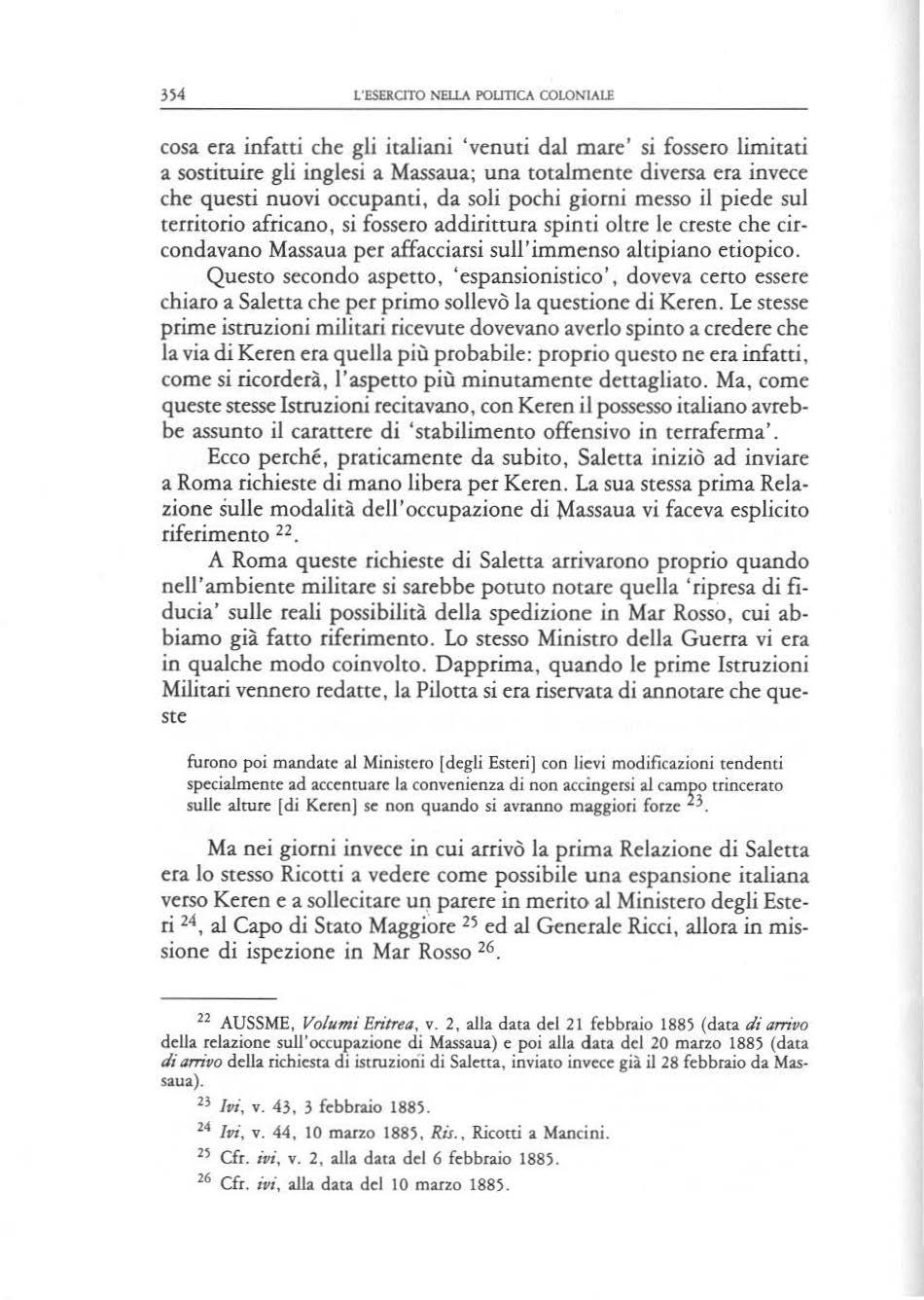
25 Cfr. ivi, v. 2 , alla data del 6 febbraio 1885.
26 Cfr. ivi, alla data del l O marzo 1885.
354 l ' ESERCITO NEI.U. POUTICA COLONIAL.E
Più entusiasticamente di tutti rispose Cosenz, il Capo dello SME. Cosenz, che pure aveva firmato un paio di mesi prima quella assai cauta Memoria sulle difficoltà di una spedizione in Africa orientale, ammetteva di aver «cambiato un po' idea» 2 7 . E faceva seguire un dettagliato piano di operazioni.
La questione per Cosenz sembrava apparire tutta e solo tecnica. Cinque-sei battaglioni, tre batterie d'artiglieria, uno squadrone di cavalleria , una compagnia di zappatori ed una sezione telegrafioea del Genio: tutto questo e non più di dieci dodici giorni e Keren sarebbe stata italiana.
Ma il pensiero di Cosenz andava più in là. Keren, come forse in cuor suo pensava anche Saletta da Massaua, non era utile da sola: si doveva così andare sino a Cassala. Ed anche per questo Cosenz aveva già pronte le cifre. Quattrocento cammelli (tutti gli effetti di trasporto avrebbero dovuto essere d'ora in poi 'cammellati '), otto-novemila uomini per la spedizione vera e propria, sei-settemila per la guardia delle linee di operazioni, il tutto articolato in scaglioni di truppa che avrebbero dovuto marciare separati ed incolonnati, pronti però a riunirsi in caso di inferiorità numerica di fronte al nemico. Per andare a Cassala erano in sostanza necessari 647 ufficiali, 16.689 soldati, 1.111 quadrupedi: una divisione 'rinforzata', quasi mezzo Corpo d'Armata. Ecco l'obiettivo militare italiano del prossimo autunno, secondo Cosenz. Tutto ciò, comunque, concludeva il Capo dello SME, «Sarebbe grandemente agevolato qualora sin dalla primavera venisse occupato Keren» 28 .

Apparentemente insomma vi erano molte condizioni perché Keren (la cui guarnigione inglese, secondo sicure informazioni, sarebbe stata smobil itata in breve tempo) potesse essere inserita nei piani dei militari italiani : un interesse del Ministro della Guerra, una richiesta del Comandante locale, un piano dettagliato del Capo di Stato Maggiore dell'Esercito.
Ma Cosenz, forse non volendo, aveva fatto un errore: aveva co llegato troppo immediatamente Keren con Cassala.
Infatti, proprio in quei giorni, come abbiamo visto, Mancini aveva ricevuto da Londra un deciso diniego a qualsiasi azione italiana verso Cassala 29. E se di ·cassala, operativamente, non si sarebbe più
LE PRIME PROVE 355
27 AUSSME, Carteggio En'trea , racc. 57 , fase. 2 1, 16 marzo 1885, Ris. ma Pers. , Cosenz a Ricotti. 28 Ibidem. 29 Cfr. GIGUO , L 'impresa di MaJsaua 1884 -1885, cit., pp. 132-1 33
parlato, che senso avrebbe avuto Keren? Certo è che a metà marzo tutte le più alte autorità militari parevano favorevoli ad una qualche azione verso il paese dei Bogos.

Si era ad un punto di svolta? Ma è proprio in questo scenario che torna ad emergere la personalità di Ricotti.
Oltre a Ricci che (sentendo in quei giorni il vero 'polso della situaz ione ' a Massaua) aveva risposto all'interrogativo su Keren con uno documentato e deciso 30, fu infatti proprio Ricotti che avvertì la pericolosità di quell'obiettivo: forse al corrente della negativa conclusione degli abboccamenti avuti da Mancini con Londra, forse riprendendo quel suo personale e caratteristico distacco da imprese coloniali ed africane che sarebbero costate all'amministrazione militare 'spese e sforzo' (distacco che, come si è visto, aveva contraddistinto l'operato del Ministro della Guerra sin dai primissimi giorni della preparazione della spedizione) , Ricotti iniziò a dubitare. Il piano di Cosenz (Keren, ma poi anche Cassala) gli dovette parere eccessivo. Insieme a Depretis, il novarese fu, tra i responsabili della gestione dell'impresa coloniale, uno dei pochi a capire- sia pure dopo una iniziale 'ripresa di fiducia' conseguente alle primissime realizzazioni (presa di Massaua, etc.) - quanto radicalmente era cambiato o doveva cambiare nella politica coloniale italiana dopo la caduta inglese di Khartum.
Se Mancini rincorreva i suoi disegni di affermazione personale , se Cosenz cedeva alle lusinghe di una ardita spedizione, Ricottiche pure non era stato all'inizio contrario ad un allargamento del presidio da Massaua a Keren - rifiutò poi assolutamente di mettere il suo suggello di Ministro della Guerra a imprese eccessive: le quali, oltre a presentare il pericolo di una distrazione di ingenti forze militari dall'Italia e dai suoi interessi continentali, avevano il grande difetto di non essere sostenute dalla 'grande potenza' cui in molti modi gli italiani dovevano essere debitori della loro presenza in Mar Rosso. Fino a quando in zona c'erano stati gli inglesi, si poteva anche sperare in qualcosa di più: adesso che si erano ritirati (o che comunque se ne stavano andando) si trattava al massimo di consolidare quello che c'era. Forse Ricotti avrebbe ancora appoggiato qualche proposta per Kereo, ma, visto che quelli che adesso sostenevano necessario andarci volevano trascinarlo addirittura in Sudan, opponeva il suo rifiuto.
356 L' ESERCITO NEllA
POliTICA COLON[A.LE
3° Cfr. AUSSME, Volumi Eritrea, v. 2, alla data del 21 marzo 1885.
È interessante notare come il suo pensiero, pur partendo da sponde diverse, veniva a coincidere con quello del presidente del Consiglio. In un appunto, scritto di getto dal Ministro della Guerra in margine al piano di Cosenz per Keren-Cassala, si legge

Mi pare veramente eccessivo il numero delle bocche da fuoco. In ogni occasione sopra questa marcia progenata non si prenderà nessuna determinazione senza aver prima sentito il parere del Geo. Ricci. Appena avuto quel parere, che sarà verso la metà di aprile, bisognerà trattare la questione in Consiglio dei Ministri 3l_
Ormai la decisione di Ricotti era di fatto già presa. L'unico 'piano' o obiettivo organico, che l'ambiente militare italiano aveva autonomamente espresso in quei giorni, veniva così a decadere.
L'idea di Keren, che non era durata lo spazio di un mattino come certi 'piani' di Mancini e per cui- in un determinato momento -si erano schierate tutte le più alte cariche militari, si fermava, per il sopraggiungere degli eventi (Khanum) e soprattutto per il freno imposto dal Ministro della Guerra. E non si dimentichi il fatto che ad azioni simili non poteva non andare il favore di Umberto I (che, presiedendo personalmente il Consiglio dei Ministri della sera dell'8 febbraio, aveva anzi richiesto una maggior audacia coloniale per la 'potenza' italiana).
A sostenerla ancora per qualche tempo rimasero Saletta da Massaua, che vi faceva riferimento in vari dispacci e che continuava a chiedere rinforzi militari 32 (che gli venivano concessi in poco od in nulla), e Cosenz.
Sia pure come in una parentesi, per concludere, è infatti opportuno ricordare come più volce il Capo dello SME ricordò al Minisuo della Guerra la via per il paese dei Bogos. A fine marzo 33 e poi in aprile 34 egli chiese a Ricotti, di cui già conosceva la maturata oppo-
31 AUSSME, Carteggio En'trea, racc. 57, fase. 21, appunto manoscritto di Ricotti a margine di 16 marzo 1885, Ris.mo Pers., Cosenza Ricotti.
32 Il 19 febbraio 1885 era giunta a Roma la richiesta di Saletta di almeno quattro battaglioni e di una batteria di Attiglieria da montagna; il 21 febbraio la richiesta era di una batteria di Artiglieria da campagna e di qualche mitragliatrice; il9 aprile Saletta voleva che gli fossero inviati 50 uomini del Genio e 50 dell'Artiglieria (più gli ufficial.i) nonché sei pezzi di Artiglieria: inoltre subordinava l 'occupa.zione di Arhlo alla concessione di un battaglione di Fanteria c di uno squadrone di Cavalleria. Cfr. AUSSME, Volumi En'trea, v. 2, alle date ricordare.
33 Cfr. AUSSME, Carteggio Eritrea, racc. 57, fase. 20. 28 marzo 1885, Cosenza Ricotti.
34 lvi, l aprile 1885, Cosenza Ricotti.
LE PRIME PROVE 357
sizione a Keren, se invece non fosse stato per caso favorevole ad un'espansione non più nel paese dei Bogos ma nella regione del Mensa, sempre allo scopo di stabilirvi «una possibi l e stazione estiva» per le truppe, «pel caso non si ritenesse conveniente occupare fin da questa primavera Keren come punto di panenza ad ulteriori operazioni» 35. Ma Ricotti non defletteva e, siccome anche il paese dei Mensa era sempre sulla via per Cassala (e comunque il suo trovarsi sull' altipiano avrebbe condotto assai probabilmente un'eventuale azione militare italiana a scontrarsi direttamente con i rappresentanti locali dell'Impero etiopico), egli non fece altro che lasciar decadere le proposte del Capo dello SME 36.
Il Ministro della Guerra, se disse infine no a Keren, tanto più si oppose agli altri 'piani' di Mancini che pure in quei giorni continuavano a pervenirgli . Ad esempio, quando Mancini, con l'assenso del Capo dello SME, chiese al Ministro della Guerra di pronunciarsi su una possibile operazione italiana verso il Sudan (che la Consulta voleva proporre a Londra) 37, Ricotti la bollò nella sua risposta a Mancini come «una sped i zione di grande importan za la quale prometterebbe d'altronde effetti politici e commerciali di ben poca importanza» 38 Se invece ci fosse stato il consenso britannico e operando invece noi su Cassala e gli inglesi contemporaneamente da Suakim su Berber e da Dongola su Khartum , allora la cosa sarebbe pratica e ragionevole. Tuttavia anche in quel caso essa non sarebbe scevra da gravi difficoltà ed esigerebbe una spesa certamente non inferiore ai quaranta milioni di lire 39.
Ricotti si rendeva conto che Londra non sarebbe stata d'accordo su questo ennesimo 'piano' di Mancini e che una spedizione italiana isolata «sarebbe stata un'impresa oltremodo malagevole e sotto l'aspetto militare imprudente» 4o.
Ecco quindi che non può essere sottovalutato il più responsabile atteggiamento che Ricotti (in qualche modo insieme a Depretis) prese, almeno a panire dalla metà di marzo 1885, nella conduzione della politica colonia le italiana e che trovò la sua prima chiara espii-
Ibidem.
36 Cfr. ivi, 7 aprile 1885, Ricotti a Mancini.
37 Cfr. GIGLIO, L 'impresa di Massaua 1884- 1885 , cit. , p. 142 e sgg.

3S AUSSME, CarteggioEn'trea, racc. 57, fase. 21,7 aprile 1885, Ris.moPers., Ricotti a Mancini.
39 lvi. 40 lvi.
358 L' ESERCITO NELLA POUTICA COLOJ:o..'lAJ.E
cazione nella questione di Keren. È indubitabile che il suo intervento e le sue idee contribuirono decisivamente ad impedire al presidio di Massaua di andare incontro- sin da allora- a brutte sorprese. In questo senso, va aggiunto che ad una tale posizione di Ricotti non erano estranei motivi di politica interna. A quella data, oltre allavorìo segreto di Mancini o di Cosenz, c'era solo un ambiente politico che sosteneva a spada tratta la necessità di rendere più gagliarda l'azione coloniale italiana: l'opposizione parlamentare crispina 41 . E come Ricotti fosse avverso a Crispi lo abbiamo già sufficientemente messo in luce.
Un'ultima riflessione merita di essere fatta su questa 'via per Keren' dei militari italiani, sinora così poco conosciuta.
Keren ed il paese dei Bogos non erano località qualsiasi nello scenario abissino. Come abbiamo visto, il trattato Hewett le aveva concesse al Negus d'Etiopia in cambio di unasupervisione ed una garanzia di una sicura evacuazione delle truppe anglo-egiziane dal Sudan. Ed il Negus le aveva volute proprio perché con Keren e con Cassala egli avrebbe potuto controllare la 'porta' del Sudan. Era quindi pensabile che le avrebbe cedute senza reagire al nuovo occupante italiano?
Se la 'via per Keren' era in vari aspetti diversa dai 'piani' di Mancini, per il suo ignorare i fondamentali cardini diplomatici che interessavano quell'area geografica e per quel suo sottova lut are la pericolosità di una collisione politica o militare con l'Etiopia, vi era invece in più modi rapportabile.
L'Italia sapeva ancora troppo poco di quanto in realtà era accaduto o accadeva in quella parte dell'Africa in cui aveva voluto indirizzare la sua prima espansione coloniale. La sua politica non poteva non risentirne .
Eppure, già qualche anno prima, c'era stato chi aveva consigliato le autorità diplomatiche di informarsi maggiormente e più accuratamente sulle dinamiche di quell'area.
In un interessante rapporto al Ministro degli Esteri, il Cav. Giovanni Branchi aveva scritto:
Quello che però si ignora anche alla costa, ed a fortiori in Europa, si è l'espansione graduale e costante che la potenza del Re di Abissinia ha ottenuto in quesli ultimi anni 42.
41 ar. BOCCACCIN1 , La PenJarçhia e l'opposizione fil trasformismo, cit., p. 127. 42 Branchi era stato il Regio Console in Abissinia. Cfr. la pubblicazione riservata Missione in Abissinia d el R. Console Cav. Giovanni Branchi (1883), Roma , Tip. del Gabineno del Ministero degli Affari Esteri, 1889. La citazione è dalla p. 38, alla data del 30 giugno 1883. Una copia io AUSSME, Carteggio Eritrea, racc. 127, fase. 2.

LE PIUME PROVE 359
E fu proprio nella Etiopia (direttamente o indirettamente) che i piani di espansione italiana andavano ad unare.
'Raccoglimento coloniale': e Saati?
Il reale problema che si era apeno per l'Italia colla presa di Massaua e - soprattutto - con la decisione inglese di ritirarsi dalla zona era se Roma avrebbe potuto reggere da sola il peso di un eventuale scontro colle forze etiopiche. Ma l'Etiopia rimaneva allora , agli occhi dei protagonisti, ancora lontana sullo sfondo. Così, quel problema appariva ai protagonisti italiani in forma affatto diversa: in che modo e sino a che punto l'Italia avrebbe potuto estendere e consolidare il suo presidio di Massaua?
A dare una risposta a quel problema stava provando a modo suo Mancini con i suoi 'piani' , ma con i risultati che conosciamo; ci avevano provato i militari , prima di imbattersi nella forte opposizione di Ricotti a farsi trascinare su quella via che , ponando a Keren, rischiava di coinvolgere il presidio di Massaua e l ' Italia in uno scontro diretto con la forza etiopica o con la rivolta mahdista.
Così, sembrando per il momento accantonata l'aspirazione a ' grandi' piani, per chi in ogni modo aveva bisogno di affermare l'onore della 'potenza' italiana, non rimaneva che la carta della 'piccola' espansione, del consolidamento del presidio attraverso un successivo ma lento avanzamento della sua linea di difesa militare 1
In fondo, era stata proprio questa la via indi cata e praticata da Saletta sin dall ' inizio con la sua occupazione dei fortini di Moncullo e di Otumlo. Inoltre , si pensava , questo tipo di espansione del perimetro dei possedimenti italiani nel Mar Rosso avrebbe potuto realizzarsi forse senza bisogno di ricorrere ogni volta alla ricerca di un assenso diplomatico britannico, che si faceva invece sempre più improbabile, come Mancini andava accorgendosi a sue spese; e una tale espansione avrebbe potuto concretarsi facendo uso delle sole truppe presenti allora a Massaua , visto il crescente sfavore con cui il Ministro della Guerra andava vedendo le 'grandi' imprese del Mar Rosso.
Quesro tipo di espansione , però , in mancanza di reali novità e miglioramenti nelle trattative tra Roma e Londra a proposito della

360 L' ESERCITO NEU.A POUTIC/. COLONIALE
1 Sulla contraddi tto ri età e su ll'oscil laz ione tra p iccol e m ete e grandi ambizioni nel p rim o coloniali smo cfr. gi à BATIAGLIA, La prima g uerra d 'Africa, cit ., p. 188 e sg g .
st,essa Massaua, lasciava intatta la più grossa incertezza dell'occupazione italiana del porto abissino: la questione del condominio istituzionale tra Egitto e Italia 2 .
Immediatamente dopo la caduta di Khartum, temendo che un qualche colpo di mano dei militari a Massaua peggiorasse il tono delle relazioni anglo-italiane (dalle quali invece tanto Mancini sperava), si spedirono altre Istruzioni a Caimi e Saletta 3.
Queste ordinavano di «evitare tutto quanto possa suscitare intempestivamente una controvers ia diplomatica qualsiasi», di osservare scrupolosamente le norme del trattato di Hewett, di «mantenere relazioni benevoli» con le tribù indigene confinanti e soprattutto di «non rinnovar nulla nell'ordinamento presente dei vari servizi» 4
Questa dichiarata volontà di congelamento e di conservazione però non risu l tava esente da talune contradditorietà. La stessa direttiva diplomatica, ad esempio, determinava che tale indirizzo di conservazione istituzionale andasse perseguito in ogni caso, tranne quellonon meglio precisato - «di necessità assoluta o di evidenza di mig lioramento» 5.
Questo tipo di contraddizioni coinvolgeva anche Saletta, cui ricadevano in larga parte compiti di natura politica come di natura m ilitare. Ricotti , infatti, scriveva al Comandante delle truppe esortandolo ad «essere conciliante con la guarnigione egiziana» ma anche «ad operare con risoluzione ove sia necessario o si presenti qualche pericolo» 6.
Saletta, che già aveva sollecitato il Ministro ad una chiara presa di posizione riguardo la questione del paese dei Bogos 7 e che già in diverse occasioni aveva avuto modo di dimostrare il suo marcato e spigoloso carattere, doveva certo rirnanerne contrariato. In mancanza di istruzioni precise in tema di contegno con le tribù viciniore (aspetto questo che gli pareva decisivo), seccato dal comportamento contraddittorio di chi gli ventilava spedizioni verso l'interno ma poi
2 «Il trattato Hewett, infine, diveniva ben presto il pomo della discordia». GIANNI, Italia e Inghilterra alle porte del Sudan: la spedizione di Massaua {1885), cit., p. 97 (il volume di Angelo Gianni è in larga parte la sua tesi di laurea, condotta sotto la guida di Carlo Morandi).

3 AUSSME, Volumi Entrea, v. 2, alla data del 6 febbraio 1885.
4 lvi, v. 44, 6 febbraio 1885, Ris.mo, Mancini a Ricotti.
5 lvi, v. 2, alla data del 6 febbraio 1885.
6 lvi, alla data del 22 febbraio 1885.
7 lvi, alla data del 21 gennaio 1885.
LE PRIME PROVE 361
gli negava anche quei pochi battaglioni che - secondo il colonnello - erano necessari ad una 'forte difesa' della Piazza di Massaua, Saletta inviò il 28 febbraio una vera e propria «Domanda di istruzioni:. 8 . Io particolare il Comandante di Massaua chiedeva chiaramente maggiori delucidazioni su cosa si fosse voluto significare a Roma per «operazioni a tre-quattro giornate di marcia:. con le forze allora disponibili a Massaua: secondo quanto lo stesso Saletta aveva telegrafato qualche giorno prima, si trattava del raggio della difesa della piazza? di quello più ampio delimitato dai forti (m a qui si trattava sempre di qualche ora di marcia, al massimo )? o di una vera e propria mossa offensiva (casomai verso l'Abissinia)? Da Roma , invece , gli arrivava quella solita risposta che il colonnello tanto pareva non gradire: «temporeggiare:. 9.
Un tale indirizzo, inoltre, contrastava anche con le difficoltà della stessa delicata vita quotidiana del presidio di Massaua e dell'incerto equilibrio di poteri di due Stati che non piaceva a Saletta. Un equilibrio reso più difficile , oltre che dalle resistenze e dali' ostruzionismo delle autorità egiziane, dalla stessa particolare composizione della popolazione. 397 famiglie, 5. 026 abitanti (ovviamente, esclusi gli italiani) così ripartiti: 3.302 massauini, 358 arabi , 468 sihani , 235 abissini, 146 daokali, 275 sudanesi, 30 indiani, 25 turchi, 15 armeni oltre ad un centinaio circa di europei lO. Con una tale varietà etnica anche la semplice politica dell ' ordine pubblico esponeva Saletta e gli italiani ad una grande e seria difficoltà; tanto più che, come scrisse poi lo stesso colonnello,
in mezzo a questo inuicato labirinto di interessi locali, la nostra occupazione aveva destato un'impressione diversa, speranze negli uni , irritazione negli alui, soddisfazione in taluni , io rutti un senso di diffidenza e di sospetto 11 .
In questo scenario e tra tante difficoltà, sarebbe forse stato meglio consolidare definitivamente il presidio di Massaua, piuttosto che attendere a nuove espansioni il cui stesso retroterra (Massaua appunto) poteva rischiare di esporre a pericoli le forze italiane.
Invece, e (come è stato acutamente notato) anche «per placare l'opposizione e l'opinione pubblica nel paese, le quali attendevano

8 lvi, v. 44 , 28 188:> , Salena a Ricotti.
9 Cfr. anche ivi , v 2 , alla data del 22 febbwo 188:>
10 Dati tratti da un censimento fano svolgere da Saletta. Cfr. ivi, v. 43, 7 ottobre 188:>, Ricotti a Mancini, che allega 14 settembre 188:> , Salena a Ricotti .
11 AUSSME, Carteggio En'trea, racc. 9. fase. l, p. 4:>.
362 L'ESERCITO NEU..A
COLONIALE
POLITlCA
impazienti ulteriori 12 , visti i deludenti risultati delle trat· tative con Londra circa le 'grandi' mete (Sudan, Harrar, etc.), Mancini decise di dare il via ad un cauto ampliamento del dominio italiano 13. Lo scopo era quello di arrivare a cont rollare alcune località lungo la costa da Massaua ad Assab, località di cui si era parlatoanche se vagamente - nelle prime trattative con Londra a proposito di Massaua. Trattandosi di località costiere, il peso dell'operazione sarebbe gravato sulla Marina e su Caimi, che però sarebbero stati coadiuvati da Saletta e dai suoi soldati 14.
La prima, e la più imponante, di queste località era Arafali. La sua collocazione, in fondo alla baia di Zula (o Zulla) assicurava il controllo della baia stessa ed allargava il cerchio della presenza militare italiana. Vi fu quindi stabilito un presidio di forze militari, dell'esercito 15.
Fu poi la volta di Arkiko che, con il suo fortino posto nelle vicinanze di Massaua, contribuiva alla difesa del porto maggiore. Anche in questo caso, dopo l'occupazione effettuata da una compagnia di marirtai, la località fu presidiata da soldati del!' esercito. In occasione dell'occupazione, però, le forze italiane avevano miracolosamente schivato un ceno pericolo: il pugno di forze egiziane che ancora tenevano il fortino, costituite da una banda di irregolari al soldo del Cairo, non essendo state avvertite esattamente del!' arrivo di forze italiane (e dell'opponunità 'diplomatica' di arrendersi), volsero contro queste i loro canno ni Stavano per aprire il fuoco contro il repano di soldati italiani- che, armati di soli moschetti, dovevano occupare la postazione - quando un provvidenziale ordine del loro comandante, tale Aga (connivente con gli italiani), impedì che si consumasse una tragedia. Saletta, in seguito, premiò questo Aga conferendogli il grado di Capo dei bashibazouk italiani 16.
Questo tipo di operazioni seppure 'dirette' dalla Marina venivano di fatto a estendere il raggio d'azione di Saletta e del! 'Ese rcì to,
12 GIGUO, L'impresa di Massaua, cit., p. 81.
13 Cfr. anche ZAGHI, P.S. Mancini e il problema del Medite"aneo 1884- 1885 , cit. p. 111.

14 Cfr le reazioni e il giudizio di Saletta in AUSSME , Carteggio Entrea , racc. 9, fase 11, p 41.
l 5 Per le decisioni roioisreriali cfr. AUSSME, Volumi En'trea , v. 2 , alla data del 17 marzo 1885. Il villaggio fu occupato il lO aprile 1885 Cfr. anche Storia militare della Colonia En'trea, ci t. , p. 91.
16 Cfr. AUSSME , Carteggia En'trea , racc. 9, fase. l, p. 55.
LE PRIME PROVE 363
rendendo sempre più complicato il tema delle reciproche attribuzioni tra Comandanti locali delle due forze armate e ormai illogica la definizione di $aletta quale Comandante ddla (sola) piazza di Massaua.

Nel frattempo, va ricordato che Saletta aveva sollecitato un parere circa le sue idee di arrivare a controllare Keren 17 . Da Roma arrivò il parere contrario del Ministro 18, ma a Massaua arrivava anche l'eco di altre voci, più favorevoli, come quella dello Stato Maggiore.
Comunque, una politica di 'piccole' annessioni, di azioni di forza calib rate, si riteneva a Roma, non avrebbe dovuto preoccupare le altre potenze (Francia, Gran Bretagna, Russia) interessate al Mar Rosso. Ed infatti così fu. Rischiavano però di provocare in Italia aspettative ed attese eccessive 19.
Così, già alla fine di marzo, Depretis, attraverso il soli to «Popolo romano», aveva ammonito che
le guerre coloniali d'oggi non si possono più fare con i criteri di una volta , quando cioè i popoli barbari o semiselvaggi erano armati di picche e di lance di legno, e bastava un buon cannone o quattro scariche ben dirette di due o ue battaglioni per disperderli( ... ) Con il mare alle spalle non c 'è mtlla da temere( ... ) Ma se un giorno per avventura gli avvenimenti portassero a dover prendere altre decisioni (cioè un'espansione per terra), converrà tener conto delle lezioni che ci offrono gli altri e non avventurarsi io un'impresa , anche se limitata , senza largheggiare in precauzioni , per quanto si rifletta a forze e mezzi materiali 20 .
Con queste paro le sembrava che Depretis volesse ulteriormente restringere -per allora- l'ambito di qualsiasi politica coloni,ale italiana alla sola Massaua. '
In questo senso Depretis non era isolato.
17 Cfr. ivi, p. 39 e sgg.
18 Qualche forma di rapporto (anche se non stretto e frequente) tra Saletta e Cosenz, senza il passaggio intermedio di Ricotti , dovette esserci anche in quei primi mesi.
19 Ovviamente , esula dalla nostra ricerca uno studio delle reazioni dell ' opinione pubblica all ' avvio della prima espansione coloniale. Non crediamo però che queste, tranne qualche raro caso, furono poi determinanti per il concreto indirizzo della politica del Governo (o, meglio, della Consulta e della Pilotta). Nonostante si sia talvolta tentato di applicare ai rapporti tra Governo ed opinione pubblica, nel 1885 e a proposito della spedizione di Massaua, una sorta di modello adano più alle funesti 'radiose giornate' che alle vicende appunto del 1885, la nosrra impressione è che -particolarmente in quei primi mesi di espansione coloniale italiana e poi un po' in tutte le vicende della 'spedizione di Massaua', almeno flno a Dogali- il primo policy-making coloniale italiano si svolse prevalentemente nel chiuso delle stanze della Consulta (e della Pilotta).
20 cii popolo romano:., 28 marzo 1885, Politica coloniale.
364 l ' ESERCITO NELLA
POUTICA COLO NIALE
Ormai conveniva con lui, come abbiamo visto, anche Ricotti. Ed in quei giorni anche il generale Ricci, di ritorno dalla sua ispezione a Massaua, aveva avuto modo di poter dire la sua. Invece di sostenere le opinioni di chi avrebbe voluto una più ardita politica coloniale, il Comandante in seconda dello Stato Maggiore - in questo probabilmente in contrasto con le idee del suo diretto superiore Cosenz - proponeva in una sua Relazione a Ricotti a ddir ittura il principi o (politico e niente affatto militare, difensivo e per niente offensivo) di contrarre un'alleanza- anche se temporanea- con il Negus.
L'occupazione di Massaua ha insospettito grandemente il Re d'Abissinia, e da lettere del Nareni che mi furono mosuate a Massaua , appare la preoccupazione prodotta in lui da tale stato d ' animo del Re Giovanni. Bisogna assolutamente dissipare questa diffidenza, se vogliamo essere solidamente stabiliti a Massaua. Nella mia mente un ' alleanza con l'Abissinia , come è possibile farne una con quel paese , dovrebbe , nel momento anuale , essere l ' obiettivo della nosua politica; più tardi poi si vedrà che cosa convenga di fare 21
Infine va not ato che proprio in qu e ll e settimane si andavano accumulando gli insuccessi di Mancini , e quindi si andava ulteriormente indebolendo la sua posizione politica personale e le sue mire espansionist ich e.
Era così in questo quadro generale, te nuto conto anche dell'approssimarsi dell'estate e della molto probab ile sosta nelle operazioni militari che comunque essa avrebbe comportato, che il governo di D epretis pareva orientarsi verso un rac cog lim ento ed una stasi nell'azione coloniale.
A metà aprile il Ministero della Guerra emanò alcune 'Norme speciali di servi zio per le truppe distaccate in Africa' 22 mediante le quali veniva costituito il Comando Superiore delle truppe italiane io Mrica (Comando que sto che, pur con competenze es clusivamente limitate alle truppe dell'Esercito, comportava per chi lo avesse rivestito una denominazione che, co me ammis e poi lo stesso Saletta, cdata al Comandante Militare del! 'Es ercito, doveva ferire la suscetti-
21 AUSSME, Volumi Eritrea , v. Il , 19 aprile 1885, Ri cc i a Ricotti , Relazione , con allegato D ocumento D. 'Le n ostre col onie nel Mar Rosso '.
22 Cfr. cGiornale militare ufficiale •, 19 aprile 1885, atto n. 51. Erano già pronte da qualche giorno. Cfr AUSSME , Volumi Eritrea , v. 2, alla data del 17 aprile 1885. Furono poi comunicate ufficialmente alla Marina solo dopo quasi una settimana. Cfr. ivi, alla data del 22 aprile 1885 .

LE PRIME PR OVE 365
bilità del Comandante le forze navali:.) 23. In quella stessa occasione fu deciso che il Comandante Superiore avrebbe avuto cle attribuzioni di competenza dei Comandanti di Divisione:., cosa che dava a Saletta le funzioni non più di colonnello ma di generale.
In quegli stessi giorni il Consiglio dei Ministri veniva riunito e si accordava su una 'stretta' per l'azione coloniale.
Ricotti faceva riferimento a quella riunione quando scrisse a Saletta annunciandogli (vagamente) che «condizioni speciali», che pure «per ora non si possono prevedere», avrebbero potuto consigliare di climitare le nostre forze di occupazione ad un solo battaglione sussidiato di una sola compagnia di Artiglieria e di una del Genio, col concorso di qualche nave da guerra». Poi, più chiaramente, Ricotti scrisse che ci l Governo [era] d'avviso che l'occupazione di Massaua [dovesse] rivestire un carattere esclusivamente difensivo» e che vi erano «pochissime probabilità di dovere operare da Massaua nell'interno verso Keren e Cassala» non solo subito, io primavera, ma anche cnella ventura stagione autunnale:. 24
Per Saletta, che ancora solo qualche giorno prima avrebbe voluto andare a Keren, una comunicazione come questa equivaleva ad una sconfessione. Il piano di una stasi coloniale appariva inoltre dettagliato e predisposto in modo da interessare non solo Massaua, ma tutti i distaccamenti italiani della costa del Mar Rosso. Per Beilul, per la cui occupazione erano ancora impegnate un certo numero di forze militari italiane, ad esempio, si pensava di costruire qualche opera di fortificazione col «concetto di poter mantenere quel punto con forze limitate e ciò allo scopo di poter ridurre in seguito quel distaccamento a mezza compagnia» n.
La po litica, 'responsabile' e di contenimento, di Ricotti sembrava insomma aver evidentemente avuto la meglio sui fantastici 'pialli' di Mancini. Ma poteva essere un 'successo' solo apparente.
Per praticare questa politica di raccoglimento (in un momento in cui l'attesa dell'opinione pubblica era assai viva) 26 ci sarebbe vo-
23 Cfr. AUSSME, Carteggio Enlrea, racc. 9. fase. l, p. 67.
24 Questa citazione e la precedente sono traete da AUSSME, Volumi Eritrea, v. 43, 13 aprile 1885, Ris.mo, Ricotti a Saletta.
2 ) lvi, v. 2, alla data del 17 aprile 1885.
26 Anche nella società civile, sia pure in forme differenziate (ed ancora da precisare oggi con ricerche specifiche e documentate), cresceva l'interesse per gli affari africani. Questo aveva anche risvolti, individuali, curiosi. Tra le ca rte della Presidenza del Consiglio si trovano ancora incartamenti di pratiche riguardanti richieste di singoli cit-

366 l 'ES ERCITO NELI.A POUTICA COLONIALE
luto forse una grande omogeneità della classe dirigente politica ed una ferrea opera di controllo da parte di Depretis e dalla sua Presidenza del Consiglio. Ma queste due condizioni non esistevano. Per il momento Depretis dovette accontentarsi di aver scongiurato, con gli ammonimenti sulla scampa della fine di marzo e con la 'stretta' di metà aprile, i pericoli derivanti da quella 'grand e' espansione che Mancini pareva minacciare, con quei seg reti contatti con gli ambienti diplomatici londinesi. Ma non poteva fe rm are i meccanismi avviati per la 'piccola' espansione.
Il 'raccoglimento', q u indi, rischiava di essere una politica proclamata ma non praticata.
Questo rischio (che da una pane avrebbe reso meno credib ile la vo lont à co lon iale itali an a negli ambienti dip lomat ici delle Cancellerie europee e dall'altra avreb be contribuito a disorientare la quotidiana conduzione amministrativa e politi ca dei presidi da pane dei Comandanti militari locali) era in qualche modo aggravato dalla presenza di altre contraddizioni nelle stesse Istruzioni impartite dai Ministeri che quel 'raccoglimento' doveyano gestire.

In generale, si potrebbe dire che questo era uno degli effetti politici del disorientamento provocato, nella classe dirigente italiana, dalla decisione britannica di ab bandonare il Sudan senza per questo vole r aiutare la 'piccola' It a lia a prendervi il posto che era stato della stessa Inghilterra. D isorientamento che lasciava la neo na ta politica coloniale italiana senza il grande scudo protettivo al cui riparo aveva dapprima creduto poter all'occorrenza ripararsi.
Depretis, e con lui forse una buona parte della classe dirigente italiana (se si escl udono Man cini per motivi personali, Crispi e l' opposizione crispina per motivi puram ent e politico-parlamentari e taluni settori- ma non tutti - dell'opposizione più conservatrice per motivi ideo logici di ' grandezza ' e 'onore' dello Stato), vedeva con chiarezza che mancavano all'Italia le energie economiche, politiche e sociali perché fosse avviata una grande campagna di espans ione coloniale 2 7. Le ene rgie militari, da part e loro, fo rse si sarebbero po-
tadini per pratiche varie. Tra queste , quella di un ceno Perosini Costantino che scrive, con la calligrafia incerta dell'uomo comune , a Deprecis per ottenere cun impiego qualsiasi in Africa.. ACS , Presidenza del Consiglio dei Mini.stn·, b. 56 , f. 57, 16 febbraio 1885.
27 Cfr. H. ERLICH, Ethiopian an d En.trea During the Scramble for Afnea: A Politica/ Biography ofRas Alula, 187.5-1897, Michigan -Tel Aviv, Michigan State Univ. & T el Aviv U niv ., 1982, pp. 2 -3. Contrariamente a quamo fatto sinora con opere non italiane , citeremo più volte il volume di Erlich.
LE PIUME PROVE 367
tute trovare: ma il Presidente del Consiglio, come molta altra pane del personale politico della sua generazione, era forse propenso acredere che l 'Ese rcito sareb be stato più utile in Italia o comunque su l fronte europeo-continentale che su quello , lontano, coloniale.
D'altra parte, anche a presc indere dalle politiche e dagli orientamenti personali , non erano molti gli s pazi per una espansione coloniale in quei mesi nel territorio alle spalle di Massaua: la forza del mahdismo non accennava a scemare e la crisi dell'Impero etiopico non era an cora consumata.
Comunque fosse , il ' disorientamento ', o quantomeno l'osc illazion e, è ad esempio ben visibile in tutti i più imporranti dispacci che Ricotti inviò nelle settimane successive a Saletta.
In un documento qui già ricordato, dopo aver minacciato la verticale riduzione del presidio di Massaua , e con esso la fine di qualsiasi espansione colonial e italiana in Mar Rosso , il Ministro della Guerra si affrettava ad aggiungere che cuna tale eventualità, giova ben affermarlo, non entra per ora nelle idee del Governo» 28. E continuava :

anzi nulla osta che al presente, finché non vi sia a prevedere seri attacchi di numerose forze nemiche , si conservino gli attuali distaccamenti nei forti avanzati, o si possano anche occupare Arkiko e Arafali , od eseguire qualche ricognizione od ese rcitazione di marcia nei dintorni di Massaua verso l'interno. Tutto questo però non deve per nulla compromettere la difesa di Taulud e di Gherar 2 9.
Più tardi , il 23 aprile, Ricotti scriveva a Saletta che compito pri oritari o era «no n estendere l 'occupazione di Massaua ma limitarla a scopo commerciale» 30 . Ma , come già qualche giorno prima, a questo seguiva immediatamente la 'c orrezione':
Ciò non toglie che l'andamento della politica potrebbe modificare nuovamente quella situazione, donde quelle alternative e quelle co n traddiz io ni che rendono difficile la posizione del Comando di Massaua , ma che pure bisogna accettare come conseguenza di fatti d'ordine su periore 3 1
Infine, il15 maggio, a prop osit o della fondamentale questione di co me mantenere il co ntroll o italiano sui foni avanzati ( Moncullo
28 Citiamo ancora da AUSSME , Volumi En'trea, v. 43 , 13 aprile 1885, Ris .mo, Riconi a Saletta.
29 Ibidem
30 lvi, v. 2, alla data del 13 aprile 1885.
3! Ibidem .
368 l 'ESERCITO NELLA
POUTICA COLONIALE
e Otumlo) che Saletta aveva deciso di occupare sin da quando sbarcò sulla costa del Mar Rosso, il Ministro della Guerra ammetteva implicitamente di non sapere cosa dire.
In merito ai foni staccati, si reputa pericolosa l'occupazione permanente di quelli che non siano in grado di resistere ad un colpo di mano, mentre dall'altra parte si riconosce che il loro sgombero potrebbe presentemente tornare di grave danno al prestigio della nostra autorità e della nostra forza 32 .
La contraddizione, ed il disorientamento, parevano toccare tutti i campi di interesse di una politica coloniale. Sul delicato tema della politica da seguirsi con le tribù indigene, nello stesso giorno, furono ordinate addirittUra due cose diverse, a secon da che si scrivesse al Comandante del presidio di Assab o al Comandante Superiore delle truppe italiane in Mrica. Al primo si scriveva di
tenersi interamente estraneo ai privati dissidi ua gli indigeni c: che [si doveva) intervenire con la truppa solo nel caso che bande provenienti dall'interno tentino un attacco di viva forza 33,
mentre al secondo veniva ricordato
essere dovere delle truppe intervenire sempre a proteggere gli indigeni che siano posti sotto la nostra protezione da qualsiasi parte provenga l'attentato alle loro persone o alle loro proprietà 34.

Nella vacanza di un indirizzo superiore chiaro e preciso era inevitabile che l 'auto rità che alla fine si sarebbe imposta era quella locale; nel nostro caso il Comando di Saletta. Esemplarmente, a proposito della questione ora ricordata dei fortini, lo stesso Ricotti ammetteva:
Non avendosi dati sufficienti per giudicare in proposito con piena conoscenza di causa, il Ministero lascia al colonnello Saletta di prendere quelle determinazioni che crede rà più ofportuoe , pur tenendo presente i criteri principali che gli vennero comunicati 3 .
Il largo spazio di manovra che doveva venire a Saletta, parados-
32 lvi, v. 2, alla data del 15 maggio 1885.
33 lvi, alla data del 4 maggio 1885.
34 Ibidem.
35 lvi, alla data del 15 maggio 1885.
LE PRIME PROVE 369
salmente, proprio dalla politica di 'raccoglimento' della primavera '85, si può ricavare anche dalle contraddizioni in cui era caduta più volte la politica ministeriale nei confronti di quella che avrebbe dovuto essere la 'politica indigena' del presidio di Massaua. Proprio nelle settimane successive alla decisione del Governo Depretis di contenere l'espansionismo italiano entro il perimetro di Massaua, dovevano infatti venire da Roma al colonnello italiano alcuni dei più calorosi incoraggiamenti ad un'azione «dura ed efficace» contro il 'brigantaggio' che dal punto di vista dei militari italiani «infestava» le contrade intorno a Massaua 36.
La reale motivazione di questi inviti era chiara: non si poteva lasciare in una inattività completa un presidio militare che arrivava ad essere fone nel suo totale di più di tremila soldati. Se il miraggio dei 'grandi' piani doveva essere svanito, se anche la fase della piccola espansione sembrava essersi frenata (anche se, come vedremo, non era proprio così), non rimaneva altro che dare il via ad una campagna di ordine pubblico africano o, come si sarebbe detto qualche decennio dopo, di ' polizia coloniale'. Tra l'altro, il15 maggio, Ricotti scriveva a $aletta:
Se si presenta l'opportunità, dia pure senza riguardo delle buone lezioni ai predatori ed aggressori di qualunque specie e razza 37, anche se poi, conscio dei grandi spazi che così dicendo egli veniva ad offrire al colonnello, lo ammoniva a ricordare come «un insuccesso, quali sarebbero l'eccidio o la prigionia di qualche nostro ufficiale o di qualche nostro piccolo drappello potrebbe bastare per trascinarci ad una guerra offensiva nel centro dell'Africa» 38, che era appunto quanto Depretis , Ricotti e il governo allora non volevano.
Ma quali fossero le discriminanti da tenersi tra le turbolenze di qualche tribù, le razzie di rappresaglia di qualche banda beduina, le azioni di rivolta di una turba di rnahdisti e le malversazioni dei 'veri briganti' non erano mai specificate. E , soprattutto , cosa si sarebbe dovuto fare se dietro quella vaga definizione di 'brigantaggio ' abissino si fosse celato qualcosa del concreto risentimento proprio di una riconosciuta autorità politica locale, di un Ras etiopico- ad esempio - come Ras Alula, che non accettava che Saletta (per lui niente 36 Ibidem.
37 lvi, v. 43, 15 maggio 1885, Ris., Ricotti a Saletta. 38 Ibidem.

370 L'ESERCITO NEllA POLITICA COLO NIAlE
più di un occupante militare straniero) pretendesse di dettar legge a modo suo in terra non propria? E cosa fare, infine, se un'azione italiana contro una banda locale od una piccola tribù avesse potuto non piacere al Ras od allo stesso Negus etiopico? Eppure, di questi gravi e formidabili problemi, non si trova traccia nelle cane e negli atti di Saletta.
Forse per la prima volta da quando era arrivato a Massaua, il colonnello, che tanta opinione aveva di sé e che tanto aveva sperato in una 'grande' espansione militare italiana verso Keren, vedeva aprirsi di fronte vasti spazi di manovra.
Se anche nell'occupazione di Arafali non si volesse vedere un qualche effetto della sua continua azione di spinta (si ricordino a questo proposito le continue richieste di uomini e di materiali che il colonnello aveva fatto giungere a Roma da quando era stato nominato Comandante della piazza di Massaua), si deve riconoscergli un notevole sprezzo del pericolo nella ricognizione a Saati ed Ailet che egli compì per vari giorni consecutivi nell'aprile 1885 39_
Lasciato l'ufficio di Comandante Superiore al suo vice, Saletta si diresse verso Saati per controllarvi la realizzabilità di un'occupazione italiana del villaggio abissino, situato a sole due ore dal confine tra la zona di Massaua e quella più propriamente etiopica del paese dei Bogos. Quindi svoltò verso Ailet, ormai in territorio etiopico 40; sulle pendici delle alture che cingevano Massaua saggiò lo stato delle forze militari abissine che ancora tenevano quella postazione. Infine si diresse ad Amba.
La ricognizione in terreno nemico era stata certamente rischiosa per l'inesatta conoscenza dei luoghi (il gruppo perse più volte la strada maestra) e delle popolazioni. La pericolosità della cavalcata, non specificatamente autorizzata dal Ministero e che - nel caso avverso di un'imprevista imboscata - avrebbe potuto persino privare il presi-
39
La descrizione più dettagliata si ha in AUSSME, Carteggio Eritrea, racc. 9, fase. l, p. 52 e sgg.
40 Saletta doveva rendersi conto di aver oltrepassato il conflne ua territorio massauino e territorio etiopico (sia pur così imprecisamente definito dal trattato Hewett), Poco credibile appare quanto egli scrisse poi, a sua giustificazione, al Ministro della Guerra accusando «<a mancanza di una carta anche approssimativamente esatta» sui confmi abissini. AUSSME, Volumi Entrea, v. 43, 23 aprile 1885, Ris., Saletta a Ricotti. Era una questione, comunque, che Saletta avrebbe dovuto aver presente, perché strutturale ed inuinseca ai rapporti coloniali del tempo tra potenze colonialiste e stati africani. Su questo tema, cfr. S . BONO, Le frontiere in Africa. Dalia spartizione coloniale alle vicende più recenti (1884-1971), Milano , Giuffré, 1972.

LE PRIME PROVE 371
dio di una delle due massime cariche militari, venne poi ricordata da Saletta in questi orgogliosi termini:
Con ciò [la ricognizion e su Saaci ed Ailet) io assunsi soltanto su me stesso tutta la responsabilità della mia decisione e delle conseguenze che ne sarebbero potute venire 41 .
Di fatto la ricognizione di Saletta su Saati ed Ailet apriva una nuova strada di espansione per il presidio dj Massaua. Se, dopo l' immediata occupazione del febbraio, era parso che dovesse essere la Marina a far compiere i primi passi del colonialismo italiano in Mar Rosso (anche se poi era sempre l'Esercito a vedersi alla fine gravato di nuove responsabilità), dopo la ricognizione di Saletta (e la nascita concreta - per così dire - dell'obiettivo di Saati che ne doveva conseguire) avrebbe dovuto essere l 'Esercito a sostenere l'onere e l'onore delle ulteriori occupazioni italiane.
Saletta sembrava aver bene scelto anche i tempi di quello che poteva essere un disegno a cui pensava da tempo. Il disorientamento della politica coloniale italiana dopo la notizia della caduta di Khartum, se pure imponeva di non superare i limiti di una 'piccola' espansione (non era ancora venuto il tempo per andare a Keren , insomma) lasciava un certo spazio ai Comandanti militari locali. In questo senso (se pure il controllo di obiettivi come Saati o Ailet poteva trovare in sé qualche giustificazione tecnica) non va dimemjcato che essi si trovavano pur sempre sulla via di Keren.

In quei giorni, così, il colonnello aveva inviato al Ministero della Guerra una relazione in cui si accennava alla utilità di un'occupazione di Amba e di Saaci 42 Aveva poi scritto in merito anche al Negus 43. Infine, in uno scambio di lettere di ordinaria amministrazione con Ras Alula , Saletta annunciò anche al capo locale abissino la sua intenzione di occupare Saaci: questi, da pane sua , rispose riaffermando i suoi diritti e dimostrando di non dare troppo peso alle parole del colonnello 44
41 AUSSME, Carteggio En'trea, racc. 9, fase. l, p. 53.
42 Cfr. ancora AUSSME, Volumi Eritrea, v. 43, 23 aprile 1885, R.i.r., Saletta aRicorri.
43 Cfr. ibidem.
44 Il carteggio, con gli originali delle risposte di Ras Alula, in AUSSME, Volumi Eritrea, v. 44 , 5 maggio 1885, Saletra a Ras Alula; 11 maggio 1885 , Ras Alula a Saleua; 12 maggio 1885, Saletta a Ras Alula; 13 maggio 1885 , Ras Alula a Saletta; 14 maggio 1885, Ras Alula a Saletta; 27 maggio 1885, Salena a Ras Alula; 28 maggio 1885. Ras Alula a Saletta; 5 giugno 1885, Salerra a Ras Alula. Per la vicenda, cfr. anche DEL BOCA, Gli italiani in Africa on'entale. Dall' unità alla marcia su Roma, cit., p. 208.
372 L'ESEROTO
NElLA POliTICA COLONIALE
In questa situazione , il 9 maggio Saletta fece occupare Amba da una compagnia di bersaglieri (che poi verrà ritirata) e da una cinquantina di irregolari indigeni, armati e assoldati a Massaua, destinati a presidiare la località 45.
In quegli stessi giorni egli si mise in contatto con il rappresentante inglese Chermside e riuscì ad ottenere che gli irregolari egiziani che in quel momento stavano tenendo militarmente la località di Saati passassero al soldo degli italiani 46
A questo punto, e con poca fatica, sembrava che la strada verso Saati fosse apena.
Il 'piccolo piano' di Saletta di avanzare la linea di difesa di Massaua non più lungo la costa ma verso l'entroterra abissino poteva dirsi avviata. Il colonnello avvertiva il rischio cui esponeva il presidio, estendendo il perimetro della zona di occupazione militare italiana proprio all'approssimarsi della stagione estiva? Pensava che anche un piccolo ma significativo allargamento dell'occupazione italiana avrebbe potuto insospettire il Rase, per lui, lo stesso Negus? Forse. Ma più probabilmente, con lo stesso sprezzo del pericolo (o, meglio, sottovalutazione del rischio reale) che aveva dimostrato nella sua cavalcata su Ailet, Saletta dovette credere che una politica dei fatti compiuti Ili avrebbe impressionati ed avrebbe fatto apprezzare anche in quelle contrade la 'potenza' italiana.
Ma qualcosa fermò invece Saletta. Ed anche la presa di possesso di Saati fu cosa che si realizzò in realtà solo a metà.
A dissuadere il colonnello dalla sua azione fu forse proprio una rinnovata turbolenza delle tribù locali 47 che dovevano aver avvenito questa nuova attività militare dell'occupante. O forse gli stessi inviti alla moderazione ed al raccoglimento che continuavano a giungergli da pane del Ministero della Guerra. Proprio Ricotti aveva scritto che la ricognizione su Ailet «non [era] stata ispirata ai dettami della necessaria prudenza» e che in linea di massima era contrario all'occupazione di Amba e Saati e che per gli stessi forti avanzati si riservava di far cadere sulle spalle del colonnello qualsiasi responsabilità 4s.
Cfr. AUSSME, Volumi Eritrea, v. 2, alla data dell9 maggio 1885 (data di am·vo del telegramma inviato da $aletta).
46 Cfr. Storia militare della Colonia En"trea, ci t., p. 94.

47 Cfr. AUSSME, Volumi En.trea, v. 2, alla data del 9 giugno 1885. Salma, in un rapporro giunto al Ministro della Guerra in quella data, parlava di Beilul come fosse cquasi prigioniero il presidio colà distaccato:o
48 Cfr. ivi, alla d-ata del 15 maggio 1885.
LE PRIM E PROVE 373
La volontà (di Depretis o di Ricotti, o di tutti e due) distasi e di raccoglimento coloniale doveva inoltre essersi fatta più decisa proprio in quei giorni in cui Saletta iniziava a muoversi, se si arrivò a parlare di abbandonare Moncullo, Otumlo e Arkiko e forse anche di demolire lo stesso fortino di Otumlo.
Contro questo, in notevole sintonia con le azioni di Saletta, si era nel frattempo schierato il Capo di Stato Maggiore. In una lettera al Ministro della Guerra in cui riconosceva necessario concedere al colonnello una più lata autonomia («il Comandante Superiore delle truppe in Mrica deve considerarsi come il Comandante di una piazza in tempo di guerra») 49 , Cosenz si opponeva a qualsiasi arretramento dalla nuova linea difensiva. E, con tono incisivo, scriveva delle popolazioni delle coste del Mar Rosso che «quella è gente che non stima e rispetta altro che la forza ed ha il massimo disprezzo della debolezza» 50_ Non si era ancora alla sottovalutazione di De Robilant dei 'quattro predoni' , ma vi si era pericolosamente vicini.
Ma nonostante la difesa di Cosenz, a Saletta, quindi, non rimaneva altro che consolidare l'esistente con le varie necessarie opere di difesa, a cui fu atteso in più riprese tra il maggio e il giugno 51, collaudare la capacità militare dei suoi soldati con esercitazioni tattiche e persino con una prova generale di attacco nemico su Massaua 52 e rinsaldare qua e là lo spirito bellico dei suoi ufficiali. Il tutto nell' attesa delle grandi calure estive.
A Saati, in qualche modo, anche se di nuovo in 'condominio' come a Massaua, si era arrivati. Ma il disegno più generale di Saletta (arrivare a Saati per andare avanti) era fallito. Intanto il seme era stato gettato: una politica coloniale in Abissinia non si sarebbe potuta fare solo sulla costa (mercè la Marina) ma anche verso l'interno, e grazie all'Esercito. L'obiettivo di Saati, importante quando non si poteva andare subito a Keren, era nato.
Chi vi era stato, in quella località utile per la sosta delle carovane, aveva scritto che «a Saati non vi sono capanne, non è quindi un paese , è semplicemente una sorgente incassata in un buco» 5 3 _ Chi
49 Cose nz aveva scritto alcuni «concetti su lla condotta da tenersi nei presidi d'Africa». Volumi En'trea, v. 44 , 21 maggio 1885, Cosenz a Ricotti. 'Concerti' sui quali forse Riconi espresse qualche critica. Cfr. ivi, 28 maggio 1885, Ricotti a Cosenz.
50 Ibidem
5! lvi , v. 4, 19 maggio 1885 e 5 giugno 1885 .
52 Cfr. AUSSME, Carteggio Enirea, racc. 9. fase. l , p. 78.
53 NEGRI, Massaua e dintorni , cit., p. 30.

374 l ' ESERCITO NELLA
COLONIALE
POUTICA
aveva da tempo fatto rilev are la costante pericolosità della mancanza di un accordo tra etiopici ed italiani sulla questione dei confini, aveva anche dimostrato che il possesso di Saati non avrebbe obbligatoriamente risolto la questione a favore degli italiani. Il cav. Maissa, soStituto Commissario Civile a Massaua , lo aveva sc ritto a chiare lettere al suo superiore al Ministro degli Esteri. Ed illustrando gli scarsi risultati che si sarebbe ro potuti conseguire anche con una ' Saati italiana' aveva concluso il suo rapporto con le parole: «Colp irà Vostra Eccellenza come rimaniamo strozzati da quella pane• 54.
Ma intanto, in una mani e ra od in un'altra si andava a Saari. Seppui paradossalmente di pochi chilom etri , l'Etiopia era più vic ina. E a Massaua si era sempre in 'con dominio ' .
La pn·ma ordinaria amministrazio ne coloniale
Massaua , una volta occupata, non si teneva solo presidiandon e le strade od il porro: andava anche amministrata . Infatti Salettatra i tanti problemi politici e militari che gli si ponevano - doveva fare anche il 'governatore' . E qualsiasi raccoglim e nto implicava un maggior lavoro amministrativo.
Gli affari più propriam ente militari non erano i soli su cui Sale tta potesse così portare in quei giorni il suo interesse.
In mancan za di una più precisa definizione della struttura politica ed istituzionale del presidio d'occupazion e italiano (ed in presenza soprattutto di alcune tendenze 'interventiste' dello stesso Saletta in qualsiasi settore deJla vita ammini strat iva massauina ), il colonnello si trovava ad affrontare - il più dell e volte senza pre cise istruzioni - i più svariati aspetti della vita quotidiana coloniale in Mrica.
Attraverso le sue cane si può così gettare un approfondito sguardo sul reale andamento della vita della prima co lonia italiana 1
Parlando di Ailer, poi , Maissa ammoniva correttamente sul fatto che esso cè oggi presidiato dagli abissini, e non potremo occuparlo senza aperta rorrura col Negun. Cit. in V. MANTEGAZZA, Da Mas.saua a Saati. Narrazione della spedizione de/1888 in AbiSiinia, Milano, Treves, 1888 , p. Xll.
1 Un esame esa uriente della vita ammi nis t ra tiva d i quei prim i mesi a Massaua richiederebbe un più va riegato apporto documentario rispetto a quello che la documentazione militare da sola può offrire. Eppure, dalla lettura di queste cane, emerge già

LE PRIME PROVE
In questo senso non interesserà tanto vedere, qui, come Saletta poi dirimesse effettivamente le varie ed ingarbugliate questioni che gli si presentavano, quanto piuttosto dare una prima occhiata alle questioni stesse, ai problemi in quanto tali, alle comp licazioni 'normali' della prima amministrazione coloniale ed a come vi si avvicinava una amministrazione straordinaria militare.
Il punto caratterizzante di tutta la congerie di problemi amministrativi dei primi mesi pare riassumersi, come vedremo, nella mancata soluzione dell'affare del 'condominio', mentre la principale delle difficoltà che Saletta dovette affrontare non era forse tanto da ricercarsi nei problemi che aveva di fronte quanto nello scarso aiuto (o addirittura nelle contraddittorietà dell e istruzioni) che gli veniva da Roma. La capitale, e in questa lo stesso Ministero della Guerra , si presentava quindi agli occhi del colonnello come un superiore avaro, che pretendeva ottimi risultati senza però metterlo in condizioni di poterli raggiungere e senza fornirgli univoche indicazioni. A sua volta, vista da Roma , l'attività amministrativa di Saletta appariva incerta, talvolta azzardata e tale da mettere a repentaglio la stessa sicurezza del presidio coloniale. Per l' incenezza deIl' amministrazione coloniale italiana c'erano inoltre molte altre spiegazioni: c'era il disorientamento della generale polt'tica coloniale (cui, però, il colonnello credeva di poter mettere qualche riparo con la sua logica mziitare dei fatti compiuti); c'era la disattenzione politica italiana ai temi complessi di una politica di occupazione di un territorio africano (il dibattito politico di quei mesi, in Italia, si era ristretto all'alternativa espansione/raccoglimento e aveva del tutto trascurato gli aspetti amministrativi ed istituzionali, pure inediti e importanti per una potenza che faceva le sue prime prove coloniali); c'era il prevalere nella stampa, n eli' opinione pubblica e tra i responsabili della stessa politica coloniale, di interessi più immediati e specificatamente parlamentari (si avvicinava la crisi di Gabinetto del giugno '85, che doveva condurre Depretis , attraverso il licenziamento di Mancini, a fare un altro passo verso Destra) 2 • Ma nessuna di que ste spiegazioni può giustificare l'assoluto stato di impreparazione in cui era tenuto Saletta.
con chiarezza l 'impreparazione, le incenezze c le difficoltà (anche a livello locale) del primo colonialismo italiano. Con un analogo taglio di indagine, per l'es perienza britannica e con un occhio al complesso di quella amministrazione coloniale (non solo militare) cfr.). CEli, Bn'tish Colonia/ Administrati'on in the ltfid-nineteenth Century. The policy-making process, New Haven, Yale Universicy Press, 1970.
2 Cfr. Storia del Parlamento italiano, v. VIli , La sinistra al potere, cit., p. 387
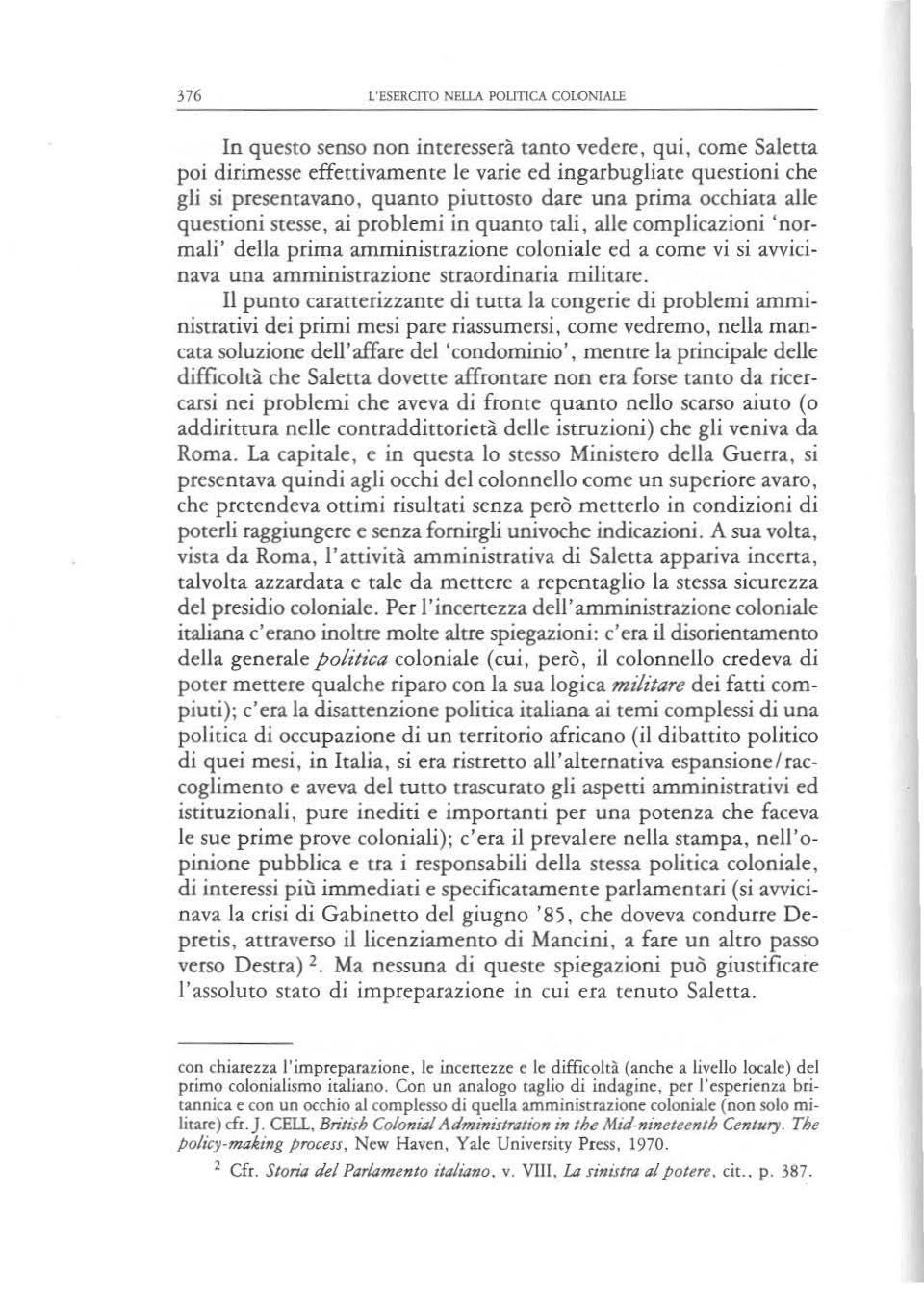
376 L'ESERCITO
NEUA POUTICA COLONIALE
E si noti che, erano varie le questioni (minori ma imporranti, quando si pensi che si trattava del primo tentativo coloniale italiano) che lo impensierivano. La mancata soluzione di quei problemi siripercuoteva inoltre sull'andamento dei rapporti tra il colonnello e il suo Ministro - già increspati per la questione di Keren -e certo non contribuivano a migliorarli. Saletta, lasciato arbitro della situazione, si dovette sentire isolato. La questione delle attribuzioni personali e reciproche dei Comandanti delle forze terrestri e marittime, per esempio, chiamava direttamente in causa i due diversi Ministeri della Guerra e della Marina. Questo tema, già delicato sin dai giorni dell'occupazione, era stato risollevato dal quasi contemporaneo rimpatrio del Contrammiraglio Caimi 3 con la riorganizzazione dei servizi militari sul Mar Rosso dipendenti dal Ministero della Guerra. Ricotti aveva scritto in quell' occasione al Ministro della Marina che era «cessato quel periodo nel quale la flotta doveva non solo concorrere ma avere ali' eventualità la parte principale nelle operazioni» 4 e che quindi, comunque fosse stato impostato il problema per l'innanzi, il Comandante Superiore delle truppe avrebbe dovuto essere considerato come la massima autorità della colonia. La cosa fu solo apparentemente accettata dalla Marina, che qualche giorno dopo scrisse alla Pilotta specificando che il precedente scambio di note andava inteso (e di fatto stravolto) nel senso di assegnare al Comandante Superiore la responsabilità sull'interno del possedimento italiano ma di lasciare al Comandante le forze navali quella sul litorale s. Come vedremo, il non essere stati precisi su questo punto, forse sperando che non si sarebbe presentato il caso di un conflitto di competenze, lasciò deteriorare la situazione sino a rendere insanabile il dissidio tra le due autorità militari di Massaua. Dissidio che già doveva sentirsi in modo acuto nel giugno quando Saletta si era lamentato con Ricotti che «l'autorità superiore italiana in Massaua [era] la marittima» 6. La questione della direzione della dogana di Massaua era un'altra 'pratica' che doveva assillare Saletta per tutti i mesi della sua permanenza in colonia e che il colonnello dovette lasciare irrisolta al mo-

3 Cfr. AUSSME, Carteggio Entrea, racc. 9. fase. l, p. 75.
4 AUSSME, Volumi Eritrea, v. 43, 22 aprile 1885, Ricotti a Brin.
5 Cfr. AUSSME, Volumi Entrea, v. 2, alle date del 2 e del 3 maggio 1885.
6 lvi, alla data del24 giugno 1885 (data di amvo del dispaccio da Massaua aRoma).
LE PRL'IiE PROVE 377
mento del suo richiamo in patria. La dogana era un'istituzione importante perché costituiva l'unico introito economico garantito della colonia 7: il suo funzionamento era previsto dal trattato Hewett, che aveva regolato i rapporti tra l'Abissinia e il protettorato inglese sull'Egitto.
Per via del 'condominio' la direzione della dogana era rimasta in mano egiziana e in essa aveva dei forti interessi personali un influente cittadino greco di Massaua, tale Marcòpoli, il cui favore politico era decisivo nello svolgimento dell'ordinaria amministrazione della cittadina. Per la dogana, e perché essa cadesse in mano italiana, si fronteggiavano due soluzioni. O il penetrarvi gradatamente, inserendo progressivamente funzionari italiani e conquistandosi la fiducia e l 'appoggio del Marcòpoli, soluzione questa caldeggiata dal Ministero degli Esteri e dall'incaricato italiano di affari al Cairo (che a tale scopo pareva avere avuto abboccamenti con gli ambienti governativi egiziani) 8; oppure il destituire d'un tratto il greco , al limite accusandolo
7 La documentazione conservata presso l' AUSSME è costellata da comunicati o dispacci di parte militare o diplomatica tn proposito. Non spetta a noi analizzare la convenienza economica a breve o a media scadenza della colonia italiana di Massaua. Si può intanto ricordare come, qualche anno più tardi, una Commissione d'inchiesta sull'Eritrea denunciò pubblicamente la scarsa dimensione dci profitti commerciali, quando scrisse che «insignificante è l'invio di merci da Massaua in Italia , c poche quelle che, nonostante la franchigia, l'Italia manda alla sua colonia.. Per quanto riguarda il periodo da noi preso in esame, si rifletta sul fatto che nel1886 (quando una maggiore calma c tranquillità nei rapporti del presidio con le popolazioni abissine circostanti avrebbe pure potuto facilitare c stimolare il commercio italiano) furono recapitate a Massaua dall'Italia merci per sole L 591.231, mentre il valore delle merci provenienti da altri paesi saliva già a ben 10.205.231. Cfr. Relazione generale della Regia Commissione d'lnchie· sta sulla Colonia En"trea, Roma , Tip. Mantcllatc , 1891, p. 56. Eppure, come anche venne serino, «il solo modo di rendere popolare in lralia la polittca africana è quello di renderla uùb. V. NAZA.RI, La colonizzazione dei nostri possedimenti in Africa, Casale, Cassone, 1891, p. 3. Uno srudio in proposito è ancora da fare. Si può così solo avanzare qualche ipotesi. Una pouebbe essere quella che vede come lo stesso governo, all'inizio non sepl?e e non volle incoraggiare le sia pur non numerose iniziative di pcnetrazionc economtca italiana a Massaua. Nelle carte della Presidenza del Consiglio si crovano varie richieste incvase di piccole ditte italiane che avrebbero voluto avviare una qualche attività economica sulle coste del Mar Rosso. Cfr. tra le altre, ACS, Presidenza del Consiglio dei Ministri, b. 58, fase. 122, 10 luglio 1885; ivi, b. 19, fase. 6, 24 novembre 1885; ivi, fase. 38, 8 febbraio 1886, c cos1via. Ma soprattutto, a sconsigliare l'iniziativa privata, già in quei primi anni, dovette essere in ultima analisi l'ingombrante monopolio militare nella gestione coloniale in loco. «( )la natura stessa della nostra prima occupazione di Massaua, co n forma esclusiva dt militare )?Ossesso, ci obbliga a procedere nell'impianto della Colonia con una serie di 'ripieghi ( )•. NAZARI, La colonizzazione dei noJtri possedimenti in Africa... , cit., p. 11. Per il periodo successivo cfr. RAINERO, I primi tentativi di colonizzazione agricola e di popolamento deii'En"trea (1890·1895), cit.
8 Era la cosiddetta 'soluzione Stcfanoni', dal nome del funzionario civile italiano che avrebbe dovuto dirigere la dogana di Massaua, secondo questo ordine di idee .

378 l ' ESERCITO NEllA POUTICA COLONIALE
(cosa non difficile visti i suoi inuicati e multiformi interessi) di ostacolare la presenza italiana, soluzione più cara agli ambienti militari e a Saletta personalmente 9 . L'osci llare tra queste due solu zioni, od anc he il non poterne seguire almeno una ma con decisione, doveva ceno diminuire il prestigio di Saletta a Massaua in quanto Comandante delle forze occupanti, ed aumentava la sua irritazione. Un'altra questione, quella del commercio delle armi con g li abissini, non vedeva allineati il Ministero degli Esteri con quello della Guerra. Gli Esteri , attraverso i vari esploratori che si erano avvenmrati in quelle regioni (e principalmente , tra loro , attraverso il conte Antonelli), avevano stabilito buoni contatti con sultani e ras della zona, spesso interessati all'acquisto di armi anche non recentissime né in buono stato. In questo senso, esploratori e avventurieri anche italiani avevano ripemtamente tratto ottimi vantaggi dallo sme rcio di moschetti e vecchi fucil i . L'occupazione italian a, se da una pane aveva offetto a tali individui più ampie occasioni di guadagno, aveva insospettito il Ministero della Guerra per questi passaggi di armi in grande quantità: esse avrebbero pomto essere usate , in qualche sciagu rata occasione , anche contro le stesse truppe italiane . Nel maggio 1885 , ad esempio, il Comandante del presidio di Assab, aveva scoperto, e immediatamente riferito al suo Ministero , che - prima dell' arrivo delle truppe di occupazione nel febbraio - funzionari (civil i) dell'amministrazione della Consu lta si erano serviti di Reali Carabinieri (cioè militari) per addestrare le popolazioni dei Danachili all'uso di Wetterl y e Remington provenienti clandestinamente dall'Italia 10. Il fatto aveva provocato una dura condanna da pane della Pilotta 11 e ripemti tentativi di sminuire, ma non di negare, del Ministero degli Esteri 12.
Anche le questioni giudiziarie intralciavano l 'ope rato di Saletta
9 Per la posizione di Saletta, cfr. AUSSME, Carteggio En.trea, racc. 9. fase. l, p. 78 e sgg. Non era la prima volta che autorità civili e autorità militari venivano a contrasco su lle coste del Mar Rosso. Già nell e primissime settimane dopo l'occupazione, l'autorità consolare a Massaua si era !agnata direttamente col Minimo degli Esteri per il comportamento dei militari Cfr. AUSSME, Volumi En.trea, v. 2, alla data del 31 marzo 1885. Questo aveva comportato una dura reazione della Pilotta (cfr. ivi, alla data del 2 aprile 1885 ), cui però la Consulta rispose difendendo l'operato del rappresentante civile degli Esteri a Massaua , cav. Pestalozza.

1° Cfr. ivi, v. 2 , alla data del 13 maggio 1885 (data di am·vo del rapporto panico da Massaua il 23 aprile 1885).
11 Cfr. ivi, alla data del 15 maggio 1885.
12 Cfr. ivi, alla data del 17 maggio e del 30 giugno 1885.
LE PRIME PROVE 379
e stavano lì a ricordare ai responsabili deJJ 'espansione coloniale la delicatezza dell'assetto istituzionale di Massaua. Il 'condominio' rendeva difficile, o impossibile, anche la soluzione di piccoli fatti di ordinaria amministrazione. Esemplare il caso d eU' arresto a Beilul di un arabo, imputato dell'omicidio di un suo connazionale. Il problema era: chi poteva giudicarlo? L'autorità locale abissina e cioè l'Anfari di Aussa? Ma questo avrebbe voluto dire che l'autorità effettiva a Beilul era quella 'i ndigena'. Meglio allora consegnarlo alle autorità egiziane: ma gli italiani non occupavano Beilul (seppure in condominio coi sudditi del Khedivè) sin dal gennaio di quell'anno? Doveva quindi essere cosa della giustizia italiana: ma allora in base a quale cod ice di diritto giudicarlo? In base a quello civile ordinario o a quello militare? E in questo ultimo caso, si sarebbero applicate le norme del tempo di pace o quelle, straordinarie e più severe, proprie del tempo di guerra 13?
Il Ministro della Guerra, sottolineando il doppio aspetto politico e giuridico della questione, giudicava la cosa «gravissima per le conseguenze politiche e giuridiche che potranno derivare dal precedente che sarà stabilito• 14.
La pratica così si trascinò a lungo. Il Ministero degli Esteri, durante l'interim di Depretis (e la concreta direzione di Malvano in quanto segretario generale), disse essere il tutto di competenza della giurisdizione militare 15, ma il Ministero deUa Guerra rispose che in linea di principio tale giurisdizione aveva vigore per i" civili solo in caso di «gue rra vera dichiarata• 16. Ma era giunto il momento di dichiarare lo stato di guerra a Massaua e in colo nia? L'Avvocato Generale Militare, richiesto di un parere, sostenne essere possibile accostarsi a quanto successo a Beilul per mezzo degli articoli del codice penale comune e della procedura ordinaria, affidando il caso ad un ufficio istruttore italiano di Assab 17. Tutti , insomma , sembravano voler lavarsene le mani. Alla fine, dalla Consulta arrivò l'assai moderato e dilatorio consiglio di restituire l'imputato all' Anfari di Aussa,
I3 Cfr. ivi, alla data del 9 luglio 1885.
14 Cfr. ivi, alla data del 13 luglio 1885 .
I) cNon rimane quindi che la giurisdizione militare, non potendosi esercitare una regolare giurisdizione civile in un territorio che è bensì occ upato, ma non legalmente annesso•. lvi, alla data del 21 luglio 1885.

I6 Ibidem.
!7 lvi, alla data del 3 agosto 1885.
380 L'ESERCITO NEllA POUTICA COLONIAli
scansando così la complessità della situazione 18 ; in questo senso pare si dovette scomodare addirittUra il governo, che sospese qualsiasi provvedimento di parte italiana contro l'imputato 19.
Due diverse impostazioni (quella diplomatica e quella militare) a riguardo dello stesso tema erano presenti, oltre che a Roma, anche sulle rive del Mar Rosso dove il Comandante militare del presidio di Assab riteneva il fatto di competenza della giustizia militare zo, mentre il Commissario civile della stessa località avrebbe preferito consegnare l'imputato all' Anfari di Aussa 21 . E dai documenti pare che alla fine risultasse applicata proprio questa ultima soluzione. Nel frattempo, e ancora prima della torrida estate, anche la base del Corpo di spedizione coloniale cominciava a dare i primi segni di incertezza, a fornire a Saletta le prime preoccupazioni. I diari militari registrano, per esempio, nel maggio alcuni tentativi di diserzione 22 e tal uni casi di grave indisciplina 2 3. I casi, pur non sorprendenti, presentavano in territorio coloniale alcuni aspetti delicati. Come si sarebbe potuto risolver! i? Mantenere nelle loro unità (e cioè in Mrica) i soldati turbolenti o, peggio, disertori avrebbe potuto corrompere e degradare la necessaria saldezza militare delle compagnie; condannarli avrebbe rischiato di incrinare l'immagine dell'esercito occupante nei confronti degli 'indigeni'; richiamare i soldati in patria, come acutamente commentavano ambienti del Ministero della Guerra, avrebbe potuto «forse tornar loro cosa gradita ed anzi eccitare altri a mettersi in analoghe condizioni» 24.
Per finire, come se non bastasse, Saletta con il suo carattere «duro come un acciaio non temperato» 25 non tollerava che dalla madrepatria o addirittura dallo stesso territorio posto sotto il suo comando
18 Cfr. ivi, alla data del 21 agosto 1885. Eppure si era sostenuto qualche giorno prima che, praticamente, in colonia si poteva fare qualsiasi cosa! «Fino a quando non sia possibile defmire stabilmente le condizioni territoriali di Beilul occorre considerarlo quale territorio militarmente occupato, con quella maggior larghezza di corollari giuridici che è consentita dalla circostanza che, malgrado il preesistente dominio egiziano, non ha [sic] mai esistito e non esiste a Beilul traccia di istituzione civile:.. lvi, alla data dell'8 agosto 1885 .
l9 Cfr. ivi, alla data del 23 agosto 1885.
2° Cfr. ivi, alla data del 17 ottobre 1885.
21 Cfr. ibidem.
22 Cfr. ivi, alla data del 23 maggio 1885. Ma il fatto era del 18 aprile 1885.
23 Ibidem.
24 Cfr. ivi, alla data del 25 maggio 1885.
25 Cfr. CHIESI, NORSA, Otto mesi d'A/n'ca, cit., p. 26.

LE PRJME PROVE 381
potessero avviarsi verso l'Italia indiscrezioni 26 o campagne giornalistiche contro il suo operato. Fino a che un più organico sistema di norme non fu varato, iniziò la lotta tra gli astuti corrispondenti e la ferrea censura, che veniva praticata soprattutto in loco. Ma i giornalisti italiani che si avventuravano a Massaua spesso riuscivano ad avere la meglio.
Era questo il caso, per esemp io , di Belcredi, corrispondente per «<l seco lo » di Milano e la «Tr ibuna» di Roma (ambedue quotidiani della Sinistra), che sfuggì nel1885 addirittura ad un mandato di espulsione dalla colonia. Saletta, secondo il resoconto che il colonne llo inviò al Ministero della Guerra a metà aprile, aveva personalmente riconosciuto (n el corso di un suo spostamento per via mare su una nave della Marina Militare italiana) il giornalista, nonostante questi si fosse travestito da inserviente. Insospettito, il Comandante italiano condusse allora un 'inchiesta, da cui si sco prì che Belcredi aveva ricevuto il permesso d 'imbarco da uno degli ufficiali della Marina; infine, dal Ministero della Guerra, partì in data 21 luglio la decisione di espellere il corrispondente. Ma ques.ti riuscì in qualche modo ad avere notizia del provvedimento. Quando Saletta, il 25 luglio, fece per arrestarlo (tre mesi dopo i primi sospetti , ma solo quattro giorni dopo la decisione ministeriale) si scoprì che Belcredi era a quella data g ià ad Alessandria d 'Egitto pronto a rimpatriare col suo 'prezioso' carico di indiscrezioni ed informazioni esclusive 27!
Inoltre nessun accurato controllo poteva arrestare la pubblicazione della quantità di lettere anonime che i militari stessi spedivano o facevano comunque arrivare da Massaua ai giornali italian i o di cui questi ultimi venivano in qualche modo a conoscenza 28.
È stato acutamente scritto che la diversità fondamentale tra il compito affidato ai militari i n territorio nazionale in tempo di pace ed il ruolo che essi dovevano svolgere nei territori coloniali, o comunque extrametropolitani, risiederebbe nella più larga sfera di attribuzioni che questo secondo teatro imponeva loro. In sostanza nel loro passare da 'ge neral i' a 'proconsol i ' 29.
26 Emblemacico il caso del rappono che Salerta inviò al Ministro della Guerra circa la sua ricognizione su Saaci ed Ailet. NeiJo stesso giorno in cui esso pervenne alla Pilotta, una sua copia veniva pubblicata da cL' Opinione». Cfr. ivi, alla data del15 maç-gio 1885. Più spesso le indiscrezioni e le critiche erano ospitate dai giornali pemarch1ci.
2 7 Cfr. ;,;, alle date ricordate
28 Rivelatore un esame delle annate de cL ' esercito italiano:., per co mprendere le dimensioni del fenomeno.
29 HOWARD, u forze armate, cit., p. 285.

382 L'ESERCITO NELLA POLITICA COLONLALE
La questione è complessa, ed un suo studio in merito anche alle prime esperienze coloniali italiane in Mar Rosso comporterebbe l'esame di aspetti amministrativi, giuridici e politici non tanto di breve quanto di lungo periodo che qui non è 11ostra intenzione sollevare. Un esame anche di quegli aspetti dell'espansione coloniale italiana potrebbe comunque contribuire a superare le oleografie e le visioni di maniera del colonialismo italiano, nonché a demolire quell'interpretazione etico-politica- talvolta ancora operante nella nostra storio grafia coloniale- che cerca a tutti i costi di vedere (anche quando non ci fu) nella storia coloniale italiana un ceno «se ntimento di mitezza e umanità che l'Italia portava anche dove non doveva. 30.

In merito alle prime esperienze politico-amministrative di Saletta, non pare proprio che la questione vada affrontata in base ad una sua presunta 'umanità' od alla sua 'mitezza', ma casomai in termini di chiarezza politica e di razionalità amministrativa, che ambedue mancavano alla Massaua dei primi mesi. E non sembra che si debba nemmeno scomodare l'impegnativa deftnizione , dal vago suono pretoriano, di 'proconsolato': che anzi, più di quello di 'proconsole', per un Saletta che non riusciva a far condannare un assassino, né a far cessare un pericoloso traffico d ' armi sarebbe più adatto il termine di protagonista e vittima di una politica coloniale incerta e 'dopp ia'.
Era un'incertezza che sarebbe durata non poco.
Caldo africano e polemiche mtlitan.·
Se da un lato , già in quei giorni a Massaua , le ' piccole' questioni amministrative dovevano chiamare in causa i grandi problemi politici che avevano segnato la prima spedizione coloniale italiana , dall' altro le grandi difficoltà o i rilevanti dissidi che interessavano le massime autorità militari del presidio non potevano non minare il prestigio personale degli stessi Comandanti che la stavano conducendo.
Chiusa per decisione del Governo (e per riconosciuta irrealizzabilità) la via a 'grandi' espansioni, interrotta per volere di Depretis e di Ricotti (per il comparire di proteste abissine) anche la via dei
30 Dietro tanta storiografia ha operato questa ingiustificatamente benevola definizione del colonialismo italiano di B. CROCE, Storia d 'Italia da/1871 a/1915, Bari, Laterza, 1928 (ed. cons. 1977). p. 119
LE PIUME PROVE 383
'piccoli' ingrandimenti come Arafali, Arkiko e Saati, non rimaneva al presidio di Massaua che attendere l'estate.
La stagione estiva 'singolarmente micidiale', come la aveva chiamata Cosenz , era di per sé pericolosa come una grande battaglia. A ciò si aggiungeva il fatto che proprio durante, o poco dopo, l'estate sarebbe venuto il momento di sostituire le truppe allora distaccate a Massaua con altri, più fres chi contingenti di leva.
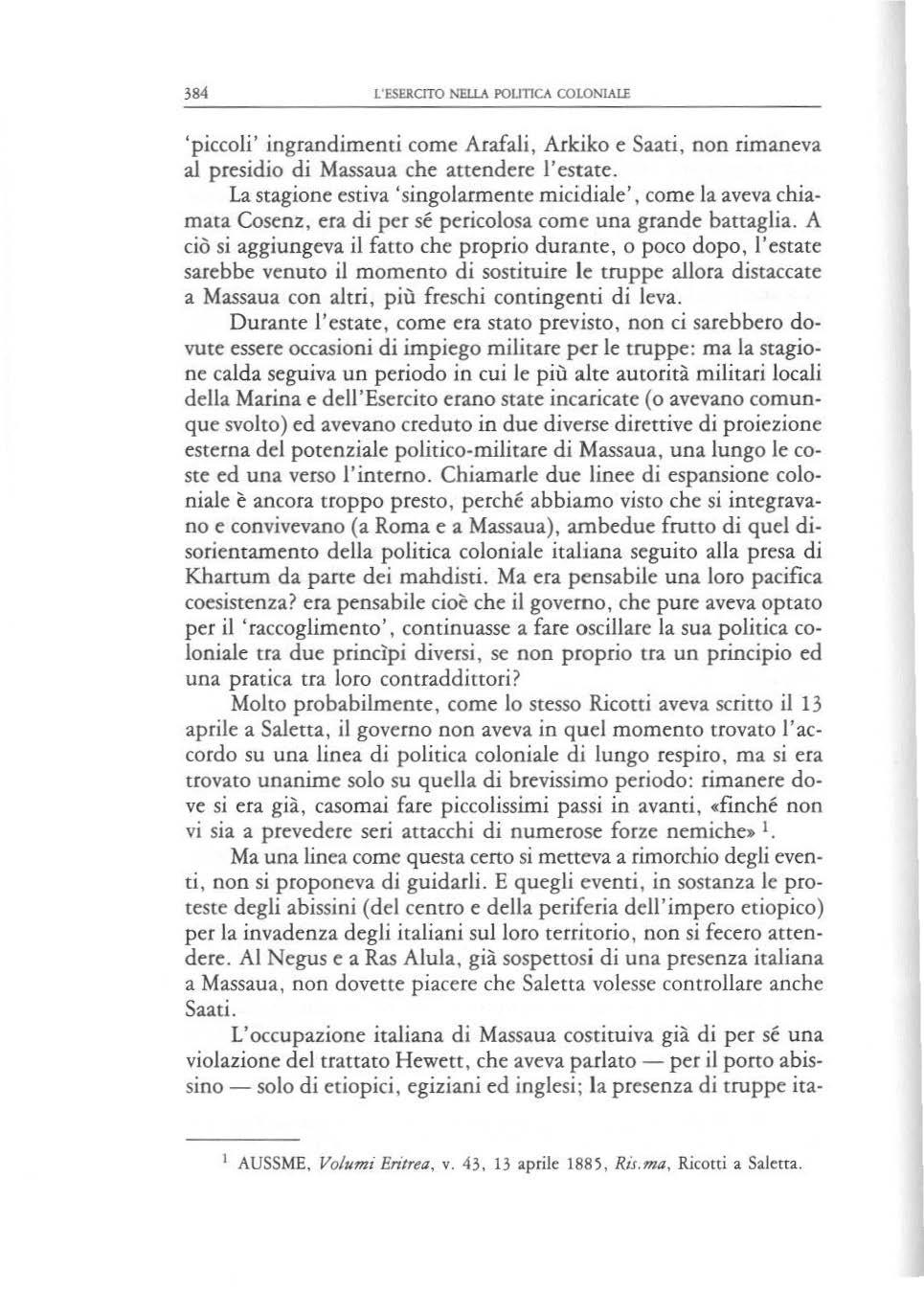
Durante l'estate, come era stato previsto, non ci sarebbero dovute essere occasioni di impiego militare per le truppe: ma la Stagione calda segui va un periodo in cui le più alte autorità militari locali della Marina e dell'Esercito erano state incaricate (o avevano comunque svolto) ed avevano creduto in due diverse direttive di proiezione esterna del potenziale politico-militare di Massaua, una lungo le coste ed una verso l'interno. Chiamarle due linee di espansione coloniale è ancora troppo presto, perché abbiamo visto che si integravano e convivevano (a Roma e a Massaua), ambedue frutto di quel disorientamento della po l itica coloniale italiana seguito alla presa di Kharrum da parte dei mahdisti. Ma era pensabile una loro pacifica coesistenza? era pensabile cioè che il governo, che pure aveva optato per il 'raccoglimento', continuasse a fare oscillare la sua politica coloniale tra due prinàpi diversi, se non proprio tra un principio ed una pratica tra loro contraddittori?
Molto probabilmente , come lo stesso Ricotti aveva sc ritto il 13 aprile a Saletta, il governo non aveva in quel momento trovato l'accordo su una linea di politica coloniale di lungo respiro, ma si era trovato unanime solo su quella di brevissimo periodo: rimanere dove si era già, casomai fare picco lissimi passi in avanti, «finché non vi sia a prevedere seri attacchi di numerose forze nemiche:. 1
Ma una line a come questa cerro si metteva a rimorchio degli eventi, non si proponeva di guidarli. E quegli eventi, in sostanza le proteste degli abissini (del centro e della periferia d eli' impero etiopico) per la invadenza degli italiani sul loro territorio, non si fecero attendere. Al Negus e a Ras Alula, già sospettosi di una presenza italiana a Massaua, non dovette piacere che Saletta volesse controllare anche Saati.
L'occupazione italiana di Massaua costituiva già di per sé una violazione del trattato Hewett , che aveva parlato - per il porro abissino- solo di etiopici, egiziani ed inglesi; la presenza di truppe ita-
384 L' ESERCITO NElLA POUTICA COLONIALE
1 AUSSME, Volumi En.trea, v. 43, 13 aprile 1885, Ris.ma, Ricotti a Saletta.
liane (o comunque al soldo degli italiani) a Saati spostava poi di fattO il fronte militare dell'occupazione a sole due-tre ore dal confine etiopico sancito da quel trattato. Per la popolazione abissina e per i suoi governanti questo doveva essere troppo 2
Ma, ancor prima del pericolo delle bande e de ll e tribù (se non addirittura dello stesso Impero etiopico), a Massaua stava arrivando il caldo.
Nonostante che, come si è visto, le autorità militari centrali si fossero preoccupate del fattore climatico sin dalla fase preparatOria della spedizione, va notato che poi a questa preoccupazione iniziale non corrispose nel passare dei mesi una adeguata azione amministrativa. Le truppe italiane affrontarono così il torrido clima estivo del l So parallelo di Massaua con lo stesso equipaggiamento pensato per il 42 o parallelo di Roma. Le «Norme spec iali di servizio per le truppe distaccate in Mrica» del 19 aprile 1885 non avevano in sostanza preso in esame la questione , e solo con la disposizione ministe riale del 3 1 luglio si provvide ad adeguare il vestiario 3. Anche tutto il precedente interessamento ministeriale per alcuni modelli inglesi e francesi di elmetti coloniali, da far poi costruire in Italia, pare si fosse risolto in un nulla di fatto 4 L'im preparazione infine giocava brutti scherz i anche ai massimi dirigenti militari e faceva confondere anche l'esperto generale Ricci il quale, al ritorno dalla sua ispezione sulle coste del Mar Rosso, riteneva paragonabili (e sopponabili) i venti caldi di Massaua a quelli della mediterranea costa tunisina 5.
Appena sbarcato, Saletta si era accorto della gravità del problema costituito dal rifornimento di acqua potabile e ceno l'aver dimenticato in Italia le due cassette mediche per l'analisi dei liquidi non lo aveva aiutato 6. Per il ghiaccio qualche cosa era stata fatta, con l'installazione di due potenti macchine refrigeratrici sopra due navi. Al baraccamento si poté pensare qualche giorno dopo l'occupazione e furono raggiunti, soprattutto grazie al lo spirito di adatta-
2 Cfr. ERJ.J.CH, Ethiopia an d Eritrea Aming the Scarmble for Africa , ci r., p 89
3 «Giornale militare ufficiale», 31 luglio 1885, atto n. 125.
4 Cfr. AUSSME, Addetti militan· Francia, racc. 4, 2 gennaio 1885, Ris.; e ivi, 5 gennaio 1885, Ris.
5 Ricci definì il soffio torrido e impetuoso del Khamsin «SOpportabile», aggiungendo: cfano che ebbi a constatare personalmente io stesso nell'estate dell864 in alua pane dell'Africa.. Ma e rano le coste della Tunisia (e non quelle del torrido Mar Rosso) quelle in cui il generale aveva fano la sua prima esperienza africana Cfr AUSSME , Volumi En"trea, v. 11, 19 aprile 1885, Ricci a Ricotti, Relazione.
6 Cfr. AUSSME, Carteggio En"trea, racc. 9. fase. l, p. 22.

LE PRIME PROVE 385
bilità delle truppe italiane, taluni risultati 7; ma anche il ripetuto desiderio di trovare qualche forma dì accantonamento sulle alture di Keren dimostra che ancora molto rimaneva da fare. Le tOmbole 8, i festeggiamenti per le ricorrenze natali dei sovrani regnanti e l'attenzione per il lavoro delle 'madame' 9, attività queste tutte ben curate, non dovevano poi riuscire a riequilibrare lo stato d i disagio dei soldati.
Tutto questo, comunque, sembrò come collassare al sopraggiungere della stagione estiva. I termini generali della questione sono già noti: Saletta in una sua relazione del12 luglio scriveva di comandare un presidio di cui un terzo era convalescente e i rimanenti due terzi deperiti 10 ed inabili ad una qualsiasi azione militare.
La forza militare italiana nel Mar Rosso era intanto passatacon le tre successive spedizioni di truppe che si erano susseguite dal gennaio al marzo - dalle poche unità del distaccamento di Assab a 806, poi 968 e quindi 2.491 elementi. Con successivi rinforzi e rirnpiazzamenti, alla data del6 giugno, il presidio di Massaua radunava
12) ufficiali e 2. 950 so ldati , quello di Assab rispettivamente 30 e 559, per un totale di 3.6)) unità 11 .
Una percentuale altissima, vicino alla metà, fu toccata dalle tipiche malattie e dai gravi disturbi che il clima tropicale spargeva tra gli organismi indeboliti dei soldati 12.
Ma anche più delle cifre degli ammalati e dei ricoverati in infer-
7 Lo ricordava anche BATIAGLIA, La prima guerra d 'Africa, cit., p. 210.
8 lvi, p. 213.
9 Cfr. ivi, le fotografie tra p. 448 e p. 449.

IO Vi si accennava già in ìvi, p. 209.
11 Cfr. AUSSME, Volumi Eritrea , v. 4.
12 Cfr. ivi. I daci sulle vittime sono, purtroppo, assai meno precisi (anche se ceno più elevati di quelli esposti in Parlamento da Ricotti). ln AUSSME, Carteggio Eritrea, racc. 62, compaiono vari tentativi di computo totale. Si trovano così le cifre di 40 decessi nell885 (di cui 30 dunnte l'estate e 3 suicidi) (cfr. ivi, fase. 7) cui andrebbero però aggiunti altri quattro, arrivati moni a Napoli di rirorno da Massaua. Ma altri registri parlano di 46 decessi, solo per Massaua (cfr. ivi, fase. l). Nel 1886, se i decessi di Massaua erano 'scesi' a 21 (ma l'entità del comingenre era quasi stato dimezzato, rispelto all'anno precedente), i soldati arrivaci moni a Napoli dopo la traversata erano addirittura 13 (cfr. ivi, fase. 3). Tristemente interessante la documentazione riguardante il caso occorso a Massaua ad un giovane di leva. Alle autorità militari, che affermavano che il giovane si era tolto la vita, il padre del coscrino aveva indirizzato un memoriale in cui invece sosteneva essersi trattato di un assassinio maturaro all'interno dell'ambiente militare di Massaua. T u tta la questione fu messa a tacere: niente trapel9 sulla stampa. Persino una Commissione Militare d'inchiesta nominata all'uopo non riusa bene a chiarire gli oscuri risvolti della vicenda. Cfr. ìvi, fase 2.
386 L'ESEROTO NELLA POUTICA COLONIALE
meria o alJ' ospedale coloniale, sono indicative quelle dei rimpatriati, cioè dei malati più gravi. Tra il 10 giugno e il 19 ottobre, data in cui gli effetti sanitari anche indiretti della lunga estate africana si poterono considerare esauriti, ben 373 erano stati i militari costretti addirittura a rimpatriare in Italia perché giudicati inguaribili a Massaua: cioè più di un decimo dell'intera forza ope rante 13. Poco meno di un soldato ogni dieci e poco più di un ufficiale ogni cinque non potevano guarire sulle coste del Mar Rosso: e a questi, come si è detto, andavano aggiunti tutti quei militari che quotidianamente si recavano in infermeria o che comunque dovevano essere dispensati dai servizi. il tuttO sino a comporre l'allarmante quadro descrittO dalla relazione di Saletta.
Il Paese, dal canto suo, non venne messo a conoscenza della reale entità de ll a situazione sanitaria, nonostante, specialmente durante i caldi mesi dell'estate, si fossero diffuse le più pessimistiche voc i .
Anzi: Ricotti assicurò più volte in Parlamento che la situazione era sotto controllo o addirittura migliore che in Italia 14 La gravità della situazione sanitaria si evidenziava invece senza necessità di commenti.
La saldezza del presidio di Massaua, inoltre, stava in quei giorni per essere scossa anche dall'operazione dei congedi e delle sostituzioni nella truppa. Per queste, le prime disposizioni ministeriali erano datate 23 giugno: individuavano in ottobre il mese in cui tale ricambio avrebbe dovuto essere comple t ato per quanto riguardava le truppe e prevedevano per gli ufficiali e sottufficiali una permanenza minima a Massaua di due anni 15.
Ma l'acutezza della condizione sanitaria dovette incidere su tali propositi. Durante luglio e agosto si ripeterono gli inviti del Min istero al Colonnello Saletta a largheggiare nella concessione dei congedi per i soldati, soprattutto se ammalati l6. Poi, il 4 agosto fu presa la decisione (visto l'alto numero di rimpatriati per malattie) per cui nessuno - nemmeno tra gli ufficiali - avrebbe potuto permanere sulle coste del Mar Rosso più di due estati consecutive 17.
n Cfr. wi, fase 3.
14 Cfr. AA.PP ., Camera, Legisl. XV, sess. unica, Discussioni, tornata del4 aprile 1886.

l) Cfr. AUSSME , Volumi Eritrea. v. 4, parte prima, 23 giugno 1885.
l6 Cfr. ivi, 19 lugli o 1885 e 16 agosto 1885.
17 Cfr. ivi, 4 agosto 1885.
LE PRIME PROVE 387
Nel frattempo erano state prese in esame le modalità secondo cui effettuare il congedo della classe 1863 da Massaua: da una relazione del Segretario Generale Marselli al Ministro apprendiamo che era possibile scegliere: o l'uso normale e ripetuto delle navi della Marina Militare e di quelle della Navigazione Generale Italiana che facevano scalo in quei lidi, oppure l'utilizzo in un unico viaggio di una potente nave militare (o meglio di un piroscafo all ' uopo noleggiato sul libero mercato, visto che nessun legno militare poteva da solo soddisfare le esigenze dell'esercito di spostare in breve tempo quasi quattromila so ldati nei due sensi) 18.

Probabilmente sì sarebbe preferito compi ere il congedo con navi statali ma l'emergenza sanitaria non lasciò di fatto alternative al pronto e veloce traspono dei militari. Fu così che le necessità delle forze armate si sposarono ancora una volta cogli interessi delle grandi compagnie armatoriali (anche se persino queste furono incapaci di evitare l'ennesima avarìa che ritardò il compiersi dell'operazione) 19. Comunque in due mesi, dal21 agosto al19 settembre, 1786 militari furono congedati e sostituiti con altri soldati di leva. Al 31 ottobre i presidi di Massaua e Assab tornavano a contare - dopo la lu nga pausa estiva- rispettivamente 3.171 e 514 elementi alloro attiVO.
La battaglia con il caldo africano (che era costata anche la vita al vice di Saletta, il colonnello Putti , che in un momento di sconforto durante la sua lunga malattia si era gettato in mare dalla naveospedale) era finita. Nonostante la si fosse temuta sin dall'inizio della spedizione, in sostanza i l presidio vi era giunto impreparato. L'efficacia militare di Massaua, peraltro scompaginata dal movimento di truppe dovute a congedi, si era annullata nella stagione estiva sino a ridurre la prima co lonia italiana ad un grande ospedale di febbricitanti. Eppure fu proprio prima della fine dell'estate che, colle proteste abissine per la presenza militare italiana a Saati, si sarebbe fatto minacciosamente sentire - co me vedremo - lo spettro di un colpo di mano di Ras Alu la su Massaua.
Nonostante tutto ciò, quella del caldo non era l'unica battaglia che venne co mbattuta in quelle settimane a Massaua . Mentre i so ldati e gli ufficiali affrontavano la canico la , i loro Comandanti militari si affrontavano con accuse di ingerenza reciproca e ricorrevano
388 L'ESEROTO NEllA POUTI CA COLONIALE
18 Cfr. AUSSME,
!9 AUSSME,
Carteggio En'trea, racc. 92, fase. 8, 16 agos to 1886.
Volumi En trea, v. 4, parte prima , 28 agosto 1885.
per via gerarchica ciascuno contro l'altro.
Abbiamo già detto dell'incongruenza di cene istruzioni militari e della possibile sovrapposi zione delle cariche e abbiamo già ricordato (o l tre i caratteri spigolosi degli ufficiali incaricat i di reggere i Coman di) le responsabil ità d i t ipo pol itico o m iniste riale. Vale a d esso la. pena ri p ercorrere la vicenda saliente di quel contrasto di cariche e di competenze (e cioè il conflitto Noce-Saletta) secondo quanto i documenti stessi ci narrano.
La riorganizzazione dei presidi africani del l 7 aprile era stata resa, senza toccare le questioni po litiche del condominio istituzionale italo-egiziano, a concedere in loco un più largo spazio alla decisionalità e all'influenza dell'Esercito - e attraverso di esso- al Ministero de ll a Gue rra. Ma, di fatto, la Marina non aveva accolto passivamente tale disposizione: la sostituzione del Contrammiraglio Caimi per motivi di salute coli' Ammiragl io Noce (effettuatasi l' 8 aprile) era stata solo apparentemente una concessione a tale punto di vista 20 Inoltre, nonostante il parere espresso da Ricotti, la Marina Militare non aveva affatto terminato il suo com p ito nel Mar Rosso; anzi, l' occupazione dell'isola Dahl ak p rospicente Massaua (occupazione, prima ispirata e poi sconsigliata da Saletta, effettuata il 9 giugno) 21 e la missione compiuta dal18 al29 giugno 1885 lungo la costa tra Massaua e Assab (in cui, quando fu possibile, fu consegnata ai capivillaggio una bandiera italiana e promessa una protezione m ilitare) 22 parevano aver dato nuova dignità alla presenza marittima in co lon ia, prima di questo messa in ombra dell'allargàmento della sfera d'influenza terrestre operato da Saletta nelle settimane appena precedenti. In realtà, cosa si dovesse fare di questi punti della costa solo «moralmente occupati» non era ben definito; d'altra pane gli ambienti della Marina deplorarono polemicamente che cla direzione del
2° Cfr. Storia militare della Colonia Entrea, cit., p. 90 e sgg.

21 AUSSME, Volumi Eritrea, v. 2, alla data del 9 giugno
22 Lo stesso Brio non voleva alcun aiuto da parte dell'esercito in questa missione che, più che un protettorato , voleva stabilire un «semplice indizio di presa di possesso:. lvi, alla data dell'li maggio 1885. Le navi della Marina toccarono il 23 giugno Edd, il24 Madir, il 26le isole Hauakil, il 28 Machanile di fronte a Zula. ln ognuna fu innalzata la bandiera italiana e sparate le tradizionali ventuno salve di cannone: il tricolore veniva innalzato su un pennone in loco e poi lasciato in custodia ai capi-villaggi o locali. Non sempre però runo andò bene. Alle isole Hawakilcla bandiera fu innal zata durante la sola funzione della proclamazione del protenorato e poscia ritirata a bordo, essendosi il capo dei notabili dimostrato poco soddisfatto dell'offerta più che generosa fattagli da Marchesi (Comandante della nave da guerra 'Esploratore', incaricata della missione) per custodirla:>. Storia militare della Colonia Eritrea, cit., p. 93.
u; PIUME PROVE 389
servizio politico militare fosse interamente affidata al comando delle truppe•. Finiva così che, anzi, la Marina preferiva disimpegnarsi e non accrescere, coll'occupazione di porti e baie tra Assab e Massaua, il proprio controllo su zone e in ambito cche non sono di sua esclusiva competenza o che non possono mai essere ben definiti • 23.
La querelle tra i Comandanti locali dell'Esercito e della Marina, infme, era complicata dalle stesse improprie definizioni gerarchiche. Noce era ammiraglio (e quindi a buon diritto rapponabile in grado ad un generale di divisione dell'Esercito) e Saletta era solo colonnello, e quindi subordinato. Sull'altro versante, oltre che al suo carattere freddo ed orgoglioso, Saletta si appellava invece alle misure ministeriali del 17 aprile che gli concedevano se non il grado almeno le attribuzioni di Comandante di Divisione; e, secondo questa interpretazione, pari in grado a Noce.
la situazione predisponeva quindi facilmente allo svilupparsi di incomprensioni e di rancori: quando poi, come nel caso di Saletta e Noce, ci fosse stata di mezzo una questione politica sostanziale (espansione coloniale lungo le coste o verso l'interno) e fosse mancato l'intervento chiarificatore dell'autorità politica o amministrativomilitare superiore, la miscela non poteva non essere esplosiva.
L'incidente che risollevò in maniera definitiva la questione fu l'allontanarsi di Saletta (per un giorno) dal presidio d i Massaua senza averne prima dato formale comunicazione a Noce. Questi, risentito dell'autonoma decisione del Comandante Superiore delle truppe, gli scrisse in un messaggio riservato:
Da oltre un mese che mi trovo in queste acque ho sempre atteso che la S. V. mi riferisse sull'andamento dei vari servizi affidati alle sue cure ma mentre ho rilevato che mi diresse molte lenere per scopi secondari come l' accomodamento di instrumenti musicali, le richieste d'acqua , d 'olio, di vino ecc. alle quali si sarebbe potuto provvedere verbalmente , ha poi omesso totalmente di riferirmi sulla pane più impottame cioè quella relativa aJia missione politico-militare che le è affidata 24
23 AUSSME, Volumi Entrea , v. 45. 9 luglio 1885 , Noce a Brin. Sorvolano, o sottovaJutano, queste problematiche sc ritti come quelli di G ALMAGIA, L 'elemento politico-diplomatt"co-coloniale nelle campagne oceaniche della R. Manna dalla fondazione del Regno all'occupazione di Massaua {1861- 188.5}, in Atti del III Congresso di studi coloniali, v. IV , Firenze, 1937 pp. 68 -85; o di G. FIORA VANZO , G VITI, L'opera della Marina, cit .
24 AUSSME, Carteggio Eritrea , racc. 44, fase. l , 23 luglio 1885, Ris., Noce a Saletta.

390 l'ESERCITO NEllA POLITICA COLONIM.E
Era la goccia che doveva far traboccare il vaso. Dopo questa messa in stato d'accusa, sia Noce sia Saletta si affrontarono da dietro le loro personali interpretazioni delle istruzioni loro impanite, senza concedere nulla l'uno all'altro. Il tono irritato e irritante con cui si scrivevano può essere spiegato solo con la reale imponanza che i due Comandanti annettevano al dissidio. Saletta rispose così a Noce che non sentiva di avere nei confronti dell'Ammiraglio alcun obbligo, né militare né personale, avendo egli - pur colonnello - le attribuzioni di Comandante di divisione 25. Noce, che invece vedeva pur sempre in Saletta un subordinato, ribadiva alla risposta del colonnello la superiorità gerachica del «maggior grado» 2 6. Saletta, con parole degne del suo altero carattere, replicava: «Farò come crederò più opportuno» e allargò, non richiesto, la questione tra i due singoli militari al rapporto generale tra le due forze armate scrivendo che non si sentiva di essere accusato dal momento che «per prove di riguardo fu sempre più largo l'Esercito di terra che non la Marina>>. Aggiunse poi che era disposto a prendere insieme a Noce accordi e concetti, ma non ad accettare ordini 27.
Il dissidio aveva raggiunto un punto di non ritorno e i due Comandanti fecero ciascuno ricorso ai superiori ministeriali. Noce scrisse al Ministro della Marina, che non si sentiva «di più a lungo tollerare l'indisciplina e l'insolenza di un inferiore». Aggiugendo che secondo il suo parere le istruzioni ricevute fossero «in urto» con quelle assegnate al colonnello dell'Esercito, Noce rassegnò il mandato 28 Altrettanto fece Saletta nella sua missiva al Ministero della Guerra: le sue argomentazioni erano numerose e (il colonnello ne faceva una questione generale e non solo di grado) si rifacevano alle diverse difficoltà incontrate nella sua opera di amministratore e governatore della colonia 29. Le campagne giornalistiche in patria, la questione delle dogane, e persino affari vecchi di mesi, come quello di certe 'lance a vapore' ritenute e poi concesse dalla Marina , o assai recenti, come un preteso scarso aiuto delle forze di mare prestato a quelle di terra in occasione della occupazione di Arkiko: tutto pareva a Saletta avere a che fare col dissidio tra lui e Noce.
2 5 Cfr. ivi, 23 luglio 1885, Rù., Saletta a Noce.
26 lvi, 24 luglio 1885, Ris. , Noce a Salecta.
27 lvi, 25 luglio 1885, Ris., Saletta a Noce.
28 lvi, 26 luglio 1885, No ce a Brin.
29 Cfr. ivi , 27 luglio 1885, Ris., Saletta a Ricotti.

LE PRIME PROVE 391
A Roma ceno ci si allarmò per questo conflitto tra i due massimi personaggi della colonia ma se si esclude un breve comunicato della Pilotta in cui si invitava Saletta alla prudenza e al rispetto degli o rdini superio ri 30, non si volle forse gettare altra benzina sul fuoco del dissidio. Si provò così a lasciar sbollire da sé la cosa: in realtà, qualche provvedimento andava comunque preso.
Da una parte, l 'insorgere del dissidio non migliorava la posizione e la considerazione in cui, perlomeno al Ministero della Guerra, era tenuto il dinamico Comandante Superiore delle truppe. Ma era pur sempre in gioco l'onore dell'Esercito, si pensava alla Pilotta. Dall'altra, dalla parte della Marina, si difese a spada tratta l'Ammiraglio ed il suo operato. Il Ministro Brin arrivò a chiedere da Roma esplicitamente quello che neppure Noce da Massaua aveva osato reclamare: «il conservare nell'attuale posizi one il colonnello Saletta sarebbe asso lutamente inconciliabile con le leggi militari e con il buon andamento del servizio:. 3 1 , scrisse Brin a Ricotti.
La questione si era fatta davvero troppo grossa per un governo che aveva dichiarato di volere addirittura un raccoglimento coloniale. Qui i problemi rischiavano di venire non dagli ab issirU , ma dagli stessi militari italiani.
L'epilogo ufficiale fu un rimprovero militare inflitto al colonnello, l'obbligo per lui di andare dall'Ammiraglio per presentargli le scuse e l'ordine di mutare il suo «irriguardoso contegno:.. In un telegramma congiunto inviato a Saletta dai due Ministri della Guerra e della Marina, a quasi un mese dall'incidente che aveva dato origine alla polemica, si legg e:
Il Ministero della Guerra disapprova il contenuto e la forma delle due lettere or. 355 e 347 scritte dal Colonnello Saletta al Contrammiraglio Noce [le lettere da noi citate) e gli infligge un rimprovero. Il Ministro della Marina invita l' Ammiraglio ad indicare al Colonnello Saletta le informazioni che gli debbono periodicamente essere comunicate Il Ministro della Guerra ordina al Colonnello Saletta di fornire all ' Ammiraglio rune le informa:zion che gli saranno domandate e di soddisfare altresì alle sue prescrizioni 32

E il Ministro della Guerra ordinava in un suo telegramma a Saletta:
30 AUSSME, Volumi Eritrea , v. 2 , alla data del 28 lug l io 1885.
31 AUSSME , Carteggio Eritrea , racc. 44 , 18 agosto 1885 , Ris a lui sol o, Brirt a Ricotti
32 lvi, 23 agosto 1885, Brirt e Ricotti a Saletta .
392 L'ESERCITO NEI.LA POUTICA COLONIALE
In conseguenza rimprovero contenuto telegramma N. 1026 si presenti Ammiraglio per manifestargli rincrescimento per sue lettere N. 355 e 347 non abbastanza deferenti 33.
Saletta era quindi rimasto sconfitto. Voleva questo dire che era stata battuta la sua persona od anche il suo progetto (che era poi quello per cui pareva spingessero i tempi) per una 'piccola' espansione coloniale italiana verso l'interno? Pareva esservi una certa doppiezza nel fatto per cui Saletta venisse disciplinariamente biasimato proprio quan do politicamente le sue idee cominciarono a realizzarsi .
In realtà troppe cose, anche all'interno dello stesso presidio coloniale di Massaua (dal carattere di Saletta al ruolo dato all'esercito con il 17 aprile, allo spazio lasciato ai Comandanti locali negli ultimi mesi prima d eli' estate, allo stesso presidio di Saati), spingevano per un lento ma deciso allargamento della presenza militare italiana verso l'interno.
E già qui, nell'atto amministrativo e discip l inare, in quel telegramma del solo Ricotti, c'era qualcosa che pareva suonare in maniera diversa rispetto a quello congiunto Ricotti-Brio.
C'è infatti una certa differenza tra il definire le lettere di Saletta due documenti 'non approvabili' come diceva il rimprovero RicottiBrio e l'imputarle di essere solo 'non abbastanza deferenti ' come diceva il Ministro della Guerra nel suo telegramma, quasi la mancanza di Saletta verso Noce fosse solo una questione di cortesia. Il rimprovero di Ricotti pareva insomma assai più dolce di quello che i due Ministri insieme avevano inviato a Saletta: come se l'Esercito fosse assai poco disposto a farsi giudicare - e condannare - dalla consorella Armata. Infatti, lo stesso giorno e all'insaputa del collega Minist!I:O della Marina, Ricotti inviò al colonnello un telegramma siglato «Particolare» che così suonava:

Ricordi che la punizione che esigenze disciplinari gerarchiche mi impongono infliggerle non può menomare alta stima che ho di lei per suo carattere, per sua capacità e per modo con cui ha sapuro organizzare i vari servizi e mantenere ferma la disciplina delle truppe . Affezionato suo Cesare Ricotti 34 .
Dal rimprovero il Ministro passava così (per mezzo della solidarietà d'arma e dello spirito di corpo) quasi alla lode del subordinato Saletta. Certo nessuno elogio diretto al tipo di intraprendenza mili-
lvi, 23 agosto 1885, Ricotti a Saletta.
lvi, 23 agosto 1885, Part., Ricotti a Saletta.
LE PRIME PROVE
393
33
>4
tace del colonnello o alle vere e proprie sue operazioni militari come occupazioni e ricognizioni , ma ceno quasi un incoraggiamento a seguitare la strada intrapresa. E lo spirito di corpo doveva trovare anche altri sostenitori, se è vero , come pare, che proprio in que ll e settimane abb ia scritto a Saletta- militare dell'Esercito accusato da un militare della Marina - anche il Capo dello SME, in una lettera dal co lonn e llo poi conside rata «assai lusinghiera» 35.
Purtroppo, così facendo i dicasteri militari (se salvarono l'onore di Corpo) non colsero l'occasione, pure infelice, di riesaminare la questione delle competenze delle diverse autorità militari in colonia. Ma non era tutta loro la respon sab ilità .
Nonostante perlomeno il Ministero della Guerra avesse ua l 'aprile e il maggio espresso con chiarezza quali fossero i suoi concetti per l'immediato futuro della politica colonial e ital iana nel Mar Rosso, ancora interrogativi e fantasie potevano essere suscitati in merito a non meglio precisate spedizioni verso l 'interno.
Appena uscita da una crisi governativa ris oltasi proprio con l 'estromiss i o ne dalla compagin e esecutiva del Ministro degli Esteri, e per il momento affidato questo dicastero ad un interim, l 'estate del 1885 non era il momento migliore per una definizione delle politiche d'espansione africane del Regno di Umberto I.
Fatto sta però che già a settembre fu presa la decisione di sostituire Saletta. La motivazione ricorrente nella stampa (non quella ufficiale, che si ri assum eva in un anodino 'richiamo per cessato servizio') era che per dare prestigio e autorevolezza ai presidi coloniali italiani era necessario che questi fossero diretti.
Diversi erano gli elementi che questa risollevava. Per primo, il fatto che ancora non si poteva dire conclusa la discussione politica all'interno del governo, e della classe dirigente, sulla prospettiva da dare alla politica colon iale italiana ed al presidio di Massaua. Ma su questo aspetto ritorneremo con più attenzione fra poco. Secondo , che le tendenze verso un allargamento del!' influenza italiana verso l 'interno sembravano essersi aggiudicate un aluo successo. Terzo, che ancora una volta i reali problemi della vita quotidiana della prima colonia (in questo caso i disagi delle truppe per il clima e per gli spostament i dovuti ai conged i) fossero dovuti passare in second'ordine di fronte a questioni derivanti da un'insufficientemente chiara ed univoca politica. Quarto, che i dissi di tra i più alti ufficiali (che tanto

394 L'ESERCITO NEUA POLITICA
LONIALE
CO
3) lvi , racc. 9, fase l. p. 83.
avevano nuociuto in altre e più gravi occasioni al prestigio delle forze armate già nelle guerre dell'indipendenza) tornavano così a ripresentarsi anche in territorio coloniale.

Erano, questi, elementi di varia imponanza.
Il dato preoccupante era che si fossero presentati tutti insieme , a soli pochi mesi dal primo avvio di una politica coloniale italiana, ancora prima che 'gli indigeni', gli abissini, avessero avuto il tempo di farsi vivi e di presentare le loro rimostranze per l'occupazione militare italiana. Come abbiamo già visto, nel marzo la voce ufficiosa del Ministero della Guerra aveva paventato l'ipotesi di un disastro militare italiano 'contro i Negri ' : punroppo se ne andavano facendo evidenti le possibili ragioni.
LE PRIME PROVE 395
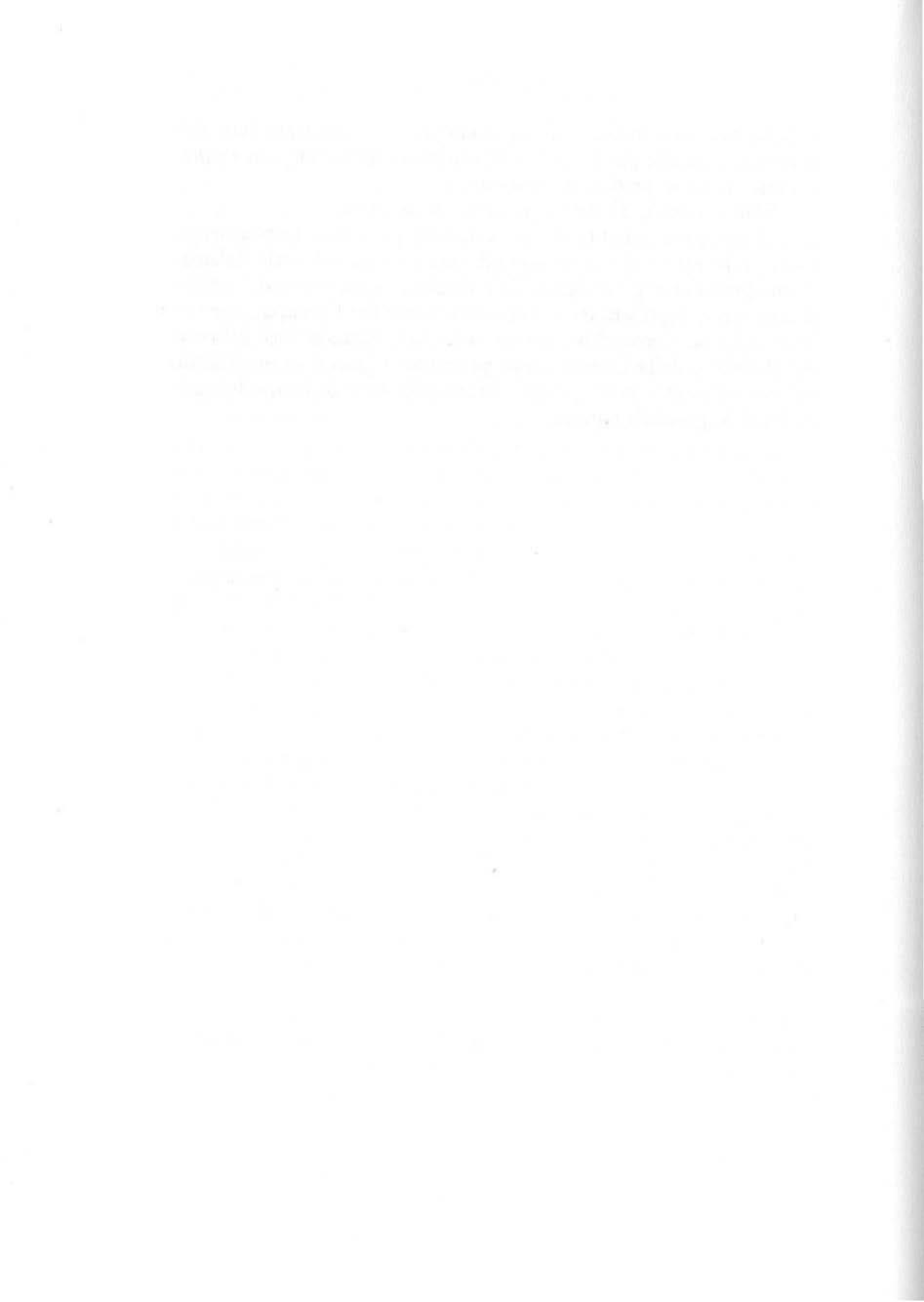
CAPITOLO TERZO
VERSO DOGALI
Un segnale sottovalutato: l'ultimatum di Ras Alula
Passata la primavera e sbollite le prime euforie 'colonialiste', Massaua doveva attirare in genere assai poco l'attenzione della classe dirigente italiana: sia dal punto di vista della 'ordinaria amministrazione' (che pure come abbiamo visto incontrava difficoltà e sollevava problemi di non poca importanza), sia da quello della definizione generale della politica coloniale italiana.
La nostra narrazione si era interrotta con l'aprirsi della pare n tesi estiva, prima della quale il dato caratterizzante dell'atteggiamento governativo era stato il disorientamento, cui era seguita la concessione (di fatto) del più largo spazio di manovra ai Comandanti militari locali, ed t·n primis a Saletta.
Dopo di allora la situazione in verità non parve migliorare.
Con il giugno, per mezzo di una crisi ministeriale, veniva sostituito Mancini: al suo posto Depretis avrebbe poi chiamato Robilant 1
Come abbiamo visto a suo tempo, l'allontanamento di Mancini non avveniva unicamente a causa del comportamen to contraddittorio tenuto (e dei troppo scarsi risultati ottenuti) sul terreno della politica coloniale, ma trovava la sua piena spiegazione nella più generale insoddisfazione per la posizione diplomatica italiana nel conce rto europeo. Ma se questo è vero, è d'altra pane indubbio che il fallimento di tutti i 'piani' coloniali di Mancini aveva decretato la necessità di una sua sostituzione.
Dal canto suo Robilant, autorevole esponente di quell 'ambiente conservatore verso cui Depretis voleva spostare l'asse della sua maggioranza parlamentare, prometteva- a differenza di Mancini- un
1 Cfr. Stona del Parlamento italiano, v. VIII, La Sinistra al potere, cit., p. 389 , e ivi, v. IX, Tra Crispi e Giolitti, cit., p. 12; e GIGUO, L'impresa di Massaua 1884-1885, cit., p. 156.

maggior interessamento per le questioni continentali, le sole su cui l'ex-ambasciatore a Vie nna consid era va possibil e far cresc ere e consolidare un prestigio dell'Italia come 'gran de potenza' 2 . E, come Robilant , anche i setto ri più autorevoli d e lla Desua parlamentare andavano in quei giorni considerando con una cena suffic ienz a il presidio di Massaua e l'imponanza che Man cini a veva vo luto annettergli. Un quotidiano del calibro de «L'opinione» aveva scritto chiaramente che
Massaua, se non c'è l'occasione di operare cogli inglesi in foni imprese, le quali ci diano una delle tante chiavi del Mediterraneo african o, non rappresenta che un pericolo politico senza il compenso di un qualsiasi vantaggio commerciale 3.
Nonostante qu este perentori e asserzioni, però, proprio su quel terreno co loniale che si era rivelato fatale per Man cin i , non ci fu per il momento alcun sostanziale riorientamento della politica italiana.
In pane per via del fatto che Depretis fu cos tre tt o da Robilant (che tardava a concedere il proprio assenso alla sua ste ssa nomina a Ministro deg li Esteri) a reggere la Consulta con un interim che du rò più di un trimestre 4 , la correzione di rotta che l 'avve nto di un uomo nuovo agli Esteri avrebbe potuto significare si fece attendere.
L'in ten'm di Depretis non soddisfò le attese di quanti avrebbero voluto una più chiara politica italiana verso il Mar Rosso. Del Presidente del Consigli o era no ta la prudenza politica e la moderazione che lo re ndevano costi tuzionalmente avverso ad assumere vincolanti impegni in territorio africano ) . Lo stesso Depretis aveva reso pubblico l'orientamento diplomatico che avrebbe seguito nel suo t'nterz'm agli Esteri con un lungo anicolo su «<l popolo romano » in cui si premurava di ri cordare a tutt i - p o liti ci, diplomatici e militari - come la «nostra modesta posiz ione nel co ncen o europeo» 6 non doveva l asciare spazio ad avventure colon iali. Si poteva così legittimamente presumere che Depretis avrebbe cercato di ricon durre il presidio di Massa ua alla so la occupazione del pono a puri ftni commer-
2 Cfr. CHABOD, Storia della politica estera italiam1 dal 1870 al1896, p. 691 e p. 696.
3 cL'Opinione», 22 giugno 1885, Assab o Mauaua?.
4 Scarsi a questo proposi to gli accenni di CAROCCI, Agostino D epretù e la politica interna dal1876 a/18B7, cit., p. 594.
5 Superficiale l'analisi io GlGUO. La politica africana di Agostino Depretù, cit., p. 19.
6 eli popolo romano», 2 luglio 1885, La soluzione della crisi.

398 L'ESERCITO NELLA POUTICA COLONIALE
ciali, come pure il governo aveva dichiarato di volere, nell'aprile. Ma anche il Presidente del Consiglio preferì non impegnarsi in vicende africane. Visto anche che ormai l'unico a reclamare una politica colo niale più decisa era rimasto - oltre a qualche ambiente militare- il solo Crispi , l'anziano Presidente d el Consiglio non si senti va certo invogliato a calarsi in quel complesso intrico di questioni diplomatiche internazionali e di problemi politici e militari che l' affaire co loniale portava con sé.
Così, in realtà , J'intenm trascorse senza che fosse fatto niente. Troppe dovevano essere le forze (po litiche , diplomatiche, militari) che non erano disposte ad arretrare di un centimetro dalle posizioni guadagnate in Mrica tra tutti i pericoli e co n tutte le difficoltà prima ricordate. ' Bandiera issata, non si ripiega mai' 7 : questo era il ritornello che cominciava a circolare, già a pochi mesi dalla nascita della politica co loniale italiana.
A Depretis sarebbe bastato che Massaua non creasse problemi grossi durante il suo t'nten·m, e poi tutto sarebbe stato affare di Robilant. In questo senso, anzi, una certa autonomia veniva di fatto concessa al Ministero della Guerra ed al suo responsabile, tenendo conto che durante la stagione estiva il massimo problema sarebbe stato quello di mettere i l più possibile al sicuro dal caldo le truppe del presidio.
Si rimandava quindi per l'ennesima volta di discutere l'utilità e le prospettive di un possedimento coloniale dal perimetro difensivo ormai così sb ilanciato verso l'interno (Saa ti) e non più basato sul possesso della costa, come pure il governo aveva voluto. Intanto cose importanti , anche se non appariscenti, stavano accadendo a Massaua.
Saletta, dal canto suo, aveva tentat o di consolidare la sua posizione personale nel presidio, ce rcand o di ottenere una qualche sorta di attribuzione di 'carta bianca' da parte del Ministro della Guerra.
Già prima dell'esplosione del dissidio con Noce, il colonnello aveva tentato la via delle dimissioni unilaterali ed 'a sorpresa' per saggiare la disponibilità di Ricotti a ' rein vestirlo', casomai con qualche più lata attribuzione politico-militare. Non è improbabile che Saletta, che era riuscito a controllare il posto di Saati, pensasse ancora alle alture ed alla via per Keren che così calorosamente aveva so-

VERSO OOGAU 399
7 Lo riprese poi L. Pelloux , in AA.PP ., Camera, Legisl. XVI, sess. prima , Discussioni, tornata del 15 dicembre 1886.
stenuto in primavera s. Nei primi giorni di luglio, cogl iendo l'occasione di u na ennesima campagna giornalistica della stampa pemarchica contro la conduzione della politica co lon iale da parte di Ricotti e di Saletta, accusati anche di imp re parazione nell'affrontare il peso della stagione est iva africana, i l colonnell o - inaspettatamentechiedeva l'esonero d eH' incarico.
Sentendosi di non aver mancato, trovandosi impotente ed esautorato di fronte alla calunnia trionfatrice della pubblica stampa, che non ammette alcun freno, egli [Saletta] chiede ed insta presso il Ministero perché venga sostituito nel Comando delle truppe in Africa 9.
In verità la reazione del colonnello e ra spropositata. Saletta era se mpre stato duro con i giornalisti e ceno non dovettero piacergli quegli attacchi mossigli proprio quando eg li stava affrontando la 'battaglia del caldo'. Ma è ovvio che questa richiesta di esonero, impossibile ad essere acco l ta, e che avrebbe crea to di fatto queJl' incidente politico che proprio Depretis aveva mostrato di non voler sul terreno co lonial e durante il suo interim, doveva nascondere qualcosa. Lo stesso Ministro della Guerra si dimostrò «sorpreso per l'importanza data da Saletta a qualche comunicato giornalistico» 10. E forse intuendo qualcosa nella manovra di Sal etta, Ricotti, che aveva a suo tempo detto l'ultima parola (negativa) sui progetti per Keren , si affrettò a telegrafare che - nonostante le campagne d i stampa -a $aletta «dove-
8 L'occupazione di Saati nel giugno 1885 fu emblematica dei limiti del colonialismo italiano. Fu effettuata io un momento di massimo disorientamento della politica co loniale del Governo, condotta grazie ad una notevole autonomia dei comandanti militari locali (Saletta), realizzata senza ricercare alcun accordo con la potenza etiopica. Ma, soprattutto, ancora una volta, fu resa possibile solo grazie alla supervisione cd al consenso dei britannici (nel caso specifico, dell'autorità inglese locale, il col. Chermside, forse ancora prima di quella superiore e politica, londinese). Fu grazie al benvolere di Chcrmside che, giunto il momento della evacuazione degli irregolari egiziani che tenevano quella posizione , una parte di questi passò al soldo italiano. Saletta, dopo qualche tempo, forse illudendosi che ormai Saati era divenuta di fatto italiana, fece costruire alcune costruzioni in murarura e sostituire quegli irregolari ex-egiziani con altri irregolari assoldaci direttamente dagli italiani a Massaua. Ma su questa seconda fase della presa di possesso italiana di Saati torneremo più tardi. Cfr. Storia militare della Colonia Eritrea, cit., p. 94. È difficile rendersi conto di quante complicazioni, da una manovra apparentemente così precaria e assai poco 'eroica' avrebbero potuto verure.

9 AUSSME, Volumi En"trea, v. 2, alla data dell'8 luglio 1885.
IO lvi, alla data del 9 luglio 1885
400 L'ESERCITO NEU.A POLITICA COLONIALE
va bastare la fiducia che gli dimostravano i suo i superiori:. 11
Ricotti, quindi, non era disposto a mutare in nulla le istruzioni che Saletta aveva a suo tempo ricevuto, e che pure questi in qualche occasione aveva oltrepassato (la questione Saati era esemplare). Al colonnello non rimase così che rinunciare qualche giorno dopo alla sua richiesta; adducendo come pretesto l'acutezza della situazione sanitaria e la «malattia:. che aveva ponato a fme prematura il suo stesso vice 12 , il colonnello rimaneva Comandante Superiore delle Truppe in Mrica, ma di altre e più vaste istrUZioni non si poteva nemmeno parlare.
Prima che dal presidio italiano, però, le principali novità dovevano venire in quei mesi proprio dalle popolazioni abissine.
La calma intorno a Massaua si andava di giorno in giorno deteriorando. Il Comando Superiore era se mpre più impensierito dai pericol i di scorrerie e di puntate offensive dei ribelli mahdisti 13; qualsiasi spedizione di civili italiani verso l'interno dell'Abissinia veniva sconsigliata 14 . Qualsiasi individuo sospetto di aiutare i 'predoni' veniva duramente punito: un abissino, capo di una carovana che trasponava cereali (che pure solo si supponeva destinata ai 'briganti'), per aver tentato di l asciare Massaua se nza l'autorizzazione delle autorità occupanti, venne condannato ai lavori forzati 15.
Ma non si trattava di episodi isolati: tutto il mese di agosto fu segnato dagli allarmi lanciati da Saletta a Roma. Il colonnello scrisse al Ministero della Guerra per segnalare l'utilità che qualsiasi carovana fosse sco nata da truppe italiane l6, per sotto lineare il perico lo dei predoni 17 , per ric ordare ai suo i superiori che - per via del caldo e della rinnovata turbolenza della zona - dovevano considerarsi interrotte le manovre di istruzioni che sino ad ora erano state condotte
11 Ibidem . Da militare a militare , Ricotti scrisse qualche giorno dopo a Salena che , in verità, aveva fano male a prendersela così ramo per qualche attacco dei giornali pen· rarchici e della sinistra. eGli apprezzamenti poco benevoli che provengono da certi straci sociali - sentenziava Ricotti a proposito delle accuse dei giornali democratici e 'operai' al colonnello - tornano maggiormemte ad onore e sono quasi sicura prova del retto operare di coloro che intenderebbero colpire•. Che era un po' un ragionamento da ancien regime. lvi , alla data del 17 luglio 1885.

l 2 lvi, alla data del 15 luglio 1885.
13 Cfr. ivi, alla data del l agosto 1885.
14 Cfr. ivi, alla data del 4 agos to 1885
Cfr. ivi, alla data del 29 agosto 1885 .
16 Cfr. ivi, alla data del 14 agosto 1885
17 Cfr. ivi, alla data del 15 agosto 1885
VERSO DOGAIJ 401
al di fuori del perimetro di Massaua 18. Infme, nell'ultima settimana di agosto, Saletta comunicava allarmato che una grossa banda di 'predoni' (più tardi si seppe che erano uomini di Ras Alula) aveva effettuato una scorreria nei pressi di Ua-à, a pochissimi chilometri da Massaua 19: e non molto lontano le truppe del Ras stavano battendo la regione del Goggiam alla ricerca di mahdisti.
Fu in questo complesso e pericoloso scenario, che proiettava le sue ombre sino a quasi le porte di Massaua, che da Saati si ritirarono gli irregolari egiziani (poi passati in forza al Comando italiano) e vi rimasero solo truppe irregolari direttamente al soldo degli italiani. Già questo era un mutamento che, per quanto apparentemente di scarsa importanza, doveva risultare agli abissini un segnale sufficientemente esplicito dell'interesse di Saletta per Saati.
Inoltre, Saletta ordinò di far costruire sulle alture prospicenci la località alcune piccole casermette in murarura 20 , che avrebbero dovuto avere la funzione di ospit.are gli irregolari italiani e di aiutarli nel loro compito di osservazione sul confine abissino. E di rutto questo, puntigliosamente, volle avvertire Ras Alula.
Per Ras Alula, che come abbiamo visto in quei giorni era già impegnato nella sua guerra politica e religiosa contro i musulmani (ma poi per lo stesso Negus, quando questi venne a sapere della più stabile sistemazione degli italiani a Saati) questo era troppo.
La risposta di Ras Alula fu immediata ed altera
Mi avete detto che andrete a piantare i vostri rucul a Saati ; ciò non sta Non solo i rucul ma anche le genti che sono a Saati non debbono rimanervi ; la terra appartiene al Negus. Io non posso comandarvi. Dunque sgombrate Saati 21
La minaccia di Ras Alula era grave.
Proprio in quei giorni il capo abissino aveva mostrato di volere e poter riprendere la sua guerra ai ribelli mahdisti, e per questo scopo aveva armato un consistente nerbo di truppe 22 . Avrebbe egli voluto riprendersi anche Saaci? La preoccupazione, a Massaua e poi a Roma, diveniva di colpo la nota predominante: si ripresentava il timore di un insuccesso 'contro i Negri'?
18 Cfr . ivi, alla data del 21 agosto 1885 .
19 Cfr. ibidem.
20 Cfr. Storia militare della Colonia Er-itrea, ci t., p. 20.
21 Cfr. anche DEL BOCA , Gli ilaliani in Afn'ca orientale. Dall'unità alla marcia su Roma , c it ., p . 20 9.
22 Cfr. BATIAGLIA, La pn'ma gue"a d 'Africa , cit. , pp 220-221.

402 l 'ESERCITO NELLA POUTJO. COLONIALE
L'Italia si trovava di colpo spiazzata e impreparata di fronte all' atteggiamento bellicoso ed al minaccioso ultimatum di Ras Alula. Quel poco di attività politica e diplomatica italiana di quei giorni, che non fosse stata interrotta dalle ferie estive, correva infatti su tutt' altri binari. C'era stato il timore, in quelle settimane, di trovarsi di fronte ad una manovra inglese che avrebbe potuto escludere l'Italia da un accordo diretto Gran Bretagna-Etiopia , a riguardo di Cassala 23. Si era anche assistito al ripresentarsi proprio in quei giorni di una cena divergenza di interessi e di analisi tra ambienti diplomatici ed ambienti militari, a proposito del tema cruciale dell'indirizzo da darsi a futuri eventuali rapporti italo-abissini. Nei circoli della Consulta andava prendendo piede l'idea che- sia per ostacolare eventuali piani britannici tendenti ad emarginare l'Italia dai contatti con il Negus, sia perché ormai appariva cosa di per sé sempre più necessaria - sarebbe stato utile per l a politica coloniale italiana inviare al Negus una missione diplomatica 24 . Tal e missione avrebbe potuto anche, nel migliore dei casi, risolvere la questione dei confini e chiarire meglio come dal trattato di Hewett si poteva passare alla nuova situazione politica e diplomatica rappresentata dalla presenza militare italiana a Massaua e nella zona circostante. L'idea non era ancora ben precisata ma si andava affermando. Nei circoli militari del Ministero della Guerra , invece, anche in seguito agli allarmi lanciati da $aletta nei giorni precedenti (anco ra non si sapeva nulla dell'ultimatum di Ras Alula) si riteneva che andasse co ncretizzata subito una qualche misura energica. Fosse essa la missione (che non avrebbe potuto escludere l'ipotesi , cara a Ricotti, di una riduzione degli effettivi del presidio di Massaua) o , meglio, qualche azione più propriamente militare (assicurando meglio la difesa di Massaua o scoraggiando quei 'turbo len ti indigeni', dando loro 'u na buona lezione') 2 5.
23 Cfr. ERLICH , Ethiopia and Eritrea Dun'ng the Scamble for AftUa.. , cit., p. 23.
24 Alcune (imprecise) notizie in ZAGHI, La missione Ferran· e Pozzolini in Abis· sinia, in cRivista delle co lonie italiane•, a. VII (1933) n. 9 (l'imp recisione è evident e anch e nel titolo).
n La missione diplomatica (e la demolizione dei tukul di Saati, se non la sua evacuazione) era invece assai ben vista dal Negus in persona nonché da Ras Alula, che sperava in un alleggerimento del suo ' fronte orientale' - gli italiani da Massaua - per poter dedicarsi alla decisiva lotta al mahdismo sul suo 'fronte: nord-occidentale'. Il fatto di aver disprezzato e sottovalutato i segnali di una benevola accoglienza abissina all 'i· potesi di una missione diplomatica italiana (segnali assai evidenti tra agosto e settemb re 1885) costituisce un'ulteriore aggravante del componamemo dei militari e dei politici italiani.

VERSO OOGAU 403
La non perfetta corrispondenza tra gli indirizzi dei due Ministeri, in sé cosa non nuova ma in quei giorni più carica di conseguenze, era divenuta chiara allo stesso Sale tta. Se, dalla parte della Consulta, il co lonnello era alla fine «lasciato giudice dell'opportunità delle cose» 26, dalla Pilotta g li arrivava invece un mandato amp io ma preciso.
Per dare maggiore sicurezza alle carovane che passano per Saaci ed impedire così che il commercio devii da Massaua ed anch e per non danneggiare il nostro prestigio in quei paesi , s'invita il colonnello Salerra a vedere se non fosse il caso, contrario a quanto gli venne già telegrafato per iJ passato , di far occupare Saaci ed anche qualche altra località intermedia ua Saaci e Monkullo con distacca.men· ti delle nostre truppe . In oltre gli si dice di esaminare la convenienza o meno di stabilire un turno periodi co per le carovane da e per Saati prendendo naruralmcntc necessari accordi con il capo abissino Ras Alula 2 7 .
Nonostante le solite contraddizioni (come facevano i militari italiani ad accordarsi con Ras Alula e nello stesso tempo occupare una località posta sotto il su o controllo?) , quell o che in tale dispaccio del Ministero della Gu e rra era significativo era che, in qualche modo , Ricotti sembrava accedere all'idea di riaprire le vie per una soluzio ne mtlitare per Massaua. Piu ttosto, e prima , che l a m issione diplomatica, doveva e sse re la forza militare che occupava Saa ti a garantire i rapporti tra Massaua, il Ras e d il N egu s.

Questa divergenza t ra militari e diplomatici ebbe però per l'immediato poche conseguenze perché, dal canto suo, ci pensò Ras Alula a far saltare tutti i piani: il suo ultimatum e la minaccia militare che esso comportava sve lavano comunque la l eggerezza e la scarsa conoscenza della real tà abissina co n cui spess o venivano a Roma stes i e immaginati i ' pian i ' coloniali.
Colto il Minist ero degli Esteri in una deli ca ta fase di inten'm , quale sarebbe stato l'atteggiamento delle a ut orità italiane? La questio ne di Saati, che Saletta in qualche modo era riu scito ad occupare , diveniva di colpo quella del suo sgombero, dal momento che non si voleva che proprio d a lla politica coloniale potessero venire al governo motivi di accuse od oc casioni di polemiche: lo stesso Mancini aveva perduto appena due mesi prima il suo posto di Ministro proprio per aver vo lu to annett ere troppa importanza all ' impresa di Massaua
404 L' ESERCITO NElLA
POUTICA COLONIALE
. 26 AUSSME, Volumi Enirea, v
2,
27 lvi.
.
alla data del 21 agosto 1885.
Da parte sua, il Ministero della Guerra aveva autonomamente iniziato a studiare la possibilità di prendere una drastica soluzione 'tecnica': dichiarare lo stato di guerra per il presidio del Mar Rosso. In questo senso era stato interessato l'Avvocato Generale Militare 28. Una tale estrema misura - oltre a riaffermare che la 'potenza' italiana non poteva essere intaccata dalle intimazioni di un 'indigeno' qualsiasi (come in fondo era visto Ras Alula) ed a risolvere taluni problemi di tipo giuridico interno ed internazionale - avrebbe portato a far considerare l'autorità militare (anche locale) quella superiore su ogni altra ed avrebbe potuto chiudere definitivamente il difficile e disonorante capitolo del condominio itala-egiziano a Massaua. Così facendo, inoltre, si sarebbe detto chiaramente a tutta l'Europa che l'occupazione italiana era definitiva e non transitoria, e che quindi qualsiasi azione militare si fosse colà voluto intraprendere (ad esempio, la stessa occupazione di Saati) sarebbe stata legittima.
Ma l'affacciarsi di una tale ipotesi bellicosa e 'militarista' non deve far credere che tra i militari (cioè tra quei pochi militari italiani bene al corrente degli eventi massauini) ci fosse univocità di giudizi.
Già tra Ministro della Guerra e Segretario Generale della Pilotta i pareri non concordavano perfettamente. Ricotti era convinto della necessità di rimanere a Massaua (ma c'era già chi lo metteva in forse?) pur essendo disposto a restituire Saati, anche se «solo dopo regolare trattato)) 2 9. Marselli, piuttosto che dall'incidente di Saati, era infastidito dali' idea della missione diplomatica, che avrebbe tolto ai militari la possibilità di poter decidere in autonomia: e in quanto Segretario Generale del Ministero della Guerra desiderava che l'eventuale personale militare dì quella missione fosse «ridotto allo stretto indispensabile» 30.
Diversa ancora era invece la posizione della Consulta. Per prima cosa si rimproverava la mossa di Saletta a proposito dell'occupazione di Saati, <<pesando su di quegli [Saletta] la responsabilità di tutto ciò che colà può accadere» 31. Ma soprattutto si sollevava il tema della missione diplomatica.
Che con una tale missione si potesse risolvere tutto, era cosa che
28 lvi, alla data del 31 agosto, e cfr. poi alla data del 13 settembre 1885.
29 AUSSME , Carteggio Eritrea , racc. 121, fase. 11, 3 settembre 1885, Ricotti aMarselli.
30 lvi, 13 settembre 1885, Marselli a Ricatti.
31 AUSSME , Volumi Eritrea, v. 2, alla data del 2 settembre 1885.

VERSO DOGAU 405
non convinceva i militari e particolarmente Saletta. Il quale, oltre ad essere seccato da quella che lui considerava una 'intromissione' di civili (i d iplomatici) in un fatto secondo lui tutto militare (l' occupazione di Massaua e la questione di Saati), sembrava assai preoccupato dalla situazione locale. Nei giorni seguenti l ' ultimatum abissino, il colonnello aveva spedito a Roma più di un segnale di allarme circa la rinnovata turbolenza della zona: fosse il caso di una supposta ostilità tra abissini ed arkikesi 32 , di invii di armi a Ras Alula da pane del Governo egiziano 33 e di razzia di d ervis·ci a soli quindici chilometri da Massaua 34 . Tutto agli occhi di Saletta, con quella Saati ancora italiana, sembrava segnalare il pericolo per la colonia di un aumento della tensione.
Riassumendo, si potrebbe dire che questo era il risultato dell' ultimatum di Ras Alula: al disorientamento grande seguito in Italia alla notizia della caduta di Khartum pareva, in quei giorni di settembre, esse re subentrata una cena confusione. Si era forse intuito il grado di minaccia politica e militare costituito dall'ultimatum, ma in realtà non si sapeva cosa poter fare per evitarla.
La politica coloniale italiana si pose, anche in quei giorni, al rimorchio degli eventi. Lo 'stellone', però, aiutò ancora una volta.
Ras Alula, infatti, era in quei giorni più preoccupato di infliggere un duro colpo all'effervescenza mahdista che dell'occupazione italiana del villaggio di Saati. E fu per questo che non fece seguire, all 'ultimatum, quell'azione militare che tanto aveva impensierito Saletta 3).
Saati rimaneva così italiana, almeno per allora. E giorno dopo giorno le nubi su Massaua erano destinate, per qualche tempo , a disstparsi.
Rimaneva comunque il fatto che, di fronte al presentarsi del più grave rischio politico e militare per Massaua dal giorno della sua occupazione militare (che cosa avrebbe potuto accadere se Ras Alula con qualche migliaia di armati fosse sceso su Saati o su Massaua? E che cosa avrebbe salvato Saletta e gli italiani se davvero, oltre alle
32 lvi , alla data del 14 settembre 188).

33 lvi, alla data del 16 settembre 1885.
}4 lvi, alla data del 13 settembre 1885.
35 Ras Alula pattì nella sua campagna contro i Dervisci, ch e culminò nella battaglia di Kufit (23 settembre 1885) dopo aver lanciato i suoi ultimatum per Saati e dopo aver ricevuto da Saletta la promessa dell'invio di una missione diplomatica italiana ad Asmara e dal Negus .
406 l 'ESERCITO NEllA POUTICA COLONIALE
bande del Ras, si fosse mosso anche solo una parte dell'esercito del Negus, per conto del quale Alula agiva in quelle zone?), Ministero ddla Guerra e Ministero degli Esteri non erano riusciti ad intervenire né attivamente né rapidamente né concordemente .

Questa confusione (che ancor prima che frutto di una lotta tra vere linee colonialistiche diverse, appariva come un risultato sia della disinformazione sia de lla diversità degli interessi e degli scopi) doveva risaltare massimamente in merito alla questione dello sgombero di Saati. Se al p rimo diffondersi delle notizie sull'ultimatum abissino non dovette mancare chi lo considerasse una misura necessaria ed intelligente 36, con il passare dei giorni e coll'affievolirsi delle possibilità che Ras Alula - adesso allontanatosi dalla zona di Saati per dare la caccia ai ribelli mahdisti - decidesse di intervenire militarmente sul nuovo possesso italiano, lo sgombero di Saati andava sfumando la sua urgenza. Anzi, ent rava in gioco l'onore italiano.
Il punto di vista italiano era chiaramente e sinceramente espresso qualche giorno dopo in un dispaccio del Ministero della Guerra a Saletta .
Si scrive al colonnello Saletta che sarebbe nosuo intendimento di lasciare Saati e di limitare l'occupazione del territorio circostante a Massaua fino ad Arkiko ed a un punto a qualche chilometro da Monkullo verso Saati ( ... ) Però dopo l'orgogliosa lettera di Ras Alula relativamente alle capanne che dovevano ricostruirsi a Saati pel ricovero degli irregolari, il trattare di volontario abbandono potrebbe sembrar atto di debolezza anziché una pura condiscendenza del rutto spontanea 37.
Prevaleva quindi l'indirizzo di rimanere a Saati.
Doveva finire in una bolla di sapone il grave per icolo corso dal presidio di Massaua? Purtroppo, per la persona di Saletta, non era così.
Se anche nulla cambiò nella dislocazione delle truppe di occupazione coloniale italiana in Mar Rosso (e se anche, quindi, nulla fu fatto per venire incontro alle proteste abissine per la questione di Saati e tutto rimaneva tale e quale Ras Alula aveva dimostrato di non gradire), quello che in qualche modo venne meno negli ambienti politici fu la fiducia in Saletta. La sua immagine, già insidiata da que lle continue richieste di truppe e di materiali, non disgiunte da quella sua dichiarata tend enza ad avanzare la linea 'difensiva' del
36 Da vari accenni pare che questa fosse l'opinione personale di Depretis. 37 AUSSME, Volumi Eritrea, v. 2, alla data del 23 settembre 1885.
VERSO DOGALI 407
presidio militare di Massaua, era stata fortemente indebolita dal contrasto avuto con Noce nel luglio (un conuasto che aveva di fatto esposto la prima colonia italiana al pericolo di una crisi 'istituzionale'). Infine, la questione di Saati aveva definitivamente minato la sua figura di Comandante militare locale.
Tutto ciò andava coincidendo con la rinnovata insoddisfazione - militare (anche di Ricotti) ma poi politica e generale - verso il 'condominio' istituzionale a Massaua, nei cui confronti si stava consolidando la convinzione di dover d'ora in poi tenere «Un atteggiamento più risoluto• 38.
Fu in questa atmosfera di insoddisfazione per l'operato di Saletta, all'incirca al l a metà di settembre (di fatto verso la fine di quell' inten·m in cui Depretis aveva programmaticamente stabilito di non vo ler, invece, fastidi dali' Africa), che si riunì il Consig lio dei Ministri con all'ordine del giorno le nuove necessità del presidio di Massaua. L'unico risultato concreto di quella riunione fu così quello di andare, in tempi da definirsi, verso il superamento del condominio e soprattutto di procedere alla sostituzione di Saletta 39. Di fronte alla spigolosa ed irrequieta figura del colonnello fu scelta la più bonaria e quieta personalità del generale Carlo Genè, le cui uniche qualità 'col oniali' erano quelle di essere un generale (come vedremo) e di essere momentaneamente Direttore dell'I st ituto Geografico Militare di Firenze 40.
Il grado di generale serviva perché, per arrivare a l superamento del 'condominio', era necessario che fosse chiaramente stabilito quale era il militare italiano ad avere la superiorità gerarchica su tutti gli altri , fossero essi della Marina o dell'Esercito. Era infatti in questo senso che «SÌ decise di riordinare rutti i servizi del presidio del Mar Rosso e che al Maggiore Generale Genè ne [fosse] data la direzione generale, e che quindi a l ui [dovessero] far capo tutte le varie autorità che hanno interessi in quella località» 41 . Ma , a pane la nomina di Genè alla successione del colonne ll o (nomina che non esauriva ma che era solo il primo passo verso l'accentramento politico e ammini-
38 L'espressione di Robilant, che bene sintetizza il suo pensiero , è in un suo dispaccio al R. incaricato d'affari al Cairo. De Martino. Cfr. i11i, alla data del13 settembre 1885.

39 Cfr. ivi, alla data del 19 settembre 1885.
40 Il grado di generale serviva per rendere effettiva la carica divisionale che dall'aprile i presidi di Massaua rivestivano e per poter meglio subordinare a quella carica rutti i servizi italiani, civili e militari , della Marina e dell'Esercito , presenti in colonia.
41 Cfr. ancora AUSSME, Volumi Eritrea, v. 2, alla data del 19 settembre 1885.
408 L' ESERCITO NE.Ll.A POUTICA COLOMAI.E
strativo della colonia al Ministero della Guerra, come vedremo) e la decisione che non ci si sarebbe mossi da Saati, l'unico effettivo provvedimento concreto preso dal Consiglio dei Ministri del settembre era appunto la destituzione di Saletta.
Proprio colui che tanto aveva fatto - anche oltre le istruzioni politiche e militari ricevute- per arrivare a Saati, doveva andarsene una volta che si era deciso a restarci.
A pane questo paradosso, rimane l'impressione che i governanti italiani credessero che la complessa situazione politica , militare, istituzionale creatasi - come abbiamo sin qui visto - a Massaua fosse risolubile con la semplice misura tecnica di perfezionare la struttura del Comando: quasi dimenticando che il pericolo maggiore corso dal presidio in quell ' ultimo mese non era dovuto ad una questione di architettura istituzionale bensì - più concretamente - al sommarsi della ormai già nota irritazione abissina verso la presenza italiana a Massaua con la nuova e radicale opposizione di Ras Alula a quella pratica militare di Sale t ta che - dal pono ai fonini a Saati - poteva ben far credere volontà espansionistiche e spinte aggressive italiane, dalla costa verso gli altopiani e contro l'Impero etiopico. Per àlleggerire il clima politico e diplomatico intorno al presidio di Massaua, praticamente , assai poco fu fatto: si sostituì Saletta, è vero , ma si rimase a Saati.

La stessa idea della missione diplomatica, come vedremo, sembrava perciò destinata a perdere sempre più di interesse agli occhi del governo e dei Ministri.
A fine settembre 1885, poco meno di otto mesi dopo lo sbarco di Massaua, magro era quindi il bilancio della ' potenza' coloniale italiana : nessuno sgombero di Saati , almeno per allora; nessun patteggiamento con gli 'indigeni' (fossero essi piccole tribù degli altipiani abissini o plurisecolari imperi dell' Mrica orientale); attendismo e nessuna considerazione d eli' importanza dell ' attività diplomatica; nessuna particolare misura militare di rinforzo del presidio italiano con truppe o servizi; sostituzione (in un momento di fatto delicato) del Comandante Militare.
Che cosa sarebbe rimasto dalla politica coloniale italiana se considerazioni politiche e strategiche (legittime dal punto di vista etiopico) non avessero fatto preferire a Ras Alula una campagna contro i mahdisti ad un colpo di mano su Saati o Massaua?
Solo dopo Dogali si sarebbe potuto apprezzare in Italia l'entità del pericolo che , tra agosto e settembre 1885, politici e militari italiani avevano eccessivamente sottovalutato.
VERSO DOG AU 409
Verso un 'nuovo' corso con Genè e Robtlant
Tra il settembre e l'ottobre 1885, oltre all'atteggiamento abissino (e contemporaneamente ad una nuova considerazione britannica della vantaggiosità per Londra di un più saldo stabilimento italiano in Mar Rosso) 1 , un altro evento doveva segnare la politica coloniale italiana. Dopo tre mesi di inten·m di Depretis, anche per il diretto intervento di Re Umberto I , la Consulta tornava ad avere uno stabile Ministro: si trattava del conte di Robilant.

Ex-ambasciatore a Vienna, Robilant non aveva mai mostrato di apprezzare oltremodo la situazione in cui i 'piani' coloniali di Mancini avevano cacciato l'Italia 2 Convinto sostenitore dell' importanza della Triplice, era certo che i problemi più grossi l'Italia li aveva sul fronte continentale, sul quale un eventuale appoggio inglese (secondo Mancini ottenibile grazie a punti di intesa con quella potenza, punti che avrebbero invece per forza di cose dovuto interessare ambiti mediterranei) non sarebbe stato di grande aiuto per Roma. Robilant, non avrebbe quindi tardato a dare a tutta la conduzione ddla politica estera italiana un tono più conservatore e più triplicista. Tutto questo fu sensibile in maniera chiara più tardi (quando, il divampare del conflitto nei Balcani minacciò di mettere in crisi l' assetto europeo in maniera assai più radicale di quanto, qualche anno prima e sotto il ministero di Mancini, avevano potuto i conflitti marittimi e mediterranei tra Francia ed Inghilterra per l'Egitto). Ma qualcosa cominciò sub ito a farsi evidente, già nei primi giorni di permanenza di Robilant alla Consulta, proprio sulla, questione coloniale.
Già nel settemb re l'Italia era parsa incamminarsi sulla via di un atteggiamento 'più risoluto' (sostanzialmente verso l'abolizione del 'condominio'). Robilant si inserì in questa tendenza e la portò con decisione alle sue necessarie conseguenze.
Già sulla questione della missione diplomatica al Negus, che avrebbe comportato che un paese 'civile' come l 'I talia riconosceva di andare a trattare con un 'sovrano africano', Robilant non sembrava entusiasta. E tra i primi suoi provvedimenti ci fu qudlo di ritardarne i preparativi di quasi due mesi 3. Sulla questione dello sgom-
1 Influiva, in questo senso, il mutato orientamento politico del Governo di Londra.
2 Cfr. ZAGHI, P.S. Mancini e la questione del MediteTTaneo 1884- 1885, cit., pp. 150·1)1.
3 Cfr. AUSSME, Volumi Entrea, v. 2, alla data del 7 ottobre 1885.
410 L'ESERCITO
NELLA POliTICA COLONIALE
bero di Saati, inoltre ribadì e rafforzò il concetto che, 'per l'onore della patria', non era decoroso abbandonare quello che si era già occupato 4 . E in buona pane si dovette proprio all'azione diplomatica di Robilant ed al suo atteggiamento 'militare' se nel dicembre si poté arrivare finalmente al superamento del 'condominio' di Massaua, con il 'colpo di stato' di Genè (come fu chiamata la sostituzione del potere militare italiano a quello egiziano, ancora formalmente valido per via del Trattato di Hewett) 5.
Tutto questo nell'accezione di Robilant era fatto non tanto per dare al presidio del Mar Rosso quella omogeneità interna e quella solidità istituzionale necessarie per andare avanti nell'opera di espansione coloniale verso l 'interno dell' Mrica, quanto per poter accantonare una volta per tutte un fastidioso problema che non prometteva nulla di molto interessante per la volontà di 'potenza' europea dell'Italia umbenina.
In conclusione - se anche il governo con la sua riunione del settembre non lo avesse già sufficientemente determinato - con Robilant agli Esteri la politica coloniale italiana doveva diventare una questione di interesse politico e diplomatico assolutamente secondario per l'Italia. Sempre che condotta militare o minacce abissine lo avessero permesso.
Nonostante questa (perlomeno decisa e chiara) impostazione politica, è comunque interessante dare uno sguardo più ravvicinato alle vicende di quel mese e mezzo in cui Saletta - avuto notizia del suo prossimo trasferimento- rimase a Massaua ad attendere Genè.
Il co lonnello non era rimasto spettatore silenzioso di fronte alle correzioni nella politica coloniale che erano andate maturando. Egli aveva avuto un peso non trascurabile nella decisione di non sgomberare Saati. E, come si vedrà, stringendo una sorta di patto d'azione con tal une tribù musulmane d eli' entroterra massauino (una mossa che Rase Negus, copti, mai gli avrebbero perdonato), avrebbe in-
4 Cfr.
data del 25 settembre 1885.
5 Sarebbe interessante conoscere meglio i retroscena diplomatici, italiani e b!itanoici, dell'operazione politica del 'colpo di stato' di Robilante Gené a Massaua. E vero che, dal punto di vista politico, la mossa del2 dicembre eliminava in gran parte i fastidi e gli ostacoli del 'condominio'. Ma è anche vero che - a parte questo- non mutava niente nella conduzione politico-militare del primo presidio coloniale italiano: né nei rapporti col Negus o con Ras Alula, né in quelli con le popolazioni musulmane circostanti, né nella linea militare 'difensiva' (fortini -Saati). Volle forse sembrare una prova di forza , ma lasciava inalterati tutti i principali punti di debolezza (e di pericolo) del primo colonialismo italiano.

VERSO DOGALI 411
ivi , alla
fluenzato in qualche modo il successivo corso degli eventi.
Il colonnello aveva tempestato di rapporti tra settembre e ottobre le autorità militari della Capitale, ora accettando di differire la questione dei conflui (cui teneva molto) purché perlomeno fosse trovato un modus vi vendi con le tribù viciniore 6, ora sostenendo la necessità di mantenere Saati occupata da truppe regolari e di istituire con truppe regolari italiane vere colonne mobili lungo le carovaniere che da Massaua conducevano al villaggio occupato 7, ora prospettando gravi pericoli in caso di sgombero e lamentandosi del persistere del 'condominio' istituzionale 8
Ma - soprattutto - Saletta era «fermissimamente contrario» allo sgombero di Saati 9. Se il nucleo di tale sua convinzione era chiaramente comprensibile (tenere Saati poteva vol er dire mantenere aperta la via per gli altipiani, per Keren, ed oltre), le motivazioni con cui la argomentò con insistenza al Ministro della Guerra erano le più varie. Abbandonato Saati (pur signilicativamente e spontaneamente definito «isolato, privo di ogni risorsa all'infuori dell'acqua») 10, Salet ta sosteneva che le carovane avrebbero dovuto fare sosta a Monkullo dove invece l'acqua non abbondava e dove un qualsiasi ulteriore rifornimento idrico per le carovane sarebbe andato interamente a scapito di quello di Massaua. Inoltre, diceva , si sarebbe data una motivazione in più al Negus e agli abissini che in quei giorni mettevano in giro voc i sulla 'irrisolutezza' degli italiani 11 : proprio quando il monarca abissino cercava in più villaggi di far pressioni sulle rimanenti vestigie di governo egiz iano locale contro quei 'Naib' che in qualità di propri rappresentanti gli italiani avevano intanto collocato (e stipendiato) in posti di responsabilità ad Arkiko, Otumlo o Monkullo 12
Nella sostanza, colui che accettava più di tutti le posizioni di Saletta era il nuovo Ministro degli Esteri , conte e generale Robilant. Anzi. Se Saletta non voleva ritirarsi da Saati ma almeno credeva cosa importante discutere col Negus, nella missione diplomatica che
6 Cfr. AUSSME, Volumi En.trea, v. 2, alla data del 7 ottobre 1885.
7 Cfr. ivi, alla data del 10 ottobre 1885.
8 Cfr. t'vi, alla dara del 15 ottobre 1885.
9 AUSSME, Volumi En.trea, v. 43, 13 ottobre 1885, Saletta a Ricorri. 10

412 L'ESERCITO
NELLA POUTICA COLONIALE
Ibidem.
Ibidem.
Ibidem.
11
12
si andava profilando, di un possibile accordo bilaterale sulla questione dei confini, Robilant conveniva con il colonnello che l'onore della Patria impediva che si indietreggiasse da Saati, ma proponeva addirittura di non parlare di confini con il Negus nella missione ( quando mai si fosse fatta): forse nella segreta speranza che gli abissini avessero un giorno potuto accettare il dato di fatto dell'occupazione militare. Perché ogni cosa - aggiungeva Robilant- andava condotta <<in modo tale da preservare intiera la nostra dignità e da escludere ogni apparenza di debolezza» 13.
Chi voleva differenziarsi da Saletta, invece, proprio perché non ne condivideva la tendenza verso imprese militari impegnative e costose, era addirittura il Ministro della Guerra.
Cesare Ricotti scrisse così al collega della Consulta che, se anche i motivi politici impedivano il ritiro da Saati, i motivi militari (nella personale analisi fattane da Ricotti) dicevano invece con chiarezza quanto pericoloso doveva essere per l'Italia e per il presidio del Mar Rosso tenere quella posizione 14 . Il pensiero di un possibile colpo di mano abissino su Saati doveva aver colpito, correttamente, l'immaginazione del generale novarese: per questo motivo egli proponeva (ma alla lunga non venne poi accontentato) che a presidiare il villaggio fossero al massimo truppe irregolari. «Non saremmo costretti ad operare d'urgenza se venissero presi i Basci-bazouk», terminava il Ministro l5. Il Ministro, già seccato per i vari grattacapi che Saletta gli aveva procurato con quella sua ripetuta volontà di espansione coloniale a tutti i costi (anche 'in sedicesimo'), andava convincendosi sempre più di quella impostazione 'difensivistica' e di raccoglimento coloniale che il Governo aveva pure varato alla fine della primavera. Impostazione che Ricotti non era alieno dali' interpretare nel senso di affrettare i tempi di una drastica riduzione dell'impegno militare italiano.

Se non era quello il momento, ad un mese e poco più dall'ultimatum di Ras Alula, per parlare di riduzione della forza dell'esercito sulle coste del Mar Rosso, certo Ricotti era assolutamente convinto che quell'autunno-inverno che si andava aprendo non avrebbe do-. vuto assolutamente impegnare la politica coloniale italiana in alcuna velleità di espansione. In questo senso, come a proposito di Saati Ri-
l3 lvi, 7 novembre 1885, Ris., Robilant a Ricotti.
VERSO DOGALI 413
14 Cfr
15
AUSSME , Volumi Eritrea, v. 2, alla data del 12 novembre 1885.
Ibidem.
cotti si erà differenziato da Saletta e da Robilant , il Ministro della Guerra non ebbe alcuna esitazione a differenziarsi da tal uni ambienti dello Stato Maggiore.
A riprova di questo sta l'esito negativo che la Pilotta volle imporre ai timidi ma significativi tentativi di taluni ambienti militari e diplomatici di riaprire un fronte di espansione coloniale italiana che da Massaua menasse , questa volta, verso Harrar.

La cosa non era in sé nuova: già Mancini aveva tentato questa via , anche nei suoi colloqui con Londra , ma con gli esiti che abbiamo prima ricordato La ripresa autunnale d e ll o Harrar come meta coloniale italiana sembrava destinata a compiere analoghe parabole.
Tutto era panito da quella che sembrava , un ' altra volta, una disponibilità britannica. Un'imponante carica militare inglese di stanza ad Aden, il maggiore Hunter, aveva mostrato un ceno favore durante alcunj suoi contatti con militari italiani nell'estate 188 5 a proposito di una possibile occupazione italiana dello Harrar e di Zeila suo capoluogo 16. Un ufficiale italiano di St ato Maggiore era stato designato a prendere ulteriori contatti , nell ' agosto, con l' ufficiale inglese per sondare quanto nelle sue affermazioni c' era di personale e quanto invece di ufficioso 17 In ottobre, dopo la nomina di Robilant , la Consulta ste ss a richiese al Ministero della Guerra che venissero inviati due ufficiali italiani , in incognito , ne llo Harrar per sondare meglio l'attualità del piano 18.
Significativamente , invece, Ricotti negò la legittimità e l'importanza di qualsiasi ipotesi di espansione militare del presidjo coloniale. Giudicò tutto l'interessamento «non necessario:. e ironicamente propose che la Consulta inviasse essa qualche civile nello Harrar «poiché per quanto può ave r tratto con le esigenze militari di una spedizione in quella regione il Ministero possiede già daci sufficienti:. 19 . In realtà , dati ed informazioni esa tt e sull ' Africa non furo no mai troppo abbondanti alla Guerra , e il diniego di Rico tt i rive lava la sua intima convinzione che per allora la prima colonia italiana doveva rimanere quello che era , a Massaua.
Se era contrario ad espansioni coloniali (e gli eventi de il' agosto -
16 Cfr. i vi, all a data del 5 agosto 188 5.
17 Cfr. ivi, all a data del 26 agosto 188 5
18 Cfr. ivi, alle d ate del 19 ottobre e d el 25 ottobr e 1885.
19 l vi, alla data del 29 ottob re 1885. Il Ministero degli Affari Este ri fu poi costretto a soprassedere a q uesti suoi inte ressi p er lo H arrar. Cfr. ivi, a ll a d ata d el 2 n ovem b re 1885.
4 14 L'ESEROTO NE1.LA
POLITICA COLONIALE
settembre e di Saati lo dovevano ancor più convinto), Ricotti non era però insensibile a quella cosa vaga ma fonemente sentita che andava sotto il nome di 'onore dell'esercito' e giudicava negativo tutto quello che limitava od ostacolava l'autorità dei rappresentanti militari nel presidio del Mar Rosso. Era perciò avverso al 'condominio' italo-egiziano. Così, dopo la nomina di Genè e durante i lavori preparatori per la stesura del decreto che ne avrebbe stabilito le competenze quale Comandante Superiore italiano a Massaua, il Ministro deHa Guerra fece in modo di ottenere un'autonomia quanto più larga possibile per il nuovo Comandante militare.

Dalla Marina, il cui ruolo veniva drasticamente ridimensionato, la Pilotta poté esigere la sostituzione di Noce, che con la sua anzianità di servizio - maggiore di quella di Genè, nùovo incaricato del Comando Superiore - avrebbe potuto ricreare quegli intralci che tanto avevano indispettito il colonnello Saletta 20. Dagli altri Ministeri, Ricotti poté ottenere - con l'avallo della presidenza del Consiglio 21 - un decreto di nomina di Genè con una larghezza tale di attribuzioni che prevedeva persino la supervisione personale del Comandante Superiore nelle questioni correnti e contabili delle varie amministrazioni civili italiane (Poste, eventuali lavori pubblici etc.) presenti sul territorio della colonia 22 Di cariche minori, che avrebbero potuto dare ombra alla figura del Comandante Superiore ed al nuovo corso 'più risoluto' che si voleva varare - cariche quali un richiesto (da parte della Marina) Comando Locale Marittimo di Assab -, Ricotti volle che non si parlasse neppure 23.
Ma non era con la sola - pur imponante - abolizione del condominio e con una assoluta subordinazione di ciò che fosse italiano a Massaua al Comandante Superiore dell'esercito che si sarebbe potuto rendere più stabile il presidio coloniale di Massaua (come l'ultimatum di Ras Alula aveva ricordato essere necessario) o che si sarebbe potuto estendere la zona di occupazione coloniale italiana (come pure non cessavano di richiedere alcune forze politiche e qualificati settori dell'opinione pubblica).
Fu comunque con alle spalle questo scenario che Genè, con un
VERSO DOGAU 415
2° Cfr. ivi,
29
21 Cfr. ACS, Presidenza del Consiglio
,
alle date del
settembre e del 16 ottobre 1885.
dei Ministri
b. 58, f. 201. 22 AUSSME, Carteggio Entrea, racc. 39, fase. l, 23 ottobre 1885, Genala a Ricotti. 23 Cfr. ivi, 26 ottobre 1885, Brina Ricotti. Ma anche ivi, 2 novembre 1885, Ricotti a Brin.
decreto firmato dal Re il 5 novembre (ma che avrebbe avuto vigo re a Massaua dal1 o dicembre), prendeva possesso della sua nuova carica il 14 novembre e con il 2 dicembre in qualità di Comandante Superiore eliminava il con dominio egiziano e proclamava l'autorità italiana (e ci oè la sua) come l 'unica autorità effettiva sul territorio di Massaua 24 .
Con queste date doveva iniziare una fase di raccoglimento coloniale, quel raccoglimento che Saletta non aveva voluto garantire e che il Governo aveva invece già deliberato più di un se mestre prima. Non tutto doveva però andare cosl liscio.
Ancora allO novembre , il Ministero degli Esteri non sapeva quali erano le reali attribuzioni militari del Co mandante Superiore delle Regie Truppe nel Mar Rosso (questa era l'esatta, lunga definizione) e ne sollecitava comunicazione essendo ciò «divenuta cosa urgentissima» 25.
E il decreto del 5 novembre? E tutti gli studi per le attribuzioni del Comandante in cui il Ministro della Guerra pareva essersi tanto impegnato? E tutta l 'i mportanza che pareva essere stata accordata a queste misure dopo l'ultimatum di Ras Alula?
E, in generale, con quale prospettiva coloniale, con quali rapporti con le tribù abissine, entro quali conftni politi ci si sarebbe mosso il nuovo Comandante Superiore?
Insomma, ancora una volta con qualche preoccupante defoillance, si apriva una 'nuova' fase della sto ria della prima co l onia italiana.
Già Roberto Battaglia, che pure aveva condotto la sua ricerca su fonti documentarie diverse da quelle da noi utilizzate , si era lamentato nel 1959 della pochezza delle informazio ni storiche disponibili per il periodo in cui Genè mantenne il comando del nuovo possedimento italiano 26 . E come lui anche Angelo Del Boca, che ha ripreso e sviluppato la ricostruz ione degli eventi coloniali anni prima avviata da Battaglia 27.
Purtroppo anche noi - pur nella nostra più specifica e circosc ritta ricerca - non possiamo che ripe tere quel rammarico. Relati-
24 Cfr. AUSSME, Volumi En'Jrea , v. 2 , alle date ricordate.
25 AUSSME, Volumi Eritrea, v. 43, 10 novembre 1885, Urg.mo, Robilam aRicotu.
26 BATIAGUA, La pn'ma gue"a d'Africa, cit. , p. 211.
27 DEL BOCA , Gli italiani in Africa orientale . Dall' uni/ii alla marcia su Roma, cit., pp. 216-217, che appunto non riesce a dare - su tutte le vicende massauine del 1886 - più di due pagine di stampa.

416 L'ESERCITO NElLA POUTICA COLONIALE
vamente abbondanti per il primo anno, le testimonianze sul periodo successivo al 1885 della spedizione di Massaua sono scarsissime, come se rutti avessero voluto dimenticare e far dimenticare quei mesi : in parte, si potrebbe dire, questa poch ezza di informazioni è anche un indizio dello scarso interesse di quelle vicende. A Massaua, dopo Saati, pochi si interessarono. Comunque tutta la documentazione che abbiamo potuto consultare conferma il trend che abbiamo descritto sinora.
Genè era indubbiamente un altro carattere di militare rispetto a $aletta.
Se il colonnello si era sempre mostrato insoddisfatto ed esigente nei confronti delle autorità militari centrali, il nuovo Comandante, appena preso possesso della sua carica, scrisse invece al Ministero della Guerra che a Massaua «ogni cosa si svolgeva in modo regolare e soddisfacente» 28. Per tutta una lunga fase Genè si astenne dal ch iedere nuove truppe per il possedimento coloniale di sua competenza. Dodici giorni dopo il suo arrivo in colonia (un lasso di tempo che qualche mese prima era bastato a Saletta per rendersi conto dell ' insufficienza delle istruzioni ricevute , per rimediarvi con piena autonomia d'iniziativa, per chiedere l 'invio di truppe e servizi e per fare rim ost ranze al suo Ministro), quasi incredibilmente Genè scriveva a Ricotti: «Non sono ancora perfettamente in grado di completamente riferire circa a Massauv 2 9!
Persino quei civili che avevano dipinto Saletta come «freddo , riservato, contegnoso» 30, di Genè scrissero invece che
è un buon uomo, in tutta l'estensione deiJa parola. È anche un distinto e colto ufficiale: ma in lui emerge troppo la qualità del carattere mite e delicato, per farne quello che secondo noi dovrebbe essere l'ideale di un generale 3 1
Con un comandante di tale stampo, Ricotti (e il governo) poteva essere sicuro che non si sarebbero ripetute a Massaua le impazienze espansive di un Saletta.
Nel frattempo anche al Ministero della Guerra, a Roma, si avviavano le pratiche per normalizzare la quotidiana amministrazione della co l onia. Fu deciso di non dare più la preferenza, nella determi-
28 AUSSME , Volumi Eritrea , v. 43 , 14 novembre 1885 , Gené a Ricotti. 29 lvi, 26 novembre 1885, Gené a Ricotti.
3° CHIESI, NORSA, Otto mesi d ' Africa, cit .• p. 223. 31 lvi, p. 224.

VERSO DOGALI 417
nazione e n eli' invio degli ufficiali occorre n ti per i presidi africani, a coloro che ne avessero fatto personale domanda, scoraggiando così l'avvio di una particolare forma di volontariato militare 32. Fu stabilito di interrompere il rappono con i privati dellà Navigazione Generale per rutto ciò che riguardava traspono marittimo di personale e servizi pubblici, facendo provvedere a ciò la Marina militare 33. Fu data risposta negativa al romano conte Brazzà (socio in affari del conte Antonelli) che aveva chiesto alla Pilotta di poter vendere agli indigeni scioani un grande quantitativo di vecchie armi che, a quel tempo, giacevano in utilizzate in un deposito del Ministero della Guerra 34. Pur continuando a tenere Saati (cui però non si faceva più cenno), e quindi pur mantenendo aJl'estensione della col onia il carattere che il Capo dello SME avrebbe definito di 'testa di ponte offensiva', gli italiani si apprestavano così a varare sulle coste del Mar Rosso una politica - diremmo - difensiva, da ordinaria amministrazione.
Le pratiche tendenti alla normalizzazione della presenza militare italiana sul Mar Rosso, come le abbiamo appena ricordate, non erano slegate le une dalle altre, ma tendevano a ricomporsi in una manovra complessiva che Ricotti così delineava in un messaggio, riservato, indirizzato a Genè.
Si invita in via riservata il Comandante Superiore in Mrica a trasmettere un progetto panicolareggiato di dislocazione e di formazione dei singoli distaccamenti col criterio di avere la forza totale di essi ndotta a 2000 uomini , riservandosi il Ministero di tcadurlo in atto soltanto quando tale nomina venga ad essere consigliata da considerazioni politiche e sia indicata come opportUna dal Coman· dante Superiore 35.
Con Genè si voleva in somma allargare la strada del disimpegno militare: a questo doveva in fondo ridursi l'atteggiamento più 'deciso' vo l uto da Robilante concretizzatosi nel 'colpo di Stato' del 2 dicembre 1885.

Ecco il motivo di quella gestione del possedimento coloniale come se fosse stato un paesetto dell'Italia contadina del tempo, in cui non pare di essere in una colonia politico-militare europea in territorio africano ma in cui- anzi- tra genetliaco del Re, ricorrenza dello
32 Cfr. AUSSME, Volumi Eritrea, v. 4, parte prima, 22 novembre 1885.
H lvi, 25 novembre 1885.
34 Cfr. AUSSME, Volumi Eritrea, v. 4, parte terza, 2 dicembre 1885.
3) lvi, parte prima, 26 dicembre 1885.
418 L'ESERCITO NElL\ POUTICA COLONIAll
Statuto e cinquantesimo anniversario della fondazione dei bersaglieri, «osni occasione è buona per far festa» 36.
E solo così che si può inquadrare correttamente la vicenda della missione diplomatica italiana al Negus. È questo il primo importante event o del periodo di Genè (forse l'unico, se si esclude, per un aluo verso, Dogali) e di per sé dà l 'idea della volontà politica italiana di lasciare fermo tutto l'affare africano, di non voler riconsiderare a fondo la legittimità, la consistenza e gli obiettivi di un colonialismo italiano.

Un'ambasceria guidata dal (e di fatto quasi risuetta al) generale Pozzolini , figura di militare da anni membro di società geografiche e coloniali, deputato al Parlamento per il partito moderato 37, fu inviata sulle coste del Mar Rosso: ma, dopo qualche settimana di soggiorno a Massaua, venne richiamata in patria.
Costantemente promessa a Ras e Negus sin dai primi momenti dello sbarco a Massaua, per dare dignità e regolarità ai rapporti ua l'Italia e l'Abissinia, una missione ed un contatto diplomatico si erano di fatto resi necessari dopo l'occupazione di Saati per rassicurare il Negus sulle intenzioni italiane circa i confini del suo Impero. Ma come abbiamo visto, da più pani si era premuto perché essa perd esse la sua originale impostazione e fosse ridotta sostanzialmente ad una pura ambasceria da cerimoniale, senza che essa potesse discutere e risolvere la spinosa questione dei confini, la quale veniva così lasciata in balìa della forza delle armi (o del libero spirare dei venti diplomatici in Europa). In questo senso, il ritardare cont inuamente la data della partenza della m issio n e e il nominarne responsabile non più il Comandante Superiore di Massaua (come pure si era in primo tempo pensato) ma un generale che in precedenza non era stato affatto tenero colle forme prese dall'espansione coloniale italiana, davano di per sé l'idea di quantO poco a Roma si credesse ormai nell'utilità di trattative dirette it alo-abissine.
Un tale atteggiamento diplomatico si può ricavare dagli stessi documenti ufficiali. In un primo momento, il Ministero degli Esteri, in una circolare informativa agli ambasciatori italiani, aveva dichiarato che la missione Pozzolini aveva come scopo il raggiungimento d i «un accordo soddisfacente per tutte le pani• 38. Ma più tardi la
VERSO DOGAU 419
36 BATIAGLIA, La prima guma d'A/n'ca, cit. , p. 213. 37 Cfr •L'Esercito italiano• , 8 settembre 1885 , Un discorso dell'on Pozzolini.
Consulta rivelava che
il Governo italiano nello inviare il generale Pozzolini presso il Negus ha per unico scopo di dissipare le diffidenze che altri credette opporruno far nascere nell'animo suo [del Negus] per l'occupazione di Massaua e, ciò ottenendo, rassicurare noi pure intorno alle intenzioni del Negus a nostro riguardo e permetterei così di ridurre la forza di occupazione entro i limiti da noi desiderati per evidenti ragioni di bilancio ( ... ) Tutte le altre voci di protettorato e altro sono assolutamente false 39
Come se questo non bastasse, i rappresentanti italiani all'estero apprendevano che (se pure si fosse addivenuti, alla corte del Negus, a parlare di confini) Pozzolini «non era munito di pieni poteri per la stipulazione di un vero e proprio trattato».
Doveva quindi destare poca sorpresa che infine, 1'8 marzo, il Ministro degli Esteri scrivesse a Pozzolini ordinandogli di fare ritorno in Italia: e questo dopo che il generale era rimasto a Massaua oltre un mese e mezzo in attesa dell'autorizzazione della Consulta ad inoltrarsi verso l'interno etiopico.
La spiegaz ion e ufficiale fu trovata da Robilant nel fatto che il Negus non aveva risposto ad una missiva diplomatica italiana che gli annunziava l'arrivo dell'inviato del Regno sabaudo; e che, avendo abbandonato l'imperatore etiopico la normale residenza per i confini meridionali del suo regno, tutto era stato fatto in modo che «la sicure zza delle persone come il successo della missione [dipendessero] unicamente dal capriccio del sovrano africano» 40.
In realtà i motivi del richiamo di Pozzolini vanno cercaci in quella deliberata volontà (di non cercare impegnative trattative diplomatiche e di lasciare tutto nello status quo) che già nell'ottobre Robilant aveva teorizzato. Influirono indubbiamente, nel senso del richiamo di Pozzolini, anche cene interessate lettere che il conte Antonelli spedì da:l suo soggiorno nella eone dello Scioa alla Consulta e che affermavano il maturare di sentimenti ostili all'Italia da pane del Negus 41 .
3S Cit. in MANTEGAZZA, Da Massaua a Saati. Na rrazione della spedizione del 1888 in Abissinia, cit., p. XXXIII.
39 Ibidem.
40 Sono parole di Robilant citate in ZAGHJ, La missione Ferrari e Pozzolini in Abissinia, ci t., p. 877.
41 Cfr. BATTAGLIA, La prima guerra d'Africa, cit., pp. 222-224. Qualche anno più tardi vi fu chi vide, nel richiamo della missione Pozzolini, che stava «cominciando in embrione la politica scioana:.. MANTEGAZZA, La guena d'Africa Firenze, Le Monnier, 1891, p. 98. Lo stesso tecnico e distaccato Melli segnalava la gravità dell'occasione

420 l'ESEROTO
NELLA POUTICA COLONIJ\LE
Sia per questi mouv1, sia perché in Italia andava prevalendo un'atmosfera politica di smobi litazione (si era in quei giorni nell ' attesa delle elezioni politiche o di rimpasti governativi) 42 , la prima conc reta possibilità di sistemazione del contenzioso italo -a bissino era sfu mata.
Il richiamo della missione italiana inoltre non era certo una mossa delle più avvedute, se si conside ra il fatto che prima l'occupazione di Massaua e poi soprattutto il 'colpo di stato' del 2 dicembre continuavano a suscitare ancora, all'in izi o del 1886, risentimenti diversi tra i governi europei. Anche se non gravi.
L'Inghilterra, col suo nuovo Governo conservatore, era semp re meno disposta a fare concessioni all'Italia circa le quest ioni del Mar Rosso. Il Ministro degli esteri inglese non si peritò dali' affermare al Regio incaricato d'affari italiano a Londra che coll'occupazione di Massaua e poi con il 'co lpo ' del 2 dicembre «you have given me a good dea/ of troubfe» 43. Anche l'alleata Austria sembrò appoggiare una circolare diplomatica turca in merito alla fine del condominio italoegiziano e esternò un atteggiamento poco amichevole verso l 'alleato italiano (o che a Roma fu giu d ica to comunque assai meno amiche-
perdura dall'Italia, con il richiamo di Pozzoli.ni, per remare di migliorare i rapporti italoabissini. Con il richiamo della missione, così, «ormai si vide lo stato di guerra latente rra l'Italia e l'Etiopia, e l 'ottimismo del Governo non arrivava a dissipare le preoccupazioni•. B. MELLI, La colonia Entrea dalle sue origini sino al l marzo 1900, Parma, Battei, 1900 (2• ediz.). Allo stato attuale delle conoscenze non si può dire con cenezza se già allora, col 1885-86, ci fosse una linea scioana diversa e alternativa ad una linea massauaina (se non già rigrina). Certo c'erano iniziaùve personali diverse e sco/legate, ressure da interessi e legami poco chiari. Di quesù interessi, il conte Anronelli era la figura più rivelatrice. I suoi legami con la Consulta e - più direttamente - con la Corona datavano ormai da diverso tempo. Tra le molte alrre testimonianze di quei legami , si veda tra le carte dello Stesso Mancini uno scambio epistolare tra Antonelli , Mancini e Rattazzi (Segreteria parùcolare del Re) per via di una elargizione segreta- una delle tan te - ad Amonelli di 100.000 lire per non meglio precisare spese personali affrontate allo Scioa dallo stesso Amonelli e dal suo socio io affari, conte Brazzà (me rcante d'armi). Cfr. MCR, Carte Mancini , se. 648, fase. 16, doc. 9, 18 settembre 1884, Rattazzi a Mancini. Per l'azione di Anronclli, cfr. anche P. ANTONELLI, Rapporti sullo Scioa al R. Ministro degli Affari Ester-i dal 22 maggio 1883 al 19 giugno 1888, Roma, s.d. (ma 1889), pubblicazione diplomatica riservata di 18 esemplari (una copia anche io ACS , Carte Cnspi, serie Reggio Emilia, se. 9. fase. 18).
42 La comunicazione di Robilant a Pozzolioi era dell'8 marzo 1886. A Roma, nel Parlamento, dopo vari giorni di accese discussioni finanziarie, il 5 marzo il Governo era riuscito a scansare un voto di sfiducia a suerùssima misura. E la stampa già con il 16 marzo parlava di uno scioglimento probabile delle Camere. Si andava così irreversibilmente verso le elezioni del maggio.
43 AUSSME, Carteggio Eritrea, racc. 152, fase. 2, 31 dicembre 1885, Nigra a Mancini (copia).

VERSO DOG.AU 421
vole di quello della Germania di Bismarck) 44. Il tutto in coincidenza di una congiuntura diplomatica in cui sia la Turchia (dopo la temporanea risoluzione della crisi serbo-bulgara) sia il governo egiziano (insidiato da un ennesimo tentativo britannico di riordinare le fmanze) potevano sperare di essere benevolmente ascoltati dal concerto europeo delle potenze 45.
Durante i11886 il pendolo della situazione internazionale vide anche un pur debole e indiretto tentativo inglese di risolvere diplomaticamente la questione dei confmi italo-abissini, ma che non fu preso in seria considerazione dalla Consulta 46. E vide, più importante e più pericoloso, un tentativo francese di riequilibrare a vantaggio di Parigi la bilancia mediterranea con un avvicinamento diplomatico di lstambul a Parigi (in vista di un ipotetico parallelo allontanamento della Turchia dall'Inghilterra) 47. Il tentativo francese non riuscì dal momento che il colosso ottornano considerava i suoi interessi tutto sommato ben custodici dalla potenza britannica. Ma il fatto deve far riflettere, sulla delicatezza della situazione internazionale e in essa della posizione dell'Italia (come deve far riflettere, sul velleitarismo e sulla pericolosità di cene aspirazioni - politiche e militari italiane di quel tempo - ad una 'po liti ca di potenza', il fatto che quel tentativo diplomatico francese avesse fatto perno sulla diffusione da parte di Parigi di notizie riguardanti presunti preparativi militari italiani per l'occupazione della Tripolitania) 48.

Il 1886, e particolarmente l'autunno-inverno che lo concluse, fu soprattutto il periodo in cui il Regno di Umberto I cominciava a pensare al problema del rinnovo o della rifomulazione del trattato della Triplice Alleanza.
I problemi continentali, europei, erano così in quei mesi assai maggiormente rilevanti di quanto non lo fosse qualche avanzamento o indietreggiamento di alcuni chilometri (o il possesso o meno di qualche villaggio di capanne) in terra africana. Qualsiasi ipotesi che fosse diretta a 'tirare i remi in barca' a Massaua era quindi ben vista alla Consulta. Ecco perché, con Robilant che non voleva missioni o trattati fra l'Italia e i sovrani africani e 'incivili' (e con Ricotti che
44 Cfr. ivi, 4 gennaio 1886, Robilam a De l.aunay (copia).
4
5 Cfr ifli, 24 gennaio 1886, De Manino a Robilant (copia).
46 Cfr. ivi, 5 giugno 1886, De Manino a Robilant (copia).
47 Cfr. ivi, fase. 3, 16 sertembre 1886 (copia).
48 Cfr. ivi, 29 settembre 1886, Malvano a Robilant (copia).
422 L'ESERCITO
NEllA POUTICA COLONIALE
già dall'aprile-maggio 1885 aveva esplicitamente fatto capire a Saletta la sua volontà di un 'raccoglimento coloniale' e che aveva richiamato il colonnello al primo apparire di pericoli militari per via di Saati) Genè poteva esser sicuro che da pane di Roma sarebbe stato fatto tutto il possibile per lasciare tranquillo lui e il lontano presidio africano.
Che cosa invece si voleva fare da pane del Negus, Genè credeva di saperlo ma in realtà non lo sapeva.
Impreparazione mtlitare e questioni politiche
Il disimpegno politico e diplomatico italiano (adeguato alla politica proclamata nella primavera 1885, ribadito nel settembre e reso definitivo con Genè) passava anche, a livello militare, per la via della riduzione del contingente di Massaua. La diminuzione degli effettivi militari, che era stata in precedenza da più pani avversata, cominciava così ad essere possibile 1 .
Senza grandi clamori , quasi all'insaputa dell'opinione pubblica , nel giugno 1886 il Ministero della Guerra diminuì l'organico delle truppe di Massaua, come ritirandosi 'strategicamente' di fronte all' aprirsi della seconda gestione calda.
Finalmente Ricotti aveva raggiunto il suo scopo.
L'assottigliars i della presenza militare italiana a Massaua rivelava però chiarame nte come si sottovalutasse un qualsiasi pericolo abissino. D'altra parte Genè continuava ad inviare a Roma rassicuranti rapponi. Nell'atmosfera di rilassatezza che pareva aver così avvolto la colonia italiana furono persino iniziati anche esperimenti di coltivazione agricola, richiesti a Ricotti e a Genè dal Ministero dell'Agricoltura e diretti sul luogo da personale militare 2 Tra palme e cereali nessuno pareva più pensare in colonia alla possibilità di un serio conflitto armato.
Esemplare è a questo proposito la vicenda della costituzione di drappelli di irregolari 'indigeni' sotto la bandiera italiana. Utili per la loro resistenza fisica e per la conoscenza dei luoghi, le truppe indi-

1 Diminuiscono di circa un migliaio (cioè di quasi due quinci). Cfr. ANGHERÀ, L 'azio ne militare n ella nostra politica colo niale, ci t., p. 1140.
2 Cfr. AUSSME , Carteggio Entrea, racc. 139, fase. 10, 19 settembre 1886 , Grimaldi a Ricotti.
VERSO DOGALI 423
gene erano per questo apprezzate e reclutate da tutti gli eserciti coloniali europei del tempo.
I primi irregolari eritrei arruolati dai militari italiani durante il periodo di Saletta avevano però fatto (ali' inizio) una non buona impressione, come quando nel maggio 1885 un gruppo di questi aveva defezionato - armi in pugno - dal presidio appena occupato di Amba. Il colonnello non era parso molto favorevole all'organizzazione di tali drappelli, ma aveva accettato comunque, per motivi politici, quegli 'indigeni' che avessero voluto passare dalla dipendenza egiziana a quella italiana. Con il 1886, dopo il 'colpo di stato' del 2 dicembre 1885, si trattava quindi di regolarizzare la posizione di questi abissini che avevano accettato il 'soldo' italiano, nonché di allargare le loro file.
Genè, evidentemente intento ad una struuurazione pacifica del presidio, non colse la potenziale utilità di questa formazione militare che invece tanta parte aveva avuto e doveva avere nelle guerre coloniali della Gran Bretagna e di tutti gli eserciti coloniali europei. Richiesto di un parere in merito dal Ministero della Guerra già col febbraio 1886, in aprile il Comandante di Massaua ancora non si era degnato di rispondere e fu solo dopo ripetuti e autori t ari soll eciti che a novembre (dopo otto mesi!) Genè espose in una succinta relazione le sue idee a Ricotti.
Il Ministero aveva proposta una nuova organizzazione degli ' irregolari',
inquadrandoli rutti o in parte con le nostre truppe, in guisa da poterli impiegare sia in unità separate sia riuniti alle truppe regolari, il che potrebbe pure permet· tere una riduzione nelle forze attuali dei presidi d·Africa 3.

Genè rispose invece che sottoporli al comando di ufficiali italiani «sarebbe [stato] rovinarli, togliere loro quella mobilità che hanno in sommo grado» e che il Comandante di Massaua considerava «il pregio esclusivo deg li irregolari» 4 . Con ciò dimostrando di non cogliere l'utilità (anche 'diplomatica' , come aveva dimostrato l'episodio di Saati) delle forze indigene , che non stava solo ne l saper correre- sotto il sole africano - più veloci degli italiani.
P robabilmente, la realtà delle forze militari italiane non avrebbe dovuto consentire tali leggerezze da pane di Genè.
424 l ' ESERCITO NELLA POLITICA COLONIALE
3 lvi, racc. 88 , fase. 3. 2 febbraio 1886, Ricotti a Gené. 4 lvi, 4 novembre 1886, Gené a Ricotti.
Il presidio militare italiano di Massaua non era rimasto inattivo dal giorno del suo arrivo sulle coste del Mar Rosso sino alla tragica giornata di Dogali. Esso infatti, come qualsiasi altro corpo coloniale europeo, aveva affrontato le difficoltà dell'occupazione militare di territori infidi e sconosciuti, le insidie della gestione dell'ordine pubblico nei confronti di popolazioni ribelli o comunque riottose ad accettare la nuova autorità italiana, i pericoli del 'brigantaggio' e della conflittUalità endemica in quelle regioni. Ma va osservato che su molte delle operazioni militari - anche circoscritte - di questo t ipo (e di cui abbiamo trovato documentazione) pesa l'ombra dell'impreparazione o della sorpresa.
Già il 18 gennaio 1886, vicino ad Arafali un gruppo di soldati si imbatté in una banda di 'predoni' che fuggiva da una razzia. Gli italiani (forse più per la sorpresa subìta che per deliberato comando e autonoma scelta di formazione bellica) li affrontarono in 'ordine sparso' e da pane italiana non ci furono perdite più per un caso fortunato che per merito militare. Il combattimento e le scariche di fucileria erano state comunque immediate e violente.
L'essere arrivati impreparati all'incontro e l'aver scompaginato le fi l a dovette avere la sua importanza se a proposito di questo episodio militare si scomodò persino il Capo dello SME. Avuto notizia dello scontro di Arafali, in un dispaccio a Ricotti, Cosenz volle invece insistere sul concetto per cui in Africa «è molto vantaggioso tenere la catena molto serrata e sempre rincalzata da presso da sostegni in ordine chiuso» 5.

Non molto meglio andarono le cose il 3 marzo quando l'operazione, condotta da una mezza compagnia italiana, consistette in un incontro imprevisto con un gruppo della banda di Debeb sulla strada che da Monkullo ponava a Saati, in un suo inseguimento e in tiro mirato da fermo. Dopo un'ora di fuoco italiano, la banda era scomparsa ali' orizzonte ma senza lasciare perdite visibili sul terreno 6. Analogamente si potrebbe dire di una più impegnativa operazione di rastrellamento avvenuta nel villaggio di Margable, dove il 4 giugno parve si fossero rifugiati alcuni negrieri con la loro carovana di schiavi. L' operazione esposele truppe italiane e i suoi comandanti ad un grande rischio, senza peraluo permettere che fosse raggiunto lo scopo prefisso. Fatte controllare le principali uscite del villaggio
5 Cfr. ivi, racc. 53, fase. 13 , 18 gennaio 1886 , Urg , Robilant a Ricotti; e ivi, 2 febbraio 1886 , Cosenz a Ricott i.
6 Cfr. ivi , racc. 51 , 3 marzo 1886.
VERSO DOGAU 425
da plotoni di soldati (che però così si trovarono ad essere sparpagliati in un largo raggio d'azione), l'ufficiale italiano fece immobilizzare un abissino di passaggio e tentò di fargli rivelare l'ubicazione del supposto rifugio dei negrieri. L'ostaggio, dapprima remissivo, appena fu nelle immediate vicinanze di Margable iniziò ad urlare e a divincolarsi, richiamando l'attenzione degli altri abitanti del villaggio, che con urla minacciose e lance appuntite si avvicinarono agli italiani. Dal gruppo di soldati, forse impauriti, e nonostante che l'ufficiale avesse ordinato il pied-arm (almeno questa fu la versione presentata nel rapporto ufficiale a Genè), partirono colpi d'arma da fuoco ad altezza d'uomo che tra l'altro uccisero un indigeno e ferirono una donna del villaggio all'altezza del torace. Gli abitanti di Margable, sorpresi della improvvisa e sproporzionata reazione italiana, indietreggiarono e dettero modo agli italiani, peraltro assai intimoriti dalla vivace reazione degli abissini, di lentamente ritirarsi, senza però aver scovato i ricercati negrieri 7.
Il l o settembre, in prossimità di Zula, reparti di truppe italiane caddero infine in una imboscata. Per questo che fu ammesso essere stato «uno scontro di qualche entità», Genè scrisse lapidariamente nel suo rapporto a Ricotti che «da parte nostra ebbimo [sic] perdite gravi» s.
I rapporti segreti militari riferiscono di altre perdite, questa vo lta tra gli irregolari, con quattro morti e cinque feriti, in un inseguimento a Ma-atali. In questo caso il tentativo dei militari italiani di soccorrere una carovana caduta nel mirino dei 'predoni', nonostante fossero inflitte loro rilevanti perdite, si scontrò con «la difficoltà dei luoghi [che] non permise che un liberamemo parziale» 9.
Tutte queste operazioni militari, che potremmo dire di ordinaria amministrazione in qualsiasi caso di occupazione coloniale, non furono forse mai molto di più che «qualche scambio di fucilate» IO.
7 Cfr. ivi, racc . 53, fase . 12, 18 giugno 1886, Gené a Ricotti.
8 lvi, fase. 14, 3 settembre 1886, Gené a Ricotti.
9 lvi, fase. 8, 18 ottobre 1886, Gené a Ricotti.
10 ANGHERÀ, L'azione militare nella nostra politica coloniale, cit., p. 679. Tra i militari italiani, quasi subito , si notò che i primi tempi dell'espansione coloniale in Mar Rosso avrebbero lasciato poco spazio ad 'eroiche' azioni belliche. «Né per ora v'è luogo a sperare che la 'modesta e casalinga' politica coloniale , in cui trovasi da poco impegnato l'onore italiano, giunga a rinvigorire nell'esercito e nella nazione l'infiac· chito spirito militare( )». Il morale dell'esercito , cit. , p. 18. Oltre a!Ja real tà dell'impossibile estensione del presidio di Massaua , quelle note erano co!Jegate anche all'episodicità, alla laconicità ed alla confusione delle notizie ufficiali. Il timore delle indiscre-

426 L'ESERCITO
NELLA POUTICA COLONIALE
Ma pure vanno ricordate: anche per capire come Dogali, pur rimanendo un incidente, fosse qualcosa di più di un caso, e per sottolineare che non grande esperienza fu da essi tratta in quel calmo 1886 di Genè. Il quale, minimizzando l'entità degli scontri, non pare sia mai ricorso ai suoi superiori (Ministro, Capo dello SME) per ricevere il necessario supplemento di istruzioni in fatto di tattica militare in territorio africano.
Ad un diverso e superiore livello, quella che era la qualità della presenza militare italiana a Massaua avrebbe potuto essere ridiscussa anche in un'altra occasione: nei giorni successivi al massacro della spedizione Porro, quando si rinnovarono in Italia gli incitamenti ad allargare la zona controllata militarmente dagli italiani ed a 'vendicare' l'onore nazionale offeso. Ma anche in quel caso si preferì lasciare tutto nello status quo.
La spedizione Porro, panita dall'Italia pochi giorni dopo quella d i Pozzolini, con obiettivi geografici e commerciali non trascurabili, era stata annientata a Gidessa tra il 5 e il 6 aprile probabilmente per errori e incomprensioni con le tribù di cui stava attraversando il territorio 11 Il fatto, di per sé episodico seppur funesto, avrebbe potuto essere per Genè un segnale che qualcosa nell'atteggiamento degli abissini verso gli italiani stava cambiando. Ma non fu così. La tragica fine di Porro, comunque, ebbe grande risonanza in Italia, dove parve dar ragione a chi accusava di inadeguatezza e di «tirchioneria>> 12 la politica militare del governo Depretis che non era riuscito a garantire la sicurezza della spedizione italiana. L'eccidio diede così nuovo spazio alle correnti che avevano sempre cercato in colonia l'onore nazionale e che in quel momento di stallo in politica interna (si attendeva lo scioglimento delle Camere e le elezioni politiche) tornarono ad agitarsi, contro la politica coloniale governativa considerata impari alla 'potenza' italiana e sui temi della vendetta e della 'lezione' agli africani 13
zioni e delle rivelazioni da pane dell'autorità militare non aiutava la comprensione, nell'opinione pubblica, dei veri termini della partita giocata a Massaua. Evidentemente confuso dalle contraddittorie notizie ufficiali a proposito dell'importanza- nel terriro.rio massauino - di Ras Alula (capo di predoni? o bendisposto verso gli italiani?), significativamente «L'esercito italiano• tiro lava il24 maggio 1885: Chi ne capisce nulla?
11 Cfr. DEL BOCA , Gli italiani in Africa orientale. Dall'unità alla marcia su Roma, cit., pp. 224 - 225.
12 Sono parole di CHIESI, NORSA , Otto mesi d'Africa, ci t., p. 26.
13 Cfr. CARAZZI, La Società Geografica Italiana e l'esplorazione coloniale in Africa, ci t., p. 91.

VERSO DOGALI 427
Dopo che la notizia del massacro fu giunta io Italia, il Capo dello SME scrisse al Ministero della Guerra, risollevando quei temi di una possibile espansione italiana nello Harrar che erano stati già avanzati nell ' estate precedente a seguito delle affermazioni del Maggiore inglese Hunter l 4. Non conosciamo il tenore della risposta di Ricotti. Ma si può credere che essa non fu sollecita, come inoltre si può ritenere che il Ministro della Guerra abbia in quell'occasione ri petuto i suoi consueti richiami alla cautela e ai margini dei bilanc i m ilitari. Coseoz infatti fu costretto a tempestare (letteralmente) di missive il Ministro l) prima che questo si decidesse (nel giugno 1886) ad inviare al Ministro degli Esteri taluni piani da tempo preparati dallo SME per una possibile spedizione militare italiana in Harrar 16.
Il ritardo non era casuale: già qualche giorno prima i due Ministri si erano messi d'acco rdo perché la questione dello Harrar «riman[ esse] impregiudicata», cioè sostanzialmente accantonata. Robilant si accontentava di sapere ed avere dalla Pilotta e dallo SME solo «dati» e non piani precisi. Ma anche prescindendo dalla deliberazione dei due Ministri, grazie a quel voluto ritardo di Ricotti, era passato nel fra tt empo più di un mese da quando Cosenz aveva risollevato il tema dello Harrar, si era ormai alle porte dell'estate e qualsiasi azione militare avrebbe dovuto forzatamente essere rimandata.
Io realtà, sia le ipotesi militari di Cosenz sia la manovra di Ricotti erano destinate a rimanere solo segnali indicativi di due diverse tendenze, e ad avere scarsa rilevanza concreta. Infatti, il Ministro della Guerra - che da lì a poche settimane avrebbe drasticamente ridotto l'organico del corpo di occupa zione di Massaua - era assolutamente contrario alle ipotesi di Cosenz e dello SME. I potesi che (attraverso l'invio di una forte spedizione che 'vendicasse' l'eccidio di Gidessa e prendesse io qualche modo l'Barrar) tendevano a voler riaprire verso Zeila e la sua regione quell'espansione coloniale italiana che sembrava arenarsi intorno a Massaua e a Saati.
Ricotti, per essere più sicuro che Robilant non rimanesse suggestionato dai 'piani' di Cosenz, ricorse anche a mezzi poco eleganti, quali la 'correzione' dei piani stessi con l'aumento dei preventivi di
14 Cfr. AUSSME, Carteggio Entrea, racc . 175, fase. 3, l maggio 1886 , Cosenza Ricotti.
n Cfr. ivi, 9 maggio 1886 , Cosenz a Ricotti; ivi, 19 maggio 1886, Ris ., Cosenz a Ricotti ; ivi, 2 3 maggio 1886, Conf, Cosenz a Ricotti; ivi, 5 giu gno 1886, Cosenz a Ricotti.
16 Cfr. tvi, 7 giugno 1886, Ris. Pers., Ricotti a Robilant .

4 28 L'ESERCITO NELLA POUTICA COLONJAI.E
di Cosenz e la sottolinearura dei rischi militari su !l'intera operazwne.
Nel frattempo, dopo l'evacuazione delle forze inglesi ed egiziane, lo Harrar stava per avere già un altro padrone n ella persona di quel Ras Menelik, alla cui corte Antonelli stava tramando i suoi 'piani scioani' 17.
Così, qualsiasi piano militare italiano verso lo Harrar aveva perduto concretezza.
Qualcosa di quel piano - la sua impostazione strategica data al problema militare di occupare territori africani - però merita di essere ricordato, perché in qualche modo ha a che fare con il seguito della politica coloniale italiana. Si può dire infatti che fu proprio sulla falsariga di questo piano, seppure allora impraticato ed impraticabile, che sarebbe stata in seguito condotta qualsiasi grande azione militare italiana nella zona del Mar Rosso.
Per estendere il dominio italiano da Massaua allo Harrar il Capo dello SME prevedeva con realismo come necessari «tre mesi di effettiva preparazione e se i mesi di operazioni verso l'interno:. lS e tre ipotesi (o fasi) a seconda: che si volesse occupare solo il capo lu ogo della provincia, che si volesse occupare il capoluogo e distaccare lungo la principale arteria di comunicazione forti presidi militari che esercitassero la loro influenza nell'interno (occupazione temporanea), o che si volesse occupare militarmente tutti i principali nodi della regione (occupa zioqe permanente). Se per la prima ipotesi si dicevano sufficienti 1000 uomini (ma in realtà ce ne erano voluti quasi 3000 per tenere Massaua sulla costa!), per le altre sarebbero state necessarie le forze di 6000 soldati, riorganizzando comp letamente il Corpo di Spedizione sul modello ingl ese 19.
17 Cfr. BATIAGUA , La prima gueTTa d'Africa, cit., p. 225.

18 AUSSME, Carteggio En lrea, racc. 175, fase. 3, 4 giugno 1886 , Ris. Pers., Cosenz a Ricotti.
19 Il piano dello SME si dilungava poi in particolari minuti di organica militare; più interessante ci pare invece riportare un brano di Cosenz scritto senza ripensamenti ma poi cancellato e non inviato a Ricotti. Mentre il piano per lo Harrar infatti presupponeva una larga fiducia sulle capacità operative delle trupp e italiane , il brano poi cancellato si soffermava sulla tattica militare coloniale e su talune carenze e insufficienze già evidenziate (secondo il punto di vista del Capo di Stato Maggiore dell'Esercito) nelle prime esperienze militari operative cui era andato incontro nel 1886 il Corpo italiano di Spedizione di Massaua. A differenza della questione strategica sopra ricordata, le considerazioni dì Cosenz sulla ranica militare da adonarsi in Africa non ebbero nessuna diretta influenza (se non in negativo , anche perché vennero persino depennate dalla sua lettera al Ministro ) sul corso degli eventi. Eppure avrebbero potuto costituire un
VERSO DOGAU 429
In realtà, nonostante la buona volontà del pianificatore Cose nz , l 'Harrar non avrebbe mai potuto essere i taliano in quel rorno di mesi del 1886, a meno di non rompere le compatibilità finanziarie e politiche del trasformismo. Eppure, ciò può essere utile per riportare la nostra attenzione sul tema della mancanza di coord inamento (cioè di univoca politica) già nelle prime fasi del colonialismo italiano e
imporrante spunto di riflessione Cosenz indicava infatti come necessari per qualsiasi forza armata civile operante negli insidiosi terreni africani la confidenza in se stessa, l'adozione di cene forme tattiche (quali l 'ordine chiuso e le formazioni serrate, che i progressi delle scienze militari avevano considerato superati nelle banaglie tra eserciti organizzati europei e armate indigene aveva richiamato in vigore) nonché una speciale cura nel comando del fuoco delle truppe (per evitare che queste potessero trovarsi in qualche momento del combattimento senza munizioni)
Le raccomandazioni di Cosenz, un piccolo condensato del più disteso saggio sulla 'tattica degli italiani in Africa' che egli stesso avrebbe steso qualche tempo dopo, potrebbero apparire di poco como solo a chi non avesse sufficientemente presente che fu anche per questioni di tattica, di fuoco e di fiducia in se stessi che gli italiani andarano incontro a Dogali ed una disfatta militare tanto cocente quanto inevitabile.
Cosenz aveva quindi coscienza di alcune delle deficienze, da noi prima rilevate , deUe 'truppe coloniali' italiane di Massaua. Fano sta, però , che depennando dalla sua lettera a Ricotti il brano relativo, riteneva opporruno non insiste cvi proprio quando proponeva al Ministro della Guerra un ardito piano di espansione militare. Quasi che una politica coloniale più audace potesse fare a meno di un più adeguato suumemo militare . cUna cosa di somma imponanza- scriveva Cosenz- sarebbe inculcare nella mente dei componenti la spedizione, in modo che per essi divenga articolo di fede: la grande superio rità che deriva alle nostre truppe di fronte agli africani, armati di lance o di fucili a pietra o di armi a ripetizione di cui non sanno convenientemente servirsi, daUa superiorità del nostro armamento e dalla nostra superiorità nel maneggio delle armi da fuoco. Questa superiorità è tale che pochi uomini , purché essi non si lascino sgomentare dalla grande superiorità numerica dell'avversario, possono far fronte e riuscire vittoriosi contro migliaia di nemici. Soprattutto è importante insistere sulla necessità diprendere formazioni compalle nelle quali si possa far fronte simultaneamente da tutte le parri, e nel mantenimento di un fuoco continuo essendo le pause favorevoli ad un avversario la cui tattica consiste nel gettarsi sul nemico aU ' arma bianca. Ritengo infine che !'impiego di cartucce a mitraglia nel periodo acuto della lotta darebbe senz a fallo grandi risultati». Come vedremo , Dogali fu innanzitutto una sconfitta militare, seppure incidentale, e non sappiamo se -sul mero piano militare - la giornata avrebbe avuto un esito diverso se queste considerazio ni di Cosenz avessero potuto essere conosciute, diffuse ed applicate Rimane il fatto che deficienze militari (sollevata anche dai non smaglianti risultati delle operazioni mili tari da noi più sopra ricordate), esistevano realmente in seno al presidio di Massaua; come rimane il fano che poco o niente si fece per porvi rimedio.
Una tale considerazione, fondata su obiettiva documentazione, deve però essere collocata nel quadro più generale che le compete.
Soluzioni tecniche (come quelle stesse inuaviste da Cosenz) non sarebbero mai bastate, nella storia del colonialismo italiano , a riparare a pesanti errori politici generali. Formazioni compatte o cartucce a mitraglia non potevano rimediare all'inutile e provocatoria occupazione di Saati , né ripagare due anni di occupazione militare e di errori diplomatici (motivati , come nel caso della missione Pozzolini , e poi in quello dei ' quatuo predoni', da immotivate 's uperbie ' colonialiste).

430 L'ESEROTO
NELLA POLITICA COLONIALE
al tempo stesso non può non riaprire il cap itolo deHe responsabilità.
Le specifiche responsabilità dei militari italiani erano quelle di chi, costretto per questioni di servizio e di disciplina a risiedere per lunghi mesi suHe coste del Mar Rosso, non era riuscito a farsi un ' idea dell'avversario , della sua forza e delle motivazioni che spiegavano i suoi componamenti, politici e militari.
In aggiunta a questo (e tratto caratteristico e ricorrente dei militari italiani che operarono in colonia nel peri odo da noi preso in esame , da Saletta a Genè) fu semp re quello deHa ingenua e pericolosa sottova lutazione dell'avversario africano 20: tratto questo riscontrabile in Saletta che occupa Saati senza sapere se potrà poi difendere convenientemente la stessa Massaua da un colpo di mano abissino, come in Genè che trascorre un anno e più in colonia praticament e tra esperimenti agricoli, genetliaci del Re e tomb ole per i soldati , con l ' aggravante militare - rispetto al colonneHo che lo aveva preceduto - di non obiettare alcunché quando gli vennero ridotte le truppe ma lasciati inalterati i gravi co mpiti politici e militari .
Altra, più pesante, responsabilità politica e militare hanno invece autorità co me Ricotti e Cosenz: il prim o - almenocoerente mente impegnato il più delle volte a ridurre il contingente ·e a tentare di ridimensionarlo quasi a semplice tutore deH ' ordine pubblico sul Mar Rosso (anche se questo sarebbe stato, con quei tukul a Saati , a ben vedere impossi bile) , il secondo spesso intento a disegnare piani per l ' espansione militare italiana che il più delle volte servivano (quando pure venivano utilizzati) per manovre politiche, durante il periodo di Mancini , o ad immaginare irrealizzabili miti coloniali (c ome quello per lo Harrar , negli anni di Robilant) che avrebbero abb isognat o di potenze e finanze e politiche ben più consistenti di quelle italiane degli anni di Depretis .
Altra e grave responsabilità era quella di uomini come Depretis che pure , intimamente non credendo un granché a ll 'espansionismo, permettevano che in colonia le cose andassero come andavano.
Tra tante e diverse responsabilità, si andava così dipanando il filo d ell a prima politica coloniale italiana.

VERSO DOGAU 431
2
° Cfr. ROCHAT, Il colonialismo italiano, ci t.. p. 23
Sulla via che conduce a Dogali
L'aspetto militare di tutta la vicenda colonial e italiana del1886 doveva tornare alla ribalta col mese di agosto, quando taluni segnali minacciosi vennero a turbare la quiete del torrido paesaggio africano intorno a Massaua . Piccoli avvenimenti frnùono per mettere in moto grossi eventi, a dimostrazione che molti e intricati erano i nodi già aggrovigliatisi nella politica coloniale italiana tra il 1885 e 1886 .
L'italiano Naretti era stato espulso dalla coree del Negus, dove frno ad allora aveva svolto in maniera ufficiosa la figura di rappresentante del Regno sabaudo. Se già questo doveva essere un significativo sintomo di un cambiamento dell'umore abissino nei co nfronti degli italiani, assai più grave fu la grande scorreria che Ras Alula aveva effettuato nel paese degli Habab a non grande distanza da Massaua e con completo disprezzo di tutto l'operato italiano in favore della sicurezza del commercio indigeno , delle carovane e per la repressione del 'b rigantaggio ' 1
Queste ed altre piccole cose dovettero impressionare un po' il placido Genè, che tra l'altro comandava da giugno un presidio a forze ridotte. Genè rispose all'affacciarsi della minaccia abissina solo con una serie di spostamenti nella dislocazione delle truppe, per arginare volta per volta i punti in cui egli supponeva più alto il pericolo di un colpo di mano 2 Dopo il combattimento d i Zula (di cui ab-
1 Cfr. BATIAGUA, La pn'ma guerra d'Africa, cit., p. 226.
2 Cfr. AUSSME, Carteggio Eritrea, racc. 41, 22 gennaio 1887, Gené a Ricotti. Le vicende che precedettero e che condussero a Dogali sono in buona pane note. Per una loro sintetica narrazione ci riferiremo spesso a questo interessante documento, che è un lungo e dettagliato rapporto di Gené sulla sua attività a Massau a nelle settimane prima di Dogali . Intanto, è necessario ricordare l'elemento della costante sortovalutazione da pane italiana dell'avversario militare abissino . .:Conoscete il sistema militare in vigore in Abissinia? L'esercito è formato da una massa di briganti, i peggiori soggetti di quei paesi vi sono ascritti, il numero compensa la qualità... E. DU ILI O. L'Italia e le colonie, Torino, Stamp. Gazzetta del Popolo, 1887, p. 29. Simili sciocchezze (che, si badi bene, avevano corso anche dopo Dogali ) traducevano bene un'idea diffusa: anche se poi i singoli militari- tra cui Cosenz, come si è visto - potevano personalmente dire di avere un'idea un po' (ma non molto) più vicina alla realtà. Per la giornata di Dogali, cfr. qualche accen no anche in E. BEllA VlTA, Adua. I precedenti, la battaglia, le con · seguenze, 1881-1931, Genova, cRivista di Rom» Editrice, 1931; A. BOLLATI, Enci· clopedia dei nostrùombattim enti colonialifino al 2 ottobre 1935, Torino, Einaudi, 1936; G. DEL BONO , Da Assab a Adua, Roma , UEI, 1935. Icastico il giudizio di un critico come F.S. Merlino: cL'avvenrura militare di D ogali ha fatto onore al nostro esercito; i nostri soldati, infarti, si sono fatti uccid ere fmo all'ulrimo uomo: lo credo bene (non si veda qui alcuna irriverenza per la memoria di quei giovani manici), erano accerchiaci•. MERLINO, L'Italziz qual'è, cit., p. 42.

432 L'ESERCITO
NEllA POUTICA COLONJALE
biamo già parlato), il Comandante italiano asso ldò anche 150 irregolari.
Infine il 23 novembre fece occupare l'importante posizione di Uà-à.
Pur impressionato , Genè non doveva ancora essere terrorizzato (come pare che divenne invece più tardi) e, confidando nella sua capacità di cont rollo della situazione, permise ad una spedizione guidata dal conte Salimbeni, e di cui facevano parte il tenente Savoiroux e il maggiore Piano (gli ultimi due vollero però celare agli abissini la loro carica militare) di dirigersi verso la corte di Ras Alula 3. Questi in realtà , venuto a conoscenza del grado militare dei due esploratori, forse insospettito e temendo una loro attività di spionaggio, fermò la spedizione e trattenne come ostaggi i suoi componenti .
La mossa di Ras Alula contribul fortemente ali' agitazione di Genè che adesso si considerava anche responsabile di aver m esso ne lle mani di un 'indigeno' alcuni importanti italiani, peraltro assai vicini agli ambienti della Corte di Re Umberto. Da qui , e dalle rinnovate voci di ostilità abissina verso gli ital iani , vennero approntate da parte di Genè tutta una se rie di misure militari che culminarono nel rinforzare tra il 6 e 1'8 gennaio 1887 il fortino di Arkiko (anche se con truppe di leva appena giunte dall'Italia) e quello di Uà-à. Così facendo, la situazione gli parve forse essere ritornata sotto il controllo .italiano e l' 11 gennaio i rinforzi furono alleggerici.
Ma già il giorno prima Ras Alula aveva indirizzato a Genè una lettera altera e decisa in cui chiedeva l o sgombero di Uà-à e di Zula. Questo era purtroppo il punto di non ritorno che Genè aveva sino allora scongiurato: un altro ultimatum abissino ad un presidio militare ital iano. Si ripeteva la situazione di Saati, ma questa volta aggravata dalle nuove turbolenze de lla zona e dalla questione Savoiroux. Non rispondere al Ras avrebbe potuto significare il massacro dell a spedizione in mano abissina; rispondere in senso difensivo avrebbe voluto dire contraddire le indicazioni della Consulta che voleva ad ogni costo difeso l'onore nazionale e militare (e particolarmente in quei mesi io cui si stava trattando il rinnovo della Triplice Alleanza); rispondere con una decisa puntata militare contro le forzeperaltro soverchianci - del Ras avrebbe rischiato di esporre il presidio e il suo Comandante ad ambedue i rischi or a ricordati. Eppure qualcosa andava fatca.

VERSO DOGALI 433
3 Vivace la defmizione in DEL BOCA , Gli italiani in Africa onentale. Dall'unità alla martia su Roma, ci t., p. 218 e sgg.
La situazione era obiettivamente difficile: Genè scelse la via della forte difesa della cerchia militare intorno a Massaua. Rinforzò di nuovo, il14 gennaio, Arkiko e Uà-à, incrementò potentemente il presidio di Saati anche con truppe italiane e con artiglieria; poi il 18 fu la volta di Monkullo e di nuovo di Arkiko. Gli spostamenti verso la linea dei forti avanzati erano stati così ingenti che rimanevano a Massaua solo cinque compagnie tra bersaglieri, genio e artiglieria. Nel frattempo, la sera del 14 e poi il 21 arrivarono altri ultimatum di Ras Alula a Genè: tutti avevano il minaccioso tenore del primo , mentre Savoiroux, Piano e Salimbeni rimanevano incatenati a Ghinda dove il Ras si era portato con truppa e fare minacciosi.
Il generale Genè, pare, non sapeva come uscire da un simile incastro.
La concitazione del comandante italiano, e al tempo stesso forse la volontà di non far apparire nella sua completezza quello che era davvero un cui de sac, doveva davvero essere grande se cene evidenti contraddizioni apparivano persino nelle sue comunicazioni coi vari Ministeri. !115 gennaio chiedeva alla Consulta «di tener pronto» un rinforzo militare (fo rse di quattro battaglioni) ma poi telegrafava che era invece «necessaire que soit prèt envoi». Il 22, dopo aver ricevuto gli altri ultimatum, richiedeva di «envoyer promptement» quanto prima richiesto, e di aggiungervi quattromila fucili Remington per armare gli irregolari indigeni 4 . Così spiega Roberto Battaglia:
Le prime spese di tale contegno le pagarono i tre malcapitati nostri emissari che furono incatenati e costretti a ribadire i termini dell'ultimatum al generale Genè: cPrima di mozzarvi il capo - disse loro Ras Alula - voglio ancora farvi una grazia. Scrivi al generale Genè che se fra tre giorni egli non si ritira da Saati io taglio la testa a tutti e vado a fare guerra contro di lui. Se io muoio non me ne impona:o. Conosciuta la minaccia , così la commentava da Roma il De Robilam, rivolgendosi al comandante superiore in Africa: «Spero che Ras Alula non commetterà tale follia, ma, ove occorrà , gli faccia sapere che se egli osa toccare un capello ai nostri tre viaggiatori, la pagherà cara. Aspetto notizie. Faccia assegnamento che, se necessario, le saranno mandati tutti i rinforzi di cui Ella potrà aver bisogno per infliggere una severa lezione:. 5.
Il Ministro degli Esteri continuava però a parlare al futuro, ma Genè in quei giorni del gennaio 1887 era incalzato a Massaua da un
4 Cfr. AUSSME, Carteggio Entrea , racc. 41 , 15 gennaio 1887, Gené a Robilam ; ivi , 15 gennaio 1887, Gené a Robilant (telegramma); ivi, 22 gennaio 188 7, Gené aRobilam.
BATIAGUA, La pn'ma guerra d 'Africa , cit. , pp 226-227.

434 L'ESERCITO
NEI.l.A POUTICA COLONIALE
pericoloso presente, che presto avrebbe avuto un nome: Dogali. Come si svolsero i fatti d'arme di Saati e di Dogali è cosa nelle linee generali complessivamente nota. Rinforzata Saati, lo si munì di cdue rudimentali fortini» 6; il 25 gennaio, avvistata «una considerevole orda di abissini» sul retro del villaggio, la si spinse a battersi di fronte al forte italiano, munito di una buona anche se limitata artiglieria. Nonostante cinque morti, da pane italiana il successo fu notevole: cinque-seimila etiopici erano stati respinti con forti perdite da pane dell'attaccante. Purtroppo la situazione all'interno del fone si era gravemente deteriorata, con i viveri e le munizioni per i fucili esauriti, e fortemente ridotte quelle per le artiglierie.
Chiesto un rinforzo a Massaua per Saati, Genè decise di inviare una colonna di circa cinquecento soldati e di una ventina di ufficiali; la colonna comandata da De Cristoforis, che doveva partire nella notte e giungere sicura a Saati all'alba, partì invece solo al sorgere del sole. A poco più di un'ora da Saati, gli abissini, che si erano spostati dalle vicinanze del forte verso la strada carovaniera nell'attesa di cogliere al varco un'eventuale missione di soccorso italiana, avvistarono l'avanguardia della colonna italiana. Questa fece fronte al nemico e si appostò in formazione su una altura, dopo aver accostato il convoglio con le munizioni e i viveri ad un'altra.
Ma vista l' aggirabilità di quella posizione e il deludente funzionamento delle due mitragliatrici, De Cristoforis decise di spostarsi su un'altra altura retrostante. Da lì i soldati schierati in posizione di difesa aprirono il fuoco contro il nemico. Questo, invece, lentamente, accerchiava la posizione e dopo quasi due ore di estenuante manovra si gettava sui militari italiani ormai sprovvisti di munizioni e li finiva con un corpo a corpo furioso cui seguiva l'accurata e consueta spoliazione. Nonostante avesse infeno qualche perdita agli abissini, la colonna italiana era stata completamente annientata 7.
6 lvi, p. 230.
7 Non è nostra intenzione aggiungere alua carta stampata alla già sterminata letteratura sull'episodio tragico di Dogali. Gli eventi militari della giornata sono ormai abbondantemente noti e, per parte nostra, crediamo di aver già chiarito come non sì trattò (dal punto di vista politico. diplomatico, militare) di un incidente casuale. Vorremmo sottolineare qui, semmai, ad un altro livello di analisi, il dramma fatale di quei soldati di leva, di quei giovani morti nel canalone di Dogali A questo proposito torna opponuno il resoconto (sino ad oggi inedito) di uno dei pochissimi - souo la decina -scampati all'eccidio. Le parole del soldato semplice Vito Sciannarneo , se non aggiungono nuovi lumi alla ricostruzione dell'episodio , e pur confermando le varie responsabilità dei vari comandanti militari italiani, restituiscono l'atmosfera terribile di una colonna militare sopraffatta, accerchiata e annientata. cSiamo partiti quella manina poco

VEltSO DOGAU 435
Come ci siamo affrettaci sul fatto d'arme, così, nell'economia della nostra narrazione, accenniamo qui solo brevemente alle questioni della 'leggenda di D ogali'; cioè alla versione patriottarda ed edulcorata che d i quel fatto d'a rm i venne data in I talia, e alla fun-
prima dell'albeggiare- dice Sciannameo , classe 1865 - con fiacco le e lumi: appartenevo al plotone di esuema avanguardia( ). Si marciava quasi colla certezza di non incontrare il nemico. Nelle prime due ore di marcia nessun incidente di importanza ( )Si prosegue per un ' altra ora, quand ' ecco tornare indietro al galoppo il Ten. Comi che precedeva cogli irregolari : veniva ad avertire che il nemico si trovava sulle alture di fronte molto numeroso. Arrestatasi la colonna( ) si ordinò di cominciare il fuoco al comando a 1600 m ( ) Sentii per qualche istante i co lpi della mitragliatrice. Gli Abissini erano visibilissimi sul monte a noi di fronte: si affacciavano al suono di una campana sulla cima in grandi masse , sboccando dal versante opposto chi a piedi e chi a cavallo( ... ) in breve, scesi tutti giù dal monte in fondo alla valle, che ci separava da loro, non furono più visti coperti com'erano dai folti spini e da ondulazioni del terreno ( ... )Noi stando in quella prima posizione per due buone ore facevamo fuochi a salve dirigendo la mira su quel fumo che si levava dal terreno: ho consumato allora tutte le munizioni , tranne un pacco a pallottola e i due a mitraglia. I pochi tiri degli abissini erano molto alti , non ci facevano danno( ... ) Non c' eravamo ancora cerro accorri che il nemico ci girava di fianco e alle spalle, quando venne l' ordine di portarsi indietro a sinistra su d'una altura un po' meno elevata( ... ) Quando si cambiava la posizione, abbiamo visto i basci-bazouk [italiani) fuggire verso Monkullo seguiti dalla nostra carovana carica di viveri e di munizioni che fino ad allora si era tenuta indietro di )00 m. coperta da cene ondulazioni del terreno. Noi per punirli del loro vergognoso abbandono , volevamo far fuoco su di loro( ... ) Giunti sulla seconda altura, come per incanto, ci accorgemmo di essere circondati da tutte le parti. Il nemico non poteva essere a più di 500 m( ... ) e subito aprì un buon fuoco , ci vennero distribuite altre munizioni , a me ne toccarono tre pacchi: appartenevano queste parte ai feriti e ai morti, che cominciavano ad essere numerosi, pane alle casse portate sopra co l mulo. Ben tosto il nostro fuoco, eseguito a volontà, si fece intenso e acccleraro. Il ten. colonnello ordinava talvolta colla tromba di cessare il fuoco, ma molti continuavano a sparare perché si vedevano il nemico molto vicino lo meno di mezz'ora abbiamo consumato tUtte le munizioni: il nemico poteva essere allo ra a circa 200 m dalla pane dove io mi trovavo . Noi so ldati domandavamo al ten. colonnello( ... ) 'per amo r di Dio , dateci cartucce !' e il ten. colonnello: 'figliuoli, combattete coi sassi!' ( )Il nemico irrompeva ormai da tuue le parti: poteva essere a 50 metri quando il reo. colonnello ordinò alla baionetta. Solo una trentina noi ha potuto alzarsi per eseguire l'ordine, gli altri erano già tutti morti o feriti ( )E stata breve la lo t ta perché i nemici erano diversamen te numerosi». Il preciso ed impressionante resoconto di Vito Sciannameo, contenuto in un rapporto inviato a Genè dal Comandante del 2 • Btg. Fanteria Mrica, continua poi con la storia dell ' avventuroso ritorno verso Massaua. Caduto nell ' ultimo assalto , fintosi morto e sfuggito alla spoliazione delle vittime da pane abissina , il veotiduenne soldato italiano si incamminò verso Monkuilo , dove fu poi ritrovato e condotto a Massaua. Nella memo ria del soldato semplice- che non poteva conoscere il complicato intrico di responsabilità politiche, diplomatiche e militari che lo avevano condotto sul Mar Rosso - erano rimasti gli episodi salienti di quella giornata: la partenza ritardata (all'alba, invece che a notte fonda), la presunzione da parte dei comandanti militari di non trovare ostaco li , la sottovalutazione del nemico, alcune errate e confuse disposizioni tattiche, l'incepparsi delle mitragliatrici, la paura che attanagliò la colonna e i fuochi a volontà che consumarono in breve tutte le munizioni. La conferma , insomma, di una irresponsabile sottovalutazione degli abissini. Cfr. AUSSME, Carteggio Eritrea, racc. 39.

436 L'ESERCITO NELLA
POUTICA COLONIALE
zione indubbiamente compattatrice che la risonanza dell'episodio ebbe nel paese. Dogali, tra l'altro, favorì un ulteriore avvicinamento tra Stato e Chiesa 8 e la creazione di un mito nazionale che ebbe larga presa tra le popolazioni dell'Italia rurale minata dalla crisi agraria.
È stato detto che ciò che era stata per l'Italia una sconfitta militare fu mutata sul lungo periodo in una rivincita ideologica: e la definizione rende bene l'idea che si vuole esprimere 9.
A chi, piuttosto che seguire nel dettaglio gli eventi, interessasse cogliere sinteticamente quale fu il comportamento dei diversi protagonisti della spedizione coloniale, quali furono le loro reazioni ali' episodio di Dogali non potrebbe sfuggire che la condotta della Consulta, della Pilotta e del Comandante Superiore di Massaua non furono univoche: particolari e specifiche preoccupazioni, favorite anche dalla mancanza di una ricomposizione politica unitaria causata dalla crisi di governo lO, spinsero ciascuno dei protagonisti a muoversi e a sollecitare gli altri per suo conto.
Genè, in primo luogo, sentiva bruciare la sconfitta su di sé e sulla sua carriera, e temeva fortemente che la durezza che gli abissini avevano dimostrato verso i malcapitati di Dogali si potesse ripetere nei confronti degli augusti ostaggi di Ras Alula. Quindi oscillava, nelle sue missive a Roma, tra impegnativi propositi di rivincita e tanto inutili quanto immotivate minimizzazioni.
Di Robilant, in qualità di Ministro degli Esteri era costretto a prendere atto che il governo - per lo stato di crisi e forse per una sotterranea speranza che il trascorrere del tempo potesse alleggerire la situazione in loco - intendeva differire quanto più possibile qualsiasi soluzione radicale della questione, in un senso o nell'altro.
Ricotti, Ministro della Guerra, si vedeva da più parti accusato d eli' intera responsabilità e soprattutto esperiva il fallimento di una politica coloniale come la sua. Una politica durata quasi due anni, indirizzata da una parte al disimpegno e al contenimento del peso politico e militare dalla spedizione coloniale italiana ma contradditoria ed incapace (e forse anche non desiderosa) di opporsi a quelle altre, più organiche, tendenze che avevano imposto prima l'avanzamento della linea di difesa di Massaua con la presa dei fortini, poi l'occupazione di Saati, infine la vanificazione delle - già scarse -
8 Cfr. RAGIONIERl, La stona politica e sociale, cit. , p. 175 7 . 9 Cfr. BATTAGLIA , La pn·ma gue"a d 'Africa, ci r., p. 262.
IO Cfr. Stona del parlamento italiano, vol. IX , Tra Cnspi e GiolitJi, cit.

VERSO DOGALI 437
possibilità di risolvere diplomaticamente il contrasto italo-abissino. In generale, di fronte ali' opinione pubblica ed ai politici, Ricotti non era tanto il militare che si era opposto ai piani verso Keren o verso l'Harrar quanto colui che -limitando le spese coloniali e riducendo l'entità del Corpo di Spedizione- aveva autorizzato Saletta prima e Genè poi a rimanere a Saati. E Dogali era molto vicino a Saati, geograficamente e pol i ticamente. Nonostante tutto questo, Ricotti, da esperto generale capiva che qualcosa andava fatto per sottrarre il presidio dall'immobilismo e dalla paura. Così finì per chiamare di nuovo a dirigerlo quel Saletta da cui pure nel 1885 tante cose avevano finito per dividerlo.
Intorno a tutti questi personaggi l 'opinione pubblica nazionale discuteva appassionatamente i temi della rivincita coloniale sugli 'indigeni'.
Con la giornata e l'eccidio di Dogali, si chi udeva così di fatto la 'spedizione di Massaua' .

Una fase nuova e più impegnativa doveva aprirsi per la politica coloniale italiana: una politica che doveva perdere assai velocemente l'illusione di poter continuare 'senza sforzo e senza spesa'.
Questo aspetto è stato più volte sottolineato dalla storiografia 11 Ma qui conviene, a noi, seguire ancora un poco il comportamento dei principali protagonisti dell'impresa italiana di Massaua, anche dopo Dogali. Per qualche giorno, per qualche settimana, quando praticamente sino ai primi di aprile sullo scenario della politica interna come in quello della politica coloniale si videro i primi importanti segru politici della nuova fase (soluzione della crisi governativa e formazione del Gabinetto Depretis-Crispi-Bertolè Viale, sostituzione di Genè con Tancredi Saletta, pianificazione e avvio della preparazione di quella che sarà poi la spedizione Di San Marzano), i principali protagonisti della politica coloniale italiana rimangono gli stessi e continuano di fatto a ragionare ed a agire come nella fase che si era invece appena chiusa.
E come si vedrà, intorno alla questione dello sgombero di Saati come a quella della liberazione degli ostaggi in mano a Ras Alula, ancora tra la fine di gennaio e l'aprile saranno le preoccupazioni di politica interna e le mosse avventate dei rappresentanti co lon iali italiani in loco a forzare l'indirizzo e la sorte del primo possedimento coloniale italiano.
43 8 L'ESERCITO
NEllA POUTICA COLONIALE
11
Cfr. ancora ROCHAT , Il colonialismo italiano, cit. , p. 23.
Due giorni dopo il massacro di Dogali, Genè scrisse a Di Robilant illustrando quale era a quella data la situazione militare in colonia. Ritirate le truppe da Uà-à, da Arafali e da Saati, i1 presidio italiano aveva difensivamente stabilito i suoi avanposti in Monkullo, Orumlo e Arkiko (oltre evidentemente a Massaua) 12 Dopo due anni, così, si era quasi tornati alla situazione del febbraio 1885, in cui Saletta aveva messo piede in Africa. Denominato il momento come cun ben definito stato di guerra contro l'Abissinia-. (che era proprio quanto a Roma non si sarebbe voluto sentire e com unque quello che si era accuratamente tentato di evitare, esuberanze militari di Saletta permettendo , in due anni di espansione coloniale) il Comandante Superiore chiedeva l'invio immediato di alcuni rinforzi, suggeriva l' allestimento di un forre Corpo di Spedizione di 8-10.000 uomini e proponeva un largo quanto fantastico piano: rinsaldare l ' alleanza con le tribù vicine (c he poteva essere stata scossa dali' onta che aveva subìto l'onore militare italiano), riuscire in un'alleanza con i dervisci (cioè con le popolazioni musulmane e mahdi st e avverse ai copti abissini), sollevare le popo l azioni viciniori contro Ras Alula e scalzarlo dal potere , addirittura occupare il paese dei Bogos per avere lib e ra la strada verso Cassala e Kharrum. Il tutto prima della stagione delle piogge, cioè entro maggio.
Se tutto questo era di fatto irrealiscico (e chi mai, in fondo, avrebbe affidato alla direzione di un tale piano a Genè?) più veritiera risultava la desc rizione della situazione:
Ci sono, - ammetteva Genè -, per cons egu enza [di Dogali], ch iuse tutte le vie dell 'interno e non potremmo ricevere approvvigionamenti che per via di mare. E questo stato non può essere temporaneo; sino a tanto che non potremo fissare in modo sicu ro più lontani i confini, sarà impossibile essere tranquilli da pane degli Abissini, ed avere qualsiasi co municazione con l'interno in modo sicuro. In una parola noi siamo pressoché bloccaci a Massaua e ridotti ad una difesa continua ed attenta.
La maggio r baldanza abissina e la minor fede delle altre popolazioni, nostre naturali allea te [sic]. hann o per conseguenza sicura di rendere difficilissimo, seppur non vuoi dirsi impossibile, qualsiasi commercio con l'interno , unica ragione per cui Massaua possa avere qualche valore.
Così essepdo le cose, io ritengo si presenti una sola via da batte re , quella di prend e re una pronta e definitiva ri vincita 13.

VERSO DOGAU 439
( )
12 Cfr. AUSSME, Carteggio Eritrea, racc. 41, 28 gennaio 1887, Gené a Robilant. l3 Ibidem.
Ricotti, per pane sua, inviò quei rinforzi che Genè aveva domandato (anche se non ci risulta che ne avesse mandati molti di più di quanti gliene furono richiesti) e il 17 febbraio fece dichiarare le truppe in Mrica sul piede di guerra 14. Questo non significava ancora né implicava la dichiarazione di stato di guerra del presidio né di guerra all'Abissinia, cui evidentemente qon si voleva politicamente arrivare. Ma era il segno della gravità della situazione.
Di Robilant, che pure aveva parlato a Genè di destituzione di valore del trattato di Hewett non accettava l'ipotesi del grande corpo di spedizione e anzi il18 febbraio- riferendo di talune posizioni del governo - diceva che «miglior consiglio ci parve differire ogni risoluzione definitiva-. 16.
Intanto la questione dei confini andava intrecciandosi con quella dell'onore nazionale ferito: e a Roma troppo spesso ci si interrogò sul significato che una rioccupazione di Saati avrebbe rivestito non tan to in sé (quale obiettivo di politica colo niale ) quanto in rapporto alla vicenda dei tre prigionieri (pe r la cui sorte pare si fosse preoccupato lo stesso Umberto l): e cioè- in ultima analisi- per questioni e obblighi di politica interna. Circa lo sgo mbero di Saati, ma nel se nso che si è detto, Robilant, ai primi di marzo, volle ulteriori informazioni da Genè chie dendo una «rispos ta immediata» 17. Ricotti fece altrettanto ma in modo forse da voler condizionare la risposta da Massaua lS. Fatto sta che Genè doveva temere moltissimo per la sorte dei tre ostaggi in mano abissina e rispose ch e
la rioccupazione di Saati sarebbe disastrosa per i nomi prigionieri. È indispensa· bile aspettare risultato delle trattative avviate anche per vedere se le intenzioni dell'Abissinia sono realmente rivolte più ad un accomodamento che alla guerra 19.
La foga guerriera sembrava quindi scomparsa in Genè che anzi, per agevolare il rilas cio degli ostaggi, compì forse una delle sue mos-
14 La questione di Ma.ssaua o la miuione dell'Italia in Africa, Voghera, Ti p. Gatti, 1887' p. 36.

n Cfr. AUSSME, Carteggio Eritrea , racc. 41, febbraio 1887, Robilant a Gené ( telegramma).
l6 Ci t. in MANTEGAZZA, Da Massaua a Saati. Nai"Tazione della spedizione del 1888 in Abissinia, cit., p. XU.
17 Cit. in ivi, p. XUV.
18 Cfr. AUSSME, Carteggio Eritrea , racc. 41 , 8 marzo 1887 , Ricotti a Gené.
l 9 Ci t. in MANTEGAZZA, Da Mauaua a Saatì. Nai"Taztone della spedizione del 1888 in Abissinia, ci t., p. XUX.
440 L'ESEROTO
NELLA POUTICA COLONIALE
se più avventate (e certo una delle meno apprezzate dai suoi superiori alla Pilotta e alla Consulta): fece restimire a Ras Alula 1000 fucili a lui destÌrlati ma sino ad allora sequestrati a Massaua dalle autorità italiane.
La cosa, prima ancora che indicativa della preoccupazione di Genè verso le persone di Salimbeni e compagni, doveva di fatto suonare sinistramente bizzarra a Roma e Ìr1 Italia. A Massaua si regalavano armi ai massacratori di Dogali e di De Criswforis.
Robilant, appena informato, in un biglietto personale inviatO a caldo al «Caro Ricotti» sentenziava:
Non posso dirti quanto ne sia impressionato. La cosa è ai miei occhi di una enormità; e non ti nascondo che se non otteniamo fra otto giorni l'annuncio che i prigionieri sono liberi troverei assolutamente indispensabile l'immediato richiamo dj Genè che ben si vede si è lasciato impressionare dalle suppl icazi oni di Piano e compagni 20
E pensare che solo il giorno prima il Ministro degli Esteri aveva scrittO a Massaua chiarendo così la sua posizione:

Credo io pure che rioccupazione Saati potrebbe costare la vita ai nostri compatrioti prigionieri; ma d'altra parte il sangue versato a Dogali chiede riparazione. L'onore d'Italia lo esige. Non può dunque in ogni caso che trattarsi di momento più o meno prossimo da scegliere per rioccupare Saati e dar battaglia a Alula se ci volesse sloggiare. Il governo del Re riserva ancora una decisione a questo riguardo. Ma quanto ad un accordo pacifico, noi non possiamo pensarci che dopo aver preso una rivincita. Nasconda il suo gioco, se è possibile, affinché i prigionieri siano liberati, ma non si impegni in seri negoziati di pace la nostra intenzione, beo stabilita è quella che qui le faccio conoscere 1
La divergenza di opillioni tra il responsabile della politica estera nazionale e Genè non poteva quindi essere maggiore.
Certamente, e forse anche contro la volontà dei Ministri allora in carica, che avrebbero preferito l asciare indefinita la situazione ai loro successori (il nuovo governo fu ricostruito il 4 aprile e né Ricotti né Robilant ne fecero pane), la questione dei fucili aveva fatto precipitare le fortune personali di Genè. La cosa era inoltre aggravata dal passare dei giorni, dimostrando l'inutilità assoluta della mossa del Comandante Superiore ai fini della liberazione degli ostaggi vistO che Ras Alula, doppiamente vittorioso, continuava a tenerli ben incate20 AUSSME, Carteggio En"trea,
VERSO DOGAU 441
racc. 41, 15 marzo 1887, Robilant a Ricotti. 21 lvi, 14 marzo 1887, Urg. Ris., Robilant a Gené.
nati. 1118 marzo Genè, infine, fu ufficialmente destituito dall'incarico. A sostituirlo fu chiamato il Generale Saletta (che prese possesso della sua carica il23 aprile), cui era anche stata chiesta nei giorni precedenti la stesura di un promemoria da cui fossero chiari i punti essenziali del suo pensiero sulla situazione dd presidio africano. Intanto, Robilant aveva stilato un acerbo rimprovero dell'operato di Genè («Ella ha agito senza autorizzazione, senza istruzioni ( ... ) bisogna che Ella si fermi immediatamente sul pendìo in cui Ella si è messa») e gli aveva intimato in qualche modo di disinteressarsi della sorte dei tre ostaggi.
D'ora in avanù Ella lascerà senza risposta veruna ogni comunicazione di Ras Alula intorno a Savoiroux. Si limiti a non provocarlo finché non abbia istruzioni di farlo , ma, se si presenta l'occasione; gli faccia comprendere che pouà fare tutto quello che vorrà del suo prigioniero 22 ·
Per un militare, come Genè, non poteva esserci sconfessione più aperta.
Infine, Robilant aveva insistito sull'ordine già comunicato a Genè di stabilire il blocco della costa a nord e a sud di Massaua, ordine che invece il Comandante Superiore si rifiutò addirittura di eseguire 2 3. La misura forse non era assai utile in sé, ma perlomeno avrebbe dato internazionalmente un'impressione di forza alla risposta italiana.
Il 2 aprile 1887 Ricotti scriveva il suo ultimo messaggio a Genè impartendogli le sue istruzioni militari. Modellate sul promemoria di Saletta, che era consistito in un'enunciazione di principio sulla tattica da osservarsi nella prossima estate e in dettagliato elenco di richieste di rinforzo (in uomini, in opere di difesa fissa, in numero di quadrupedi, in munizionamento individuale, in quadro organico degli ufficiali superiori, in dotazione di somme di denaro per comprare l'amicizia delle tribù vicine , in numero di interpreti, in sistemi di avvistamento , in mezzi per un più razionale e agibile attendamento e baraccamento delle truppe, in lavori di opere pubbliche a Massaua e in mezzi di trasporto marittimo) 24 , le istruzioni di Ricotti in realtà indicavano chiaramen te qual era il concetto direttivo degli

22 AUSSME
' 23 Era ancora da decretare, quando, un mese dopo, arrivò a Massaua Saletta per sostituire il Gené.
24 Cfr. AUSSME, Volumi Eritrea, v. 46.
442 L'ESERCITO NELLA
COLONIALE
POLITICA
, Carteggio Eritrea , racc. 41 , 20 marzo 1887 , Urg. Ris., Robilant aRicotti , che allega il messaggio di Robilant a Gené.
ambienti militari in quei giorni: rivincita militare sì, ma con moderazione, e comunque non subito. La rivincita andava accuratamente preparata: non si poteva correre il rischio di un altro 'insuccesso contro i Negri'. Guerra all'Etiopia andava dichiarata, la 'potenza' italiana lo esigeva: ma se ne sarebbe parlato solo in autunno e solo dopo un'attenta preparazione che eliminasse- questa volta- qualsiasi rischio di insuccesso.

l) Durante l'estate, cioè ftno a tutto settembre 1887, le truppe del presidio di Massaua saranno specialmente impiegate per la difèsa della città e delle due penisole di Gherar e Abdelkader, dei forti di Otumlo, MonkuUo e Arkiko e dei territori fra detd forti e la città;
2) Nello stesso periodo di tempo, nella estate dell887, il Comandante Superiore potrà impiegare le truppe nel modo che egli giudicherà oppottuno, per escursioni ed occupazioni temporanee di posizioni all'infuori della stessa linea dei fotti e lungo la costa.
3) Il Comandante Superiore farà prontamente al Ministero della Guerra quelle proposte che stimerà opportune per modificare occorrendo l'attuale presidio di Massaua, onde aJJicurare nel miglior modo da possibili attacchi degli abissini durante tutta l'estate, avendo pur presente la difficoltà della esistenza di un gran numero di truppe in quei luoghi in detta stagione e le conseguenze igieniche che ne potrebbero derivare.
(...)
5) Il Comandante Superiore dovrà colla massima possibile sollecitudine proporre al Ministero l'occorrente in personale, quadrupedi e materiale di ogni specie, che dovrà essere concenuato in Massaua nell'ottobre prossimo venturo, per potere iniziare nell'ottobre stesso, od al più tardi in novembre, operazioni offensive contro l'Abissinia.
In questo progetto di operazioni devesi però escludere il caso di una vera invasione nell'interno dell'Abissinia, e le operazioni stesse non dovrebbero essere spinte a grande distanza da Massaua, quale sarebbe l'attacco e l'occupazione temporanea di Asmara od altra pane importante del territOrio abissino 2 5.
Con queste parole e queste direttive perdeva senso la permanenza di Genè a Massaua e si chiudeva la parentesi della «sosta» coloniale. Questa si era di fatto infranta sugli scogli della politica indigena (sottovalutazione del pericolo abissino) e della politica militare (sopravvalutazione delle forze italiane, della possibilità di tenere con quegli organici e quella direzione una testa di ponte offensiva, della capacità di affrontare vittoriosamente i rischi di una guerra già a suo tempo individuati da Cosenz).
Terminava così veramente la «spedizione di Massaua». Questa
VERSO DOGAU 443
25
AUSSME, Carteggio En.trea, racc. 10, 2 aprile 1887, Ris., Ricotti a Saletta.
sorta di decisivo prologo alla storia del colonialismo italiano che si era consumato in due anni intorno al porto del Mar Rosso aveva però contribuito ad evidenziare drammaticamente - da subito - talune insufficienze del colonialismo politico e militare italiano.
L'influenza dei militari, che pure era stata come si è visto decisiva in quei primi due anni, doveva tendere in quelli successivi ad aumentare, sia pure in forme ed in rapporti nuovi. Il fatto che il nuovo Comandante Superiore destinato a sostituire Genè non dipese, come Genè stesso, dal Ministro degli Esteri e dal Ministro della Guerra, ma principalmente dalla Pilotta doveva esserne :un primo, rivelatore, segnale 26.
Eppure, anche nei due anni che avevano portato i soldati italiani da Massaua a Saati e a Dogali, il ruolo ed il peso militare nella politica coloniale non era stato secondario. Una volta tralasciati i piani di Mancini, militare era stata la decisione sulla quantità di forza necessaria a presidiare il territorio coloniale, come militari erano stati gli entusiasmi espansionistici di Saletta (che avevano portato il tricolore prima sui fortini avanzati e poi su Saati), il disegno di Ricotti di ridurre quanto prima possibile l'effettivo del presidio, i piani e gli interessamenti dimostrati in momenti cruciali dallo Stato Maggiore. Militare, infine, la scelta di Genè come militare la sua ultima, infausta, serie di misure per salvare troppe cose insieme (sicurezza del presidio, onore italiano, vita degli ostaggi, credibilità di Comandante).
Certo, lo spazio in cui i militari facevano le loro scelte era quello, angusto ma al tempo stesso in più di un'occasione velleitario, della politica coloniale italiana del tempo: una politica che con 'poco sforzo e poca spesa' voleva ottenere molto più prestigio, considerazione e vantaggi di quanti in realtà sì sarebbe potuto 2 7.
È anche un dato di fatto che la crisi arrivò, e Dogali mieté le sue vittime, proprio in un momento in cui dal Mar Rosso l'Italia non si aspettava nulla, nel bene e nel male. Fu il fallimento di una politica che aveva detto di essere tesa al raccoglimento a rendere meno accettabile all'opinione pubblica, e meno giustificabile a quella politica, le ragioni del tracollo.
Se anche poi il mito che passò a livello popolare e di larga pane dell'opinione pubblica fu quello- retorico, 'nazionale' e patriot-
26 Cfr. BATIAGLIA, La prima guerra d'Africa, cit., p. 323.
27 Cfr. ROCHAT. Il colonialismo italiano, cit., pp. 220-221.

444 L' ESERCITO NllLLA POLITICA COLONIALE
tardo - dell'eroica resistenza e dell'estremo sacrificio della colonna De Cristoforis, in realtà fu la conduzione militare della spedizione di Massaua che fu messa da subito in stato di accusa, insieme e più di quella politica. Lo stesso Ricotti, intervenendo al Parlamento poche settimane dopo la sua sostituzione al Ministero della Guerra con Benolè Viale, ne era già cosciente. Da una parte ribadì l'onore guadagnato dai soldati a Dogali: e qui trovò approvazioni io tutta la Camera
Tutti i militari ed, anche i non militari sentono che, dopo questo fatto, il nosuo giovine esercito ha guadagnato (Voci. Sì! Sì! Approvazione) nell'opinione nostra stessa 28.
Ma dall'altra capì che un esame politico delle vicende dei primi due anni coloniali non potevano non condurre ad un vaglio assai critico della condotta militare. Proprio in quanto militare ed in quanto ex-Ministro della Guerra egli aveva iniziato il suo discorso affermando che «<o, in questa questione, sono l'accusato, gravemente accusato dall'opinione pubblica e dalla Camera ( ... )» 29.

Ricotti poi, non disinteressatamente, si diffuse nel suo discorso in tentativi di convincere la Camera della sua previdenza e degli sforzi da lui tentati per far desistere ora Saletta ora Genè da mire espansionistiche che volessero superare i confini di Massaua. E forse in questo, particolarmente in quanto atteneva alla sua opera di freno nei confronti del colonnello, aveva anche ragione.
Ma dove Ricotti non poteva essere convincente era nell'esame delle ragioni di fondo dello scacco coloniale che l'Italia era venuto a subire. Ragioni che erano politiche, ma la cui responsabilità immediata doveva farsi ascendere a militari. Massaua, nata come meta coloniale all'interno di un progetto più grande di cooperazione politica e militare italo-inglese (progetto, purtroppo, scaturito e presente solo nell'immaginazione di Mancini), rimaneva una conquista dal valore dimezzato quando, con la caduta di Khanum, ogni velleità di cooperazione si era allontanata per sempre. Di fronte al grande problema su che cosa fare di Massaua a decidere erano stati in realtà, per primi, Saletta che si spinse sino a Saati, Ricotti che non impedì questa scelta, e Genè che anzi - in un momento di tensione - vi
VERSO DOGAU 445
28 AA.PP., Carnera, Legisl. XVI, sess. prima, Discussioni, tornata del31 maggio 1887. 29 lvi.
NELLA POUTICA COLONIALE
mandò «truppe regolari e cannoni» 30. Con una forza militare, nell'ordine di qualche battaglione (forza che che persino lo Stato Maggiore aveva da subito giudicato dover «non quindi costituire l'inizio dell'operazione ma fornire soltanto i mezzi per rendere possibile la ricognizione preparatoria della operazione stessa») 3l, l'Italia aveva preteso di svolgere un ruolo da protagonista nella surriscaldata regione abissina. Con una forza simile, si era voluto tenere una posizione che non era semplicemente difensiva ma che assumeva uno spiccato carattere offensivo verso la potenza etiopica.

Perché si fosse abbandonata quella iniz iale e più conveniente (anche se non per questo più sicura) posizione militare riassumibile nella sola difesa del porto di Massaua, lo abbiamo provato a spiegare nelle pagine precedenti. I motivi furono diversi, ma dal punto di vista militare per Saletta e Ricotti e Cosenz una rilevanza particolare doveva avere avuto quella tendenza, quella spinta a liberarsi della tutela e dal controllo che una subordinazione alla Marina significava per l'Esercito sulle coste del Mar Rosso. Una spinta che era apparsa già chiaramente allo stesso Cosenz quando stese quel primo piano di spedizione militare nel Mar Rosso. «La nostra nascente colonia [e si noti la precisione terminologica con cui lo Stato Maggiore già in quei primissimi giorni voleva che si chiamassero i futuri presidi del Mar Rosso] si può bensì considerare come abbastanza protetta finché lo stazionario della R. Marina è ancorato presso la costa. Essa è però esposta a correre gravi rischi per le probabili incursioni dei feroci abitanti dell'interno ogni qualvolta lo stazionario se ne allontana, come accadde abbastanza di frequente» 32 Perciò, per tenere a bada quei 'feroci abitanti', per non dover condizionare la colonia alle esigenze della Mariria, per essere sicuri - soprattutto - non solo della parte di mare ma da quella di terra, l ' influenza decisiva in colonia doveva secondo Cosenz essere quella dell'Esercito. E per tutto questo, sottintendeva il Capo dello SME, non bastava più 'l'invio di qualche battaglione' e per questo, comunque, l 'influenza determinante doveva essere quella dell'Esercito.
Questa iniziale distonia nei rapporti tra Marina ed Esercito fu
446
L'ESERCITO
AUSSME, Carteggio Eritrea, racc. 41, 22 gennaio 1887 , Gené a Ricotti.
MCR, Carte Mancini , b 651, fase. 12, doc. 2, 4 gennaio 1885, Coseaz a Ricot-
Mancini).
lvi.
30
31
ti (e a
32
poi risolta con la fine del 1885, con il 'colpo di stato' di Genè. Ma ormai, anche per quei motivi, si era a Saati. E il presidio italiano vi sarebbe rimasto sino a Dogali.
La spinta verso l ' interno, comunque, era l'unica spinta colonialista possibile , una volta che non si fosse chiaramente stabilito di rimanere sempre e solo a Massaua. Un'occupazione simbolica dei villaggi delle coste non aveva alcun senso e nessuna possibilità di essere duratura. Esigenze militari, dell'esercito, ed 'esigenze colonialistiche• per un tratto marciarono assieme.
Oltre ai caduti di Dogali , oltre alle migliaia di giovani italiani di leva che transitarono in quei due anni sulle infuocate spiagge del Mar Rosso, oltre - in fondo- all'Italia che così dolorosamente faceva il suo ingresso nell'arengo delle 'potenze coloniali', chi pagò politicamente quest'insieme di intricate responsabilità per la gestione della 'spedizione di Massaua' fu il Ministro della Guerra Cesare Ricotti.
Ricotti poteva anche, come fece in quel suo discorso del maggio 1887, riconfermare alcune sue caratteristiche di militare eterodosso, imprevedibile, sospetto (ai militari ed all'opinione pubblica): come quando non volle perdere l'occasione di criticare pubblicamente il comportamento militare di quel De Cristoforis che pure da poco era divenuto un eroe nazionale. Questi lati del carattere non potevano però impedire la sua messa in stato di accusa tra i politici come tra i militari. Il generale novarese diveniva in qualche modo una vittima politica di Dogali anche se in realtà ne era stato uno dei responsabili.

Come si è visto, in questa 'spedizione per Massaua', diverse responsabilità si erano sovrapposte a diversi livelli. Quella di Ricotti consisté principalmente nell'avere - correttamente - intuito l'imponanza di non estendere il presidio oltre Massaua e nell'aver in varie riprese ridotto il contingente inviatovi ma nell'aver avallato la permanenza a Saati anche dopo gli ultimatum abissini e nel non aver voluto insistere per una diplomatica chiarificazione del contenzioso italo-etiopico che si era così creato. L'eccessiva fiducia nel fatto (militare) compiuto contagiò quindi anche il cauto Ministro della Guerra. La mancata chiarezza nel distinguere, a livello militare, tra un dispiegamento delle forze difensivo ed uno offensivo e la mancata volontà nel far rispettare quella distinzione creò le premesse perché si passasse- lungo una stessa strada- da Massaua , a Saati a Ua-à. Ma era una strada che sboccava a Dogali.
Analogamente - ed a un livello superiore - una volta che non
VERSO DOGAU 447
si era politicamente stabilito in modo chiaro e deciso di rimanere sempre e solo a Massaua (e si è visto come il governo non aveva voluto, o potuto , frenare le varie dinamiche diplomatiche e militari, centrali e 'locali ', nonostante quella sua verbale ricerca del 'raccoglimento') , la spinta verso l'interno- ora per Saati o per Keren, poi per Asmaro e oltre - si sarebbe ripresemata.
Il meccanismo coloniale si era messo in moto.

448 L'ESERCITO N'Elli\ POLITICA COLONIAlE
CONCLUSIONI
Il nostro esame del se condo Ministero Ricotti ci ha riponato alla questione di fondo di qualsiasi studio di storia militare su quel periodo. Furono gli anni Ottanta del secolo XIX un o d e i periodi più felici della storia dell'esercito italiano? 1 Ed all'interno di quel decennio il secondo Ministero Ricotti rispecchiava fedelmente le caratteristiche dell'intero arco degli anni Ottanta?
Dal punto di vista finanziario ciò è indubitabile: i bilanci di Guerra e Marina conobbero rapidi incrementi. Ma, se quest o è vero , è d'altra pane necessario non dimenticare che una politi ca di alte spese militari , in realtà , fu sem p re sentita come una necessità dalla classe dirigente dell ' Italia liberale 2 Vari , e noti , erano i motivi: garanzia d e l! ' ordine politico e pubbli co , prestigio internazionale , reale consistenza delle minacce estere all'integrità dello Stato nazionale così faticosamente conquistato.
Tra il 1861 ed il1866 più di una lira su tre di spese pubbliche fu devoluta alle istituzioni militari. Le Finanze ne uscirono stremat e . N e seguì una riduzione, ma già intorno al18 76 - dopo che la maggiore delle forze armate , l'esercito , fu ingrandita e ristrutturata - le spese militari ave vano raggiunto la considere vo le altezza di un quinto delle intere spese sta t ali . Al di sotto di quel li ve llo , praticamente , non scesero mai . Comin ciò anzi una salita d e ll a percentuale delle spese militari sul total e delle spese statali: più lenta negli ultimi anni Settanta, più veloce ed improvvisa negli anni Ottanta (dal 21,5% del1880 all'episodico ma significativo 32 ,3 % del1889, un 'pi cco' statistico comunque precisato dal 27,3 del 1888 e dal 26,6

1 Cfr., co m e g ià si è vistO, tra g l i alui , CEVA, Le forze armate, cit., p . 93.
2 Sul g iu dizio circa le spese m ili tari cfr di nu ovo ROCH AT , MASSO BR10, Breve storùz dell'esercito italiano dal 1861 a/1943, cit., p 66 e sgg .; DE ROSA, I n cid e nza delle spese militan· sullo sviluppo economico italian o, éit., p. 183 e sgg.; PEDONE , Il bilancio dello Stato, cit., p. 216. Pe r alcuni p rimi dati ag gregati cfr. F.A. RE PA CI , Lafinanzap ubblicaitalian a n elsecolo 1861-1960, Bolog n a, Zanich e ll i, 1962, pp . 35-37.
del 1890) , frenata nel lustro successivo e poi stabilizzatasi - dopo Adua- su un valore medio che oscillava tra il 22,5% del 1898, il 20 del 1906 ed il 22,6 del1910. Dopo di che, più o meno costantemente, iniziò il riarmo prebellico che consentì la campagna di Libia e poi l'ingresso dell'Italia nella prima guerra mondiale. Nel frattempo, lentamente, era andata aumentando la ricchezza del Paese: cresceva il prodotto interno lordo, il reddito nazionale, l'imposizione fiscale, il bilancio dello Stato. Sino alla fine del secolo la mancanza di un decollo industriale impedì quel rapido ed omogeneo processo di accumulazione che in altri Paesi si era già notato , ma non rese impossibile all'istituzione statale di accrescere il suo peso sull'economia. Se nel 1862 le spese effettive dello Stato erano assommate a 900 milioni di lire e le entrate a 4 50, nel1913 esse erano salite rispettivamente a 2.843 e 2.287. In particolare si può notare che il disavanzo effettivo, particolarmente forte nei primi anni dell'indipendenza, riuscì ad essere contenuto solo negli esercizi finanziari tra il 1874 ed il 1880. Dopo quella data esso si ripresentò - negli anni Ottanta e nei primi anni Novanta - in forme minacciose e dovette passare un quindicennio perché fosse riportato prima ai valori del 1880 e poi lentamente ripianato e trasformato in un attivo. Dopo il 1910 però crisi economica, sviluppo del Paese, tendenza al riarmo ed altri fattori fecero riapparire il disavanzo e lo resero un fatto strutturale dell'economia e della politica italiana.

Da tale punto di vista, l'aumento dei bilanci statali e la costanza (tendente al rialzo) dello spazio, all'interno di questi, concesso alle spese militari danno l'esatta misura dell'importanza delle forze armate nell'Italia liberale. E, sop rattutto, inquadrano esattamente il problema degli stanziamenti per l'esercito e la marina. Tra i due, naturalmente, fu sempre l'esercito ad essere il destinatario della quota maggiore.
Le spese straordinarie per l'esercito ebbero andamento alterno: sia pure escludendo ovviamente i 'picchi' raggiunti dapprima durante gli anni tra la seconda e la terza guerra d'indipendenza, poi in coincidenza con la campagna di Roma, quindi con gli assegni crispini del 1888-89 per le fortificazioni e i fucili e del 1895-96 per la campagna africana, poi conclusasi ad Adua, esse rimasero sotto i venti milioni annui sino al 1876, superarono poi quella cifra e, tra il 1882 ed il 1891, oltrepassarono i 40 annui (più di una volta in larga misura); quindi diminuirono di colpo a meno di venti milioni e fu necessario attendere un decennio perché tor-
450 IL GENERALE
CESARE RICOTn ( 1884·1887}
nassero a superare quella cifra; nel 1909 raggiunsero quota 54 e nd 1910 quota 73 milioni. In conclusione, quindi, le spese straordinarie pesarono sugli esercizi finanziari dell'Italia liberale per una media di circa 30 milioni annui (escludendo quei 'picchi' cui prima si accennava e che , se considerati , farebbero salire la media degli assegni straordinari per il solo esercito a quasi 40 milioni annui).

Le spese ordinarie, dal loro canto, crebbero quasi costantemente .in valore assoluto. Dai 150 milioni del1867 ai 165 del1876 , erano divenuti più di 170 con l'arrivo al potere della Sinistra storica e passarono poi da 190 a 257 dal 1880 al1890; dopo di che subirono una certa contrazione. Ma ritornarono a 255 nel1897. Da allora aumentarono lentamente ma costantemente , sino allo scoppio della Grande Guerra.
Dall'esame di queste linee di tendenza generale emerge con ch.ia-' rezza che gli anni ottanta- per ognuno dei trend qui ricordati (altezza delle spese militari, rapporto tra entità del bilancio statale e dimensione del deficit effettivo , consistenza rispettiva delle spese ordinarie e di quelle straordinarie per l'esercito) - segnano un momento di ' picco ' . E la particolarità più evidente della politica militare di questo decennio sta tutta qui, in questo suo situarsi come imersezione al punto più alto di tutte queste curve.
Ma sottolineare questo primo aspetto generale dice ancora poco su come vennero effettivamente impiegati questi larghi fond i Che cosa si fece per miglorare l'esercito , per colmare alcune note lacune nella sua composizione, per correggere alcuni suoi difetti nella preparazione, per portarlo allivello degli altri potenti eserciti europei ed al punto di garantire gli interessi nazionali e gli scopi della politica estera?
Per trovare una prima risposta - sia pur dentro i limiti della documentazione sin qui da noi analizzata - uno studio sul secondo Ministero Ricotti presentava l'utilità di offrire un interessante punto di osservazione .
L'esercito italiano nei primi anni Ottanta , e più specificatamente nell'arco di anni da poi preso in esame , costituiva a prima vista un forte strumento militare. Almeno quantitativamente, infatti, un esercito di 12 corpi d ' armata, 22 reggimenti di Cavalleria , 17 di Artiglieria , 4 del Genio poneva militarmente l ' Italia in una posizione certo distanziata ma non più troppo lontana dalle altre potenze eu-
CONCLUS IONI 4 51
ropee 3. La vocazione a 'grande potenza' dell'Italia in quegli anni poteva basarsi così molto più sulla forza del dispositivo militare che sull' incisività dell'iniziativa diplomatica, sul numero della popolazione o sulla ricchezza del Paese.
Questo era sostanzialmente un risultato delle riforme militari del 1870-76 4.
Esse avevano permesso il passaggio dell'ordinamento militare da un 'mode llo francese', basato su un esercito d i truppa a lunga ferma e a base ristretta, a quello 'prussiano' caratterizzato dal servizio militare obbligatorio, dalla ferma più breve, dalla coscrizione nazionale, dalla possibilità di procedere ad un regolare ed ord inato richiamo in servizio - in caso di guerra - di quelle classi di leva che avessero già soddisfatto gli obblighi militari e che venivano inserite in Milizie di seconda e di terza linea. Nell'intenzione dei riformatori militari non doveva più accadere, co m e era successo in due delle tre guerre di indipendenza, che l' ese rcito- passati i primi scontri - non potesse colmare i vuoti aperti dai combattimenti con riserve pronte ed addestrate. Inoltre, il numero dei Corpi d'Armata non era poi così distante da quanto le allora più moderne teorie organiche prevedevano che dovesse essere in rapporto con la popolazione del Regno. La scelta riformatrice, infine, era stata realizzata in un momento internazionale non facile per l'Italia e sulla base di un Bilancio militare che ancora risentiva delle ristrettezze imposte dal non entusiasmante risultato della guerra del 1866.
Tutto questo complesso sforzo nazionale , però, non significava di per sé che quel nuovo esercito, necessario per il prestigio internazionale che ne derivava e sufficiente per il mantenimento dell'ordinamento politico e dell'ordine pubblico, fosse poi perfettamente pronto a rispondere a tutti i suoi compiti.
La riforma Ricotti, infatti, lasciava in eredità alla politica militare del Regno d'Italia numerosi problemi importanti da risolvere che - negli anni Ottanta, ma spesso anche dopo - si ripresentarono ai vari Ministri della Guerra. Il contingente di leva , che pure venne continuamente aumentato, era assai alto rispetto alle capacità finanziarie dei Bilanci militari mentre rimanevano semp re assai ampi la cos tosa intelaiatura dei quadri e l'organico del Corpo Ufficiali. Le
3 Cfr. , L 'eseràto e i suoi corpi. Sintesi storica , cit.
4 Cfr. ROCHAT, MASSOBRlO, Bre11e storia dell'esercito tialiano da/1861 a/1943 , cit., p . 84 e sgg. ; e DEL NEGRO, Esercito, Stato, società. Saggt di st oria militare , cir. , p 192 e sgg.

452 IL GENERALE CES ARE RJ COTII (1884-1887)
truppe di riserva si volevano inquadrate nella Milizia Mobile e nella Milizia Territoriale, ma la seconda restò a lungo sulla carta mentre l'efficienza dei riservisti iscritti nella prima fu poche volte provata tramite richiami regolari che, peraltro, presentavano costi non trascurabili. Nonostante lo studio della Commissione per la Difesa dello Stato negli anni Sessanta ed il forte dibattito sviluppatosi all' inizio del decennio succesivo, il sistema delle fortificazioni militari del Regno rimaneva lacunoso e risentiva ancora del fatto di essere spesso una sommatoria dei singoli sistemi fortificatoti dei precedenti Stati regionali pre-unitari (e poi delle varie preoccupazioni dei diversi Ministri della Guerra) piuttosto che la sintesi e lo strumento di un originale piano strategico. Lo stesso esercito permanente soffriva di uno squilibrio tra le varie Armi, per cui la Cavalleria e l'Artiglieria risentivano di un insufficiente sviluppo e di una attardata formazione organica, nonostante che le recenti guerre avessero messo in evidenza il loro nuovo possibile uso strategico. Il reclutamento di ufficiali e sottufficiali, infme, non andava indenne da varie pecche strutturali.

A questo si aggiungeva il fatto per cui l'esercito, pensato in vista di un efficace mantenimento dell'ordine istituzionale e politico e strutturato per una·forte difensiva nazionale (questa era in fondo l'ottica di Cesare Ricotti e di tanti suoi coetanei 'generali dell'indipendenza'), andava- verso la fine degli anni settanta e poi ancor più cogli anni ottanta - caricandosi di aspirazioni, di piani, di velleità e di miti offensivistici. La situazione politica europea non permise per lungo tempo ai militari italiani di andare oltre, nella pianificazione della guerra, la pura difensiva. Questa veniva, al massimo, corretta con l'affermazione verbale della possibilità di una ripresa e di un'azione controffensiva delle armi nazionali, nel caso fortunato in cui queste non fossero già risultate annientate da una prima grande battaglia campale.
Tutta questa situazione si fece con l'andare del tempo ancora più critica se si pensa che le potenze europee, negli anni a cavallo tra i decenni '70 e '80 , andarono perfezionando le loro forze armate ispirandole sempre più ad una dottrina strategica offensiva e sostenendone le aspirazioni militari con formidabili progressi nei meccanismi di mobilitazione: aspetto quest'ultimo assai poco affrontato in Italia. Infine, sempre a livello europeo , andava imponendosi la pratica di affinare i sistemi d'arma e di aumentare sempre più la forza presente alle armi (aumentando la forza organica di guerra e di pace delle compagnie), cosa questa che avrebbe permesso un più immediato uso degli eserciti permanenti.
CONCLUS IONI 453
Dopo le rif0rme Ricotti qualcosa fu fatto in Italia per ovviare a questi difetti. Ma mai a sufficien za e per svariati motivi. Si identificò e si rese stabile, tra l 'altro, il quadro territoriale dei Comandi dell'esercito del tempo di pace con quello da adottarsi in tempo di guerra, si dette nuovo stimolo (militare e finanziario) agli stu di ed alle realizzazioni in tema di fonificazioni permanenti, si tese ad aumentare il contin gente di leva . Quando nel 1882 un lungo dibattito politico e militare sulla necessità di aumentare la forza d eli' esercito condusse alla creazione di due nuovi Corpi d'Armata, in realtà la cosa significò un aumento notevole ma solo quantitativo dell' ordinamento militare.
Se l'Italia sperava- così facendo- di accrescere il suo prestigio internazionale, le forze armate si trovavano in realtà costrette a fronteggiare i soliti problemi, moltiplicati però dalle dimensioni del progresso militare europeo.
È a questo punto, all'incirca a metà degli anni Ottanta, che Cesare Ricotti tornava a reggere il Dicastero della Guerra.

Come abbiamo visto dal nostro studio su questo suo 'secondo Ministero' (e sul dibattito politico e militare che lo accompagnò) non ci furono in quegli anni né la volontà politica né gli spazi politici, economici, militari, per ovviare a quelle cosl gravi lacune: nonostante questo, continuarono ad aumentare ii peso dell'esercito e le responsabilità cui esso era fatto carico dalla Triplice Alleanza e dalle prime aspirazioni coloniali. È in questo senso davvero corretto affermare che Ricotti, seppure malgré lui, «aveva trasformato l 'ordinamento Ferrero da potenzialmente offensivo ad effettivamente offenCiò non poteva non far risaltare, tra l'altro, nel dibattito politico e militare, tutte le lacune e le insufficienze dell'esercito stesso. Il fatto infine che questa seco nda esperienza ministeriale di Ricotti fosse stata segnata e gravata (mo lto più che la prima) dalla congiuntura politica non toglieva interesse ad un a sua attenta e ravvicinata disamina, e casomai riapriva- pur senza volerlo esaurire - il difficile capitolo delle relazioni tra politici e militari nell'Italia umbertina.
In generale, molte cose cambiarono in Italia dopo quel sesto e quel settimo Gabinetto Depretis, nei quali Ricotti fu appunto Mini-
Il GENERALE
CES ARE RICOTI1 ( 1884-1887)
5 DEL NEGRO, Esercito, Slalo, società. Saggi di stona militare , cit. , p. 128.
stro della Guerra 6.
Con quei due Governi si chiudeva l'esperienza del trasformismo di Depretis e del suo confuso e continuo aggregarsi e disaggregarsi di maggioranze (parlamentari e sociali): forze politiche e sociali più decise erano destinate a prendere il suo posto. Si apriva in generale la strada ad un diverso orientamento complessivo della politica italiana con il progressivo costituirsi di un blocco conservatore di forze politico-sociali , più stabile e più forte di quello su cui si era retto Depretis.
Nell'ottica di questo trapasso da Depretis a Crispi, i militari degli anni del secondo Ministero Ricotti rappresentarono un elemento io qualche modo attivo. Anche a livello parlamentare, il fallimento di Ricotti (di fronte all'opinione pubblica militare come io faccia alle reali 'sfide' della politica militare di quegli anni) fu uno dei fattori che contribuirono ad indebolire decisamente la politica di Depretis e del trasforrnismo.
Dopo il 1887, dopo Depretis e Ricotti, nello specifico campo della politica militare alcuni elementi si evidenziarono panicolarmente. Si concretizzava con apposita convenzione lo sbocco strategico della coop erazione militare i talo -germanica; si appesantiva il carico militare dell'espansione coloniale; diveniva di fatto sempre di più 'intoccabile' l'ordinamento su dodici corpi d'armata, so lo io qualche parte ritoccato; si restringevano sempre di più i margini per un'azione riformatrice che aggredisse le più grosse carenze dell'organismo militare; si qualificava di fatto la carica di Capo di Stato Maggiore; si assisteva ad un rafforzamento della Marina Militare (pe r l'articolarsi della politica estera nazionale e per il rafforzarsi dei gruppi a rmatoriali e cantieristici). Tutti elementi decisivi, questi, che aumentavano in misura nuova il peso contrattuale dei militari , ma che pure non curavano le vecchie malattie d e li' esercito 7.
Durante la permanenza rninisteriale di Ricotti molti di questi elementi avevano già fatto qualche prima apparizione. Alcuni andavano nella stessa direzione delle idee e delle aspirazioni di Ricotti, e avevano avuto l'avallo ministeriale; ma per la maggior parte si dovevano rivelare estranei ali' orizzonte politico ed alla prospettiva mi-
6 Cfr. CAROCCI, Storia d'Italia dall'unità ad oggi, cit ., p. 89; RAGIONIERI, La storia politica e sociale, cit., p. 1753.
7 Cfr. PIERI, Storia mzlitare del Risorgimento. Guerre e insurrezioni, cit.; MANACORDA, Introduzione, a PELLO UX , Quelques souvenirs de ma vie, cit.; DEL NEGRO, Esercito, Stato, società. Saggi di storia militare, cit.

CONCLUSIONI 455
litare del novarese (anche se, talvolta, egli li aveva- trasformisticamente - tolle rati)_
Ricotti, così, si trovò sconfitto sia sul breve sia sul lungo periodo_
Sul breve periodo, a ben vedere, è significativo il fatto che egli abbia dovuto lasciare il Ministero della Guerra per un episodio di quella politica coloniale che il novarese nel suo complesso non aveva mai visto di buon occhio e per un coalizzarsi di forze politiche e militari (tra cui la stampa militare, la deputazione militare al Parlamento, ceni ambienti dello Stato Maggiore) verso cui Ricotti, in ultima analisi, non era stato mai molto indulgente_
SuJla lunga distanza , molte delle cose cui Ricotti si era opposto (o che almeno egli non aveva favorito nel corso del suo secondo Ministero) risultarono vincenti_ Le spese mi litari, che egli avrebbe voluto vedere non ridotte ma regolate (se non altro perché non si fidava deJla proclamata solvibilità finanziaria illimitata dello Stato uscito dalle guerre d'indipendenza e perché aveva sempre temuto le conseguenze di quei subitanei restringimenti dei Bilanci, di cui aveva già visto i risultati sull'amministrazione militare dopo il 1866) , furono poi invece aumentate venicalmente con Crispi e altrettanto rapidamente ridotte con Di Rudinì e Pelloux, dando così origine proprio a quello che Ricotti aveva sempre paventato: una, seppur congi unturale, crisi militare_ La car ica di Capo di Stato Maggiore, che tanto Ricotti aveva voluto ridurre a mero ufficio tecnico e consultivo , andò invece acquistando nel tempo sempre maggiore imponanza e contribuì sempre più nel lungo periodo a relegare le competenze del Ministro della Guerra al solo campo amministrativo_ Quella sona di modello militare formato da un forte Esercito e da una debole Marina, sostenuto da Ricotti (e da altri generali della sua generazione) come dato di fatto immodificabile del potenziale militare italiano, in realtà andava incrinandosi di fronte all'incisivo seppur lento potenziamento della flotta militare: la quale , inoltre, per dottrina strategica e per consistenza militare, non gradiva più vedersi 'costretta' nel puro scopo di difesa degli arsenali e di prevenzione degli sbarchi nemici e modificava la sua dottrina strategica in una direzione sempre più offensivistica_ Il nodo dell 'avanzamento degli Ufficiali andò , anche nel decennio successivo , sempre più complicandosi, sino a divenire un problema così grosso da sopravvivere poi anche alla prima leggequadro del 1896 e da costituire una delle cause non secondarie che portarono alla nascita (intorno a Fabio Ranzi) di quel movimento militare di opinione detto 'rnodernista' _

IL GENERALE
CESARE RICOTII (1884-1887)
La stessa prospettiva strategico-militare (quale tipo di battaglia e di guerra l'esercito italiano avrebbe potuto combattere) parve poi nella realtà divergere alquanto dalle ipotesi di Ricotti. Ma quello che nella prospettiva strategica andava mutando, lentamente seppur radicalmente, secondo i documenti consultati, era proprio l'ipotesi di una grande battaglia definitiva nella pianura padana, su quei campi irrigui e fratti della valle del Po che già avevano conosciu to tutte le battaglie dell'indipendenza italiana. Mentre , sino a Ricotti, essa era in sost anza l'unico obiettivo militare proponibile per l ' esercito italiano (come era successo nelle guerre d'indipendenza), dopo il1887 e meglio dopo la firma della conven zione militare itala-germanica voluta da Crispi e da Cosenz , lo studio della pianificazione della guerra italiana sarebbe stato costretto a tenere conto d eU' ipotesi di inviare una consistente Armata (tre-quattro corpi d'armata , più una divisione autonoma di Cavalleria, con annessi servizi) sulle pianure del Reno.
Per il dispositivo militare italiano questa era una novità strutturale, seppure attesa da anni in certi ambienti militari , e che non va sottovalutata. In qualche modo quella era la legittimazione 'europea' (o della Triplice) dello sfo rzo militare italiano durato più di un quindicennio, dal 1870 perlomeno. Anche se Ricotti, nel 1884-8 7, non parve essere entusiasta di questa nuova prospettiva, essa era di fatto il coronamento delle riforme militari da lui dirette nel decennio precedente.
Questi furono , in sostanza, i grandi nodi della politica militare italiana degli anni Ottanta: prima, durante (e talvolta malgrado) Ricotti, ed oltre.

Un Ricotti 'sconfitto' su diversi piani dal ' progresso ' delle cose politiche e militari non deve però dare l'errata impressione di un politico chiuso, di un uomo non lungimirante, di un militare 'reazio. ' nano .
Ricotti non fu tutto questo.
Non va dimenticato , per quanto la cosa abbia un significato simbolico, che Ricotti fu praticamente l ' ultimo militare ad occupare la ca ri ca di Ministro della Guerra che avesse guadagnato il grado di generale in più di una campagna per l'indipendenza. Questo di per sé lo caratterizzava . Il mond o militare in cui eg li era cresciuto era stato quello piemontese lamarmoriano e l ' ambiente in cui aveva fatto le prime importanti prove belliche e politiche era sostanzialmente
CONCLUSIONI 457
quello che aveva combattuto per l'unità d ' Italia. L'unificazione e poi il lungo ' regno ' della Destra storica era stato lo scenario in cui si era mosso ormai come protagonista. Lo stesso suo grande operato di riforma tra il1870 ed il 1876, che in profondità rimane ancora da studiare, risentì a ben vedere di questo carattere dell'uomo (e della sua generazione di militari). Nonostante l 'età non avanzata, gli erano in un ceno senso estranei il governo della Sinistra storica, il trasformismo di Depretis , gli anni Ottanta.

È in fondo per questo suo ' impersonificare ' la tradizione e la continuità dell 'eserci to italiano che la notizia della sua nomina (pur tra le apprensioni circa lo svil uppo o rganico dell'esercito) fu vista come un segno di forza militare e di prestigio politico non solo della maggioranza parlame ntare trasformista ma dell'inte ro Stato umbertino . Questo avrebbe dovuto, nei piani del presidente del Consiglio, rafforzare la maggioranza: e fu così, ma solo su l breve periodo. Già sulla media distanza (due-tre anni) doveva invece essere prop rio l'ambiente militare a dichiararsi insoddisfatto delia politica militare dei governi di Depretis e di Ricotti e a guardare co n interesse a quegli aspetti di autorità e di prestigio che la politica crispina vistosamente voleva presentare.
L'ese rcito finiva così per criticare il suo Ministro.
Si può ritornare così agli interrogativi da cui la ricerca aveva preso le mosse. Erano gli anni Ottanta un periodo felice per l'esercito italiano? Lo era stato anche il triennio di Ricotti?
Una valutazione storiografica puramente ottimistica non pare corrispondere in pieno alla compless ità della realtà storica.
Cenarnente i bilanci militari lievitarono considerevolmente in quel periodo, il ruolo interno ed esterno dell 'esercito aumentò, la sp edizione militare a Massaua - seppure momentaneamente e tragicamente bloccata a D ogali- aveva aperto nuo ve strade di impiego militare, col passare degli anni andava aumentando il ruolo ed il prestigio dello Stato Maggiore dell'Esercito e del suo Capo, gli organici erano di nuovo cresciuti (rispetto allo stesso grande passo in avanti fatto nel '70-'7 6) e la consistenza numerica del Corpo Ufficiali veniva continuamente- anche se non vistosamente - fatta aumentare. L' esercito sempre più consolidava il suo ruolo di alfiere d eli' onore nazionale , il fantasma di Custoza cominciava ad allontanarsi nel tempo.
Ma all'interno della macchina militare rimanevano le già note crepe.
458 IL GENERALE
CESARE RJCOTil {1884·1887)
Il meccanismo della mobilitazione italiana non sembrava aver riportato decisivi miglioramenti, la riserva di terza linea era ancora lungi dali ' essere inquadrata, il secondo p iano delle fortificazionii cu i lavori peraltro furono ral lentati e ritardati - non aveva risolto il prob lema de ll a difesa permanente.
Il rapporto tra Esercito e Marina (a livello sia organico sia strategico) non era ancora ben definito, e tendevano ad emergere impostazioni con traddittorie.
L'armamento italiano non aveva conosciuto (anche nel campo della 'artiglieria portatile', sino al1890) quelle migliori soluzioni adottate negli altri Paesi europei.
L'eterogeneità dei quadri, che era stato uno dei massimi difetti evidenz iatisi nella guerra del 1866, cominciava ad essere attenuata dal i ' affiatamento creatasi tra gli uffic ial i dopo quasi un ventennio di permanenza ne ll 'esercito e dall'operato delle scuo le militar i , di cui però si lamentava la scarsa qualità deg li studi.
Il problema dei sottufficiali continuava a non essere valutato in tutta la sua importanza militare e tendeva ad essere ripetutamente posto solo dal punto di vista della ricerca di forme d'impiego per quei sottufficiali che avessero lasciato il servizio nei repani.
Le compagnie, prima come dopo le misure prese da Ricotti , erano costantemente tenute 'sottoforza', con discapito dell'istruzione delle reclute e della pratica degli ufficiali.

Il servizio di ordine pubblico, particolarmente importante negli anni Ottanta in coincidenza con le lotte del Partito Operaio Italiano e con le agitazioni del movimento contadino del 'la boje!' e dei primi scioperi urbani , continuava a distrarre la truppa dal regolare addestramento.
Le misure prese per )"educazione militare' del soldato , mosse dall'intento di avvicinare il cittadino all ' istituzione militare e di ricreare una sona di afflato 'risorgimentale' tra nazione e 'nazione armata', furono condotte con mezzi ed in forme attardate e paternalistiche, senza reali mutamenti nel sistema di reclutamento e nella vita di caserma che continuava invece ad essere assa i dura. Le misure di Ricotti, insomma, il cui miglior e più rappresentativo esempio rimane il concorso per il 'libro del soldato', non potevano impedire che si perpetuasse l'estraneità popolare al mestiere ed agli obblighi militari , nonché all'esperienza della leva. Estraneità nella qualenei due decenni successivi - trovò il suo migliore terreno di coltura il nascente antimilitarismo politico.
Le teorie 'offensivistiche' , spesso presenti nel dibattito militare
CONO.USJONI 459
e diffuse tra i giovani ufficiali, continuavano ad apparire talvolta semplici petizioni di principio piuttosto che il lievito di una originale reimpostazione del 'problema militare italiano'.
In questo senso, i gridi di allarme sulla efficienza e sulla preparazione dell'esercito, lanciati sia pur strumentalmente dall'opposizione politica (per esempio nell'inverno 1886-87, in mezzo ad una crisi diplomatica internazionale tra le più acute, che più di altre portò l'Europa sull'orlo della guerra), non mancavano di qualche giustificazione.

Poco di questo fu emendato durante i 'felici' anni Ottanta.
Ecco che allora, alla prova dei documenti disponibili, la valutazione così ricorrente degli anni Ottanta come decennio 'felice' per l'esercito italiano pare accettabile (più che in se stessa) solo se riferita relativamente ad altri periodi della sua storia, ancora più difficili, ancora più contrastati, ancora più drammatici.
460 !L
GENERALE CESARE RJCOTII (1 884-188 7)
FONTI


FONTI
a) fonti inedite
Archivio Centrale dello Stato, Roma (abbr. in ACS)
Carte Crispi, serie Roma
Carte Crispi, serie Reggio Emilia
Carte Depretis, serie prima
Carte Depretis, serie quarta
Carte Pelloux
Presidenza del Consiglio dei Ministn·
Archivio del Museo Nazionale del Risorgimento, Torino (abbr. in MNR.TO)
Carte Govone
Archivio dell'Ufficio Storico dello Stato Maggiore dell'Esercito, Roma (abbr. in AUSSME)
Addetti mtlitan·. serie Austria
Francia
Germania
Russia
Serbi a
Biografie
Campi e manovre
Carteggio En.trea
Comspondenza del Corpo di Stato Maggiore
Libia
Ordinamento e mobzfitazione
Scacchiere occidentale
Scacchiere on·entale
Studi particolan·
Volumi En.trea
Archivio della Camera dei Deputati , Roma (abbr. in ACD)

Disegni di i, ·.;ge (abbr. in Ddl)
Archivio Storico della Marina Militare, Roma
Titolario
Biblioteca dell'Archiginnasio, Bologna (abbr. in AGBO)
Carte Minghetti
Museo Centrale del Risorgimento, Roma (abbr. in MCR)
Carte Mancini
Carte Perazzi
Carte Farini
b) fonti edite
Atti parlamentari (abbr. in AA.PP.), Camera e Senato
«L'esercito italiano», Roma
«Giornale di medicina militare», Roma
«Italia militare», Roma
«Nuova antologia», Firenze
«L'opinione», Roma
«Il popolo romano», Roma
«Rivista di Artiglieria e Genio», Roma
«Rivista di Cavalleria», Roma
«Rivista militare italiana», Roma

464 IL GENERALE CESARE
RICOlTI ( 1884 1887)
INDICI


INDICE DEI NOMI
Abdelkader, 443
Abissinia, 248n, 295 - 297, 359 e n, 362, 365, 374, 378, 401, 419, 432n, 439-440, 443
Actoo, Ferdinando {1832 -1891) , 140, 277
Adami, Luigi {1834-1913), 202
Aden, 414
Adri atico, mare, 140, 207
Adua , 316, 450
Mghanistan, 287, 345
Mrica, 31, 15ln, 190n, 192-194, 260 , 268, 270, 276 , 282, 284 , 287-289, 292, 294, 297 -2 99, 305n, 308o, 310 n , 323, 332, 338-340, 344, 347o, 355, 359, 365, 369-370, 374 -375. 381, 385, 399-401, 408, 411, 418, 424-425, 429n-430n, 436n, 439-440
Aga, 363
Ahmed, 301 - 303
Ailet, 339, 371-373, 375o, 382n
Airaghi, Cesare {1840-1896), 54n
Albania, 310n
Albini, Augusto {1930- 1909), 264
A/brecht-Game, Renè, 110n, 237n, 277n, 279n
Alessandria, 131
Alessandria, d'Egitto, 139, 286, 299. 382
Alge ri, 312
Almagià, G. , 390n
Alp i , 113-114 , 126-12 7, 135-136
Alula, Ras, 266 , 300-301, 303-304, 370, 372 e n, 384, 388, 403 e n-407, 409, 411n, 415 -416 , 427n, 432-434, 437, 438-439 , 441
Amba, 371-373, 424
America Latina, 282
An cona , 196 n, 332n
Andolenko, S., 6n
Angherà , Annibale, 75o, 423n, 426n
Anguillara, 332n
Anseba , 35 1
Antinori , Orazio , 311
Antonelli , Pietro , 294-295, 304, 379, 418 , 421n , 42 9
Arafali, 363. 368, 371, 384, 425, 439
Araldi, Antonio {1820-1891), 101n
Arbib, Edoardo, 47o, 67n, 205n, 241n, 264
Arkiko, 357n, 363, 368, 374, 384, 391, 407, 412, 433-434, 439. 443
Arimondi, Giuseppe {1846-1896), 215n
Asia, 345
Asmara , 406, 443, 448
Assab, 191 , 194o 278, 281, 284, 289, 294-295, 323n, 325-328n, 332, 336-338, 340, 363. 369. 379-381, 386, 388- 390. 415
Assaona , 300, 303
Aussa, 380-381
Ausuia-Ungheria, 107, 109-110, 123, 140, 231, 234 , 421
Baccarini, Alfredo, 45, 47, 88, 96, 11 9, 128
Balcani , 111, 23 7n, 410
Baldissera, Antonio {1838 -1 9 17), 302
Pasquale , 280n
Bani Amer , 301
Baraòeri , Oreste {1841-1901), 8, 88 , 119n, 155 , 215n, 265, 306n, 308 e D· 309, 311

Barone, Gtuseppe, 37n-39n, 86n, 127n, 139n, 230n
Barsanti, Pietro {1849-1870), 59
Battaglia, Roberto, 8n, 15n, 275n, 277n-2 78o, 282n-283n, 322n, 324n, 327n- 328n, 335n, 338n, 340n-3 41n , 347o, 352n, 360n, 386, 402n, 416 e n, 419n , 429o, 432n, 434 e n , 437n, 444n
BattisteUi, Fabnzio, 212n
• Nell'indice sono inseriti persone, autori e luoghi menzionati. Come di consueto, ooo sono stati i nomi presenti nei titoli delle opc:re citare. I riferimenti sono da intendersi al resto (es.: Anseba alle note (es.: Araldi IOln), od al testo cd alle note di una stessa pagim (es.: Abissinia c n ). In caso di riferimenti a pagine consecutive, sono indicare solo la prima c l'ultima della serie (es .: Africa 192-194, o anche Alula 40 3 e n·407).
467
Bava Beccaris , Fiorenzo (1831-1924),
!In , 19-20, 71o, 107n, 204n
Beilul, 3 17- 320, 326, 343-344 , 373 n, 380-38 In

Belcredi, 382
Belgio, 197, 287, 290
Bellavita, Emilio, 4 32n
Bengasi , 321
Benini, Rodolfo, 162n
Berber, 358
Bergamo , 332n
Berger, H ., 181n
Berlino, 7, 70, 72, 109-1 10 , 113-114, 117, 125, 128 , 132 , 229, 234 e n-235, 237-238, 277 -2 78, 281, 287-288, 313, 318
Benelli, G., 24ln
Benocci, A., 233n
Benolè Viale , Ettore (1829- 1892), 18 , 56 e n, 76 , 179n, 200 , 236, 264, 268-269. 438 , 445
Benolo, 311
Biagini, Antonello , 22n , 229n , 237n
Biancardi, Raffaele , 196n
Biancheri , Giuseppe (1821- 1908), 62, 67
Bianchi, Gustav o, 284, 294. 325
Bigotti, 232n
Bini, 195, 200
Bismarck , Otto von, 315
Bixio Nino, 55n
Blanc, Alberto, 113n
Boccacim: Giampaolo , 37 n , 41n, 8n , 230n, 359n
Bogos , 292 , 299-300, 351, 353 e n, 356-359, 361, 371, 439
Bo/detti, A. 34n
Bollaci, Ambrogio, 215o, 4 32 n
Bologna , 332n
Bonanate, L., 277n
Bond, Brian, 158n
Bonelli, Franco 38n, 138n
Bonghi, Ruggero, 90-9 1
Bono, Salvatore , 371n
Borelli, Bartolomeo, 73 n , 157n
Boselli, Paolo, 163n
Bosco Naitza , G., 2 76 o
Bona, 183
Boulanger, Geogers-Emest-Jean-Marie ( 1837-1891), 238 , 265
Bivio, Ore.rte, 96, 244n
Bozzo, Anna, 276 n, 305n
Bracci ano , 144
Branca, Ascanio , 83 , 263
Branchi , G., 294, 359 e n
Braudel, Fernand, 286n
Brazzà , L., 418, 421n
Brentari , Ottone, 94n
Brescia , 332 n
Bngnoli, Marziano, 306 n
Brignooe, Antonio (1822- 1897), 198n, 290n
Brin, Benedetto (1833-1898), 140 , 147 , 154 e n, 261, 318 e n, 323n, 326 e n, 337n, 377n, 390n- 393. 415 n
Brindisi , 207, 319, 321
Broccoli, L., 276n
Brown, 298n
Brunialci, Attilio, 284 n, 294
Brusati, Ugo (1847 -1 936), 284n, 294
Bruz:zo , Giovanni Battista ( 1824-1900) , 101n, 106
Bulgaria , 288
Bury , G.P. T. , 166n
Bu.rquel.r, julio, 158n
Cadorna , Luigi (18 50-1928), 114n
Cadorna , Raffaele (1815-1897), 29, 306n
Cairni , Pietro (1830 -1886 ), 323n, 326 e n , 328, 337 e n, 340 e n- 343 , 361, 363. 377 , 389
Cairo, 28 7, 298. 317 , 342, 363, 378, 408n
Cairoli, Ben ederto, 60 n
Calandra, Piero, 35n
Calchi Novatt: Giampaolo, 276n
Caldemaro , A ., 242n
Camerun, 287
Camperio, Manfredo, 283n, 294-295 e n , 307n
Cande /oro, Giorgio, 34n, 36n
Caneva, 145 , 215n
Canini, G., 5n
Capon e, Aldo, 198n
Caprin , G. , 112n
Caracciolo, Alberto , 9n, 17n, 38n
Carazzi, Maniz , 276n-277n, 297n, 306n, 42 7n
Carini, 3 16
Carocci, Giampiero, 18n, 34n -37n , 40 n-4ln , 43n , 45n-46n, 50n, 67n-68n , 90n-92n, 9 5n, llln, 230n, 28ln, 286n, 398n, 455n
Cartagine , 316
Caserta , 260
Ca.rettz: N., 54 n
468 ll GENERAlE
CESARE RICOTI! ( 1884-ISlìi)
Cassala, 290, 292, 339-341, 347, 349. 351, 355-359, 366, 403, 439
Cassese, Sabin o, 9n, 17n, 16Jn
Castellani, Luigi, 175 e n
Casteln u ovo, Gi u lio, 283 n
Caslronovo, Valen'o, 35n, 38n, 50n, 181n-183n, 275n
Catellani, E., 292n
Cavaciocchi, Albeno ( 1862-1925 ), 19-20
Cavalletto, Albeno, 129, 264
Cavalloni, Felice, 129
Cecchi, Antonio, 294-295. 323n, 351n
Celi,]., 376n
Cenni, Quinto (1845 - 1917), 196
Cerroci, Filippo {1819-1882), J04n
Ceva, Luct'o, 6n -7n, 19n, 85n, 160n, 449n
Chabod, Fedenco, 15n, 35n, 57n, 72n, l09n, 1lln, 12 7n , 190n, 276n, 279n, 398n
Charlcroi, 197
Chermside, 319- 320, 341-342n, 373, 400n
ChiaJa, Luigi {1834 -1904), 282n, 289n. 323n, 345n
Chiesi, Gustavo, 75o, 381n, 417n, 427n
Cialdini, Enrico (1811-1892), 269
Ciasca, 275n
Cisotti, Lodovico, 180n
Civitavecchia, 143-146
Cl ava r ìno , F , 2 15 n
Cocincìna, 28 7
Colapietra, Ra/foele, 3 5o, 230n
Co/lotti, Enzo, 277n
Comi, 436n
Gonfalonieri, A., 38n
Congo, 191, 287, 290, 294. 323
Coppioo, Michele, 244o
Corbino, Epzearmo, 256n
CorreaJe, 49
Correnti, Cesare, 47n, 49n
Co rse!li, Rodolfo (1873 - 1961), 305n
Co rsi, Carlo (1862-1905), 20-21, 65n, 86n, 91 n , 105 n , 164 n , 182n, 247o
Corsi, V., 215n
Corte, C lemente, 307-309
Corcicelli, Carlo (1847-1925), 215n
Corvetto, Giovanni ( 1830-1898), 264
Coscnz, Enrico (1820-1898), 8, 20, 62o, 103-104n, 125, 143- 144, 152, 206, 214-216n, 217 e n, 220-226, 252, 254-255, 264, 309n, 314 c n, 315 c n, 323 c o - 337, 340, 347n, 350-353, 355 e o, 359, 364n-365, 374 c n, 384, 425 e n, 428 e n -432n, 443, 446 c n, 45 7

Costamini, 244n
Craig, GordonA., 6
Crispi, Francesco. 34, 42-43, 83, 88, 97, 119, 257, 259-260, 269-271, 308- 309n, 359. 367, 399. 438, 455, 457
Croce, Benedetto, 383n
Cugia, Eflsio, (1818-1872), 55-56 e n
Cuneo, 152
Custoza, 55, 76, 241, 325, 334, 458
D'Amoja, Fulvio, 111n
D'Angz'olini, Piero, 38n, 42n, 127n
D'Avanzo, Nicola, 295n
Da Bormida, Vittorio ( 1842-1896), 54 n, 120n, 215n
Dahl ak, 389
Danzica, 234
De Amezaga, Carlo {1835-1899), 278, 294
De Bono, Emilio (1866-1944), 160n, 169n, 204n, 225n
De Chaurand, Felice, 57n, 160n, 305n, 309n
De Cristoforis, Tommaso (1841-1887), 179. 266, 435, 441, 445. 447
De La Gorce, Pau/ Marie, 6n
De Launay, Edoardo, 422n
De Leone, Ennco, 291n
De Lu ig i , Francesco, 183, 185, 188, 198
D e Lun a, 305 n
De Martino, 317, 408n, 422n
De Rosa, Luigi, 15n, 43n, 256 n , 449 n
De Rossi, Eugenio, 73n, 160n, 195n
De Vecchi, Ezio (1824-1893), 14n
De Zerbi, Rocco, 70, 129, 263
Debbeb, 303
Debeken, 326
Del Boca, Angelo, 15n, 275n, 277n, 282n, 289n, 3lln, 319n, 324n, 341n, 347n, 3 72n, 402n, 416 e n, 427 n , 433n
D el Bo n o, Giu l io, 432n
Del Negro, Piero, 5n-7n, 10n- 12n, 19n, 2 2n , 28n, 30n, 33n, 63n, 83-84n, 104n, 114n, 119n-120n, 138n, 155n, 160n-162n, 164n, 177n, 201n-202n, 244n, 262n, 307n, 347n, 452n, 454n-455n
Del Vecchio, Edoardo, 9n, 111n
Del Verme Luchino, 145, 215n
Delbrueck, Hans, 99n-100n
Deleuse, 169n
Demeter, !VJrl, 158n
INDICE DEl NOMI 469
Depretis , Agostino, 14n, 19, 34 -37, 40-50 e n, 60n-62 e n, 64, 67 -68, 77-80, 82-85, 89-93. 96, 147, 154, 201, 206n. 230, 257, 267, 270, 281, 288, 335-336 e n, 349, 356, 358, 364, 367 e n, 370, 374, 380, 383, 397-400, 407-408, 410, 427, 431. 438, 454-455, 458
Di Lenna, Giuseppe ( 1838-1902), 215n
Di Marzio, C., 286n
Di Rudinì, Antonio, 42n, 66, 92, 96, 206, 259-260, 264, 270, 456
Di San Marzano, Alessandro, ( 1830-1906), 182n
Dogali, 20, 41-43, 179. 182, 189 , 194, 200, 206n, 231, 236. 242n-243, 255. 257. 266-268, 270-271, 303-304, 308n, 320, 333n, 353n, 364n, 409, 419,425, 427,432, 435-439 441, 444-445. 447' 458
Dogliotti, G., 215n
Dongola, 358
Dotto de' Dauli , Carlo, 244n
Duilio , 148
Duilio, E., 432n
Durando, Giacomo {1807-1894), 164 e n, 167
Edd, 389n
Egitto, 278-280, 286-289, 298, 315, 318, 323, 361, 378, 410
Einaudi, Luigi, 22n
ei-Obeid, 287, 292-293 , 345
Emilia, 29
Erfurt, 234
Eritrea, 348, 378n
Erlich, Haggai, 351n, 367n, 385n , 403n
Etiopia, 284n, 286 e n, 289 - 290, 298 e n-299. 326, 340, 348, 359, 360 , 403, 421n, 443
Europa, 32, 110, 114, 237, 285. 290, 292, 419
Fabbri, L, 276n
Fanchiotti, 242n
Fara, Amelio, 102, 105n
Faralli, Giovanni, 353n
Farini, Domenico , 8 e n, 54n, 60n, 78n, 130n, 307-308n
Fameti, Paolo, 35n
Fenoaltea, S., 44n
Ferrante, Ezio , 148n
Ferrara, Patrizia , 51 n
Ferran's, Carlo, 215n
Ferrero , Emilio{1819-188 7), 11, 18, 20. 33n, 48n, 60n, 62n, 65 e n-66, 74 -77, 79-80, 82, 84-85, 87-88, 101, 105. 113 e n, 115, 117-118, 132, 134, 169, 170, 173, 177 c n, 179, 184-185, 19ln, 217-218, 232, 247-248 , 254, 267. 454
Fieldhouse, David K. , 286n
Ft'lesi, TeobtTJdo, 282n
Fioravanzo, G., 277n, 390n
Fiorentino, F , 34n
Firenze , 144, 175, 332, 408
Fisogni , C .• 94n
Fiumi , Ulisse, 175 e n
Fiumicino , 144
Foggia , 332n
Fonzi, Fausto, 18n, 46n
Francia , 110, 123-126 , 131, 133-134, 136. 139-141, 231, 234-235. 237, 240, 279-281, 286, 28 7, 290, 312, 334, 364, 410
Franzosi, Pier Giorgio , 6n, 180n
Frattolz'llo , Fernando, 212n-213n
Friz, Giuliano, 107n, 139n , 153n
Frosinone, 145
Frugoni , Pietro, 215n
Fuà, Giorgio, 15n
Gabriele, Mariano, 107, 139n-140n, 148n, 153n
Gaeta , 143
Gaibi. A., 305n
Galla, 296, 299
Gallagher, }. , 310n
Galleani, 233
Vincenzo, 6n-7n, 10n, 57n, 201n, 237n, 247n
Gandolfi , Antonio {1835-1902), 88, 204, 261
Gazzera, G., 215n
Genala, Francesco, 415n
Genè, Carlo (1836 -1 890), 268, 303, 333n, 408, 411 e n, 415, 417 e n-419, 423-424 e n, 426 e n-427, 431-435, 438-446

Genova , 207, 323n
Gentz'li, Anna Maria, 276n
Genzano, 146
Germania, 54, 72, 107 , 109, 112, 114, 123, 125, 127-128, 134-136, 198, 229, 231, 235. 237-240, 278, 280-281, 287-288n, 422
470 IL
GENERALE CESARE RJCOTn (1884-1887)
Gherar, 339, 368, 443
Ghinda, 434
Carlo, 35n, 336n
Giacchi, Niccolò, 49n
Angelo, 282n, 289n, 292n-293n, 361n
Gidessa, 427 -428
Giglio, Carlo, 83n , 120n, 275n-276n, 278n, 282n, 286n, 291n-292n, 295n, 305n, 310n, 317n, 319n, 320n, 326-327n, 336n-337n, 345n, 347n-349n, 355n, 358n, 363n, 397 n-3 98n
Giolitti, Giovanni, 42n, 60, 95
Giordani, P., 286n
Giovagnoli, Raffaello, 88n, 128n
Giovanni IV, 296. 299·302, 365
Gi rola, M., 215n
Giudici, Vitto rio (1819-1897), 84
Giura, 123, 135
Goggiam, 402
Gog/UJ, 276n
Goiran, Giovanni (1842 - 1913), 145, 215n
Gooch, john, 6n, 15o, 33n, 123n
Gordoo, Charles George ( 1833-1885 ), 292-293. 299. 345
Govone, Giuseppe (1825-1872), 54 e n, 59n-60o
Gran Bretagna, 364, 403, 424
Granville, George Leveson-Gower, 347, 348
Grasselli, E., 305o
Grassi, Fabio, 276n
Grecia, 232, 238
Greenfield, R., 298o
Grew, Richard, 18n
Grimaldi, Bernardino, 33n, 423n
G uaita, Ennia, 162o
Guardafuj, 294
Guardiooe, F., 213o
Gubbio, 143
Gugliella, G., 278n
Guiccìoli, Alessandro , 8, 47n-50 e n, 62n, 64 e n, 67 e n-68n, 86n, 236n, 239-240n
Guinea, 287
Gwa, 300
Habbab, 300-303, 432

Hallgarten, George W. F., 231n
Harnasen, 300
Harrar , 296, 303, 348, 363, 414 e n, 428 -431
Harries-}enkins, G., 17n, 94n
Hawakil, 389o
Hertner, Peter, 38n
Hewett, 292, 334, 345, 347n, 361 e o, 371n, 378, 384, 403, 411, 440
Hidaru, 298n
Hinsley, Francis Harry, 15n, 285o
Hobsbawm, Enc }. , 240n
Howard, Michael, 15o, 54n, 115n, 157o, 166o, 248o, 382n
Humer, 414, 428
Hunhnglon, S.P., 17n
Imperiale, C., 241n
India, 345
Inghilterra, 285-286, 289, 291-292, 294, 322, 334, 340, 367, 410, 421-422
lppolito, Felice, 44n
Istambul, 422
Italia, 5, 7·8, 10, 15, 19, 22, 32, 72, 107, 109-112, 114-115, 123, 125, 128, 131, 132, 134-136. 138-140, 151 e o, 158, 194, 198. 229-230. 239. 241, 245n, 276-281, 283, 288-289, 291 -292, 294. 301, 306. 310, 315, 326, 336, e o, 344, 347n. 352, 359-361, 367-368, 378n, 382-383, 387, 398. 403, 410-411, 419, 421 e n-422, 441, 446, 449-451, 453. 458
janowilz, Momi, 17n, 181n
Kanoum, 317, 333-334, 339. 345-348, 350- 351, 356 -358, 361, 372. 384, 406, 439. 445
Kereo, 340, 351-360, 364. 366, 371 - 372, 374, 377, 386, 399-400, 412, 438 Kufit, 406
La Marmora, Alfonso ( 1804-1878), 53. 56o, 61, 164 e n, 217, 269
La Porta, Luigi, 129
La Spezia, 146, 149-150 e n, 207-208, 210
Lanaro, Silvio, 310n
Langer, W.L., 285n
Lanza, Giovanni, 56n, 67n, Larrigue , 340n
INDICE DEl NOMl 471
Leitenitz, Alfredo (1838-1895), 215n, 327
Levi, F., 5n, 18n
Levi, Ulderico, 178 e n, 262

Levra, Umberto, 5n , 18n, 120n
Liberia, 286
Libia, 191, 224, 316, 321, 450
Liddell Hart, Basi/, 166n, 231n
Lione, 123
Lissa , 325, 334
Livorno, 144
Lo Preve, 327
Loescher, 183
Lombardia, 131
Londra, 29, 279, 286, 289, 291-293. 317. 345-348, 351, 355·356, 358, 360, 363, 410 n , 414, 421
Lucca, 207
Luchini Odoardo , 244n
Lumley, 349
Luraghi, Raimondo, 286nLuzzana Caraci, l., 277n
Ma-atali, 426
Maccarese, 145
Machanile, 389n
Macola, Ferruccio, 160n
Madagascar, 287
Maddalena, 207
Madi.r, 389n
Magliani, Agostino, 40, 42-44, 79 , 86, 96-97, 230, 257 , 259. 267
Mahdi , 286
Mainoni d'Incignano L., 215n
Majolo Molinari, O., 182n
Maìssa, 375 e n
Malatesta, Alberto, 202n
Maldini, Galeazzo, 259
Ma/inverni, Bruno, 120n, 230n
Malvano, Giacomo, 319n, 380, 422n
Manacorda, Gastone,8n, 16n, 18n, 42n -43n, 6ln, 455n
Mancini, Pasquale Sranislao, 83-85, 90, 111 e n, 186, 279-283n , 285, 288-291, 293 -295, 304 e n, 308n, 312-315, 317-328, 335, 339-340, 342 e n, 345-347 e n, 348-351 e n, 354n-358 e n, 359, 362n, 365-367, 376, 397-398, 410, 421n, 445-446n
Mannlicher, Ferdìnand von, 234
Manregazza, Vico, 375n, 420n, 440n
Mantova, 332n
Manzotti, F., 108n
Marazzi, Fortunato, 202
Marchesi, 389n
Marcopoli, 378
Marcus, H. G., 298n
Margable , 426
Mariani , Felice, 140
Mariotti, Ternistocle (1838 -1 92 1), 241n -242n
Markov, Walter, 286n
Marocco, 139, 279
Mar Rosso, 41, 95, 122, 191, 283-285, 289-295. 298-299. 304, 308n, 315, 317, 321-322n, 325-326, 328, 333n -334, 336-339. 348, 350,
353-354, 356, 360, 364, 366, 368-369.
374, 377-379n, 381, 383, 385 e n-387, 389, 391, 405, 407 -408, 410-4ll, 413,415-416, 418 -419,421 , 426n, 429, 431, 436 n, 444, 446-447
Marselli. Niccola (1832-1899). 9 - 12, 15 , 49, 69, 76, Sin, 86n. 117, 119n, 155, 165 e n, 167 e n, 187-188, 195n, 197 , 200, 214n. 225n. 241 e n, 243, 251. 310n, 321n, 324 c n-325, 347n. 388, 405n
Martel, 126n, 305n
Martini, Ferdinando, 294-295
Martucci, R., 34n
Massa, A., 241n
Massaua , 20, 83, 92, 111, 153, 156, 191 - 194 e n , 199, 225, 258, 282, 284-285, 289. 291-293, 295 -2 98, 300-304, 308n, 310 e n-312, 317-323 e n, 326-328n, 330, 332 e n-351, 353n·357, 359-366, 368, 370-375 e n, 377 e n-380, 382-388, 390. 392-394, 397-409,411-412,414-417,419-430, 432, 434-4 38, 440-448, 458
Massobno , Giulio, 5n-8n, 12n, 15n- 16n, 19n, 27n, 30n, 57n, 64n, 108n, 1l3n , 120n, 123n, 138n, 160n, 212n-213n. 216n, 247n, 356n, 449n, 452n
Marrei, Emilio, 210-211
Maurizi , G., 276n
Mauser, Wilhelm (1834-1882), 234
Mazzaccara, Carlo, 212n
Mazzetti, Massimo , 6n, 15n, 107n-108n, llln, 113n, 123n
Mazzoleni, A ., 24ln
Mazzonis, Filippo, 6n, 179n
Mediterraneo, 111, 139,279-280,283, 289, 293-294. 311, 316
472 IL
GENEIW..E CESARE RICOTil (1884-1887)
Melli, Beniamino, 421n
Menelik, 296, 299, 300, 304, 429
Mensa, 300-301, 358
Merlino, Francesco Saverio, 127n, 432n
Messina, 319, 321
Mezzacapo, Carlo (1817 -1905), 62n, 89-90, 97 e n, 150, 178, 187, 219n, 271, 308n
Mezzacapo, Luigi (1814-1885), 14o, 59. 62o, 69, 72 e n, 75-77, 79, 105-106, 126, 184, 247 -248, 262
Miaglia , C.F., 307n
Miege, }ean Louis, 276n
Mi/anini, Kemeny,276n, 306n
Milano, 382
Milo, 311
Mingbetti, Marco , 36, 46-47 e n, 49n, 97
Minniti, Fortunato, 6n - 7n, lln, 15n-17n, 58n, 69n, 73n, 85n-86n, 10ln, 104n-105n, 107n, 114n, 121n, 127o-128n, 184n, 190n, 212n-214n, 247n -248n, 279n
Mirabello, 312
Mirri, 202
Misdea, 32-33
Mocenni, Stanislao (1837-1907), 179n, 215n
Modena, 324
Mohammed Ali, 298
Molfese, Franco, 34n
Moltke, Helmuth von (1800-1891), 71, 107, 113, 116o, 123, 129
Mondaim; G., 286n
Monkullo, 342, 360, 368, 374, 407, 412, 425, 436n, 439, 443
Monte Amiata, 143
Monte Argentario, 144
Monteilhet, }. , 6n
Monticone, Alberto, So
Montù, Carlo, 52n-53n, 216n, 231n, 236n
Morana, Giovanni, 14n, 267
Morandi, Carlo, 108n, 361n
Morelli, Emtlia, 8n, 48n, 163n
Mori, Giorgio, 15n, 37n-39n, 137n-138n, 213n
Morra Di Lavriano, Roberto ( 1830 -1917), 265
Moscati, Amedeo, 44n, 51n
Moscos, C.L., 17n
Mozambico, 294
Mozzati, M., 295n
Napoli, 143-144, 148n, 207, 284, 321, 332n, 336, 338, 386n
Narbone, Luigi, 33n
Naretti, Giovanni, 432
Nava, Luigi, 145 -146
Navigazione Generale Italiana, 388, 418
Na.zari, V., 378n
Negri, Luigi, 294-295n, 374n

Nicotera, Giovanni, 36, 207
N igra, Costantino, 127n, 348, 421n
Nilo, 326, 333, 338. 346
Nizza, 135
Noce, 92n, 389-393. 408
Nocera, 143
Norsa, 75n, 381n, 417n. 427n
Novara, 333n
Nubar, 317
Nunziante, Alessandro (1815-1881), 182
Oblieght, 183
Obok, 290, 295
Oliva, Gianni, 95n, 120n
Orbetello, 143
Orero, Baldassarre (1841-1914), 145, 215o
Orto/eva, Peppino, 305n
Osio, Egidio (1840- 1902), 65n
Osman, Digma, 302, 352
Orumlo, 342, 360, 369. 374, 412, 439, 443
Pagliaini, A., 158n , 18ln
Pais-Serra, Francesco , 88n , 118n, 178 e n, 260
Palermo, 33, 144
Panara, A., 148n
Pankhurst, Richard, 298n
Parenzo, Cesare, 96
Parigi, 29. 229 , 234, 238, 312, 422
Parma, 207, 332n
Pasquino, G., 17n
Pavante, E., 298n
Pedone, Antonio, 15n, 85n, 449n
Pellegrini, B., 278n
Pellicciante, E., 244o
Pelloux, Luigi Girolamo (1837-1907), 8 e o, lln, 14n, 54n, 58n, 60-62n, 65n-66, 74-77. 80, 82, 88, 95, 119n, 128, 154, 162n-163 e n, 177n, 179n, 204, 206 e n-207, 220, 232n, 252, 263-264, 267, 269-271, 307 e n, 339n. 455n-4)6
INDICE DEI NOMI 473
Perazzi, Costantino, 48 e n, 62, 64 e n, 67, 333n
Perlmutter, A., 17n
Perosini, 367n
Perrucchetti, Giuseppe (1839-1916), 120n, 137n
Perticone, Giacomo, 35n, 37n, 108n, 112n, 277n-278n
Pesci, Ugo, 90n, 180n, 308n
Pesenti, G., 305n
Pestalozza, 379n
Pianeti, Giuseppe Salvatore (1812-1892), 8
Piano, 433-434
Piemonte, 131
Pieri, Piero, 10n, 14n, 51n, 53n, 55n -57n, 100n, 455n
Pietroburgo, 110, 229, 235, 237
Pigli, M., 290n
Pistoia, 144
Plebano, Achille, 95, 261
Po, 113, 457
Pollio, Albeno (1852-1914), 215n
Porro, 427n
Pono Empedocle, 144
Pozza, 232n
Pozzolini, Giorgio (1834-1920), 88, 104, 128, 145, 204, 215n, 221, 223n, 226, 261, 303, 306-308, 419 -421n, 427, 430n
Pozzuoli, 207
Preston, Richard A., 6n
Preti, 37n
Pright, U., 179n
Primerano, Domenico ( 1829-1911), 73n, 215n, 219n
Provenza, 113
Pruriastola, 241n
Prussia, 116n
Putci, 388
Quaini, M., 137n
Rabat, 312
Radicati, 145
Ragionien·, Ernesto, 9n, 18n, 35n, 113n, 285n, 347n, 437n, 455n
Rainero, Romain, 275n, 286n, 306n- 307n, 330n, 378n
Ranzi, Fabio (1859-1922), 456
Rapoport, D., 17n
Rattazzi, Urbano, 421n
Rau, 125n
Ravenni, A., 305n
Remin gton. 379, 434
Reno, 124, 127-128, 130, 135 - 137, 457

Repaci, F.A., 449n
Revelli, M., 305n
Ricci, Agostino (1832-1896), 8, 29, 120n, 144-145, 149-152, 154, 208, 261, 311 -312 e n, 314 e n-315, 324 -325, 327, 337, 343-344, 349. 353-354, 356-357, 365 e n, 385 e n Riccio, Giovanni Battista (1822-1905), 84n
Ricotti-Magnani, Cesare ( 1822-1917).
8,14, 18-21, 27-28, 30 -31, 34, 45, 47
e n-75 e n , 77-97, 100-109, 112-113, 115, 117 -122, 127 -134, 136-138, 141-143, 145 -147, 149- 157, 16 1, 163-164, 166- 167, 170-171, 173-174, 176- 192. 194 -197. 201 -202, 204 -213, 215, 217 e n-223n, 225-227, 231-233, 235 -236, 239 -240, 243 e n -250, 252-255, 257-262, 264-271, 281n, 304n, 308 e n, 313 -316, 322n -325 e n , 327n-328n, 330-335 , 337n , 340n, 342n, 346n-347n, 350-351. 353n-359. 361 e n - 362n, 364n -366 e n, 368 e n-374 e n, 377 e n, 384 e n -387, 389, 391n-393 e n, 399-401 e n, 403-405 e n, 408, 412 e n-418, 423 e n -426 e n, 428 e n -432n, 437-438, 440-447, 449, 451-459
Rinaudo, Carlo, 165n, 167n
Ritter, Gerhard, 6n, 99n
Rizzi, B., 306n
Robilant, Carlo Felice Nicolis di (1826-1888), 92. llln, 127n, 145, 229n-230, 294, 303, 374, 397-399, 408, 410-414, 416n, 418, 420 e n-422 e n, 435n, 428 e n, 431, 434, 437 , 439 e n-442 e n
Robinson, R. E., 310n
Rochat, Giorgio, 5n -8n, 12n, 15n-16n, 19n, 22n, 27n, 30n, 57n, 64n, 108n, 113n, 120n, 123n, 138n, 160n, 212n-213rn, 216n, 247n, 256n, 275n, 285n, 305n,431n, 438n, 444n, 449n, 452n
Rogier, Francesco (1841-1916), 160n
Rohmato, 298n
Rolandi, 202
474 Il GENERALE
CESARE RICOTII (1884-1887)
Roma, 70, 105 -108, 110 , 113, 115, 117, 143, 145-146 , 182n , 196n , 230n , 232n, 237 - 238, 277 , 279, 284 , 288 , 2 91, 293 -294, 312 , 316, 320 , 328n , B2n, 341, 346 , 354, 357n, 360, 362, 3-64 , 370-371, 376-377n, 381 -382, 3-85, 392, 401-402 , 406, 410, 417, 419, 421 e n, 423, 439-441 , 450
Ro .manelli, Raffaele , 9n, 35n
Rosbache, 129
Rossetti, C., 290o
Rotei/i, Ettore, 17n, 336n
Ro vigo , 332n
Rubattino, Raffaele, 277-278, 284
Russia, 109, 237-238 , 345 , 364
Saati, 301 -302, 339, 371-375, 382n, 384 -385, 388, 399-410, 412-413, 415, 417 -418 , 423, 425, 428, 431 , 433, 435, 437-441, 444 -445, 447-448
Saccone, 276n
Saint Boo, Simooe Pacoret eli (1818-1892), 140 , 142
Saladino , G., 213n
Saletta , Taocredi (1840-1909), 92, 193, 301-304, 312 e n , 327 e n-328 e n, 332-333n , 335, 337 e n , 339-344, 350, 354 e o-355, 357 e n, 360- 364 e n, 366 e n, 368 e n-377, 379 e n, 381-384 e n, 387 - 394, 387, 400 -402, 404 , 406 e n -409, 411 -417, 423 -424 , 431, 438 -439, 442 -446

Salimbeni, Augusto , 433-434 , 441
Salvadori , R. , 37n
Sallvalitici, L, 233n
Salvatore/li, Luigi, 35n, 64n, l 08o-109n , 111, 229n
Salvemim; Gaetano, 108n
Salvestrini, Ama/do, 22n
Santalena, A. , 345n
Santangelo, Felice (1862-1930), 19n, 163, 168n
Sapelli, A., 296n
Sapeto, Giuseppe, 278
Sapio, E., 215o
Saracco, Giuseppe, 83
Sarti , Telesforo , 202n, 207n , 242n
Sartoris , Ermanno, 56n
Savoiroux , Tancredi, 434 , 442
Sciaonameo , Vito, 435-436n
Scioa, 296, 299-300, 302 , 304, 348
Segre, S., 6n
Segreto, Luciano, 38n
Seismit-Doda , Federico , 96
Sella , Quimino , 47 , 60n, 203
Senait, 340 e n
Serafini , Bernardino , 84
Semam , W. , 158n
Sforza Terni , 206n , 270n
Siacci, Angelo Francesco (1839-1907), 202, 262
Sismondo, Felice (1836-1912) , 215n
Skieroowice, 110
Sonnino, Sidoey, 96
Spadoni, U., 279o
Spagna, 209 , 232 , 280 , 288
Spaodau , 234
Stefoni, Filippo
Stefaooni, 378n
Sticca, Giuseppe , 158n
Stradella , 34
Stn'k Lievers, Lorenzo, 180n
Suakim , 292 -293, 322, 336-337, 339, 351-352
Sudao, 286-287 , 289-290, 292-294, 298 e n-299, 345, 348 , 351, 358-359 , 363, 367
Suez, 286, 289 , 319, 336
Surdich, F. , 276n
Svizzera , 136
Tagiura, 290 , 295
Talamo , Giuseppe , 280n , 336n
Tamborra, Angelo, 112n, 229n
Tanlongo , 106n
Taranto, 148n, 207
Taulud, 339. 368
Taverna , Rinaldo {1839 -1913), 84 , 106n , 204
Taylor, A/an ].P. , 109n , 229n, 275n, 278n
Teodoro II, 296. 298-299
Terni, 138
Terracina, 144
Thaon di Revel , Genova (1817-1910) , 56 e n
Ticino , 131
Tigrè, 296 , 299-301, 303
Tirreno, 133, 207
Tognan'ni, Ivano , 22n
Togo, 287
Tomassim; Luigi, 22n
Tonchino, 287
Toniolo, G., 44n
Torino, 131
Torre, A. 108n
INDICE DEI NOMI 475
Torre, Federico (1815-1892), 162n, 202
Toscana, 143
Tosti, 19n
TranfogHa, Nicola, )n, 18n, 127n, 305n
Tripoli, 316 , 321, 337n-338
Tripolitania, 283, 293-294 , 311-312, 315, 323, 422

Trucco, 319-321, 343-344
Tuccari , 23o
Tunisi, 7, 312, 316, 321
Tunisia, 139, 287, 311, 385
Turchia, 348
Turi, Carlo (1838-1900), 207 -211, 264
Turi, Gabriele, 9n
Ua-à, 303, 402, 433, 439, 447
Uccialli, 304
Ugolini, Romano, 160n
Ulema, 283n
Umberto I, 13, 32-33, 45n, 63-64, 67, 82, 129, 134, 150, 265, 288, 347 e n, 357, 394, 410, 422, 433
Ungaro, 95
Ungheria, 110
Vacchelli , Pieuo , 96 -97
Vagts , Alfred, 158n
Valle, Pietro, 305n
Van Doorn, ]-, 181n
Venezia, 332n
Ventun'ni, Fernando, 6n, 8n, 17n-18n, 46n, 58n, 61n, 65n, 80n, 84n-85n, 87n, 89n, 91, 103n, 138n, 149n. 154n-155n , 161n, 179n, 207n, 246n, 248n, 262n
Verona, 175
Viareggio, 144
Vienna, 29, 117 , 132, 234 e n, 235, 238, 278, 398, 410
Viganò, Franco, 14n, 145
Viganò, Giuseppe (1843- 1933), 215n
Pasquale, 242n
Violante, Luciano, 34n
Vitale, 232
Vitali, Giuseppe (1845 - 1920), 236
Vitelleschi, Francesco, 295
Viti, G., 277n, 330n
Vittorio Emanuele li, 67 e n, 203
Voghera, 183
Volpe, 148
Werrerly, Friedrich (1822 -1882), 236, 379
Wise, S.P., 6n
Wissemburg, 129
Woenh, 129
Wolda Michael, 300
Wolseley, Garnet (1833 - 1913), 293, 299. 329n, 345
Woolf, Stuart )., 275n
Zaghi, Carlo, 83n, 1lln, 275n, 279n, 28ln, 293n, 296n, 308n, 313n, 320n, 345o, 351n, 363n, 403n, 410n, 420n
Zambrano, Gaetano, 14n
Zaoe l ti, C., 102o
Zaneili, S., 116n
Zanni Rosieilo , Isabella, 17n
Zano lini, Cesare ( 1823 -1902), 259
Zavattari. Oreste, 215n
Zeila, 295, 348, 414, 428
Zula, 363, 426 , 432-433
Zurcher, L.A., 94n
476 Il GENERALE CESARE RJCOTII (1 884 -1 88 7)
l - UN ESERCITO PER RICOTTI
Esercito e politica nel trasformismo ........
Cesare Ricotti, un militare particolare .....
Le tidee e il programma di Cesare Ricotti
Politici oppositori e militari dissidenti
l
Difese, fortificazioni e cinte .. . . .. . . ....
La prima Triplice e l 'Italia militare: tra difensiva ed offensiva Confini e coste, Esercito e Marina
III - MILITARI NEGU ANNI OTTANTA
Il Corpo Ufficiali e le polemiche sull'avanzamento delle carriere
La stampa d'informazione militare
o deputati militari

Lo Stato Maggiore del! 'Esercito: la preparazione della guerra
IV - LE RAGIONI DELLA CADUTA DI UN MINISTRO
Voci di guerra europea e calma italiana
resentazione Pag. 3 Introduzione » 5 PARTE PRIMA POLITICA E PO LI TICA MILITARE
INDICE GENERALE P
............... . • ..........
.. . .
.... .
.
.... .
... .. .... . .... .
.
. . ... . ..... . .... .
.
.............. .
..... .
.. . ....... . .
Il -
PROBLEMI MlllTARI .... . .... . .... . .... .
.... . . .
. .. .
..................... . . Militari
... . ................. .
deputati
Politici e militari
............... . ..... . ... .
SECOND A L'ESERCITO NELLA POLITICA COLONIALE l - ALLE ORIGINI DELLA SPEDIZIONE PER MASSAUA » 27 » 27 » 51 » 61 » 77 » 99 » 101 » 107 » 137 » 155 » 157 » 180 » 201 » 212 » 229 » 229 » 246 » 275
contro Ricotti
PARTE

478 ll. GENERALE
RICOlTl
Verso una politica coloniale italiana .... . ...... . .... . . ... . » 275 Il colonialismo delle Potenze europee » 285 Colonialismo italiano e Africa orientale .............. . ... . » 294 Militari italiani e colonialismo .......................... . » 304 La spedizione militare verso il Mar Rosso: Comando e truppe .............................................. . » 321 II - LE PRIME PROVE • • » 336 Istruzioni e realtà: l'occupazione di Massaua .............. . » 336 Dopo Khartum, sulla via per Keren ..................... . » 344 'Raccoglimento coloniale': e Saati? » 360 La prima ordinaria amministrazione coloniale .. . .......... . » 375 Caldo africano e polemiche militari ........... . .......... . » 383 III - VERSO DOGALI .. ... .. ... ........ ..... ..... . ..... . » 397 Un segnale sottovalutato: l'ultimatum di Ras Alula .. . ..... . !) 397 Verso un 'nuovo corso' con Genè e Robilaot .. ...... . ..... . !) 410 Impreparazione militare e questioni politiche ............ . . » 423 Sulla via che conduce a Dogali ......................... . . !) 432 Conclusioni ...... .. ............. . . . .. . ............ .. . . » 449 Fonti » 461 Indici » 465
CESARE
(18S4-1887)








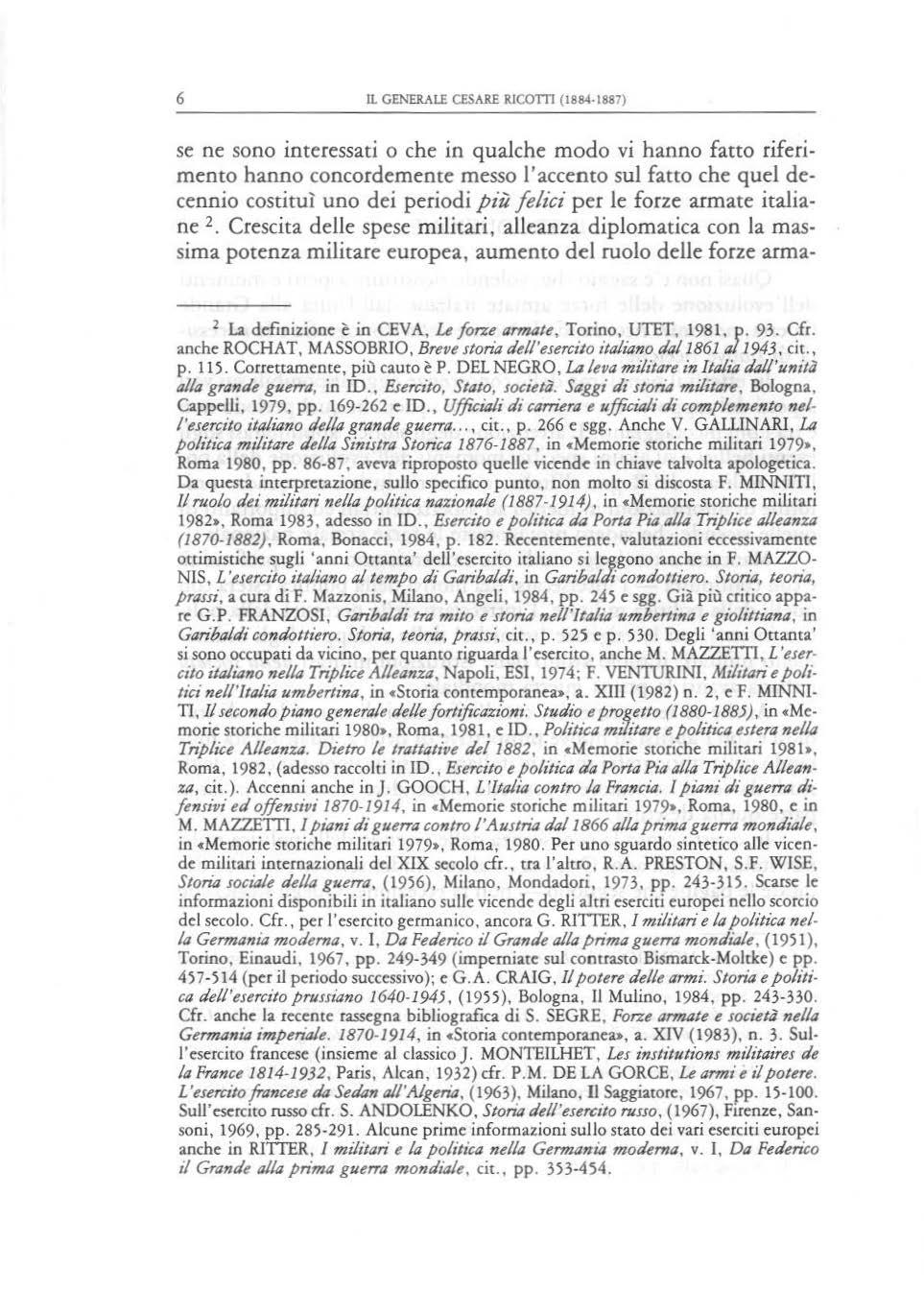
























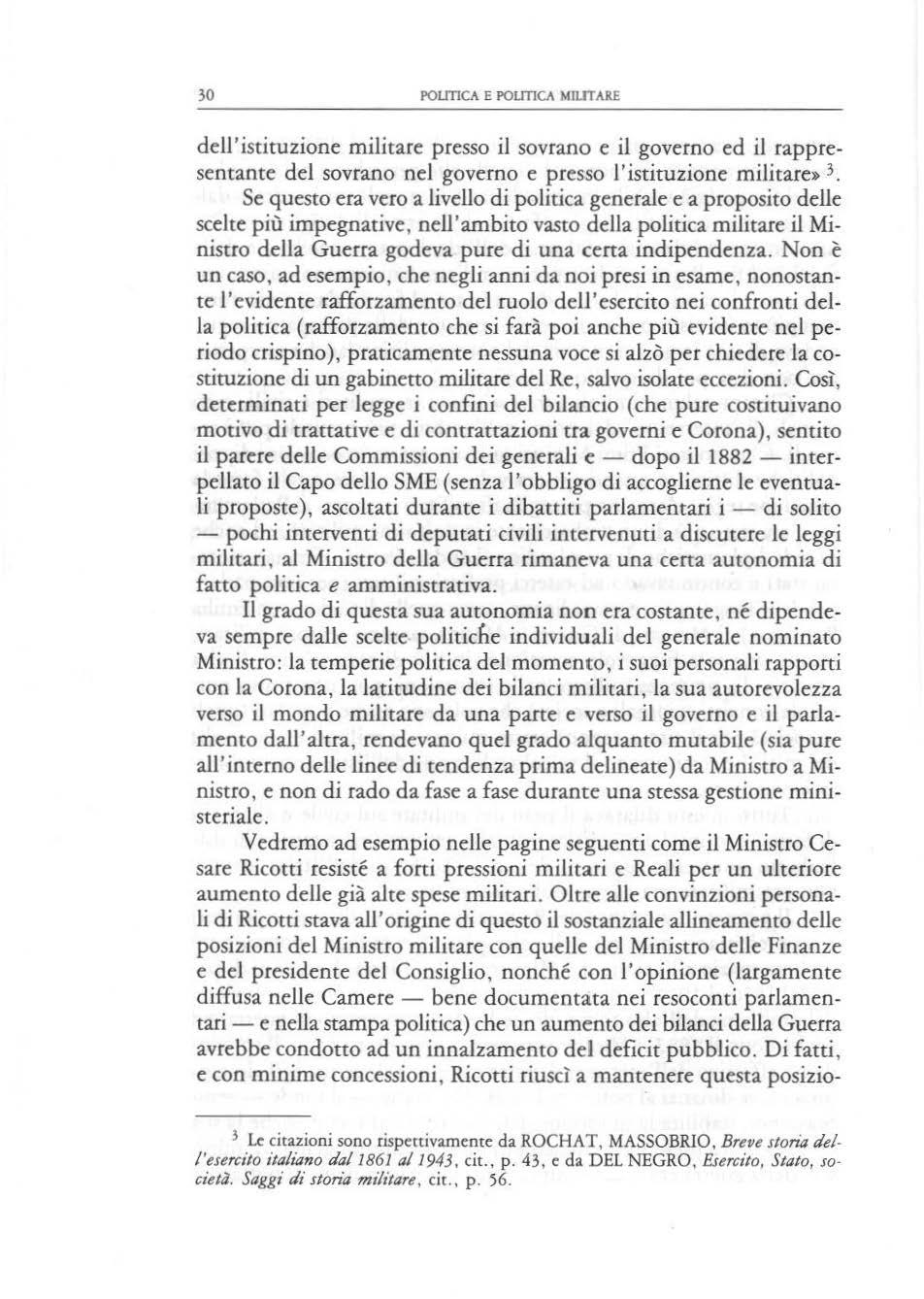




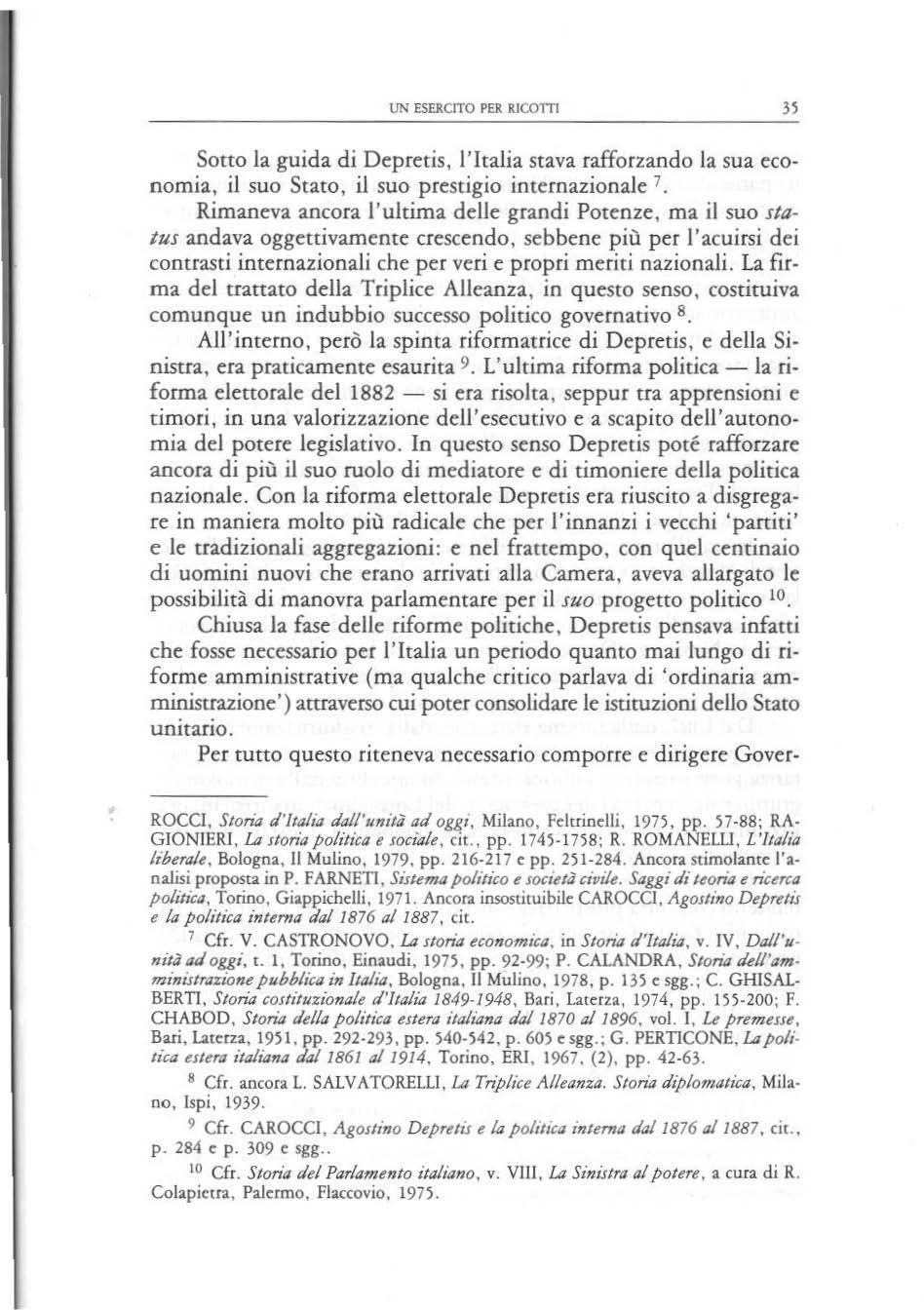
























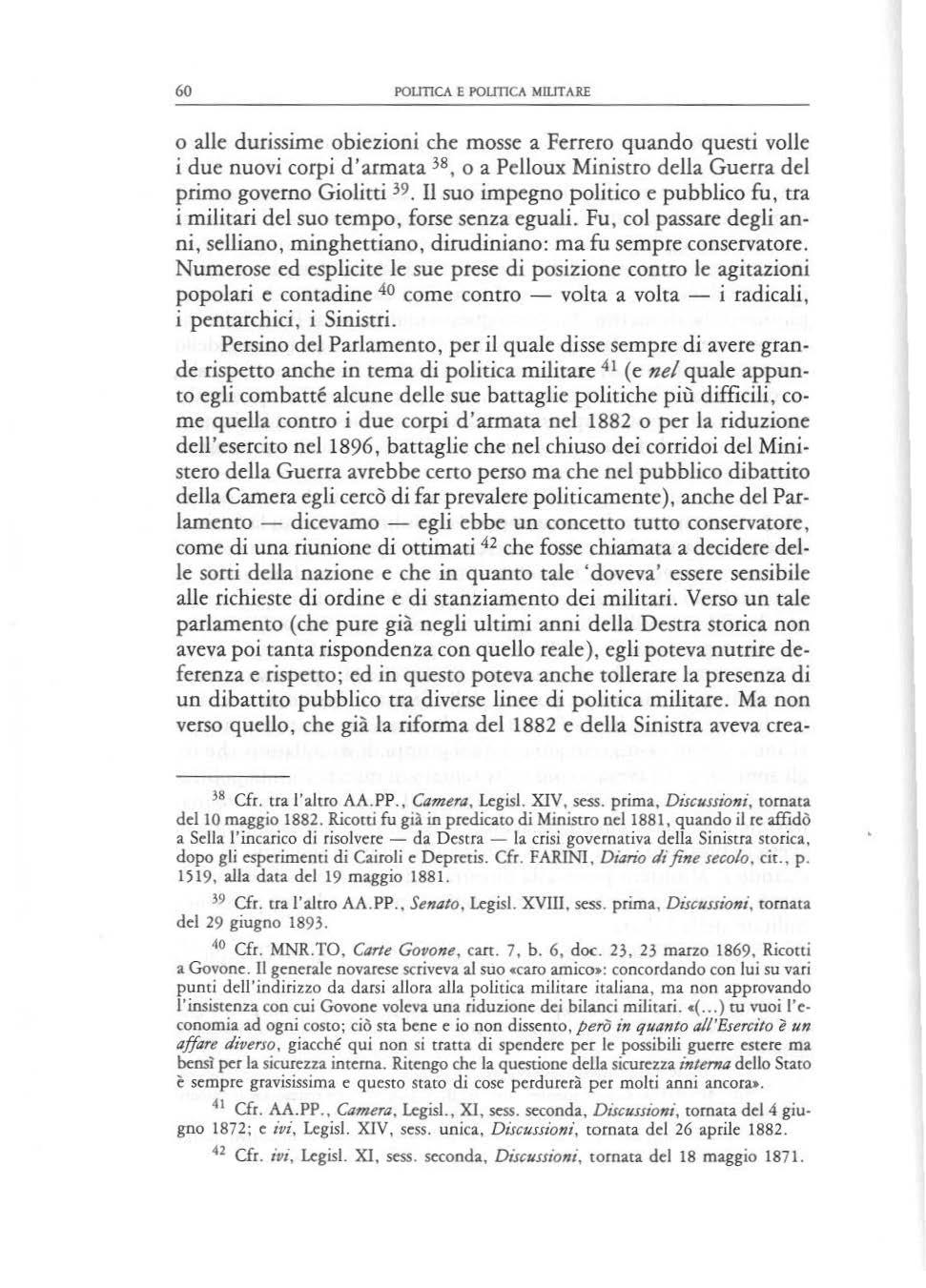








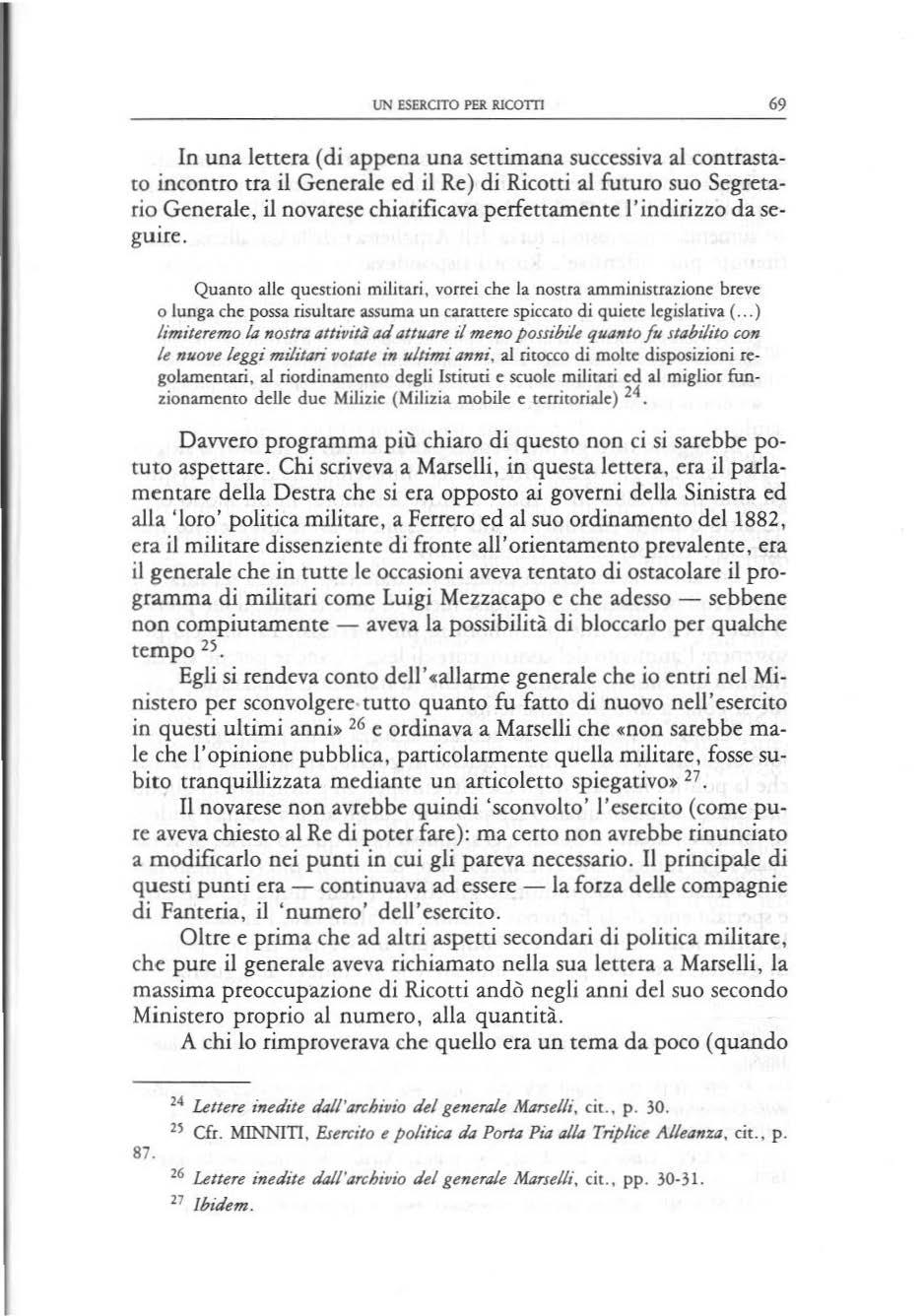











































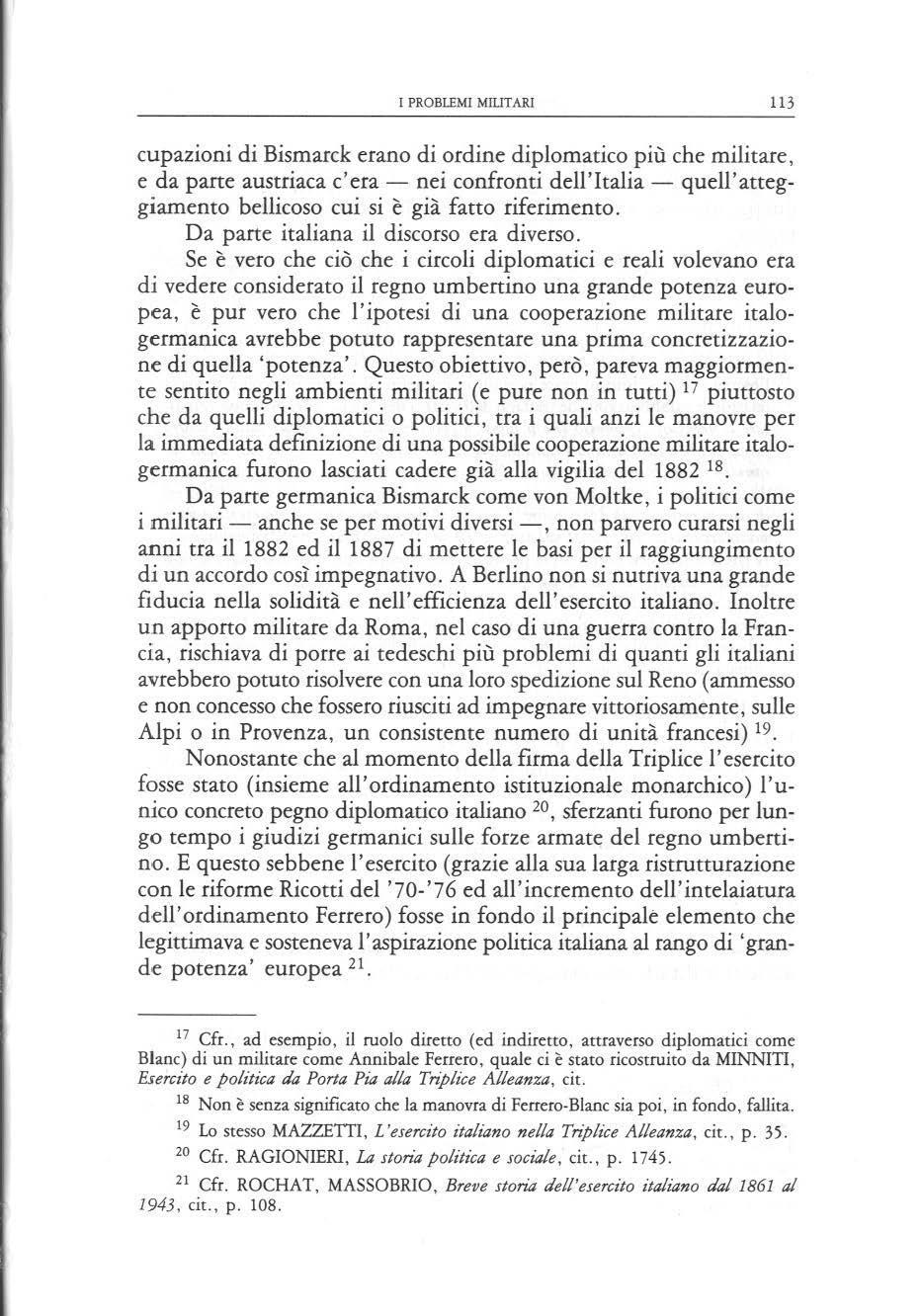
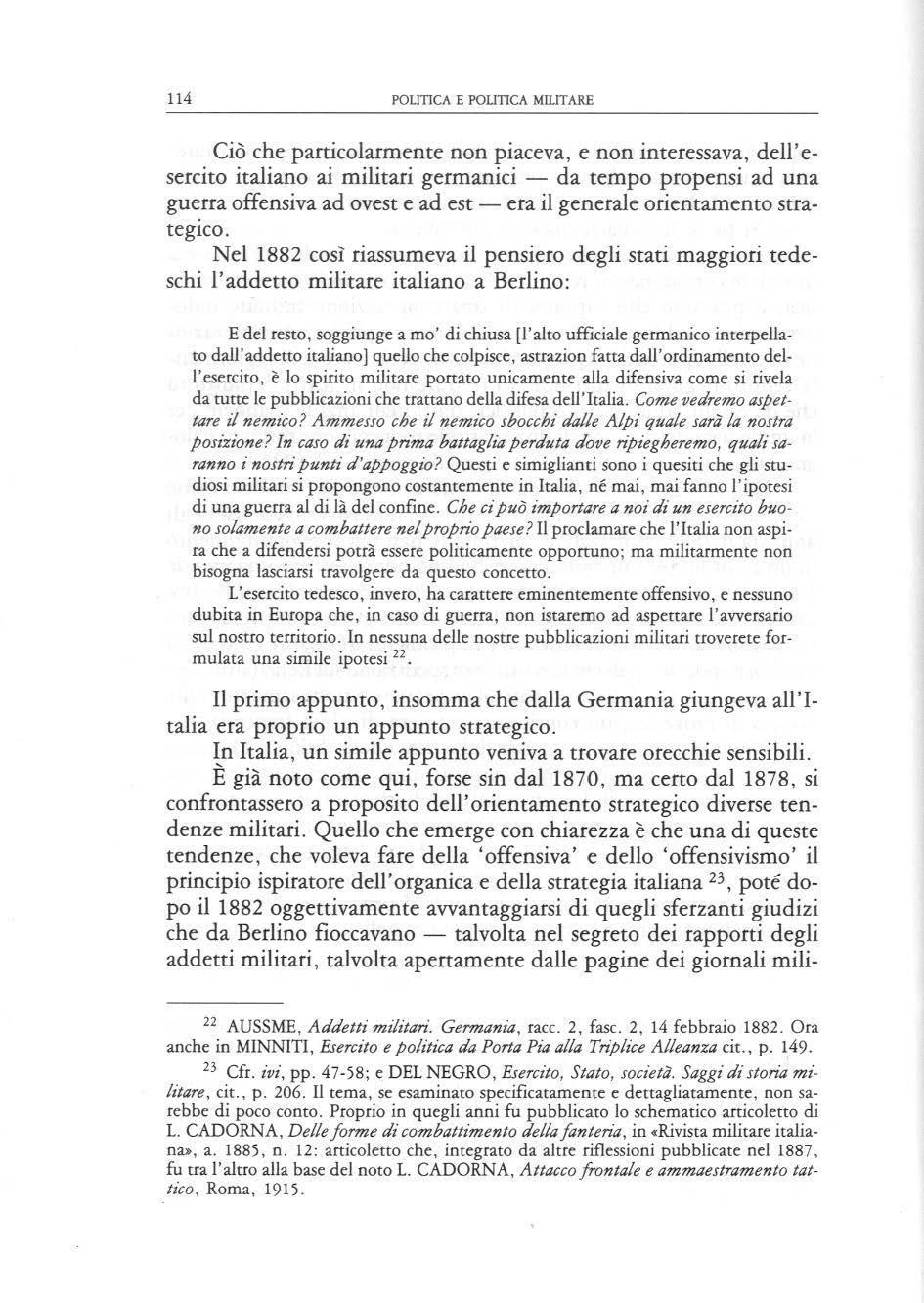


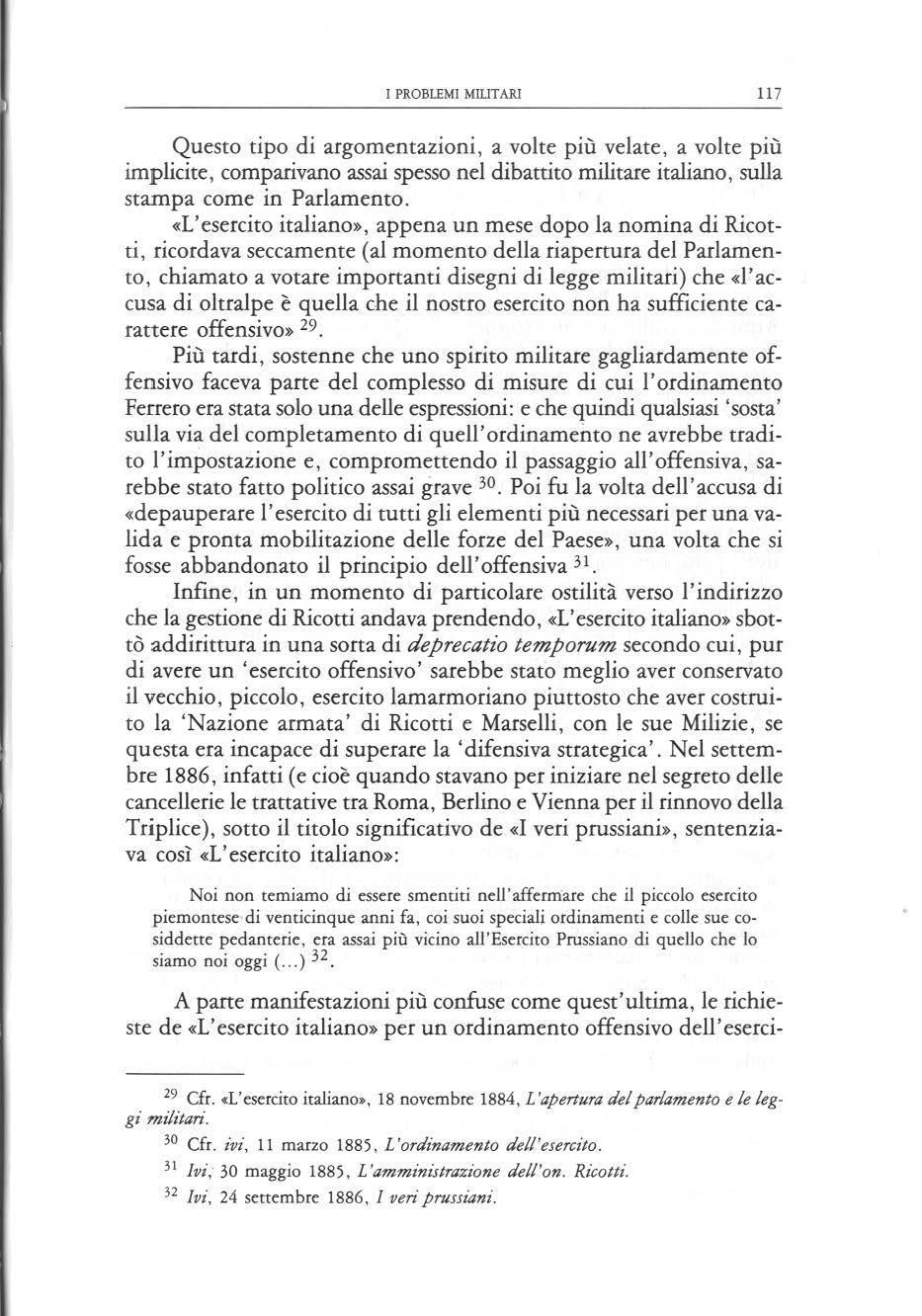













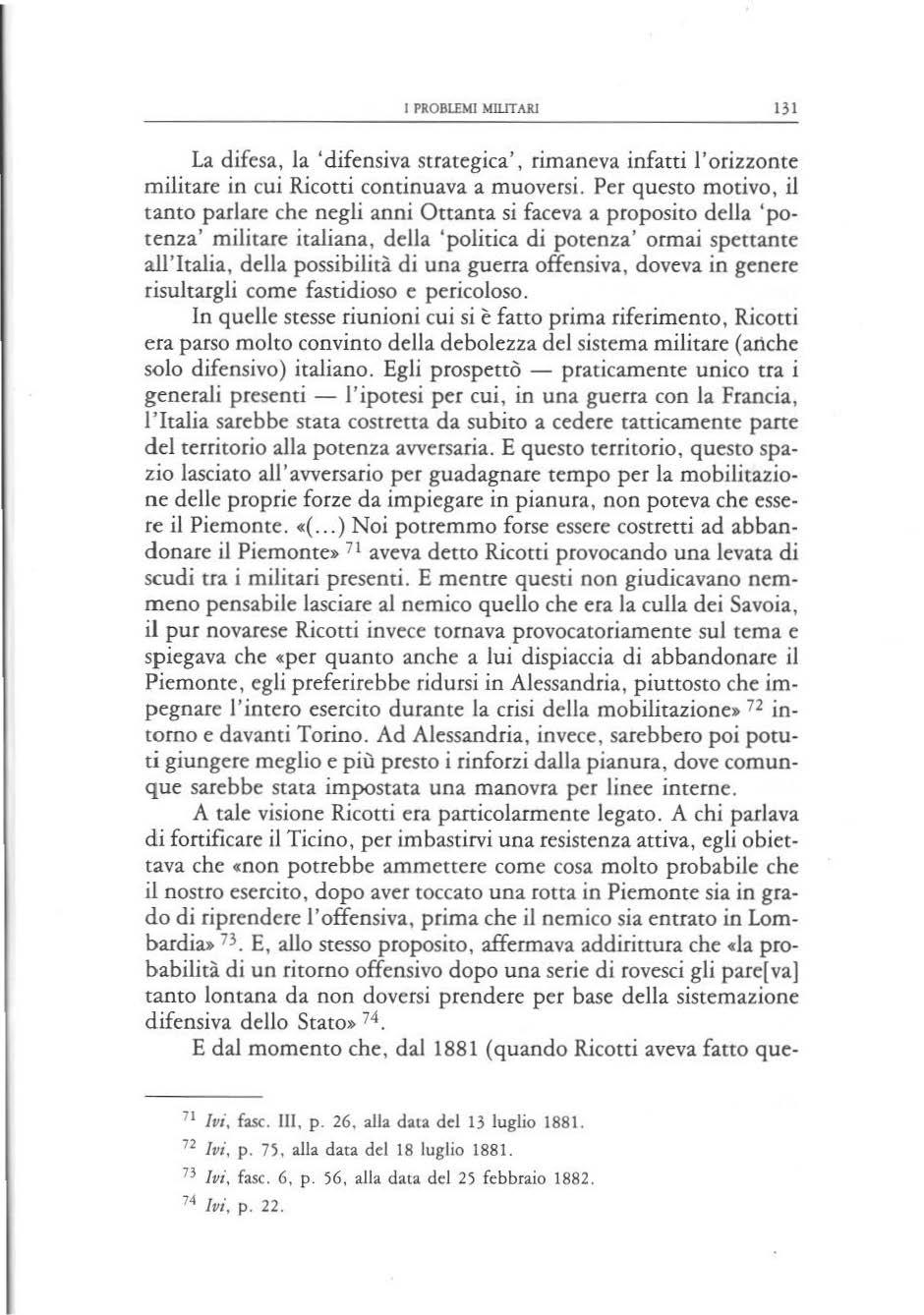























 società. Sagg i di storia mtlitare, cir. pp. 205-206 .
società. Sagg i di storia mtlitare, cir. pp. 205-206 .