l TELEGRAFISTI NELLA GUERRA 1915-1918
ISTITUTO STORICO E DI CULTURA DELL' ARM A DEL GENIO ROMA 1963


ALLA MEMORIA

DI TUTT I I CAD UTI
DEL 3° E 7° GENIO TELEGRAFISTI
CHE M OSTRAND O E ADDITANDO
CON L' INGEGNO NELLA LORO TECNICA
E L' ARD O RE NE L COMBATTIMENTO
LA VIA DELLA VITTORIA
S EPPE RO CADE RE PER LA PATRIA
F EDEL MENTE ED UMILMEN TE
«O sole, tu non possa ve d er mai nuLLa più grande e bello d' Italia ».

l'Arma del Genio riannodando sot to l'uragano de l fer r o e del fuoco i tenui fili onde passa l 'intelligenza reg ola trice della battaglia, lanciandosi all'assalto in epica gara con i fanti, prodigò sacrifici ed erois mi pe,r la grandezza della Patria !
(dalla motivaz i one deLla medagLia d'oro concessa alla B andiera dell'Arma deL Genio con R.D. 5 giugno 1920)

 R eti telegrafoniche d et SO R egg. G eni o.
R eti telegrafoniche d et SO R egg. G eni o.
PRESENTAZIONE
La pubblicazione delLa pT esent e monografia è avvenuta a puntate isul Bollettino de ll'Istituto StaTico e di .Cultu1·a dell' ATma del Genio.

Nel suo Lavoro, dedicano (LUa memoria di tutti i caduti aeb e del 7° Reggimento Genio Telegmfisti, i cui nomi samnno ripQrtati in apposi to allegato, L ' autore espone la storia del seTvizio tele · grafico militare da lle pTime, origini (1859) al 191 9 .
L'autoTe ha accuratamente e diligentemente raccolto ed espo· sto -tutti i dati e Le attività Telativi ai Teparti Genio T elegrafisti mettendo in evidenza l'evoluzione dei mezzi e dei criteri di impiego nonchè gli episodi di valore e le benemerenze di cui si sono resi me·ritevoli su ogni circostanza i telegrafisti.
Dal diligente, appassionato lavoro del cap. Angelotti appare il suo profondo at t accamento all'Arma del Genio ed in particolare alla specialità telegrafisti cui ha appartenuto e nella quale ha degnamente opemto.
I fascicoli , completati .dagli alle ga ti, vengono 1-iuniti in apposito volume che fa pa1-t0. della collezion e di monogmfie storiche dell'Istituto .
l '
 PREMESSA
PREMESSA
Quei soldatin i che s'incontra no per l e vie, marziali, distinti nell'uniforme che simboleggia una tradiz ione tecnico-m ilita re , portan ti sulla mani ca sinistra un segno a forma di «ragno » e che invece rappres enta una scin tilla elettrica, sono i tclegrafisti.
Essi appart engono oggi alla costituenda Arma delle Trasmiss ioni, e, se ques ta si stacca dall'Arma madre, quella del Genio, essi sono pur semp re fieri delle antiche glorie e del comune patri. monio spirituale.
Nei ponderosi scritti sulla guerra, il telegrafista fu qua si sem. pre ignorato, sebbene i suoi 1400 morti della prima guerra mondiale (il 16% dei 9204 caduti d e ll' Arma del G enio, di cui 424 ufficiali) e quelli assai più numerosi delle successive guerre, con j molti e spesso sconosciu ti episodi di valor e, abbiano dato al Genio telegrafisti un posto d'onore fra gli altri combattenti.
L'esercito in guerra aveva nel servizio telegrafisti un insostituibile mezzo per l ' esercizio dell'azione di comando, come un sistema nervoso che stendeva i suoi fili conduttori i n tutto il fronte e in tutta la zona di operazioni.

Attraverso quei fili arrivavano gli ordini fino ai reparti in trincea come pure arrivava al Fante la parola incitatrice della Patria.
Si può dire che, dal 24 maggio 1915 al 4 novembre 1918, sia passata, in quelle migliaia di chilometri di fili, tutta la nostra Storia.
Ed j. telegrafisti, uniti con i radiotelegrafisti, lanciarono al
mcmd0 lo storico Bollettino d e lla Vittoria e dissero agli Italiani, il pomeriggio del 4 novembr e del 1918, che Trento e Trieste erano entra te definitivamente a far parte della gran Madre Italia.
Mi propongo, con queste pagine, di ricordare l'opera preziosa svolta dai Telegr afisti durante la prima guerra mondiale e il contr ibuto che essi d i edero alla grande v ittoria italiana.

Ricordi di vita vissuta
Lontano 1914! Partimmo nel grigiore dell'autunno, con il cuore in tumulto per «l'odore di polvere » che ci veniva da ll'occidente l m guerra.
Da Firenze, culla e sede del 3° reggimento G enio T el egrafisti, fummo inviati a Mantova. V'era un battaglione telegrafisti «da fortezza », ben distinti, allora, da al tri ba tt aglioni, che si chiamavano da campagna.
Compiuto un primo ciclo di add estramento militare, venivano selezionati gli elementi che si ritenevano particolarmente idonei pe1 frequentare il Corso «Allievi Telegrafis t i », che durava circa r m esi.
Ven ivano imp a r tite nozioni generali di elettricità e magnetismo, di telegrafia elettrica ed ottica, nozioni pratiche sulle linee permanenti e volanti e sugli apparati, nonchè le norme di co rr ispondenza telegrafica.
Chi non ricorda, fra coloro che appartengono al Genio Telegrafis ti, i tasti di esercitazione, la grande aula con cen t inaia di cassettine telegrafiche da campo e di t avoli Morse? E le soste cavanti all'eliografo Faini-Triulzi che, con gli altri apparati, ci ·appariva allora come un congegno meravigl ioso e perfezionatiss imo ?
Dalle cognizioni puramente teoriche si passò, alle più interessanti e suggestive applicazioni pratich e.
Olt re ad approfondire la conoscenza delle famose « cassettine Morse», non molto d issimili da quelle apparse fin dal 1855 per l e
I teLegrajìsti neLLa guerra 1915-18 13
linee telegrafiche da campo, fummo rapidamente inizia ti anche ai s'egreti degli apparati telefonici. [ Il primo di e ssi fu il mic:rotelefono da campo a chiamata fonica. In seguito si studiò l'apparato modello 1888-1891, trasformato n el 1902, che, per quel tempo, poteva con siderarsi un mezzo rispondente e di utile impiego].

Notevole parte nelle istruzioni ebbe l'appa rato da campo per telegrafia ot tica Faini-Triulzi, che, pur nella sua semplicità, doveva rendere preziosi serv·igi.
Ma l'aspetto più interessante delle istruzioni era, indubbiamente , quello riguardante l'impianto e l'esercizio delle linee telegrafiche, telefoniche ed ottiche.
L'organizzazione di questi 'collegamenti impegnava, quo4idianament e , quasi tutta la compagnia. Lungo le strade dell'uber tosa campagna mantovana, quante volte le squadre teleg rafisti &ostarono per far buche, in nalzare pali, distendere fili, impiantare stazioni, ben compresi n el più scrupoloso assolvimento del proprio compito, nel quale spiegavano tutta la capacità acquisita durante l'addestramento.
In ta l modo si preparavano militarmente, tecnicamente e TI!O· ra l mente i soldati del 3° reggimento genio, che all'inizio della guerra 1915-18 erano già circa 8000 e che costituivano la spina dor· sale dei ·60.000 che, aWepoca dell'armistizio, appartenevano al 3c e al 7° reggimento telegrafisti successivamente costituito.

Cap. I.
LE ORIGINI DELLA SPECIALITA'
l - Il 3° reggimento genio fu cos tituito a Firenze il 1° ottobre 1883, con elementi tratti dal ro e 2° reggimen to genio, in mag. gioranza zappatori.
Il primo comandante fu il colonnello Carlo Colonna, che ne assunsè il comando in data l u novembre 1883 .
Il nuovo reggimènto, ancora misto nelle sue specialità, risultava in tale data così composto: l Stato maggiore, 2 Brigate telegrafisti su 6 compagnie, l Brigata Ferrovieri su 4 compagnie, 2 Compagnie treno, l Deposito ed l Plotone d'istruzione.
Più precisamente ebbe, in origine, la seguente dislocazione: a Firenze, l brigata di 2 compagnie zappatori - 2 brigate di telegrafìsti (5 compagnie) - 2 compagni e treno e d eposito; a Roma, l brigata di 2 compagnie zappa tori ed l compagnia telegrafisti, l brigata di 4 compagnie .ferrovieri.
Nell'ordinamento dell 'anno 1894 cessò la distinzione fra le compagnie zappatori e telegrafisti, le quali furono tutte indicate col nome di zappatori-telegrafisti, il che portò da quell'epoca alia fusione delle du e specialità nel 3o Regg. , sia nell'is truzi one che nel servizio comune.
Finalmente per R.D. dell5 ottobre 1895 il 3° Regg. genio prese il nome di « 3° Reggimento genio tele grafisti » ed ebbe la seguente composizione:

l Stato Maggiore
4 Brigate zappatori-telegrafisti (12 compagnie) , l Brigata specialisti distaccata a Roma, 2 Compagnie treno, l Deposito.
I distaccamenti erano: l Brigata di tre compagnie a Piacenza, l Brigata di tre compagnie a Verona, l Compagnia Treno a Roma.
Nello stesso 1895 il comando del reggimento venne assunto dal tenente colonnello Zaccaria Finardi.
Nell' anno 1896 venne creato un d istintivo per il telegrafista effettivo, consistente in sei frecce con il gambo a zig-zag, uscenti tre superiormente e tre inferiormente da un nucleo centrale, con un fregio sotto le frecce inferiori.
Nell'anno 1897 fu dato il distintivo anche all'allievo telegraflsta, che era uguale come disegno, ma senza il freg io inferiore
Questo distintivo venne poi da noi denomina to il ragno, simbolo significativo dei nostri telegrafisti, che tanto si distinsero nel realizzare la grande ragnatela costituita dai fili dei collegamenti attuati durante la guerra.

Con R. D. del 22 dicembre 1898 veniva soppres.sa la denominazione di Brigata « zappatori telegrafisti » e adottata invece quella più rispondente di «Brigata telegrafisti ».

Le trasformazioni avvenute nel 3° G enio Telegrafisti prima dell'anno 1915 furono le seguenti:
Nel 1909 la Brigata specialisti, comprendente il servizio Aerostatico, il Servizio fotografi militari, il Servizio fotoelettricisti e il Servizio della radiotelegrafia, cessò di appartenere al 3° Reggimento e divenne autonoma.
Nel 1911 il 3° Genio telegrafisti costituì un nuovo distaccamento di 3 compagnie, a Mantova.
Con R. D. dello stesso anno 1911 la deno minazi one di «Brigata Telegrafisti » venne sostituita con quella di «Battaglione telegrafisti ».
Nello stesso anno venivano costituite, alla sede del reggimentc-, altre 4 Compagnie di telegrafisti ma due di esse vennero dislocate una a Messina e l'altra a Ozieri.
In quell'epoca il reggimento, forte di sedici compagnie telegrafisti, assunse il suo vero carattere della specialità per la attuazione dei collegamenti tele grafici, telefonici e radiotelegrafici.
L 'uniforme di campagna del soldato del 3° reggimento Genio telegrafisti, dopo aver subito le evoluzioni dei tempi, era all'inizio della guerra 1915-18 composta da: giubba, pantaloni e mollettiere in panno grigio verde; sul bavero della giacca mostrine in velluto nero con filettatura in velluto amaranto, sul braccio sinistro il ragno per i « telegrafisti » ; copricapo in panno grigio verde co.:1 trofeo orifiamma, dal cui centro (con l'indicazione del numero del Reggimento) si dìpa rtivano 5 frecce per parte fatte a zig-zas (saette), e sotto due appie incrociate, legate da un nodo.
L'armamento consisteva in un moschetto modeUo 1891, sciabol a baionet ta con cinturone e giberna unica.
I colonnelli che si susseguirono nel comando del 3° Reggimento genio-telegrafisti, dal 1901 al 1918, furono:
1901 - Carlo Buffa
1905 - Pietro Mirandoli
1909 - Enrico Marantonio
1911 - Umberto G iustetti
1913 - Nata lino Mazzone
Questi, dal mese di maggio 1915, ebbe la dir ezione di tutt i i collegamenti dell' esercito in guerra con la qualifica di «Ispettore capo del Servizio telegrafico militare», carica che esercitò sino alla fine di f€bbraio del 1917.

Dal marzo di que ll'anno e sino alla fin e della guerra, la stess<1 carica fu retta dal colonnello Gae tano Cardona che comandò poi H 3° R eggi mento genio telcgrafisti fino a quando, nel 1919, fu di . sciolto e i battaglioni telegrafisti furono dislocati presso i singoli corpi d'armata territoriali (l).
(l) Il col. Cardona venne nominato comandante del genio del Corpo d'Armata di Firenze; incarico in cui rimase con la pr omozione a Generale
Cap. II
ATTIVITA' ANTERIORE AL 1915
2 - Compiti tecnici disimpegnati in guerra dai telegrafisti del Genio, prima della costituzione del 3° Reggimento Genio Telegrafisti.

D u r ante le campagne d'indipendenza d el 1848-1849 non esistevano mezz i tecnici di collegamento campal e. Soltanto nella gu e rra d el 1859 troviamo il telegrafo a se gnaH <<Sistema Rocci » che collegava Casale, San Salvatore, Alessan· dr ia e Novi: il comando supremo era stabilito a S. Salvatore ed era tenuto in dire tta comuni cazi one con i comandi delle t ruppe <'!Vanzate con Casale e Novi. fu la prima lin ea t eleg r afica ele ttrica italiana utilizzata a scopo militare.
Il telegrafo a seglfali ideato dal Maggiore Al essandro Rocc'i, (l) fu impiegato soltanto in stazioni fisse: l'impianto v enn e esegui to dal capitano Luigi Giannetti (che n e diresse il servizio) con la collaborazione dei sottotenent i Molteni e Galletti, e di pochi sottufficiali e soJdati.
Occorre che tutti gli appartenen ti al genio telegrafisti, ricordino questi nomi de i primi te Legrafist i miLit ari itaLiani.
Però i primi collegamenti telegrafici elettrici di campagna avvennero i!l modo tanto irregolare, che mancarono spesso al loro importante compito. L e r agioni sono da ricercarsi nel non aver s ub ito sottoposto ad· un'unica direzione e disciplina il personal e ClVile e militare addetto all'importante servizio e nel non aver potu to p r edisporre tutto il ma ter iale necessario .
(l) cfr MARIAN O BORCATTI - Storia de ll 'Arma del Genio - pag. 1358 e segg Il sistema Rocci deriv ava dal sistema Chappe.
Invero ogni divisione disponeva soltanto di due apparati Morse ·completi da campo- 42 elementi di pila Dani ell - 35'0 pali telegrafici - 50 staffe per fare i pali doppi - Kg. 250 di filo di rame scoperto - 50 kg. aì filo rivestito - isolatori - barelle - 5 tamburi per filo telefonico - tavolo per l'apparato Morse - letto da ·Campo - strumenti accessori da telegrafista e per zappatori.
Tutto questo materiale veniva caricato su apposito «carro telegrafico».
3 - Campagna di Ancona (Aprile-Settembre 1860) - Italia Meridionale (Ottobre 1860- Febbraio 1861). l
L'organ izzazione del servizio telegrafico in guerra, anzichè migliorare, peggiorò per l'emanazione di nuov e norme che ne sottraevano l'impiego al personale militare. Sebbene la direzione generale del servizio telegrafico spettasse al Comando superiore dell'Arma del Genio, esso dovette essere svolto con il personale che U Ministero dei LL. PP. avrebbe dovuto mettere a disposizione con il relativo materiale.

Avvenne così che tutto il materiale in dotazione alle Divisioni, che avevano operato nel 1859, fu restituito con il personab <:ivile telegrafico al Ministero dei LL. PP. L'autorità militare, peraltro, durante la campagna, dovette fornire il personale per lo delle linee nonchè quello per il trasporto dei materiali, con i relativi mezzi.
Questi compiti vennero affida ti agli zappatori del genio. Nessun progresso, per'tanto, ne era conseguito al servizio telegrafico in guerra.
Nondimeno le notizie risultanti dalle relazioni di quella campagna ci riferiscono che i due corpi operanti (il 4° per Castelfidardo e d il 5° per Perugia) verso uno stesso obiettivo, ma divisi dall'Appennino, furono costan teme nte tenuti collegati con una doppia linea telegrafica, distesa. Così durante i primi due giorni di assedio della città di Ancona furono distesi 20 km. di linea telegrafica e impiantati cinque apparecchi riceventitrasmittenti. che assicurarono il collegamento tra 1 due corpi di
operazione e con la flotta la quale operava d i intesa con il Quartiere Generale.
I predetti due corpi operanti continuarono ad essere impegnati anche nella successiva campagna dell'Italia meridionale, (Gaeta). Anche per questa campagna ìl servizio e l 'impiego de] materiale vennero affidati esclusivamente al personale civile, con 11 concorso di personale militare come innanzi detto.
I due corpi furono collegati con il Quartier Generale mediante tre stazion i telegrafiche impiantate a S. Centore, a Castresa ed a Sessa. Pe r la battaglia del Garigliano e per l'assedio di Gaeta furono stesi circa 40 km. di linee telegrafiche e impiantate sei stazioni (che erano presso a poco le attuali cassettine telegrafiche l\;1orse) realizzando anche il collegamento con il Comando dell'Artiglieria.

In questa campagna si impiegarono per la prima volta Linee telegrafiche volanti (così chiamate· fin d'allora).
4 - Organizzazione dei telegrafisti militari.
Con R. D. dell'anno 1862, in previsione della crescente impoL. tan za del servizio telegrafico in guerra, furono attuat e le riforme intese ad affidare completamente il servizio stesso a mil itare, alle dipendenze del Comando Superio re del Genio Militare, pur continuando a prevedersi l'impiego di personale civile. All'entrata in campagna dell'esercito, il ma t eriale telegrafic0 sarebbe passato dai magazzini dell 'Amministrazione militare ai Parchi del Quartier Generale e a quelli dei Corpi d'Armata. Il Quartier Generale poteva perciò disporre di due f urgoni uffici), di 35 Km. di filo di rame per linee pesanti, con adeguato numero di pali telegrafici e 4 cassettine Mors e da campo.
Il Comando d el Corpo d'Armata avrebbe avuto a disposizione invece, un furgone ufficio, 30 km. di filo per linee pesanti, 16 km. di ·filo per linee vo l anti, adeguata dotazione di pali telegrafici e due cassettine Morse .
Ci avviamo ora a grandi passi all'ordinamento che doveva portarci alla completa sostituzione del personale civile ed alla preparazione di personale militare specializzato per il servizio telegrafico campale.
Istruzioni appositam ente emanate dal Ministero della Guerra ,._;ell'anno 1864, a solo titolo di esperimento, contemplavano l'irnpiètnto delle linee con criteri non molto dissimili da quelli attuali.
In conseguenza di queste norme, l'addestramento dei soldati del genio per le suddette mansioni incominciò ben presto ad essere svolto presso tutte le compagnie zappatori ed i militari ai quali era riconosciuta l'idoneità per diventare buoni trasmettitori e ricevitori venivano inviati presso gli uffici tele grafici civili per il perfezionamento con esercitazioni grafiche.
Successivamente, il l novembre 1864 fu costituita in Alessandria la prima scuola di istruzione telegrafica militare, la « Scuola Telegrafica per le tl·uppe del Genio », ed ivi venivano ammessi per turno sedici ufficiali subalterni, sedici sergenti e sedici caporali dei reggimenti zappatori.

La durata di ciascun corso era di quattro m esi per gli ufficiali e di due mesi per le truppe.
Da quella scuola ebbero origine i primi telegrafisti del geni..).
Con circolari del Ministero de lla Guerra del maggio e agost') 1866 vennero diramati ulteriori norme confermando il principio che «il Genio militare costruisce e mantiene con il proprio personale e materiale le linee telegrafiche che occorrono all'esercito».
Perciò, nella campagna del 1866, il servizio telegrafico venne svolto interamente dalle truppe del genio.
Le compagnie zappatori che vi parteciparono con questo particolare incarico furono la 5\ la 15\ la 17", del l 0 Regg. Genio, la 9\ la 14' e la 16" del 2• Regg. Genio; furono stesi 780 km. di linea ed impiegati 160 apparecchi telegrafici Morse.
L'innovazione apportata all'ordinamento del genio dopo tale campagna, non è elle la separazione organica dei telegrafisti dagli zappatori, avvenuta il 31 dicembre 1882.
5 - Campagna d'Africa (1895-1896) - Gue rra Italo-Turca (19111912).
Il 3° Regg. Genio Telegrafisti partecipò per la prima volta a una campagna di guerra (1895-96) nella Colonia Eritrea, con set te ufficiali e centonovantadue uomini di truppa. Nella guerra italoturca (anni 1911-1912) mobilitò ed inviò in Libia tre compagnie (la P, la 7a, e la 9") e tre plotoni autonomi, di cui uno destinato a Rodi.
6 - Benemerenze civili.
Reparti de l 3° Reggimento Genio e precisamente 2 plotoni di 50 uomini ciascuno e, in seguito, una compagnia (la 10a) co n relative dotazioni di materiali, venn ero inviati in Calabria e in Sicilia subito dopo il terremoto del dicembr e (1908) per ripristinare i collegamenti telegrafici.

A ssolsero il loro compito sollecitam ente ed in modo pienamente rispondente a quelle particolari difficili circostanze, distin· guen dosi per capacità, spirito di sacrificio, elevato sentimento del dovere, spirito d'iniziativa e rendimento
L e benemerenze civili che essi meritarono in quella occasione tornano ad onore di tutti i telegrafisti d el genio (2).
(2 ) L'argomento riguardante le origini e i primi sviluppi della specialità telegrafisti venne largamente trattato dal B ORGATTI nella sua Storia de ll'Arma del (dalle origini al 1914) Cap. XII pagg. 1332-1406, dove il lettore potrà t ro vare altre notizie (n. d. r. ).
Cap. III.
PERSONALE E MATERIALE DEL GENIO TELEGRAFISTI
7 - Reclutamento e addestramento del personale.
Con la costituzione del 3 ° Regg. Genio (avvenuta nel 1883) la Scuola di telegrafia pra tica venne trasferita da Alessandria a Firenze.

Nell'anno 1911, con la successiva costituzione dei battaglioni distaccati a Verona, P iacenza e Mantova, e delle compagnie distaccate a Messina e Ozieri, gli insegnamenti vennero impartiti oltre che a Firenze, anche nelle sedi dei predetti battaglioni e compagnie.
I soldati per la specialità telegrafisti venivano reclutati dai d istretti fra gli elementi migli ori, fisicamente, moralmente e culturalm ente, dando la preferenza a coloro che .eserci,tavano la p ro. !fessione di telegrafista civile.
I battaglioni di Firenze e di Piacenza e Le compagnie di Mes· sina e Ozieri erano chiamate <<'battaglioni e compagnie telegrafisti da campagna », perché in caso di mobili tazio ne dovevano essere assegnati a grandi unità operanti.
Il battaglione di Verona era denominato «da montagna», perchè doveva operare con le truppe alpine. Il battaglione di Mantova era denominato «da fortezza», perchè ne era previsto l'impiego nella sistemazione difensiva ai nostri confini e lungo la fascia costiera.
All'inizio della guerra 1915-18 questa suddivisione non si mostrò rispondente all'esigenza, e tutti i reparti telegrafisti furono
avviati ed impiegati dove fu necessaria la loro opera, ed agirono in piena collaborazione con le altre armi.
Presso i battaglioni telegrafisti del 3° Regg. Genio distaccati a Verona ed a Piacenza si svolgevano anche corsi periodici di telegrafia ottica per l'addestramento di sottufficiali e soldati di artiglieria .

I corsi regolari per la truppa del genio telegrafisti ebbero, prima della mobilitazione, la durata di nove mesi circa, divisi in due periodi: dopo i primi quattro mesi, gli allievi promossi avevano dir i tto all a no mina di «Allievo Telegrafista », dopo il secondo periodo di cinque mesi, i promossi avevano diritto alla qualifica di « telegrafista effettivo».
Durante la guerra invece, con l'aumento straordinario del numero delle compagnie telegrafis t i, non essendo sufficienti gli ufficiali forniti dai corsi dell'Accademia Militare di Torino (anche perchè pochi di essi passava no alla specialità telegrafisti) si istituirono, presso il Comando Supremo, speciali corsi per Allievi Ufficiali telegrafisti.
Nell'anno 1916-17 tali corsi si svolsero a Udine e nell'anno 1917-18, in seguito al ripiegamento sul Piave, a Ravenna.
Vi potevano partecipare solamente gli elementi proposti dai comandanti deil e compagnie telegrafisti (salvo l'approvazione dell'Ispettore Capo del Servizio Telegrafico in guerra) scelti naturalmente fra quelli che, per titoli di studio, qualità morali e fisiche, nonchè per meriti acquisiti, erano ritenuti idonei.
Per la truppa si risentì la mancanza di un centro d1 preparazione, che potesse istruire in modo conveniente i militari intorno ai nuovi compiti tecnici, cui la scienza e la te cnica in continuo progresso fornivano mezzi sempre più perfezionati, più complessi e di maggior rendimento.
D ifatti durante i p eriodi più critici ebbero luogo corsi bre . vissimi presso le sedi dei depositi del 3° Reggimento G enio: in quattro mesi, al massimo, i tel egrafisti venivano addestrati e poi destinati alle compagnie che ne· difettavano e che si trovavano fronte. Presso le compagnie operanti questi uomini, dopo un mese,
divE>ntavano perfetti telegrafisti ed ottimi soldati. Per quanto in seguito alla mobilitazione fossero rientrati, al 3° reggimento genio Lelegrafisti, i richiamati appartenenti alla milizia mobile e a quella territoriale, il personale telegrafista risultava però sempre nu mericamente insufficiente per poter soddisfare le nuove e sempre maggiori esigenze.
Invero, se si pensa alla estensione del nostro fronte, che raggiungeva, dallo Stelvio al mare, circa 650 chilometri; alla necessità di assicurare i servizi costieri e quelli di importanti centri militari nell ' interno del Paese; alla dislocazione delle truppe in Oriente ed in Francia e ai presidi nelle colonie, ci si rende subi t o conto che la circa il completamento del personale era un problema esse nz iale, la cui soluzione doveva assicurare l'efficienza dei collegamenti elettrici ed ottici.
In consid erazione di ciò, per disposizioni supenori, si ricorse al reclutamento di elementi delle altre armi. Infatti in quasi tutte le compagnie telegrafisti di Armata e di Corpo d'Armata furono organizzati corsi pratici per soldati di tutte le armi, in possesso dei necessari requ is iti culturali.
In questo modo, e particolarme nte per ciò che riguardava i collegamenti telefonici e la manutenzione delle linee (che erano i servizi più importan ti da disimpegnare) la scarsità del personale fu gradatamente meno sentita, sebbene fino al termine del primo conflitto mondiale sia stata sempre lamen tata la penuria di telegrafisti.
8 - Parchi e d otazioni.
le prime norme che determinarono la costituzione regolamentare dei parchi presso l e compagnie telegra fis t i si ebbero nell'anno 1910.
All 'atto della mobilitazione e secondo le norme riassunte nel manuale dell'Ufficiale del genio in campagna, (edito nell'anno 1915) le compagnie telegrafisti si mobilitarono con un parco co-
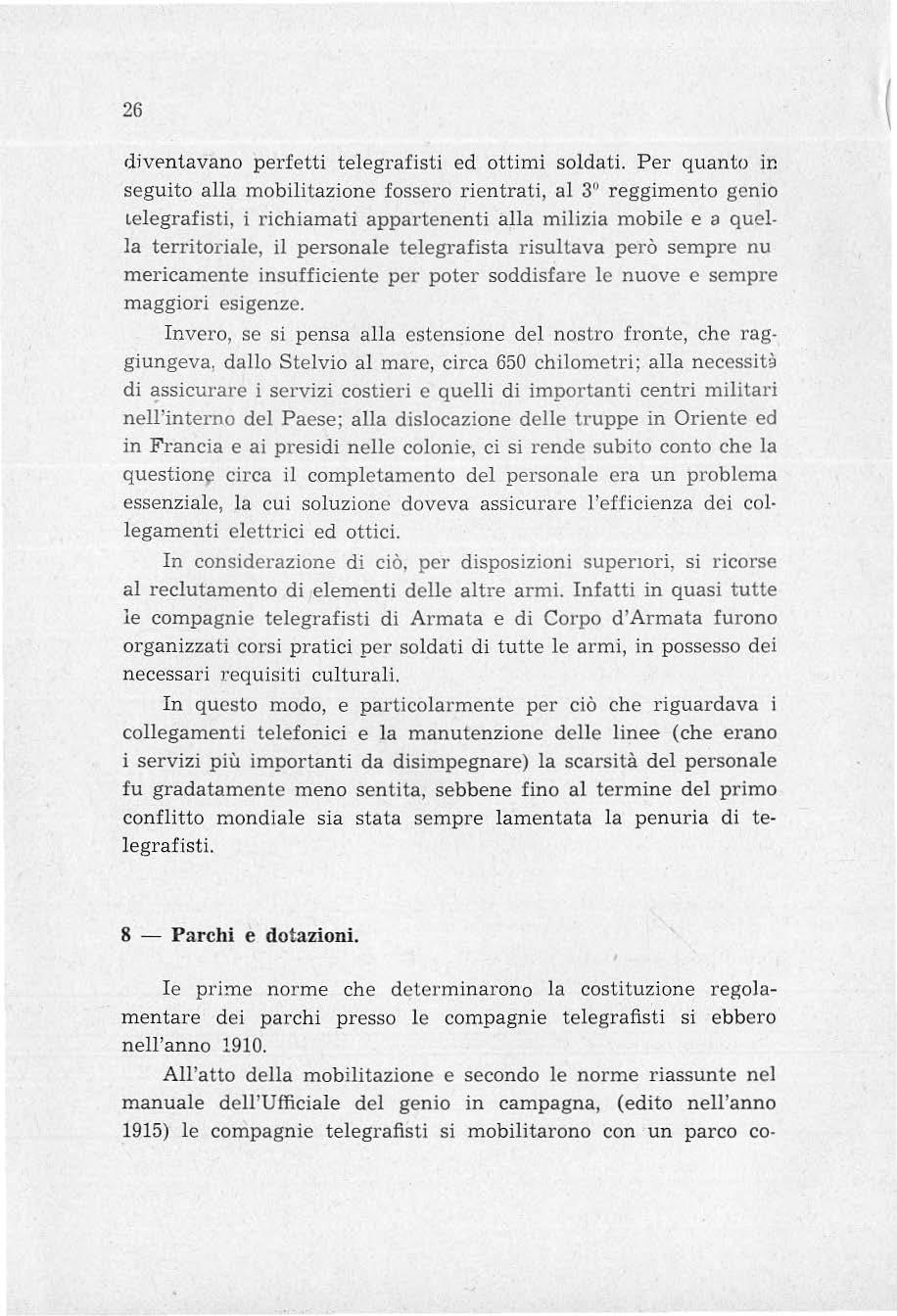
stituito da carri (a quattro ruote) o da carretti (a due ruote) da montagna . Il parco telegrafisti su carri a quattro ruote comprendeva una sezione el ettrica con 3 carri per materiale pesante e ire per materiale volante, una sezione con 6 vetture per servizio ottico; una sezione di riserva con un carro per materiale ùi riserva, un carro trasporto, due carrette da battaglione. Inoltre vi erano dodici biciclette per la sezione ottica e due per il servizi o della compagnia.
In complesso con materiale della sezione elettrica, si potevano stendere senz 'altro 65 km. di linea ed impiantare 22 stazioni telegrafiche e 24 stazioni microtelefoniche.
Con i materiali della sezione ottica si potevan,o impiantare 6 staz ioni ottiche, ciascuna dotata di due apparati microtelefonici e relativa dotazione di cordoncino telefonico.
Il parco telegrafico su carrette a due ruote comprendeva : una sezione elettrica con 6 carrette per materiale telegra fico volante, una sezione ottica con 6 vetture per servizio ottico, una sezione di riserva con l carretta per materiale telegrafico di riserva, 2 carrette di equipaggiamento e 14 biciclette.
T ale parco consentiva le stesse p restazioni di quello su ca rn a 4 r uo te Si andava intan to diffond endo sempre più l'impiego del telefono per le sue evidenti, vantaggiose caratteristiche, risp etto telegrafo. N ell'ottobre del 1915 furono costituite le· sezicm telefoniche per fanteria e per gruppi alpini, reparti indipendenti dalle compagnie zappatori, nonchè le autosezioni telegrafiche per cavalleria. Le prime disponevano di 40 km. di cordoncino e di 16 apparecchi microtelefonici; le seconde di 10 km. di cordoncino volante, di 2 apparati Morse da campo e di 4 microielefoni.
Fra il materiale in dotazione al 3° reggimento genio telegrafisti, p er la telegrafia ott ica, merita speciale ricordo l'eliografo diottrico « Faini » da campo, ideato e costrui to nel 1866 dall'allora capitano Gaetano Faini, apparecchio che rese ottimi servizi.
I parchi delle compagnie te legrafis ti erano costituiti da materiale di normale impiego, in cui vi era una riserva da utilizzare soltanto in caso di assoluta necessità, come avvenne quando si
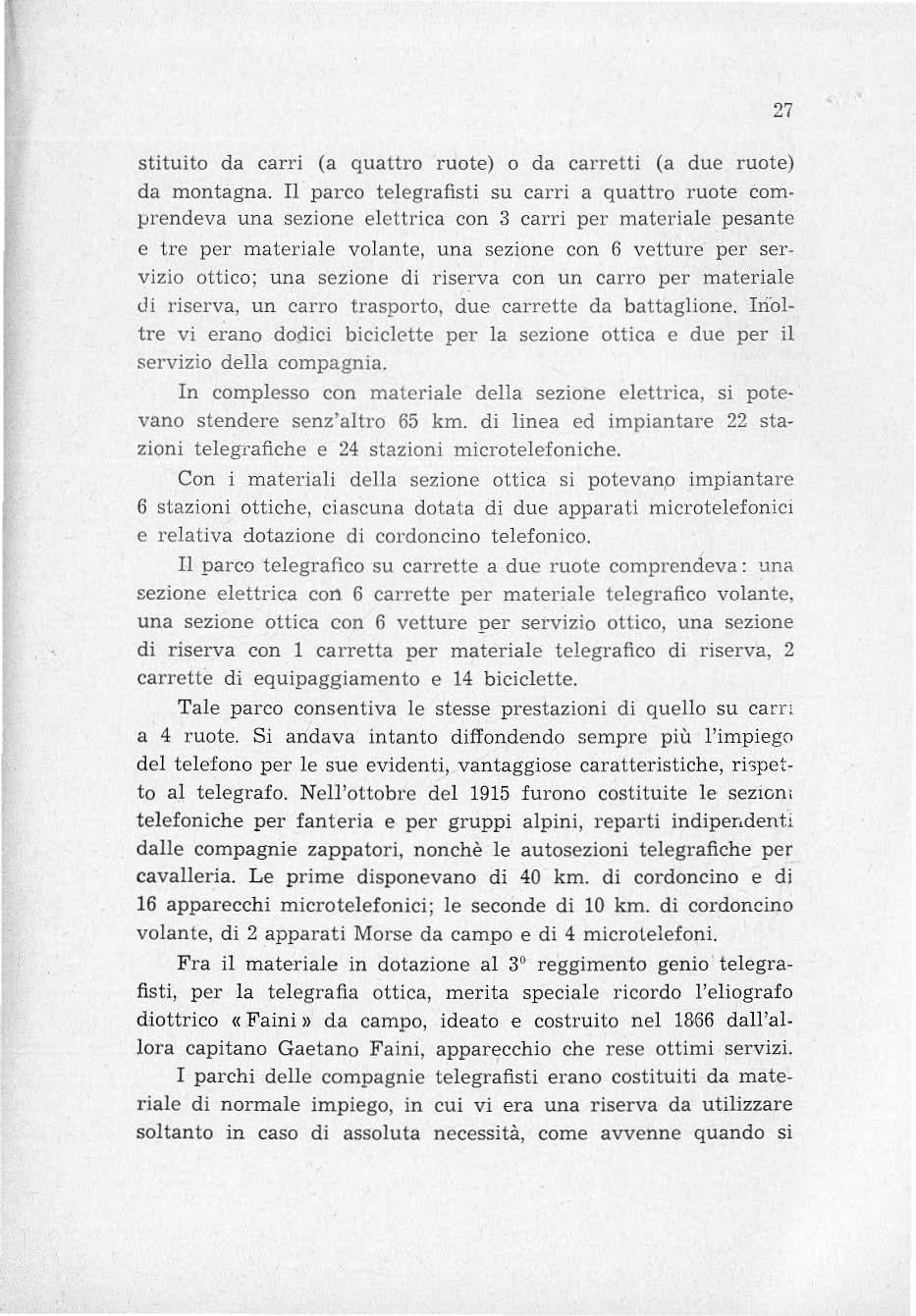
dovette far fronte alle varie esigenze con i materiali da prelevarsi presso i magaz zini del genio di Armata, magazzini pei qùali erano previste anche aliquote avanzate.
Il materiale d ei parchi eve ntualmente impiegato avrebbe dovuto essere reint egra to al più p re sto possibile median te prelevamenti presso i magazzini del genio di Armata.
Ad evitare poi perdite di tempo per la riparaz ione di appa· recchi guast i, fu creato presso quasi tutte le Ar mate un laboratorio elettrote cnic o d'Armata, con personale operaio sp e cializzato. Questi laboratori furono utilissimi e rimasero in v ita sino al termine del conflitto.
Le line e telegrafiche furono costruite quasi tutte con material e «perman ent e » (pali, filo di ferro zincato o bronzo fosforoso e isolatori) poichè il tel egrafo arrivava da tergo sino ai comandi di grande unità.
G li apparecchi impiegati nelle stazioni telegrafiche furono le no r mali cassettine telegrafiche da campo, mentre il Comando Supremo, i comandi d'Armata, che si trova va no più lonta ni dalla linea del fuoco, usarono indifferentemente casssettine telegrafiche da campo e tavoli Morse. Qualche comando ebbe pure a C: i sposizione apparati celeri Hughes.

L e linee telefoniche cost ruite con materiale pesan te, si chiamarono «permanenti » perché rispond ev ano a esigenze di lunga durata e soprattutto per i collegament i a maggi ori d istanze. S i cchè quasi tutte le linee telefoniche principali delle grandi unità furono di t ale tipo, mentre le Hnee telefoniche aven ti carattere di temporaneità e quelle più urgenti v e nivano costruite general mente con cordoncino telefonico volante.
Si conoscevano allora due ti p i di app arecchi telefonici pe r impianti permanenti e da campo. Quelli d el primo tipo, gli appara ti tele fonici dei modelli 1888, 1891 e 1902, avrebbero servire in guerra quali telefoni a muro, da impiantarsi in stazioni aventi carattere di lunga stabilità, ma sebbene ottimi non vennero quasi mai usati, non essendo di facile impianto e pratici per il servizio di guerra. Perciò furono gradata mente sostituiti da numerosi modelli di più facile impiego, talchè - poco dopo
l'inizio dell e ostilità - non ci fu più distinzione fra gli apparecchi te l efonici a muro per impianti pe rmanenti e quelli da campo.
N el dicembre 1915 l' I spettore capo del Servizio Telegrafico Militare, ano scopo di evitare la possibilità di intercettazioni da parte del n emico, ordinò che tutte l e linee telefonich e del fronte venissero · trasformate da circuito misto a circuito metallico, e che i pochi microtelefoni rimasti fossero sostituiti con telefoni a chiamata magneto-elettrica. Questo provvedimento ebbe pure U.f:!. altro importante scopo: quello di eliminare i disturbi d'induzione che si veri ficavano durante la corrispondenza telefonica, specialmente per il continuo moltiplicarsi dei circuiti.

Il progressivo, crescente sviluppo delle trasm issioni a filo dall ' inizio alla fine della prima guerra mondiale risu lta con chiara evidenza dalla seguente tabella:
Compagnie Forza Rete APPARATI Data telegrafotelegra fis ti totale nica Km. telegra fici t elefonici
Maggio 19 15 24 8.100 1.500 320 560
Gennaio 19 16 30 10.200 10 .000 610 2 050
Luglio 1916 39 14 .000 17.000 780 4.100
Gen n aio 1917 58 20 500 3'3.000 1.000 7.400
Ottobre 1917 70 32.000 64 600 1.2 50 13 .6 00
Giugno 1918 130 48 .9 00 80 .700 1.320 19.00ù
Ottobre 1918 136 60.000 100. 000 1.400 24.200
Gli apparecchi telefonici di commutazione (centralini) cominciarono a diffondersi verso l'autunno del 1915. E' perciò evidente in quali condizioni di difficoltà si svolgessero in un primo tempo i nostri collegamenti telefonici, costretti ad essere frazionati in linee indipendenti, quando più necessarie, più numerose e più sollecite erano le richieste delle conversazioni te l efo niche.
Il disagio tecnico, durato a lungo, apportò un lavoro improbo ai telefonisti del genio, sia per la molteplicità di linee da costruire, sia per il gravoso servizio delle trasmissioni telefoniche senza pos-
sibilità di commutazio ni multiple . Bisogna inolt r e tenere conto del maggiGr consumo di materiale richiesto per la costruzione de i suddetti impian ti.
I primi centra lini furono a poche linee , poi a molt e linee, sino a ra ggiu ngere, secondo l'impo r t a nza delle installazioni, 75 e 100 linee. Si crea rono così de ll e vere e p roprie cen trali telefoni ch;;, s p ecialmente presso il Comando Supremo ed i comandi di Armata, organizzate con ottimi criteri tecnici.
In seg uito al ripieg amento d i Caporetto, co nsidera to che il parco delle com pagnie te legrafisti era troppo pesante in relazione ai rapidi spostamenti da effettuare, l'Ispettore Capo del Servizio Telegrafico di guerra dispose che tutte le compagnie riducessero il loro parco a : 6 carrette legge re, 2 carrette per equipaggiamento, 2 vetture ottiche, 2 autocarri Fiat 15 Ter, nell' in tesa però che il mat erial e tecnico (34 km . di cordoncino telegrafico, 6 stazioni te l e . grafich e elettriche, 2 stazion i ottic he 16 stazioni telefoniche) dovesse essere conse rvato quale scorta intangibile e mob ile destinata a sopperire ad urg enti necessità.
L e compagnie d el genio telegrafisti fu ro no sottoposte ad un la voro oneroso e spesso estenuante, pe r soddisfare l e continue e sempre più numerose richieste di impianto ed esercizio di collegamenti.
La scarsità dei mezzi aJ principio della guerra ed in tante altre occasioni fu supe rata da una volontà di acciai o, e fu r ono compiuti veri prodigi per l e virtù e le capacità degli ufficiali e dei gre gari tutti e per il loro spirito di sacri ficio.

Si costruirono linee di lunghezza notevole, anche d i 25, 30 s bO chilometri; si impiantarono p res so le bat te rie e gli oss ervatori stazioni telefoniche i n posizioni molto ba ttut e dal tiro dell'artiglieria , mantenendo sempre i collegamenti; si superarono con campa te di 50, 100 e 200 metri paurosi preci p izi con perizia t ec nica indiscutibile.
Possiamo quindi affermare con coscienza che, nel corso della 1• guerra mondial e, il nostro com ple sso s istema dei collegamen t i funzionò perfettamente mercè la f e lice organizzazione delle numerose, complesse reti e l ' abnegazione dei militari dei due reggimenti telegrafisti.
Cap. IV.
SERVIZIO DI I NT ERCETTAZIONE TELEFONICA
9 - Origini e scopi.
Una nuova attività, poco nota, della nostra specialità è stata la intercettaz ione telefo n ica che e bbe un 'importanza enorme duran te la campagna 1915-18.
L'intercettazione fu possibile a causa di difetti di costruzione tecnica dei circuiti telefonici.
Invero all'inizio del conflitto, i disturbi induttivi e le d i spe rsioni di corrente, prodotti dai circ uiti misti, costi t ui ti da un solo filo conduttore e dalla terra come filo di ritorno, davano luogo all 'intercettazion e telefonica e compromettevano la segretezza delle comunicazioni.
Dall' esame di diversi docu menti originali è risultato che i primi accenni di intercet tazioni t elefo niche si e bbero:
a) nel se ttembr e 1915, n ella Zona Carnia e sul Monte Ross o (53a Divisione d el IV C.A.) con la ricezion e cas uale, da nostre stazioni telefoniche, di fonogrammi austriaci;
b) n ell'autunno 1916 sul Carso per l'indiscrezion e di alcuni prigionieri austriaci che accenna ron o come il nemico fosse riuscito ad intercettare le nostre trasmissioni telefoniche;
c) nel novembre 1915 sul costone Viola del Carso, per la cattura di una cassetta telefonica di tipo non conosciuto che più tardi si scoprì essere un apparecc hio intercetta tore austriaco.
Non auindi possi bile precisare a chi spetti la priorità della scoperta dell'intercettazione fra le nos tre linee, è però certo che il nemi co aveva ben organizz ato fin dal1914 tale servizio.

10 - Le p rime intercettazioni.
Una narrazione interessante ed ancora inedita è data dal Col. (poi generale) Carmelo Squillace, del 131• Fan teria sull'episodio che ci permise di venire in possesso dell'accennato apparecchio austriaco di intercettazione:
«Alcuni giorni dopo la conquista del Costone Viola, (parte superiore della dorsale che dalla Cima l di S. Michele del Carso scende sull'Isonzo) nel Nov.-Dic. 1915, dal comandante del battaglione, che aveva completato con un'ardita avanzata l'occupazione, mi venne segnalata, fra gli abbondanti materiali catturati, la presenza di una cassetta telefonica nuova.

«Era quello un materiale assai p rezioso per noi, che tanto ne difettavamo al principio d ella guerra e p erciò ordinai che mi venisse tosto inviata. Ed infatti poco dopo , l'apparecchio telef onico, centralino a quattro linee, era presso il mio rudimentale pos to ài Comando.
«Ripulito dal fango ed esposto al sole per farlo asciugare, lo sottoposi all'esame di un mio caporale telefonista, buon conoscitore, al quale sembrò che mancasse qualcosa all'apparecchio e difatti i successivi tentativi per metterlo in linea sulla nostra rete, dettero risultati negativi.
«Ero molto contrariato per dove r rinunciare all'impiego di quel telefono, allorchè la provvidenziale ·Cattura di un telefonista di nazionalità rumena, appartenente al 3° Regg. Honved, che ci fronteggiava, giunse assai opportunamente per trarci d'imbarazzo. Il buon soldatino rumeno col suo zainetto da guardafili perfettamente al completo dei materiali per riparazioni, fu da me invitato (dopo una discreta merenda nella quale non mancarono due bicchierini di cognac) ad esaminare il telefono (preda bellica) e dopo avermi assicurato che conosceva molto bene apparecchi di quel modello, con molta perizia ed in pochi minuti lo mise in co ndizioni di fu nzionare.
« Gli espressi la mia riconoscenza con una tavole tta di cioccol ata ed un pacchetto di sigare tte.
« S orridendo mi ringraziò, ma prima di allontanarsi con gli altri compagni con lui catturati, mi disse che era più volte uscito cautamente fuori dell a trincea all'alba per ricuperare quella cassetta telefonica che teneva in un tratto di trincea abbandonato, ma sor-
preso quella mattina dalle nostre vedette, aveva finito per alzare le braccia.
«Messo in linea l'apparecchio, incominciarono a servirsene i miei telegrafisti.
«Subito notammo la sua grande superiorità s u i nostri te lefoni a llora in distribuzion e. Esso era munito di chiamata fonica, e ciò destò la curiosi tà delle stazioni con le quali era collegato, perchè il nostro materiale era invece fornito di chiamata a campanello.
«La sera dellO dicembre il capo d el posto telefonico con grande circospezione, venne ad annunci armi che dal ricevitore del nuovo te l efo no aveva sentito parlare una lingua a lui sconosciuta . I o stesso re catomi sul posto, dopo lunga attesa, sentii lontane P flebili voci che comunicavano fra loro; ritenni d appr ima trattarsi di una intercettazione di qualche conversazione di ufficiali italiam in lingua estera per non farsi comprendere dai no stri soldati, come talvolta si faceva per mantenere il segreto sulle intenzioni dei Comandanti, ma chiamati i miei interp reti, tedesco e magiaro, essi durante la notte arrivarono a sorprendere parecchie conversazioni che dubbio erano fra i posti avversari che ci fronteggiavano.
«Compresi allora che ci trovavamo davan ti ad un vero caso d'intercettazione telefonic a e perciò mi detti subito premura di raccogliere i militari del reggi mneto che conosc evano l e varie lingue dell'Impero Austro-Ungarico e potei così avern e due che parlavano il serbo e tre o quattro conoscitori del rumeno e del tedesco.

«Ordinai il segre to su quanto veniva operato e nei giorni successivi raccogliemmo num erose notizie sul nemico, ma frammentarie, perchè i miei ascol tatori, non conoscendo più lingue, potevano solo rilevare una parte delle conversazion i, mentre i nostri avversari, specie se ufficiali, alternavano il tedesco con il rumeno con il magia ro e con il serbo.
«L'interessante per me fu il trovarmi davanti ad un fenomeno nuovo perchè (se purtroppo mi era avvenuto in pace di apprendere sul telefono notizie private d i persone a me sconosciute, mentre ero in comunicazione con quelle da me chiamate) quanto mi stava capitando in trincea, acquistava una no tevo le importanza per la guerra in genere e per noi sul Carso in modo particolare.
«Per mantenere il segreto e mentre escogitavo molteplici ten-
tativi p er aumentare la raccolta di notiz ie, no n ne volli da re par. t eci pazione sub i t o, neppure ai Comandi superiori , as petta ndo prima migliori e più sicuri risultati.
«La notte daJ 14 al 15 dicembre una sorpresa tentata dal nemico contro una nostra trince a avanzata al Costone Viola, venne prontamente rintuzzata dai nostri e l'avversario lasciò sul ter. reno parecchi uccisi.

«L 'allarme intanto si era propagato a tutta la linea ed io riferii sommariamente al Comando Super i ore. Ma ve rso l e ore sette ciel mattino dal nostro telefoni no veniva intercettata l a seguente notizia:
"Il plotone forte di 40 uomini, uscito stanotte dalla trincea ha dovuto ripiega re sotto il contra ttacco avversario; pe rdite: sei uominì rimasti fuori dalla trincea, f eriti dieci, dispersi due".
« N otificai questa informazione al Comand o Supe riore e, dopo breve intervallo, dal Comando della Di visione mi veniva direttamente richiesto come avevo potuto precisare quei risultati.
«Risposi subi t o che quelle notizie me le aveva fornite lo stesso avversario, e con rapporto ri servatissimo spiegai come mi trovavo in possesso di un apparec chio che mi metteva in grado d'interc ettare molte tele fonate d el nemico. Tale comunicazione, come m i fu detto poi, arrivò presso quel Comando men tre non sapevano darsi spiegazione della mia oscura rispost a telefonica . Come già accennai , febbrilmente col concorso dei tele fo nisti escogitavo ogni mezz o per rendere più chia re le intercettazioni, che divenivan o semp re più frequenti ed interessanti.
«Il p rim o p r ovvedimen to da me stesso escogitato fu di portare un filo diramato dalla linea che congiungeva il mio pos t o con quello più avanzato, fuori delle trincee (e quanto più possibile vicino alla trincea nemica) coprendolo bene con stracci, terra e pietre.
«Successivamente i fili divennero multipli ed ancora ti in cor. rispo ndenza dei probabili posti di comando avversario; all'estremità di essi applicamm o pe zzi di latta e perfino coperc hi di gavetta, collocandoli però b e ne a con tatto del terreno; ed i risu ltati sempre più favo r evoli mi fece ro arrivare ad applicar e latte d i pe trolio, aperte al l 'estremità del filo e collocate bene ader enti al terreno.
«Per queste ardite e pericolose operazioni concessi speciali premi ai militari che volontariamente se ne ass unsero l'incarico,
e debbo subito aggiungere che i richiedenti furono subito numerosissimi. La fortuna ci arrise e tutte le piccole operazioni notturne, spesso favorite dal tempo piovoso, riuscirono perfettamente.
«In quest i nuov i tentativi risu ltò che con il terreno umìdo l'in tercettazione era più chiara.
«Intanto il telefono da me isolato era adibito unicamente per l'ascoltazione. La cabina formata da sacchetti venne rivestita COi'l legname, e coperta di lana, in modo da avere in essa il massimo si. l enzio e due successive chiusure la isolavano dal movimento este:rno.
«Il servizio di ascoltazione (reso continuo con frequente cambio degli ascoltatori, perchè, mancando nei primissimi tempi le cuffie, i telefon isti dovevano tenere con una mano il microfono e con l'al t ra il lapis per scrivere meglio ciò che sentivano) riusciva :t:nolto laborioso anche perchè dava una notevole tensione nervosa agli individui.
«La squadra di tali mi litari venne aumentata con tutti quelli del reggimento che prima de lla guerra per esigenza di lavoro, erano stati in Austria ed avevano imparato Je lingue di quell'Impero. Questi furono e l ementi preziosissimi, verso i quali fui largo di encomi e compensi .
«Giun te però le cose a tale punto ne riferii al Comando del Gen io della 3a Armata e S.A.R. il Duca di Aosta m'inviava subito un Tenente del Genio Telegrafisti, ottimo funzionario dell'amministrazion e telegrafica statale, ed ordinava un rifornimento di tutti i materiali necessari per continuare le esperienze intensifican· dole, nonchè la costituzione· d i un apposito reparto, alla mia dipendenza, di circa 50 militari di tutte le Armi e Co r pi d ell'Armata ·ottimi. conosçitori delle lingue che a noi interessavano.

«Con l'aiuto di quel tecnico (Ten. Bianchini) gli esperimenti divenn ero sempre più interessanti, per la scelta del terreno più favor evole alla raccolta delle intercettazioni e per il loro ricevimento. e difatti si dovett e più volte cambiare la improvvisat3 cabina di ascoltazione ed i pun ti di posa delle lastre metalliche fuori d ella tr incea.
«Le notizi e d el n emico venivano trascritte subito su appositi fogli, poi tradotte testu almente, anche se sconclusionate, ed inviate giornalmente al Comando deJ l a Divisio ne, salvo ve ne fosse -
ro di quelle che potevano interessare le nostre operazioni o quelle che preparava l'avve rsario, ed allora l'ufficiale, che stava sem· pre sul posto, faceva u rgenti comunicazioni a me ed a l Comando della Divisione e della Armata.

«Quando al Comando dell'Armata sembrò non più dubbia la efficacia grandissima di quella scoperta, l'apparecchio venne ritirato dal Comando del Genio dell'Armata, presso il quale furono compiuti interessanti esperimenti su terreni di diversa natura, attraverso reticolati, corsi d'acqua, boscaglie, ecc., che portarono all'impiego razionale delle intercettazioni telefoniche ed alla organizzazione del servizio I.T. che ebbe tanto largo impiego negli anni 1917-18.
«S.A.R. il ComandantE: dell'Armata volle degnarsi di esternare il suo compiacimento per quanti avevanp concorso dall'inizio ai vari tentativi per l'intercettazione telefonica e fino ' al loro coronamen to, colla seguente lettera al Comandante dell 'XI C.A.: " 21 Dicembre 1915
Con piacere ho visto l'interessamento posto dal Comando del 131 R egg. Fanteria per utilizzare l 'a pparato telefonico austriaco per intercettare le comunicazioni nemiche. L'E.V. vorrà perciò partecipare al detto Comandante il mio compiacimento e così pure al personale dipendente che lo ha coadiuvato nella scoperta ed ap.che al T e nente del Genio Bianchini che tanto utilmente ha concorso per riuscire meglio nello scopo.
Il Ten. Gen. Com. dell'Armata Emanuele F iliberto di Savoia»
Successivamente, quando, com pi u ti tutti gli esperimenti presso quel Coma nd o , l'apparecchio rivelatore divenne , quasi inser. vi bile, S.A.R. lo destinò in dono al Comando del 131o Regg. Fan. teria quale prezioso cimelio, a ricordo del nuovo mezzo che doveva apportare, come effettivamente poi avvenne, notevole con· tributo al servizio d'informazioni .
Ora la «cassetta miracolosa» ha trovato l a sua gi u sta sede nel Museo Storico dell'Arma del Genio in Roma dove, in conformità di ist ruz ioni a suo tempo date, è stata inviata dopo il rientro in Patria dei reparti nell'inverno 1919-20.
Provvedimenti per l'intercettazione.
Non appena fu segnalata la possibilità di intercettare le conversazion i telefoniche, il Comando G eneral e del Genio impartì ordini a t utti gli ispettori telegrafici d'Armata per l'abolizione di tutti i misti dei collegamenti telefonici e la loro sostituzione con circuiti mteramente metallici, mentre si disponeva un maggiore controllo per la segretezza d eUe nostre trasmissioni.
Un altro provved imento adottato più tardi ed atto ad impedire l'intercettazione del nemico, fu il servizio di contro-intercettazione fatto con correnti disturbatrici emesse dalle nostre stazioni intercettatrici, che avevano anche il compito di individuare quelle linee telefoniche avanzate che si p restavano alla ricezione delle conversazioni nemiche.
Vennero così attentamente esaminate le varie linee telefoniche, eliminando d ifetti o inconvenienti, ripiegando tutte le linee inutili o abbandonate, sia nostre che lasciate dal nemico nelle zone che aveva dovuto sgombrare. Venne inoltre osservata una severa disciplina nelle conversazioni, usando parole cifrate o vocaboli e frasi convenzionali.
Il Comando Supremo ordinò inoltre a tutte le Armate di organizzare, sulla base delle istruzioni del Comando Generale del Genio, l'intercettazione delle conversaz ioni telefoniche del nemico.
L 'Ispettore T elegrafico della 2" Arma ta (allora Col. del Genio Giuseppe Guasco) esperimentò, con buon esito, un apparecchio di sua costruzione nel territorio di Zompitta (Tricesimo), sulle Colline di Attinis, Faedis, Ravosa e quindi stabilmente (nel gen· naio-febbraio 1916) a Plava, a quota 383, a Zagora ed a Globna.
Il Comando del Genio della 3a Armata dopo studi ed esperimenti eseguiti dall'Ing. Ten. Pelizzi, e con il concorso della Ditta P erego di Milano, fece costruire un apparecchio intercettatore che, provato sulle Colline di Medeo, dette pure buo ni risultati e fu subito perfezionato e dis tribu ito a lle d ive rse Armate. Sul terre no della 311 Armata le prime stazioni intercettatrici furono que lle di Monfalcone, Selz, Bosco Capuccio, San Michele, Podgora, Lenzuolo Bianco. Cosicchè arrivando al settembre 1916, ed in seguito ai perfezionamenti apportati agli apparecchi intercettatori venne costituito, a cura dell'Ispettore Telegrafico della 2ll Armata, il primo Centro I. T.

Oltre alla compilazione delle istruzioni tecniche sul serviZIO cielle intercettazioni telefoniche e sulla protezione delle nostre linee ·telefoniche avanzate furono O\rganizzati numerosi corsi di istruzione per gli ufficiali, graduati e soldati da adibire al nuovo spe-ciale incarico.
Tutto ciò cont ri buì a riordinare questo servizio che diede p resto i suoi benefici, fornendo notizie preziose ai vari uffici di informazioni.
Il nemico, fattosi acco rto, impartì a sua volta severi ordini per impedire l'intercettazione deUe sue conversazioni. L'inadempienza a ques ti ordini era punita con grande rigore, mentre largheggiava in premi per ,i militari isolati e in pattuglia che riuscivano ad asporta te le lastre metalliche pos te da noi in prossimità delle loro posizioni. Ma, non ostante tutte le difficoltà, la racco l ta d elle intercettazioni nemiche invece di diminuire andò aumentando, me,rcè la capacità e abnegazione del personale addetto a questo servizio.
12
- Organizzazione del servizio I.T. e risultati ottenuti.
Il servizio I.T. presso l e Armate fu orga n izzato n e l modo seguente:
Al Comando del Genio d'Armata era affidata la direzione e h sorveglianza tecn ica; esso curava gli impianti e la manu tenzione delle stazioni, preparava e modificava gli apparecchi intercettatori ed add es trava gli uff iciali ed i soldati che dovevano prestare servizio di stazione, (interp reti, elettri cisti, e guardafili) .

Al Comando dell'Armata in vece, per il tramite dell'Ufficio I nf ormazioni, spettava l'esercizio del servizio di intercettazione: esso riceveva, dai vari centri di raccolta, notizie in tercettate dalle smgole stazioni operanti nel territorio dell'Armata e ne pubblicava un riassunto, riportando le più importanti, in un bollettino giornaliero che veniva diramato a t u tti i Comandi.
Col passare del tempo l'organizzazione del servizio I.T. risultò perfetta, mercè la diligenza che vi ponevano ufficiali, capi stazione e capi centro e si può affermare che tale servizio fu la fonte

delle più importanti e sicure notizie dell'Ufficio Info rmazioni del Comando Supremo.
Gli austriaci dovettero riconoscere che, da semplici scolari, in brevissimo tempo era vamo diventati maestri.
Un documento au striaco ricuperato dall'Ufficio Informazioni della nostra 4" Armata, di cui più avanti viene riportato il testo, ci dice chiaramente in quanta considerazione era tenuto il nostro servizio I.T.
Per capire lo sviluppo da esso preso, basta considerare che, n e l solo settore dell'Isonzo, duran te il mese di gennaio del 1917, esistevano ben 37 stazioni intercettatrici, di cui 23 della 2a Armata e 14 della 3• Armata.
Pre.ziosi servizi diedero poi le stazioni I. T. durante il periodo di preparazione della nostra offensiva del magg io 1917: esse meri tarono il vivo apprezzamento e l'enco mio del Generale Badoglio, allora Capo di S.M. del Co mando Zona G orizia, come risulta dalla seguente lettera: 9 maggio 1917

« Al Comando G enio Zona Gorizia
«In questi giorni il Comando della Zona ha avuto occasione «di constatare il buon funzionamento ed il rendimento delle Sta« zìoni I.T. dip endenti, dall e quali si sono avute spesso informa« zionì pre;:>;ìose. Il magg ior rendimento non è dovuto solo a lla ope« rosità del personale addettovi, ma anche alla bontà dei nuovi am<< plificatori ad audion ideati e costruiti con tanta cura da codesto « Comando. Si prega far pervenire al personale che vi è più spe« cialmente inca ricato, una parola di sentita lode.
D'ordine
Il M. Gen. Cap. di S.M. Badoglio».
13 - Alcune importanti informazioni ric evute dal servizio I.T della 2a Armata riguardanti l'oflìensiva nemica su Caporetto.
APRILE 1917.- Antecendetemente alla nostra azione sul Vadice si sentì per la prima volta parlare di compagnie germa niche nella Zona di Go ri zia.
Stazione I. T. fissa (tipo 2a Armata).
GIUGNO 1917. - Lungo le stazioni del settore di Tolmino, si parlava di visite di ufficiali germanici alla fro nte Giulia.
LUGLIO 1917. - La nostra stazione I.T. di Volzana (sulla destra dell'Isonzo di fronte a T olmi no), segnalò numerose visi te in prima linea, nella zona Tolmino-S. Lucia, di generali ed ufficiali &uperiori austria ci, seguite qualche giorno dopo da visite di quattro altissimi ufficiali germanici; e nello stesso tempo la stazio n e di Gorenie Polie annunciò quella prossima del Generalissimo Conrad.

Nello stesso mese di luglio si seppe dell' arrivo su tutto il fronte dell'Isonzo di reggimenti provenienti dal settore orientale (batterie mitragliatrici, Alpenjager e Kaiserjager).
AGOSTO 1917.- La stessa stazione di Volzana intercettò che una grande adunata di truppe doveva avvenire a Modreje (dietr!> Tolmino), alla presenza del Gen. Boroevic e dove si sarebbe letto un proclama dell'Imperatore Carlo I. Questa cerimonia non ebbe poi luo go per il tempestivo intervento d ei nostri aviatori.
SETTEMBRE 1917. - Sempre la stazione di Volzana segnalò la presenza del Gen. Von Kowes, Comandan te la VII Armata Austriaca, e ci fornì notizie dell'arrivo in quel settore di reparti d'assalto, cdmposti di croati, bosniaci e perfino di turchi.
Stazione intercettatrice telefoni ca.
Alla fine de l mese, la stazione I.T. di Cigini intercettò l 'ordine di sospensione delle licenze; mentre si conosceva che negli altri settori i turni dì lecenza continuavano regolari.
OTTOBRE 1917. -Il giorno l si riuscì a conoscere, mediante l'intercettaz io ne di un 'ordine trasmesso dal Generalissimo Konrad, che le nov ità dovevano essere comunicate tre volte durante la giornata, e cioè alle tre, alle dieci antimeridiane, ed alle due pomeridìane.
Da questo momento le stazioni I.T. non segnalarono che arrivi di autocolonne di munizioni, sezioni di lanciabombe, lanciafiamme, mitragliatrici, compagnie d'assalto, arditi e rinforzi di Landsturm su tutto il settore. Tanto intenso fu questo movimento che, nei din·

torni di Tolmino, in un sol giorno furono avvertiti 500 autoca rri carichi d i truppe e di munizioni diretti a S. Lucia. La stazione I.T. d1 Cigini informò della presenza di alti ufficiali germanici, mentre su tutta la zona d ell'alto e medio Isonzo si dis pensava alla truppa, cognac e rhum. La stessa stazione i nform ò di aver sentito richieder e mazze f erra t e .
Un ' important e intercettazione fu quella fatta d a lla stazione di quo t a 509 di Lom: questa il 22 settembre intercettò un fonogramma in cui si richiedevano uom ini di fatica da inviare al comando del Regg. p er ritirare l e uniformi i t alian e, e si sentì pure parla re di una co mpagnia d i ass alto con unifo rmi italiane. Si seppe poi che, per trarre in inganno le nostre trupp e, l ' Austria vestiva i suoi reparti di assa lto con divise to lte ai nos tri prigionieri o fatt e fare appositamente.
Nella zona di Volzana fu segnalata l a presenza di ufficiali germanici e di lO com p. d'Assalto, nel ment re si seppe dell'arrivo di altri regg. dalla Rus sia .
OTTOBRE 4. - S 'intercettò l'ordine di fotografare tu tte le nostre posizioni.
OTTOBR E 9. - S'intercettò la not izia che segnalava da due giorni la p rese nza dei Gene rali Von Arzt e Konrad; e che veniv an o impartiti ordini di riviste accurate alle trupp e p er accertarsi che av essero tutto il necessario in caso di un lungo combattimento.

S ' intercettò anco ra, dalla parola dei Comandan ti tedesclii, la notizia di un a grande offensiva che avrebb e dovuto segnare la sconfit t a sicw·a de ll' Italia.
OTTOBR E 23. - Si potè interce ttare dallo Sleme l 'ordine dir a mato dal Comando Austro Tedesco, per l 'inizio dell'offen siva. informando che il tiro di distru zio ne sarebbe sta to iniziato alle ore due an ti meridian e del 24 otto bre.
Anche in q uesto nuovo servizio, affida to agli organi d el G enio T e l eg rafisti, furono date prove di grande ab i lità t ecnica, degn e di o gni elogio, anche a risc hio costante dell a vi t a nell'impiego dei m ezzi.
CARATTERISTICHE ED IMP IEGO D EI PRINC IPALI ME ZZI DI COLLEG AMENTO
14 - Mez zi di trasmissione .
L a grande guerra ha pi enamen te confermato un adeguato e raz i onale sistema di collegamenti e ha permesso ai comandi di esplicare, pur da grandi distanz e, la loro azione, assicurando l'opportuno coordinam ento delle singole attiv i tà pel conseguimen to dello scopo finale.
Invero sebbene tutti i mezzi di corrispondenza impiegati siano necessari, s u ness un o di essi si deve fare esclusivo ass egname n to. Occorre quindi impiegare simultaneamente tutti i mezzi di trasmissione di cui si può disporre, organizzandoli in modo che ciascuno d i essi p ossa so ddis fare le varie esigenze. E ciò v enne applicato in guerra con pieno successo.
Così i mezzi di trasmissione tecnici, che richiedo n o un person ale tecni co special izzato per il l oro impianto e funzionamento ( telegrafia e telefonia elettrica, telegrafia ottica, geotelegrafia), vennero affidati alle specialità del 3° e 7° Genio telegrafisti; mentre la r adiotele grafia ven iva d isimpegna t a dai r eparti del b attag lione specialisti.
E poich è i mez zi di tr asmissione ordinaria no n richie d ono l'i m piego d i perso n ale specia lizzato (collegam enti d iretti con l a voc e o con segnali semplici, staffette o catene d ' uomini e co1om-

bi viaggiatori), accenneremo semplicemente ai mezzi tecnici impiegati dai telegrafisti, cioè dai «ragni», escludendo perciò il servizio rad iotelegrafico e quello dei colombi viaggiatori.
15 - La telegrafia elettrica.
La telegrafia elettrica con l'ordinario sistema Morse (che si è dimostrato di più pratico impiego generale in campagna, rispetto agli apparecchi celeri Hughes impiegabi in alcuni collegamenti d'Armata e di Corpo d'Armata) dimostrò, durante la guerra 19151918, di essere un mezzo di corrispondenza sicua:o e abbastanza rapido.

Ma il telegrafo, se offrì pure ìl vantaggio di essere· il mezzo più controllabile di corrispondenza (evitando i danni delle erronee interpretazioni dei dispacci e dando modo di avere il testo scritto) ebbe per contro qua l che inevitabile svantaggio: necessità di perso nale dotato di ottima preparazione tecnica, difficoltà per il suo addestramento in guerra, maggior tempo per l'impianto delle linee, obbligo della vigilanza continua per porre pronto riparo agiti eventuali guasti, lentezza della trasmissione che era effettuata con caratteri dell'alfabeto Morse.
Il collegamento telegrafico, comunque, non venne spinto (verso il nemico) oltre i comandi di divisione.
16 - Tel efonia e lettrica.
Il telefono fu certamente il mezzo principale di corrispondenza durante la detta guerra e lo sarà anche per l'avvenire. Invero gli apparati tel efonici sono semplici e di facile impiego e vennero preferiti da tutte le unità operanti.
I vantaggi del collegamento telefonico sono: la possibilità di conversazione diretta fra gli interessati, trasmissione e ricevimento simultaneo di più trasmissioni sullo stesso filo, il funzionamento semplicissimo, tanto da poter essere affidato anche a sol-
Centr alino a 50 linee .

dati di modesta cultura generale. Inoltre molto più solleciti sono l'istruzione e l'addestramento del personale . Questi vantaggi superarono di gran lunga i poc hi i nconveni enti cui va soggetta la corrispondenza telefonica e cioè :
l) sensi b ilità alle perturbazioni atmosferiche (neve, gelo, venti);
2) facile interrompibilità del conduttore specialmente nelle zone avanzate;
3) facilità di intercettazioni da parte dell'avversario.
Il telefono è stato qu indi l ' unico mezzo di trasmiss ione che m guerra sia arrivato ai posti avanzati ed anche ol tre per collegare financo talune pattuglie.
Tra i vari tipi di telefoni adoperati in guerra diedero migliori risultati, a mio parere, il tipo Kellogg da campo, il tipo Western per il servizio dei guardiafili e il centralino K e llog g da campo.

17
- Tebegrafia ottica.
La telegrafia ottica pur non offrendo la sicu rezza assoluta dei collegamenti per l'incostanza dell e condiZiioni atmosferiche, e pur •essendo la sua corrispondenza l enta e richiedendo personale specializzato per ri:l qua le era necessario un lungo addestramen to, è stato ottimo mezzo sussidiario agli altri- due precedentervente indicati . Questo sistema ha reso prezi osi serv i_g1i durante la guerra 1915-18 come mezzo semplice ed economico, potendo consentire la pronta corrispondenza anche fra due lo cali tà molto distanti e separa t e da terreno diffic ile, molto battuto dal fuoco nem ico .
L' appare cchio o t t i c o d a campo più ·diffus o in seno alle nostre truppe operanti è stato il « Diottrico - Eliografo F aini Triulzi » e alla fine della guerra 1915-.18 erano impiegati b en 681 di tali apparecchi.
1 8 - Geotel egrafia.
Un nuovo mezzo di corrispondenza impiegato durante la guerra 1915-1 8 fu la « g eotelegrafia », ossia la telegrafia attraverso il suolo (T.P.S.). Tale m ezzo venne preferito come collegamento n e lle zon e più avanzate, a causa dell a sua poca vul ne ra bili tà . Ogni posto di corrisponde nza aveva un a stazione telegrafica completa a r icezione auricolar e, consistente cioè in un apparato di

trasm issione e di r icevimen to semplice e di facile funzionamento. L e basi di questa corrisponden za erano costituite da un conduttore isolato, interrato o posato direttame n te sul suol o, lun go circa cento metri nella stazione più a vanzata e duecento metri in quella più arretra ta. Tali apparati di p iccole' dim ensioni potevano essere tenuti f acilmente in ricoveri per sottrarli ai danni dei bombardamenti.
Con queste stazioni, di tipo francese, si trasmettevano corren ti elettriche mediante la conduzion e del suolo, perciò la portata di questa conduzione, a seconda de lla natura del terreno (sabb ioso, roccioso o ac quitrinoso) era in media di soli 2-3 chilometri).
Oltre lo s v an taggio di aver piccola portata l e trasmissioni così effe ttuate erano facilmente disturbate dall e corre n t i elettriche, tel egrafÌ:che e t e l efoniche, s p e cialmente se a ciJrcu,ito m i sto, e dalle correnti a l ternate.
Peraltro tali stazioni T.P.S. offrivano il pericolo della intercettazione e se troppo vicine tra loro si disturbavano vicendevolmente.
Tutti i mezzi di collega mento possono non essere sempre assolutamente sicuri, ma con la loro opportuna scelta, in relazione alla sit uazione del momen t o, al terre no, a l tempo ed ai mezzi disponibili, possono garan t i re la sicure zza e la continuità dei collegamenti, che cos tituiscono u na n e cessità inderogabile .
19 - Le Centrali Telefoniche e le reti telegrafoniche.
Affinchè il lettore sia reso edotto dello sforzo compiuto dai telegrafisti nell 'impianto e nell'ese rcizio delle reti telegraf oniche, ho creduto necessario di riportare qui di seguito uno specchio riepilogativo del mat eriale impiega to nel pe riodo più intenso delle operazioni durante la campagna 1915-18:
COMANDO D'ARMATA - Centralino a cen to linee per la sede normale.
COMANDO DI C.A. l CO MAND O DI ARTIGL IERIA DI C.A. ( a 60 linee . COMA!NDO DI REGG. E D'ARTIGLIERIA)

lCOMANDO DI DIVISIONE - Centralino a 40 linee.
COMANDO DI BRIGATA- Centralino a 30 linee.

COMAND O DI RE G GIMENTO
COMA ND O DI BATTAGLIONE .
COMANDO DI GRUPPO
Centralmo da 10 a 20 linee. COMANDO DI BATTERIA
A complemento di tale specchio basterà accennare che vi erano due r eti distinte: una per il servizio general e e l'a l tra per il servizio di artiglieria .. Altri circuiti ausiliari collegavano i centri più importanti delle due reti accennate, per poter sussidiare una delle reti con l'altra. Le stesse reti erano poi completate con appositi circuiti per i collegamenti tattici tra la Fanteria e l'Artiglieria, in modo da assicurare il coordinato impiego delle due Armi. Infine, per i servizi speciali (aeronautici, antiaerei, logistici
Altre re t i t e le g raf o nic h e d el 3° Re g gimen to Geni o. d' i nformazione ecc ) per i quali n on er a sta t o possibile utilizzare i circuiti d ell'una o d e ll'altr a delle anzidette du e ret i erano state stese apposite l ine e .
N e l seguen te specchio sono r iportati il numero d e lle compagni e te l egr a f is ti i m p iega te , i km. d i linee telegrafoniche e t elefoniche stese p er le v a r ie reti , il n ume r o d e gli a p parati telegrafici e telefonici, nonchè dei centralin i impiantati.
Da t al e specchio e dai grafici a corredo si può ag evolmen t e rilevar e l ' ingente lavoro e l ' in te nsa attività esplicati dall e compagnie teleg rafisti nel periodo più intenso della campagna 1915-18 .




Grafico relativo agli apparati telegrafonici impiegati e ai Km di linee stesi durante la guer·ra 1915- 1918.
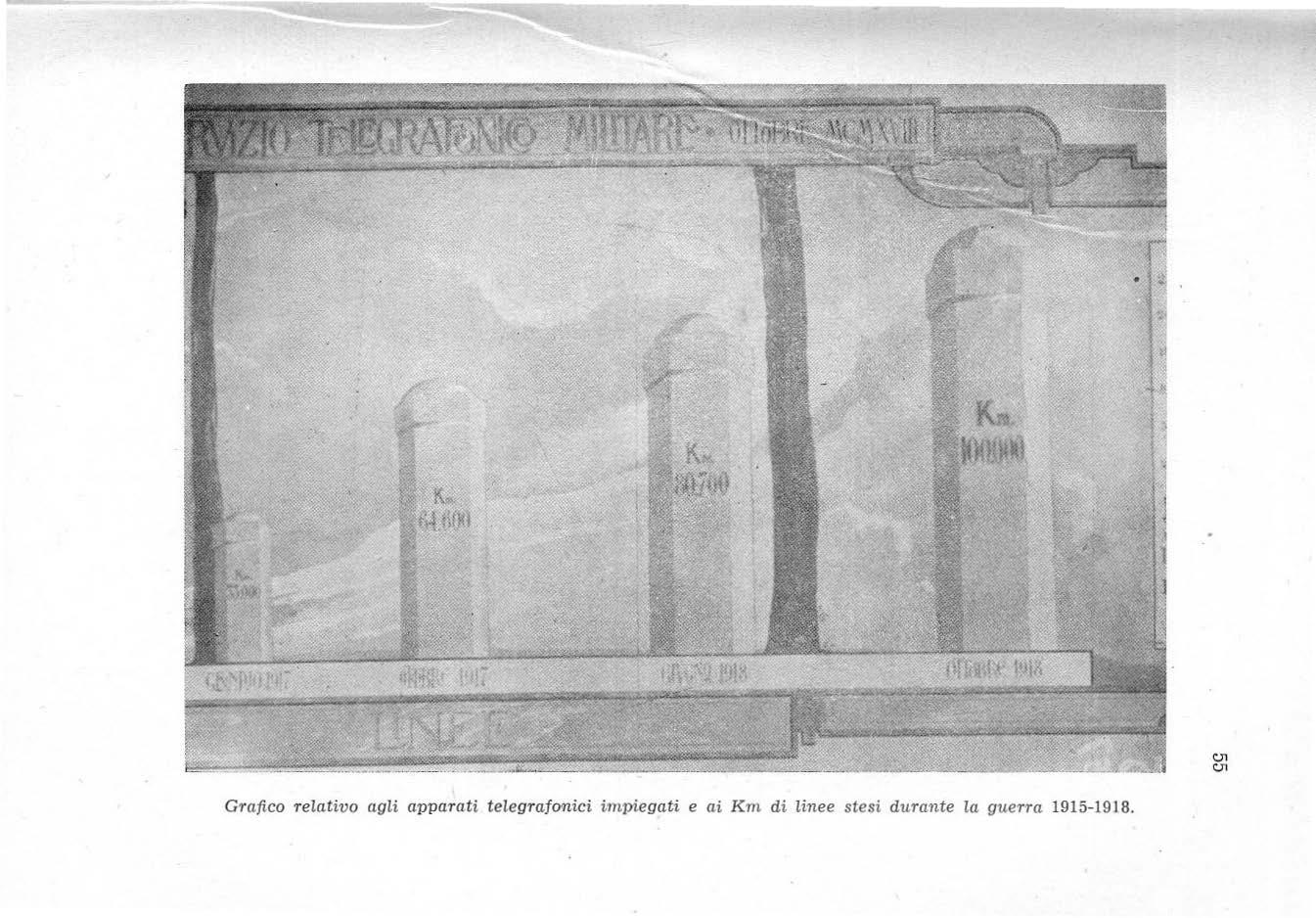
Cap. VI
LE COMP AGNIE TELEGRAFISTI D URA NTE LA G UERRA
20 - Evoluzione organ ica.
L e compagn ie del 3o R eggimento genio te l egrafisti, in seguito a ll' aumen to di nu ove uni t à orga nich e, era no 24 all' inizio de lla guerra 1915-18 e ciascuna era costituita da: personale telegrafista, una sezione treno con quadrupedi per il traino del carreggio, e un p ar co te le grafico.

Il persona le te legrafista, costitui t o dall' i nsieme deg li elemen ti necessari al Comando, all'amministrazione della compagnfa, all 'impianto ed al funzionamento delle linee e delle reti telegrafich e, telefoni che ed otti ch e, comprend eva: un capita no, 4 subalte rn i , 7 sottuffic i a li, 243 fra caporali e soldat i, 5 cavalli di ufficiali.
La sezione treno comprendeva un ufficiale ed un numero variabile di graduati e conducenti de l treno e dei quadrupedi, in rela zion e alle qua li t à e qua ntità del carreggio impiega to per il traspor to de l materiale.
Il parco telegrafico, come si è già accennato, era costituito dall'in sieme del carreggi o e dei m a teriali ne cessari, si a per l'impia nto e il fun zion ame n t o de lle linee, delle stazioni t el egrafic h e , telefo n iche ed ottiche, sia per il servizio generale della compagnia.
L e 24 compagnie del 3° Reggimento genio telegrafisti furono così distribuite: un a comp a gnia te l egrafisti l a (7 a) alle dip e ndenze dirette del Comando Supremo; qu attro compagnie t e l e grafisti (16\ 21"', 22• e 24") u na per ogm co mand o d'armat a ;
sedici compagnie ielegrafisti, una per ogni comando di corpo d'armata; tre compagnie telegrafisti (l"', 2"' e 3a) avevano i propri plotoni dislocati nelle diverse fortezze di frontiera e nella piazzafort e di Venezia.
E siccome il servizio telefonico divisionale era in stretta relazione con quello svolto dalle compagnie telegrafisti, a ciascuna delle 35 divisioni dì Fanteria mobilitate fu assegnata una sezione telefonica, che faceva parte integrante della Compagnia zappaton della divisione stessa. Perciò nel primo periodo di guerra risultarono impiegate: 35 sezioni te lefoniche divisionali, composte ciascuna di: un ufficiale subalterno e 35 telefonisti, fra graduati e uomini di truppa. ·
All'inizio delle ostilità contro l'Austria, le compagnie telegrafisti dovettero cedere una buona parte del personale specializzato, per inviarlo quale ausiliario negli uffici civili della zona arretrata d'operazioni o del territorio nemico occupato dalle nostre truppe. Ottimo provvedimento fu poi quello di togliere dalle formazioni dislocate alla frontiera occidentale il personale telegrafisti ad dettovi.
Verso la p rimavera del 1916, in conseguenza del continuo accresce rsi del servizio telefonic o, si rese necessario separare le sezioni telefoniche dalle compagnie zappatori, costituendole in reparti autonomi alle dipendenze del Capo di Stato Maggiore della Divisione. L 'organico di dette sezioni fu portato a: 2 sottufficiali e 150 circa fra graduati e soldati. Ma per poter far fronte alle crescenti esigenze dei collegamenti si dovette ricorrere alla assegnazione alle unità telegrafisti di ausiliari delle altre armi; in questo modo si arrivò ad avere comp_agnie numericamente molto consisten ti; qualcuna raggiunse la forza di mille uomini con immutato n um ero di ufficiali ed occorse, perci ò, molto tempo per addestrare i nuovi assegnati.
L'assegnazione di nuovi ufficiali provenienti dall'Accademia militare di Torino e dai corsi per ufficiali telegrafisti di Udine e Ravenna consentì di migliorare le condizioni delle compagnie telegrafisti.
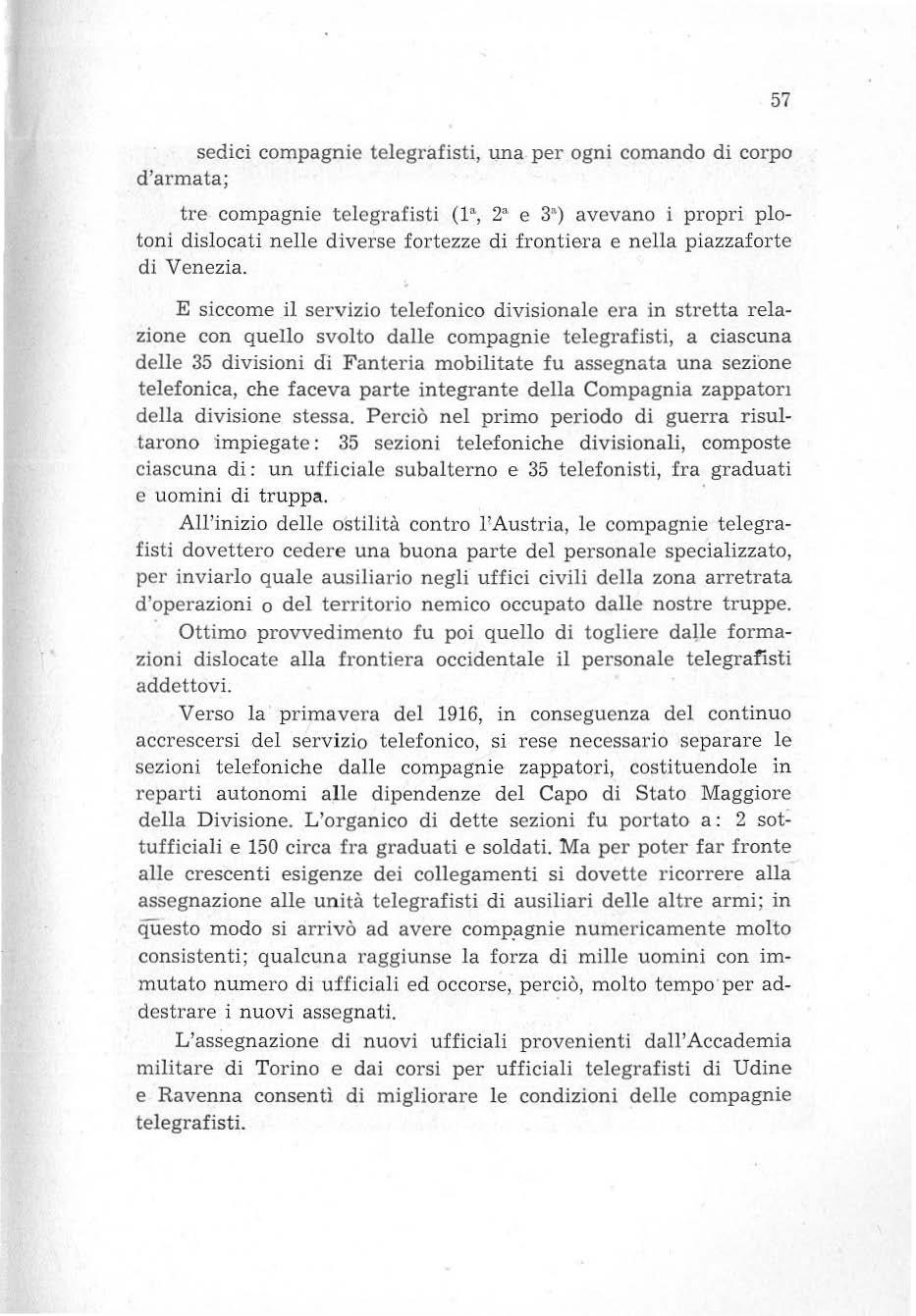

In seguito, tenuto conto dei servizi troppo gravosi per una sola compagnia , incaricata di tutte le comunicazioni relative al servizio generale. e a quello di artiglieria di corpo d 'armata, e della proposta dell'Ispettore Capo del Serviz.io T elegrafico Militare , venne effettuato un p r imo sdoppiamento delle compagnie telegrafisti .
Si eb be così modo di separare meglio il servizio di artiglieria da quello generale al quale fu destinata una compagnia telegrafisti per ogni due corpi d'armata. Nel maggio del 1916, infatti, la distribuzione delle compagnie telegrafisti risultava la segue n te : Divisione - Una sezione telefonic a autonoma divisionale

Corpo d'Arma t a - S ervizio di Artiglieria: una compagnia telegrafisti per Corpo d'Armata
Servizio genemle - Una compagnia telegrafisti per ogni due corpi d'armata
A1·mata - Una compagnia telegra fisti
Comando Supremo - Una compagnia telegrafisti
Nonostante questi aumenti il servizio telegrafico, telefonico ed ottico .delle compagnie telegrafisti po té svolgersi con maggiore aderenza alle esigenze e con notevo l e vantaggio per il rendimento, la sicurzza e la continuità dei collegamenti .
Successivamente altre esigenze sopraggiunsero: prima la battaglia di Gorizia, poi quella della Bainsizza, indi il ripiegamento di Caporetto, ed in seguito tutte le altre operazioni che caratterizzarono il periodo dopo l 'otto bre del 1917. Fu perciò necessario costituire nuove unità telegrafisti allo scopo di poter assicurare il servizio e migliorarlo sempre di più.
Le sezioni telefoniche autonom e d ivisionali, che avevano ormai una forza d'uomin i e di materiali quasi pari a quella delle normali compagnie telegrafisti e con compiti aff ini, furono le prime ad essere trasformate. Con ordine del Comando Generale del Genio, nel febbraio del 1918, venne infatti dispost o che tutte le sezioni telefoniche autonome divisionali si trasformassero in compagnie telegrafisti, formando così un secondo reggimento telegrafisti e cioè il 7° Reggimento Genio Telegrafisti.
Collegamenti divisionali (75a D ivisione).

Con piccoli spostamenti di personale, dotando queste nuove compagnie del paréo regolamentare e completandol e nei quadri con nuovi ufficiali, furono costituite b en 68 compagnie telegraÙsti, che sì chiamarono divisionali (dalla 101 a alla 168') pe r dis t inguerle dalle altre 79 del 3° Reggim ento Ge nio, rimaste al servizi o dei comandi di Co rpo d'Armata, di Armata e del Comando Sùpremo.
Le compagnie te l egrafisti raggiunsero in questo modo, con una perequazione di uomini, di materiale e di servizi, un'organizzazione agilissima, con una razionale r ipar tizione di compiti, e ven!lero quindi ad assumere la seguente definitiva assegnazione:
Comando Supremo - Una compagn ia telegrafisti per tutti i servi zi. Comando d'Armata - Due compagnie tel egrafisti (una pei . servizi gene rali ed una pei servizi di Artig l ieria)
Comando di Corpo d'A. - Due compagnie telegrafisti (una pei servizi generali ed una pei servizi di Artiglieria).

Comando di Divisione - Una compagnia telegrafisti per tutti i servizi.
Queste compagnie provvidero a mantenere in efficienza, oltre la rete telegrafonica per il servizio generale, le reti telefoniche particolari di artiglieria, que lle per il servi zio pi aeronautica e p er l e batterie controaerei, per il servizio segreto delle informazio ni, ecc. ed infine le reti ottiche vastissime, in ausilio delle comunicazioni elettriche.
21 - Impiego delle Compagnie telegrafìsti.
Le ultime disposi zioni emana t e nel 191 8 dall'Ispettore Ca po del Serv izio T elegrafico Militare circa l'impiego dei reparti telegrafisti, mentre miglio ravano semp re p iù l'organizzazione dei collegamenti, confermavano in massima le direttiv e precedenti . E ' necessario ricordare che nell'ottobre 1917, la rete telegrafonica cos tituita dalle compagnie telegrafisti venne integrata dalla rete permanente dello Stato interessante le operazioni militari, col passag-
gio dall'Intendenza G enerale alla d ipendenza dell'Ispettore Capo del Servizio Telegrafico Militare degli organi che vi erano preposti.

La compagnia telegrafisti del Comando Supremo aveva il compito di collegare:
- il Comando Supremo con le armate dipendenti, con l 'Intendenza generale e con le retrovie ;
- i vari enti c4e facevano parte del Comando Supremo o ne dipend evano direttamente;
- gli e lementi della difesa contro aerei nella zona dove aveva sede il Comando Supremo;
- l'Intendenza genera le con la rete telegrafonica dello Stato, in modo che l'Intendenza stessa potesse comunicare facilmente anche con il Paese.
All'impianto ed all'esercizio delle linee che si trovavano nelle retrovie concorse validamente anche il personale del Commissariato G enerale Telegrafico appartenente al Ministero Poste e Telegrafi.
Le compagnie telegrafisti d'Armata organizzavano ed esercivano i collegamenti di cui in appresso :
- una compagnia le linee tr a il Comando d'Armata, i comandi di Co rpo d'Armata dipendenti e gli altri enti dell 'armata;
- l'alt ra compagnia l e linee per l'Artigli eria e quelle di carattere gene rale comprese nella zona di giurisdizione de ll 'Armata e che non interessavano i corpi d'armata.
Delle due compagnie telegrafisti assegnate a ciascun comando di corpo d' armata :
- una provvedeva all e comunicazioni di carattere generale sino ai comandi di divisione;
-l 'altra provvedeva ai comandi di artiglieria: da1 comandi di artiglieria di corpo d'armata ai comandi di raggruppamento di artiglieria d'assedio, pesan ti, campali e di bombarde, ai comandi di reggimento di artiglieria da campagna ed ai Comandi di gruppo di assedio, pesanti, campali o da bombarde.
Le compagnie telegrafisti divisionali, infine, organizzavano ed esercivano :
- le comunicazioni di carattere generale interessanti la Divisione;
- i collegamenti per la fanteria, sino ai. comandi di battaglione;
- L e comunicaz ioni fra i comandi di reggimento di artiglieria da campagna ed i rispettivi comandi di gruppo;
- i collegamenti fra · Artiglieria e Fanteria .
. I collegamenti nell'interno dei battaglioni di fanteria venivano assicurati dai battaglioni stessi con i normali mezzi di corrispondenza
Le comunicazioni occorrenti alle varie specialità d'artiglieria, dai comandi di gruppo alle ba tterie e nell'interno di queste, venivano assicurate con personal e dei reparti stessi.
22 - Compiti degli ufficiali delle compagnie telegrafisti.

Gli ufficiali del genio telegrafis t i che erano i diretti responsabili dell'impiego dei m ez zi del p ersonale hanno adempiuto ! propri doveri con elevatezza di sentimenti e altissimo s p irito militare, dando prova in ogni ci r costanza di somma perizia e di moltissimo spi r ito di abnegazione e di sacrificio Spettava ad essi :
.:..._ decidere sulla convenienza delle nuove richieste di collegamenti, scegliendo opportunamente il sistema d i trasmiss ione più adatto nei singoli casi;
- agevolare con ogni mezzo lo smaltimento delle comuniorganizzando nel miglior modo il complesso servizio telegrafonico dellè unità alle quali erano addetti;
- ripa rti re ed organizzare gli orari ed i turni di se rv izio, regolando gli avvicendamenti secondo i servizi più disagiati e pericolosi.
Cap. VII
IL SERVIZIO TELEGRAFONICO NELLA GRANDE GUERRA 1915-1918
23 - Organi diretti vi.
Gli enti direttivi del serV IZIO telegraf onico dell'esercito mobilitato, all'inizio del conflitto itala-austriaco 1915-18, erano i seguenti:
COMANDO GENERALE DEL GENIO
Ispettore Capo del servizio telegrafico in guerra. Ispettore telegrafico di armata.
Compito : Tutto il servizio telegrafoni co e radiotelegrafico della rispetti va Arm ata.
INTEND ENZA GENERALE.
Commissario Capo - Commissari telegrafici per zona di armata Compito : Rete permanente dello Stato, interessante le operazioni militari.
Nel 1917 l'Ispettore Capo del Servizio Telegrafonico Militare, in considerazione della vastità e complessità della rete telegrafor.ica sviluppatasi in tutti i settori del nostro fronte, aveva segnalato la n ecessità di destinare anc he ai comandi del geni o di corpo d ' arma ta un ispettore te l egrafico, non essendo più s ufficiente il solo i spettore di Arm ata.
A causa della scarsa dispon ibilità di ufficiali superiori pratici della speciali tà telegrafisti fu provveduto soltanto all'assegnazione di un ufficiale superiore quale sotto ispettore, in aiuto agli ispe ttori telegrafici di quelle armate che avevano alle loro dipendenze

più di tre corpi d'armata (circolare n. 118.550 in data 19 1917 del Comando Sup remo - Ufficio Ordinamento e Mobilitazione) .

Questo ripiego dimostrò subito come non si fosse raggiunto lo scopo d i snellire i l servizio e di ripartire gli oneri che gravavano sull'Ispettore T elegrafico d'Armata ..
Successivamente però, a causa dell'enorme sviluppo assunto dalle reti telegrafoni che, ottiche e radiote l egrafiche , l e quali superarono già aai primi mesi dell'anno 1918 quelle es isten ti nei primi mesi de lla guerra in una intera armata, il Comando Supremo - con circolare n. 14.400 del 6 giugno 1918 - d isponeva la p.ssegnazione di un isp ettore telegrafico per ciascun corpo d'armata, sopp r imendo nel cont empo i sotto ispe ttori te l egrafici di armata.
Con tale nuovo ordinamento gii organi d iretti vi del servizio telegrafonico furono : l
COMANDO GENERALE DEL G ENIO
!9peitore Capo del Servizio Tel egr a fico Militare (Comandante dei reparti del 3° e 7° Reggim. Genio Te l egrafisti mobilitati).
- Ispettorj Telegraf ici d'Armata.
COMANDO DEL GENIO D'ARMATA
Ispettore Telegrafico di Armata (ufficiale superiore).
- Commissario Telegrafico d'Armata.
- U ff icial e Superiore (o capitano) direttore del Ser v. R. T. dell'Armata.
- Compagnie Tel egrafisti e repart i R. T. dipen denti.
- Ispettori Telegrafici di C . A.
COMANDO DEL GENIO DI CORPO D'ARMATA.
Ispettore Te le grafic o di Corpo d'Armata (uff. superiore o capitano).
- Coma n danti le Com pagnie teleg r af di C. A.
- Comanda nti le Compagni e telegraf. Divis
Con t ali p rovve d ime n ti ogni grande unità, dall'Armata alla Divisione, possedeva finalmente una sola autori tà tecnica -responsabile di tutti i collegamenti telegrafici, tel efo nici, ottici e radiotelegrafici di guerra.
- Attribuzioni e funzioni degli org·ani direttivi.
Con circolare n. 24722 del H) giugno 1918 del Comando G-=neral e del Genio (Ispettore Capo del Servizio T elegrafico Militare) furono precisati i compiti ed il funzionamento dei vari organi direttivi del servizio telegrafonico dell'Esercito in previdel ciclo operativo che doveva condu rci alla vittoria.

AWispetto1·e Telegrafico d'Armata incomb eva :
- la direzione tecnica di tutta la rete te legrafica, elettrica ed ottica, telefonica e radiotelegrafica d e ll' Armata;
- la Sovrintendenza del Commissariato Telegrafico dell'Armata, del Direttore del Servizio radiotelegrafico dell'Armat a, delle compagnie t e legrafisti d'Armata, delle sezioni telefoniche, dei gruppi alpini eventualmente assegnati all'Armata, così pure degli Ispettori telegrafi ci del C. A. costituenti l'Armata stessa;
- l 'organi zzazione unitaria delle varie reti telefoniche e raciiotelegrafi che, in modo che ciascuna rete, con successive opportune modificazioni, venisse coordinata e adattata continuamente all e mutevoli esigenze operative dell 'Armata;
- l'alta vigilanza tecnica del servizio telefonico ed ottico dell'Artiglieria (dai comandi di gruppo in avanti) e della Fanteria, ottenendo la massima economia n ell'impiego dei materiali telegrafonici ed ottici di ogni specie;
- la consulenza tecnica riguardante l'impiego de i mezzi ordinari di collegamento;
- le richiest e al rifornim e nto de l personale occorrente a tutti i reparti telegrafisti e radiotelegrafisti dell'Armata e del materiale necessario;
- l'organizzazione tecnica del servizio di intercet tazio ne telefonica e r . t.
All'Ispetto1·e Telegrafico di Corpo d'Armata spettava:
- dirigere il servizio delle comunicazioni telegrafoniche ed ottiche nell'ambito del proprio corpo d'armata con funzioni analoghe a quelle indicate dianzi per l'ispettore d'Armata e a seconda delle direttive dell'ispettore stesso;
- sov r intendere alle compagnie te l egrafisti del C. A., alle compagnie telegrafisti divisionali e alla sezione radiotelegrafica di C. A.
Ai Comandi delle compagnie telegrafisti di C. A. e Divisionali spettava:
- dirigere rispettivamente nell'ambito del C. d"A. e della Divisione, il servizio te]egrafonico ed ottico, sulla base delle direttive de ll 'ispettore telegrafico di C. A.
Per quanto si r i ferisce al pe rso nale, al mate ri ale, aì lavori ed alle re la zioni di servizio acc enniamo b reve m ente qui di seguito: Personale.
Il rifornimento del personale (telegrafisti ottici ed ele ttr ici) per tutte le compagnie telegrafisti e sezioni R. T. doveva essere chiesto all'Ispettore Capo del Servizio Telegrafico Mili t are, che ne curava l'assegnazione da parte degli organi competenti.
Mate1·iali .
L'Is pettore di Arma t a, secondo le necessità, chiedeva all'Ispet. Capo il materiale e l ettrico, ottico, te l egrafico e . radiotelegrafico occo rren te.
Era i n facoltà d e ll'Ispet tore T elegrafico d ' Armata e a seconda delle esigenze del servizio o degli qrdini ricevuti dall'Ispettore Capo (c ircolare 11.178 del 4 giugno 1918) dì trasferire materiale telegrafonico .da un corpo d'armata ad un altro.

Allo stesso Ispettore d 'Armata era affidato il compito d e lla sollecita riparazione degli apparati te legrafonici, ottici e radiotelegrafic'i, che richiedevano lavorazioni effettuabili nel laboratorio elettrotecnico dell'Armata . L avori.
L'Ispettore Telegrafico d'Armata doveva provvedere all ' impianto dei collegamenti teleg rafonici e radiote l egrafici ne l modo ritenut o più opportuno. Doveva all'uopo stab ilire le linee da stendere e l 'attrib uzione dei compiti fra i comandanti delle compagnie direttamente dipendenti e gli ispettori te l egrafonici di C. A.
Quando gli impianti esigevano impiego ingenté di materiale. '
l'Ispettore d 'Armata doveva chiederne l 'autorizzazione all'Ispettore Capo, al quale era ris ervata la decisione circa i provvedimenti da att uarsi. (Circolare del 3 gennaio 191 8 de l C. S. - Ufficio Tecnico). ReLazioni di servizio.

L 'Ispettore Telegrafico di Armata, gli ispettori telegrafici di C. A. ed i comandanti delle compagnie telegrafisti di C. A. e divisionali dipendevano dal rispettivo comandante del Genio. Norma lmente quindi tali organi telegrafi ci direttivi dovevano corrispondere fra dj loro pel tramite dei detti comandi del Genio, ma per la caratteristica essenziale del servizio stesso, che è la celerità, in pratica erano spesso costretti a corrispondere direttamente fra di loro, info rmando nel contempo i rispettivi comandanti del Genio.
L'Ispettore telegrafico d'Armata doveva, infine, tenere al corrente, con grafici e relazioni periodiche, l'Ispettore Capo, i dipendenti ispettori telegrafici di C. A. e gli ispettori telegrafici delle armate laterali, di tutti i collegamenti stabiliti nell'Armata. Analogamente dovevano regolarsi gli ispettori telegrafici di C. A. verso i comandanti delle compagnie telegrafisti di C . A. e delle compagnie divisionali dipendenti e gli ispettori telegrafici di C. A. laterali.
Similmente dovevano pure regolarsi i comandanti delle compagnie telegrafisti divisionali verso i comandanti delle compagnie laterali, per i collegamenti che potevano interessarli.
Pe r avere un'idea dell'attività svolta dall e compagnie telegrafisti e della mole del lavoro, basta considerare, per esempio, che presso la 3.. Armata, prima del ripiegamento dell'ottobre 1917, era stata impiantata e veniva gestita una rete telegrafonica corrispondente a 15.000 km. di circuiti, 300 centrali telefoniche, 3200 apparati telefonici, 150 apparati telegrafici, 60 stazioni ottiche e 15 stazioni radiotelegrafiche.
E poiché in questo capitolo abbiamo fatto sovente cenno agli ispettori telegrafici d'Armata, riportiamo qui di seguito - per comodità di consultazione - uno specchio nominativo di quelli che dall 'inizio alla fine dell a guerra 1915-18 s i sono avvicendati nei div ersi ispettorati telegrafici dei comandi di grandi unità.
ELENCO DEGLI ISPETTORI TELEGRAFICI CHE S I SONO AVVICENDATI DALL'INIZIO ALLA FINE DELLA GUE RRA NEI DIVERSI ISPETI'ORATI TELEGRAFICI DEI COMANDI DELLE GRA NDI UNITA'
IlUnità presso cui Ispettorato
Data di successione Grado degli Ispettori Telegrafici prestava servizio Telegrafico dell' Ispettore Assunzione Cessazione
Cognome e nome
Comando Capo Col. Mazzone Cav. Natalino 27-5 -15 7- 1-17 Supremo Servizio Col. Cadorna Cav. Gaetano 20-3- 17 1- 1-17 Telegrafico T Col. Ferri Cav. F r ance sco 3- 1-19 10-4 -1 9 Milit. T. Col. Levi Cav. Ugo 10-4- 19
Comando Ispettorato T. Col. Cav. Gius eppe 15-6- 16 19-8- 16 la Armata Telegrafico T . Col. Ricci Cav. Carlo 21-8 - 16 15-4-17 1a Armata T. Col. De Vincentis Cav. Cesare 15-4- 17 17- 3-19 Capitano Franzos ini Sig. Victor 17-3-19 20- 9-19
Comando Ispettor ato Maggiore Guasco Cav. Gi useppe 17-5-15 15-6-16 2• Armata Telegrafico 14-5- 15 2.. Armata 6-3-17 Zona Ispettorato T . Col. Ricci Cav. Carlo 15-6- 16 18-8 - 16 Gorizia Tel egrafico 6-3-17 Zo n a di 1-6-1 7 Gorizia
Coma ndo Is pe ttorato Col. Guasco Cav. Gius eppe 19-8- 16 13-1 - 19 2"' Armata Telegrafico 1-6-17 2a Armata 1-6-18
Comando Ispettorato Maggiore Barnizza Cav. Ernesto 13- 8- 18 31 -1-19 ga Armata T e legr afico 3-6- 18 8" Arm ata 31-1-19
Comando I spettorato Maggiore Bottura Cav. Luigi 24-5- 15 12-2-16 3a Armata Telegrafico Col. Guiolia Cav. Giovanni 13-2- 16 1-3-19 3"' Armata Maggiore Ricci Cav Tito 2-3- 19 22-7-19
Coma n d o Ispettorato Maggiore Grandis Cav. Giu seppe 24-5-15 13- 6 -1 5 4"' Armata Te legrafico_ Col. Sartori Cav. Pietro 14 - 6-15 22- 2- 17 4a Armata Col. Faronato Ca v. Berna r do 1- 3-17 9-6- 19 T. Col. Mattini 9- 6-19 18-7- 19 (segue)

Segue: El enco degli Ispettori Telegrafici che si sono a vvice ndati dall'inizio alla fine della guena nei diversi Ispettorati Telegrafici dei Comandi de ll e Gr andi Unità.
Unità presso cui Ispettorato Cognome e nome Data di successione Grado degli Ispettori Telegrafici prestava servizio Telegrafico dell'Ispettore
Assunzione Cessazione
Comando Ispettorato T Col. Ricci Cav. Carlo l - 5-18 15-6- 16 5" Armata Telegrafi co 1-5 - 16 5a Arm ata
Coman,do Ispettorato Maggiore Campanini Cav. Alberto 7-3-18 9a· Armata Telegrafico 7 - 5-18 9a Arma ta Comando Ispettorato Maggiore Campanini Cav. Alberto 7 - 3- 18 aa Armata Telegrafico 15,1 -19 aa Arma ta
Comando Ispettorato Maggiore Giam berini Cav Curzio 12- 191 6 11-1917 sa Armata Tel egrafico Maggior e Ch ini Cav. Romo lo 11-1917 31-1 - 18 6" Armata Maggiore Gualtiero t ti Cav. Mario 1-11-19 5-7-19 Capitano Storchi Cav. Enrico 5-7 - 19 1-7-1 9
Com ando Ispettorato T . Col. Levi Ca v. Ugo 11 -11- 17 11-11- 18 III C . A. Telegrafico s ino III C. M. al Ispettorato T. Col. Levi Cav. Ugo 11-11 - 17 11-11- 18 23-1- 19 Telegrafico poi Com. 7" Armata 7o. Armata
Zona Carnia Ispettorato Maggiore Astier Cav. Umberto 28-4-15 10 -1917 dal Telegrafico 24-2- 15 Z ona Comando Carnia 2• A r mata I spettor ato Ma ggiore Astier Cav. Umberto 28-4-15 10 -1 917 dal Telegrafico 6-11-17 2" Armata
Zona Carnia Ispetto r ato M aggiore Astier Cav. Umber to 28-4-15 10-1917 dal Telegrafico 1-6-1 7 Zona Carnia

Cap. VIII
IL PATRIMONIO SPmiTUALE DEL GENIO TELEGRAFISTI NELLA GRANDE GUERRA
25 - Attività delle compagnie telegrafisti.
Allo scopo di rendere non solo un commosso, reverente omaggio alla memoria dei telegrafisti caduti nel corso delle operazioni su i v a ri fronti, ma anche di riconoscere il dovuto titolo di merito ai supers titi, accennerò ora all 'attività svolta dalle compagnie te legrafisti durante la campagna 1915-1918.
Ciascuna compagnia t e l eg rafisti, per il suo carattere relativamente au tono mo, ha avuto una propria storia, più o meno importante a seconda della data della sua costituzio ne, dell'impiego avuto, e del f ronte cui ha operato.
Purtroppo molti degli innumerevoli episodi cui parteciparono gli uomini del 3° e 7° G enio sono ignorati. Scrive a quesfo proposito il Maresciallo G iardino nelle sue « R ievocazioni e riflessioni di guerra» , vol. II, parlando della battaglia del P iave : «Dopo la ba ttaglia tutti 1 comandi segnalarono i grand iss imi sforzi fatti dai telegrafisti del genio per riattare, sotto la temp esta, le linee interrotte, e la devozione infinita dei porta-ordini nel re' capitare, attraverso le zone più bat t ute, gli ordini e le notizie.
«Eroismo particolarmente mirabile quello di questi isolati, che, lontani da ogni sorveglianza di superiori, senza l'eccitamento d e lla lo t ta , affrontarono i più gravi pericoli per riallacciare un

filo o portare un biglietto, del quale non sapevano neppure se fosse molta o poca l'importanza.
«Quante volte li ammirammo e li premiammo come meritavano! Ma quante altre volte saranno scomparsi, anonimi eroi di un oscuro dovere?».
L'Ispettore Capo del Servizio Telegrafico Militare dispos€ subito, alla fine della guerra, che tutte le compagnie telegrafisti det due reggimenti (3" e 7" Genio), compilassero, sulla scorta del loro diario storico, una relazione particolareggiata degli ordini ricevuti e dell'attività svolta durante la campagna, delle operazioni alle quali avevano partecipato, indicando le perdite subite, le ricom· pense, eventualmente concesse i fatti più salienti, documentando J:attività svolta con opportuni dati, grafici, fotografie ecc.

A causa del graduale scioglimento di molte compagnie teleg r afisti, iniziato dopo l'armistizio e del progressivo congedamento del personale, non tutte le relazioni furono presentate ed alcune non furono compilate in modo completo ed esauriente.
E' pertanto possibile che nella descrizione che segue non sempre risulti pienamente illustrata l'attività svolta da qualche reparto, come pure che non sia riportato qualche episodio pur me· ritevole di essere segnalato.
Gli àntichi commilitoni vog liano quindi scusarmi nel caso di eventuali omissioni del genere, che potranno essermi segnalate affinché possa meglio completare la memoria che ho compilato.
26
- Le compagnie telegrafisti sul Carso.
Non potendo seguire una vera cronologia, darò la precedenza alle compagnie che furono impiegate nella zona Carsica, illustrando ( e così farò pure per le compagnie telegrafisti impiegate n €gli altri settori del fronte) i fatti d'armi più importanti cui presero parte i telegrafisti del genio; e quando sarà possibile dirò, oltre il numero della compagnia, anche i nomi dei protagonisti di notevoli atti di valore.
Il servizio dei collegamenti nella zona della 3a Armata ebbe una particolare attivi tà, perché dovette seguire un ritmo accelerato, intensissimo per le trupp e operanti in quella zona, le q"uali combatterono ben dodici durissime battaglie.
I telegrafisti che operarono e combatterono sul Carso, sono perciò i primi a ricevere la luce d'oro che brilla sull'orifiamma del Genio telegr afìsti.
27
- Castelnuovo del Carso.
Il valore del combattente italiano non fu mai messo a dura prova come fra le asprezze del Carso.
Gli austriaci, con l'esperienza acquisita in un anno di guerra. avevano approntato sulle colline del Carso numerose linee di reticolati e potenti difese arretrate per impedire la nostra avanzata in quel settore. Perciò rifulsero in numerevoli episodi di singolàre valore i nostri soldati, che affrontavano le posizioni, aprendosi varchi con rudimentali mezzi (quali le pinze tagliafili e i tubi esplosivi), sotto le raffich e de lle mitragliatrici avversarie.
Durante un contrattacco austriaco iniziato il 5 luglio 1915 nella r€gione di Castelnuovo del Carso, il solda to Costanzi Alfredo, teJefonista in un trinceramento, ad onta dell'avvicinarsi del nemico e dell'immediato pericolo, ligio al suo dovere, continuò imperturbabile il proprio servizio, seguitando a tenere informato il comando retrostante sulle vicende della lo tta. Gli fu la medaglia di bronzo al valor militare.
Nella notte del 18 luglio 1915, dopo un tiro di preparazione dell'artiglieria, le nostre truppe rius cirono ad impossessarsi di vari elementi di trincee nella zona di Castelnuovo del Carso.
Mentre perdurava l'attacco delle fanterie, il sottotenente Bianchi Tranquillo, della 10a compagnia teleg!'l8.fìs.ti, er.a sulla Linea del fuoco con una sezione ottica. Caduto il comandante di un plotone di :fanteria, il sottotenente Bianchi 1o sostituiva nel comando e procedeva neWassalto, riuscendo a 'catturare molti prigionieri, fra i quali sette ufficiali. Gli fu concessa da S.A.R. il Duca d'Aosta, comandante dell'Armata, una medaglia d'argento al volor militare.

Sulle alture d i Seltz il 7 ottobre 1915 l'artiglieria aus triaca bombardava le nostr e linee e il nemico faceva segu1re subi to uno dei t a n ti contrattacchi che trovò rea zi one da parte delle nostre truppe.
L ' unico tangibile risultato degli aus triac i fu quello di aver devastato le line e telefoniche di un gruppo di artiglieria situato nei pressi di S . Graziano.
Il caporale Massa Annio, preposto a questa importante rete telefonica, si recò più volte a riattivare il funzionamento sfidando ogni pericolo e, p ur riman endo l'u l t i ma volta ferito, v olle ritornare a l proprio posto di lavoro, rifiutando ogni invito di essere ricoverato all'ospedale
In contingenze il soldato Rocca Marcello, guardafili presso un pos to telefoni co nelle v i cinanze di Staranzan o, provvid e a riallacciare le linee telefoniche ripetutamente interrotte dall'int enso tiro della artiglieria nemica e infine, colpito contemporaneamente alle due braccia da schegge di granata, dove t te n ecessariamente recarsi al posto d i medicazione.
Il 16 ottobre 1915 , in una giornata in cui l'artiglieria nemica bombardava intensamente i nostri trinceramenti presso Polazzo, il soldato Castigliani Marcello si offrì volontario con un altro guardafili, per r iordinare le comunicazioni telefoniche i n terrotte.

Sotto l'imperversare del fuoco nemico, sprezzante del pericolo, iniziò col compagno il suo lavoro, ma quest'ultimo cadde gravemente ferito, m entre il Castiglioni, superand o l'angoscioso momento con nobile sere nità, non indugiò a trasporta re il ferito nel posto di medicazione, per poi ritornare prontamente al suo p ericoloso lavoro.
Il 22 otto bre 1915 al Bosco Tr i an golare (sul Carso) la notte era tr a scorsa co n una certa tranquillità.
Presso un osserva torio di artiglieria il soldato Colombo Clodoveo assolveva da tre mesi il suo compito di telefonista con due suoi compagni : i t elefonisti Reboan i Adolfo e T urco Carmelo.
Nelle prime ore del mattino un violento tiro di artigli eria nemica di medio calibro si concentrò sull'osservatorio, che fu distr utto da u n colp o di gran ata, ri man endo u cciso l'uffici ale che vi era ad detto e gravemen te ferito il Colombo.
I due compagni trasportarono il ferito quasi esanime al pos to di medicazione, dove il Colombo, pur straziato nella carne, trovava la forza d'animo di rammaricarsi al pensiero di non pote r fare più nulla p er la· sua Patria.
Ritornati i due telefonisti all'osservatorio distrutto, riuscir ono non solo a recuperare gli apparecchi telefonici e gli altri strumenti, ma concorsero altresì alla ricostruzio ne dell 'osservatorio stesso, che fu nuovamente colpito e ciò nonostante i due telefonisti si p rodigarono per ripristinare l e linee telefo niche che ad esso facevano capo.
Ai tre valorosi soldati venne concessa la medaglia d'argento a l valor militare .
Pure singolare· è la prova di valore del guardafili Di Carlo l'lario e del telefonista T ettamanti Pietro in una trincea di prima lmea a Palazzo (29 ottob re 1915).

Un nutrito fuoco di mitrag liatrici e fucil eria nemiche diretto sulla trincea, interruppe le comunicazioni telefoniche .
Il D i Carlo uscì alla ricerca del guasto, non curandosi dell'intenso tiro nemico, e riuscì in breve tempo a riattivare le comunicazioni, ma appena r i entrato nella trincea una granata lo colpiva in pieno, uccid e ndolo .
Il telefonis ta Tettamanti, ferito gravemente ad una gamba, fu testimone della tragica morte del compagno e continuò il servizio finché le forze lo sostenne ro. Entrambi furono decorati con me>daglia di bronzo al valor militare.
Degni di loro sono stati i te l efonisti Ce rasa Elio e Paciucci Vitaliano preposti al servizio te lefonico di Fogliano, i quali con calma e serenità continuarono a disimpegnare il servizio sotto l'intenso fuoco dell 'artiglieria nemica e furono mortalmente colpiti mentre trasmettevano g li ordini d el comando.
Nello stesso settore carsico, i telefonisti Maffi Angelo e Sormani Angelo, sebben e contusi per il crollo del posto telefonico colpito in pieno da una granata, riattivarono prontamente le linee mentre p erdurava il fuoco nemico e ripristinavano i collegamenti.
Sul M. San Michele i te l egrafisti della 10 compagnia erano in linea con i fanti e con gli zappatori del genio.
,Presso un osserva torio di artiglieria era comandato il soldato
Porinelli Carlo il quale, interrotta la linea telefonica non esitava ad uscire per ripararla, affrontando con cuore intrepido il fuoco n emico che in quel momento imperversava rabbioso nella zona; ma, quando riparato il guasto si accingeva a riprendere il suo lavoro, fu ferito gravemente alla testa Per il suo valoroso comportam ento gli fu concessa la medaglia d'argento al valor militare. La medaglia di bronzo al valor militare fu concessa anche ai telegrafisti Bottani Francesco e Paterna Tommaso che particolarmente si distinsero nei combattimenti dal 16 al 28 novembre 1915 sulla cima 4 del monte San Michele.
Nelle vicinanze di Castelnuovo d el Carso, sotto il fuoco della a ttiglier ia nemica, che imperversava di giorno e di notte, il soldato A,ngelini La rghetti Pietro, sprezzante sempre del pericolo, pr·ovvedeva più volte alla riparazione delle linee telefoniche, ma alla fine cadeva colpito durante l'assolvimento del suo pericoloso compito. Alla sua memoria venne concessa la medaglia di bronzo al v. m .
Il 18 1916, a Bosco Cappuccio, sul Ca rso, il guardafili Biglia Edo.11rdo si offriva spontaneamente per riparare le linee telefoniche interrotte e, senza perdere tempo ed affrontando a cuor sereno la pericolosa impresa, riusciva con altri compagni a individuare i guasti. F erito mortalmente da una granata e soccorso subito dopo dai colleghi, raccomandava loro di non esporst ulteriormente, mentre li esortava a controllare se le linee telefoniche avevano ripr eso il loro funzionamento.

Anche sul Podgora, durante le operazioni della primavera del 1916, il genio telegrafisti diede il suo g eneroso contributo di sangue.
In un osservatorio avanzato di quella contesa posizione il telefonista Paterna Tommaso, già distin tos i, come si è visto, sul Monte San Michele , disimpegnava con zelo e calma il suo delicato servizio, quando l'artiglieria ne mica, individuato l 'osservatorio, vi concentrava un violento fuoco. Il Paterna, invitato ad abbandonare la posizione insostenibile, rispondeva: « Non posso muovermi, questo è il mio posto!» Dieci minuti dopo un colpo di granata colpiva la stazione telefonica ferendo gr avem ente l'umile ma coraggioso telegrafista.
28 - La 28° compagnia te)egrafisti.
Questa compagnia fu destinata al VII e poi al XIII Corpo di Armata nel settore Ca rsico. .

Il telegrafìsta Palladino Rodolfo, nell 'aprile 1916 trovavasi a Punta Sdobba, p r esso una batteria da 149, che gli aus tr iaci riuscirono ad ind ividuare
La batteria non potè sfuggire ai colpi nemici, però fu ammirevo le l'imperturbabilità del telefonista Palladino, il quale restò al proprio posto, continuando a trasmettere al comando superiore quanto avveniva a Punta Sdobba.
A San Pietro del Carso, sul campanile della chiesa era stato destinato come telefonista un s oldato della 28• compagnia, il cui nome non è stato segnalato nella 2·elazione del comand ante.
Chi conobbe quella località durante quell'epoca sa quale ammasso di rovine presentasse: solo il campanile rimase miracolosamete in piedi malgrado i numerosi proiettili avver sa ri che scoppiavano tutt'intorno .
Su qu el campanile fu fatto sa lire un g iovane soldato de lla 28" compa gnia te legrafisti . E gli doveva osservare e, a m ezzo d el telefono, riferire tutto ciò che poteva interessare i nostri comandi, i quali utili zzar ono lè notizie ricevute per lo svolgimento cii una cont ro azione.
La risposta del nem ico fu immediat a e con qua lche tiro b ene ass estato inco minciò a sgretolare i fianchi del campanile; ma \l telefon ista fu impassibile e conti nuò a disimpegnare il proprio serviz io, finchè non gli pervenne l'ordine perentorio del comandante la compagnia d i scendere per non esporre ulteriormente la vita.
L 'off en siva d el 4 lugli o 1916 da parte d ella nostra 3" Armata scatenò la reazi one avve rsaria, che riuscì a distruggere ed in terr ompere la q uasi totalità de)la rete t e lefonica stesa tra l e linee av anzate, ma trovò gli uomini della telegrafisti ben preparati alla dura lotta e il loro intervento - dove era necessario riparare rapidamente i guasti - fu così pronto da suscitare la generale ammirazione
29
- Il Campo degli asfissiati.
Il 29 giugno 191,6 le nostre tr upp e operavano a San Michele, mentre l'offensiva austriaca del Trentine, che si era arrestata nel mese di maggio, incoraggiò poi il nemico a cercare di conseguire, anche con i mezzi più disumani, qualche concreto successo.

Il suo piano, preparato con sapiente organizzazione e nella più cculata segretezza, veniva effettuato il 29 giugno presso San Ma rtino sul Monte San Michele, mediante un attacco preceduto dall'emissione di gas asfissiante.
L'arma n uo va, di mici diali tà spaventevole, mietè numerose vittime, perchè trovò i militari impreparati al nuovo terribile mezzo di guerra.
Ma anche in questa pericolosa circostanza il G enio Telegraflsti seppe dare altra degna prova della sua forza morale e della sua perizia.
La salvezza delle posizioni non dipendeva che dall'arrivo dei rinforzi di truppe fresche, che dovevano sbarrare la via al nemico, non appena la nub e gassosa avesse cessato i suoi micidiali effetti.
Invero su quel tratto di fronte nessun telefonista vacillò dinanzi al pericolo e tutti continuarono l'assolvimento del loro àovere, cooperando validamente alla diramazione degli ordini che valsero a salvare la posizio ne.
Fra gli altri ricordiamo l'eroico caduto Cariolato Luigi, caporalmag gio re della 10a compagnia telegrafisti, decorato con medaglia d'argento perchè, a Bosco Cappuccio, capo di una stazione ottica da una nube di gas asfissiante, rimase fermo all'apparato fino all'ultim o. Aggravatosi per l 'azion e dei gas, s pirò, al posto di medicazione.
Alle case di San Martino presso un comando di Brigata davano la lo ro opera di telefonisti il cap oral e Balducci Benedetto e il soldato Petralia Sebastiano, quando li raggiunse l'ondata der gas asfissianti. Anch',essi con t e na ce volontà, pur soffrendo atr ocemente, continuarono a prestare il loro servizio. Entrambi furono decorati con medaglia d'argento al va lor militare.
Sul Monte San Michele anche il soldato Farinola Roc co , capo di una stazione te l efonica, sebbe!le dai ve;.1.efici gas. res t ò imper t e rrito a l proprio posto per co mpiere n suo dovere sir. o a quand o fu possibile la sua sostitezione. Anch'egli si merit ò la medaglia d'a rge nto al valor militare.
30 - La
Battaglia
di Gorizia ( 4-17 agosto 1916).

La battaglia di Gorizia vide operare con rinnovato impegno i nostri te l egrafisti su un settore molto ampio, e cioè: dal Saboti no, Mont e Santo p er Oslavia, Grafemberg, Podgora, San Michele, s ino alle alture a nord di Monfalcone .
Tutti con tribuirono, secondo l e proprie capacità e con t u tte le loro forze, al raggiu gimento dell'obiettivo, che si identificava nella conquista di Go rizia!
Gli ufficiali e i soldati del Genio T elegrafisti superarono, durante la battaglia, ogni previsione ottimistica, talchè furono davvero ammirevoli nell'offrire i loro sacrifici dinanzi al supremo dovere.
Perfetta f u , peraltro, l 'intesa con i comandi avanzati, osservatori, tr upp e di rincalzo, reparti di artiglieria e comandi dell e gran di unità arretrate, pronte ad entrare in azione.
Le se zioni te l efo nich e divisionali addette ai comandi assicurarono l a continuità ed il perfetto funzionamento dei collegamenti loro affidati durante tutto lo svol gimento delle operazioni, adeguandoli tempestivamente alle mutevoli esigenze operative e rea · lizzando sollecitamente i nuovi collegamenti, in relazione alla avanzata delle truppe attaccanti.
Il 9 agosto 191 6 il tricolore sventolava sul Castello di Gor izia: insieme al fante entrarono in qu ella città soldati del G en io Telegrafisti, che p er primi diedero all'Italia l a notizia da tempo attesa e vivamente desid erata
Fra i reparti telegrafìsti che parteciparono con valore alla aspra battaglia, ricordiamo la 10" sezione telefonica (de lla 12a divisione). Nella giornata dell'8 agosto i bravi telegrafìsti guadarono varie volte l'Isonzo, sull'esempio del loro comandante, te-
nente Boidi Angelo, sotto l 'imperversante fuoco nemico, riuscendo a ristabilire ripetutamente comunicazioni interrotte.

Il tenente Boidi era già stato decorato di una medaglia d'argento e. di una di bronzo al valor militare sul Podgora, nel 1915. Qui meritò una nuova medaglia d 'argento al v. m. con lusinghiera motivazione che fa fede del valore suo e del suo reparto.
I telegrafisti del genio Fe rrari Daniele e Galloni Aldo sul San Michele, nella notte antecedente la presa di Gorizia, mentre nuclei di fanteria uscivano ad occupare un trinceramento aus triaco della cima anzidetta, senza por tempo in mezzo, stendevano sul terreno battuto da un fuoco tambureggiante 150 metri di linea, collegando telefonicamente il comando di battaglione con i nuclei• avanzati, per cui fu anch e possibile assicurare la trasmis· sione ai comandi arretrati de lle comunicazioni relative allo svolgimento dell'azione in corso.
Il fante ebbe sempre vicini in ogni circostanza i commilitoni del genio telegrafisti. Lo dimostra ancora una volta il fatto che le truppe schierate presso Poteano, nell'attacco delle posizioni nemiche, ebbero il valido sostegno della squadra telegrafisti comandata dal caporal maggiore Ingrassia Gaspare il quale, insieme ai suoi compagni, sempre volenterosi e arditi, seguì le fanterie lan ciate all'attacco e, non ostante la viva reazione del nemico, stese al seguito d elle truppe attacca nti le linee telefoniche necessarie per mantenere il collegamento con i comandi.
In q u ell'azione, un comandante di sezione telefonica divisio· naie, il tenente D'Allara Dante, sfruttava il particolare momento in cui il nemico si ritirava, riuscendo, con uomini dotati dello stesso spirito di devozione e coraggio, a precedere la fanteria sulle posizioni conquista te.
L'azione della fanteria venne così facilitata da questa ardimentosa operazione dei telefonisti del genio, che riusciron o a collegare subito telefonicamente l e truppe occupanti le posizioni avanza te col comando di divisione.
Il tenente D'Allara pur lievemente ferito, potè continuar e il proprio lavoro, ma sorte più crudele ebbero, invece, due suoi telefonisti, uccisi dallo scoppio di una granata che aveva colpito in pieno la stazione telefonica .
Al tenente D 'Allara, per il suo valoroso comportamento e l'opera espli cata durante t utto l o s v olgimento dell'azione, ve n ne concessa l a med aglia d'argento al v a lore militare.
31 - L'Sa Compagnia te legr a fis ti durante la bat taglia di Gorizia.
Questa compagnia disimpegnò i suoi servizi in favore de l VI Corpo d'Armata e meritò un encomio solenne che, sebbene tributato alla persona del comandante, rispecchia fedelmente le benemerenze d ella compagnia.
L'encomi o d ice:
«Comandan t e l a compag nia t el egrafisti d el V I Corpo d 'Armata, du r an te l e operazioni contro l a testa di ponte di Go ri zia, seppe con i nt elligenza, abilità, vera competenza tecnica, far f r onte, pure con scarsezza di mezzi, alle esigenze della situazione, organizzando con prontezza una rete di comunicazioni che, per l'a ssai aumentato numero di reparti e di artiglierie alle dipendenze del VI Corpo d'Armata, si presentava assa i complessa.
Tenen t e G enerale Capello»
L'azione da svolgers i per l a presa di Go r i zi a era tr oppo se nt ita da t u tt i i comba ttenti, sia p er la lunga sosta in trince a, s ia per rispon d ere a ll'offensiva austriaca d el ma ggio 1916, ed in fi n e pe r il desiderio d i fare un grande s b alzo in avanti.

Durante lo svolgimento di quelle operazioni, si prese n tarono casi abbasta n za difficili per il mantenimento delle comunicazioni fra i comandi e l e unilà operanti, a ca us a d el tiro avvers a ri o, de lla congestion e de lle strade per lo spostamento delle art igl i erie, per l e lun g hissim e col onne di sa lmeri e, d e i r inforzi ch e a fflu ivano, de i rif orn imenti e dello sposta mento in a v anti dei v ari se r vizi.
I te l eg r afìsti dell'S" compagn ia non si p erd ettero d'a n imo, ma , aumentaro n o, a n z i, g li sforzi e, percorrendo attraverso campi e colline, die ci n e d i chilometri a piedi , ca richi di materiali, rius cirono a stabilire i collegamenti con le divisioni e con i reparti avanzati in posi zioni duramente battute dal fuoco dell'avversario.
Così subito dopo lo sbal zo in avanti delle fanterie, il capftano comandante ricevette l 'ordine di collegare telefonicamente q comando del settore (229" fanteria) presso il convento del Monte santo, con il comando del Corpo d'Armata. Lo stendimento d ! 16 km d1 linea, per la zona interamente battuta dal tiro avversario, riuscì difficoltoso e perico loso, ma gli uomini dell'8" compagnia superarono ogni ostacolo e difficoltà.
L 'itinerario seguito dalla linea era molto vulnerabile ai tiri di artiglieria, ma lo spirito di sacrificio dei guardafili seppe assicurare la continuità dei collegamenti.
Su Monte Santo, presso il comando di settore, era stata impiantata anche una stazione ottica, che corrispondeva con quella installazione a quota 609 di Monte Sabotino, ed acc anto alla stazione ottica vi era quella tel efonica. Senza alcun riparo l e due stazioni funzionarono in modo meraviglioso, sia durante il v i olentissimo tiro di reazione nemica, sia durante le op erazioni svoltesi per il possesso della cima del monte.
Molti furono i disagi sofferti da questi soldati, anche per la mancanza di viv eri, a causa della difficoltà dei rifornimen ti, ma ·m queste circostanze essi diedero degnissimo esempio di abnegazione e attaccamen to al dovere.
Purt ropp o l e due stazioni furono poi colpite in pieno e moltl telegrafisti del drappello furono uccisi e feriti.
Per l 'attraversamento dell'Isonzo, il comandan te della compagnia era stato autorizzato a superare il fiume di notte su una portiera scorrevole.
Durante lo spostamento d ell'8"' divis ione da quota 535 di Monte Sabotino, un violentissimo bombardamento interruppe le linee telefoniche, che i telegrafisti di quel settore provvidero immediatamente a riparare.
Per l'opera prestata in quella occasione dalla compagnia, il Comando della 2" Armata rivolse un e ncomio solenne al t ene nte Maniera Antonio ed al sottotenente Simonetta V incenzo. Nella stessa occasione, il caporale Punzi Giovanbattista, capo della stazione ottica sul Mo n te Santo e quivi ferito, venne dec orato della medaglia d'argento. e sette soldati telegrafisti furo no nominati «arditi».

Anche per la conquista di San Gab r iele , molte furono le difficoltà incontrate dall'S'' compagnia telegrafisti. Avuto l'ordine di collegare otticamente e t elef onicamente il comando della Brigata operan t e su q. 526 del Veliki (S. Gab r i ele ), la compagnia dispose che la stazione ottica venisse impiantata all'albergo Preval (Sella d i Dol), iniziando nel conte mpo lo stend imento dal predetto <.:ornando di Brigata fino al cen trali no di smistamento d el· la compagnia sito al Ponte 14. L a linea risult ò di uno sviluppo complessi vo d i circa 10 km. e dovendo segui re necessariame n t e l'unica strada di accesso alla zon a avanzata, r i mase esposta ai tiri dell ' artigli eria, delle mitragliatrici e dei f uc ili del nemi co. Nonostan te ciò, il circuito, pe r l 'opera p r onta e att iva dei brav1 telegrafisti, potè funziona re costantemente e il comando del Corpo d ' Arma ta ebbe la possibilità di teners i collegato con i comandi delle truppe che r i salivano il San Gabr ie l e.

I guardiafili, compresi dell'importanza delle linee telefoniche e ottiche, che erano gli unici collegament i in quella zona avanzata, nulla lasciarono di intentato per ottenere il massimo 1endimento
N e i momenti di re lativa calma provvidero alla sostituzione dei tratti fortemente danneggiati, che nei punti più battu t i assumevano anch e la lungh ezza di tre km ; e ta le sostituzione durante le operazioni avvenne ben 25 volte.
Vi ancora lo spirito di sacrificio e l'a lto sen t imento del dover e dei telegrafisti ott ic i, i quali gareggiavano coi guardiafili in coraggio e bravura. Alcune stazioni ottiche , per quanto colp i t e da scheggie di proiettili nemici, vennero fatte funzionar e in modo davvero eccellente; altre subirono anche la rottu r a dell a lam pada ace ti lenica, e i t elegrafisti ricorsero ad ogni possibile ripiego , sostituendo l a fiamma con quella di altr e lampade e di candele, e servendosi, al posto dell 'acqua per la produzione del gas, finanche dell'urina
Al seg u ito de lle truppe avanza te vennero assegnate stazioni ottiche, che furono impiegate sulle quote 552 e 600 del Mon te San Gabriele, e sebb e ne l e diff icoltà andassero aum entando, de tte stazioni assicura r ono il servizio dei anche dur an-
te le successive azioni svolte per opporsi agli insistenti contrattacch i avversari.
I due telegrafisti della stazio ne ottica impiantata presso l'albergo Preval caddero mortalmente colpiti da scheggie di granata, mentre durante una delle azioni compivano coraggiosamente 1l loro dovere.
32
- Offensive dell'autunno 1916.
Il martellamento senza tregua contro il nemico e gli attacchi intesi a sradicarlo dalle posizioni d el roccioso terreno carsico, alle quali si era tenacemente abbarbicato, continuarono durante t utto l'autunno.
Il 14 settembre, non astante l'uggiosità della nebbia e della pioggia che rendeva insostenibile la vita nel fango della trincea, si iniziò uno dei nostri attacchi, preceduto da un violen tissim o tiro di artiglieria dalla zona di Goriz ia fino a tutta la linea del Carso.
Particolarmente efficace fu il tiro delle bombarde, a cui era devo lu to il compito di aprire i varch i nei reticolati. Successivamente il grosso delle fanterie mosse all'attacco, ottenendo risultati pronti ed insperati: le al t ure della Q. 265 ad occidente di Veliki- Hribach, le case di Nova Vas pos te più a sud e la Q. 208 a nord furono occu pate. Ma l 'immediato contrat t acco nemico ci obbligò a ritorn ar e nelle nostre posizioni di partenza.
Co me sempre, durante questa azione i telegrafisti del genio ass icurarono ai reparti di fanteria attaccanti la tempe stività de lle co municaz ioni telefoni che. Purtroppo, mentre s i effettuava l o stendimento delle linee telefoniche gli zelanti guardiafili subirono diverse perdite, e mancarono quindi al momento opportuno gli uomini per riparare l e linee stesse . Vi supplì la tenacia del sergente che li comandava, il qua le, con alto se ntimentò del dovere e con sprezzo del pericolo, assicurò - con i pochi guardiafili rimasti - la continuità dei collegamenti.
L'a zione nostra durò tr e giorni, intensa. nono sta n te [a èontinua pioggia e il fango. Gli altri attac chi furono diretti sul-

le alture di S. Grado e sulla parte di Loquizza ad est di Oppacchiasella con esito favorevole.
Fra gli uomini del genio telegrafisti che più si distinsero in quell'occasione sono da citare i protagonisti d ei seguenti episodi:
Un modesto soldato, a nome Castoldi Giovanni, incaricato con altri compagni di ese guire alcuni allacciamenti telefonici sul Nad Logem, sotto il fuoco micidiale dell ' artiglieria nemica, fu travolto e confuso dallo scoppio di una granata, ma non curante d e lla sua persona riprese impassibile la propria opera. Dopo cfue giorni, in analoga circostanza, dava nuova prova di coraggio. Trovatosi infatti con altri compagni nuovamente sotto il fuoco dell ' artiglieria austriaca, che feri gravemente uno di essi, Il Castoldi lo raccolse e lo trasportò al più vicino posto di med icazione, per poi ritornare senza indugio al proprio lavoro.
Il soldato Conti Mario, telefonista presso un osservatorio avanzato molto bersagliato dal tiro dell'artiglieria avversaria, dopo aver soccorso il compagno ferito, riattava il collegamento telefonico e alla meglio l'osservatorio, continuando a svolgere, con animo impertubabile, il proprio servizio.
Ai predetti soldati fu concessa la medaglia d'argento al valo r militare .
Nelle vicinanze di Oppacchiasella un nucleo di te l efonisti del genio era in servizio al posto tattico d el comando della Brigata c-he occupava quella posizione. Durante uno dei tiri contro detto posto, una granata colpiva in pieno la stazione telefonica, uccidendo il personale addettovi e lasciando incolume soltanto il telegrafista Tremarosi Guido. Questi, ben sapendo che il comando della Brigata era rimasto senza collegamento, non perdette tempo e, sotto il grandinare dei proiettili nemici, rintracciò e riparò sollecitamente i circuiti telefonici. Inoltre, conscio d e lla propria responsabilità, provvide a modifica re oppo rtunamente il tra cciato delle linee telefonch e, in modo da re nderle meno vulnerabili Rl tiro nemico.
La 3"' Armata sul finire dell'autunno raggiunse, con l'ottava battaglia dell'Isonzo, i margini più avanzati della regione carsi-

ca. La d istrutta Loquizza, la Cres ta del Nad Bregon, la con tes a quota 208 sud costituivano i cardini dell a l inea ten u ta da quelle truppe.

D u rante una d elle ultime azioni, il soldato telegrafista Fan e lla Carlo, nel settore di Nova Vas, v is to cadere ferito un proprio compagno l o soccorse p ront amente e lo trasport ò quindi al posto di medicazione, tornando subito dopo al proprio posto. Successivamente, recatosi lungo la linea per ripar a re le interruzioni ca gionate dal ti ro nemico, veniva colpito da una sch eggia di granata. Subito soccorso, non pensando alla grave ferita riportata, raccomandava ai compagni il sollecito ripristino della linea t el efo n ica interrotta, r amm aricandosi di non potervi provvedere egli stesso.
33 - Campagna invernale 1916 -1917.
Subentrata la stagione invernale, i l freddo e le intemperie portarono, specialmente in alta mon tagn a , una sosta n elle operazioni.
Questo pe riodo fu impi ega to , specialmente dal personale tecnico, per rivedere impian ti e mat eriali già installati, per la p r ogettazio ne di nuov i e per una m igliore sistemazione generale, affinché la primavera prossima trovas se t utt i preparati (comprese le compagnie telegrafist i) a far fronte ad ogni esigenza . Nuove uni tà di recente formazione furono assegnate alla 3a Armata e quindi fu possibile svolgere un no tevole lavoro di riassetto del servizio te legrafonico. Le opere effettuate in quell 'epoca fur ono molteplici: sistemazione di tutta la rete telefonic a ; ampliamento di una vasta rete ottica e radiote l eg rafica; impiego d i cavi e cavetti armati, iso lati da truogoli di legno, per i circuiti d e ll'artigli eria e d egli osservatori; conveni ent e sistemazion e in cavern e di centrali t elefo niche; prepa r azion e di centrali sussidiarie in caso d i ine vitabili danneggi am e n ti; masc h eramento de i fasci di linee, per evitare che il nemico individuasse la posizione dei posti di comando, osservatori ecc.
I telegrafisti del genio si sottoposero ad ogni disagio, adattandosi a compiere i più svariati mestieri (di sterratori, mura:tori, minatori, ecc. ), lavorando senza sosta, nonostant e le avverse condizioni metereologich e e il tiro nemico, senza dare mai segni di stanchezza .
Alla stazione telefonica del centro di collegamento di Palijkisce si trovavano in servizio sette uommi del genio telegrafisti, di cui tre guardiafili, tre telefonisti comandati dal caporal maggiore Giannini Cesare. Il nemico, sempre in agguato, tentava di disturbare con i suoi tiri d'interdizione ogni nostra mossa sospetta. Durante un concentramento di fuoco, su Palijkisce la stazione te lefonica fu colpita, furono interrotte l e comunicazion i, ucc:tso un te l efonista e feriti gravemente altri tre.
Il caporal maggio re Giannini, resosi subito conto della gravità della situazione, impose calma al personale, fece restare al loro posto gli incolumi e trasportare i feriti a l posto di medicazione e poi ordinò il trasferimento degli apparati e lo spostamento dei circuiti in altra posizione più sicura, aiutando i compagni nelle materiali operazioni. Fece quindi eseguire dai suoi guardiafilì Archini Vittorio e Maugeri Sebast iano il pronto riallacci amento di tutte le comun icazioni telefo n iche i nte rrotte; operazione che fu sollecitamente effettuata nonostante il continuo f uoco di artiglieria.

A D osso Fa iti, presso un comando di Brigata in linea, era addetto in servizio di guardiafili il telefonista Fe rrante F rances co. Da più ore l'avversario aveva diretto su questa posizione il fuoco delle proprie artiglie r ie, allo scopo d'impedire l'uscita delle n ostre fanterie, che dov evano attaccare le posizioni nemic he.
Tut te le linee tel efoniche che facevano cap o a detto comando di brigata furono così interrotte. Senza bisogno di ordini e consapevole della urg ent e esige nza, il Ferrante uscì dalla stazione per riattivare l e comu nica zioni telefoniche interrotte, ma una granata n emica l o colpiva in pieno.
Con pari valore si comportaro no a Segeti i due guardiafili Bruno G iovanni e Da Vico Mario. Da otto giorni essi prestavano
continuamente il proprio servizio di sorveglianza alle linee che con frequenza venivano interrotte dai tiri di artiglieria. Il Bruno fu fer i to gravemente da una sch eggia di granata e, sebbene il comandante della stazione telefonica gli imponesse di andare a farsi medicare, egli si allontanò soltanto quando venne -sostituito.
Il Da Vico fu invece colpito da pallottola di shrapnell al polso, ma con sangue freddo, dopo essersi automedicato, ritornò a ripar a re le linee sotto la pioggia dei pro iettili.
A Dosso Fa iti gli uomini di una squadra telegrafisti sono colpiti da un pauroso fuoco di in terd izione Rimane isolato il comandante, sergente Ardemagni Francesco, che è contuso in varie parti del corpo. Questi, appena riavutosi, non perde un minuto di temp o e, att raversata la zona b at tuta dal fuoc o nem ico, ries ce ·a riparare le linee telefoniche interrotte, preoccupandosi soprattutto di mantenere efficiente il collegamento dell'osservatorio di Brigata con il comando di Di visione.
Naturalmente gli ufficiali telegrafisti non erano es tranei a siffatti esempi di coraggio, t enace vo lontà e spirito di sac rifi cio.
Per quelle azioni in corso era stato ass egnato a dirigere la costruzione di nuovi allacciamenti telefomci, per gli osservatori costruiti lungo le posizioni di re cente conquista, il tene n te Todaro Ugo, ed egli - non curante del pericolo ·- diresse con disinvoltura e tecnica perfetta i lavori ac cenna ti.
App ena sis tema ti i circ u iti vo lle assicurarsi d el loro perfe tto f unzionamento, andando di persona presso tutti gli osservatori, m a durant e una di que ste visi te, in un osservatorio a vanz ato , investito dallo scoppio di una granata nemica, riportò grave ferita.
La primavera del 1917 fu particolarmente movimentata per la r ipresa in grande stile dell e op erazioni offensive a cui pa rteciparono la 2" e da 3a Armata.

La Armata dov eva premere sul se ttore M. Kuk-VodiceM . San to -Al tu r e di Tivoli; la 3a Ar ma ta, invece, doveva continuare a forzare di fronte pel restante territorio, dal Vippacco al mar e.
Le azioni, che dura rono 19 g iorni, ci po r tarono a conquistare l ' im portante linea di sbarramento che ancora chiudeva le porte alla nostra meta : Trieste!
Gl i austriaci, nonostante l a pote nza di mezzi d ifensivi impiegati, dovett ero cedere all 'impeto delle nostre truppe . Ogni tentativo di contrattacco fu energicamente stroncato. E i te l egrafisti del genio emularono i fanti, protesi nel comune sforzo.
A quota 126 del Carso, un caporale del genio telegrafisti, Scuro Corradino, da più giorni prestava servizio con un apparec.chio ottico da campo. Into rno a lui piovevano bom be, fucilate, col p i di mitragliatrice, proiettili di ogni genere, ma egli se guiva imperterrito gli sbalzi dell e truppe attaccanti, assicur ando il loro collegamento con i comandi retrostanti e rendendo così preziosi servizi

In un delicato mom ento dell'azion e, a causa di un violento contrat taco nemico che aveva prodotto un 'inevita bile oscillazione d ella linea raggi unta, il capora l e Scuro, -r imasto m iracol osamente "illeso dallo scoppio di alcune granate e, rendendosi conto dell'assoluta necessità di assicurare il collegamento affidato alla propria stazione ottica che costituiva l'unico mezzo di comunicazione possibile in quelle particolari condi zioni, - con pronto e fe lice in tuito provvide a spos tare l ' appar ecchio in un tra tto di trinceram e n to abban don ato dagli austriaci e poi anche dagli italiani. In tale posizio n e, al quanto più riparata da l r abbioso tiro avversario, potè assicuare il collega men to con il Comando retrostante. L e nostre artigli erie poterono così intervenire tempestivamente ed il loro p ronto intervento potè stro ncare il contrattacco n e m ico e r i d are alle nostre tr uppe l a possibilità di av anzare.
Al capora l e Scuro venne concessa la medag lia d ' argento al va lor militare .
Lun go l e linee te lefoniche nel settore di Fiondar, occupato da pochi giorni dalle nostre truppe, faceva servizio il guardiafili S t anghe tti N azz a re no, il quale - con ze l o instancabile, sprezzante di ogni p ericolo, incit ando e é\nimando i compagni - si recava a ripa rare una linea t e lefonica inte rr otta dal ti r o nemi co. Colpito a morte e bbe ancora il coraggio di esor tare i compagni a che si prodigass ero n ella ric erca e n e lla pronta riparazion e dei gu as ti, che il nemic o aveva prodo tto lungo l e nostre linee . Alla di lui memo r ia ve nne concessa la meda glia al v"alor militare.
Il telegrafista Schiepati Amerigo venne mort alm ente colpito mentre, incurante anch ' egli del pericolo. si accingeva a stendere - sotto una tempesta di .ferro e di fuoco - una linea telefoni ca pe r collegare col retros tante comando il proprio reparto, che aveva appena occupato, dopo furibonda lotta, la posizione vivamente contesa dall'avversario.
34 - ll Comando della 3u Armata.
Una vicenda di guerra singolare, che mise in evidenza la tecnica e il va l ore di una compagnia telegrafistt, emerse dal seguente episodio.
Gli austr iaci, in seguito ad esat te informazioni, il 14 magg io· 1917 dire ssero contro il comando della Armata di Cervignano sedici proiettili a granata, con il cannone a tiro lungo, calibro 381. Fu maggiore la so rpr esa prodotta dall'inatteso regalo, che i danni subìti, ridotti allo sventramento di alcune case e alla interruzione di parecchi circuiti telegrafonici.
Il servizio era affidato alla 21"' compagnia telegrafisti, che immediatamente dispose per il ripristino dei collegamenti, mentre i centralinisti diedero bella prova di fierezza, rimanendo ciascuno al proprio posto.

Il Comandante della 3.. Armata dispose per il suo trasferimento a S trasso ldo. Col comando 'dell'armata dovettero spostarsi anche i suoi servizi, tra cui l 'importante centrale telegrafonica all a quale fac evano capo 145 circuiti telegrafonici.
Non fu perduto un minuto di tempo; la 21" com pagnia telegrafisti da una parte e il Commissariato telegrafico militare dal:l'altra p rovv idero allo spostamento dei circuiti anzidetti alla nuova centrale di Strassoldo, se nz a tuttavia interrompere il servizio dell e comuni cazion i, ed occultando al nemico l'esecuzione dei lavori.
Due giorni dopo la centrale e ra sistemata in luogo sicuro e definitivamente completata.
La 21" compagnia è perciò all'ordine del giorno nel quadro d elle op ere tecniche svol t e fra tutte l e compagnie telegrafisti durante la guerra.
Sul Piave si è rifatta l a storia d 'Italia, travolta da lla sventura di Caporetto.
Dovunque. nel doloroso ripiegamento, le nostre resistenze, a prezzo di generoso sangue, ritardarono l 'i nvasione nemica.
I repa rti del genio tel egrafisti dovettero affrontare problem! ardui, talvolta insuperabili, ma nessun dubbio, nessuna titubanza li fece vacillare, persuasi com'erano della gravità della situazione, che imponeva rapidità di decisione e di azione.

Fin dal pri mo momento dell'invasione austriaca, i comandi delle compagnie telegrafisti dovettero assicurare i collegamenti con Je unità che ripiegavano, trasportare il materiale non impiegato, distruggere le reti che a man o a mano resta vano inutilizzate e porre in salvo :. pri)D !:';
In quell e grav1 e difficili contingenze il G enio telegrafisti dovette improvvisamente organizzare un diverso impiego del materiale e degli uom i ni, molti plicando in ogni mo do l e varie atti vità.
Le compagnie in tere ssate direttamente nel ripiegamento furono quelle della 2•, 3• e 4• Armata. Anche nel rapido rincalzare degli avvenimenti. le com unica zioni più impor tanti furono mantenute, e se l acu n e si verificarono, esse dipesero da condizioni di tempo, di luogo e dalle condizioni metereologiche, cause tutte giuste di forza maggiore che furono tuttavia superate dai prodigi di volo ntà che ind istintame n te compirono ufficiali e telegrafisti del genio, per assicurare i collegamenti fra tutte l e truppe che combattevano ripiegand o ·
· Nel r ipiega men to al Piave innumerevoli furono gli episodi d i valore, che ebb ero per protagon isti anche i soldat de l genio telegrafisti
36 - La 38n Compagnia
telegrafisti.
All'iniz io della nostra offensiva (agosto 1917) erano stesi circa mille chilometri di linea in una rete omoge nea e perfetta.
Il lavoro degli osservatori, trattandos i di zona montuosa, aveva per la direzione del fuoco , somma importanza, e perciò furono
ri v olte speciali cu re perchè, in cas o d i rea zio ne d ell'artiglieria nemica, nes s ;.1no degli osservat ori r ima n esse i sola t o dai comandi di artig li eria da cui d ip e ndevano.
Olt re i te lefoni, an ch e l e sta zioni otti che e le s t a zioni radio pe r aviazion e, occorre n ti all ' artigli eria, ebb2ro q u ind i import a nza n otev ole pel b u on esi t o d e lla b at taglia .
Il 17 ag os to 1917 l e trup pe de l XXIV C. A. , efficacem ent e a ppoggi a te dall'artiglieria di medio e grosso cali b r o e dalle b ombarde ch e annientavano l e di fese au stri a che, passarono su lla sinistr a d e ll 'Iso n zo f ra Bo drez e A n ho vo In una ser ie di scontr i v it to r iosi d ur a ti fin o a lle prime g iornate di settembre, l e nost r e tru ppeconquistati il F r a tta , il Semm e r , lo Scedrik , lo Jel enik, e sup erata l 'accani t a .resis te nz a del nem ico - si affacc i a r ono s u tu t to l 'a ltipia no d ella Bains izza , co n sen te ndo così a l II C. A. di occu pare i] Mon t e Santo.

Al s u ccesso d i q u es ta opera zione validi ssimo fu il con tri b uto d ella p erfe tta organizz a zi one d ei collegamenti fra i co m and i e in particolar e fr a q u elli di a r ti glie r ia e l e fan t e r ie che av anz ava no comba ttendo.
Pe r s trade impervie, se nz a r iforn im enti, g l i u omini trasp art aron o a spalla, al seguito dell e fa nte r i e e d elle ar t ig lieri e, tutto H m a t erial e delle s t az ioni ed il fi l o n e cess ari o a i colle gamenti. La 38• compagnia tele graf isti riuscì nello svo l g imen t o s uccessiv o dell 'azio ne a ristab ilire i co n tatt i te l efon ici fr a l e artig lierie stesse ed i coma nd i rima sti s ulla v e cc hia linea.
T elegrafìsti ottic i sal iti a l S e mmer, al F ra t ta , a llo Sced ri k ed allo J eleni k durante l'avanza t a e l a conq uista d elle a n zidette posi zioni riuscirono a s e gnalar e il progred ire d elle trupp e a ll' art iglier ia r imasta n e lle v e cchie posi zio ni e che con tinuava a f ar fuoco, sfru ttando t u t ta la sua g itta t a .
Ques ti solda ti aff r onta rono il lo ro compito sotto i bombardam e nti n emici e sen za che p er q uattro g ior ni fosse possib ile riforni rli di viveri.
D urante la ba t ta g lia ca dd ero g l oriosamente a D r aga d i S . Spirito il capor ale Ma r i Martino, cinque soldati ed altri che n ella re lazione d el comanda nte la compagnia n on sono s t a ti precisat i.
Sul Mont e San t o i te legrafisti avevano funzi onato sin dai primi giorni d ell'ocdlp&zione, nonostante che molte lo ro stazion i telefon iche fossero state distrutte o danneggiate dal fuoco nemico, e fossero rimasti gravemente feriti numerosi telegrafis ti.
Il soldato Lecis Efisio, rimasto solo e senza viveri alla stazione ottica di quota 337 di San Gabriele, continuava instancabile il p r op r i o :>ervizio. Egli, b enchè lo ntano dal suo repa rto e t rovandosi nell 'impossibilità d i chi edere aiuti, ad empiva coscienziosan"ienLe la propria missione sino all'estremo d elle sue forze, rientrando poi alla sua compagnia estenuato e gravemente ammalato. Ricoverato all 'ospedale ed in seguito mandato in licenza, decedeva n e lla propria casa.
Anch e durante il ripie gamento, la 38" compagnia te l egrafisti asso l se il proprio dove re: soldati ed uffici ali formarono un unico fascio di volontà, attorno a l comandante che serenamen te dir esse la difficile opera, mettendo in salvo gli apparati delle stazioni. senza subire il travolgimento delle truppe in ritirata e senza sbandamenti.
Tutti i t elefo nisti del Veliki ed il telegr afista ottico della stes: sa stazione furono amm irevoli n el d i simpegnare il servizi o fino all' estremo, e i guardafili di Bodrez si accanirono fino all'ultimJ nel ristabilire le comunicazioni schiantate dal tiro tedesco.
Fu anche enco miabile l'opera del comando di compagnia che, nei g iorni 25, 26 e 27 ottobre, nulla lasciò d'intentato p er mettere in salvo la maggi or e quantità di materiali depositato al Ponte di Bodrez ed a Senico.
Che cosa dire dei militari lasciati a guardia dei magaz zini di Senico e, successivamente , di Casale Spessa , i qua li si ritirarono soltanto dopo aver d ato alle fiamme, sotto il tiro della fucileria nemica, tutto quello che non era possibile trasportare?
Che cosa dire dell 'umil e te legrafista Mauservizi B erna rdo, apparecchiatore (già encomiato per p re ced ent i atti di che il 25 otto b re 1917. in piena ritirata. ritornava alla conca Vhr dist ruggendo l a centrale telefonica del co mando tattico di arti glieria e raggiungendo poi , sotto le raffiche della mitragliatrice, la propria compagnia?
Che cosa dire d ei te l egrafisti d e lla 38a compagnia ad detti alla

centrale telefonica del 46° Artiglieria da campagna che, per ben du e volte, insieme con a rt iglieri e carabinieri si lanciavano alla ba ione tta per rin tuzz ar e l'audacia dell e pattuglie nemiche uscite dali 'Ossoinka?
Che cosa dire, infine, del telegr af ista Cartotto Mario, addetto alla stazione ottica deUo Sce drik , il quale, rimas t o al proprio posto e ci r condato dal nemico, riusciva a tarda notte a sfuggirgli e, servendo da guida ai compagni, riusciva a raggi un gere la compagnia, portando in salvo l'apparecchio ottico?
37 - La 35" Compagnia flelegrafisti.
E' interessante far conoscere di quanto zelo e quanto magnifico senso del dovere furono animati costantemente soldati, sottufficiali e ufficiali della 35"' compagnia telegrafisti, dislocata nella zona dove avvenne lo sfondamento austro-tedesco.
Squadre di telegrafisti addette all e stazioni telefoniche erano dislocate ovunque: a Slemo, presso il comando della 10a divisione; c quota 920, dove si trovava l'osservatorio del XVIII C. A.; a Canale, presso la centrale telefonica; sul Velik Vrh Velo osservatorio di sinistra d ello stesso Corpo d'Armata; a Monte Kalì presso il comando tattico delle riserve; e infine a Villa Rubini dov e esisteva una centrale telegrafica e un centralino telefonico a 50 lin ée.

La rete delle comunicazioni telegrafiche e telefoniche era completata da 32 stazioni ottiche fin presso i reggi· menti in linea.
Nonostante che i centri telefonici sopra nominati fossero situati nelle zone più esposte, continuarono svolgere fino all 'estre · mo il loro servizio sotto l'incessante bombardamento nemico.
Ad un certo momento i posti avanzati furono distrutti, mentre gli alt ri, i cui circuiti continuamente interrotti, venivano sollecitamente riattivati con nuovi stendimenti eseguiti sotto il t iro d ella fucil eria n emi ca.
Alle ore l del 24 ottobre 1917 il Capo di S. M. del C. A. avvertiva il comandante della compagnia che alle 3 gli austro-te-
desch i avrebbero iniziata l'offensiva, facendola p re ce d ere da bombardamento, e soggiungeva che il comando tattico non avrebbe più potuto por tars i a ll'o sserva tor io dello Scedrik, ma che inv ece era necessario collega r e otticamente la det t a locali tà con l a sede d el C. d ' A in Lozice.
E ssendo l a d ista nza fra lo Scedrik ,e Lozi ce maggio re della portata dell'apparecchio ottico, fu necessar io imp ian tare una stazion e ottica in terme dia sullo J elenik, cosa che solleci tamente eseguita nonostante che la fosse intensamente battuta dal fuoco avversario.
L'attacco nemico t rav olse tutta la rete ottica, impiantata presso il 38° Fanteria lungo la Valle dell'Aucek a quota 920: in quei luoghi i telegrafisti diedero numerose prove di eroismo e di fedeltà alla consegna. rimanendo sino momento al proprio posto, tanto che pochi di essi si salvarono.

Seguirono la stessa sorte i telegrafisti comandati presso l e stazioni ot ti che di Citovnik, Leupa e Velik-Velo. _
Alle 3 la situazione si aggravò e le comunicazioni telefoniche tra il C. d'A e la 49a Divisione vennero gravemente interrotte dal tiro dell'artiglieria nemica, che rese inservibili anche molti apparati e materiali di stazione
Gli avvenimenti incalzavano, ma era necessario mantenere ad ogni costo i collegamenti.
Si impiantarono perciò nuove linee: la 49a Di\rrsione, ai Molini di Ausoek, dopo soltanto un'ora em già in collegamento con il C. d'A., sebbene i lavori di stendimento delle linee fossero osta-colati dal ti·ro d ell'artiglieria nemica, che impiegava anche proiettili con g;as asfissianti, m e ntre la ùivjsione ,er:a costretta ad indietreggiar e, lasciando sul pOiSto un comando d.i brigata.
Al Comando della 35a Compagnia telegraf is ti giunse intanto la notizia che le stazioni di Ronzina , Auscek ed Auzza erano state d istrut te dal bomba r damento che aveva provocato anche un mcendio. I telegrafisti superstiti delle tre stazioni d is trutte, sfidando la bufera del fuoco , rientrarono alla propria compagnia a Canale.
Intanto gli ordini s i susseguivano .agli ordini. Il Capo di S. M. alle ore 8 del giorno 24 avv er tì il comandante della compagnia
che la Brigata Treviso occupava il vallone Po tek Potok, e che la Brigata Palermo occupava l'Ossoinka a protezione del fianco sinistro del C. d'A.: si rendeva perciò indispensabile e urgent e collegare i due comandi di brigata rispettivamente con le centrali di Canale e di Vhr.
Alle ore 15 il comandante della compagnia fu chiamato dal Capo di S. M. il qua le gli comunicò l'ordine di collegare le seguenti unità con la centrale di Canale:
l) La brigata Bersaglieri del generale Bogliani (che intanto nella notte valorosamente era ri uscita a rioccupare il Globokak):

2) la brigata Lambro (che si doveva schi e rare fra Loga e Fratta);
3) la brigata Treviso (che si trasferiva dal "l='otek Potok al San Pet er).
L 'artiglieria austriaca era riuscita a distruggere le no stre difese, ma non l'ardore dei no stri fanti e dei telegrafìsti che, con sollecitudine esemplare, riuscirono ad effettuare tutti i predetti coJlegamenti in tempo utile, nonostante il continuo tiro delle artig lieri e nemiche.
A 1,;mlla valse l'opera d ei comandanti e dell e truppe che cercavano di contrastare l'azione del nemico, che avanzava in forze e fu necessario di conseguenza ordinare, con il ripiegamento, il ritiro dell e s t azioni ottiche dag li osse rvator i avanzat i della 10a e della 68a divisione.
A Vhr una granata incendiaria aveva colpi to il cen tralino, distruggendolo e la posizione stessa cominciava ormai ad essere investita dalle raffiche delle mitragliatrici nemiche.
All e ore 11 del giorno 25 la stessa posizione era insostenibile e fu ordir.ato al personale che l'occupava di ripiegare, il che avvenne sfuggendo all'accerchiamento del nemico che avanzava dal Vallone di Auscek, mentre i telegrafisti fecero in tempo a ritornare alla propria compagnia dislocata a Canale.
Analoga disperata situazione si verificava alla centrale dello Scedrik, colpita e distrutta dal tiro delle artigli-erie nemich e . Il comandante della compagnia, in relazione agli ordini del comando
delle truppe operanti, ordinò, a mezzo eliografo, al proprio personale di distruggere il materiale che non poteva essere messo in salvo e di r ip i egare per l'unica strada possibile, che era quella di Bate, pure b attuta dal tiro avve rsari o.
Alle 14,30 g li uomini comandati ai centralino di Ossoinka, per ordine de l comando della 68a divisione che ripiegava, dovettero ritirarsi, ma lungo il cammino pochi riuscirono a sottrarsi alla cattura del nemico. Soltanto un ufficiale e gli uomini copresso il comando della lQ& divisione, ritirati gli apparecchi elettrici ed ottici nella conca di Slemo, riuscirono a mettersi in salvo insieme con i soldati del comando della Divisione, passando per il Vodic e e Plava.
La sera del 25 ottobre il comando del C. d'A. si trasferiva a S. Jacob, mentre gli avvenimenti precipitavano.

Alle ore 19 il ten. colonnello Levi, ispettore telegrafico della 2A Armata, assunse la direzione del servizio telegrafonico ed alla stessa ora, venuto a conoscenza che nessuna delle stazioni corrisr,ondenti con Canale rispondeva più alle chiamate, ordinò di togliere anche tale importante stazione telegrafonica.
Partiti da Canale gli ultimi superstiti della 35,. compagnia, rimasero sul posto il tenente colonnello Levi e il tenente De Martino della d etta compa gnia, che avevano chiesto e ottenuto l ' incarico di far saltare i due ponti a valle di Canale, non appena le retroguardie foss ero passate sulla destra dell'Isonzo.
Il primo ponte, a valle, fu fatto saltare alle ore 18 del giorno 25, perché ormai inservibile; alle ore 16,15 del giorno 26, dopo che tutte le trupp e si erano messe in salvo, fu dato ordine ai disporsi a difesa dell'accesso all'altro ponte. La truppa si era già schierata per la difesa, quando una granata incendiaria colpiva il ponte, incendiandolo.
Le fiamme stavano per propagarsi, minacciando le cariche delle mine. A qu esto punto i due ufficiali del genio ordinarono alle truppe di ripassare immediatamente il ponte e, dopo essersi assicurati che nessun soldato era rimasto sulla sinistra del fiume, dopo aver passato per ultimo il ponte già invaso dalle fiamme, p1 ovvidero a far buttare l e cariche, facendo così crollare rovinosamente il ponte.
Te rritorio della l a A rmata - La 411 Compagnia te legrafis ti.
Nel settore della 5a Divisione di fan t eria, n ella regione del Tonale, il gi orno 23 se ttem bre 1915 una squadra dl dieci uòmini, comandata da UJ! ufficiale, a ttendev a alla cos tru zione di una linea telefonica vo l ant e fra il Torrione e Mon t ozzo. Mentre si svolgeva lo stend imento, la· posizione d el Torrione subiva un violentissimo bo m bardamen to , qui ndi, reso si impossibile mantenerla, dovett e €'ssere abbandonata dai nostri.
Le truppe si schierarono sulle posizioni dell' A lbio lo p er op· p orsi ad un probabile a tta cco delle fanterie n e miche.
I telegrafisti ad de tti allo stend imento, guid a ti dal loro co· mandante, si uni ron o con gli alpini, tene ndo testa al nemico, che orma i d al Torrione bat teva l'A lbi olo, oltre che con l'artiglieria, anche con raff iche di mitragliatrice.
Alla sera gli ufficiali dell a 4a compagnia telegrafisti con le t ruppe d elle alt re armi, prese ro parte al contrattacco per rioccupa re le posizioni perdute e coadiuvarono gli alpin i e gli artiglien al ricupero dei p ezz i da montagna. T anto fu il loro ardi men to che si portaron o con una mitragliatrice fin sotto la posizione aus tri aca, sostando in prima linea per parecchi giorni e prendendo parte attiva a tutte l e azioni tendenti alla rico nquista d el Torrion e.
Un plotone della stessa compagnia distaccato allo Stelvio stava cos truendo il giorno 29 settembre 1915 alcune linee telefoniche Una batteria situa ta in quell a posizione fu assoggettata tutto il gior no ad un intenso fuoco nemico, che costrinse i serve n ti u.d allontanarsi per cerca re rip aro . Uno d ei soldati di quel ploto ne telegrafisti si offrì spontaneamente e col suo esempio indu sse gli uomini della batteria a r itornare al proprio posto.

Cap. IX
I TELEGRAFISTI DURANTE LE OFFENSIVE AUSTRIACHE
39 - Altre compagnie telegrafisti sull'Altipiano di Asiago.
Le compagnie telegrafisti (23. 24. 37. 32. 40. 39. 34. 44. 56. 36. 102. 128. 157.) che ebbero la ventura di appartenere. sia pure per breve tempo, alle grandi unità che operavano sull'Altipiano di Asiago, furono sottoposte a sacrifici di ogni genere, per la natura impervia del terreno, il clima invernale rigidissimo e l'ostinatezza del nemico che tormentava con continui attacchi tale !'ettore.
L'importanza di quella zona crebbe in seguito all'offensiva austriaca del maggio 1916, diretta e limitata ad est del Brenta, a sud della pianura vicentina (da Bassano ad Arsiero) e ad ovest dall'Asti co.

Fino al maggio 1916, l'Altipiano era p ressoché privo di comunicazioni telegrafiche e telefoniche. Non appena costituito, in tale epoca, il Comando Truppe Altipiano di Asiago, che ebbe il grave compito di fronteggiare la «spedizione punitiva austriaca» e di passare poi alla controffensiva, furono assegnate ai quattro Corpi d'Arma ta XIV-XVIII -XX e XXII sei compagnie telegrafisti e cioè: la 23; 24; 37; 32; 40; e la 39, quest'ultima alle dirette dipendenze .del predetto Comando.
Tali compagnie provvidero, sin da quando imperversava l'offensiva austriaca, a costruire le reti telegrafoniche, tanto s0llecitamente che ai primi di luglio funzionavano già i circuiti telegrafici che da Enego per Rendole, Campiello, Pria dell 'Acqua ,
100
Asiago, Bertico, Gallio, portavano a Foza, per un totale di c1rca 150 km. di lin ee telefoniche permanenti, 100 km. di circuiti telegrafici e 600 km. di linee campali In queste cifre sono compresi 1 tratti dei circuiti esiste nti prima d el maggio 1916 utili zz ati p er la costruzion e delle nuove reti telegrafoniche.

Nel dicembre 1916, con le unità del Comando T ruppe Altipiano di Asia go, si costituiva il Coma ndo d e lla 6" Armata.
L'Armata comprendeva allora tre C. d'A.: il XXII (con la 32a e 40" compagnia telegrafisti); il XX (con la 34a e 37• Com pagnia telegr a fisti); il XVII (con la 33"' e 44.. comp. telegrafisti) che operavano dalla Val d'Assa, per l'Altipiano di As iago e la Valle di Campo Mulo alla Val Sugana dalle falde di Civaron, per la Co nca Tesino, al Ci mon Rev a - Forcella Magna di Primiero. E' facil e immaginare quali e quante difficoltà dov ette ro superare quei reparti per costruire o ripristinare l e comunicazioni telegrafiche e telefoniche in modo da re sistere a lle inclemenze d ell'inverno. L a n eve raggiunse nell' inverno 1916-1917 l'altezza di un metro sul margine aell 'Altipiano e più di tre metri a nord di Asiago, Campo Mulo, Malcesina e Castel T esino.
Il trasporto del materiale quando era possibile veniva fatto <:on slitte e con muli e talv olta anche a spalla dai telegrafisti, superando dis livelli fortissimi.
Come era prevedibile, gli elementi avversi dalla natura danneggiarono in gran parte i circuiti tanto pazienteme nte impianta ti, ma, non stante tutte l e diffic oltà le compagni e telegrafisti stabilirono e mantennero in servizio sempre e dovunque i colleeamenti occorrenti. Furono pure costrette a sostituire gran par te dall'armamento, e cioè circa 1400 km. di linee, e per ogni palo da impiantare, prima di fare le buche nella roccia durissima, gli uomini dovevano togliere fino a 2 o 3 metri di neve. Il lavoro durò ben tr e mesi e vi contribuirono prima sei e poi otto co mpagnie teleg rafisti, affrontando ogni sorta di disagi.
Si stesero linee permanenti a 2000 metri di altitudine, attraverso valli e canaloni pieni d i neve, si gittaro no campate di 151) metri (conduttori sos t enuti da funi di acciaio) e, per superare forti cHslivelli, si ricorse ai cavi armati che risalivano pare ti di rocclcl
quasi verti cali come la linea che da Caoria portava alla quota 2490 del Cauriol.
Tutti i Comandi ed i reparti più avanzati vennero collegati con più linee a tracciato differente.
Nella primavera 1918 e cioè dopo il ripiegamento di Caporetto, pu r col raccorciamento del fronte; i collegamenti ebbero maggior incremento: in 60 giorni e con circa 600 uomini a d is posizione si completò una rete di 3000 km. di linee permanenti e 4000 km. di linee volanti, sussidiate dalle reti ottica e radiate· le grafica.
Durante l'offensiva austriaca del giugno 1918, le compagnie tPlegrafisti fu rono degne di ogni elogio per il faticoso lavo ro eseEuito, ri u scendo in ogni posizione a mantenere in efficenza i col· legamenti.

E' accertato, per esempio, che alcune stazioni ottiche della JJ4• Compagnia continuarono a funz ionare in p rima linea nei momenti più cri tici, tanto da esse re travolte dall'impiego del nemico quando riuscì ad irrompere nelle nostre prime linee.
Alcune centrali telefoniche per il servizio di art iglieria do•.rettero restare in continuo servizio durante gli attacchi svolti con gas asfissian ti. Per il comportamento dei telegrafisti in tali circostanze, meritarono l'e ncomio solenne la 37" e 102" Compagnia t e legrafis ti del Corpo d'Armata, ed altri encomi ebbe r o la 128· 114•, 157"' e la 6" Sezione radiotelegrafica.
Furono inoltre distribuite tre medaglie al valo re militare sul cctmpo e furono inoltrate 45 proposte per ricompense al valor militare ai telegrafisti che più si erano disti nti.
40 - Offensiva austriaca del giugno 1918 - La 33a Com!)agnia telegrafisti.
Con regolarità cronomet rica, il bombardamento austriaco col· pì Lamone in Valsugana dove le nostre truppe in trincea resi· stettero con valore e tenacia agli assalti dell'avversario, che si npetevano inin terrottamen te.
Nuclei di soldati telegrafisti della 33" Compagnia, che do-
vettero ripiegare le stazioni telefoniche avanzate, non rientra rono nel reparto , ma si schierarono volontariamen te in linea con i fanti. I combattimenti si ripeterono e l ' urto fu sostenuto mirabilmen te anch e dai telegrafisti , che in più tratti del trinc eramen to nella lotta corpo a corpo, impugnarono l a baionetta a guisa cii pugnale.
Sul Monte Lisser (Altipiano di Asiago) era impiantata una stazion e ottica con du e soldati telegrafisti, i quali, incuranti delruragano di fuoco, continuarono imperterriti a trasmettere, allo scoperto, gli ordini del Comando ai reparti che combattevano.
Una granata esplose nelle vicinanze della stazione, colpendo con una scheggia un telegrafista, che immolò così la sua giova. ne vita.
N e i giorni che videro le eroiche difese di Col d'Ap rile, Col nella Berretta , Monte Pertica, Monte Asolone e Monte Solarolo, l& 33' Compagnia teleg ra fisti, nonostante la scarsità del mat er:a l e e i continui spostamenti sotto intensi bombardamenti, mantenne nelle località anzidette la co n tinuità de i collegamenti, riuscendo di valido aiuto all e truppe operanti. Durante la ritl!·ata i plotoni dei t elegrafisti , che erano stati lasciati indietro, ripiegarono lentamente, mantenendo 11 collegamento delle retroguardie con le altre truppe e ponendo in sal vo quasi tutto il materia l e telegrafonico .
Ad Arsiè i telegrafisti si ritirarono per ultimi e le comunicazioni furono tolte soltanto quando apparvero le prime p a ttu glie nemiche e finch é non fu fatto saltare il ponte sul Cismon. L 'Ufficiale telegr afìsta che comandava questo plotone fu proposto p er una ricompensa a l valore.
41 - La 133a Comp ag ni a tel egrafi sti.
Il 21 giugno 1918, gli austriaci nel settorP fra l'Altipiano di Asiago e la foce del Piave, premendo disperatamente con la s peranza di passare, r iuscivano a stab ili re presso Losson un saliente minaccioso. Li fronteggiava il II Battaglione del 209° Rgt. fanteria,

che fu subito collegato, da una squadra telegrafisti della 133a compagnia ad un centralino telefonico situato a Castelleto Sud.
In tutta la giornata del 21 giugno, l 'eroico battaglione ne l'urto d'impetuosi attacchi, e passarono per quell'unica linea telefonica tutti gli ordini e le comunicazioni riguardanti la bat· taglia.
Nel pomeriggio il nemico, con un nuovo violento attacco di sorp resa , riusciva quasi ad accerchiare il battaglione, che non poté chiedere il tempestivo aiuto dell'artiglieria, per la temporanea interruzione della linea telefonica, causata dal tiro avversario.
Mentre tutto il p ersonale del Comando di Battaglione impugnava le armi per l'es trema difesa, i guardafili della 133" Compagnia, con sprezzo del pe rico lo , individuavano le interruzioni e le riparavano.
Poté così. giungere alle nostre artiglierie la richiesta di fuoco del Battaglione co n conseguente immediato intervento che consentì di ristabilire l'equilibrio della situazione e di respingere successivi attacchi nemici.
42 - La 3a Compagniia telegrafisti.
Ques ta compagn ia apparteneva alla 2" Divisione ma, poco dopo il ripiegamento di Caporetto, fu assegna ta al 14° Corpo Britannico che occupò, success ivame nte, i settori: Piave, Altipiano J: Asiago.
In questo ultimo settore, alle ore 18 del 15 giugno 1918, durante l 'offensiva austriaca, sotto l'imperversare della furiosa lotta sostenuta dalle artiglierie avversarie, tutte le comunicazioni telegrafoniche vennero inter rotte , e fu isolato così il Comando della Brigata Pavia che operava in accordo colle truppe inglesi nella regione di S. Biagio d i Collalto.

Il Comando della 3a Compagnia telegrafisti dette ordine al sergente Giuliani Aurelio di recarsi presso quel Comando di Brigata, per rendersi conto delle necessità occorrenti e per ripri· sti nare le linee telef oniche.
Il sergente Vl accorse servendosi dell 'autocarro della Com-
pagnia, ma ad un certo punto della strada dovette retrocedere, poiché alcune infiltrazioni nemiche impedivano l'ulteriore transito.
Il Giuliani, con gli uomini messi a sua disposizione dal Comandante della Compagnia, procedette a piedi verso il Co mando di Brigata, che, per un momentan eo arretramento, aveva spostat a la propria sede. Sulla strad a, intanto, veniva costituendosi uno sbarramento, con mitragliatrici ed un pezzo di artiglieria. Il sergente Giuliani oltrepassava volontariamente tale sbarramento, e quasi isolato, so tto il grandinare delle pallottole, provvedeva al sollecito riattivamento delle linee, rendendo così possibile l'immediato collegamento fra - il Comando di Divi sione e quello di Brigata.
Ultimato il suo lavoro rientrava alla Villa Cucca; la ripresa dei collegamenti rese possibile al Comando di organizzar·e i l contrattacco e di respingere il nemico verso Ca ' Martini.
43 - La 11411 Compagnia tel egrafisti.
A l contrattacco degli italiani per ricacciare gli austriaci nel· le posizioni di par te nza concorse validamente anche la 114• Compagnia, che prestava servizio presso la 14• Divisio ne nella regio ne dell'Altipiano d i Asiago, e cioè a Cima Echar - Valbella - C ol del Rosso.
All'operazione, che ebbe svolgimento dal giorno 28 giugno. parteciparono squadre formate appositame n te da t ale Compagnici e all'u0po istruite: esse seguirono il movimento delle colonne <:tvanzamenti e provvidero a l collegamento ottico e telefonico fr a queste, i Comandi tattici e l'artiglieria interessata.

I t elegrafisti divennero ancora fanti guidati impavidame nte dal sot tot ene n te Battisti Luigi che cadde sul campo colpito a morte da granata nemica.
44 - Nella zona del Piave
Prima di na rrare gli e pisodi di valo re d elle div erse Compagnie telegrafìsti durante la battaglia del Piave , citerò l'elogio aù esse tributato dal Comandante della 3• Armata; il Duca d'Aosta.
Esso venne indirizzato al Comando del Genio dell'Armata, e resterà scolpito a lettere d'oro tra le belle pagine scritte dal Genio telegrafisti nella guerra 1915-18.
«Ho constatato con vivo compiacimento, la precisione con la quale si è svolto il servizio telegrafico, telefonico e radiotelegrafico, durante l e giornate della battaglia del Piave e mi rendo conto pienamente delle difficoltà che furono superate, perché il servizio stesso procedesse così bene.
« La massa e l'urgenza delle comunicazioni , i danni del tiro, il fluttuare delle nostre linee, avrebbero gius tificata qualche de · ficenza nel complesso e delicato servizio delle comunicazioni elettriche e il non essersi questo verificato è vanto delle Compagnie telegrafisti, che non risparmiaro no zelo, attività, intelligenza nel fare funzionare la folta rete telegrafon ica. ·
<<Mercé l'abnegazione ed il largo tributo di sangue del personale telegrafico, per tutta la durata della dura e lunga battaglia, furono sempre assicurati i collegamenti di capitale importanza fra i comandi e di questi con le truppe, fra i vari organi dell'artiglieria , fra queste e le fanterie e con gli aerei. Spetta perciò ai telegrafisti la loro parte nel merito e nella gioia per la vittoria.
«Mentre informo di aver pregato il Comando Supremo di voler ricordare in qualche comunicato ufficial e l'op era dei telegrafisti (e specialmente della 135• e 158" Compagnia) sono lieto d; esprimere a tutti i telegrafisti e radiotelegrafìsti dell'Armata la mia soddisfazione e la mia più ampia lode, e prego codesto Comando di portare a conoscenza di tutto il personale telegrafonico queste mie parole.
F / to Emanuele Filiberto di Savoja )).
Le Compagnie telegrafìsti che meritarono l'elogio del Duca ci'Aosta furo no tutte quelle che in quell'epoca appartennero alla 3 Armata e cioè : la 10. 18. 21. 45. 46. 55. 60. 62. 103. 104. 107. 111. 123. 125. 131. 133. 137. 145. 158., infine la 3a Sezione radiotelegrafica.

Dal gennaio al giugno 1918, le C ompagnie telegrafisti dis l ocate lungo il fronte del Piave, ebbero tem po sufficiente per realizzare una ricchissima rete telegrafonica, a circ ui ti mutipli.

Tutte le diffic oltà furono superate con instancabile lena dai telegrafisti del G enio. I collegamenti, dal più urgente al meno urgente, ebbero pronto fun zionamen to a filo di r etto senza intoppi o arresti, con il vivo compiacimento dell e unità combattenti.
I più duri sacrifici furono imposti, naturalmente, alle compagnie tel egrafisti divisiona li l e cui linee telefoniche erano sovente interrotte dal tiro nemico.
L ' ondata impressionante delle colonne nemiche avanzant i è prossima ad impossessarsi dell e stazioni ottiche di prima linea?
I gas asfissianti e qualli lacrimogeni tormentano le stazion! telefoniche avanzate?
Non importa: le stazioni ot tiche saranno travolte ma avranno funzionato sino all'ultimo, l e stazioni telefoniche cesseranno la loro attività, gli a pparec chi saranno distrutti, ma i telegrafi&ti del G enio impugneranno il moschet to, schierandosi con i fanti in trincea oppure concorreranno alla difesa delle nostre arti· g l ierie.
Innumerevoli furono gli esempi di dedizione al dovere: ad ese mpio una squadra di telegrafìsti sorpresa e circondata d al nemico, non disponen do di altri mezzi per dare notizie, le trasmise per 36 ore di seguito con un apparecchio geo telegrafico.
Così pure l e stazioni telefoniche avanzate su b irono l 'ur to delle prime ondate nemiche, ma quei pochi telegrafisti seppero d;.. fend ersi col moschetto e la baionetta.
Nuov a g loria si conquistarono i guardafili, ch e, per tu tte le l unghe giornate della strenua lotta, sotto violentissimi bombardam enti, garantirono le trasmissioni anche con nuovi circu iti stesi sot to l' imperversare del fuo co nemico.
Invero, la fluttuazione de i reparti avanzati e di quelli che accorrevano di rincal zo, era seguita n elle sue alterne vicend e dai b ravi guardafili, che procuravano loro il mezzo d i poter comunicare con i comandi retrostanti. Fu loro sommo onore se neppure un apparecchio telefonic o rimase in possesso del n emico.
Anche là, dove l'imprerversare della b attaglia aveva impedito di servirsi di apparecchi elettrici e della telegrafia a segnali,
i telegrafisti del Genio si trasformarono veri e prop ri combattenti schierandosi talvolta con i bat taglio ni operanti. Molti telegrafisti caddero nell'adempimento del proprio dovere, altri ebbero le carni straziate, altri caduti prigionieri, af frontarono la morte, pur di poter ricon gi ungersi alla propria Compagnia.
A Fagaré, Ca' Ninni, Fornaci di Monastir, Palazzotto, interi plotoni di telegrafisti, a conta tto con le truppe austriache, sepp ero arditam ente rintuzzare il loro impeto, difendendo fino all' es tremo le posizioni occupate e condividendo la gloria del fante.
A Salettuol, in un osservatorio avanzato di arti glieria, face· vano servizio come guardafili du e solda ti del G enio Telegrafis t i , Capannotti Mario e Maggio Silvio . Durante un at tacco nem ico, tendente a conquistare la riva del Piave, essi disimp eg narono serenamente il loro s ervizio e , successivamente quando i nostri ar, tiglieri furon o costretti ad abbandonar e l 'osservatorio, vol ontari ame nte si unirono all;l Brigata di fanteria che in quel mom ento passava alla controffensiva. Duran te l'avanzata il Maggio rimase ucciso dallo scoppio di un proiettile, il Capannotti invece, dopo aver dato prova di eroico slancio duran te l 'attacco alla baionetta, nella foga della battaglia fu fatto prigioniero e provvisoriamente collocato con altri in un isolotto della Pi ave vecchia. Ma riuscJ poi a fuggir e e a raggiungere, dopo inaud ite fatiche e pericoli , la nostra sponda destra già sgombra dal nemi co.
Nell'infuriare del combattimento il sergente Rebagliati Al essio e il soldato Racchi F ernando , a casa Girardi, sfidarono div erse volte la morte per uscire a riparare i circuiti tèlefonici.
Una granata di grosso calibro, distrutta la stazione ed uccis i gli altri compagni, non li fece perdere d'animo: i due generosi tel egrafisti rimasti miracolosamente salvi, si adoperarono imm ediatamente per riparar e alla meglio i danni alle linee e agli apparati, pur di mantenere quel collegamento che rappresentava la salvezza di tutti.
Un ufficiale che m er ita di essere segnala t o. per il suo brillante comportamento in quelle tempestose giornate, è il tenen te Ricci Vincenzo, comandante di un plo tone telegrafisti dislocato a Ca' la Campagna.

Quest'ufficiale si adoperò fin dai primi giorni dell'offensiva austriaca, affinché la rete te l egrafica ed ottica che era alle sue d ipende nze non avesse in t erruzione di sorta.
· Nel mom e nto più critico della lotta, che parve dare agli austriaci la prevalenza, numerosi sbandati de lle unità in linea furono fe r mati dal t enent e Ricc"i che li riunì e , rincuorandoli , si mise alla lo r o t e sta, ripo r tandoli sulla linea del fuoco.
Ma continuiamo a raccontare gli episodi più importanti.
N el settore di Fossalta, dove il fuoco nemico bruciava ogn1 palmo di t erre no, esisteva una s t azion e intercettatrice italiana, colpita, fu m e ssa fuori servizio. Il Comandante de lla Divisione diede ordine di rimet t erla in efficienza.
Il Comandan t e la Compagnia t elegrafis t i non sapeva chi mandare, non essendovi disponibile personale specializzato.
Il telegrafis ta Parini Primo, benché ammalato, conscio della imper iosa n e cessità, partì volontariame nte, incuran te del suo male p e r ripris t inare la stazione danneggiata.
Dopo essere riuscito a ripararè l'apparecchio, sotto il tiro dell ' artiglieria nemica, s t endeva allo scoperto le nuove linee di presa di terra per assicurare l 'intercett azione.
Frattanto p enetrazioni nemiche riuscirono ad arrivare sin presso il Comando del R e ggimento trinc e rato in quel settore.
Il Parini dalla sua buca di talpa, mentre stava in ascolto per interceUare le notizie del n emico, intui la sfavorevol e situazione dei nostri. Armatosi di moschetto si pose alla testa di una nostra pattuglia di fante ria e riuscì alla fine ad aver ragione dei nuclei nem ici avan zati.
Due suoi compagni , i soldati P aoletto Antonio e Sbarbaro Gio Batt a , sotto l'uragano di fuoco che martellava e sconvolgeva ogni difesa, d ovettero uscire d a lle stazioni pe r riattiv are co n sollecitudine le linee i n terrotte.
Tutti e du e rimasero feriti gravemente fra Osteria Fossalta e Ronche di Piave; ma con generoso ardimento voll ero rim anere su1 posto, con grave pericolo della loro vita, sino a che non furono riattivati i circuiti telefonici.
Al Parini, al Paoletto e allo S b arbaro fu concessa, in p remio del l oro comp ortamen to , la medaglia d'Argento al v a lor militare.

Sul tratto della sponda destra del Piave il nemico poté pe· netrare nel settore difeso dalla 61 " Divisione .
Gli austriaci infatti riuscirono, in quel tratto, raggiungere il torrente Meolo.
Naturalmente fu la .zona più aspramente contesa: si doveva ad ogni costo fermare il nemico e riccacciarlo sulla sponda di partenza.
Nel settore operava la 158" telegrafisti. Pe r l'approssimarsi del nemico, il Comandante della Compagnia impartì ordini per il ritiro (in quanto possibile) del materiale del parco -e di quant'altro stava per cadere nelle mani dell'avversario.
Allora il sergente Moletto Michele, dopo essersi prodigato con una squadra di telegrafisti per riparare i circuiti telefonici mterrotti dall'infuria re della battaglia, benché ferito e bisognoso di pronte cure, si accinse a porre in salvo il parco, facendosi aiutare da aucuni compagni.
Medicatosi alla meglio, si pose quindi a disposizione del Comandante di Compagnia, che gli affidò l ' incarico di altri ciamenti telefonici.
A Paludello sul Piave era collocato, presso il Comando · di Reggimento che operava in quel settore, un centralino telefonico col caporalmaggiore Bettoni Cesare ed alcuni soldati telegrafisti.

Nell'i!llperversare d el fuoco nemico la calma del bravo graduato dinanzi al pericolo, servì di esempio ai suoi uomini che continuarono a disimp egnare il servizio.
Una raffica di mitragliatrice si abbatté sulla stazione telefonica, ed una pallo ttola penetrando nell'interno, colpì a morte Jl centralinista di servizio, che cadeva fra le br-accia del Bettoni.
Questi continuò a mantenere le comunicazioni, infondendo · nuova energia ai superstiti.
A Fornaci di Monastir altre prove di audacia dettero duè nostri telegrafisti : il Caporale Porzio Francesco e d il marescial10 Beccattini Vi ttorio; quest'ultimo, capo del servizio de i collegamenti di quella località.
Come su tutto il resto del Piave anche alle Fornaci di stir il nemico aveva diretto un violentissimo bombardamento, dJstruggendo anche molti circuiti telefonici.
Ma il servizio non permetteva nessuna sosta ed i bravi guar. dafili continuarono a mantenere i collegamenti che tanto urgevano.
11 Comandante del reparto d'assalto per il quale i nostri telegrafìsti prestavano il loro servizio rilevò, encomiandolo, questo spirito di sacrificio, tanto più significativo, in quanto la loro vita era minacciata senza che essi av essero la possibilità di di. fenderla.
Gli austriaci , rotte le prim e nostre resiste nze, dilagarono sulla nostra sponda, e, sotto la protezione della propria artigli eria, iniziarono la penetrazione e F ornaci di Monastir fu la prima località ad essere investita.
Intuito il pericolo, dopo brevissima consultazione tra il Ma· resciallo Beccattini ed il cap. Porzio, fu presa la d ecis ione di raggiungere il reparto d 'assalto che in quel momento stava tentando il contrattacco.
Un solo uomo rimase alla ce ntrale telefonica, tutti gli altri telefonisti e guardafili guidati dal loro sottufficiale presero le armi e corsero a dare man forte agli a rditi per arrestare l'avanzata delle truppe nemiche.
Molti del piccolo plotone telegrafìsti, confusi con i fanti, caddE:ro valorosamente combattendo. Il Mar esciallo Beccattini riuscì perfino a ricuperare un'autoblinda che era caduta in mano al n emico.
Coragg ioso e pieno d'iniziativa personale si dimostrò il sergente Zambon Pietro, in servizio alla centrale telefonica di Zezon (medaglia d'Argento al valor militare).
Questo sottufficiale, nella tema che i suoi dipend enti non compissero con il dovuto zelo e la necessaria sollecitudine la riparazione dei circuiti danneggiati dal tiro del nemico, decise di e5"eguire personalmente tale lavoro.
Ma gli austriaci, passando il Piave ed iniziando l'avanzata

oltre il fiume, resero inutile l'ulteriore opera del bravo sottufficiale. Egli allora armatosi di moschetto e di bombe a mano, si pose alla testa di un gruppo di dispersi, affrontò una pattuglia avversaria e la pose in fuga, facendo altresì prigionieri un gruppo di austriaci
45 - La 125" Compagnia telegrafisti.
La 25.. Divisione di fanteria operava lungo il Piave, nel tr atto Fornaci di Monastir - Meolo - Lonor - C. Botter. Il servizio dei collegamenti era affidato alla 125a Compagnia telegrafisti.
Era il periodo più burrascoso dell'offensiva austriaca. I fanti resistevano a quell'inf erno di artiglieria, pronti a respingere l'attacco della fanteria avversaria.
Nel pomeriggio del 16 giugno 1916 reparti nemici riuscivano ad impossessarsi delle Case Franceschini, difese in quel settore dal 232° Reggimento Fanteria. I telegrafisti, costretti ad arretrare, non esitarono ad incendiare e distruggere tutto il materiale telefonico che non era possibile asportare con le linee che vi facevano capo e poi a fermare il nemico unendosi ai superstiti del 232° F anteria insieme ai quali combatterono con onore ed accanimento, lasciando due morti sul campo.

Gli austriaci, procedendo nella loro offensiva, il giorno 19 giugno 1918, nell e prime ore del pomeriggio, riuscivano ad occupare San Pietro al Novello sin presso Fornaci (Com. Divisione).
I collegamenti elettrici sono interrotti e non è più possibile comunicare con nessuno.
Gli uomini nentrano tutti alla propria Compagnia, le tr uppe in linea, falcidiate dal fuoco nemico, combattono e contrastano C'nn tenacia la pression e austriaca.
Il Comandante della Compagnia Telegrafis ti, nell'angosciosa situç.zione vuo l e 1mp egnare i propri uomini disponibili sulla linea del fuoco e senz'alt ro si reca volontariamente a prendere ordini dal Comandante di Divisione, che gli assegna la posizione da occupare. Anche qui i t elegrafisti mostrarono il loro valore combattendo con i Fanti.
Il nostro consolidamento sulla linea del Piave si r istabilì
appena il nemico si ritirò dai pochi punti dell'argine destro in cui era riuscito nei giorni precedenti a penetrare.
Nei p r imi di dicembr e il caporale Balestrin To mmaso scoperse che lungo la riva .destra del Piave, erano ancora in opera pali di una linea elettrica èhe poteva facilitare l'interce ttazione da parte austriaca. Volontariamente decise di andare a distruggerli Affrontando l e raffiche di fucileria e di mitragliatrici austria che, g iunse alla sponda destra de l fium e e con serenità, salito sui pali, vi tagliava i fili, riuscendo a rientrare incolume nellu nostre posizioni.
Diverso d esti no fu riservato al soldato Grego-rio Mario .della 58a Sezione tèlefonica, che partecipò all'azion-e del 14 dicembre suUa Piave Vecchia.
Quale centralinista nei settori più avanzati, poiché il fuoco delle artiglierie interrompev a continuamente linee, si offrì per collaborare con i guardafili nella loro delicata mansione. Pre· stò inoltre la sua opera assolvendo scrupolosamente importanti inca ri chi di fiducia affidatigli dal Comando della Divisione. N ell'ul t imo di questi servizi cadde falcia to da una raffica di mitragliatrice. Alla sua memoria fu concessa la medaglia d' Argent(\ al valore militare.
A Zenzon, n egli ultimi giorni del febbraio 1918, prèstava se rvizio di centralinista il caporale Brioschi Esperio. Gli austriaci, immobilizzati sull'argine, da dove speravano spiccare un nuovo balzo in avanti, si mostravano in que1 giorni assai attivi, d irigmdo sulle nostre linee abbondante grandinata di proiettili di ogni calibro.

I telegrafisti erano chiusi con i loro apparecchi telefonici in una casa, che poteva essere una trappola, perché già colpita dal fuoco nemico. Invero, durante il bombardamento colpo ·i e sulla stazione telefonica, seppellendo tra le rovine i telegra· fisti. For t unatam e nte non vi furono vit time né feriti.
Il caporale Brioschi, sebbene contuso in più parti, si preoccupava perché le linee fossero immediatamente ripristinate, ac· cvrrendo egli stesso con i propri compagni là dov e i circuiti avevano subito maggiori danni.
Ma nei giorni successivi fu mortalmente colpito da una S<'heggia di granata. I compagni, subito accorsi, lo trovarono ago-
r:..izzante; ciò nonostante rivolse loro parole di incitamento, lamentando soltanto di non potere offrire alt ro alla sua Patria. Alla sua memoria fu concessa la meda glia d'Arg ento al valore m ili tare.
A Fossalta di Piave era il tenente G albiati Vittorio, con l'incarico di stendere circuiti telefonici che dovevano allacciare iJ Comando di Divisione con i comandi dei reggi m enti in linea.
La località era fra le più tormentate dal tiro dell'artiglieria austriaca, essendo la località stessa luogo di convergenza di vari itinerari.
Il tenente Gal biati fu colp ito al capo da una scheggia di granata. Egli volle soltanto una sommaria medicazione, per tornare con sollecitudine a riprendere la direzione dei lavori, restandovi smo al compimento di essi e suscitando l'ammirazione dei suoi soldati. Al suo ritorno in compagnia, rifiutavasi di entrare in luogo di cura, preferendo una guarigione più lenta , pur di rimanere con i propri soldati.
46 - La 46" Compagnia telegrafisti.
Questa Compagnia, formata il 7 settembre 1916, appartenne successivamente al XIV e al XIII Corpo d'Armata ed operò sul Ca rso e poi sul Piave.

A dimostrare come i compiti affidati a questa compagnia venissero assolti con eccezionale perizia val e il comportame nto di un suo ufficiale, che p er poco non vi perdeva la vita.
Il Comandante della 46"' Telegrafìsti aveva impartito disposizioni affinché ogni allacciamento telefonico fosse preceduto da una ricognizione sul terre no per avere maggiore garanzia circa la sicurezza dei circuì ti.
Per l 'impianto di una importante stazione telefonica sul fron te della 35.' Divisione venne comandato il tenente Levi, che senz'altro conduceva con sé la squadra di uomini nec essari per eseguire il la voro.
La prescritta ricognizione venne fatta, questa volta, con il Capo di S.M. della Divisione, sotto raffiche di mitragliatrici e scoppi di proiettili.
Tale ricognizione non sfuggì alla vigilanza dell'avversario, e
un tiro d i gra na ta colpì il n ucl eo u ccid endo otto t elegrafisti, e ferendo gravemente ad una gamba il tenente Levi.
L'offen si va au str iaca de l gi u gno 1918, nel primo periodo, aveva dato agli avversari la possibilità di penetrare in qualche p unto de lle no s tre difese (su lla des tra d el Piave) e d i impossessarsi anche d i parte della rete telefonica stesa dalla 46a Compagnia. Caddero prigionieri anche sei soldati telegrafisti, poiché gli austriaci avanzarono con tanta rapidità, sfruttando l a sorpresa, che arrivarono sino al ce n tralino della {il • Divisione.

Il caporale capo stazione Marc h i Antonio da Conegliano, intuendo il p ericolo provvid e, d'iniziativa , a spostare più volte il centralino , secondo l e vicende della battaglia, a ssic u ran d o così la continuità del funzionamento dei circuiti telefonici. Fu decorato. sul campo, con l a medaglia d ' argent o al v alore militare.
A conclusione di quanto è stato detto pel valoroso compor· tHme n to della 46a Compag ni a te l egrafist i. citia mo il seg u ente episodio, del quale fu protagonista il soldato Barile Francesco, uno dei sei prig io nie r i fa tti da gli a us tria ci dura nte la l or o bre ve avanzata nell'offensiva del giugno.
Cadut o nelle man i de l ne m ico e tra s por ta to co n g li a ltri m un campo di concentramento a Ponte di Piave, decise di tentare co n ogni mezzo l a fuga. Un pr im o te n tat ivo fallì. U n secondo t entativo fu coronato dal successo: il Barile poté raggiungere Vitto rio Ve n eto e, successiva men t e, d opo aver s u perato varie d ifficoltà, passare a nuoto il Piave, riuscendo a raggiungere il suo Co· ma n do di ·Co m pagni a .
47
L'OFFENSIVA DELL'OTTOBRE 1918
- Dall'Altipiano di Asiago alla foce del Piave.
Dopo l ' offensiva austriaca del giugno 1917, le compagnie telegrafisti, particolarmente quelle impiega te n e l tratto di fronte dall'altipiano di Asiago alla foce del Piave, dovettero provvedere al riordinamento della rete telegrafonica, in gran parte devastata durante la battaglia.

A tale opera, l'Unga e snervante, sovente ostacolata dal tiro nemico, si accinsero instancabili, come sempre, gli ufficiali ed 1l personale di tr uppa.
I lavori procedette ro sollecitamente ed ai primi di settembre si ebbe la sicurezza dei collegamenti telefonici, teleg raf ici ed ottici in tutti i settori di quella vasta zona.
Ma, proprio ·nei primi giomi dell'autunno 1918, nel territorio d e lla 3" Armata si abbattè un violento nubifragio , che, oltre a sconvolgere le nostre difese, dis truss e anche molte linee telegrafoniche.
Ma anche questi danni furono riparati con celerità e perizia: infatti, in .meno di 24 ore nell'intera rete dei collegamenti il servizio aveva ripreso il suo regolar'e funzionamento, pur nell'imperversare del ):'llal tempo.
In questa occasione si distinsero la 21' e 46" Compagni.a t elegrafisti ed il Comando della 3"' Armata con pieno riconoscimento, indirizzò alle compagn ie telegraf isti il seguente ordine del giorno:
21" e 46a Compagnia
TeLegrafisti
« Interrotti tutti i collegamenti teleg:-afonici a causa di un ciclone di eccezionale violenza, scatenatosi nel pomeri ggio del 23 settembre 1918 nella zona centrale dell'Armata, che abbattè l e plificazi oni per lung h i tratti e s pezzò in molti punti i fasci di fili della vasta e complessa rete delle trasmissioni, i telegrafisti riuscirono co n alacre ed in telligente lavoro, svoltosi in condizioni specialmente difficili per i l persistente imperversare della bufe ,r a e per l'oscurità della notte, a riattivarli completamente in brevissimo tempo, v incen do p ure diff i coltà tecnich e ed affron ta ndo con vera abnegazione e con elevato sentimento del dovere gli inevitabili disagi ».
F.to T en . Gen. la 3a Arma ta Emanuele Filiberto di Savoja

Al 1° ottobre 1918 le compagnie telegraf isti di tu t to il fronte , in vista di una nostra ripresa offensiva, avevano la loro rete com pletamente effic ente : rinn ovati p arecchi circuiti vecchi, so stituiti gli apparecchi difettosi, curati e occultati i circuiti, rinforzate le stazioni col pe rsonale occorrente , predisposta la necessaria ri serva di ;materiale e di uomini.
Le compagnie tel egrafisti operanti sul Piave, per l'attraversamento del fiume avevano predi sposto accuratamente molte squadre di guardiafili e di telefoni sti che dura nt e l 'attraversamento dovevano assicurare prontamente i collegamenti telefon ici, utilizzan d o anche l e li n ee n emiche abband onate
Al l o ottobre 1918, le compagnie telegrafisti destinate alla avan zata eb be ro la segue nte dislocazione, lungo la fronte di schi eramento delle Grandi Unità che parteciparon o a ll'offensiva:
P A RM ATA (Generale P ecori - Gira l di)
S e tto re ·di schieram ento: dal Ga rda alla spo nd a sinistra d e ll 'Astico - Compagnie telegrafisti:
11\ 15\ 16', 25", 38•, 41", 42", 54" 11 2", 124\ 132a, 134•, 138", 151", 157"', 158', 1<63".
3" ARMATA (S.A.R. Duca · d'Aosta)
Settore di schieramento: Basso Piave- Compagnie telegra fi sti : 10", 21", 36", 45•, 550., 62", 72&, 123", 125\ 131", 1373 145", 153", 154' .
4" ARMATA (Gen . G iardino)
Settore di schieramento: Grappa - Compagni e te legrafis t i: 3\ 4", 5", 8", 12", 22", 26", 29\ 30", 33", 101', 111", 115", :i 17", 118", 136", 142", 159', 161".
6"' AR MATA (G en. Montuo ri)
Settore di schierame nto: Altipia n i _ Compagnie telegrafis ti: 343 , 37", 39", 44•, 47", 56\ 65", 74"', 102"', 114", 128", 129", 152".

7" AR MATA (Gen. Tasson i)
Settore di schieramento: dallo Stelvio al Garda - Compagnie telegrafisti : 2\ 9", 17"', 23", 57", 58", 64", 68", 103"', 105", 106", 121"', 1<67
8" ARMATA (Gen. Caviglia)
Settore di schieramento: Monte llo - telegrafisti: 24", 32", 40", 43•, 48.. . 49.., 59•, 63\ 139 \ 140'", 141', 143", 156", 166•.
g• ARMATA (Gen. Morrone)
Settore di schieramento da Lonigo p er tutta la linea pedemo ntana sino al mon te Tomba - Compag nie telegrafisti:
13" 18" 19"' 28" 35" 53" 60" ' 71" 73• 104" 107" 113' 120"' ' ' ' ' ' , ' ' ) ' ' ' ' 122"' 127", 133\ 149 \ 150\ 168".
Complessivamente, dunque , b en 11 0 compagni e Telegrafisti presero parte alla battaglia.
Le altre due Armate, cioè la 10• e la 12", costituite per la nostra offensiva dell ' ottobre 1918 e comandate rispettivamente dal G e -
nerale inglese Lord Cavan e dal Generale francese Graziani, si inserirono, la prima fra la 4a e l' a a Armata, e la seconda fra l' a a e la 3a Armata. Per i collegamenti di sp osero di parte delle compagnie telegrafisti della 9(\ Armata e di parte di quelle direttamente dipendenti dall'Ispettore Telegrafico Capo d el S.T.M. di Gu erra.
E' a tutti noto che la nostra ultima offensiva , iniziata il 24 ottobre 1918 nelle prime ore del mattino, ebbe, fin dall ' inizio, un c: si t o fortuna t o.

Il cuneo aperto dal Gen. Caviglia, con 1'8" Armata, nel fronte austriaco, segnò un cplpo decisivo nel cuore dell'ex Impero Asburgico. Dopo solo dieci giorni di lotta il nemico era costretto ad arrendersi chiedendo l'armistizio.
Le truppe del Gen io Telegrafisti per la rapidità con cui si &volsero le azioni di quei giorni, adeguarono i loro procedimenti di lavoro al fe bb rile incalzare degli avvenimenti.
Le comunicazioni elettriche ebbero, tuttavia, alcuni momenti cii inevitabile crisi: fu allora che fu ro no posti in gi usta luce i collegam enti radiotelegrafici, con tutti gli altri semplici e tradizionali mezzi di trasm issi one.
I telegrafisti divennero portatori di ordini a piedi o in bicicletta e, dove ciò era possibile, vennero in l oro ausilio i colombi \'Iaggiatori che, in una sola Armata dal 27 ottobre al 4 novembre, portarono b en 700 colomb igrammi con notizie da ogni punto raggiunto dalle nostre colonne avanzanti.
Al quadrivio del Paradiso, presso Castions di Strada. cadeva eroicamente colpito da mitragliatrice austriaca (mentre in quel momento all e ore 15 d el 4 novembre 1918, aveva inizio l'a rmistizio) l 'ultimo fa nte il T en. dei be rsaglieri Riva di Villasanta!
Tre giorni prima, all'Isola C aserta sul PiaV1e, due soldati d ella 1373 Compagnia Telegrafisti (Cireri Antonio e Pettinati Antonio) si prodigarono pe r dar e ad un Comando un importante collegamento telefonico: lo stendimento doveva essere eseguito con la maggiore urgen za so tto il tiro d' interdizione del nemico.
Non appena i lavori furono iniziati lo scoppio di una granata f eriva gravemente i due soldati: gli ultimi della numerosa schiera dei telegrafisti che avevano versato il sangue sul campo, nel corso della prima guerra mondiale.
48 - Compiti svolti da lle Compagnie Tel•egrafisti d u rante l 'a rm istizio.
Con l'arm istizio le compagnie t e legrafisti, pur in iziando la smob ili taz ione d egli an zi ani, d ovettero prov ved ere a d u h ingente numero di lavori, anche perché molte di esse dovettero far parte delle truppe di occupazione impegnate in territorio austriaco, oltre i l n uovo confi n e I lavori affidati alle compagnie, si p ossono così riepilogare:
a ) Ri ordinamento radic al e di tutti i c ircuiti te l efonici e teleg raf ici preesistenti nel territ or i o occup ato . A fia nco d e l p erso nale civil e venne posto il nostro personale militare .
b) Im pian ti d i n uovi collegamen ti, fra il Coma n do Su p re mo, i Coma nd i d ' armata e le truppe occ u panti il Tren ti no, la Venezia Giulia. Tali collegamenti dovevano poi servire per le future necessità fra le terre redente e la Ma d re Patria.
c) Imp i anto pro vvisorio di collegamenti telefonici ne ll'i nterno delle grandi unità, per assicurarvi il funzionamento dei ser\ ·izi ne lla nuov a sit uaz ione.
d) Ripiegamento dai due fronti di guerra, già occupati dal t ·ostro esercito, di tutti i circuiti telegrafonici permanenti e vol an ti n on p i ù n ecessari.
49 - Com p a gnie Telegrafisti ch e parteciparono a lle azioni di g u erra in a ltri tea t r i di operazione.

II 'CO RPO d' A RMATA IN F RANCIA
( 6\ 52", 108", 148a
Com pagnia T e le gr.)
Il II co.rpo d'Armata che combatté con tanto onore in terra di Francia e bbe con sé fin da ll ' in izio d ella guerra la •6" Co mpa gni a Telegrafisti, e nell'ottob re 1916 anc h e l a 52a.
N el periodo dal marzo al giugno 1917 esse avevano partecipato a lla co nqu ista de l Mo nte K uk - Vo dice - Mo n te Santo, dando prova d i s piccata p eriz ia tecn i ca ed es p erie n za ac qu istate d u rante gli anni precedenti, operando su di un terreno difficilissimo.
Luglio - Settembre 1917 - Nella zona conquistata avevano riordinato le linee distese durante l'azione e costruitene delle nuove, portando cavi protetti sul Monte Kuk - Vodice- Monte Sabotino e Monte Santo, stendendoli anche sotto il tiro nemico fino al Comando di Divis ione, che era vicinissimo all e prime lin ee .
Agosto 1917 - Le Compagnie del II Co rpo d ' Armata parteciparono all'offensiva della Bainsizza.
Ot tobre 1917 - Durante la ritirata di Caporetto le Compagnie Telegrafisti ripiegarono in pedetto ordine, distruggendo tutte le linee che non fu possibile ripiegare e collegando i Comandi durante i loro vari e celeri spostamenti. Il materiale delle Compagni e venne caricato al completo sul ·carreggio e trasportato sino verso Codroipo, ma disgrazia volle che, per il grave ingombro stradal e, una piccola parte di esso dovette rimanere sulla sinistra del 'Tagliamento.
Aprile 1918 - In questa epoca il II Corpo d'Armata, venne inviato in Francia.
Il 17 giugno 1918 il C.A. italiano entrava già in linea a occidente di Reims, e prendeva posizi on e a cavallo del fiume Ardre.
I telegrafisti trovarono i collegamenti in cattivo stato: si dovettero pertanto dedicare principalmente a organizzare l'intera rete telefonica.
Questa funzionò con ottimo re nd imento durante l'azione del 15 luglio nella quale il Corpo d'Armata italiano fu molto impegnato.
Il 23 luglio, il nostro Corpo d'Armata fu poi sostituito dal 22° Corpo d 'Armata inglese.
Agosto - Novembre 1918 - Verso la metà di agosto il II Corpo d'Armata Italiano, dopo un periodo di riordinamento nelle retrovie rientrava in linea nel settore di Verdun. L e compagnie tel egrafisti provvidero a riattivare tutte le linee preesistenti.

L'll settembre il C . d'A. si trasferiva a Chàteau Thier ry ed il 18 nel settore della Veesle; il 21 Fére en Tardenéis.
Le compagnie telegrafisti si dedicarono, oltrechè agli impianti delle nuove linee, anche alla rettifica e ad una più conveniente sistemazione delle vecch ie.
L'll ottobre, il II Corpo d'Armata Italiano si spostava a Jouaigne, il 14 a Festie u se, il 7 novemb r e a Simonne , 1'8 a Di zy le Gros, il 10 a Ronzenj sur S eine.
Tutti gli spostamenti furono seguiti da collegamenti efficienti e-d effettuati con prontezza e abilità.
Le co mpagni e tel eg rafisti che parteciparono co n il II C.A . all e azio ni del magg io ed agosto 1917 sul Monte Santo e sul Yodice perdettero 101 militari, mentre in Francia dal luglio all ' ottobre 1918, lasciarono 169 morti!
50 - Comando Superiore delle F orze nei Balcani.
(31 a, 51a , Com p. T e l. in serv izio presso il XVI Co r p o di Armata).
(llOa, 113", 119", 155a Comp. Tel. in servizio presso le Divisioni).
Le compagnie telegrafisti che operarono in territorio albanese si trovarono a combattere più che col nemico, con le difficoltà del terreno e con le sfavorevoli condizioni di clima e di ambi ente.
Esse, co)ne le altr e trupp e , dovettero su pe rare l e difficoltà dovute alla primitiva rete stradale, alla povertà di risorse e, particolarmente, alla deficienza di acqua .
Per il solo servizio ge ne rale furo no costrui ti 963 Km di linee telegra fich e stesi 2269 K m di line.e e 1080 chilometri di linee volanti.
51 - 35a Divi sione a Saloni cco. (143 e Compagnia Telegrafisti)
La 35a Divisione ch e operava con il contigente interalleato sul fronte della Macedon ia ebbe alle sue dipendenze la 14a e 1353 Compagnia telegrafisti, ch e sbarca rono a Sa lonico, con 400 uomini ciascuna, il 14 ag osto 1916.
Le du e Compagnie assolsero con in stanca bile alacrità tutti i

loro comp iti, singolarmen te complessi per l a consis tenza del contingente e per le avv e rs ità climatiche.
I telegrafisti, pur trovandosi in una regione sconosciuta, s u li un fronte dove combattevano trupp e di diverse r-azionalità, dettero anche qui prova del loro valore professionale e militare . Le azioni cui parteciparono f urono le seguenti :
1° - impiego sul fronte del Krusa-Balcan ;
2• - offensi v a in teralleata dell'ottobre-novembre 1916 (presa di Monastir);
3° - cambiamento dal Krusa-Balcan all ' ansa della Cerna, avvenuto dal 4 al 29 dicembre 1916;
4• - offensiva p er l a liberazione della Serbia.
CONC LUSI ONE
52 - Abbiamo rivissuto, attraverso tanti episodi della guerra 1915 - 1918, in gran parte sconosciuti agli stessi soldati del Genio, ciò che i telegrafisti ·seppe ro comp iere.
Questa monogr afia che ebbe i consens i del Gene r al e Gaetano Ca rdona, che fu dal marzo 1917 a l ge nna io 1919 , Ispettore Capo del Servizio Telegrafico Militare , e quelli del Generale Ugo Levi dell'Ispettorato dell'Arma del G enio, (che si interessarono per farci mettere a disposizione il materiale di studio esistente presso l ' Istituto Stor i co dell'Arma del Genio in Roma) doveva esse re pubblicata nell'anno 1934, in una edizion e da di s t r ibuirsi ai battag lioni t e legrafisti , cos titu iti allo ra in se no ai r eggimenti del Gen io. Ma la modesta opera non potè essere pubblicata. Appare oggi, in questo Bollettino che rievoca le gloriose memorie dell'Arma del Genio. Possano queste pagine ricordare ai vecchi telegrafìs ti le remote vicende di cui furo no pa rtecipi e far conoscere ai telegra fisti di oggi, appart enenti alla nuova Arma delle Trasm issioni, alcun e fra l e più significative pagin e della loro Stor ia.


' '

VIII CORPO D'ARMATA
Oneglia, 20 gennaio 1920
A S.E. il Ten . Gen. GIOVANNI MARIENI Comandante Generale del Genio ROMA
Restituisco, munito della mia firma autografa, l 'e ncomio da me tributato alla Compagnia Tel egrafist i dell'VIU Corpo d' Armata n elle giornate della battaglia sul Montello.
Sono fiero che tale documento rim anga nel museo stori co del Genio ad aggiungere lu stro a quest'Arma che tanto ha meritato dalla Patria e che nella battaglia sul Montello con la Compagnia Telegrafisti non solo. ma anche con due suoi battaglioni zapp ato r i, da me trasformati in batt.a· glioni d'as salto, ha contribuit o alla Vittoria in un'ora tragica in cui non avevo più ri se rve e l'intera Armata dell'A rciduca Giu se ppe premeva con tutto il suo peso sull'esile ma eroico VIII Corpo d'Arm ata, de cisa ad aprirsi ad ogni costo la via su Treviso e su Castelfranco per aggirare la nostra 3a Armata e l' Ar mata del Grappa.
Il Ten. Gen. Comandante l'VIII C.A. A. GANDOLFO Documento 2

Repa r ti del Genio Telegrafisti che mer ita rono dal Comando Supremo l'onore di speciale menzione per la valorosa condotta durante la battaglia di Vittorio Veneto.
I ARMATA
Per l'energ i ca e p r onta azione esplicata nella manovra di Trento: 133a e 136a COMPAGN IA TELEGRAFISTI
I II ARMATA
Per l'ardimento e lo slancio dimostrati: 123a' e 153a COMPAGNIA TELEGRAFIST I
IV
ARMATA
Per i sacrifici eroicamente compiuti nel settore Asolone, Col della B erretta e pe r l a celere marcia d'inseguimento:
121a 1 223 140a e 32a COMPAGN I A TELEGRAFISTI
che sotto il fuoco nemico e cont ro la violenza del fiume, lavorarono 24 ore per tentare d i collegare telefonicamente le due opposte rive del Piave, finché riuscirono nell'intento.
3 novembr e 1918 l
Il Ten. Gen. Com.te Generale del Gmio MARIENI Documento 3

Al REPARTI DEL GENIO TELEGRAFISTI DELLA 33 sn e sa ARMATA
che meritarono dal Comando Supremo l'ono re di speciale menzione oer la valorosa condotta durante la battaglia dall'A s tice al mare:
- Sali ente Capitello di Pennar (Asiago);
- Reg io n e del Montello;
- Zon a F agarè- Musile.
L'arduo servizio dei collegamenti teleg r afici , telefonici ed ottici tra le prime linee ed i comandi arretrati, tra i velivoli solcanti il cielo ed i post i terrestri, si svolse regolare e sicuro, pur sotto l'offe sa del fuoco nemico e tra continue gravissime difficoltà tecniche, superate grazie all'organizzazione preordinata dagli enti direttivi (Ispettorati e Commissariati Telegrafici), ed alla devozione ed abnegazione degli ufficiali e delle truppe del 3ç> e 7° Reggimento Genio.
Un elogio particolare mentarono i guardafili, esposti di continuo a lla morte nell'infaticab i le lavoro di riallaccia r e sotto il tiro le comun ica zioni spezzate.
(Dnlta reLazione ufficiaLe deLLa battaglia dalt'Astico at Mar<!)
15 giugno 1918
Il Ten. Gen. Com.te del Genio MARIENI
CO MAND O DELLA SECO NDA AR MATA S. M.
6 gennaio 1917
Sono lieto di segnalare a l l'Armata gl i ottimi servizi resi nel corso delle operazioni dalle Compagnie 24a, 26a, 3" Regg imento Tetegrafist.i alle quali tributo un encomio solenne con la seguente motivazione:
« In svariatissime circostanze e malgrado non lievi difficoltà, fra cui la vicinanza e l'oftesa del nemico assicuravano in modo lodevole, celere, e completo il se r vizio delle comunicazioni» . (A u tunno 1916)
Il prese n te o r din e sarà portato a conoscenza di tutte le truppe dipendenti e a ciascun militare delle compagnie e ncomiate ne sarà rilasciata un a copia , in t es ta ta al s uo nome, con la firma d el ri spettivo Comanda n te d i Compagnia.
Il Tcn. Gen. Comanda n te dell'Ar mata GA R IONI
Documento 5

COM ANDO D EL IX CORPO D' A RMATA (4a ARMATA) S. M.
17 gi u gno 191 8
N . 5008 prot. s eg. pers. OGGETTO : e ncom io
Mi è grato segnalare ad esempio la condotta tenuta nella giornata dei 15 c.m. dal plotone detta 3 a Compagnia Tetegrafisti, distaccato a Ca' Nosellari.
Sotto l'inte n so ed efficace bombardamento nemico, che asportava interi tratti di linea telefonica e minacciava gli impia n ti stessi del centralino d: Cà Nose ll ari gli uffi ci ali ed i soldati t u t ti di que l plotone gareggi a vano per bravu r a , a ttivi tà, c al m a c sprezzo del p e ri co l o, assicu r ando il pr o nto ristabilime n t o de lle co m un icaz ion i ogn i qual volta d a ll 'incessan t e tiro de lle a r tiglie ri e a vve r sarie esse v e n ivano in ter ro tte
T ri b uto pe rt an t o a t u tto il Plot o n e Nosellari un vivo elog i o, q ua l e palese ri co n osci men to de l valore dimostra t o e q u ale incitamento agl i alt r i reparti perché sappiano in ogni circostanza em ula r lo.
Il Maggiore Gene r ale Comandante Interinale del C A. EMILIO DE B ON O
COMANDO D'ARTIGLIERIA DEL IX C. A. (4a ARMATA ) Al Comando d el IX C. A.
Giugno
1918
N. 5040 d i protocollo
OGGETTO: etogio atta 5a Compagnia Telegrajìsti.
S ento il dovere di segnalare a codesto Comando il contegno serbato e l'opera compiuta dalla 5a Compagnia Te legrafi sti durante l'ultima azione e specialmente nei gio rni 15, 16, 17 c.m. Nonostante il violento ed aggiustato tiro nemi co, i militari della detta compagrtia, con mi r abile ardimento , con calma e solleci tudine , incuranti d i f atiche e di pericoli, rimanendo alcuni feriti, sono riusciti (come è noto a codesto Comando) a mantenere con assidua sorveglianza e con rapide riparazioni, le comunicazioni telefoniche ed ottiche fra questo Comando , i Comandi dipendenti e quelli di Divisione e di Artigliera division ale Propongo pertanto alla 53 Compagnia Telegrafist i. sia tributato un en comio solenne da codesto Corpo d'Armata.
Il Com.te l'artig. de l IX C. A. PIZZONI
COMANDO I CORPO D 'A RMATA (4 3 ARMATA) S. M.
2 Luglio 1918
N. 2408 Prot. op. Collegamenti telefonici.

Al Comando Genio 4a Arm ata
D urante le recenti operazioni offensive nemiche, i collegamenti· telefonici nel territorio del C.A. funzionarono egregiamente ed in modo continuo, nonostante il violento tiro dell'artiglieria nemica.
Ciò è senza dubbio frutto dell'assidua e diligente opera preparatoria delle compagnie telegrafisti e della modesta abnegazione del personale, specialmente dei gua rdafili. Ment r e per questi ultimi è i[ià stato provveduto
per la distribu:Gione . di ricompense a quei mili tari che maggiormt!Jlc :.i segna larono, prego codesto Comando di voler esprimere il mio compiacimento per l'opera loro veramente encomiabile, ai dipendenti reparti telegraji.sti ed in modo particolare ai capitani
MASCIELLO e SCIORTINO
che, quali ispettori teleg rafi ci, con intelligente interessamento e con accurate predisposizioni, assicurarono il buon funzionamento delle reti telcfo· niche anche nei più critici momenti.
Il Ten. Gen. Com.te il C. A. PIACENTINI
Documento 8

COMANDO XX CORPO D'ARMATA (6t1 ARMATA)
37a e 1023 Compagnie telegrafisti
15 e 18 giugno 1918
Duran te l'offensiva nemica, anche quando l'artiglieria avversaria batteva f u riosamente le posizioni dov'e r ano postatc stazioni telefoniche ed ottiche il tutto, ufflciali e truppa, con abnegaz ione e sacrificio sprezzanti del pericolo, mantenendo costantemente ininterrotte le comunicazioni, cooperarono nel modo più efficace alla riuscita delle operazioni. (Val Brenta- Col Moschin- Col d'Asiago)
Il Ten. Gen. Com.te il C. A. FERRARI
Documento 9
COMANDO DI ARTIGLIERIA 33 ARMATA
9 febbraio 1917 N. 35 di protocollo
OGGETTO: Elogio alla 18a- 45a- 47 a Compagnia telegraji.sti deL Genio.
Il funzionamento di questo servizio, che deve la sua efficacia a ll a pos.. sibilità di intervento rapidi ssimo e simultaneo delle artiglierie, fa naturalmente in ogni momento assegnamento sulle comunicazioni.
Esse, è doveroso riconoscerlo , assai curate dalle compagnie de l Ge nio che vi sono preposte.
Il movimento dell'assetto recentemente compiutosi ha richiesto nuovi ed importanti lavori di allacciamento telefonico. Tali lavori, nonostante le condizioni difficili di viab ili tà, le difficol tà del terre no, la lunghezza delb linee e l'insis t en t e tiro da p a r te del nemico so no stati compiu t i in tempo brevissimo e così efficacemente da rispond ere ad ogni esigenza.
Il merito, non vi è dubbio è del personale del Genio che ha superato ogni difficoltà con un buon volere, una ammirabile, e pertanto si segnala all'attenzione di codesto Comando per quel tributo di e l ogio che sarà ravvisato opport uno.
Il Colonnello SASSOCOMANDO DELLA 17a DI,VISIONE DI FANTERIA S. M .
24 giugno 1918
N 1524 di protocollo
OGGETTO : Encomio sol enne.
Ordi ne giorno N. 178
Senza dubbio, fra g li elementi che concorsero a determinare l'insuccesso nemico nell'azione de l 15 giugno c.m., sono d'annove r arsi la rapidità e la co n t i nuità con la quale i comandi furono sempre informati delle mosse avversarie ed i l funzionamento dei collegamenti durante lo svolgersi delle azioni: in tal modo fu resa possibile l'attuazione di quei provvedimenti che valsero a rintuzzare l'aggressione nemica ed a procurare nuove g lorie alle armi italiane.

L a 117a Compagnia anche in ques t'o ccasione assolse in modo esempl a r e il suo delicatissimo comp ito ; sia lode agli ufficiali c he nelle ore dell'at tesa plasma rono l'animo dei dipendenti e poi alla parola aggiunsero l 'esempio.
Sia l ode a tutti coloro che nei momenti più d iffi cili ebbe r o forte l'an i mo e non furono dist olti dal compimento del dovere neppu re dalla visione della morte.
Sia lode a color o che fra gli scoppi e i s ibili, sprezzando il pe ric olo, gittarono fili e ripararono guast i.
Agli ufficiali ed ai militari della 117a C.T. il pensiero di aver contribuito a tene r e alto l' onor e italico, sia conforto per l e trascorse f at i che. sia sprone p er i futuri cimenti. Con animo g r ato tributo: alla 117a Compagnia Telegrafi,sti l'encom io solenne d i v i sionale per il seguente mo tivo :
«Pe r aver mantenuto super iormente a ogni elogio in perfetta efficenza, sotto il t iro de ll'a rtiglieria nemica, le linee tele foniche ed eliografiche, assicu r ando i n ogn i cont ingenza le comunicazioni fra l e truppe ed i Comandi »,
Zona dell ' Asolane, 15 e 16 g i ugno 1918
Il !VIagg Gen. Com.te la Div i s ione LEONCINI
Documento 11

COMANDO DELLA 10a DIVISIONE
OGGETTO: Col!E:;gamen t ì.
Ordine del giorno
19/6/ 1918
L a pro va d ata in quest i giorni dall'organizzazione dei co llegamen ti ci assicura su d i un cos ì impor ta nte serv i zio in qu a l siasi circostanza.
Il mantenere i lega mi di coma n do dur ante le operazioni, in mod o da coord i na re gli sf orzi dei s ingoli cap i allo scopo da raggiungere , dà quella fiducia nel r eciproco apl[)oggio che fac ilita i ni ziativa ed al mome n to in coraggia ad osare, man tenendo i n t utti vivo quello s pir ito aggressivo che è il solo che p uò da r ci la v ittoria
I ntanto faccio solenne encomio aLla 157a Compagnia T elegr ajìsti che, c on l imitati mezzi e non sempre provetto personale, h a sap u to con la volo nt:ì e l a resiste nza fisica, man t enere vivo in questi giorni il se r vizio telegrafonico ed otti co nella massima efficenza da n do bell'esempio di disciplina e di te na cia ne l sopp or t a r e i disagi.
Il !VIagg. Gen. Com.te la Divisi one GALLIANI
ELENCO DEI CADUTI DELLA GUERRA 1915-1918 DEL 3° REGGIMENTO GENIO TELEGRAFISTI
AGOSTINELLI Giovanni
ALESSANDRONI Cesare AMBROSETTI Giuseppe ANDREI Vittorio ANDRICHETTI Vittorio ANGELA Alessandro ANGELOTTI Virgilio ARIGLIANI EttC're ARCUINO Elio Pico

BABACCT Mario BACCARO Ciro BALEN Egidio BALLARDINI Zefferino BARDELLI Romeo BARESI Paolo BARCELLI Bruno BARILARI Domenico BASSAN Pasquale BASSANETTI Vittorio BATTISTA Luigi BEATA Giovanni BENEVENTANI Carlo BERNASCONI Federico BERTACCHINI Luigi BERTELLI Giuseppe BERTONI Giacomo BERTOT Luigi BESSONE Severino BIADJ. Guglielmo BIANCHESSI Giovanni BIELLI Adriano BIGLIA Riccardo B INASCO Sante Arturo
BODEI Ba ttista BOGGIO Cesare Oreste BONELLI Giovanni BONI Giovanni BORDACCHINJ Mari o BORLA Pietro BOSONI Santino
BREDJ Emilio BRIOSCHI Asperio :SRIZZI Carlo BROCCHINI Roberto BRUSTIA Egildo FùRATTI Tullio BTJSIGNANI Guido CAPPIELLO Nicola CARAMEL Gio Batta CARIOLATO Luigi CARiv'1AGNJNI Ernesto CARMEN Alfredo CAROLI Arturo CASALI Elio CAVALIERI Egeo Giovanni C,1VALLARO Giuseppe CAV ALLIERI Vincenzo CACCHI Carlo CECCHI Giovanni CECCHI Luigi CERCHIAR! Guido CHIA VEGETTI Aldo CHXA VETTI Luigi CIARDI Basilio CIATTAGLIA Giuseppe CIOCCI Flavio CfVIDALI Claudio COELLI Giovanni COLACI Francesco COLLINA Vito COLOMBARI Pio COLOMBO Eugenio COLOMBO Carlo CONDORELLI Sante CREPALDI Carlo CR08ATO Antonio DAINA Francesco DALESSIO Antonio DALL'AVO Augusto DANGENTA Cosimo DAURIA Angelo DE MARCHI Giuseppe
DE PELLEGRINI Bisca GUISCI Gennaro
DE RITA Ugo YAMARINO Giova nni DE SCIORA Giuliano LACAVALLA G iacinto DESIASTI Francesco LA MANNA Renato DESSI Angelo L ASAGNA Gioacchino DEZZANA Luigi LAZZARINI Augusto
DI FRANCESCO Guido LENZl Ald o DI GIORGIO Giorgio LODI Emilio
D'INTINO Camillo LORETO Michele
DI PERNA Ange lo LUCCA Giuseppe
DI PRIMO Angelino LUONGO Ciriaco DO Antonio Lu PI Aldo DOMINI Nello LURASCHI Giovanni DURIGHELLO S ilvestro MAFFEI Enrico FABBRI Aldo MAGGIO Silvio FABBRI Alfon so MANCINE LLI Pio FABBRO Ottavio MANENTI Vito FABBRI4I Ugo MANZOTT I Gi use ppe FERRARI S Giuseppe MARCHI Giovanni FERRAZA America MARI Martino FONTANA Giovanni MAR TIGNONI Angelo
FRANZONI Cesa r e MARTIN! Oreste FRECCIERO Bernar do MARTORANA Bernardo FRESLI Giov a nni MASOERO Cesa r e GAGLI ONE Gennaro MAUSIELLO Giovanni GALLO Ant onio MAZZANTI Luig i GALVANI Orazio MAZZON I Domenico GANDO LFI B runo MAZZONI Giovanni CARD I Felice MAZZU TTINI Guido GAY Antonio MEDICI Siro
GENTILE Sigismondo MELONI Dino GIB I LARO S a lvatore MERLI Giu sep pe GIOLLI Mario MIGLIACCIO Giorgio GIORGI S alvatore MISCA Giovanni GIUDICIANNI Antonio MORO Giuseppe GORELLI Sabatino MURRA Michele GRANATA Mario MUSSUTO Giuseppe GRANDI Francesco MUTTO Luigi

GRAVILI Enrico NANFORA Rosario GRECIS Gia com o NEDROTTI Giovann i GRILLO GIO Batta
NOCCO L eona rdo GUARDA Ettore NOVATI Mario GUASTELLA Giovanni ORI Carlo
GUERRINI Giovanni ORLANDO Vincenzo
GUGLIELMI Agostino PADOVANI Vittorio GUGLIELMO Guglielm o PAITA Quinto
PALUMBO Gustavo
P ANERAZZI Filippo PARTIPILO Nicantonio PASQUALIN! Nazzareno PAVAN Giovanni
PAZZI Pietro
PEDERIVA Alfonso PELLACCINI Cesare PERNICIARO Iginio
PETTI Antonio PEZZATO Luigi PICCHI Marcello PICCOLO Giuseppe
PIETROLETTI Giacomo PINI B ernardo PINOLI Luigi PIROTTI Luigi PIRO VANO Angelo P I TINO Giovanni PIZZORNI Cesare POLI Sante POLI Antonio POLO Giuseppe
POMPIGNOLI Alessandro PORTELLI Alberto POZZI ATTILIO Vittorio QUATRUCCI Govanni RADELLA Andrea RAPPARINI Alfredo RATTI B attisti RATTo · Salvatore REDINO Mario RICCI Benedetto RICOTTONE Sante RIMANDI Giuseppe
RIZZO Guseppe ROCCA Dante ROLLA Adone ROMEO Michele
ROM!TI Arturo
ROSSATO Antonio ROSSI Giuseppe ROTA Annibale RUSSO Vincenzo
SABATINI Alessandro SABATINI Gaspare SALCE Eustacchio
SALAMONI Angelo
SAPIE NZA Carlo SARULLO Francesco SCARAMUCCI Josè SCAROLA Nicola SCAVOLINI Ferdinando SCIARETTA Giuseppe SCINTO Salvatore SEMINO Arturo SERRA Gio Batta SERRI Alessandro SESIA Giuseppe
SIMONELLI Giuseppe SIVIANZI Guseppe SOLLESCHI Giovan ni SPACCIAR! Marco SPERDUTO Michele SPEZZAFERRI Alberto SQUEGLIA Nicola STRIGELLI Antonio STRINGANO Raffaele TALONGU Carmine TANGOCCI Dario TICOZZELLI Giuseppe TIN AZZ I Angelo TISO Vincenzo TRAPELLA Roberto TRIVELLI Giovanni TROMBETTI Giovanni TROMBETTO Domenico VALDINOCI Augusto VALENTI Ferdinando VALENTINI Antonio VALERI Cesare VALPERESA Giovanni V ALZANI Achille VERGINE Luigi VICARI Nazzareno VICENTINI Gino VICHINI Primo VIOLA Giovanni VIOLATO Stefano VISTOLI Augusto ZAMBONI Oliviero ZAMPICENI Mario ZU FFA Angelo

ELENCO DEI CADUTI DELLA GUERRA 1915- 1918 DEL 7° REGGIMENTO GENIO TELEGRAFISTI

Tenen te CONETTI Aldo
Soldato ARMENIO Pasquale )) DE BLASI Edoardo )) AZZOLINI Ca rlo )) FINOCCHI Elvidio )) BACCHI Aldino S. Ten. AZZONI Luigi )) BAFFI Amedeo )) BROCHET R omano )) BAGGINI Lorenzo )) CUCCHIETTI Giuseppe )) BARTOLETTI Nicola )) MOTTURA Emilio )) BASSANELLO Giuseppe )) OLMEN Mario )) BELLETTI Guido )) TORRE Stefano )) BERTIN Silvio Maresc. BERNABO' Tullio )) BERTUCCELLI Enrico )) CERRONE Sabatino )) BERTUCCIOLI Amedeo Serg.te ORSINI Acursio )) BESSUTTI Oreste )} RIBANI Ubaldo )) BEUSSI Giovanni }) TONINI Luigi )) BfAMINO Giuseppe Cap. M. FILIPPONI Ferdinando )) BIANCO Gennaro )) MORETTA Giovanni )) BIANCOLI Francesco » PERUZZI Vittorio )) BILL! Adriano Caporale BALDETTI Vitale )) BOCCA Romolo )) BIANCHI Ugo )) BONCI Luigi )) BIONDI Iginio )) BONELLI Giuseppe
)) BORGOGLIO Amalio )) BORTOLOTTO Giuseppe )) BRIN Ange lo )) BORTOT Luigi )) BROSOLO Leonardo )) BRAVIN Pietro )) BRUNASSO Fortunato )) BRIGNONI Giacomo )) CREMASCHI Vittorio )) BROGLIO Franchin . )) GOBELLINI Bruno )) B U SANELLI Giuseppe )) LIRONI Ettore )) B UZZO Basilio }) ORLANDO Vincenzo )) CABRINI Luigi )) PARODI Aldo )) CALDAGNO Stefano )) ROSSELLI Renato )) CANDELETTI Giovanni Soldato AGNELLO Angelo )) CANOCI Mario )) AL BENGO L ino )) CANTARINI Romolo )) ALBERA Pietro )) CAPENUCI Nello )) ALDOVINI A lfr edo )) CAPOZZA Pasq ua l e )) AMICUCCI Amore )) CAPPABIANCA Lu igi )) ANGELOTTI Guido )) CAPRIGLIA Spiridone )) ANDRETTA Giuseppe )) CARO Luigi )) ANVERSA Giuseppe )) CASTALDINI Mario )) AQUIARI Gualtiero )) CASTELLI Giovanni )) ARDEGNANI Virgilio )) CAVALLERO Giacinto
Soldato CISTANI Antonio
S oldato FRATTO Creste
)) CIULLA Vito )) FRESU Giovanni )) CLEMENTUCCI Severino )) FUMAGALLI Fortunato )) CODE RO Carlo )) FUMAGALLI Natale )) COLAMURO Celeste )) GALLINOTTI Francesco )) COLOMBO Attil o )) GAGL IARDI Carlo )) COMIO TTO An gelo )) GALASSO Benedetto )) CONDELLI San te )) GALEOTTI Sisto )) CONTI Vittorio )) GALIMBERTI. Luigi )) CORBELLA Francesco )) GALLINI Ritardo )) CORSI Pietro )) GANDOLFO Adelchi )) CROCE Giulio )) GENNA Silvino )) CRUCIANI Decio )) GENOVA Umberto )) D'AGOSTINO Antonio )) GENTILE Felice )) DALLA Marno Luigi )) GIACOMELLI Angelo )) DAMIANI T r anquillo )) GIAMPIERI Etele r edo )) D'ANNA Antonio )) GINOTTI Guido )) DAVI Enea )) GIRARD I Lino )) DE BERNARDINIS )) GIUFFRIDA Antonio )) DEGL'INNOCENTI )) GRASSANO Antonio )) DE Y:ANA Luigi )) GRASSANO Felice )) DELLA POZZA )) GRAVA Antonio )) DE NO BILI A lessandro )) GRAVIOLO Pietro » DENTI Albino )) GREGORI T omaso » DE RENTIS Antonio )) GRICEO Francseco )) DE SIMONI Carlo )) GUGLIERI Ermenegildo )) DE VITA Carlo )) JACCHIA Antonio )) DEZZANI. Carlo, )) LA MANNA Alf r edo )) DI BONA Nica s tr o )) LAT INI Nazzaren o )) DI MARCO B en i amino )) UBOI Dante )) DI NUNZIO D ante )) LONGARINI Giuseppe » DI PERNA Angelo )) LUNA Giuseppe » DONATI Ferruccio )) MACCAFERRI Umberto )) ERCOLANI Ottavio )) MAGNONI Angelo )) F AILLA Rocco )) MAGRI Giuseppe )) FALSETTI L uigi )) MALATESTA Remo )) FANTUZZI Arnaldo )) MALINVERNI Vittorio )) FAUSTI Eugenio )) MANTO VANJ. Ar chimede )) FEDELI A ngelo )) MARCARlNO Enrico )) FERRADINI Angelo )) MARC HESI Guido )) FERRAIUOLO Giuseppe )) MA RCI-IETTI Eugenio )) FERRANO Vin cenzo » MARCO Creste )) FILIPPI Mari o )) MAR GHE RITIS Giovanni )) FORENZO Giuseppe )) MA TTOLETTI Andrea )) F ARLANO Carlo J MATTOSO Marco » FRATICELLI Vincenzo J MAZZA Augu sto

Soldato MAZZALI Dante
Soldato RASI Albino )) MAZZOLENI Giuseppe )) RAT Tommaso )) MENEGALI Guido )) REGGIANI Giuseppe )) MERCADANTI Luigi » REGGIANI Renzo )) MIGLIARINI Renato )) RIZZARDINI Nicolò )) MIRATELLA Luig i )) RIZZITANO Antonio )) MOLTENI Spirito )) ROCCA Dante )) MONBELLI Cesare )) ROCCI Giovanni )) MONTANI Eugenio )) ROMITI Arturo )) MOSCHETTINI Giuseppe )) ROMITr. Cesare )) MOSELE Marco )) RONDELLI Giuseppe )) MOTTEUCCI Lorenzo )) ROSSETTI Pietro )) MUSI Arturo )) ROSSI Giuseppe )) MUSSINANO Pietro )) ROVARIS Angel o )) NEGRO Gius eppe )) SALATI Ettore )) NOFERI Zalino )) SAMMARTINO Roberto )) NUTI Vincenzo )) SANGALI Luigi )) ORLANDINI Mario )) SARACINI Giovanni )) PACINI P i et r o )) SAVIO Vittorio )) PACINI Ubaldo )) SCALA Emanue l e )) PAIOLI Eliseo )) SCALETT I Achille )) P ANELLO Arturo )) SCANNICCHIO Nicola )) PAOLONI Quinto )) SCHINCAGLIA Pietro )) PAPI Orazio )) SCHIVAZAPPA Lino )) P ARRINI Enrico )) SCOTTI Carlo )) PASI Giovanni )) SCREMIN Domenico )) P ASQUINELLI Italo )) SCRIBANTE Arturo )) PASSINI Paolo )) SEGALA Bernardo )) PATRIZIO Pie t ro )) SESIA Giuseppe :> PAVAROTTI Lorenzo )) SEVIERI An gelo )) PEIRON Luigi )) SIMION Raffaele )) PELAGGI Giuseppe )) SITA Giuseppe )) PERETTJ Fioreli u )) SOMMARLVA Giovanni )) Giusepoe )) SONCIN I Camillo )) PETRI Luigi )) SORESINA Giovanni )) PETROSINO Vil: cenzo )) SP ALLINA Pietro )) PEZZELLA Biag1o )) STEF ANI Alfredo )) PIANTONI N icola )) TAGLIARINI Salvatore )) PIZZINATO )) TAMBER Marcello )) POLO Giuseppe )) TANGORRA Vitangelo )) PONTECANI Rodolfo )) TENCONI Domenico )) PRADELLA Giuseppe )) TISI Angelo )) PIUTTI Piet ro )) TONON Attilio )) PRANDO Battista )) TRIANI Oreste )) PRECERUTTI Luigi )) TROMBETTI Giovanni )) QUAGLIATO Alessandro )) VALENTINO Luigi

Soldato VANUETTI Giulio
Soldato VOLPI L uig i
)) VENTRELLA Dom en ico )) ZABOGLIO Agos tino )) VERINI Ma rio )) ZAMBONI Giovanni )) VIGLIOTTI. Angelo )) ZANIN1 Antonio )} VIGNALI Dante )} ZARLOCCO Giulio )} VILLARDI Antonio )) ZIRONI Mario )} VIOLA Mario )) ZUCCIII Ottone )} VOLPI Bortolo )) ZUCCHINI Guido

GLORIE D ELLE TRASMISSIONI

Sotto q uesto t i to lo la S c uol a delle T r asmissioni ha pubblicato nel marzo 1962 un volumetto con le motivazi on i delle r ic ompense al valo r militare concesse alla memoria dei trasmettitori caduti durante il t r entennio 1915 -19 45.
Stralc iamo d a ll a suddetta p u b bl ica zio n e l e motivazioni de lle r i c ompense concesse alla mem o ria de i teleg r a fist i ca d uti du r ante la p ri m a guerr a mo ndia le , avve r.tendo , c ome di ce i l volume t to che :
«La scelt a de lle mo t i vaz i o ni da i nse rire nella prese nte r a cc ol ta è sta ta molto l a bor iosa , n on soltan t o pe r la di ffi c ol t à di r eper ire tu tt e le f on ti a ute n tic he, q ua n t o p e r l'imp recis io ne d i mo l t e m otivazioni rifl ettent i a tti di valore no n co nn ess i con a t tività specifi c he d e lle diverse s pec ia li zz a zi on i delle trasmissi on i.
<<Ne sono derivati molli c a s i di ince r tezza, specie quando in l u ogo della precisa ind icazione d el re parto di appartenenza de l s ingolo deco r ato , il Bollettino Ufficiale s i l i mita a fornire i ndicazion i più generiche ( re ggime n to ge ni o... b attag lio ne misto geni o) .
« S c artati t ut ti i casi dubbi , ne ll a p r esen te r a ccolta sono ripo rt a te s olo le m ot ivazion i de lle d eco r az io n i c on c esse a ll a m e m oria d i Caduti pe r i qu all l'appa rt enenza a lle " Tras m i ss io n i", ri sult a a ccer ta t a d a ll a c h ia r a in d i cazi o ne del r epar t o , o p pure d a un es plic i to rife r i m e n to, nel te s to de lJ a mo ti vazio ne , ad a tti vi tà t i pic h e delle " Trasm i s sioni " ».
L E ME DAGLIE D 'ARGEN T O AL V. M. << ALLA MEM OR I A »
GU ERRA MO NDIALE 1915- 1918
Te n e nt e Ugo CE CCH I 30 rg t. g telegratistt S. Te n. cp l. L u ig i MUTTO 30 rg t . g. teleg r a fist i Ca p. Magg Lu igi C ARIOLA RO 30 r g t. g. t eleg r a fist i (loa c p. t. ) Ca pora l e Esper io B R IOSCHI 30 rg t. g. teleg raft sii S old ato R iccardo B IGL IA 30 rg t . g. t eleg r a ft st i Soldato Anton io GIUL IANI 70 r g t. g telegra ft sti S oldato Gu ido MARZUTT1Nl 70 r gt. g . teleg r afist i Soldato Carlo POR I NELLI JO r gt g. teleg r afist i ooa c çJ. t.) S oldato G iovanni VTETTI 3" r gt. g. t elegrafìsti
e i n o r d ine cro nologico:
Sold ato Carlo POR INELLI
3° r eggimento genio telegrafisti - 10a compagnia telegrafisti
« Com andato in qualità di telegr afista ottico ad un osservatorio di artiglieria, avendo sapu to che la linea telefonica dell'osse r vatorio, in un momento nel quale e r a n ecessario il s uo funzionamento, e ra interrotta, si recava volontariamente a r i p a r ar l a, sotto i l vivo f uo co dell'artiglieri a nemic a. Grav eme nt e colp ito al capo, decedev a in luo go di c ura pochi giorn i app re sso».
Monte San Michele, 18 novembre 1915.
Soldato Riccar do BIGLIA
3° reggim ento gen io telegra fist i
« Costante esem pio di zelo ed attività, in terreno scope r to e molto battuto dal fuoco nemico, si offriva spontaneamente per la verifica di una linea· telefonica interrotta. Ferito mortalmente dopo aver ris tabilito la comunicazione, dava prova di mirabile calma e coragg io, preoccupa ndosi unicamente della incolumi tà dei compagni accorsi per raccoglierlo ».
Bc>sco Cappuccio, 18 · gennaio 19 16.
Caporal Maggiore Luigi CARIOLARO
3° reggimento genio telegrafìsti - 1oa compagnia telegrafisti

« Capo di una stazione ottica , avvolta da una nube di gas asfissianti lanciati dal nemico, non i nterrompeva, nonostante l'imminen te pericolo, l a trasmi ss ione di un teleg r a mm a importante , rim anend o fermo all'apparato fino a ll'ulti mo. Aggravatosi per l'azione de i gas, ord inò ai suoi dipendenti di non curarsi di l ui e d i dedica r si unicamente al servi zio, e scese da solo al posto di medicazione, dove spirò appena ».
B osco Cappuccio, 29 giugno 1916.
Soldato Giovanni VIETTI
3° reggimento genio teleg rafi sti
« Sotto violento fuoco d'interdizione dell'artiglieria nemica, incurante del pericolo, si recava ripe tutamente a r iatta r e le comunicazioni telefoniche interrotte, finché lasciava gloriosamen te la vita sul cam po».
Grazign a, 16 maggio 1917.
Tenente Ugo CECCHI
3° regg i mento gen i o telegrafisti
« Comandante di una stazione radiot elegrafica addetta ad u n comando di divisione, dinanzi all'incalzare del nemico , cercava, con calmo e sereno coràgg i o, di porre in salvo la stazione affidatagli ma essendogli preclusa ogni via d i ono revole salvezza, dopo a ter distrutto gli appar ecchi ed i p r ez iosi document i di c u i era in possesso, piuttosto di arrendersi all'imbaldanzito nemico , p r efe ri va u na mo r te glor iosa; f u lg ido esemp i o ai s uoi soldati di n obile e p uro valore m ilitare ».
Ponte di Caporetto, 24 ottobre 1917.
Caporale Esperia BRIOSCHI
3° r egg imento genio teiegraftst i
« Sotto l 'intenso tiro nemico, rimasto sepolto tra le rovine di una casa, con esemp l are calma ripristinava in breve tempo le comun icazioni te l efonic h e, malg r ado i gravi danni subiti dalle linee e dagli appa r ecch i. Pochi gio rni dopo, benché gravemente ferito, n onc urante di sé, rivol geva a i so ldat i belle ed i sp ir ate pa r ol e di fede, finché spirava, r ammaricandosi soltanto di non pote r l avora r e per l a Patria».
Zenson, 24- 28 febbraio 1918.
Soldato Antonio GIULIANI 7° reggime n to gen io tel eg r afisti

« Nei momenti in c u i maggio r mente i n fieriva l' ira nemi ca, essendo i nterrotte le comun icazio n i telefoniche, attraversava ripetutamente zone battute da violento fuoco pe r p r endere e portare ordini, e, con e l evato sent i mento del dovere e sprezzo de l pericolo, manteneva il collegamento ottico con l 'a rtiglieria e col comando della divisione».
Cima Echar, 15 giugn o 1918.
Sottoten e nte di cpl. Lu igi MU T TO 3° re ggimento genio telegrafisti
« D u rante lo di una linea telefonica co llegante un comando co n nucle i impegn ati, ferito una prima volta gravemente ad un a ma n o da una pallottola di fucile, a c h i lo consigliava d i ritirars i ri spondeva: " Occupatevi del lavoro che è più importante della mia fe r ita " e rimaneva sul pos t o finché, col pito una secbnda vo lt a ed a morte da una granata nemica. cadeva gloriosamente s ul c am po ».
Casa P in Villa Bert i (Piave), 20 gi u gno 1918.
Soldato Guido MARZUTTIN I
7° r eggimento genio teleg r afisti
Medaglia d'Argento al Valor Mili tare «alla mem oria»: «Durante l'attacco nemico, mante n e va fino all'u ltimo le comun ica zioui otti c he Ferito un a prima vo l ta , provvedeva a mette r e in sal v o il pers on ale cd il mater iale della stazione st essa. finché r aggiunto dal nemic o in calzante, cadeva nuovamente colpito a morte». Cuitron - Valle Ardea, 17 luglio 1918.
MEDA GLIE D I BRONZO AL V. M. « ALLA MEM OR
IA »
GUE RRA MONDIALE 1915-
18
Soldato Pietro ANGEL INI LARGllE'rTI 3° rgt. g. telegra fist i (23a cp. t .)

S oldato Mario DI CA RLO 3° r gt. g. telegrafi sti (15a cp. t.)
e in ordine cro no logico:
S oldato Mar io D I CARLO
3° r eggime n to genio te legrafist i - 153 co mp agnia telegrafisti
« Guardafili nelle t rincee avanzate durante un'azione sotto il fuoco di fucileria nemica, procedeva con fermezza, alla ricerca dei guast i ed alla rip a r azione della linea tele foni ca. R ien trato alla stazione sempre fatto bersaglio ad intenso fuoco, si fermava a coadi u vare il telefonista, rimanendo co l pito a mort e per lo scoppio di una granata avvers aria».
Alture di Pal azzo, 29 ottobre 1915.
S oldato Piet r o ANGELINI LA R GHETTI
3° r eggime n to genio teleg rafis ti - 23° co mpa gn ia tc le grafist i
«Più volte, di gio rn o e di notte, so tto il vivo fuoco d'artiglieria nemica, pro vvedeva, sprez zante del pericolo, alle riparazioni telefoniche, in servizio dell'artiglieria pesante campale. Cadeva colpito a morte dur ante l'adempimento del suo com pito» .
Sag r a do- Castein uovo, 18 ottobre - 7 no vembre 1915.
• * *
Vogliamo aggiungere a que sta raccolta che s intetizza il valo re dimostrato dai tr asm ettitori du r ante la prima guerra mondiale, il r ic ordo del maggiore Ma r io Fior e deco r ato di medaglia d'oro a l va l or milita r e « a lla
memoria» e caduto sul Piave il 17 giugno 1918, al comando del 790 battaglione zappato ri.
Trattandosi d i un uffici ale che aveva trascorso auasi per intero la sua breve, luminosa ed inte n sa carriera nelle specialità telegrafisti e radiotelegrafisti, lasciata per assumere il comando di un battaglione zappa tori, riteniamo opportuno citarlo e riportare la motivazione che riafferma ancora una volta come nei nos t ri genie ri l'elevata perizia tecnica non atfievolisca ma esalti le virtù militari :
« Fulgida figura di soldato, ardente di patriottismo, fu costante esempio di abnegazione ai suoi dipendenti sui quali ebbe sempre sicuro ascendente. Comandante di un valoroso battaglione zappatori del genio, accorso in linea con le fanterie in momenti gravi della battaglia, fu durante tre giorni di accaniti combattimenti, per serena calma e cosciente sprezzo del pericolo, esemplare, mantenendo salda ed invitta la resistenza del suo reparto. In u n pericoloso infiltrarsi di mitragliatrici nemiche, trascinò a pro n to e d imp etuoso contrattacco que lli c h e l o circonda va no e cadde colpito al cuo r e A ncora ne ll 'ultimo gest o in citava i suoi a quèlla resistenza che f u dalla magn i fica vittoria co ronata ». (San Mauro del Montello. 15 - 17 giugno 1918).
Aggiungiamo infine un breve «curriculum vitae » dell'eroico maggiore Fiore.

1910: promosso tenente ed assegnato al 3° genio teleg r afìsti;
1911-1913: pa r tec ipò alla guerra di Lib i a con l a ga compagn i a telegrafisti; 1913-1914 : fre quen tò il 1o corso dell' Istit u to Mili tare di rad i o telegr afia in Roma;
1914-1915: destinato in Eritrea per l'impianto di stazioni R. T. fisse· ' '
1915-1918: col grado di capitano fu comandante della Sezione R. T. della 3a D ivisione di Cavalleria e poi della Sezione R.T. della 1a Arma ta.


