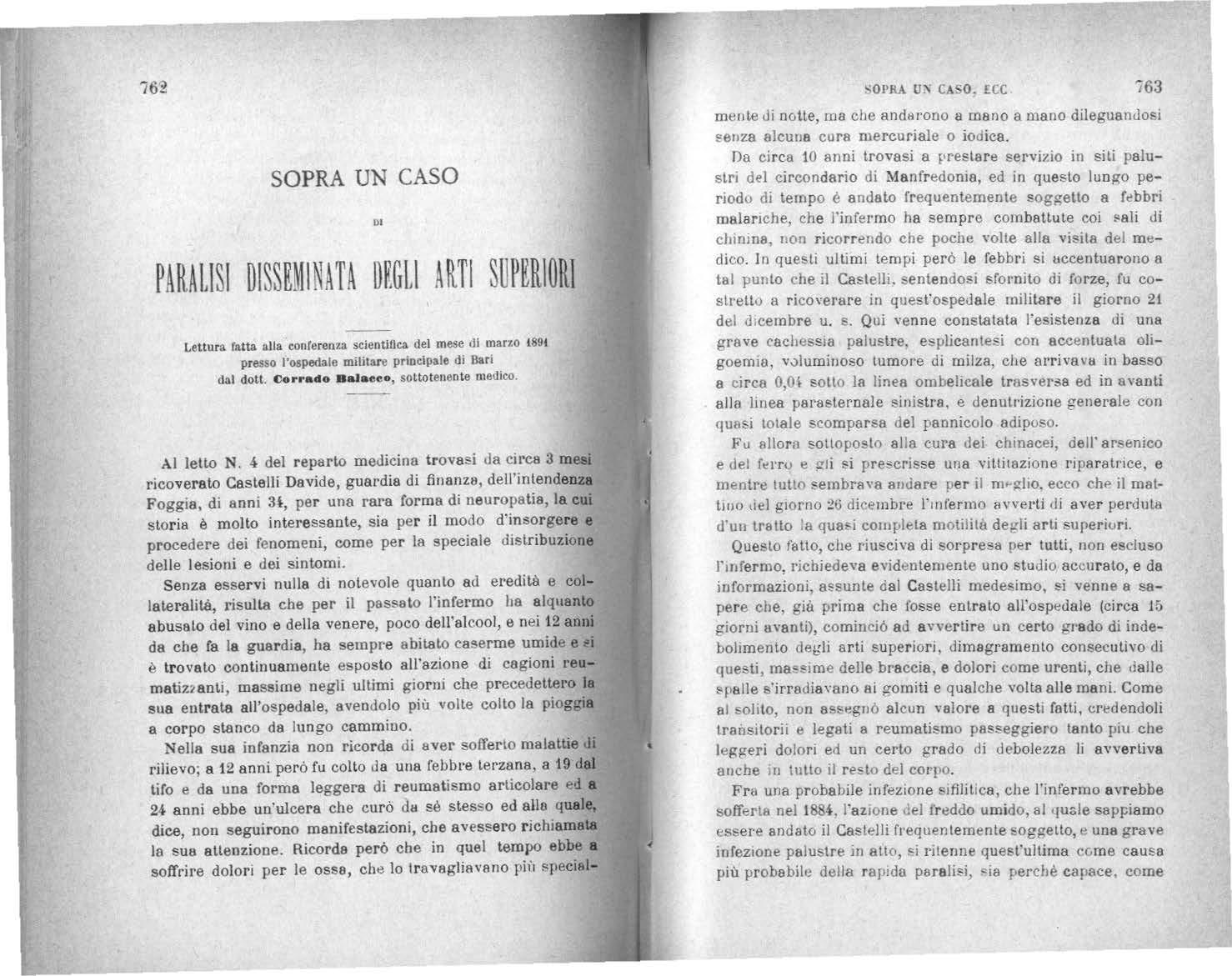
16 minute read
PARALISI DISSEMINATA DKGLI ARTI SUPER\ORI
Al Jett.o N. 4 del reparto medicina trovasi <la ci rca 3 meei ricoverato Castelli Davide, guardia di finanza , dell'intendenza Fogg ia , di anni 31, per una rara forma di neuropatia, la cui storia è molto interessante, sia per il modo d'insorgere e proced ere dei fenomeni, come per la speciale distribuzione delle lesioni e dei sintomi.
Senza esservi nulla di notevole quanto ad eredità e collateralitil, risulta che per il passato l'infermo ha alquanto abusato del vino e della venere, poco dell'alcool, e nei 12 anni da che fa la guardia, ha sempre a bitalo caserme umide e ei è trovato continuamente esposto all'azione di cagioni reumatiz~ anti , massime negli ultimi giorni che precedettero la sua entrata all'ospedale, aven dolo più volte colto la pioggia a corpo stanco da lungo cammino.
Advertisement
Nella sua infanzia non ricorda di aver sofferto malattie Ji rilievo; a 12 anni. però fu collo <la una febbre terzana, a 19 dal tifo e da una forma leggera di reumatismo articolare ed a 24 anni ebbe un'ulcera che curò d1t sé stesso ed alla quale, dice, non seguirono manifestazioni, che avessero richiamata la sua allenzione. Ricorda però che in quel tempo ebbe a soffrire dolori per le ossa, ch e lo travagliavano più !-pecial-
SOPRA U:'.\ CASO. ECC ,63 mtlole di notte, rna che and11rono a mano a mano dileguandosi seuza alcuna cura mercuriale o iodica.
Da circa 10 &nni trovasi a ~·restare servizio in siti palustri del circon dario di Manfredonia, ed in questo lu ogo periodo di tempo é andai.o frequentemente sog~eUo a fc!bbri malariche, che l'infermo ha sempre combattute coi l'ali di chi nina, i.on ricorrendo che poche volle alla visita del mt:dico. In questi ultimi tempi però l e febbri si uccentuarono a tal punto che il Castelli,. sentendosi sfornito di forze, fu coslreLlo a ri co ,·erare in quesfospedale militare il giorno 21 del dicembre u. s. Qui venne constatata l'esistenza ùi una gra ve cachessia palustre, esplicantesi con accen tuata oligoemia, v0lumi11oso tumore di milza, elle arriva va in basso a ci rca O,M sollo la linea ombelicale trasver3a ed in avanti alla linea parasternale sinistra , e de nutrizione gen erale con quasi totale scomparsa del pannicolo adiposo .
Fu alloro sotloposlo alla cura dei chinacei, del!' arsenico e del fc!l'ru e ~li si pre;;crisse una villitazione riparatrice, e mentre tutto sembrava a11ùare µer il m..~lio, ecco che il mattrno del giorno :W dicembre J" mfermo avverti d i aver perduti! d"un tratto !a qua.-i cornplela motilità de,;li a r ti superio r i.
Queslo fatlo, che riusciva di so rpresa per tutti, non escluso l'inferm o, richiedeva eviden temente uno studio accu ra to, e da informazioni, assunte da l Cas telli medesimo, si venne a saper e che, già prim a che fo sse entrato all'ospedale (circa 15 giorni avanti), cominciò a d a,·,·ertire un certo grado di indebolimento degli a rti s uperi ori, dimagramento consecutivo <li questi, massime delle bra ccia , e dolori come urenti, che da lle spalle s'i rradiavano ai gomi ti e qualche volta alle roani. Come al solito, non asseguò alcun valore a questi fatti, c redendoli traòsitor ii e legati a reumati smo passeggier o tanto piu che leggeri dolori ed un certo grado di debolezza li avvertiva anche rn tutto il resto del corpo.
Fru una pr obab ile infezio ne sifilitica, che l'infermo avrebbe sofferta nel 188-i , r azione del freddo umido, al qu:,le sappiamo tsser·e andato il Castelli frequentemente soggetto, e una grave infezione palustre in alto, si ritenne quesl"ullima cc. me cau sa più pr obabile della rapido. para lisi, <>ia perché car,ace, come
SOPRA U!'i CASO
tutte le infezioni gravi. di produrre fenomeni consimili, sia perché si era innanzi ad un infermo, la cui nola predominante era la grave cachessia malarica. Si ricorse allora alle iniezioni ipodermiche di chinina, al decollo di china, unito a dosi frazionale di chinina. ma in un mese circa di questa cura poco si ottenne quanto alla j)aralisi, mollo però quanto all'infezione palustre esssendosi ridotto abbastanza il tumore di milza e miStliorato lo slato olig,oemico.
Intanto da un esame fisico ed elettrico, più volte ripetuto, per essere certi della costanza dei fenomeni, ri~ullò che mentre i muscoli elevatori delle spalle, <]Uelli del collo e della faccia erano integri quanto a fum:ione e nutrizione, parecchi gruppi muscolari delle spalle. dellé bra ccia, degli avambracci e delle mani avevano, quale più quale meno, perduta l'eccitabilitA motrice e su di essi si scorgevano le note di una rapi da atrofia.
L'infermo poteva allontanare di poco, tanto in avanti, come indietro ed infuori, ra,·to superiore destro dal tronco, mentre il sinistro poteva, con rapido movimento di abduzione, portarlo in posizione orizzontale senza per ò poterlo mantenere in ta1P posizioni>, perchè subito dopo l'arto ricadeva per l'roprio peso in posizione perpendicolare. Perduta completamente era la flessione degli avambracci sulle braccia, mentre era ancora possibile il movimento di estensione perché, fletlendo artificialmente gli avambrncci, e portando nel contempo le braccia in posizione orizzont.sle, l'infermo poteva, sebbene con lentezza, compiere il movimento di estensione degli avambracci
Abolito era ancora a destra il movimento di supinazione, mentre a sinistra si compiva con difficoltà, ed egualmente aboliti erano i movimenti di estensione delle mani e delle dita, come pure l'abduzione delle mani, ad eccezione dell'e!lleni;;ione d~J pollice destr o ed in parte anche del sinistro. Erano poi integri i movimenti di flessione delle dita sulle mani e di queste sugli avambracci, e tanto all'uno come ali' allro lato il polso era in pronazione completa e mantenuto alquanto flesso sull'avambraccio. Un particolare, che va rendendosi a mano a a mano meno manifesto. è che la flessione completa delle mani !lugli avambracci non è diretta, ma 1tccompagnala da marca- tiss1ma adduzione del margine cubitale delle mani. I movimenti di allontanamento e ravvicinamento del!€' dita erano alquanto lenti, ed alla mano destra quasi aboliti.
Quanto all'atrofia, i muscoli più colpi ti. senza essere complelamenle atrofici, erano i deHoidi,prevalentemenle il de-:tro, quelli delle braccia ed in minor grado quelli della regione esterna degli avambracci, il radiale a!lteriore Jestro ed i mu"Scoli tenari, ipotenari ed interossei.

Un certo grado di par esi e d'atrofia si riscontrava anche negli arti inft!rior1: l'infermo, infatti, non poteva cammina1·e speditameute, il suo passo era lento e cadenzato, sollevava di poco i piedi dal suolo e andava incontro a facile stanchezza, per cui era costretto a passare io lello molle ore della giornata. Non esisteva però tilubazion~ od incoordinazione dei movimenti volontarii, né alcun disturbo nella funzione della vescica e del retto.
Quanto all'esplorazione elettrica i l'isultali sono stati dei più neLti: la cont,·azione si è riscontrata perfetta in lutti i muscoli che hanno conservata la motilila, essa si è trovata abolita nei muscoli inerti. I risultali sono stati gli stessi sia applicando la corrente ai muscoli, sia facendo uso della elettrizzazione nevro-muscolare, applicando cioé uno dei poli dell'apparecchio sopra un cordone nervoso e l'altro :,(opra uno dei muscoli animali da questo ne1·vo.
La reazione eletlrica quindi si è mostrata abolita nei muscoli delle spalle, delle braccia, meno i tricipiti, che rispondono leggermente, nei radiali ed io tutti gli altri , che nell'avambraccio sono innervati dal nervo radiale, meno il corto e lun:;ro estensore del pollice destro, che rispo ndono con una certa energia.
La sensibilità (laltile . termica, dolor ifica, elettrica, quella al i:,olletico, alla pressione) si é trovala leggermente aflìevolita negli art, superiori come negl'inferiori e que,;to affievolimento è maggiore nelle zone dei muscoli inerti degli arti superiori.
I riflessi cremaslerici, patellari e dei tendini d'Achille erano molto affievoliti; quelli degli arti superiori,poi,completamente aboliti: né si sono mai verificali movimenti flbrillari sui rnu~coli paralizzati.
Questo era lo stato del nostro infermo ver.~o il principio del g e nnaio ultimo, e tale rimane tutt'ora , ad eccezione di un graduale e le~giero miglioramento delle condizioni generali e dell'atrofia degl'arti superiori in particolare.
Si tratta, dunque, d'una malattia apirettica, che dura da circa tre mesi, caratte rizza ta da a lcuni dolori alle estremità degl'arti superiori e dall'impotenza motrice degl'avambracci ed in pa rte delle braccia, delle mani e degl' arti inferiori . Questa impotenza motrice è limitata a certi gruppi muscolari, i muscolì cosi colpiti sono più o meno atrofizzati, essi hanno tutti perduta la loro contrattilità elettrica e la loro motilità riflessa; infine l'irregolarita, che presenta la sede di questi sintomi, r.on è che apparente, poiché essi sono rigorosamente localizzati secondo la distribuzione anatomica di certi cordoni nervosi. La sensibilità è alterata in un'estensione molto minore, ma questi disordir.i hanno la stessa localizzazione anatomica dei disturbi di motilità.
Avendo così esposto nei loro dettagli i caratteri clinici di questo fatto, passo alla discussione ed alla diagnosi.
La prima quistione a risolvere è la seguente: e essa una paralisi propriamente delta, o e un· a trofia muscolare con impotenza motrice consecutiva? Non mi sembra c.he si possa nel caso nostro ammettere un·atrofia muscolare progressiva, tanto per il rapporto cronologico dell'atrofia e dell'impotenza motrice, come per il modo ùi distribuzione delle lesioni e dei sintomi. Nell'atrofia muscolare progressiva la diminuzione di volume dei muscoli precede i disturbi di movimento. Le deformità parziali, la scomparsa delle sporgenze norma li, fatta ogni riserva dai dolori iniziali, ecco il primo sintoma per ordi ne cli data; l'impotenza motrice, più o meno completa, che gli succede, è la conseguenza diretta del degradamento del sistema muscolare; ci ha meno movimento prodotlo, perché ci E'ono meno elementi contrattili per produrlo, ecco tutto: ma i muscoli alterati obbediscono alfa volontà, non ci è dunque paralisi, perché questa parola, nel senso preciso che convien darle, indica l'esistenza di un disturbo nell'innervaziÒne motrice volontaria; questa è intatta, solo il muscolo è insufficiente a compiere le manifestazioni;
Di Paralisi Disseminata Degli Arti Supbrjori 767
più è insufficiente, più le manifestazioni motrici sono difficili ed incomplete. Si ha cosi un rapporto rigorosamente proporzionale tra la perdila muscolare ed il grado dell'acinesia, questa seguendo quella, come l' effetlo segue la causa che lo genera.
Ora nel caso nostro abbiamo delle informazioni circostanziate sul modo di origine degl'accidenti, e noi sappiamo che la difficoltà e l'energia motrice ba preceduta costantemente quel che l'infermo chiama dimagramento delle parti.
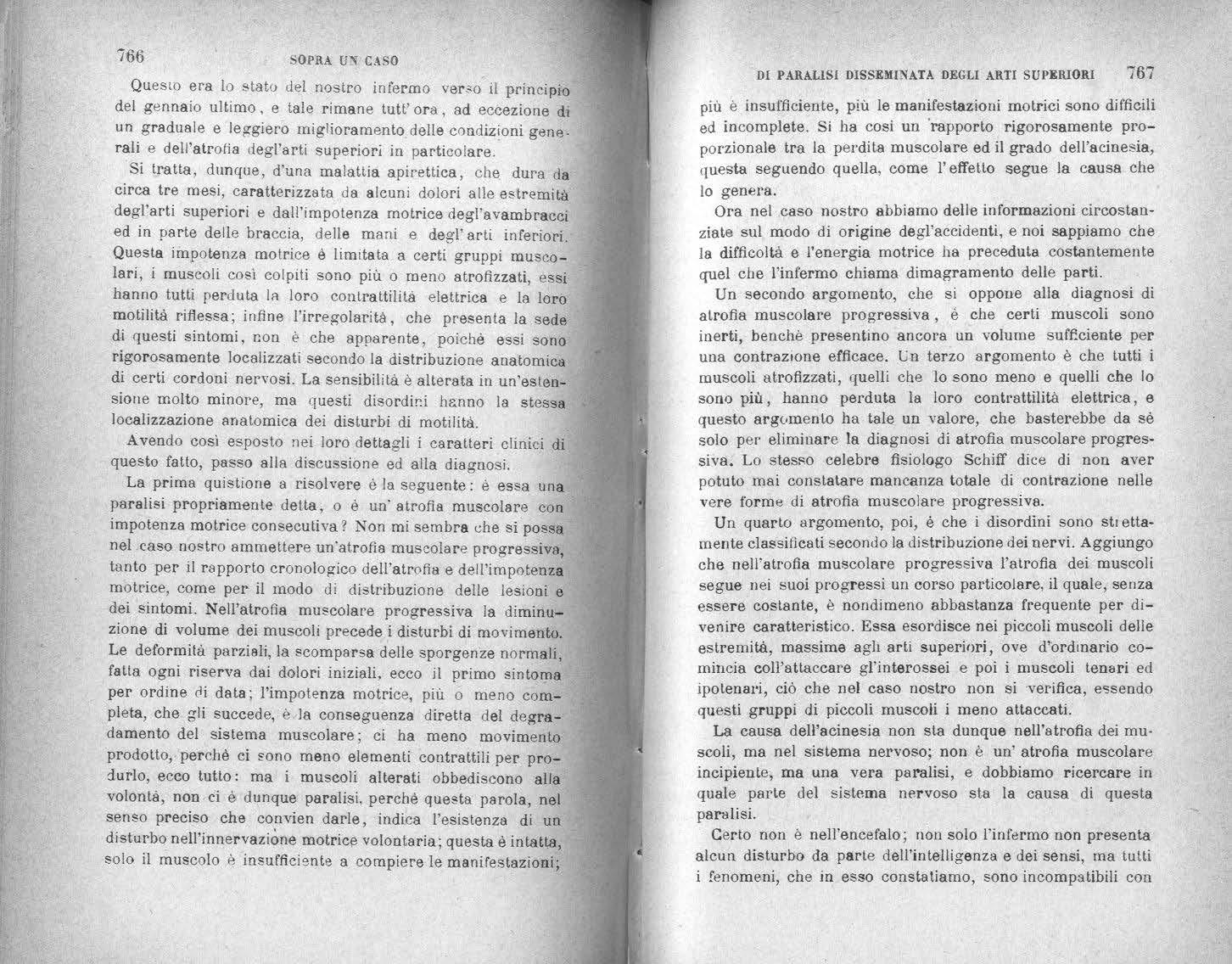
Un secondo argomento, che si oppoue alla diagnosi di atrofia muscolare progressiva, é che certi muscoli sono inerti, benchè presentino ancora un volume sufF..ciente per una contrazione efficace. Co terzo argomento è che tutti i muscoli atrofizzati, cruell i che lo sono meno e quelli che lo sono più , hanno perduta la loro contrattilità elettrica, e questo arg(,mento ha tale un valore, che basterebbe da sè solo per eliminare la diagnosi di atrofia muscolare progressiva. Lo stes!"O celebre fisiologo Schiff dice di non aver potuto mai constatare mancanza totale di contrazione nelle vere forme di atrofia muscolare progressiva.
Un quar to argomento, poi, e che i disordini sono st1 ettamente classificati s econdo la distribuzione dei nervi. Aggiungo che nell'atrofia muscolare progr essiva l'atrofia dei muscoli segue nei suoi progressi un corso particolar e, il quale, se11za essere costante, è nondimeno abbastanza frequente per divenire caratteristico. Essa esordisce nei piccoli muscoli delle estremità, massima agli arti superil)ri, ove d'ordinario comincia coll'attaccare gl'interossei e poi i muscoli tenari ed ipotenari, ciò che nel caso nostro non si verifica, e<sseodo questi gruppi di piccoli muscoli i meno attaccati.
La causa dell'acinesia non sta dunque nell'atrofia dei muscoli, ma nel sistema nervoso; non è un' atrofia muscolare incipiente, ma una vera paralisi, e dobbiamo ricercare in quale parte del sis tema nervoso sta la causa di questa paralisi.
Ce rto non è nell'encefalo; non solo l'infermo non presenta alcun disturbo da parte dell'in telligenza e dei sensi, ma tutti i fenomeni, che in esso constatiamo, sono incompatibili con l'idea di una paralisi d'ori~ine encefalica. Nella r,arahsi per le!<rone dell'encefalo, infatti. ratrofia accade quando, la lesione non guarendo, la paralisi persiste ; ma quest'atrofi a è essenzialmente tardiva, e ssa è l egttla alla degenerazione secondaria di certe parti del midollo, e questo lavorio regressivo, pr odotto da alterazione encefalica, non comiu cia che dopo alcuni mesi, come hanno stabilito le rimarchevoli osservazioni di Tiirck, meglio ancora p1·ecisate da Charcot Dagli studii d1 Tiirck risulta che la distruzione della capsula interna di un emisfero arreca, dopo alcun i mes,, una degenerazione secondaria, la quale s i può segoire nel peduncolo cerebrale corrispondente, nella protube r anza, nella piramidt> anterior e del bulbo e nel fascetto laterale del midollo dal lato opposto alla lesione cer ebra le; ma più tardi Charcot ha dimostrato che le lesioni corticali delle cir convoluzioni e dei centri psicomotori possono ugualm ente produrre, allorquando sìeno estese. degenerazioni se~ondarie discendenti, il che proverebbe che Yi sono lascelli diretti , che vanno dalla capsula intern1:1 alle circonvoluzioni, senza inte rruzi one a livello <lei nuclei centrali dì sostanza gri!!ia. Oltre ali" atrofia rapida, si oppone anche la per dita dei movime11li riflessi, che, vice versa, in lesioni encefaliche dovrebbero essere esagerati.
L'encefalo essendo fuori quistione, egli;, chiaro cl1e la paralisi ha la sua or igine nell'apparecchio spinale. Ma questo si compone del midollo e dei ner vi, che ne partono: trattasi dunque determinare se la causa della paralisi sta nel midollo o nei nervi periferici. In questa quic::tiorre sta tutto l'interess e de l fa tto.
Nelle paralisi per lesione del midollo l'atrofia può mancare completam ente se la lesione ha completamente interrotta la continuità dell'asse spinale, senza produrre l'alterazione, la disor ganizzazione del segmento inft:!rior e.
Quando 11uesto segmento e esso stesso alterato. !"atrofia succede, ma non è mai conte mporanea all'i mpotenza motrice; la n utrizione dei mm,coli non comincia ad essere compr ome ssa che quando la loro eccitabilita è perduta, c ioè a dire cinque o sei mesi dopo il principio della paralisi. Allora
DI PARALISI DlSSEmNAfA OEGU ARTI SUPERI ORI i69
anche la contrattilità elettrica è abolita, !:iebben... i muscoli &bbiano un volume asc:ai più consi<lerevol1:1 di quello, che vediamo nPl nostro caso speciale. O' c1ltra parte, volendo ammettere una lesione del midollo, noi non potremmo lo~alìzzarla che ud rigonfiamento cervicale, <'t.l allora mancherebbero almeno gli accenni di disturbi da parte dei movimenti automa tici del respiro e della deglutizione.
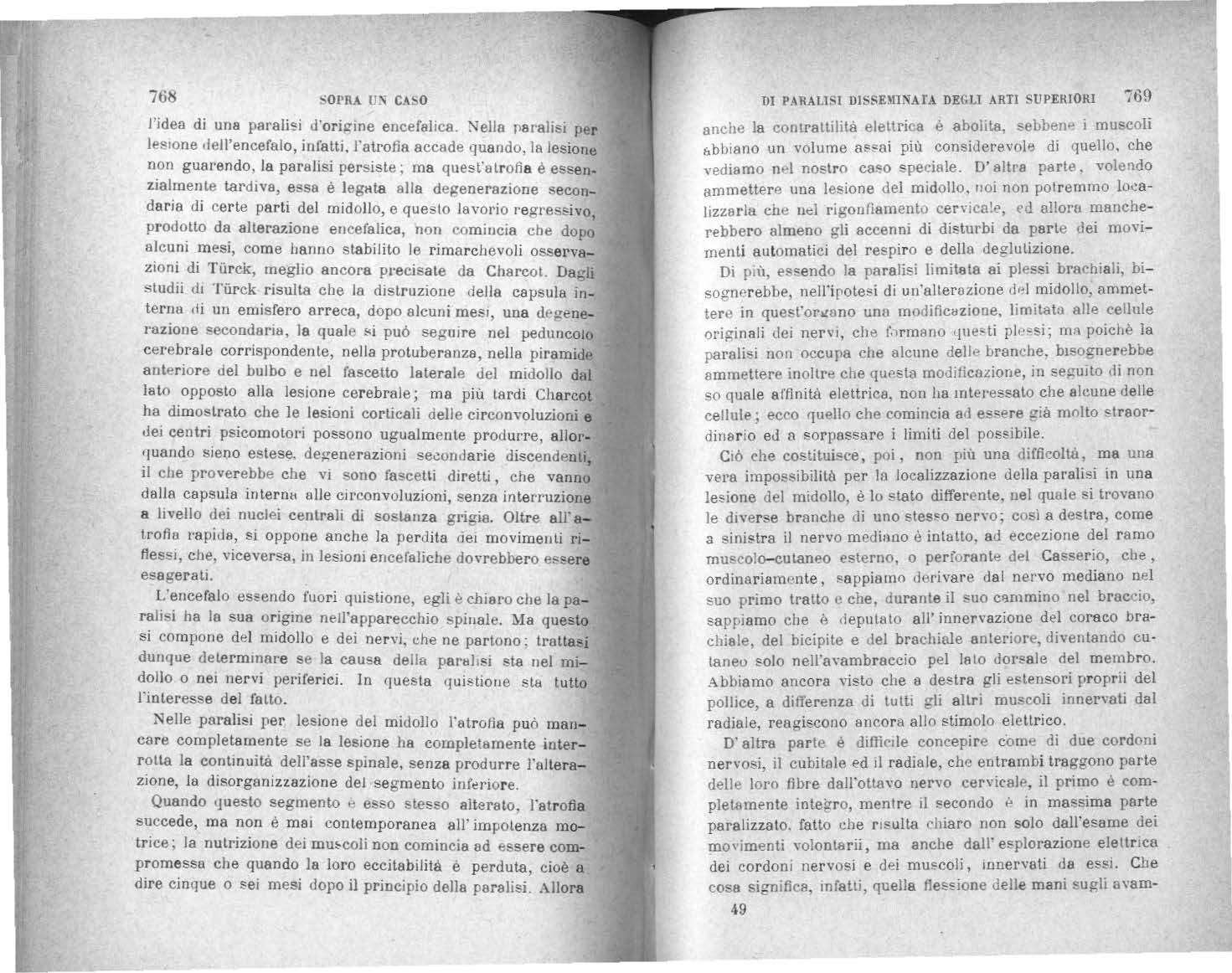
Di più, esc:endo la paralisi limitata ai plessi brachiali, bisognnebbe, nelripotesi di un"alterazione d,·1 midollo, ammetter~ in quesl'or!lano um1 modifìc~ziooe, limitato alle ce lule origin ali dei nervi, che f,1rmano que»ti pl.,.,si; 1w1 poiché la paralisi non occupa che alcune dell e branche, b1c::ogner ebbe ammettere inoltre che quPsla modificoLione, in seguilo di non so quale al'flnità elettr ice, non ha m t e!'essato che alcune delle cellule; ecro quello che comincia ad esc::ere già molto "'traor· dina r 10 ed a sorpossaro i li miti del possibile.
Ciò che costituic::ce, poi, non più una difficolti.t, ma una vera impossibililà per lfl localizzazione della paralisi in una lesione del midollo, è lo stato diffe rente, nel quale si trovano le diverse branche di uno sleS!"O nerYo; così a destra, come a sinistr a il nervo medinao è intatto, ad eccezione del ramo mu"'co!o-cutaneo esterno, o perìorante del Cas.,erio, che, ordinariam<•n le, c::a ppiamo ùerivar e dal nervo media no nel suo primo tratto e che, durante il suo CQmmino nel brac,:ìo, sappiamo che è deputato ali' innel'\'azìone del coraco brachiale, del bicipite e del brachiale anteriore, diventando cutaneo solo nelraYambraccìo pel lato dorsale del membro. Abbiamo ancora visto che a destra gli estensori pro prii del pollìce, a differenza <li tutti gli a llr1 mu,-coli ìnner,·ati dal radiale, reagiscono ancora allo stim olo elettrico.
D'altra parte è diflirile concepire come di due cordoni nervosi, il cubitale ed 11 radiale, che entram bi traggono parte delle loro fibre dall'ottavo nervo cer,·icalP, il primo è completamente integro, mentre 11 secondo f' in massima parte paralizzalo. fatto che r is ulta rhiaro non solo dall'esame <lei mo dmenti Yolonlarii, ma anche dall' esplorazione elettrica dei cor doni nervosi e dei muc:coli, mnervali da essi. Che cosa significa, mfatli, quella flessione dell e mani su~?li avam- bracci, accompagnata da marcatissima adduzione del margine cubitale delle mani, se non la prevalenza dei cubitali sui radiali paralizzati? Oltre a ciò i nervi radiali presentano una condizione delle più int.eres~anti, vale a dire clie, mentre i rami che forniscono agli avambracci ed alle mani sono paralizzati, le branche, invece, che sono deputale all'innervazione del muscolo tricipite sono in parte intatte, come intatta è a destra la branca di questo nervo, deputata all'innervazione degli estensori proprii del pollice.
Questa distribuzione dei disordini, !'-ulla quale ho creduto necessario intrattenermi, sopratutto perch é di grande aiuto per la diagnosi, io credo che sia inconciliabile con l'idea di un'alterazione del midollo, ed al contrario parla io favore di un'alterazione disseminata dei nervi periferici dei plessi brachiali. Questo dato diagno~tico acquista maggiore importauza a fianco degl'allri, più sopra menzionati, quale l'atrofia precoce dei muscoli e la perdita rapidissima dell'eccitabilita elettrica. Parrebbe dunq ue accertato che nel caso nostro traUisi di una paralisi disseminata dei neroi periferici dei plessi brachiali e più specialmente delle branche di di r amazione dei neroi radiali .
Questa paralisi, per fortuna dell'infermo, pare non segua un decorso progressivo, il elle si rileva sia per la migliorata nutrizione dei muscoli, sia percl1è il grado della paralisi, massime in questi ultimi giorni, è diminuito, per cui credo poter formulare una prognosi fausta quo ad oitam e riservala quo ad oaletudinem,
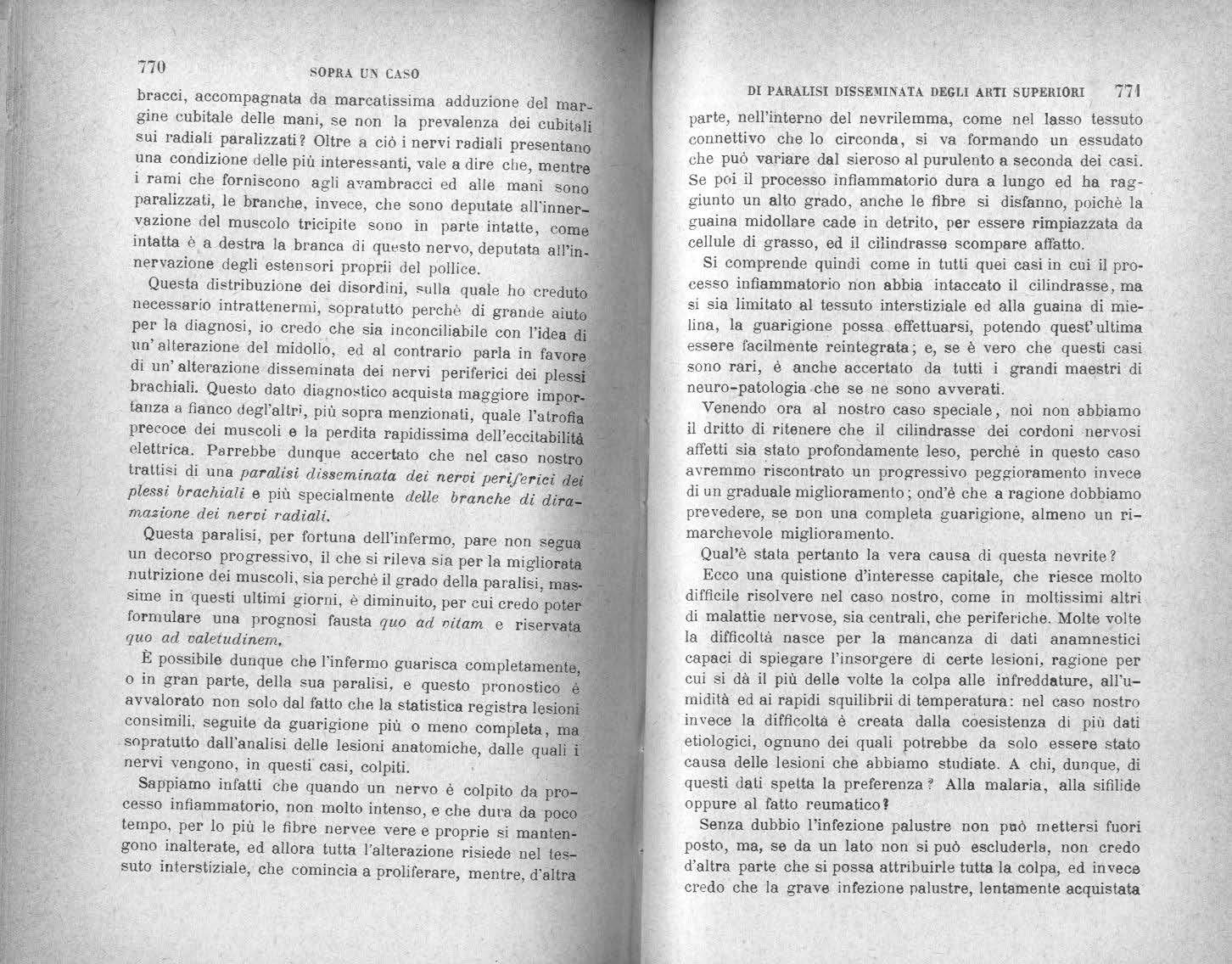
È possibile dunque che l'infermo gu1:1risca completamente, o in gran parte, della sua paralisi, e questo pronostico è avvalorato non solo dal fatto che la statistica registra lesioni consimili, seguite da guarigione più o meno completa, ma sopratutto dall'analisi delle lesioni anatomiche, dalle quali i nervi vengono, in questi" casi, colpiti.
Sappiamo infatti che quando un nervo è colpito da processo infiammatorio, non molto intenso, e che dura da poco tempo, per lo più le fibre nervee vere e proprie si mantengono inalterate, ed allora tutta l'alterazione risiede nel tessuto interstiziale, che comincia a proliferare, mentre, d'altra
DI PAR,ALISI DISSE)IINATA DEGLI ARTI SUPERIORI 771 parte, nell'interno del nevrilem_ma, come nel lasso tessuto connettivo che lo circonda, s1 va formando un es~udat? che può variare dal sieroso al purulento a seconda dei cas1. se poi il processo infiammatorio dura a lungo ed ha raggiunto un alto grado, anche le fibre si disfa~no,. poichè la cruaina midollare cade in detrito, per essere runp1azzala da ~Jlule di O'rasso ed il cilindrasse scompare affatto.
Si comp:ende ~uindi come in tutli quei casi in cui il pros so infiammatorio non abbia intaccato il cilindrasse, ma ce . . si sia limitato al tessuto interstiziale ed alla guaina d1 m1elJ.na la O'uari afone possa effettuarsi, potendo quest' ultima ) o t,, • • essere facilmente reintegrata; e, se è vero che questi ~as'. sono rari, è anche accertato da tutti i grandi maestri dt neuro- patologia che se ne sono avverati. .
Venendo ora al nostro caso speciale, noi non abbiamo il dritto di ritenere che il cilindrasse dei cordoni nervosi affetti sia stato profondamente leso, perchè in quest~ caso avremmo riscontrato un progressivo peggioramento invece di un graduale miglioramento; ond'é che a ragione dobbia~o prevede re, se non una completa guarigione, almeno un rimarchevole m iglioramento.
Qual'è stata pertanto la vera causa di questa nevrite?
Ecco una quistione d'interesse capitale, che ri~s~e ~olt~ difficile risolvere nel caso nostro, come in m0It1ss1m1 altri di malattie nervose, sia centrali, che periferiche. Molte vo~t~ la difficoltà nasce per la mancanza di dati anamnest1c1 capaci di spiegare l'insorgere di certe l~sioni, ragione ~er cui si dà il più delle volte la colpa alle mfreddature, all umidità ed ai rapidi squilibrii di temperatura: nel ca.so ~ostr~ in,·ece la difficoltà è creata dalla coesistenza di prn dati etiologici, ognuno dei quali potrebbe da solo essere stat~ causa delle lesioni che abbiamo studiate. A chi, dunque, d1 questi dati spelta la preferenza r Alla malaria, alla sifilide oppure al fatto reumatico t . .
Senza dubbio l'infezione palustre non paò mettersi fuori posto, ma, se da un lato non si può escluderla, non. credo d'altra parte che si possa attribuirle tutta la colpa, ed 1~vec.e credo che la grave infezione palustre, lentamente acqmslala
SOPRA U" CASO
dal Castelli per la prolungata sua dimora in siti nH1larici . , abbia preparata la catastrofe, alterando gradatamenlE> il tro. fismo e forse anche il chimismo del sistema uen·oi:<o, allo stesso modo cbe sappiamo avvenire per gli altri tessuti, ren. dendolo quindi meno atto a resistere alle influenze, di qua. Junque natura esse sieno, capaci di agire direttamente o indirettamente su di esso.
Questo modo di vedere e favorevole quindi ad un sisteroa d1 cura, in cui entrino a far parte i chinacei e r arsenico , perché in tal modo si rende l'organismo più resistente, cercando di eliminare o attenuare quell'infez1one, che avrebbe agevolata l'insorgere della nevrite; e ciò è tanto più giusto, in quanto che il lieve miglioramento che l'infermo prei:<e nta è con grande probabilità dovuto alla cura antimalarica con. giunta alla cura elettrica.
Quanto alla sifilide, non é assolulamenle provato clw l'infermo abbia sofferto questa infezione, né ri;;contransi falli obbiettivi tali da farcela ammettere; ciò non pertanto, per eliminare questo du bbio, da più di un mese si è istituita una cura mista di mercurio e ioduro, ma nulla lln"ora s·p osservato di speciale, all'infuori del lento e graduale migliora,. mento che già si iniziava prima della cura ant1sifili tica.
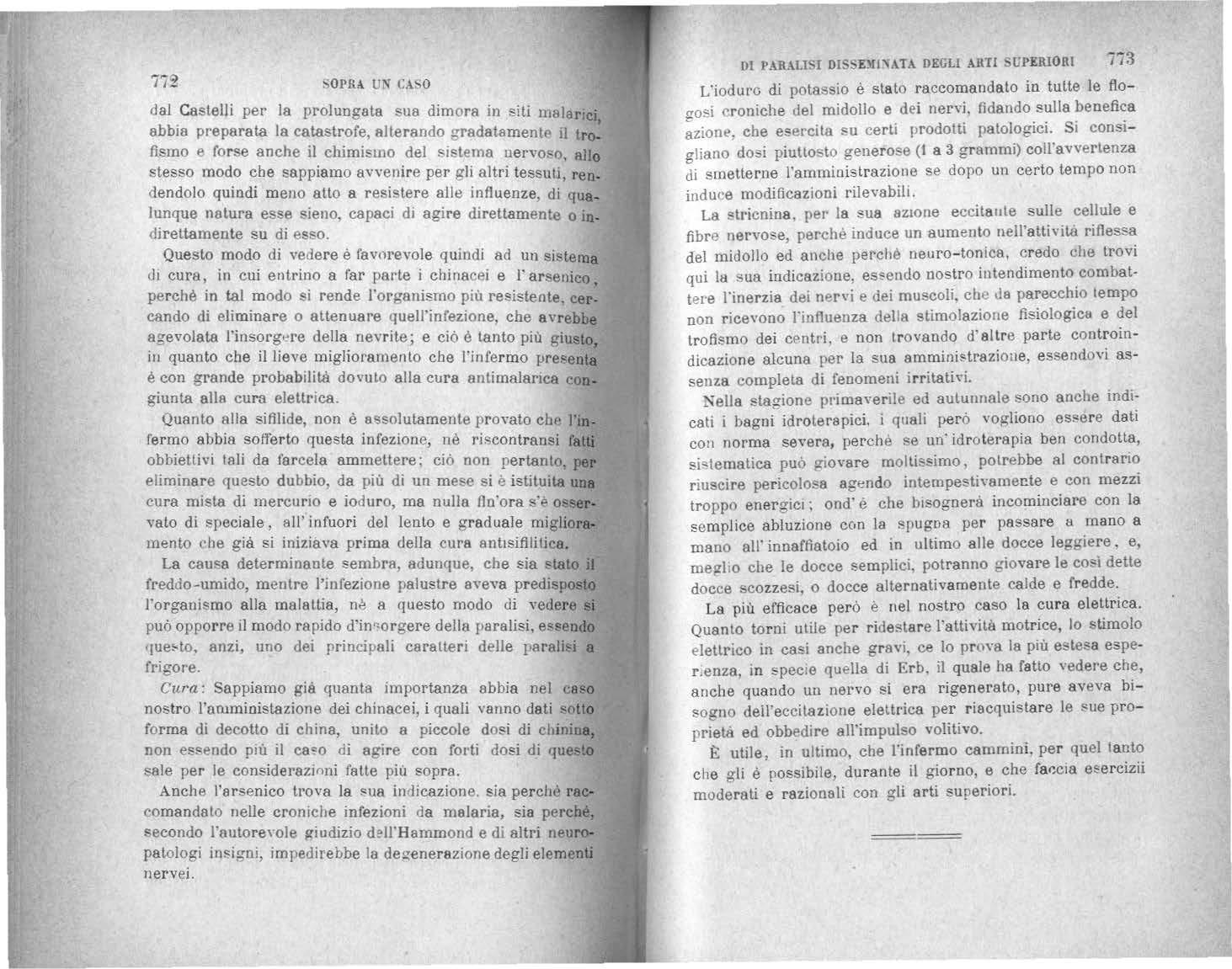
La cau!"a determinante sembra, adunque, che sia stato il freddo-umido, mentre l'infezione palustre aveva predisposto l'organismo alla malaltia, nè a questo modo di vedere si può opporre il modo rapido d'in•,orgere della paralisi, es~endo quel-to, anzi, uno dei principali caratteri delle paralisi a frigore.
Cu ra: Sappiamo già quanta importanza abbia nel caso nostro l'aruministazione dei chinacei, i quali vanno dati !'otto forma di decotto di china, unito a piccole dosi di ch inina, non es!'endo piu il ca~o di agire con forti dosi di questo sale per le considerazinni fatte piu sopra.
Anche l'arsenico trova la sua indicazione. sia percbè rac<'Omandato nelle croniche infezioni da malaria, sia pe rché, secondo l'autoreYole ~iudizio dt>IrHammond e di altri neu ropatologi insigni, impedirebbe la degenerazione degli elementi nervei.
DI PARALISI DISSElt:l,ATA DEGU ARTI SGPERIORI 'i73
L'ioduro di pota~sio e stato raccomandato in tutte le tloaogi <'roniche del midollo e dei ner\·i, fidando sulla benefica ;zione, che esercita su certi prodotti patologici. Si consiuliano dosi piuttosto generose (1 a 3 grammi) coll'avvertenza ,::, di smetterne l'amministrazione se dopo un certo tempo non induce modificazioni rilevabili.
La stricnina , per la sua azione eccitante sulle cellule e fibre nervose, perché induce un aumento netrattivilà riflessa del midollo ed anche perché neuro-tonica, c redo che trovi qui la Hua indicazione, essendo nostro intendimento combattere l'inerzia dei ner\'i e dei muscoli. che da parecchio tempo non ricevono l'influenza della stimolazione fisiologica e del trofismo dei centri, e non trovando d'altre parte controindicazione alcuna per la sua amministrazione, essendovi assenza completa di fenomeni ir ritath·i.
Nella stagione prima,·erile ed autunnale sono anche indicati i bagni idroterapici, i quali però vogliono essere dati con norma seYera , perché i:<e un· idroterapia ben condotta, si~temalica può iziovare moltissimo, potrebbe al contrario riuscire pericolosa agendo intempestiYamecte e con mezzi troppo energici ; ond' é che bisognerà incominciare con la semplice abluzione con la spugna per passare tt mano a mano ali' innaffiatoio ed in ultimo alle docce leggiere, e, me~lio che le docce semplici, potranno giovare le così dette docce scozzesi, o docce alternativamente calde e fredde.
La più efficace però è nel nostro caso la cura elettrica. Quanto torni utile per ridestare l'attività motrice, lo stimolo elettrico in casi anche gravi, ce lo prova la piu e::;lesa esper,enza, in specie quella di Erb. il quale ha fatto vedere che, anche quando un nervo si era rigenerato, pure aveva bisogno deil'eccilazione elettrica per riacquistare le ~ue proprietà ed obbedire all'impulso volitivo.
I!: utile, in ultimo, che l'infermo cammini, per quel tanto che gli é possibile, durante il giorno, e che fMc1a esercizii moderali e razionali con gli arti superiori. -------










