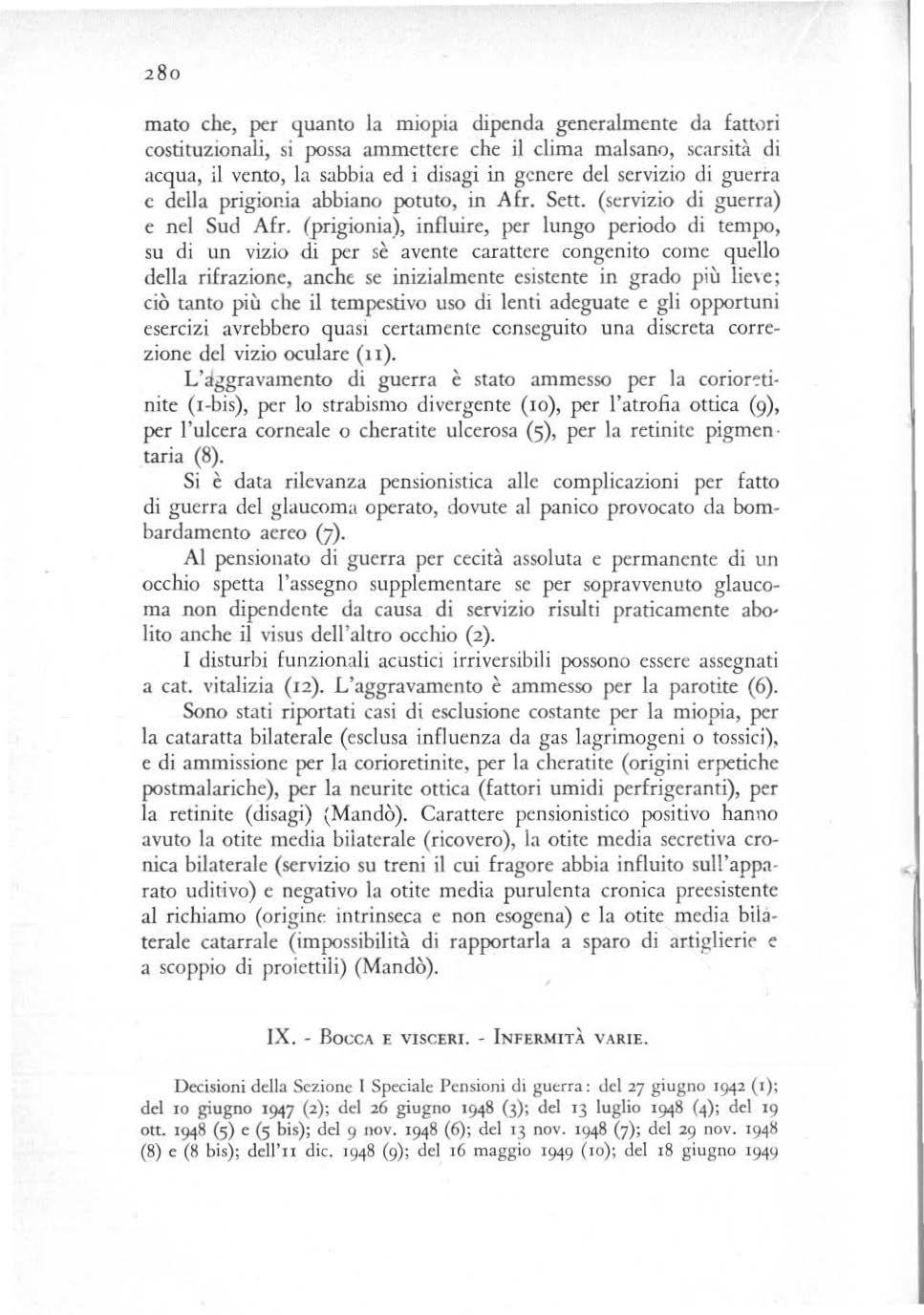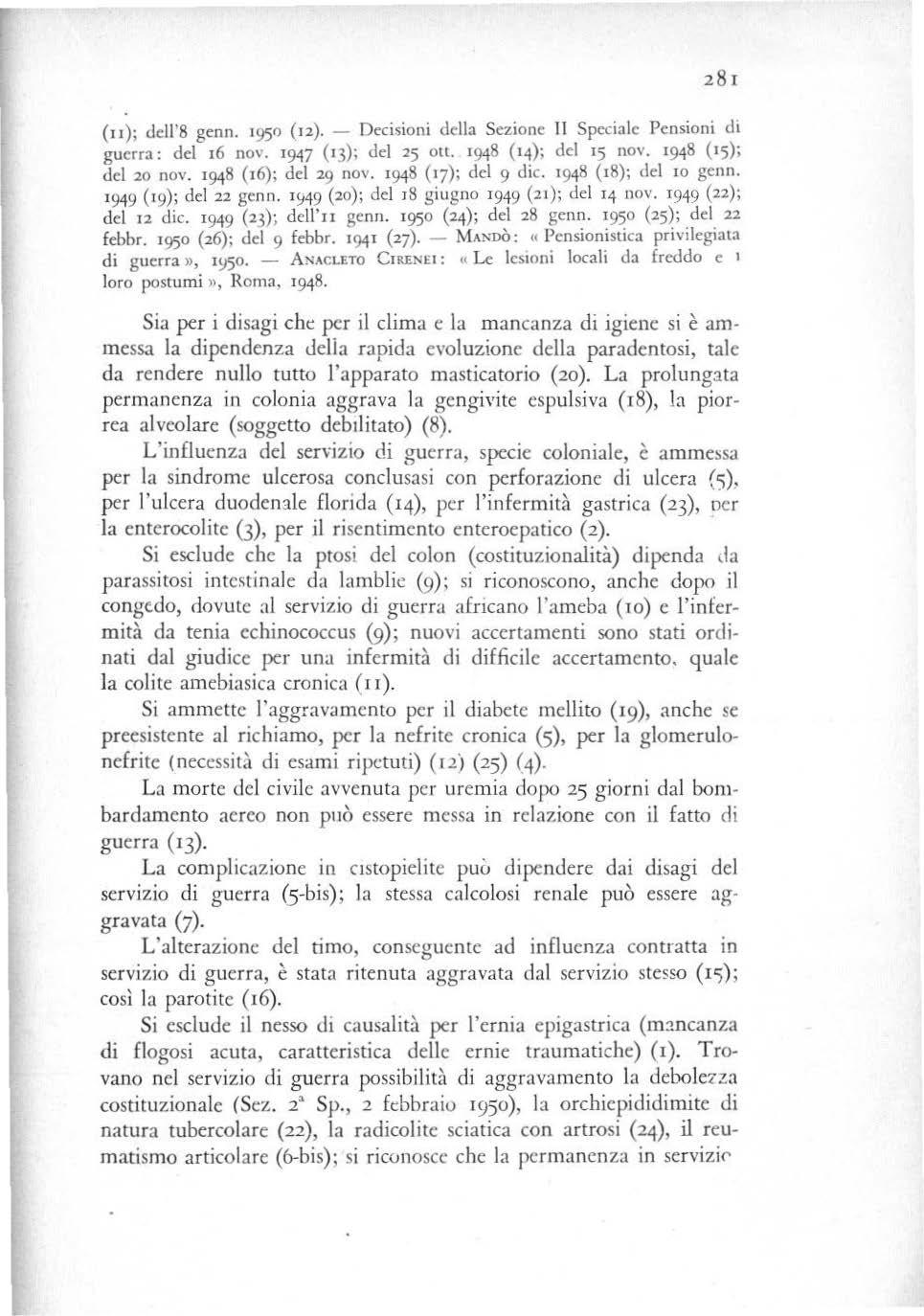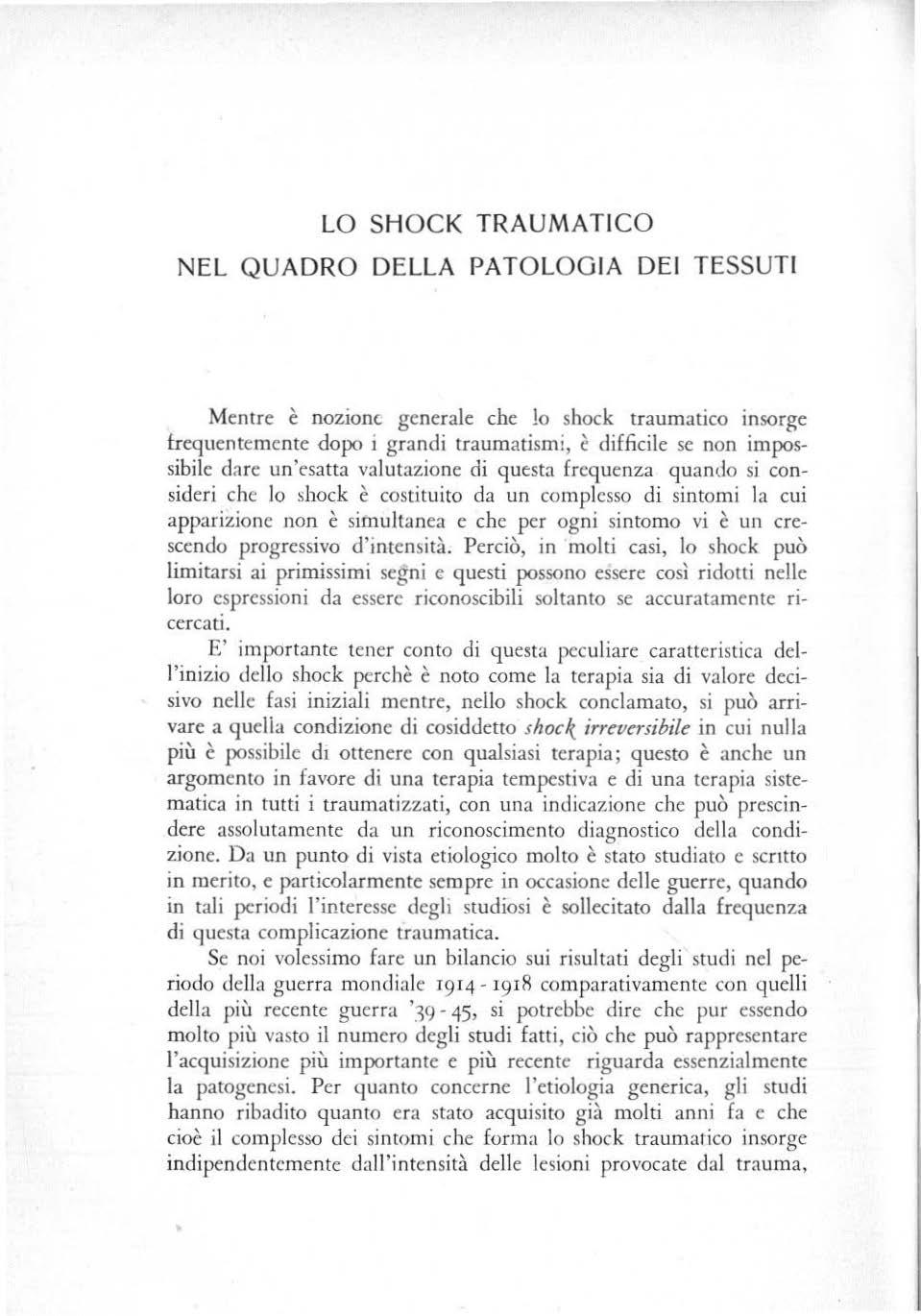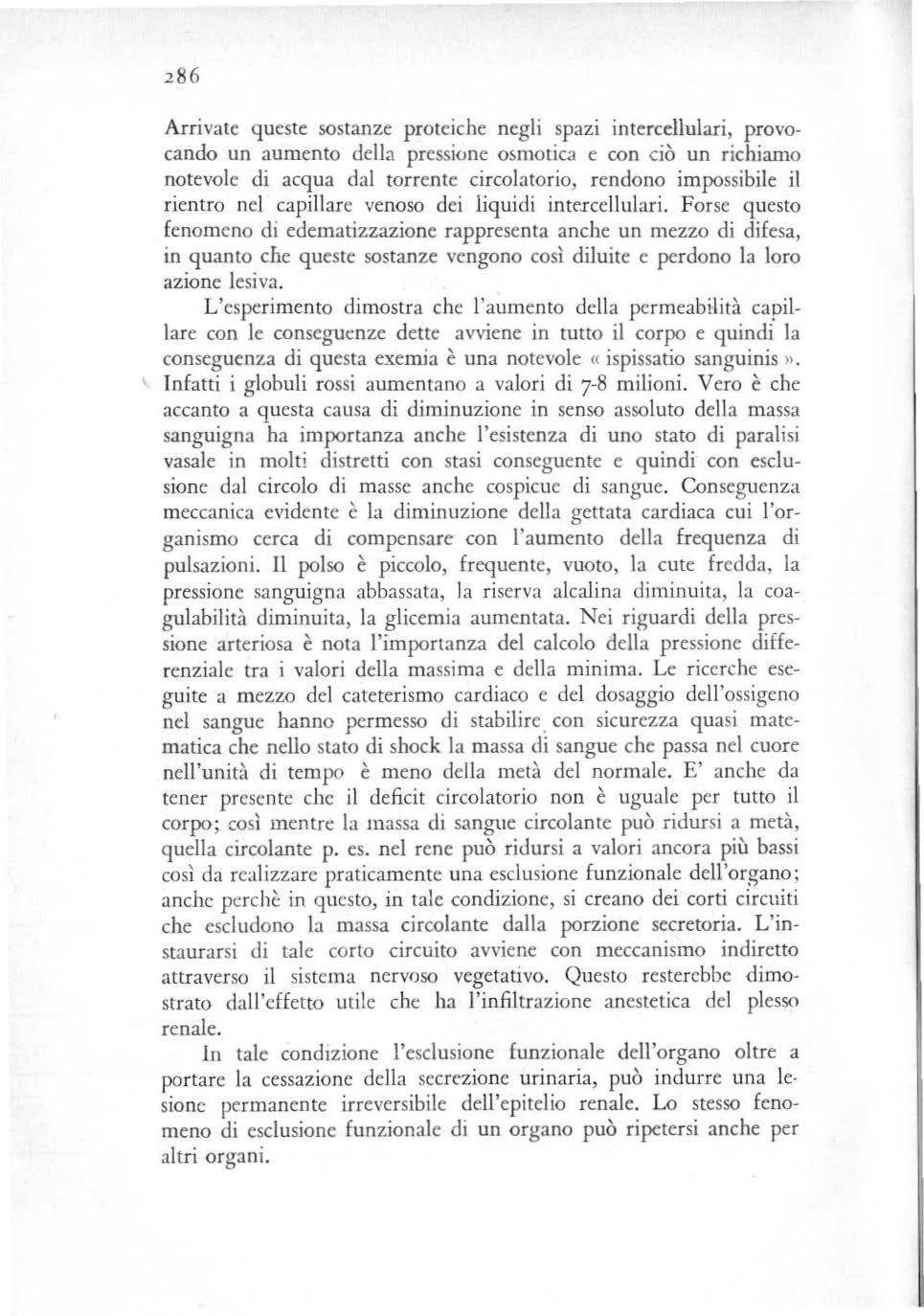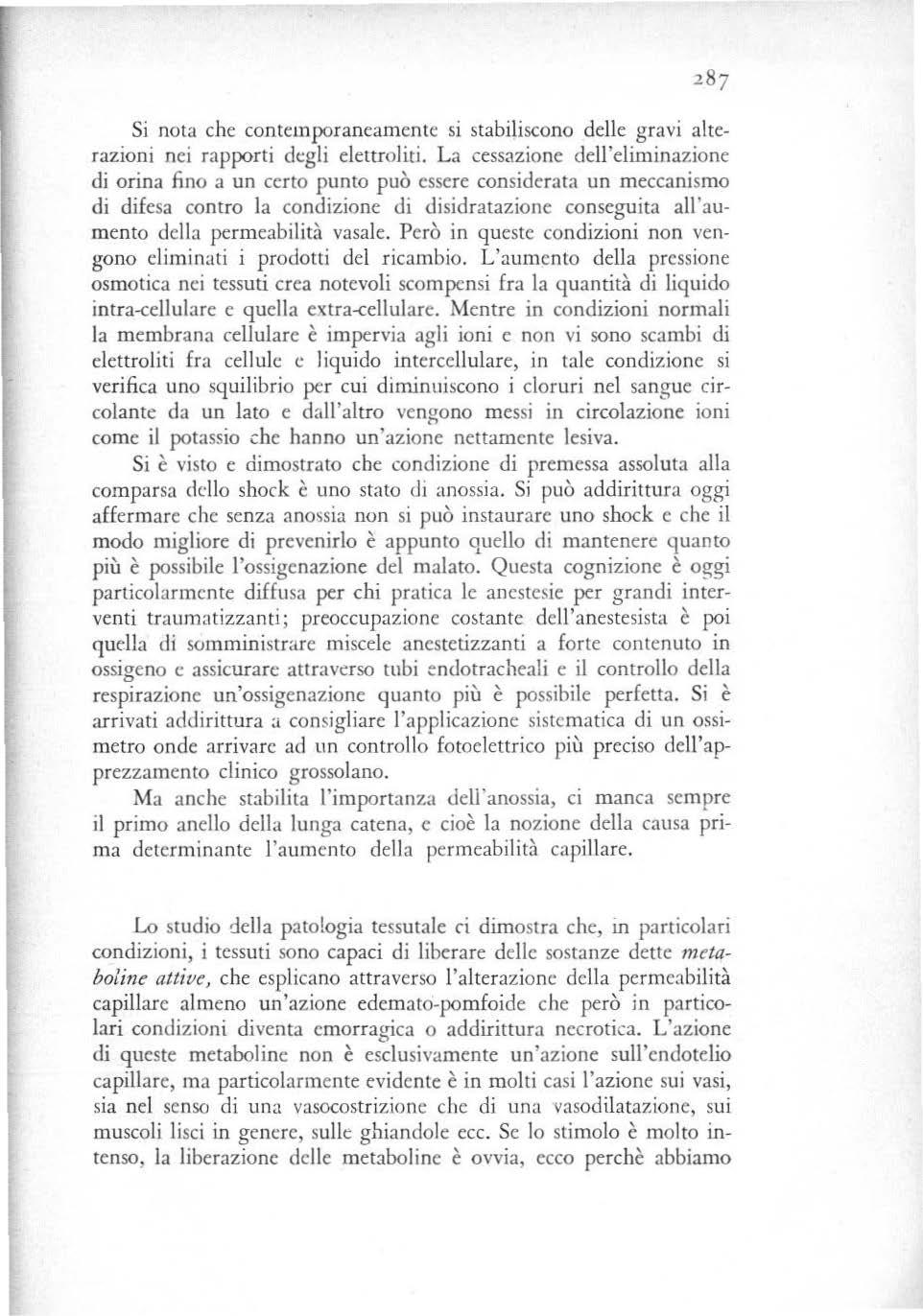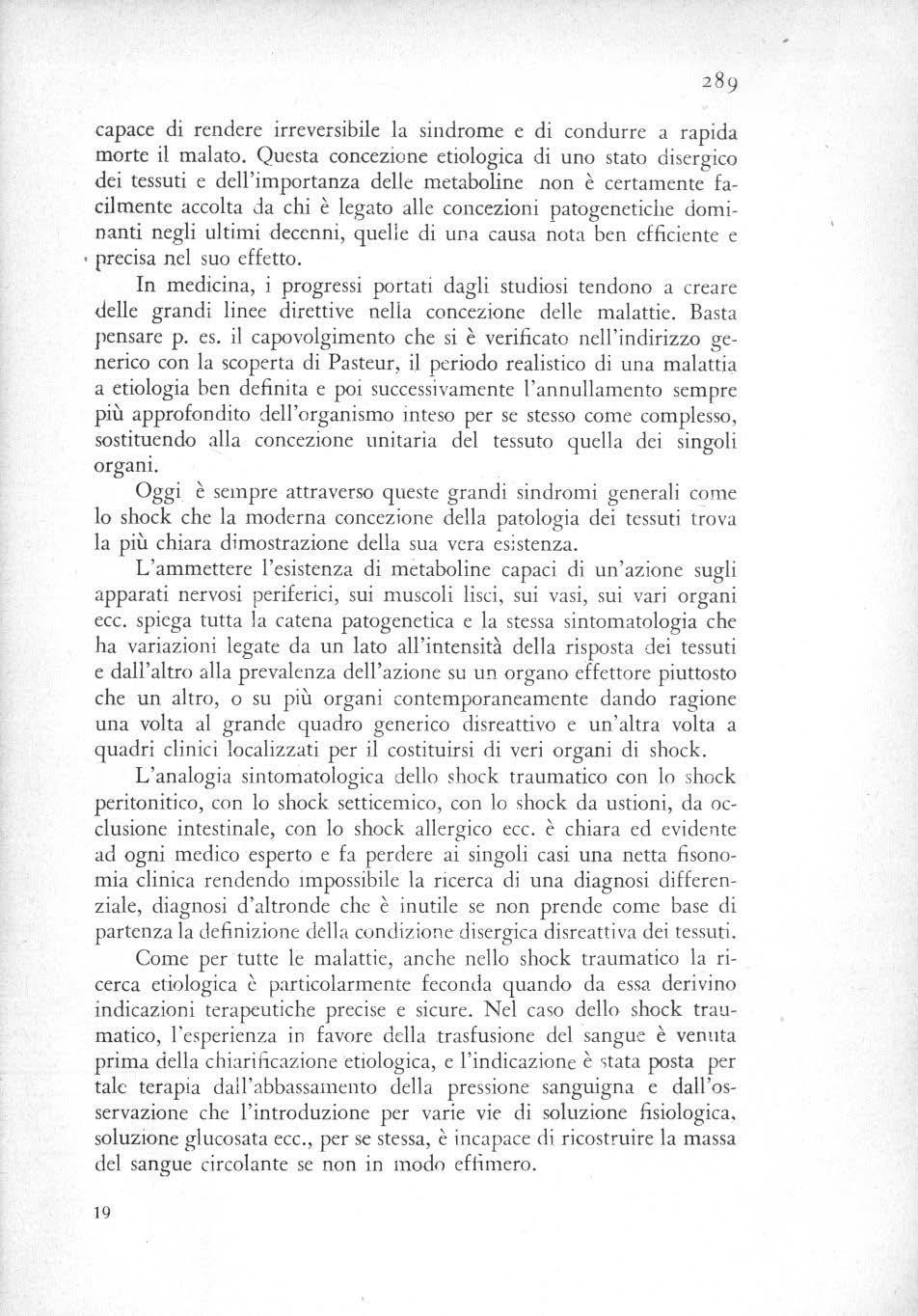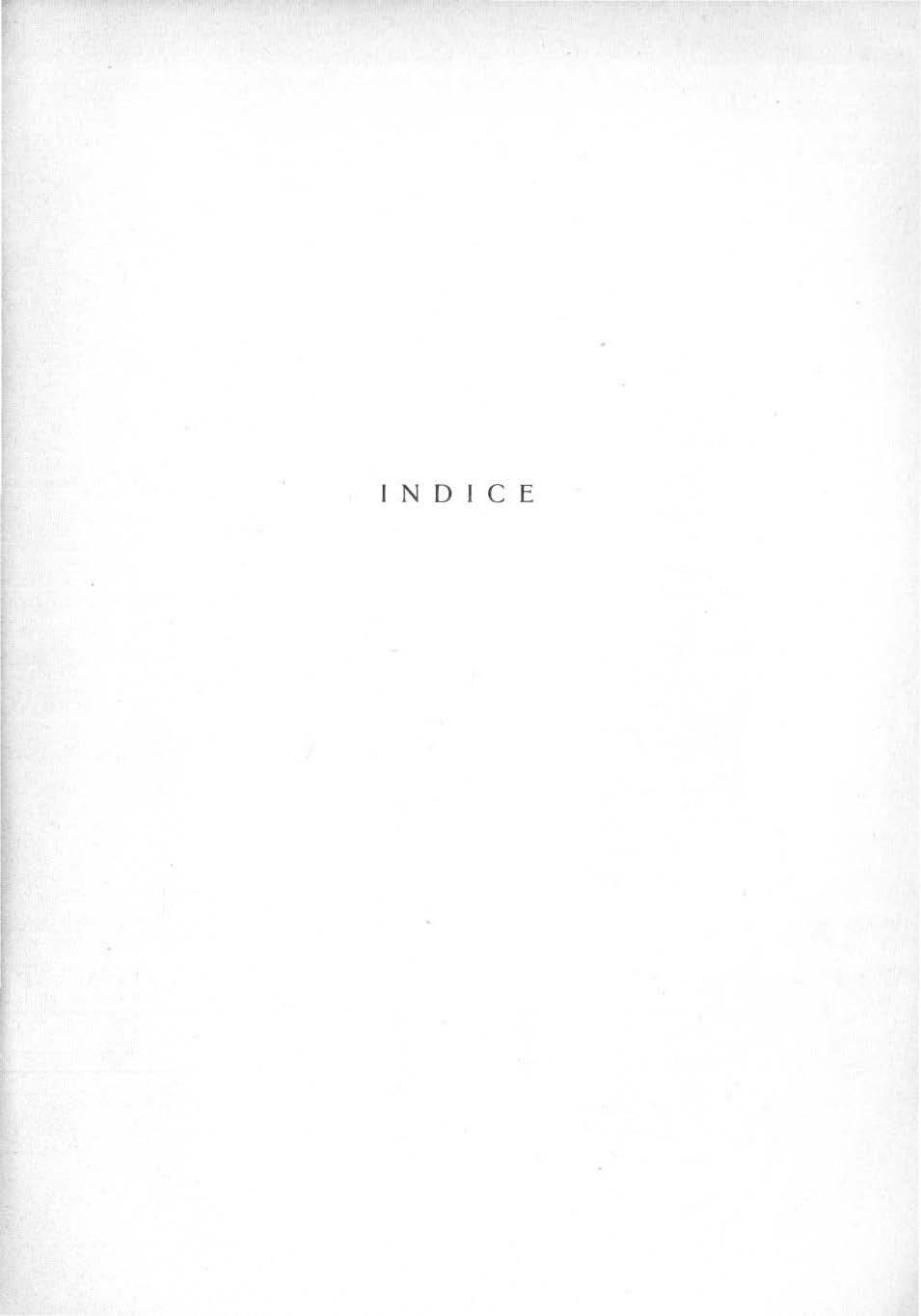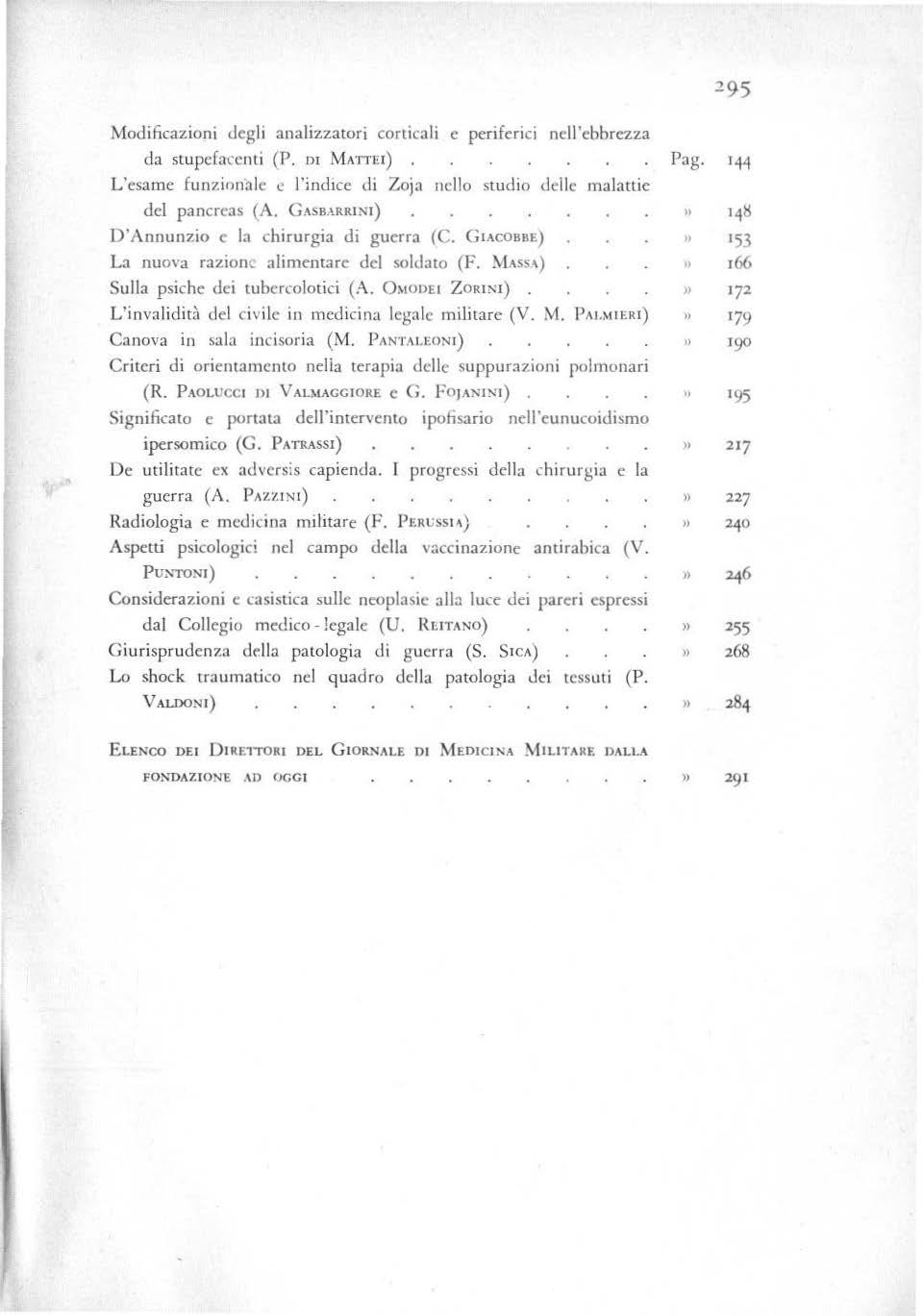GIORNALE 01 MEDICI NA
nEL COUPO SANI'I'AIUO DEUJ 1 UUIATA SAR
(itfa •n . Pt :uza \ ltlOrto Eaianur1e, 9 . - Le l1•tl ··rl• p::r =-•·lhmilut:.mt.l al t;iuro.Jic de,·ouo es..oro rJ arcowpag nale .la ''anlla poslale.
• St'it•nlilira tll1<' \'0!11' il IJ H•.:r
• J)j, i·itll• alr
• ·cn izio, t! i ,taltil irr
• ti! lt• .,
Fino cta t in ('tfÌ il C<IJ'tlll :'llilitarr ru ùotah> del 111.10 111 Bt•!;ulauu·utu 1 :ifltl'uttultrt• t 1'111' li1 t•o,rituila :<u lta-i più ; ,. più t·uu-•Hil' ai tlrlta llll'tli,·a t' ch•ttt• 1•:111 i•· i-t s i fNI' allanwult• ,,•utin· il hi-t•):hu t1'un nlt'lll':'"l' iu llltfltW n•I,IZ iOIIl' ;::i . gti:l :\letlinl-militart• e lt1ru frutti "''"'' t·ourPn·ntr
• t'OI·,j
prol fi\' izi o n'' fu f.ii ta nella conf 1 fl'ltltraill , fu appt·u, ata all'unanimità; era olata ,.,.; l('l'lllini:
• Et·co' i rouro<·ati coll'appt·orazionc di chi ci di1igl' p•·r nclirr, pct' disr.utcrc c, se lo cred<'lc op·
• porluno. ,,,.,. apps·o, ar·r rei inviat·c al Su-
• prr iorc di Sanitù l' C!\pt·e•.c;ionc \'O
• l'lte, hcntgnanwut(' a ('co lt o dai r! o.c;tri Superiori, to
• a granùù ul ilità. della Scie nza da noi
• sa tn. a lustro (' decoro Ùt'l Co rpo c p;·on-e-
• ad u u tempo al mutuo c fratrll c \ o lc eon-

• fra tutti i Collt't;hi nostri drlt'armata.
• Per del dei :)0 d'oll ohre
P· Jl· corre ohhli r o tutti i Medici 111ilitari c he sono di
• prtsi«lio do1 un Oi \'is ionalt , non:·
• • fJU tlh allo ùi in 'tdiJiil
oqua l i a re u pro del1co, ccsi che 1ralasci 11 p>s·ù di IJUal e c CJIIaoto ma gg iore tt •r le uos t• c isti tuzioni i 1:1\0I'Ì rh c fauno in ti il isionr H' rO puhhlical i e $Ì pe r tal mod o d:uui ·
lo.
1 \ Crsah• ntilii it a lutti g li Uli?.ial i del Co1po co lt'i s ti -
• tuzi onc d'un Giornah• "!
• Dac rhè il G 6 \ 'CI'I10 cd :1 çon s igl io S uperiore 1\lili-
• lllt'e di tanto mi glior;lf •o no le so rti uol' trr ,
• s pella a uoi il corri s pond ere «k ;; namrutl' ai las·trit i
• favori, Jli'OV\' rdendo all'onoJ' C r•l a t decor o 'Uòralt•
1 dc•l nostro Corr o. La puhhti citit dci no stt ·i lai'OI'i
• S\'n irà a fare co uosr!\ r c con «tuanta nlt il itit s 'atteuda '• nllo s tudio, con qua le 7. t:'!o ci oc<·ttpiam(J
• JH' t' i•• dci so ltla t i c l'al'i1 fl•tle alla nazione
• dcll'utilitit d e ll e no <. trc t!IIG\l! istiluzioui c dci Sl'n·
• lÌttH:nli da c ni tuili animati pe1•'i l unon au
• dMu c nt o df.'tl ' imporlautc !'!te c i fn afTid:tto. " Ati ot trn e r e Giornal e io porto opinione rhr
• bas ti il cl tictiPrlo r c he il uo:: t1·o 1\l (' di co Di\ isionalr,
• so llto r ito d; IJilnt•t O i• dircllo ull ' mtOI' I' clt·l
• CoJ po ed a t bene clrl Sl'rYizio, \ Of!)i.l i in t crprr.tr
• e mcùintor c il (on'>ivt:o !'uprriorf.' eli questo,
• nostr o tl c,. idrrio. •
l , oli dc:i militari, qan ziati a Sciamltrri , non tardaronn ad pirnaml' nlt: c'!'.'lUtliti .
v ll ANNO 1. c 2s lu gli o 1ss1 )
--------- -·--------------- ---nou ,, rit''''" dh' pN' uu 3tHw e ··omincto col l - 11 fiiorn:.l•· \ l J•r.r tt.o '" l't' t\ HU l , f' Fif ! Htl IH: I. .S•I\Ittf\tn l r ..-n l :V O!'f WU .IT ABI In To>rinu l Ili In l'u1111 q • 1. tu l"'"' i urli• francu ''' n Il In ('N\'Ìnci• fran< o •l i po<l.a 13 I.' AIJI>onamcnln dHe 1.-r "" n••• l n : &lu il"'li. l Jlll,•diri Mili liro in riti ro Qodnun ;;,t i al e"i 'an.'"3Si ji io Sf'n·irio ltti , o l.ft p e r i 11011 util i lari 11 r• · Y""O alta 1'II'Ot;t\ ,, ,' \H t: tJtlru.:c
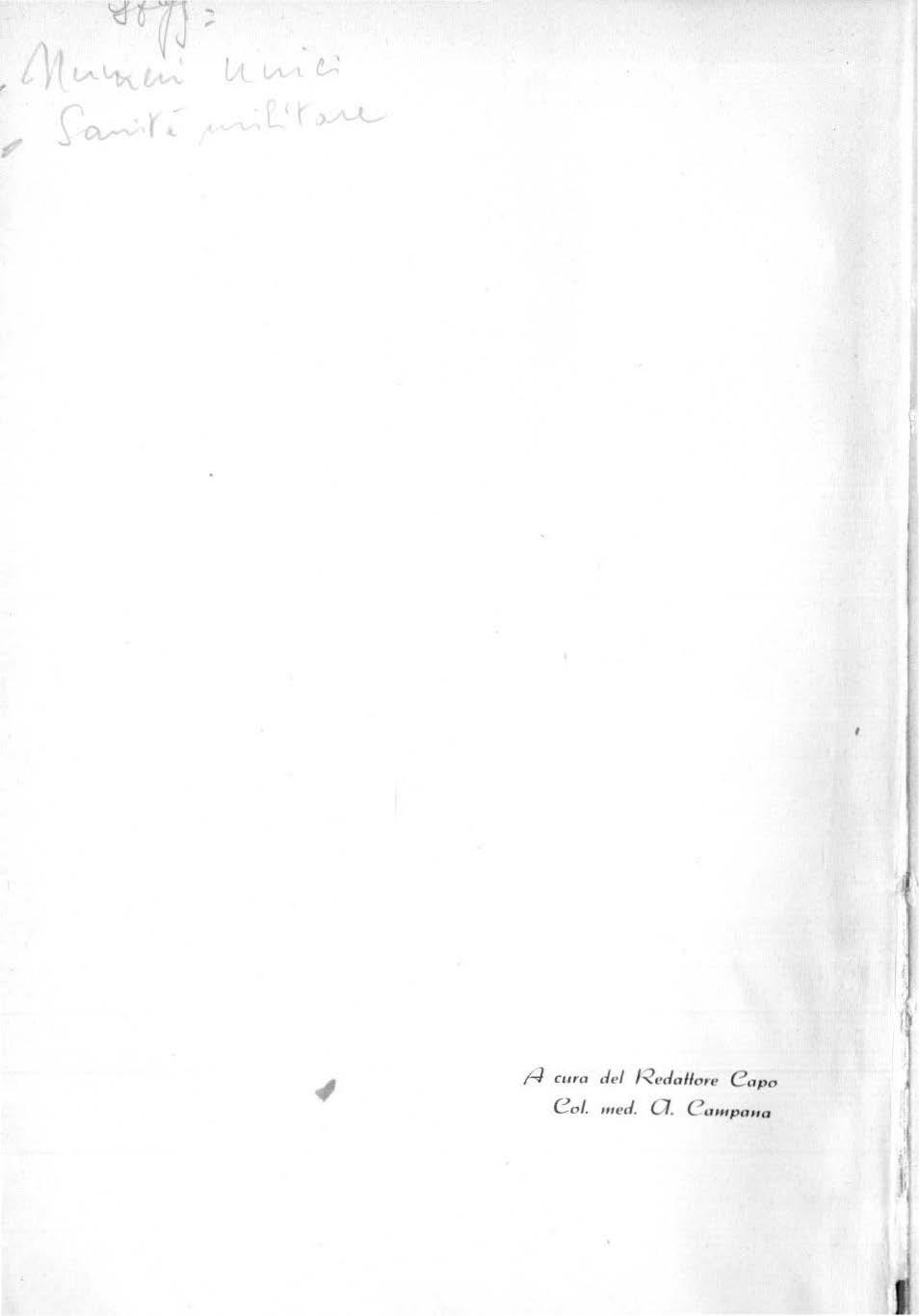
;-J cura del 1-<f!dallole e,lpo Col. 1111!<1. Lt. C!umpo11a
GIORNALE DI MEDICINA MILITARE
fORINO 1851 · ROM.I !05!
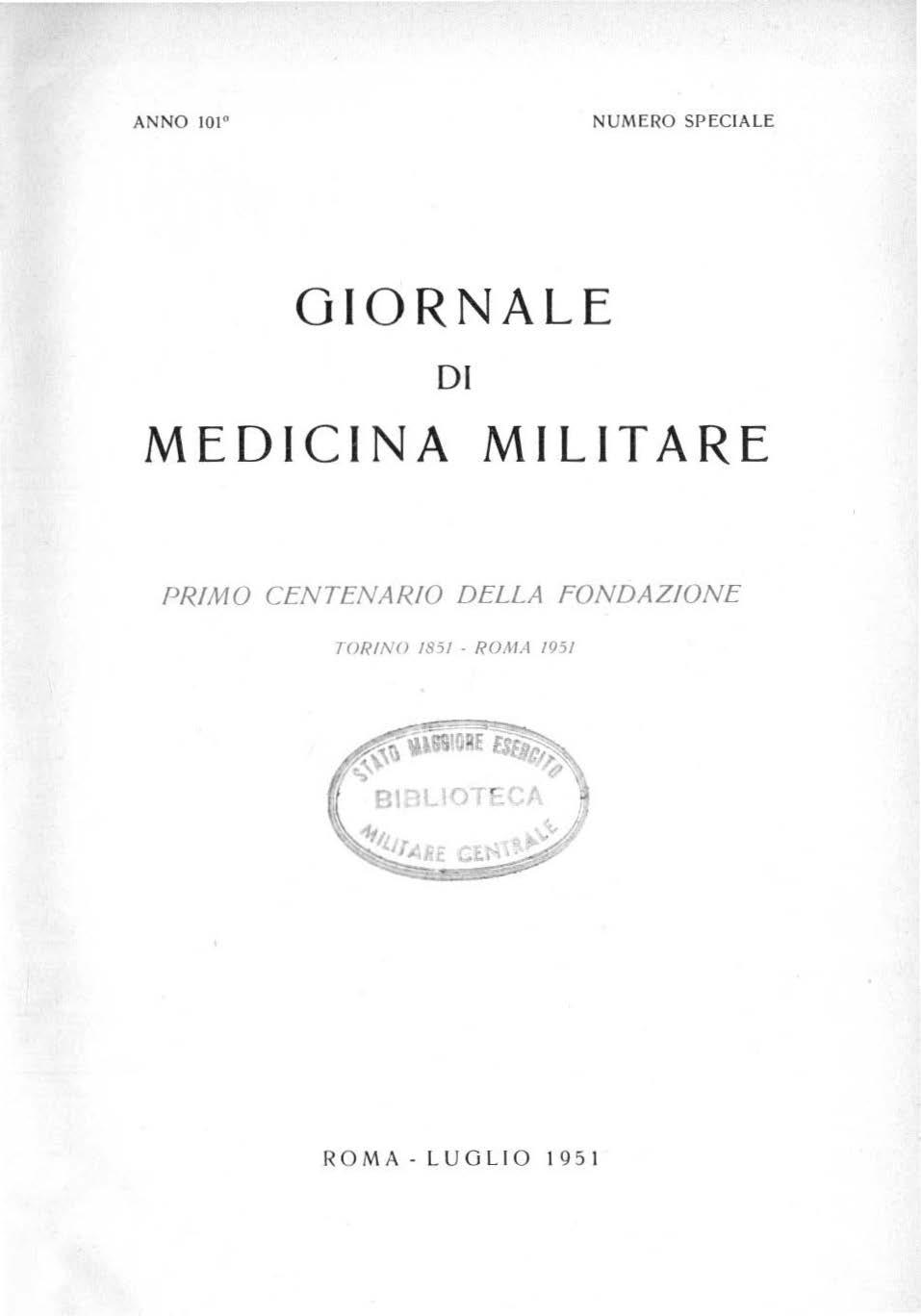
ANNO 101 ° NUMERO SPEC I A L E
PRIMO CENTENARIO DELLA FONDAZIONE
L UG LI O 1 95 1
ROMA-
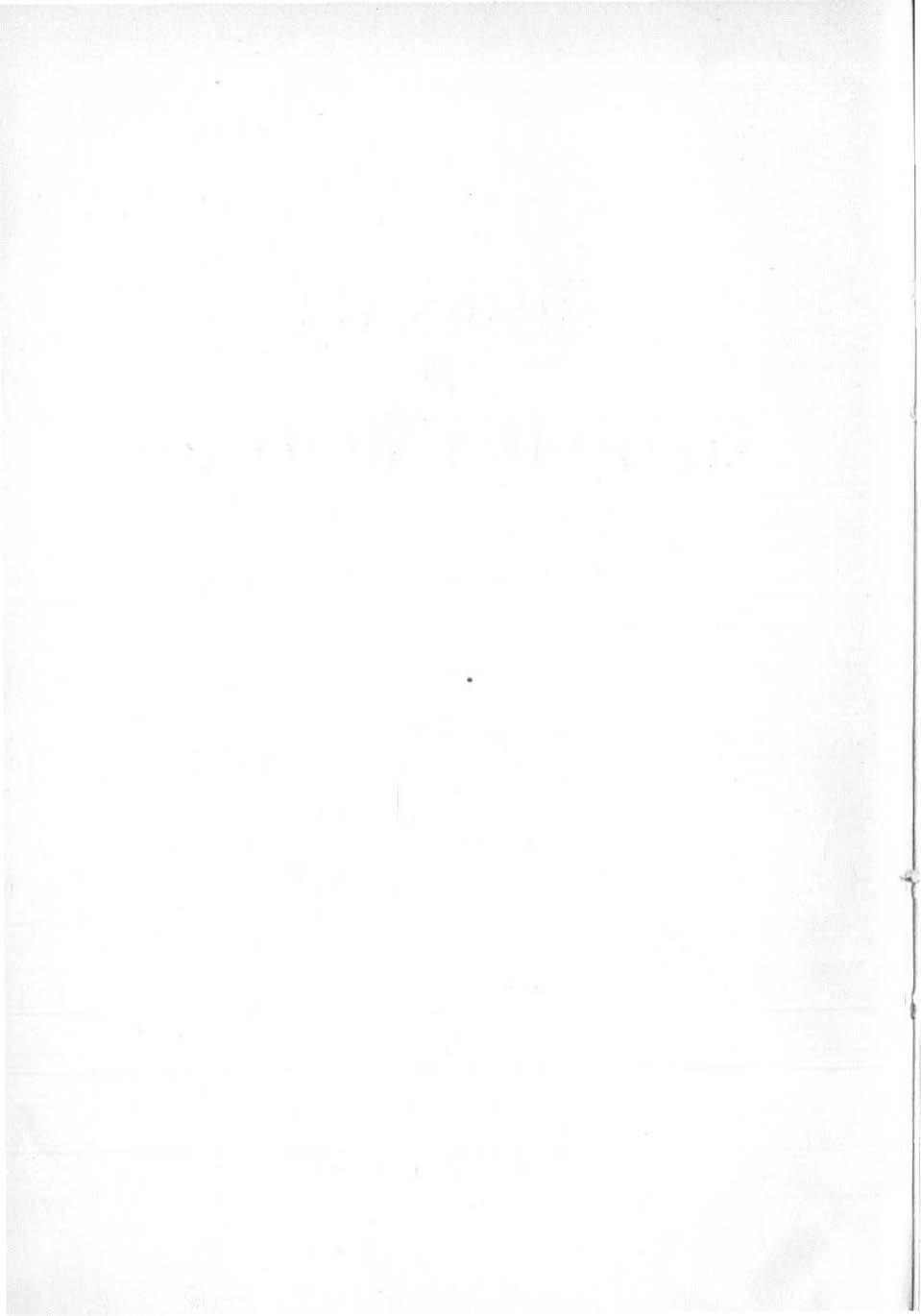
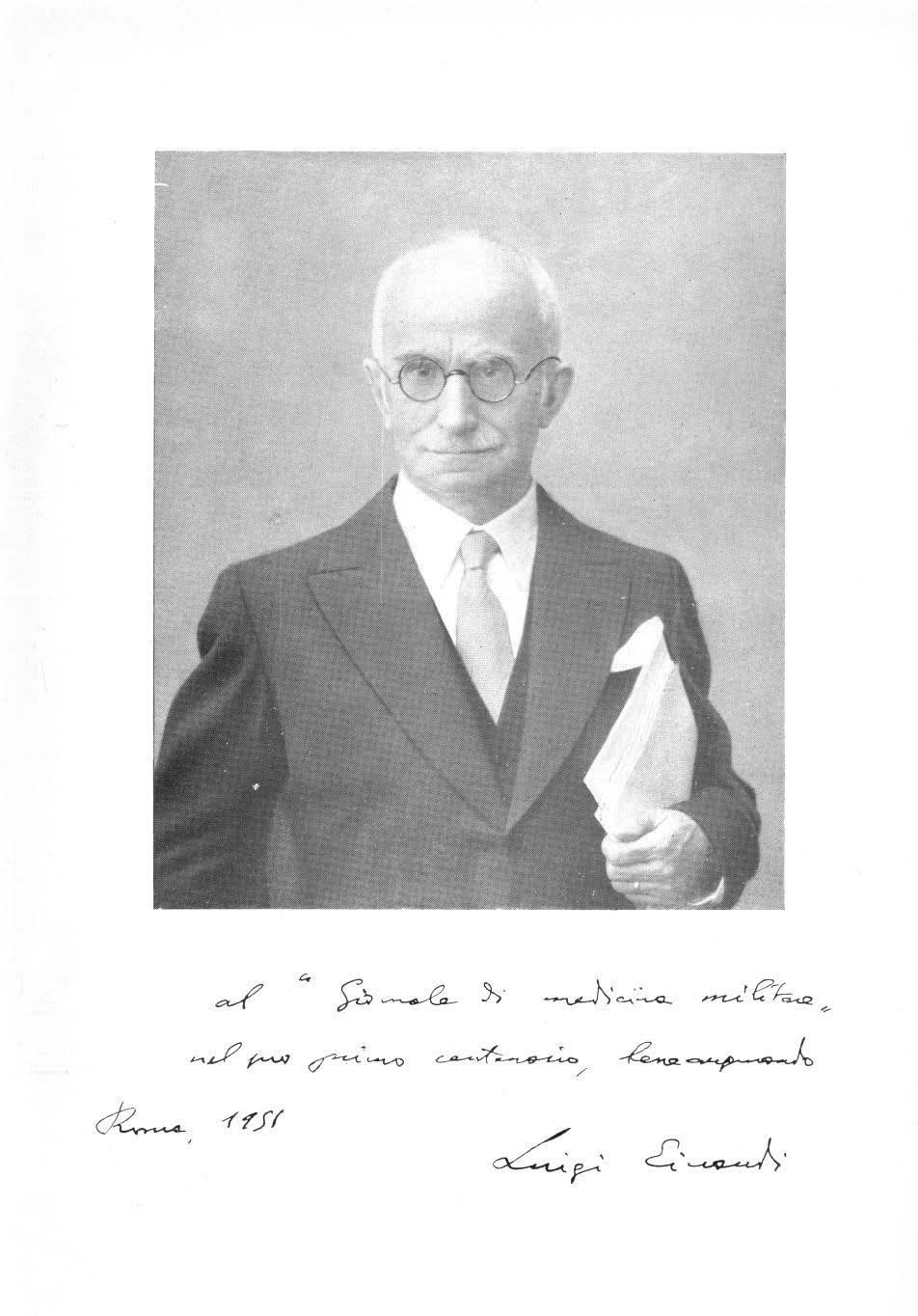
c.. --v--1\·.. .... .vP f-'--vJ

N ella ricorrenza del l centenario della fondazione del Giornale di M edicina Militare mi è gradito inviare un saluto fervidamente augurale al Corpo Sanitario Militare.
Una Rivista scientifica che può celebrare un secolo di vita dà la dimostrazione evidente della sua utilità, e il Giornale di M edicina Militare, che ha il privilegio di essere oggi il periodico medico più antico d' I talia, ha visto passare nelle sue pagine, col riflesso di un secolo di storia della Nazione, tutte le conquiste della medicina negli ultimi cento anni: avvenimento non frequente e di alto interesse storicoscientifico.
R assegna di studi e di esperienze del Corpo Sanitario Militare, il Giornale costituisce anche llfl utile strumento di reciproca conoscenza e di affiatamento fra i componenti la famiglia medica militare.
Alla Direzione e alla R edazion e del Giornale di M edicina Militare, che vedo/lO così lietamente coronata la loro fatica, il mio compiacimento e i voti più vivi per un'affermazione sempre maggiore del periodico.
Roma, 12 Luglio 195 1
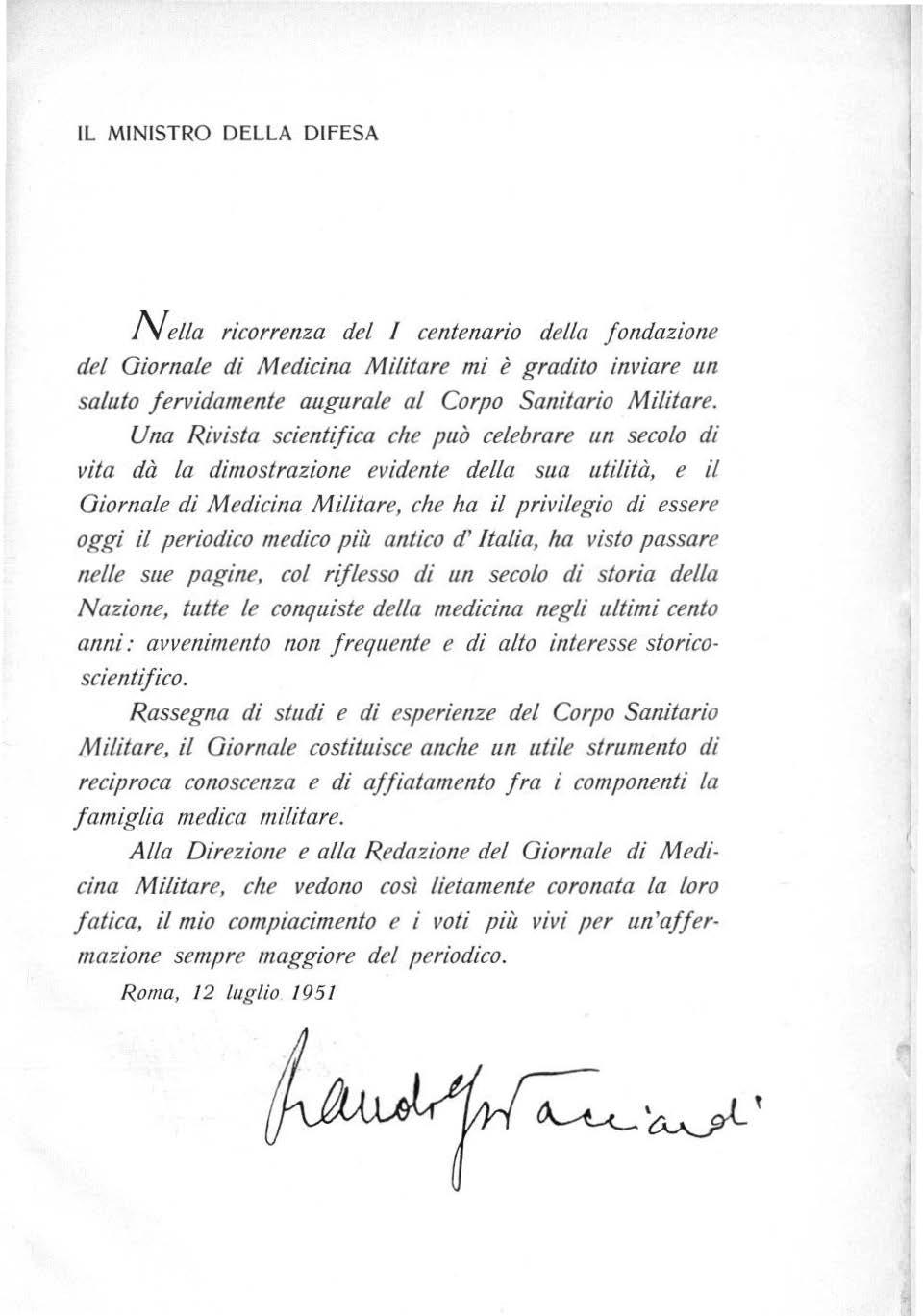
IL MIN ISTR O DELLA D I
FESA
L ' IGIE NE E LA SANIT À PUBB LI CA
Mi è sommamente cm·o rivolgere iL mio saluto ed il mto a ugurio ul Giorna l e di Medici na Militare ciJe celebra quest'atmo il centenario della sua fondazione.
In uri secolo di vita di questo importante periodico quanti avvenimenti politici e militari per la nostra Patria!
Il Corpo Sanitario del nostro Esercito fu sempre presente nelle guerre di indipendenza, nelle battaglie di Africa del 1896, nella conqttista della Ltbia, nelle d ue grandi guerre mondiali. Do vunque rifulse e primeggi{; con episodi di eroismo e di valore, fedele alla sua nobile missione C01J sublime Jpirito di sacrificio.
Con l' evoluziotle della scienza medica che ha in questi cento anni ottenuto le più brillanti vittorie neLla lotta contro il male, con le sue grandi conquiste nei r,•ari campi delL'igiene, della medicina c della chirurgia, il G iornale di Med icina Mi l itare si è anda t o trasformando allineandosi .cempre più con i migliori periodici italiani e st ranieri, attraverso l'attiva collaborazione dei più insigni Cultori e Maestri dell'arte medica.
I n queJta nobile gara di attività scientifica la Sanità Milita re non solo ha mantenuto stretti rapporti con la Sanità Pubblica ma li ha sempre più intensificati, acciocchè da questa comune fa tica scaturissero i mezzi migliori per la più p erfetta ed idonea assisteuza all'umanità sofferente.
Roma 1 " luglio 1951.
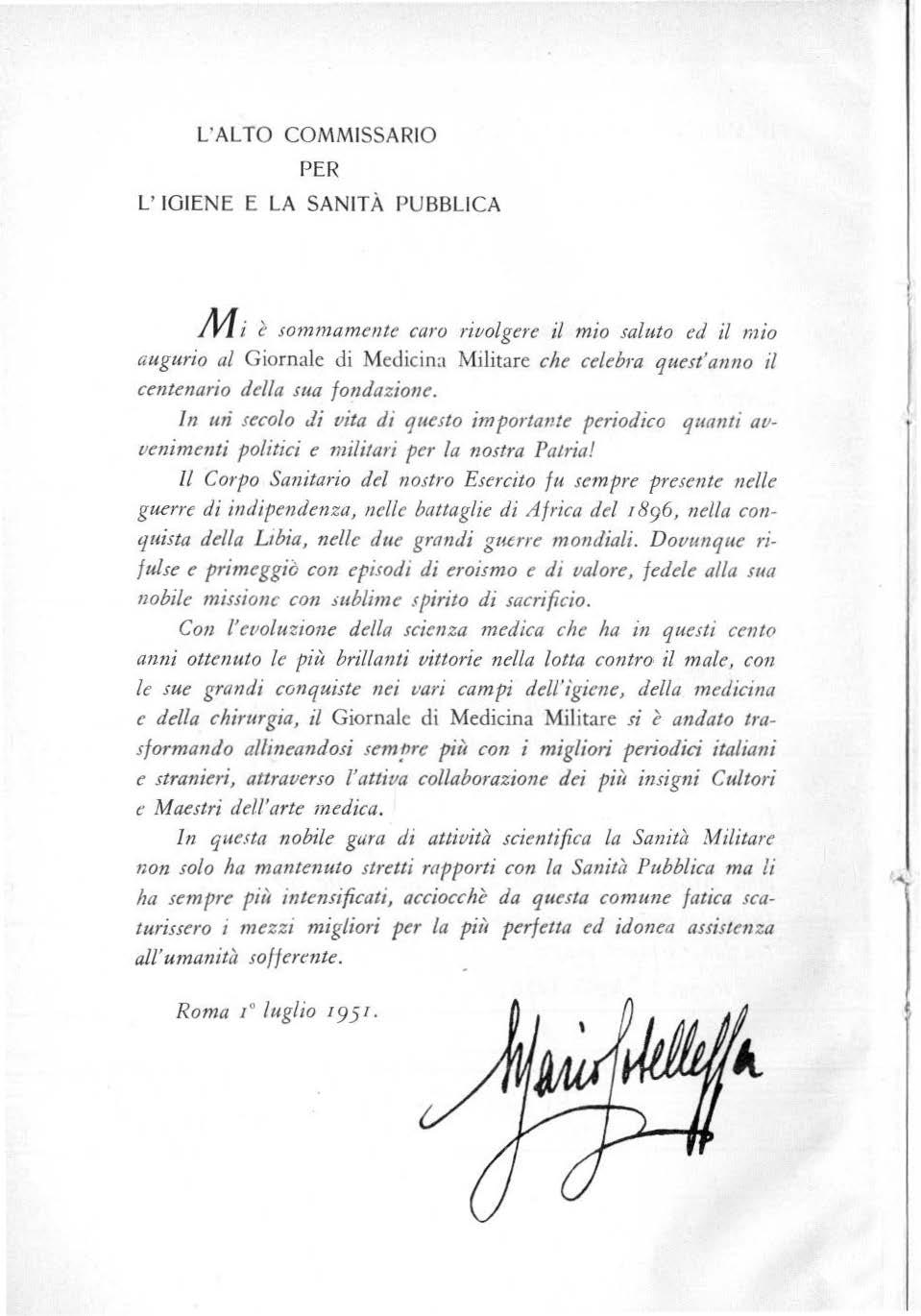
L' ALTO COMM ISSAR IO PER
IL PRESIDENTE

DELL A FEDERAZIONE NAZIONAL E DEGLI ORDIN I DEl MEDICI
La Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici, nella ricorrenza del l Centenario di Fondazione del Giornale di Medicina Militare, è lieta di inviare in nome di tutti i Medici d 'I talia i più fervidi e sentiti voti augurali al Corpo Sanitario Militare Italiano, che nel primo secolo di Sua esistenza e fin dagli albori del Risorgimento nazionale ha sempre dato fulgidissime prove di eroismo, di attaccamento al dat/Cre e alla scienza, e di amore indefettibile verso la Patria .
Roma 5 luglio r 95 1.
I L CAPO D ELLA SAN ITÀ MILITARE
DELL' ESE RCI T O
N el presentare questo numero speciale, commemoratiVO del centenario di fondazione del Giornale di Med icina Mil itare, de ridero innanzi tutto esprimere la viva gratitudine del Corpo Sanitario Militare ai chiarissimi Autori ch e, con la loro collaborazione, hanno ancora una volta riaffermato qu egli intimi e proficui legami che uniscono la fa m iglia medica militare a quella universitaria ed ospedaliera, al mondo medrco civile in una parola.
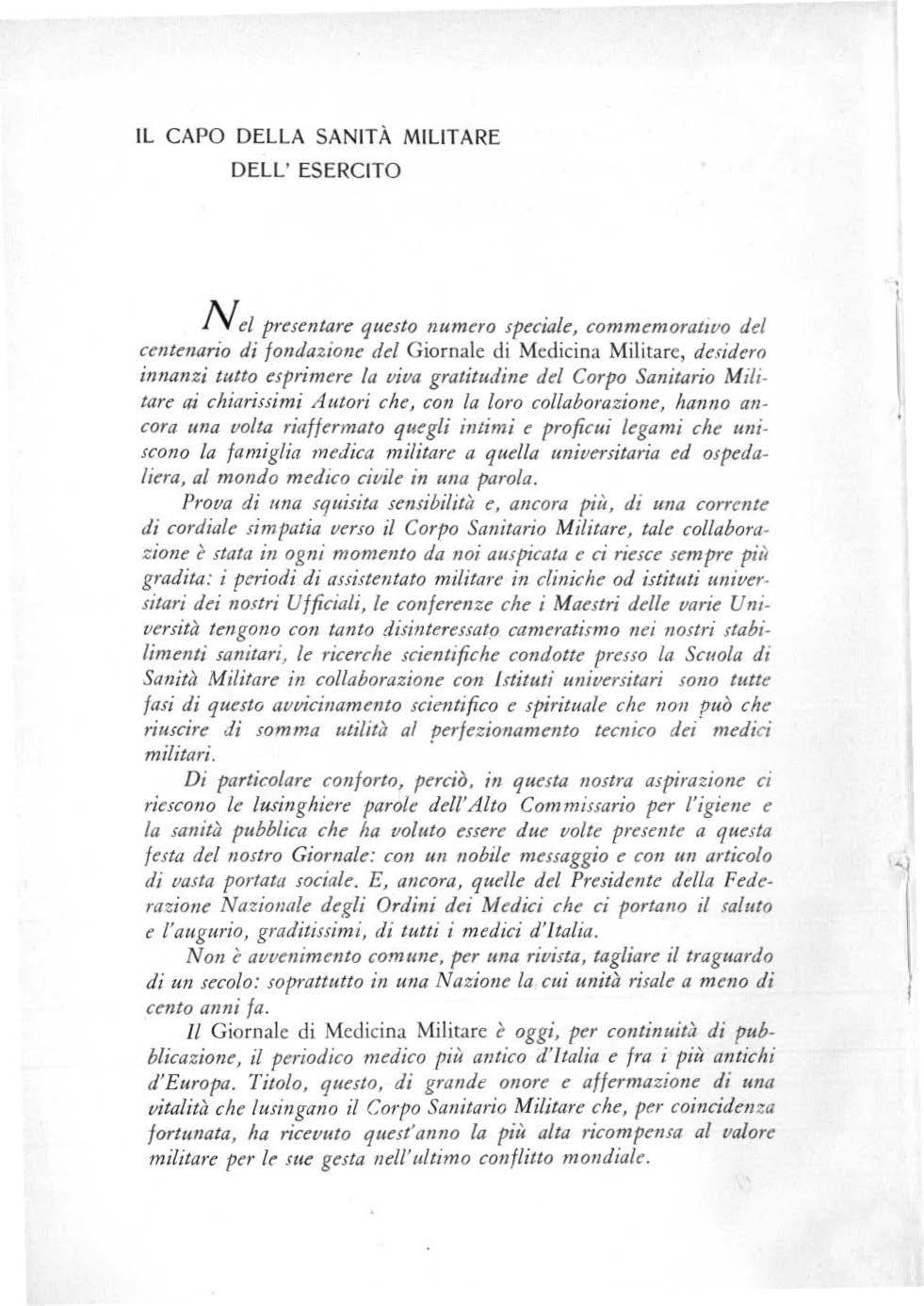
Prova di una sq uisita sensibilità e, ancora più, di una corrente di cordiale JÌmpatia verso il Corpo Sanitario M ilitare, tale collaborazione è stata in ogni momento da noi auspicata e ci riesce sempre più gradita: i periodi di assistentato militare in cliniche od istitt>tti universitari dei nostri Ufficiali, le conferenze che i M aestri delle varie Università tengo no con tanto dùinteressato cameratismo nei nostri stabilimenti sanitari, le ricerc/Je scientifiche presso la Swola di Sanità Militare in collaborazione con I stituti universitari sono tutte fasi di questo avvicinamento scien tifico e spirituale che non può che riuscire di somma utilità al perfezionamento tecnico dei mediri militari. ·
Di particolare conforto, perciò. in questa nostra aspirazione cz riescono le lusinghiere parole dell ' Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica che ha volt#o essere due volte presente a questa festa del nostro Giornale: con un nobile messaggio e co n un articolo di vasta portat!l sociale. E, ancora, quelle del Presidente della Fed era?:ione Na?:ionale degli Ordini dei M edici che ci portano il .ralut o e l'augurio, graditissimi, di tutti i medici d ' Italia.
Non è avvenimento comu ne, per una rivista, tagliare il traguardo di un secolo: soprattutto in una Na z ion e la cui unità risale a meno di cento anni fa.
Il Gi o rn ale dì Medicina Militare è oggi, per continuità di pubblicazione, il periodico medico più antico d' It alia e fra i più a ntic hi d' Europa. Titolo, questo, di grande onore e affermazione di un a vitalità che lusingano il Co rpo Sanitario M ilitare che, per coincidenza fortt>tnata, ha ricevuto quest' anno la più alta ricompensa al valore militm·e per l e .we gesta nell'ultimo conflitto mondiale.
1
Coincidenza fortunata, ma non casualr., forse, perchè il Servizio sanitario militare e il Giornale di Medicina Militare, nati fressochè insieme e per volere dello stesso Uomo - Alessandro Riberi -, hanno semprr marciato parallelamente in una continua amia di evoluzione, di aggiornamento. E se guardiamo al cam m ino percorso, possiamo dirci veramente soddisfatti. M ai come oggi, infatti, con l'incalzare tumultuoso delle scoperte nel campo medico. la nostra Sanità ha vissuto e vive di questa aspirazione, procedendo ogni giorno a nuove e imponenti realizzazioni nel campo organizzativo, assistenziale, tecnico: spesso all'avanguardia in preziose innovazioni.
Tutto ciò sta a testimonia re la passione e l'alto livello Jcientifico dei nostri ufficiali medici e chimici farmacisti.
IL Giornale di Medicina Militare è la (( palestra 11 di questo addestramento culturale così neceuario e prezioso. Ma esso costituisce anche un vivo, indis.•·olubiLe legame sentimentale fra i componenti la nostra famiglia: e non solo fra qur:lli del servizio attivo ma anche fra quelli che, lasciato il servizio, continuano a rimanere fedeli abbonati, dando prova di uno squisito spirito di cameratismo. Invio ad essi, nella mia duplice qualità di Direttore generale della Sanità Militare e di Direttore del Giornale di Medicina Militare, un particolare ringraziamento e l'assicurazione che il Corpo Sa1litario non li dimentica ma conta, anzi, sulla !oro collaborazione, oltrechè mila loro opera in caso di emergenza.
Gli auguri del Capo dello Stato e del Ministro della Difesa, di tante persoualùà del mondo politico, giomalistico, culturale che sono pervenuti al Giornale - significativi quelli di molti confratelli esteri - sono un premio alla fatica redazionale del Giornale, ma sono anche lo sprone a migliorare sempre più questa nostra insegna di cultura e di affratellame n to per il raggiungimento di mete sempre più alte e fruttuose.

Il mio compiacimento e il mio augurio per questo meritato successo sono particolarmente vivi e collegiali.
Roma 15 Luglio 19 51.
9
r
A QUESTO NUMERO GIUBILARE :
BANISSONI pro{. FERRUCCIO, Direttore dell'Istituto di Psicologia del Consiglio Nazionale delle Ricerche.
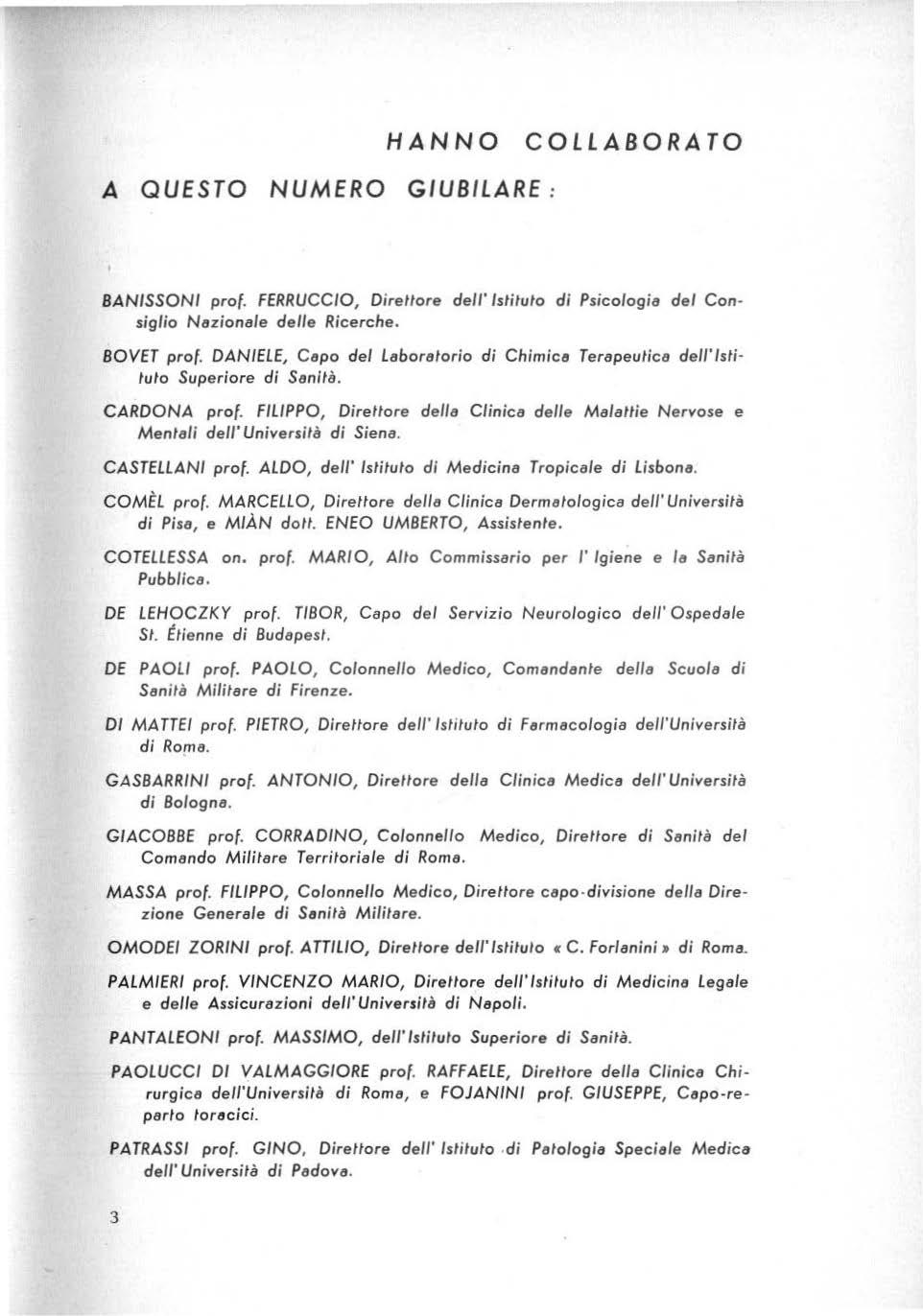
BOVET pro{. DANIELE, Capo del Laboratorio di Chimica Terapeutica dell'Istituto Superiore di Sanità.
CARDONA pro{. FILIPPO, Direttore della Clinica delle Malattie Nervose e Mentali dell'Università di Siena .
CASTELLANI pro{. ALDO, dell' Istituto di Medicina Tropicale di Lisbona
COMÈL pro f. MARCELLO, Direttore della Clinica Dermatologica dell'Università di Pisa, e MIÀN dott . ENEO UMBERTO , A.ssistente.
COTELLESSA on. prof MARIO, Alto C o mmissario pe r /'Igiene e l a Sani tà Pubblica
DE LEHOCZKY prof TIBOR, Capo del Servizio Neurologico dell'Ospedale St . ltienne di Budapest .
DE PAOLI pro{. PAOLO , Colonnello Medico , Comandante della Scuola di Sanità Militare di Firenze.
DI MA TTEI pro f. PIETRO, Direttore dell'Istituto di Farmacologia dell'Università di Roma
GASBARRINI prof ANTONIO, Direttore della Clinica Medica dell'Università di Bologna
GIACOBBE prof. CORRADINO, Colonnello Medico, Direttore di Sanità del Comando Militare Territoriale di Roma.
MASSA pro( FILIPPO, Colonnello Medico, Direttore capo - divisione della Direzione Generale di Sanità Militare
O MODEI l ORINI prof. ATTILIO, Direttore dell'Istituto «C. For/anini » di Roma.
PA LM IERI prof. V INCENZO MAR IO, Direttore dell'Istituto di Medicina Legale e delle Assicurazioni dell ' Univer sità di Napoli.
PAN TALEONI prof. MASSIMO, dell'Istituto Superiore di Sanità.
PAOLUCCI DI VALMAGGIORE pro( RAFFAELE, Direttore della Clinica Chirurgica dell'Università di Roma, e FOJ A NINI pro{ GIUSEPPE, Capo-reparlo lor aci c i.
PATRASSI prof. GINO , Direttore dell'Istituto di Patologia Speciale Medica dell'Università di Padova
HANNO C O L LABORA T O
3
PAZZINI prof. ADALBERTO, Direttore dell'Istituto di Storia della Medicina dell'Università di Roma.
PERRIER prof. STEFANO, Generale Medico Ris., Presidente della Federazione Regionale Piemontese degli Ordini dei Medici .
PERUSSIA prof. FELICE, Diretfore dell'Istituto di Radiologia Medica dell'Università di Milano
PUNTONI prof. VITTORIO, Direttore dell'Istituto d'Igiene dell'Università di Roma.
REITANO pro(. UGO, Generale Medico , Presidente del Collegio Medico-legale
SICA avv SALVATORE , Direttore dell'Ufficio Massi mario e Studi della Corte dei Conti.
V ALDONI pro f PIETRO, Direttore dell ' Istituto di Patologia Speciale Chirurgica dell'Università di Roma
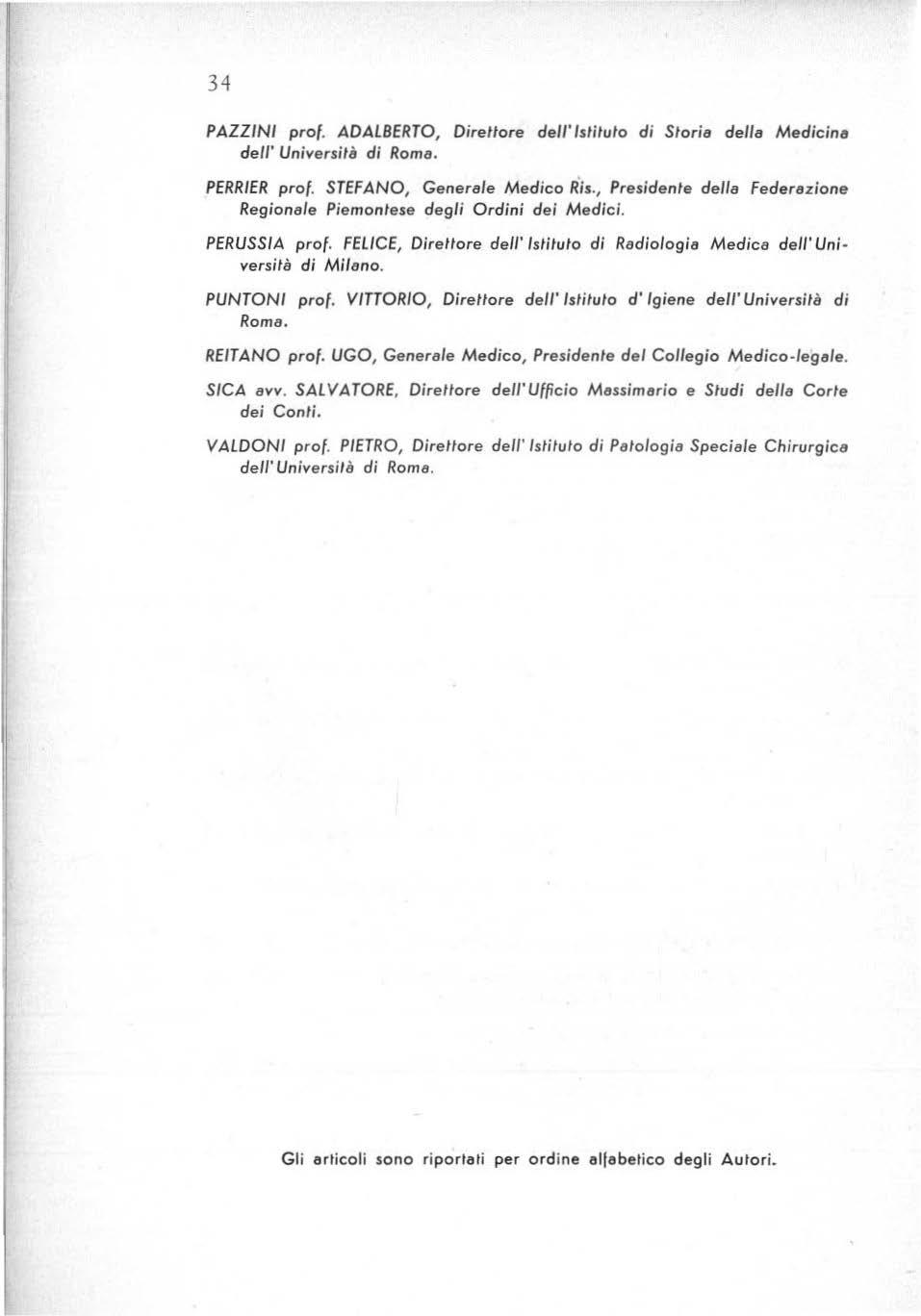
34
Gli articoli sono riportati per ordine alfabetico degli Autori.
LA SELEZIONE ATT IT UDINALE
E. L A COLLABORAZIONE MEDI CO- PS I COLOG I CA
La selezione attitudinale, che vuole collocare l'uomo adatto al posto adatto, viene attuata da medici e da psicologi con la collaborazione di tutti gli altri competenti responsabili dell'adeguata scelta, dell'adeguato addestramento e dell'adeguato impiego dei chiamati alle armi, degli aspiranti all'arruolamento volontario e degli aspiranti ufficiali.
La collaborazione medico-psicologica non è uno dei frequenti postulati teorici, cui hanno ancora da seguire (e spesso non seguono) le realizzazioni pratiche; essa è mvece, nelle Forze Armate italiane, una realtà da tempo in atto, collaudata e dimostratasi ormai efficace nella valutazione di circa un milione di soggetti.

l1n'applicazione tanto ampia, effettuata silenziosamente e rapidam ente con mezzi modestissimi in tempi eccezionali, non sarebbe stata possibile se, attuando i nuovi metodi, non si fosse tenuto nel dovuto conto quanto anteriormente serviva di base e di guida nell'impiego dei militari, e cioè i precedenti scolastici e professionali, ma, soprattutto, la valutazione clinico-fisiologica che è compito specifico della Sanità militare.
L 'at tivi tà medica-militare ha per scopo, com'è noto, non solo la cura e la profilassi, ma anche la selezione.
V engono infatti constatati difetti, imperfezioni e malattie in atto che impediscono il reclutam en to, e, nello stesso t empo, graduati i normali relativamente al loro aspetto modo-fi siologico generale (ad esempio: coefficiente di robustezza) e alla loro efficienza se nsoriale.
La visita medica militare può dunque essere anche un «o rien tamento n egativo » i n quanto mette in luce le ((controindicazioni », indica cioè chi, per esempio, non può essere soldato in genere oppure in partico l are bersagliere, sommergibilista, aviatore, ecc
Quest a indispensabile fondamentale attività non può però dare ind icazioni positive sulla più opportuna modalità di utilizzazione degli
esclusi da determinati impieghi e dt ogni reclutato avente idoneità generica.
Di fro nte all'estendersi del numero e della complessità delle specializzazioni, alla brevità della ferma e alla necessità di rendere pienamente redditizi i servizi e le scuole militari, era indispensabile continuare a perfezionare, oltre che l'attività curativa, l'attività valutativa e selettiva, ma, per passare ad indicazioni positive, orientative tra le moltissime possibilità d'impiego, valersi dell'esperienza della vita civile e del lavoro, che si basava sui clati dell'indagine scientifica psicologica.
Dalla comprensione di tali necessità è nata la così detta selezione attitudinale, fondata collaborazione medico-psicologica con gli esponenti respcnsabili del reclutamento e dell'impiego. In tal modo è sorta la Permanente M ista per le applicazioni della psicologia all'esercito, composta da rappresentanti dello Stato Maggiore, della Sanità militare, del Servizio di reclutamento e clell'Istituto Nazionale di Psicologia del Consiglio Nazionale delle Ricerche.
La visita psicologica, integrativa della visita medica, vuole indicare i campi in cui , tenuto conto dei risultati della ,·isita medica, è attendibile il migliore rendimento.
La selezione attitudinale, dal punto di vista della psicologia applicata, ha alcune caratteristiche dell'orientamento scolastico e pro(essionale ed alcune della selezione professionale.
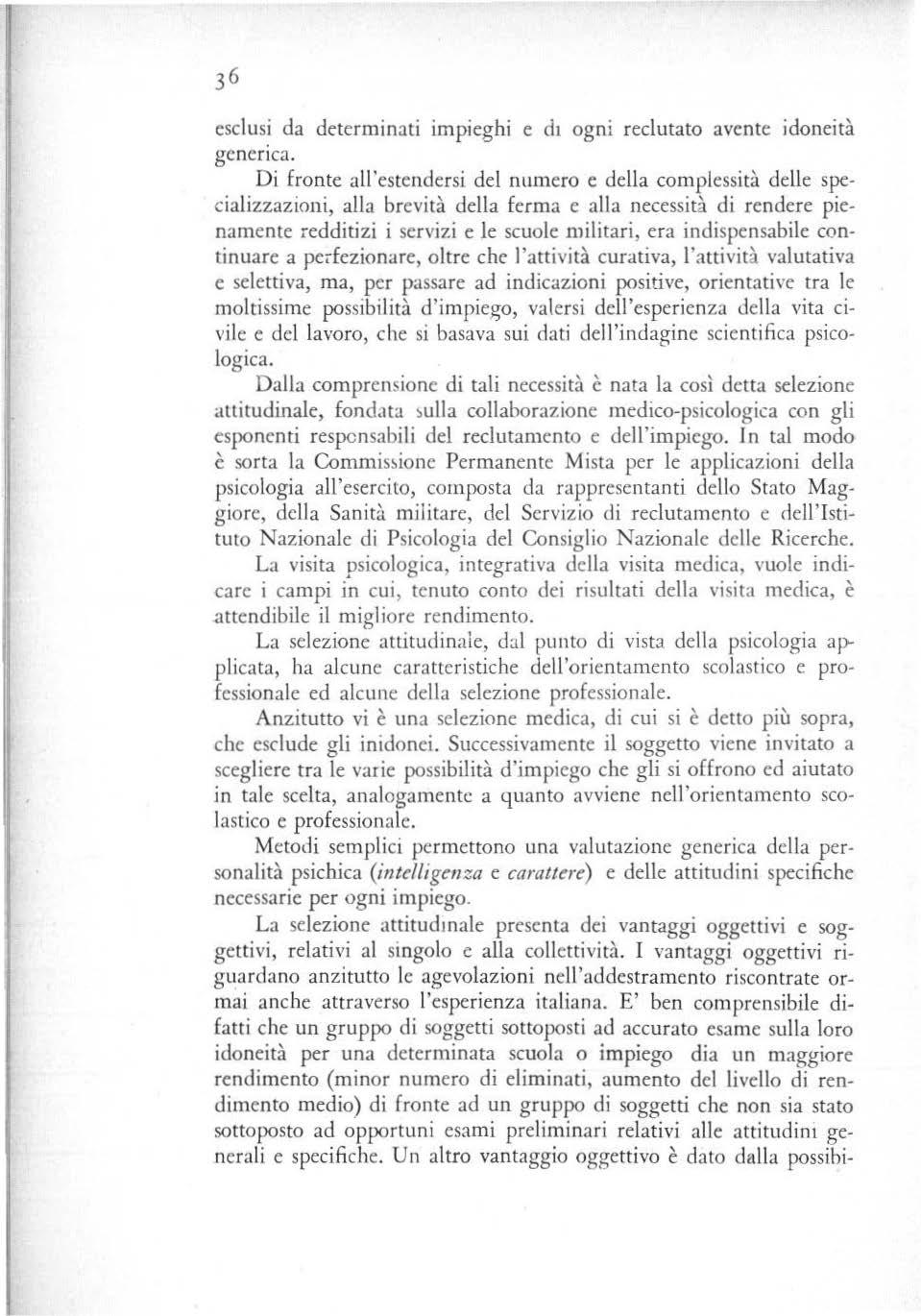
Anzitutto vi è una selezione medica, di cui si è detto più sopra, che esclude gli inidonei. Successivamente il soggetto viene invitato a scegliere tra le varie possibilità d'impiego che gli si offrono ed aiutato in tale scelta, analogamente a quanto avviene nell'orientamento scolastico e professionale.
Metodi sempl ici perme ttono una va lut azione generica della personalità psichica (intelligenza e carattere) e delle attitudini specifiche necessarie per ogni impiego.
L a selezione attitudmale presenta dei vantaggi oggettivi e soggettivi, rela t ivi al singolo e alla collettività . I vantaggi ogge ttivi rig uard ano anzitutto le agevolazioni nell'addestramento riscontrate ormai anche attraverso l' esper ienza italiana. E' ben comp r ensibile difatti che un gruppo di soggetti sottoposti ad accurato esa m e sulla loro idoneità per una determinata scuola o impiego dia un maggiore rendimento (minor numero di eliminati, aumento del livello di rendimento medio) di fronte ad un gruppo di soggetti che non sia stato sottoposto ad opportuni esa m i preliminari relativi alle attitudim generali e specifiche. Un altro vantaggio oggettivo è dato dalla possihi-
lità di coprire i quadri degli specializzati, anche con soggetti che non abbiano precedenti scolas tici e professionali adeguati, per un impiego in una specia lizz azio n e militare. Nei paesi e nelle regioni dove la maggioranza delle reclute hanno frequentato scuole tecniche e indu striali e sono stati operai in una fabbrica, le cose sono ben più fa ci li che nei paesi c nelle regioni dove la preparazione culturale e la sti m ol azione l avorativa sono mancate.
La selezione attitudinale rivela i soggetti incolti portatori di eccellenti doti native e suscettibili di rendimento sufficiente in breve tempo e può dare previsioni di successo impossibili per ogni altra via.
Tenuto conto dei dati ottenut i, si prosegue in rapporto alle esigenze dei servizi, facendo una opportuna selezione per l'assegnazione.
Viene però tenuto il debito conto delle aspirazioni, tendenze, desideri del singolo non trascurando, sin dal primo incontro, questo aspetto così importante della personalità.
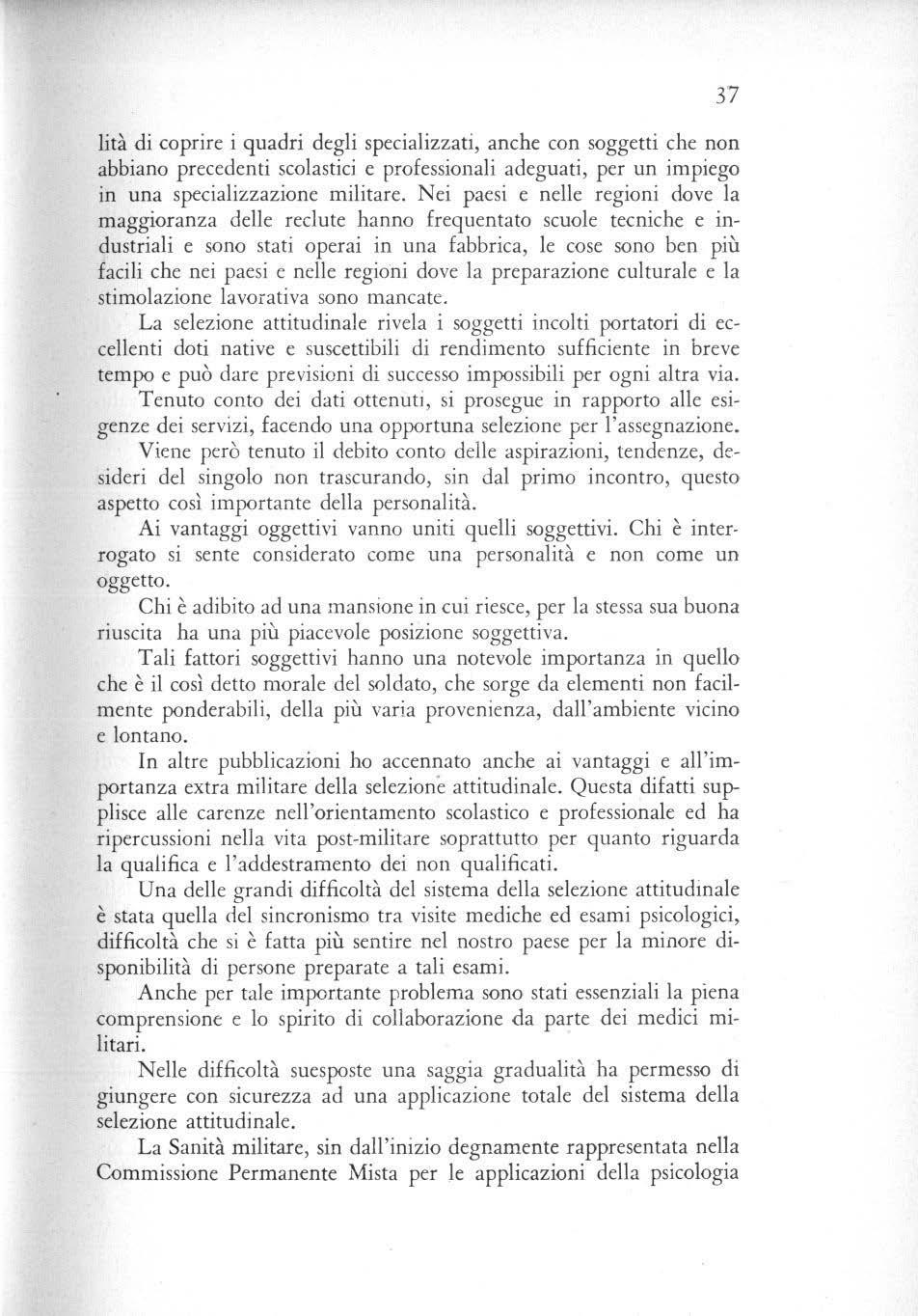
Ai vantaggi oggettivi vanno uniti quelli soggettivi Chi è interrogato si sente considerato come una personalità e non come un oggetto.
Chi è adibito ad una mansione in cui riesce, per la stessa sua buona riuscita ha una più piacevole posizione soggettiva.
T ali fattori soggettivi hanno una no t evole importanza in quello che è il così detto morale del soldato, che sorge da elementi non facilmente ponderabili, della più varia provenienza, dall'ambiente vicino e lontano.
In altre pubblicazioni ho accennato anche ai vantaggi e all'importanza extra militare della selezione attitud in a le . Questa difatti supplisce alle carenze nell'orientamento scolastico e professionale ed ha ripercussioni nella vita post-militare soprattutto per guanto riguarda la qualifica e l'addestramento dei non qualificati .
U n a delle grandi difficoltà del sistema della selezione attitudinale è st a ta quella del si ncronismo tra visite mediche ed esami psicologici, difficoltà che si è fatta più sentire nel nostro paese per la minore disponibilità di persone preparate a tali esami
Anche per tale importante problema sono stati essenziali la piena comprensione e lo spirito di collaborazione da parte dei medici militari.
Nelle difficoltà suesposte una saggia gradualità ha permesso di giungere con sicurezza ad una applicazione totale del sistema della selezione attitudinale.
L a Sanità militare, sin dall'inizio degnamente rappresentata n ella Commissione P ermanente Mista per le applicazioni della psicologia
37
all'esercito, ha dimostrato un'alta comprensione ed offerto una fattiva co ll aborazione che ha un alto valore in linea assoluta c ne acquista uno anche maggiore in linea comparativa.
Deve purtroppo affrontare le difficoltà che in altri campi della vita sociale si incontrano perchè la valutazione della personalità venga effettuata da parte medica modernamente integrata con opportuni esami psicologici.
Nel campo della scuo l a, del lavoro, della disoccupazione, del riadattamen to lavorativo e sociale dei mutilati ed inva l idi di guerra e di pace si possono oggi prendere come esempio la comprensione e la non clamorosa, fattiva attività svolta nel campo militare per la valutazione somato-psichica della personalità e il conseguente opportuno impiego.
Soltanto da poco è finita la discussione al Senato del disegno di legge per l 'appl icazione in campo naziona le dell'orientamento professionale .
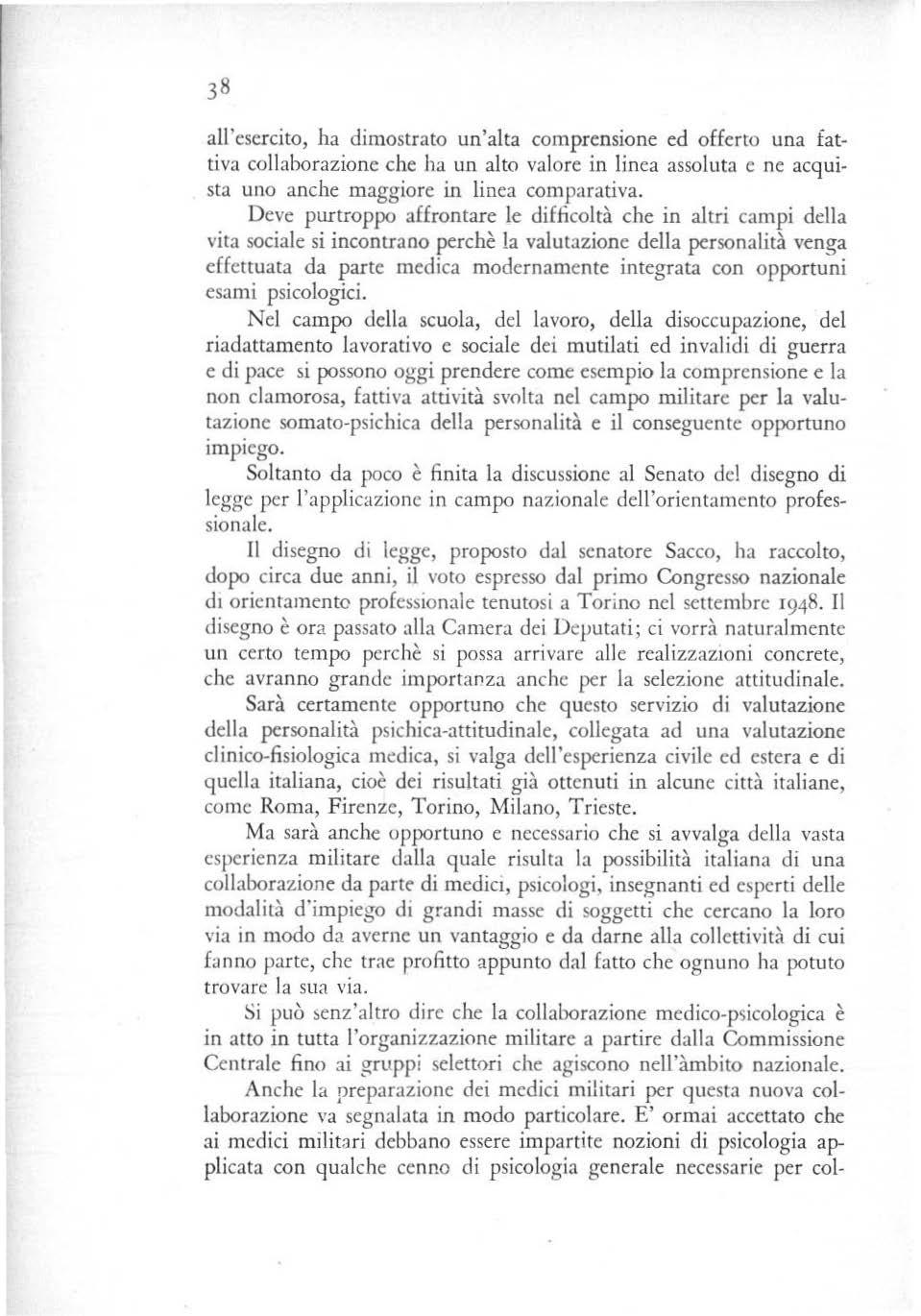
Il disegno di legge, proposto dal senatore Sacco, ha raccolto, dopo circa due anni, il voto espresso dal primo Congresso nazionale dt orientamento pro(cmonale tenutosi a Torino nel settembre 1948 Il disegno è ora passato alla Camera dei Deputati; ci vorrà naturalmente un certo tempo perchè si possa ar r1vare alle real izzaz10ni concrete, che avranno grande importaf1za anche per la selezione attitudinale.
Sarà certamente opportuno che questo servizio di va l utazione della personalità psichiea-attitudinale, collegata ad una valutazione clinico-fisiologica mèdica, si valga dell'esperienza civile ed estera e di quella italiana, cioè dei risultati già ottenuti in alcune città italiane, come Roma, Firenze, Torino, Milano, Trieste
Ma sarà anche opportuno e necessario che si avvalga della vasta esperienza militare dalla quale risulta la possibilità italiana di una collaborazione da parte di medict, psicologi, insegnanti ed esperti delle modalità d'impiego dt grandi masse di soggetti che cercano la loro via in modo da averne un vantaggio e da darne alla collettività di cui fanno parte, che trae profitto appunto dal fatto c h e ognuno ha potuto trovarè la sua via.
Si può senz'altro dire che la collaborazione medico-psicologica è in atto in tutta l'organizzazione militare a partire dalla Commissione Centrale fino ai gruppi selettori che agiscono nell.àmbito nazionale.
Anche la preparazione dei medici militari per questa nuova collabo r azione va segnalata in modo particolare. E' ormai accettato che ai medici mi l it a r i debbano essere impartite noz io n i di psico logia applicata con q u alche cenno di psico logia generale necessarie per co l-
mare la lacuna nella preparazione general e dei medici. Questi difatti, a differenza di quanto avviene in altri paesi, non hanno avuto un insegn amento di psicologia nella scuola media, ed hanno avuto soltanto in qualche università un insegnamento di psicologia, sempre però come materia (acolta6va o complementare. E' da rilevare però che negli ultimi anni sono stati istituiti nuovi ordinariat1 di psicologia in varie Università italiane. Ma i medici militari fruiscono anche di corsi informativi e di aggiornamento destinati loro esclusivamente per quello che riguarda problemi e tecniche di selezione attitudinale.
Non è forse inopportuno dare ai colleghi medici qualche precisazione su uno dei punti più discussi della selezione attitudinale, cioè sui così detti reattivi mentali o menta! tests.
Nella selezione attitudinale hanno difatti parte importante i reattivi mentali (mental tests) di cui la Sanità militare ha concretamente compreso il significato. I reattivi sono delle prove che impegnano volta a volta vari aspetti della personalità e permettono di stabilire delle graduatorie di soggetti esaminati. Tali graduatorie possono essere confrontate con graduatorie relative agli stessi soggetti in rapporto al loro rendimento in scuole o impieghi, rendimento valutato dopo una lunga osservazione. La coincidenza o non coincidenza ·della graduatoria ottenuta con i reattivi mentali ci dice l'opportunità o meno di usare tali reattivi, che sono di rapida esecuzione, per la previsione di futuri rendimenti. Per esperienza nostra, confermata da quella universale, il metodo dei reattivi permette, con una probabilità superiore al 90 °{, , la rapida segnalazione degli inidonei o dei pessimi e la rapida segnalazione deglt eccellenti o dei particolarmente dotati .
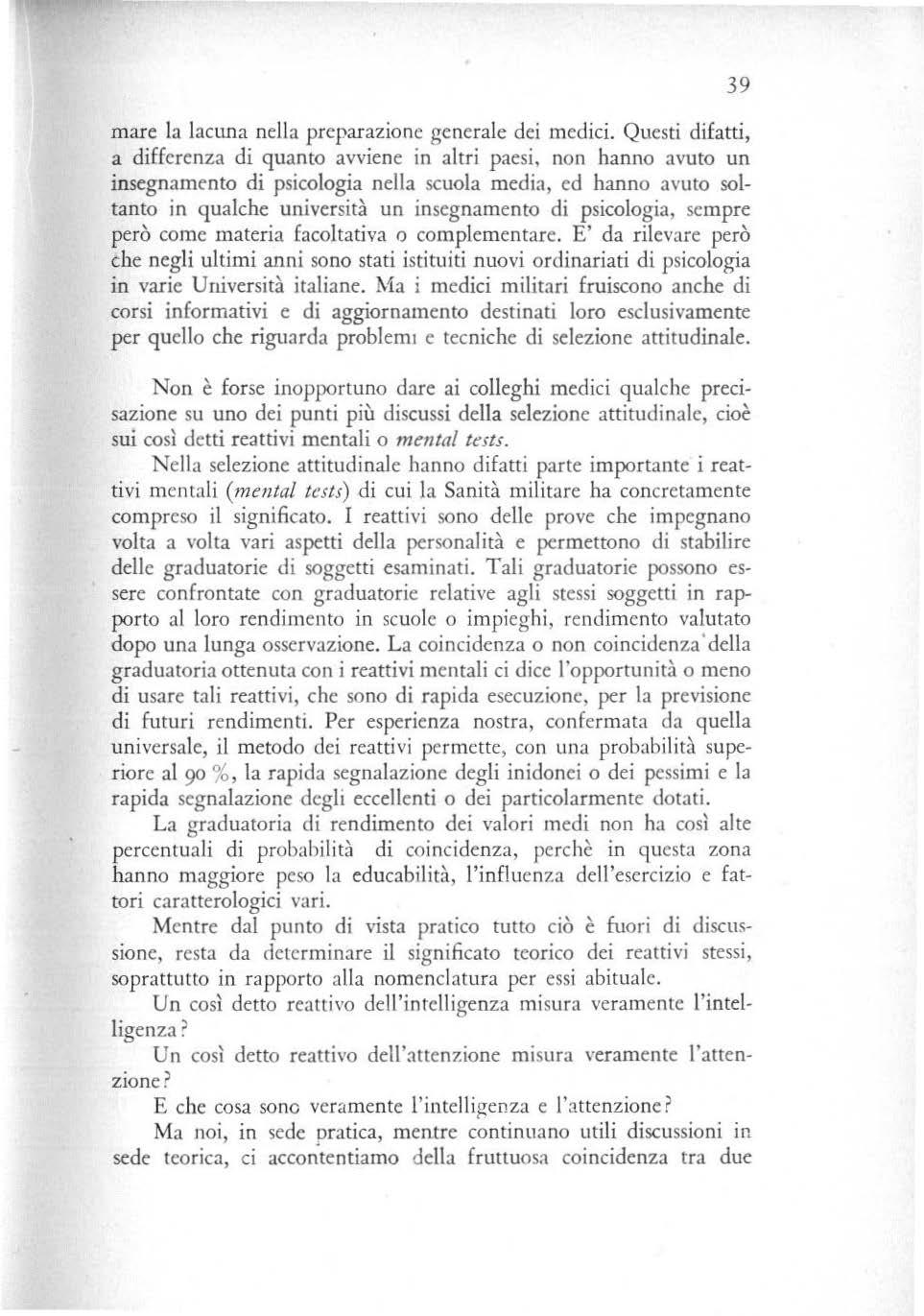
La graduatoria di rendimento dei valori medi non ha così aJte percentuali di probabilità di coincidenza, perchè in questa zona hann o maggiore peso la educabilità, l'influenza d eli 'esercizio e fattori caratterologici vari .
Mentre dal punto di vista pratico tutto ciò è fuori di discussione, resta da determinare il significato teorico dei reattivi stessi, soprattutto in rapporto alla nomenclatura per essi abituale.
Un così detto reattivo dell'intelligenza misura veramente l'intel1.1genza.)
Un così detto reattivo dell'attenzione misura veramente l'attenzione?
E ch e cosa sonc verame nte l'intelligenza e l'attenzione?
M a noi, in sede pratica, mentre continuano utili discussioni in sede teorica, ci accontentiamo della fruttuosa coincidenza tra due
39
graduatorie e dei vantaggi che derivano dalla possibilità di una previsione che risparmia denaro, tempo e disagio e concentriamo i nostri sforzi per trovare i mezzi per far coincidere le due graduatorie. Naturalmente, assolvendo tali compiti pratici, si ottengono dati di grande importanza dal punto di vista teorico e dottrinale, oltre che applicativo.
Purtroppo i reattivi mentali, che vogliono e devono presentarsi nel modo più semplice per non intimidire i soggetti, deludono quelli che non sono consapevoli che i reattivi, nella loro faticata semplicità, richiedono c nascondono deliberatamente la lunga preparazione , i continui controlli, la lunga elaborazione.
Altrettanto e ancor più si dica del così detto « colloquio >> , anche esso in apparenza molto semplice e di facile, uni\·ersale applicazione per la sua non casuale e ricercata somiglianza con un discorso tenuto in tono gentile.
I medici milltari italiani, dimostrando fattiva comprensione, con la loro concreta prezJosa collaborazione al servizio di selezione attitudinale hanno acquistato meriti particolari dando possibilità di applicazione a quella psicologia che in Jltri paesi l1a una estensione molto più vasta e da noi non molto conosciuta.
Il volume Psychology for the Armed Sert,ices edito a Washington nel 1948 Infantry Journal Press » a cura di un Comitato del National Research Council, con la collaborazione di vari specialisti e sotto la direzione del noto psicologo E. Boring, dà una utile visione d'insieme della questione, dalla quale risulta che la selezione (classificazione e scelta dell'uomo adatto al posto adatto) è uno dei sette in cui la psicologia è ritenuta necessaria per i bisogni delle forze armate. Gli altri sei campi sono espressi come segue:

a) osservazione dei limiti dell'esattezza nella percezione e metodi per disporre dell'esperienza percettiva nel modo più efficace. vita militare è estremamente importante tener conto delle differenze percettive di ciascun individuo; occorre studiare le percezioni visive, uditive, dell'olfatto. Per gli aviatori è importante anche la percezione dell'orientamentc topograEco;
h) efficienza (raggiungimento di abilità nel lavoro e nell'azione); per raggiungere l'abilità nel lavoro occorrono l'esercizio continuo e la conoscenza dei metodi, avere un buon rendimento col minimo spreco di energia. In questo problema occorre tener presenti i fattori fatica, noia, caldo e freddo, alcoo l;
c) addestramento;
d) ctdattamento (individuale) alla vita delle ar m i Problema del morale dei soldati per riu sc ire a far cooperare personalità sane e ben adattate. Problem a dell'emozione e della paura. Problema sessuale. Problemi dell'instabilità e della mancanza di resistenza;
e) relazioni socia li: importanza della buona prepara z ione degli ufficiali. Gli ufficiali devono avere alcune nozioni di psicologia di per poter far fronte alle varie situazioni (per es. panico, ccc.);
f) opinioni e propaganda (sondaggio dell 'opinione pubblica e propaganda in campo nemico).
Come è evidente, anc h e in questa elenca7.ione molto sintetica la collaborazione tra medici e psicologi è quasi se mpre essenziale.
I medici che non avessero informazioni sull'entità dell'apparato globale da parte della psicologia, co n la quale trovano ormai in collabora zio ne fattiva, possono avere qualche interessante notizia da un altro volume recente.
C. W. Bray n el volume Psychology and Mihtary Proficiency ci dà molte i nfor mazioni sulla portata della collaborazione psicologica alle forze armate degli S. U e dell'importanza lì data alla psicologia.
Dal 1939 n egli Stati Uniti fu richiesto agli psicologi, occupa ti sin allora in ricerche di altro genere, di occuparsi di psico logia militare allo scopo di eleva r e il livello di efficienza dell'esercito.

Alla fine del 1943 dei 4500 psicologi più di 1000 erano impegnati in lavori at tinenti alla psicologia militare, impo stati ai fini di carattere t:minente m ente pratico.
li lavoro cominciò con l'inizi o della guerra co n l'esame dei soggetti destinati a l1:1 Marina, volto a migliorare i metodi della guerra sottomarina Questo primo iavoro portò alla costituzione del Sclection and Tr aining of Unde rwater Sound Operators, di cui facevano parte non so lo degli psico logi, ma fisici, ingegn e ri , m edici, psichi:.J.tri, statisti, ecc .
I n segui to il Na tional R esearch Council insieme al D efense R esea rch Committee formarono il Comrnittee of Service P ersonnel l che si trasformò poi n ell 'App li ed P syc hological Pannel che lavorò per tutto il periodo della guerra Fa cevano parte di q u es ta organizzazione 200 p sicologi i quali lavoravano in piccoli gruppi di 3 o 4 fino a 10 o 12 ricercatori, occupati ciascuno nell'elaborazione di un particolare programma volto al miglioramento dell 'efficie nza militare di un o o più tipi di personale.
L e ricerche intraprese dall' Applied P sycho logical Pannel si co ncentrarono su 20 principali campi di ricerca, m ediante l'elaborazione
di reattivi attitudinali, di metodi di classificazione, lo studio di meto<ii di addestramento, dell'equipaggiamento, ecc.
Per quanto riguarda la classificazione, l' Applied P sychologica l Panne! elaborò e precisò il metodo di esame e di assegnamento delle reclute. A questo scopo:
1 " - fu elaborata una serie di reattivJ di capacità e ùi tratt i di carattere abbastanza generale: capaci tà verbale, meccanica, aritmetica ecc. che Vènivano a mano a mano perfezionati sulla base dei risultati che si andavano ottenendo;
2° - il P an nel si occupò di preparare il personale seiettore;
3° - fu preparata anche una serie di reattivi per va lutare particolari attitudini necessarie all'espletamento di un lavoro particolare.
The V. S . Nauy Basic C!assification Test Battery, elaborata dall'Applied P sychological Pann e! e tarata, fu adottata nel gennaio 1943, sostituendo i reattivi attitudinali si no allora in uso nella marina.

La selezione degli specialisti si iniziò nella primavera del 1942 quando si poneva urgente il problema del personale per la lotta antiaerea, per g li osservatori notturni, radiotrasmettitori, telefonisti, ecc
Fu il Pannd ad occuparsi di un piano di ricerca sull'addestramento e la selezione di tale personale.
Ho creduto opportuno dare qualche som maria notizia su realizzazioni di altri ambienti guardando con fiducia all'avvenire delle possibilità italiane, ma, restando sul nostro tema della collaborazione medico-psicologica, osservo in modo particolare che, anche da noi, sull'istessa parte riservata ai medici, il sistema della selezione attitudinale ha conseguenze ritenute benefiche dagli stessi medici militari. Esso dà nuove valide motivazioni perchè la classica visita medicoclinico-psicologica venga co mpiuta in condizioni migliorate e più redditizie, perchè vengano posti a disposizione nuovi sussidi diagnostici (per es. la sc h ermog r afia) e mezzi per una più precisa valutazione psicose nsoriale, specialmente nel campo delle esperie nze visive ed uditive.
In più ha portato nuovi accertamenti diagnostici e progressistici neuro-psichici in rapporto a varie situazioni emozionali e al logorio della guerra. Tra g li studi più notevoli vanno segnalati quelli sulle psi co-neurosi, sull'ansia, sulla !abilità e sull'equilibrio psichico.
Vi sono quindi conseguenze pratiche e immediate della collaborazione medica alla selezione attitudina le: perfezionamento di tecniche, approfondimento di ricerche ecc
Ma a queste conseguenze vanno aggiunte altre non così chiaramente evidenti, ma certamente importanti.
L a medicina militare ha sempre dimostrato comprensione e inter esse per appl icazioni di avanguardia della medicina generale : come ad es. medicina sportiva, medicina del lavoro e per indirizzi rinnovatori, come quello bio.tipologico . Ora, partendo dalla considerazione dell'uomo quale inscindibile unità somatica e psichica, cui si informa la biotipologia, e partendo dai fecondi risultati pratici (ancora in discussione per quanto riguarda l'interpretazio ne teorica e l 'in segnamento dottrinale) della psicanalisi e della psicologia in profondità, è in via di crescente affermazione l a così detta medicina psicosomatica, che desta molto interesse in vasti ambienti medico-militari.
Quale si sia la posizione di fronte a queste applicazioni ed a questi indirizzi, è giustificato l'interesse della medicina militare che parte dalla considerazione dell'uomo come persona lit à somatopsichica rapportata a situazioni normali ed eccezionali dal punto di vista fisiologico, ma spesso più ancora psicologico.
Tale a movimenti d'avanguardia dà a sua volta alla medicina militare una pos!zione avanzata , che allarga le basi della medicina tradizionale e nello stesso tempo la conso l ida.
I n questo quadro va intesa la sempre più ampia e perfezionata collaborazione della medicina militare alla selezione attitudinale ed alle moderne applicazioni della psicologia.
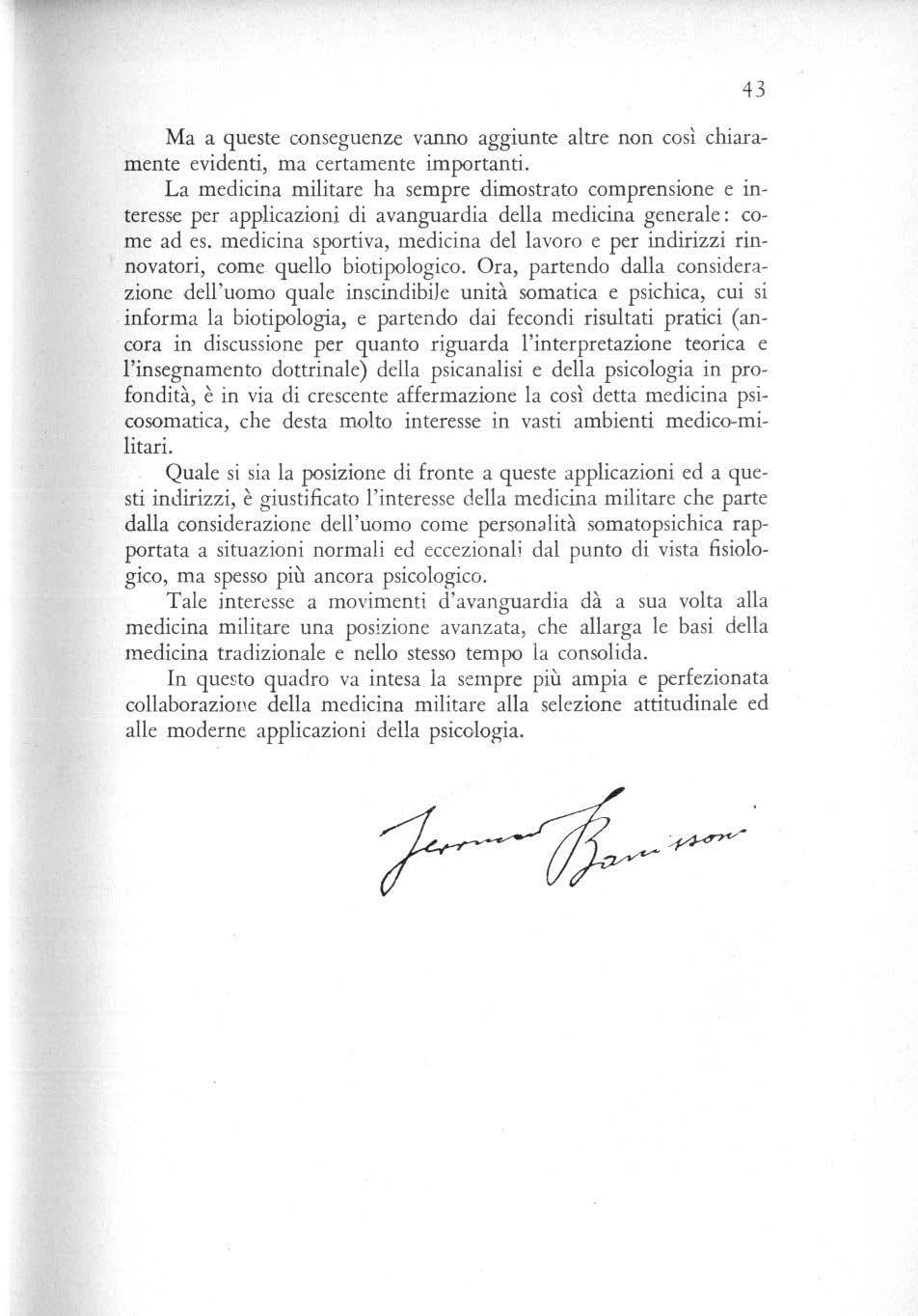
43
l CU R A R I
CO ME CO A D I UV A N T I D ELL ' ANES T ES I A
C HIR U R O l CA
In una recente seduta della Ro yal Society of Medicine un chirurgo inglese, R. Maingot (1), ha detto con umorismo anglo sassone: << l curari so no la risposta alla seg reta preghiera dci c hirurgi n . Ed in poche argute parole ha so ttolineato così l ' importanza estrema che l'introduzione Ji curari naturali c di si ntesi ha avuto nell'anestesia e di riflesso nella tecnica chirurgica in questi ultimi anni.
Veleno di freccia degli indigeni dell'America Centrai e, si dice che il curaro fosse impiegato an che come un farmaco del l 'epilessia e del tetano: non ha mai cessato di interessare ed incuriosire clinici e ricercatori, o ltr e che far sogna r e per le su e proprietà particolan, attraverso i romanzi di avventure, ge nerazioni di adolescenti.
Con fortune diver se, ora m ol to st udiato - come nel tardo '700 e nel mezzo '8oo - ora quasi dtmenticato come nel primo trent en nio del '900 - il curaro è stato proposto come agente farmacologico di ricerca e co me agen te terapeutico a più riprese, ha destato grandi speranze, h a di silluso, è stat o ripreso , poi di nuovo abbandonato.
E se nz a attardarci in una cronologia c he potrebbe apparire fastidiosa, dobbiamo qui ricordare come nel 1942 la pubblicazion e di Griffith (2) sulle prime applicazioni del curaro veniva a coronare una serie di ric e rche sc ientifiche.
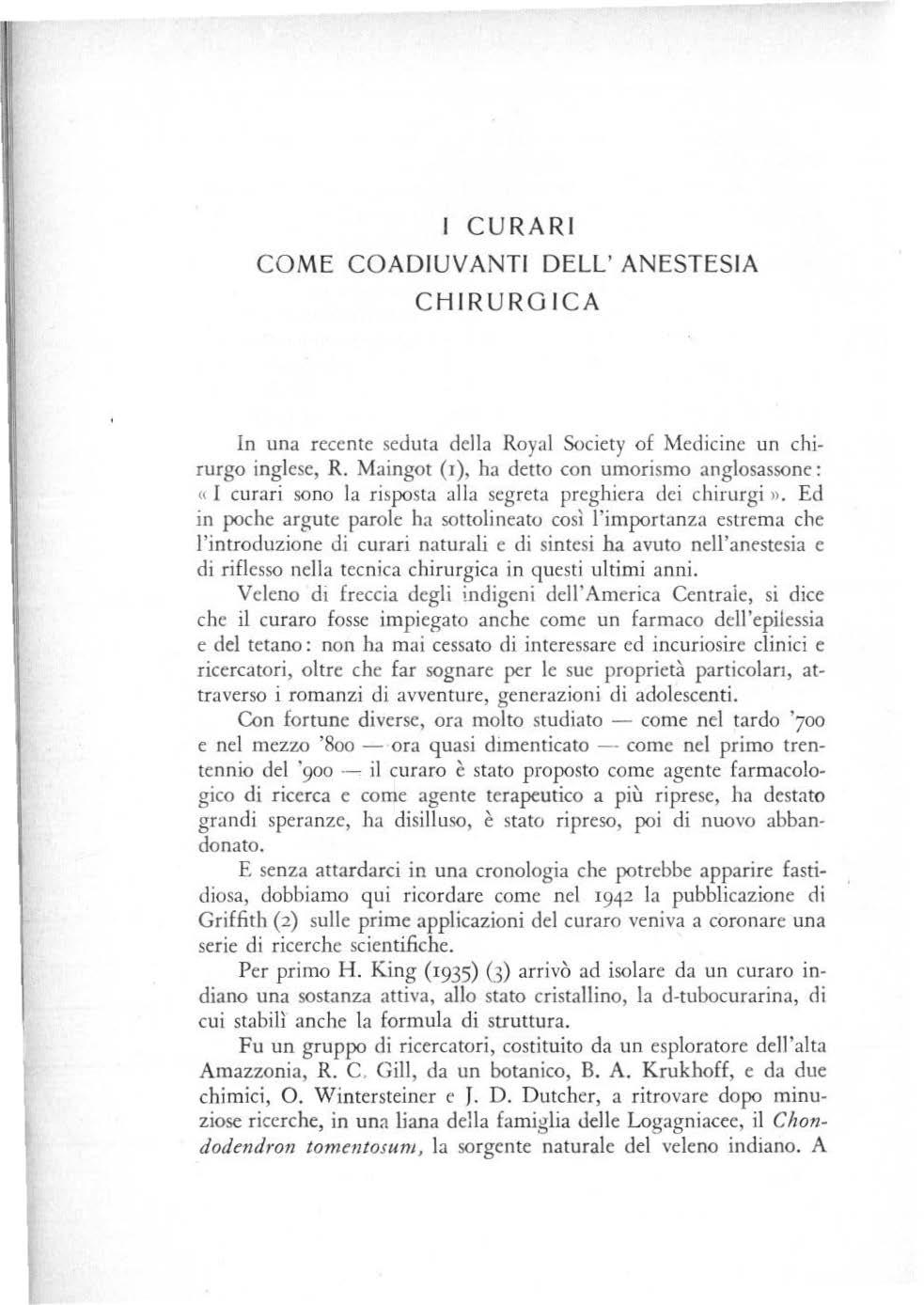
Per primo H King (1935) (3) arrivò ad iso lar e da u n curaro indiano una sos tanza attiva, allo stato cris tallin o, la d-tubocurarina, di cui stabilì anche la formula di struttura
Fu un gruppo di ricercatori, costituito da un esploratore dell'alta Amazzonia , R. C . Gill , da un botanico, B. A. Krukhoff, e da due chimici, O. Wi n tersteiner e J. D . D utcher, a ritrovare dopo minuziose ri ce rche, in un a liana della famiglia Jelle Logagniacee, il ChO?zdodendron torneuto sum , la sorgente naturale del veleno indiano . A
questi studi già così originali e brillanti si aggiunse l 'iniziativa di un fa r macologo - A. R. Mc Intyre - il quale dopo aver mmuziosamente studiato in laboratorio gli effetti dell'alcaloide arrivò a convincere uno psichiatra - A. è . Bennett - di sperimentare il curaro per preve n ire gli incidenti de ll 'ele t tro-s hock-terapia n ei malati (1940- 1942).
In seguito alle pnme prove cliniche, e allo scopo di sosUtUJre agli alcaloidi naturali prodotti più facilmente accessibili e c1nche più maneggevoli, noi ci siamo domandati se non fosse possibiie, prendendo come modello ja nota formula della d-tubocurarina, di arrivare alla sintesi di sostanze molto vicine negli effetti. Abbiamo così descritto de r ivati che dapprima mo l to simili al modello prescelto (4) sono andati semplificandosi (5) fino ad arrivare a prodotti relativamente assai più semp l ici (6), i quali hanno però dimostrato proprietà curaro-simili elevate e sono oggi largamente in uso nella pratica chirurgica
La tabella I ria ssume brevemente le fasi di questo la,oro d'indagine.
L'interesse del trietere del pirogallolo, chiamato anche ttiioduro di 2, 3 benzene, o 2559 F., o Flaxedil, o Sincurarina, o Gallamine Triethiodide, consiste soprattutto nel fatto che non presenta gli effetti secondari tossici come ipotcnsioni, bronco costr izio n i, effetti istaminici che spesso so no stati osservati nell'imp iego dei derivati naturali .
el nuovo Laboratori o di chimica terapeutic:1 dell' I stituto Superiore di Sanità abbiamo dal 1947 continuato questo studio intrapreso n ell'Istituto Pasteur di Parigi, e, dati anche i mezzi eccezionali di ricerca che sono stati messi a nostra disposizione, abbiamo potuto condurre ad una conclusione diremo quasi logica il disarticolamento della m olecola della d-tubocurarina da cui eravamo partiti.
D escriven d o infatti nuove serie di sosta n ze curaro-s i mi li, e cioè a lc un i de ri va t i de ll a bc n zoilco l in a (7) ed alc un i de ri va t i de ll a succini lco li n a (8 ) , noi abbiamo potuto confe r mare l 'ipotesi g ià emessa da n oi ne l 1946, e cioè che i derivati che co m porta no due o più f un zio n i ammonio-qua t ernario sono suscettibili di far prova di prop r ietà curaruzzanti elettive.
Tralasciando di enumerare le altre conclusioni di ordine strutturale a cui siamo giunti, sarà però interessante di menzionare che u no dei derivati, il bisiodometilato del succinato di dimetilammino-
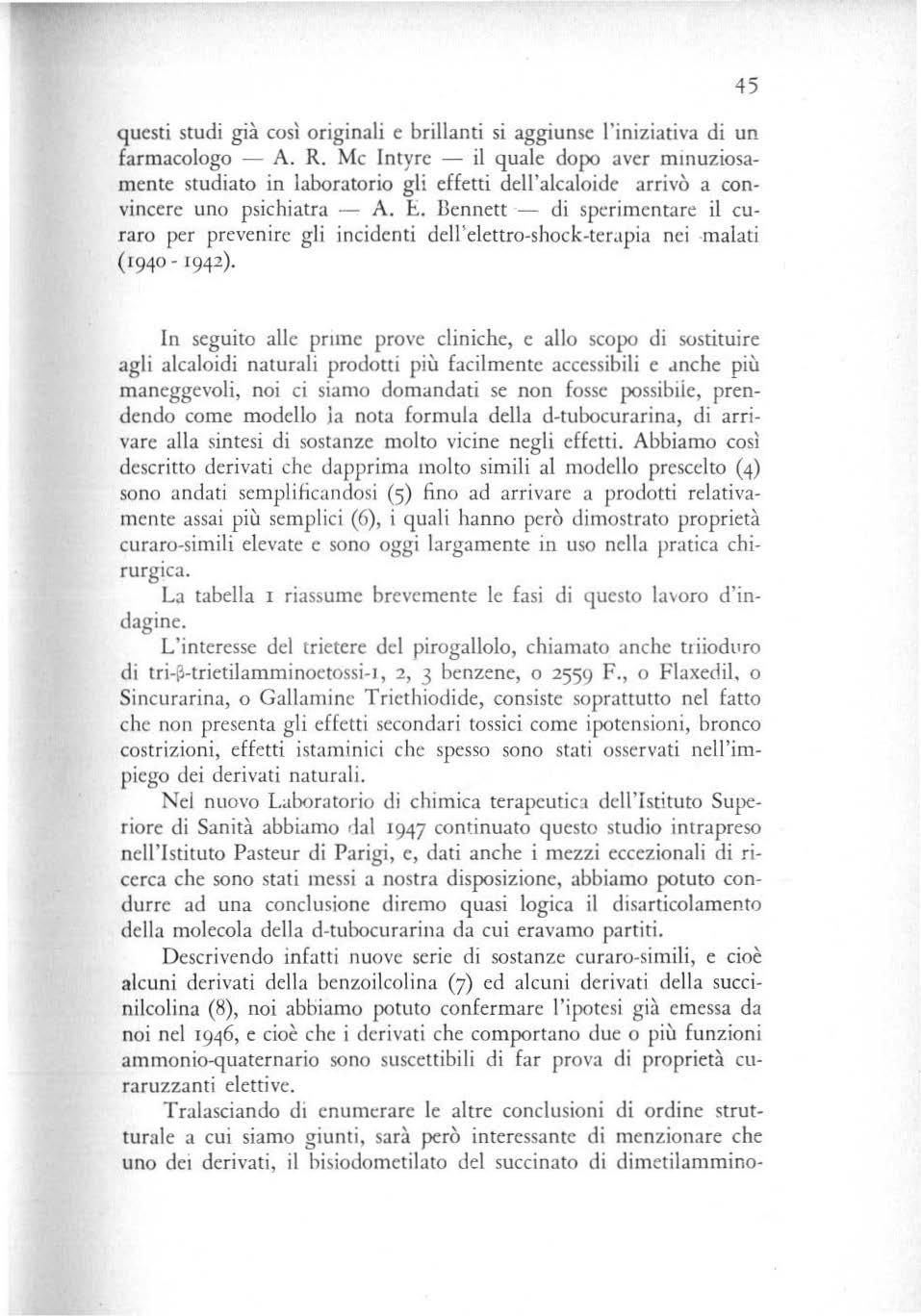
45
etile, o succinilcolina l. S.) non è che la molecola raddoppiata dell'acetilcolina, il che riveste il grande interesse teorico se si ammette, anche parzialmente , la teoria chimica della trasmis si one neuro-muscolare.
T ABELLA I.
STR UTTURA CHIMICA
DELLA d -TUBOCURAR ll':\ E DEI CURARI S INTETICI
Tubocurarina.
l (C H 3) 3 N(CIIs>,o N(Cil 3 ) 3 l loduro di d eca metomum ( decontrax).

l nuovi derivati sono stati studiati in clinica dal prof. Valdoni (9) e dai suoi collaboratori (IO). Alcuni di essi, per la fugacità stessa della loro azione e pe.r l'elettività elevata di cui fanno prova, sono suscettibili di applicazioni originali nel campo della chirurgia che ha più specialmente riguardo alla chiusura della parete addominale a fine intervento, al blocco dei movimenti diaframmatici ed infine alle endoscopie in genere.
Perchè il curaro rappresenti un progr esso come coadiuvante dell'anestesia, ha spiegato molto bene Cole (n): « Il termine di anestesia
C H 2 COO CH 2 C H 2 l' (C I1 3 ) 3 l CH 2 COO CH 2 CH 2 :"(C H 3 ) 3 l Succinilcolma. Flaxedil
o sincurarina.
-scrive infatti i l Cole - era impiegato generalmente per designare l'abolizione del dolore, ma l'impiego tecnico della parola impl ica attualmente una immobilità ed un rilasciamento muscolare suscettibile di permettere i più difficili int erve nti chirurgici l> .
Questo effetto è generalmente ottenuto con un'anestesia detta profonda, che rende necessaria nel sangue una concentrazione elevata io anestetico. Lo shock che ne risulta è !ungi dall'essere inoffensivo:
Fig. 1. - c< Head-drop Method » : Per realizzare un dosaggto biologico delle p1·eparazioni di curari naturali, Holaday ha proposto di utili zzare il cambta,. mento di posizione del coniglio a cui sono state somministrate dosi minime dell'alcaloide. La diminuzione del tono dei muscoli della nuca si traduce con una caduta della testa che viene cosl a toccare terra.
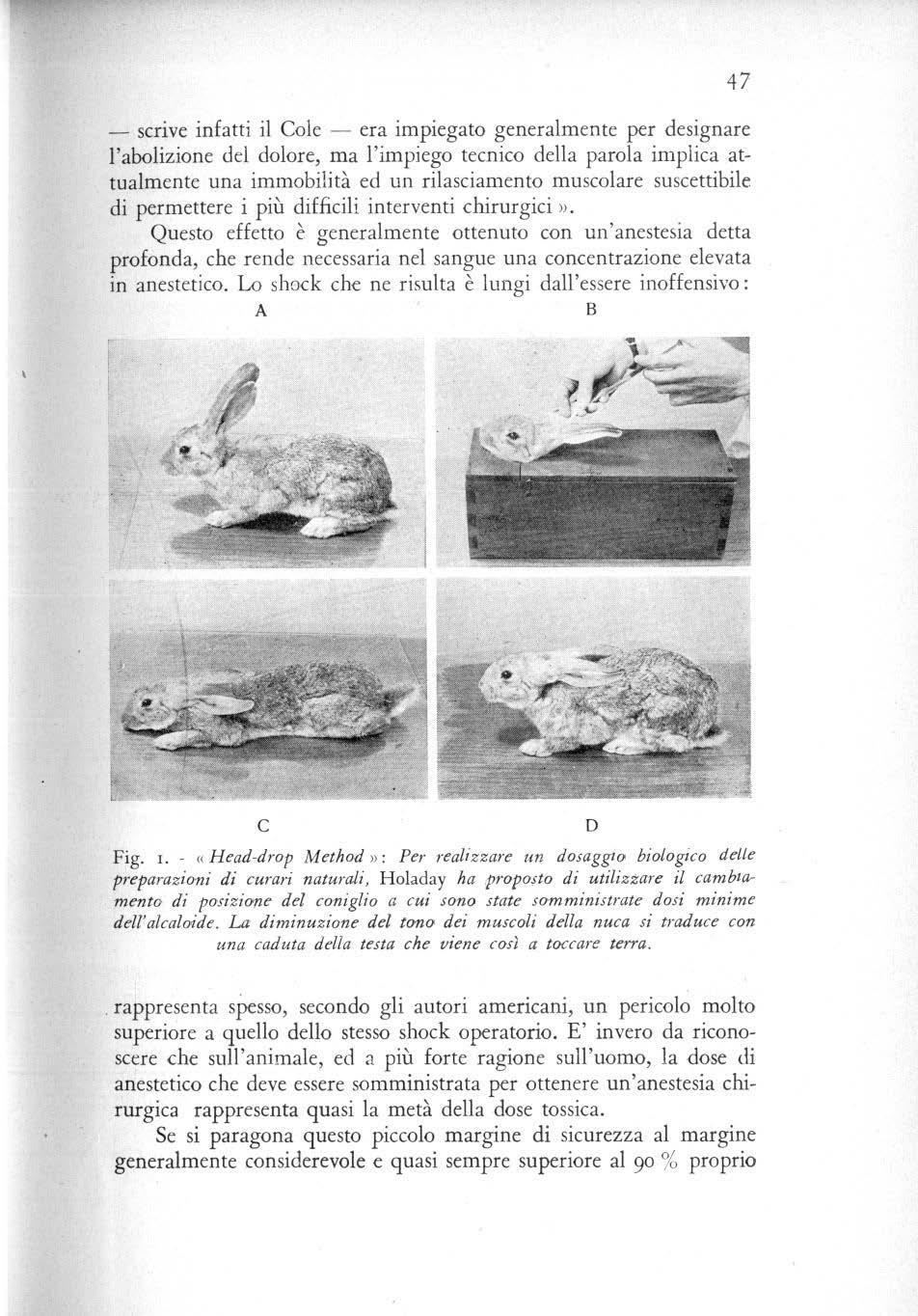
rappre se nt a spesso, seco ndo gli autori americani, un pericolo molto superiore a quello dello stesso shock operatorio. E' invero da riconoscere che sull'anima le, ed a più fort e ragion e sull'uomo, la dose di anestetico che deve essere somministrata per ottenere un'anestesia chirurgica rappresenta quasi la metà della dose tossica.
Se si paragona questo piccolo margine di s.icurezza al margine generalmente considerevole e quasi sempre superiore al 90 % proprio
47
A 8 c D
dell'impiego degli altri mezzi terapeutici chimici, se si tiene conto del fatto che la tossicità propria dell'anestetico si aggiunge allo shock rappresen tato Jall'intervento chirurgico, se si aggiunge infine che i mezzi di cui disponiamo per scongiurare gli accidenti della narcosi sono notevolmente poco efficaci, si apprezzerà l'interesse di un metodo che permette di diminuire la dose necessaria di anestetico.
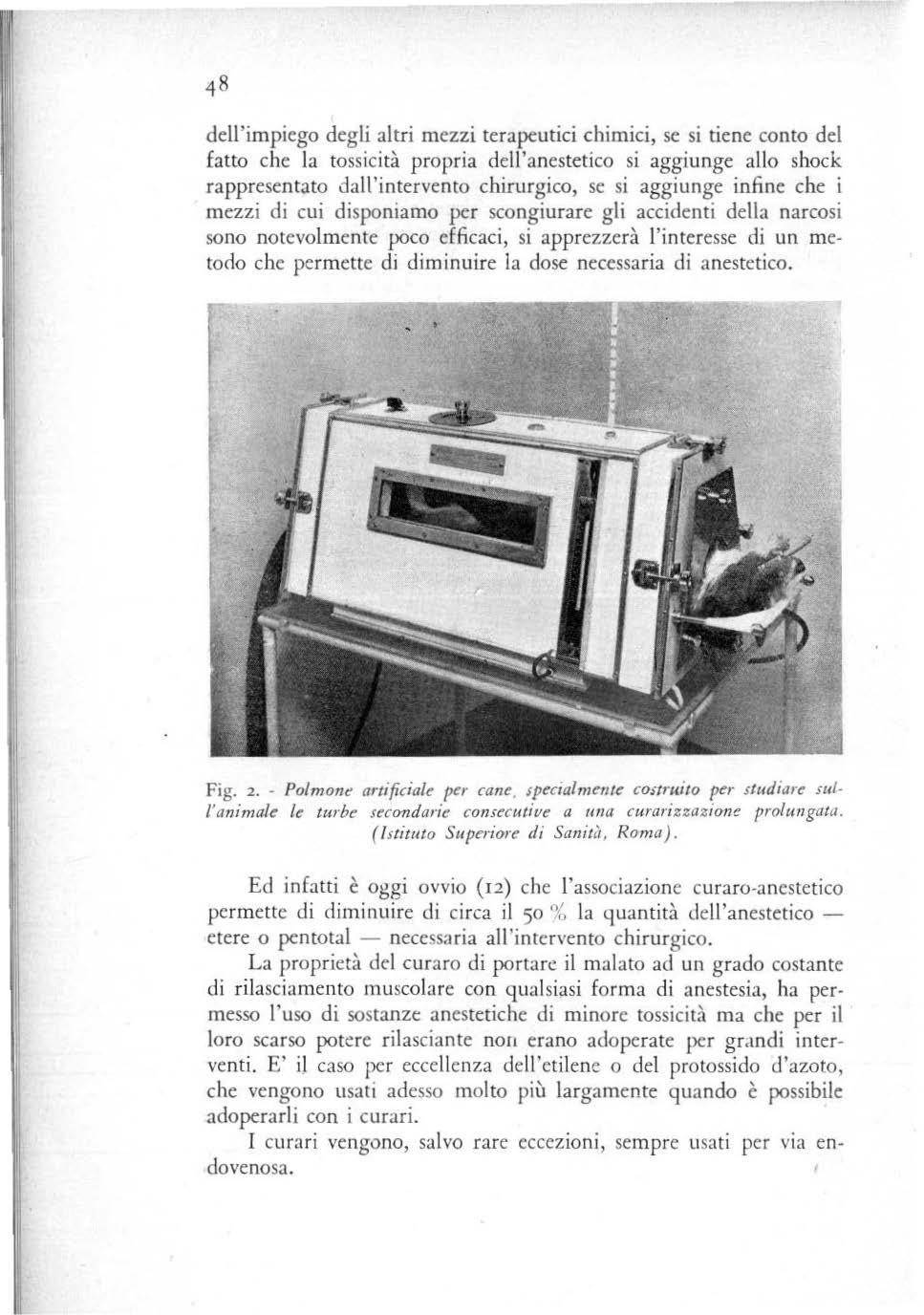
Ed infatti è oggi ovvio (12) che l'asso ciazion e curaro-anestetico permette di diminuire di circa il 50"{, la quantità de ll'anesteticoetere o pentotal - all'intervento chirurgico.
La proprietà del curaro di portare il malato ad un grado costante di rila sciame nto muscolare con qualsiasi forma di anes tesia, ha permesso l'uso di sostanze anestetiche di minor e tossicità ma che per il loro scarso pott:re rilasciante non era no adoperate per grct ndi interve nti. E' il caso per eccel lenza dell'etilen e o del protossido d'azoto, che vengono usati adesso molto più largamente quando è possibile adoperarli con i curari.
I curari vengono, salvo rare eccezioni, sempre usati per via endovenosa.
Fig. 2. - Polmone per cane co;·trwto studiare sull'animale le turbe secon darie consecutive a una curarizzazione prolungata. {Istituto Superiore di Sanitcì, Roma).
Le dosi di d-tubocurarina e l'ioduro del decametonio (Decontrax, C1o) normalmente utilizzate nell'uomo vanno da 5 a 15 mg. in toto, e da 40 a 6o mg. per il 2559 F. (Sincurarina o Flaxedil). Per un lungo intervento può essere utile il ripetersi della dose.
Gli interventi chirUigici in cui è particolarmente indicato l'uso del curaro si trovano elencati nella pubblicazione di Schlesinger (13) che ha anche analizzato le caratteristiche delle associazioni fra curaro e differenti anestetici.
In chirurgia addominale, le sostanze curariche provocano un r il asciamento completo della parete che varia da 30 a 50 minuti, per una dose media. I muscoli si lasciano scostare con facilità e i visceri che non tendono più a formare ernia possono venire esplorati senza difficoltà.
L e indicazioni più classiche sono la gastrectomia, colecistectomia e appendicectomia. Negli interventi in cui è richiesta l'immobilità completa del diaframma, ed in particolare nella chirurgia delle vie biliari, la curarizzazionc viene spinta fino all'apnea, con introduzione della respirazione artificiale.
Anche la possibilità di controllare completamente i movimenti respiratori giustifica l'uso dci curari nella chirurgia toracico-polmonare, particolarmente in interventi delicati come la dissezione dell'ilo o le suture dei bronchi.
Nel campo dell'applicazione clinica l'uso del curaro si è rivelato come uno dei mezzi più sicuri per evitare o prevenire i traumi astroarticolari della convulsoterapia.
Eccettuato per i grandi interventi chirurgici in ostetricia, l'uso del curaro durante il parto - usato a dosi infra-curarizzanti e per via intramuscolare - è stato oggetto di molte discussioni.
Il fatto che dosi elevate di curaro possono portare alla paralisi respiratoria, costituisce uno dei loro particolari vantaggi così come il maggiore pericolo della loro applicazione.
Per queste ragioni abbiamo sottoposto in Laboratorio i nostri d erivati a dei criteri rigorosi di controllo, e uno dei migliori ci è sembr ato quello della somministrazione di più dosi mortali ad un cane mantenuto in respirazione artificiale in un po lmone d'acciaio . E' noto infatti che il curaro agisce paralizzando progressivamente i muscoli, e che la paralisi di quelli respiratori determina in generale la morte.
Grazie all'ing. Paladino (14) un polmone d'acciaio è stato costruito in questo I stituto e ciò ci ha permesso di valutare con grancle r igore le conseguenze dei derivati da noi studiati in animali che, pur

49
4
avendo ricevuto fino a 300 volte la d ose mo rtale per un animale normale, sopravvivevano dopo aver eliminato il tossico .
L a tabella II riporta il riassunto dei ri sultati su cinque tipi di sostanze curariche e dà al tempo stes so un 'idea assai chia ra della loro tossicità e della loro azione curariz zante .
l qose N. di dosi Dose Dose massima tol· tossiche Durala minima tossicn dal) 'a· tollerat e massima curariz zante In dall'nn l mal e della c ura · ! respirazione in respirA· rizzazione mgjkg. mg/k g. controllata zione mg/ kg controllata
(l) Le prove sono state limitate d1lla quamita di prodouo di cui disponiamo e queste cif re sono probabilmente al di sotto del limite che potre bbe essere raggiunto.
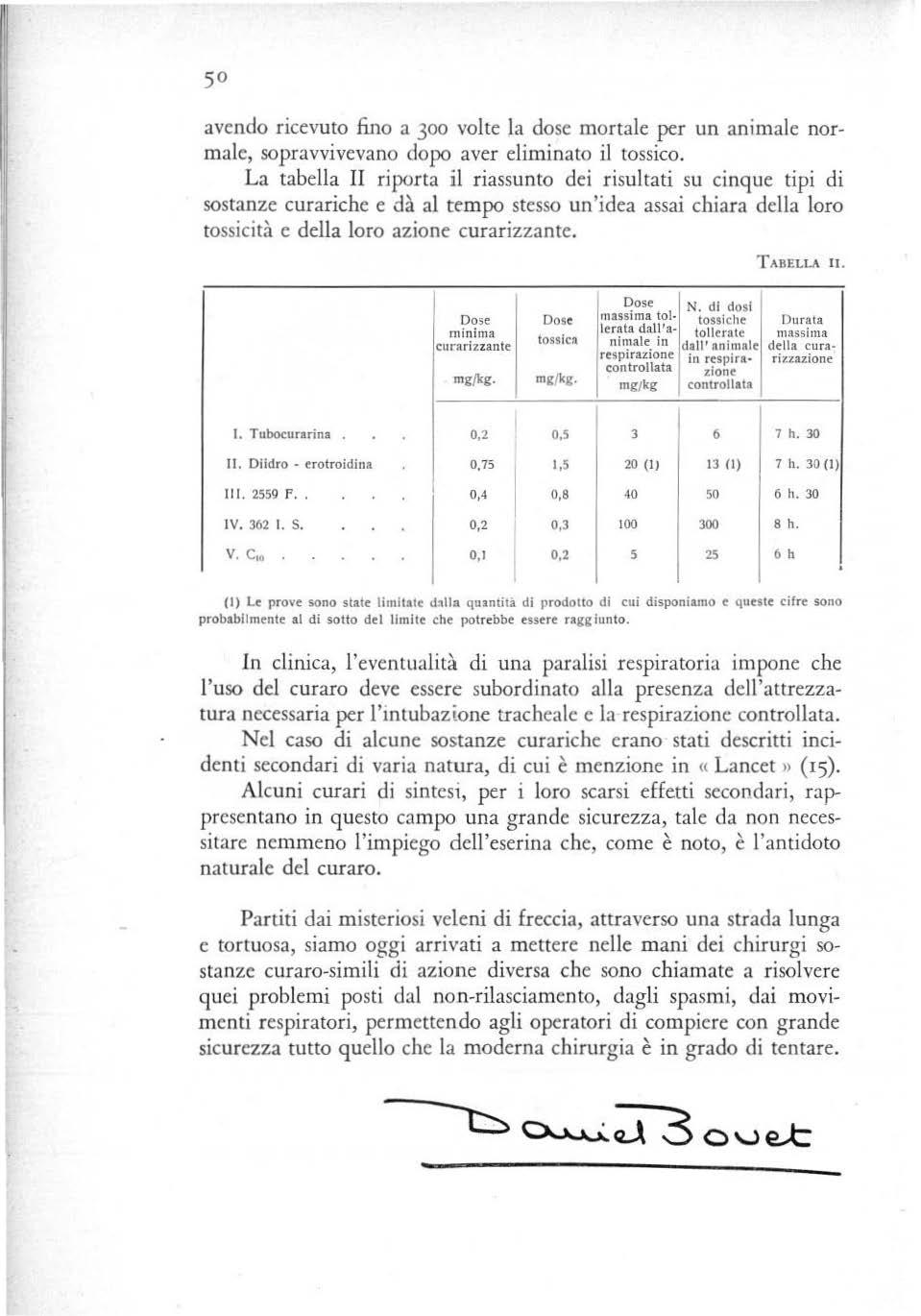
In clinica, l 'eventua lit à di una paralisi respiratoria impone che l ' uso del curaro deve essere subordinato alla presenza dell'attrezzatura necessaria per l'mtubazione tracheale c la respirazione co ntrollata . Nel caso di alcune sostanze curariche erano stati descritti incidenti seco ndari di varia n atura, di cui è menzione in « L a n cet » ( rs). Alcuni curari di si nte si , per i loro scarsi effetti secondari, rappr ese ntano in questo campo una grande sicurezza, tal e da non necessitare nemmeno l 'impiego dell'eser.ina che, co me è noto, è l'antidoto n at urale del curaro.
Partiti dai mist eri osi veleni di freccia, attraverso una strada lunga e tortuosa, siamo oggi ar rivati a mettere nelle mani dei chirurgi sostanze curaro-simili di azione diversa che sono chiamate a risolvere qu ei problemi posti dal non-rilasciamento, dagli spasmi, dai movimenti r espiratori, permettendo agli operatori di compiere con grande si curezza tutto quello che la moderna chirurgia è in grado di tentare.
so
11.
l. Tubocurarina 0,2 0,5 3 6 7 h. 30 Il. Dìidro • e rotroidina 0,75 1,5 20 (l) 13 Il) 7 h. 30 (l) 111. 2559 f . 0,4 0,8 40 50 6 h. 30 IV. 362 l. S. 0,2 0,3 100 300 8 h. V C10 O , l 0,2 5 25 6 h
T ABELLA
1. MarNGOT R.: in (' Proc Roy. Soc. Med. », 43, 599 (r95o).
2. GRIFFI11i H. R. e JoHNSON G. E.: in « Anesthesiology >>, 3, 418 (1942).
3· KxNc H.: in « J. Chem. Soc. >l, 1935, 1381.

4· BOVET D., CouRvOISIER S., DucROT R. e HoRCLOJS J.: in ((C. R. Ac. Se. >l, Paris, 223, 597 ( 1946).
5· Idem in «C . R. Ac. Sc.11, Paris, 224, 1733 (1947).
6. BovET D., DEPIERRE F. e DE LESTRANCE Y.: in «C R. Ac. Se. l> , Paris, 2 2 5· 74 (1947)·
7· BOVET D., BovET - NITTI F., GUARINO S. e LoNco V. G.: in <<Rend iconti Ist. Sup. San. >l, 12, So (1949).
8. BOVET D., BovET- Nrrn F., GuARINO S., LoNco V. G. e MAROTTA M.: i11 « Rendico nti !st. Sup. San. ,1, 12, 104 (1949).
9· VALDONt P.: in «Re ndiconti lst. Sup. San. ll, 12, 255 (1949).
ro. MAZZONI P. e MARGHIERI L.: in << Giorn. !tal. Anestes. » , 16, 2 (1950).
n. Cou F.: in << Anesthesiology >l, 6, 48 (1945).
12. ADAMS R. C.: in << Surg. Clinics North America, Mayo Clinics North America, Mayo Clinic >1, number 25, 735 (1945).
13· ScHLESINGER E. B., M. D.: in (( Am. Journ. Med. ll, I' 518 (1946).
14. PALADINO S.: in "Rendiconti Ist. Sup. San. >l , 12, r68 (1949).
15. Editoriale del << Lancet >l, 258, 1034 (1950).
BIBLlOGRAFIA
sr
CONSIDERAZIONI DI PSICOLOGIA
SU LLA PRIMA E SECONDA GUERRA MONDIALE
Dopo ogni guerra è sorta naturale la domanda se essa abbia prodotto psicosi e neurosi.
Questo perchè, più su dati di intuizione che su dati di fatto, si pensa che emozioni e patemi d'animo possano produrre danni alla psiche umana fino a provocare la follia. Anzi i dati di fatto sono contrari: cos.ì l'inchiesta psichiatrica. dopo il terremoto di Messina (rgo8), così l'insieme di studi psichiatrici sulla psicopatologia di guerra dopo la conflagrazione mondiale 1914- 1918 (lavori in tutte le nazioni; ne cito alcuni : Birnbaum, Sommer, Dumas, Sollier, Aimè, Fragnito, Baldi. ecc ..).
Allora si dimostrò che la guerra e i grandi cataclismi non producono nuove psicosi, ma agevolano un poco lo scoppio di esse nei predisposti aumentano, in modo non marcato, le nevrosi e le ps1conevros1.
Anche dopo la recente guerra ( 1939 - il problema è ritornato, come si dice, sul tappeto .
V ari autori si sono occupati di ciò (Lothar B. Kalinowski, Bally, Minkowski, Parin, Ey, Cornavin, Sargant, Slater, Padovani, ecc.), per non citare che gli Autori di lavori più specializzati.
Al I Congresso Internazionale di Psichiatria (Parigi, 1950) l'argomento è poi stato trattato come tema.

Le conclusioni sono le stesse : la seconda guerra mondiale, pur con le sue cataclismatiche azioni di bombardamento aereo, pur con i nuovi mezzi bellici tcrrifici ecc . , non ha prodotto nuove psicosi, nè si è registrato un aumento dei malati psichici (anzi una din1inuzione) e non si è avuto neanche un sicuro aumento delle nevrosi.
Questo in linea di massima, con alcune varianti però secondo i paesi.
Così pare che, riguardo ai soldati, le nevrosi e psicosi siano state più frequenti nelle truppe statunitensi che non in quelle di
altri paes1 m specie inglesi e tedesche, dove i fatti di psicopatia e di nevrosi sono stati ancor più rari che non nella prima guerra mond ia le.
Riguardo alle popolazioni civili, se scorriaroo la l etteratura psichiatrica, vediamo che in quelle più colpite dalla guerra e specialmente dai tremendi bombardamenti aerei (inglesi, tedesche, italian e, ecc .) non appaiono quasi casi di follia, d'isterismo grave, ecc per eventi bellici.
Solo in Russia, per lo meno a stare al libro del Guiliarowski, troviamo alcuni casi d1 stupore, di stato d'arresto psicomotorio da bombardamento aereo, ma anch'essi in numero ben modesto e in soggetti predisposti.
Riguardo poi all' It alia, tutti noi abbiamo visto gran distruzioni da aerei nell e città, ma quasi mai n elle popolazioni colpite improvvisi fatti isterici gravi, scoppi di psicopatia clamorosa, neanche n ell' I talia meridionale, che si reputa più emozionabile.
Aggiungo, ma questo fatto può avere varie cause, che durante la guerra in Italia le ammissioni agli ospedali psichiatrici erano assai d iminuite; ciò è avvenuto anche in Francia e in altri Stati europei.
In complesso sono giuste le conclusioni del Padovani al Congresso di Psichiatria di Parigi (1950) e cioè:
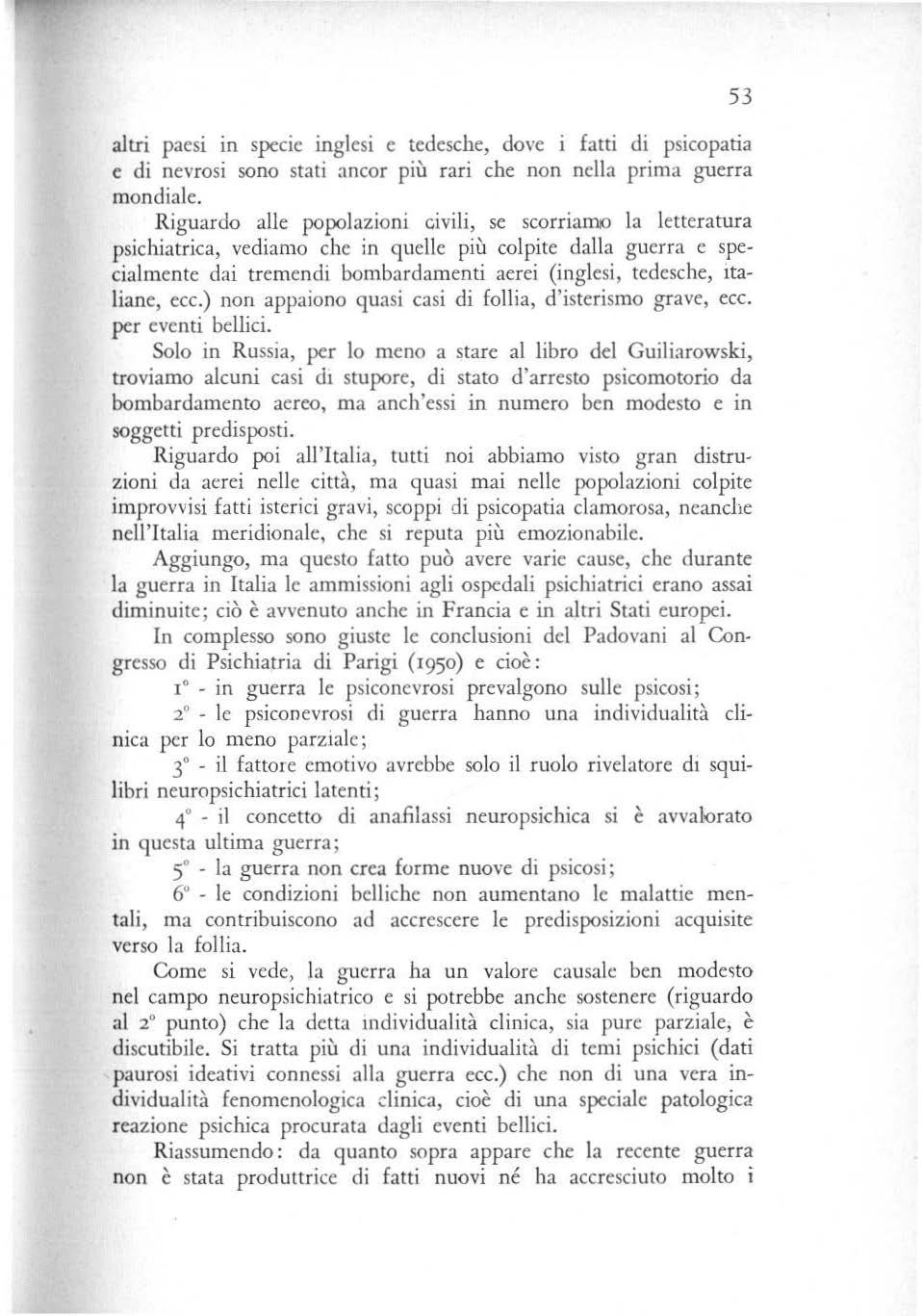
1° - in guerra le psiconevrosi prevalgono sulle psicosi;
2" - le psiconevrosi di guerra hanno una individualità clinica per lo meno parziale;
3• - il fattOle emotivo avrebbe solo il ruolo rivelatore d1 squilibri neuropsichiatrici l atenti;
4• - il concetto di anafilassi neuropsichica si è avval()rato in questa ultima guerra;
s· - la guerra non crea forme nuove di psicosi;
6u - le condizioni belliche non aumentano le malattie mentali , ma contribuiscono ad accrescere le predisposizioni acquisite verso la follia .
Come si vede, la guerra ha un valore causale ben nel campo neurop sichiatri co e si potrebbe anche sos tenere (riguardo al 2 • punto) che la detta mclividualità clinica, sia pure parziale, è discutibile. Si tratta più di una individualità di temi psichici (dati paurosi ideativi connessi alla guerra ecc.) che non di una vera individu alità fenomenologica clinica, cioè di una special e patologica rea zione psichica procurata dagli eventi bellici.
Ria ssumendo: da quanto sopra appare che la recente guerra non è stata produttrice di fatti nuovi né ha accresciuto molto i
53
fatti già noti di psicopatologia. In una frase, si possono accettare le conclusioni di Ey e Cornavin: « Cc qui nous a frappés c'est beaucoup plus la résistance psychique aux événements de guerre que Jeur fonction pathogène discutable » Qu esti Autori si riferiscono ali' esperienza in Francia, dove notarono, n eli 'ultima guerra, una diminuzione di malati negli O spedali psichiatrici, e solo qualche rara psicosi di reazione ai bombardamenti, all'esodo ecc., psicosi di reazione, mai però pure.
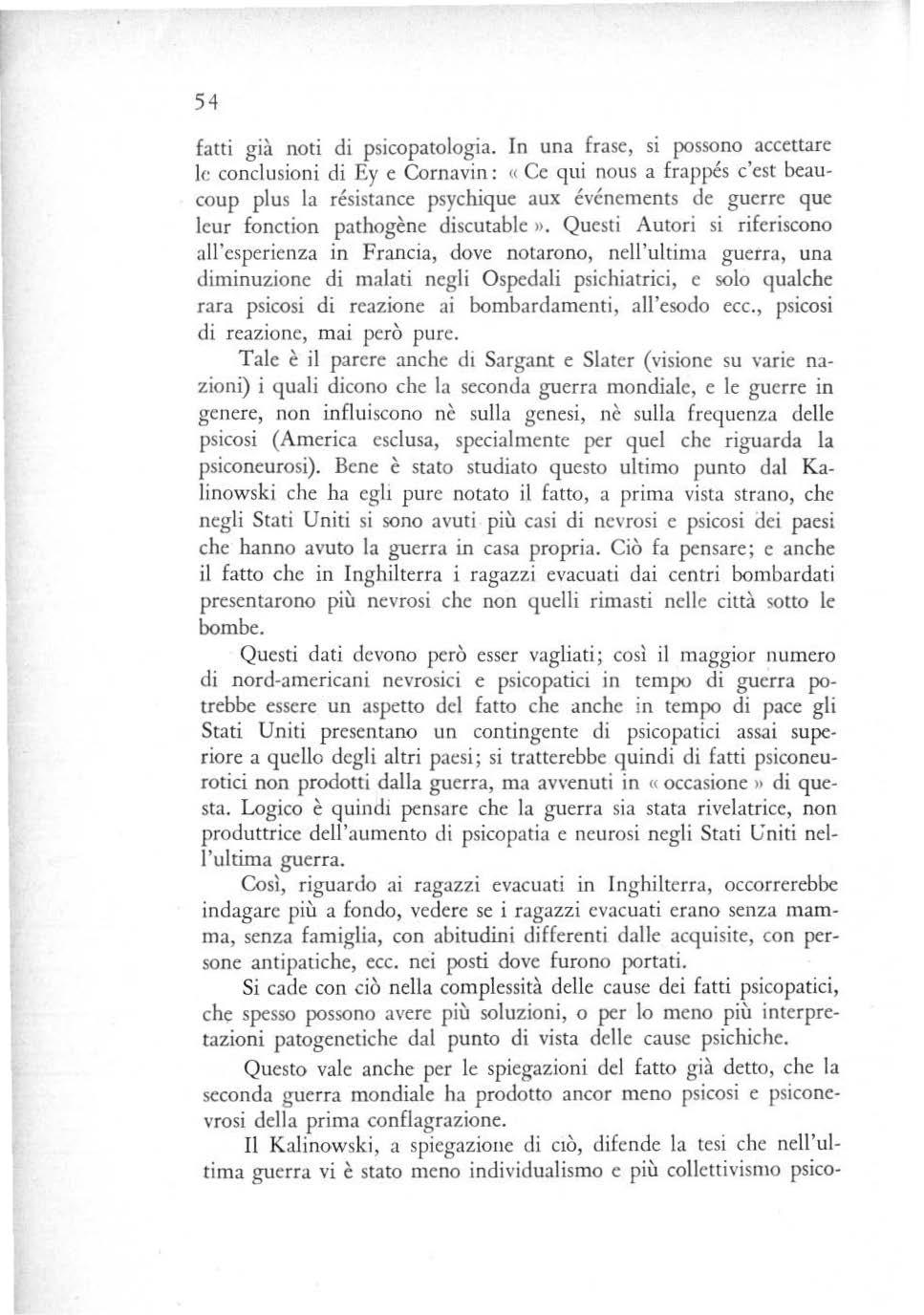
Tal e è il parere anche di Sargant e Slater (visione su varie nazioni) i quali dicono che la seconda guerra mondiale, e le guerre in genere, non influi sco no nè sulla genesi, nè sulla frequenza delle psicosi (America esclusa, specialmente per quel che riguarda la psiconeurosi). Bene è stato studiato questo ultimo punto dal Kalinowski che ha egh pure notato il fatto, a prima vista strano, che negli Stati Uniti si sono avuti più casi di nevrosi c psicosi dci paesi che hann o avuto la guerra in casa propria. Ciò fa pensare; c anche il fatto che in Inghilterra i ragazzi evacuati dai centri bombardati presentarono più nevrosi che non quelli rimasti nelle città le bombe.
Questi dati devono però esser vagliati; così il maggior numero di nord -americani nevrosici e psicopatici in tempo di guerra potrebbe essere un aspetto del fatto che anche in tempo di pace gli Stati Uniti presentano un contingente di psicopatici assai superiore a quello d eg li altri paesi; si tratterebbe quindi di fatti psiconeurotici non prodotti dalla guerra, ma avvenuti in « occasione >> di questa . Logico è quind1 pensare che la guerra sia stata rivelatrice, non produttrice dell'aumento di psicopatia e neurosi negli Stati uniti nell 'ultima gue rra.
Così, riguardo ai ragazzi evacuati in Inghilterra, occorrerebbe indagar e più a fondo, vedere se i ragazzi evacuati erano senza mamma, senza famiglia, con abitudini differenti dalle acquisite, con persone antipatiche, ecc. nei posti dove furono portati.
Si cade con ciò nella complessità delle cause dei fatti psicopatici, che spesso possono avere più soluzioni, o per lo meno più interpretazioni patogenetiche dal punto di vista delle cause psichiche.
Questo vale anche per le spiegazioni del fatto già detto, c he la seconda gue rra mondiale ha prodotto ancor meno psicosi e psiconevrosi della prima conflagrazione.
Il Kalinowski, a spiegazione di c1Ò, difende la tesi che nell'ultima guerra vi è stato meno individualismo e più collettivismo psico-
54
logico; ciò sarebbe di aiuto nel sopportare paur e , traumi p sichici, emozioni violente, ecc.
Senza fare appello a concezioni di psicopatologia dì folla o generale, è certo che il male in compagnia si sopporta meglio (il proverbio dice: mal comune è mezzo gaudio), ma è anche più certo che l'uomo soffre dì più e come tale ha più danno psicologico di front e all'ingiustizia che lo colpisca personalmente (e che sotto sotto genera l'invidia, così logorativa per la psiche) che non Ò1 fronte a un danno eventuale, diffuso però, quasi eguale, << per tutti >> di cui non può accusare il suo triste destino, ma il fato del mondo , le disgrazie dell'umanità.
Ecco pcrchè sì avevano più nevrosi e psicosi nell'altra guerra, dove l'esercito combattente sopportava tutto il peso e i danni, mentre le popolazioni, il paese non ne avevano quasi.
Di qui l'invidia logorativa dei soldati in trincea, nel pensare agli « imboscati )) ' ai rimasti tranquillamente a casa. Di qui le nevrosi e le psiconevrosi, perchè è nolo in psichiatria essere l ' ingiustizia, sop ratt utto co lpente l a propria persona, uno degli elementi più dannosi per lo sviluppo di fatti neuropsichici patologici e soprattutto per il loro aggravamento. Su questo punto ha insistito recentemente il Baruk, il creatore della psichiatria « morale »
Invece nella seconda guerra mondiale lo stare « a casa >> spesso volt:va dire, sia per i bombardéiiLle nti aerei, sia per le invasioni ecc., essere in zona più pericolosa del fronte, il quale sovente era vago e mobil e . Nell'ultima guerra quasi non apparve la figura dell' « imboscato >> e i so ldati non avevano l'invidia per coloro che rimanevano in « pac::se >1 , ma lél paura per i propri familiari in pericolo.
Potrei dilungarmi su ma il lettore può facilmente intuire quanti elementi dì differenza vi fossero tra la seconda e la prima guerra mondiale nella posizio n e psicologica dei so ld ati e dei civili.
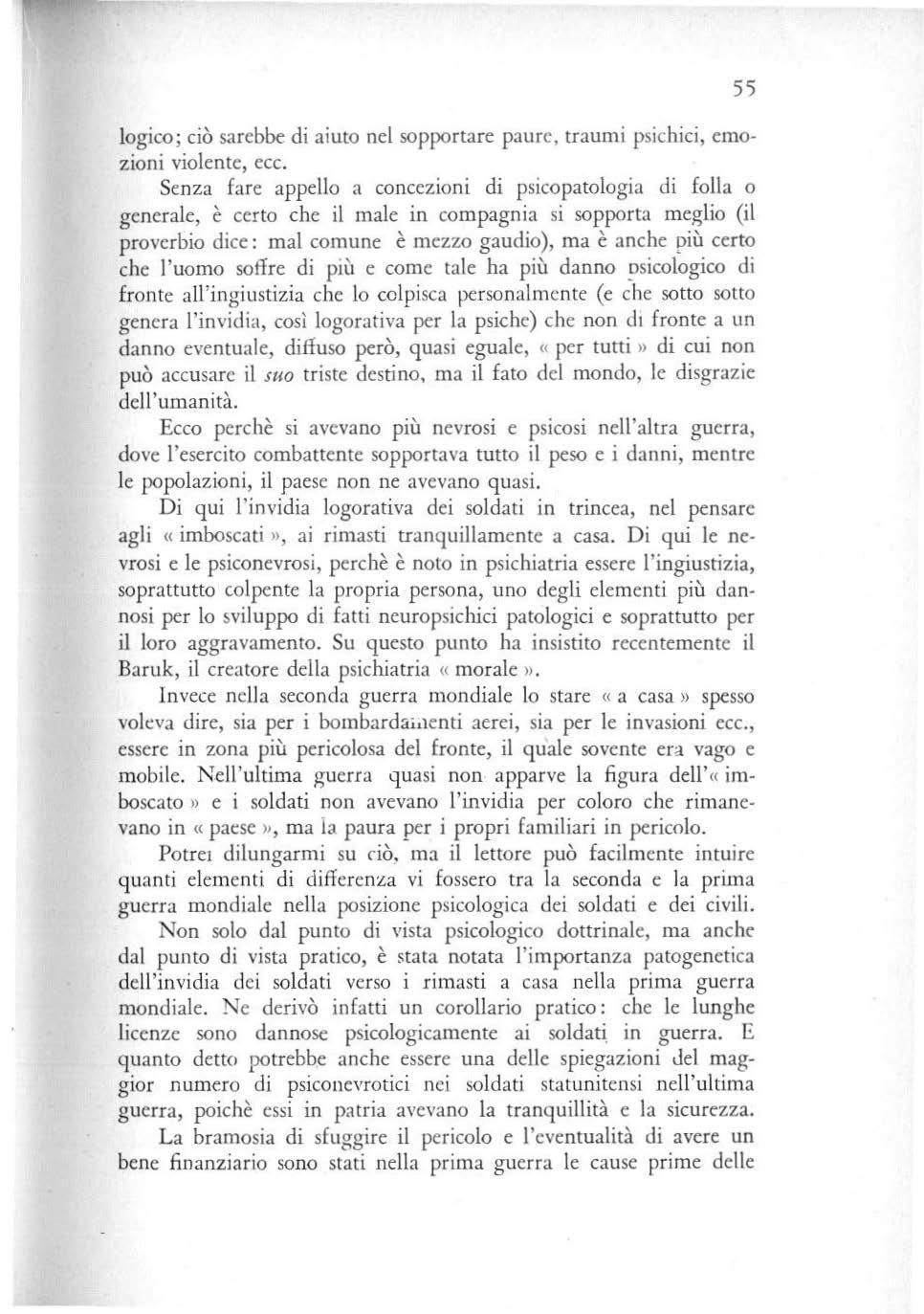
Non solo dal punto di vista psicologico dottrinal e, ma anche dal punto di vista pratico, è stata notata l'importanza patogenetica dell 'inv idja dci so ldati verso i rimasti a casa nella prima guerra mondiale. N e derivò infatti un corollario pratico: che le lunghe li cenze sono dannose psicologicamente ai in guerra. E quanto detto potrebbe anche essere una delle spiegazioni Jel maggior numero di psiconevrotici nei soldati statuni t ensi nell'ultima guerra, poichè essi in patria avevano la tranquillità e la sicurezza.
La bramosia di sfuggire il pe ricolo e l'eventualità di avere un bene finanziario so no stati nella prima guerra le cause prime delle
5'5
psiconevrosi. E' questo il concetto che fu sostenuto specialmente dagli psichiatri tedescht.
Essi sostennero che gli eventi bellici di per sè non producono nevrosi, ma queste sono causate dall'habitus psicologico di evadere dai danni e di avere « una pensione ll Da ciò si ricavò il Jato, attuato, di non risarcire allora in Germania e di non pensionare i soldati nevrosici in occasione della guerra; il risultato pratico fu affermativo, cioè si ebbe netta diminuzione delle nevrosi nei soldati tedeschi.
Del resto l'esperienza che un desiderio di indennizzo aggravi e a volte produca fatti nevrosici è nota anche nella pratica infortunistica civile. Ciò ha dato adito a controversie dottrinali di interpretazioni; ma il fatto sussiste, come sussiste il fatto che nelle forme nevrosiche da infortunio « l'indennizzo » migliora e spesso guarisce l'ammalato.

Tutti quesn dati fanno pwsare a una wmponcnte isterica nel gruppo delle psiconevrosi anche d'altra natura.
Con questo si abborda il grande problema dell'isterismo e tutti gli Autori sono d'accordo nel vedere una grande diminuzione dell'isterismo d i guerra nella seconda conflagrazione mondiale.
Cos1, per esempio, non si sono avute quasi le grandi sindromi spettacolari (isteriche per vari Autori) da « éclat d'o bus » frequenti invece nell'altra guerra; eppure gli << obus » erano ben cresciuti di calibro!
Ciò potrebbe tuttavia essere un aspetto della diminuzione ID genere dell'isterismo, anche in tempo di pace, che si è verificata in questi ultimi trent'anni in tutti i paesi « civilizzati » Questo fatto, come si sa, ha molte cause, ma soprattutto quella che nella vnta « moderna » l'isterismo è trattato con indifferenza se non con disprezzo. Basta spesso ciò per guarire un isterico, e per impedire una manifestazione isterica, poichè se ii pubblico è indifferente o sprezzante l'isterismo ... muore nel nascere.
E' merito dei medici pratici (da noi in specie i medici condotti)
I' aver trattato, in questo mezzo secolo, con una certa durezza (così curativa per l'isterico) l'isterico e l'isterica alle prime manifestazioni, impedendo così lo svilupparsi della malattia. Qual differenza coi secoli passati e soprattutto con la metà del secolo scorso, in cui l'isterico era addirittura coltivato e di questa « coltivazione » fu accusata soprattutto la Scuola eli Charcot.
Oggi sappiamo che l'isterico ha bisogno di spettatori per lo meno indulgenti; se trova il vuoto o il disprezzo guarisce. Quanto
detto è certo una delle cause della diminuzione dell'isterismo nell'uomo moderno e civilizzato. Questo si riferisce anche ai soldati, ed a riprova vi è il fatto sotto lin eato dal Parin che nella seconda guerra mondiale gli unici che abbiano presentato un certo numero di fatti isterici sono stati i partigiani jugoslavi, e la causa di ciò sarebbe, per il Kalinowsky, la « primitività » di questi uomini. Ne l campo dell'isterismo un'altra cosa ha convalidato la seconda guerra mondiale: la scarsa i mportanza dell'emozione nella genesi delle manifestazioni isteriche, contrariamente a quanto si credeva nel passato. Questo fatto l'ho già rilevato nella mia relazione al Congresso di Psichiatria di Roma nel 1946 dove scrivevo: « Molto sarebbe da discutere il problema emozionale dell'isterismo Per esempio nella recente guerra i cataclismatici bombardamenti aerei delle città non hanno neanche procurato del le semplici convulsioni isteriche ... e le emozioni non sono mancate! » .
Tutti noi siamo stati testimoni di ciò, c anche nelle città d'Italia meridionale, reputata più emozionabile, non abbiamo visto convulsioni isteriche ecc. neanche in soggetti femminili; al massimo si udivano lamentele!
Il problema dell'emozione nell'isterismo, come si sa, è discusso assai, però quanto sopra deve far riflettere e ricordare, malgrado la opinione di vari Autori che credono a una genesi emozionale delle manifestazioni isteriche, quanto sosteneva il Babinsky: se alberga veramente nell'animo umano una vera emoziont, non vi è posto per l'isterismo! E l'emozione da bombardamef:lto aereo la ... possiamo riconoscere per vera!
Altro fatto .importante in questo campo è che nella seconda guerra mondiale sono state quasi assenti nei soldati le cosiddette paralisi fisiopatiche (da molti autori considerate di natura isterica) che erano così frequenti nell'altra guerra mondiale. Ciò è stato discusso da Campana alla « Grande Settimana Medica Ungherese >> (Budapest, 4- 12 settemb re 1948).
Era allora piuttosto facile riscontrare so ld ati che dopo una piccola ferita al braccio o alla mano presentavano strane contratture con le dita e la mano fisse in curiose posizioni (cioè non corrispondenti a quelle procurate da irritazione o lesione dei vari nervi della mano) con gonfiore, edema, rossore deile parti molli ecc.
Queste forme furono assai discusse, specialmente Babinski e Froment difesero il concetto dell'organicità della sindrome e l'dencarono nella patologia del sistem a simpatico, a l tri negarono ciò e sostennero la diagnosi d'isterismo (vedi il lavoro di Fragnito sull'argomento).

57
Questi ultimi ebbero, per lo meno praticamente, ragione; difatti pochi giorni dopo l'armistizio del 1918 le molte migliaia di paralisi fì.siopatiche ricoverate nei vari centri neurologici militari (italiani e esteri) guarirono come per incanto in brevissimo tempo, rivelando con questo la loro origine psicogena, cioè dal desiderio del malato di non tornare più «al fronte » .
Questo punto va ben vagliato. Prospettata la causa psicogena, vediamo qua le potrebbe essere il meccanismo per arrivare alla forma di paralisi fisiopatica.
Il Rivers, partendo da concezioni psicoanalitiche, nella prima guerra mondia le osservò che negli ufficiali si avevano più nevrosi, più depressioni psichiche con ansia o, come si dice in psicanalisi, nevrosi d'angoscia e le interpretò come una delle maniere primordiali di difesa: l'agitazione, il movimento. Primordiale, ma superiore all'altra maniera di difendersi, quella dell'animale che ha paura di essere ucciso: la reazione di immobilità. Quest'ultima la riscontrò soprattutto nei soldati (più a basso livello psicologico, in genere, degli ufficia li) che presentavano specialmente paralisi isteriche, forme di stupore, para l isi fisiopatiche (in definitiva anch'esse di marca isterica).
Ma senza entrare in cause di psicologia di profondità o ancestrale, vi potrebbe essere una spiegazione più semplice dei fatti di paralisi fi.siopatica: quell a classica dell'isterismo.
Il soldato che ha visto il suo compagno di fatiche e di paure tornare alla tranquilla casa in famiglia (nella prima guerra mondiale) per una ferit1 grave che gli aveva deformata la mano, quando a sua volta viene colpito a ll a mano da ben piccola ferita, ha più o meno conscio un gran desiderio che ìa sua mano diventi come quella de l compagno e possa perciò condurre anche lui alla tranquillità familiare. Penserà poi « l'isterismo » a fare una grossolana e brutta imitazione della lesione o r ganica alla mano, facendo una << paralisì fi.siopatica » . Questa riproduzione, questa imitazione non è certo ancor oggi conosciuta nel suo meccanismo patogenetico, ma conoscerla vorrebbe dire risolvere il « mis tero>> dell'isterismo, il che ancora non è possibile malgrado i molteplici studi odierni in materia.
Ammesso questo, come spiegarsi che le paralisi fisiopatiche, così frequenti nelle truppe della prima guerra mondiale, sono state rarissime nella seconda?
Io credo che abbia influito, oltr e la diminuzione verifi.catasi in questo ultimo trentennio dell'isterismo in genere, il motivo prima detto e cioè che nel soldato della seconda guerra mondiale non vi era la g ran paura del fronte e l'angoscioso desiderio di tornare a

i sB
casa, ben sovente anch'essa sul fronte aereo o per lo meno essa pure non tranquilla e pericoli. Mancava quindi nella tralila psicologica elencata un :mello della catena - la sicurezza della casa e della famiglia- e quindi il fenomeno non si è avverato.
Penso anc h e che questi motivi: la minor paura del cosiddetto fronte (che tra parentesi nella seconda guerra mondjale era a volte piuttosto vago) e la non esistenza della « sicurezza » a casa, siano anche, in parte, la causa ru un altro fenomeno che si è verifi cato nell'ultima guerra (specie in Italia): la netta diminuzione delle zioni di malattie mentali, specie di quelle « spettaco lari » nei soldati.

Difatti durante la prima guerra mondiale, per esempio a Firenze, non passava, si può dire, settimana, senza che un soldato, un richiamato si spogliasse nudo nel centro della città e fosse quindt portato all'Ospedale psichiatrico. Questo fatto non si è quasi mai verificato nell'ultima guerra c ciò, ossia la diminuzione delle simulazioni di malattie mentali nei soldati, è stato notato in altri paesi europei da molti autori. Ma se pensiamo, riferendoci all'esempio precedente, che !"Ospedale psichiatrico di Firenze è situatv proprio accanto alla linea ferroviaria Firenzc:-Roma, ed a pochi passi da zone più volte bombardate, sì comprende come l 'esser n ricoverato non fosse una . . . buona raccomandazione per sfuggire ai pericoli guerreschi.
L'ultima guerra vide in prima linea le città italiane ed è chiaro che se non vi è un potente desiderio di sottrarsi al pericolo la simul azione non avviene, e non avviene neanche quando il risultato della simulazione servirebbe solo a cambiare pericolo e forse in peggio !
Quanto detto può riferirsi anche agli eserciti europei in genere.
Un'ultima nota: pur avC'ndo meno psicosi e meno neurosi, si è notato che la seconda guerra europea ha presentato un aumento dì forme depressive psichiche per lo meno relativo. Questo specialment e nei paesi europei e in modo più marcato nel dopoguC'rra. In Italia ciò è stato poi evidente.
Qui il fenomeno è, credo, assai più complesso dal punto di vista psicopatogenetico e penso vi abbiano influito molti fattori, di cui fa ccio un incompleto elenco.
Danni ai beni da bombardamenti aerei, lotte politiche e relative paure, lotta partigiana, l'ingiustizia di veder premiato il « doppio giuoco », i lutti famihari e d'amici per bombardamenti aerei e per invasione e altri eventi bellici, la svalutazione della moneta, la miseria, l a fame e la paura di essa, la coercizione morale (specie nei regimi totalitari), la paura del carcere e dei campi di concentramento; nei paesi occupati dai Tedeschi l'imbarazzo Jella scelta di una con-
59
dotta, il passar da traditore o per gli uni o per gli altri, ecc. insomma tutte le « delizie » della passata guerra. In questa l'elemento « logorativo » psicologico di recriminazione, dubbio, ingiustizia, paure è stato ben più in p rimo piano (come lesivo psichico, producendo o agevolando la forma ad esso corrispo ndente, ossia la depressiva), che n on le grandi emozioni della guerra guerreggiata, che non l'emozione- choc dei g r andi bombardamenti aerei a cui dovrebbero (a lume di logica, contraddetta però dalla pra ssi) corri spondere le gra ndi malattie psichiatriche, i grandi isterisrni, le grandi nevrosi.
Questa mia breve nota ha più che altro un valore indicativo, quello di richiamare l'attenzione (e di dare qualche spiegazione s ull e cause psichiche) sui seguenti dati osservati:
I. - La guerra moderna, pur coi suoi cataclismatici bombardamenti aerei, pur con le sue micidiali armi, non ha prodotto un aumento di psicosi gravi, di psiconevrosi ecc.
II. - Nella seconda guerra mondiale si son visti ancor meno casi di p sicosi e neurosi ecc. che nella prima guerr a mondiale.
Ili. - Specialmente l'isterismo (in cui includo anche le paralisi fisiopatiche) è stato minore nella guerra mondiale, anzi quasi asse nte.
TV. - La simulazion e delle malattie mentali n e i soldati è stata minima nella seconda guerra mondiale.
V. - Il danno psichico, procurante forse i soli stati depressivi, della guerra moderna sta più nei suoi aspetti d'ingiustizia personale, di colpa, di logorio, di indecisione, che non nei fatti emozionali acuti da esplo sioni, bombardamenti aerei ecc di carattere impersonale.
VI.- Una spiegazion(. del num ero inferiore, nella seconda guerra mondiale rispetto alla prima, di fatti i sterici gravi, di paralisi fi siopatiche, di sin1ula zioni delle malatti e mentali ecc., sta forse nel fatto che nell'ultima gu erra il danno era diffuso a tutta la popolazione c non vi era perciò nei soldati (come nella prima guerra mondiale) l'invidia, la r abbia, la bramosia verso la « tranqui ll a popolazione l> rimasta « a casa » .

6o
BIBLIOGRAFIA
Per la psicopatologia Jdb guerra 1914-18 vedi specialmente i seguenti lavori (c relativa bibliografia): BALDI F.: Le nevrosi trat-tmatiche dz guerra, cd. Giannini, Napoli, 1922; RoniET et FRtBOURG- BLANC: La folie et la guerre de 1914 - 18, ed. Alcan, Paris, 1930.
Per la psicopatologia della guerra mondiale c per gli argomcmi trattati nel presente studio vedi soprattutto (o ltre i rapporti di Sargant, Slater, Bally, Padovani. ccc. al I Congresso internazionale di psichiatria di Parigi, 1950):
BALLY G.: Zur Anthropologic d es Kn'cgszeit in « Schweizer. Archi\ fi.ir N euro!. u. Psych. )), 61, 22, 1948.
BAR UR I I.: Psychiatrie morale cxpbùncntale zndivtdue//c et sociale, Presse Universiraircs de France, 1945.
CMWONA F.: Sintomi p;·ichici nella patologia delle formazioni della base encefalica. (Relazione al XXII Congresso della Società italiana di psichiatria, Roma, ottobre 1946).
Ev H. et CORNAVI:-l F.: Les événements de guerre et l'activité d'un service de psychiatrie in « Schwcizer. Archiv fi.ir Neurol. u. Psych. )), 61, 405, 1948.
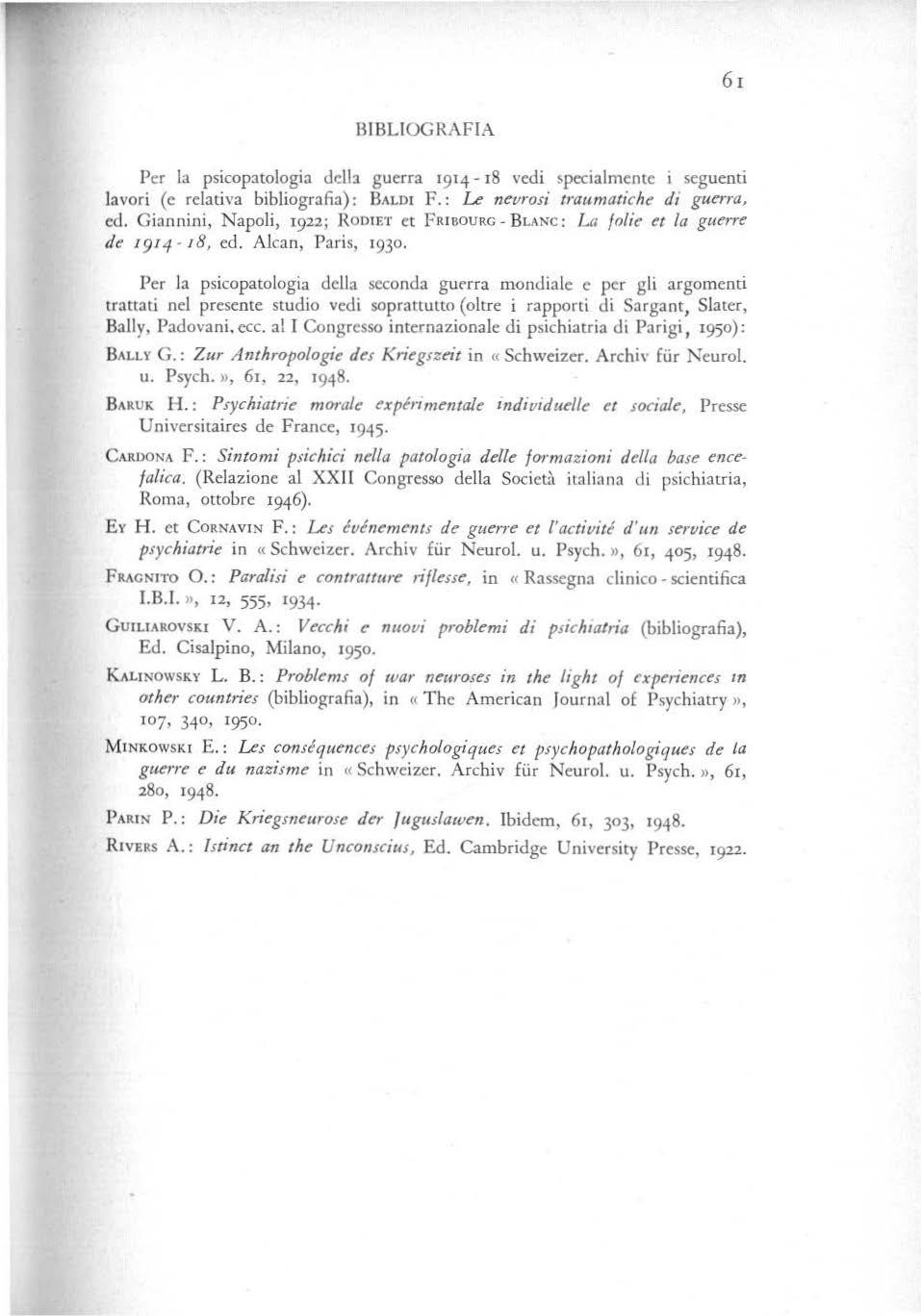
FRACNITO O.: Paralisi e contratture riflesse, in « Rassegna clinico- scientifica f.B.I. 1 ' • 12, 555· 1934·
GurLIAROVSRI V. A.: Vecchi e nuovi problemi di psichzatria (bib liografia), Ed. Cisalpino, Milano, 1950.
K.ALINOWSKY L. B.: Problems of rvar neuroses in the light of cxpen'ences m other countries (bibliografia), in cc The American Journal of Psychiarry H, 107, 340, I9SO.
MrNKOWSKr E.: Les conséquences psychologiques et psychopathologiques de la e du nazisme in cc Schweizcr. Archiv fur Neurol. u. Psych. », 61, 280, 1948.
PARIN P.: Die Kriegsncurose der Ibi dem, 61, 303, r948.
Rl vERS A.: lstinct an the Uncorucius, Ed. Cambridge University Presse, 1922.
6r
CONSIDERAZ I ON I SULLE UL CE RI DELLA GAMBA
OSSERVAB ILI NE I TROPICI E SUBT ROPICI
DESCRI Z IO NE DI DUE ULCER.I POCO CONOSCIUTE:
ULCUS TR.OP I CALOIDES E MACR.OULCUS PER.STANS
11 soggetto delle '' ulceri della gamba >', cioè ulceri che hanno come sede di predilezione la gamba, è di grande importanza pratica specialmente nei Tropici e nei Subtropici, ma sino a tempi recentissimi regnò sull ' argomento grande confusione, dovuta principalmente al fatto che gli autori indicavano collo stesso termine lesioni di origine etiologica differentissima. Ad esempio sino a pochi anni or sono il termine « velcl so re » o « ulcera del deserto » era usato per denotare ulceri di origine molto diversa, mentre adesso dagli autori moderni viene ristretto ad ulceri di origine difterica (vedasi l'ultima edizione, 1950, di Tropical Diseases) di Manson-Bahr, pag. 686).
In yuesto lavoro mi propongo di trattare le comuni ulcere della gamba specialmente quelle osservabili nei Tropici e nei Subtropici e, per inciso, voglio precisare che adopero l'espressione « ulc era >> nell'usuale significato clinico di una abbastanza grande perdita di sostanza non inferiore ad un cm di diametro quando comple tamente sviluppa t a ed in generale molto più estesa.
Le comuni ulcere della gamba sono le seguenti:
1 ° - Ulcus tropicum (ulcera tropicale, vera ulcera tropicale) ;
2 ° - Ulcus veldis (ulcera di Veld, ulcera difterica del deserto);
3" - Ulcus pyogenicum vel septicum (ulcera settica causata da cocchi piogeni , ulcera settica del deserto);
4o - Ulcus tropicaloides (ulcera tropicaloide, ulcera micetoide del deserto);
5o - lvfacroulcus perstans;
6° - Ulcus varicosum (ulcera varicosa);
7o - Ulcus lu eticum (ulcera sifilitica terziaria)
In questo lavoro non mi occuperò delle ultime due esse ndo ulceri cosmopoli te conosciutissime .
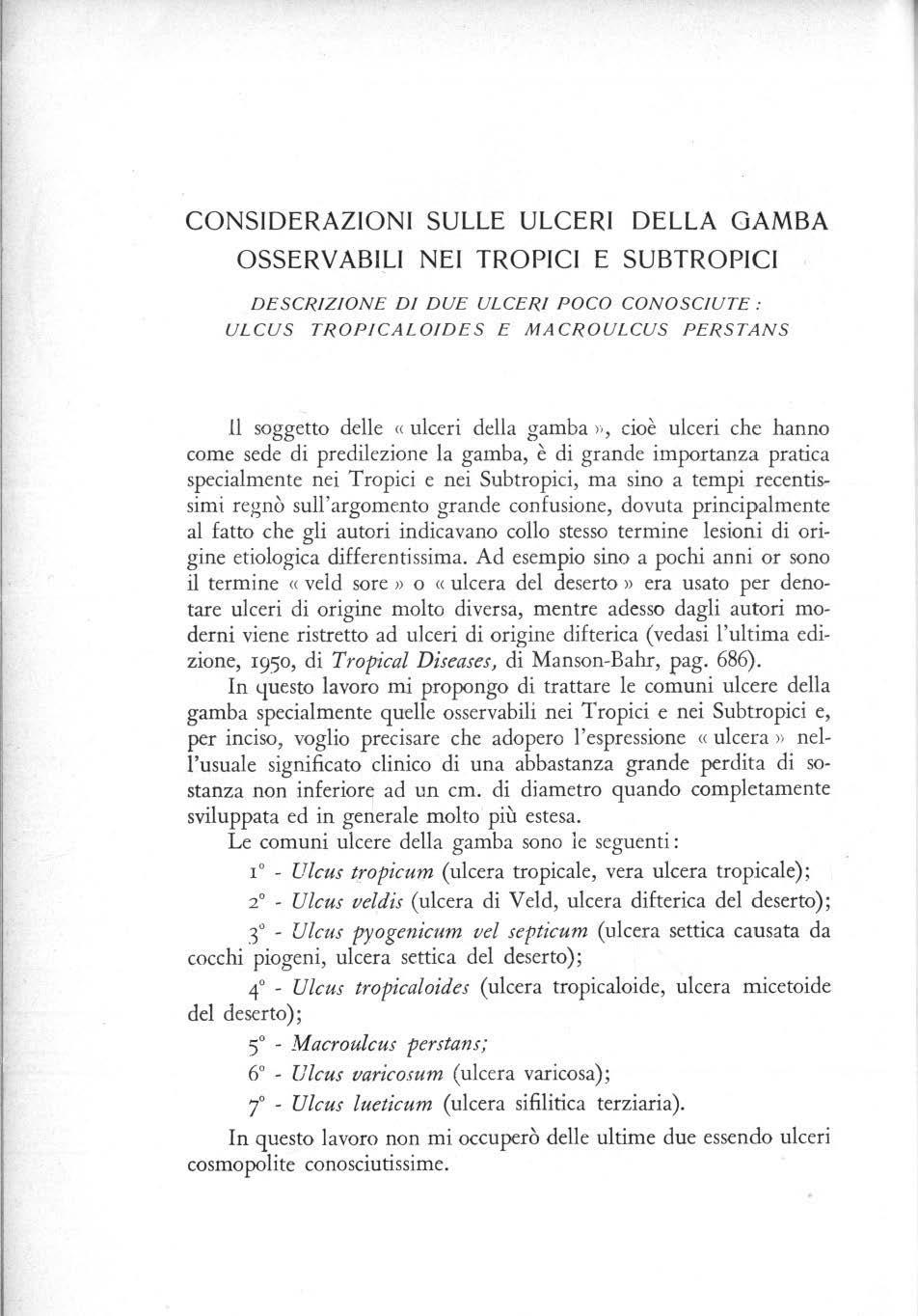
ULCUS TROPICUM (U L CERA TROPICALE).
Quest'ulcera è conosciuta con molti nomi: ulcera dello Yernen, ul cera di Aden, ulcera di Annarn, ulcera di Cochim, ulcera di Naga, ulcera di Yangli (T aida), ulcera del Mozambic o, Sarnes (Congo), ulcera d el Cooly, ecc.
Essa è comune in tutte le regioni tropicali del mondo e la sua frequenza diminuisce gradualmente a mano a mano che ci si avvicina alle regioni temperate. Per esempio, è comunissima nell'Africa Equatoriale e Tropicale, mentre nell'Africa del Nord, specialmente Libia e Cirenaica, è rarissima, i medici generici locali ado-
perino spesso questo termine per denotare ulceri superficiali del tutto dive rse, quaJi l 'ulcera tropicaloide.
E' rarissima in Europa, ma io ne ho visti alcuni casi nell'Italia meridionale e nei Balcani. E' ritenuta generalmente di origine spi rochctica, alcuni AA. la considerano dovuta alla spirocheta descritta da Prowazeck, S. Schaudinni (Prowazeck, 1907), altri all'associazio ne di que st a spirocheta o di sp irochete similari col Bacillus fusiformis (Fusiformis fusiformis), la così detta sirobiosi spirochetico-(usiforme di Vincent. Pochi credono che il B. fusiformis siJ. il vero agente etiologico. Fu, inoltre, avanzata l'ipotesi che l'ulcera non fosse di origine parassitaria, ma avitaminosa.
Non v'è bisogno di dare una de ttagl iata descrizione dell'ulcus tropicum poichè la si può trovare in tutti i testi di medicina tropicale.
 Fig. r. - Ulcus Lropicum.
Fig. r. - Ulcus Lropicum.
I principali aspetti clinici sono i seguenti: è generalmente localizzata nei due terzi inferiori della gamba, ed è singola nella maggio-
ranza dei casi; inizia rapidamente con una papula, o papulo-pustola rosso-viva, dolorosa (a volte pruriginosa), circondata da una :ueola ro ssa infiltrata, che si rompe in un periodo da 2 a 4 giorni, e si forma un'ulcera, per un processo di necrobiosi, che rapidamente si estende in profondità e superficie. Dopo un certo tempo il processo ulcerativo cessa di estendersi nella maggioranza dei casi, limitand osi spo nt a neamente l'ulcera. I n altri casi sopravviene un processo fagedenico, con grande distruzione della pelle, dei muscoli, dei tendini. L'ulcera è ripicameNe rotondeggiante od ovalare e i margini che generalmente sono continui e senza dentellature sono pochissimo ispessiti, sopraelcvati ed induriti, salvo che nei casi inveterati; non sono mai sottomi nati ; possono essere tagliati nettamente ma non perpendicolarmente come è nelle tùceri luetiche. Il fondo è non raramente alquanto concavo . La cicatrizzazione è lentissima e solo raramente avviene prima di un anno o due. Spesso si forma una esile cica trice che si può rompere al più piccolo trauma e l'ulcera può formarsi di nuovo. Nelle zone in cui la framboesia è comune, come Ceylon, non raramente l'ulcera si infetta con le spirochete della framboesia, abitualmente per mezzo delle mosch e, e l'ulcera
diverrà papi!lomatosa e mostrerà i caratteri di un frarnboesoma, che sarà poi seguito da una generalizzazione della eruzione framboesica.
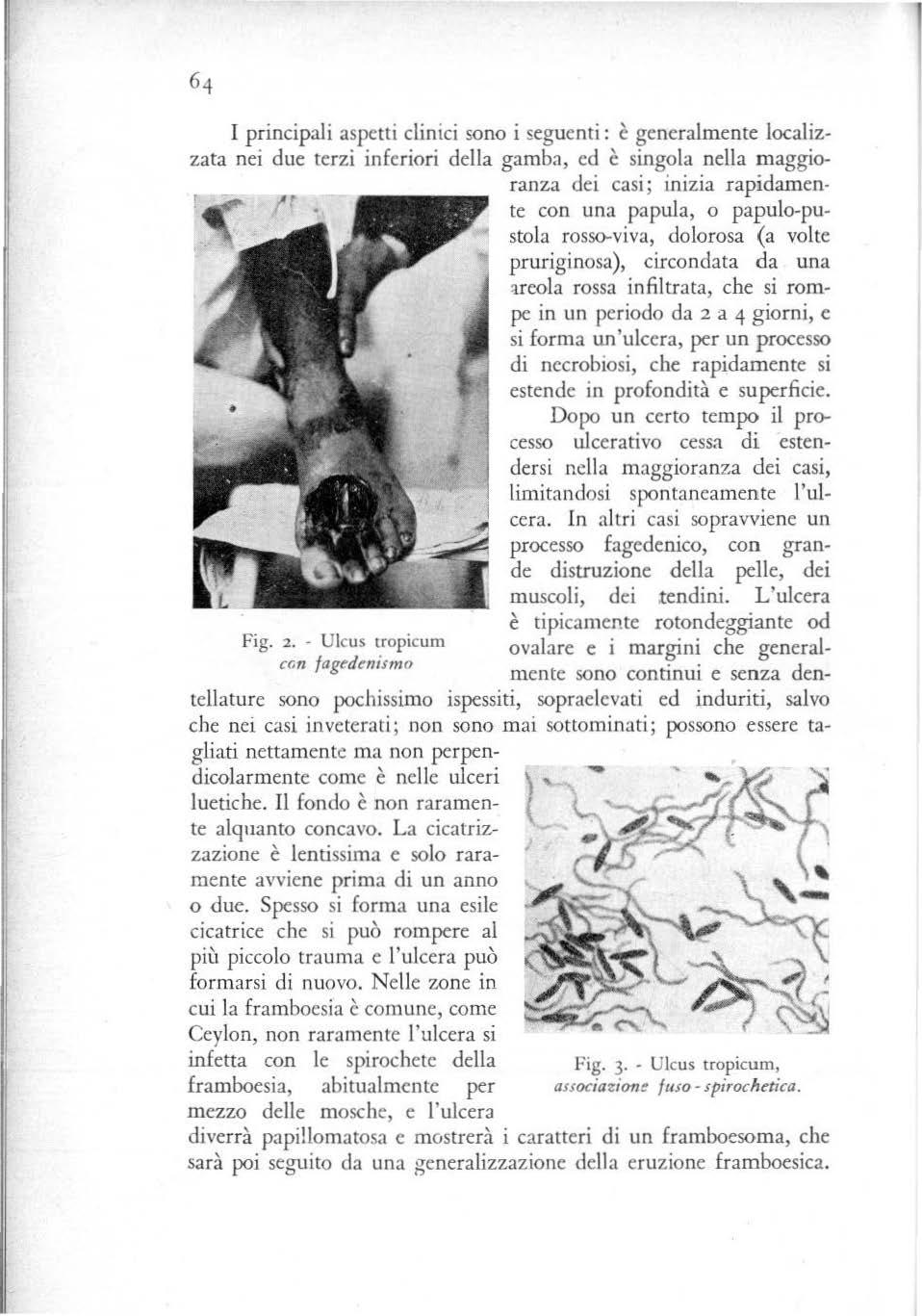 Fig. 2. - Ulcus tropicum ccn fagt'dt:nisma
Fig. 3· · Ulcus tropicum, fuso- spiroch etica.
Fig. 2. - Ulcus tropicum ccn fagt'dt:nisma
Fig. 3· · Ulcus tropicum, fuso- spiroch etica.
La terapia è inefficace, nonostante le molte affe rmazi on i che sono st ate fatte di aver trovato una terapia specifica . Per lo più l 'antico tratt amento, consistente i n ripo so, bagni lo ca li con una soluz io n e all'I : 2000 di permanganato di potassio, e, quando l 'ulcefa si è detersa, nell'app li cazione di po m ata di protargolo al 5 %, dà i risultati mig l iori. E' stata suggerita la penicillina, ma non ha dato risultati rimarchevoli. Io b o trova to u tile la seg u ente lozione di iodoformio e carbone : iodoformio g . 5; carbone vegeta le g . 5; tintur a benzoino g . 2,5; ete r e etil ico cc. 200
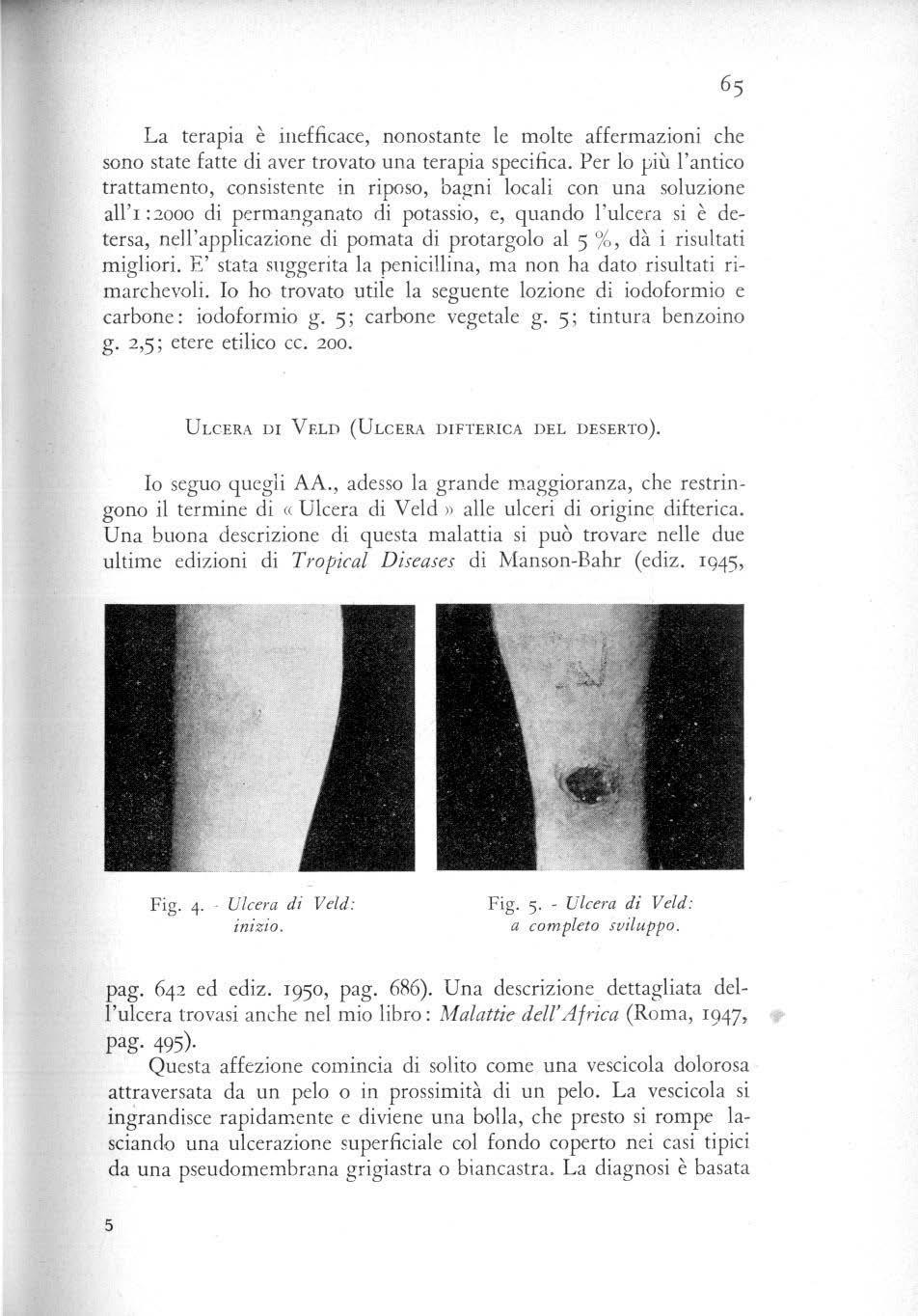
ULCERA DI VF.LD (ULCERA D I FTER l CA DEL DESERTO).
Io sei:,rtiO qu egli AA., adesso la grande maggioranza, che restringono i l termine di « Ulcera di Veld >l alle u lce ri di origi n e difterica. Una buona descrizione di questa malattia si può trovare nelle due ult ime edi z io ni di Tropical Diseases di Manson-Bahr (ediz . 1945,
pag. 642 ed ediz . r 950, pag. 6R6). Una descrizione dettagliata dell'ulc era travasi anc h e ne l mi o l ibro : Malattie dell'Africa ( Roma, 1947, pag. 495).
Qu esta affezione comincia di solito come una vescicola dolorosa attraver sa ta da un pelo o in prossi mità di un pelo . L a vescico la si ingrandi sce rapidam ente e diviene una bolla, c h e presto si rompe lasciando una ulcerazione super ficiale co l fondo coperto n ei casi tipici da una pseudomembrana grigiastra o biancastra. La diagnosi è basata
Fig. 4· Ulcera di Ve/d: t!II ZIO.
Fig 5· - Ulcera di Veld: a completo sviluppo.
5
sul reperto batteriologico. In alcuni casi la si può sospettare clinicamente, poichè il paziente può presentare segni di paralisi c paresi (del velopentlolo, ad esempio), sintomi cardiaci (aritmie), benchè la difterite delle fauci in casi di ulcera sia rarissima. Non vi è praticamente tendenza alla guarigione spontanea. Il trattamento migliore è col siero antidifterico per iniezione o per applicazione locale.
ULCERA SETTiCA (ULCERA PlOGENICA, ULCERA SETTICA DEL DESERTO, ULCERA DEL DESERTO DA PIOGENJ).
Quest'ulcera è dovuta a streptococchi e stafilococchi. Nella mia esperienza raramente bo visto vere lesioni ulcerative prodotte da soli stafil ococchi (ulcera settica stafilococcica) . Più frequentemente lo fanno
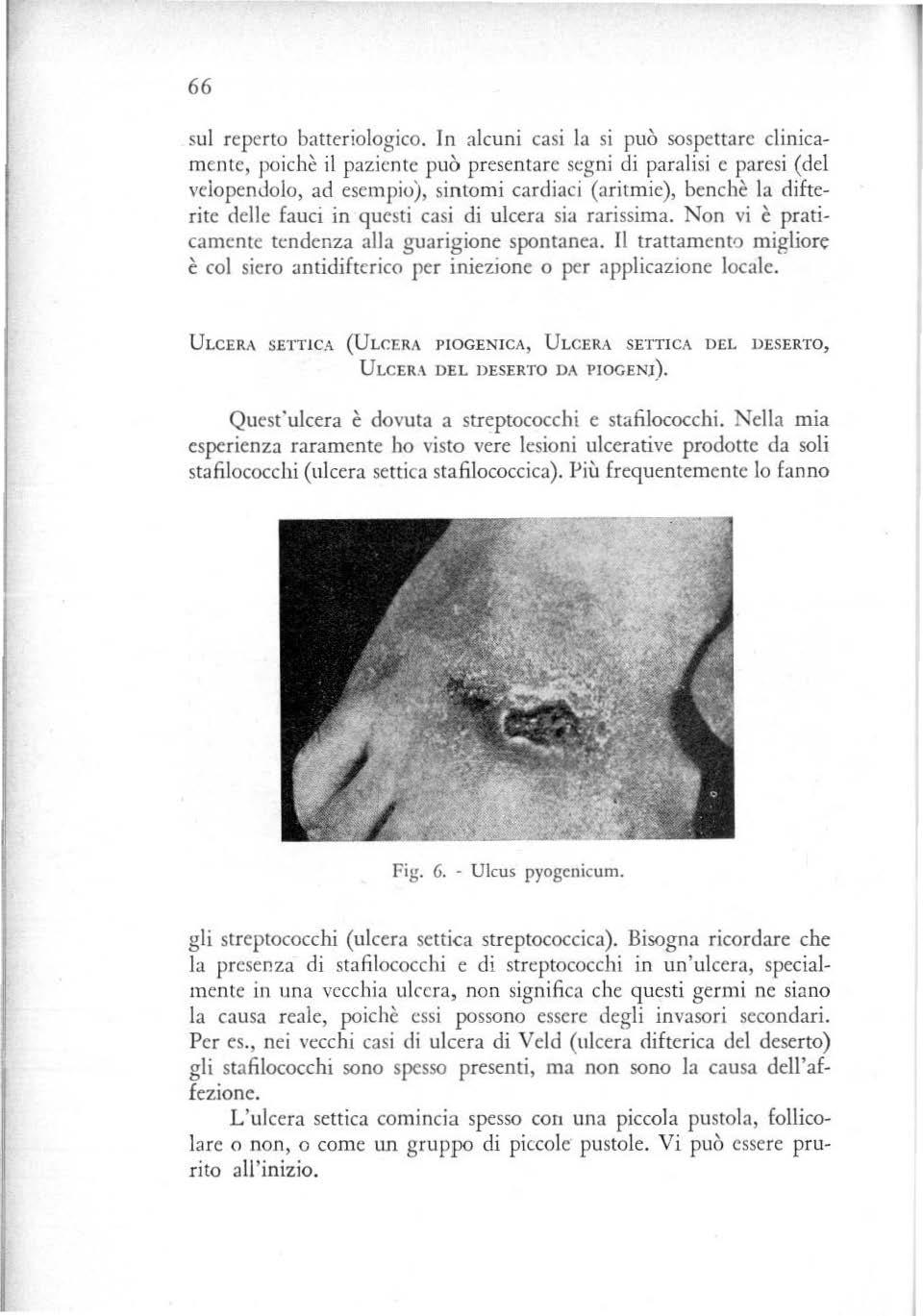
gli streptococchi (ulcera settica streptococcica) . Bisogna ricordare che b presenza di stafilococchi e di streptococchi in un'ulcera, specialmente in un a vecchia ulcera, non signifi ca che questi germi ne siano la causa reale, poichè essi possono essere degli invasori secondari. Per es., nei vecchi casi di ulcera di Veld (ulcera difterica del deserto) gli stafilococchi sono spesso presenti, ma non sono la causa dell'aff ezione .
L'ulcera settica comincia spesso con una piccola pustola, follicolare o non, o come un gruppo di piccole pustole. Vi può essere prurito a ll 'inizio.
66
Fig. 6. - Ulcus pyogcnicum.
Una o, occasionalmente, più ulceri settiche possono sv ilupparsi su una gam ba dopo un attacco di eri sip ela dell'arto. L ' ulc era se t tica non ha in genere nulla di cara tt er istico, è per lo più piuttosto superficial e, rotond egg iante od ovale, e può rassomigl iare molto da vicino all'ulcera di Velù (ulcera dift eric a del des er to). Può essere a contor;1o irregol are.
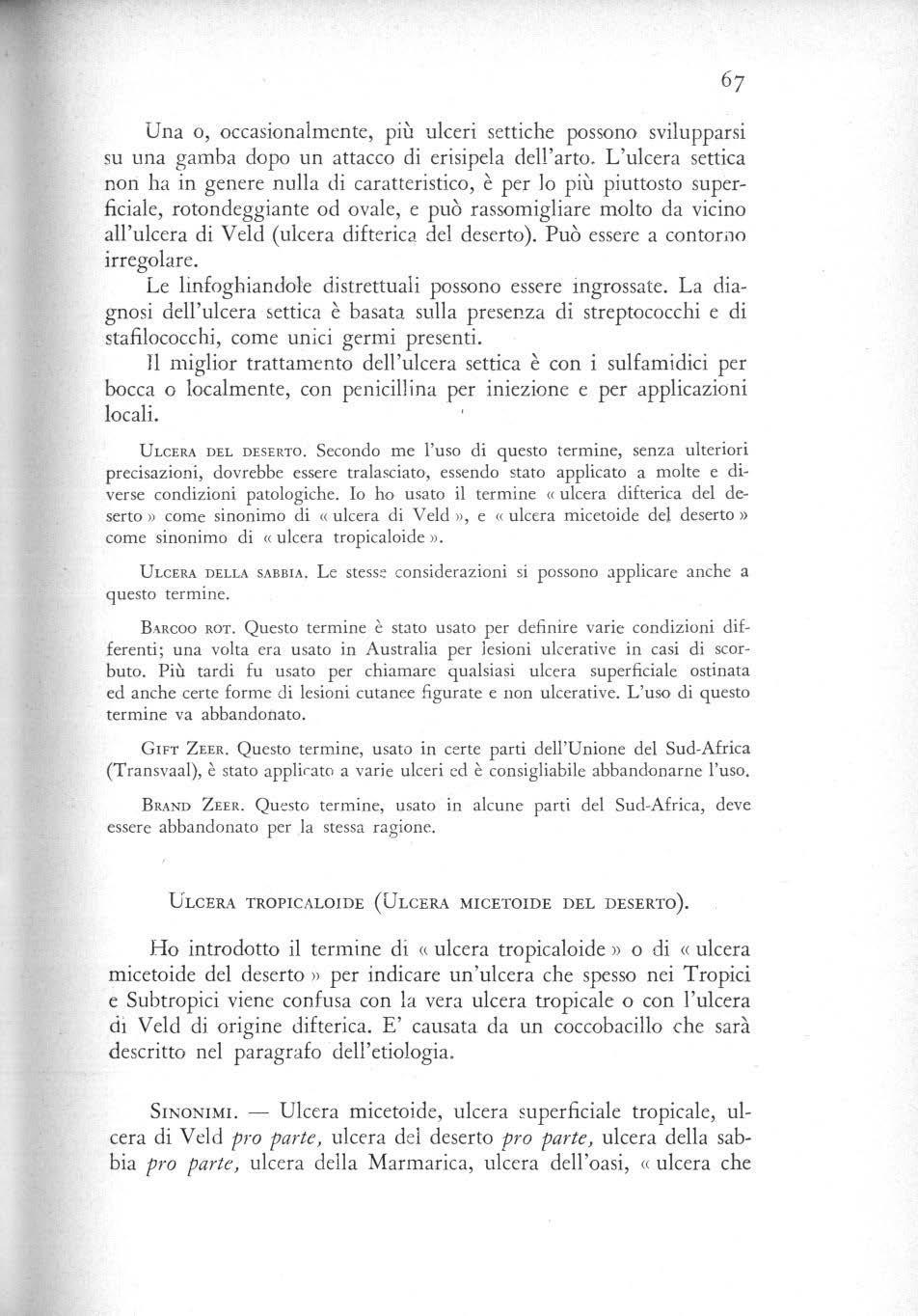
Le linfoghiandole distrettuali possono essere ingrossate . La diagnosi dell'ulcera se ttica è basata sulla presenza di streptococchi e di stafilococ c hi, come unici germi presenti
n miglio r trattam en to dell ' ulc era settica è con i sulf amidici per bocca o localmente, con penicillina per i niez io n e e per applicazioni locali.
ULCERA DEL DESERTO . Secondo mc l'uso di questo te r mine, senza u lteriori precisazioni, dovrebbe essere t ra lasciato, esse nd o st a t o appl icato a mo lte c diverse condiz ioni paro logiche. Io ho usato il termine « ulcera difterica del deserto l) come sinonimo di « ulc era di Ve ld )) ' e <! u lcera micetoide del deserto l) come sinon i mo di !< ulcera trop icaloide >>
ULCERA DELLA SABB I A. Le stess:: cons iderazioni si possono lpplica re :tnche a questo termine.
ROT. Questo termin e è stato usa to per definire va ri e cond iz ioni differenti; una vo l ta era u sa to in Au st ral ia per les ioni ukerati ve in casi di scorbuto. Più tard i f u usato per qualsiasi ulcera superficiale os tinata ed anche certe forme di lesioni cutanee figurate e non ulcera rive. L'uso di questo t e rmin e va abbandonato
G tFT ZEER. Que sto termine, usato in certe parti dell'Un ione del Sud-Africa (Tra nsvaa l), è sta t o ap pl irato a va ri e ulceri c d è cons igl iabi le abbandonarne l' uso
BRANO ZEER. ter min e, usato i n alcune parti del Sud-A fr ica, deve essere abbandonato per la stessa ragione
ULCERA TROPI CALOIDE ( ULCERA MI CETOIDE DEL D ESERTO).
Ho introdotto il termine di « ulcera tropica loide >> o di « ulc era micetoide del deserto » per indicare un ' ulcera che spesso nei Tropici e Subtropici viene confusa con la vera ulcera tropical e o con l ' ulcera cii Vel d di origine difterica. E ' causata da un cocco bacillo che sarà de sc ritto n el paragrafo dell'etiologia.
SINONIMI. - U lc era micetoide, ulcera superficiale tropicale, ulcera di Veld pro parte, ulc era d el deserto pro parte, ulcera della sabbia p1-o parte, ulc er a della Marmarica, ulcera dell'oasi, « ulcera che
dura n , ulcera dt Castellani (Servi no e Tari zzo), dermatite ulcerosa di Castellani (Servino e T:mzzo), ecc .
STORTA r.
GEOGRAFICA. - 1\cl periodo 1940- 1942 accorsero in Libia e Cirenaica numerosi casi di ulceri contagiose, che divennero localmente note con i nomi più sopra citati.

Feci ricerche su quest'ulcera durante gh anni 1941 -1942 e venni alla conclusione che era dovuta ad un cocco o coccobacillo Gramnegativo costantemente presente nelle lesioni non aperte. Pu bblicai una breve nota sull'etiologia di questa condizione morbosa sugli <' Annali d'Igiene » (r942, XII, 349) chiamando il microrganismo Micrococcus mycetoidcs (Coccobacillus mycetoides). H o dato una descrizione dettagliata del microrga nismo e dell'ulcera che ne è causa nel (< Journ:tl o( T ropical Medic in e and Hygiene >> , dicembre rq43.
L'ulcera è comune in molte parti dell'Africa. Ri cordo di aver visto ulceri simili molti anni fa in Uganda, nella Colonia del Kenia, in Somalia ed in Etiopia, non infrequentemcnre associate nello stesso paziente con la vera ulcera tropicale (ulcus !ropicum), cd in Ceylon, in India ed in Estremo Oriente, ed, in tempi più recenti, nell'America centrale, ma sebbene io ritenessi che fossero diverse dall'ulcus tropicum, non potei intraprendere ricerche specia li su questo argomento . Dai medici locali erano generalmente considerate come forme superficiali di ulcera tropicale. Non ho alcun dubbio che le ultcnori ric erche dimostreranno che questa condizione morbosa è cosmopolita. Può senza dubbio occorrere nelle zone temperate, poichè negli ultimi 5 anni diversi casi tipici sono stati descritti da mc, da Servino, da Tarizzo, ecc ., in Italia (Abruzzi e regione Pontina), in Spagna e Portogallo.
PATOGE NESI ED ISTOLOGIA PATOLOGlC \. - La lesione primitiva è, nel la maggioranza dei casi, una vescicola intraclcrm 1ca . Questa si allarga in una grossa vcscicola od in una bolla che dopo tre o quattro giorni si e si forma un'ulcera superficiale per un processo di necrobiosi, che di r ado si approfonda. La perdita di sostanza nel corion è di solito circondata da una zona di infiltrazione che consiste in polimorfonucleati, linfociti, plasmacellule e cellule fusiformi. Le sezioni 1stologiche sui margm1 dimostrano spesso una acantosi.
68
B.nTERTOLOGIA. - Esame dei preparati strisciati con la .recrezione dell'ulcera. Se i preparati sono fatti con co.ntenuto della vescicola iniziale, si vedono dei piccoli organismi coccoidi o coccobacillari, Gramnegativi. A vo l te essi sono riuniti in coppie .
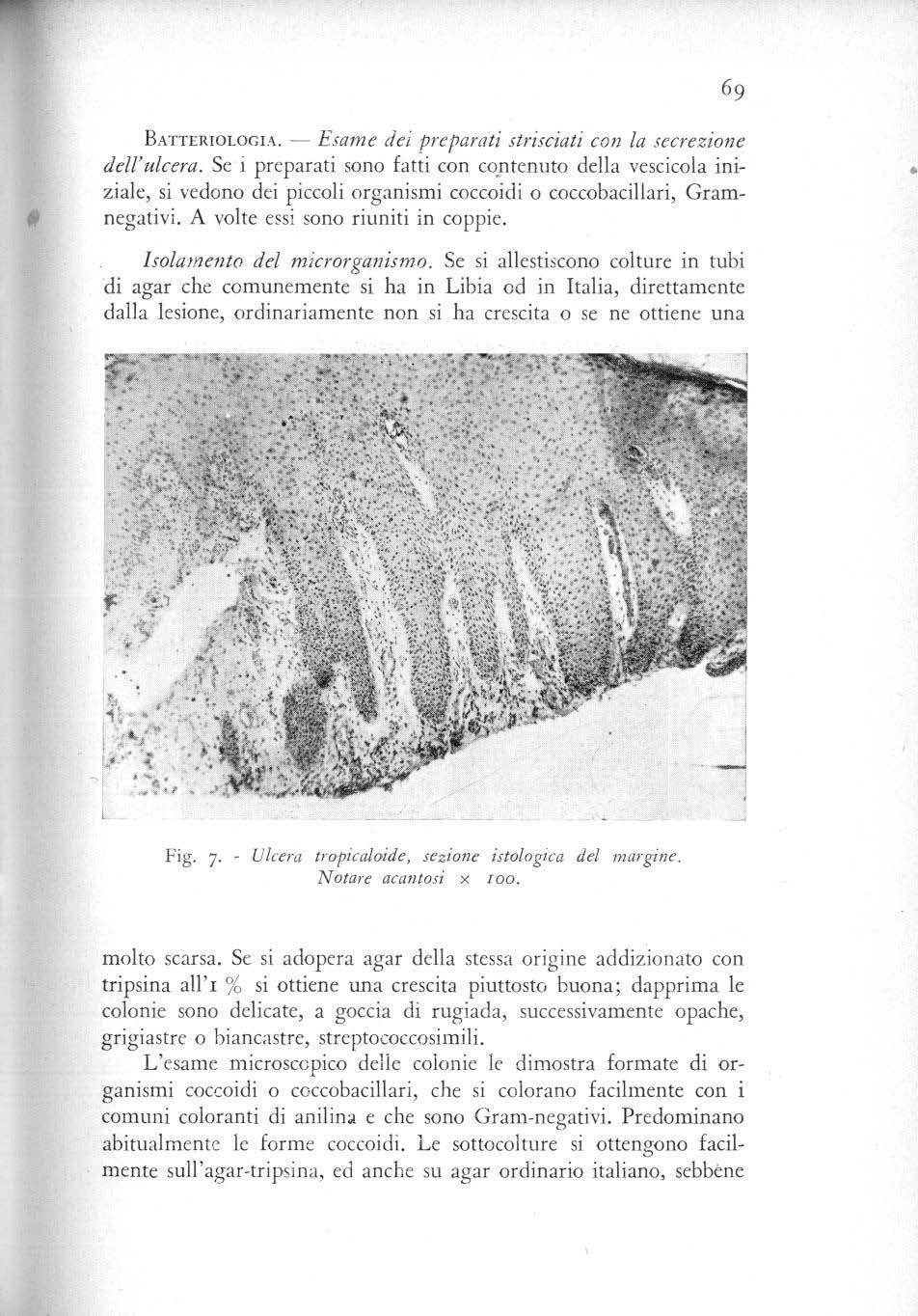
lsolan1enta del microrganismo. Se si allestiscono colture in tubi di agar che comunemente si ha in Libia od in Italia, direttamente dalla lesione, ordinariamente non si ha crescita o se ne ottiene una
Jmolto scarsa. Se si adopera agar della stessa origine addizionato con tripsina all'I % si ottiene una crescita piuttosto buona; dapprima le colonie sono deli ca te, a goccia dì rugiada, successivamente opache, grigiastre o biancastre, streptococcosimili .
L'esame microscopico delie colonie le dimostra formate di organismi coccoidi o coccobacillari, che si colorano facilmente con i comuni coloranti di ani l ina e che sono Gram-negativi . Predominano abitualment e le forme coccoidì. Le sottocolture si ottengono facilmente sull 'agar-tr ipsina, ed anche su agar ordinario italiano, sebbene
Fig. 7· - Ulcera tropimloide, sezio11e istologica del mm·gine. Notare acantosi x roo.
•
su quest'ultimo la crescita sia scarsa e possa a volte essere assente Le sottocolture possono essere anche fatte in terreni liquidi, brodo ed acqua peptonata, ed in questa maniera possono essere studiate le proprietà fermentative del microrganismo . L e forme coccoidi hanno in genere un diametro da o,6 ad un micron, c quelle bacillari hanno una lunghezza da o,6 a 2 micron e più ed una larghezza da 0,3 a o,6 micron. Nei terreni liquidi il miCI·organismo cresce in piccoli gruppi, in
Fig. 8. StrisCio da ulcera tropicaloide colorato col Cra m usando come colomzione di contrasto la fucsina diluita, l cocchi sono stati colorati in rosso dalla fucsina ( Gramnegativi) x 1000.

coppie e in corte catene. Il microrganismo di recente isolato è usualmente Gram-negativo.
La crescita su agar, su agar-tripsina e specialmente sull'agar glucosato al 2 % preparato con terreni americani (Difco) è molto più abbondante, ed un aspetto molto interessante si ottiene dopo 24-48 ore di termostato a 35°, 1t od anche a temperatura ambiente dopo un tempo poco più lungo: le colonie prendono una tinta giallastra che su ccessivamente assume Ul!a pigmentazione gialla marcata. Il pig-
JO
mento non si diffonde nel mezzo. Questa pigmcntazione gia lla sui terrent all'agar Difco è costante. Pensai che possibilmente altri batteri, che ordinariamente non producono colonie pigmentate s ui terreni preparati con il comune agar italiano, potessero sviluppare un pigm ento su terreni agar Difco, ma ciò non è per i germi che io ho a que sto riguardo sperimentati, e. g. vari streptococchi, varie specie di Shigella e di Escherichia. I n questo terreno Difco predominano le
(Gram-negativi) x 1 000.
form e coccobaci ll ari e baci ll ari c il microrganismo può divenire a volte in parte o del tutto Gram-positivo, a lternandosi irrego larmente le fasi di Gram-positività con quelle di Gram-ncgatività.
Nel siero coagulato la crescita è scarsa e il mezzo non è liquefatto. La gelatina non è liquefatt a .
Rea.zioni fermentative . 1 on produce gas negli zuccheri, nè in alcun altro composto del carbonio sperimentato: produce acidità n el

71
; ,. ', • . . .. .. ,. . . , .. l , • • , l • • l .. .. . ...... l • # • l' r • l l' / •• • \ • ' , • t l 1 . , ... ..•
Fig. 9· - Prt•ptmlto da cultura su agar - tripsina col01·ato col Cram usando come colorazione di contrasto la fucsina diluita. l cocchi e coccobacilli sono stati col01·ati in rosso dalla fucsina
glucosio e levulosio e di in molti altri carboidrati . Il mannitolo è di regola n egativo.
Emolisi. Il microrganim10 è spesso capace di produrre emolisi.
Azione patoge11a sugli animali di laboratorio. 11 germe non ha apparentemente azione patogena su cavie, con igli e ratti bianchi quando è inoculato intraperitonealmente o sot tocute.
Classificazione del germe. L'esatta classificazione del ge rm e è difficile specialmente ptrchè, mentre è presente nelle lesioni come un piccolo cocco Gram-negativo, nelle colture può prend<:'re dopo alcuni trapianti un definito aspetto coccobactllare o bacillare e divenire parzialmente o totalmente per alcun tempo, fasi di Gram-po sitività al ternandosi irregolarmente co n fasi di Gram-negatività . Per via dell'aspetto del germe nelle co lo nie su agar italiano io fui dapprima orientato a classificarlo nel genere Streptococcus, ma presto mi convinsi che ciò non era possibi le per le seguenti ragwni:
1°- il germe nelle lesioni e nelle colture di recente isolamento su terreni fatti con agar italiane è Gram-negativo;
2 ° - mentre le colonie su agar italiano sono non pigmentate e a volte streptococciformi cd i preparati faui con mostrano principalmente forme coccoidi, le colonie su terreni all'agar Difco sono di color giallo e nei vetrini preparati da esse predominano le forme coccobacillari e b::tcillari, che possono essere le uniche forme a volte presenti.
lJn maggior lavoro di ricerca dovrà essere con dotto prima di poter raggiungere una definita classificazione. Pe r ora dobbiamo, credo, contentarci dd nome che io gli diedi quando lo descrissi la prima volta cioè Micrococcus (Coccobacillm) mycetoides.
Flora batterica as.wciata. Come già detto, nelle primissime lesioni vescicolari o bollose, non ancora aperte, il Micrococcus (Coccobacillus) mycctoides è l'unico microrganismo presente . Nelle ulceri aperte, se recenti, lo ste sso germe è presente in gran numero, con piccole quantità dì Staphylococcus albus ed occasionalmente di S. aureus. Nelle vecchie ulceri la flora associata può essere abbondantissima e M. mycetuides può essere iso lato con diffico l tà . I germi della flora abitualmente associata sono in questi casi S. albm, S. aureus, S. citreus ed i bacilli difteroidi.
Riproduzione delle ulceri con colture d1 M. mycetoides. Ciò è stato fatto in Roma 13 volontari: 12 uomini ed una donna. Solo un uomo era prima di allora stato in Africa . La tecnica seguita fu la
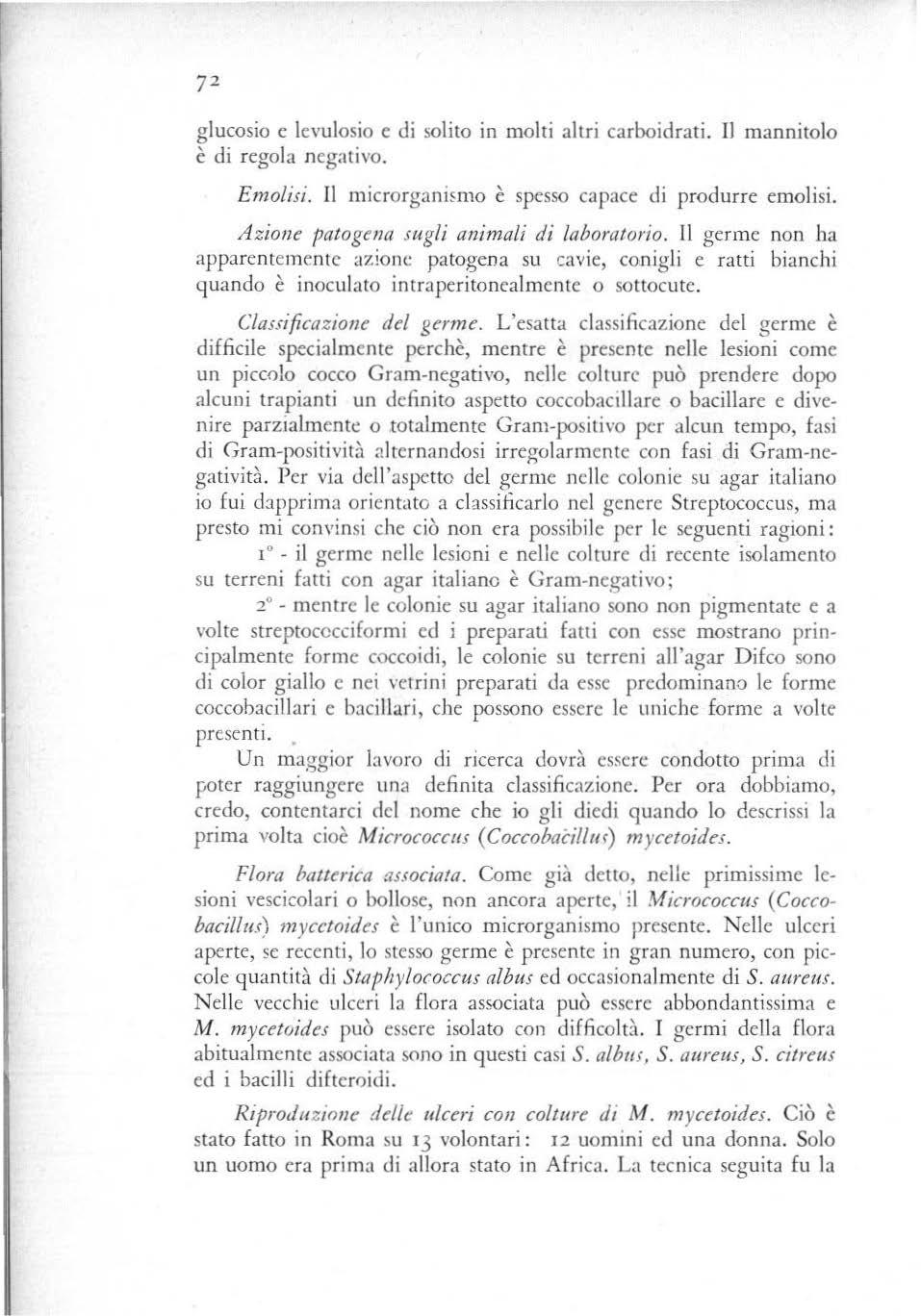
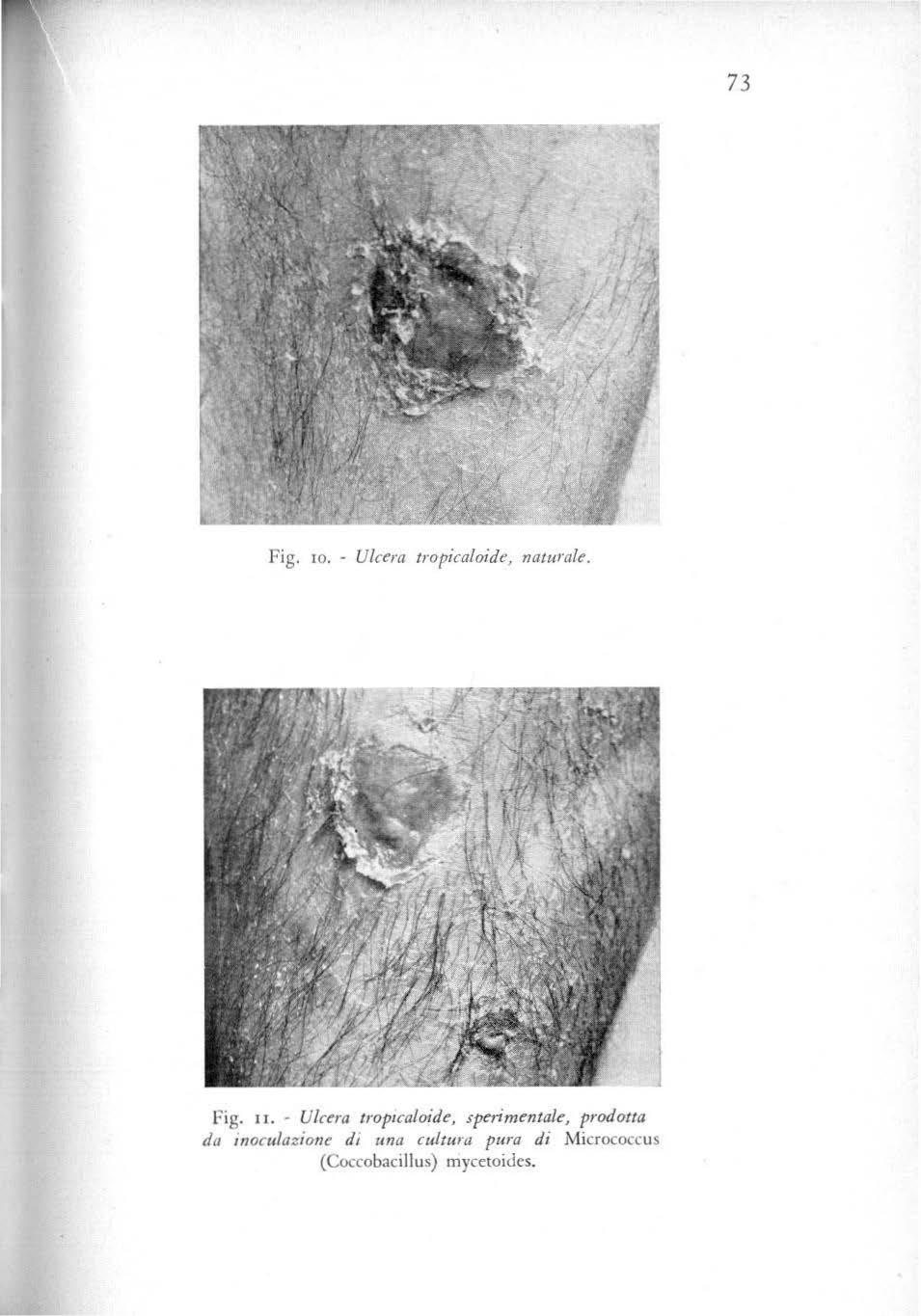 Fig. 10. • Ulcera tropicaloide, naturale.
Fig. 10. • Ulcera tropicaloide, naturale.
73
Fig. 11. - Ulcera troptcaloide, sperimentale, prodotta da moculazione d1 una cttltura pura di Micrococcus (Coccobacillus) mycetoidcs.
seguente: scarifìcazione della cute della gamba in 2, 3, 4 punti, ed applicazione sulle aree scarnificate di 2 o 3 ansate di M. mycetoides da una coltura di recente isolamento; applicaz ione di garza steri le e bendaggio per mantenere l a sede protetta.
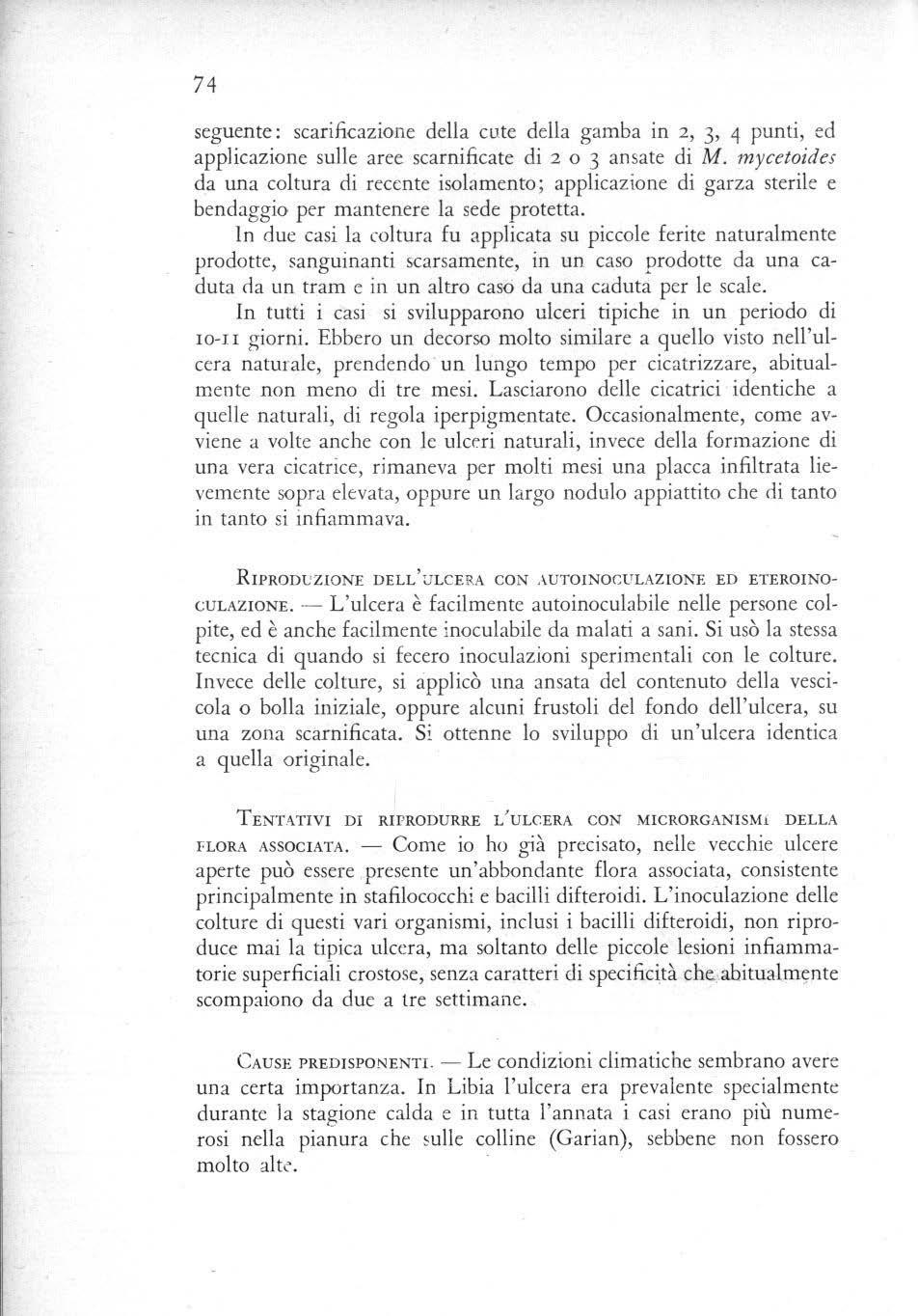
ln due casi la coltura fu applicata su piccole ferite naturalmente prodotte, sanguinanti scarsamente, in un caso prodotte da una caduta da un tram c in un altro caso da una caduta per le scale.
In tutti i casi si svilupparono ulceri tipiche in un periodo di 10-rr g iorni. Ebbero un decorso molto similare a quello visto nell'ulcera naturale, prendendo un lungo tempo per cicatrizzare, abitualmente non meno di tre mesi . Lasciarono delle cicatrici identiche a quelle naturali, di regola iperpigmentate . Occasionalmente, come avviene a vo lt e anche con le ulcr.ri naturali, invece della formazione di una vera cicatrice, r imaneva per molti mesi una placca infìltrata lievem ente sopra elevata, oppure un largo nodulo appiattito che eli tanto in tanto si infiammava.
RIPRODVZlONE DELL 'ULCE RA CON ,\UTOINOCtrLAZ!ONE ED ETEROINO(;ULAZIONE. ·- L ' ulcera è facilmente autoinoculabile nelle persone colpite, ed è anche facilmente inoculabile da ma lati a sani. Si usò la stessa tecnica di quando si fecero inoculazioni sperimentali con le colture. Invece delle colture, si app li cò una ansata del contenuto della vescico la o bolla iniziale, oppure alcuni frustoli del fondo dell'ulcera, su una zona scarnificata. Si ottenne lo sviluppo di un'ulcera identica a quella originale.
TENTATIVI DI RIPRODURRE L ' ULCERA CON MICRORGANISMi DELLA FLORA ASSOCIATA - Come io ho già precisato, nelle vecchie ulcere aperte può essere presente un'abbondante flora associata, consistente principalmente in stafìl ococcht e bacilli difteroidi . L'inoculazione delle colture di questi va ri organismi, inclusi i bacilli difteroidj, non riproduce mai la tipica ulcera, ma soltanto delle piccole lesioni infiammatorie superficiali crostose, senza caratteri di specificità che. abitualmente scompaiono da due a tre settimane .
CAUSE PREDISPONENTI. - Le condizioni climatiche sembrano avere una cer ta importanza. In Libia l'ulcera era prevalente specialmente durante la stagione calda e in tutta l'annata i casi erano più numerosi nella pianura che colline (Garian), sebbene non fossero molto a l t-' .
74
h!\WNITÀ. - Non sembra che esista un'immunità naturale. L'immunità acquisita sembra essere scarsa od assente poichè facilmente inoculano con l'ulcera individui che ne hanno già sofferto in passato o che ne stanno sof fr endo.
CuTI-REAZIONE.- L'iniezione intradermica di o,ro cc. di una emu lsio ne del microrganismo in soluzione fisiologica (ucciso al caiore o mediante addizione di acido fenico al 1 1 2 "é, ) causa l'immediata comparsa di un pomfo che, dopo due o tre minuti, viene circondato da una grande zona di eritema, abitualmente molto pruriginosa. Dieci o quindici minuti più tardi que sta zona eritematosa comincia a infiltrarsi e il prurito cessa. L'infiltrazi one dura per due o tre giorni, poi resta un nodulo c he dura tre o quattro setti mane c, dopo risoluzione, lascia una piccola macchia iperpi gme ntata che rimane per cinque o sei mesi cd anche più. L'iniezione di filtrati di co lture o di emulsioni non produce reazione.
- Nei casi tipici abbastanza avanzati si vedono sui due terzi inferiori della gamba una, due e anche tre, occasionaimente quattro di più), ulcere che possono essere o aperte o coperte da croste. Ogni ulc era è rotondeggiante od ovalare, piuttosto superficiale, con un diametro che varia da un centimetro a quattro e più. I margini non sono sensibilmente rialzati o infiltrati, nè abitualmente sono sottom inati ; possono mostrar e piccole dentellature: il pavimento è ro ssast ro, a volte coperto da un velo di pus, a volte g ranuleggiante; occasionalmente il fondo può essere coperto qua e là da piccole pseudomembrane fibrino se . L 'ulcera è spesso circondata da un alone infiammatorio rosso-vivo che più tardi diventa infiltrato e può essere coperto da croste.
Quando l'ulcera è completamente sviluppata può rimanere aperta, oppure può essere coperta da una spessa crosta che si este nde al di là Jel margine della perdita di sostanza. La crosta può essere scura, rossastra, giallastra o biancheggiante. Se si rimu ove la crosta, si vede un'ulcera con i caratteri già descritti. L'ulcera è dolorosa, specia lmen te se il malato resta a letto; può essere dolente alla pressione; il prurito per le più è assente, eccetto a volte durante la cicadell'ulcera. Le inguinali non sono ingrossate e non si è mai notata Jinfangitc:. La r egione di elezione, come ho già detto, è la gamba ne1 suo1 due terzi inferiori, ma l'ulcera si può
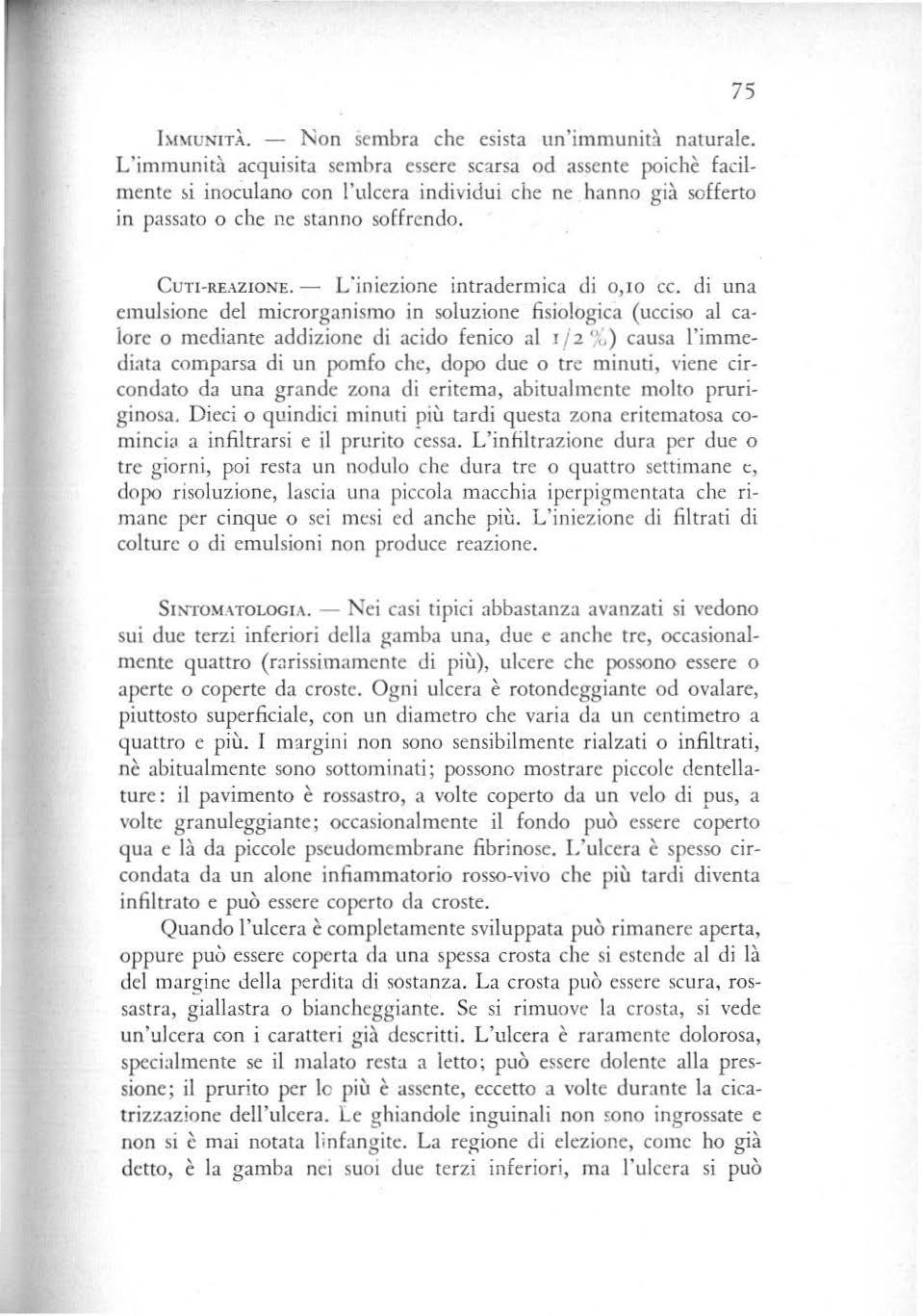
75
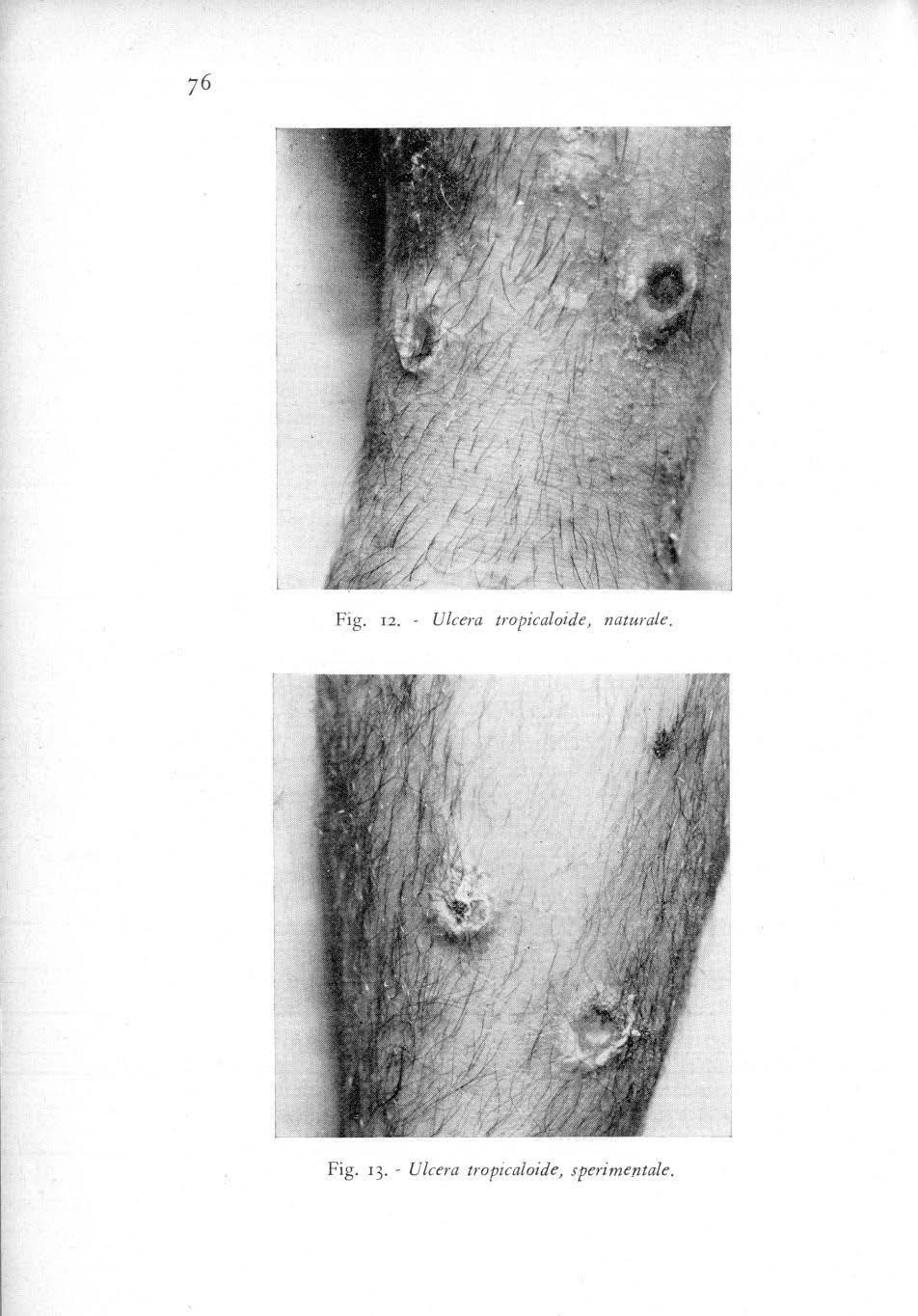 Fig. 12. - U!cera tropicaloide, 11aturale.
F ig . 13. - Ulcera troprcaloide, sperimemale .
Fig. 12. - U!cera tropicaloide, 11aturale.
F ig . 13. - Ulcera troprcaloide, sperimemale .

77
Fig. 14 - Ulcera tropicalo-ìde, naturafe.
Fig. 15 - Ulcera tropiealoide, sperimentale.
ritrovare su ogni parte del corpo e non è ransstma su1 piedi, sulle mani e sulle braccia.
DEcoRso. - Dopo un breve pcrioJo d 'inc ubazione, da 2 a ro giorni per lo più, appare una piccola vescicola sul punto d'inoculazione. Questa vescicola abitualmente non è follicolare, aumenta rapidamente di volume c si trasforma in una grossa vescicola del volume di una lenticchia o in una bolla di dimensioni più grandi, da 0,5 a I cm. e più di diametro. La vescicola o la bolla è abitualmente poco elevata, a volte appiattita, e dopo due o tre g iorni si rompe; così comincia un processo ulcerativo che, nella maggioranza dci casi, non si app rofonda molto ma si estende in superficie. La durata dell'ulcera è lunga, di rado meno di un tre- sei mesi, a volte dura un anno e anche più perchè vi è scarsa tendenza alla guarigione spontanea. La cicatrice dell'ulcera è generalmente iperpigmcntata, a volte ipopigm entata, a volte non si forma una vera cicatrice, ma un ispessimcnto infiltrato lievemente sopraelevato o un nodulo appiattito che ha una superficie liscia di color ro sato, a volte lievemente dolente all a pressione. Il nodulo può ogni tanto infiammarsi in seguito a qualche piccolo trauma, e si può formare un'ulcera. Dopo alcuni mesi la placca infiltrata o il nodulo si trasformano in una vera cicatrice per un processo di fibro si
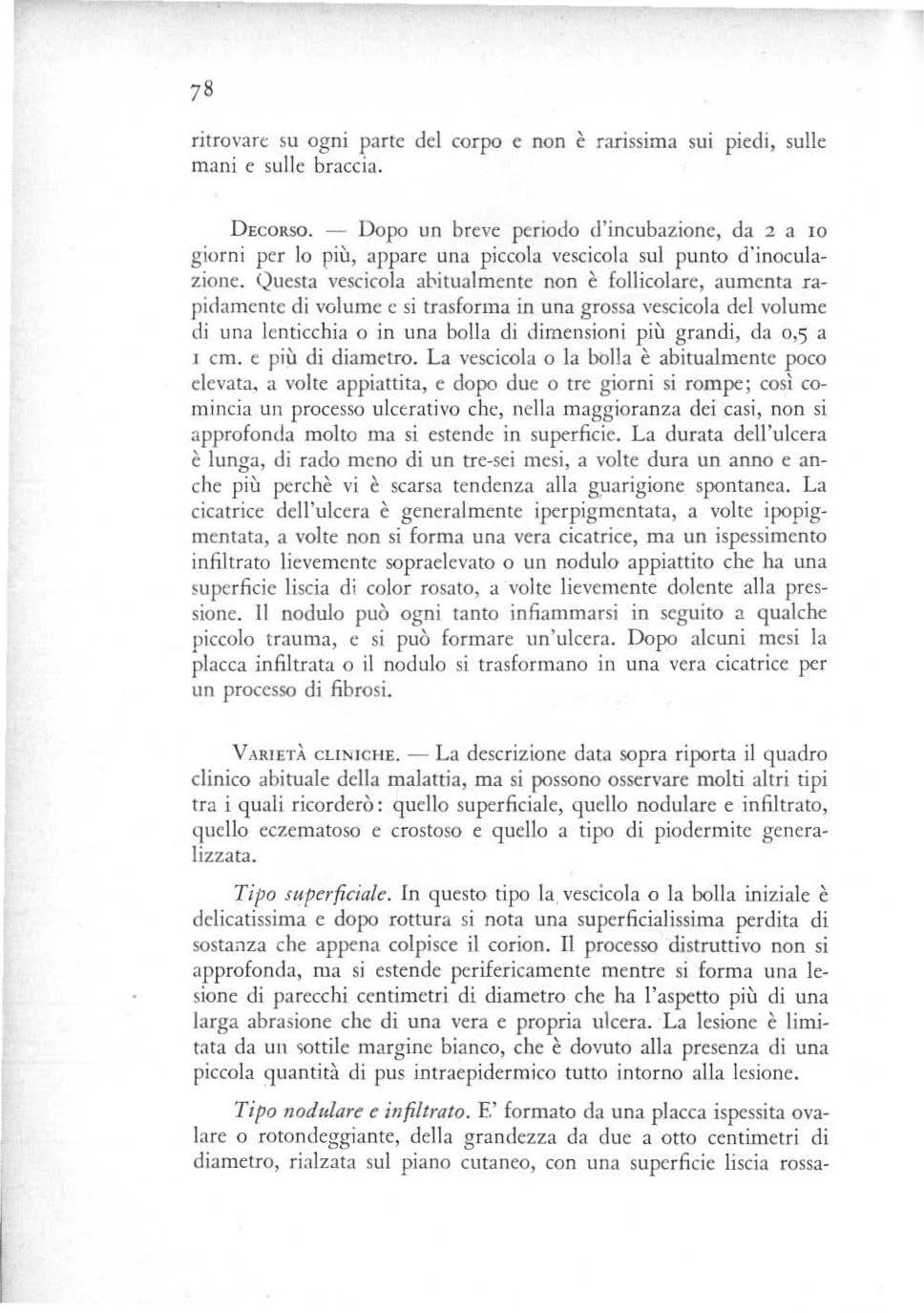
V.-\JHETÀ cLINJCIIE. - La descrizione data sopra riporta il quadro clinico abituale della malattia, ma si possono osservare molti altri tipi tra i quali ricorderò: quello superficiale, quello nodulare e infiltrato, quello eczema to so e cro stoso e quello a tipo di piodermite generalizzata.
Tipo superficiale In questo tipo la vescicola o la bolla iniziale è delicatissima e dopo rottura si nota una superficialissima perdita di sostanza che appena colpisce il corion. Il processo distruttivo non si approfonda, ma si estende perifericamente mentre si forma una lesione di parecchi centimetri di diam etro che ha l'aspetto più di una larga abra$ione che di una vera e propria ulcera. La lesione è limitata da un 5ott11e margine bianco, che è dovuto alla presenza di una piccola quantità di pus intraepidermico tutto intorno alla lesione.
Tipo nodulare e infiltrato. E' formato da una placca ispessita ovalare o rotondeggiante, della gra nd ezza da due a otto centimetri di diametro, rialzata sul piano cutaneo, con una superficie lisci a rossa-
stra su cui si formano delle ulcere minute. In pochi casi la lesione diventa nettamente nodulare.
Tipo eczematoide crosto .ro . E' formato da una o più aree arrotondate od ovali, con l a superficie ricoperta da cros t e che possono essere grandi o piccole. Con la rimozione delle croste si vede un a superficie a rro ssata umida. Le pbcche sono ben definite, quasi marginate, e possono rassomigliare alle placche ispessite dell'eczema nummulare.
Tipo piodermite generalizzata (Pioderma My cetoides). Su tutto il corpo, con eccezione abitualmente della faccia c della nuca, si notano lesioni pustolose o crostose, alc une superficia l i, altre profo nd e. La prima impressione clinica è quella di una piodermitc ge n eralizzata, causata dagli abituali cocchi piogeni, ma, esaminando attentamente il pazien t e, allontanando le croste, si troveranno una o due ulceri tipiche per lo più sulla gamba che h anno un decorso cronicissimo e dalle quali si può isolare il .\ficrococcus (Coccobacillus) mycetoides.

79-
Fig. 16. - Ulcera tropicalorde ttpo C1-ostoso, naturale.
Personalmente non ho alcun dubbio che le futur e ricerche dimostreranno che un certo numero .di casi che il medico generico chiama di piod ermite cronica resist ente, si troveranno essere dovuti a Miet·ococcus ( Coccobacillus) mycetoides.
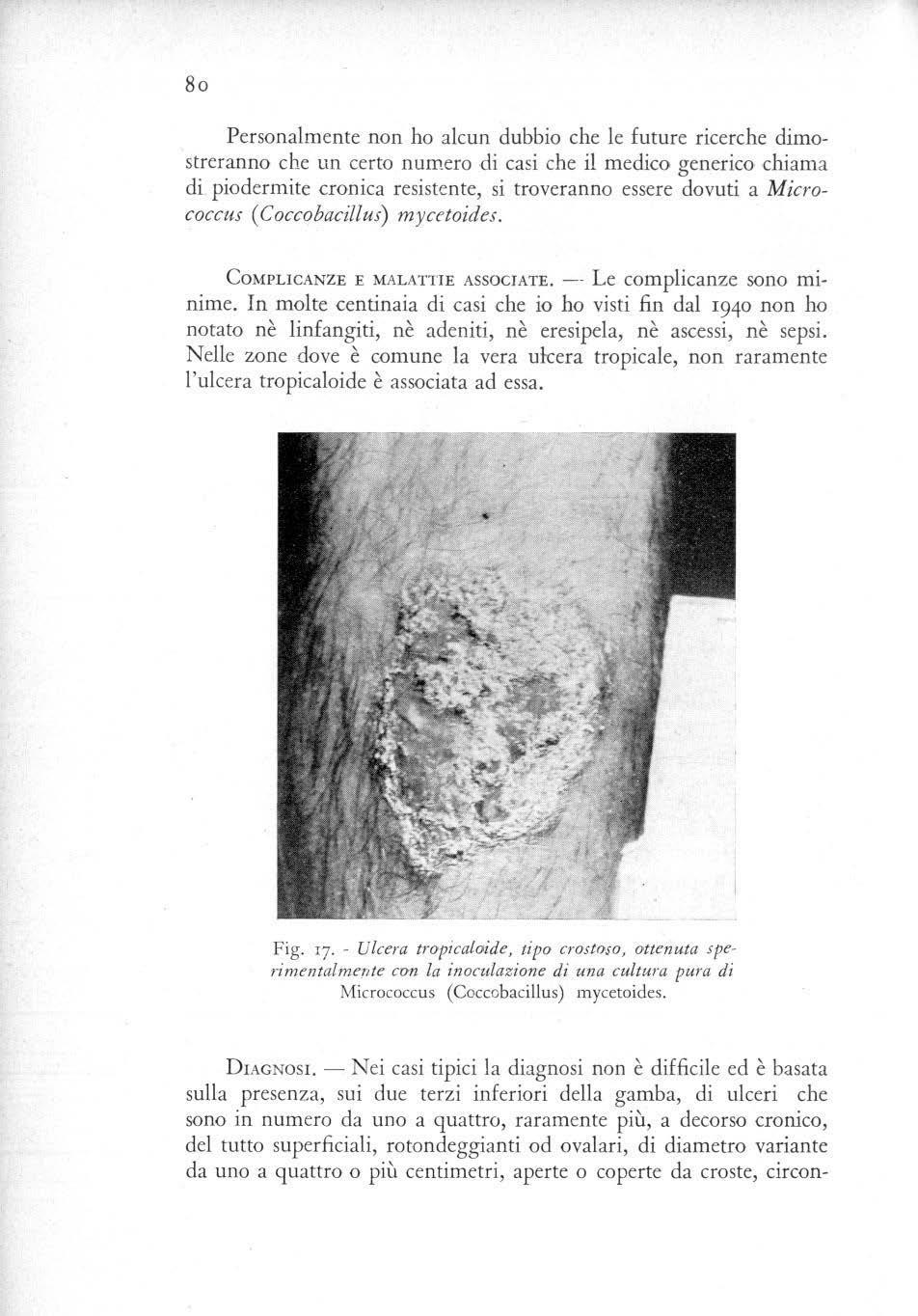
CoMPLICANZE E MALATTI E ASSOCIATE. Le complicanze sono minime. In molte centinaia di casi che io ho visti fin dal 1940 non ho notato nè liniangiti, nè adeniti, nè eresipela, nè ascessi, nè sepsi. Nelle zone dove è comune la vera ukera tropicale, non raramente l 'ulcera tropicaloide è associata ad essa.
DIAGNOS I. -Nei casi tipici la cliagnosi non è difficile ed è basata sulla presenza, sui due terzi inferiori della gamba, di ulceri che sono in numero da uno a quattro, raramente più, a decorso cronico, del tutto superficiali, rotondeggianti od ovalari, di diametro variante da uno a quattro o più centimetri, aperte o coperte da croste, circon-
Bo
Fig. 17. - Ulcera troptcaloide, tipo crostoso, ottenuta spet·imentalmettle c011 la inoculazione di u11a cultura pura di \11icro cocc u s (Coccobacil lus) mycetoicles.
date spesso da un alone iperernico, a volte da infiltrazione; i margini non sono sensibilme nte elevati, nè sono infìltrati e per lo più non sono neppure sottominati: le ghiandole regionali non sono ingrossate. L 'esame batteriologico dimostra la presenza del Micrococcus (Coccobacillus) mycetoides la cui dettagliata descrizione è stata già data sopra.
DIAGNOSI DIFFERENZIALE - In pratica l'unica condizione morbosa dalla quale deve esser e principalmente differenziata è l'ulcera tropicale vera (ulcus tropicum), con la quale tantissimi medici gene-
Fig. 18. - Lesioni prodotte in un volontarzo da inoculazioni, eseguite lo ste.;so giorno ed alla stessa o·ra, di culture pure di un «difteroide » (in alto a sinistra), dì uno Staphy lococcus aureu s (in alto a dest1·a) , di uno Staphylococc us a lbus (nel mezz o) e di Mic rococcus ( Coccobac illus) mycetoides (in bass o), germi isolati da un caso di ulcera tropicaloide, aperta, dì vecchia data.
nc1 dei T ropici la identificano Le principali note caratteris6che cliniche dell'ulcus tropicum sono già state date. E' un quadro molto più serio che incomincia con una papu lo-pustola dolorosissima, che rapi-

81
6
damente si rompe, e per un grave processo di necrosi si sviluppa una ulcerazìone che i.n breve si estende in ampiezza e profondità, divenendo a volte fagedenica; il processo ulcerativo è molto pìì1 profondo che nell'ulcera tropicaloide ed il decorso anche più prolungato, potendo durare a volte due anni e più; i margini dopo un certo tempo possono essere ispessiti; l'esame microscopico dell'essudato dimostra usualmente la presenza di spirochete e di bacilli fusiformi (Fusiformis fusiformis).
Ulcera di V eld (ulcera della sabbia, ulcera del deserto). Sebbene il te r mine di ulcera di V eld sia stato usato in passato per indicare differenti condizioni morbose, adesso è limitato ad ind.icare. ulceri di origine difterica.
Questa malattia comincia spesso con una lesione follicolare dolente. L'esame batteriologico rivelerà la presenza del vero bacillo difterico (tossico) Corynebacterium diphteriae. In alcuni casi di vecchie ulceri tropicaloidi possono essere presenti dei bacilli difteroidi in associazione con altri germi ed il germe specifico, ma mai il vero bacillo difterico.
I termini: ulcera del deserto cd ulcera della sabbia, quando sono usati senza specificazione, sono ora considerati come sinonimi di ulcera di V el d (ulcera del deserto difterica).
Pyoderma volgare. Dei principali tipi di pioderma, impetigine ed ectima, quest'ultimo colpisce spesso la gamba, ma generalmente ha inizio con una pustola situata profondamente, appiattita, della grander.lza eli un piccolo ad un pisello, il cui contenuto rinsecca in una crosta affossata nel la pelle sotto cui la piccola perdita di sostanza cicatrizza in due-quattro settimane, lasciando una piccola cicatrice. A volte l'ulcera e la cicatrice risultante possono essere di più grandi dimensioni. L'esame batteriologico dimo stra l a presenza di comuni streptococchi Gram-positivi producenti colonie non pigmentate e di stafìlococchi. Come io bo già menzionato, comunque, credo che certi casi che il medico generico definisce di pioderma pe rsistente o intrattabile siano con tutta probabilità dovuti al Micrococctts ( Coccohacillus) mycetoides e non ai cocchi piogeni ordinari
PROGNOsr.- L'ulcera ha un decorso prolungato, da tre a sei mesi, ed a volte dodici mesi ed anche di più . Nella maggior parte dei casi le condizioni generali di salute non sono compromesse, e, se la gamba è mantenuta fasciata, il paziente è generalmente in grado di svo lgere le sue attività dato che il disturbo locale e i dolori sono lievi nella
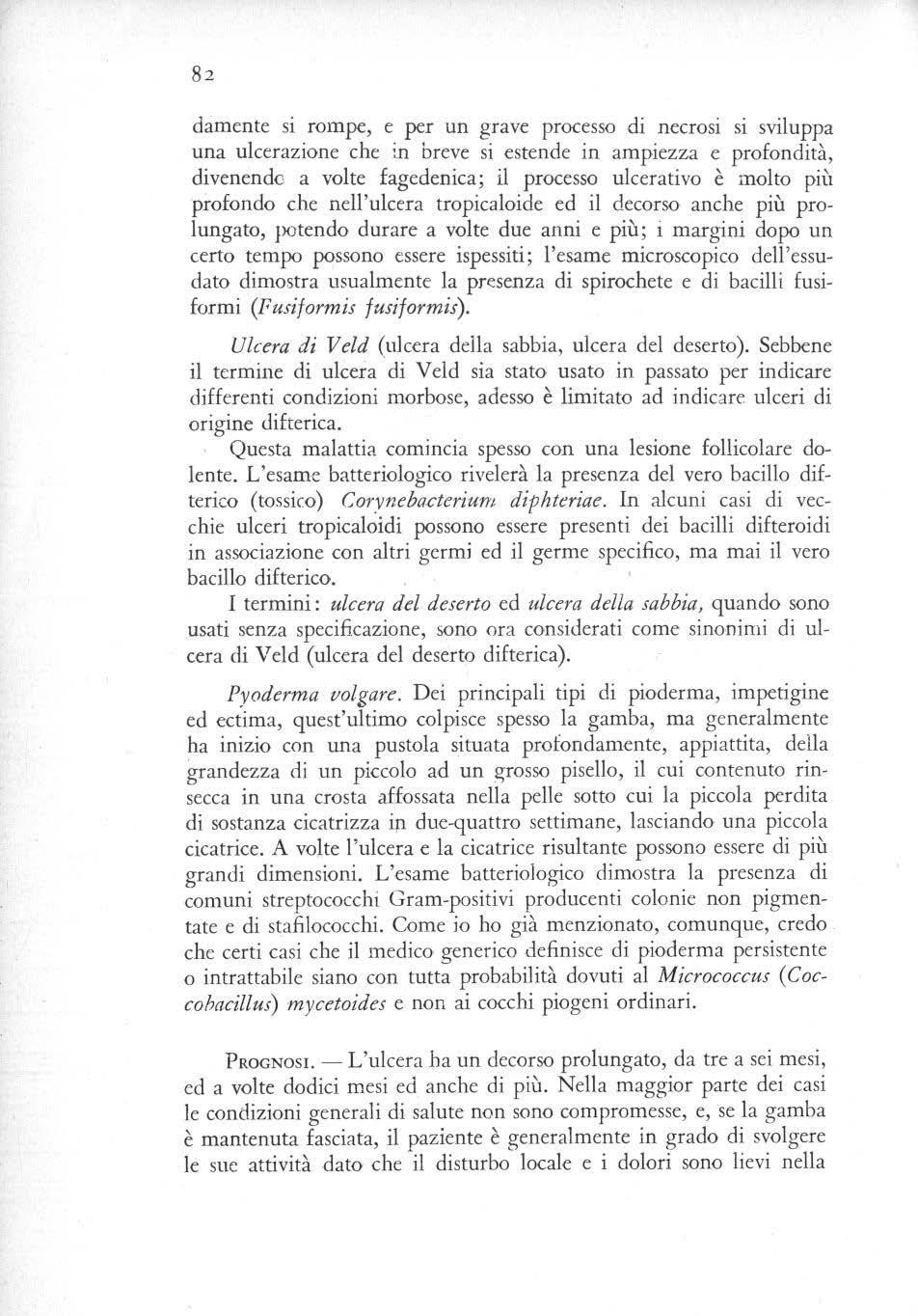
maggior parte dei casi. In qualche caso però, circa 10-15 è necessario il ricovero ospeda liero .
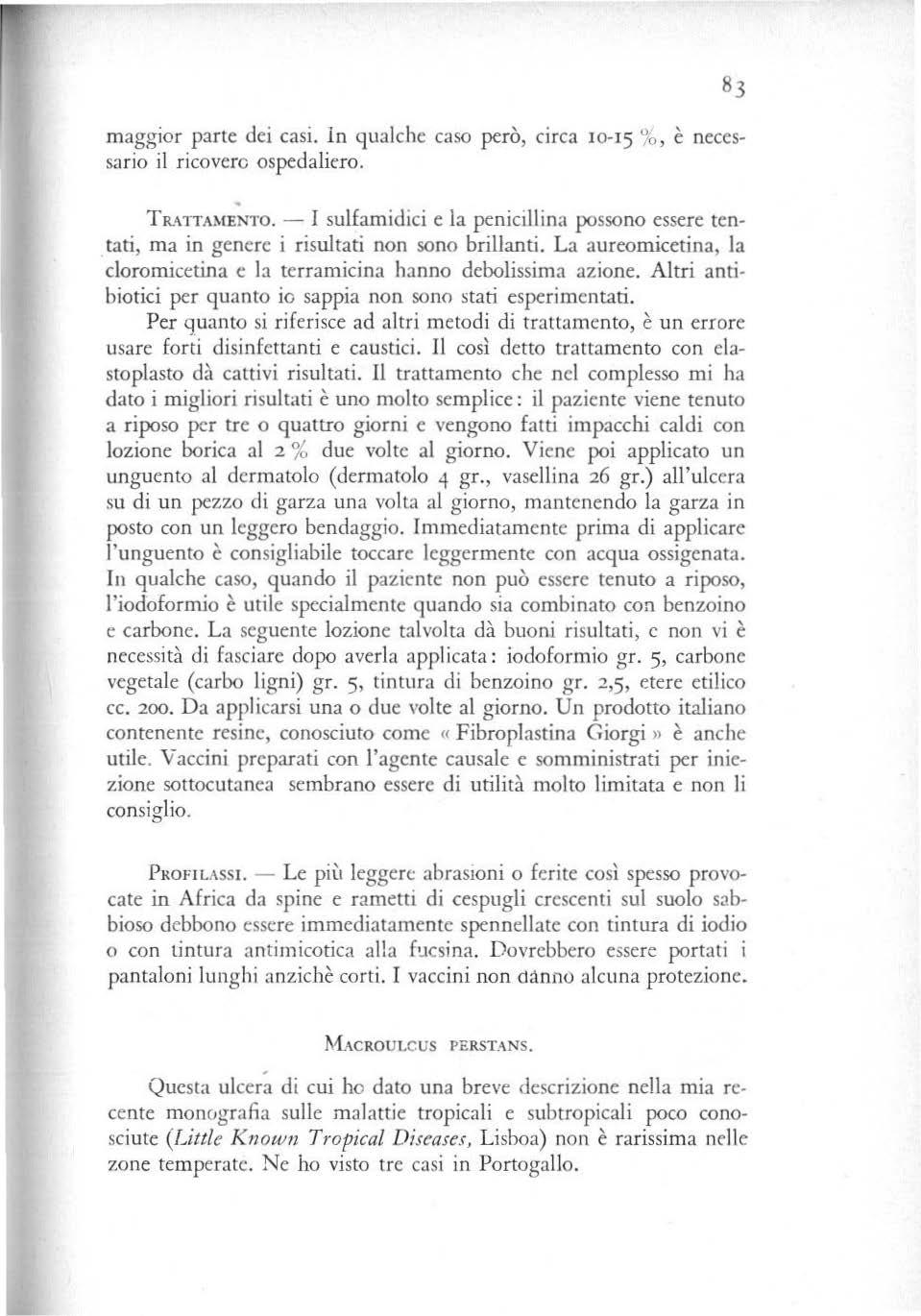
TRATTAMENTO. -I sulfamidici e la penicillina possono essere tentati, ma in genere i risultati non sono brillanti. La aureomicetina, la cloromicetina e la terramicina hanno debolissima azione. Altri antibiotici per quanto io sappia non sono stati esperimentati.
Per guanto si riferisce ad altri metodi di tr attamento, è un errore usare forti disinfettanti e caustici. Il così detto trattamento con elastoplasto dà cattivi risultati. Il trattamento che nel complesso mi ha dato i migliori risultati è uno molto semplice: il paziente viene tenuto a riposo per tre o quattro giorni e vengono fatti impacchi caldi con lozione borica al 2 % due volte al giorno. Viene poi applicato un unguento al dermatolo (dermatolo 4 gr , vasellina 26 gr.) all'ulcera su di un pezzo di garza una vo l ta al giorno, mantenendo la garza in posto con un leggero bendaggio. Immediatamente prima di applicare l'unguento è consigliabile toccare leggermente con acqua ossigenata. I n qualche caso, quando il paziente non può essere tenuto a riposo, l'iodoformio è utile specialmente quando sia combinato con benzoino e carbone. La seguente lozione talvolta dà buoni risultati, c non vi è necessità di fasciare dopo averla appl icata: ìodoformio gr. 5, carbone vegetale (carbo ligni) gr. 5, tintura di benzoino gr. 2,5, etere etilico cc. 200. Da applicarsi una o due volte al giorno. Un prodotto italiano contenente resine, conosciuto come cc Fibroplastina Giorgi » è anche utile. Vaccini preparati con l'agente causale c somministrati per iniezione sottocutanea sembrano essere di utilità molto limitata e non li co n siglio.
PROFILASSI. - Le pil.t leggere abrasioni o ferite così spesso provocate in Africa da spine e rametti di cespugli crescenti sul suolo s:lbbioso debbono essere immediatamente spennellate con tintura di iodio o con tintura antimicotica alla h1csina. Dovrebbero essere portati i pantaloni lunghi anzichè corti I vaccini non dànno alcuna protezione.
tvi.>\CROUL CUS PERSTANS.
Questa ulcera di cui ho dato una breve descrizione nella mia recente monografia sulle malattie tropicali e subtropicali poco conosciute (Little Known Tropical Diseases, Li sboa) non è rarissima nelle zone temperate. Ne ho visto tre casi in Portogallo.
Il pro cesso ulcerativo inizia per lo più sopra una piccola les io ne di continuo causata da trauma (caduta, piccola ferita di guerra, ccc.) e prend e anni prima di arrivare a completo sviluppo. In un caso tipico avanzato un a enorme ulcera (che p uò raggiungere 15-20 c m. di diametro m ass imo) è prese nte s ull a ga mba, a contorno u sua lm e nt e festonato. I n genere è poco dolorosa. I margini son o in filtrati ma n o n · si nota « ca ll osi tà »; non sono mai sottomina t i. Il fondo è usualmente
granuleggiato ma in casi tra sc urati è ri cope rto di un a abbondante secrezione contenen t e innume r evoli batteri. Di tanto in tanto notansi parziali proc ess i di cicatrizzazione spo ntanea, ma la cicatrizzazione co mpl eta di tutta l'ulcer a è eccezio n ale Per m o lti centimetri la cute intorno all'ulcera è edematosa e in fi l trata, ed in alcuni casi nota si una pseudoelefanùasi dell'arto . N on vi sono m ai attacchi febbrili con chiazze erisipelatose come nella vera elefantiasi filarica cd anche nella elefantiasi nostra . L e g h iandole in guinali possono essere ingrossate ma non molto, cd u su a lme nt e non so no dolenti nè sponta n ea m ente nè alla pressione. La sa lute gene r ale può m antenersi abbastanza buo n a per lunghi anni. Il sangue non presenta niente di specifico,
 Fig. 19. - Macroulcus
Fig. 19. - Macroulcus
vi può essere leggera anem1a ipocromica. La reazwne di Wassermann è negativa .
ETIOLOGIA. - E' ancora incerta. Gli esami batteriologici mettono in evidenza una flora batterica mista, ed è interessante il notare che non si trovano mai streptococchi e gli stafilococchi non sono abbondanti e possono mancare del tutto. Il germe costante e generalmente presente in gran numero è la Pseudomona:; aeruginosa (Bacillus pyocianettS) ed il sangue può contenere agglutinine per lo stipite isolato dal malato. In un volontario non mi è riuscito riprodurre la lesione con tale batterio In alcuni rari casi possono osservarsi qualche spirochete e qualche bacillo fusiforme, ma sempre in piccolissimo numero, un micrococco Gram-negativo, molto vicino al Micrococcus afermetans da me descritto in certe lesioni cutanee anni or sono (1928), ed alquanto simile al Micrococcus catarrhalis Frosch e Kolle. Non produce acidità nè gas in alcuno zucchero. Nei tre casi portoghesi ho trovato anche due bacilli che ho descritto coi nomi di B. albolisbonensis e B. flavolisbonensis. In un caso era presente Sen·atia marcescens (Bacillus prodigiosus).
Ii Bacillus albolisbonensis e il Bacillus flat;o/isbouensis sono stati descritti da me, assieme ad altri organismi poco noti, al Congresso Internazionale di Microbiologia (Rio de Janeiro, 17 - 24 agosto 1950) ed al Congresso della Frei Vcreinigung Deutscher Hygieniker und Mikrobiologen (Harnburg, 27 settembre I<:JSO). Questi due organismi vivono strettamente associati e possono essere separati solo con difficoltà . Lo Albolishonensis produce colonie bianche, il Flavolisbonensis colonie gialle. Non producono gas in alcun zucchero. Sono con tutta probabilità non·patogeni.
DIAGNOSI. - L'ulcera è facilmente distinguibile dall'ulcus tropicum per la sua durata cronicissima senza tendenza al fagedenismo, il suo contorno festonato, l'assenza, usualmente, dell'associazione spirocheta-bacillo fusiforme. E' distinguibile dall'ulcera varicosa per l'assenza di vere c proprie vene varicose, e perchè il riposo prolungato dell'arto non produce sensibile miglioramento. Si differenzia dall'ulcera cronica streptococcica progressiva di Maleney perchè in questa i margini sono sempre sottominati, vi è costante presenza di uno streptococco microaerofìlico e risponde a un trattamento a base di ossigeno nascente (perossido di zinco ecc.). Si differenzia dall'ulcera tubercolare per l'assenza del bacillo della tubercolosi, prove
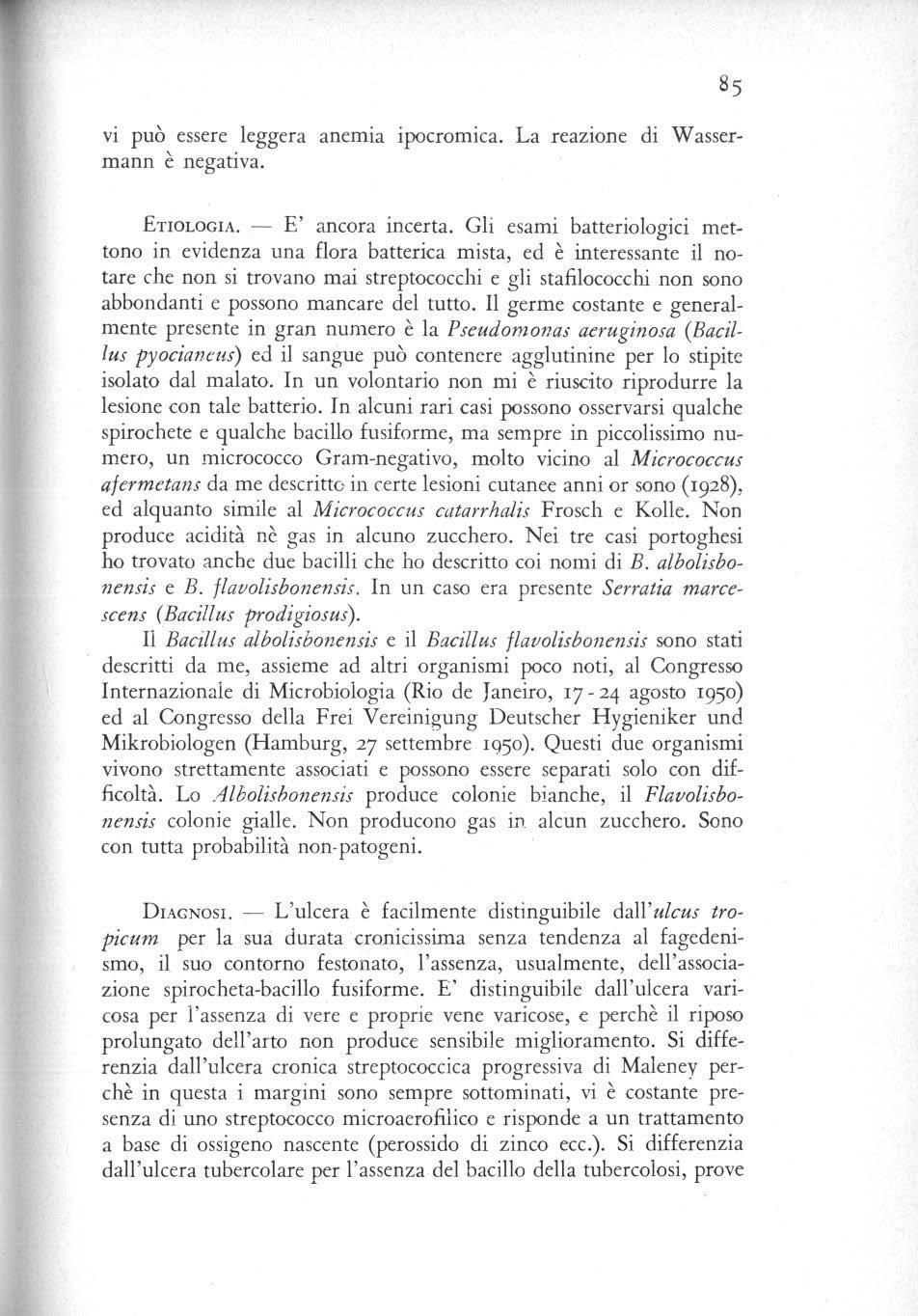
ss
cutanee negative, inoculazione di materiale nella cavia negati va. Si differenzia dalla rarissima ulcera arnebica per l'assenza di ameba ed inutilità dei trattamenti alla emetina ed altri antiamebici. Si differenzia dall'ulcera luetica ( terziari a) perchè la reazione di Wassermann è negativa ed il trattamento al bismuto, al mercurio , all'arsenico non dà alcun risultato. Si differenzia dall'ulcera tropicaloide (ulcera del deserto mycetoide) per l'assenza di Micrococcus ( Coccobacillus) mycetoides e per le dimensioni molto più grandi ed il decorso cronicissimo; si differenzia dall'ulcera di V el d (ulcera del de)erto difterica) per l'a ssenza del bacillo difterico, c dall'ulcera set tica per l'assenza o rarità dei comuni germi piogeni. Dall'ulcera leishmaniae si distingue per l'assenza di leishmani ae e dall'ulcera micetica (blastomicosi, coccidiomicosi, paracoccidiomicosi, actinomicosi., histoplasmosi, ecc .) per l'assenza di miceti.
Dalle ulcere della gamba, non rare in casi di anemia a cellule falciformi {drepanocytosis), si differenzia per le dimensioni molto più grandi e per l 'assenza di eritrociti falciformi all 'esame del sangue.
PRoGNosr. - Questa è buona quoad vitam, ma il decorso è straordinarian1ente l un go e la cicatrizzazione completa del l 'ulcera è eccezional e.
TRATTAMENTO CURATIVO. - Questo è difficilissimo . L a penicillina in enormi dosi per iniezioni e i sulfamidici in polvere localmente dànno un miglioramento, talvolta assai notevole, ma mai una vera guarigione. La terramicina e la cloromicetina non h anno azione . La aureomicetina ha azione nulla o quasi nulla. Altri antibiotici non sono stati spe rimentati.
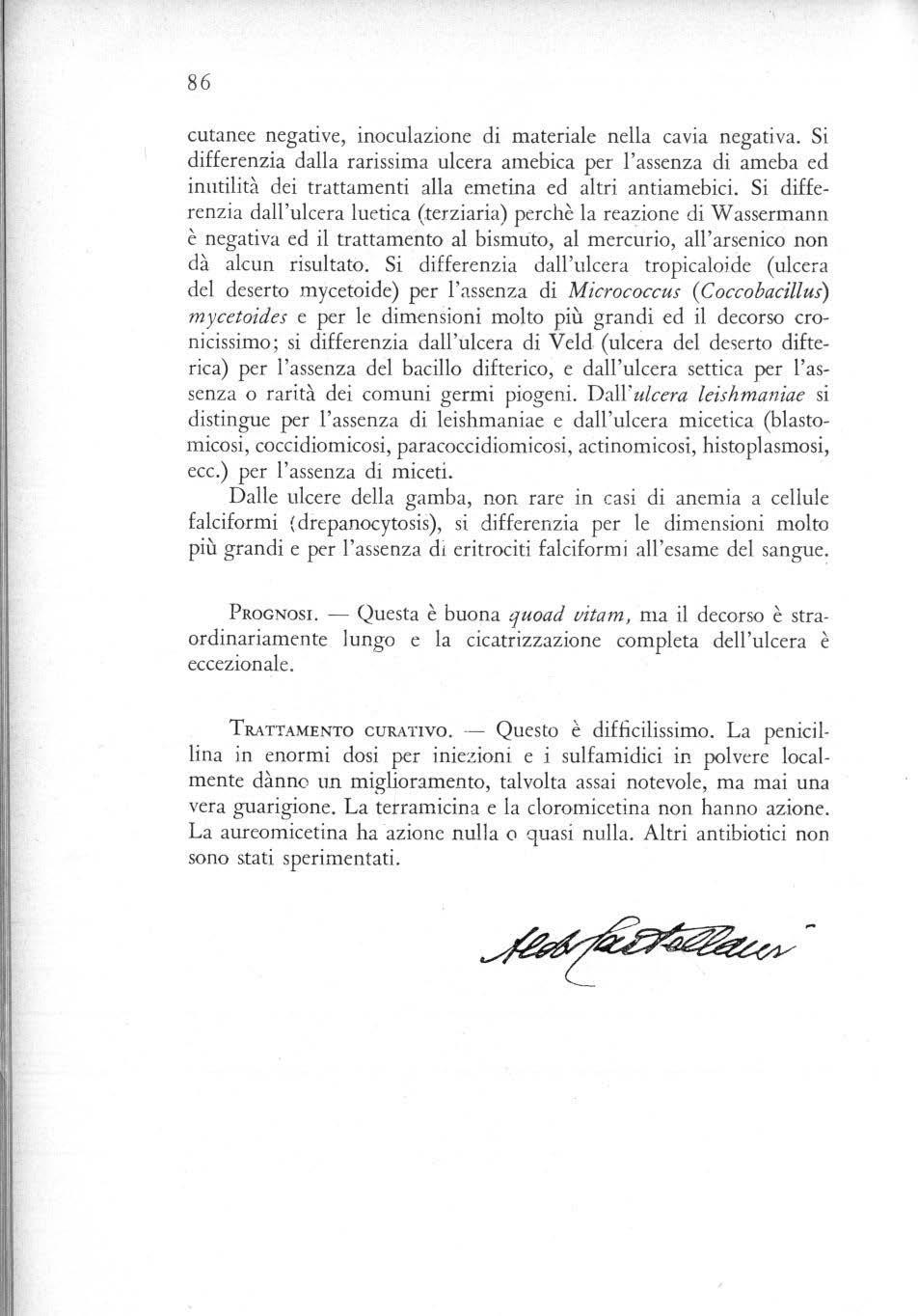
86
BIBLIOGRAFIA
CASTELLAN I A.: Le malattie dell'Africa, Roma, 1947·
Tropicaloid ulcer (myutoid desut sore), in J o urn al of Tr opical Med icine
:md Hygiene, vol. 51, n. 12, pag. 245, 1948.
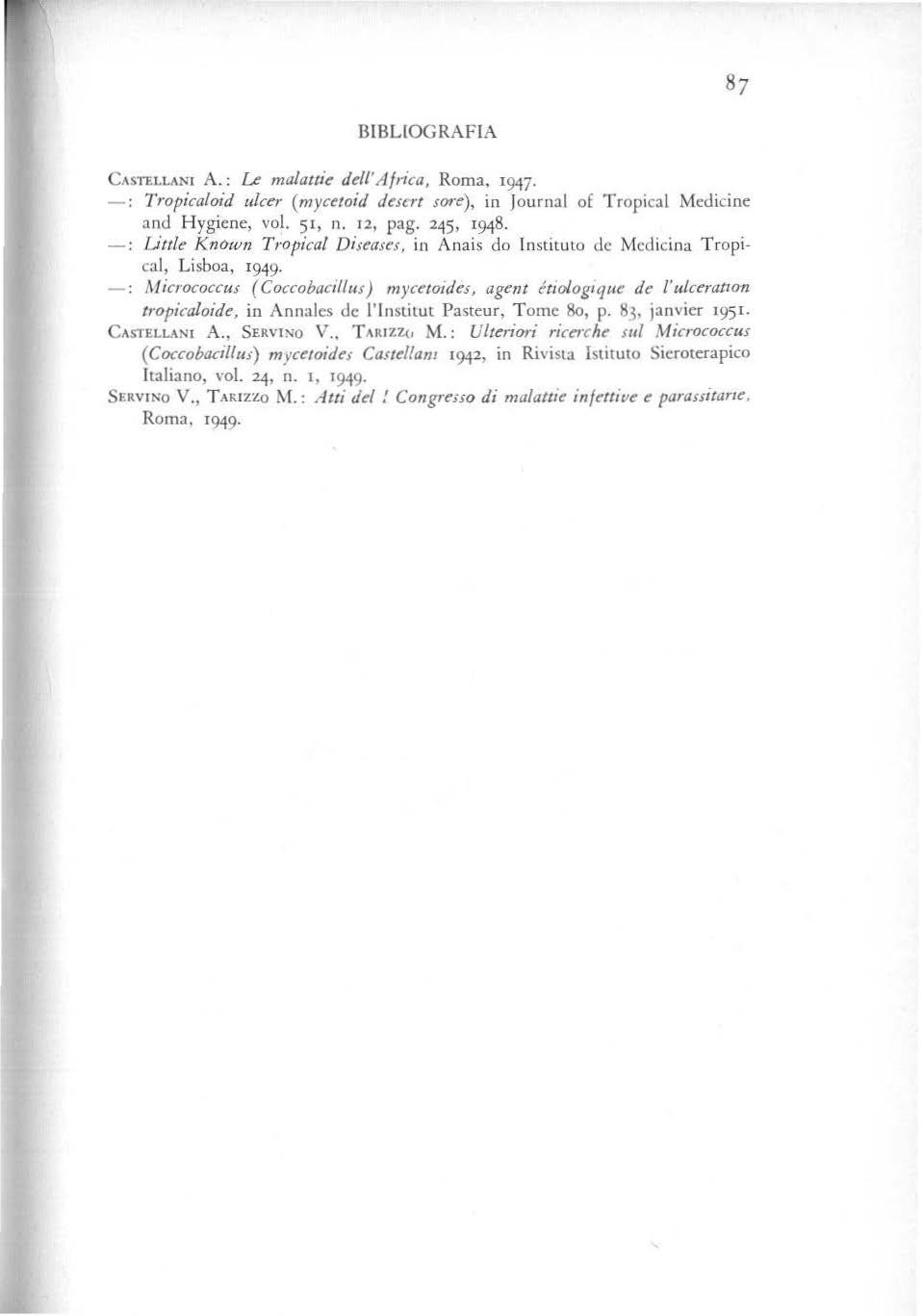
Little Known Tropical Diseases, in Anais do lnstituLo dc Med icina Trop ical, Li sboa, 1949.
Micrococcus ( Coccobacillu s) mycetoides, agen t ét iologtque de l' tropicaloide, in Annales dc l'lnstilut Pasteur, T ome 8o, p. janvier 1951.
CAsTELLANI A SERVINO V., TARIZZ(, M.: Ulteriori ricerche sul Micrococcus ( Coccobacillus) m ycetoides Castellam '9-42> in Ri' isLa Istituto Sieroterapico
Italiano, ,-ol. 24, n. 1, T949·
V., TA .- I ZZO ritti del : Congresso di malattie infettive e parassitaru: , Roma. 1949.
OR IE NTAMENT I PRA T I C I
SU LLA TERAP IA DELLE U STIO N I NELLA M O DERNA MEDI C I N A MILITA RE
Secondo attendibili statistiche (1), il profilo della frequenza assoluta dei casi di ustion e in que sta prima metà di secolo regi stra, in corrispondenza dei due grandi conflitti mondiali (1914-19r8 e 1939-1945), due cuspidi significativamente elevate: documento esauriente della sensibile influenza esercitata dagli eventi militar i e bellici sull'andamento casistica delle u stioni, già di per è notevolmente alimentato dall e caratteristiche m eccanic he della vita contemporanea. La stessa fisionomia delle modern e forze armat e operanti rende chiara ragione del fenomeno: incremen t o cospicuo della motorizzazione, sviluppo delle operazioni aeree, profuso impiego dell'energia elettrica c di quella da combustione, dilatazione spa z ial e e massiva del co nc etto di << vo l ume di fuoco » mediante bombardamenti a distanza , uso di proiettili incendiari ecc.
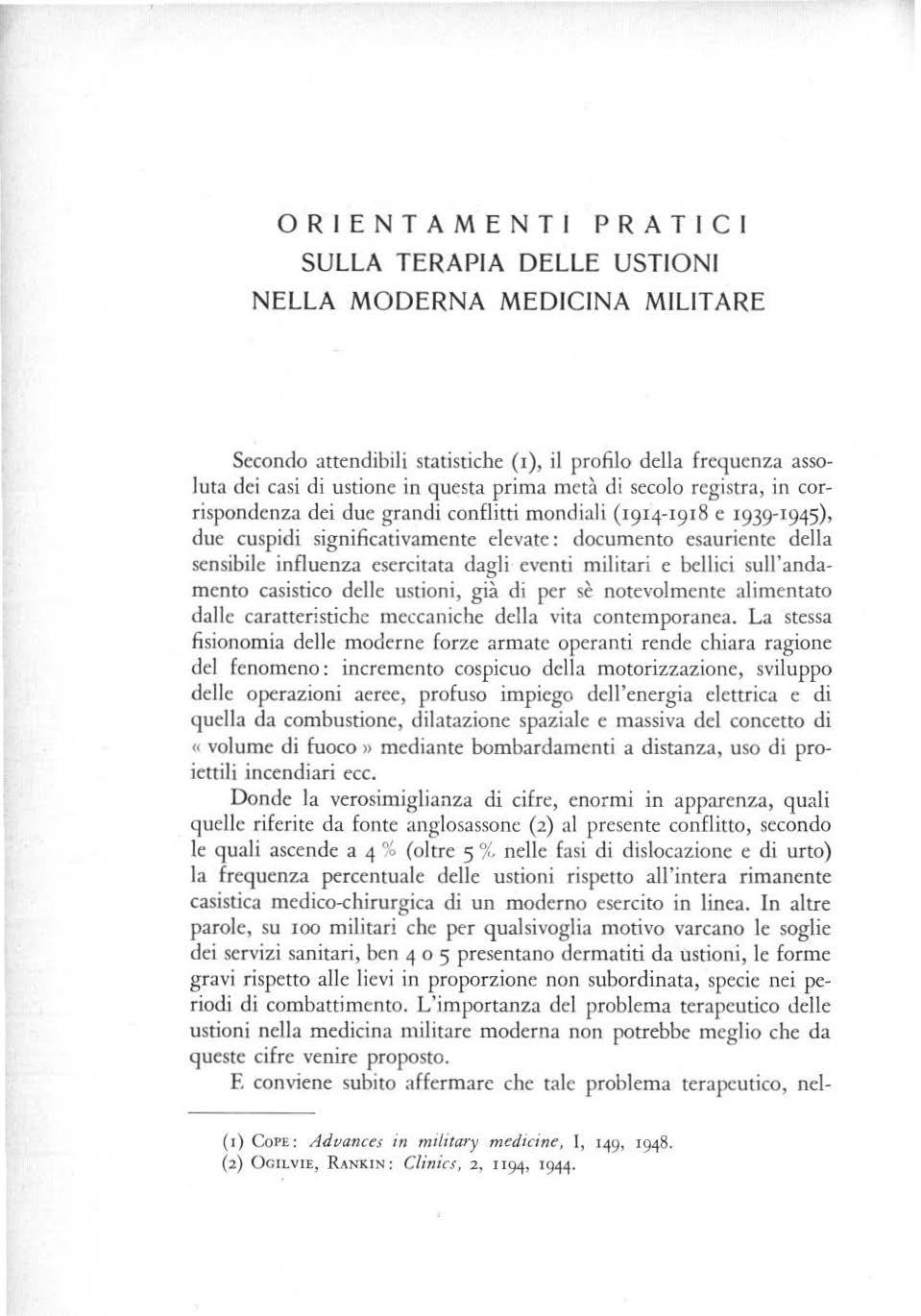
Donde la verosimiglianza di cifre, enormi in appar enza, qual i quelle riferite da fonte ang losassone (2) al presente conflitto, seco nd o le quali ascende a 4 (oltre 5 o/., nelle fasi di dislocazione e di urto) la frequenza percentual e delle ustioni ri spetto all'intera rimanente casistica medico-chirurgica di un moderno ese rcito in linea. In altre parole, su roo mi! itari ch e per qual sivoglia morivo varcano le soglie dei servizi sanitari, ben 4 o 5 presentano dermatiti da ustioni, le forme gravi rispetto all e l ievi in p r o porzione non subord in ata, specie ne i periodi di combattimento. L'importanza del problema terapeutico delle ustioni nella medicina militare moderna non potrebbe m eg lio che da queste cifre venire proposto.
E conviene subito affermare che t a le problema terapcutico, nel-
(1) CoPE: Advances in mtlitary medicine, l, 149, 1948.
(2) OctLVIE, RANKIN: Clinics, 2, n94, 1944·
l'ambiente mil itare, non si nei rapporti tra sanitari e ferito ma concerne un vaste e delicato prob lema d'organizzazione. Buona parte d elle prob abi lità di succesw nell'azione curativa dell'ustionato, la quale va intesa come terapi a di estrema urgenza, consiste nella precoc ità e nella tempestività dell'intervento sanitario: pr es uppone quindi una razionale impostazione del pronto soccorso.
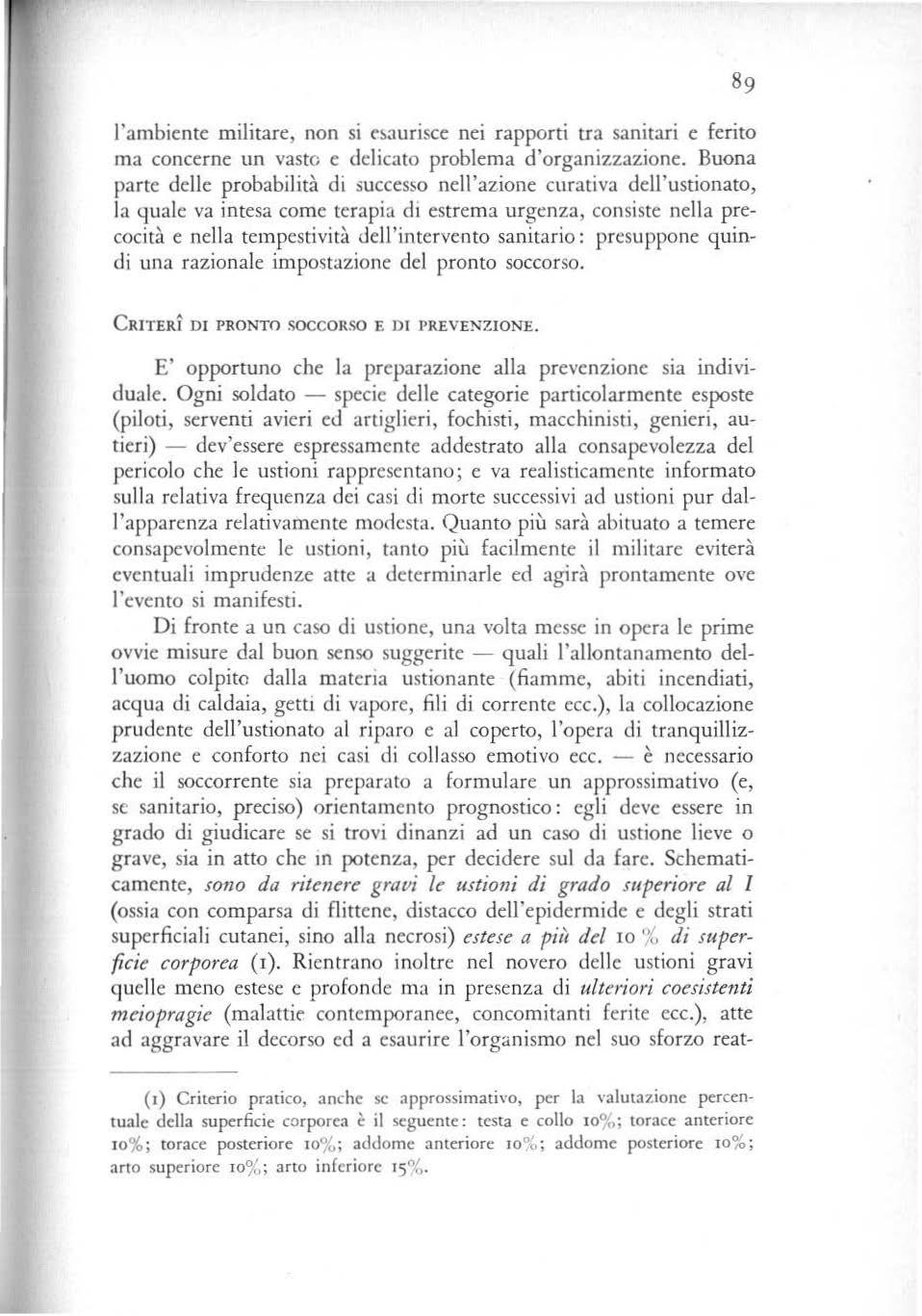
E ' opportuno che la preparazione alla prevenzione sia individuale. O gni soldato - specie delle ca tegorie particolarmente espos te (piloti, se rvenci avieri ed artiglieri, fochisti, m acc hini sti, genieri, autieri) - dev'essere espressame nt e addestrato alla co n sapevo le zza del pericolo che le ustioni r appresenta no; e va reali stica m e nte informato sull a relativa frequ enz a d ei casi di morte successivi ad u stio ni pur dall 'appa renza relativamente modesta. Quanto più sarà abit uat o a temere consapevolmen te le ustioni, tanto più facilmente il militare eviterà eventuali imprudenze atte a dete rmin arle ed agirà pronta m ente ove l'evento si manifesti.
Di fronte a un caso di u stione, una volta me sse in opera le prime ovvie m isure dal buon senso suggeri te - quali l'allontanamento dell 'uo mo colpito dalla matena ustionante (fiamme, abiti incendiati, acqua di caldaia, getti di vapore, fili di corrente ccc .), la collocazio ne prud ente dell'ustionato al riparo c al coperto, l 'o p era di tranquillizzazione e co nforto nei casi d i collasso emotivo ecc . - è necessario c he il socco rrente sia preparato a formulare un approssima tivo (e, se sa nitari o, preciso) ori entamento prognostico: eg li deve essere in grad o di giu dicare se si trovi dinanzi ad un caso di ustione lieve o grave, sia in atto che m po t enza, p er decidere sul da fare . Schematicamente, sono dc< ritenere gravi le ustio11i di grado supe riore al l (ossia co n comparsa di flittene, distacco dell'epidermide e degli strati superficiali cutanei, si no alla necrosi) estese a più del IO di sup erficie corporea (r). Rientran o i noltr e nel novcro d e ll e ustioni gravi quelle meno estese c profonde ma in presenza di ult eriori coesistenti meiopragie (malattie contemporanee, conco mit anti ferite ecc .), atte ad aggravare il d eco rso ed a esaurire l'organismo n el suo sfo rzo reat-
( 1) Criterio pratico, anche se approssima tivo, per la valutazione percen· tuale della superficie co rporea è il seg uente: testa e collo I0°, ; torace anteriore 10% ; torace posteriore 10° 0 ; addome anteriore 10°;, ; addome posteriore IO % ; arto superiore arto inf er iore 15";, .
CRITERl D I PRONTO SOCCORSO E DI PREV ENZIONE.
tivo di emergenza. Tale orientamento prognostico va formulato con rigore, indipendentemente dal momentaneo stato generale dell'ustionato, che nelle prime ore può essere a volte relativamente poco compromesso, con ingannevole antitesi tra gravità reale delle ustioni e risparmio apparente dello stato generale. Le ustioni lievi possono essere affrontate dai servizi sanitari di prima lirJea o di immediata retrovia. Le ustioni gravi reclamano l'immediato trasferimento a centri appositi preparati al trattamento delle ustioni gravi, nella retroguardia.
Le prime misure curative consistono in un'azione di detersione delle arce di dermatite da ustione, costantemente - e più nella casistica militare - inquinate. Sono indicate le medicazioni umide, blandamente disinfettanti, quali ad esempio i clorossidanti (5-ro %). Nelle ustioni di ! 0 grado l'immediata applicazione di clorossidanti ipertonici (10 % e oltre) può inibire la conversione successiva in dermatite di 2 " grado, con conseguente disepitelizzazione e notevole ritardo nella cicatrizzazione. La profilassi antitetanica è consentita (casi di tetano conseguente ad ustione sono tuttavia eccezionali), l'uso parco di analettici (dietilnicotamidici, feniletilaminici, caffeinici ccc.), opportuno. Nel caso delle ustioni gravi, l'azione detersiva ed una prima medicazione umida clorossidante è indicata, ma non conviene che essa rallenti o ritardi eccessivamente il trasporto del ferito al centro di cura definitivo . Nc1 casi in cui, per forza maggiore, il trasporto debba essere differito, sarà necessario ricorrere, d'anticipo, alla prevenzione del collasso mediante plasma o siero di sangue ovvero - in assenza di tali mezzi, che pure dovranno essere di estesissima, capillare dotazione alle forze armate - con soluzioni fisiologich e non colloidali (glucosio, cloruro e lattato di sodio, ad es.) e soluz10ni colloidali non fisiologiche (polivinilpirrolidone) (r). La dose si orienterà sulla pratica formula: 50 cc. per unità 0 b di superficie corporea lesa . L 'uso di analettici sarà, in tal caso, largo, associandovisi il trattamento corticosurrenale. Quello della morfina invece proscritto o molto prudente e guidato da condizioni di ad esempio ustioni da inalazione dclb glottide; crisi eretistiche del ferito, intrasportabile, sulla linea del fuoco. Ma in tali casi l'atteggiamento più razionale del sanitario periferico sarà la consapevolezza della propria impotenza
( 1) Nell'ambiente a ereo - na, al c si r e nde spe sso, per ra g io ni logi sti c he, co nveniente l ' u so delle albumine um a ne, più stahili c più con ce ntrabili ( e quindt di più agevole trasporto): va avvertito tuttavia c he il loro alto potere oncotico (25 gr. corrispondono a 450 rc. di pi:l sma) ne rende J lquanto mala gevole l'impi ego.
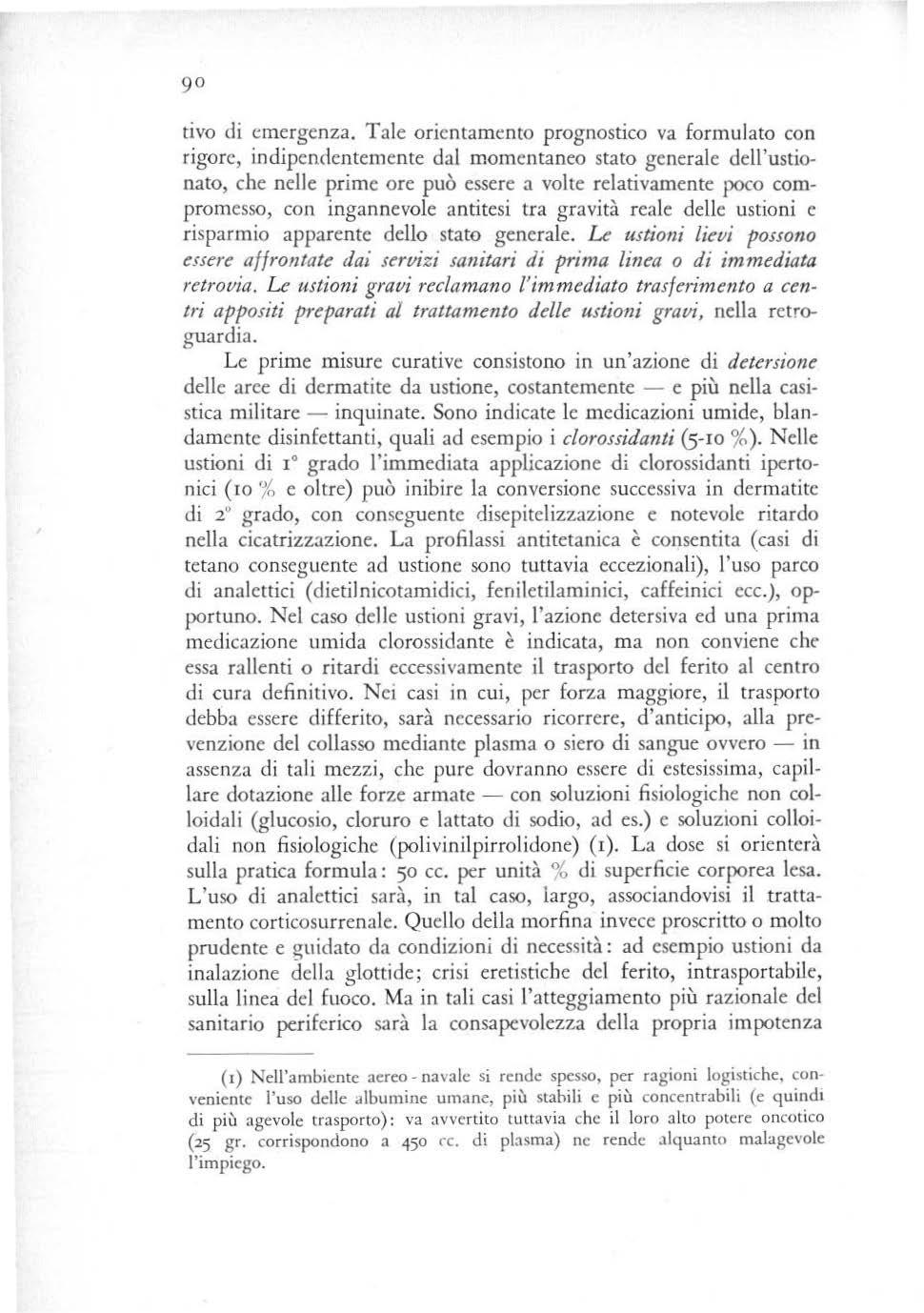
e lo studio del trasporto, più rapido e confortevole che sia possibile (autoambulanza, treno, aereo), al prossimo centro per il trattamento delle ustioni.
TRATTAMENTO DELLE USTIONI LIEVI.
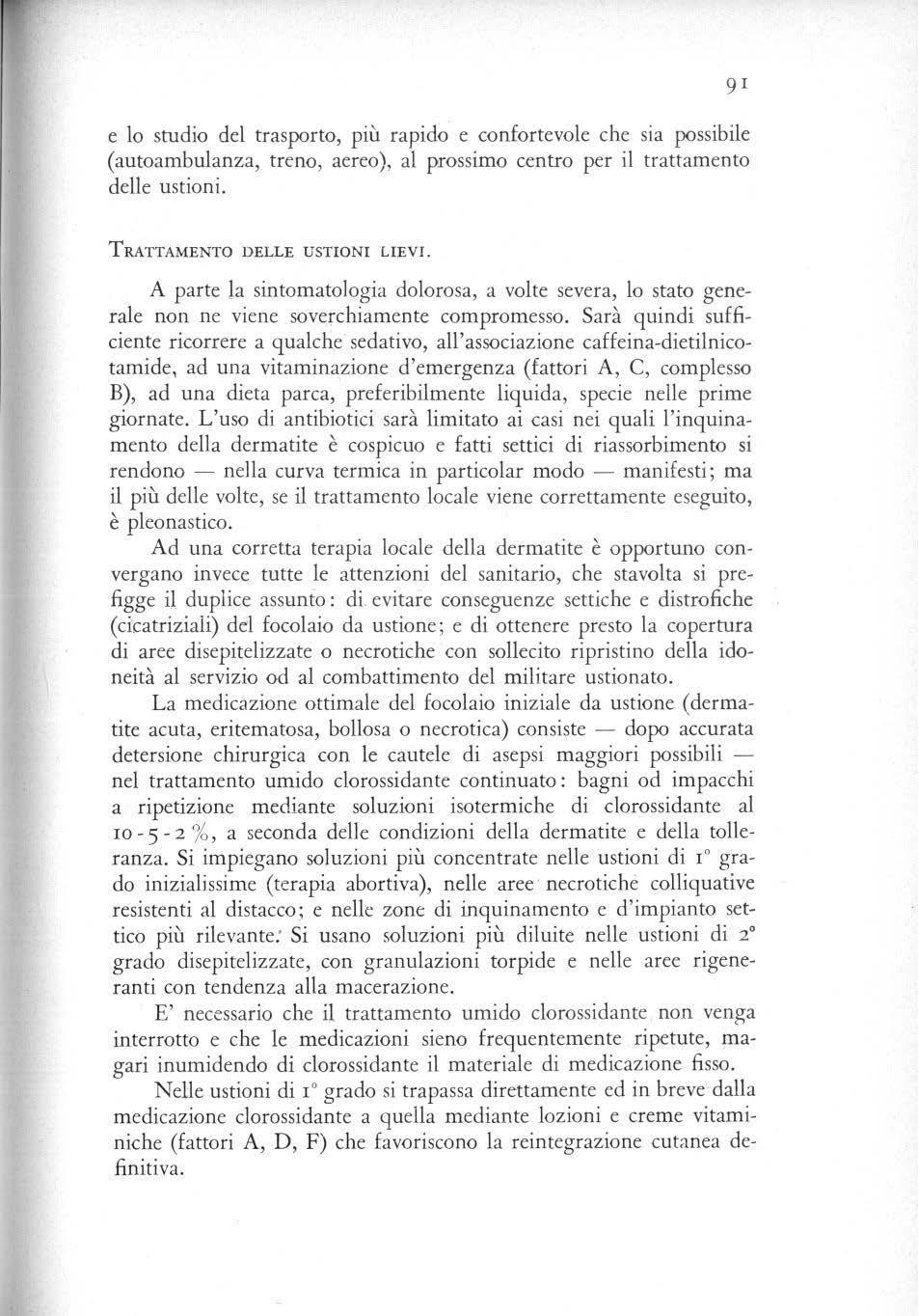
A parte la sintomatologia dolorosa, a volte severa, lo stato generale non ne viene soverchiamente compromesso. Sarà quindi sufficiente ricorrere a qualche sedativo, all'associazione caffeina-dietilnicotamide, ad una vitaminazione d'emergenza (fattori A, C, complesso B), ad una dieta parca, preferibilmente liquida, specie nelle prime giornate . L'uso di ant ibiotici sarà limitato ai casi nei quali l'inquinamento della dermatite è cospicuo e fatti settici di riassorbimento si rendono - nella curva termica in particolar modo - manifesti; ma il più delle volte, se il trattamento locale viene correttamente eseguito, è pleonastico.
Ad una corretta terapia locale della dermatite è opportuno convergano invece tutte le attenzioni del sanitario, che stavolta si prefigge il duplice assunto: di evitare conseguenze settiche e distrofiche (cicatriziali) del focolaio da ustione; e di ottenere presto la copertura di aree disepitelizzate o necrotiche con sollecito ripristino della idoneità al servizio od al combattimento del militare ustionato.
La medicazione otrimale del focolaio iniziale da ustione (dermatite acuta, eritematosa, bollosa o necrotica) consiste - dopo accurata detersione chirurgica con le cautele di asepsi maggiori possibilinel trattamento umido clorossidante continuato: bagni od impacchi a ripetizione mecliante soluzioni isotermiche di clorossidante al IO-5-2 'Yo , a seconda del l e condizioni della dermatite e della tolleranza. Si impiegano so lu zioni più concentrate nelle ustioni di I 0 grado inizialissimc (terapia abortiva), nelle aree necrotiche colliquative resistenti al distacco; e nelle zone di inquinamento e d'impianto settico piLJ rilevante .' Si usano so lu zioni più diluite nelle ustioni di 2° grado disepite l izzate, con granulazioni torpide e nelle aree rigeneranti con t endenza alla macerazione.
E' necessario che il trattamento umido clorossidante non venga interrotto e che le medicazioni siena frequentemente ripetute, magari inumidendo di clorossidante il materiale di medicazione fìsso.
Nelle ustioni di I 0 grado si trapassa direttamente ed in breve dalla medicazione clorossidante a quella mediante lozioni e crem e vitaminiche (fattori A, D, F) che favoriscono la reintegrazione cutanea definitiva.
Nelle ustioni di 2 ° grado si prosegue la medicazione clorossidantc sino a che il tessuto di granulazione formatosi (e del quale è spesso indicata una levigazione con sapienti toccature di nitrato d'argento, specie ai margini) non viene rivestito da epitelio. Si tr apassa quindi, anche stavolta - con o senza l'intermedio uso di polveri neutre eritrocitiche o antibiotiche - al massaggio per frizione di olii c creme epifilattiche.
Nelle ustioni di 3o grado occorre favorire il processo di distacco delle escare, regolando opportunamente la concentrazio ne ed il ritmo della medicazione clorossidante. Sul successivo tessuto di granulazione i! trattamento seguirà la traccia di quello delle ustioni di 2 ° grado, con l'avvertenza che fenomeni cheloidei successivi so no in questi casi molto più probabili e che per la loro prevenzione una particolare diligenza nello svolgimento del citato schema di trattamento può essere dirimente.
E' un assunto, questo, del trattamento delle ustioni lievi che, come appa r e, non è superiore alle possibilità di un'infermeria da campo bene fornita. Oc corre tuttavia osservare che le misure di terapia locale vanno eseguite con puntualità e cautela oltre che con la massi ma pulizia: l 'inquinamento cl elle les10ni ritarda la riparazione e ne deforma i caratteri.
TRA'rfAMENTO DELLE usnoNr GkAVI ( INTENSE ED ESTESE).
Vanno assistite con la massima prontezza e dedizione. Rapp rese ntano la sintesi clin1ca di cinq ue gruppi di momenti patogenetici correlati : dermatite, collasso, tossicosi, sepsi, distrofia, con diverso rilievo presenti nei singoli casi. A tale quintuplice concatenazione, sull a cui essenza fisiopatologica non è nostro tema addentrarci (r), possiamo schematicamente contrapporre un quintuplice ordme di misure curative: medicazione tòpicJ istofila, terapia con Cluidi, complemento microergico, biochcmioterapici, dieta (pentalogo di terapia istofila microergica, Come!):
- una corretta terapia tòpica è della massima importanza anche nei casi ovc la considerazione dell'imponente risentimento generale sembra porla in secondo ordine. La traccia è quella già delineata per le ustioni lievi, con l'avvertenza c he l'applicazione integrale deve essere stavolta, se mai, ancora più avveduta c diligente. In tale ma-
( 1) Cfr. E. U. M1ÀN: Cii nira e terapia delle rtstirmi , Vallecchi editore, Firenze, 1949·
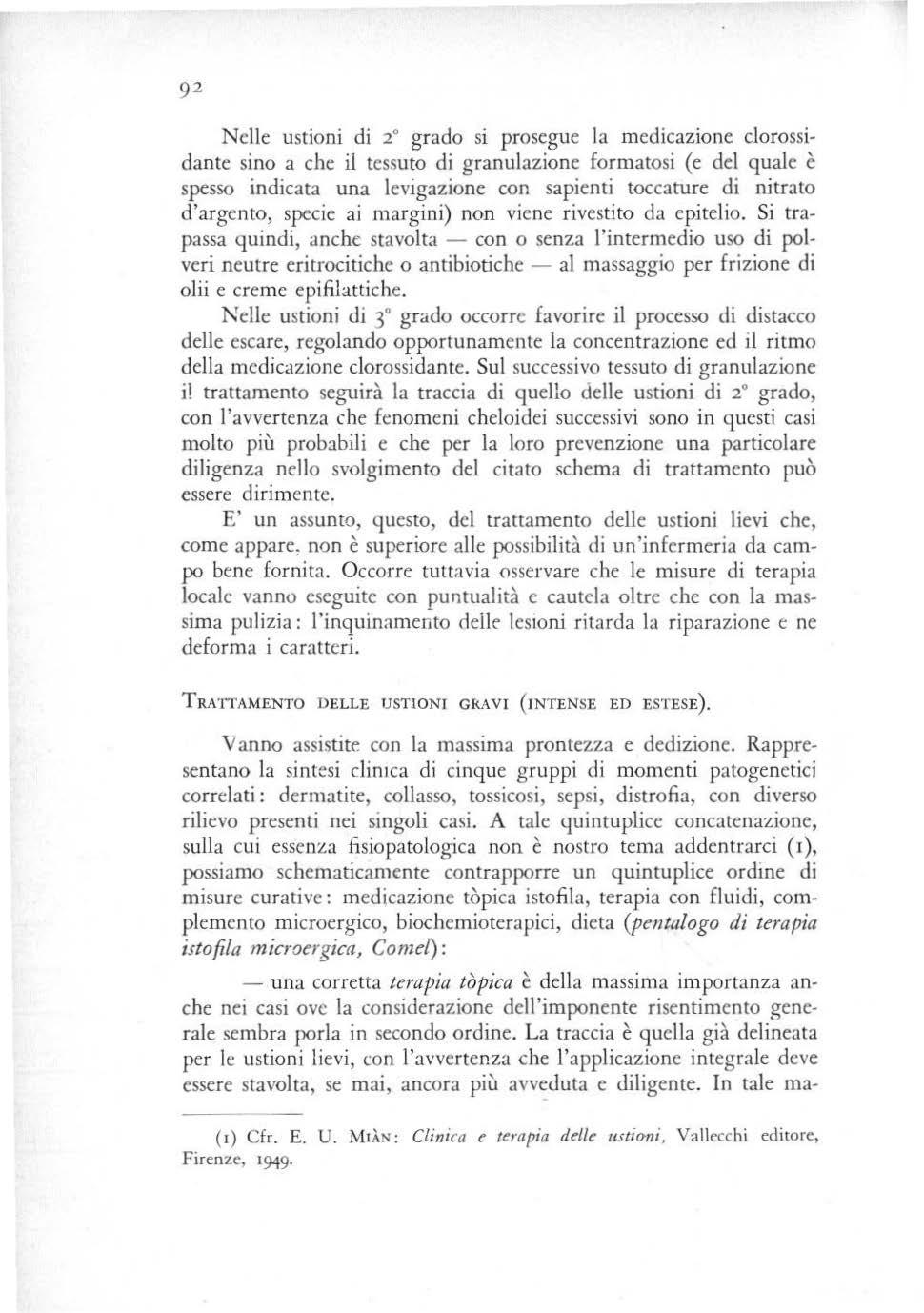
niera si rende possibile la detersione con tinua del focolaio, la sua sterilizzazione senza pericolo di ledere i tessuti colpiti (vedi antisettici forti), o di promuovere fenomenj di assorbimento tossico (v. tannizzazione) . Il mig liore influenzamento dello stato generale ed il decorso più favorevole della dermatite sono, a paragone della pur diffusa tecnica di fasciatura compressiva permanente (metodo K ochAllen), compenso adeguato della maggiore indaginosità Ove le circostanze lo coDsentano, trapianti precoci o tardivi, di competenza de l chirurgo plastico, si affiancheranno allo schema di medicazione citato;

il dispositivo della terapia con fluidi costituisce lo strumento moderatore dei fenomeni di collasso (neurogeno ed cxemico): consiste in una regolata massa di fluidi (p lasma e siero di sangue, soluzioru colloiòali fisiologiche , soluzioni fisiologiche non colloidali, acque oligometalliche, ossigeno) da somministrare per via trasfusionale, orale, rettale, ipodermoclitica, con molteplici intenti : restaurazione della crasi ematica e della massa circolante, controllo degli scambi • ematocontestuali, ripristino della diuresi, veicolo di principi alimentari.
Quantità, qualità ritmo c via di somministrazione sono definiti, sulla scorta del decorso clinico, da dati provementi dal Laboratorio : dalla proteinemia (il cui abbassamento è indice di deplezione azotata e di pre-collasso) nei confronti del siero e del plasma; dall'ematocrito (il cui aumento è indice di inspissatio sanguinis) nei confronti della componente idropinica; dalla riserva alcalina e da l livello ematico di elettroliti inorganici, rispetto alle soluzioni fisiologiche non colloidali. La terapia con fluidi deve tendere a l ripristino dei normali livelli ematici e con tale intento, con carattere eminentemente sostitutivo, viene rego lata Ovvia la necessità di eseguire - fin dove le circostanze lo consentano - l 'azione trasfusoria « d'anticipo )) rispetto al delinearsi dei fenomeni d i squasso;
- nel complemento microergico viene sintetizzato l'insieme dei presidì opoterapici, vitaminici e catalitici, impiegati neil 'i n tento di contrastare la componente tossiemica della « malattia-ustione>>. L ' efficacia dell'uso di determina t i preparati epatici, di estratti d'interrenale, di fattori vitaminici (A, complesso B, C, P, K particolarmente) gode in tal senso di una già esauriente documentazione;
- i biochemiotempici vengono contrapposti ai processi settici, di origine cutanea o endogena, atti a complicare ed a rendere il decorso vicppiù severo. L a scelta cadrà, a seconda dei germi in causa,
93
su diversi a ntibio tici; segnatamente sulla penicillina , il cu1 unpiego anche preventivo è raccomandabile per le modalità istofi.le della sua azione, o sulla streptomicìna, attiva anche su germi penicillino-resistenti (coli, proteo, piocianeo) frequenti ospiti del focolaio di ustione inquinato. Più prudentemente conviene ci si astenga altresì dall'uso delle sulfonarnidi, meno tollerate;
- la dieta è strumento validissimo nel correggere le deviate intonazioni metaboli che che, nel corso dell'ustione grave, si rendono manifeste. Iniz ialmente la dieta, lattea e liquida di rigore, viene ad ingranare nel citato dispositivo della terapia con fluidi . Superato il periodo dell'incombente collasso si trapassa gradatamente a diete più nutrienti, concepite secondo criteri di risparmio dei visceri rimasti maggiormente meiopragici nella loro funzionalità, in seguito al co lla sso ed alla tossicosi iniziale. Il Laboratorio fornisce anche in questo campo dati preziosi, nello svelare gli aspetti più alterati ed abnormi del ricambio, nel porre in evidenza situazioni carenziali ed oligoemich e, altrimenti latenti.
Dai cenni sopra riportati appare come di essenziale importanza per una efficace condotta nel trattamento delle ustioni sia l'armonico congegno dell 'organizzazione d'assistenza . Dal commilitone bene addestrato alle prime misure di soccorso, al primo nucleo d'assistenza sanitaria (detersione asettica delle ferite, me dicazione topica, trasfusione preventiva, cure sintomatiche), alle operazioni di trasporto ai centri retrostanti, al trattamento definitivo (corretta ed integrale esecuzione del citato pentalogo di terapia), alla collabora zione tra servizi al letto del malato e servizi di Laboratorio, la catena deve articolarsi snoda ta, senza inceppi e rallentamenti. Giacchè tanto sorpre ndenti e miracolosi a volte possono essere i successi di una terapia ben condotta dal principio alla fine, quanto irrimediabili possono r iuscire gli errori eventualmente intercorsi nell'organico svolgimento del sistema di cura: errori riferiti a male intesa « terapia » loc ale (linimento oleocalcare e altri unguenti no civi), a male accorta va lu tazione prognostica (e conseguente fatale ritardo nelle misure di prevenzione del collasso e d ella to ssiemia), ad errori d! trattam ento (dosaggio erroneo di diete, medicamenti, fluidi, per carente o imperita valutazione dei reperti di L aboratorio).
E' necessario che la Sanità Militare sia in grado di organizzare in maniera efficiente tale congegno di assistenza, di dotare con ricchezza i dispositivi adibiti a tale còmpito (copioso materiale di medi-
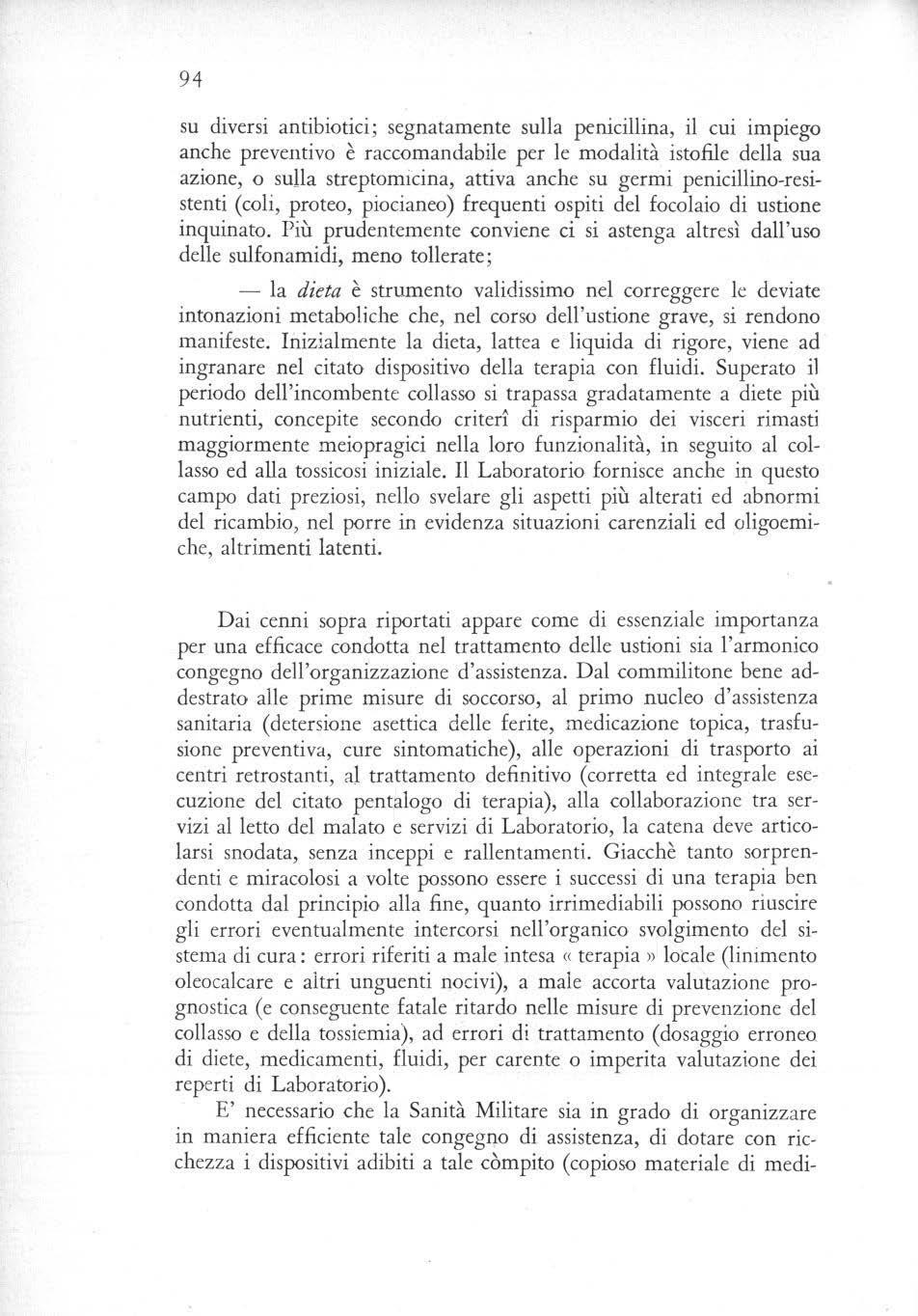
94
cazione e trasfusione, coordinamento di trasporti, ampio ricorso a reperti di Laboratorio), c di evitare con ogni vigilanza gli errori terapcutici, con la puntuale istruzione di tutti i membri partecipi del piano di assistenza.
N. B. - Non viene espressamente considerato l'argomento dd trattamento delle ustioni successive a deflagra1ioni atomiche, soggetto ancora ad !ncompiuta elaborazione sperimentale.
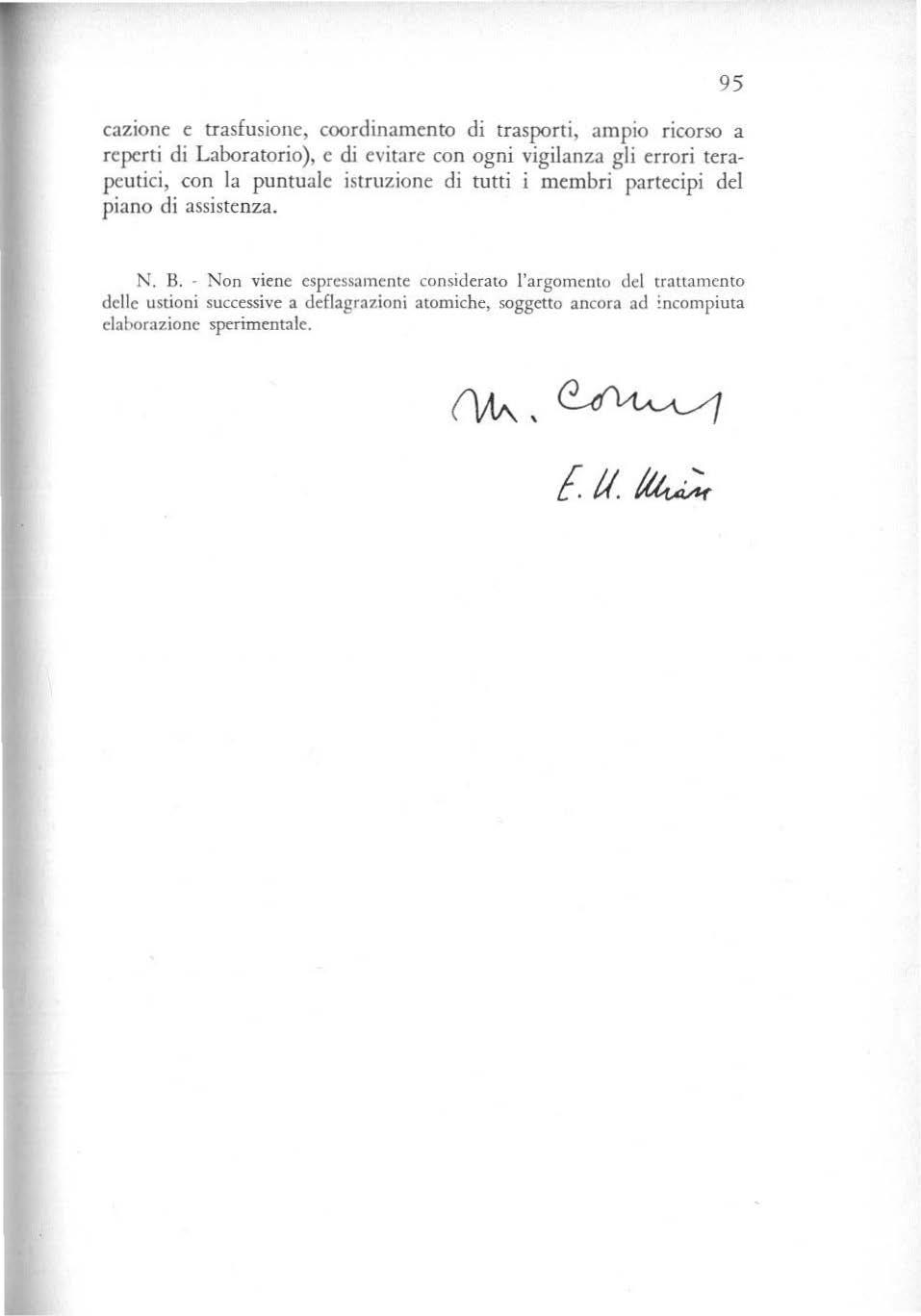
95
L ' ORGANIZZAZIONE SANITARIA
NEI VARI PAESI DEL MONDO
Nel primitivo abbozzo di sanità civ il e che ebbe a sorgere all'a lba dei tempi dalla moltitudine iniorme di individui e di famiglie, è c hiaro che la prima attività di Governo tosse pe rt inente alla giustizia e conseguentemente all'ordine interno.
M a tale inte r vento ha due fondamentali aspetti: quello della sicurezza fisica dell'individuo e quello della garanzia de l possesso dei be ni materiali. Necessariamente venne a poco a poco a prendere fisionomia propria, nell'attività stessa di Governo, quel complesso di funzio ni intese ad assicurare la sicurezza del corpo, cioè la salute, bene fondamentale presupposto di t utti gli altri, che ancora oggi sono base di ogni pubbl ica amm inistrazione sanitaria.
T ale principio costituisce con chiara uniformità il fondamento degli or gani e delle ist ituz ioni che se pur diversamente disciplinati sono espressioni delle mo l tepl ici Amministrazioni di Sanità Pubblica nei diversi Paesi del mondo. Pertanto, d'intesa con il Ministero degli Esteri, l'Alto Com m issariato ha vo luto condurre a tal fine una i n chiesta per trovare l'esistenza di questo denominatore comune nelle varie Amministrazioni Sanitarie.
Confo rm eme nt e alia genesi comune cd allo svi luppo, nel corso dci secoli, dell'intervento in tale materia dello Stato, inteso questo come emanazione dell'interesse e d ella volontà della società organizzata, è poss ibi le identificare nei confronti della Sanità Pubblica alc un i t ipi-base di organizzaz ione, riflettenti appW1to i vari st adi da essa attraversati durante il suo lento sviluppo. Anzitutto ritroviamo i n tutte le N az ioni con un analogo grado di evo l uzione sociale uno stesso tipo di Organizzazione Sani t aria con base comune di interve nto contro le m alattie cosiddette esotiche e pertanto le prescritte quarantene ed u n a specifica X.lione con t ro l e malattie i nfettive, donde le norme di profilassi e di prevenzione ru dimenta li all 'inizio, sempre più perfezionantisi di poi con lo sviluppo delle Nazioni st esse.

Variazioni dunque qualitative e quantitative della assistenza sanitaria pubblica, che potremmo definirla in questi casi della sanità collettiva, nei Paesi classificabili quali primitivi nei quali la medicina è tuttora nella fase magico-religiosa senza alcuna parvenza di organizzazione sanitaria vera e f!Opria.
Costituisce que5to un primo tipo ancora rudimentale di orga· ni zzazione, nel quale cioè non si è manifestata la diffen.:nziazione dal nucleo del potere amministrativo centrale anche perchè in tali Paesi l'evoluzione politico-sociale non ha raggiunto la fa se di piena maturità democratica.
Ciò è più palese se si consideri che il presuppos.to per la detta enucleazione è l'indispensabile decentramento delle funzioni, tanto più spinto quanto maggiore è il senso di autogoverno c di consapevole responsabilità dei singoli cittadini.
Tuttavia, non sempre questo parallelismo si realizu così assiomaticamente in quanto, sotto la spinta di fattori vari, per lo più di natura politica e comunque non direttamente condizionanti la sanità e l'igiene, si determina a volte una polarizzazione di speciali interessi et erogenei attorno all'esercizio della tutela della salute pubblica, tale da risolversi in una organizzazione a struttura morfologicamentc decentralizzata alla quale non fa riscontro una analoga funzionai ità .
11 decentramento allora non risponde ad esigenze di ordine tecnico bensì di natura o politica o politi co-amministrativa in prevalenza.
Un diverso tipo di organizzazione sanitaria è identificabile in quelle Nazioni che hanno, insieme ad un livello civile elevato, una struttura sociale ben differenziata, ma priva di vero equilibrio stabile nei rapporti di composizione quantitativa.
In questo secondo gruppo di Nazioni l'Organizzazione della Sanità Pubblica o risent e in parte del mancato raggiungimcnto della piena espressione democratica, Gvvero, anche se questa è stata raggiunta, permane ad una fase precedente di transizione non adeguata al nuovo assetto. Tale mancato adeguamento che perdura nel tempo mn grave ost:tcolo per la efficacia funziona le dell'organizzazione, -costituisce un serio danno per essa se pur vada lentamente modificandosi in molti Stati moderni.

Infine, in un terzo gruppo di Nazioni, il più numeroso, vige il tipo di Organi zzazio ne sa nitaria che potrebbe dirsi perfetto, in quanto più evoluto sia nella struttu r a, sia nelle funzioni.
La rispondenza tra decentramento politico- amministrativo e decentramento tecnico non limita il potere sanita rio centrale nelle
97
7
sue prerogative di coordinamento e di superiore guida, ma nemmeno condiziona la proficua iniziativa degli organismi periferici ai quali è lasciata la più consapevole e responsabile autonomia funzionale.
Si realizza in questo terzo tipo di Organizzazione sanitaria uno stab ile equilibrio tra 1'intervento della comunità e la libertà del singolo nelle questioni concernenti sia la medicina sociale, in genere, sia la medicina assistenziale e mutualistica propriamente detta, :lnche nella forma di medicina curativa. E' il tipo di organizzazione sa nitaria attuato nelle grandi democrazie europee e nord- americane nelle quali il potere centrale esercita accanto all'azione vigilatrice ispettiva anche quella promotrice in base però al principio di non sostituirsi all'iniziativa locale bensì dì creare le condizioni per il fiorire della iniziativa, mediante la compartecipazione attiva e consapevole dei singoli. Ciò spiega l'importanza assunta dall'azione educatrice, intesa a dare all'individuo la coscienza igienica e quindi l'interesse nella compartecipazione all'esercizio della pubblica.

Da quanto sopra potrebbe dedursi che salvo poche ecceziom l'intervento attivo, specialmente finanziario, dello Stato in tal materia è inversamente proporzionale al livello democratico-sociale della più parte della popolazione ed in funzione anche della capacità di essa.
Una disamina più particolareggiata dell'assetto dell' Organizzazione Sanitaria nei vari Paesi varrà a meglio lum eggiare quanto sopra.
Vi sarebbe però da considerare, prima, un quarto tipo di organizzazione, tipo che potrebbe dirsi futuro, ma che è già attuale in vista dell'attività svolta dall'O.M.S. in campo internazionale. Difatti, già alcuni aspetti dell'assistenza della Sanità Pubblica possono considerarsi giunti a perfezione sotto il punto di vista della universalizzazione di essi. Così le statistiche delle cause di morte, elaborate dall'O.M.S. ed adottate dalla qu!:si totalità degli Stati membri. Ciò consente quella omogeneità indispensabile dei dati per la proficua comparabilità di essi. Un altro aspetto che ha già raggiunto la uniformità pratica è quello attinente ai se rvizi quarantenari i quali attualmente sono ispirati a nonne pressocchè universa lmente accettate e che tendono ad un continuo perfezionamento sotto il punto di vista della sempre crescente necessità di adeguare le misure quarantenarie a tale celerità ed al progresso della conoscenza scientifica. La costituzione di una Farmacopea Internazionale i cui studi sono in stato di avanzato lavoro stanno a confermare questa tendenza a regolamentare in senso internazionale alcuni in1portanti problemi sanitari.
Tale spinta alla universalizzazionc dei servizi fondamentali della Sanità Pubblica tende a riportare questa ad uno stato uniforme che, sia pure evolutosi e sviluppatos1 enormemente nei mezzi tecnici e nei modi di applicazione pratica, riattinge nella essenza profonda i motivi fondamentali che ne hanno determinato la nascita e condizionato lo sviluppo: ciò, giova ripeterlo, in funzione di quel bene sovrano ed immutabile, da difend ere e da salvaguardare in ogni tempo , che è la salute, intesa nella più vasta accezione della parola, vale a dire, secondo la definizione dell'O.M.S., lo stato di benessere fisico, mentale e sociale di ogni uomo.
Ciò premesso, passando all'esame del primo tipo di organizzazion e sanitaria, è facile rilevare in esso che la differenziazione tra l'attività sanitaria propriamente detta cd il nucleo dell'attività politico- amministrativa interna del Governo non ha ancora raggiunto quella precisione di rapporti che caratterizza invece gli altri stadi di maggiore evoluzione.
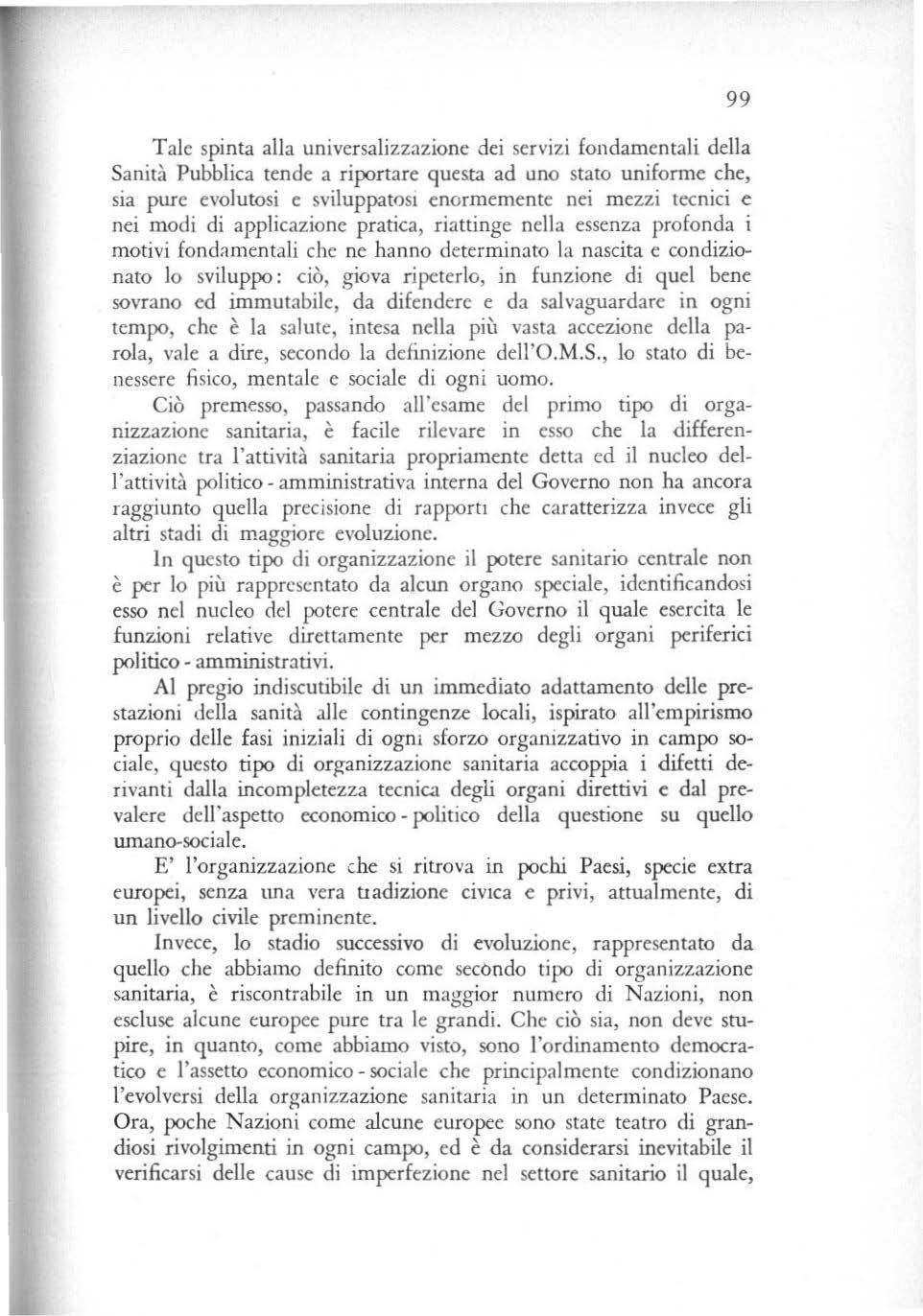
In questo tipo di organizzazione il potere sanitario centrale non è per lo più rappresentato da alcun organo speciale, identificandosi esso nel nucleo del potere centrale del Governo il quale esercita le funzioni relative direttamente per mezzo degli organi periferici politico- amministrativi.
Al pregio indiscutibile di un immediato adattamento delle prestazioni della sanità alle contingenze locali, ispirato all'empirismo proprio delle fasi iniziali di ogm sforzo orgaruzzativo in campo sociale, questo tipo di org-anizzazione sanitaria accoppia i difetti derivanti dalla incompletezza tecnica degli or gani direttivi e dal prevalere dell'aspetto economico - politico della questione su quello wnano-sociale.
E' l'organizzazione che si ritrova in pochi Paesi, specie extra europei, senza una vera ttadizione civ1ca e privi, attualmente, di un livello civile preminente.
I nvece, lo stadio successivo di evoluzione, rappresentato da quello che abbiamo definito come secòndo tipo di organizzazione sanitaria, è riscontrabile in un maggior numero di Nazioni, non escluse alcune turopee pure tra le grandi. Che ciò sia, non deve stupire, in quanto, come abbiamo visto, sono l'ordinamento democratico e l'assetto economico- sociale che principalmente condizionano
l'evolversi della organizzazione sanitaria in un detenninato Paese. Ora, poche Nazioni come alcune europee sono state teatro di g randiosi rivolgimenti in ogni campo, ed è da considerarsi inevitabile il verificarsi delle cause di imperfezione nel settore sanitario il quale,
99
in quanto tecnico, ha insita una certa inerzia nell'adattarsi sollecitam ente alle variazioni richieste dal mutare degli eve nti economicopolitici, ai quali si adeguano invece sollecitamente le altre st rutture statali non squisitamente tecniche come la Sanità.
I n questo caso esiste se m pre un organo centrale sanitario che varia nella deno m inazione, nella estensione dei poteri, nei rapporti di dipendenza dell'ordinamento governa t ivo del quale quasi se mpre fa parte integrante.
P er qua nto concerne la denominazione, essa rispecchia per lo più le condizio ni funzionali, più che struttura i i, del l'o r gano centrale stesso, accentuandc n e anche formalmente lo stadio di tranquillità .
I n queste Nazioni, il concetto di dem<X:razia nel campo sociale non ha a ncora pienamente permeato di sè tutti gli strati della popolazion e ma è, potrebbe dirsi, una prerogativa di molt i m a non di tutti , così c he non em erge ancora alla cosc ienza naziona le b incongruenza, e a volte l'anacronismo delle istituzioni superate, m e ntre la loro conseguente inefficienza viene spesso attribuita er ratamente a cause intrinseche.
L'esigenza dell'adeguamento di tutti gli orga n i e di tutte le istituzioni de ll o Sta to ai pri ncipi del decentramento democratico anche nel ca mpo tecnico si attm di rego l a spo ntaneam e nt e in quelle Nazioni n ell e quali il metodo democratico è convi ncim en to assiom:nico di ogni cittadino.

In tali "Nazioni si attua il tipc di Organizzazione sanitaria che abbiamo definito co m e terzo.
Altr a cara tteri stica differenziante i vari tipi sop radd etti è la cstendci po t eri attribuiti agli Organi sanitari.
Qu esta difatti è in lin ea generale t anto meglio delimitata quan to più evo luto è il tipo di Orga n izzazio ne In vero, soltanto nelle Nazioni più progredite si realizza la distinzione, anch e nel campo pratico o ltre che in qu ello teorico, tra le n ri e forme nelle quali può estrinsecarsi l 'in terve nto ass istenziale della collettività n eg li int eressi dell'individuo.
Nel quadro comp lesso della assiste nza sociale possiamo distinguere infatti quell a c he è l 'ass istenza sanitaria veram ent e detta, che si esplica attraverso l e prestazioni della medicina preventiva, di quell a profilattica e di qudla curativa, nonchè quella c he è l 'assistenza p revidenzia le che si estri nseca attrav er so le istituzio n i a base mutualistica ed assicurativa.
L ' una si esplica in soccorso de!ruomo malato e, soltanto in parte, a beneficio dell ' uomo sano; mentre l'altra si limita ad alle-
100
viare i bisogni materiali e morali dell'uomo sano inteso non come individuo bensì come parte della società organizzata. Ebbene, noi vediamo come tale differenziazione si palesi con maggiore evidenza pratica là dove la evoluzione d eli 'Organizzazione sanitaria ha raggiunto il massimo grado mediante distinte attribuzioni dell'una e dell'altra forma di assistenza ad organismi differenti facenti capo a Ministeri diversi.
Tratteggiato così a grandi linee la genesi e gli stadi evoìutivi dell ' Organizzazione sanitaria , appare utile ora accennare alla attuale situazione delle più importanti Nazioni del mondo, specialmente allo scopo di cogliere il parallelo con la schematizzazione innanzi fatta e trovare delle citazioni esemplificative che illustrino i concetti già esposti.
Nell'Arabia Saudita , per esempio, la di stinzione d ei servizi sanitari è fatta praticamente solo a livello del potere centrale, nel senso che esiste una Direzione Generale di Sanità (Al Niabah) che ha sede a La Mccca e che dipende direttamente dal Gabinetto del Vicerè, mentre alla periferia i compit1 non sono distinti mediante attribuzioni ad organi tecnici specifici. .
Nella Russia Sovietica, invece, si ha una differenziazione formale esatta tra attività sanitaria ed attività politico- amministrativa di Governo, sia al centro, dove esiste il Ministero della Sanità, sia alla periferia, dove funziona una bene organizzata rete di istituzioni per la erogazione di tutte le forme di assistenza sociale.
Anche n eli 'Un ione delle Repubbliche Sovietico-Socialiste lo Stato, e per esso il Ministero della Sanità, interviene minutamente nell'::tpplicazione pratica deJb Sanità pubblica ed il servizio è disciplinato alla stessa stregua di quello postale o ferroviario.
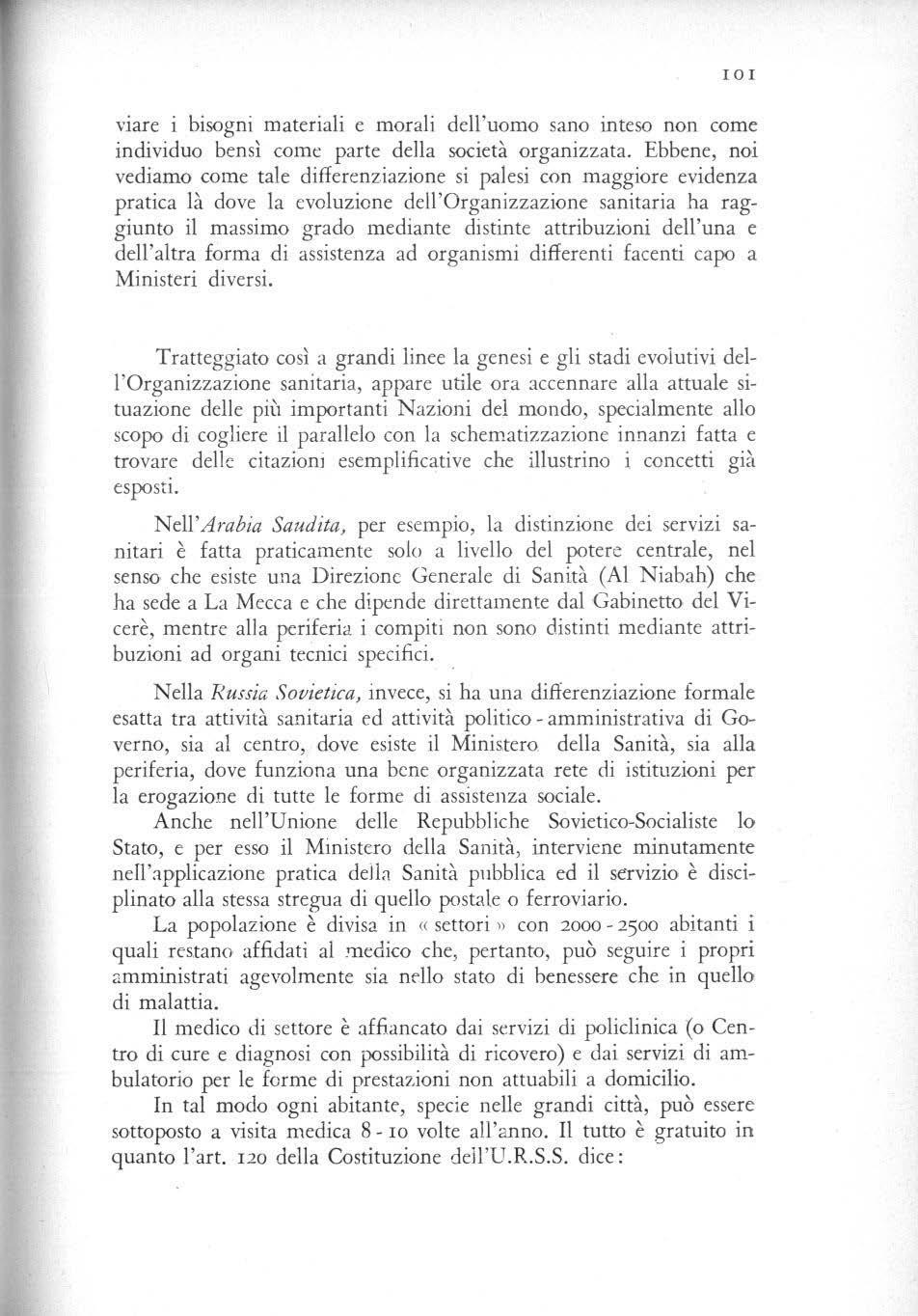
La popolazione è divisa in « settori 11 con 2000-2500 abitanti i quali restano affidati al .rncdico che, pertanto, può seguire i propri amministrati agevolmente sia ne-llo stato di benessere che in quello di malattia.
Il medico di settore è affiancato dai servizi di policlinica (o Centro di cure e diagnosi con possibilità di ricovero) e dai servizi di ambulatorio per le forme di prestnioni non attuabili a domicilio.
In tal modo ogni abitante, specie nelle grandi città, può essere sottoposto a visita medica 8- IO volte all'anno. Il tutto è gratuito in quanto l'art. 120 della Costituzione dell'll.R.S.S . dice:
IO!
« I cittadini deii'URSS hanno diritto ai mezzi materiali di assistenza per la vecchiaia, nonchè in caso di malattia e di perdita della capacità lavorativa >1.
Questo diritto è assicurato dall'ampio sviluppo delle assicurazioni sociali degli impiegati e degli operai a spese dello Stato, dalla assistenza medica gratuita ai lavoratori, dalla vasta rete di stazioni di cura che è messa a disposiziont> dei lavoratori stessi.
Oltre al sistema generale dell'assistenza medica specializzata gratuita alla popolazione, neii 'U RSS esiste un p1ccolo numero di policlinici non gratuiti e di altre istituzioni di cura gestiti dagli istituti superiori, dagli istitu ti di ricerche scientifiche, ecc .
In questi Istituti gli ammalati possono rivolg ersi ad ogni medico, secondo i propri bisogni, indipendentemente dal luogo di residenza.
Nell'URSS è stata pure ammessa l a pratica medica privata a domicilio. Comunque, dato che la cura degli ammalati è assicurata al completo dagli Istituti del Commissariato o Mini ste ro della Sanità Pubblica, gli isti ruti di cura a pagamento e la pratica medica privata non hanno avuto un sensibile sviluppo.
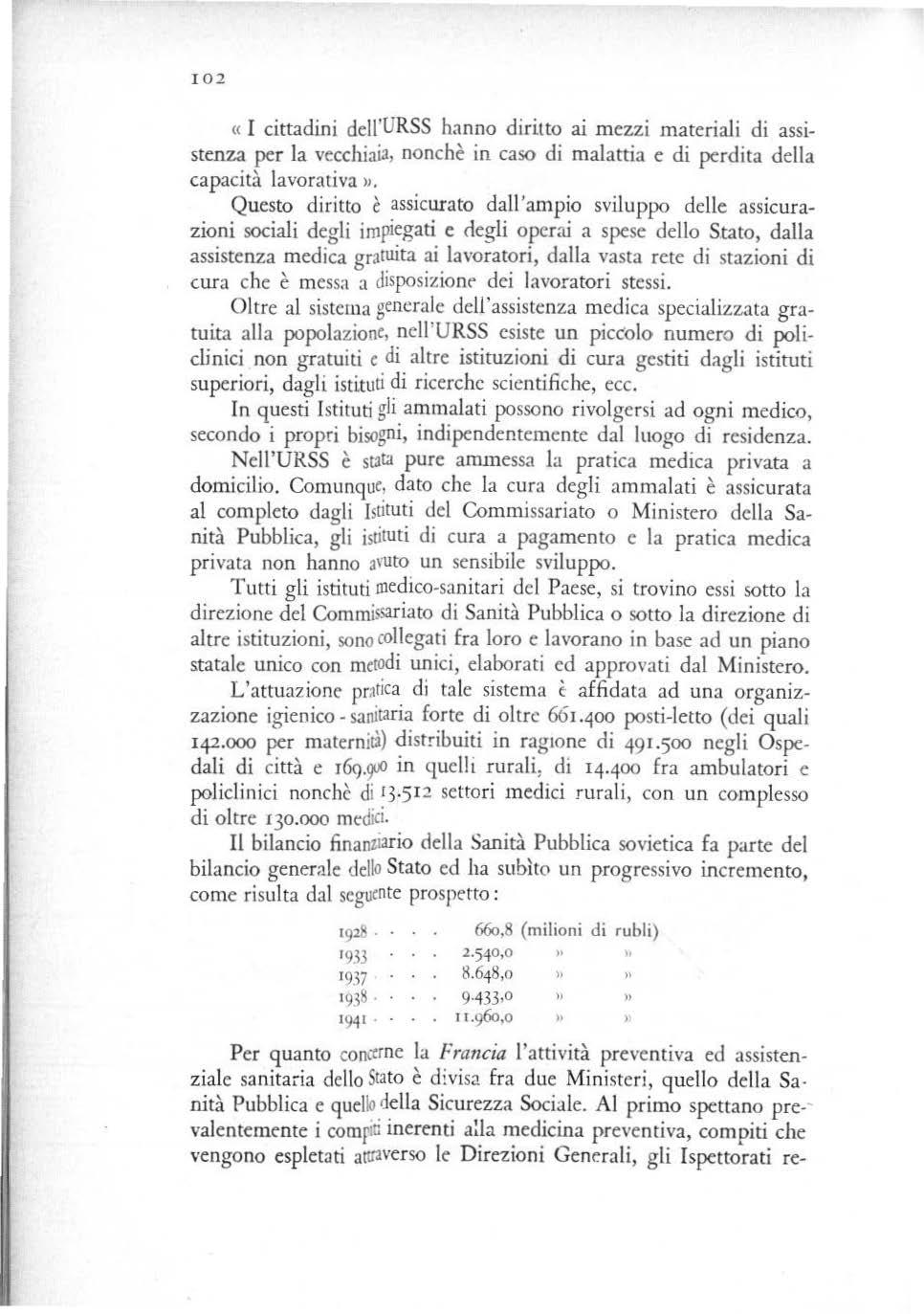
Tutti gli istituti 01edico-sanitari del Paese, si trovino essi sotto la direzione del di Sanità Pubblica o sotto la direzione di altre istituzioni, sono co llegati fra loro e lavorano in base ad un piano statale unico con metodi unici, elaborati ed approvati dal Ministero.
L'attuazione pratica di tale sistema è affidat a ad una organizzazione igienico- sanitaria forte di oltre 661.400 posti-letto (dei quali If2.000 per rnatern i!à) distribuiti in ra grone di 49 1.500 negli Ospedali di città e in quelli rurali , di 14.400 fra ambulatori e policlinici nonch è di 13-51:2 setto ri medici rura l i, con un complesso di oltre qo.ooo me dici.
Il bilancio finan ztario della Sanità Pubblica sovietica fa parte del bilancio generale dello Stato ed ha subìto un progressivo incremento, come risulta dal seguente prospetto:
Per quanto la Francia l'attività preventiva ed assistenziale sa nitaria dello Sta to è di visa fra due Mini steri, quello della Sa · nità Pubblica e quello della Sicurezza Sociale. AJ primo spettano prevalentemente i comr:ri inerenti aUa medicina preventiva, compiti che vengono espl etati anraverso le D irezioni Generali, gli Ispettorati re-
102
192 66o,8 (m ilioni di rubli) 19B l-540,0 8.648,0 )) )) 9·433>0 l ) )) 194 1 •r 4io.o "
gionali ed i medici dipartimt·ntali, mentre al Ministero della Sicurezza Sociale spettan o 1 compiti inerenti alla medicina previdenziale p. d. e relative prestazioni.
Questa non riguarda, peraltro, i grandi problemi igienico- sanitari a carattere nazionale, quali per es., la tbc., a risolvere i quaLi intervengono coordinatamente parecchi org:mi centrali.
Perifericamente, sono i medici comunali ad applicare le provvidenze, sotto la diretta responsabilità delle Autorità locali sanitarie.
Una complessa legislazione regola le fasi della profilassi e dell'intervento assistenziale con le varie prestazioni in favore dei lavoratori inabilitati da malattie, da infortunio, da vecchiaia, come pure per g ravidanza e per disoccupazione involontaria.
Lo Stato, pertanto, interviene direttamente nel mantenimento della salute dei cittadini, ma non tota lm e nte, in quanto solo i lavoratori in gene.re possono fruire d1 tali benefici, m e ntre parte della popolazione deve provvedere con i propri me zzi alla conservazione ed al miglioramento della propria salute .
Nel Belgio l'Arnministrazi!Jne delia Sanità è affidata al Ministero della Sanità Pubblica e della F allllglia.
Alla periferia, esistono Commissioni di assistenza pubblica che sono, per legge, comunali e provvedono all'assistenza in favore dei non abbienti e alla sorveglianza sull'organizzazione ospedaliera pubblica. Nella loro attività vengono controllate dal Consiglio comunale, dal governatore della Provincia e dal Mini stero della Sanità.
Esiste un'organizzazi one denominata « Fondo nazionale di assic urazione malattia cd invalidità » che dipende dal Mini stero della Previdenza sociale.
L 'assistenza antitubercolare in tutto il Pa ese è gratuita per tutti gli iscritti al suddetto fondo nazionale e per i non abbienti.
Lo Stato provvede anche al mantenimento di una rete di dispensari antivenerei, ove si procede alla diagnosi ed alla cura gratuita di tali malattie in favore di tutti i cittadini, e sovvenziona centri per la lotta contro i tumori maligni.
Il bilancio ordinario del Ministero della Sanità Pubbli ca e della per l'esercizio 1949 è s tato di franchi belgi 1.253·6o7.ooo
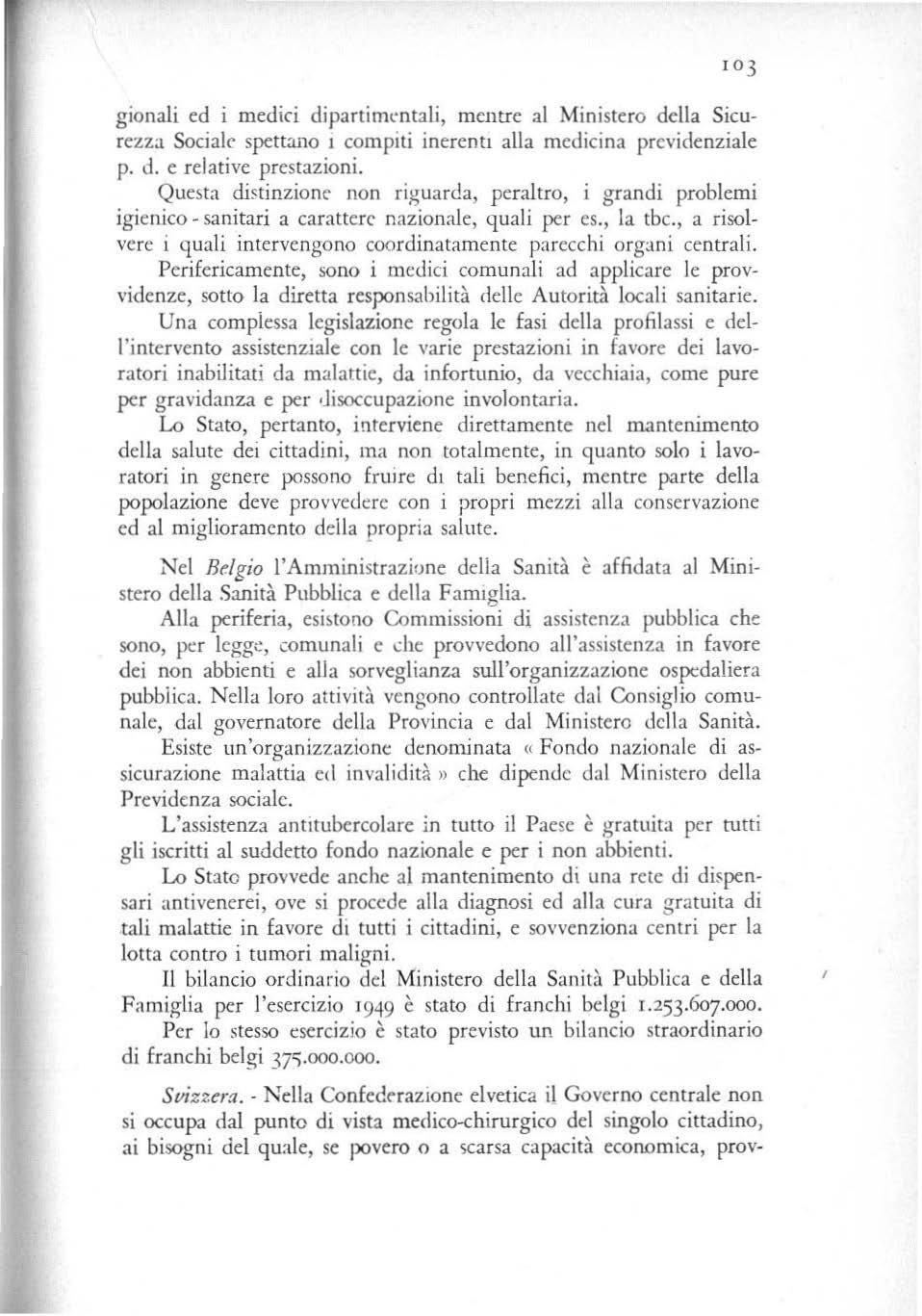
Per lo stesso esercizio è stato previsto un bilancio straordinario di franchi belgi 37').000.000.
Svizzera. -Nella Confeè<"raziOne elvetica il Governo centrale non si occupa dal punto di vista medico-chirurgico del singolo cittadino, ai bisogni àel quale, se povero o a scarsa capacità economica, prov-
103
vedono il Municipio ::> ti Governo cantonale, medtante le rispettive organizzazioni ospedalicre c dispensanali
Fa eccczio'le sanatoriak per la tubercolosi la quale, essendo di portata nazionale, è curata dal Governo Federale, ma sempre indirettamente, mediante le autorità sanitarie locali.
L'individuo è quindi costretto in ge n ere a provvedere con i p r o-pri mezzi a]le spese per il recupero della propria salute e soltanto in parte trova nella collettività ufficiale quell'aiuto che gli viene offerto, spesso, dalrassociazione spontanea di nuclei locali paesani o cittadini
Tale sistema poggia su una organizzazione largamente decentralizzata in modo da conferire la massima possibilità di attività alle Autorità comunali alle quali è più facile conoscere i bisogni della popo lazione, specialmente lavoratrice, variabile da 7-0na a zona.
L'Ufficio delle Amministrazioni sociali Sl occupa della materia inerente alla medicina assistenziale in occasione di ma lattia e di infortunio nonchè di vecchiaia, di vedovanza c di morte di genitori (servizio orfani minon:nni) gestendo i fondi relativi a tali voci.
L'Ufficio predetto, e quello parallelo dell'industria per la protezione anche assicurativa ed assis tenziale dei lavoratori, dipendono dal :Yfimstero deil'economia pubblica.
Un organo speciale, l'Ufficio di guerra per l'assistenza, di recente istituzione, predi!opone ed attua, sempre indirettamente e tramite le Autorità sanitarie centrali e comunali, !e misure social i imposte da ll a guerra e consistenti in assicurazioni sociali, igiene, servizi sa n itari di frontiera, assistenza ai profughi, rimpatri, opere sociali e danni di guerra compresi quelli di o r dine sanitario.
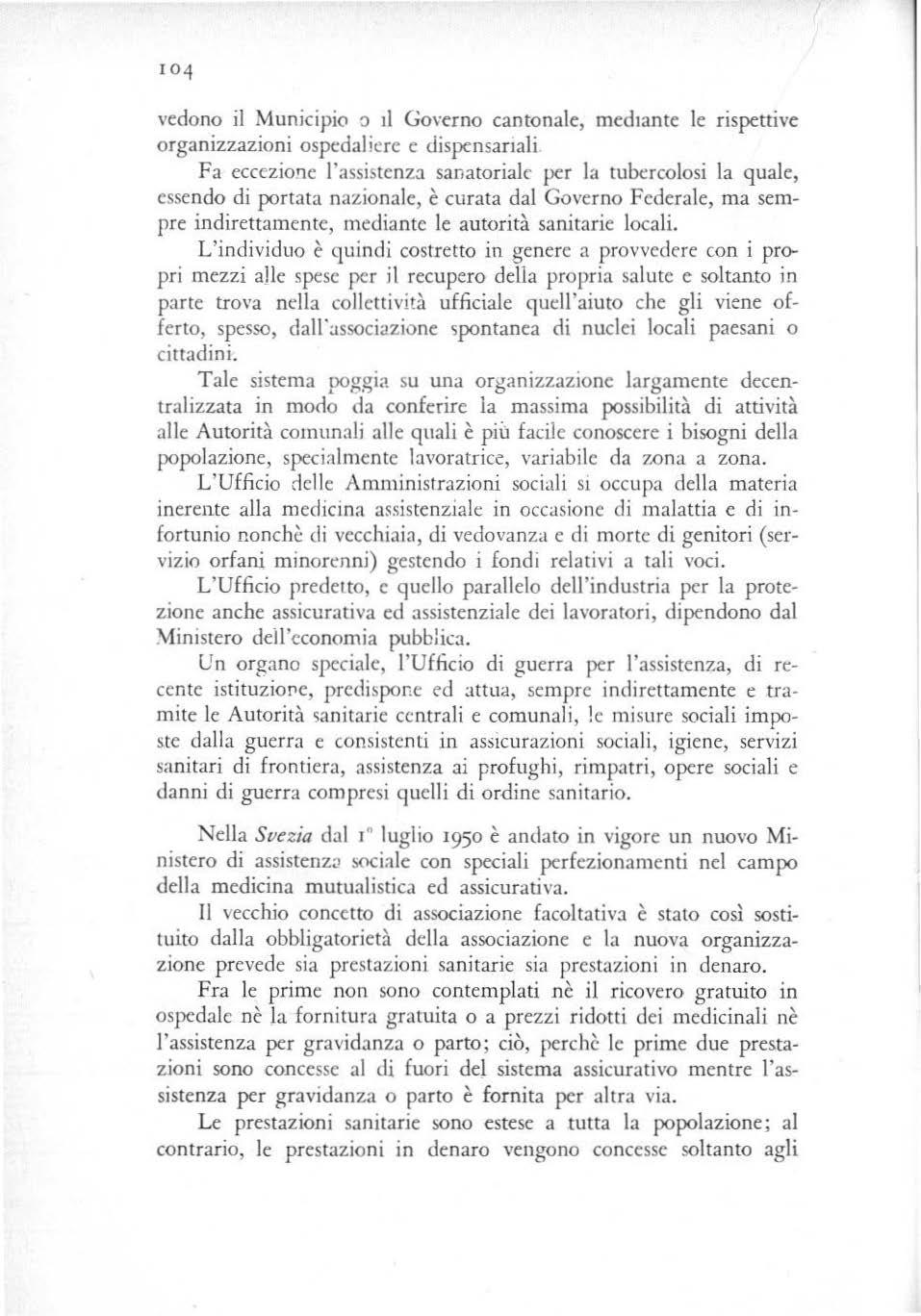
Nella Svezia dal 1 ° luglio 1950 è andato in vigore un nuovo Ministero di assistenz;1 wciale con speciali perfezionamenti nel campo della medicina mutualistica ed assicurativa
Il vecchio concetto di associazione facoltativ:1 è stato sostituito dalla obbligatorietà della associazione e la nuova organizzazio n e prevede sia prestazioni sanitarie sia prestazioni in denar o .
Fra le pri m e non so n o contempl ati nè i l ricove r o grat u ito in ospedale nè Ja fornitura gratuita o a prezzi ridotti dei medicinali nè
l'assistenza per gravidanza o parto; ciò, perchè le prime due prestazioni sono concesse al di fuori del sistema assicurativo mentre l'assistenza per gravidanza o parto è fornita per altra via
L e prestazioni sanitarie !>Ono estese a tutta la popolazione; al contrario, le prestazioni in denaro vengono concesse soltanto agli
iscritti a1le casse malattia i quali abbiano un reddito lavorativo di 6oo corone.
E' utile sottoiineare che le prestazioni sanitarie coprono il 75 % delle spese per le cure mediche, ivi comprese le eventuali spese di viaggio del medico curante e del paziente.
Le prestazioni in danaro sono invece rappresentate da una indennità di malattia.
Per ogni malattia è previsto, ai fini della concessione deJla relativa indennità, un periodo di scadenza di tre giorni nonchè una durata massima di erogazione di 730 giorni per la stessa malattia.
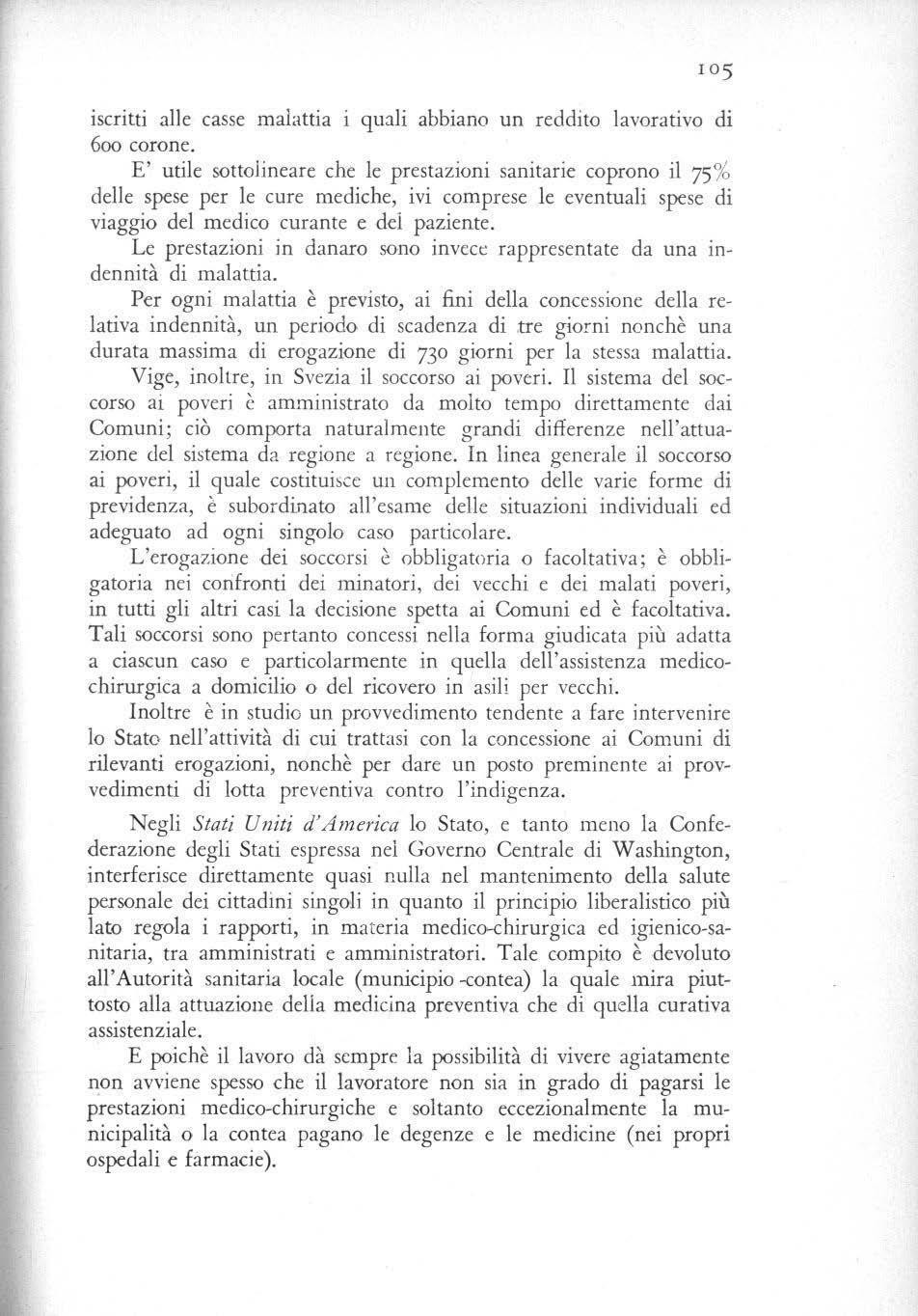
Vige, inoltre, in Svezia il soccorso ai poveri. Il sistema del soccorso ai poveri è amministrato da molto tempo direttamente dai Comuni; ciò comporta naturalmente grandi differenze nell'attuazione del sistema da regione a regione. In linea gener::tle il soccorso ai poveri, il quale un complemento delle varie forme di previdenza, è subordinato all'esame delle situazioni individuali ed adeguato ad ogni singolo caso particolare.
L'erogazione dei soccorsi è obbligatoria o facoltativa; è obbligatoria nei confronti dei minatori, dei vecchi e dei malati poveri, in tutti gli altri casi la decisione spetta ai Comuni ed è facoltativa.
Tali soccorsi sono pertanto concessi nella forma giudicata più adatta a ciascun caso e particolarmente in quella dell'assistenza medicochirurgica a domicilio o del ricovero in asili per vecchi .
Inoltre è in studio un provvedimento tendente a fare intervenire lo Stato nell'attività di cui trattasi con la concessione ai Comuni di rilevanti erogazioni, nonchè per dare un posto preminente ai provvedimenti di lotta preventiva contro l'indigenza
Negli Stati Uniti d'America lo Stato, e tanto meno ]a Confederazione degli Stati espressa nel Governo Centrale di Washington, interferisce direttamente quasi nulla nel mantenimento della salute personale dei cittadini singoli in quanto il principio liberalistico più lato regola i rapporti, in materia medico-chirurgica ed igienico-sanitaria, tra amministrati e amministratori. Tale compito è devoluto all'Autorità sanitaria locale (municipio -contea) la quale mira piuttosto alla attuazione della medicina preventiva che di quella curativa assistenziale.
E poichè il lavoro dà sempre la possibilità di vivere agiatamente non avviene spesso che il lavoratore non sia in grado di pagarsi le prestazioni medico-chirurgiche e soltanto eccezionalmente la municipalità o la contea pagano le degenze e le medicine (nei propri ospedali e farmacie) .
L'iniziativa di singole associazion i mutualistico-assistenziali h a in tal modo larga possibilità di sviluppo. Stato e Confederazione, quando intervengono, lo fanno con erogazioni alle contee o ai municipi, senza specifica destinazione dei fondi erogati.
Per quanto concerne igienico- sanitaria vari organi, alle dipendenze del Governo Confederale, regolano la materia.
Da essi dipendono i varii servizi specia li co me quelli per l'igiene scolastica, l'assistenza alla maternità e infanzia e per il bilancio igienico- sanitario della propaganda.
La legge fondamentale è quella denominata « Social Security Act » nell'ambito della quale il (< Children's Bureau >> presiede in modo particolare a quanto la maternità e l'infanzia.
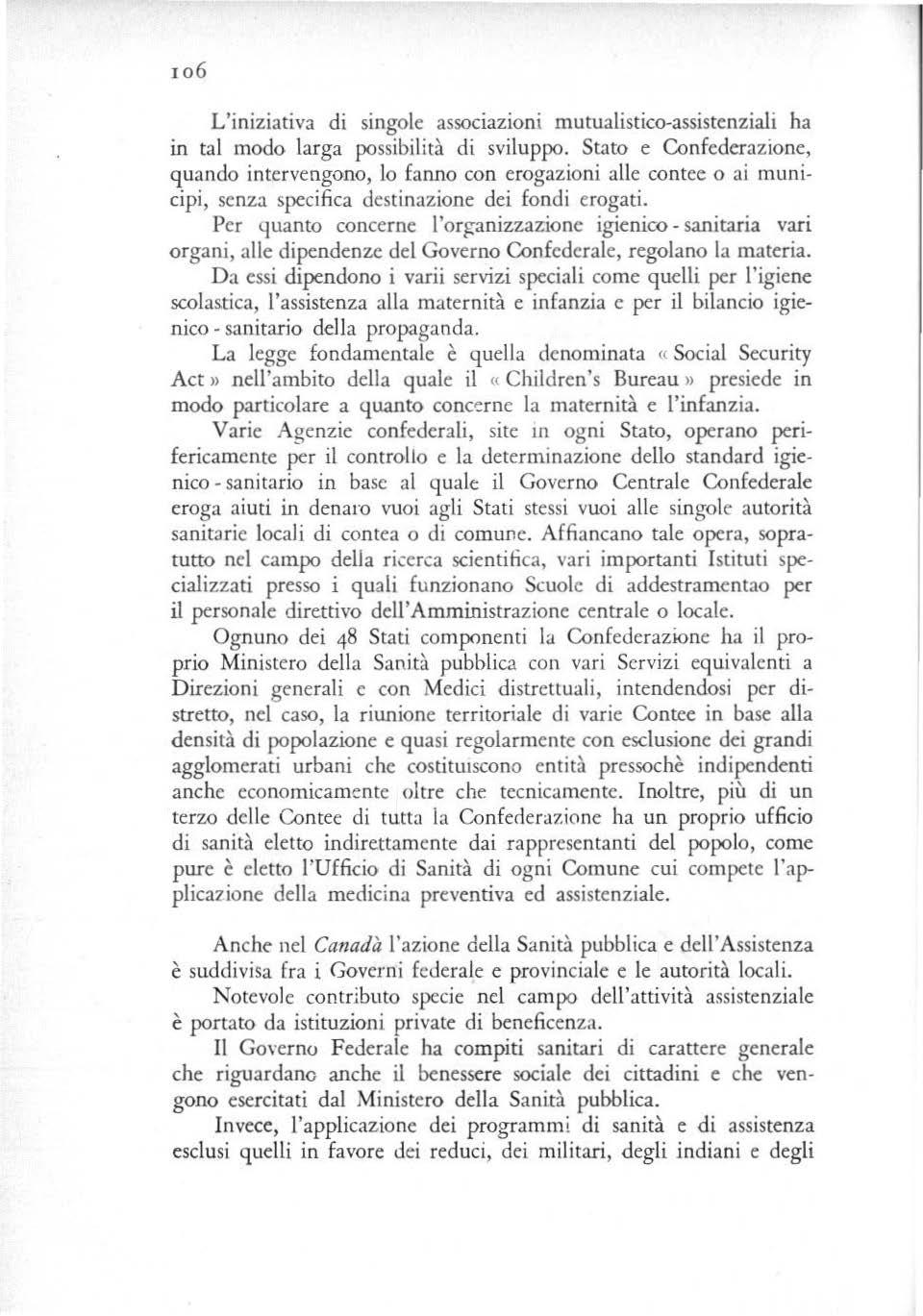
Varie Agenzie confederali, site m ogni Stato, operano perifericam ente per il controllo e la determinazione dello standard igienico - sanitario in base a l quale il Governo Centrale Confederale eroga aiuti in denaro vuoi agli Stati st essi vuoi alle singo le autorità sanitarie local i di contea o di co mun e . Affiancano tale opera, sopratutto nel campo della ricerca scientifica, vari importanti Istituti specializzati presso i quali funzionano Scuol e di addestramentao per il personale direttivo dell'Amministrazione centrale o locale.
Ognuno dei 48 Stati componenti la Confederazione ha il proprio Mini stero della Sanità pubblica con vari Servizi equivalenti a Direzioni genera li c con Medici distreuuali, intendendosi per distretto, nel caso, la riunione territoriale di varie Contee in base alla den sità di popolazione e quasi regolarmente con esc lusion e dei grandi agglomerati urbani che costitmscono entità pressochè indipendenti anche oltre che tecnicamente. Inoltre, più di un terzo delle Contee di tutta la Confederazione ha un proprio ufficio di sanità eletto indirettamente dai rappresentanti del popolo, come pure è eletto l'Ufficio di Sanità di ogni Comune cui compete l'applicazione della medicina preventiva ed assistenziale.
An che nel Canadà l'azione della Sanità pubblica e dell'Assistenza
è suddivisa fra i Governi federale e provinciale e le autorità locali.
Notevole contributo specie nel campo dell'attività assistenziale
è portato da istituzioni private di beneficenza.
Il Governo Federale ha compiti sa nitari di carattere generale che riguardano anche il benessere sociale dci cittadini e che vengono esercitati dal Mini stero della Sanità pubblica.
Invece, l'applicazione dei programmi di sanità e di assistenza esclusi quelli in favore dei reduci, dei militari, degli indiani e degli
J06
eskimo, è di competenza dci vari Governi provinciali che si avvalgono in quest'opera della collaborazione delle autorità locali.
Sono previsti stanzia menli di bilancio da parte del Governo Federale in favore Jellc singole province su una base unitaria per ogni abitante, al fine di rendere possibile l'attuazione di un vasto piano assistenziale e previdenziale e la soluzione di problemi più particolari quali quello della tubercolosi, la costruzione di nuovi ospedali, l'addestramento di personale medico e di assistenza, sussidi alle varie società di beneficenza, ecc.
I n varie province è già attuata l'assistenza medica ed ospedaliera grat u ita per alcune categorie di cittadini.
I n tutto il Paese esistono centri organizzati dai Governi locali per la diagnosi e la cwa gratuita delle malattie veneree. E' stata anche iniziata di recellle la costituzione di istituti per la lotta contro altre malattie sociali
Per quel che riguarda l'organizzazione dal punto di vista amministrativo essa risulta costituita dal Ministero della Sanità pubblica e dell'A ssistenza coadiuvato da un Consiglio di Sanità che si interessa specialmente dei rapporti con le Amministrazioni sanitarie provinciali. Il Consiglio è composto dal Vice ministro della sanità, dai dirigenti i servizi sanitari provinciali e da cinque membri aggiunti.
Nelle province poi vi sono le Unità sa nitarie, con un direttore e personale medico e di assistenza, che vengono distribuite su una o più contee (ad es. la provincia di Quebec che comprende 74 contee ha 63 Unità secondarie).
Spese per la Sanità pubblica e l'Assistenza per il 1947 sono state:

Assegni familiari . Lst.
Pensioni di vecchiaia . l>
Pens ioni per i ciechi . n
Stanziamenti per il fondo di « benessere fisico 11 !>
Stanziamenri per le scuole di lavoro sociale >l
Amrr.inistrazione dei Servizi di •·
Ammini straz:one dei Servizi di Sanità "
Stanziamcnti vari »
Spese amministrative . H
Spese dei Governi Provinciali:
Pensioni per ,·ecchiaia
Assistenza sanitaria ( medica osped. igienica)
Beneficenza
Altre spese .
254· 14L000
43-830.000
r.615.ooo
150.000
9l'i·ooo
1 .s57.ooo
6. II].000
w6.ooo
446.ooo
Lst. 299·358.oòo
LsL 21.300.000
)) 63·400.000
l> 6.300.000
)) 24-700 000
Lsr. 115·700.000
107
In linea generale è da notare c h e le spese del Governo Federale canadese sono di mo lto superiori a quelle delle due amministrazioni provinciale e locale riunite (Federazione 76 'Yo, Provinciale r6 %, Municipale 8 %) e questo, malgrado che l'assistenza e la previdenza sociale siano per la maggior parte al di fuori delle sue competenze.

Come espressione di recente organizzazione unificata ma che ha dato prove di efficienza, giova citare quella dello Stato di Israele. In esso tutti i servizi sono affidati a l Ministero della sanità che è articolato su 8 Direzioni generali concernenti la Sanità, la T ecnica, le Professioni mediche, la Sanità per le mjnoranze, la M edicina sociale, l'Igiene e la Medicina preventiva , le Farmacie e la Malaria, nonchè su altri uffici relativi alla biostatistica, al personale, ecc. Al centro il Ministero avvale anche dell'opera di Commissioni tecniche speciali.
Alla periferia vi sono gli Uffici sanitari distrettuali che, pur collaborando con le Autorità loca l i, politico- amministrative, dipendono però direttamente dal Ministero.
Questi uffici si occupano della vigilanza igienico- sanita ria- c della profilassi nelle zone di loro competenza territo ri ale.
Nel Paese esistono organizzazioni assistenziali e previdenziali che vengono denominate « Fondi per malati >> (Sick Funds) a cui risulta iscritto circa il so % della popolazione.
Il bilancio del Ministero della Sanità è stato proposto ·nella misura di due milioni di lire d'Israele (una lira di I sraele equivale a 3 dollari americani) per quello ordinario, più un bilancio straordinario di Lst. 1.2oo.ooo per la costruz ion e di nuovi ospedali e gli aiuti agli impiegati.
Le spese del bilancio ordinario sono cosl ripartite:
ro8
Municipali: Centri metropolitani Centri urbani minori Zone rurali L st. )) )) 23·700.000 18.400.000 9 300.000 Lst. 51.4oo .ooo
Spese
Spese amministrative Lsr. 71.000 3·5% Laboratori centrali )) 27.000 1,4% Uffici sanitari di strettuali >) 126.ooo 6, 3% OspeJali generali . , 012.000 30,6 % Ospedali psich iatrici )) 141.000 7 O/ o A riportare Lsr. 977·000
Sanatori
Sovvenzioni ospedali non govern::ttlvl
Sovvenzioni altre anidtà san itarie
Rette ospedali non governativ i (tbc.)
Servizi epidemiologici ed anùmalarici
Ambulatori villaggi arabi Materiale
Inghilt erra. - Dal 5 luglio 1948 è in atto, sebbene con qualche:: difficoltà di ordine economico ed in parte organizzativo, l'intervento diretto dello Stato che si è assunto il servizio medico- chirurgico e specialistico per tutti i cittadini poveri c ricchi dietro pagamento di una tassa annua, esigua rispetto alla mole delle prestazioni fornite e pari a circa Lit. 120 alla settimana pro capite.
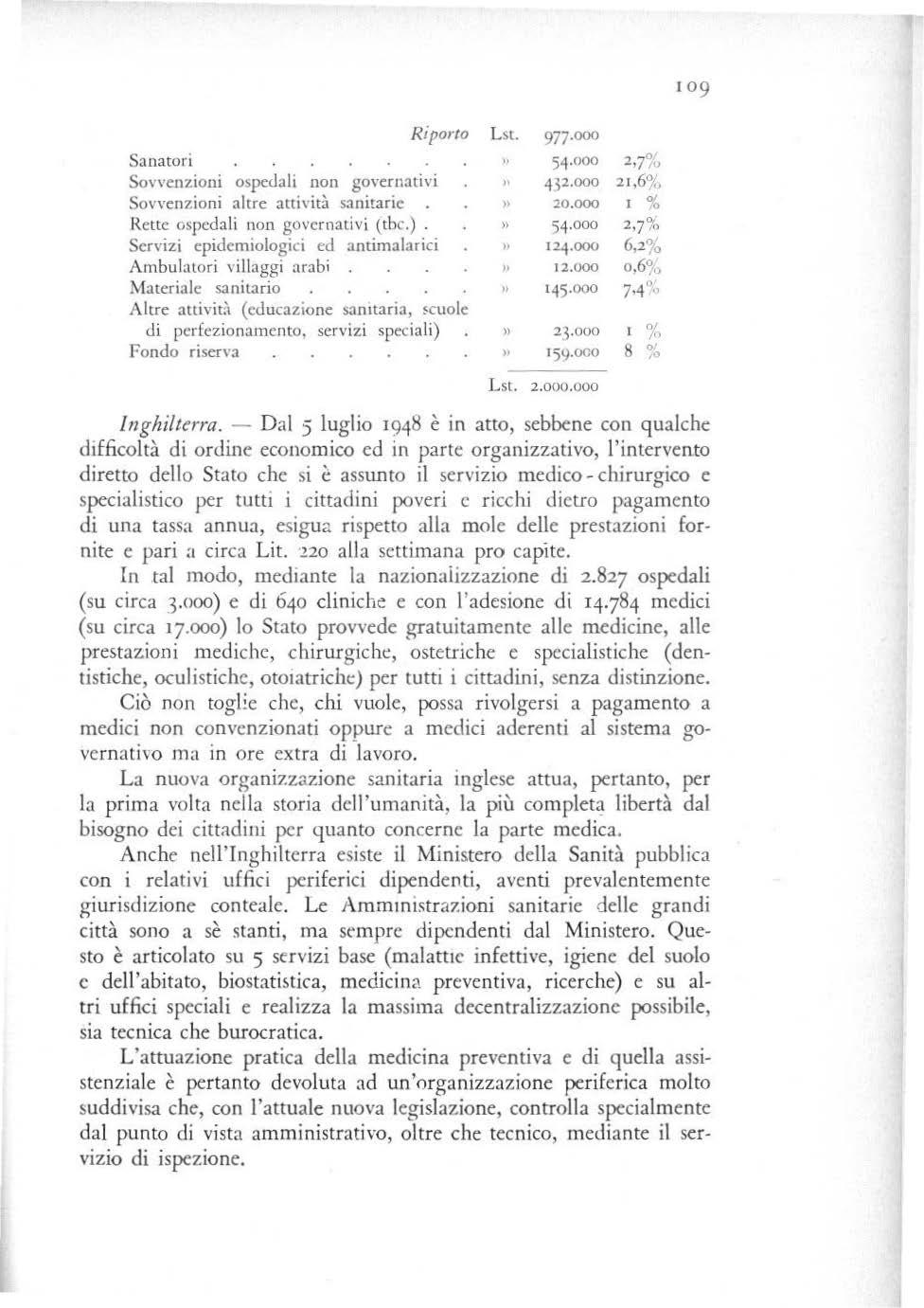
In tal modo, mediante la nazionaiizzazione di 2.827 ospedali (su circa 3 .ooo) e di 640 cliniche e con l ' adesione di 14 784 medici (su circa 17 .000) lo Stato provvede gratuitamente alle medicine, alle prestazioni mediche, chir urgiche::, ostetriche e specialistiche (dentistiche, oculistichc, otOJatrichc::) per tutti i cittadini, senza distinzione.
Ciò non togl!e che, chi vuole, possa rivolger si a pagamento a medici non convenzionati oppure a medici aderenti al sistema governativo ma in ore extra di lavoro.
La nuova organizzazione sanitaria inglese attua, pertanto, per la prima volta nella storia dell'umanità, la più completa libertà dal bisogno dei cittadini per quanto concerne la parte medica. Anche nell'Inghilterra esiste il Ministero della Sanità pubblica con i relativi uffici periferici dipendenti, aventi preva lentemente giurisdizione conteale. Le Ammmtstrazioni sani tarie delle grandi città sono a sè stanti, ma sempre dipendenti dal Ministero. Questo è articolato su 5 servizi base (malatttc infettive, igiene del suolo c dell'abitato, medicina preventiva, ricerche) e su altri uffici speciali e realizza la massima decentralizzazione possibile, sia tecnica che burocratica.
L 'attuazione pratica della medicina preventiva e di quella assistenziale è pertanto devoluta ad un'organizzazione periferica molto suddivisa ch e, con l'attuale nuova legislazione, controlla specialm ente dal punto di vist a amministrat ivo, oltre che tecnico, mediante il servizio di ispezione.
Riporto 977.000
Altre auività (ed
Fondo riserva )l .. ,, .. )) )o 54·000 20.000 54·000 124.000 12.000 145·000 1)\I.OCO Lst. 2.ooo.ooo •• 2I,6°1;, I "'o 2,7% 6,2 o'o 7·4"'t 'X-. 8
sanitario
ucazione samtaria, di perfezionamento, serv1z1 spec iali)
La nuova orgamzzazione tentata dal R egno Unito costitUisce l'esempio della estensione massima dell'unificazione dei servizi sanitari. L'esperimento peraltro è stato possibile in funzione della capacità economica di quella Nazione ed ha sollevato notevoli critiche per l'alto costo della gestione .
Tuttavia i risultati sono stati finora così tangibili e lusinghieri che il sistema, opportunamente perfezionato, è destinato a migliori sviluppi.
Troppo lungo sarebbe riportare, sia pure succintamente, l'Organizzazione sanitaria nei vari Paesi del mondo.
Basti qui citare l'attuale assetto dei servizi sanitari centrali nelle più importanti Nazioni. , Su 77 Nazioni, risulta che 40 di esse hanno un Ministero della igiene o della sanità oppure un analogo Dipartimento equivalente al Ministero predetto. Ciò significa che in circa il 52% dei Paesi esteri, ivi compresi i più grandi ed i più importanti, esiste un vero e proprio Ministero della sanità.
In altri r8 la Sanità è abbinata o all'assistenza (in n. 15) o alla previdenza (in n. 3) ovvero ai servizi concernenti la famiglia (in n. I), la popolazione (in n. r), l'educazione fisica (in n. r) o la giustizia (in n. 1) mentre i n un caso la Sanità è abbinata agi i affari interni dando la qualifica al relativo Dicastero.
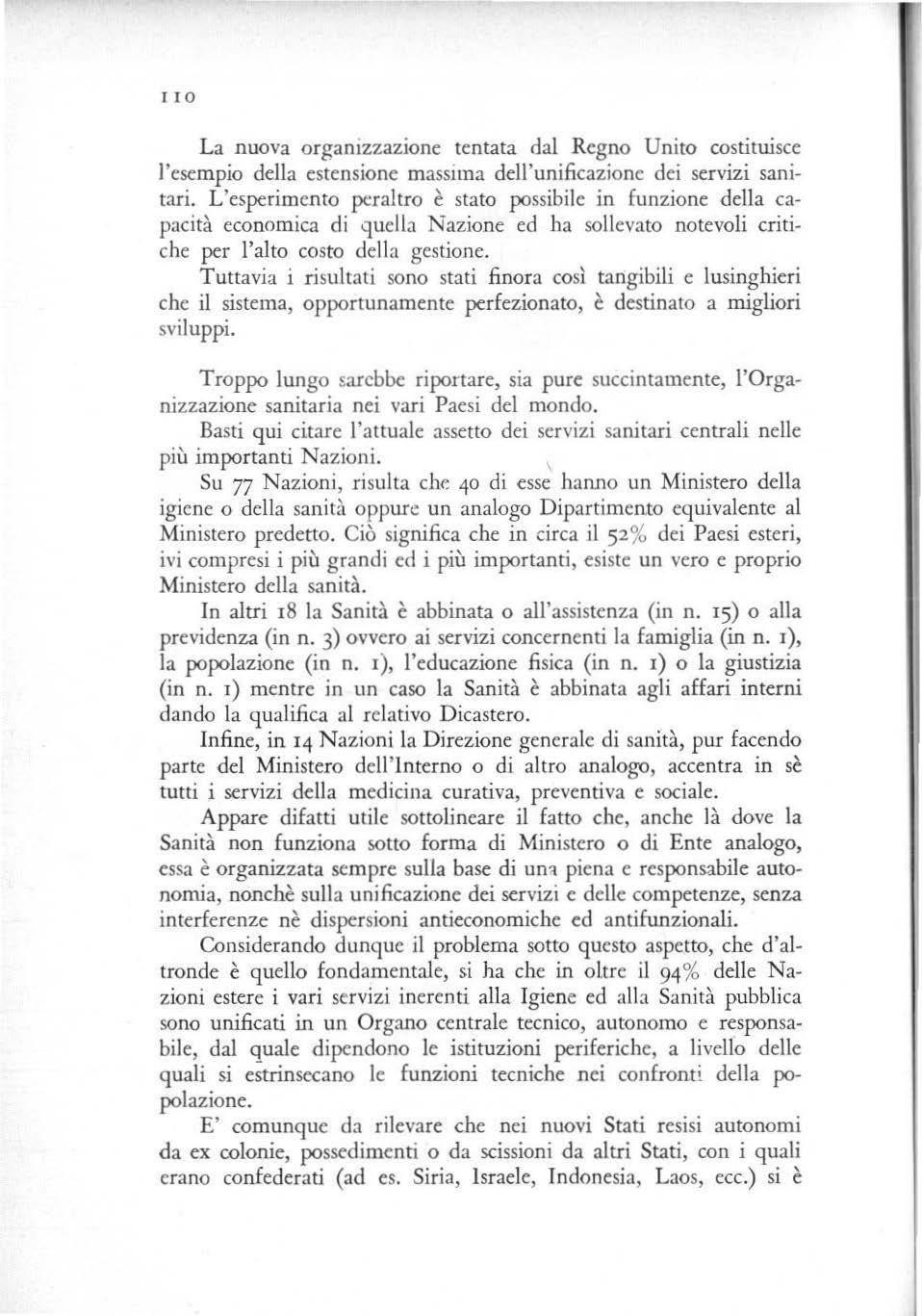
Infine, in 14 Nazioni la Direzione generale di sanità, pur facendo parte del Ministero dell'Interno o di altro analogo, accentra in sè tutti i servizi de!Ja medicina curativa, preventiva e sociale .
Appare difatti utile sottolineare il fatto che, anche là dove la Sanità non funzion a sotto forma di Ministero o di Ente analogo, essa è organizzata sempre sulla base di piena c responsabile autonomia, nonchè sulla unificazione dei servizi e delle competenze, senza interferenze nè dispersioni antieconomiche ed antifunzionali.
Considerando dunque il problema sotto questo aspetto, che d'altronde è quello fondamentale, si ha che in oltre il 94 % delle Nazioni estere i vari servizi inerenti alla Igiene ed alb Sanità pubb li ca sono unificati in un Organo centrale tecnico , autonomo e responsabile, dal quale dipendono le istituzioni periferiche, a livello delle quali si estrinsecano le funzioni tecniche nei confronti della popolazione.
E' comunque da rilevare che nei nuovi Stati resisi autonomi da ex colonie, possedimenti o da scissioni da altri Stati, con i quali erano confederati (ad es. Siria, Israele, Indone sia, Laos, ecc.) si è
IlO
senz'altro attuata la creaziOne di un Mini stero della Sallità essendosi riconosciuta l'importanza e b vastità dei compiti da affidare ad un tale Dicastero.
Schematicamente, l'assetto dci servizi sanitari centrali nei vari Paesi esteri è il seguente: Europa.
Albania: Ministero della Sanità Pubblica.
Austria: Ministero della Previdenza Sociale.
Belgio: Ministero delJa SanitJ Pubblica c Famiglia.
Bielorussia: Mini stero della Sanità Pubbli ca .
Cecoslovacchia: Ministero della Salme e della Educazione Fisica.
Danimarca: Gen. di Sanità Pubblica.
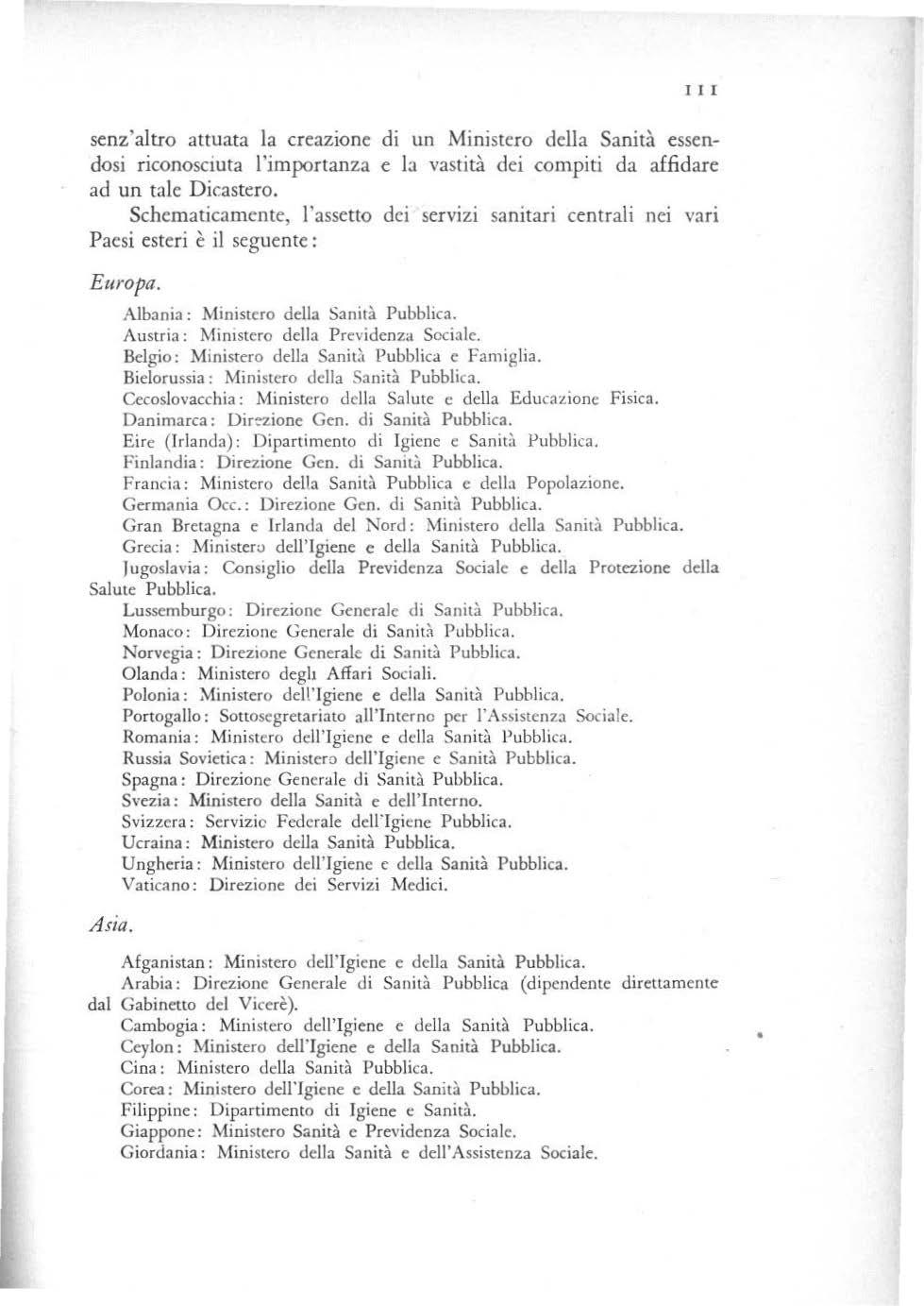
Eire ( Irland a): Dipartimento di Igiene e Sanità Pubblica.
Finlandia: Direzione Gcn. di Samtà Pubblica.
F ran c aa: Ministero della Sanità Pubblica c della Popolazione.
Germania Occ.: Direzione Gen. di Sanità Pubblica.
Gran Bretagna e Irland a del Nord: della Sanità Pubblica .
Grecia: Ministew dell'Igiene e della Sanità Pubblica.
Jugoslavia: Consaglio della Previdenza Sociale e della Protezione della Salute Pubblica.
Lussemburgo: Direzione Generale di Sanità Pubblica.
Mona co: Direzione Generale di Sanità Pubblica.
Norvegia: Direzi one Generale di Sanità Pubbli ca.
Olanda: Minister o degh Affari Sociali.
Polonia: Minister o dell'Igiene e della Sanità Pubblica.
Portogallo: Sottosegretaria w all'Interno per Sociale.
Romania: Mini stero dell'Igiene c della Sanità Pubblica.
Russia Sovietica: Ministero dell'Igiene e Sanità Pubblica.
Spagna: Direzione Generale tli Sanità Pubblica.
Svezia: Mini stero della Sanità c dell'Interno.
Svizzera: Servizi c Federale dell'Igiene Pubblica.
Ucraina: Minister o della Sanità Pubblica.
Ungheria: Minist ero dell'Igiene c della Sanità Pubbli ca
Vaticano: Direzi one dei Servizi M edic i.
Asia.
Afganistan: Mini stero dell'Igiene c della Sanità Pubblica.
Arabia: Direzione Gen erale di Sanità Pubblica (dipendente direttamente dal Gabinetto del Vicerè).
Cambogia: Mini stero dell'Igiene c della Sanità Pubblica.
Ceylon: Ministero dell'Igiene e della Sanità Pubblica.
Cina: Mini stero deUa Sanità Pubblìca.
Corea: Ministero dell'Igiene e della Sanità Pubblica.
Filippine: Dipartimento di Igiene t: Sanità.
Giappone: Ministero Sanità e Previd enza Sociale.
Giordania: Mini stero della Sanità e dell'Assistenza Sociale.
I I I
India: Dipartimento di Sanità
Indonesia: Ministero dell' Ig iene e della Sanità Pubblica
Ir aq: Ministero deg li Affari Sociali.
Israele: M inistero de ll ' Igiene e della San ità Pubblica.
Laos : Ministero Jeli'Igiene e della Sanità Pubblica.
Libano: Ministero della Sanità e dell'Assistenza Pubblica.
Pakistan: Direzione Genera le d i Sanità.
Persia: Ministero dell 'Igiene c della San :tà Pubblica.
Siria : Ministero dell' Igiene e dell'Assistenza Pubb l ica.
Transgiordania: Sottosegretariato di Stato per b Sanità.
Thai land ia: Ministero de ll ' I giene e della Sanità Pubb lica.
Turc hi a : Ministero della Sanità c della Assistenza Sociale.
Vietnam: M inistero della Sanità Pubb l ica.
Africa.
Egitto: Minister o I g ien e e Sanità Pubbl ica.
Etiopia: Ministero I giene e San ità Puhblica.
Liberia: D irezio ne Generale di Sanità .
Tangeri: Direzione di Sanità.
Un ione Sud - Africana: Dipartimento di Sanità Pubblica.
America.
Argentina: Mini s tero Igiene e Sanità Pubbli ca .
Boli via: Ministero Igiene e San ità Pubblica.
Brasile: Dipartimento Nazionale della Salute.
Canadà: Mini stero della Sa ni tà e dell'Assistenza.
Ci le: Ministero della Sanità.
Colombia: Ministero dell'Igiene e Sanità.
Costarica: Min istero del l'Igi ene ec Sanità.
Cuba: Ministero de lla Sanità e dell'Assistenza Sociale.
Dominicana (Rep ub blica): Ministero della Sanità e dell'Assistenza Pubblica.
Equador: Ministero San ità e de lla Previdenza Soc iale.
Haiti: Direzione Generale di Sanità.
Hondu ras : Mini stero Giusti zia e Sanità Pubblica.
Mess ico: Ministero del la Sanità e dell'Assistenza.
N icaragua: M inistero dell' I giene e Sanità Pubblica
Panama: Min i ste ro degli Affari Soc iali.
Perù: M ini ster o della Sanità e dcii' Assistenza Socia le.
Salvador: Direzio ne Genera le di Sanità.
Stati Uniti: Dipartimento di San ità (ogn uno dei 48 Stati della Federazione).
Urug uay : Ministero dell' I giene e della Saojtà.
Ven ez uela: Minister o della Sanità Pubblica e A ss iste nza Sociale.
Aust ralia e Oceania.

Au st ralia: Mini stero dell' Igiene e della Sanità.
Nuova Zelanda: Dipartimento d i Sanità.
!12
Per quanto riguarda l 'Italia, allo stato attuale delle cose, le molteplici attività sanitarie, senza alcun collegamento con l'Alto Commissariato in e$trernamente delicati, quali ad es. gli ospedali, l'assistenza ai iavoratori, l'igiene scolastica, le opere igieniche, la bonifica, gli aspetti igienico-sanitari dei trasporti, delle case di pena, dell'emigrazione e di territori ex coloniali, nonchè, in misura ancora più vasta, per ciò che concerne l'igiene materna ed infantile ed il servizio di pronto soccorso in genere, sono svoLte in campi vari da n Ministeri. Se, peraltro, le interferenze sono frequenti e gravi al centro per la cennata dispersione dell'attività igienico-sanitaria, si verificano con frequenza ed intensità ben più marcate nei confronti dei servizi periferici i quali, come si è detto, sono strutturalmente restati quali erano.
Vi è, come è chiaro, anche notevole contraddizione fra il centro ove l'organo tecnico è autonomo e responsabile e la periferia ove tali servizi non sono giuridicamente e materialmente idonei per i loro compiti.
L'organo centrale finisce così per essere quasi fine a se stesso in quanto mancante dei mezzi strutturali Idonei ad esplicarne le funzioni, il che costituisce un elemento deficitario dell'organizzazione sanitaria la quale anche per effetto delle modificate condizioni sociali, economiche e politiche der ivanti sia dalla guerra, sia dal mutato regime costituzionale, non risponde più alle esigenze sentite e constatate nei diversi settori.
Commissioni di studio, referenùum del gruppo medico- parlamentare, Enti ed assicurazioni operanti nel campo sanitario hanno formula to ed espresso vo t i ispirati al concetto deli'indispened i n dilazionabi le un ificazione dei servizi inerenti all'igiene cd alla sanità in un solo organo che abbia quella autonomia e quella diretta articolazione periferica senza le quali qualsias i azione è destinata a restare soltanto allo st ato potenziale
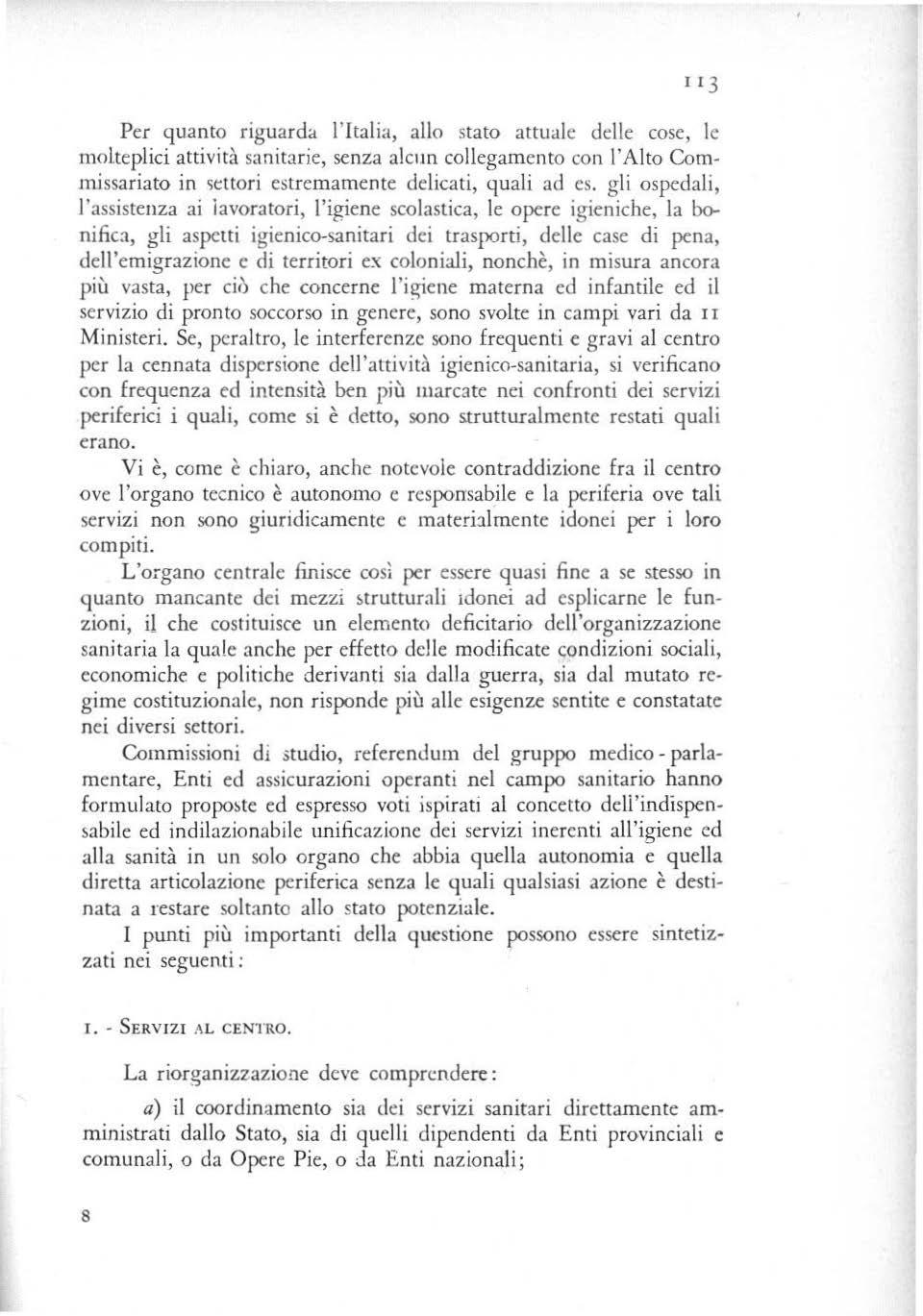
I punti più importanti della questione possono essere sintetizzati nei seguenti:
La riorganizzazione deve comprendere:
a) il coordinamento sia dei servizi sani t ari direttamente amministrati dallo Stato, sia di quelli dipenden ti da Enti provinciali e comunali, o da Opere Pie, o da Enti nazionali;
I I 3
J. - SERVIZI AL CENTRO.
8
b) i! bilancio: qualora si facesse un esame comparativo dei bilanci delle varie Amministrazicni sanitarie estere con quello analogo italiano, si metterebbe in luce, da una parte la esiguità del bilancio dell'organizzazione sanitaria statale (circa 24 miliardi e mezzo di lire) sulla quale gravano peraltro i compiti più onerosi c delicati, e per contro, l'ampiezza delle disponibilità finanziarie dei vari Enti parastatali che con la Sanità hanno com unan za o parallelismo di attività.
L'unificazione quindi non dovrebbe rappresentare un aggravio del bilancio dello Stato, bensì un vero e proprio risparmio se si pensi che attualmente l'Amministrazione sanitaria fruisce di una percentuale trascurabi le (circa il 2 %) dell'intero bilancio statale (circa 1200 miliardi);
c) il personale tecnico c amministrativo: per quello tecnico occorre curare soltanto il miglioramentc qualitativo mediante una migliore disciplina dei criteri di cernita e, soprattutto, mediante la istituzione dt apposite Scuole di preparazione specifica per !a carriera della Sanità pubblica.

Per quelk: amministrativo ocwrre la costituzione del ruolo proprio, parallelo al ruolo tecnico, conferendo ai gradi direttivi l'indispensabile preparazione specifica nella Scuola di addestramento sopraddetta, con opportuni idon ei corsi.
La riorganizzazione deve parimenti comprendere:
A) Il coordinamento.
Per quanto efficiente possa essere un coordinamento al centro, appare evidente la necessirà di coordinare i servizi sanitari anche alla periferia, perchè non si potrebbero ottenere i risultati desiderati se nza estendere tal e coordin amento fino ai più piccoli centri abitati.
Tale coordinamento potrebbe realizzarsi anzitutto con l 'istituzione di Centri sanitari locali, corrispondenti a zone sa nitarie di estensione adeguata alle condizioni locali (popolazioni, viabilità, stato sanitario ecc.), così come viene attuato nei più progrediti P aesi, con risultati co ll audati da tanti anni di esperienza .
Tali Centri dovr ebbe ro comprendere, tranne i servizi ospedalieri propriamente detti, tutte le altre attività connesse con la Sanità Pubblica, co me: l'assistenza agli indigenti; i servizi per la lotta contro la tubercolosi, la malaria, il tracoma , le malattie veneree; nonchè contro
2. - SERVIZI ALLA PERifERIA.
le principali malattie degenerative quali il cancro, il diabete, le cardiopatie, ecc .. Dovrebbero altresì comprendere i servizi di prevenzione, come quelli inerenti alla tutela della maternità ed infanzia, all'igiene mentale.
Inoltre, le possibilità diagnostiche di questi Centri potrebbero essere messe a disposizione, con modalità da stabilirsi, ài tutti gli altri medici.
I detti Centri sanitari locali dovrebbero essere dotati di servizi e di personale qualitativamente e quantitativamente adeguati ai bisogni sanitari della popoiazione compresa nella rispettiva circoscrizione.
Essi dovrebbero essere coordinati e controllati dall'Organizzazione sanitaria centrale attrave rso i propri Organi provinciali ed eventualmente regionali.
Occorre, inoltre, dare una migliore personalità e quindi più concreta responsabilità agli Uffici sanitari provinciali, ai quali dovrebbe essere conservata, ampliandola, la competenza circoscrizionale su tutti gli aspetti della medicina (curativa, preventiva, sociale e previdenziale). Detta personalità è strettamente condizionata dalla piena autonomia responsabile, sia tecnica, sia amministrativa, e dalla diretta dipmdenza giundica e disciplinare, più che burocratica, dall'Organo centrale tecnico sanitario.

B) Il bilancio.
Non è concepibile una efficacia di azione se si prescinda dalla tempestività di essa, determinata a sua volta dalla disponibilità e dalla capacità finanziaria dell'ufficio.
Nell'àmbito, dunque, della provincia è indispensabile che il medico provinciale disponga e risponda della sua competenza tecnica con maggiore prestigio e responsabilità se pur con necessari controlli consuntivi del su o operato.
C) IL perso11ale.
E' troppo nota la grande pletora medica esistente in Italia e medici ben preparati potrebbero provvedere convenientemente ai servizi sanitari, purchè più equamente e razionalmente distribuiti.
Invece, come del resto accade in altri Paesi, è stato constatato che vi è una grave deficienza nel numero delle infermiere professionali e del personale sanitario ausiliario in genere. Si è da più parti constatata b notevole sca r sità del personale addetto ai servizi igienico-sanitari e la necessità ili regolari ridistribuzioni più adeguate, onde at trarr e e mantenere in servizio personale idoneo
115
Dovrebbero venir garantite ai medici, ai chimici, agi i ingegneri sanitari ed al restante personale laureato, remunerazioni paragonabili alle entrate nette di un buon libero professionista. Le infermiere professionali, le assistenti visitatrici, i tecnici di laboratorio e l'altro personale ausiliario dei servizi igienico-sanitari, dovr ebbero percepire retribuzioni adeguate al rispettivo livello cu ltur ale cd alle mansioni esplicate.
Sarebbe anche opportuno che tutti i ruoli del personale sanitario fossero nazionali e che gli avanzamenti di carriera venissero basati soprattutto sui meriti individuali e sulla preparazione, con la possibilità di passaggio tra i diversi ruoli.
Per quanto concerne la preparazione del personale specificatamente tecnico dei servizi di sanità pubblica, è da notarsi quanto segue:
a) Medici: il corso d'igiene per studenti in medicina è stato reso fondamentale nelle Facoltà mediche italiane dal 1870. Tale insegnamento, impartito in modo assai vasto ed unitario negli Istituti univer sita ri d'igiene, concerne peraltro assai più gli aspetti scientifici della materia c he non la sua pratica applicazione.

Per i laureati, si tengono in Italia corsi di perfezionamento presso gli Istituti d'igiene universitari; mancano le Scuole sopraccennate, veramente adatte all'istruzione pratica del personale tecnico ed ammini strativo da assumere nei pubblici serviz i igienico-sanitari.
Questa lacuna potrebbe essere colmata con l'istituzione di Scuole di sanità pubblica, intonate ad un tipo pratico di addestramento, funzionanti in modo autonomo.
Dette scuole dovrebbero mantenere stretti rapporti con le Facoltà di Medicina ed utilizzare, nel modo più largo, l'esperienza del personale della Sanità pubblica. E sse dovrebbero essere poste so tto la direzion e di persone di vasta esperienza nel campo della Sanità pubblica, e vi si dovrebbero impartire insegnamenti n elle molte e svariate discipline dell'Igiene pubblica e dell'Amministrazione sa nitaria. Il personale insegnante di un::J tale scuola dovrebbe esse re composto di esperti nelle varie materie, che abbiano una vasta preparazione cd una l arga esperienza.
b) Ingegneri sanitari: rappresentano una categoria di tecnici alla quale non si può più a lungo rinunziare.
La nece ssità dì preparare un idoneo corpo di ingegneri sa nitari è ormai tanto più sentita quanto più st retti legami la medicina va prendendo con i vari rami della tecnica. Oc corre per ciò dare incremento all'i stituzione di Scuole di perfezionamento in ingegneria sanitaria
II6
presso alcune Facoltà di Ingegneria che potrebbero bene assolvere tale compito.
c) Personale sanitario ausiliario: uno dei più gravi problemi riguardanti lo sviluppo di un adeguato servizio sanitario in Italia è la deficienza di assistenti sanitarie visitatrici. Si calcola ora che vi sia una A . S. V. ogni 22.000 abitanti, rapporto veramente inadeguato perchè si ritiene, in linea generale, che il minimo indispensabile sia una A S. V. ptr s.ooo abitanti. Questa grave deficien za può trovare rimedio soltanto con lo sviluppo delle vigenti Scuole di preparazione dì questa ca tegcrìa di personale. E' n ecessa rio, pertanto, ampl1arc e perfezionare le Scuole esistenti che potrebbero, ovc possibile, essere affiancate alle Scuole per infermiere professionali e , ove esistano, alle Scuole di sani tà pubblica, con personale direttivo ed insegnante oppo rtunam ente se lezion a to e preparato.
Questo aspetto unitario del problema non disgiunto da una radicale ed armonica trasformazione funzionale della pe riferia verrebbe, ne son certo, a dare a questo settore indubbiamente non secondo a tanti altri gangli vitali dello Stato una attività funzionante e produttiva per il miglioramento della Sanità pubblica italiana.
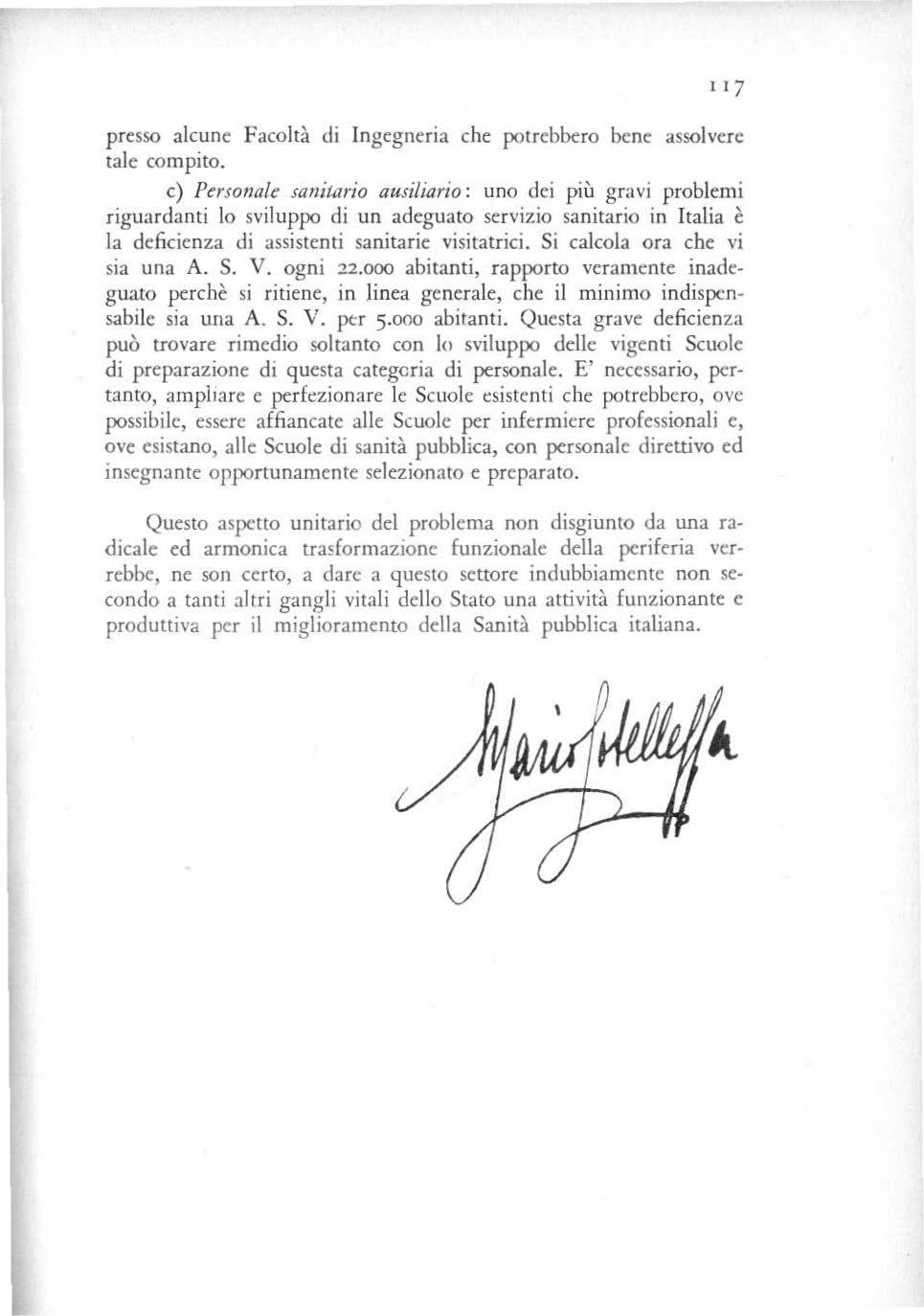
l l 7
E F FET S SU R
DE LA RADI O THÉ R AP I E
L ' É PENDYMOBLAS TO ME
DE LA MO E LLE É P I N I ÈR E
L'épendymomc est une tumeur, rare dans le ccrveau, fréqucnte par contre dans la moclle épinièrc. Divers autcurs cn chiffrent l'incidcnce à 2.75, so it 42-54 •:;, Wrrth ci mer, All égre, Garde trouvent tout récemment (1950) 7 épendymomes sur 20 lumeurs intra-médullaires. La maladie s'étend habitucllement sur plu ieures années. Les symptomes s'annoncent le plus souvent par la douleur, l'cngourdissement, brusquemcnt suivis dc sig nes paraplégiques qui indiquent l'aggravation de l'élat morbide.

Sujct rnSle, 25 ans, dont ne conticnt nul fan notablc. Son état actuel a déhut.é 3 ans avant l'admission à notre scrvice. Lors d'une rnanoeuvre rnilitaire, se voyant obligé ck dégringolcr rapid cmcnt le flanc d'une diguc élcvée, il perdit pied. Touchant terre, il éprouva la sensati on d'avoir rcçu un << coup sur la tete » Une sernaine plus tard: engourdisserncnt, dans Ics pmbes. Transporté à l'hopital, il y subit, entre autres, un examen au lipiodol. Par la suite, son état empira, mais 3 ans après il était cncore capable de rnarchcr tout seui. Fin aofit de la memc année, le maladc ne peut plus march cr. Simultanérnent: cessatioo dc l'engourdissement dans Ics 2 jambes ct à la région lombosacrée. Ces syrnpt8mes sont remplacés par !'anesthésic complète jusqu'à hauteur dc la hgne ombilicale. D cp uis 3 scmal!les : incontinence d'urine et dcs se llcs, 'imp otence scx uelle, cép halées fréquentes, la vue baissc, de temps à autre: douleurs da mie dos.
Observation: oscillation nystagmt(orme bilatérale, indemnité des autrcs nerfs cérébra ux. M otilité: cxtrémités supérieures: tonus musculaire norma l, force de pression i nta c tc, pas d'at::txie. Mernbrcs i nférieur s: hypertonie bilatérale acc usée, prédominantc à droite. Abscnce dc ta moti lité activc, flexion passive trés restreinte. Sensibilité: ancsthésie jusqu 'à D.5. H ypoesthésie géné rale en toutes qualités jusqu"à C.;. R éflexes: brachiaux bilatéralement r éduits. Réflexes abdominaux abolis, réflexes pateUaires très accusés particuliéremcnt du coté droit, Ics ac hi lléens prépondérants à g:wche. Babinski bi latéra l discret, clonus occasione! du pied gauche. Sédimcnration sanguine: 55-86, WaR nég., urine: nég., liquide CR: cisternale négatif, lombaire de co ul cur jaunatrc, albumine 300 m!f;, taux cell ulaire 5/ 3• globules rouges, Pandy, Takata, L onne + + + B. · WaR nég. Examen oculaire: négatif. Formule sa nguine: anémie
hypochromc IIB 45 °,, . Globu lcs rouges 2.76o.ooo . Radiographie: co lonne vertébrale inférieure inaltérée. Goute lettes dc lipiodol, en arrangemem linéaire à la hauteur de 6-8 D. Résidu discret de lipiodol dans le sac de la dure -mère.
Thérapie: roborante, puis radioirradiaùon de la moelle épinière correspo ndant à (8 x 200 = t6oo r ). L 'état du malade resre stationaire durant quclqu es mois. P lus tard, aggravation p rog ress ive, d ec u bit us, fìèv re scptig u e, infìltration foca le bilatérale dcs sommets pulmonaires. Après 4 ans de maladte, décès à la suite d'insuffisance cardiaque.
A utop1ie: tuberculose miliaire dans tous les lobes des deux poumons, particuliéremenl dans !es plèvres viscéra les. Exsudat ion d'aspcct trouble, fibrineusc, - environ rzoo cm 3 - dans l'cspacc p leura l droit. D égé nérescence parc n chy-
matcuse du myocarde, dilatation du ventri c ulc droit. Oégénércsccnce graisseuse du foie, rate septique, abcès dans la prostate, thrombo\CS aux veines périprostat iq LI CS.
durcs et malles mètcs de la mocllc ép inièrc ·montrcnt des adhésions par couches d'cnviron 20 cm. dans les parties dorso-lombaircs. La moelle ép in ière s'élargit soud:unement à la partie ccn·icale inférieure en y formant des conv olutions ballonérs, parfois rcsscrrées, et attcim une large ur maximalc de 3 cm. à la limite ccrv ico-dorsale. P lu s bas, cc diamètre diminue successin:ment pour céder à une srructur e normale à partir dc la partie supéricure d u gonflcme nt lombairc.
Tableau macroJcoplque dc la moell c épinière (Fig 1 et 2). La moelle cer\ ' Ìcale in(érieure, dorsale sup.!rieure et médiane des gonflements ballonés. La structure normale de la moelle est méconnaissa ble à la co upe rransversa lc, le ce ntr e Jc la ro up e transvrrsa lc est occupé par une s ub stance tumora le fìnemcnt gra nul ée et part:e llem ent né cro tique. La substa n ce neurale est repoussée, aplatic, parfois elle ne forme qu'un mince ruban, lcq u el en tou re !a masse néoplasique.

119
Fig 1. - Voir text.
Histologte: la panie supérieure dcs coupes cc rvi calcs et Jorsales une substan cc néop lasique, Ics autrcs scctions dc la mocllc som indcmncs. La moelle cerv icale es t aplmic jusqu 'à ne form cr qu'une étroitc bandelene de substance neurale, Ics 3 4 Je b coupe rr:tnsvcnale é tant occupés par la substance L a spécificité structur elk dc la neuralc (cornes antéricurcs, etc.), a complércment nous rrou,ons une hyperplasie abondante d'anérioles (Fig. 3 et 4). le conjoncuf de l'espacc sous-arachnoì'dien a <ub1 une prolifération marquéc et compone plusieurs de grosseur moycnne, dont Ics manifestent une dégénére sccncc hyalinée (F ig . 5). La tumoralc d'aspect si \arié qu'il est diffici le d'y retrouver la su lmance original e. Dcs Formations cystiq u es plus
ou moins é1cndues ,-oisincr.t :1\CC des partics cnli:!rcmcnt .:omposées dc mcnus cys1cs Ccux-ci comportcm une cavité remplit. de malière sércusc, coag ul ée en toil e d"araignéc, leur s parois :omis te nt de ccllules turnorales (Fig . 6 el 7). Par cndroits: formatioe dc pscudo-roscttes périva sc ulair es (Fig. o -R), ai lleurs, nous reconnaissons des zoncs nécrobiotiques allongécs cn bandelcttes (Fig. 9)Le type dcs cellules néoplasiquc) corrcspond à celui dc l'épendymoblastome. Absence dc mitose nucléaire. La tumeur est de typc csscntiellement cellulaire, composée de cellulcs épithéliales en pelit nombre, dc taisccaux solides Cl de cellules cubiqucs netternent \ isiblcs. La s ub stancc néoplasiquc frappe par so n aspect nécrob iotique, la co loration du plasma est fréquem ment cfTacéc, pale, (Fig. 8 et g), Ic s noyaux sont de gr andeur irréguli èrc . Ct: fair s'exp li quc partiellement par Ics altérations trés des vaisseaux. Dans la tumcur m€me.

120
Fig. 2. - Voir text.
ceux-ci sont trés oombreux et de diverses altératioos importanLcs, telles qu'épaississemcnt de la paroi vascubire, dégénérescence hyalinéc, obl itération complète (thromboscs, voir Fig. 10, JO<l et Il).
La substancc de la moelle dorsale inférieure est nécrobiolique, d'un coté la cornc anterieurc est comp létemcnt absente. Elle est remplacée par une substance gliale criblée dc mcnus trous qui ne conticm pas de cellulc s neurales et manifeste une ri<.:hc prolifération g li ale. Du coté opposé : meme aspect,
Haemat oxyline van Gieson. Agrandt s· sement 72. Vascularisation abo11dante dans le twu neural
Voìr Fig. 3· Agra ndissement 360. Les parois vasculaìres sont épaissìes, en hyalm{e.
clairsemé de ce llule s motrices cn dégénérescence. A ce nivcau, la substa ncc néoplasiquc siègc dans l'espacc sous-arachnoidien, elle comprime conséqucmmcnt la substance neuralc de l'extérieur et n'occupe qu'une modeste partir de l'axe transversal. Accrochéc: à la substancc neuralc, elle ne la pénètrc quc dans une zone limitée (Fig. 12). L'aspect structurcl est celu i décrit plus haut, avec, toutefois, un plus grand nombrc dc « n et de
Diagnose histologique: épeodymoblastome atypique. L'atypie est carac térisée par: 1 - la vascularisation surabondante; 2 - l ' hyalinose cles parois vasculaires.
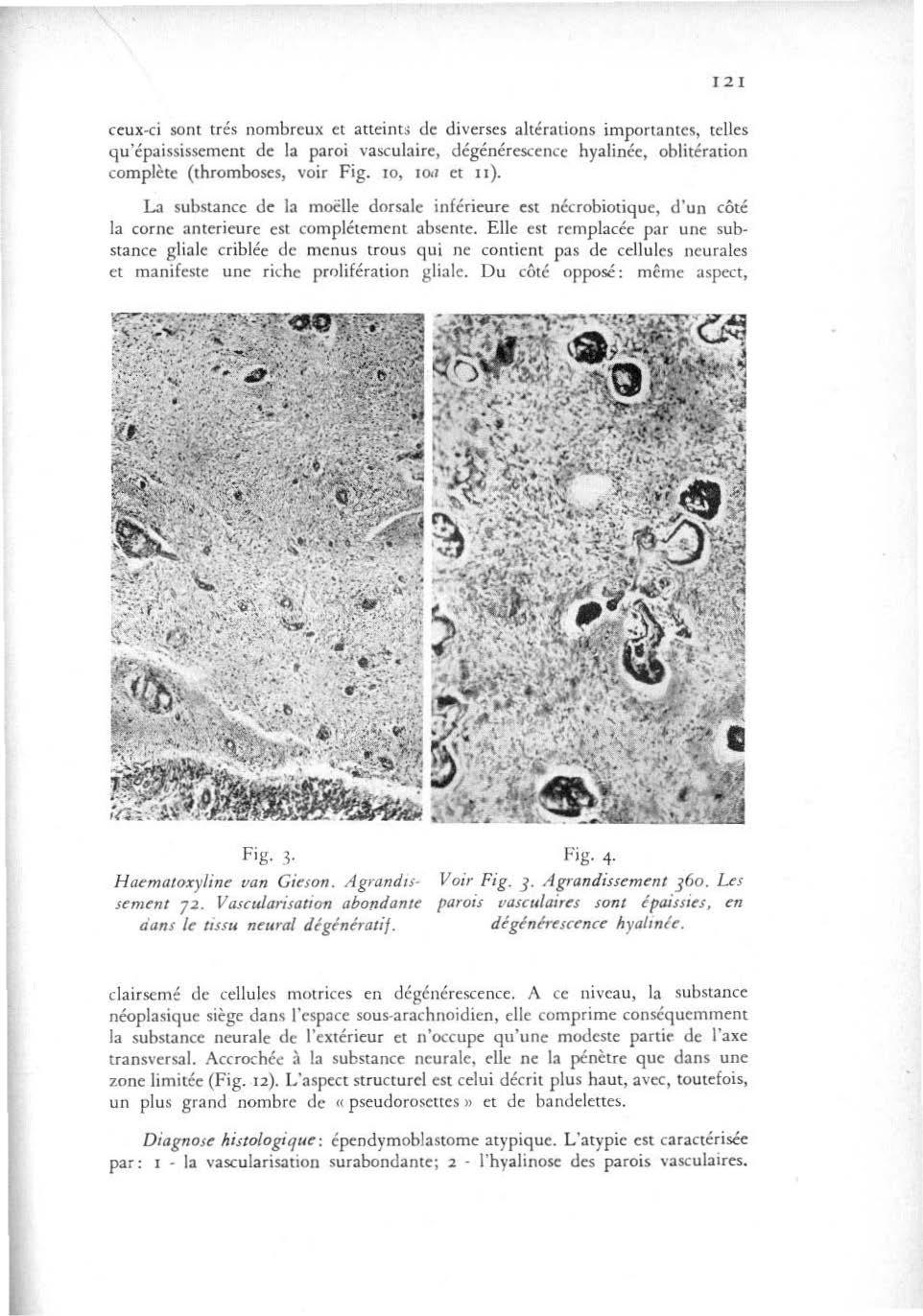
121
Fig. 3·
Fig. 4·
et leur thrombose; 3 - la nécrose de la subst31KC tumorale; cnfin: 4 - la dégénérescence cystique.

DISCUSSION.
Notre maladc - sujet male de 25 ans - a éprouvé le premier symptomc dc sa maladie, un engo urdi ssement cles jambes, au cours de son mi l itaire. Étant donné qu'il avait g li ssé brusqucment
du fatte d'une digue élevée environ une semainc auparavant, et ressenti commc « un co up porté à la t ete », il établit une coincidence causale entre les dcux faits. L'état était re sté stationnaire durant environ 3 ans, sur quoi l'affaiblissement de la motilité succéda à l'engourdissement, sui vi fìnalcment dc paraplégic complètc. Parallèlcment: la se nsation dc fourmille m ent céda it à l 'anesthésie tota le, s'étendant jusqu'à la zone ombilicale. Quelques scmaines plus tard, lors de l'admission à notre service, nous obscrvons une paraplégie spastique, accompagné d'anesthésie jusqu'à la hauteur de D. 5· et hypo esthésic
122
Fig. 5· - Haematoxyltn e van Gieso n. AgrandtSsement 72. Prolifération conjonctive dans la zone sous-arachnoidienne. Dlglnérescence des parois vascu/aires.
 Fig. 6. Haem at oxylin'! van Gieson. Agrandwement 72. Cystej séreux, 11aisseaux aux parois dans la substance tumorale.
Fig. 6. Haem at oxylin'! van Gieson. Agrandwement 72. Cystej séreux, 11aisseaux aux parois dans la substance tumorale.
123
Fig. 7· - Voir Fig . 6. Agrandissement 360.
jusqu'à C. 5 . , un syndrome Froin dans le liquide CR, et cles go uttes de l ipiodol à la hauteur de 6-8 D . Ce rempiissage avait eu lieu plusieures années a uparavant, dans un H opital militaire. Vu l 'aggr avation constante de l'état morbide, l'évo lu tion de la symptomatologie et les données cliniques, nous avons dés lo rs estimé gu 'i l s'agissait d ' une tumeur intramédullaire. donné l'incidence
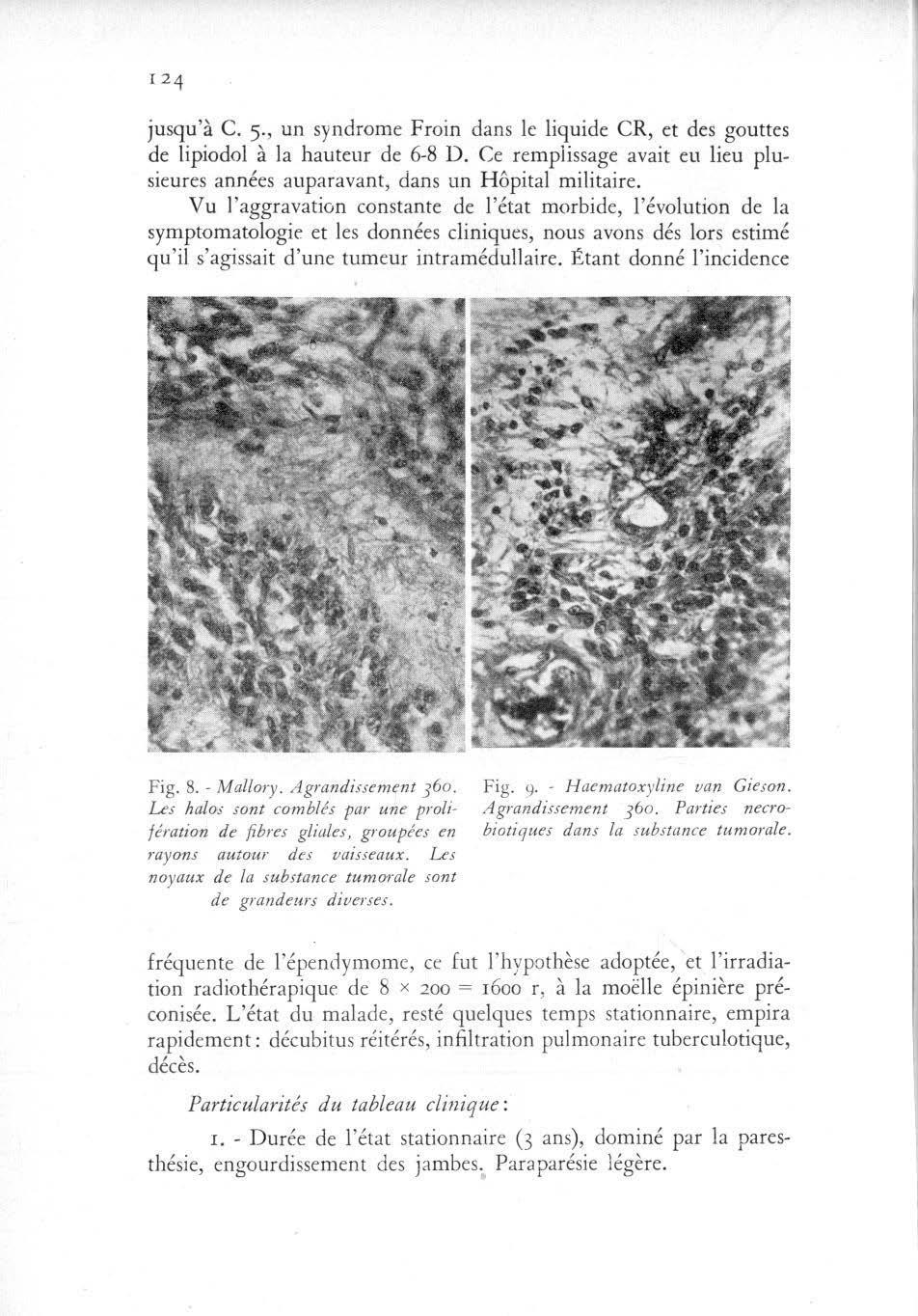
par une proliféra tion de fibres gliales, groupées en rayons autour des vaisseaux. Les noyaux de l a substan ce tumorale sont de grandeurs diverses.
fréquente de répendymom c, cc fut l'h ypo thèse adoptée, et l 'irradiation radiothérapiqu e de 8 x 200 = 16oo r, à la moel le épinière préconisée. L' état du mala de, r esté guelques temps sta ti o nnaire, empira rapidcment: décubitu s r éitérés, infiltration pulm o naire tuberculotique , décès.
Particularités du tableau clinique :
I. - Durée de l 'é tat stationnaire (3 aos), dominé par la paresthésie, engourdissement des jambes. Paraparésie légère .
Fig 8 - Mallory. Agrandiuem t; nt 360. Les halos sont co mblés
Fig. 9· - H ae m at oxyline va n Cieson. Agrandissement 360. Pat·ties necrobiotiques dans la subsw nce tumorale.
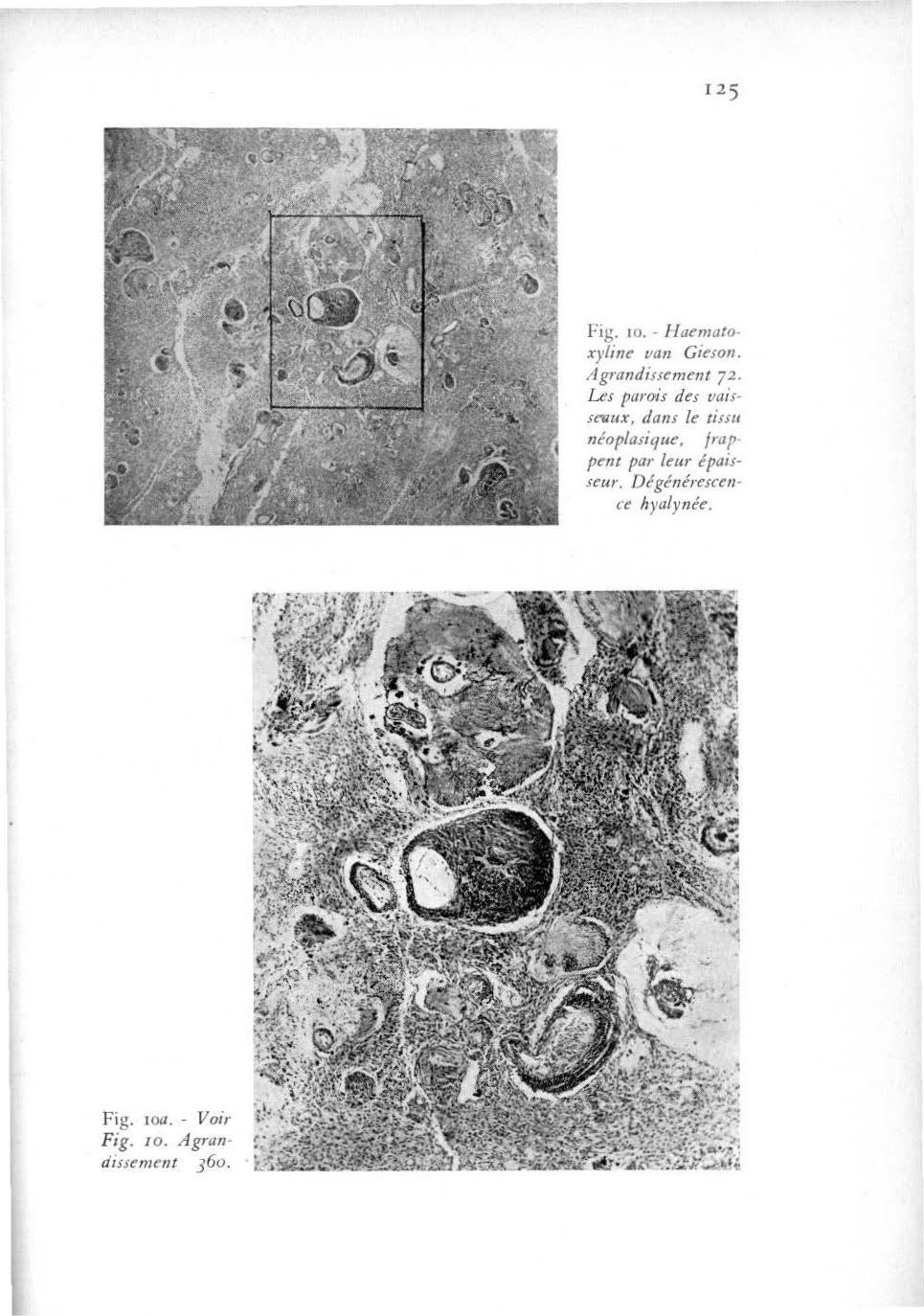 Fig. 10a. - Voir
Fig. 10. Agrandisse ment 360.
Fig. 10. - l laemuto xrlim: van Gieson. Agmndisscment 72. Les paroù des vaiisC'flux, dans le tissu néoplasique, frar pent par leur épaisscur. Dégénérescena h yaly née.
Fig. 10a. - Voir
Fig. 10. Agrandisse ment 360.
Fig. 10. - l laemuto xrlim: van Gieson. Agmndisscment 72. Les paroù des vaiisC'flux, dans le tissu néoplasique, frar pent par leur épaisscur. Dégénérescena h yaly née.
2. - Développement rapide de la paraplégie complète, de l'incontinence et de l'anesthésie.
3· - Cessation simultanée - par « tractotomie spontanée »de la paresthésie.
Particularités du tableau pathologique:
1. - L a tumeur occupait presqu'entièremcnt la coupe transversale de la modle cervico-do rsale, si bien que la structure de cette dernière n'était plus discernable.
2.- A l'examen hystologique: la tumeur se révèle comme épendymoblastome, mais les graves altérations vasculaires - dégénerescence hyalin ée, épaississcmen t ma ssif cles parois vasculaires, thromboses - que nous y avons rencontrées sont généralemcnt atypiques dans cette tumeur. Plus loin, nous avons trouvé de nombreux cystes contenant cles exsudations séreuses, cles nécroses fréquentes, partiellement expliquées par les altérations vasculaires et par l'effet probable de la radiothérapie appliquée 8 moi s
Fig. I r. - van Gie- avant le décès. son. Agrandissement 72. Voir texte. l 1 · d" I est reconnu que es 1rra tations X altèrent en premier lieu les artérioles et capillaires de la tumeur cérébrale, y provoquant l'épaississement du m ésenchy m e, la nécrose fibrinoide et )es thromboses (Pennybaker- Ru sse!). En raison de la perméabilité accrue, une matière colloidale ou amyloidacée est précipitée dans la substance nerveuse. J'ai eu l'occasion d'obscrver des hémorragies capillaires, de la trasudation séreuse, un épaississement cles parois vasculaires de la dégénérescence hyalinée et dcs nécroses dans une tumeur hypophysaire, quelques jours après l'irradiation. L es expériences sur l'animai de Lyman, Ku palov, Scholz (1933) nous apprennent que 6 à 8 mois après l'irradiation ]es artérioles manifestent: une dégénércscence hyalinée, d es thromboses; l es a r tères: un épaississement de l'intima et le rétrécissement du lumen vasculaire. Marburg- Sgalitzcr, Mogilnitzky, Podljaschuk et bien d'autres sont arrivés à des conclusions similaires.

Conséquemment, les altérations histologiques constatées dans le cas présent sont telles que leur rapport direct avec l 'irradiation radiothérapique est trés vraisembable. Nous supposons clon e que la radiothérapie appliquée 8 mois plus tot peut etre responsable de la structure atypique de l'épendyblastome en question. La gravité des altérations vasculaires, les cystes séreux d'un grand nombrc, les zones nécrobiotiques concourent à souligner ce fait. Par égard à la nécrose d e la substance tumorale , nom faisons remarquer que si l'épendymo-
mc est généra lcment radio -résis tant, il faudra cependant admcttre une sensibilité plus prononc ée dans le s formes mures (épendyblastome). Tcl est notre cas et l'effet de l'irradiation s'y montr c évidemment plus accusé.
Certains auteurs (We rth cimer, Allègre, Garde), ont tout récemment établi une différence entre l'épendymome et l'épendymogliome. L a seconde espèce comprendrait les tumeurs dans lesquelles les cellules de type épendymaire e t la prolifération g lial e se rejoignent.
À notre avis, la dénomination de « gliomes mixtes » selon les éléments dont ils se compo se nt est certainement aussi compliquée que

I2J
Fig. 12.- Haematox yline-éos ine. Agrandissement 72. Voir texte.
difficile. La méthodc préalable nous semble plus indiquée: nous tacherons donc la tumeur au type ccllulaire qui s'y trouve en prépondérance. Now. inStStons sur le fait que l'atypie de notre cas ne consistait pas dans la préscncc mixte de diverscs cspèccs g lial es. Elle résidait bien plutot dans la prédisposition nécrotisantc de la substance néoplasique et dans Ics altérations remarquablcment graves des vaisseaux . Ces dernières s'cxpliquent, ainsi quc nous l'avons indiqué, probablemcnt par Ics effets de la radiothérapie.
BIBLIOGRAPHIE
DE LEHOCZKY: Archivio /nu:rnazionale di Studi Neurologici, 1950, I, III.
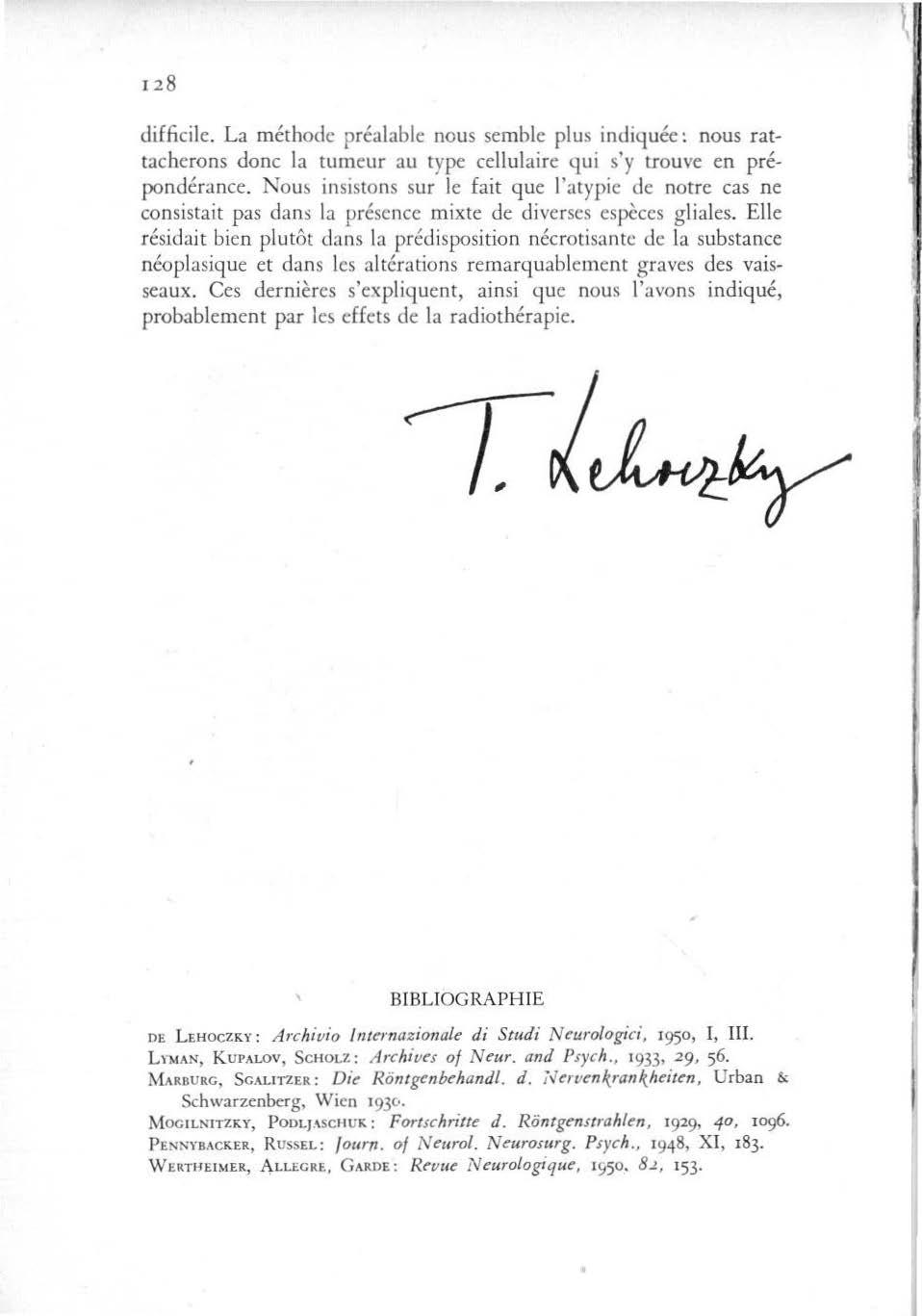
Lnv.N, KuPALOV, ScliOLZ: Archives of Neur. and Psych., 1933, 29, 56
MARBURG, ScALITZER: Dit: Rontgenbehandl. d. Nervenkrankheiten, Urban & Schwarzenberg, Wicn 193c:•.
MociLNITZKY, FortJchritte d. Rontgenstrahlen, 1929, 40, 1096.
PENNYBACKER, RussEL: fourn. of Neurol. Neurosurg. Psych., 1948, XI, 183.
\VERTHEIMER, ALLEGRE, GARDE: Rf'vue Neurologique, 1950. 82, 153.
128
LE CON VE NZ IO N I DI G INEV RA
N ELLA D OT TRINA E NELLA PR A TI C A
In una rivista medica ( r) , che ha indubbiamente la più vasta diffusione nel mondo, è stata inclusa, da du e anni ci rca, una rubrica che, nell'incertezza della situazione internazionale odierna, appare di viva attualità. F.ssa è intitolata: La médecine devant la guerre.
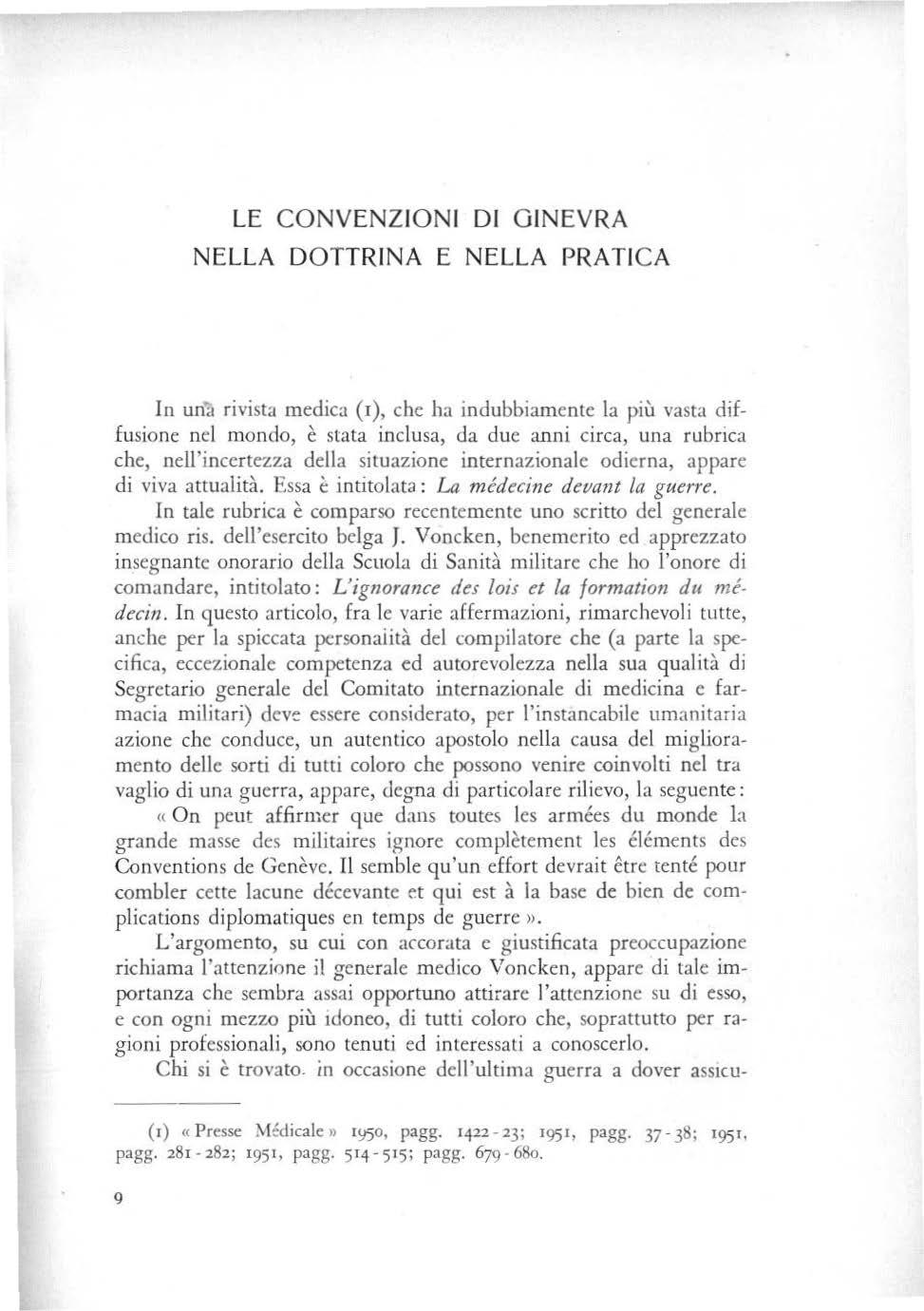
In tale rubrica è comparso recentemente uno scritto del generale medico ris. dell'esercito belga J. Voncken, beneme rito ed apprezzato insegnante onorario della Scuola di Sanità militare che ho l'onore di comandare, intitolato: L'ignorance des lois et la formation du médecin. In questo ar ticolo, fra le varie affermazioni, rimarchevoli tutte, anche per la spicca ta personalità del compilatore che (a parte la specifica, eccezionale competenza ed autorevolezza nella sua qualità di Segretario generale del Comitato internazionale di medi cina c farmacia militari) deve essere considerato, per l'instancabile umanitaria azione che conduce, un autentico apostolo nella causa del mi g lioram ento delle sorti di tutti coloro che possono venire coinvolti nel tra vaglio di una guerra, appare, degna di particolare ril ievo, la seguente:
« On peut affirmer que dans toutes les armées du monde la grande masse des militaires ignore complètement Ics éléments des Conventions dc Genèvc. Il semble qu'un effort devrait ètre tenté pour combler cette lacune d éceva nte et qui est à la base de bien dc complications diplomatiques en temps de guerre>>.
L'argomento, su cui con accorata c giustificata preoccupazione richiama l'attenzione il generale medico Voncken, appare di tale importanza che sembra assai opportuno attirare l 'attenzione su di esso, e con ogni mezzo più tdoneo, di tutti coloro che, so pr attutto per ragioni professionali, sono tenuti ed interessati a conoscerlo.
Chi si è trovato . in occasione dell'ultima guerra a dover asstcu-
9
(1) «Presse 19)0, pagg. 1422 - 23; 1951, pagg. 37-38; 1951, pagg. 281-282; 1951, pagg. sr4-515; pagg. 679 - 68o.
rare in qualsiasi veste e compito, di maggiore o minore portata, l'assistenza sanitaria in un paese (e purtroppo il nostro è stato fra quelli) che ha conosciuto l'occupazione di eserciti stranieri ed il fluttuare della lotta o l'avvicendarsi di situazi01ù diverse, ha sentito assai spesso la necessità di invocare il rispetto delle leggi umanitarie internazionali che allora vigevano .
Quanti di noi, di fronte alla necessità di tutelare gli stabilimenti di cui dovevano assicurare la continuità di funzionamento o di fronte alla necessità di garantire l'indispensabile soccorso e protezione anche a coloro che, per le eccezionali circostanze del momento, potevano essere perseguiti da inumane, anche se ritenute necessarie, prescrizioni dell'occupante, non hanno dovuto cercare una salvaguardia nel testo della Convenzione internazionale di Ginevra che, nell'isolamento in cui si trovavano, ha costituito spesso l'unico mezzo da cui hanno potuto trovare ausilio per risolvere incresciose situazioni?
Lo spirito che anima le nuove Convenzioni internazionali di Ginevra deve considerarsi appunto frutto di tanti orrori, dolori e sofferenze verificatisi in occasione dell'ultimo conflitto mondiale. Per una legge che è comune in natura e per una ben comprensibile reazione, dalle sofferenze inaudite cui l'umanità è stata allora sottoposta, è derivato un organico complesso di norme int ernazionali benefiche.
La data del 12 'agosto 1949, giorno della stipulazione delle nuove Convenzioni di Ginevra, che sono state via via sottoscritte dai rappresentanti diplomatici d i ben 61 Nazioni, deve restare fra guelle degne di tutta la dovuta evidenza nella storia del progresso umano.
Quando si considerino i benefici, sotto ogni forma di assistenza, che furono resi possibili in occasione dell'ultimo conflitto alle istltuzioni che, in vir tù della Convenzione di Ginevra del 1929, operavano sot to gli emblemi della Croce Rossa o quelli sirnilari, e quando si pensa, per contrapposto, a ll 'immensità di sciagure e di dolori che non fu in alcun modo possibile allevi:.Jre per le circostanze eli guerra verificatesi in territori di Nazioni che n on avevano aderito alla Convenzione stessa, si può avere il più alto motivo di compiacimento nel sapere che le nuove Convenzioni sono st ate firmate dalla maggior parte delle Nazioni civili fra cui l'Unione del le Repubb li che Sovietiche e gli Stati ad essa legati da vincoli di trattati.
E' da augurarsi che, con un elevato senso di responsabilità, analogo a quello che ha animato le Alte Parti contraenti nel sottoscrivere le Convenzioni, si addivenga, da parte delle stesse, alla neces-
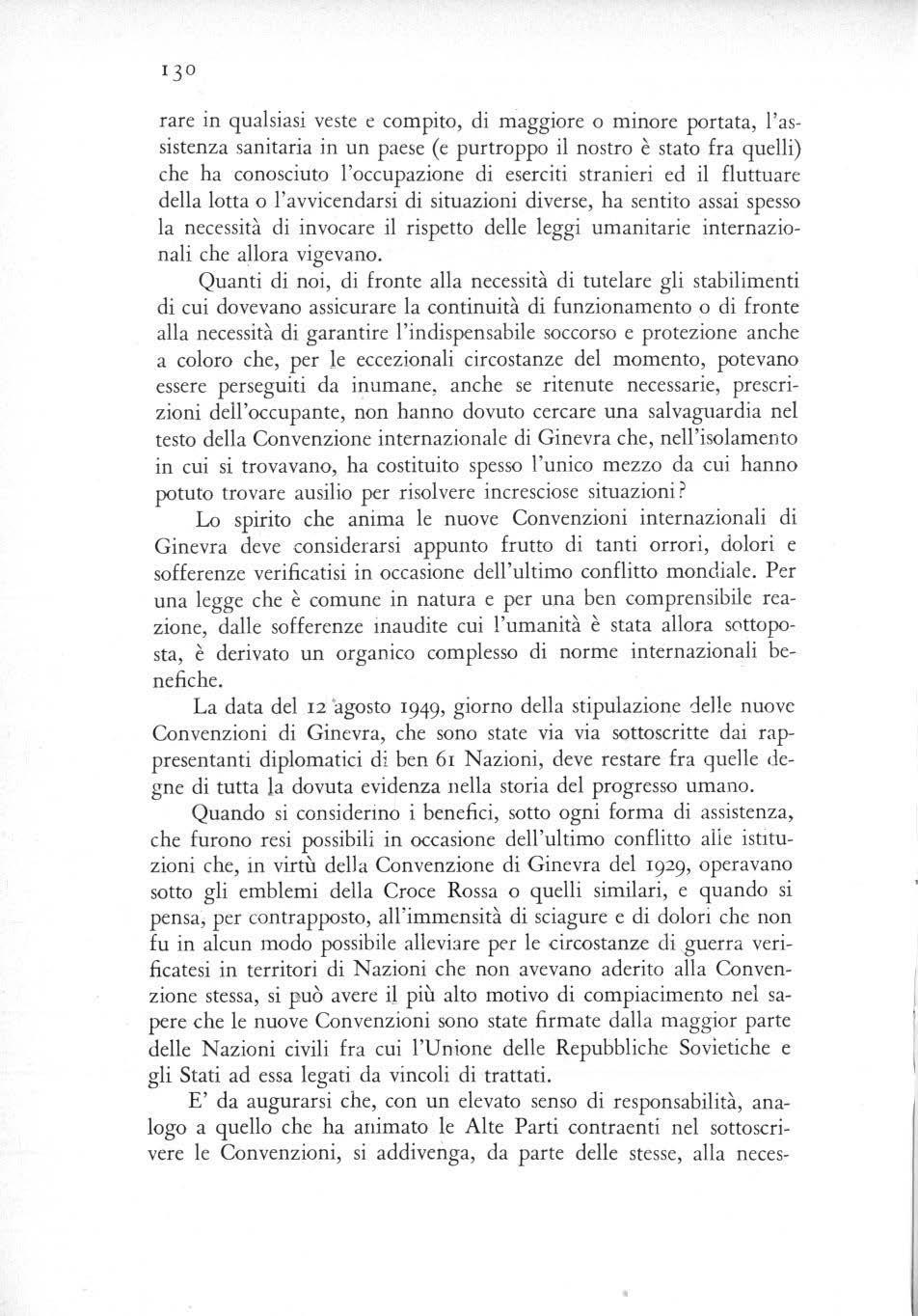
130
saria ratifica, sei mesi soltanto dopo la quale le Convenzioni acquistano valore di leggi.
Dopo queste premesse è opportuno ritornare allo spunto iniziale dell'esposizione e chiederci se si possa convenire con l'affermazione, senza dubbio grave, fatta dal - generale medi co Voncken della troppo scarsa conoscenza delle Convenzioni internazionali dalla quale potrebbe derivare l 'i nefficacia della loro pratica applicazione.
Purtroppo c1 sembra, sia pure con qualche riserva, di dover convenire col generale Voncken sulla constatazione fatta. Ne consegue quindi la necessità di porre in opera quanto è possibile per eliminare il giusto inconveniente lamentato. Senza di ciò vano sarebbe stato il lavoro fatto con tanto elevato se nso di respon sabilità e di umanità da eminenti rappresentanti di varie Nazioni. Senza di ciò dovrebber o restare ster ili i frutti di tante sofferenze che invece, con la piena c sc rupolo sa applicazione delle norme, potrebbero e dovrebbero venire evitate.
Non rientra nei limiti propostimi un 'analisi dettagliata delle Convenzioni. D 'altra parte solo la lettura del testo originale potrebbe adeguatamente illuminare sul loro contenuto.
Non si deve dimenticare che nell'interpretazione di importanti questioni giuridiche dibattute in Convenzioni del genere, talvolta si sollevano questiom di interpretazione dei testi stessi, il che si cerca di ovviare con l a compilazione di essi in vari e lingue.
Dovrò quind1 !imitarmi ad un cen no sommario della costituzione delle nuove Conv enzioni , dello spirito che le anima e delle principali questioni che si agitano per l 'appli cazione di esse
Nel 1939, all ' inizio della seconda guerra mondiale, la so rte dei feriti e dei malati, in caso di guerra, era tutelata dalle norme della Convenzione di Ginevra del 1864 r evisiO nata nel 19o6 n el 1929; quella dei feriti, dei m alati e dei naufraghi nelle guerre sul mare era invece tutebta dalla Convenzione dell'Aia del x899 revi sionata nel 1907, mentre lè n c rme sul trattamentc ciei prigionieri di guerra erano assicurate da apposite Convenzioni stipulate a Ginevra nel 1929.
N essuna specifica convenzione esisteva invece nei riguardi della protezione alle popolazioni civili all'infuori di qualch e articolo contenuto n e lla Convenzione dell'Aia del 1899 concernente le leggi e g l i usi della guerra terrestre , la cui conoscenza ed app lica zione sa-

rcbbe stata, tuttavia, sufficiente ad impedire od almeno a limitare tanti soprusi o crimini commessi nell'ultima guerra mondiale. Voglio riferirmi soprattutto all'artico lo 46 di tale Convenzione così concepito: «L'onore ed i diritti della famiglia, la vita degli individui e la proprietà privata, così come le convinzioni religiose e l'esercizio dei culti devono essere rispettati. La proprietà privata non può essere confiscata » ed all'articolo 50 che sanciva che: « Nessuna pena collettiva, finanziaria o di altro genere, potrà essere applicata alle popolazioni a causa di fatti individuali di cui esse non potranno essere considerate come solidalmente responsabili »
Fu soprattutto la constatata necessità di colmare le defic1enze che le vicende della seconda guerra mondiale avevano rivelato esistere nelle norme internazionali allora vigenti e di adeguare le norme all'evoluzione dei mezzi e delle modalità di condotta della guerra moderna, che indusse, subito dopo la fine delle ostilità, il Comitato Internazion ale della Croce Ro ssa a svol gere un accurato lavoro preparatorio consiste nte dapprima in una raccolta di documentazioni; poi in una conferenza preliminare delle Società Nazionali della Croce Rossa convocata a Gmevra nel 1946, cui seguì la riunione di una commissione di esperti sempre a Ginevra nel 1947.
I progetti elaborati furono ancora oggetto di discussione ed adattamento nella conferenza della Croce Rossa tenuta a Stoccolma nel 1948, presieduta dal compianto Conte Bernadette. Dopo qnesto accurato lavoro preparatorio, finalmente, fu iniziativa del Consiglio Federale Elvetico il convocare la Conferenza Diplomatica che, composta di rappr esentan ti di 63 Governi scelti fra i più competenti giuri sti nel campo del diritto i nternazionale e tecnici, fra cui quelli più qualificati nel campo della medicina militare, iniztò i suoi lavori nell'aprile 1949 e li concluse il 12 agos.to dello stesso anno. Il lavoro è stato condotto quindi co n tutta l a dovuta garanzia di un elaborato e completo scambio di vedute che, talvolta, furono anc he sensibilmente contrastanti . L'elevata capacità ed il senso di responsabilità dei delegati seppero trovare, tuttavia, la più opportuna soluzione a tutte le questioni poste in esame. L e conclusioni a cui si è potuto giungere costituiscono motivo di alta benemerenza per il Comitato Internazionaie della Croce Rossa, per il Governo Svizzero e per tutti i delegati ed esperti che h anno contribuito ai la vori .
In relazione alla .necessità di m eglio classificare gli argomenti trattati ed in riferimento alle differenti categorie di persone di cui
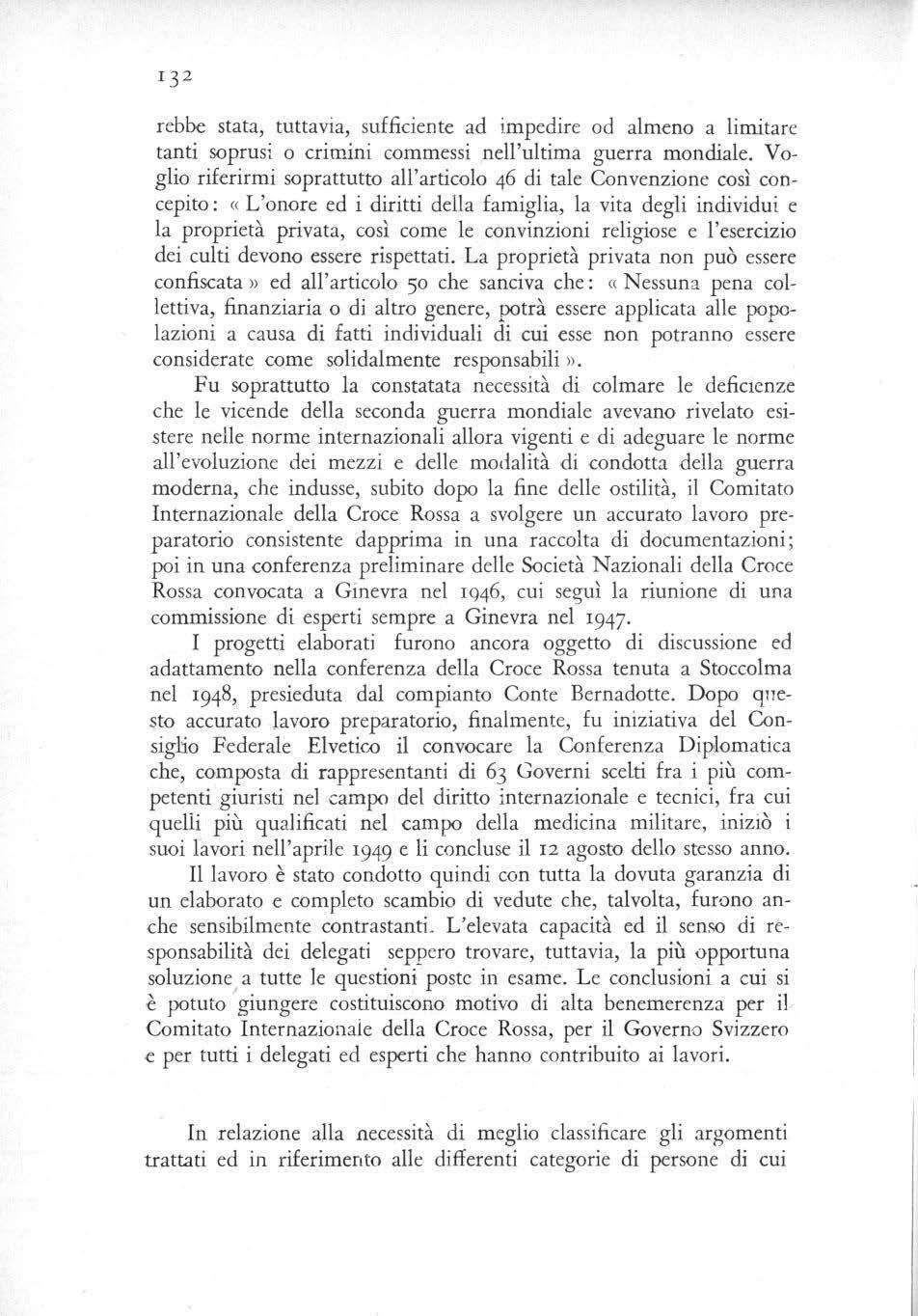
si intendeva tutelare la sorte, la Conferenza Diplomatica addivenne alla stipulazione delle 4 Convenzioni seguenti :
I Convenzione, relativa al miglioramento della sorte dei feriti e malati delle Forze Armate in guerra;
II Co n venzione, relativa al rr attamento dci prigionieri di guerra;
111 Convenzione, per il miglioramento della sorte dci feriti, dei malati e dei naufraghi delle Forze Armate sul mare;
IV Convenzione, per la protezione delle popolazioni civi li in tempo di g uerra.
PRINCIPII GENERALI DELLA COll.lVENZIONE

Lo spirito che ha fatto nascere l 'idea della Croce R ossa, quello di alleviare le sofferenze materiali c morali arreca te agli esseri umani in conseguenza della guerra, rimane il fattore essenziale anche delle nu ove Convenzioni, le quali si riferiscono, tuttavia, anche ai principìi genera li conttnuti nella u Dichiarazione universale dci diritti dell'uomo >> adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il IO dicembre 1948 c c10è: rispetto della personalità umana; garanzia contro le torture, pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti.
DI FFUSIONE DELLE CONOSCE NZE DELLE CONVENZIONI.
Import ante, agli effetti dei dubbi avanzati nelle premesse, è l'impegno, sanzionato dalle P arti contraenti, di dare la massima diffu sione al testo delle Convenzioni fra le rispettive popolazioni e di includere lo studio delle Convenzioni stesse nei programmi di i st ru zione mi litare c civi le . Su questo punto, di essenziale import anza, sarà opportuno ritornare nelle conclusioni.
EsTENSIONE DELLE CONVEN ZIONI ALLA GUERRA CIV ILE, A QUELLA NON DICHIARATA ED ALLE OCCUPAZIONI DI TERR ITO RI SENZA CONFLITTO.
L 'esperienza recente delle dolorose conseguenze di guerre civili, nelle quali più che in quelle a carattere internazionale si manifestano brutali istinti di esseri umani divi si da differenti ideolog1e, h a fatto stabilire i l pri n cipio che le Convenzioni debbano essere applicate anc he quando le ostilità no n rivestono carattere i nternazionale cd insorgano in una parte del territorio di uno Stato contraent e.
Le Convenzioni, inoltre, entrano pure in vigore in cast m cui un qualsiasi conflitto insorga fra Parti contraenti, anche senza prelimin a ri dichiarazioni di g uerr a ed in caso di occupazione di un territorio, anche se non vi sia stata resistenza militare.

ZONe O LOCALITÀ SANITARIE E ZONE DI Sl CUREZ Z ,\.
In rela zio ne a l le caratteristiche ass unte dall'ultima guerra mondiale è da mettere in rilievo l'importanza di creare, in caso di conflitto, prevedcndole fin dal t em po di pace, se n ecessario, apposite zo n e o localit à sanitarie o zo n e di s icurezza, ove gli effetti de\la guerra possono essere ridotti al minimo per un'opportuna dis ta nza da qualsiasi obbiettivo militare. C iò per poter assic ur are un a co n ve niente as!.istenza e serenità ai malati, feriti ed al per!.onale addettovi, oppure per ga rantire un 'adegu ata sicu r ezza a popolazioni in ermi, con speciale riguardo a donne, vecc h i e bambini .
T a li norme mentano tutta l'attenzione e l'approvazione dei medici da qu a ndo si è verificato ch e, per lo sviluppo dell'offesa aerea, per il fluttuare degli eserciti in relazione alla loro motorizzazione o addirittura all a poss ibilità del loro aviotrasporto ed avio lan cio (anche volendo auspicare l'esclu sione di ar m i particolarmente dtstruttive o cieche), qualsiasi zo na del te rritorio di un a Nazi o ne , per qu a nto es te so, può essere sot topo sta ag li orrori di una guer r a .
L'approvazione e l'appoggio dei medici all'applicazione di tali norm e sono dovuti non so ltanto per ragioni um a nitarie m a a n ch e tecniche, in qua nto, come anche l'attuale esperienzl della guerra in Corea insegna, il c riteri o del trattamento a dis t am:a dall e zone rli comba ttim ento va se mpre più affer m andosi . Ciò in virtù sop rattutto dei mig lio r ati m ezzi di sgo mbero e delle poss ibilità co ns entite per es . d ag li a ntibiotic i e ciai mezzi semp r e più efficienti per la prevenzione e cura dello c hoc.
D 'a ltrond e lo sgo m bero a distanza, possibilme nte in t ali zone sanitarie, diviene di n ecessità per la grande fa cilità di movimento dei fronti di co mbattim e nto ch e non consentirebbero a stabilimenti avanzati una po ss ibilità di trattamento -li feriti o m alati, co m e è st at(l invece possibile e convenie n te i n guerra cii posizione
Una norma di vivo interesse perchè ha investito, dolorosamente, nell ' ultima g uerra mondial e anche la classe sa nitaria di un o de i paesi
l - ORME CON1'RO LE ATRO C I TÀ DI GU ER RA.
in lotta (norma che si ripete in p1ù di una delle Convenzioni) è quella, in base alla t}uale saranno proibiti gb attentati alla vita, all'integrità del corpo, le mutilaziont , le torture, la cattura degli ostaggi, gli esperimenti biologici, i trattamenti umilianti e degradanti b d ignità della persona umana.
In casi cii tale genere le Convenzwni prevedono (cosa di grande importanza), una doppia responsabilità e cioè quella dell'esecutore oltre che dello Stato da cui egli dipende. Non potrà quindi l'esecutore di uno dei crimini previsti trarre , a giustificazione, l'argomentazione di aver ottemperato ad un ordine specifico o generico, ma sarà consid erato personalmente responsabile del crimine commes<;o.
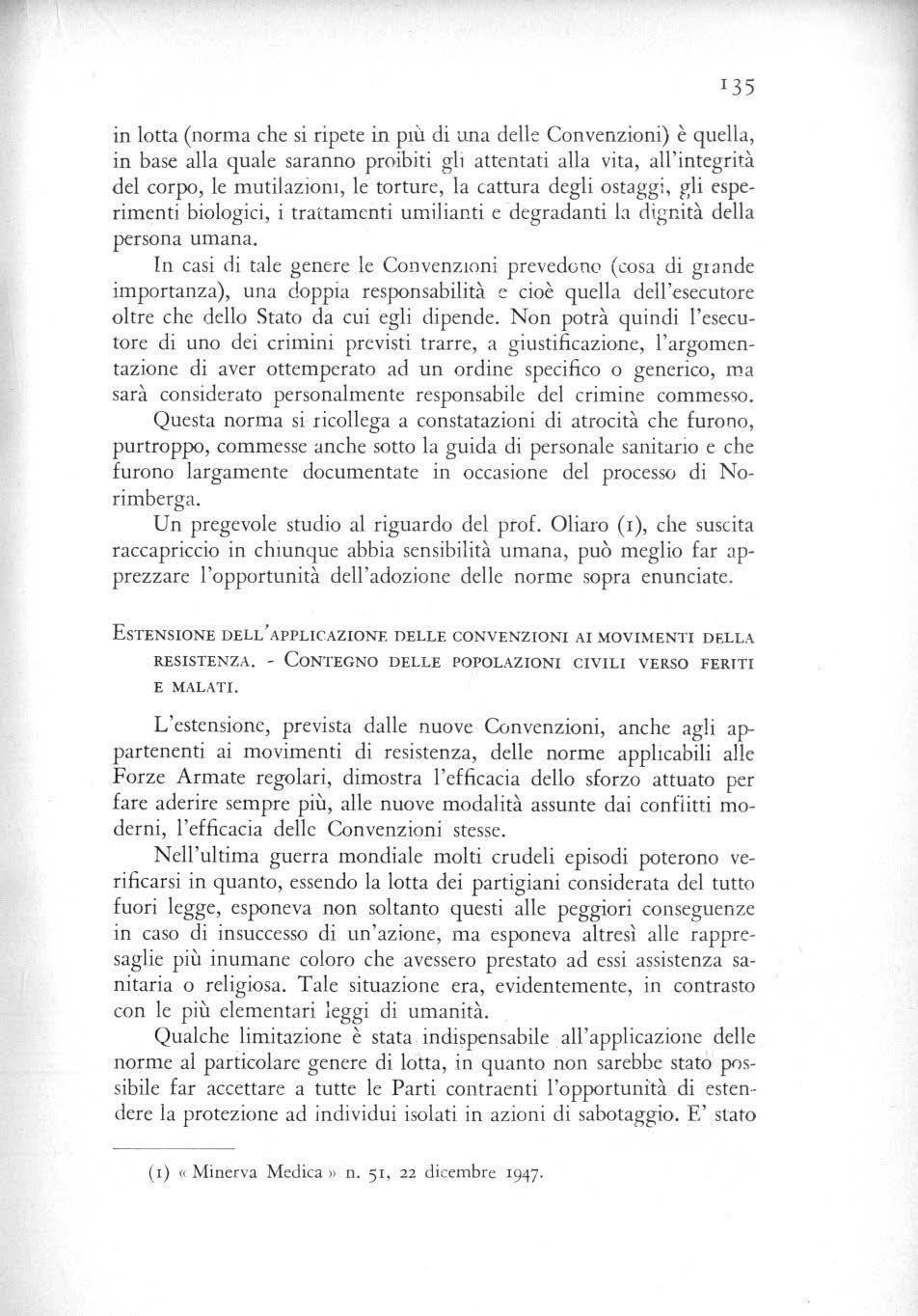
Questa norma si ricollcga a constatazioni di atrocità che furono, purtroppo, commesse anche sotto la guida di personale sanitario e che furono largamente documentate in occasione del procesSù di Norimberga.
Un pregevole studio al riguardo del prof. Oliaro (r), che suscita raccapriccio in chiunque abbia sensibilità umana, può meglio far apprezzare l'opportunità dell'adozione delle norme sopra enunciate.
EsTENSIONE DELL ' APPLIC'AZIONF. DELLE CONVENZIONI AI MOVIMENTI DELLA
RESISTENZA. - CONTEGNO DELLE POPOLAZIONI CIVILI VERSO fERITI E MALATI.
L'estensione, prevista dalle nuove Convenzioni, anche agli appartenenti ai movimenti di resistenza, delle norme apphcabili alle Forze Armate regolari, dimostra l'efficacia dello sforzo attuato per fare aderire sempre più, alle nuove moda lità assunte dai confiitti moderni, l'efficacia delle Convenzioni stesse .
Nell'ultima guerra mondiale molti crudeli episodi poterono verificarsi in quanto, essendo la lotta dei partigiani considerata del tutto fuor i legge, esponeva non soltanto questi alle peggiori conseguenze in caso di insuccesso di un ' azione, ma esponeva altresì alle rappresag lie più inumane coloro che avessero prestato ad essi assistenza sanitaria o religiosa. Tale situazione era, evidentemente, in contrasto con le più elementari leggi di umanità.
Qualche limitazione è stata all'app l icazione delle norme al particolare genere di lotta, in quanto non sarebbe stato pnssibile far accettare a tutte le Parti contraenti l'opportunìtà di e stendere la protezione ad individui i solati in azioni di sabotaggio. E' stato
(r) « Miner va Medica » n. sr, 22 dicembre 1947.
considerato, in linea d1 reqmslto necessario per il diritto alla estensione delle Convenzioni, una regolare organizzazione dei movimenti della resistenza e l'ottemperanza di questi alle norme del diritto internazionale.
Le stesse norme si applicano anche alle popolazioni civ:Ii, anche quando, non preventivamente organizzate, insorgono contro un mvasore e sempre che, tali popolazioni, risultino ricorrere all'uso delle armi in maniera palese e rispettino le leggi di guerra.
Fra tali leggi le nuove Convenzioni comprendono la prescrizione di rispettare non solo, ma anche di soccorrere , i feriti o malati di parte avversaria che, per le vicende di guerra (clementi paracadutisti o della resistenza), vengono a trovarsi isolati. Tale principio sanziona, per logico contrapposto, che nessuna molestia potrà essere arrecata per aver prestato assistenza o cure a feriti e malati. In tal modo viene ad essere rimosso un inumano ostacolo, col quale, nell'ultima guerra mondiale, si erano stabiiiti limiti inammissibili all'attività del personale sanitario o di chiunque nutrisse sentimenti di pietà.

TRATTAMENTO DEL PERSONALE SANITARIO E RELIGIOSO.
La so luzione di tale argomento fu tra quelle che suscitarono nella Conferenza Diplomatica i maggiori dissensi in quanto, in base alle contingenze verifica tesi in occasione dcii 'ultimo conflitto mondiale, alcune Parti contraenti avrebbero ravvisato la nece ssità di applicare le norme generiche stabilite per i prigioni eri di guerra anche al personale medico e religioso.
Prevalse invece, assai opportunamente, una tesi meno intransigente, sostenuta, fra l'altro, dalla nostra Delega zione In tal modo fu stabilito che il oersonale sanitario caduto in mano al nemico non foss e consider:lto prigioniero, pur beneficiando del minimo dei diritti di tale categoria. La restituzione di tal e versonale, dopo assicurata la necessaria assistenza sanitaria ai prigioni eri, è prevista dalle norme adottate, che ne stabiìiscono le modalità.
Restano tuttavia alcuni dubbi che tutte le clausol e wora enunciate possano non trovare all'atto pratico piena e soddisf;cente applicazione, qualora venisse data, sia pure nei limiti della termino!ogia giuridica adottata, un'interpret az ione troppo restrittiva da parte di qualche Parte contraente.
Tale qu es tione è !>tata portata, di recente, all'attenzione della classe sanitaria (la più interessa ta, non tanto per le ripercussioni eventuali verso se stessa, ma per quelle che potrebbero aversi nei riguardi
q6
dell'efficacia dell'attivttà benefica da svolgere) da parte del generale medico Voncken (r) che è stato ed è fra gli infaticabili sostenitori che lo stato giuridico dei medici in un conflitto mondiale dovrebbe essere tale da porli, senza limiti di sorta, al disopra ed al di fuori della mi sc hia .
Il Comitato Internazionale della Croce Rossa ha predisposto un apposito questionario, indirizzato a tutte le autorità medico-militari ed assistenziali del mondo. Tale questionario vorrebbe clùarire il pensiero dei tecni ci sulle modalità pratiche di attuazione delle norme relative alla protezione del person::tle nello spirito delle conclusioni raggiunte dalle Convenzioni di Ginevra. In base al con tributo, certamente di grande interesse, che le risposte al questionario stesso potranno offrire, l'argomento verrà discusso nelle prossime riunioni del Comitato Intern aziO nale di Medicina c Farmacia Militari.
Sempre allo scopo di rendere opcrant;, con maggiore agio c chiarezza, nei riguardi del personale protetto e quindi delle funzioni che questo deve assolvere, le norme delle Convenzioni di Ginevra. si dovrà discutere, nello stesso Comitato, anche tale importante argomento per il quale, a scopo preparatorio, la 13• Sessione dell'Ufficio Intern a zionale di Medicin.t Militare, riunitasi a Monaco nel maggio r950, ha rivolto a nltte le Direzioni dei Servizi Sanitari dei vari Eserciti un apposito questionario.
Le Convenzioni eh Ginevra del 1949, tenendo conto de1 gravi inconvenienti verificatisi durante l'ultimo confli tto mondiale pe r il mancato tempestivo riconoscimento di appancnenza a personale protetto, in assenza di idonei documenti di identità, hanno ribadito la necessità (già d'altra parte prevista dalle precedenti Convenzioni) che tale personale porti al braccio sinistro il segno distintivo della Croce Rossa col timbro del Comando Militare e sia munito di te sse ra di identità che dovrà portare la fotografia e J'jmpronta digitale oltre ai comuni connotati.
Una carta consimile, secon do l'articolo 20 della IV Convenzione dj Ginevra del 1949, dovrà essere rilasciata anche al personale degli Ospedali Civili che, in caso di c0nflitti, fanno parte delle I stituzion i che devo no beneficiare delle norme intern azionali.
E ' precisato, fra l'altro, che tali ospedali dovranno tenere aggior-
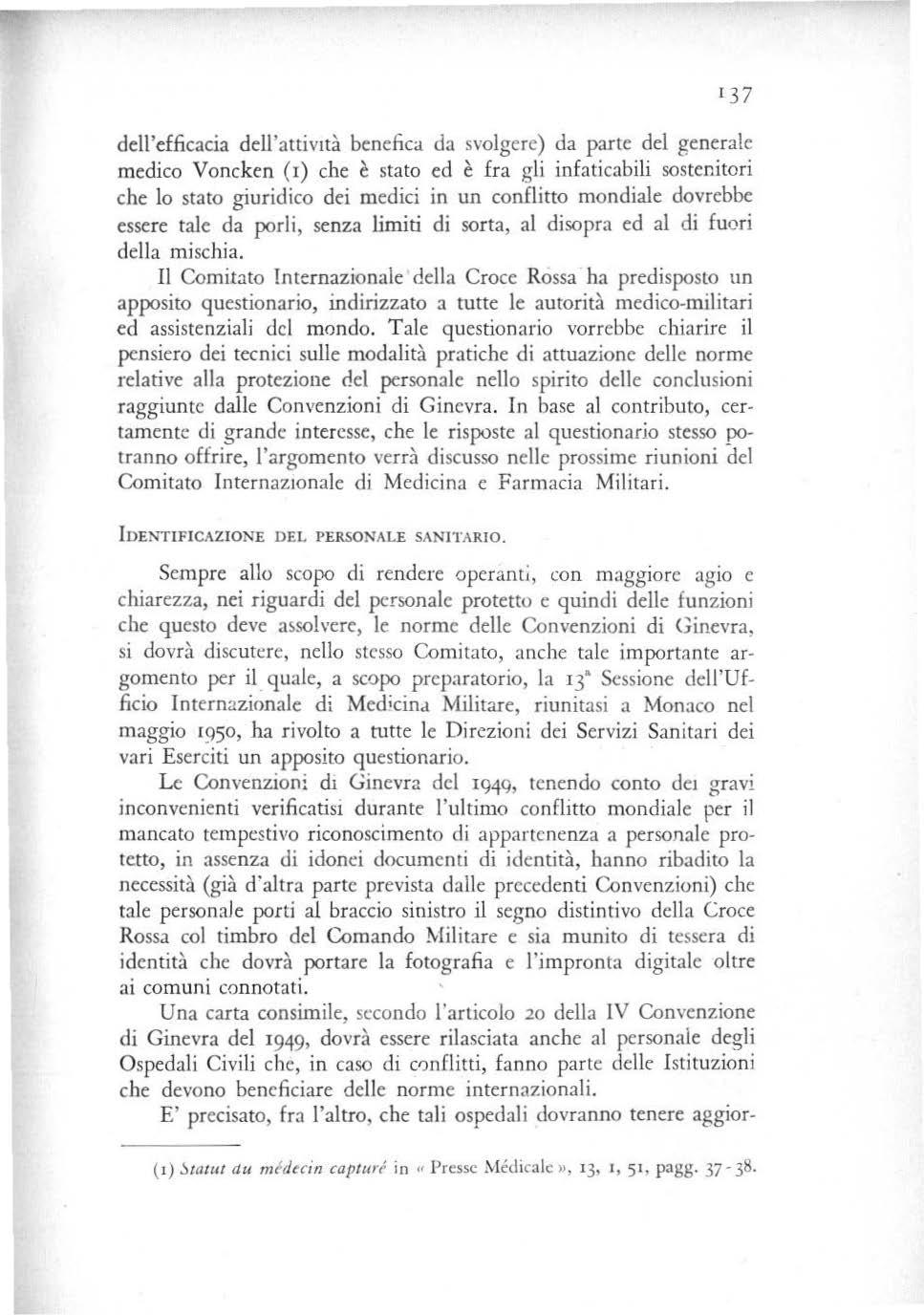 IDENTIFI CAZIONE DEL PERSONALE SAN I TARIO.
IDENTIFI CAZIONE DEL PERSONALE SAN I TARIO.
( 1) l au médtcin capturr i n •• Presse .\<1éd icalc: » , 13, r, 51, pagg. 37- 38.
nato un elenco comprendente appunto il personale da considerarsi protetto.
Secondo il testo del questionario si cercherà di chiarire l'opportunità d i fissare un modello di carta d'identità ul'iico per tutti gli Stati aderenti alle Convenzioni. Inoltre, nell'occasio ne, è stato sollevata la questione dell'opportunità di adottare distintivi unici per tutti i serv izi sanitari degli eserciti delle parti contraenti.
Si è pure sollevata la que stione di allegare al docun1ento di identità il testo del <<g iuramento » (derivato da quello di lppocrate) adottato dall'Associazione Medi ca Militare Mondiale; giuramento che dovrebbe essere sottoscritto dal titolare della tessera d'identità. Tale giuramento vincolerebbe solennemente al compimento dei doveri umanitari stabiliti dalle norme professionali e da ll e Convenzioni ed impegnerebbe, altrettanto solennemente, a sottrarsi ad eventuali atti contrari ai principii stessi (doveri negativi, secondo il generale Voncken), che dovessero esse re imposti al personale sanitJrio.
Non vi è dubbio che l'unificazione di distintivo c tale giuramento potrebbero avere ,m alto valore morale nello stabilire quei legami di sempre maggiore affratellamento di cui si intravede la necessità fra i medici di ogni Nazione devoluti a le nire , in circostanze tanto tragiche come quelle della guerra, le sofferenze umane.
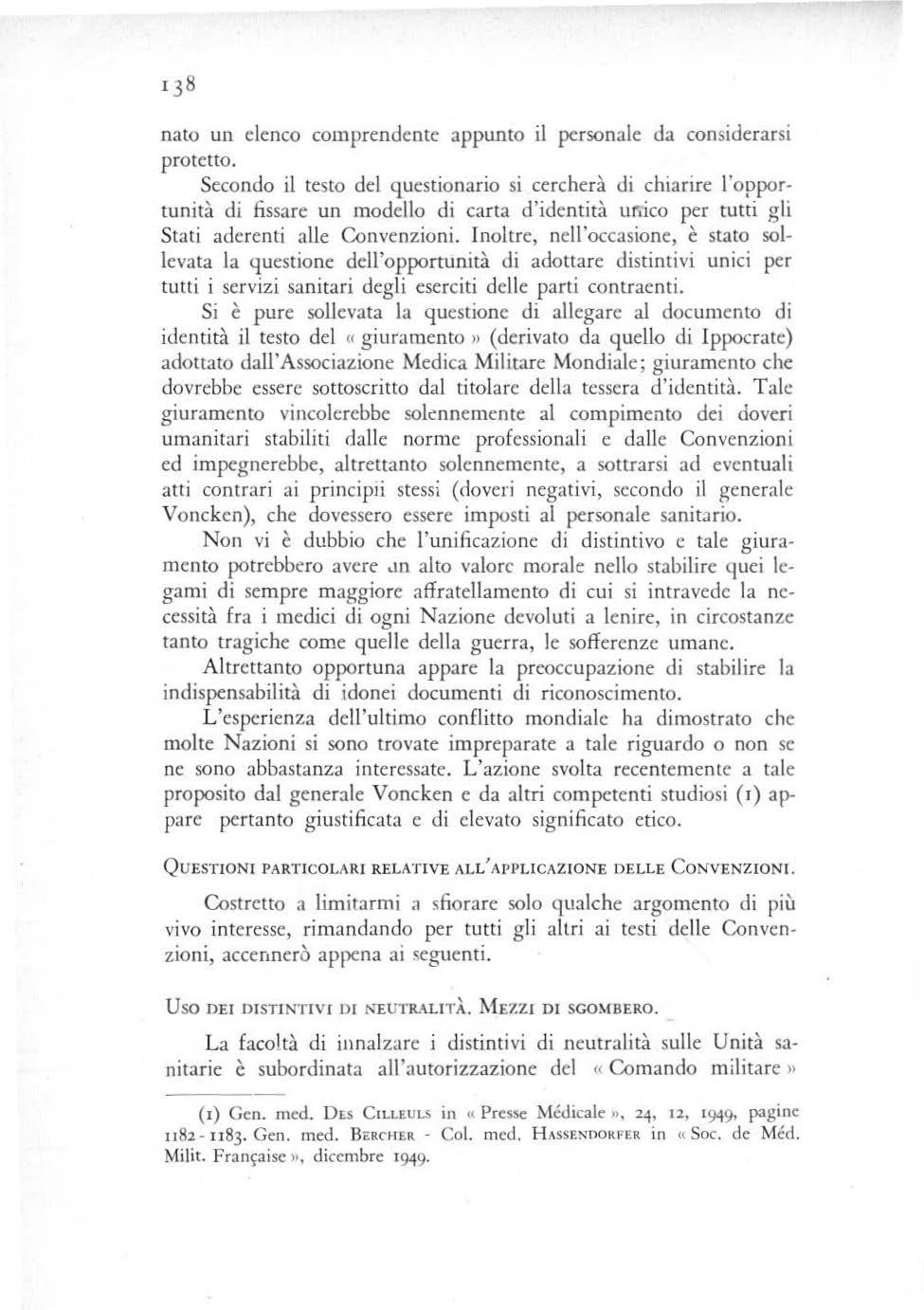
Altrettanto opportuna appare la preoccupazione di stabilire la indispensabilità di idonei documenti di riconoscimento.
L 'espe rienza dell'ultimo conflitto mondiale ha dimostrato che molte Nazioni si sono trovate i m preparate a tale riguardo o non se ne sono abbastanza in teressate. L 'azione svo l ta recentement e a tal e proposito dal generale Voncken e da altri competenti studiosi (1) appare per ta nto giustificata c di elevato significato etico.
QUESTIONI PARTICOLARI RELATIVE ALL'APP LI CAZIONE DELLE CONVENZIONI.
Costretto a !imitarmi él sfiorare solo qualche argomento di più vivo int eresse, rimandando per tu tti g li altri ai testi de ll e Convenzioni, accennerò appena ai segue nti.
Uso DEI msnNTivr m 1\'".EUTRAUTÀ. MEZZI DI SGOMBERO.
L a facoltà di innalzare i distintivi di neutralità sulle Unità sanitarie è subordinata all'autorizzazione del <<Comando militare 11
'94 9·
( 1) Gcn. med. DE s CILLEULS in •• Presse M édicale " • 24, 12, 1949, pagine u8z-n83. Gen. med. Br:RCIIER - Col. mcd. HAs SEN OOkF ER in « Soc. de Méd Milit. Française l>, dicembre
cui l'Unità appartiene. Da tale pnne1p10 consegue, logicamente, quello che soprattutto le Unità avanzate, cui per ragioni tattiche venga inibito l'uso degli emblemi di neutralità, si avvalgano, con opportuni criteri, di m1sure di mimetizzazione.
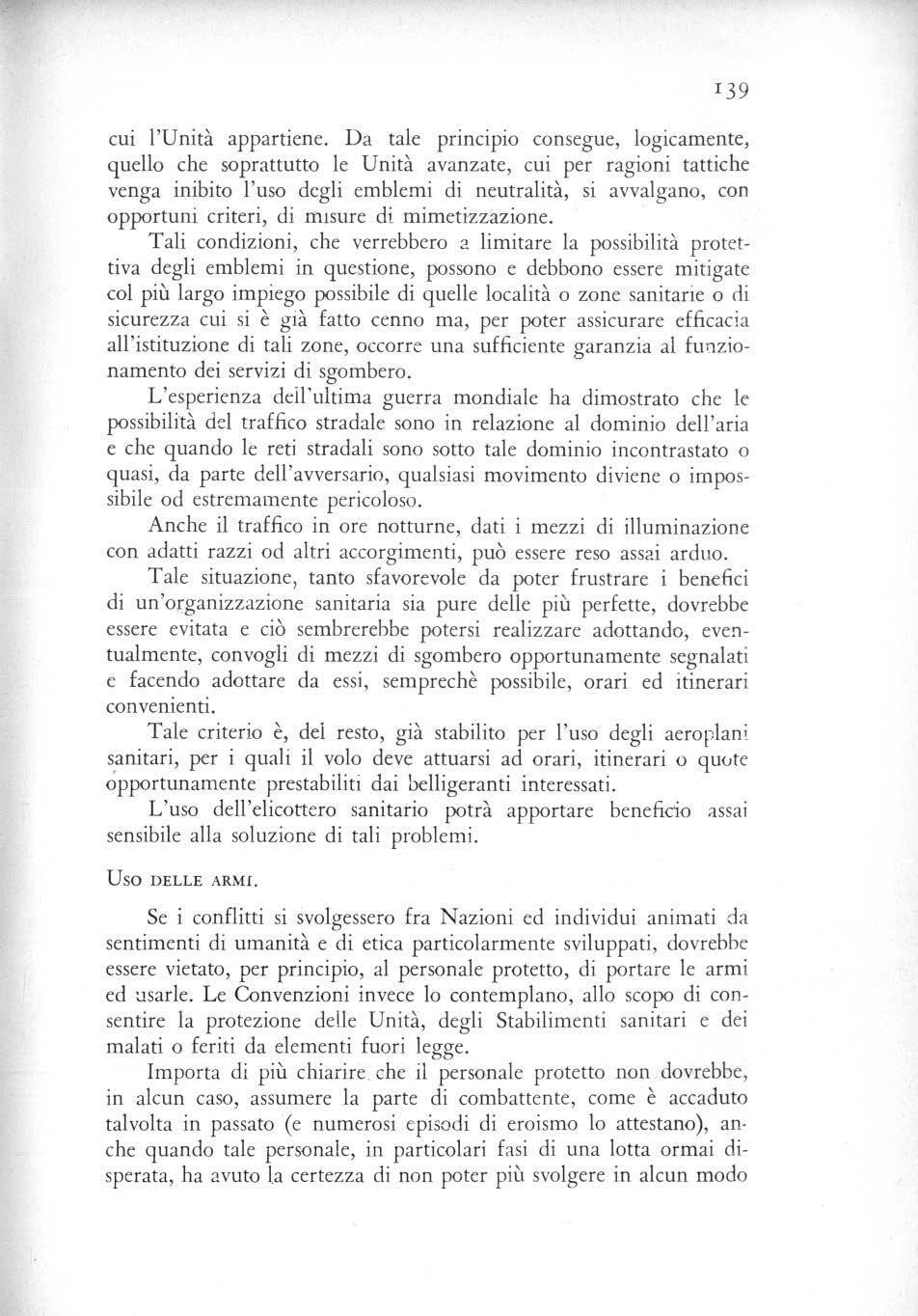
Tali condizioni, che verrebbero a limitare la possibilità protettiva degli emb lemi in questione, possono e debbono essere mitigate col più largo impiego possibile di. quelle località o zone sanitarie o cii sicurezza cui si è già fatto cenno ma, per po ter assicurare efficacia all'is tituz ione di tali zone, occorre una su fficiente garanzia al funzionamento dei. servizi di sgombero.
L'esperienza deil'ultima guerra mondiale ha dimostrato che le poss ibi l ità dd traffico strada le sono in relazione al dominio de ll 'aria e che quando le re ti stradali sono sotto tale dominio incontrastato o quasi, da parte dell'avversario, qualsiasi movimento diviene o impossibile od estremamente pericoloso .
Anche il traffico in ore notturne, dati i mezzi di illuminazione con adatti razzi od altri accorgiment i, può essere reso assai arduo.
Tale situazione, tanto sfavorevole da poter frustrare i benefici di un'organizzazione sanitaria sia pure delle più pe r fette, dovrebbe essere evitata e ciò sembrerebbe potersi realizzare adottando, eventualme nt e, convogli eli mezzi di sgombero opportunamente segnalati c facendo adottare da ess i , semprechè possibi le , orari ed itinerari convenienti .
Tale criterio è, del resto, già stabilito per l'uso degli aeroplani s.anitari, per i quali il vo lo deve at tuarsi ad orari, it inerari o quvte opportunamente prestabiliti dai belligeranti interessati.
L'uso dell'elicottero sa nitari o potrà appo rtare beneficio assai sensibile alla soluzione di tali problemi.
Uso DEL LE ARMI.
Se i conflitti si svolgessero fra Naz ioni ed individui animati da se ntim e nt i di um a nit à e di etica particolarmente svil u ppati, dovrebbe esse r e vie t ato, per principio, al personale protetto, di portare le armi ed usarle . L e Convenzioni invece Io contemplano, allo scopo di consentire la protezione delle Unità, degli Stabilimenti sanita r i e dei malati o feriti da el ementi fuori legge.
Importa dr pi ù chiarire ch e il personale protetto non dovrebbe, i n alcun caso, assumere la parte di comba tt ente, co m e è accadu to t alvol t a in passato (e numerosi episodi di ero ismo lo attestano), an· che quando tale personale, in particolari fasi di una lotta o rm ai disp e rata, ha av uto la certezza d i no n poter più svo lgere in alcun modo
139
la sua funzione umanitaria. Il principio sancito dalle nuove Convenzioni che, in nessun caso, i feriti, i malati ed il personale sanitario e religioso, possono rinunciare, sia parzialmente che totalmente, ai diritti loro riservati dalle Convenzioni stesse. non sembra consentire dubbi in proposito.
La sco rsa fatta su alcuni soltanto dci principali argomenti tratta ti dalle nuove Convenzioni, per quanto necessariamente breve e frammentaria, dovrebbe es:>ere sufficiente a dimostrare, a conforto dei senti m enti di umanità che devono animare soprattutto -.:hi è destinato a prestare assistenza a malati e feriti in caso di guerra, cb<' le atrocttà, le sofferenze, le difficoltà verificatesi nell'ultimo conflitto mondiale hanno indotto le Nazi oni civili a predisporre opportun<' con trom isu re.
Le sanzioni, previste in caso di tra:>gressione all'applicazione di tali norme, sanzioni su cui le C-onvenzioni stesse si diffondono negli indispensabili dettagli giuridici, dovrebbero essere suffici enti a garantire il rispetto delle norme stesse anche in carenza di quella particolare sensibilità che dovrebbe animare tutti i popoli degni dell ' appellativo di civili.
M a le Convenzioni sarebbero destinate a rimanere senza scopo, se non si realizzasse la più diffusa conoscenza di esse. Dovrebbe essere, innanzitutto, colmata la grave lacuna lamentata dal gene ral e medico Voncken con le espressioni ricordate all'inizio della trattazione.
Anche se, a nostro conforto di Italiani, possiamo citare che alla nostra « I struzione per il se rvi zio di Sanità in guerra 'l ( edizion e r935) era riportato in appendice il t esto delle Com·enzioni di Ginevra del 27 luglio 1929; che la raccolta delle Convenzioni I nt e rn azionali, sia riguardanti i feriti e i malati che i prigiomeri di guerra, erano a disposizione dei principali Comandi sotto forma dt pubblicazioni curate dal Ministero della Difesa e se, ancora, possiamo ricordare, a titolo di onore per la no stra Sanità Militare, il fatto citato recentemente dal generale Voncken ( r) , della priorità nella iniziativa di creare la nostra Scuola di Sanità Militare di Firenze una Cattedra di etica medica internazionale, non dobbiamo tuttavia di sconoscere che molto ancora debba essere fatto perchè lo spirito e la materia delle Convenzioni possano entrare a per-
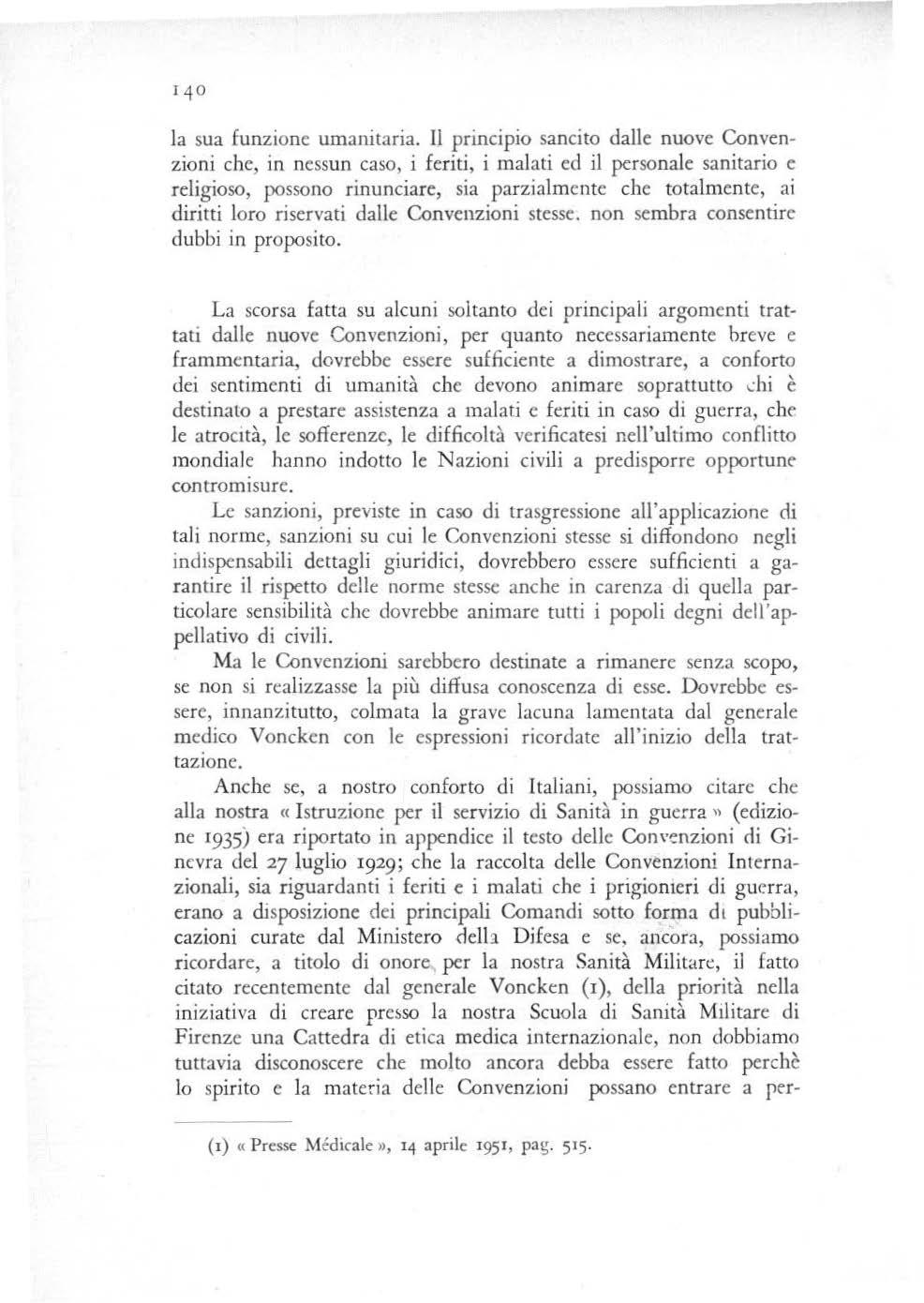
(x) << Presse Méd icale >>, 14 aprile 1951, pa g 515.
mear e gli animi di tutti quanti sono tenuti ad adottarle, risoettarle o di coloro che possono avere necessità della protezione da esse accordata.
Solo a tali condizioni le Convenzioni potranno aver ragione di essere. Solo così questa grande concezione umanitaria che è rappresentata dalle nuove co nvenzioni di Ginevra - una delle poche realizzazioni che possa attenuare il senso di sconforto che deriva dal dover constatare come tante meravigliose conquiste recenti del pensiero umano valgano a creare nuovi argomenti di preoccupazioni e di pericoli, anzichè di sollievo - potrà assolvere a quegli Kopi per cui fu ideata ed attuata in virtù del pensiero e dell'azione di Henry Dunant. Il mancare al dovere di contribuire, con ogru mezzo, a far cOnoscere le prescrizioni delle Convenzioni eq uivale già, per le P arti contraenti, ad una violazione di esse, oltre che ad un tradimento nei riguardi degli elevati scopi, per conseg uire i quali le Parti stesse hanno contribuito.
Pertan to è anzitutto che lo studio delle Convenzioni di Ginevra, nel loro spirito e nelle loro clausole più importanti, venga a costituire materia obbligatoria d ' insegnamento in tutt e le Accademie militari, Scuole militari per ufficiali, allievi ufficiali e sottuffìciali. Il programma dovrà essere, naturalmente, opport unam en t e adattato ai vari ambienti. Così, nelle Scuole per il personale di Marina esso comprenderà particolarmente la materia contenuta nella III Convenzione, mentr e il personale dell'Aeronautica dovrà essere particolarmente istruito sui doveri relativi al rispetto d elle Unità, Stabilimenti e mezzi di trasporto contrassegnati dagli emblemi di neutralità.
A tale proposito si ravvisa la nece ssi tà che, per garantire ai mezzi aerei sanitari di svo lger e le loro mlSSioni, venga prevista la possibilità di rendere neutr ali, con opportune segnalazioni, appositi campi di aviazione di slocati il più possibi le in prossimità di « zon e sanitarie » . Ciò in considerazione che i comuni campi di aviazione, costituendo obbiettivi bellici di particolare importanza, male si presterebbero per consentire l'umanitaria attività di aerei sanitari.
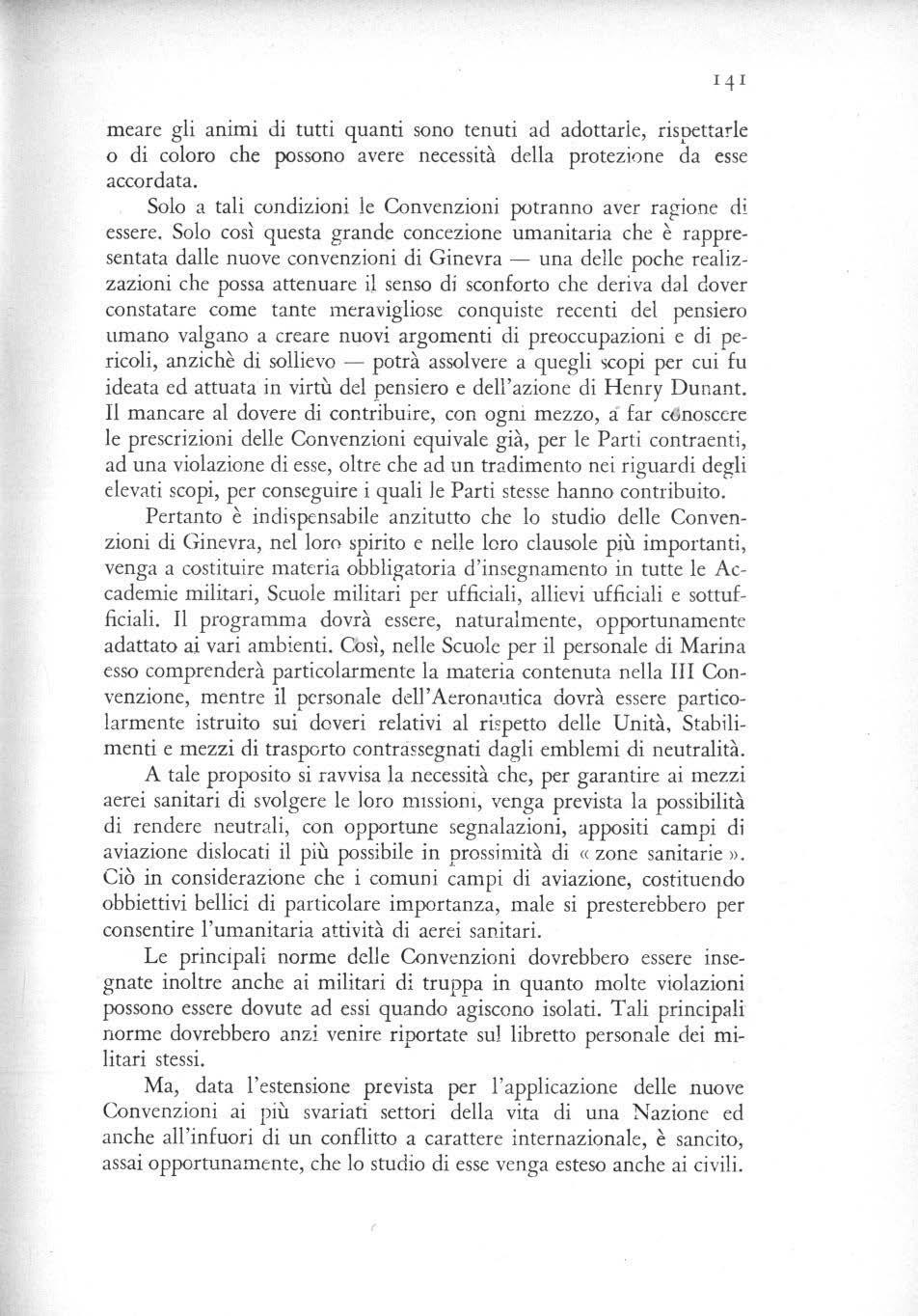
Le principali norme deUe Convenzioni dovrebb ero essere insegnate inoltre anche ai militari di truppa in quanto molte violazioni possono essere dovute ad essi quando agiscono isolati. Tali principali norme dovrebbero anzi venire riportate sul libretto personale dei militari stessi.
Ma, data l' es tensione prevista per l'applicazione delle nuove Convenzioni ai più svar iati settori della vita di una Nazione ed anche all'i nfuori di un conflitto a carattere i nternazional e, è sancito, assai opportunamente, che lo studio di esse venga esteso anche ai civili .
Senza entrare troppo in detta gli appare evidente la n ecessità che tutti i sa nitari abbiano una sufficient e co no scenza delle Conv enzioni , dei diritti e dei doveri che dall'applicazione di esse rlerivano, così da poterle sempr e rispettare, non solo, ma da poter esse re se mpre in gra do di esige rn e anche l'o sse rv anz a. Alla realizzazione di ciò m olto potrebbero contrib u ire gli « Ordini dci Me dici >> attraver so un'azione comune. predisposta dalla F ede razi one deg li Ordini ste ssi, oppure dagli orga ni equ ival en ti per le altre N azioni

A d evitare poi l'inconveniente vcrificatosi in occasione dell'u ltimo conflitto che, proprio nel mom e nto in cui si rendeva necessario adoperarsi per esigere il ri spetto delle norm e delle Convenzioni internazionali, riu sciva arduo, se non impossibile, repen rne un t es to, dov r ebbe essere prescritto che i testi in questione o, per lo meno, adegua ti stralci di essi (stralci che per aver valore dovrebbero esse re predisposti co n accordi supplementar i fra le Parti , e, possibilmente, pub · blicati a cura del Comitato Internazionale della Croce R o ssa) costituiscano dotazione fi ssa di dete rmin ati Ent i od uffici . Tra questi semb rerebb e ne cessa rio includere so prattutto : la direzion e degli militari e civili senza di stinzione d 'impo rtanza; i Comuni, soprattutto pe r u so degl i ufficiali sanitari; le Università degli Studi , presso le quali, co me già si è attuato in a ltre Nazioni, l'inse g namen to, per quanto rig uarda gli studenti di medicina, dovrebbe entrare a far parte del programma di Medicina L ega l e In oltre, dato che le Convenzioni riguard a no oltre al personale san itario quell o religioso e tenuto conto d ella distribuzione capillare del Clero, si vedrebbe opportuno che i testi delle C'..onvenzion i costituissero materia di studio negli I stitut i ec clesia stici e dotazione degli Uffici parrocchiali. Con tali principali m odalità sembrerebbe possibile assicurare, oltre che la più es t esa cono sce nza delle Convenzioni, anc h e la reperibilità del loro testo in caso di necessità.
T utti questi ac corgi menti non sarebbero però ancora sufficienti se, da parte di chiunqu e abbia se ntim enti di umanità, non si reagisse per vincere lo scettic ismo di colo ro c h e, forse per le dolorose circostanze verificatesi nell'ultimo conflitto mondiale, non hanno eccessiva fiducia nell'applicabilità pratica di molte dell e norm e sancite dalle Convenzioni internazionali.
Estensione della co no sce n za delle Convenz ioni, delle sa nzioni p rev iste per l 'inade mpie nz a di esse e reazione contro lo sce ttici s m o ch e può sussi ste re ::irca la lo ro efficacia; sono i presuppos ti esse nz ia L i perchè l'umani t à possa avere ancora un mezzo, sia pure inadeguato , per lenir e i dolo r i e g li orrori che i m oderni conflitti, a ttra -
verso restensione che tendono ad a ssumere ed mezz1 di lottJ impiegati, determinano.
Deve essere considerata utopia la possibilità che le norme delle Convenzioni possano trovare applicazione qualora, in deprecata ipotesi, se ne dovesse verificare la neces sità? Si può rispondere negativamente quando si consideri soltanto tutta la benefica opera che ha potuto svo lgere la Croce Rossa Int ernazionale in occasione dell'ultima guerra mondiale.
Ma anche se utopia potesse sembrare, ugualmente indispensabile adoperarsi con entusiasmo e fed e per la sua realizzazione, nella certezza che, presto o tardi, le forze del bene finiscono sempre per prevalere su quelle del male.
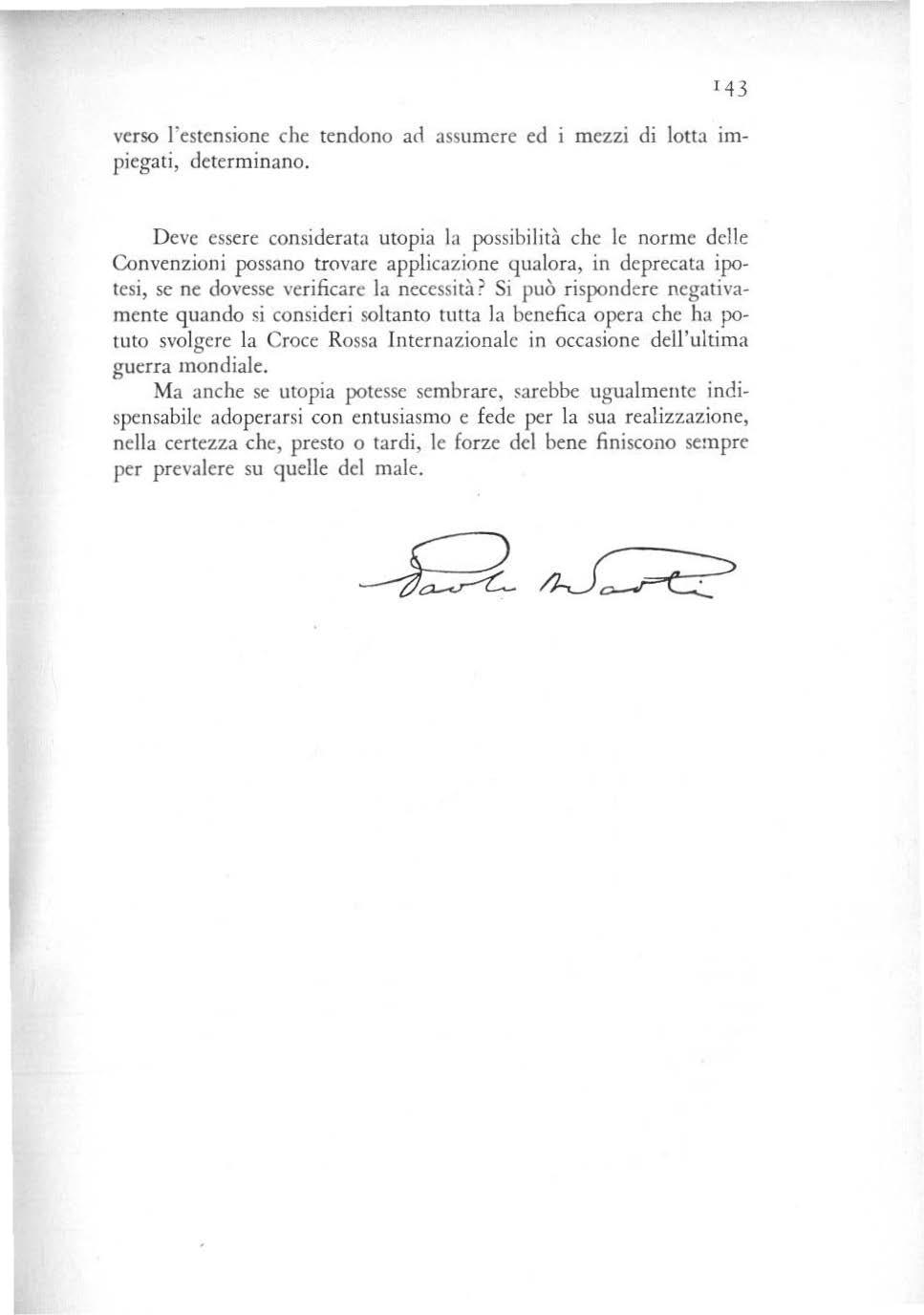
MOD I FI CA Z I ON I
DE G LI A N A LI ZZATO RI CORT ICALI E PER I FERIC I
ll determinismo de i riflessi condizionati comincia a richiamare orm ai l'attenzione degli studiosi ed è facile presagire il sicuro pro fitto, anche per la farmacologia, del la fine ana lis i delle alterazioni psichiche indotte Ja farmaci . E' vero simile che non solo vecchie sostanze ad azione cerebrale m a soprattutto nuovi farmaci di produzi _ e sintetica vengano a fornire nuovi ist rum enti utili all' es ame della formazione e dell 'a lte raz ione di ri sposte p sic hi che «co ndizionate ,,, favorendo, altresì, inte ressa nti interpre tazioni sia dell'effetto di farmaci « stimolanti >, le funzioni corticali (o come s1 diceva una volta « n ervini ») sia degli effetti più o meno g-ravemente dissennanti di altri farmaci. Credo, anzi, che l ' interpretaziOne di certe <<e bbrezze » to ssic he possa risultarne avvantaggiata, trasportando il fatuo ed incomprensibile turbamento psichico su un t erreno fisiologicamente co m pre n sibile e sufficientemen t e schematizzabile.
La m in utis sima in dagin e, p. es., di mol ti dci caratteri stici turbamenti psichici e sensoriali d a morfina e cocaina, diversissimi fra loro, con sente, a mi o avviso , di intra vede re una certa unità n el senso di dna alterata reazi one a stimoli interni cd esterni. L'associarsi e l'orientarsi di molte id ee, l a conoscen z a de l mondo es t erno ed il g iud izio relativo, sempr e più conso lidati in ciascun soggclto normal e, provengono normalmente dal continuo ori gina rsi di sensazioni e rappresentazioni , de r ivate dagli « analizzatori)) (r) interni ed esterni, se m pre p iù coo rdinati per ripetizion e (abi tudine) e facilmen te attiv abi li a nch e dall'eccitamento di altre zone sensoriali per collegamento co ndi · zionato . Modifi cazio ni temporanee a carico delle funzioni degli anal izzatori potrebb e ro esse r suffi cie nti a sovvert ire questa norm ale e ben co nsolid ata catena. L 'i ndizi o più imperlante di alte razione degli aoa-
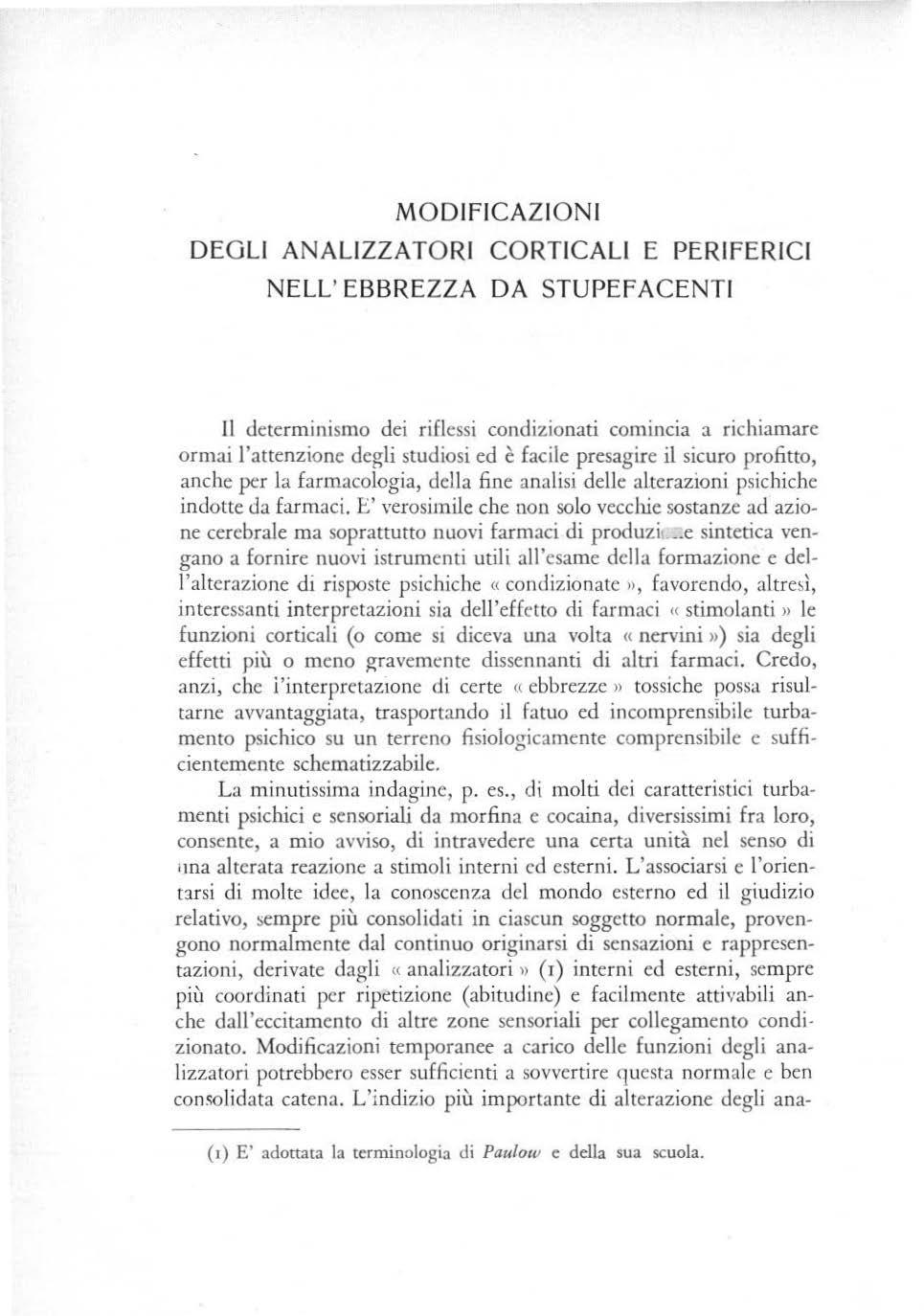
UPEF
ENTI
NE L L ' EBBR EZZ A D A ST
AC
(1) E' adottata la terminologia di Paulow e della sua scuola.
lizzatori, nel caso della morfina. è dato precisamente dall'mcapacità di avvertire stimoli dolorosi. Inoltre nelle esperienze di Paulow e collaboratori sui nflessi condizionati di secre:àone s'è potuto documentare con m etodo rigorosamente fisiologico non solo l'imponente capacità discriminativa de-gli ana lizzatori, supporto a ben concatenate reazioni condizionate, ma il facilissimo m odificarsi, agevolarsi o inibirsi di tale reazione, per perturbazioni anche minime degli analizzatori. Queste perturbazioni sono su fficienti a modific are la capacità differenziativa che caratterizza gli analizzatori e a sopprimere, conseguentemente, la reazione condizionata dipendente, mentre altre reazioni condizionate remote legate al medesimo stimolo, ad elementi di tale stimolo o ad altri stimoli, gjà sopraffatte od inibite dallo sviluppo della capacità differenziativa, potrebbero qui impensatamente emergere e svolgere la loro catena di sensazioni e rappresentazioni.
Paulow ha bene stabilito che la « differenziazione dei diversi componenti di une stimolo si ottiene per un processo di inibizione che sopprime l'attività di tutte le parti dell'analizzatore eccetto una sola, ben determinata Ora se si in troduce in un cane preparato ad una cena finezza differenziativa, .:ui è legato un rifl esso secretore, semplicemente della caffema si vede immediatamente la differenziazione fin là solidamen te stabi lita sparire completamente, naturalmente in modo transitorio. Una sostanza che deprima o pure inibisca le inibizioni, come agevolmente fanno stimoli nuovi (perchè non la morfina?) può modificare questo potere sele ttivo e restituire all'analizzatore la capacità di avvertire tutti o taluni stimo li del mondo esterno, il che significa risuscitare un numero enorme di nuove ed antiche reazioni psichiche semplici c condizionate. Kraeplin, il più fine tore dei processi psicofisici durante: influenze tossiche, in altra epoca, già accertò questo dato, che mi sc mhra di singo lare importanza: che la morfina alla dose di gr . o,or induce una facilità maggiore a percepire il mondo ambiente. Ora, appunto l'iperattività immaginativa, l'ipermnesia con rapidissime cd esatte evocazioni spontanee, l'agi lit à in calcoli aritrneùci, le rapide associazioni di parole, la stessa illusione di intelligenza, l'eretismo corticale morfìnico, in som ma, mi sembrano indizio convincente di perdita della raffinata capacità differenziativa, selettiva degli analizzatori, con conseguente liberazione di quegli eccitamenti dipendenti da stimoli adeguati e ven tualmente presenti, ed incatenati nell'individuo a pregresse sensazioni c rappresentazioni psichiche. Solo in questo l'azione della m o rfina mi sembra paragonabile al sonno: per la possibilità durante il sonno di disinibizioni, con facilità a reazioni psichiche (sogni) caotiche, tumultuose,

10
evocative, non autoctone, m a conseguenti a qualche particolare eccitamento , che, a diffe renza dello stato di veglia, può ora svolgersi liberamente , in seguito a stimoli esterni od interni. Sono i sogni suscitati da un rumore, un odore, un contatto, ccc , che si svolgono sul tema dello stimolo, in quanto non sono che reazioni corticali costituite da vecchie c più o meno attivabili rappresentazioni dipendenti per abitudine da quello stimolo, o dallo sti molo come ora è avvertito o addirittura da altri stimo l i assenti, qui sostituiti per rapporto CG.1dizionato da quelli attuali cd agenti.
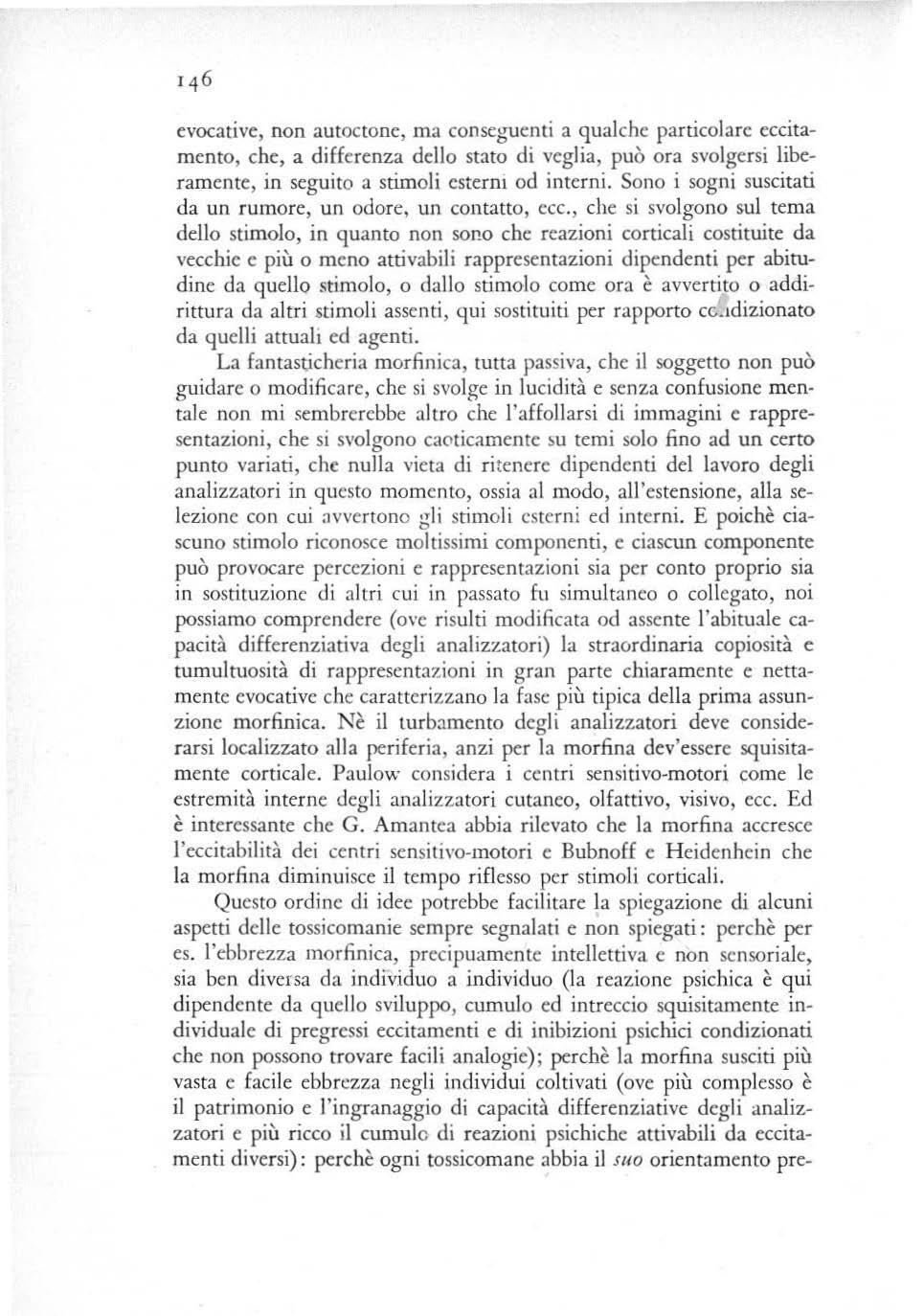
La fantasticheria morfin ica, tutta passiva, che il soggetto non può guidare o modificare, che si svolge in lucidità e senza confusione mentale non mi sembrerebbe altro che l 'affo llarsi di immagini c rappresentazioni, che si svolgono caoticamente temi solo fino ad un certo punto variati, che nulla vieta di ri tenere dipendenti del lavoro degli analizzatori in questo momento, ossia al modo, all'estensione, alla selezione con cui avvertono g li stimo li esterni ed interni. E poichè ciascuno stimolo ri conosce moltissimi componenti, e ciascun componente può provocare percezioni e rappresentazioni sia per conto proprio sia in sostituzione di altri cui in passato fu si multaneo o collegato, noi possiamo comprendere (ove risulti modificata od assente l'abituale capacità differenziativa degli analizza t ori) la straordinaria copiosità e tumultuosità di rappresentazioni in gran parte chiaramente e nettamente evocative c he caratterizzano la fase più tipica della prima assunzione morfinica. N è il turbamento degli analizzatori deve considerarsi localizzato alla periferia, anzi per la morfina dev'essere squisitamente corticale. Paulow considera i centri sensitivo-motori come le estremità interne ùegli analizzatori cutaneo, olfattivo, visivo, ecc. Ed è interessante che G. Amantea abbia rilevato che la morfina accresce l 'eccitabilità dei centri sensitivo-motori e Bubnoff c H eidenhcin che la morfina diminuisce il tempo riflesso per stimoli corticali.
Qu esto ordine di idee potrebbe facilitare la spiega zione di alcuni aspetti delle tossicomanie sempre segnalati e non spiegati : perchè per es . l'ebbrezza morfinica, precipuamente intellettiva e non scnso riale, sia ben diversa da individuo a individuo (la reazione psichica è qui dipendente da quello sviluppo, cumulo ed intre ccio squisitamente individuale di pregressi eccitamenti e di inibizioni psichici condizionati che non possono trovare facili analogie); perchè la morfina susciti più vasta e facile ebbrezza negli individui coltivati (ove più complesso è il patrimonio e l'ingranaggio di capacità differenziative degli analizzatori e più ricco il cumulc di reazioni psichiche attivabili da eccitamenti diversi): perchè ogni tossicomane abbia il suo orientamento pre-
q6
vaJente di ebbrezza (in evidente rapporto col ripetersi , per azione della droga, di quelle modlficazioni degli analizzatori, cui è legato un certo sistema di percezioni e di connessioni psichiche), perchè finalmente taluni aspetti psichici delle tossicomanie possono trovare riscontro in certe lesioni anatomiche della corteccia (interruzione, modificazione degli analizzatori).
Non mi pare improbabile che in questi concetti possano rientrare , altresì, talune espressioni morbose psichiche e soprattutto sensoriali da cocaina. In un campo sensoriale è più facile l'uniformità che non in quello psichico tutto individuale e perciò molte caratteristiche illusioni od allucinazioni visive, acustiche, tattiJi dei cocainomani appaiono frequenti e diffuse. Mi pare che nel cocainomane molto spesso si riveli tipicamente la inesatta valutazione del mondo ambiente, per cui la sua reazione psichica e motoria è logica, lucida ma errata. Anche qui potrebbe trattar si di alterazioni a carico degli analizzatori che hanno temporaneamente perduto la capacità differenziativa, lungamente educata, e rendono possibile l'inoltro di eccitamenti « grezzi » , non selezionati, che suscitano reazioni motorie e psichiche logiche, ben adeguate a quegli eccitamenti, e quindi '' grezze » anch'esse, primitive, insolite, e, ora, praticamente fuori posto. Illusion i ed allucinazioni nei cocainomani sembrano avere appunto il punto di partenza alla periferia, sia esterna che interna (frequentissima quest ' ultima) ed è ben probabile che modificazioni degli analizzatori (cutanei specialmente) abbiano partecipazione e responsabilità in determinate reazioni psichiche.
Comunque studi in queste direzioni sembrano giustificati per vedere i risultati che possono dare .
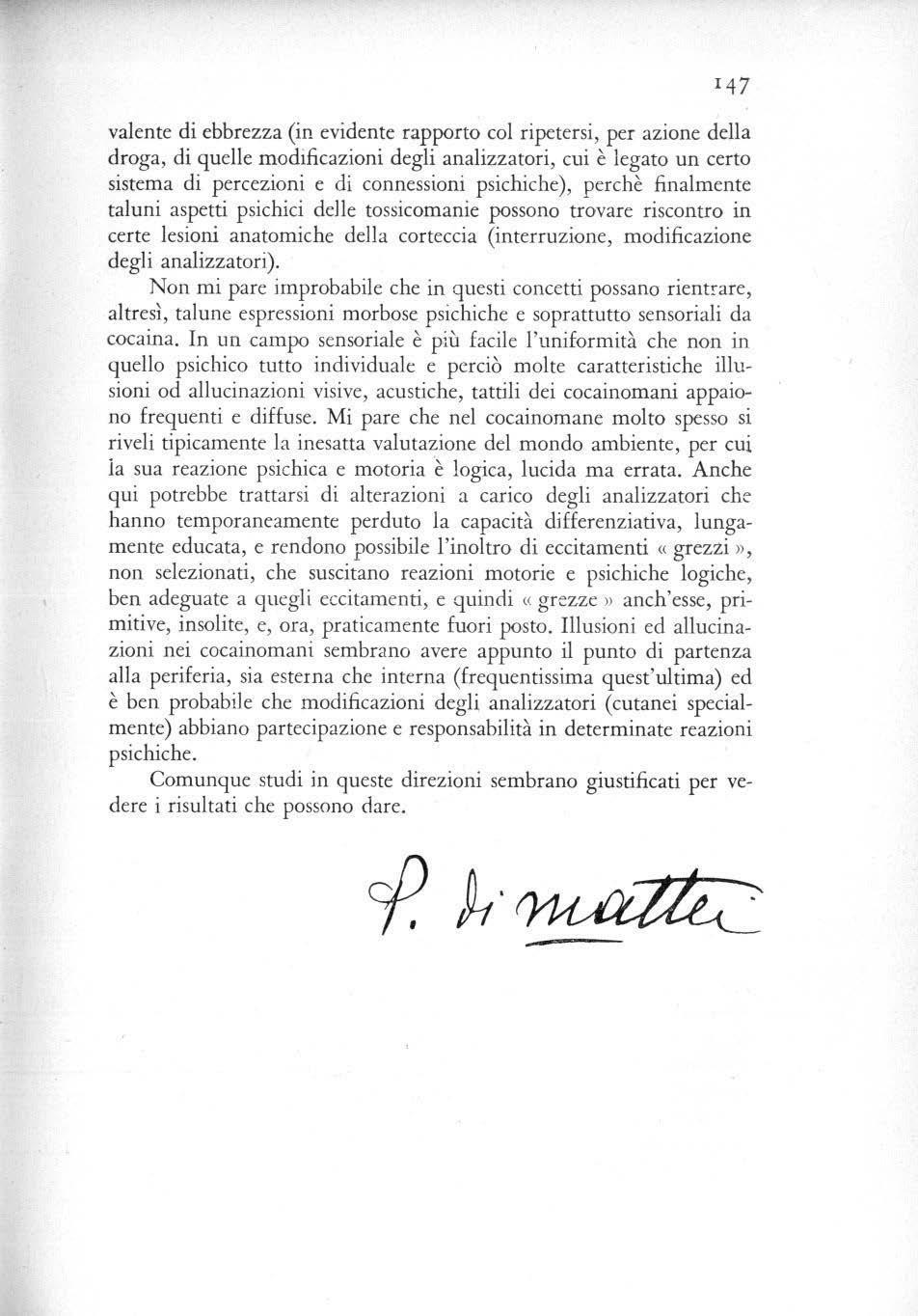
L
'ES AME FUNZIONALE E L ' I ND ICE DI ZOJA
NE L LO STUD IO DELLE MALATTI E DEL PANCREAS
E' noto che nella diagnostica delle malattie del pancreas molto più dell'esame semeiologico diretto è l'indagine funzionale che, opportunamente applicata ed interpretata, può dimostrare in modo chiaro e sicuro la sofferenza del viscere ed attesta re talora anche l'entit à del danno; lo studio della funziona l ità pancreatica, inoltre, praticato in molte complesse sindromi addominali, sotto questo aspettc mute dal punto di vista clini co, permette di ev id enziare la compartecipazione del pancreas e di stabili re il coefficiente pancreatico nella genesi della sin tomatol ogia morbosa, con la pratica conseguenza di una t erapia più razionale ed attiva.
In molti casi la disfunzione del pancreas è facilmente dimostrabile, ed anche un semplice esame delle fe ci, correttamente eseg uito , può consentire dati sicuri t rilievi orientativi; in altri i disordini c;ecretori possono essere più complessi e più difficili a svelarsi. Ricor do a que sto proposito le dissociazioni delle secrez ioni esterne del pancr eas, ben studiate anche dalla nostra Scuola (Sotgiu, D'Ignazio, Montani, Bauce), in cui l'in sufficien za enzimatica è limitata ad uno o ad altro dei fermenti con ri spa rmio degli a ltri, e lo studio funz ionale, perchè possa dare sicuro responso, deve essere condotto con m etodiche speciali c varie indagini di laboratorio.
L 'esa m e delle feci forni sce el eme nti diagnostici e criteri direttivi abbastanza esatti , specie se viene eseguito dopo un pasto standard di prova, giacc h è so lo conoscendo la quantità c la qualità d eg l i a lim enti assunti è possibi le dosare con una certa precisione i residui fecali ed attribuir loro il giusto valore e significato . La crea torrea, l'?milorrea e l a steatorrea sono i classici segni dell'insufficienza pancreatica, più sicuri in pratica di molti altri conseguibili solo con metodiche di studio più difficili e meno utilizzabili; la m assi ma impor tanza dev e attribuir si al comportamento dei re s idui grassi, e ciò perchè la digestione di questa categoria ::li alimenti !>Ì compie quasi

esclusivamente ad opera del fermento steapsmtco, mentre gli altri enzimi pancreatici, il proteolitico e quello amilolitico, possono vare di sovente supplenze compensatorie Sul potere digestivo dei grassi, pertanto, si basano le principa li prove funzional i del pancreas.
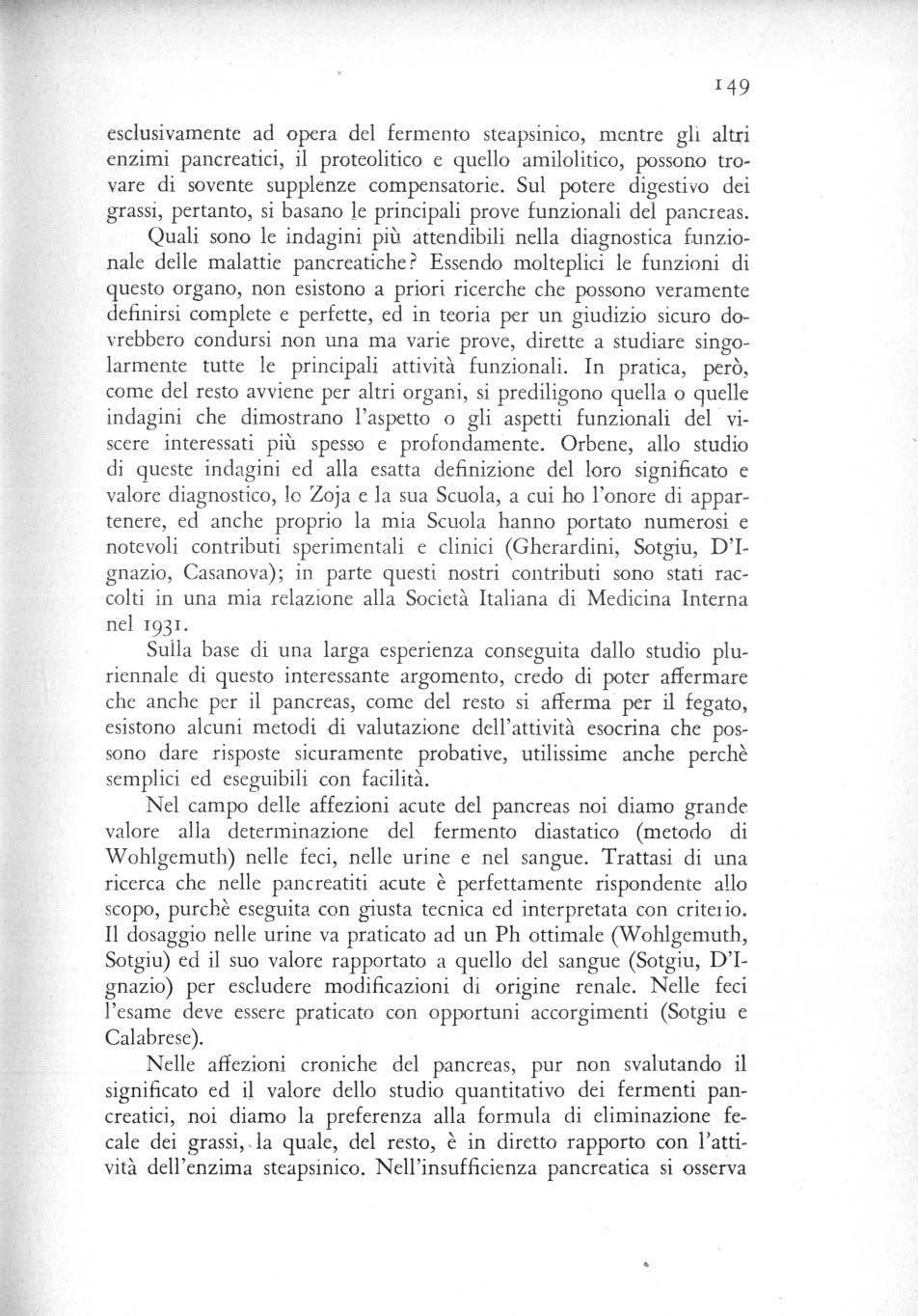
Quali sono le indagini più attendibili nella diagnostica naie delle malattie pancreatiche? Essendo molteplici le funzioni di questo organo, non esistono a priori ricerche che possono veramente definirsi complete e perfette, ed in teoria per un giudizio sicuro vrebbero condursi non una ma varie prove, dirette a studiare singolarmente tutte le principali attività funziona li. In pratica, però, come del resto avviene per altri organi, si prediligono quella o quelle indagini che dimostrano l'aspetto o gli aspetti funzionali del viscere interessati più spesso e profondamente. Orbene, allo studio di queste ind agini ed alla esatta definizione del loro significato e valore diagnostico, lo Zoja e la sua Scuola, a cui ho l'onore di appartenere, ed anche proprio la mia Scuola hanno portato numerosi e notevoli contributi sperimentali e clinici (Gherardini, Sotgiu, D'Ignazio, Casanova); Ù1 parte questi nostri contributi sono stati raccolti in una mia relazione alla Società Italiana di Medicina Interna nel1931.
Sulla base di una larga esperienza conseguita dallo studio pluriennale d i questo interessante argomento, credo di poter affermare che anche per il pancreas, come del resto si afferma per il fegato, esistono alcuni metodi di valutazione dell'attività esocrina che possono dare risposte sicuramente probative, utilissime anche perchè semp lici ed eseguibi li con facilità.
Nel campo delle affezioni acute del pancreas noi diamo grande valore alla determinazione del fermento diastatico (metodo di Wohlgemuth) nelle feci, nel le uri n e e nel sangue. Trattasi di una ricerca che nelle pancreatiti acute è perfetta m ente rispondente allo scopo, purchè eseguita con giusta tecnica ed interpretata con criteJ io. 11 dosaggio nelle urine va praticato ad un Ph ottimale (Wohlgemuth, Sotgiu) ed il suo valore rapportato a quello del sangue (Sotgiu, D ' Ig n azio) per escl ud ere rnodificazioni di origi ne renate. Nelle feci l'esame deve essere praticato con opportuni accorgimenti (Sotgiu e Calabrese).
Ne ll e affezioni croniche del pancreas, pur non svalutando il significato ed il va lore dello s tudi o quantitativo dei fermenti paucrea tici, noi diamo la preferenza alla formula di elim ina zione fecale dei grassj, . la quale, del resto, è in diretto rapporto con 1 1 attività dell'enzima st eapsi nico. Nell'insufficienza pancreatica si osserva
una cospicua diminuzione dei sapom m rapporto ai g rassi neutri ed agli acidi grassi, ed il quoziente di queste frazioni, che in condizioni normali oscilla attorno all'unità, si eleva fino a cifre anche elevate (Zoja).
Per quanto molti siano gli anni trascorsi da quando lo Zoja ha introdotto questo metodo di studio della funzionalità pancreaùca, noi riteniamo di poter conclude re, sulla scorta di una larga messe di osservazioni cliniche c sperimentali, in se nso decisamente favorevole sul suo r eale, sicuro valore orientativo ed anche quantitativo; esso risponde in pieno alle esigenze della ricerca clinica e può additare anche nei casi più dubb"i il coefficiente pancreatico. In rare condizioni in cui se mbra mancare allo scopo, esistono in realtà motivate e particolari cause che non devono sfuggire allo studio attento del caso, così che anche queste risposte incerte o negative non significano infedeltà od inattendibilità della ricerca.
Le critic he mosse a questa indagine sono per lo più di AA. che hanno trascurato di approfondire il significato dei criteri patogeneùci e clinici dello Zoja, preoccupandosi di considerare soprattutto la percentuale dei grassi totali contenuti nelle feci senza dare il giusto valore alla composizione dell e varie frazi o ni ; i diversi indici e coeffic ienti proposti in segui to (di utilizzazione quantitativa, di non assorbimento dei grassi neutri, di G a ultier, di Labbé, di Goiffon , ecc.) non hanno certo condotto a nessuna modificazione sostanziale in senso migliorativo, trattandosi di rice rche che studiano in ge nere l'utilizzazione dei grassi, ma che non hanno un preciso indirizzo rivolto all'indagine dello specifico fattore pancreatico.
Tanto alcuni AA. francesi (Goiffon, Labbé, Carnot), quanto alcuni tedeschi (Schmidt, W endt, Katz, ecc .) si sono polarizzati prevalentemente su lla determinazione del residuo grasso delle feci; oppur-e, 'studiando isolatamente le varie frazioni, hanno trovato gravi moti vi per svalo ri zzarle nelle molteplici cause che possono interferire su di esse.
Orbene, se è vero che molteplici sono le cause estranee capaci di incidere sulla co mpo sizione dei grassi fecali, e fra di esse in particolare l' aumentata rapidità del transito intestinale, la presenza nell'intestino di bacten atti a scindere i grassi neutri in ac1di grassi (Gross), nonchè la qualità dei cibi ingeriti ( H oesslin), la quantità di alcali, di componenti salini, di enzim i enterici e della stessa bile, pur tuttavia è certo a nostro avviso che queste interferenze non diminuiscon o il valore dell'indice proposto dallo Zoja. L'azione lipolitica dci bacteri intestina li no n va sop ravalutata come causa d'er-

rore, giacchè essi possono scindere i grassi neutn m acidi grassi e glicerina, ma non formare i saponi. Gli acidi grassi costituiscono nell'equazione dello Zoja il numeratore assieme con la frazione non scissa, destinato ad elevare l'indice in confronto alla frazione salificata. Si è detto che, una volta scissi, i grassi neutri possono unirsi agli alcali presenti nell'ambiente intestinale; l'abbiezione, se basata su di un fatto reale, potrebbe molto infirmare il valore dell'indice di Zoja. Peraltro, la pratica dimostra che quanto appare a prion presumibile non risponde poi a realtà, e che la lipolisi batterica avviene solo nelle sezioni più basse dell'intestino; del resto, sia perchè le feci vengono rapidamente emesse, sia perchè nel colon non sussistono altri fattori chimici o fisico-chimici che permettono la saponificazione, anche nelle gravi insufficienze pancreatiche noi troviamo gran parte del grasso idrolizzato (acidi grassi) e non mai un alto titolo di saponi, che anzi di regola risultano scarsi.
All'abbiezione dell'esistenza di lipasi extrapancreatiche è facile rispondere, giacchè se è vero che tali enzimi esistono, è indubbio però che essi non hanno pratica importanza . La lipasi gastrica di Volhard agisce in ambiente acido e si annulla nell ' intestino; le lipasi intestinali svolgono azioni inconsiderabili.

La bile, che indubbiamente è un importantissimo elemento nella scomposizione e nell'assorbimento dei grassi, non può gran che turbare con le sue variazioni quantitative l'indice dello Zoja. La sua notevole diminuzione oà anche la sua completa mancanza produce un innalzamento dell'indice assai più modesto di quello che si osserva nell'insufficienza pancreatica, e ciò forse perchè la steapsina può svolgere nel tenue una certa attività lipolitica anche in assenza dd secreta epatico e gli acidi grassi così formatisi si uniscono agli alcali presenti, determinando una quota di saponi che impedisce all'indice di elevarsi di molto.
L'interferenza, infine, dell'accelerato transito intestinale non può essere negata. Peraltro, considerare che anche in quelle condizioni morbose (Basedow, sprue) in cui questo fattore genetico della steatorrea merit:t attento esame, è possibi le talora dimostrare la compartecipazione del pancreas cd il suo interessamento più o meno diretto (v . caso tipico di sprue studi ato da Sotgiu con indice elevato e pancreatite atrofica controllata al tavolo). A questo riguardo mi piace accennare anche a lla steatorrea che può osservarsi nei cardiaci scompensati, nella cui genesi se mbra pure doversi considera re in primo piano il fattore <c pancreas )) ' diretto, per sofferenza propria dell 'organo inerente alla stasi, e sopra t tutto indiretto, per ostacolato
rsr
deflusso nel duodeno del succo pancrea t ico a causa dell'edema e della congeslione della papilla di Vater (Sotgiu e Corazza) .
Questi in breve sintesi alcuni cenni sull'indice di Zoja ed in genere sulla steatorrea. Vari possono essere i fattori considerabili nella genesi di quest'ultima, ma cerlamente il più com1me e dominante deve ritenersi quello pancreatico. Tale la conclusione che ci sentiamo di p<Aer trarre dopo un lungo ed approfondito studio dell'argomento, sulla scorta di una vasta esperienza clinica, la quale parla tutta a fa\ore del sicuro villore diagnostico della ricerca c del dosaggio dei grassi fecali secondo i criteri suggeriti dallo Zoja.
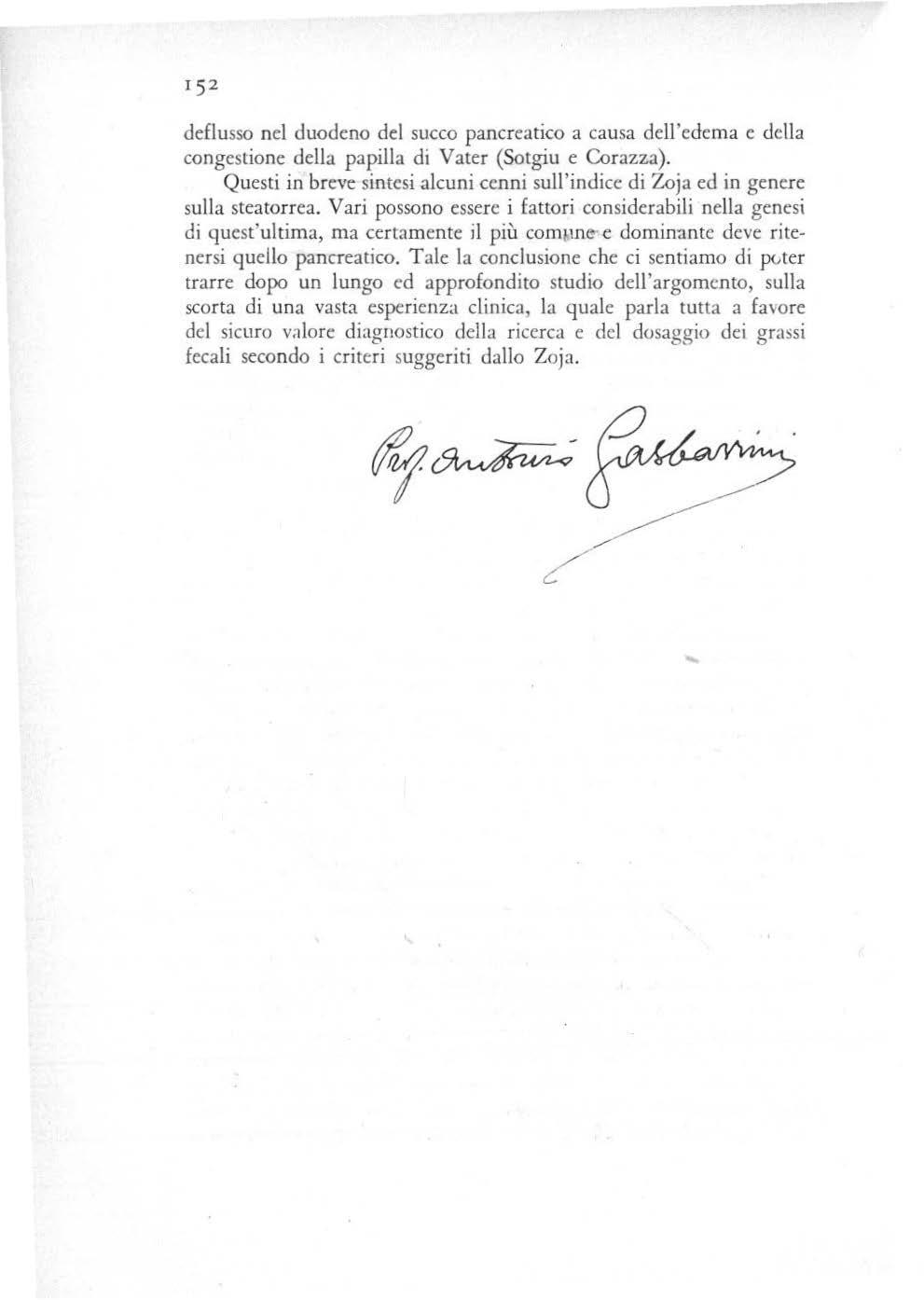
...
D'ANNUNZ I O E LA C HIR URGIA DI GUERRA
Gabriele:: d'Annunzio nel novembre 1889 indossò per la prima volta la divisa di solda to per compiere a Roma presso il 14° reggimento cavalleggeri il prescritto periodo di volontariato, avendoquale studente universitario - differito il servizio militare al vcntiseesimo anno di età

L a vita e la di caserma, una da cavallo, il ricovero in ospedale e la malaria contratta nella Romagna solatìa non potevano certo lasciare un ricordo gradito nel giovane ed irrequieto poeta, che nel Libro segreto ebbe a scrivere: « Ho posto al sommo d'ogni valore umano la disobbedienza » .
D'Annun zio amava però e amò sempre, anzitutto e sopra tutto, la Patria.
Aveva infatti appena quattordici anni quando il 22 marzo 1877 dal Cicognini di Prato scriveva ::d Sisti: << Voi sapete quanto amo la nostra Italia, t1oi sapete che darei tutto per essa )). E nel marzo 1902 inviava ai giovani ginnasti della Società << Andrea Doria » di Genova un'ode in c ui cantava:
O invitta, Trieste, sogno dti nostri rncrti, viva Ferita incisa entro le carni nostre, Tu non invano, tu, non invano attendi.
Dopo aver spiegato sin dali 'inizio del primo conflitto mondiale una intensa attività per l 'i ntervento dell'Ita l ia contro l'Austria, quando l'ora solenne dd destino giunse anche pel nostro paese tornò soldato e fieramente pronto ad ogni audacia se ntendo che all'eloquenza doveva seguire l'azione, all'a nelito ideale l'offerta della persona. Ma prima di partecipare a tante.. c tante imprese rischiose volle - in una
sera del luglio 1915 - ritornare in Abruzzo alla sua casa intnstJ.ta (e fu l'addio) per riabbracciare la vecchia m adre, che non vedeva da tanti anni: « Bisognava accomiatarsi dalla mad1·e mortale, prima di donarsi alla madre immortale! '' ·
La s ua vita è da allora tutta coronata di lauri di guerra e una sfida continua a lla m o rte.
Gabriele d'Annunzio - farà rilevare il dantista Nicola Zi n garelli - vi.ve nella guerra come son vissuti Dante -e F oscolo, Mamel i e Po erio .
Du rante tutto il periodo del lungo confl itto (aveva già superato i cinq u ant'anni!) si sfor zò anche di assume re a ttitu dini e ab itudini militari.
L a religione s uprema dell'amor di P atria infia mm ò sempre più l 'anima e l'estro del Poeta, c he fu non soltanto i l bianco lanciere, ma fante tra i fanti, marinaio, aviatore .
Nella g uerra trovò fina lm ente un campo degnissimo nel quale riuscì a far coincidere poesia ed azione eroica, costruendo con l'ardimento e il dolore il supr em o mito di se stesso L'epopea predominerà sulla lirica, il solda to sul cantore
La sua sarà dunque una poesia di guerra e avrà il colore della porpora e il freddo balenìo dell'acciaio.
« La guerra - affermerà Egli nel Libro ascetico - mi lza insegnato le più bel/t: cose dell' uomo; e mi ha insegnato anche l'umiltà! )) .
Tr a i fanti assistè a tutte l e fasi della battaglia del San Mi chele, de l Sabotino e di tante altre dell' I sonzo, r accog li endo co n amore i feriti che furono gli alfieri deU'insegna ve r miglia. F requentissime erano le sue visite ag l i ospedali, dove sapeva trovare le parole consolatrici per i so fferenti.
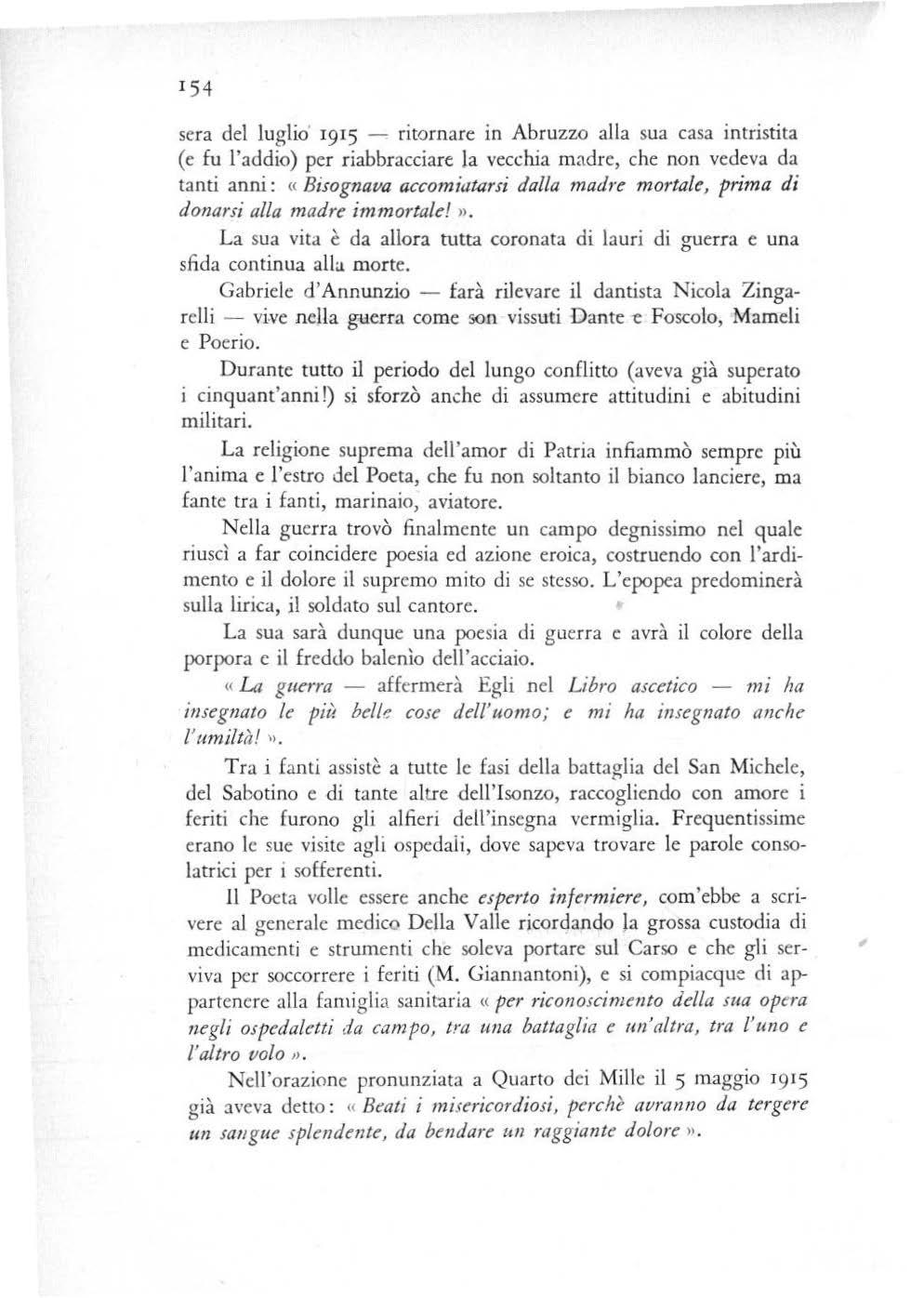
1l Poeta volle essere anche esperto infermiere, co m 'e bbe a scrivere al gene rale medico D ella Valle ricordando la grossa custodia di medicamenti e stru m enti che soleva portare sul Carso e che gli se rviva per soccorrere i feriti (M. G iannantoni), e si compiacque di appartenere alla fam igl ia sa nitar ia « per riconoscimento della sua optra negli ospedaletti da campo, tra uua battaglia e un'altra, tra l'uno e l' altro volo '' ·
Nell'orazione pronunziata a Quarto dei Mille il 5 maggio 19 15 già a\'cva detto: « Beati i misericordiosi, perclzè avranno da tergere un sangue splendente, da bendare t-1-11 raggiante dolore 11
154
Il ricordo delle battaglie suli ' I sonzo sarà pot se mpre presente nel Poeta.
Quanti e quanti feriti!
E tutti so no lutti nel sa ngue innounti . ..
L e scene di dolore .:: di morte, di sangue e di violenza si succedono in cento e cento pagine. A volte par qua si di udire il crepitio delle mitragliatrici, il rombo dei motori, le grida dei combattenti.
Ecco « i com;oglt dei feriti gtù per i camminamenti ingombri di carname fracid(l o lungo i boschi a cuore e i boschi a lancia schian -

1 55
tali i11carboniti rinfoltiti da intralci di mutilazioni e da grovigli di viscere » (l segnali dell"erba).
E veramente mirabile è la visione del ferito, che diviene di una serenità grandiosa, quando - con contatto più intimo di Antèoha il proprio sangue alla propria terra.
Ma ascoltiamo le parole del P oeta! Mentre imperversava il nembo di ferro e di fuoco « i colpiti qua e là rimanevano come co11{itti uella poltiglia rossa, come cementati uel sasso trito, o si toravano intomo a quei elle d'essi era reciw e ancor vivo; o si rotolavano intorno all'addome sparato o si trascitzatJarzo ululando n.
La Chiesa di Dobcn.lò
A mucchio w la tavola dell'altare stanno gli elmetti dei morti, le scarpe ae1 mor/1
Ltt preghiera di Doberdò ci descrive con impr essionante verismo tutta la tri ste e penosa via crucis che fatalmente dovevano percorrere i f er iti di guerra prima dt poter raggiungere un ospedale da campo. Ci par di vedere una lunga , interminabile teoria di barelle su cui sono
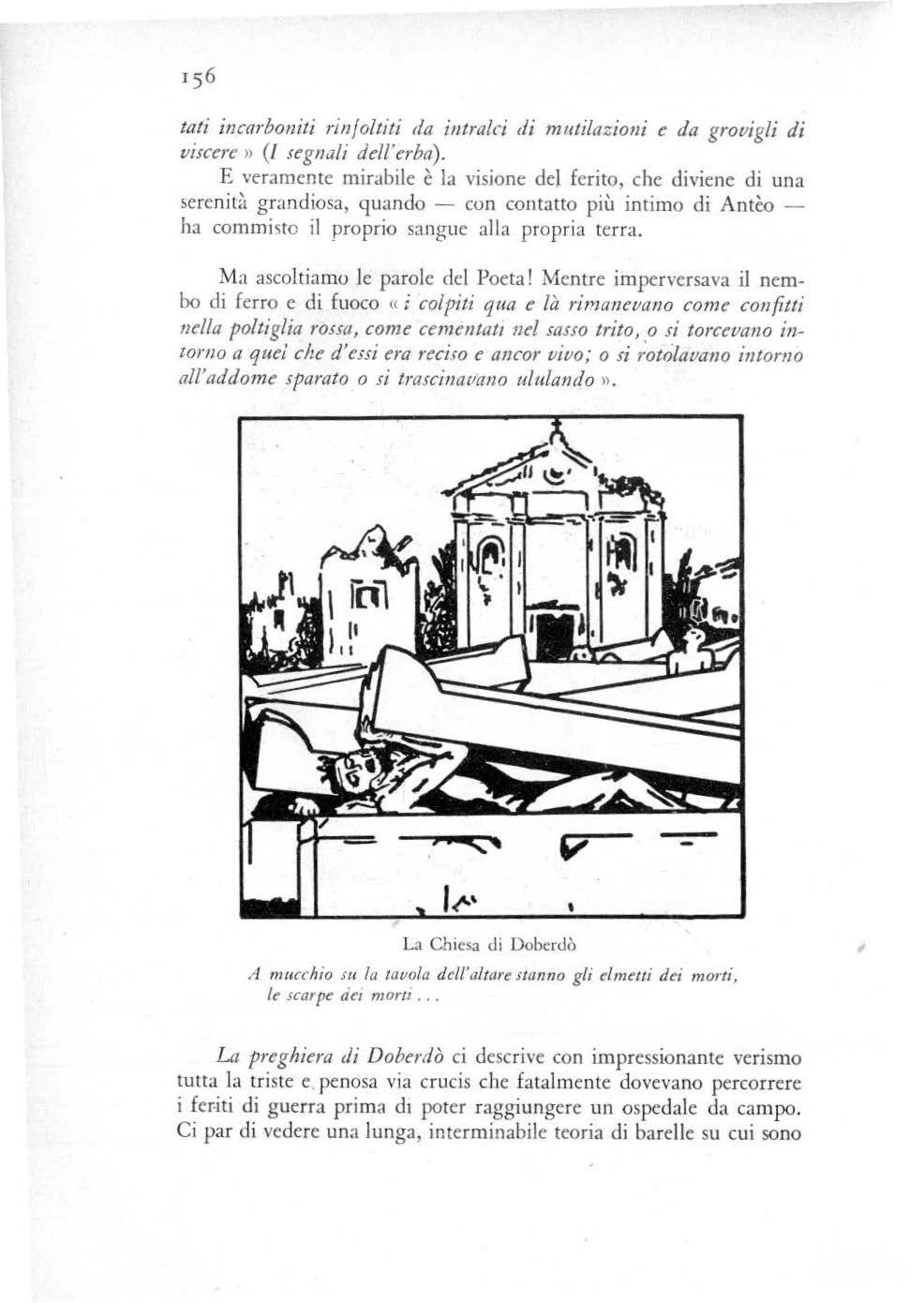
,.,,
,
stesi esangui e muti i feriti, che dopo breve tempo dall'inizio del combattimento non possono essere più contenuti nell'angusto posto di medicazione.
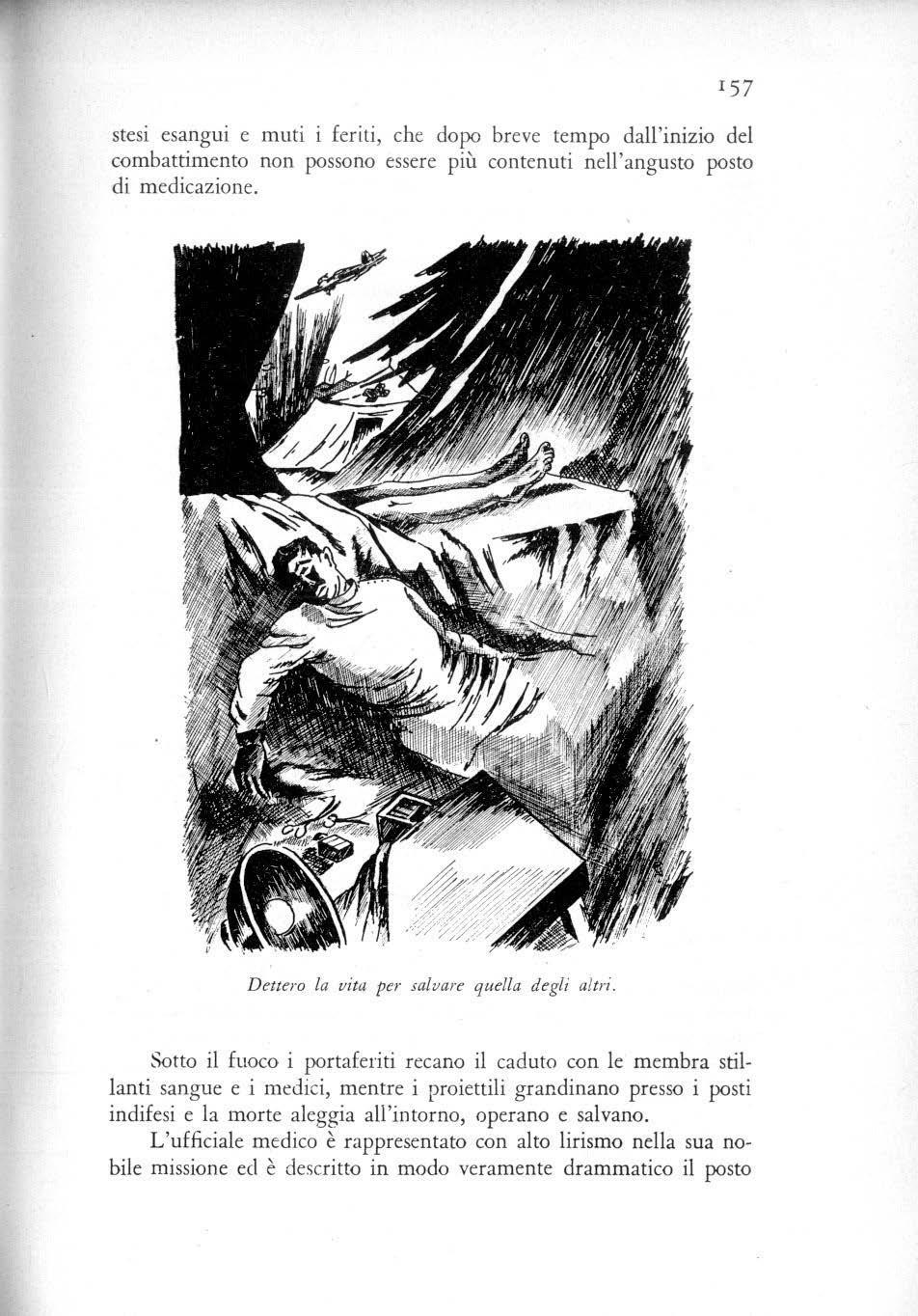
Sotto il fuoco i portaferiti recano il cad uto con le membra stillanti sangue e i medici, mentre i proiettili grandinano presso i posti indifesi e la morte aleggia all'intorno, operano e salvano.
L'ufficiale medico è rappresentato con alto lirismo nella sua nobile missione ed è descritto in modo veramente drammatico il posto
I 57
Dettero la vita pe1· salvare quella degli al tn·.
di medicazi0ne impiantato in quella chiesetta che accolse migliaia di feriti cd ove gli apostoli della pietà e della scienza non solo recarono conforto, speranza e vita, ma rimasero anche travolti, confondendo ed aggiungendo sangue a sangue in un supremo olocausto alla P atria.
<' Entra una barelLa che porta un soldato con la benda sugli occhi, con una gamba prigione tra due assi grezz e >' .
Oh, ricordo del lavoro penoso di trincea - fa rilevare M. Giannantoni - - in cui due pezzi di legno erano sufficienti per immobilizzare temporaneamente un arto fratturato!
u Bocconi giacciono a covare il dolore , o supini a fisarlo, o ml fianco e sul gomito, o rattratti, o col braccio dietro il capo, o col capo tra i ginocchi, o con un sorriso d'infante nella bocca assetata. o con nelle occhiaie torbide la vertigine della batt-aglia n
a Non si lagnano, notl chiamano, non dimandano, non fanno parola. Taciturni, aJpettann che di strame in strame li trasmuti la Patria, con le tabelle quadre legate al collo da un filo, or/è scritto la piaga e la sorte l)
Prodigioso artefice della parola, con realistica perfezione espressiva Gabriele d'Annunzio, profondo osservatore c conoscitore di medicina, descrive con precisione e con proprietà di linguaggio.
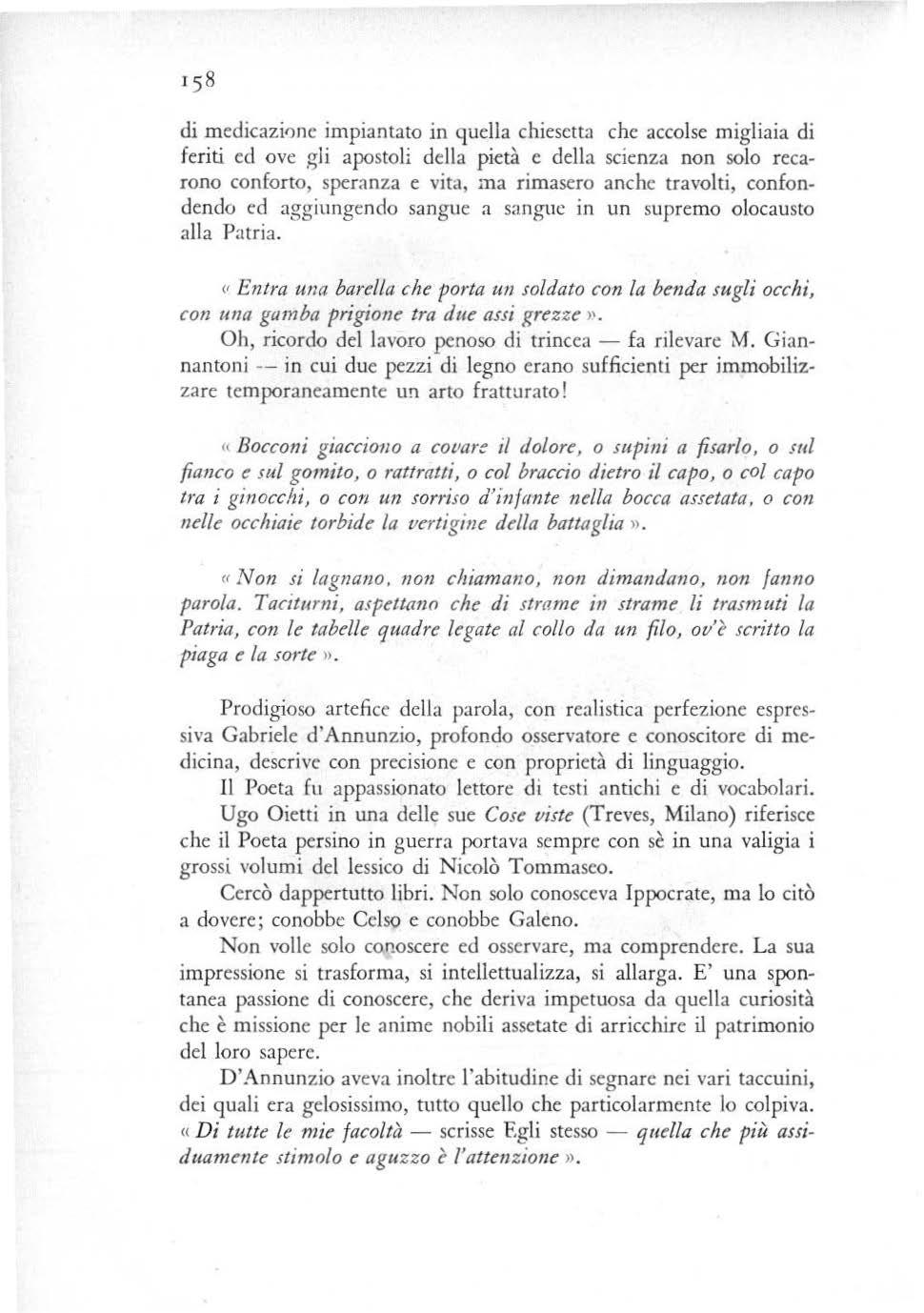
Il Poeta fu appassionato lettore di testi antichi e di vocabolari.
Ugo Oietti in una delle sue Cose viste (Treves, Milano) riferisce che il Poe ta persino in guerra portava sempre con sè in u na valigia i grossi volumi del lessico di Nicolò Tommaseo.
Cercò dappertutto libri. Non so lo conosceva Ippocrate, ma lo citò a dovere; conobbe Celso e conobbe Galeno .
Non volle solo conoscere ed osservare, ma comprendere. La sua impressione si trasforma, si intellettualizza, si allarga . E ' una spo ntanea passione di conoscere, che deriva impetuosa da quella curiosità che è missione per le anime nobili assetate di arricchire il patrimonio del loro sapere.
D'Annunzio aveva inoltre l'abitudine di segnare nei vari taccuini, dei quali era gelosissimo, tutto quello che particolarmente lo colpiva
« D i tutte le mie facoltà - scrisse Egli stesso - quella che più assiduamente stimolo e aguzzo è l'attenzio11e » .
Egli intese anche che dal cadavere ben esamimto si puo lfnparare molto e volle perciò frequentare le aule di anatomia.
Nel Notturno, 111 quelle pagine scritte col sangue, nel diario cioè della sua degenza al buio quando fu ferito, ricorderà: «il mio occhio triste è là, sopra il tavolino, accanto a un posacenere, come uno di quei pezzi anatomici arteficiati e dip·inti che da anni il bidello spolvera e il professore matleggia facendo la Lezione agli studenti svogliati > • .
D'Annunzio, allievo prediletto del grande Moleschott, non fu soltanto uno studioso appassionato delle scienze mediche ed un osservatore profondo, ma fu anche un grande ripensatore delle osservazioni altrui.

Complessa e versatile, lucida e robusta fu l'intelligenza del Po eta. E' un nome imponente il suo che so lleva un turbine di idee e di questioni scientifiche.
Troppo lungo sarebbe l'esaminarne, anche in scorcio, l'opera colossale. Ci limitiamo quindi ad alcuni punti salienti, che si riferiscono alla traumatologia di guerra.
'' Alla soglia dell'ospedaletto il bianco delle fasce trapassate dal sangue, la povera carne messa fuori di combattimeuto, la bocca inqt.tieta di chi non vede, l'odore tenace della trincea e della caverna, lo stupore della battaglia abbuiata. Nulla più » .
E' qui, nella fragile baracchetta operatoria, S<luassata dal vento, il chirurgo sempre vigile c pronto a dare il conforto della sua arte, s traziato soltanto se le sue mani non riusciranno a lenire il dolore e a salvare quelle vite che gli sono state affidat e . Ma ricordiamo per tutti un grande uomo di scienza e di misericordia, un chirurgo sommo dalle mani sapienti e fraterne, che sa i portenti del ferro salutare e che li compie nella luce della bontà, un salvato re: Raff aele Bastianelli, che Gabriele d'Annunzio andò a cercare nel « vallone del sangue » per Nino Randaccio.
«E in quel giorno di morte e dz ascensione io lo avevo cercato, io lo avevo chiamato, il Salvatore. Io lo at•et•o sollecitato e accompag1lato, il Sente?Zziatore.
«Sapevo che laggiù, in qualche padiglione bianco, sotto qualche tenda crociata, pei campi e per le vie della guerra, come un nomade insonne, viveva u1z genio di sapienza e di misericordia armato di ferri miracolosi.
« Lo cercai d'asilo Ì1l asilo, di rifugio in rifugio, di tristezza in tristezza, ostinato.
1 59
« Udii nuovi lamenti, vidi nuove piaglze, conobbi nuovi martirù. Lo trovai a Gabrije, in fondo al L'allone del sangue. Era di poco trascorso il mezzogiorno. Era l'ora del suo riposo. Parte della notte e tutto il mattine aveva lavorato nella carne dolente dell'uomo. E lo trovai chino su la tuvola, ccm tre libri: uno aperto e due chiusi: il Convito di Platoue, la 'fr..tgedia di Macbeth, i Canti di Giacomo Leopardi.
<< Era bello che Egli 1-isafisse dalle profondità dello spirito per venire a visitare il nostro compagno sublime ,, , Co n esattezza sin tom atologica c con aggettivazione perfettamente intonata al fatto morboso il Poeta descrive la mortale ferita - bione midollare - riportata da R andaccio, il compagno tanto amato e poi sempre ricordato, che investito da una raffica di mitraglia « non sentì più le gambe e cadde » .
Durante il penoso trasporto in barella era « già spento dall'inguine in giù »
Due soli aggettivi - insensibile e inerte - rappresentano efficacemente con perfezione espressiva la paralisi di moto e di senso determinatasi a ca rico degli arti inferiori. M entre infatti l'illustre chirurgo romano esaminava il pro& soldato morente questi « era inerte e insensibile dalla cinta in giù; non aveva quasi più polso; si raffreddava a poco a poco » .
Che si poteva fare presso il letto di Ran daccio? Niente altro che attendere. Così aveva ri sposto , così deve aver risposto il salvat ore invocato, che null a potè pel fratello tanto caro al Poeta.
Tutto san g uina all'in torno . D i qu es ta mano non re sta p iù che un mig nol o appeso ad un lembo ; questo viso non è più riconoscibile: di questa coscia nient e altro che un ammasso sa nguinant e di ossa c di mu scoli.
E il P oeta dirà ( Italia e Vita) co n pr ec isio n e di linguaggio : « N oi abbiamo visto pii't di una volta, nella guerra, un braccio o una gamba al taglio d'una sch cggi'l di granata rimaner penzoloni per un solo filamento rosso, per la fibra d'un muscolo o per il cordone d 't"'n tendine, mentre il ccrpo si dissanguat1a a fiotti e la faccia del ferito si faceva smorta>>
E' questa una impr essionante, raccapricciante descrizione delle tremende amputazioni tr aum atiche determinate dalla violenza d ell'agente vulnerante .
L 'osservazione diretta fornisce al P oeta particolari che Eg li ra ppresenta con precisione come gli pervenissero da cog n izio ni g ià esatt a-
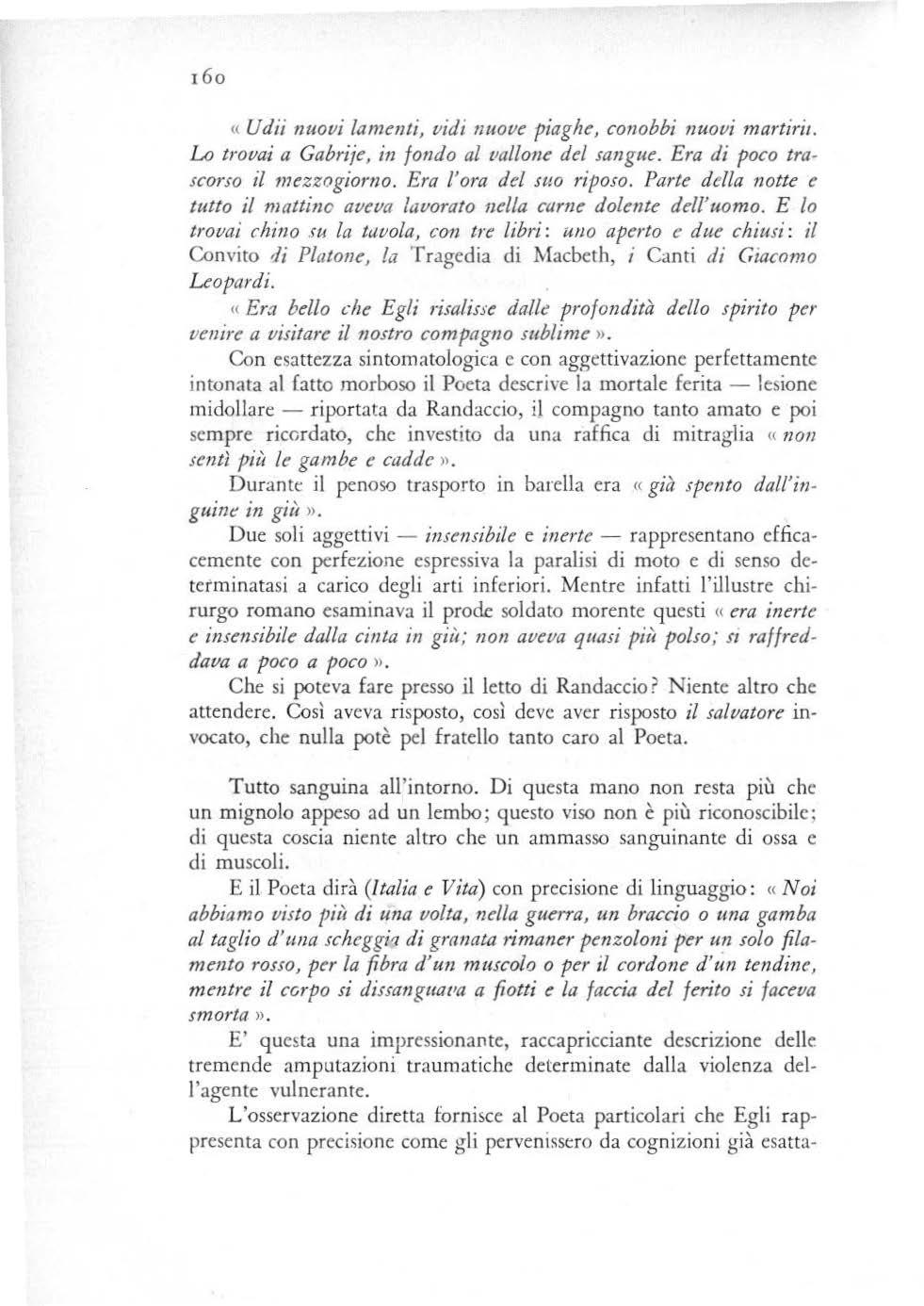
160
mente conosciute. E ' così che Egli ci dà una descrizione della sintomatologia ddla cancrena gassosa, della estrema gravità della più terribile complicanza delle ferite di guerra, del penoso trattamento che la tremenda infezione ha reclamato purtroppo inesorabilmente: atti. operativi demolitori , spesso ripetuti. E questi rappresentano indubbiamente la parte più triste della già tanto penosa e difficile chirurgia d i guerra!
Nel Notturno sono messi in rilievo i sintomi dominanti: u nell' orribile fetore delle sue gambe irwase dalla cancrena gassosa n .
Ecco un ferito le cui carni so no state più \·oltc st raziate: « Egli aveva patito in verità lo scarpello nella sua caPte e nelle stte ossa. Il dzirurgo Faver/a collocato e ricollocato sulla tavola dieci volte, venti volte, trenta VQlte l'a11eva fasciato e sfasciato; aveva combattuto contro la cancrena invincibiie a for za di tagli a misura di ferro; aveva tagliato le mani fino ai polsi e poi le braccia {i11o al gomito; e poi i piedi e poi le gambe )) ,
Ed ancora: ,, Ogni volta il paziente avet'a senza ira detto al dolore: io sono più .forte di te. Tanto egli er.1 diminuito nella carne e tanto era ingigantito nella pa z ienza '' <• così mutilat?, così mangiato dalla cancrena, così ridotto dai ferri'' ·
lmpressionante è anche ]a visione dei congelati.
La più antica segnalazione delle catastrofi provocate c-lal freddo e da cui forse nessun esercito è andato mai esente risa le all'epoca della ritirata dci diecimila, descritta mirabilmente nella Anabasi ( libro IV , cap. IV) da Senofonte, che fece anche rilevare con notevole precisione taluni sintomi di assiderazioni e congelamenti .
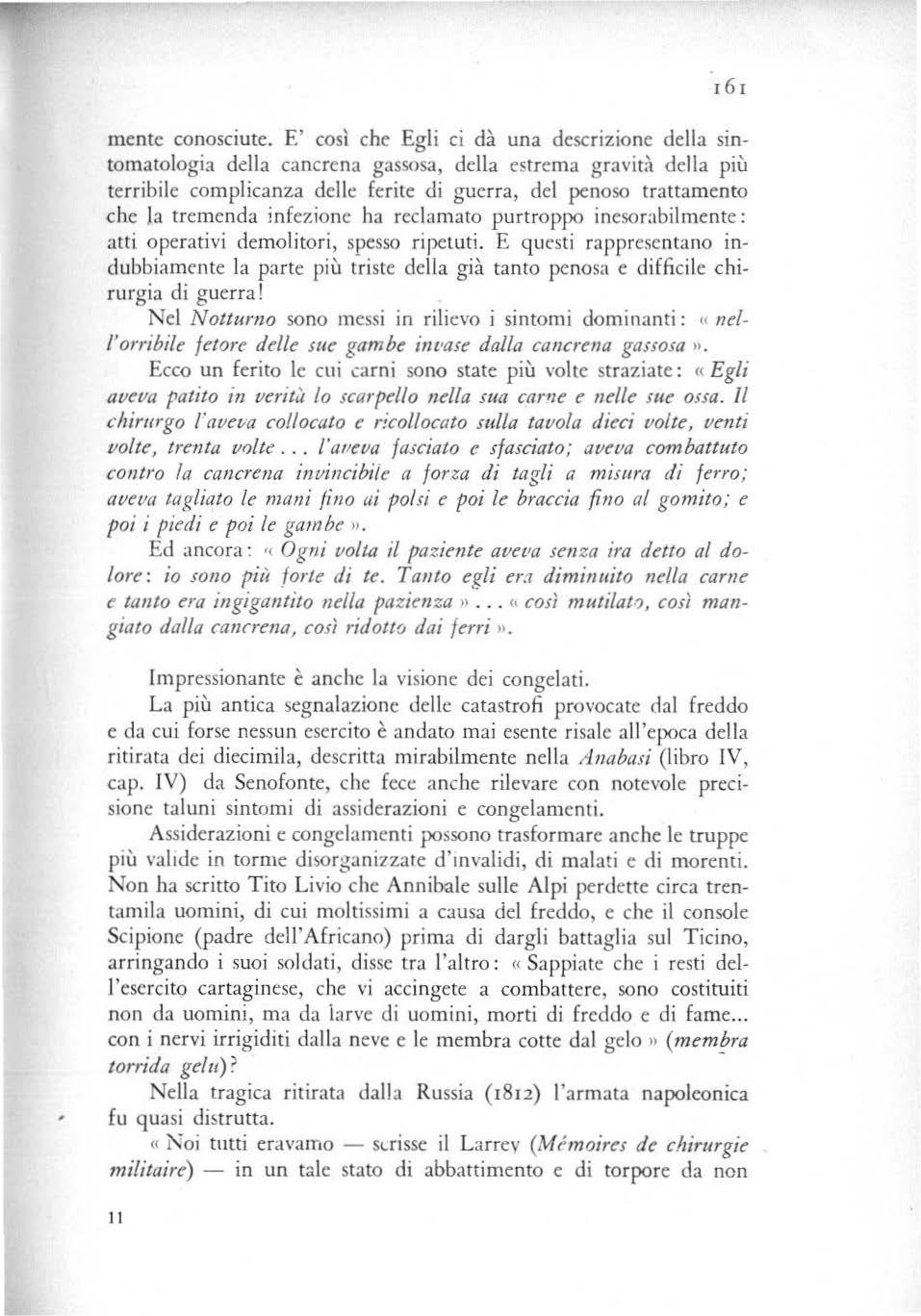
Assidcrazioni e congelamenti possono trasformare anche le truppe più valtdc in torme disorganizzate d'mvalidi, di malati e òi morenti. Non ha sc ritto Tito L ivio che Annibale sulle Alpi perd ette circa trentamila uomini, di cui moltissimi a causa del freddo, e che il console Scipione (padre dell'Africano) prima di dargli battaglia sul Ticino, arringando i suoi so l dati, disse tra l 'a ltro: <c Sappiate c he i resti dell 'ese rcito car t aginese, ch e vi accingete a combattere, sono costituiti non da uomini, ma da larve di uomini, morti di freddo e di fame ... con i nervi irrigiditi dalla neve e le membra cotte dal ge lo " (mempra torrida geltt)?
Nella tragica ritirata dalla Ru ssia (1812) l'armata napoleonica fu quasi distrutta.
<< 1'\oi tntti eravamo - SLrisse il L arrey (Mhnoires de chirurgie militaire) - in un stato di abbattimento e di torpore da non
11
essere qua si in grado di riconoscerei ; si marciava in un c upo silen zio con la vista ed i muscoli indeboliti al punto che riu sciva difficile seguire la propria direzione e conservare l 'equilib r io ».
Nel primo conflitto mondiale per il nostro ese rcito i co ngelat i raggiunsero l'enorme cifra di trecen tomila. Grande fu a nch e il num e ro dei morti per successive complicazioni settiche, notevole qu ello degli amp utati, specie nel primo anno di guerra .
Freq uentissimi furono i casi di « piede da trincea " ·
L e trincee s'empivano infatti di acqua c i fanti stavano con le gambe nel fango fino alle ginocc hi a . Ed inoltre come - dopo la morte del tenente Miraglia crocefisso alla sua ala - G. Parini ebb e a riferire al Poeta « le loro scarpe che e rano rimaste ai piedi per giorni e per giorni e per giorni in fango in polvere in sasso, e furono rotti i legàccioli per ti r ar le dai piedi freddi allineati su l'orlo della sepoltura » era no di pessima qualità e fornite dai frodatori che godevano di tutte le indulgenze invece di essere fu cilati in massa o forzati a rimanere tre giorni nella morta go ra della trin cea con qu elle loro sca rpe ai piedi. <<Tre giorni - affermava d'Annunzio - bastano a fini1 ·e un uomo anche ladro! >> .
(( ..... gli alpini, con le gambe congelate, cercavano di sollevarsi al suo passaggio e sorrideva n o. U gentilez.za d'I talia! I n un sol giorno il chirurgo aveva mo zzo i piedi a duecento cinq uanta uomini 11 (Notturno).
Questa cifra enorme, addirittura iperbolica, a l Po eta sarà stata suggerita da quanto avvenne nell a battaglia della Mosko wa (1812) in cui il cel ebre chirurgo di Napoleone. il barone Larr ey, operò su l campo di bat tagli a, ccn eccezionale abilità e rapidità , ben duecento amputazioni nell e ventiquattro or e!
Ed ancora: u l piedi sono la ggiù, lontani, estranei , come quelli d'un mutilato per congelazione, simili a quellz che vedemmo appaiati negli ospedaletti alpini quando tl ferro del chirurgo lavorava senza riposo » (Notturno).
E in Sett e documenti d 'a more (Il Vittoria/e, Meditazione del 16 agos to 1919, p. 309): " ..... i soldati avevano nel cuore la preghiera del ro z z o alpino che vide recidere tanti piedi congelati: O Signore, lascia che riaprano gli occhi i nostri morti e vedano il frutto del loro sacrificio! » .
Con verismo impr ess ionante sono descritti: « ... i mo12chi, gli _rtroppi, i rattratti, i torsi rimaJtÌ su gli inguini Ù1 luogo di calcagua ,

i visi rabberciati con le ricuciture e con gli innesti, i sa nti mostri che stentano mezzi automi e mezzi i nati dalla matrice rifatti dall' arte meccanica, tutti quei corpi umani che pota la guerra e la potatura atroce li accresce Ji magtwnimità come rinvigorisce gli alberi » (Riscossa).
Una tremenda potatura è invero quella <<amputazione anatomica », a sez ione piana cioè (metodo di Celso) usata un tempo anche da Ambrogio Pareo (1545), che consigliava per non spargere molto sa ngue di «spedire l'opra con un colpo solo » Botallo d'Asti, che aveva costruito una s pecie di mannaia (De curandis vulneris sclopetomm, Lione, 156o), ammoniva addirittura d i praticare l'amputazione di braccio con due scuri taglientissime, una fissa e una appesantita da piombo cadente dall'alto! E' un metodo rapido, ma brutale e che appartiene al passato, a un'epoca cioè in cui, non essendo ancora possibi le ricorrere a un mezzo efficace di anestesia, bisognava cercare di far presto, il più presto possibile. E' da rilevare tuttavia che tre secoli dopo, nel 1843, a Losanna: Mathias Mayor escogitò un « tachiotomo >J (specie di ascia su cui si batteva con un martello) per praticare celermente anche amputazioni di cosci a!

Nel primo conflttto mondiale l'amputazion e anatomica tornò di moda, specie in Francia. E' un metodo da sconsigliare senz'altro, ma che peraltro, correttamente eseguito, senza ricorrere ai raccapriccianti mezzi di tortura un tempo escogitati ed usati (è sufficiente un comune bisturi!), poteva tuttavia essere giustificato solo eccezionalmente. E' in effetti un intervento rapidissimo, espone meglio la ferita operatoria all'azione dell'ossigeno e permette l'amputazione anche in casi disperati quando cioè la cancrena tende ad invadere la radice dell'arto.
Nel brano riportato troviamo anche un fugace accenno alla chirurgia riparatrice ( « i vist rabberciati con ìe ricuciture e con gli sti »)e alla protesi( « rifatti dall'arte meccanica »).
E i mutilati cht: sono definiti anche fruttiferi , poichè « la potatura atroce li accresce di magnatlimità come rinvigorisce gli alberi», ridivenuti artieri e contadini, tornano ad assaporare la sere na gioia del lavoro fecondo: «O Serafino Tancredi, o contadino di Teramo, tu che non puoi più seminare con la mano sinistra, ma che puoi sempre seminare con la destra e gettare la semenza sempre più lontano, perchè sento che t'è l'nuimo nel polso nella palma e 1lelle dita 11
Nel Notturno è ricordato l'eroismo di Ore ste Salomone, mort:tlm ente ferito, che sembra d'avorio senza vene, santamente scolpito .
Come è espressivo quel « d'avorio senza vene l> , che indica la brusca caduta della e 1! rapido spegnersi delle forze per effetto dell'anemia post-emorragica!
Accenniamo a un ferito con pneumotorace aperto all'esterno. P ar di udire il rumore dell'aria: << • : • un mitragliere ferito nel polmone da cui escivano un gorgoglio e un sibilo a/temi u
Ed ecco un altro « ferito alla testa da un colpo folle che gli aveva bucato in più parti il labbro la gvta il coLLe e l' omero senza uccider/o. Si dissanguava. LI sangue s'anneriva sul grigio; la mano si stagnava sul sasso. LI lagno era una bolla scoppiante, la parola era un gorgoglio rosso, era un rantolo caldo e sordo >• . Il (erito venne amorevolmente soccorso dal P oeta st esso che, servendosi della sua custodia di strumenti e di medicine, cercò frenare l'imponente emorragia: « deterJ·i, esplorai, stagnai, fasciai. Affidai a due di voi il fratello beudato, perchè lo accompagnaste a un carro d'ambulan z a, sotto le Officine dell'Adria » (Per l'Italia degli Italiani).
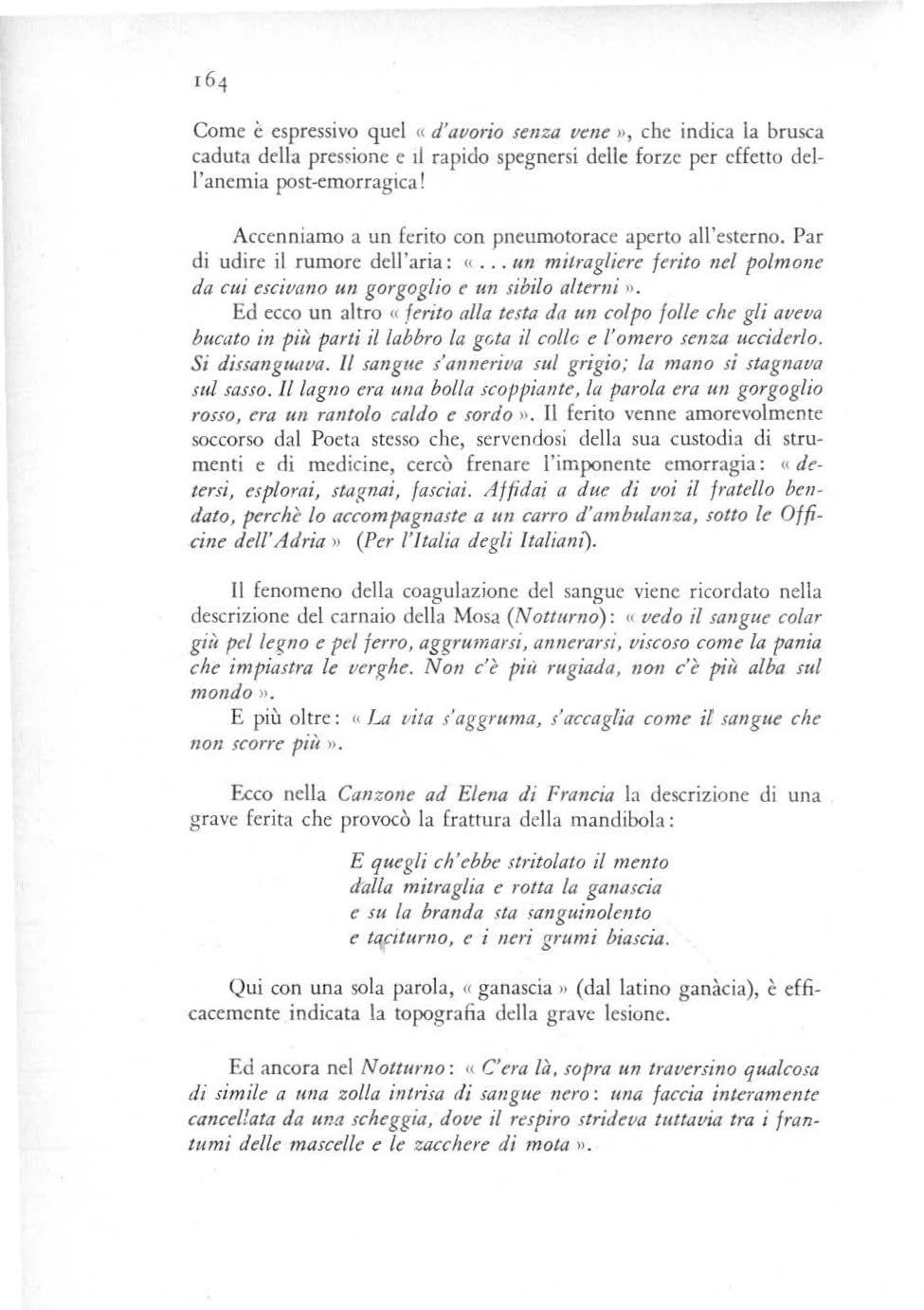
Il fenomeno della coagulazione del sangue viene ricordato nella descrizione Jel carnaio della Mosa (Notturno): u vedo il sangue colar giù pc! legno e pel ferro, aggrumarsz, annerarsi, viscoso come la pania che impiastra le verghe. Non c'è pià rugiada, non c'è fÌÙ alba sul mondo >>
E più oltre: << La t'ila s'aggruma, s'accaglia come il sangue che non scorre più ))
Ecco nella Canzone ad Elena di Francia la descrizione di una grave ferita che provocò la frattura della mandibola:
E quegli ch'ebbe stritolato il mento dalla mitraglia e rotta la ganascia e su la branda sta •anguinoleuto e taczturno, e i neri gru mi bioscia.
Qui con una sola parola, << ganascia , (da l la t ino ganàcia), è efficacemente indicata la topografia della grave lesione.
Ed ancora nel Notturno: •< C'era là, sopra un traversino qualcosa di simile a una zolla intrisa di sangue uero: una faccia interamente cancellata da una scheggia, dove il respiro strideva tuttavia tra j frantumi delle mascelle e le zacchere di mota >l
Gli esempi urgono irresistibili, ma non è possibile riferire le tante altre lesioni delle più svariate parti del corpo, descritte realisticamente e che dimostrano l':malisi compiuta al riflesso di cognizioni acquisite e profondamente elaoorate e con un linguaggio che sa suscitare un cumuio eli pensieri, di sentimenti e di emozioni.
M a vogliamo infine ricordare solo i'Ode per gli Italiani morti in Africa (Capitan Fracassa). E' la descrizione d'un campo di battaglia in cui i muti eroi, composti in coro:
Morti coprono il terreno, chi squarciato il ventre e il seno, chi la testa o un braccio meno, altri a mezzo il cranio aperto, altri l'inguine scoperto, giaccion morti, nel deserto.
Ed è per quanto sommariamente abbiamo accennato che Gabriele d'Annunzio ha diritto di privilegiato domicilio nella grande famiglia sanitaria e di essere ricordato come un profondo conoscitore della chirurgia di guerra.
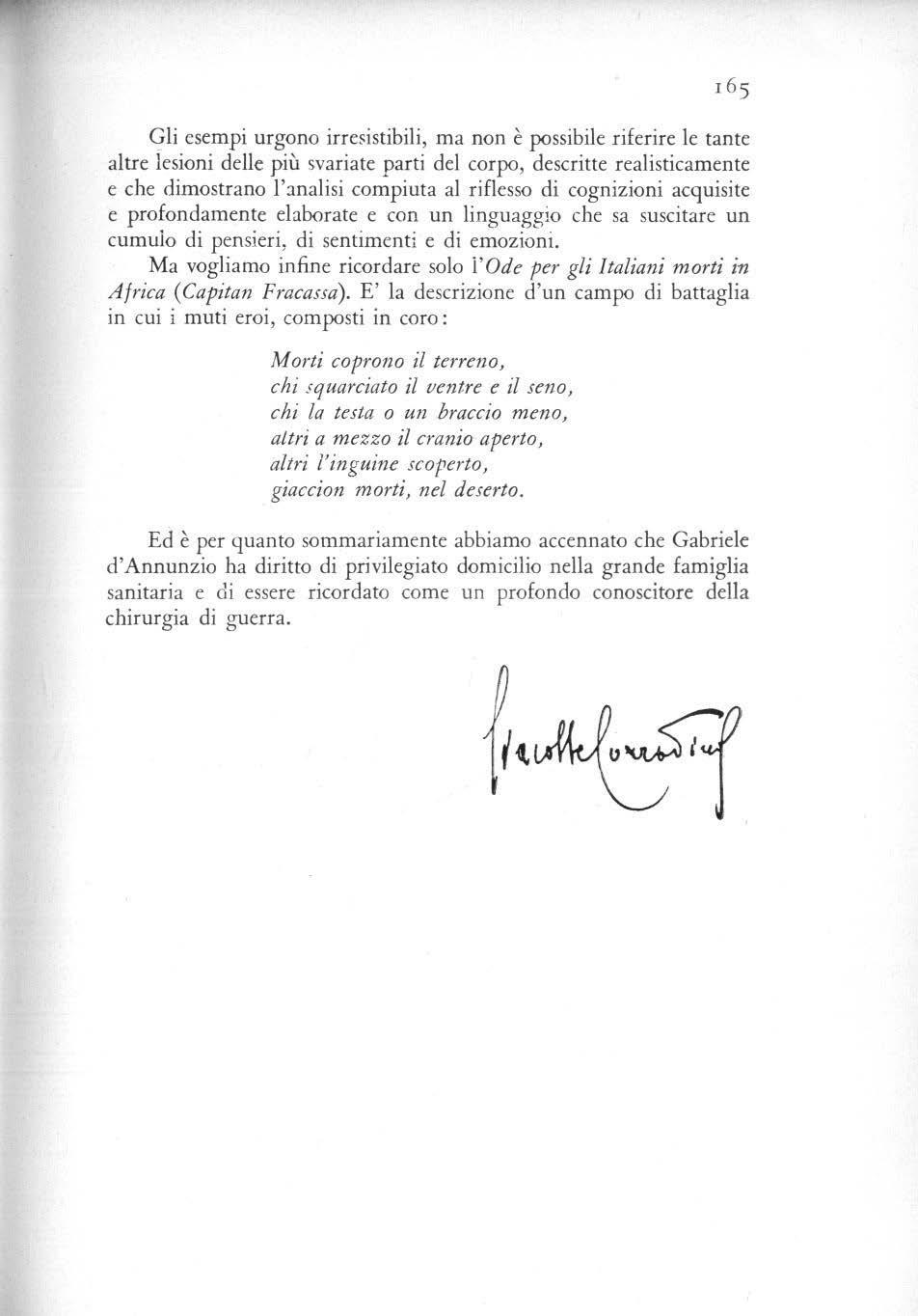
LA NUOVA RAZ I ONE ALIMENTARE DEL SOLDATO
L'attuale razione alimentare del soldato - studiata dagli organi ministeriali del Commissariato e della Sanità -raggiunge finalmente quelle mète che fisiologi ed igienisti hanno in passato auspicato invano, e costituisce una delle più importanti provvidenze attuate nell:i riorganizzazione delì'esercito per il raggiungimento di una sicura efficienza fisica e moral e delle truppe.
Riteniamo pertanto utile precisare le realizzazioni conseguite, tanto più cbe esse sono anco ra poco conosciute negli ambienti civili.
RAZIONE VIVER I OROINARIA GIORNALIERA (DA CONSUMARE Il' DUE PASTI PRINCIPALI ED UNA PRIMA COLAZ I ONE DOPO LA SVEGLIA).
Pan e (abburr.to 8o %) gr. 500
Pasta . >l 200
Riso >l 2') (Sosùtuibile a pari peso, in caso di · indisponibilità, con pasta).
Carne fresca o congelata, con osso . gr . 200
Legumi secchi » 40 (Da sostituire due volte alla settimana con gr. 120 di patate; tale sostituzione è consentita altresì in caso di indispon ibilità dei legumi).
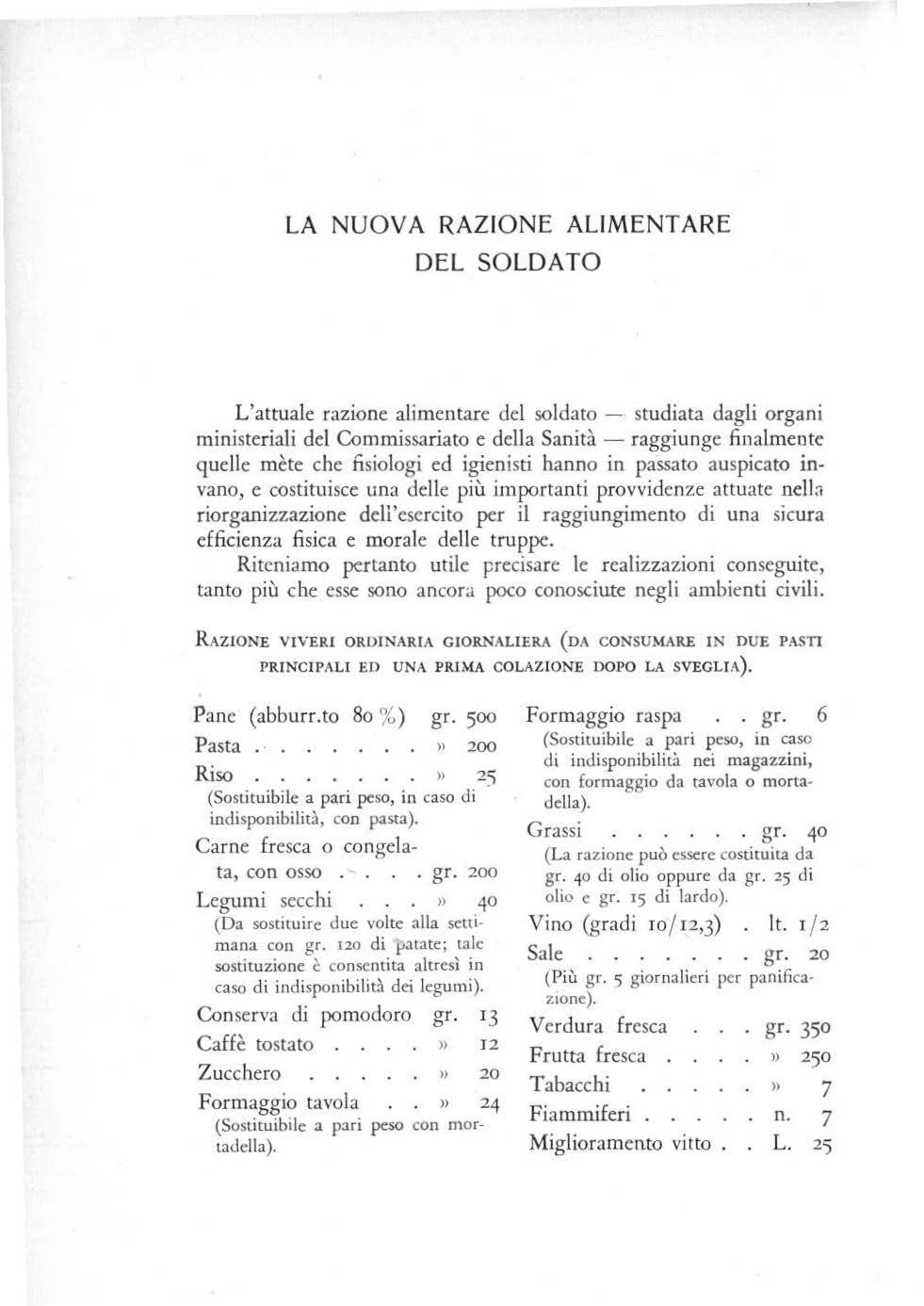
Conserva di pomodoro gr . 13
Caffè tostato . » 12
Zucchero >) 20
Formaggio tavola » 24 (Sost itui bilc a pari peso con mortadclla).
Formaggio raspa . gr. 6 (Sostituibile a pari peso, in cas o di indisponibilità nei magazzini, con formaggio da tavola o mortadella).
Grassi . gr . 40 (La razione può essere costitu ita da gr. 40 di olio oppure da gr. 25 di ol io c g r. 15 di lard o).
Vino (gradi IO / 12,3) lt. I /2
Sale gr . 20 (Più g r. 5 giornalieri per panifìcaZIOne).
Vcrdura fresca g r . 350
Frutta fresca
Tabacchi
Fiammiferi
Miglioramento vitto .
)) 250 )) 7
n. 7
L. 2'5
Durante ogni quindic in a vengono distribuiti:
- per 1 r giornate: carne fresca o congelata;
- per due giornate: generi vari da acquistarsi con l'equivalente del costo della razione di carne (quota giornata libera);
- per due giornate: gr . 7S di formaggio da tavola o mortadella. Eventualmente in luogo di gr. 75 di formaggio potranno essere distribuiti gr. 200 di pesce congelato .
La razione cruda presenta le seguenti medie per i principali elementi nutritivi: protidi gr. 125, lipidi gr. 65, glucidi gr. 545, a cui bisogna aggiungere 40 gr. di alcool, o tten endo così un valore energetico complessivo superiore alle 3600 calorie.
Analizzati quantitativamente e qualitativamente, i generi alimentari ora forniti al soldato presentano le seguenti favorevoli caratteristiche:
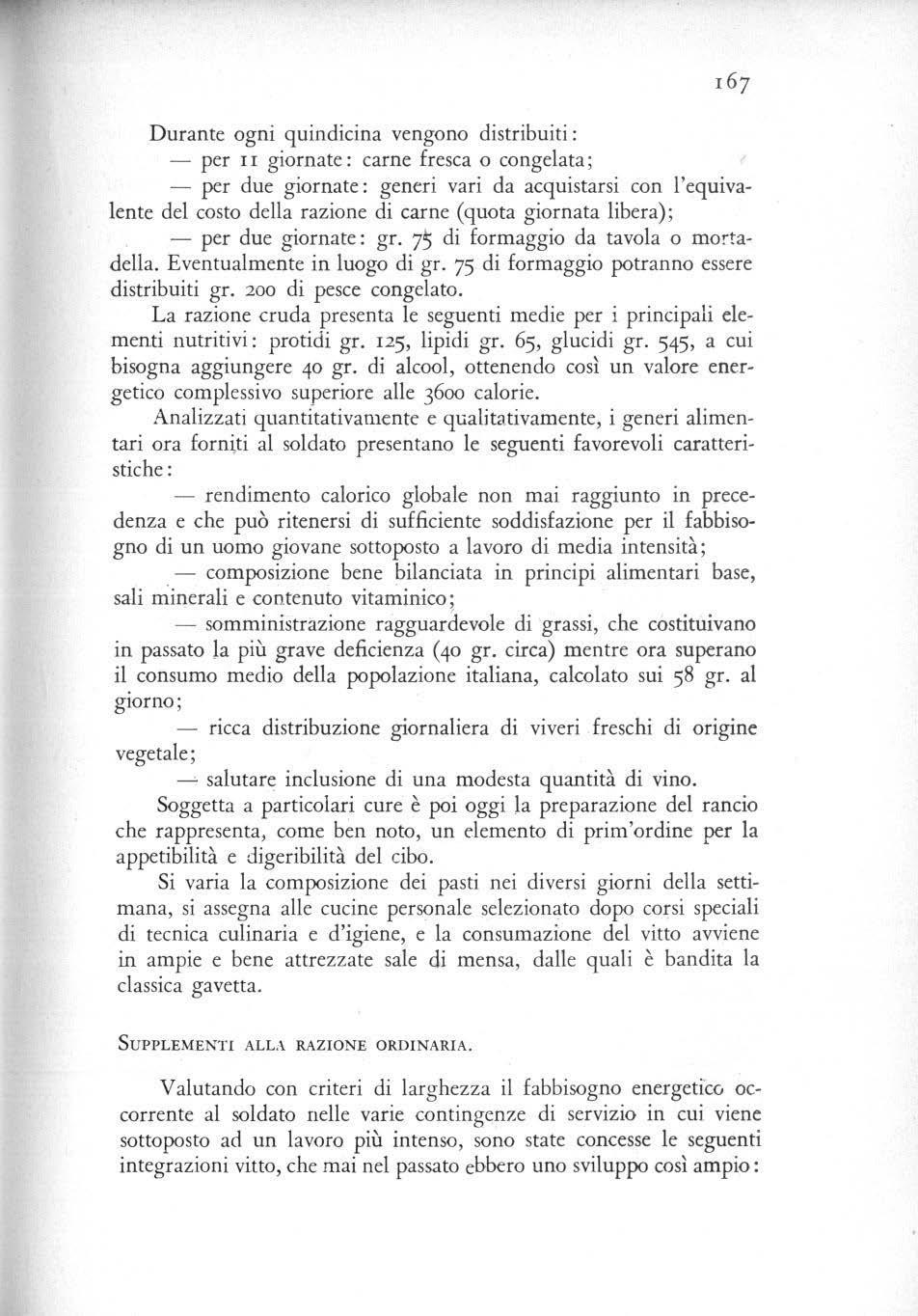
- rendimento calorico globale non mai raggiunto in precedenza e che può ritenersi di sufficiente soddisfazione per il fabbisogno di un uomo giovane sottoposto a lavoro di media intensità;
- composizione bene bilanciata in principi alimentari base, sali minerali e contenuto vitaminico;
- somministrazione ragguardevole di grassi, che costituivano in passato la più grave deficienza (40 gr. circa) mentre ora superano il consumo medio della popolazione italiana, calcolato sui 58 gr. al g10rno;
- ricca distribuzione giornaliera di viveri freschi di origine vegetale;
- salu tare inclusione di una modesta quantità di vino.
Soggetta a particolari cure è poi oggi la preparazione del rancio che rappresenta, come ben noto , un elemento di prim'ordine per la appetibi lità e digeribilità del cibo.
Si varia la composizione dei pasti nei diversi giorni della settimana, si assegna alle cucine personale selezionato dopo corsi speciali di tecnica culinaria e d'igiene, e la consumazione del vitto avviene in ampie e bene attrezzate sale di mensa , dalle quali è bandita la classica gavetta.
SUPPLEMENTI ALL;\ RAZIONE ORDINARIA.
Valutando con criteri di lar g h ezza il fabbisogno energetico occorrente al soldato nelle varie contingenze di servizio in cui viene sottoposto ad un lavoro più intenso, sono sta te concesse le seguent i integrazioni vitto, che mai nel passato ebbero uno sviluppo così ampio:
- allievi di Accademie e Scuole militari: carne gr. roo, pane gr. IOS, formaggio da tavola gr. 36 (per 6 giorni della settimana);
- allievi di Scuole sottufficiali: carne gr. 100 (per g10rni della settimana), pane gr. 100;
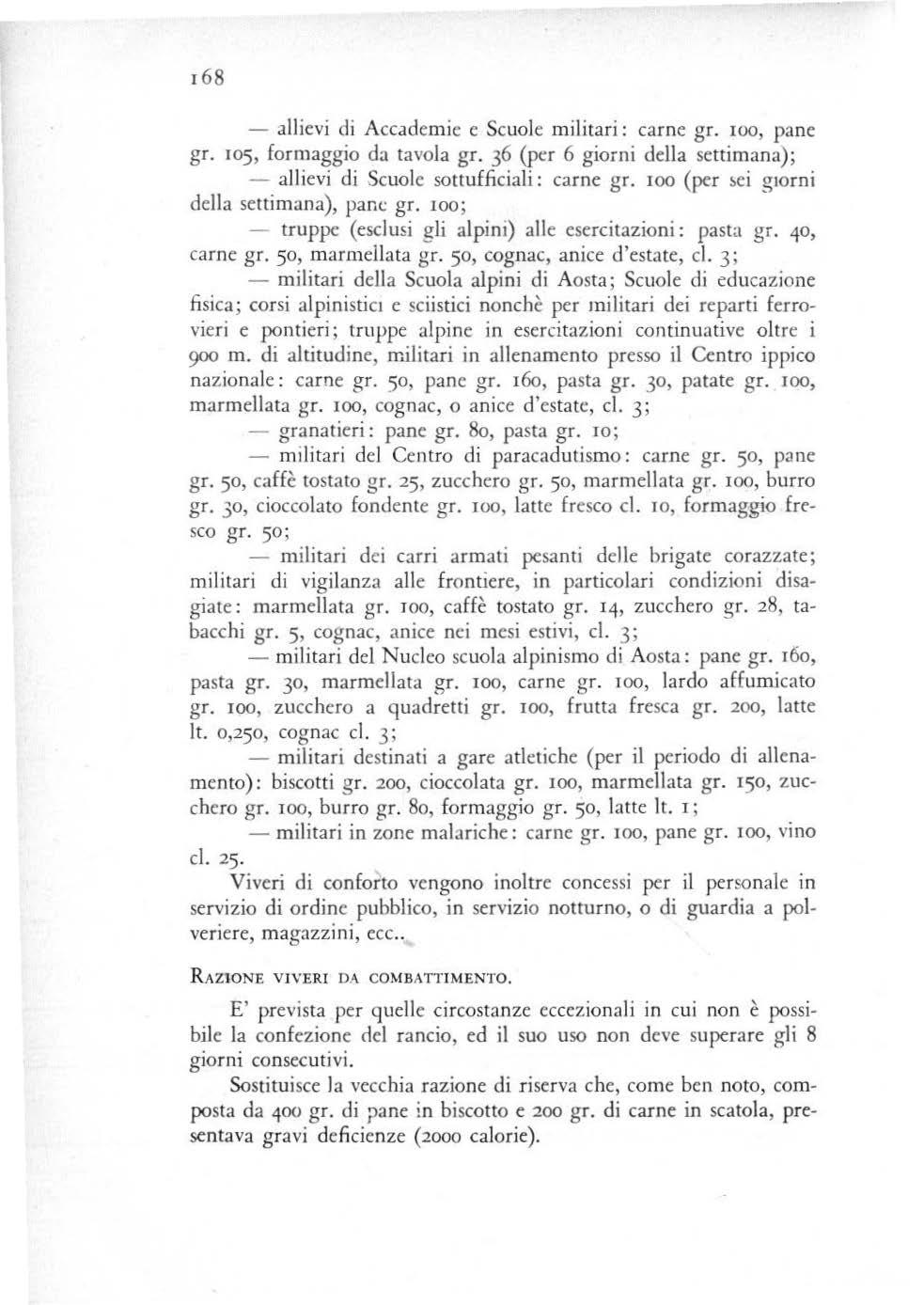
- truppe (esclusi gli alpini) alle esercitazioni: pasta gr. 40, carne gr. so, marmellata gr. so, cognac, anice d'estate, cl. 3;
- militari della Scuola alpini di Aosta; Scuole di educazione fisica; corsi alpinistici c sciistici nonchè per militari dei reparti ferrovieri e pontieri; truppe alpine in esercitazioni continuative oltre i 900 m. di altitudine, rr.ilitari in allenamento presso il Centro ippico
nazionale: carne gr. so, pane gr. 16o, pasta gr . .30, patate gr. roo, marmellata gr. 100, cognac, o anice d'estate, cl. 3;
- granatieri: pane gr. 8o, pasta gr. IO;
- mditari del Cent ro di paracadutismo: carne gr. so, pane gr. so, caffè tostato gr. 2S, zucchero gr. so, marmellata gr. 100, burro gr. 30, cioccolato fondente gr. 100, latte fresco cl. Io, formaggio fresco gr. so;
- militari dci carri armati pesanti delle brigate corazzate; militari di vigilanza alle frontiere, in particolari condizioni disagiate: marmellata gr. roo, caffè tostato gr. 14, zucchero gr. 28, tabacchi gr. s, cognac, anice nei mesi estivi, cl. 3;
- mi l itari del Nucleo scuola alpinismo di Aosta: pane gr. 160, pasta gr. 30, marmellata gr. 100, carne gr. 100, lardo affumicato gr. roo, zucchero a quadretti gr. 100, frutta fresca gr. 200, latte l t. o,2so, cognac cl. 3;
- militari destinati a gare atletiche (per il periodo di allenamento): biscotti gr. 200, cioccolata gr. 100, marmellata gr. rso, zucchero gr. 100, burro gr. 8o, formaggio gr. so, latte l t . I;
- militari in zone malariche: carne gr . 100, pane gr. 100, vino cl. 25
Viveri di conforto vengono inoltre concessi per il perso n ale in servizio di pubblico, in servizio notturno, o di guardia a polveriere, magazz1nt, ecc . .
R AZl ONE V I VERI DA CO MBATT I MENTO.
E ' prevista per quelle circostanze eccezio n ali in cu i no n è possibile la confezione del rancio, ed il suo uso non deve superare gli 8 giorni consecutivi.
Sostitu isce la vecchia razio n e di rise r va che, come ben n oto, co mposta da 400 gr. di pane in biscotto e 200 gr. di carne in scatola, presentava g r avi de fi cienze (2000 calorie).
r68
Questo nuovo tipo cii razione trovasi tuttora in esperimento ed è stato studiato a luJ1go per raggiungere un valore nutrjtivo corrispondente alle reali esigenze di chi compie una attività fisica considerevole in condizioni disagiate di servizio, e per fornire nello stesso tempo generi alimentari vari e graditi, pronti al consumo, di limitato peso e volume e di facile ::tpprovvigionamento e condizionamento.
Composizione della razione:
1 ° pasto, colazione.
Galletta .
Biscotti .
Caffè solubile
Zucchero
Cara melle
Galletta .
Carne scatolata
Marmellata
Compresse vitaminiche (vit. C mgr 7S) zuccherine
gr. so Cioccolato con aggiunta
>> so di cola e di vitamine B
>> 8 (mgr. 2) B2 (mgr. 2,6)
n 2 0 C (mgr. 7S) . gr. s o
l) 17
2 " pasto, pran z o.
gr. 200 Caramelle
)) 2 00 Polvere con estratto di
)) 100 agrumi, v itaminizzata con vit. C , per acqua da tavola
)) I2
3" pasto, cena.
Galletta
Biscotto .
Formaggio
gr . 100 Cacao zuccherato .
n 50 Caramelle
>> IOO
gr. I.., l
)) 30
gr. 30
)) 17
Completano la razwne: I pacchetto di IO sigarette, I scatola di fiammiferi Minerva, IO fogli di ·carta igienica.
Inoltre al saldate vengono dati a parte J scaldarancio, r coltello a serramanico con apriscatole.
Condizionamento . - - Tutti i generi componenti la razione sono contenuti in involucri di carta impermeabile, in modo da avere tre pacchetti (corrispondenti ai tre pasti) a loro volta immessi in una scatola a tenuta ermetica, colorata in kaki, costituente l'imballaggio esterno dell'intera razione, così da tenere bene assestato il contenuto ed impedire l'infiltrazione di umidità. Nella scatola, munita di apertura a strappo lungo il perimetro, sono anche messi i IO fogli di carta igienica, un talloncino di controllo ed un'i struzione sull'uso della razione .

..
Valore tlUtrtttvo. - Il potere calorico globale è di circa 38oo calorie con principt alimentari organici così suddivisi: gr. I40 di protidi, gr. 95 di lipidi, gr. 580 di glucidi.
Peso. - Il peso netto dei viveri è di gr. 1050, quello lordo dell'intera scatola di gr. 1500.
Conservabilità. Calcolata in almeno un anno.
CARATTERISTICHE DEI GENERI COMPONENTI LA RAZIONE.
Galletta. - Il tipo di galletta tradizionale in uso nell'esercito è stato modificato rnigliorandone le proprietà organolettiche e riducendone il formato. Si presenta a forma rettangolare (cm. 7 x 7,5), e viene confezionato con farina di frumento abburattata al 75 %, con aggiunta di sale (1 %) e di grasso idrogenato vegetale (1 %).

Biscotto dolce . -- E' proJotto con pura farina di frumento, ab-burattata al 72-75 %, ed aggiunta di zucchero e di grassi. La composizione chimica per gr. 100 di sostanza è: umidità 5,97, ceneri o,6s>, cloruro di sodio 0,23, acidità (in acido lattico) 0,20, azoto I,8o, sostanza grassa 7,06, cellulosa 0,28, zuccheri, sacca rosio, 17,03. I biscotti hanno le dimensioni di cm . 5,5 x 4,5 e sono condizionati in pacchi da gr. 50, con doppio strato di carta (oleata e pergaminica).
Carne bouina scatolata. - Nessuna modificazione è stata portata al tradtzionale tipo di preparazione. In definitiva ogni scato letta contiene circa 150 gr. di puro muscolo rosso mentre il rimanente è costituito da gelatina e grasso, con un va lore nutritivo che corrisponde a quello della carne occorsa per la preparazione, che in media si aggira sui 400 grammi.
Formaggio. l- Scatolato in involucri di latta, è del tipo fuso con un contenuto in grassi (su sostanza secca) del 40,2 %.
M armellata. - Preparata con diverse varietà di frutta (pesche, albicocc he, prugne, mele) in forma solida, immessa in sca tola di latta, ha un tenore zuccherino del 65,8 %.
Cioccolato. - E' del tipo fondente, costituito esclusivamente di pasta di cacao e di saccarosio con aggiunta di vitamine e di nervini. Pr esenta il 50-51 % in zucchero (saccarosio) ed il 28-3o % in grassi (burro di cacao). Per ogni razione di 50 gr. è poi garantito un contenuto di vitamina B mgr. 2, vitamina B2 mgr. 2,6, vitamina C mgr. 75· P er aumentare l'apporto dei nervini è stata considerata l'aggiunta,
170
per ogni tavoletta di gr. 50 di cioccolato, di gr. 3 di noce di cola oppure gr. 0,025 di caffeina.
Caramelle. - Preparazione in discoidi, di zucchero saccarosio con aggiunta di glucosio sino al massimo del 33 % e di lattosio sino al 3 %, addizionati di coloranti innocui, ed aromatizzati con essenze naturali di arancio, limone, mandarino, menta . Umidità non superiore al 3 %. Sono condizionate in astuccio cii indrico di foglio di ali uminio, intercalato e fascettato con carta. Ogni astuccio risulta del peso netto di gr. 15 /17 .
Compresse zuccherine vitaminizzate. - Sono di puro saccarosio, aromatizzate al limone od all'arancio, con aggiunta di acido ascorbico nella misura di mgr. 75 per ogni razione da gr. 12 . Umidità non superiore all'I %. Sono racchiuse in carta pergamena e fascettate .
Caffè solubile (prodotto Nescafè). - La razione di gr. 8 di polvere di caffè è immessa in una capsula metallica. Solubile in acqua calda oppure fredda permette di preparare I / 4 di litro eli ottima bevanda . Il con t enuto in caffeina si aggira sul 2 % ed il titolo di umidità non supera il 3,50 %.
Cacao zuccherato. - Si tratta d i polvere di cacao zuccherato, compressa, che può essere consumata sol ida oppure sciolta in acqua calda (r/5 di litro), ottenendo un'ottima bevanda. I dati di composizione sono : umidità non più del 3 .% , sostanze grasse ro %, zucchero 65 %. Preparazione in forma di parallelepipedo con dimensioni di cm 5 x r,2; peso unitario gr. 30. Ogni compressa è avvo lta in fo- · glio di alluminio, intercalato e fascettato con carta.
Polvere con estratto di agrumi, vitaminizzata. - E' costituita dalla polvere per acqua da tavola « Salitina » aromatizzata all'arancio ed aggiunta di mgr. so di acido ascorbico. La miscela consente di preparare, all'istante, una gradevole bevanda (r j 2 litro) frizzante . La dose giorna liera è ripartita in due aliquote, in corrispondenza di una tacca divisoria nell'invo lu cro. E ' così possibile preparare separatamente due dosi di bevanda da r /4 di litro ognuna.
La razione viveri giornaliera di guerra non è stata ancora definita.
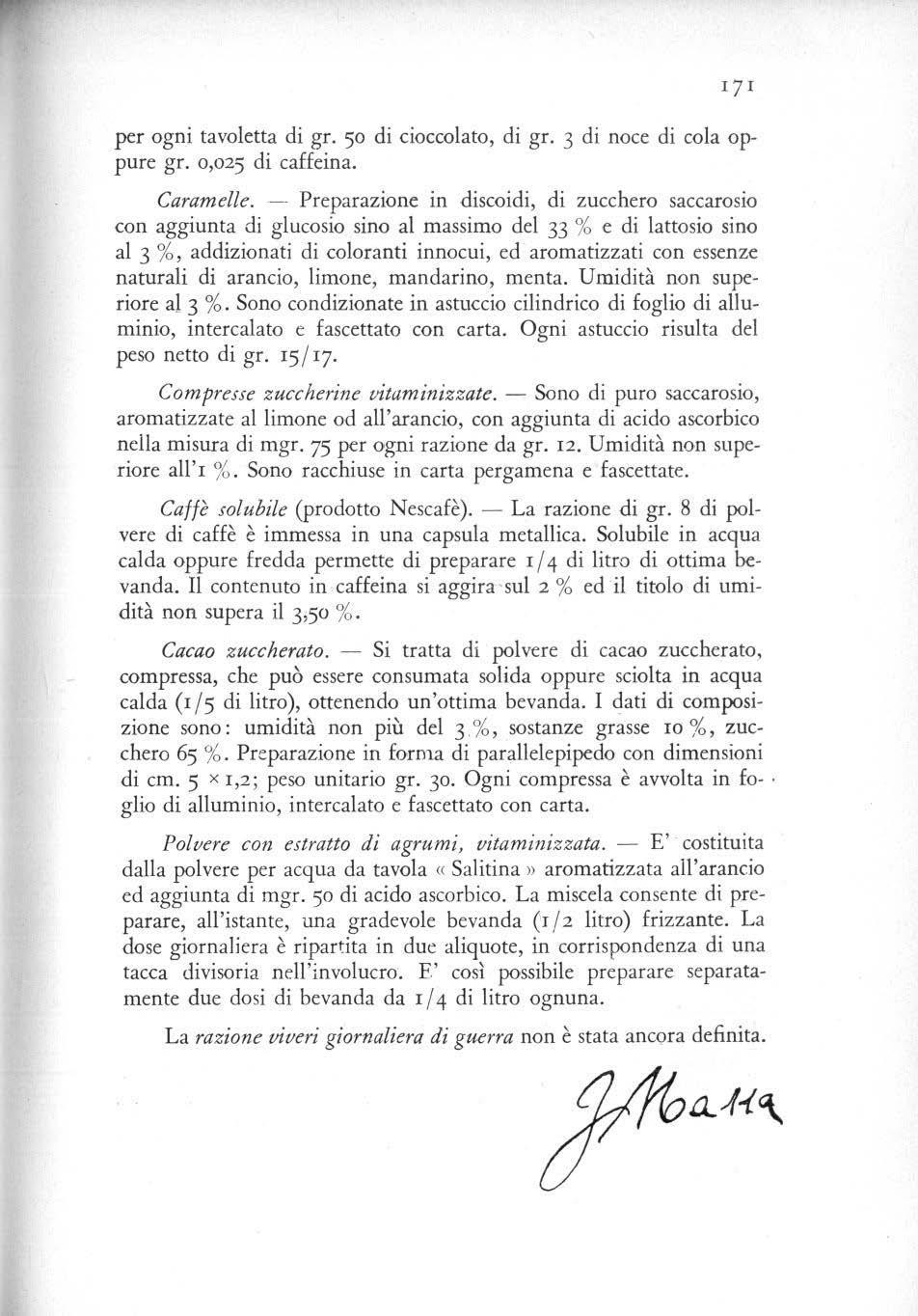
171
SULLA PS ICHE DE l TUBERCOLOTIC I •
Ascrivo a titolo d'onore di poter parlare a una eletta schiera di tunzionari di P. S. che p artecipano a -1uesto corso di perfezionamento orga nizzato dal chiarissimo prof. L eto, e di poter trattart: un tema di notevole interesse medico-sociale e psicologico, quale è quello della psiche del tubercolotico, sul quale si sono espressi pareri così discordi da parte di studiosi che non vivono la vita abituale dei Sanatori.
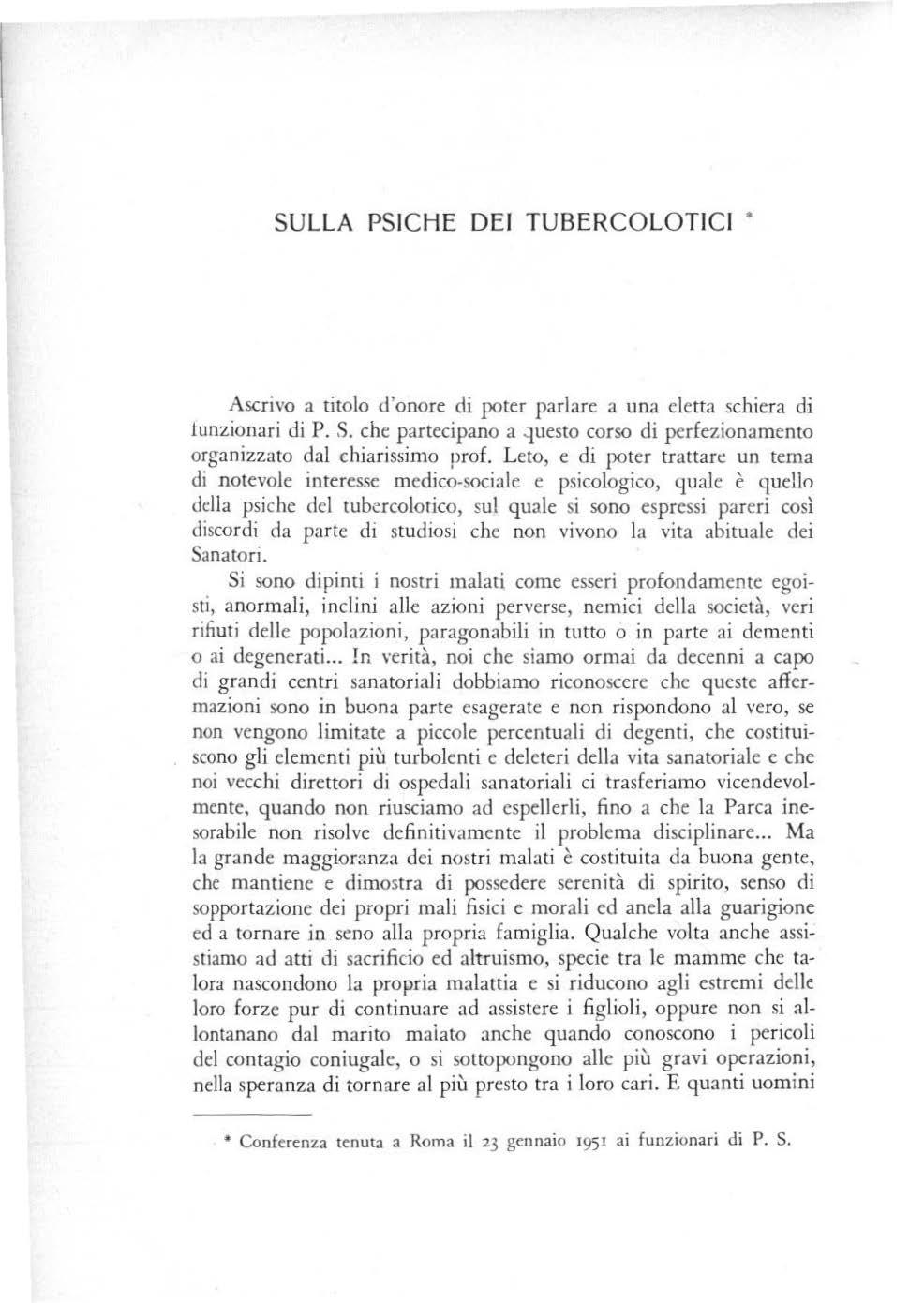
Si sono dipinti i nostri malati come esseri profondamente egoisti, anormali, inclini alle azioni perverse, nemici della società, veri rifi uti delle popolazioni, paragonabili in tutto o in parte ai dementi o ai degenerati I n verità, noi che siamo ormai da decenni a capo di grandi centri sanatoriali dobbiamo riconoscere che queste affermazioni so no in buona parte esagera t e e non rispondono al vero, se non vengono limit ate a piccole percentuali di degenti, che costituisco no g li elementi più turbolen t i c deleteri della vita sanatoriale e c h e noi vecchi direttori di ospedali sanatoria li ci trasferiamo vice nd evolmente, quando non riusciamo ad espellerli, fino a che la Parca inesorabile non risolve definitivamente il prob lema disciplinare Ma la grande maggiorGnza dci n os tri malati è costituha d a buona gente, c he mantien e e dimostra di possedere sereni tà di spirito, senso di soppo rtazione dei propri ma li fisi ci e morali cd anela alla gua r igione ed a tornare in seno alla p r opria famiglia. Qualche vo lta anche assistiamo ad atti di sacri ficio ed altruismo, specie tra le mamme che talora nascondono la propria malattia e si ridu cono agli estremi delle loro forze pur di continuare ad assistere i figlio li, oppure non si a llontanano dal marito maiato anche quando conoscono i pe r icoli del contagio coniugale, o si sottopo ngono alle più gravi operazioni, nella spe r a nz a di tornare a l più pres to tra i loro cari. E quanti uomini
• Conferenza tenuta a Roma il 23 gennaio 1951 ai funzionari di P. S.
illustri, grandi poeti, musicisti, scienziati, filantropi, mJStlCl e santi hanno pagato il loro tributo alla tubercolosi, e ciò non pertanto hanno dato un grande contributo di bene all'umanità! Basti citare i nomi g loriosi di Chopin, Mozart, Leopardi, L aennec, S. Luigi Gonzaga, S. Francesco d'Assisi, in mezzo a una lunga eletta schiera di tubercolotici, per riten ere che la malattia tubercolare, !ungi dallo smorzare la loro fiamma geniale, ha determinato una più vivida e intensa smania creativa, quasi un'ansia di raggiungere al più presto una meta di gloria e di alta idealità.
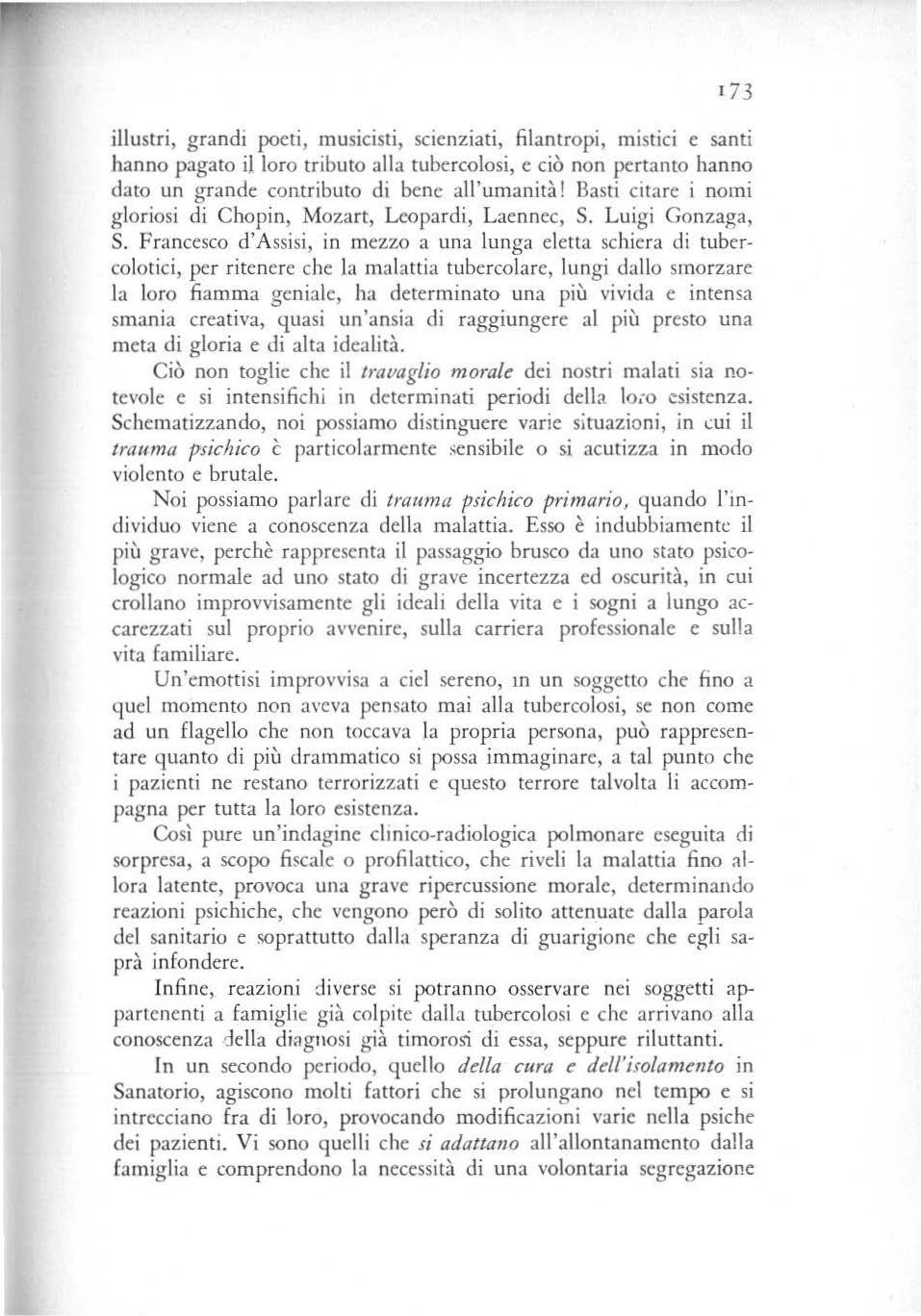
Ciò non toglie che il travaglio morale dei no stri malati sia notevol e e si intensifichi in determinati periodi della lo.-o .::sistenza. Schematizzando, noi possiamo distinguere varie si tuazi oni, in cui il trauma p'Sichico è particolarmente o si acutizza in modo violento e brutale.
Noi possiamo par lare di trauma psichico primario, quando l'individuo viene a conoscenza della malattia. Esso è indubbiamente il più grave, perchè rappre senta il passaggio brusco da uno sta to psicologico normale ad uno stato di grave incertezza ed oscurità, in cui crollano improvvisamente gli ideali della vita e i sogni a lungo acca rezzati sul proprio avvenire, sulla carriera professionale e sulla vita familiare.
Un'emottisi improvvi sa a cie l se reno, m un soggetto che fino a quel momento non aveva pensato mai alla tubercolosi, se non come ad un flagello che non toccava la propria persona, può rappresentare quanto di più drammatico si possa immaginare, a tal pun to che i pazienti ne restano terrorizzati e questo terrore tal volta li accompagna per tutta la loro esistenza.
Così pure un'indagin e clmico-radiologica polmonare eseguita di sorpresa, a scopo fiscale o profilattico, che riveli la malattia fino allora latente, provoca una grave ripercussione moral e, determinando reazioni psichiche, che vengono però di solito attenuate dalla parola del sanitario e soprattutto dalla speranza di guarigione che egli saprà infondere.
In fine, reazioni diverse si potranno osservare nei sogge tti appartenenti a famigli e già co lpit e dalla tubercolosi c che arrivano alla conoscenza della diagnosi già timorosi di essa, seppure riluttanti.
In un secondo periodo, quello della cura e dell'isolamento in Sanatorio, agiscono molti fattori che si prolungano nel tempo e si intrecciano fra di loro, provocando modificazioni varie nella psiche dei pazienti. Vi sono quelli che si adattano all'allontanamento dalla famiglia e comp rendono la necessità di una volontaria segregazione
173
dalla società e di un periodo di cure rigoroso di riposo fisico e mentale, con limitazione della libertà individuale, ed altri inadattabili, che non restrizioni di sorta e vivono in un perenne stato d'animo ansioso e ribelle, richiedono continui permessi di uscita, il che incide sfavorevolmente sull'andamento della malattia e 5ull'esito delle cure.
Naturalmente hanno un grande peso le vicende familiari, dal lato affettivo ed econo mico. Purtroppo non è raro al giorno di oggi che intere famiglie si sfascino. e si allentino i legami affettivi, questi malati si sentono isolati, estraniati dalle loro famiglie e dalla società, e divengono apatici e immorali.
\fa il trauma psichico si ripete spesse volte - sotto mutate spoglie - al momento in cui i soggetti, guariti o stabilizzati, debbono rientrare nella normalità della vita. Dopo anni di 1solameuto e dì inattività, e dopo avere faticosamente raggiunto un certo grado di adattamento al t1po di esistenza imposto dal Sanatorio, il pensiero dì dover affrontare una lotta per conquistarsi una nuova posizione sociale li turba profondamente e ne scuote le energie già compromesse. A questo si aggiunga la difficoltà dì trovare lavoro, data la forte disoccupazione, o l'impossibilità di riprendere il proprio mestiere, troppo pesante per la loro capacità lavorativa residua, e ci potremo allora facùmente convincere del perchè alcuni di essi (c non sono l'assoluta minoranza) non vogliono lasciare il Sanatorio e chiedono continue proroghe delle loro dimissioni, accusando una serie di disturbi inesistenti. Il problema post-sanatoriale è realmente di una notevole gravità, e in questo campo c'è ancora molto da fare da parte del Governo e degli enti deputati alla lotta antitubercolare, se non vogliamo che questi poveri naufraghi della società vadano ad ingros sare le fila dei disperati e dei delinquenti.
Qual'è l' orietttarmmto psicologico predominante nei nostri mfermi, durante il soggiorno sanatorialc?
A parte una p:(cola aliquota di pessimisti ed un'altra di indifferenti, la maggioranza dei nostri pazienti è fondamentalmente ottimista, e tale ottimismo è alimentato al giorno d'oggi dalle nuove terapie che si sono vittoriosamente affermate, tanto che non si può più parlare di t< malattia che non perdona », ma di malattia guaribile nel maggior numero dei casi.
La mortalità generale per tubercolosi è scesa nel 1950 a 22.000 unità in tutta Italia (era 35-36.ooo prima della guerra) e le possibilità di guarigione sono molto aumentate (in rapporto naturalmente con la precocità delle diagnosi) , grazie ai progressi della
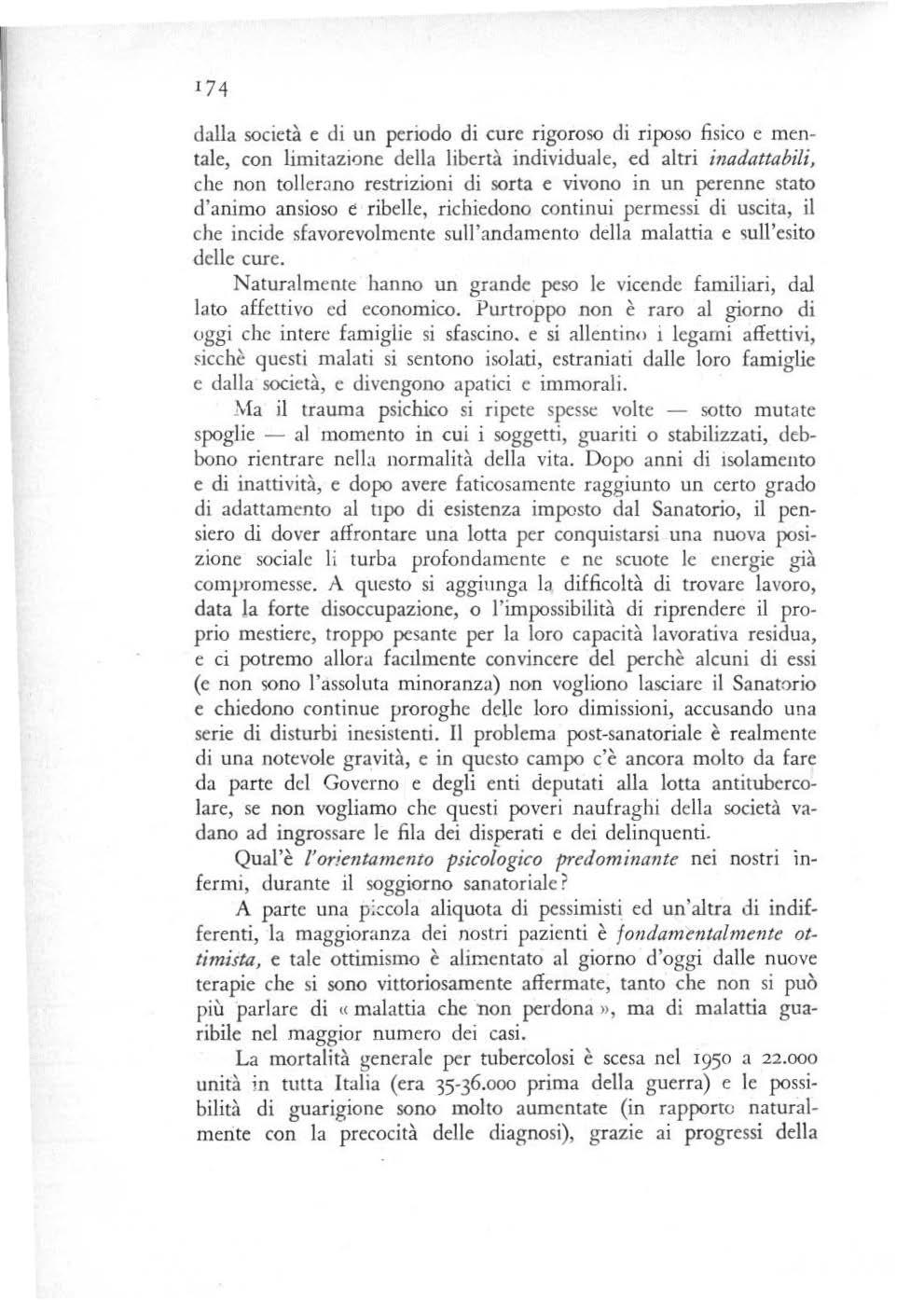
1 74
terapia pneumotoracica di Forlanini, della terapia chirurgica e tibiotica.
Altro carattere comune a tutti J tubercolotici, ma che è stato esagerato nella m en talità comune, è l'egoismo. E' indubbio che la malattia impegni il soggetto colpito in una dura battaglia, che pone l'individuo nella dura neces si tà di pensare unicamente a se stesso, e que sta è una espressione di egoismo. T uttavia, siamo ben }ungi dal ritenere che tale egoismo giunga proprio al desiderio di infettare gli esseri sani per portarli al loro stato, ciò che si verifica fortunatamente nella minoranza dei casi.
In genere, è diversa la reazione alla vita sanatoriale degli uomini e delle donne. Gli uomin i sono meno coraggiosi delle donne di fronte al male fisico, tanto ch e rifiutano più sovente di sottoporsi ad atri operativi sul torace. Inoltre, essi sono abituati ad una vita di lavoro che si compie al di fuori delle mura domestiche; è naturale, quindi, che la disciplina sanatoriale gravi sull'anima maschile con particolare durezza e determini un certo stato di ribell io ne e una particolare attitudine psichi ca, tanto da ritenersi vitume di una ingiusta persecuzione. Nei reparti maschili si nota subito uno scarso spirito di adattabilità, che si manifesta con una trascuratezza dell'ordine, della pulizia, della disciplina. La donna, invece, è avvezza a sopportare i dolori fisici, è abituata a una vita di lavoro più raccolta tra le pareti domestiche e trova più facilmente la di adattarsi alla nuova esistenza, raggiungendo un equilibrio psichico che le consente di fronteggiare gli eventi. Q ues t a m aggiore possib il ità di adattamen to si traduce in una maggiore scrupolosità nell'eseguire le cure prescritte, in una più abbandonata fiducia nei confronti del medico e in una accettazione più rassegnata di ogni sofferenza fisica e moral e.
D irò ancora poche parole sul problema erotico dei prima di affrontare il quesito di maggiore interesse per voi, cioè dei rapporti tra tubercolosi e reato.
E' opinione diffusa nel pubblico profano che nei tubercolotici si ve r ifichi una esaltazione dell'amore sessuale, originata e sostem1ta da una iperattività degli organi sessuali, sotto l'azione stimolante delle tossine tubercolari. C1ò non è esatto, perchè è dimostrato anzi che le tossine del bacillo di K och hanno un'azione deprime nte sugli organi sessuali. E' innegabile, però, che esista un certo stato di erotismo psichico, dovuto all'ipernutrizione, al superriposo, alla promiscuità dei sessi, alla noia, alla febbricola tubercolare che provoca quasi

1 75
sempre una piacevole sensazione di stordimento e accelera la successione delle idee su base erotica.
A questo si aggiunga il desiderio di godere, di bruciare le tappe della vita e lo stimolo della conservazione dell'individuo e della specte.
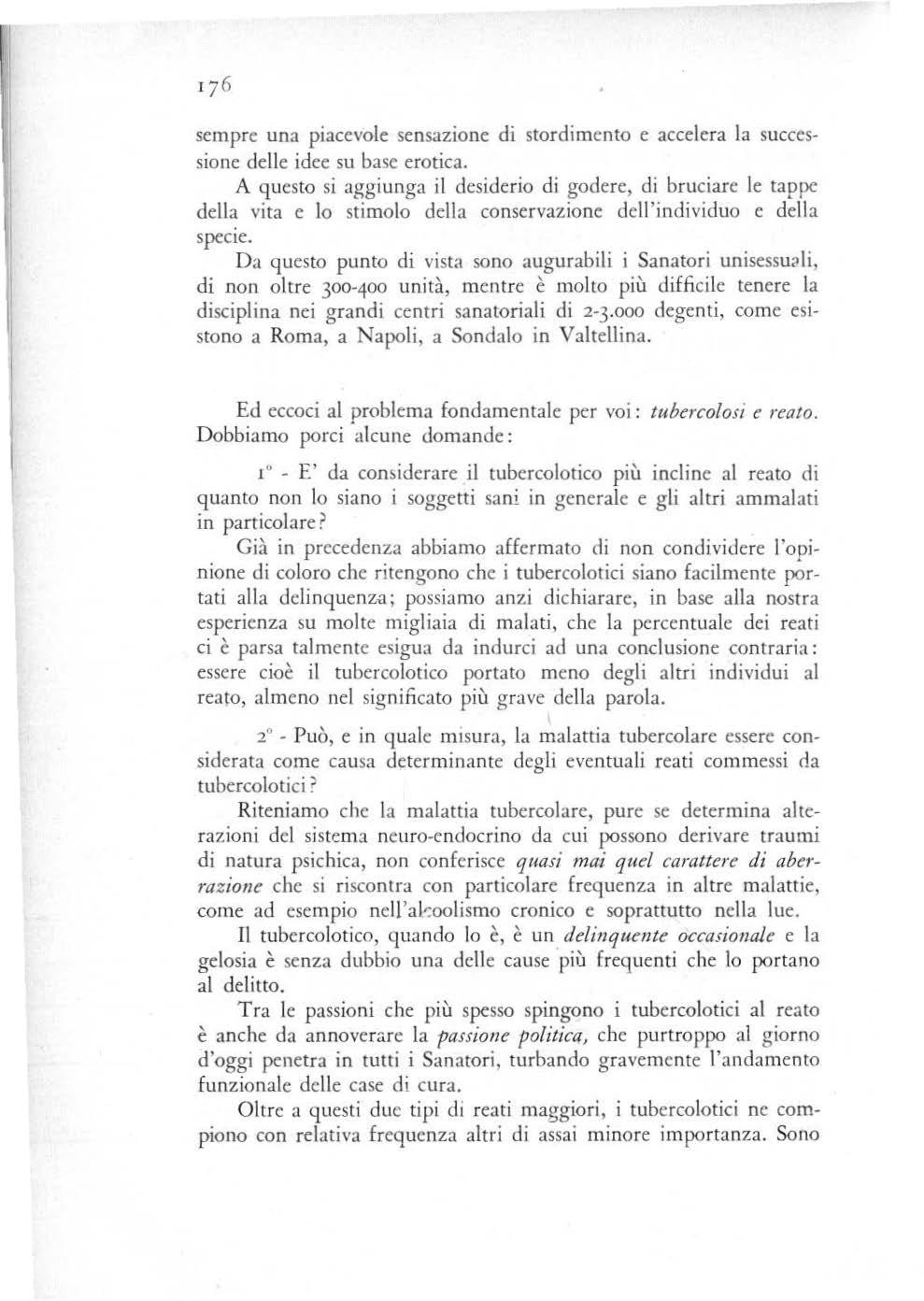
Da questo punto di vista sono augurabili i Sanatori di non oltre 300-400 unità, mentre è molto più difficile tenere la disciplina nei grandi centri sanatoriali di 2-3 .000 degenti, come esistono a Roma, a Tapoli, a Sondalo in Valtellina.
Ed eccoci al problema fondamentale per voi : tubercolosi e reato. Dobbiamo porci alcune domande:
t " - E' da comiderare il tubercolotico più incline al reato di quanto non lo siano i soggetti sani in generale e gli altri ammalati in particolare?
Già in precedenza abbiamo affermato di non condividere l'opinione di coloro che ritengono che i tubercolotici siano facilmente portati alla dclinquenZfl; possiamo anzi dichiarare, in base alla nostra esperienza su molte migliaia di malati, che la percentuale dei reati ci è parsa talmente esigua da indurci ad una conclusione contraria: essere cioè il tubercolotico portato meno degli altri individui al reato, almeno nel significato più grave della parola.
2 ° - Può, e in quale mtsura, la malattia tubercolare essere considerata come causa determinante degli eventuali reati commessi da tubercolotici?
Rit eniamo che la malattia tubercolare, pure se determina alterazioni del sis tema neuro-endocrino da cui possono derivare traumi di natura psichica, non conferisce quasi mai quel carattere di abe1·razione che si riscontra con particolare frequenza in altre malattie, come ad esempio nell'akoolismo cronico e soprattutto nella lue.
Il tub ercolotico, quando lo è, è un delinquente occasio1lale e la gelosia è senza dubbio una delle cause più frequenti c he lo portano al delitto.
Tra le passioni che più spesso spingono i tubercolotici al reato è anche da annoverare la passione politica, che purtroppo al giorno d'oggi penetra in tutti i Sanatori, turbando gravemente l'andamento funzionale delle case di cura.
Ol tre a questi due tipi di reati maggiori, i tubercolotici ne compiono con relativa frequenza altri di assai minore importanza. Sono
i piccoli reati di infrazione alla disciplina e di insubordinazione verso tutto ciò che appare ordine costi tuito e son l'espressione di quell'i stinto di ribellione che fa del malato l'avversario di qualsiasi genere di imposizione; così pure una certa tendenza ai piccoli furti, cui i degenti sono portati da un istinto di vera e propria cleptomania.
Dobbiamo pure prendere in considerazione il massimo reato contro se stessi : il suicidio.
La percentuale det suicidi nei ricoverati dei nostri Sanatori è talmente minima, da non meritare alcuna considerazione .
Nelle statistiche dei suicidi per malattia, in genere prevalgono quelli per malattie nervose e mentali, o per tumori maligni, o per nevralgie ribelli , ma non per tubercolosi.
lo ricordo nella mia ormai lunga carriera sanitaria (oltre 20 anni) ben pochi suicidi . Le cause di questo fatto sono moltep! ici. Il tubercolotico, infatti, è un individuo c he lotta per vivere, che crede e spera quasi sempre nella guarigione; inoltre, la malattia tubercolare non provoca che eccezionalmente quel parossismo di dolore fisico, che è proprio di altre malattie c che può essere di per sè causa di atri disperati.
In ogni nazione civile, poi. l'individuo che si ammal.l di tubercolosi diventa spesso automaticamente un cc assistito >> sia che tale assistenza gli venga praticata dai propri congiunti, sia che gli venga fornita dagli enti di previdenza.
Vi è infine da valutare l'importanza e l'infuenza benefica della (ede religiosa, e della persuasione del medico, c he riescono a sostenere le forze fisiche e morali di un gran numero di infermi, anche in condizioni disperate.
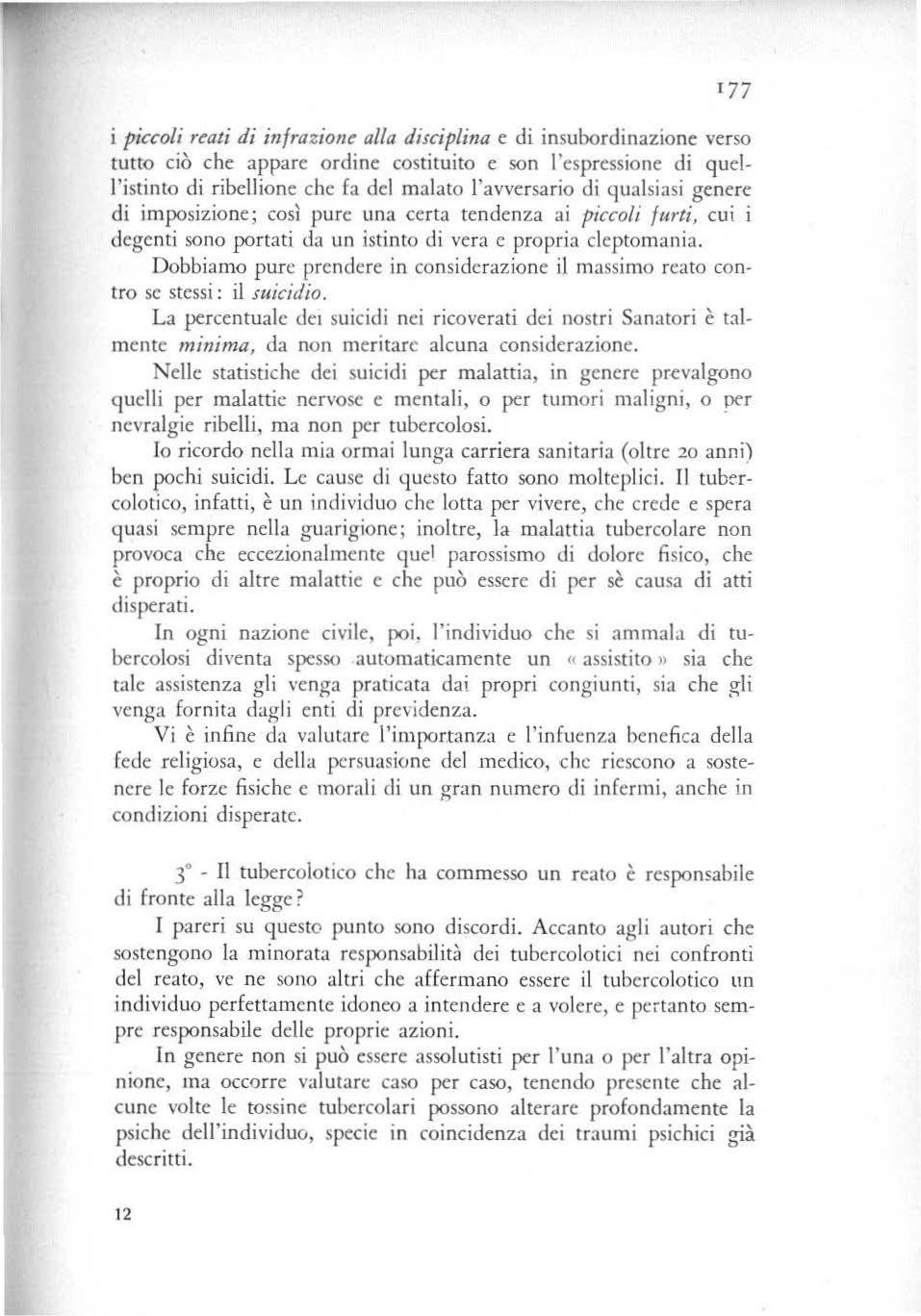
3o - Il tub ercolotico che ha commesso un reato è responsabile di fronte alla legge?
I pareri su questo punto sono discordi . Accanto agi i autori che sos tengono la minorata respo nsab ilità dei tubercoloti ci nei confronti del reato, ve ne sono a l tri che affermano essere il tuber co lotico un individuo perfettamente idoneo a intendere e a vo lere, e pertanto sempre responsabile delle proprie azioni.
I n genere non si può essere asso lutisti per l'una o per l'altra opinione, ma occorre valutare caso per caso, tenendo presente che alcune volte le to ssine tubercolari possono alterare profondamente la psiche dell'individuo, specie in coincidenza dei traumi psichici già descritti.
177
12
Occorre pure ricorda re che talora i tubercolotici cronici e gravi sono tossicomani e in questo caso bisognerà valutare anche il danno psichico provocato dall'abuso di sos tanze stupefacenti Ed ho finito. Spero di avere tracciato davanti a voi, se pure in breve sintesi, quanto risulta alla nostra esperienza di psicologi, oltre che medici sanato rial i, c quanto dovete pure voi conoscere nell 'àmbito della vostra professione.

'
l. -La medicina legale militare non importa soltanto accertamenti tecnici sui militari, ma altresì sui civili, in determinate contingenze c più specialmente quando venga dichia r ato titolo alla ferma m inore di 3" grado dell'arruolato per essere egli unico sostegno di parenti invalidi, ovve ro in caso di erogazione di pensioni od assegni a superstiti di militari morti per causa di servizio di guerra o attinente alla guerra o del civile morto per fatti di guerra, ed infine per erogazione di quote compleme ntari di carovita per genitori a carico. Nel primo caso il giudizio medico-legale spetta in prima istanza ali'Of.ficia lc medico del Consiglio di leva ed eventualmente al Direttore dell'Ospedale militare dove il soggetto ve n ga inviato per più dettagli at i accertamenti; in caso di contestazione il giudizio è rimesso ad una visi ta collegiale presso l 'Ospedale militare competente per territorio ovvero, se qu es ti siasi già pronunciato, ad una visita collegiale presso la Direzione di Sanità. Per il conferimento di pensioni, assegni ed indennità di guerra è competente l ' apposito Comitato di liquidazio ne, composto Ja magistrati dell'ordine giudiz iario ordinario, del Consiglio di Stato e della Corte dei Conti, da Ufficiali generali o superiori medici, Professo ri ordinar i e Liberi docenti di Univer si tà ( a preferenza appar t enenti a F aco ltà di Medicina), funzionari ministeriali e cittadi n i designati da associazioni determinate, secondo il disposto dell'art. 99 del T. U. sull e pen sio ni di guerra, 10 ago· sto 1950, n. 648.
Gli accertamenti sanitari relativi alle cause ed all'entità delle menomazioni dell'integrità .fisica del militar e e del civile vengono eseguiti m ediante visita diretta da parte di una Commissione composta di Ufficiali medici, di cui almeno uno superiore co n funzioni di presidente, e di altri sanitari civ ili , de signati secondo le norme dell'art. 1 03

L
NVA LI D
' I
ITÀ DE L C I V IL E I N MED I C I NA L EGA L E M ILI TARE
La Commissione giudica con l'intervento di tre membri, di cui almeno uno militare con funzioni di presidente.
Per l'accertamento del diritto alla corresponsione dell'indennità di carovita, la visita è effettuata da un solo ufficiale medico, c. nei casi di revisione, da un ordinario collegio medico ospedaliero (§ 712 lettera g del regolamento sul servizio sanitario militare territoriale).
Il termine di riferimento in tutti i casi è quello dell 'inabilità a qualsiasi proficuo lavoro, che, nella sua genericità, merita di essere opportunamente precisato, allo scopo di assicurare un'applicazio ne razional e ed uniforme delle disposizioni legislative, in rrlazione alle finalità sociali che esse si prefiggono.
Non sembri, y_uindi, superf luo riparlarnc, nè strano che ne parli un medico civile, che solo per breve tempo ha avuto l'onere di indossare la divisa militare, laddovc la lett era tura esis tent e al rigua rd o proviene esclusivamente da egregi Ufficiali di carriera del nostro Esercito.
II. - Il collocamento in congedo antlctpato del militare perchè unico sostegno di famiglia viene regolato dagli artt. 85 ed 88 del T. U. sul reclutamento, approvato con R. D. 24 febbraio 1938.
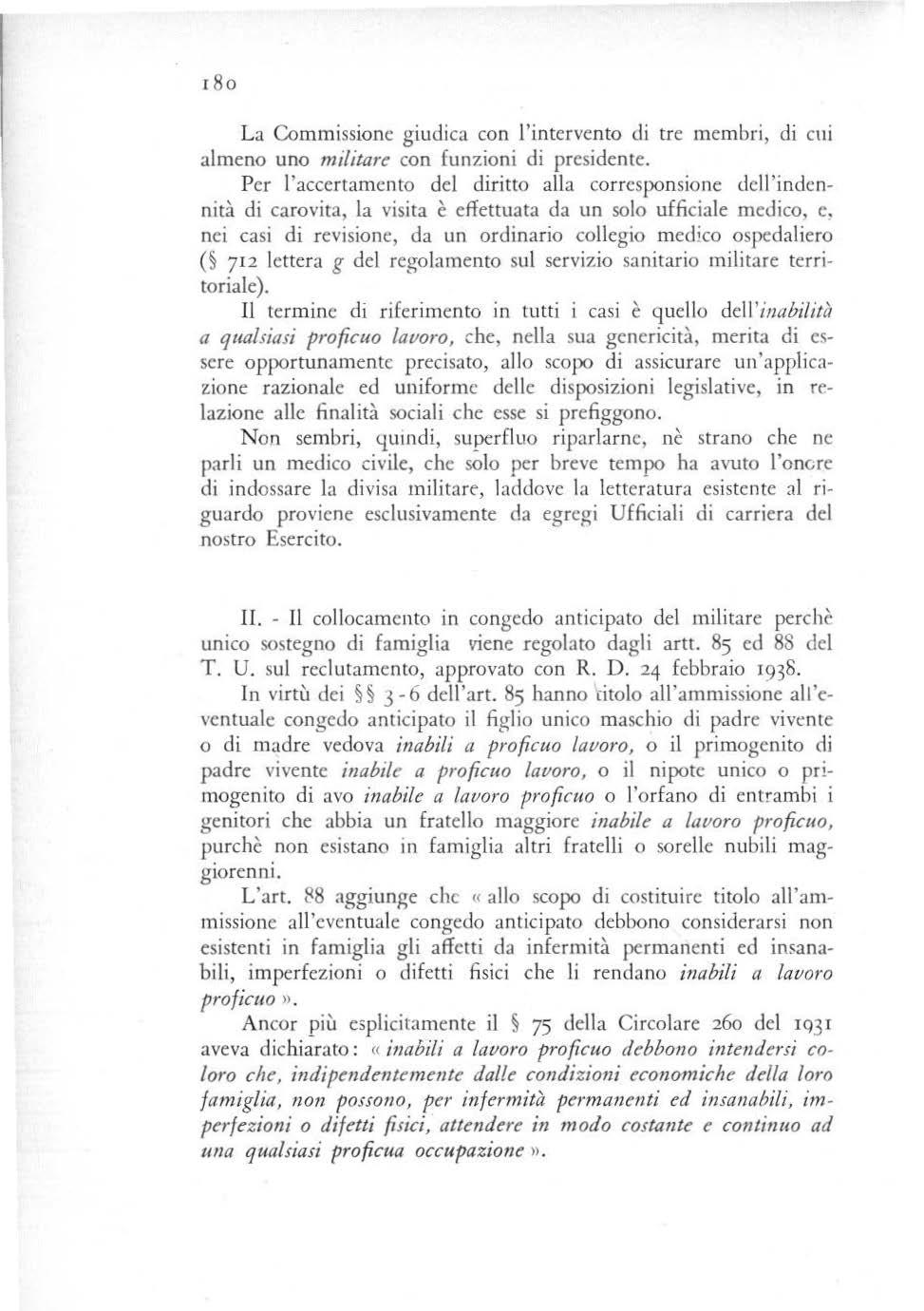
ln virtù dci §§ 3-6 dell'art. 85 hanno citalo all'ammissione all'eventuale congedo anticipato il figlio unico maschio di padre vivente o di madre vedova inabili a proficuo lavoro, o il primogenito di padre vivente inabile a proficuo lavoro, o il nipote unico o primogenito di avo inabile a lat;oro proficuo o l'orfano di entrambi i ge nitori che abbia un fratello maggiore inabile a lavoro proficuo, _non esis tano in famiglia altri fratelli o sorelle nubili maggto rennt.
L'art. aggiunge che << allo scopo di costi tui re titolo all'ammission e all'eventuale congedo anticipato debbono considerarsi non esistenti in famiglia gli affetti da infermità permanenti ed insanabili, imperfezioni o difetti fisici che li rendano inabili a lavoro proficuo »
An cor più esplicitamente il § 75 della Circolare 260 del IQ3 I aveva dichiarato: << inabili a lavoro proficuo debbono intendersi coloro che, indipendentemente dalle condizioni economiche della loro famiglia, non posso110, per infermità permauenti ed imanabili, imperfezioni o difetti fisici, attendere in modo e continuo ad una qualsiasi proficua occupazio11e ».
180
Il concetto è ribadito dal Regolamento sul servizio sanita rio militare territoriale (art. 136, n . 593) in questi termini: « Il perito sanitario, nella valutazione delle malatti e o difetti fisici presentati o allegati dagh interessati, deve tener e presente che una malattia è da conside rar si permanente ed insanabile quando criteri semiologic1 e clinici inducono fondato convincimento che la malattia non possa più guarire; non si può tener conto della possibilità di guarigione con operazioni cruente, non potendo alcuno esservi assoggettato senza suo consenso . - Il perito sanitario terrà altresì presente che l'individuo deve essere considerato inabi le a proficuo lavoro solo quando una malattia abbia p rodotto in lui tale menomazione della capacità lavorativa da rendere <.1uella residua insufficiente ad una qualsivoglia attività lucrativa E' ovvio che tale residua capacità al lavoro deve essere compatibile con la dignità personale c con l'adattabilità dell'individuo e tale da consentirgli di sopperire alle proprie comuni necessità della vita c di dare qualche aiuto alla famiglia, prescindendo dal mestiere o professione eserci tati dal visitato e dalle sue condizioni economiche. - Spetta al giusto criterio del perito sanitario di valutare il grado di questa incapacità, la quale - si noti bene - può essere determinata anche da malattie la cui azione inabilitante sia dovuta ad aggravamenti periodici od accessionali cui esse van n o soggette e che impediscono la continuità di un lavoro redditizio nel senso voluto dalla legge, come ad esempio cardiopatie con tendenza allo scompenso, affezioni renali gravi, ecc. >>.
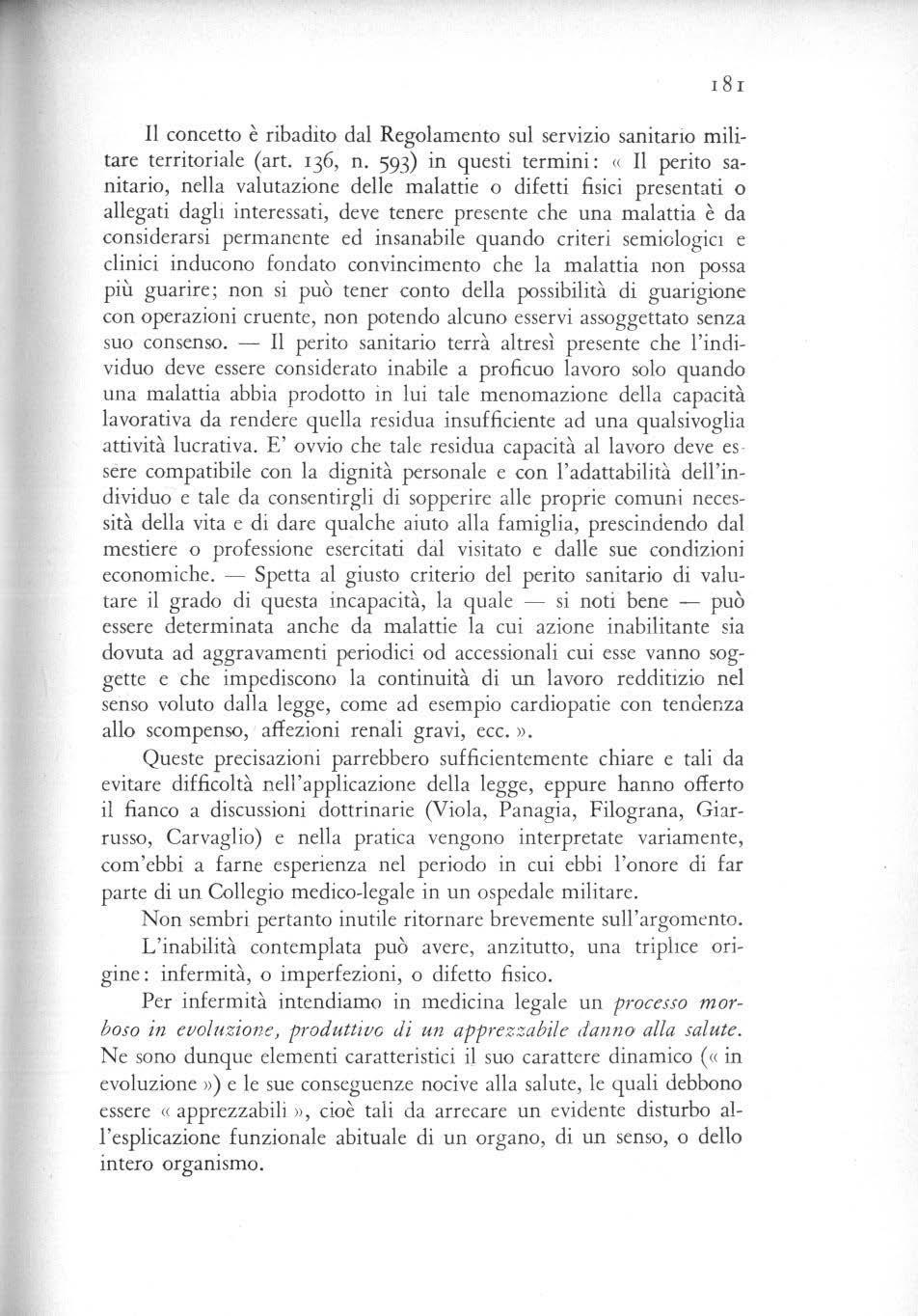
Queste precisazioni parrebbero sufficientemente chiare e tali da evitare difficoltà nell'applicazione della legge, eppure hanno offerto il fianco a discussioni dottrinarie (Viola, Panagia, Filagrana, Giarrusso, Carvaglio) e nel la pratica vengono in t erpreta te variamente, com'ebbi a farne esperienza nel periodo in cui ebbi l 'ono re di far parte di un Collegio medico-legale in un ospedale militare.
Non sembri pertanto inutile ritornare brevemente sull'argomento.
L'inabilità contemplata può avere, anzitutto, una triphce origine : infermità, o imperfezioni, o difetto fisico.
Per infermità intendiamo in medicina legale un processo morboso in evolu:àone, produttivo di un appre zzabile danno alla salute. Ne sono dunque clementi caratteristici il suo carattere dinamico ( « in evo luzione >> ) c le sue conseguenze nocive alla salute, le quali debbono essere « apprezzabili » , cioè tali da arrecare un evidente disturbo all'esplicazione funzionale abituale di un organo, di un senso, o dello intero organismo.
18r
Tale definizione è indubbiamente più esatta di quella formulata dal legislatore nella relazione ministeriale al vigente codice penale, secondo cui è malattia « indistintamente qualsia si alterazione anatomica o funzionale dell'organismo, ancorchè localizzata e non impegmtiva delle condizioni organiche generali » ; m essa manca il necessario riferimento al carattere evolutivo dell'alterazione, con conseguente pericolo di confusioP..e tra la vera malattia ed un postumo stabilizzato di essa o addirittura una deformità congenita.
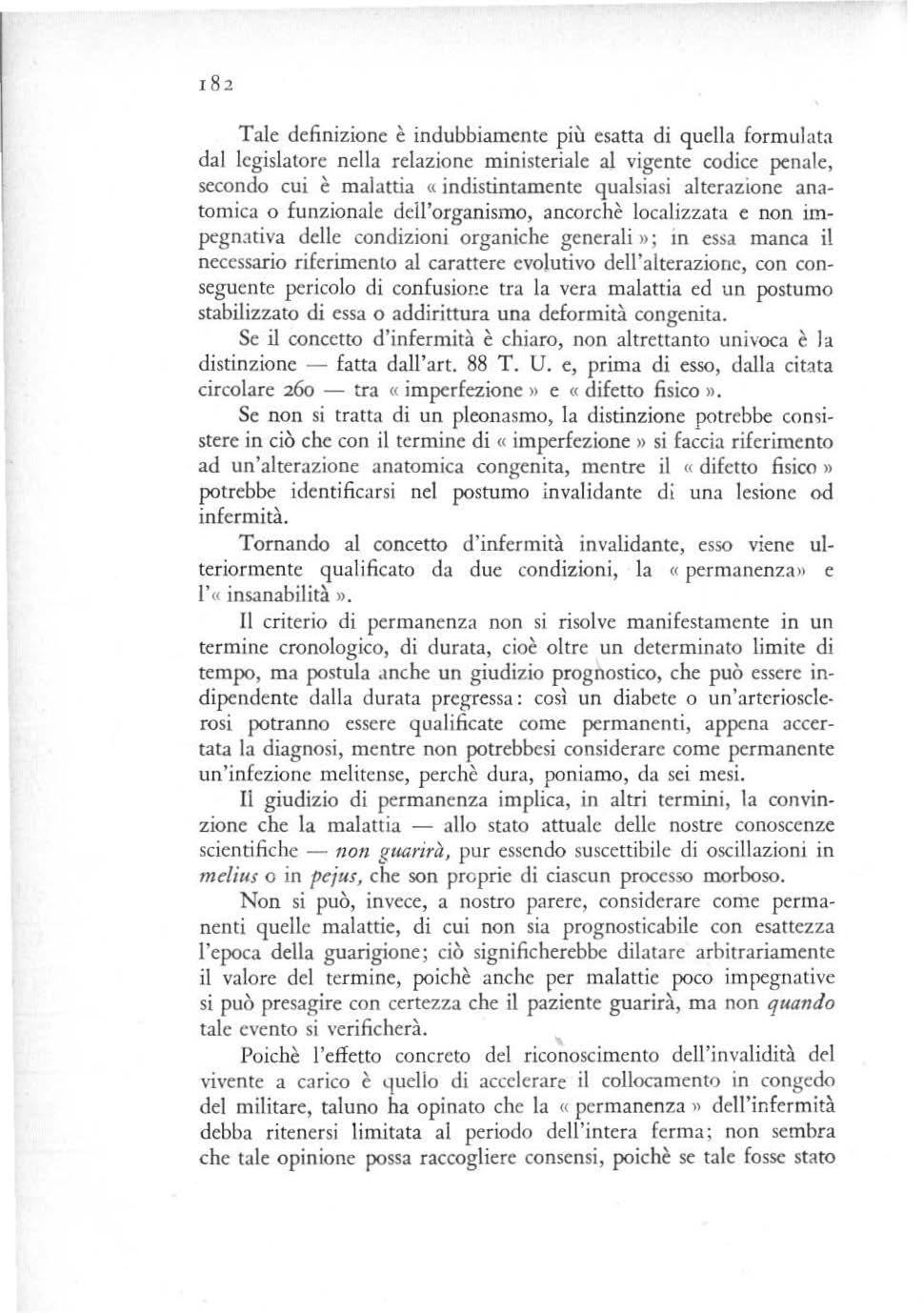
Se il concetto d'infermità è chiaro, non altrettanto univoca è la distinzione - fatta dall'art. 88 T . U. e, prima di esso, dalla citata circolare 26o - tra « imperfezione >> e « difetto fisico >>
Se non si tratta di un pleonasmo, la distinzione potrebbe comistere in ciò che con il termine di « imperfezione >>si faccia riferimento ad un'alterazione anatomica congenita, mentre il « difetto fisico >> potrebbe identificarsi nel postumo invalidante di una lesione od infermità.
Tornando al concetto d'infermità invalidante, esso viene ulteriormente qualificato da due condizioni, la « permanenza )) e l' « insanabilità >> .
Il criterio di permanenza non si risolve manifestamente in un termine cronologico, di durata, cioè oltre un determinato Limite di tempo, ma postula .tncbe un giudizio prognostico, che può essere indipendente dalla durata pregressa: così un diabete o un'arteriosclerosi potranno essere qualificate come permanenti, appena accertata la diagnosi, mentre non potrebbesi considerare come permanente un'infezione melitense, perchè dura, poniamo, da sei mesi.
Il giudizio di permanenza implica, in altri termini, la convinzione che la malattia - allo stato attuale delle nostre conoscenze scientifiche - non guarirà, pur essendo suscettibile di oscillazioni in melius o in pejus, che son proprie di ciascun processo morboso.
Non si può, invece, a nostro parere, considerare come permanenti quelle malattie, di cui non sia prognosticabile con esattezza l'epoca della guarigione; ciò significherebbe dilatare arbitrariamente il valore del termine, poichè anche per malattie poco impegnative si può presagire con certezza che il paziente guarirà, ma non quando tale evento si ver ificherà.
Poichè l'effetto concreto del riconoscimento dell'invalidità dd vivente a carico è quelio di accel erare il collocamento in con ge do del militare, taluno ha opinato che la « permanenza n dell'infermità debba ritenersi limitata al periodo dell'intera ferma; non sembra che tale opinione possa raccogliere consensi, poichè se tale fosse stato
l'intendimento del legislatore, egli non avrebbe mancato di dichiararlo, ed è norma di ermeneutica giuridica che al testo della legge non possa darsi altra interpretazione se non quella derivante dal senso proprio delle parole usate secondo la connessione di esse. Ora <' permanente » significa propriamente « di durata indefinita » e non limitata ad un periodo determinato di tempo, sia pure notevole.
L'unica precisazione che il legislatore ha aggiunto alla qualifica di permanente è che l 'infermità sia anche «insanabile » , il che sta a chiari re che il giudizio di permanenza dev'essere subordinato alJo esito constatato o semplicemente prevedibile delle cure opportune.
In tali casi invero il vivente a carico si pres enterà al sani tario o al collegio medico-legale con un'autentica documentazione di cure inutilmente espletate per un tempo suf ficiente, e qui il giudizio sarà a posteriori; ma potrà essere formulato anche a priori quando, pur non avendo il paziente espletato cure, o avendole sperimentate in scarsa misura, il collegio ritenga che - allo stato delle nostre> possibilità terapeutiche - l'infermità diagnosticata sia insuscettibile di guarigione, o di miglioramento tale da rendere l'infermo idoneo a proficuo lavoro.
Il termine di insanabilità va quindi inteso in senso relativo, non riferito, cioè, alla completa guarigione, ma pure ad un tal grado di miglioramento stabile da incidere notevolmente su l'invalidità. Vi sono infatti molti cronici che posseggono tma sufficiente capacità di guadagno, nel senso che di qui a poco preciseremo.
Qualche precisazione va fatta però anche sulla latitudine delle cure prospettabili per rimuovere l'attuale invalidità del vivente a canco.
Vanno -a nostro avviso - infa tt i conside rat e:
a) la natura delle cure;
h) la durata presumibile di esse;
c) il loro costo;
d) il grado di probabilità che esse nmuovano lo stato invalidantc.
Sub a) notiamo c he non possono proporsi al vivente a carico cure che non possono imporsi al militare, e quindi in prima linea gli interventi operativi (v. Regolamento sul servizio sanit ario tocritoriale, art. 136, § 593).
Quanto alla durata presumibile dd trattamento atto a rimuovere lo stato invalidante, occorre tener presente la finalità dell'accertamento che è quello di restituire evenh1almente alla famiglia il suo unico o principale sostegno economico.
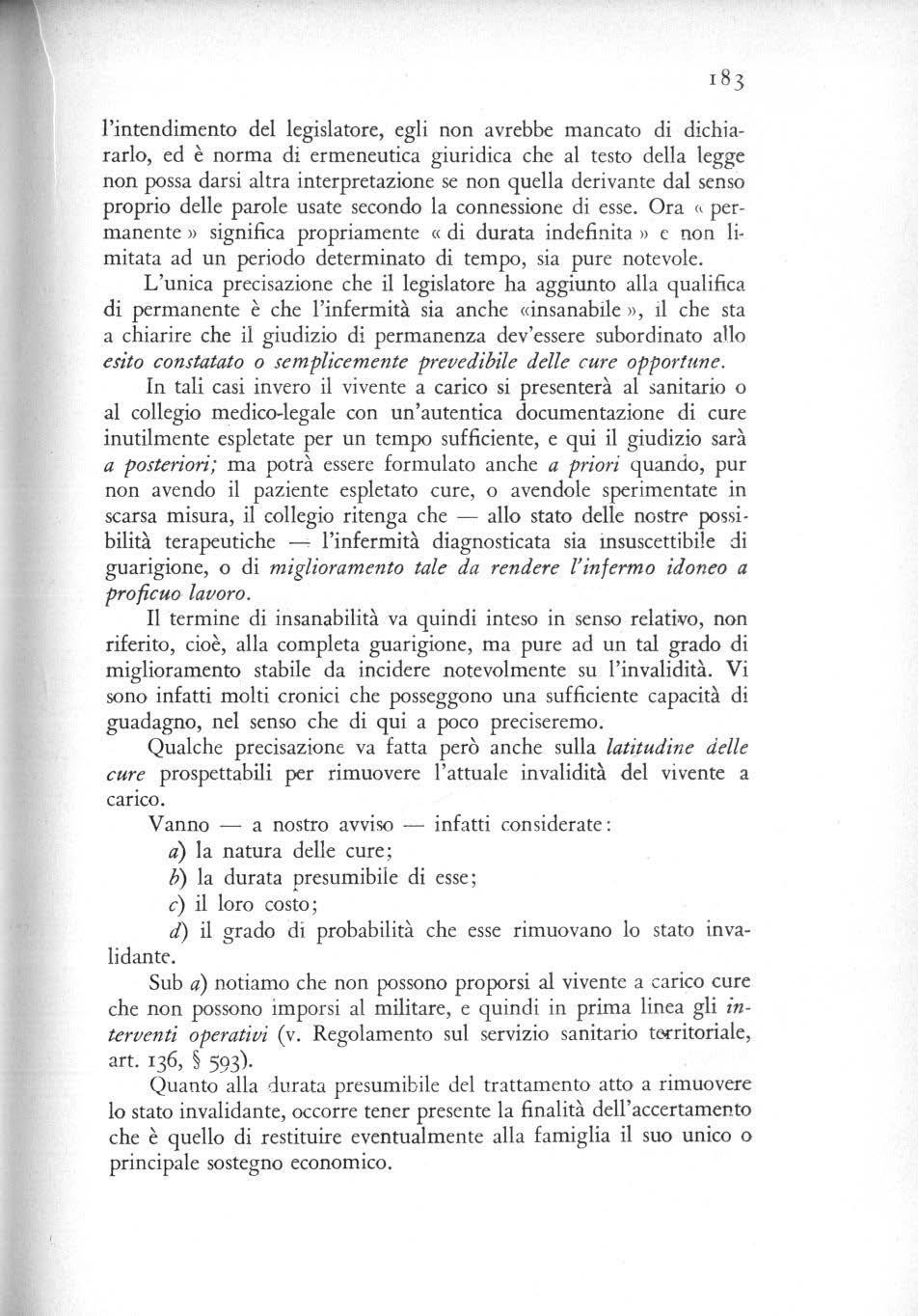
Siamo quindi di fronte ad uno stato di urgenza che non consente rinvii di notevole durata, e pertanto saranno proponibili sol tanto quelle cure il cui successo sia prevedibilmcnte rapido.
Nè va dimenticato il fattore (( costo », in relazione - s'intendeallo stato economico dei!'interessato ed alle forme pri!vidcnziali su cui egli possa eventualmente far cadere l'onere delle cure.
Ed infine è necessario che la prospettiva di rimuovere con cure rispondenti alle considerazioni predette sia ben concreta e non puramente ipotetica.
Abbiamo già accennato incidentalmente che non ogni infermità permanente ed insanabile, imperfezione o difetto fisico del vivente a carico può provocare l'an6cipaz10ne del collocamento in congedo del militare, ma solo queìla da wi derivi l'impossibilttà di .lttèndere (( in modo cos tante e continuo ad una qualsivoglia proficua occ u.fYcl zio n e >> .
N otiamo anzitutto che il termine di riferimento non è la capacità di lavoro, sibbcne la capacità di guadagno; la distinzione non è oziosa perchè i due concetti - com'è noto - non s'identificano, potendo sussistere una capaci tà lavorativa, c ui non corrisponde capacità lucrativa proficua, capace cioè di « sopperire alle proprie comuni necessità di vita e di dare qualche aiuto alla famiglia >> (n. 593, art. 136 T. O . Serv. San . Mil. T err .). Non può quindi venir presa in considerazione una capacità residua infima, c h e permetta guadagni insignificanti; ciò frustrerebbe evidentemente le finalità della disposizione .
Ancorchè quest'ultima si riferisca a qualsivoglia occupazione, purchè proficua, è chiaro che l 'occupazione debba essere conjacente alle attitudini ed alle abitudini dell'interessato. Suonerebbe infatti g rav e irrisione un'interpretazione lettera le, che non permette sse di escludere nessun'arte, professione o mestiere, purchè compatibile con le residue capacità psicosomatiche del soggetto, si riconosces se nel contempo che per tali occupazioni il soggetto non possiede attitudini (che potrebbe acquistare solo in seguito a speciale addestramento), o che esse implichino una grave dislocazione dal suo ceto . Il « qua lsivoglia » serve viceversa e soltanto a sganciare la valutazione di merito dall'occupaziOne personale precedente; c vale ad indicare che non si tratta di determinare un'incapacità al guadagno specifica, ma una incapacità di più ampia portata, che - se nz 'essere generica - implichi anche altri tipi di occupazione, i quali compo rtino magari anche un modesto declassamento, ma risultino compatibili con le lttitudini e le abitudini della persona.

Che ciò corrisponda alla mens del legislatore, si deduce dalla norma dell'art. 136, n. 593, del Regolamento sul servizio militare territoriale: « la residua capacità a l lavoro (veramente dovrebbe dirsi « capacità al guadagno >> !) dev'essere compatibile con la dignità personale e con la adattabilità dell'individuo >> .
La clausola che la valutazione dell'invalidità dev'essere fatta « indipendentemente dalle condizioni economiche della >> ci conferma nella convinzione che il giudizio non possa esaurirsi nel riconoscimento di una qualsiasi capacità lavorativa geDerica non qualificata. Il congiunto del militare può essere anche a capo di una azienda agricola, od industriale o di un commercio, o un professionista; a costoro non può essere evidentemente contestata la invalic!ità perchè potrebbero fare, poniamo, l'usciere.
Che la capacità di attendere a lavoro proficuo debba essere di carattere continuativo è del pari evidente, poichè non potrebbesi considerare proficu_a, nei senso da noi precisato, un'attività che la malattia consentisse di svolgere rolo in modo saltuario.
Il § 75 del Regolamento miiitare adopera a questo scopo il termine <\ costante e continuo » , che rende chiaramente il concetto; la duplice aggettazione trova la sua ragione nel fatto che continuo significa incessante nel tempo, mentre costante implica il rico noscimento di un livello sensibilmente eguale di intensità.
E' in sostanza la formu la cui è pe r venuto il legislatore - dopo annoso travag lio dottrinario e giurisprudenziale - per definire l'in validi tà pensionabile nel quadro dell'assicurazione obbligatoria contro l'invalidità e la vecchiaia. R ecita infatti l'art. IO della legge 6 luglio r 939, n. 1272: « si consider;1 invalido l 'assicurato la cui capacità di guadagno in occupazioni confacenti alle sue attitudini, sia ridotta in modo permanente, per infermità o difetto fisico o mentale, a meno di un terzo del suo guadagno normale per gli operai, o a meno della metà per g li impiegati l> .
Quest'evidente identità di impostazione ci porta al quesito se i due tipi d'invalidità, quella degli ::rtt. 85 -88 dd T. U. sul reclutamento dell'Esercito c q u ella dell'assicurazi0ne di previdenza sociale, si sovrappongano in modo tale da poter essere determinate con gli stessi criteri.
La lettera de l la disposizione legislativa militare sembrerebbe postu lare maggiore severi t à, ma abbiamo cercato di dimostrare come una razionale interpretazione della norma porti necessariamente a c r iteri d i maggiore larghezza, i soli corrispondenti allo spirito del provvedimento.
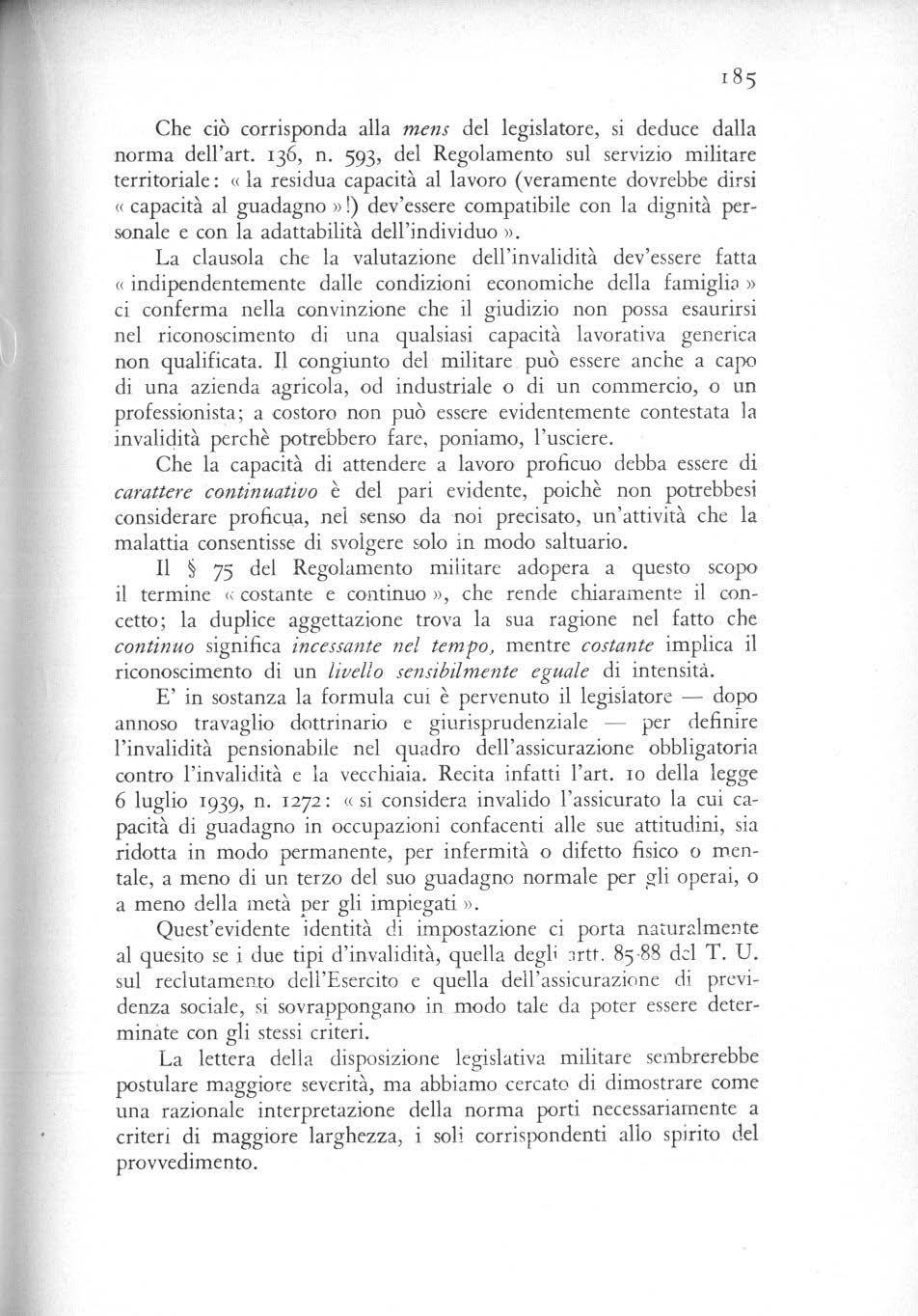
D'altra parte è che le due situazioni sociali cui s'intende venire incontro sono sostanzialmente identiche: da una parte (legge militare) vi è una famiglia che chiede la restituzione dell'unico membro valido, dimostrando che gli altri elementi della convivenza non sono, per le proprie condizioni di salute, in grado di assicurarne il sostentamento; dall'altra (legge civile) vi è un lavoratore che postula una prestazione economica, non essendo egli ulteriormente in grado - per le proprie wnd1zioni fisiche - di assicurare il sostentamento proprio e del nucleo familiare .
A me sembra pertanto che la formula dell'art. IO della legge di Previdenza Sociale possa servire utilmente di guida nella determinazione dell'invalidità del vivente a carico in medicina legale militare. Non andrei oltre, verso, cioè, criteri di ancor maggiore larghezza, quali quelli applicati dall'assicurazione di malattia per determinare l 'invalidità del coniuge della lavoratrice assicurata; si ritiene infatti sufficiente, a tale scopo, il riconoscimento di << una riduzione della capacità di guadagno a meno del 5o % di quella normale» .
Osservo che tale riconoscimento ha finalità ben più modeste di quelle di provocare l'anticipato congedo di un militare (c quindi la sottrazione da un obbligo che incombe su tutti i cittadini validi) o l'erogazione di una rendita vitalizia; esso imp lica semplicemente la assunzione a carico dell'istituto dell'assistenza del coniuge in caso di malattia.
A finalità più moùeste e concernenti un rischio non solo accidentale e saltuario, ma d'immedtata urgenza, come la malattia nella sua fase acuta, è giusto che corrispondano criteri di maggiore ampiezza nella valutazione dei requisiti dei candidati.
III. - Un altro settore della Medicina legale militare in cui vi ha luogo a valutare l'mvalidità di un civile è quello del conferimento eli pensioni a congiunti di militari morti per causa di servizio di guerra o attinenti alla guerra, o dei civili morti per fatti di guerra.
Nella legge 10 agosto 1950, n. 648, che ha riordinato la complessa materia delle pensioni di guerra, al titolo III sono contemplati i diritti della vedova e degli orfani, ed al titolo I V quelli dei genitori, dei collaterali e degli assimilati.
L'art. 56 attribuisc e alle vedove in possesso di pensione di guerra un assegno di previdenza di annue L. 42.000 quando abbiano raggiunto il 6o" anno di età, o, anteriormente, qualora siano o divengano itzabili a qualsiasi proficuo lavoro e risultino in stato di bisogno; secondo

186
l'art. 6o i figli e le figlie nubili, se maggiorenn i, sono equiparati at minorenni qualora siano o divengano inabili a qualsiasi proficuo lavoro per Hn'infermità ascrivibile alla prima categoria dell'annessa tabella A; anche se non esistano orfani nelle condizioni previste dallo stesso articolo, la vedova del militare o del civile può egualmente conseguire la pensione nella misura indicata dalle tabelle I ed L quando sia o divenga inabile a qualsiasi proficuo lavoro per tm'infermità a.scrivibilc- alla prima categoria dell'annessa tabella A e ri sulti in istato di bisogno.
L 'inab ilit à a qualsiasi proficuo lavoro della vedova è da considerarsi presente al compimento dell'età di 70 anni
Secondo l'art. 63, nei casi previsti dal precedente articolo hanno diritto alla pensione :mche i figli e le figlie nubili maggiorenni divenuti inabili a qualsiasi proficuo lavoro per un'infermità ascrivibile alla prima categoria dell'annessa tabella A, prima di aver raggiunto la maggiore età c prima della data di cessazione del diritto alla pensione da parte del genitore.
La pensione si perde dagli orfani quando siano giunti all'età maggiore, salvo (art. 65) il caso d'inabilità a qualsiasi proficuo lavoro prevista dal primo comma delL' art. 61. Quando il militare morto per causa del servizio di guerra o att inente alla guerra od il civile deceduto per i fatti di guerra contemplati dall'art. TO non abbia lasciato vedova o figli con diritto a pensione, la pensione è concessa (art. 71) al padre che abbia l'età di anni s8 oppure sia inabile a qualsiasi proficuo lavoro per tm'infemzità ascrivibile alla prima categoria della annessa tabella A: in mancanza di altri aventi diritto la pensione è concessa a coloro che abbiano provveduto al mantenimento cd alla educazione dell'orfano fino alla maggiore età e fino alla chiamata alle armi ovvero fino alla data dell'evento dannoso, semprecchè si verifichino nei loro confronti le condizioni previste per i genitori.
Ai genitori in possesso di pensioni di guerra è concesso (a rt. 72) un assegno di previdenza di annue L. 42.000, quando abbiano giunto il 65° anno di età, o, anteriormente, qualora sia no o divengano inabili a qualsiasi proficuo lavoro e risultino in istato di bisogno.
Ed infine (art. 82) ai gen itori , collaterali o assimilati del militare o del civile che si trovino nelle condizioni di cui al primo comma dell'art 73, ed inoltre si ano inabili a qualsiasi proficuo lavoro per un'infermità ascrivibile alla prima categoria dell'anneJsa tabella A è co ncessa la pensione, ecc.
L a semplice l ettura di queste norme fa rilevare come talora (artt . s6 e 72) si faccia riferimento all'inabilità a qualsiasi lavoro pro-
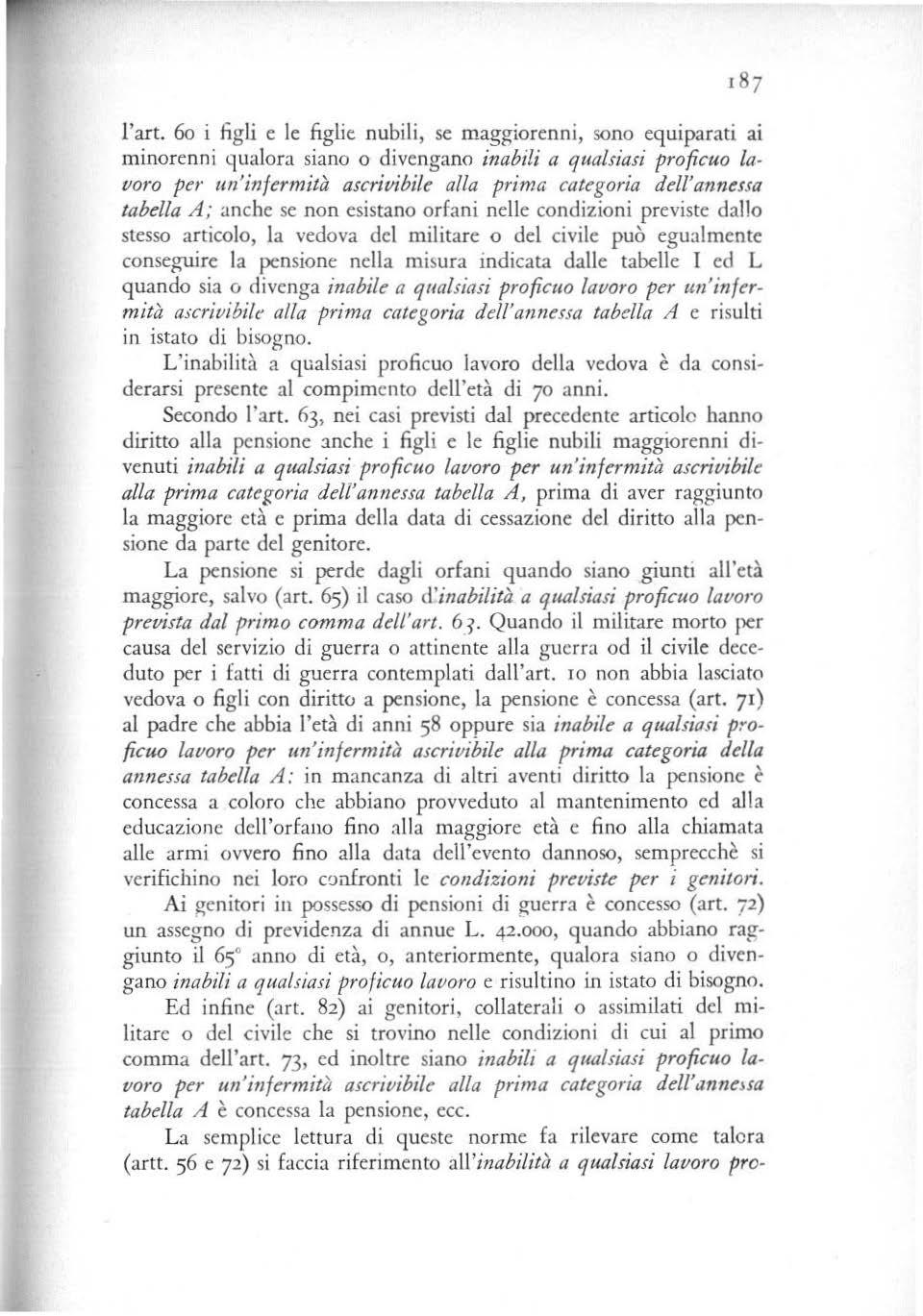
ficuo, se nza altra m e ntre n elle altre ipotesi si pr ecisa dovere l'inabilità derivare da un 'infermità ascrivibile alla prtma catego ria defl'anrJ essa ta b . A.
Qu est' ultima prevede 27 tipi di minorazioni gravissime, la magg ior parte del le quali importa, nel r egim e degli infortuni civ ili, una re ndita del 100 \, Il mancato nfrrimcnto a questa tabella per le ipotesi di cui agli artt. 56 c 72 non può ritenersi cas ual e, tanto più che ri g ua rdano la concessione n on de ll a pe n sione propriamente dett:1, ma di asint egra tivo di previdenza a superstiti (vedova o genitori) già in possesso J ella pen•ion<.:. e lo sta to (rinvalidità viene equiparato all'età se nil e (rispettivamente ·di 6o a nni per la vedova e di 65 per i ge nit or i).
Versiamo dunque manifestamente in in cui si debbono adottare criteri di magg iore latitudin e, quali quelli c h e abbiamo g ià indicati, nella prima pa rt e di questa nota, pe r il riconosci m ento della vivenz<! a ca rico di prossimi cong iunti del militare c he postuli, per t ale causa, l':mticipato collocamento in congedo.
IV. - Ed infine, al dipendente c he non abbia fratel li o sore lle maggiori di lu i con propri redditi a qual s iasi titolo ed i cui gen itori sia no assolutamente e permanentemente inabili al lavoro per Ìlljermità ascrit1ibile alLe prime due categorie di cui all a tab . an n e!>sa a!la legge 19 feb braio 1942, n. 137, e privi di risorse per provvede re a l proprio sostentamento, e che ri sultino conv iv en ti ed a carico, spe tta per ciascun genitore una qu ota compleme ntare di L. 3000 mensili lo rde (art. 2 D. L. L. del 21 novembre 1945 , n. 72; ei re. 473, G. M. 1945).
Ecco, quindi, profil ars i un terzo « tipc » d'invalidità, intermedio tra i due sinora considerati. Ed invero mentre l'invalidità del pare nte a carico, che dà diritto all'anticipazione del congedo o all 'assegno integrativo della pensione di guerra, può essere valu t atacome abbiamo vis to - con g li stessi criteri va levoli per il dizio medico-legale in regi m e previdenziale civile, e cioè come tale da indurre un "incapacità al g1.1adagno osc illante tra du e t erz i e metà Ji quella abituale , c mentre l'invalidità del superstite per la concessione di pensiOni di guerra corrispo nde ad un 'i ncapacità al guadagno prcssocchè totale, quale quella con t empla ta dalle <• voci » della t abella A annessa alla legge I o agosto 1950, l 'inva lid ità del ge nitore che dà diritto :dia quot a int egrativ a di carov it a va determinata con r iferimento alle prime due categorie della tab. A annessa alla legge r9 febbraio 1942, che contempla no minorazioni dal 100 al 75 % circa.
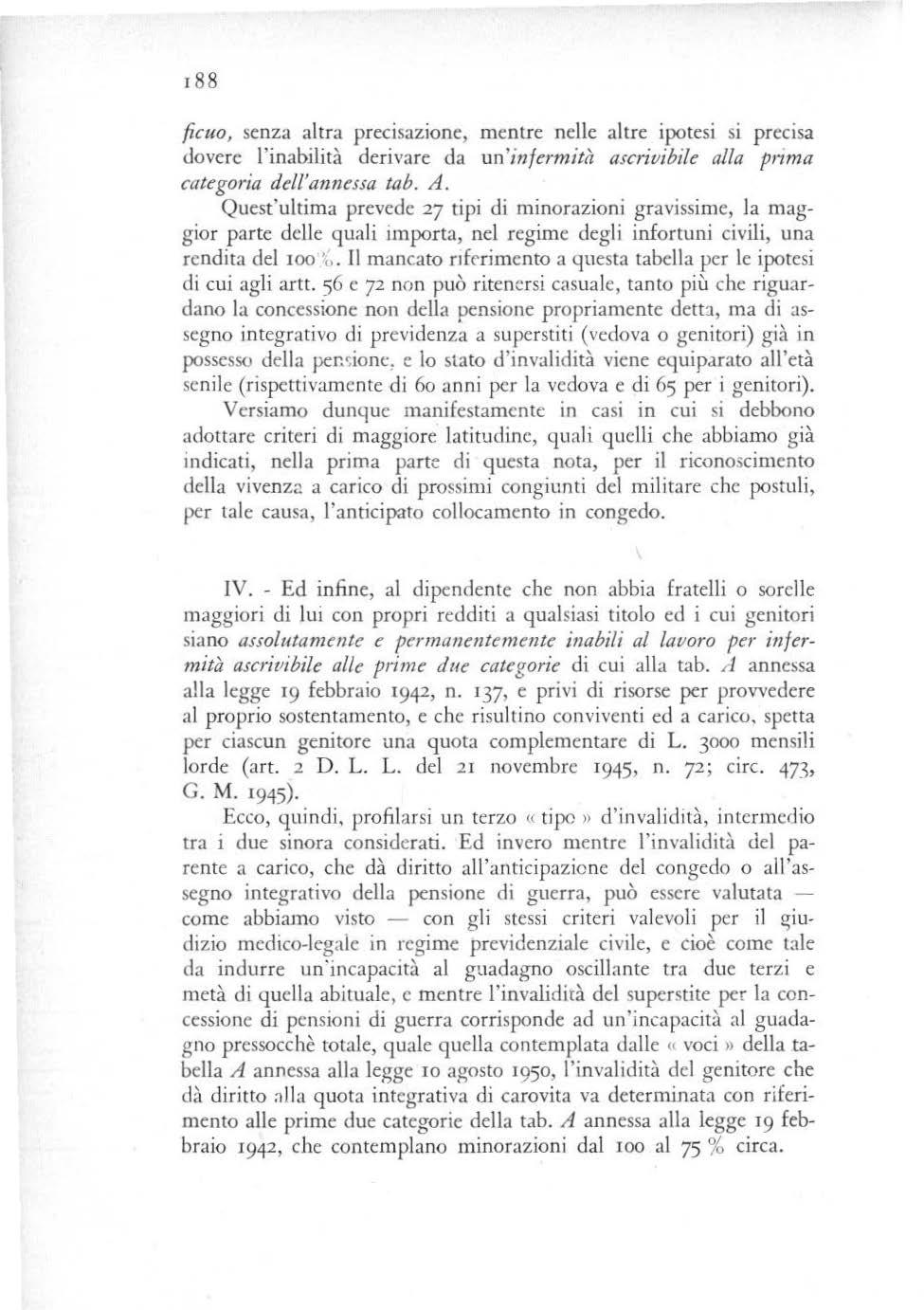
188
Va infine precisato che le due tab. A cui si fa riferimento - cioè quel la della legge 19 febbraio 1942 e quella della legge IO agosto 1950 - non sono perfettamente identiche. Infatti la prima catego ri a della tab. A 1950 contiene 2 « voci » in più della precedente, e p1 ecisamente la sae la 2t; la 5" contempla (( le alterazioni organiche ed irreparabi li di un occhio che ne abbiano prodotto cecità asso luta e permanente, con l 'acutezza visiva dell'altro ridotta tra r f so ed T j 2') del la normale n ; e la 2t la « sordità bilatera le organica assoluta e permanente, quando si accompagni alla perdita o disturbi grav1 c permanenti della favella >> .
Inoltre risu l ta modificato il testo della « voce » 6a, che nella legge 1942 comprende « le alterazioni delle facoltà mentali, permanenti, insanabili e gravi al punto di rendere l'individuo totalmente incapace a qualsiasi lavoro proficuo o pericoloso a sè ed agli altn >>, mentr e la corrispondente « voce >> (t) della legge 1950 indica « tlltte le; alterazioni delle facoltà mentali (schizofrenia e sindromi freniche, demenza paralitica, demenze traumatiche , dem enza epilettica, di stimie gravi, ecc.) che rendano l'individuo inc.lpace a qualsiasi attività » .
La seconda categoria comprende in ambedue le tabelle lo stesso numero di « voci >> , ma è modificato il testo della 21\ che nella legge 1942 riflette << l a perdita di una coscia sopra il terzo inferiore >l , mentre in quella 1950 concerne « la perdita di una coscia a qualsiasi altezza »
BIBLIOGRAF IA
CARVACLIO E.: (( Medicina lega le militare >>, vol. r, Corticelli ed , 1942.
D ' ALE SSANDRO R.: « Medicina e med icina lega le militare ,, , Pozzi ed , 1936.
FILOGRANA: « La valutazione del lo stato d'inabil i tà a l lavoro proficuo » in Gio-rnale di Medici-na Militat·e, 1932, fase. I.
LAMPIS: cc Visus cd inab ilità al lavoro proficuo ll , in Giorn. M ed. Mil., 1930
PALMIERI V M : « Medicina legale ass ic urativa », vol. Il. Vallardi ed., 1942.
-: cc Medi cina forense >>, V edizione, Moran o ed., 1951.
P AN AGI.>\: « 11 concetto valutativo di inabilità al lavoro proficuo in medicina legale militare >> , in Giornale di medicina militare, 1935, fase. V.

TROMHE1TA E.: << Manual e di medicina lega le mil i tare ll , Hocpl i ed., 1908.
V IOL ,\ D.: « Considerazioni sul giudizio d'inabi l ità a proficuo lavoro ai fini della legge su l reclutamento nel R. E. >> , in G. M. M., 1933, fas e VIT.
CANOVA IN SAL A JNCISOR I A
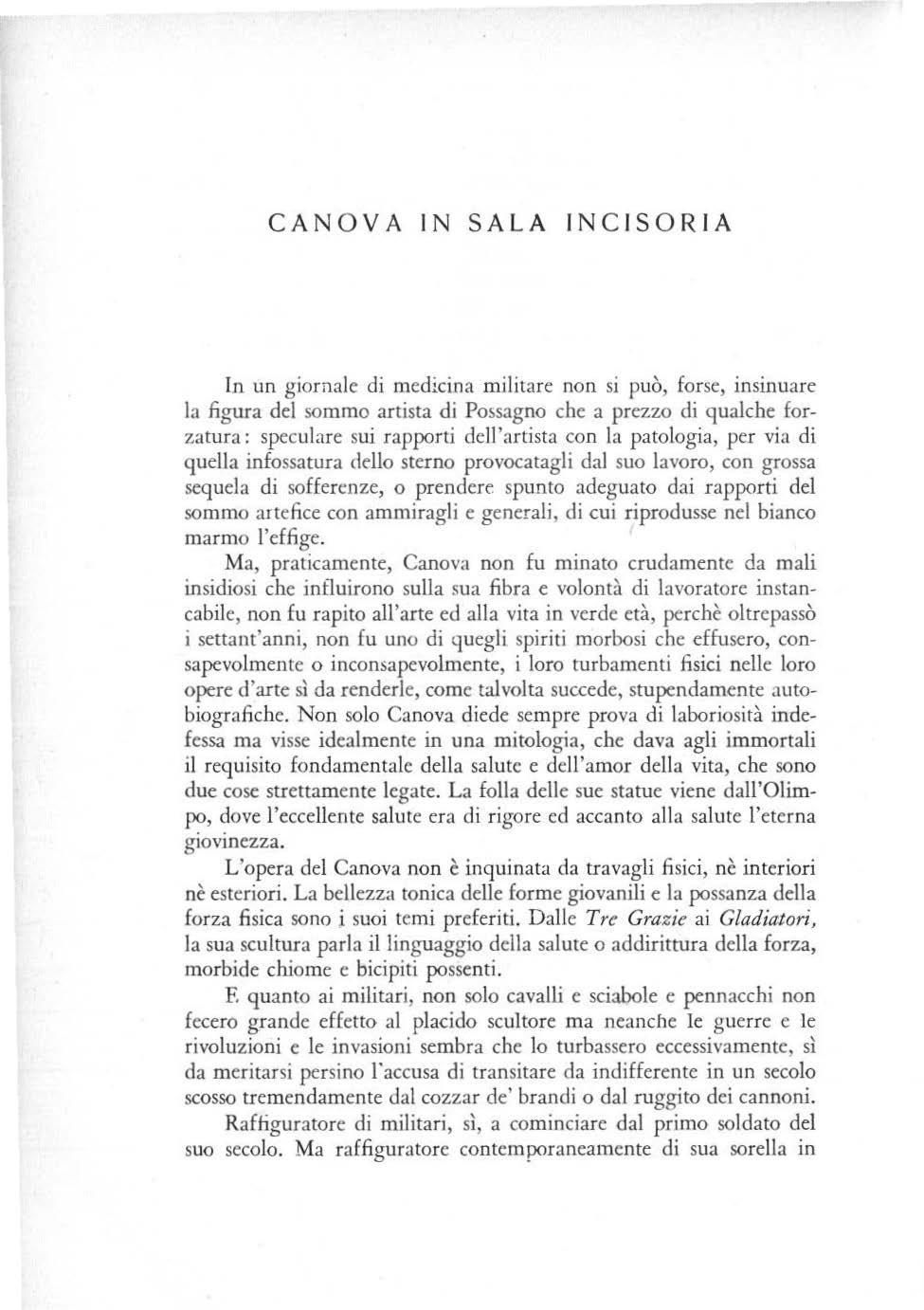
In un giornale di medicina militare non si può, forse, insinuare la figura del sommo artista di che a prezzo di qualche forzatura: speculare sui rapporti dc li 'artista con la patologia, per via di quella infossatura dello sterno provocatagli dal suo lavoro, con grossa sequela di sofferenze, o prendere spunto adeguato dai rapporti del sommo artefice con ammiragli e generali, di cui riprodusse nel bianco marmo l'effige.
Ma, praticamente, Canova non fu minato crudamente da mali insidiosi che int1uirono sulla sua fibra e volontà di lavoratore instancabile, non fu rapito all'arte ed alla vita in verde età, perchè oltrepassò i settant'anni, non fu uno di quegli spiriti morbosi che effusero, consapevolmente o inconsapevolmente, i loro turbamenti fisici nelle loro opere d'arte sì da renderle, come talvolta succede, stupendamente autobiografiche. Non so lo Canova diede sempre prova di laboriosità indefessa ma visse idealmente in una mitologia, che dava agli immortali il requi sito fondamentale della salute e dell'amor della vita, che sono due cose strettamente legate. La folla delle sue statue viene dall'Olimpo, dove l'eccellente salute era di rigore cd accanto alla sa lut e l' eterna giovin ezza.
L'opera del Canova non è inquinata da travagli fi sici, nè interiori nè esteriori. La bellezza tonica delle forme giovanili e la possanza della forza fisica sono i suoi temi preferiti. Dalle Tre Grazie ai Gladiatori, la sua scultura parla il linguaggio della salute o addiri ttura della forza, morbide chiome e bicipiti possenti.
F. quanto ai militari, non solo cavalli c sciabole e pennacchi non fecero g rande effetto al placido scultore ma neanche le guerre e le rivoluzioni c le invasioni sembra che lo turbassero eccessivamente. sì da meritarsi persino l'accusa di transitare da indifferen t e in un secolo scosso tremendamente dal cozzar de' brandi o dal ruggito dei cannoni.
Raffiguratore di militari, sì, a cominciare dal primo soldato del suo seco lo. Ma raffiguratore contemporaneamente di sua sorella in
veste - diciamo veste di Venere e di Papi in preghiera. In fatto, poi, di interpretazioni dello spirito militare, ci sarebbe da discutere. Sappiamo che non fu motivo dì grande soddisfazione per Napoleone vedersi ritratto, dopo tanta attesa, non solo a piedi, senza il grandissimo cavallo commlSSionato, ma addirittura senza stiva l i, senza spalline, senza tricorno, senza neanche la popolare uniform e di piccolo caporale, c, diciamolo pure, se nza camicia: ignudo davvero. Deifi-
Nato a Po rsagno il / 0 novembre 1757·
Morto in Vene·;ta il 13 ottobre 182 2.
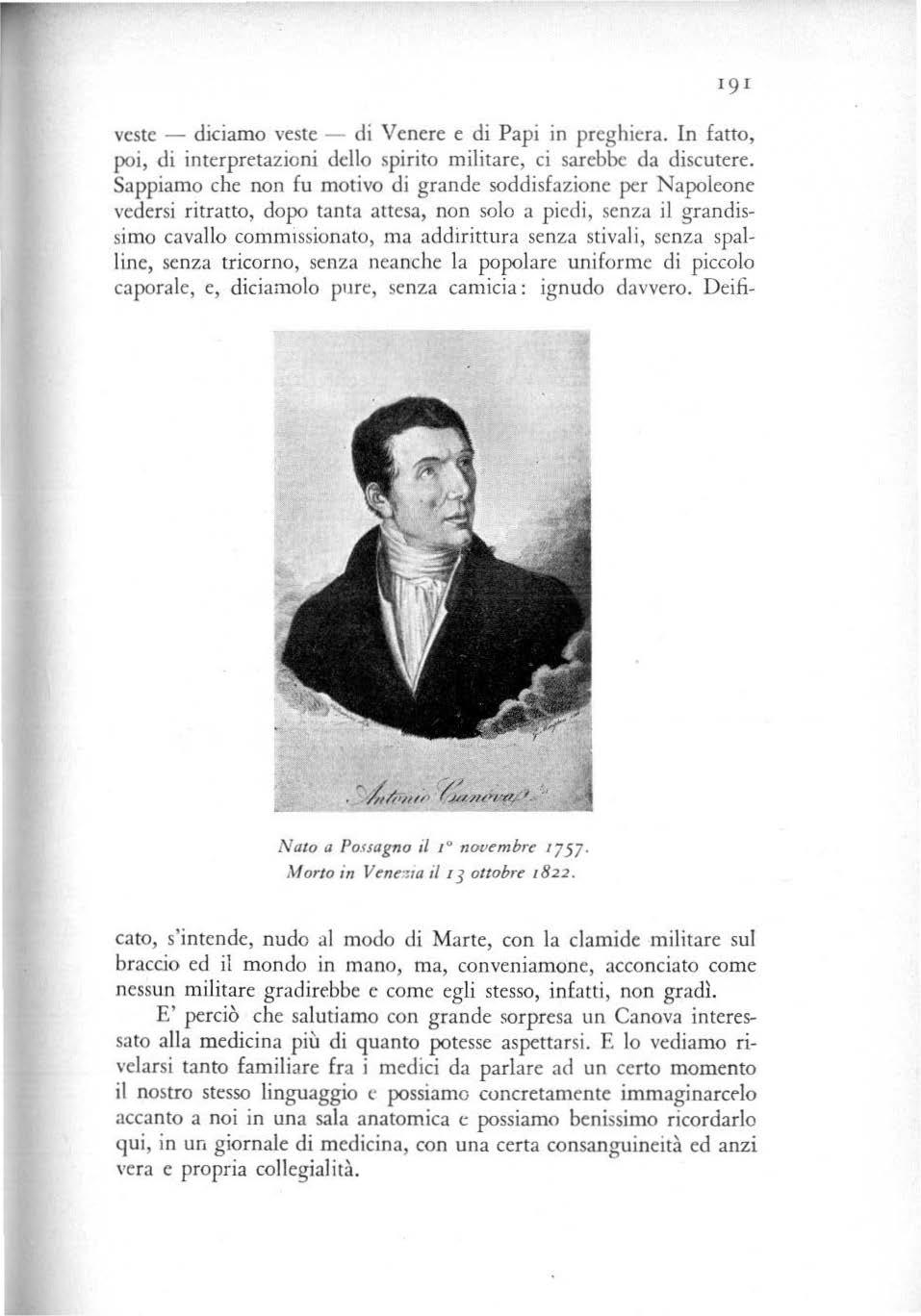
cato, s'intende, nudo al modo di Marte, con la clamide militare sul braccio ed il mondo in mano, ma, conveniamone, acconciato come nessun militare gradirebbe c come egli stesso, infatti, non gradì.
E' perciò che salutiamo con grande sorpresa un Canova interessato alla medicina più di quanto potesse aspettarsi. E lo vediamo rivelarsi tanto familiare fra i medici da parlare ad un certo momento il nostro stesso linguaggio c: possiamo concretamente immaginarcrlo acca nto a noi in una sala anatomica e possiamo benissimo ricordarlo qui, in un giornale di medicina, con una certa consanguineità ed anzi vera e propria collegialità.
Lui scultore (e di quale statura) e noi medici (lasciamo le dimensioni) abbiamo per brev·ora avuto in co mune gli stessi studi, appreso le stesse cose, r imirato gli stessi cadaveri, parlato a llo stesso modo di inserzioni, di tendini, di gran supin :-t torc c di deltoide. E g li ha fatto, anzi, certamente meglio di noi, che praticavamo la dissezione con aperti davanti aglt occhi le tavole del Te::stut o l'atlante dello Spaltehol z, eg li ha btto, di wa mano, i suoi a tl anti a natomi ci, sul cad avere, dal ve ro, tanto vero che dipingendosi l e:: tavole egli è riusci to a da r così giusto tono di colore da sorpassare T est ut e Spalteholz
Canova an:nomo? Chi l'ha detto? Eppur ecco qui la sua Descrizione dei mu scoli este riori del corpo umano, una cartell a, ch e ognuno può vedere, qui a Roma all'Istituto Superiore (h Sanità, e che il diretto re, Domenico Marotta, seppe acquisire allo Stato . Dopo di che ne volle debitamente divulgazione (r).
L a carte lla con ti e ne 17 g ra nd i disegni a colori di mano certa del Canova, ignorati fi no ad oggi . I disegni riproducono muscoli, gru ppi di musco!i, atteggiamenti degli arti c del tronco umano. Ogni muscolo è descritto nel suo decorso, nelle sue inserzioni, nell a sua funzione da notazio ni dello stesso Canova, a fianco di og ni disegno . Un atlante st upendo, che fa brillare gli occhi di ogni medico, che rapisce -ogni artista." Non c'è medico c he abbia veduto quei seg ni , che ignorandone l'a utore non abbia !> ubito pensato ai massimi artefici dell a nostra arte figurativa. I nsomma un cimelio Canoviano, di alto interesse medico e artistico, pr ez ioso, comunque, dal lato biogra fico dell'a rtista . Questo è infatt i il ricordo di un'epoca della vita di Canova e propria della sua giovinezza non so lo appassio nat a all'art e ma onestamente devota alle esigenze dell'arte.
S'i ntende che gueste tavole non sono un atla nte anatomico, non so no il vade mec um dello scie nziato, invece il promemo ria di un arti sta. N on è anato mia descrittiva e tanto meno si tratta di anatomia topografica, è anatomia funzionale, che vuole di ogni mu scolo conoscere, ricordare la fun z10ne e la forma in movimento. Il mu scolo inerte del cadavere diss ez io nato pr e nde:: ndl a fantasia dello scultore vit a co me se egli vedesse g 1à marcarsi le possenti mu sco la tur e del suo Ercole che scaraventer à in mare il subdolo Li ca, so rrid e:-e Ebe, inprocaci e lascivi i li sci seni cii Pflolina e pregare Papa Clemente.
( 1) Nl. (Istituto Superiore di Sanità): DtSegm anatomici di AnJonio Canova, Editore : Fondazione Emanuelt: Paternò, Roma.

E' interessante che siano i muscoli ad attirare l'interesse dello scultore, i muscoli che dànno la forma, che compongono il gesto, che delimitano la figura.
All'anatomico che osserva freddamente da scienziato quelle tavole, non sfuggono, conveniamone, ta lun e numerose imperfezioni nella rappresentazione grafica. Nell'artista c'è la tendenza a disegnare
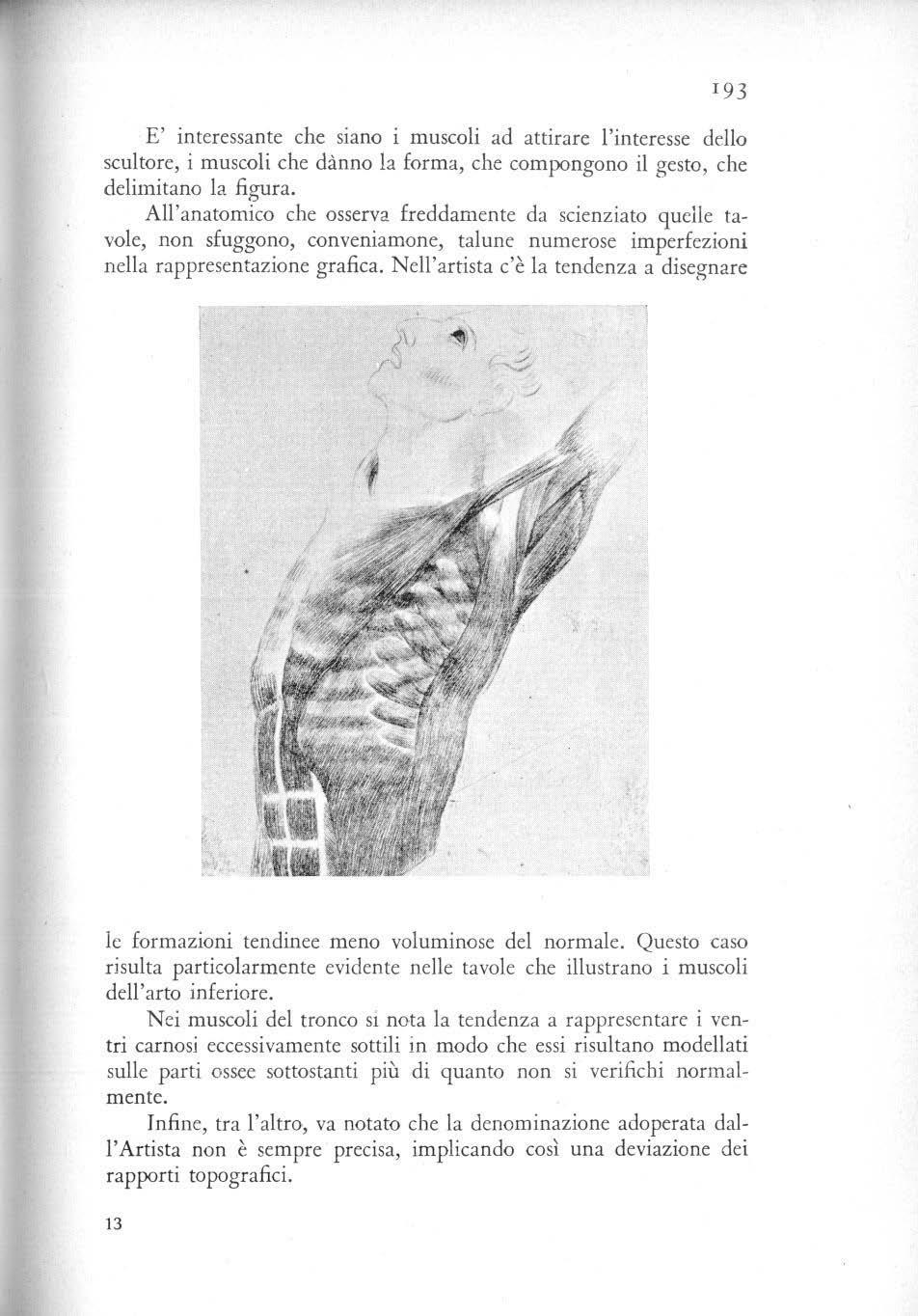
le formazioni tendinee meno voluminose del normale. Questo caso risulta particolarmente evidente nelle tavole che illustrano i muscoli de Il' arto inferiore.
Nei muscoli del tronco s1 nota la tendenza a rappresentare i ventri carnosi eccessivamente sottil i in modo che essi risultano modellati sulle parti ossee sottostanti più di quanto non si verifichi normalmen te .
Infin e, tra l'altro, va notato che la denominazione adopera t a dall'Arti sta non è sempre precisa, implicando così una deviazione dei rapporti topo grafici.
1 93
'
13
Non disconosciamo che gli occhi dell'Artista non saranno mai quelli dello scienziato, egli rimarrà sempre strumento della natura, osservatore obiettivo ma nello stesso tempo allegorico .
Deve aver provato quell'adolescente (aveva intorno ai 18 anni) una specie di esitazione nel penetrare nel mistero della natura, nell'osservare il documento fisico che resterà poi il presupposto indispensabile alla sua divina arte raffigurativa.
Se questa te sti monianza non è nel senso stretto della parola un documento tecnico è pur tuttavia, se non d'arte, una pagina di cvidente preparazione a ll'arte.
A tanti anni dalla sua morte, le sue opere nobilitano di perenne bellezza il mondo c la loro armonia fa contrasto vivace con le raffigurazioni oggidì di moda. Questo piccolo documento è insieme un cimelio c forse un ese mpio.
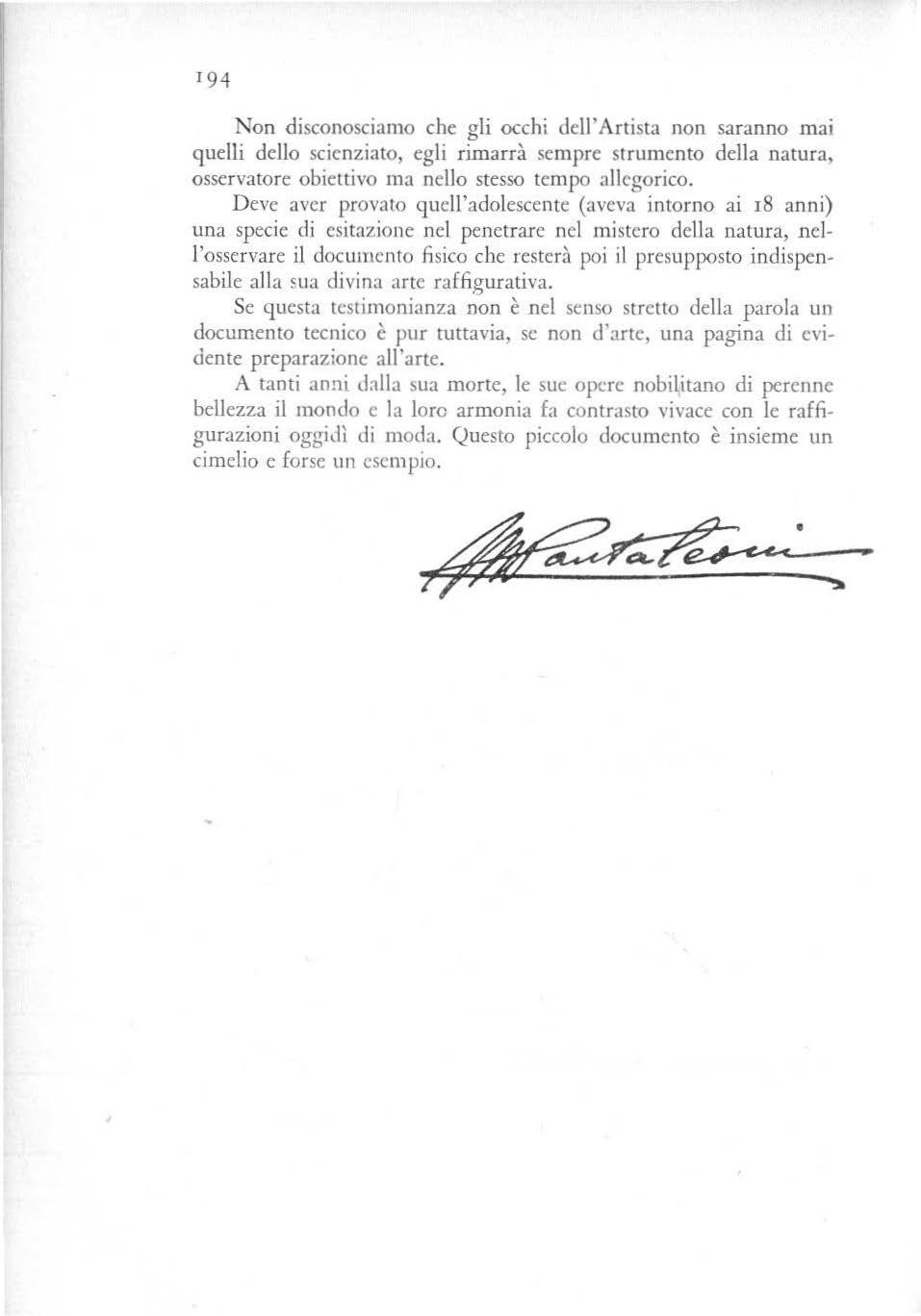
1 94
CR
ITERI DI ORIENTAMENTO NE LLA TERAPIA
DELLE SU PP U RAZ I ON I PO LMO NAR I
Più di vent'anni di esperienza ci hanno dato la fortuna di seguire i profondi e diremo fonunati ri volgimenti nella terapia medica e chirurgica delle supp urazioni polmonari. Abbiamo visto il sorgere cd il declinare all'oblio, for se ingiustificato, di numerosi maci e metodi di cura per assistere poi all'avvento degli antibiotici che a tutt'oggi costituiscono ancora il miglior mezzo terapeutico tra qu elli adottati; abbiamo !leguito ed accompagnato i passi della rurgia conservatrice (pneumotomia, resezion e opcrcolarc polmonare, ccc.) per poi assistere c contribuire alla chirurgia di exeresi che si è ormai largamente sostituita alla precedente.
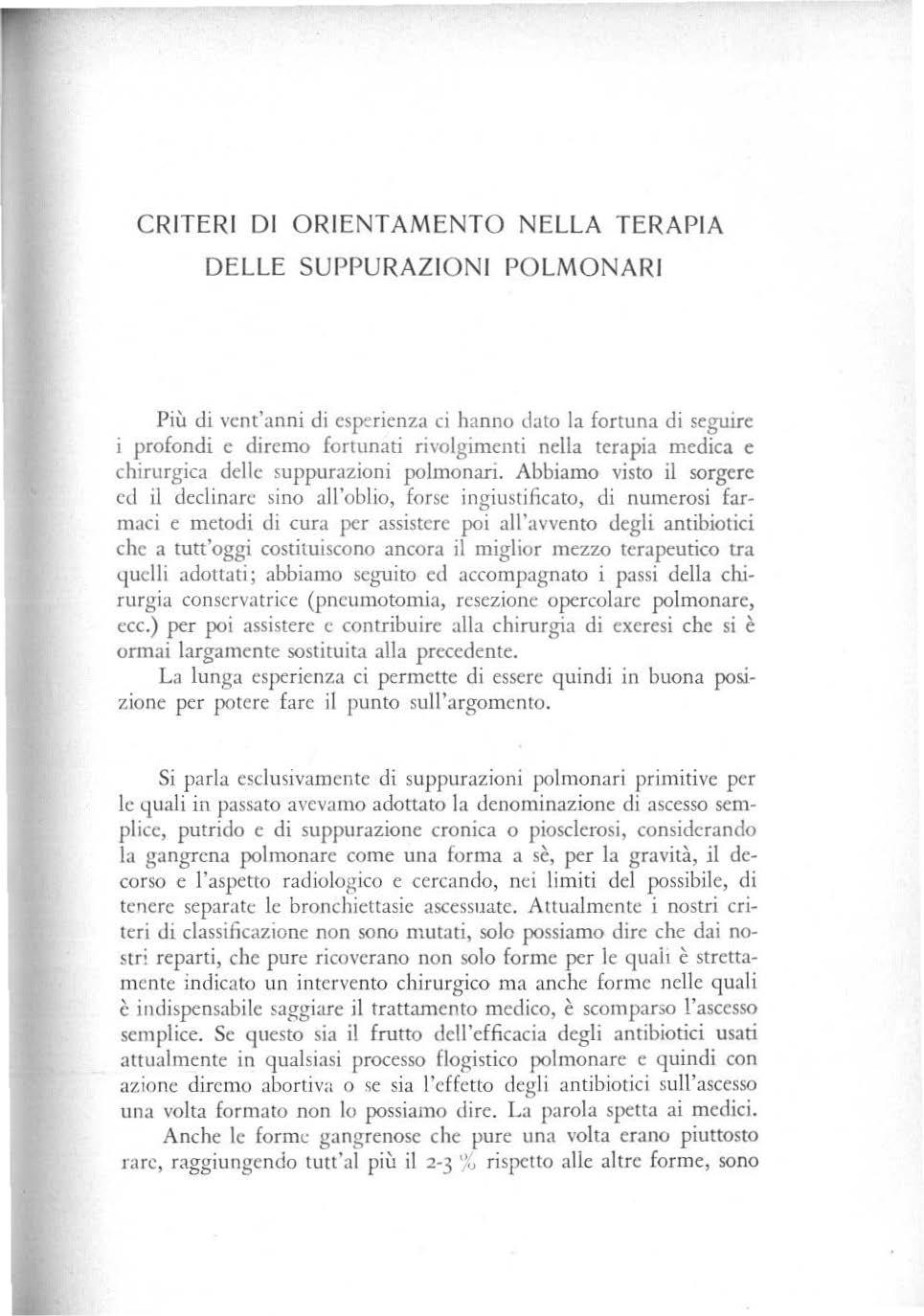
L a lunga esperienza ci permette di essere quindi in buona zione per potere fare il punto sull'argomento
Si parla di suppurazioni polmonari pnm1t1ve per le qua l i in passato avevamo adottato la denominazione di ascesso plicc, putrido c di suppurazione cronica o piosclerosi, considerando la gangrena polmonare come una forma a sè, per la gravità, il corso e l'aspetto radiologico e cercan do, nei lim iti del possibile, di tenere separate le bronchiettasie ascessuate. Attualmente i nostri teri di classificazio ne non sono mutati, solo possiamo dire che dai stri reparti, che pure ricoverano non solo forme per le quail è m en te indicato un i nt erven to c h irurgico ma anche form e nelle guaii è indispensabile saggiare il trattamento medico, è scompano t'ascesso semplice . Se questo sia il frutto dell'efficacia degli antibiotici usati attualmente in qualsiasi processo flogistico polmonare e quindi con azione diremo abortiva o se sia l'effetto deg li antib iotici sull'asc esso una volta formato non lo possiamo dire. L a parola spetta ai medici. Anche le forme gang renosc che pure una volta erano piuttosto rare, raggiungendo tutt'al più il 2-3 "•J rispetto alle altre forme, sono
oggi di ecce-Lionale osservazione ed anche per esse la prognosi è cambiata.
Il termine di ascesso semplice viene attualmente usato non più nel semo di una volta ma ad indicare forme unicavitarie, non accompagnate da reazione pneumonica estesa nè da fibrosi o bronchiettasie. L a presenza di ascessi satelliti, di reazione polmonare intensa, di fibrosi e di bronchiettasie caratterizza invece gli ascessi che si dicono complicati, termine al quale noi preferiamo quello di complessi. Quc!>ta classificazione può an!re una certa ma non importanza ai fini della prognosi
Se anche per gli ascessi putridi acuti sia diminuita l'inciàenza non lo possiamo dire poichè da chirurgi non siamo nelle condizioni giuste per poter fare una statistica. Noi non possiamo confrontare la percentual e dci ricoveri attuali con quella dell'epoca preantibiotica poichè in quel periodo aveva già fatto buoni passi l'abitudine di inviare i pazienti al chirurgo dopo 4-6 settimane di cure mediche. Oggi noi sappiamo che gli antibiotici in mano al medico hanno ragione dell'ascesso acuto in un'alta percentuale di casi, secondo alcuni superiore al 90 quindi un cospicuo num ero di ammalati non gJunge p1ù all'osservaz10ne del chirurgo. Abbiamo però notato un altro fatt o, e con noi altri, cioè che giunge al chirurgo un numero maggiore di forme croniche diffuse. La spiegazione per noi è facile. Un ottimismo ha portato a dimenticare due canoni fondamentali che valevano per le cure mediche usate in passato c valgono anche oggi p e r la penicillinoterapia: primo, è inutile insistere con tali cure se esse non danno un risultato tangibile entro un determinato pcrioòo di tempo; secondo, solo l'esame radiologico ci può dare il giudi7io di guarigione e ci puè) mettere in guardia contro le apparenti remissioni cliniche.
Più di una volla abbiamo riesaminato l'archiviO radiologico della Clinica alla ricerca di clementi che ci perm ettesse ro di stabilire sin dal prime esame quale sarebbe stato il decorso di un ascesso a prescindere dalla terapia. Soprattutt0 ci eravamo fissati su due elementi: volume dell'ascesso, esiguità di quella che per convenzione chiameremo reazione perifocalc (i n pratica la differenziazione tra ascesso semplice e complesso secondo la nuova classificazione sopra acr.ennata). Volevamo principalmente vedere se era possibile fare una prognosi favorevole in quei casi che rispondessero a particolari requisiti. D obbiamo dire che se qualche elemento di vaga presunzione può essere ammesso, segni sicuri non ne esistono; ci eravamo perciò sempre più convinti della necessità del controllo radiologico periodico,
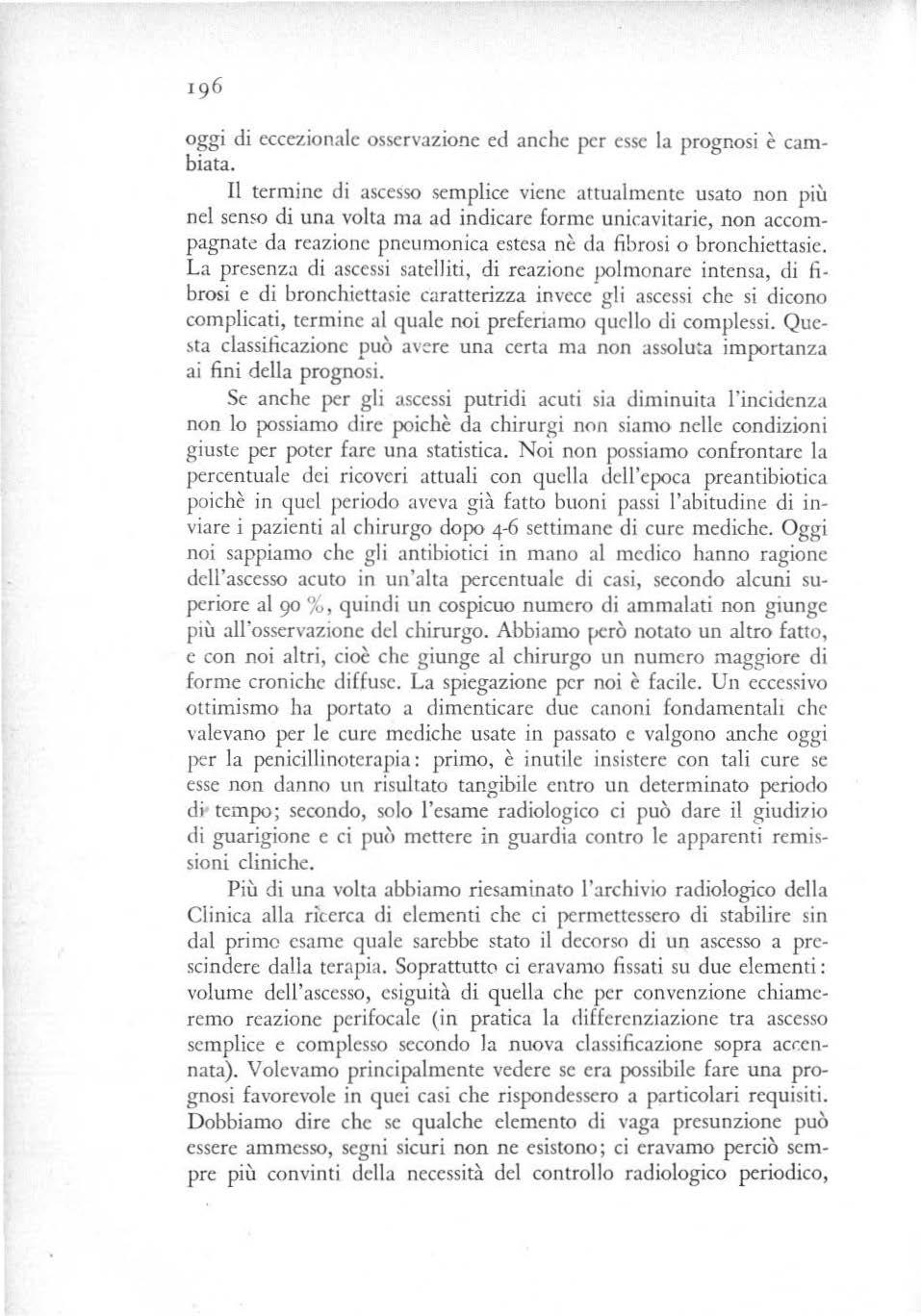
almeno ogni 15 giorni. Anche oggi, nel pieno fulgore della terapia con antibiotici, questa norma elementare non va trascurata.
Non vogliamo dare dati stati stici sui successi ed insuccessi della terapia con antibiotici poichè il nostro materi ale non è cospicuo al riguardo; i dati degli AA. se pure molto confortanti non so no del tutto concordi. Sappiamo e siamo sicuri dei successi come siamo al corrente eli insuccessi e di tentativi tcrapeutici inutilmente protratti che hanno portato alla cronicizzazione del processo e, quel che è peggio, alla sua diffusione.
Perchè la terapia con antibiotici fallisca, in qualche caso ci sfugge in altri lo possiamo intuire: insensibilità all'antibiotico, insufficiente drenaggio della cavità per inwngruo rapporto con il bronco. presenza di sequestri, larga tstensione del processo, ccc. Per noi è solo importante sapere che può fallire per autorizzarci a richiamare l'attenzione sulle conclusioni esposte al congresso della Società Italiana di Chirurgia del 1938 :
a) è possibile, in due controlli radiografici a 15 giorni di distanza l'uno dall'altro, presumere in molti casi quale sarà la evoluzione di una suppurazione polmonare;
b) non si deve insistere oltre sei settimane nel trattamento se la forma morbosa non evolve sensibilmente verso la guarigione.
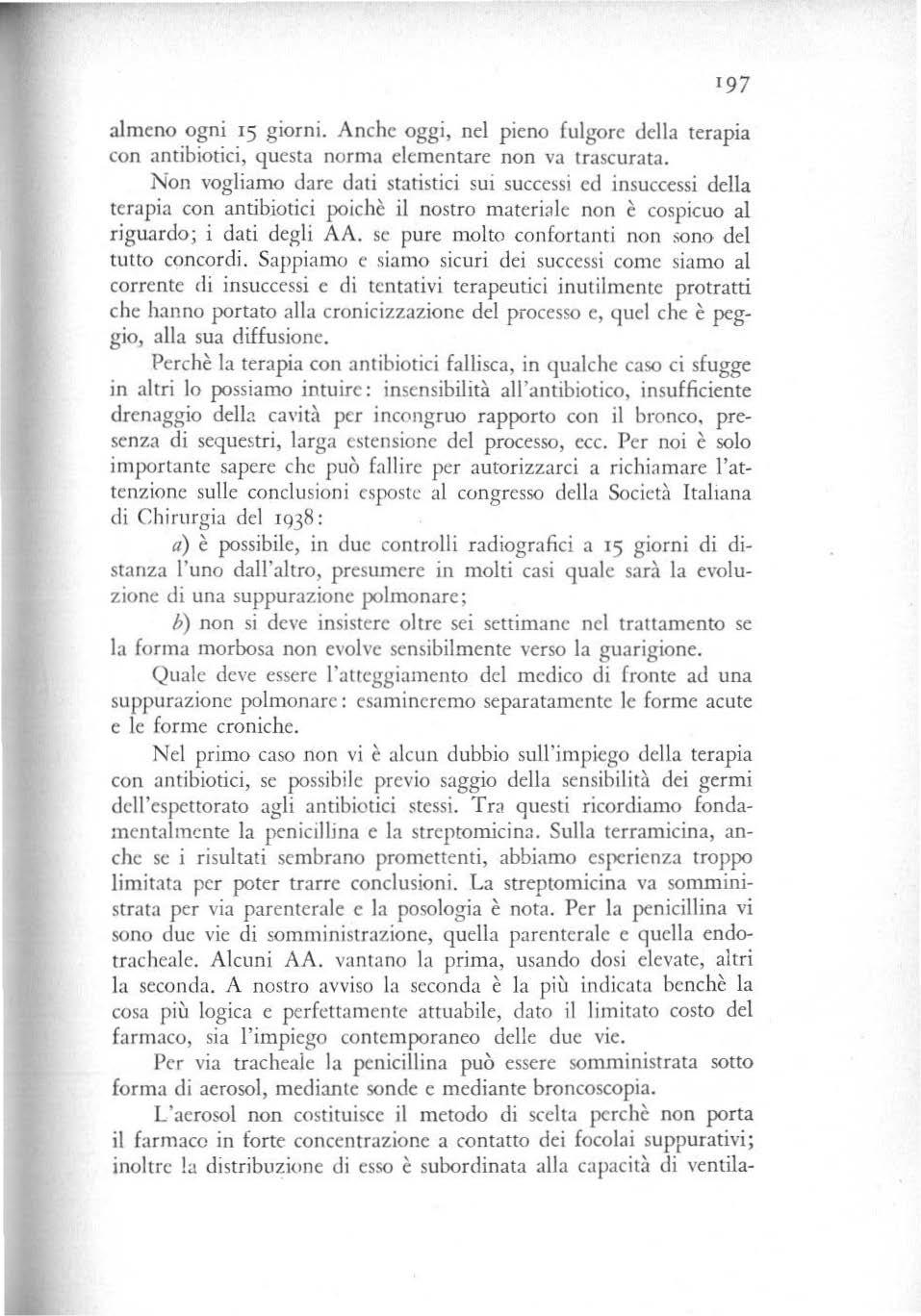
Quale deve essere l'atteggiamento del medico di fronte ad una suppurazione polmonare: esamineremo separatamente le forme acute c le forme croniche.
N el primo caso non vi è alcun dubbio sull'impiego della terapia con antibiotici, se possibile previo saggio della sensibilità dei germi dell'espettorato agli antibiotici stessi. Tra questi ricordiamo fondamentalmente la peniciiUna e la Sulla terramicina, anche se i risultati sembrano promettenti, abbiamo esperienza troppo limitata per poter trarre conclusioni La streptomicina va somministrata per via parenterale e la posologia è nota. P er la penicillina vi sono due vie di somministrazione, quella parcntcrale c quella endotracheale. Alcuni AA. vantano la prima, usando dosi elevate, altri la seconda. A nostro avviso la seconda è la più indicata benchè la cosa più log ica e perfettamente attuabile, dato il limitato costo del farmaco, sia l'impie go co nt emporaneo delle due vie.
Per via tracheale la penicillina può essere somministrata sotto forma di aerosol, mediante so nd c c mediante broncoscopia.
l 'aerosol non costituisce il m etodo di scelta pcrchè non porta il farmaco in forte concentrazione a con tatto dei focolai suppurativi; inoltre la distribuzione di esso è subordinata alla capacità di ventila-
zionc delle singole arce polmonari. La broncoscopia richiede una strumentazione facile in man i abituate ma non alla portata di tutti c non semb ra ben tollerata dai pazienti. E' però un ottimo coadiuvante della tc.:rapia intrabronchialc con sonde perchè permette l'aspirazione completa delle secrezioni, l a disostruzione bronchi.1le ed il trattamento di eventuali lesioni bronchiali concomitanti o determinanti. E' bene però che questo metodo non sia applicato nel le prime tre settimane di m alattia.
La via tracheale con sonde è di gran lunga la preferibilc. Usando sondc a curva fissa di Métras oppure la sonda a curvatura variabile recentemente ;ntrodotta da Gau (x) e guidandole sotto schermo radiologico è possibile portare il farmaco nel lobo o nel segmento polmonare interessato. Chi non avesse sonde o impianto radiologico può usare con buone probabilità di successo la tecnica che descriviamo: introduzione in trachea per via transnasale di un comune catetere di Kelaton n. 15-16 ed della penicillina attraverso la sonda; mettendo il paziente in posizioni adatte, il liquido che cola lungo la trachea ed il bronco prillcipale dovrebbe ad un certo punto imboccare i bronchi lobari e quindi quelli segmentari. Ricordiamo che a destra il bronco lobare superiore nasce dal contorno esterno del bronco principale e si dirige obliquamente in fuori ed in a lto, che il bronco lob:tre medio nasce dal contorno anteriore del bronco principale c si dirige obliquamente in basso ed in avanti c che dci bronchi del lobo inferiore ha importanza il posteriore (superiore) che nasce dal contorno posteriore del bronco lobare mferiore e si dirige obliquamente in dietro ed i n basso. A sinistra il bronco lo bare superiore nasce dal contorno esterno (superoesterno) del bronco principale, debordando un poco sulla faccia anteriore ed il bronco scgmentario posteriore (superiore) nasce come a destra dal contorno posteriore del bronco lobare inferiore. Quindi per far giungere l'antibiotico ai lobi superiori il paziente dovrà essere collocato sul fianco con la parte inferiore del torace leggermente più alta della superiore (basta un piccolo rotolo); per il lobo medio il decubito sa rà vcntrale, per i bronchi seg mcntari posteriori (del lobo inferiore) sarà dorsale con lieve i nel i nazione sul fianco sinistro se si vuole c he il liquido imbocchi il bronco di si nistra o a destra per essere ancor più sicuri che imbocchi il bronco destro. Per gli altri bronchi inferiori il decubito sarà seduto con leggera inclinazione in avanti o in dietro se sono interessati i segmenti ventrali o dorsali e naturalmente a destra o a sinistra.
( 1) Pre;u 1950, LVIII. 1028.

..
E ' certamente un metodo molto meno preciso dei precedenti ma, come abbiamo detto, ha il vantaggio di essere alla portata di tutti; comunque l a pe ni ci llina da usare ogni volta varia, a seco nda degli AA., da mezzo a un milione, diluita in 6-8 cc. di soluzione fisiologica; la frequenza de ile applicazion i oscilla da due a tre la settimana; il numero di esse non è precisabile perchè deve essere l'esame r adiologico a dirci se è opportuno abbandonare la cura c passare il malato al chirurgo oppure contin uare fino a guarigione conclama t a.
Qu esto per quel che riguarda l 'ascesso acuto; pe r quelle forme che giu n gono all'osserv azione del medico già allo stato cronico noi chiediamo la ospedalizzazione in reparti chirurgici. Non perchè il chirurgo in tervenga subito ma perchè applichi il trattamento endob ronchi ale, trovandosi però ndle migliori condizioni non già per dec id ere se tale terapia porti ad un miglior ame nto e se questo potrà continuare fino alla guarigione, ma per stabilire il ma ssimo risultato utile raggiungibi le e per mettere in atto se nz a ulteriori indugi il trattamento chirurgico qualora l':111damento della malattia non quello desiderato.
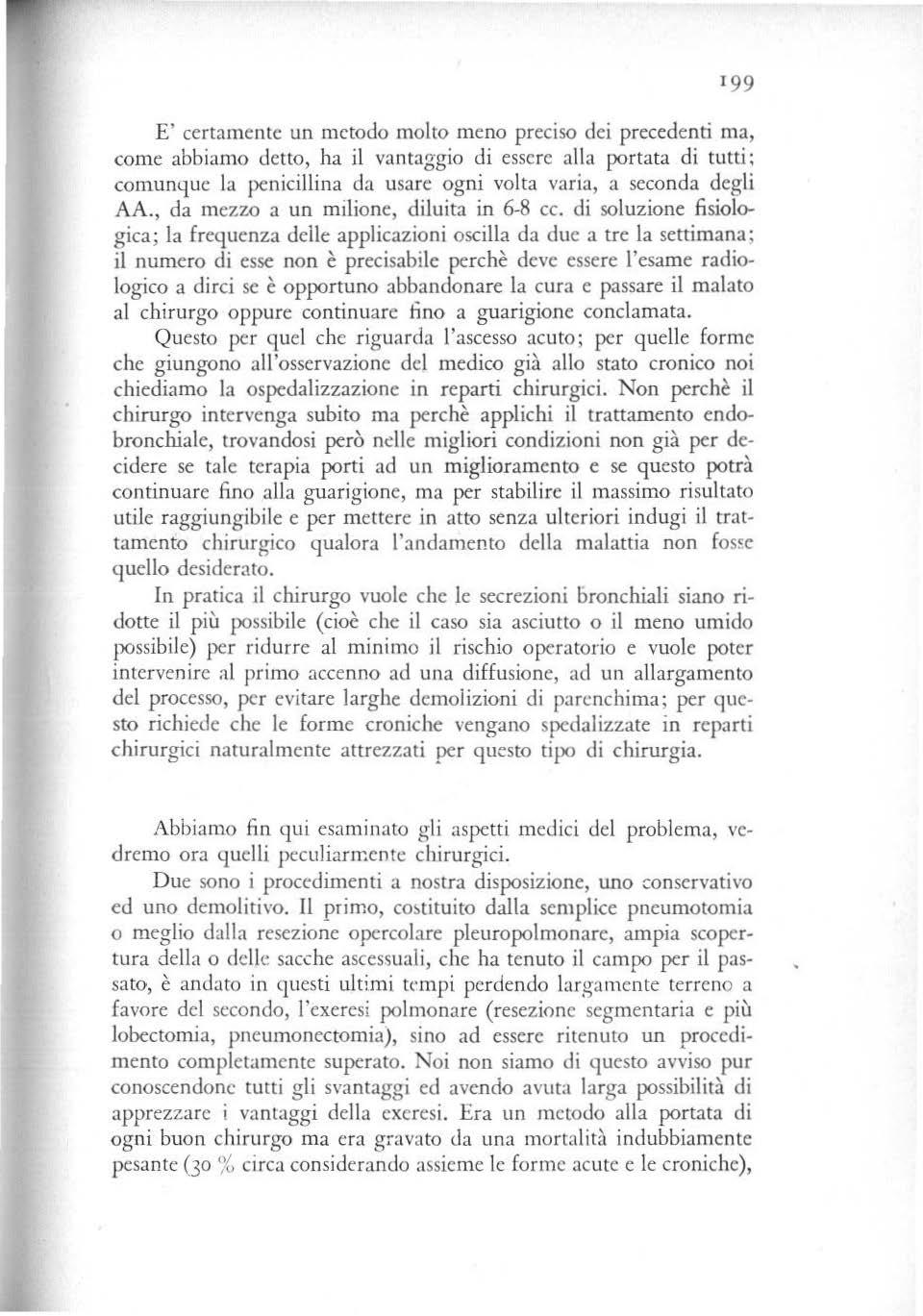
In pratica il chirurgo vuole che le secrezioni bronchiali siano ridotte il più possibile (cioè che il caso sia asciutto o il meno umido possibile) per ri d u rre al minimo il rischio operatorio e vuol e poter intervenire a l primo accenno ad una diffusione, ad un allargamento del processo, per evitare larghe demolizioni di pan::nchima; per questo richiede che le forme croniche vengano spedalizzate in reparti chirurgici naturalmente attrezzati per questo tipo di chirurgia.
Abbiamo fin qui esaminato gli aspetti medici del problema, vedremo ora quelli peculiarmente chirurgici
Due sono i procedimenti a nostra disposizione, uno conservativo ed uno demolitivo. Il primo, dalla semplice pneumotomia o meglio dalla resezione opercobre pleuropolmonare, ampia scopertura della o d ell e sacche ascessual i, che ha tenuto il campo per il passa to , è andato in questi ult imi tempi perdendo lar gamente terren o a favore del seco nd o, l'exeresi polmonare (rese zio n c segmen taria e più lobectom.ia, pneumonectomia), si no ad essere ritenuto un procedimento completamente superato . Noi non siamo di questo avviso pur conoscendone tutti gli S\'antaggi ed avendo avuta larga possibilità di apprezzare i vantaggi della cxcresi . Era un mcLOclo alla portata di ogni buon chirurgo ma era gravato da un a m ortalità indubbiamente pesante (30 %circa co nsid erando assie m e le form e ac ute e le cronic h e),
1 99
se non proprio immediata certo a non lunga scadenza, mortalità in gran parte l egata alla non radicalità dell'intervento .
Questa mortalità si andava riducendo con l'uso degli antibiotici (negli anni 1946-48 era già nel nostro materiale, al I7 <y.. ) c tutto lasciava sperare che sarebbe scesa a cifre tollcrabili. Nel frattempo però la chirurgia di exeresi andava prendenJo il sopravvento così da toglierei la possibilità di raccogliere un numero di osservazioni tali da poter fare un confronto sostanziale. Secondo noi però il dato negativo di maggior peso a carico della chirurgia conservatrice, sempre legato alla sua non radicalità, è costituito dai risultati a diIl I 0 Congresso della Società Italiana di Chirurgia Toracica ci ha dato l'occasione per controllare, a distanza fino di dicci anni <.bil'intervento, un buon numero di opera t i nella nostra Clinica, un centinaio. Rimandando per i dati alla comunicazione al Congresso, \ ' 0gliamo solo ricordare i risultati globali della nostra inchiesta: nell'Br o/., suppurazioni acute i risultati si potevano considerare buoni , nel I5 % discreti, nel 3 mediocri; nel 58 % delle suppurazioni croniche buoni, nel 26 % discreti, nel I5 % mediocri; complessiva mente 67 % di risultati buoni, 22 °{, di discreti, IO % di mediocri (r). Le cifre non hanno bisogno di commenti D'altra pane la terapia di cxeresi ha raggiunto attualmente cifre di mortalità più che ragionevoli ed ha il vantaggio della radicalità e dei buoni ri su ltati a distanza.
Con tutto questo noi riteniamo che l a terapia chirurgica conservatrice abbia ancora delle indicazioni o se non altro che viva delle controindicazioni della chirurgia di exeresi c cioè che si debba ricorrere ad essa in quei casi in cui la particolare acuzie del processo, accompagnata da grave risentimento dello stato generale, faccia pensare alla necessità almeno di drenare la raccolta, inoltre in quei casi acuti e cronici nei quali le prove funzionali cardiache, polmonari, renali cd epatiche facciano presumere troppo rischiosa la terapia di
(t) Rwdrati buoni: ferita operatoria chiusa, assenza di recidive o di ricorrenze, condizioni subiettive buone, lavora t iva conservaw, assenza di espettorato oppure scarso espettorato la mattina o nel corso della giornata (gran parte dei nostri ammalati continua a fumare).
Risultati discreti: pr<.senza di fistola hroncoparietale scarsamente sece rn e nte, assenza di recidive o di ricorrenze, conJizioni subiettive buone, tapac ità lavorativa buona o di pocc- ridotta, scarso espettorato.
Risultati mediocri: fistola bronchiale ampia o complessa, secernente, espettorato presente in discreta quantità, episodi di ricorrenza o di recidiva, capacità lavorativa anche conservata ma impedimento ad una normale vita di relazione.
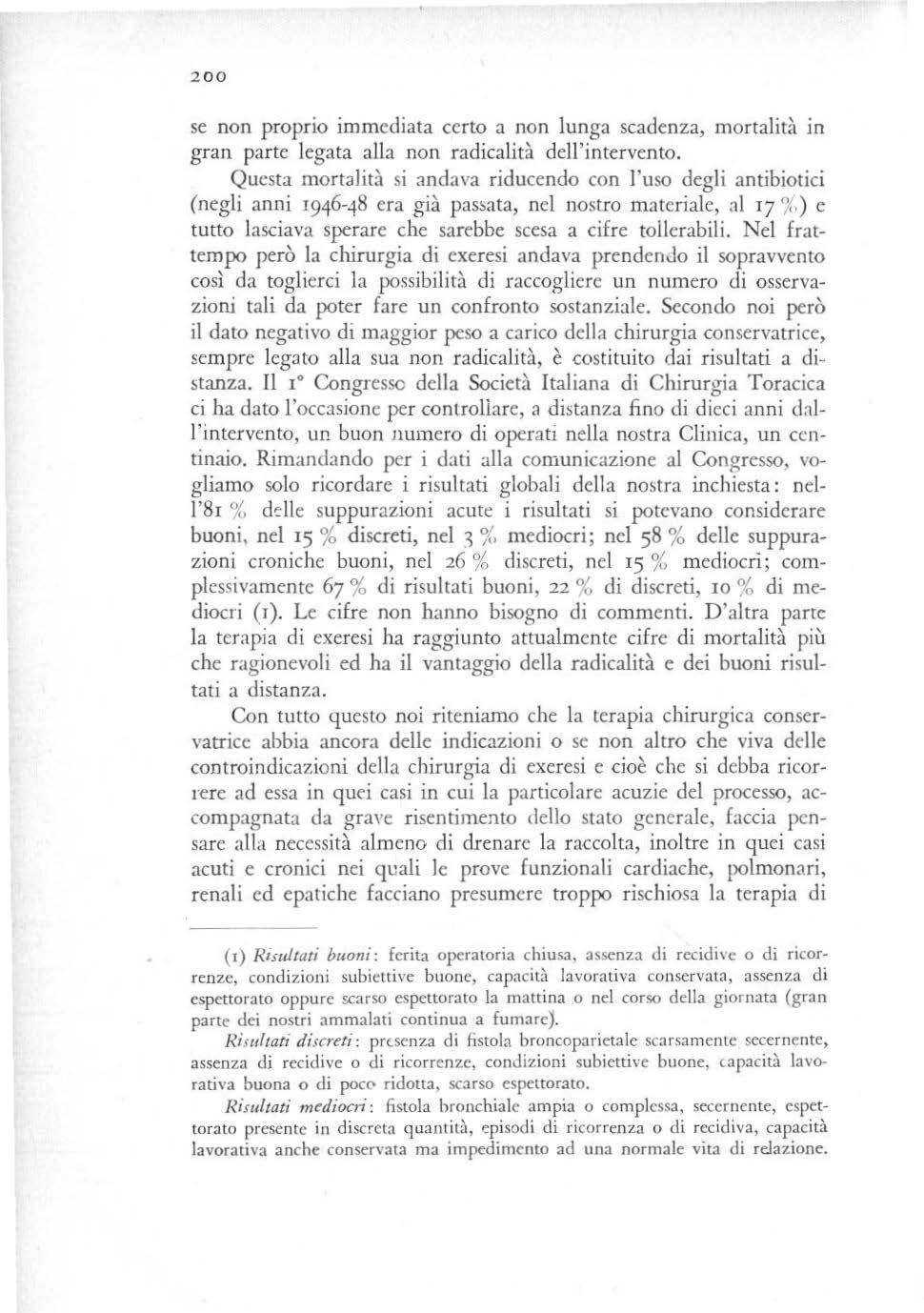
200
exe resi ed infine in qualche forma, generalmente acuta, con lesioni ben localizzate, circoscritte.
A proposito di quest'ultima indicazione vogliamo richiamare l'attenzione su di un procedimento tecnico che non è nuovo ma che in p:.tssato (cioè nell'epoca prcantibiotica) è stato usato sempre con una ce rta preoccupazione. La tattica operatoria classica della terapia c hirurgica conservatrice l'apertura del focolaio suppurarivo a pleure adese, quindi il piombaggio extrapleurico qualora questa adesione non fosse presente o non fosse sufficiente al momento dell'intervento. Ciò allo di evitare quella che era la più temibile delle complicanze della suppurazione polmonare, l 'empiema. 11 piombaggio oltre che essere una necess1tà, aveva anche il vantaggio di collassare quella parte di polmone che sarebbe stata in un seco ndo tempo, durante l'apertura rlella cavità, c quinrli di diminuirne la circolazione. Non vogliamo affatto sostenere che attualmente si possa sempre (are a meno del piombaggio nella ch;rurgia conservatrice, solo d1ciamo che ora, con gli antibiotici a disposizione, ci permettere ii in particolari condizioni, di drenare !"ascesso a pleura libera, pre\'ia fissazione del polmone alla parete con punti, cioè eli marsupializzare.
Comunque ai nostri giorni il campo è dominato dalla chirurgia di exeresi sia nelle forme acute ribelli al tratt amento medico, sia nelle forme cro nich e e vorremmo rlire che l 'a tti vità rlel chirurgo si esplica quasi esclusivamente sulle forme croniche.
Abbiamo precedentemente parlato di cure rn:::dichc protratte, di guarigioni illusorie, ecc. ed abbiamo ancora una volta insistito sulla necessità della cura chirurgica dopo 6 al massimo 8 settim:me di inutile medi::o. 1\ia che cesa succede di questi ammalati t]Uando giungono al chirurgo al limite del tempo? Se l'espettorato è abbondante, se come si Htol dire ii caso è umiòo, il clmurgo è portato ad attendere poichè la prognosi operato ria è, per qucstv fatto, meno buona e poichè il blocco del bronco durante l'intervento, allo scopo di imp edire la fuoriuscita del le secrezioni, è infido, specie a destra. Naturalmente nell'attesa si continua con la cura medica. Ne risulta quindi fatalmente, in molti di questi casi, uno sl ittamento verso la forma cronica Però il chirurgo sa che deve rompere gli indugi appena la forma tende anche minimamente ad estendersi e perciò richicrle che questi ammalati siano sotto il suo controllo.
Vogliamo da ultime ricordare brevemente una terapia coadiuvante su lla quale noi insistiamo molto, cioè sul rlrenaggio posturale.

201
Anche in questo campo non vi è nulla di nuovo, so lo qualche cosa di dimenticato.
n drenaggio va praticato alm eno un paio di volte al giorno, lontano dai pasti per evitare il vomito e va mantennto per almeno un'ora. Può dar si che alle prime applicazioni il paziente non tolleri la posizione obb ligata per un tempo così lungo ma con il passare dei giorni si arriva facilmente a tale limite. Naturalmente non va applicato in presenza di emoftoe e va sospeso subi to se l'emoftoe compare.
Per il drenaggio dei segmenti superiori dei lobi superio r i il paziente sarà sed uto con il tronco leggermente inclinato verso il bto oppos to a quello della lesione, per i segmenti anteriori sarà in decubito ventrale con l'emitorace malato S<Jllevato da cuscini in modo che la posizione venga later a lizzata.
Per il drenaggio del lobo medio ii paziente deve essere supino con un cuscino sotto alla parte destra del corpo mentr e i piedi del lettino saranno S<Jlleva ti di ci r ca 12- 15 cm. La stessa pos1z1one si usa per la lingula mettendo però i cuscini sotto alla parte sinistra del corpo .
Per i lobi inferiori è consigliabile una pvsizione standard: il paziente è mesS<J di traverso sul lettino e vi si appoggia con l'addom e; il tronco è piegato verso il pavimento con una inclinazione di circa 45 o ed in tale posizione è sostenuto da1 gomiti che poggiano su du e sgabelli; è questa la posizione più faticosa per il paziente c difficilmente viene tollerata per più di mezz'ora. E' perciò opport uno ripetere il drenaggio anche quattro volte al giorno. E' sempre bene che il drenaggio posturale preceda ogni introdu:;:.ione di penicillina per via trachea le.
Aggiungiamo ora l 'espos izione schematica di alcuni casi scelti non perchè tipici ma per dare l 'idea dei problemi terapeutici che ci si sono presentati e del modo come li abbiamo risolti.
OssERVAZIONE I (C. Pietro di anni 37). - Ascesso putrido acuto del polmone destro man i festatosi in corso di elettroshockterapia . I p rimi segni della malatt ia risalgono alla metà di settemb r e del 1950. Trattato con pen ici llin a ha avuto temporaneo mig lioramento. La ricomparsa della sintomatologia lo po:ta al ricovero in Clillica i l 31 ottobre 1950. E' stato sottopos to a drenaggio posturale ed a penicillinoterapia endobronchiale (r3 applicazioni). Viene dimesso i l 6 dicembre 1950 con gi udizio di miglio ramento, migl ioramento che potrà diventare g uarigione a distanza di tempo. (Figg. r , 2).
Pur con ogn i prud enza non si può d isconoscere il risultato della cura medi ca.
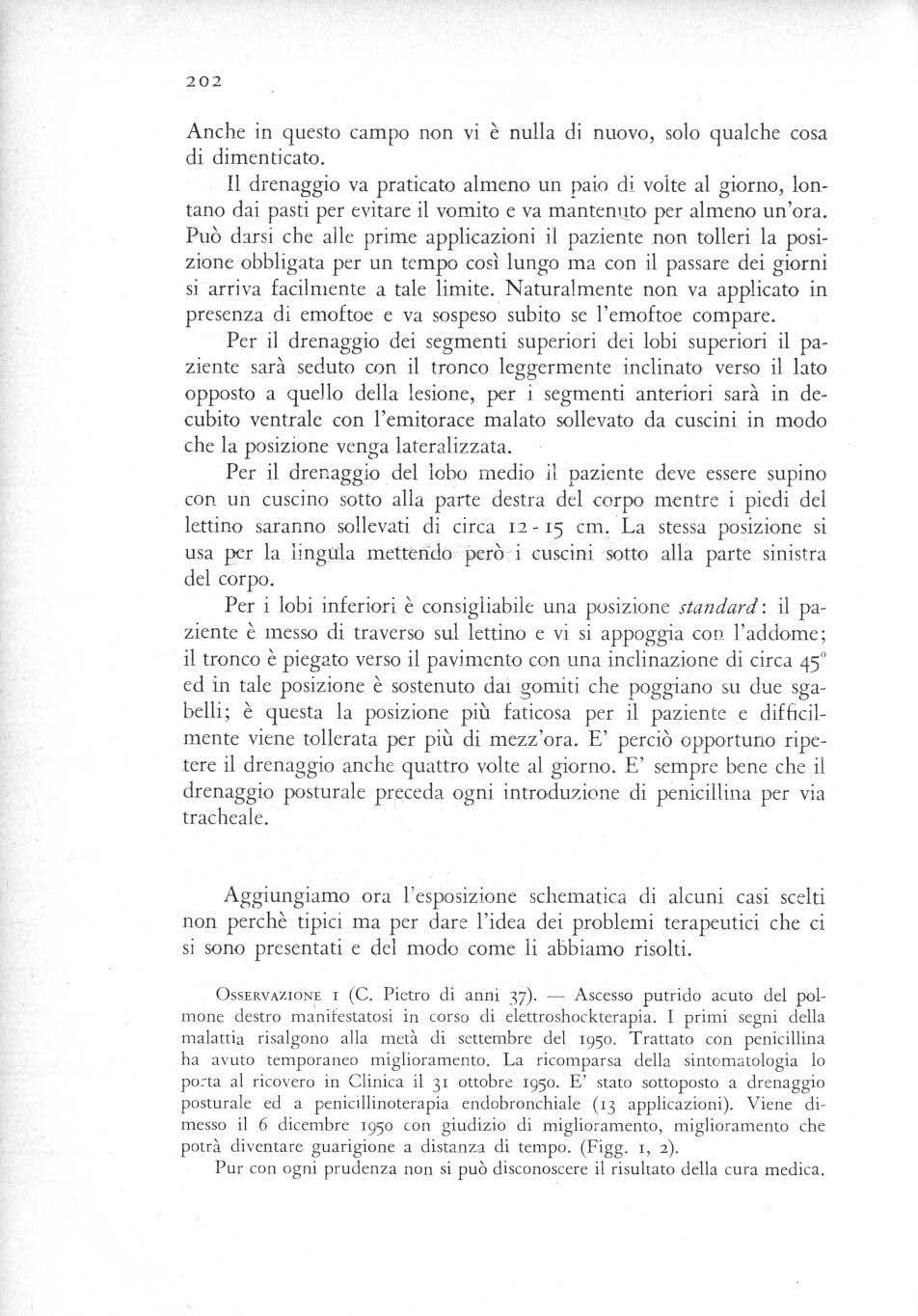
202
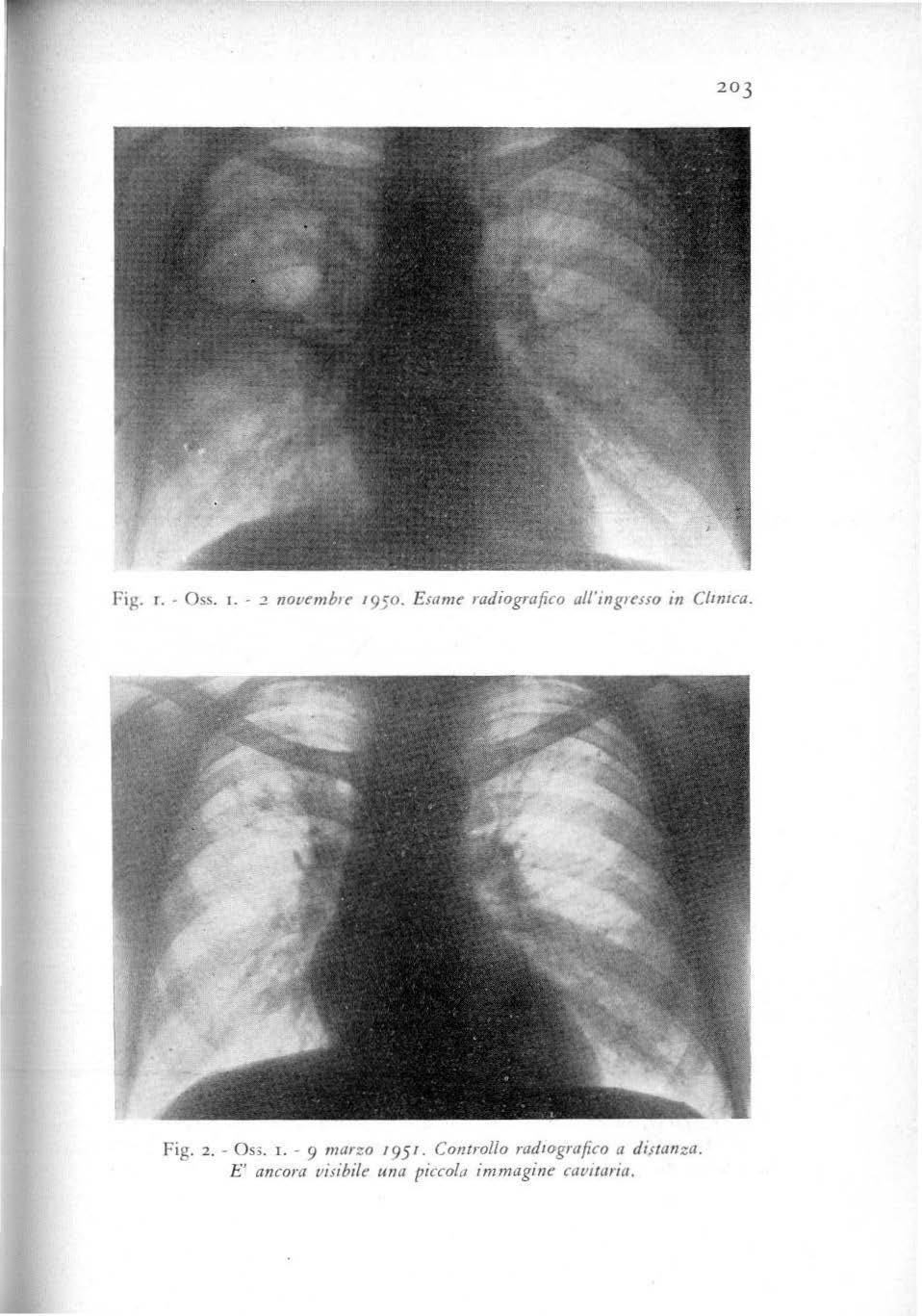
203
r. - Oss. 1. - 2 novemb1e Esame radiografico alf'mg,euo 111 Clnuca.
Fig. 2. - Os;. 1.-9 marzo '95'· Comrollo radiografico a distanza. E' ancora visibile una picco/,, immagine cavuaria.
OssERVAZIONE 2 (C. Giuseppe di anni 44). - Suppurazione del po lmone sinistro. La simomatologia risale a circa c inque mesi pnma dell'ingresso in Clinica avvenuto il 14 dicembre 1950. Fu curaro con penicil lina e streptomicina perchè fu sospettata una forma tubercolare in base alle frequenti emoftoe e malgrado la negatività degli esami. All'ingresso si affaccia il sospetto di una forma neoplastica senza che nessuno degli esami praticati (stratigrafia, augiostratigralìa, broncoscopia, esame dell'espettorato ecc.) riesca a confermare una diagnosi del genere. Ci resta però sempre il sospe tto , in considerazione delle difficoltà che può incontrare l'accertamento di tumori del lobo superiore soprattutto se periferici. Si interviene pertanto . il 19 dicembre 1950 con il programma di una pnewnonectomia. A torace aperto una puntura esplorativa della massa dà esito a pus franco, e lemento questo senza particolare significato. Si incide allora la massa cadendo in una cavid che sembra quella di un, comune ascesso. Pertanto si decide di drenarla. Si introduèe una Pezzer nella cav ità le cui pareti vengono dapp rima chi use a tenuta attorno al tubo e poi fissate alla p leura parietale nella zona di fuoriuscita del drenaggio. Si fa espandere il polmone e la dilatazione viene mantenuta con un altro d renaggio dec live collegato con l 'aspirazione continua.
Il paziente viene dimesso guarito il 22 gennaio 195r. E' stato recentemente controllato; possiamo mantenere il g iudizio eli gua rigio ne. Si tratta in definitiva di un drenaggio a pleura l ibera, in un tempo. (Figg. 3, 4, 5).
OssERVAZIONE J (P. Luigi di anni 43). - Suppurazione cronica del lobo inferiore destro consecut iva ad intervento eli resezione gastri ca. La sin tomatologia ascessuale risale all'agosto 1948. E' staw sottoposto ripetutameme a penicillinoterapia. Viene ricoverato in Clinica il 13 lug lio 1950. Preparato all ' intervemo con drenaggio posturale e penicillina int rabronchia le viene operato il 20 novembre 1950 di lobectomia inferiore destra . (Figg . 6, 7, 8).
OssERVAZIONE 4 (L. Anton io di anni 45). - Suppurazione de l lobo inferiore sin istro con predominante componente bronchiettasica, forse anche bronchiettasia suppurata . I primi sintomi risalgono a tre mesi prima del ricovero avvenuto il 2 ottobre 1950. La presenza di evidenri bronchiettasie ci ha portato subito verso l'imervemo eli excresi cd il drenaggio posturale unito a qualche applicazione eli penicillina intrabronchiale ha avuto uno scopo puramente prepara· torio. Operato di lobectomia in te r iore sinistra il 2') novembre 1950. (Figure 9, IO, II).
OsSERVAZtONE 5 (D i R G iovanni di anni 41). - Suppurazionc cronica del lobo s uperiore destro. La sintomatologia risale al gennaio 1949. E' stato trattato ripetutamente con penic illina ed ha attraversato periodi di calma e di ricaduta. Entra in Cl ini ca il 2 ottobre 1950 e viene trattato con drenaggio posturale e penicillina intrabronchiale che portano ad un certo miglioramento. Viene operato il 16 genna io 1951 di lobectomia superiore destra. Le radiografie dimostranG chiaramente il risultato ottenuto. (Figg. 12, 13, 14).
OssERVAZIONE 6 (V. Eliseo di anni 39) - Suppurazione del polmone Sll1 1stro. La risale a tre mesi prima del ricovero in C linica avvenuto il 6 dicembre 1949. Mal grado lo scarso miglioramento la penicillina è stata
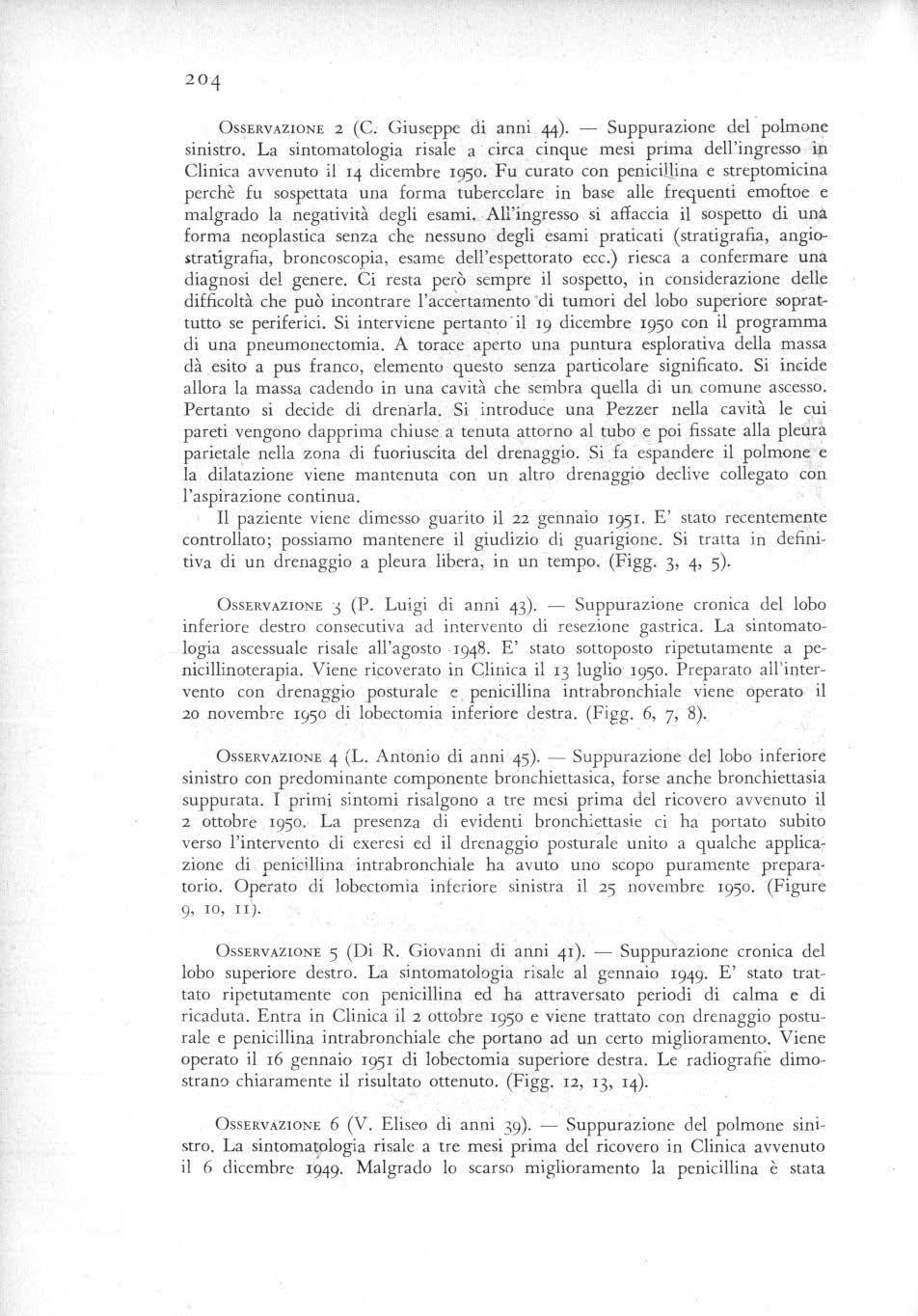
continuata oltre i limiti rag10nevoh ed il p. all'ingresso in Chnica presentava una suppurazione diffusa del lobo superiore con anche del segmemo superiore del lobo inferiore. E' nato operato di pneumonectomia sinistra i l 12 gennaio 1950. Si è recentemente per il controllo ed è in ottime condizion i . 15, 16, 17).
Oss llRVAZ I O:-!E 7 (A. V tncenzo Ji anni 39). - Suppurazione diffusa del po lmone destro. La sintomato logia data da tre anni. Curato ripctutameme con penicillina ha attraversato i soliti periodi di miglioramento e ricadma sino al ricovero in Clinica avvenuto il 3 marzo 19)0. Si è resa necessaria una pneumoncctomia destra (6 magg:o 1950) data la diffusione plurisegmentaria della forma morbosa. E' stato controllato re.::entemente ed è in ottime condizioni. (Figg. t8, 19, 2o).
OssERVAZIONE 8 (De A. Gio' anni di anni 50). - Suppurazionc cronica del polmone destro. La simom:nologia risale :Jl lugl io 1950. Anche t)ucsto paziente (: st:lto sottoposto ripetutamenrc a pcnicillinotcrapia prima del ricovero avvenuto l' t 1 novembre 1950. Tutti gli esami praticati non hanno portato a confermare il sospetto clinico d i tumore del polmone. Anche per questo sospetto siamo stati portati ad una pneumonectomia (8 gennaio 1951) che però era pienamente data l'estensione del processo patologico. Kel controllo postoperatorio, che riproduciamo, è ancora presente scarsa quantità di liquido in pleura, liquido che è stato s,·uotato pnma di dimettere il paziente. recentemente è in ottime condizioni cd il l3\0 è asciutto. (Figg. 21, 22, 23).
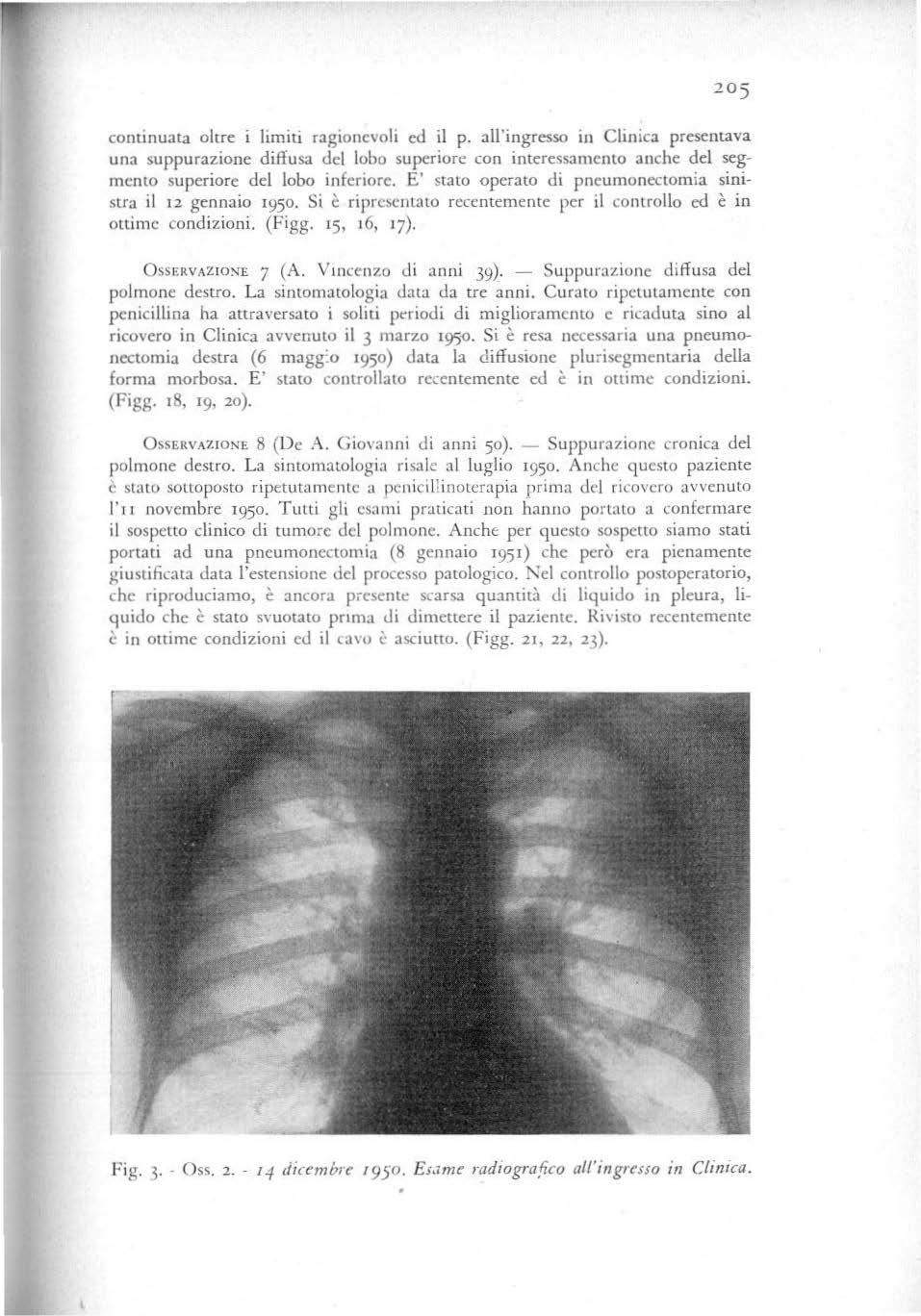
20)
Fig. 3·- Oss. 2 - 14 dicembre 1950. Es,une rad,ogra.fìco all'ingreuo in Climca.
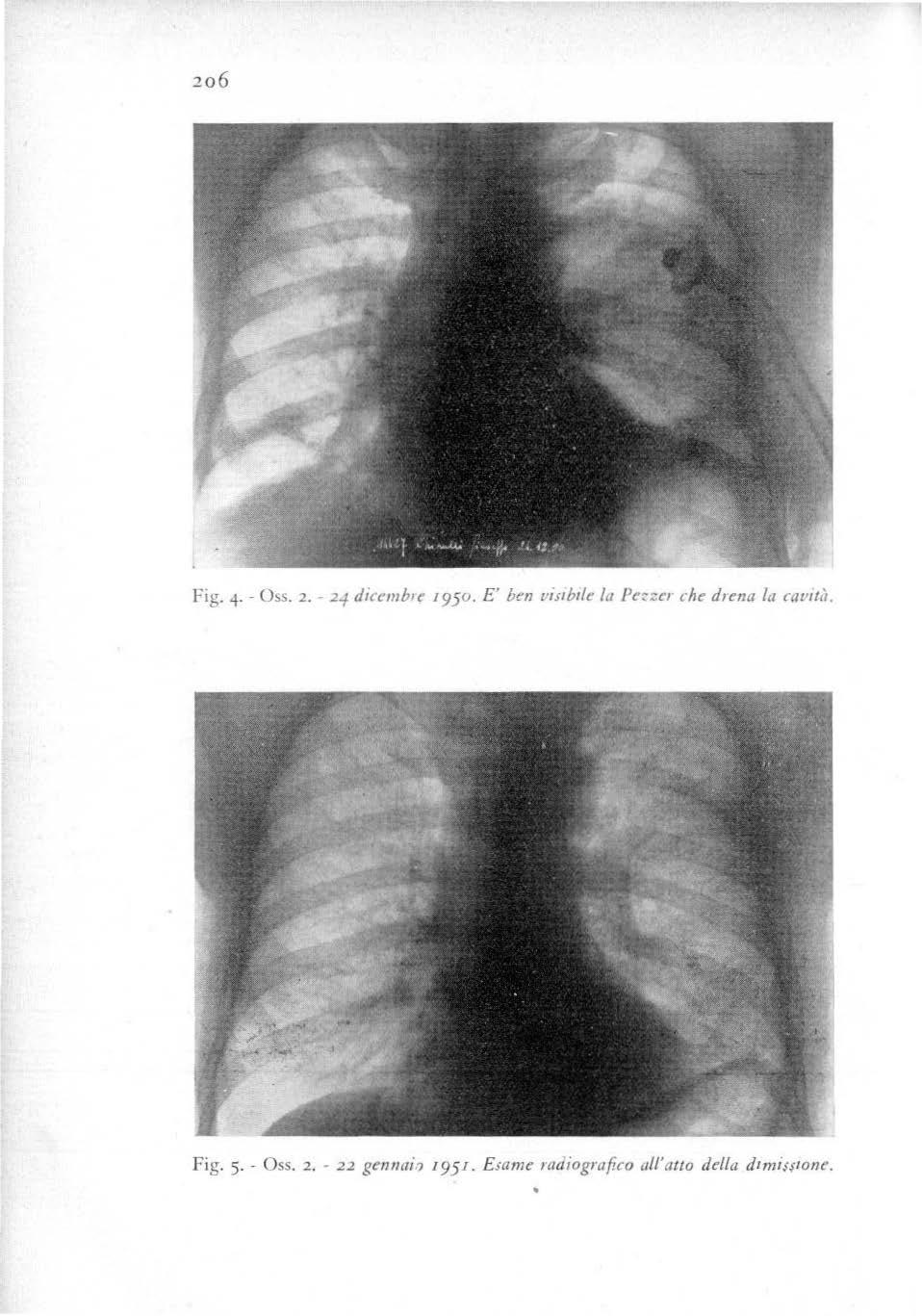
206
Fi g 5· - O ss 2 - 22
Fig. 4· · 2.- 2-f diremb•e 1950. E' ben t•is1btle la Pe::-:e1 che d1ena la nmttì.
gennai.? 1951. E sa me waiografiro all'atto della d1miss1one.

207
Fig. 6. - Oss. 3· - :8 ottobre 1950. Esame radiogmfìco, in corso di trattamento medico preparatorio all'in tervento.

208
Fig. 8.- Oss. 3· - 22 febbraio 1951· Ccmtrollo a tre mesi dall'itztervento.
Fig. 9· - Oss. 4· - 22 novembre 1950. Esame broncografico.
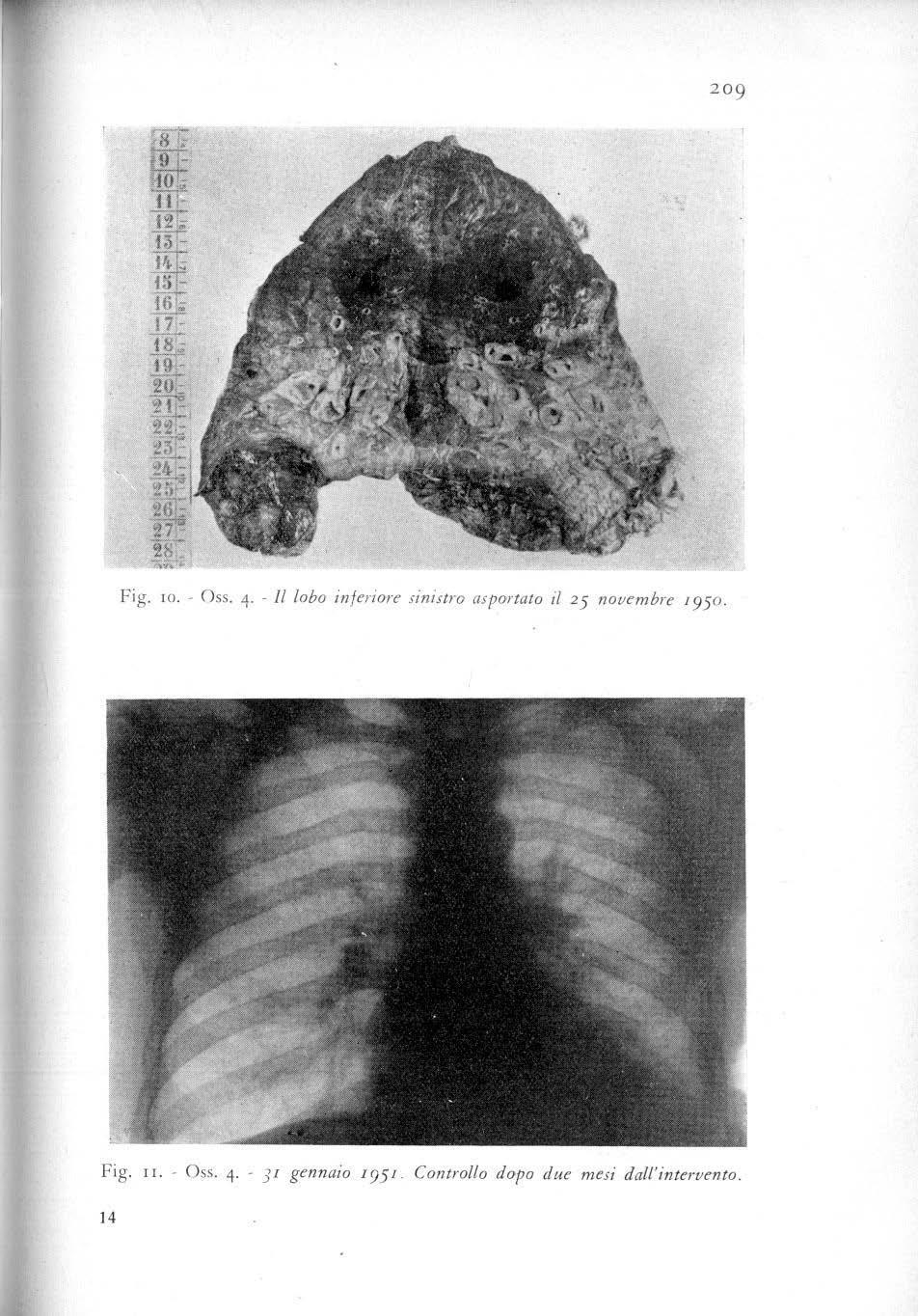 Fig. 10. - Oss. 4·- 11 lobo inferi ore sinistro asportato t! 25 novembre 1950 .
Fig. 10. - Oss. 4·- 11 lobo inferi ore sinistro asportato t! 25 novembre 1950 .
14
Fig. 11. - Oss. 4· - J L gennaio I 951 Controllo dopo due mes i dall ' i11tervento.
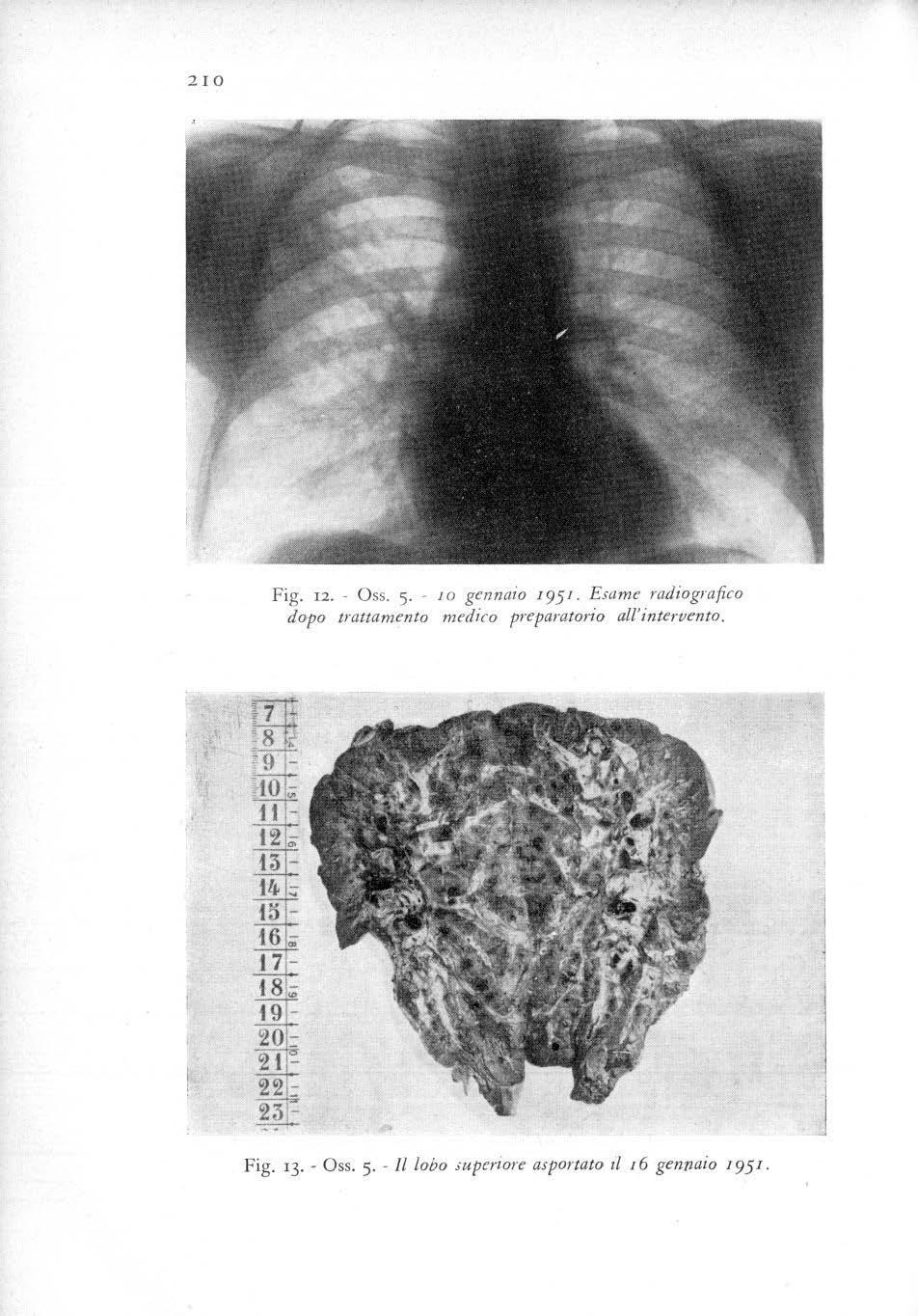
210
·wt.; TITm i3lit 711 i9 l#t=
Fig. 12. - Oss. 5· - 1o gennaio J 951. Esame radiografico dopo trattamento medico preparaton·a all'intervento.
f7n ! 9 l-
Fig. 13.- Oss. 5·- Il lobo .;uperiCFre asportato t! 16 gennaio 1951.

2 I I
Fig. 14. - Oss. 5· - 9 marz o 1951. Controllo a drstanza dalla dimtSSrone.
Fig. 15. Oss. 6. -7 drum bre 1 949· Esa me radiografico all'ingresso rn Climca.
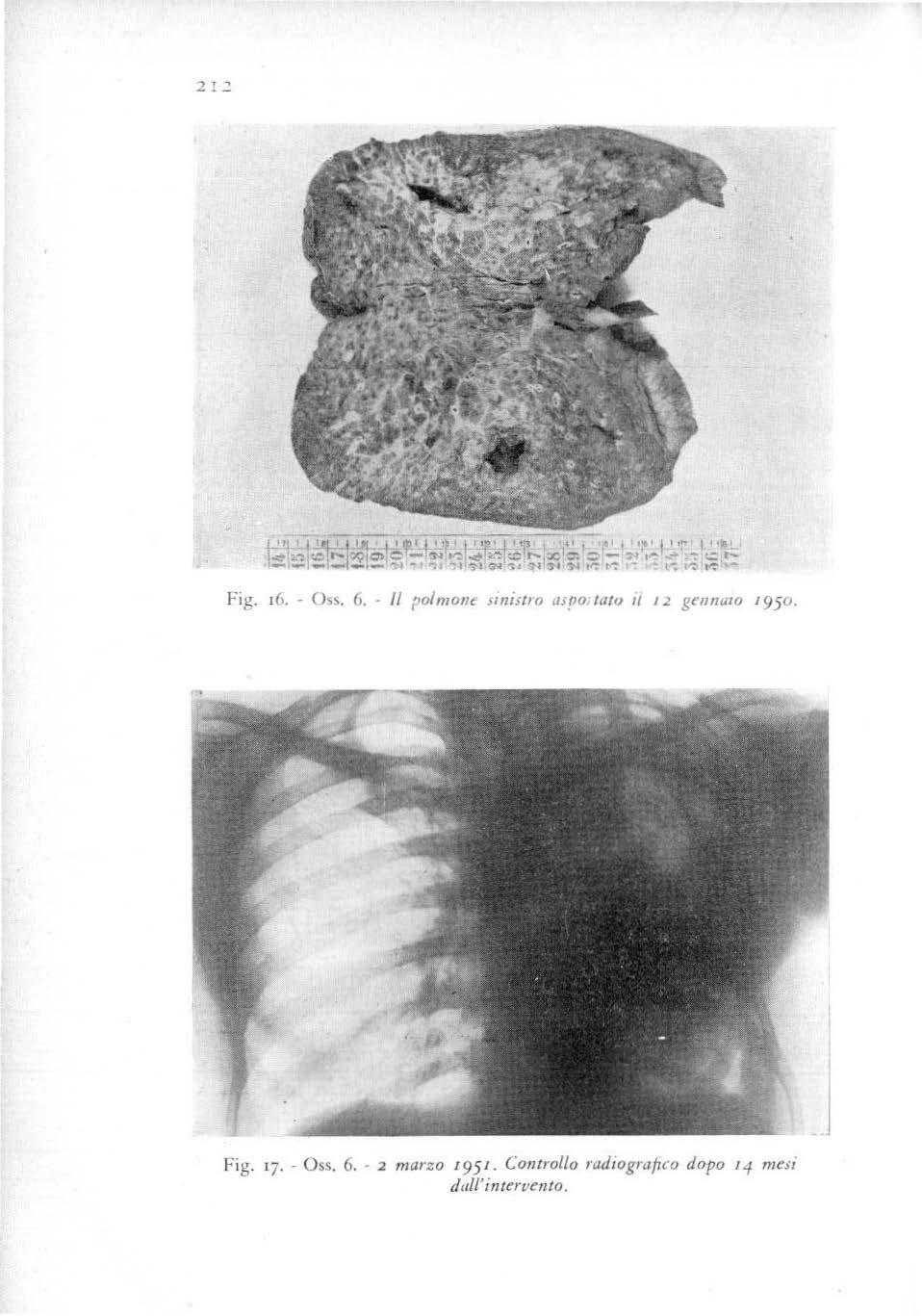
212
Fig. 16. - 6. - Il pol mone sznistro <iifJO 1<1/IJ 11 12 genJUJIO 1950.
Fig. 17. - Oss. 6.- 2 marzo 1951. Controllo radiografico dopo 14 mes1 dall 'imer vento.
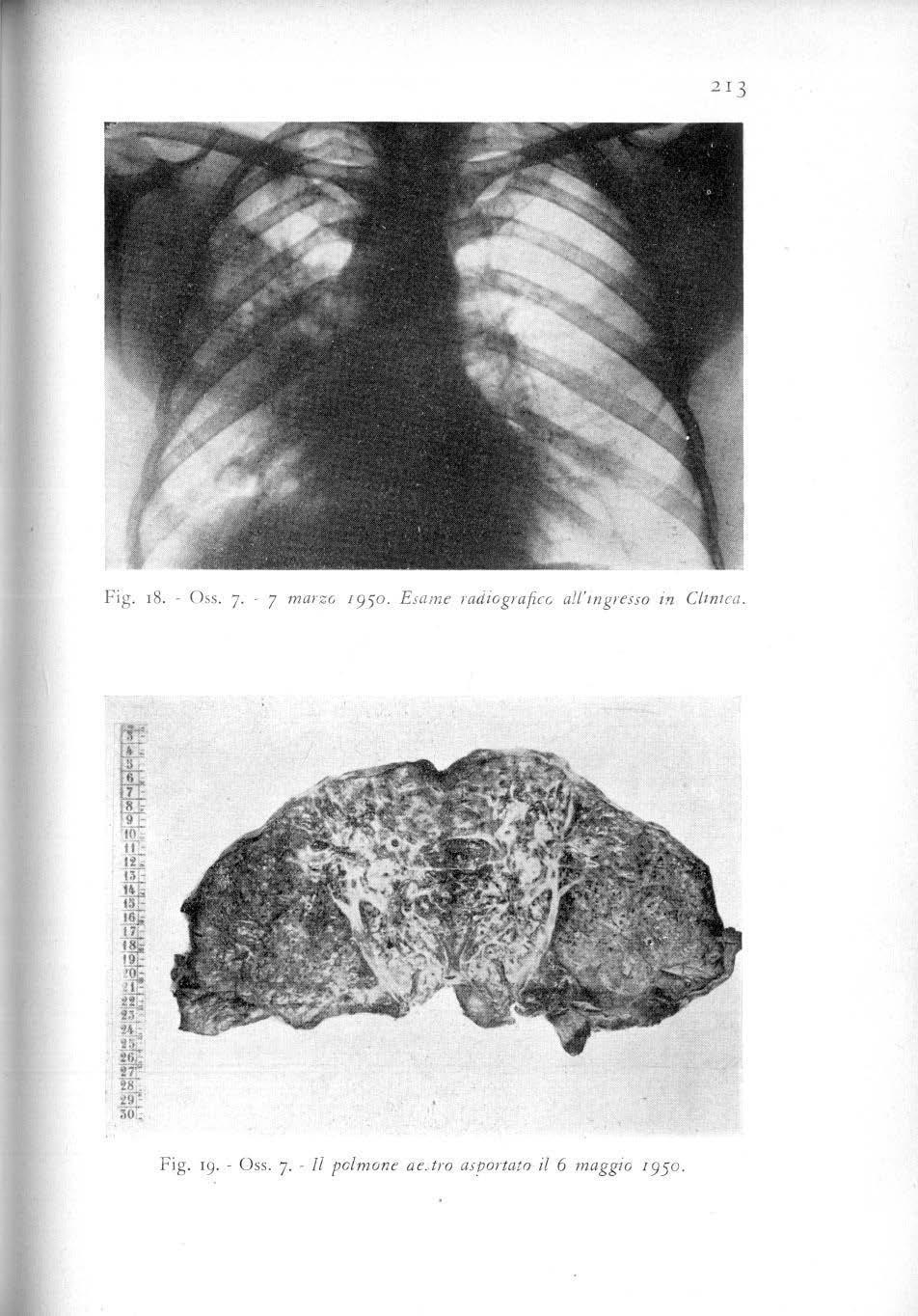
213 Fi g . 18. - O ss . 7- · 7 marz c '9)0 . E Jnme radrcgraficr- a!l'lllgresso 111 Cltnt ca
Fig. 19.- Oss. 7- - Il polmone ae.tro asportato il 6 maggio 1950.
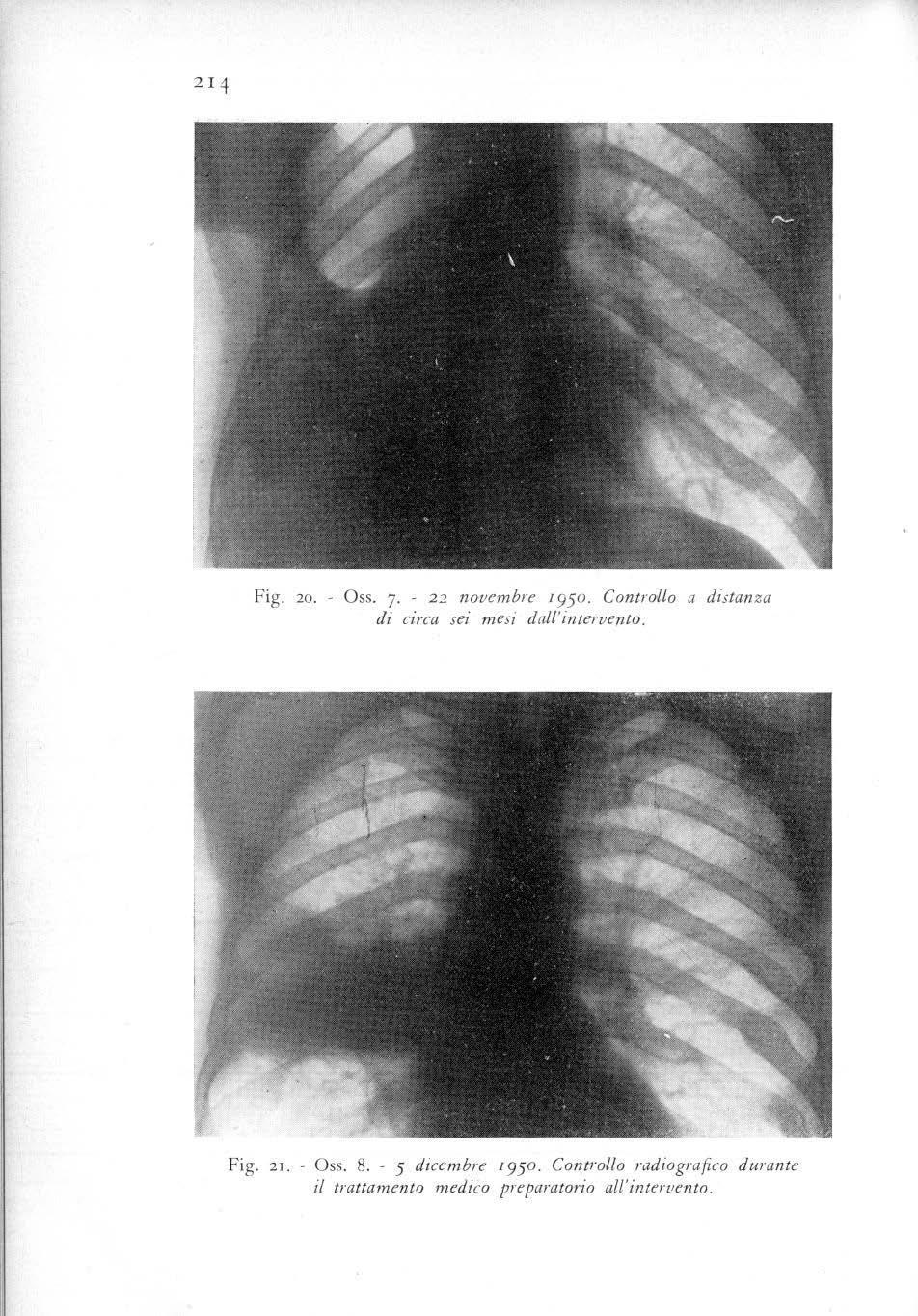 Fig. 20. - Oss. 7· - 22 novembre 1950. Cont1·olto a distan z a di circa sei mesi dall 'intervento.
Fig. 21. - Oss. 8. - 5 dicembre 1950 Controllo radiografico durante il trat.tamento medic o preparatorio al/'interuento.
Fig. 20. - Oss. 7· - 22 novembre 1950. Cont1·olto a distan z a di circa sei mesi dall 'intervento.
Fig. 21. - Oss. 8. - 5 dicembre 1950 Controllo radiografico durante il trat.tamento medic o preparatorio al/'interuento.
 Fig. 22. - Oss. R Il polmone des tro a.· portato 1'8 gennato 1951
Fig. 23. - Oss. 8. - 26 genna to 1951. Controllo radtografico pochi giorni dopo la dimissio-ne.
Fig. 22. - Oss. R Il polmone des tro a.· portato 1'8 gennato 1951
Fig. 23. - Oss. 8. - 26 genna to 1951. Controllo radtografico pochi giorni dopo la dimissio-ne.
breve disarn:n:! ci sembra per orient are su quelle che oggi riteniamo le linee fondamentali della terapia delle wppurazioni po lm onar i.
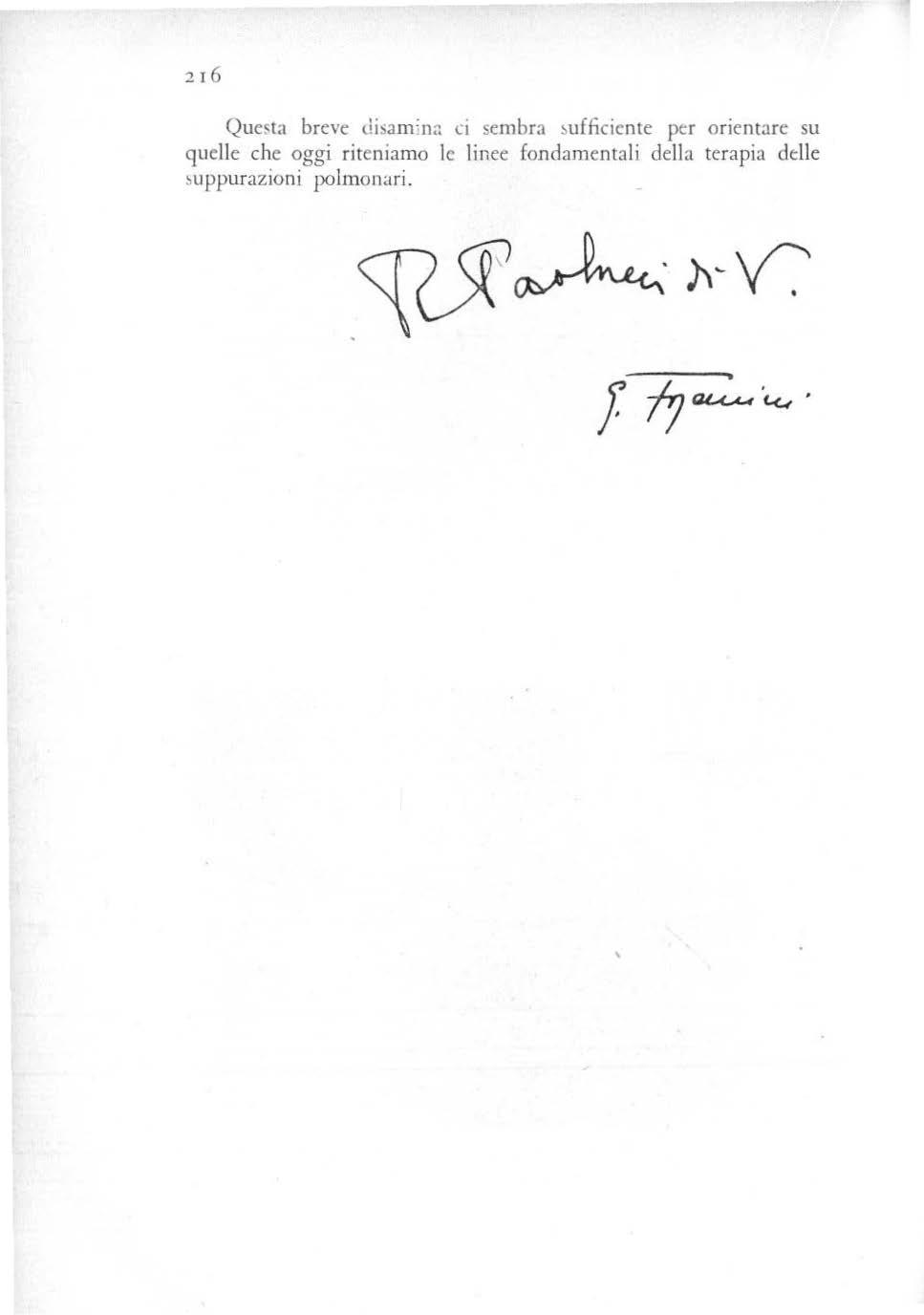
2r6
SI GN I FI CA T O E PORTATA DE L L ' IN T ERVENTO
IPOF ISAR I O NELL ' EUNUCO I D I SMO I PER SOM I CO
Sv1luppo somatico c sviluppo genitale sogliano procedere in armonico parJIIelismo sia in condizwni normali sia in buona parte delle patologiche: l'uno c l'altm attraversano il loro periodo d1 maggiore nel la fase di preparazione puhcrtaria, quasi che ad un c.omunc rcgolaton: spellasse il compito globale di imprimere la svolta cktcrminante c risolutiva a l processo di completamento somatico e dell'individuo: compito attribuito pu comune consenso all'ipofi,i. cui è riconosciuta una pos1zionc Ji prestigiO e di supremazia mi dd le g hiand ole a secrezione
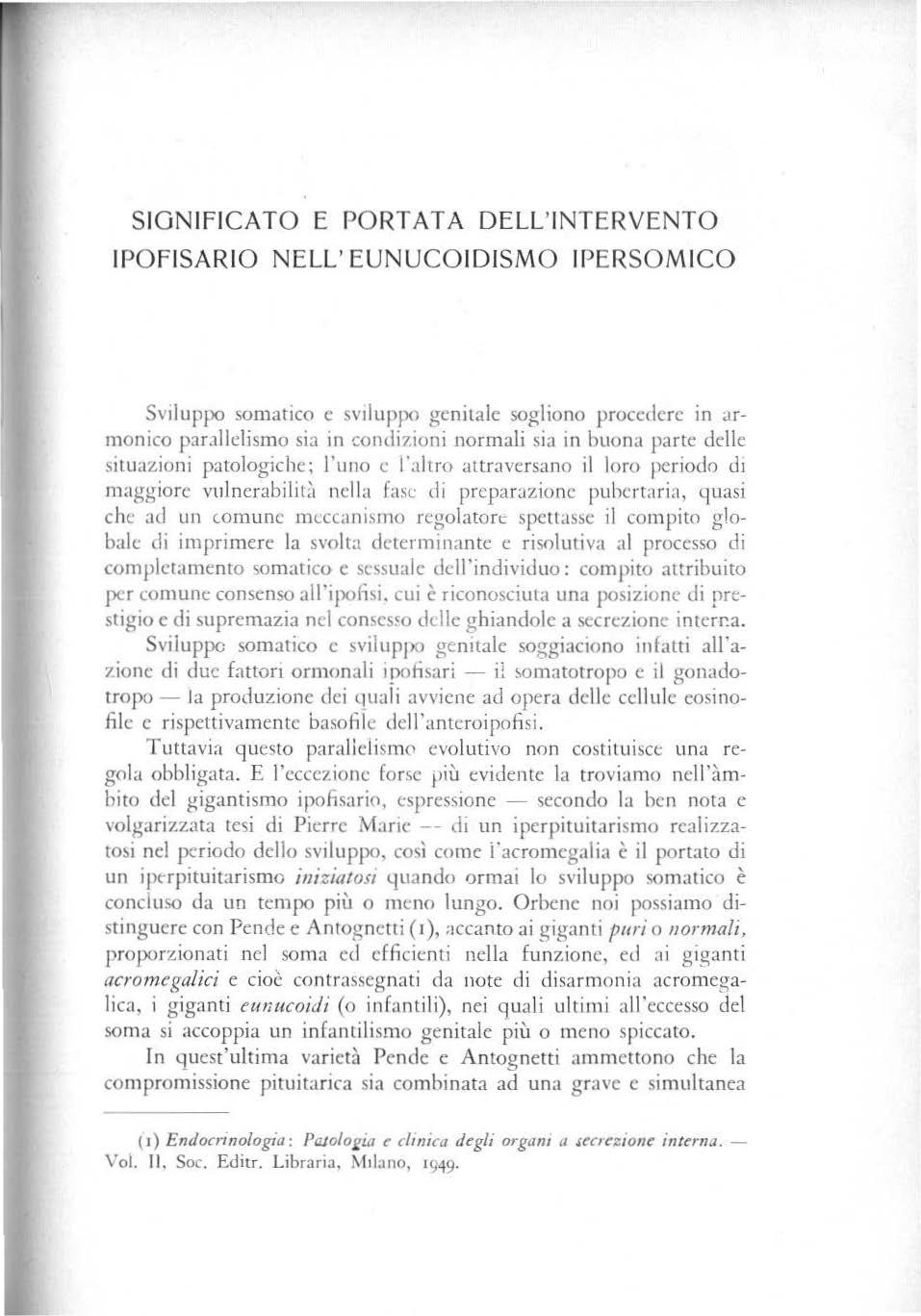
Sviluppo som:1tico c sviluppo gemtale soggiac10no infatti all'a7ione di due fatton ormon:1li 1pofisari - il e il gonadotropo - la produzione dei quali avviene ad oper a de l le cellu le eos lnofilc c rispettivamente basofile dcll'ant eroipo fìs i.
Tuttavia questo paralle l ism0 evolutivo non CO!>tituisct una regola obbligata . E l'ecc ezione forse più evidente la troviamo nel l'àmbito del gigantismo ipofisario, espressio ne - secondo la ben nota e \Olgarizzata tesi di Pierre Marie di un iperpituit,trismo realizzatosi nel periodo dello sv1luppo. così come i'acromcgalia è il portato di un iptrpituitarismo ini ziatos1 quando o r mai lo sviluppo so mati co è conciuso da un tempo più o meno lungo. Orbene noi possiamo disting uere con Pende e Antogn cni (1), ai g iganti puri o normali, proporzionati ne l soma ed efficienti nella funzione, cd ai giganti acromegal ici e cioè co ntr assegnat i da no te di di sa rmon ia acromcgalica, i gigan ti eunucoidi (o infant il i), nei qua l i ultimi ;d i ' eccesso de l soma si accoppia un infantilismo genitale più o meno sp iccato
In quest'ul tima varietà Pende e A ntognetti ammettono che la co mpromissione pituitarira sia co mbinata ad una g ra\' C c si multanea (
1) Endocrinologia: Pa.tolOEW c d mica degli orgam <1 secrez1one interna.Vol. Il, Soc. Editr. Lib raria, HJ49·
insufficienza genitale. « Il gigantismo eunucoide è dunque - secondo questi AA. - una sindrome plurighiandolare ipofisaria-genitale, poichè in esso dominano così i sintomi d'iperpituitarismo (gigantismo vero, con semplice statura ip ernormale), che i sintomi d'ipogenitali(rnacroschelia e deformazione eunucoide dello scheletro, ipogenesia dei caratteri sessuali secondari))).
A questo g igantismo eunucoide, a patogenesi primitivamente pituitarica, è da contrappcrre l'eunucoidismo con note di eccessivo sviluppo corporeo, nel quale f'\ttore primitivo e fondamentale è l'insufficienza endocrina genitale. E' noto infatti che in conseguenza della castrazione interviene una ritardata delle strie carti laginee epi fisarie e quindi il permanere oltre i normali limiti - delle possibi lità di crescita in lunghezza.
E' questa la ragione per la quale non di radò i castrati e gli eunucoidi - al pari degli iperpituitarici - raggiungono stature notevolmente superiori alla norma, pur non raggiungendo i valori staturali dei giganti ipofìsari An.cor più che quantitativa, la differenza fra 1perso mia dei giganti ipofisari e ipersomia deg li eunucoidi è qualitativa, perchè in questi ultimi - mentre testa e tronco res t ano proporziona lm en t e piccoli - sono g li arti (specia lmente inferior i) che prevalgono in lunghezza per il particolare sviluppo dei loro segmenti distali (avambracci e gambe) .
Se comunque la discriminazione di principio può apparire agevole, nella pratica non sempre facile è distinguere fra giganti eunucoidi ed eunucoidi ipersomici; il ch e eq ui va l e a prender posizione sul terreno patogenetico fra pr imarietà del fattore ipofisario o di quello genitale.
E' questo il punto che a me partico larmente inte ressa mettere in fuoco, valendo m i di alcuni reperti di cunucoidi ipersomici raccolti negl i ultimi anni.
l. - Il soggetto (R. M., contad i no, da Conselve) è osserv:uo in età d1 28 anni. Lo svi luppo somatico, mantenutosi UQ po' tardiYo fino ai 20 anni, ha subìto un notevo le impulso f ra i 20 e i 22; sv iluppo psichico sempre un po' torpido. Riformato per ins uffi cienza toraci ca . Confessa uno sca rso i nteresse per il sesso femm inile; ha cominc iato a masturbar si intorno a i l'l ann i.
Obbiettivamente i l paziente (fig. r) si presenta come un longi lineo as tenico , notevo lmente magro; la pelle è morbida e sotti le; il sistema pilifero è scarso e ridotto al monte del pube. I testico l i hanno le dimension i di una piccola nocciola; la verga è di d imen sio n i cons iderevolmente ridotte. Altezza: m. 1,80. Peso: kg. 62. Pressione art. (R.R.): nof 8o. La radiografia de l cran io dimostra una sella turcica di dimensioni molto picco le a pareti regolari ; la

218
ricerca delle cartilagmi epifisanc ai ginocchi cd ai polsi melle in e\'idenza baia teralmente una stria densa all'epifisi distale del radio (fig. 2).
Ricambio ba5ale sensibilmente ridotto (-:;"o; - 20', 2 n, ). Cur\'a glìc:cmh.: a da c:tr ic o pi:tlla (a: t,aa; 1,14; a,aa; a0 fu 11 cnuo 2 ore e mc.,z:t). Curva da in su l ina (ro U; fino a 3 ore c mezza dopo) caratterizzata da perdurante inflessione dopo iniziale rialzo (a: 1.37: o,7o; O,)O; 0,5 1 ; o.65).
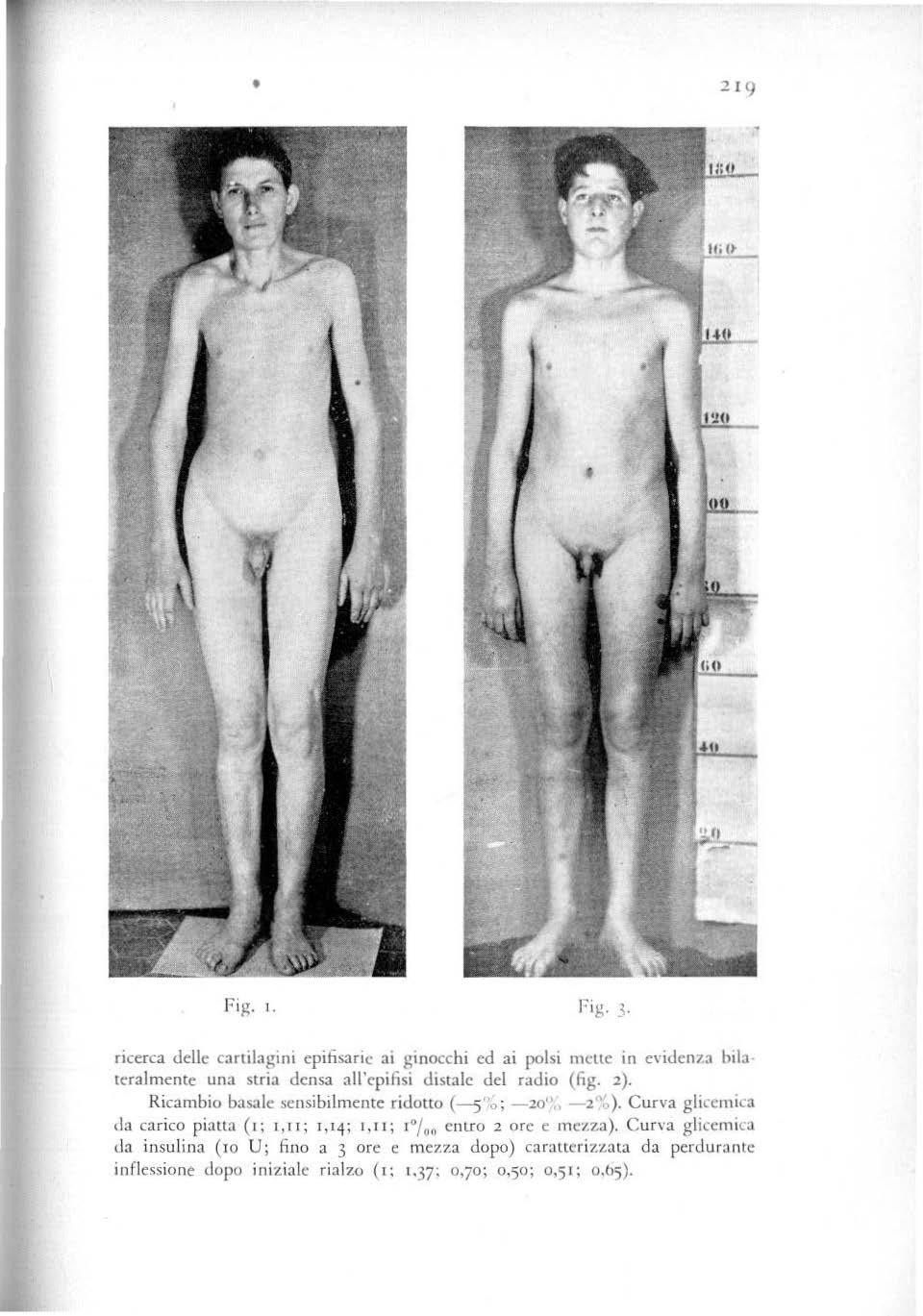
•
Fig. 1.
Fig. 3·
II. - Soggeuo di 20 anni ( M. E., ope rai o, da Verona). Sviluppo in altezz" notevolmente spiccato dai 15 anni in po i. Sviluppo psichico buono; desidererebbe partec ipare ag]j svaghi de1 coetanei, ma se ne astiene per un senso di permanente inferiorità Non ha appetito sessuale; tenta tullavia Ji masturbarsi, senza però pervenire all'eiaculazione . Presenta or ientamento ncuamentc longil in eo (fig. 3), ma le sue forme sono arrotondate per una certa pastos ità della cute e per una cena ricchezza dell'adipe sottocutaneo. L'aspetto è infantile; glabra la faccia. Scarsa peluria al pube. Testicoli delle ditmnsioni di un fagiuolo; verga piccola e sotti le. Altezza : m. 1,79- Pe.-o: kg. Press:onc aneriosa (R.R.) : ros f 8o
Ricambio basale: + 1,7",, . Normale il reperto radiografi co della sel la. Cun-a g li cemica da carico con sensibi le cuspide in prima fase (o,87; 1,6; 1,33; r; o,r; t '\,).
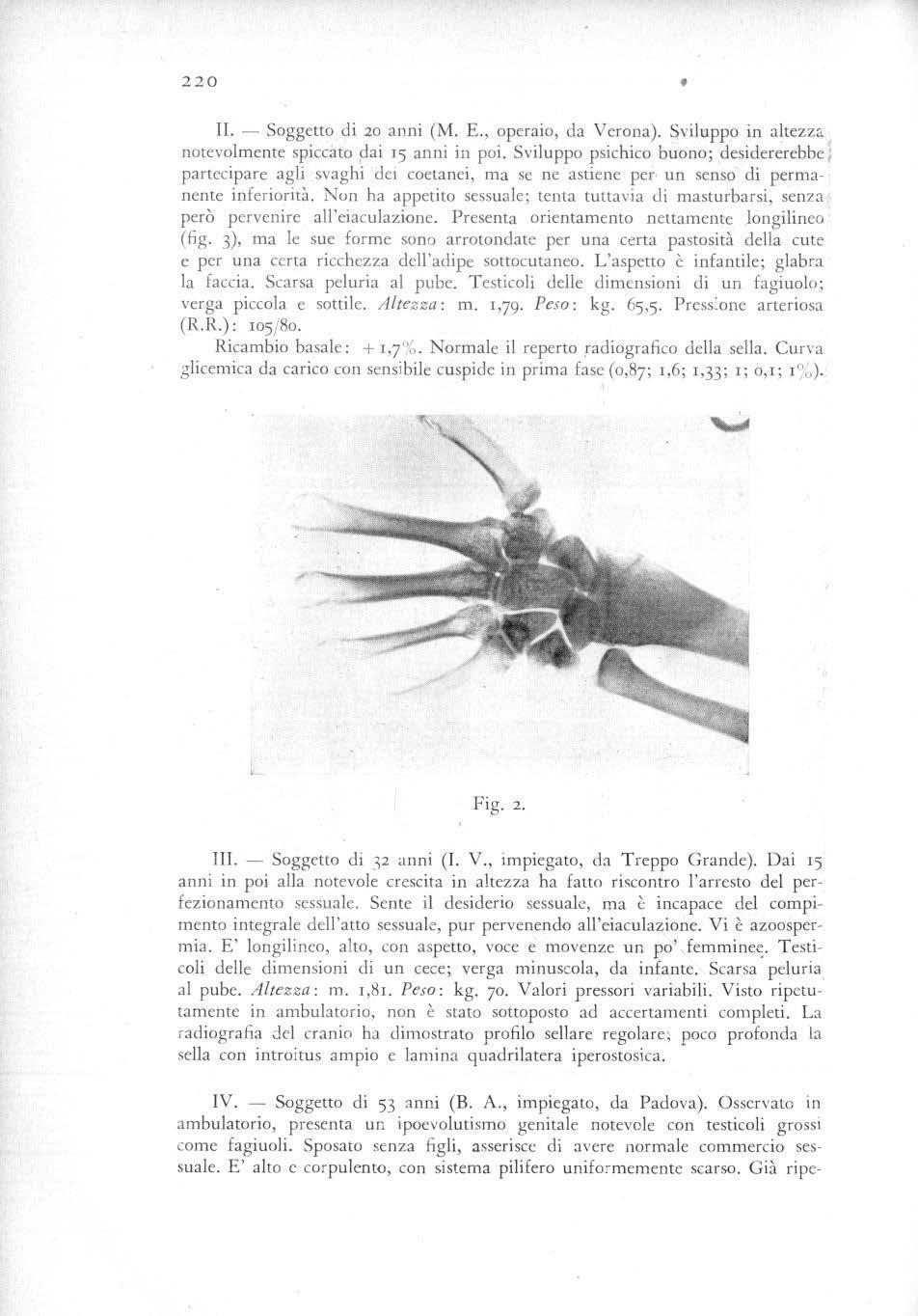
HL - Soggetto di i2 anni (T. V., imp iegato, da Treppo Grande) Dai 15 anni in poi alla notevole crescita in altezza ha fauo riscontro l'arresto del perfeziona m ento sessuale. Sente il desiderio sess ual e, ma è incapace de l compimento dell'atto sess ual <:, pur pe r venendo all'eiaculazione. Vi è azoospermia. E' loogìlinco, alto, con aspetto, voce e movenzc un po ' Testico li delle dimensioni di un cece; verga minusco la, da infante. Scarsa peluria al pube. Altezza: m. 1,81. Peso: kg. 70. Valori pressorì variabi l i. Visto ripet utamente in ambulatorio, non è stato sottoposto ad accertamenti completi. L a rad iografia Jcl cran io ha dimostrato profi lo se llare rego lare; poco profonda la se lla con intro it us ampio e lamin a i pcrostosica
IV. - Soggetto dì 53 anni (B. A., impiegato, da Padova). Osservato in ambulatorio, presenta un ìpoevolutismo gen itale notevole con testicoli grossi .:ome fagiuoli. Sposato senza fig li, asserisc e di 3\'Cre normale commercio sessual e E' a lto c corpldcnto , con sistema pilifero unifo r memente scarso. G ià ripe-
220 •
Fig. 2.
tutamente curato per ulcera duodenale, è st:.to anche operato per talcolosi colecistica. Interessante è il fatto rhe negli ultimi anni k due mammelle si sono fatte d isc retamente voluminose c dolenti, prima la destra c poi la sinistra; la destra è stata a 11zi in via prudenzia le asportata, cd il suo controllo istologico ha messo i n ev idenza il quadro di un adenoma cistico.
L a mia cas istica, descritta per somm i capi, è dominata da una evidente d isarmonia fra sviluppo genitale e svi l uppo somatiw; spiccatamente de fi c itario il p ri mo, eccede n te sulla media normale dell'a ltezza il secondo . P arlare di «gigantismo '' sarebbe indubbiamente esagerato - · perchè l'altezza è sta t a in tutti inferiore a quella che i tra t tatisti co nsiderano !a c i fra-l i mite, e cioè m . 1,90- a nzi erroneo, perchè la st ruttura scheletrica dci miei soggetti, soprattutto per i caratteri del tronco, per la sottigliezza e lunghezza degli arti ed infine per l'aspetto della sella turcica rimpicciclita o normale è que ll a dei longi! inei astenici.
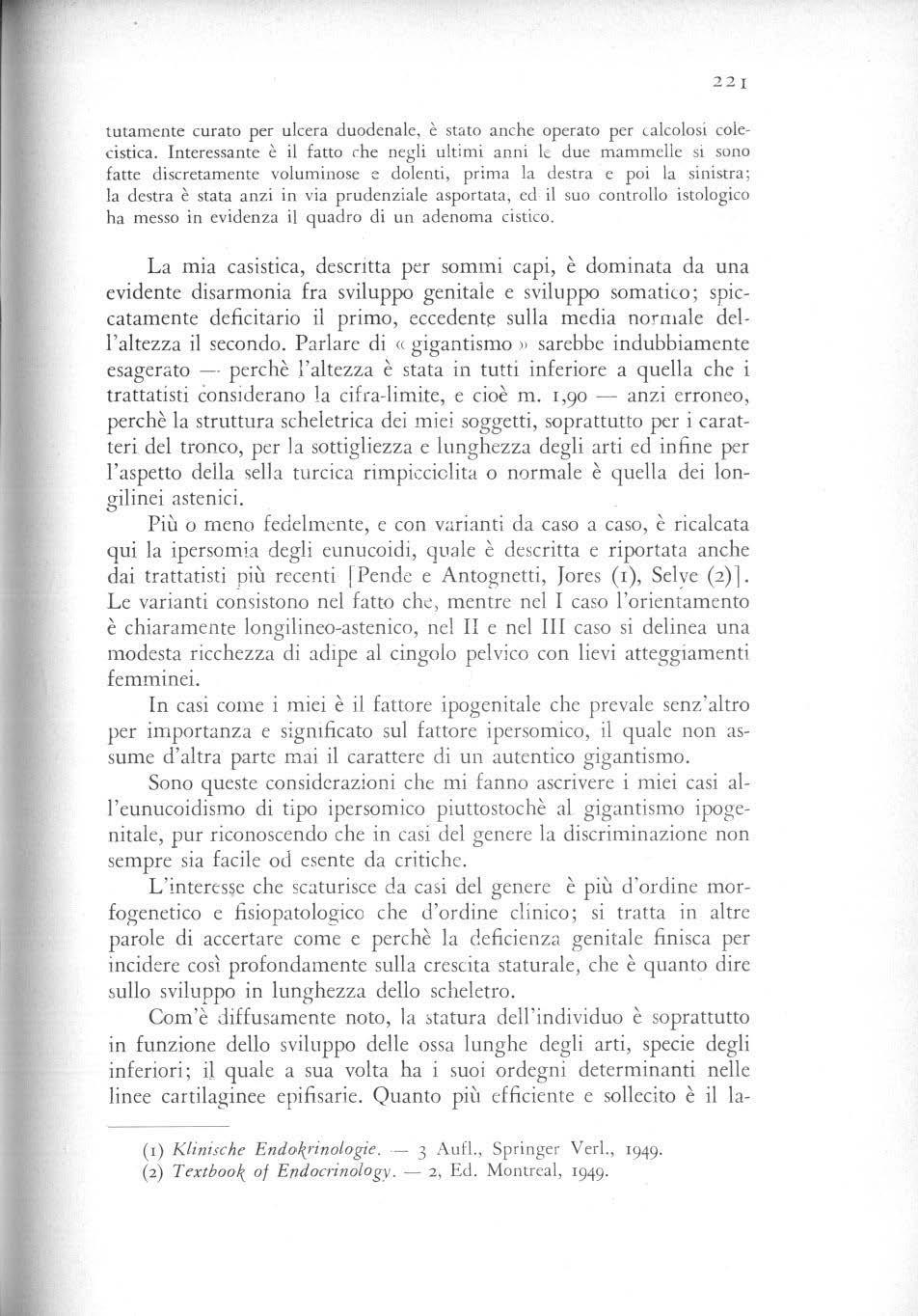
Più o meno fedelmente, c con var ianti da caso a caso, è ricalcata q u i la ipersomia degli eunucoidi, quale è descritta e riportata anche dai trattatisti più recenti l Pende e Antognetti, Jo r es (1), Selye (2)1. Le varianti consistono nel fatto eh.:, mentre nel I caso l'orientamento è chiaramente longilinco-astenico, nel II e nel III caso si delinea una modesta ricchezza di adipe al cingolo pel vjco con lievi atteggiamenti femminei.
In casi come i miei è il fattore ipogenitale che prevale scnz'altro per importanza e sign 1ficato sul fattore ipersomico, il quale non assume d'altra parte mai il carattere di un autentico gigantismo.
Sono queste considerazioni che mi fanno ascrivere i miei casi all'eunucoidismo di tipo ipersomico piuttostochè al gigantismo ipogenitale, pur riconoscendo che in casi del genere la discriminazione non sempre sia faci le od esente da critiche .
L· intertssc che scaturisce da casi del genere è più d·ordine morfogenetico e .fisiopatologico che d'ordine clinico; si tratta in altre paro le di accertare come e perchè la deficienza genitale .finisca per incid:::re così profondamente sulla crcsc.ita staturale, che è quanto dire sullo svi l uppo in lunghezza dello scheletro .
Com'è Jiffusamente noto, la dell'individuo è sopratmtto in funzione dello sviluppo delle ossa lung h e degli arti, specie degli inferiori; quale a sua volta ha i suoi ordegni determinanti nelle li n ee cartilaginee epifisarie. Quanto più efficiente e so llecito è il la-
221
(1) Klinische Endokrinologie. - 3 Aufl.. Springer Veri., 1949· (2) Textbook of Endocrinology. - 2, Eu. Montrcal, 1949.
varo dello strato colonnare cartjJagineo, dal quale si originano i nuovi strati di osso, tanto più spedita è la crescita dell'osso nel suo asse longitudinaJe. Scomparse le linèe cartilaginee delle ossa lunghe - e ciò avviene di norma intorno ai 20 aru1i - la crescita staturale deve considerarsi senz'altro ultimata; finchè questo strato cartilagineo si mantiene attivo, esiste la possibilità di un ulteriore accrescimento.
Può sembrare a prima vista strano che le turbe estreme dello sviluppo in altezza, il gigantismo e il nanismo ipofisario, siano ambeàue contrassegnate da una persistenza - oltre i normali limiti di tempodelle cartilagini epifisarie. Che ciò avvenga per la prima delle due affezioni, non meraviglia, in quanto vale a spiegarci l'eccedenza del potenziale di crescita. Per la seconda è jnvece da invocare un vero « torpore» delle linee epifìsarie, le quali- per dirla con Erdheim (1) - rimarrebbero «co ngelate >' perchè ad esse è venuto a mancare il <<so le degli ormoni l>.
E questi ormoni sono sostanzialmente l'ormone ipofisario della crescenza o somatotropo (di Evans) e l'ormone tiroideo.

Un eccesso dell 'ormo ne somatotropo entra in giuoco in Patologia umana nell'acromegalia e nel gigantismo; in Patologia sperimentale con la somministrazione di questo ormone Evans e poi Teel e Cushing ottennero uno sviluppo gigantesco in ratti e cani. Un difetto dello stesso ormone ricorre invece nel nanismo ipofìsario.
D 'altra parte un deficit di principi attiVi tiroidei - determinatosi nel periodo dello sviluppo - si traduce nel nanismo ipotiroideo, le cui caratteristiche osteogenetiche all'indagine radiologica concordano sostanzialmente con quelle del nanismo ipofìsario.
In qual guisa si completino o si stimolino a vicenda ormone ìpofìsario e ormone tiroideo, non è del tutto chiaro. E' ben vero che le recenti ricerche di Elijal e Turner - dimostranti un certo parallelismo fra ritmo di sviluppo e quantitativo di ormone tireotropo nell'ipofìsi anteriore - orienterebbero nel senso che l'ipofìsi possa· agire essenzialmente per tramite della tiroide; il che in fondo finirebbe per porre in pr i mo ptano quest'ultima in tema dì regolazione de1l'osteo-genest.
Fondamentale tuttavia a me (z) sembra il reperto sperimentale di Evans, Simpson e Pencharz, secondo i quali l a somministrazìone di principi tiroidei normalizza lo sviluppo di animali tireoprivi, ma non
( 1) Fortschr. Rontgenstr., 52, 234, 1935·
222
(z) Moderni orientamenti di fisiopatologia tir oidea. (Relazione al 48° Congresso Soc. it. med. int., Roma, 1947).
di animali ùreoipofiseoprivi. E ' verosimile dunque che dalla armonica e interdipendente collaborazione fra ipofisi e tiroide sorga lo stimolo necessario ad una efficace rcgolazione del ritmo di crescita delle cartilagini epifisarie . Altri fattori che agiscano con eguale efficienza su llo svolgersi della osteogenesi non sono noti nè dimostrabili.
Una riserva potrebbe esser fatta per la possibilità che fattori neuroregolatori intervengano nel promuovere l'accrescimento scheletrico. Gli argomenti finora Jddotti non sono però molto probativi. Molto citato è il caso di acromegalia descritto dal Campailla (1), nel quale l'integrità macroscopica dcll'ipofisi constatata alrintervento operativo suggerisce all'A. una patogencsi mesocefalica della sindrome, su base lu etica; va tuttavia rilevato che in questo contributo non si fa cenno di un controllo istologico ddl'ipofisi; ragion per cui se si può escludere un voluminoso adenoma ipofisario - non si può negare la possib ilità di un incremento proporzionale delle cellule eosi nofil e ipofisarte.
Allo stato attuale delle conoscenze dunque non esistono elementi probativi in favore della presunzione che anche altri organi endocrini - oltre all'ipofisi ante riore c alla tiroide - intervengano a regolare c promuovere lo l>Viluppo scheletrico.
siamo indotti a ritenere già attraverso un ragionamento induttivo che anche l'ecce<.so staturale degh eunucoidi dçbba effettuarsi attraverso questa trafib patogenetica e soprattutto attraverso le ripercussioni indott e dall'ipogcnitalismo sulla composizwne e sulla fun zione del! 'ipofisi.
Ormai a mio avviso (2) de, ·e ritenersi sorpassato l'indirizzo che (accva dell'ipofisi un organo che regolava il ritmo funzionale delle altre ghiandole endocrine in posizione esclusivamente sopraordinata c quindi esente da ogni obbligo di reciprocità.
Dapprima gli istopatologi ci hanno mostrato che l'ipofisi risente profondamente di ogni grave turba delle altre ghiandole ritenute subordinate : gravidanza, menopausa ma soprattutto tiroidectomia e castrazione inducono una profonda trasforma7-ione str utturale che consiste in una alterata proporzione dei nNmali clementi ipofìsari o perfino nella comparsa di categorie cellulari di nuovo conio (cellule della gravidanza, cellule da cast razione , cellule da tiroidectomia). Per quanto riguarda la castraz ione, che a noi particolarmente interessa, sia nei sesso femminile sia in quello maschile a questo inter-
(1) Policlinico (Sez. med.), 74ll, 1934.
(2) Atti lsr. Veneto Scr., 103,
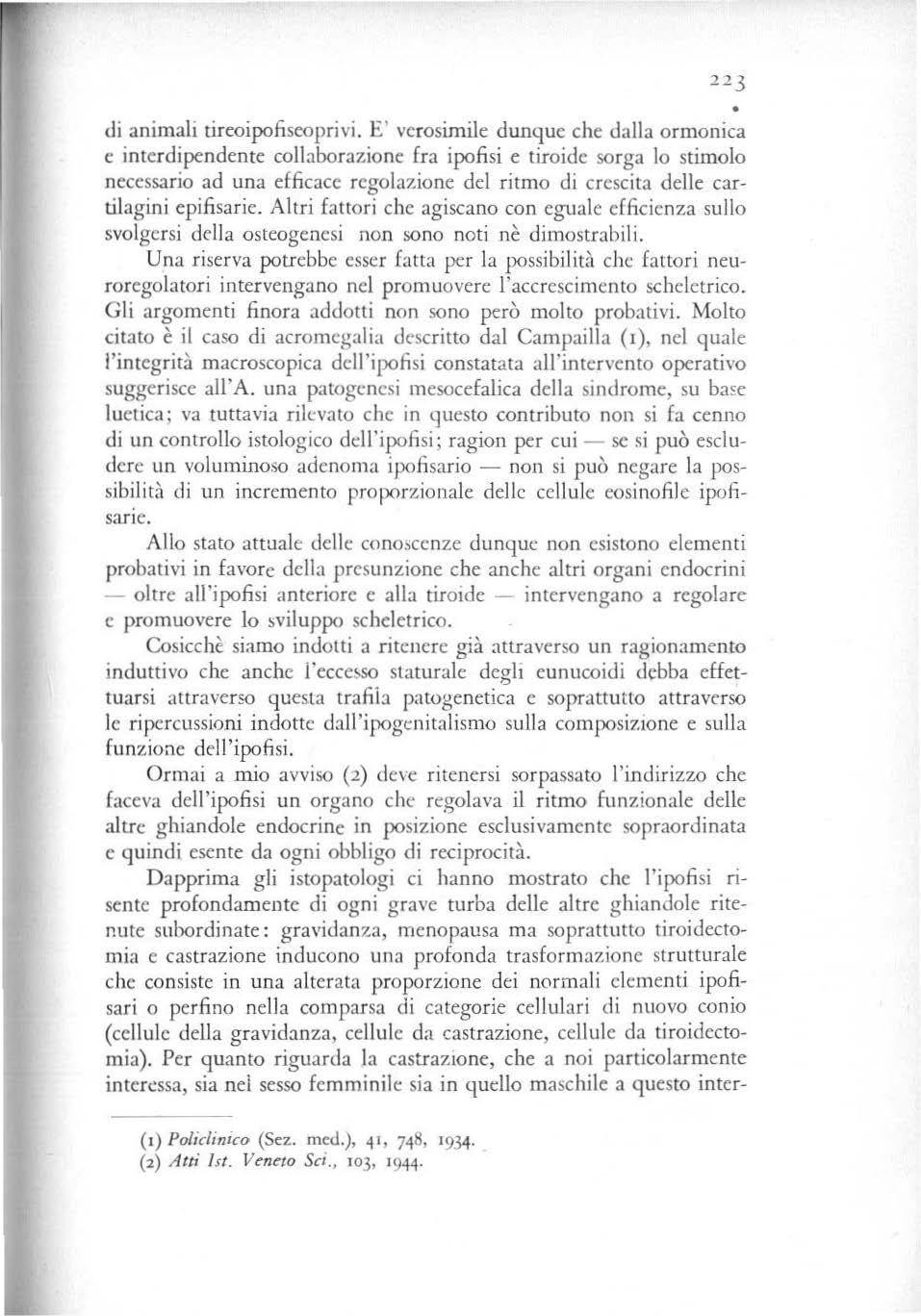
223 •
\ ento segue una tum esce nz:1 dell'ipofi s i, co n aumento numerico delle cell ul e eosinofìle, mentre le basofile sa r ebbero non di rado diminuite di num e ro (Kraus, Be rblinger).
Al reperto istopatologico si è affiancato in un seco ndo tempo <.Juello fisiopatologico. E' ormai assodato infatti che alla asportazione chirurgi ca o al deficit funzionale di un a ghiandola endocrina corrisponde di regola un ir.cremcnto dell'ormone ipofisario glandotropo corri s pon dente (il cosiddetto cc fenomeno della castrazione>> in senso lato: van Dyke, Salte r). Così alla tiroidcctomia e all'ipotiroidismo sp<.mtaneo corrisponde un'aumentata produzione di o rmone tireotropo ; alb castrazione cd al climaterio un aumento delrormonc gonadotropo) c così via.
Dare un giudizio sul s ignificato biologico di qu esta manife stazione reatt iva non è facil e. Qualificarla come un reperto se nza significato cd importanz:1, è tr oppo poco.; ritc nerla come un es pediente compensatorio è forse tro ppo; o per lo meno è con ce tto bisognoso di p robative conferme.
A voler concili:1r<: reperti istopatologici c reperti fisiopatologici dobbiamo conclud::re che il cosiddetto ' fenomeno del\:1 castrazione " tllfficdmente può essere inteso co m e una m anifestazio n e automat icamente c l imita t amente intercorrente fra ghiandola periferica dtficitaria ed ormone glandotropo cor ri spo ndent e. Non foss ·a l tro perchè, mentre gli o rm om g landotropi dell'ipofisi 'ono parecchi, le categonc cdlula ri di questa ghiandola sono soltanto tre, il che ha come comcguuwa che almeno qualcuna di queste categorie celluhri (senza dubbio le basofile) deve essere deputata all'allestimento di più di un ormone insomma di fmnte all'abnorme situaziont detcrmiin seguito .tli:J deficienza di un altro 0rgano endocrino - subisce un istologico ed un adattamento funzionale più complessi dt quanto non sarebbe nchiesto per la produzione in eccesso dd solo ormone glandotropo
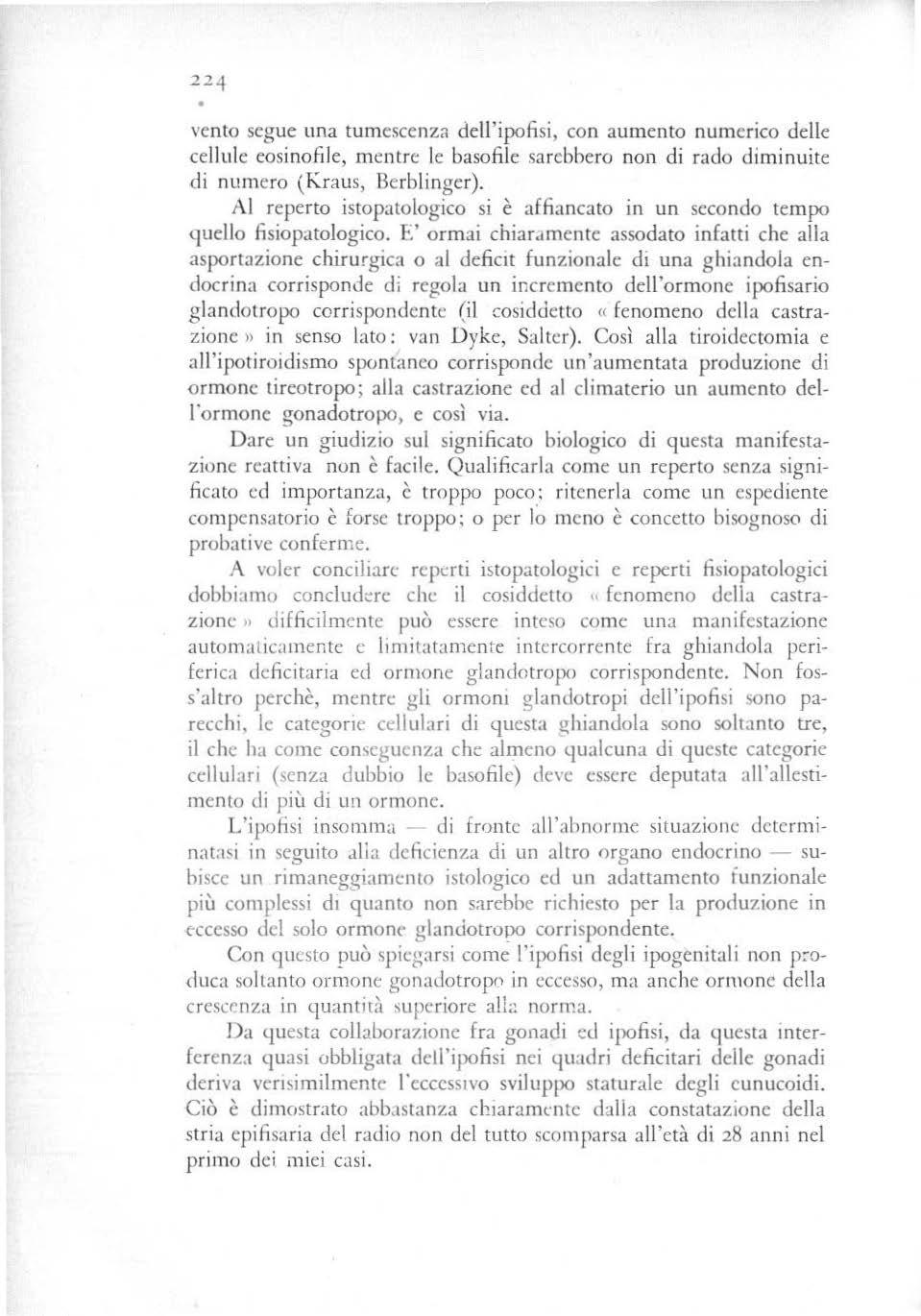
Con quc.sto può spiegarsi come t'ipofisi degli ipogenitali non p:-oduca solta nto ormone gonadot ropn in eccesso, ma anche orn. tonc della cresct·nza in quantità superiore norwa.
Da collaborazione fr a gonadi ed ipofisi, da questa mt erferenza quasi obbligata dcll'ipofisi nei quadri deficitari deile gonadi denva vcnsimilmente l'eccessi\'O sviluppo staturale degli cunucoidi .
Ciò è dimostrato abb,tslanza chia r amt"ntc tblla constatazione della s tria ep ifi sa ria del r ad io no n del tutto scom parsa a ll 'età di 28 anni nel primo dci miei casi.
Come bo insisti to sopra, la turba ipofisaria non è diretta in un unico se nso e in modo esclusivo, tant'è vero che nel r • caso emerge anche un netto ipometabolismo (forse per contemporanea deficienza dell'ormone tireotropo) e nel r ' e 2° caso una prova di carico glucidico alterata in direzione divergente (forse per alterato allestimento degli ormoni glicoregolatori ipofìsari).
Siamo tornati con ciò al punto di partenza, e cioè alla difficoltà di praticare una netta e profonda separazione fra « gigantismo eunucoide » e « eunucoidismo ipersomico Il Nell'uno co me nell'altro l'ipofisi collabora sul terreno patologico con le gonadi; solo che nel prim o è l'ipofisi, nel secondo sono le gonadi primitivamente alterate, con secondaria compromissione dell'altro protagonista.
Questa collaborazione morbosa fra gonadi cd ipofisi trova forse più ampie di estrinsecazione clinica di quanto non si creda. Vorrei qui tiferirmi a quel classico paradigma morboso che va sotto il nome di « distrofia adiposo-genitale», la qual e è per comune consenso inclusa fra le forme morbose di pertinenza diencefalo-ipofìsaria e per la quale il sistema diencefalo-ipofìsario è considerato come il fattore patogenetico primitivo e fondamentale. Che tale interpretazione sia plausib1le nella maggior parte dei casi e soprattutto per quelli nei quali esiste una dimo strabile o almeno logica co mprodel se ttore diencefalo-ipofisario, è ovvio.

Io mi pongo tuttavia il quesito se in una percentuale non trascurabile dei casi - nei quali tale compromissione non risulta cbjaramente- non possa esser invocata una successione patogenetica simil e a quella che abbiamo ammesso per l' eunucoidismo ipersomico: c cioè primitivo deficit genitale c secondaria ripercussione pituitarica.
E' noto del resto da tempo che castrati ed eunucoidi possono presentare du e divergenti direttive di morfologia somatica, alle quali corrispondono un << tipo adiposo >) ed un « tipo longilineo-ipersomi co n; e vi è chi-·· come Bauer - ha cercato di spiegare questo opposto contegno morfogenetico attraverso un subs trato familiare; in qu anto l'eunucoide proveniente da famiglie polisarcichc sa rebbe adiposo, l'eunucoid e proveniente da famiglie ad alto fattore staturak sarebbe ipersomico. Comunque sia, è certo che - se l'eunucoidismo ipersomico si riavvicina negli aspetti clinici se non nella successione patogenetica al gigantismo eunucoidc - adiposo dà la m ano alla distrofìa adtposo-genitale nella quale si continua.
22)
15
E' questa una prospettiva di interesse dottrinario non trascurabile> anche per i concetti che ne possono scaturire.
Le forme fruste od appena appariscenti dì distrofia adiposo-genitale hanno del resto una frequenza non trascurabile. Si tratta di soggetti meglio noti ai medici militari attraverso il controllo delle giovani generazioni chiamate alle armi , che non a noi medici civili ai quali sfuggono sia per il loro pieno benessere soggettivo sia per la riluttanza a ricorrere ad un curante per quella che è considerata ed in sostanza è - una lieve imperfezione somatica spesso conciliata con un pieno rendimento funzionale . Sono soggetti nei quali la crisi puberale rivela punti c\eboli dell'attrezzatura endocrina; nei quali la crisi puberale sembra prolungarsi oltre l'ordinaria misura di tempo, pur realizzandosi poi un soddi sfacente perfezionamento genitale e somatico. Sono individui insomma nei quali più tardi soltanto l'occhio dell'esperto potrà riconoscere eventualmente le sfumature ed i relitti di un processo di maturazione che ha conosciuto burrasche o incertezze.
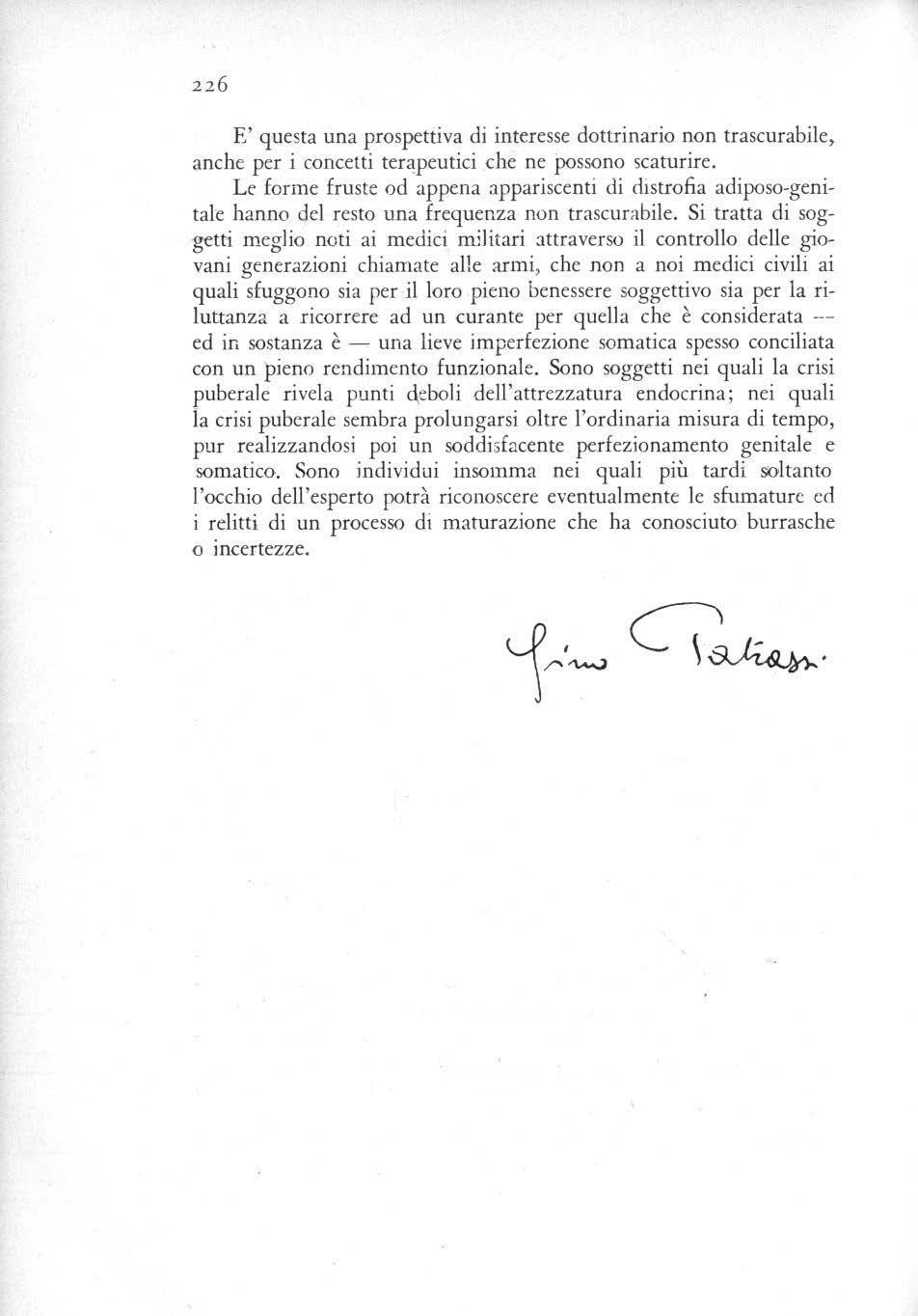
226
DE UTILITA TE EX ADVERSIS CAPI ENDA .
l PROGR ESS I DELLA C HIRURGIA E LA GUERRA
Un grande ge nio italiano, la cui vita fu tutta w1a gra nde guerra intima o palese contro avvers;tà e peripezie svolgentisi in una atmosfera di tragedia spirituale continua, in occasione del più violento dramma della sua vita scrisse un libro il cui titolo è un monito ed un insegnamento che ha sorpassato i secoli: D e utilitate ex adversis capienda.
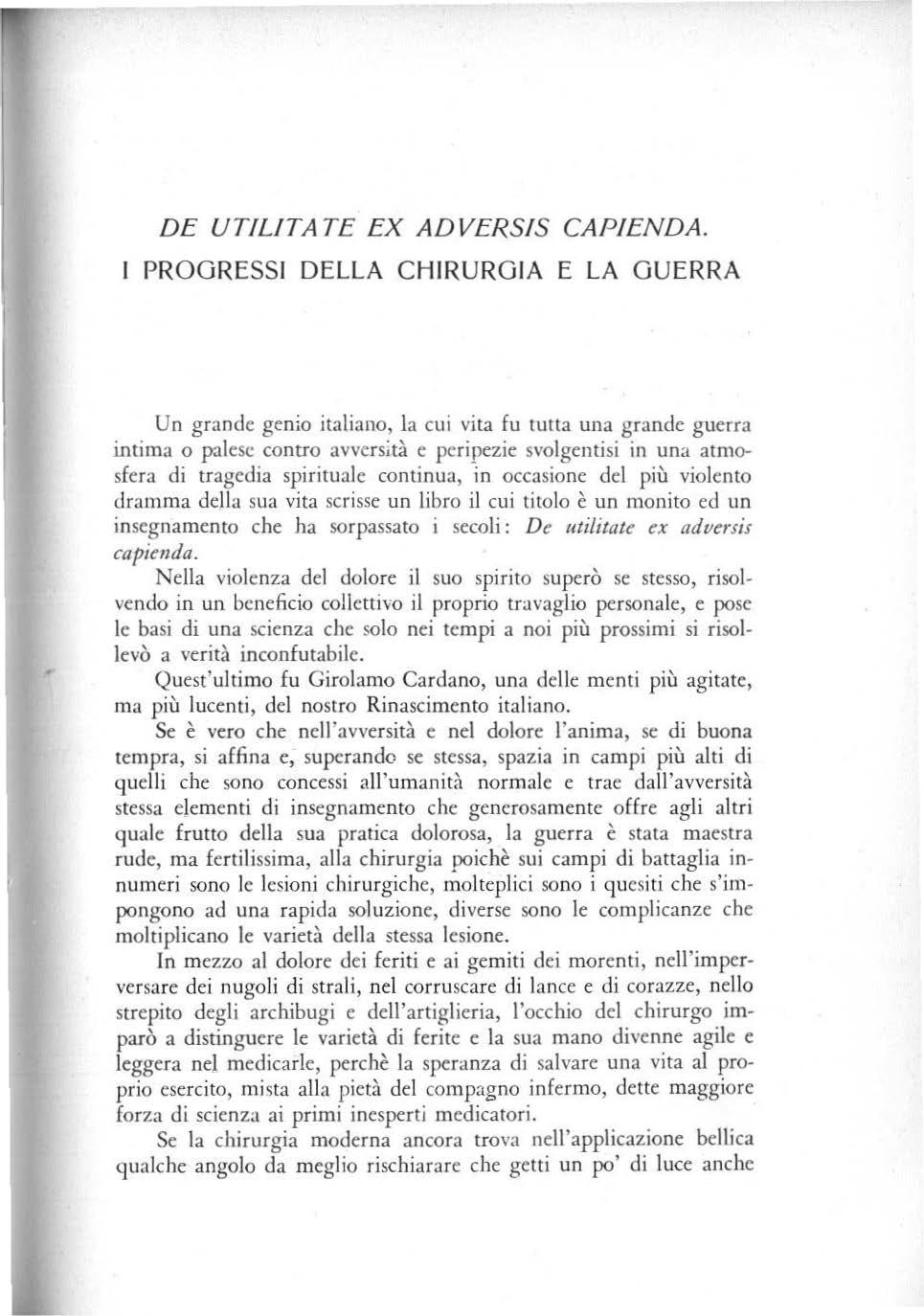
Nella violenza del dolore il suo spirito superò se stes so , risolvendo in un beneficio collettivo il proprio t ravaglio persona le, e pose le basi di una scienza che solo nei tempi a noi più prossimi si risollevò a verità inconfutabile.
Quest'ultimo fu Girolamo Cardano, una delle menti più agitate, m a più lu cen ti , del nostro Rin ascimento italiano.
Se è vero ch e nelravversità e nel dolor e l 'an ima , se di buona tempra, si affina e, superando se stessa, spazia in campi più alti di quelli che sono concessi all ' uma nità norm ale e tra e da ll 'avversi tà stessa ele m e nti di insegnamento che generosame nt e offre agli altri quale frutto della su a pratica dolorosa, la gue rr a è stata mae st ra rude , ma f erti l issima, alla c hir urgia po ichè sui ca mpi d i battaglia innum eri sono le lesioni chi rurgich e, moltepli c i so no i q u esi ti c he s'impongono ad una rapid a soluzione, diverse sono le complicanze che moltiplicano le va rietà della stessa lesione.
In m ezzo al dolore dei feriti e ai ge mit i dei morenti , nell 'imperversare dei nu go li di strali , nel corru sc are di la n ce e di corazze, nello strepito degli a rchibugi e dell'artiglieria, l' occhio del chirurgo imparò a distingu ere le varietà di ferite e la sua mano divenne agile e leggera nel medicarlc, perchè la spera nza di sa lvare una vita al proprio ese rcito, mista alla pietà del co mpagno infermo, dette maggiore forza di scienza ai primi inesperti medicatori.
Se la ch irurgia mod erna ancora tro va nell'applicazione bellica qualche angolo da m eglio rischiarare che getti un po' di luce anch e
nella chirurgia che possiamo dire di pace, è ben facile immaginare di quanto e qual e insegnamento dovesse riuscire la pratica del campo di battaglia ai primi chirurgi che, neces sariamente , dovevano limitare tutta la chirurgia alle più facili lesioni esterne.
Nell 'o rizzonte brumoso deila prima umanità, che si disperde nelle caligini della preistoria, ved iamo erigersi colossali figure di millenarie civiltà .
Esse stanno nelle primt lu ci sfumanti nella n ebbia e non sempre se ne possono discernere i contorni.
Così la più antica civiltà indiana rappresentataci dai sacri Veda e più ancora, nel caso nostro, nelle due epopee sanscrite, il Mahabarata e il Ramayana, dove frequenti sono le descrizioni di guerre, di feriti, e di cure, mo stra già evidente l'intervento dei chirurgi.
Da alcuni episo di si può arguire quale fosse, in quelle antichissime epoche, questo genere di soccorsi.
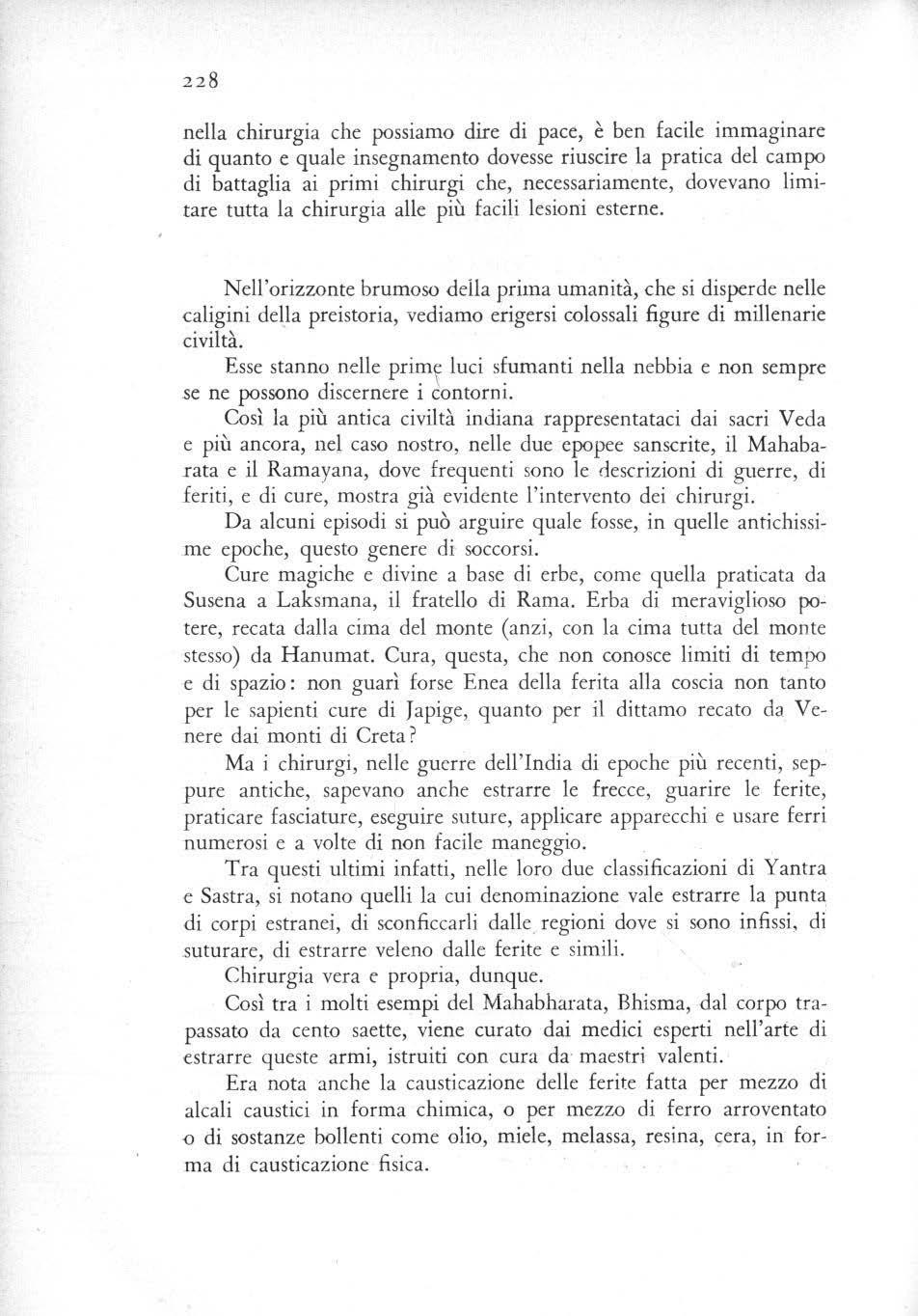
Cure magiche e divine a base di erbe, come quella praticata da Susena a Lak smana, il fratello di Rama. Erb a di meravi g lioso potere, recata dalla cima del monte (anzi, con la cima tutta del mo nte s te sso) da Hanum at. Cura, qu es ta, che non conosce limiti di tempo e di spazio: non guarì forse Enea della ferita alla coscia non tanto per le sapie nti cure di Japige, quanto per il dittamo recato da Venere dai monti di Creta?
Ma i chirurgi, nelle guerre dell'India di epoche più recenti, seppure antiche, sapevano anche estrarre le frecce, guarire le ferite, praticare fasciature, eseguire sut ure, applicare apparecchi e usare ferri nume ro si e a volte di non facile maneggio.
Tra questi ulùmi infatti, nelle loro due classificazioni di Yan tra e Sastra, si notano quelli la cui denominazione vale estrarre la punta di corpi es tranei, di sconficcarli dalle regioni dove si sono infissi, di suturare, di estrarre veleno dalle ferite e simili.
Chirurgia vera e propria, dunque.
Così tra i molti esempi del Mahabharata, Bhisma, dal corpo trapassato da cento saette, viene curato dai medici esperù nell'arte di estrarre queste armi, istruiti con cura da maestri valenti .
Era nota anche la causticazione delle ferite fatta per mezzo di alcali caustici in forma chimica, o per mezzo di ferro arroventato o di sostanze bollenti come olio, miele, melassa, resina, cera , in forma di cJusticazione fisica.
Le fasciature erano part ico larmente prese in considerazione, sia per la varietà de ll a loro forma, sia per l a materia con la quale erano praticate.
Quattordici varietà di fasciature da usarsi in casi ed in regioni diverse, stanno a testimoniare la perizia tecnica di quei lontani chirurgi.
I mportanti, infine, erano k precauzioni rivolte ai feriti durante la loro degenza. Essi dovevano essere posti in camere speciali, sorvegliati accuratamente, lonl:tni dalle donne e dai demoni notturni i qual i, avidi di sangue, potevano attaccarsi alle ferite e guastarle.
La tenda del mediCo, posta vicino a quella del raià, doveva essere fornita di tutti gli strumenti adatti ad ogni eventualità. Inoltre essa doveva essere controsegnata in modo particolare a[finchè tutti la potessero subito riconoscere.
l chirurgi indiani, sul campo di battaglia, conoscevano dunque presso a poco gli stessi metodi di cura che erano conosciuti dai nostri chirurgi medioevali prima che l'artiglieria facesse la sua comparsa tra le file dei combattenti.
Altra figura colossalt.: nelle prime epoche della vita dell'umanità è quella della civ1ltà egiziana.
La sua chirurgia applicabile alla traumatologia di guerra non appare tuttavia così ricca di risorse come quella indiana: potrà esserne forse ragione la minore occasione che gli Egizi ebbero di guerreggiare o anch e l'assenza di componimenti poetici narranti le t radiz ioni epiche della loro gente con le relative descrizioni di ferite e di cure .
D al papiro di Smith, il più nutrito di cognizioni chirurgiche, apprendiamo tuttavia che le cognizioni diagnostiche delle ferite erano abbastanza estese e che esistevano cinque termini particolari per indicare altrettante varietà di ferite: la ferita semplice, quella con fessura dell'osso, quella con frattura dell'osso lungo, quella con frattura dell'osso piatto e la ferita contusa.
Le fratture dd cranio, e particolarmente quelle con infossamento, venivano curate con la trapanazione : le lussazioni venivano ridotte. Erano co nosciu ti gli apparecch i di contenzione per l'immobilizzazione degli arti fratturati.
La cura delle ferite non appare ìnvero molto appropriata Sì legge in alcuni passi del suddetto papiro il consigiio di curarle in un primo tempo con l'applicazione di carne fresca e in un secondo tempo con mie le.
Assai più ricca dì riferimenti in proposito ci appare la civiltà preellenica e pelasgica dì cui la guerra di T roia fu l'episodio terminale.
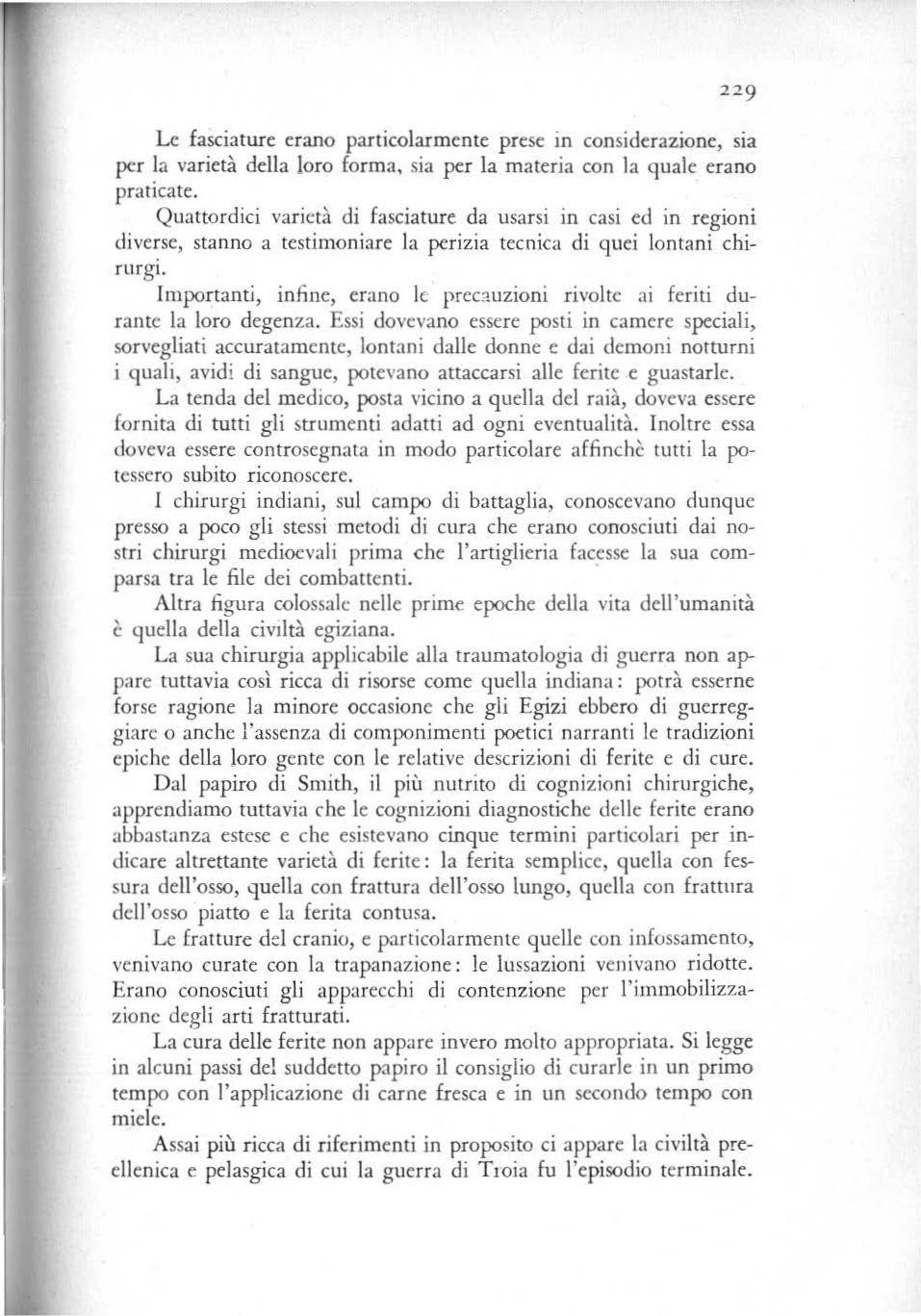
229
Prezioso documento ne è la narrazione omerica cui si ispirarono non poche pitture vascolari, utilissime per completare la descrizion e poetica.
Abbiamo il nutrito elenco della varietà delle ferite (a seconda dell'arma, della regione colpita e della gravità) ma non trascuriamo di notare come attento osservatore sia stato chi ne fece così copiosa descrizione.
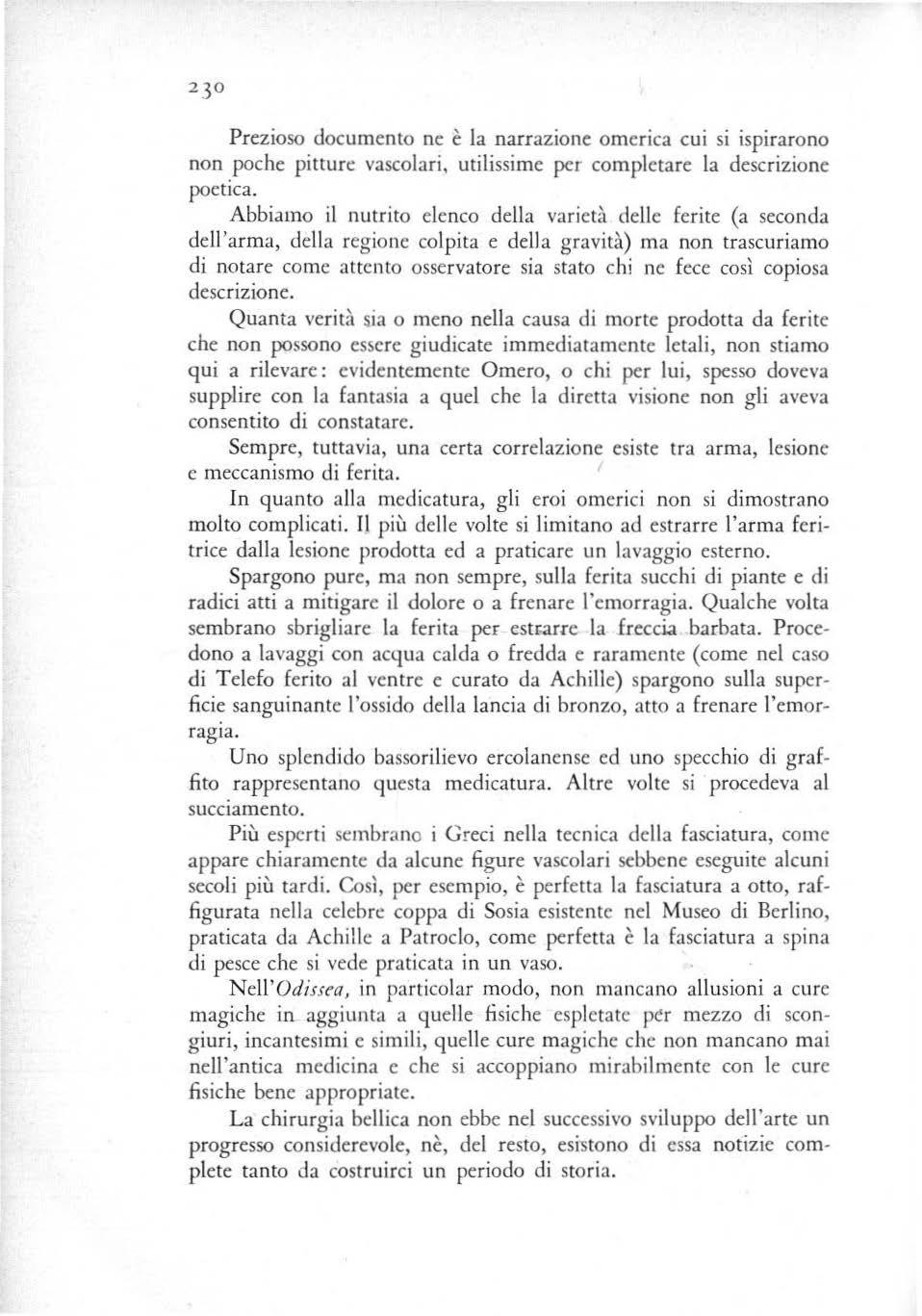
Quanta verità sia o meno nella causa di morte prodotta da ferit e che non possono essere giudicate immediatamente letali, non stiamo qui a rilevare: evidentemente Omero, o c hi per lui, spesso doveva supplire con la fanta sia a quel che la diretta visione non gli aveva consentito di constatare.
Sempre, tuttavia, una certa correlazione esiste tra arma, lesione e meccanismo di ferita.
In quanto a ll a medicatura, gli eroi omerici non si dimostrano molto complicati. Il più delle volte si limitano ad estrarre l'arma feritrice dalla lesione prodotta ed a praticare un lavaggio es t erno
Spargono pure, ma non sempre, sulla ferita succhi di piante e di radici atti a mitigar e il dolore o a frenare l 'emorragia. Qualche vo l ta sembrano sbrigliare la ferita per es t r-arre la freccia barbata. Procedono a lavaggi con acqua calda o fredda e raram en te (come nel caso di Telefo ferito al ventre e curato da Achille) s pargono sulla superficie sanguinante l'ossido della lanc ia di bronzo, atto a &enare l'emorragia.
Uno sp lendido bassorilievo ercolanense cd uno specchio di graffito rappresentano questa medicatura. Altre volte si procedeva al succiamento .
Più esperti sembrano i Greci nella tecni ca della fasciatura, come appare chiaramente da alcune figure vascolari sebbe ne eseguite alcuni secoli più tardi. Così, per esempio, è perfetta la fasciatura a otto, raffigurata nella celebre coppa di Sosia esistente nel Museo di Berlino, praticata da Achill e a Patroclo, come perfetta è la fasciatura a spina di pesce che si vede praticata in un vaso.
Nell'Odisseo, in partico lar modo, non mancano allusioni a cure magiche in aggiunta a quelle fisiche esp letat e per mezzo di sco ngiuri, incantesimi e simili, quelle cure magiche che non mancano m ai nell'antica medi ci na e che si accoppiano mirabilmente con le cure fisiche bene appropriate.
La chirurgia bellica non ebbe nel successivo svi luppo dell'arte un progresso considerevole, nè, del resto, esistono di essa notizie complete tanto da cost ruir ci un periodo di storia.
Più nota, invece, è la chirurgia in epoca romana, che molto progredì, anche nelle contingenze belliche, sia per la qualità e quantità dello strumentario, sia per le varietà di interventi chirurgici praticati.
. Innanzi · tutto è con l'apparizione del medico militare romano che appare per la prima volta l'astuccio chirurgico contenente i ferri necessari per il pronto soccorso di prima necessità sul campo: un cilindro di rame o di bronzo, con coperchio e con attaccaglia laterale, contenente una pinza e vari tipi di specilli, e di tente.
Naturalmente questi strumenti non erano gli unici ad essere usati sul campo.
Nel celebre affresco pompeiana rappresentante Japige in atto di curare Enea ferito da una punta di freccia alla coscia destra, il medico ha in mano uno strumento identificabile con il forceps et·colanense, robusta pinza atta ad estrarre corpi estranei, frammenti e sequestri ossei dalle ferite.
Così pure il medico, che nel fregio della colonna Traiana appare in atto di medicare il compagno, ha in mano un oggetto che, pur non potendo essere precisamente identificabile, non è certamente alcuno di quelli contenuti nel piccolo astuccio detto del medico di guerra.
Nello strumentario chirurgico di epoca romana numerosi sono infatti i pezzi utilizzabili nella traumatologia bellica.
Anzitutto quel forceps già citato. ·
Non mancava il trapano di varia forma: terebra (a lancia) modiolo (a corona) quale era stato descritto da lppocrate, abatista quale è descritto da Galeno. Ed ecco la vasta famiglia degli specilli e delle sonde atte a misurare la profondità delle ferite ed esplorarne. il tramite, nonchè quella dei cauteri a punta, a gamma, a semiluna, a tricuspide, olivari, atti tra l'altro a frenare le emorragie . E in ultimo la varietà di pinze tra le quali una precorritrice della pinza emostatica.

Con questo genert di strumentario la chirurgia bellica ebbe, naturalmente, miglior modo di attuarsi.
Per quanto riguarda gli atti operatori si ricordi il lettore che la legatura dei vasi, sia in massa con i tessuti, sia del vaso isolato, è gloria prettamente romana, essendo stata descritta da Celso.
Le ferite venivano lavate con vino o aceto: quelle da taglio con medicamento quod suppurare vetet, chiara allusione ad un metodo disinfettante, oppure con mezzi atti a procurare la suppurazione (o meglio ad affrettarla) per le ferite lacero-contuse.
L'emostasi attuavasi con filacce, compresse di aceto, medicamenti emostatici e cauterizzazione.
I medicamenti disinfettanti (ante literam) erano, tra gli altri, il cinabro, il litargirio, la cadmia, il minio ecc.
Le fratture erano curate con bendaggi e stecche di contenzione e .le lussazioni riclucevansi mediante manovre di foru, facendo l eva su di un cavalletto o, in mancanza di meglio, su di un piolo di scala.
Per quanto riguarda le ferite di guerra, tra le tante ricordo quella che rappresenta, nella causalità della sua evenienza, il primo esempio di pneumotorace curativo. Falareo, narra Plinio (H. N., VII, so) affetto da inguaribile malattia polmonare cronica, si gettò nel folto della mischia per tro varvi la morte. Ferito al torace, non solo non morì per il colpo infertogli, ma guad pure dena sua malattia.

Decadde Roma con la sua potenza, con la sua civiltà; i primi secoli del medioevo ritornarono molto indietro.
La chirurgia di guerra è quasi assente. I feriti sono soccorsi alla meglio dai commilitoni o condotti, come nella leggenqa di Lancil.lotto del Lago, al più vicino monastero dove qualche monaco infirmario praticava il rimedio suggerito dalla ingenua medicina conventuale che allora muoveva i primi passi.
Ma più spesso non appare soccorso di sorta: così, per esempio, nella canzone di Rolando, dove l'eccidio non ha conforto se non nella morte.
Un accenno di chirurgia bellica o per lo meno adottato alla guerra si affaccia in I talia nel secolo XIIT .
La chirurgia risorge a Salerno, e Salerno detta le rego le anche per curare i feriti sul campo o di ritorno dal campo .
Ricordo solo, perchè sono troppo celebri per essere trattate diffusamente , le prime opere di ch irurgia salernitana: que ll a di R uggero di Frugardo e quella di Rolando da Parma.
In esse, commista con la pratica civile, è quella bellica, ed erano sui libri commiste le due pratiche, come ne ll a vita la guerra era commista alla pace. .
Tutte le ferite belliche vengono esaminate e trattate nel modo più esaurien t e possibile, a quei tempi: ferite leggere di spada in regioni di non vi t ale importanza; fe r ite più gravi di treccia bardata, in regioni di maggiore interesse; ferite gravissime toraco-po lmonari con ernia del polmone.
I vasi recisi venivano legati ai d ue capi; e così pure Ro l ando consiglia di suturar e anche il nervo rag lia t o, previa cauterizzazio ne dei rnonconi, ottenendo, secondo lui, il r ipristi no della fu n zione nerv0sa .
Le ferite comuni da taglio, previo nettamento, sono sutu rate. Tuttavia è più frequente che non nell'epoca antica il precetto di produrre la suppurazione, mediante unguenti, lardo, c stuelli di lino imbevuti di grasso . C-ontro questo abuso si oppone il celebre vescovo chirurgo, Teodorico de' Borgognoni, .figlio di Ugo, chirurgo anch'egli cd anc h e chirurgo di guerra.
Interessante la diagnostica delle ferite del cuore, del polmone, dello stomaco e del diafr amma, riconoscibili per la fuoruscita di sangue nero o di sangue scbiumoso accompagnato da dispnea o da sostanze alimentari, o da dispnea intensissima rapidamente seguita dalla morte.
Le ferite dell'intestino si curavano «scaldando » in primo luogo l'intestino con un animale vivo e messo sopra e quindi s uturando la lesione, previa introduzione nel lume intestinale di un cannello di sambuco adattato in modo da far passare le materie alim entari. L a ferita dell'addome !asciavasi ape rt a fino a cicatrizzazione dell'intestino .
Le ferite toraciche con ernia del polmone si curano, seco ndo Rolando, scaldando il polmone come è detto sopra, allargando l'apertura, riducendo il polmone e Im pedendo il cicatrizzarsi fino a guang10ne.
Interessante il consiglio di metter e questi pazienti affetti da emo torace o da empiema su di una tavola, coricati sul lato della ferita in modo da far sco lare fuori il sangue o il pus: ad un dipresso come oggi si fa per la toraccn t esi libera
In questa ste ssa epoca (e cioè circa il 1250) pe r merito di un altro chirurgo italiano che più dei precedenti merita il titolo di militare per le campagne fat te, e cioè Giovanni da Casamicciola, risorge la tecnica della legatura isolata dei vasi, con .filo di seta condotto con · l'ago sotto il vaso st esso dall'una pa rte all'altra.
Questa tecnica (che da taluno si vuoi far ri sali re ad Ambrogio P aré) è dunque roman a di origine, italiana di tradizione.

Contemporaneamente si arricc hi sce lo strum entario utile alla chirur gia bellica particolarmente descritto dal chirurgo di Filippo il Bell o, Enrico da M ondeville.
Così, per esempio, vengono ideate delle pinze-divarica tori a cucchiai, le cui branche, introdotte nel tramite della ferita prodotta dalla freccia, ed ai lati dì questa a n cora co nfi cc ata, allargavano i tessuti sfiland o in tal modo da essi gli aculei delle barbe che vi erano co nficcati.
Da qualche t empo nella tecnica chirurgica cra si infil trato l'uso, alla mod a araba, d el t agliente- cauterio .
Al vantaggio di produrre il taglio e l'emostasi contemporaneamente opponevansi tuttavia quelle conseguenze infiammatorie e consecutivamente suppurative, che è facile immaginare.
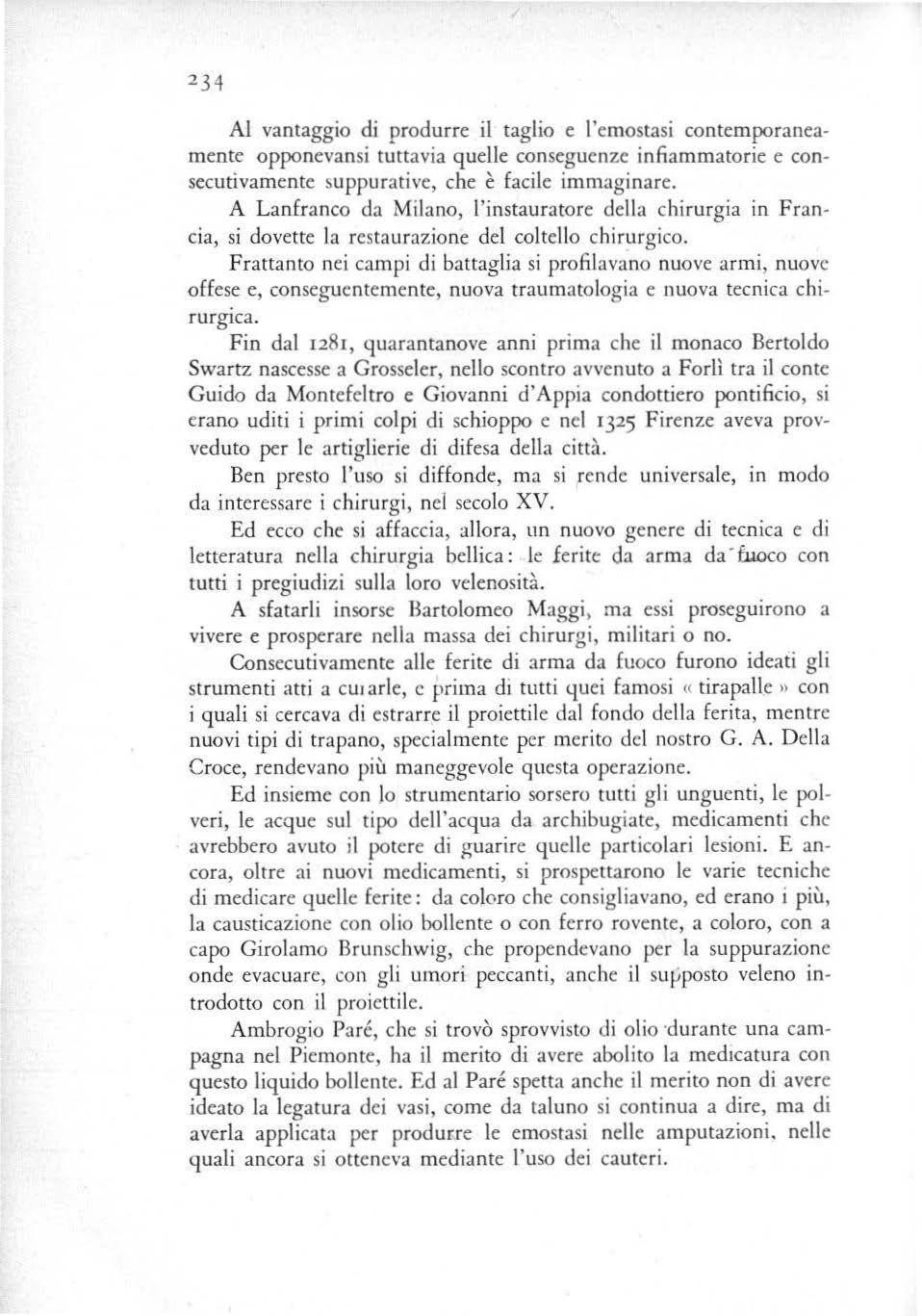
A Lanfranco da Milano, l'instauratore della c hirurgia in Francia, si dovette la restaurazione del coltello chirurgico
Frattanto nei campi di battaglia si profilavano nuove armi, nuove offese e, conseguentemente, nuova traumatologia e nuova tecnica chirurgica.
Fin dal 128r, quarantanove anni prima che il monaco Bertoldo Swartz nasce sse a Grosseler, nello scontro avvenuto a Forlì tra il conte Guido da Montefelt ro e Giovanni d'Appia co ndottiero pontificio, si e rano uditi i primi colpi di schioppo e nel 1325 Firenze aveva provveduto per le artiglierie di difesa della città.
Ben presto l'uso si diffonde, ma si rende universale, in modo da interessare i chirurgi, nel secolo XV.
Ed ecco che si affaccia, allora, un nuovo genere di tecnica e di letteratura nella chirurgia bellica: le ferite da arma da - fuoco con tutti i pregiudizi sull a loro velenosità.
A sfatarli insorse Bartolomeo Maggi , ma essi proseguirono a vivere e prosperare nella massa dei chirurgi, militari o no.
Consecutivamente alle ferite di arma da (uoco furono ideati gli strumenti atti a cut arie, c prima dì tutti quei famo si « tira palle >> con i qua li si cercava di estrarre il proiettile dal fondo della ferita, mentr e nuovi tipi di trapano, specialmente per merito del no stro G . A. Della Croce, rendevano più maneggevole questa operazione.
Ed insieme con lo stru mentario sorsero tutti gli unguenti, le polveri, le acque sul tipo dell'acqua da archibugiate, medicamenti c he avrebbero avuto il potere di guarire quelle particolari lesioni. E ancora, oltre ai nuovi medicamenti, si prospettarono le varie tecniche di medicare quelle ferite: da coloro che consigliavano, ed erano i più, la causticazione con olio bollente o con ferro rovente, a coloro, con a capo Girolam o Brunschwig, che propendevano per la suppurazione onde evacuare, con gli umori peccanti, anche il veleno introdotto con il proiettile.
Ambrogio Paré, che si trovò sprovvisto di olio durante una campagna nel Piem onte, ha il merito di avere abolito la medtcatura con questo liquido bollente. Ed al Paré spetta anche il merito non di avere ideato la legatura dei vasi, come da taluno si continua a dire, ma di averla applicata per produrre le emostasi nelle amputazioni, nelle quali ancora si otteneva mediante l'uso dei cauteri.
2 34
Fu questo il vero merito di Ambrogio Paré, mentre Giovanni di Vico, da Rapallo, aveva ancora in sis tito, qualche anno prima, sul la legatura dei va si nelle ferite.
Oltre all'innovazione di tec nica indotta da una innovazione traumatologica, si prospetta un'altra importante operazione bellica: l'amputazione.
Le amputazioni erano già note prima del rinascimento, fin dall'epoca greca avendone dato già Ippocrate qualche ragguaglio . Ma pericolosissime furono sempre considerate per la difficoltà di frenare l'emorragia. Sembra, per altro, che Archigene di Apamea, vivente all'epoca di Traiano, avesse già preconizzato l'allacciatura preventiva dei vasi. Tuttavia la difficoltà di produrre l'emostasi ottenuta comunemente in modo non sicuro, mediante caustici, non esclusa la pece bollente, riduceva al mmimo le occasioni di questi interventi.
Fu la tecnica proposta dal Parè, di allacciare preventivamente i vasi, che permise la maggiore diffusione _ di questa operazione, cui Bartolomeo M aggi aggiunse un perfezionamento di grande portata : la formazione dei lembi ottenuti mediante il forte stiramento in alto della pelle sull'arto da amputare . in modo che questa, ritornando alla primitiva lunghezza, dopo il tag lio, ropravanzasse il monèone e formasse il lembo da ricoprirlo.
Ma se qualcuno, desideroso di maggiore precisione storica, volesse accer t are a chi spetti realmente il merito di questa priorità, dovrebbe giungere ad altri italiani, non precisamente chirurgi, o per lo meno chirurgi ... assai arditi : i carnefici della Repubblica Veneta , i quali vantaggiosamente avevano sperimentato il sistema sui ladri e spergiuri condannati all'amputazione d ella mano.
L a chirurgia bellica progrediva così anco ra di un passo, mentr e i l rimanente della traumatologia non subiva mutamenti radicali.
D opo aver ricordato di sfuggita, percbè non prettam ente bellico, il « medicar rado n Jel Cappuccino chirurgo C. Magati da Scandiano, se icentesco, eccoci al settecento .
Nei primi anni de l secolo XVIII, ad opera di Gian Luigi P etit, sempre a proposito della emostasi nelle amputazioni, viene ideato il « tourn iquet )) , strumentino a pressione mediante una vite, con il quale si produceva la chiusura del vaso prima di procedere al taglio.
Come mezzo coadiuvante -della pratica chirurgica bellica, appare, pure per opera del Petit, la barella.
Ma non crediamo opportuno a questo proposito soffermarci su tutto ciò che poteva offrire un vantaggio alla chirurgia bellica, nè per la sua attuazione pratica nè per la migliore organizzazione del

235
personaJe, nè per scuole che potessero migLiorare ·la preparazione dei chirurgi militari.
Dovremmo altrimenti intrattenerci sull'opera svolta dal nostro Brambilla, in favore della cultura e della preparazione dei medici e chirurgi dell'esercito imperiale, a Vienna; dovremmo parlare dell'instaurazionc delle ambulanze volanti per opera del Goercke nell'esercito prussiano e del Larrey n eli' esercito na poleonico; dovremmo accennare all'istituzione di speciali corpi di infermieri e portaferiti e di infermiere volontarie, intorno all'anno r8oo, per giungere finalmente alla gloria prettamente italiana, anche se misconosciuta, del principio della neutralità e del soccorso internazionale ai feriti bellici.
Volendoci intrattenere, sia pure di sfuggita, solo sulla chirurgia in rapporto alla guerra, tutto ciò costituisce un insieme assai favorevole di circostanze concomitanti allo svolgersi della pratica chirurgica su l campo, ma non un perfezionamento della chirurgia stessa.
La quale chirurgia, nel secolo XVIII aveva progredito per alcuni versi, era pur rimasta ·pressochè stazionaria per altri punti.
Così per esempio ancora si usava succhiare direttamente le ferite, con la bocca, tanto è vero che Domenico Anel, chirurgo militare, scrisse un'opera dal Del modo di succhiare le piaghe senza servirsi della bocca dell'uomo.
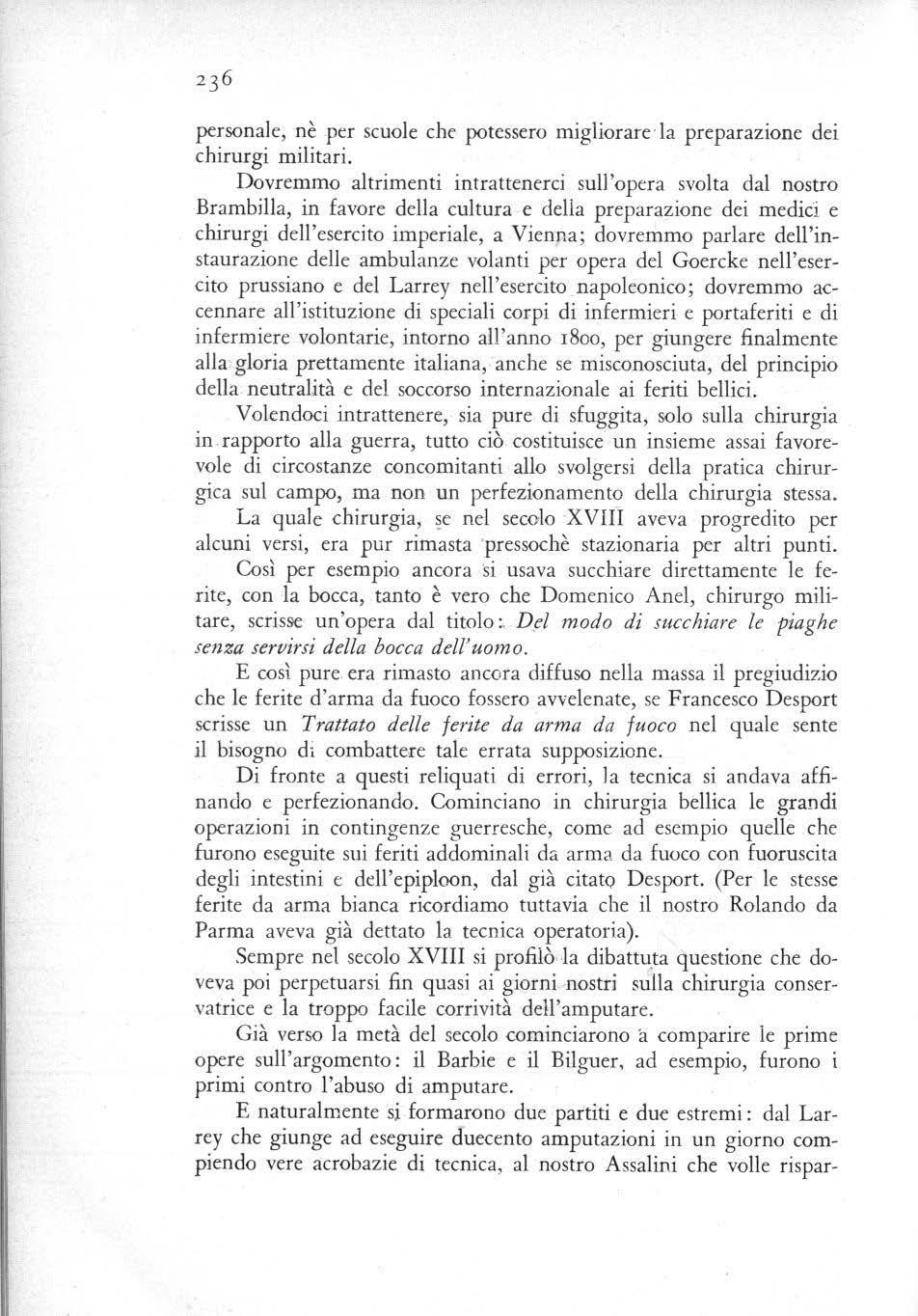
E così pure era rimasto ancora diffuso nella massa il pregiudizio che le ferite d'arma da fuoco fossero avvelenate, se Francesco Desport scrisse un Trattato delle ferite da arma da fuoco nel quale sente il bisogno di combattere tale errata supposizione.
Di fronte a questi reliquati di errori, la tecnica si andava affinando e perfezionando. Cominciano in chirurgia bellica le grandi operazioni in contingenze guerresche, come ad esempio quelle che furono eseguite sui feriti addominali da arma da fuoco con fuoruscita degli intestini e ddl'epiploon, dal già citato Desport . (Per le stesse ferite da arma bianca ricordiamo tuttavia che il nostro Rolando da Parma aveva già dettato la tecnica operatoria).
Sempre nel seco lo XVIII si profilò la dibattu.ta questione che doveva poi perpetuarsi fin quasi ai giorni nostri sulla chirurgia conservatrice e la troppo facile corrività dell'amputare.
Già verso la metà del seco lo cominciarono a comparire le prime opere sull'argomento: il Barbie e il Bilguer, ad esempio, furono i primi contro l'abuso di amputare.
E natura lmente si formarono due partiti e due estremi : dal Larrey che giunge ad eseguire duecento amputazioni in un giorno compiendo vere acrobazie di tecnica, al nostro Assalini che volle rispar-
miare un dito rimasto attaccato con una sola lacinia di pelle. Conse rvatore fu anche Fran cesco Percy, l'altro grande chirurgo napoleonico compagno di Larrey.
La medicatura delle ferite era in una fase di crisi tra l'ultimo scorcio del settecen to e l'ottocento.

Decadevano le acque vul ner arie (che tuttavia non erano del tutto condannabili , essendo compos te con acquavite), ed al loro posto subentravano altri liquidi di lavaggio: liquidi emollienti con acqua semplice fredda o tiepida, soluzioni ipertoniche.
Era frattanto sorta l 'epoca degli studi di A. Bassi sui contagi e su ll e infezioni e re lative disinfezioni: il grande Lodigiano, che in moltissimi punti tra i più salienti precorse Pasteur, aveva indicato già l'utilità di lavare le piaghe con liquidi disinfettanti.
Gli studi del Bassi condo tti parecchi anni prima di quelli pasteuriani trovarono nei decenni succ essivi larga conferma.
Prima del Li ster, padre putativo dell'antisepsi chirurgica, va nominato Bottini, ma prima di Bottini, nel r864, un chirurgo di reggimento, Federico Tosi, lavava le ferite con una soluzione di sublimalo al 3 per mille e con questa stessa soluzione lavava gli strumenti chirurgici.
Il servizio antisettico tuttavia (c ciò a maggior gloria del no stro italiano) non faceva ancora presa nella mentalità dei chirurgi militari perchè, si diceva, avrebbe ostacolato il servizio di pronto soccorso in prima linea.
Anche lo strumentario trovò nel secolo XIX, nella pratica bellica, motivo di incremento e di perfezionamento.
Così è noto che per meglio esp lora re la ferita di Garibaldi, N elaton ideò lo specillo che da lui prese il nome. Paolo Assalini, seguito dal Percy, ideò una specie di pinza a pressione graduale per le arterie, dalla quale origina rono le varie pinze em ostatic he. Allo stesso si dovette l'inv enzione di numerosi altri strume nti utili nelle contingenze belliche anche perchè limitavano la necessità di assistenti.
Nella chirurgia militare prese il nome, seppure non giustamente, la fascia di Esmarch, dal grande chirurgo militare ted esco c he se pur n on può avere il merito di avere ideato questo metodo di anemizzazione dovuto al nostro Grandesso Silvestri, ebbe quello di esserne stato il più auto r evole asserto re.
La chirurgia militare della metà dell' ottoce nto fu davvero lerreno fertile di studio: la tragedia delle corsie colme di amputati c di feriti dove l 'eresipela, la canc ren a nosocomiale, la setticemia generalizzata mettevano in evidenza, come una enorme e pur macabra lente
2 37
di ingrandimento, quel che comunemente verificavasi nella pratica comune.
L 'eca tomb e di uomini scosse le menti degli studio si a cercare le cause delle imperfezio n i: quando si pensa, secondo il rapporto del dr. Chenu, che di 50o.ooo uomini spediti in Crimea Io .ooo morirono sul campo e altrettanti morirono in seg uito a cv111plicazioni, e che di 1681 operati alla coscia solo 136 resistettero alla infezione, c'è da concludere, con l'estensore del rapporto, che l'insuccesso della chirurgia era disp erante.
Ma ap punto dalla tragedia sorsero la necessità della ricerca e la vittoria.
Già il nostro Agostino Bassi aveva affermato che le cancrene so no sostenute da esseri micros copici . E si era appena nel 1844! Nicola PirogoH, il grande chirurgo militare russo, poco tempo dopo, colpito dalla violenza delle epidemie nosocomiali, istituì ospedali di isolamento per cercare di restringerne il dilagare impressionante.
Seguirono, poi, gli studi e le scoperte di Pasteur e, più ancora, in questo campo, di Klebs e di Koch sulla etiologia e la patologia delle malattie traumatiche infettive, l e quali confermarono le asserzioni del nostro Bassi.
Conosciutane la causa, la vittoria su questa tragica ecatombe si rendeva facile: dall'orrore della guerra sì elevava un beneficio per l'umanità tutta.
Quanto vale per le infezioni chirurgiche, per le medicazioni, per le tecniche operatorie, per lo strumentario, valga per altri molteplici argomenti. Con l'enorme materiale di studio, di osservazione e, nel senso migliore, di esperienza, le modalità dei singoli interventi ebbero ammaestramenti rudi, sì, ma benefici, e se non per il singolo paziente, per la collettività: e se non per la collettività di aJlora, per quella futura.
La chirurgia di guerra prosegue ancora nella via e nell'aspirazione ad un sempre migliore perfezionamento . Le armi di oggi sono veramente piò micidiali dì quelle di ieri, ma, in compenso, il soccorso è proporzionatamente più adeguato alla m icic:\ialità stessa dell'offensiva.
Grandi leggi di compenso regolano la gran de vita del Cosmo per non turbarn e l'armonia: e queste grandi leggi si riflettono anche nelle cose del no stro pianeta, e consecutivamente, anche nella guerra .
Se l'odio per l'uomo dà armi con mezzi di distruzioni sempre più efficaci, l'amore per l'uomo, dà armi, per salvarlo, anch'esse sempre più efficaci.
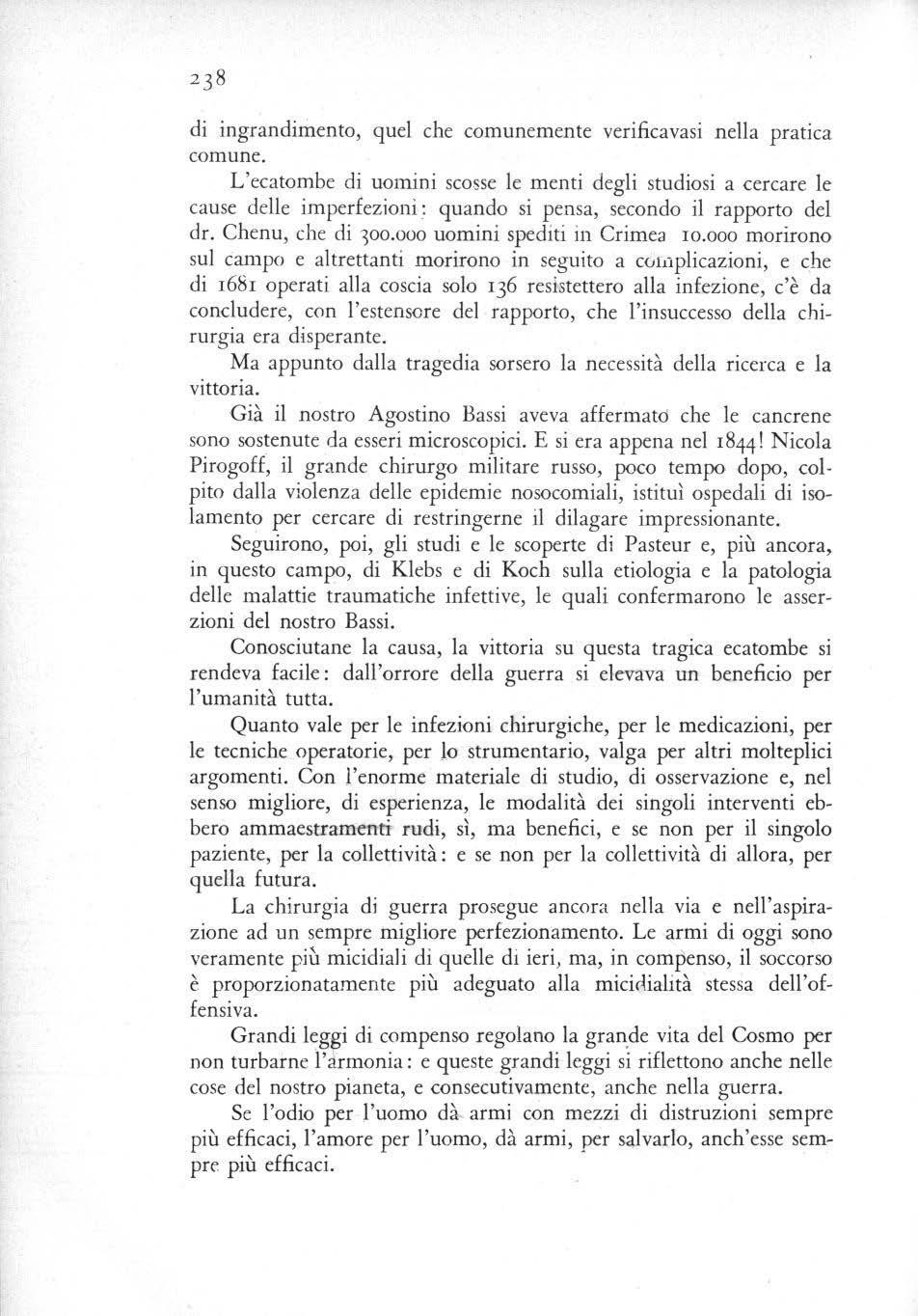
Di fronte alfinnocua palla di pietra da 24 libbre, c'è la bomba che cade dal cielo carica di sconvolgente esplosivo.

Ma in luogo delle corsie affogate nel fetore della cancrena, ci sono i candidi ospedali lucenti nell'asepsi.
Di fronte ai carri che lentamente portavano gli armati, pur se trainati da focosi cavalli, sono gli autotrasporti celerissimi, e in luogo della lenta carretta dove il ferito moriva per l'emorragia, c'è la veloce autoambulanza, c'è, quando serve, il bianco trimotore che, più veloce della morte, spe sso conserva molte vite alla patria.
RADlOLOOlA E MEDlClNA MILITARE
Se qualunque branca delle mediche discipline presenta interesse per la Sani t à militare, non v' ha dubbio ch e la radiologia è fra quelle di maggiore importanza, ove si consid eri la complessità e la delicatezza dei compiti che è destinata ad assolvere, sia in pace come in guerra, e che van no dal fornire elementi preziosi per il giudtzio di idoneità al se r vizio militare, al contr ibuir e coi rilievi diagnostici alla cura ed a l ricupero del so l dato malato o ferito, al documen t are infine e valutare i postumi di lesioni, facilitando spesso anche il giudizio peritale di causa lità di servizio .
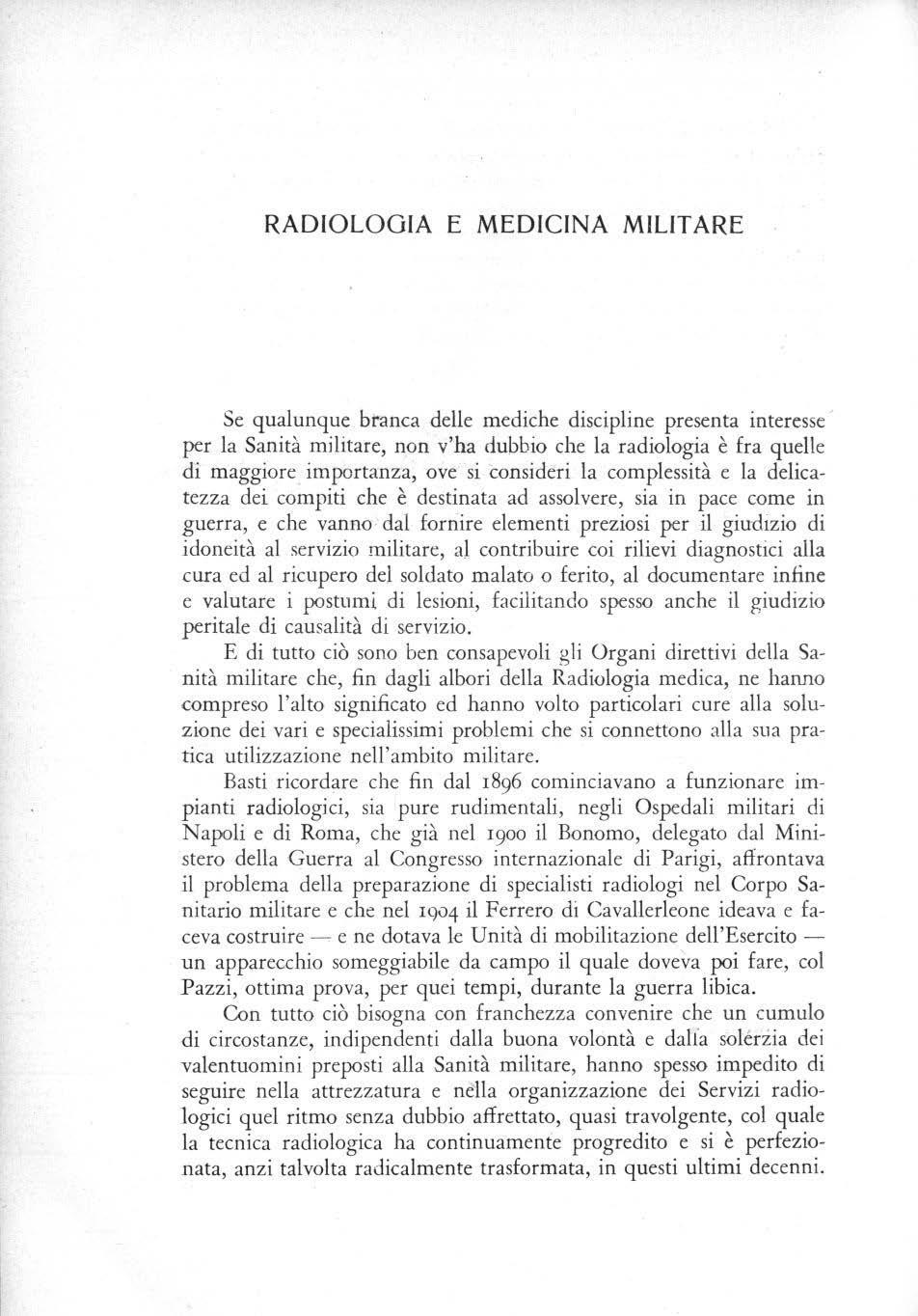
E di tu tto ciò sono ben consapevoli g li Organi direttivi della Sanità militare che, fin dagli albori della Radiologia medica, ne hanno compreso l'alto significato ed hanno volto particolari cure alla soluzione dei vari e specialissimi problemi ch e si connettono al la sua pratica uti lizzazione ne ll 'ambito militare .
Basti ricordare che fin dal 1896 cominciavano a funzionare impianti radiologici, sia pure rudimentali, negli Ospedali militari di Napoli e di Roma, che già nel 1900 i l Bonomo, delegato dal Ministero della Guer ra al Co n gresso internaz io n ale di P arig i, affro nt ava il problema della preparazione di specia li sti radiologi nel Corpo Sanitario militare e che nel ll)04 il Fe rrero di Cavallerl.eone ideava e faceva costruire - e ne dotava le Unità di mob ilit azione dell'Esercitoun apparecchio someggiabile da ca m po il quale doveva poi fare, col Pazzi, ottima prova, per quei tempi, du ra nte la g u erra libica.
Con tutto ciò bisogna con franchezza convenire che un cumulo di circostanze, indipen denti dalla buona volontà e da lia so ler zia dei valentuomini prepost i alla Sanità militare, hanno spesso impedito di seg uire ne lla attrezzat ura e n ell a o r ga niz zazio n e dei Servizi radiol ogici quel ri t m o senza dubbio affre ttato, quasi travolgente, col qual e la tecnica radio log ica h a co ntinu amen t e progredito e si è perfezio11 ata, a n zi talvolta radica lmente trasformata, in questi ultimi decenni.
Basti del resto ricordare, ad esempio, la resistenza che trovò negli organi responsabili, prima che alla pnma grande guerra e uropea, la mia proposta di dotare l'esercito mobilitato di automobili radiologiche, munite di una mod erna e completa attrezzatura, in sostituzione almeno parziale degli apparecchi Ferrero di Cavallerleone, che potevano ritenersi ormai superati cd inadeguati, tanto che dovetti rivolgcrmi alla Croce Ro ssa Italiana per poter realizzare, col Balzarini, la prima automobile radiologica italiana, La quale si dimostrò poi, alla prova dei fatti, tanto utile da persuadere, solo però più tardi, della convenienza di comuirne altre simili per uso del Ministe ro della Guerra. Ed invero la se conda guerra mondiale ci trovò in questo campo ben preparati con le ottime automobili radiologiche della nostra Sanità militare, realizzate sotto la guida di Crespellani, Vassalli e Piconé, per l'esercito mobilitato.
Io sono perfettamente conscio delle difficoltà che impediscono ad una Or ganizzazione, dai compiti così svariati e comp lessJ come quelli òella Sanità militare, eli modificare contin uam ente, anzi rinnovare attrezzature costose quali sono quelle radiologiche c di potere al tempo stesso disporre sempre di un personale specializzato che sia anche adeguato sufficientemente per numero alle esigenze del Servizio radiologico; per cui, se mi permetterò in questo scritto di considerare, da un punto di vista strettamente radiologico, alcuni lati del problema della radiologia militare, non avrò cerro la pretesa di suggerire qualcosa di nuovo a chi ne sa più di me e tanto meno di muovere critiche ad una Organizzazione che è costretta a tener conto di tanti e tanti clementi conti ngenti che interferiscono e spesso ostacolan o realizzazioni auspicate, fra i quali non ultimo quello talvolta proibitivo della mancanza di mezzi finanziari. Mi si permetta tuttavia di toccare alcuni argomenti che mi sembrano i più utili ed urgenti da discutere per i! migliore funzionamento del Servizio radiologico militare e soprattutto queilo dell'impiego della e quello della preparazione di personale medico c tecnico specializzato.
Se vi è una contingenza nella quale l'indagine schermografica è de stina ta a portare benefici enormi di di econo mia, di precisione è proprio quella dell'arruolamento ddle reclute.
Si richiede al medico militar e, che esamina i giovani di leva, di formulare in pochi minuti un vero e proprio giudizio medico-legale: questo giudizio è di grande importanza tanto per l'individuo quanto per la collettività nella quale il giovane dov1 ebbe essere immesso,

16
quanto infine per le Stato. E' necessario eliminare dall'arruolamento dei giovani che, oltre a non essere atti a soppo rtare i disagi della vita militare, potrebbero inconsciamente in sidiare la salute dei compagni e, non riconosciuti malati, potrebbero più tardi attribuire allo Stato la respo n sabili tà per cause di servizio di una preesistente malattia e chiedergli, oltre alla assistenza, anche il risarcimento del presunto danno, imponendo all'Erario un onere non indifferente.
Questa visita, inoltre, all'infuori delle specifiche finalità che si propone, può indirettamente conseguirne :dtre di altissimo valore sociale, mettendo in luce malattie ignorate che, curate t.::mpestivamcntc, sono suscettibili di guarigione, riuscendo così anche a salvaguardare dal pericolo di un contagio, neppure sospettato, il nucleo familiare.
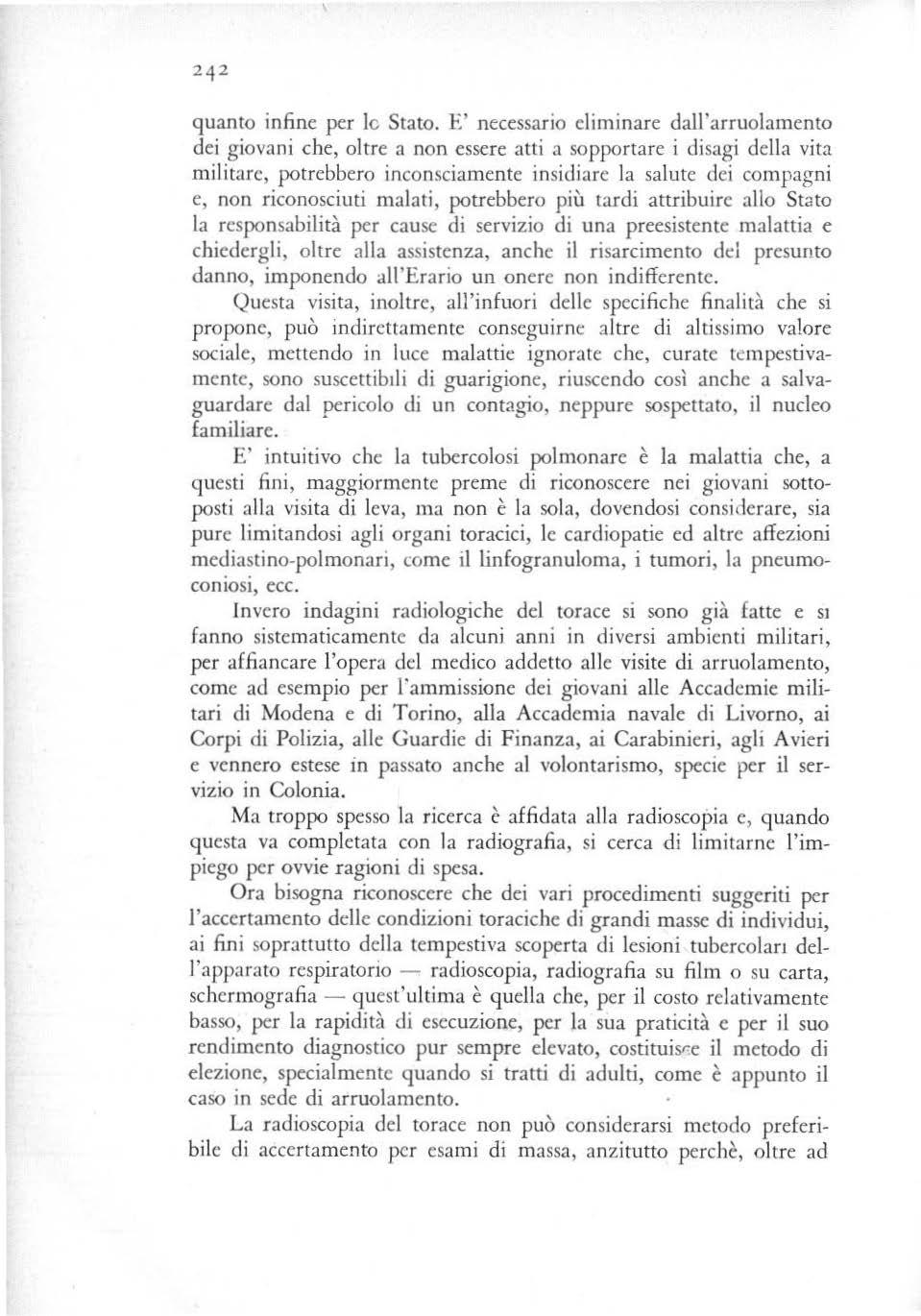
E' intuitivo che la tubercolosi polmonare è la malattia che, a questi fini, maggiormente preme di riconoscere nei giovani sottoposti alla visita di leva, ma non è la sola, dovendosi considerare, sia pur e limitandosi agli organi toracici, le cardiopatie ed altre affezioni mediastino-polmonari, come il linfogranuloma, i tumori , la pneumoconiosi, ecc.
1nvero indagini radiologiche del torace si sono già fatte e st fanno sistematicamente da alcuni anni in diversi ambienti militari, per affiancare l'opera del medico addetto alle visite di arruolamento, come ad esempio per l'ammissione dei giovani alle Accademie militari di Modena e di Torino, alla Accademia navale di Livorno, ai Corpi di Polizia, alle Guardie di Finanza , ai Carabinieri , agli Avieri e vennero estese in passato anche al volontarismo, specie per il servizio in Colonia.
Ma troppo spesso la ricerca è affidata alla radioscopia e, quando questa va completata con la radiografia, si cerca di [imitarne l'impiego per ovvie ragioni di spesa.
Ora bisogna riconoscere che dei vari procedimenti suggeriti per l'accertamento delle condizioni toraciche di grandi masse di individui, ai fini sopra ttutto della t empestiva scoperta di lesioni tubercolari dell'apparato respiratorio - radioscopia, radiografia su film o su carta, schcrmografia- quesl'ultima è quella che, per il costo relativamente basso, per la rapidità di esecuzione, per la sua praticità e per il suo rendimento diagnostico pur sempre elevato, costituisre il metodo di elezione, specialmente quando si tratti di adulti, come è appunto il caso in sede di arruolamento.
La radioscopia del torace non può considerarsi metodo preferìbile di accertamento per esami di massa, anzitutto perchè, oltre ad
essere pericolosa per il radiologo, è per lo anche troppo gravosa. Quando subentra nel radiologo la sta nch ezza per le molte radioscopic, scema poi anche 1l rendimento diagnostico di ({Uesto metodo e, dovendosi l imitar e per queste diverse ragioni il numero delle indagini, la radioscopia finisce a diventare poco economica per la necessi tà di protrarre nel tempo le operazioni di esame Essa riesce così anche più costosa della schermografia alla quale poi è sicuramente in(eri?re in quanto a percettibilità di detta g li c quindi a valore diagnostico.
Si aggiunga che la radioscopia è fondata del tutto su di una valutazione soggettiva c che non lascia documentazione.
Quanto aJla rad10grafia su film, se è senza dubbio superiore alla schermografia per definizione fotometrica c geometrica e per dettagli semeiologici, è così costosa, così lenta ad eseguirsi, così difficile ad archiviarsi da Pon potersi assolutamente consid era re metodo pratico per indagini di Altr ettanto può dirsi per la radiografia su carta che è invece meno costosa, ma meno esatta e ch e a sua volta presenta alcuni innegabili sva nta ggi pratici che derivano soprattutto dalla scarsa resistenza meccanica del materiale fotografico durante le operazioni di sviluppo.
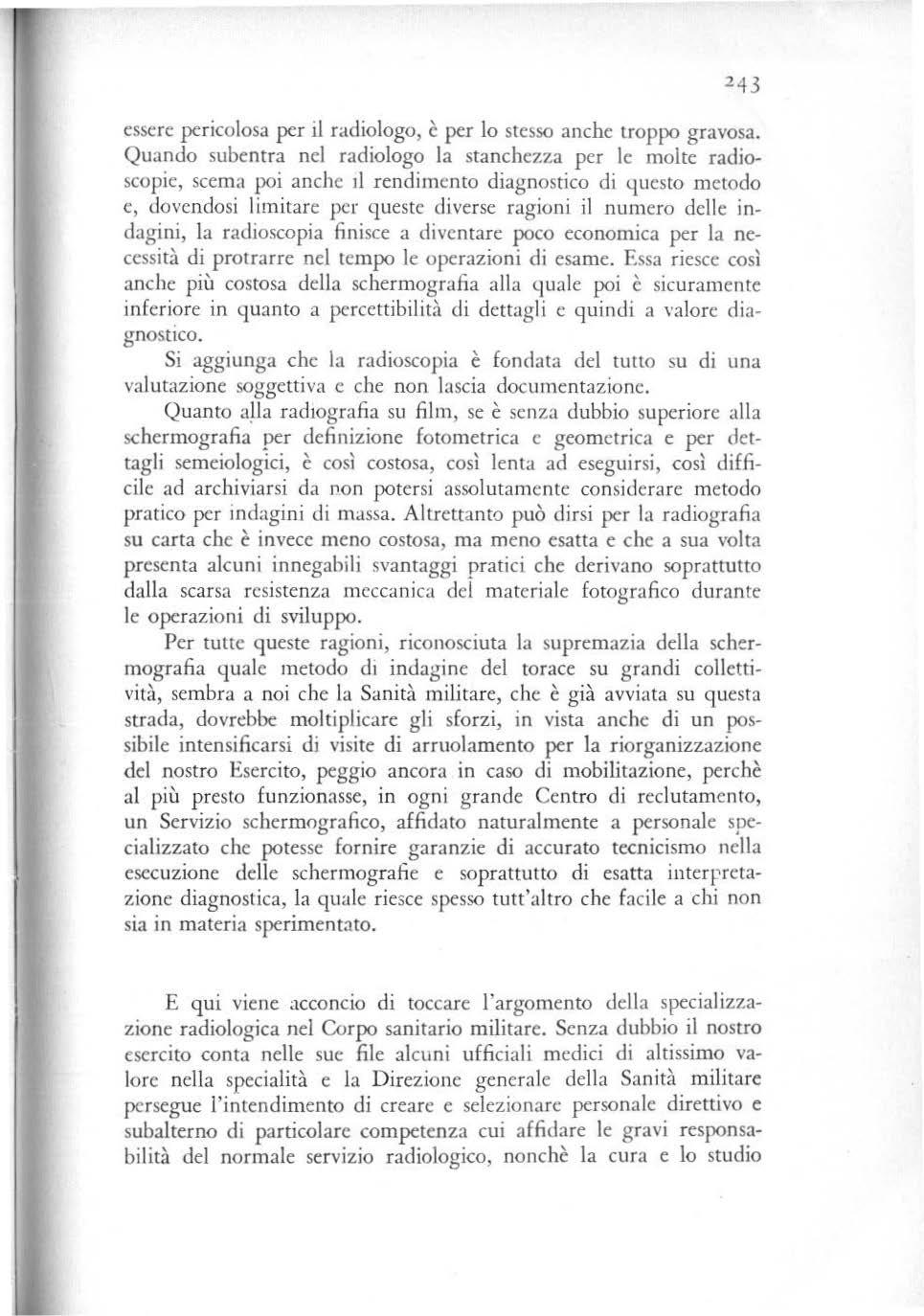
Per tutte queste ragioni, riconosciuta la sup remazia della schermografia quale metodo di indagine del torace su grandi collettività, sembra a noi che la Sanità militare, che è già avviata su questa strada, dovrebbe moltiplicare gli sfo rzi, in vista anch e di un possibile intensificarsi di visite di arruolamento per la riorganizzazione del nostro Esercito, peggio ancora in caso di mobilitazione, perchè al più presto funzionasse, in ogni grande Centro di reclutamento, un Servizio sc hermografico, affidato naturalmente a personale specializzato che potesse fornire garanzie di accurato tecnicismo nella esecuzione delle schermografie e soprattutto di esatta interpretazione diagnostica, la quale riesce spesso tutt'altro che fa ci le a chi non sia in materia sperimentato.
E qui viene acconcio di toc care l'argomento della specializzazione radiologica nel Corpo sanitario militare. Senza dubbio il nostro esercito conta nelle sue file alcuni ufficiali medici di altissimo valore nella specialità e la Direzione generale della Sanità militare persegue l'intendimen to di creare e selezionare personale direttivo e subalterno di particolare competenza cui affidare le gravi respon sabilità del normale servizio radiologico, nonchè la cura e lo studio
delle unità radiologiche di guerra che intende mantenere in piena efficienza e consone ai progressi della tecnica.
Ufficiali medici in servizio eftettivo vennero comandati periodicamente presso Ist ituti universitari di radiologia ed io stesso ·posso compiacermi di averne avuti di ottimi fra i miei assistenti. Si fecero un tempo richiami, a scopo di istruzione, di ufficiali medici specialisti e di personale subalter no, destinati ad eventuale impiego nelle unità specializzate.
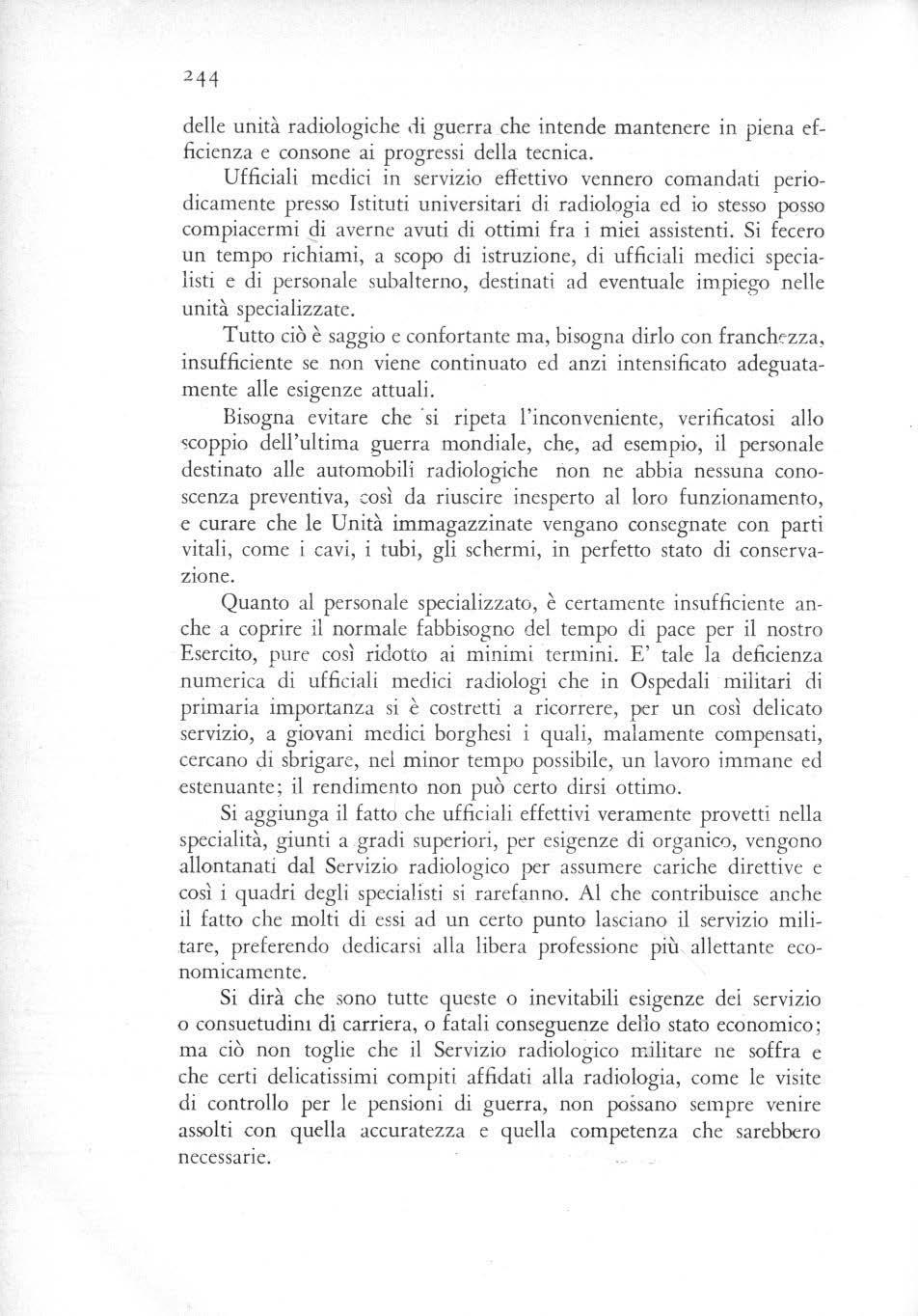
Tutto ciò è saggio e confortante ma, bisogna dirlo con franchezza, insufficiente se non viene continuato ed anzi intensificato adeguatamente alle esigenze attuali.
Bisogna evitare che "si ripeta l 'i nconveniente, verificatosi allo dell'ultima guerra mondiale, che, a.d esempio, il personale destinato alle automobili radiologiche ri.on ne abbia nessuna conoscenza preventiva, così da riuscir e inesperto al loro funzionamento, e curare che le Unità immagazzinate vengano consegnate con parti vitali, come i cavi, i tubi, gli schermi, in perfetto stato di conservazwne.
Quanto al personale specia lizzato, è certamente insufficiente anche a coprire il normale fabbisogno del tempo di pace per il nostro Esercito, pure così ridotto ai minimi termini. E' tale la deficienza numerica eli ufficiali medici radiologi che in Ospedali militari di primaria importanza si è costretti a ricorrere, per un così delicato servizio, a giovani medi ci borghesi i quali, malamente compensati, cercano di sbrigare, nel minor tempo possibile, un lavoro immane ed estenuante; il rendimento non può certo dirsi ottimo.
Si aggiunga il fatto che ufficiali effettivi veramente provetti nella speciali tà, giunti a g radi superiori, per esigenze di organico, vengono allontanati dal Servizio radiologico per assumere caric he direttive e cosi i quadri degli specia listi si rarefanno. Al che contribuisce anche il fatto che molti di essi ad un certo punto lasciano il servizio militare, preferendo dedicarsi alla libera professione più a l lettante economicam e nte.
Si dirà che so no tutte queste o inevitabili esigenze dei servizio o consuetudint di carriera, o fatali conseguenze del l o stato economico; ma ciò non toglie che il Servizio radiologico militare ne soffra e che certi delicatissimi compiti affidati alla radiologia, come le visite di controllo per le pensioni di guerra, non possano se mpre ventre asso l t i con quella accuratezza e quella competenza che sarebbero necessane .
Ora, se si considera quale onere gravoso sopporti l'Erario appunto per le pensioni, le quali, !>ia pur mis ere, sono purtroppo non di rado continuate a percepirsi indebitamente, si deve giungere alla conclusione che un maggiore sforzo finanziario che facesse io Stato per accrescere l'efficienza del Servizio radiologico militare sarebbe pur sempre largamente compensato.
Io non faccio che accennare al problema, di c ui riconosco le difficoltà di soluzione Prot1ideant Consules.
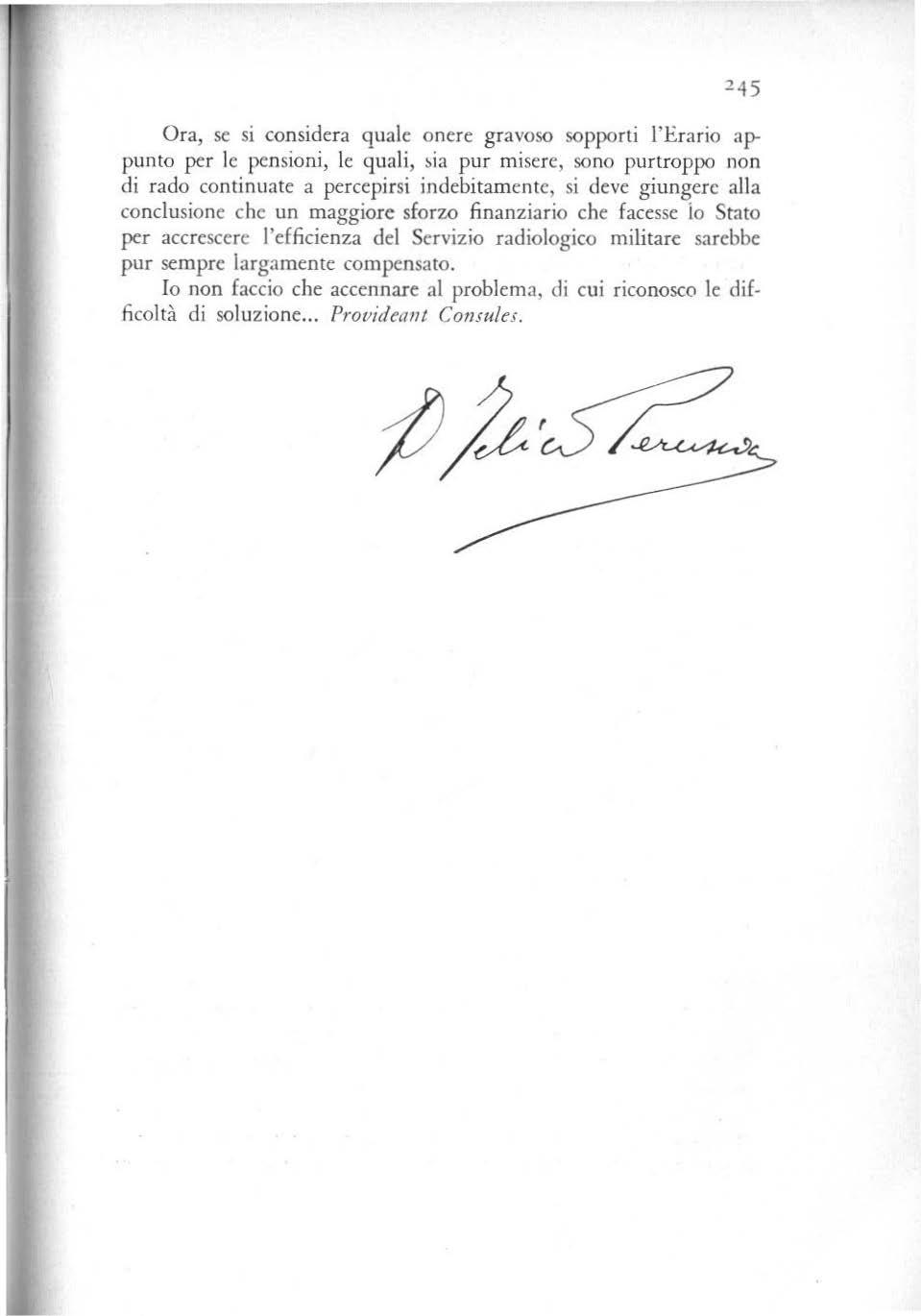
ASPETTI PS I G::O LOOICI
NEL CAMPO DELLA VACCINAZIONE ANT IRABI CA
Le indicazioni di vaccinazione antirabica sono oltremodo chiare dal punto di vista puramente tecnico e nella loro enunciazione teorica; ma quando si passi alla loro applicazione pratica ed al lato psicologico che sovente deve essere preso in considerazione nei riguardi della personalità del morsicato, la questione si complica e può ingen erare dubbi ed esitazioni perfino nei più competenti .
Scopo del presente scrit to è di passare in rivista i più comuni aspetti psicologici che si presentano in molti di coloro che accorrono negli Isti-tuti antirabici; aspetti che meritano di essere profondamente valutati e considerati da chiunque compia l'opera dd medico da un punto di vista veramente umano.
Questi aspetti vengono trascurati da quei medici i quali abbondano senza misuro. nella vo.ccinazione antirabica, vuoi per tema di responsabilità, vuoi per ca u se diverse, prescrivendola· anche quando le probabilità di contaminazione sono infinitamente al di sotto del danno che, sia pure raramente, può essere apportato dalla vaccinazione stessa .
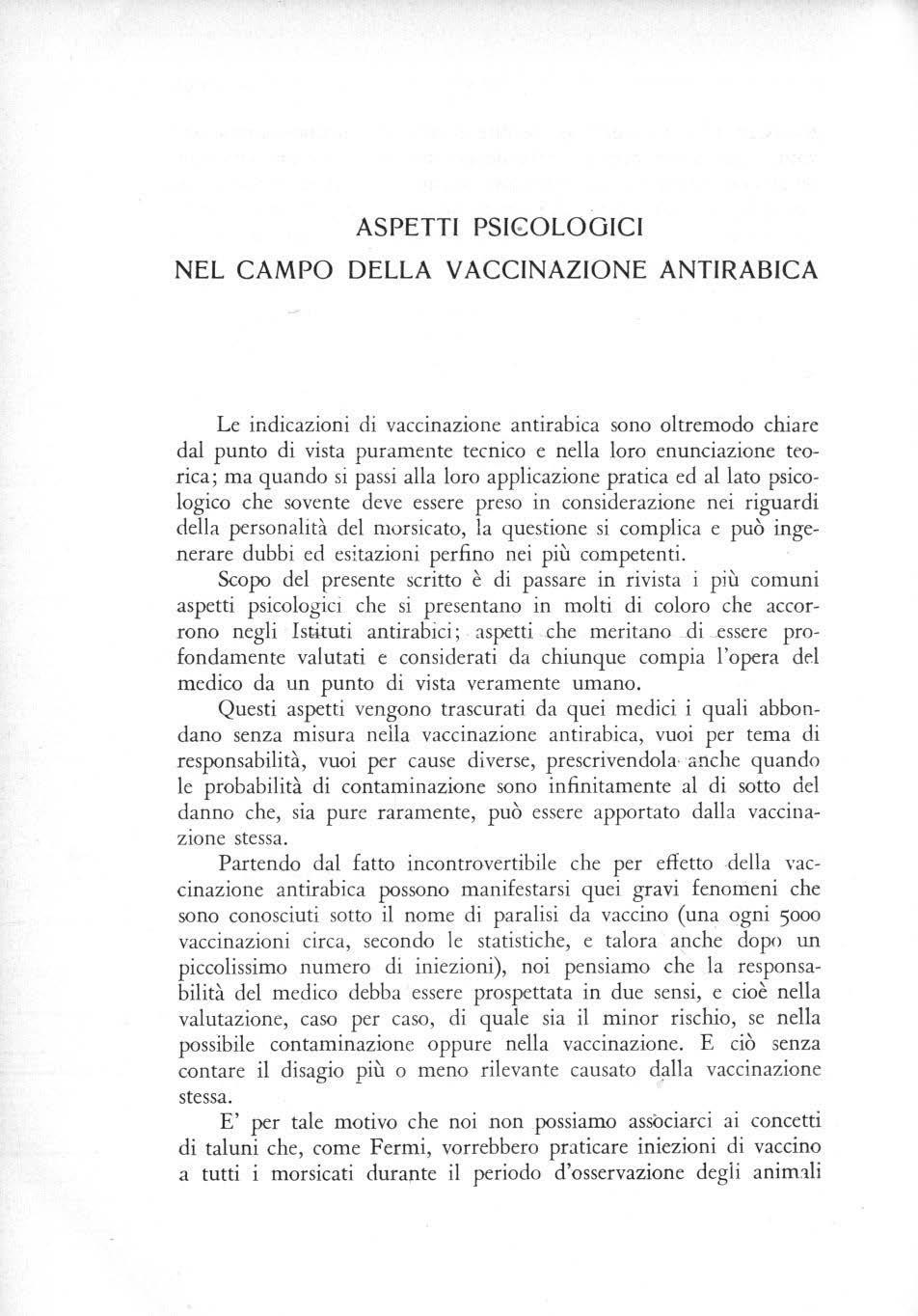
Partendo dal fatto incontr overt ibil e che per effetto della vaccinazione antirabica possono man i festarsi quei gravi fenomeni che sono conosciuti sotto il nome di paralisi da vaccino (una ogni 5000 vaccinazioni ci rca, secondo le statistiche, e talora anche dopo un piccolissimo numero di iniezioni), noi pensiamo che la responsabilità del medico debba essere prospettata in due sensi, e cioè nella val utazion e, caso per caso, di quale sia il minor rischio, se nella possibile contaminazione oppure nella vaccinazione. E ciò senza contare il disagio più o meno rilevante causato d;1lla vaccinazione stessa .
E' per tale motivo che noi non possiamo assòciarci ai concetti di taluni che, come Fermi, vorrebbero praticare iniezioni di vaccino a tutti i morsicati durante il periodo d'osservazione degli anim:1li
morsicatori (cioè 15 giorni); mentre preferiamo valutare, volta per volta, l'entità del pericolo, attendendo senz'altro nei casi che non presentano urgenza, e !imitandoci a] minor numero possibile di iniezioni precauzionali quando vi sia una certa gravità delle ferite. In ciò siamo in pieno accordo con le prescrizioni dettate dal Comitato internazionale degli esperti per la rabbia, presso l ' Orgamzzazione Mondial e della Sanità.
Ciò premesso, passiamo ad esaminare i vari aspetti della question e.
I FOBICI DELLA RABBIA.
Il caso più tipico fra quelli occorsi nell'Istituto ant irabico di Rom a riguarda una signora ungherese, la quale sovente veniva presa dal dubbio di essere stata contaminata da qualche cane passatole vicino o che l'aveva appena sfiorata. Questa idea diveniva in lei ossessionante e tale da turbarle profondamente lo stato mentale; venn e condotta per la prima volta all'Istituto da un neurologo , il quale ritenne necessaria, ai fini psicoterapici, di praticare una vaccinazione (che venne effettuata a dosi ... omeopatiche!), in seguito alla quale la paziente riacquistò piena tranquillità. La predetta persona ritornò altre volte nelle stesse condizioni e venne curata nello stesso modo.
Senza arrivare a questi estremi, che c0nfinano co n la paranoia, ma che - per fortuna - si presentano solo raramente, vi sono molte persone, straordinariamente apprensive per il proprio stato di sa lut e, le quali, avendo avuto contatti gene ri ci, assolutamente privi di pericolo (contatti con il pelo, contatti anche con la bocca ma avendo la pelle delle mani assolutamente integra) con animali rabbiosi o sospetti , entrano in un forte stato di agitazione, e restando insensibili - o almeno dubbiosi - di fronte alle paro le tranquillizzanti del medico esperto, richiedono con insistenza la vaccinazione.
Soggetti intelligenti cominciano a consulta re Libri ed enciclopedie, ad interrogare medici non esperti in fatto di rabbia, e finiscono per trarre personali conclusioni pessimistiche che li pongono in uno stato di tremendo dubbio; soggetti non istruiti danno ascolto a fanta stici racconti di persone ignoranti, che trovano molto spesso più credito del medico, e divengono essi pure degli apprensivi difficilmente suscettibili di persuasione . Le sale d'aspetto degli Istituti antirabici sono spesso i luoghi delle più perniciose conversazioni!
Persone molto suggestionabili, impressionate da letture e da racconti, possono credersi già in preda ai sintomi della idro_fobia, dichiarando che trovano difficoltà a bere. Medici poco espertt, che
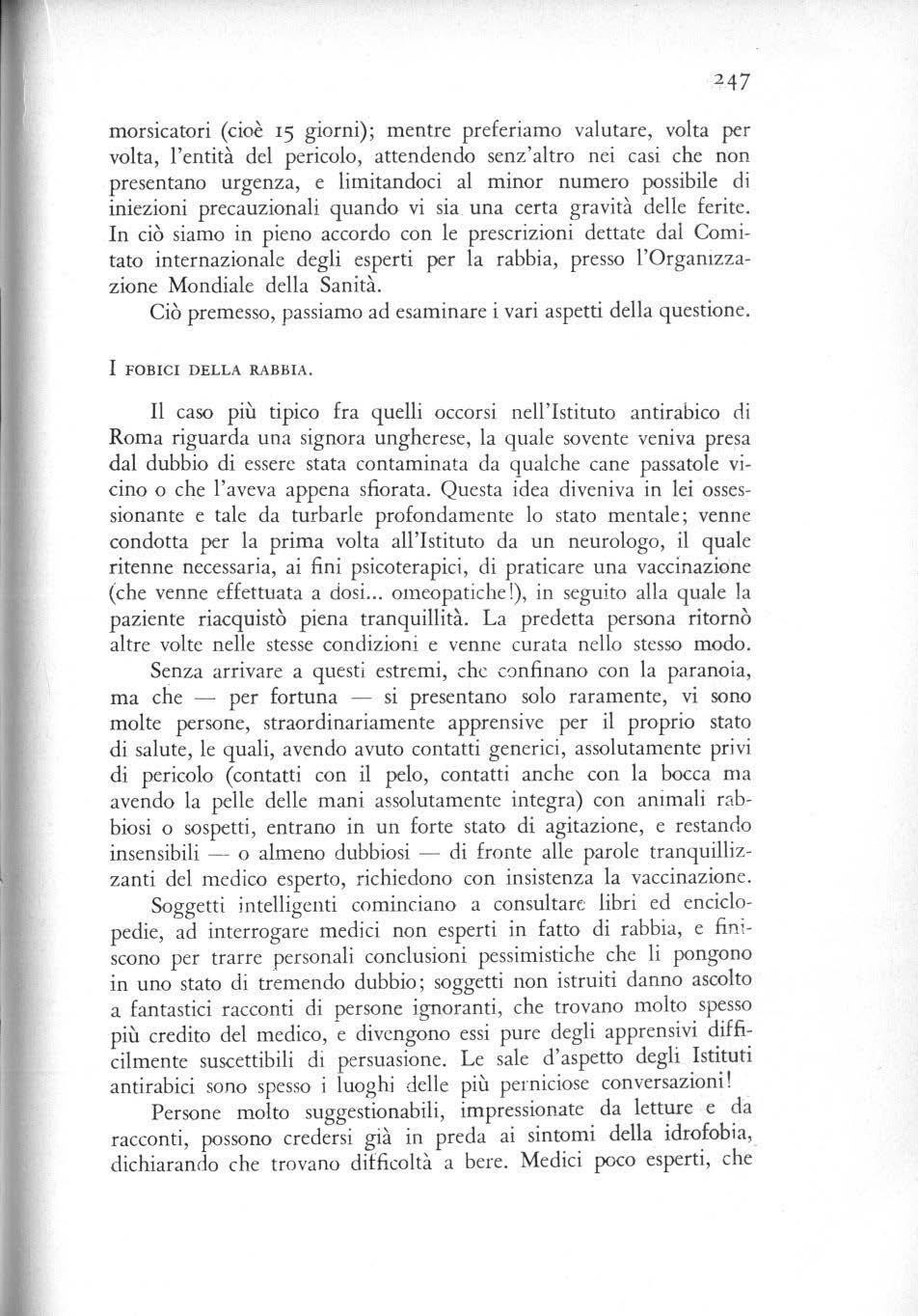
non hanno mai visto casi di vera Idrofobia, possono essere tratti in inganno, come noi !>tessi abbiamo potuto constatare più volte. Ma l'assenza della febbre (sempre presente nell'idrofobia), le notizie anamnestiche, la data della morsicatura, e soprattutto il modo con il quale si manifesta questa idrofobia da suggestione , profondamente diversa dalla vera idrofobia, pongono facilmente i n grado il medico esperto di escludere la rabbia.
Non sempre il medico preposto a1 antirabici arriva ad esercitare la propria autorità ed a smontare ingiustificati timori; qualche volta, ad evitare lo stabilini di veri stati nevropatici, può essere opportuna una certa condiscendenza, limitando la vaccinazione ai tempi più brevi ed eventualmente inoculando simboliche dosi è1 vaccino, che ridanno la tranquillità. In questa linea di condotta noi siamo stati talvolta confortati ed incoraggiati dal parere di specialisti neurologi.
Si dà anche il caso che taluni di questi apprensivi, dopo essersi mostrati momèfltaneamente convinti dalla parola rassiciJI ante del medico, tornino :,uccessivamcnte alla carica facendo una nuova deposizione, diversa dalla prima, frutto talora di un'autosuggestione, talaltra di calcolo, per ottenere l'intento della vaccinazione; diranno ad es. che ricordano di aver avuto una ferita sanguinante a lla mano, oppure di avere avuto un colpo di lingua sulla bocca, o anche di essersi portati alla bocca una mano che era stata leccata dal cane Di &onte a queste affermazioni il medico si trova di sarm1to e nell'alternativa di credere o di non credere, di assumersi o non assumersi una responsabilità, finisce per capitolare e prescrivere una vaccinazione che, in coscienza, ritiene estorta!
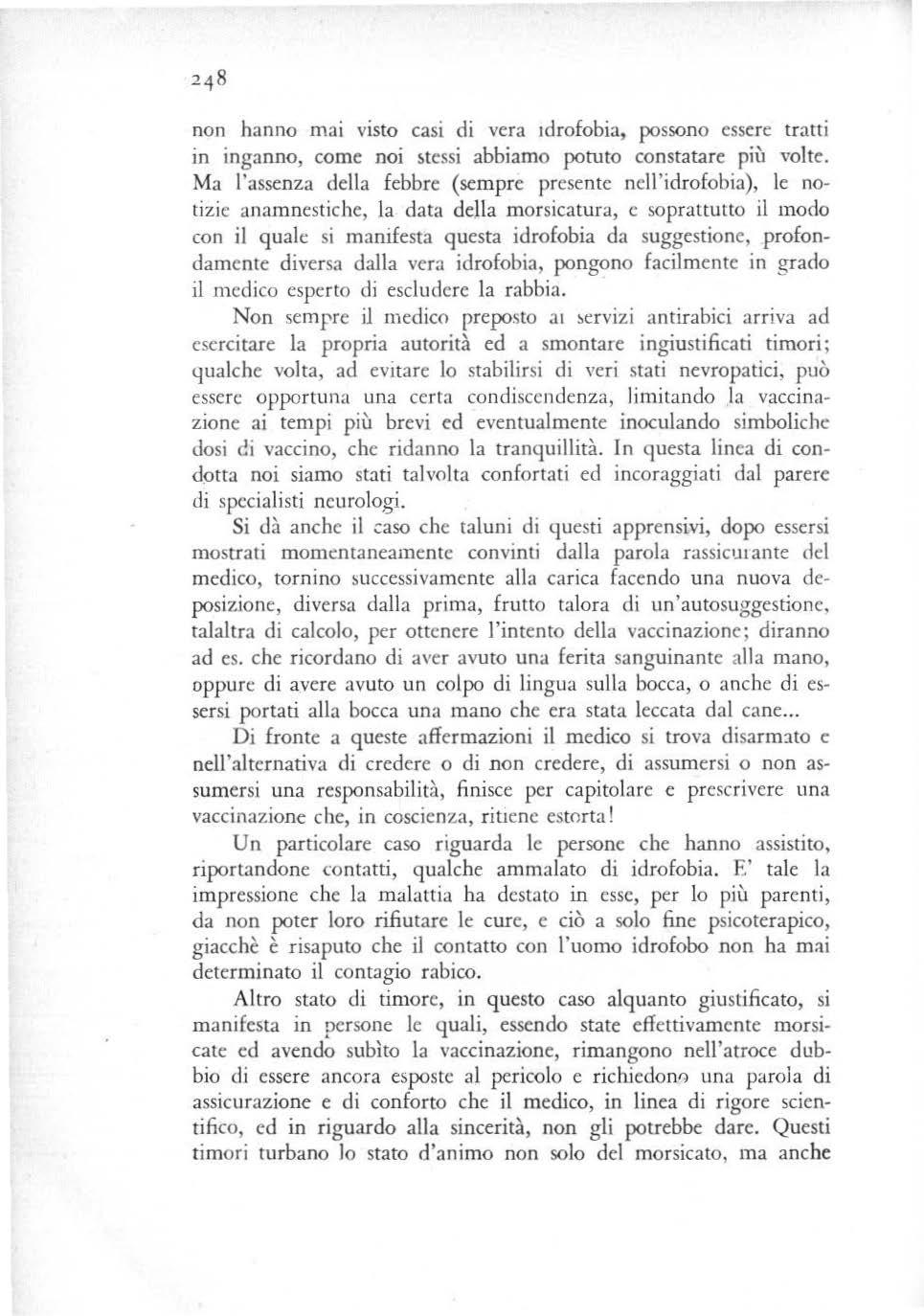
Un particolare caso riguarda le persone che hanno assistito, riportandone contatti, qualche ammalato di idrofobia. E' tale la impressione che la malattia ha dest:no in esse, per lo più parenti, da non poter loro rifiutare le cure, e ciò a solo fine psicoterapico, giacchè è risaputo che il contatto con l'uomo idrofobo non ha mai determinato il contagio rabico.
Altro stato di timore, in questo caso alquanto giustificato, si manifesta in persone le quali, essendo state effettivamente morsicate ed avendo subìto la vaccinazione, rimangono nell'atroce dubbio di essere ancora esposte al pericolo e una parola di assicurazione e di conforto che il medico, in linea di rigore scientifico, cd in riguardo alla sincerità, non gli potrebbe dare. Questi timori turbano lo stato d'animo non solo del morsicato, ma anc h e
dei suoi congiunti; vi sono molte madri tormentate dall ' atroce dubbio per i loro figli.
Il modo di oomportarsi in questi casi lo appresi, ne1 begli anni in cui ero studente, da un grand e Maestro della medicin::t, da Luigi Silvagni, Egli stesso discepolo ÙJ un più grand e Maestro, di Augusto Murri, il grande clinico di Bologna.
Una madre , che aveva avuto il figlio morto per paraiisi cardiaca post-difterica , ed avendo un secondo figlio convalescente di difterite, trovandosi in terribile ansia consultò Silvag ni, nell'ambulatorio della clinica, per sapere se anche quest'altro figlio il pericolo di finire come il primo . Silvagni, dopo avere ascoltato il fanciullo con il nudo orecchio, died e alla madre la matematica assicurazione che nulla sarebbe accaduto: c la donna parve ritornare a vita (in effetti il bambino si salvò). Stupiti, gli domandammo poteva dare una simile assicurazione; ci rispose che in effetti tale assicurazione non poteva essere data, ma che non dipendendo la sorte del fanciullo dal tono della sua risposta, non vedeva il motivo di allarmare qu ella donna. « E se il bambino morisse? » gli fu chiesto « Alla peggi o mi daranno della b es tia, ma io intanto ho confortato la madre! »
Questi insegnamenti umani sono quelli che non si dimenticano e che sono più preziosi delle cure materiali. Quando una persona vaccinata, o quando la madre di un bambino vaccinato mi chiede trepidando se c'è ancora qualche probabilità di pericolo, io dimentico che la vaccinazione antirabica può dare il 2, o il 3, o il 5 per mille di insuccessi e garantisco che si può essere matematicamente sicuri del successo. Alla peggio mi daranno ... come diceva Silvagni!
Una caratteristica situazione psicologica determinata da ing:ustifìcato terrore della rabbia e impern iata su quella parola « matematicamente » , è stata in modo magistrale immaginata ed interpretata da Alfredo Panzini in quel capolavoro di novella che porta per titolo « Il topo di biblioteca >'. Bisogna aver vissuto lunghi anni in un istituto antirabico per apprezzare la profonda ver1tà umana contenuta in quello scritto, che merita veramente di essere letto.
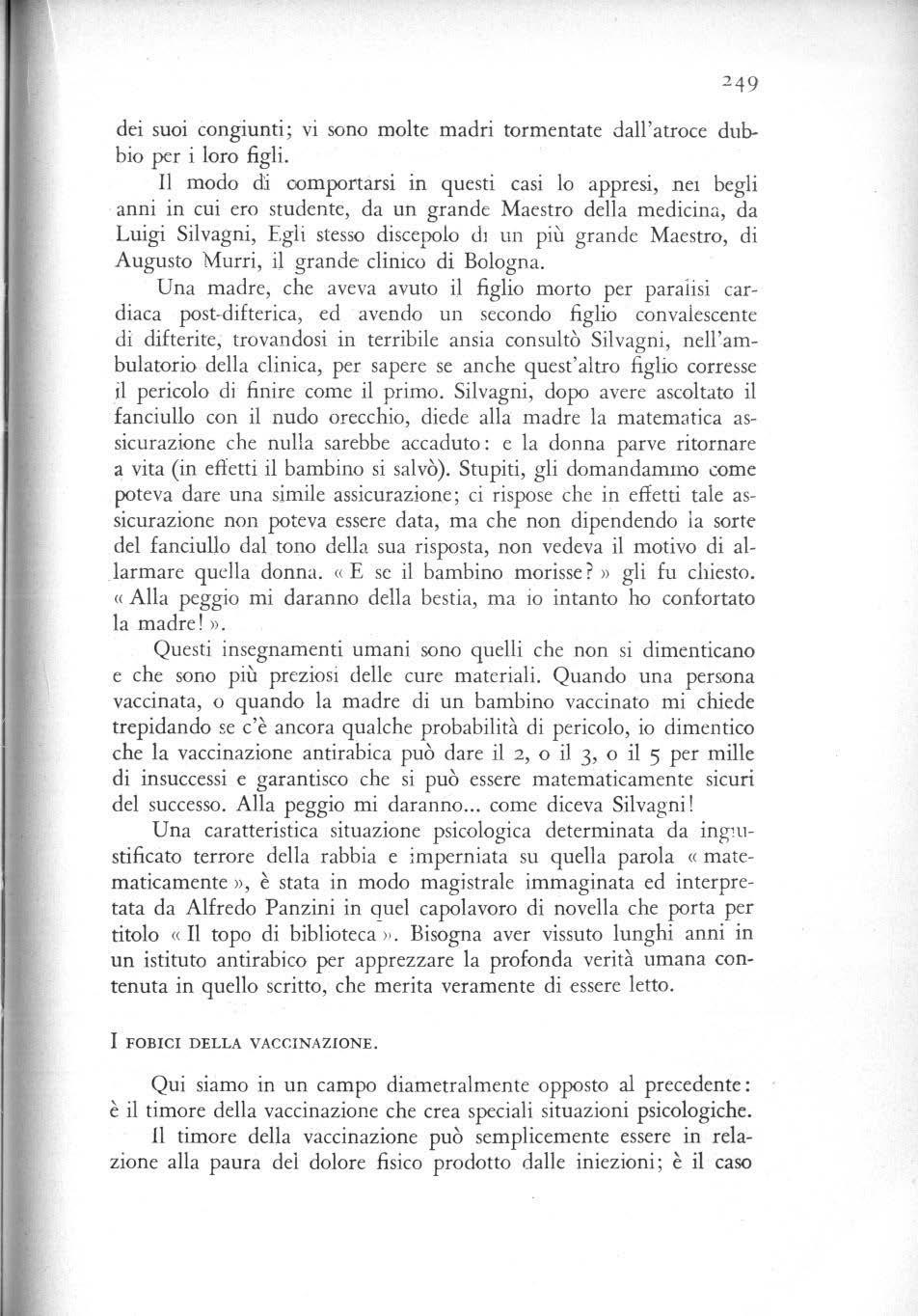
Qui siamo in un campo diametralmente opposto al precedente:
è il timore della vaccinazione che crea speciali situazioni psicologiche.
H timore della vaccinazione può semplicemente essere in relazione alla paura cleì dolore fisico prodotto dalle iniezioni; è il caso
l FOBICI DELLA VACCINAZfONE.
dei fanciulli, i quali, per non essere sottoposti alla vaccinazione, mentiscono nel modo più manifesto, negando lesion i o contatti che hanno effettivamente avuto luogo. Sono oltremodo comuni le scene che avvengono fra i ragaz zi, che giura no e spergiurano di non ave r avuto contatti con animali rabbiosi, ed i loro genitori che asseriscono il contrario e che - nell'ansia di sapere i figli in pericolo - finiscono anche per esagerare. Come linea di condotta si deve se mpre dubitare delle dichiarazioni negative dei ragazzi che si presentano come in uno stato di allarme c di difesa, e che sono troppo deci si nell'affermare il nessun rapporto con cani di casa; la dimestichezza che i ragazzi hanno con i cani, la comune abitudine di avvicinare la faccia al muso Jel cane rende oltremodo f acili le lambiture al volto, il c ui pericolo non può essere posto in dubbio. Per lo più, quando si dubiti di l..tmbiture al volto o su lesioni di co ntinuo della pelle, è opportuno rimettersi al g iudizio che i genitori danno su ll a intimità dei rapporti fra i ragazzi e l'animale divenuto rabido.

M a i ragazzi non sono dei veri fobici della vaccinazione: sono semplicemente dei timorosi delle iniezioni, allo stesso titolo c he sono timorosi di qualsia si intervento sa nitario.
I veri fobici sono tutt'altra cosa; sono soggetti i quali vedono nella vaccinazione antirabica qualche c.:osa di pauroso, quasi un rischio indefinito del quale non sanno render si conto. La loro paura non riguarda quei danni che, sia pure raramente, la vaccinazione può determinare, perchè in generale essi non li sospettano neppure; ma deriva da un qualch e cosa di ignorato, associato alla terribilità della malattia, per cui terribile è sospetta to anche il rimedio.
fobici tentano di sminuir e la reale consistenza dei fatti, alterando l'anamnesi del cane o di altro animale che li ha morsicati o contaminati c svalut.ando i rapporti avuti con essi. Si direbbe che vogliano insinuare e trasformare nel medico la convinzione del nessun pericolo ed attendono poi una paroia tr:mguillizzatrice che sono pronti ad accogliere come un 'assoluzione. La loro menzogna è inconsapevole e forse dallo scrupo lo che un troppo obiettivo racconto dei fatti, senza va lutazione personale, possa sviare il medico, anzichè illuminarlo sulla vera situazione.
Quando esistono le indic::.zioni di vaccinazio ne , è per lo facile persuadere queste persone, mediant e buoni argom enti, circa l'opportunità del trattamento; vi sono tuttavia alcuni soggetti che vi si rifiutano con fermezza e che firmano la dichiarazione di assu mersi personalmente la responsabilità di quanto possa accader e
Quando invece la constatazione obiettiva dei fatti porti ad escludere il pericolo ed a tali persone possa essere effettivamente detta la parola tranquillizzante, allora si vedono delle vere ed immediate guarigioni dello spirito, il sollevamento da un peso che accasciava e, non di rado nelle donne, quelle crisi di pianto che sogliono seguire aè una imperata gioia.
SrMULATORr E RICATTATORI.
Costedoat, in un libro dal titolo: La simulation des symptomes pathologiques et des maladies, edito da Baillière (Parigi, 1933), in un paragrafo che tratta delle morsicature simu late, narra che fu scoperta una banda eli truffatori i quali aveva no attuato un mezzo ingegnoso ed originale per sfruttare i proprietari di equini. Uno di essi passava vicino ad un cavallo fermo presso un marciapiedi, mentre il proprietario era as sente. Quindi si poneva improvvisamente a gridare come se fosse stato morsicato, e mentre era soccorso e spogliato, mostrava su lla spa ll a o sul braccio ddle piccole ferite simili a quelle che soglio no essere prodotte dalle morsica tu re; i complici affermavano l'autenticità del fatto. Fu poi scoperto che le ferite venivano prodotte con uno speciale strumento appli cato suUa· pelle, il quale , a prezzo di modico dolore, simulava assai bene la morsicatura di un cavallo. Il finto morsicato poteva evidentemente stabilire su ciò il piano di un ricatto, anche se gli veniva rifiutata la vaccinazione antirabica in seguito aà accertamento del buono stato di salute del caval lo.
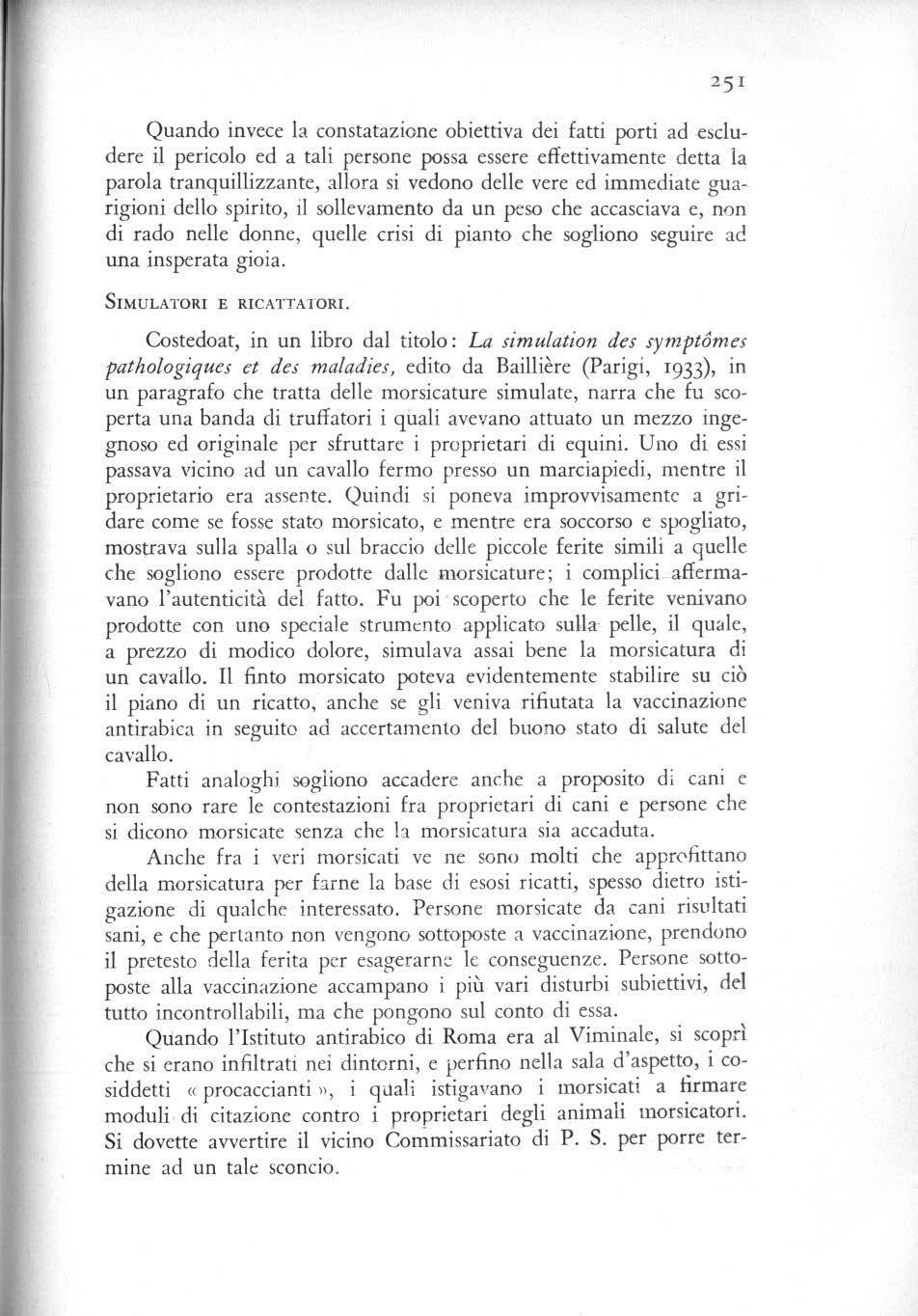
Fatti analoghi sogl ìono accader e anche a proposito di ca ni e non sono rare le contestazioni fra proprietari di cani e persone che si dicono mor sicate che la morsicatura sia accaduta.
Anche fra i veri mor sicati ve ne sono molti che appr0fìttano della morsicatura per farne la base di esosi ricatti, spesso dietro istigazione di qualche interessato. P<:>rson e morsicate da cani risu lta ti sa ni, e che pertanto non vengono sottoposte a vaccinazione, prendono il pretesto della ferita per le conseguenze. Persone sottoposte alla vaccinazione accampano i più vari disturbi subiettivi, dd tutto incontrollabili, ma che pongono su l conto di essa.
Quando l'Ist1t uto antirabico dì Roma era al Viminale, si scopd che si e rano infìltrati nei dintorni, e perfino nella sala d'aspetto, i cosiddetti « procaccianti 11, i quali istigavano i morsicati a tìrmare moduli di citazione contro i proprietari degli animali morsicatori. Si dovette avvertire il vicino Commissariato di P. S. per porre termine ad un tale sconcio.
Il .simulatore o ricattatore è sempre un soggetto ostinato, che reclama la vaccinazione antirabica anche quando non è indicata e c he giunge ad imprecare quando la vaccinazione gli viene rifiutata.
l PROFIITATORI.
Nel 1937 P. Remlinger, sotto il titolo: Les resquilleurs de la vaccination antirabique, richiamava l'attenzione, con una nota pubblicata nella (( Presse Médicale >> (anno 45, p. 228, 1937), sopra un fatto d'altra parte ben noto a tutti i Direttori di istituti antirabici, e cioè su quell e persone le quali, per un qu alsiasi movente, ad ottenere una vacbnazione antirabica che non sarebbe necessaria.

Il termine « resquilleurs » usato da Remlinger e tradotto col termine « profittatori >> nel presente articolo, implica evidentemente un interesse non confessato di coloro i quali, alterando i fatti, sorprendono la buona fede clel medico , costringendolo a co prire la propria responsabilità con 1l prescrivere la vaccinazione.
Si tratta sempre cE soggetti che fingono di essere stati morsicati, ma si differenziano dalla categoria precedente perchè il loro fine non è il ricatto (infatti asseriscono di non conoscere il proprietario dell'animale), ma semplicemente quello di subire una vaccinaz ione antirabica che richieda la loro permanenza in un determinato luogo .
R emlinger, nel suo articolo, cita moventi assai vari, sia nella vita civile che nella vita militare . Nel la vita civile può essere preso il pretesto di una simulata morsicatura per ottenere, a spese del Comune o eli altro Ente, un trasferimento eli qualche settimana da una zona rurale in una ci ttà sede di istituto antirabico; oppure per ricevere gratuitamente il battesimo dell'aria quando, in condiz io ni coloniali, per accedere al più vicino Is t ituto antirabico occorra il traspo r to per via aerea; oppure il desiderio di conseguire un periodo di riposo per lavoratori soggetti a lavori molto pesanti; o anche il desiderio di ottenere un viaggio gratuito .. .
Nel nostro paese questi moventi sono pressochè sconosciuti nella popolazione civile, mentre lo stesso non può dirsi nel campo militare, dove i profittatori, scarsissimi in tem pi normali, si sono sempre moltiplicati durant e le guerre.
I n tempo di pace il profìttatore è in genere una recluta chiamata sot to le armi, che desidera di ritardare la sua partenza.
In tempo di guerra sono sempre soldati inviati in licenza i quali, quando questa sta per scadere, adducono il pretesto della morsicatura per prolungarla.
La sto ria che raccontano è st r ao rdin ariam e nte monotona: tutti sono stati aggrediti da nn cane sconosciuto che poi si è dileguato ed è sfuggito ad ogni ricerca; a testimonianza del fatto mostrano una qualsiasi lesione di continuo. I noltre la simulazione è preparata e st udiata : il soggetto h a sempre pronta la risposta a d ogni doma nda, sa dare le ca ratte ri stic h e del cane, sa dire in che luogo è stato morsicato, sa raccontare i particolari del fatto .
Quando il m o r sicato viene inviato all ' I stituto antirabico con regolare richiesta dell'Autorità militare, egli prende tutti 1 pretesti per fare delle assenze c prolungare così il periodo della vaccinazione, oppure acc u sa di sturbi vag hi ed inconvenienti per ottenere per iodi di riposo e li cenza di convalescenza.
L'esempio è contagioso; qu::tlche volta s! sono avuti episodi epidemi ci, vera ment e carat t eri stici, e che danno la sicurezza che si debba trattare di profitta tor i. Tanto nella prima guerra mondiale, qtianto nella guerra d'Africa, qua nto nell a seco nd a guerra mondiale, le sal e d'aspetto degli I stituti antirabici si sono sempre popolate di militar i profittatori .
R em linger accenna alla possibilità di acquistare la convinzione della sim u lazione su ll a base d e ll a personalità del soggetto, unitamente alle circostanze del presunto accidente c dell'assenza di testimoni; e lamenta che manchi spesso il coraggio civile nel prendere certe determinazioni; ma in effetti il rifiuto della vaccinazione implica una cos ì grave responsabilit à che io non sapre i consigliarlo .
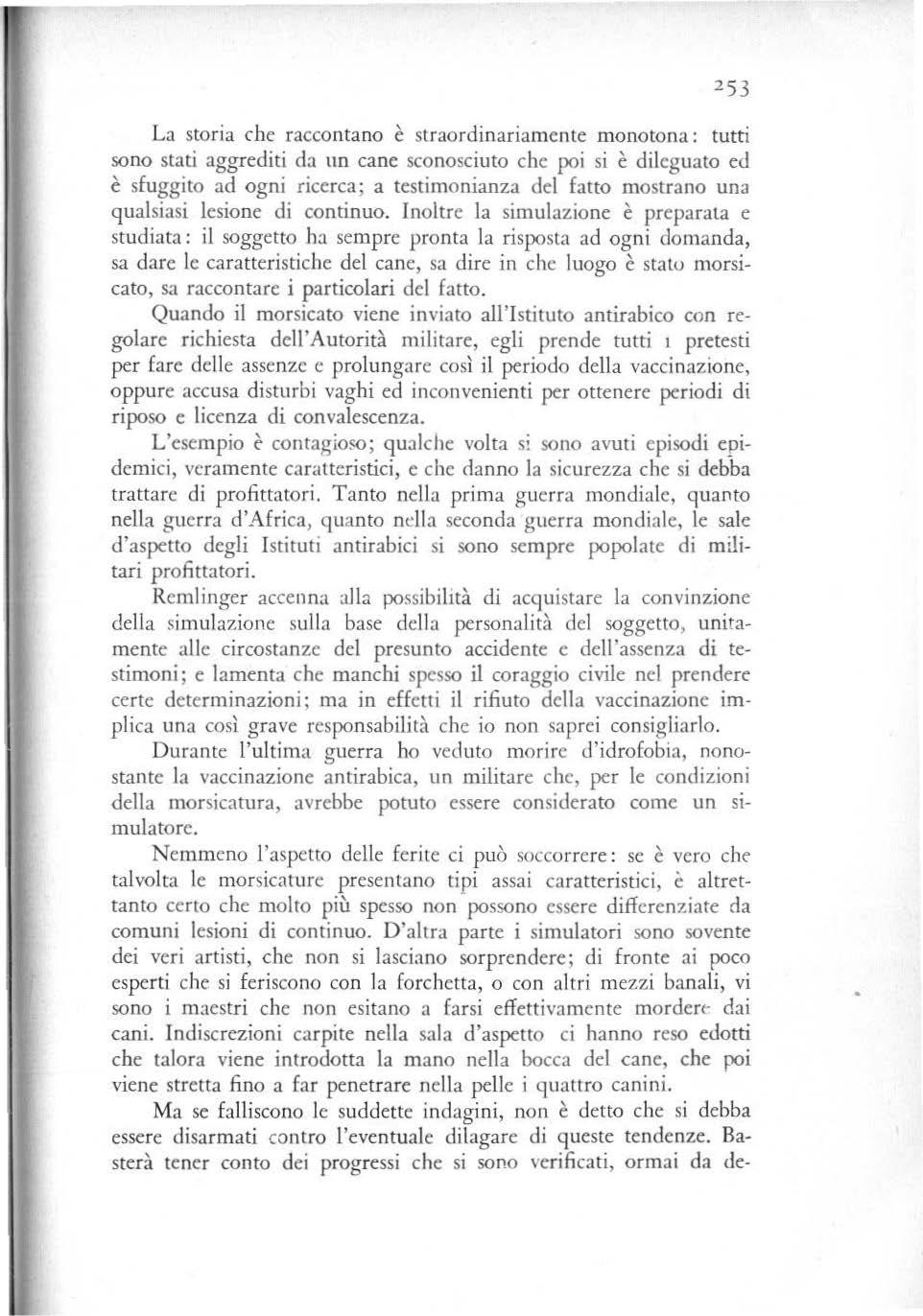
Duran te l'u l tima gue rra ho veduto morire d'idrofobia, nonostant e la vaccinazione antirabica, un militare che, per le condizioni della morsicatura, avrebbe potuto essere considerato come un stmulatore.
Nemmeno l'aspetto delle feriLe ci può soccor r ere : se è vero che talvolta le morsicat ur e presentano tipi assai cara tteristi ci, è a ltrettanto ceno che molto più spesso non possono essere differenziate da comuni lesioni di continuo . D 'altra parte i simulatori sono sovente dei veri a rti sti, che non si la scia no so rprend ere; di fronte ai poco esperti c he si feriscono co n la forchetta, o con altri mez zi banali, vi sono i m:1cstri che non esi tan o a farsi effettivamente morder(- dai cani. Indi screzioni ca r pite nella sala d'aspetto c i hanno reso edotti che talo r a viene introdotta la mano nella bocca del cane, che po i viene stretta fino a far penetrare n e lla pelle i quattro canini .
M a se falliscono le s uddette indagini, non è d e tto che s i d ebba essere di sa rmati co ntro l'eventual e dilagare di queste tend e nze. Basterà te ne r conto d ei p rogressi c he si sono ve rifi cati, ormai da de-
cenni, nella vaccinaziOne antirabica mediante l'uso dei vaccini fenicati e con la possibilità di effettuare le vaccinazioni fuori degli Istituti produttori e perfino a domicilio.
Questo progresso ha già arginato, a detta dello stesso Re mlinger, gli abusi che si avevano nel campo civile. E' più pratica ed economica l a spedizione dci vaccwo dall'Istituto produttore al domicilio del morsicato, che non l'invio del morsicato alla sede dell'Istituto.
Invece l'Autorità militare non ba finora ritenuto opportuno di orientarsi verso questo indirizzo. Ad es., per ciò che riguarda Roma, i militari che dichiarano di essere stati morsicati, vengono curati in Roma stessa anche se - per licenza - provengono da guarnigioni distanti. Ottengono così il loro intento che, durante la guerra, è duplice: prolungare il soggiorno presso la propria famiglia, e sottrarsi, per un pari periodo di tempo, ai disagi ed al pericolo.
Il rimedio contro una tale situazione è pertanto evidente: esso consiste nell'adottare le vaccinazioni antirabiche presso i Corpi. Verrebbe così a cadere il movente della simulazione, la quale non avrebbe più scopo.
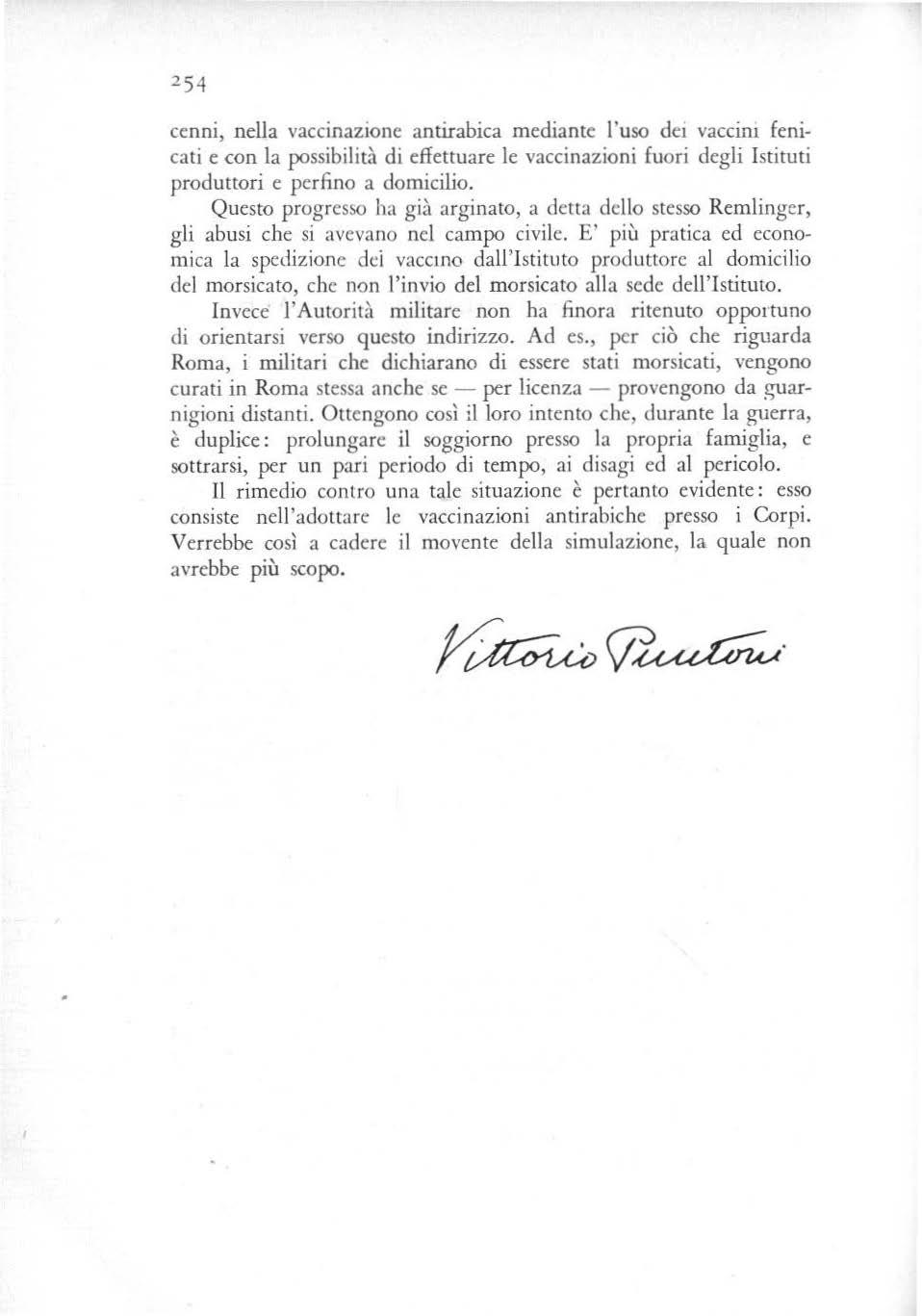
CONS I DE RAZ IONI E CAS I ST I CA SU LL E NEOP L AS I E
A LL A L UCE DE I PA RER I ES PRESS I
DA L COL L EG I O MED I CO -LEGA L E
Uno degli argomenti più compltssi e indaginosi che deve affwntare il Collegio medico-legale, su richiesta di parere ai fini pensionistici da parte di Enti var i, e in specie da parte della Corte dei Conti, èquello delle neoplasic in sen so lato, ivi comprese l e leucemie, che oggi moltissimi fr a i p iù autorevoli rappresentanti del progresso scientifico includono nel grande capitolo delle affezioni neoplastichc.
Premesso che non si può generalizzare e che giova sempre dicaso da caso, si rende necessario 1mpostare un criterio direttivo o, co m e si dice co mun emente, stabilir e un a prassi ch e se rva di punto di partenza per giungere, attraverso le considerazioni cltnico-scientifiche, c1d un sereno ed obbiettivo parere medico-legale.
Il meccanismo czio-pa togenetico delle neoplasie, nonostante l'enorme lavoro di indagmi c di ricerche, c he si rinn ovano, si ampliano, si moltiplica no con crescente fervor e, n o n è stato ancora sicuramente accertato; è noto tuttavia che determinati fattori irritativi, speete se agiscono in m aniera prolungata nel t<·mpo, possono condurre a delle tra sformazioni in seno ai t essuti che favoriscono l'insorgenza e lo sviluppo di una neopla sia; ed è noto altresì che talune sostanze agiscono da veri fattori ca n ce ro ge ni in patologia spe rimental e. Ma, si tratta di casi ben limitati. Nella grande m aggiora n za dei casi, che giungono all'esame del Collegio medico, non si intravede, presrochèmai, rapporto diretto fra eventi di servizio, militare o civile, cd insorgenza d ell a n eo p lasia; anche eventuali fattori co n causa li appa iono spesso incerti o addotti male a proposito dalla parte interessata.
E' nozione ormai acquisita c he le neoplasie sono in reale e continuo aumen to, che rappresentano una d elle più importanti cause di morte, che colpiscono sogge t ti di qua l siasi condizio n e socia le, o tra il benessere e gli agi o fra stenti e fatiche contin ue , che vi so no organi e tessuti c h e pltl facilmente di altri sono suscettibili di trasformazioni
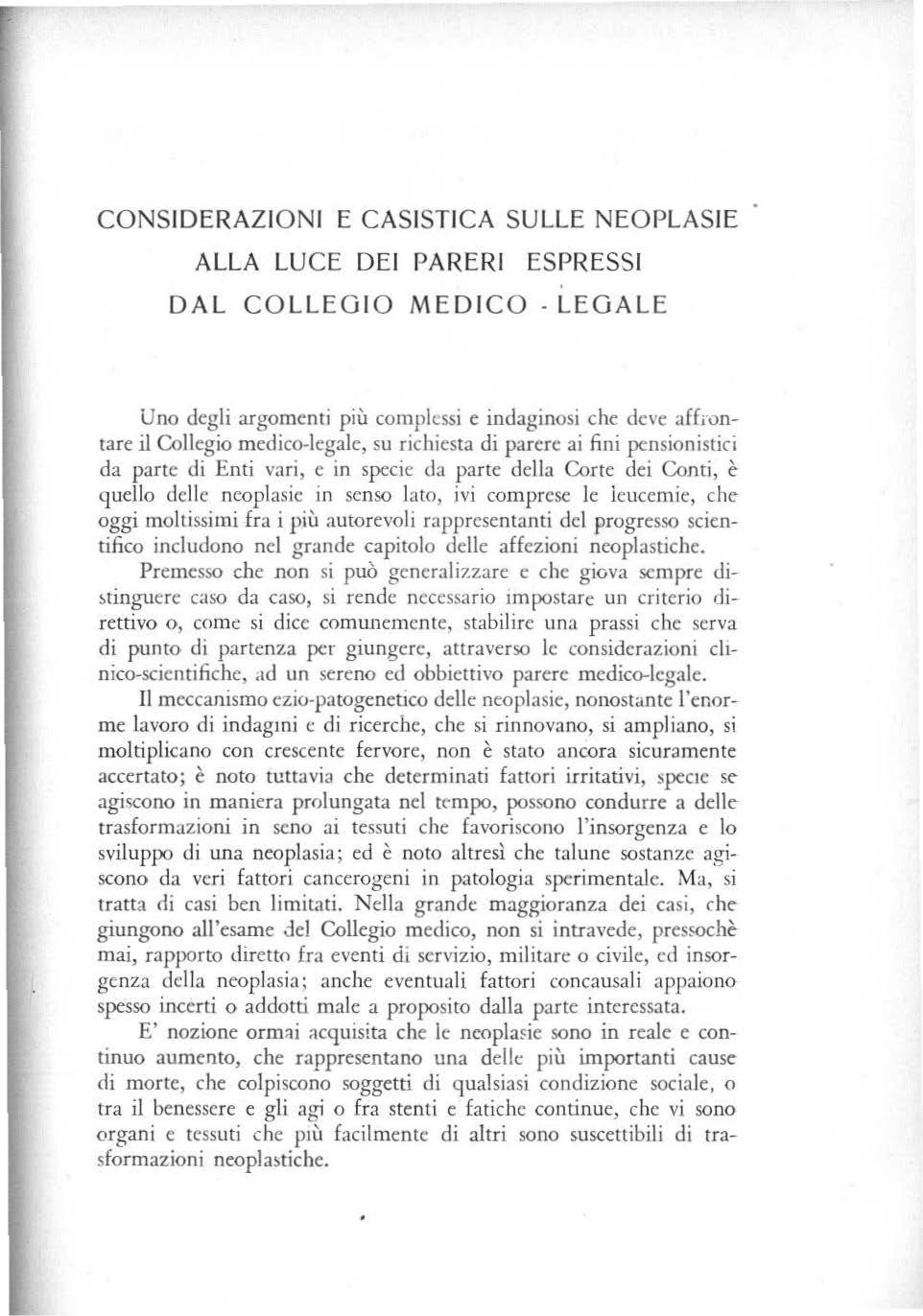
Diagnosi precoce dunque, ove possibile, e conseguente tempestivo trattamento terapeutico sono due momenti di importanza preminente nella valutazione medico-legale dci singoli casi.
I n sostanza, si tratta di valutare:
1" - se g l i eventi di serviz io (iv1 compresa una precedente infermità già riconosciuta come dipendente da causa di servizio) quali risultano veramente assodati dagli atti, possano avere agito da fattori concausali per l'insorgenza o per l'ulteriore più rapido decorso, rli quello considerato come abituale, di una data forma neo plastica;
2 ° - se dette ragioni di serviziG abbiano impedito la formulazione dell'esatta diagnosi, sempre che questa, a prescindere dal servizio stesso, si sarebbe potuta fare o almeno sospettare a l primo mizio del p r ocesso neo plastico;
3o - se, posta la Jiagnosi in tempo uti le, g l i eventi di serv izio abbiano impedito l'applicazione di quei sussidi terapeutici che la cli nica r iconosce efficaci se non altro per il prolungamento della vita dell'infermo .
Siamo sempre in tema di fattori concausali preponderantJ o di fattori di aggravam e nto i quali, ai fini della pensionistica di privilegio, secondo le vigenti norme in materia, hanno, come è noto, lo stesso valore delle cause dirette di servizio.
L'esatta va lu tazione di ques t i tre punti di impor t anza dominante non sempre riesce agevole, tenuto conto che spesso l 'a n amnesi è incerta, che gli atti alla documentazione appaiono talvolta contradditori, che la parte interessata pone, come è natu r ale, tutto l'impegno per far prevalere la propria tesi cercando, ove non fosse altr o, che il dubbio e l'incertezza penetrino nell'animo dd perìto
Il Collegio medico dispone di una ricca casistica in materia, acquisita attraverso gli anni; limitandosi ai pareri espressi in questi ultimi tempi, il Collegio avrebbe fatto conoscere almeno i casi più importanti se non avesse creduto opportuno a tte n dere che la Corte dei Conti pronun c iasse il suo verdetto per ogn i s in gol o caso, in m o d o da fornire al lettore non so lo le considerazioni tecniche fatte dal Collegio m ed ico per motivare i l p arere favorevole o co n trar io, ma anch e un es tr atto deUa sentenza della Corte dei Conti, ch e ritiene valida o rige ttata la tesi sostenuta dal Collegio medico E pertanto si è venuti neila dete rm i n azio n e di ill u strare, ai fini divulgativi, solo i casi co m r leti man mano che si vi:: n c a conoscere il giudizio definitivo della Corte dri Co n ti.
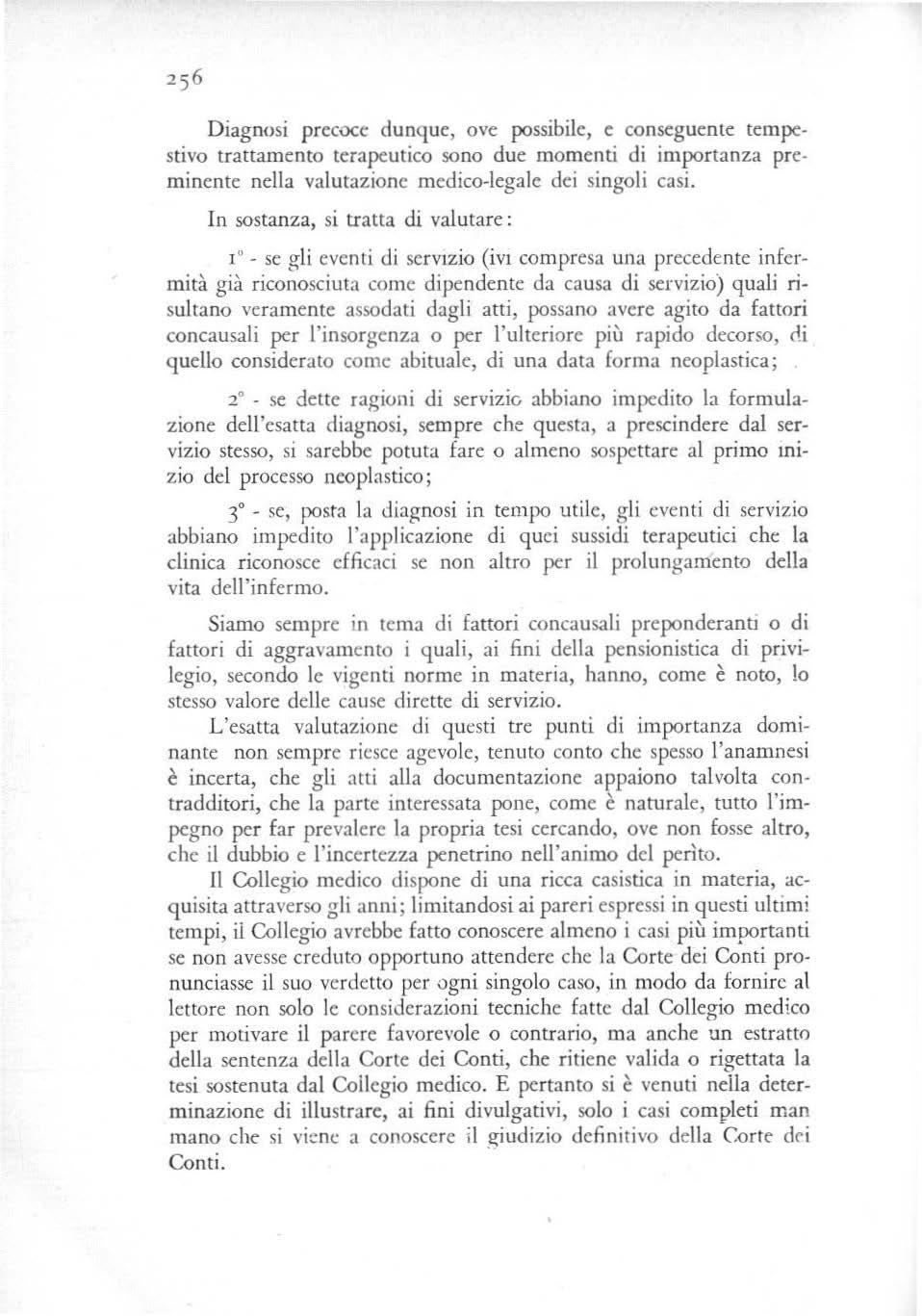
Parere per Soc i Casimiro, cla sse 188r. - Verbale 926/50 del 2 maggio 1950. K. di posiz. 222631. N eoplasia gastrica; dipend e nza e aggravamento da ca u sa di se r vizio di guerra.
Milite inserviente nel ruolo normale della C. R. l. il 25 maggio 1931; richiamato in servizio ed asseg nato allo Stabi lim ento n. 3 d i Roma il 7 maggio 1940, venendosi a trovare io terr itori o dich iarato in stato di guerra (Roma) l' u giugno 1940. Il 19 luglio 1941 nominato caporale cu oco. Compì sci viaggi con trcm ospeda li in zona eli operaz ion e n pr im o della comp lessiva d ur ata di sei gio rni, fra andata c ritorno, nel marzo 194r, in Jugos lavia, il seco nd o, sempre nel 1941, della d urata comp lessiva d i un dici giorni in Ru ssia; il terw, il quarto, il quinto, il sesto nel 1942 nei treni ospedali che .lOdavano e venivano dalla Russia, della durata rispettiva di 17 giorni, 4.0 g iorni , 27, 73· L ' ultimo viaggio compi uto il 22 dicembre 1942. T ota le effettivo del periodo Ji servizio re so su i treni ospeda li della C. R. l. che andavano alla zona di operazione e ne ritornavano, giorni J74·
Il 12 gennaio 1943 veniva assegnato al IX Centro mobi litaz. di Roma, Depos. personale, ed il 22 gen naio 1943 era sottoposto a visita co ll eg iale presso la C .R.I. perchè soffr iva da ci rca 5 mesi, come ebbe a riferire, d i disLUrbi gastric t, consistenti in dolori dopo i pasti, talvolta accompagnati da vomito Posta la diagnosi di « probabile in filtrazione neoplastica dello stomaco )) il Soci tu giudicato non più idoneo al servizio nella C.R.I., e collocato in co n gedo il 10 marzo 1943. Decede\ a in Roma il3 febbraio r944 con di « neoplasma gas tri co »
Il Comita to di li quidazio ne pen s ioni guerra riteneva l'infermità non dipend ente nè aggravala da causa di se rvizio di g uerra.
Parere medico-legale : Il Colleg io m edi co -legale, considerato che i primi disturbi del sogge tto ri salivano a cinque me si prima della data in cui l'i nfermità venne identificata, secondo le asserzioni del paziente, non ha difficoltà ad amm ettere che la neoplasia abbia avuto inizio nel periodo di t empo tra scorso dal Soci in servizio nel recente conflitto . Non ri sulta tuttavia che il milite durante questo servizio sia andato incontro all'azione di quegli agenti fisici o chimici ritenuti dall 'esperienza clinica come dotati di attività irritativa tali da favorire l'oncogen esi; e d'altra parte non sa rebbe gi ustifi ca to, in base alle nos tre attuali conosce nze su tale argo m ento, il volere accordare una simil e attività agli eventi generici di servizio che confi gurano il se rvizio reso d al militar e (inserviente prima e caporale cuoco in tr eni osp eda li dopo). Nel caso in esame quindi l ' insorgenza della neopl asia gastrica è da ricercarsi soltanto in quel dato fattore endogeno non ancora ben inrlividuato . D 'altra parte, dal momento in cui la malattia fu individuata, in uno stadio di già abbastanza avanzata evoluzione, concesse oltre un anno di vita al pazie nte; sì che si può riten ere che il decorso di essa si sia compiuto in un periodo di
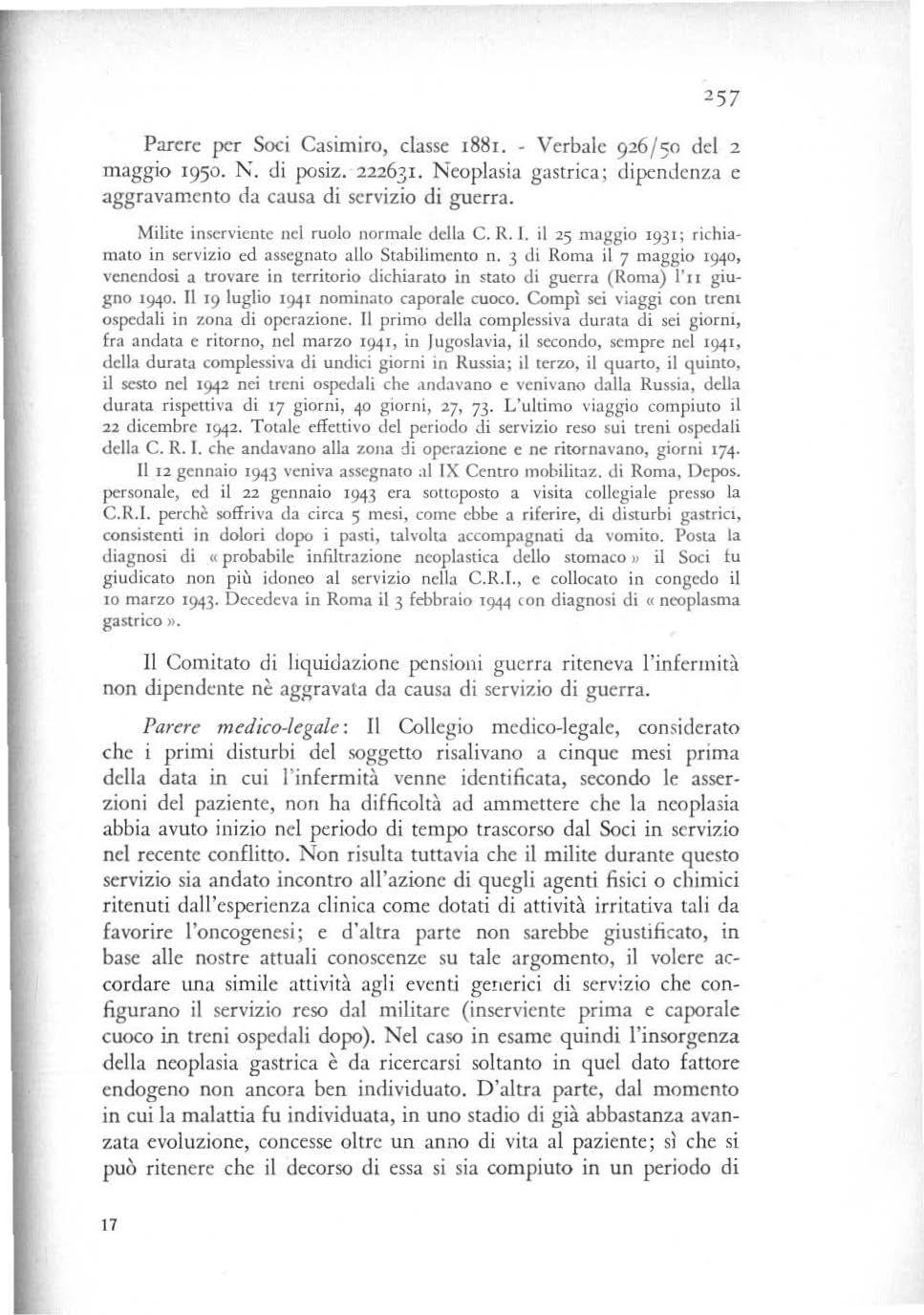
17
tempo che, per durata, corrisponde a quello che una simile infermità, data la n atura e l a sede, suole presentare. E' da rilevare ino ltrr che l a affezione fu individuata non appena l'infermo ebbe a palesare i suoi disturbi e tempestivi furono i provvedimenti medico-legali adottati. M anca quindi ogni ragione per ammettere che il servizio abbia concorso ad imprimere alla malattia una più rapida e grave evoluzione, a ritardare la scoperta della neoplasia e ad impedire la tempestività de ll 'eve nt ua le problematica terapia.
Ciò posto, il Collegio medico esprime i l parere che l'infermità letale del Soci sia da ritenere non dipendente nè aggravata da causa di se r vizio di guerra.
Decisione della Ceme dei Conti: Osservato preliminarmente che la natura del servizio sedenta rio prestato dal Soci non esclude c he esso sia stato servizio di guerra e c he il soggetto si trovò ben 244 giorni in zona di operazioni, la Corte ritiene che la motivazione, nddotta da l Collegio medico, sia contradittoria e non conforme alle risultanze degli ani.
Invero , il Collegio medico-legale, mentre da un lato afferma che la malattia venne identifi cata cc già in stato di abbastanza avanzata evoluzione» dall'altra esclude che « il servizio abbia co nco rso a ritardare la scoperta del l 'infermità e a danneggiare la tempestività della terapia )l
Dagli ani invece risulta che so lo dopo cinq ue Ja quando il Soci cominciò ad a cc usare disturbi gastrici, si sospettò che si potesse trattare di un neoplasma, c la diagnosi di questa infermità fu possibile solo dopo che tu eseguita la radiografia del tuho digerente (,·erbale visita 22 gennaio 1943).
Ciò premesso, non si può ammettere che la constatazione sia stata tempestiva c non dubitare, invece, che i disturbi gastrici denunciati nei cinque mesi dal Soci siano stati ritenuti banali disturbi della digestione o ulcere gastriche.
Più volte, sia il Collegio medico-legale sia questa Sezione, hanno ritenuto che causa dell'aggravamento di un ' infermità neopla stica possa essere anche la sua tardiva identificazione, c, se la ritardata esatta diagnosi è stata determinata dal servizio, questo dc,•e essere ritenuto causa dell'aggravamento dell'infermità stessa.
Per que st i motivi la Corte dei Conti - Sez . 2a spec. per Pcns. guerradefinitivamente pronunciando, in dilformit.ì delle conclusioni del P rocuratore Generale, accoglie il ncorso di Antonelli Germana e riconosce l ' infermità del di le i marito, aggravata da causa del servizio prestato durante la recente guerra.

Ci sia consentito u n breve commento i n sede t ecnica :
La Corte dei Contt, Sez . 2 A spec., ha ritenuto che il Collegio mcdico-legale fosse caduto in contraddizione; e si tratterebbe in questo caso di una contraddizione di natura tecnica, di ordine cioè squisitamente clinico.
11 Collegio medico ha già rilevato che la malattia fu individuata non appena l'infermo ebbe a palesare.: i dist1.1rbi gastrici; e c.ome sarebbe stato possibile diagnosticare o sos pettare una neoplasia gastrica
in un soggetto se questi non palesa al medico almeno qualche sintomo subbtettivo? Che i disturbi gastrici durassero da circa cinque mesi si apprese allorchè l'infermo fu sottoposto a visita. L'esperienza clinica, in simili casi, insegna che il paziente, in genere, ricorre all 'ope ra del sanitario quando purtroppo la malattia è già da qualche tempo impiantata ed in corso di svil uppo (e spesso quando già esiste la met:tstasi epatica) non avendo accordato grande importanza ai fatti che spesso accompagnano il carcinoma gastrico al suo pnmo truzto.
E ' da considerare inoltre che la scienza non possiede ancora dei mezzi idonei per accertare il primo inizio del carcinoma gastrico (può avvertire sole il pericolo potenziale che su una ulcera dello stomaco si impianti talvolta un carcinoma) il cui impianto è quanto mai subdolo .
Allorchè il clinico, in base ai sintomi subbiettivi accusati dal paziente, all'età del soggetto (c si sa che il carcinoma gastrico è in genere un'affezione non certamente giovanile), all'eventuale reperto palpatorio, alle indagini radiologiche e chimiche, al decadimento generale dell'organismo, siano tutti o taluni soltanto presenti questi sintomi subbiettivi cd obbiettivi, accerta o sospetta la neopbsia gastrica, è in genere troppo tardi per un intervento demoliti vo di una qualche efficacia. Non si può quindi parlare in simili casi di tardiva identificazione della neoplasia maligna.
D'altra parte, se per un puro caso il carcinoma fosse stato sospettato qu?lche mese prima, è presumibile, al lume dell'esperienza clinica, che avrebbe avuto un decorso diverso? In altri termini, e so lo in via di pura ipotesi, se si fosse intervenuti chirurgicamente (dato che non esiste una terapia medica per simili forme) qualche mese prima, si potrebbe, con fondata presunzione, ritenere che l'esito letale sarebbe avvenuto in data sensibilmente posteriore di quella in cui effettivamente avvenne? A questi interrogativi, che ovviamente balzano subito alla mente del perito più sereno cd obiettivo, il Collegio medico aveva già risposto negativamente.
In realtà il Collegio medico ha ritenuto che, con ogni probabilità, al lwne dell'esperienza clinica, se il Soci non avesse compiuto il servizio nella CRI in qualità di inserviente e di caporale cuoco, il carcinoma gastrico sarebbe insorlo lo stesso c non avrebbe avuto de· diverso se il soggeuo fosse rimasto a casa sua.
In conclusione appare estremamente difficile al Collegio medico ravvisare in quale effettiva contradizione sia potuto incorrere.

2 59
Parere per Schiavoni Umberto. - Verbale 1192 / 48 e Y9) / )o
del 18 giugno 1948 e 9 marzo 1950. - Posiz. 208rr. Epitelioma cutaneo della regione iombare. Dipenden za od aggravamento causa servizio guerra o attinente alla guerra.
Rich iamato alle armi da l distretto militare di Bengasi il 4 luglio 1940 fu destinato al Tribunale militare della X Armata in Cirenaica, co l grado di tenente colonnello de!Ja giustizia militare, ruolo ausiliario come sostituto avvocato militare.
Il 5 clicembre 1940 partì da Bengasi e il 9 dicernbn: fu ricoverato all'ospedale militare eli Napoli, dove fu fatta diagnosi di cc epitelioma cutaneo della regione lombare » Nel biglietto di uscita dell'ospedale in data 30 clicembre 1940 è annotato: <<trasferito all'Istituto per tumori per accertamenti diagnostici ed eventuali cure».
Il 21 gennaio 1941 ottenne 6o giorni di conva lescenza.
Il 2r marzo 194r, visitato dalla C. M. O. di Chieti lo Schiavotti ottenne ancora 6o g iorni eh convalescenza per •< processo infiammatorio subacuto della regione lombare sinistra di c?.iologia ignota)). n 21 maggio 1941, la medesima C. M. O. con diagnosi di «dermatosi cronica della regione lombare sin istra dt eziologia ignota; lievissima >> concesse altri 6o giorni di licenza di convalescenza.
Alla visita di rito presso la C. M. P. G. di Roma il 13 iuglio 1941, con diagnosi di (( epitdiom:ttosi benigna della regione lombare )) fu proposta rs· categoria di pensione rinnO\ abile per anni due, qualora ammessa la dipendenza da causa di serviz1o.
La C. M. S., nella seduta del 15 marzo 1946 negò b dipendenza o l'aggravamento da causa di servizio di p:uerra.
Da un certificato della Clinica dermosifilopatica di Roma, in data ro settembre 1946, si rilcv:. che lo Sc hiavctti era stato curato, nella suddetta clinica, per «epitelioma superficia le cutaneo della regione lombare sinistra» a mezzo della diaterrnocoagul:lzion e, negli anni 1942-1945 e 1946 (cura non ancora terminata).
Parere medico-legale: Attraverso la Storia clinica e sulla base dell'attendibile certificato della Chnica dermosifilopatica di Roma, la diagnosi di « epitelio ma cutaneo della regione lombar e » non è da mettere in dubbio. Si tratta di un'affezione di natura neoplastica a decorso lentissimo e cronico, generalmente di natura benigna, la cui cura si basa essenzialmente sulla elettrocoagulazione o sull a diatermocoagulazione. Circa l'eziologia può dirsi che << l'epitciioma cntaneo » o epitelioma piatto insorge o per cause endogene non ben definite o per cause esterne che agiscano sulla cute (traumi ripetuti in sito, irritazione prolungata da particolari sostanze chimiche, o da agenti fisici irritanti). Nel caso in specie nessuno di questi agenti esterni determin an ti o anche aggravanti può essere invocato, sia perchè la sede dell'affezione è in una parte del corpo coperta dagli in-

dumenti (regione lombare), sia perchè il serviZIO di soli 5 mesi, prestato presso il Tribunale di guerr a di Bengasi dallo Schiavotti, quale sostituto avvocato milìtare, non è di tal natura da esporre .il soggetto ai fattori esogeni suaccennati.
E pertanto il Collegio medico-legale esprime parere che l'infermità, di cui fu ricono sciuto affetto lo Sch.iavotti nella visita collegiale del 13 luglio 1941 (epitelioma cutaneo della regione lombare sinistra) non sia eia riten ere dipendente o aggravata da causa di st>rvizio di guerra o attinente alla guerra.
2° Parere medico-legale: Questo Collegio nella seduta de l r8 gi ugno 1948 prendeva in i documenti concernenti lo Schiavotti ed esprimeva il pa rere ch e l'infermità da cui (u riconosciuto affetto nella visita collegiale del 13 lugli o 1941 (epitelioma cutaneo della regione lombare si nistra) non era da ritenersi nè dipend ente nè gravata da causa di servizio di guerra od attinente alla guerra.
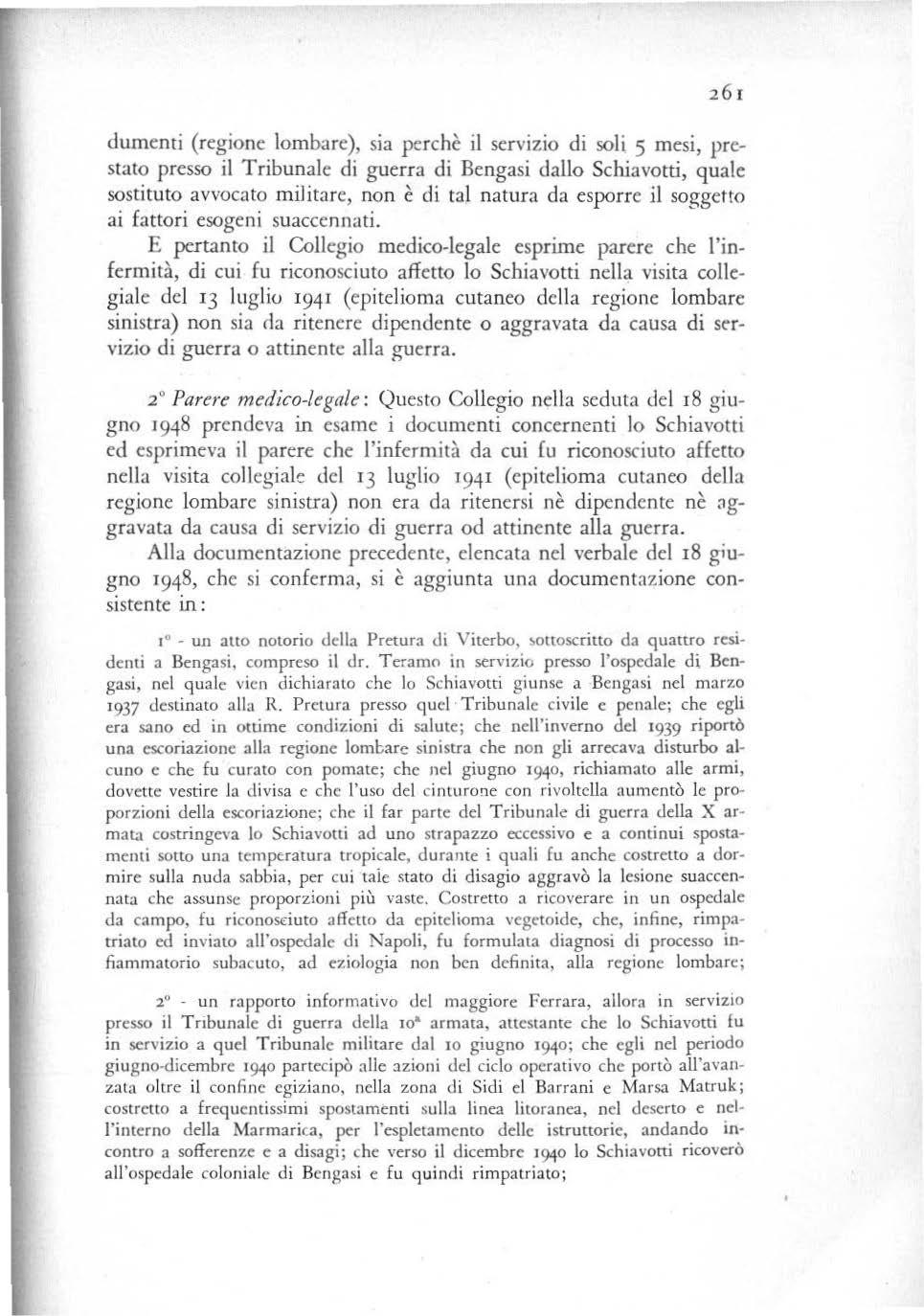
Alla documentazione precedente, elencata nel verbale del r8 giugno 1948, che si conferma, si è aggiunta una documentazione consistente in:
1° - un atto notorio della Pretura di Viterbo , \Ottoscritto da quattro residenti a Bengasi, compreso il dr. Teramo in servizio presso !"ospedale d\ Bengasi, nel quale vicn dichiarato che lo Schiavotti giunse ,l Bengasi nel marzo 1937 JcsùnalO alla R. Pretura presso quel , Tribunal e civi le e pennle; che egli era sano ed in otùme condizioni di salute; che nell'inverno del 1939 riportò una escoriazione nlla regione lombare sinistra che non gli arrecava disturbo alcuno e che fu curato con pomate; che nel giugno 1940, richiamnto alle armi, dovette vestire la Jivisa c che l' uso del ci nturone con ri vo l tell a aumentò le proporzioni della esco ria zione; che il far parte del Tribun ale di guerra della X armata costringeva lo Schiavoni ad un o strapazzo eccessivo e a continui spostamenti sotto una t e mperatura tropicale, durante i qunli fu anche costretto a dor· mire s ulla nuda sabb ia, per cu i taie stato di disagio aggravò la lesione suaccennata c he assunse proporzioni più vaste, Costre tto a ricoverare in un ospedale da campo, fu ri conosE:iuto affetto da epitelioma vegetoide, che, infine, rimpntriato cd im iato all'ospedale di apoli. fu formulata diagnosi di processo infiammatorio sub:Jcuto, ad e7.iologia non ben definita, alla regione lombar e;
2° - un rapporto informat;vo del maggiore Ferrara, allorn in servizio presso il T rìbunale di guerrn della 10" armata, attestante che lo Schiavotti fu in servizio a quel Tribunale militare dal IO giugno 1940; che egli nel periodo giugno-dicembre 1940 partecipò alle azioni de l ciclo operativo che portò all'avanzata o lt re il conii ne egiziano, nella zona di Si d i el Barrani e Mnrsa Matruk; costretto a frequentissimi spostamenti sulla linea litoranea, nel deserto e nell'interno della Marmaric.a, per l'espletamento delle istruttorie, andando in· contro a sofferenze e a disagi; che verso il dicembre 1940 lo Schiavoni ricoverò co lonia le di Benga si e fu quindi rimpatriato;
3°- due comunicazioni dell'Ufficio Storico dello Stato Maggiore dell'Esercito attestanti che dal 10 settembre al 5 febbraio 1941 il Tribunale, in cui prestava servizio lo Schiavoni, faceva parte integrante del Comando di una grande unità operante c quindi ammesso a turri i benefici previsti dalla legge a favore dei combattenti.
La nuov a documentazione, recentemente acqu isit a agli atti, non fornisce elementi comprovanti che l 'epitelioma superficiale cutaneo della regjone lombare sinistra, dal quale lo Schiavoni è affetto fin dall'autunno 1939 (quando ancora non era stato richiamato alle armi), sia insorto o aggravato per causa di servizio di guerra o attinente alla gue rr a . Ben è vero che i nuovi documenti attestano che lo Schiavotti, appartenente al Tribunale Militare della X Armata, andò incontro a disagi e a fatiche e a continui spostamenti per l'espletamento delle sue funzioni; ben è vero che i componen ti di tale Tribunale, essendo esso parte integrante del comando di una grande Unità, sono ammessi a tutti i benefici previsti ùalla legge a favore dei combattenti; ben è vero, e non si può mettere in dubbio dopo la testimonjanza dei quattro ex residenti a Bengasi, che il far parte del detto Tribunale costrinse lo Schiavotti a strapazzi e a continui disagiati durante i quali fu anche lo Schiavotti costretto a dormire sulla nuda sabbia, ma è altresì vero ed inequivocabi!e che l'affezione di cui è affetto lo Schiavotti è di natura ncoplastica, a decorso lentissimo e cronico, la cui cura si basa essenzialmente sulla elettrocoagulazione o sulla diatermo-coagu lazione; che essa si è iniziata nell'autunno-inverno 1939, quando ancora lo Schiavotti non era stato richiamato all e armi e non aveva subito il minimo d1sagio della vita militare, sotto forma di una escoriazione, come infatti attestano i firmatari dell'atto notorio, e che essa, per la sua natura neoplastica, andò, seco ndo il nor male decorso di essa, lentamente e progressivamente ingrandendosi, assumendo i caratteri veri e propri della neoplasia; che si sa rebbe ingrandita ed estesa lo stesso, e nelle stesse proporzioni c con gli s tessi caratteri, ar.che se lo Schiavoni non avesse fàtto parte del Tribunale Militare della X Armata, anche se egli non avesse indossato la divisa mi l itare con l'obbligo di portare il ci nturo ne c la pistola, anche se, infine, lo Schl:Jvotti anzichè spostarsi continuamente e dormire sulla nuda sabbia. soffrendo disagi e strapazzi, avesse condotto una vita tranqui lla , comoda ed affatto disagiata. Ciò infatti è confermato dall'epoca in cui insorse la infermità (autu nno -inverno 1939), dal subdo lo apparire di essa (sotto forma d1 escoriazione), dalla particolare natura neoplastica insorta senza alcuna causa specifica determinante e dal decorso comune a tali lesioni croniche della pelle: progress ivo e lento.
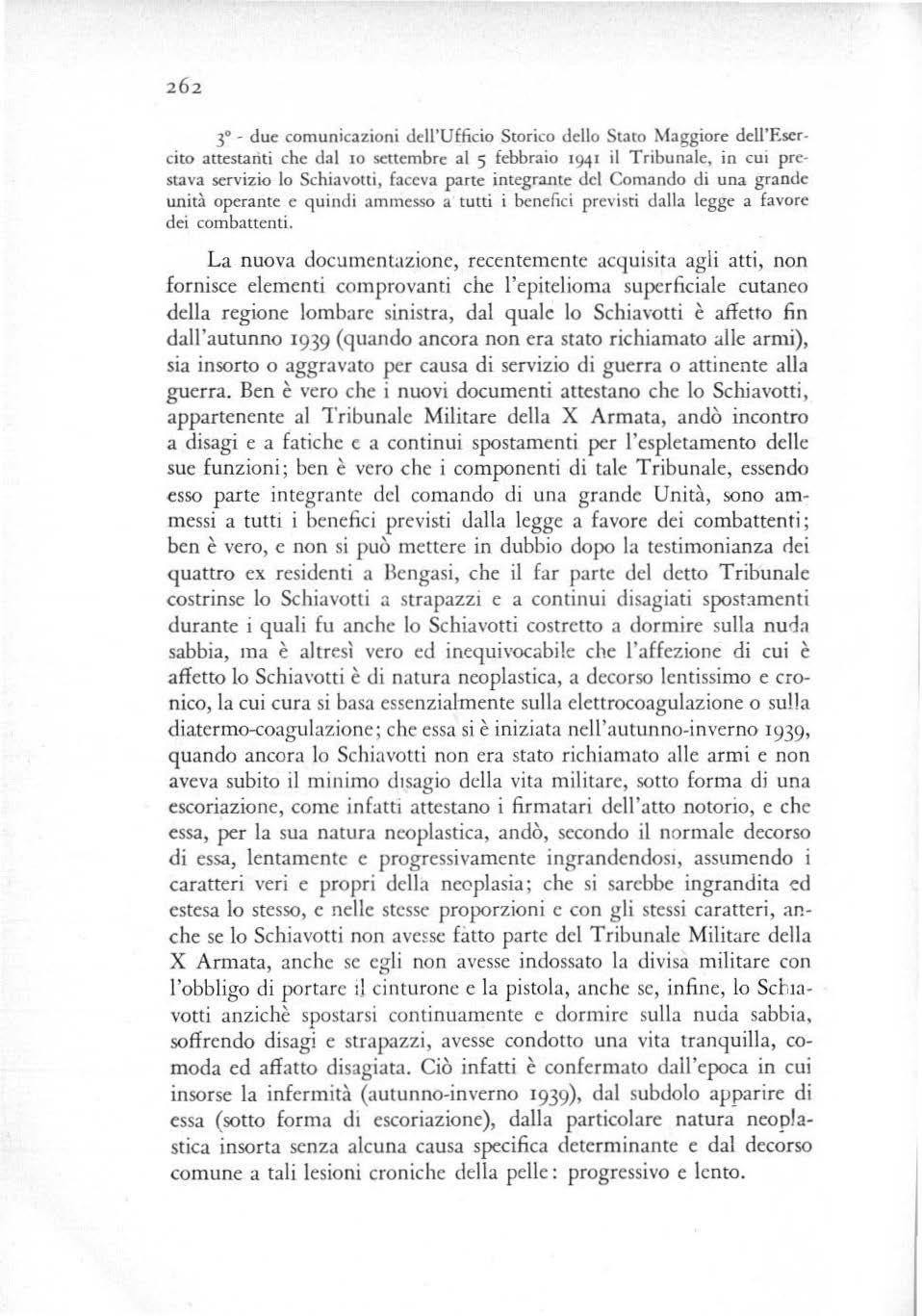
Questo Collegio sulla scorta dei nuovi documenti non può che confermare, data la natura della malattia e la sua msorgenza in epoca anteriore al richiamo alle armi, il parere espresso nella seduta del 18 giugno 1948, che cioè l'infermità, di cui fu riconosciuto affetto lo Schiavoni nella visita collegiale del 13 luglio 1941, non può ritenersi dipenden t e nè aggravata da causa di servizio di guerra o attinente alla guerra.
Decisione della Corte dei Co11ti: L ' infermità della qua le è affetto lo Schiavoni, insorta indubbiam ente nell'autunno-inverno 1939 (in epoca, cioè, anter iore al richiamo alle armi), sotto forma di una escoriazione, venne in seguito diagnosticata in var i modi dalle autt)rità sa nitari e che ebbero ad esaminare il paziente

L'ospedale militare di Napoli, nel dice mbre 1940, d ia gnosticò «epitelioma cutaneo della regi,ne lo mbare )) ; la Commissione medica ospedaliera di Ch ieti, nel marzo 1941, << processo infiammatorio subac uto della regione simstra di ezio logia ignota»; la stessa Commissione, nc:l maggio 1941, <<de rmatosi cron ica della regione lomb are sinistra di ez io logia· ignota )l ; l a Commissione medica per le pens ioni di guerra d i Roma, nel lu g li o 1942, << epiteliomatosi benigna della regione lombare"·
Attraverso la storia clinica Jell'infermità, sulla base della attendibilità del certificato della cl ini ca derm()sifi lopatica di cui si è fatto cenno in narrativa , la diagnosi di <<epitel ioma superficiale cutaneo della regione lombare sinistra>> ind icata in detto certificato, non è da mettere in dubbio.
Si tratta di un'affezione di natura neoplasti ca a decorso lentissimo e crc>n ico , generalmente d i nat ura benigna. la c ura delia quale si basa esse nzialmente sulla elettrocoagulazione o sulla diatermocoagulazione.
Circa la eziologia d i detta infermità, i l Collegio medico l egale afferma che « l'epitel ioma cutaneo >> o ep itelioma piatto, insorge o per cause esterne che agiscono sulla cute (traumi ripetuti in sito, irritazione prolungata da parti colari sostanze c himi che, come ad esempio g li idrocarburi ciclic i, o da agenti fisici irritanti).
Nel la specie, però , nessuno di questi agenti este rni determinanti o anche aggravanti può essere in vocato (non vi furono, intatti, tra·umi nè irritazioni da s()stanze chi miche); nè le fatiche, i disagi, g l i strapazzi per i continui spostamenti cu i lo Schiavotti fu so ttoposto, e che lo cos trinsero talvolta anche a dorm ire sulla nuda sabbia, possono assurgere ad elementi causali dell 'a ggravamento.
La infermità ebbe inizio , infatti, quando lo Schiavotti non era sta to ancora richiamato alle armi e non aveva subìto i.l minimo disagio della vita militare; insorta so tto forma d i escoriazione, essa, per la sua natu ra ncoplastica, andò, secondo il suo normale decorso, assumendo lentamente e progressivamente i caratteri veri e propri della neoplasia, e si sarebbe egua lm ente ingrandita ed estesa nelle stesse proporzioni e con g li stess i caratteri anche se lo Schiavotti non avesse indossata la divisa mi litare co n l'obbl igo di portare il cinturone e la pistola (particolare a cui si accenna ne ll'atto notorio a lle gaw al ri co rso); ed anche se egl i, anz ichè spostars i cont inuamente c do rmire talvolta sulla nuda sabbia soffrendo disagi e stra pazzi, avesse condotto una vita tranquilla, comoda ed atfatto d isagiata.
Il che è confermato dall'epoca di dell'infermità, dal subdolo appa r ire di essa, dalLa natura neoplastica i n sorta senza alcuna causa speciale determinante, e dal decorso comune a tali lesioni della pelle, in fo rm a, cioè, lenta c progressiva.
Per le suesposte considerazioni ritiene la Co r te, confortata nel suo convincimento anche dal parer e del superiore organo di sanità militare, che per lo Sc h iavotti non possa considerarsi verificata la precipua condizione (d ipendenza o aggravamento della infermità da causa di servizio di guerra o attineme alla g u erra) cui la legge art. r e 2 del R decreto I2 l uglio I923 n. 1491 c corrispondenti della recente legge IO agosto 1950 n. 648 subordina la concessione del trattamento pensionistico agli invalidi di guerra; e, per le c.onsiderazioni stesse, ritiene anche che, nel caso, possa considerarsi provata la mancanza di qua lsiasi nociva influenza del $ervizic prestato dallo Schiavotti su l decorso dell'infermità i.r. lui riscontrata (art. 5 del R. D n. 1383 del 1924).
Quanto al la favorevole giurisprudenza (del resto assai scarsa, perchè limitata a casi gravissimi) Ji questa Corte in materia di tumori, cui si è accennato dalla difesa nella memoria e in udienza , non sembra ..:he essa possa essere invocata nel caso in esame, in cui non si tratta di tumore vero e proprio con caratter i eli asso l uta gravità (la difesa c i ta, come precedente, un caso di tumore al cervello), ma semp licemente d i una lesione dell a pelle, di natura neoplastica, in forma benigna, per la quale la Commissione medica di Roma escluse perfino (vedi esame obiettivo nel relativo verbale), la gravità di decorso del vero cc ep itelioma » , e propose una classifica di ultima categoria.
Il ricorso dello Schiavotti si appalesa, dunque, privo di fondamento e non può, di conseguenza, essere accolto, mentre deve confermarsi il decreto impu· gnato che non merita alcuna censura.
Per questi motivi la Corte dei conti - Sezione seconda speciale per le pensioni di guerra - pronunciand0 definitivamente in conform ità delle concl usioni del P r ocuratore Generale, respinge il ricorso prodotto da Schiavoni Umberto, fu Pietro, avverso il decreto n d!cembre I946 n. Io26503 del Ministero del tesoro.
P arere per Molinar! Giovan Battista - Verbale n. 763 l 50 del 2 maggio 1950 - Posiz. 207794 - L eucemia acuta - Sua relazione diretta, o meno, con la malaria.
Prese parte alla guerra 1915- IX. l n zona di g uerra nel novembre I9I7 col 222° fanter ia. li IS settembre 1918, tr,ovandosi a Zenzon sul basso Piave, contrasse malaria: fu ricoverato all'ospeda le civi le d i Gozzano e poscia trasferito all'infermeria pres idiaria - Sezione specia l izzata rep. malarici di Messina. Dimesso il 7 d icembre 1918, fu agg regato presso l'ospedale militare di Messina. ove prestò servizio fino al 3 marzo 1921, data in cui fu collocato in congedo. La scheda ind i vidua le per militari malarici del la Sezione specializzata di Messina attesta che il Molinari fu curato per malaria quotidiana semplice dal IO novembre 19I8 al 7 delle stesso anno. Il 12 novembre 1931 il Molin ari presentò domanda tendente ad ottenere pensione vita l izia di g u erra per malattia contratta in guerra (malaria). In detta domanda l'interessato attesta d i aver presentato il 3 agosto 1921 domanda per pensione di guerra tra mi te l'Associazione naziona le com battenti di Castro dei Vo lsci

Il 30 novembre il Mo linari ri co \Crava del Litto rio in Roma con diagnosi di leucemia e usciva senza miglioramento il 17 dicembre 1942·
Il 18 dicem br e 1942 decedeva in Ro ma per leucemia acuta come da ce rùficato necroscopico.
Un certificato del dr. Pittclli di Roma in data 16 marzo 1943 attesta che il detto sanitario fin dal 1934 tenne in cura il Mo linari per infezione malarica cronica co ntratta nel basso Piave; che di detta ma lattia il Mol inari, nonostante le c ure, non p otè liberarsi; c he negli ultimi tempi s i accemuò un decadimento fisi co con acce ntuato pallor e delle mucose, che ricoverato i11 ospedale, il professor Sebastiani, dopo ri cerc he ed indagini, pott: concl udere che il Molinari era alletto da anem ia perniciosa a tale stadio da non da re alcuna spe ranza d i sal vezza; che il 18 dicembre il Molinari cessav a d i vivere.
A ve ndo la vedova chiesto la corresponsione di pensiom: privilegiata di guerra, il Comitato di liquidazione delle pens ioni di g uerra, nell'adunanza co lleg ial e del 22 aprile 1946, esc lu deva che la leucemia acuta, allo stato degli attt, potesse d ipen dere dalla malaria contratta in g uerra nel 1918 e propone,·a di non dare corso al progetto di pensione provvedendo in senso negativo .
Risulta , da un foglio aggiunto al Mod. ro6 (59) de l Distretto di Frosinone , concernente il M o linari, c he il Molina ri fu richiamato il 3 lu glio 1940 per esigenze di carattere eccezionale, che si presentò il 28 agosto 1940 c fu assegnato al 345° battagl ione T. mobilitato; che fu ricollocato in congedo ti 30 sette mbre 1940, c he fu ancora richi::tm:Jl o il 14 ::tprile 194r ed a ncora assegnato al 345" battag li one territoria le; c he fu ricollocato in congedo il 15 se ttembre 194r (data però no n ::tc t:: t>rta ta)
Pm·ere medico-legale: N0n può esse re messo 1n alcun dubbio che il Molinari con trasse malaria nel basso Piave. Esiste infatti appos1ta annotaz ion e nel foglio matricolare, cd anche la sc heda per malarici in data 7 dicemb re 1918, n ella qual e è esplicitamente dichiarato che la data dell'ultimo accesso febbrile fu il ro novembre r9r8, c he il Molinari praticò CUGI intensa chininica e che fu dimesso d alla sezione specializzata il 7 dicembr e 1918.
Il fogli o matricolare però non fa altro cenno di provvedime n ti medico-legali; attes ta che il Mo1in ari fu aggregato all'o spedale di M ess ina e che fu inviato in congedo il 3 mar zo 1921. D a una richiesta per pen sio n e per malaria contratta in guerra, inoltr ata dall'intere ssa to al Mini stero delle Finanze il 1 2 no vembre 1 931, si apprende che il Molinari inoltrò domanda pensionistica 1'8 agosto 1921, tramit e l'As.soc ia z. Combatte nti di Castro dei V o lsci, domanda c he, però, n on ebbe esito favorevole non es se ndo pervenuta a destinazio ne.
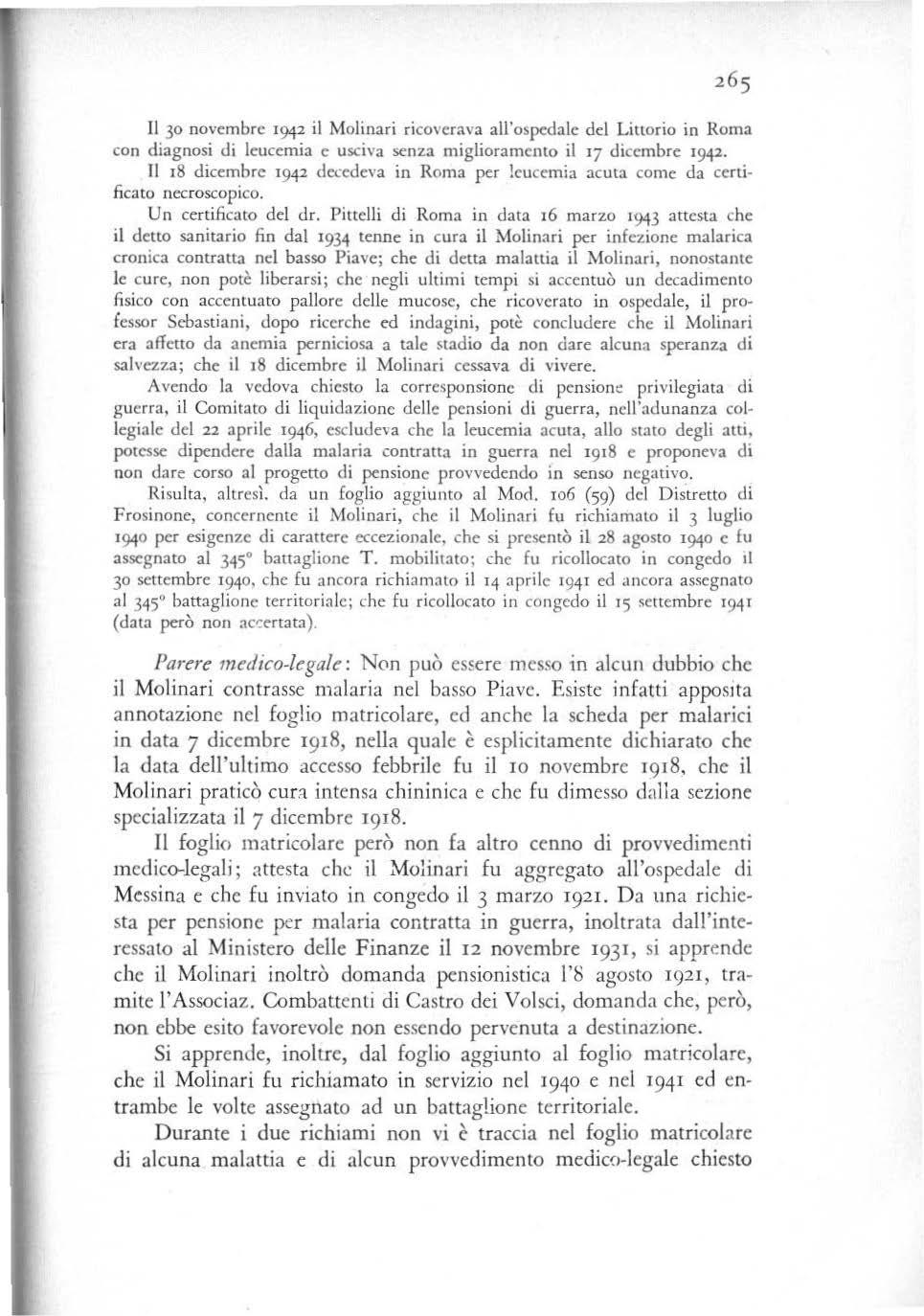
Si apprende, inoltre, dal foglio aggiunto al fogli o ma t ricolare, che il Molinari fu richiamato in ser vizio nel 1940 e nel 1941 ed e ntrambe le volte assegnato ad un battaglione ter ritori ale.
Durante i due ri c h iami non vi è traccia nel foglio matricol a re di alcuna malattia e di alcun provvedimento mediw -legale chiesto
dall'interessato e menzionato da Enti Mil itari. Il 30 novembre 1947 il Molinari - indubbiamente trovandosi g ià in congedo - en trò :dl'Ospedale del Littorio di Roma perchè affetto da leucemia, infermità questa che lo condusse a morte il r8 dicembre 1942. Ora, che vi si2 rapporto di interdipendenza etiopa togenetica od anche concausale fra la malaria sofferta dal Molinari nel lontano 1918 e la leucemia acuta, indubbiamente insorta a più d! venti anni di distanza, e cioè posteriormente al 1941, e successivamente al suo ultimo richiamo alle armi, è da escludere in modo indubbio perchè nessun dato di fatto, serio ed obiettivo di ordine scientifico-clinico e cronologico, può indurre a ritenere che essa leucemia acuta sia conseguenza della malaria sofferta dal Molinari più di Yent'anni prima o sia stata da essa malaria, a così grande distanza, derivata. Malaria e leucemia sono due entità nosologiche completamente a sè stanti; la prima riconosce la sua origine puramente infettiva, la seconda, secondo la mod er na patologia, è una forma a tipo neoplastico dei tessuti ematopoietici. D i leucemta di qualsiasi forma possono inoltre essere colpiti giovani ed adulti, maschi e femmine in qualunque condizione d i vita civile o militare, indipendentemente da qualsiasi precedente morboso, sogget ti che sono stati sempre sani o soggetti che hanno sofferto di svariate malattie.
Se si considera, pertanto, che n ess un nesso patologico esiste tra malaria e leucemia, entità nosologiche del tutto differenti e senza alcuna relazione di i nterdipendenza fra loro ; se si considera che la leucemia acuta è insorta nel Molinari dopo più di vent'anni della sofferta malaria e che la mfczione malarica è per il Molinari so lo un precedente morboso dt nessun va lore per l'insorgenza della leucemia, questo Collegio esprime il parere che l'infermità che condusse a morte il Molinari non può mettersi in relazione con ia malaria contratta nella guerra 1915- 1918.
Decisioni della Corte dei Con11·: Nella specie risulta in modo in confutab ile che i l Molinari, militare in servizio di guerra, contrasse nel 1918 affezione malarica e fu in conseguenza curato intensamente con trattamento chinini co e ricoverato nell'osp ed al e, sezione per in fe rmi malaric i.
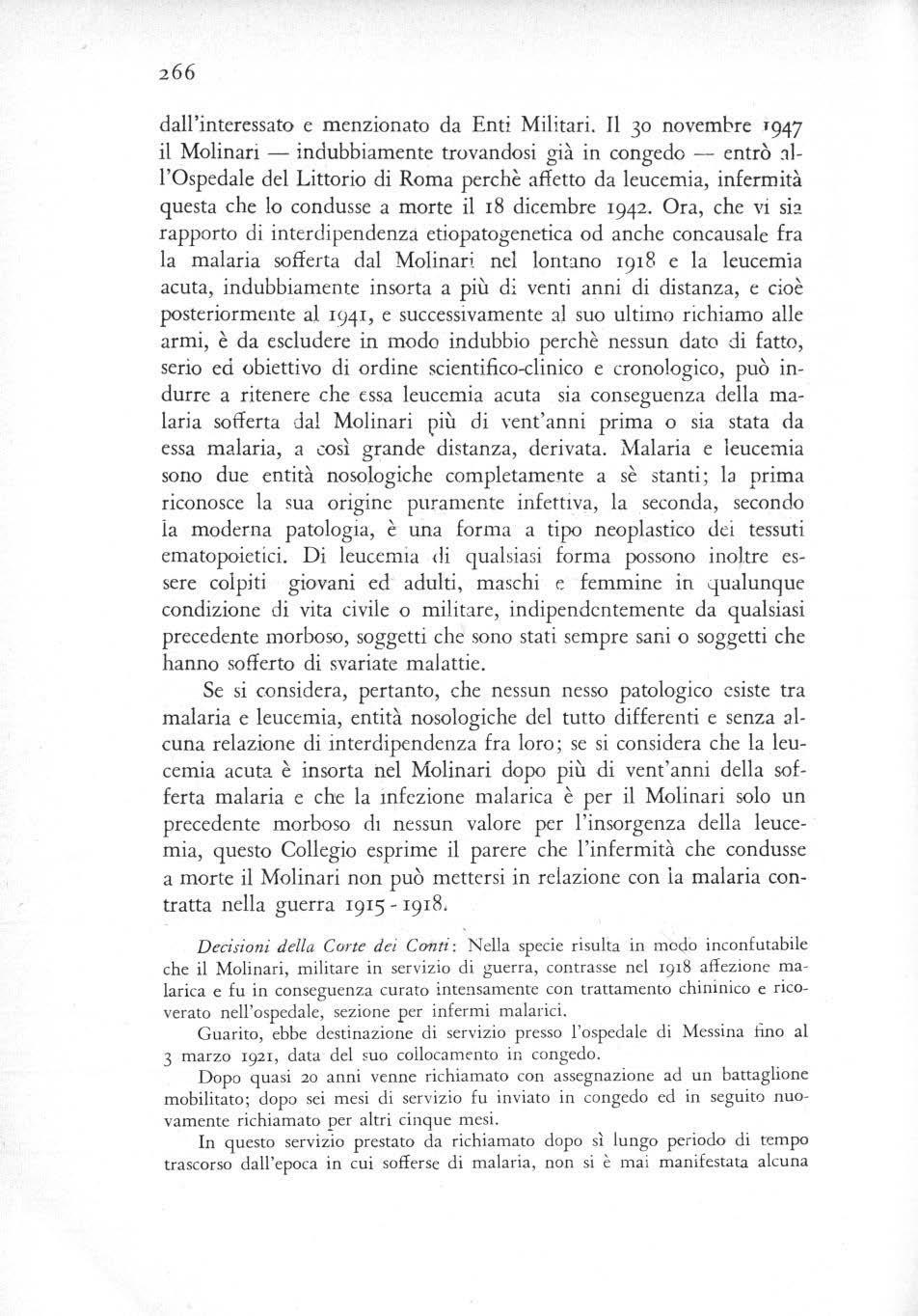
Guarito, ebbe destinazione di serv izio presso l'o spedale di Messina tino al 3 marzo 1921, data de l suo coilocame-nto in congedo.
Dopo quasi 20 anni venne richiamato con assegnazione ad un battaglione mobilitato; dopo sci mesi di servizio fu inviato in congedo ed in seguito nuovamente ri chiamato per a ltri c inqu e mesi.
In questo servizio prestato da r ichi amato dopo sì lungo periodo d i tempo trascorso dall'epoca in cui sofferse di ma laria, non si è ma i manifestata alcuna
malattia, come ne è prova l ' assenza di r i co veri ospedalieri o wmu nque di denunzia da parte del militare.
Dopo 22 mesi si manifesta la leucemia acuta, c he nella malaria non trova legame attraverso un processo evolutivo o degenerativo mai verificato dopo il 19r8, nè poteva per a ltro verificarsi, come afferma i l Collegio medico legale nel suo motivato parere, esscndc la leucem ia un'affezione con caratteri propri nel suo andamento, con origine a sè stante, indipendeme da quals iasi altro processo morboso e della natura dello stesso soggetto che può essere colpito, senza distin· zione d i sesso e di età, di condizioni di v ita e di salute.
Ritiene in conseguenza la Corre, associandosi all'espresso parere, che l'infermità causa della morte del Molinari non ha alcuna relazione diretta con la malattia da lui contratta nella guerra del 1918.
Per questi motivi la Corte dci Conti - Sezione seconda speciale per le pensioni di guerra - definitivamente pronunciando in conform ità delle conclusioni del Procuratore Generale, rigetta il ricorso prodotto da Polisena Annunziata vedova Mo li nari avverso il decreto del Ministero del tesoro n. 1024439 del r8 aprile 1947·

GIURISPRUDENZA
DELLA PATOLOGIA DI GUERRA
Possono sen•ire di propedeu t ica: G G. GABRIELLI: << di serv izio ed occasione di servizio in materia di pensioni d i guerra » in Rivista di Mediana Legale, 1919; R. PELLEGRINI: << Criteri medico-l egali per la valutazione della inabi l ità pens ionabi lc >> in Ass. Soc., 1937, 2° Suppl.; RiiHF.: << Grund lagen cles arztl ic h en U rte ils im Wehrmachtfi i rsorgc-und versorgungsgcsetz >> i n Aerztt. Sachv., n 21, 1931; A. BucCIANTF.: <<Legislaz ione dell'assistenza ai mil itari minorati >>, 1942; « Pcnsionistica privllegiata di guerra » , 1950.
Vogliamo toccare qui il punto della sensibilità della patologj:t umana ad essere considerata patologia di guerra. Secondo uno schema pratico passeremo in concisa rassegna le malattie del cuore e dei vasi, i tumori, la tubercolosi , altre malattie degìi organi della respirazione, le malattie n ervose e mentali, la malaria ed altre malattie infettive, le mala tti e degl i occhi ed orecc hi , le m ala t tie de ll a becca e dei visce r i cd i n fer mi t à varie.
Decisioni della Sez. l Spec. Pensioni di guerra: del 23 ott. 1948 ( 1); del 12 dic. 1949 (2); del 1° giugno 1950 (3); del 26 giugno 1950 (4). - Decisioni della Sez. Il Spec. PensiOni di guerra: del 12 febbraio 1948 (5); del 23 sett. 1948 (6); tle l 14 ott. 1948 (7); del 26 ott. 1948 (8); del 15 nov. 1948 (9); del 22 gcnn. 1949 (10); del ro maggio 1949 (n); del 5 gen n. 1950 (12); del rs marzo 1950 (r3); del 6 giugno 1950 (14) - MANnÒ: << Pe ns ionis ti ca pr i vi legiata cl i g u er r a», rgso, P· ll 4, !24, 129, J3L

L a r ivelazione, attraverso l 'au top sia, rl'ipertrofia ed o pacam ento del l 'e n doc ar dio nel militare deceduto per sincope m servizio di guerra h a indotto a d am m ettere una decorr enza ignora t a ed asinto m atica dell'i nfer m ità cardilca, agg ravata dal richiamo alle ar mi, e q uindi
ta le da conse n tire il tratta men to pe nsio n istico di gue rr a (8) Il se rvizio di g uerra aggrava la cardiopa tia p r eesistente ( 7), la quale è an-
J. - MALATTIE DEL CUORE E DE l VAS I.
che aggravata e rivelata dal bombardamento aereo, avente quindi carattere di causa diretta, violenta ed immediata (u); tale infermità può essere denunciata anche dopo una licenza di convalescenza quando risulti che sul suo aggravamento influirono emozioni e fatiche di un settore di guerra particolarmente delicato (9). Il fronte greco-albanese deve avere aggravato la prcesistente insufficienza in un anno di servizio (6); e lo stesso si è detto del fronte albanese (r2); la prcesistenza della malattia non esclude il trattamento per aggravamento.
Equiparatosi alla lesione il congelamentb in trincea, è altresì considerata lesione l'affez1one cardiaca riconosciuta nel militare rimasto in acqua per varie ore per siluramento della nave (2).
L 'endoarteritc può essere aggravata dalla infezione ed amputazione di un arto per fatto di guerra (r4). L'angina pectoris può dipendere dal psichico c fisico causato dalle incursioni (5). E' stato escluso il trattamento ove il decesso per emorragia cerebrale, determinata da affezione cardiovascolare, sia avvenuto a distanza di alcuni anni dal rimpatrio, e fondatamente dipendente da antica lue (r). Il trattamento per aggravamento è stato riconosciuto per emiplegia da ictus cerebrale, legato alla miocardite cronica, peggiorata da fatiche, strapazzi, disagi, tensione emotiva e preoccupazioni dipendenti dal servizio di gue rr a (ro) . La miocardite può essere messa in relazione a ferita da arma da fuoco ed all'uso prolungato dell'apparecchio di protesi per amputazione al terzo inferiore della coscia (3). Escluso che il militare fosse stato sottoposto d'autorità ad intervento operatorio, si nega la dipendenza da causa di servizio di guerra (o attinente alla guerra) del decesso per embo lia cardiaca seguita ad operazione di ernia di natura costituzionale e non aggravata dal servizio ( r3). E' stata imputata all'enfisema, in soggetto che ne soffriva, la miocardite, rivdatasi a distanza di anni dalla ferita non seguita da processo settico, e quindi negato il trattamento; è noto infatti che l'enfisema si sviluppa g rad atame nte dall'asma e l'asmatico va considerato come un paziente disturbato non solo nella dinamica respiratoria, ma anche in quella vas co lar e (4).
Le varici costi tuiscono una malformazione delle pareti venose in soggetti costituzionalmente predisposti; tuttavia possono aggravarsi a causa del disagio degli spostamenti a piedi io località sfornite di strade e dellanecessità della stazione eretta per lungo tempo (ro).
Sono stati riportati casi di cardiopatia per aggravamento di guerra della pregressa tachicardia; di esclusione dell'aggravamento della cardiopatia (stenosi mitralica) in mancanza di si ntomi rivelatori; di
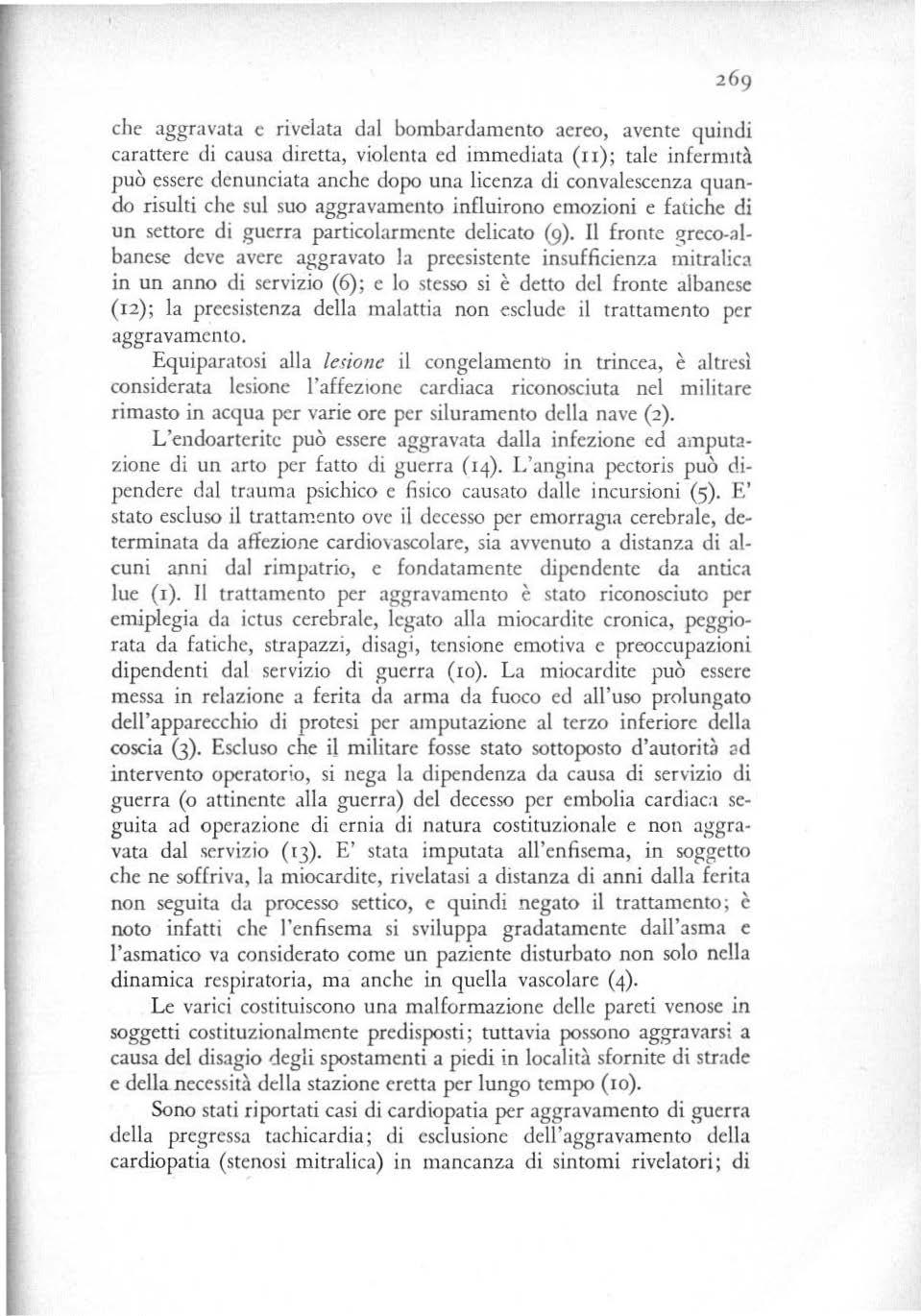
aggravamen to per causa del servizio di guerra della cardiopatia ignorata all'atto del richiamo; dì esclusione del l a dipendenza da fatto di guerra della cardiopatia manifestatasi nel civile per difficili ed anorma li condizioni di vita della popolazione a causa della guerra (Mandò).
Il -TuMORI.
Decisioni della Sez. I Spec. Pensioni di guerra: del 10 maggio 1948 (1); del 9 nov. 1948 (z); dell'II nov. 1948 (3); del 22 nov. 1948 (4). - Decisioni del la Sezione Il Speciale Pensioni di guerra: del 14 maggio 1949 (s); del 3 dic 1949 (6); de l 4 febbr. 1950 (7); del 21 aprile 1950 (8). - MANI)Ò: (( Pensionistica privi legiata d i guerra » , p . 120, 12P-.

Il tumore, apparso e constatato durante il servizio di guerra, costituisce una presunzione di dipendenza dal servizio di guerra iuris tantum, contro la quale la prova contraria è ammessa ma che non potrebbe essere f"rnita da nessuno; si concede pertanto il trattamento (5)-(8). Ora, pure restando incerta l'etiologia dei tumori, non si può negare che il gravoso e disagiato servizio di guerra possa avere nociuto sull'organismo favorendo l'evoluzione del processo morboso; non osta alla concessione del trattamento il fatto che durante il servizio di guerra fosse ancora mancata la rivelazione clinica del neoplasma localizzato al mesencefalo, di cui erano stati constatati soltanto sintomi non decisivi (7).
Il tumore stenosante del colon (a cui seguì decesso del militare già riconosciuto affetto da tubercolosi in dipendenza del servizio di guerra) può avere trovato nella riacutizzazione tubercolare un tale impoverimento delle difese 0rganiche da subirne l'aggravamento a decorso letale (4); si è negato però che il decesso per epiteliale dell'esofago possa avere rapporto con la tubercolosi polmonare riconosciuta dipendente da servizio di guerra (2). Una manifestazione del tipo del linfogranuloma con localizzazione osteoperiostea può riportarsi al servizio di guerra cessato da tre anni: ciò in considerazione della natura subdola e del lento decqrso di tale infermità nonchè della gravità del servizio di guerra (3) · n carcinoma, rivelatosi dopo alcuni anni dal congedo, viene collegato con l'ulcera pilorica e con la gastrite, su cui ebbero ad influire il servizio di guerra combattuta e l'incongrua alimentazione (r); parimenti la mancanza della tempestiva terapia nonchè la incongrua vittitazione e la gravosità del servizio di guerra possono avere influito sul più rapido decorso del tumore faringeo (5). Le sofferenze .fisiche e morali per i maltrattamenti e la detenzion e dai nazifa scisti e l 'in terruzione della terapia
270
possono avere mfluito sul rapido decorso l etale della neopiasJa de!b vescica (6).
Sono stati già riportati dalla dottrina casi: di dipendenza dal servizio di guerra del tumore intracranico insorto in sede traumatizzata; di escl u sione della dipendenza della neoplasia epiteliale dell'e!>ofago da una lesione di guerra (Mandò).
Per le formazioni benigne a decorso cronico lentissimo l a gturlsprudenza è fredda.
II I. - TuBERCOLOSI.
Decisioni della Sezione l Speciale Pensioni di guerra: del 24 giugno 1948 ( 1); del 18 ott. 1948 (2); del 21 nov. 1949 (3); del 6 luglio 1950 (4). - Decisioni della Sezione II Speciale Pensioni di guerra: del 28 ott. 1948 (5); del 15 nov. 1948 (6); del 27 agosto 1949 (7); del 21 nov. 1949 (8); del IO gcnn. 1950 (9); del 17 gcnn. 1950 (10). - BucciAN,.E: « Legislazione dell'assistenza ai militari minorati », 1942, p. 193, 195, 205, 207. - BucctANTE: « La tubercolosi rispetto alla causa c concausa di servizio ed al trattamento pensionistico di privilegio di guerra e ordinario >> in Lo Corte dei Conti, lugliCK>ttobre 1942, p. 1 e seg.MANI>Ò: cc Pensionistica privilegiata di guerra», p. 104, 106, IO], 108, 112, 120, 121, 122, 124 , 127, 132.
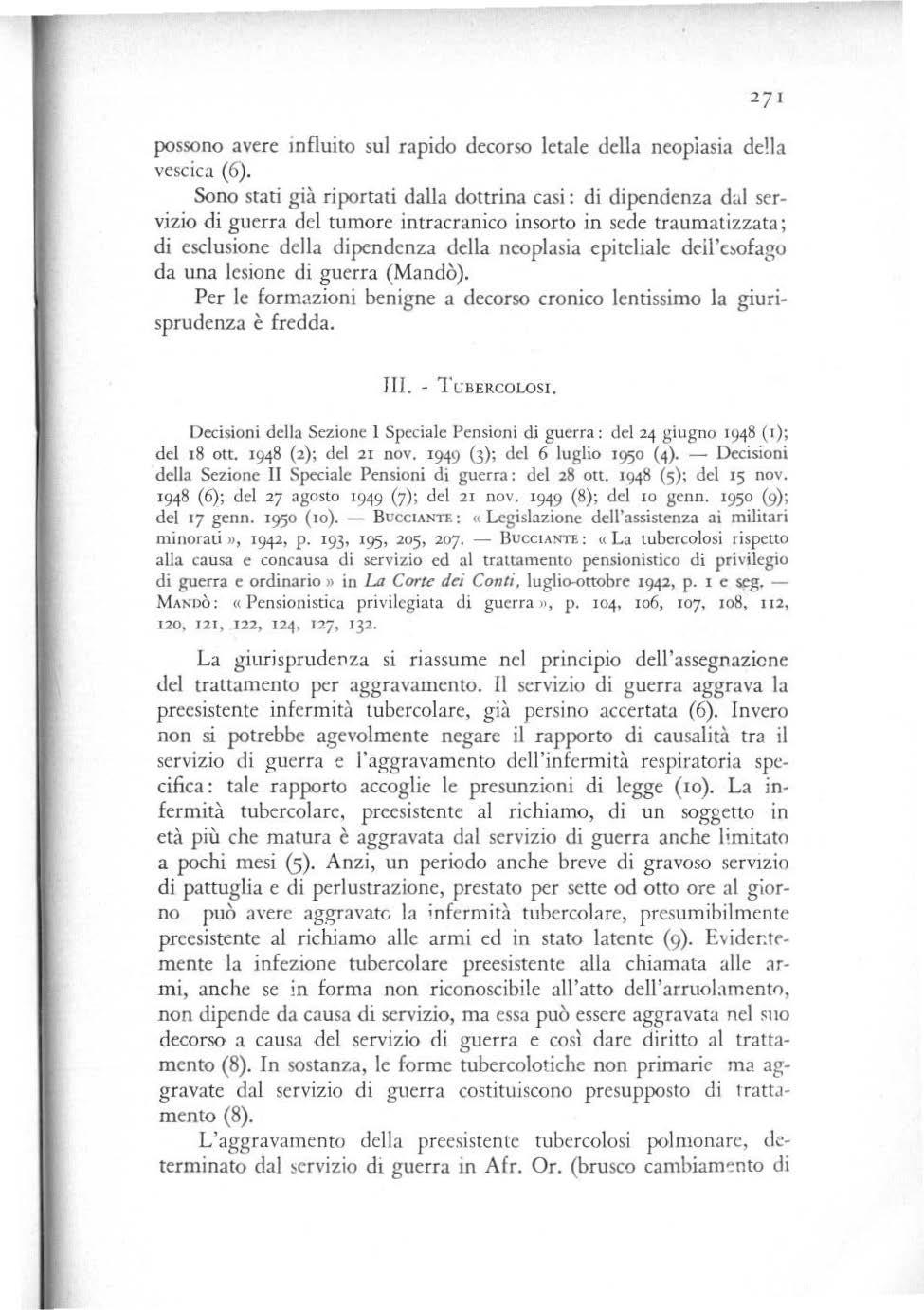
La giurisprudenza si riassume nel principio dell'assegnazione del trattamento per aggravamento. Il servizio di guerra aggrava la preesistente infermità tub ercolare, già persino accertata (6). Invero non si potrebbe agevolmente negare il rapporto di causalità tra il serviz io di guerra e l'aggravamento dell'infermità respiratoria specifica: tale rapporto accoglie le presunzioni di legge (10). La infermità tubercolare, preesistente al richiamo, di un soggetto in età più che matura è aggravata dal servizio di guerra anche limitato a pochi mesi (5). Anzi, un periodo anche breve di gravoso servizio di pattuglia e di perlustrazione, prestato per sette od otto ore al giorno può aver e aggravate la infermità tubercolare, presumibilmente preesistente al richiamo alle armi ed in stato latente (9). Evider.t('mente la infezione tubercolare preesistente alla chiamata alle mi , anche se in forma non riconoscibile all'atto ddl'arruobmento, non dipende da causa di servizio, ma essa può essere aggravata nel mo decorso a causa del servizio di guerra e così dare diritto al trattamento (8) In sostanza, le forme tubercolotiche non primarie ma aggravate dal servizio di guerra costituiscono presupposto di t ratt.lmento (8).
L'aggravamento della preesistenlc tubercolosi polruonarc, determinato dal di gue rr a in Afr. Or. (brusco cambiam'!nto di
271
clima, di ambiente e di abitudini, rapidi sba lzi di temperatura, fatiche, disagi, alimentazione wcongrua), costituisce fondamento per la concessione del trattamento pensionistico di guerra alla vedova (2).
I disagi di guerra possono determinare una riattivazione di focolai sop iti e dare luogo attraverso fasi di miglioramento e peggioramento ad una forma evolutiva più grave (1).
Una grave limitazione della funzione di un arto in conseguenza di ferite da mitragliatrice può avere creato uno stato di minorazione fisica c morale capace di influire sul decorso e sull'esito letale di un processo tubercolare (4).
Sul riconoscimento a distanza dal servizio, la giurisprudepza dubita; si è detto (1948) che un banale deperimento organico: constatato in corso del servizio di guerra, può conside rarsi (pure essendo la sua espressione comune a tante infermità a carattere cronico) come la prima mat,jiestazione della forma tubercolare constatata parecchi anni più tardi allo stato di sclerosi in fase rievolutiva.
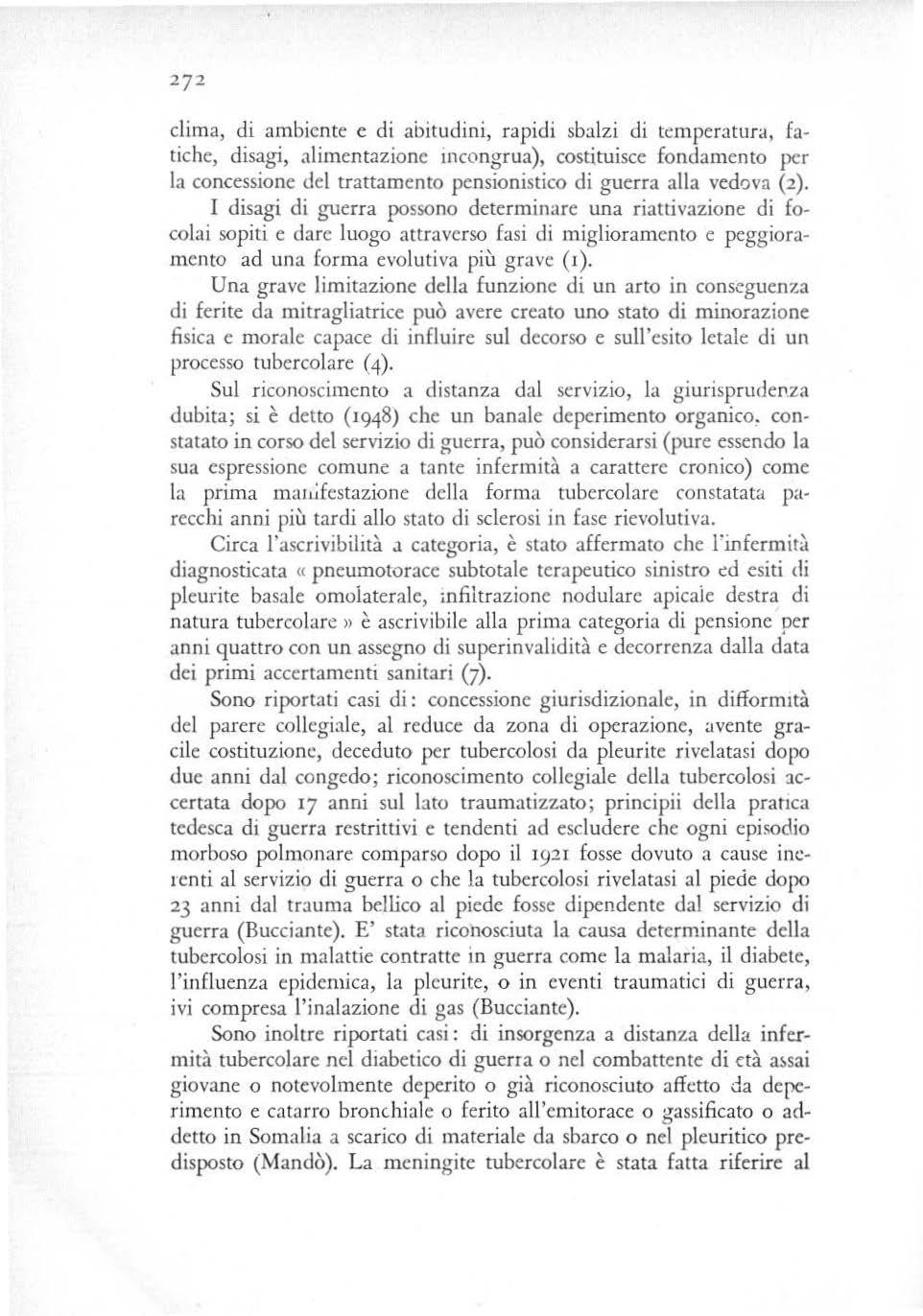
Circa l'ascrivibilità .1 catego ria, è stato affermato che l'infermità diagnosticata « pneurnotorace subtotale terapeutico sinistro ed esiti di pleurite basale omoiateralc, infiltrazione nodulare apicaic destra di natura tubercolar e >> è ascrivibile alla prima categoria di pensione per anni quattro con un assegno di superinvalidità e decorrenza dalla data dei primi accertamenti sanitari (7).
Sono riport ati casi di: concessio n e giurisdizionale, in difformttà del parere collegiale, al r ed uce da wna di operazione, avente graci le costi tu zione, deceduto per tubercolosi da pleurite rivelatasi dopo due anni dal congedo; ricono scimento collegiale della tubercolosi cena ta dopo 17 anni sul lato traumatizzato; principi i della prauca tedesca di guerra restrittivi e tendenti ad escl udere che ogni episodio morboso polmonare comparso dopo il 192r fosse dovuto a cause inctenti al servizio di guerra o che la tubercolo si rivelatasi a l piede dopo 23 anni dal trauma bellico al piede fosse dipendente dal servizio di guerra (Bucciante). E' stata riconosciuta la causa determinante della tubercolosi in malattie contratte i n guerra co me la malaria, il diabete, l'influenza epidemica, la pleurite, o in eventi traumatici di guerra, ivi compresa l'inalazione di gas (Bucciante).
Sono inoltre riportati casi : di insorgenza a di stanza della infermità tubercolare nel diabetico di guerra o nel combattente di età assai giovane o notevolmente deperito o già riconosciuto affetto da deperimento e catarro bronc.hiale o ferito all 'cmi torace o gassificato o addetto in Somalia a scarico di materiale da sbarco o nel pleuritico predispo sto (Mandò). La meningite tubercolare è stata fatta riferire al
catarro bronchiale aprcale o considerata seco ndaria ad infezione miliarica derivata da focolai tubercolotici riattivati dai disagi del servizio di guerra, sia pure breve (Mandò).
IV. -ALTRE MALATilE DEGLI ORGANI RESP I RATORI.
D ecisioni della Sez. l Spec. Pensioni di guerra: del r8 ott. 1948 (r); del 25 ott. 1948 (2); del 6 dic. 1948 (3). - Decisioni della Sez. II Spec. Pens. di guerra: del 25 ott. 1948 (4). « Pensionisnca pri\ ileg•ata di guerra " • p. 105, 106, 107, 109, 117, 123.
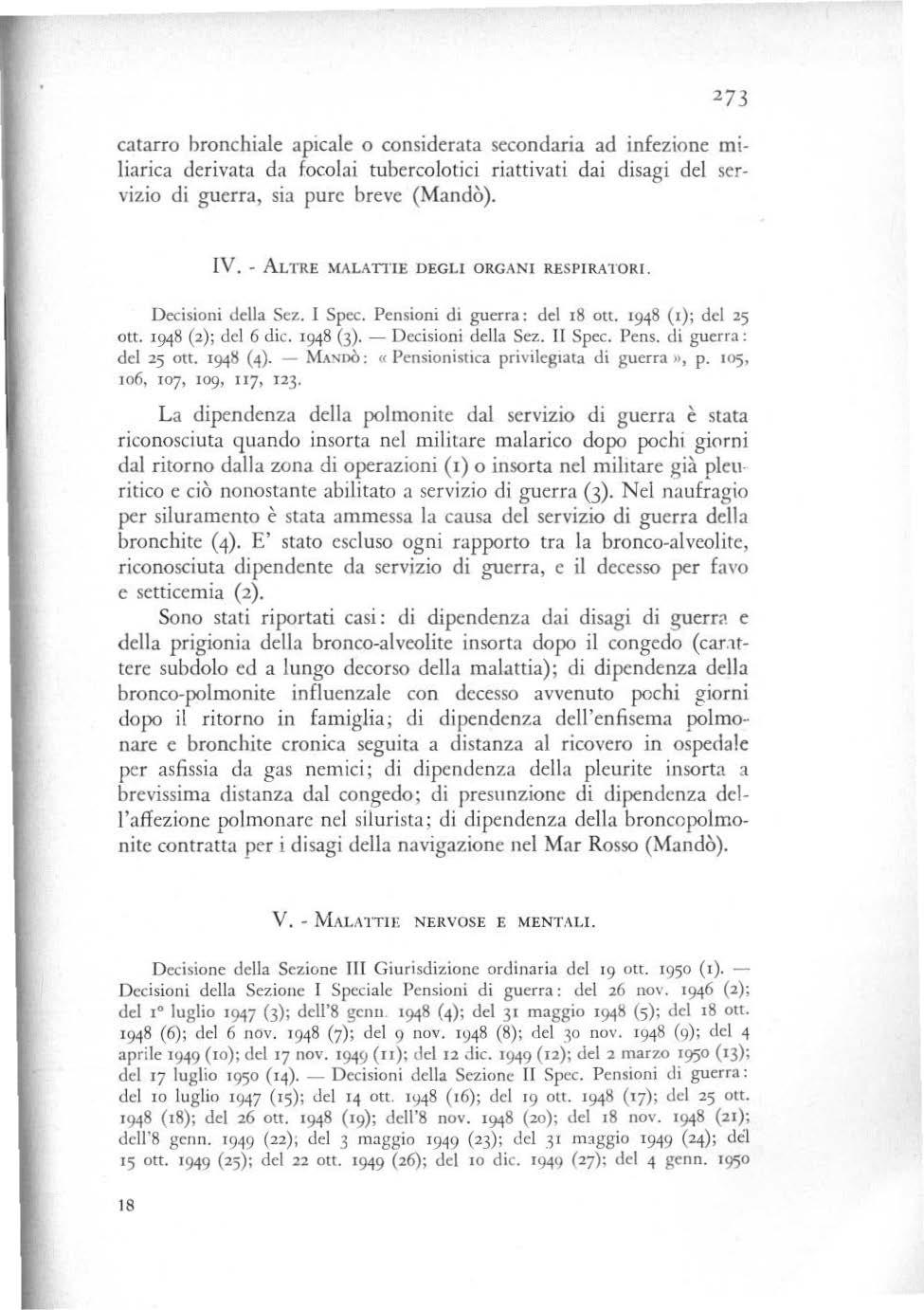
La dipendenza della polmonite dal servizio di guerra è stata riconosciuta quando insorta nel militare malarico dopo pochi gi0rni dal ritorno dalla zona di operazioni (1) o insorta nel mìlttare già pleu · ritico e ciò nonostante abilitato a servizio di guerra (3). Nel naufragio per siluramento è stata ammessa la causa del servizio di guerra della bronchite (4) . E' stato escluso ogni rapporto tra la bronco-alveolite, riconosciuta dipendente da servizio di guerra, c il decesso per favo e se tticemia (2).
Sono stati riportati casi: di dipendenza dai disagi di guerré! e della prigionia della bronco-alveolite insorta dopo il congedo (canttere subdolo ed a lungo decorso della malattia); di dipendenza della bronco-polmonite influenzale con decesso avvenuto pochi giorni dopo il ritorno in famiglia; di dipendenza dell'enfisema polmonare e bronchite cronica seguita a distanza al ricovero in ospedale p e r asfissia da gas nemici; di dipendenza della pleurite insorta a brevissima distanza dal congedo; di presum.ione di dipendenza dell'affezione polmon:ue nel silurista; di dipendenza della broncopolmonite contratta per i disagi della navigazion e nel Mar Rosso (Mandò).
D ec i sione della Sezione m Giurisdizione ordinaria del 19 OH. 1950 (l). -
Decis ioni della Sezione I Speciale Pensioni di guerra: del 26 nO\. 1946 (2): del 1° luglio 1947 (3); dcll'8 genu . 1948 (4); del 31 maggio 1948 (;); del 18 ott. 1948 (6); del 6 nov 1948 (7); del 9 nov. 1948 (8); del 30 nov. 1948 (9); del 4 aprile 1949 (ro); del 17 nov. 1949 (II); del 12 ,lic. 1949 (12); del 2 marzo 1950 (13); del 17 luglio 1950 (14). - Decisioni della Sezione II Spec. Pensioni c.li guerra: del IO luglio 1947 (r5); del I4 Otl. 1948 (16); del 19 ott. 1948 (17); del 25 ott. 1948 (18); del 26 ott. 1948 (19); dell'8 nov. 1948 (20); del 18 nov. 1948 (21); dell'8 genn. 1949 (22), del 3 maggio 1949 (23); del 31 maggio 1949 (24); del 15 ott. 1949 (25); del 22 ott. 1949 (26); del 10 di c. 1949 (27): del 4 gcnn. 1950
2 73
V . - NlALATTm NERVOSE E MENTALI.
18
(28); del 18 genn. 1950 (29). - A. ALBERTI: « Le psicosi di guerra >> , Atti l Con gusso nazionale invalidi d1 guerra, 16-20 clic. 1948. - C. BEsTA: « Criterì direttivi per l'assistenza agli invalidi per lesioni dd sistema nervoso >> , 1919.C. SESTA: << Osservazi on i trattamento di pensione agli epilettici da ferita cerebrale di guerra >• , Il Bollettino. 1927, n. 6. - BucctANTE: <<Legis lazione dell'assistenza <?.cc.>>, 1942, p. 211, 213, 215, 225, 232, 234. - BucciANTE: c<Le ma lattie nervose e mentali rispetto alla ca u sa di servizio ed al trattamento pensionislico di privilegio di guerra e ordinar io » in La Corte dei Co11ti, 1943, p. 8. - MANDÒ: << Pcnsionisti ca privilegiata di guerra », 1950, p. 105, 108, n3. 115, 122, 12) , 128, 131 , 133; ll7, 123, 128 ; 104, 108, I O<). IJ8; 130; l 14; 132; 125: 108, I O<J, 126; n6, 125. 127. 129.
Per il lato delle prove, dei termini, delle procedure e della capacità si è detto: che, ai fini della sospensione dei termini pert>ntori in materia di pensioni di guerra, non occorre un vero e propr io deme nzial e ma l a incapacità di fatto ad accudire ai propri interessi; ch e non si ver itìca quindi decadenza per la tardiva domanda del soggetto affetto da nevrastenia cerebro-spina le (13); che l a document;jzione incompleta per gli affetti da encefalite letargica e le lievi discordanze degli atti nulla tolgono al complesso degli accertamen t i positivi sulla dipendenza (n); che la schizofrenia. rivclatasi a quattro giorni di distanza dall'inizio di una licenza di convalescenza e dopo un lungo servizio di guerra, non potesse senz'altro considerarsi estranea al servizio c che pertanto la decisione interlocutoria ordinasse un suppleme nto di istruttoria affi.nchè fossero interpellati Comandi, i superiori diretti ed i carabinieri del paese del militare circa il contegno da costui tenuto in varie occasioni (27); ch e la demenza precoce, sviluppatasi anteriormente al 31 dicembre 1930 (data di legge) potesse costituire una forma degenerativa del parkinsonismo postencefalitico, contratto nella guerra 1915-1918, e che quindi si potesse riconoscere valida l! tempestiva la relativa domanda (9); che la l>Ìndrome parkinsoniana encefalitica con note di indebolimento mentale coinvolge spesso sm dall'inizio le facoltà mentali onde si ammette che l'interessato, privo della capacità di curare i propri interesst, possa be neficiare della sospensione dei termini sancita per i dementi (10). Quanto agli accertamenti circa il parkinsonis m o postencefalitico rel ativo alla gue rr a 1915-1918, la esp ressio n e « in modo non dubbio » contenuta nell'art. 1 della legge 20 marzo 1940 n. 216 deve intendersi non nel senso rigidamente letterale, ma nel senso che risul t i validamente fondato che la infezione encefalitica venne contratta in occasione di qu ella gue r ra (3). Ai fini poi dell'applicazione d1 deter m inate disposizioni di favore si è ammesso che la tardiva sindrome parkinsoniana, preceduta si n dal 1929 da rigidità nei movimenti e
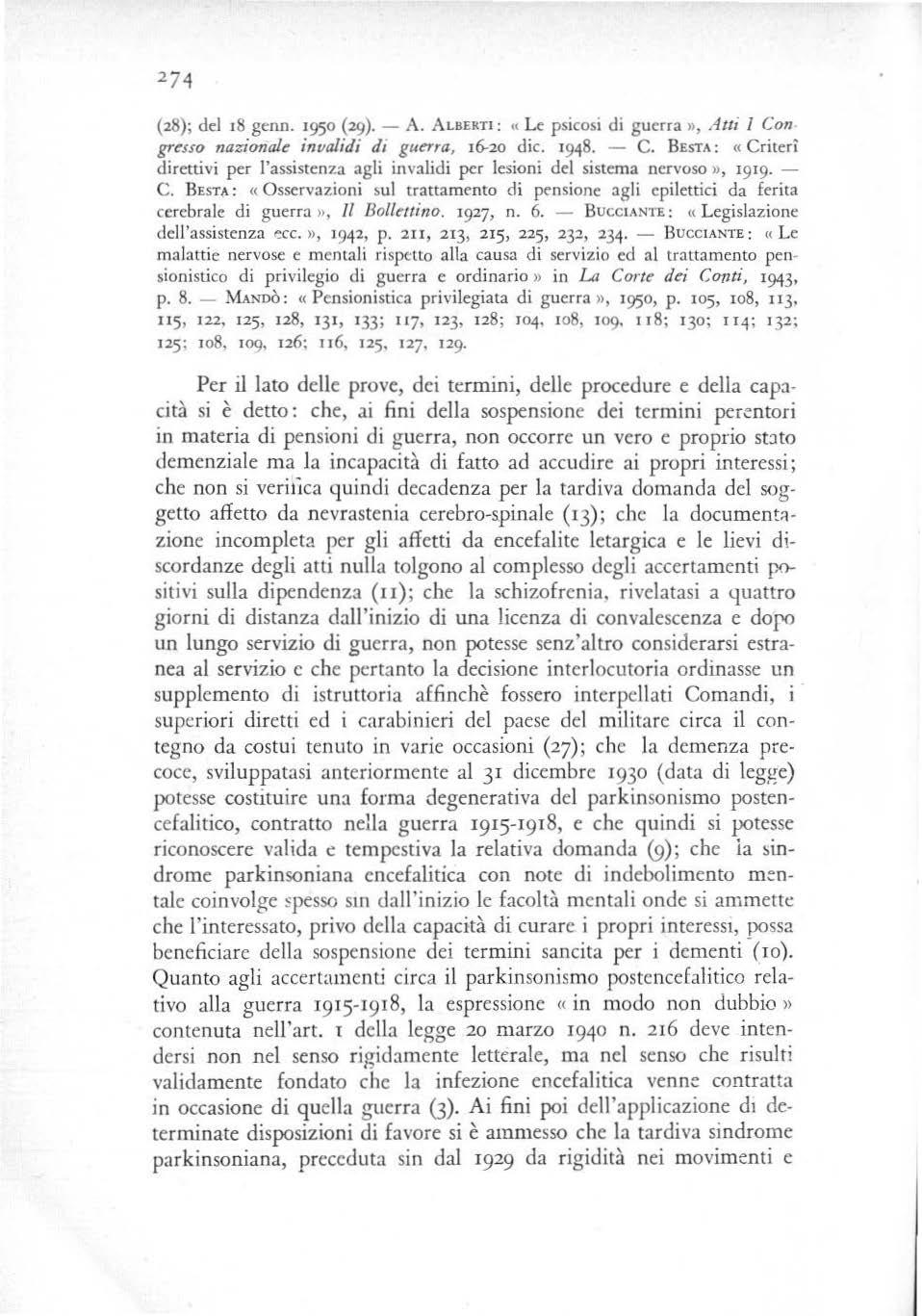
2 74
da fissità nello sguaròo, possa far ritenere che la infermità si sia manife stata anteriormente al 31 dicembre 1930 (12).
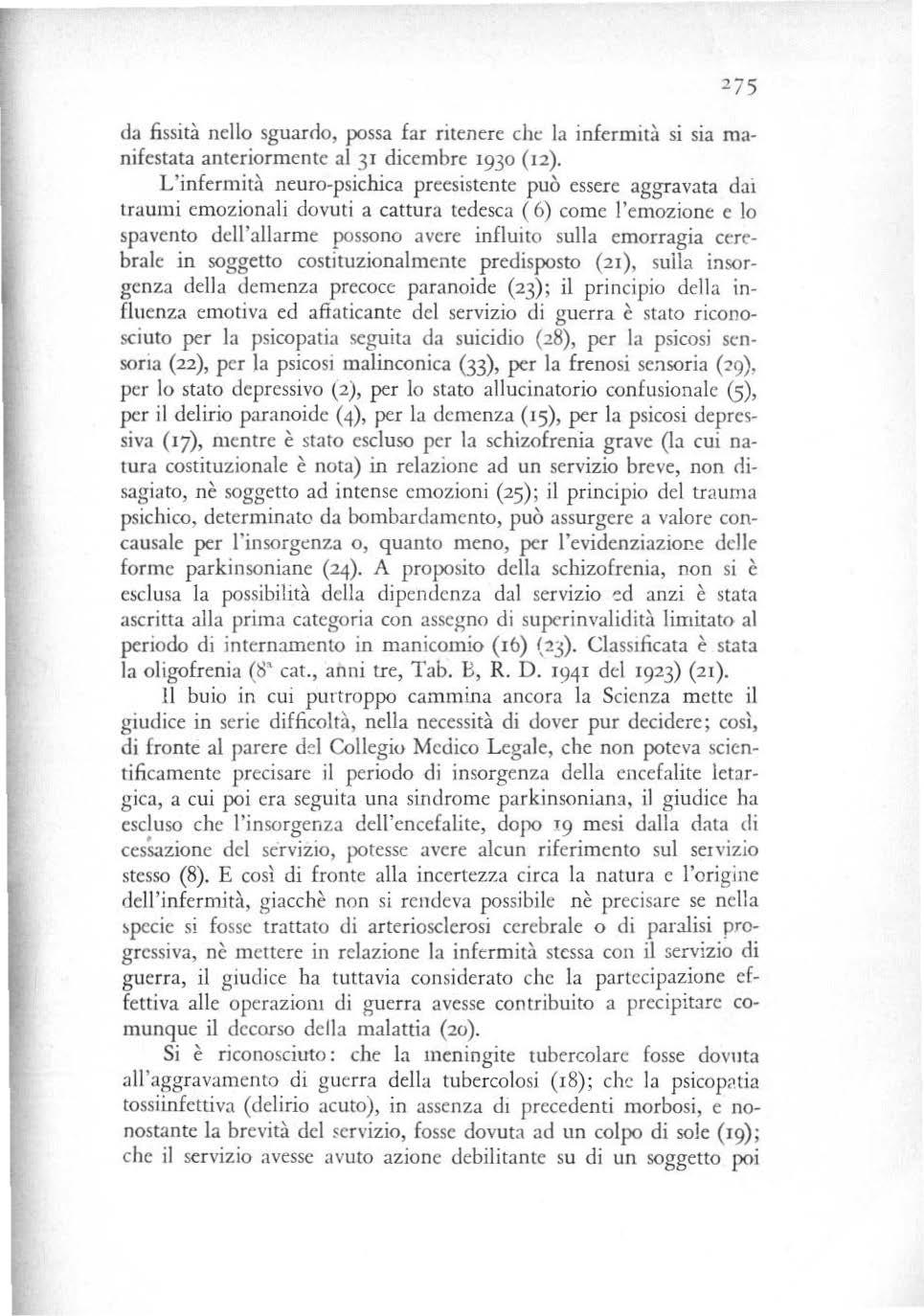
L'infermità neuro-psichica preesistente può essere aggravata dai traumi emozionali dovuti a cattura tedesca ( 6) come l'emozione e lo spavento dell'allarme possono avere influito sulla emor ra gia cerebrale in soggetto costituzionalmente predisposto (21), sulla insorgenza della demenza precoce paranoide (23); il principio della influ enza emotiva ed affaticante del servizio di guerra è stato riconosciuto per la psicopatia seguita da suicidio (28), per la psicosi stnsona (22), per la psicosi malinconica (33), per la frenasi se:tsoria (:H)). per lo stato depressivo (2), per lo stato allucinatorio confusionale (5), per il delirio paranoide (4), per la demenza (15), per la psicosi depressiva (17), mentre è stato escluso per la schizofrenia grave Qa cui natura costituzionale è nota) in relazione ad un servizio breve, non disagiato, nè soggetto ad intense emozioni (25); il principio del trauma psichico, determinato da bombardamento, può assurgere a valore conca usale per l'insorgenza o, quanto meno, per delle forme parkinsoniane (24). A proposito della schizofrenia, non si è esclusa la possibilità della dipendenza dal servizio anzi è stata ascritta alla prima categoria con assegno di supcrinvalidità limitato al periodo di internamento in manicomio (16) (23). Classificata è stata la oligofr enia (8 ' cat., ann i tre, Tab. B, R. D. 1941 del 1923) (21).
li buio in cui purtroppo cammina ancora la Scienza mette il giudice in serie difficoltà, nella necessità di dover pur decidere; così, di fr onte al parere del Collegio Medico L ega le, che non poteva scientificamente precisare il periodo di insorgenza della encefalite lctargica, a cui poi era seguita una sindrome parkinsoniana, il giudice ha escluso che l'insorgenza dell'encefalite, dopo r9 m esi dalla data di cessazione del servizio, potesse avere alcun riferimento sul sex vizio stesso (8) E così di fronte alla incertezza circa la natura c l'or1 gine dell'infermjtà, giacc hè non si rendeva possibile nè precisare se nella si fosse trattato di arteriosclerosi cerebrale o di par:ùis i progr essiva, nè mettere in relazione la inftrmità stessa con il servizio di guerra, il gi u d ice ha tuttavia considerato che la partecipazione effettiva alle operaziom di guerra avesse contribuito a precipitare comunque il decorso della malattia (20)
Si è che la meningite tubercolare fosse dovu ta all'aggravamento di guer ra della tubercolosi (18); c he la psic opé1.tia tossiinfettiva (de lirio acuto), in assenza di precedenti morbosi, e nonostante la brevità del fosse dovuta ad un colpo di sole (19); che il servizio avesse avuto azione debilitante su di un soggetto poi
275
riformato ed in modo tale da causare l'encefalite letargica nel periodo immediatamente successivo al servizio di guerra (7); che dipendesse da l servizio di guerra l'aggravamento della preesistente demenza paranoide, seguita poi da suicidio (6) nonchè della tabe c della paralisi (16).
Malattie nervose e dd cervello sono state riportate al le origini del servizio eli guerra come per la polineurite da difterite, per l'ascesso cerebrale da infezione otitica, per l'amnesia da esplosione, per la neurosi di guerra, per la sinusite da ferita frontale, per i disturbi psiconeurotici bronchiale, per la [X>lineurite da cachettici, per la polineurite dal diabete, per la epi lessia da tensione emozionale, per lo stato psiconeurotico e per la perdita della capacità mental e da traumi, per malattie nervose e mentali dipendenti da malattie tropicali.
Al primo Convegno nazionale per l'assistenza agli invalidi di guerra (191 8), Alberti, Boschi e Bucciante hanno principalm ente preparato le basi scientifiche per le risoluzioni giuridiche in tale complessa materia. Celebri rimangono i princip! eli Bucciante per la va lutazione dell'efficienza di un trauma nell'insorgenza di una neuropatia.

Sono stati riportati casi: di dipendenza dai disagi di un lungo servizio di guerra della infezione encefalitica insorta poco dopo il ritorno in patria, specie nel malarico, o durante il periodo di licenza o lontano dal fronte, c così della demenza paralitica, della psicosi schizofrenica da tubercolosi di guerra (Bucciante). Sono stati riportati inoltre casi: di dipendenza rlal servizio di guerra della dc>menza precGce manifestatasi a distanza di anni dal congedo, di demenza precoce da spondilite tubercolare di guerra, della schizofrenia 1a risentimento entero-epatico, del legame delia demenza precoce col pregresso parkinsonismo postencefalitico di guerra.
E, ancora, ,delia dipendenza deli'epilessia il cui fatt<:re costituzionale non esclude per sè il concorso di cause di guerra, della dipendenza della psicosi depressiva seguita a pregresse lesioni multiple di guerra, della epi lessia seguita a f . a. f. alla regione carotidea, dell 'aggravamento di guerra della paralisi progressiva, della dipendenza della retrazione palmare bilaterale (morbo di Dupuytrcn) da eventi di natura traumatica (Mandò) . E' ammessa la presunzione di dipendenza nel caso in cui il combattente sia stato riformato per non preesistente od ereditaria schizofrenia, non fX>tendosi dimostrare che le cause di guerra non abbiano agito sulla psicosi (in giurispr. ci tat a da Mandò).
Decis ioni della Sezione I Speciale Pensioni di gue r ra: del 14 genn. 1947 (1); del 6 aprile 1948 (2); del 15 aprile 1948 (3); dell'8 nov. 1948 (4); del 23 nov. 1948 (5); de l 9 dic. 1948 (6); de l 19 genn . 1950 (7); del 26 gcnn. 1950 (8); del 26 genn. 1950 (9); del 30 genn. 1950 (ro). - D ec isioni della Sezione II Spec ial e Pensioni di gue r ra: del 16 aprile 1949 (n); del 12 clic. 1950 (12). - BucC IANTE: '' Legislazione dell'assistcnz:t ecc. " • 1942, p. 213. - SAI'TI. ''Breve sintesi della patogenesi della mahria >> in Rivista della Corte dei Conu, fase. 5·6, 1950, pane III , p. 96. MANDÒ: " Pcnsionisùca privilegiata di guerra », p. 104, 105, 11 0, 129, 131.
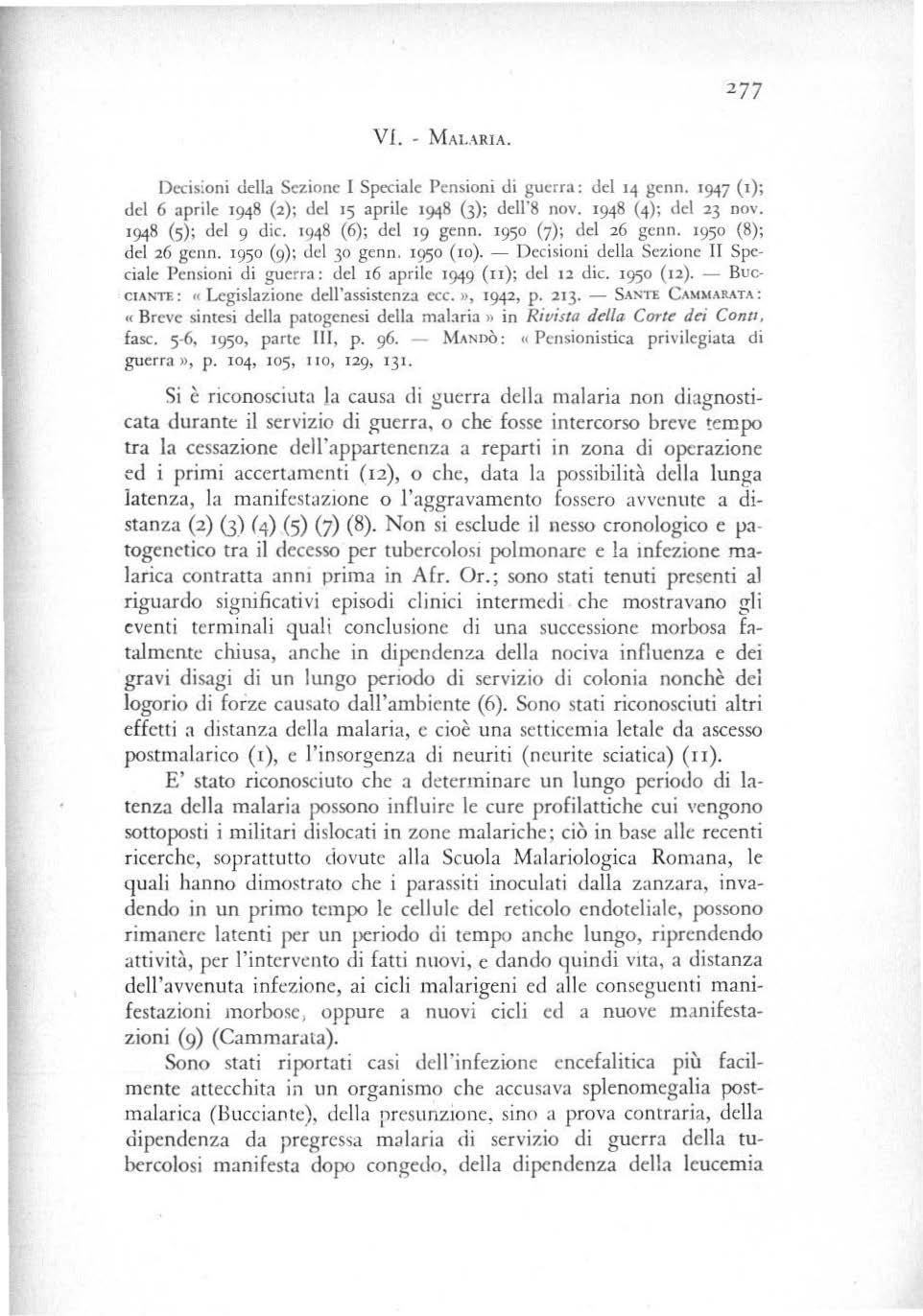
Si è riconosciuta la causa di gue rra delb malaria non diagnosticata durante il servizio di guerra, o che fo sse intercorso breve tempo tra la cessazione dell'appartenenza a reparti in zona di operazione ed i primi accertJrn enti (12), o che, data la possibilità della lunga latenza, la manifestaziO ne o l'aggravamento (ossero avven ute a distanza (2) (3) (4) (5) (7) (8) . Non si es clude il nesso cronologico e patogencti co tra il decesso per tubercolosi polmonare e la mfezione malarica contratta annJ prim a in A(r. Or.; sono stati tenuti presenti al riguardo significativi episo di clinici intermedi che mostravano gli eventi terminali quali co nclu sione di una successione morbosa fatalmente chiusa, anche in dipendenza della nociva influenza e dei gravi disagi di un lungo penodo di servizio di colonia nonchè d ei logorio di forze caus.1to dall'ambiente (6). Sono stati riconosciuti altri effetti a distanza della malaria, c c io è una settice mia letale da ascesso postmalarico (t), e l ' in so rgenza di neuriti (neu rite sciatica) (n) .
E' sta to ri conosciuto che a determinare un lungo periodo di latenza della malaria possono influire le cure profi lattiche cui vengono sottoposti i militari dislocati in zone malariche: ciò in base al le recenti ricerch e, sop rattutto dovute alla Scuola Malario logica Roma na, le quali hanno dimo stra to che i parassiti inoculati dalla zanzara, invadendo in un primo tempo le cellule del r eticolo endoteliale, possono riman ere latenti per un periodo di tem po anc he lungo, riprendendo att ività , per l'intervento di fatti nu ovi, e dando quindi vJta, a di sta nza de ll 'avvenuta infez io ne, ai cicli ma larigeni cd a ll e conseguenti manife stazioni morbose , oppu re a nuovi cicli ed a nuove m :mifestazioni (!:;) (Cammarata).
Sono stati riportati casi dell'infezione encefalitica più facilme nte a tt ecchita in un organismo che accusava splenom ega lia postmalarica (B ucciante) . del la presunz10ne, sin o a prova contraria, della òipende nza da pregressa m a la ria di serv izio di guerra della tubercolosi manifesta dopo congedo, della d ipende nza della leucemia
Vl.
- MALARIA.
mieloide da pregressa malaria di guerra, e così dell'affezione bronchiale e della cheratite ulcerosa (Mandò).
VII. - MALATIIE INFETIIVE
Dec isioni della Sezione I Speciale Pensioni di guerra: de l 26 aprile 1945 (x); dell'S genn. 1948 (2). - Decisioni della Sezione II Spec iale Pensioni di guerra: de l 23 giugno 1947 (3); del 25 genn. 194<> (4); del 2 luglio 1949 (5). De cis iom: della Sezione 1II Spe.::ialc Pensioni di guerra: dd 13 genn. 1951 (6). - BuccrA:-:TE: « L'infortunistica di guerra e le donne marocchinare > ' in Giornale d t Medicina Mil;tare , ge nn. -(eb br. 1949. - Buec rANTE: « Legislazione dell'assistenza ccc. " • 1942, p. 209. - • Pen sionistic:a privilegiata di guerra .,, 19)0, P· ns. T2I, J22, 120, 130.

Mancando la prova che una malauia di natura infeuiva (mieltre trasversa del tratto lombo- s:tc rale) si sarebbe ugualmente manifestata ancorchè il militare non si fosse trovato alle armi, ricorre la presunzione ài dipend enza da causa di servizio, anche se non risulti che nel periodo in cui il militare contrasse la malaria si siano verificati, nell'ambiente m cui egli viveva, epidemie Ji alcun genere (5).
11 comportamento di un ufficiale c he, per giustificato ritardo, sale sul treno in movimento per raggiungere la zona di non costituisce colpa grave; e pertanto la morte per set ti cemia conseguente alla caduta dal tr eno è da riconoscersi dovuta a ca usa di servizio di guerra o attinente al la guerra (3).
La vitiligine estesa, conseguente a tifo addominale (addisonismo), manifestatasi a poc hi giorni dal rimpatrio, è stata riconosci ut J dipendente dal serv izio (6). E' stato concesso il trattamento alla vedova per la morte del militare dovuta a paratifo, manifestatosi in territorio metropolitano, dopo ch e in zona di operazione il militare stesso aveva sofferto di enterocolite accertata (4).
Accertato clinicamente che l' eccessivo deperimento organico ed esaurimento nervoso, per cui sia stato disposto il ricovero in ospedale. può costituire U•la fauna prodromica di tabo-paralisi, non si può esclude re che nel decorso deHa infermità abbiano influito i disagi della campagna, del clima e delle condizioni di vita coloniale; in casi di infezione sifilitica recente la interruzione delle cure per causa di se rvizio di gue rra può determinare la cronicizzazione della malattia e la insorgenza, a scadenza più o meno lunga, di affezioni metaluetiche quali la tabo-paralisi (2) . 1o n si è concesso trattamento per sifilide contratta durante il se rvizio di guerra in Afr. Or. (r).
E' stato accertato che le darne marocchinate sono rimaste infette
il di annessite blenorragica, il 20 % di vulvo-vaginite blenorragica, il ro % di sifilide, il ro % di blenorragia c sifilide; è stata criticata la classificazione alla 7" categoria delle donne rnarocchmate rimaste infette di sifilide (.Bucctante). E' riportato il caso di tabo-paralisi manifestatasi a distanza di circa 9 anni dal congedo c per essa fu riconosciuto l'aggravamento della preesistente infezione luetica per effetto della deficienza di cure specifiche dovute al servizio di guerra (Bucciante). E' stato ricordato l'aggravamento per incompletezza di cura e per i disagi àr guerra influenti sulle non integre condizioni del luetico. Si è esclusa la dipendenza dal servizio di guerra della congiuntivite blenorragtca quando il militare abbia trascurato le regole d'igiene possibili anche durante il servizio in reparto mobilitato; sulla insorgenza della piodermite è stata ammessa l'influenza del servizio di guerra; per le ma lattie epidemicc-contagiose si è detto che non occorre indagare sulla natura del servizio per valutare la utilità ai fini di guerra ma è sufficiente che si tratti di servizio militare prestato per le esigenze della guerra; ai fini della dipendenza da causd del servizio di guerra del parkinsonisrno postencefalitico, manifestatosi oltre sei mesi dopo la cessazione della guerra T915-I918, può trovare applicazione l'art. 2 del D. L. n . 1383 del 1924, per cui si debbono considerare dipendenti da causa di servizio di guerra le malattie epidemico-contagiose manifestatesi nei periorlo immediatamente successivo al congedo in relazione all'indebolimento .fisico riferibile al servizio prestato (Mandò).
Decisioni della Sezione I Speciale Pensioni di guerra: del r8 on. 1948 ( r) ( r bis); del 25 ott. 1948 (2); del 22 no v. 1948 (3); del 25 no v. 1948 (4). -
Decisioni della Sezione II Speciale Pensioni di guerra: del 15 no v. 1948 (5); del 20 oov 1948 (6); del 4 giugno 1949 (7); del 3 clic. 1949 (8); dell'II genn. 1950 (g); del 14 febbr. 1950 (ro); del 15 aprile 1950 (rr); del 15 fehbr. 1951 ( r2).
- MANDÒ: << Pensionistica privilegiata di guerra », 1950. - Bucc i ANTE: « I traumi oculari nella guerra mondia le )) in Giornale di Medtcina Mrlitare , gennaio 1938.
L 'indole costituzionale o congenita ha fatto escludere che la cataratta coronari a avesse potuto essere aggravata dal servizio automobilistico di guerra in Somalia (r) o che la cataratta com u nque ad orig ine d iscrasica potesse rappo r tarsi al servizio di guerra (3). Tale servizio non infl u ire su ll a miopia, neppure sotto i l profilo del l 'aggravamento (2); nonostante tale principio, si è tuttavia affer-
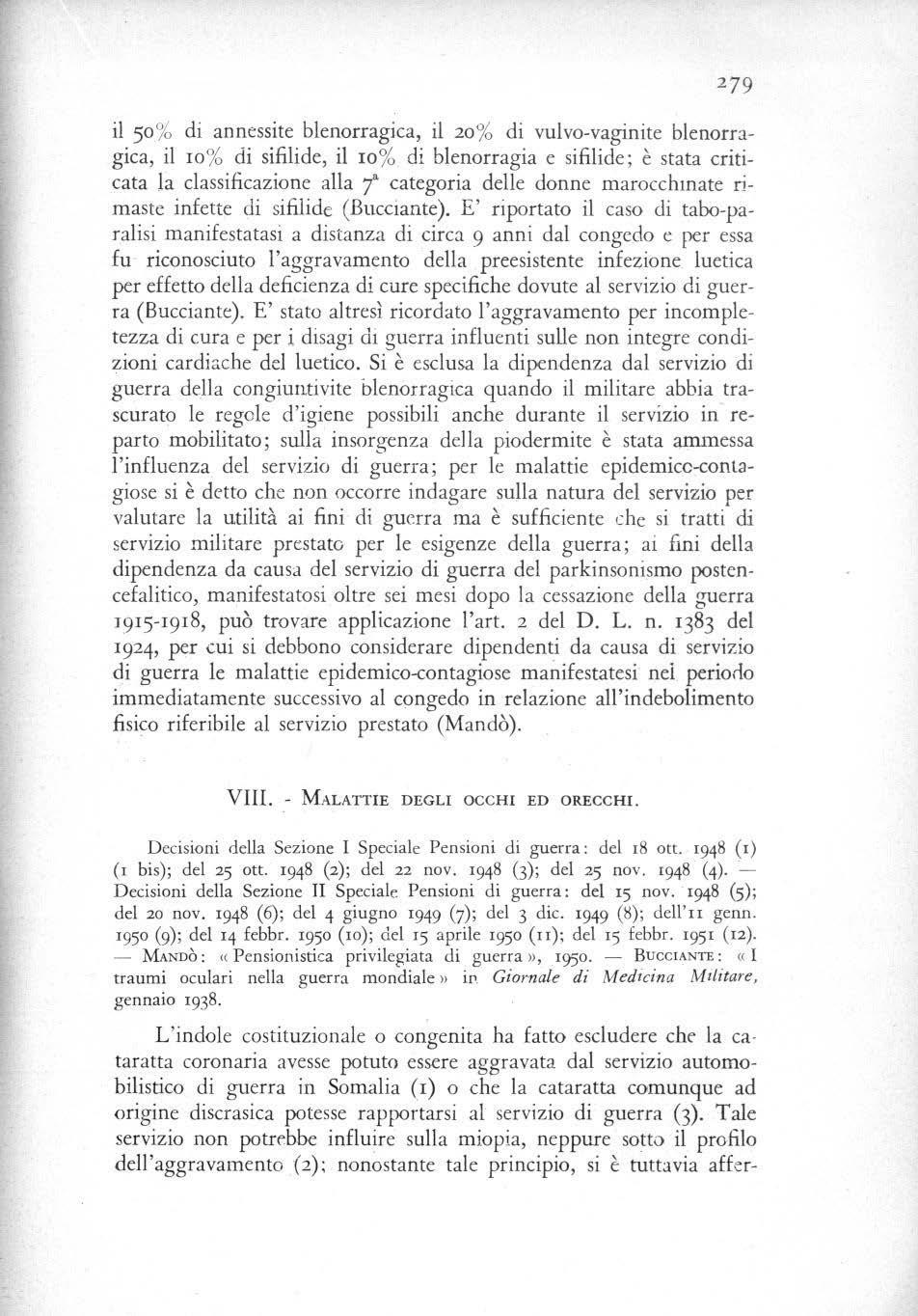 VIli. - MALATTIE DEGLI OCCHI ED ORECCHI.
VIli. - MALATTIE DEGLI OCCHI ED ORECCHI.
mato che, per quanto l a mwp1a dipenda generalmente da fatwri costituzionali, si possa ammettere che il clima malsano, scarsità di acqua, il vento, la sabbia ed i disagi in genere del servizio di guerra c deUa abbiano potuto, in Afr. Sett. (servizio di guerra) e nel Sud Afr. (prigionia), influire, per lungo periodo di tempo, su di un vizio di per sè avente carattere congenito come guello della rifrazion e, anche se inizialmente esistente in grado più lie,e; ciò tanto più che il tempe stivo uso di lenti adeguate e gli opportuni esercizi avrebbero certamente conseguito una discreta correzione del vizio oculare ( 11 ).
L' c.lggravame nto di guerra è stato ammesso per la corior".:tinite (r-bis), per lo strabismo divergente (ro), per l'atrofia ottica (9), per l'ulcera corneale o cheratite ulcerosa (5), per la retinite pigmeo· taria (8).
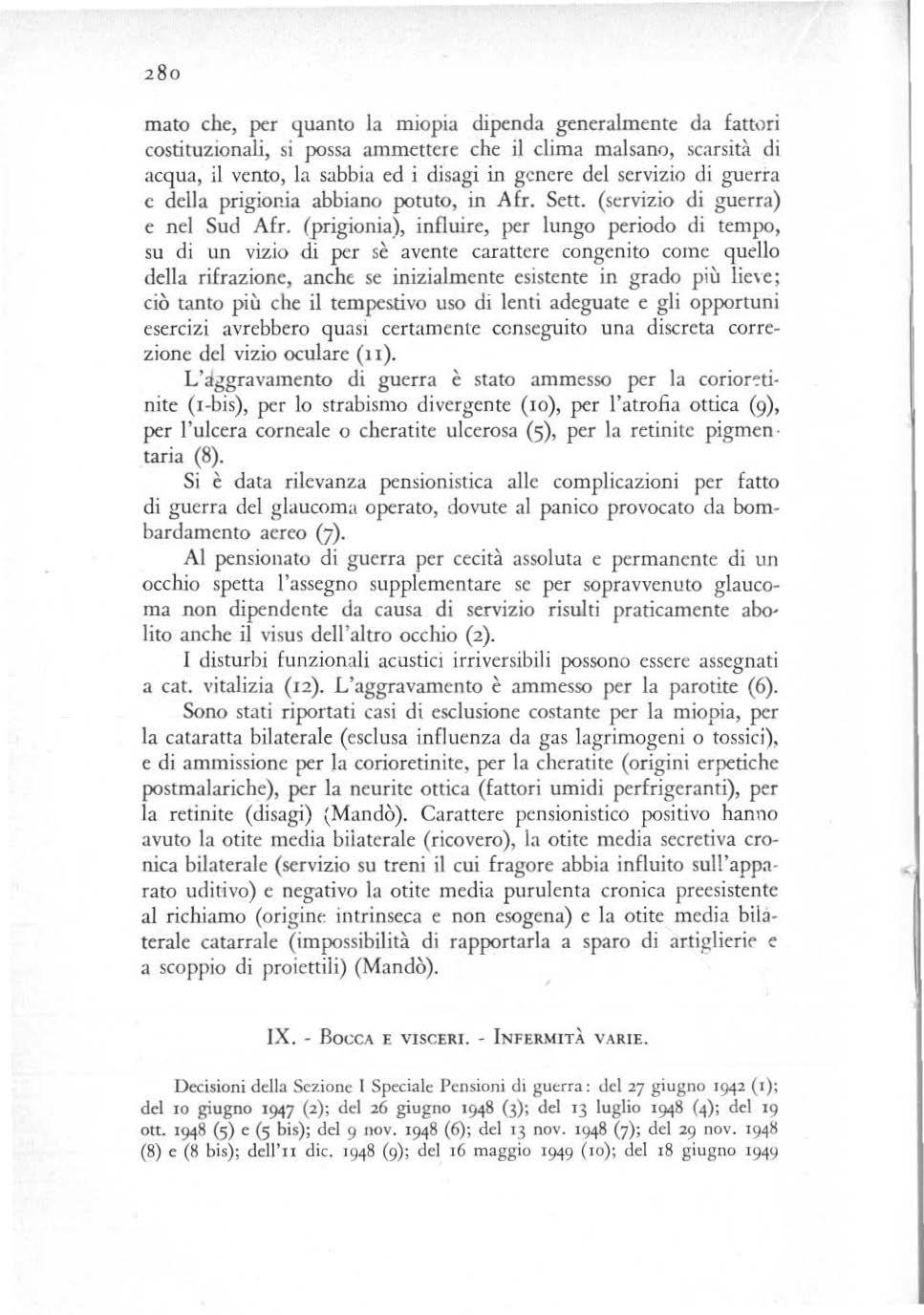
Si è data rilcvanza pensionistica alle complicazioni per fatto di guerra del glaucoma ope rato, dovute al panico provocato da bombardamento aereo (7).
Al pensionato di guerra per cecità assoluta e permanente di un occhio spetta l'assegno supplementare se per sopravvenuto glaucoma non dipendente da ca usa di servizio risulti praticamente abo· lito anche il visus dell 'altro occhio (2).
I disturbi funzionali acustici irriversibili posson o essere assegnati a cat. vitalizia (12). L 'aggravamento è ammesso per la parotite (6). Sono stati riportati casi di esc lusion e costante per la miopia, per la cataratta bilaterale ( es clusa influenza da gas lagrimogeni o tossici). e di ammissione per la corioretinite. per la che ratite (o rigini erpetich e postmalariche), per la neurite ottica (fattori umidi perfrigeranti), per la retinite (disagi) (Mandò). Carattere pcnsionistico positivo hanno avuto la otite media biìatcrale (ricovero), la otite m edia sccretiva cronica bilaterale (servizio su treni il cui fragore abbia influito sull'apparato uditivo) e negativo la otite media purulcnta cronica pre::esistente al richiamo (origint intrinseca e non esogena) c la otite media bilaterale catarrale (impossibilità di rapportarla a sparo di artiglierie e a scoppio di proiettili) (Mandò).
D ecisioni della Sezione l Speciale Pensioni d1 guerra: oel 27 giugno 1942 ( r); del IO giugno 1947 (2); del 26 giugno 1948 (3); dd 13 luglio 1948 (4); del 19 ott. 1948 (5) e (s bis); del 9 nov. 1948 (6); del 13 nov. 1948 (7); del 29 nov. 1948 (8) e (8 bis); dell'n dic. ·1948 (g); del 16 maggi o 1949 (10); del 18 g iu g no 1949
IX. - BoccA E VISCERI. - INFERMITÀ VARIE.
( 11 ); dell'8 genn. 1950 (12). - Decisioni della Sezione 11 Speciale Pensioni dt guerra: del x6 nO\. 1947 (13); dei 25 oll. 1948 (14); del 15 nov. 1948 (15); del 20 nov. 1948 (r6); del 29 nov. 1948 (17); del 9 dic. 1948 (x8); del 10 genn. 1949 (rg); del 22 genn . (2o); del r8 giugno 1949 (21); del 14 nov. 1949 (22); del 12 dic. 1949 (23); dell'u genn r95o (24); del 28 genn 1950 (25); del 22 febbr. 1950 (26); del 9 febbr. 1941 (27). - MAI'DÒ: 11 Pensionisti ca privilegiata di guerra», 1950. - A:-<ACLETO CrREt-:U: u Le lcsLOni locali da freddo e • loro postumi ll, Roma, 1948.
Sia per i disagi che per il clima e la man canza di igiene si è amme ssa la dipendenza Jelia rapida evoluzione della paradentosi, tale da rendere nullo tutto l'apparato masticatorio (2o). La prolungata permanenza in colonia aggrava la gengivite espulsiva (18), la pierrea alveolare (soggetto debditato) (8).
L'influenza del servizio di guerra, specie coloniale, è amme!lsa per la sindrome ulcerosa conclusasi con perforazione di ulcera (5). per l'ulcera duodenale florida (14), per l'infermità gastrica (23), ner la enterocolite (3), per il ri sentimento enteroepatico (2) .
Si esclude che la ptosi del colon (costi tu zionalità) dipenda ,la parassitos i int estinale da lamblie (9); si ricono scono, anche dopo il congedo, dovute al servizio di guerra afncano l'ameba (10) e l'infermità da tenia echinococcus (9); nuovi accertamenti sono stati ordinati dal giudice per una infermità di difficile accertamento, quale la colite amebiasica cronica (u) .
Si ammette l'aggravamento per il diabete mellito (19), anche se preesistente al richiamo, per la nefrite cronica (5), per la glomerulonefrite (necessità di esami ripetuti) (12) (25) (4).
La morte del civile avvenuta per uremia dopo 25 giorni dal bombardamento aereo non pnò essere messa in relazione con il fatto di guerra ( 13) .
La complicazione in cJs topielit e può dipendere dai disagi del servizio di guerra (5-bis); la stessa calcolosi renale può essere aggravata (7).
L 'a ltera zione del timo, conseguente ad influenza cont ratta in servizio di guerra, è stata ritenuta aggravata dal servizio stesso (I)) ; così la parotite (16).
Si esclude il nesso di ca usalità per l'ernia epigastrica (m:mcanza di flogosi acuta, caratteristica delle ernie traumatiche) (r). Trovano nel servizio di guerra possibilità di aggravamento la debolezza costituzionale (Sez. 2"' Sp., 2 febbraio T950), la orchiepididimite di natura tubercolare (22), la radicolite sciatica con artrosi (24), il reumatismo articolare (6-bis); si riwn osce che la permanenza in servizi<'
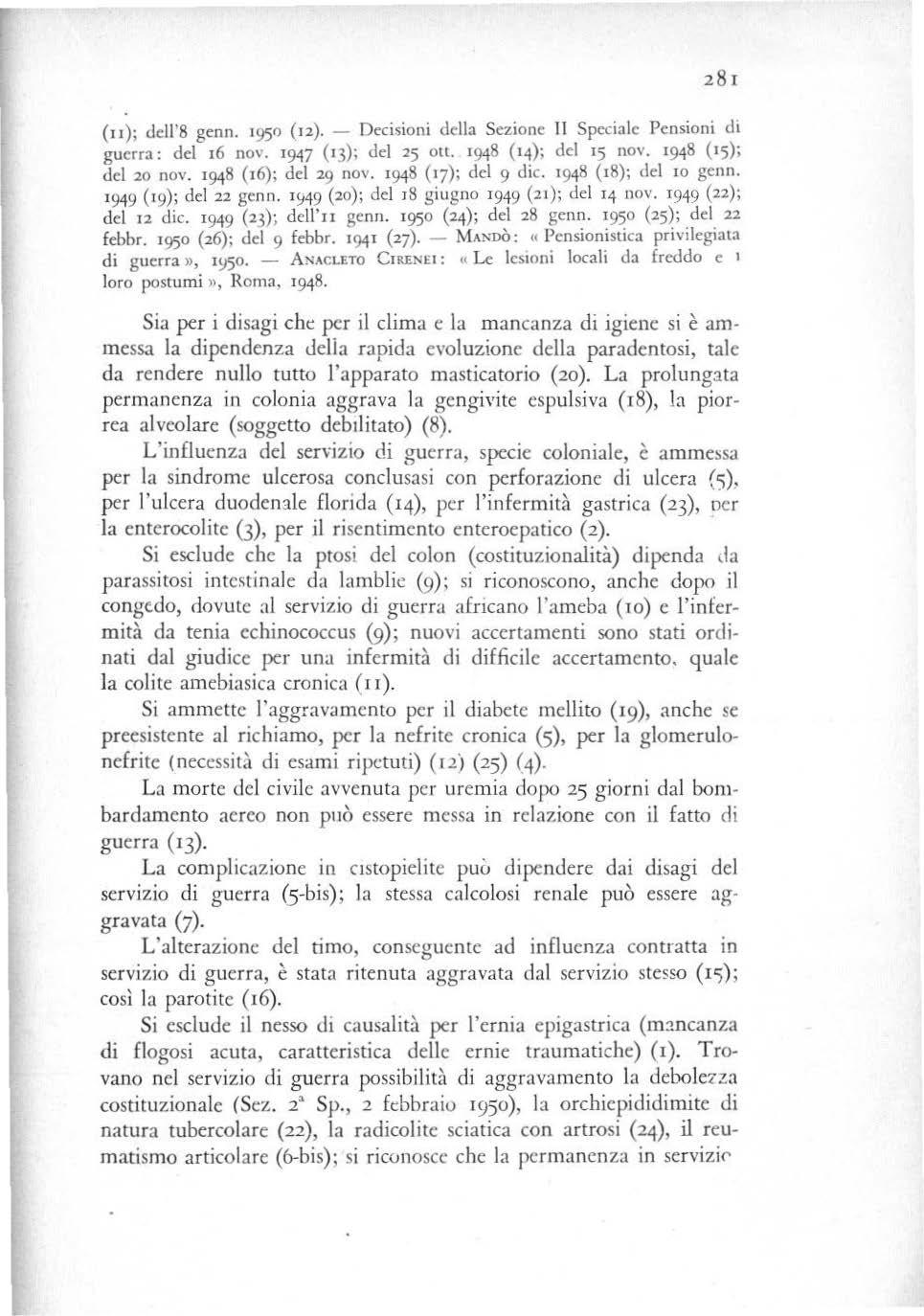
dopo la consta t az io n e della fis tola perianaie (genera lm ente di natura abbia aggravato il processo tubercolare (27).
Sono stati riportati casi pensionabi l i di aggravame nto o di cau sa lità ne l serv izio di g uerra della gastro-e nterostomia, d e ll a mia micloidc (da malaria di gue r ra), di ascessi multipli da pregre'>sa frattura ossea, del morbo di Pott, della gastroenterite cronica, della enterocolite, dell a sinu site frontale da f a f. riportata in combattimento, della lombo-artrosi (da malaria), della febbre consecutiva a tifo, del ti fo esantematico, della peritonite tubercolare, del);t epatite ipertrofica, della spondilosi (da pregrcssa poliartrite reumatica) , de lla end oarterit e ob literant e, della !lpo n di lite deformante lomb are ( da trauma), di varici alle gambe, della mieli te trasve rsa del tratto lombo-sacrale (Mandò).
Complicato sarebbe seguire la giurisp rud enza per le lesio1li da freddo, c he Ja scienza ha r iassun te in alterazioni nervose, disturbi del circo ìo, turbe del trofismo de ll e partt molli, alterazioni dello schelet ro, vizi secondari di atteggiamento e di posizione, fenomeni dolorosi, manifestazioni complicanti tardive (Cirenei).
La imponente materia wffoca la trattazione modesta ed esigerebb e la f o nda zione di una apposita bra nc a della medi cina lega le, che spa rsa m entc si va cr ea ndo all'estero. In Francia Georges Felix (L es droits des anciens combattents de la guerre, Paris, 1930) fondò la disciplina giuridica della patologia di guerra; nell' « Ann. de Med. Légal e », Brisard e Ba lth azard e molt i a ltri più vo lte ci illuminano su importanti argomenti. In Am er ica Willi a m H. Glasson, John Oli\ er, Weber e Schmekebier, ì"U S. Veteran's Bureau, il « Bull etin for Medicine », H eld, Porter (causa di servizio per operazioni dell'esercito)
Forrest H ar rison (Marina), R eina tz (A vi azione), L eo Bartenseie r (in · fortunio civi le), Salomo n e Yakov lev (psic hiatria di g ue rra) , l ' I stituto di patologia dell'esercito ·degli Stati Uniti, h anno apportato larghi co ntri buti. E . D evine (D isabled soldicrs Oxfo rd , Univ. Press, N. Y. 1919) gettò ampie di studio.
In Germania K. crsc h ensteur, W cige t , Fulling, Ger th , Kaufman, Korschensteiner (HatJdworterbuch der Staatswissenschtaften, V vol.) Schenkel, Ruhe, Tonnis hanno st udiato l 'a rgom ento m edico-legale. In Itali:.t Bucciante, che ha approfondito il conc etto di colpa, c F e lsa ni , che va pubblicando un massimario ed una statistica di g rande interesse, sono i fondatori di un a sc uola; Mandò ha compiuto il primo tentativo di sis tem azio ne; t esori di esperienza m edico- legali

sono rinchiusi negli archivi del Collegio medico-legale e dell ' Ufficio Massimario della Corte dei Contt, che ci vengono in parte dati dal «Giornale di Medicina Militare n c dalla « Rivista della Corte dei Conti » .

Noi abbiamo voluto toccare il punto della semibtlità della pato logia umana ad essere considerata patologia di guerra.
Ciò contribuirà a (ar valutare adeguatamente il nobtle sforzo che in una materia così delicata, ma sempre grandiosa, com'è la patologia di guerra, hanno compiuto e compiono (oltre l'amministrazione ed altri organi) il Collegio medico-legale e la Corte dei Conti. Materia delicata e grandiosa, sì, che occorre trattare a capo scoperto.
LO SHOCK TRAUMATICO
NEL QUADRO DELLA PATOLOGIA DE I TE SSU TI
M entre è nozione generale che !o shock traumatico insorge frequentemente dofX> i g r andi traumatismi, è difficile se non impossibile d<lfe un'esatta valutazione di questa frequenza quand o si co nsideri che lo shock è costituito da un comp lesso di si ntomi la cui apparizione non è simu lt anea e che per ogni sinto mo vi è un crescendo progress ivo d'intensità. Perciò, in molti casi, lo shock può limitarsi ai primissimi segni e questi possono essere così ridotti nelle loro espressioni da essere riconoscibili soltanto se accuratamente ricercati.
E' importante t ener co nto di questa peculiare caratteristica dell'inizio de ll o shock pcrchè è noto come la terapia sia di valore decisivo nelle fasi iniziali mentre, nello shock conclamato, si può arrivare a quella condizione di cosiddetto shock irreversibile in cui nulla più è possibile d1 ottenere con qualsiasi terapia; que sto è anche un argom ento in favore di una terapia tempestiva e di una terapia sistematica in tutti i traumatizzati, con una indicazione che può prescindere assolutamente d a un riconoscimento diagnos ti co della co ndizione. Da un punto di vista etiologico molto è sta to studiato c scntto in merito, e particolarmente sempre in occasione delle guerre, quando in tali periodi l'interesse degli studiosi è sollecitato dalla frequenza di questa complicazione traumatica .
Se noi volessimo fare un bilancio sui risultati degli studi nel periodo della g uerra mondial e r914- 1918 comparativamente co n q u e lli della più recente guerra '39- 45, si potrebbe dire che pur essendo molto più vasto il numero degli studi fatti, ciò che può rappresentare l 'acqui sizione più importante e più recente riguarda essenzialmente la patogenesi. Per quanto co n cerne l'etiologia generica, gli studi hanno ribadito quanto e r a sta to acquisito già molti anni fa e che cioè i l co mplesso dei sinto mi che forma lo s hock trauma1ico insorge indi pendentemente dall'intensità delle lesioni p rovocate dal trauma,
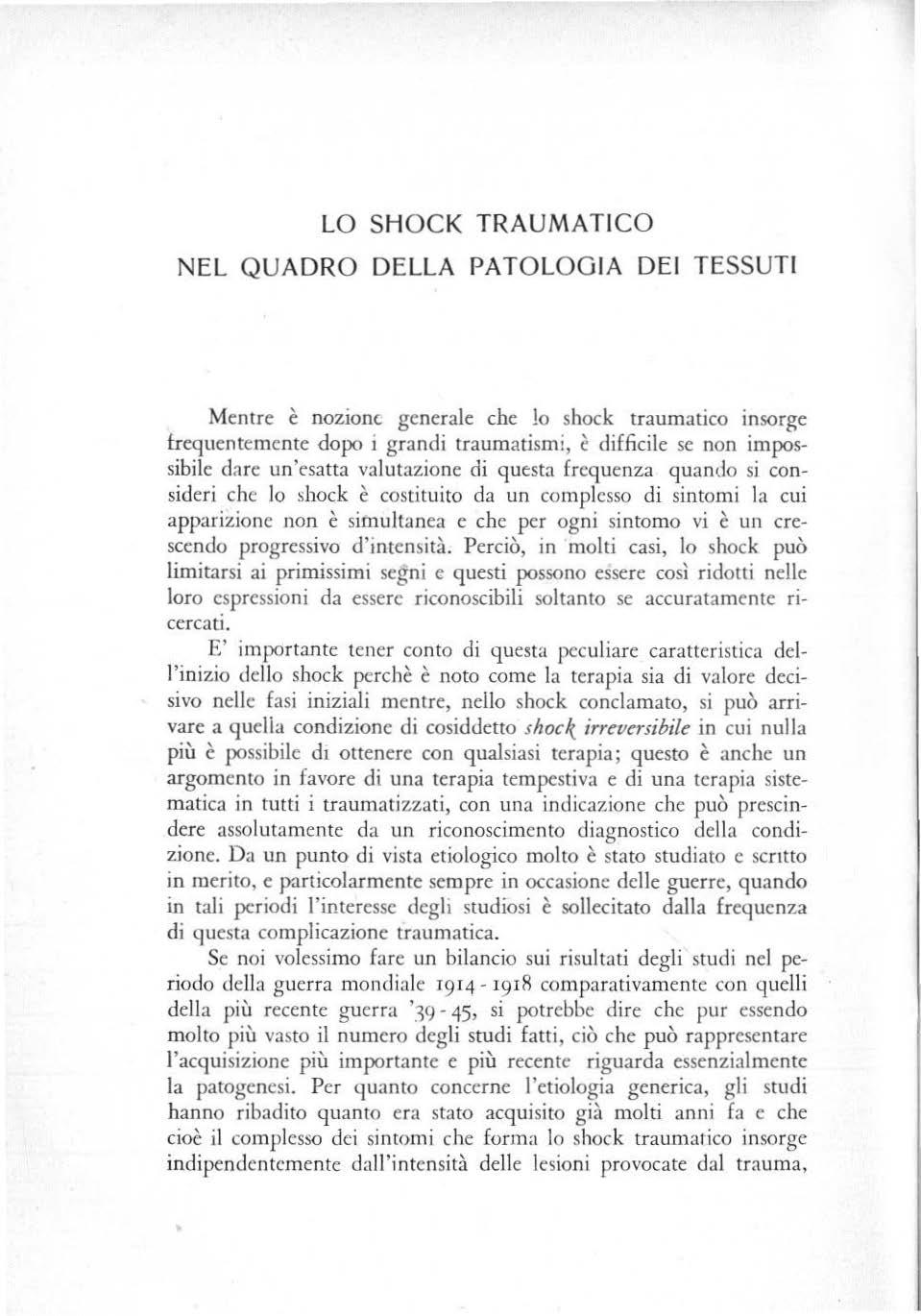
ma in stretta dipendenza all'azione del trauma stesso. Con questa affermazione si viene ad escludere dal gruppo degli shock traumatici quelli che sono in rapporto all'intensità dell'azione traumatica come p. es. lo shock da contusioni generalizzate nei casi eli bombardamento, la sindrome da schiacciamento o uremia traumatica ecc.
E' nota la classificazione che ormai è accettata c che è di origine americana (Blaìock), di shock a tipo centrale con meccanismo cardiogenico e shock a tipo periferico con meccanismo neurogenico (una volta detto shock primario), con meccanismo vasogenico e con meccanismo ematogenico (una volta detto shock secondario) e che è il più importante per la sua frequenza.

Lo shock di tipo periferico neurogenico viene abitualmente considerato come un riflesso vaso-vagale; infatti mentre in questo tipo di shock troviamo quella che è la caratteristica essenziale di tutti gli shock, e cioè la caduta della pressione arteriosa, il polso invece che essere aumentato di frequenza è rallentato. In questi casi il trauma agisce probabilmente sul centro vasomotorio provocando una dilatazione dei vasi muscolari che è causa della caduta della pressione arteriosa. La via nervosa probabilmente passa attraverso il bulbo e inizia nelle terminazioni periferiche o nei tronchi vasali. Ciò sarebbe dimostrato dal fatto che l'interruzione anestetica di un qualsiasi punto della catena riflessa o un'anestesia generale rende impossibile la riproduzione sperimentale di questo tipo eli shock che può essere riprodotto faciJmente. Alcuni AA hanno pensato invece ad un eccesso di stimolazione del simpatico così che prevarrebbe il fenomeno della neuro-costrizione periferica a cui sarebbe da attribuire il pallore di questi malati.
Lo shock di tipo vasogenico viene attribuito ad una azione tossica da parte di sostanze che si liberano in particolari condizioni dai tessuti, p . es ., ad opera eli uno schiacciamento.
Tali sostanze avrebbero un'azione istamino-simile e, con meccanismo analogo a quella che vedremo poi, porterebbero a tutti i sintomi caratteristici.
Più importante per la sua frequenza è lo shock di origine ematogenica. Come vedremo poi, la distinzione con la forma precedente non è sempre possibile, per quanto nella prima sia preminente la lesione dei tessuti. In questa forma, la più studiata, si ammette che a base di tutta la sintomatologia sia un aumento della pcrmeabilità delle pareti capillari, aumento che spiega la fuoruscita dai capillari stessi di albumine e anche globuline che abitualmente per il loro peso molecolare non sono in condizione di superare la barriera endoteliale.
Arrivate queste sostanze protciche negli spazi intercellulari, provocando un aumento della pressione osmotica e con ciò un richiamo notevole di acqua dal torrente circolatorio, rendono impossibile il rientro nel capillare ve noso dei liquidi intercellulari. Forse questo fenomeno dì edematizzazione rappresenta anche un mezzo di difesa, in quanto che queste sostanze vengono così diluite e perdono la loro azione l esiva .
L'esperimento dimostra che l'aum ento della permeabilità capillare con le conseguenze dette avviene in tutto il corpo e quindi la conseguenza di questa exemia è una notevole « ispissatio sanguinis )) .
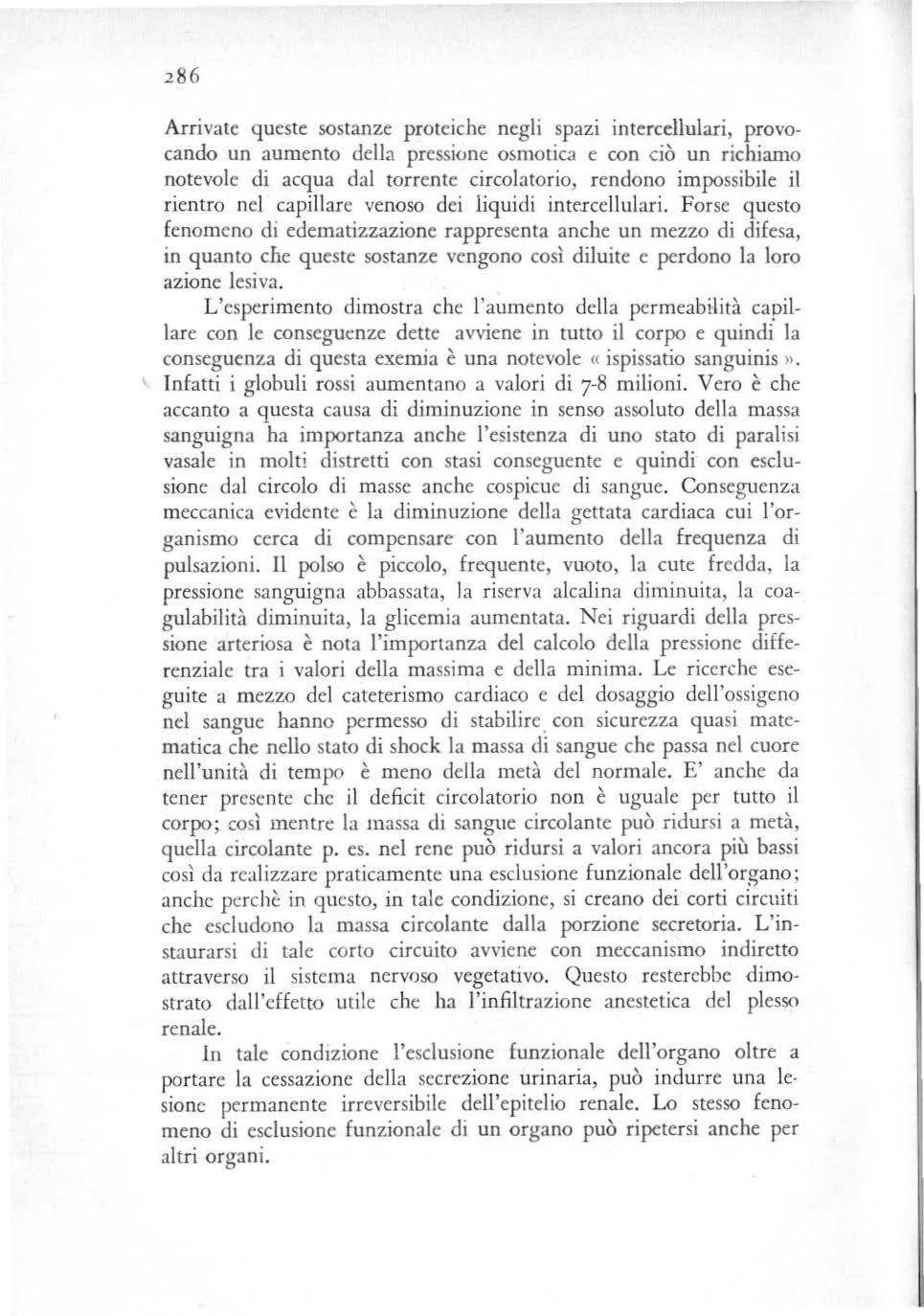
Infatti i globuli ro ssi aumentano a valori di 7-8 milioni. Vero è che accanto a questa causa di diminuzion e in senso assoluto della massa sangui gna ha importanza anche l'esistenza di uno stato di paralisi vasale in molti distretti con stasi conseguente e quindi con esclusione dal circolo di masse anche cospicue di sangue. Conseguenza meccani ca evide nt e è la diminuzione della gettata cardiaca cui l'organismo cerca di compensare con l'aumento della frequenza di pulsazioni. Il polso è piccolo, frequente, vuoto, la cute fredda, la pressione sa nguigna abbassata, la riserva alcal ina diminuita, la coagulabilità diminuita, la glicemia aumentata. Nei riguardi della pressione arteriosa è nota l'importanza del calcolo della pressione differenzial e tra i valori della massima e della minima. Le ricerche eseguite a m ezzo del cateterismo cardiaco c del dosaggio dell 'ossigeno nel sangue hanno per me sso di stabilire con sicurezza qua si matematica ch e nelìo stato di shock la ma ssa di sangue che passa nel cuore nell'unità di tem po è meno della metà del normale. E' anche da tener presente che il deficit ci rcolatorio non è uguale per tutto il corpo; mentre la massa di sangue circolante può ridursi a metà, quella circolante p. es. nel rene può ridursi a valori ancora più bassi così da re:1lizzare praticamente una esclusione funzionale dell 'organo; anche perchè in questo, in tale co ndizione, si creano dei corti ci rcuiti che escludono la massa circolante dalla porzione sec retori a . L'instaurarsi di tale corto circuito avviene con meccanismo indiretto attraverso il siste ma nervoso vegetativo. Questo resterebbe dimostrato dall'effetto utile che ha l'infiltr azio ne anestetica del plesso renale.
l n tale cond1zione l'esclusione funzionale dell'organo oltre a portare la cessazione della secrezio ne urinaria, può indurre una lesione permanente irreversibile dell'epitelio renale. Lo stesso fenomeno di escl usion e funzionale di un organo può ripetersi anche per altri orga n i.
Si nota che contemporaneamente si stabiliscono delle gravi alterazioni nei rapporti dt:gli elettroliti. La cessazione dell'eliminazione di orina fino a un certo punto può essere considerata un meccani smo di difesa contro la condizione di disidratazione conseguita ali 'aumento della permeabilità vasale. P erò in queste condizioni non vengono eliminati i prodotti del ricambio. L'aumento della pressione osmotica nei tessuti crea notevoli scompcnsi fra la quantità di liquido intra-cellulare e quella el!:tra-cellulare. Mentre in condizioni normali la membrana cellulare è impervia agli ioni e non vi sono scambi di elettroliti fra cellule e liquido intercellulare, in tale condizione si verifica uno squi libri o per cui diminuiscono i cloruri nel sangue circolante da un lato e dall 'a ltro vengono mes si in circolazione ioni come il potassio che hanno un'azi one nettamente lesiva
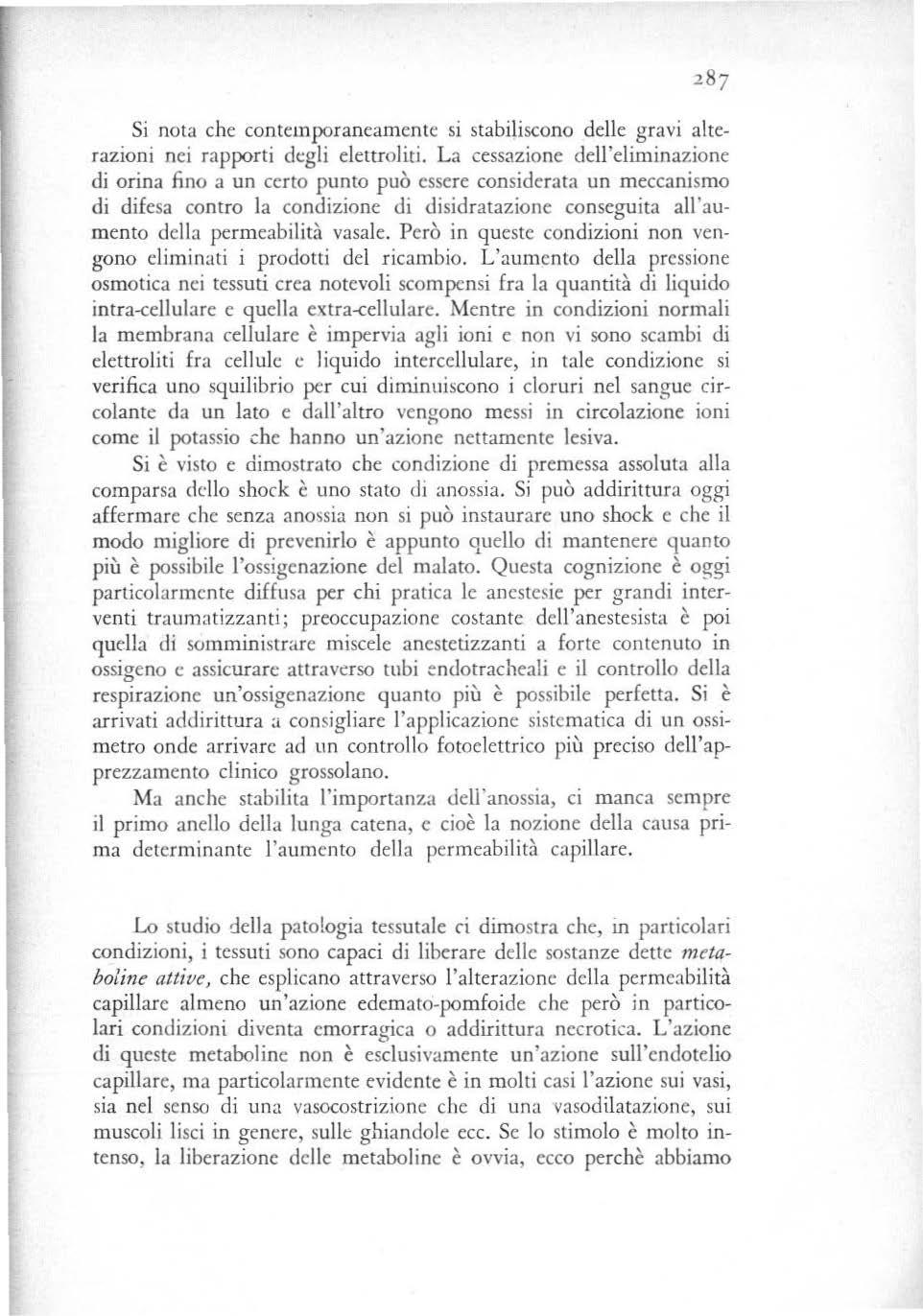
Si è visto e dimostrato che condizione di premessa assoluta alla comparsa dello shock è uno stato di anossia. Si può addirittura oggi affermare che senza anossia non si può instaurare uno shock c che il modo migliore di prevenirlo è appunto quello di mantenere quanto più è possibile l'ossige nazione del malato. Questa cognizione è oggi particolarmente diffusa per chi pratica le per grandi interventi traumatizzanti; preoccupazione costante dell'anestesista è poi qudl a cii somministrare miscele anestetizzanti a forte contenuto in ossigeno c assicurare attraverso tubi e il controllo della respirazione un'ossigenazione quanto più è possibile perfetta . Si è arrivati addirittura a consigliare l'applicazione sistematica di un ossimetro onde arrivare ad un controllo fotoe lettrico più preciso dell'apprezzamento clinico grossolano.
Ma anche stabilita l'importanza dell'anossia, ci manca se mpre il primo anello della lunga catena, c cioè la nozione della causa prima determinante l'aumento della permeabilità capillare .
Lo studio della patologia te ssutale ci dimo stra che, in particolari condizioni, i tessuti so no capaci di liberare delle sostanze dette metaboline attive, che esplicano attraverso l'alterazione della perme:1bilità capill are almeno un 'azione edemato-pomfoide che però in particolar i condizioni diventa emorra gica o addirittura necrotica. L 'azione di queste metaboline non è esclusivamente un'azione sull'endotelio capillare, ma particol:lrme nte evidente è in molti casi l'azione sui vasi, sia n el senso di una vasocostrizion e che di una vasodi l atazionc, sui muscoli li sc i in genere, sulle ghiandole ecc. Se lo stimolo è molto intenso, la liberazione d e lle metaboline è ovvia, ecco perchè abbiamo
detto che difficilmemc si può fare una netta distinzione tra lo shock ematogenico e quello vasogenico in cui la caratteristica è costituita dalla presenza di un trauma intenso sui t essuti con liberazione dell'istamina, dell'acetilcolina, delle sostanze « H >• , ccc. Queste sostanze sono tutte identificabili con le metaboline; naturalmente molte altre non sono state ancora e h i m ica m e nte definite.
NeUa comparsa dello shock traumatico è però evidente che l'intensità dell'azione traumatica non è molto importante. Ecco dunque che è giocoforza di ammettere che la comparsa delle metaboline possa avvenire anche nel corso di piccoli traumi qualora questi esercitino la loro azione su tessuti che sieno in particolari condizioni di reattività, tessuti cioè che, di fronte ad uno stimolo poco efficiente o addirittura qua l itati vamente non adatto a scatenare la comparsa delle metaboline in un tessuto normale o normo-at tivo, portino allo stesso risultato che si può osservare a seguito di un grande trauma. Questa condizione di modificata reattività dei tes s uti viene abitua lm ente indi cata con il termine di patergia e l'alterazione indotta in essi con yucllo di disergia tessutale (A.
Lunedei).
La condizione disergica di un tessuto può essere in rapporto alla presenza di anticorpi oppu re può essere in rapporto alla presenza di tossine o a una particolare « preparazione n come variamente viene indotta nella provocazione del fenomeno di Sanarelli-Schwartzmann. Può ancora essere in rapporto con il sistema nervoso in particolari condiz io ni dell'eccitamento e addirittura, come più recentemente è affermato da Sel ye, con un errore d ell'adattame nto nella sua concezione pitl comp lessa della sindro me generale dell'adattamento in rapporto con uno •< stress >) La poss ibi lità di un meccanismo patologico imperniato su li 'ipofìsi e sulla corticale surrcnale, impostato da Selye, non esclude la possibi lità dì meccanismi c nd ocri nologici pi ù complessi.
Tutto quanto si è detto a proposito dei fattori colpevoli della mutata reattività dei tessuti, ci spiega quelle esitazioni che hanno incontrato gli studiosi n ell'ammettere una etiolog ia ben definita tenendo co nto della variabilità delle condizio ni con cui lo sh oc k si presenta; c ciò in quanto ali 'identico st im olo si hanno notevoli variabilità di risposta. In fondo anche l'osservazione clinica aveva portato ad osservare che i casi di shock erano più frequenti in soggetti affaticati, in sogge tti mal nutriti o sofferenti per il freddo o in particolari condizioni di eccitabilità psichira o di depressione nervosa. Spiegano ancora perchè, in un individuo shockato, il sopraggiunge re di un nuovo trauma, tal volta addirittura solo di un traum a psichico, sia

288
capace di rendere irreversibile la sindrome e di condurre a rapida morte il malato. Questa concezione etiologica di uno stato disergico dei tessuti e dell'importanza dellt metaboline non è certame nte facilmente accolta da chi è legato alle concezioni patogenetiche dominanti negli ultimi decenni, quelle di una causa nota ben efficiente e · precisa nel suo effet to.
In medicina, i progressi portati dagli studiosi tendono a creare delle grandi linee direttive nella concezione delle malattie. Basta pensare p. es. il capovolgimento che si è verificato nell'indirizzo generico con la scoperta di Pasteur, il periodo realistico di una malatti a a etiologia ben definita e poi successivamente l'annullamento sempre più approfondito del l 'organismo inteso per st stesso come complesso, Jlla concezione unitaria del tessuto quella dei singoli orgam .
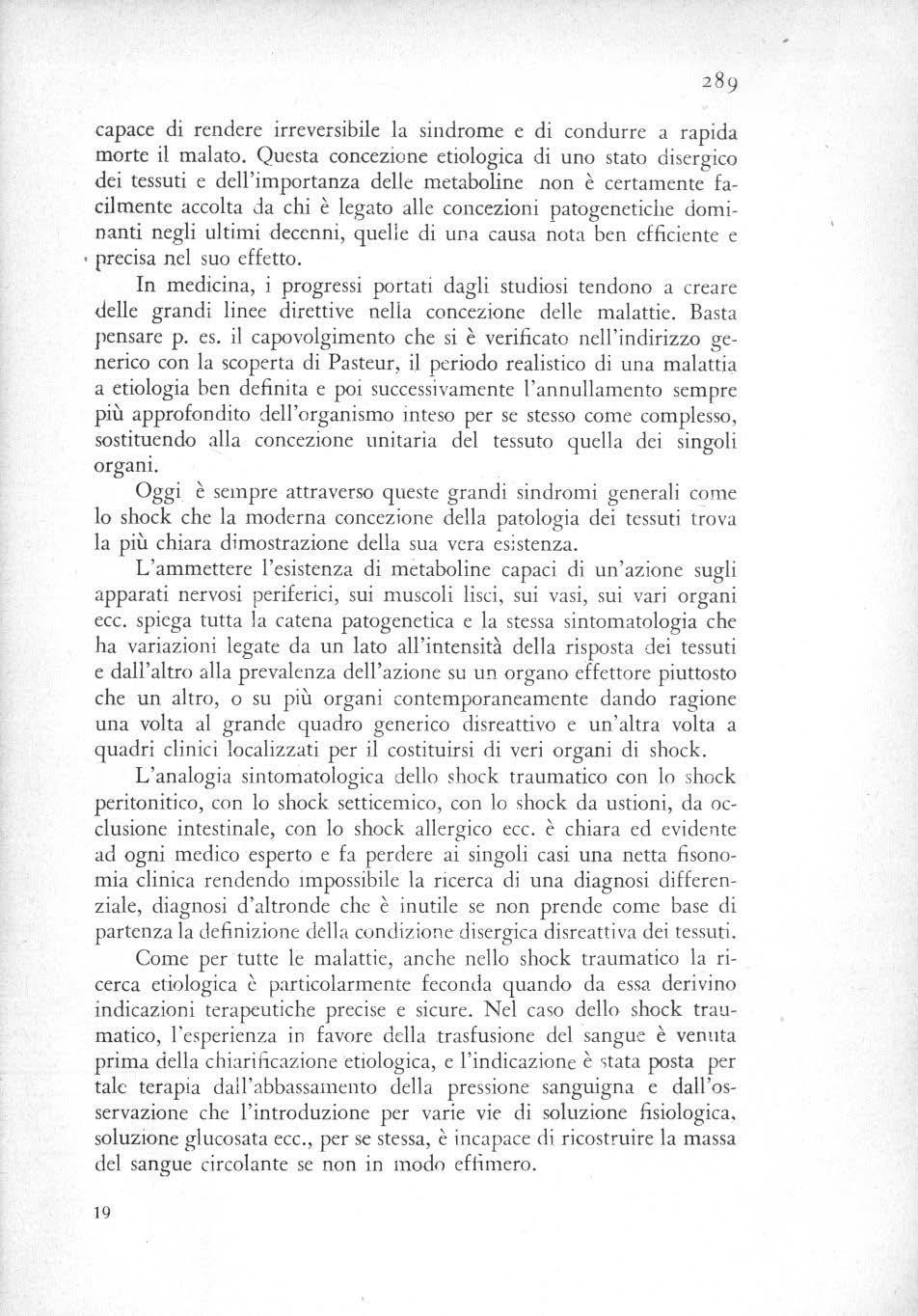
Oggi è sempre attraverso queste grandi sindromi generali come lo shock che la moderna concezione della patologia dei tessuti t rova la più chiara dimostrazione della sua vera esistenza.
L 'a mmettere l'esi stenza di rnetaboline capaci di un'azione sugli apparati nervosi periferici, sui muscoli li sci, sui vasi, sui vari organi ecc. spiega tutta la catena patogene6ca e la stessa sintomatologia che ha variazioni legate da un lato all'intensità della risposta dei tessuti e dall'altro alla prevalenza dell'azione su un organo effettore piuttosto che un altro, o su più organi contemporaneamente dando ragione una volta al grande quadro generico disreatcivo e un'altra volta a quadri clinici localizzati per il costituirsi eli veri organi di shock.
L'analogia sintomatologica dello shock traumatico con lo shock peritonitico, con lo shock setticemico, con lo shock da ustioni, da occlusione intestinale, con lo shock allergico ecc. è chiara cd evidente ad ogni medico esperto e fa perdere ai singoli casi una netta fisonomia clinica rendendo Impossibile la ricerca di una diagnosi differenziale, diagnosi d 'a ltronde che è inutile se non prende come base di partenza la definizione della wndizione disergica disreattiva dei tessuti.
Come per tutte le malattie, anche nello shock traumatico la ricerca etiologica è particolarmente feconda quando da essa derivino indicazioni terapeutiche precise e sicure. Nel dello shock traumatico, l'esperienza in favore della trasfusione del sa ngue è venuta prima della chiarihcJzione etiologica, e l 'i ndicazione è <; tata posta per tale terapia dall'abbassamento della pressione sanguigna e dall'osservazione che l'introduzione per varie vie di soluzione fisiologica. so luzione g l ucosata ecc., per se stessa, è incapa ce eli ricostruire la massa del sangue ci rcolante se non io modo effimero.
19
La trasfusione di sangue è certamente il mezzo ptu sicuro per la condizione disreattiva dei tessuti in condizione eurcattiva, arrestando il processo di liberazione di sostanze attive come le metaboline che hanno carattere difensivo e riparativo, ma che in condizione disergica diventano causa di malattia. Sotto questo punto di vista vanno considerate anche le terapie volte a modificare le particolari condiziont di eccitamento del sistema nervoso vegetativo rappresentate essenzialmente dalla novocaina c dagli ormoni a tipo cc D ocae )) (desossi-cortico-sterone): quest'ultimo con l":.nionc di rimuovere j!li eventuali errori di adattamento di origine corticosurrenaie.

•
l DI RETTORI
DEL G I O R NALE D I M ED ICI NA MI UTAR.E
DALL A FO NDA ZI ON E AD 000 1
CoM ISED"I Antonio da l lugl io r 85r al l uglio 1853·
CARELLA CARNEV ALE Antorzio dall'agosto 1853 al dicembre 1866 .
DE N rcous Bonat,entura
dal gennaio 1867 all 'a p ri le
CERALE Giacomo
0RSELLI Luigi
dal marzo 1870 al gennaio 1873.

dal febbraio 1873 al giugno 1873·
MANAYRA Paolo da l marzo 1874 al gennaio 188o .
EL I A Giovarmi da l febbraio r88o all'ottobre r882 .
B.'\ROFFIO Felice
R EGrs Stefano
Tos r Federico
dal novembre 1B82 al febbraio r892.
dal marzo 1892 al febbraio 1896.
Rrcci>\RDI Ettore da ll 'ottobre 1896 al settembre r897·
P ANARA Panfilo da ll 'o ttob re r8y7 all'ottobre 1898
GJVOCRE Gio. Battista
dal novembre al febbraio 1B99.
PANARA Panfilo
dal marzo 1899 al settembre 1899.
LANDOLFI Federico
dall'ottobre rB99 all'ottobre 1903.
RANL>ONE Giovanni
dal novewbre 1903 all'aprile 1907.
lMBRI.\CO Pietro
dal maggio 1907 al dicembre 1907.

FERRERO DI CAVALLERLEONE Luigi
dal gennaio 1908 al dicembre 1909.
SFoRZA Claudio
dal gennaio 1910 al febbraio 1913, e dall'aprile 1915 al dicembre 1916.
TROMBETTA Eduardo
dal gennaio 1917 al novembre 1920.
CASARINI Arturo
RrvA Umberto
FRANCHI Luigi
MAZZETTI Loreto
dall'aprile 1921 al giugno 1931.
dal luglio 1931 al gennaio 1933.
dal febbraio 1933 ali 'ottobre 1936.
dal novembre 1936 al dicembre 1940.
lNGRAVALLE Alfredo
FADDA Siro
FERRI Guido
dal 1941 al giugno 1943·
dal luglio 1945 all 'apr ile 1948.
dal maggio 1948.
INDICE
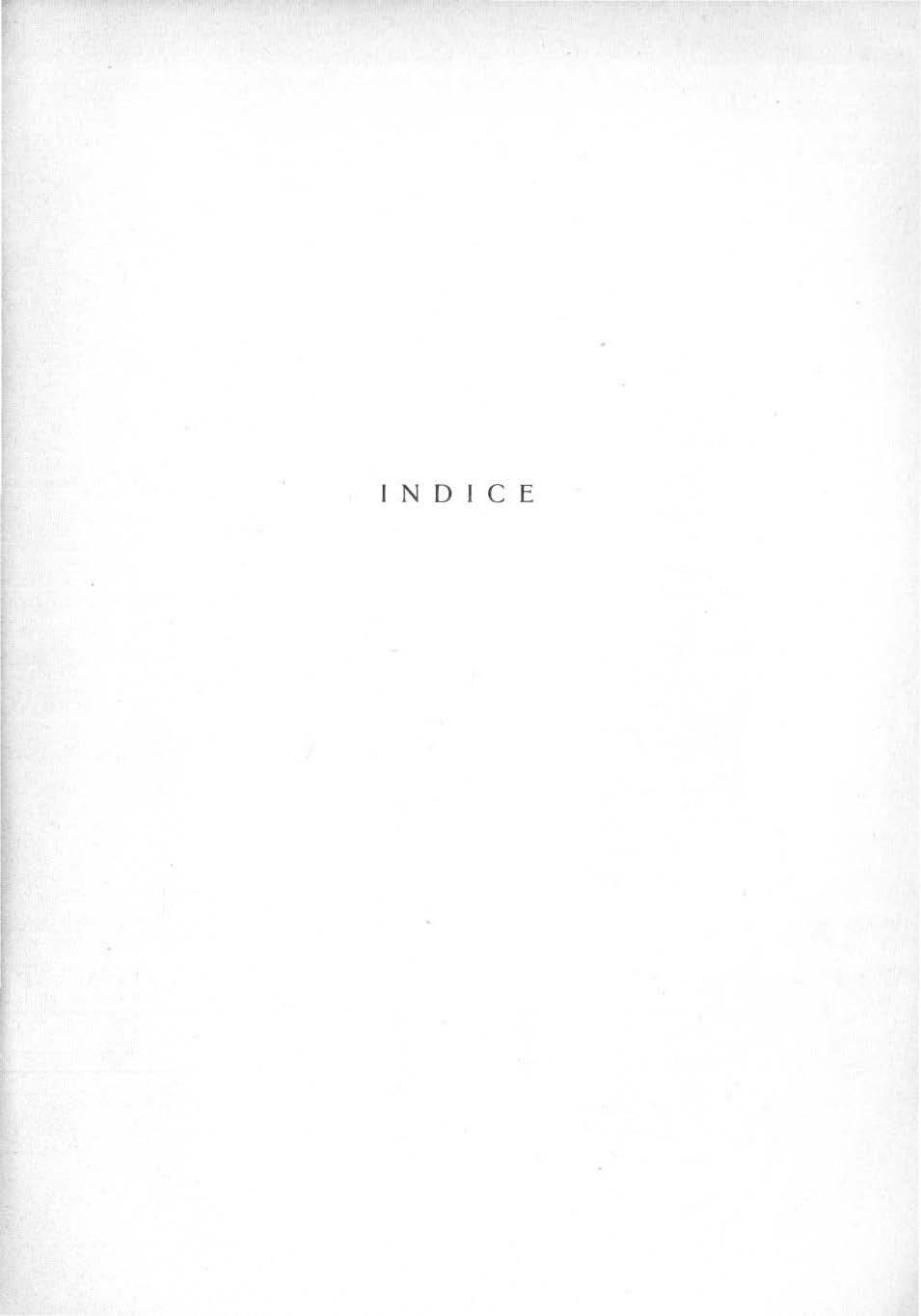
MESSAGGI AUGURALI:
Il Capo deiiCl Stato.
Il Mini stro della Di fesa Pag. 5
L 'Alto Commissar io per l ' Ig iene e la Sanità Pubblica » 6
Il Pr es id(!nte de lla Federazione Naziona le àeg li O rdini dei Mediçj n 7
PRESENT AZ TONE:
ll Capo de ll a Sanità Militare dell'Esercito
REOAZIO.t'-'ALI:
l cento ann i di vitJ del Giornale di Medicina Militare (A. CAMPANA)

Alessandro Riberi fondatore del Corpo San:tario Mi litare e del G iornale di Medicina Mi hrare ( 1794- t86x) (S. P ERR1ER) .
GLI ARTICOLI:
La attirudinalt: c la collaboraz ione medico· psicologica (F. BANISSONI)
l curari come coad iuvami dell'anestesia chirurgica (D. BovP.T)
Considerazioni dt prima seconda guerra mondiale (F. CARDONA)
Cons id c.:razion i sulle ukeri della gamba osse rvabili nei Tr opici e Subtr op ici (A.
Ori e ntam ent i pratici tt•rapia delle ustioni nella moderna medicina mi litare (M. CoMh c E. U M1ÀN) .
L' organizzazione sanitaria nei \'ari paesi de l mond o (M. EITets de la rachothérapic sur l'épcndymub lastome dc la moelle épi nière (T. t>F LEIIOCZ.KY)
L e Convcnzion t di Ginevra nella dottrina c nella pratica (P. r>E PAOLI)
)l )) )l )l Il Il )) Il )) )> 8 13 20 35 44 Il8
Modifìcazioni degli analizzatori cort icali e periferi ci nell'ebbrezza da stupefacenti (P m MArr m)
L'esame funziona le ..: l'ind1ce di Zoja nello studio delle ma lattie del pancreas (A. GASBARRJNI)
D'Annunzio c la chir urgia di guerra (C. GIACOBBE)
La nuova alimentare del soldato (F.
Sulla psiche dci tubercolot ici (A. 0MODEJ ZoRJtoo.I) .
L'inva lidità del ci vi le in medicina legale militare (V. M. PAJ.Mif.Rl)
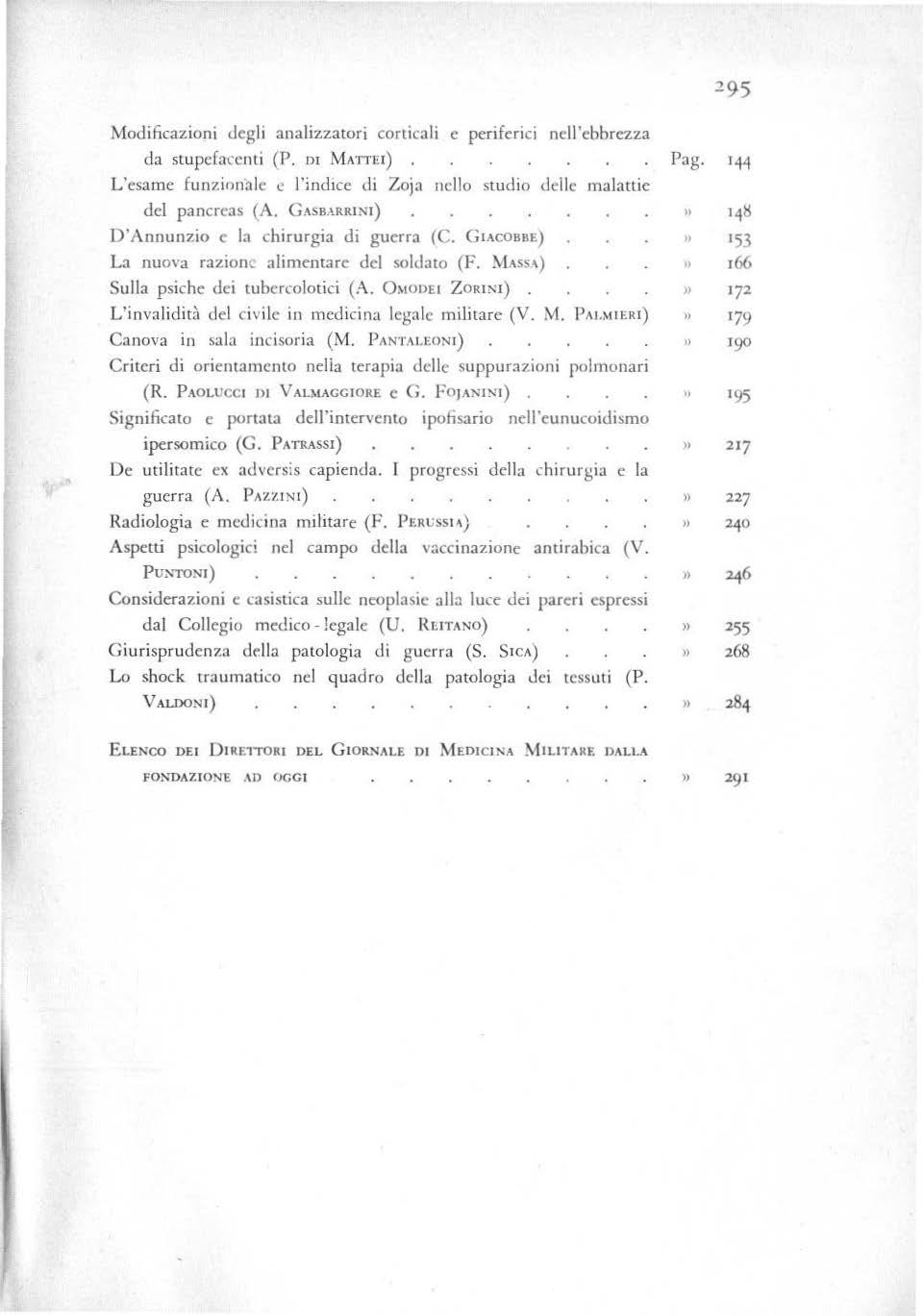
Canova in ineisor ia (M. PANTAJ-EONT)
Criteri d i orientamento nella terapia del le suppurazioni polmonari (R . PAOLC CC I J)l vAUIAGGIORE c G. FOJANINI) .
Significato e portata dell'intervento ipofisario ipersomico (G. PATRASSI)
Dc urilitat e ex advers is capiend a. l progressi della c: hi rurgia c la guerra (A. PAZZTN r)
Radiologia e medicina militare (F.
A spe tti psicologici nel campo della vaccinazione antirabica (V.
Considerazioni e casistica sulle neoplasie alla luce dei pareri espressi da l Collegio medico- legale (U. Rr:.JTANO)
G iuri sprudenza patologia di g ue rra (S. STcA)
Lo shock traumati co nel qua d ro della patologia J ei tessuti ( P. VALDONr) ELEI'CO DEl OntE110RJ
FOI'<'DAZIONE OGG I Pag. )l )l Il ) l )l li )l )) )) •> )) )) )) )) 2 95 144 14!:! 1)3 166 172 IJ9 190 217 227 240 246 2 55 268
DEL GI ORNA LE 0 1 MEDI CINA \11LJ TARE DALL...

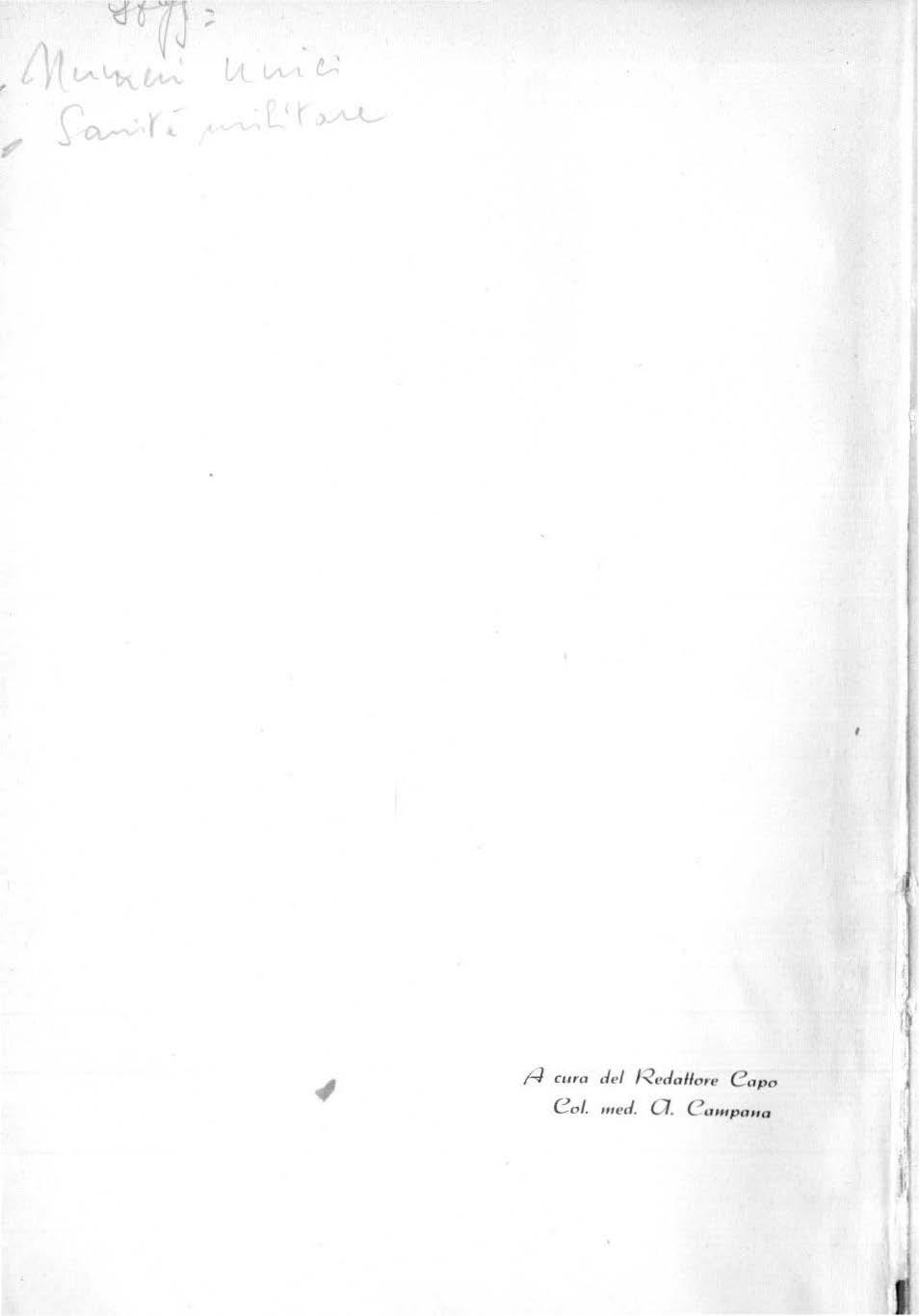

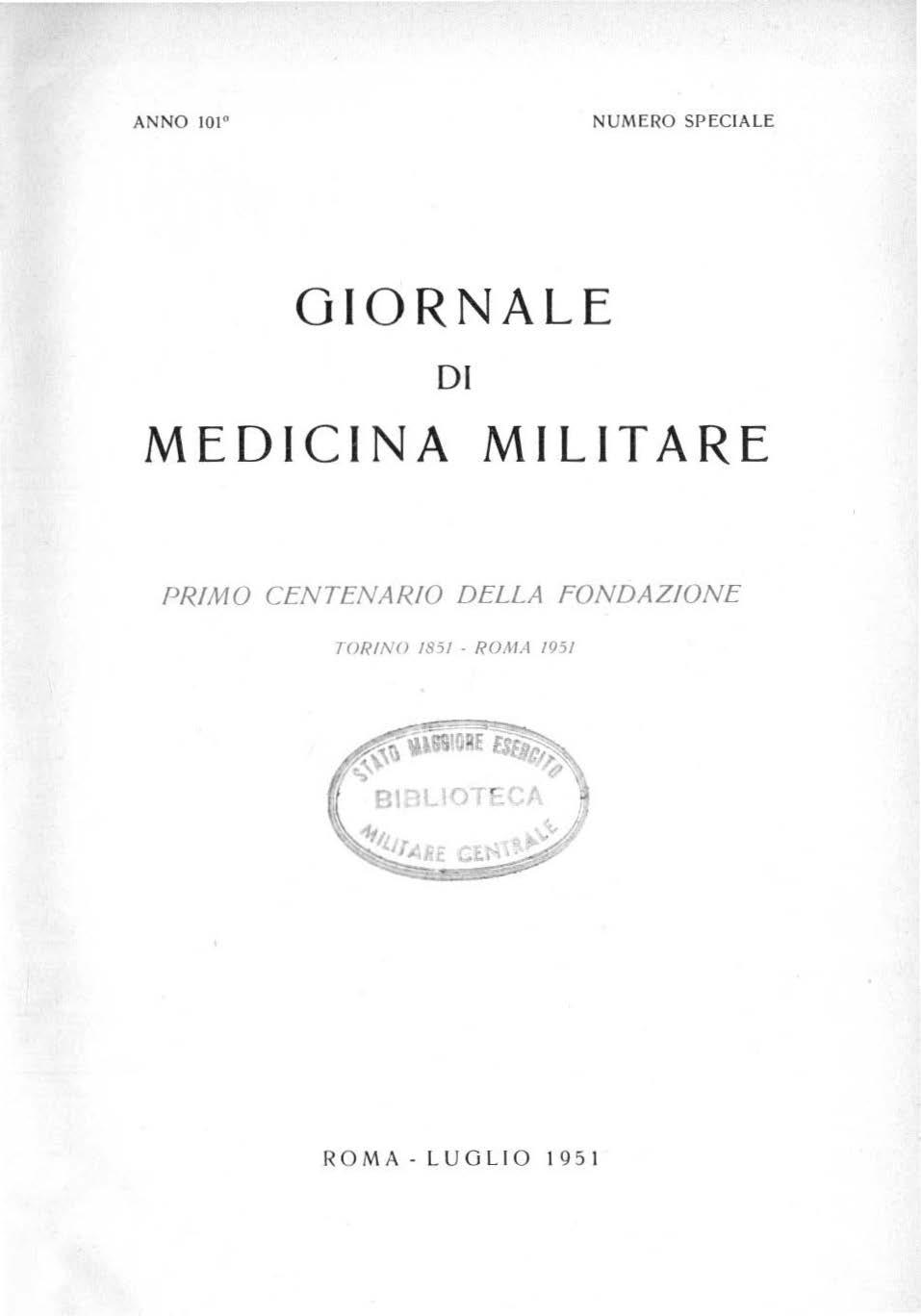
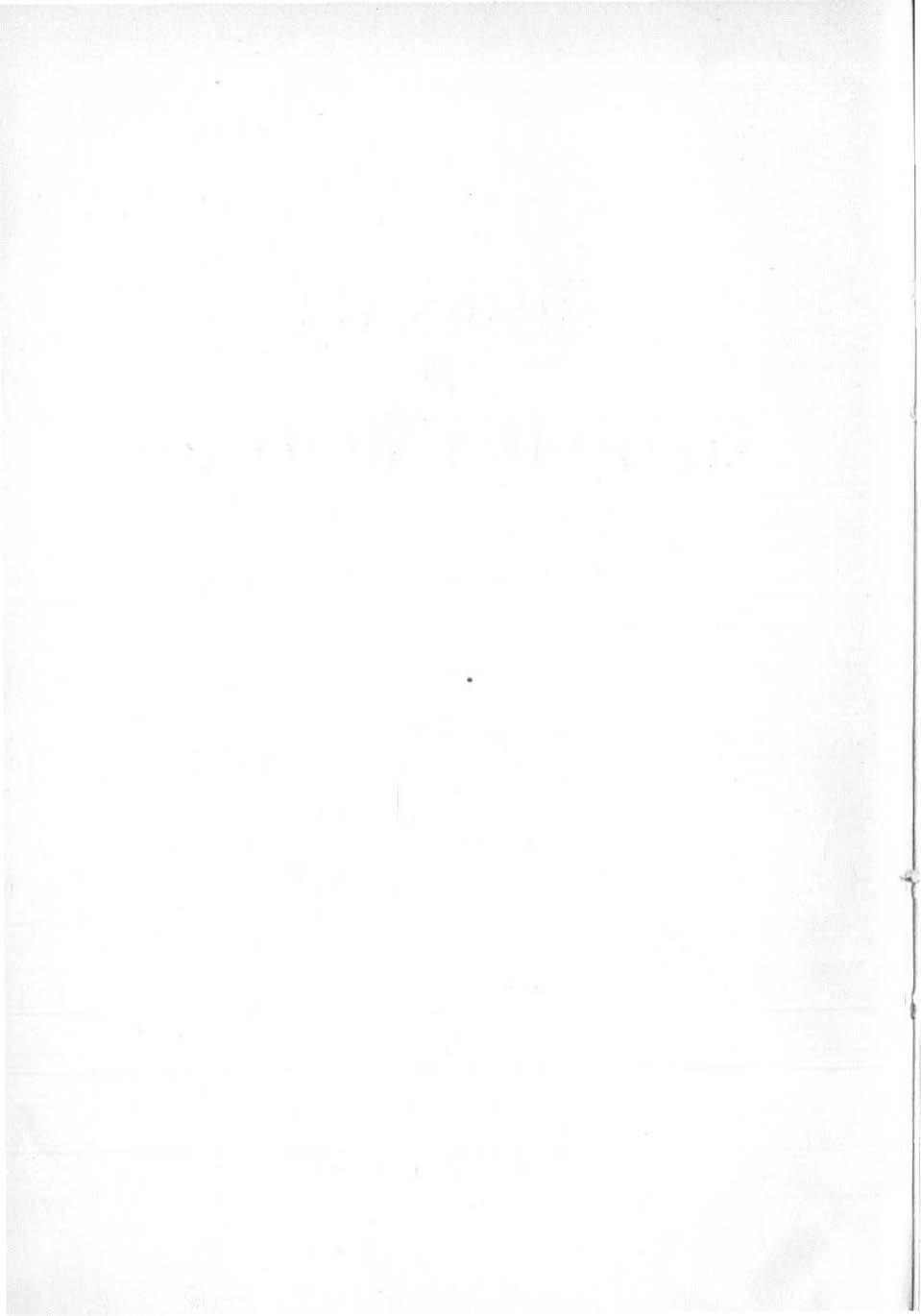
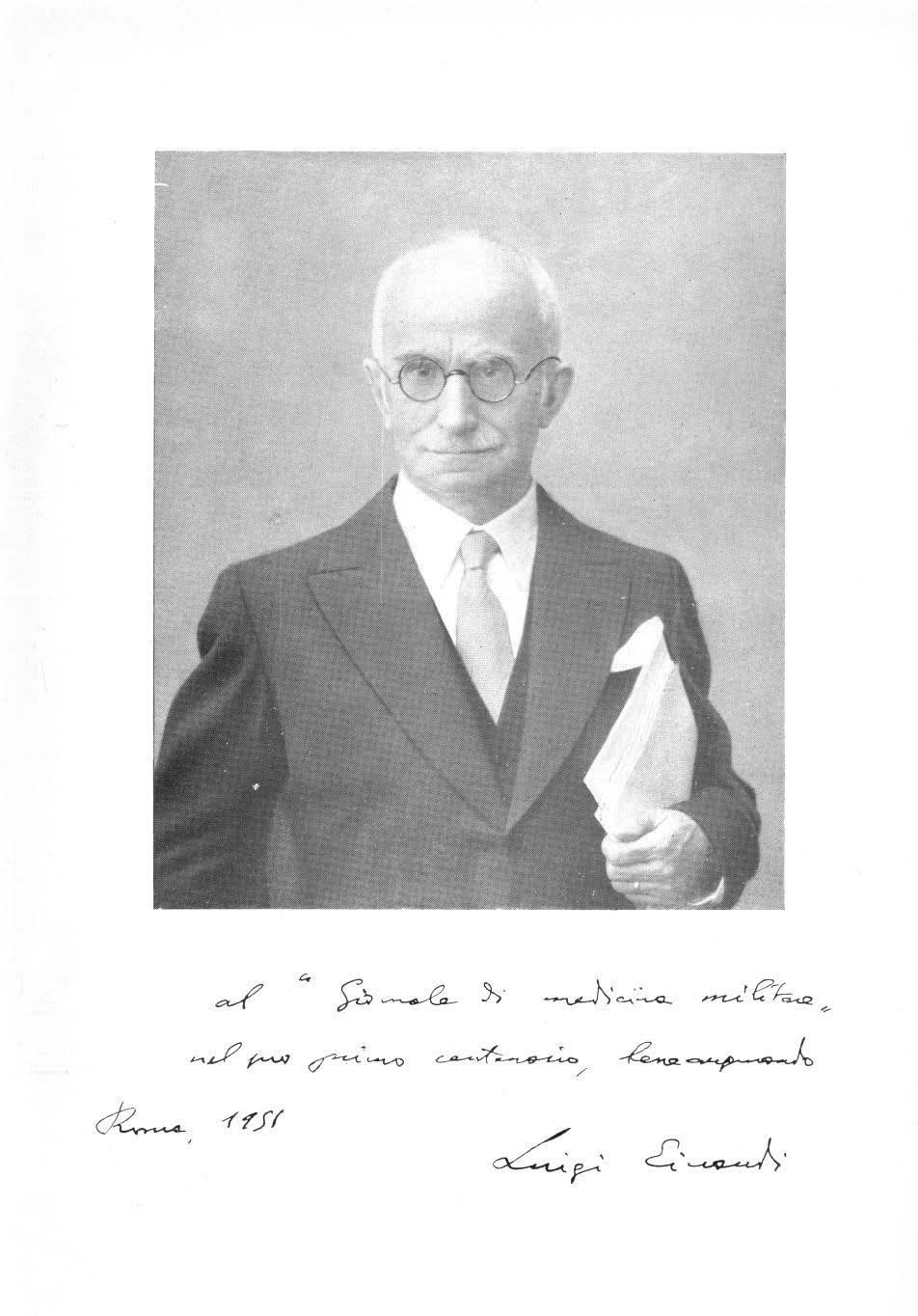

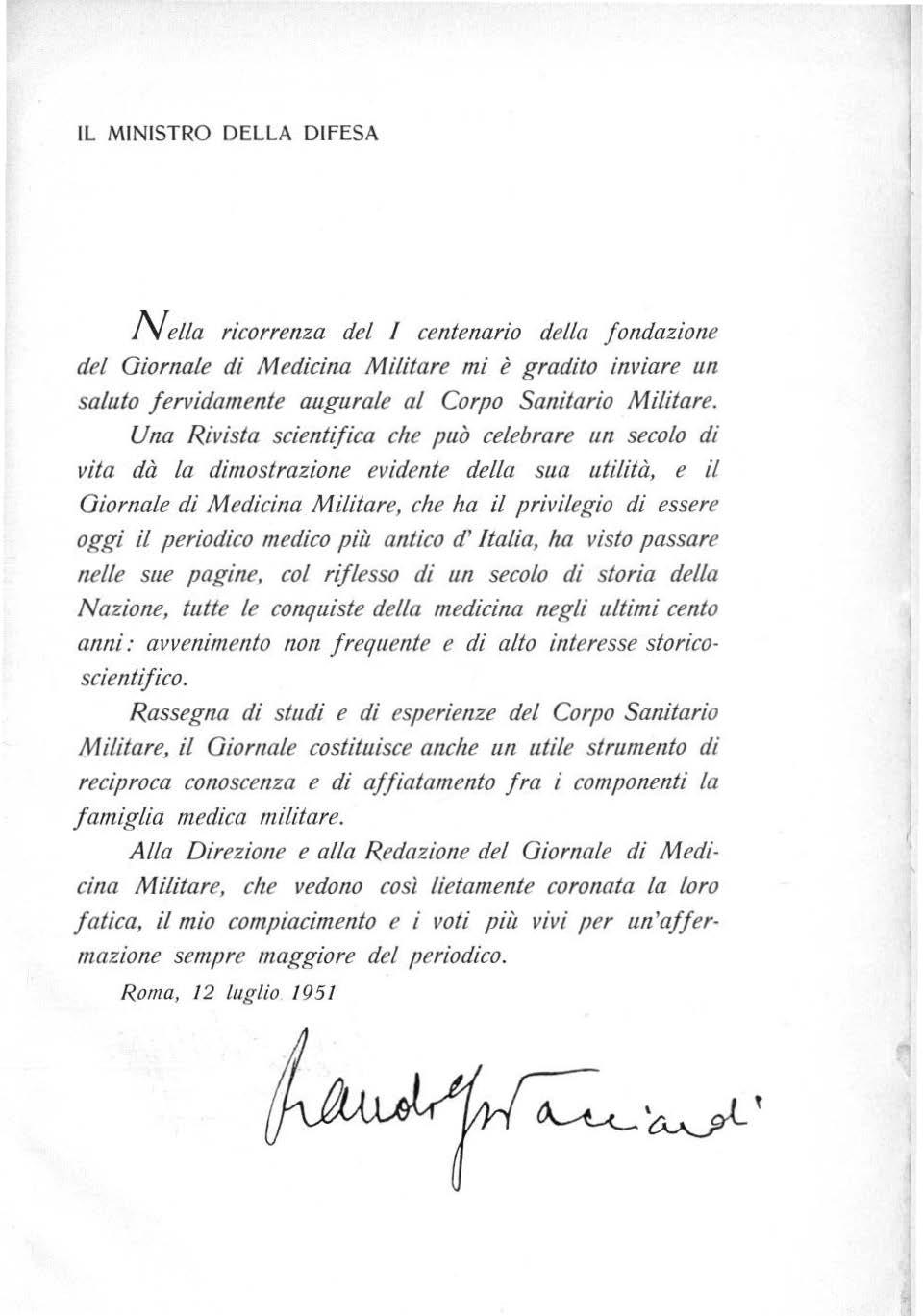
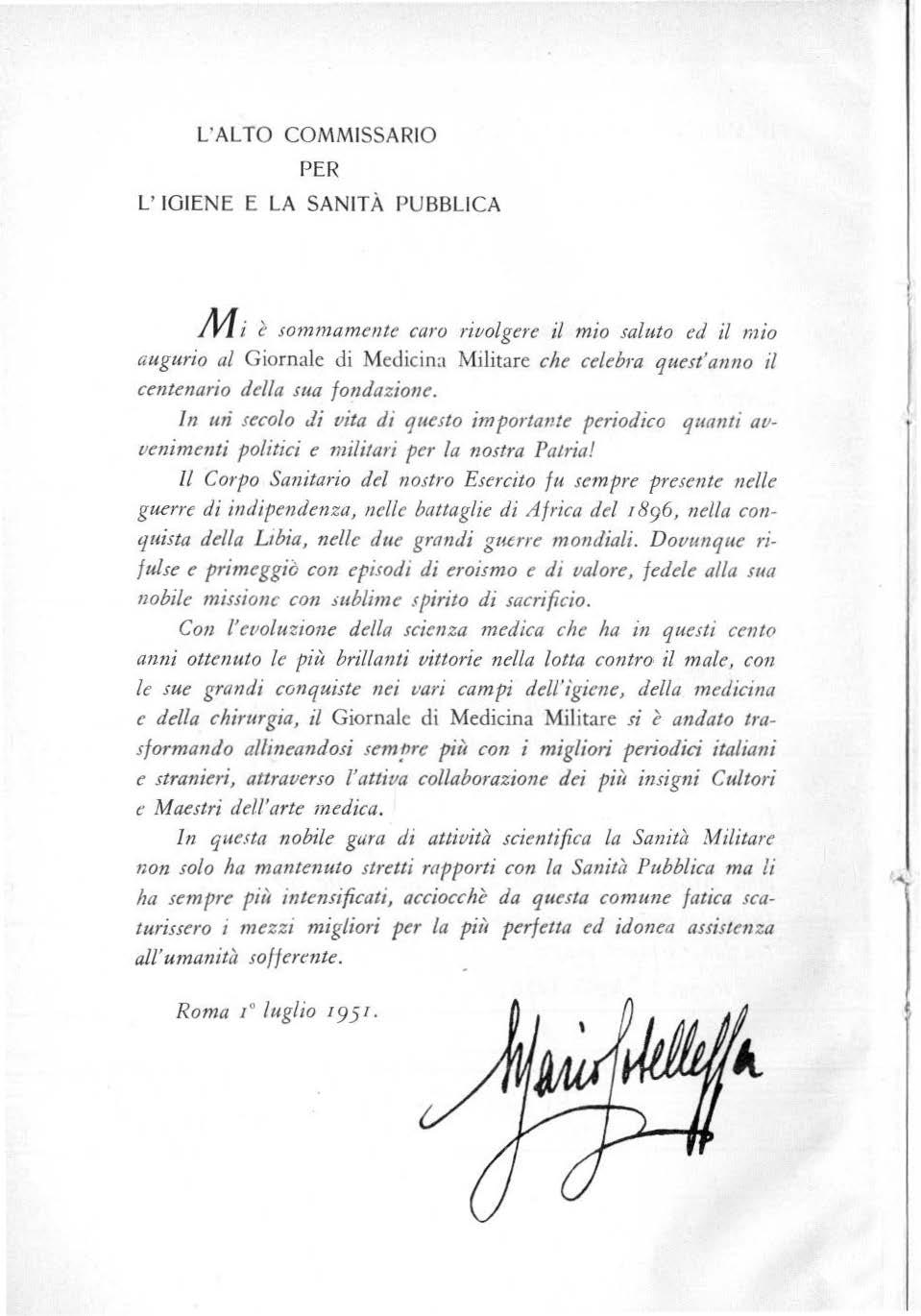

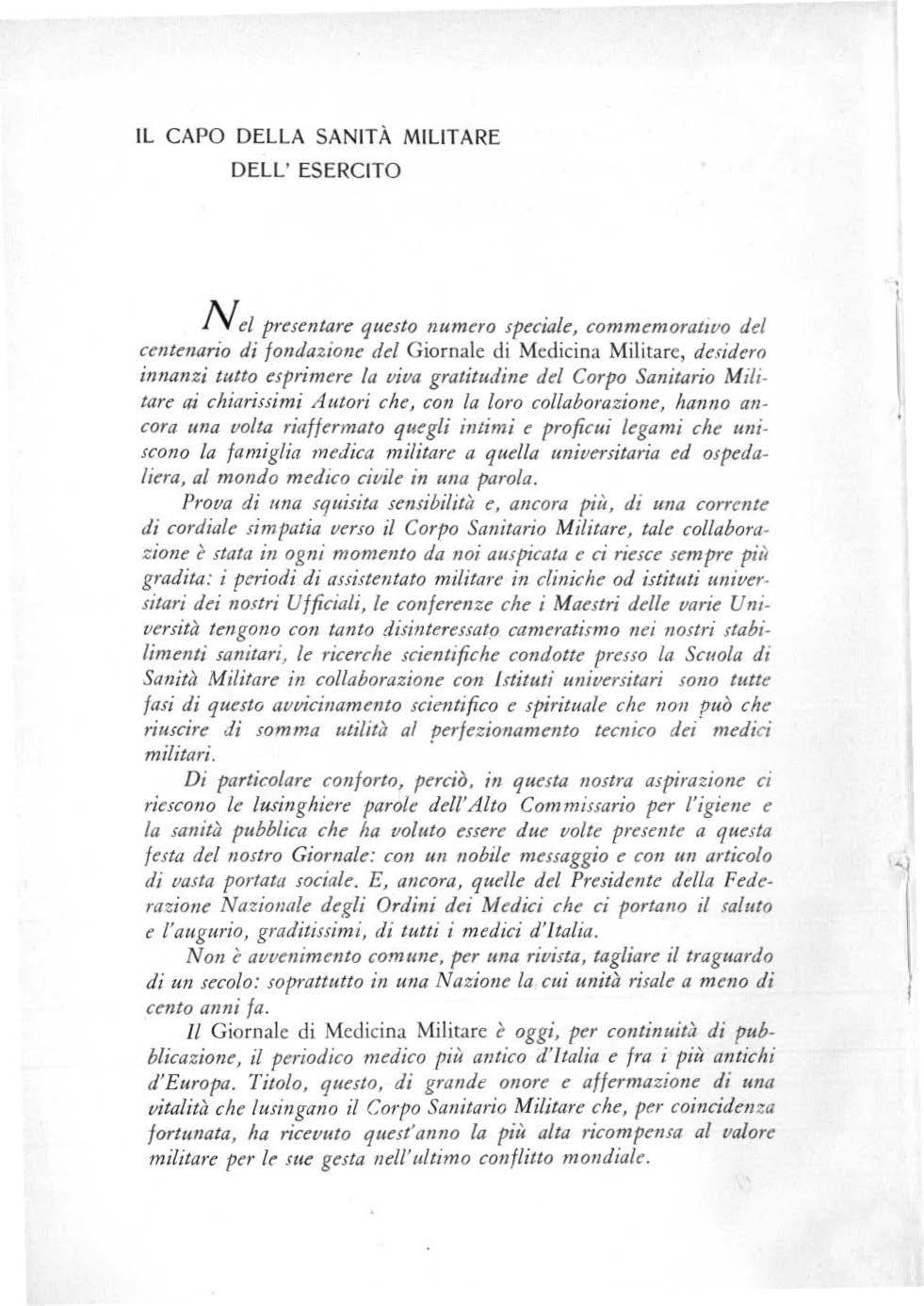

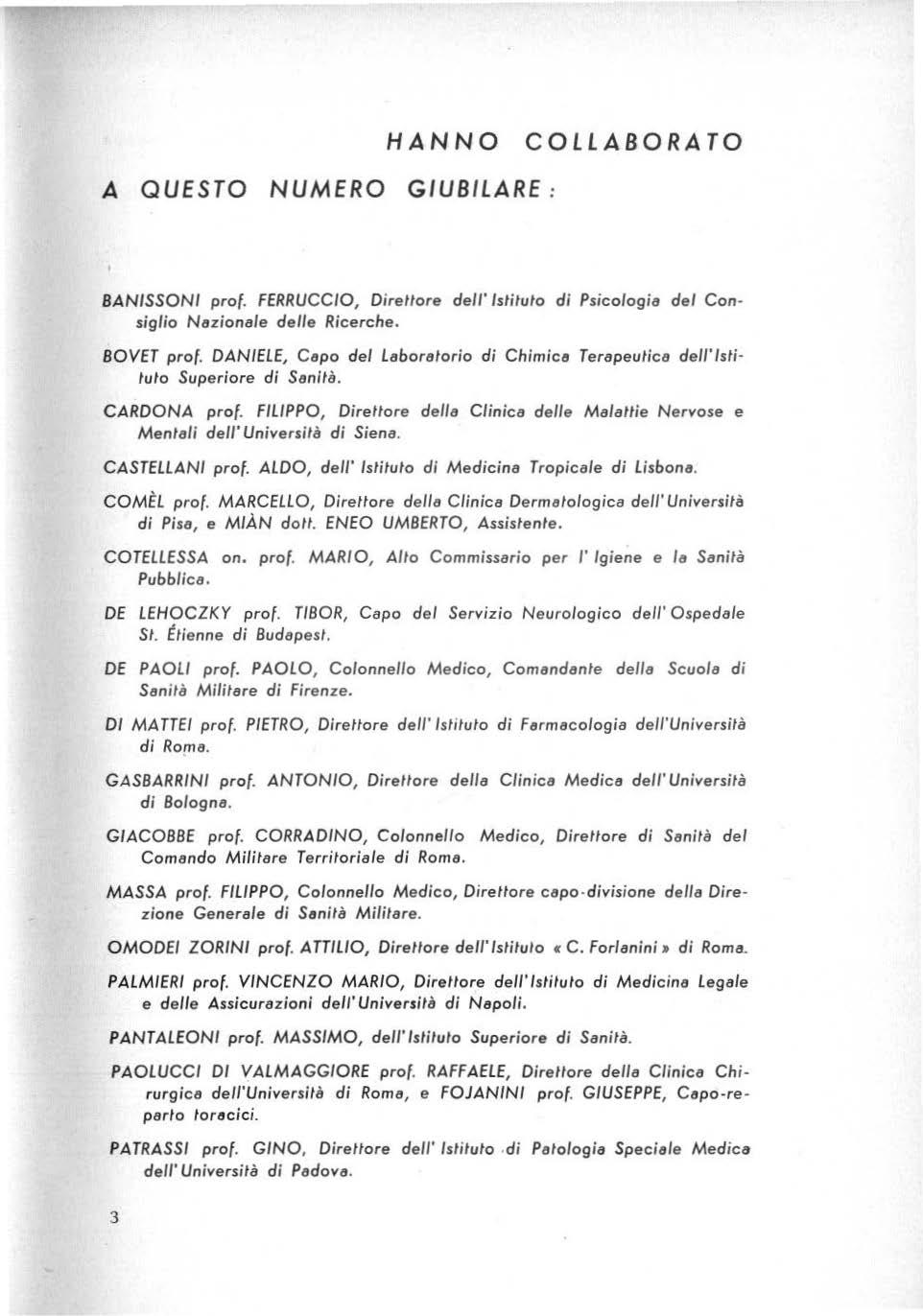
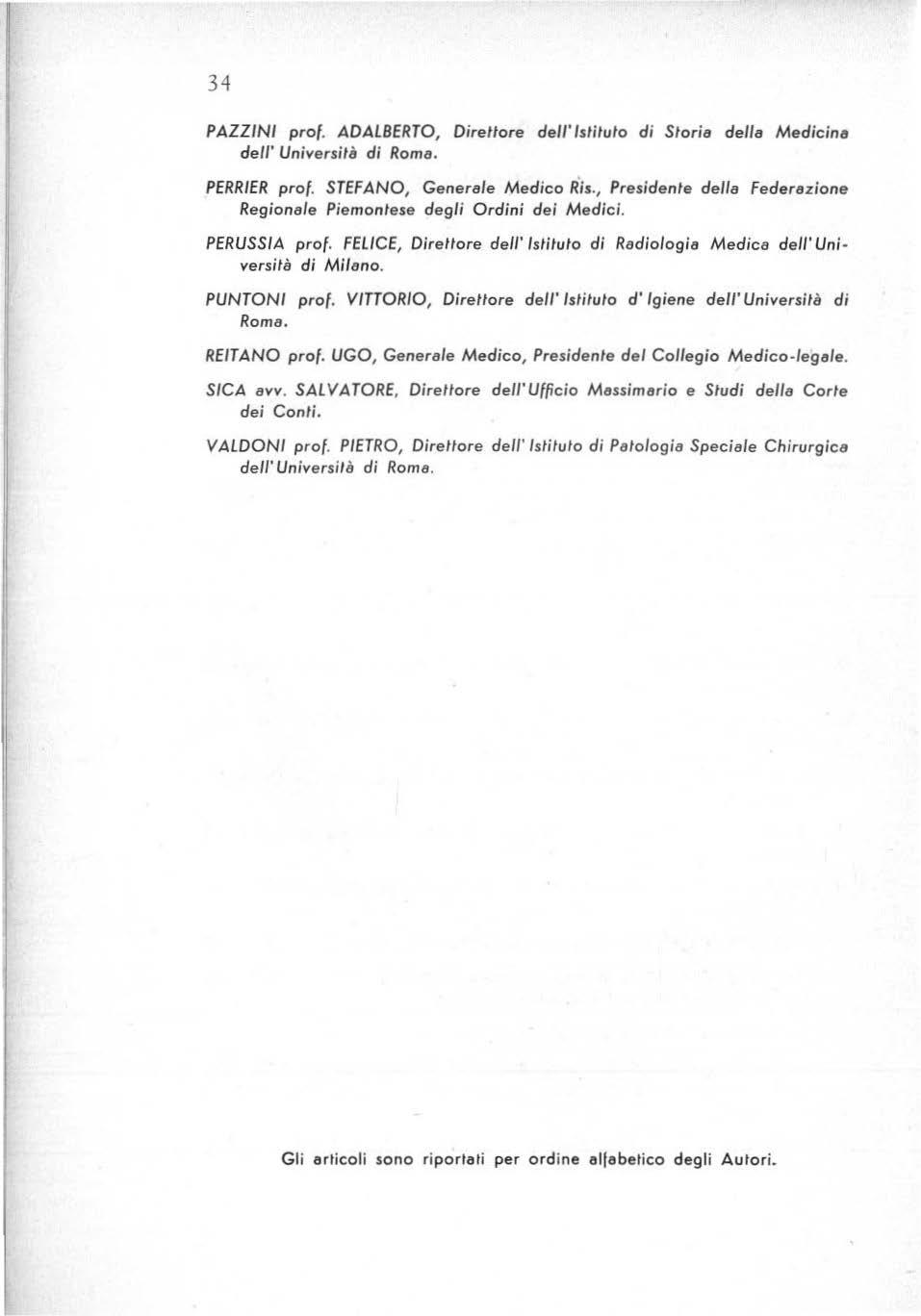

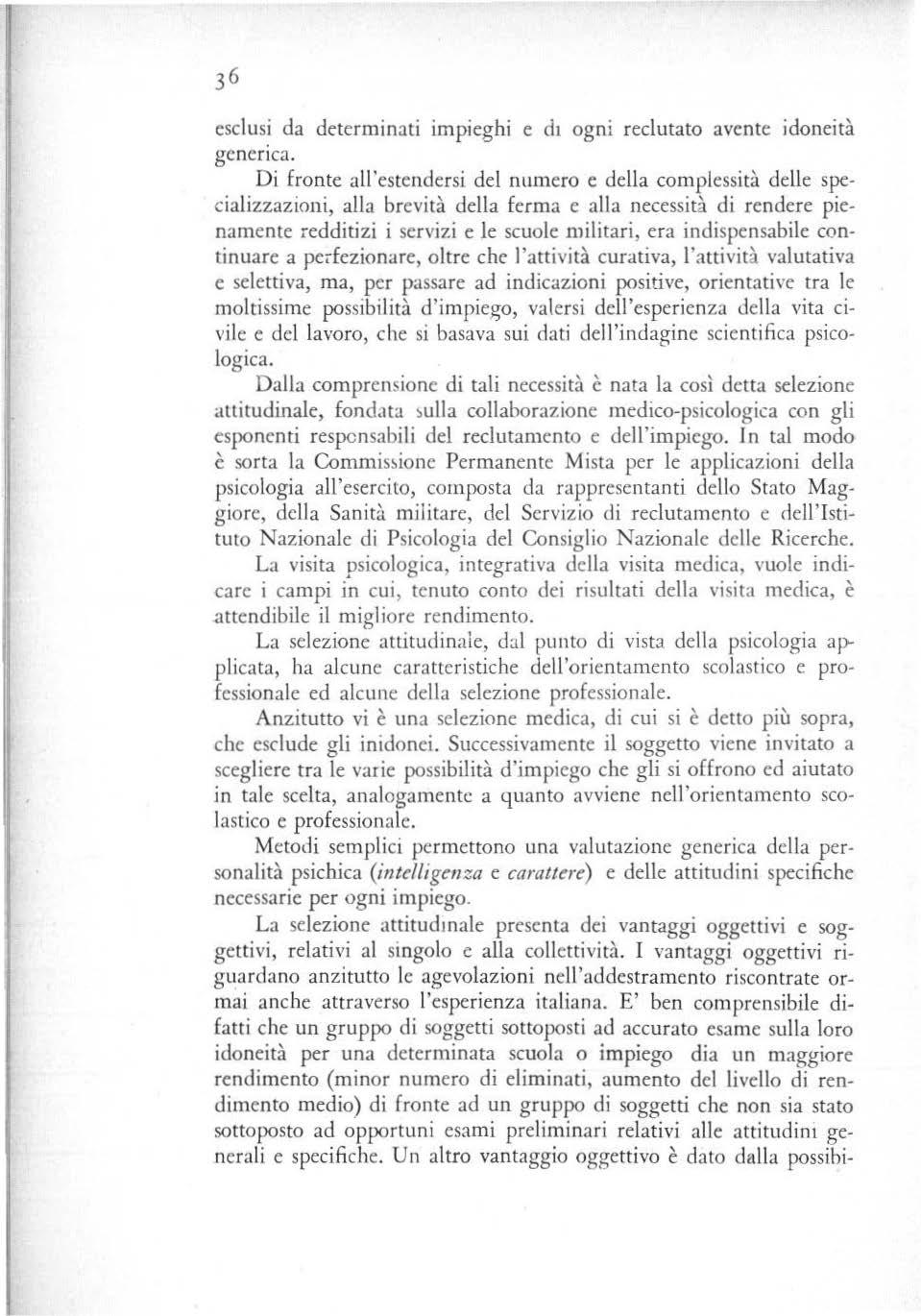
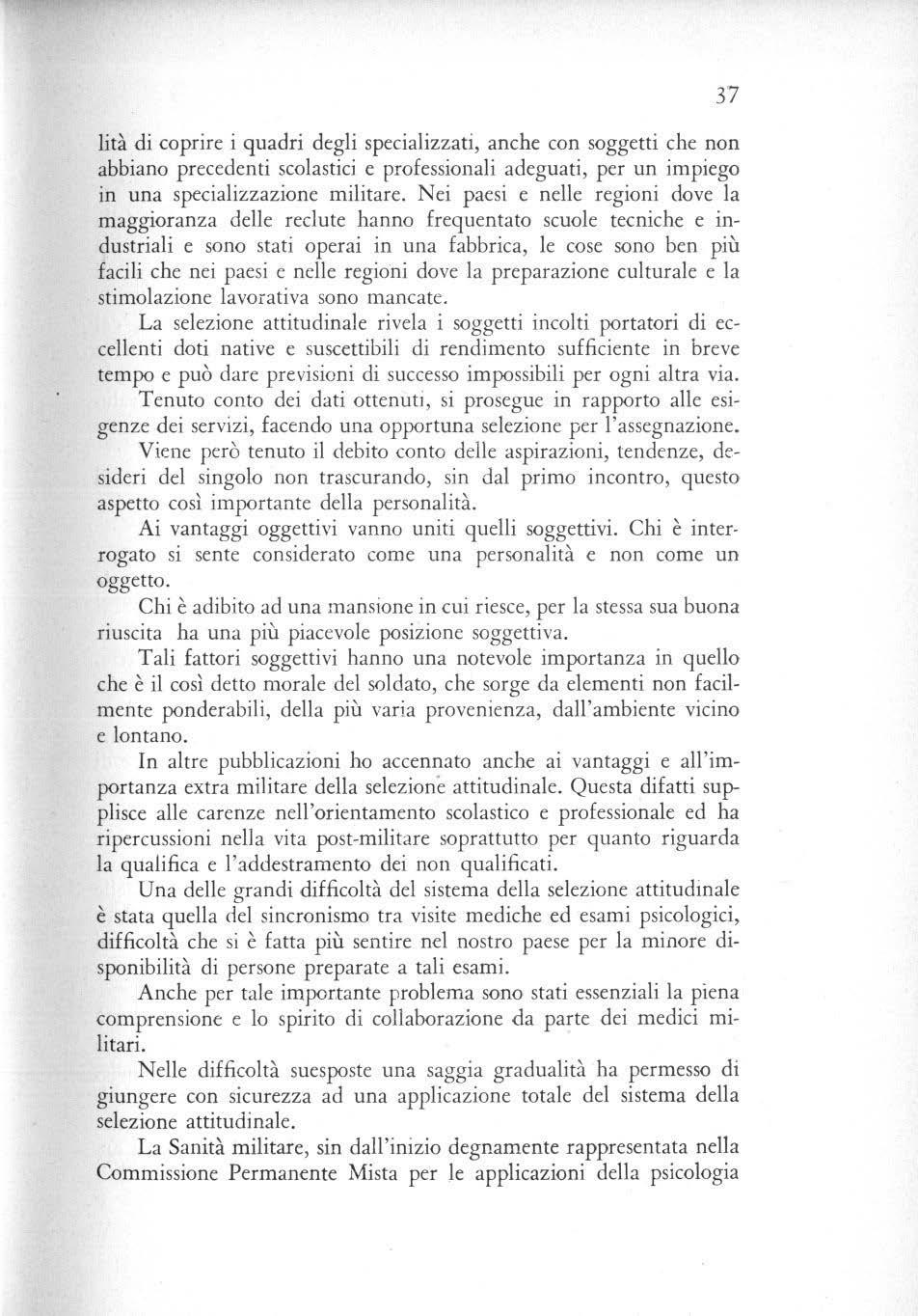
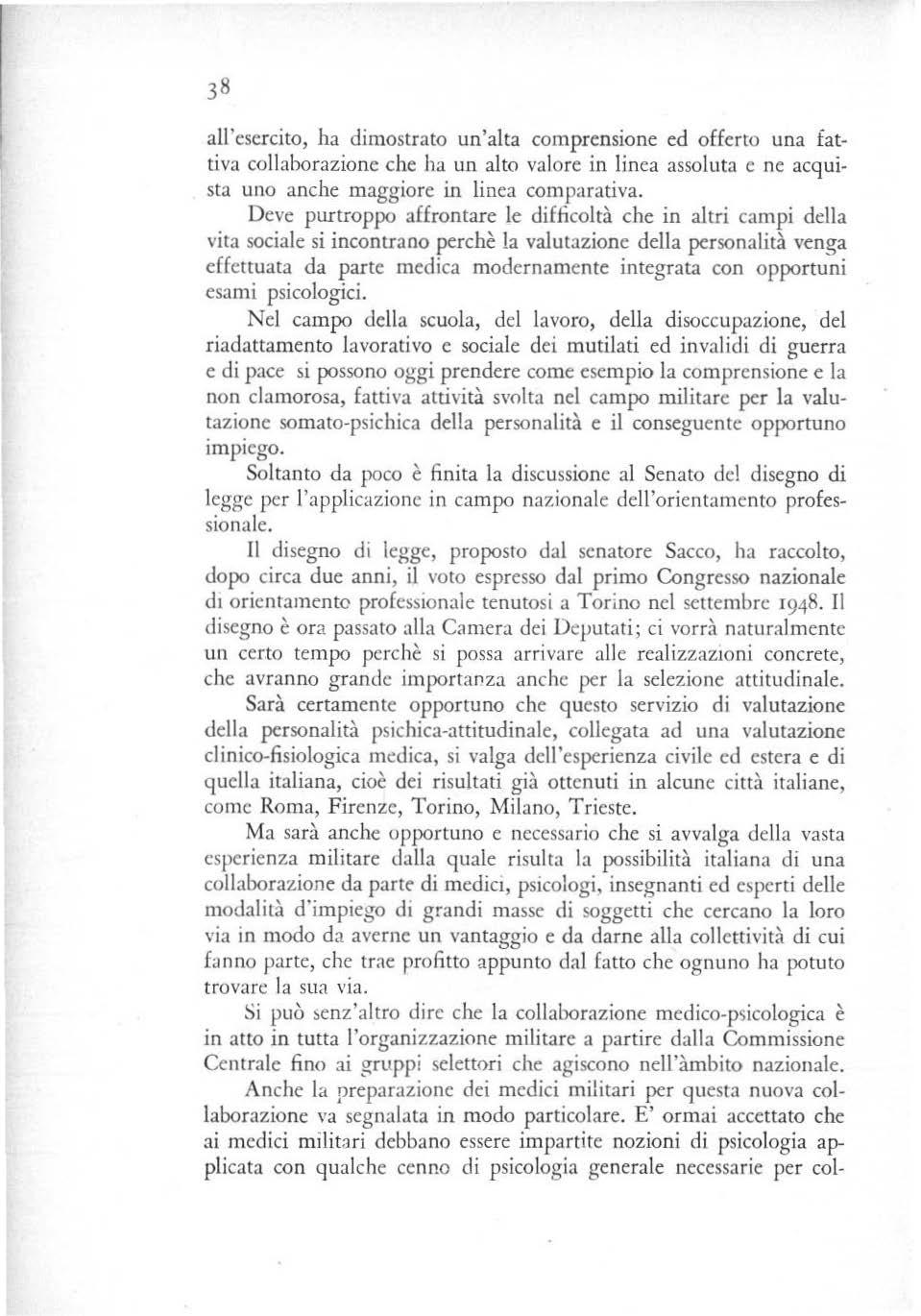
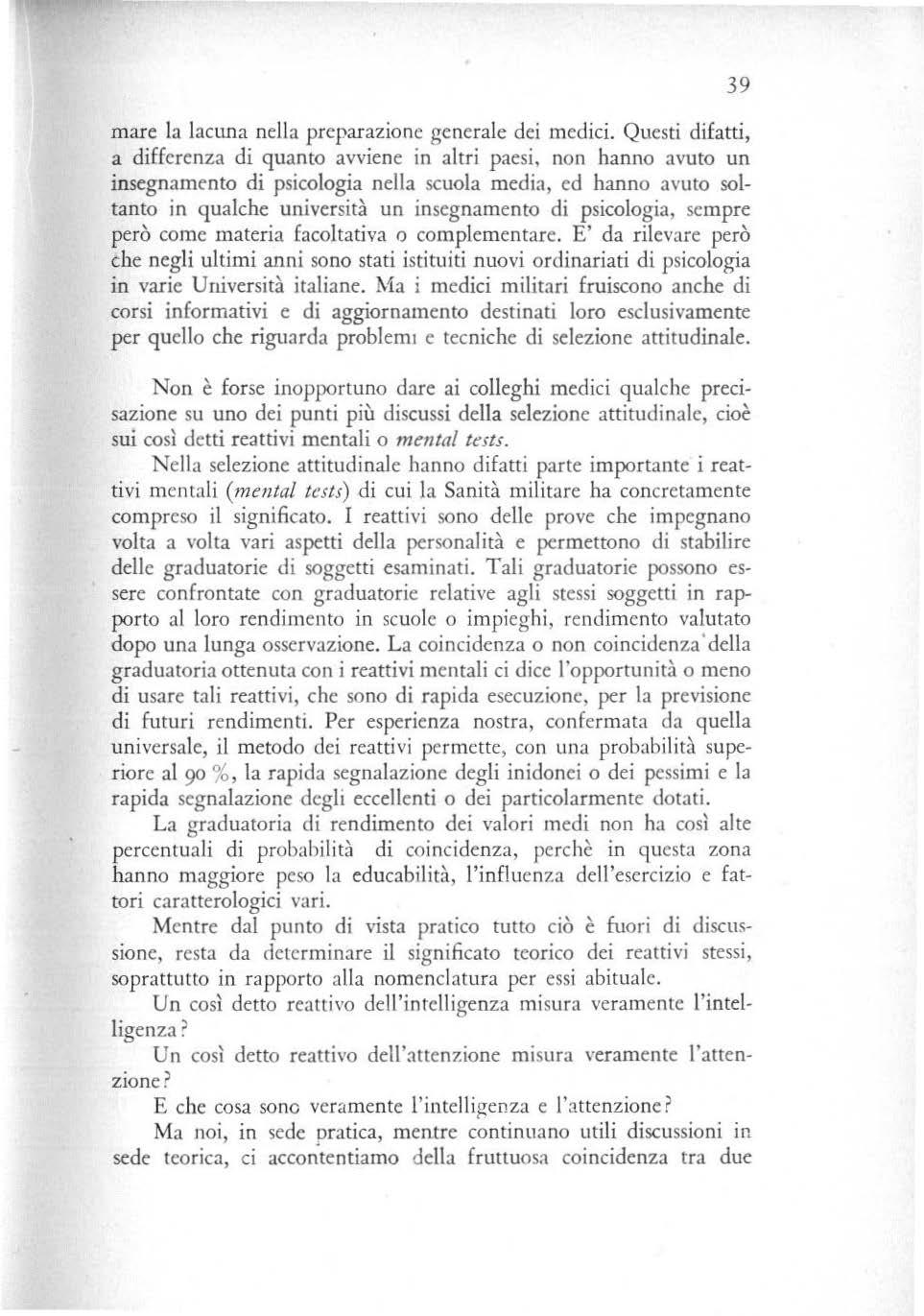



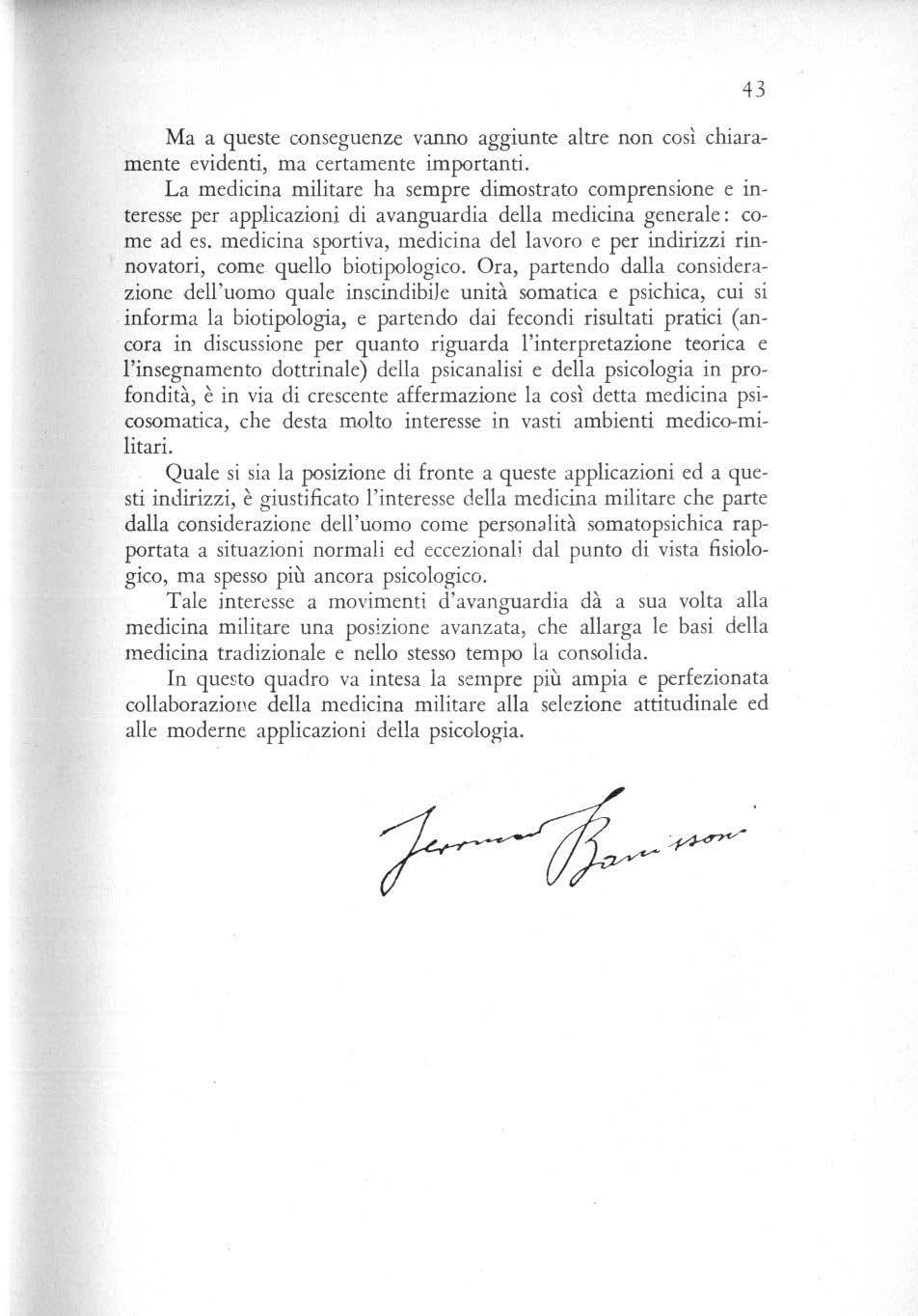
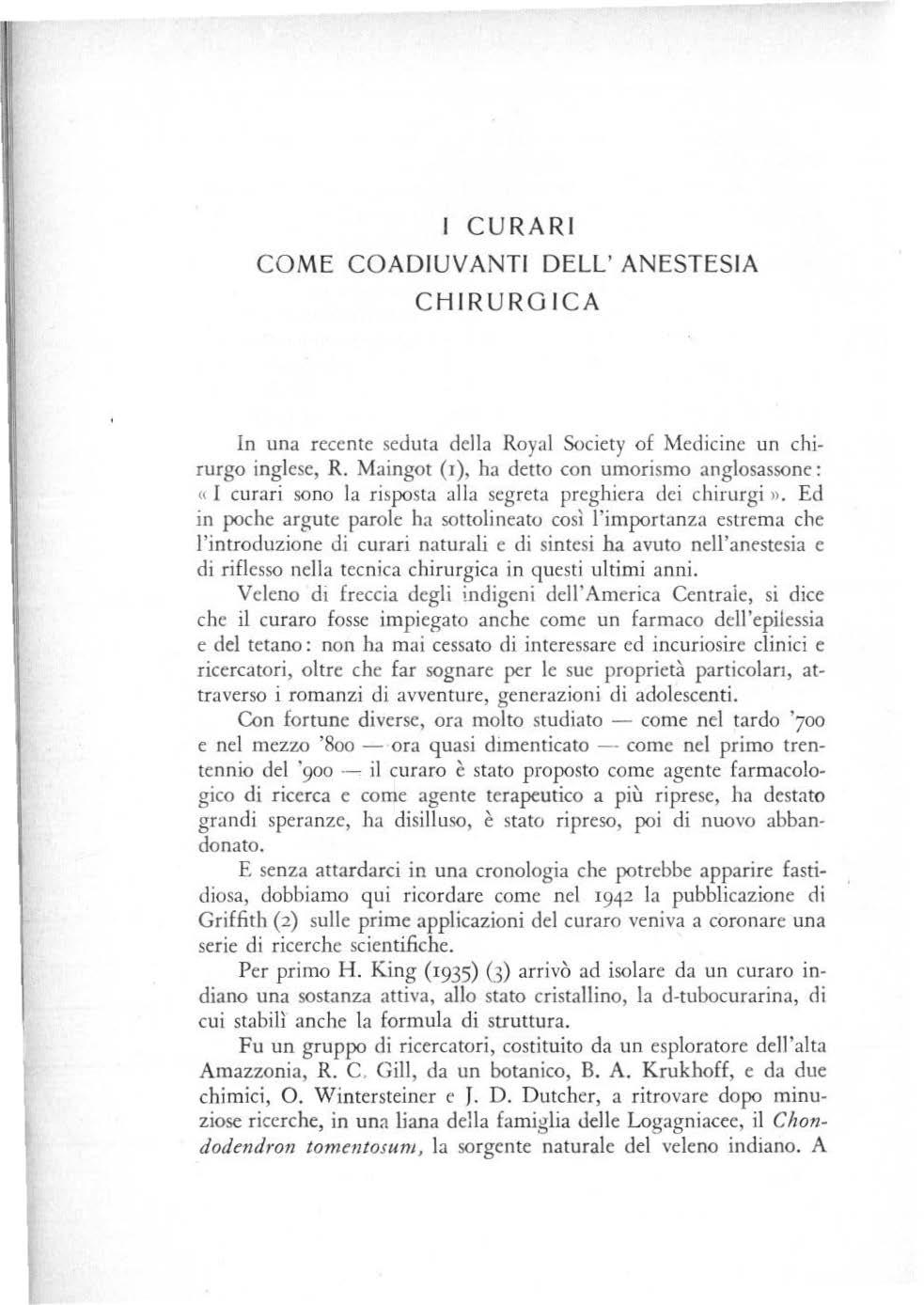
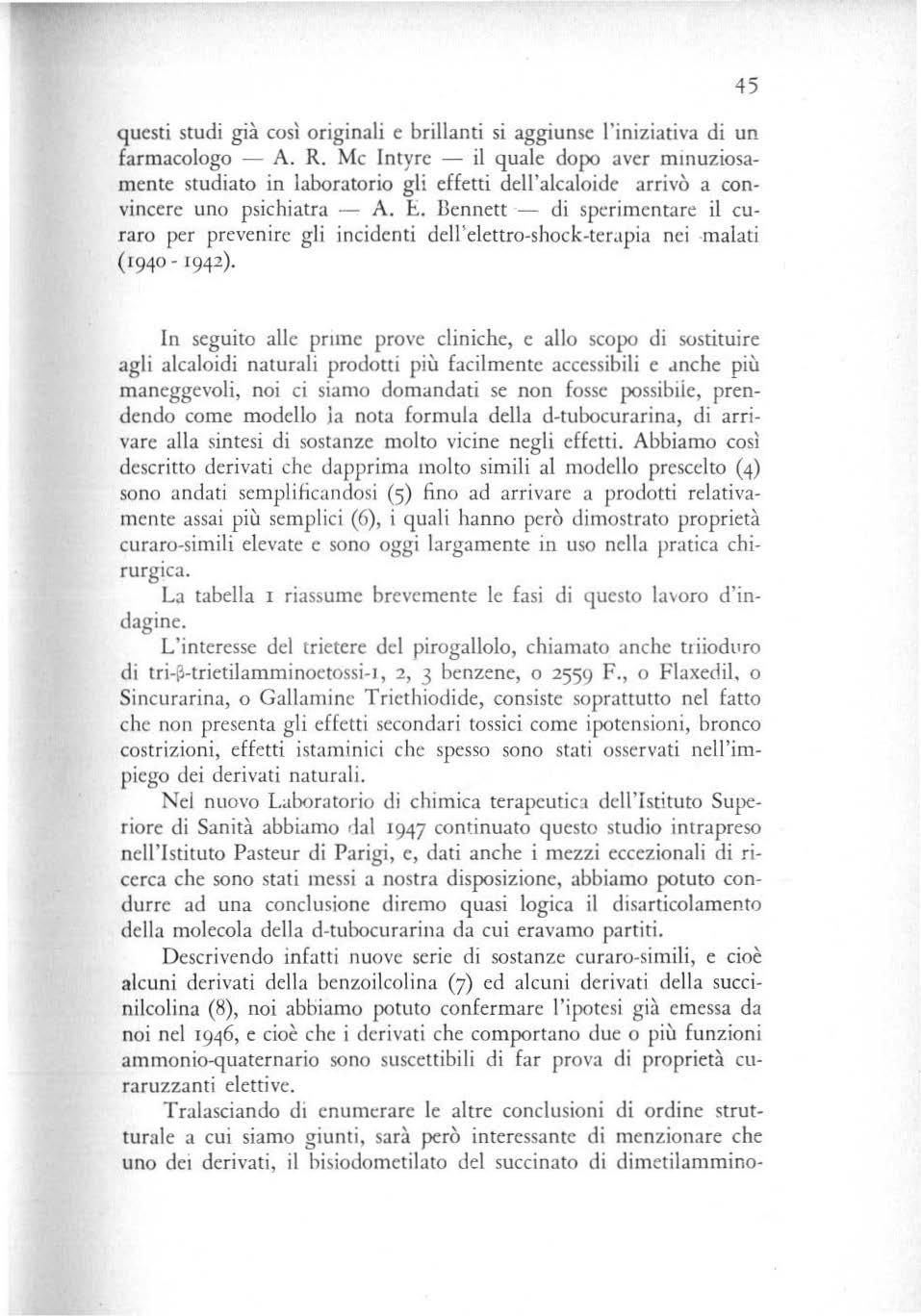

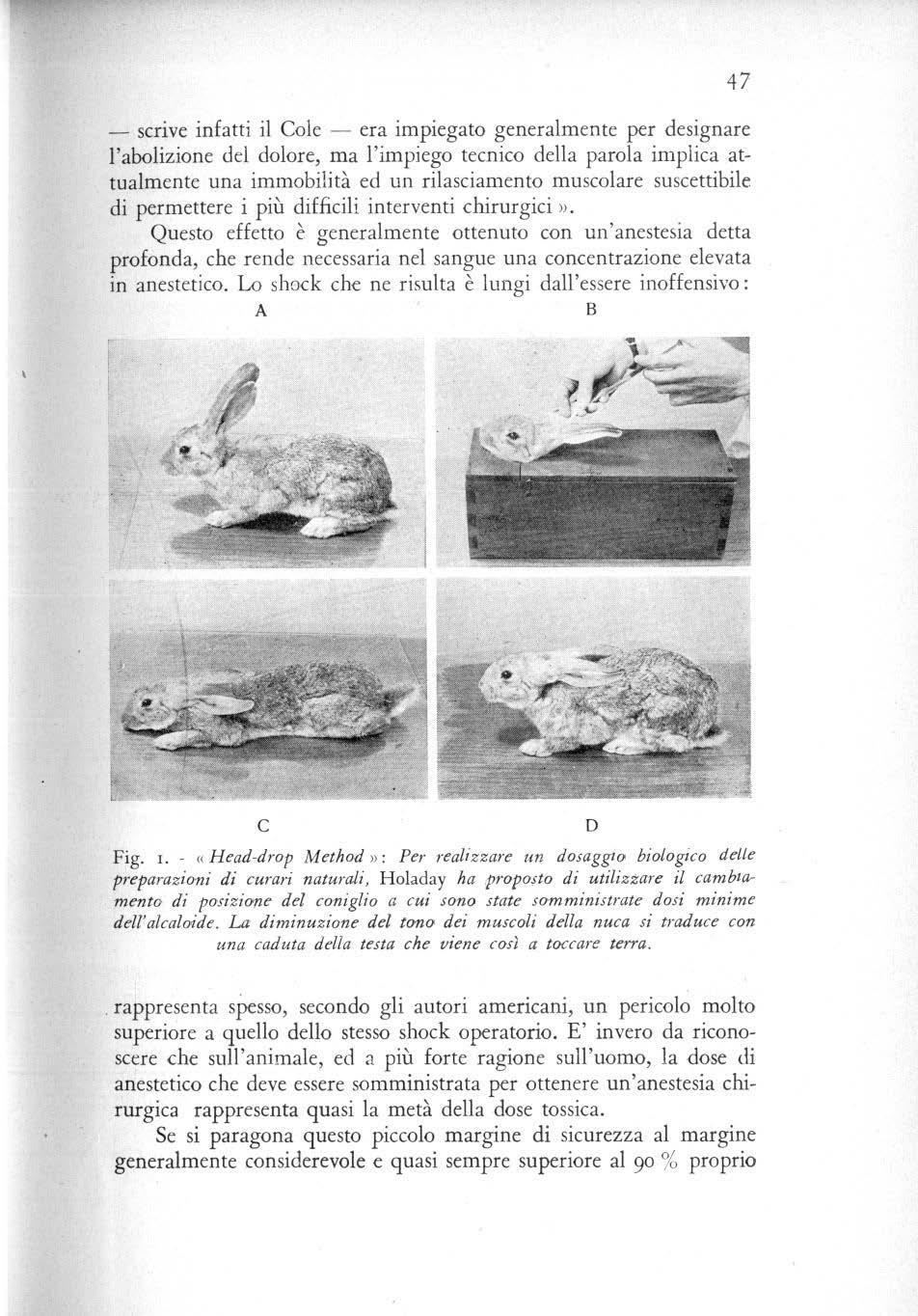
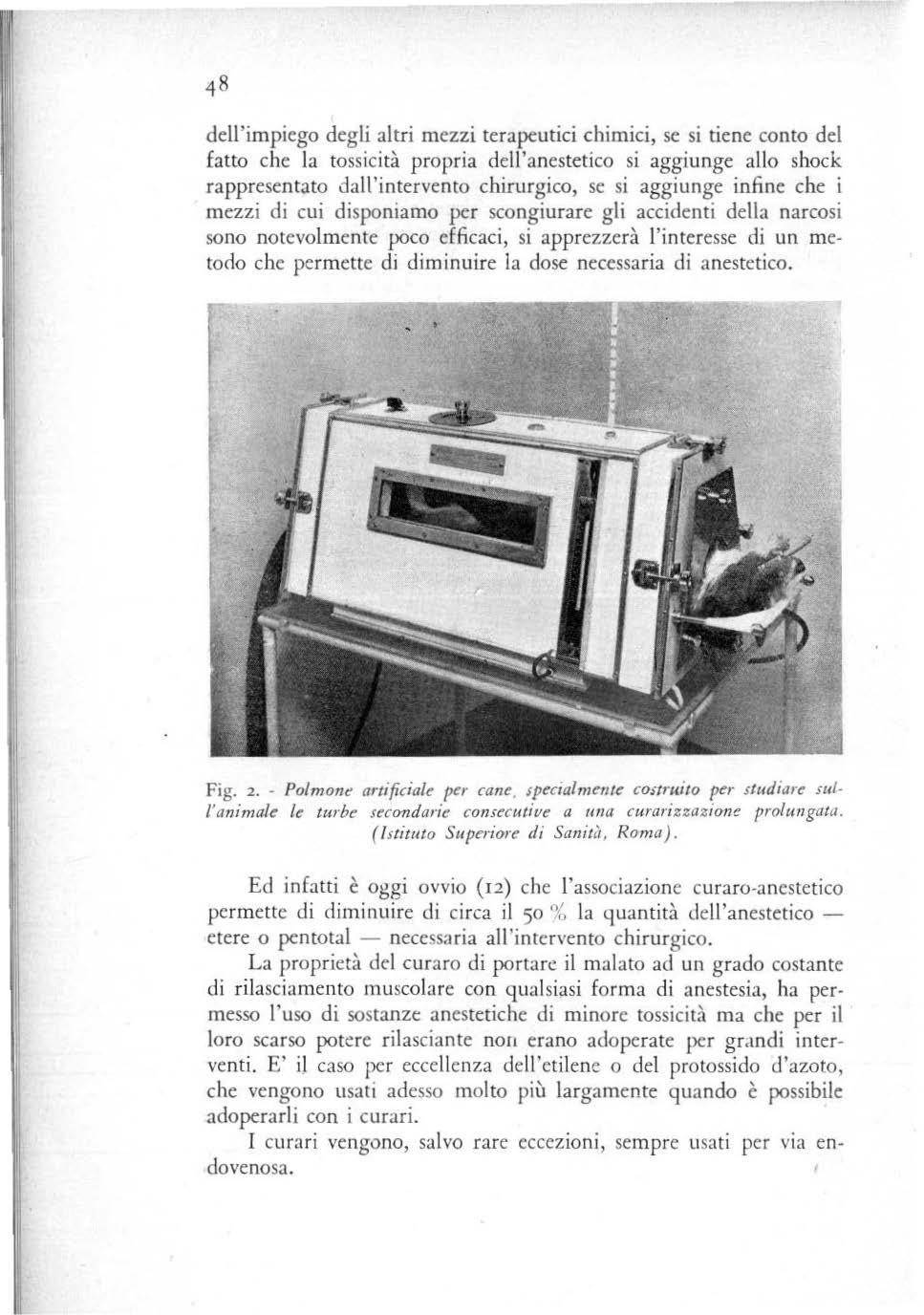

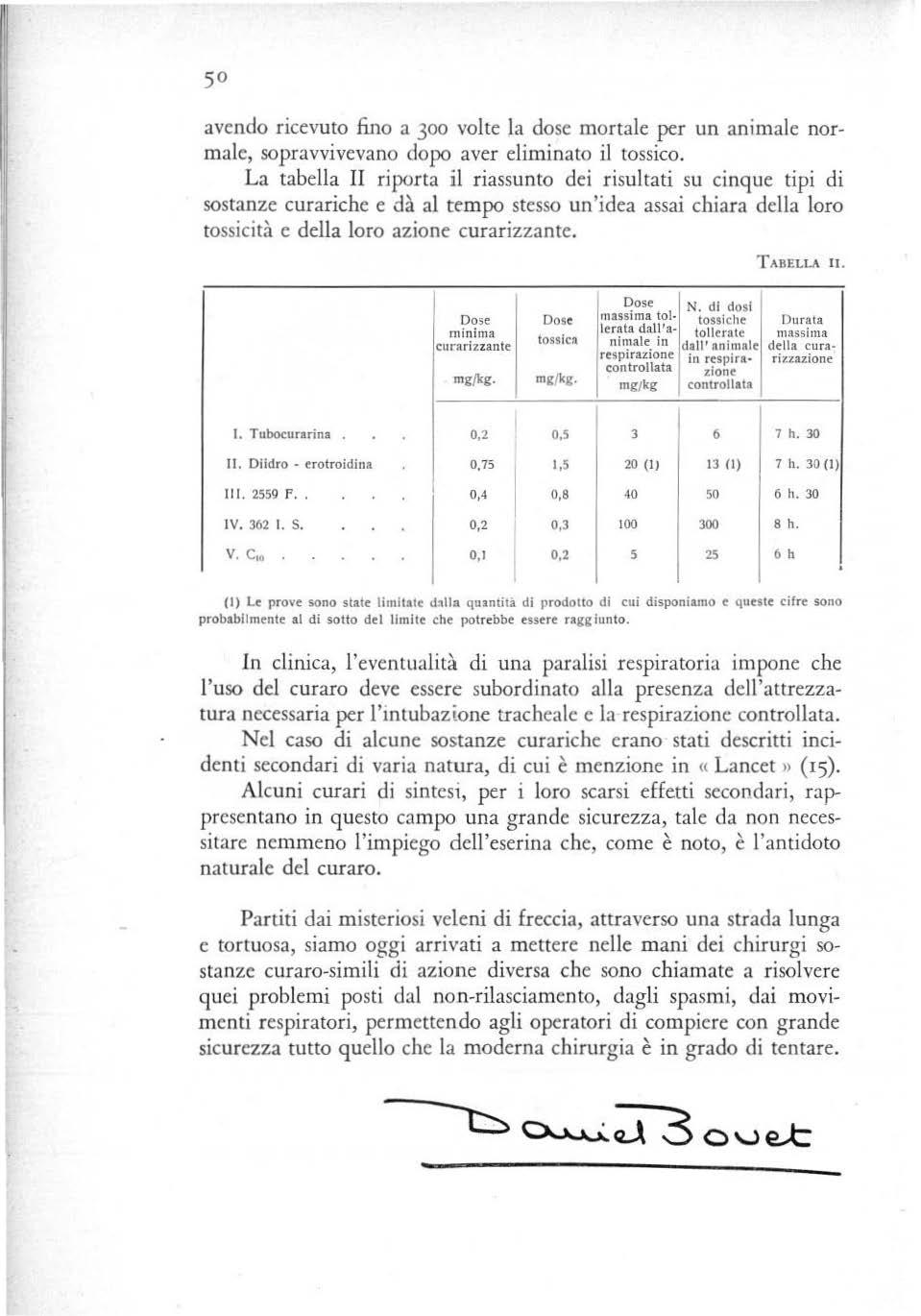


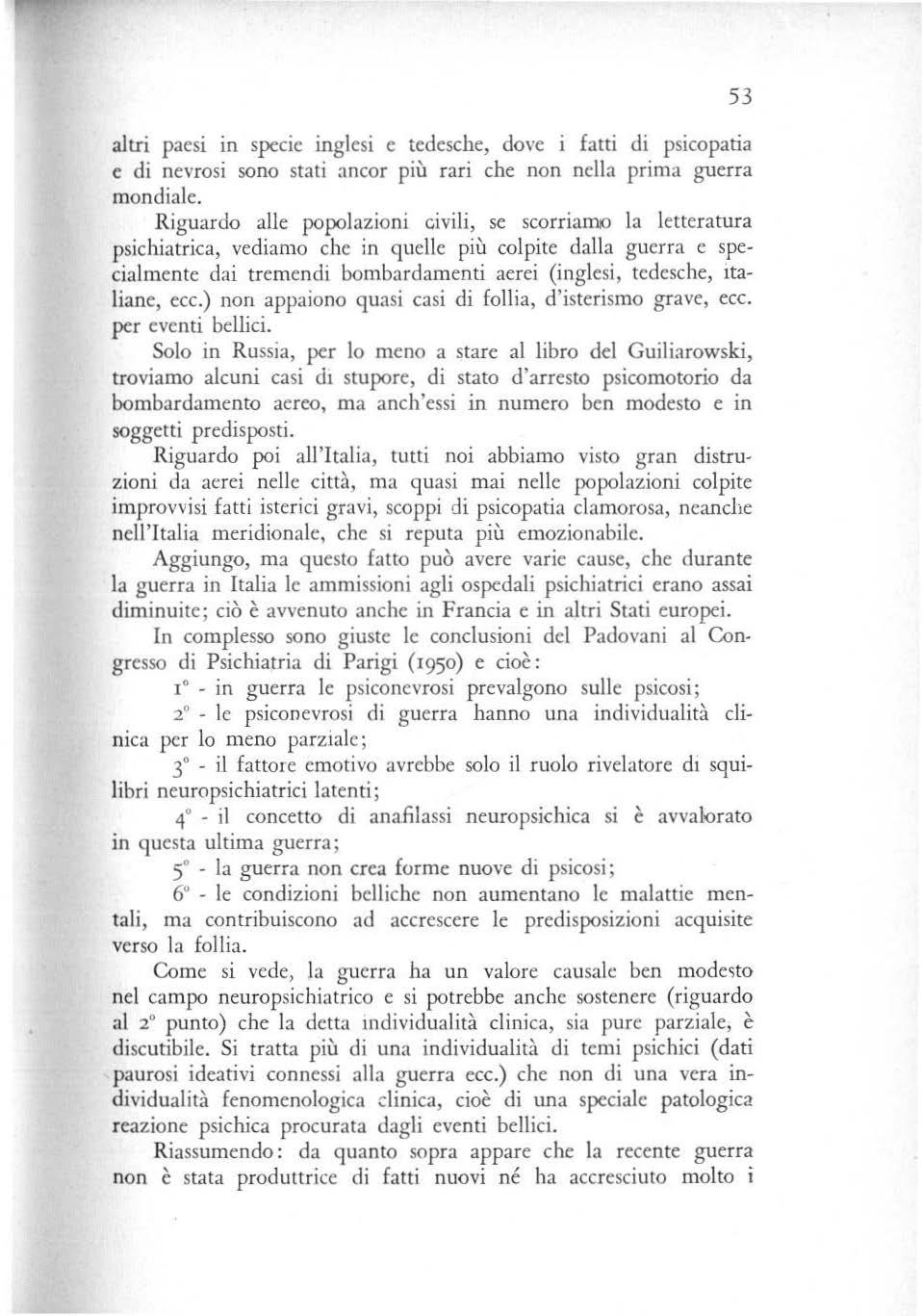
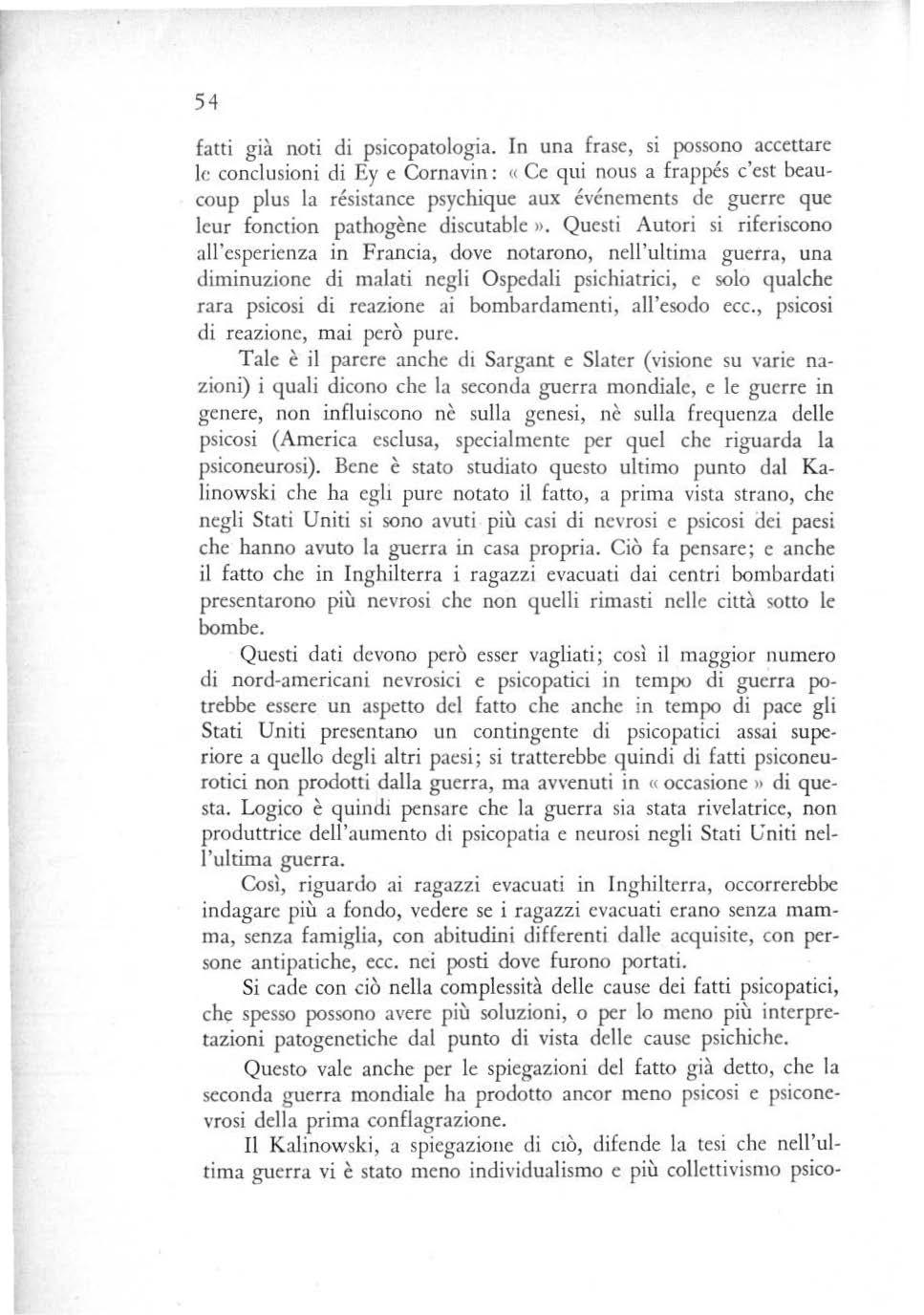
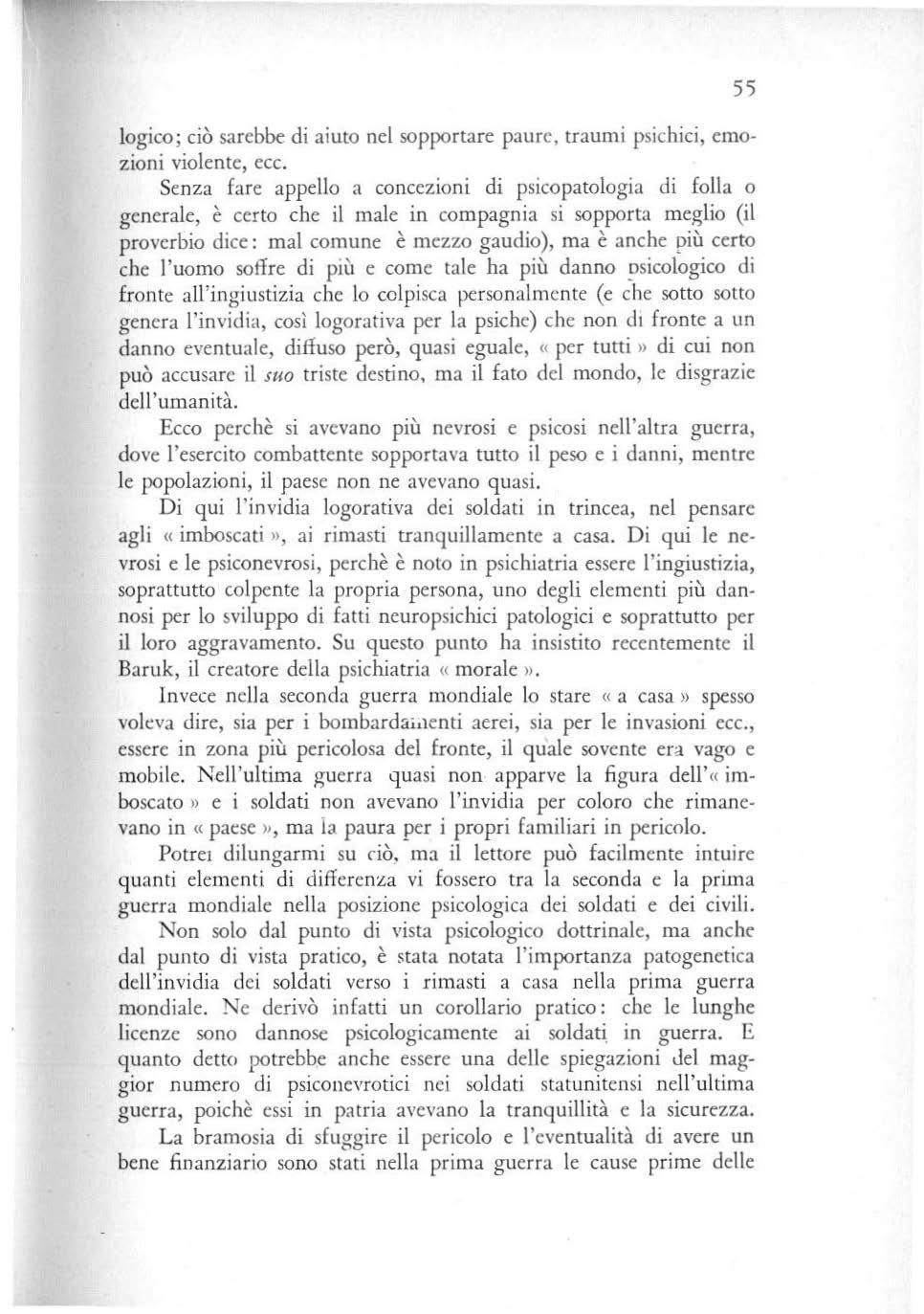





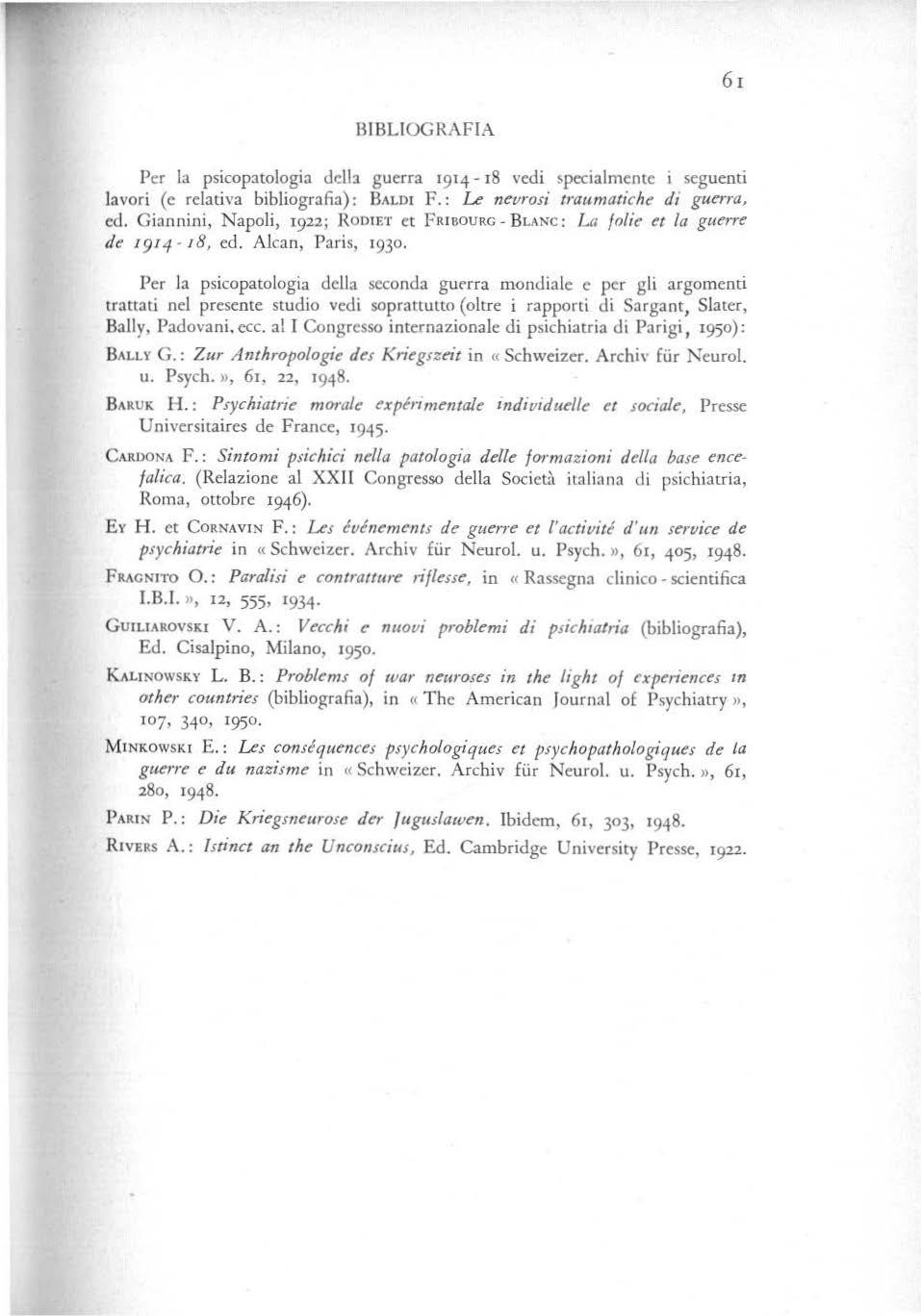
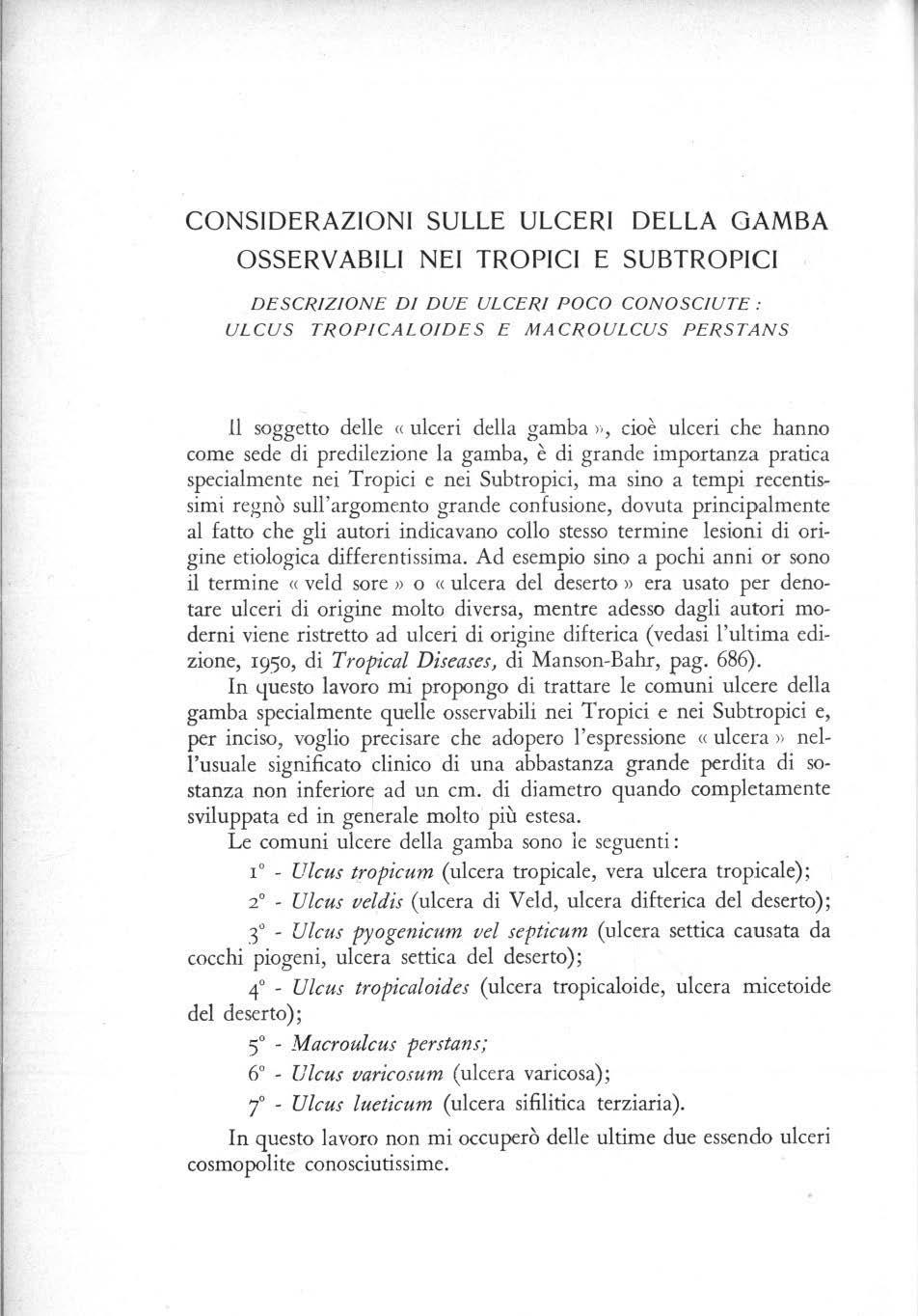
 Fig. r. - Ulcus Lropicum.
Fig. r. - Ulcus Lropicum.
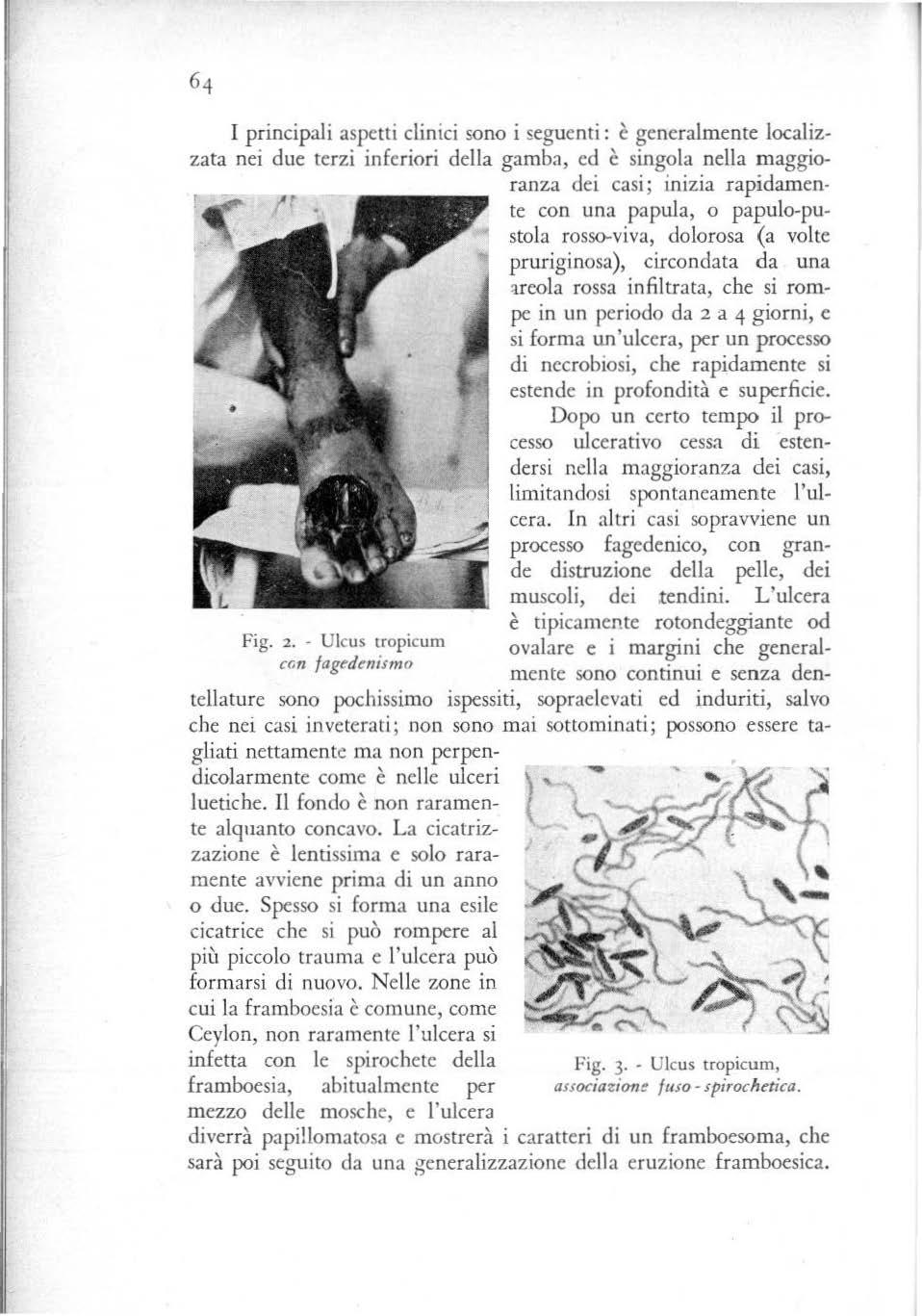 Fig. 2. - Ulcus tropicum ccn fagt'dt:nisma
Fig. 3· · Ulcus tropicum, fuso- spiroch etica.
Fig. 2. - Ulcus tropicum ccn fagt'dt:nisma
Fig. 3· · Ulcus tropicum, fuso- spiroch etica.
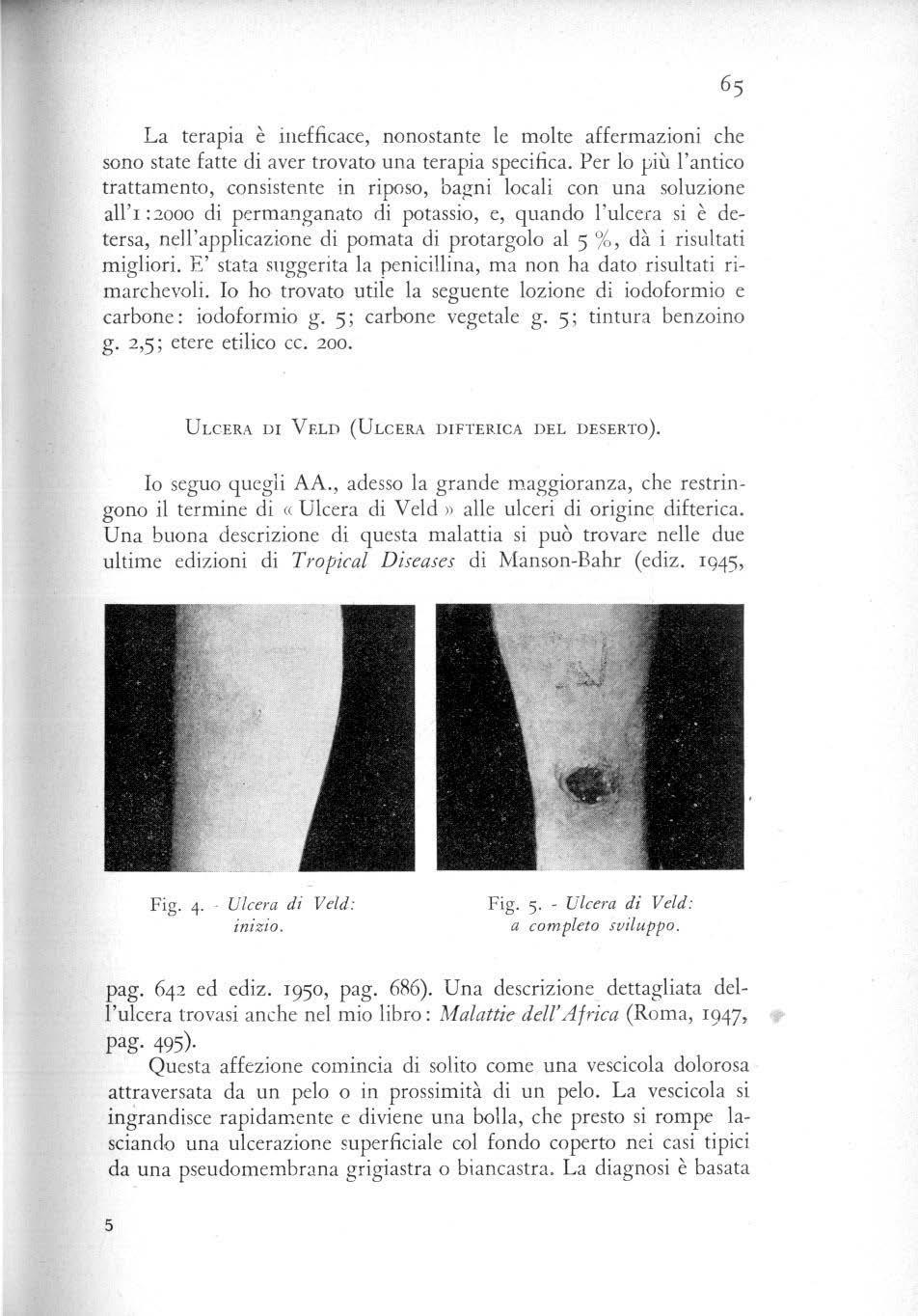
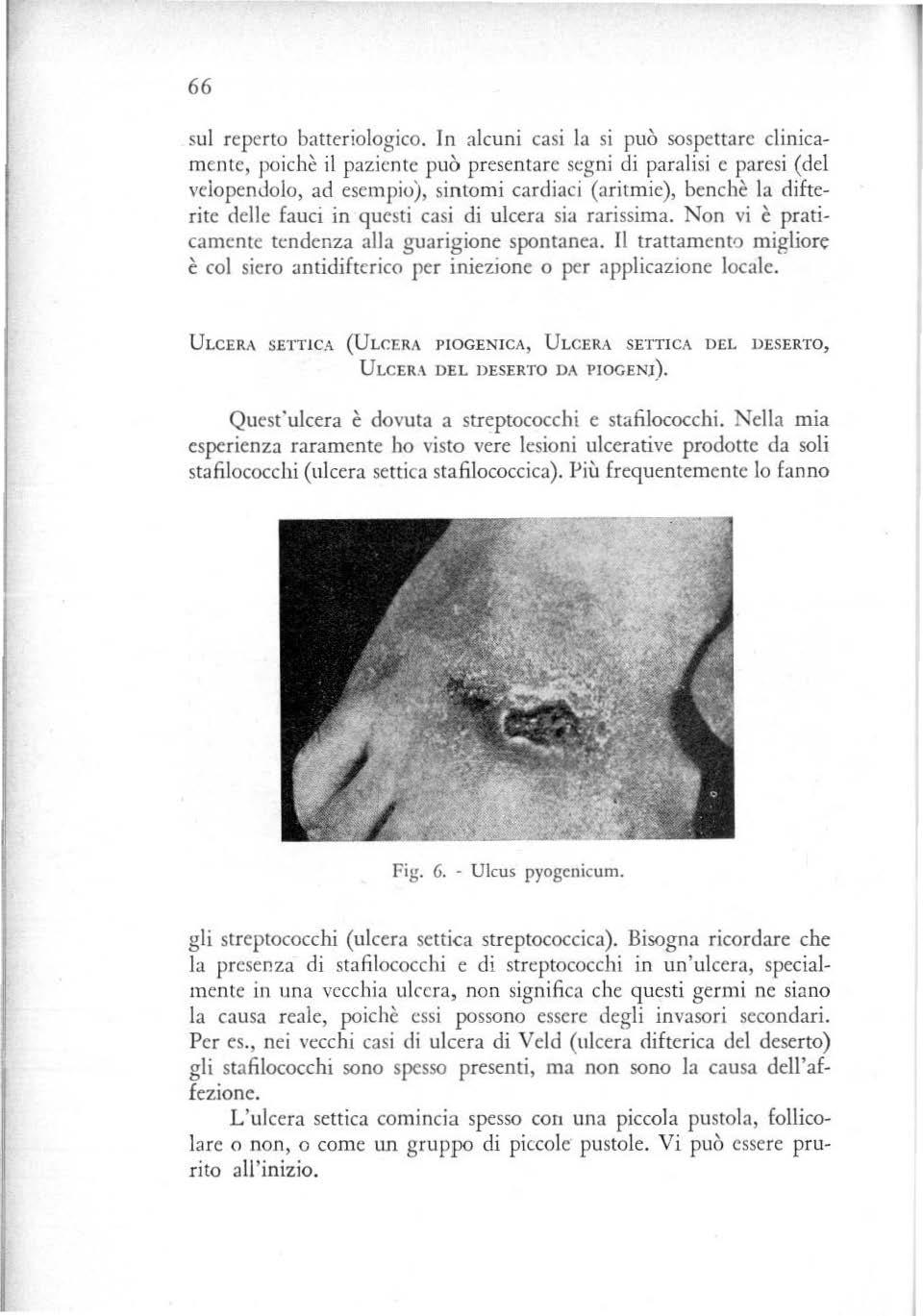
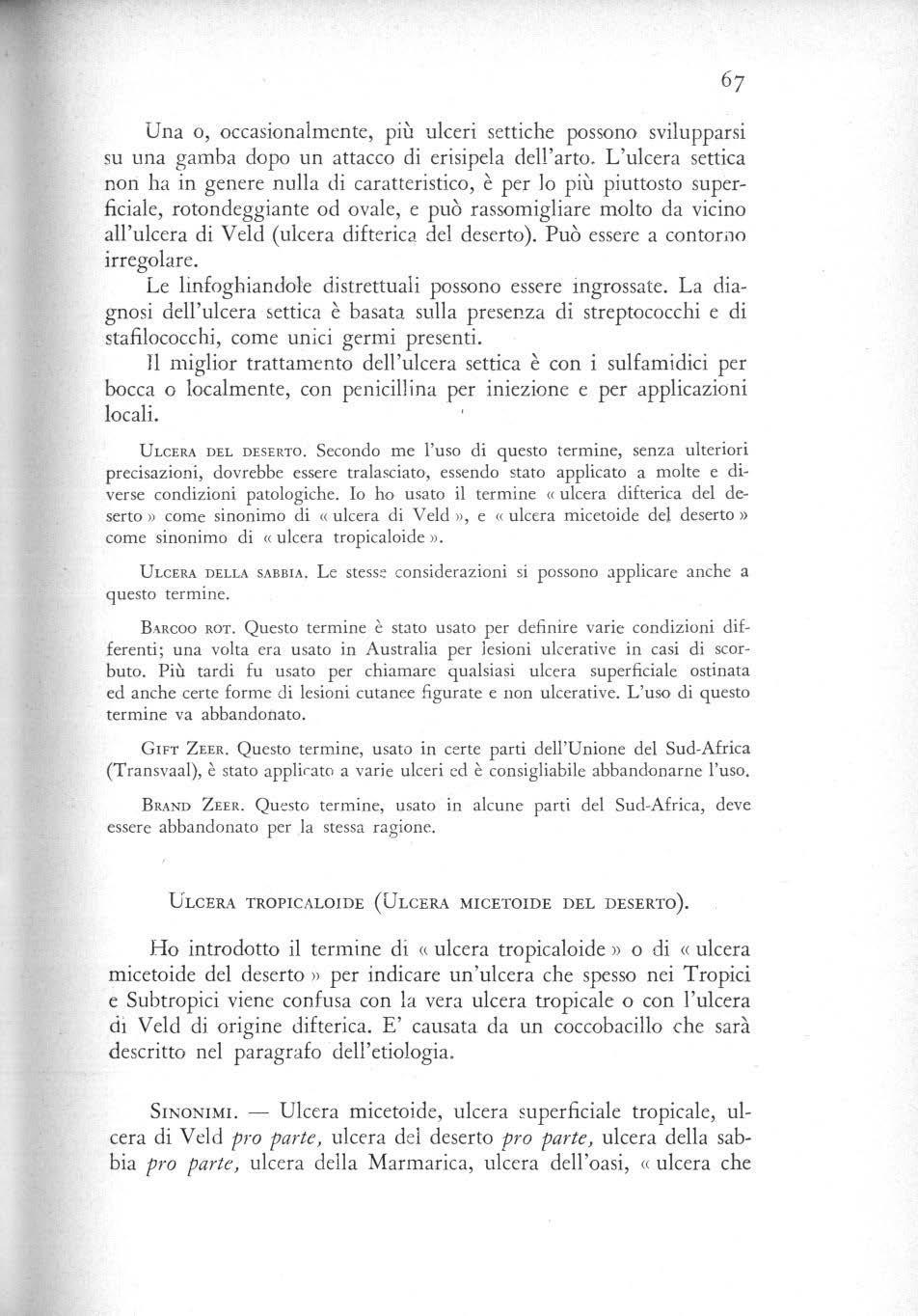

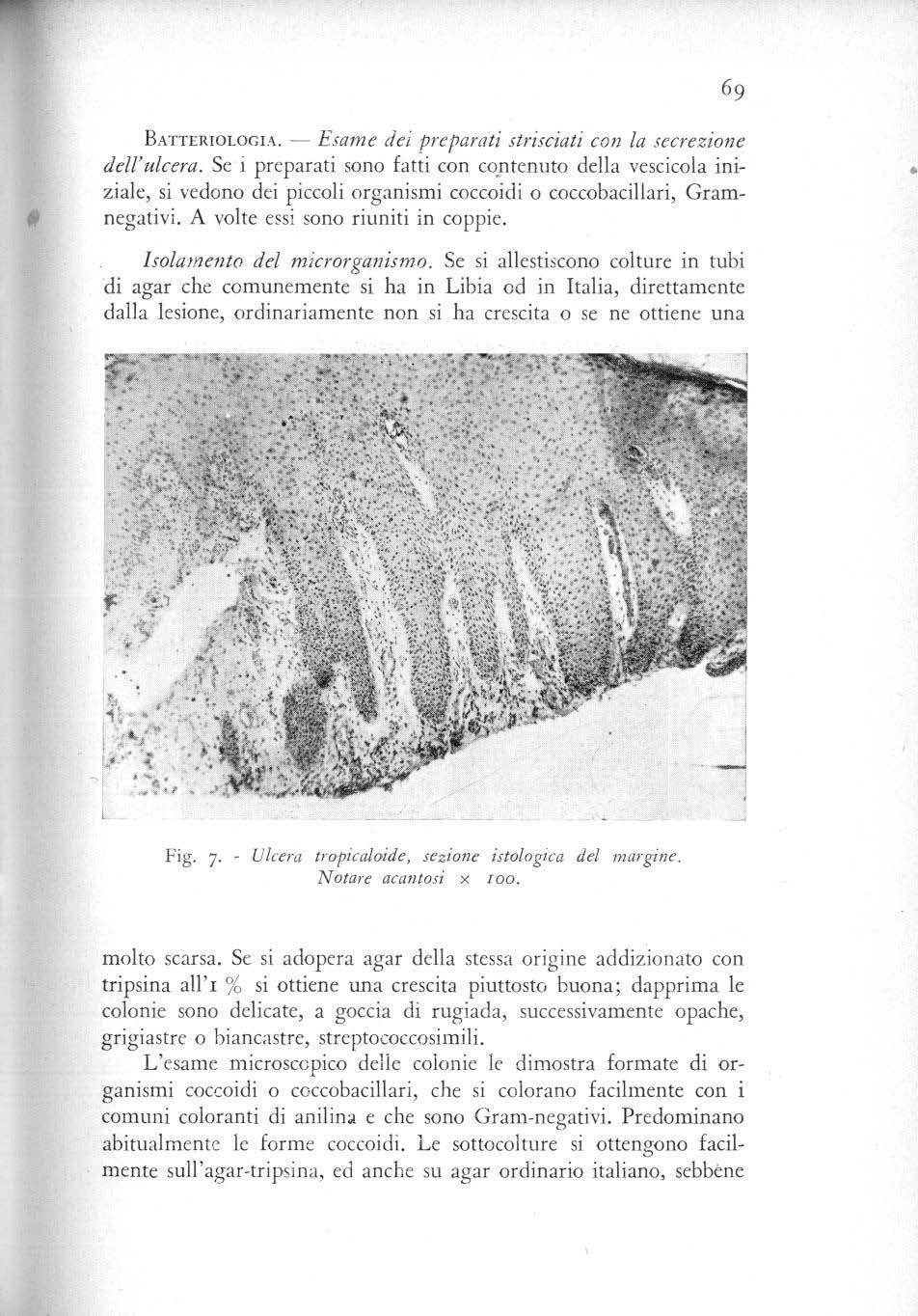


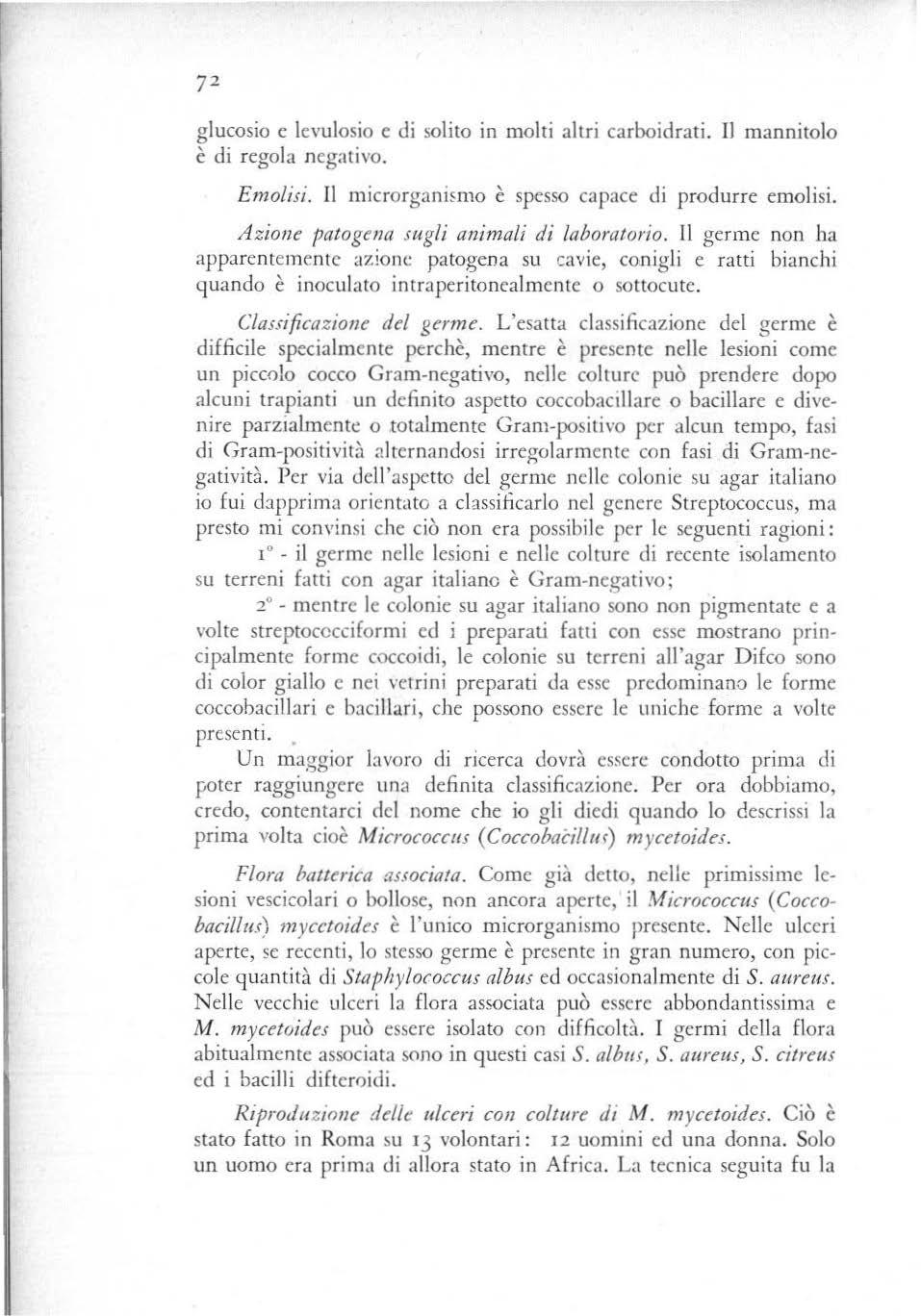
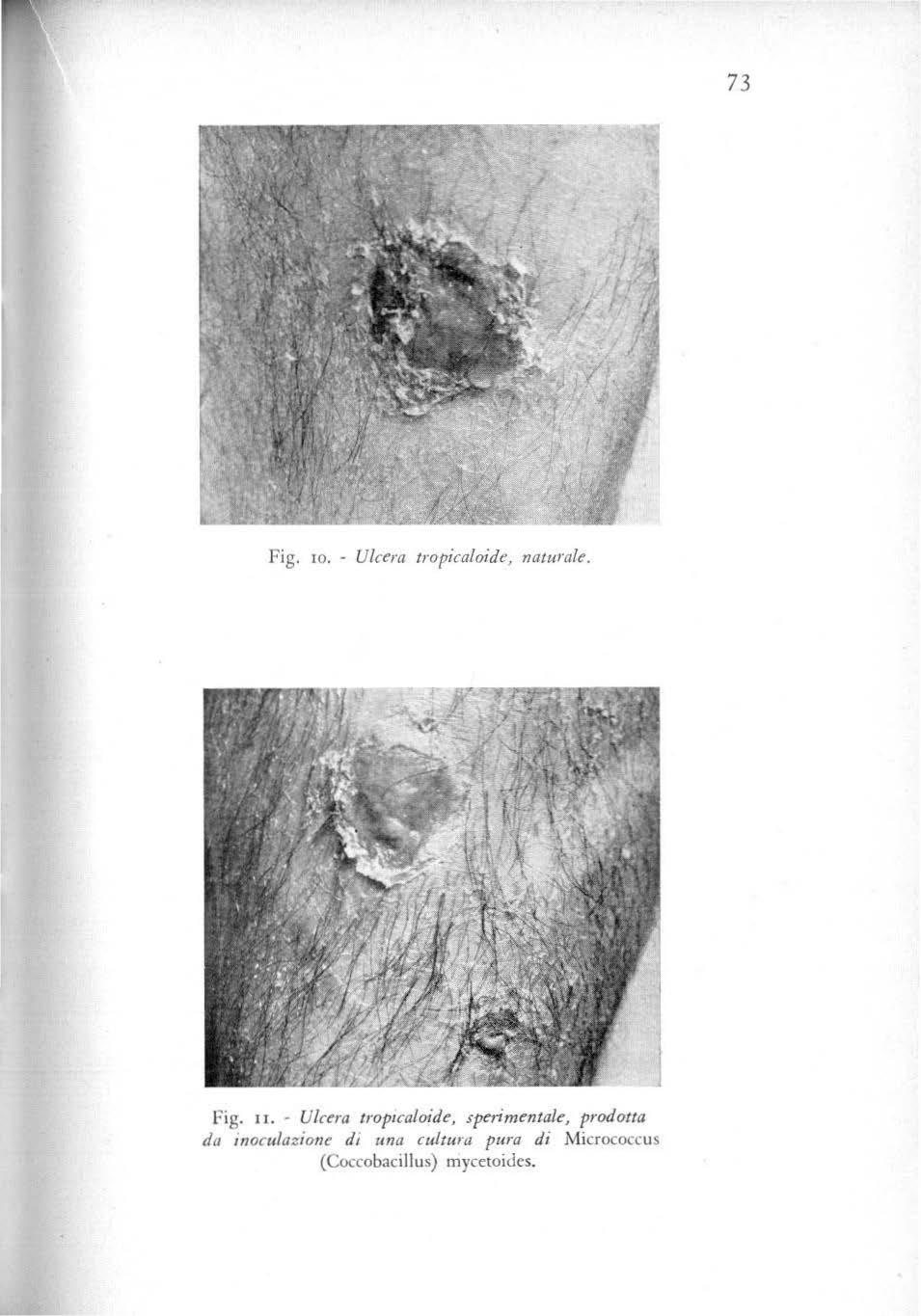 Fig. 10. • Ulcera tropicaloide, naturale.
Fig. 10. • Ulcera tropicaloide, naturale.
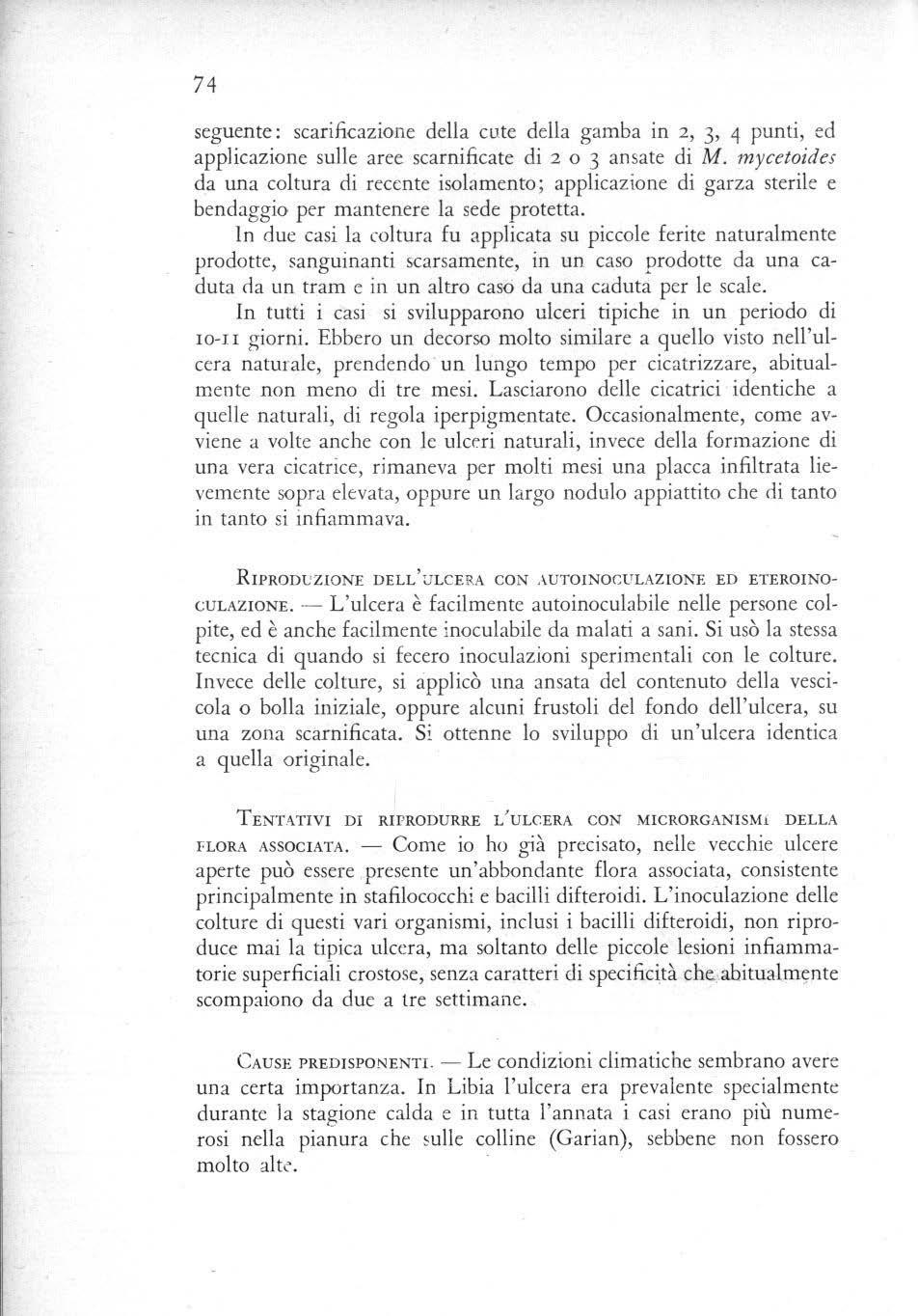
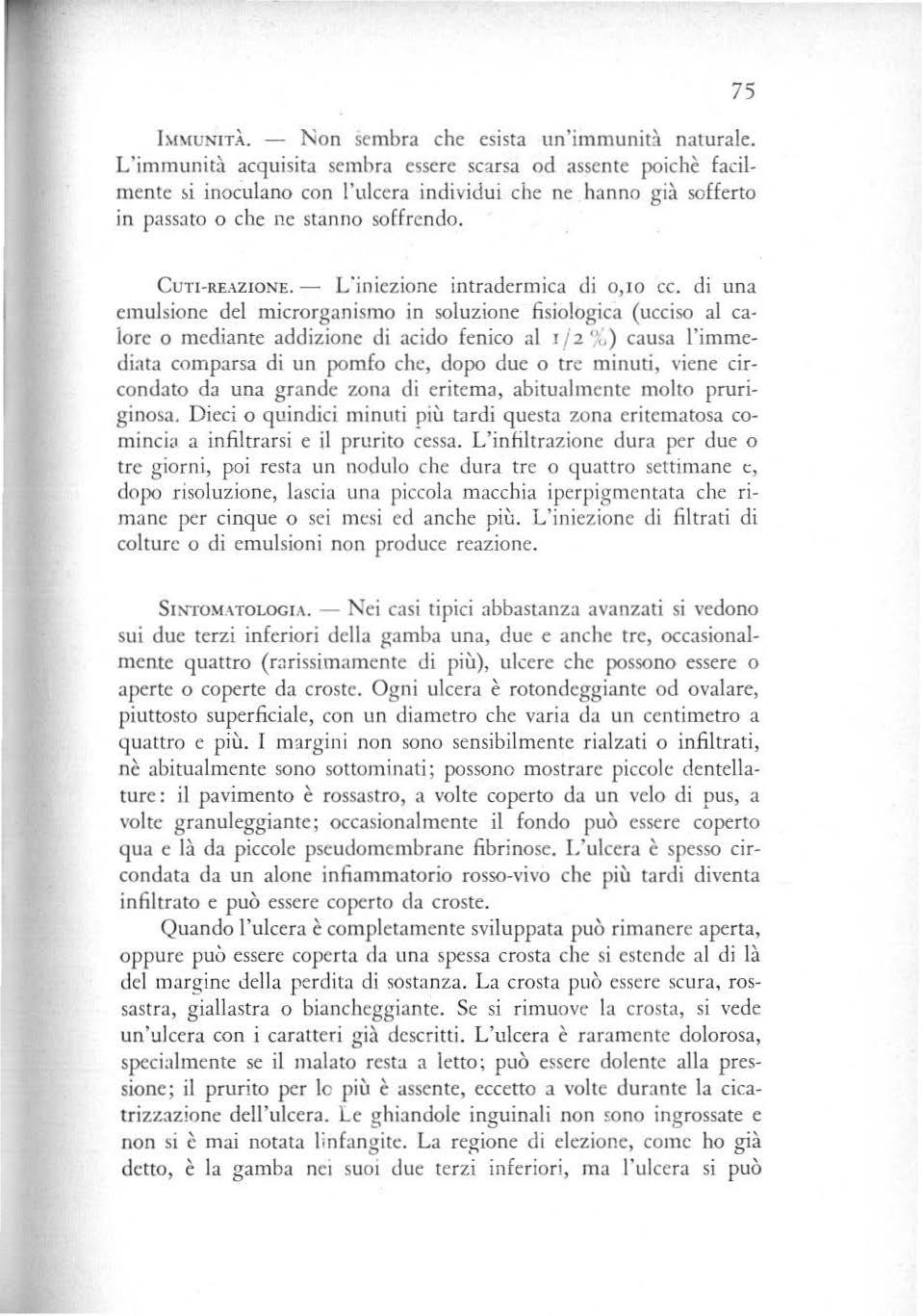
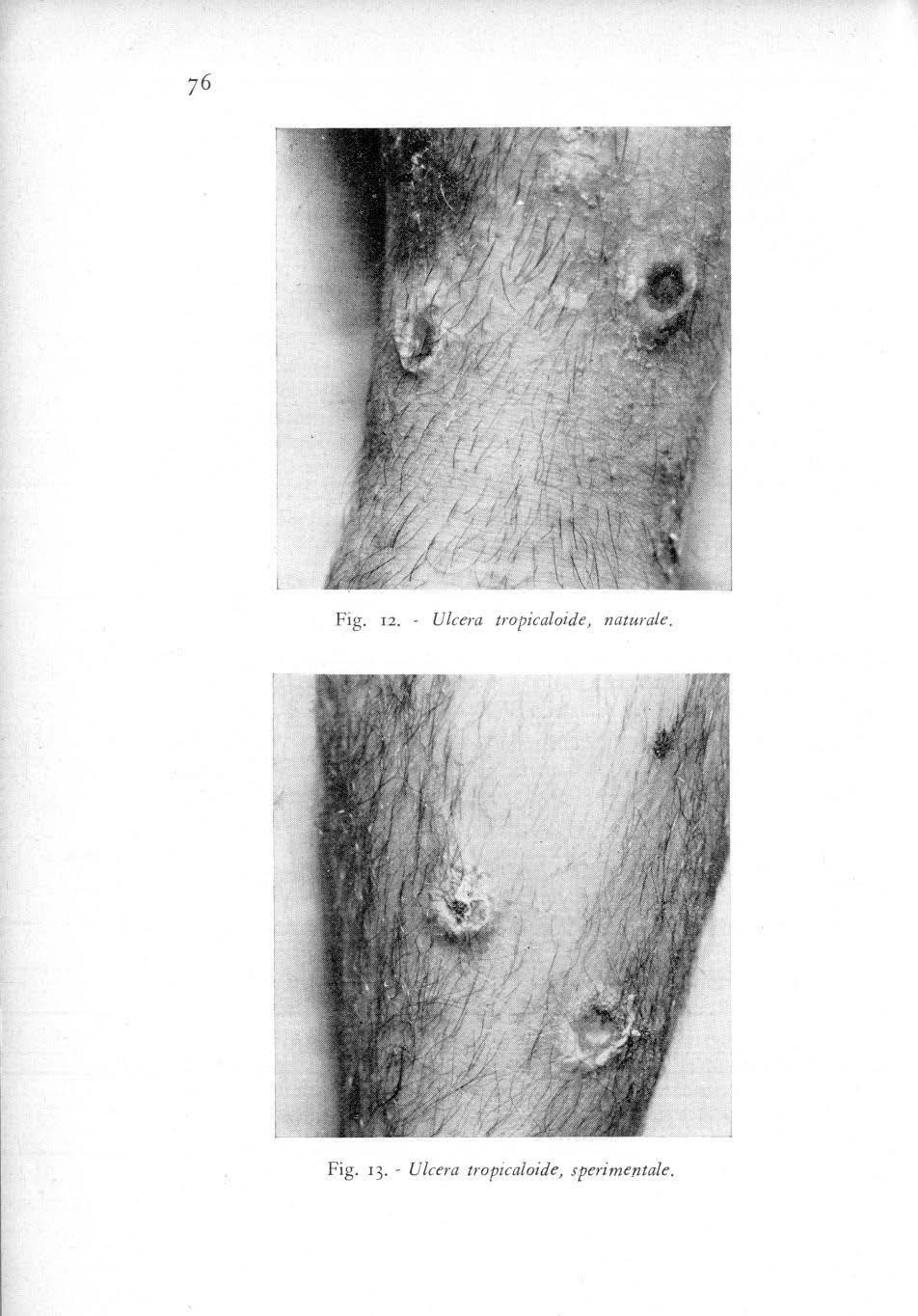 Fig. 12. - U!cera tropicaloide, 11aturale.
F ig . 13. - Ulcera troprcaloide, sperimemale .
Fig. 12. - U!cera tropicaloide, 11aturale.
F ig . 13. - Ulcera troprcaloide, sperimemale .

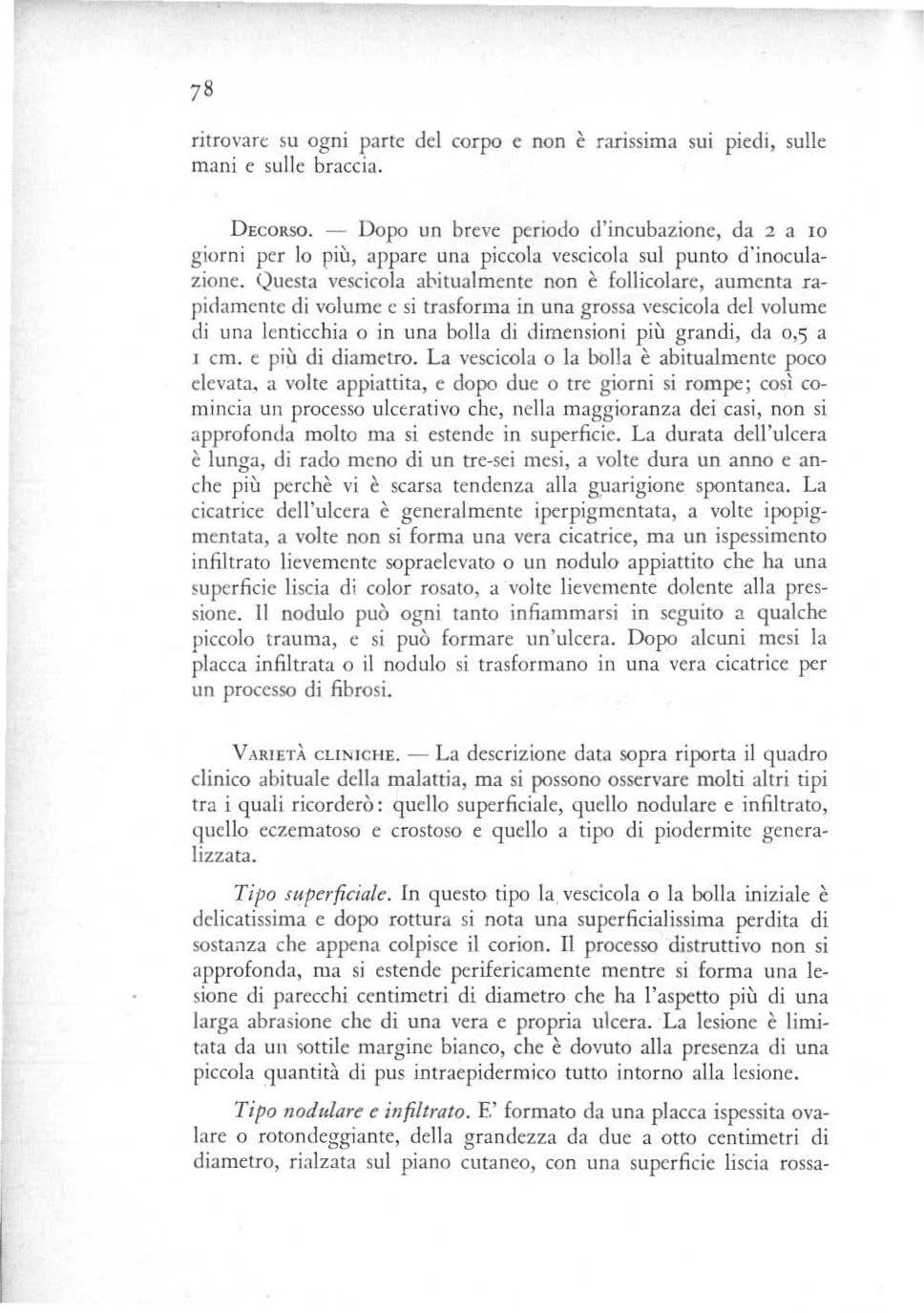

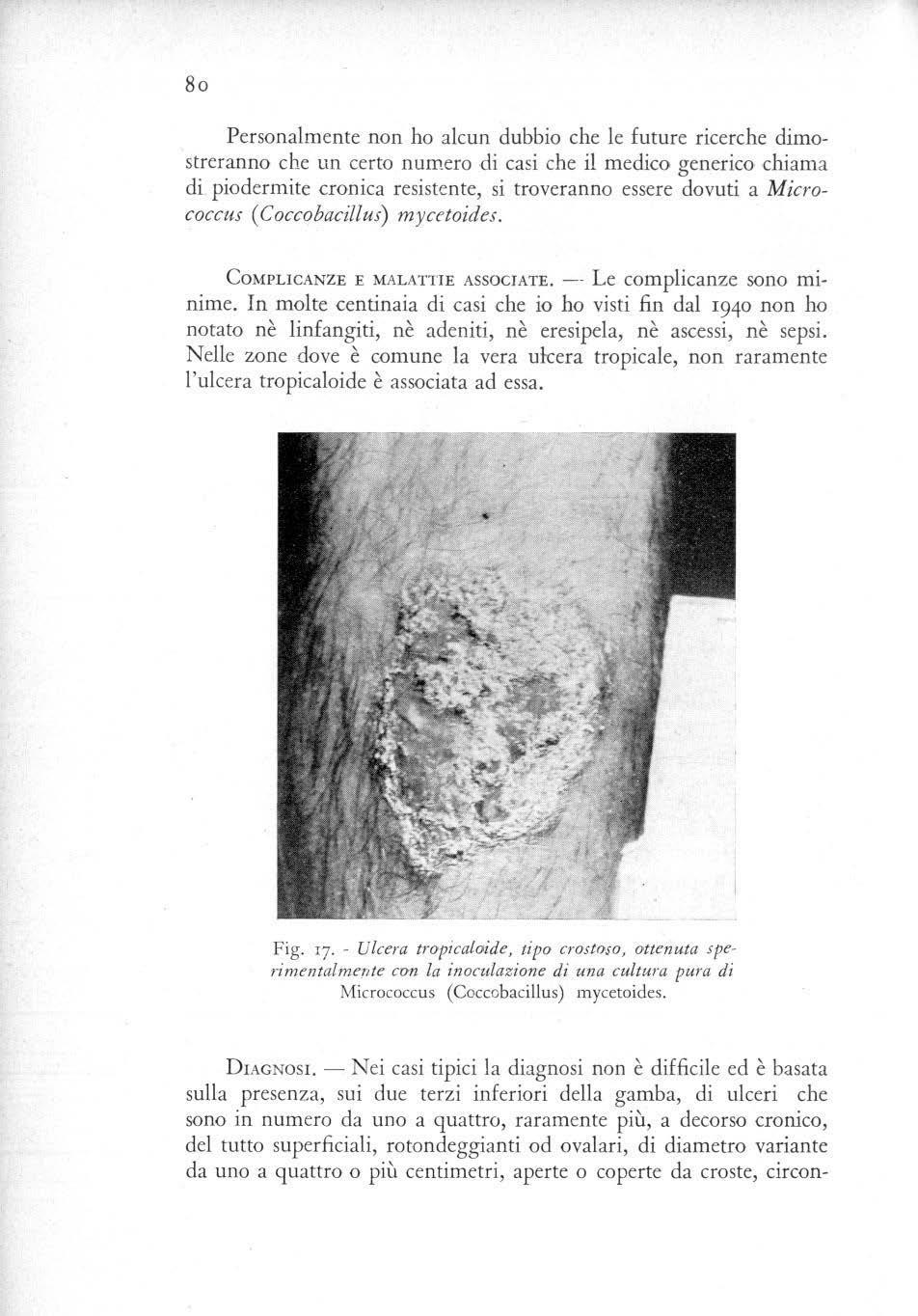

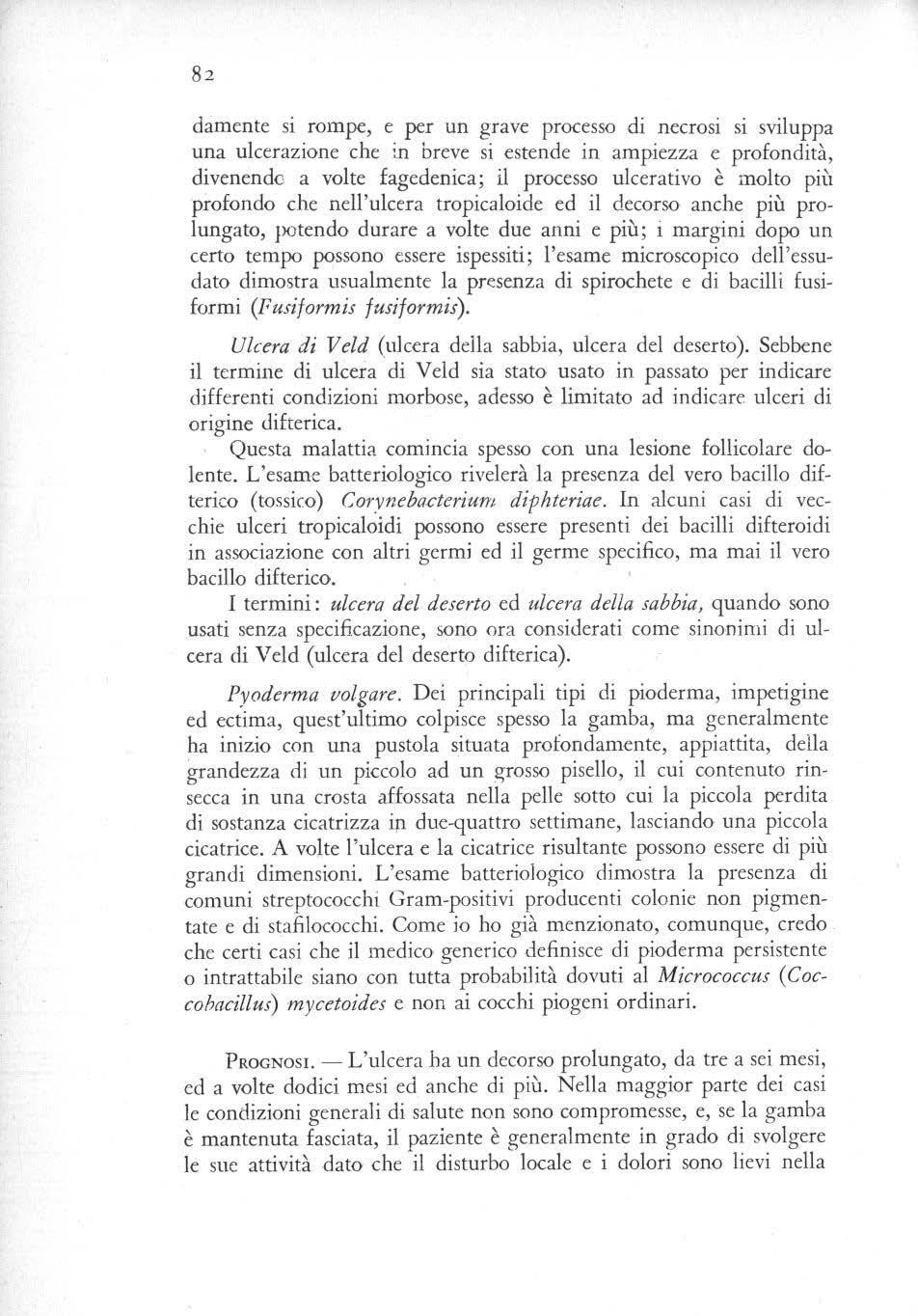
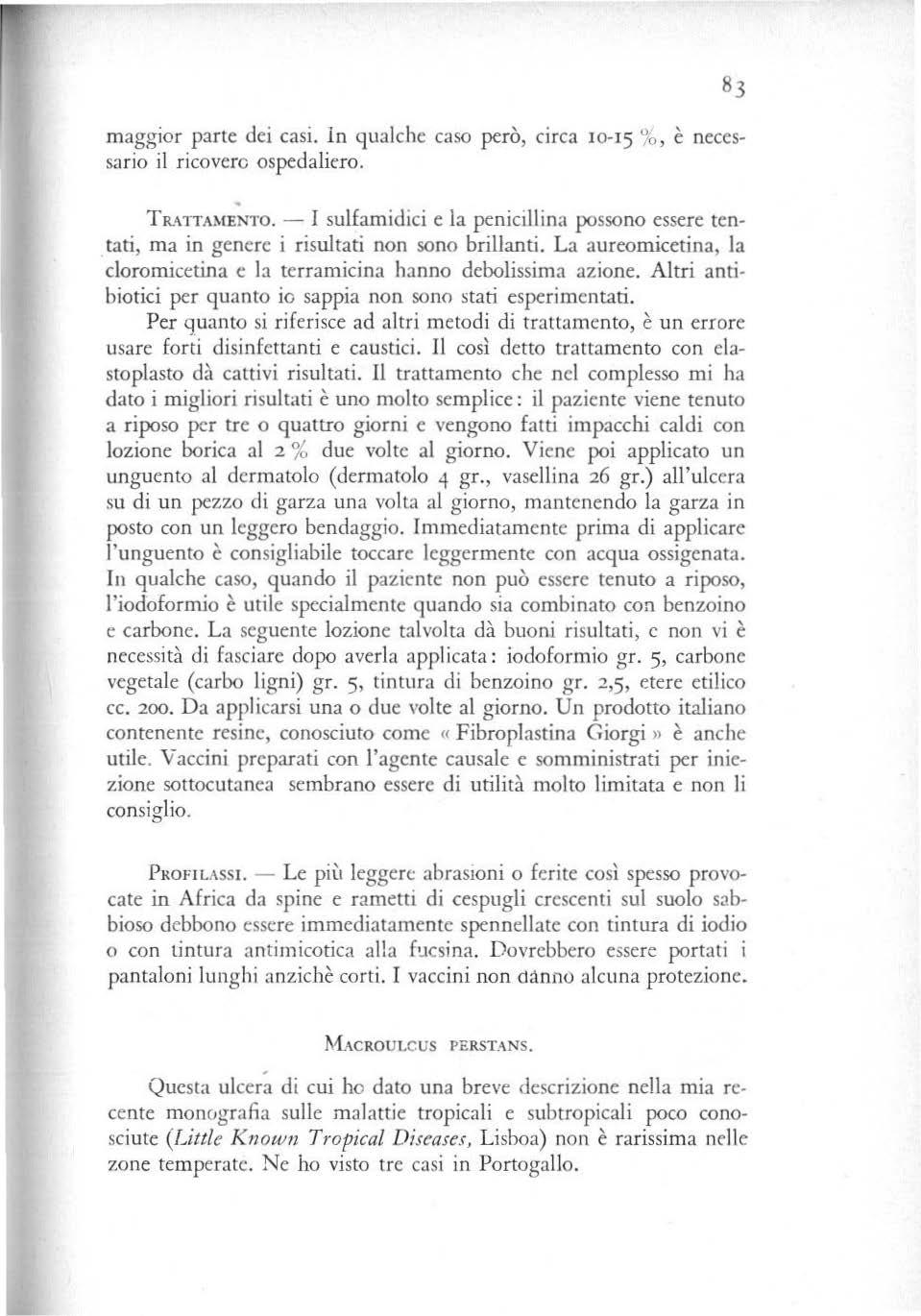
 Fig. 19. - Macroulcus
Fig. 19. - Macroulcus
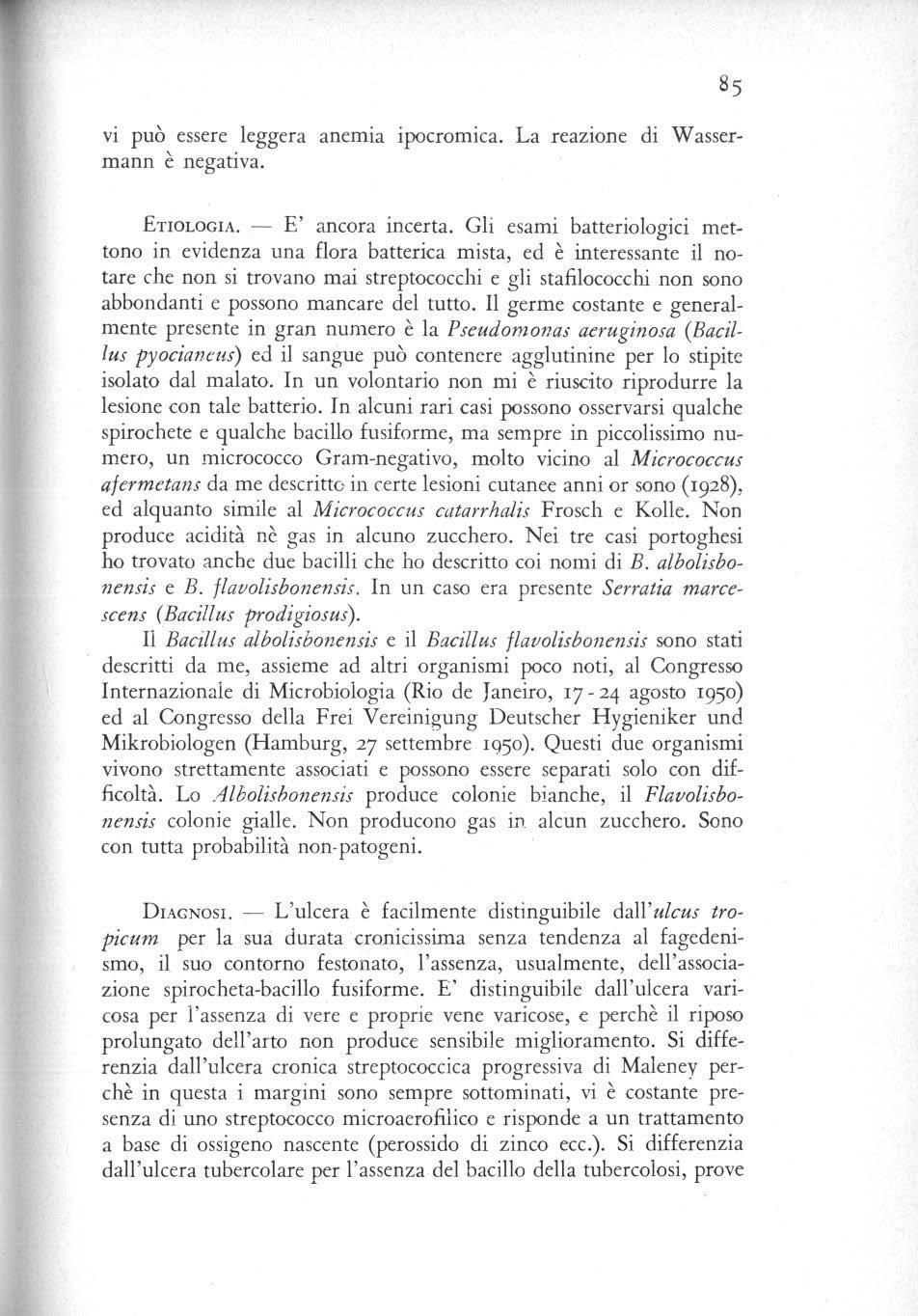
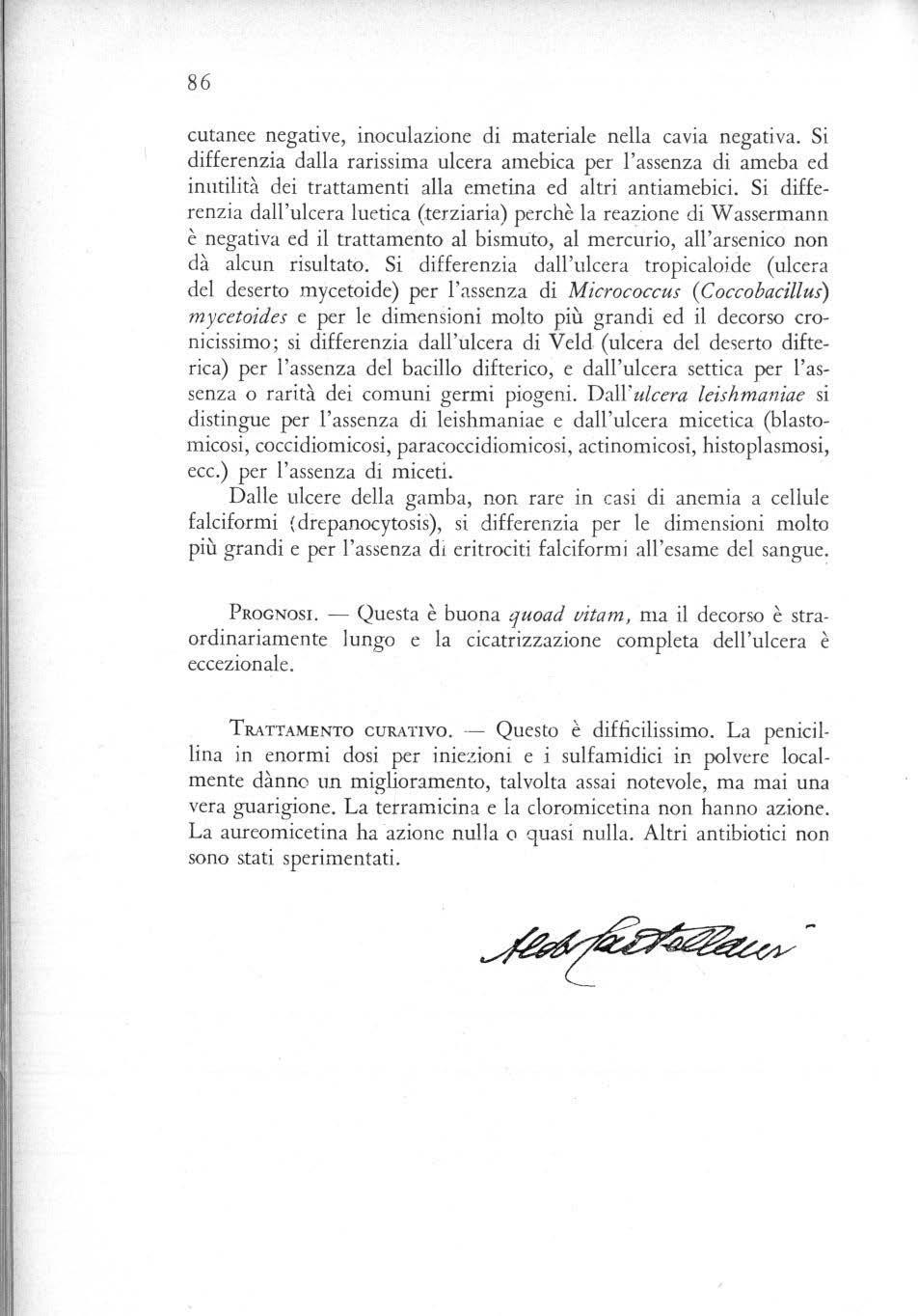
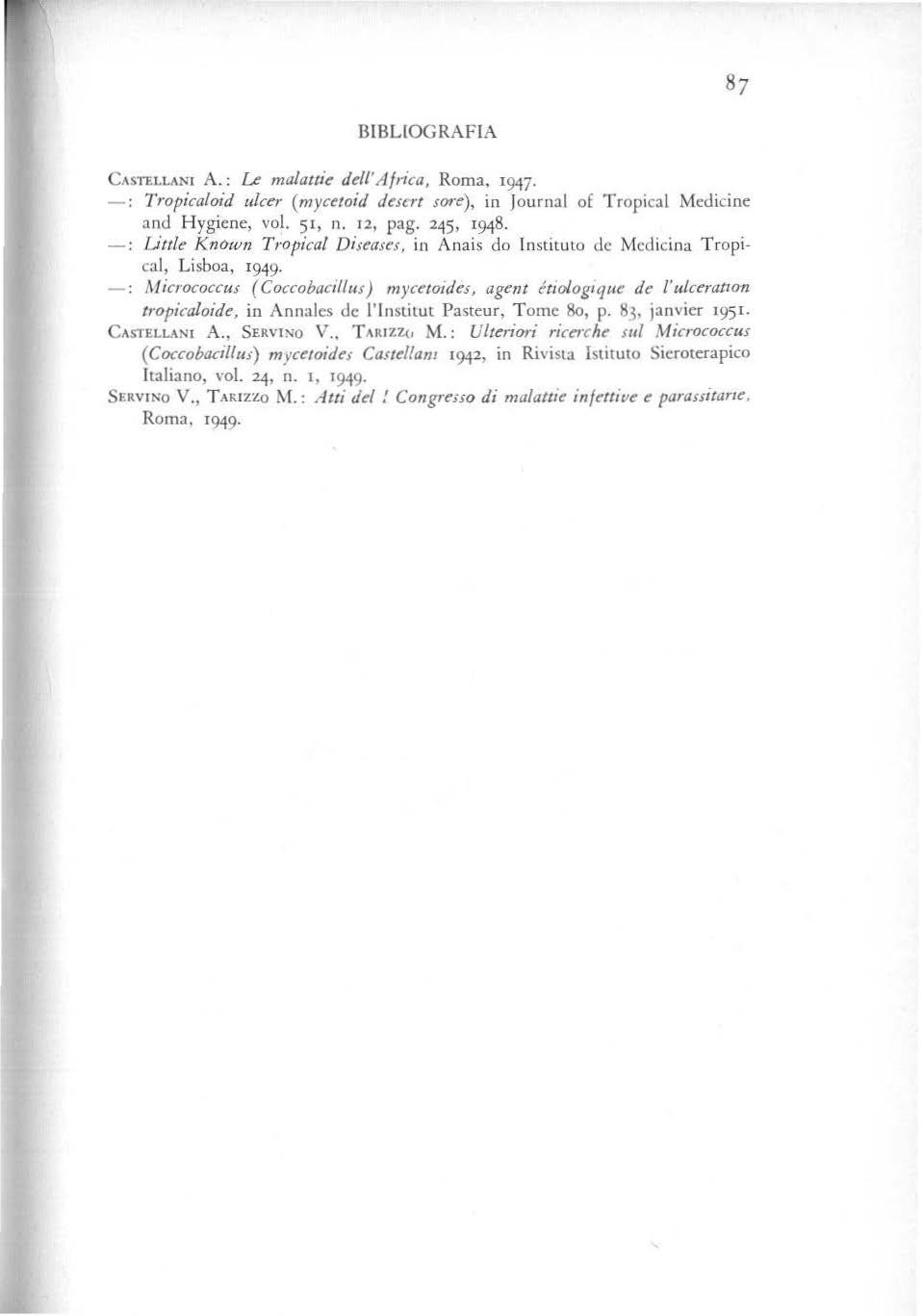
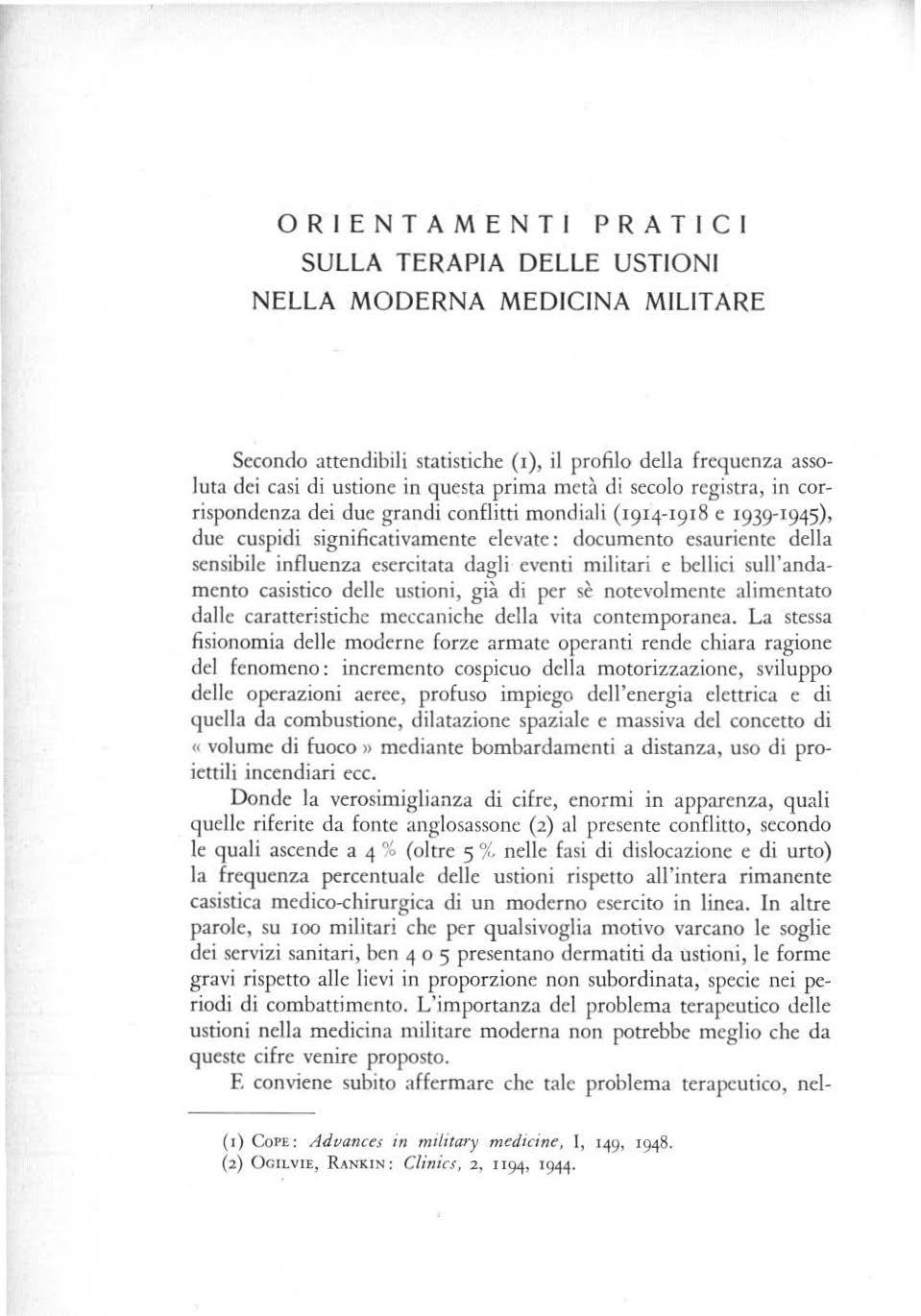
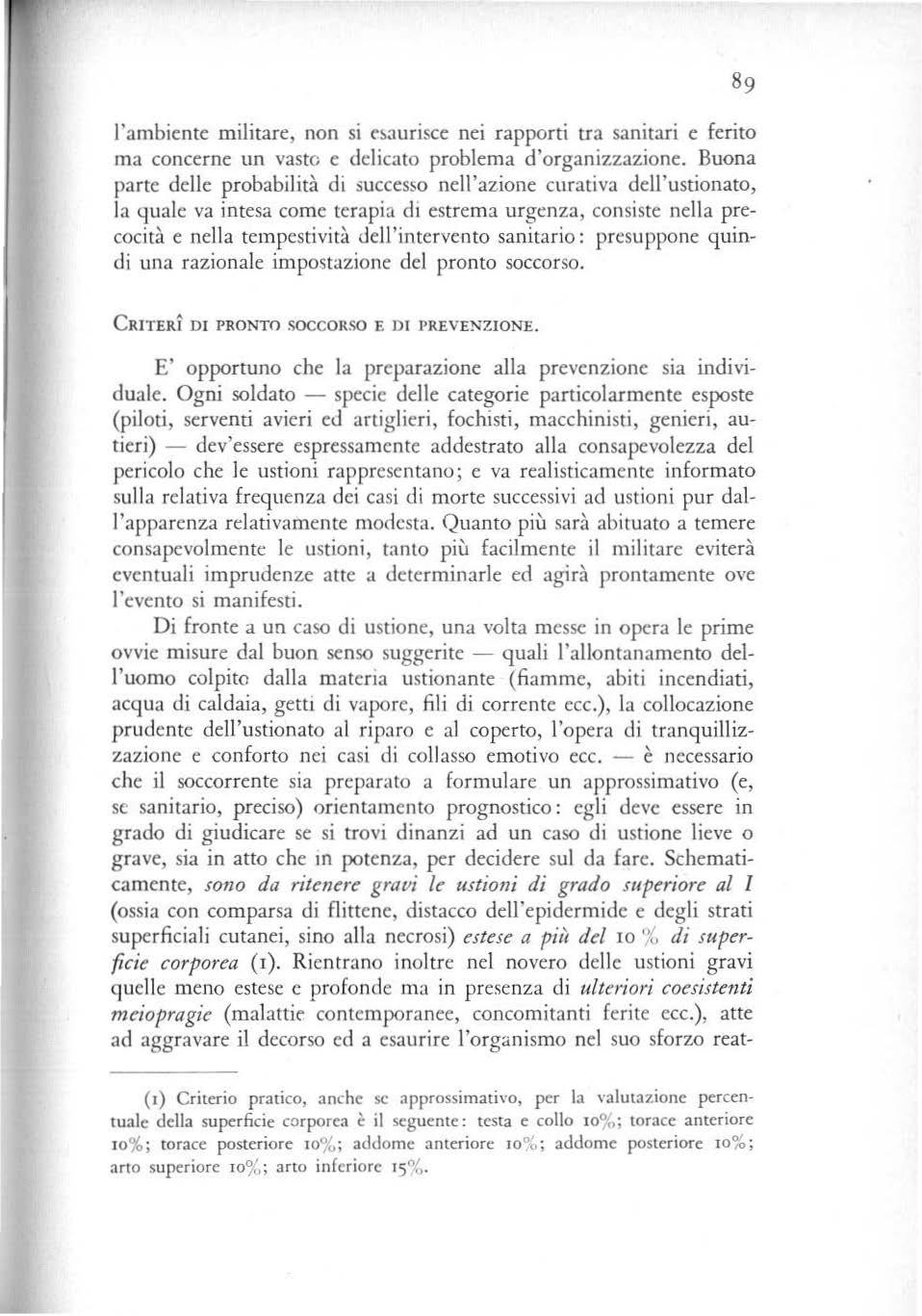
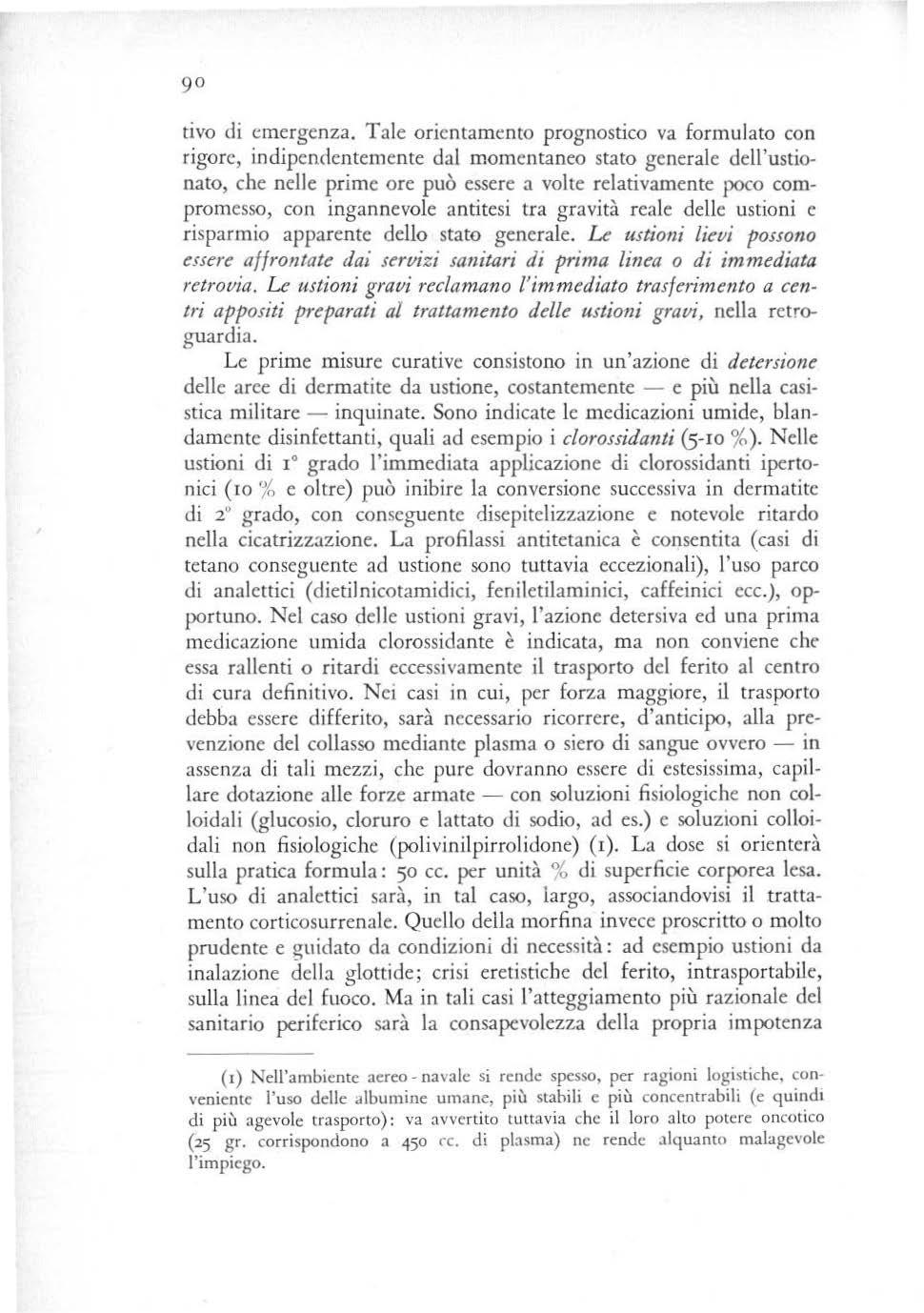
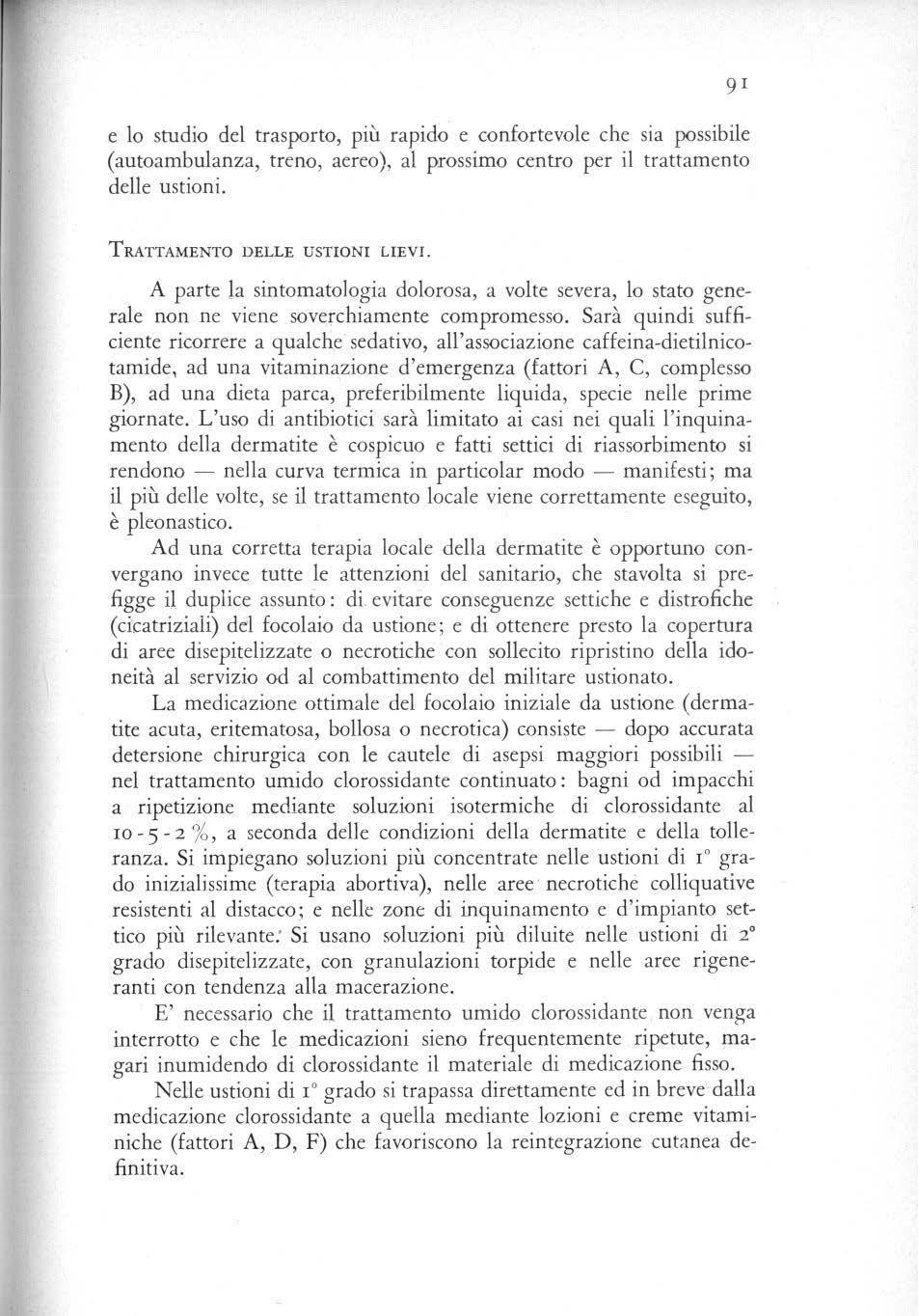
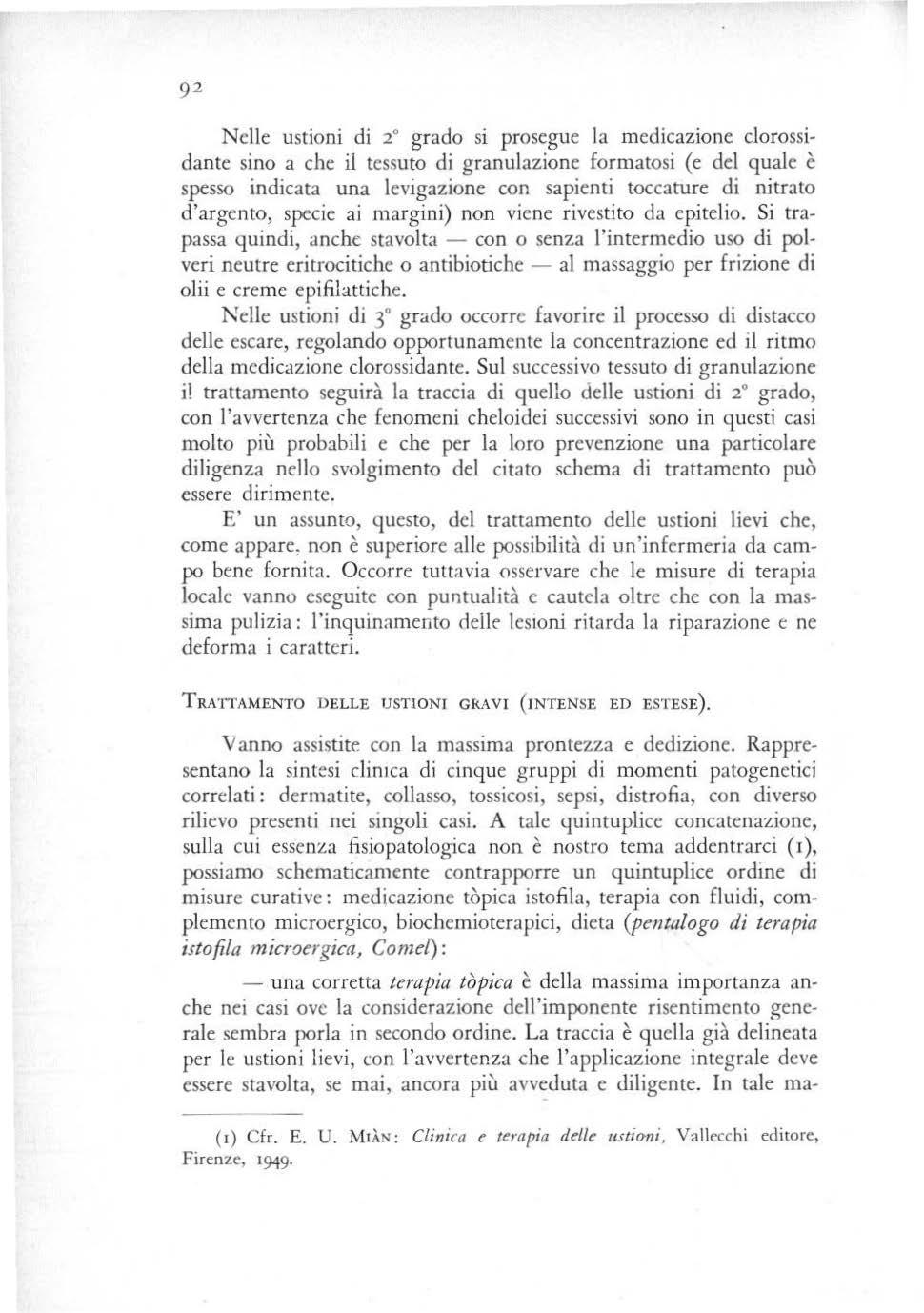

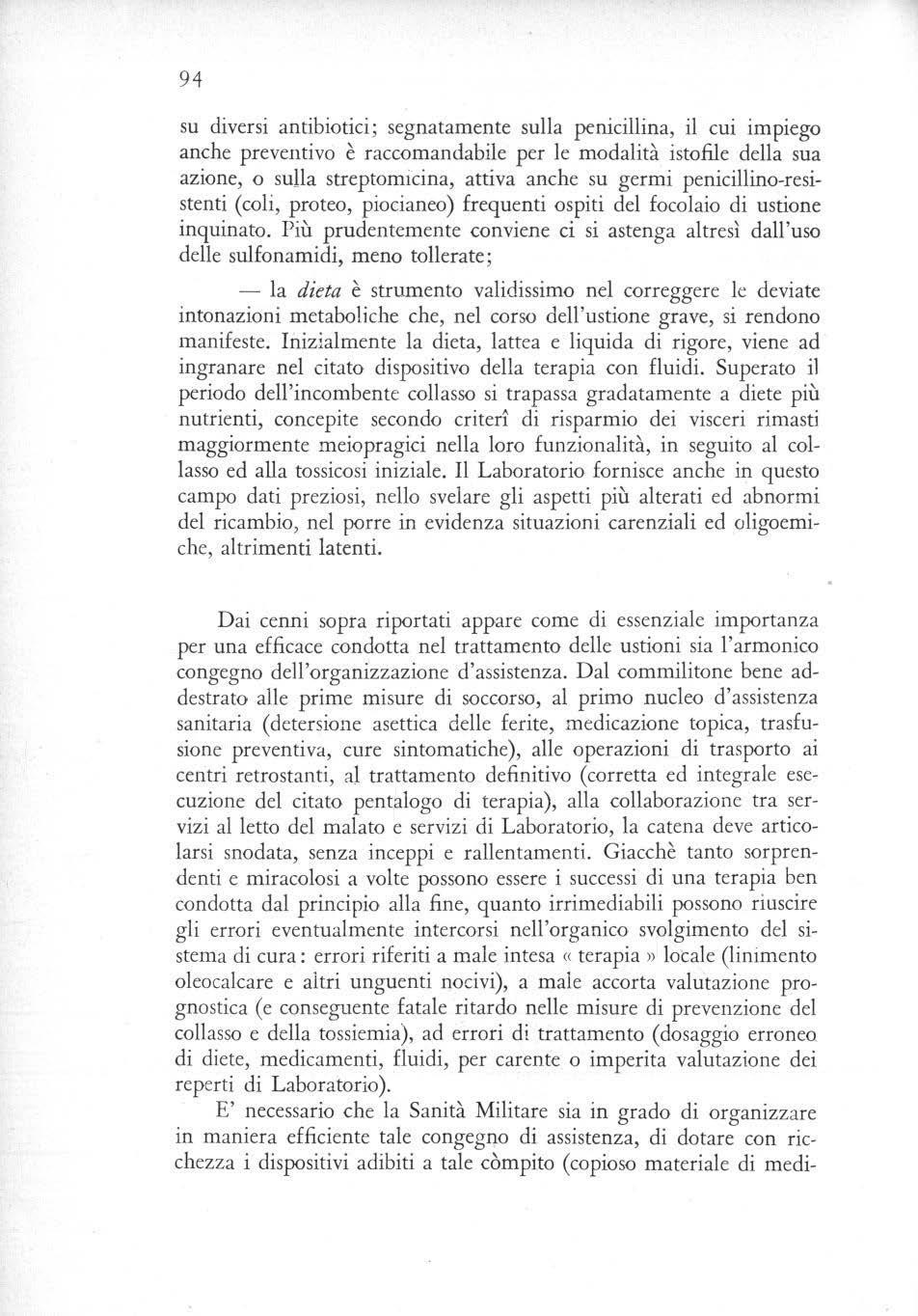
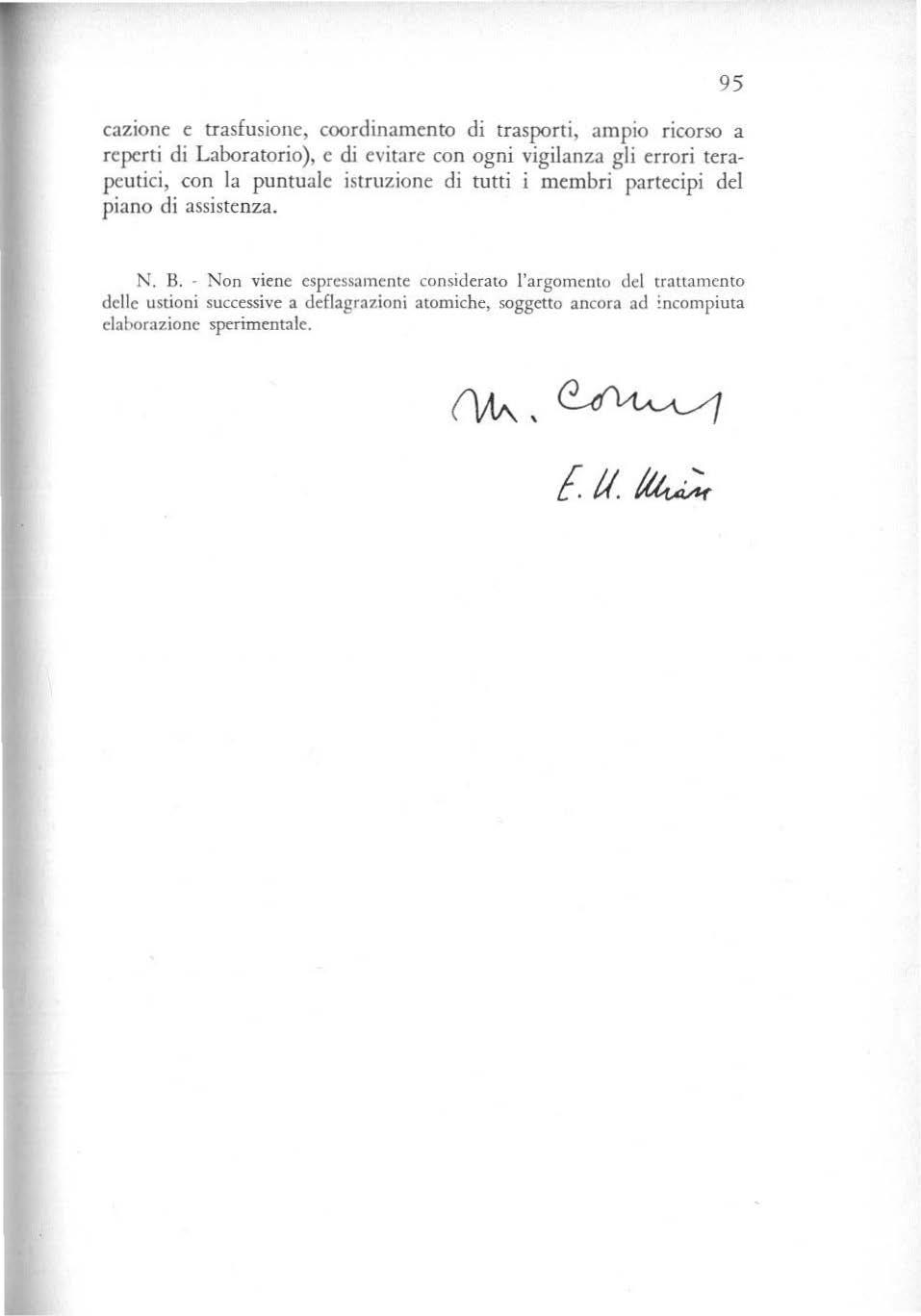



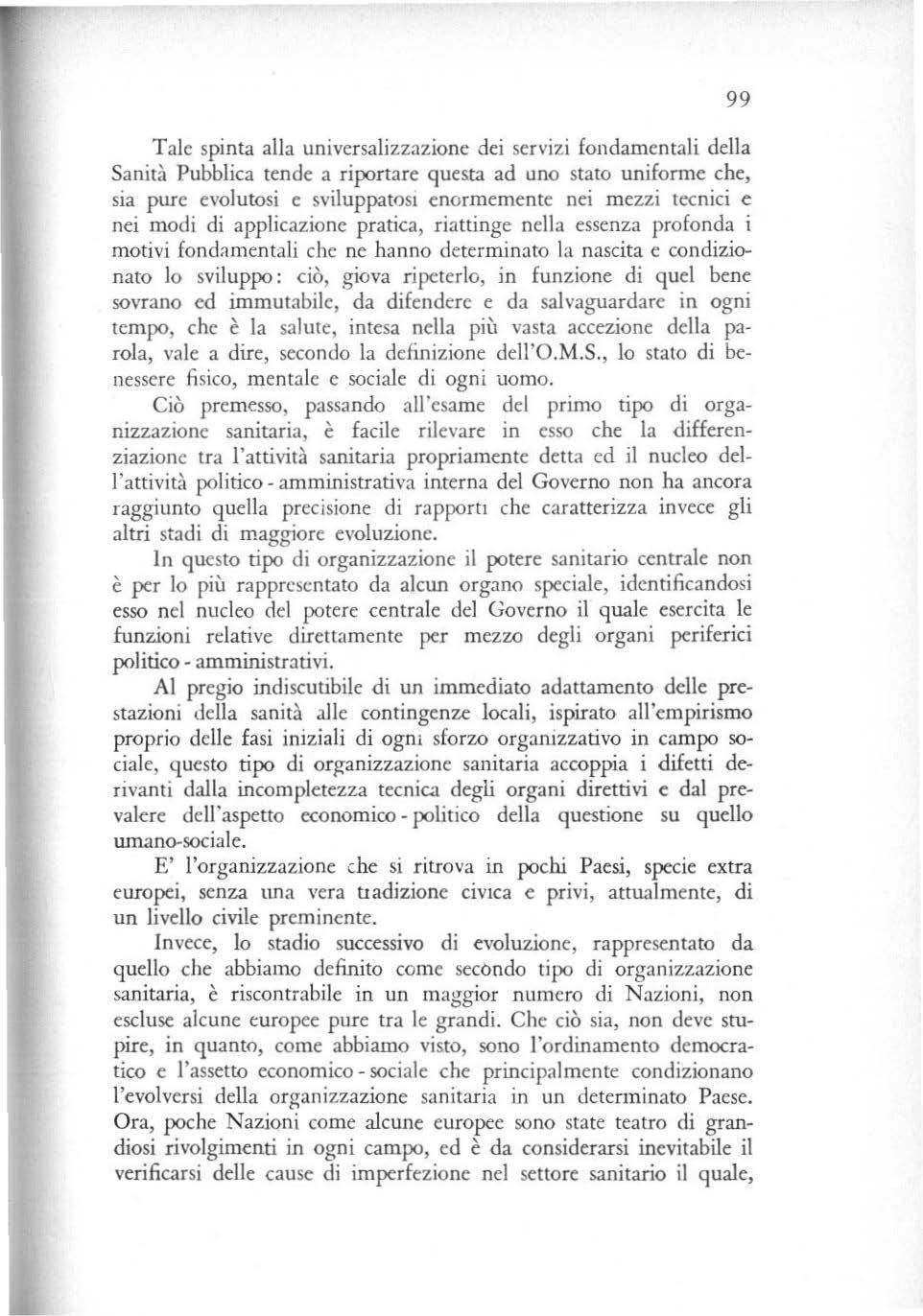

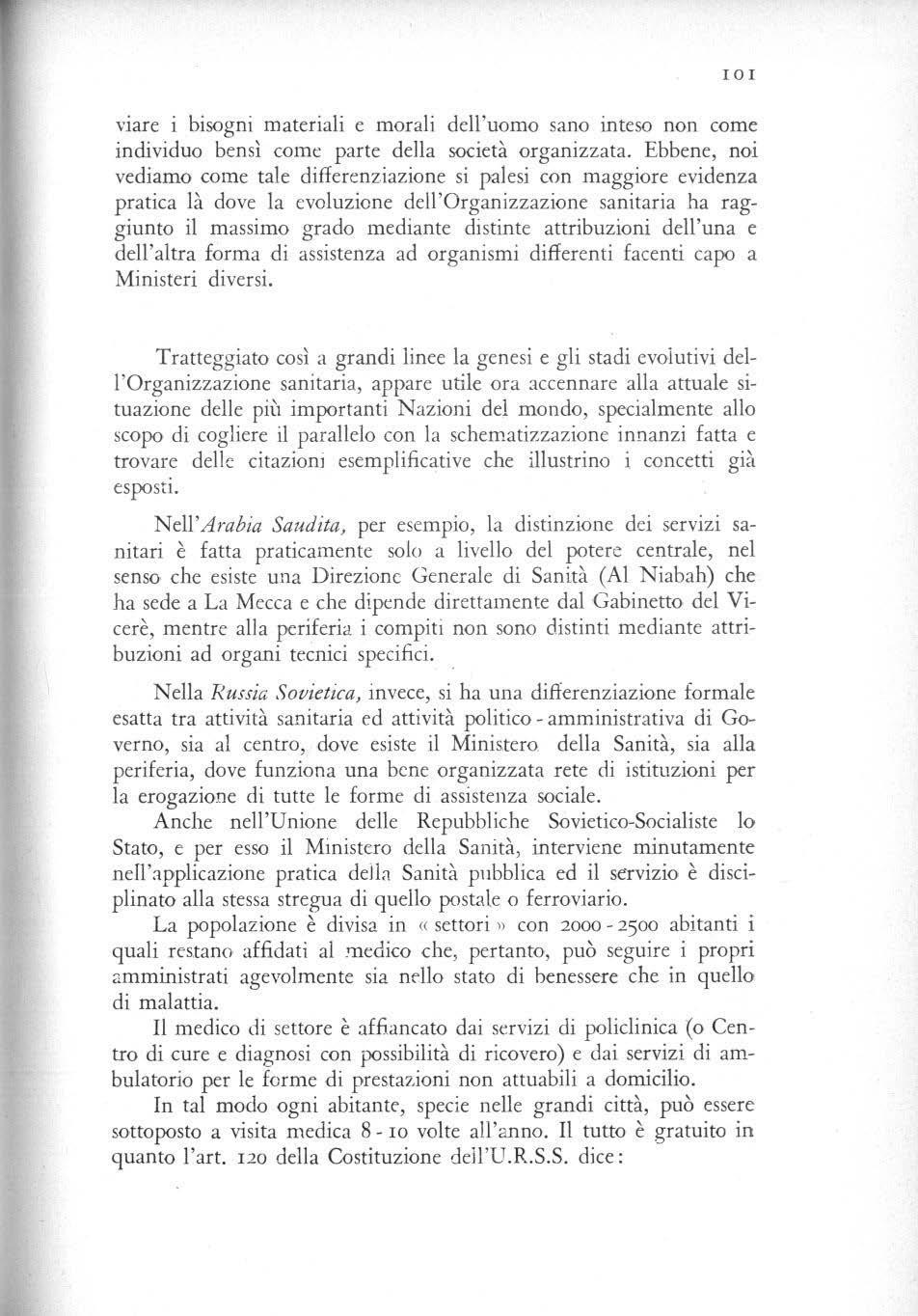
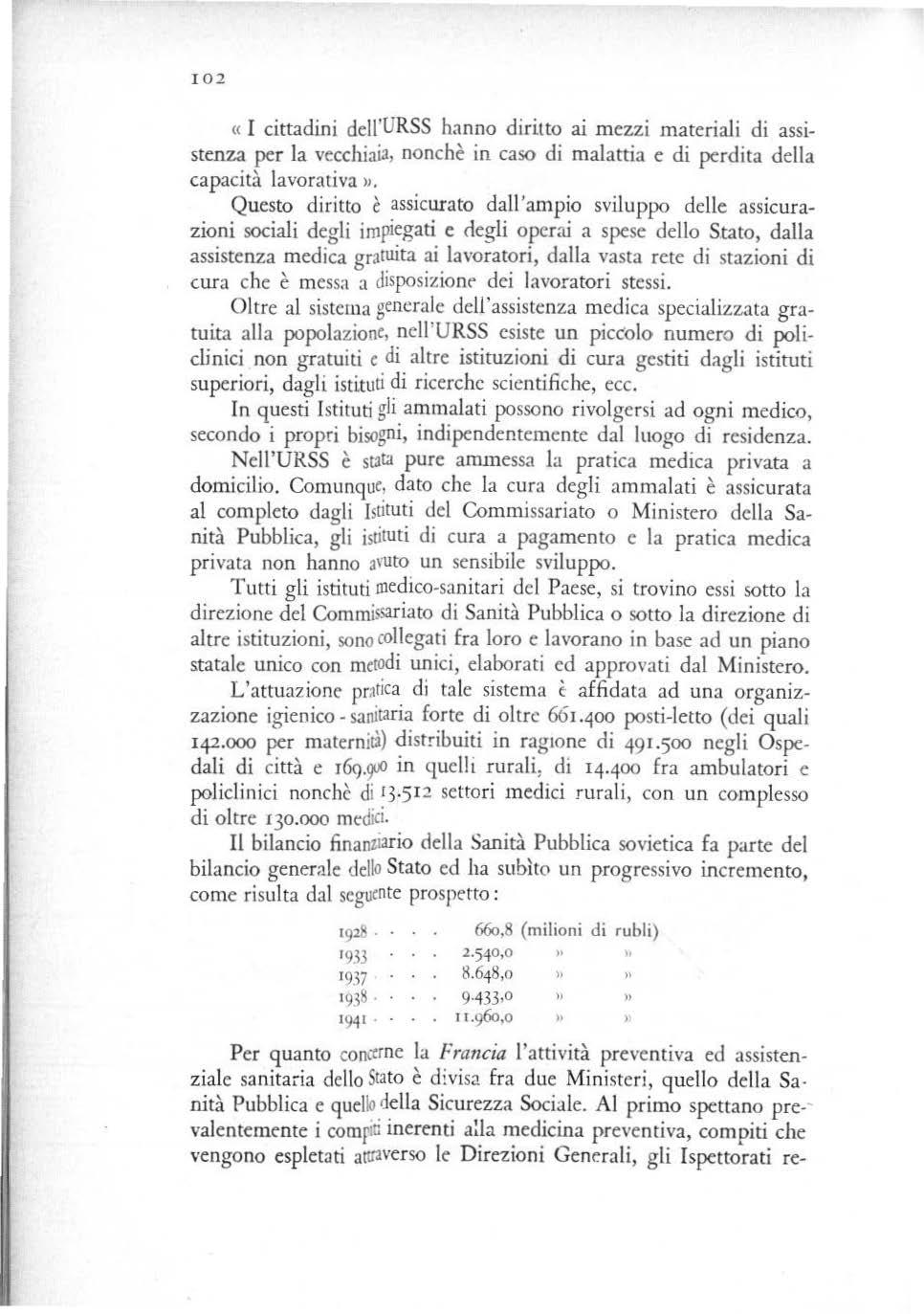
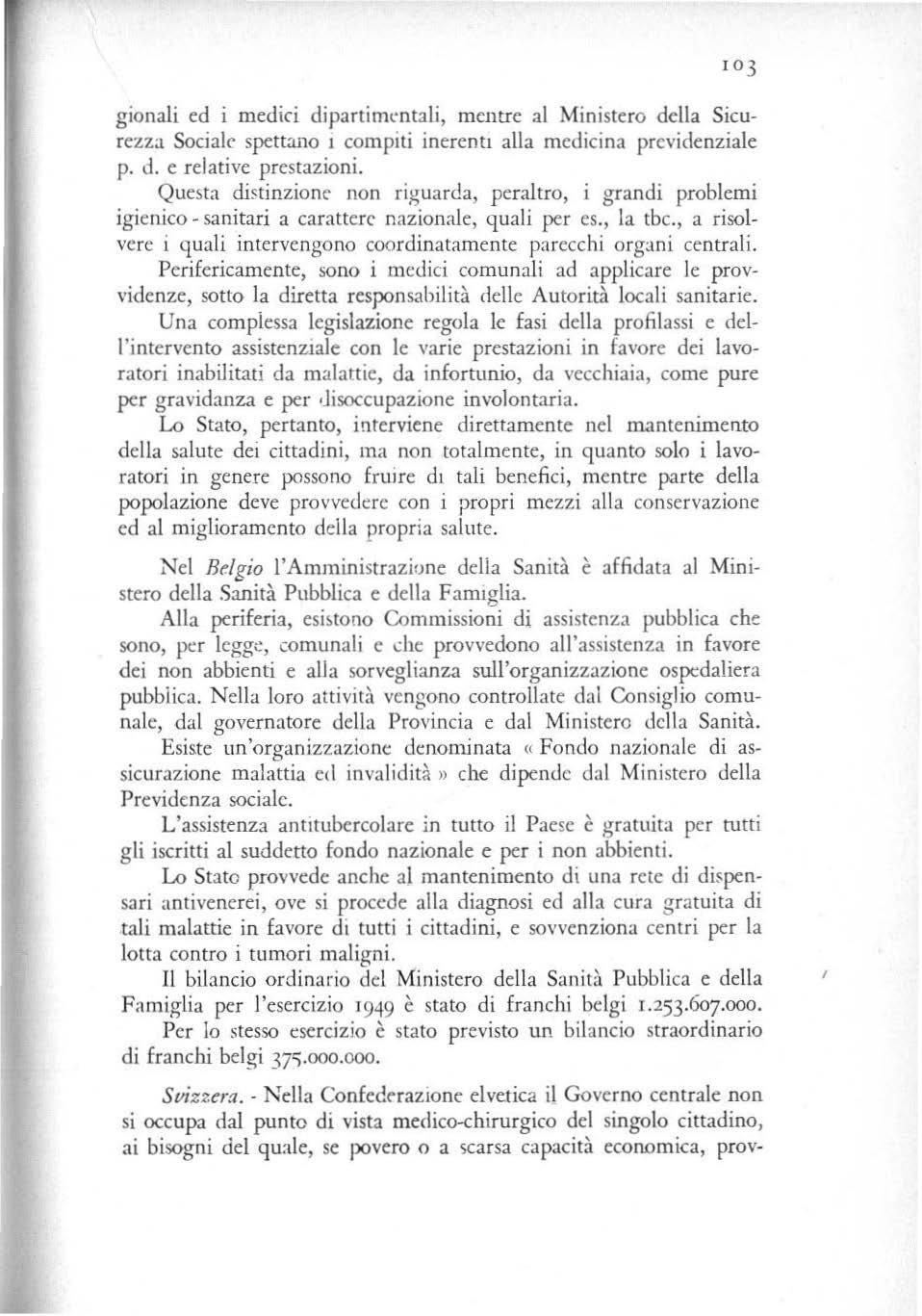
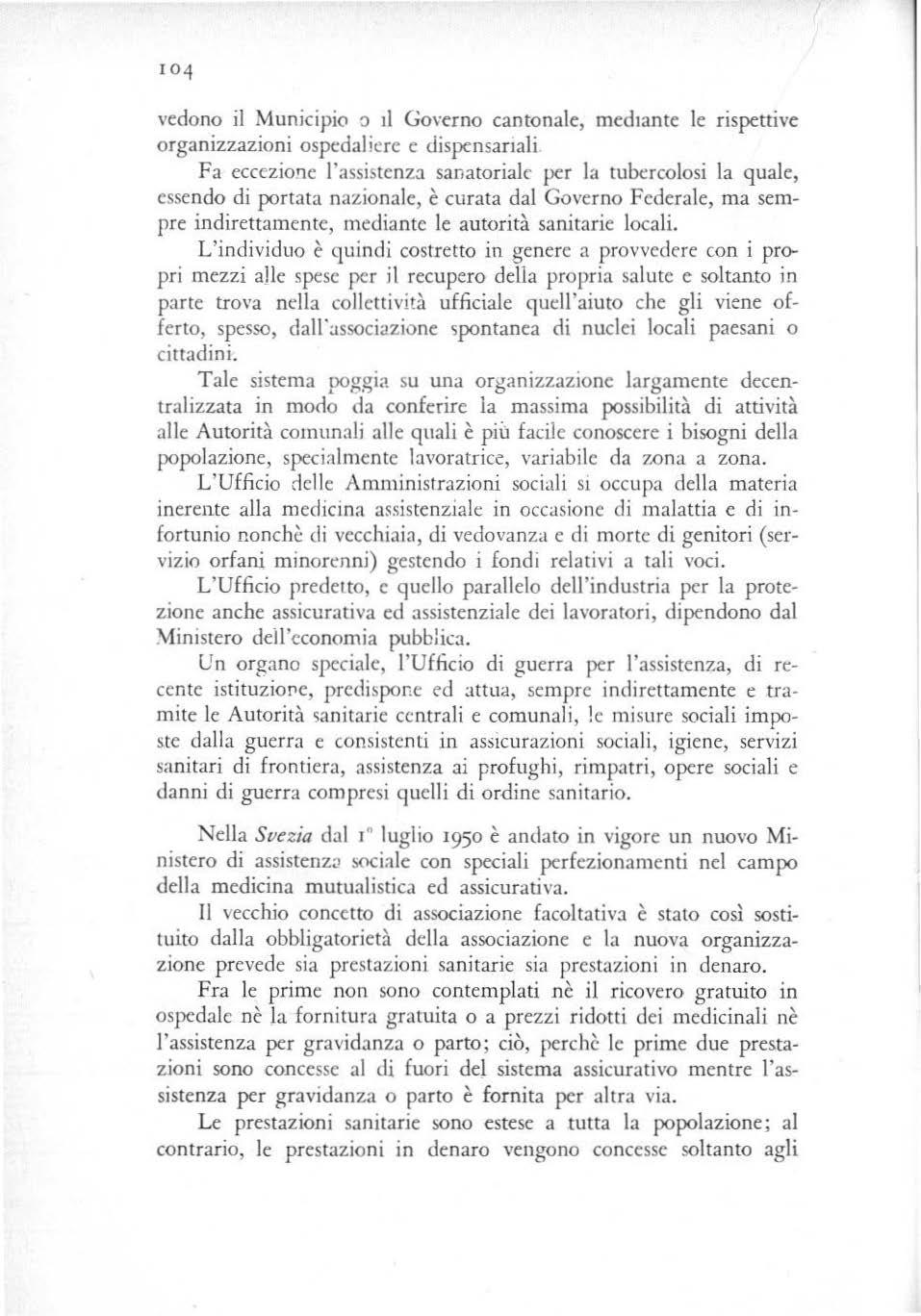
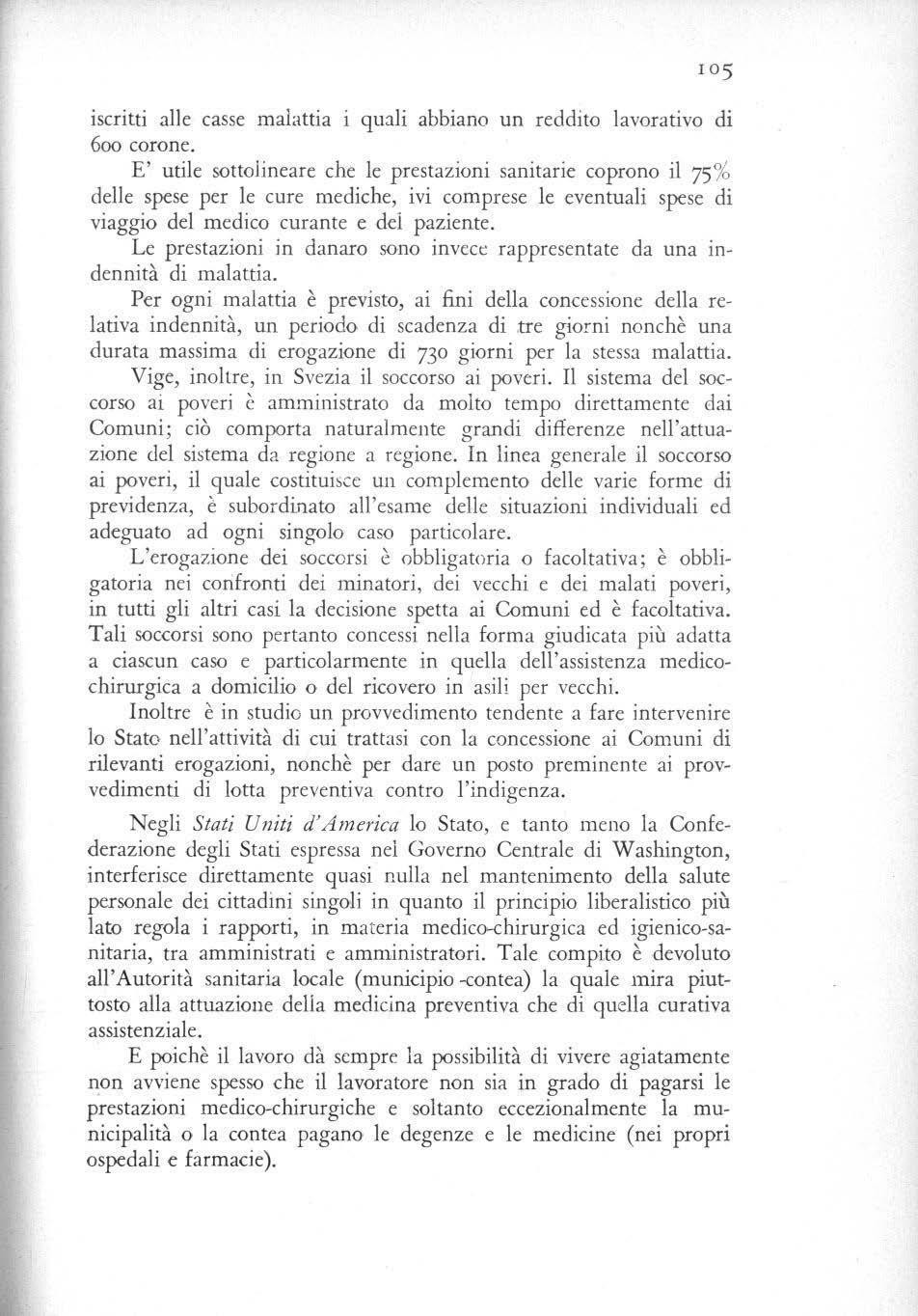
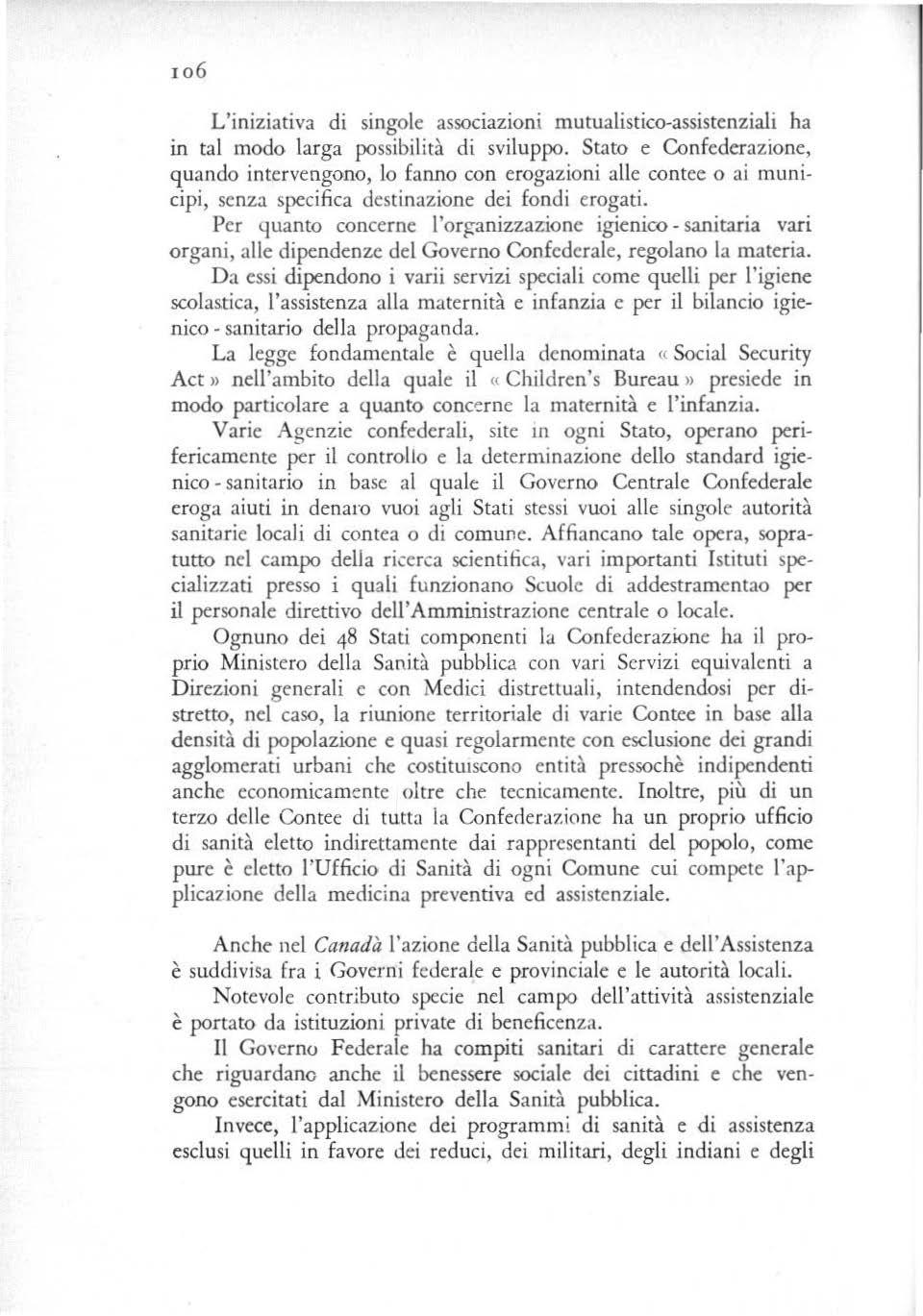


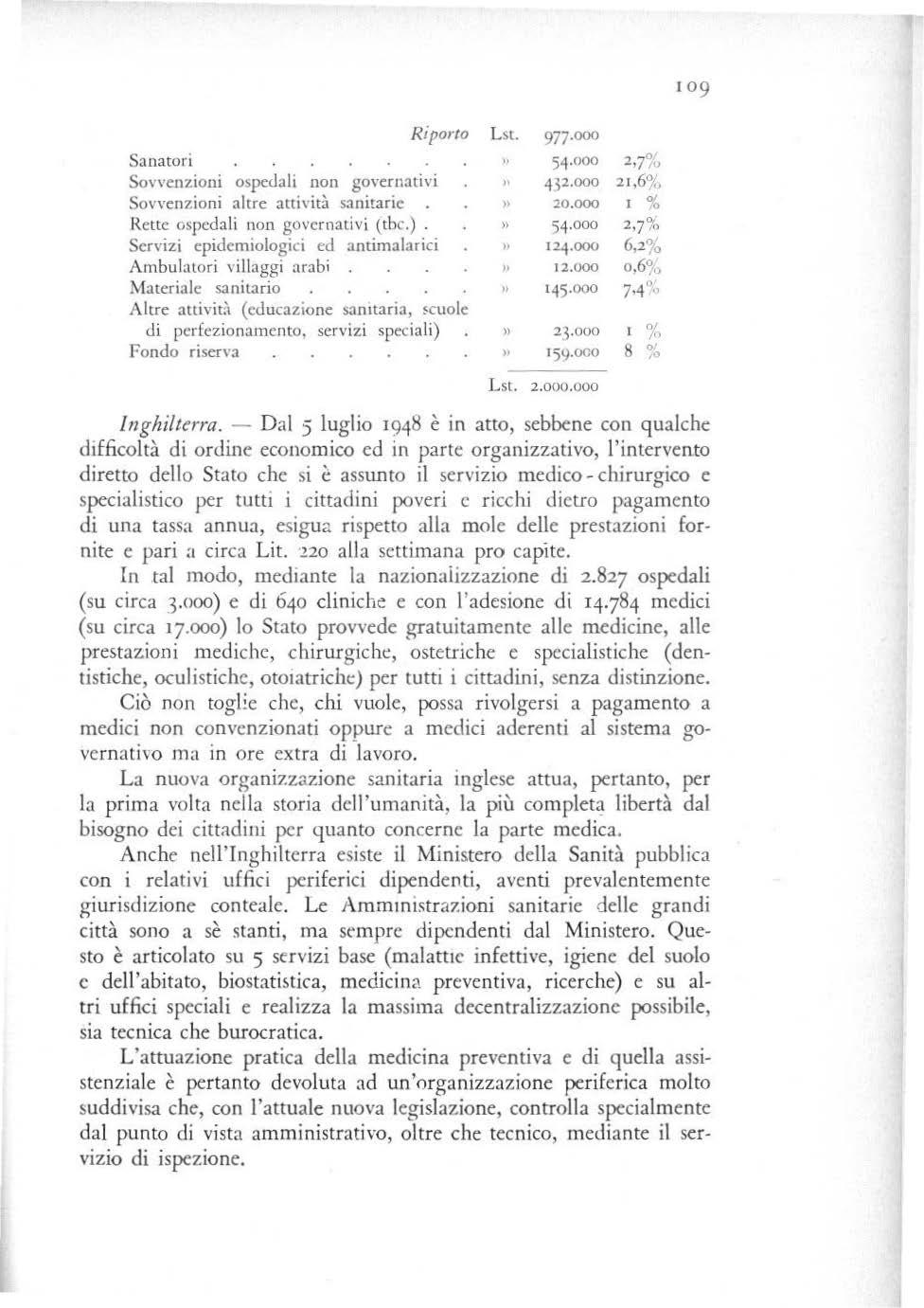
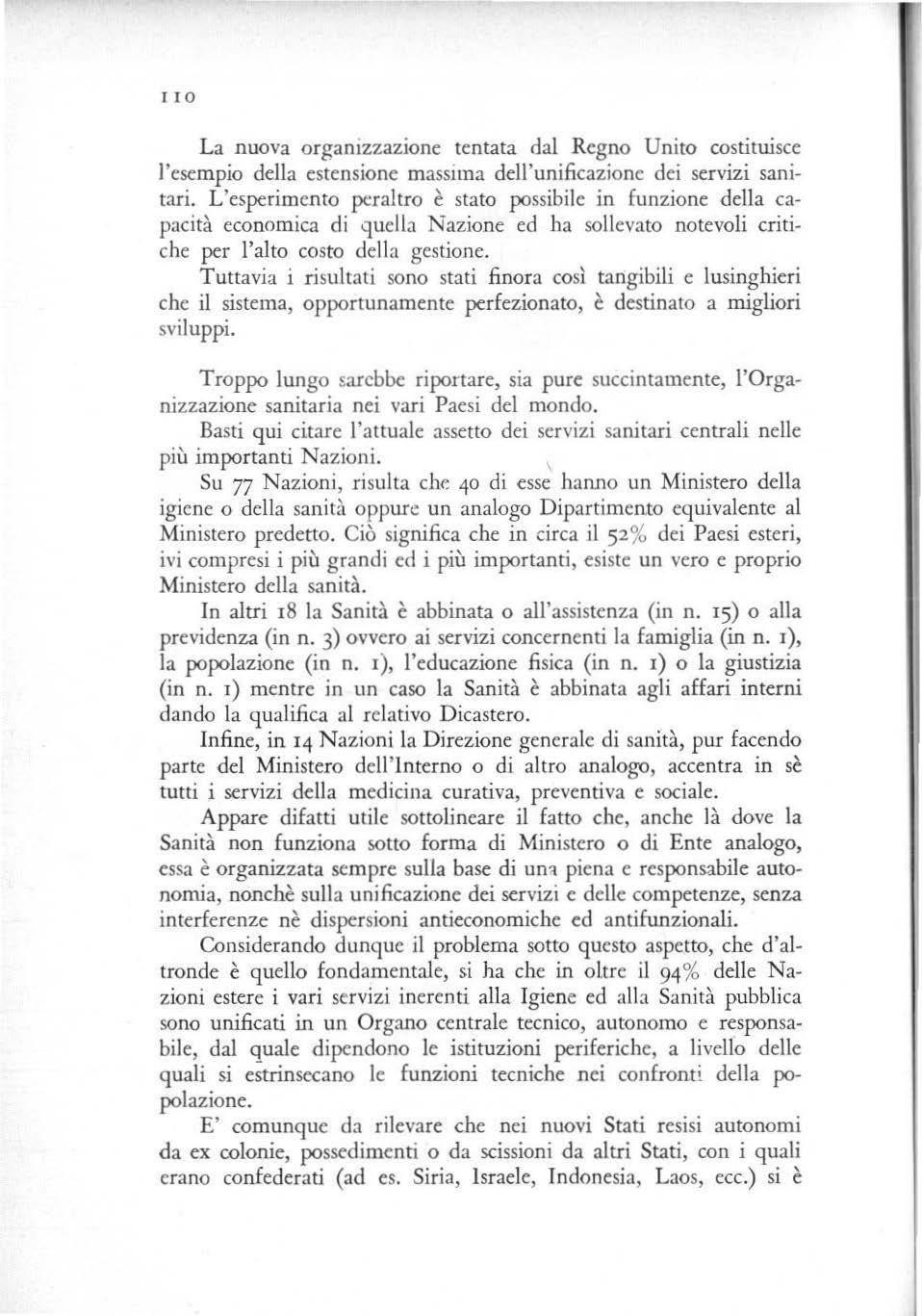
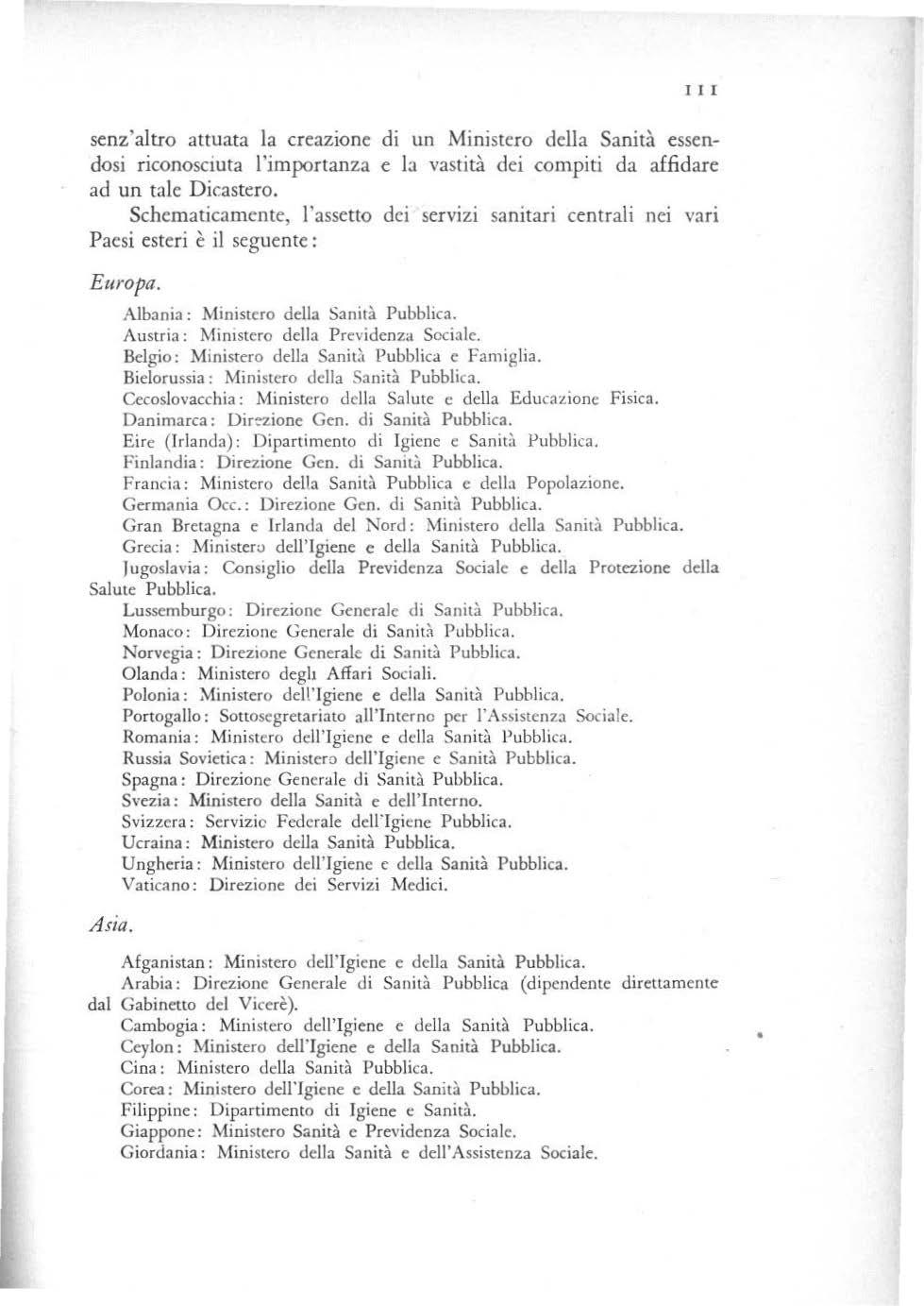

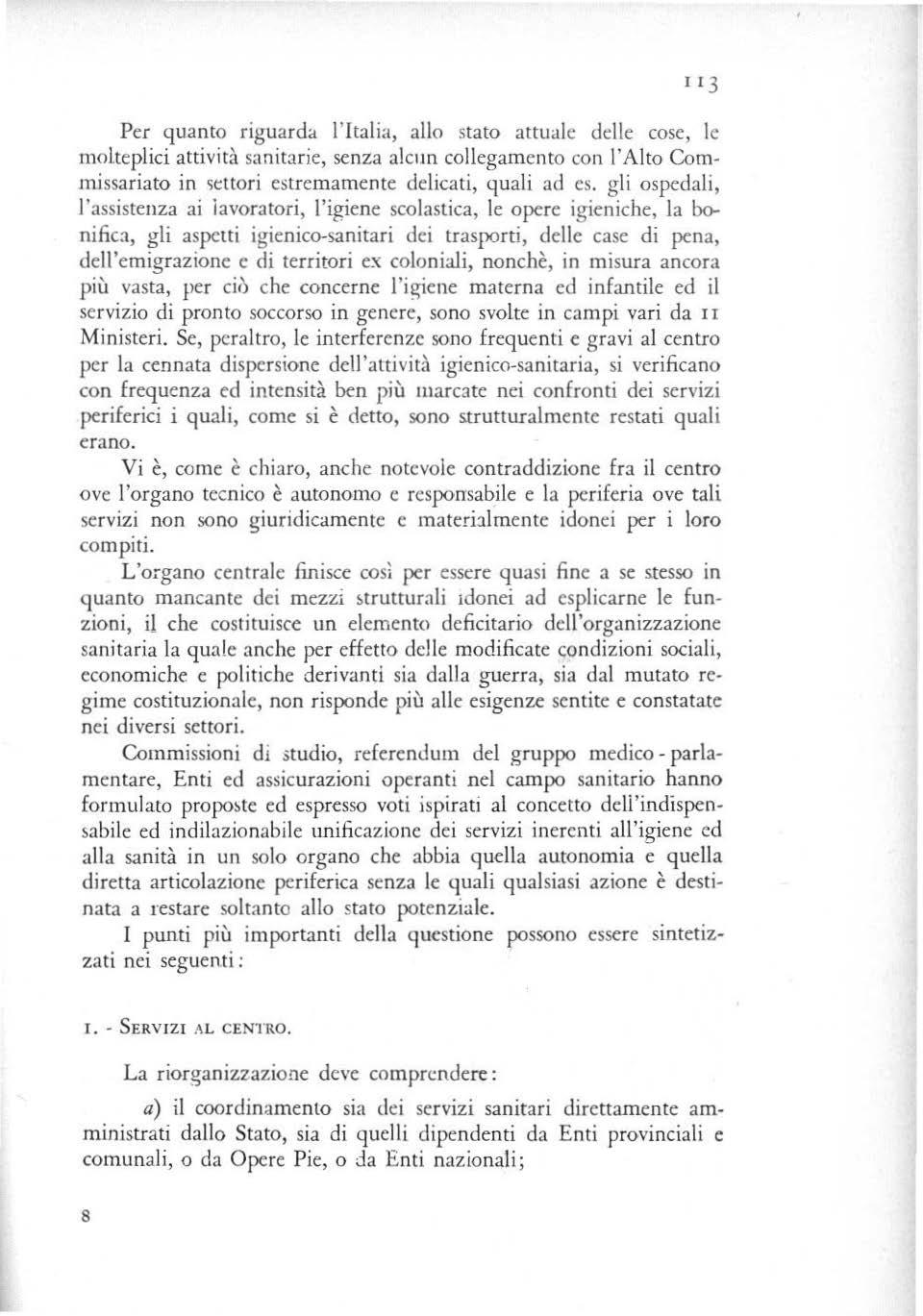



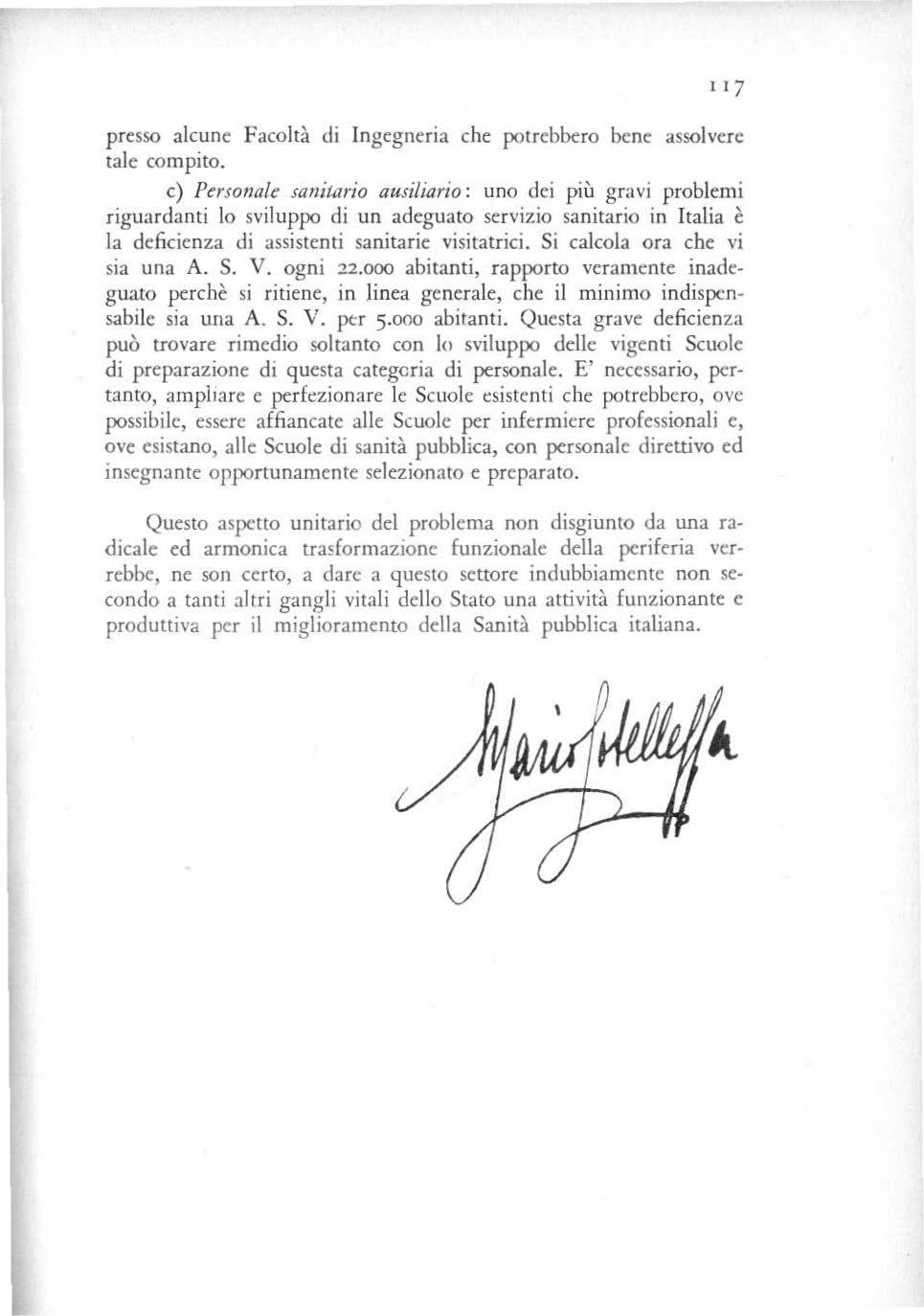



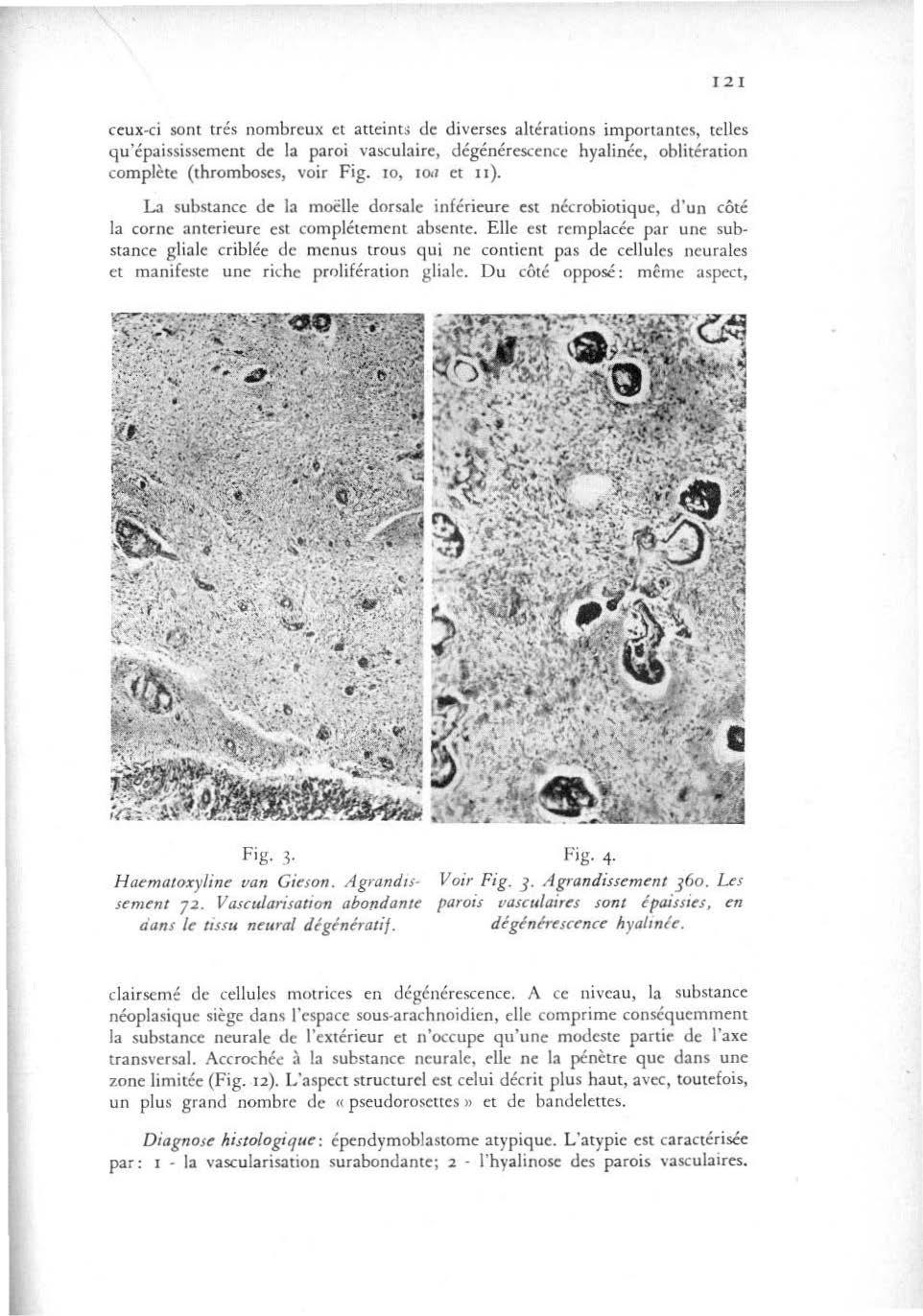

 Fig. 6. Haem at oxylin'! van Gieson. Agrandwement 72. Cystej séreux, 11aisseaux aux parois dans la substance tumorale.
Fig. 6. Haem at oxylin'! van Gieson. Agrandwement 72. Cystej séreux, 11aisseaux aux parois dans la substance tumorale.
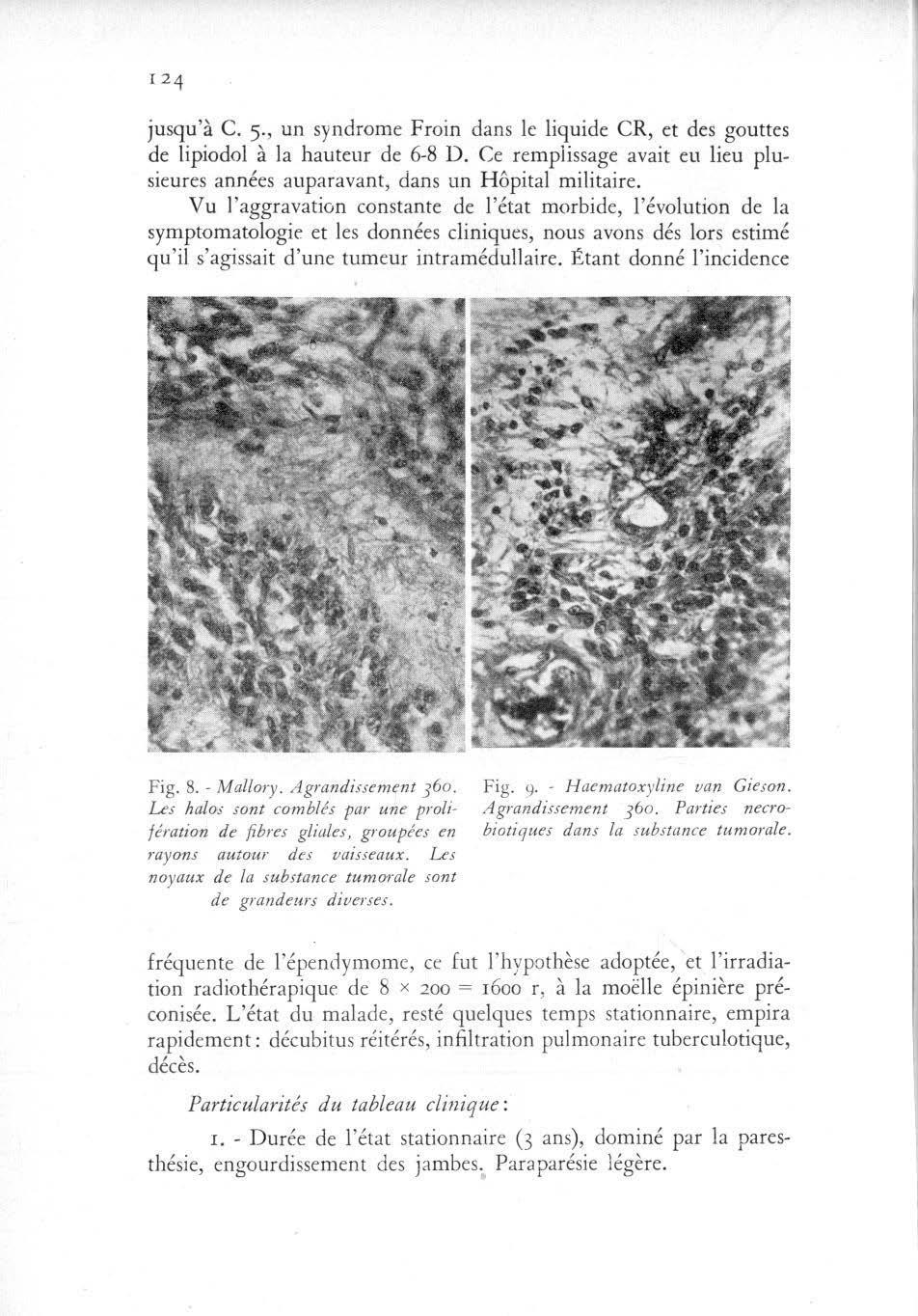
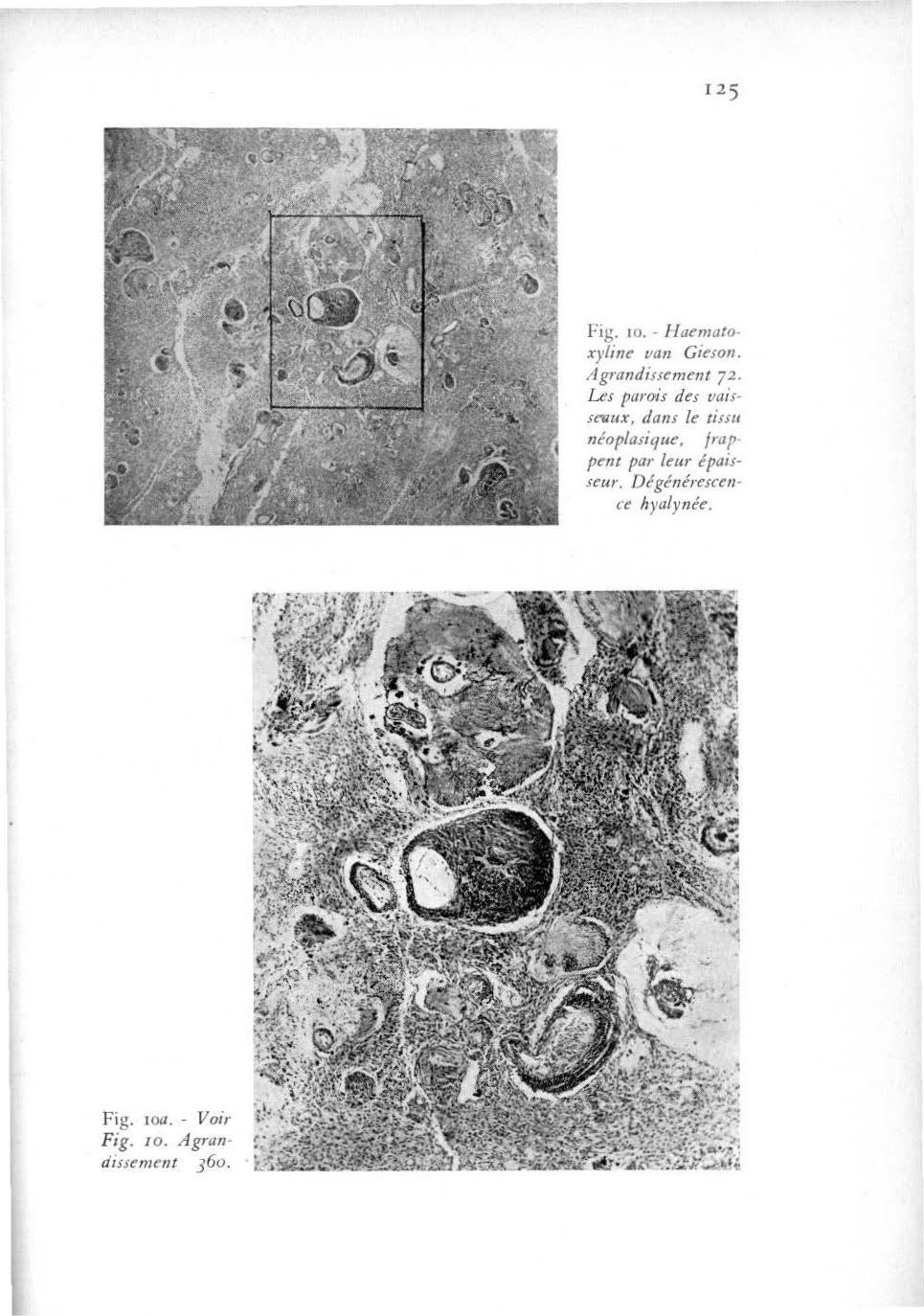 Fig. 10a. - Voir
Fig. 10. Agrandisse ment 360.
Fig. 10. - l laemuto xrlim: van Gieson. Agmndisscment 72. Les paroù des vaiisC'flux, dans le tissu néoplasique, frar pent par leur épaisscur. Dégénérescena h yaly née.
Fig. 10a. - Voir
Fig. 10. Agrandisse ment 360.
Fig. 10. - l laemuto xrlim: van Gieson. Agmndisscment 72. Les paroù des vaiisC'flux, dans le tissu néoplasique, frar pent par leur épaisscur. Dégénérescena h yaly née.


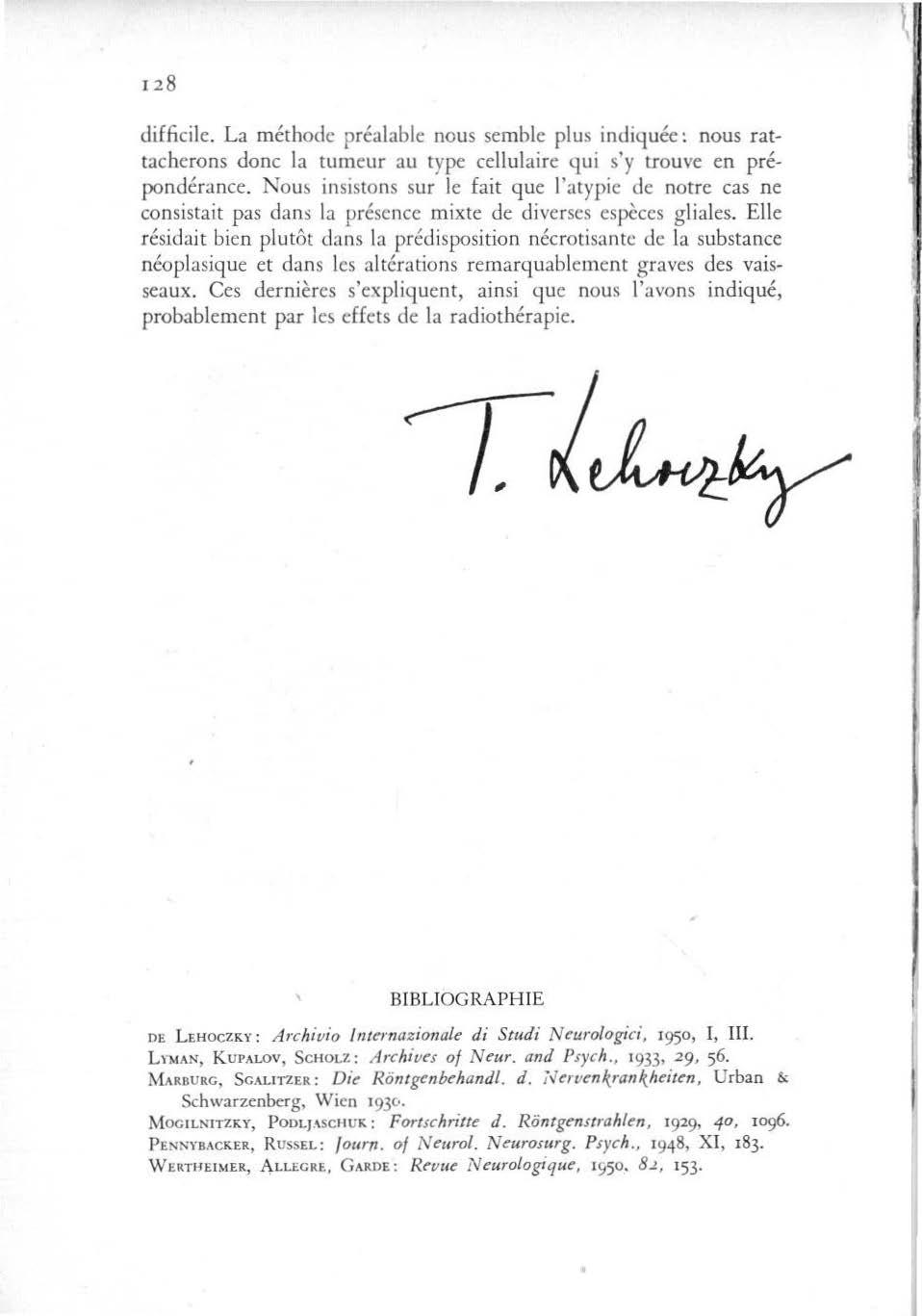
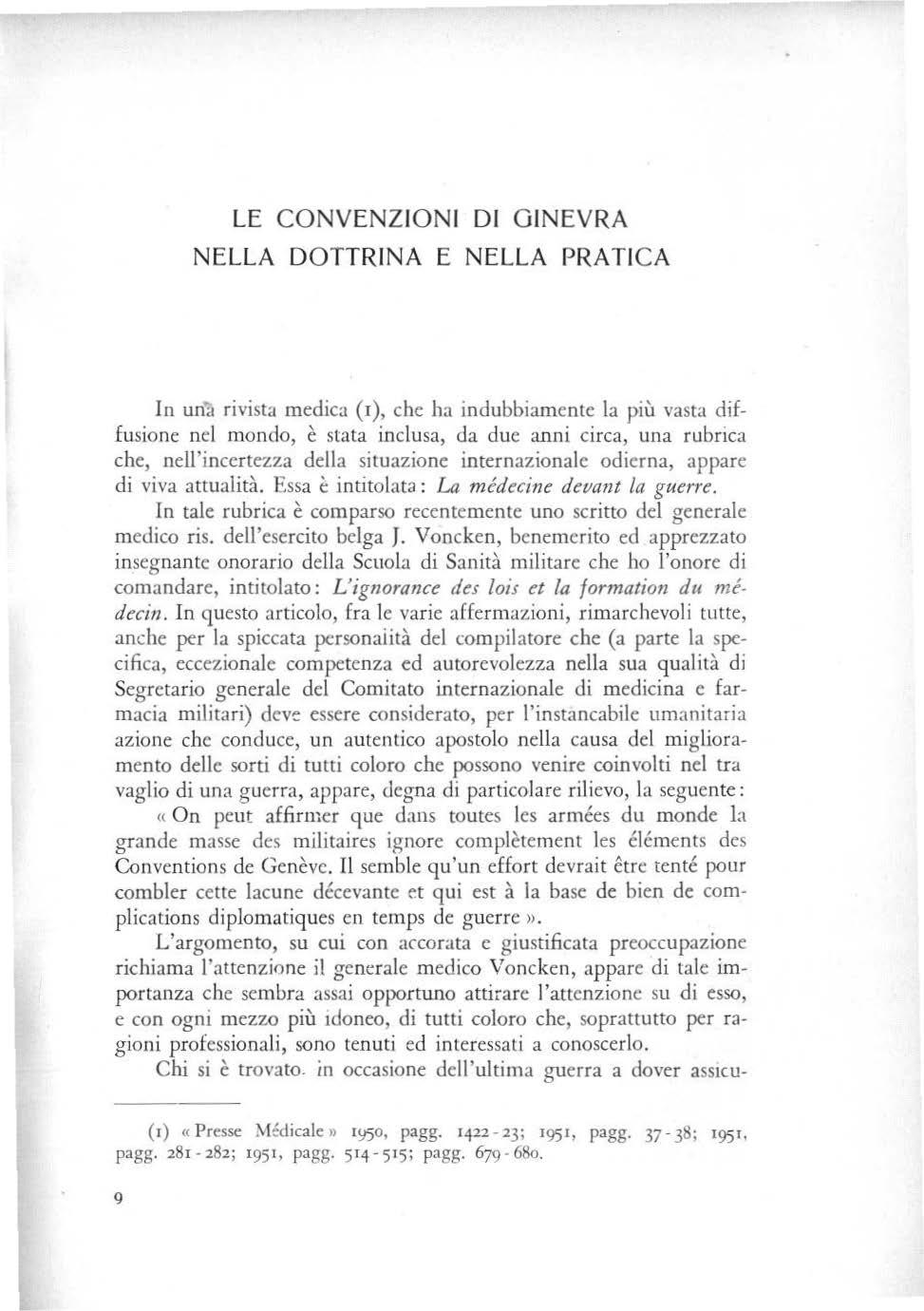
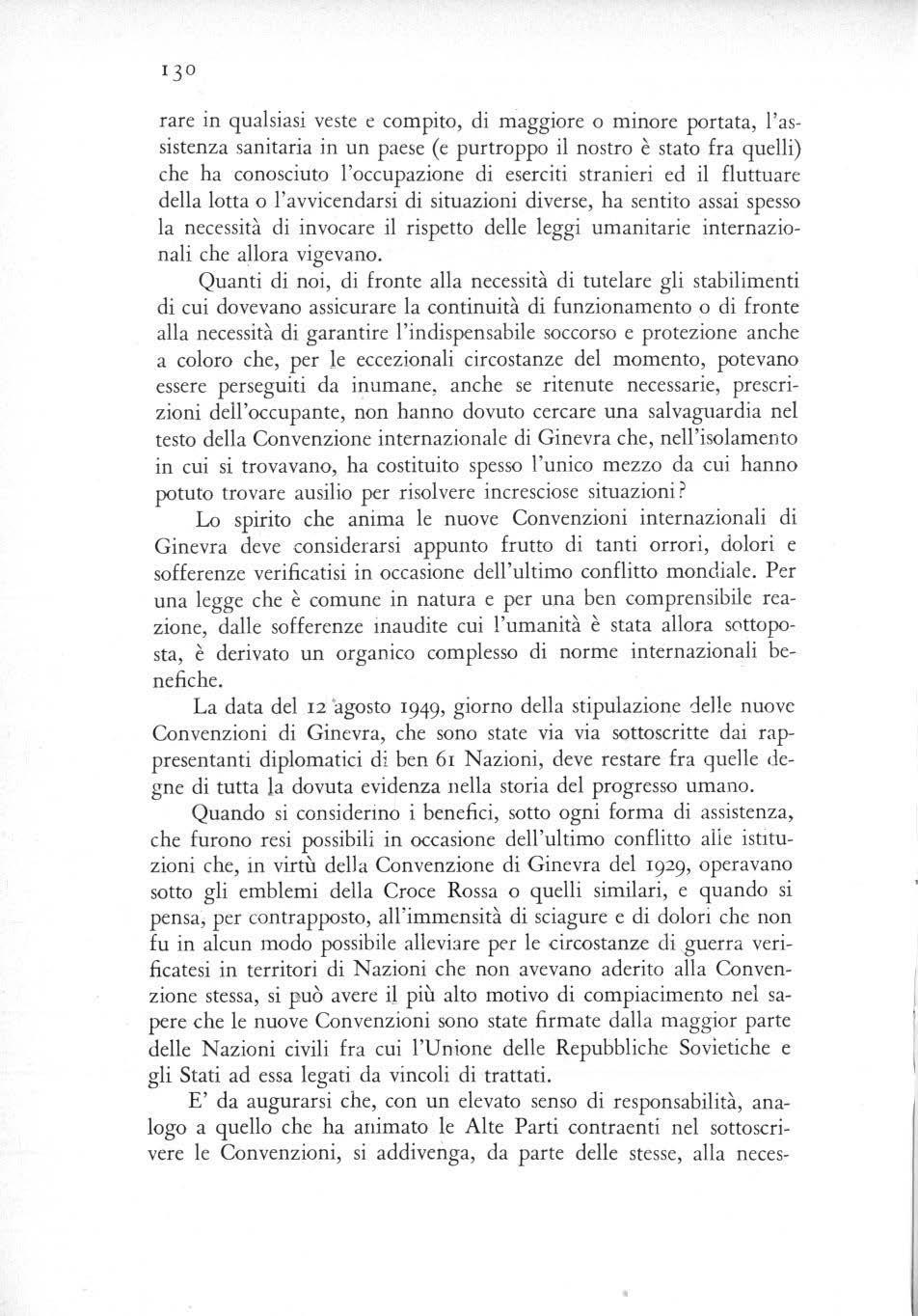

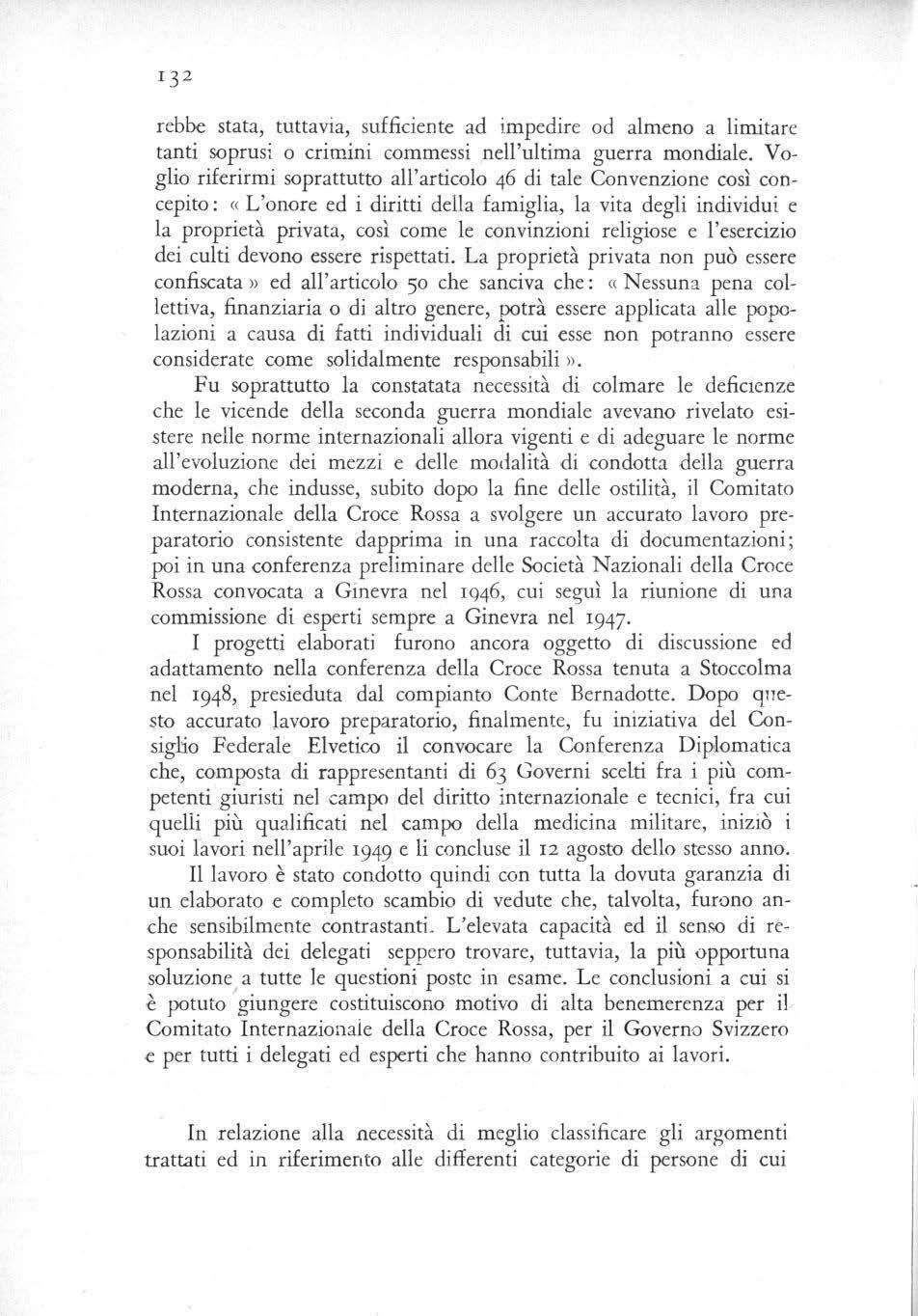


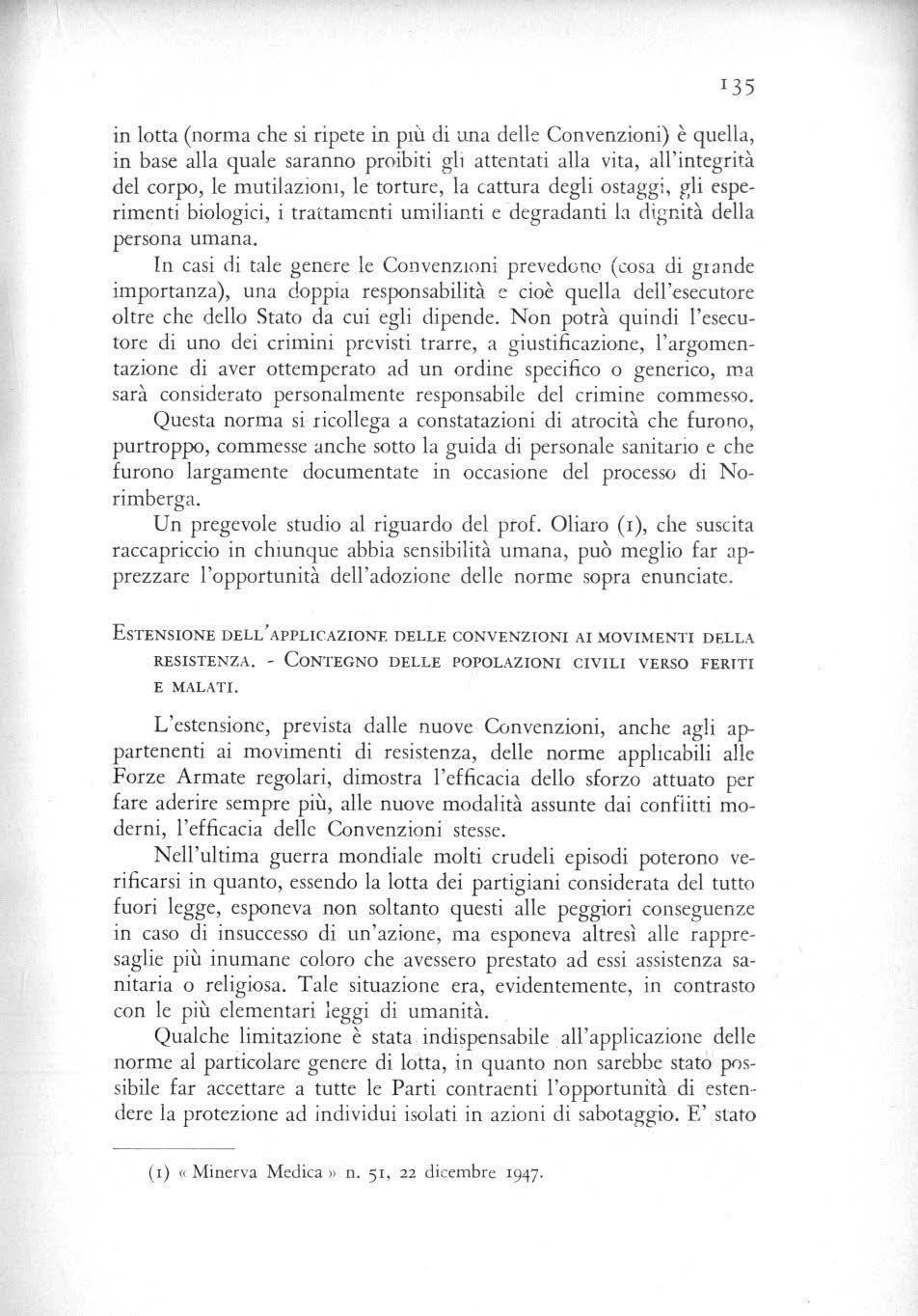

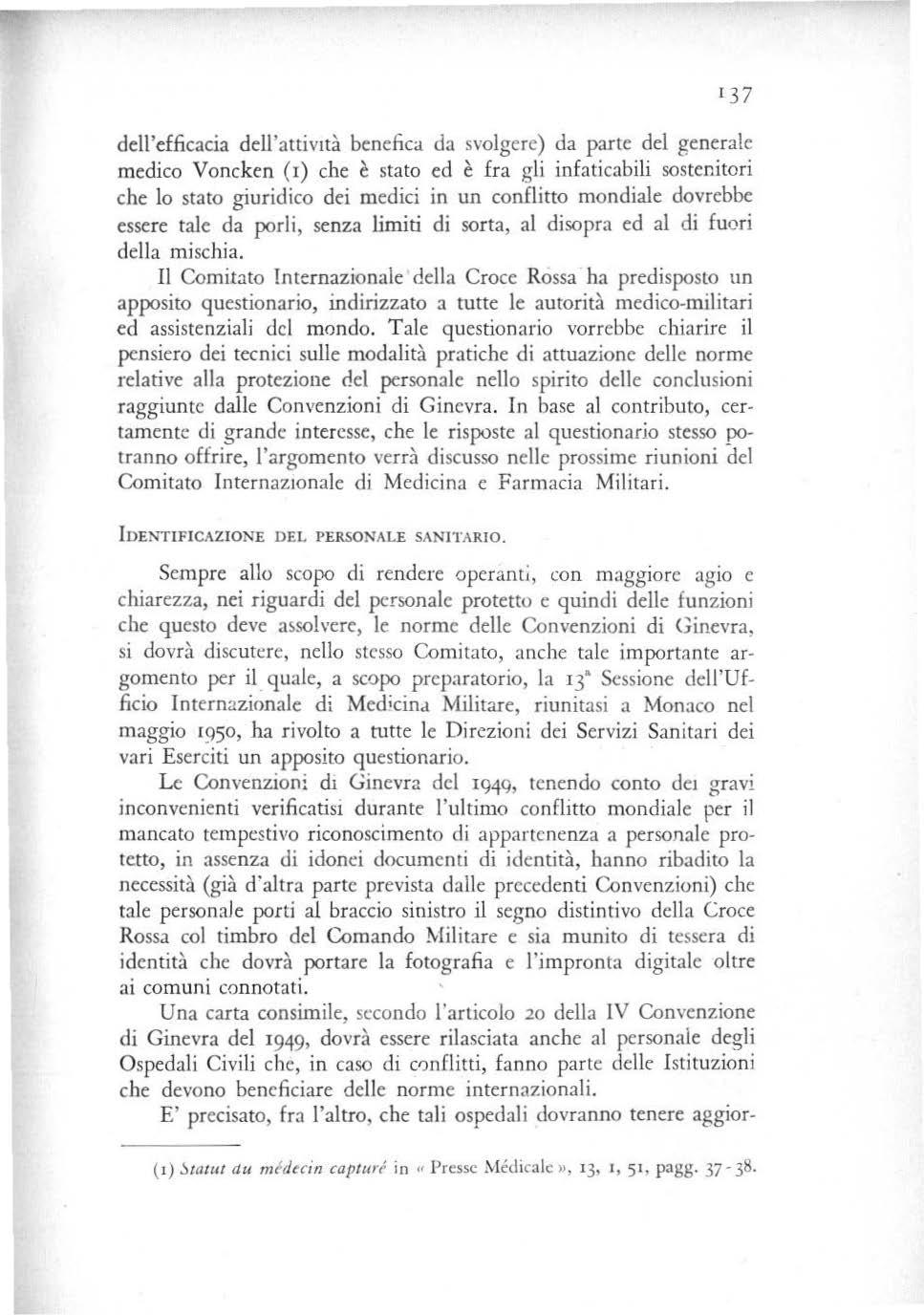 IDENTIFI CAZIONE DEL PERSONALE SAN I TARIO.
IDENTIFI CAZIONE DEL PERSONALE SAN I TARIO.
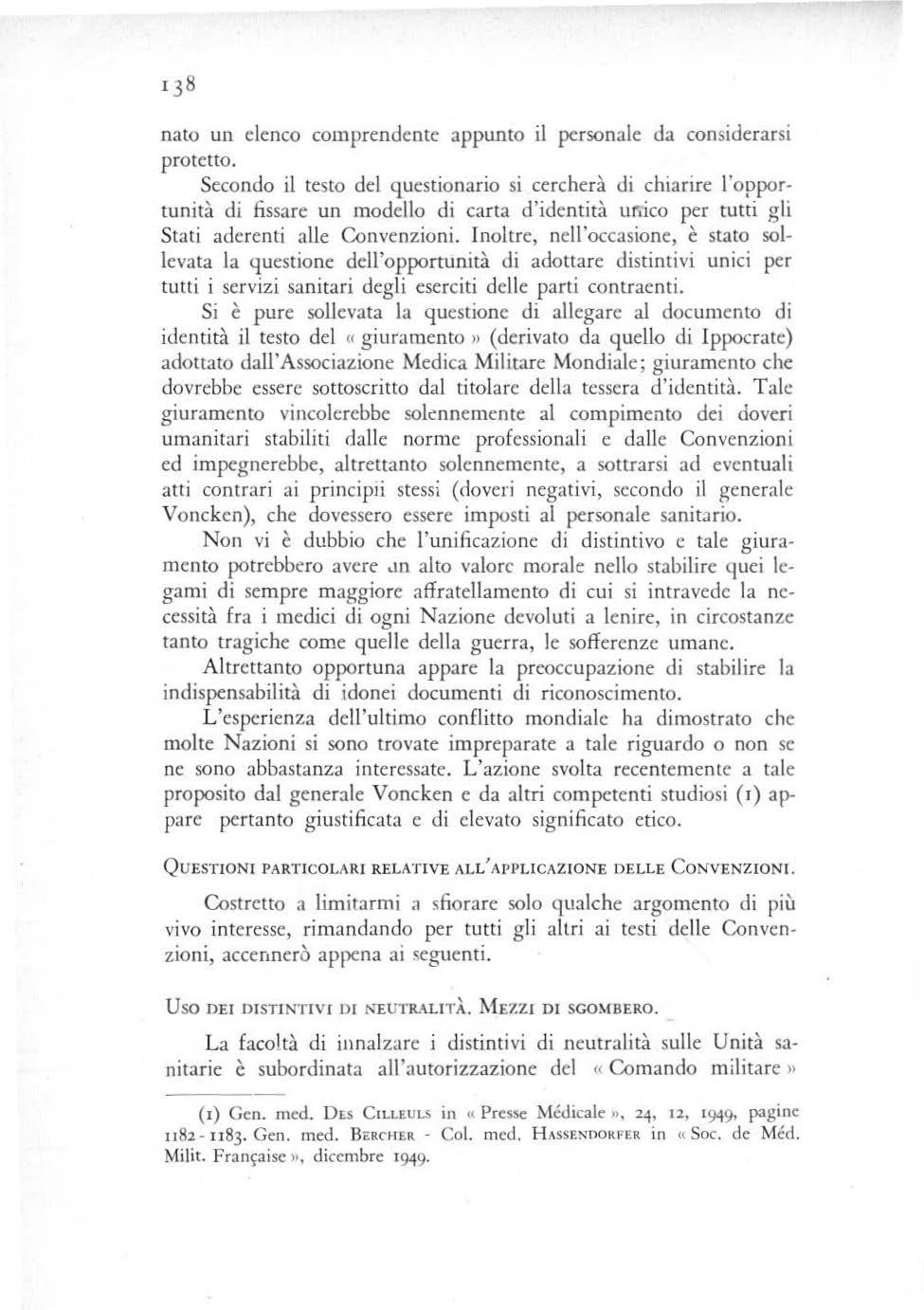
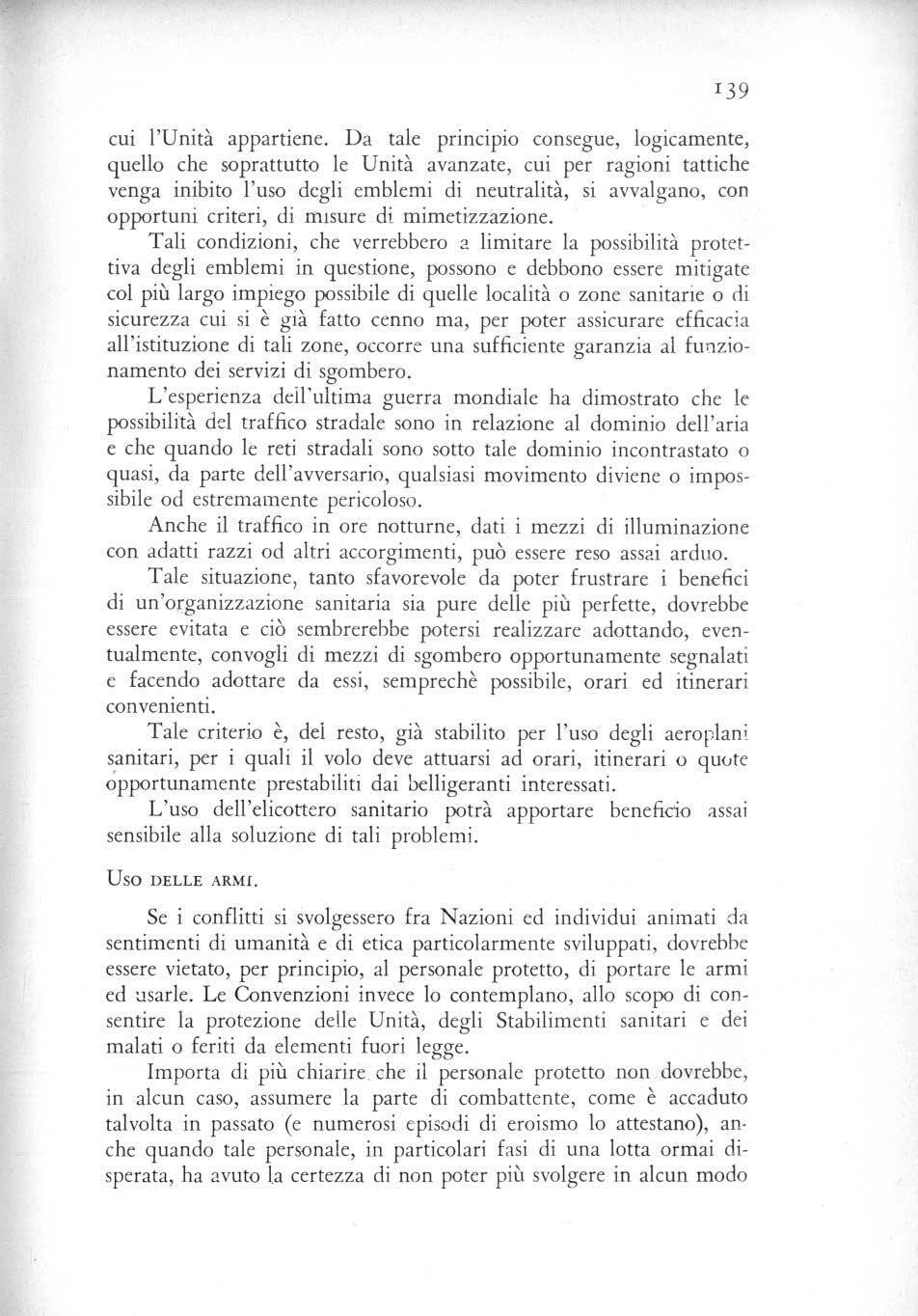
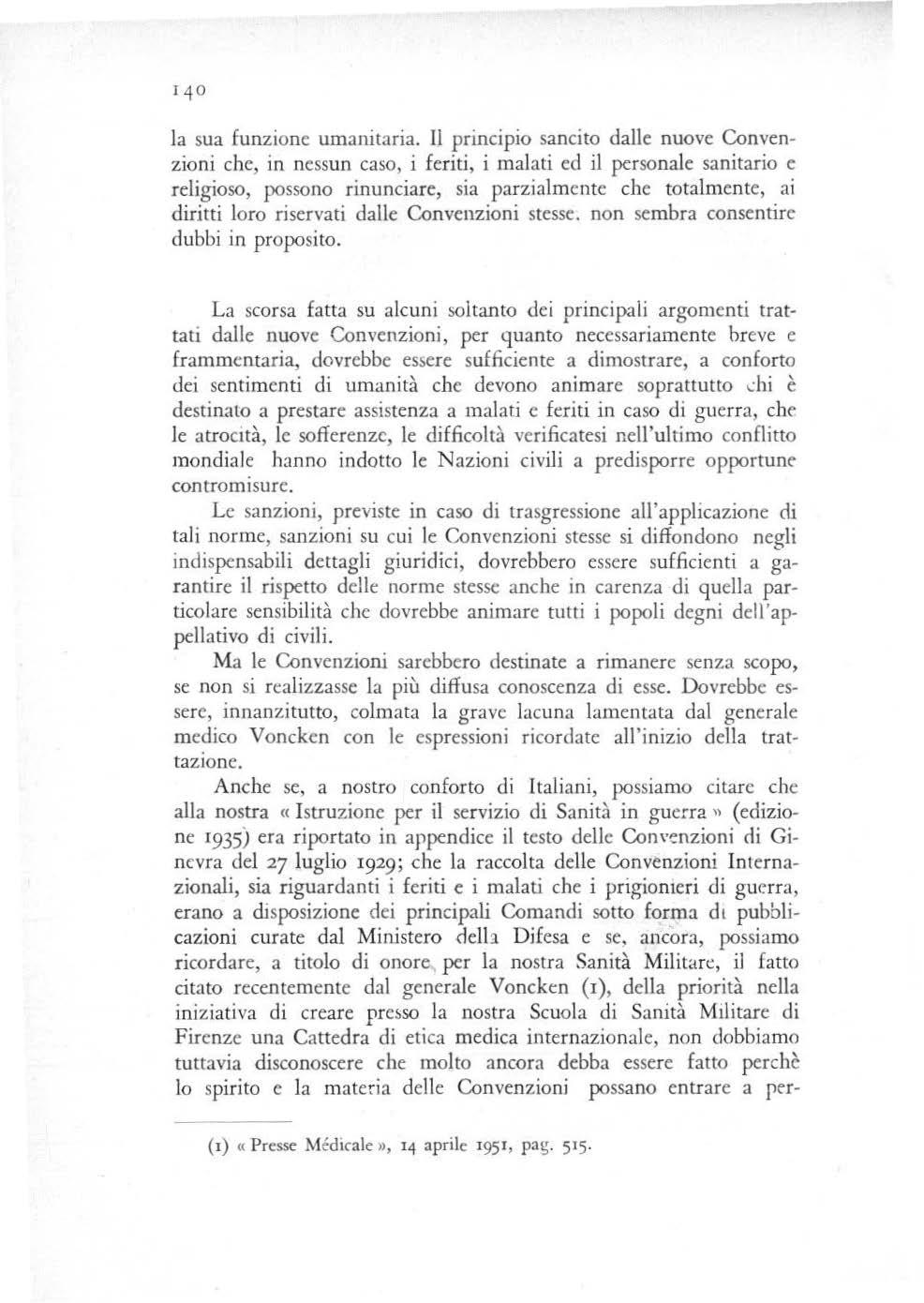
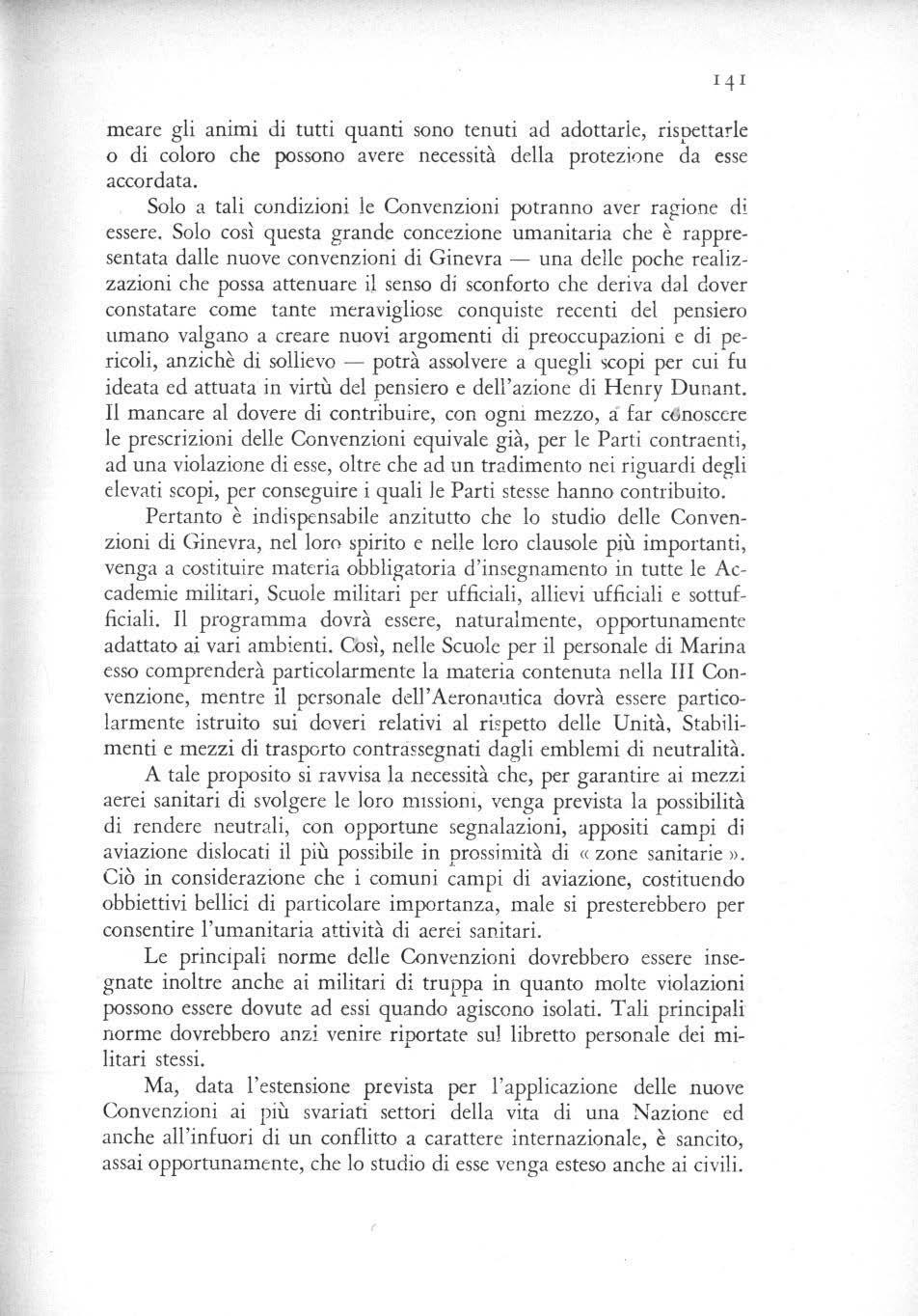

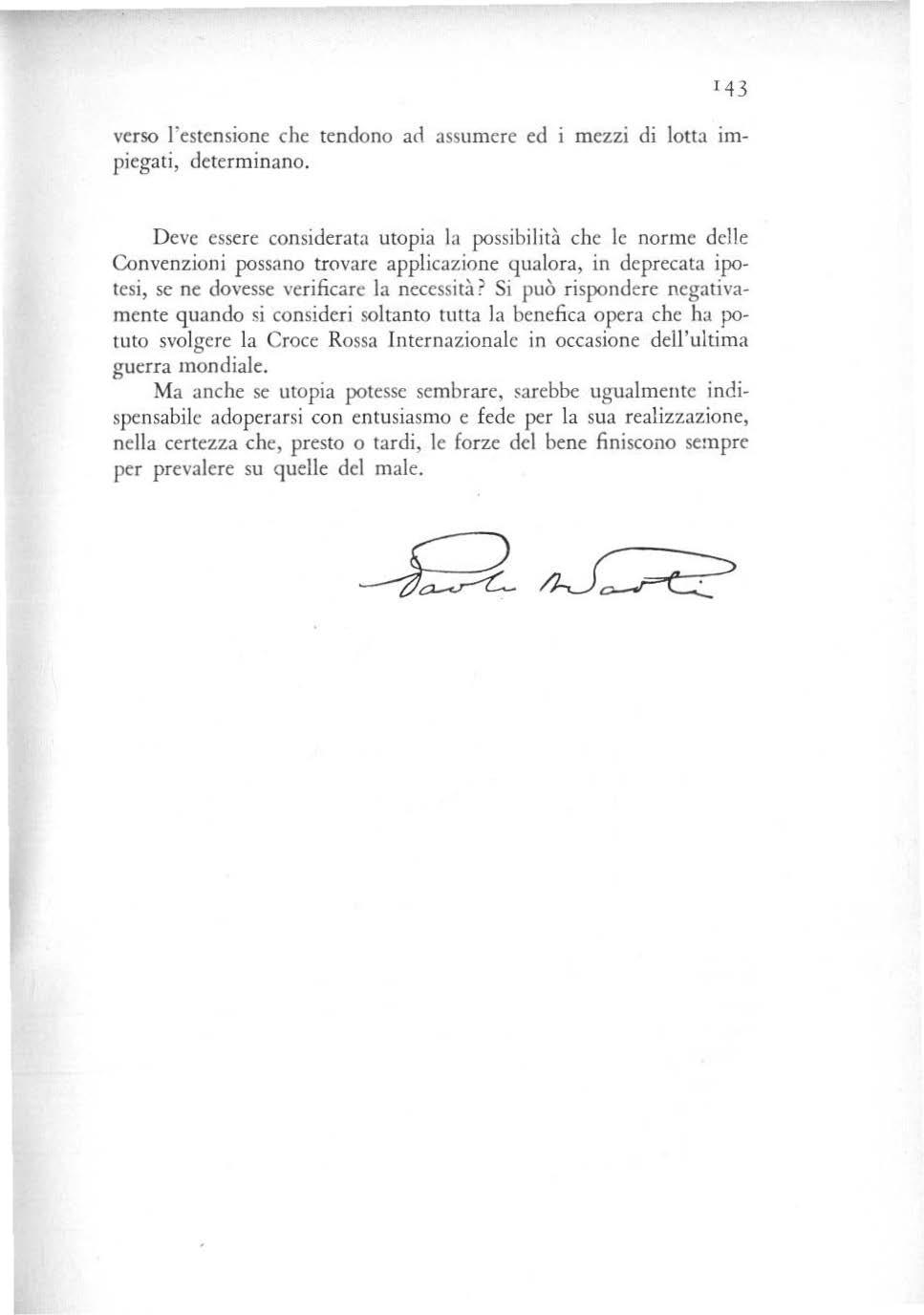
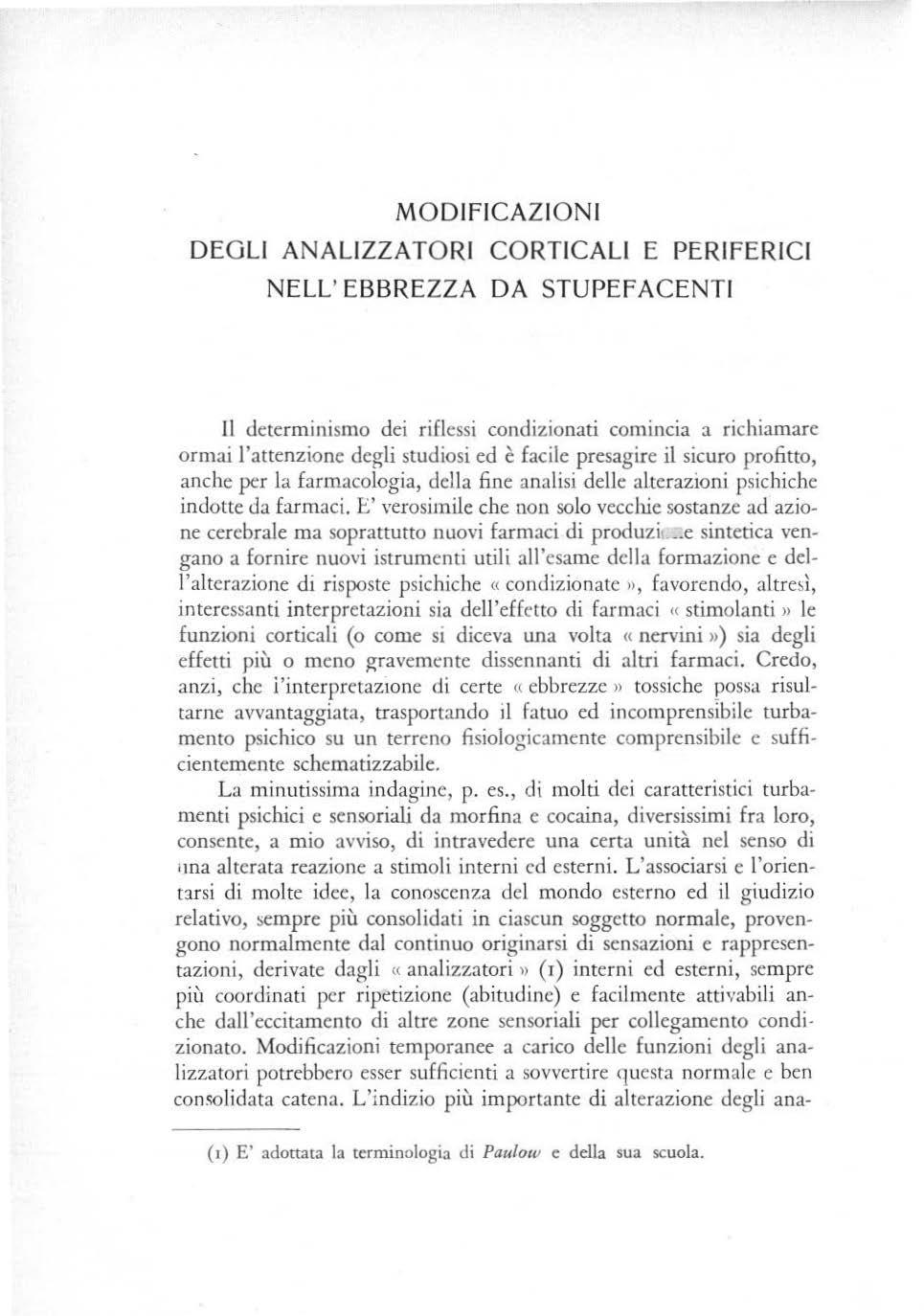

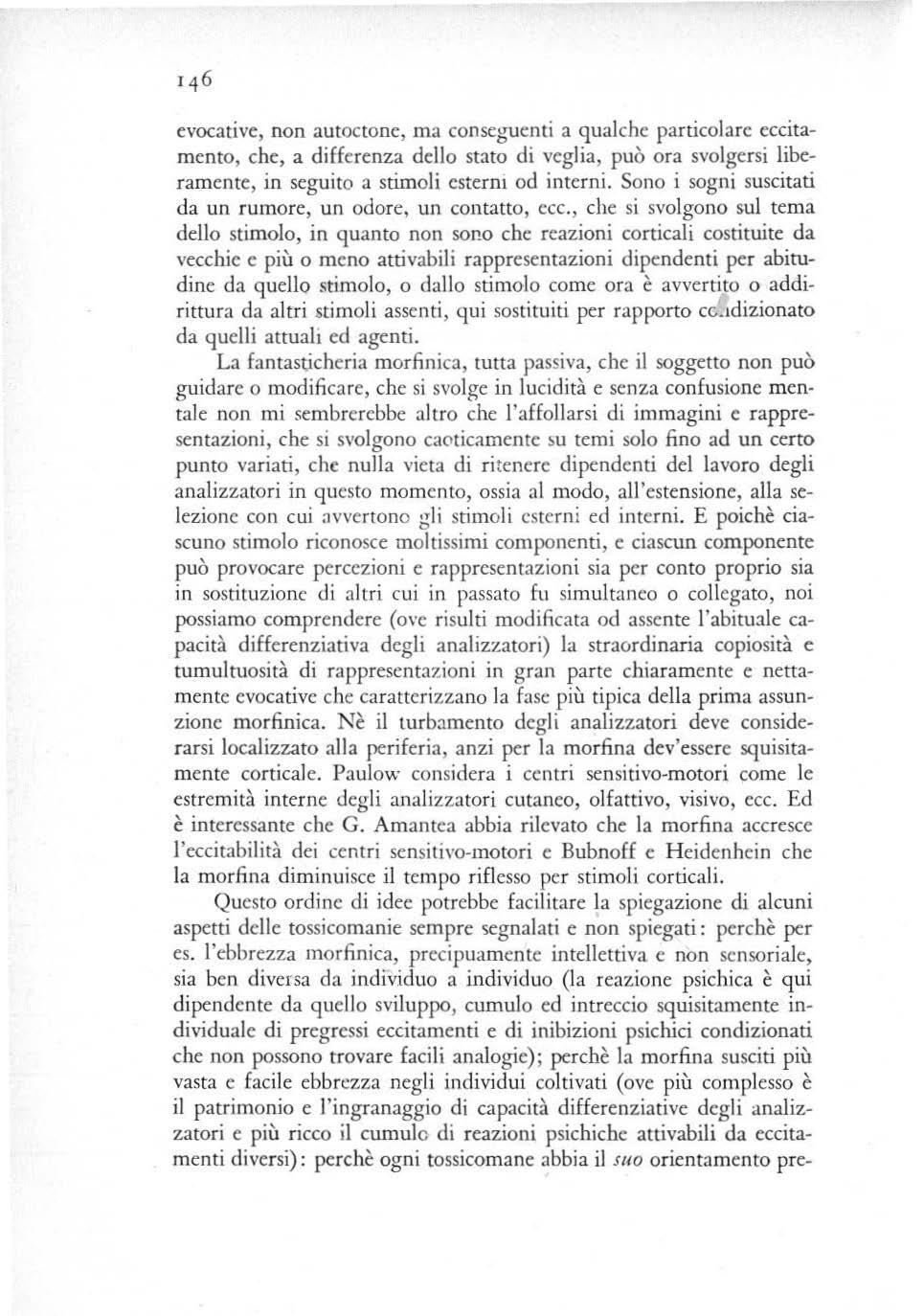
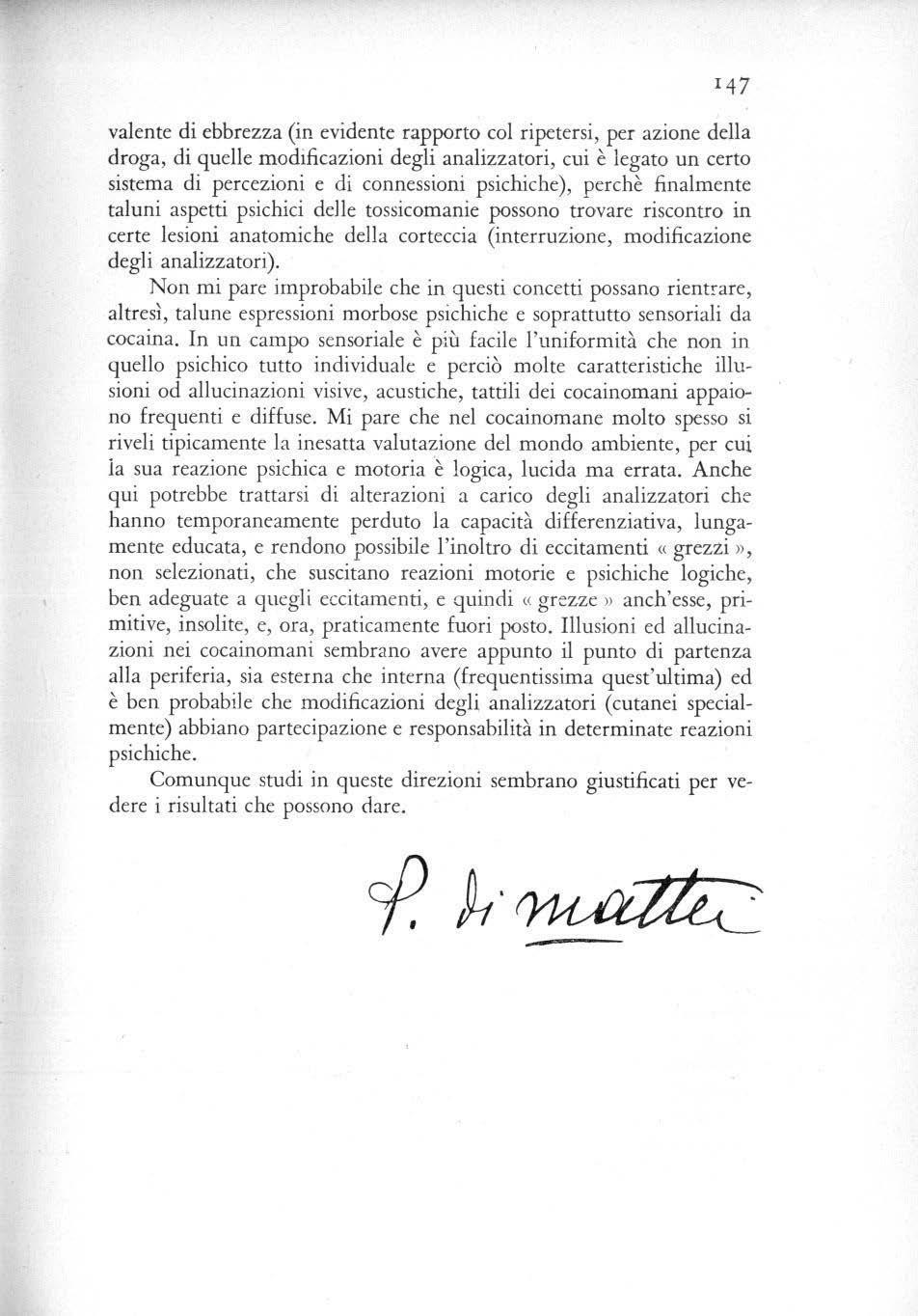

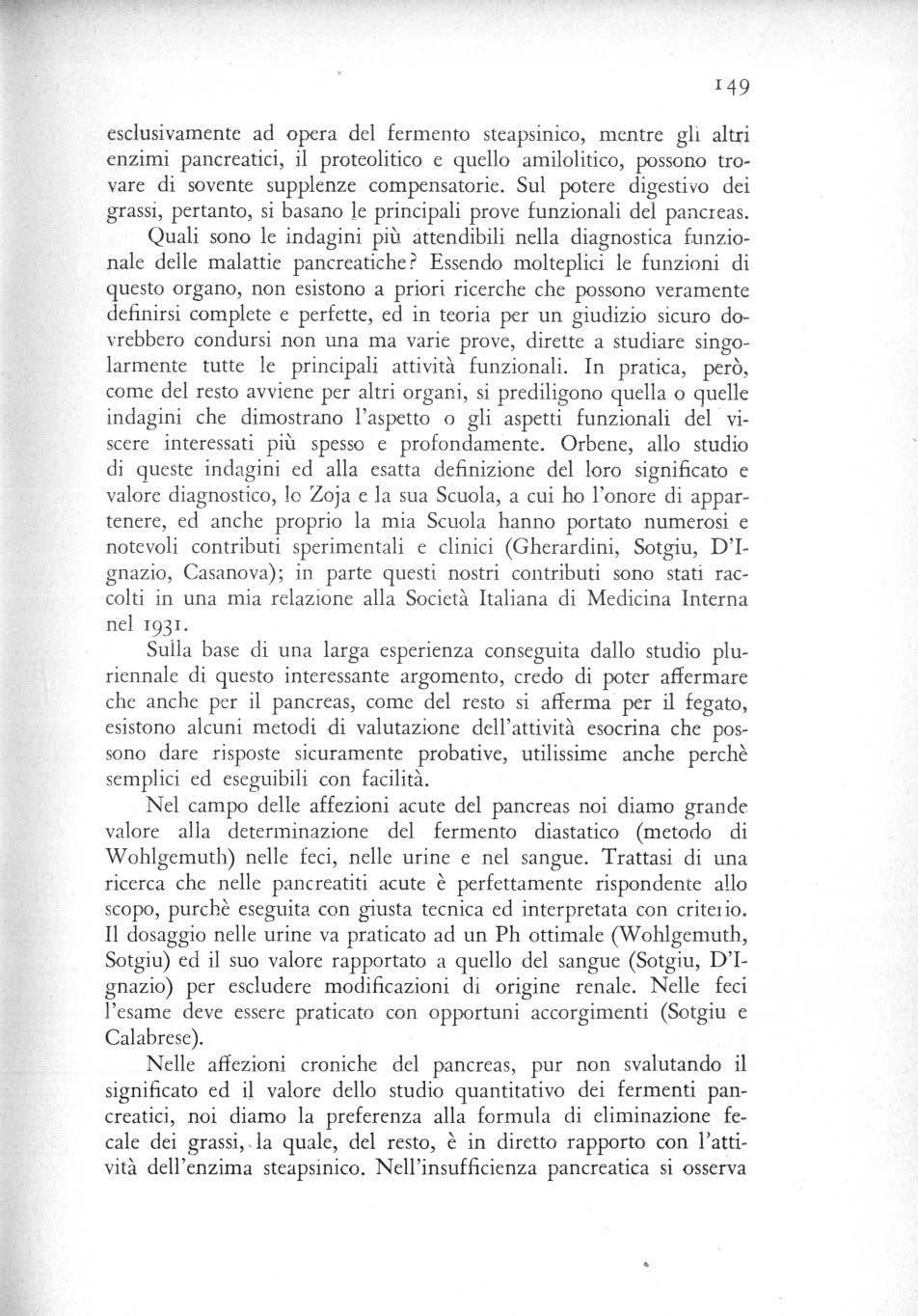


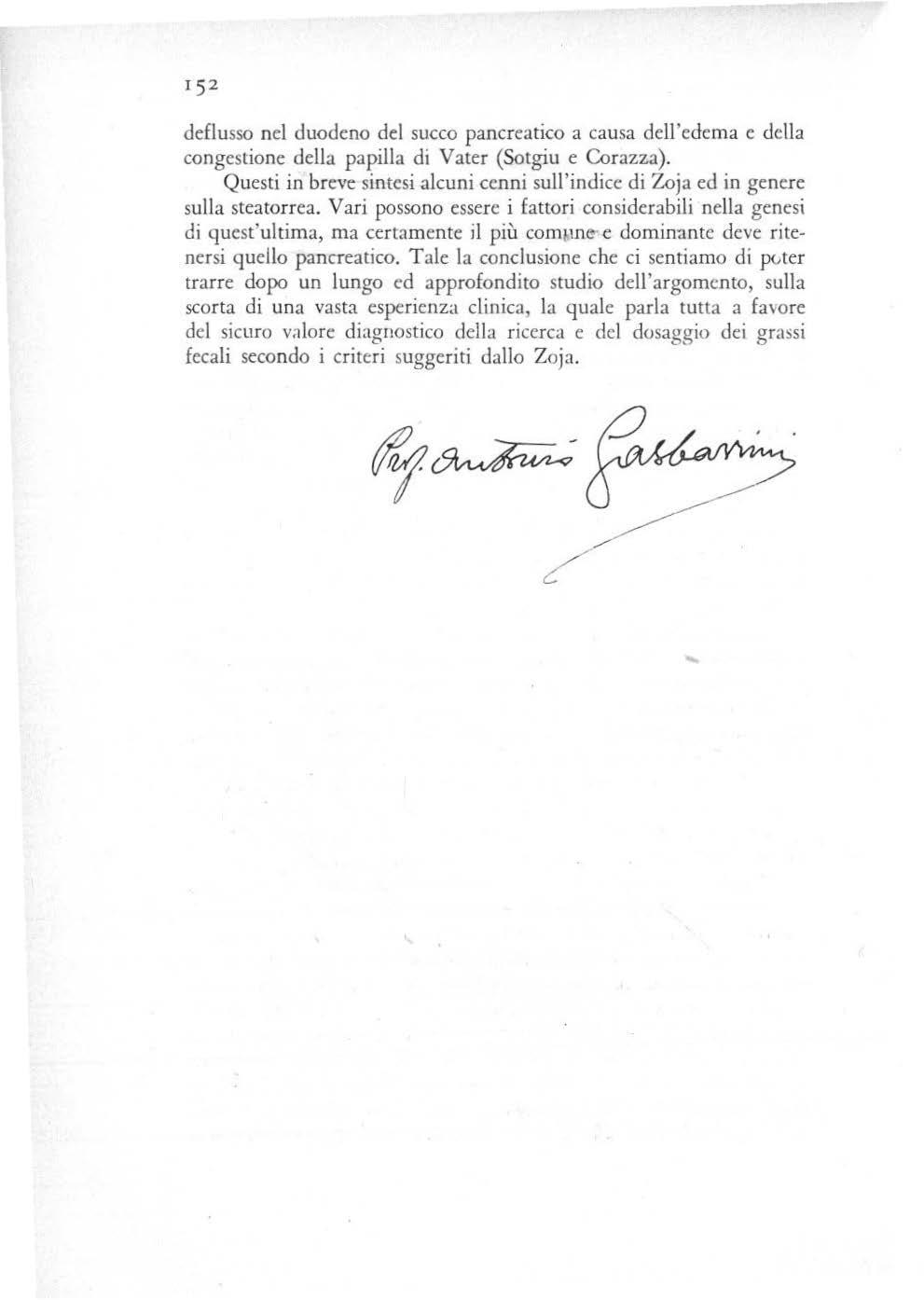

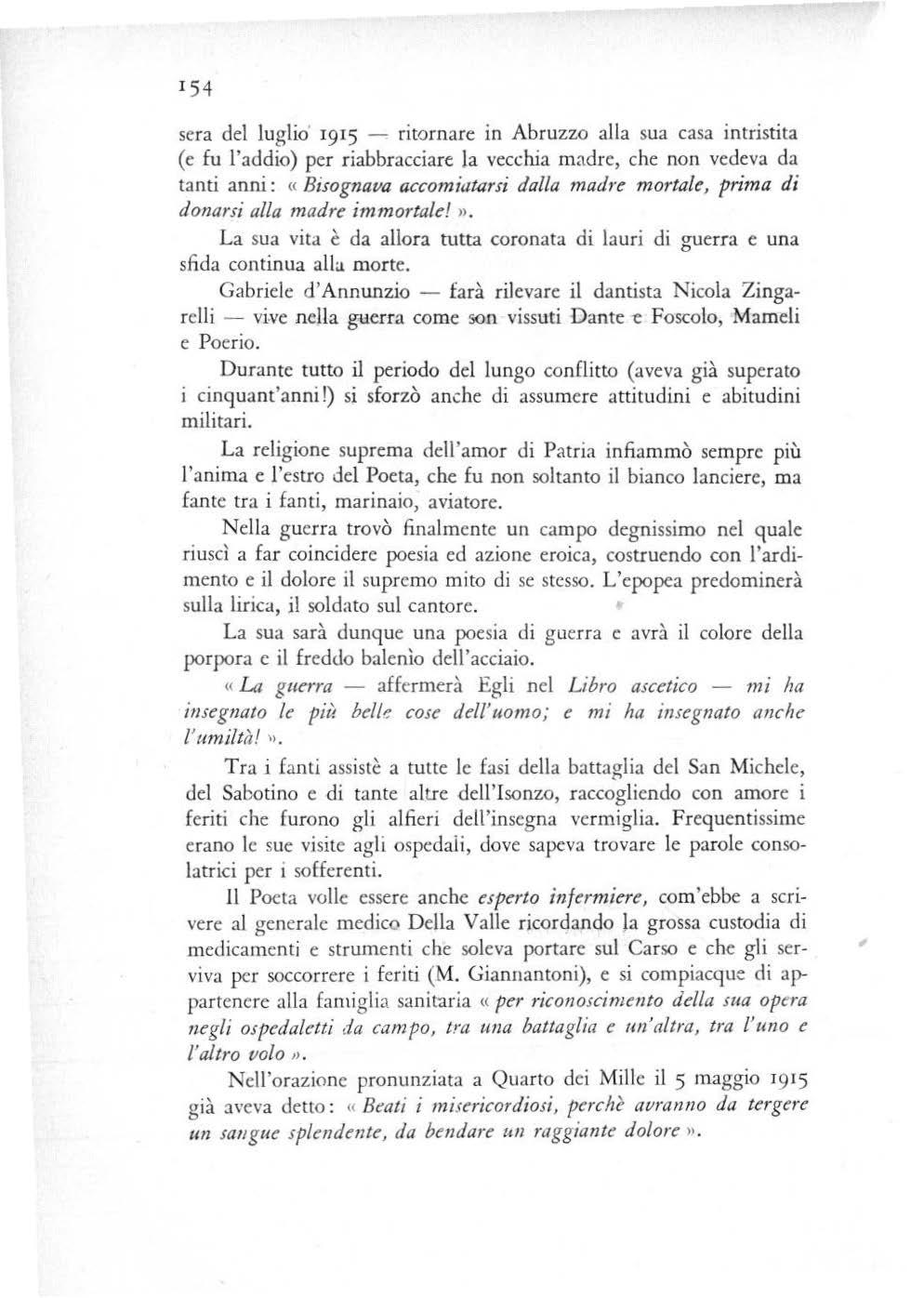

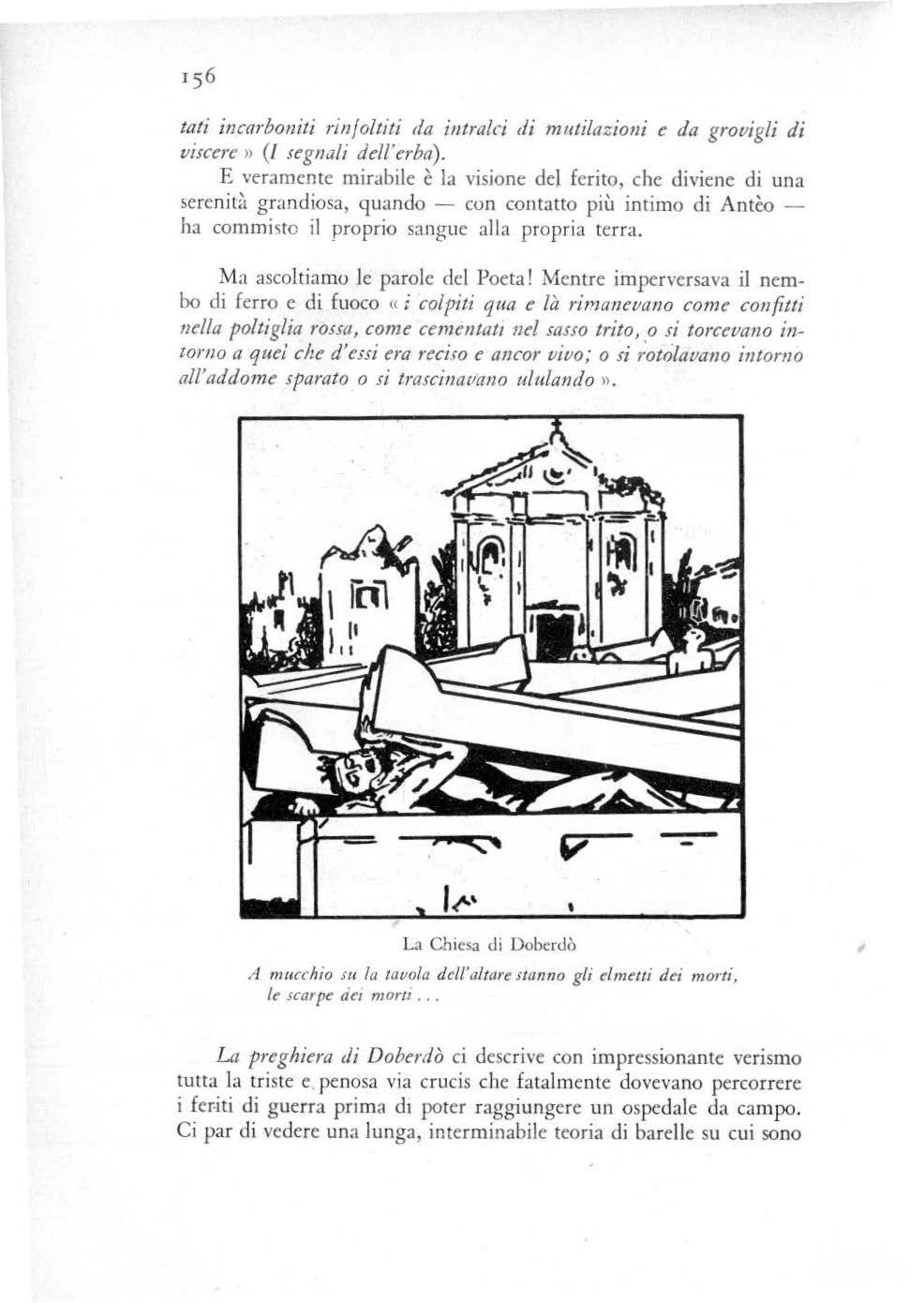
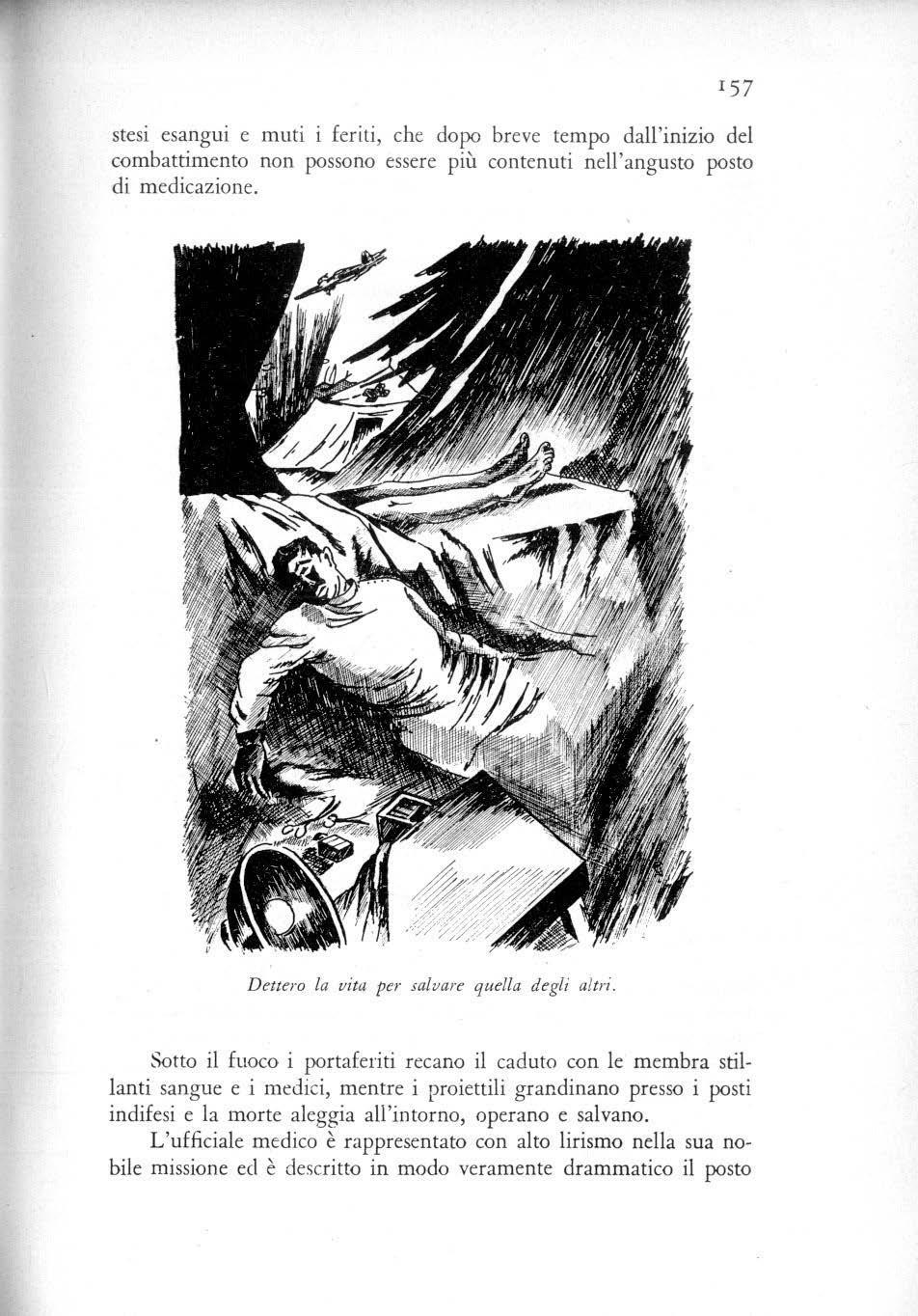
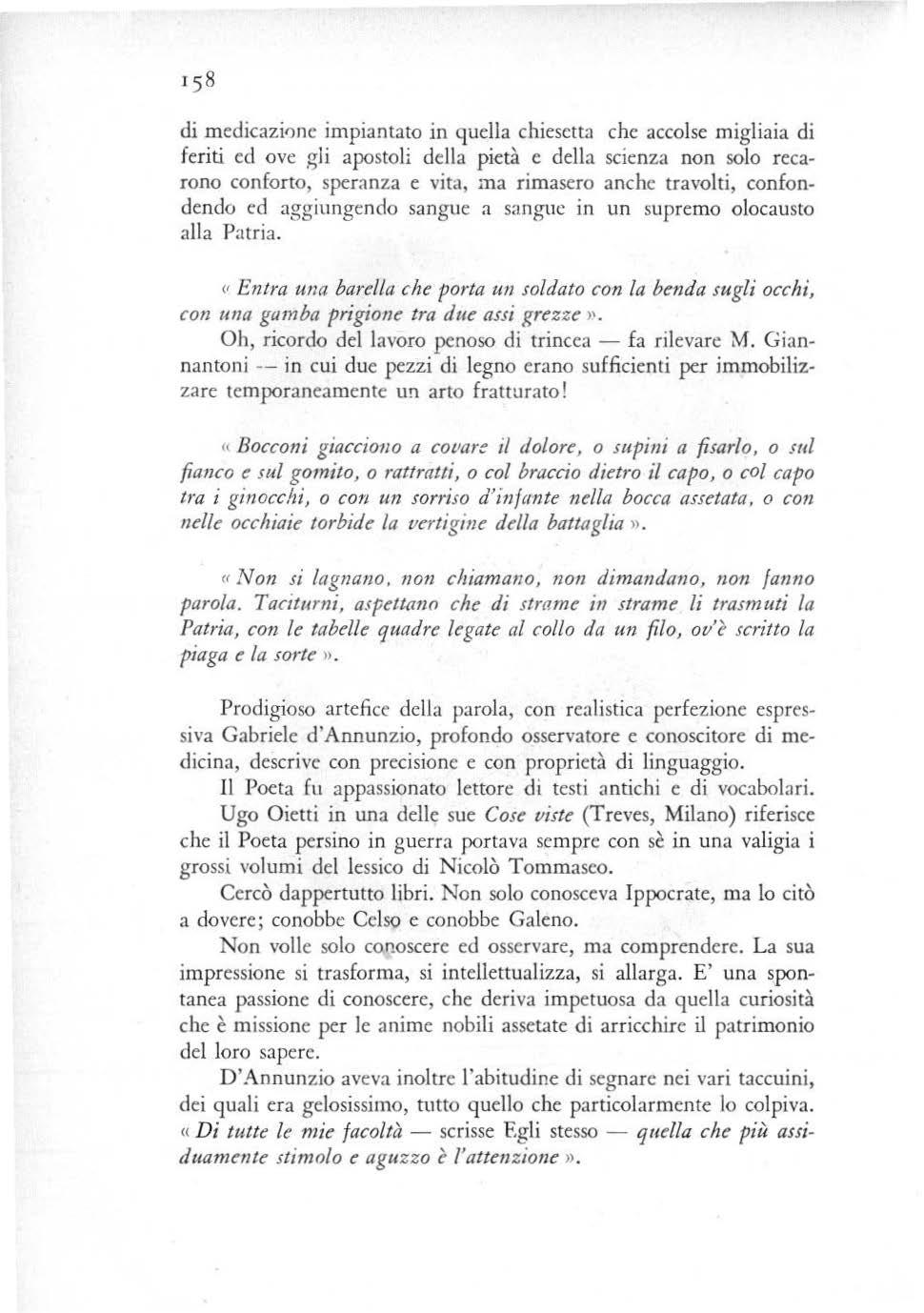

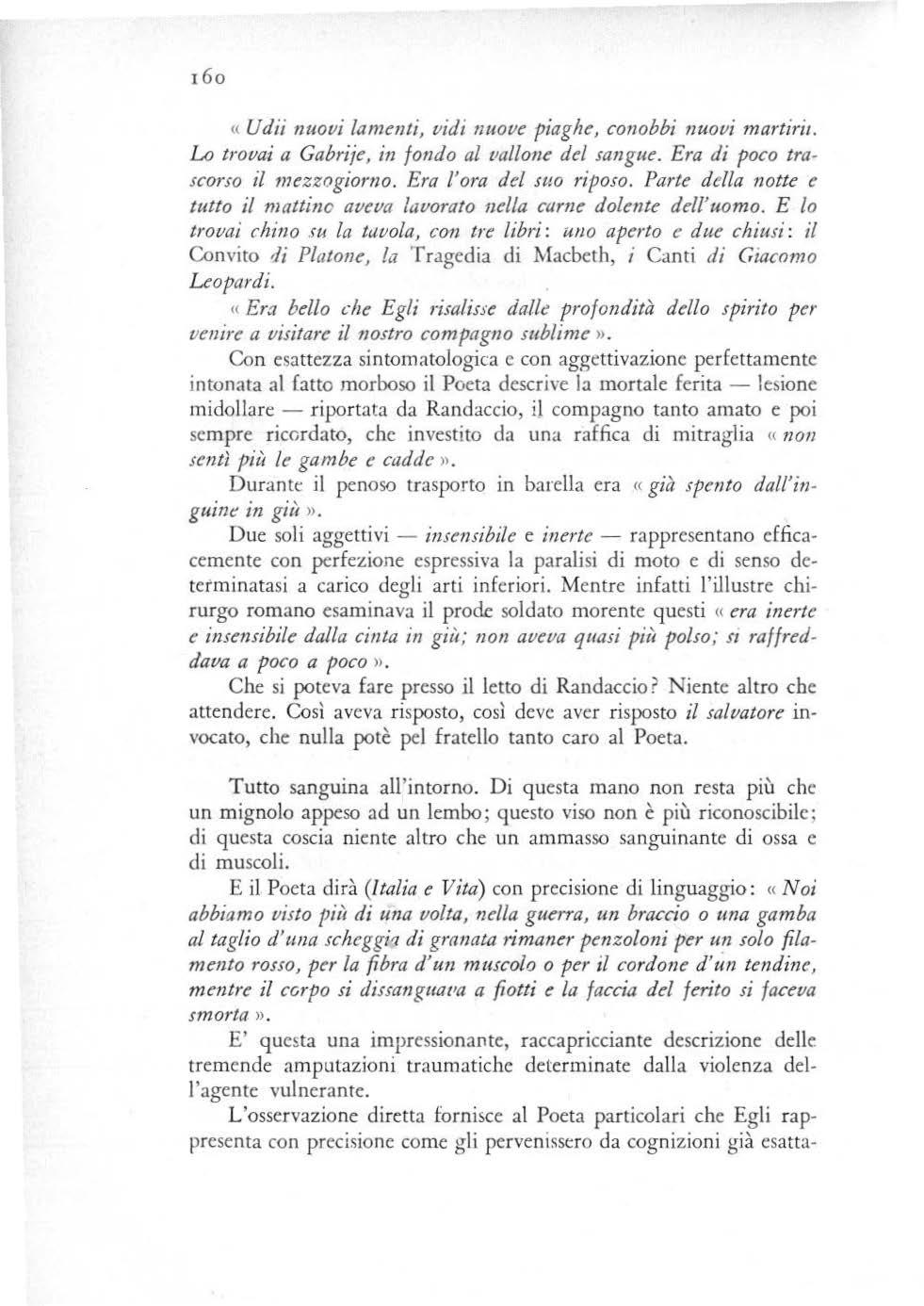
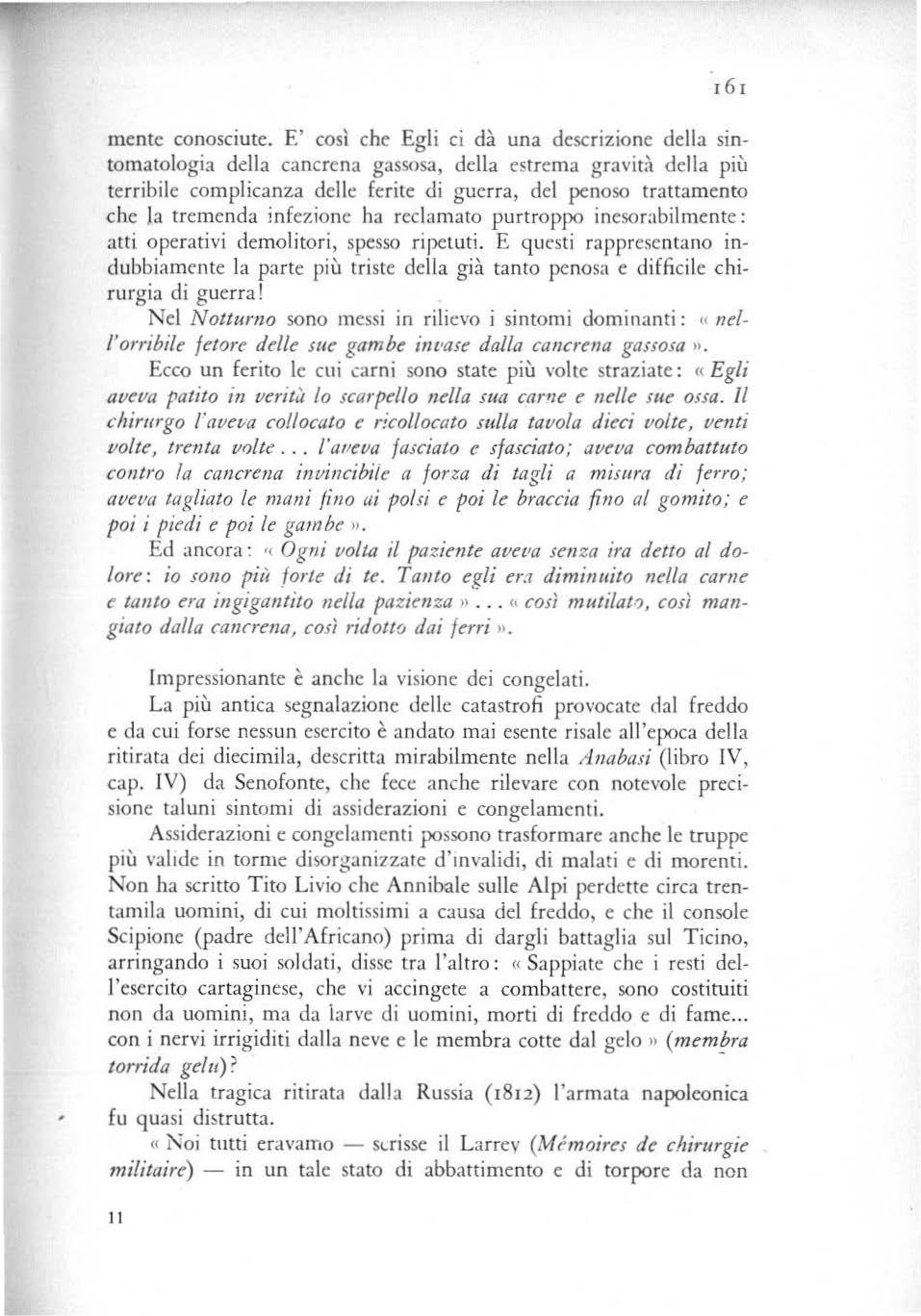


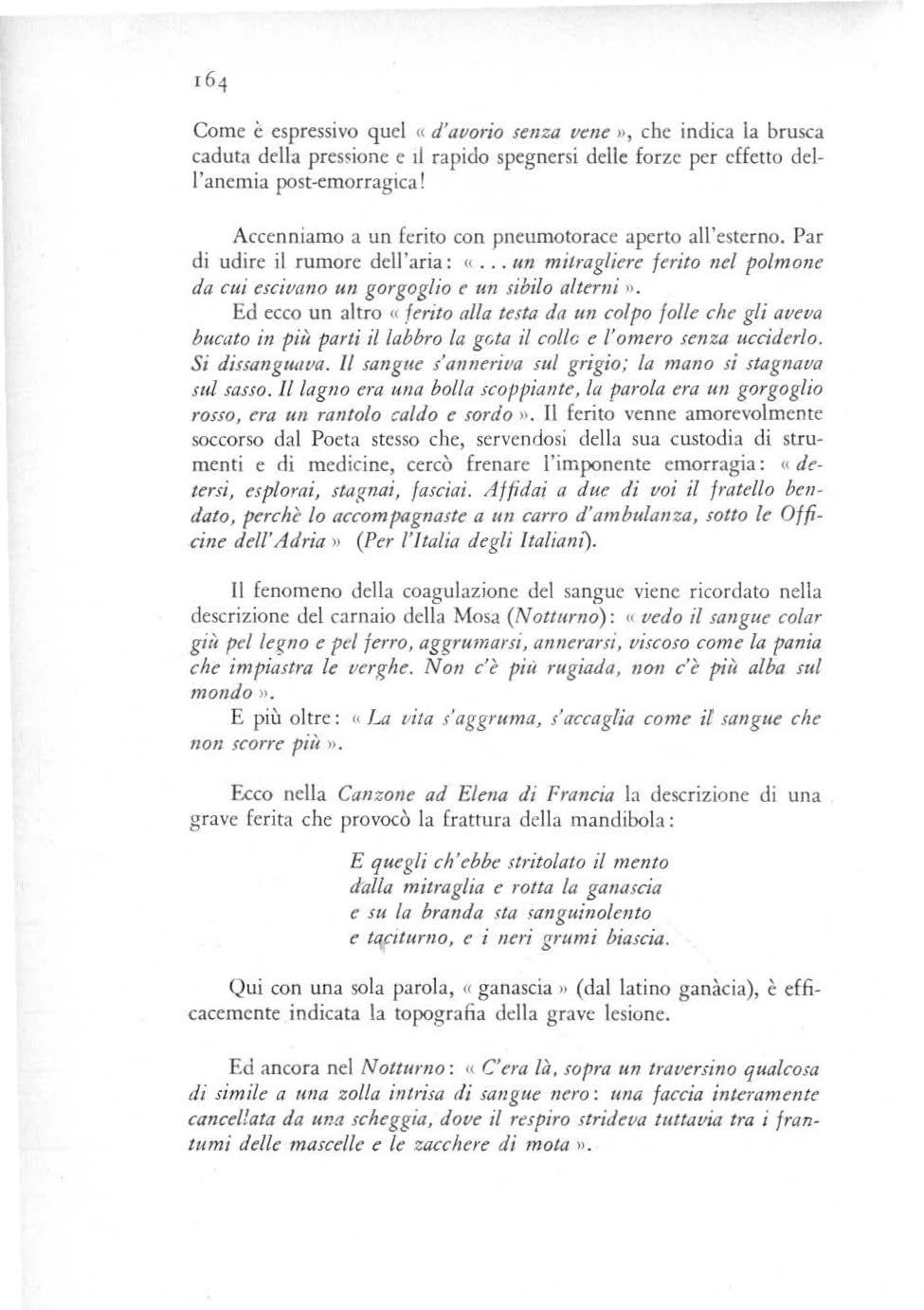
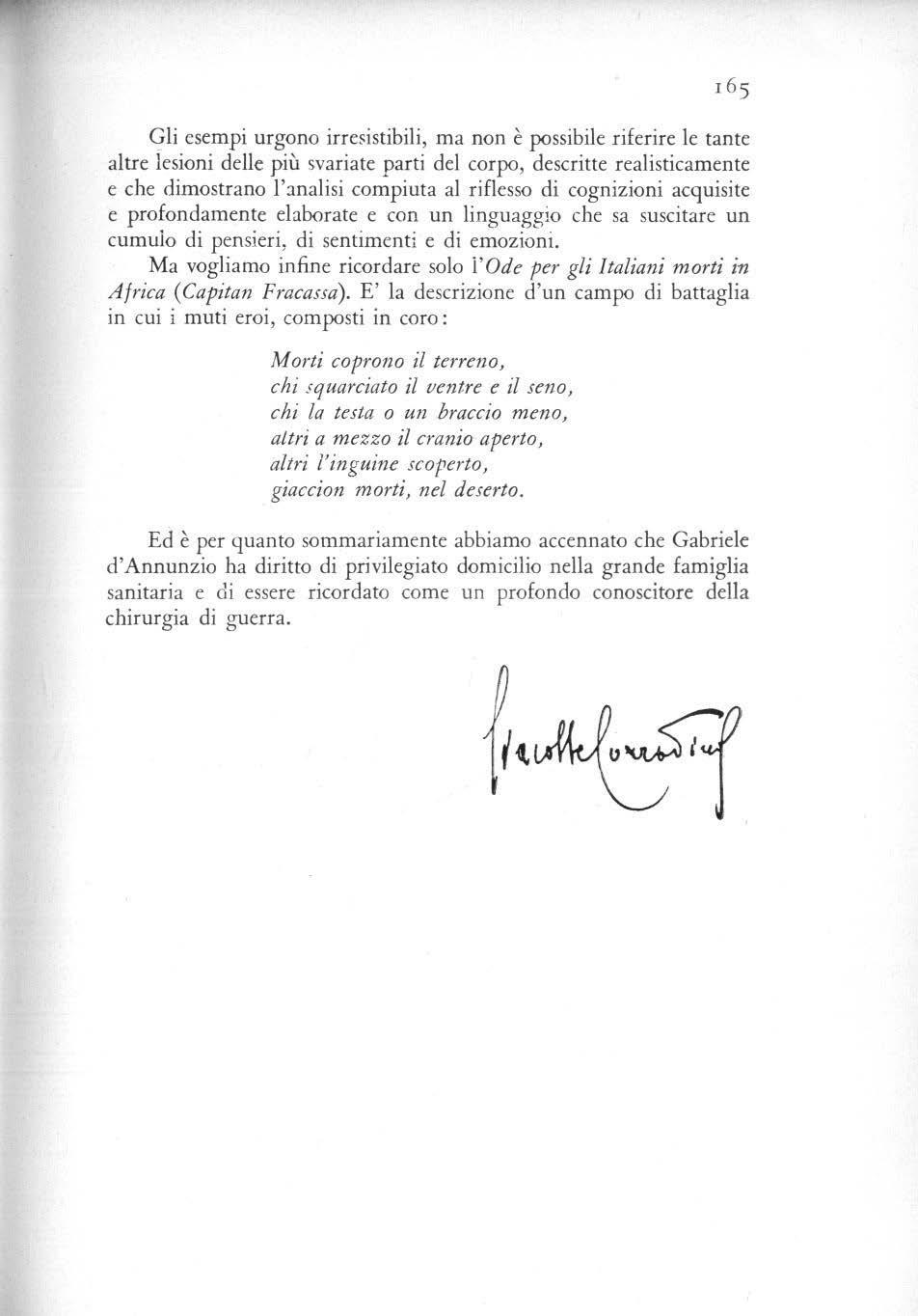
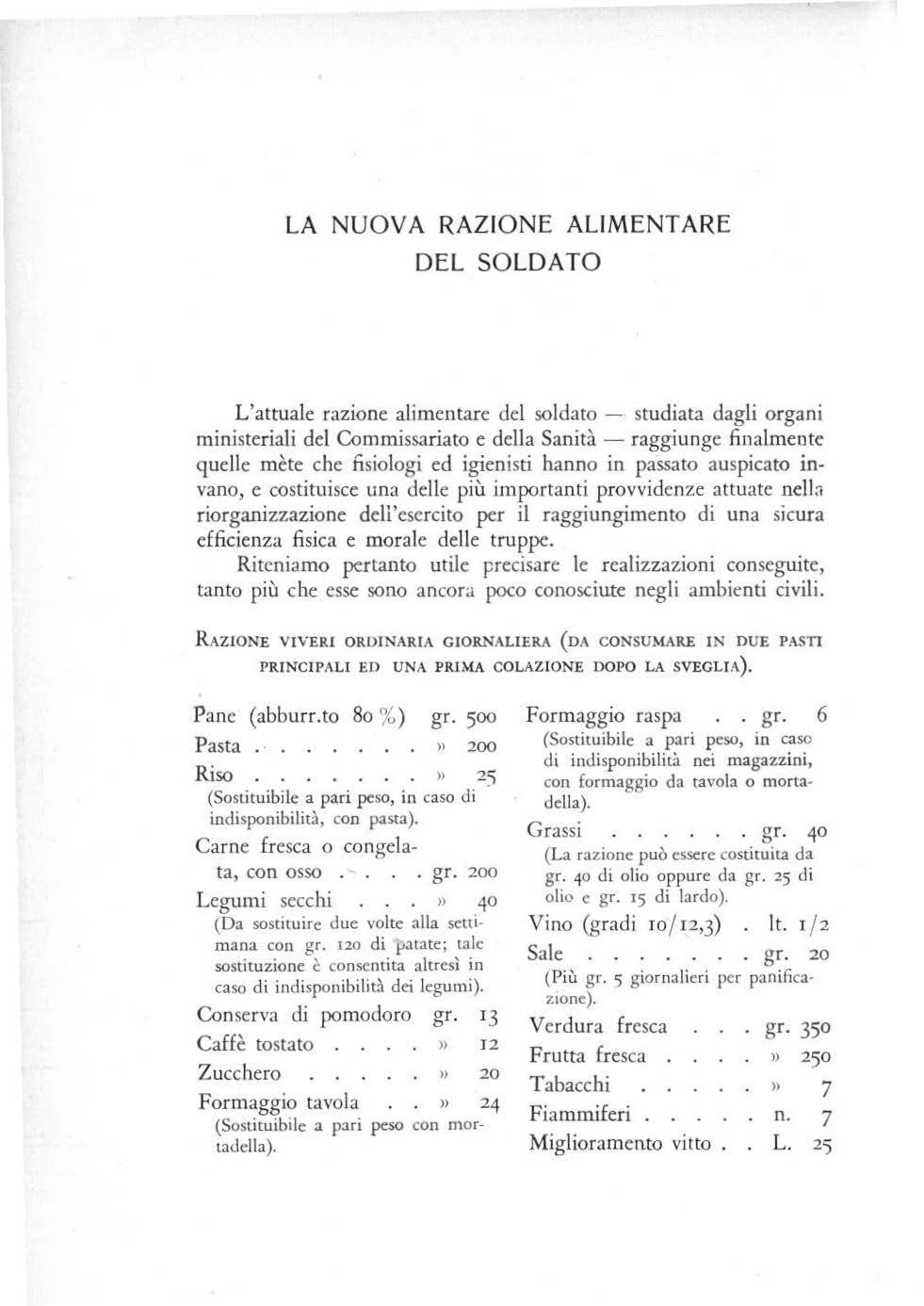
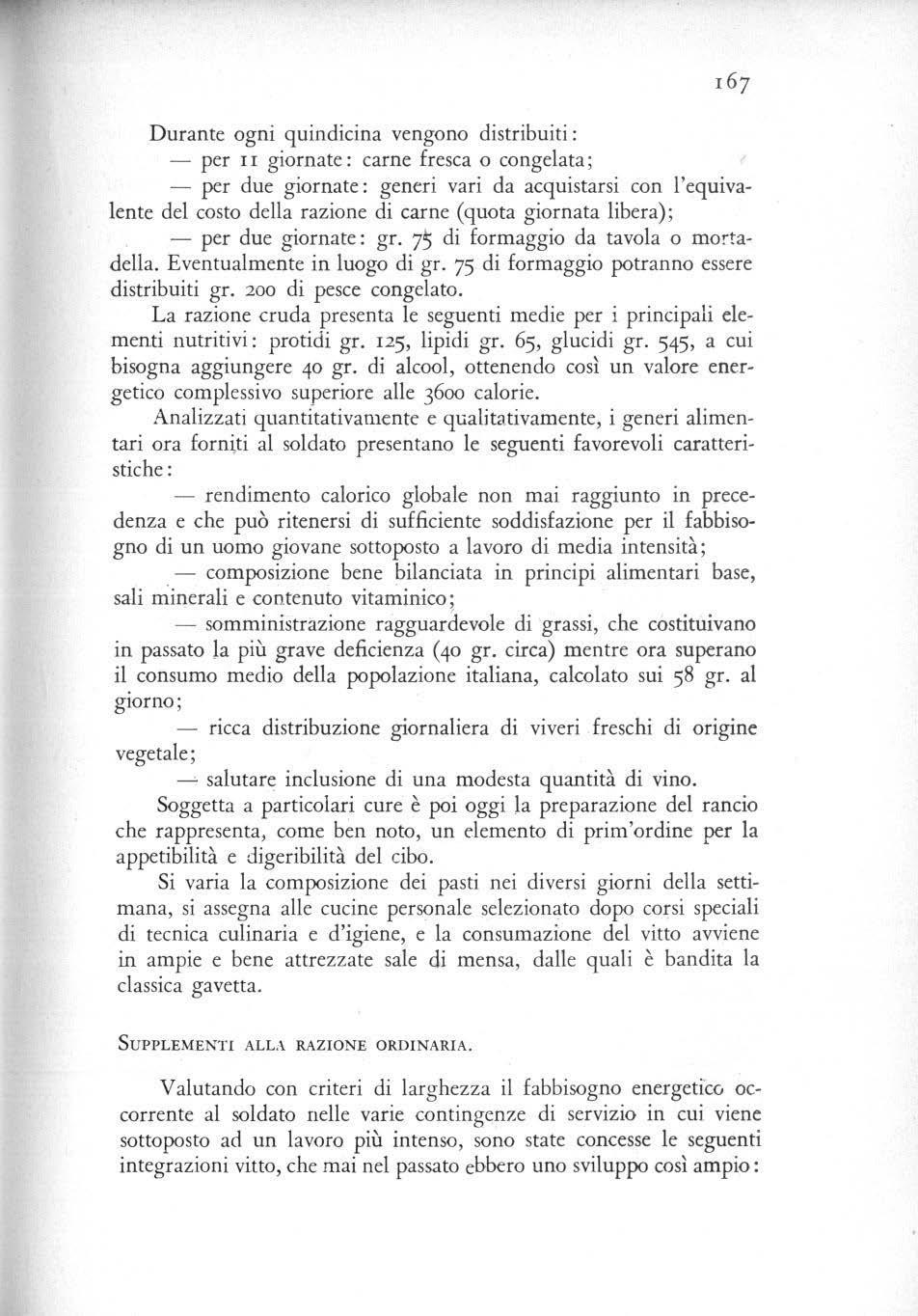
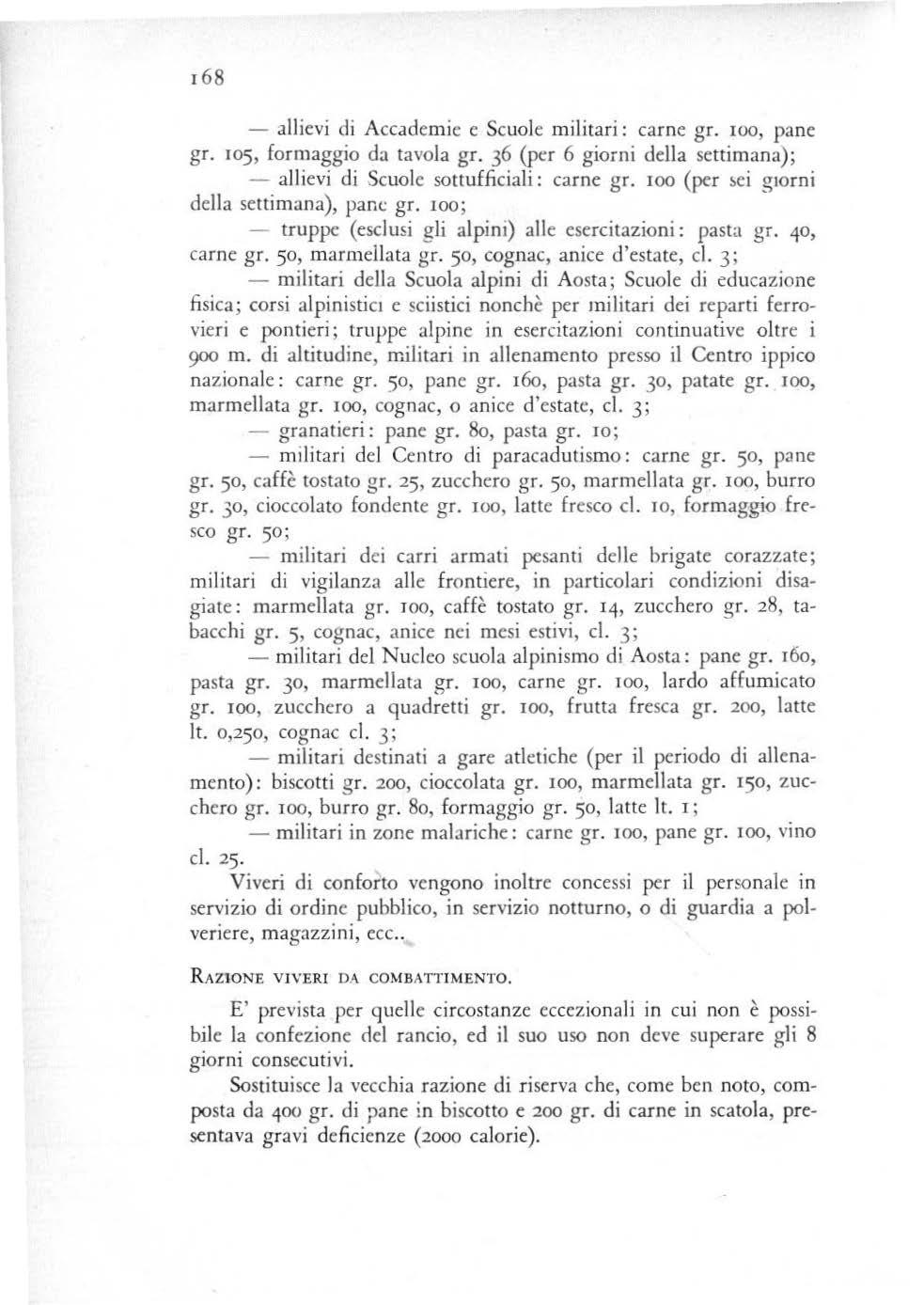


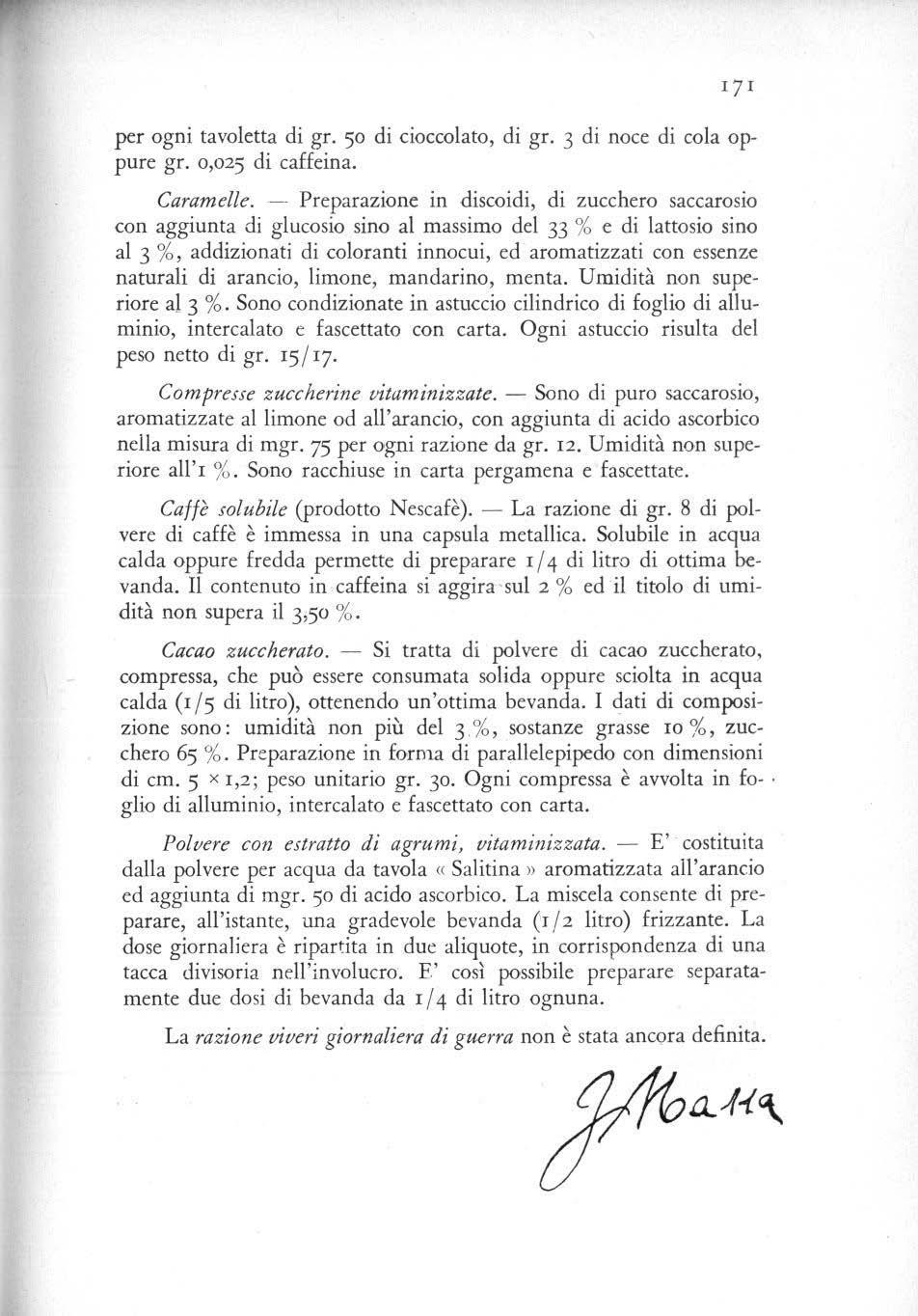
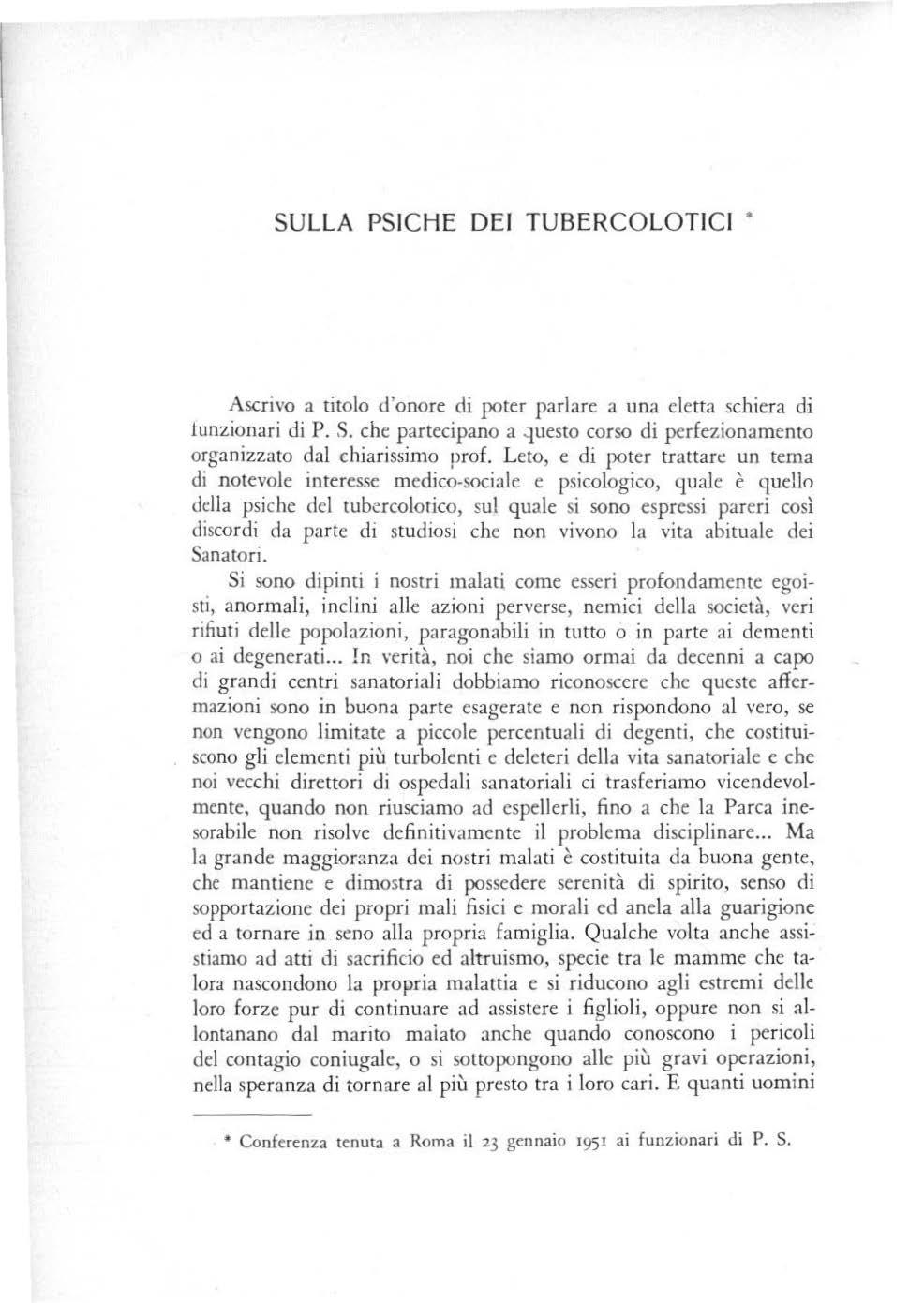
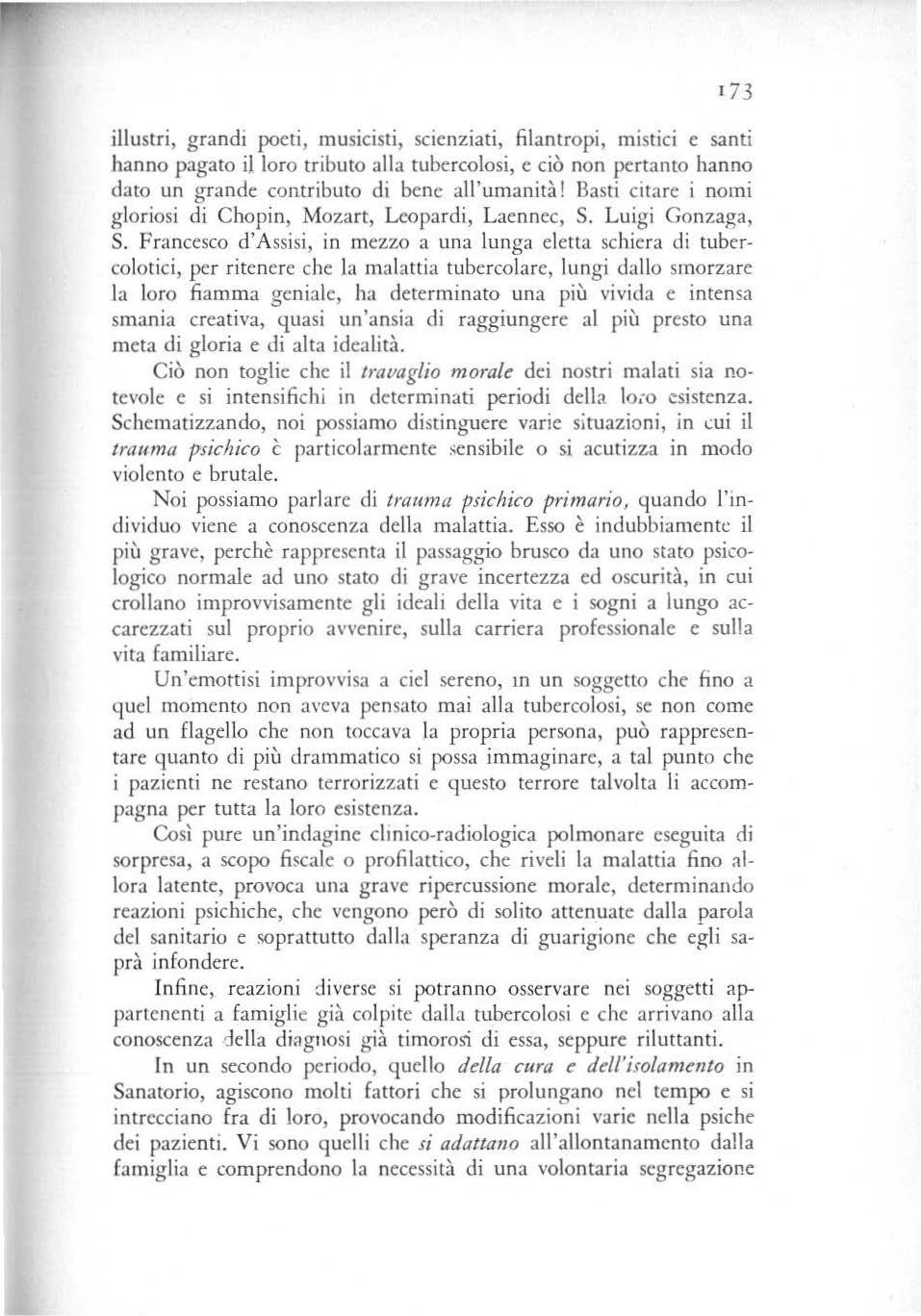
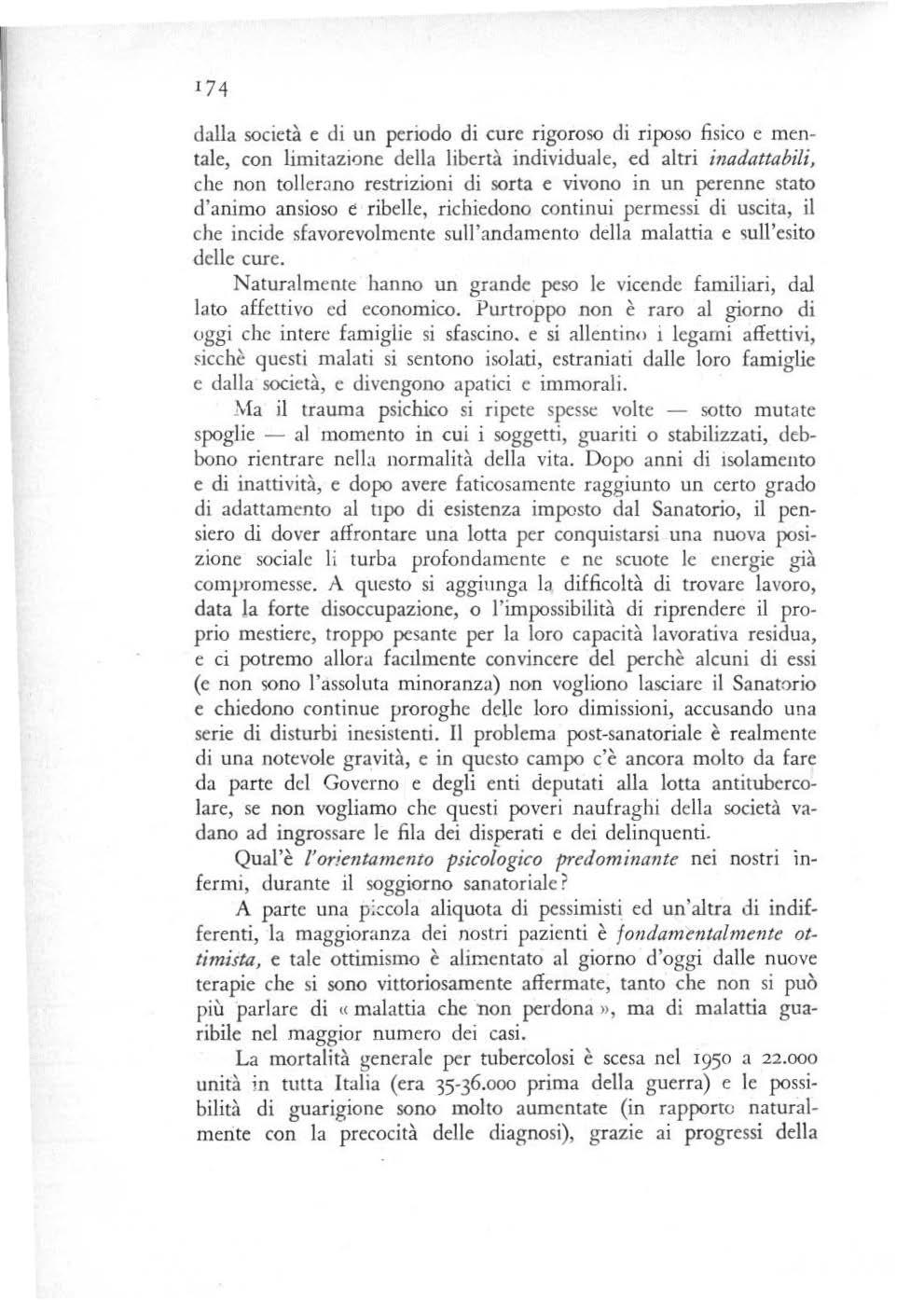

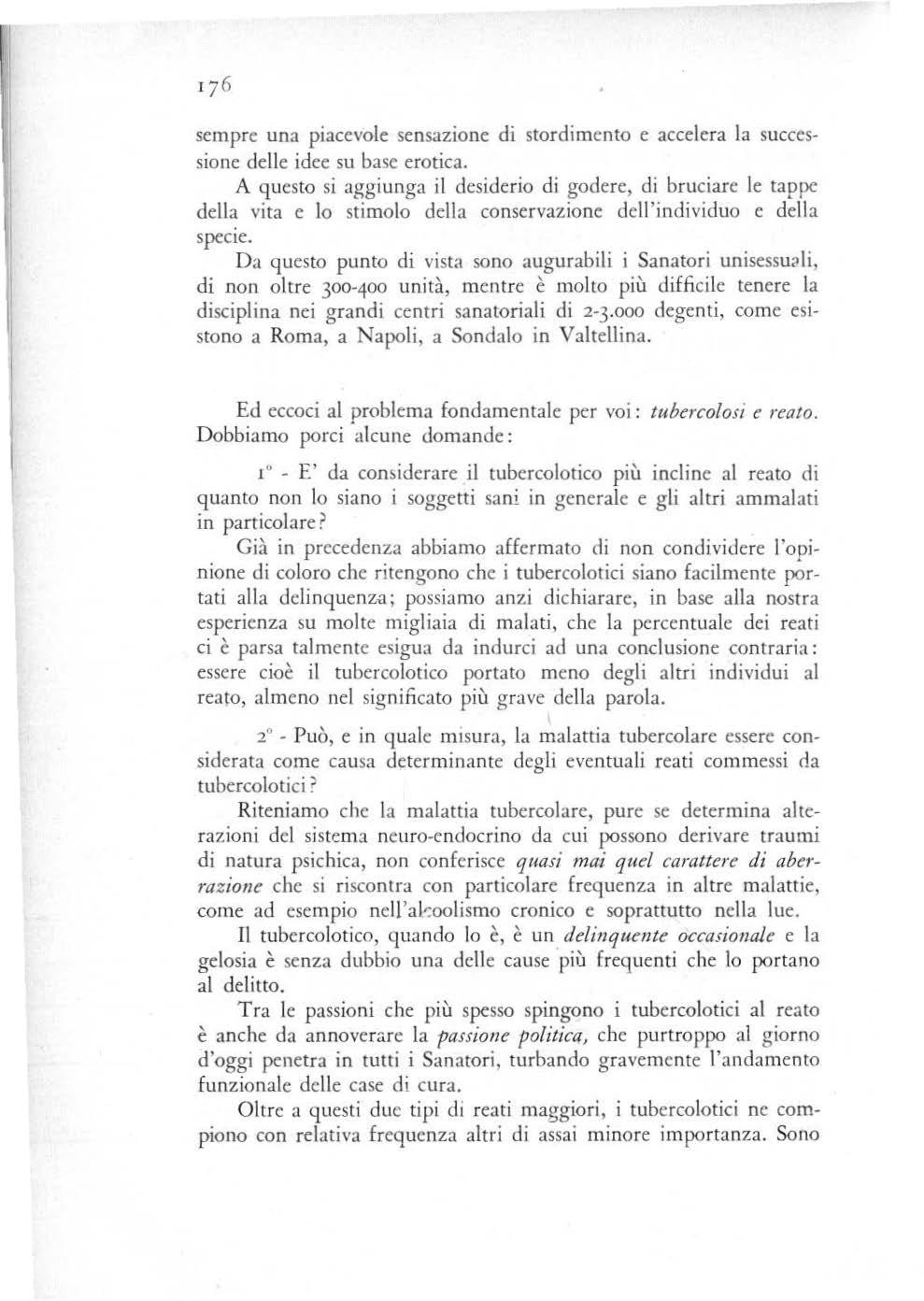
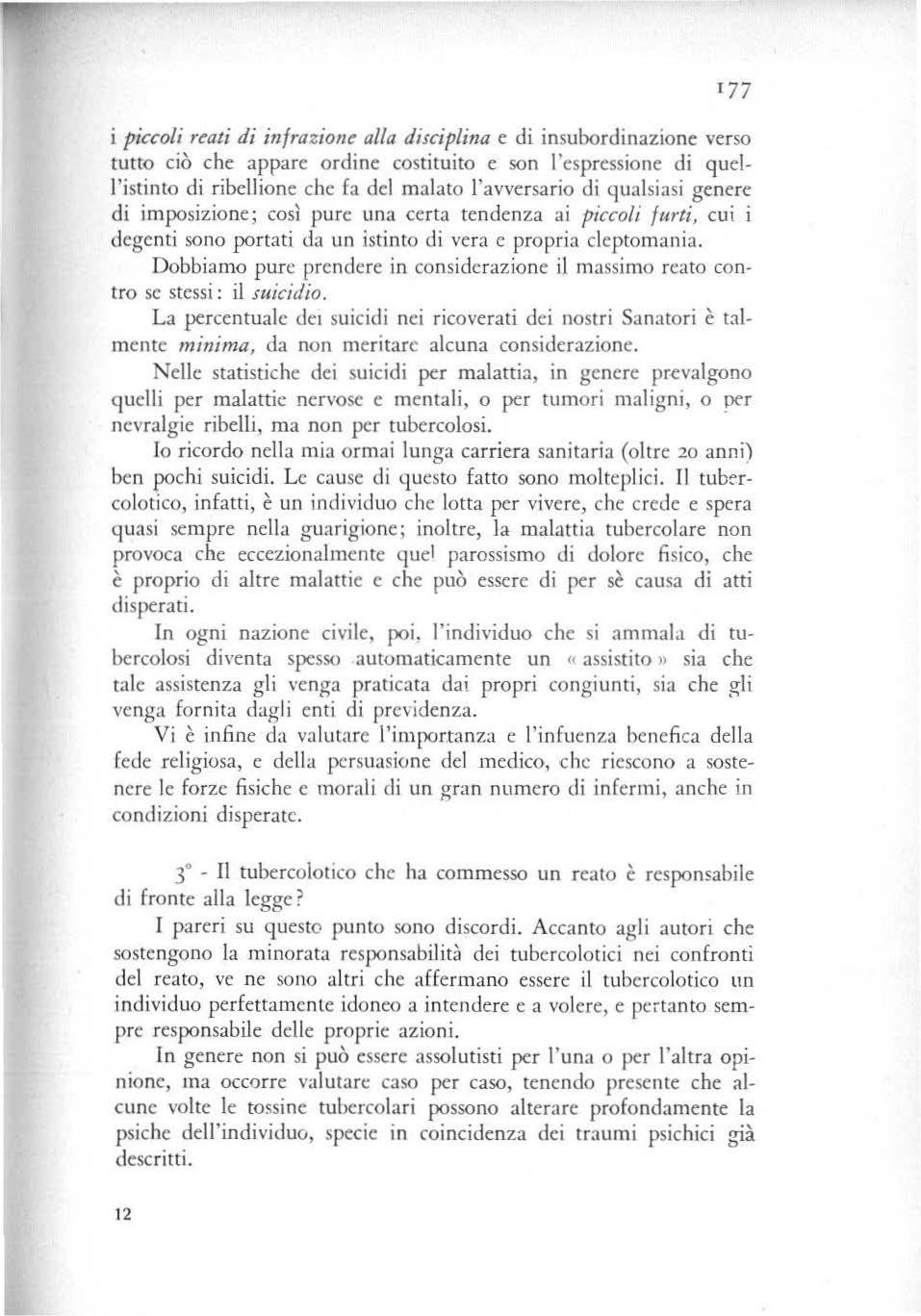


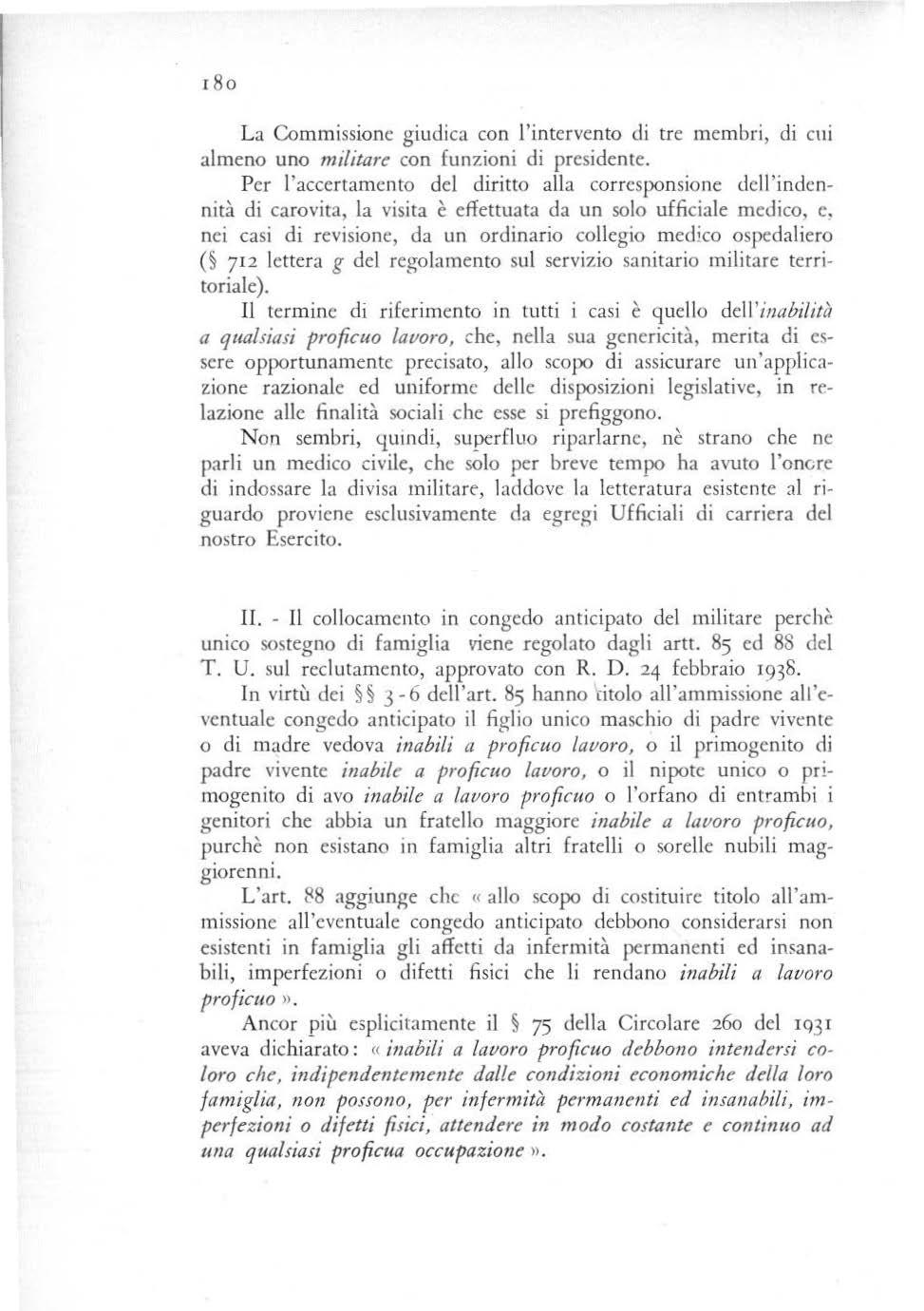
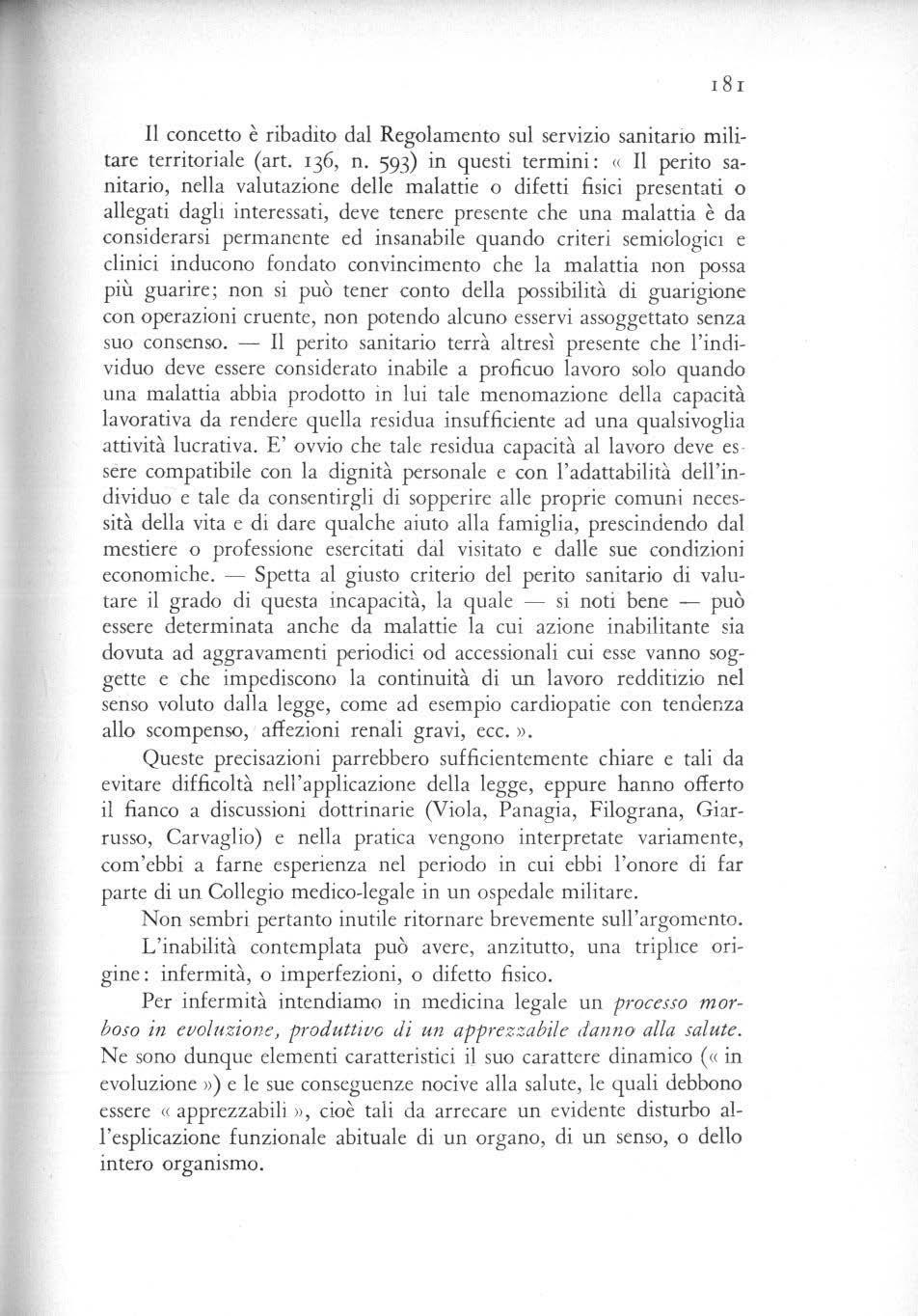
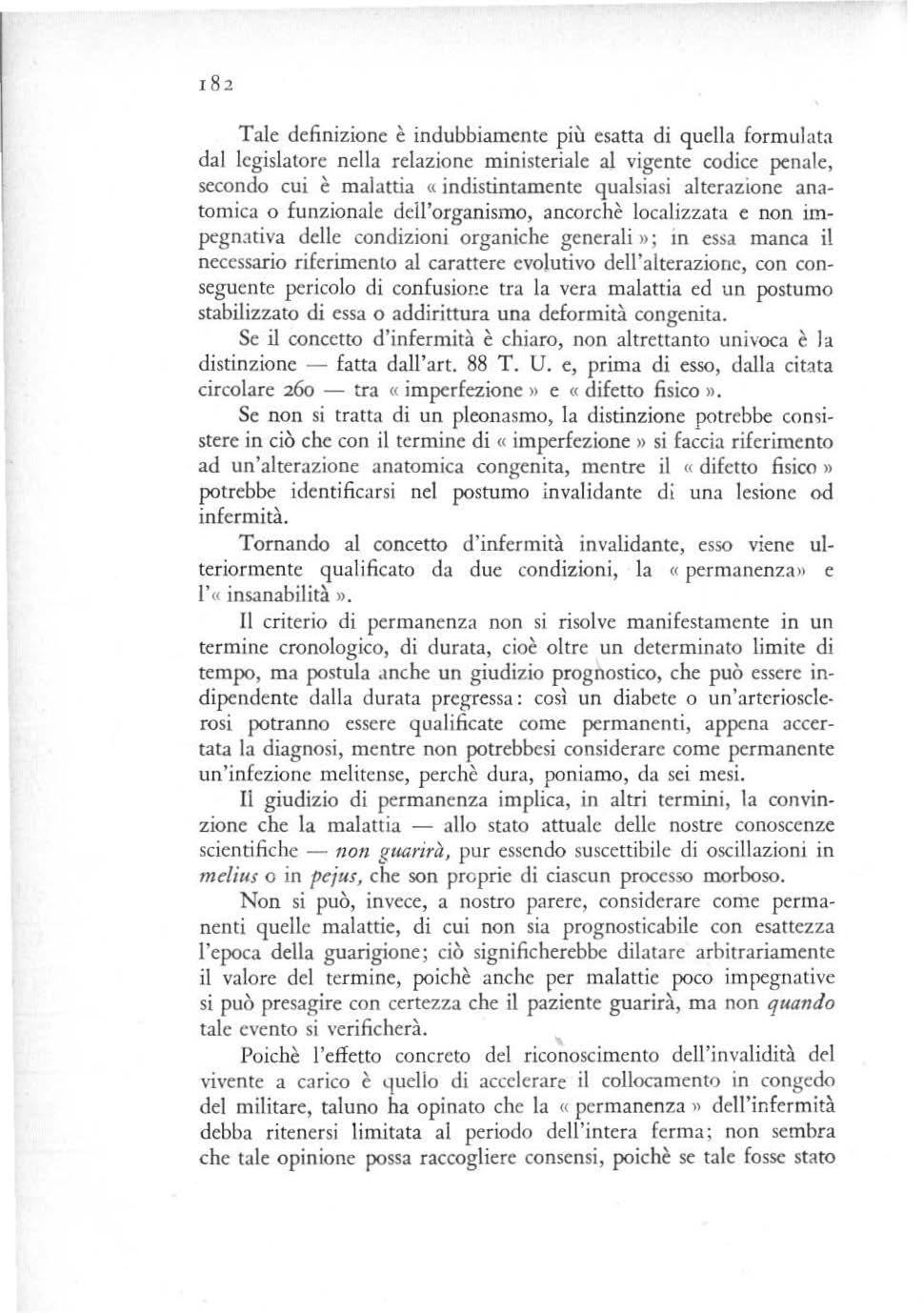
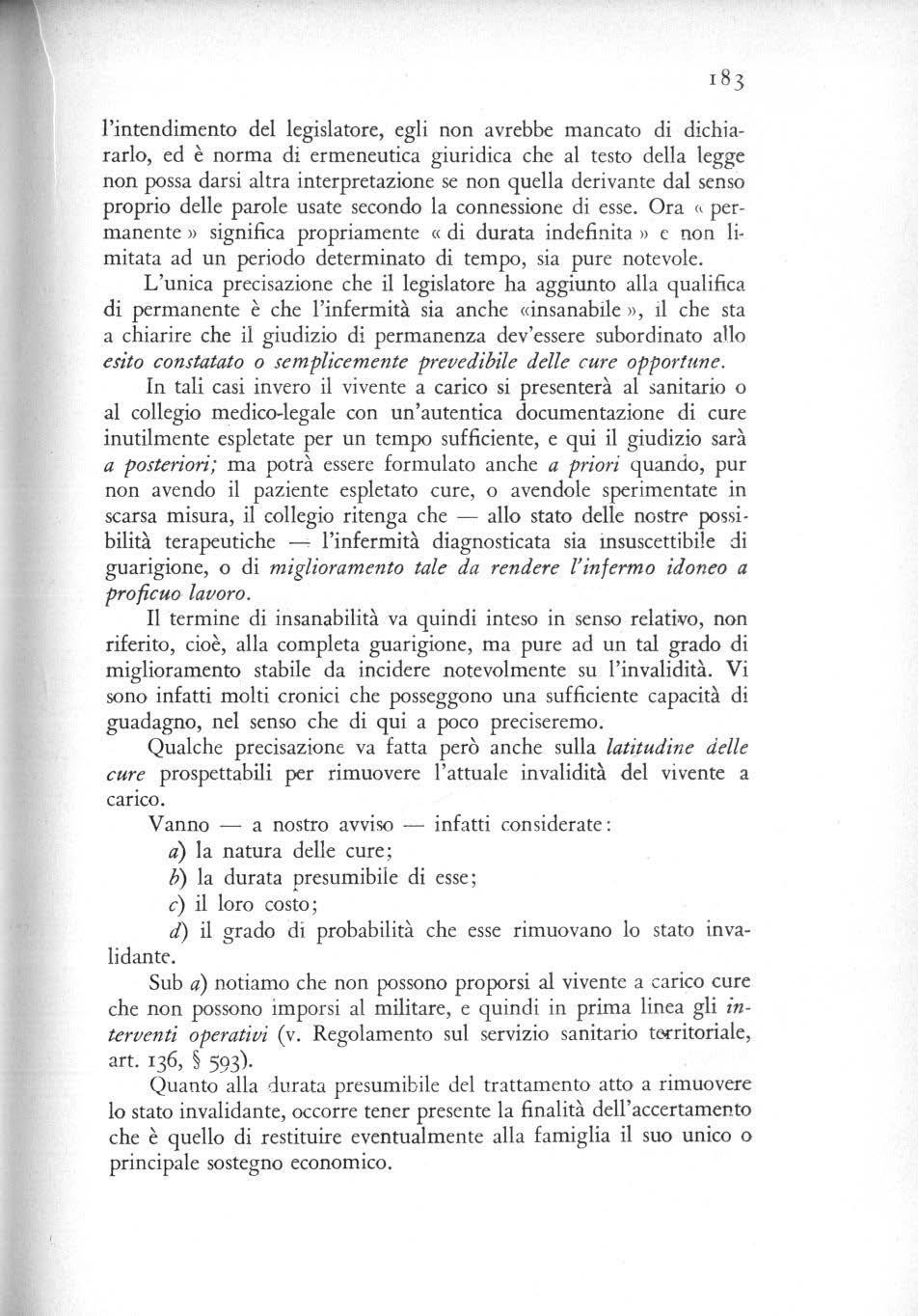

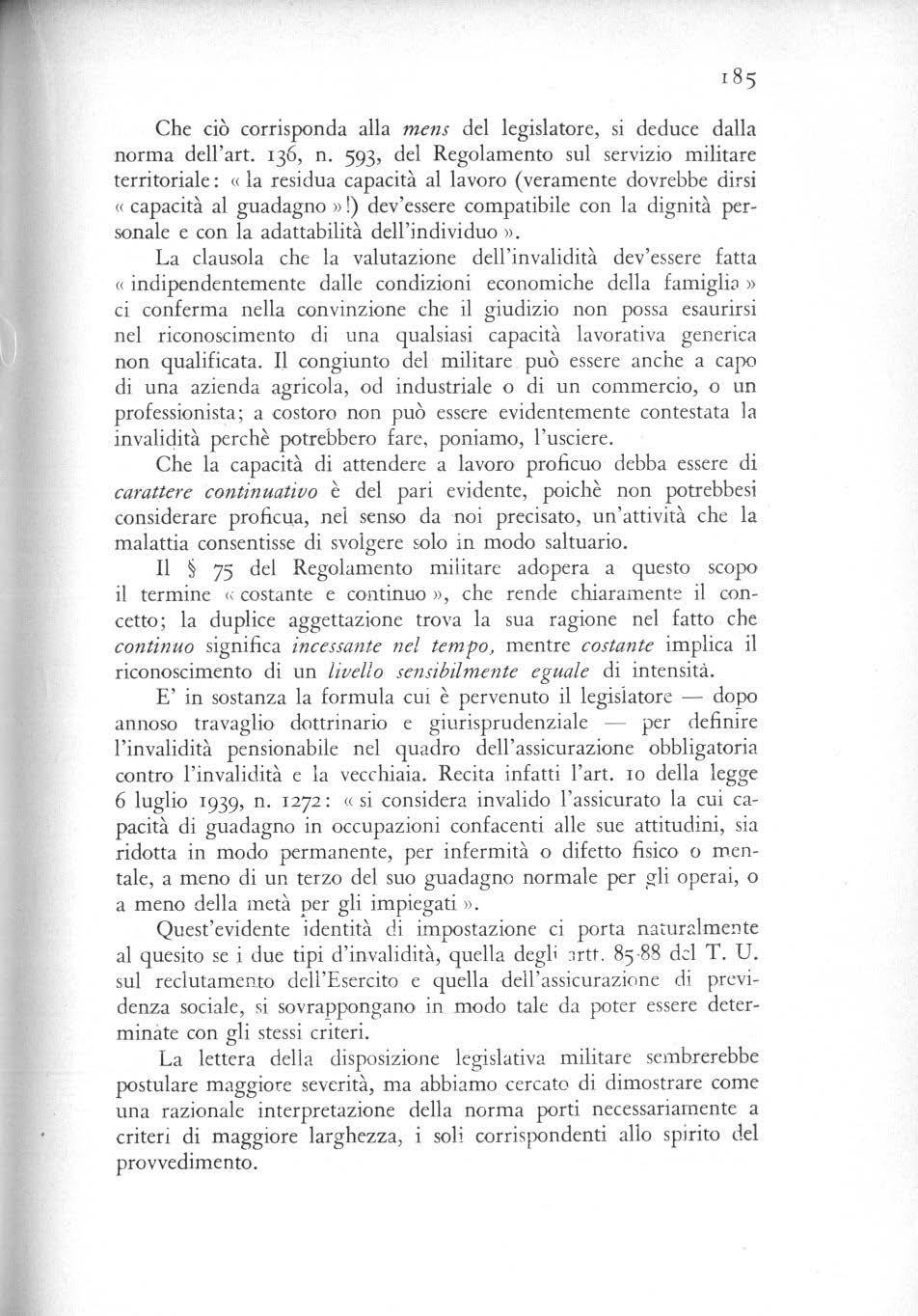

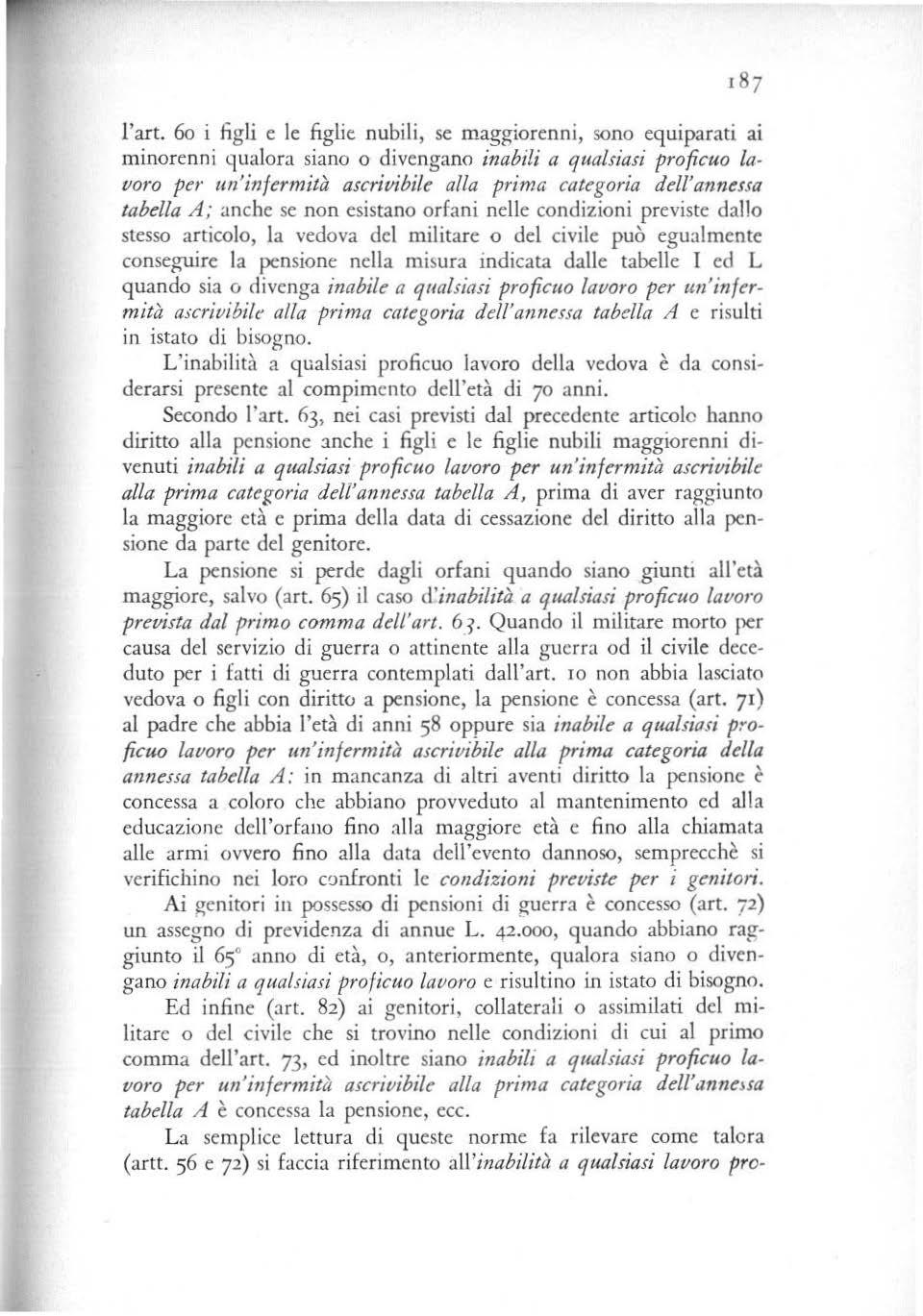
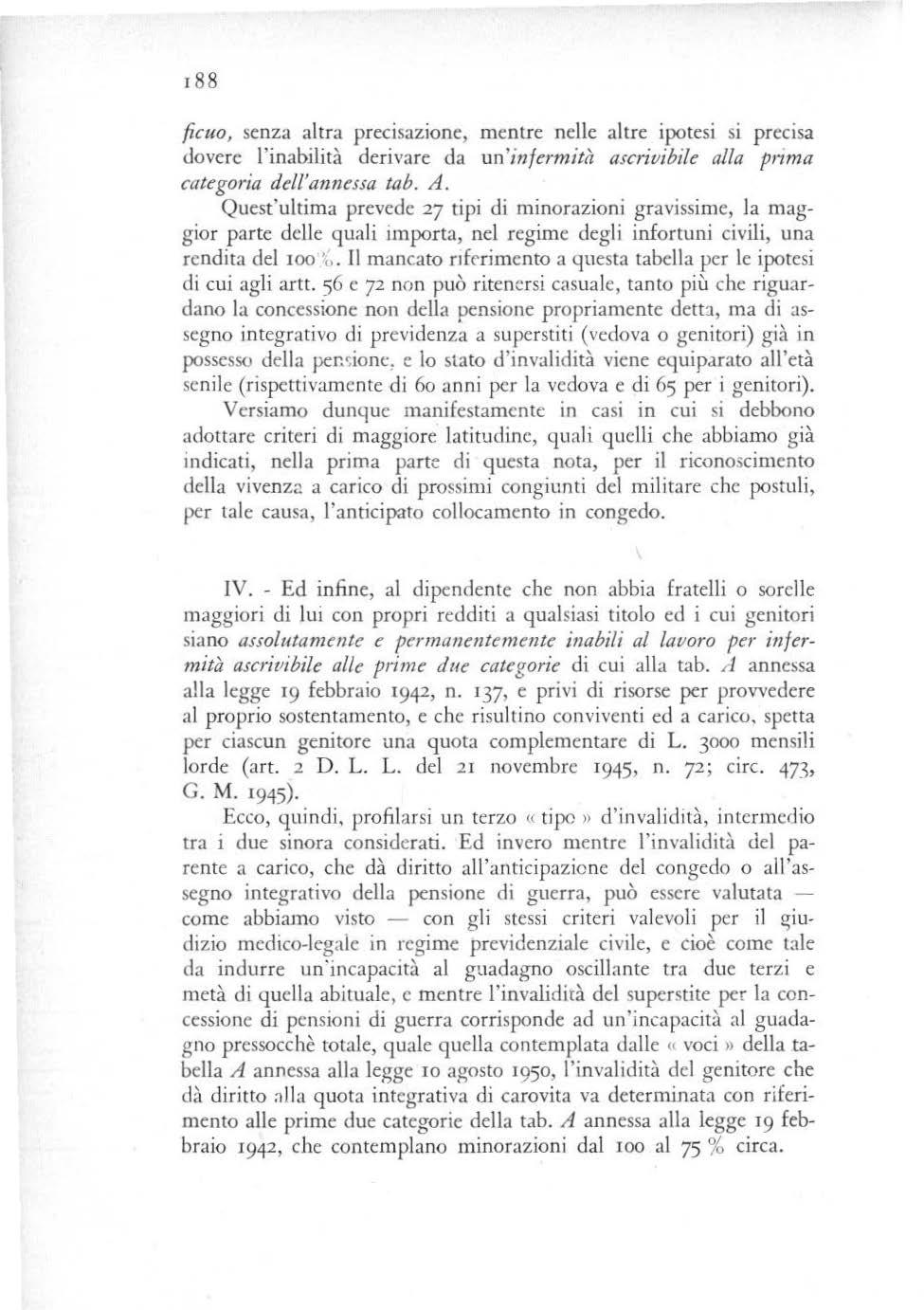

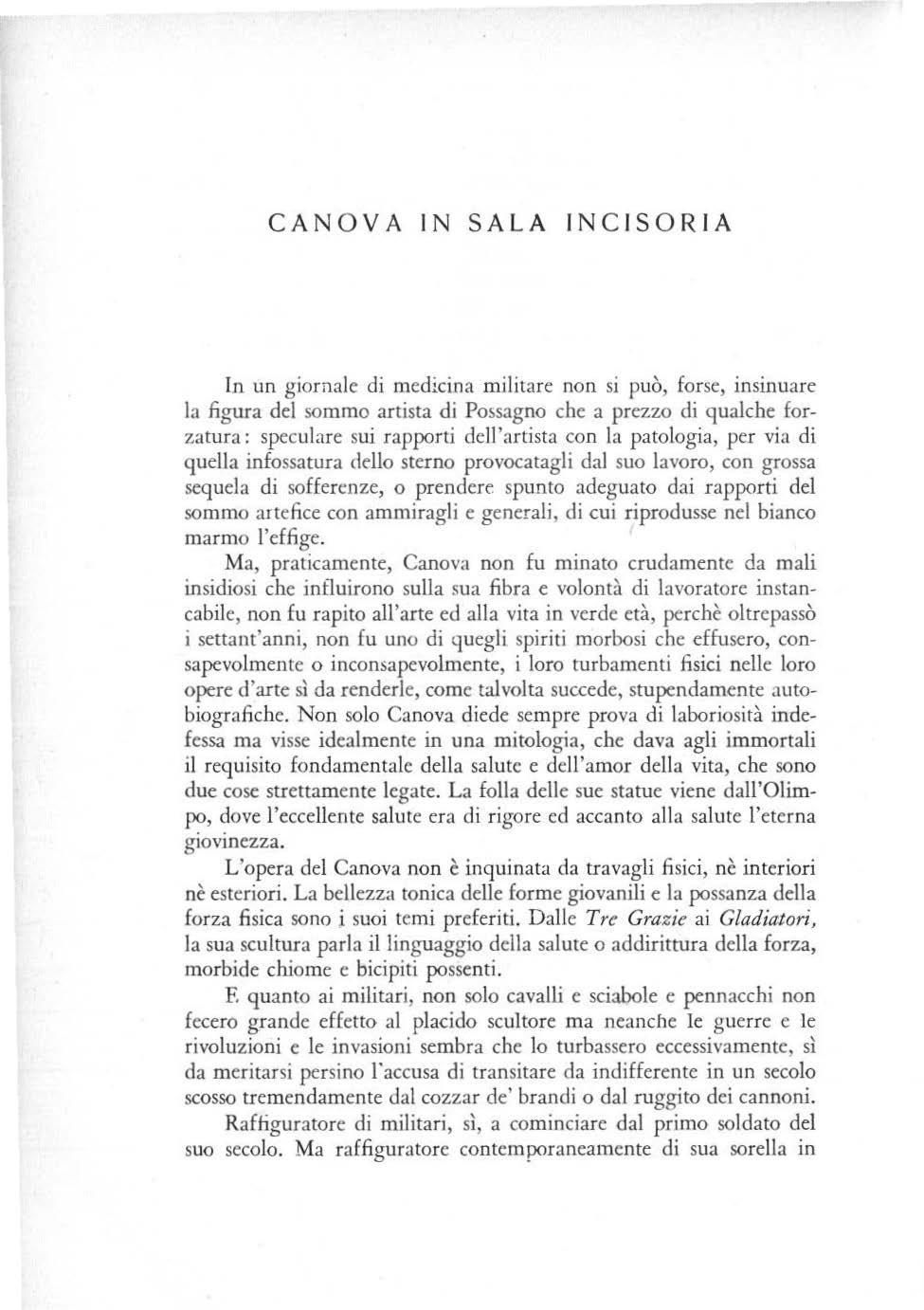
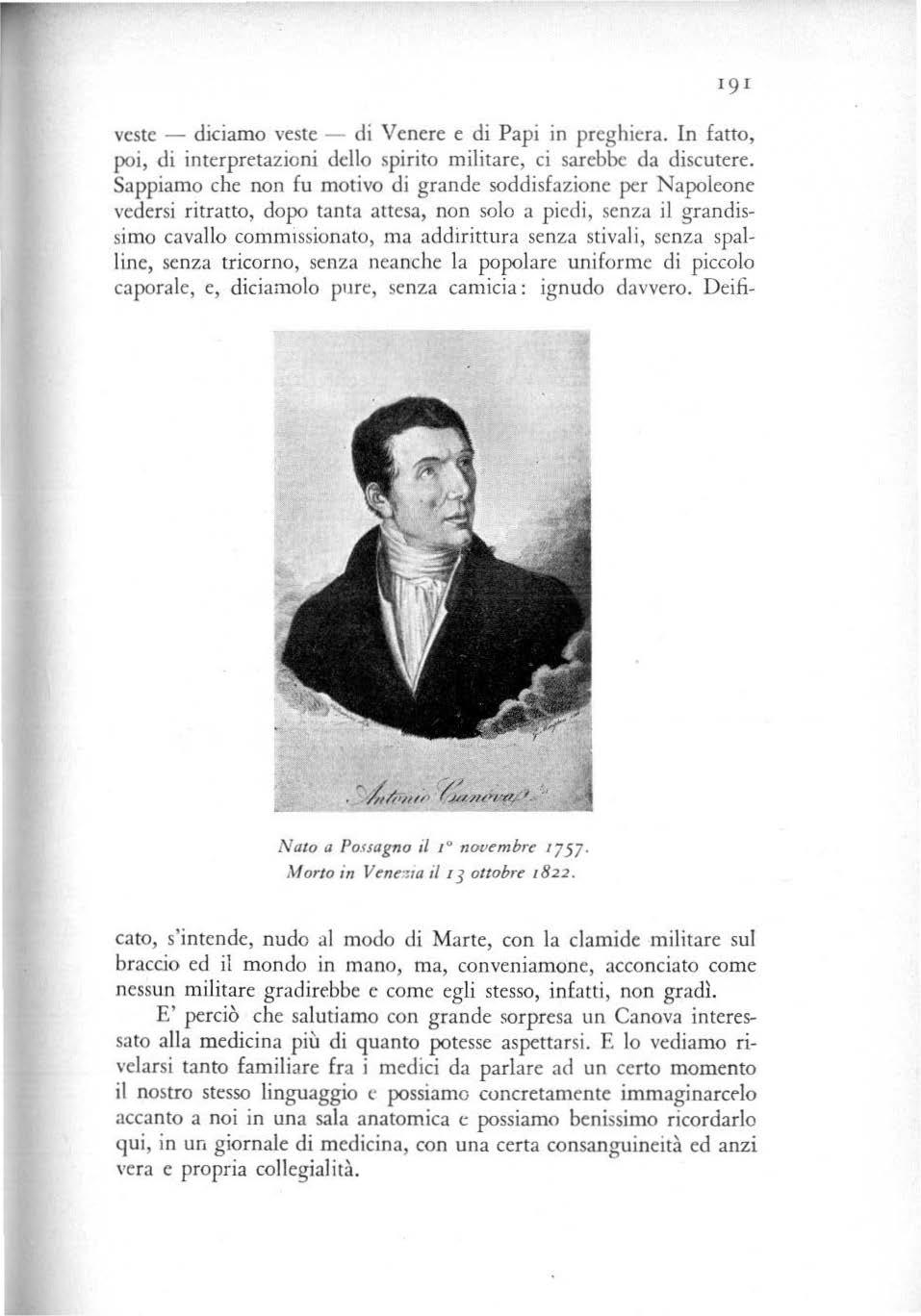

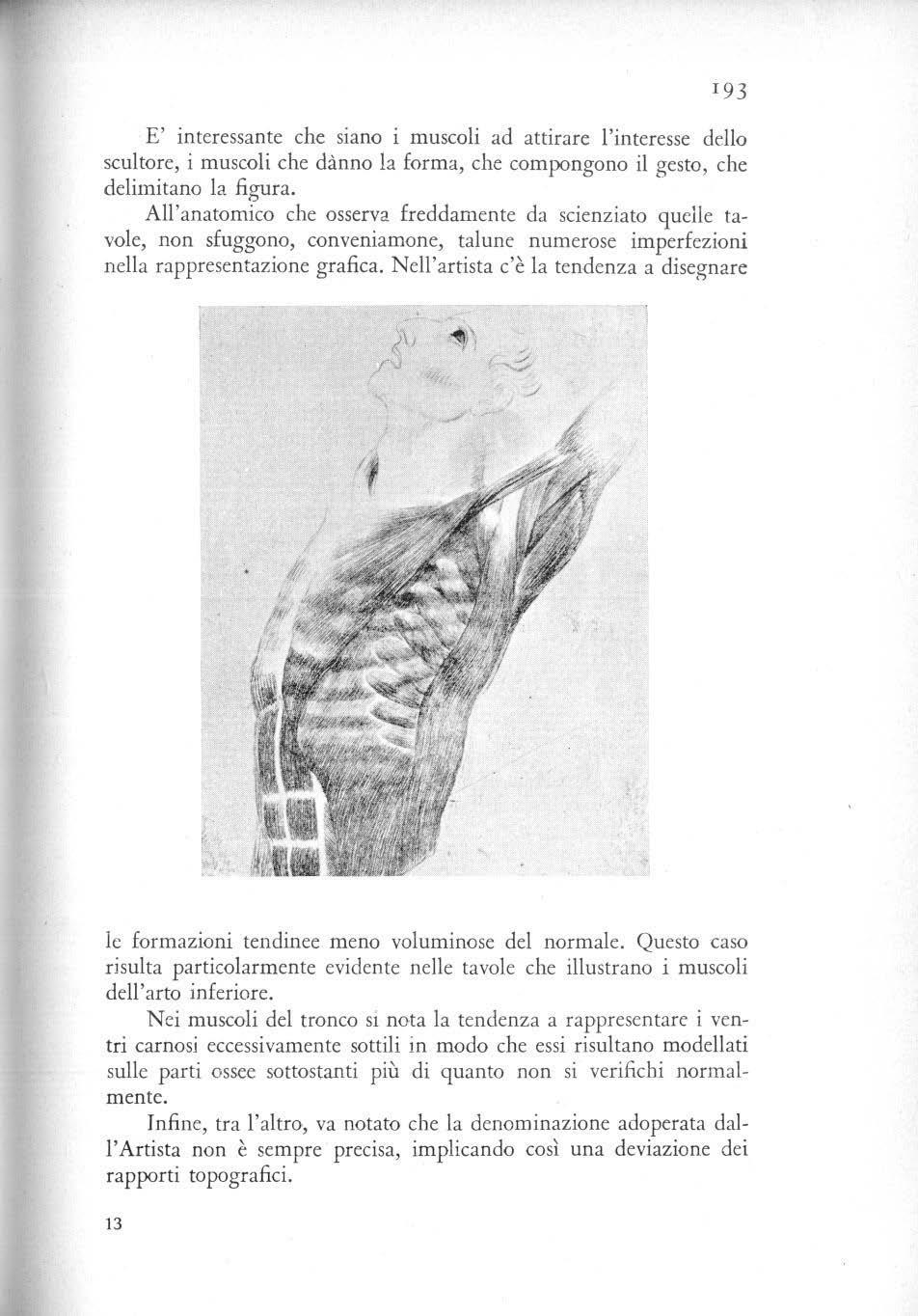
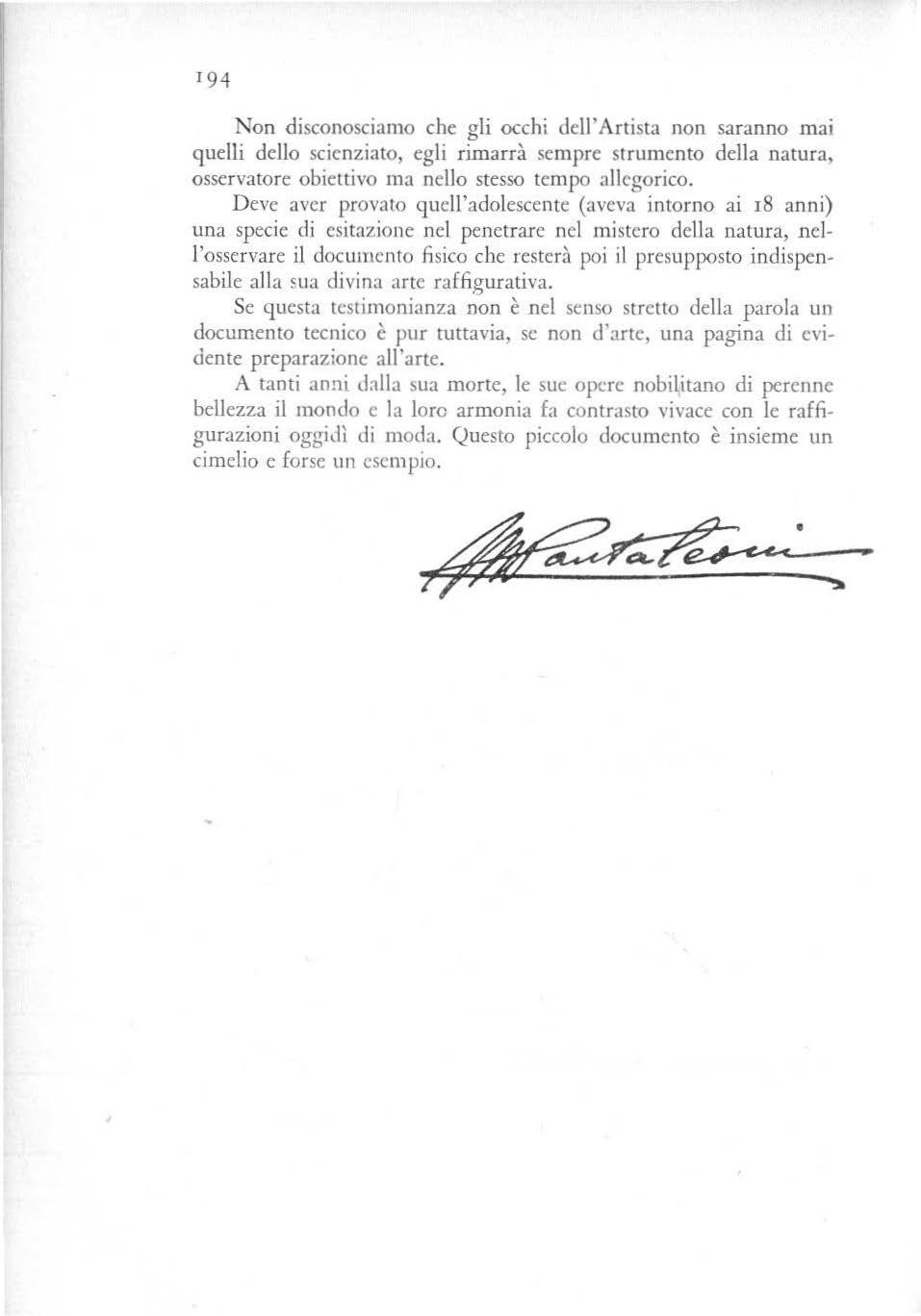
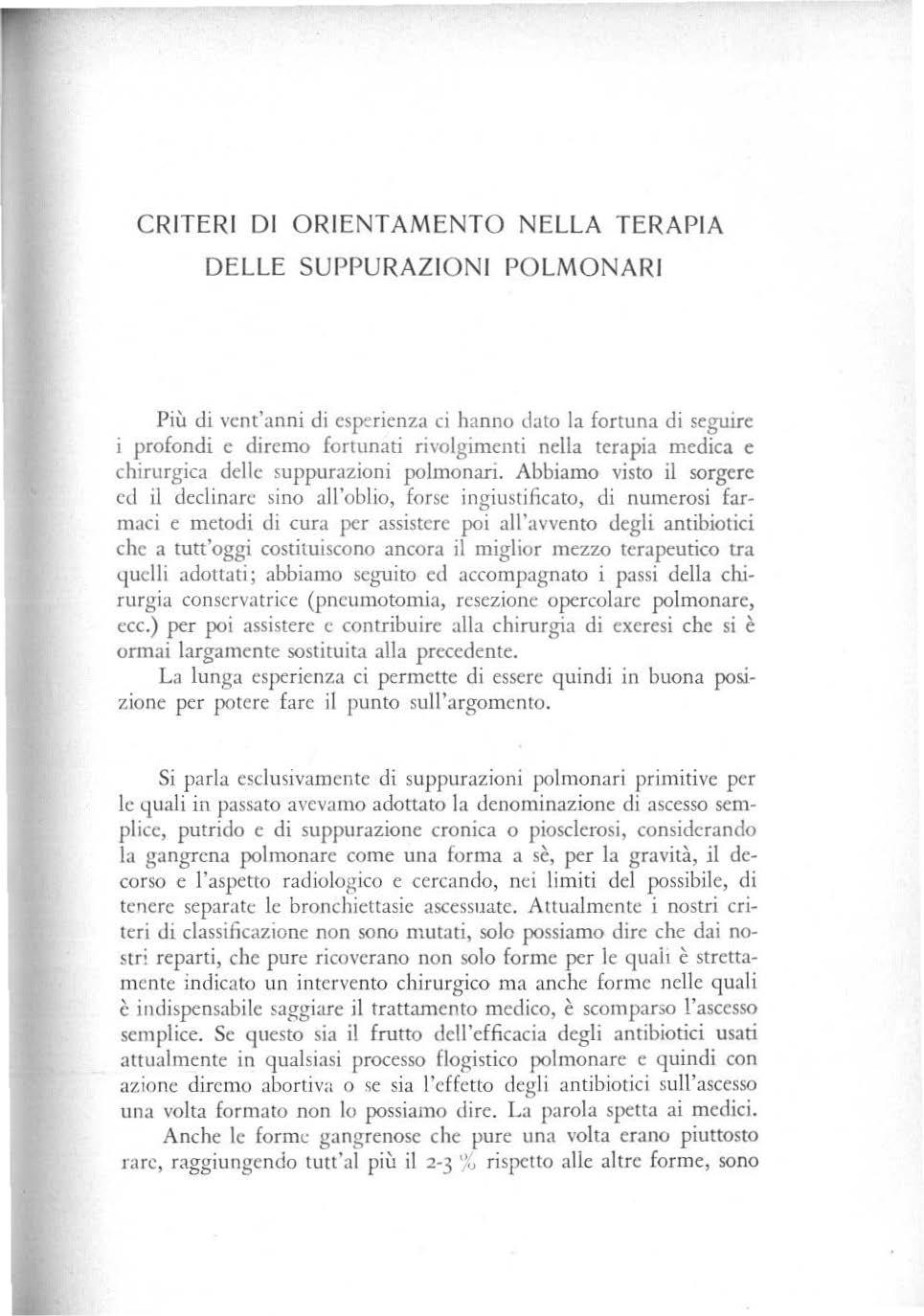
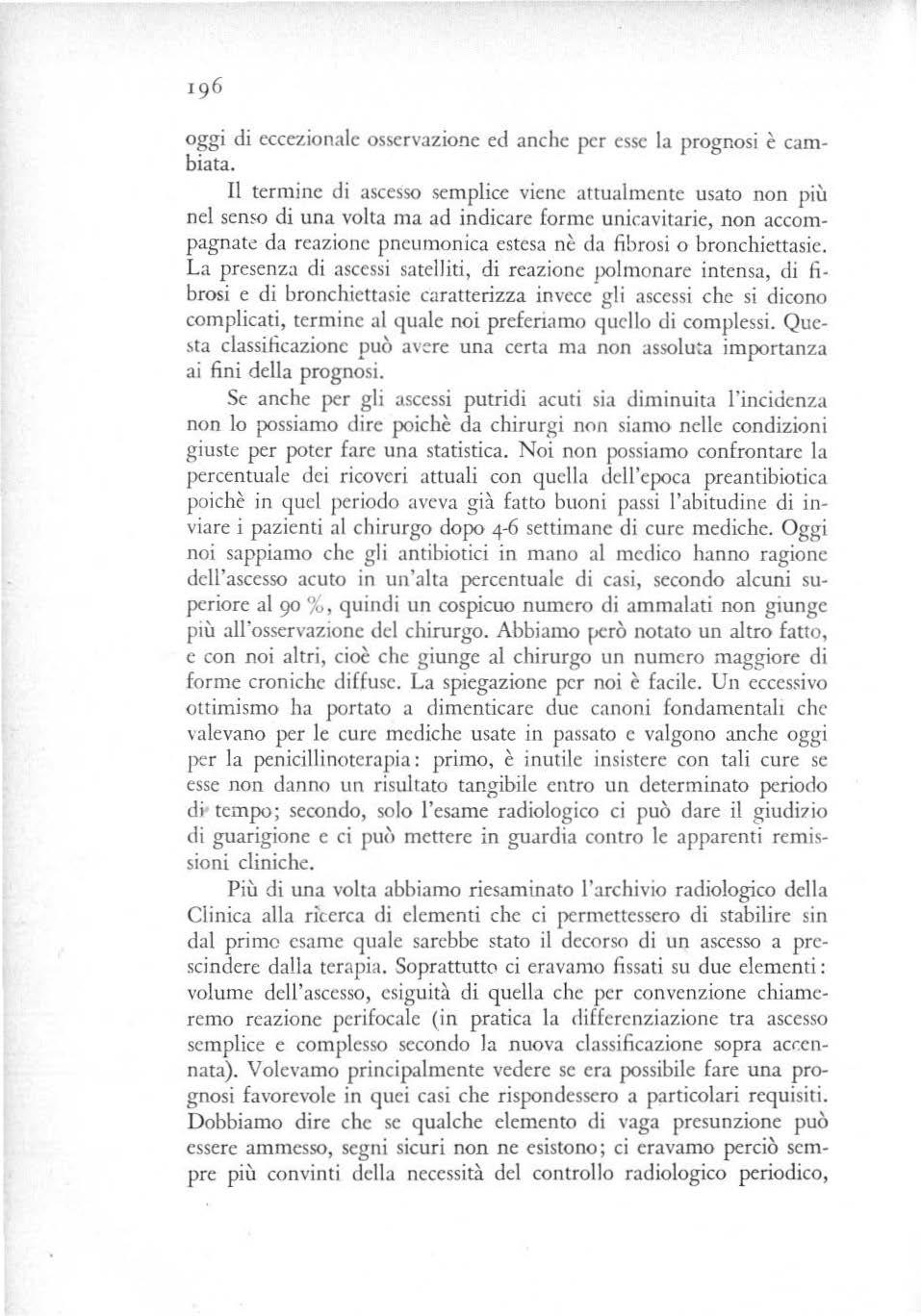
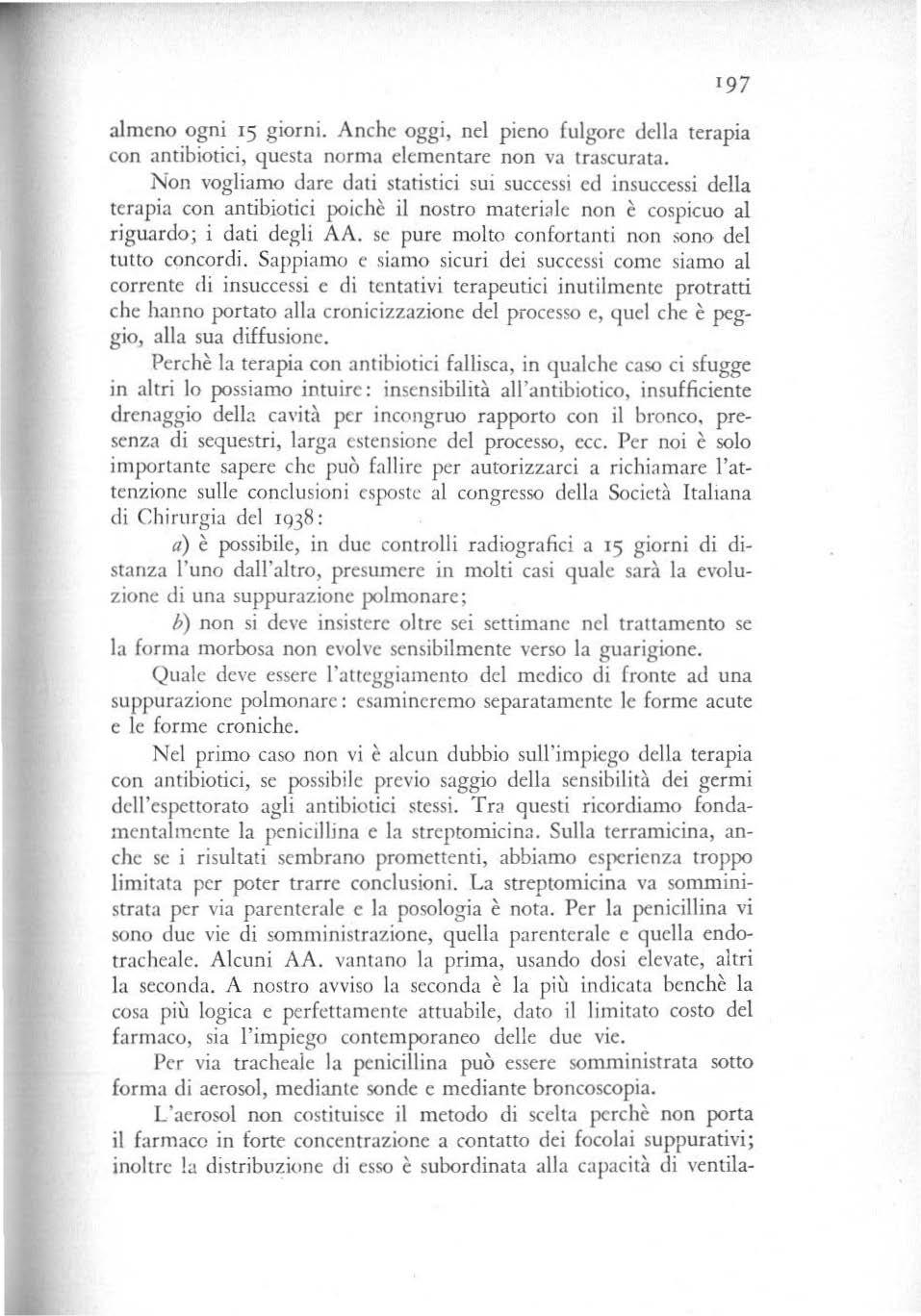

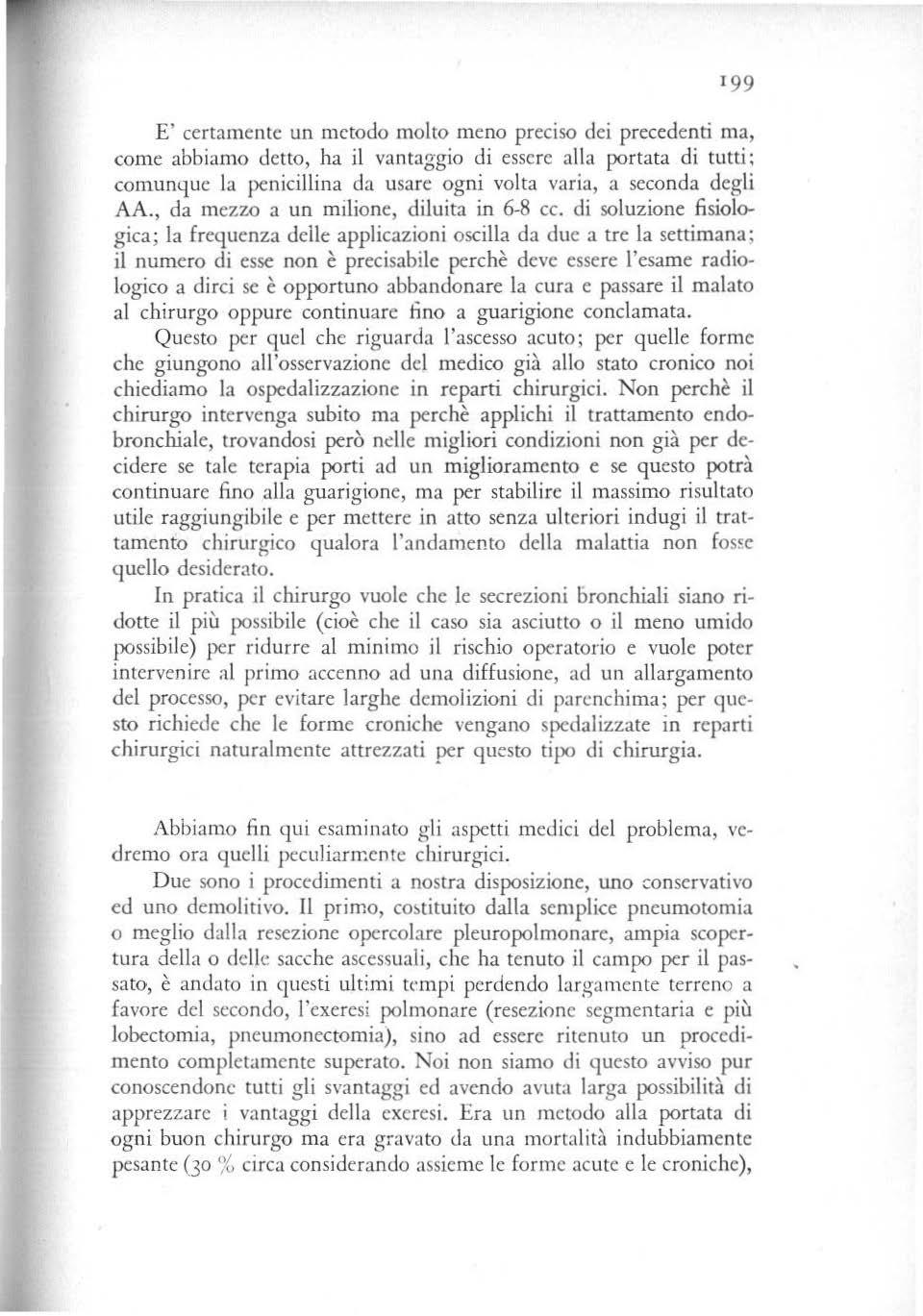
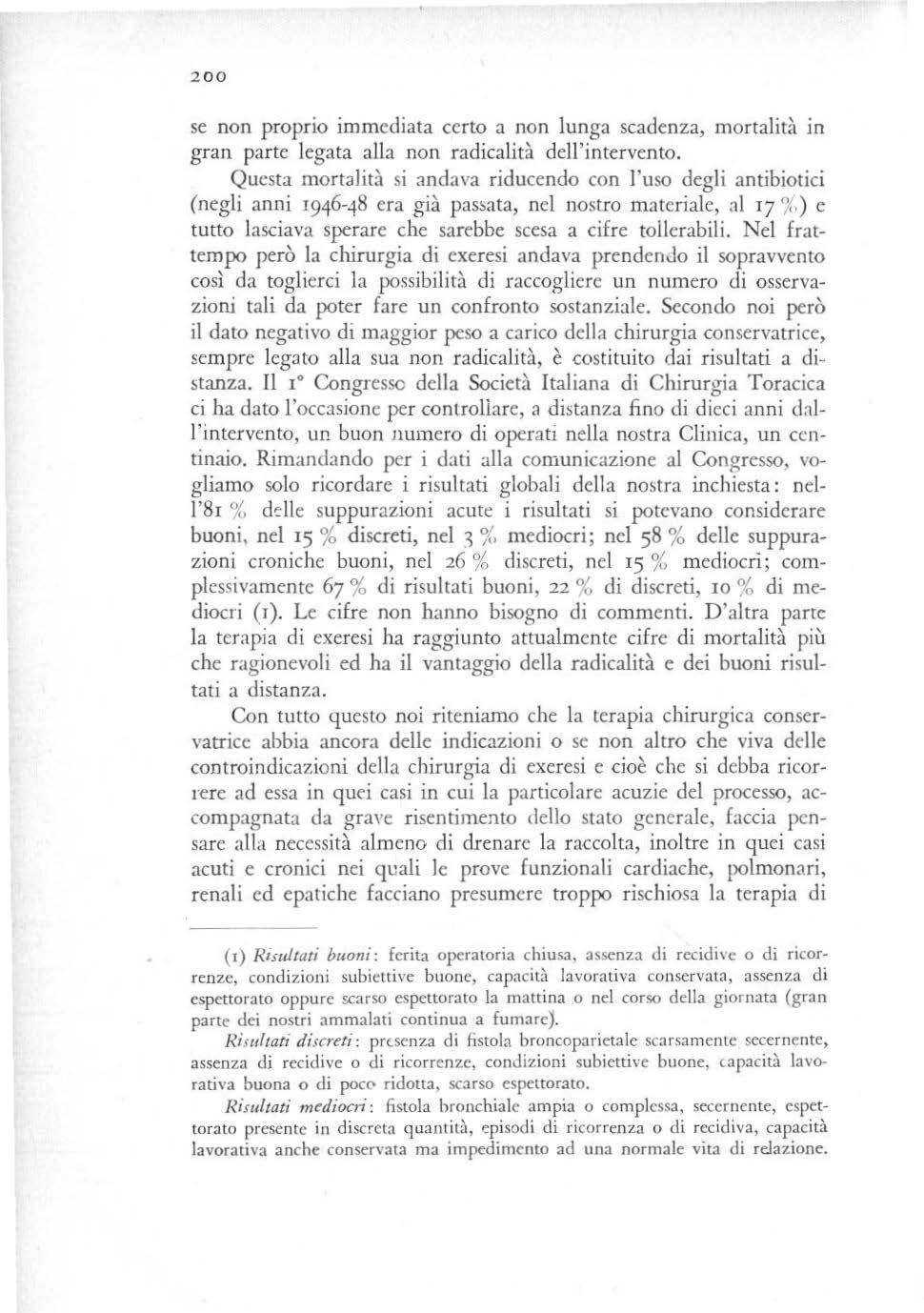

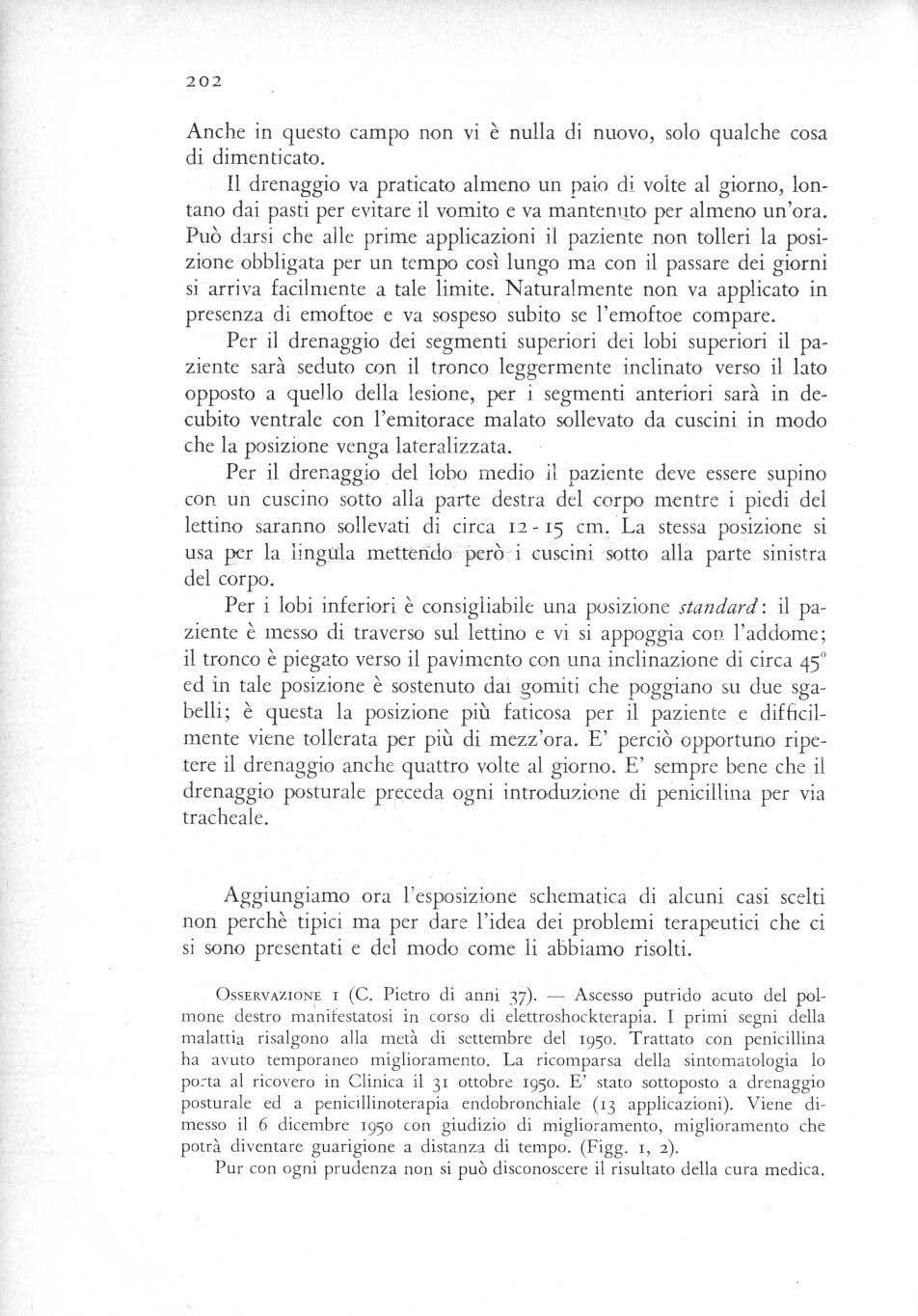
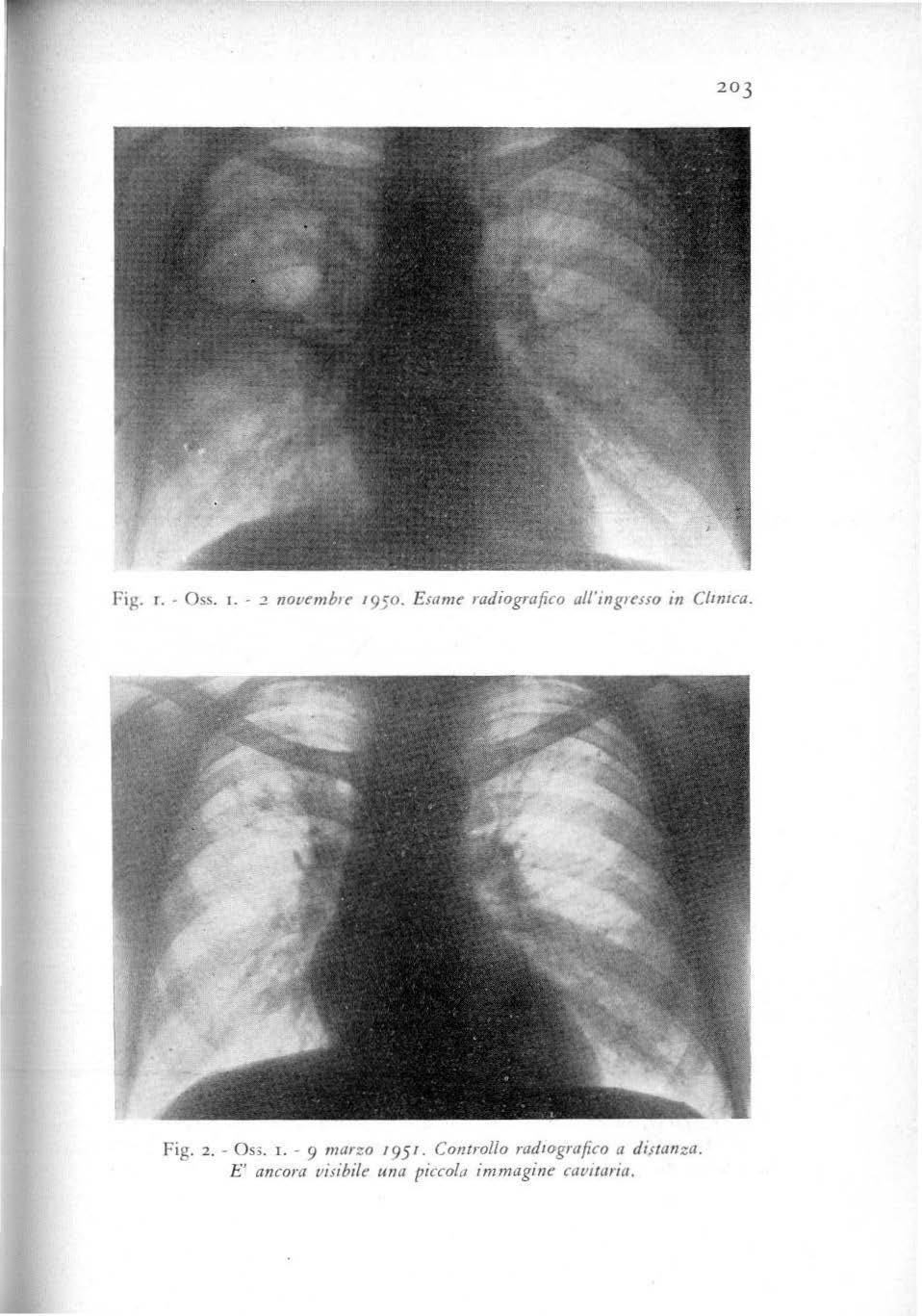
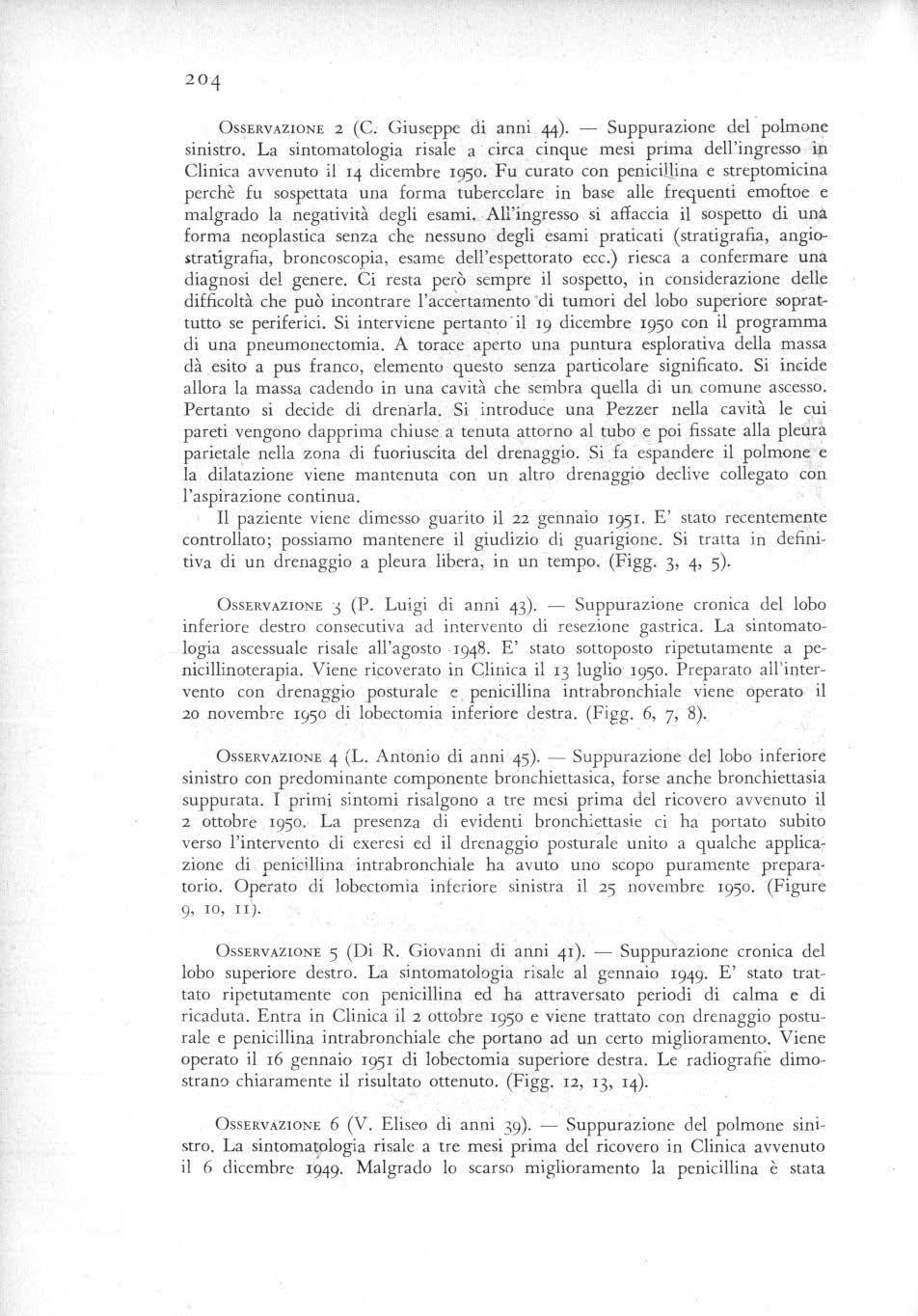
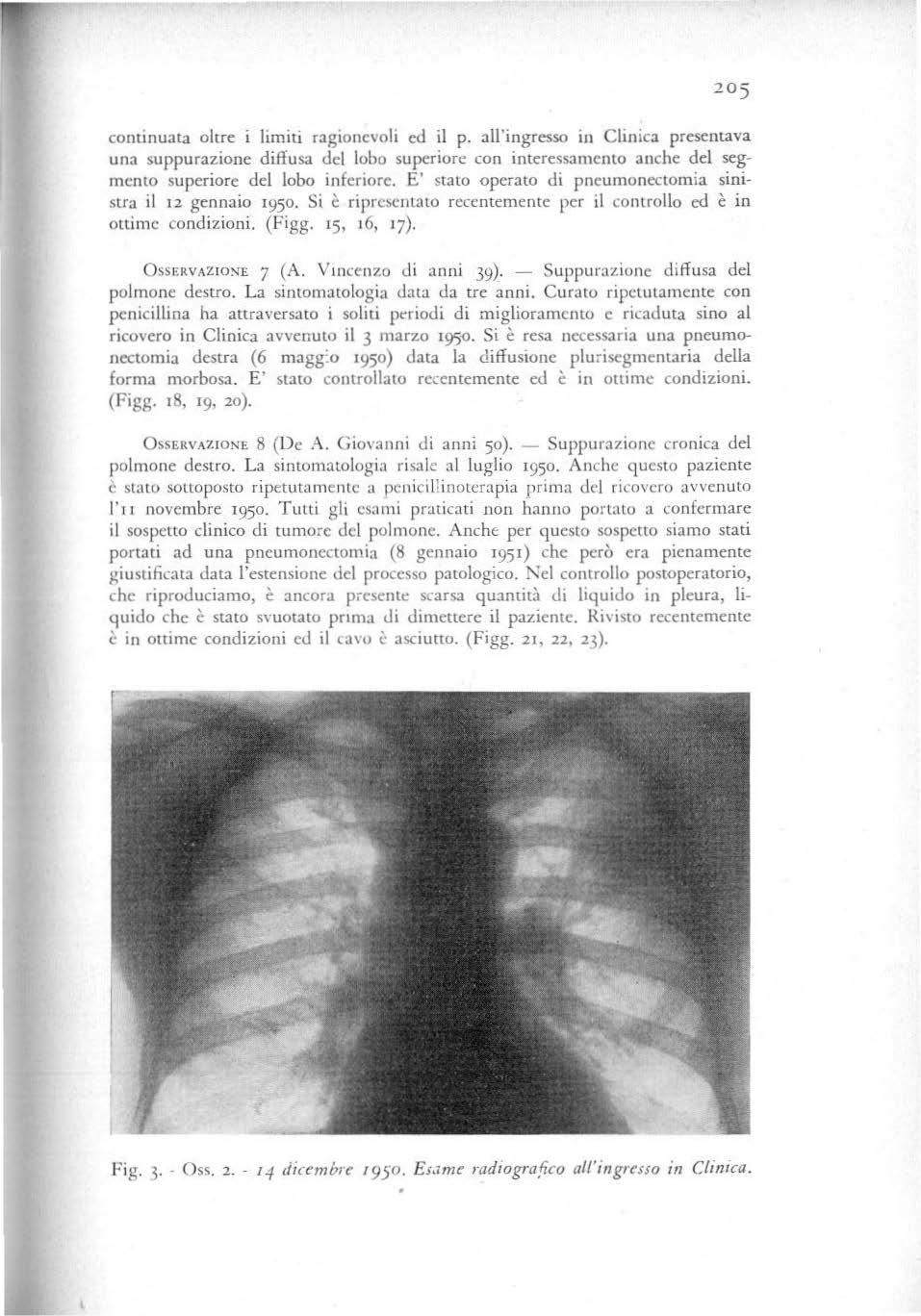
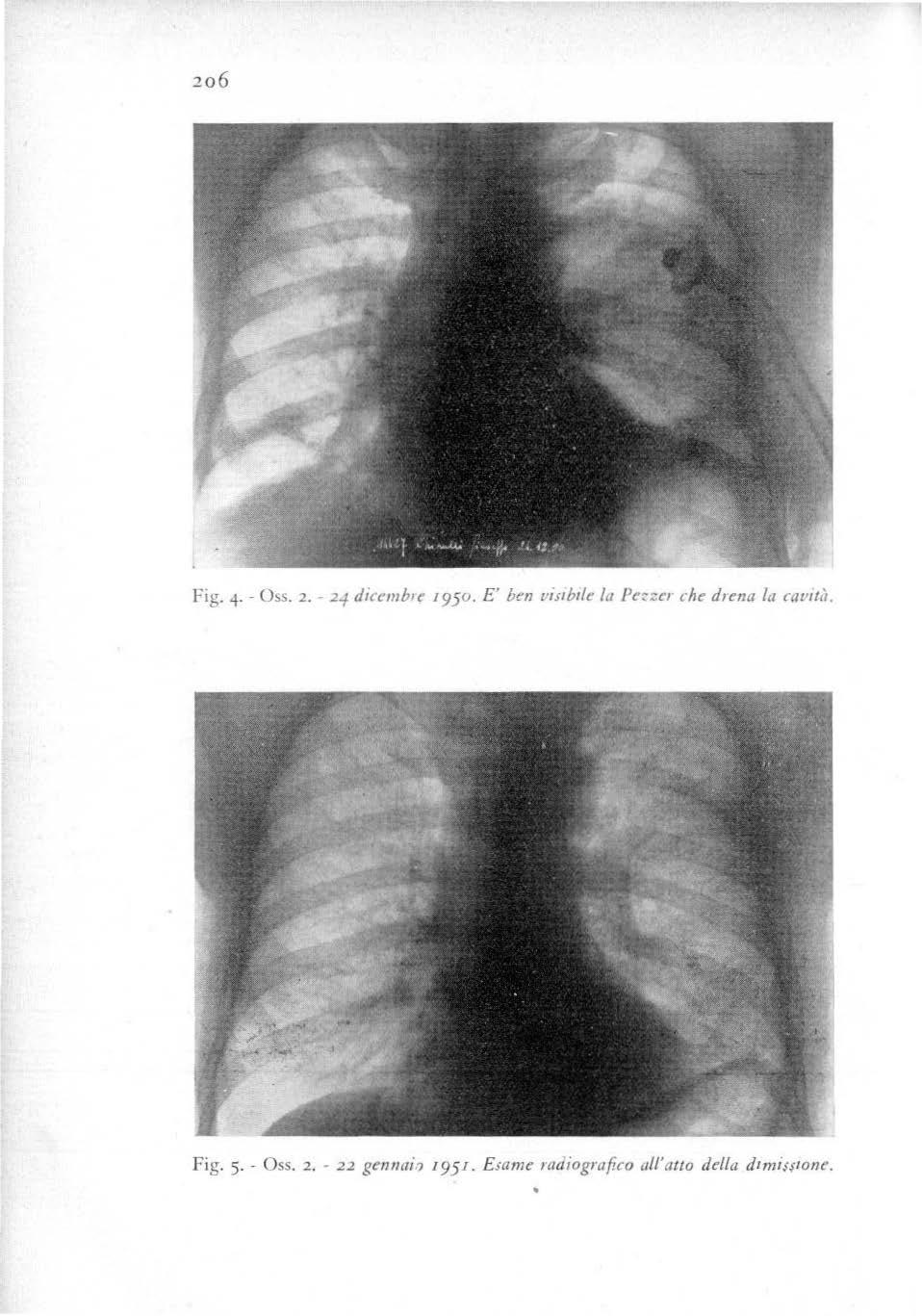


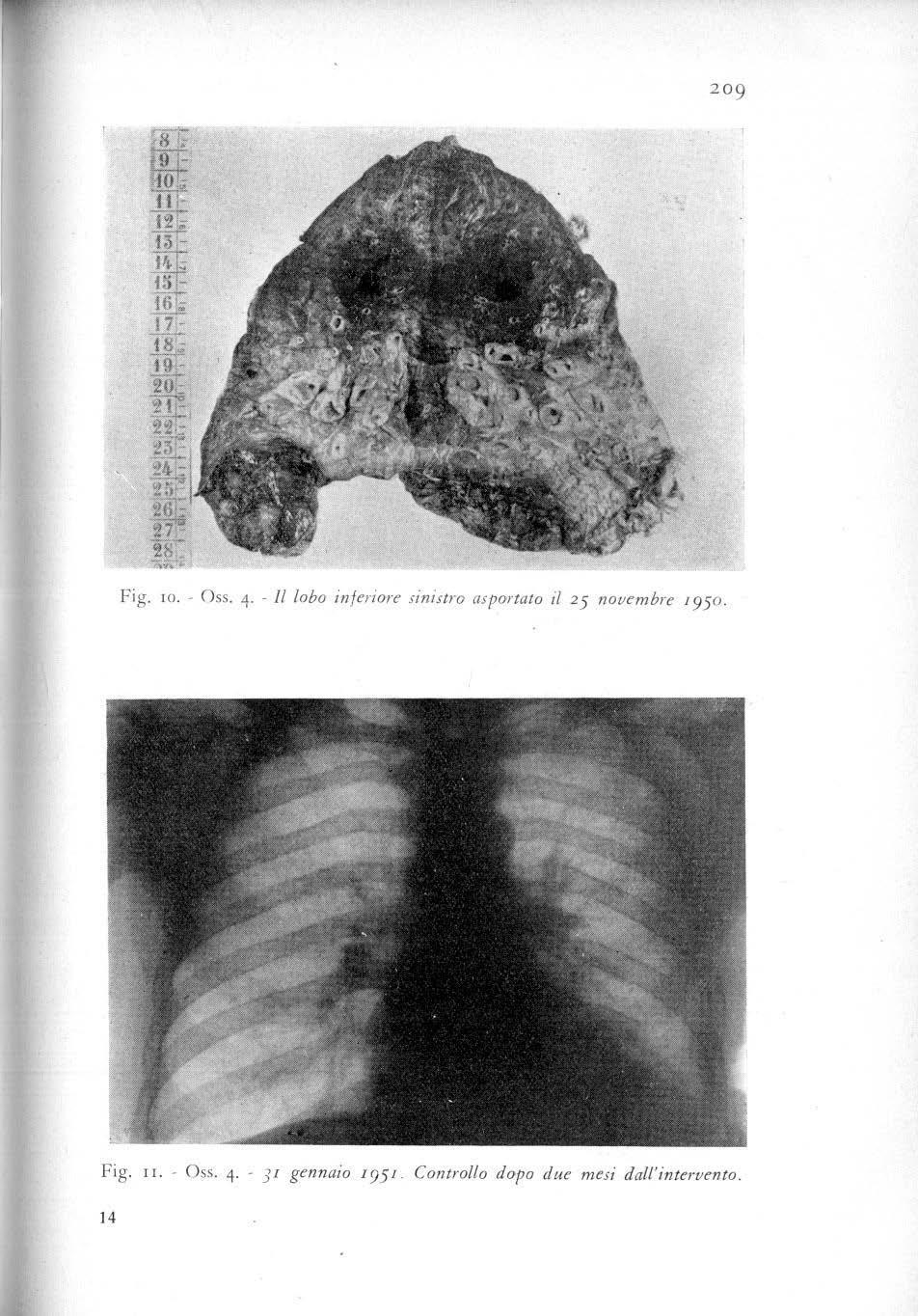 Fig. 10. - Oss. 4·- 11 lobo inferi ore sinistro asportato t! 25 novembre 1950 .
Fig. 10. - Oss. 4·- 11 lobo inferi ore sinistro asportato t! 25 novembre 1950 .
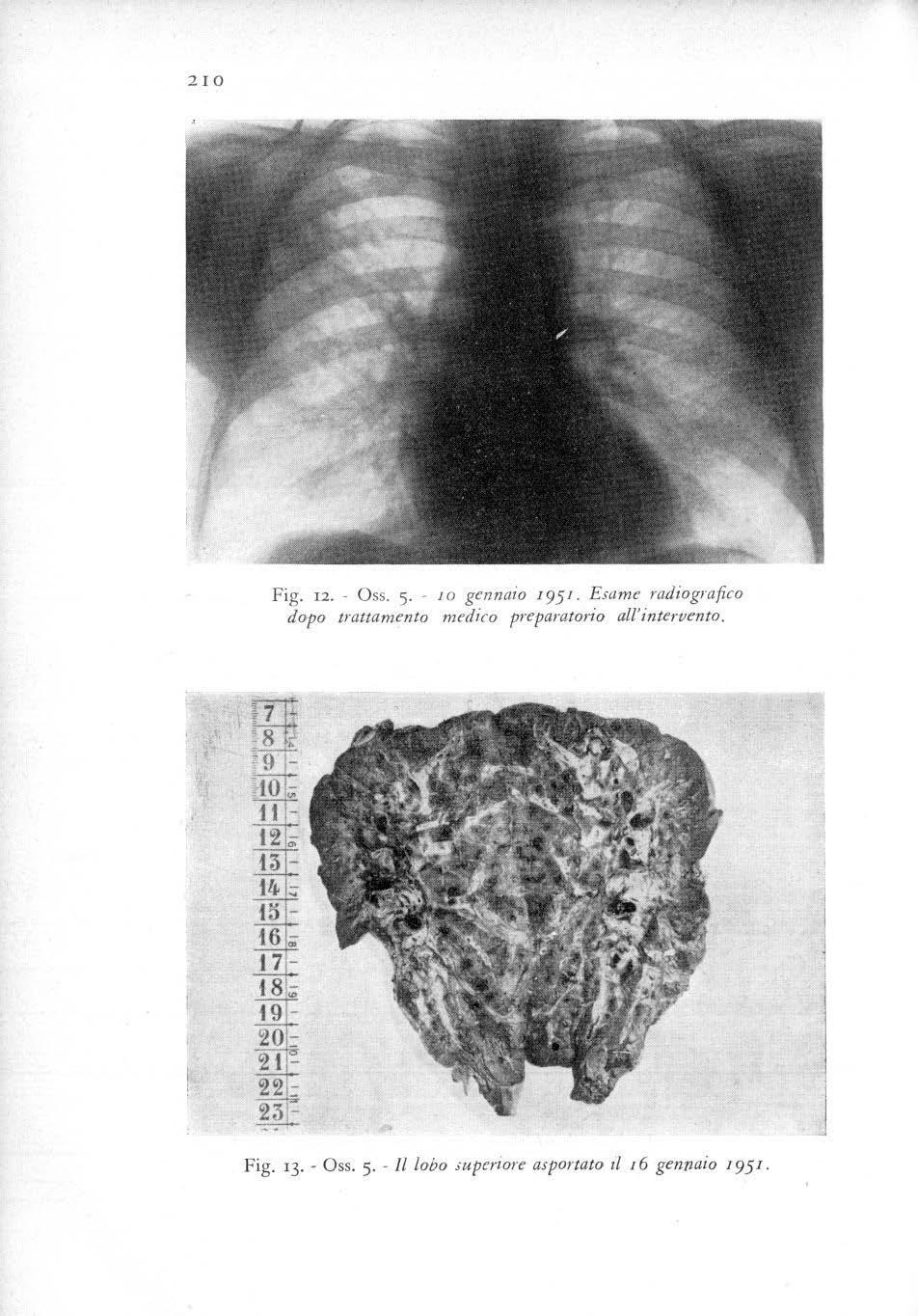

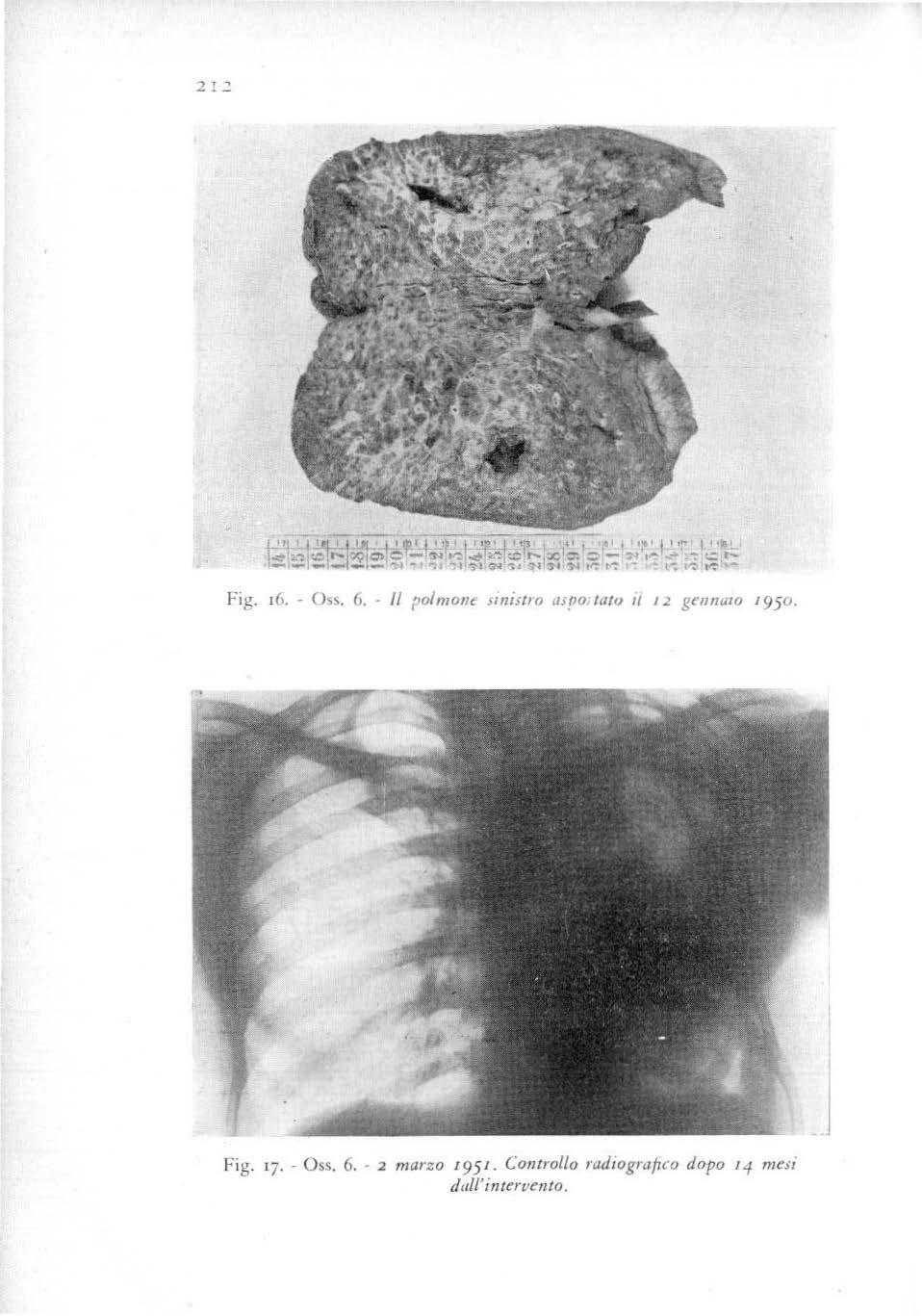
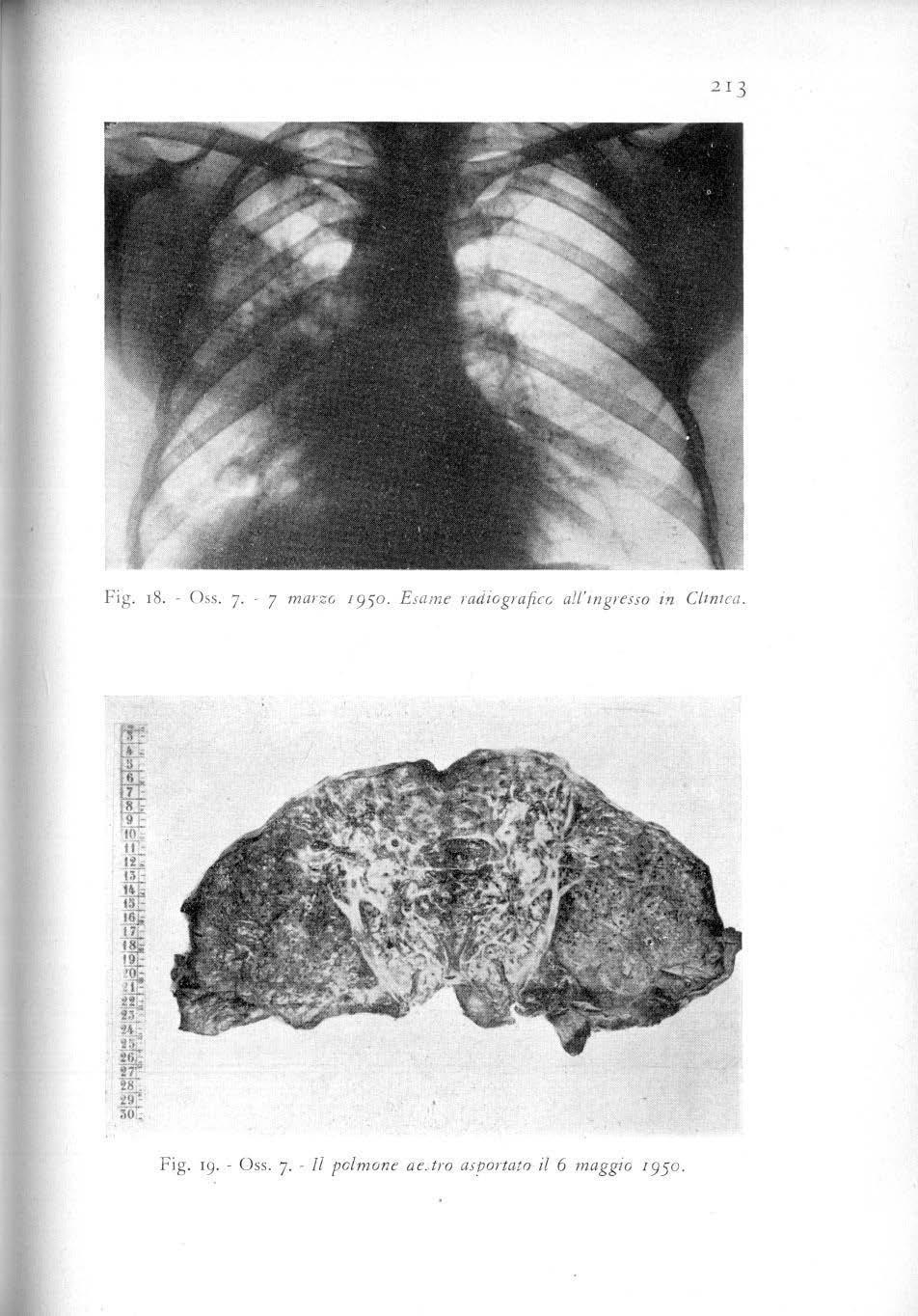
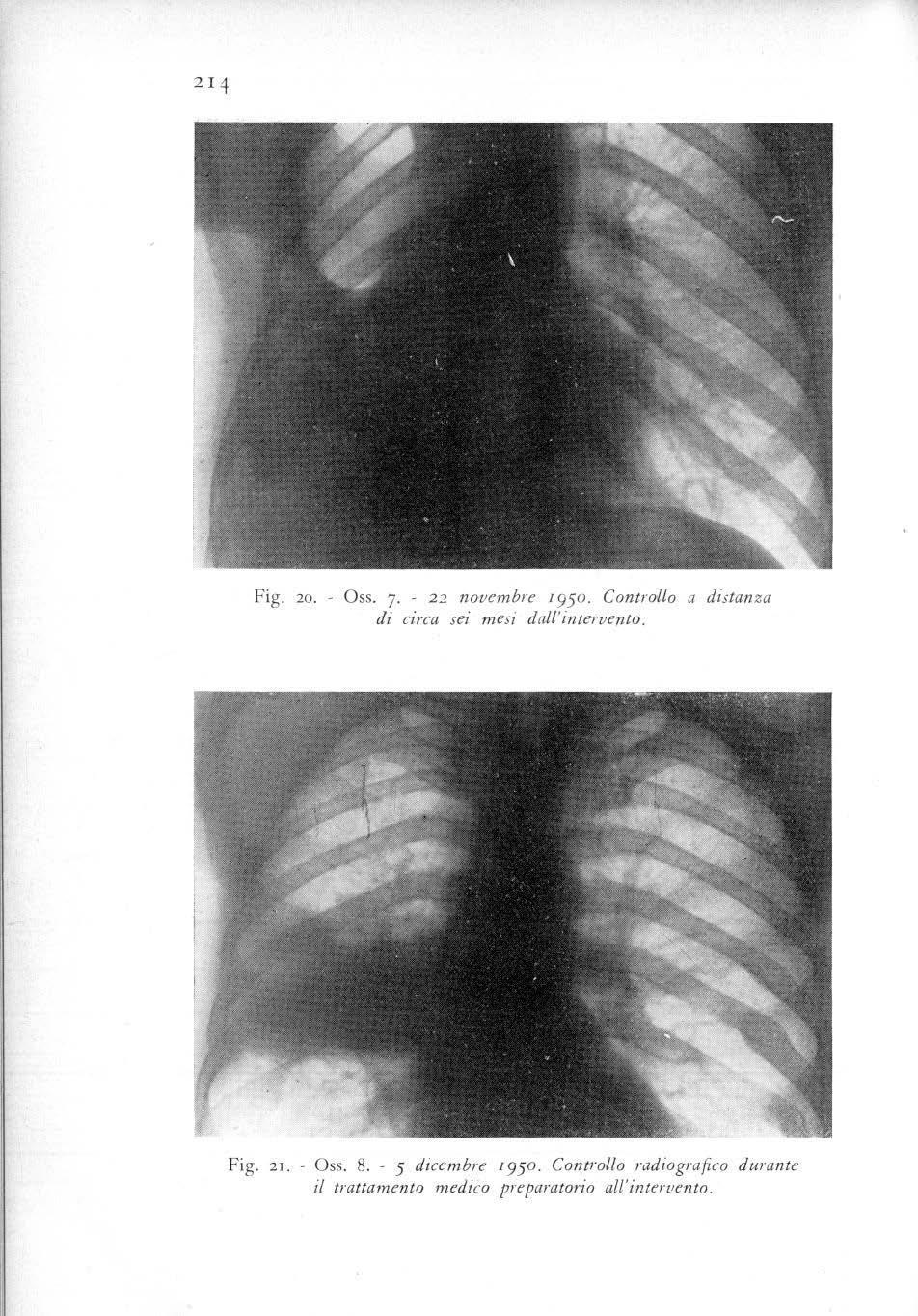 Fig. 20. - Oss. 7· - 22 novembre 1950. Cont1·olto a distan z a di circa sei mesi dall 'intervento.
Fig. 21. - Oss. 8. - 5 dicembre 1950 Controllo radiografico durante il trat.tamento medic o preparatorio al/'interuento.
Fig. 20. - Oss. 7· - 22 novembre 1950. Cont1·olto a distan z a di circa sei mesi dall 'intervento.
Fig. 21. - Oss. 8. - 5 dicembre 1950 Controllo radiografico durante il trat.tamento medic o preparatorio al/'interuento.
 Fig. 22. - Oss. R Il polmone des tro a.· portato 1'8 gennato 1951
Fig. 23. - Oss. 8. - 26 genna to 1951. Controllo radtografico pochi giorni dopo la dimissio-ne.
Fig. 22. - Oss. R Il polmone des tro a.· portato 1'8 gennato 1951
Fig. 23. - Oss. 8. - 26 genna to 1951. Controllo radtografico pochi giorni dopo la dimissio-ne.
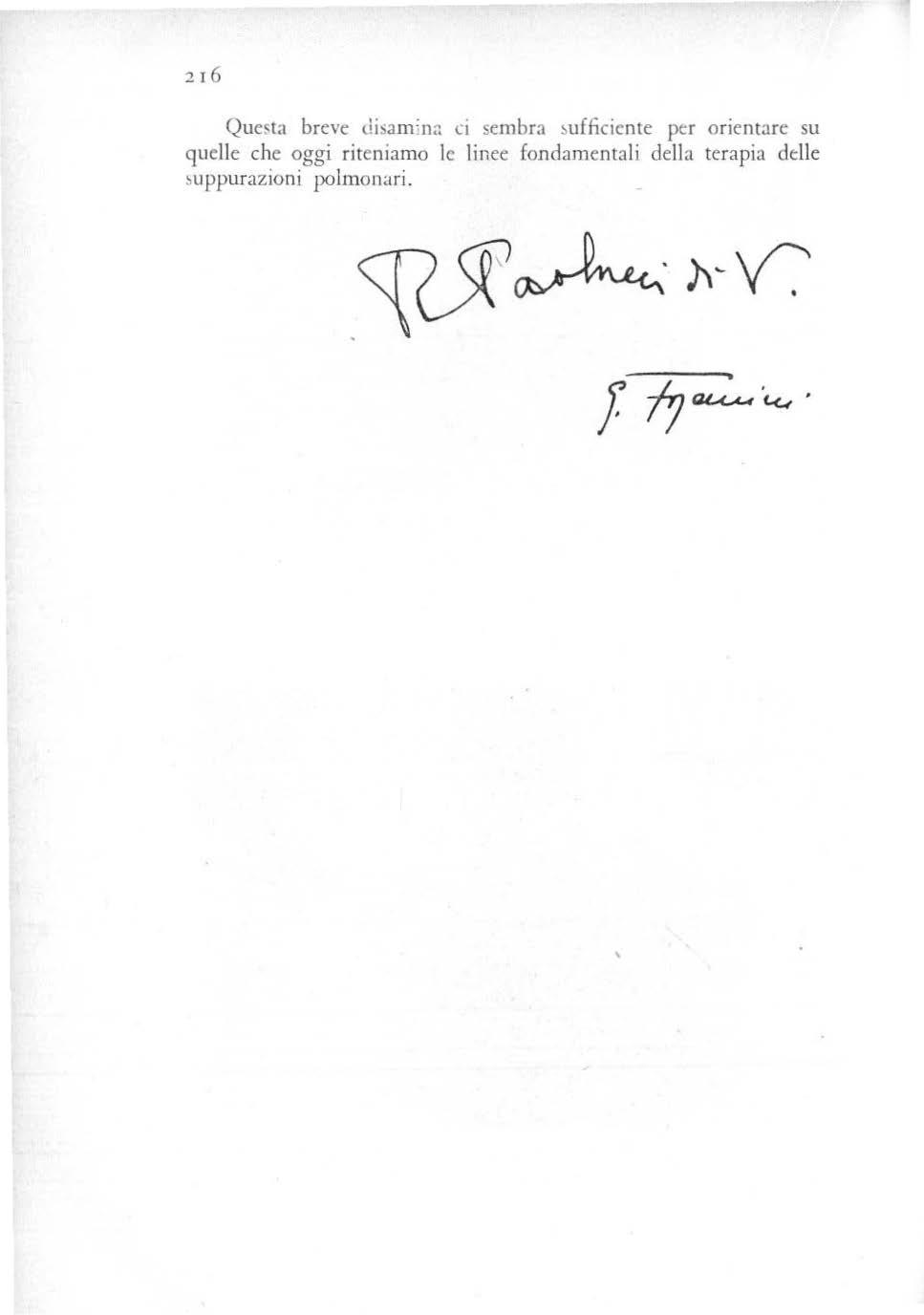
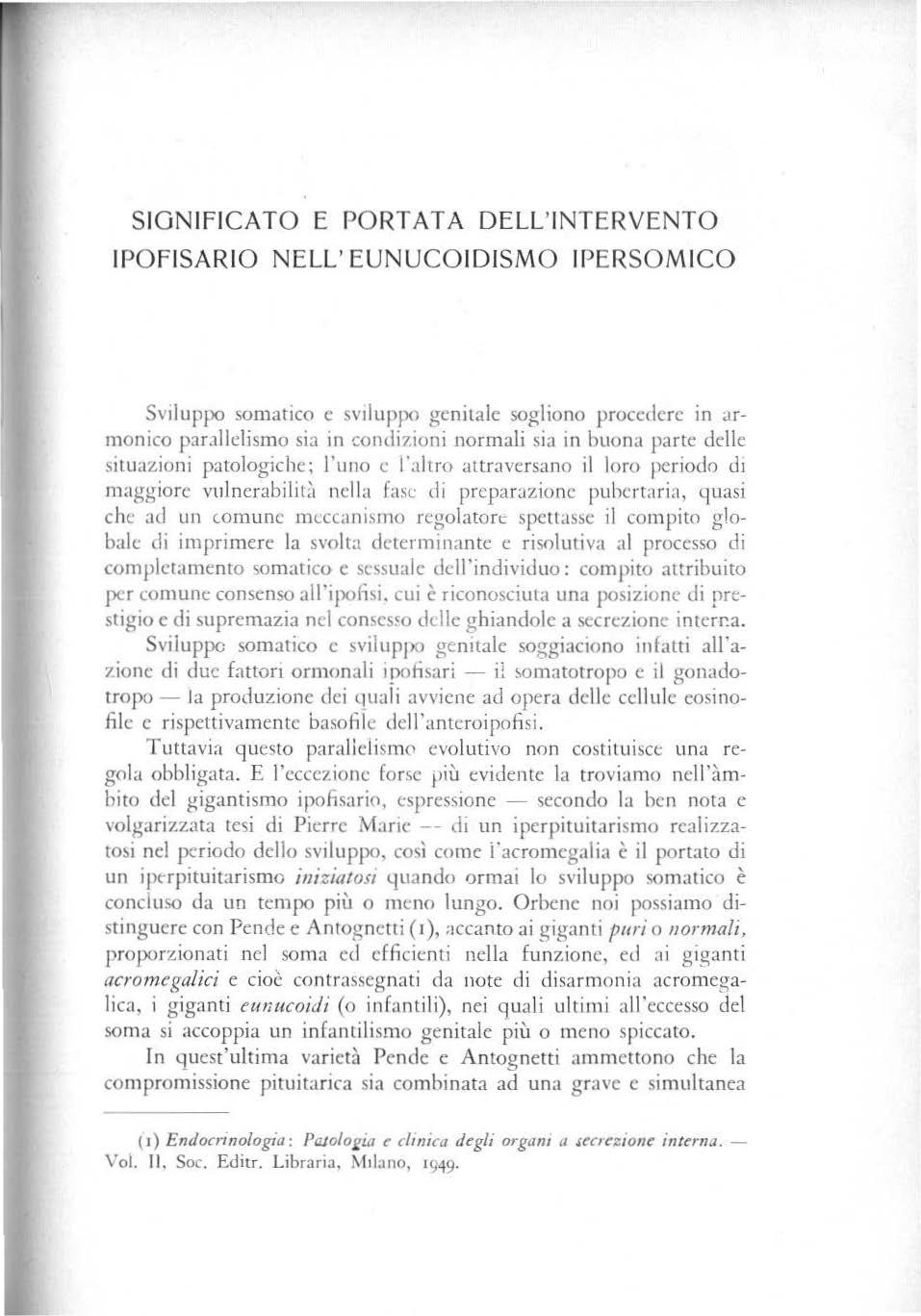

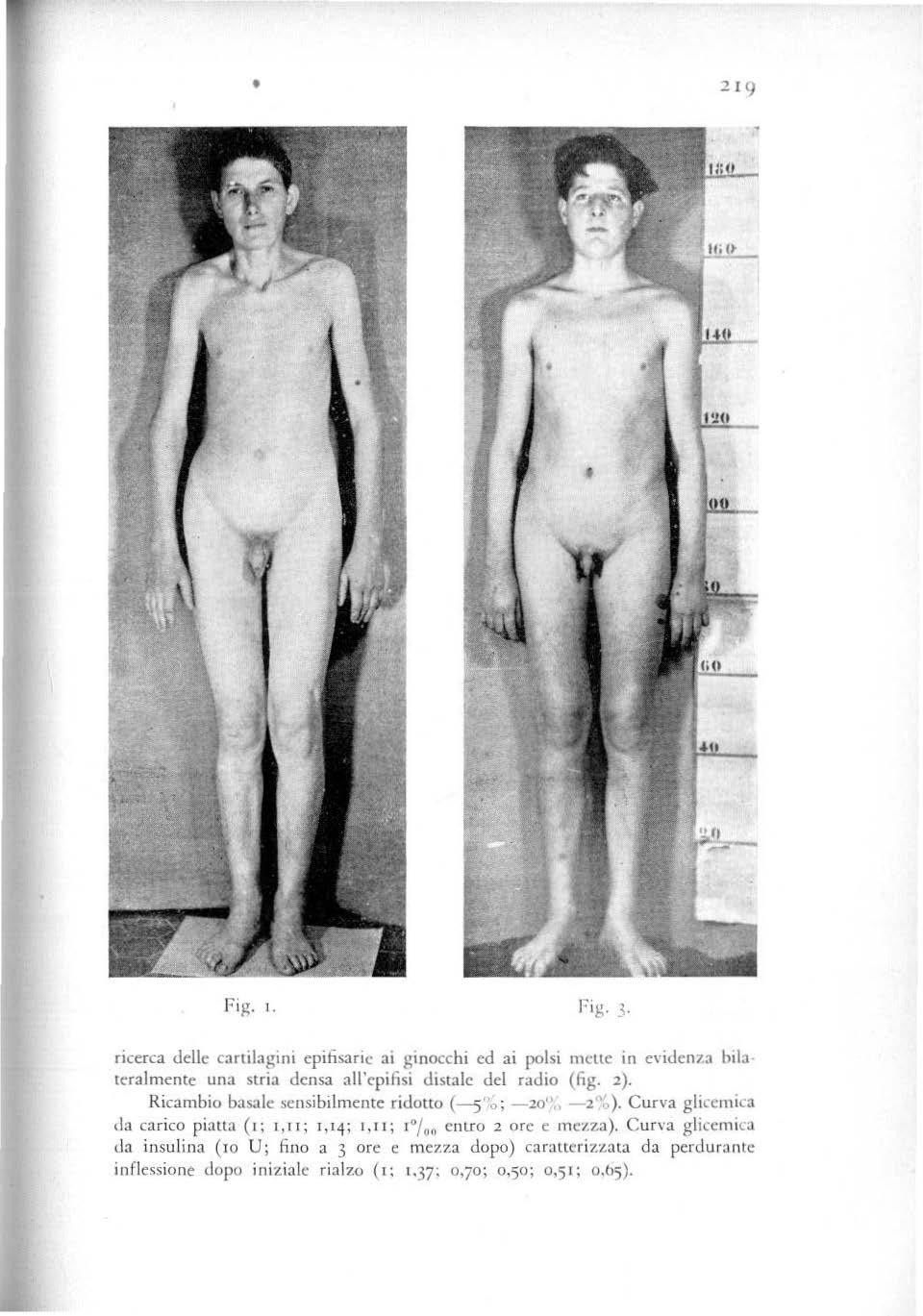
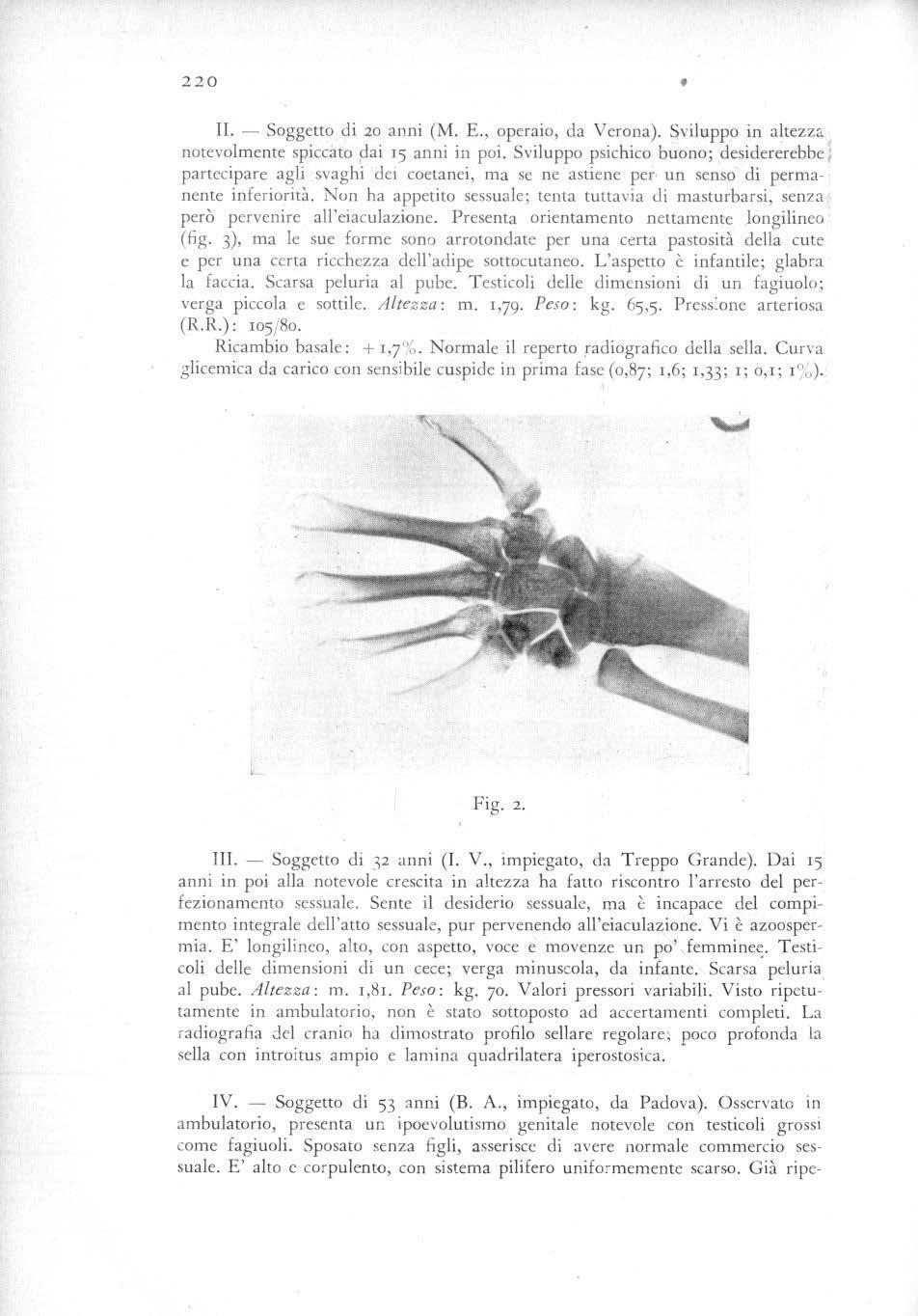
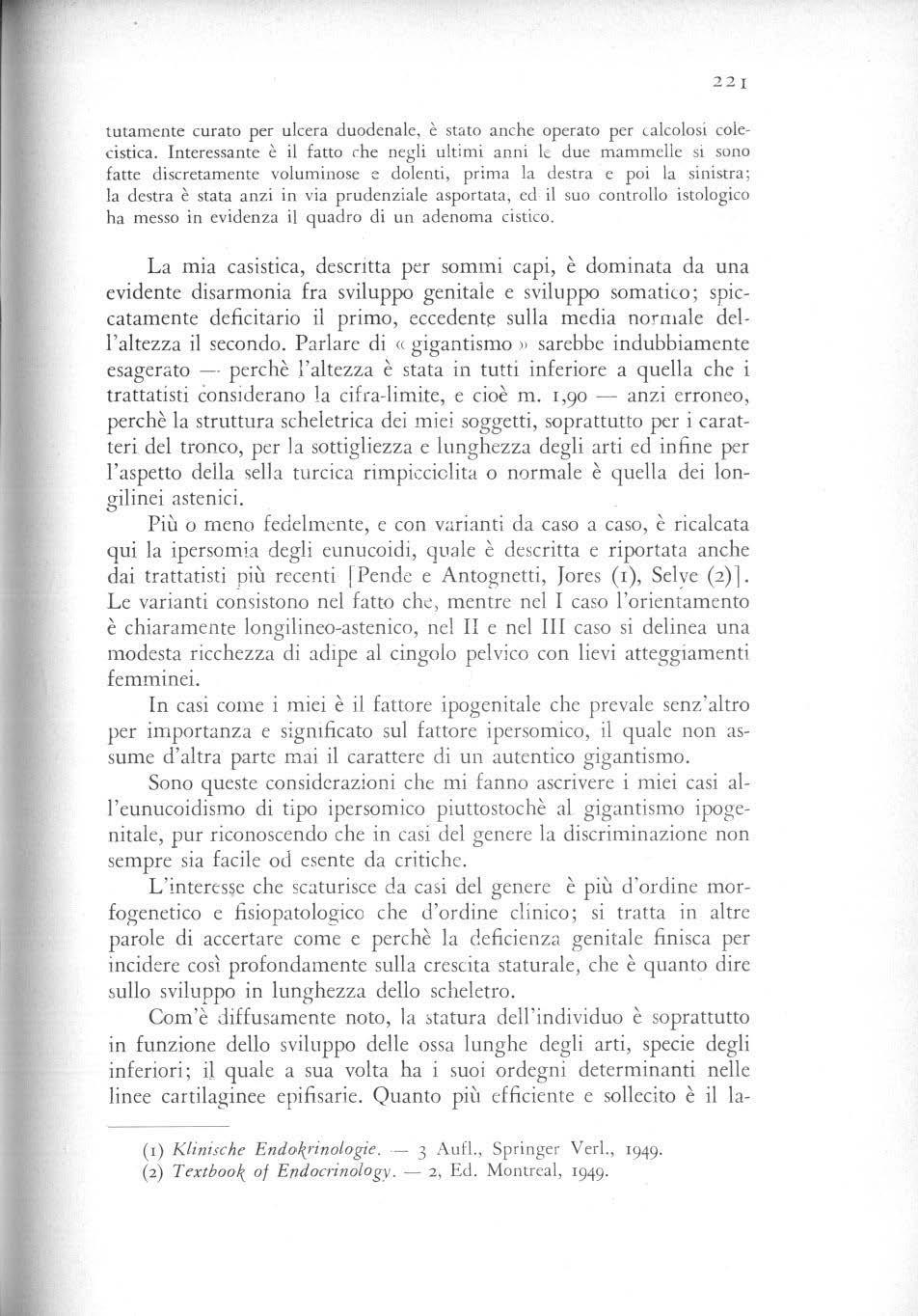

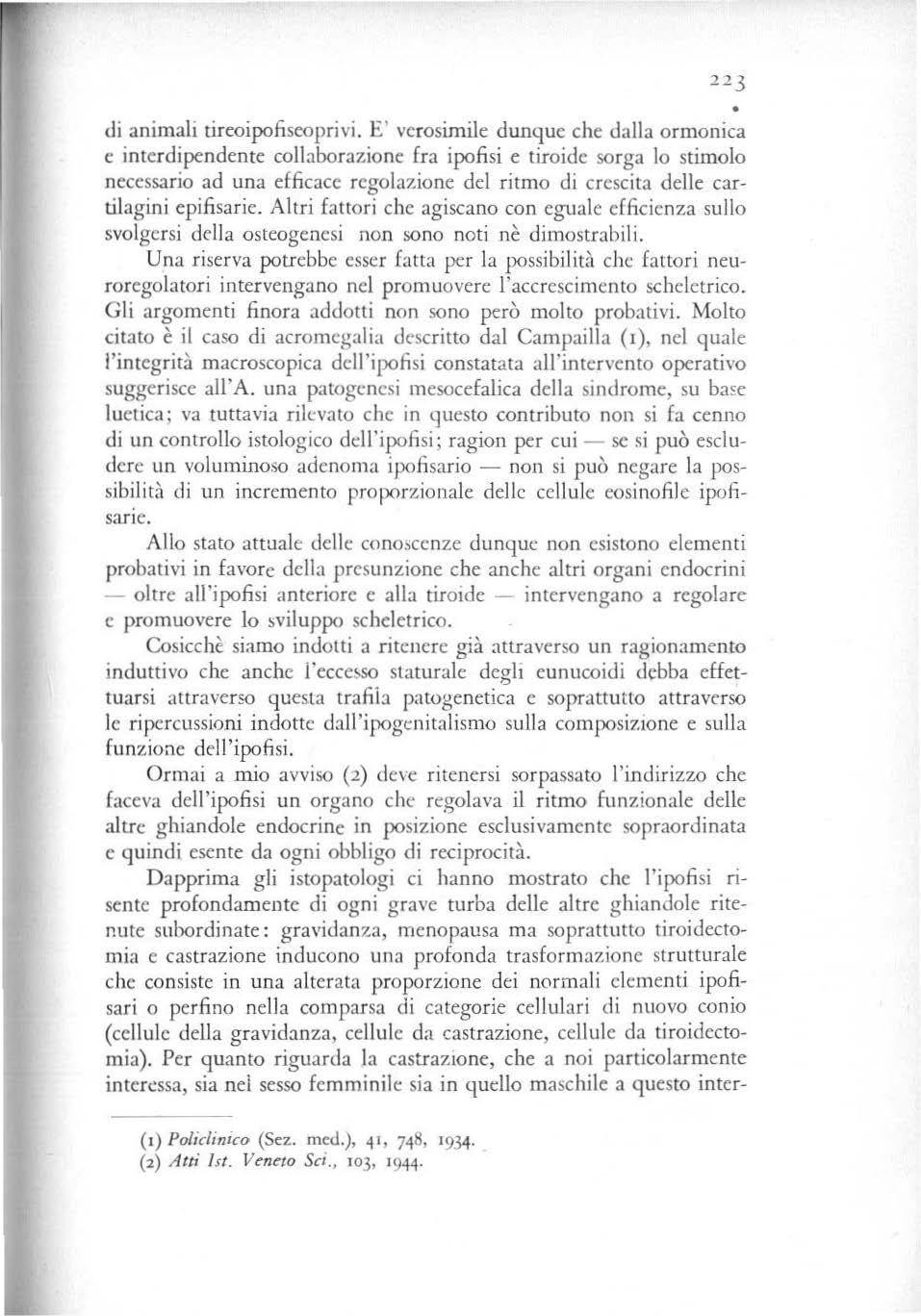
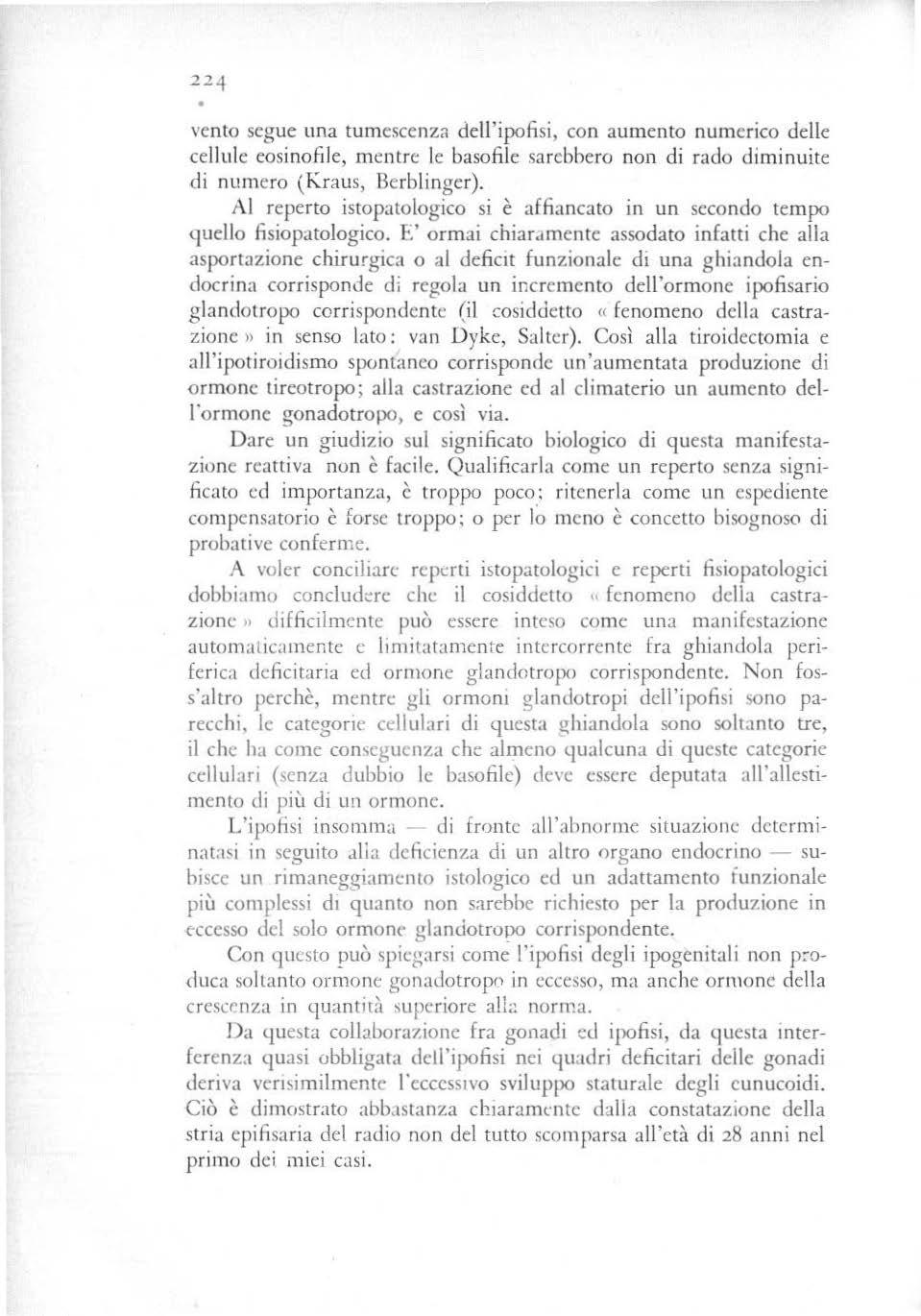

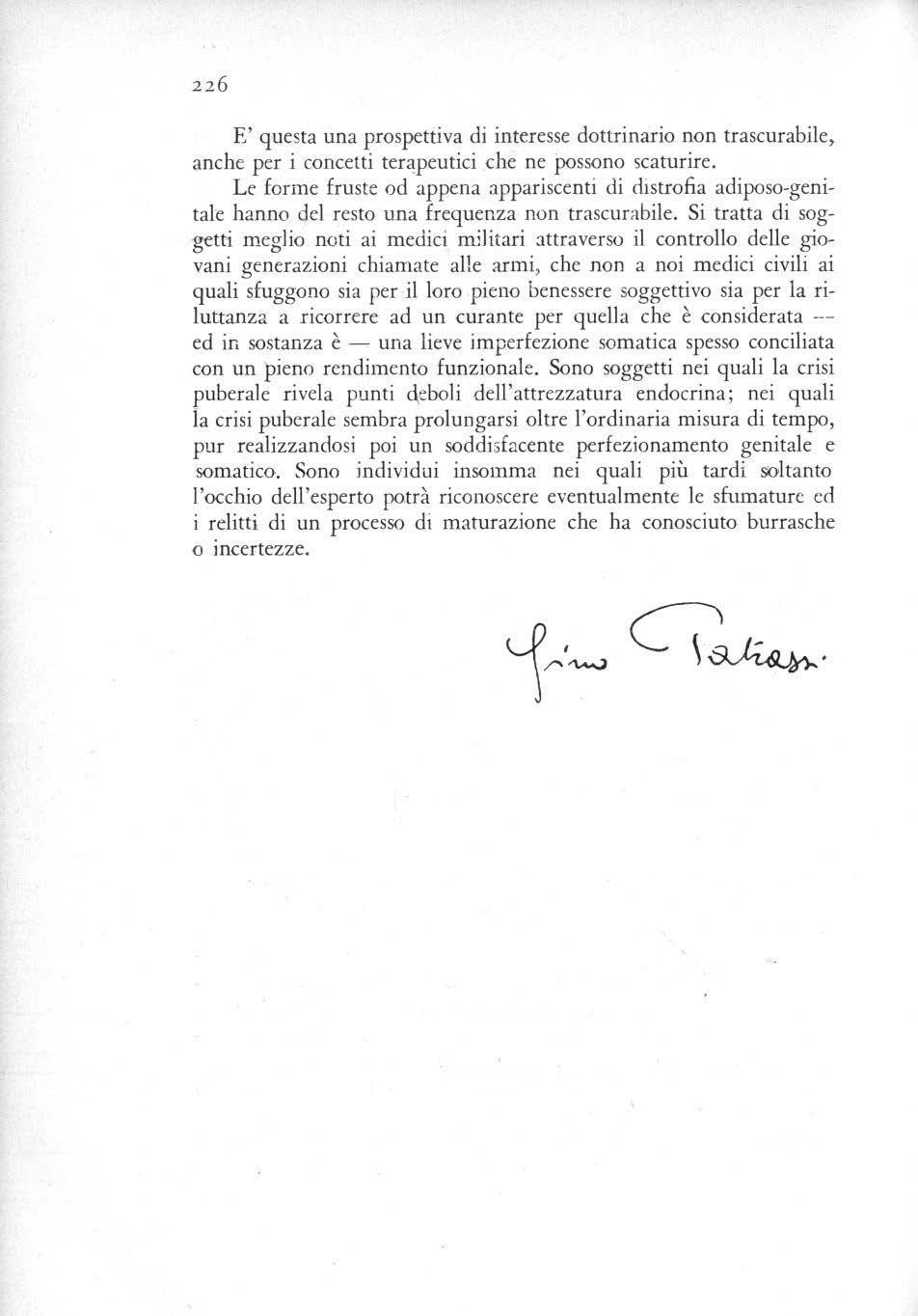
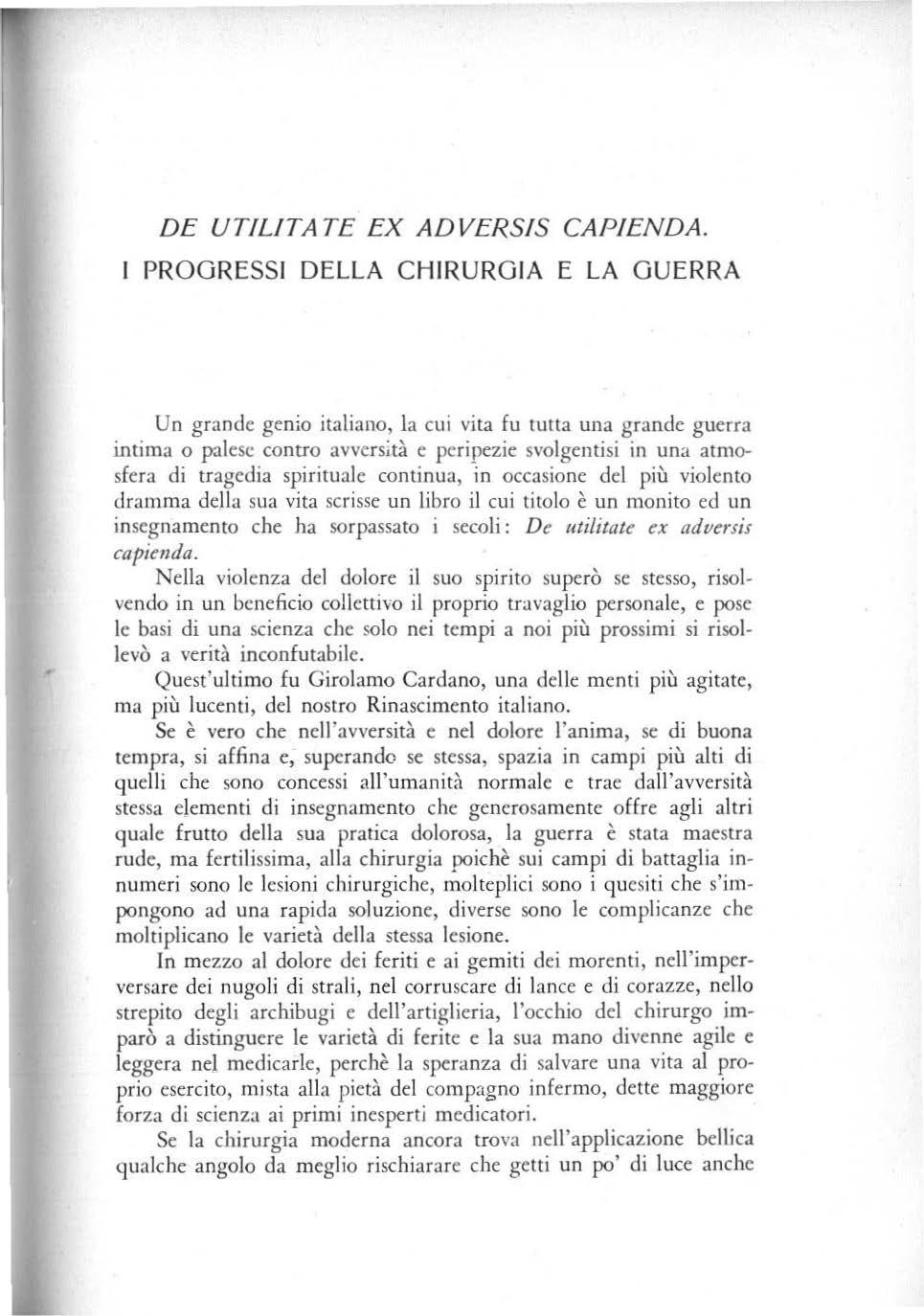
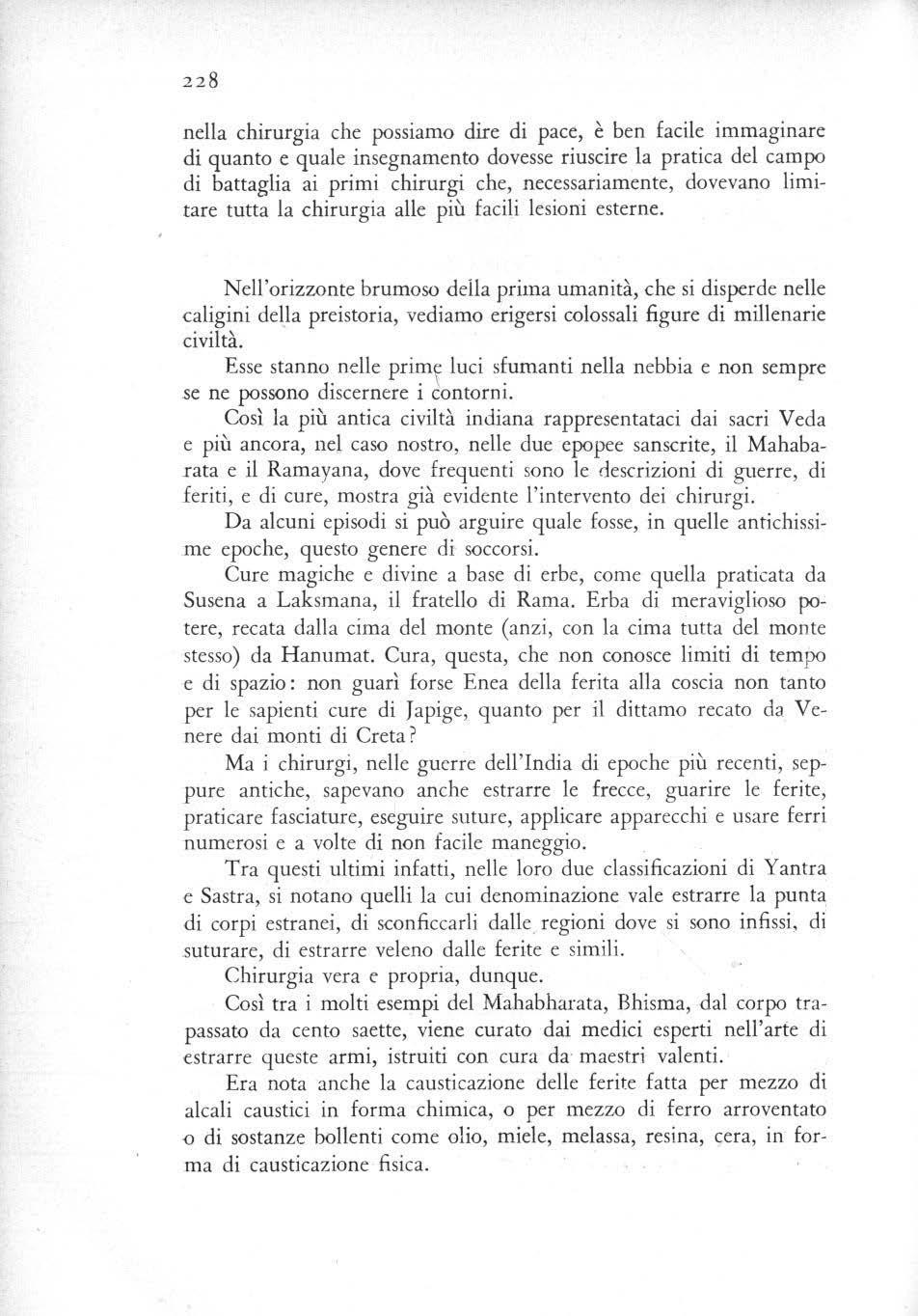
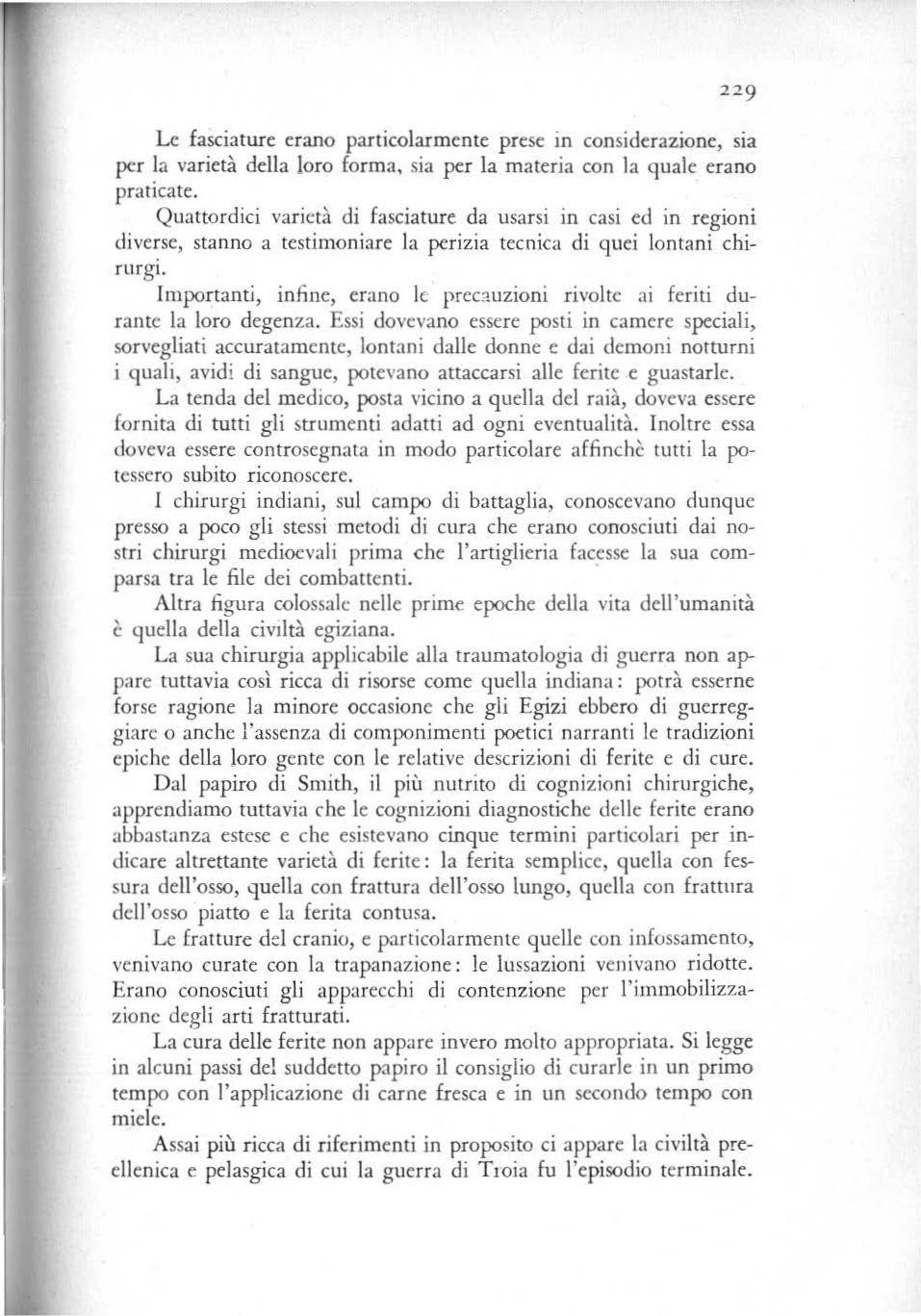
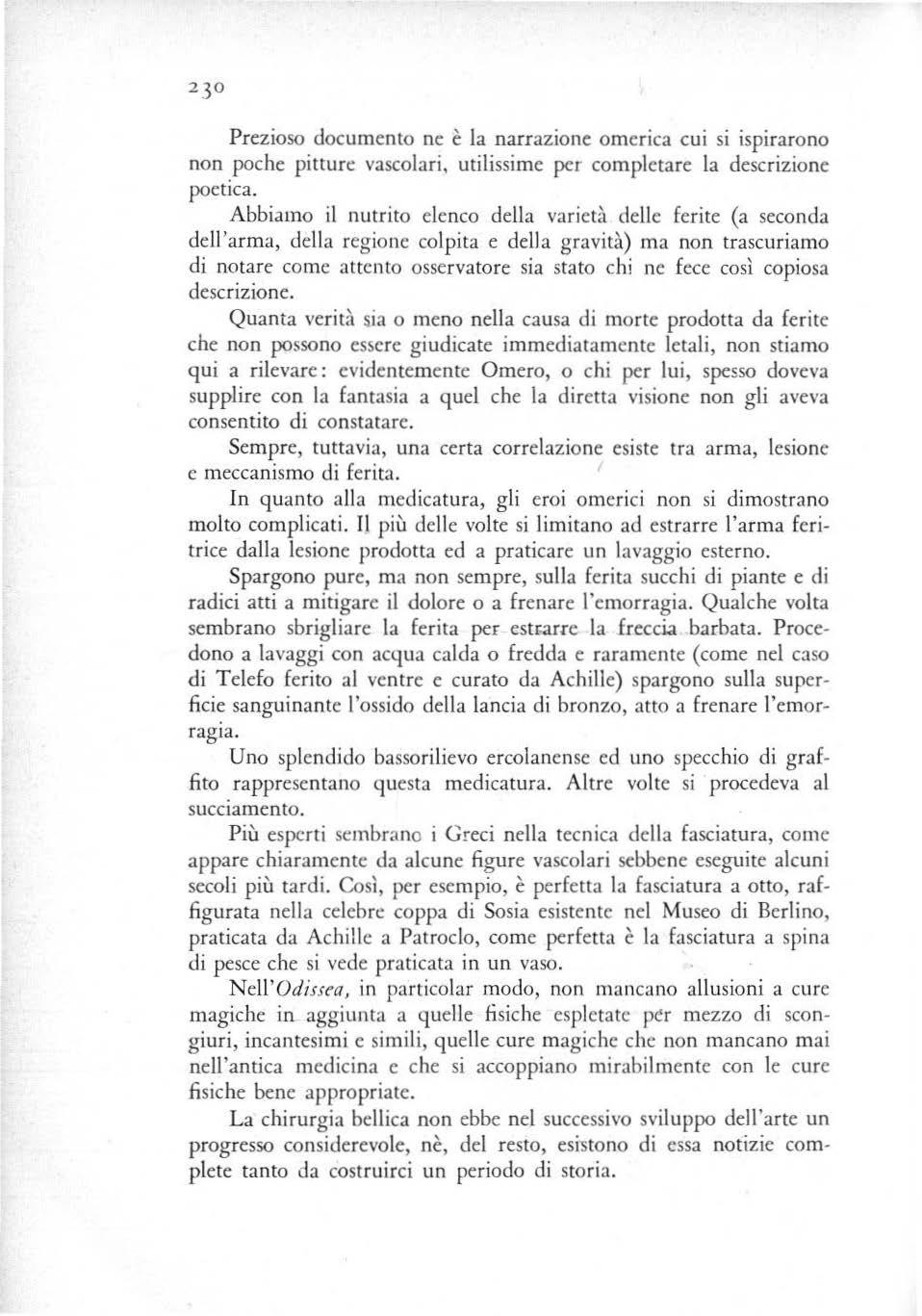



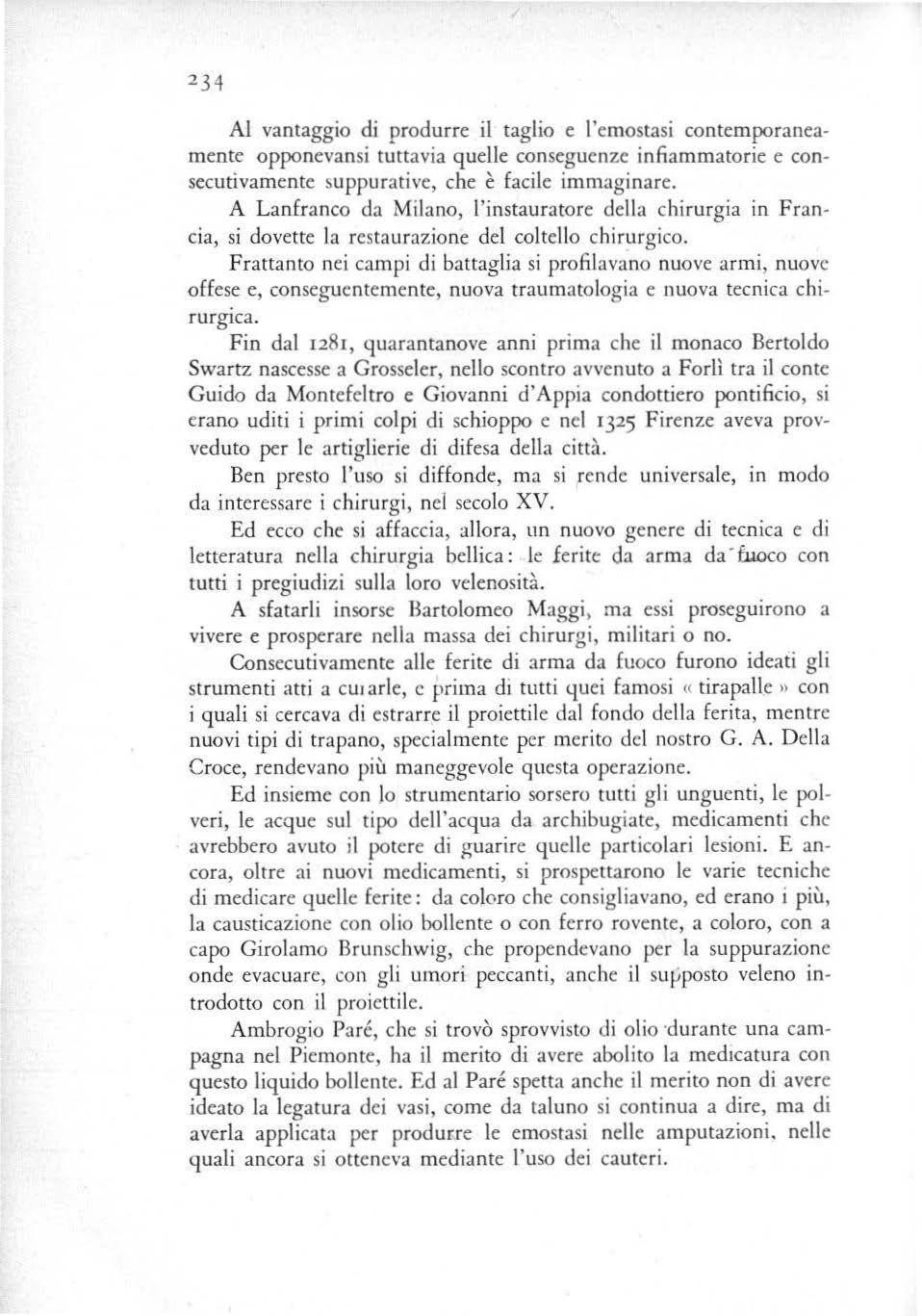

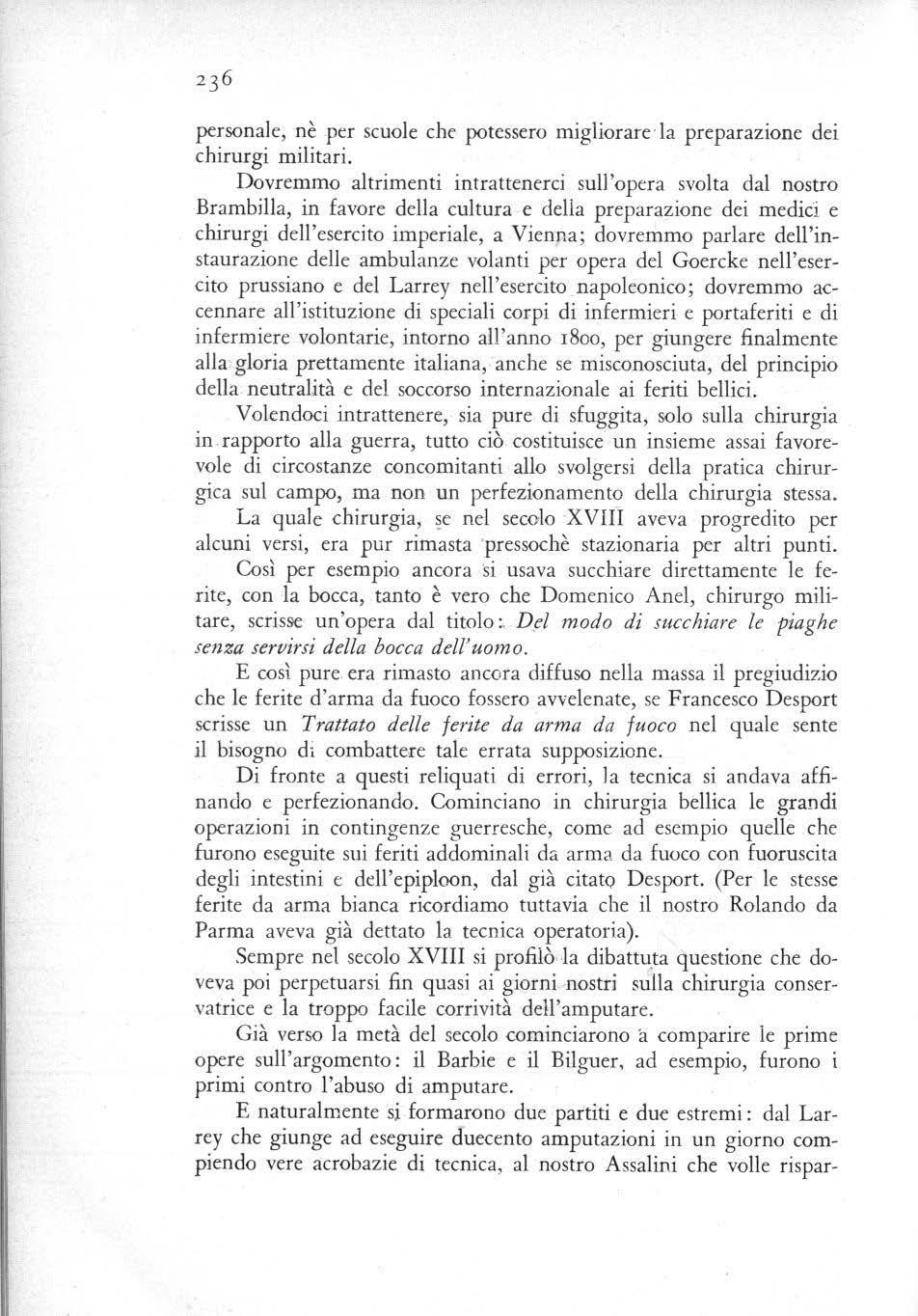

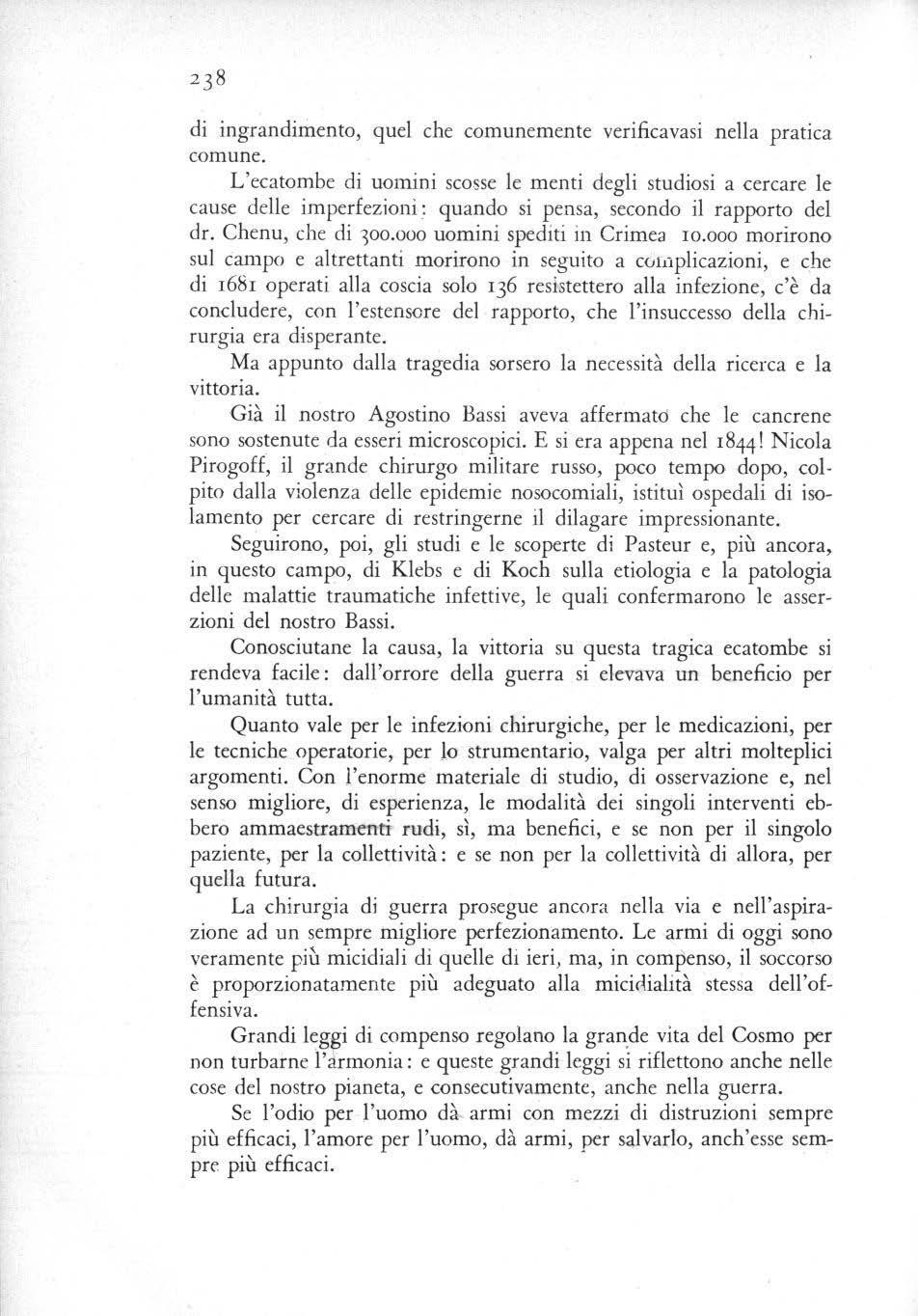

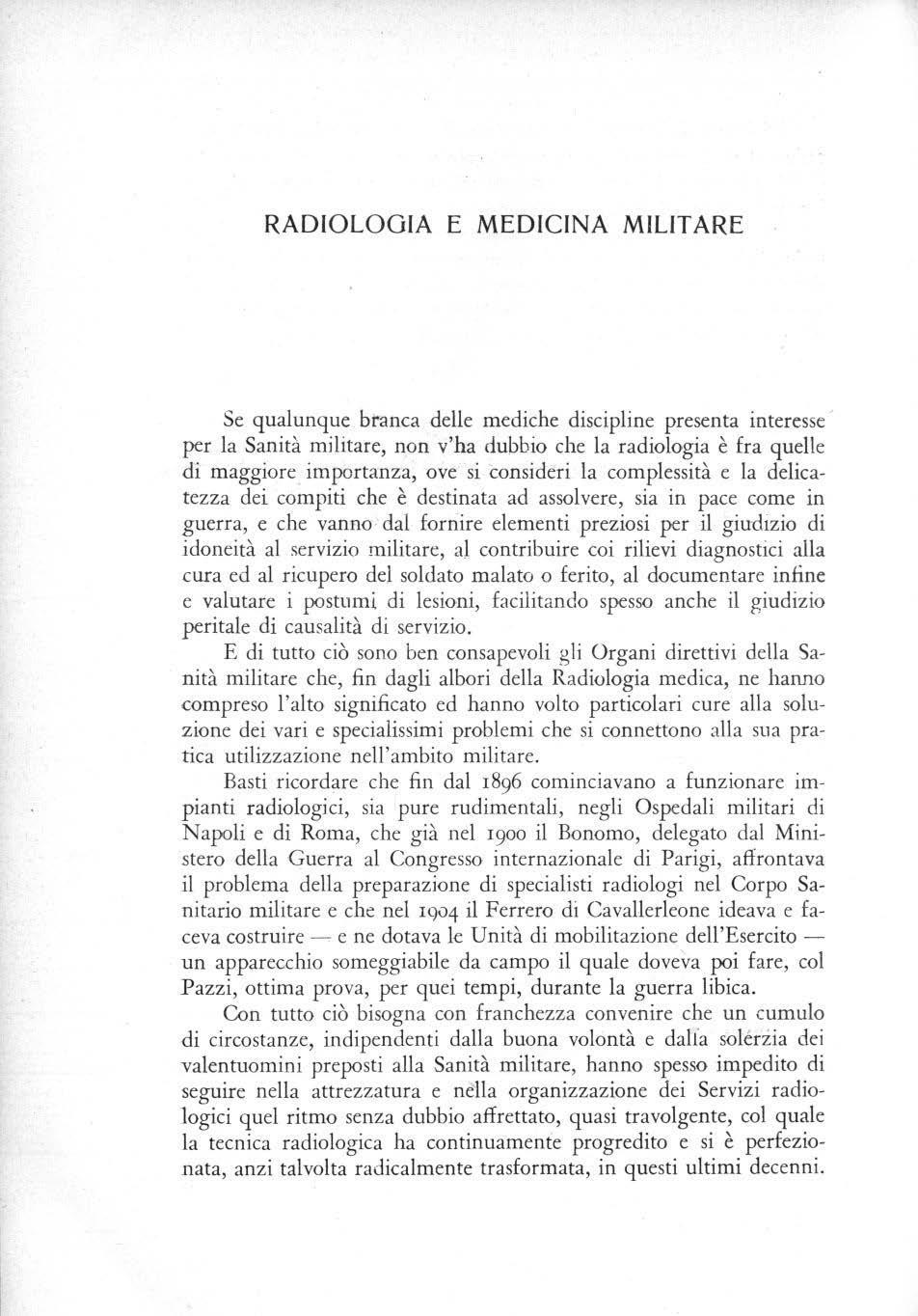

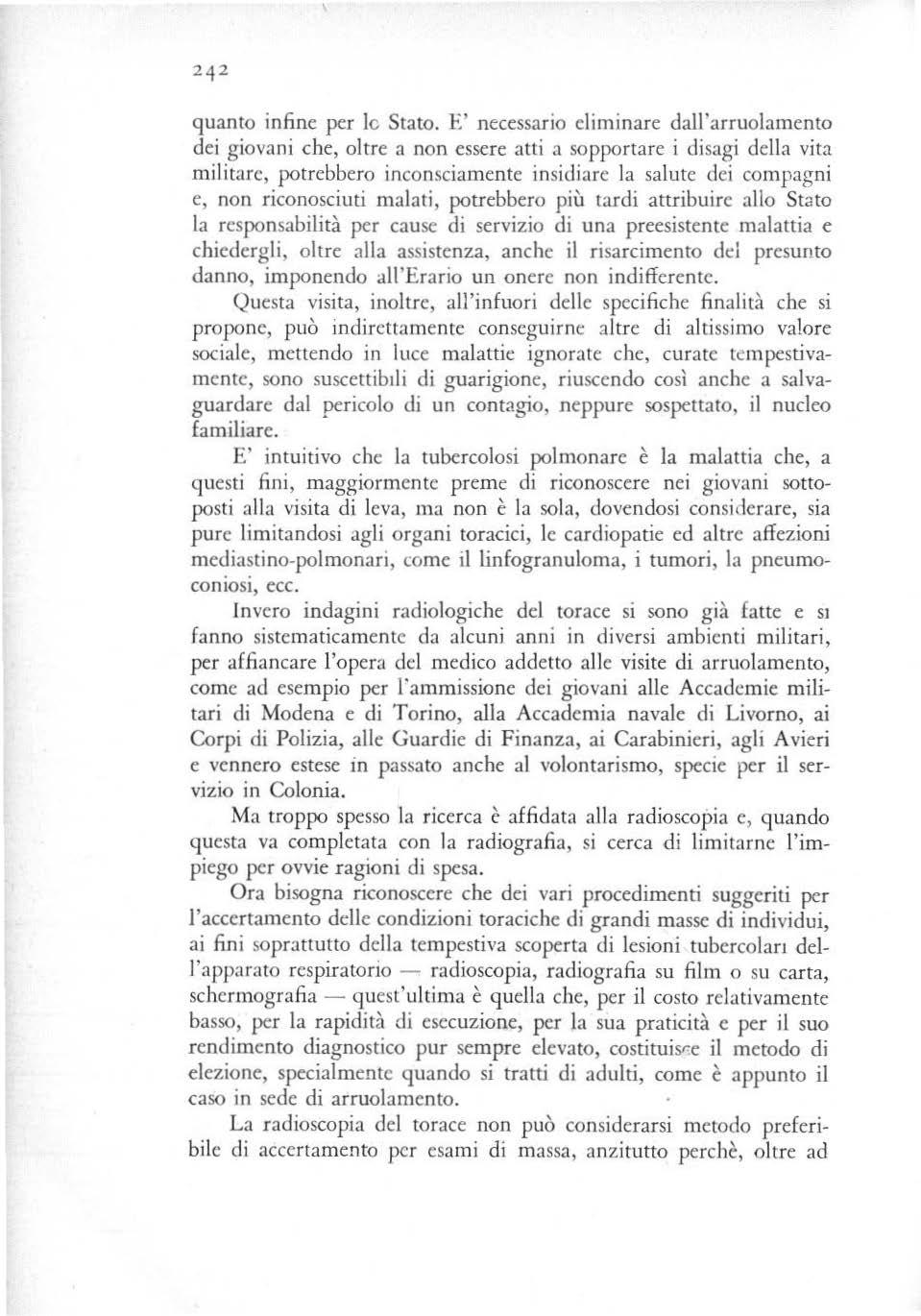
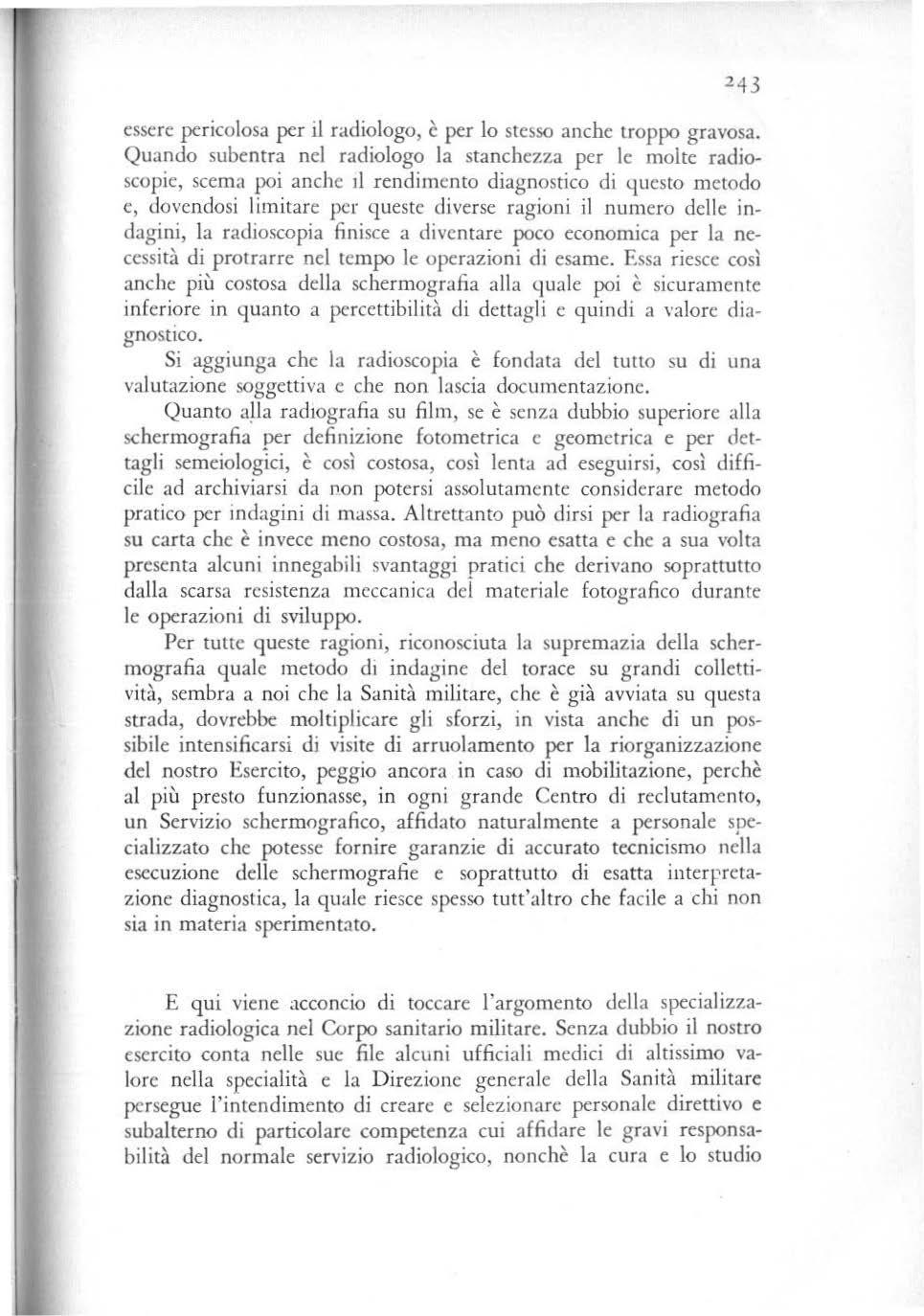
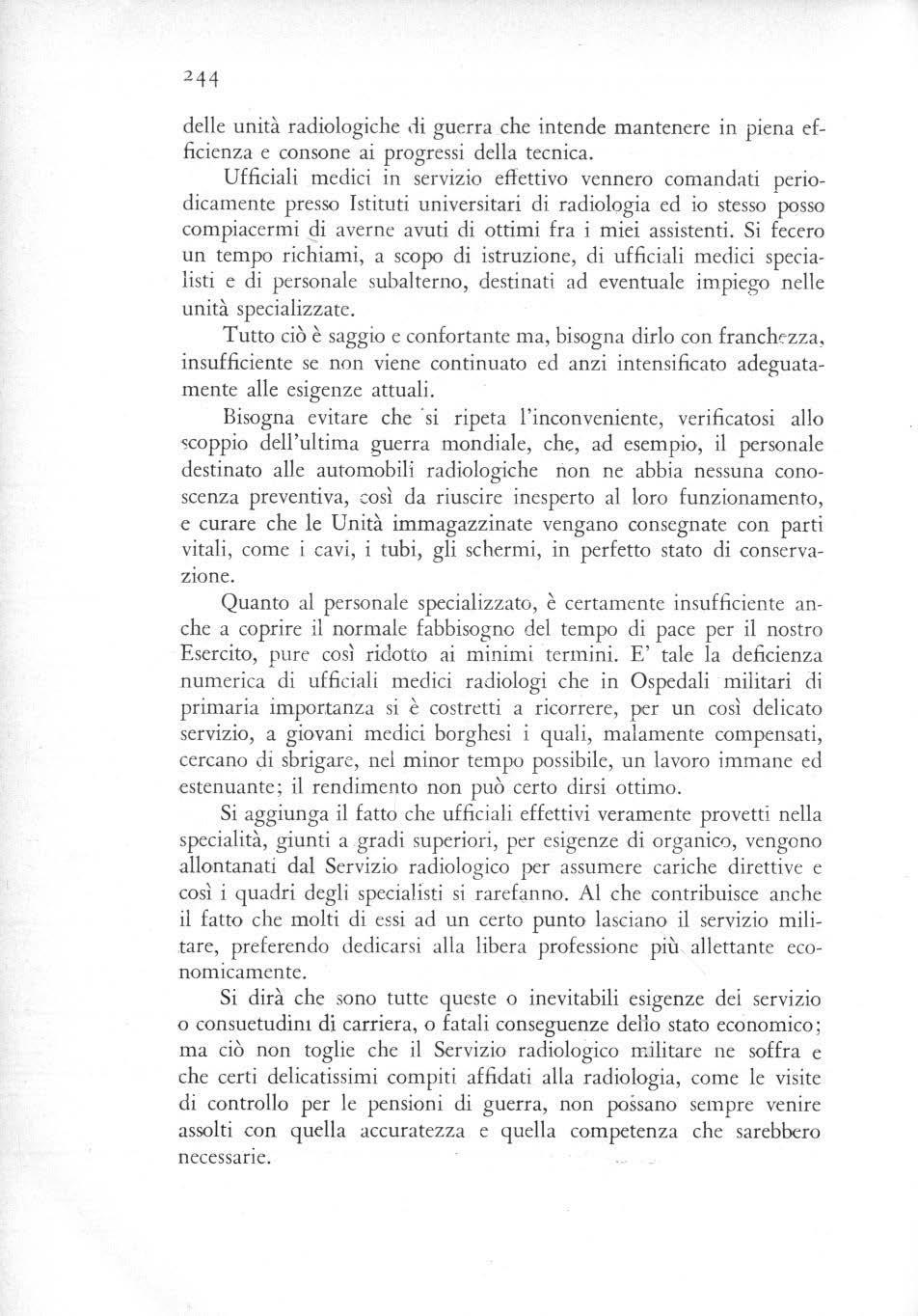
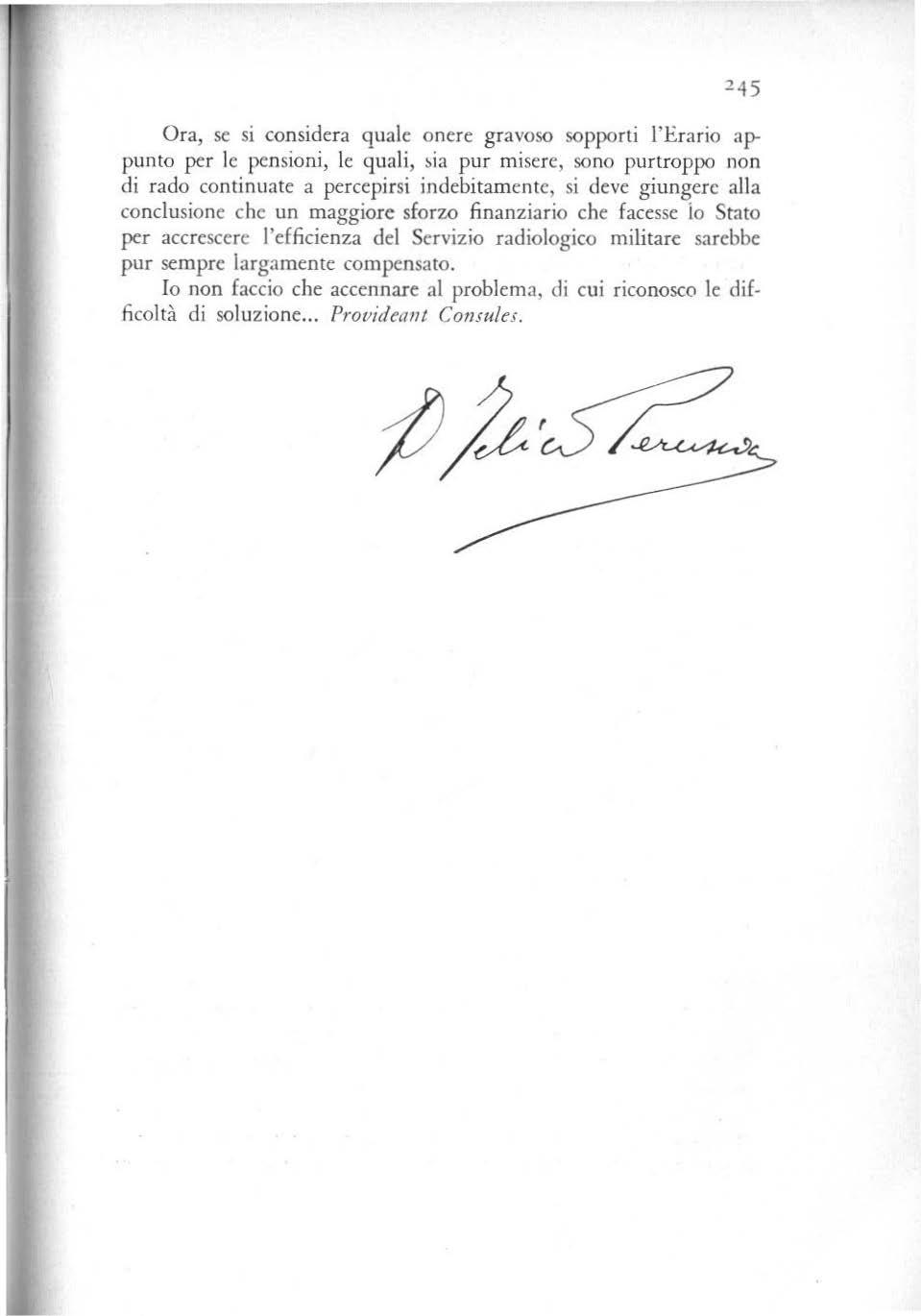
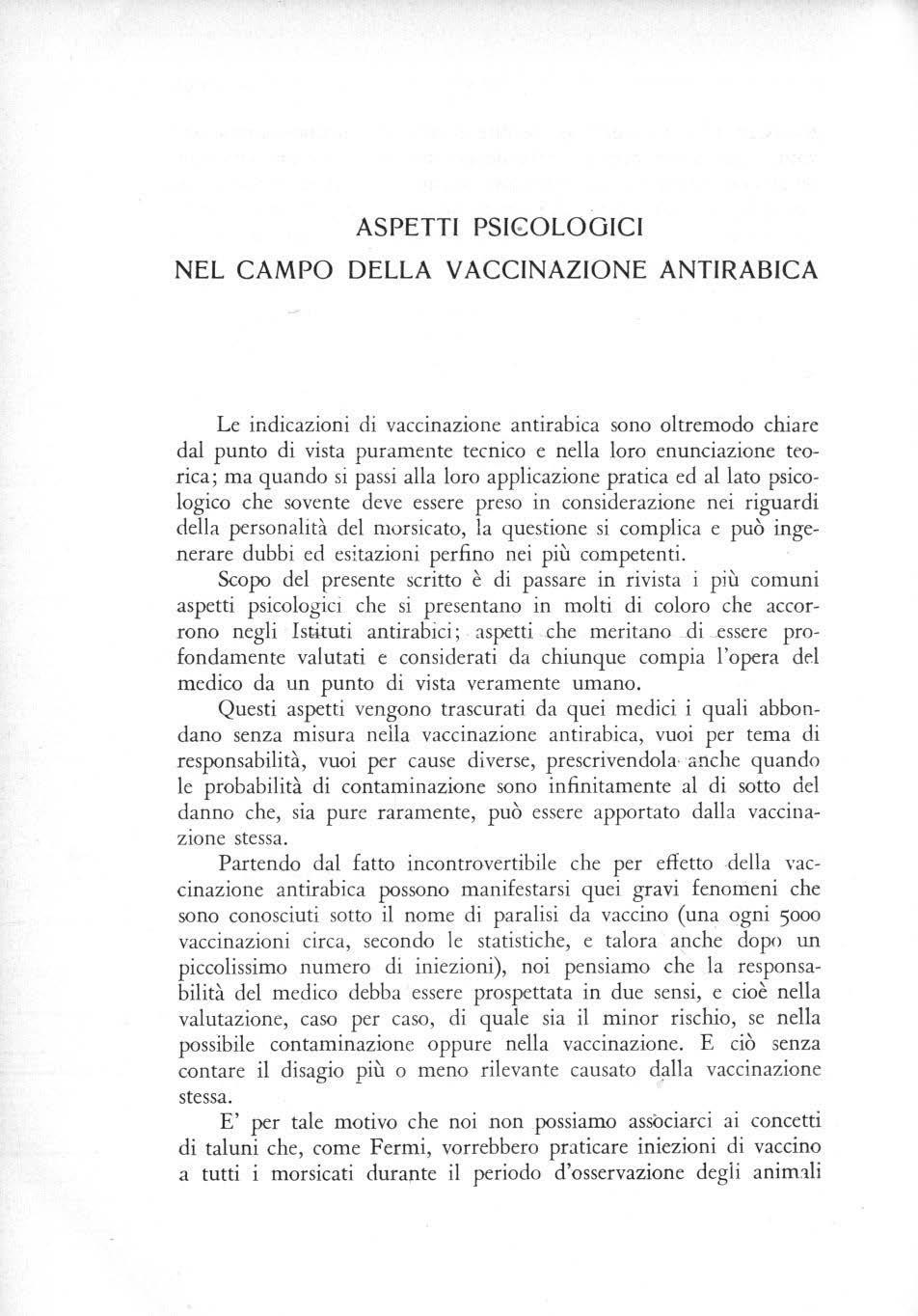
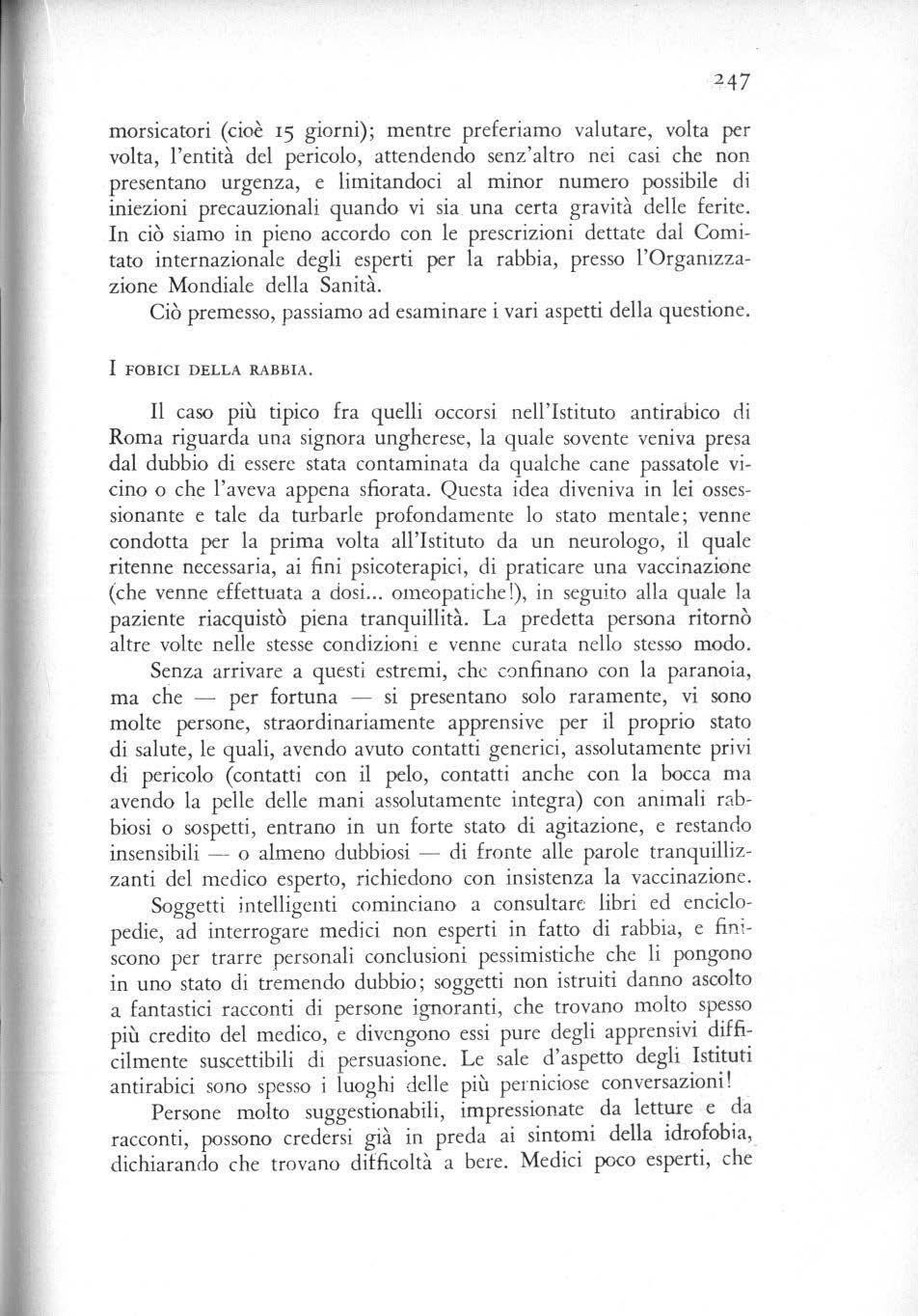
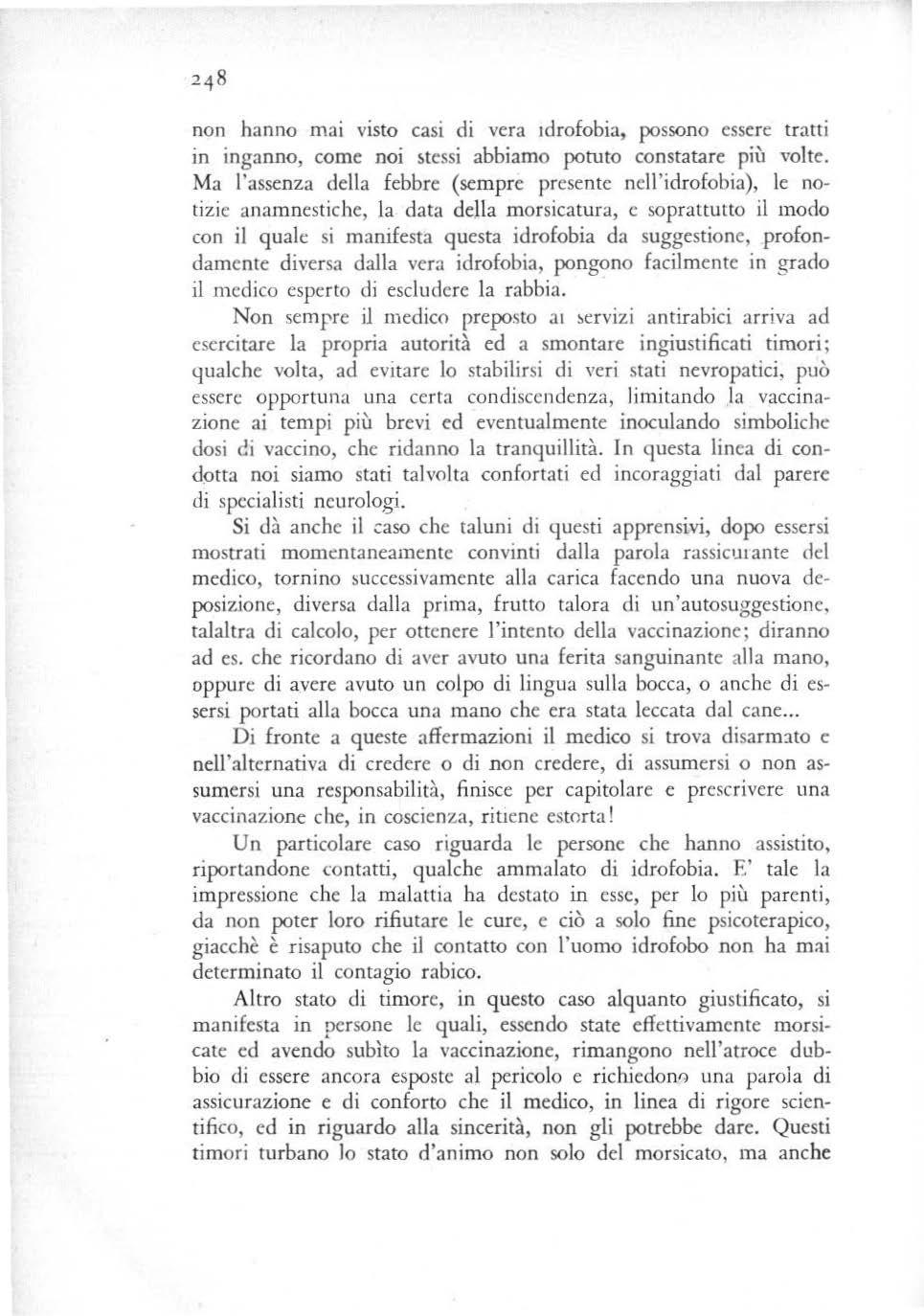
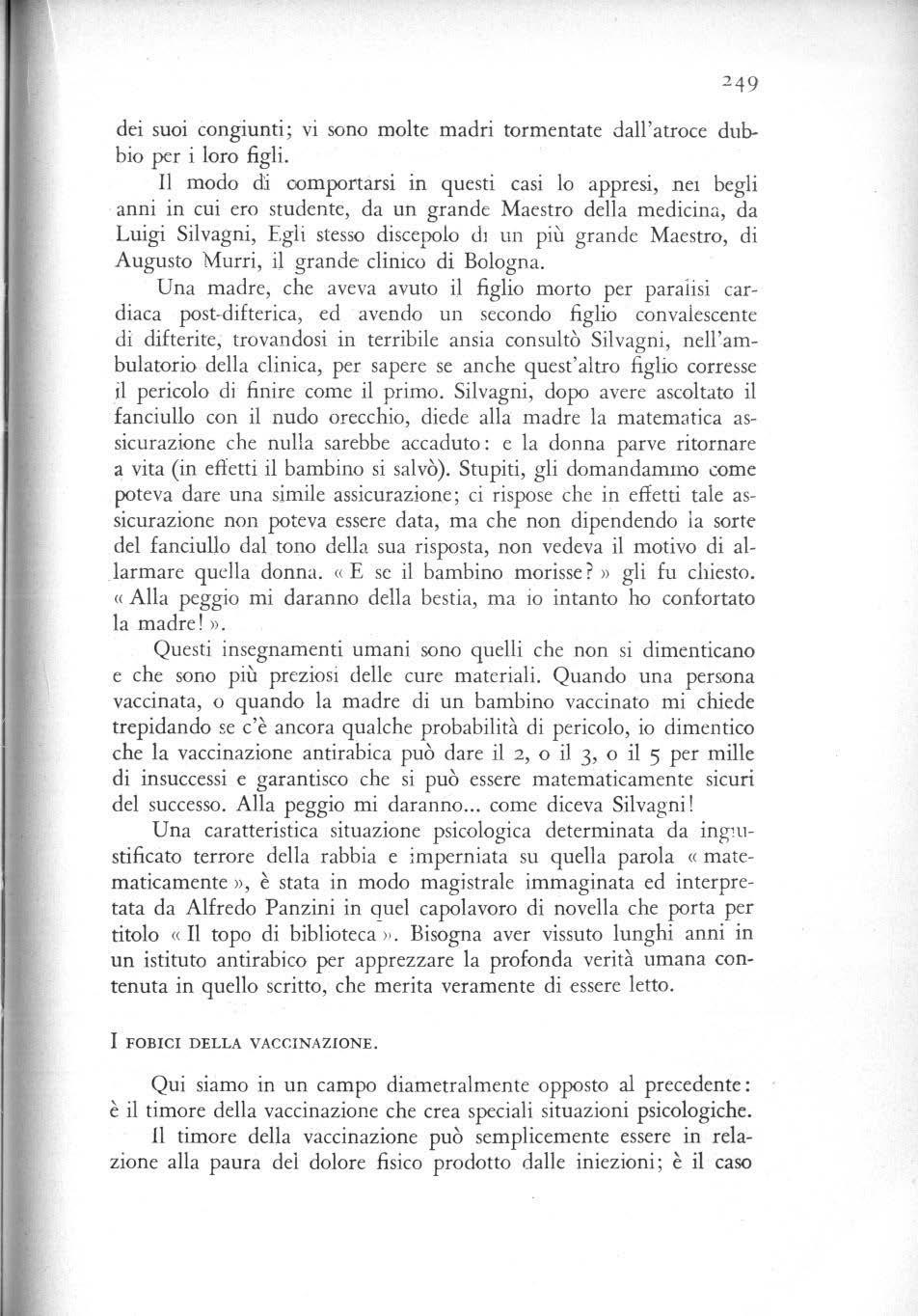

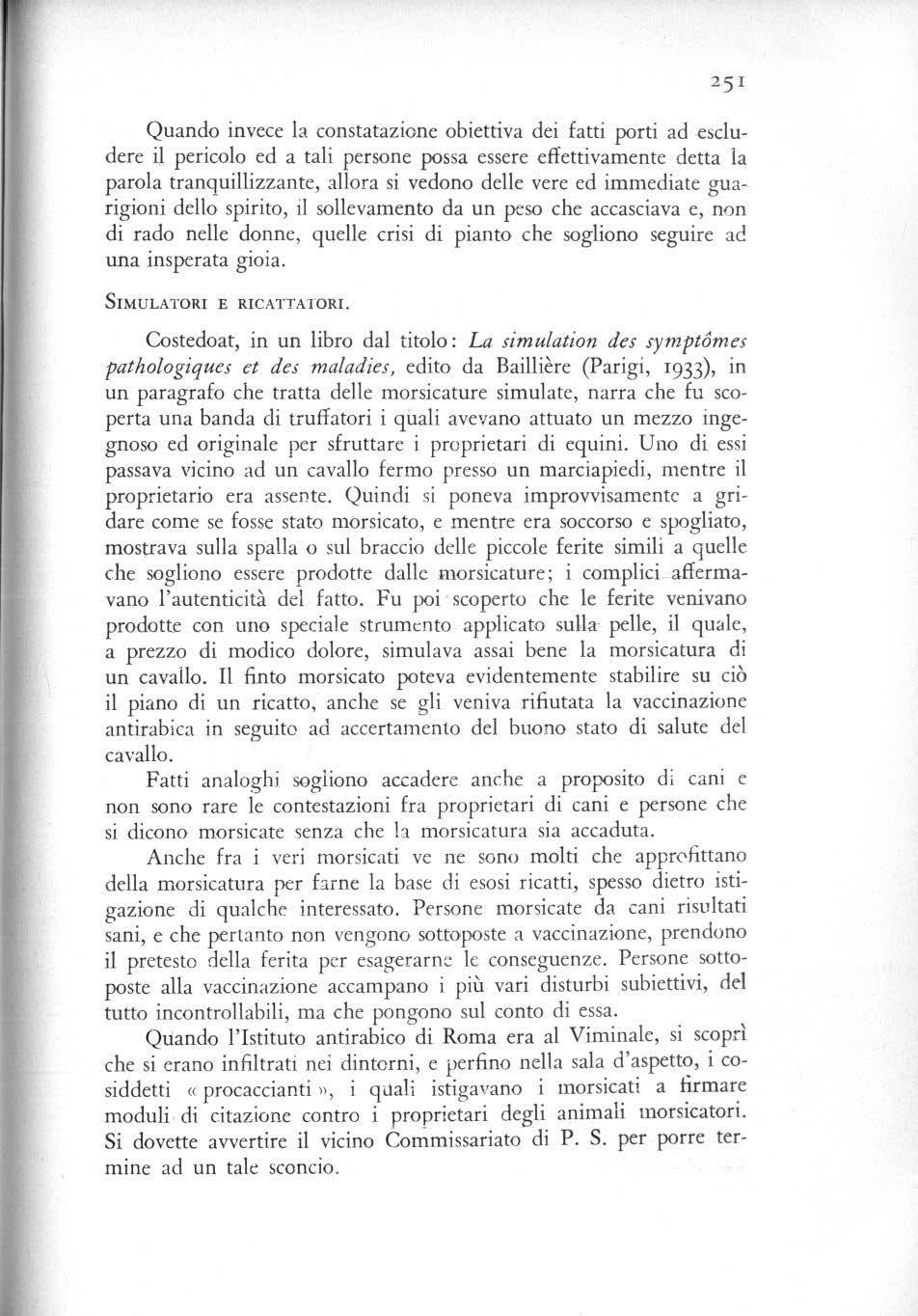

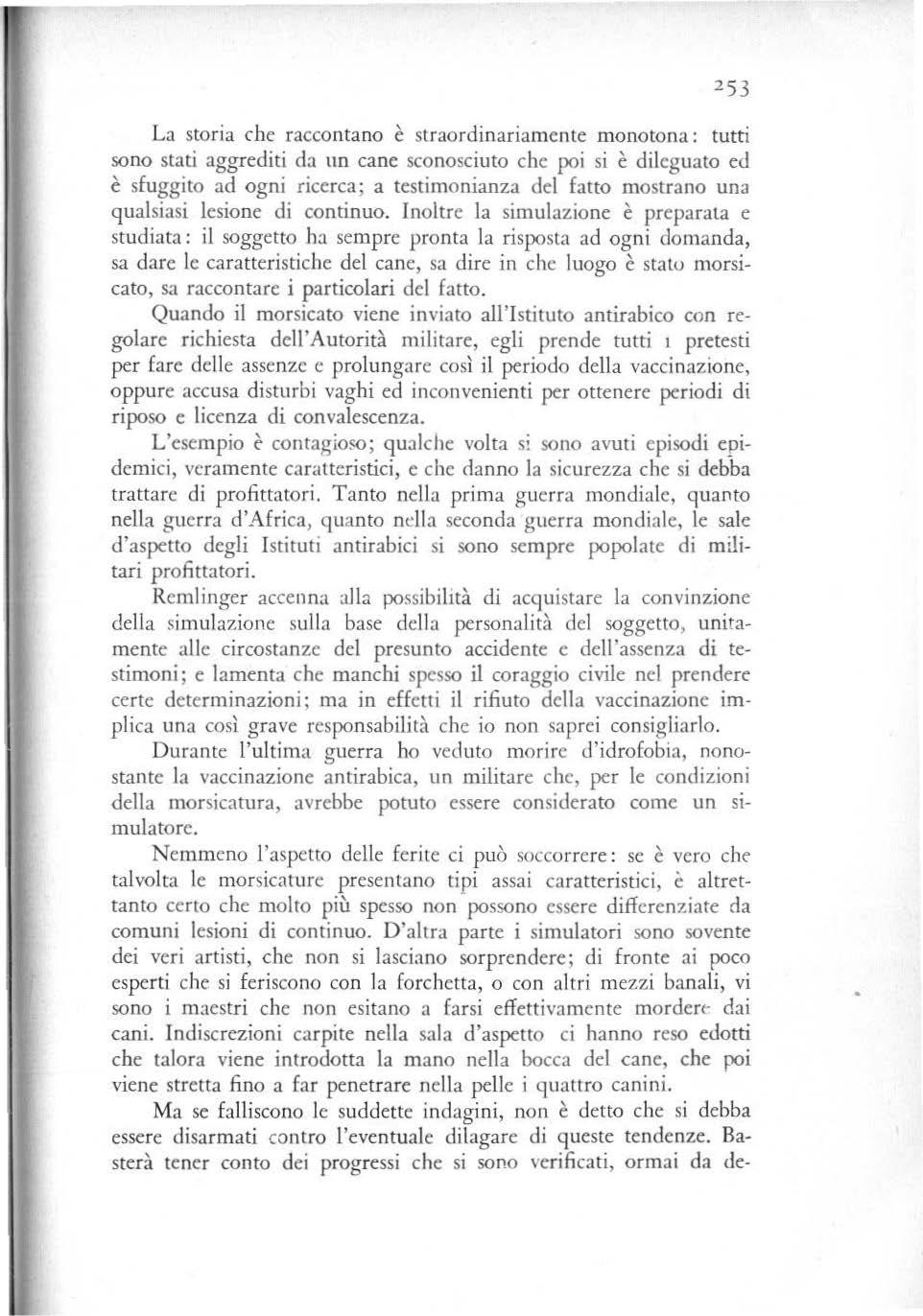
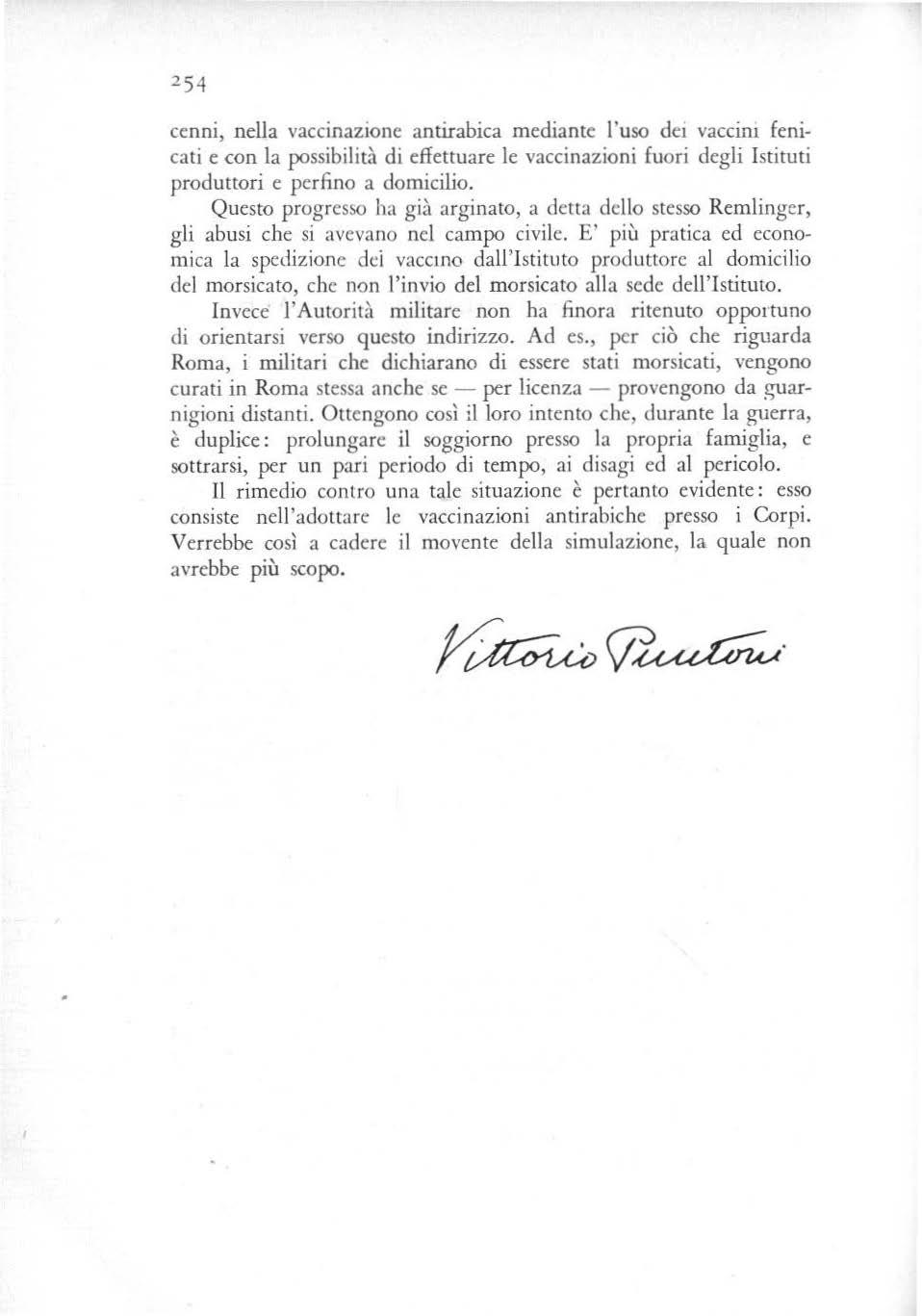
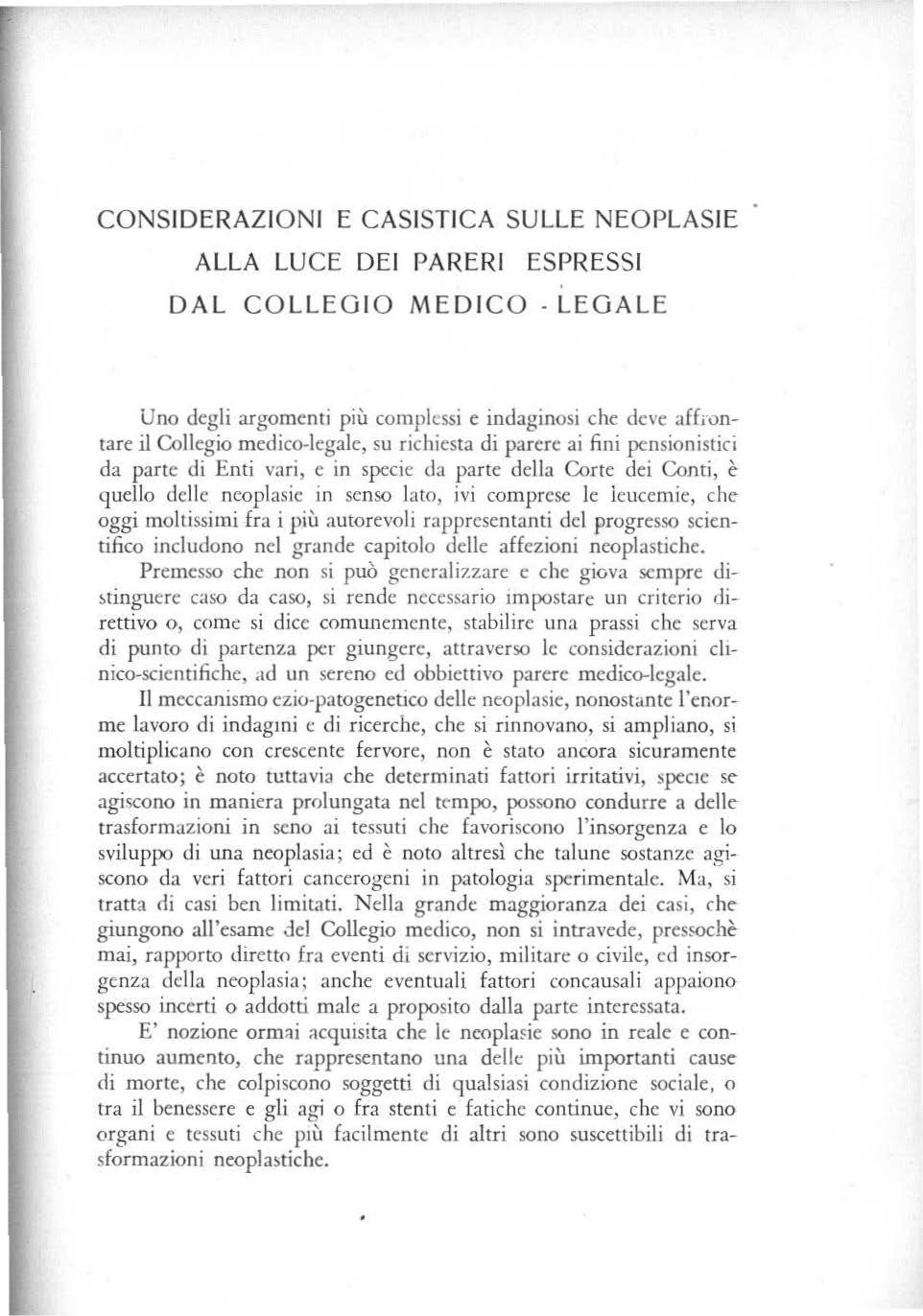
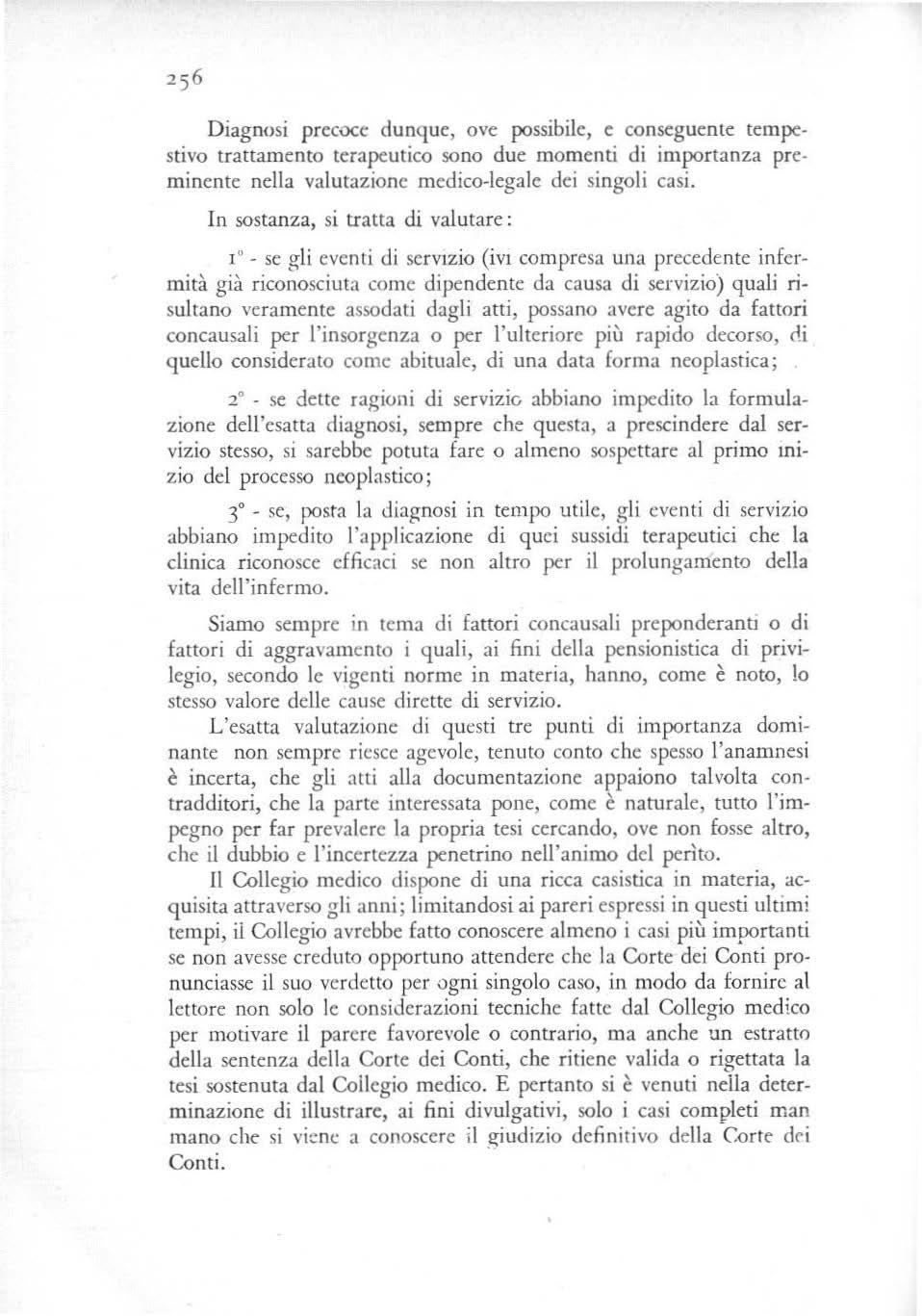
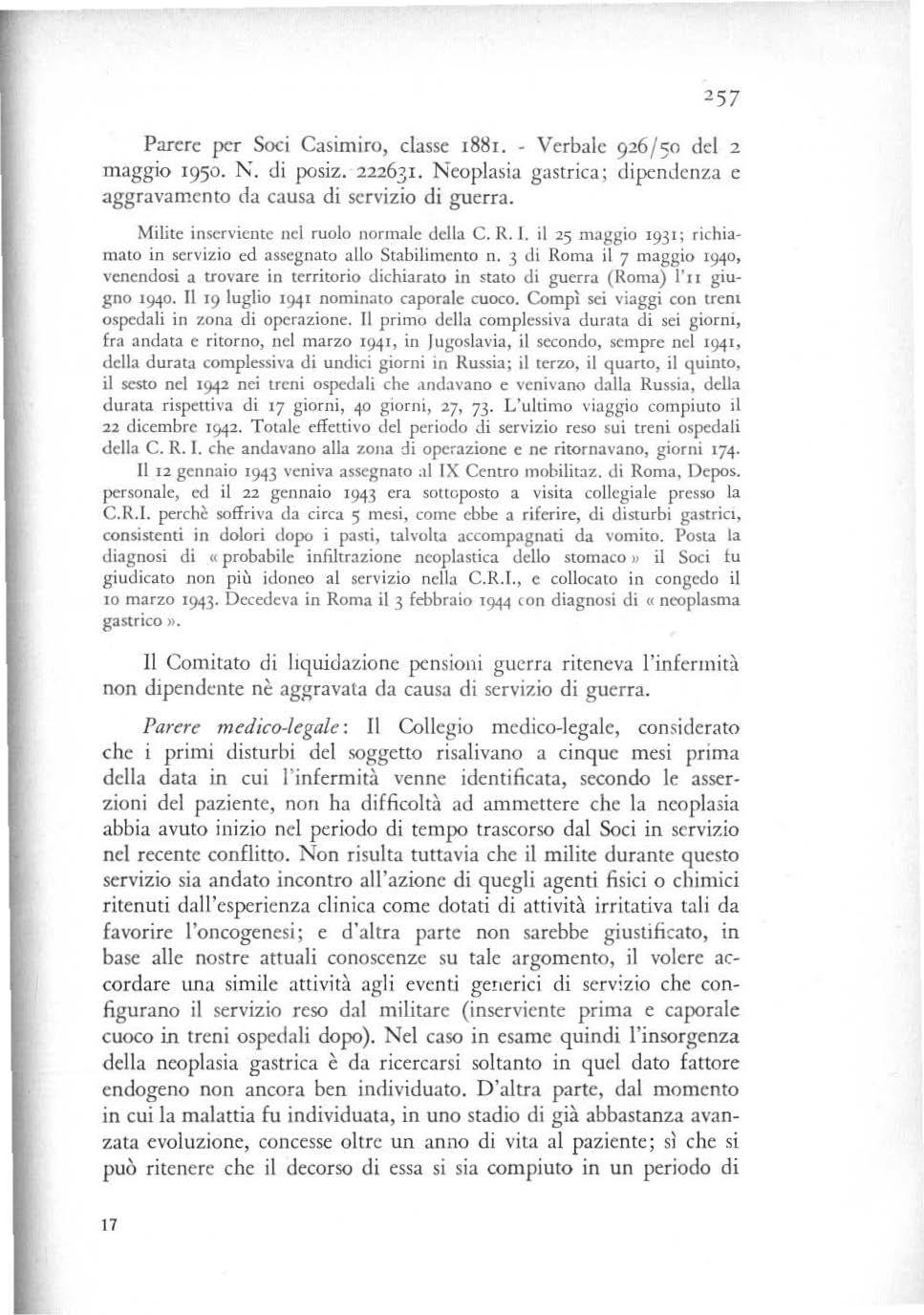



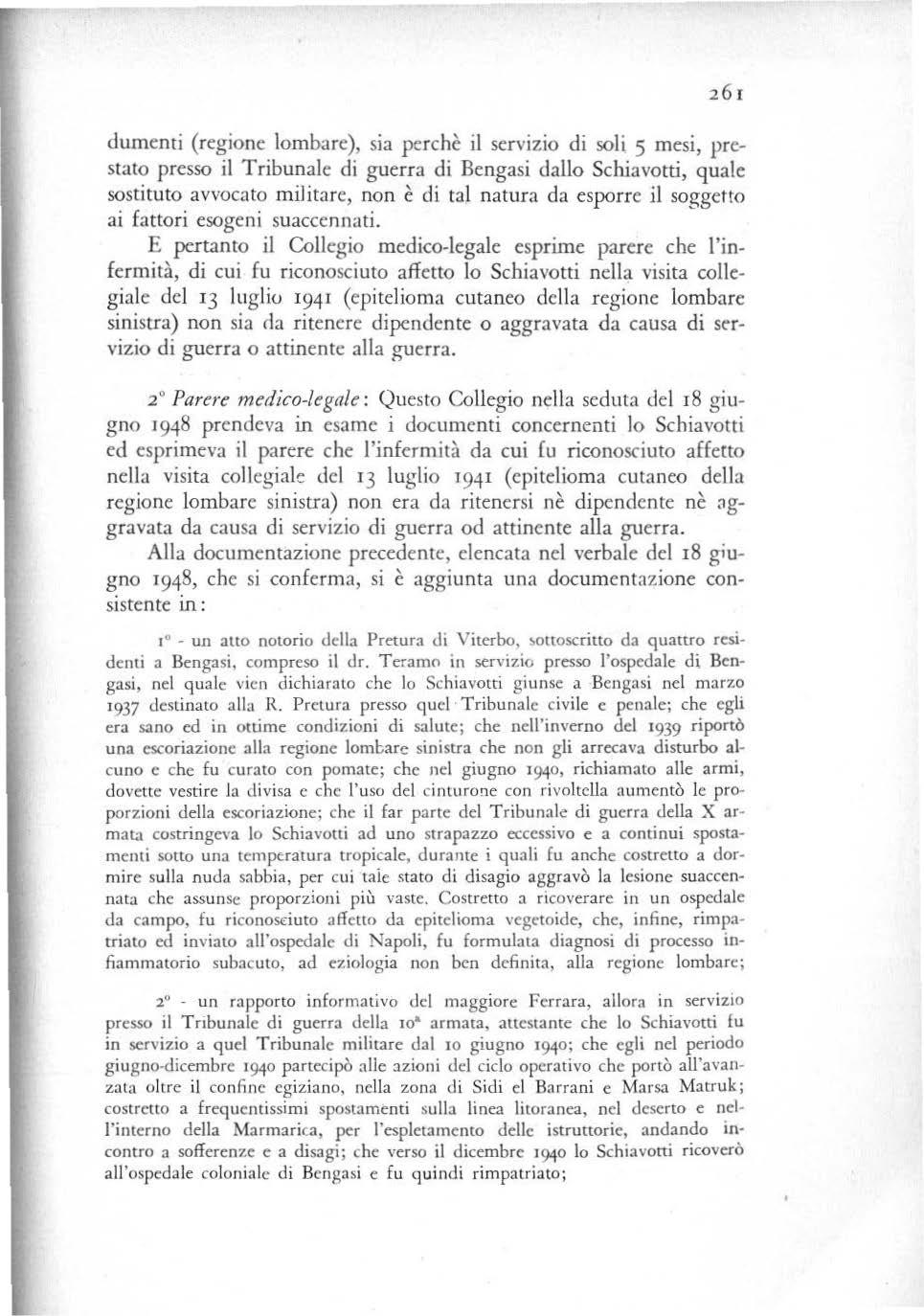
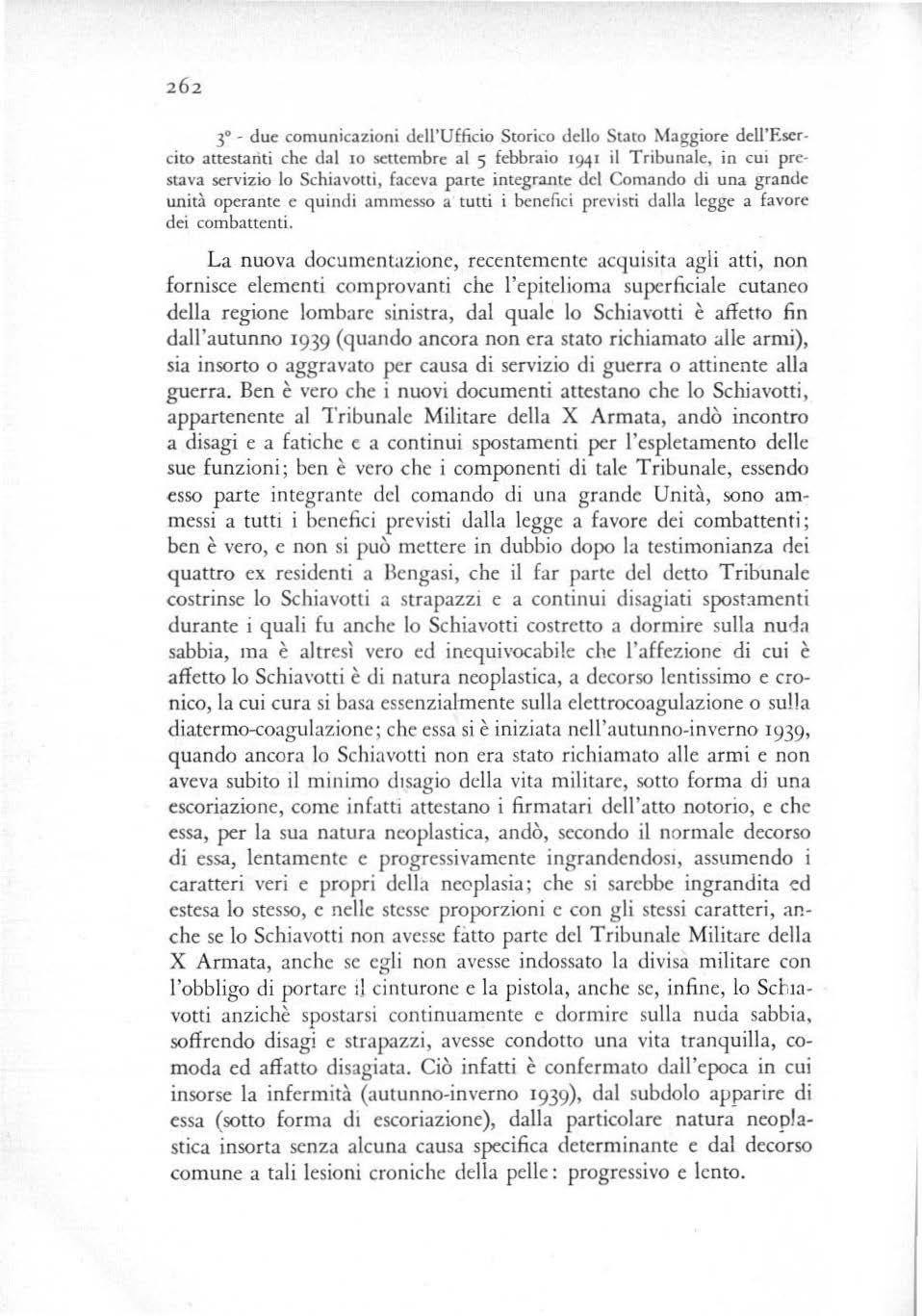


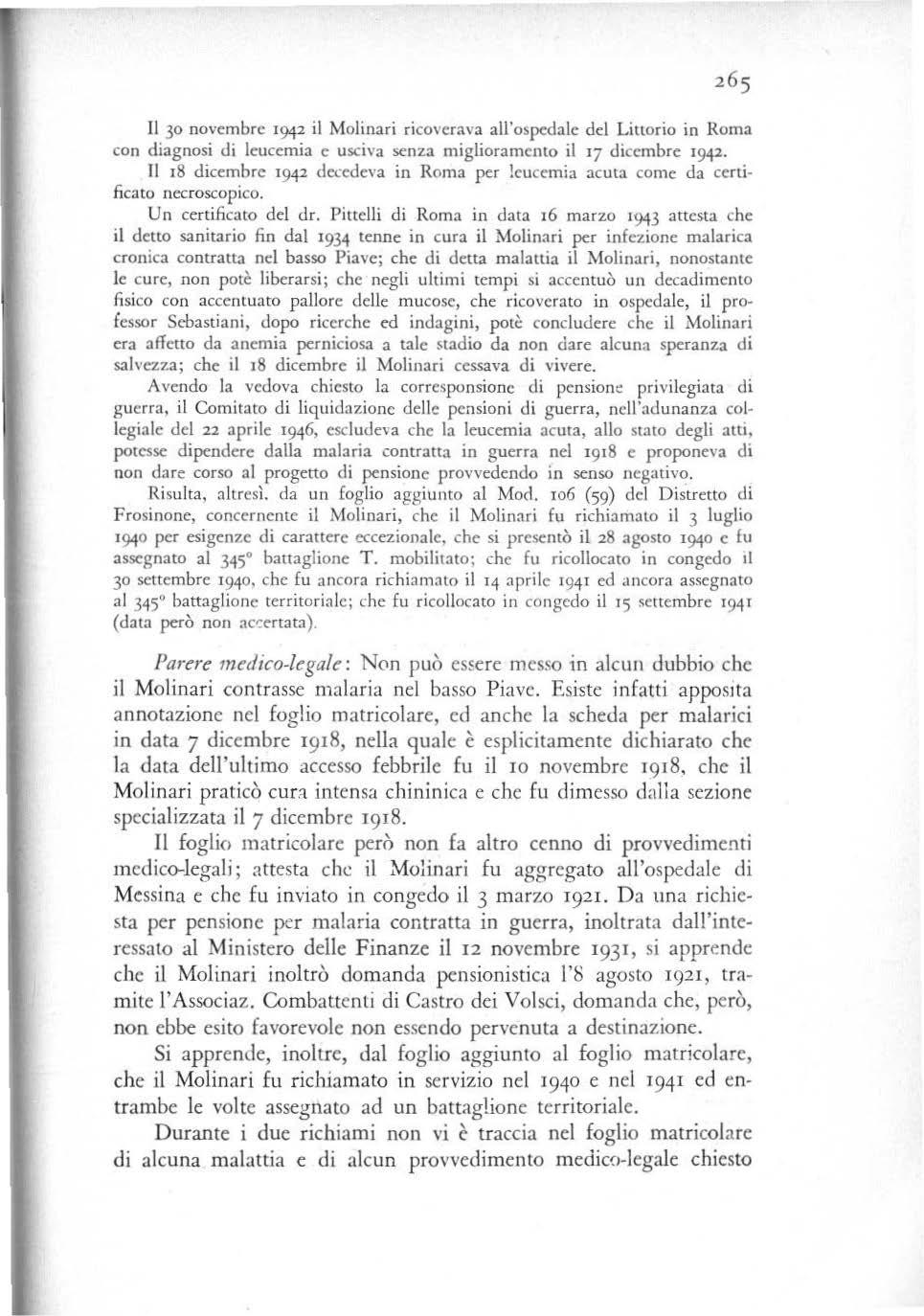
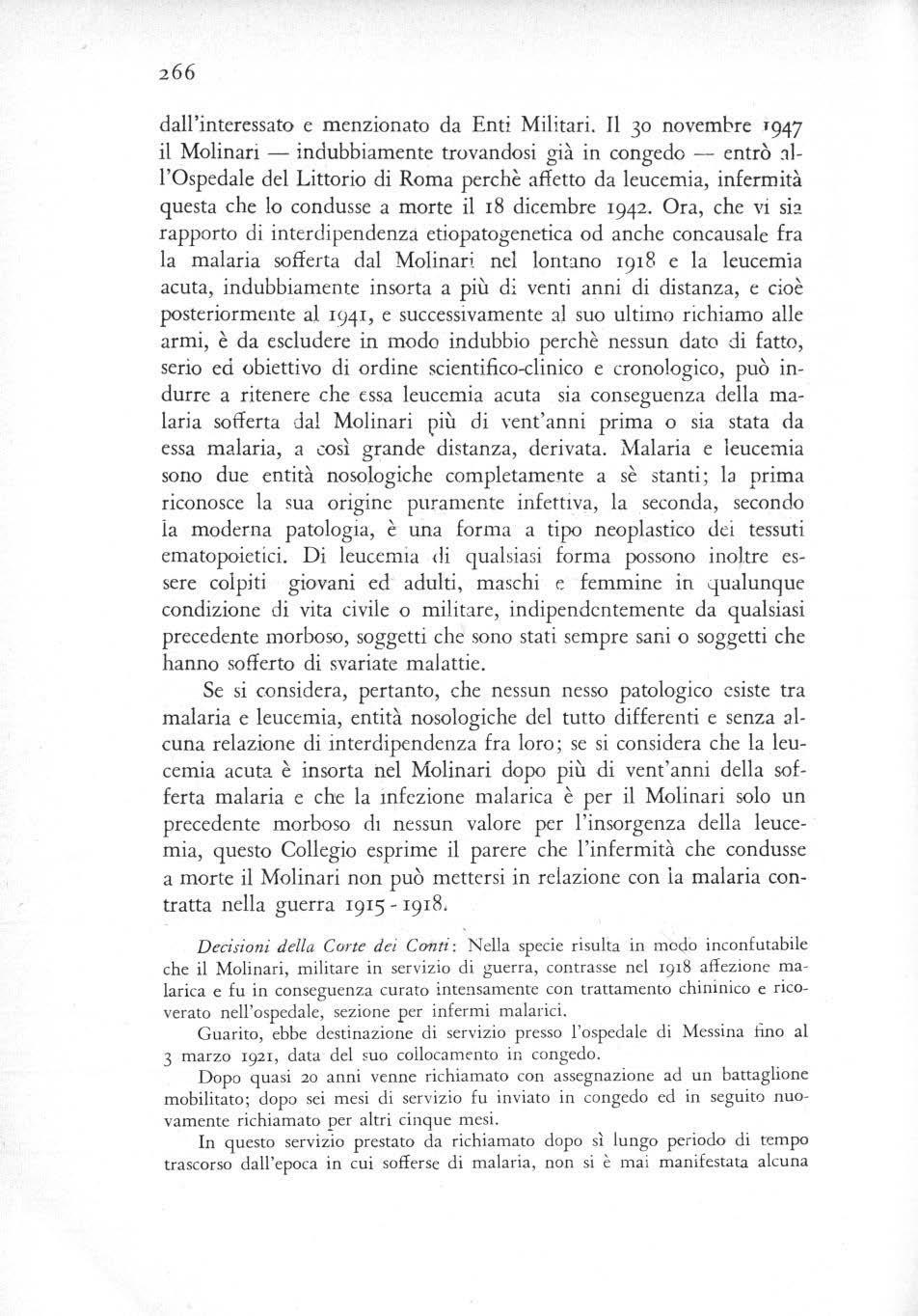


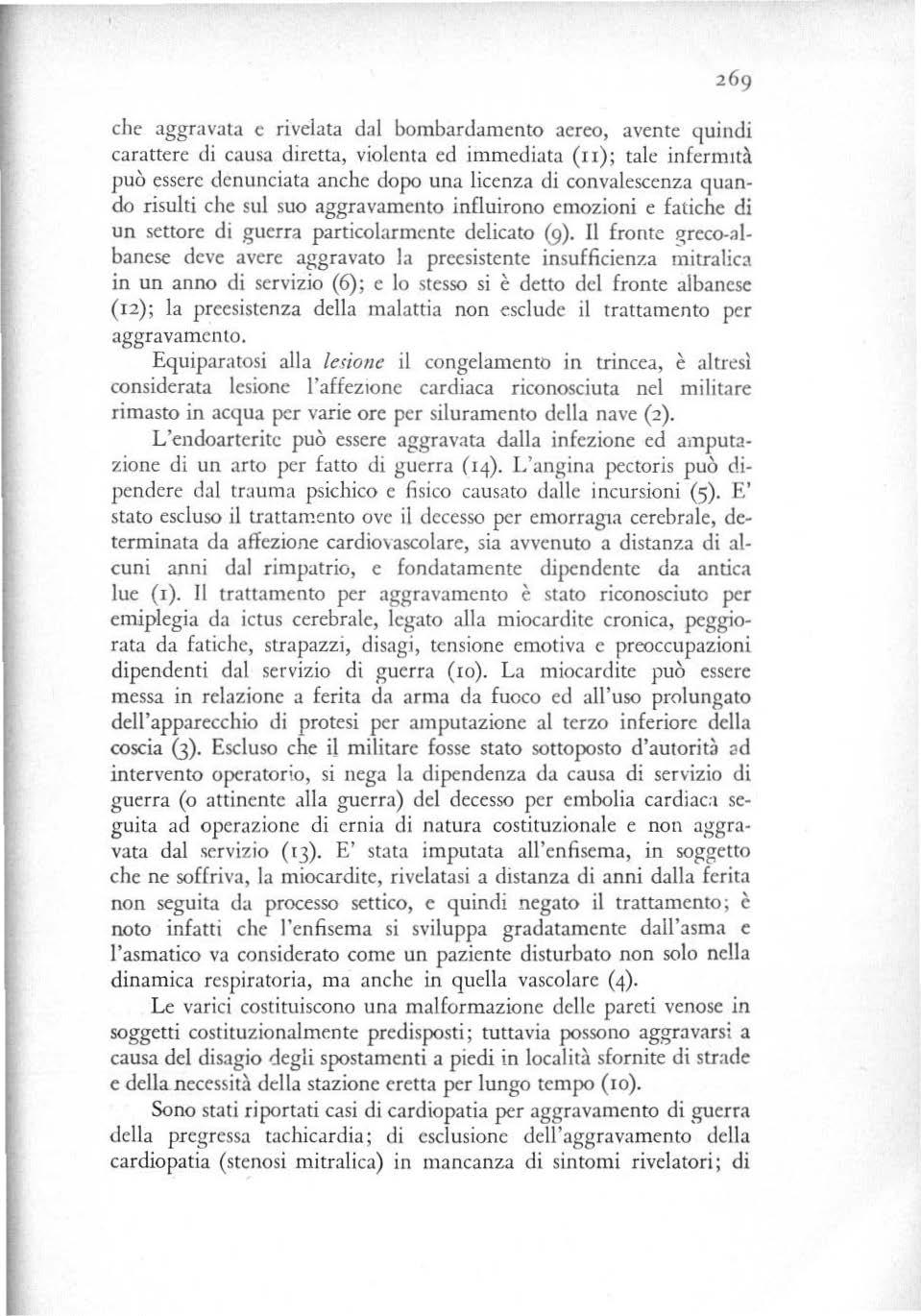

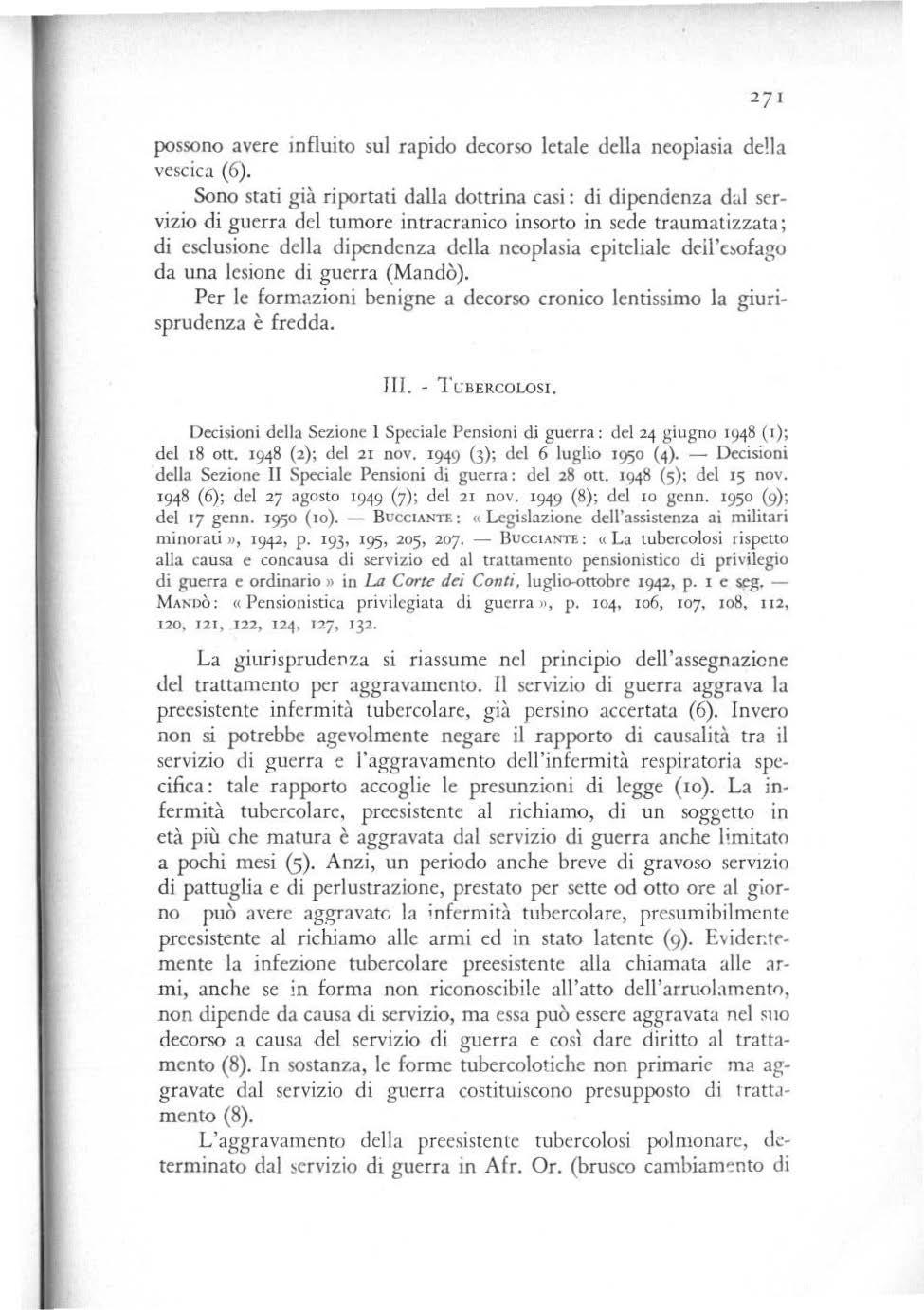
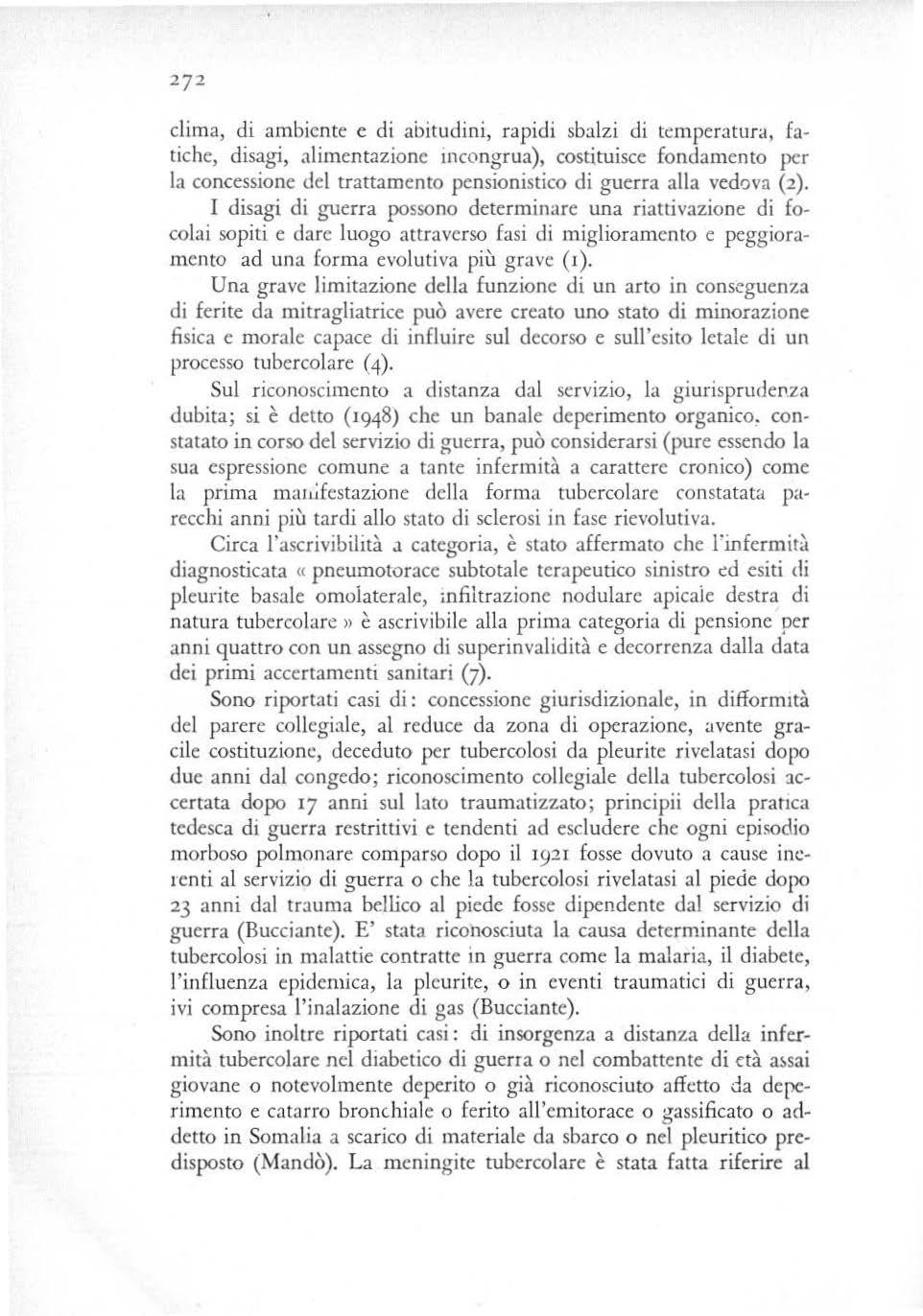
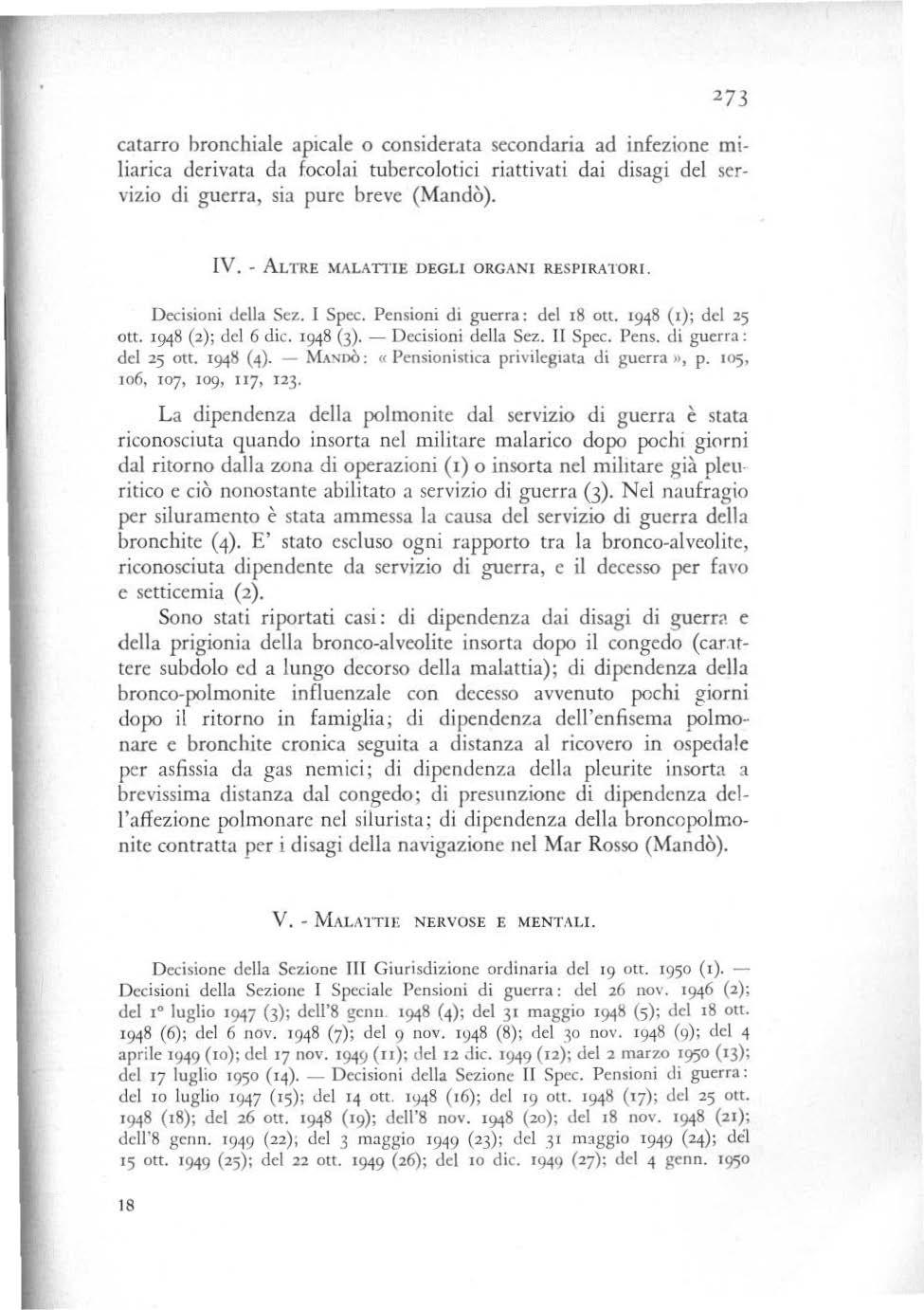
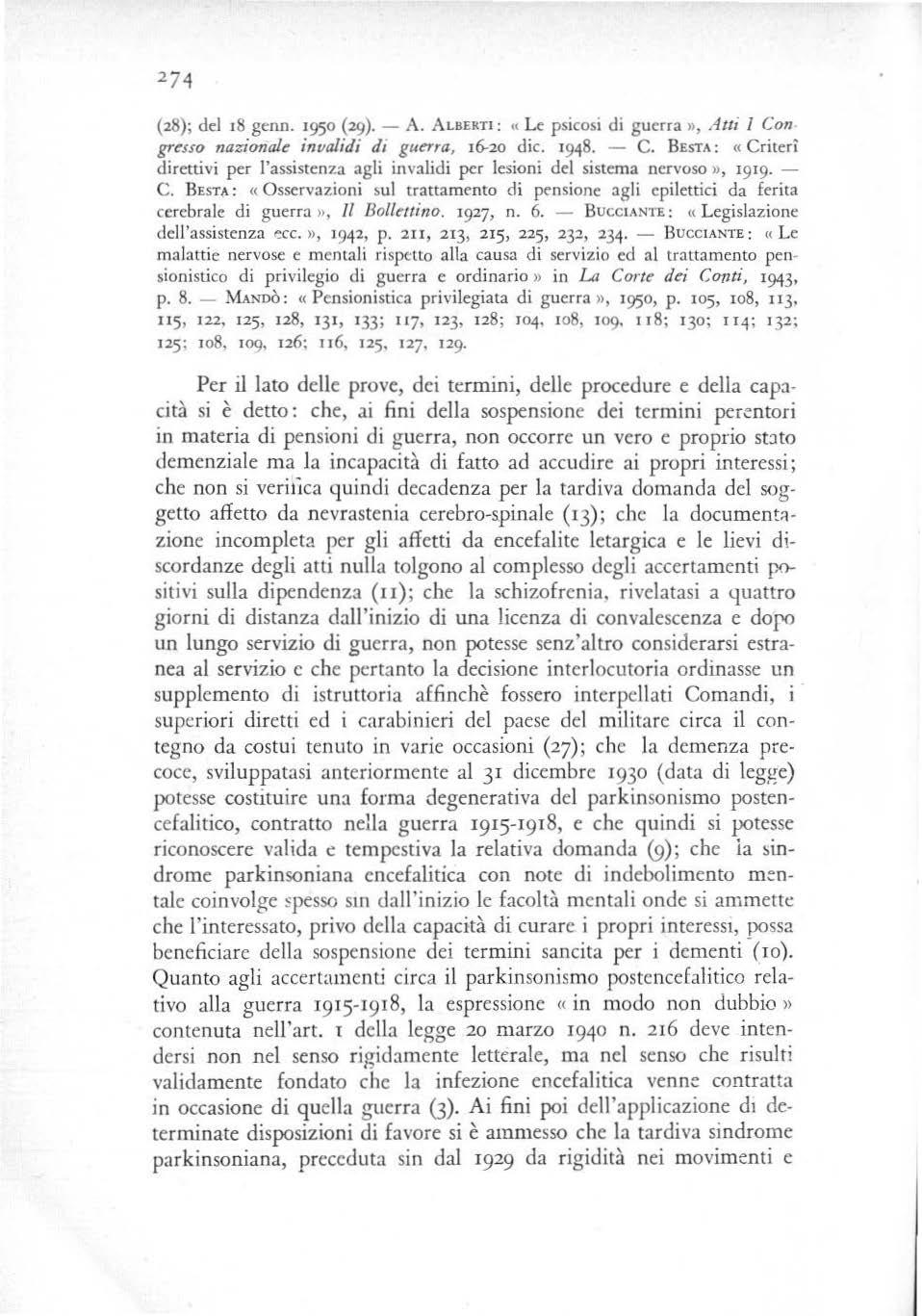
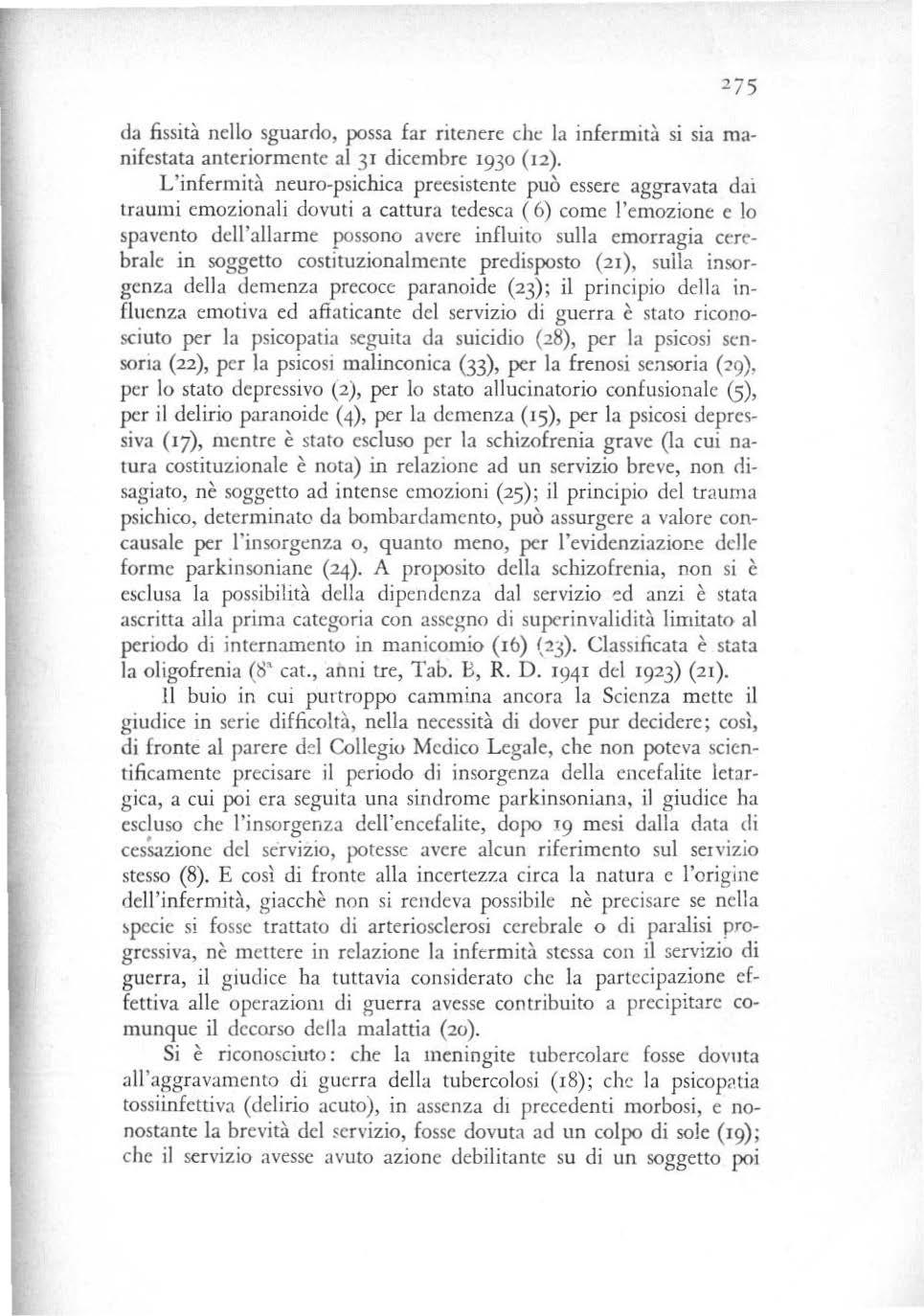

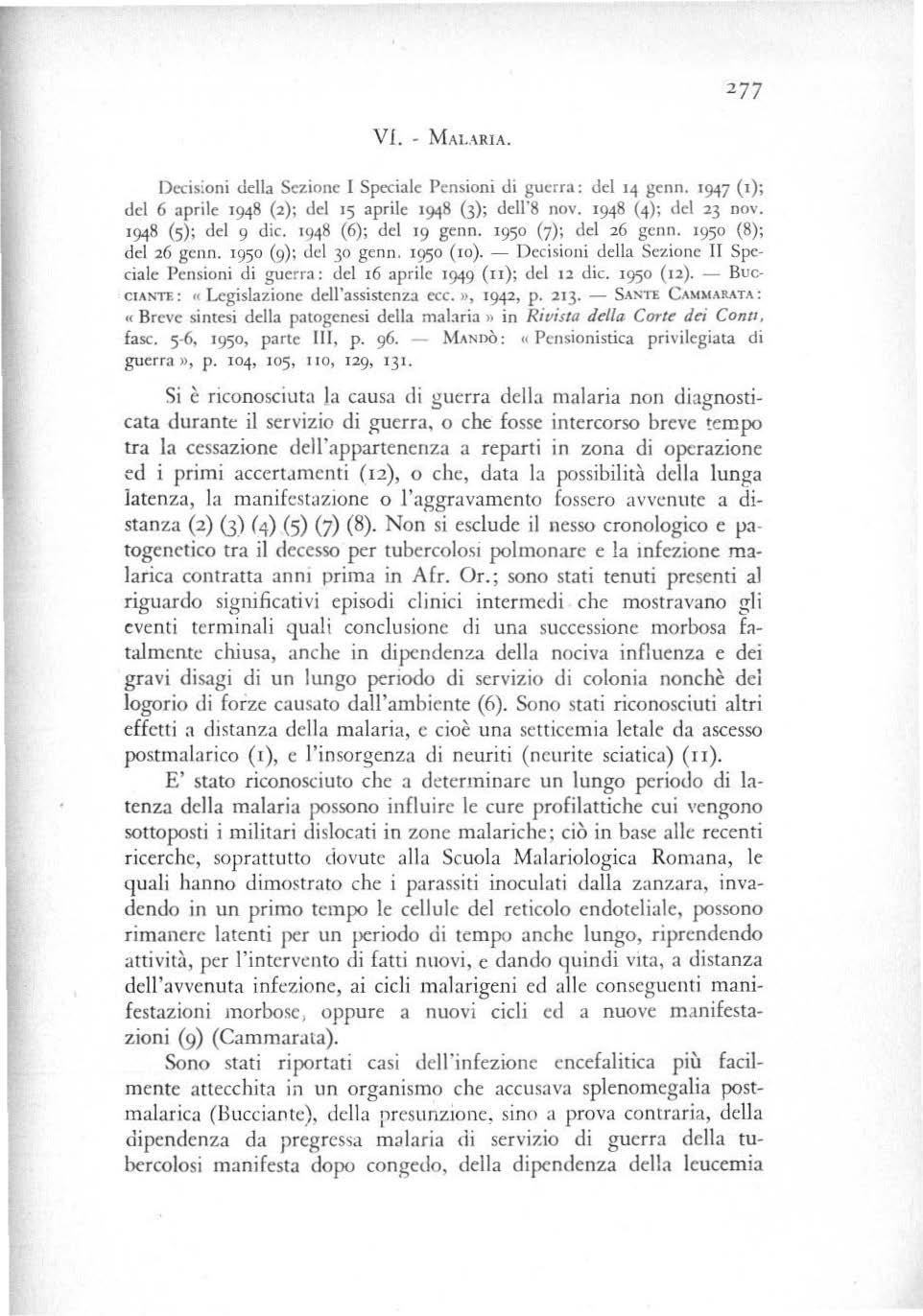

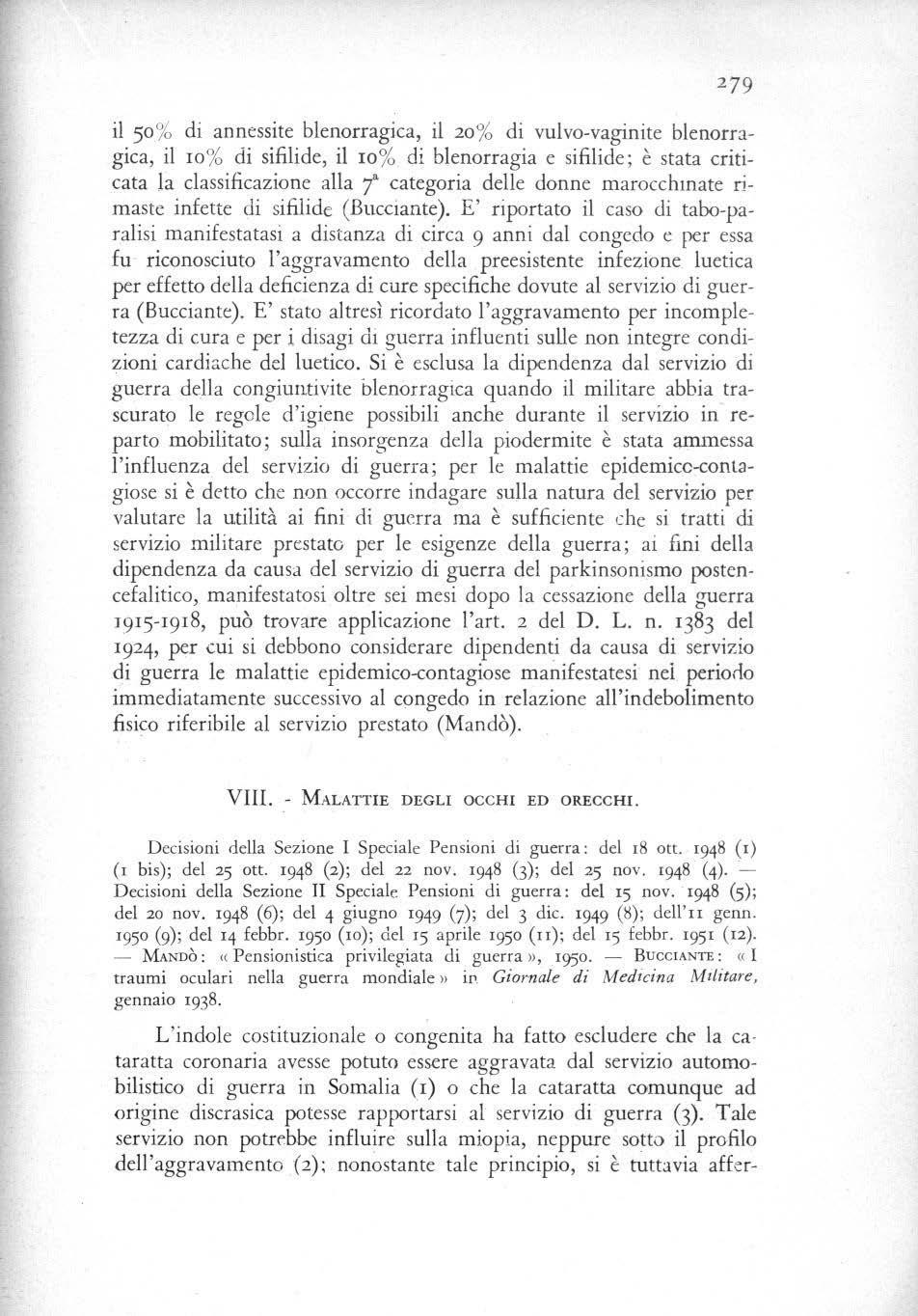 VIli. - MALATTIE DEGLI OCCHI ED ORECCHI.
VIli. - MALATTIE DEGLI OCCHI ED ORECCHI.